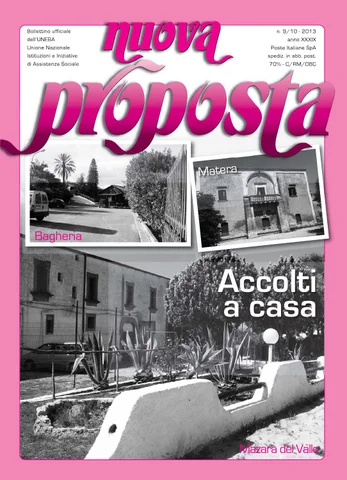Bollettino ufficiale dell’UNEBA Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale
n. 9/10 - 2013 anno XXXIX Poste Italiane SpA spediz. in abb. post. 70% - C/RM/DBC
Matera
Bagheria
Accolti a casa
Mazara del Vallo
Palermo: ritrovarsi a “casa” L
a “Casa dei gi ovani ” di Palermo è una ONLUS attiva dal 1983 (dal 1985 è un’associazione riconosciuta) che ha come principale scopo statutario quello di dare ai propri utenti supporti mirati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dal disagio sociale. E’ presente sul territorio nazionale con tre Centri residenziali, quattro Centri di accoglienza, il “Progetto Maddalena” rivolto a donne vittime della “tratta” e della prostituzione (D.Lgs. n. 286/1998), un Centro di prima accoglienza per soggetti tossicodipendenti in fase attiva e HIV positivi, due Progetti volti al reinserimento socio-lavorativo di ex tossicodipendenti, la Comunità alloggio “Casa Amaltea” per minori abusati-trascurati-maltrattati. Come facilmente intuibile, l’Associazione svolge un’attività complessa e molto vasta sia - e soprattutto - riguardo al numero degli assistiti sia a quello di operatori con professionalità specifiche. Come traccia e invito per ulteriori approfondimenti (gaetanolopiparo@casadeigiovani. it - tel. 091 903068 – www.casadeigiovani.it) richiamiamo, con qualche annotazione, alcune iniziative.
Centro di pri ma accogl i enza Attivo dal 1997, opera con il supporto dell’Amministrazione pubblica rivolgendosi a tossicodipendenti e soggetti HIV positivi che non hanno ancora elaborato il bisogno di un percorso terapeutico per liberarsi dai condizionamenti indotti dall’uso di droghe. Attualmente ha in carico 530 utenti. Centri semi resi denzi al i per soggetti di pendenti da sostanze d’abuso Gli interventi di terapia dinamica e i supporti alle In copertina: Alcune strutture della “Casa dei Giovani - Palermo
2
necessità di vita quotidiana, oltre che ai giovani tossicodipendenti, si rivolgono ai problemi delle loro famiglie. Una specificità dell’Associazione è quella riservata a condannati con pena definitiva e a soggetti in attesa di giudizio. Comuni tà terapeuti che resi denzi al i per soggetti di pendenti da sostanze d’abuso Quanto praticato nei centri semiresidenziali trova qui maggiore continuità e completezza, normalmente per la durata di un biennio, con attività ancorate particolarmente alla terapia individuale e di gruppo, alla ergoterapia (agricoltura, artigianato, zootecnia, giardinaggio), alla formazione professionale (licenza media inferiore) e lavorativa vera e propria. Tali comunità si trovano a Bagheria, Mazara del Vallo, Matera (che realizza un interessante interscambio tra Sicilia e Basilicata). Progetto “Maddal ena” E’ nato a Palermo nel 2001 (sinergia tra arcivescovado e prefettura) per far fronte alla piaga della “tratta” della prostituzione, soprattutto extracomunitaria, attraverso iniziative di protezione sociale, emergenza, accoglienza residenziale, assistenza giuridica, orientamento educativo-culturale. Progetto “Amal tea” E’ nato nel 2003 per dare consistenza a un progetto del comune di Bagheria rivolto ai minori (0-14 anni) che il Tribunale dei minorenni affida all’Associazione per dare loro ospitalità in quanto violentati o abusati oppure perché privi di un nucleo familiare ritenuto inadeguato ad offrire ai figli assistenza e tutela.
SOMMARIO 3 5 7 9 12 13 15 18 20 24
FAMIGLIA speranza e futuro per la società italiana Protagonisti del nostro futuro: i bambini… …‘E figlie so’ ffiglie… Fiducia: in via di estinzione? Sponsorizzazioni fra pubblico e privato Imprese e terzo settore CCNL Uneba: “deregulation” per il contratto a termine 5 per mille: le domande più frequenti Norme giuridiche e Giurisprudenza Colpo d’ala
FAMIGLIA
FAMIGLIA speranza e futuro per la società italiana L
’impressione che si riporta normalmente dalla partecipazione ad una S e t t i m ana S o c i al e de i C at t o l i c i It al i an i s i può s em pre ri as s um ere nell’antico detto: “Fa più rumore un albero che cade, che una foresta che cresce”. Si rimane impressionati, come già avvenne a Reggio Calabria tre anni fa, dal numero, dalla competenza, dalla generosità, dalla originalità e dallo spirito ecclesiale di tanti cristiani, soprattutto laici, che da ogni Chiesa italiana portano il loro contributo alla riflessione comune. Al di là delle relazioni e degli interventi ufficiali, il vero polso dell’assemblea si è potuto rilevare, a mio avviso, soprattutto nelle due mezze giornate di lavoro dei gruppi tematici, in cui si sono registrati più di 500 interventi appassionati, pertinenti e rigorosamente contenuti nel tempo di tre minuti. Questa volta il tema era di quelli particolarmente “sensibili” e decisivi, ma anche articolato e “trasversale”, in quanto non esiste ambito vitale in cui il “fatto re fami g l i a” non abbia il suo ruolo primario e insostituibile. Il rischio, come è stato rilevato da un vescovo, è che possa essere considerato come un problema “dei cattolici”, una bandiera sotto la quale si ritrova una certa parte della società italiana, idealmente ben caratterizzata e individuabile.
3
Certo, la visione cristiana del mondo e della vita fornisce delle motivazioni originali e stringenti per porre all’ordine del giorno una tale questione, ma è anche evidente che nessuno può sentirsi ad essa estraneo e indifferente, poiché occuparsi della famiglia coincide con l’occuparsi del “bene comune”, anzi, proprio dalla famiglia si può comprendere il significato di “bene comune”, che non è la somma ma il prodotto dei tanti “bene di ciascuno”. Si è venuto delineando un quadro della situazione della famiglia italiana che si potrebbe a buon diritto definire paradossale, in cui a principi precisi, condivisi e, a
volte, altisonanti, fanno riscontro normative, prassi e situazioni di fatto decisamente di segno opposto. Nella prima delle relazioni introduttive, quella della prof.ssa Lorenza Violini, si è preso in esame l ’aspetto l egi sl ati vo, in cui il dettato degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione è apparso essere stato in gran parte disatteso e corre oggi il rischio di essere radicalmente posto in discussione. Fatto è che alcuni termini, come famiglia, matrimonio o sessualità, all’alba della Repubblica avevano un’evidenza che oggi è venuta a mancare, in seguito alle profonde trasformazioni culturali in cui siamo tutti coinvolti. Il Card. Bagnasco, nella sua prolusione, ha lucidamente analizzato due processi di fondo che minano alla base l’istituto familiare: la messa in questione del dato naturale della sessualità, che viene ricondotta ad una mera autopercezione individuale e la caduta del dialogo intergenerazionale, con la conseguente cri s i del rappo rto educati v o . A questo proposito si è osservato che la questione è anzitutto culturale, prima che giuridica e che il tema della persona precede quello della famiglia, per cui la domanda: “Quale mondo lasceremo ai figli?” si può capovolgere nel suo reciproco: “A quali figli lasceremo il mondo?”. Il secondo ambito da cui emerge una prospettiva preoccupante è quello demo g rafi co , illustrato con chiarezza scientifica dal prof. Gian Carlo Blangiardo, Ordinario di Scienze statistiche. La famiglia, luogo di costruzione del futuro, fonte primaria di nuova vita, non riesce più ad assolvere a questa sua insostituibile funzione: l’Italia si distingue rispetto alla media europea per bassa natalità, il forte invecchiamento della popolazione, per cui “se è vero che già qualche anno fa si è assistito al sorpasso dei nonni sui nipoti – avendo
FAMIGLIA 4
gli ultra 65enni superato di numero i residenti meno che ventenni – è altrettanto vero che in un prossimo futuro osserveremo il sorpasso dei bisnonni sui pronipoti: a partire dal 2028 la popolazione ultra80enne sarà più numerosa di quella con meno di 10 anni” (Blangiardo). Sono dati che lasciano trasparire un certo comportamento tipico della famiglia italiana: dovendo affrontare situazioni come la disoccupazione, soprattutto dei giovani, la diminuzione del reddito, la riduzione della spesa pubblica per il welfare, la famiglia italiana tende a chiudersi in se stessa e, trincerata dietro le proprie risorse, fa fronte alla crisi rimandando la decisione di avere un figlio e lo stesso matrimonio. I sociologi ormai parlano, a fronte di questa situazione di un “suicidio demografico” dell’Italia, come ha affermato il prof. Luca Antonini, dell’Università di Padova. Tutto questo aggrava un ulteriore paradosso nel campo socio-economico e delle politiche familiari, per il quale, a fronte di ruolo sempre maggiore di ammortizzatore sociale, da tutti riconosciuto alla famiglia, fa riscontro un sempre minor numero di provvedimenti presi a suo sostegno, con una spesa pubblica a lei destinata pari al 4% del PIL in Italia, mentre è dell’8% nel resto di Europa. Amaramente ironica è risuonata l’iniziativa provocatoria della Caritas di una diocesi del Nord, che ha pubblicato recentemente un opuscolo dal titolo “Dieci buone ragioni per non sposarsi”. Il prof. Stefano Zamagni ha rivendicato alla famiglia la qualità di soggetto, non solo dotato di propria personalità giuridica, ma anche di forte ri l ev anza eco no m i ca, in quanto l’impresa non è solo quella capitalista, ma ogni realtà che genera valore e la famiglia non è solo consumatrice, ma anche produttrice di capitale umano e sociale. Le proposte avanzate per riequilibrare la situazione vanno dall’ambito fiscale, con il riconoscimento anche graduale del Fattore Famiglia, una maggiore simmetria delle tariffe ed equità intergenerazionale, a quello istituzionale, con la proposta di riconoscere il diritto di voto dalla nascita, esercitato dai genitori del minore, con la creazione del Distretto Famiglia, delle Alleanze locali per le famiglie, del Marchio Famiglia, della Giornata Nazionale della Famiglia, a quello socio-economico, con una più attenta redistribuzione delle risorse, meno scarse di quanto si pensi, con
l’armonizzazione dei tempi di lavoro e tempi di vita familiare, con la ricerca di modelli organizzativi family-friendly, che, in ultima analisi, risultano economicamente vantaggiosi per l’impresa stessa. L’esigenza emersa indistintamente in tutti i gruppi di studio è stata quella di promuovere un sempre più esteso e capillare lavoro “in rete”, una sempre maggiore responsabilizzazione, con il passaggio da una logica assistenzialistica a una logica “abilitante”, un crescente coinvolgimento, a partire dalle nostre comunità cristiane, con il compito, che si rinnova ad ogni Settimana Sociale, di far giungere le tematiche, i contenuti e le proposte del lavoro assembleare nei luoghi e nei tempi della pastorale ordinaria. Ciò è tanto più urgente, quanto maggiore è il rischio che nei nostri stessi ambienti continuino a sussistere lentezze nel percepire le nuove sfide che la famiglia è chiamata ad affrontare, come si è rilevato nei gruppi che hanno riflettuto sugli ambienti di vita e sulla salvaguardia del creato, insieme a preconcetti e pregiudizi, che non ci sono estranei, come riguardo alla necessità di un cammino comune con le famiglie immigrate. Su questi temi siamo tutti chi amati i n causa e tutti partecipi della stessa missione, come ci è stato ricordato nella conclusione di Mons. Arrigo Miglio, Presidente del Comitato Scientifico e Organizzatore, con la specificità di essere portatori di un Valore Aggiunto: l’Amore, che ci precede, ci è donato e ha il volto concreto di Gesù Cristo, da rendere presente in ogni periferia umana, secondo la felice espressione di Papa Francesco. Senza dubbio, oltre tutti i contributi di idee raccolti in questi intensi giorni, proprio Papa Francesco può insegnare alla Chiesa italiana ciò che è più importante e decisivo: l’atteggiamento e lo stile necessari per svol gere i l propri o servi zi o all’intera società nella promozione e valorizzazione della famiglia. Vale a dire la capacità di ascolto e di attenzione a tutti, la disponibilità semplice alla condivisione e alla collaborazione, la speranza cristiana gioiosa ed esigente, che sono i segni distintivi dell’opera dello Spirito del Risorto nel cuore di ogni credente. Vi ncenzo Api cel l a V escovo di V elletri - S egni
MINORI
Protagonisti del nostro futuro: i bambini… di Giovanni Santone
U
na buona notizia a fine marzo 2013: la quinta “D” della scuola elementare Grimani di Marghera-Venezia ha vinto una gara promossa dall’Assessore regionale all’identità veneta; premio 1000 euro allo spettacolo presentato all’Auditorio di Ca’ Foscari di Venezia di canti e dialoghi in dialetto veneziano, che racconta di un uomo che si sente solo in una nuova città e ricorda la nonna veneziana. Quale la novità? Gli attori sono 26 alunni di cui ben 15 stranieri, la maggior parte nati in Italia. C’è da riflettere sulla sorpresa di una maggioranza di ragazzi non veneti (e neppure cittadini italiani) che vincono un premio sull’identità veneta. Mi chiedo se aveva ragione Montanelli, quando diceva anni fa che dobbiamo prendere atto che siamo un popolo di bastardi, nel senso di incrocio di razze e di culture. Il messaggio è il seguente: quando occorre ancora aspettare per dare la cittadinanza ai bambini stranieri che ci danno una lezione sulla parola “identità”? Eppure le sollecitazioni autorevoli ci sono state. Ricordo che sull’argomento della cittadinanza dei bambini stranieri nati in Italia la Presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini (intervista a Otto e Mezzo di Lilli Gruber del 24 marzo c.a.) ha indicato tale diritto tra le priorità da affrontare. E precedentemente il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (era il 22 novembre 2011) aveva sollecitato il Parlamento ad affrontare la questione dei bambini stranieri nati in Italia, superando il principio dello ius sanguinis con quello dello ius soli (vedi articolo Minori stranieri: diritto di cittadinanza in “Nuova Proposta” n. 3-4/ 2012).
5
E’ ancora attuale parlare dei bambini e del loro diritto ad avere una famiglia, ma soprattutto del principio che i figli sono tutti eguali, senza alcuna distinzione, e non sono proprietà degli adulti. Questo è stato ricordato in occasione dei 20 anni della Convenzione ON U sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata il 20 novembre
1989. Al riguardo Nuova Proposta nel numero 1/2010 ha pubblicato materiali interessanti, frutto di iniziative e dibattiti, auspicando il rilancio di una politica per i minori e le loro famiglie. Lo stesso messaggio si riscontra nelle note dal titolo Disagio sociale di bambini e famiglie, pubblicate da Nuov a Proposta nel numero 3-4/2011, preoccupazione ripresa successivamente nel numero 11-12/2012 sul rischio povertà (in aumento) di bambini e famiglie. Bambini tutti eguali, senza alcuna distinzione, sostegno alle famiglie in difficoltà, diritto del minore ad avere una famiglia (innanzitutto quella naturale e, in caso non esista o sia inadeguata, una famiglia sostitutiva mediante l’adozione), sono questi gli obiettivi sacrosanti ancora da raggiungere. Ma in concreto cosa accade? I buoni propositi spesso si scontrano con disorganizzazione, confusione di ruoli, assenza di risorse (non solo economiche), ma soprattutto mancanza di adeguata e aggiornata competenza ai vari livelli. A ciò si aggiunga che il disprezzo più grande della dignità dei bambini avviene quando vengono utilizzati, senza alcun rispetto della loro persona, come oggetto di contesa tra i genitori. E’ questa la vicenda del bambino Leo di Cittadella (PD), anni 10. Una guerra, iniziata qualche mese fa, che giornali e televisione hanno continuato a sfruttare, ora sostenendo le ragioni della madre (la Cassazione con sentenza del marzo scorso ha restituito il bambino alla madre, che con i familiari, armati di telecamera, sono andati a prelevarlo alla comunità cui era affidato). Come è stato notato, in 5 mesi Leo ha cambiato letto ben 3 volte: madre, comunità per minori (sotto vigilanza del papà), ancora madre. E tutto ciò senza che il bambino abbia avuto la possibilità, come pare, di dire la sua, viste anche le reazioni non proprio tranquille del primo allontanamento, che tutti abbiamo visto trasmesse da varie TV. E tanto per ricordare: i soggetti protagonisti di questa paradossale vicenda sono stati: la giustizia (dal Tribunale
MINORI
MAMMA, MI UCCIDONO!
“M
amma, mi uccidono” hanno urlato i due bambini di 7 e 8 anni sottratti alla madre, come riferivano giornali e televisori lo scorso fine aprile. La vicenda è avvenuta a Battipaglia e l’allontanamento forzato è stato deciso dalla Corte d’appello di Salerno su richiesta del padre separato. I bambini ora sono stati ospitati presso una comunità per minori. E non è finita, se sarà interessata la Cassazione. Copia conforme è la vicenda del bambino Leo di Cittadella (Pd), anni 10, della quale si è parlato in questo articolo. Tutto ciò senza che il bambino abbia avuto la possibilità, così sembra, di dire la sua, come peraltro è successo con i due bambini di Battipaglia.
I soggetti protagonisti di queste paradossali vicende sono stati: la giustizia ( dal Tribunale per i minori, alla Corte d’Appello, alla Cassazione), gli Enti locali (servizi sociali dei Comuni), le forze dell’ordine, ma soprattutto ci ha sguazzato il mondo mediatico. Qualche interrogativo si pone: c’era proprio bisogno del clamore, senza alcun rispetto dei bambini, ignorati come persone? Non si potrebbe dare esecuzione (così si dice!) ai provvedimenti con più delicatezza, soprattutto da parte di operatori dei diversi organismi (forze dell’ordine e servizi locali e sociali) preparati e coordinati tra loro? E i mezzi di comunicazione non potrebbero evitare di trasmettere certe immagini, che vengono fornite dai genitori ( o loro clan familiari) in guerra tra loro e preoccupati solo di fare un dispetto all’altro coniuge, senza tener presente le conseguenze sui figli e sul loro futuro? In sintesi, come pubblicato da “Nuova Proposta” n. 3\4-2013, non dimentichiamo di mettere “I bambini al primo posto” (è il titolo di un interessante articolo di Francesca Succu, che merita di essere riletto). G. S . per i minorenni, alla Corte d’Appello, alla Cassazione), gli enti locali (servizi sociali dei Comuni di Cittadella e di Padova), le Forze dell’ordine, ma soprattutto nella vicenda ci ha guazzato tutto il mondo mediatico. E continuerà ancora, perché la guerra non è finita, almeno in base a quanto dichiarato dalla responsabile della comunità di Padova, che si è sentita offesa per le valutazioni, non del tutto positive, da parte della madre e del relativo clan di parenti, per l’ospitalità presso la struttura. Chi pensa che la vicenda, derivante dal conflitto tra i genitori, fosse arrivata ad un traguardo, si sbaglia. Leggo sul Corriere della Sera del 21 maggio che la corte d’Appello di Brescia, su ricorso del padre, ha ribaltato la precedente sentenza nel modo seguente: collocamento principale del bambino presso il padre, che ne eserciterà la patria potestà. Non entro nei particolari del provvedimento. Al riguardo bene riassume il Corriere, “figlio diviso a metà. Un giorno a testa e due case. Lei decide lo sport, lui la gita”. Non mi dilungo sui particolari del provvedimento. Mi permetto un solo commento: ma è questo il bene che si vuole al bambino?
6
Se la situazione di Leo è eclatante, per una serie di avvenimenti che trascurano la persona del bambino, vi sono anche altre sofferenze che vengono inflitte ai bambini. Qualche esempio nella scuola. Può succedere che, al contrario di quanto detto all’inizio di queste note sull’integrazione nella scuola Grimani di Marghera-Venezia, i bambini “diversi”, anche solo per meno rendimento, vengano emarginati con una linea immaginaria che l’insegnante traccia
tra i bravi e i somari. Deve preoccupare quello che è successo quest’anno con la festa del papà in un asilo del quartiere Africano di R om a. I geni t ori chi edono l’abolizione della festa del papà, e pure quella della mamma, soprattutto per evitare situazioni di imbarazzo in quei bambini che non hanno genitori, si fa per dire, “regolari”, o quando imprudentemente la maestra chiede ai bambini, tra i quali vi sono anche quelli adottati, di portare a scuola una fotografia di quando erano nati. Annoto solo che per evitare errori del genere non sono necessari particolari corsi di formazione, ma semplicemente prendere atto che siamo in una realtà dove la famiglia è diversa da quella di una volta. Dai fatti accennati si possono trarre alcune considerazioni. Vi è una frantumazione delle competenze a livello di istituzioni che si occupano di minori: stato, regioni, enti locali, altri (es. ASL o addirittura comunità montane) che spesso tra loro non si parlano. Occorre chiarezza di competenze e di responsabilità, non solo dichiarate. Ma occorre anche preparazione e direi delicatezza anche da parte di quanti vengono chiamati ad eseguire provvedimenti, come quello di Cittadella. Mi riferisco a polizia dello Stato, locale e carabinieri. Perché non istituire una squadra sociale coordinata e opportunamente preparata? Al riguardo le comunità di accoglienza dei minori (di tipo familiare come prevede la legge 149/2001) non possono essere improvvisate e anche per esse si chiede personale preparato. Di seguito ancora qualche riflessione su
MINORI
quanti avvicinano i minori. Particolare specializzazione e superamento “delle disarmonie della separatezza degli organi giudiziari” sono obiettivi da perseguire con una riforma auspicata dall’Associazione Italiana Magistrati per i Minori e la Famiglia (AIMMF). Al riguardo è apprezzabile il documento dell’Associazione del 22 febbraio 2013, che, sulla base delle Linee Guida del Consiglio d’ Europa, indica al legislatore come pilastri portanti: - l’istituzione di un tribunale unico per la persona, i minorenni e le relazioni familiari, che accentri tutte le competenze; - presenza di personale specializzato e a composizione multi-professionale, opportunamente selezionato, preparato e aggiornato. Per una visione completa del documento si può consultare il sito www.minoriefamiglia.it. Prendo spunto dall’interessante documento per affermare che analoga visione complessiva dovrebbe essere realizzata nelle istituzioni pubbliche, che si occupano di minori
e famiglia, con l’accorpamento delle competenze nei comuni singoli (di certe dimensioni) o associati, senza dimenticare la necessaria preparazione e l’aggiornamento continuo di quanti operano nel delicato campo dei minori. Infine, richiamando anche il paragrafo del documento dell’AIMMF sulla fase esecutiva della pena per i minori (si dice giustamente che deve perseguire finalità educative) mi piace concludere con il forte messaggio di Papa Francesco il Giovedì Santo di quest’ anno, con la lavanda dei piedi dei minori (tra i quali anche stranieri e islamici) del carcere di Casal del Marmo. A conclusione rimane sempre attuale l’augurio del Papa prima di lasciare il carcere: “Avanti e non lasciatevi rubare la speranza”. Vale per i minori in sofferenza, ma anche per quelli in situazioni familiari difficili, senza dimenticare quanti (operatori pubblici e privati e volontari) operano in questo delicato campo del nostro futuro.
…‘E figlie so’ ffiglie… a proposito dell’equiparazione dei figli di Giovanni Santone
N
7
el lontano 1946 Eduardo de Filippo scrisse la nota commedia “Filumena Marturano”. La protagonista conclude con la celebre frase: “i figli sono figli e devono essere tutti eguali”. Così metteva a tacere la curiosità dei maschi con i quali aveva avuto le sue avventure amorose. Questo l’inizio di un riquadro a pagina 11 di Nuova Proposta n. 9-10/2012. E la nota proseguiva con l’elenco delle situazioni di bambini con meno diritti, meno tutele e comunque conosciuti come diversi (figli naturali, adottivi…), situazioni che si auspicava venissero superate. Sempre Nuova Proposta (n. 1/2007) ha ri-
portato alcune note scaturite in occasione della ricorrenza del primo anniversario della scomparsa, avvenuta il 18-11-2005, di Alfredo Carlo Moro. E’ stato commemorato l’alto magistrato, ma soprattutto si è ricordato Moro come profeta dell’infanzia, giudice della persona e sostenitore del ruolo della famiglia, campione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Egli sosteneva che per difendere la famiglia non serve l’ideologia… e il termine famiglia non è limitato solo alla famiglia che si radica sul “coniugio”, ma si estende anche a quella che è investita di identiche responsabilità dei genitori nei confronti dei figli,
MINORI 8
sia legittimi che naturali. Sul pensiero di Moro molto materiale è disponibile presso la Fondazione Zancan di Padova. Quanto tempo è passato per arrivare ad una legge e successivo decreto legislativo (novembre 2012 e luglio 2013) sull’equiparazione tra figli naturali, adottivi e legittimi! In queste occasioni l’autocelebrazione di Governo e Parlamento è di rito. Nessuno si ricorda che la rimozione dei limiti all’equiparazione dei figli doveva esser fatta non appena emanata la Costituzione; non c’era quindi bisogno che ce lo ricordasse – come spesso avviene – anche l’Unione Europea. In breve i contenuti del decreto legislativo approvato nel luglio 2013. Si introduce il principio dell’uni tà del l o s tato di fi g l i o ; con questa norma non troveremo più le differenti definizioni di figlio “legittimo” (quello nato da genitori regolarmente sposati), di figlio “naturale” (nato da genitori senza il vincolo del matrimonio), di figlio “adottivo” (maternità e paternità non biologica). Conseguenza di questo principio è che la filiazione fuori del matrimonio ha gli stessi diritti all’eredità, ma soprattutto la parentela allargata svolgerà effetti positivi sulla crescita dei bambini, che avranno formalmente una cerchia familiare di nonni, zii e cugini, come tutti gli altri, superando la percezione da parte dei figli naturali e adottati di essere considerati di serie B. Coerentemente, l’ultimo provvedimento citato ha abolito la possibilità dei figli legittimi di soddisfare con danaro il diritto alla legittima dell’eredità dei figli naturali. Ma di fronte a questi aspetti positivi rimane una perplessità sulla soluzione adottata per i figli incestuosi (quelli concepiti tra parenti in linea retta o collaterale). In tali casi il riconoscimento avviene, previa autorizzazione del giudice (quale? Con quale provvedimento? Sulla base di quali elementi? Forniti da chi: esperti, avvocati, servizi sociali?). Si presume che si parli di figlio già maggiorenne, mentre per i minorenni il riconoscimento è autorizzato dal Tribunale per i minorenni. Non si capisce la logica e la motivazione di una tale decisione. Torna ancora il problema sull’esistenza di bambini con meno diritti e con una etichetta loro attribuita senza alcuna colpa. Se il problema è quello di conoscere le proprie origini, c’è già una norma che lo consente per i figli adottivi al compimento dei 25 anni (non basterebbe la maggiore età dei 18 anni?), ma
con le dovute precauzioni. Un’altra interessante novità è la sostituzione di “potestà genitoriale” con “responsabi lità genitoriale”. Al riguardo già anni fa, come citato all’inizio di queste note, Alfredo Carlo Moro, in occasione di seminari della Fondazione Zancan di Padova, aveva parlato di identiche responsabilità dei genitori. Al diritto del figlio di essere mantenuto, educato e istruito si aggiunge quello di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti. Inoltre si è esplicitato che in tutte le questioni che lo riguardano (esempio: scelta dell’indirizzo scolastico, affidamento in caso di separazioni e divorzi…) il minore, che abbia compiuto i 12 anni (e anche di età inferiore se capace di discernimento), ha diritto di essere ascoltato. Si spera che la norma eviti lo spettacolo, al quale si è assistito anche di recente, di bambini strappati dal genitore affidatario separato o divorziato. Non so se basterà una tale affermazione per cambiare una mentalità, che vede purtroppo ancora i figli come proprietà e non come persone. Un’ultima osservazione. Questa poteva essere l’occasione per mettere al suo posto un altro tassello: quello del riconoscimento della cittadinanza ai bambini figli di immigrati nati in Italia, di cui si è già scritto in Nuova Proposta n.3-4/2012. Al riguardo sempre più si riconosce ai bambini e agli adolescenti stranieri una integrazione nelle scuole e nelle attività educative e del tempo libero, ma si nega da parte delle forze politiche di prendere atto che i tempi sono maturi anche per l’equiparazione con i bambini italiani. In attesa l’UNICEF ha lanciato nel novembre 2012 un invito ai comuni italiani di concedere ai minori nati in Italia la cittadinanza onoraria, che si attribuisce a persone che hanno un forte legame con la città, come dimostrano i bambini nei luoghi che frequentano e nell’idioma con il quale si esprimono. E’ un gesto simbolico, che molti comuni, di differente colore politico, hanno già adottato, con il quale si rafforza la richiesta al Parlamento di approvare una legge che conceda la vera cittadinanza ai bambini nati in Italia. Come cittadini, come associazioni e come istituzioni private si può interessare il proprio comune ad adottare questa iniziativa, ripeto, simbolica, ma anche di sollecito a una soluzione formale del problema, del quale si sono fatti carico, anche di recente, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e quello della Camera dei deputati Laura Boldrini.
CITTADINANZA
Fiducia: in via di estinzione? di Alessio Affanni
EURISPES 2013 Il R ap p o rt o E u ri s p e s , pubbl i cat o all’inizio del 2013, dava indicazioni ormai note e la conferma è arrivata anche dagli orientamenti delle ultime elezioni politiche: la fiducia degli italiani nelle istituzioni è sempre più in calo. Probabilmente sull’andamento dell’indagine Eurispes aveva inciso anche la contemporanea resa incondizionata dei partiti a un governo tecnico (quello di Monti, che ricevette l’incarico proprio durante quei mesi) che ha avuto il compito di portare a termine il lavoro di risanamento del debito concordato con l’Europa, inclusa l’approvazione del “fiscal compact”, con approvazione trasversale sia del centro-destra che del centro-sinistra. L’investitura di quel governo tecnico da molti cittadini fu percepita come un’imposizione che non rispecchiava le
persone ai vertici della politica, con carriere di raccomandazioni e favoritismi. Se un tempo la politica coinvolgeva, appassionava gli italiani, oggi, in una “società impersonale”, si tende a dire che la politica logora il prestigio di chi la fa (di “onorevole” è rimasto solo l’appellativo). Per il 2013 si evidenzia un ulteriore peggioramento nel giudizio degli italiani nei confronti delle istituzioni e un grado di sfiducia che sale dal 71,6% del 2012 al 73,2% di quest’anno. Scorporando i dati per classi d’età, gli sfiduciati sono soprat t ut t o gl i ul t ras es s ant aci nquenni (76, 4%) e quelli tra i 45 e i 64 anni (75, 4%), s egui t i dai 35-44enni . D’altronde, sono le fasce d’età maggiormente toccate, per diversi motivi, sia dalla crisi economico-sociale sia dalle ulti-
NELL’ULTIMO ANNO LA S UA FIDUCIA NELLE IS TITUZIONI E’… Anni (Serie storica/Valori percentuali) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Aumentata 8,9 7,4 4,1 9,9 5,1 10,5 39,0 Diminuita 38,0 36,5 49,2 46,7 49,6 55,6 45,8 Rimasta invariata 51,5 53,9 44,1 40,0 40,7 32,6 14,1 Non sa/non risp. 1,6 2,2 2,1 3,4 4,6 1,3 1,1 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Tabella - Fonte: www.eurispes.eu
9
scelte indicate democraticamente con il voto elettorale ma, a ben vedere, le tuttora vigenti regole elettorali hanno favorito il crescente allontanamento dei cittadini da quel momento di massima rappresentatività. Sull’astensionismo ha influito moltissimo anche la condotta priva di etica, onestà e coerenza (in alcuni casi anche di decenza) di molti personaggi investiti di ruoli istituzionali (che in alcuni casi, quando non sono riconfermati si reinventano come “consulenti” delle amministrazioni pubbliche). Basti pensare che secondo un recente sondaggio il 77% degli italiani considera “mediocri” le
2011 2,2 68,5 27,5 1,8 100,0
2012 4,1 71,6 21,6 2,7 100,0
2013 5,3 73,2 19,1 2,5 100,0
me misure fiscali correttive. A livello geografico, il Nord-Est si segnala come l’area con il dato più critico: le istituzioni non raccolgono l’apprezzamento dei cittadini nel 76% dei casi. Leggendo i dati del Rapporto, si può vedere una spaccatura nel sentire degli italiani verso le più importanti realtà istituzionali del paese. Da un lato la fiducia pressoché unanime nei confronti delle Forze di polizia e di sicurezza e del volontariato: sono le realtà tangibili, calate nel presente, con le quali i cittadini quotidianamente si confrontano e dalle quali ottengono in cambio si-
CITTADINANZA curezza, aiuto e solidarietà nei momenti di difficoltà. Da un altro lato, invece, c’è una distanza dalla politica, dai partiti, dai sindacati, che dovrebbero costruire e progettare il futuro e che, invece, appaiono del tutto autoreferenziali e inaffidabili (ed in modo né inconsapevole, né incolpevole).
ISTAT 2013 Una seconda indagine sulla quale ragionare (pubblicata a maggio 2013 dall’ISTAT) è il Rapporto annual e (2013) sul l a si tuazi one del paese: giunto alla 22esima edizione, analizza le trasformazioni che interessano economia e società. Il Rapporto conferma che il paese è attraversato non soltanto da una profonda crisi economica, ma anche da una diffusa insoddisfazione dei cittadini verso la politica e le istituzioni pubbliche. La fiducia dei cittadini nelle istituzioni si conferma bassa: giudizi più positivi vengono attribuiti soltant o ai vi gi l i del fuoco e al l e forze dell’ordine, mentre i partiti politici sono a livelli minimi. La fiducia nelle istituzioni locali si colloca ad un livello intermedio: vivibilità del territorio e fiducia nelle istituzioni locali sono strettamente legate, sottolinea l’ISTAT. La possibilità di poter accedere a servizi pubblici di qualità e di godere di favorevoli condizioni socio-ambientali nell’area in cui si risiede hanno un impatto sul benessere, sulla soddisfazione dei cittadini e sulla loro fiducia nelle istituzioni, in particolare quelle locali.
CITTADINANZATTIVA E FONDAZIONE ETICA
10
Contestualmente, il R appo rt o s ul l a Tras parenza nel l e pubbl i che ammi -
ni s trazi oni (P.A.), di Cittadinanzattiva e Fondazione Etica ci conferma che mentre la corruzione dilaga, le P.A. sono ferme al palo sul versante della trasparenza. Che la corruzione in Italia continui a crescere, lo dicono ogni anno le classifiche di Transparency International: la graduatoria, compilata sulla base della percezione della corruzione da parte dei cittadini di 174 nazioni, segna un grave arretramento del nostro paese che rispetto al 2011 scivola dal 69esimo al 72esimo posto (peggio di noi, in Europa, solo Bulgaria e Grecia) ed i sondaggi sui cittadini italiani intervistati denunciano tuttora la pratica diffusa delle tangenti.
DICESI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Sappiamo anche che l’azione di contrasto delle istituzioni pubbliche è modesta: il Rapporto sul l a corruzi one i n Ital i a del Ministero per la Pubblica Amministrazione, presentato il 22 ottobre 2012, conferma che i delitti di corruzione e concussione scoperti e perseguiti sono sempre meno (311 nel 2009, 223 nel 2010) ma ciò può dipendere anche dalla diminuzione dei casi denunciati. La cosa più grave, dal punto di vista dei cittadini, è la carenza dei i dati relativi alla gestione dei servizi pubblici, cioè la principale area di informazione sulla quale la riforma del 2009 ha puntato per promuovere il controllo sociale dell’attività amministrativa. Ulteriori elementi considerati critici sono i tempi di conclusione dei procedimenti ed i tempi medi di pagamento, per i quali il grado di adempimento è decisamente basso. Per quanto riguarda le Regioni, nel Rapporto sono presentati i risultati del Rating Etico Pubblico (R.E.P.), promosso da Fondazione Etica: in generale il punteggio medio delle Regioni è basso. Al di sopra della media, in questa sorta di gara al ribasso sulla trasparenza, vi sono Toscana, Veneto, Lombardia, P uglia, Marche, Liguria, Abruzzo, Piemonte. Assoluta la mancanza di trasparenza anche nell’impiego delle risorse comunitarie, con l‘incapacità di acquisire e spendere le risorse provenienti dall’Europa e le conseguenti ricadute sulla produttività delle amministra-
CITTADINANZA
zioni pubbliche regionali e locali. Del resto, è notizia recente che in un ricorso difensivo presentato, in ambito europeo, da una Regione indebitata dall’acquisto di prodotti finanziari (i cosiddetti “derivati”) è stato anche indicato che non erano state comprese le clausole in inglese dei contratti che si stavano sottoscrivendo (!). Sul fronte della spesa pubblica, non è una buona idea continuare a ridurre i costi per l’istruzione: in un sistema economico, ciò ha ripercussioni negative sullo sviluppo tecnologico e produttivo, mettendo a rischio crescita e competitività. La formazione e l’utilizzo della tecnologia, che sembra essere lontanissima da alcuni ambiti della burocrazia in cui sono ancora in funzione metodi lavorativi ottocenteschi, consentirebbe probabilmente di utilizzare personale in eccesso su aree poco presidiate dallo Stato, quali ad esempio le infrastrutture, razionalizzando l’impiego di risorse e con un netto beneficio per le aziende e le attività produttive. Cosa pensare, in questo scenario, con l’attuale scarsità di risorse finanziarie? Quali proposte di riforma ipotizzare? C’è chi propone l’adozione di un modello di valutazione qualitativa e di misurazione del rendimento complessivo delle P.A. da parte di un organo esterno ed indipendente, che non interferisca sulla loro autonomia, ma non sia neppure soggetto alla loro discrezionalità nel fornire i dati. Trasporre tale esperienza in ambito pubblico significa non limitarsi a leggere i bilanci di un Comune o di una Asl, ma saper valutare anche la qualità del servizio svolto. In altri termini, preoccuparsi non solo di “quanto” spende la macchina pubblica, ma anche di “come” e “per cosa”. Lo scopo sociale delle P.A., infatti, non è il mero svolgimento di un servizio, ma il perseguimento del bene comune.
11
In una griglia di valutazione di una P.A., quindi, oltre al profilo economico e finanziario, gli indicatori potrebbero essere la sua governance (se c’è un organismo di controllo esterno, se c’è verifica degli obiettivi raggiunti), il rapporto con il personale (la formazione dei dipendenti, età media e di servizio, pubblicazione dei curricula), il rapporto con i cittadini/utenti (ad esempio, numero di sportelli per residenti, tempi medi di evasione di una pratica, livello di contenzioso), il rapporto con i fornitori (ad
esempio, trasparenza delle gare di appalto, tempi medi di pagamento), il rapporto con l’ambiente (ad esempio, quale tipo di approvvigionamento energetico e di smaltimento rifiuti). Tutti questi indici permetterebbero di avere un risultato che può aiutare a misurare le performances di ogni amministrazione e a capire meglio le criticità sulle quali intervenire (con una migliore allocazione delle risorse pubbliche). Per ora, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, il Codi ce di comportamento dei di pendenti pubbl i ci . E’ un Regolamento che indica i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
ANCORA ISTAT Concludendo la lettura del Rapporto ISTAT gli italiani appaiono arrabbiati e impauriti, a volte rancorosi, in una società con la tendenza a fare da spettatrice a quello che accade e che poi inveisce contro tutto e tutti. Se un tempo tutto si coagulava intorno all’appartenenza di classe e all’identità politica, oggi i fattori di tensione sociale sono individuati nel conflitto tra chi paga le tasse e chi non le paga (28,5%), tra autoctoni e immigrati (27%), tra ricchi e poveri (18%). Solo il 6% degli italiani avverte tensioni derivanti dalla diversità delle opinioni politiche. A tenerci insieme e a farci sentire vicini agli altri, secondo il 26% degli italiani, sono gli stili di vita simili, cioè fare le stesse cose nel tempo libero ed avere un rapporto simile con i consumi. Molto più che condividere valori fondamentali o l’appartenenza alla stessa generazione o vivere in prossimità o la comune dimensione politica o religiosa. C osa ci può suggerire, allora, il primo Rappo rto s ul benes s ere urbano equo e sosteni bi l e, pubblicato il 15 giugno scorso? Frutto del progetto U rBes coordinato da ISTAT e condotto insieme ad alcune amministrazioni locali, il Rapporto disegna la mappa della qualità della vita nelle realtà urbane d’Italia, analizzando con criteri e parametri innovativi il benessere degli individui e della società. Da questi indicatori, dunque, si può partire ed iniziare a discutere, per approfondire la riflessione su cosa voglia dire il benessere (e non solo nelle città) e quali misure si possono individuare, condividere ed applicare.
TERZO SETTORE 12
Sponsorizzazioni fra pubblico e privato di Sergio Zanarella
L
a sponsorizzazione, considerata quale rapporto di collaborazione fra impresa ed ente non profit, si caratterizza per l’abbinamento del nome, del marchio, del l ’i mmag i n e o del p ro do t t o di un ’i mp res a a un’iniziativa benefica e suscita crescente interesse sia da parte delle organizzazioni non profit, sia da parte degli operatori economici. La prima rinviene in essa, infatti, una modalita’ per il reperi mento di ri s o rs e, o anche di beni e servizi, da destinare al perseguimento dei propri scopi istituzionali; i secondi dimostrano di ritenere particolarmente proficua l’attività promozionale ottenuta dal sostegno di una specifica mi s s i o n di un ente no n pro fi t. Tuttavia nella pratica questo istituto viene uti l i zzato po co co ns apev o l mente da parte degli enti non profit, spesso anche confuso e sovrapposto al contributo liberale. Il Decreto 19 dicembre 2012 del Ministero dei beni culturali (Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate) fornisce una elaborazione dottrinaria in tale materia che può orientare l’azione di tutti gli operatori interessati all’applicazione del comp l es s o quadro n o rmat i v o at t ual men t e v i g en t e s ul l e sponsorizzazioni. Sulla base della definizione generale elaborata dalla dott ri n a e dal l e g i uri s p ruden za, i l co n t rat t o di sponsorizzazione può in via generale definirsi come negozio a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, stipulato tra due parti cosi’ definite: 1) lo sponsee (cioè lo sponsorizzato) che, nell’ambito di iniziative destinate al pubblico si obbliga a fornire prestazioni di veicolazione del nome, del marchio, dell’immagine, delle attività o dei prodotti di un altro soggetto (lo sponsor); 2) lo sponsor, generalmente un’impresa, che si obbliga, in cambio della suddetta veicolazione, ad una prestazione pecuniaria, ovvero ad assumere in proprio la realizzazione di lavori, servizi o forniture in favore dello sponsee. Semplificando, nella pratica avviene che il ruolo di sponsee è svolto dalle associazioni non profit e quello di sponsor dalle imprese, e l’oggetto del negozio atipico di s p o n s o ri zzazi o n e è l a p ub b l i ci t à p er i l qual e l’impresa si impegna a finanziare l’ente non profit o a provvedere direttamente alle attività richieste da quest’ultimo; men t re l ’o b b l i g azi o n e ch e g rav a s ul l ’o rg an i zzazi o n e n o n p ro fi t e’ di mezzi e non di risultato, dovendosi ritenere preclusa la possibilità per lo spon-
sor di dolersi dell’eventuale mancato ritorno pubblicitario. Peraltro, sebbene la causa comune a tutti i contratti di sponsorizzazione sia da identificare nella promozione dell’immagine dello sponsor, cio’ non deve condurre a confondere il contratto in oggetto con quello strettamente pubblicitario. Nei contratti di pubblicità, infatti, l’evento pubblicizzato deve essere semplicemente diffuso attraverso un determinato canale di comunicazione che ha la funzione quindi di puro contenitore e spazio di esposizione, nella sponsorizzazione, in particolare quella da noi ipotizzata in cui è presente un ente non profit, si realizza un vero e proprio processo di abbinamen t o o di as s o ci azi o n e, l eg at i al l a n o t o ri et a’ dell’evento o del soggetto che lo realizza, ed il canale comunicativo passa in secondo piano, con effetti potenzialmente molto più intensi o protratti nel tempo rispetto a quelli garantiti da una comunicazione pubblicitaria. Inoltre, se la pubblicità tende a privilegiare lo sviluppo e la creazione delle vendite del prodotto identificato ed abbinato al marchio divulgato, la sponsorizzazione è uno degli strumenti più utili per creare le condizioni migliori per la vendita promuovendo l’immagine dello sponsor e solo indirettamente i suoi prodotti. Date le caratteristiche descritte occorre che gli enti non profit siano bene attenti a verificare il contenuto degli accordi che sottoscrivono con le imprese private e verifichino di volta in volta se l’ente può stipulare un vero e proprio contratto di sponsorizzazione o un tipo di collaborazione diversa. L’esempio tipico che spesso si verifica è la pubblicazione di un giornalino da parte di una organizzazione di volontariato, finanziato dalle somme che le aziende versano per avere visibilità nella pubblicazione. Come spesso succede, le aziende che operano nello stesso territorio delle organizzazioni di volontariato vedono nelle pubblicazioni delle medesime un efficace veicolo di comunicazione pubblicitario, stante la capillarità della distribuzione del giornalino e l’attenzione che esso riscuote da chi – volontario, socio o donatore – lo riceve. D’altro canto le organizzazioni, anche per far fronte alle diverse spese di gestione (tra le quali quelle del giornalino), vedono positivamente l’interesse delle aziende. Da ci ò deri v a l a natura co mmerci al e del rappo rto , in quanto sorge un rapporto negoziale tra una parte che svolge una prestazione (l’associazione) e l’altra parte (azienda) che riconosce a detta prestazione un valore economico. Per cui rimane da interpretare se e come
TERZO SETTORE
sia compatibile un’attività commerciale con la veste della organizzazione di volontariato, partendo dalla L. 2 6 6 / 9 1 (Leg g e quadro s ul v o l o n t ari at o ) ch e el en ca all’articolo 5, c. 1 le sette tipologie di entrate dalle quali le organizzazioni di volontariato “traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività”. Detto elenco ricomprende alla lettera g) anche le “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali”, successivamente normate dal Decreto Ministeriale 25 maggio 1995 e tale elenco è da ritenersi esaustivo, per cui non possono essere ricomprese altre forme di entrata. Rimane tuttavia una possibilità lasciata dal tenore della lettera a) del comma 1 di detto D.M. (attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato) poiché è in parte sovrapponibile con le raccolte pubbliche di fondi operate in generale dagli enti non commerciali, raccolte che nel complesso delle attività risultano decommercializzate e escluse dall’IVA dal combinato dell’art. 143, c. 3, lett a), D.P.R. 917/86 e dall’art. 2, c. 2, D. Lgs. 460/97. Tal e prev i s i o ne di deco mmerci al i zzazi o ne può risultare utile in caso di sponsorizzazione attuata in concomitanza con le celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Qui entrano in gioco due elementi. Il primo è quello della occasionalità, il secondo è relativo ad una Risoluzione che a fine 2002 ha ammesso la possibilità – per le Onlus – di mettere in atto rapporti di sponsorizzazione nel solo caso questi si verifichino, appunto, in occasione delle raccolte pubbliche di fondi. E’ anche vero, però, che l’Amministrazione Finanziaria
afferma che “sarebbe tuttavia necessario evidenziare il carattere sostanzialmente liberale della causa negoziale, emergente in particolare dalla prevalenza della somma versata dall’impresa rispetto al valore economico della prestazione pubblicitaria ricevuta”. La contraddizione ci sembra stia nei termini. O si accetta che un negozio giuridico di certa natura commerciale (sponsorizzazione) venga “decommercializzato”, oppure si sta parlando di donazioni che non hanno alcuna necessità di essere decommercializzate. Comunque sia, la debole apertura dell’Agenzia delle Entrate può essere utile solo in un rapporto che preveda una prestazione (quella pubblicitaria) limitata a certi periodi dell’anno e in concomitanza di ricorrenze. Ciò potrebbe significare che in concomitanza a eventi di raccolta fondi / celebrazioni che prevedono conveg n i , ap p ro fo n di men t i , man i fes t azi o n i i n p i azza e quant’altro, si potrebbero prevedere un ringraziamento pubblico (anche per il mezzo del giornalino) per il sostentamento generale della giornata di sensibilizzazione, il rapporto sarà di donazione, magari modale (793 c.c.), cioè gravata di un piccolo onere. In questo caso è di particolare importanza la scrittura tanto dell’atto di donazione (che se non è di modico valore deve essere effettuata per atto pubblico), quanto delle formule di ringraziamento da apporre sul giornalino. Fuo ri da ques ti cas i , no n appare po s s i bi l e per un ’ o rg an i z z az i o n e di v o l o n t ari at o ricevere le somme a fronte di un servizio che implichi la sua disponibilità a pubblicare sul giornalino la propaganda di una o più aziende, né appare condivisibile rilasciare a fronte di tale complessa attività una ricevuta per contributo liberale da parte dell’ente non profit che riceve la somma di denaro, in quanto è palese il rapporto di sponsorizzazione che di fatto si è instaurato.
Imprese e terzo settore a cura di Sergio Zanarella
L
13
e aziende continuano ad orientarsi principalmente verso quella che viene definita “dimensione esterna” della CSR (Responsabil i t à So ci al e di Imp resa), p erch é p ro i et t at a all’esterno, verso le proprie comunità di riferimento. Al primo posto (66% delle aziende investitrici) le iniziative di solidarietà sociale e le azioni umanitarie che, visti gli accadimenti dello scorso anno, testimoniano la risposta immediata delle aziende alle diverse chiamate di emergenza. Un’impresa ha molti modi per essere social-
mente responsabile. Dai dati emergono tre evidenze importanti: la partecipazione delle aziende è soprattutto di tipo passivo, con oltre 1/3 del campione che si limita a fare delle erogazioni economiche e/o materiali; seppur s eco n dari o , n o n è cert o t ras curab i l e l’impegno delle aziende che hanno deciso di scendere in campo in prima persona mettendo a disposizione le proprie risorse o addirittura at t i v an do dei g rup p i di l av o ro i n t ern i ; l e aziende continuano a puntare, in maniera molto più incisiva rispetto a due anni fa, sulla diffusione di questo tipo di cultura anche fra i di-
TERZO SETTORE
pendenti: 1/3 delle imprese li ha coinvolti in maniera diretta e/o indiretta per sostenere il terzo settore. Dai risultati dell’indagine emerge sempre più chiaramente la “rivoluzione sociale” attualmente in atto. Le aziende cominciano a trasformare la propria scelta di fare del “buon business” in azioni sempre più concrete nel contesto sociale, politico e ambientale nel quale operano. Nella selezione delle iniziative su cui investire, quasi 3 aziende su 10 decidono di puntare sullo staff involvement, rivelando una maggiore propensione alla condivisione interna della CSR. Ma anche le credenziali dell’ente proponente/beneficiario (serietà e affidabilità) continuano a guidare le scelte degli imprenditori, che inseriscono una terza persona tra il proprio “dire e fare” (27%). Non manca, infine, quella fetta di aziende - circa 1 su 4 - che guarda in maniera meno altruista alla responsabilità sociale, lasciandosi guidare solo dalle prospettive di un ritorno in termini di reputazione. L’ultima indagine presentata dall’Istituto Italiano della Donazione è stata condotta nella prima metà di aprile 2012 su un campione di 153 imprese/enti/associazioni rappresentative delle oltre 1000 che hanno partecipato ad almeno una delle 10 edizioni del Sodalitas Social Award (2003-2012). Il campione è composto per il 76% da imprese e per il 24% da amministrazioni locali, associazioni imprenditoriali ed istituzioni pubbliche (ospedali, scuole, università…). Il campione delle imprese – diversificato per dimensione e fatturato – è composto per quasi la metà (47%) di imprese italiane operanti solo in Italia, per circa un terzo (30%) di imprese italiane operanti anche all’estero e per poco meno di un quarto (23%) di filiali italiane
di multinazionali straniere. La sostenibilità rappresenta un valore di riferimento per la quasi totalità (88%) delle imprese e delle istituzioni facenti parte del campione, a conferma che i partecipanti al Sodalitas Social Award rappresentano oggi nel nostro Paese una «pattuglia avanzata» per quanto ri g uarda l ’i mp eg n o s ul fro n t e del l a CSR/sostenibilità. L’impegno risulta in crescita per più aspetti: oggi c’è maggiore consapevolezza da parte dei vertici aziendali (90%), più coinvolgimento dei dipendenti (82%), maggiore integrazione nelle strategie (81%) e nell’operatività quotidiana (73%). La maggioranza delle imprese ha un codice etico (68%) e redige un Bilancio di Sostenibilità (55%) che nella metà dei casi è certificato da un ente terzo indipendente. Per la maggioranza delle imprese (54%) la crisi non ha avuto effetti di rilievo sull’impegno a favore della sostenibilità, per oltre un terzo lo ha accresciuto e solo per il 10% lo ha ridotto. E la prospettiva indicata da due terzi del campione è che questo impegno sia destinato ad aumentare ancora nei prossimi anni. In sintesi questa indagine mostra che la prospettiva della sostenibilità ambientale e sociale è considerata ormai un impegno non reversibile, destinato a divenire sempre più parte integrante della gov ernance e dunque del core business delle imprese. E si tratta di un impegno da cui - nel medio se non nel breve termine – ci si attende un ritorno anche sul piano dei risultati economici, per il contributo che può dare all’efficienza gestionale e all’innovazione di prodotto oltre che di processo. Tratto da http://www. istitutoitalianodonazione.it/it/indagini/indagini-enti-esterni
A PROPOSITO DI DONAZIONI…
L
14
a Legge n. 96/2012 detta norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti. Tale legge ha aumentato la percentuale di detraibilità fiscale per le erogazioni liberali in favore di partiti e di movimenti politici e, all’art. 15, ha esteso tale regime – si suppone senza volontà di assimilazione ma solo per evitare disparità di benefici – anche agli enti del terzo settore: si stabilisce infatti l’innalzamento dell’importo detraibile dall’imposta lorda, dal 19% al 24% per l’anno 2013, ed al 26% a decorrere dal 2014 per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, nei Paesi in via di sviluppo. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento tracciabili. Per i privati o le imprese che effettuino donazioni alle ONLUS resta, comunque, in alternativa, la possibilità di optare per la (più favorevole) deducibilità fiscale di tali erogazioni liberali, prevista dalla Legge 80/2005.
UNEBA
CCNL Uneba: “deregulation” per il contratto a termine I
l nuovo CCNL Uneba 8.5.13 ha una chiara impronta derogatoria rispetto a recenti riforme del mercato del lavoro. Le parti contrattuali, in sede negoziale, hanno infatti convenuto di dedicare la massima attenzione alla copertura delle assenze programmate o programmabili, puntando principalmente sul contratto a termine, nella consapevolezza che tale strumento fosse essenziale per gli Enti associati ai fini della garanzia di continuità del servizio. Rispetto al contratto a termine, il risultato contrattuale si configura come una serie di vere e proprie contro-riforme.
15
1 ° CONTRORIF ORMA: i nterv al l i tra un contratto a termi ne e i l successi vo L’art. 18 lett. g) del nuovo CCNL riporta indietro le lancette dell’orologio, stabilendo che gli intervalli nella successione di contratti a termine ritornino a 20 giorni (qualora il precedente contratto sia stato inferiore a 6 mesi) o 30 giorni (qualora il precedente contratto sia stato superiore a 6 mesi). La c.d. “Ri forma Fornero” (L.22 giugno 2012 n.92 art.1 comma 9, lettera g) aveva abnormemente dilatato l’intervallo obbligatorio fra contratti a termine. In particolare erano stati imposti 90 gi orni di pausa per contratti superiori ai 6 mesi, e 60 gi orni in caso di contratti fino a sei mesi. Tale intervento veniva enfatizzato come volto a “dissuadere” ovvero ad “intralciare” pratiche datoriali abusive. La riforma conteneva peraltro ipotesi di derogabilità a 20/30 giorni quasi del tutto inapplicabili ad un settore di servizi. Allo stesso tempo il D.L. 22.6.2012 n.83, detto “decreto sviluppo”, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, all’art. 46 bis poneva un parziale correttivo alla innovazione della riforma Fornero, stabilendo che i termini ridotti a 30 o 20 gi orni trovano applicazione anche “i n ogni al tro caso previ sto dai contratti col l etti vi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sin-
dacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Ciò legittimava il CCNL Uneba 8.5.13, che su questa materia è ampiamente deregolatorio, consentendo intervalli di 20/30 giorni per qual si asi causal e. Tuttavia s u c c e s s i v am e n t e il D. L. 28.6.2013 n.76, detto“pacchetto lavoro”, all’art.7 lett.c) punto 3 stabilisce: “Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonchè in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” Dunque anche l’ordinamento, su questa materia, ha fatto passi indietro notevoli (dove siano finite le nobili finalità dissuasive della riforma Fornero nonché il contrasto alle pratiche abusive, non è dato sapere). Di certo, l’ondivago atteggiamento del legislatore ha creato un danno all’Uneba che, con il CCNL stipulato appena un mese prima dell’ultimo intervento legislativo, aveva sì ottenuto deroga alla lunghezza degli intervalli, ma con contropartite, del tutto vanificate dalla legge. Possiamo pertanto affermare che una parte della nostra trattativa sia stata resa improduttiv a da interventi legislativi impropri ed incoerenti (o che si tratti di quelli antecedenti, o di quelli successivi). Attualmente ci troviamo di fatto davanti ad una situazione paradossale: gli intervalli possono essere di 10/20 giorni in forza della legge 76/2013 o di 20/30 giorni in forza
UNEBA Il nuovo “Contratto col l etti v o nazi o nal e di l avoro per i l personal e di pendente dai s etto ri s o ci o as s i s tenzi al e, s oci os ani t ari o e d e duc at i v o U n e b a 2 0 1 0 - 2 0 1 2 ”, a s u o t e m p o p u b b l i c at o sul si to www. uneba. org, è o ra di s po ni bi l e anche i n v e rs i o n e s t am p at a. P er i nf o rm azi o ni e ri c hi e s t e t e l e f o nare al l a s eg ret eri a del l 'U neba tel . 06/ 5943091.
16
del CCNL. Quale dei due limiti dovrà essere osservato dagli Enti associati? Secondo i principi generali, dovrebbe prevalere ciò che è più favorevole al lavoratore. Ma in questo caso, dobbiamo considerare più favorevoli al lavoratore i 10/20 giorni della legge oppure i 20/30 giorni del CCNL? Aspettando che qualcuno ce lo venga a spiegare, sarà opportuno comportarsi secondo criteri cautelativi. Qualora il lavoratore a termine, ad esempio, venisse riassunto dopo 15 giorni, egli non avrebbe diritti secondo la legge, ma potrebbe invocare il CCNL. L’ o p z i o n e c au t e l at i v a è du n qu e aspettare comunque i 20/ 30 gi orni . S ECONDA CONTRORIFORMA: 42 mesi Il cumulo per effetto della successione di contratti a termine sale da 36 mesi a 42 mes i , considerando cumulabili i contratti stipulati per “mansi oni equi val enti ”. Dal ginepraio del concetto di “mansioni equivalenti” ci districhiamo nel seguente modo: le mansioni equivalenti sono quelle mansioni inquadrate (o inquadrabili) nello stesso livello contrattuale. T E R Z A C ON T R OR IF OR M A : i l qui nquenni o La verifica del cumulo dei 42 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi,va effettuata s ul l ’arco del l ’ul ti mo qui nquenni o . Non avremo più pertanto la necessità, come richiede la legge, di andare indietro all’infinito alla ricerca di tracce di contratti a termine fino all’età della pietra. QU A R T A C ON T R OR IF OR M A : escl usi one del l e sosti tuzi oni dal cumul o per successi one dei contratti Formano cumulo, ai fini del superamento dei 42 mesi, solo i contratti a termine motivati con ragioni tecniche, organizzative e produttive; non quel l i moti vati da sosti tuzi one. Si verifica pertanto la seguente situazione: A) Contratti a termi ne scaduti anteri ormente al l ’8 maggi o 2013 Questi ricadono integralmente sotto la precedente normativa. Nel precedente regime il periodo massimo consentito come sommatoria era di 36 mesi, indifferentemente che si trattasse di motivazioni organizzative o di sostituzioni, andando a ritroso senza limiti temporali. Pertanto i contratti a termine anteriori all’8 maggio 2013 si sono conclusi:
•
•
o con una interruzione della sequenza; in tal caso essi o restano in ballo fino a max 5 anni dall’8.5.13 per formare cumulo con futuri contratti con motivazioni tecniche, organizzative e produttive ma non con quel l i aventi moti vazi oni sosti tuti ve; o avendo già dato luogo ad una automatica trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (in tal caso, non sono più di ns. interesse).
B) C o n t rat t i a t e rm i n e a c av al l o del l ’8 maggi o 2013 Il periodo precedente all’8 maggio 2013 ricade sotto la precedente normativa, quello successivo sotto la nuova. Pertanto il periodo precedente – fino all’8 maggio compreso - concorre a formare cumulo con i precedenti contratti a termine, andando a ritroso senza limite temporale, a prescindere dalle motivazioni apposte in contratto. Se, durante lo stesso periodo precedente, sono stati raggiunti i 36 mesi, opera la trasformazione automatica. Il periodo contrattuale successivo all’8 maggio concorre a formare cumulo con precedenti contratti a termine nel quinquennio 8 maggio 2008 – 8 maggio 2013 solo se il contratto in corso è motivato da ragioni tecniche, produttive ed organizzative. In questo caso, il periodo massimo complessivo oltre il quale scatterà automaticamente la trasformazione del rapporto è di 42 mesi salvo proroga nei termini contrattuali e di legge. Qualora il contratto a cavallo dell’8 maggio fosse stato stipulato per ragi oni sosti tuti v e, il periodo successivo all’8 maggio 2013 non forma cumul o con contratti precedenti . C) Contratti a termi ne sti pul ati dopo l ’8 maggi o 2013 I contratti stipulati dopo l’8 maggio 2013 ricadono integralmente sotto la nuova normativa. Pertanto essi formano cumulo con precedenti contratti nel quinquennio 8 maggio 2008 – 8 maggio 2013, entro il limite di 42 mesi, solo se stipulati per motivazioni tecniche, produttive ed organizzative. Qualora stipulati per motivazioni sosti tuti ve, tali contratti non formano cumul o con precedenti contratti . QUINTA CONTRORIFORMA: ness un mas s i mal e per i co ntratti per sosti tuzi one L’art.20 del nuovo CCNL stabilisce una percentuale massima del 30% del per-
UNEBA
sonale in servizio a tempo indeterminato per l’utilizzo dei contratti a termine e di somministrazione (all’interno di questo 30% la somministrazione non può superare l’8%). Tuttavia i contratti a termine per sostituzione non rientrano nei predetti limiti; pertanto, in caso di assunzione a termine per sostituzione, non si pone nemmeno il problema di verificare il limite percentuale raggiunto. Lo stesso dicasi nell’ipotesi di utilizzo di lavoro temporaneo mediante personale somministrato a termine ex art.19 nuovo CCNL.
S ES TA CONTRORIFORMA: s enza l i mi ti anche l e Case per feri e, i vi l l aggi -vacanza, i soggi orni cl i mati ci Oltre ai contratti per sostituzione, dal limite del 30%, ai sensi dell’art. 20 del nuovo CCNL, esulano anche le Case per feri e, i vi l l aggi -vacanze ed i soggi orni cl i mati ci . Viene così salvaguardata la piena operatività di strutture ricettive a carattere stagionale che svolgono un ruolo importante nei programmi di recupero psico-fisico degli assistiti.
IL CODICE DELLE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE
I
17
l Ministero della Giustizia ha approvato il Codice etico-comportamentale che l’UNEBA ha elaborato, dando attuazione alla legge delega 29 settembre 2000, n. 300, e al decreto legislativo di attuazione n. 231 dell’8 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni. L’approvazione è intervenuta a conclusione di una lunga procedura per adeguare il documento alle richieste dello stesso Ministero ed alle modificazioni legislative che si sono via via succedute nel sistema sanzionatorio che disciplina le forme di responsabilità amministrativa degli enti (associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, ONLUS, etc) per reati che possano essere stati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono posizioni apicali nella loro struttura, da dipendenti o da collaboratori degli stessi enti. E’ una normativa molto complessa ed articolata e comporta la responsabilità dell’Ente per tutti gli atti compiuti nel loro vantaggio o interesse, ed è “presunta” quando l’illecito sia stato compiuto da persona che riveste posizioni apicali nell’Ente, “da dimostrare”, quando sia stato compiuto da un dipendente o altra persona che abbia agito a suo nome. Questa responsabilità dell’Ente può tuttavia essere evitata, se sia stato adottato un Codice etico comportamentale contenente la dichiarazione dei valori cui si ispira l’attività e l’insieme dei diritti e doveri e delle responsabilità di dipendenti, collaboratori, fornitori, etc. ed un modello organizzativo contenente le procedure da seguire nello svolgimento delle attività. Questi documenti, se approvati dal Ministero della Giustizia, in caso di contestazioni in sede giudiziaria sono considerati idonei dal giudice per regolamentare le diverse ipotesi di responsabilità a tutela degli amministratori e dell’ente stesso. Per venire incontro alle esigenze dei propri associati, l’UNEBA, in attuazione dell’art. 6 del decreto n. 231/2001 che prevede che le associazioni rappresentative degli enti possano redigere Codici di comportamento sulla base dei quali adottare coerenti modelli di organizzazione e gestione ha elaborato il documento sulle attività amministrative da cui possono derivare responsabilità amministrative dell’Ente gestore di servizi socioassistenziali, sociosanitari e socioeducativi, il modello organizzativo ed il codice etico-comportamentale Una prima bozza di questo era già stato reso disponibile sul sito UNEBA con l’avvertenza che si era ancora in attesa dell’approvazione ministeriale. Il testo, che è consultabile nella parte riservata del sito UNEBA, è stato approvato dal Ministero della giustizia con provvedimento (circolare n.11) del 19 giugno 2013, giudicandolo idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall’art. 6, comma 3, del D. Lgvo n. 231/2001. Lo stesso Ministero ha precisato: “Resta impregiudicata ogni valutazione sulle modalità di implementazione del codice e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti”. Invitiamo gli enti a prenderne visione e ad adottarli con provvedimento formale che eventualmente introduca nel pieno rispetto delle leggi, anche ulteriori aspetti o adattamenti in relazione all’attività svolta ed alla propria realtà e ponendo costante attenzione alla sua applicazione.
TERZO SETTORE
5 per mille: le domande più frequenti a cura di Alessio Affanni
E’ disponibile una nuova sezione, sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dedicata alle domande poste più frequentemente (le cosiddette FAQ, cioè le “Frequently Asked Questions”) sul 5 per mille. Riportiamo le più significative, rinviando, per la consultazione completa, al sito www.lavoro.gov.it SEZIONE EROGAZIONE DEL BENEFICIO Anno fi nanzi ari o D) Sul bonifico del 5 per mille che ho ricevuto sono riportati due anni 2010 e 2009, ma a quale contributo si riferisce dei due? R) I due anni indicati sono l’anno finanziario e l’anno dei redditi sui quali si applica il 5 per mille, es. 2010/2009 indica l’anno finanziario 2010, redditi 2009. Nelle comunicazioni delle Amministrazioni viene generalmente indicato uno solo di tali anni, l’anno finanziario. Anche nelle comunicazioni dei beneficiari è opportuno indicare sempre e solo l’anno finanziario.
18
Mancato accredi to del contri buto D) Dagli Elenchi pubblicati dall’A genzia delle Entrate risulta che abbiamo diritto al 5 per mille degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 ma ad oggi non abbiamo ancora ricevuto gli importi relativi. Cosa dobbiamo fare per avere accreditati questi fondi? R) Le somme iscritte nel bilancio dello Stato cadono in perenzione (non sono più disponibili nel bilancio dello Stato) dopo il secondo esercizio finanziario successivo: ad esempio, nel 2013 per il contributo del 5 per mille sono in perenzione gli anni finanziari dal 2006 al 2009. Tali contributi perenti non sono perduti perché il Ministero dell’Economia e Finanze emana un decreto di reiscrizione in bilancio per i soggetti aventi diritto che ne hanno fatto richiesta dettagliata al Ministero del Lavoro. La richiesta di reiscrizione, ognuna distinta
per ciascun anno finanziario, con i dati del legale rappresentante (nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita), la firma in originale e copia del suo documento di identità, deve essere inoltrata, con raccomandata, al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma. Deve contenere la dichiarazione specifica di avere ancora diritto alla percezione al contributo del 5 per mille, l’importo esatto del beneficio, a quale anno finanziario si riferisce e le coordinate IBAN per il versamento sul conto. Modal i tà di pagamento D) La nostra associazione dovrà beneficiare di una somma del 5 per mille; non abbiamo un conto corrente intestato all’associazione, vorremmo sapere se ci sono delle vie alternative. R) Al momento sono consentite solo due modalità di pagamento del contributo. Per somme superiori a 1.000 euro unicamente tramite versamento in conto corrente bancario o postale intestato all’Ente. Per somme inferiori a 1.000 euro sia tramite versamento in conto corrente, sia tramite rimessa diretta al legale rappresentante dell’Ente presso la Tesoreria provinciale della Banca d’Italia (è possibile solo se l’Ente non ha un conto corrente e non desidera aprirne uno e se i contributi sono inferiori ai 1.000 euro). La richiesta va presentata direttamente al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma, indicando i dati del legale rappresentante (nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita) e dichiarando di avere ancora diritto alla percezione al contributo del 5 per mille.
SEZIONE RENDICONTAZIONE DEL BENEFICIO Resti tuzi one del l a somma percepi ta o di una parte di essa D) In quali casi va restituita la somma percepita dall’l’Ente beneficiario? R) Quando non è stata spesa entro l’anno successivo al momento della percezione;
TERZO SETTORE
quando l’attività è cessata o l’ente non persegue più gli scopi sociali; quando non ha trasmesso al Ministero del Lavoro richiedente le integrazioni richieste (es. fatture, buste paga) oppure sia stata accertata la mendacità delle dichiarazioni effettuate. D) Come si restituisce la somma? R) Presso la Banca d’Italia compilando il modello 121T di riversamento a disposizione presso tutte le sue sedi territorialmente competenti con le seguenti indicazioni “Capitolo: 3670 - Capo: 27 - Causale: Restituzione 5 per mille anno 20__ Codice Fiscale e NomeAssociazione”. In alternativa è possibile pagare con bonifico bancario (non on line perché dovrà poi essere trasmessa al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma copia del bonifico il cui originale vale come ricevuta). In questo caso è necessario utilizzare il codice IBAN della Tesoreria territorialmente competente presso la quale dovrà essere effettuato il versamento. Tale IBAN è scaricabile collegandosi al sito della Ragioneria Generale dello Stato – Tesoreria dello Stato – Codici IBAN (fare riferimento al capitolo 3670 capo 27 dell’elenco). Devol uzi one D) La nostra associazione che si sta sciogliendo ha deciso di devolvere il proprio patrimonio ad un’altra associazione. S i può devolvere anche il contributo percepito come 5 per mille? R) Il contributo del 5 per mille non può essere devoluto. Infatti, ai sensi del DPCM del 23/4/2010, l’Ente beneficiario non ha diritto al contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l’attività o non svolga più l’attività che da diritto al beneficio. Unica deroga nel caso in cui l’Ente sia stato autorizzato alla devoluzione dall’ex Agenzia del Terzo Settore.
19
Accantonamento D) E’ possibile accantonare la somma oltre l’anno da quando è stata percepita per progetti futuri? R) No, le norme richiedono che la somma sia spesa e rendicontata per l’intero a pena di restituzione, in quanto può essere impiegata per vari scopi, anche per le spese generali della struttura, ovvero per l’acquisto di beni essenziali al suo funzionamento o per il pagamento di utenze. Tuttavia, la possibilità dell’accantonamento di una parte della somma è prevista nelle nuove linee-guida sulla rendicontazione, recente-
mente pubblicate sul sito del Ministero. Rendi contazi one di spese pri ma del pagamento D) Posso inserire nel rendiconto le spese che ho sostenuto prima che mi venisse effettivamente liquidato il contributo? R) La norma prevede che la rendicontazione riguardi le spese sostenute dopo il pagamento; tuttavia, a causa del considerevole lasso di tempo che intercorre tra la dichiarazione dei redditi e l’effettiva liquidazione della somma, si accettano come correttamente rendicontabili anche le spese sostenute (ed illustrate in una relazione descrittiva) a partire dalla pubblicazione dell’elenco definitivo, nel quale il beneficiario risulta ammesso al contributo. D) Posso rendicontare le spese sostenute per ambulanze o beni di utilità sociale? R) Si, purché lo stesso bene non sia stato già acquistato interamente con altre sovvenzioni pubbliche. Pertanto si richiede una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 a firma del legale rappresentante dell’Ente. Rendi contazi one cumul ati va di pi ù anni D) È possibile presentare rendiconti cumulativi di vari anni? R) No i rendiconti devono essere separati per anno di contribuzione e possono non coincidere con l’anno solare/esercizio finanziario del bilancio. Contatti Per informazioni il Centro di Contatto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde al numero gratuito 800 196 196 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 20.00. - Per informazioni relative alla mancata o erronea erogazione del 5 per mille è possibile inviare una email a Quesiti5perMille@lavoro.gov.it - Per informazioni sulla rendicontazione delle spese relative al 5 per mille è p o s s i b i l e i n v i are u n em ai l a Rendicontazione5perMille@lavoro. gov.it Nell’email dovranno essere indicati sempre l’anno finanziario del contributo e il codice fiscale, l’indirizzo ed email/ telefono/fax/cellulare dell’Ente.
* a cura di Alessio Affanni e Sergio Zanarella
Norme giuridiche e Giurisprudenza n.154 STATO PRIMI INTERVENTI URGENTI PER L’OCCUPAZIONE, LA COESIONE SOCIALE E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 150 del 28 giugno 2013 Con Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013 (convertito poi nella Legge n. 99 del 9 agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2013) sono stati stabiliti i primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. Le principali novità sono rappresentate dagli incentivi previsti a favore dei datori di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori giovani e dalle misure finalizzate a favorire l’utilizzo del contratto di apprendistato. Il Decreto, inoltre, incide sul lavoro a tempo determinato, intermittente, a progetto e occasionale accessorio, modificando la legge di riforma del mercato del lavoro (Legge Fornero) e si chiude con alcune disposizioni in materia fiscale (tra le quali il previsto aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA al 22 %). Si segnala, in particolare, l’art. 3 del Decreto, riguardante misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno: si introducono misure per promuovere l’imprenditorialità e coinvolgere in tirocini formativi i giovani inattivi fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno, nonché per favorire la promozione e realizzazione di progetti promossi da giovani e da persone di categorie svantaggiate per l’infrastrutturazione sociale e la valorizzazione di beni pubblici. Previsto anche il finanziamento del Piano di Azione e Coesione, misura rivolta a enti e organizzazioni del privato sociale che coinvolgano giovani in progetti di valorizzazione dei beni pubblici e di inclusione sociale. Al fine di ridurre la povertà assoluta viene avviato il “Programma per l’inclusione sociale”, estendendo la nuova ”Carta per l’inclusione sociale” a tutti i territori del Mezzogiorno che non siano stati già interessati da tale intervento. Le Regioni potranno finanziare ulteriormente o ampliare l’ambito territoriale, se dispongono di fondi propri. All’art. 6 sono indicate disposizioni in materia di istruzione e formazione professionale: gli istituti professionali potranno utilizzare fino al 25% dell’orario annuale delle lezioni per sviluppare argomenti connessi alle specifiche necessità di settori del mercato del lavoro. All’art. 8 si stabilisce l’istituzione della Banca dati delle politiche attive e passive presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, finalizzata a raccogliere informazioni sui soggetti da collocare sul mercato del lavoro, sulla domanda di lavoro proveniente dalle imprese, nonché sui servizi destinati a migliorare le opportunità di impiego. Nelle disposizioni finali del Decreto, relativamente all’immigrazione: - si introduce la preliminare verifica della presenza di un lavoratore
disponibile sul territorio nazionale prima di avviare il processo di istruttoria per il rilascio del “nulla osta al lavoro subordinato” che consenta l’ingresso dall’estero di un lavoratore non comunitario; - vengono semplificate le procedure di rilascio dei visti per studio e formazione professionale, nei confronti di stranieri ammessi a frequentare i corsi di formazione professionale e a svolgere i tirocini formativi; - viene rifinanziato il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che per l’anno corrente risultava privo di disponibilità, per far fronte, almeno parzialmente, alle esigenze finanziarie degli enti locali; - si prevede uno snellimento del procedimento di emersione dei cittadini non comunitari irregolari.
DECRETO DEL “FARE”: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA Supplemento Ordinario n. 50 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 144 del 21 giugno 2013 Il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, cosiddetto Decreto del “fare” (convertito poi nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013), stabilisce misure per il rilancio dell’economia e prevede semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro e impresa. Vi sono, però, anche altre disposizioni riguardanti i cittadini, illustrate di seguito. Per quanto riguarda l’Agenda digitale, vengono previste misure per favorire la diffusione del domicilio digitale: all’atto della richiesta della carta d’identità elettronica o del documento unificato, il cittadino potrà chiedere una casella di posta elettronica certificata (PEC). La PEC verrà inoltre attribuita automaticamente al momento della richiesta di iscrizione all’anagrafe, di cambio di residenza o del nuovo documento unificato, che andrà a sostituire l’attuale tesserino sanitario, ma sarà attivata solo su richiesta del cittadino. Viene inoltre istituito il servizio SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese) per facilitare l’accesso in rete a tutti i servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni. Prevista la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, che conterrà anche un dossier farmaceutico con i dati e le notizie riguardanti le terapie necessarie. Prevista la liberalizzazione dell’accesso ad Internet (wi-fi libero). Resta l’obbligo del gestore di garantire la tracciabilità mediante l’identificativo del dispositivo utilizzato, ma l’accesso ad internet per il pubblico sarà libero e non richiederà più l’identificazione personale dell’utilizzatore (se l’accesso alla rete offerta dal gestore non costituisce la sua attività commerciale prevalente). Per quanto riguarda la donazione degli organi, per rendere più efficiente l’operatività del sistema nazionale dei trapianti, si introduce l’obbligo per i Comuni di comunicare tempestivamente con mezzo telematico al Sistema Informatico Trapianti gli atti di consenso all’espianto manifestato ai donatori. Per quanto concerne l’acquisizione della cittadinanza italiana, si prevedono semplificazioni delle procedure di riconoscimento della
*consulenza per enti non profit - www.studiononprofit.it - www.facebook .com/studiononprofit.snp
20
cittadinanza del figlio nato in Italia da genitori stranieri al compimento della maggiore età - nei casi previsti dalla legge - in modo da evitare che disfunzioni o inadempienze. Possibilità di ottenere la cittadinanza italiana anche per il neo diciottenne che non abbia adempiuto a tali obblighi amministrativi, non per colpa sua ma per responsabilità attribuibili all’amministrazione o ai genitori, con possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti con qualunque documento. Per quanto riguarda l’efficienza della pubblica amministrazione, viene previsto per le imprese un indennizzo di 30 euro al giorno fino ad un massimo di 2.000 euro in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo promosso ad istanza di parte. Le singole amministrazioni devono pubblicare lo scadenziario delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi. In merito alle attività di Equitalia, se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Rateizzazione dei debiti tributari fino a 72 rate mensili, con ulteriori dilazioni in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Viene, infine, ripristinata la procedura della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause civili, incluse quelle relative alla responsabilità medico-sanitaria, con l’esclusione delle controversie per danni da circolazione stradale: l’obiettivo è quello di diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata.
di ONLUS (capitolo 3.16) e a cessioni di terreni effettuati da privati a favore di ONLUS (capitolo 4.9) la Guida precisa che è dovuta l’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro, ove ricorrano le seguenti condizioni: – che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività; – e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni dall’acquisto. Per le organizzazioni di volontariato si applicano le disposizioni di maggior favore previste dall’art. 8‚ comma 1 della Legge 266/91‚ laddove si stabilisce l’esenzione anche dall’imposta di registro. A questo si aggiunge, in ogni caso, il versamento di un’imposta ipotecaria del 2% e un’imposta catastale dell’1% sul valore del bene trasferito o ceduto. L’associazione beneficiaria decade dall’agevolazione descritta in caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per lo svolgimento della propria attività istituzionale nel biennio. In caso di decadenza viene recuperata l’imposta in misura ordinaria e applicata una sanzione amministrativa pari al 30% della stessa imposta. Se l’acquisto dell’immobile non è destinato all’attività principale svolta dalla ONLUS, ma ad un’attività accessoria, il regime di tassazione segue le regole ordinarie dettate per i trasferimenti dei relativi immobili. La parte 6 (cap. 6.48) è incentrato invece sugli atti costitutivi di enti diversi dalle società con conseguente trattazione delle agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato. Si stabilisce (in modo chiaro e definitivo, come già previsto nella circolare 38/E del 1° agosto 2011) che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3 della legge n. 266 del 1991 e gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro. L’applicazione dell’esenzione dall’imposta è subordinata alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano iscritte nei registri del volontariato tenuti dalle regioni e dalle province autonome. La Guida però sottolinea che molte leggi regionali stabiliscono che le organizzazioni di volontariato possano richiedere tale iscrizione solo dopo la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto. Pertanto esse fruiscono dell’esenzione d’imposta prima dell’iscrizione in tali registri, ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione all’Agenzia delle Entrate in cui sono stati registrati gli atti. Gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti avvenuta l’iscrizione nei tempi utili per l’accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.
AUMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 147 del 25 giugno 2013 Con la Legge n. 71 del 24 giugno 2013, di conversione del Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013, è stato stabilito l’aumento dell’imposta di bollo. In particolare, gli importi in precedenza stabiliti in 1,81 e 14,62 euro passano, rispettivamente, a 2 e 16 euro. L’aumento riguarda una serie di documenti che interessa diversi soggetti. In particolare l’imposta di bollo che oggi è pari a euro 2 riguarda: le fatture che contengono importi non assoggettati ad Iva; gli estratti conti o altri documenti di accreditamento o addebitamento per somme superiori a euro 77,47; ricevute o lettere commerciali presentate per l’incasso presso gli istituti di credito per somme inferiori a 129,11 euro. L’aumento, invece, da euro 14,62 a euro 16 riguarda, a titolo esemplificativo: gli atti rogati o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale; le scritture private per le quali viene effettuata la registrazione presso gli uffici dell’agenzia delle entrate (es. statuti o loro variazioni oppure le convenzioni); istanze, memorie, ricorsi, dirette agli organi dell’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici territoriali tendenti ad ottenere rilasci di certificati ovvero provvedimenti amministrativi. È possibile continuare ad utilizzare le vecchie marche da bollo da euro 1,81 e da euro 14,62, integrandole con marche da bollo che raggiungano i nuovi importi dovuti.
REGIONI CALABRIA NORME SUI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA Supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013 al Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 7 del 2 aprile 2013
ONLUS: CHIARIMENTI DEFINITIVI SULLE ESENZIONI D’IMPOSTA DI REGISTRO
Con la Legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013, la Regione Calabria ha inteso promuovere e sostenere gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. I nidi e i servizi integrativi possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da ampliare le opportunità di offerta, assicurare la continuità e contenere i costi di gestione, e possono essere istituiti
Circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata sul sito il 29 maggio 2013 L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 18/E del 29 maggio 2013, ha pubblicato una Guida operativa sull’imposta di registro. In merito a trasferimenti di fabbricati effettuati da privati in favore
21
anche all’interno dei luoghi di lavoro. Soggetti pubblici e privati possono istituire micro nidi di infanzia, che prevedono l’accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l’infanzia già funzionanti o di nuova istituzione. La Giunta regionale approva il Piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni, con cui definisce i criteri di programmazione, promuove il riequilibrio territoriale dei servizi e valorizza il rapporto tra pubblico e privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi educativi. I servizi educativi integrativi al nido sono: a) i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell’educatore, che possono accogliere al massimo cinque bambini in spazi idonei e sicuri; b) i centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini insieme ad un adulto accompagnatore per fini di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione ed incontro per gli adulti; c) gli spazi gioco per bambini, che con finalità di cura, educativa, ludica di socializzazione per bambini da diciotto a trentasei mesi (senza servizio di mensa e spazi per il riposo). La Giunta regionale definisce, con uno o più regolamenti, i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia. I soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione. L’autorizzazione è concessa dal Comune, sentito il parere del gruppo tecnico, in presenza dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti. Anche l’accreditamento è concesso dal Comune, sentito il parere del gruppo tecnico, in presenza di requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l’autorizzazione al funzionamento (tra i quali l’adozione di una Carta dei servizi, l’accoglienza di tutti i bambini, compresi quelli disabili, e una supervisione pedagogica continuativa). L’accreditamento costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti pubblici da parte di servizi educativi gestiti da privati. Chiunque eroghi un servizio socio-educativo senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa. I Comuni, anche su richiesta della Regione, procedono a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti richiesti. Presso ciascun Comune sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata d’inizio attività. La legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 (Disciplina degli asili nido) è abrogata.
CAMPANIA PROGRAMMA REGIONALE SPERIMENTALE PER PERSONE AFFETTE DA SLA Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 12 del 25 febbraio 2013 Con Delibera della Giunta Regionale n. 34 dell’8 febbraio 2013 è stato approvato il Programma regionale sperimentale per persone affette da SLA e da altre malattie del motoneurone (inte-
grando le azioni previste dalla precedente Delibera di Giunta, la n. 115 del 20 marzo 2012). Per l’attuazione del Programma regionale sperimentale, allegato alla Delibera, si prevedere che le risorse disponibili siano ripartite ed assegnate ai Comuni capofila, sulla base del numero di progetti personalizzati predisposti, anche a ciclo continuo, fino ad esaurimento delle risorse. Al fine di garantire pari condizioni di accesso a tutti i destinatari del programma sperimentale, i Comuni capofila potranno includere nella progettazione di Ambito anche interventi per persone ammalate residenti in Comuni non associati o che non espletino le procedure previste. In allegato alla Delibera c’è anche la modulistica per la presentazione delle domande da parte dei cittadini affetti da SLA ed altre malattie del motoneurone o dei loro familiari, con definizione dei livelli di disabilità e bisogno socio-assistenziale per l’accesso agli assegni di cura.
LOMBARDIA ATTIVITA’ DI PROMOZIONE DEL RECUPERO E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI AI FINI DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie ordinaria n. 9 del 27 febbraio 2013 Con Delibera della Giunta regionale n. IX/4878 del 21 febbraio 2013 sono state determinate le attività di promozione del recupero e della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale. Il primo scopo è incrementare il raccolto, in particolar modo dai canali industria e distribuzione nonché dai punti di vendita della Grande Distribuzione Organizzata sia in termini di quantitativo raccolto (tonnellate) che di numero di aziende donatrici coinvolte. Il secondo scopo è incentivare i rapporti di mutua assistenza fra gli enti, sia al fine di razionalizzare la logistica, che per migliorare il servizio agli assistiti (fare rete) con azioni che favoriscano l’integrazione fra strutture già convenzionate e quelle in”lista di attesa”, nonché il raggiungimento di un maggior numero di poveri razionalizzando e favorendo una sinergia operativa tra strutture “omogenee” per origine (es. S. Vincenzo, unità pastorali Caritas) e per localizzazione territoriale. Terzo scopo è la promozione e la formazione alle strutture caritative con l’obiettivo di innalzare la capacità di gestione e il livello di consapevolezza nel trattamento di alimenti freschi e deperibili. Come quarto scopo c’è il supporto alle emergenze, sulla scorta delle esperienze passate (terremoto di Abruzzo ed Emilia). Per quanto riguarda il miglioramento qualitativo dei prodotti forniti, si mira ad un’azione coordinata secondo le indicazioni del Ministero della sanità sul fabbisogno nutrizionale ideale per soggetti sani, anche al fine di rispondere alle esigenze delle fasce di destinatari maggiormente vulnerabili. Previsti convegni, manifestazioni ed eventi culturali sul tema e lo sviluppo del “Progetto scuola”, volto a portare nelle scuole il valore della solidarietà e della lotta allo spreco.
22
PUGLIA NUOVE NORME IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 21 dell’11 febbraio 2103 Con la Legge Regionale n. 7 del 6 febbraio 2013 la Regione ha pubblicato alcune norme urgenti in materia socio-assistenziale, che vanno a modificare la normativa vigente in materia di organizzazione del sistema integrato delle azioni e dei servizi sociali (Legge regionale n. 19 del 2006). Vengono definite le competenze istituzionali di Regione, Province e Comuni per la gestione degli interventi indifferibili per i minori fuori famiglia e i minori stranieri non accompagnati, per gli alunni disabili e per le madri nubili con figli. La Regione promuove forme innovative di strutture e servizi per le persone, in relazione alla evoluzione del sistema dei bisogni della popolazione pugliese, definendone, in apposito regolamento, i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento. Tra i servizi innovativi: le casa-famiglia con servizi formativi alle autonomie per l’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità, il centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza, l’albergo diffuso per l’accoglienza di lavoratori stagionali stranieri immigrati ed il centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora. Si puntualizza il ruolo delle ASP (Aziende di Servizi alla Persona) nella definizione della programmazione sociale nelle materie di competenza. Vengono apportate anche delle modifiche urgenti che riguardano le procedure di autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi, specificando le competenze anche in materia di verifica e controllo esercitate dai Comuni e vengono altresì definite le procedure di trasformazione delle IPAB esistenti. Si dà la possibilità all’Osservatorio regionale delle politiche sociali di promuovere collaborazioni non onerose con istituzioni pubbliche e private no profit, iscritte negli appositi registri regionali, nell’area delle diverse abilità e delle patologie invalidanti. Altra disposizione approvata riguarda le persone affette dal morbo di Hansen: assegnato un finanziamento annuale nella misura dell’1% del Fondo globale socio assistenziale da ripartire tra i Comuni di residenza sulla base del numero degli aventi diritto. A favore delle persone con problemi di vista viene istituto il Centro regionale dell’audiolibro, al fine di promuovere le tradizioni e la cultura accessibile con funzioni didattiche e di scambio intergenerazionale. Viene, infine, costituita la Commissione regionale Alzheimer e viene adottato il Piano annuale regionale per la cura e l’assistenza dei malati di Alzheimer e altre forme di demenza, con la corresponsione di un assegno di cura mensile ai pazienti che si trovano in stato vegetativo o di minima coscienza. Si fa presente che è stato presentato un ricorso (n. 55 del 18 aprile 2013) per sollevare la questione d’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni di questa Legge: nella parte in cui autorizza la sostituzione di accordi contrattuali (in luogo della procedura di accreditamento) delle convenzioni già in essere, stipulate dalla Regione con le strutture sanitarie residenziali extra ospedaliere, e nella parte in cui si revoca il trasferimento alle ASL di alcuni fondi con cui vengono effettuati rimborsi delle spese di trasporto o di viaggio e soggiorno per interventi di trapianto.
LINEE GUIDA REGIONALI SULLE ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 58 del 30 aprile 2013 Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 722 del 11 aprile 2013 sono state approvate le Linee guida regionali sulle adozioni nazionali ed internazionali. Il provvedimento di apre con un quadro normativo e programmatorio nazionale e regionale e viene definito il ruolo dei vari soggetti istituzionali, incluso il Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con funzioni di segnalazione, promozione, monitoraggio e vigilanza, e quello della Commissione per le adozioni internazionali che, tra le varie funzioni, ha anche quella di autorizzare l’attività degli enti (curando anche la tenuta del relativo albo) che assistono la coppia che intende portare a termine un’adozione in un Paese straniero. Si prevede un ruolo anche per le scuole di ogni ordine e grado, le quali possono contribuire concretamente, tra l’altro: • ad un corretto processo di socializzazione di ogni minore; • al superamento di stereotipi, a volte ancora presenti in alcuni libri di testo, come quello di una rappresentazione dei rapporti familiari basata sui soli legami biologici; • alla promozione del cambiamento culturale che deve vedere i minori come soggetti di diritti e non oggetti dei bisogni dell’adulto. L’Ufficio Scolastico Regionale dovrà garantire quindi, anche attraverso circolari e momenti di confronto, che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado mostrino particolare attenzione ad alcuni aspetti peculiari della realtà del bambino adottato (tra cui l’inserimento scolastico e le difficoltà di comportamento e di apprendimento). I soggetti del terzo settore e dell’associazionismo familiare potranno promuovere e realizzare gruppi di mutuo e auto-aiuto tra le famiglie disponibili all’accoglienza e le famiglie adottive o altra forma di supporto e sostegno alla genitorialità. In accordo con le azioni d’Ambito Territoriale, con il sostegno dei Servizi Sociali e la supervisione dell’équipe integrata, i soggetti del terzo settore potranno altresì promuovere la cultura dell’accoglienza e della solidarietà nel territorio, sensibilizzando le comunità locali ad una partecipazione attiva ed efficace. Dettagliatamente definite anche le fasi post adozione. Si ritiene fondamentale: - accompagnare e sostenere l’inserimento adottivo e i nuovi equilibri familiari, soprattutto in presenza di altri figli, monitorando eventuali segnali disfunzionali - favorire l’integrazione del bambino nel nuovo contesto sociale e la costruzione di un progetto educativo di inserimento e accompagnamento scolastico personalizzato - promuovere e offrire opportunità di confronto e di sostegno reciproco tra genitori adottivi - implementare le azioni di follow up richieste dal Tribunale per i Minorenni e dalle autorità centrali straniere - in particolare, nell’adozione internazionale, offrire un’adeguata tutela sanitaria del bambino, a partire dal rientro in Italia, a fini preventivi, diagnostici e terapeutici in base all’area geografica di provenienza - prevedere incontri cadenzati con la famiglia adottiva e con il bambino e visite domiciliari. Alla Delibera è allegato lo Schema di protocollo operativo.
23
COLPO D’ALA
Questa pagina vuole essere un “colpo d’ala”, cioè una proposta per un momento di riflessione.
Caduti nella rete Ora a me pare che chiunque potrebbe come il ragno filare dal suo interno la propria cittadella le punte delle foglie e dei rami su cui il ragno si appoggia all’inizio dell’opera non sono molte, eppure esso riempie l’aria delle proprie circolari volute di squisita bellezza. L’uomo dovrebbe accontentarsi di appigli altrettanto scarni sui quali appuntare la tela della sua anima, e tessere un arazzo empireo, un ordito di simboli decifrabili dall’occhio spirituale, di dolcezze godibili dal tatto spirituale, di spazio per il suo fantasticare, di immagini di esatta precisione per il suo godimento. Ma così varie sono le menti dei mortali e dedite a viaggi così diversi, che l’esistenza di una comunanza di gusti e di una affinità tra due o tre persone potrebbero sembrare dapprima del tutto impossibili – tuttavia è vero il contrario. John Keats - Lettera a John Hamilton Reynolds
Bollettino ufficiale dell’UNEBA - Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale Direttore Responsabile: MAURIZIO GIORDANO Redazione ed Amministrazione: 00185 Roma - Via Gioberti, 60 - Tel. 065943091 - Fax 0659602303 e - mail: info@uneba.it - sito internet: www.uneba.org Autorizzazione del Tribunale di Roma N. 88 del 21/2/1991 Progetto e realizzazione grafica: www.fabiodesimone.it Stampa: Consorzio AGE Arti Grafiche Europa - Roma
24
Il giornale è inviato gratuitamente agli associati dell’UNEBA Finito di stampare nel settembre 2013