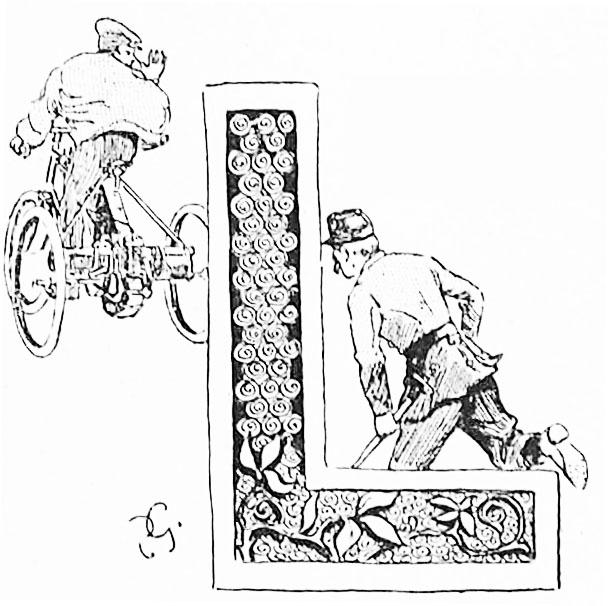Automotoclub Storico Storico Italiano Commissione Cultura
I tricicli de Dion - Bouton
Lorenzo Morello Maggio 2020
PRESENTAZIONE Non posso nascondere che le automobili e le motociclette degli ultimi anni del XIX secolo destino in me un interesse particolare, anche se non ho mai avuto la possibilità (o il coraggio) di possederne una. Il principale motivo di questa predilezione è lo stupore, che sempre provo, ammirando questi cimeli e costatando la molteplicità e la complicazione delle soluzioni tecniche adottate, dovute sia alla mancanza di esperienza, sia alle barriere brevettuali allora esistenti che costringevano i costruttori a differenziarsi anche in ciò che oggi è standardizzato. Un motivo non secondario è l’ammirazione per i primi intrepidi gentlemen drivers che accettarono di cimentarsi con questi marchingegni pur di poter provare l’ebbrezza della velocità. A un certo punto dei miei studi su questi veicoli, mi sono imbattuto nelle pubblicazioni, ormai introvabili, di Louis Baudry de Saunier (1865 – 1939), forse il primo pubblicista dell’automobile che ha giocato un ruolo importante nel diffondere la conoscenza dei veicoli a motore, soprattutto in Francia che, anche se spiace ammetterlo, è stata la patria dell’invenzione dell’automobile, intesa come prodotto industriale di larga (per allora) diffusione. Le pubblicazioni di Baudry de Saunier spaziano dal 1891 al 1924, inizialmente dedicate alle biciclette, poi sempre più concentrate sui veicoli a motore; hanno toccato anche il turismo, considerato scopo principale dell’uso del veicolo a motore. La fama allora conquistata gli permise anche di diventar direttore della rivista ufficiale del Touring Club di Francia. Alla sua morte fu scritto: C’est un grand vulgarisateur qui disparaît, le créateur d’une formule qui permettait au lecteur, même le moins préparé, de comprendre les sujets techniques les plus ardus. L’automobile théorique et pratique, stampato per la prima volta in due volumi a Parigi, da Omnia nel 1897, è forse la sua opera più importante e contiene una prima parte sul funzionamento degli organi principali dei veicoli con motore a scoppio, una seconda sui principali modelli in vendita in quegli anni, ossia i tricicli e le auto di de Dion e Bouton, sia quelli costruiti da loro, sia quelli altrui muniti dei loro motori, il triciclo Léon Bollée, le vetturette Benz, Georges Richard, Panhard e Levassor, Delahaye, De Dietrich e Bolide; l’opera
2
comprende anche sezioni dedicate agli accessori e ai consigli per la scelta, la guida e la gestione di questi mezzi. È particolarmente interessante che, per ogni modello considerato, venga anche spiegato il modo di usarlo correttamente, i difetti principali e il modo per ripararli. Un ultimo pregio dell’opera risiede nelle numerose illustrazioni che, a causa o per merito delle tecnologie tipografiche di quegli anni, sono costituite da incisioni su legno, create dal vero nel laboratorio di Louis Poyet (1846 – 1913), artista particolarmente dotato, specializzatosi nelle illustrazioni scientifiche ma talentuoso anche nella grafica creativa, come dimostra la sua spiritosa opera Orgue á chats, presentata più in basso. Sperando nell’interesse dei lettori, che in questo periodo purtroppo dovrebbero abbondare, ho pensato di presentare la traduzione, che ho cercato di rendere quanto più possibile coerente con l’originale, della parte dedicata ai tricicli de Dion e Bouton, ben rappresentati nelle collezioni dei nostri associati. Buona lettura!
3
I - GENERALITÁ
a nostra macchina è semplicemente un normale triciclo rinforzato in tutte le sue parti, sulla quale sono stati sistemati, in aggiunta agli organi che servono a muoverla con la forza muscolare, quelli che servono a muoverla con la forza meccanica. Vediamo in fig. 1 l’illustrazione di un triciclo dell’ultimo tipo 1 ¾ CV con campana. L’assale posteriore, quello delle ruote motrici, può quindi essere azionato con la catena ciclistica (motore umano) e con una corona dentata comandata dall’organo principale di propulsione (motore a benzina).
La parte ciclistica si compone di un telaio solido, montato su tre robuste ruote pneumatiche che sopportano una pedaliera, una sella e, anteriormente, un manubrio. Una sola osservazione essenziale: la pedaliera comanda la catena che aziona il treno posteriore ma non è comandata da essa; in questo modo, quando il triciclo è lanciato, la catena continua a ruotare sulla corona dentata della pedaliera ma non trascina con sé i predali, dispositivo che
4
permette al cavaliere1 di rimanere immobile senza produrre alcun lavoro motore2. Questa indipendenza di movimento della pedaliera rispetto al motore è stata indispensabile, poiché, a meno di una moltiplicazione esagerata, le gambe del cavaliere non avrebbero potuto seguire il movimento sovente rapidissimo che il meccanismo conferisce al triciclo e, in ogni caso, avrebbe richiesto una fatica esorbitante. Un comando ad arpioni assai semplice, nascosto nella scatola della pedaliera, ottiene il risultato richiesto. Notiamo ancora che se l’asse motore non influenza la pedaliera per la marcia avanti, inversamente la pedaliera non avrà influenza sull’asse motore per la marcia indietro, ciò che significa che non è possibile contro-pedalare o pensar di rallentare con i pedali. Un triciclo a benzina non può essere pensato senza freni, poiché solo questi possono ottenere un arresto rapido. La parte meccanica è montata su un sistema ciclistico. Il motore verticale a un solo cilindro è sistemato sul posteriore sopra il ponte del triciclo: alla sua destra si trova la bobina per l’accensione elettrica; alla sua sinistra la marmitta di scappamento, dove i gas combusti si espandono e attenuano il loro rumore. Sotto la sella si trova un serbatoio di benzina di forma triangolare, in cui l’aria atmosferica, entrando attraverso speciali orifizi che studieremo nel dettaglio, si carbura prima di essere aspirata dal motore. Davanti alla sella, sopra il tubo del telaio, un serbatoio rettangolare racchiude degli accumulatori o delle pile3, da cui la corrente va direttamente alla bobina. L’impugnatura sinistra del manubrio è mobile intorno al suo asse e serve da interruttore. Quando l’indice metallico che essa reca è nella nicchia segnata Marche a lettere rosse, la corrente va dalle pile alla bobina e conseguentemente la scintilla può prodursi e accendere la miscela esplosiva; quando l’indice è nella nicchia Arrêt, la corrente non passa più. Come si vede, gli organi non sono numerosi: un motore con il suo carburatore e la sua marmitta; un circuito elettrico (pile o accumulatori, interruttore, bobina e fili).
1 Nota del traduttore: Il pilota viene solitamente chiamato cavaliere ma, in certe parti aggiunte in questa seconda edizione, compare già la parola motociclista. 2 Vedere più in là la sezione Pedaliera. 3 Nota del traduttore: gli accumulatori erano ricaricabili per chi aveva la corrente in casa, le pile non erano più utilizzabili dopo la scarica.
5
II – IL TRICICLO DA 1 ¼ CV I Signori de Dion e Bouton hanno debuttato nella costruzione dei loro tricicli automobili con il tipo detto di ¾ CV. L’anno dopo, hanno presentato il tipo 1 ¼ CV che, anche se oggi non è più l’ultimo grido nei prodotti dei grandi costruttori di Puteaux, è nondimeno così diffuso che è indispensabile che i miei lettori lo conoscano in tutti i dettagli. Tutti i motori per motocicli dei signori de Dion e Bouton sono stati progettati con gli stessi principi, per il semplice motivo che non si cambiano i principi che hanno condotto al colossale successo di questa marca. Conseguentemente, tutto ciò che studieremo per il tipo 1 ¼ CV si applicherà esattamente al tipo recente 1 ¾ CV, di cui vedremo più avanti qualche particolarità. L’incisione di figura 2 annuncia sommariamente la posizione e la funzione dei diversi organi che compongono il triciclo. Quattro manette ne comandano il funzionamento. Il cavaliere deve conoscere i loro effetti con precisione.
La prima (davanti a lui, a destra) serve a introdurre nel gas che si forma nel carburatore la quantità d’aria esatta affinché il gas diventi esplosivo. È dunque la manetta detta di carburazione.
6
La seconda (davanti a lui, a sinistra) apre o chiude il rubinetto d’entrata del gas esplosivo nel motore. Più aprite questo rubinetto, più permettete, di conseguenza, di inviare gas al motore. Questa manetta è detta di ammissione. La prima influisce dunque sulla ricchezza della miscela; la seconda sulla quantità di miscela data al motore. La terza (proprio sotto la sella), detta di anticipo, comanda lo spostamento del vibratore4 elettrico intorno alla camma che lo fa vibrare. Anche qui ne vedremo i dettagli più tardi. Questa ha l’effetto di produrre l’accensione del gas nel momento più opportuno della corsa del pistone. Più viene abbassata, più l’accensione è anticipata e viceversa5. Questa terza manetta deve trovarsi in sintonia, come vedremo, con il movimento della seconda. Tutte e due cambiano l’andatura del triciclo; una maggior ammissione porta a un’andatura più rapida, che corrisponderà anche a un maggiore anticipo di accensione. La quarta manetta, detta di compressione (a metà del tubo porta-sella), serve unicamente ad aprire o chiudere un rubinetto, sulla sommità del cilindro, attraverso il quale, al momento dell’avviamento, scappa l’aria che il pistone comprime. In effetti, se il fondo del cilindro restasse chiuso, si comprende che il pistone, nel momento in cui sposta il gas per comprimerlo (2° tempo), opporrebbe alle pedalate del cavaliere una resistenza considerevole, che impedirebbe l’avviamento del motore e conseguentemente la messa in marcia del triciclo. Aprendo temporaneamente il fondo del cilindro, si rende impossibile la compressione, annullando così la resistenza; si chiuderà il rubinetto nel momento in cui, essendosi avviato il triciclo, avrà acquistato una forza viva sufficiente a vincere da solo tale resistenza. ----------------- 000 -----------------Il motore è fissato al triciclo in quattro punti: in basso, con una vite orizzontale che si attacca dietro la pedaliera; in mezzo, con due viti che si attaccano a due mensole speciali del ponte del triciclo; in alto, con una brida avvitata alle due estremità. Quando tutti gli attacchi (come pure i dadi, che collegano al motore i tubi di aspirazione e di scappamento, e i fili che vanno dalla candela al vibratore) saranno smontati, avremo fra le mani il motore propriamente detto che rappresentiamo di faccia e profilo nelle due figure 3 e 4. Il suo peso è di circa 22 kg, la sua altezza totale di 45 cm e lo spessore massimo di 28. La parte superiore, detta testa o culatta, è cava. È al suo interno che si fa arrivare con un tubo l’ammissione o aspirazione, arrivo regolamentato dalla valvola con lo stesso nome. È ancora da essa che s’invia il gas attraverso il tubo di scappamento (invio ugualmente regolato 4 Nota del traduttore: il dispositivo è ancora chiamato nel testo vibratore, come nei primi motori in cui un rocchetto continuava a vibrare anche quando non era necessaria la scintilla; qui sarebbe più corretto già chiamarlo spinterogeno. 5 Qualche costruttore che impiega i motori de Dion-Bouton per i suoi tricicli presenta un movimento invertito, in altre parole sollevando la manetta per anticipare l’accensione invece che abbassarla. É un piccolo dettaglio che non cambia le conclusioni.
7
dalla valvola con lo stesso nome), dopo che il gas, avendo prodotto il suo effetto sul pistone, non resta più che un rifiuto da gettare al vento.
Fra i due tubi di entrata e uscita del gas, è sistemata la candela, in altre parole il piccolo tubetto di materiale isolante che porta nel gas all’interno della testa la corrente proveniente dai poli della bobina, in modo che essa faccia scoccare la scintilla che produce l’esplosione. Notiamo che, in accordo con i principi che abbiamo studiato nella parte teorica6, la valvola di ammissione è automatica; nessuna punteria la fa muovere ma una piccola e semplice molla l’aiuta a ricadere sul suo seggio quando il motore cessa di aspirare. Al contrario, la valvola di scappamento è meccanica; essa si apre quando una punteria speciale, che si vede a destra del cilindro nell’immagine di profilo, viene urtata dal basso, per obbligarla a sollevarsi per mezzo di un dispositivo che esamineremo. L’una valvola e l’altra sono visibili attraverso un foro chiuso da un tappo metallico, che basta svitare, sia per 6 Nota del traduttore: Si ricordi che questo capitolo ne segue alcuni non riportati, dedicati a spiegare il funzionamento di un motore a scoppio a quattro tempi.
8
costatare lo stato di pulizia o d’incrostazione delle valvole e smerigliarle se c’è n’è bisogno, sia per comprendere se la scintilla scocca regolarmente all’estremità della candela. La testa reca infine nella sua parte superiore il rubinetto di compressione che abbiamo visto parlando dell’avviamento. ----------------- 000 -----------------Immediatamente sotto la testa, si trova il cilindro che racchiude il pistone. La parte bassa del motore è una scatola di alluminio a due facce uguali, verticali, serrate una contro l’altra da bulloni, chiamata carter o batì. Questa scatola racchiude il volano, formato da due dischi eguali fra cui si muove la testa di biella. Esternamente, questa scatola in due parti porta a sinistra dei rinforzi di fusione a forma di stella, al cui centro si trova il pignone motore montato sull’asse del volano. Questi rinforzi sostengono l’albero e impediscono alle scatole di fessurarsi per un urto. Il piccolo pignone è forzato sull’albero e inchiavettato; in aggiunta è tenuto fermo da un dado con controdado. È importante, in effetti, che non si muova perché è l’organo principale di trasmissione, l’ingranaggio maestro.
9
A sinistra, la scatola porta un rigonfiamento pronunciato, formato da due parti unite fra loro. La parte più vicina alla scatola è fusa insieme con essa. Nella cavità interna sono nascosti gli ingranaggi (uno di diametro doppio rispetto all’altro, essendo un motore a quattro tempi) che fanno sì che la punteria di comando della valvola di scappamento sia percossa una volta ogni due giri; è egualmente necessario che il vibratore non fornisca la scintilla che una volta ogni due giri. Questo gruppo è il cuore di ciò che nel motore si chiama distribuzione. Il vibratore è montato su un sopporto isolante, articolato in modo che esso possa spostarsi, lungo il profilo della camma che lo fa vibrare, di quanto il cavaliere desidera, come studieremo più a fondo. Questa camma è sempre calettata sull’albero con un angolo fisso e, conseguentemente, aprirà il vibratore più o meno prima del termine della fase di compressione a seconda dell’anticipo. Infine, nel punto più basso del batì, un tappo (alettato in modo che sia più facile da svitare con le dita) chiude un foro di svuotamento per l’olio. Ecco tutte le complicazioni di questo piccolo motore! Si vede che è sufficiente analizzare con metodo ogni parte di un meccanismo perché tutto il timore che si poteva avere sulla sua complessità svanisca immediatamente. ----------------- 000 -----------------Siamo adesso giunti a un momento critico: vedere cosa c’è nella pancia del nostro motore! Oserei troppo se, prima di procedere oltre, raccomandassi caldamente ai lettori, che possiedono uno di questi giocattoli meccanici, di accontentarsi della descrizione, che qui gli sarà data, della parte intestinale del loro motore, senza intraprendere un’ispezione in corpore vivi? Smontare è sempre facile; le chiavi e le pinze ti permettono tutto; ma esse non conoscono le delicatezze che il costruttore ha profuso per dar vita al proprio bambino. Ma rimontare!...Rimontare è, per la maggior parte del tempo, assassinare, pezzo a pezzo, membro a membro, questo povero animale metallico. Se non gli si dà la morte tutte le volte, spesso lo si porta in stato preagonico. Io non parlo qui, ben inteso, delle mani particolarmente addestrate e competenti del meccanico, il cui talento conferma con precisione la mia regola: non smontate mai senza il più grave motivo e senza un addestramento speciale. Non smontate mai per curiosità, perché siete molto bravo o perché il meccanico vi conosce: vi fareste aprire il ventre per pura curiosità? Crediate pure che il ventre di una macchina non ama la vostra indiscrezione più di voi e si vendicherà più tardi della violazione inflitta, con un intervento di soccorso e con il conto da pagare a chi riparerà i suoi mali. ----------------- 000 ------------------
10
Quattro grossi dadi chiudono, in alto sul motore, le quattro colonnette che uniscono la testa al batì. Smontiamole. La testa ci rimane in mano (fig. 5).
La testa A forma un sol blocco con le due valvole B (scappamento), C (ammissione) e la candela (che si trova dietro e non può essere rappresentata sull’incisione). La sezione a sinistra ci mostra che è cava; la cavità si chiama generalmente camera di scoppio. I tre tratteggi circolari che si notano sulle figurine indicano dove arriva il gas (in C), dove esce (in B) e dove si produce la scintilla della candela, al centro della camera di scoppio. La semplice osservazione di questo dispositivo ne spiega il funzionamento. Il gas arriva nella sede C e non entra nella camera se la valvola non è aperta e non lo lascia passare.
11
Abbiamo visto che la depressione creata dalla discesa del pistone nel cilindro ha per effetto l’apertura di questa valvola. Il gas, aspirato violentemente, penetra non solamente nella camera di scoppio ma riempie anche tutto il cilindro man mano che il pistone discende (1° tempo). Il pistone risale, comprime il gas nella camera di scoppio, fino a raggiungere circa tre atmosfere (2° tempo). Ben presto, nel gas compresso, con le sue molecole ben ravvicinate, scocca la scintilla. L’esplosione immediata respinge bruscamente il pistone nel cilindro (3° tempo). Il pistone risale spingendo il gas morto dopo l’esplosione: in questo momento, la valvola B, mossa dal motore, si solleva dal suo seggio e lascia fluire i residui nella camera sopra di essa e da questa, attraverso il tubo di scappamento e il silenziatore, nell’atmosfera (4° tempo). L’ispezione delle valvole si può fare, come abbiamo visto, attraverso due orifizi posti sopra di esse, chiusi dai tappi B’ e C’, avvitati nella testa con una chiave speciale. Questa chiusura deve essere assolutamente ermetica, perché la minima perdita diminuirebbe sensibilmente il valore della compressione e conseguentemente della pressione di scoppio. I tappi sono forniti nella loro parte sottostante di rondelle di rame sottile in cui è inserita una guarnizione d’amianto. Queste guarnizioni si adattano perfettamente al tappo e conferiscono una tenuta ermetica. Sarà bene, inoltre, mai riavvitare questi tappi senza aver bagnato i filetti con un po’ di benzina. L’avvitamento sarà facilitato e l’adesione migliorata. Le valvole, in cui le figurine a destra rappresentano i dettagli, sono formate da una sorta di disco metallico poco spesso, chiamato fungo con bordi leggermente conici, al quale è unita una coda metallica che si chiama stelo. Un occhio, praticato al termine dello stelo, permette d’inserirvi una chiavetta, che tiene in posizione la molla. Notiamo che le valvole di ammissione e scappamento non sono simili in tutto. La valvola di ammissione C è più piccola e più leggera della sua compagna B. Essa è leggermente concava, dove la compagna è convessa; la sua molla di richiamo C” è molto corta e debole, dove quella di scappamento B” è lunga e vigorosa. Le figurine, che rappresentano l’una e l’altra, indicano bene le differenze essenziali che le distinguono. Queste differenze provengono dal diverso ruolo che le valvole sono chiamate a giocare. La valvola di ammissione deve essere leggera, in maniera da opporre meno resistenza possibile al passaggio del gas, quando il motore aspira; la sua molla deve avere la forza strettamente necessaria a richiamarla rapidamente sul seggio quando il motore non aspira più, in modo che al momento della compressione nessuna particella di gas abbia a scappare. La valvola di scappamento deve esser più pesante e munita di una molla rigida, perché essa non può contare sulla compressione per ridiscendere sul proprio seggio e non è sospinta che dalla molla, dovendo anche resistere, come la vicina, all’aspirazione che il motore produce. La valvola di ammissione si apre poco (3 mm) e resta aperta relativamente7 a lungo. La valvola di scappamento non si apre che poco di più (da 3,5 a 4 mm) ma resta aperta più a lungo; la punteria inizia ad attaccarla quando il pistone in discesa è circa a un terzo della corsa che deve compiere. 7 Non dimentichiamo che si tratta di un motore a quattro tempi, che funziona a 1.800 giri al minuto: Ne deriva che le valvole si aprono e si chiudono ciascuna 900 volte in un minuto. Questa nota dà senso alla parola relativamente.
12
Il pezzo K è la candela di accensione. Essa non figura sulla tavola che per motivi di completezza: Ne parleremo più tardi a proposito dell’accensione. ----------------- 000 -----------------Tolta la testa, è semplice prendere il cilindro, perché non è avvitato sul batì ma semplicemente appoggiato su di esso, in una cavità circolare con una guarnizione di grafite, cui ne corrisponde una simile fra la parte superiore del cilindro e la testa. Il cilindro non è fissato al motore che dalla pressione ben ripartita (questo risultato si consegue con un montaggio accurato) esercitata dai quattro dadi avvitati sulle colonnette. Solleviamo il cilindro verso di noi. Verrà via facilmente. Quando sarà completamente estratto, uscirà il pistone. Il cilindro (D), abbiamo visto, è un semplice tubo con l’interno perfettamente cilindrico, brillante come la canna di un fucile ben tenuto, e con l’esterno munito di una quindicina di mensole circolari, le alette. Il pistone (P) ha la forma di un bicchiere senza piede. È quindi cavo e chiuso da un fondo; al centro della sua cavità, si articola la biella, come mostra la sezione. L’esterno è molto liscio, per scorrere con il minor gioco e la minor resistenza possibile, all’interno del cilindro; verso il fondo porta tre gole circolari S, ciascuna contenente una specie di braccialetto piatto di ghisa elastica, chiamato segmento. Abbiamo visto all’inizio il compito dei segmenti e non torneremo sull’argomento. Diremo solo che, per evitare ogni infiltrazione di gas fra le pareti del cilindro e del pistone, i segmenti, al momento del montaggio devono essere triplettati, ossia disposti in modo che le loro fenditure siano disposte a un terzo di giro di distanza una dall’altra. ----------------- 000 -----------------Se ora sciogliamo tutti i bulloni che uniscono, l’una contro l’altra, le due scatole del batì e rimuoviamo gli ingranaggi e le altre parti che possono impedirne l’apertura, ci troveremo alla presenza di due coperchi di alluminio M N, molto simili, portanti ciascuno la flangia per due colonnette (fig. 5). Questi due coperchi racchiudono il doppio volano VV, nel cui mezzo si monta la manovella in posizione eccentrica. Quando i coperchi sono chiusi, il doppio volano gira nell’olio e lo trascina verso un balconcino N’ interno ai coperchi che forma un incavo con un foro nel fondo, da cui l’olio cade sull’albero, a goccia a goccia. Dopo averlo lubrificato, cadrà sul fondo del batì, da cui sarà ripescato dal volano. La circolazione dell’olio è assicurata così automaticamente da questo semplice ma ingegnoso accorgimento. L’asse principale del motore è necessariamente costruito in due parti che terminano ciascuna nel rispettivo volano. Si comprende, infatti, che la biella non potrebbe compiere il suo movimento se il centro del volano fosse sbarrato dal passaggio dell’asse. La parte destra dell’asse principale porta in T il piccolo pignone, che è il comando del movimento del triciclo.
13
La parte sinistra dell’asse principale reca in O un altro piccolo pignone, di diametro minore, che comanda la distribuzione. Ingrana con una ruota L di diametro doppio, che fa corpo con la camma F. Questa ha la funzione di sollevare (ogni due giri del motore) la punteria R. Già conosciamo il compito di questa punteria: urtando la valvola di scappamento la forzerà ad aprirsi all’istante voluto, per far passare i gas esausti. ----------------- 000 -----------------Il dimezzamento dei giri è indispensabile nel motore a quattro tempi, per la distribuzione del gas e della scintilla (poiché il gas è ammesso e acceso una volta ogni due giri); questo dispositivo è compreso meno facilmente dal pubblico mentre, invece, sarebbe essenziale averne una conoscenza perfetta. Studieremo con grande attenzione quello del piccolo motore de Dion, di particolare semplicità. L’asse principale (al centro dei volani) reca a una delle sue estremità un piccolo pignone che trasmette il movimento al triciclo. L’altra estremità reca egualmente un piccolo pignone A (fig. 6) che aziona una ruota dentata B di diametro doppio, situata al di sopra. È evidente che la ruota B e ogni cosa montata sul suo asse faranno esattamente metà dei giri di A. L’albero che attraversa questa ruota (fig. 11), detto asse secondario, reca, facendo corpo con esso, due camme, separate da una certa distanza, che comandano una lo scappamento, l’altra l’accensione. La prima è C (fig. 6), un pezzo di acciaio piatto e arrotondato che è provvisto di una parte eccentrica, indicata in figura con proporzioni volutamente esagerate. La punteria di apertura della valvola di scappamento J porta in basso un piccolo piattello arrotondato, in modo da appoggiare costantemente sulla camma C e da seguirne il contorno con precisione. Per la maggior parte della rotazione, essendo la camma circolare, essa non produce nel piattello alcuno spostamento; ma appena la parte eccentrica della camma si presenta sotto di esso, il piattello è istantaneamente spinto in alto (fig. 7); la punteria J di conseguenza si alza e la valvola K è bruscamente aperta. Il gas, cacciato dal ritorno del pistone, è espulso nella marmitta di scarico e di lì nell’atmosfera. La seconda camma portata dall’albero secondario è E (fig. 8). È anch’essa un pezzo d’acciaio piatto e arrotondato, munito di un intaglio che gli conferisce le vaghe sembianze di una chiocciola. Il vibratore R è munito alla sua estremità inferiore di una parte strisciante e di una massa che segue il contorno della camma. Per la maggior parte della rotazione, poiché la camma è circolare, il vibratore è tenuto lontano dal punto S e conseguentemente la corrente
14
non può passare; ma appena si presenta la parte intagliata, l’elasticità del vibratore lo farà cadere nella fenditura (fig. 9). Il contatto sarà stabilito in I fra S ed R, poi s’interromperà e la scintilla scoccherà all’estremità della candela accendendo la miscela. Tutto ciò non è molto complicato, dovete ammetterlo. Ricordiamo solo accuratamente, per comprendere le spiegazioni che seguiranno, che le camme di scappamento C e di accensione E sono calettate in modo immutabile sull’albero secondario, ossia è impossibile cambiare la loro posizione durante il funzionamento. ----------------- 000 -----------------Tuttavia, è necessario che una parte qualsiasi del meccanismo possa essere spostata dal cavaliere per variare l’anticipo di accensione, come si è visto nella sezione teorica! Vediamo allora che è necessario ancora un accessorio. L’espressione anticipo di accensione è assai impropria. Il termine esatto dovrebbe essere regolazione dell’istante di accensione, poiché lo scopo che si prefigge il costruttore dando al cavaliere la facoltà di anticipare l’istante in cui scoccherà la scintilla è di permettergli di stabilire il momento esatto in cui l’esplosione dovrà prodursi nel gas ammesso, momento che deve cambiare con la velocità del motore. Quale effetto produce dunque quest’anticipo e qual è la sua conformazione fisica? La distribuzione del gas è sempre svolta, come si è visto, nello stesso modo. Tutte le parti del motore sono, da questo punto di vista, immutabili. Se esaminiamo la fase in cui il gas è compresso dal pistone (2° tempo del ciclo), vedremo il pistone salire nel cilindro, spostare davanti a sé la miscela ammessa e imprigionata, che non potrà fuggire da nessuna parte perché le valvole sono ermeticamente chiuse. La compressione aumenterà sempre più man mano che il pistone sale. Essa sarà al massimo quando la manovella e la biella saranno allineate, ossia quando il pistone sarà al punto più alto della corsa. In questo momento la camma di accensione presenterà la sua parte incavata al vibratore; il vibratore scenderà e la scintilla scoccherà. L’esplosione sarà istantanea? Si, risponderemmo, facendo uso dei nostri sensi grossolani, incapaci di percepire la frazione di secondo che in realtà separa il momento della scintilla da quello dell’esplosione, durata infinitesima che è necessaria alla fiamma per propagarsi alla totalità del gas ammesso. Il pistone discenderà egualmente ma, in questo caso, il motore girerà poco veloce. Supponiamo che invece di far scoccare la scintilla in questo istante, la si faccia scoccare un po’ in anticipo, giusto del tempo necessario alla fiamma per propagarsi. Che cosa succederà? Il pistone non dovrà più aspettare la salita della pressione. Appena arriva nel punto più alto della corsa sarà respinto in basso. Il motore girerà, allora, più veloce. Se infine avanzassimo ancora di un po’ l’istante della scintilla, il pistone prima di arrivare alla fine della corsa in fondo al cilindro incontrerebbe non solamente un gas pronto a esplodere ma un gas già esploso che lo ricaccerebbe indietro, se la forza viva del triciclo non prestasse man forte per aiutarlo a completare la compressione, anche se il gas è già rivolto
15
contro di lui. Si capisce dunque, che il gas, contrariato nelle sue tendenze violente, spingerà il pistone a una velocità8 ancor maggiore.
Queste indicazioni ci aiutano a capire perché è impossibile, su un triciclo a benzina, mettersi in marcia con un’accensione troppo anticipata. L’esplosione si produrrebbe prima che il pistone giunga al suo punto più alto e poiché la forza muscolare del cavaliere sarebbe incapace di imprimere una velocità sufficiente, il pistone sarebbe ricacciato in senso contrario al normale. Il triciclo si arresterebbe bruscamente e il cavaliere sarebbe proiettato sul manubrio. ----------------- 000 ------------------
Com’è fatto in pratica quest’anticipo di accensione? (fig. 10, 11 e 12) 8 Nota del traduttore: La spiegazione è grossolana, anche se affascinante; sappiamo che in realtà esiste un anticipo ottimale, sopra e sotto il quale le prestazioni diminuiscono.
16
La camma E è fissata sull’asse secondario e ruota con esso. Il vibratore M, al contrario, è montato su un pezzo di ebanite C che abbraccia la camma e può ruotare intorno al suo asse. Noi possiamo, a piacimento, spostarla in modo che il vibratore si sposti lungo la direzione st. Questo spostamento è indipendente dalla camma E, tanto che l’incavo nei due casi avrà una direzione costante ab. Se il pezzo di ebanite è posizionato a sinistra, la massa del vibratore M non cadrà nell’incavo m che nel momento in cui il pistone è completamente in alto o il gas è completamente compresso. Saremo allora a una bassa andatura. Se il pezzo di ebanite è al contrario nella posizione di destra, la massa del vibratore M sarà scesa di alcuni millimetri. È evidente che la camma E, girando nel senso della freccia avrà presentato l’incavo con grande anticipo rispetto al caso precedente. La scintilla scoccherà prima che il pistone abbia compiuto la compressione. Ci troveremo ad andatura elevata. È ovvio che tutte le posizioni, intermedie fra i casi estremi, possono essere impresse al vibratore e, per conseguenza, tutte le velocità intermedie possono essere ottenute nel motore e perciò nel triciclo. Lo spostamento del pezzo di ebanite è prodotto dal cavaliere per mezzo di un’asta mossa dalla manetta posta sotto la sella, che abbiamo prima descritto. ----------------- 000 -----------------La disposizione esatta delle camme di scappamento e di accensione è mostrata dalle figure 13, 14 e 15 che rappresentano il fianco del motore nella sua zona vitale.
L’asse principale (quello direttamente mosso dalla manovella) si trova in S. L’asse secondario in P (fig. 13). La sua estremità riposa in un foro (non visibile) praticato nella stessa scatola del batì, che serve da cuscinetto. Abbiamo visto che un condotto interno al batì porta l’olio su questa estremità dell’asse. La ruota N è inchiavettata sull’asse. L’asse è
17
mantenuto in posizione da una scatola B che lo ricopre (fig. 14), lasciando lo spazio necessario a supportare la camma di accensione. La punteria di apertura della valvola di scappamento R che si vede sull’alto della figura scorre in un foro nella fusione che fa corpo con la scatola A. La cavità della scatola A racchiude il piattello, invisibile nella figura, che termina la punteria R e la camma di scarico; questi due pezzi sono fra loro in contatto costante.
Questa camma forma un unico pezzo con la ruota dentata N che aziona il piccolo pignone principale M. Basta dunque infilarlo sull’asse secondario e mettere i denti nel punto giusto perché tutto sia al suo posto. Una chiavetta attraversa lo spallamento e gli impedisce di ruotare sull’albero. La scatola A reca due perni D che servono a guidare e sopportare una seconda scatola (fig. 14) che racchiuderà ermeticamente gli ingranaggi. Cinque dadi la fissano solidamente. Nella sua parte superiore un piccolo foro con una biglia forma una valvola per l’uscita libera dell’aria compressa dalle parti in movimento. I perni DD (fig. 15) si accoppieremo con il pezzo di ebanite mobile con due fenditure che limiteranno lo spostamento intorno alla camma K, inchiavettata all’estremità di P. Questa scatola porta sulla parte superiore i due capicorda di rame S ed S’ a cui attaccheremo più tardi i fili dell’accensione. In I, si vede la vite di rame, che termina con una punta di platino, che regola la distanza esatta, che ci deve essere fra le punte, perché la scintilla si produca nel momento giusto; in J, si vede la piccola vite di pressione che mantiene la grande vita di rame I nella posizione corretta. In T, appare la massa del vibratore che cade, a ogni giro della camma K, nell’intaglio L.
18
Infine, in F e F’, si vedono due piccoli bulloni fissati sul pezzo di ebanite che ricevono un coperchio, rappresentato di faccia e di profilo nelle figure 3 e 4, che protegge le parti interne dell’accensione dalla polvere e dalla pioggia.
----------------- 000 -----------------Dopo che i principali organi del motore de Dion et Bouton ci sono stati ora presentati, e il loro funzionamento ci è stato comunicato fin nel minimo dettaglio, ci restano da studiare due servizi ausiliari, importanti per il funzionamento del motore: la centrale del gas e la centrale elettrica. Questi termini, che possono sembrare esagerati, descrivono, invece, molto bene le funzioni del serbatoio della benzina e dell’energia elettrica. Il carburatore non è in questo caso distinguibile dal serbatoio. È costituito da una scatola di lamiera di forma pressappoco triangolare, sistemata sotto la sella del triciclo. I sui dettagli interni sono rappresentati nella fig. 17, supponendo di eliminare una delle sue pareti o, se si preferisce, sostituendola con una lastra di vetro. La benzina è versata in questo serbatoio-carburatore attraverso un orifizio chiuso da un tappo di sughero. Un galleggiante metallico, sormontato da una lunga asta, è in grado di salire a misura del liquido versato. Una lamina metallica, messa orizzontalmente sopra la benzina, fa corpo con un tubo di rame detto camino, che si può alzare o abbassare a volontà, insieme alla lama nel serbatoio. Più benzina si versa nel serbatoio, più il camino deve essere tirato fuori, in modo che la lama rimanga sempre a 1 cm di distanza dal livello raggiunto dal liquido.
19
La figura rappresenta l’asta appena sopra l’orifizio del tubo; il disegno è volutamente impreciso perché se l’asta fosse disegnata dove dovrebbe essere, non potrebbe essere vista. La posizione reciproca del galleggiante e della lastra deve essere determinata per il miglior rendimento del motore, ma la precisione non è così indispensabile.
Il serbatoio-carburatore è pieno quando il camino è stato alzato al massimo e l’asta del galleggiante si trova 1 cm circa sotto l’orifizio. Contiene circa tre litri di benzina, la provvista utile per una sessantina di chilometri. ----------------- 000 -----------------Presentiamo, qui di seguito, la descrizione della produzione della miscela e della sua ammissione nella testa del motore. Il motore non può essere disinnestato dal triciclo. Questa è una sua particolarità. Il pignone motore è costantemente ingranato con la corona dentata calettata sull’asse delle ruote motrici (vedere fig. 19). Conseguentemente, se il pignone pone in rotazione questa corona quando il motore funziona, inversamente questa corona può porre in rotazione il motore quando esso non funziona. Sarà agendo sulla pedaliera che potremmo avviare motore e veicolo. Il motore è pertanto avviato dalle gambe del cavaliere. Il pistone, scendendo, produce il vuoto nel cilindro e aspira. Immediatamente l’aria atmosferica è risucchiata nel serbatoio attraverso il camino. Passa sotto la lastra e lambisce la superficie della benzina, arricchendosi d’idrocarburi. Poi rimonta nella zona superiore del serbatoio, dove si trovano i due rubinetti collegati alle due manette alla portata del cavaliere, che aprono e chiudono la quantità necessaria (fig. 17) e regolano la carburazione.
20
L’aria miscelata con i vapori di benzina può essere ricca o meno di benzina; nel caso più frequente è troppo ricca perché possa comportarsi come una miscela esplosiva. Essa attraversa un primo rubinetto in cui una nuova quantità d’aria è aggiunta per correggere la ricchezza. Questa nuova quantità è regolata con l’apertura che il cavaliere comanderà attraverso questo rubinetto. La difficoltà consiste nel trovare il grado di apertura esatto, che renda la carburazione perfetta, in altre parole che renda esplosiva l’aria carburata. Avendo determinato questo grado d’apertura, l’aria passa attraverso il secondo rubinetto (quello a sinistra) che serve a regolare la quantità di miscela esplosiva che si vuole fare arrivare al cilindro. Molto gas dà molta forza e velocità; poco gas ha necessariamente l’effetto contrario.
La figura 18 spiega i dettagli dei due rubinetti separati da una distanza J, necessaria per far passare una vite verticale che li fissa al carburatore. Essi strisciano all’interno di una bussola che serve loro da astuccio. L’aria che ha dunque lambito la benzina, che talvolta la ha anche attraversata gorgogliando (quando la lama è immersa nel liquido invece che sollevata), è quindi miscelata con idrocarburi in una certa proporzione e monta, sempre per effetto dell’aspirazione del pistone, nel rubinetto A, attraverso l’orifizio b. Questo rubinetto ha due vie, ossia nella sua parte inferiore ammette l’aria arricchita, come indicano le frecce bianche, nella sua parte superiore fa passare dell’aria atmosferica che entra attraverso un altro orifizio seguendo la freccia nera. La manetta di destra M fa ruotare questo rubinetto intorno al suo asse. Più l’apertura superiore scopre l’orifizio, più quello inferiore b chiude l’ingresso dell’aria carburata e viceversa. Qualche tentativo permette al cavaliere di trovare il punto di carburazione in cui la miscela ha le proporzioni necessarie a renderla esplosiva. L’aria carburata (freccia bianca) e l’aria atmosferica pura (freccia nera), giustamente dosate, attraversano il secondo rubinetto B che possiede una sola finestra d. La manetta di sinistra N permette di farlo ruotare in modo da scoprire l’apertura del tubo di ammissione T e, di conseguenza, di ammettere la quantità voluta di gas nel cilindro.
21
Questo tubo è rappresentato tagliato. In realtà, attraversa il carburatore da parte a parte come indicato in figura 17, per arrivare alla camera di sicurezza che precede l’entrata nel cilindro. Questa camera (vedere fig. 3) contiene una serie di reti metalliche e rondelle serrate le une contro le altre per evitare che, nel caso che la valvola di ammissione si chiuda malamente, la fiamma non si propaghi fino al carburatore. Questa camera di sicurezza è progettata in base al principio fisico ben noto delle reti metalliche che sono per esempio applicate alle lampade dei minatori.
Notiamo che il serbatoio-carburatore, nella sua parte inferiore, è attraversato da un altro tubo più stretto (fig. 17). Serve a condurre una parte dei gas caldi provenienti dalla valvola di scappamento e a scaricarli poi nell’atmosfera, scaldando, così, la benzina in modo che la carburazione avvenga più facilmente, precauzione notoriamente necessaria d’inverno. ----------------- 000 -----------------Rimontiamo il motore sul triciclo. L’asse principale comanda allora le ruote posteriori con un piccolo pignone da 12 denti inchiavettato su di esso, in presa con una ruota dentata da 84 denti, montata sul differenziale (tipo 1 ¼ CV). La proporzione fra gli ingranaggi è dunque di 1 a 7; il pignone fa un giro quando l’asse delle ruote ha compiuto solamente 1/7 di giro. La demoltiplicazione è molto grande. Le ruote del triciclo misurano 0,65 m di diametro e, quindi, sette giri del motore, 3 ½ esplosioni, sono necessari per fargli compiere 2,05 m circa. Ogni esplosione lo spinge per circa 58 cm. Si deduce facilmente che per coprire un chilometro, le ruote motrici devono ruotare 488 volte e il motore scoppiare 1.708 volte, ruotando per 3.488 giri. Poiché il triciclo de
22
Dion ha sovente coperto un chilometro in 1 minuto e 20 secondi, 50 km/h, si vede l’estrema rapidità con cui si succedono i 4 tempi di ammissione, compressione, esplosione e scappamento, in questo piccolo motore a benzina che, in un sol minuto, ha svolto 1.436 volte questo ciclo completo, facendo 2.872 giri! La trasmissione demoltiplica la velocità, ossia ottiene dal motore più forza a scapito della velocità, aumentando il diametro della ruota calettata sul differenziale. Come si può vedere dalla figura, la distanza fra gli assi delle ruote non è sufficiente sul tipo da 1 ¼ CV a permettere la sostituzione della corona con una più grande. Se fosse possibile, si aumenterebbe la velocità del veicolo ma si diminuirebbe, quel che io definisco il suo potere ascensionale, la sua capacità di compiere le salite. Qualche costruttore ha aumentato la velocità del veicolo (diminuendo contemporaneamente il suo potere ascensionale, secondo un’ineluttabile legge della meccanica), aumentando il diametro delle ruote motrici, portandolo da 65 a 70 cm. Sul differenziale è montato un tamburo che è investito da un nastro metallico guarnito di cuoio, comandato da una leva posta sotto la mano del cavaliere; è il freno. A sinistra vediamo la marmitta di scappamento, di cui conosciamo l’uso, che è fissata alla testa del motore da un tubo che conduce i gas esausti. Questa marmitta si compone di un tubo A (fig. 20), bordato all’ingresso, bucherellato da numerosi piccoli fori, racchiuso in un involucro B egualmente bucherellato, ma con fori sfalsati, rispetto ai primi, distante circa un centimetro. Il tutto è inserito in una scatola C, che reca nella sua parte bassa tre fori, attraverso i quali escono i gas di scappamento. Questa scatola, al cui interno è stabilita una chicane, permette ai gas di espandersi prima di uscire all’atmosfera. Essa attenua notevolmente il rumore che essi farebbero. Questa proprietà lo fa indicare come silenziatore. A destra la bobina d’induzione serve a produrre le scintille.
23
III – L’ACCENSIONE DEL MOTORE DE DION E BOUTON Non entreremo nei dettagli della costruzione delle bobine impiegate dai signori de Dion e Bouton. Ho esposto i principi di quest’organo nella sezione teorica. Farò solamente notare le modifiche importanti che questi costruttori hanno apportato al dispositivo. Se riflettiamo razionalmente, comprendiamo che, per quanto rapide siano i movimenti del vibratore della bobina9, per quanto rapida sia la successione delle scintille, potrebbe accadere che la durata dell’accensione della miscela non coincida con quello di una scintilla, cioè che il momento adatto all’accensione, per esempio, abbia luogo in un periodo fra due scintille. Per eliminare quest’inconveniente, i signori hanno tolto il vibratore dalla bobina e l’hanno sistemato sul motore. Per conseguenza non è più la magnetizzazione prodotta dalla pila che aziona il vibratore; è il motore che si serve da solo, ogni due giri, inviandosi a colpo sicuro la sua scintilla vitale! Il riportare sul motore il vibratore che normalmente è fissato alla bobina, ha obbligato necessariamente il costruttore a riunire con lunghi fili il vibratore alla bobina. Da ciò una complicazione più apparente che reale. Il loro dispositivo è composto come in seguito descritto (Fig. 21). L’induttore della corrente – che proviene dalle pile o dagli accumulatori – arriva su una delle estremità della bobina attraverso i fili che vediamo in alto a destra10. La corrente percorre le spire di filo grosso e va al vibratore, che ogni due giri la lascia passare e la interrompe subito dopo. Le spire dell’indotto, di filo più sottile, avvolte nella bobina intorno all’induttore, terminano, per uno dei poli, su un capocorda situato sull’altra estremità della bobina, al centro, per l’altro, su uno dei due cerchi metallici che sopportano la bobina attaccata al ponte. 9 Nota del traduttore: Si fa qui riferimento a un vibratore non comandato da un interruttore meccanico ma dal campo magnetico della bobina, come accadeva nella maggior parte dei motori di quegli anni; in questi si elevava la tensione ritmicamente, indipendentemente dalla necessità e, solo nell’istante voluto, un interruttore li collegava alla candela. Questo dimostra che non fu Kettering (Cadillac) a inventare nel 1910 lo spinterogeno, come certi libri riportano. 10 Davanti, sul tipo 1 ¾ CV. In questo caso la bobina reca accanto ai capicorda le lettere PP, che indicano che lì devono essere collegati i fili provenienti dalla pile, e MM accanto ai capicorda che devono essere collegati al vibratore.
24
----------------- 000 -----------------Come può essere che le due estremità del filo dell’indotto, che sembrano così lontane una dall’altra (fig. 22), siano in grado far scoccare una scintilla fra loro?
Due parti di corrente indotta si riuniscono in realtà, e si comprenderà questo fatto facilmente se si presta attenzione, osservando la candela che è rappresentata in sezione nella figura 23. La prima parte di corrente indotta arriva alla candela per mezzo di un filo ricoperto di una sostanza molto isolante. Attraversa in linea retta la parte centrale della candela che è fatta di porcellana o un’analoga sostanza isolante e resistente al calore. Questa prima parte arriva dunque fin dentro la testa del motore, dove è ammessa la miscela esplosiva. La parte centrale termina con una punta di platino, metallo ottimo conduttore dell’elettricità. Quasi a contatto con essa, a un solo millimetro di distanza, si presenta una seconda punta ricurva, al fine di trovarsi alla giusta distanza dalla prima. È la punta che reca la seconda parte della corrente indotta11. È fra queste che scoccherà la scintilla. Questa seconda parte di corrente non arriva alla candela attraverso un filo. Si noterà che la piccola punta curva è montata su una parte filettata d’acciaio che forma una flangia intorno alla candela (la porcellana isola da essa ciò che l’attraversa); la parte filettata, in acciaio, buon conduttore dell’elettricità, è avvitata nel motore in ghisa, sostanza egualmente conduttrice, a sua volta montata con viti e piastre metalliche al ponte del triciclo, tutte parti fatte di sostanze conduttrici. Basta dunque che uno dei poli dell’indotto sia in contatto con uno dei cerchi metallici che collegano la bobina al triciclo, perché la corrente possa stabilirsi fra le punte della candela. Uno dei poli dell’indotto è collegato alla candela con un filo, l’altro attraverso la massa del triciclo, rendendo un secondo filo superfluo. 11 Nota del traduttore: Non è una seconda parte di corrente, bensì la corrente di ritorno; Ørsted aveva già ben chiarito il tema nel 1820, evidentemente non letto da de Saunier.
25
La candela, che è rappresentata nella figura 23, è una delle parti delicate dell’accensione. Mi farò premura di aggiungere che le sue debolezze si correggono facilmente: basta avere in tasca una candela supplementare. La sostituzione si fa in tre minuti. Abbiamo visto che la candela è l’organo dal quale scocca la scintilla che infiamma la miscela detonante. La testa della candela sporge leggermente nella camera di scoppio. Abbiamo visto anche che la corrente indotta, la cui interruzione fa scoccare la scintilla, arriva alla candela da una parte attraverso una successione di contatti metallici e dall’altra attraverso un filo esterno. Occorre quindi che le due parti di corrente indotta non s’incontrino in alcun altro punto del loro percorso, poiché l’elettricità, che prende sempre il cammino più breve, passerebbe per un corto-circuito invece che darsi la pena di andare fino alle punte della candela; la scintilla, in questo caso, non scoccherebbe. Ossia, il filo interno della candela (quello che nasce al capocorda di rame A e che un tratteggio indica uscire in m) deve molto accuratamente essere protetto con un involucro di porcellana BB da ogni contatto con l’esterno che è a massa. Da qui la struttura della candela è facilmente comprensibile. Una colonna di porcellana BB racchiude un filo Am. Essa è mantenuta in posizione dall’insieme di una vite a testa esagonale (fra le lettere B e C), che mai il cavaliere dovrà svitare per il rischio di cambiare la posizione del filo m. Il tutto è montato in un contenitore metallico (fra le lettere C e B) formante lui stesso una grossa vite a testa esagonale che serve per avvitare la candela sul motore. I filetti della vite portano un piccolo uncinetto di platino n che si deve avvicinare alla parte m a circa 1 mm. Questo è l’intervallo minimo T perché la scintilla scocchi. La candela potrà essere diversa ma il principio di funzionamento sarà sempre lo stesso. ----------------- 000 -----------------Ci resta da studiare qualche dettaglio sulla corrente dell’induttore. Come si è visto, la corrente è interrotta dal vibratore. Queste interruzioni sono indispensabili per produrre le scintille. Ma il passaggio della corrente deve ancora essere sottomesso alla volontà del conduttore del veicolo che non ha altro mezzo per arrestare il motore che impedire alla scintilla di scoccare. Si è dovuto allora inventare un secondo interruttore, comandato dal cavaliere, che doveva trovarsi sempre sotto mano. I costruttori l’hanno sistemato nella manopola sinistra del manubrio; una rotazione di un quarto di giro interrompe la corrente. I signori de Dion e Bouton hanno sistemato nel circuito dell’induttore ancora un terzo interruttore, che altri costruttori hanno soppresso e che è assolutamente facoltativo. Lo chiamerò, a sua volta, interruttore di sicurezza. Consiste in una piccola spina di rame che si può estrarre e mettere in tasca e la cui presenza sul triciclo è indispensabile per la riunione delle due parti del circuito. Una volta che la spina sia ritirata, nessun malintenzionato potrà utilizzare il veicolo poiché la corrente dell’induttore non potrà attraversare la bobina e far scoccare la scintilla, salvo che il
26
malintenzionato suddetto non possegga una spina simile o un perno di metallo di diametro eguale. Questo interruttore è dunque una sicurezza relativa. La sua utilità è tuttavia elevata. Può accadere, in effetti, che il cavaliere ricoveri la sua macchina in rimessa un po’ frettolosamente e che lasci la manopola-interruttore per dimenticanza nella posizione di contatto. Dunque, la corrente può passare e se la sfortuna vuole che il vibratore sia nell’incavo della camma, ossia anche lui in contatto, la corrente passerà per tutta la notte. Gli accumulatori si scaricheranno e il triciclo non funzionerà più all’indomani. La piccola spina di rame salverà i distratti da questa sgradita sorpresa, alla condizione che essi non siano così distratti da dimenticarla sul triciclo!
La manopola-interruttore è rappresentata in figura 24. Esteriormente ha la forma di una manopola qualsiasi. Le sole differenze apparenti consistono nel fatto che reca un collare nichelato con un piccolo indice che si arresta sia sulla parola Marche, sia sulla parola Arrêt, incise sul manubrio e nel fatto che essa può essere fatta ruotare di un quarto di giro per mezzo della mano. Se facciamo una sezione di questa manopola, costatiamo che due fili mantenuti in posizione dalla rondella fissa B la attraversano in senso longitudinale. Essi arrivano fino a essa passando invisibili all’interno del manubrio. I miei lettori avranno già capito che la corrente venuta da uno dei poli delle pile o degli accumulatori arriva per uno dei due fili e se ne va per l’altro. Questi due fili terminano con una testa piatta di rame; due molle a elica si appoggiano sulla rondella B comprimendo continuamente le teste contro la parte facente da interruttore. La figura in alto mostra la manopola nella posizione in cui la corrente non passa, ossia di Arrêt. Noteremo che A porta una piccola placca di rame, orizzontale nella figura in alto, e che A fa corpo con la manopola per mezzo delle due viti di estremità. Se ruotiamo la manopola di un quarto di giro, ruoteremo della stessa misura la parte A. La placca di materiale conduttore farà passare la corrente da una testa all’altra dei due fili. L’indice mostrerà allora la posizione Marche.
27
L’interruttore di sicurezza, la spina di rame (fig. 25), è ancora più semplice. Anche solo guardando l’incisione, se ne comprende il funzionamento. Il filo che porta la corrente di ritorno dalla manopola è sezionato. Un pezzo di ebanite, fissato al tubo con un collare, porta due morsetti che ricevono le estremità di questo filo e le collegano a due piastrine di rame ricurve a forma di uncino. I due uncini non si toccano; la corrente non può allora passare. Essi formano una sede circolare nella quale possiamo inserire la spina di rame; la corrente allora passerà. L’elasticità dei due uncini manterrà in posizione questo piccolo pezzo. ----------------- 000 -----------------Terminiamo lo studio dell’accensione elettrica con uno schema di ricapitolazione della posizione dei fili nel triciclo de Dion e Bouton. La figura 26 servirà dunque ai lettori per seguire questo riassunto. La corrente dell’induttore parte dal polo positivo (a destra sulla figura), attraversa il manubrio e la manopola sinistra (che la ferma o la lascia passare) e ritorna sul tubo del telaio del triciclo. Il manubrio porta al centro due piccoli morsetti che servono per staccare il manubrio in caso di riparazioni, senza che per questo si debbano tagliare i fili. La corrente positiva arriva dal manubrio lungo il tubo del telaio del triciclo, arriva all’interruttore di sicurezza (che la lascia passare o l’arresta) e cammina ora parallelamente alla corrente proveniente dal polo negativo. I costruttori hanno cura di avvolgere i due fili (ciascuno isolato con una propria guaina) in uno stesso involucro per andare fino al vibratore12 passando sul ponte del triciclo. Non ci sono inconvenienti se si scambiano i fili tra loro. L’unico filo di corrente indotta va dalla bobina (parte sinistra) alla candela.
12 Nel tipo da 1 ¾ CV con campana i fili passano all’interno del ponte.
28
IV – LA PEDALIERA DEL TRICICLO A BENZINA I pedali trascinano il treno motore ma il treno motore non trascina i pedali!.... Ai più questo semplice meccanismo sembra contenere qualche sortilegio. Smontiamo allora una di queste pedaliere e vediamo cosa racchiude. La pedaliera, una volta che sia tolta la catena e sia separata dal telaio, appare come in figura 27. È costituita da una specie d’involucro tondo e spesso che porta sul suo diametro maggiore una corona dentata, al centro della quale passa un asse che a ciascun’estremità reca un pedale. Si noterà che sulla parte sinistra è presente un eccentrico, che si alloggia in una sede circolare sul telaio; esso serve a tendere la catena alla bisogna. Togliamo i pedali e il disco, tenuto da una vite, che racchiude il meccanismo. Ecco (fig. 28) una vista dell’interno della pedaliera, in scala aumentata per poterne apprezzare i dettagli. L’albero che muove i pedali non è legato alla corona dentata in modo indissolubile, come in un triciclo normale. La corona e la scatola che la sorregge sono montate su un mozzo a basso attrito, ossia tale che si potrebbe ruotare la corona facilmente a mano nel senso che si vuole. L’interno della corona porta un arpionismo, ossia una successione di denti eguali in cui un lato è inclinato e l’altro sensibilmente verticale. Se noi poniamo all’interno del rocchetto un braccio metallico articolato (ad esempio 2 in fig. 28), costateremo che in un senso esso saltellerà da un dente all’altro, nell’altro s’incaglierà nel primo dente che incontra, trascinando il rocchetto con sé. L’asse dei pedali non porta con sé uno solo di questi piccoli bracci, che a rigore non avrebbero alcun bisogno di essere moltiplicati, ma ben tre, per maggior sicurezza e miglior ripartizione degli sforzi. Questi bracci 1, 2, 3 sono alloggiati ciascuno in una corrispondente nicchia che lascia loro una piccola capacità di movimento; delle molle elicoidali li premono contro i denti del rocchetto. Vediamo cosa accade durante l’avviamento del veicolo: i pedali in figura 28 trascinano i tre piccoli bracci fissati sull’asse. Ciascuno scivolerà nell’incavo di un dente e lo spingerà insieme alla corona dentata, che attraverso la catena metterà in movimento il treno posteriore e il motore. Ma appena il movimento del motore diventa più rapido di quello del piede, il rocchetto sarà trascinato dalla catena troppo in fretta, perché i tre piccoli bracci possano appoggiarsi sulla faccia verticale dei denti, e le gambe perderanno il loro effetto. La lubrificazione di quest’organo si fa attraverso un forellino tappato da una vite che si trova sulla faccia interna della pedaliera.
29
La figura 28 bis rappresenta il differenziale di de Dion. Le ruote dentate A e B sono eguali; i piccoli pignoni C, D, E e G sono intercambiabili (questo è un organo che il motociclista non dovrà mai smontare ma semplicemente riempire di lubrificante di quando in quando, attraverso un orifizio chiuso da una vite.
30
V – IL TRICICLO DA 1 ¾ CV TIPO 98 Un anno dopo l’apparizione del tipo 1 ¼ CV, i signori de Dion e Bouton misero in produzione il tipo da 1 ¾ CV, rappresentato nella figura 29; contiene un motore migliorato rispetto al precedente e preannuncia il modello detto a campana che essi producono attualmente. Il modello 1 ¾ CV s’incontra frequentemente. Si vede che ben pochi cambiamenti lo fanno differire da quello che abbiamo studiato.
Esteriormente (fig. 29), l’unica differenza riguarda la disposizione della valvola di ammissione. Questa non è più fissata a fianco della sua sorella di scappamento ma sopra di essa con il fungo in basso e lo stelo e la molla in alto. Il tubo di ammissione arriva in basso e nasconde agli occhi la molla e lo stelo della valvola di ammissione. La candela è avvitata sulla testa del motore, fra le due valvole, un po’ più in basso del motore da 1 ¼ CV. La camera di sicurezza è sistemata all’uscita del tubo d’ammissione, fra le pareti del carburatore.
31
Il piccolo cilindro liscio, chiuso in basso da un rubinetto, che si vede dietro il cilindro alettato, è un serbatoio d’olio, non un oliatore, che racchiude due misure d’olio necessarie alla lubrificazione del motore13. Una modifica felice è stata apportata alle due manette di apertura del rubinetto di compressione e di regolazione dell’anticipo. Tutte e due sono state portate avanti (vedere la figura). Esse comandano i loro organi con un rinvio a ginocchiera. Le quattro manette sono ora a portata di mano del cavaliere che non deve più abbassarsi per manovrarle. La scatola nera che si vede davanti al serbatoio del carburante non è peculiare del modello da 1 ¾ CV. Si trova su molti dei tricicli di ogni potenza. È una scatola che al suo interno alloggia le pile e, nello spazio rimanente, un secondo serbatoio per la benzina; questo tipo a doppio serbatoio è ora abbandonato. ----------------- 000 -----------------Il motore da 1 ¾ CV è un po’ più grande del predecessore. L’alesaggio era 58 mm nel motore da ¾ CV, diventò 62 mm nel motore 1 ¼ CV ed è qui di 66 mm. Lo spessore delle pareti del cilindro è di 3 mm, come nei tipi precedenti. La corsa del pistone non è mai cambiata: essa è sempre 70 mm. Le alette sul cilindro erano 17 nei modelli ¾ e 1 ¼ CV e misuravano rispettivamente 15 e 17 mm di profondità. Nel tipo da 1 ¾ CV sono 16 e sono profonde 19 mm. Quanto agli attacchi del nuovo motore, nulla è cambiato. È dunque possibile sostituire il motore da 1 ¾ CV a uno precedente. Occorre, in questo caso, cambiare anche il carburatore (a causa della nuova camera di sicurezza), la testa, il cilindro e il pistone.
13 Vedere più avanti l’UTILIZZAZIONE DEL TRICICLO A BENZINA.
32
VI – IL TRICICLO TIPO 1 ¾ CV A CAMPANA L’attuale motore, che costruiscono i signori de Dion e Bouton per i loro motocicli, è del tipo da 1 ¾ CV di potenza, dotato di campana.
Questo modello (fig. 1 e 30) non differisce dal precedente per la potenza del motore, sebbene il dispositivo della campana accresca la potenza di 7 – 8 chilogrammetri per secondo, come vedremo14, ma solamente per dei perfezionamenti di dettaglio. Il motore da 1 ¾ CV (tipo 98) non differisce dal motore da 1 ¼ CV che per la forma della testa e per l’alesaggio del cilindro; il volano e la distribuzione sono identici. Il perfezionamento più importante consiste nella campana che si vede sopra la scatola delle valvole, detta campana del condotto di ammissione. La sua ragion d’essere è di consentire l’accesso rapido alle valvole e al raffreddamento del condotto. Per accedere alle valvole, nel dispositivo da 1 ¼ CV i lettori hanno appreso che occorreva rimuovere i tappi posti sulla testa. 14 Nota del traduttore: circa 1/10 di CV.
33
Nel modello successivo, l’1 ¾ CV (tipo 98), l’operazione è più lunga. Per scoprire ad esempio la valvola di scappamento, è necessario svitare di qualche giro il dado che riunisce il tubo di ammissione al seggio della valvola, smontare l’insieme della valvola e del suo seggio, per scoprire infine la valvola; operazione che vi permetterà di accedere anche alla valvola di scappamento. Similmente, per ispezionare lo stelo della valvola di aspirazione e la molla è ancora necessario svitare il dado a cappello. Il lavoro non è considerevole; ma un costruttore accorto ha sicuramente interesse a ridurlo il più possibile.
La fig. 31 mostra una sezione della campana del condotto di ammissione e della scatola delle valvole. Descriviamo il gruppo partendo dal basso, in altre parole nell’ordine in cui si montano i pezzi. Le valvole sono entrambe sistemate come nell’ultimo modello, la valvola di scappamento in basso e la valvola di ammissione in alto; la candela fa scoccare la sua scintilla fra le due. La figura mostra anche, in basso, il tubo di scappamento sezionato. Alla sinistra, la parete è svuotata in modo da formare il condotto sia per i gas carburati, che vanno al motore, sia per i gas combusti, che ne ritornano, indicati con delle frecce. L’assieme della valvola di ammissione e del suo seggio non è avvitato nella parete della testa ma è semplicemente appoggiato sopra il foro di aspirazione su una superficie piana; fra
34
le due è interposta una piccola rondella d’amianto, non raffigurata sul disegno, in modo da assicurare una perfetta tenuta. L’assieme è ricoperto da un tubo curvo molto somigliante al camino di una pipa. Siccome le due parti sono solo appoggiate (valvola e pipa) com’è possibile che esse siano tenute in posizione? A questo provvede la campana, un pezzo metallico che la imita nella forma, nel quale sono praticate tre aperture di grandi dimensioni. La parte bassa della campana entra in un alloggiamento speciale praticato nella testa. È sufficiente farlo ruotare di un sesto di giro perché, grazie a un innesto a baionetta, esso sia fissato stabilmente. Ecco dunque un pezzo rigido che permette di bloccare le due parti sovrapposte (valvola e pipa). Effettivamente, la parte superiore di questa campana reca un bullone la cui punta va a premere sulla pipa e, di conseguenza, sulla sede della valvola di ammissione. La tenuta stagna è perfetta; essa è ottenuta dalla sola pressione, senza alcuna vite o giunto. La figura mostra una sezione, a sinistra, del tronco inferiore della campana trattenuta dal filetto a baionetta della scatola delle valvole e, a destra, la parte aperta per l’inserimento. Per ispezionare le valvole, ecco come si deve procedere. Inizialmente separeremo il motore dal condotto di aspirazione; sviteremo il nipplo che unisce il tubo di ammissione alla pipa. Poi sviteremo di qualche giro il bullone superiore della campana; la ruoteremo di un sesto di giro e la leveremo. La valvola di ammissione e il suo seggio sono semplicemente posati uno sull’altro e possono essere smontati. La valvola di scarico sarà ora visibile sul fondo; se vogliamo smontarla, sarà sufficiente togliere la molla e sollevare la valvola con l’aiuto di un filo di ferro fine. Per rimontare le valvole, le manovre si compiranno in senso inverso; molto semplicemente, non è vero? ----------------- 000 -----------------Il secondo vantaggio della campana è di migliorare il raffreddamento della valvola e del condotto di ammissione. A ogni aspirazione si produrrà l’ingresso di un peso di gas leggermente maggiore e a più bassa temperatura. La potenza del motore aumenterà per questo di qualche chilogrammetro al secondo. Il miglior raffreddamento è ottenuto, come si vede, dall’irraggiamento della superficie della campana e dalla corrente d’aria che passa fra le sue fenditure e, infine, dall’isolamento dalla testa per mezzo della guarnizione d’amianto. Il peso del volano di questo nuovo modello è leggermente aumentato. L’asse del motore è stato leggermente ridotto per inchiavettare anche un pignone da undici denti, se è preferito. Si aggiunga che la distanza fra il ponte del triciclo e l’asse delle ruote motrici permette di sistemare una corona dentata più grande e, quindi, i nuovi tricicli de Dion possiedono il vantaggio di salire meglio sulle strade in pendenza. La potenza è aumentata e la demoltiplicazione è maggiore di prima! Di conseguenza i tricicli si presentano ora con tre rapporti a scelta. Se amate le velocità folli, richiedete il rapporto da corsa (ma allora pedalerete un po’ nelle salite!). Se vi ponete in una posizione intermedia fra le velocità folli e il turismo saggio, richiedete il rapporto
35
intermedio. Se vi accontentate di una trentina di chilometri l’ora e desiderate far le salite senza pedalare – anche rimorchiando un carrozzino carico – esigete il rapporto turistico e sarete felici (corsa: 15/102; intermedio: 13/104; turistico: 11/106). ----------------- 000 -----------------Il nuovo triciclo a benzina modello 99 non è solamente stato migliorato nel motore. La trasmissione e la parte ciclistica hanno anch’esse subito delle modifiche. Ci ricorderemo che nel tipo 1 ¼ CV e nel modello vecchio 1 ¾ CV il pignone, calettato sull’asse motore, e la ruota dentata in bronzo, calettata sull’asse delle ruote, ingranano all’aperto, ossia nessun involucro le protegge dalla polvere, dall’acqua e dal fango. La lubrificazione è difficile, perché nessun lubrificante aderisce bene ai denti e, se aderiscono, formano rapidamente con la polvere un impasto che logora il metallo. Gli involucri di protezione parziale finora applicati non hanno mai presentato sufficiente solidità. Si capiva che non erano nati insieme al triciclo. I signori de Dion e Bouton hanno saputo immaginare un carter robusto che, facendo parte del batì del triciclo è sia una protezione contro le impurità della strada, sia un capace serbatoio per il lubrificante. A questo fine (vedere la fig. 30), il carter porta in basso, sotto il rigonfiamento che contiene il pignone, un dado che permette di accedere all’interno. Si toglie il tappo, ci si arma di una spatola e di un vasetto di vaselina e s’imburra copiosamente. Ecco fatto per sei mesi! Vedrete sicuramente che questo miglioramento ha qualcosa di buono. I lettori noteranno, sulla stessa figura, che l’asse delle ruote motrici sembra alquanto più massiccio di prima. Non è proprio l’asse delle ruote ciò che si ha sott’occhio ma semplicemente un robusto tubo che serve da involucro per quest’asse. Questo tubo non ruota ma mantiene la carreggiata fra i cuscinetti. L’asse ruota al suo interno. La sezione in figura mostra questo dispositivo concepito per aumentare la rigidezza del veicolo e per semplificare le riparazioni al treno posteriore. Nel vecchio modello, quando c’era necessità di smontare le due parti dell’asse posteriore, occorreva smontare il differenziale. Il lavoro era lungo e difficile. Nel modello nuovo, è diminuito. Ciascuna parte dell’asse è montata in un tubo. Prendiamo ad esempio l’asse della ruota sinistra. Esso è sopportato dai due cuscinetti a sfere le cui piste si avvitano alle due estremità del tubo. Sono cuscinetti a tre punti di contatto che non hanno necessità di lubrificazione. Questo montaggio si presenta un po’ come quello dei pezzi che formano la pedaliera di una bicicletta e che tutti i lettori conoscono: un asse interno a due coni opposti e due scatole porta sfere. Per regolare i cuscinetti è sufficiente agire su una sola delle scatole, quella esterna, perché l’altra è solidale. La semplicità di regolazione è dunque garantita.
36
La semplicità di smontaggio ne consegue. Effettivamente, l’asse (è la parte sinistra che continuiamo a esaminare) porta al suo esterno un quadro che s’impegna in un incavo che gli corrisponde nel mozzo della ruota dentata. La ruota dentata (messa in rotazione dal pignone) trascina dunque l’asse motore di sinistra per effetto della forma del mozzo. La figura 32 mostra la parte dell’asse che stiamo esaminando; il quadro è all’estremità e, a destra del cono su cui rotolano le sfere. L’asse della ruota destra è esattamente simmetrico. In conclusione, con questo sistema, non solo il tipo di montaggio si avvicina a quello comune alle biciclette, ma anche i cuscinetti a sfere beneficiano in precisone di montaggio. Il freno, detto a cucchiaio, che agiva sullo pneumatico della ruota direttrice è stato sostituito con un freno a nastro, che agisce sul tamburo sistemato a sinistra dell’asse della ruota. Il freno posteriore (fig. 32 bis) è ancora a nastro ma il diametro del tamburo è stato aumentato, accrescendo l’efficacia del freno. Il nuovo modello si caratterizza dunque in tre punti: robustezza, semplificazione e capacità di affrontare salite.
37
VII – L’UTILIZZAZIONE DEL TRICICLO A BENZINA Studiamo ora le nozioni preliminari, che potremmo identificare con l’educazione stradale del motociclista. Mettiamo il nostro apparecchio in ordine di marcia e iniziamo la prima prova. Dopo, lo guideremo su strada e descriveremo le pannes che la nostra inesperienza gli provocherà. Studieremo insieme i rimedi da applicare a questi piccoli malanni. ----------------- 000 -----------------Se il triciclo vi è stato venduto da un agente o da un amico, vi sarà stato consegnato sulle ruote, in ordine di marcia. In tal caso, salite subito in sella. Se il triciclo vi è stato spedito dalla fabbrica, vi arriverà in una cassa. Fatela aprire con cura, in maniera che nessun pezzo sia danneggiato e nessun filo sia tagliato. Tirate fuori la macchina e completatela con il manubrio; sistematelo all’altezza che vi si adatta e così fate per la sella. Fissate i fili ai due morsetti che il manubrio reca nel mezzo. Generalmente la cassa di legno racchiude in una scatola, che è fissata a essa, una borsa porta ferri contenente anche gli accumulatori o le pile15. Fissate la borsa dove preferite sulla macchina (preferibilmente vicino alla bobina), avendo cura che le cinghie di fissaggio non rompano i fili e non interferiscano con i comandi, ad esempio del freno. Quanto agli accumulatori o alle pile, mettetele nella scatola metallica a loro destinata e stabilite il contatto con i fili. ----------------- 000 -----------------Alimenterete quindi il motore. A questo scopo basterà che vi siate muniti di un bidone di capacità da due a cinque litri di benzina a 680°16 e di un altro piccolo bidone d’olio speciale. Il serbatoio-carburatore deve essere vuotato bene di ogni traccia di benzina vecchia, che avrebbe potuto servire per le prove del costruttore (potrete farlo levando la vite che si trova a sinistra in basso); sistemate nel bocchettone, chiuso dal tappo di sughero, un imbuto pulito, di preferenza munito all’interno di una reticella metallica, e versate circa ½ litro di benzina, sufficiente per ora. Costaterete che, abbassando il camino in fondo, il galleggiante salirà man mano che verserete la benzina. Riempito poi il serbatoio della quantità desiderata, alzerete o abbasserete il camino in modo che l’asta del galleggiante sia sotto di 1 cm rispetto al suo bordo. Siccome le vibrazioni producono frequentemente variazioni in questa distanza, avrete 15 Gli accumulatori a liquido sono spediti senza liquido. Per riempirli all’arrivo è necessaria una cura particolare che è spiegata in un foglio d’istruzione ad hoc. Gli accumulatori di questo tipo sono sempre meno usati. Le pile a secco sono preferibili per la loro maggiore praticità. 16 Nota del traduttore: La dicitura è impropria ma impiegata a quel tempo; si tratta dell’indicazione della densità, in questo caso, di 680 g/l.
38
la precauzione di sistemare sul tubo del camino un collarino di gomma che gli impedisca di scendere sotto la posizione corretta. La scatola che racchiude il doppio volano del motore sarà probabilmente vuota (ve ne assicurerete svitando il tappo a galletto sistemato in basso, verificando che non esca una sola goccia d’olio) e, se è così, sistemerete nel suo bocchettone superiore con il tappo esagonale un imbuto senza reticella, in cui verserete il contenuto esatto di un misurino per l’olio che troverete nella borsa. Questo misurino non è scelto a caso ma è stato progettato con cura. Sarà meglio versare nel motore piuttosto un po’ meno del giusto che troppo. ----------------- 000 -----------------Il triciclo è in ordine di marcia e lo avvieremo17. Non siate emozionati, la bestia è gentile. Mettetevi in sella, i piedi sui pedali, e spostate la manopola di sinistra su Arrêt. In primo luogo aprite il rubinetto di compressione; se ve ne dimenticate, la compressione del pistone v’impedirà di partire. In secondo luogo mettete in verticale le due manette vicine che trovate davanti a voi e assicuratevi che l’anticipo sia al minimo. Allora, pedalate un po’. Il triciclo si muove grazie a voi. State sostituendo il motore. Girate la manopola su Marche. La vostra mano sinistra lascerà allora la manopola e la destra dirigerà il triciclo e sposterà lentamente avanti e indietro la manetta della carburazione cercando la posizione in cui si produrranno degli scoppi. Un’esplosione avviene finalmente! Ci siamo! Uno, due, tre… scoppi; chiudete subito il rubinetto di compressione. Ora le esplosioni si susseguono senza interruzione. Sono poco rumorose perché avvengono all’interno del cilindro, ma il triciclo va già avanti da solo a buona andatura. Finalmente i piedi rimangono immobili sui pedali. Siete partiti. Riflettete adesso sui fenomeni sotto il vostro controllo. Sotto la mano sinistra si trova l’arresto del motore. Un ottavo di giro e la corrente non passa più. Sotto la mano destra, si trova l’arresto di sicurezza e il freno. Davanti a voi, due manette. Quella di sinistra regola la carburazione. L’avete messa a posto un momento prima; non toccatela più. Quella di destra regola la quantità di gas che immettete nel cilindro. Se il terreno è cattivo, in pendenza o, in definitiva, pensate che il motore deva darvi più forza subito, spingete allora la manetta in avanti. Il terreno migliora? Perché consumare inutilmente del gas, ossia della benzina? Riportate la manetta indietro, il motore non ha bisogno di tanta forza. Sotto la sella (tipo 1 ¼ CV) o davanti a voi (tipo 1 ¾ CV) una manetta regola l’accensione. Ricordatevi che l’anticipo di accensione deve sempre variare con la velocità del motore: se rallenta, riducete l’anticipo. Questa prima lezione di guida è terminata; potete scendere dal veicolo, aprire il rubinetto di compressione e, dall’alto del cilindro, iniettate con un oliatore, impiegato solo 17 Non dimenticate il perno del contatto!
39
per questo, due o tre gocce di petrolio (assolutamente non benzina) e conducete il vostro triciclo a mano in rimessa. Questa dose di petrolio ha lo scopo di eliminare le lacche dai segmenti, ossia evita che l’olio si dissecchi su di loro impedendone il corretto funzionamento.
40
VIII – LE PRINCIPALI PANNES Riprendiamo il triciclo in rimessa e facciamo una seconda passeggiata; il vostro apprendistato è terminato. Tiriamolo fuori alla luce e assicuriamoci che nessuna vite sia allentata. Versiamo nel serbatoio la benzina necessaria, eliminiamo le lacche18 dai segmenti, poi mettiamo la spina di contatto e in sella! Il triciclo non parte. Se non ottenete esplosioni, scendete. La prima funzione da ispezionare è l’accensione, perché nove volte su dieci è qui che si localizza il malanno. Occorre procedere per deduzione. Assicuratevi che scocchi la scintilla. Mettete la manopola su Marche, poi togliete la scatola che copre il vibratore, e mettetelo nell’intaglio della camma. Togliete il filo dalla candela e presentate la sua estremità spelata a due o tre millimetri da una qualsiasi parte metallica del motore intanto che con l’altra mano farete muovere il vibratore. Delle scintille dovrebbero apparire all’estremità del filo. Se vedete scintille, può darsi che il difetto sia nella candela. Smontatela e guardate se le punte non siano deviate, se si trovino a 1 mm una dall’altra, se la porcellana non sia rotta, se il filo centrale non sia staccato, ecc. In caso di anomalia, cambiate la candela. In caso d’integrità rimettetela a posto, serrate a fondo, ricollegate il filo. Se il male risiedeva nella candela e l’avete riparato, rimontate in sella; il triciclo dovrebbe partire. Se la candela è stata giudicata indenne, il difetto sarà nei collegamenti elettrici. Perché non c’è corrente? Perché o le pile sono scariche o perché un filo si è rotto. Prendete una chiave o un pezzo metallico e mettete in corto circuito i morsetti del pezzo mobile di ebanite. Se la corrente passa si vedranno tante piccole scintille. Il malanno è localizzato fra i morsetti e la candela, ossia al vibratore. Il vibratore potrebbe essersi spostato in seguito a uno scossone. Smontatelo e guardatelo. Se è deviato, raddrizzatelo e rimontatelo in posizione. Potrebbe non andare sufficientemente a contatto contro la vite platinata. Nella posizione normale, quando si trova nell’intaglio, deve trovarsi in leggera interferenza con il contatto. Potrebbe essersi fessurato. In tal caso avrà perso la sua elasticità e andrà sostituito. Potrebbe anche essersi sporcato d’olio. Tutto potrebbe essere in ordine. Rimettete la scatola a posto e guardate più lontano. Un filo avrebbe potuto rompersi. Percorrete tutto il circuito e guardate con attenzione i punti di 18 Nota del traduttore: Anche se qui non viene spiegata, l’eliminazione delle lacche dai segmenti avviene facendo scorrere della benzina nella camera di combustione e aspettando che asciughi.
41
attacco ai morsetti della bobina, della camma, della candela e del volante, risalendo fino alle pile. Se non avete trovato rotture, dovete concludere che le pile sono scariche. Misurerete la carica con l’aiuto di un amperometro (fig. 33). I poli dello strumento devono essere messi in contatto con quelli della pila; la lancetta deve indicare almeno 2 ½. Sotto la carica è insufficiente. Le pile nuove indicano in genere 5 o 6 ampères19. Per servirsi dell’amperometro, il modo più semplice consiste nell’appoggiare i due fili del piccolo strumento ai morsetti della bobina marcati P, ovvero i più lontani quando ci si mette dietro la macchina. Nota bene: Ben inteso, occorre che la spina sia montata, la manetta nella posizione Marche ma il vibratore non si trovi nell’intaglio della camma. Se per caso l’amperometro va sulla parte negativa della scala, occorre scambiare i morsetti. Se le pile sono cariche e tutto il resto è a posto, il malanno non può che essere nell’impugnatura che non fa contatto. Smontatela e assicurate bene i pezzi che la compongono serrando le viti che possono essersi allentate per le vibrazioni. Per strada, se non avete il tempo di montare e smontare l’impugnatura, sistemate i due fili al centro del manubrio sullo stesso morsetto e fermate il motore sregolando al massimo la carburazione. Tutte queste ricerche lunghe da spiegare si eseguono rapidamente. Frequentemente il difetto di accensione risiede nella candela o nel vibratore. Il male è presto trovato e riparato. Se l’accensione funziona regolarmente e il triciclo non parte, dovete concludere che la carburazione non va perché la benzina è troppo densa o troppo poco volatile. Questo incidente è frequente d’inverno. La benzina è evidentemente meno volatile che d’estate e l’aria che entra nel motore non si è caricata di vapori a sufficienza. I rimedi sono diversi. Quelli che non hanno paura di nulla, raccomandano di mettere sotto il serbatoio, un tampone d’amianto imbibito di benzina per riscaldare il liquido. Penso che questo pericoloso rimedio non debba essere usato che nei casi estremi, perché è meglio evitare il rischio di far saltare il serbatoio per causa di una perdita. Preferisco vuotare completamente il serbatoio e versarvi della benzina nuova, alla temperatura in cui si trova quando è conservata in un ambiente chiuso dove non faccia troppo freddo. Preferisco anche aiutare la carburazione versando per il foro di compressione qualche goccia di benzina; il liquido si volatilizza rapidamente e quando il pistone aspira, l’aria si miscela istantaneamente con il vapore e ne deriva subito qualche scoppio. Talvolta ho miscelato a una benzina troppo vecchia della gasolina da 650°20 al solo scopo di produrre 19 Nota del traduttore: Forse si tratta di un voltmetro e le indicazioni sono da intendersi in Volt. 20 Nota del traduttore: Dovrebbe corrispondere alla benzina avio di oggi.
42
l’avviamento. I primi scoppi ottenuti riscaldano leggermente la massa della benzina nel serbatoio e la carburazione prosegue regolarmente. Raccomando, soprattutto d’inverno, di non versare nel serbatoio-carburatore niente più della quantità di benzina che si crede necessaria per il tragitto. ----------------- 000 -----------------Leggendo queste spiegazioni, i lettori potrebbero pensare che occorra tanta pazienza e competenza per mettere in strada un triciclo a benzina! Li rassicurerò, certificando loro che di solito l’apparecchio si mette in marcia al primo colpo. Ma dobbiamo comunque esaminare le situazioni difficili che possono presentarsi ed eccoci così forzati a occuparci ancora d’incidenti! Diversi altri piccoli inconvenienti possono ancora presentarsi all’avviamento. Per esempio, il triciclo parte sussultando; spesso dalle prime esplosioni sembra che voglia liberarsi del cavaliere, facendolo volare sopra il manubrio. In questo caso il problema viene da voi. Se il triciclo sussulta, siete voi che vi siete dimenticati di mettere la manetta dell’anticipo al minimo, come dovevate fare; le esplosioni sono allora troppo anticipate rispetto alla compressione per la bassa velocità cui procedete. Può essere che voi facciate molta fatica a smuovere il veicolo pedalando. Molto spesso il male proviene da un freno che sfrega sul tamburo. Scendete e con l’aiuto di un cacciavite o di un pezzo metallico qualsiasi sollevate il ceppo o meglio, regolatelo come si deve. Le altre cause di scarsa scorrevolezza del triciclo sono: l’aver dimenticato di eliminare le lacche dai segmenti prima di partire; l’apertura insufficiente del rubinetto di compressione, la sregolazione o il grippaggio di un cuscinetto a sfere; un’esagerata tensione della catena. Tutte queste piccole noie, lo ripeto ancora, sono rare; le cito per evitare ai miei lettori di trovarsi sorpresi da una di queste. ----------------- 000 -----------------In strada. Abbiamo esaminato nella nostra prima passeggiata l’uso delle manette. È difficile fornire regole precise che permettano di risolvere tutti i problemi che si presentano su strada. L’abilità del motociclista è importante nel condurre il triciclo, come in tutte le altre automobili. Un cavaliere abile percepisce i cambiamenti, a volte frequenti, a volte rari, che occorre apportare all’apertura dell’aria. Essi accadono quando la benzina inizia ad abbassarsi o a impoverirsi delle parti più volatili; quando il motore funziona da lungo tempo, di conseguenza, la benzina sarà ben riscaldata dallo scappamento e conseguentemente più volatile; inversamente, se si marcia da poco; se si marcia sotto il sole o sotto la pioggia; se si marcia al sole o all’ombra. In altre parole, il buon guidatore si preoccupa costantemente delle indicazioni che riceve dalle orecchie e dalle vibrazioni del motore per regolare l’aria sempre al punto esatto.
43
Su un terreno pianeggiante e secco, l’apertura del rubinetto di ammissione può essere completa e l’anticipo portato al massimo. L’andatura può essere molto veloce perché, se il lavoro da farsi è più lieve, il motore può girare veloce senza chiedere troppo gas. Secondo l’andatura che si vuole ottenere, si deve ricercare la combinazione di posizione delle manette che permetta di usare meno gas possibile. Sarebbe ad esempio ridicolo, su terreno piano, accelerare facendo uso del solo rubinetto del gas, lasciando l’anticipo al minimo. Si sprecherebbe molta benzina e non si accelererebbe tanto perché gli scoppi arriverebbero troppo in ritardo. Si deve cercar di marciare con il minimo gas e il massimo anticipo. In una discesa dolce, chiudete quasi totalmente l’ammissione e, se il terreno è buono, la strada priva di ostacoli, anticipate al massimo. La velocità sarà alta senza consumo. In una discesa più ripida, girate la manopola su Arrêt in modo che il motore non spinga più, state attenti a non far aumentare la velocità e tenete le mani vicino al comando dei freni. In una discesa molto ripida, girate la manopola su Arrêt e avanzate lentamente serrando i freni a intervalli in modo che non si riscaldino. Le salite si compiono facilmente se si ha cura di attaccarle con una carburazione appropriata. Il punto essenziale consiste nell’assicurare più che mai la perfetta carburazione nel momento in cui la salita inizia. Le salite dal 3 al 7% si compiono facilmente senza pedalare. Basta aprire leggermente il rubinetto di ammissione e aggiustare l’anticipo in misura del rallentamento del motore. Le salite più dure, fino al 12% circa, richiedono che il cavaliere pedali per aiutare il motore e, soprattutto, per tenerlo a una velocità minima, sotto la quale si arresterebbe. I consigli sono difficili su questa materia. L’esperienza di ognuno sarà più utile. ----------------- 000 -----------------Se si rompesse qualche pezzo di cui non si ha il ricambio e il motore s’immobilizzasse, occorrerebbe informarsi su dove portare a forza di muscoli il veicolo per la riparazione. Per far ciò, dovreste disinserire il motore, estraendo con l’aiuto di un cacciavite il piccolo pignone. Lo sforzo delle vostre gambe sarà tutto destinato al movimento del triciclo, pesante è vero, ma più scorrevole se doveste trascinare insieme anche il motore. Gli incidenti più frequenti su strada prevengono da urti, dall’attraversamento violento di un solco, di una cunetta o dalla marcia su una cattiva pavimentazione. Se il triciclo si ferma, il più delle volte si è rotto un filo o si è deviato il vibratore. Qualche volta, assai raramente, la molla della valvola di ammissione si è staccata e persa. Se non avete questo pezzo di ricambio, potrete fabbricarne uno nuovo con del filo di ferro sottile o potrete semplicemente tenerla chiusa applicando un piccolo peso allo stelo, come una chiave. L’essenziale è che la valvola sia leggermente richiamata in chiusura dopo l’aspirazione. Le valvole. Le sole parti che il motociclista deve verificare ogni tanto sono l’accensione e le valvole. Dell’accensione abbiamo parlato a lungo; vediamo ora le cure che occorre avere nei confronti delle valvole.
44
Le valvole non chiudono sempre bene sia per l’uso prolungato, sia a causa della sporcizia provocata dall’olio bruciato. Si costata facilmente l’imperfetta chiusura dal difetto di compressione che questa provoca. Se la valvola d’ammissione non chiude bene, quando il pistone risale nel cilindro, ricaccia l’aria attraverso la perdita; ve ne accorgete per la poca fatica che farete a muoverlo anche con il rubinetto di compressione chiuso. Per smerigliare le valvole, occorre anzitutto togliere i tappi metallici che le ricoprono (tipo 1 ¼ CV), o smontare il tubo di scarico e la campana (tipo 1 ¾ CV). Poi si versa un po’ di petrolio su ciascuna di esse e si girano a mano, tirandole fortemente con lo stelo in modo che si appoggino bene al seggio. Le superfici di contatto si puliranno un po’ e si adatteranno al seggio. Questo è una smerigliatura leggera da farsi solo su strada, in caso di necessità.
Per fare questo lavoro con la cura che merita, poiché dalla sua buona esecuzione dipende il buon funzionamento del motore, occorre togliere le molle delle valvole (cosa facilissima per la valvola di ammissione). Prendendo infine ciascuna valvola in mano si distribuirà sui bordi una pasta fatta con polvere di smeriglio tipo 000 (ossia molto fine), impastata nell’olio o nel petrolio, avendo cura che nessun grano di questa polvere vada altrove nel motore. Si rimette la valvola in sede e, sia a mano (per la valvola di ammissione solamente), sia aiutandosi con un cacciavite (per la valvola di scarico, che reca per questo sul fungo un taglio di cacciavite), si gira lentamente la valvola tenendola contro il seggio con la mano (vedere la fig. 34). La rotazione deve durare qualche minuto, finché i bordi della valvola non appaiano brillanti e privi di rigature. ----------------- 000 -----------------
45
Questi sono i brevi consigli, evidentemente molto succinti, che posso darvi sul triciclo de Dion e Bouton, su questa macchina facile da guidare anche dalle donne, così semplice da aver potuto dare grande slancio al progresso dell’automobile!21
21 Questo motore è ora costruito dai signori de Dion e Bouton non solo per i motocicli ma anche, in un formato più grande, per le vetturette a due posti. In questo caso, il raffreddamento è ottenuto con una circolazione d’acqua. Non ci sono altre differenze; tutto quello che si è detto, vale quindi anche per le vetturette.
46
Automotoclub Storico Storico Italiano Commissione Cultura www.asifed.it
www.asifed.it