








1911-1919



© 2022 Centauria Editore srl – Milano
Publisher
Balthazar Pagani
Per i testi
© Paolo Mieli
© Francesco Cundari
Per le illustrazioni
© Ivan Canu
Graphic design
PEPE nymi
Proprietà artistica letteraria riservata per tutti i Paesi.
Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata.
Prima edizione giugno 2022
Isbn 9788869214714
1911-1919
illustrazioni di
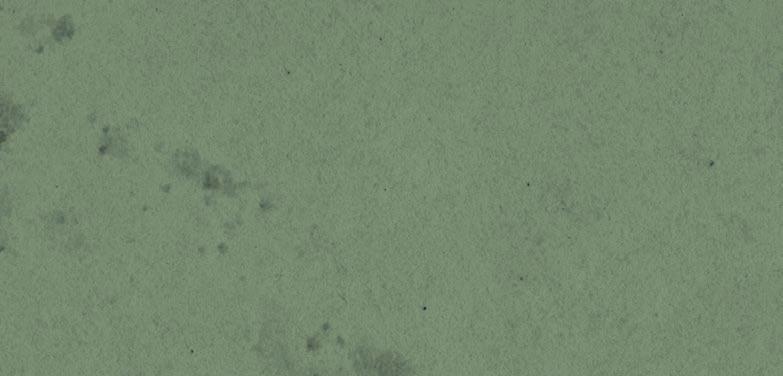










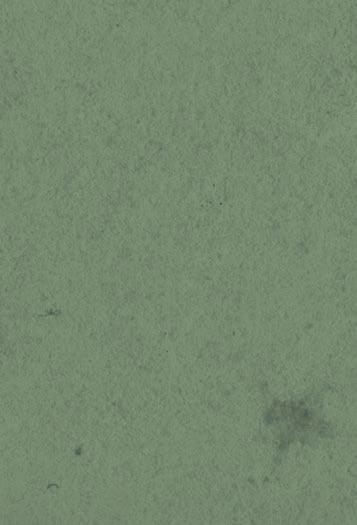


La catastrofe
Sonnambuli, geni e sinistri scricchiolii 11
Dietro lo sparo di Sarajevo:
Gavrilo Princip e gli altri 15
I giorni che resero normale l’orrore 24
Il prezzo del conflitto 34 Il problema storico della colpa
50 RITRATTI
Luigi Albertini
Francesco Baracca
Luigi Barzini
Cesare Battisti
Benedetto XV
Maria Bergamas
Leonida Bissolati
Ivanoe Bonomi
Bruno Buozzi
Luigi Cadorna
Luigi Capello
Filippo Corridoni
Alfredo Dallolio
Gabriele D’Annunzio
Ludovico D’Aragona
Alceste De Ambris
Grazia Deledda
Cesare De Lollis
Armando Diaz
Giulio Douhet
Eleonora Duse
Alfredo Frassati
Carlo Emilio Gadda
Giovanni XXIII
Piero Gobetti
Margherita Incisa di Camerana
Margherita Kaiser Parodi
Lussu
Curzio Malaparte
Giacinto Menotti Serrati
Giovanni Minozzi
Benito Mussolini
Vittorio Emanuele Orlando
Ferdinando Maria Perrone
Maria Rygier
Antonio Salandra
Gaetano Salvemini
Nazario Sauro
Matilde Serao
Arrigo Serpieri
Renato Serra
Scipio Slataper
Ardengo Soffici 157
Sidney Sonnino 159
Carlo e Giani Stuparich 161
Luigi Sturzo
Paolo Thaon di Revel

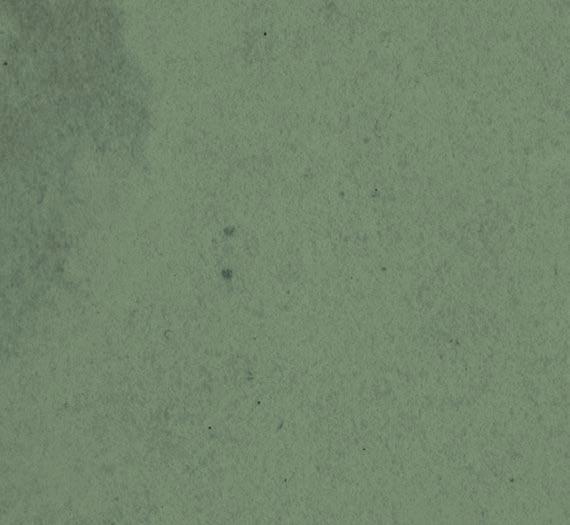




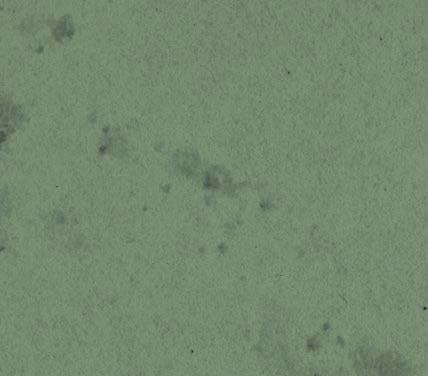


















Come il mondo precipitò nella guerra
Non è sempre agevole ricostruire successivamente e con sufficiente obiettività le percezioni che i contemporanei ebbero dei grandi eventi storici cui si trovarono ad assistere (o a partecipare). Alla vigilia della Prima guerra mondiale si ha però l’impressione che le classi dirigenti europee fossero davvero composte da sonnambuli. «Apparentemente vigili e però non in grado di vedere, tormentati dagli incubi ma ciechi di fronte alla realtà dell’orrore che stavano per portare nel mondo», come ha scritto Christopher Clark nel suo ampio studio sulle origini del conflitto: I sonnambuli. Come l’Europa arrivò alla Grande guerra (Laterza).
Eppure questi sonnambuli avevano dato vita a un mondo unico, pieno di talenti e per certi versi magico. È quel che ha provato a dimostrare lo storico dell’arte Florian Illies in un altro magnifico libro: 1913. L’anno prima della tempesta (Marsilio).
Che cosa ha avuto di particolare quell’anno, l’ultimo prima dello scoppio della guerra? Semplice: l’Europa si è riempita di personalità ineguagliabili. Una concentrazione incredibile, occasione di incontri, coincidenze e relazioni imprevedibili.
Nel gennaio del 1913 è probabile che a Vienna l’esiliato Iosif Stalin e Adolf Hitler si siano sfiorati mentre passeggiavano, come era loro abitudine, nel parco di Schönbrunn. Sempre a Vienna, in febbraio, Stalin e Trockij si incontrano per la prima volta, proprio nel momento in cui a Barcellona nasce Jaime Ramón Mercader, il sicario che ucciderà Trockij per conto di Stalin. In quegli stessi giorni Lenin scrive a Maksim Gor’kij: «Una guerra fra Austria e Russia potrebbe essere molto utile alla rivoluzione nell’Europa occidentale; solo è difficile immaginare che Francesco Giuseppe e lo zar Nicola vogliano farci questo piacere».
Il 1913 è l’anno in cui a Monaco Oswald Spengler, suggestionato dal naufragio del Titanic, avvenuto l’anno prima, inizia a scrivere Il tramonto dell’Occidente. È l’anno in cui Pablo Picasso e Georges Braque passano al «cubismo sintetico». E anche quello della definitiva rottura tra Sigmund Freud e Carl Gustav Jung («Le propongo di cessare completamente i nostri rapporti privati; io non ci perdo nulla, perché ormai da lungo tempo ero legato a Lei soltanto dal filo sottile delle delusioni» scrive in gennaio il maestro all’allievo).
La stagione in cui, oltre a Freud, a Vienna davano eccezionale prova di sé Arthur Schnitzler, Egon Schiele, Gustav Klimt, Adolf Loos, Karl Kraus, Otto Wagner, Hugo von Hofmannsthal, Ludwig Wittgenstein, Georg Trakl, Arnold Schönberg, Oscar Kokoschka. Tra loro si stabilisce una rete di curiose interrelazioni. Che ingloba Robert Musil, a cui un medico diagnostica «chiari segni di nevrastenia» («Ma quella che nel 1913 diventa malattia mentale» annota nel proprio diario l’autore dei Turbamenti del giovane Törless parlando di Dante Alighieri, «nel Duecento potrebbe essere stata considerata una semplice manifestazione di eccentricità»).
La rete si estende anche fuori da Vienna. A Praga ci sono un altro nevrastenico eccellente, Franz Kafka («Voglio curarmi mediante il lavoro» scrive all’amico Max Brod), e Albert Einstein, che lascerà la città alla fine del ’12. A Berna Hermann Hesse. In Inghilterra Virginia Woolf, che nel pieno di una depressione porta a termine La crociera (fino al 1929 ne venderà solo 479 copie). In Germania Thomas Mann, a Parigi Rainer Maria Rilke. Marcel Proust pubblica il primo volume di Alla ricerca del tempo perduto («La vita è troppo breve e Proust troppo lungo» lo stronca Anatole
France). E ancora a Berlino George Grosz, a Monaco Vasilij Kandinskij, che stringe amicizia con Paul Klee, nella capitale francese Robert Delaunay, František Kupka e Marcel Duchamp, in Russia Kazimir Malevič, in Olanda Piet Mondrian.
Il 1913 è l’anno in cui Albert Schweitzer vende tutti i suoi beni e si trasferisce in Africa. Walter Gropius pubblica i Progressi della moderna architettura industriale. Igor’ Stravinskij festeggia la prima di Le sacre du printemps. Max Weber conia l’espressione «disincantamento del mondo». Edmund Husserl dà alle stampe Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica. Ludwig Mies van der Rohe apre il suo studio di architettura a Berlino. Di nuovo a Parigi André Gide, Igor’ Stravinskij e Jean Cocteau assistono assieme alle prove del balletto di Nižinskij su coreografie di Djagilev e musica di Claude Debussy: litigano con gli artisti perché definiscono lo spartito «esile» e il costume del ballerino «effeminato e ridicolo». Alla prima assiste Gabriele D’Annunzio, giunto in Francia per fuggire dai creditori italiani. Giorgio de Chirico dipinge Piazza d’Italia. Frank Wedekind si rifugia a Roma dopo il divieto di mettere in scena Lulu («Ma se ci si vuole divertire, meglio andare a Parigi» scrive alla moglie Tilly). Verso la fine dell’anno tutto si fa più cupo. Carl Schmitt prende nota di una intenzione suicida. «A nessuno importa niente, a nessuno importa di me, a me non importa di nessuno» scrive. Walther Rathenau dedica il suo libro Meccanica dello spirito alle «nuove generazioni». Il 20 novembre Kafka annota nel suo diario: «Al cinematografo. Ho pianto». Il 15 dicembre Ezra Pound scrive a un James Joyce pressoché sconosciuto e povero in canna per chiedergli qualcosa da pubblicare. «Egregio Signore, stando a quanto mi dice Yeats, potrei quasi pensare che io e Lei siamo accomunati da qualche avversione» gli dice. Poche settimane dopo Joyce gli invia Ritratto dell’artista da giovane e Gente di Dublino. Il 31 dicembre Arthur Schnitzler confida al proprio taccuino di aver finito di dettare la novella Follia, di aver letto un libro di Ricarda Huch sulla guerra in Germania (quella del 1870) e di aver trascorso una «giornata molto nervosa». Il ritratto che Florian Illies traccia dell’ultimo anno di pace è davvero fuori dal comune. Decine, centinaia di storie offrono il quadro di un concentrato di geni (e qui ne abbiamo tralasciati moltissimi) probabilmente unico nella
storia dell’umanità. Geni che si affacciarono al 1914 con qualche presentimento di quel che stava per accadere. Anche se tutti lo percepivano come qualcosa di individuale che atteneva alla sfera della melanconia, di un qualche turbamento del proprio sistema nervoso. Così come i loro governanti. Tanto che, quando poi scoppiò la guerra, le classi dirigenti fecero fatica ad accorgersi di quel che stava davvero succedendo.
Qualcuno, come il corrispondente del «Times» Henry Wickham Steed, dirà poi – ricorda Christopher Clark – d’aver avvertito lo scricchiolio. In una lettera del 1954, Wickham Steed scriverà al direttore del «Times Literary Supplement» che, quando nel 1913 aveva lasciato l’Impero austroungarico, aveva «sentito» che «stava scappando da un edificio destinato alla fine» (ma nel ’13 aveva scritto tutt’altro, e cioè che «in dieci anni di osservazione e di esperienza» non aveva percepito «nessuna ragione sufficiente» per cui la monarchia asburgica «non dovesse mantenere il suo legittimo posto nella comunità europea»).
All’epoca dello scoppio della guerra la consapevolezza di quanto stava per accadere era dunque assai scarsa. Tant’è che, nota Clark, in Francia la notizia di Sarajevo venne di fatto scalzata dalle prime pagine dei giornali dallo «scandalo Caillaux».
In marzo Madame Caillaux, moglie dell’ex primo ministro Joseph Caillaux, era entrata nell’ufficio del direttore del «Figaro», Gaston Calmette (l’amico cui Proust aveva dedicato il primo volume della Recherche), e gli aveva sparato sei colpi. Il movente del delitto era, a detta della donna, la campagna che il quotidiano aveva condotto contro suo marito, pubblicando fra l’altro le lettere d’amore che la signora aveva scritto al futuro coniuge quando lui era ancora sposato con la prima moglie. Il processo avrebbe dovuto aprirsi il 20 luglio «e l’interesse del pubblico per questa vicenda, che univa uno scandalo a sfondo sessuale e un “crime passionnel” commesso da una donna molto in vista nella vita pubblica francese, fu naturalmente immenso».
Ancora il 29 luglio, l’importante «Le Temps» dedicò all’assoluzione di Madame Caillaux (decretata in base alla tesi secondo cui «la provocazione era un elemento tale da giustificare il delitto») un rilievo doppio rispetto a quello riservato alla crisi che di lì a qualche giorno avrebbe trascinato in guerra l’intera Europa.

A parziale giustificazione dell’inconsapevolezza dei contemporanei, bisogna anche dire che l’arciduca Francesco Ferdinando, assassinato da Gavrilo Princip il 28 giugno 1914, non era certo il primo uomo di Stato a venire ucciso in quel modo. Nei vent’anni precedenti, la stessa sorte era toccata al presidente della Repubblica francese, Marie François Sadi Carnot, assassinato dall’anarchico italiano Sante Caserio nel 1894; allo scià di Persia, Nasser al-Din, ucciso in un attentato nel 1896; al presidente dell’Uruguay, Juan Idiarte Borda, e al primo ministro spagnolo, Antonio Cánovas del Castillo (anche quest’ultimo, peraltro, per mano di un anarchico italiano: Michele Angiolillo), nel 1897; al presidente del Guatemala, José María Reina Barrios, e all’imperatrice d’Austria, Elisabetta di Baviera, meglio nota come Sissi, nel 1898; al presidente della Repubblica dominicana, Ulises Heureaux, nel 1899; al re d’Italia Umberto I, assassinato a Monza dall’anarchico Gaetano Bresci, dopo essere già scampato a diversi altri attentati, nel 1900; al presidente degli Stati Uniti, William McKinley, anche lui vittima di un anarchico, questa volta però di origini polacche, nel 1901; al re e alla regina di Serbia, Alessandro I e Draga Obrenović, uccisi da una congiura di militari nel 1903; al primo ministro greco, Theodōros Dīligiannīs, nel 1905; ai primi ministri di Bulgaria e Persia nel 1907; al primo ministro egiziano nel 1910; al primo ministro russo nel 1911; al primo ministro spagnolo (un altro, ovviamente) nel 1912; al presidente del Messico e al re di Grecia nel 1913. A rendere diverso il caso dell’assassinio di Francesco Ferdinando, però,
non è solo quello che accadde dopo – come tutti sanno: lo scoppio della Prima guerra mondiale – ma anche quanto era avvenuto negli anni precedenti. Per ritrovare il filo degli avvenimenti bisogna cominciare dall’annessione della Bosnia-Erzegovina, nel 1908. Tre anni dopo, nel 1911, non per niente, viene fondata l’associazione terroristica antiaustriaca Unione o morte, più conosciuta come la Mano nera, cui si richiamava anche il movimento Giovane Bosnia del diciannovenne Gavrilo Princip (nonché gli ufficiali che avevano ucciso i reali di Serbia nel 1903). Insomma, come ha scritto uno dei maggiori storici del ventesimo secolo, Johan Huizinga, «la povera Europa si avviava verso la prima guerra mondiale come un’automobile sgangherata in mano di un conducente ubriaco per una strada tutta buche e cunette».
Eppure, bisogna ripeterlo, non era questa l’impressione dei contemporanei. Al contrario. Rievocando quei giorni, Stefan Zweig scriverà: «Non si temevano ricadute barbariche come le guerre tra popoli europei, così come non si credeva più alle streghe e ai fantasmi; i nostri padri erano tenacemente compenetrati dalla fede nella irresistibile forza conciliatrice della tolleranza. Lealmente credevamo che i confini e le divergenze esistenti tra le nazioni o le confessioni religiose avrebbero finito per sciogliersi in un comune senso di umanità, concedendo così a tutti la pace e la sicurezza, i beni supremi».
In Italia, quell’equilibrio apparentemente immutabile comincia a incrinarsi proprio nel 1908, lo stesso anno dell’annessione della Bosnia, con un’ondata di agitazioni studentesche a carattere irredentista che si conclude, a fine anno, con un moto di solidarietà e di soccorso alle popolazioni colpite dal sisma che aveva appena devastato la costa della Sicilia orientale e quella calabrese.
Come ha ben messo in evidenza John Dickie in Una catastrofe patriottica. 1908: il terremoto di Messina (Laterza), quegli aiuti si inserivano in uno schema retorico che proponeva uno stretto parallelismo tra la tragedia naturale e la guerra. Schema che, di lì a breve, avrebbe avuto occasione di ripresentarsi per l’aggressione coloniale alla Libia, nel 1911, e poi per l’ingresso dell’Italia nel primo conflitto mondiale, nel 1915.
Ma è proprio nel 1908 che tutto si mette in moto, come spiega Catia Papa
in L’Italia giovane dall’Unità al fascismo (Laterza). L’occasione che diede il là al movimento fu il pellegrinaggio studentesco alla tomba di Giosuè Carducci in un fine settimana di metà febbraio, nel primo anniversario della morte del poeta. «Dimenticate o rimosse le contestazioni degli studenti bolognesi a Carducci del 1891, quando la sua adesione alla politica crispina aveva generato un autentico tumulto nell’Ateneo emiliano» scrive Papa, «l’Associazione degli studenti milanesi redasse un manifesto, pubblicato su “L’Azione studentesca”, nel quale celebrava il “Maestro che insegnò la religione della Patria e del Dovere”, invitando tutti gli studenti ad andare a deporre una corona di fiori sulla tomba eretta ad “Altare della Patria”.»
L’irredentismo, Carducci e Messina erano in realtà poco più che pretesti per dar sfogo a una rivolta dei figli contro i padri appartenenti alla «generazione di mezzo» (di mezzo tra quella che aveva fatto l’Italia e quella che avrebbe combattuto nella Prima guerra mondiale) accusati di essere privi di ideali e inadatti a raccogliere le bandiere affidate loro dai genitori del Risorgimento.
All’inizio del Novecento in molti Paesi europei si diffusero associazioni promosse e gestite per dare un orizzonte ideale agli adolescenti. La più famosa fu quella tedesca dei Wandervögel («uccelli migratori») che George Mosse nelle Origini culturali del Terzo Reich (il Saggiatore) ha definito «il simbolo della rivolta delle nuove generazioni contro la vecchia». Winfried Mogge, che se n’è approfonditamente occupato con I Wandervögel: una generazione perduta (Socrates), ha messo in evidenza come nell’estate del 1914 molti ragazzi appartenenti a questa associazione risposero volontariamente e con entusiasmo all’appello della patria in guerra, immolandosi a migliaia nei campi di Langemark, la cittadina delle Fiandre teatro della prima grande battaglia seguita all’invasione tedesca del Belgio. Anche da noi le cose avevano cominciato a muoversi già da molto tempo. Nel marzo del 1901 molte comunità universitarie italiane erano andate in piazza per attestare solidarietà al movimento studentesco russo violentemente represso dalla polizia zarista. A Roma in quattrocento si danno appuntamento alla Sapienza per votare un ordine del giorno di protesta contro il regime di San Pietroburgo e chiamare tutti gli atenei del Regno alla mobilitazione. Altre manifestazioni si svolgono a giugno per chiedere la proroga
della sessione di esami a favore degli studenti che hanno partecipato ai cortei di marzo. Contro di loro scendono in campo gli studenti socialisti, i quali si pongono in contrapposizione al «volgarissimo contegno di quei giovani universitari che hanno cercato di affermare un loro particolare interesse in modo tanto indecoroso». Alla fine di quello stesso 1901 il socialista Enrico Ferri, docente di diritto nell’ateneo romano, pronuncia alla Camera un discorso che gli studenti nazionalisti giudicano «offensivo dell’onore nazionale». In vista della ripresa delle lezioni di Ferri, nel gennaio del 1902, il circolo universitario monarchico fa circolare appelli affinché gli studenti facciano valere le loro ragioni contro il professore. Il rettore rinvia l’inizio del corso ma sostenitori e detrattori di Ferri si affrontano più volte, anche in modo violento, finché il rettore decide di chiudere l’università e di farla piantonare dai carabinieri. Segno che qualcosa stava cambiando. Fu in quel clima che nacque, a opera di Efisio Giglio Tos, uno dei più importanti sodalizi studenteschi dell’epoca: i Corda fratres, il cui primo congresso si tenne a Roma nell’aprile del 1902, alla presenza del ministro dell’Istru zione, Nunzio Nasi, nonché di molti professori e rettori. «In assenza di un movimento giovanile di contestazione dell’autoritarismo paterno e degli adulti in genere in famiglia o tra le aule scolastiche» scrive Papa, «la retorica generazionale rappresentò uno strumento di promozione sociale e politica di un’élite intellettuale che seppe fare dell’Italia una patria d’elezione del “ribellismo giovanile” a fini patriottici.» Dopo la guerra di Libia che pure, riferisce Papa, viene parzialmente criticata da questi patrioti perché (essendo «fatalmente inutile») avrebbe potuto distrarre dagli obiettivi dell’irredentismo, si afferma una nuova identità di questo movimento giovanile. Dai circoli alle piazze, durante la mobilitazione per la «vera guerra» dell’Italia (quella per Trento e Trieste), «l’immagine dell’élite studentesca custode e garante delle tradizioni nazionali, il culto della patria come fattore identitario, quindi ancora l’etica e l’estetica del sacrificio poterono più di qualsiasi distinzione partitica». L’unità delle varie anime dell’interventismo italiano «fu sperimentata con successo in primo luogo nel mondo studentesco, ancora una volta sotto l’egida delle società nazionali, largamente egemonizzate dai nazionalisti ma formalmente apolitiche e tradizionalmente votate a far da cerniera tra sensibilità patriottiche anche divergenti».
È il contesto di «rivolta giovanile» nel quale a opera di Giovanni Papini e Giuseppe Prezzolini nascono il «Leonardo» e poco dopo «Il Regno», il primo periodico nazionalista italiano ideato assieme a Enrico Corradini e ad alcuni esponenti dei Giovani liberali di Giovanni Borelli. È il momento di Filippo Tommaso Marinetti e dei futuristi, di cui ha efficacemente trattato Emilio Gentile in La nostra sfida alle stelle (Laterza), che glorificavano la giovinezza come principio guida della storia con tanto di esaltazione della guerra quale «rito di iniziazione primitivo e necessario di una gioventù votata alla grandezza nazionale».
Altre e più importanti riviste furono «La Voce» dello stesso Prezzolini e «Lacerba» di Papini e Ardengo Soffici, che si proponevano di rifondare l’Italia sotto la guida di «minoranze coscienti e volitive», capaci di orientare le masse. «Percepirsi parte di una generazione, rivendicare il primato sociale dell’intellettuale e autocandidarsi alla leadership culturale e politica del Paese erano in sostanza tre momenti di un’unica partitura.» Partitura destinata a riproporsi più volte nel corso del Novecento.
Nel 1914 e 1915 la piazza interventista italiana venne «animata da questi giovani ormai trentenni e dai loro fratelli minori, dagli studenti universitari e secondari». Come hanno più volte messo in luce Mario Isnenghi e Silvio Lanaro, forte di un clima culturale e politico ampiamente dissodato, il «codice generazionale assorbì larga parte della propaganda per l’entrata in guerra dell’Italia». La guerra, scrive Papa, «come impeto di eroismo giovanile, come occasione di rigenerazione del “corpo” nazionale infiacchito da un ceto dirigente senile e da egoistiche tensioni sociali, come opportunità per far saltare i vecchi equilibri di potere e promuovere l’ascesa di nuove e virili aristocrazie nazionali». La guerra «nobile voluta dai giovani, per un’Italia destinata a nuova grandezza, contro la guerra ignobile delle classi che nei decenni precedenti aveva rischiato di logorare l’organismo nazionale». Tanto più che quelle guerre erano state perse. In un saggio dedicato alle «radiose giornate» del ’15 (pubblicato dal Mulino nel volume a più voci Miti e storia dell’Italia unita) Giovanni Sabbatucci ha ben spiegato come questa «piazza» giovanile esercitò una pesante pressione sulle scelte della classe dirigente, al fine di determinare la nostra entrata in guerra a fianco dell’Intesa, «o meglio di impedire che la decisione in
tal senso, già presa dai responsabili della politica estera italiana (Salandra, Sonnino, Vittorio Emanuele III), ufficialmente sancita il 26 aprile dalla firma (peraltro segreta) del Patto di Londra, potesse essere sconfessata da un pronunciamento in senso contrario della Camera elettiva». Democratici intemerati come Bissolati e Salvemini, osserva Sabbatucci, non seppero riconoscere «le valenze antidemocratiche (oltre che antiliberali) implicite in una mobilitazione diretta contro il primo Parlamento eletto in Italia a suffragio (quasi) universale maschile». Personalità di grande spessore civile non avvertirono l’esigenza di dissociarsi dagli «aspetti più beceri e più violenti della campagna interventista»: dalla «ripetuta minaccia (a volte attuata) di passare a vie di fatto contro gli avversari alla denuncia isterica delle presunte infiltrazioni tedesche nel mondo dell’economia e della cultura (compresa la campagna, di sapore razzista, contro le “mogli tedesche”), agli insulti distribuiti a piene mani contro la “falsa” rappresentanza elettiva». È in quel momento che nascono l’idea della «contrapposizione di un paese rea le supposto buono a una rappresentanza giudicata falsa e corrotta», «l’attribuzione alla propria parte del ruolo di autentico interprete degli interessi nazionali», «la rivendicazione della guida del paese alle minoranze eroiche e alle autodesignatesi élite consapevoli».
Sono temi, questi, messi molto bene a fuoco da un altro libro pubblicato dal Mulino: Di padre in figlio. La generazione del 1915 di Elena Papadia. Che quella di cui stiamo parlando sia una generazione esistita come tale è dimostrato dal fatto che essa, ha scritto Papadia, «soddisfa tutti i criteri chiamati in causa di volta in volta per definire un’identità generazionale»: ebbe «una forte coscienza di sé, instaurò un rapporto dialettico/antagonistico con la generazione precedente (e si autoinvestì dunque, letteralmente, di un compito di rigenerazione), si costruì attorno a un evento specifico e per di più altamente perturbante, in grado cioè di interrompere con uno stacco netto il lento fluire degli eventi».
La mobilitazione di questi giovani «espresse un rifiuto violento del mondo ereditato dai propri padri (i “figli dei liberatori”, ovvero degli eroi del Risorgimento) che appariva corrotto da mercanti e politicanti, estenuato dalla perdita di ogni slancio vitale, dominato dalla gelida logica delle “cose”».
Giovanni Giolitti (grande statista ma, all’epoca, sottoposto a una campagna
ostracizzante: «male nazionale», lo definì Adolfo Omodeo, «ministro della malavita», lo bollò Gaetano Salvemini) fu eretto a simbolo della generazione dei «figli dei liberatori», dimostratasi «indegna dei propri padri», talché toccava adesso ai ventenni il compito di «redimere la mediocrità della generazione di mezzo, rinnovando appena possibile i fasti della nazione». Di qui «la sovrapposizione continuamente ribadita, anche negli anni del primo dopoguerra, tra i caduti del ’15-’18 e i martiri e i volontari del Risorgimento che stringeva esplicitamente il nesso tra nonni e nipoti, i quali, diventati “fratelli” nel nome delle comuni idealità e della loro giovinezza, rendevano la posizione della generazione di mezzo sempre più pericolante».
Fu nel maggio del 1915 – quando i movimenti giovanili scesero in piazza per imporre l’entrata in guerra – che la «generazione dei figli» occupò definitivamente la scena. E la occupò, sottolinea Papadia, «con una particolare concezione della democrazia che continuò per un certo tratto a caratterizzare anche il campo dell’antifascismo […]. Democrazia sostantiva e non procedurale, che, in nome di un principio etico superiore, poteva coesistere con il disprezzo del Parlamento, dei partiti e delle maggioranze». E che, soprattutto, «legittimava l’azione di una minoranza virtuosa, convinta di tenere nelle proprie mani il destino della nazione». Del resto tutto può essere ricondotto, secondo Papadia, «al mito di derivazione mazziniana dello Stato nuovo come forma di protesta permanente contro la realtà delle cose che divenne un tratto identitario di lungo periodo del ceto dei colti». La storica mette l’accento sulla «reversibilità ideologica di alcuni elementi costitutivi del mazzinianesimo, reversibilità ampiamente dimostrata dalla fede mazziniana di personaggi di spicco del fascismo e dell’antifascismo, da Giuseppe Bottai a Nello e Carlo Rosselli, da Italo Balbo a Ferruccio Parri, dal Delio Cantimori fascista a quello comunista».
Più volte nella storia del nostro Paese si presenterà una minoranza che si autoinvestirà di una missione salvifica nel nome della quale porsi a contrasto delle maggioranze prodotte dalle elezioni. Minoranze eredi inconsapevoli di quella del 1915, caratterizzata da una notevole «carica antiparlamentare e dall’apologia della violenza quale strumento risolutivo della presunta impasse politico-istituzionale in cui versava il Paese».
La presenza di corpose sezioni giovanili della Trento-Trieste e della Dante
Alighieri, della Corda fratres e della Terza Italia «rese superflua la creazione di veri e propri comitati studenteschi di propaganda interventista». Piuttosto si formarono battaglioni volontari studenteschi più o meno federati alla Sursum corda. Battaglioni «che non avevano e non potevano avere alcuna reale aspettativa di partecipare alle operazioni belliche, appagando piuttosto il desiderio dei giovani studenti di esibire pubblicamente la loro volontà guerriera». Volontà guerriera che andò a sfogarsi «con un uso spregiudicato della violenza» contro i neutralisti e, in particolar modo, i socialisti.
Il tono di questi giovani si configura in queste parole pubblicate sull’«Ora presente» nel gennaio del 1915: «E poi che saremo proprio noi giovani che daremo il sangue per questa guerra lungamente attesa, poi che saremo proprio noi i primi a pagare di persona, si degnino i benpensanti d’Italia di fare qualche inevitabile sacrificio di denaro […]. Se ritorneremo con le gambe sane ci concederemo l’impagabile gusto di indennizzarli a calci nel sedere». E, in quello stesso gennaio, così scriveva «L’appello dei giovani»: voi socialisti «siete guasti e corrosi dal malor civile, non avete più una speranza, avete perduto tutto ciò che significa conquista, ideale, abnegazione, siete diventati dei bruti tuffati nello sterco, come i dannati nella bolgia infernale […]. Quando si arriva a tal punto di pervertimento è consigliabile un bel colpo di rivoltella».
La campagna contro i docenti germanofili e pacifisti reclutò adepti sia nella destra sia nella sinistra dello schieramento interventista. All’università di Roma furono aggrediti i professori Giuseppe Chiovenda e Cesare De Lollis, impedendo a entrambi per giorni e giorni di tenere lezione. Il 20 febbraio 1915 il rettore decise di chiudere La Sapienza per evitare che fosse occupata dagli interventisti. Subito partirono agitazioni in molti atenei e, sei giorni dopo quel divieto, gli studenti, ricostruisce Catia Papa, si ritrovarono a Bologna per protestare contro «quei professori che calpestano gli ideali di grandezza patria». La sera di quel 26 febbraio si riversarono per le strade con intenzioni, a detta del prefetto, «tutt’altro che pacifiche poiché nella maggior parte erano armati di nodosi bastoni che nascondevano sotto i soprabiti».
Le manifestazioni proseguirono fino ad aprile e colpirono ancora De Lollis
e, a Milano, il docente del Regio istituto tecnico superiore (il futuro Politecnico) Max Abraham, indicato da Benito Mussolini come un «nemico» da espellere «con ogni mezzo» dalla comunità accademica italiana. De Lollis decise di reagire e si rivolse alle autorità offrendo la sua versione dell’accaduto: «Improperi, minacce, vie di fatto, nulla mancò […]. Fra quelli dell’uditorio che insorsero a protestare in mio favore e i dimostranti vi furono colluttazioni, dalle quali qualcuno uscì malamente e ben visibilmente contuso». Ma le forze dell’ordine fecero finta di niente e le manifestazioni a lui ostili si intensificarono.
Qualche giorno dopo De Lollis incontrò a Villa Borghese uno dei suoi contestatori e lo schiaffeggiò. Ne scaturirono altre agitazioni. Alcune manifestazioni ebbero come meta l’«Avanti!», la cui sede fu fatta oggetto di una sassaiola. Ai primi di maggio il professor Abraham lasciò «volontariamente» il Regio istituto, ma gli studenti avevano già obiettivi più ambiziosi e a metà mese assalirono Montecitorio riuscendo a imporre la guerra a un Parlamento a maggioranza non interventista.
Una volta che l’Italia fu in guerra le manifestazioni anziché cessare ebbero un’intensificazione. A La Spezia si distinse l’associazione Giovane Italia promossa dal poeta Ettore Cozzani, che incitava i giovani contro la «generazione di mezzo», «parassiti ignobili d’un albero nato dal patimento dei padri e nutrito dal sangue dei fratelli maggiori».
Grande animatore della campagna interventista, con un’accentuazione antipatizzante nei confronti di Giolitti, fu Luigi Albertini, direttore del «Corriere della Sera». Il «Corriere» fu alfiere della campagna interventista ma anche di quella per il cambio di alleanza.
La Triplice alleanza tra gli imperi di Germania e Austria-Ungheria e il Regno d’Italia era stata stipulata a Vienna il 20 maggio 1882 e confermata, pur tra molte difficoltà, cinque volte. La Triplice intesa era nata nel 1907 con l’accordo tra Russia e Inghilterra, la quale era legata alla Francia dall’Entente cordiale del 1904.
Nel frattempo in Italia si era sviluppata una vasta mobilitazione per portare a compimento il disegno risorgimentale, integrata alla vigilia dell’esplosione del conflitto da un forte impegno a passare dal campo della Triplice alleanza a quello della Triplice intesa.

Nel mese di marzo del 1914 Giovanni Giolitti rassegna le dimissioni e Antonio Salandra, leader della destra liberale, diviene presidente del Consiglio. Giolitti conta di tornare presto al posto di capo del governo che considera suo. Il 14 maggio scende in campo il «Corriere della Sera» con un editoriale del direttore, Luigi Albertini, Dove andremo?, in cui si denunciano manovre tedesche dietro la crisi di governo italiana. Il 7 giugno una manifestazione antimilitarista ad Ancona viene repressa nel sangue. È l’inizio della «settimana rossa»: agitazioni, scioperi e scontri con le forze dell’ordine in tutta Italia.
Si arriva così al giorno fatidico. Il 28 luglio, a un mese esatto dall’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando, l’Austria dichiara guerra alla Serbia. Il 1° agosto Austria e Germania dichiarano guerra alla Russia, che si era mobilitata per la Serbia.
In tutte le capitali d’Europa – incredibile a dirsi, guardando agli eventi con la sensibilità di oggi – si tengono manifestazioni entusiaste a favore del conflitto. Il governo Salandra, in ogni caso, proclama la neutralità dell’Italia, adducendo come pretesto il fatto che, pur facendo parte il nostro Paese della Triplice alleanza, l’Austria non ci aveva consultati prima di attaccare la Serbia.
Il 4 agosto inizia quello che passerà alla storia come «lo stupro del Belgio», Paese neutrale, da parte dei tedeschi, che invadono anche il Lussemburgo e il Nord della Francia, giungendo a quaranta chilometri da Parigi. A fine agosto i russi attaccano la Prussia orientale ma vengono fermati da Paul von
Hindenburg ed Erich Ludendorff nella battaglia di Tannenberg. Il 2 settembre il governo francese abbandona Parigi in pericolo per l’avanzata tedesca, che sarà fermata solo nella battaglia della Marna (5-9 settembre). Il 14 settembre il Kaiser rimuove il capo di Stato maggiore von Moltke e nomina al suo posto Erich von Falkenhayn.
Nel frattempo, in Italia, si compie la svolta interventista del «Corriere», che il 14 agosto 1914 pubblica, assieme al francese «Le Figaro», l’ode di Gabriele D’Annunzio Per la resurrezione latina, e il 24 un articolo di Andrea Torre, che scrive: «La neutralità è un’attesa, non una soluzione […] dei nostri bisogni, dei nostri interessi, dei nostri diritti». Il 20 settembre si svolgono a Roma manifestazioni interventiste. Democratici e nazionalisti chiedono di entrare in guerra a fianco della Triplice intesa (Inghilterra, Francia e Russia). Restano a favore della neutralità i socialisti, i cattolici e i liberali giolittiani.
Il 20 ottobre re Alberto del Belgio fa inondare dall’Yser le campagne tra Nieuwpoort sulla costa delle Fiandre e la massicciata ferroviaria da Nieuwpoort a Diksmuide per ostacolare il passaggio delle truppe tedesche. Il 29 ottobre la Turchia entra in guerra a fianco degli imperi centrali. Il 1° novembre il nuovo pontefice, Benedetto XV, condanna la guerra.
Il 15 novembre nasce «Il Popolo d’Italia», giornale interventista di Benito Mussolini, ex direttore dell’«Avanti!», che ha rotto con il Psi dopo aver pubblicato sul giornale socialista l’editoriale dal titolo Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante (18 ottobre).
Il 4 dicembre, Giolitti dice a Olindo Malagodi, direttore della «Tribuna»: «Se la guerra si conclude senza vantaggio per noi, saranno guai. Anche i neutralisti odierni tireranno pietre […]. Bisogna trovare modo d’intervenire quando l’Austria sia caduta; intervenire pel testamento». Il 12 dicembre Sonnino scrive a Malagodi: «La guerra sarà lunga, bisognerebbe entrarci il più tardi possibile, ma che però non sia troppo tardi».
Si giunge così al 1915, l’anno in cui l’Italia fa il suo ingresso nel conflitto.
Il 1° gennaio 1915, il «Corriere» evoca la formazione di un fascio parlamentare, reso coeso dal «comune sentimento della patria» che «ha la stessa natura generosa del sentimento della famiglia: l’uno come l’altro dà la forza e la gioia dei sacrifici necessari». Nel febbraio del 1915 si svolgono in tutta Italia
cortei a favore o contro la guerra. Il 25, ad Ancona, la polizia spara contro una manifestazione socialista (neutralista) uccidendo un militante.
Il 18 marzo con l’ingresso delle navi alleate nello stretto dei Dardanelli ha inizio la battaglia di Gallipoli, che entrerà nel vivo con lo sbarco delle truppe inglesi il 25 aprile e dopo un’imprevista quanto strenua resistenza della Turchia si concluderà in dicembre con una disfatta di Francia e Inghilterra (e Australia).
Il 26 aprile Salandra e Sonnino firmano, senza informare il Parlamento ma con l’accordo di Vittorio Emanuele III, il Patto di Londra, che prevede l’entrata in guerra a fianco della Triplice intesa. Il Patto prevede che in caso di vittoria l’Italia ottenga il Trentino, il Sud Tirolo fino al Brennero, la Venezia Giulia, la penisola istriana (ma non Fiume) e una parte della Dalmazia.
In tutta Italia si svolgono grandi manifestazioni a favore dell’intervento in quelle che vengono definite le «radiose giornate di maggio». Il 5 maggio viene inaugurato a Quarto il monumento dei Mille. Gabriele D’Annunzio, oratore ufficiale della cerimonia, «dichiara guerra» all’Austria.
Il 7 maggio un sommergibile tedesco affonda il piroscafo Lusitania con duemila persone a bordo (di cui 125 americani) in viaggio dall’Inghilterra agli Stati Uniti. Quello stesso giorno il ministro degli Esteri Sonnino informa il Consiglio dei ministri della firma del Patto. Il giorno successivo il re dichiara che abdicherà se la Camera non approverà la scelta di Salandra. Ma il Parlamento resta contrario all’intervento. L’11 maggio Mussolini pubblica sul «Popolo d’Italia» l’editoriale dal titolo Abbasso il Parlamento!
Il 12 maggio ben 320 deputati e un centinaio di senatori solidarizzano con il neutralista Giolitti, fatto oggetto di manifestazioni ostili. Nelle sue memorie Carlo Emilio Gadda ricorda di aver sfilato avendo in mano un cartello con su scritto: «Morte a Giolitti!».
Il 13 maggio Salandra presenta le sue dimissioni, ma Vittorio Emanuele III le respinge.
Il 15 maggio Ardengo Soffici, su «Lacerba», scrive l’articolo dal titolo Sulla soglia, contro gli antinterventisti tra i quali include Benedetto Croce. Ecco i termini usati da Soffici: «La vile canizza giolittiana, l’ignobile, losco, vomitativo Giolitti; gli analfabeti dell’“Avanti!”, i preti, i giornalisti venduti, i generali bulowiani [cioè al servizio di Bernhard von Bülow, ex cancelliere
tedesco, marito della figlia di Marco Minghetti, ora nei panni del mediatore per il non intervento dell’Italia], la melma fetente universitaria, professorale, filosofica; la ciurmaglia cancrenosa, bavosa, laida del senato […] con che moneta pagheranno prossimamente, quando l’Italia, raggiunti a dispetto della loro vigliaccheria e infamia, i suoi fini di nazione civile e fatta per l’avvenire, troverà il momento di fare i conti con essi?».
Il 17 maggio si svolge a Roma una manifestazione per non consentire l’ingresso alla Camera dei parlamentari in odore di pacifismo.
Il 20 maggio la Camera si ricrede e, per evitare una crisi istituzionale, vota – con l’eccezione dei socialisti – la concessione dei poteri straordinari al governo.
Editoriale del «Corriere della Sera» del 22 maggio: L’Italia s’è desta. Albertini non solo è direttore del giornale, ma – come mette in evidenza Simona Colarizi nel Corriere nell’età liberale (Rizzoli) – fa da ambasciatore tra il ministero della Guerra e gli industriali, in particolare Ernesto Breda e Giovanni Caprotti, costruttore di aerei da combattimento. Albertini si muoverà «interpretando, blandendo e accompagnando il blocco moderato e governativo dalla decisione per la neutralità a quella per l’intervento nel campo opposto», scrivono Mario Isnenghi e Giorgio Rochat nella Grande guerra (La Nuova Italia).
Il 24 maggio l’Italia entra in guerra contro l’Impero austroungarico. Il 23 giugno ha inizio l’offensiva sull’Isonzo. Scrive Giani Stuparich nel diario Guerra del ’15: «C’è in tutti una tensione esasperata. Tutti sono impazienti di percorrere presto la pianura, con la baldanza e la facilità con cui si è già passato l’Isonzo. Il più – il passaggio dell’Isonzo – è fatto. L’ha compiuto la nostra compagnia, c’è stato un morto solo e un ferito. Ora bisogna superare la pianura e varcare l’altipiano per essere in quindici giorni a Trieste». Illusioni. L’Isonzo sarà teatro di numerose battaglie e resteranno sul campo seicentomila italiani, secondo le stime di Mario Silvestri in Isonzo 1917 (Einaudi) e John R. Schindler in Isonzo, il massacro dimenticato della Grande Guerra (Libera editrice goriziana).
Il 5 agosto gli imperi centrali espugnano Varsavia costringendo i russi alla «grande ritirata» dalla Galizia, mentre la Germania estende il suo controllo sulle terre polacche, oltre che sulla Lituania e su gran parte della Lettonia.
Il 21 agosto l’Italia dichiara guerra alla Turchia.
28 settembre, circolare 3525 del comando supremo: «Ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi e di retrocedere, sarà raggiunto prima che si infami dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti e da quella dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato da quello dell’ufficiale».
Inizia così il 1916, l’anno nel quale le cose per l’Italia, e per i suoi alleati, si fanno più difficili.
In gennaio gli anglo-francesi si ritirano dai Dardanelli: dei cinquecentomila soldati impegnati (molti australiani e neozelandesi) ne hanno persi la metà.
In Consiglio dei ministri Ferdinando Martini, ministro delle Colonie, denuncia: «Noi volevamo Gorizia e non l’abbiamo presa. Ora ci si dice che bisogna stare fermi per tre mesi a cagione della neve. A primavera ricominceremo a fare quello che abbiamo fatto fin qui. Ed io desidero che mi si spieghi perché otterremo al fiorir delle rose ciò che non abbiamo ottenuto al passo dei tordi».
Il 21 febbraio inizia la battaglia di Verdun, dove francesi e tedeschi perderanno oltre cinquecentomila uomini nel giro di nove mesi. Il 22 il «Corriere» pubblica un articolo di Luigi Barzini in cui si esalta il generale Luigi Cadorna, «mago vivificatore di tutte le energie», «anima atletica», autore di «un famoso opuscolo sull’attacco frontale che è un capolavoro di letteratura militare».
Il 14 maggio gli austriaci danno il via in Trentino alla Strafexpedition, spedizione per punire il tradimento dell’Italia e, ai primi di giugno, avanzano per venti chilometri in territorio italiano. Ma le truppe austriache del generale Franz Conrad von Hötzendorf, logorate, sono costrette a fermarsi.
Il 12 giugno Salandra, sempre più critico nei confronti di Cadorna, è battuto in Parlamento. Accusato tra l’altro di aver imboscato i suoi tre figli, si dimette da presidente del Consiglio. Il re incarica allora il liberale Paolo Boselli di formare un governo di «coalizione nazionale» (in cui entrano il riformista Leonida Bissolati, il repubblicano Ubaldo Comandini e il cattolico Filippo Meda).
Il 1° luglio inizia la battaglia della Somme che impegnerà, contro i tedeschi, i soldati inglesi (per i quali quel 1° luglio fu in termini di morti il giorno più
sanguinoso della guerra). Il bilancio sarà di centinaia di migliaia di perdite da ambo le parti. Resterà ferito anche l’allora caporale Adolf Hitler.
Il 10 luglio vengono impiccati a Trento Cesare Battisti e Fabio Filzi. Entrambi trentini, fuggiti in Italia allo scoppio della guerra, si erano arruolati come volontari nell’esercito italiano ed erano stati fatti prigionieri nel corso della Strafexpedition.
Il 6 agosto il colonnello Pietro Badoglio conquista in trentotto minuti la vetta del Sabotino e apre la via per Gorizia. Il prestigio del sessantaseienne Cadorna è recuperato. Il 9 agosto gli italiani entrano a Gorizia, ma il prezzo è assai alto: oltre ventimila morti e cinquantamila feriti.
In Germania, nel frattempo, Paul von Hindenburg, coadiuvato dal suo «quartiermastro generale» Erich Ludendorff, assume il comando supremo al posto di Erich von Falkenhayn.
Il 10 agosto viene impiccato a Pola Nazario Sauro, irredentista istriano che si era arruolato in Italia per poi imbarcarsi su un sommergibile che si era incagliato. Sauro, messosi in salvo, era stato catturato dagli austriaci e condannato a morte.
Il 27 agosto l’Italia dichiara guerra alla Germania. È la «sanzione giuridica di uno stato di fatto» scrive il «Corriere». Contemporaneamente fa lo stesso anche la Romania, invadendo Transilvania e Ungheria, ma nel giro di tre mesi le armate romene vengono fatte a pezzi dai tedeschi.
1° novembre, nuova circolare del comando supremo italiano: «Non vi è altro mezzo per reprimere reati collettivi che quello di fucilare immediatamente i maggiori colpevoli e allorché accertamento identità personali dei responsabili non è possibile, rimane ai comandanti il diritto e il dovere di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari e punirli con la pena di morte».
Entriamo così nel 1917, l’anno più critico per l’Italia. Ma è il mondo intero ad andare sottosopra. In gennaio scoppia la rivolta araba guidata dall’emiro Faysal e da Lawrence contro l’Impero ottomano. Tra l’8 e il 15 marzo 1917 (ultima settimana di febbraio per il calendario russo), a seguito di una sollevazione popolare, lo zar Nicola II abdica e viene nominato un governo provvisorio, mentre a Pietrogrado si formano i soviet («consigli») degli operai e dei soldati: è la Rivoluzione di febbraio. L’11 marzo gli inglesi conquistano Baghdad e cacciano i turchi.
Il 6 aprile gli Stati Uniti entrano in guerra contro la Germania. Il 16 aprile la Francia lancia un’offensiva sull’Aisne, clamoroso fallimento. In poche settimane perde duecentosettantamila uomini. Rivolta tra i soldati, imponenti fenomeni di diserzione.
In Italia, nel frattempo, le cose non vanno meglio. In maggio, a Milano, esplode una rivolta popolare contro le difficili condizioni di vita. A giugno e nei mesi successivi, a causa del protrarsi della guerra di trincea, si moltiplicano gli episodi di ammutinamento che vengono repressi con inaudita durezza (episodi descritti in Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu, pubblicato da Einaudi, ma anche in La guerra sugli altipiani, a cura di Mario Rigoni Stern, edito da Neri Pozza): le denunce per reati commessi in tali circostanze saranno quattrocentomila, le condanne duecentomila, di cui quattromila a morte. Tra il 10 e il 25 giugno ha luogo la «battaglia del Monte Ortigara» per riprendere i territori conquistati dagli austriaci l’anno precedente.
Il 1° agosto papa Benedetto XV definisce la guerra una «inutile strage» ed esorta ad avviare trattative di pace.
Il 13 agosto si svolge una grande manifestazione socialista a Torino. Il 22 agosto, sempre a Torino, una nuova agitazione per la mancanza di pane. In pochi giorni cinquanta morti e duecento feriti.
Il 14 agosto la Cina entra in guerra a fianco dell’Intesa. In settembre Sun Yat-sen a Canton forma un governo rivoluzionario separatista che si oppone all’entrata in guerra.
Il 18 agosto settecentomila soldati italiani vanno all’attacco e le truppe austriache cedono nel settore della Bainsizza. Ma i morti sono tantissimi, centomila in pochi giorni, e la spedizione è costretta a fermarsi. Contemporaneamente il generale Luigi Capello, alla testa della II armata, decide di fare di testa sua e il 19 avanza su Tolmino. La sua missione sarebbe stata quella di andare in soccorso del generale Enrico Caviglia, impegnato alla Bainsizza. Ma si intestardisce su Tolmino e poi sul monte San Gabriele. Cadorna ha cattivi rapporti con il governo e non può permettersi di chiedere le dimissioni del disobbediente Capello.
Il 4 ottobre il governo italiano vara un decreto contro il disfattismo. Dovrebbe prevenire o punire gli effetti provocati da coloro che sopravvivono a trincee e battaglie. Scrive Antonio Gibelli in L’officina della guerra (Bollati
Boringhieri): «Le testimonianze medico psichiatriche sono piene di riferimenti a figure ai limiti dell’umano, colte a vagabondare senza sapere perché, attonite, sudice, con l’abbigliamento lacero o nude: sono i reduci o meglio i transfughi della terra di nessuno, coloro che hanno cercato una fuga senza scampo dal territorio della guerra, vagando per ore, spesso per giorni». Il 24 ottobre austriaci e tedeschi sfondano a Caporetto (l’attuale Kobarid slovena) e avanzano nel Friuli. Nella conca di Plezzo vengono usati i gas contro gli italiani, che abbandonano le postazioni. Un milione di persone tra militari e civili rifluisce verso il Veneto. Il generale Cadorna parla dei soldati italiani «vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico». Una tesi che non troverà riscontro nelle ricostruzioni storiche.
Il 26 ottobre si dimette il governo Boselli. Vittorio Emanuele Orlando è il nuovo presidente del Consiglio. Il 27 ottobre il generale Cadorna ordina la ritirata e chiede all’esercito di attestarsi sul Tagliamento. Il 2 e il 3 novembre gli austriaci travolgono anche la linea di difesa sul Tagliamento. Cadorna ordina allora un’ulteriore ritirata sulla linea del Piave.
Il 9 novembre – anche su sollecitazione, il 6 novembre a Rapallo, di Francia e Inghilterra – Cadorna è sostituito da Armando Diaz. Alcuni giornali, l’«Avanti!», «L’Idea Nazionale» e il «Secolo», accusano il «Corriere» di aver ingannato l’opinione pubblica dando conto del morale delle truppe a tinte eccessivamente ottimistiche. Un anno dopo, il 24 ottobre 1918, Albertini dirà di Caporetto che è stata una tappa della «via crucis del Risorgimento italiano, una terribile stazione di amarezza e di dolore presso alla vetta». E indicherà i responsabili di quel disastro in «coloro che con le parole e con gli scritti, in alto e in basso, uomini politici e privati cittadini, partigiani prima che italiani, partigiani ad onta di tutto e a costo della salute della patria dissero a chi combatteva: “il tuo sacrificio è vano”; dissero a chi soffriva: “la tua sofferenza è iniqua”».
Andrea Ungari in Le inchieste su Caporetto: uno scandalo italiano, pubblicato nel novembre del 1998 su «Nuova Storia Contemporanea», documenta le responsabilità di Pietro Badoglio nel disastro militare e come Benito Mussolini avrebbe in seguito tacitato la vedova del generale Alberto Cavaciocchi che era stato sacrificato al posto di Badoglio. Due mesi dopo Caporetto un gruppo di intellettuali, tra i quali Felice Momigliano, Romolo Murri, Vincenzo Torraca,
Umberto Zanotti Bianco, dà vita a un Comitato per l’esame nazionale che dovrebbe riscrivere l’intera storia d’Italia dal Rinascimento a Caporetto.
Intanto il mondo cambia. Il 2 novembre il ministro degli Esteri inglese Arthur James Balfour si dichiara a favore di un focolare nazionale ebraico (national home) in Palestina: è una data storica per il futuro Stato di Israele di cui si pongono le basi proprio con la «dichiarazione Balfour». Il 6 e 7 novembre (24-25 ottobre per il calendario russo) i bolscevichi prendono il potere: è la Rivoluzione d’ottobre.
Sempre in novembre, in Francia, diventa primo ministro Georges Clemenceau, che dichiara guerra al «disfattismo» e diventerà assieme al generale Philppe Pétain l’uomo simbolo della vittoria francese nella Grande guerra. Il 10 e il 26 novembre l’esercito italiano respinge le offensive austro-tedesche sul Piave. Il 4 e il 23 dicembre i soldati italiani respingono gli austriaci ancora sul Piave e sul monte Grappa.
Il 9 dicembre gli inglesi avanzano in Palestina e occupano Gerusalemme. 31 dicembre. Dal diario di Carlo Emilio Gadda, fatto prigioniero dopo
Caporetto: «Finisco l’anno nel carcere, coi miei diciannove compagni di prigione, che stanno spogliandosi. Ho fame perché ho mangiato un quinto di pane, un pezzetto di gelatina di pesce puzzolente e un mestolo di acqua e sedano. Ho fame e ruberei per sfamarmi. Ho le calze in brandelli, e una berretta sulla testa, tagliata da una coperta… Fuori c’è neve e silenzio nella campagna morta. Qui siamo in una tomba. Sono certo che la mamma, che i miei fratelli mi seguono con l’anima […]. Nessun altro penserà a me in questo momento, non amici, non una donna; nessuno pregherà per me. Il pensiero di questa solitudine mi pesa oggi più che mai: mi vedo solo e perduto nel mondo, con le più pure speranze infrante; e sogno i miei alpini, il mio quinto reggimento, i miei monti e vorrei essere là con loro e sentirli cantare: “ce lo dico, signor capitano, che in licenza mi deve mandar”». Inizia così il 1918, l’anno della vittoria. Anche se, sulle prime, questa vittoria non appare affatto scontata. Il 3 marzo la Russia di Lenin firma con la Germania il trattato di Brest-Litovsk con il quale si ritira dalla guerra e cede alla Germania le province baltiche, la Polonia e l’Ucraina. Forte di questo trattato, il 21 marzo la Germania lancia l’operazione Michael, l’ultima grande offensiva.
In maggio si apre una crisi di governo connessa alle ingerenze del ministro del Tesoro, Francesco Saverio Nitti, nelle attività degli altri ministeri. Il 9 aprile la Germania tenta l’«ultimo azzardo», una disperata offensiva sul Lys.
In giugno l’Italia respinge nuovi assalti nemici sul Piave (Battaglia del solstizio). All’inizio di luglio comincia la controffensiva alleata sul fronte occidentale: i tedeschi ripiegano.
In ottobre le truppe arabe guidate da Faysal e da Lawrence occupano Damasco. Faysal è proclamato «re degli arabi».
Il 24 ottobre Diaz lancia l’attacco sul Piave. Nei giorni precedenti Diaz, Badoglio e Nitti, convinti che la guerra sarebbe durata ancora nel 1919, si erano detti contrari all’offensiva. Era stato Vittorio Emanuele Orlando a decidere. L’esercito austriaco è in rotta. Annota Ernest Hemingway, all’epoca diciottenne autista di un’ambulanza della Croce rossa (era stato ferito l’8 luglio): «È stata una grande vittoria che ha mostrato al mondo quali meravigliosi combattenti siano gli italiani».
Il 29 ottobre gli italiani entrano a Vittorio Veneto e gli austriaci chiedono l’armistizio. Viene fatto prigioniero il giovanissimo Ludwig Wittgenstein, arruolato nell’esercito austriaco, che resterà tale fino al 1919. Albertini in Venti anni di vita politica (Zanichelli) sostiene che gli italiani «si limitarono a cogliere i frutti della ribellione che stavano ormai dissolvendo l’esercito austriaco». Ancor più deciso Giuseppe Prezzolini in Vittorio Veneto (La Voce): «A Vittorio Veneto non abbiamo vinto l’esercito austriaco che era già vinto; non abbiamo distrutto l’Austria che era già in pezzi; non abbiamo fatto una guerra di manovra se non nel senso della manovra di piazza d’armi». Piero Melograni in Storia politica della Grande Guerra (Mondadori) ha messo l’accento su ammutinamenti e rivolte nell’esercito austriaco che in quell’occasione spianarono la strada agli italiani. Il 30 ottobre Fiume proclama la propria unione all’Italia, due settimane dopo truppe del nostro Paese entreranno nella città. Il 3 novembre i soldati italiani fanno il loro ingresso a Trento e a Trieste. A Padova, Villa Giusti, viene firmato l’armistizio. Il 4 novembre cessano definitivamente gli scontri sul fronte italiano. Il 9 novembre scoppia la rivoluzione in Germania: il Kaiser fugge in Olanda. L’11 novembre i rappresentanti del governo provvisorio tedesco firmano l’armistizio nel villaggio di Rethondes in Piccardia. La guerra è finita.
In conclusione non si può non citare Peter Englund che in La bellezza e l’orrore. La Grande Guerra narrata in diciannove destini (Einaudi) riporta queste parole del settantatreenne Anatole France nel 1917: «La borghesia che si ciba dei giornali reazionari è conquistata dall’idea di una guerra infinita; in breve, solo il fronte è pacifista». Fussell nel suo La grande guerra e la memoria moderna (il Mulino) spiega che la Prima guerra mondiale «rese normale l’orrore» e preparò i genocidi. Antonio Gibelli in L’officina della guerra (Bollati Boringhieri) scrive che fu «un corso accelerato e violento di modernità imposto a milioni di uomini in situazioni estreme di sradicamento e di minaccia per la vita, di sofferenza e di dolore». Vladimir Nabokov, nato nel 1899 a San Pietroburgo e divenuto americano negli anni Quaranta del secolo successivo, nell’autobiografia Parla, ricordo (Adelphi) racconta: «Scoppiò la Prima guerra mondiale. Una folla di patrioti e lo zio Ruka presero a sassate l’ambasciata tedesca. Pietroburgo fu declassata a Pietrogrado contro ogni regola di priorità nomenclatoria. Risultò che Beethoven era olandese». Anche questo fu la Prima guerra mondiale.

La Grande guerra causò in Europa quindici milioni di morti su un totale di centoventi milioni di maschi adulti mobilitati. I feriti furono più di trentaquattro milioni (tra cui otto milioni di mutilati e invalidi) e undici milioni i prigionieri, decine di migliaia dei quali morti nei campi di prigionia. Tra i prigionieri seicentomila circa furono italiani, la metà dei quali cadde nelle mani del nemico dopo la disfatta di Caporetto: una cifra altissima se
confrontata con quella corrispettiva dei francesi (cinquecentoventimila), dei britannici (centottantamila) e persino dei tedeschi (ottocentomila, ma su un numero di richiamati alle armi che era il doppio del nostro).
L’Italia per di più considerò gran parte dei propri prigionieri alla stregua di disertori o quantomeno di gente che si era arresa senza combattere e, di conseguenza, li aiutò ben poco. Nel 1917 (sempre all’epoca di Caporetto) fu dichiarato da fonti ufficiali che i disertori italiani ammontavano a ben cinquantacinquemila, senza far cenno alla circostanza che, di questi, trentamila erano poi rientrati spontaneamente nei ranghi.
Unica fra le grandi potenze in lizza, come scrive Marco Mondini in La Guerra italiana. Partire, raccontare, tornare: 1914-18, l’Italia affrontò la guerra non all’improvviso ma «dopo quasi un anno di tentennamenti e trattative».
Se gli altri europei «scivolarono» nel conflitto inconsapevolmente, i governanti italiani ci entrarono in piena coscienza: «Il che non vuol dire che avessero pienamente compreso ciò che stava succedendo; i lunghi mesi di neutralità servirono poco per preparare il paese e l’esercito, ma in compenso alimentarono uno scontro sull’opzione dell’intervento, la cui violenza non trova eguali nell’Europa del 1914».
Nelle grandi città italiane, lo abbiamo visto, l’annuncio delle ostilità non fu certo una sorpresa.
Quando il governo chiese ai propri prefetti di informarlo su quale sarebbe stata la reazione della popolazione di fronte all’intervento (ormai deciso) dell’Italia, si sentì rispondere che dopo mesi di tentennamenti, annunci, smentite e voci, l’idea della guerra era «entrata nella pubblica coscienza»: pochi la volevano ma tutti vivevano come se quella che già veniva chiamata «la Grande guerra» fosse inevitabile.
Che la «si fosse a lungo temuta come il peggior incubo o attesa ansiosamente come una grande occasione», la guerra fu accolta, per usare le parole del giornalista Ugo Ojetti, «come la liberazione da una lunga febbre che non voleva finire».
Mondini definisce la Prima guerra mondiale per quel che riguarda l’Italia «un paradosso» contraddistinto da «bizzarre antinomie». Il nostro intervento nel conflitto europeo fu presentato come l’ultima campagna del Risorgimento che avrebbe consentito finalmente a tutti gli italiani di far parte di un
unico Stato nazionale. Ma «il governo che condusse il paese in guerra aveva poco in comune con le idealità del nazionalismo romantico e democratico di Mazzini o con l’ispirata strategia politica di Cavour […]. Per combattere contro i propri ex alleati, il presidente del Consiglio, Antonio Salandra, e il suo ministro degli Esteri, Sidney Sonnino, pretesero la cessione del territorio di Bolzano, popolato da duecentocinquantamila austro-tedeschi, ma lasciarono al suo destino la città di Fiume, abitata da una popolazione di lingua e di cultura italiana».
Non dimentichiamo poi che il tradimento del patto che ci legava dal 1882 all’Impero austroungarico e a quello tedesco non fu indolore. Nemmeno ai tempi dell’iniziale dichiarazione di neutralità, dopo la quale l’addetto militare a Berlino, il generale Luigi Calderari, si dimise «indignato della slealtà dimostrata dal proprio governo», mentre gli ambasciatori a Berlino e Vienna, Riccardo Bollati e Giuseppe Avarna, contrari ad abbandonare quelli che per trentadue anni erano stati i nostri alleati, si opposero così veementemente a un intervento a fianco dell’Intesa da essere ritenuti inaffidabili, e poi tenuti all’oscuro delle successive trattative avviate dal governo.
E ancora: la guerra avrebbe dovuto essere la «prova del fuoco» per il carattere degli italiani, il momento in cui avrebbero dimostrato al mondo di essere una nazione coesa, forte e degna di sedere tra le grandi potenze. E invece «l’Italia entrò in guerra lacerata da profonde rivalità sociali e politiche contro il volere della maggioranza parlamentare e di gran parte della popolazione».
Divisioni ideologiche più che radicali in grado di sopravvivere alla vittoria. Talché, afferma Mondini, si può dire che «l’ultimo colpo di cannone della guerra non fu sparato il 4 novembre 1918 contro gli austriaci, bensì il giorno di Natale del 1920, quando la Regia marina bombardò la città di Fiume occupata dai legionari dannunziani, in un bizzarro (ma sanguinoso) strascico fratricida del conflitto».
Non è tutto. La guerra che esplose nell’agosto del 1914 ci colse impreparati. Il giorno dell’attentato di Sarajevo, l’esercito italiano contava poco meno di trecentomila uomini sotto le armi, tra ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, più quarantamila nella Regia marina. Il 24 maggio 1915, quando i primi reparti italiani varcarono il confine italo austriaco, la forza dell’eser -
cito operante, vale a dire il complesso delle unità combattenti realmente impegnate al fronte, toccava i novecentomila uomini. Quando la mobilitazione generale venne effettivamente compiuta, con molti giorni di ritardo rispetto alle previsioni, il Regno d’Italia schierava lungo tutto il confine dal passo dello Stelvio al mare circa un milione e centomila uomini, più altri cinquecentomila circa impegnati nei servizi e nei presidi all’interno della penisola.
L’esercito italiano che il 24 maggio varcò la frontiera dell’Austria-Ungheria era dipinto come la parte migliore del Paese, una comunità salda e disciplinata di cittadini in armi, guerrieri superbi devoti al re e ai propri comandanti. Peccato, fa notare Mondini, «che non avesse mai vinto una battaglia sul suolo europeo e che a Adua, nel 1896, fosse andato incontro alla peggiore sconfitta subita da un’armata bianca in Africa, uno scacco eclatante che, insieme alla disfatta di Custoza nel 1866, avrebbe lasciato agli italiani la perpetua fama di pessimi soldati».
Il catastrofico andamento delle battaglie combattute dal 1848 in avanti, culminato nel doppio tracollo per terra e per mare a Lissa e Custoza nel 1866, aveva per di più avuto «un’eco mediatica enorme» e il disastro di immagine era stato a malapena arginato dai successi personali di Giuseppe Garibaldi, «l’unico eroe combattente popolare e di successo di tutto il Risorgimento, ma anche una figura irregolare e politicamente marginale».
Gli stessi generali, rimarca Mondini, «non avevano fiducia nelle proprie truppe». Luigi Cadorna, capo di Stato maggiore e comandante sul campo, era convinto «che la sua armata fosse formata perlopiù da contadini ottusi e operai traviati dalla predicazione socialista, che potevano essere tenuti in riga solo attraverso una disciplina ferrea corroborata da continue punizioni esemplari».
Eppure, mette in rilievo l’autore, «quei fanti, alpini, bersaglieri, ritenuti inaffidabili e indisciplinati, si dissanguarono per tre anni in testardi assalti frontali sul peggiore dei fronti europei, tra le alte cime delle Dolomiti e il brullo e roccioso altipiano del Carso, sopportando perdite spaventose senza alcun segno di cedimento».
Quando, nell’autunno del 1917, quegli uomini ripiegarono sotto i colpi di una brillante offensiva congiunta austro-tedesca, Cadorna seppe offrire come unica spiegazione dell’accaduto – abbiamo visto anche questo, ma
merita tornarci – la «vigliaccheria» di alcuni reparti e la «fantastica illazione» che altri, sobillati dalla propaganda sovversiva, avessero inscenato uno «sciopero militare». Eppure quegli stessi soldati alcune settimane dopo il supposto «sciopero militare» seppero dare, sul Piave e sul monte Grappa, prova di grande determinazione e coraggio.
Proprio loro che per quasi due terzi (quattrocentomila su seicentocinquantamila) avevano dovuto contare un numero di caduti nelle undici offensive dell’Isonzo davvero impressionante. «Un tasso di mortalità che non aveva nulla da invidiare ai peggiori settori del fronte occidentale.»
Non è vero inoltre che da noi (checché ne abbia detto l’agiografia nazionalista postbellica) si sia avuta una mobilitazione giovanile pari a quella degli altri Paesi europei. E se ci fu, a essa non corrispose poi un marcato impegno nei combattimenti. Il King’s College di Londra perse il quindici per cento dei propri studenti al fronte e oltre la metà degli studenti universitari berlinesi arruolatisi nel 1914 morì nel primo anno di guerra. Da noi la mortalità fra gli studenti fu pari al sei per cento, «largamente inferiore a quella media del resto dei combattenti e lontanissima dalle vere e proprie stragi registrate nei ranghi degli studenti francesi, britannici o tedeschi». Certo, questo «risparmio di vite tra gli studenti» fu possibile perché molti universitari furono assorbiti nelle armi e nelle specialità più qualificate (e quindi meno esposte al fuoco nemico) dell’artiglieria, del genio e della sanità. E tanti furono impiegati in posizioni ancora più sicure, nei comandi di retrovia e negli uffici. Pressoché tutti, o almeno quelli che sopravvissero ai primi mesi di combattimenti, prestarono servizio in qualità di ufficiali di complemento. Tra i 132 caduti dell’università di Pisa (su millecinquecento arruolati), cento erano ufficiali di fanteria e solo cinque morirono indossando la divisa da soldato o graduato di truppa. E «se in un grande ateneo come Padova, dalle cui aule erano usciti ufficiali di tutte le armi, i morti oscillavano mediamente attorno al dieci per cento degli arruolati, le scuole di specializzazione per ingegneri e i politecnici vantavano normalmente tassi di sopravvivenza molto maggiori (al Politecnico di Torino cadde meno di uno studente arruolato su venti)». Altro che giovani ardimentosi come negli altri grandi Paesi europei, di loro si cominciò presto a parlare come di «imboscati».
La fama di imboscati degli addetti all’artiglieria e al genio era così elevata «che i più spavaldi in cerca di gloria tentavano in ogni modo di farsi destinare alla fanteria o alle specialità più pericolose»: Paolo Caccia Dominioni, studente al terzo anno di Ingegneria a Milano, nel timore che lo si accusasse di essere un vigliacco, chiese (senza successo) di essere assegnato all’artiglieria di montagna. Qualcuno si accorse che si trattava di una sorta di strana psicosi a scatole cinesi. Scrisse Silvio D’Amico: «Pei richiamati sotto le armi sono imboscati i borghesi, gli artiglieri che sparano dicono imboscati a quelli che sono ai Comandi [...] in compenso le pattuglie di fanti che la notte escono oltre i reticolati in ricognizione dicono imboscati ai compagni rimasti in trincea».
Il fatto è, osserva l’autore, che «fra coloro che vestivano l’uniforme, alcuni rischiavano la vita quotidianamente, altri solo talvolta, e una folta schiera di privilegiati praticamente mai».
Nell’estate del 1915 alcuni ufficiali guidarono i loro soldati a un qualche massacro (restò celebre l’assalto del colonnello Mario Riveri a forte Basson, dove furono persi millecento uomini su duemilaottocento). Molti graduati furono uccisi in imprese come quella del forte Basson e dovettero essere rimpiazzati da ragazzi appena arruolati: gli ufficiali di complemento. Che sarebbero stati oggetto nel 1930 di una forte polemica tra Adolfo Omodeo che li teneva in buona considerazione («Quello di cui c’era bisogno nel nostro esercito» scrisse di loro) e Gioacchino Volpe, che li considerava invece «fatti contro voglia, snidati dagli uffici, ragazzi usciti appena dalla casa paterna, fabbricati in un mese». È falso che l’uniforme indossata da questi ragazzi provenienti dalla società civile e trasformati in ufficiali di complemento incutesse soggezione e rispetto. A differenza di quanto succedeva in Germania o in Francia, rileva Mondini, l’uniforme da noi non era affatto un segno di distinzione e chi sceglieva di divenire ufficiale di complemento era attratto normalmente dalla ferma più breve, dal servizio meno faticoso e dalle condizioni di vita migliori, non da una (inesistente) promozione sociale. Gli ufficiali di carriera «trattavano sprezzantemente gli allievi e con indifferenza i subalterni di prima nomina, ritenendo che “non valessero e non sapessero nulla del mestiere”, venendo ricambiati con aperta disistima dai “civili”, i quali non vedevano l’ora di riporre l’uniforme nell’armadio, non
manifestavano nessun attaccamento al reggimento (solo un terzo di loro rispondeva ai periodici richiami per aggiornamento) e si guardavano bene dal fare domanda per raffermarsi».
Come avrebbe ricordato il generale Emilio De Bono, «noi ufficiali permanenti non li prendevamo sul serio e loro ufficiali di complemento se ne infischiavano». Per lui erano stati nient’altro che «ragazzini impacciati». «La vera piaga dell’esercito», secondo il colonnello Angelo Gatti, collaboratore allo Stato maggiore di Cadorna, «figli di calzolai, di portinai, gente refrattaria ad ogni spirito di rifacimento morale».
La Prima guerra mondiale, secondo Mondini, è stata sempre ricordata in modo insoddisfacente (eccezion fatta per gli storici dotati di scrupolo). Fino agli anni Sessanta è stata raccontata, dai più, come «una sublime prova di concordia e di unità nazionale, durante la quale il popolo in armi era stato guidato alla vittoria da uomini politici integerrimi, generali autorevoli (sia pure con qualche scelta discutibile) e da una borghesia entusiasta che aveva affollato i ranghi degli ufficiali di complemento». Successivamente si è ecceduto in senso opposto. Dagli anni Settanta in poi, «con l’avvento di una nuova generazione di studiosi legati alla contestazione e ai movimenti di sinistra, i generali sono divenuti carnefici con velleità dittatoriali e i soldati vittime inermi, ansiose solo di sfuggire al combattimento, facendosi passare per pazzi o passando al nemico». Facendosi passare per pazzi? Un momento. L’impazzimento non fu simulazione. O quantomeno non lo fu in moltissimi casi. In uno straordinario libro, Ammalò di testa. Storie dal manicomio di Teramo (1880-1931), Annacarla Valeriano ha ben ricostruito quel che provocò, a seguito di quell’immane conflitto, «l’orrore dei combattimenti e l’angoscia delle perdite». A partire da quanto annotò nel suo diario di trincea lo psichiatra veneto Marco Levi Bianchini, futuro direttore del manicomio della città abruzzese: «Tutti abbiamo la febbre nelle vene e l’angoscia nel cuore: solo lo spirito rimane freddo in mezzo agli ordigni che insidiano ed annientano». Parole dalle quali, secondo Valeriano, emergeva soprattutto «la pervasività della violenza a cui i fanti erano esposti e che avrebbe costituito una delle caratteristiche più peculiari del conflitto: una “brutalizzazione” dello scontro che non colpì soltanto coloro che combatterono in prima linea ma si estese anche alle popolazioni civili, provocando ferite nel corpo e nell’anima
[…]. Le conseguenze psichiche della violenza si manifestarono sotto forme diverse: i nuovi stimoli derivanti dalla “guerra di luci e di scoppi terribili” furono infatti smaltiti dalla psiche dei soldati attraverso una serie di reazioni che continuarono a dispiegare per lungo tempo i loro effetti». Nel 1923, in occasione del Congresso internazionale di medicina militare, il tenente colonnello medico Placido Consiglio tenne una relazione sulle psicosi e le nevrosi dei militari, in cui affermava che «l’effervescenza della lotta, la paura della morte, l’orgasmo terrificante dello scempio umano e l’azione logoratrice e depressiva della vita nelle trincee» avevano provocato un ottundimento del senso della vita e del pericolo in coloro che erano stati nelle zone di combattimento.
In un libro importante, Il nostro soldato. Saggi di psicologia militare, lo psicologo e medico Agostino Gemelli notava nel 1917 come il protrarsi dei bombardamenti fosse in grado di determinare «una tale scossa in tutto il sistema nervoso, una tale inibizione di qualsiasi energia, una tale paralisi di tutta la vita psichica che il soldato è reso incapace di compiere anche il minimo sforzo, subisce qualsiasi cosa, non desidera altro che la fine di tale angoscia, e, rintanato in un cantuccio, nasconde il volto e attende la fine». Assai particolare fu il caso dei contadini. Già nel 1930, Arrigo Serpieri fece rilevare in La guerra e le classi rurali italiane che, tra il 1915 e il 1918, su 5.758.277 uomini arruolati 2.618.234 (quarantasei per cento del totale) erano lavoratori agricoli e la maggior parte prestava servizio in fanteria, in un reparto cioè destinato a subire il novantacinque per cento delle perdite. Nella retorica militarista, cui si aggiunsero poi le voci della classe psichiatrica, come ha scritto Annacarla Valeriano, «l’atteggiamento di passività dei contadini soldati assunse sfumature ben diverse: la rassegnazione di questi uomini venne celebrata come virtù in grado di apportare un contributo decisivo alla causa nazionale». Nel già citato libro del 1917, Gemelli, tratteggiando la figura di un soldato ignaro delle ragioni per cui combatteva, individuava «nella spersonalizzazione della vita di trincea la caratteristica principale delle classi rurali» che fino a poco tempo prima avevano vissuto (parole di Gemelli) «la vita grama del loro lavoro dell’officina o dei campi», senza alcuna ambizione, ma che in guerra avevano dimostrato il loro adattamento cessando di essere individui e diventando parte di un tutto.

Tutte le fonti documentarie sono zeppe di attribuzioni di colpa. «Era un mondo in cui le intenzioni aggressive venivano sempre addebitate all’avversario, e quelle difensive attribuite a se stessi» scrive Clark nel suo importante libro sulle origini del conflitto che abbiamo già più volte citato.
Una delle tante ragioni di demerito del trattato di pace di Versailles, infatti, fu proprio quella di avere individuato negli sconfitti i responsabili della guerra (per la precisione all’articolo 231). Ma lo scenario balcanico da cui scaturì il conflitto per Clark «non fu il risultato di una politica né di un piano o di un complotto maturato costantemente nel corso del tempo». Lo scenario balcanico – «che di fatto era uno scenario serbo» – non spinse l’Europa verso la guerra che poi sarebbe effettivamente scoppiata nel 1914. «Esso piuttosto fornì il quadro concettuale all’interno del quale la crisi venne interpretata una volta che si aprì.» Ed è nel contesto di quel quadro concettuale che la Russia e la Francia finirono per legare, in modo estremamente asimmetrico, la sorte di due fra le maggiori potenze mondiali ai destini di uno Stato turbolento e a tratti violento quale era appunto la Serbia. La ricerca della colpa «predispone chi indaga a interpretare a priori le decisioni dei responsabili politici come fossero pianificate in anticipo e mosse da un intento coerente». Bisogna mostrare che chi ha causato la guerra aveva la consapevole volontà di farlo. Nella sua forma estrema, questo modo di procedere genera racconti influenzati dall’idea del complotto, nei quali una ristretta cerchia di individui potenti, «come i cattivi dei film di spionaggio», controlla gli eventi da dietro le quinte seguendo il copione di un piano per -
verso. Si può capire «la soddisfazione morale che tali ricostruzioni possono comportare», e ovviamente a lume di logica non è impossibile che nell’estate del 1914 la guerra sia scaturita da un processo del genere, ma a seguito di un vaglio accurato va detto nel modo più netto che tale interpretazione «non è sostenuta da elementi di fatto».
Eppure gran parte dell’immensa mole di ricostruzione dell’antefatto, dello svolgimento e delle conseguenze della Prima guerra mondiale deve fare i conti con la nozione di «colpa», con la ragion politica più che con la libera ricerca storica. Soprattutto tra le due guerre, allorché la Germania pubblicò un’opera in quaranta volumi, che comprendeva 15.889 documenti suddivisi in trecento aree tematiche al solo scopo di confutare la tesi colpevolista del trattato di Versailles.
La Francia, per parte sua, fece lo stesso e il ministro degli Esteri Jean Louis Barthou, nel 1934, ammise che la pubblicazione di documenti predisposta dal governo di Parigi aveva un «carattere essenzialmente politico».
A Vienna il condirettore della collana che pubblicò i documenti austriaci,
Ludwig Bittner, nel 1926 spiegò che si era proceduto in tal senso prima che qualche organismo internazionale li obbligasse a farlo «in circostanze meno favorevoli». Anche a Vienna dunque la spinta fu interamente politica. Così come in Russia.
Le prime raccolte di documenti di parte sovietica furono almeno parzialmente motivate dal desiderio di ricondurre allo zar, e al «suo amico Raymond Poincaré» (il presidente francese), la responsabilità di aver iniziato la guerra «sperando con ciò di delegittimare le richieste francesi di rimborso dei prestiti prebellici».
La Gran Bretagna, invece, annunciò che avrebbe pubblicato tutto, anche ciò che fosse politicamente sconveniente, ma presto si poté constatare che «la raccolta documentaria data alle stampe presentava tendenziose omissioni tanto da offrire un quadro non del tutto equilibrato del ruolo che gli inglesi avevano avuto negli eventi che precedettero lo scoppio della guerra». Un immenso caos che, già nel 1929, lo storico militare tedesco Bernhard Schwertfeger definì «guerra mondiale dei documenti».
Per non parlare poi dei macroscopici casi di reticenza. Nel libro sul conflitto pubblicato nel 1919, il cancelliere tedesco Theobald von Bethmann-Holl -
weg non dice pressoché nulla sui comportamenti suoi e dei suoi colleghi nel luglio del 1914, il mese decisivo che precedette lo scoppio della guerra vera e propria. Le memorie del ministro degli Esteri russo, Sergej Sazonov, in alcuni punti sono a ogni evidenza mendaci. I dieci volumi delle memorie di Poincaré «sono attenti più alla propaganda» che a rivelare notizie di una qualche sostanza. E si riscontrano «sorprendenti discrepanze» fra i ricordi dell’ex presidente in merito agli eventi e le note che all’epoca aveva scritto nel suo diario. «Vaghe» vengono giudicate da Clark le «pur piacevoli» rimembranze di Sir Edward Grey, già ministro degli Esteri britannico. Ci sono poi gli infiniti casi che stanno lì a dimostrare i riaggiustamenti della memoria. Nessuno ricordava di aver fatto degli sbagli. Quando alla fine degli anni Venti lo storico americano Bernadotte Everly Schmitt venne in Europa per parlare con i protagonisti dei fatti di quindici anni prima, Grey fu l’unico che ammise di aver commesso qualche errore, pur se di importanza secondaria. Ma secondo lo storico le parole di Grey «riflettevano una concessione all’autodenigrazione che rientrava nel tipico stile di chi in Inghilterra occupa posizioni di rilievo, piuttosto che una sincera ammissione di responsabilità». Schmitt rintracciò poi l’ex ministro delle Finanze russo Pëtr Bark, che faceva il banchiere a Londra e non ricordava quasi nulla (ma fortunatamente aveva tenuto qualche prezioso appunto su quei delicatissimi giorni).
C’erano infine problemi di evidente manipolazione postuma. Quando nell’autunno del 1937 lo studioso Luciano Magrini si recò a Belgrado per intervistare i sopravvissuti tra quanti avevano partecipato al complotto che aveva portato Gavrilo Princip a premere il grilletto, dovette constatare che alcuni testimoni riferivano di questioni delle quali non potevano avere conoscenza, altri tacevano o alteravano quello che sapevano e altri ancora aggiungevano «fronzoli ai loro racconti o si preoccupavano di cercare giustificazioni a proprio vantaggio». Peggio. Molti contatti importanti tra i principali protagonisti erano a voce e non hanno lasciato traccia, sicché possono essere ricostruiti soltanto ricorrendo a fonti indirette o a testimonianze successive. Le organizzazioni serbe collegate con l’attentato di Sarajevo avevano un carattere rigorosamente segreto e non lasciavano quasi nessuna documentazione scritta.
Risultato: la letteratura sulle cause della Prima guerra mondiale – vent’anni fa si stimavano venticinquemila tra volumi e saggi su questo tema – oggi non aiuta a capire. O, comunque, aiuta meno di quanto ci si aspetterebbe.
Oltretutto ha assunto proporzioni talmente vaste che nessun singolo storico («Neppure un’immaginaria figura di studioso in grado di padroneggiare tutte le lingue richieste») può sperare di poterla leggere per intera nell’arco di una vita.


