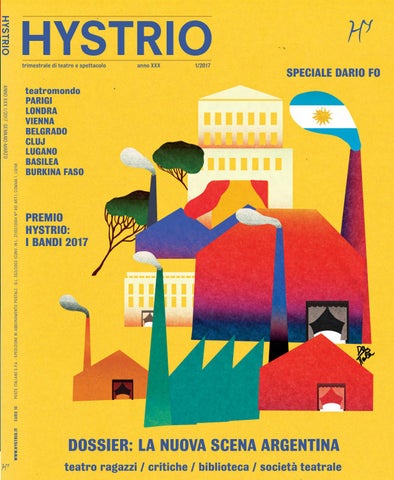trimestrale di teatro e spettacolo
ANNO XXX 1/2017 GENNAIO-MARZO
SPECIALE DARIO FO
teatromondo PARIGI LONDRA VIENNA BELGRADO CLUJ LUGANO BASILEA BURKINA FASO
PREMIO HYSTRIO: I BANDI 2017
WWW.HYSTRIO.IT
EURO 10
POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) ART.1, COMMA 1, LO/MI
anno XXX 1/2017
DOSSIER: LA NUOVA SCENA ARGENTINA teatro ragazzi / critiche / biblioteca / società teatrale