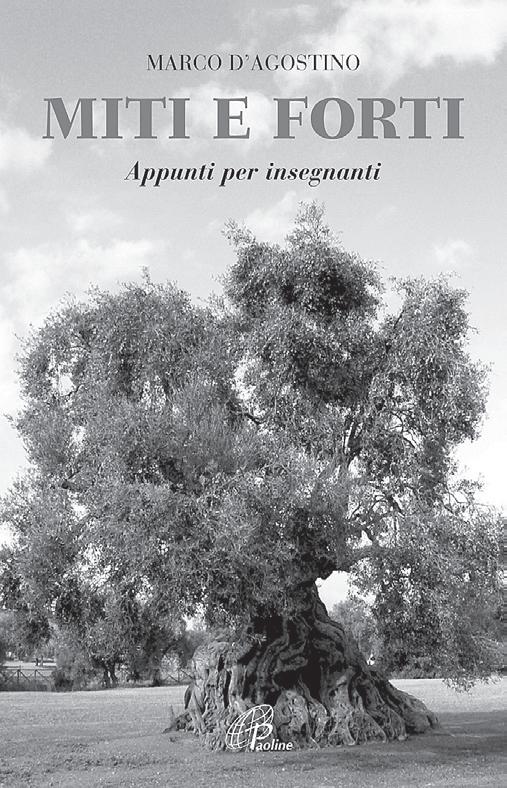
5 minute read
Giocare insieme Un cuore che funziona
Il palazzetto dello sport si ferma. Quasi d’incanto.
Le grida, i cori, i battimani, il tifo è come, d’un tratto, smorzato.
Le persone sugli spalti si «spengono», come per accogliere un evento, nella partita stessa, che ha bisogno di silenzio, di raccoglimento. Quasi di preghiera.
La partita che si sta svolgendo non è una partita «ordinaria». Lo è, perché fa parte di un campionato regolare, ma, al contempo, è anche una partita speciale perché, nel campo, ci sono ragazzi e ragazze speciali. Che hanno bisogno di essere visti con occhi differenti, non pietosi ma diversi sì. Con occhi di fede, che sappiano vedere, al di là di ciò che si vede, anche ciò che si può vedere solo con un occhio da professionista. E da credente.
È vero, in campo c’è chi non vede, chi non sente correttamente, chi è immerso in un suo mondo, chi non corre, chi sta fermo, chi è da anni sulla sedia a rotelle. Ma tutti giocano, e da titolari. Con maglia e numero regolarmente registrato dal direttore di gara.
Tutti partecipano da giocatori convocati. Insieme ad altri appassionati di basket, che frequentano anche altri campi, altri campionati, altre strutture.
Si sta giocando una partita di baskin, sport straordinario, inventato a Cremona nel 2003, con l’obiettivo di permettere a tutti i partecipanti, maschi e femmine, ragazzi «cosiddetti normodotati» e ragazzi con disabilità fisica e intellettiva, di giocare insieme e di esprimere il massimo delle proprie capacità.
Una partita bella e... possibile. Grazie alla quale le persone non sono in campo «per caso», ma con un ruolo specifico e preciso.
Una partita che dura nel tempo e invita ciascuno a pensare come la vita sia da affrontare e davanti alle difficoltà di qualsiasi genere – educative, fisiche, di rapporto, d’integrazione e inclusione – non ci si debba arrendere. Mai e per nessun motivo.
Certamente il campo non può essere come quello del basket. Ognuno ha le proprie esigenze e le proprie specificità. Serve una palla da basket, più canestri, non tutti alla stessa altezza, qualche area in più sul campo regolare. E soprattutto serve tanto cuore.
Sì, per vivere la partita educativa, bella e possibile, è necessario un cuore che funzioni. Dell’adulto che educa. E dell’adolescente che riceve e partecipa al lavoro educativo.
Ha dichiarato Fausto Capellini, già insegnante di scienze motorie e inventore, con Antonio Bodini, del baskin a Cremona: «Penso al processo di socializzazione tra i ragazzi. Nessuno di noi è nato per stare da solo. Il piacere di migliorare se stessi, sotto tutti gli aspetti, porta alla sana competizione che si basa sull’etica sportiva. Tutto questo è indirizzato verso la fiducia nell’altro».
Possiamo aiutarci a migliorare?
Ce la facciamo ancora a credere che la partita educativa, bella e possibile, possa giocarsi sul campo, non per compassione, ma per amore?
Riusciamo a darci tempo e a trovare qualche strategia per educare, processo lungo e inclusivo, perché ragazzi, adolescenti e giovani entrino nel mondo adulto, facendo parte di una comunità scolastica, civile, religiosa, sportiva?
Il baskin, con le sue regole sportive, chiama a giocare, a vivere un campionato vero e proprio, a giocare il tutto per tutto sul campo per vincere. Per alzare la coppa.
La palestra del seminario vescovile di Cremona, dedicata ad Andrea Micheli, sportivo e appassionato di sport, morto per Covid-19 nel 2020 a soli trentasette anni, è da qualche anno il campo nel quale si giocano molte partite educative: le bocce paraolimpiche, il calcetto per persone con deficit visivi, la pallavolo integrata, il baskin, tutti progetti educativi sportivi di integrazione tra ragazzi del liceo Vida e ragazzi affidati alla neuropsichiatria infantile.
Queste partite sono sudate, si dà il massimo per vincere, nella correttezza e nel fair play, caratteristiche di ogni competizione. Anche dell’educazione.
Poi, talvolta, ci si ferma a cena. Insieme. La squadra di San Michele e Sant’Ilario di Cremona, dopo la vittoria del campionato e prima di partire per i nazionali di baskin, in Veneto, dove ha conquistato lo scudetto del 2022, si è ritrovata per condividere una cena in seminario.
A parte l’entusiasmo e la bellezza dello stare insieme in semplicità e gioia, ciò che mi ha colpito di più sono stati l’amore e la comunione tra tutti i partecipanti: dirigenti, allenatori, giocatori e genitori. E costatare come la condizione di disabilità, anche se grave e faticosa, non sia un impedimento ma una risorsa. Non un ostacolo ma un incoraggiamento.
Nessuno si lamentava della fatica. Tutti cercavano nell’altro come crescere, fare dei passi avanti, provare ad aiutarsi vicendevolmente.
La partita educativa può essere giocata così.
Come persone, di differente età ed esperienza, che vivono insieme e offrono il tutto per tutto per giocare insieme.
L’educazione, soprattutto dopo anni di pandemia, potrebbe – perché no? – essere una carezza silenziosa, un «fare la strada insieme», un mettersi «in rete» tra adulti, agenzie educative e ragazzi stessi, che diventano, anno dopo anno, protagonisti della loro stessa crescita.
La vita non va impostata come un «contro» qualcuno, ma come un «per».
Solamente in questa dimensione ciascun ragazzo è invitato a estrarre da sé il buono. Lo vedrà, avrà elementi di giudizio per valutarlo e coraggio per spenderlo e farlo circolare.
Vivere la partita, in campo, insieme. Non gli uni contro gli altri, come una specie di «tiro alla fune». Diversamente ci troveremo sempre, come educatori e genitori, dall’altra parte della fune. A tirare e basta. A strattonare fino alla perdita inutile delle forze. Sperando che gli adolescenti, figli oa lunni che siano, cadano sfiniti perché la nostra forza nel tirare è maggiore.
Ma potrebbe anche verificarsi il caso che i ragazzi mollino la corda, e così la scuola, la casa, l’oratorio, lo sport cadrebbero a terra, perché, dall’altra parte, è stata lasciata la presa.
La fatica dell’educazione, soprattutto dopo questi anni di chiusura, sta proprio nel riprendere discorsi e fili che si sono ingarbugliati, senza moralizzare, senza calcare la mano, senza rinfacciare ciò che non si è fatto. Nel risentire insieme il fischio d’inizio della partita. Mettendoci, insieme con gli adolescenti, tirando dalla stessa parte, allenandoci, con discorsi, esperienze, confronti, affinché nel campo, tutti, possiamo dare il massimo, gli uni per gli altri.
Lo scopo di questi appunti è solamente questo. Non di insegnare dalla cattedra a chi ha le mani in pasta, ma di far intravedere che si può vivere felici, la vita può essere buona, secondo il Vangelo, insieme si possono costruire cose belle. E tante. Basta crederci.
Ricordando che la vita va abbracciata insieme, ragazzi e giovani, adulti e anziani, senza tentennare. Provando e riprovando. Con un po’ di frizzante attesa e di agitazione per il fischio d’inizio.
In campo, in partita, nella vita sperimentiamo che le cose fatte insieme, con forza, consapevolmente, sono quelle sulle quali si fatica e si soffre maggiormente, ma sono anche quelle che nutrono. E durano, lungamente. Premiano, con soddisfazione.
Perché le abbiamo vissute insieme.
Da esse possiamo ripartire, ogni volta.
Nei rapporti interpersonali c’è spesso molta aggressività anche a scuola. La tentazione degli insegnanti, se provocati, sarebbe di rispondere a tono, ma come cristiani abbiamo come modello di comportamento Gesù, «mite e umile di cuore».
A partire da alcuni episodi biblici, queste pagine offrono spunti per riflettere sull’educazione alla mitezza, fondamento della vera forza interiore, in tempi in cui il principio di autorità e la fiducia verso chi educa sono messi in discussione.


