Riconosciuto come pioniere della Narrative Art, Bill Beckley (Hamburg, Pennsylvania, 1946) è stato uno dei primi artisti a usare la fotografia come mezzo di espressione nell’ambito della pittura e della scultura, accostando immagini a testi scritti.
Questo libro, curato dallo Studio Trisorio di Napoli, racconta l’evoluzione del suo lavoro attraverso una selezione di più di cento opere ed è arricchito dai testi critici di David Carrier e Andrea Viliani. Inoltre, in una vivace conversazione con Laura Trisorio, Beckley ripercorre le fasi salienti della sua carriera e descrive alcune delle sue opere più iconiche attraverso aneddoti che impreziosiscono il racconto e svelano il metodo di lavoro di un artista concettuale.
Le opere di Bill Beckley sono presenti nei più prestigiosi musei e collezioni d’arte internazionali come il Museum of Modern Art, il Solomon R. Guggenheim Museum e il Whitney Museum of American Art di New York, il Victoria and Albert Museum di Londra, la Sammlung Hoffmann di Berlino.

E LA NARRATIVE ART
BILL BECKLEY
9 7 8 8 8 9 2 8 2 2 6 5 8 euro 50.00
Bill Beckley
Ai miei figli Tristan e Liam, Ai miei cari amici Laura Trisorio e Gianfranco D’Amato, In memoria di Pasquale Trisorio, che ho visto per l’ultima volta mentre camminava nel sole del tardo pomeriggio sul lungomare di Napoli
Bill Beckley e la Narrative Art
Il binomio parola-immagine e l’estetica del bello
Sommario
“Bill Beckley” David Carrier
Capitolo uno - Punti d’ingresso
Capitolo due - Il binomio parola-immagine
Capitolo tre - L’estetica del bello
Capitolo quattro - Neapolitan Holidays
Opere
Dagli anni ’60 agli anni ’70
Dagli anni ’70 agli anni ’90
Steli
Neapolitan Holidays, 2019
Florilegio: una storia dell’arte, per come ci è stata raccontata da Bill Beckley Andrea Viliani
Una conversazione Bill Beckley
Biografia
Elenco delle opere
6 7 47 137 197 21 59 157 207 228 237 246 264
“Bill Beckley”
David Carrier
Capitolo uno Punti d’ingresso
Osserviamo Myself as Washington (1969), la piccola foto in bianco e nero che mostra Bill Beckley con i capelli incipriati e in abiti d’epoca signorili. A vederla così, sembra un’immagine semplice di un soggetto alquanto riconoscibile, almeno negli Stati Uniti dove non v’è scolaro che non conosca i dipinti di George Washington realizzati da Gilbert Stuart e al primo sguardo, quindi, è naturale pensare che Beckley abbia realizzato un autoritratto fotografico imitando uno di quei quadri. A dire il vero, però, il giovane Beckley non somiglia a Washington, che nei dipinti in questione è raffigurato molto più avanti negli anni, e non si è sottoposto nemmeno a una di quelle impegnative trasformazioni a cui ricorrono gli attori cinematografici per aderire al personaggio. Allora come va interpretata questa immagine? Senza il titolo, Myself as Washington non sembra avere senso e ci vuole più di una riflessione per coglierne il significato.
Tra le storie che si raccontano sulla vita del primo presidente americano, una vuole che un giorno, quando era bambino, egli abbia detto al padre “non so dire bugie”. In realtà, tutti sanno che l’aneddoto è un’invenzione di uno scrittore degli inizi del XIX secolo quindi si può ipotizzare che Beckley con la sua foto abbia voluto costruire un falso, una bugia fotografica, o almeno è così se lo si scambia davvero per George Washington. Senza il titolo, è solo la foto di una messinscena, ma se si considera l’opera d’arte nel suo insieme, la foto con il titolo, allora la si può interpretare come un commento allegorico sulla politica americana della fine degli anni Sessanta del XX secolo.
Quando fu eletto Richard Nixon non si parlava d’altro che di presidenti americani che non dicevano la verità. Da Washington a Nixon, secondo la sinistra, nel tempo le bugie presidenziali erano diventate una vera e propria specialità americana. In quel contesto, allora è probabile che con la sua foto Beckley abbia voluto lanciare, con un costrutto ellittico, un messaggio politico sull’inaffidabilità dei presidenti americani: mentono, come la sua fotografia.
Quattordici anni dopo, nel mio primo libro, Truth and Falsehood in Visual Images (1983), scritto a quattro mani con Mark Roskill, affrontai proprio il tema del rapporto tra falsità e verità nell’arte e non sorprende, quindi, che fossi incuriosito, d’altronde lo sono ancora, da quell’opera sofisticata realizzata dall’allora giovane artista concettuale. Può essere suggestivo considerare Myself as Washington come un falso visivo ma è fuorviante, anzi, volendo essere precisi, è falso, perché
7
Beckley non si propone nella foto come il primo presidente americano, ma dichiara apertamente che si è messo in posa as Washington, come Washington. Non dice alcuna bugia, non vuole ingannarci inducendoci a pensare che si tratti di una foto di Washington. È un’immagine in posa, una messinscena.
Eppure, l’affermazione implicita “mi sono messo in posa da presidente Washington”, a rifletterci bene, è straordinariamente complessa, almeno se la si prende in modo letterale, perché ci pone di fronte a una metafora visiva, a una similitudine, perché si tratta una persona come un’altra. Osservando la foto con il suo titolo, siamo spinti a cercare di individuare le somiglianze tra Beckley stesso e George Washington perché, come dice Arthur Danto nel suo trattato di estetica The Transfiguration of the Commonplace (La trasfigurazione del banale: una filosofia dell’arte, Laterza, Roma-Bari 2008), rimandando ad altro da sé la struttura metaforica mette in moto la mente di chi guarda invogliandolo a cogliere la similitudine. È questo il significato primo della parola as nel titolo, con cui Beckley ci chiede di cercare le somiglianze tra il suo aspetto e quello del primo presidente americano. Se il titolo dell’opera fosse Myself as Wittgenstein resteremmo interdetti, perché Beckley non somiglia affatto al filosofo, mentre nella foto in questione è vestito e acconciato in modo da ricordare un po’ Washington. Si può dire che sia come un attore che interpreta una persona con la quale altrimenti non potrebbe mai essere confuso.
Myself as Washington funziona come opera d’arte proprio perché i due uomini hanno qualcosa in comune: entrambi sono maschi, adulti e bianchi. L’artista non avrebbe potuto presentarsi in modo plausibile in una foto intitolata Myself as Mao, mentre somiglia un po’ a Washington da giovane, per come possiamo immaginarcelo visto che i dipinti di Stuart Gilbert ritraggono il presidente da anziano. Come dicevo, le metafore ci sollecitano a individuare le somiglianze. Quando realizzò la foto Self-Portrait in Drag (1981), Andy Warhol si travestì per interpretare la parte. Non abbiamo difficoltà a comprendere che si dica che una persona è come un mulo per dire che è ostinata, che è come una canna di bambù per dire che è flessibile, o che è come una quercia per dire che è salda e irremovibile, ma se sentiamo dire che una persona è come una lampadina restiamo perplessi perché non cogliamo immediatamente alcuna similitudine. Allo stesso modo, se il titolo della foto di Beckley fosse Self-Portrait as a Woman saremmo sconcertati perché non è vestito da donna. Si potrebbe pensare che stia inutilmente complicando una cosa intrinsecamente semplice, rifiutandomi di stare al gioco della messinscena. In fondo, Myself as Washington non è che una goliardata che qualunque studente d’arte saprebbe fare o un’immagine che potremmo trovare su un invito a una festa a tema “Travestirsi da personaggio storico”. Sembra questo il gioco di Beckley ma come ogni buona barzelletta, è facile da capire ma (forse) difficile da spiegare. Quattro anni dopo, in Cake Story (1973) Beckley riflette e ragiona sull’espressione idiomatica “you can’t have your cake and eat it too”, non si può avere una torta e al tempo stesso mangiarla (in italiano equivale, in genere, all’espressione “non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca”) e si chiede, del tutto legittimamente, perché mai qualcuno dovrebbe volere una cosa del genere, che è ovviamente una contraddizione in termini. Poniamoci un’altra domanda: perché il gioco con Washington funziona come opera d’arte? Per quanto ne so, non se n’è scritto molto, quindi proviamo a rispondere noi. La fotografia di Beckley è arte perché spinge chi la osserva a porsi degli interrogativi e, in fondo, almeno al giorno d’oggi, le opere d’arte sono tali solo se devono essere interpretate.

9 8
51 × 41 cm
Myself as Washington, 1969 Fotografia in b/n
Una foto tessera, in genere, funziona solo come un documento d’identità e non suscita particolari dubbi o interrogativi, a meno che non si tratti di documenti falsi in un film di spionaggio.
Myself as Washington funziona proprio perché stimola la riflessione. Non è un caso che Beckley, in seguito, sia diventato docente di semiotica, visto che già agli esordi della sua carriera giocava con la linguistica. Si noti, per esempio, l’uso del pronome deittico myself nel titolo. Gli elementi deittici (qui, a questo punto, ora o me) sono complessi perché, siccome servono a situare l’enunciato nello spazio e nel tempo, il loro significato dipende da chi sia il soggetto parlante e quello ascoltante. Se la stessa fotografia fosse intitolata Bill Beckley as Washington, sarebbe un’opera d’arte diversa perché in questo caso sarebbe inequivocabile che è Beckley a dire a chi osserva che deve vederlo come se fosse Washington, almeno se vogliamo trattare il titolo come un’affermazione. Il titolo scelto da Beckley, con il deittico, pone chiunque guardi la foto nella condizione di affermare di voler essere visto come Washington.
Il che non ha senso, come voler avere la torta e volerla mangiare allo stesso tempo.
Alla fine degli anni Settanta, divennero molto famosi gli autoritratti concettuali di Cindy Sherman. Molto si è scritto sulla sua serie Untitled Film Stills, alcuni critici erano convinti che l’artista alludesse a scene di film di serie B, altri si interessarono alle implicazioni psicoanalitiche dell’uso di stereotipi femminili da parte di una donna, ipotizzando che la sua arte stigmatizzasse i ruoli di genere per dimostrare che le donne non sfuggono agli stereotipi. Quando Richard Prince usò le foto pubblicitarie delle sigarette Marlboro Man per le sue opere, si avviò una riflessione interessante anche sui ruoli maschili nell’immaginario cinematografico. Considerando questi sviluppi, è legittimo affermare che la fotografia di Beckley rientri in una corrente che si è sviluppata qualche tempo dopo di lui, diventando una tradizione americana nel cui solco, tra l’altro, si muove anche Kehinde Wiley, l’artista afroamericano che realizza opere con giovani neri nelle pose tipiche della pittura europea degli Antichi Maestri.
All’epoca in cui Sherman e Prince cominciarono a realizzare foto concettuali, Beckley era già andato oltre; d’altronde interessarsi a un nuovo tema, svilupparlo a fondo e passare ad altro è stato sempre il suo stile. E poiché il mio obiettivo in questa sede è descrivere la nascita dell’arte concettuale muovendo da una prospettiva incentrata sull’arte di Beckley, Myself as Washington è un buon punto di partenza. Cominciamo contestualizzando l’opera dal punto di vista storico.
Come è potuto accadere che un’opera d’arte come Myself as Washington sia apparsa solo nel 1969? La fotografia in bianco e nero esisteva da oltre un secolo e sarebbe stato tecnicamente possibile realizzarne una simile prima. Nella storia dell’arte è sempre interessante risalire agli eventuali precedenti. Quando fu realizzata la prima opera monocromatica? Il primo quadro astratto? A quando risale il primo dipinto di paesaggio puro della pittura europea, rispetto ai paesaggi sullo sfondo delle scene sacre nei dipinti rinascimentali?
Ciò che conta non sono tanto le innovazioni isolate quanto la presenza in quel momento storico di un ambiente artistico pronto a prendere sul serio forme artistiche nuove. Le innovazioni premature non sono di immediata comprensione; un caso emblematico è quello di Duchamp che ottenne scarsa attenzione quando presentò Fontaine (1917) e gli altri ready mades finché negli anni Sessanta il mondo dell’arte non fu pronto ad accorgersi di quelle opere. Nadar (1820-1910), il grande fotografo francese contemporaneo degli Impressionisti, aveva di certo le capacità per realizzare
un autoritratto simile a quello di Beckley, magari un Myself as Napoleon, ma è difficile immaginare che avrebbe potuto incontrare interesse nel mondo artistico di Manet, Seurat o del primo Matisse. Nadar frequentava Charles Baudelaire (1821-1867), che era abbastanza ironico da potergli commissionare un ritratto fotografico intitolato Myself as Napoleon, ma il mondo dell’arte del suo tempo non era pronto per un’opera del genere.
D’altronde, un’opera d’arte concettuale come Myself as Washington avrebbe potuto essere realizzata a New York nel 1948, a Parigi nel 1910 o a Roma nel 1520? Più ci distanziamo dal momento in cui fu effettivamente realizzata e più sembra difficile da concepire. Poussin avrebbe potuto realizzare qualche opera di arte concettuale, oltre a tutto il resto? Avrebbe potuto dipingere un quadro scherzoso intitolato Myself as the King of France (1640)? Inconcepibile. L’arte concettuale non avrebbe trovato posto nella vita artistica della Roma del XVII secolo perché c’era ancora tanta arte da realizzare prima che una cosa del genere potesse risultare comprensibile. Vediamo cosa mancava allora. L’arte concettuale nacque a New York intorno al 1969. Sono tre i concetti chiave da tener presenti per seguire il racconto della sua nascita e del suo sviluppo: il concetto di entry point, il momento storico in cui un artista fa il suo ingresso sulla scena e si rende conto di ciò che può fare; il concetto di brief o agenda dell’artista, proposto dallo storico dell’arte Michael Baxandall, ovvero l’intenzionalità dell’artista, il suo piano programmatico, che può essere specifico come nel caso di un incarico, in epoca rinascimentale, per un ritratto da parte di committenti ben identificati, o vago come l’incarico ricevuto da Picasso: “Mi sorprenda”; e poi il concetto di mondo dell’arte, quella comunità di artisti, storici, critici e galleristi di cui l’artista entra a far parte. Questi tre concetti ci serviranno nel prosieguo del discorso.
Grazie al magnifico Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, di Lucy Lippard, uscito nel 1973, abbiamo una sorta di archivio degli artisti legati, in misura maggiore o minore, all’arte concettuale e molti storici ne hanno scritto ancora di recente, ma questo mio scritto è una cosa a sé perché muove da un punto di osservazione particolare. Per ripercorrere la storia dell’arte concettuale si dovrebbe approfondire il lavoro di tanti artisti ma qui è Beckley il soggetto e l’oggetto della trattazione e ne ricostruiremo il percorso, del tutto peculiare, con riferimenti solo marginali ad altri autori.
Ogni artista si iscrive nel solco di una tradizione, immettendosi in un flusso evolutivo, rispondendo a chi lo ha preceduto e, se ha successo, suscitando una risposta in chi viene dopo. The Shape of Time (1962) di George Kubler (La forma del tempo, Einaudi, Torino 1981), un libro che ebbe molta influenza sugli artisti della generazione di Beckley, descrive quello che io chiamo entry point, il punto d’ingresso, il momento in cui un artista entra nel mondo dell’arte, e spiega perché fare arte sia sostanzialmente un’attività storica: ciò che un artista può fare e come può farlo dipende, almeno in certa misura, dagli strumenti disponibili nella sua cultura visiva. Il successo di un artista dipende da quanto sa mettere a frutto ciò che il suo punto d’ingresso gli consente. Deve fare delle scelte, perché non si può fare tutto; deve perseguire un obiettivo, sapendo che scegliere un’opzione implica spesso doverne escludere altre.
Kubler era uno storico esperto della cultura ispanica, ma la sua analisi ha una valenza generale. Dovendo parlare del mondo artistico di Beckley, in questa sede conviene rilevare che la tesi di Kubler ben si applica ad alcuni degli Antichi Maestri, ad alcuni Modernisti e anche all’arte
11 10
contemporanea. In un certo senso, la situazione di Nicolas Poussin quando giunse a Roma, cuore pulsante dell’arte europea intorno al 1620, non era così diversa da quella in cui si ritrovò Édouard Manet a Parigi verso il 1840 o Beckley nella New York degli anni Settanta: preceduti, nel loro recente passato, da una grande tradizione, con davanti a sé tante possibili strade artistiche da imboccare, in una situazione molto stimolante e interessante per dei giovani. Proprio come Poussin poteva voltarsi indietro e guardare al tardo Rinascimento, e Manet poteva riferirsi ai successi di Delacroix e Ingres, anche Beckley era consapevole di avere alle spalle una tradizione americana molto ricca; per ciascuno dei tre era difficile decidere che percorso intraprendere, tanto più che nel momento in cui ognuno dei tre, nella rispettiva epoca, è apparso sulla scena artistica, proprio per via del successo dei suoi predecessori, c’era un generale interesse per l’arte e i giovani potevano contare su molti mecenati.
Volendo limitarci esclusivamente alla situazione americana, ricordiamo che una volta consolidato il mercato dell’Espressionismo astratto, e poi negli anni Sessanta della Pop Art e della Minimal Art, era naturale che galleristi e collezionisti si aspettassero qualcosa di nuovo. In un contesto del genere, sono due le cose che passano per la mente di un giovane artista che si affaccia al mondo dell’arte: sarà difficile avere successo per l’alto livello dei maestri che mi hanno preceduto oppure, siccome chi ha avuto successo prima di me è stato un innovatore, vale la pena tentare strade nuove. E, ovviamente, ci sarà concorrenza. Molti credono di avere la vocazione ma solo pochi sono gli eletti. All’inizio gli artisti concettuali si ribellarono all’idea di realizzare oggetti da mettere in vendita a prezzi alti, ma ben presto alcuni di loro cominciarono a entrare nel mercato dell’arte, il che implicava la necessità di individuare forme nuove. A questo punto, è utile sottolineare che bisogna tenere su due piani distinti la storia dell’arte di lungo periodo, esposta nei musei, e la storia del passato recente, le opere più direttamente significative per un giovane artista. Per Beckley furono molto importanti i primi Black Paintings di Frank Stella, del 1959. Alcuni artisti, compreso lo stesso Stella, vedevano quei dipinti come uno sviluppo della tradizione espressionista astratta, ma li si poteva anche considerare il segno della fine di quella tradizione, o della pittura in generale. Una volta che si comincia a fare arte applicando su tela il colore nero con larghi tratti lineari, forse si è raggiunto il massimo a cui può arrivare la pittura e a questo punto della storia, il passo successivo è l’arte concettuale.
Teniamo a mente la distinzione tra il piano del passato recente, in cui un giovane artista ritrova predecessori di cui subisce l’influenza diretta e il piano della storia di epoche più lontane, con il quale non è minimamente in risonanza. A Beckley non interessava realizzare quadri astratti, ritratti cubisti alla Picasso o dipinti storici come Poussin. Quelle tradizioni precedenti, per quanto potesse averle ammirate, non avevano alcun legame diretto con la sua arte.
Questo è il punto di ingresso, l’entry point di Beckley intorno al 1969. Oggi, come è ovvio, le cose sono cambiate; nel 2021, se un giovane artista è mosso dagli stessi interessi del primo Stella, allora si dovrà confrontare con una mole di opere, comprese alcune dello stesso Stella, che nel frattempo quei temi li hanno elaborati e sviscerati. Vi sono anche casi di artisti che sono ripartiti dall’inizio, come quando, nel 1990, Elaine Sturtevant fece sua l’idea dei Black Paintings, rifacendoli e dando luogo a un dibattito su una nuova possibile interpretazione di quelle opere, ormai canoniche. Ma l’appropriazione non rientra tra gli interessi di Beckley.
Un interessante esempio di incrocio di mondi artistici risale agli anni Ottanta, quando due pittori astratti molto diversi, Frank Stella e David Reed, cominciarono a interessarsi all’arte barocca italiana del XVII secolo. Non realizzavano pale d’altare, ma l’uso dello spazio e del colore in quell’arte sacra era rilevante per le loro opere. E un’artista come Hilma af Klint ha realizzato sia paesaggi tradizionali sia astrazioni radicali. Se scoprissimo che Beckley ha realizzato qualche opera figurativa, lo considereremmo incoerente perché abita due mondi artistici diversi? Non direi, ma comprendo che queste contaminazioni possano risultare complesse da interpretare.
Non è la mera vicinanza temporale a determinare le fonti di un artista; in genere gli artisti sono più interessati al lavoro dei loro immediati predecessori, ma a volte guardano più indietro, a epoche più lontane. Bob Thompson (1937-1966), pittore afroamericano che visse e lavorò in Italia, fece di Poussin una delle sue fonti primarie pur operando in modi che riflettono senza dubbio l’influenza della figurazione modernista. Le opzioni che risultano disponibili in un dato punto di ingresso dipendono anche dalla scelta personale di un artista tra le varie tradizioni a cui attingere, e solo ex post si comprende quali fossero quelle più promettenti. Kubler spiega che vi possono essere punti di ingresso migliori o peggiori, in funzione anche di come si combina il talento individuale con le potenzialità di una tradizione. Per un pittore con capacità e interessi figurativi, il 1969 è stato un punto di ingresso sfortunato, mentre per qualcuno con abilità concettuali, è stato l’ideale, come risulta ovvio, con il senno di poi, a giudicare il successo di Beckley.
L’espressione “mondo dell’arte” si usa in genere per indicare la comunità di persone interessate alla creazione artistica, allo studio critico e all’esposizione delle opere. In senso lato, comprende tutti coloro che sono coinvolti in qualunque forma di arte visiva, ma in questa sede mi attengo a una definizione più ristretta. Il mondo dell’arte a cui mi riferisco nel mio ragionamento è un gruppo di individui che condividono una visione e sono portatori di un comune sentire; in pratica, il mondo dell’arte è un macrocosmo costituito da una miriade di microcosmi.
In un certo senso, tali microcosmi artistici si possono paragonare a gruppi religiosi. Proprio come un cattolico può discutere di teologia cristiana con altri credenti cattolici ma, forse, non con dei buddisti o dei musulmani, così un artista concettuale può valutare e analizzare criticamente opere di altri artisti della sua stessa comunità, ma non opere di esponenti di altre comunità o correnti artistiche, presenti o passate. Dal punto di vista di Beckley, per esempio, per quanto interessante sia il recente sviluppo della pittura astratta, non ha nulla a che fare con la sua arte. E nel quarto capitolo, quando si parlerà del mondo di Caravaggio, vedremo che Beckley ne ammira i dipinti pur riconoscendo che le sue tematiche sono distanti dalla sua visione; in effetti, è alquanto improbabile che realizzi una pala d’altare fotografica. Talvolta c’è una certa teatralità quando si decide di lasciare una comunità artistica, come è accaduto quando il famoso pittore minimalista Jo Baer ha deciso di abbandonare l’astratto o quando Philip Guston ha deciso di passare all’arte figurativa, come se si trattasse di una conversione o di un’abiura.
Ciò detto, l’analogia tra il mondo dell’arte e le comunità religiose va usata con cautela. È impossibile essere cattolici e musulmani allo stesso tempo, perché le due religioni si basano su fondamenti opposti. E, nella stessa linea di ragionamento, un non credente può considerare san Tommaso d’Aquino un filosofo straordinario, capace di sviluppare solide argomentazioni, ma non per questo rientra nella comunità cattolica. Una cosa è ammirarne l’argomentare e un’altra cosa
13 12
è accettarne le implicazioni e diventare credenti. Ma almeno per i critici d’arte è possibile ammirare opere contemporanee prodotte in microcosmi diversi.
Alcuni microcosmi artistici sono costituiti da gruppi che si influenzano interagendo direttamente. Nel 2012 il raffinato gallerista David Zwirner organizzò una mostra, “112 Greene Street: The Early Years (1970-1974)”, il cui catalogo offre un quadro esaustivo del mondo artistico del primo Beckley. All’epoca, sulla scena di Manhattan erano disponibili grandi loft a buon mercato a SoHo, l’arte concettuale praticamente non si vendeva, gli artisti concettuali erano giovani, ed era possibile qualsiasi sperimentazione, anche la più ardua. Gli artisti avevano ampi spazi postindustriali a disposizione per le loro installazioni. Era il luogo e il momento ottimale per la funky art. Naturalmente, ora le cose sono del tutto cambiate e il fatto che dopo quarant’anni un grande gallerista abbia organizzato una mostra sugli artisti del 112 Greene Street è un segno dell’ordine di grandezza del cambiamento. Zwirner ha ricreato l’ambiente e l’atmosfera post-industriale negli spazi eleganti delle sue raffinate gallerie.
112 Greene Street rivelò molti artisti promettenti. Le decostruzioni architettoniche di Gordon Matta-Clark, che usano in modo attivo le architetture in degrado di New York, sono diventate famose e molti di questi artisti, compreso Beckley, hanno avuto un grande successo, ma molti altri sono scomparsi. In effetti, questo microcosmo dell’arte contemporanea era come la Roma di Caravaggio nel 1590 o di Poussin nel 1620, dove c’erano molti bravi pittori, come si è potuto vedere in alcune mostre recenti, ma non tutti sono diventati famosi.
Inutile dire che un patrocinio come quello di Zwirner è un’arma a doppio taglio. Grazie al suo sostegno, gli artisti hanno potuto mantenersi, vendendo opere o insegnando, e si è parlato e scritto molto della loro arte, ma la progressiva gentrificazione di New York, con la trasformazione dei quartieri popolari in zone abitative di pregio, ha di fatto reso impossibile lo stile di vita bohémien dei primi concettualisti, minando le condizioni stesse dell’esistenza di quella comunità. In una situazione del genere, la nostalgia è una cattiva guida, perché l’intera economia mondiale è cambiata troppo per rendere possibile il ritorno al passato. Se il mondo dell’arte deve continuare, la prossima generazione dovrà imparare a formare comunità in un ambiente molto diverso.
Una comunità è un gruppo di persone in contatto l’una con l’altra; la funzione delle accademie e delle scuole d’arte è proprio quella di far incontrare persone diverse. In un mondo dell’arte come quello di Beckley, in cui il cambiamento è stato repentino, le tecniche di insegnamento tradizionali non servivano: non voleva imparare a dipingere come Stella. È sempre limitato ciò che si può imparare in accademia, dove i docenti sono artisti della generazione precedente: gli studenti devono imparare quali abilità e competenze rifiutare perché questa è la chiave per andare avanti.
Collochiamo Myself as Washington nel suo contesto storico. Una foto come questa, come dicevamo, si sarebbe potuta realizzare anche in epoche precedenti ma l’opera d’arte, ovvero la fotografia più il titolo Myself as Washington a mio avviso, solo nel 1969 sarebbe potuta entrare nel mondo dell’arte, il mondo dell’arte concettuale. Qualche rigo sopra ho sottolineato che è importante che il mondo dell’arte sia pronto per un’opera; proprio come a un appuntamento non si deve arrivare né troppo presto ma nemmeno troppo tardi, così c’è il momento giusto anche per le opere d’arte, solo che, in genere, si può giudicare che il momento è quello giusto
solo retrospettivamente, una volta che si vede quello che un artista fa di ciò che ha a disposizione al suo punto d’ingresso.
Quest’opera del primo Beckley potrebbe anche essere definita un ritratto immaginario di George Washington. Come vedremo, qualche decennio dopo si interessò molto agli Imaginary Portraits (1887) di Walter Pater, una raccolta di finte biografie di personaggi storici. Questo progressivo offuscamento del confine tra realtà storica e finzione è rimasto un tema importante per Beckley. È tipico per lui interessarsi a un personaggio della letteratura non molto noto nel mondo dell’arte contemporanea e introdurne le tematiche nella sua arte.
Beckley spiega l’origine di questa fotografia con una storia molto complicata. Si trovava in Pennsylvania e dipingeva linee su un campo e mentre cercava di tracciarle attraversando il fiume Delaware, la corrente impetuosa gli portò via il barattolo di vernice. Arrivando sull’altra sponda, scorse una targa che indicava che quello era il punto in cui Washington aveva attraversato il fiume. Festeggiò il ritrovamento soggiornando al George Washington Motel e abbattendo un ciliegio. Nelle sue opere fotografiche narrative svilupperà altre storie strampalate come questa.
Cosa dobbiamo pensare di questa bella storia? Probabilmente è frutto dell’immaginazione come lo è il racconto su Watteau di cui Pater racconta la vita attingendo al diario immaginario di una donna innamorata di lui. In fondo, anche l’idea di provare a dipingere delle linee su un fiume che scorre non ha senso ma talvolta è un errore riflettere troppo sugli aneddoti artistici, perché si perde tutto il piacere. Forse è giusto che Carter Ratcliff, uno scrittore d’arte affascinato dalle storie di finzione, abbia registrato questo racconto senza né capo né coda, ma perché data l’opera al 1971 e non al 1969? È un’altra finzione? Ed è interessante che Beckley sia un grande lettore di Vladimir Nabokov, che spesso gioca con realtà alternative; essere un esteta significa, forse, sapere vedere il potenziale delle realtà immaginarie.
Se un’opera d’arte è troppo avanti per il suo tempo, può risultare incomprensibile. Se nel 1855 Nadar avesse realizzato davvero una foto raffigurante Baudelaire come Napoleone, un Myself as Napoleon sarebbe risultata sconcertante. Era possibile realizzarla tecnicamente ma il mondo dell’arte non era pronto e, di converso, se un’opera d’arte è troppo indietro rispetto al suo tempo, appare obsoleta o copiata. A meno che un giovane studente di Beckley non faccia un’altra foto Myself as Washington (2021) come appropriazione o citazione, o come omaggio al suo insegnante, rispondendogli come fece Sturtevant con i Black Paintings di Stella.
Affermando che Myself as Washington (1969) entrò nel mondo dell’arte quando fu realizzata è come se firmassi un pagherò, assumendomi l’impegno di poter offrire un resoconto storico plausibile. Le storie sull’arte concettuale sono molte e trattandosi di un movimento internazionale con molti artisti coinvolti, in questa sede è impossibile darne conto nel dettaglio, ma metterò comunque il pagherò all’incasso offrendo una panoramica delle origini del concettualismo parlando di Beckley, semplificando alcuni dettagli e mettendo in risalto alcune considerazioni filosofiche.
Immaginiamo un giovane artista che arriva a New York alla fine degli anni Sessanta, appena uscito da una scuola d’arte. Fresco di studi della storia del Modernismo, sa come sono andate le cose. Sa che soltanto da poco, dopo molto tempo dalla loro realizzazione, hanno successo i ready mades di Marcel Duchamp e sa che, sebbene alcuni espressionisti astratti continuino a dipingere, quel movimento appartiene a un passato relativamente più lontano e che anche la Pop Art e la
15 14
Minimal Art dei primi anni di quel decennio hanno fatto il loro tempo. Ma questa storia gli insegna che l’innovazione radicale viene sempre premiata; nel 1969 è troppo tardi per diventare un espressionista astratto, un artista pop o un minimalista, perché quegli spazi sono occupati, e ad arrivare in ritardo si sbaglia sempre.
Il nostro giovane artista attinge ai suoi studi alla scuola d’arte per immaginare il suo futuro; gli è stato insegnato che spesso le opere nuove e significative sono state realizzate “andando oltre”. Gli artisti astratti sono andati oltre quando hanno eliminato i soggetti dell’arte figurativa tradizionale. I land artists come Dennis Oppenheim sono andati oltre non limitandosi a rappresentare dei siti, ma intervenendo direttamente sui paesaggi per modificarli. E gli artisti monocromatici sono andati oltre quando hanno abolito o abbandonato la composizione tradizionale. Si fa presto a dire “andare oltre”, la maggior parte di questi “oltre” sono improduttivi, solo pochi portano al successo. E allora proseguendo la storia, il nostro giovane artista potrebbe decidere di guardare alla tradizione definita dai ready mades, dai piatti di Carl Andre, dalle serigrafie di Andy Warhol e dalle scatole di Donald Judd per prolungarla e svilupparla.
Questo fu il ragionamento di Beckley.
Tale procedura è del tutto giustificata: tradizionalmente nella creazione artistica c’erano due componenti, quella mentale e quella fisica. Un artista pianificava cosa fare, realizzava disegni o schizzi e poi eseguiva materialmente il progetto quindi, in linea di principio, le due componenti si potevano anche separare e, in effetti, in alcuni casi accadeva che dopo che l’artista aveva realizzato il progetto, la parte esecutiva venisse lasciata ad altri; è il caso, per esempio, di Michelangelo, che per alcune opere ha disegnato degli schizzi che furono poi eseguiti da altri artisti; e anche molti Antichi Maestri, Rubens e Luca Giordano per citarne alcuni, avevano un esercito di assistenti che preparavano le tele, organizzavano lo studio o la “bottega” ed erano incaricati delle parti meno importanti dei dipinti.
Con l’arte contemporanea, è diventato sempre più frequente che la parte fisica della realizzazione dell’opera venisse delegata ad altri, perché di secondaria importanza: gli assistenti di Warhol lavoravano sulle serigrafie e Judd assumeva collaboratori perché costruissero i suoi lavori; erano le idee di Warhol su come usare le immagini fotografiche e i progetti di Judd per gli oggetti tridimensionali che contavano. Questa progressiva divisione del lavoro è andata di pari passo con un altro processo, la dequalificazione del lavoro della creazione artistica, perché ormai un artista non deve più necessariamente possedere le abilità manuali tipiche del “mestiere”. Per dirla con alcuni importanti critici d’arte americani legati alla rivista di sinistra “October”, in luogo della “consueta enfasi sul virtuosismo nel disegno e la sapienza del tratto pittorico”, troviamo “i segni del lavoro manuale” e la linea di demarcazione tra produzione industriale e manifattura artistica spesso scompare. Warhol e Judd, ciascuno a suo modo, sono stati protagonisti in tal senso.
Bisogna andarci piano con l’andare oltre, perché talvolta si esagera. Supponiamo che un giovane, essendosi reso conto che gli artisti a inizio carriera aprono sempre un atelier, faccia solo questo primo passo, mettendo su uno studio e nient’altro. Forse non basta per potersi definire artisti, anche se ora sta prendendo piede la tendenza a esporre gallerie vuote, mettendo in mostra solo gli spazi, quindi, forse, avere solo un atelier vuoto può bastare. E immaginiamo, per esempio, che questo giovane artista utilizzi questo suo spazio per sviluppare concepts di opere d’arte.
Oppure immaginiamo una storia diversa. Il nostro giovane artista fa un passo in più. Se la parte più significativa è l’attività mentale dell’artista, perché non saltare del tutto la parte del lavoro fisico? Perché non produrre solo una traccia, una registrazione dell’idea e definire quella un’opera d’arte? Molta arte concettuale segue esattamente questo iter e Song for a Chin-Up (1971) di Beckley ne è un esempio. Egli compose un brano musicale per accompagnare esercizi di trazione alla sbarra, e assunse un cantante perché lo cantasse durante la performance in cui era lui stesso a fare gli esercizi. E sebbene nel caso di Myself as Washington abbia realizzato di persona il suo autoritratto, in un certo senso il principio alla base dell’opera è lo stesso. Chiunque può scattare una foto di sé stesso; non farebbe alcuna differenza, secondo me, se Beckley avesse assunto un fotografo, perché è l’idea, l’elaborazione concettuale che mostra l’intelligenza visiva di Beckley.
A questo punto, visto che oggi il mondo dell’arte comprende non solo gli artisti ma anche i critici, vale la pena che io dica qualcosa di me perché la conoscenza di qualche elemento del mio approccio alla critica d’arte può facilitare la comprensione del mio racconto dell’evoluzione artistica di Beckley. Negli anni Ottanta, agli inizi della mia attività, mi interessai a un particolare microcosmo dell’arte contemporanea, quello dei pittori astratti più giovani, per i quali i temi della grande tradizione degli espressionisti astratti erano scontati. Per loro, astrattisti leggermente più anziani quali Brice Marden, Robert Mangold e Robert Ryman, per quanto da ammirare, appartenevano a un altro universo; gli artisti concettuali avevano altri interessi.
Tra i giovani pittori astratti che conobbi in quel periodo c’erano Thomas Nozkowski, David Reed e Sean Scully, per i quali la questione principale era come riportare in auge un tipo di pittura che era stato messo in discussione. Tutti e tre, ognuno a suo modo, vollero reagire alle critiche ma il resoconto della nascita dell’arte concettuale che ho tracciato finora non li riguarda affatto, perché per loro il tema della distinzione tra atto mentale e atto fisico del fare arte, la storia della dequalificazione professionale, non erano rilevanti; qualunque fosse il loro interesse per l’arte concettuale, erano mossi da altro, a loro non importava ciò che facevano Duchamp, Andre, Judd e i loro successori: appartenevano a un altro mondo artistico e avevano una visione diversa della storia.
Per alcuni critici moralisti c’è solo un modo legittimo di fare arte contemporanea, esiste un solo mondo dell’arte e, spesso, la pensano così anche alcuni artisti perché, per esempio, per un pittore astratto, interessarsi alla storia e alle potenzialità dell’arte concettuale può essere fonte di distrazione. Ma per un critico, invece, è importante adattarsi a molti standard e a criteri diversi. Nella mia esperienza, la ricchezza dell’attuale vita artistica sta proprio nella grande varietà di microcosmi che coesistono. Un microcosmo artistico è definito da un’idea condivisa dei temi visivi che vale la pena prendere sul serio, cosa che ha anche un risvolto negativo perché i membri del gruppo saranno del tutto indifferenti rispetto ai temi caratterizzanti altri microcosmi. Per proporre un esempio estremo, oggi si realizzano ancora icone per le chiese ortodosse, ma il mondo degli artisti di icone non ha alcun legame con il mondo delle gallerie di arte contemporanea.
Avere una comunità di riferimento è essenziale per confrontarsi e avere riscontri sul proprio lavoro. Joachim Pissarro ha già scritto abbondantemente di quanto fosse importante lo scambio di idee per coppie di artisti molto diverse come Camille Pissarro (il suo bisnonno) e Paul Cézanne, e Jasper Johns e Robert Rauschenberg, e la cosa vale per tutti gli artisti. La cosa affascinante
17 16
e problematica dei cosiddetti outsiders è che non hanno sempre una comunità di riferimento, cosa che, invece, è fondamentale per l’acquisizione o il mantenimento di un senso di obiettività. In uno spazio condiviso due persone possono essere certe di vedere gli stessi oggetti, così all’interno di una comunità, gli artisti si confrontano sugli stessi problemi. All’interno del 112 Greene Street molti altri giovani artisti che avevano interessi in comune con Beckley poterono dargli conferma che era sulla strada giusta. Il giudizio, la convalida dei pari è particolarmente importante per i giovani artisti che devono scoprire come esprimersi e dar forma alle proprie istanze.
Da critico d’arte mi sono occupato di periodi e luoghi diversi, e so bene che l’impostazione della critica varia a seconda dei microcosmi artistici in cui ci si muove. Noi studiosi di Poussin seguiamo un’impostazione ben definita e abbiamo un punto di partenza imprescindibile per le nostre ricerche. Due generazioni fa, Anthony Blunt fissò un paradigma, che è stato ampliato e messo in discussione da studiosi più recenti. Distinguendo tra lo studio di Poussin intellettuale e quello di Poussin artista, egli ha tracciato un quadro con il quale tutti ci confrontiamo, così, per esempio, in una recente mostra del Louvre si è voluto evidenziare che Poussin, contrariamente all’analisi di Blunt, era un artista molto religioso, e un libro recente, Poussin as a Painter di Richard Verdi integra ulteriormente l’analisi di Blunt su Poussin pittore, come indica il titolo. Entrambe queste interpretazioni revisioniste impiegano (pur criticandola) l’impostazione critica consueta, che ha ben poco a che vedere con artisti contemporanei come Beckley.
Se si guarda a una generazione precedente quella di Poussin nel mondo dell’arte romana, quando entrò in scena Caravaggio, si riscontra una prospettiva sorprendentemente diversa. Poussin, come si sa, criticò Caravaggio quale distruttore della pittura, ma nel suo tempo, alla fine degli anni Venti del Seicento, l’influenza immediata di Caravaggio si era esaurita. E se si considerano altri periodi di cui ho scritto, la Parigi di Jacques-Louis David alla fine del XVIII secolo o il mondo dell’arte di Manet tra la metà e la fine del XIX secolo, per citare due esempi, l’impostazione delle analisi critiche era molto diversa. Come per l’artista, anche per il critico e per lo studioso ci sono molti mondi artistici diversi, ognuno caratterizzato da tematiche peculiari.
18
“Il mio lavoro è nato dal movimento della Minimal Art alla fine degli anni Sessanta. In quel periodo la pittura viveva un momento di crisi. Gli artisti concettuali intervenivano direttamente sul paesaggio o sul proprio corpo. Pur essendo attratto dal loro lavoro, mi preoccupava il fatto che le loro azioni dipendessero dalla documentazione fotografica. Nel 1969 mi feci una fotografia nelle sembianze di George Washington. Nel considerare questo lavoro pensai: ‘Questa non è documentazione, è chiaramente invenzione, io non sono George Washington’. È stato allora che ho iniziato il mio lavoro narrativo”.
Opere
Dagli anni ’60 agli anni ’70


23 22
Painted Shrubs for Sol LeWitt, 1969 Cespugli verniciati Fotografia 41 × 51 cm
Painting with Blue Squares, 1968 (in alto)
Painted Bushes for Sol LeWitt 1968 (in basso)


25 24
Twigs Painted White, 1969
Rami verniciati
Fotografia 33 × 48 cm
Vertical Horizon, 1969
Rami verniciati Fotografia 33 × 48 cm


27 26
From Sunrise to Sunset, Looking West at Midday, 1969 Una linea dipinta sui campi dall’alba al tramonto di 0,91 × 805 m
Fotografia 33 × 48 cm
From Sunrise to Sunset (Sunrise), 1969 Una linea dipinta sui campi dall’alba al tramonto di 0,91 × 805 m
Fotografia 48 × 33 cm

29 28
Washington’s Crossing, 1969 Album di fotografie, cartolina, inchiostro su carta a righe 33 × 30,5 cm
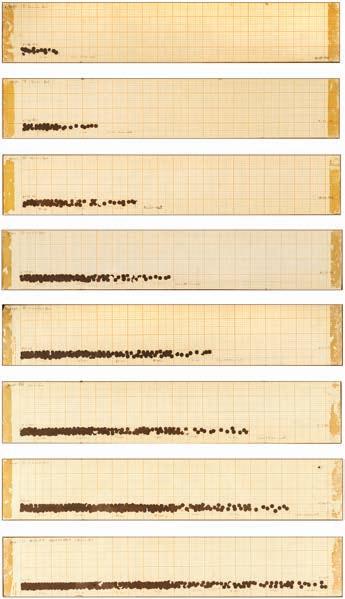
31 30
Six Minute Paper Punch Lines April 21, 1969
Inchiostro su carta millimetrata 10,2 × 56 cm (ciascun foglio)

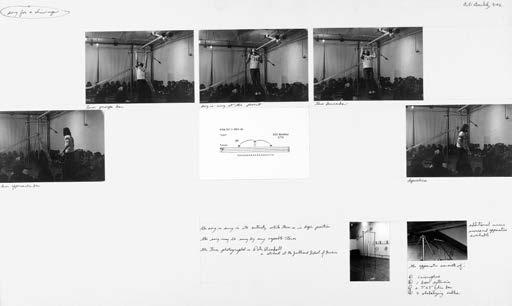
33 32
Song for a Chin-Up 1971 Performance di uno studente della Juilliard School, NYC
Song for a Chin-Up, 1972
Fotocollage e testo su cartoncino 51 × 75,5 cm

35 34
Song for a Sliding Board, 1971 Performance di uno studente della Juilliard School, NYC
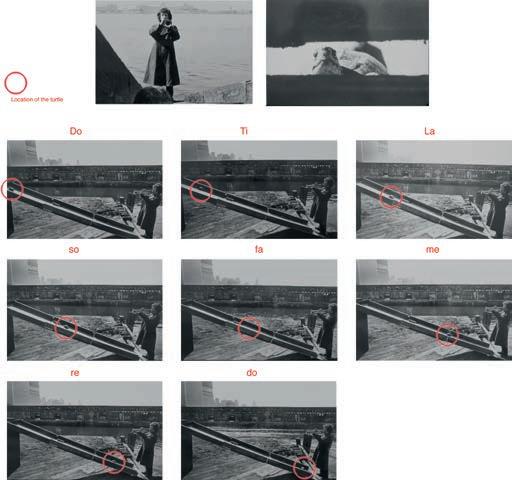
37 36
Turtle Trumpet, 1971
Performance di Bill Beckley

39 38
Brooklyn Bridge Swings, 1971
Installazione al Brooklyn Bridge, NYC
Silent Ping Pong Tables, 1971


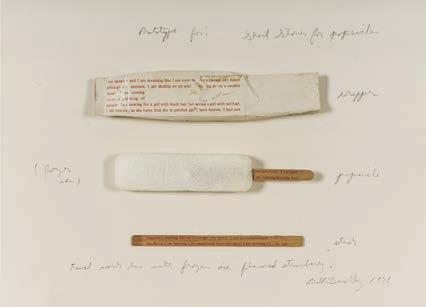
41 40
Study for Short Stories for Popsicles, 1971 Involucro di carta, ghiacciolo, bastoncino di ghiacciolo serigrafato 30 × 41 cm
Installazione alla John Gibson Gallery, NYC (in alto)
Short Story for Hopscotch 1971 (in basso) 266 × 275 cm

43 42 The Origin of And 1972 Fotografie in b/n e testo scritto 76 × 203 cm

45 44 An
Avoidance of Ann, 1972 Fotografia in b/n e testo scritto 71 × 106,7 cm
Capitolo due Il binomio parola-immagine
Per quanto riusciti fossero i Black Paintings dei suoi esordi, anche Frank Stella presto passò ad altro, sviluppando composizioni più elaborate e aggiungendo altri colori. Analogamente, pur essendo Myself as Washington un’idea geniale, Beckley non poteva accontentarsi di ripetere sempre la stessa foto come faceva Stuart Gilbert con il ritratto di George Washington, che era molto richiesto e che egli dipinse molte volte. Myself as Washington è un unicum, è una grande opera concettuale irripetibile.
Cake Story (1973), di quattro anni dopo, è un’opera in due parti, la fotografia di una fetta di torta su un tavolo, sotto la quale è disposto un breve testo in cui si parla di torte. Se all’interno di un’opera d’arte si leggono delle parole, è naturale supporre che siano collegate all’immagine. Nei collage cubisti le parole sono apposte fisicamente sugli oggetti raffigurati nei quadri; nella pittura tradizionale cinese a inchiostro la commistione tra immagini e calligrafia è molto frequente e nell’arte occidentale, in generale, sulle opere il nome dell’artista è ben indicato. Tornando a Cake Story, comunque, è naturale pensare che il testo di Beckley sia un elemento a sé, aggiunto per spiegare il significato della fotografia, un po’ come ho fatto io per Myself as Washington Vediamo una fetta di torta e leggiamo una storia di qualcuno che mangia una torta. È illuminante che dobbiamo ricorrere a due verbi diversi per descrivere il nostro modo di relazionarci con l’opera.
A una seconda lettura, però, la storia sotto la fetta di torta risulta insolita. Beckley riflette sul detto popolare “you can’t have your cake and eat it too”, non si può avere una torta e mangiarla allo stesso tempo, una di quelle affermazioni la cui banalità, se ci si sofferma sul significato, è sconcertante (di norma l’espressione italiana equivalente è “non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca”). Ipotizziamo di apportare una piccola variazione: “non si possono avere soldi e spenderli allo stesso tempo”; per quanto senz’altro vero, nessuno direbbe mai una cosa del genere. O, ancora, “non si può avere l’acqua in bottiglia e anche berla”; anche questo è vero ma fin troppo ovvio. Deve esserci qualcosa nella storia dell’avere la torta e mangiarla allo stesso tempo che rende l’espressione accettabile nonostante la sua ovvietà. Sostituire la torta con acqua e soldi non sortisce lo stesso risultato.
47
Gustave Flaubert costruì il suo ultimo romanzo, mai completato, Bouvard e Pécuchet, intorno a idee correnti e luoghi comuni, come il detto sulla torta. Lo scrittore riteneva che il fatto che fossero riportati sulla carta stampata fosse una prova incontrovertibile della stupidità del giornalismo e si dedicò a raccoglierli per farsi gioco di chi li utilizzava. Il fatto che in alcune occasioni molti di noi ripetano dei cliché non è necessariamente segno di insulsaggine perché, in fondo, anche gli scrittori più creativi hanno bisogno, ogni tanto, di ripetersi o di ricorrere a luoghi comuni, ma Cake Story è un’opera d’arte e in quanto tale è legittimo riflettere criticamente anche su un’affermazione sciocca.
A volte i luoghi comuni sono divertenti, per esempio “un quarto d’ora prima di morire era ancora vivo”. Quanto mi piacerebbe esserne l’autore, ma questo memorabile cliché è opera di Jean-Paul Sartre, che lo usò nel suo studio critico del libro di Flaubert. Bisogna essere davvero sovrappensiero per dire una cosa del genere, certo, ma anche l’espressione “you can’t have your cake and eat it too”, in fondo, non ha molto senso. Se qualcuno ci chiedesse “Si può avere una torta e mangiarla allo stesso tempo?” sarebbe naturale dubitare della sua intelligenza, o almeno della sua padronanza della lingua inglese. Se qualcuno ci chiedesse “Che sapore ha quella torta al cioccolato?”, la domanda avrebbe senso, ma se ci chiedesse “Puoi avere la torta e mangiarla allo stesso tempo?” non saremmo certi di cosa ci stia chiedendo quella persona; vuole proporre di mangiare la torta e vedere se poi è ancora lì? Chi potrebbe chiedere una cosa del genere? Nel suo testo Beckley, correttamente, osserva che è naturale domandarsi perché una persona dovrebbe avere “il duplice desiderio di avere e mangiare una torta” ma poi, stranamente, decide di ordinare una torta per “provare a risolvere la questione”, come se stesse descrivendo un esperimento. Se qualcuno ci dicesse di voler scoprire se si può trasportare acqua in un setaccio, gli risponderemmo: prova e vedrai! La domanda di Beckley sembra altrettanto ridicola, perché prima dice che questo “duplice desiderio” è di per sé privo di senso e irrealizzabile e poi decide di ordinare una torta per vedere se è possibile. Se qualcuno ci chiede se è vero che “pietra smossa non fa muschio”, gli rispondiamo forse di andare a prendere una pietra e smuoverla?
In Cake Story questa stupida questione, che Beckley chiama duplice desiderio, è posta nel contesto di una storia sulla perdita. Il narratore, che trascorre da solo il giorno del suo compleanno, è stato da poco, in compagnia, a Roma, dove alloggiava vicino al Pantheon. Seguono due frasi in cui viene descritto il ben noto monumento e poi il narratore ricorda le cene insieme a qualcuno non meglio identificato. Sulla base di queste parole non ci è difficile immaginare una storia. Come molti di noi, il narratore solitario, a cui non piace ritrovarsi da solo il giorno del suo compleanno, ricorda altri momenti felici trascorsi a Roma in compagnia. È normale avere una torta per il proprio compleanno e quindi, ci dice, ne ordina una fetta e si mette a rimuginare. In tale contesto, può darsi che riflettere su come sia possibile avere una torta e mangiarla allo stesso tempo equivalga a interrogarsi su quanto sia difficile mantenere una relazione.
Gli esperti di retorica avranno subito rilevato che sono cascato in un trabocchetto, un vero tranello teso da Beckley. Nessuno ci ha detto che l’io narrante sia infelice, né sappiamo se fosse più felice viaggiando in due. Possiamo immaginare che fosse in viaggio per vivere una storia d’amore ma poteva anche essere con un parente, un genitore o un figlio che poi era tornato a casa. La verità è che il testo narrativo non spiega perché il narratore si metta a riflettere sul modo di dire.

49 48
Cake Story, 1973
Stampa Cibachrome e fotografia in b/n 83 × 52 cm
Viaggiare in compagnia può essere fantastico oppure può trasformarsi in tragedia ma questo cosa ha a che fare con le riflessioni sul senso dell’espressione “avere la torta e mangiarla allo stesso tempo”? La Recherche, grande romanzo di Proust, scritto in parte in prima persona, riguarda un personaggio di nome Marcel che è diverso, per molti aspetti, dal Marcel autore (contrariamente a lui infatti è eterosessuale e non ha fratelli). Anche pensare che il narratore del testo di Beckley sia un “lui”, come ho fatto io finora, è opinabile; in fondo, anche le donne viaggiano e possono ordinare fette di torta per dessert. Anche in questo caso, come in Myself as Washington, il pronome deittico è fondamentale dal punto di vista della filosofia estetica.
In ogni caso, non v’è motivo di ritenere che sia una storia autobiografica che riguardi Beckley, l’autore. Dopo tutto, Cake Story è un’opera d’arte e non ci viene in mente che la foto mostri una fetta di torta fotografata effettivamente il giorno del compleanno di Beckley, quindi perché dovremmo credere che le parole scritte siano veridiche? Le bugie sono ammesse tanto nell’arte visiva quanto in quella verbale e non si parla di opere di finzione o di fantasia per caso. A quanto pare, concentrandoci sulle parole ci siamo sempre più allontanati dalla foto della torta. Torniamo indietro e riportiamo questa discussione a quanto dicevamo a proposito di Myself as Washington. Ho definito quella foto un’opera d’arte, e il filosofo Alexander Nehamas ha obiettato che si può sostenere che la mia analisi sia un po’ fuorviante in quanto la vera opera d’arte è l’insieme della foto e dell’interpretazione da me elaborata. Da sola, non è altro che la foto di una messinscena, cosa che vale anche per la parte superiore di Cake Story, la foto di una fetta di torta. Senza le parole non c’è alcuna storia, e questo dimostra che per capire l’opera si deve interpretare il testo.
L’evoluzione di Beckley nei quattro anni che intercorrono tra Myself as Washington e Cake Story è stata senz’altro un processo intuitivo, che ora io ricostruisco da studioso, nel linguaggio forbito della storia dell’arte. Per dirla in breve, all’inizio della carriera Beckley ha realizzato opere interessanti ma la sua arte, per quanto apprezzabile, era incompleta perché lo status di opera d’arte di Myself as Washington, per esempio, si poteva comprendere solo alla luce di una teoria artistica, esplicitata da Beckley stesso o da suoi commentatori, perché l’opera d’arte era la foto più un commento scritto. Per creare l’opera, Beckley ha bisogno della collaborazione di uno scrittore che offra un’interpretazione. Ovviamente, può fare anche lui stesso da commentatore, come è avvenuto quando, di recente, ha risposto ad alcune mie domande, ma il commento non è inserito nell’opera, non ne fa parte.
A questo punto è interessante collocare brevemente l’evoluzione di Beckley in una prospettiva più ampia della storia dell’arte occidentale. Nel suo Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori (1550), Giorgio Vasari narra la storia divertente di un pittore minore fiorentino, Buonamico Buffalmacco, attivo tra il 1315 e il 1336. Un collega un po’ ingenuo, Bruno di Giovanni, gli chiese aiuto perché “si doleva che le figure che […] faceva non avevano il vivo” e Buffalmacco “gli fece far alcune parole che uscivano di bocca a quella femina che si raccomanda alla Santa, e la risposta della Santa a lei”. Secondo il dotto studioso del Vasari, Paul Barolsky, si tratta del primo esempio di fumetto ante litteram. La commistione di parole e immagini per narrare storie diventa frequente a partire dall’inizio del XX secolo, ma dagli inizi del Rinascimento fino ad allora, nella pittura europea in generale le parole erano quasi messe al bando dalle raffigurazioni pittoriche, tanto diffusa era la convinzione che la pittura dovesse comunicare esclusivamente per immagini,
senza elementi testuali, e nelle varie epoche gli studiosi hanno sempre deriso l’aggiunta di parole ai dipinti, compreso il famoso storico moderno Bernard Berenson.
Barolsky ha scritto molto sulla finzione narrativa negli scritti di Vasari e sembra che l’aneddoto sulla burla di Buffalmacco sia inventato, ma anche se non veritiera, la storiella la dice lunga sul fatto che aggiungere elementi testuali nei quadri fosse considerata un’assurdità nel Rinascimento, tanto era radicata l’idea che l’arte visiva dovesse comunicare solo in termini visivi, lasciando le parole alla letteratura. L’ideale formalista che vuole che ogni arte sia pura e che utilizzi solo temi propri del suo medium, è una versione aggiornata in epoca modernista del principio rinascimentale. Secondo Clement Greenberg, non solo la parola scritta ma la narrazione in generale va lasciata alla letteratura, perché la pittura è arte astratta. D’altronde, cogliendo il riferimento di Barolsky, i critici sono stati a lungo restii a considerare i fumetti una forma d’arte, essendo inconcepibile che si raccontino storie con parole e immagini, come se queste ultime da sole non bastassero. Il fumetto è un’arte bastarda, impura, rivolta ai bambini o ad adulti con scarse capacità di lettura e negli anni Cinquanta gli album di fumetti furono oggetto di aspre critiche.
Il rapporto tra parola e immagine si evolve nel presente, e il Post-modernismo si caratterizza proprio per l’ingresso delle parole nello spazio pittorico, come elementi visivi distinti, stampati o dipinti; in fondo, la combinazione di foto e testo in Cake Story è solo una delle innumerevoli varianti sul tema che si vedono di recente: si potrebbe compilare un elenco lunghissimo di esempi, con artisti come John Baldessari, Mel Bochner, Richard Prince, Ed Ruscha e Christopher Wool che utilizzano le parole, da sole su tela oppure insieme alle immagini. Essendo una pratica corrente nel mondo dell’arte visiva recente, c’è da supporre che Beckley non si sia necessariamente ispirato agli scritti di Vasari per Cake Story e per le altre sue opere “narrative” in quanto non aveva bisogno di andare a cercare riferimenti così remoti che avallassero il suo modo di procedere. Come Myself as Washington fu riconosciuta come opera d’arte quando prese piede l’arte concettuale, così Cake Story poté avere successo solo quando anche altri artisti cominciarono a usare le parole. Sarebbe stato possibile realizzare Cake Story sin da quando esiste la fotografia perché la possibilità tecnica c’era dal 1880 in poi, ma a quel tempo non sarebbe stata considerata un’opera d’arte. Come si è detto nel capitolo precedente, gli entry points i punti d’ingresso, contano. Purtroppo, gli excursus sono per natura generici e si è perso di vista il punto da cui siamo partiti, la peculiare evoluzione personale di Beckley; generalizzando, in storia dell’arte si corre il rischio di non rendere sempre giustizia ai singoli artisti. Baldessari, Bochner, Prince, Ruscha e Wool hanno avuto un percorso molto diverso da quello di Beckley; se ci fermassimo a questa storia, sembrerebbe che Beckley si sia limitato a inserire in Cake Story un’interpretazione della sua opera e che, quindi, basterebbe aggiungere a Myself as Washington un pannello con la mia spiegazione per sancirne lo status di opera d’arte concettuale; ma l’analisi di Cake Story ha rivelato che serve ben altro.
La spiegazione di Myself as Washington proposta nel primo capitolo, ambisce a essere un’interpretazione veritiera ed eventuali errori o inesattezze non sono intenzionali, invece il testo nella parte inferiore di Cake Story, come abbiamo visto, è un racconto di fantasia ed è parte integrante di quest’opera fotografica concettuale, non una sua spiegazione o interpretazione. L’opera è costituita da due elementi: il concept che ci mostra la foto e il testo; solo che mentre nell’esempio di arte concettuale che è Myself as Washington la narrazione è venuta da un critico
51 50
esterno, in questo caso è fornita dall’artista ed è interna, consustanziale all’opera stessa: Cake Story ha una struttura bipartita, fotografia più testo, è un meticcio, arte visiva e letteratura al tempo stesso, quindi è opportuno analizzarla ricorrendo alle competenze dello storico dell’arte e a quelle del critico letterario.
Spesso nei romanzi si trova una nota dell’editore che ricorda al lettore che si tratta di un’opera di fantasia. Nella prima pagina della recente traduzione in inglese di Ragazzi di vita (1955) di Pier Paolo Pasolini (The Street Kids, 2016) una nota precisa: “Questo libro è un’opera di fantasia. Ogni riferimento a persone, luoghi ed eventi realmente esistiti è rielaborato dall’immaginazione”.
Il romanzo, ambientato nelle borgate di Roma che l’autore frequentava (Pasolini fu ucciso nel 1975, forse da qualcuno di quei ragazzi), nomina molti posti realmente esistenti e i personaggi sono probabilmente molto simili ai ragazzi che conosceva l’autore, ma non c’è dubbio che il romanzo sia un’opera di fantasia.
C’è da dire però, che alcuni romanzi hanno persone reali come protagonisti. In Alla ricerca del tempo perduto, Marcel Proust presenta opere d’arte, persone e luoghi tanto realistici da aver indotto molti studiosi a dedicare approfondite ricerche sulle fonti, del tutto vane perché Proust stesso, a un certo punto, dichiara esplicitamente che nel suo romanzo ogni cosa è frutto di invenzione, i quadri di Elstir, la musica di Vinteuil e molto altro. Con una sola eccezione: egli racconta una storia molto toccante di devozione familiare con una vena nazionalistica, la storia di una coppia di anziani benestanti che, durante la Grande Guerra, dopo la morte in combattimento del giovane proprietario di un caffè, si offrono di occuparsene dall’oggi al domani. L’autore ci dice che è grazie a questi sacrifici che la Francia è sopravvissuta. Non voglio dare alcun riferimento testuale, perché se non conoscete a memoria questo magnifico e monumentale romanzo, spero lo leggiate quanto prima per individuare questa scena emozionante. Proprio come in un grande quadro si ritrova, talvolta, un autoritratto dell’artista, così Proust introduce un frammento di realtà nella sua opera di fantasia.
In generale, comunque, per convenzione quando si trova un testo all’interno di un’opera d’arte, si tratta di una storia di fantasia, e Cake Story non fa eccezione. Si potrebbe obiettare che un artista visivo potrebbe voler scegliere di non rispettare la convenzione e che in alcune recenti produzioni letterarie, le cosiddette narrazioni vere, la linea di demarcazione tra realtà e finzione si azzeri, ma, come abbiamo visto, la storia breve di Beckley è inequivocabilmente inventata e va interpretata. Cake Story è un’opera unitaria costituita dalla combinazione di due parti, una foto giocosa e una storia di fantasia narrata in prima persona, contrariamente alla nostra prosaica interpretazione di Myself as Washington nel capitolo precedente. Certo, il mondo reale e il mondo dell’arte non sono del tutto avulsi l’uno dall’altro ma presentano delle sovrapposizioni: George Washington è realmente esistito ed era vera anche la fetta di torta della foto; i quadri, i luoghi e le persone immaginarie di Proust sono radicati nel reale così come lo sono le parole di Beckley in Cake Story, che descrivono un luogo che esiste, il Pantheon a Roma.
La versione più poetica che io conosca della relazione tra mondo reale e mondo immaginario la fornisce nei suoi romanzi un autore che Beckley ammirava enormemente, Vladimir Nabokov, che amava costruire mondi alternativi. Il suo romanzo che meglio si presta al ragionamento che stiamo sviluppando è Fuoco pallido (1962). Come Cake Story, presenta una struttura in due parti,
un breve poema e un lungo commento. A una prima lettura, il commento sembra completamente folle e senza un nesso riconoscibile con i versi, dal canto loro banali e apparentemente semplici. Inutile dire che fiumi d’inchiostro sono stati versati su questo romanzo e l’opinione più accreditata è che Nabokov abbia voluto proporre una parodia del mondo della critica letteraria accademica, per il quale nutriva profondo disprezzo.
Il commento in Fuoco pallido racconta di un esule proveniente da Zembla, un regno immaginario che ha degli aspetti in comune con la Russia che Nabokov aveva dovuto lasciare. Il titolo del poema è tratto dal Timone d’Atene di Shakespeare: “La luna è un ladro arrogante, / E il suo pallido fuoco lo ruba dal sole” (Atto IV, scena 3). Nella storia ci rendiamo conto che l’autore del commento, Charles Kinbote, non riconosce la citazione shakespeariana perché ha letto le opere di Shakespeare in una (immaginaria) traduzione in zemblano e leggiamo, in un altro risvolto della vicenda narrata che ho illustrato in una mia precedente pubblicazione, un resoconto dettagliato di come Kinbote abbia portato quella traduzione da Zembla al suo nuovo mondo. La lezione nabokoviana è che quando dei testi passano dal mondo dell’arte alla realtà, per così dire, la loro identità muta ma in modi riconoscibili tanto da consentire al lettore attento di ricostruire il percorso compiuto. Zembla, un’invenzione di Nabokov, è collegata al mondo in cui è stato scritto il poema Fuoco pallido; le persone, e anche i libri come il Timone d’Atene di Shakespeare, possono passare da un mondo a un altro, pur cambiando durante il tragitto.
Dal canto nostro, sapendo che Kinbote sta leggendo Shakespeare, riusciamo a riconoscere la fonte del titolo del poema Fuoco pallido: sono parole che provengono dal Timone d’Atene. La procedura di Nabokov, in questo e in altri romanzi, è molto di più di un’abile trovata autoriale, è una presa di posizione sulla natura della finzione nell’arte; adottando questa linea di pensiero, il senso di Cake Story risulta più chiaro perché comprendiamo come cambia la natura stessa di un testo interpretativo di un’opera d’arte concettuale quando entra all’interno dell’opera d’arte stessa. Non v’è dubbio, quindi, che lo scritto di Beckley posto nella parte inferiore di Cake Story sia narrazione, e non l’interpretazione della foto e che per interpretare quest’opera che consta di due parti si debbano analizzare sia la parola sia l’immagine. Aggiungo, onde evitare fraintendimenti, che non voglio con ciò intendere che Beckley sia uno studioso di Nabokov anche se, come ho già avuto modo di dire, egli nutre da sempre interesse per questo scrittore, ma che nella sua arte visiva egli adotta il modo di pensare nabokoviano quando combina immagine e testo. L’idea che la linea di confine tra narrazione vera e finzione sia porosa è senz’altro suggestiva.
Interpretiamo Cake Story tenendo conto della foto e del testo. Torna utile fare riferimento anche a un’altra opera che Beckley ha realizzato l’anno successivo, combinando immagine e narrazione, De Kooning’s Stove (1974), in cui a destra vediamo la foto di un fornello, con uno dei bruciatori acceso, a sinistra un testo di Beckley su Willem de Kooning e i fornelli. Per essere precisi, il testo di Beckley, pur essendo costituito da un solo paragrafo, è suddiviso in due parti, una in cui leggiamo che de Kooning non sopportava avere tele bianche e intonse intorno a sé e quindi ci scriveva sopra il nome di un oggetto presente nel suo atelier, e un’altra in cui apprendiamo che per Beckley c’erano due tipi di espressionisti astratti, quelli come de Kooning e gli altri, che ammirava di più, i precursori dei minimalisti e dei concettualisti, tra i quali c’era Barnett Newman che più tardi, come vedremo nel prossimo capitolo, divenne molto importante per Beckley,
53 52
e ovviamente Stella di cui, come abbiamo visto, aveva subito l’influenza precedentemente. Alla fine leggiamo che il narratore ha rimosso tutti i mobili dal suo studio tranne la cucina, che gli serve per tenersi al caldo ed, evidentemente, la sedia che vediamo riflessa nello sportello del mobile, rosso scintillante.
In modo ancora più complesso di Cake Story, anche questa storia è strampalata. Essendo di un anno dopo, è legittimo immaginare che Beckley abbia avuto modo di raffinare la sua tecnica. Come prima, partiamo dalla lettura del testo e supponiamo, per amor di discussione, come si suol dire, che la faccenda della paura delle tele vuote di de Kooning sia vera: perché l’artista avrebbe dovuto svuotare lo studio come reazione? Perché ciò avrebbe dovuto aiutarlo a superare la sua fobia?
E perché, dato che Beckley apprezza maggiormente altri espressionisti astratti, avrebbe svuotato anche lui il suo studio esclusa la cucina, che il narratore ci dice di usare per tenersi al caldo?
Perché Beckley dovrebbe imitare de Kooning in questo modo? Nulla ha senso, né la parte della storia che riguarda de Kooning né quella che riguarda il narratore. Come nella storia sulla torta e su Roma, anche qui ritroviamo un brano senza né capo né coda che accompagna una foto che è una sorta di illustrazione del testo, e anche qui abbiamo una narrazione in prima persona che non deve necessariamente riguardare Beckley. Sicuramente Beckley è stato a Roma ed è probabile, quindi, che abbia visitato il Pantheon, per cui Cake Story affonda le sue radici nella realtà. E per quello che ne sappiamo, potrebbe aver viaggiato qualche volta da solo e altre volte in compagnia e una cosa simile si potrebbe dire per il testo in De Kooning’s Stove: sull’artista circolano molte storie non vere, e anche Beckley ha uno studio e da giovane dipingeva e, molto probabilmente, aveva anche un fornello da cucina. Ma, per quanto ne sappiamo, non ha bisogno di accenderlo per tenersi al caldo nel suo studio fotografico e, comunque, ammesso che talvolta vi faccia freddo, la storia della fobia di de Kooning per le tele bianche non sembra attinente al suo modo di lavorare.
Anche in questo caso, ovviamente, l’io narrante non deve essere Beckley perché anche questo testo è un’opera di fantasia, come quello in Cake Story, e bisogna tenerne conto nell’interpretare De Kooning’s Stove. Negli anni, ripercorrendo i lavori di Beckley di quel periodo, ho pensato spesso che volesse quasi fare dello spirito, senza riuscirci del tutto. Le sue storie mi ricordano quelle battute umoristiche illogiche che Freud analizza in Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio (1905). In una, per esempio, un rabbino di Cracovia comunica a tutti che il rabbino di Lemberg è deceduto. Alcuni cittadini di Lemberg arrivano un giorno a Cracovia e rivelano che, in realtà, il rabbino è ancora vivo. Come risposta, uno dei discepoli del rabbino di Cracovia dice: “Che differenza fa… in ogni caso la Kück (la vista) da Cracovia a Lemberg era magnifica”. Fare dell’umorismo, come fa Freud, sull’infallibilità della sapienza rabbinica è tipico della tradizione ebraica. Forse anche Beckley vuole solo prendere in giro de Kooning ma entrambe le storie, a mio avviso, vorrebbero far ridere senza riuscirci, ma ognuno reagisce a suo modo ai motti di spirito.
Quando insegnavo filosofia e parlavo della psicanalisi, dovevo spiegare le battute, poi con il tempo ho scoperto che molti motti di spirito di Freud sono per “iniziati”, come si direbbe in un altro campo, per persone informate sui fatti. Un ebreo chiede a un altro: “Did you take a bath?” (hai preso un bagno per dire hai fatto il bagno?), l’altro risponde: “Perché, ne manca uno?”. Joke about Elephants 1973 Fotografie in b/n 63,5 × 46 cm
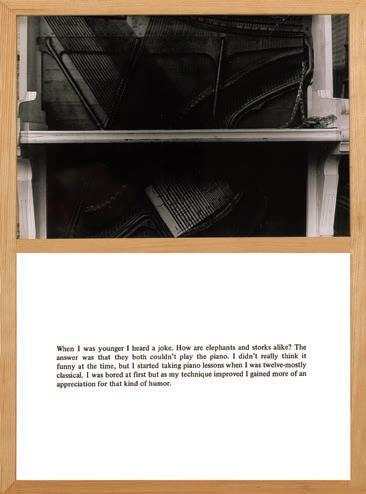
55 54
Questa battuta ha senso solo per chi sa che gli ebrei poveri dell’Europa orientale, che non avevano vasche da bagno in casa, andavano ai bagni pubblici per lavarsi. Ovviamente, un bath (che sia vasca o bagno pubblico) non è una cosa che si possa rubare come un barattolo di gefilte fish, per esempio (letteralmente pesce ripieno, gustose polpette di pesce, tipiche della cucina ashkenazita). Molte delle battute di Freud, senza una spiegazione sembrano sciocchezze senza senso; secondo lo psicanalista, spesso nei motti di spirito diamo senso a ciò che sembra non averne se siamo in grado di riconoscerne la portata aggressiva. Le due battute che ho citato ne sono validi esempi. Ridere a una battuta significa interpretarla, riconoscendo che ci consente di dire cose che, se esplicitate con molte parole, suonerebbero offensive. E questo è anche il motivo per cui i goyim, i non-ebrei, dovrebbero astenersi dal raccontare barzellette ebraiche; invece i non-artisti possono scherzare su de Kooning.
Un altro lavoro di Beckley, Joke about Elephants (1973), casca a pennello. Contiene la foto di un pianoforte e un testo su una barzelletta: “Che cosa hanno in comune un elefante e una cicogna? Nessuno dei due sa suonare il piano”. Il narratore dice che inizialmente non trovava divertente questa battuta, ma studiando pianoforte e migliorando la tecnica, ha cominciato a comprenderne lo spirito. Di nuovo la mancanza di logica è evidente: non v’è ragione di pensare che migliorando la propria abilità pianistica si comprendano le battute sul pianoforte ed è talmente ovvio che né elefanti né cicogne sappiano suonarlo che non serve nemmeno una spiegazione.
Indipendentemente da ciò che si pensi della teoria di Freud, ciò che ci rivela a proposito delle assurdità di Beckley è che non vogliono far ridere, almeno secondo me. In alcuni dei suoi dipinti narrativi, Richard Prince scrive battute alquanto stereotipate sugli psichiatri, che vogliono suscitare ilarità. Un umorismo del genere, certo, implica una certa ostilità nei confronti della psicanalisi, ma la storiella del fornello da cucina di Beckley non è ostile nei confronti di de Kooning, è insulsa, e senza senso, forse nemmeno tanto da essere sconcertante, ma di sicuro non è chiara. Anche in questo caso, come in Cake Story, si rimane interdetti nel rendersi conto che i processi mentali dell’io narrante sono illogici, come lo erano di sicuro quelli di de Kooning. Sono molti gli artisti che ne hanno subito l’influenza ma, per quel che si sa, nessuno è rimasto soggiogato fino al punto da portare via tutti i mobili tranne la cucina da casa propria. Forse è proprio questo ciò che vuole sostenere Beckley: fare arte è di per sé illogico. Ascoltando de Kooning in alcune registrazioni, traspare un’irresistibile illogicità e quindi, come per George Washington, una storiella inventata può essere rivelatrice.
La questione della fobia delle tele bianche di de Kooning, che prosegue con la precisazione sulle due scuole dell’Espressionismo astratto, è una breve storia senza né capo né coda, il che è di per sé un ossimoro perché, per definizione, le storie senza né capo né coda sono lunghe e, in effetti, più recentemente Beckley ha pubblicato alcune storie strampalate più lunghe. Vale la pena cercare di capire da dove derivi l’illogicità in questo testo: non è del tutto chiaro cosa abbia a che fare il racconto del desiderio dell’artista di guardare un fornello da cucina, o il nome di un oggetto raffigurato sulla tela, con il desiderio di Beckley di usare il fornello per riscaldarsi. Come accade con i motti di spirito, si rischia di sembrare inutilmente pedanti e vagamente sciocchi nell’ostinarsi a voler spiegare un significato che non c’è.
Nel 1990, vent’anni dopo, in un negozio di libri usati, Beckley trova per caso un volume della fine dell’Ottocento che colpisce la sua attenzione, Imaginary Portraits di Walter Pater (1887). Sebbene noto agli studiosi accademici, il libro di Pater non è tra le letture che possono interessare gli artisti contemporanei, ma Beckley ne fu così affascinato da lavorare a una riedizione del testo scrivendone la prefazione, che uscì nel 1997. Il libro offre una caratterizzazione raffinata della prosa di Pater. I suoi ritratti immaginari, racconti di fantasia su personaggi reali, utilizzano informazioni inventate per proporre un’interpretazione del lavoro e delle opere di ciascun soggetto. Contrariamente ad altri biografi, che talvolta per arricchire le storie aggiungono informazioni la cui veridicità è discutibile, Pater rende esplicita la procedura, dichiarando immediatamente che narra storie di vita immaginate sulla base delle storie vere dei personaggi. Prendiamo A Prince of Court Painters, il ritratto immaginario di Jean-Antoine Watteau (1686-1719), il grande pittore francese morto prematuramente.
Si sa poco della sua vita. In un saggio del 1856, i fratelli Goncourt, grandi fautori della pittura dell’Ancien Régime, pubblicarono quella che sostenevano essere una vecchia biografia di Watteau. Sulla base di quel testo, Pater riscrive la biografia dell’artista attraverso un diario immaginario della sorella di un altro pittore, Jean-Baptiste Pater, suo omonimo, che è innamorata di Watteau. Stando al diario, Watteau dipinge quel mondo con tanta grandiosità “in parte perché lo disprezza”. Per capire i soggetti dei suoi dipinti bisogna tener presente che non ha mai dimenticato di essere nato povero, di provenire da un mondo diverso. Si tratta di una speculazione plausibile e la vita immaginata da Pater ha un senso e non è divertente. Anche Beckley, in De Kooning’s Stove propone un ritratto immaginario, forse assurdo, dell’artista, integrato da una fotografia ma, a differenza di A Prince of Court Painters, non fa nemmeno lo sforzo di fingere che sia la verità.
Come è complessa De Kooning’s Stove! Nel loro insieme, il breve testo e la foto apparentemente semplice danno luogo a una concatenazione di riflessioni e considerazioni di semiotica. E l’analisi è solo cominciata perché ci si potrebbe soffermare e dilungare su ogni punto. Beckley ha elaborato molte varianti sul tema con la sua arte fotografica narrativa. La commistione di parole e immagini gli ha permesso di raccontare storie divertenti come Cake Story (1973) e scene erotiche come Bus (1976). Chiaramente questa meravigliosa forma di creazione artistica avrebbe potuto essere estesa all’infinito. L’evoluzione, o il passaggio dall’arte concettuale a quella fotografica narrativa fu dovuta, credo, al bisogno di colmare quella che veniva vista come una lacuna nelle opere concettuali alle quali mancava una narrazione esplicativa.
Eppure, la capacità auto-critica di Beckley lo spinse presto a dedicarsi ad altro. La bellezza non aveva trovato posto nelle sue opere fino ad allora, ma la bellezza era la sua aspirazione ultima, non l’umorismo. La riedizione di Beckley di Imaginary Portraits comprendeva anche una novella, pubblicata separatamente, The Child in the House, a cui attinse, come egli stesso ci spiega, per elaborare alcune idee su come riportare la bellezza nella sua arte. Pater si rivelò una risorsa preziosa.
57 56
“Il 1969 ha segnato l’inizio della mia cosiddetta ‘arte narrativa’. Praticamente scrivevo una storia e facevo le fotografie allo stesso tempo. Il testo si evolveva con le foto. Alcune opere non avevano il testo, ma erano comunque delle narrazioni. Negli anni Ottanta ho usato vari materiali e il lavoro è diventato più scultoreo e pittorico. Alla fine degli anni Ottanta ho trovato il modo di integrare questi materiali con la fotografia. L’integrazione tra fotografia e superficie pittorica è un aspetto importante di tutti miei lavori”.
Opere
Dagli anni ’70 agli anni ’90
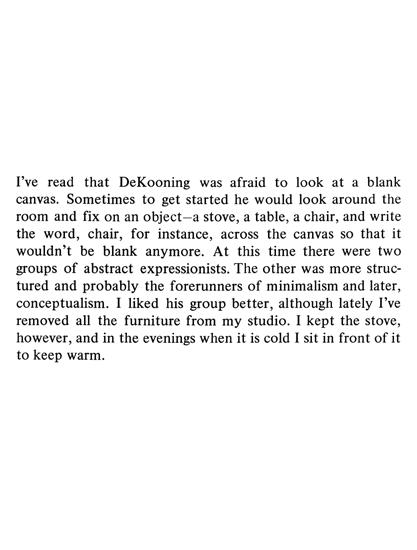

61 60 De Kooning’s Stove, 1974 Fotografia in b/n e stampa Cibachrome 104 × 157 cm

63 62 Roses Are, Violets Are, Sugar Are, 1974 Stampe Cibachrome 95 × 228 cm
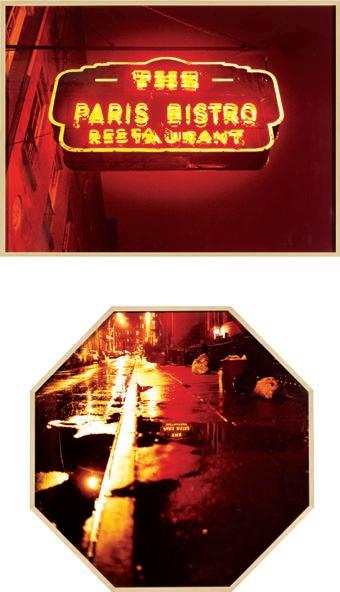
65 64
Paris Bistro 1974
Stampe Cibachrome 185 × 102 cm
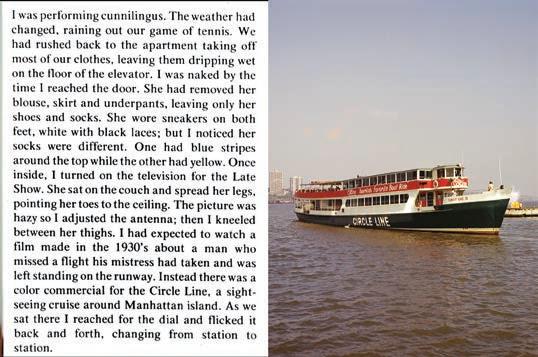
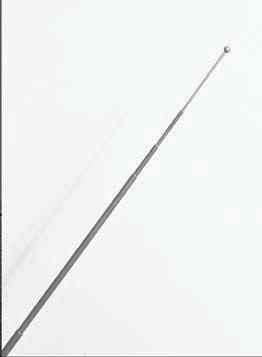


67 66
Circle Line, 1974
102
305 cm
Stampe Cibachrome e fotografia in b/n
×
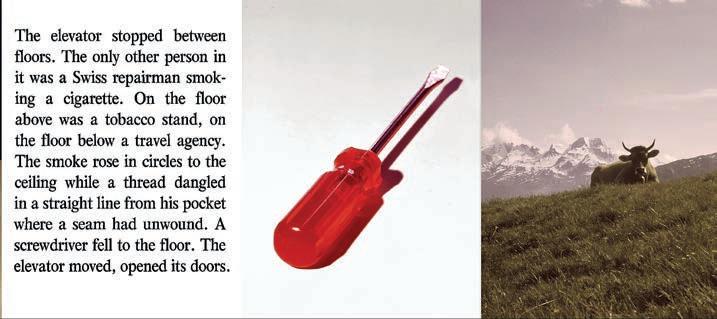
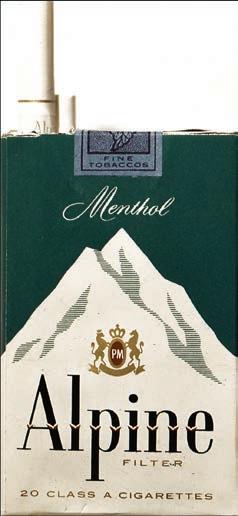
69 68
The Elevator, 1974 Stampe Cibachrome e fotografia in b/n 165 × 305 cm
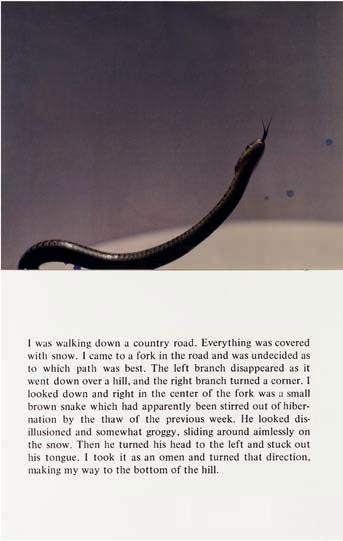
71 70
Snake Story 1974
Stampa Cibachrome e fotografia in b/n 77,5 × 50,8 cm


73 72
Rabbit Turtle, 1974
Fotografie in b/n
96,5 × 520,7 cm

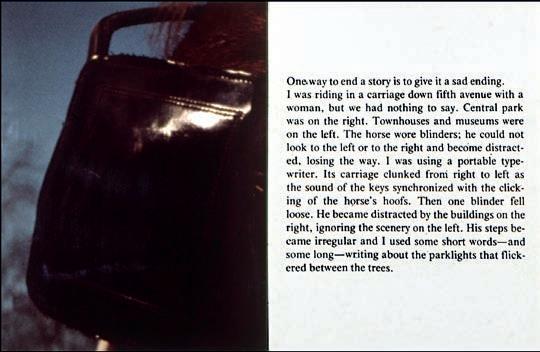
75 74 Sad Ending, 1975 Stampa Cibachrome e fotografie in b/n 60 × 200 cm

77 76
Drop and Bucket, 1975 Stampe Cibachrome 475 × 152,4 cm

79 78 Hot
1994 Stampe Cibachrome 102 × 229 cm e 152 × 381 cm
and Cold Faucets with Drain, 1975 e

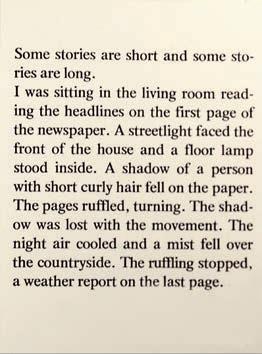
81 80
1976
Mao Dead
101 × 304 cm
Stampe Cibachrome e fotografie in b/n
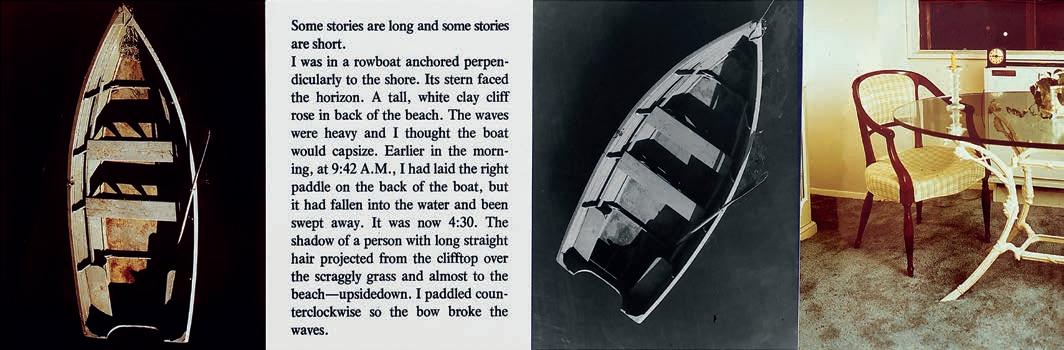
83 82 Boat, 1976
102 × 305 cm
Stampe Cibachrome e fotografie in b/n



85 84
Bus, 1976
Stampe Cibachrome e fotografia in b/n 203 × 229 cm

87 86
Elements of Romance, 1977
Stampe Cibachrome 101,6 × 304,8 cm

89 88 The Bathroom, 1977
130 × 305 cm
Stampe Cibachrome e fotografia in b/n

91 90
The Living Room, 1977
Stampe Cibachrome e fotografia in b/n 127 × 304,8 cm

93 92
The Kitchen, 1977 Stampe Cibachrome e fotografia in b/n 279,4 × 203,2 cm


95 94 Roses Are, Violets Are, Sugar Are, 1978 Stampe Cibachrome 243 × 343 cm

97 96
Rising Sun, Falling Coconut, 1978
Stampe Cibachrome 305 × 101 cm
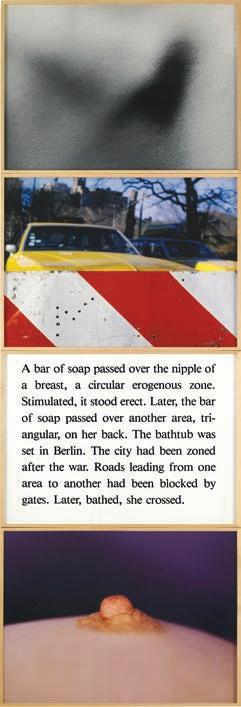
99 98
Shoulder Blade, 1978
Stampe Cibachrome e fotografie in b/n 305 × 101 cm
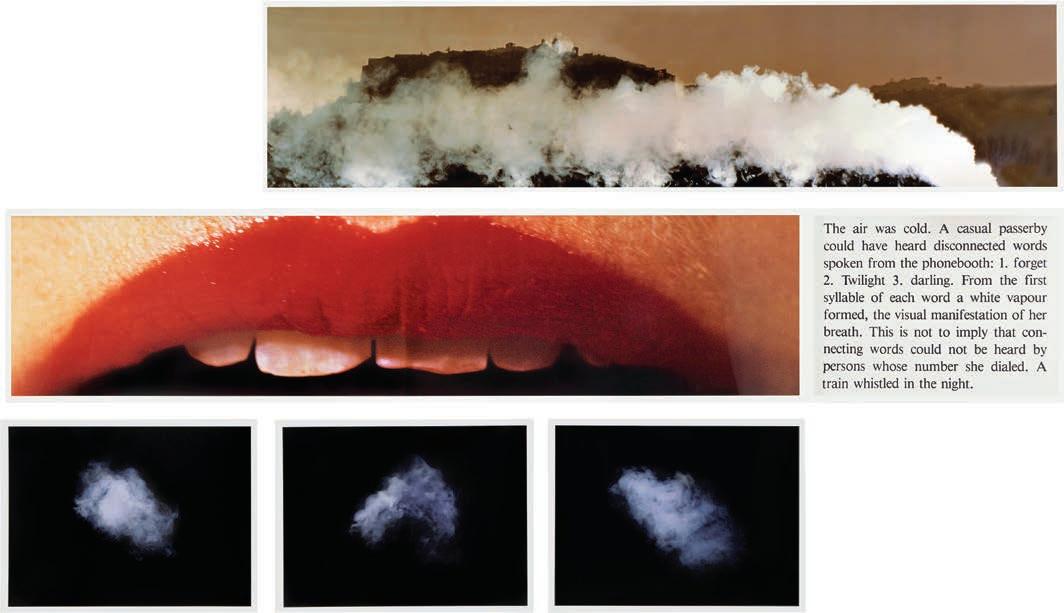
101
100
Deirdre’s Lip, 1978
Stampe Cibachrome e fotografia in b/n 177,8 × 304,8 cm


103 102
Pipes and Hics 1980
Stampe Cibachrome e tubi di alluminio 272 × 221 cm
Cah Beneath the Grass, 1980
Stampe Cibachrome e tubi di alluminio 267 × 234 cm


105 104
Cherubs V.S. Saucers 1985 Tecnica mista su carta Arches 105 × 75 cm
History of Handles and Spinning Wheel of Fortune, 1985 Tecnica mista su carta Arches 105 × 75 cm

107 106
Peaches, 1985
Tecnica mista su carta Arches 105 × 75 cm


109 108 Gardens of Pompeii, 1986 Tecnica mista su tela 187 × 81,5 cm Gardens of Pompeii, 1986 Tecnica mista su tela 187 × 81,5 cm

111 110
House of Pompeii, 1986 Tecnica mista su tela 187 × 81,5 cm


113 112
Villa of the Mysteries, 1986 Tecnica mista su tela 152,5 × 102 cm
House of the Red Capitals, 1986 Acrilico su tela 152,5 × 102 cm

115 114 BiPlane or How to Tie a Bowtie in Four Easy Lessons 1987 Legno compensato, gomma, fotografie in b/n 304,8 cm apertura alare


117 116
Bess Truman Having Tea with Her Friends, 1987 Fotografia in b/n, compensato, tessuto, bambole di pezza 130
130
× 152 cm
Sunday Paper, 1987 Fotografie in b/n, compensato, tessuto
× 152 cm


119 118
Frank (Homage to Frank O’Hara) 1987 Fotografie in b/n, carta da parato, gamba di piano, pila di quotidiani “The New York Times” (tutti dello stesso giorno) 203 × 305 cm
Front Porch, 1987 Fotografie, felci, zanzariera 152 × 488 cm

121 120
The Juggler, 1990 Stampe Cibachrome, gesso, piombo, pelle di serpente 244 × 244 cm


123 122
Study for # 5 of Seven Sins, 1991 Tecnica mista su carta museale 101 × 82 cm
Study for # Seven of Seven Sins, 1991 Tecnica mista su carta museale 101 × 82 cm


125 124
Study for # 3 of Seven Sins, 1991 Tecnica mista su carta museale 101 × 82 cm
Study for Apple Pie, 1991 Tecnica mista su carta museale 101 × 82 cm


127 126
Study for Chopsticks, 1991 Tecnica mista su carta museale 152,5 × 102 cm
Study for Fish Fry # 3, 1991 Tecnica mista su carta museale 101 × 82 cm

129 128
Bloody Mary, 1994
73
152
Stampe Cibachrome, feltro, bronzo patinato
×
cm

131 130
73
152 cm
Mixed Drinks: Margarita (Gabon, Mexico, United States), 1994 Stampe Cibachrome, tessuto, bronzo patinato
×

133 132
Niçoise at Sunrise, 1997
Stampe Cibachrome 138 × 278 cm


135 134
Down the Drain “Weeping Woman”, 1997 Struttura in legno e stampa Cibachrome
Ø 229 cm
Down the Drain, Black, 1997 Struttura in legno e stampa Cibachrome
Ø 229 cm
Capitolo tre L’estetica del bello
Fino a questo punto, l’arte concettuale di Beckley ruota intorno all’uso innovativo delle parole nelle sue opere, cosa che è trasversale all’arte contemporanea in generale. Myself as Washington aveva bisogno di un testo di accompagnamento per assurgere allo status di opera d’arte e in Cake Story e in altre sue narrative fotografiche concettuali i testi sono incorporati nelle opere visive, che comunque necessitano di interpretazione. Ma l’arte che prenderemo ora in considerazione, le sue splendide foto di fiori sfuggono, apparentemente, al bisogno di parole. Si tratta di opere originali e, quindi, per cominciare dobbiamo porci due interrogativi distinti. Come si spiega che Beckley maturi questo nuovo interesse per la bellezza? E dato tale interesse, perché ha realizzato delle foto di bellissimi fiori? Per rispondere, torna utile riferirsi alla sua sorprendente attività letteraria. Negli anni Novanta, Beckley curò la pubblicazione di quattro libri, e ne scrisse anche le prefazioni ed è indubbio che la scrittura informi la sua arte.
Il ritorno alla bellezza di Beckley, intorno al 2000, sembra avere una duplice determinante: da un lato era in dissonanza rispetto al mondo dell’arte contemporanea di New York poco incline a trattare il bello, dall’altro, leggendo Pater e Ruskin, aveva toccato con mano la sua carente educazione estetica e aveva cominciato a riflettere sul piacere visivo. In un saggio del 2015 su ARTnews furono pubblicate delle foto della sua casa di SoHo, traboccante d’arte con pezzi di Sol LeWitt e di altri artisti che ammira e conosce. LeWitt era un artista concettuale, ma alcuni suoi disegni, compresi quelli della collezione di Beckley, sono meravigliosi. Beckley, è chiaro, era diventato un esteta e quindi la sua arte rifletteva questa evoluzione. Rifiutando il puritanesimo dell’arte concettuale, a partire dal 2000 Beckley ha realizzato fotografie a colori di grande bellezza. Nel 1998, in collaborazione con David Shapiro, Beckley pubblicò Uncontrollable Beauty: Toward a New Aesthetics, un’antologia di scritti recenti, con una sua introduzione. Il volume ci presenta sia la pratica sia la teoria delle belle arti visive contemporanee e propone varie interpretazioni di bellezza. Qual è il saggio che riguarda più da vicino la sua arte? Uncontrollable Beauty era solo l’inizio, e presto curò anche la pubblicazione di un’altra antologia, Sticky Sublime (2001). In questo volume, con un gesto che ben si adatterebbe a uno dei suoi autori prediletti, Vladimir Nabokov, nella prefazione allude al testo di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente a proposito
137
di Cake Story: “Now, you can have your cake and eat it too” (ora si può avere la torta e mangiarla allo stesso tempo), con cui Beckley sembra voler dire: questi fiori magnifici risolvono i dilemmi interpretativi posti dalle opere visive narrative precedenti. Se guardiamo alle sue narrazioni fotografiche con gli occhi di Ruskin, Pater e di un lettore delle antologie di Beckley, ciò che manca è la bellezza, ma ora il bello entra nella sua arte.
La copertina di Sticky Sublime è illuminante. Un dettaglio di Puppy di Jeff Koons (1992), la gigantesca scultura di un cucciolo di cane la cui anima d’acciaio di 13 metri è ricoperta di una grande varietà di fiori. Koons era un vecchio amico di Beckley. Nel 2000 un’altra sua opera, SplitRocker, un enorme vaso pieno di fiori composto da due cavallucci a dondolo, fu esposta come installazione temporanea al Rockefeller Center. Cuccioli e fiori, cosa si può immaginare di più sentimentale come soggetto? Ma il mondo dell’arte stava cambiando; proprio come Duchamp non sceglieva a caso gli oggetti per i suoi ready mades, neanche Beckley ha scelto casualmente un bell’oggetto qualsiasi per le sue fotografie, non ha scattato foto di bei ragazzi, di auto di lusso o di case patrizie e non ha nemmeno scelto un vegetale a caso. Se avesse fotografato altre piante, dei fagiolini, una zucca o delle erbacce avrebbe creato opere d’arte differenti; come Koons, anche lui aveva interesse per i fiori e voleva creare opere belle, ma per comprendere cosa muoveva i due artisti è opportuno dire qualcosa sulla teoria estetica.

Negli anni Novanta, oltre alla riedizione di Imaginary Portraits di Walter Pater, come abbiamo già precisato, Beckley pubblicò un altro importante libro di teoria estetica dell’età vittoriana, The Laws of Fésole di John Ruskin (1877-1879). Beckley non era attratto solo da scritti contemporanei ma anche da saggi storicamente più distanti dall’immediato presente. Gli studiosi di letteratura hanno dedicato enorme attenzione sia a Ruskin sia a Pater, ma non sono molto noti a chi scrive di arte oggi. Nella seconda metà del XIX secolo, Ruskin era il grande rivale inglese di Pater. Dalla nostra prospettiva attuale, comunque, le differenze intellettuali tra i due sono meno importanti di ciò che hanno in comune. Entrambi scrivono e teorizzano su questioni superate ricorrendo a una retorica ormai datata.
Ruskin, il grande sostenitore del suo amico Joseph Turner (1775-1851), sosteneva che i suoi paesaggi, che possono somigliare a proto-astrazioni, sono raffigurazioni fedeli di cieli e mari. In seguito, Ruskin lodò in modo appassionato i preraffaelliti. Nella prefazione a The Laws of Fésole Beckley dice: “Per Ruskin … l’arte è un modo per apprezzare la natura imparando come esprimerla. Ruskin era sospettoso nei confronti del nuovo medium della fotografia, perché riteneva fosse un modo per sottrarsi all’impegno che richiede l’osservazione. Il disegno, invece, è un lavoro duro …”. Qui cogliamo la distanza abissale di Ruskin dalla nostra attuale cultura visiva. Ruskin era nato nel 1819, prima dell’invenzione della fotografia; ai suoi tempi, erano molti i critici che sostenevano che la fotografia non potesse essere un’arte legittima, cosa che oggi non è più così frequente, ma poiché Beckley è un fotografo, e nemmeno particolarmente incline alla contemplazione della natura, a cosa gli serviva l’estetica di Ruskin?
Per quanto riguarda Pater, il suo grande saggio The School of Giorgione (1877) in The Renaissance: Studies in Art and Poetry è una trattazione storica, per quanto un po’ anacronistica, del pittore rinascimentale. Sostenendo che la pittura veneziana di Giorgione, come la musica, raggiunge un’unità perfetta di forma e contenuto, Pater sviluppa un’analisi che anticipa alcune tematiche
139 138
Heroin Trade in Afghanistan (Lineup), 2008 Stampa Cibachrome 196 × 122 cm
del Modernismo. Nel libro di Pater si ritrovano anche elementi in linea con il crescente interesse per i tappeti, sempre più importante per alcuni artisti visivi del tempo, ma le sue riflessioni non sono note agli scrittori d’arte dei nostri giorni. Contrariamente a Ruskin, Pater aveva un interesse pressoché nullo per l’arte contemporanea e a lungo si è pensato che nonostante egli non si riferisca mai esplicitamente al saggio sul Modernismo di Charles Baudelaire, avesse attinto a quelle considerazioni. Più di recente, la studiosa di letteratura Patricia Clements ha dimostrato che in effetti Pater si è appropriato di frasi e idee esposte da Baudelaire in uno dei suoi Imaginary Portraits Comunque, contrariamente a Ruskin (o Baudelaire), Pater non discute esplicitamente di artisti contemporanei e in questo senso, di nuovo, è molto distante da Beckley.
Tradizionalmente gli esperti di estetica trattano la bellezza e il sublime come elementi distinti ma affini. Le cose belle ci attraggono perché ci piacciono, mentre il sublime ci attrae perché incute terrore, un terrore piacevole. Proponendo, nelle sue prefazioni, molti spunti sull’importanza della bellezza e del sublime, Beckley apre la porta della loro applicazione alla sua arte. Sta a chi commenta scegliere come usare questi strumenti, le sue quattro prefazioni alle riedizioni di Pater e Ruskin e alle antologie dedicate alla bellezza e al sublime e i testi che contengono, per comprendere le sue opere. Cosa non facile quando ci sono scritti così diversi a disposizione. Non conosco alcun artista contemporaneo che fornisca ai suoi critici tanto materiale interessante. Beckley rende l’interpretazione della sua arte una sfida davvero stimolante. Nella sua prefazione a Uncontrollable Beauty, Beckley ascrive la sua consapevolezza dell’importanza della bellezza alla lettura del libro di Dave Hickey The Invisible Dragon: Four Essays on Beauty (1993), un libro molto letto e commentato, forse anche perché di agevole comprensione. Beckley ne incluse alcuni passi nella sua antologia e altri nel suo libro sul sublime. A quel tempo erano già molti gli scrittori che si occupavano di bellezza, compreso Arthur Danto, anch’egli incluso nella prima antologia, e altri accademici che Beckley invece non selezionò per i suoi testi. Nel 1996 uscì il mio libro High Art. Charles Baudelaire and the Origins of Modernism, in cui partivo proprio da una disamina critica della sua teoria della bellezza modernista. Hickey era un critico d’arte e non uno storico quindi, anche se la sua raccolta di saggi riguarda l’arte di alcuni Antichi Maestri, va vista solo come uno scritto polemico sull’arte contemporanea, d’altronde il suo intento era questo, e non come un tentativo di presentare in modo esaustivo la teoria della bellezza. È interessante, comunque, fare un breve excursus sull’estetica visiva della bellezza.
Se guardiamo le origini della teoria estetica nell’ambito della filosofia tedesca, nella Critica del giudizio di Kant (1790) e nelle Lezioni di estetica di Hegel (1820) vediamo che l’arte visiva viene identificata con la bellezza; “L’arte estetica, in quanto arte bella, adopera come criterio di misura il Giudizio riflettente e non la sensazione” (Kant), “Queste lezioni sono dedicate all’Estetica; il loro soggetto è il vasto regno del bello e, più dappresso, il loro campo è l’arte, anzi la bella arte” (Hegel). L’Estetica era incentrata sulla ricerca e l’analisi del bello e le opere d’arte visiva di maggior successo erano definite belle, quindi definire la bellezza poteva essere utile anche a definire l’arte. Ma in seguito il Post-modernismo rifiutò in gran parte questa tradizione.
Oggi nessuno pensa che un’opera visiva debba essere bella, anzi, gli artisti concettuali della generazione di Beckley aspiravano a bandire del tutto la bellezza dalle loro opere, e nemmeno le narrazioni fotografiche di Beckley erano belle. Ma verso gli anni 2000 cominciò a realizzare belle
opere fotografiche ed è importante comprendere ciò che è alla base di tale cambiamento. Beckley racconta in proposito una storia avvincente. Passando davanti a un vivaio vicino a casa era rimasto talmente folgorato dai fiori che si recò subito al suo studio e si mise a scattare foto di fiori simili a quelli che aveva visto. Tendo a credergli anche se forse questa è solo una parte della spiegazione. In seno al movimento modernista, di certo a partire dai primi del XX secolo in poi, il tema della bellezza mantiene la sua importanza ma è accompagnato dalla presentazione ossessiva di opere non belle. L’importante antologia di Hal Foster The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture (1983) teorizzava che molta della nuova arte non era bella. Negli anni Venti si vedevano sia le splendide odalische di Henri Matisse sia i quadri espressionisti tedeschi, spesso francamente brutti, e negli anni Trenta i bei ritratti di Pablo Picasso avevano come contraltare l’arte anti-estetica del Dadaismo e del Surrealismo, nonché alcune brutte immagini di donne dello stesso Picasso. Negli anni Cinquanta le astrazioni di Willem de Kooning erano spesso belle mentre i dipinti di Clyfford Still non lo erano. E così fino agli anni Ottanta: una piccola parte dell’arte americana era bella ma il resto no. I giovani artisti degli anni Settanta, il mondo di Beckley del 112 Greene Street, non erano interessati alla bellezza né lo erano i neo-espressionisti di moda negli anni Ottanta, mentre nello stesso periodo altri artisti continuarono a realizzare arte bella.
Come sosteneva Hickey, la bellezza veniva identificata con un’arte d’evasione, non impegnata, e anche con una politica conservatrice compiacente. C’era una forte domanda di arte “politica” e il fatto che la pittura degli Antichi Maestri o anche quella modernista trattassero il bello, non faceva altro che confermare il problema, perché era molto sentito il bisogno che l’arte contemporanea rompesse con quella tradizione. Negli anni Ottanta, il Post-modernismo era molto di moda e Foster ne aveva abilmente individuato lo Zeitgeist. Comunque, qualunque cosa fosse il Post-modernismo, l’arte di Sherrie Levine, Robert Longo, Martha Rosler, Gordon Matta-Clark, Cindy Sherman e gli altri artisti che si riconoscevano in quella corrente non era di certo bella.
Nella sua accorta analisi Only a Promise of Happiness: The Place of Beauty in a World of Art (2007) il filosofo Alexander Nehamas ammette che dopo Pater e Ruskin, “la bellezza aveva da tempo smesso di andare a braccetto con la saggezza e la bontà, per finire col trovarsi, come accade oggi nel mondo, su fronti totalmente opposti”. Anche senza necessariamente concordare con questa notazione, è ovvio che un revival del bello alla fine del XX secolo non potesse implicare un ritorno a Pater o Ruskin, dopo un secolo di Modernismo e Post-modernismo. Ruskin e Pater erano scrittori d’arte del loro tempo e ormai le tematiche estetiche vittoriane non avevano alcun nesso con il mondo dell’arte nella New York della fine degli anni Sessanta, il punto di ingresso del nostro Beckley. Tra Pater o Ruskin e Beckley c’erano stati il Cubismo, il Dadaismo, il Futurismo, il Surrealismo, l’Espressionismo astratto, il Minimalismo e molto altro e un artista della generazione di Beckley non poteva ispirarsi in modo diretto a Ruskin e Pater. E allora, come fare per proporre arte bella nel 2000?
Se il bello doveva rientrare nell’arte, avrebbe dovuto essere un bello adatto alla fine del XX secolo. Quali soggetti scegliere? Una domanda di non facile risposta, quindi non sorprende che Beckley ci abbia messo un po’ a trovare una soluzione soddisfacente. Quando ne trovò una, le sue foto di fiori incontrarono molta resistenza. In proposito racconta: “Una volta vennero due critici tedeschi per vedere dei miei lavori, ma quando videro le foto di papaveri sulla parete e i fiori
141 140
appassiti nel mio studio, girarono i tacchi e uscirono senza profferire parola”. È difficile immaginare un soggetto più tradizionale e stereotipato dei fiori e sarebbe anche difficile individuare un soggetto più estraneo all’arte contemporanea nel 2000, quindi non c’è da meravigliarsi che quei critici siano rimasti interdetti; comprendere l’originalità radicale non è facile ma, forse, se avessero colto il rapporto tra i fiori di Beckley e i ready mades di Duchamp o le opere di Jeff Koons si sarebbero trattenuti più a lungo.
Nella mia tesi di dottorato alla Columbia University ho scritto in parte su Ernst Gombrich, il che mi aveva consentito di instaurare un certo rapporto con lo stimato storico dell’arte inglese. Una volta, quando era avanti negli anni, subito dopo averlo intervistato a New York per “Artforum”, mia moglie e io fummo invitati a fargli visita nella sua casa di Londra. Portammo dei fiori, dono alquanto banale, e avevo scelto dei boccioli senza nemmeno conoscerne il nome, ma ovviamente i Gombrich li riconobbero immediatamente. Offrire in dono fiori di quel tipo è un’usanza molto tradizionale.
Anche nelle opere d’arte più antiche si vedono spesso dei fiori: nell’Olympia di Manet (1865), per esempio, vediamo una domestica nera che gliene porge alcuni e gli storici dell’arte hanno riconosciuto quegli eleganti fiori di serra. In effetti i fiori sono un motivo artistico tradizionale delle nature morte; li si ritrova, infatti, nei dipinti olandesi del Secolo d’oro, nell’arte impressionista e nella pittura cinese. Per l’artista contemporaneo, comunque, il problema è che sono un soggetto stereotipato e sentimentale. Anche gli artisti anti-estetici portano fiori in omaggio alle padrone di casa quando sono invitati, ma è improbabile che ne facciano rappresentazioni artistiche.
I fiori di Beckley sono speciali, egli ne mostra lo stelo ma non le radici, sono ingranditi su uno sfondo neutro. Come lui stesso ha osservato, i suoi fiori somigliano alle “zip” di Barnett Newman. “Dipingeva linee verticali perché non voleva che vi fosse alcun riferimento a una linea d’orizzonte. Voleva essere totalmente non-oggettivo. Diceva di aver scelto linee verticali perché mentre una linea orizzontale significa immediatamente un paesaggio e un orizzonte, una linea verticale rimane una linea verticale e basta”. Un precedente lavoro sui fiori dello stesso Beckley è Roses Are, Violets Are, Sugar Are (1974) ma questo tema diventa sistematico nella sua arte solo negli anni 2000.

Anche se non sappiamo quanto costassero i fiori nelle culture premoderne, studiando le nature morte degli Antichi Maestri ci rendiamo conto che erano spesso raffigurati come un vero lusso, e lo stesso vale per alcuni cibi. Nell’Olanda del Secolo d’oro, verso la metà del XVII secolo, nelle nature morte si vedono conchiglie di pregio, fiori rari e utensili preziosi e c’era un fiorente commercio di tulipani, un’anticipazione, si dice, di quello attuale. Nel suo importante saggio Tradition and Expression in Western Still Life, Gombrich ripercorre le origini di questo genere artistico, legate in gran misura alla storia economica e sociale. “Quella che era considerata ‘opulenza borghese’ nell’Olanda del Seicento, un nobiluomo del XII secolo non avrebbe potuto nemmeno sognarlo”. Oggi, invece, si può comprare qualunque fiore, anche in pieno inverno, anche quelli che un tempo erano considerati rari.
Nel prossimo capitolo ci concentreremo sul rapporto di Beckley con Napoli e quindi, per prepararci, consideriamo un esempio partenopeo, la Natura morta con pesci, calamaro e aragosta (1655-1660) di Giuseppe Recco esposta nel museo di Capodimonte. Il contenuto del quadro lascia pregustare una cena sontuosa. Il genere delle nature morte era importante a Napoli e gli
143 142
Last
Stampa
157
122
Judgment 10, 2002
Cibachrome
×
cm
alimenti raffigurati da Recco, uno dei pittori napoletani più famosi, erano prelibatezze di gran lusso. L’abbondanza piaceva non solo ai collezionisti privati ma anche alle masse. E fino al 1770, per le celebrazioni di corte c’era l’usanza di issare davanti al palazzo reale il Monte della Cuccagna, una sorta di collina stracarica di cibarie di ogni sorta. Le guardie lo sorvegliavano fino al momento in cui la plebe affamata aveva il permesso di lanciarsi all’assalto e contendersi il bottino, anche fino ad ammazzarsi, mentre la corte si godeva lo spettacolo dalle finestre e dai balconi. Così, sostiene uno storico, mentre alcuni critici “denunciavano” i dipinti “come una prova di iniquo privilegio sociale ed economico” altri “li celebravano come spettacolari gesti di magnificenza che attestavano il fermento culturale e la raffinatezza della città”. Come in quasi tutti i dipinti degli Antichi Maestri, tali cerimonie celebravano l’abbondanza, i piaceri e il lusso in una società dove la miseria era la norma.
In seguito alcuni modernisti hanno dipinto oggetti umili nei loro quadri. Henri Matisse collezionava tessuti islamici arabescati, affatto preziosi, e Paul Cézanne dipingeva spesso mele nelle sue opere, che furono oggetto di un famoso commento da parte di Meyer Schapiro in An Essay on the Meaning of Still-life (1968). È facile interrogarsi sui gruppi di donne nude rappresentati da Cézanne, ma che dire delle sue composizioni di mele, ora come allora frutti alquanto banali?
A quanto pare, per Shapiro sono molte le cose che si possono dire, sia in termini della storia sociale di questa arte “impensabile al di fuori di una società borghese occidentale” sia in quelli dei desideri che gli oggetti rappresentati da Cézanne nelle sue nature morte “soddisfano e delle loro analogie e relazioni con il corpo umano”. È affascinante pensare che queste raffigurazioni di banali mele sono diventate beni preziosi.
Nella grande retrospettiva su Piet Mondrian del 1994, organizzata dalla National Gallery di Washington e dal MoMA, furono esposti molti dei suoi primi quadri di alberi, mentre c’erano solo due opere su carta raffiguranti dei fiori, in una delle quali, Amaryllis (1910), vediamo un fiore rosso su fondo blu acceso. L’opera era un dono per l’amica Charmion Von Wiegand; invece di portarle dei fiori, le offrì l’opera. Il fatto che Mondrian abbia spesso dipinto fiori è sorprendente considerando quanto non amasse la natura; probabilmente, come dichiarò lui stesso una volta, lo faceva solo per soldi. Alcuni studiosi si rifiutano di prendere queste sue opere sul serio ma, come osserva David Shapiro nel suo saggio in Uncontrollable Beauty, in essi si può scorgere un lato della sua personalità sfaccettata, una dimensione sensuale che nei suoi quadri astratti rimane repressa o controllata.
Una foto famosa di André Kertész, Mondrian’s Studio, del 1926, mostra un fiore in un vaso.
Ma perché i fiori di Beckley sono belli? Solo un filosofo può porre una domanda del genere, ma vale la pena riflettere. Secondo Kant “un fiore, per esempio un tulipano, è ritenuto bello perché nella sua percezione si nota una certa finalità, che, per quanto possiamo giudicare, non si riferisce ad alcuno scopo” e suggerisce che questo è il motivo per il quale proviamo piacere nel guardare dei tulipani. Di sicuro proviamo piacere, anche se non accettiamo il suo ragionamento teleologico. Finora ho parlato dei fiori di Beckley come se fossero un soggetto così ovvio da non richiedere alcuna interpretazione ed è vero che questi fiori sono oggettivamente belli, non sono certo i fiori del male di Baudelaire, ma sono stranamente insoliti e meritano un’analisi interpretativa attenta. I fiori di Beckley sono di grandi dimensioni, della stessa scala delle sue prime narrazioni fotografiche, sono quadri da esposizione, e mostrano sempre gli steli e qualche volta anche i fiori, ma mai i vasi che li contengono. Questi fiori alti e slanciati sono l’equivalente floreale delle top model statuarie.
Oppure, con un’analogia diversa, sono come gli enormi mazzi di fiori nei vasi all’ingresso del Metropolitan Museum of Art: rispetto ai bouquet che porto in dono agli amici, i fiori di Beckley sono insoliti, peculiari e di certo di dimensioni tali da essere un lusso.
L’arte concettuale del primo Beckley e le sue narrazioni fotografiche degli anni Settanta si iscrivevano in un movimento e quindi, in entrambi i casi è naturale correlarle all’arte prodotta in quei periodi, come abbiamo fatto nel primo e nel secondo capitolo. Invece per le sue foto di fiori, anche se ispirate in parte dal libro di Hickey, non esiste un movimento corrispondente sulla scena artistica del tempo, tuttavia mi astengo dal proporre un’interpretazione personale come hanno fatto Meyer Schapiro per Cézanne o David Shapiro per Mondrian, perché indipendentemente dalle sue vicissitudini personali, la scelta di Beckley risponde al suo processo di evoluzione artistica, punto sul quale tornerò più avanti nella trattazione.
Anche per un post-modernista duro e puro, allergico al bello nell’arte, la bellezza dei fiori è innegabile, e anche lui offrirà bouquet di fiori alle padrone di casa pur non ammirando le opere d’arte che li raffigurano. Non è difficile comprendere perché offrire fiori sia un costume sociale ma la domanda da porsi è un’altra, restringendo il campo: perché fotografare fiori per le mostre d’arte? Affermare che intorno agli anni 2000 Beckley cominciò a voler rappresentare cose belle nelle sue opere è una spiegazione affrettata e imprecisa. Egli ha scelto di fotografare un tipo molto speciale di cose belle, dei fiori a stelo lungo; non ha scelto di fotografare belle ragazze o bei ragazzi (come il suo amico Robert Mapplethorpe), o bei paesaggi o belle architetture. Ammiriamo le nature morte degli Antichi Maestri per l’abilità e la maestria nel raffigurare gli oggetti ma la nostra ammirazione per i fiori di Beckley non è legata in modo primario alle sue abilità di fotografo, anche se vale la pena sottolineare che è stato un pioniere dello sviluppo delle stampe fotografiche a grande scala. Nei capitoli precedenti è stato naturale e necessario interpretare le foto di Beckley nel dettaglio ma le sue magnifiche foto di fiori sono capolavori che parlano da soli, sono così manifestamente belle da non richiedere interpretazioni, e così autosufficienti da non averne bisogno. Mi è sempre sembrato strano che la sua arte abbia preso questa direzione.
Paul Cézanne dipingeva mele e Giorgio Morandi bottiglie. Questi pittori di nature morte avevano dei soggetti caratteristici e un modo tutto loro di disporli, e ciò vale anche per Beckley: egli realizza enormi foto a colori di fiori e steli di fiori, ma le sue opere sono alquanto dissimili dalle nature morte tradizionali. Per le dimensioni e la composizione, come abbiamo già notato, ricordano le zip di Barnett Newman. Nei capitoli precedenti è stato relativamente facile descrivere i lavori concettuali e le narrazioni fotografiche del primo Beckley; in effetti c’è molto da dire sul suo autoritratto in posa da George Washington e sulla foto della fetta di torta con commento, mentre cosa si può dire dei gigli e dei papaveri? Per rispondere, dobbiamo concentrarci sui titoli. Contrariamente alle comuni foto di fiori, quelle di Beckley hanno dei titoli che richiedono un’interpretazione. Alcuni sembrano significativi: Rendez-vous at Tiananmen Square - The Aftermath (2004) può essere un’opera politica, Last Judgment 10 (2002), invece, potrebbe essere una scena sacra, e le quindici Stations (2001) possono alludere al suo interesse per Newman che aveva realizzato quattordici dipinti intitolati Stations of the Cross: Lema Sabachtani (1958-1966). Il titolo di Beckley Three Graces 4 (2004), che è un trittico, sembra fare riferimento alla famosa scena mitologica, abbondantemente rappresentata dagli Antichi Maestri. Il titolo scelto per un altro
145 144
trittico, Heroin Trade in Afghanistan Saturday Night (2005), sembra conferire ai suoi meravigliosi papaveri una sinistra valenza nascosta, e un altro titolo, Not That There’s Anything Wrong with It, è tratto da una puntata della famosa sitcom Seinfeld, in cui Jerry Seinfeld ripete la frase continuamente in tante circostanze diverse.
Nella sua prefazione a Imaginary Portraits, Beckley si richiama alla distinzione che propone Roland Barthes tra testi lisibles (leggibili) che “dirigono e orientano il lettore nella storia” e scriptibles (scrivibili) “dove ogni lettore ‘scrive’ il testo attraverso la scoperta di diverse combinazioni possibili ogni volta che il testo viene letto”. Lo stesso vale per i suoi titoli: quando non si riesce a trovare un nesso plausibile tra il titolo e ciò che si vede, come capita con alcune foto di fiori, è spontaneo chiedersi cosa ci sia sotto e, secondo me, si tratta di una versione aggiornata dell’espediente dell’io narrante dalla identità incerta, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. Proprio come il testo scritto in Cake Story è difficile da comprendere a prima vista e quando lo si legge da vicino, suscita immediatamente il bisogno di interpretarlo, ci si interroga anche davanti ad alcuni titoli dei suoi fiori. Interpretare i titoli delle opere d’arte è sempre una sfida. Alcuni titoli scelti da Marcel Duchamp per i suoi ready mades sono divertenti ma ovvi: Fontaine (1917) per un orinatoio o In Advance of the Broken Arm (“Anticipo per un braccio rotto”, 1915) per una pala da neve. Una differenza fondamentale tra i ready mades e gli artefatti visivamente identici è che come opere d’arte hanno un titolo e una data, contrariamente agli orinatoi e alle pale da neve che si usano tutti i giorni. Consentendomi una piccola ma significativa variazione della solita espressione, mi piace definire queste opere “ready mades assistiti” per precisare che il titolo ne è parte integrante; in genere l’espressione ready made descrive artefatti modificati dall’artista. Il mio suggerimento, quindi, è che, aggiungendo il titolo, un artista può anche modificare l’oggetto senza alcuna manipolazione fisica. A volte i titoli delle opere d’arte possono essere dissacranti, come quando nel 1897 Alphonse Allais descrisse, in anticipo sui suoi tempi, due opere monocromatiche immaginarie Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige (“Prima comunione di giovinette anemiche nella neve”), tutta bianca, e Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge (“Cardinali apoplettici raccolgono pomodori sulle rive del Mar Rosso”), tutta rossa. Molte opere si possono ammirare senza conoscerne il titolo; spesso, nelle gallerie di arte contemporanea, serve la guida per trovare i titoli, ma altre volte il titolo ne è una parte fondamentale, soprattutto per quelle moderniste o contemporanee, è un modo, per l’artista, di indicare come guardare il proprio lavoro. E se si tratta di una creazione astratta, il titolo non sarà individuabile facilmente, al primo sguardo. Ecco perché i fiori di Beckley sono come i disegni di Sol LeWitt, che redigeva le istruzioni e spesso ne demandava ad altri l’esecuzione. Ciò che distingue un vero LeWitt è il legame con le istruzioni: finché ci sono le istruzioni, il disegno fisico si può sempre distruggere e rifare in un altro momento. Questa disamina dei titoli ha notevoli implicazioni per la nostra trattazione dell’evoluzione artistica di Beckley. Nell’analisi delle sue fotografie di fiori siamo partiti dalla convinzione che questi soggetti fossero autosufficienti; è qui che risiede la loro bellezza: i fiori sono fiori e non hanno bisogno di spiegazioni; ma se ora ammettiamo che i titoli contano, dobbiamo anche mettere in discussione l’autosufficienza dei fiori come soggetto e accettare che anche queste opere hanno bisogno di supplementi testuali come i suoi primi lavori concettuali o le narrazioni fotografiche. Serve davvero un titolo per queste fotografie? Assolutamente si, se devono essere opere d’arte;

147 146
205 × 110 cm
Station 1, 2001 Stampa Cibachrome
se in un futuro remoto i titoli delle fotografie dei fiori di Beckley andassero persi scomparirebbe anche parte della loro essenza. Come i suoi primi lavori concettuali e le sue narrazioni fotografiche, queste opere sono costituite da due parti, fotografie e parole di accompagnamento, cioè il titolo, e con ciò intendo dire che ciò che conta è che le fotografie di fiori di Beckley abbiano un titolo, e non che abbiano dei titoli in particolare.
Certamente le molteplici fotografie di fiori di Beckley sono molto diverse fra loro per colori, composizioni floreali e scala, a volte sono molto vicini, altre a una distanza maggiore, ma in realtà, a livello visivo non v’è ragione di pensare che interrogarsi sul significato dei titoli possa condurre a un’interpretazione interessante, non ritengo ci sia alcun codice segreto da rivelare. Qualcuno potrebbe leggere nelle mele di Chardin un’allusione alla storia di Adamo ed Eva nel Giardino dell’Eden e nelle sue fragole un’allegoria della fragilità umana ma, in verità, sono per lo più frutti e basta, e allo stesso modo, non credo che Three Graces 4 riguardi Parigi e che Heroin Trade in Afghanistan Saturday Night sia una critica della nostra sporca guerra in quel paese. Alcune delle prime opere narrative concettuali di Beckley sono politiche ma non è il caso dei fiori. E mentre il Cézanne di Schapiro elabora nell’arte “la sua incessante lotta interiore”, mi sembra che Beckley abbia una relazione molto meno personale con i suoi soggetti. E qui ci ritroviamo di fronte a un paradosso interpretativo. I fiori di Beckley sono immagini indiscutibilmente belle e non si capisce, quindi, cosa ci sia di interessante da dire ma, d’altro canto, i loro titoli sono enigmatici perché non è ovvio come si correlino ai rispettivi soggetti. A mio avviso, ciò che conta non è tanto il significato di ogni singolo titolo in particolare, quanto il fatto stesso che ci sia un titolo, perché è ciò che li trasporta immediatamente dalla bottega del fioraio al mondo dell’arte. Questo costrutto ellittico va spiegato nel dettaglio e lo farò raccontando una storiella che farà luce su ciò che intendo.

Supponiamo che un elegante fioraio di Madison Avenue abbia sentito parlare delle foto dei fiori di Beckley pur non essendo esperto di arte, e voglia assumerlo per delle pubblicità. “Vorrei delle foto dei fiori che vendo nel mio negozio, gigli e papaveri” dice, “e per cortesia, le faccia grandi perché voglio usarle come manifesti in metropolitana”. E immaginiamo che Beckley, lieto di aver ricevuto la richiesta ma troppo impegnato al momento, dia all’imprenditore delle copie esatte di Three Graces 4 e Heroin Trade in Afghanistan Saturday Night, che su un foglio a parte rinomina “gigli a $19,99” e “papaveri in offerta a $14,95”. Il fioraio se ne va soddisfatto perché, pur non sapendo nulla di arte sa riconoscere quello che gli piace e quelle foto sono davvero magnifiche, tanto è vero che quando vengono affissi i manifesti, i clienti cominciano ad arrivare a frotte al suo negozio.
Beckley, dal canto suo, è molto contento di ricevere la commessa, ma non ne parla al suo gallerista. Quando espone le sue foto di fiori a Chelsea, come opere d’arte riscuotono enorme successo sia in termini di quotazioni sia di critica, quando le stesse foto sono usate per manifesti pubblicitari, non valgono nemmeno la carta su cui sono stampate. Il fioraio certo non sa che da studente Beckley si era ispirato ai ready mades di Marcel Duchamp esposti al Philadelphia Museum of Art né può immaginare, visto che non viaggia sui mezzi pubblici, che un’altra foto di Beckley era già apparsa in un manifesto nella metropolitana, in una pubblicità del MoMA. Ma “gigli a $19,99”
“papaveri in offerta a $14,95”, per quanto visivamente identici alle opere esposte a Chelsea, non sono arte, sono solo poster commerciali molto ben riusciti. E senza dubbio il nostro fioraio si
divertirebbe molto se venisse a sapere che una volta un custode di un museo ha usato In Advance of the Broken Arm di Duchamp per spalare la neve.
È affascinante il modo in cui ready mades assistiti possano muoversi tra il cosiddetto mondo reale, il mondo del quotidiano e il mondo dell’arte. I lettori di Fuoco pallido (1962) di Vladimir Nabokov, uno dei romanzi preferiti di Beckley, riconosceranno l’evidente parallelismo con la facilità con cui persone e oggetti (compresi i testi) possano passare dal reale all’immaginario e viceversa.
149 148
Three Graces 4, 2004 Stampe Cibachrome 195 × 235 cm
Torniamoci su brevemente. Il romanzo consta di due parti: un breve poema di John Shade (poeta e professore immaginario) e un commento lungo redatto da Charles Kinbote (personaggio sempre immaginario). I versi sono relativamente semplici ma quando si legge il testo di Kinbote ci si convince progressivamente che debba essere pazzo; Kinbote afferma di essere un esule, fuggito dal lontano regno di Zembla per salvarsi dai suoi nemici. L’interpretazione di Kinbote del poema Fuoco pallido è molto fantasiosa: sostiene sia un’allegoria di Zembla. Il titolo è tratto da Shakespeare, ma Kinbote non può riconoscere la citazione perché possiede solo la traduzione in lingua zemblana. Nabokov traccia una parodia raffinata della propensione accademica all’iper-interpretazione, e paradossalmente Fuoco pallido è stato oggetto di molte analisi critiche da parte di studiosi e ricercatori. In effetti è strutturato un po’ come un problema di scacchi, che Nabokov amava, è come un libro di rompicapi con una soluzione. In molti dei suoi ultimi romanzi Nabokov ha sviluppato varie realtà alternative, simili ma distinte da questo mondo, ma in questa sede mi interessa solo il parallelo tra il romanzo e le opere d’arte di Beckley. Quando si muovono da un mondo all’altro, l’identità delle persone e degli oggetti cambia ma rimane riconoscibile per chi è informato, per chi è al corrente, come accade anche quando i ready mades assistiti passano dal mondo del quotidiano alle gallerie d’arte. In Fuoco pallido Kinbote cambia identità nel passare da Zembla a questo mondo e anche l’identità dei ready mades muta nel transitare dalla realtà di tutti i giorni al mondo dell’arte, e, come in Fuoco pallido, i due mondi sono distinti ma interconnessi.
Mentre Three Graces 4 e Heroin Trade in Afghanistan Saturday Night sono grandi opere d’arte, “gigli a $19,99” e “papaveri in offerta a $14,95” sono solo manifesti pubblicitari. Come i lettori di Marcel Proust sanno bene, i titoli sono importanti nell’alta società, perché chi non capisce che il Barone Charlus è il fratello del Duca di Guermantes, dettaglio fondamentale per chi è interessato alla genealogia dell’aristocrazia francese, è considerato un bifolco in quell’ambiente snob. Analogamente, chi non capisce perché Three Graces 4 e Heroin Trade in Afghanistan Saturday Night sono arte, contrariamente a “gigli a $19,99” e “papaveri in offerta a $14,95”, non sarà mai un critico d’arte. Ciò che rende le foto dei fiori di Beckley arte contemporanea è il titolo, che è parte integrante delle opere. Senza i titoli sarebbero semplici immagini di bei fiori; è la presenza del titolo che fa la differenza tra un manifesto commerciale e un’opera d’arte.
Consideriamo una variante della storiella e immaginiamo un esteta che ammira moltissimo i fiori di Beckley, ma non potendoseli permettere, decide di andare dal suo fioraio a comprare gigli e papaveri. “Che peccato che le foto costino troppo per le mie tasche, ma posso fare di meglio e acquistare i fiori veri”. Certo, i fiori veri sono più piccoli di quelli delle foto di Beckley e prima o poi appassiscono ma sul piano estetico queste differenze non sembrano, a prima vista, essenziali; e allora cosa manca? Il problema è che questi fiori non hanno titolo.
Qui torniamo al mondo dell’arte concettuale. Arthur Danto, che ammirava molto Brillo Box (1964) di Andy Warhol, e la cui teoria estetica ne fu grandemente influenzata, mi disse una volta che rimpiangeva di non aver acquistato una di quelle sculture ai vernissage ai quali aveva partecipato. All’epoca non erano particolarmente costose mentre ora, ovviamente sono delle miniere d’oro. Danto divenne amico di Mike Bidlo, un artista famoso per le sue copie “d’autore”, che gli donò una delle sue scatole, Not Warhol (Brillo Boxes, 1964) (2005), che visivamente
è indistinguibile dal Warhol e il titolo diverso sta proprio a segnalare che non vuole essere un falso, e ora anche le copie di Bidlo hanno valore, anche se sempre meno care dei Warhol originali. Ecco perché i titoli delle opere di Beckley sono interessanti dal punto di vista filosofico. All’inizio di La Trasfigurazione del banale, Danto presenta con dovizia di particolari un esempio che conferma che i titoli sono fondamentali. L’autore ci invita a immaginare un quadro monocromatico rosso intitolato Egiziani annegati inseguendo gli Israeliti attraverso il Mar Rosso e come sarebbe un’opera del tutto diversa se il titolo fosse Stato d’animo di Kierkegaard e Piazza Rossa, interessante paesaggio moscovita, oppure un’opera geometrica minimalista con lo stesso titolo, o un’illustrazione della dottrina buddista, Nirvana, o infine solo una superficie rossa, non un’opera d’arte. Ogni titolo proietta un’interpretazione e nell’ultimo caso la descrizione identifica qualcosa di rosso che non è arte. Per portare all’estremo quanto afferma Danto, se i titoli delle opere cambiassero, in tutti i casi avremmo un’opera d’arte diversa tranne nel caso della superficie rossa che non è arte.
I titoli per le opere d’arte sono come i nomi per le persone. Si tende a pensare che il titolo sia aggiunto a opera compiuta, ma quanto abbiamo detto sulle foto di fiori di Beckley dimostra che non è esatto. I titoli sono parte integrante o un supplemento dell’arte visiva? Non è possibile dare una risposta a questa domanda: nei musei i titoli delle opere degli Antichi Maestri sono indicati su etichette poste accanto alle opere stesse ma nelle chiese non si leggono titoli sulle pale d’altare. Spesso l’artista dipinge il soggetto scelto e poi aggiunge il titolo oppure, a volte, lascia il compito ad altri visto che l’attività creativa è conclusa. Aggiungere un titolo a opere più antiche è un’operazione abbastanza agevole perché con un rapido sguardo si vede se si tratta di una nascita di Venere, di una crocifissione o di un ritratto e in questi casi, applicare una targhetta è solo una questione pratica, senza nulla di complicato; in altri casi, invece, la faccenda è complessa. Il curatore John Pope-Hennessy era del parere che il dipinto di Piero della Francesca noto come La Flagellazione di Cristo abbia in realtà un soggetto del tutto differente e se avesse ragione, vorrebbe dire che il dipinto è stato intitolato in modo incredibilmente errato.
Quando ha deciso di voler realizzare arte bella, Beckley avrebbe potuto semplicemente abbandonare la fotografia e dipingere soggetti belli senza titoli ma il suo scopo era preservare la coerenza della sua evoluzione artistica in un continuum. Gli storici dell’arte degli Antichi Maestri insistono sull’importanza della continuità stilistica: Caravaggio cominciò dipingendo scene di genere e poi passò a dipingere pale d’altare su commissione e trent’anni dopo Nicolas Poussin, un altro emigrato a Roma, passò dal realizzare dipinti caravaggeschi al suo personalissimo stile classicista. Secondo molti critici recenti, il concetto di “stile” dovrebbe essere messo da parte perché l’arte contemporanea è quella che rompe con il passato e non sempre l’opera di un singolo artista rivela sul piano visivo un’evoluzione lineare. È vero che le foto dei fiori di Beckley appaiono diverse dai suoi lavori precedenti, ma è impossibile comprenderle senza individuare il filo che percorre tutto il corpus di opere, gli elementi di continuità situati paradossalmente sotto ciò che appare in superficie. Lo stesso vale, naturalmente per Duchamp, di cui seguiamo la sensibilità in evoluzione dai dipinti degli esordi, ai ready mades e alle installazioni più tarde. I ready mades di Duchamp dovevano essere indifferenti sul piano visivo, né belli né brutti, mentre i fiori di Beckley dovevano essere belli e per entrambi gli artisti la continuità conta.
151 150
In genere i titoli delle nature morte degli Antichi Maestri e dei Modernisti corrispondono al contenuto pittorico, descrivono ciò che si vede. Ciò che è complicato dei titoli di Beckley è che non c’è collegamento diretto e qualunque ipotesi sul loro significato non porta da nessuna parte, simili, in questo, alle narrazioni fotografiche degli anni Settanta. Come è difficile correlare quei testi scritti alle foto che accompagnano, così è arduo collegare i titoli ai fiori e quando il titolo non è attinente, è normale restare confusi.



Si sostiene che il problema con le Stations di Barnett Newman sia che non c’è abbastanza contenuto figurativo per giustificarne i titoli. Dopo averne realizzate alcune, aggiunse i titoli.
Sean Scully, d’altro canto, ha spiegato con cura i titoli delle sue opere astratte in cui si nominano luoghi, persone o artisti, con un commento dettagliato. Blue Poles di Jackson Pollock contiene, in effetti, delle linee blu ma Full Fathom Five e Autumn Rhythm sono titoli poetici la cui relazione con i quadri a cui sono attribuiti richiede un’interpretazione. E la serie di Frank Stella delle sinagoghe
polacche non raffigura alcuna architettura, come nella sua serie su Moby Dick di Melville non si vede nemmeno una balena. Alcuni artisti numerano i quadri, come Gerhard Richter e David Reed. Quando il significato non è ovvio, un titolo può spingere a osservare meglio l’opera. Sapere che Brice Marden dipinse Nebraska (1966), un quadro monocromatico, dopo la sua prima visita in quello Stato è un indizio importante.
Mentre il testo implicito di Myself as Washington merita una spiegazione approfondita e l’interpretazione delle parole esplicite in Cake Story stimolano una discussione, cosa si può dire delle foto senza parole? Le nature morte pongono sempre questo problema. Che cosa si può dire delle pur universalmente apprezzate nature morte di Giorgio Morandi che raffigurano comuni bottiglie? Denis Diderot aveva già affrontato questo problema a proposito delle nature morte di JeanBaptiste Chardin, di cui era un estimatore. Ci si può dilungare descrivendo opere figurative, anche poco più che modeste, nei Salons parigini, per esempio, i quadri di vita borghese di Greuze, ma cosa si può dire degli umili oggetti così mirabilmente dipinti da Chardin? Non c’è confusione, artificiosità, effetti speciali… ci si ferma davanti a un Chardin quasi per istinto, come un viaggiatore, stanco per il viaggio, si siede in un luogo verde, tranquillo, fresco e ombreggiato, quasi senza badarci. Le parole di Diderot sono laconiche e suggestive ma nel pur vivace Salon del 1767 non poté aggiungere altro.
Leggendo Ruskin e Pater, Beckley si rese conto di aver vissuto un’infanzia diversa, molto puritana e osservò che lo era anche il mondo dell’arte in cui era entrato. Certo, alcune sue opere concettuali narrative degli anni Settanta raccontano storie erotiche, come Bus (1976) e Shoulder Blade (1978), che hanno la stessa struttura analizzata nel capitolo precedente, ma, paradossalmente, l’ambiente in cui si inseriscono è puritano.
I nostri interessi intellettuali cominciarono a convergere quando Beckley e io diventammo amici. Nel 1994 pubblicai una raccolta delle mie critiche d’arte, The Aesthete in the City: The Philosophy and Practice of American Abstract Painting in the 1980s e nel 1997 curai l’edizione e scrissi la prefazione di un testo breve, England and its Aesthetes: Biography and Taste, brani scelti delle autobiografie di Ruskin, Pater e del mitico scrittore d’arte inglese Adrian Stokes. Rimasi affascinato dall’analisi sulla veridicità delle raffigurazioni della natura in Modern Painters di Ruskin. Grazie alla mia amicizia con Paul Barolsky, autore di Walter Pater’s Renaissance (1987), ebbi modo di studiare e scrivere anche di Pater e così cominciai a voler capire anche io come deve essere un esteta.
Nel mondo artistico di Beckley degli anni Settanta, e ancora nel mio degli anni Ottanta i critici di arte contemporanea più influenti erano politicamente orientati a sinistra, criticavano continuamente il sistema del mercato dell’arte, che trasformava le opere in merci costose. Provenendo dal mondo della filosofia analitica, più scevro da considerazioni economiche, ritenevo che i critici cadessero troppo facilmente in una trappola. Se si criticava il sistema di pensiero di sinistra, si veniva bollati come conservatori, cripto-repubblicani a favore dello status quo. Gli importanti critici legati alla rivista “October” elaborarono una divisione manichea tra l’arte critica politicamente “buona” e quella “cattiva”, socialmente conformista. Lo stesso titolo della rivista, che allude al film di Sergej Ėjzenštejn del 1927 sulla rivoluzione russa, non lascia dubbi sulla loro posizione politica: ammiravano quel capolavoro di sinistra, ma non quello che ne è seguito, il totalitarismo stalinista.
Per me, comunque, era ovvio che questa divisione dell’arte contemporanea non fosse plausibile perché artisti “buoni” e “cattivi” erano acclamati dalle stesse riviste, esponevano nelle stesse
153 152
Heroin Trade in Afghanistan, Saturday Night 2005
Stampe Cibachrome 241 × 340 cm
gallerie ed erano anche spesso acquistati dagli stessi musei e collezionisti. “October” propose, in particolare, una distinzione tra le opere degli esordi di Andy Warhol, “buone” perché criticavano la cultura americana, e molti quadri successivi, “cattivi” perché conformisti. Nell’introduzione a Imaginary Portraits, Beckley osserva: “Warhol non critica la cultura popolare, la guarda in controluce”. Rifiutandosi di dividere in due periodi l’opera di Warhol, offre un’interpretazione plausibile ed empatica.
Come in Italia alla fine del XX secolo molti intellettuali erano iscritti al partito comunista, così all’epoca “Artforum”, con il suo pensiero di sinistra, era molto influente. Forse inaspettatamente, quel seducente anche se fantasioso modo di pensare rese impossibile lo sviluppo di una tradizione politica veramente progressista. Anche l’ideale dell’arte “di protesta” che si concretizzava in costose opere in vendita nelle gallerie, era un ossimoro. Nel recensire una Biennale del Whitney in cui molte opere in mostra erano una critica al consumismo, la definii uno strano rituale per il fatto che si tenesse in un museo che, allora, si trovava su Madison Avenue circondato dalle boutique esclusive dell’East Side. La forza del nostro mondo dell’arte sta proprio nella sua capacità di celebrare chi lo critica, come quando si organizzano retrospettive di Hans Haacke e Barbara Kruger.
In ogni caso, ora il mondo dell’arte contemporanea è attraversato da tematiche di tutt’altra natura e quella particolare visione politica è solo di interesse storico. La questione che ancora ci può interessare, nel nostro ripercorrere la carriera di Beckley, è che cosa volesse dire nella nostra cultura visiva essere un esteta e dialogare con le istanze di Pater e Ruskin in un contesto totalmente nuovo.
Nel primo capitolo abbiamo trattato l’elaborazione che Beckley fece degli Imaginary Portraits di Pater, racconti inventati su persone realmente esistite, chiarendo che per le opere narrative di Beckley il tema dell’offuscarsi progressivo della linea di demarcazione tra realtà e finzione era fondamentale, soprattutto perché gli forniva un modo per collegare il suo materiale visivo, le fotografie, ai testi narrativi di accompagnamento. Così il testo in Cake Story è un ritratto immaginario “alla Pater” ma non funge da commento politico. In modi diversi, sia Pater implicitamente sia Ruskin in modo più esplicito, erano dei pensatori politici: Ruskin ispirò i socialisti inglesi, Gandhi e molti altri radicali del tardo Ottocento e degli inizi del XX secolo, ma come per la loro estetica generale, anche queste loro posizioni non hanno rilevanza nel presente e quindi per un bel po’ ho continuato ad arrovellarmi per dimostrare la fondatezza della mia ferma convinzione che Beckley fosse un esteta del tardo XX secolo.
Come Beckley stesso ha spiegato, negli anni Settanta, come molti altri artisti della scena di New York, leggeva Roland Barthes e gli altri post-strutturalisti francesi, materiale che ha continuato a impiegare nei suoi corsi alla School for Visual Arts. Poiché questi autori non si erano occupati in modo specifico di arte contemporanea, gli artisti erano liberi di adattarne i testi secondo le loro esigenze, anche sotto la spinta degli scrittori della cerchia di “October”, che ebbero una certa influenza in tal senso; se si capitava in visita nelle scuole d’arte, i loro libri erano sempre in bella vista e ci si aspettava che gli studenti fossero in grado di teorizzare sulla propria pratica, preferibilmente secondo lo stile allora dominante.
Ma la cosa peculiare di Beckley, che lo distingueva dalla maggior parte degli artisti che avevo conosciuto, era che gli piaceva scrivere, e sapeva farlo, simile in questo a una figura molto diversa, un altro amico, il pittore astratto Sean Scully. Ciò che definisce, almeno in parte, Beckley esteta è il suo orecchio per la prosa, come si può apprezzare leggendo le sue prefazioni ai libri di Pater
e Ruskin, o alle sue antologie sulla bellezza e il sublime. Come dicevamo, le istanze artistiche della teoria estetica di Pater e Ruskin sono superate, e quindi hanno rilevanza solo in termini di esegesi storica. Facendo mio lo splendido titolo di un libro dell’intellettuale napoletano Benedetto Croce, Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel (1907), mi chiedo: “Nel 2000, cosa è vivo e cosa è morto degli scritti di Pater e Ruskin?”.
Mentre scrivevo la mia tesi di dottorato, intorno al 1970, tutti i giorni mi concedevo una pausa a mezzogiorno per ascoltare dei programmi alla famosa radio progressista di Berkeley, KSAN, il cui slogan, diventato poi famoso, era: “Se le notizie non ti piacciono, vai fuori e creane di tue”. Allo stesso modo, si sarebbe potuto dire a un artista: “Se l’arte contemporanea non ti piace, vai fuori e creane una tua”. Nella sua vita artistica, Beckley ha fornito una risposta di grande interesse alla domanda “cosa significa essere un esteta?”: l’attenzione di Pater e Ruskin per la buona scrittura (di vario tipo) è sempre valida. Fu così che comprese di poter essere un esteta agli inizi del XX secolo. In retrospettiva, ciò che è degno di nota è l’enorme balzo in avanti che gli è stato necessario per procedere in tal senso. Dopo aver ottenuto un successo artistico vero e concreto con le sue fotografie narrative concettuali, Beckley volle realizzare opere belle, un’arte che procurasse un piacere estetico, ma nulla nella sua formazione personale o nel mondo dell’arte americano gli suggeriva che strada percorrere per riuscirci. Certo, la bellezza non era l’interesse primario dei pittori che ammirava, Frank Stella e Robert Ryman, o degli altri artisti concettuali, quindi non c’è da sorprendersi che gli ci sia voluto del tempo per individuare una soluzione soddisfacente, anche se noi, nel ricostruire il suo percorso e nel valutarne i risultati saremo necessariamente brevi. Mettere in connessione lati apparentemente distanti della propria vita può essere immensamente gratificante; d’altronde questo è uno dei motivi per i quali è una gioia leggere Proust. Il personaggio Marcel scopre che la strada di Swann, che conduce alle terre dell’agiato ebreo borghese, e la strada di Guermantes, il sentiero intorno alla proprietà nobiliare, a un certo punto si congiungono, in senso letterale perché si poteva passare dall’uno all’altra, ma anche storicamente, perché la vedova di Swann diventa una Guermantes per matrimonio, e lo stesso Marcel entra nel mondo dell’agio e del privilegio che prima aveva visto solo da lontano come un outsider. E noi, insieme a molti altri lettori di Proust, proviamo questo stesso piacere quando diventiamo esteti ed entriamo nel mondo dell’arte. La lezione di Proust, e anche di Fuoco pallido, è che il mondo reale e il mondo dell’arte sono distinti ma connessi e bisogna comprendere questa relazione per fare arte, o per saperla apprezzare. E questa è una delle chiavi per capire l’arte di Beckley.
Le fotografie di fiori di Beckley sono sicuramente molto belle e non sorprende che fossero popolari e che ne abbia realizzate molte. D’altronde, all’epoca cominciava a essere forte il desiderio di bellezza nell’arte contemporanea e lui stesso nutriva un profondo desiderio personale di realizzare cose belle. Ma di nuovo, nel ricostruire i suoi cambiamenti stilistici, bisogna tornare alla sua capacità di autocritica e alle sue motivazioni personali: nelle foto di fiori mancava qualcosa, e ciò che mancava era un legame con la storia dell’arte. Come per la sua arte concettuale degli esordi, per la quale serviva una descrizione verbale che spiegasse perché si trattava di opere d’arte, ora a Beckley serviva trovare il modo per inserire la sua evoluzione personale nella storia dell’arte. Doveva riuscire a rendere esplicito il nesso di dipendenza tra i fiori e i titoli. Quando ci riuscì, la sua arte cambiò di nuovo, come si vedrà nel prossimo capitolo.
155 154
“La scelta dei fiori come soggetto è nata dalla mia ammirazione per Barnett Newman e il suo interesse per il sublime. Come pittore, Newman ha fatto una serie di dipinti che ha chiamato Zips. Erano linee verticali perché, come astrattista, voleva allontanarsi dalle linee orizzontali che evocano il paesaggio.
Così mi sono chiesto: ‘Quale oggetto lineare
è verticale?’. Beh, uno stelo solitamente
è verticale. Così gli steli di giglio sono diventati le mie ‘zips’. Poi mi sono venuti in mente i papaveri. Così ho fotografato steli di papavero. Ma in qualche modo sembrava sbagliato escluderne il fiore, così l’ho lasciato”.
Opere Steli


159 158
Station 7, 2001 Stampa Cibachrome 205 × 110 cm
Station 8, 2001 Stampa Cibachrome 205 × 110 cm

161 160
Station 14, 2001
Stampa Cibachrome 205 × 110 cm

163 162
Station 9, 2001
Stampa Cibachrome 205 × 110 cm


165 164
Station 15 (Pink, I Think), 2002
205
230 cm
Stampe Cibachrome
×

167 166 Last Judgment 9, 2002 Stampa Cibachrome 157 × 122 cm



169 168
Three Graces 2004 Stampe Cibachrome 192 × 230 cm



171 170
Patriotism Spelled Backwards 5, 2004 Stampe Cibachrome 193 × 230 cm



173 172
American Gothic, 2004
122
cm
Stampe Cibachrome
× 205
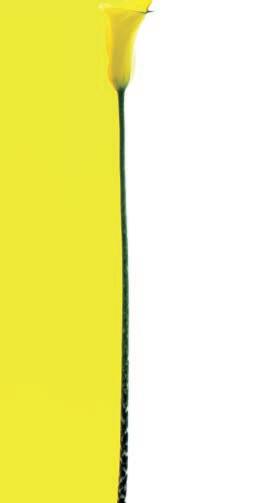


175 174
On Being Blue 7, 2004
Stampe Cibachrome 195,5 × 190,5 cm

177 176
Rendez-vous in Tienanmen Square (The Aftermath), 2004 Stampa Cibachrome 194 × 99 cm


179 178
Singles Bar - Red, 2004 Stampa Cibachrome 191 × 36 cm
Singles Bar - Blue, 2004 Stampa Cibachrome 191 × 36 cm


181 180
Heroin Trade in Afghanistan 1 (Tattered Flag), 2005 Stampa Cibachrome 196 × 99 cm
Heroin Trade in Afghanistan 4 (The Huddle), 2005 Stampa Cibachrome 196 × 99 cm

183 182
Heroin Trade in Afghanistan: For Those Who Have Died and Are Forgotten, 2005 Stampa Cibachrome 193 × 100 cm



185 184
A Drop of Water in the Breaking Gulf, 2005 Stampe Cibachrome 120 × 171 cm
Not That There’s Anything Wrong with It 3, 2005



187 186
Heroin Trade: The Intersection of 44/55 and 209, 2008 Stampe Cibachrome 195,6 × 208,3 cm
Stampa Cibachrome 195,6 × 92,7 cm


189 188
Oh to Be Young Carefree and Gay Epilogue 1, 2005 Stampe Cibrachrome 147,8 × 133,2 cm

191 190
Capote White 4, 2014 Stampa Cibachrome 193 × 119,4 cm


193 192
Dervish 4, Bayrami, 2007 Stampa Cibachrome 196 × 122 cm
Charge of the Chicken Men, 2009 Stampa Cibachrome 196 × 122 cm

195 194
Dervish 10, Sunbuli 2007
Stampa Cibachrome 196 × 122 cm
Capitolo quattro
Neapolitan Holidays
Le fotografie di fiori di Bill Beckley erano opere splendide, di enorme successo ed estremamente gratificanti, e non c’è da meravigliarsi che ne abbia realizzate in gran numero, ma anche in questo caso, come era accaduto con le opere puramente concettuali degli esordi come Myself as Washington o con le sue narrazioni fotografiche degli anni Settanta, presto sentì il bisogno di passare ad altro. La contraddizione, nel linguaggio hegeliano-marxista della nostra analisi stilistica, stava nel fatto che queste immagini, pur sembrando autosufficienti, erano opere d’arte solo con un titolo, lasciando così incompiuto il suo desiderio di creare un’arte bella, del tutto autosufficiente.
In quel periodo, però, a mio avviso c’erano anche altre motivazioni che lo animavano. Lo studio di Ruskin e Pater gli aveva dato modo di approfondire le istanze e le tematiche dello storicismo. Dal 1870 al 1970, la forma del bello era cambiata drasticamente, pertanto un artista che, come lui, volesse fare arte bella doveva ripensare i fondamentali. In particolare, uno dei problemi di Beckley era come fare in modo che i suoi lavori dessero conto della sua consapevolezza del cambiamento dei canoni di bellezza.
Egli voleva rinnovare e sviluppare ulteriormente l’arte narrativa, basata sulla commistione di parole e immagini, e ambiva anche a creare opere che fossero belle e incarnassero le sue conoscenze e i suoi studi di storia dell’arte, come definiti nelle sue antologie sulla bellezza e sul sublime. Ritengo che in questa evoluzione sia stato importante anche il modello nabokoviano di Fuoco pallido, e forse vale la pena fare ancora qualche osservazione su questo romanzo.
L’aspetto, in prima battuta, più inconsueto del racconto di Nabokov è il fatto che consti di un poema e di un commento. Vi sono tante opere letterarie in edizioni commentate, con annotazioni di studiosi che chiariscono gli elementi più complessi del testo. Spesso, soprattutto per i testi premoderni, il commento è utile per il lettore odierno, che ha bisogno di informazioni su persone e luoghi descritti nei testi. In genere, non è l’autore a redigere i commenti, anche se nulla vieta che uno scrittore se ne occupi direttamente. Talvolta i commenti sono involontariamente fonte d’ilarità. T.M. Knox, autore della traduzione in inglese di Lezioni
197
di estetica di Hegel, aggiunse in calce alcune note non proprio canoniche. È opportuno segnalare che Hegel aveva frainteso Kant o informarci che sarebbero auspicabili delle illustrazioni a margine del discorso di Hegel sulla pittura? Commenti del genere possono spingere il lettore a dubitare della “fedeltà” della traduzione. Il che, forse, non è sempre un male.
Ma ciò che è davvero insolito in Fuoco pallido è che Nabokov scrisse sia il poema che il commento. All’inizio i critici rimasero sconcertati, non comprendendo perché si fosse combinato un poema splendido, anche se banale, con una novella inutilmente lunga e senza alcuna connessione con i versi; alcuni pensarono che Nabokov volesse solo coinvolgere il lettore in un giochetto strano (e noioso). Tornando al nostro discorso, c’è da chiedersi: il poema e il commento non sono, forse, due opere letterarie del tutto scollegate? Perché riunirle in un unico libro?
Nel secondo capitolo abbiamo visto che provare a comprendere l’unitarietà delle fotografie concettuali di Beckley è una vera e propria sfida. In Cake Story, per esempio, è chi guarda a dover mettere in relazione la narrazione e la foto. In genere, le opere d’arte visive sono unitarie, nella misura in cui non v’è alcun elemento che sia superfluo. Quando osserviamo uno dei grandi capolavori degli Antichi Maestri, per esempio un affresco in una chiesa di Napoli, ammiriamo

come ogni figura rientri organicamente nel tutto, o almeno questa è l’idea. Anche nei fumetti, dove sono presenti sia immagini sia parole, gli elementi verbali e visivi si combinano per raccontare la storia. Siccome le opere narrative di Beckley presentano testo e foto su pannelli separati, montati insieme in un secondo momento, è naturale chiedersi se siano davvero un tutt’uno, tanto più che i testi sembrano avere una relazione molto vaga con le immagini; e se è difficile nelle opere in due parti cosa accade quando Beckley ne usa quattro? Vediamo!
Nel 2017, lo Studio Trisorio di Napoli, da tempo galleria di Beckley, gli mandò una ricca collezione di cartoline d’epoca, ognuna delle quali presentava una foto da un lato e un messaggio dall’altro, oltre a un indirizzo e un francobollo con il timbro postale. È sempre interessante vedere che succede quando un artista di oggi utilizza tecnologie visive obsolete. Alcuni videoartisti amano realizzare film su pellicola, altri usano vecchie macchine fotografiche e Beckley scelse alcune di quelle vecchie cartoline, le fotografò, ingrandì le foto e aggiunse un suo messaggio e una foto contemporanea per la sua serie Neapolitan Holidays (2018-2019).
La cartolina è uno di quegli oggetti quotidiani che tutti conosciamo e il cui funzionamento è talmente ovvio da non richiedere alcuna analisi. Se siamo in vacanza, al mare o da qualunque altra parte, scegliamo una cartolina con una foto del lungomare, compriamo un francobollo, e scriviamo una frase del tipo “manchi solo tu” e la spediamo a un amico. Ne ho mandata anche io qualcuna quando ero in viaggio in Italia e ne ho collezionate altre come souvenir di oggetti esposti nei musei che ho visitato. Oggi, con internet e l’avvento degli smartphones, con cui si possono spedire foto con grande facilità, le cartoline illustrate sono quasi inutili; servono ancora per la corrispondenza politica e istituzionale perché gli agenti di sicurezza possono immediatamente verificare che tutto sia a posto, non essendovi buste in cui nascondere alcunché. Per quanto ne so, non c’è davvero una letteratura sulla cartolina, tranne alcuni campioni fotografici e un libro irresistibilmente misterioso di Jacques Derrida, La carte postale (1980) (La Carte postale. Da Socrate a Freud e al di là, Mimesis Edizioni, Udine [2015] 2017).
Ray Johnson (1927-1995) usò le cartoline per la sua cosiddetta Mail Art così come fece anche l’artista concettuale giapponese On Kawara (1932-2014). La cartolina è un oggetto così banale che ci vuole davvero un filosofo per scriverci su un trattato, ma bisogna riconoscere che il suo funzionamento è interessante. Le cartoline presentano, di norma, immagini stereotipate con spiagge, turisti in festa e monumenti. C’è anche una categoria particolare di fotografie politicamente sovversive e risqué, che è meglio non mandare al proprio parroco a meno che non sia dotato di uno spiccato senso dell’umorismo. Le cartoline possono anche avere una valenza storica perché mostrano quali erano le scene che affascinavano i nostri nonni. Pensiamo alle cartoline comuni come se fossero dei ready mades assistiti, secondo la definizione proposta nel capitolo precedente. Si prende un’immagine già pronta e si aggiunge il proprio messaggio, un indirizzo e un francobollo. In fondo, il ready made assistito L.H.O.O.Q. o La Joconde (1919) di Marcel Duchamp è una cartolina con dei baffi e un titolo malizioso aggiunto alla Gioconda di Leonardo. La cartolina, come i libri con la copertina flessibile, è una creazione modernista, legata all’era del turismo di massa. Non credo che Goethe o Winckelmann spedissero cartoline in Germania dall’Italia; inoltre, il presupposto operativo di queste cartoline è che il servizio postale sia relativamente affidabile ed economico.
199 198
Study for Horse Thieves 2019 Stampa Archival a getto d’inchiostro e matita su carta museale 81 × 102 cm
Come abbiamo visto in precedenza, l’arte concettuale di Beckley e la commistione di parole e immagini nei suoi lavori rielaborano in modo innovativo alcune istanze del mondo dell’arte contemporanea: il suo interesse per il bello era condiviso anche da altri artisti all’inizio degli anni 2000, sebbene rappresentassero la bellezza in modo diverso. In ogni caso, per quel che ne so, l’uso delle cartoline in Neapolitan Holidays è assolutamente originale. I lavori di questa serie constano di quattro parti di uguali dimensioni, alcune disposte verticalmente, altre orizzontalmente: l’ingrandimento della foto della cartolina, il messaggio originale con l’indirizzo del destinatario e il francobollo, alcune parole di Beckley e una sua foto originale. Delle varie opere della serie, mi concentrerò su Horse Thieves (2019), per ragioni che chiarirò nel prosieguo.
Nel capitolo precedente ho già detto qualcosa a proposito del mio rapporto con Beckley; anche a me interessa il bello e capire cosa voglia dire essere un esteta e, per ragioni diverse, da anni anche io mi occupo di Napoli, l’ho visitata a più riprese. Inoltre sto scrivendo un libro sulla città partenopea, che amo e mi interessa per l’impareggiabile patrimonio di arte barocca custodito nelle chiese del centro storico. In particolare il mio libro comincia con un approfondimento di Le Sette Opere di Misericordia (1607) di Caravaggio, opera grandiosa e straordinaria, che raffigura le sette opere in una complessa composizione che non ha precedenti e né tentativi d’imitazione.
Per il brief attingiamo al Vangelo secondo Matteo (25:35-36): “Perché avevo fame e voi mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e mi avete dato dei vestiti, ero malato e siete venuti in mio aiuto, ero in prigione e siete venuti a trovarmi”. Il quadro deve raffigurare queste sei opere: dar da mangiare a chi ha fame; dare da bere a chi ha sete; accogliere gli stranieri; vestire chi non ha mezzi per farlo; aiutare gli ammalati; rendere visita ai carcerati. E la chiesa medievale aggiunse una settima opera, anch’essa rappresentata da Caravaggio: dar sepoltura ai defunti. Secondo san Tommaso d’Aquino (1225-1274), “essere misericordiosi è avere il cuore triste (miser) nel provare come nostra l’altrui miseria e di voler portarvi aiuto”; nella gerarchia delle virtù non è al primo posto perché se “per l’uomo è meglio unirsi con l’Altissimo che colmare il difetto del prossimo”, la massima virtù è la carità: in essa ci avviciniamo a Dio, tendiamo alla perfezione, mentre la misericordia è legata a un agire esteriore mosso dal male patito dagli altri. “Ma delle virtù agite esteriormente, la misericordia è la più grande … perché spetta a chi è superiore o sta meglio colmare il bisogno dell’altro”. Dio che è perfetto, non ha bisogno di misericordia, al contrario del nostro prossimo. Tale visione morale presuppone una gerarchia sociale e anche, come si vede bene nelle Sette Opere, una divisione tra il mondo terreno e il regno dei cieli.
Mi piace molto il commento a quest’opera del leggendario storico dell’arte Roberto Longhi. Le Sette Opere di Misericordia è “un soggetto antico, comunitario, romanico che gli sarà venuto inevitabilmente, non appena giunto, in qualche crocicchio famoso, mescolato tra ricchi e poveri, tra miseria e nobiltà”.
La cultura visiva di Caravaggio è ormai così distante che sembra impossibile che un artista contemporaneo possa mettersi in relazione con la scena sacra raffigurata; Le Sette Opere fu commissionata per una cappella mentre, oggi, quasi tutti gli artisti lavorano per istituzioni laiche.
Molti storici hanno scritto su Le Sette Opere, descrivendo la composizione, così cripticamente chiara. Indipendentemente da quanto a lungo la si guardi, mantiene una sua qualità allucinatoria.
Nella sua elegante analisi, Malcolm Bull scrive: “Tutto ciò che vediamo è così chiaro e drammatico da apparire indubitabile, anche se non abbiamo modo di definire come ogni scena si correli alle altre o nemmeno cosa viene rappresentato”. Bull osserva anche che il filosofo napoletano Giambattista Vico “equipara il guardare le cose di notte illuminandole con una lampada e il provare dolore; sono esperienze distinte che hanno in comune il fatto che ci mostrano un aspetto singolo o un unico dettaglio ma dicono poco o nulla del mondo nel suo insieme”. Bull rileva che ciò che vediamo è una scena frammentata “senza corpi completi... senza spazi continui”. Benvenuti a Napoli.
Si intuisce facilmente perché trovi il quadro di Caravaggio così straordinario. Le Sette Opere è un dipinto che non viene spostato facilmente, bisogna andare a Napoli per ammirarlo, quindi è inevitabile pensarlo legato alla città; in questa sede, però, mi preme parlare in particolare dell’uso che ne fa Beckley in Horse Thieves e di come questa sua produzione più recente si innesti nella sua evoluzione artistica. Nei quattro pannelli, da destra verso sinistra (più avanti esploreremo il significato di questa inversione del normale ordine di lettura occidentale) vediamo il recto di una cartolina con la foto di Le Sette Opere il verso con la data del 20 novembre 1948, con un messaggio abbastanza asettico, un testo di Beckley e una sua foto. Il testo è una breve spiegazione, abbastanza fredda, su come rubare un quadro, in uno stile simile a quello di Cake Story. Infine, la foto a sinistra mostra una vecchia bicicletta con una targa sui cui si legge “Vulcano Solfatara”, la caldera che si trova a Pozzuoli, vicino a Napoli.
Il testo di Beckley rimanda ellitticamente, in modo implicito, al quadro di Caravaggio, e so bene che la mia ricostruzione della relazione tra l’opera di Beckley nel suo insieme, elementi testuali e immagini, e Le Sette Opere potrà non essere in linea con altre opinioni sul tema. Sono tante le storie sui furti dei Caravaggio, e vi sono anche dei romanzi che ne parlano, trattandosi di un artista che da sempre attira l’interesse del grande pubblico; nel caso della Natività di Palermo trafugata nel 1969, circolano storie più o meno fantasiose su che fine abbia fatto e alcuni sono convinti che vi sia da qualche parte un boss mafioso che si gode questa meraviglia di nascosto. Il film di Vittorio De Sica Ladri di biciclette (1948), in cui viene rubata la bicicletta del protagonista, è uno dei capolavori del Neorealismo italiano, e in inglese, con il placet dello stesso De Sica, il titolo fu reso al singolare, The Bicycle Thief (Il ladro di biciclette). E poi Napoli, lo sanno tutti, è famosa per una certa illegalità diffusa, e furti di biciclette non ne mancheranno.
Ma un artista di oggi come riesce a usare la Napoli di Caravaggio? Non come soggetto pittoresco ma in questo modo più elusivo. Horse Thieves è una reinterpretazione del quadro di Caravaggio che si vede in cartolina? Non proprio! Il grande dipinto non descrive un arresto e non raffigura biciclette, ma c’è uno slittamento del significato che apre su Le Sette Opere. Horse Thieves va visto come le reinterpretazioni di Picasso dei dipinti degli Antichi Maestri e dei modernisti. Con il testo e la fotografia, in rapporto ellittico, come le tipiche scritte sulle cartoline, Beckley fa un uso poetico dell’opera di Caravaggio, e come ogni opera d’arte visiva o verbale, non pretende di essere presa alla lettera.
Nel parlare di Cake Story abbiamo messo in relazione la foto e il testo, ma in questo caso l’operazione presenta un più alto grado di complessità, essendo quattro gli elementi in gioco: l’indirizzo sulla cartolina, il testo di Beckley, il Caravaggio e la foto di una bicicletta. Sulla base di quanto abbiamo detto è facile intravedere un nesso, per quanto vago, tra i vari elementi.
201 200
Il meraviglioso dipinto, ovviamente, è un’opera che dei ladri ruberebbero volentieri, ma come interpretare questa relazione, che cos’è Horse Thieves?
L’opera di Beckley è composta da due parti storicamente distinte: la cartolina e il nuovo testo più l’immagine. Come si relazionano? Per rispondere, guardo a Nabokov: “La luna è un ladro arrogante, / E il suo pallido fuoco lo ruba dal sole” (Atto IV, scena 3). Abbiamo già spiegato che è il Timone di Atene di William Shakespeare la fonte del titolo del poema di John Shade, e del romanzo di Nabokov, ma Kinbote non riesce a riconoscere la citazione perché legge, ed è tra l’altro l’unica cosa che ha portato con sé da Zembla, una traduzione dell’opera di Shakespeare. Abbiamo, quindi, due mondi, il cosiddetto mondo reale, in cui Shade compone il poema, e il regno inventato di Zembla descritto da Kinbote, che sono diversi ma non del tutto disgiunti, perché persone e oggetti possono spostarsi dall’uno all’altro. Per essere precisi, entrambi i mondi sono inventati, perché entrambi esistono solo nel romanzo di Nabokov.
Già molti filosofi analitici e fisici teorici hanno elaborato dei sistemi, tanto complessi quanto controversi, di mondi speculari in comunicazione. Kant, nell’interpretazione di P.F. Strawson, un filosofo inglese moderno, affermava che “c’è solo uno spazio … Ogni oggetto in relazione con lo spazio è in relazione con tutti gli altri oggetti nello spazio”. Forse Kant si sbagliava, ma ai fini della nostra discussione, non importa se la fantasia di Nabokov sia confermata concretamente nel mondo fisico o sia solo un’invenzione letteraria.
Nel capitolo precedente abbiamo già accennato ai mondi alternativi. Arthur Danto riteneva che Brillo Box di Andy Warhol, anche se fisicamente (essenzialmente) identica a una scatola di Brillo, è un manufatto completamento diverso, è un arte-fatto di cui si parla in termini molto diversi rispetto a come si parla di un contenitore di sapone per i piatti d’uso quotidiano. All’inizio si esita a credere che questi due oggetti visivamente identici possano essere così diversi: in genere, se due cose hanno lo stesso aspetto, hanno anche le stesse proprietà, indipendentemente da dove si trovino. Allora come è possibile che si parli in termini così diversi di Brillo Box e di una scatola di Brillo? Molti filosofi dell’arte, me compreso, hanno teorizzato sulla soluzione di questo dilemma, e ora i due mondi di Nabokov ci offrono la possibilità di esplicitare la ragione di questa differenza. Brillo Box esiste nel mondo dell’arte, mentre una scatola di Brillo esiste solo nel mondo fisico. Ma naturalmente, proprio come in Fuoco pallido Zembla e questo mondo sono collegati, così anche Brillo Box esiste in una parte speciale del nostro mondo reale, il mondo dell’arte.
Anche in altri romanzi Nabokov ha proposto l’idea di mondi alternativi. In Ada, per esempio, leggiamo di un’Antiterra, un mondo simile a quello in cui viviamo. Talvolta agli storici (e anche agli scrittori creativi) piace immaginare storie alternative, racconti di cosa sarebbe accaduto se degli eventi si fossero evoluti diversamente. Nel racconto The Man in the High Castle (La svastica sul sole), Philip K. Dick immagina una storia alternativa in cui l’Asse vince la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti orientali vengono occupati dalla Germania nazista e la costa occidentale è invasa dal Giappone. In alcune storie alternative anche i mondi dell’arte sono alternativi. Nel romanzo ucronico di Kingsley Amis The Alteration (1976) (Modificazione H.A., Sonzogno, 1977), per esempio, non c’è stata la Riforma e quindi l’Inghilterra è rimasta cattolica, e nella cattedrale di Coventry, la chiesa madre dell’Impero britannico, c’è un soffitto dipinto da Turner, una finestra decorata da Gainsborough, un affresco di Blake e un mosaico di David Hockney.
Sono dell’avviso che quelle che ho identificato come due parti distinte in Horse Thieves siano in relazione come i mondi alternativi narrati nelle opere letterarie: la riproduzione di Caravaggio nella cartolina appartiene a un mondo, e il testo di Beckley e la foto della bicicletta appartengono a un altro, in una composizione che ricorda Fuoco pallido con i suoi due testi apparentemente slegati ma in realtà interconnessi. Non intendo dire con ciò che Beckley abbia letteralmente pensato al romanzo di Nabokov ma è indubbio il parallelismo strutturale. Proprio come il lettore di Fuoco pallido deve capire come il commento di Kinbote riguardi il poema di Shade, così chi guarda Horse Thieves deve capire come il testo e la foto della bicicletta di Beckley riguardino Le Sette Opere di Caravaggio.
Qual è, allora, il significato di questa procedura articolata? Nel capitolo precedente ho sostenuto che con le fotografie di fiori Beckley voleva portare nel mondo dell’arte di oggi il pensiero estetico di Pater e Ruskin attualizzandolo, ma c’era anche una finalità più intima, creare un’arte bella per rifarsi dell’infanzia povera di bellezza che aveva vissuto, realizzando opere che celebrassero l’importanza del bello. Nel passaggio ulteriore si aggiunge un altro obiettivo per Beckley, rendere esplicito il legame dialogico tra la sua arte e la storia dell’arte.
Come per quasi ogni artista degno di nota, le opere di Beckley sono sempre strettamente legate alla storia degli sviluppi artistici contemporanei. Le sue prime opere concettuali rientravano a pieno titolo in quel movimento; le sue narrazioni concettuali successive, in cui usava elementi verbali nell’arte visiva, erano basate su istanze presenti nell’arte dal Modernismo in poi e anche le sue magnifiche fotografie di fiori riflettevano i suoi studi delle teorie più recenti. In modo più articolato, quindi, Neapolitan Holidays si pone in continuità con la sua evoluzione artistica.
Come illustrato nel terzo capitolo, per i post-modernisti l’arte contemporanea, anzi, la miglior arte contemporanea doveva rompere con la tradizione. Infatti, invece dell’ormai datata analisi formalista secondo cui lo spazio profondo degli Antichi Maestri si evolve nello spazio superficiale modernista dell’Espressionismo astratto pur preservandone gli elementi fondamentali, l’arte contemporanea anti-estetica rifiuta la tradizione. L’espressione stessa “post-modernismo” voleva sottolineare che era qualcosa di completamente nuovo e, per certi versi, può sembrare che Beckley abbia fatto sua questa impostazione: dopo tutto, cosa erano la sua arte e le sue narrazioni concettuali se non una rottura con la tradizione? E come comprendere la sua evoluzione da fotografo se non in questi termini? Certo, si possono trovare precedenti per qualunque cosa; Myself as Washington ha un certo rapporto con i ritratti di Gilbert Stuart e le foto dei fiori hanno un legame di parentela con le nature morte degli Antichi Maestri. Ma insistere sulla continuità, come l’influente octoberista Rosalind Krauss sosteneva, ci fa perdere di vista l’importanza della sua recente rottura con la tradizione.
Allora Horse Thieves si riferisce al quadro di Caravaggio? Non esattamente, ma di certo il dipinto del Maestro è importante per comprendere questa opera concettuale. Beckley fa un uso poetico di Le Sette Opere, dimostrando come un artista contemporaneo possa usare Napoli. Proprio come Uncontrollable Beauty e Sticky Sublime parlano di bellezza senza dirci esattamente cosa significhino i fiori, così la foto delle Sette Opere in Horse Thieves esprime l’interesse del nostro artista per l’arte antica, senza dirci esattamente che senso abbia la sua presenza nell’opera di Beckley.
203 202
Questo è il contesto in cui interpretare Horse Thieves. Beckley ambisce a fare qualcosa di nuovo, e non mi viene in mente alcun modello classico o modernista per tale narrazione in quattro parti. Al tempo stesso, vuole dimostrare che la sua opera contemporanea si innesta a pieno nella tradizione artistica, un po’ come se volesse avere una torta e volesse mangiarla allo stesso tempo. E proprio come, in Lezioni di estetica, Nabokov innesta il poema tradizionale di Shade “Fuoco pallido” nell’alveo della letteratura contemporanea includendolo nel commento di Kinbote, così Le Sette Opere di Misericordia di Caravaggio, sotto forma di riproduzione, è incluso in Horse Thieves che, quindi, parla del dipinto. L’atto interpretativo che l’inclusione della foto della cartolina promuove, chiede a chi osserva di collegare l’esperienza presente al Caravaggio.
Finora mi sono concentrato su modelli letterari, perché trovo che l’idea di mondi alternativi di Nabokov e di altri scrittori si presti a pennello per illustrare il modo di procedere di Beckley, ma si può arricchire l’analisi anche con degli esempi musicali. Come Horse Thieves congiunge l’immagine di una pala d’altare del XVII con una foto contemporanea di una bicicletta, così molti musicisti hanno, di recente, proposto registrazioni di concerti durante i quali eseguono opere antiche in cui si innestano composizioni più recenti. Il pianista David Greilsammer suona Bach, Brahms, Schoenberg e altri compositori famosi insieme a opere di Jonatha Keren, un artista più giovane. E la violinista Patricia Kopatchinskaja, in collaborazione con la Saint Paul Chamber Orchestra, ha suonato dei brani del Quartetto in re minore di Schubert, La morte e la fanciulla, insieme a un anonimo canto bizantino, a un quintetto di John Dowland, a un madrigale di Gesualdo e a un’opera recente di György Kurtág. In entrambi i casi l’effetto dirompente fa riflettere su come ascoltiamo la musica che ci suona familiare quando è inserita in un contesto nuovo. E questo è ciò che fa, a mio modesto avviso, Horse Thieves con Le Sette Opere di Misericordia.
204
“Alcune delle mie opere migliori degli anni Settanta hanno fortemente influenzato la serie Neapolitan Holidays del 2019. Nei miei primi lavori tutto quello che scrivevo aveva
la lunghezza di una cartolina. Ogni opera della serie Neapolitan Holidays
è stata ispirata da cartoline d’epoca, datate dal 1915 al 1972, indirizzate a Napoli o inviate da Napoli. Ciò che ho trovato particolarmente toccante era che molte di esse erano state spedite durante la Prima guerra mondiale.
Il procedimento che ho utilizzato è stato quello di rispondere al testo scritto sulla cartolina con una e-mail o un sms. Su ogni messaggio è registrato un tempo specifico perché su ognuno di essi è segnata l’ora. Così una vecchia cartolina può ricevere una risposta anche cento anni dopo. Ma le mie risposte non saranno contemporanee per sempre”.
Neapolitan Holidays, 2019
Opere

209 208
Neapolitan Holidays, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 250 × 95,5 cm

211 210
War, Artillery and a Few Questions, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 95,5 × 250 cm
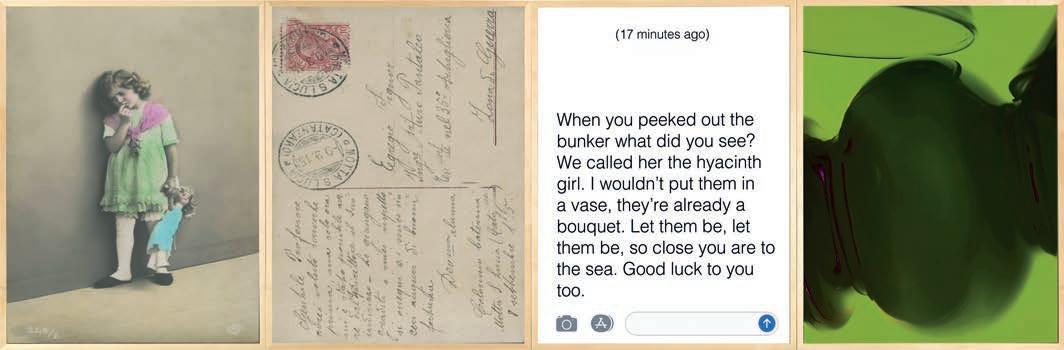
213 212
Darling Young Son 1, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 95,5 × 250 cm


215 214
Cambridge Trampoline Society, 2019 C-print su Fujiflex montata su Aludibond 250 × 95,5 cm
Bird Watching, 2019 C-print su Fujiflex montata su Aludibond 250 × 95,5 cm
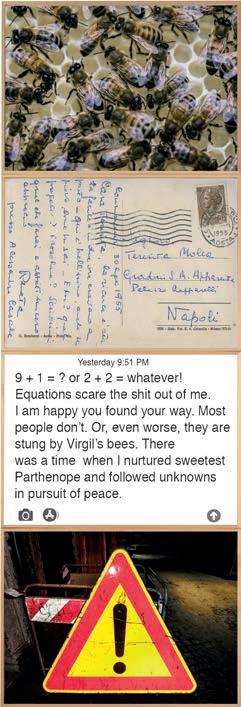

217 216
Land of Lemon Trees, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 250 × 95,5 cm
Buzz, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 250 × 95,5 cm
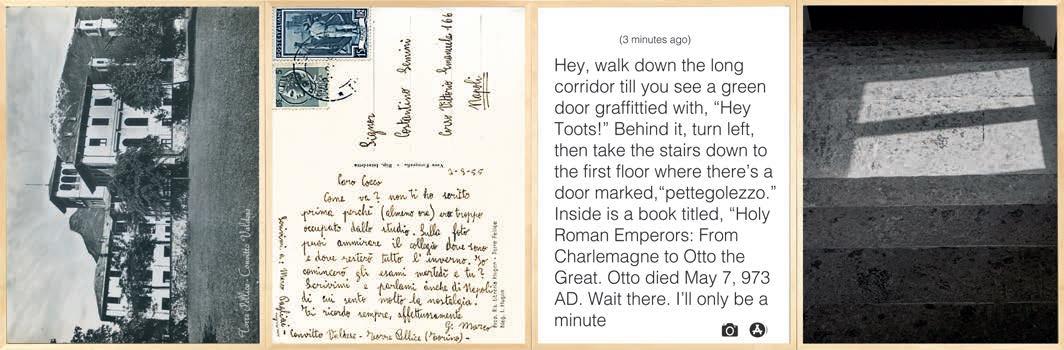
219 218
The Gossip Girl, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 95,5 × 250 cm
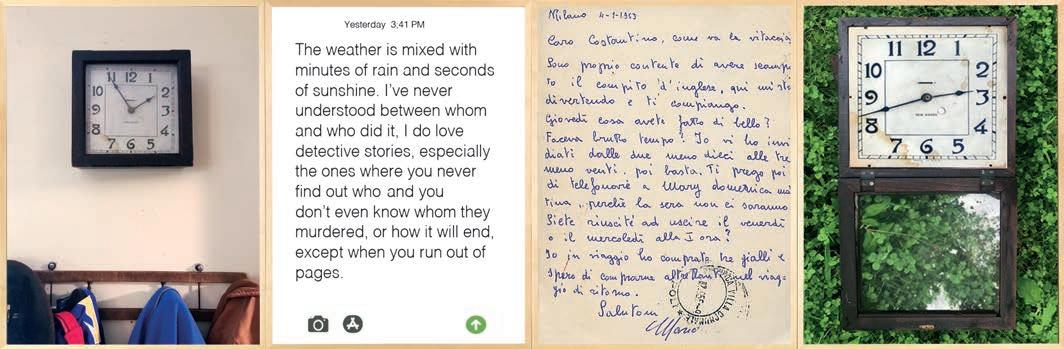
221 220
PM Mysteries, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 95,5 × 250 cm

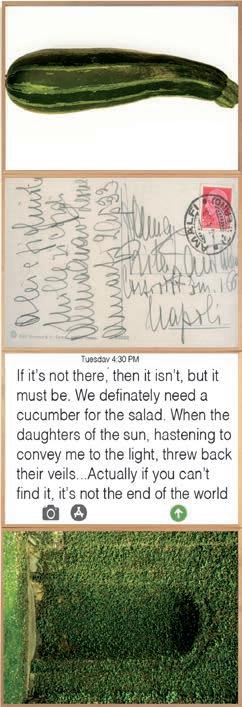
223 222
Dinner with Parmenides II 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 250 × 95.5 cm
Dinner with Parmenides, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 250 × 95,5 cm
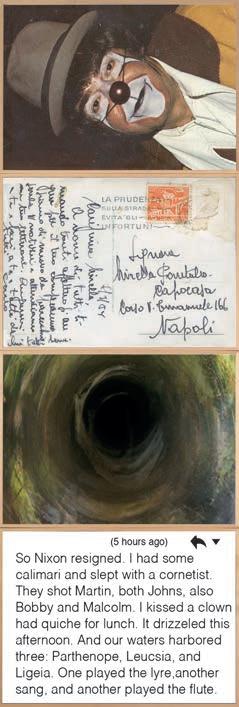
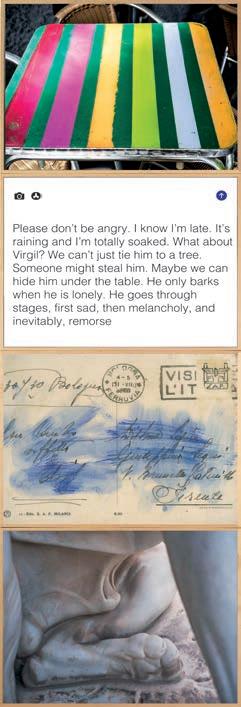
225 224
What about Virgil?, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 250 × 95,5 cm
Kissed a Clown, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 250 × 95,5 cm
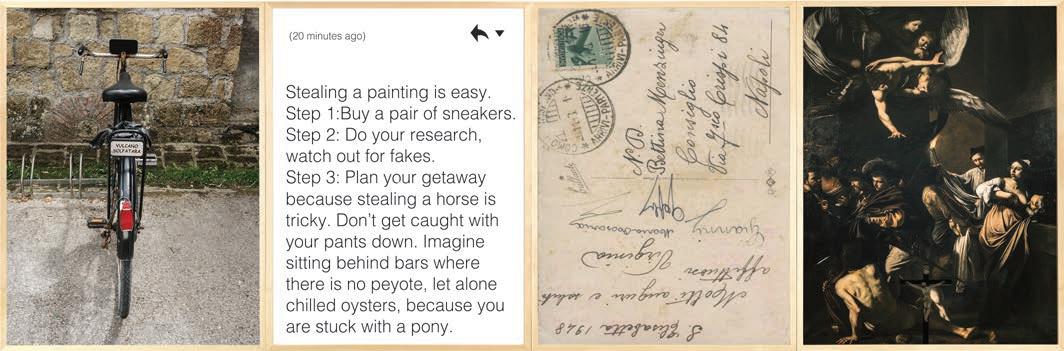
227 226
Horse Thieves, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 95,5 × 250 cm
Andrea Viliani
Bill Beckley è autore di una ricerca artistica organica e unitaria ma, contemporaneamente, non lo è.
Beckley riflette e lavora, infatti, sul molteplice – in cui nessun elemento della sua ricerca è autonomo o sufficiente a sé stesso ma sempre intrecciato e rispondente ad altri elementi; sul potenziale – in quanto le parole e le immagini che egli utilizza nelle sue opere non rappresentano solo ciò che indicano, o a cui corrispondono, ma ipotizzano anche ciò che potrebbero essere altrimenti; sull’ambiguo e, quindi, sul dubitativo – per cui niente è come appare ma è sempre oggetto di un’interpretazione.
Innanzitutto Beckley riflette e lavora contemporaneamente sia sul testo, rappresentato dall’opera d’arte (art work), sia su quel contesto che è intorno all’opera stessa, rappresentato dal mondo dell’arte (art world) e dalla storia dell’arte (art history). Se questo è vero per ogni ricerca artistica, e non lo è comunque sempre, nel caso Beckley ciò può anche essere associato alle matrici storiche della sua ricerca che si avvia alla fine degli anni Sessanta del XX secolo in un contesto come quello definito dalle ricerche concettuali a lui coeve.
In questo senso l’opera, come il suo autore, sono indisgiungibili, per Beckley, dall’inesauribile serie di interpretazioni che ne può dare il contesto di cui sia l’opera sia il suo autore fanno parte, e di cui anche noi come spettatori facciamo parte. Se ne deduce che Beckley non solo è consapevole del ruolo attivo esercitato da chi, nell’osservare un’opera, la può giudicare, ma anche della co-creazione dell’opera nell’atto della sua difforme, molteplice interpretazione. L’opera è quindi lo strumento per un costante esercizio critico e narrativo (ganglio germinale di tutta la ricerca di Beckley, come vedremo), in cui il fare l’opera coincide non solo con il pensarla – con l’analisi dei suoi valori concettuali, formali e storici – ma con l’inizio del racconto delle sue possibili variabili. Un’opera, quindi, probabile, ma non certa. Un’opera di per sé, essendo sempre soggetta a interpretazione, è al contempo reale e fittizia, non solo di fatto oggetto ma anche strumento di racconto. E per la quale se è vero che da un lato essa non esisterebbe senza ciò che ne costituisce l’orizzonte istituzionale – storia dell’arte e mondo dell’arte, intesi come la catena di interpretazioni di cui sono autori coloro che osservano e giudicano l’opera, completandola – è altrettanto vero
229
Florilegio: una storia dell’arte, per come ci è stata raccontata da Bill Beckley
che quell’orizzonte istituzionale – storia dell’arte e mondo dell’arte – non esisterebbe se non per come l’opera stessa lo apre all’interpretazione.
Si parla dell’opera, ma si dovrebbe parlare innanzitutto del suo autore, o sempre di entrambi insieme.
Una delle prime opere di Beckley è del resto un suo autoritratto fotografico nelle vesti del primo presidente statunitense, George Washington, e si intitola Myself as Washington (1969). Appare sintomatico che Beckley si metta nei panni di qualcun altro pretendendo, a quel punto, di rivestire il ruolo di qualcun altro (role-playing) e di recitare un testo (play-acting) altrui, anche se in realtà esso è composto e interpretato da lui stesso. “Pretendere” non significa solo credere in qualcosa, ma anche far finta di crederci: significa una cosa e il suo contrario.
Ecco, Beckley riflette e lavora “come se” (as if) una cosa fosse tale ma anche il suo contrario, o comunque qualcos’altro.
Il suo non è né il tempo indicativo né quello congiuntivo ma l’unione fra essi, in cui dal dato di realtà si genera una condizione di incertezza epistemica: in italiano si indica con “periodo ipotetico” una struttura sintattica composta da una proposizione reggente indicativa (apodosi) alla quale segue una proposizione subordinata condizionale, che necessita il congiuntivo (protasi). In inglese si parla invece di conditional sentences (“affermazioni condizionali”) e di clauses (“clausole”). In ogni caso una realtà data solo per ipotesi, che non è né vera né falsa ma, per certi aspetti, è entrambe le cose: “io come se fossi George Washington” non significa né che lo sono né che non lo sono, ma che sono “come se” lo fossi.
In italiano – la lingua a partire dalla quale sto giudicando e raccontando la ricerca di Beckley – “interpretare” significa del resto due cose di per sé molto diverse: fornire una propria versione – per esempio una spiegazione o una traduzione – ma anche recitare, fingere, ed ecco che critica e narrazione possono convivere, in quanto entrambe sono un atto di un’interpretazione, che procede per similarità al fine di riunire cose diverse: fornire versioni diverse dello stesso fatto, o recitare una storia nei panni di qualcun altro.
Operando “come se”, declinando conditional sentences Beckley è l’autore di opere che riuniscono piani di esperienza distanti fra loro, quando non incongrui: critica e narrazione, dimensione concettuale e bellezza decorativa, analisi semiotica e puro intrattenimento, colto e popolare, semplice e astruso.
Se l’aspetto estetico e intellettuale delle sue varie opere ha reagito al contesto artistico in cui esse sono state concepite – rispettivamente le rigorose matrici concettuali degli anni Settanta, gli anni Ottanta con il loro ritorno all’espressività, la ricongiunzione fra questi due opposti a partire dagli anni Duemila con la genesi di un concettuale differenziato innervato di personalità individuale – la sintesi che Beckley ne ha operato lo pone, anche in questo caso, “come se” egli avesse deciso di aderire e insieme di prescindere dal quel determinato contesto artistico.
Rispetto alla generazione degli artisti pop e concettuali a lui coevi, Beckley avvia la sua ricerca alla fine degli anni Sessanta, biograficamente fiancheggiando entrambi, ma appare meno interessato all’autonomia dell’icona pop e dell’idea concettuale rispetto a una divisione del lavoro per cui l’artista progetta ma non produce (conseguenza logica e diktat, sia dell’arte pop sia di quella concettuale più rigorose). Il suo è invece un operare analogo da un lato a qualcosa che precede questo scenario – il recupero supremamente ironico proprio del ready-made duchampiano,
che è di per sé un’operazione al contempo critica e narrativa – e dall’altro a qualcosa che è ancora di là da venire – quella riscoperta del piacere sensuale e della libera giocosità con cui intrecciare riferimenti e citazioni che un decennio dopo caratterizzarono le estetiche “post-moderne”¹ dei Neo-espressionismi internazionali e della Trans-avanguardia italiana. Per altro, pensando a Beckley, andrebbe notato che fra le definizioni sopra citate di Post-moderno, Neo-espressionismo, Trans-avanguardia, forse a essere preferibile è proprio quest’ultima, inventata in occasione di alcune mostre e articoli del 1979 dal critico italiano Achille Bonito Oliva, sebbene essa sia decisamente la più aliena biograficamente da Beckley: il neologismo Trans-avanguardia infatti non mette l’accento né sul nuovo (“Neo”) né sul dopo (“Post”) ma sull’attraversamento (“Trans”) del concetto stesso di avanguardia, e quindi su una congiunzione dinamica, sull’impermanenza di un dialogo, sull’imprevedibilità di un risultato.
Inoltre, sempre negli stessi anni in cui Beckley avvia la sua ricerca, si definisce anche un atteggiamento critico verso i formati e i comportamenti dell’arte, la cosiddetta “institutional critique”² radicatasi fra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta come presa di coscienza da parte degli artisti di matrice concettuale che il contesto istituzionale dell’arte è una parte integrante dell’opera d’arte, in quanto ne condiziona l’esposizione e la mediazione e di fatto, interpretandola, ne altera la comprensione non solo da un punto di vista artistico e storico ma anche economico, politico e sociale. Ma anche in questo caso Beckley, con le sue prime opere composte di parole e immagini, appare troppo interessato alle storie che racconta per ridurle a una posizione esclusivamente critica che destrutturi e annulli la narrazione, rivelandone i meccanismi di funzionamento interni o di condizionamento esterni. Così come è troppo consapevole della matrice critica delle sue narrazioni per credere che esse siano semplicemente delle storie da raccontare. La pratica foto-narrativa delle opere realizzate da Beckley negli anni Settanta si basa in effetti sulla duplicità (declinazione basica della molteplicità), sulla coesistenza di verità e bugia, su qualcosa che è oggettivamente lì da vedere e da leggere e, insieme, sulle possibili interpretazioni che se ne possono trarre (il “pretendere” e l’“interpretare” a cui si è accennato prima). Un’articolazione che è supportata anche strutturalmente dalla composizione formale delle opere in dittici, trittici o polittici in cui si distribuiscono sia la componente iconica che quella testuale dell’opera. Se in queste opere composite l’intenzione è critica, la sua applicazione e la sua resa sono narrative: immagini e parole sono combinate, infatti, per generare storie, e la storia è un mezzo impuro, al contempo vero e falso, verosimile quanto basta per crederci, ma implausibile abbastanza per dubitarne. E che lascia quindi spazio affinché operino, fianco a fianco, il giudizio e l’immaginazione, un po’ come accade quando leggiamo un romanzo o andiamo al cinema e sospendiamo per qualche ora il nostro senso di realtà per immergerci completamente nella storia che stiamo leggendo o che stiamo vedendo e ascoltando.
1. Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne: rapport sur le savoir Les Editions de Minuit, Paris 1979.
2. Per un’introduzione al tema cfr.: Benjamin Buchloh, Conceptual Art 1962–1969: From the Aesthetics of Administration to the Critique of Institutions in “October”, n. 55, 1999, pp. 105-143; Julia Bryan-Wilson, A Curriculum of Institutional Critique, in Jonas Ekeberg (a cura di), New Institutionalism, OCA/verksted, Oslo 2003, pp. 89-109; Alexander Alberro, Blake Stimson (a cura di), Institutional Critique An Anthology of Artists’ Writings, The MIT Press, Cambridge, MA - London 2009.
231 230
Opere come Cake Story (1973) – paradigmaticamente articolata in due parti, una fotografia di una fetta di torta appoggiata su un tavolo e una frase sul mangiarla ma averla ancora da mangiare (una possibilità che è di per sé anche una contraddizione) – o De Kooning’s Stove (1974) o Rising Sun, Falling Coconut (1978) sono, per citare Umberto Eco, tutte opere aperte che lasciano spazio alle molteplici interpretazioni derivate dal ruolo attivo del loro spettatore/lettore³, compartecipe delle strategie critiche e narrative del romanziere. Guardando e leggendo queste opere-testo di Beckley ho sempre pensato del resto ai romanzi a chiave di Eco che agiscono su più livelli⁴, anche se mi è nota la passione di Beckley per un altro romanziere, Vladimir Nabokov, e la sua invenzione di plausibili realtà alternative, in cui il confine fra vero e falso si fa poroso, da un lato destando l’attenzione critica e dall’altro compiacendo il desiderio di avventura del lettore. Per me poi – che nel corso degli anni ho imparato quanto la lingua napoletana (a cui anche Beckley si è riferito in alcune sue opere) contenga surreali paradossi che traducono un senso della vita fondato sulla compresenza di incanto e disincanto, facendone una lingua-testo, una lingua predisposta alla narrazione di storie e al contempo colma di saggezza critica – queste opere sembrano stranamente tradurre detti napoletani quasi intraducibili, come per esempio uno dei più paradossali, e dei miei preferiti: “miettila ‘n terra e vide si cammina…” (“mettila in terra, e vedi se cammina”, come a dire “provaci, se ti riesce”).
Un libro che certamente troverete sulla scrivania di Beckley è Imaginary Portraits, scritto nel 1887 da Walter Pater: è una raccolta di biografie immaginarie di personaggi realmente esistiti, un vademecum per chi voglia confondere fra loro fatti e finzioni, comprendere attraverso stratagemmi letterari che la verità esiste solo se raccontata nella sua complessità, nelle sue derive polifoniche.
E Beckley stesso è stato l’autore di due testi, per l’esattezza di due antologie – Uncontrollable Beauty: Toward a New Aesthetics del 1998 e Sticky Sublime del 2001 – che, nella scelta degli autori e dei brani operata da Beckley e nelle sue esplicitazioni in premessa, ci rivelano le sue idee sull’arte. Non è forse un caso che si tratti in entrambi i casi di testi antologici, di florilegi, di cui riporto l’etimo in italiano a seguire: florilègio s. m. [dal lat. rinascim. florilegium, comp. del lat. flos floris «fiore» e legĕre «cogliere», calco del gr.
ἀνϑολογία]. – Scelta di opere o di brani di opere di uno o più scrittori, raccolta in volume; antologia […]; anche, raccolta di preghiere e pratiche di devozione, soprattutto come titolo […]. In frasi scherz.: un f. di errori, di insulti, di parolacce⁵.
Per elaborare una riflessione o per raccontare una storia bisogna selezionare e raccordare la tesi, l’antitesi e la sintesi del proprio ragionamento, come bisogna selezionare e raccordare i protagonisti e gli accadimenti della propria fabula. Quella di Beckley è in effetti una mentalità non solo critico-narrativa, dove fra i due elementi non si dà più opposizione ma piena e appagante collaborazione epistemica, ma anche, e direi di conseguenza, antologica.
3. Cfr. Umberto Eco, Opera aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Bompiani, Milano 1962, e Il ruolo del lettore in Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrativi, Bompiani, Milano 1979. Cfr. anche la distinzione effettuata da Roland Barthes fra testi “leggibili” e “scrivibili” (“La morte dell’autore”, in Brusio della lingua. Scritti critici IV, Giulio Einaudi Editore, Torino 1988, pp. 51-56).
4. Il nome della rosa (1980), Il pendolo di Foucault (1988), L’isola del giorno prima (1994), Baudolino (2000), La misteriosa fiamma della regina Loana (2004), Il cimitero di Praga (2010), Numero zero (2015), tutti editi in italiano da Bompiani, Milano. 5. https://www.treccani.it/vocabolario/florilegio/.
L’antologizzare di Beckley, però, non va inteso come “citazione” o “appropriazione”, due termini che definiranno invece le estetiche predominanti emerse negli anni Ottanta sia in Europa sia nell’area nord-americana, e rispetto alle quali Beckley sembra nuovamente aderire e dissociarsi, come era accaduto un decennio prima rispetto agli approcci concettuali e pop. L’antologizzare di Beckley corrisponde piuttosto a un’azione che, per quanto concettualmente rigorosa, è però indirizzata a operare scarti conoscitivi, linguistici ed estetici: un’antologia, un florilegio che confonde categorie in genere non associate o associabili fra di loro, producendo quindi l’antologia imprevista e imprevedibile di una conoscenza metaforica, anche in questo caso definibile solo “come se”. Per cercare di visualizzare questa antologia – dato che un’immagine vale mille parole, si sa, ma non so se Beckley sarebbe d’accordo – vi invito a pensare agli affreschi delle domus pompeiane in cui sono raffigurati giardini ideali in cui compaiono fiori, frutti e animali che, nella realtà, non potrebbero coesistere insieme perché fioriscono e maturano in stagioni differenti, o vivono in climi differenti. Facendolo illusivamente coesistere tutti insieme, gli affreschi pompeiani sono dei trompe l’oeil di paesaggi fantastici e compendiari. Proprio al tema pompeiano Beckley si riferì nei suoi collage della serie Gardens of Pompeii realizzati alla metà degli anni Ottanta. Nel 2017, in occasione della mostra “Pompei@Madre. Materie archeologiche”⁶, quando conobbi personalmente l’artista, ne esposi un esemplare (Gardens of Pompeii 1986) su cui campeggiavano alcune scritte fra loro a prima vista senza alcuna connessione: “Orec”, “Spalla”, “Ena”, “Mimosa”, “Jitters”. Al tema del giardino e, più nello specifico, a quello floreale – che per ragioni etimologiche, come abbiamo visto, rinvia all’antologia e al florilegio – Beckely si dedica a partire dal nuovo millennio con le sue immagini fotografiche di gigli, calle o papaveri su sfondi neutri di vari colori, in cui, lasciando fuori dal quadro le radici o i vasi, l’obbiettivo della macchina fotografica si focalizza solo sugli steli o sui petali, gli elementi più in grado di generare immagini quasi astratte: superfici, linee, forme. Queste vedute sono inoltre per lo più ravvicinate e verticali, a staccare il più possibile l’immagine dal piano orizzontale e descrittivo del paesaggio, e quindi del radicamento del fiore nel terreno da cui esso fiorisce. Come tutta la tradizione della pittura di natura morta floreale ci tramanda, dipingere un fiore è soprattutto una questione di stile, e il fatto che Beckley si richiami al processo di astrazione che condusse Piet Mondrian a passare dagli iniziali dipinti di alberi ai suoi dipinti di forme geometriche e colori primari, o il fatto che Beckley continui una linea che dalle mele pre-cubiste di Paul Cézanne passi per le bottiglie di Giorgio Morandi e arrivi agli zip di Barnett Newman, tutto questo è già, di per sé, un’antologia, un florilegio in termini stilistici. La sua selezione antologica sembra a prima vista voler concentrare l’attenzione non tanto sull’oggetto della sua rappresentazione, dei semplici fiori, ma sulla possibilità di estrarne immagini di puro valore concettuale, di assoluto rigore astratto e minimalista. Ma anche in questo caso Beckley agisce “come se”. Perché in realtà questi fiori sono vettori di differenti movimenti cognitivi, linguistici ed estetici, sono gli attivatori di una relazione fra più piani di senso: innanzitutto fra il fiore in natura e la sua rappresentazione artistica, fra il brano di realtà e la sua interpretazione
233 232
6. “Pompei@Madre. Materie archeologiche”, a cura di Massimo Osanna e Andrea Viliani (Napoli, Madre-Museo d’arte contemporanea Donnaregina, 19 novembre 2017 - 30 aprile 2018).
nella storia dell’arte; e quindi fra l’innaturalità del concetto e la naturalità della sua incarnazione. E quindi sullo scandalo di poter congiungere l’ideale di un’arte ancora concettuale con il carattere spurio e irregolare di qualcosa di semplicemente, banalmente, umilmente e… davvero bello. Ovvero, questi fiori sono un’antologia che riflette e ci invita a riflettere sul fatto che ciò che vediamo non è mai solo ciò che vediamo, ma un palinsesto di cose pratiche e idee teoriche, che il guardare frontalmente invece che trasversalmente qualcosa non è mai il modo migliore né per giudicarla né per raccontarla. Anche se essa fosse un semplice, banale, umile fiore.
Anche in questi fiori si sono in effetti depositate – per citare l’archeologo Salvatore Settis e, con lui, lo storico e critico d’arte novecentesco Aby Warburg – le pathosformeln, le “formule patetiche” con cui alcune immagini, alcuni stilemi, alcune interpretazioni archetipiche tendono a riaffiorare anche in contesti difformi, configurando il nostro sapere storico e artistico come un pathos espressivo, un desiderio che si stratifica in espressioni ritornanti, come se esse fossero i sedimenti da cui si genera anche il nostro sapere contemporaneo, in cui ogni creazione originaria si condensa intorno alla ripetitività con cui essa si ripropone, e per cui ogni opera d’arte è di per sé anche un museo dove tutta la storia dell’arte confluisce⁷.
I fiori di Beckley sono, in questo senso, degli inganni: per quanto ci sembrino proprio gli ultimi fiori possibili della lunga tradizione novecentesca dell’astrazione, essi sono fiori velenosi proprio in quanto, agendo su un piano critico e narrativo, approfondiscono e rendono problematica la nostra percezione e la nostra conoscenza. Non a caso essi hanno, in quanto opere d’arte, anche un titolo –elemento testuale non presente in questo caso nell’opera stessa ma a essa associata per effetto di quella ulteriore codificazione del sistema e della storia dell’arte che prevede sempre un titolo per ogni opera, anche quando esso fosse un “senza titolo”. E sempre non a caso questi titoli non si riferiscono affatto ai fiori stessi, ma a qualcosa che essi hanno potenzialmente ispirato al loro autore, sebbene non sia immediatamente comprensibile da parte dello spettatore/lettore. Ancora una volta da queste opere emana una serie di interpretazioni, che si articolano sia in riflessioni critiche sia nelle storie di un narratore sostanzialmente inaffidabile, come da sempre è stato Beckley e, con lui, i suoi spettatori/ lettori. Come a dire, la storia continua… Raramente vedrete dei fiori così belli, così chiari, così dettagliati, così innocui che sono in realtà così opachi, così indiretti, così enigmatici, così complessi.
Le antologie floreali, i florilegi di Beckley, coincidono del resto con quel capitolo in corso della storia dell’arte contemporanea caratterizzato sempre di più dall’affermarsi di pratiche sempre più spesso basate sulla relazione beckleyana fra critica e narrazione e fra reale e fittizio, oltre che sull’intersecazione fra space-based delle arti visuali e il time-based di quelle performative, e sulla progressiva confusione fra il ruolo dell’artista e quello del suo interprete. In questo contesto anche le originali pratiche antagoniste dell’“institutional critique” sono state a poco a poco introiettate e persino celebrate dal sistema e dalla storia dell’arte, entrando nei musei come espressione del pathosformel istituzionale contemporaneo. Pur confermandosi come operazioni critiche, queste pratiche si sono trovate a raccontare storie, abbastanza verosimili per essere credute ma abbastanza inverosimili
7. Cfr. https://pompeiicommitment.org/commitment/salvatore-settis/.
per insinuarci il dubbio che non bisognerebbe crederci affatto, attivando il nostro giudizio critico nell’atto stesso di ascoltarne il racconto. Vorrei definire queste pratiche non più di “institutional critique”, sebbene ne siano eredi, ma più propriamente di “institutional narrative”, e credo che Beckley di questa “institutional narrative” sia di fatto uno dei più probabili e seminali antesignani. Ho iniziato a occuparmi della ricerca di Beckley verso il 2010, ma lo conobbi di persona solo alcuni anni dopo, nel 2017, quando lo invitai alla mostra collettiva “Pompei@Madre. Materie archeologiche”. Nel 2019 presentò a Napoli, in occasione della sua mostra personale allo Studio Trisorio, la serie Neapolitan Holidays, costituita da quadrittici i cui quattro elementi erano variamente composti fra loro nelle singole opere che compongono la serie e l’immagine di una vecchia cartolina selezionata da Beckley fra quelle recuperate e consegnategli dalla famiglia Trisorio; il messaggio originario riportato sul retro della cartolina e corredato dall’indirizzo del ricevente e dal francobollo necessario per l’invio da parte del mittente; una nuova immagine e un nuovo messaggio di Beckley (quasi in risposta – anche se inattesa, in quanto fuori tempo, e incongrua, per quanto a prima vista plausibile – al messaggio contenuto nella cartolina originaria). Come dimostra nella polifonia spaziale, temporale, autoriale e semiotica delle sue Neapolitan Holidays, Beckley è sempre stato un artista visivo ma, come ho raccontato, ha utilizzato i metodi di lavoro e l’immaginario di un critico e di un narratore: le immagini e le parole con cui egli scrive le sue storie sono proprio per questo inaffidabili in quanto basate sulla produttiva duplicità fra parola e immagine, sugli spazi e i tempi sospesi che si aprono fra critica e narrazione, sul potenziale interpretativo che esse (parole e immagini, critica e narrazione) dischiudono in quanto creatrici di realtà di per sé alternative, di mondi possibili, di stati di comprensione ulteriori. E per questo le opere di Beckley sono liberatorie e ci ispirano un senso inebriante di ottimismo, in quanto ci accolgono in esse, risvegliando il nostro senso critico e, al contempo, alimentando il nostro bisogno di avventura, di sorpresa, di gioco. L’opera, ma anche la mostra, il saggio, il catalogo, il museo, la galleria, la partecipazione e la ricezione del visitatore e del lettore compongono non una sola storia ma tante storie dell’arte. Quella che racconta Beckley è una di esse, anzi, è una ma anche un’altra, un’altra, e un’altra ancora.
In ogni modo nella sua antologia, nel suo florilegio di storie, nessuna storia può esistere senza l’altra, a volte sfiorandosi, a volte intrecciandosi, a volte contraddicendosi, a volte persino ignorandosi con le altre. Ognuna di queste storie va interpretata, essendo una ricreazione della realtà per come la conosciamo o per come credevamo di conoscerla.
Queste, e altre, potrebbero essere alcune delle premesse di una possibile antologia sulla “institutional narrative”, sulle sue origini, sui suoi protagonisti. Potremmo intitolarla, questa antologia, FLORILEGIO in tuo onore, Bill. E ti ringrazio, per avermi in questi anni confuso le idee, rendendo così paradossalmente più chiaro di che cosa avrei dovuto scrivere in questo mio florilegio, che ti riguarda come riguarda anche me, e il nostro lettore⁸.
8. Vorrei ringraziare Bill Beckley e David Carrier, per il suo approfondito saggio che accompagna anch’esso questo volume, insieme a Lucia, Laura, Paola Trisorio, in memoria Pasquale Trisorio, e l’amico Gianfranco D’Amato, per avermi accompagnato non solo nella redazione di questo testo ma in tutti gli anni in cui esso si è definito e ridefinito, lentamente e persino inconsapevolmente, insieme alle nostre relazioni.
235 234
Una conversazione
Bill Beckley
Il mio lavoro è nato dal movimento della Minimal Art alla fine degli anni Sessanta. In quel periodo la pittura viveva un momento di crisi: Frank Stella, Brice Marden e Robert Ryman erano arrivati a produrre opere in cui la superficie pittorica appariva completamente appiattita, senza contenuto. Artisti come Dennis Oppenheim e Vito Acconci aprirono la strada a opere concettuali realizzate intervenendo direttamente sul paesaggio o sul proprio corpo. Pur essendo attratto dal loro lavoro, mi preoccupava il fatto che le loro azioni dipendessero dalla documentazione fotografica.

Mi sono laureato alla Temple University di Filadelfia. Il mio professore, Italo Scanga, mi presentò a ex studenti e amici, tra cui Bruce Nauman, Dan Flavin, Sol LeWitt e Marcia Tucker.
In quel periodo dipingevo con il pennello direttamente sul terreno nei campi a nord della città. Ho dipinto linee larghe un metro e lunghe un’ora. Era letteralmente “pittura del paesaggio”. Ho anche dipinto dei quadrati sui cespugli che ho dedicato a Sol LeWitt, che ho incontrato quando è venuto a far visita a Italo Scanga nel 1969. Sol ha influenzato molto il mio lavoro e siamo rimasti amici fino alla sua morte, avvenuta nel 2017.
Nel marzo del 1969 ho dipinto una linea dall’alba al tramonto. La linea passava attraverso i campi, scendeva in una piccola valle e attraversava un fiume. Non appena posavo la pittura sull’acqua, immediatamente veniva portata via dalla corrente. Così ho “dipinto” una linea immerso nell’acqua, mentre attraversavo il fiume Delaware da una parte all’altra. Sulle rive del Delaware c’è un famoso punto in cui George Washington attraversò il fiume durante la Guerra d’indipendenza americana. La sua traversata in barca avvenne nella notte del 25 dicembre 1776. La mia, senza barca, il 20 marzo 1969. Avevo con me una macchina fotografica ed entrai in acqua con quattro barattoli di vernice da quasi quattro chili ognuno legati intorno alla vita. Non mi ero reso conto che il fiume era profondo, il livello dell’acqua mi arrivò proprio sopra la testa. A quel punto ho dovuto disfarmi della vernice per non affogare. Nel divincolarmi ho perso la macchina fotografica, ma ho continuato ad attraversare il fiume fino a raggiungere l’altra sponda.
Fu allora che mi resi conto che non avevo nessuna fotografia, nessuna possibile prova. Tutto ciò che avevo era una storia. Un tempo esistevano solo le fotografie analogiche, spesso erroneamente considerate come verità. Comunque, pensai: “Beh, forse dovrei fare qualcosa di più con George
237
Washington”. Così mi feci una foto con le sembianze di George Washington (Myself as Washington, 1969). Avevo i capelli lunghi e li ho scompigliati e cosparsi di borotalco per renderli bianchi. Ho messo un impermeabile nero al rovescio per fare un colletto alto sopra la camicia bianca. Era un’improvvisazione, non un costume. Ho anche fatto la mia firma imitando la sua calligrafia. Dall’ottobre del 1970 all’estate del 1974 ho esposto spesso al 112 di Greene Street a New York.
“Greene” è scritto con una “e” finale perché tutte le strade dell’asse nord-sud di SoHo, dove vivo ancora oggi, portano i nomi dei generali della Guerra d’Indipendenza. Il 112 Greene Street fu fondato nel 1970 dallo scultore Jeffrey Lew, che trasformò il piano terra e il seminterrato di un vecchio edificio in ghisa di sei piani, una ex fabbrica per lo smaltimento degli stracci, in uno spazio espositivo e di sperimentazione. Era un ambiente anarchico e informale in cui io, Barry Le Va, Alan Saret, Gordon Matta-Clark e Louise Bourgeois, per citarne solo alcuni, esponevamo il nostro lavoro. Facevamo oggetti praticamente invendibili e li lasciavamo lì per un paio di settimane. Ho costruito un lungo letto tra due pilastri e ho messo un gallo vivo in una gabbia appesa sopra il materasso. L’idea era che il letto sarebbe stato usato per dormire e il gallo (un riferimento a Robert Rauschenberg) avrebbe fatto da sveglia. Ho esposto anche quattro dei miei tavoli da ping-pong silenziosi. La pallina da ping-pong rimbalzava sulle superfici di spugna delle racchette e del tavolo senza fare nessun rumore. La maggior parte dell’arte concettuale aggiungeva una forma di linguaggio all’arte visiva, mentre io, in questo caso, ho tolto il linguaggio (il suono del ping-pong) dall’arte.
Un’altra esperienza interessante è stata la mostra collettiva all’aperto sul ponte di Brooklyn, conosciuta come “The Brooklyn Bridge Event” e organizzata nel 1971 da Alanna Heiss, fondatrice e direttrice del Clocktower Space, poi del P.S.1. Contemporary Art Center, ora MoMA PS1. Parteciparono all’evento più di venti artisti e performer, tra cui Carl Andre, Tina Girouard, Jeffrey Lew, Keith Sonnier, Gordon Matta-Clark, Jene Highstein, Sol LeWitt, Richard Nonas e Dennis Oppenheim. Il mio progetto, Brooklyn Bridge Swing, consisteva in una serie di altalene appese al livello superiore del ponte e di un secchio con pesci morti per attirare i gabbiani appollaiati sul ponte. Quindi, sopra c’erano i gabbiani che sbattevano le ali e sotto le persone che potevano dondolare. Si trattava di una combinazione di due movimenti, quello delle ali e quello delle altalene.
All’epoca conoscevo diversi artisti, tra cui i miei amici Dennis Oppenheim e Peter Hutchinson, e tutti esponevamo con il gallerista John Gibson a New York. Era un periodo in cui gli artisti concettuali facevano performance o azioni all’aperto. Cominciai a percepire il problema che ciò che veniva mostrato in galleria non era la “cosa reale” ma la sua documentazione.


La documentazione poggia sul presupposto che l’artista stia dicendo la verità e invece, in senso buono, ci sono molte menzogne. Nel considerare il mio lavoro su Washington pensavo: “Questa non è documentazione, è chiaramente invenzione. Io non sono George Washington”. È stato allora che ho iniziato il mio lavoro “narrativo”.
Ho pensato a vari modi di scrivere storie. In Short Stories for Popsicles, del 1971, la storia era scritta sull’involucro del gelato ma, per conoscerne la fine, bisognava succhiare tutto il ghiacciolo perché il finale era scritto sul bastoncino.
In Short Story for Hopscotch, sempre del 1971, ho serigrafato una storia di dieci frasi su una composizione di elementi disposti sul pavimento l’uno accanto all’altro, riproducendo i dieci numeri del gioco della Campana. Potevi perciò saltare o leggere o forse fare entrambe le cose allo stesso tempo. Era un modo per trasformare una storia in un oggetto d’arte, piuttosto che fare arte come documentazione.
In seguito, ho cominciato a scrivere piccole storie di fantasia illustrate da fotografie che non volevano dimostrare nessuna verità: The Origin of And 1972, An Analogue of An, 1972, Cake Story, 1973 ecc.
Ho iniziato dai titoli. Ne ho chiamata una An Avoidance of Ann, 1972, e non avevo idea di quale sarebbe stata la storia. Ho semplicemente pensato di evitare parole che iniziassero con una vocale, perché avrebbero implicato l’uso dell’articolo an. Se avessi voluto menzionare una “camera d’aria” (innertube) per esempio, non avrei usato la parola innertube perché avrebbe richiesto l’articolo an, ma avrei detto “a circular shaped tube filled with...” (un tubo di forma circolare riempito con...). Si trattava di evitare non solo an, ma anche una persona immaginaria di nome Ann. Ho scritto prima il titolo e poi ho cercato di capire come spiegarlo attraverso un testo.
The Origin of And era la storia di un monaco che aveva raccolto dei prodotti nei giardini di un monastero strutturato su tre livelli che comprendeva: i giardini, un livello intermedio a mezza costa dove risiedevano gli scribi e il livello superiore dove vivevano e lavoravano gli altri monaci. Quando il monaco giardiniere, tirato su dagli altri monaci, stava per raggiungere la cima con il suo sacco pieno di frutta e verdura, chiese ai suoi amici: “Datemi una mano” (“Give me a hand”). Ma prima che i monaci potessero aiutarlo a uscire dalla cesta, la corda si spezzò e lui cadde con tutta la frutta e la verdura. Gli scribi che si trovavano al livello intermedio lo videro cadere e gli sentirono dire solo l’ultima parte di “hand”, cioè “and”. Così associarono la parola and alla caduta di molte cose, al concetto di molteplicità.

239 238
Story 1973 John Gibson Gallery, New York
Rooster, Bed, Lying, 1971 112 Greene Street, New York
Bill Beckley con Silent Ping Pong Tables, 1971 112 Greene Street, New York
Cake Story invece è stata ispirata da un detto inglese che recita: “You can’t have your cake and eat it too” (Non puoi avere la torta e anche mangiarla), sollevando la domanda: “È possibile mangiare e allo stesso tempo avere la torta?”.
The Origin of And è stata la prima storia di fantasia che ho scritto. Il 1969 ha segnato l’inizio della mia cosiddetta “arte narrativa”. I miei lavori, insieme a quelli di altri artisti internazionali che seguivano la stessa tendenza, come David Askevold, John Baldessari, Peter Hutchinson, Jean Le Gac, Italo Scanga, David Tremlett, Ger van Elk e William Wegman, furono esposti nel 1973 alla galleria John Gibson di New York con il nome di Narrative Art. La scelta del nome fu fatta dal gallerista John Gibson che la preferì a Story Art. Mi ricordo che ne discutemmo durante un viaggio in auto da Basilea a Baden-Baden.
Seguirono diverse mostre collettive in Europa e in America tra cui “Narrational Imagery: Beckley, Ruscha, Warhol” organizzata da Sam Hunter all’Università del Massachusetts ad Amherst e “American Narrative / Story Art: 1967-1977” al Contemporary Arts Museum di Houston.
Alcune opere non avevano il testo, ma erano comunque delle narrazioni. Roses Are, Violets Are, Sugar Are, del 1974, derivava da “Le rose sono rosse, le viole sono blu, lo zucchero è dolce come sei tu”: una filastrocca della mia infanzia. Quindi, c’era lo stelo della rosa con uno sfondo rosso, lo stelo della viola con uno sfondo blu e poi una linea di zucchero che imitava gli steli della rosa e della viola. La frase “Lo zucchero è dolce”, non cita un colore, quindi, per completare i tre colori primari, ho reso lo sfondo giallo. Gli steli senza i fiori si riferivano intenzionalmente alle linee verticali di Barnett Newman che diffidava delle linee orizzontali come quelle usate nei paesaggi, perché sentiva che l’avrebbero potuto riportare al figurativo.
Poco prima di morire, Newman realizzò un paio di dipinti chiamati Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue, caratterizzati da linee verticali con sfondi rossi, blu e gialli. Hot and Cold Faucets with Drain (1975), uno dei miei lavori più noti, fa riferimento proprio a Who’s Afraid of Red Yellow and Blue di Newman. Il rubinetto dell’acqua calda è indicato dal rosso, quello dell’acqua fredda dal blu. L’acqua di entrambi scorre insieme in uno stesso scarico indicato dal giallo, che non è la combinazione del rosso e del blu.
Drop in Bucket, del 1974, è uno dei miei preferiti. In alto c’è una foto quadrata con l’immagine di un rubinetto, in mezzo una foto triangolare con l’immagine di una goccia e in basso un’altra foto quadrata con l’immagine di un secchio visto dall’alto. Quindi ciò che incanala la goccia nel secchio è la forma della fotografia triangolare.
In Paris Bistro (un ristorante nel West Village), del 1975, l’idea era che la foto in alto fosse un rettangolo e la foto in basso avesse la forma di un segnale di stop, in modo che l’insegna raffigurata nella foto superiore si riflettesse in quella inferiore, richiamando nuovamente l’attenzione sulla fotografia come oggetto.
In queste opere volevo che la fotografia fosse un oggetto d’arte, non una documentazione dell’arte. Altri artisti per protesta contro il capitalismo, erano contrari alla creazione di oggetti. In realtà penso che loro stessero realizzando oggetti, perché le fotografie sono oggetti sottili. Sono sicuro, inoltre, che tutte le buone fotografie concettuali siano state o potrebbero essere vendute. Ho parlato di questa questione con il mio amico Vito Acconci e lui era d’accordo con me sul fatto che la loro fosse una teoria politicamente debole.

In quegli anni di grandi disordini politici, molti artisti erano marxisti o, spesso, addirittura puritani. Mi criticavano per aver alluso nei miei lavori, metaforicamente o dichiaratamente, al sesso. Avevano ragione, anche un tubo di scarico può essere una metafora sessuale. In effetti, gli artisti concettuali sono un po’ troppo puritani per me: solo fotografie in bianco e nero, poco o niente sesso, e nessun umorismo. Io ho voluto togliere un po’ di “puritanesimo” dal mio lavoro.
Puritanesimo e marxismo sembrano andare di pari passo. L’idea di base del marxismo è: non possiedo beni, quindi non sto aderendo al capitalismo. Questa è un’idea romantica, e io sono un romantico, ma penso che il marxismo in pratica non funzioni perché, sebbene non sia necessario acquistare una Tesla, sono comunque necessari i soldi anche per una vecchia Volkswagen. Benché mi senta debitore verso il primo concettualismo, lo trovo eccessivo, costrittivo e puritano.
L’opera Mao Dead, del 1976, era originariamente la storia di un giornale, non quella di Mao. Il 9 settembre 1976 ho preso l’immagine di Mao dalla copertina del “New York Post” e ho scritto una storia che parlava di un giornale. Ho incluso una foto di un lampione e un’altra di un campo con dei filari di piante, simili alle righe di un articolo. Ho usato il “Post” con la scritta “Mao Dead” in copertina, ma avrei potuto usare qualsiasi altro giornale.
Nell’opera The Bathroom, del 1977, ho inserito l’immagine delle gambe di una donna e quella delle sue spalle con dei graffi. Questo lavoro è molto piaciuto al mio amico Jeff Koons proprio perché mette in discussione l’aspetto puritano in un’opera concettuale.
Nel 1978 ero sposato con una donna inglese che si chiamava Deirdre. In Deirdre’s Lip c’è la fotografia del suo labbro superiore, quella del vapore che esce dal fumaiolo di un treno e tre fotografie del respiro, scattate in una serata fredda, che rappresentano visivamente la pronuncia delle parole “forget, twilight, darling”. C’è una connessione tra questo vapore e quello che

241 240
The Living Room 1977 - Deirdre’s Lip, 1978 Whitney Biennial, 1979
Sunday Paper 1987 - French Fries, 1983 Albertz Benda Gallery, New York, 2018
esce dal fumaiolo della locomotiva. Nell’opera ritroviamo, dunque, il vapore del treno, la bocca e il vapore emesso pronunciando le parole “forget”, “twilight”, “darling”.
In Shoulder Blade, del 1978, ora di proprietà di Jeff Koons, c’è il triangolo di una scapola, il cerchio di un capezzolo e in mezzo una barriera. Il mio testo recita: “Una saponetta passò sul capezzolo di un seno, una zona erogena circolare. Stimolato si eresse. Poi la saponetta passò su un’altra zona, triangolare, della sua schiena. La vasca da bagno era situata a Berlino. Dopo la guerra la città era stata suddivisa in zone. Le strade che portavano da una zona all’altra erano state bloccate da cancelli. Più tardi, fatto il bagno, lei attraversò”.
In Rising Sun, Falling Coconut, 1978, ho scattato la foto a Tortola, nei Caraibi, dove sono andato con il mio amico Mac Adams, che esponeva anche lui alla John Gibson Gallery. Nella foto in alto il sole sta sorgendo, in quella in basso la noce di cocco sta cadendo.
Praticamente scrivevo una storia e facevo le fotografie allo stesso tempo. Poi, a un certo punto, dopo cinque o dieci studi e riscritture, arrivavo al lavoro finale. Il testo si evolveva con le foto. Ogni pezzo richiedeva diversi mesi per essere completato.
Negli anni Ottanta ho usato vari materiali e il lavoro è diventato più scultoreo e pittorico. Alla fine del decennio ho trovato il modo di integrare questi materiali con la fotografia. L’integrazione tra fotografia e superficie pittorica è un aspetto importante di tutti miei lavori. Queste opere rimandano alle superfici piatte dei dipinti minimalisti come quelli di Brice Marden e, allo stesso tempo, alludono, attraverso i loro riferimenti fotografici, al fenomeno dell’acqua che scorre nello scarico, creando uno spazio allo stesso tempo illusorio e reale.
La mia scelta dei fiori come soggetto è nata dall’ammirazione per Barnett Newman. Come pittore, Newman ha fatto una serie di dipinti che ha chiamato Zips. Erano linee verticali perché, come astrattista, voleva allontanarsi dalle linee orizzontali che evocano il paesaggio.
Naturalmente Newman era un pittore e come pittore poteva essere totalmente non-oggettivo.
Con le fotografie è difficile essere non oggettivi. E perché uno dovrebbe volerlo?
Sono stato influenzato dal contesto della pittura più che da quello della fotografia d’arte. Certamente all’epoca alcuni pittori come Robert Ryman e Jackson Pollock non facevano nessun riferimento agli oggetti del cosiddetto mondo reale. Ma come fotografo era problematico essere totalmente non-oggettivo perché di solito un oggetto è necessario in una fotografia, la luce deve riflettere su qualcosa.
Ammiravo Barnett Newman per una serie di ragioni, compreso il suo interesse per il sublime, un’idea che mi confonde ancora oggi. Ma all’epoca (1969) credo che Newman abbia avuto


il coraggio di essere totalmente non oggettivo. Anche con l’astrazione c’è qualche riferimento a qualcosa nel mondo.
Una fotografia di solito deve essere una fotografia di qualcosa che già esiste. Per fare un dipinto non-oggettivo non hai bisogno di niente, se non di pittura e pennello, per fare una fotografia, invece, un oggetto di solito deve avere un qualche tipo di presenza nel cosiddetto mondo.
Così mi sono chiesto: “Quale oggetto lineare è verticale?”. Beh, per prima cosa, uno stelo di solito è verticale. Dopo tutto, i fiori competono per la luce, ecco perché esistono gli steli. Così per un paio d’anni ho fotografato steli di giglio perché gli steli di giglio non avevano rami che disturbassero la chiara verticalità liscia della loro esistenza.
Gli steli di giglio sono diventati le mie zip.
I gigli sono fiori che redimono. E venendo da un rigido background puritano ad Hamburg, in Pennsylvania, ho pensato che se qualcuno aveva bisogno di redenzione, quello ero io.
Per un lungo periodo ho fotografato molti steli di giglio. Poi un giorno ho pensato: “E altri steli che non hanno rami?”. Mi sono venuti in mente i papaveri. Così ho fotografato steli di papavero. Ma in qualche modo sembrava sbagliato escludere il fiore dal papavero. Così ho lasciato il fiore. Ringrazio Barnett Newman per il bouquet.
Alcune delle mie opere migliori degli anni Settanta hanno fortemente influenzato la serie Neapolitan Holidays del 2019. Questa potrebbe anche essere stata la mia serie migliore o, almeno, una delle prime tre.
Nei miei primi lavori tutto quello che scrivevo aveva la lunghezza di una cartolina. La cosa interessante delle cartoline è che quasi sempre ciò che scrivi sul retro ha poco o niente a che fare con l’immagine sull’altro lato. Le cartoline erano i messaggi di testo di una volta. I nostri messaggi di testo sono cartoline contemporanee.
Ogni opera della serie Neapolitan Holidays è stata ispirata da una cartolina scelta fra quelle d’epoca, datate dal 1915 al 1972, inviatemi da Lucia Trisorio, tutte provenienti dalla sua famiglia e indirizzate a Napoli o inviate da Napoli. Ho scelto le cartoline che mi piacevano di più, poi Lucia le ha tradotte in inglese. Ciò che ho trovato particolarmente toccante in queste cartoline era che molte di esse erano state spedite durante la Prima guerra mondiale. Il titolo è un po’ ironico perché l’intera serie si chiama “Vacanze napoletane”.
Lo schema che ho utilizzato è stato quello di rispondere al testo scritto sulla cartolina con una mia e-mail o un sms. Su ogni messaggio è registrato un tempo specifico perché su ognuno di essi è segnata l’ora. Così una vecchia cartolina può ricevere una risposta anche cento anni dopo.
243 242
Roses Are, Violets Are, Sugar Are, 1974 - Dervish 11, Nasuhi, 2007 - Station 9, 2001 Studio Trisorio, Roma, 2009
Barnett Newman, Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue IV, 1969-1970
Ma le mie risposte non saranno “contemporanee” per sempre. Così, tutto è iniziato dalle cartoline e poi ho scritto il testo e fatto le foto.
Il lavoro Neapolitan Holidays, che ha dato il titolo all’intera mostra, si riferisce a una specifica cartolina inviata durante la Prima guerra mondiale. La cosa interessante è che fu spedita a un soldato che nel frattempo era stato riassegnato altrove e la cartolina fu quindi reindirizzata a un altro luogo per raggiungerlo. Sono sicuro che per lui non sia stata una vacanza perché era stato ferito e si trovava in ospedale. In risposta a questa cartolina ho scritto una storia allegra che racconta il tentativo di prendere il traghetto da Capri per Napoli. C’è la foto di una scarpa rossa con il tacco alto che renderebbe la corsa molto difficile. C’è anche una foto della scia del traghetto durante il viaggio da Napoli a Capri e viceversa.

Cambridge Trampoline Society ricorda, invece, il rimbalzare delle onde quando si viaggia verso Capri.
In Bird Watching parlo di un contrasto. La pietra è qualcosa di molto pesante, ed ecco una piuma, qualcosa di molto leggero. La cosa pesante è in alto e la piuma in basso. Naturalmente, la fotografia della pietra e la fotografia della piuma hanno lo stesso peso.
Buzz parla delle api di Virgilio e c’è una foto di alcune api e non è una coincidenza. Il segnale di stop è solo un segnale di stop. Non so spiegarlo al momento. Mi è molto piaciuta l’immagine. Anche il pomodoro in Dinner with Parmenides o l’interno della chiesa in Sleeves, Etc vanno semplicemente considerati nel contesto generale del rapporto tra contenuto, testo e immagine.
Sono stato a Napoli molte volte, a partire dal 1976, quando ho guidato da Londra a Napoli con la mia Morgan del 1962, un’auto che ho ancora. Adoro Napoli e gli artisti che ho incontrato qui, come Lawrence Carroll e Lucy Jones Carroll. Napoli è una calamita per gli artisti.
A Napoli, più tardi e solo spiritualmente, ho incontrato anche altri artisti come Goethe, Sartre, Dostoevskij, Stendhal e il mio caro amico e mentore Oscar Wilde. Napoli è un mondo a sé.
Vagando per le strade con la mia macchina fotografica, riprendendo teschi, leoni e chiese, mi dissero di stare attento. Sono contento di non esserlo stato.

244
Cartolina, 1915
Testo tratto da una conversazione con Laura Trisorio, ottobre 2019.
Biografia
Oggi
1995-1998
1970
1968
1946
Vive e lavora a New York City
Docente alla School of Visual Arts
Direttore editoriale di “Aesthetics Today”
Tyler School of Art, Temple University, M.F.A.
Kutztown State University, Pennsylvania, B.F.A.
Nato ad Hamburg, PA
Musei e collezioni pubbliche
Smithsonian American Art Museum, Washington, DC
The Guggenheim Museum, New York, NY
The Whitney Museum of American Art, New York, NY
Boston Museum of Fine Arts, Boston, MA
Sammlung Hoffmann, Berlino, Germania
La Jolla Museum, San Diego (MCASD), CA
Victoria and Albert Museum, Londra, UK
Musée d’art moderne, Céret, Francia
Kunstmuseum Basel, Basilea, Svizzera
Mönchengladbach Museum, Germania
National Gallery of Art, Washington, DC
Musée d’art Moderne et Contemporain, Ginevra, Svizzera
Daimler-Benz Collection, Berlino, Germania
Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach, Germania
Museum of Modern Art, New York, NY
Kröller-Müller Museum, Arnhem, Paesi Bassi
Collezioni private
Sol LeWitt
Jeff Koons
Gianfranco D’Amato, Napoli
Studio Trisorio, Napoli
Morton Neuman collection, Chicago, IL
Ed Downe, New York, NY
Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
Lise Toubon, Parigi, Francia
David and Lindsey Shapiro, New York, NY
Daimler Benz, Stoccarda, Germania
George Waterman, New York, NY
Isy Brachot, Bruxelles, Belgio
Klaus Wolf, Essen, Germania
Sabine and Bernard Duare, Perpignan, Francia
Dr. P. Rau, Berlino, Germania
Chase Manhattan, New York, NY
Yvon Lambert, Parigi, Francia
Esther Gruthen, Basilea, Svizzera
Richard Oudenhuysen, Paesi Bassi
Principali mostre personali
2019 “Bill Beckley, Neapolitan Holidays”, Studio Trisorio, Napoli
2018 “Frieze New York, Bill Beckley: The Eighties”, Randalls Island, NY
“Elements of Romance”, Rosenwald-Wolf Gallery, University of the Arts, Filadelfia, PA
“The Name of the Rose, Recent Works”, Studio G7, Bologna
“After the Orgies: Bill Beckley Works 1980s-90s”, Albertz Benda, New York, NY
2016 “Bill Beckley: Elements of Romance – Works from the Seventies”, Studio Trisorio, Napoli
2015 “Bill Beckley: The Accidental Poet (The Avoidance of Everything)”, Albertz Benda, New York, NY
2014 “Bill Beckley, An Answer from the Silence”, Silvan Faessler Fine Art GmbH, Zug, Svizzera
2013 “Bill Beckley: Facts (Fuck) I Love You”, Friedman Benda, New York, NY
“Flag Attempts”, Galerie Hans Mayer, Art Basel, Basilea, Svizzera
“Retrospective”, Galerie Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
2011 “Alternative Histories”, Exit Art, New York, NY
P420 Arte contemporanea e libri, Bologna
Galerie Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
Sammlung Hoffmann, Berlino, Germania
2010 “ArteFiera”, Studio Trisorio, Napoli/Roma
“New Works: Haben Gegenstände ein Gedächtnis”, Galerie Hans Mayer, Düsseldorf, Germania “Etcetera”, Tony Shafrazi Gallery, New York, NY
Rosenbaum Contemporary, Art Basel, Miami Beach, FL
2009 Galerie Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
Studio Trisorio, Napoli
Studio Trisorio, Roma
2008 “Ping-Pong Dialogues”, Chelsea Space, Londra, UK
Rosenbaum Contemporary Gallery, Boca Raton, FL
Galerie Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
2007 Park Ryu Sook Gallery, Seul, Corea del Sud
Bruna Soletti Gallery, Milano
Dorfman Projects, New York, NY
Galerie Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
2006 Rosenbaum Contemporary, Boca Raton, FL
2004 Robert McClain Gallery, Houston, TX
Studio Trisorio, Roma
Studio Trisorio, Napoli
2003 Galerie Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
Gallery Park Ryu-Sook, Seul, Corea del Sud
2001 “Fourteen Stations”, Tony Shafrazi Gallery, New York, NY New Works, Galerie Hans Mayer, Berlino, Germania
2000 “Selected works 1970-1999”, John Gibson Gallery, New York, NY
1998 Galerie Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
Galleria Milano, Milano
Studio Trisorio, Napoli
1997 John Gibson Gallery, New York, NY
Galerie Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
1986 Galerie Daniel Templon, Parigi, Francia
John Gibson Gallery, New York, NY
Studio Trisorio, Napoli
1984 Freidus/Ordover Gallery, New York, NY
“Retrospective”, Städtisches Museum Abteiberg, Mönchengladbach, Germania
1983 John Gibson Gallery, New York, NY
Galerie Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
1982 Studio Canaviello, Milano Bonlow Gallery, New York, NY
1981 Galerie Daniel Templon, Parigi, Francia
Marian Desson Gallery, Chicago, IL
International Center of Photography, New York, NY
Annina Nosei Gallery, New York, NY
1980 Nigel Greenwood Gallery, Londra, UK
Galerie Loyse Oppenheim, Ginevra, Svizzera
1979 Galerie Vera Munro, Amburgo, Germania
Nigel Greenwood Gallery, Londra, UK
Galerie Denise René, Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
1978 Studio G7, Bologna
Galerie Denise René, Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
“Art in Progress”, Monaco, Germania
1977 Galerie Daniel Templon, Parigi, Francia
Galerie Denise René, Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
Nigel Greenwood Gallery, Londra, UK
1976 Galleria D’Alessandro-Ferranti, Roma
John Gibson Gallery, New York, NY
Galleria Lucio Amelio, Napoli
1975 Galerie Yvon Lambert, Parigi, Francia
Galerie Patrick Verelst - Marc Poitier dit Caulier, Anversa, Belgio
Steinway Hall, New York, NY
Galleria FranÇoise Lambert, Milano
Gallery 20, Amsterdam, Paesi Bassi
1974 Gallery 20, Amsterdam, Paesi Bassi
FranÇoise Lambert, Milano
John Gibson Gallery, New York, NY
1973 John Gibson Gallery, New York, NY
Nigel Greenwood Gallery, Londra, UK
Galerie Konrad Fischer, Düsseldorf, Germania
1972 98 Greene Street, Holly Solomon, New York, NY 112 Greene Street Gallery, New York, NY Gallery 20, Amsterdam, Paesi Bassi
Galerie Rudolf Zwirner, Colonia, Germania
Galleria FranÇoise Lambert, Milano
1971 93 Grand Street, New York, NY
1969 Wabash Transit Gallery, Chicago Art Institute, Chicago, IL
Principali mostre collettive
2017-2018 “Narrative Art”, Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Etienne, Saint-Priest-en-Jarez, Francia
2015 “Art on Camera: Photographs by Shunk-Kender, 1960-1971”, MoMA, New York, NY
2014-2015 “Bad Thoughts – Collection Martjiin and Jeannette Sanders”, Stedelijk Museum, Amsterdam, Paesi Bassi
2013 “Color”, Andrae Kaufmann Gallery, Berlin, Germania
Galerie Hans Mayer, Düsseldorf, Germania
“And Those Who Were Seen Dancing Were Thought To Be Insane by Those Who Could Not Hear the Music”, Friedman Benda, New York, NY
2011 “112 Greene Street: A Nexus of Ideas in the Early 70s”, Salomon Contemporary, New York, NY
“Narration works of 1970 by Bill Beckley, Peter Hutchinson and Franco Vaccari”, P420 Arte contemporanea e libri, Bologna Rosenbaum Contemporary, Boca Raton, FL
2010 “Alternative Histories”, Exit Art, New York, NY
2004 “Behind the Facts, 1968-1974”, curata da Gloria Maure, Miro Foundation, Barcelona, Spagna
“Behind the Facts, 1968-1974”, curata da Gloria Maure, Serralves Museu, Porto, Portogallo
“Behind the Facts, 1968-1974”, curata da Gloria Maure, Miro Foundation, Kassel, Germania
Four Artists, Dorfman Projects, New York
2002 “Made in USA: Keith Haring, Robert Longo, Kenny Scharf, Bill Beckley”, Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen, Germania
Art Downtown, curata da Richard Marshal, New York, NY
1968-1977, L’art en cause, Capo Musée d’art Contemporain de Bordeaux, Bordeaux, Francia
2000 Critic as Grist, curata da Michael Portnoy e Marianne Vitale, White Gallery, New York, NY
Narrative, Studio G7, Bologna
Sammlung Hoffman, Berlino, Germania
Daimler-Benz Collection, Berlino, Germania
1999 Sammlung Falckenberg Museum der bildenden KÜnste, Lipsia, Germania
“17 Contempory Artists from America, Italy, and Mexico”, The Menil Collection, Houston, TX
“Heroines and Heros”, Cynthia Broan Gallery, New York, NY
1996 “Five Easy Pieces”, Ace Gallery, Los Angeles, CA 1995 “Five Easy Pieces”, Ace Gallery, New York, NY 1994 Galerie Hans Mayer, Düsseldorf, Germania Foundation Chateau de Jau, Cases de Pènes, Francia 1993 Galeria Pedro Oliveira,
Portogallo 1992 “On The Road To Ra”, American Opera Projects, New York, NY
1991 John
New York, NY
1990 Galerie
1989
Porto,
Studio Trisorio, Napoli
Gibson Gallery,
“Drawings”, Ace Contemporary Exhibitions, Los Angeles, CA
Daniel Templon, Parigi, Francia
Galleria Milano, Milano Studio G7, Bologna 1987 Tony Shafrazi Gallery, New York, NY
“Americans in France”, Loge de mer, Perpignan, Francia
1998 “Fotoz”, Siqueiros Koll Gallery, Los Angeles, CA
“Fotoz”, Spiral Lounge, New York, NY
“Project Plans”, John Gibson Gallery, New York, NY
“Acts of Faith”, Abraham Lubelski Gallery, New York, NY
1997 “L’Arte in Faccia”, Associazione Nazionale d’Arte Moderna, Milano
“Twentieth Anniversary Exhibition”, Chateau de Jau, Cases de Pène, Francia
“The @ Show”, Satellite Gallery, Long Island City, NY
1996 “Artist’s Photographs”, John Gibson Gallery, New York, NY
“Narrative Art”, Palazzo Rasponi Murat, Ravenna
1995 Narrative Art, Studio G7, Bologna
1994 “John Gibson, Conceptual Photographs Venticinquesimo”, Studio d’Arte Cannaviello, Milano
1993 “Collection of Vicky Remy”, Musee d’Art Modern, St. Etienne, Francia
1992 “The Seventies”, John Gibson Gallery, New York, NY
1991 “Buchstäblich”, Von der Heydet Museum, Wuppertal, Germania
“Home Show”, con il sostegno di Pat Hern Gallery, New York, NY
“Group Show”, Elysium Art Source, New York, NY
1990 “American Express”, John Gibson Gallery, New York, NY
“Aquarian Artists”, Fine Arts Center, Kingston, RI
1989 “Image World: Art and Media Culture”, Whitney Museum of American Art, New York, NY
“Annual 7”, Mandeville Gallery, University of California, San Diego, CA
“Words”, Tony Shafrazi Gallery, New York, NY
“Text and Photograph”, John Gibson Gallery Micro-Sculpture Show, University of Rhode Island, RI
“Story Art”, Heidelberger Kunstverein, Bonner Kunstverein, Drefelder Kunstverein, Germania
1978 “American Story Art”, Contemporary Art Museum, Houston, TX
“American Story Art”, Contemporary Art Center, New Orleans, LA
“American Story Art”, Art Gallery, Winnipeg, Canada
“American Story Art”, University of California, Santa Barbara and Berkley, CA
1977 “The Surrealist Heritage”, Sterling and Francine Clark Art Institute, Williamstown, MA
“Documenta 6”, Paul Dierichs Verlag, Kassel, Germania
1976 “Narrational Imagery: Beckley, Rusch, Warhol”, University of Massachusetts, Amherst, MA
“Sequenced Photographs”, La Biennale di Venezia
“Sequenced Photographs”, University Art Museum, Austin, TX
“Sequenced Photographs”, Broxtan Art Gallery, Los Angeles, CA
1975 “Camera Art”, Lund Kunsthalle, Berlin, Germania
“Sequenced Photographs”, University of Maryland Gallery, College Park, MD
“Toys”, the Clocktower, New York, NY
“Report From SoHo”, Grey Art Gallery, New York, NY
“Word, Image, Number”, Sarah Lawrence Gallery, New York, NY
Biennale de Paris, Parigi, Francia
1974 “Narrative 2”, John Gibson Gallery, New York, NY
“Photographic Art”, Flash Art, Milano
“Verbal Visual 3”, John Gibson Gallery, New York, NY
“Narrative Art”, Studio d’arte Canaviello, Roma
“Art and Architecture”, Royal College of Art, Londra
1973 “7”, Museum of Modern Art, New York, NY
1988
“This is Not a Photograph”, Akron Art Museum, Akron, OH
“This is Not a Photograph”, The Chrysler Museum, Norfolk, VA
“Large Scale Photography”, Los Angeles County Museum, L.A., CA
“Ten Years of Collecting, 1976-86”, Edward Downe Collection, Davis Museum, Wellesley, MA
“Story”, John Gibson Gallery, New York, NY
“Xerox Show”, Rochester, NY
Richard Fonke Gallery, Gent, Belgio
“Contemporanea”, Roma
1987
“This is Not a Photograph”, The John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota, FL
1986 “New Painting and Sculpture”, Indianapolis Museum, Indianapolis, IN
1985 “A New Beginning”, Hudson River Museum, New York, NY
1984 “Collage Expanded”, School of Visual Arts Museum, New York, NY
“Sex Show”, Cable Gallery, New York, NY
“Plastic”, Miriam Perle Gallery, New York, NY
1983 “Rupture, pas Rupture?”, Creation Art Press, Centre Culturel de Paris, Parigi, Francia
“Kunst mit Photographe”, Nationalgalerie, Berlino, Germania
“Kunst mit Photographe”, Kölnischer Kunstverein, Colonia, Germania
“Kunst mit Photographe”, MÜnchner Stadt Museum, Monaco, Germania
“Kunst mit Photographe”, Kunsthalle Zu Keil, Germania
1981 “A Seventies Selection”, Miami Art Museum, Oxford, OH
“Alternatives in Retrospect”, The New Museum, New York
1980 “Pier and Ocean”, Hayward Gallery, Londra, UK
“Pier and Ocean”, Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo, Paesi Bassi
“Photographic Art”, Museum of Modern Art, Parigi, Francia
1979 Whitney Biennial Exhibition, New York, NY
“Three Game Installations”, 112 Greene St., New York, NY
1972 “Projects Pier 18”, Museum of Modern Art, New York, NY
“Spaces”, School of Visual Arts, New York, NY
“112 Greene St.”, New York, NY
1970 “112 Greene Street”, New York, NY
1969 “Untitled”, Cheltenham, PA
“Art in the Mind”, Allen Memorial Art Museum, Oberlin, OH
Premi
Pollock-Krasner Grant, 1997
New York Council of the Arts, 1986
National Endowment of the Arts, 1979
New York Council of the Arts, 1976
New York Council of the Arts, 1973
Conferenze e simposi
Uncontrollable Beauty (Simposio) con Arthur Danto, Peter Schjeldahl, Jeremy Gilbert-Rolfe, e Bill Beckley at the School of Visual Arts, New York, maggio 1998
Keynote Speaker, Discussione su “Art and Design Theory” nell’ambito del 1998
International Association of Art and Design Schools, General Assembly New York, ottobre 1998
Uncontrollable Beauty (Simposio) con Wendy Steiner, Lillie Wei e Bill Beckley, Tyler School of Art, Temple University, Filadelfia, novembre 1998
On recent work (Conferenza), Accademia di Belle Arti, Napoli, maggio, 1998
On Art and Language (Simposio) con Benjamin Buchloh, Martha Rossler, David Shapiro, e Bill Beckley, School of Visual Arts, New York, 1984
On recent work (Conferenza), Princeton University, New Jersey, 1982
On Narrative Art (Simposio), con Mac Adamsand Jim Collins, University of Calgary, Canada, 1979
On Narrative Art (Conferenza), Royal College of Art, Londra, 1973
Pubblicazioni
Beckley, Katherine Aguilar, Portillo, Roberto (a cura di), The Death of Photography and Other Modern Fables on the Visual Arts Delano Greenidge Editions and The School of Visual Arts, New York 2004
Beckley, Bill (a cura di), Sticky Sublime, Allworth, New York 2001
Beckley, Bill, Introduction, in Ratcliff, Carter, Out of the Box, Allworth Press, New York 2000
Beckley, Bill, Introduction, in Gilbert-Rolfe, Jeremy, Beauty and the Contemporary Sublime Allworth Press, New York 1999
Beckley, Bill, Introduction: Doubting Thomas, in McEvilley, Thomas, Sculpture in the Age of Doubt, Allworth - School of Visual Arts, New York 1999
Beckley, Bill, Introduction: Generosity and the Black Swan in Uncontrollable Beauty, Toward a New Aesthetics, a cura di Bill Beckley e David Shapiro, Allworth Press, New York 1998
Beckley, Bill, Introduction, in Morgan, Robert C., The End of the Art World, Allworth - School of Visual Arts, New York 1998
Beckley, Bill, Introduction: Rocket Man, in Imaginary Portraits a cura di John Ruskin, Allworth, New York 1997
Beckley, Bill, Introduction, in Lectures on Art a cura di John Ruskin, Allworth, New York 1996
Bibliografia selezionata
10 Jahre Sammlung Sal. Oppenheim 10 Years Collection Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., Luxemburg 2007
Beckley, Connie, Connie Beckley: performances & installatie - Bill Beckley: partituren / tekeningen, de Vleeshal Middelburg mei-juli 84, Middelburg: Gemeente Middelburg, Bureau Culturele Zaken, 1984
Brentano, Robyn, 112 Workshop, 112 Greene Street: history, artists & artworks, New York University Press, New York 1981
Godfrey, Tony, Conceptual Art, Phaidon, London 1998
Grundberg, Andy e McCarthy-Gauss, Kathleen, Photography And Art Interaction Since 1946, Abbeville Press, New York 1987
Hoy, Anne H., Fabrications: Staged, Altered, and Appropriated Photographs, Abbeville Press, New York 1988
Hunter, Sam, American Art of the 20th Century, Abrams, New York 1979
Krauss, Rolf H., Schmalriede, Manfred and Schwarz, Michael, Kunst Mit Photographie, Frolich and Kaufmann, Berlin 1983
Naylor, Colin e P-Orridge, Genesis (a cura di), Contemporary Artists, St. James Press, London 1977
Bonito Oliva, Achille, Europe/America: The Different Avant Gardes, Deco Press, Milano 1976
Papadakis, Andreas, Farrow, Clare and Hodges, Nicola (a cura di), New Art: An International Survey. Rizzoli, New York 1991
Ruf, Beatrix, Kunst bei Ringier 1995-1998, Ringier AG, Zürich 1998
Sabau, Luminita, Index: Fotografie. DZ BANK Sammlung im Städel Museum Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2008
Sabau, Luminita (a cura di), The Promise of Photography Prestel Press, München 1998
Shapiro, David, Bill Beckley: The Art of Liberty 1969-1994, Galerie Hans Mayer Dusseldorf - Chateau de Jau, Dusseldorf - Perpignan 1994
Tannenbaum, Judith, New York Art Yearbook, vol. 1, 1975-76, Noyes Art Books, New York 1976
Articoli selezionati
Herriman, Kat. For the Birds, in W Magazine, 16 settembre 2015
Jordan, Eliza, Bill Beckley, in “Whitewall”, estate 2015
North America’s Must-See Exhibitions This Fall in “ArtSlant”, settembre 7, 2015
Wisniewski, Katherine, In a SoHo Loft, New York City’s 1970s Art Scene Lives On, in “Curbed”, 3 agosto 2015
Small, Rachel, Bill Beckley, Beyond the Rooster in “Interview”, 22 novembre 2013
Haden-Guest, Anthony, Anthony Haden-Guest’s New York in “The Art Newspaper: International Edition”, novembre 2013
Studio Visit: Bill Beckley, in “The Avant/Garde Diaries”, 29 ottobre 2013
Wayne, And Those Who Were Seen Dancing Were Thought To Be Insane by Those Who Could Not Hear the Music in “The Imagist”, 15 luglio 2013
Hernandez, Jennifer, AND THOSE WHO WERE SEEN DANCING..., in “Cultured Magazine”, 24 luglio 2013
Omojola, Ope, Raunch & Revelry: Nightlife at Friedman Benda Gallery, in “Opening Ceremony New News”, 23 luglio 2013
Colucci, Emily, Art Attack at Friedman Benda’s Glamorous Nightclubbing Exhibition in “Societe Perrier”, 23 luglio 2013
Baumgardner, Julie. “About Last Night | A Chelsea Gallery, Made Over as a Decadent Nightclub, in The New York Times Style Magazine. July 18, 2013
Small, Rachel, Art’s Wild Night Out, in “Interview”, 17 luglio 2013
Cooper, Ashton, Friedman Benda Curator on Turning Excessive Partying Into an Art Show, in “ARTINFO”, 16 luglio 2013
Zhong, Fan, Nights to Remember, in “W Magazine”, 16 luglio 2013
Lescaze, Zoë, Russeth, Andrew, Miller, Michael H. and Duray, Dan, 11 Things to Do in New York’s Art World Before July 21, in “Gallerist NY”, 15 luglio 2013
Maida, Stephanie, Everything You Need to Know This Week On New York’s Art Scene, in “Guest of a Guest”, 14 luglio 2013
Addenda: Five More Great Summer Group Show Titles at New York City Galleries, in “ARTINFO”, 13 luglio 2013
Carrier, David, Silently Among Us: The Beauty of Bill Beckley, in “Art Critical”, 4 luglio 2010
Carrier, David, Tony Shafrazi Gallery Presents Three Decade Survey of Bill Beckley’s Art, in “Art Daily”, 13 luglio 2010
Maul, Tim, Bill Beckley, in “Art in America”, 11 settembre, 2010
Leffingwell, Edward, Review of Dorfman Projects show, in “Art in America” gennaio, New York, 2008
Martin, Courtney J, Bill Beckley: Ping-Pong Dialogues, in “Artforum”, 6 giugno 2008
McEvilley, Thomas, Review in “Art in America”, marzo, 2002
Two Stations Volume 2, #1, in “Smock Magazine”, inverno, 2002
Interview on The Connection, in “WBUR Boston”, 27 marzo 2002
Shapiro, David, 14 Stations/Fourteen Questions, in “New York Arts”, ottobre 2001
Morgan, Robert, Review of Gibson show, in “Review Magazine”, 15 marzo 2000
The American Sublime: Conversation with Bill Beckley and Louise Bourgeois in “Harpers Magazine”, settembre, 1998
Cahill, Tim, A Dialogue with Beauty Reappears in Contemporary Art, in “Christian Science Monitor”, 21 agosto 1998
Tabor, Mary, Think Tank: Rescuing Beauty, Then Bowing to Her Power, in “The New York Times”, 11 aprile 1998
Newhall, Edith, The Beauty Part, in “New York Magazine”, 23 marzo 1998
Caroli, Ela, Arte. I segni quotidiani dell’americano Beckley, in “Corriere del Mezzogiorno”, 22 maggio 1998
Il Sole, in “In Galleria”, 24 maggio 1998
Von Michael George-Muller, Zeitgenössische Kunst in DÜsseldorf, Wirtschaft, 1 marzo 1998
Goodman, Jonathan, Review of Gibson Exhibition, in Art in America. settembre, 1997
Newhall, Edith, Review of Gibson Exhibition, in “New York Magazine”, 17 marzo 1997
Gauville, Herve, Les acides mésalliances de Beckley, in “Liberation”, 20 agosto 1994
Vezin, Luc, Les codes de Bill Beckley, in “Info Matin”, 7 settembre 1994
Malepeyre, Luc, L’épouse du ministre de la Culture au vernissage de l’expo de Bill Beckley in “Midi Libre”, 26 giugno 1994
Jocks, Heinz-Norbert, Subtile Poesie des Banalen (recensione della mostra alla Galerie Hans Mayer), in “Westdeutsche Zeitung”, giugno, 1994
Reinke, Klaus U, FrÜchte gemeinsamer Strategie (recensione della mostra alla Galerie Hans Mayer), in “Handelsblatt”, 2 giugno 1994
Klause, Sebastian, EisgekÜhlte Poesie (recensione della mostra alla Galerie Hans Mayer), in “Düsseldorfer Feuilleton”, 27 maggio 1994
Pinto, Antonio Cerveria, Not Photography, in “Independente”, 12 giugno 1993
Faria, Óscar, Arte de Frabricar Histórias, in “Publico”, 3 giugno 1993
Faria, Óscar, Fabrica de textos in “Publico”, 17 maggio 1993
J.S.M., Text Factory, in “Artes & Leibnões”, giugno/luglio, 1993
Roberts, C.S., Riguer et la Rupture, in “Kanal Europe”, gennaio, 1993
Notte, Riccardo, Affidiamoci alla forza d’urto delle immagini assolute in “Roma”, 9 gennaio 1992
RTM T.V., Naples, Rome “Evening News”, 12 gennaio 1992
Rubenstein, Raphael, Review, in “Arts Magazine”, maggio, 1991
Jones, Alan. “Books in Artist’s Lives, in Arts Magazine, gennaio, 1991
Uridsany, Michel, Marathon Autor de Beauborg in “Le Figaro”, 11 settembre 1990
Bill Beckley, in “La Republique”, 8 giugno 1989
Christensen, Judith, Slices of Art and Life in “Artweek”, 6 maggio 1989
Shapiro, David, Review, in “Art Scribe”, novembre/dicembre 1988
Bell, Jane. “Bill Beckley, in “Art News”, gennaio, 1988
Dagbert, Anne, Bill Beckley, L’Archeologie du Tableau, in “Art Press”, n. 93, giugno, 1985
Brenson, Michael, Review, in “The New York Times”, venerdì, 6 aprile 1984
De Chairo, Tommaso, Lo Spazio-Tempo della Narrative Art, in “Terzoocchio”, marzo, 1984
Shapiro, David, The Text Factory: An Interview with Bill Beckley, in “Arts”, vol. 59, n. 2, ottobre, 1984
Kuspit, Donald B. “Exhibition review, in “Art in America”, vol. 72, n. 9, ottobre, 1984
Handy, Ellen, Exhibition Review, in “Arts”, vol. 58, n. 10, estate, 1984
Millet, Catherine, Rupture, pas Rupture? in “Art Press 70”, 1983
Bell, Jane, Exhibition Review, in “Artnews”, vol. 82, n. 8, ottobre, 1983
Davis, Douglas, After Photography, in “Village Voice”, 1-7 aprile 1981
Levin, Les, “Camera Art in “Artes Visuales”, n. 25, agosto, 1980
Lette-Darcy, Chantal, “Interview with Bill Beckley, in “Parachute”, n. 19, estate, 1980
Stevens, Mark, “The Dizzy Decade, in Newsweek. March 26, 1979
Alinovi, Francesca, “Humor and Thrills in Bill Beckley’s Stories in “Sommario”, vol. 3, n. 6, giugno, 1978
Frank, Peter, Auto Art, Self-Indulgent? And How!, in “Art News”, settembre, 1976
Stevens, Mark, The Dizzy Decade, in “Newsweek”, 26 marzo 1976
Krugman, Michael, Exhibition Review, in “Art in America”, vol. 64, n. 4., luglio/agosto, 1976
Radice, Barbara, Bill Beckley: La struttura della causale, in “Data Arte”, maggio/giugno, 1976 Jochimsem, Margareth, Story Art, in “Magazin Kunst”, n. 2, 1974
Collins, James, Narrative (recensione della mostra), in “Artforum”, settembre, 1974
Stoullig, Claire, Bill Beckley, Le Narrative Art in “Art Press”, n. 6, settembre / ottobre, 1973
A la 8 Biennale de Paris, in “Elle”, settembre 17, 1973
Boice, Bruce. “Exhibition Review: Bill Beckley, in “Artforum”, giugno, 1973
Collins, James, Exhibition Review: Story, in “Artforum”, settembre 1973
Lew, Jeffery e Saret, Alan, 112 Greene Street, in “Avalanche”, inverno, 1971
Rohm, Robert. Outdoor Sculpture - Sculpture Outdoors, in “Pukka Magazine”, settembre 1970
 Studio Trisorio, Napoli, 2016
Studio Trisorio, Napoli, 2016
 Studio Trisorio, Roma, 2006
Studio Trisorio, Roma, 2006
 Studio Trisorio, Napoli, 2019
Studio Trisorio, Napoli, 2019
 Bill Beckley, Studio Trisorio, Napoli, 2019
Bill Beckley, Studio Trisorio, Napoli, 2019
ELENCO DELLE OPERE
Capitolo uno - Punti d’ingresso
Myself as Washington, 1969
Fotografia in b/n
51 × 41 cm
Collezione privata, Bari
p. 8
Opere - Dagli anni ’60 agli anni ’70
Painting with Blue Squares, 1968 (in alto)
Painted Bushes for Sol LeWitt, 1968 (in basso)
p. 22
Painted Shrubs for Sol LeWitt 1969 Cespugli verniciati Fotografia
41 × 51 cm
p. 23
Twigs Painted White, 1969
Rami verniciati Fotografia 33 × 48 cm
p. 24
Vertical Horizon 1969
Rami verniciati
Fotografia
33 × 48 cm
p. 25
From Sunrise to Sunset, Looking West at Midday 1969
Una linea dipinta sui campi dall’alba al tramonto di 0,91 × 805 m
Fotografia
33 × 48 cm
p. 26
From Sunrise to Sunset (Sunrise) 1969
Una linea dipinta sui campi dall’alba al tramonto di 0,91 × 805 m
Fotografia 48 × 33 cm
p. 27
Washington’s Crossing 1969
Album di fotografie, cartolina, inchiostro su carta a righe
33 × 30,5 cm
p. 29
Six Minute Paper Punch Lines April 21, 1969
Inchiostro su carta millimetrata
10,2 × 56 cm (ciascun foglio)
p. 31
Song for a Chin-Up, 1972
Fotocollage e testo su cartoncino
51 × 75,5 cm
Collezione Galleria P420, Bologna
p. 32
Song for a Chin-Up, 1971
Performance di uno studente della Juilliard School, NYC
p. 33
Song for a Sliding Board 1971
Performance di uno studente della Juilliard School, NYC
p. 35
Turtle Trumpet, 1971
Performance di Bill Beckley
Foto Shunk-Kender
p. 37
Brooklyn Bridge Swings, 1971
Installazione al Brooklyn Bridge, NYC
p. 39
Silent Ping Pong Tables, 1971
62 × 122 × 86 cm
Installazione alla John Gibson Gallery, NYC
Foto Shunk-Kender
Collezione privata, Düsseldorf
p. 40
Short Story for Hopscotch, 1971
266 × 275 cm
Foto Shunk-Kender
p. 40
Study for Short Stories for Popsicles, 1971
Involucro di carta, ghiacciolo, bastoncino di ghiacciolo serigrafato
30 × 41 cm
p. 41
The Origin of And 1972
Fotografie in b/n e testo scritto
76 × 203 cm
Collezione Gianfranco D’Amato, Napoli pp. 42-43
An Avoidance of Ann, 1972
Fotografia in b/n e testo scritto
71 × 106,7 cm
Collezioni: Hoffmann, Berlino; Holly Solomon, New York; Gianfranco D’Amato, Napoli
p. 45
Capitolo due - Il binomio parola-immagine
Cake Story 1973
Stampa Cibachrome e fotografia in b/n 83 × 52 cm
Collezioni: Collezione privata, Colonia; Falckenberg, Amburgo; Galleria Hans Mayer, Düsseldorf; Studio Trisorio, Napoli p. 48
Joke about Elephants, 1973
Fotografie in b/n 63,5 × 46 cm p. 55
Opere - Dagli anni ’70 agli anni ’90
De Kooning’s Stove, 1974
Fotografia in b/n e stampa Cibachrome 104 × 157 cm
Collezioni: Fioravanti-Meoni, Siena; collezione privata, Colonia pp. 60-61
Roses Are, Violets Are, Sugar Are, 1974
Stampe Cibachrome 95 × 228 cm
Collezione privata, Bologna pp. 62-63
Paris Bistro, 1974
Stampe Cibachrome
185 × 102 cm
Collezioni: Sylvio Perlstein, Anversa; collezione privata, Germania; Andrea e Paola Abbamonte, Napoli p. 65
Circle Line, 1974
Stampe Cibachrome e fotografia in b/n
102 × 305 cm
Collezione Princeton University Art Museum
pp. 66-67
The Elevator, 1974
Stampe Cibachrome e fotografia in b/n
165 × 305 cm
pp. 68-69
Snake Story 1974
Stampa Cibachrome e fotografia in b/n
77,5 × 50,8 cm
p. 71
Rabbit Turtle, 1974
Fotografie in b/n
96,5 × 520,7 cm
pp. 72-73
Sad Ending, 1975
Stampa Cibachrome e fotografie in b/n
60 × 200 cm
Collezione Di Bennardo, Napoli pp. 74-75
Drop and Bucket, 1975
Stampe Cibachrome
475 × 152,4 cm
Collezioni: Kunst Museum, Basilea; Campiani, Brescia; Fioravanti-Meoni, Siena; Perlstein, Anversa
p. 77
Hot and Cold Faucets with Drain
1975 e 1994
Stampe Cibachrome
102 × 229 cm e 152 × 381 cm
Collezioni: Museum of Modern Art, New York; Fioravanti-Meoni, Siena; Galleria P420, Bologna
pp. 78-79
Mao Dead 1976
Stampe Cibachrome e fotografie in b/n
101 × 304 cm
Collezioni: Museum of Modern Art, New York; Hoffmann, Berlino; Gianfranco
D’Amato, Napoli
pp. 80-81
Boat, 1976
Stampe Cibachrome e fotografie in b/n
102 × 305 cm
Collezione Falckenberg, Amburgo pp. 82-83
Bus, 1976
Stampe Cibachrome e fotografia in b/n
203 × 229 cm
Collezioni: Gerhard e Lydia Hanske, Essen; Galleria Hans Mayer, Düsseldorf p. 85
Elements of Romance, 1977
Stampe Cibachrome
101,6 × 304,8 cm
Collezioni: Château Vignelaure, Rians; Daimler Art, Stoccarda; Estate of Sol
LeWitt
pp. 86-87
The Bathroom 1977
Stampe Cibachrome e fotografia in b/n
130 × 305 cm
Collezioni: Hoffmann Berlino; Lize Tourbon, Parigi pp. 88-89
The Living Room 1977
Stampe Cibachrome e fotografia in b/n
127 × 304,8 cm
Collezioni: Museum of Fine Arts, Boston (studi preparatori); Rolf Krauss, Stoccarda; Galleria Hans Mayer, Düsseldorf pp. 90-91
The Kitchen, 1977
Stampe Cibachrome e fotografia in b/n 279,4 × 203,2 cm
Collezione Miriam Solomon, Parigi p. 93
Roses Are, Violets Are, Sugar Are, 1978
Stampe Cibachrome 243 × 343 cm
3 versioni diverse
Collezioni: DZ Bank; Städel Museum, Francoforte; Hoffmann, Berlino pp. 94-95
Rising Sun, Falling Coconut 1978
Stampe Cibachrome
305 × 101 cm
Collezioni: Douglas Chrismas, Los Angeles; Dr. Praue, Berlino p. 97
Shoulder Blade, 1978
Stampe Cibachrome e fotografie in b/n 305 × 101 cm
Collezioni: Jeff Koons, New York; Gianfranco D’Amato, Napoli p. 99
Deirdre’s Lip, 1978
Stampe Cibachrome e fotografia in b/n 177,8 × 304,8 cm
Collezioni: Smithsonian American Art Museum, Washington D.C.; Pizzuti, Columbus; Gianfranco D’Amato, Napoli pp. 100-101
Cah Beneath the Grass, 1980
Stampe Cibachrome e tubi di alluminio
267 × 234 cm
Collezione Peter Bren, New York p. 102
264
Pipes and Hics 1980
Stampe Cibachrome e tubi di alluminio
272 × 221 cm
Collezione Tate Modern, Londra p. 103
Cherubs V.S. Saucers, 1985
Tecnica mista su carta Arches
105 × 75 cm
Collezione Studio Trisorio, Napoli p. 104
History of Handles and Spinning Wheel of Fortune 1985
Tecnica mista su carta Arches
105 × 75 cm
Collezione Studio Trisorio, Napoli p. 105
Peaches 1985
Tecnica mista su carta Arches
105 × 75 cm
Collezione privata, Bari p. 107
Gardens of Pompeii 1986
Tecnica mista su tela
187 × 81,5 cm
Collezione privata, Bari p. 108
Gardens of Pompeii 1986
Tecnica mista su tela
187 × 81,5 cm p. 109
House of Pompeii, 1986
Tecnica mista su tela
187 × 81,5 cm
Collezione Studio Trisorio, Napoli p. 111
House of the Red Capitals, 1986
Acrilico su tela
152,5 × 102 cm p. 112
Villa of the Mysteries 1986
Tecnica mista su tela
152,5 × 102 cm p. 113
BiPlane or How to Tie a Bowtie in Four Easy Lessons, 1987
Legno compensato, gomma, fotografie in b/n
304,8 cm apertura alare pp. 114-115
Sunday Paper 1987
Fotografie in b/n, compensato, tessuto 130 × 152 cm p. 116
Bess Truman Having Tea with Her Friends 1987
Fotografia in b/n, compensato, tessuto, bambole di pezza
130 × 152 cm p. 117
Front Porch 1987
Fotografie, felci, zanzariera
152 × 488 cm
Installazione alla Ace Gallery, Los Angeles p. 118
Frank (Homage to Frank O’Hara), 1987
Fotografie in b/n, carta da parato, gamba di piano, pila di quotidiani “The New York Times” (tutti dello stesso giorno)
203 × 305 cm
Collezione Galleria Hans Mayer, Düsseldorf p. 119
The Juggler 1990
Stampe Cibachrome, gesso, piombo, pelle di serpente 244 × 244 cm p. 121
Study for # 5 of Seven Sins, 1991
Tecnica mista su carta museale
101 × 82 cm
Collezione Maria Letizia Pelosi, Napoli
p. 122
Study for # Seven of Seven Sins 1991
Tecnica mista su carta museale
101 × 82 cm
Collezione Studio Trisorio, Napoli p. 123
Study for # 3 of Seven Sins, 1991
Tecnica mista su carta museale
101 × 82 cm
Collezione Studio Trisorio, Napoli
p. 124
Study for Apple Pie, 1991
Tecnica mista su carta museale
101 × 82 cm
Collezione privata, Roma
p. 125
Study for Fish Fry # 3, 1991
Tecnica mista su carta museale
101 × 82 cm
Collezione Studio Trisorio, Napoli
p. 126
Study for Chopsticks 1991
Tecnica mista su carta museale
152,5 × 102 cm
Collezione Studio Trisorio, Napoli
p. 127
Bloody Mary, 1994
Stampe Cibachrome, feltro, bronzo patinato
73 × 152 cm
Collezione Esther Grether, Basilea pp. 128-129
Mixed Drinks: Margarita (Gabon, Mexico, United States), 1994
Stampe Cibachrome, tessuto, bronzo patinato
73 × 152 cm
Collezione Hoffman, Berlino
pp. 130-131
Niçoise at Sunrise, 1997
Stampe Cibachrome
138 × 278 cm
Collezione Siegfried Weishaupt, Ulm
pp. 132-133
Down the Drain “Weeping Woman”, 1997
Struttura in legno e stampa Cibachrome
Ø 229 cm
p. 134
Down the Drain, Black, 1997
Struttura in legno e stampa Cibachrome
Ø 229 cm
p. 135
Capitolo tre - L’estetica del bello
Heroin Trade in Afghanistan (Lineup) 2008
Stampa Cibachrome
196 × 122 cm
p. 138
Last Judgment 10 2002
Stampa Cibachrome
157 × 122 cm
Collezioni: Sal. Oppenheim, Colonia; Palm Beach Gardens, Florida p. 143
Station 1, 2001
Stampa Cibachrome
205 × 110 cm
Collezioni: Hoffmann, Berlino; collezione privata, Düsseldorf p. 146
Three Graces 4 2004
Stampe Cibachrome
In due diverse dimensioni:
195 × 235 cm
241 × 293 cm p. 149
Heroin Trade in Afghanistan, Saturday Night, 2005
Stampe Cibachrome
241 × 340 cm
Collezioni: collezione privata, Allschwil, Svizzera; collezione privata, Marsiglia
p. 152
Opere - Steli
Station 7, 2001
Stampa Cibachrome
205 × 110 cm p. 158
Station 8, 2001
Stampa Cibachrome
205 × 110 cm
Collezioni: collezione privata, Düsseldorf; collezione privata, Sardegna
p. 159
Station 14 2001
Stampa Cibachrome
205 × 110 cm
Collezioni: collezione privata, Düsseldorf; collezione privata, Sardegna p. 161
Station 9 2001
Stampa Cibachrome
205 × 110 cm
Collezione Fioravanti-Meoni, Siena p. 163
Station 15 (Pink, I Think), 2002
Stampe Cibachrome
205 × 230 cm
Collezione privata, Aspen, Colorado
pp. 164-165
Last Judgment 9 2002
Stampa Cibachrome
157 × 122 cm
Collezioni: Park Ryu Sook Gallery, Seul; Agathe e Maximillian Weishaupt, Monaco; collezione privata, Germania p. 167
Three Graces 2004
Stampe Cibachrome
192 × 230 cm
Collezione privata, Zurigo p. 169
Patriotism Spelled Backwards 5, 2004
Stampe Cibachrome
193 × 230 cm
Collezioni: Essl, Klosterneuburg, Austria; collezione privata, Liebefeld, Svizzera p. 171
American Gothic 2004
Stampe Cibachrome
122 × 205 cm
Collezione privata, Zurigo
pp. 172-173
On Being Blue 7 2004
Stampe Cibachrome
195,5 × 190,5 cm
Collezione Studio Trisorio, Napoli p. 175
Rendez-vous in Tienanmen Square (The Aftermath), 2004
Stampa Cibachrome
194 × 99 cm
Collezione Studio Trisorio, Napoli p. 177
Singles Bar - Blue 2004
Stampa Cibachrome
191 × 36 cm
Collezione privata, New York
p. 178
Singles Bar - Red 2004 Stampa Cibachrome
191 × 36 cm
Collezione privata, Napoli p. 179
Heroin Trade in Afghanistan 1 (Tattered Flag) 2005 Stampa Cibachrome 196 × 99 cm
Collezioni: Galleria Hans Mayer, Düsseldorf; collezioni private, Monaco, Basilea, Zurigo p. 180
Heroin Trade in Afghanistan 4 (The Huddle), 2005 Stampa Cibachrome 196 × 99 cm p. 181
Heroin Trade in Afghanistan: For Those Who Have Died and Are Forgotten 2005 Stampa Cibachrome 193 × 100 cm
Collezione privata, Svizzera p. 183
A Drop of Water in the Breaking Gulf, 2005 Stampe Cibachrome In tre diverse dimensioni: 224 × 328 cm 196 × 287 cm 120 × 171 cm
Collezioni: Studio Trisorio, Napoli; Maurizio Petta, Bologna; collezione privata, Bruxelles; collezioni private, Germania pp. 184-185
Not That There’s Anything Wrong with It 3, 2005 Stampa Cibachrome 195,6 × 92,7 cm p. 186
Heroin Trade: The Intersection of 44/55 and 209 2008 Stampa Cibachrome 195,6 × 208,3 cm
Collezione Zappa, Lecco p. 187
Oh to Be Young Carefree and Gay
Epilogue 1, 2005
Stampe Cibachrome
147,8 × 133,2 cm p. 189
Capote White 4, 2014
Stampa Cibachrome
193 × 119,4 cm p. 191
Charge of the Chicken Men 2009
Stampa Cibachrome
196 × 122 cm p. 192
Dervish 4, Bayrami 2007
Stampa Cibachrome
196 × 122 cm
Collezioni: Park Ryu Sook Gallery, Seul; Rosenbaum Contemporary, Boca Raton, FL p. 193
Dervish 10, Sunbuli, 2007
Stampa Cibachrome
196 × 122 cm
Collezioni: Fred Dorfman, New York; Siegfried Weishaupt, Ulm; collezioni private, Germania, Svizzera p. 195
Capitolo quattro - Neapolitan Holidays
Study for Horse Thieves, 2019
Stampa Archival a getto d’inchiostro
e matita su carta museale
81 × 102 cm
p. 198
Opere - Neapolitan Holidays, 2019
Neapolitan Holidays, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond
250 × 95,5 cm
Collezione Gianfranco D’Amato, Napoli
p. 209
War, Artillery and a Few Questions 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond
95,5 × 250 cm
p. 210-211
Darling Young Son 1, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond
95,5 × 250 cm
Collezione Gianfranco D’Amato, Napoli
pp. 212-213
Cambridge Trampoline Society 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond
250 × 95,5 cm
Collezione Luca Cordero di Montezemolo, Roma
p. 214
Bird Watching, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond
250 × 95,5 cm
p. 215
Buzz, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond
250 × 95,5 cm
p. 216
Land of Lemon Trees, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond
250 × 95,5 cm
p. 217
The Gossip Girl 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond
95,5 × 250 cm
pp. 218-219
PM Mysteries, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond
95,5 × 250 cm
pp. 220-221
Dinner with Parmenides, 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond
250 × 95,5 cm
p. 222
Dinner with Parmenides II 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond
250 × 95,5 cm
p. 223
I Kissed a Clown 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 250 × 95.5 cm p. 224
What about Virgil? 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 250 × 95,5 cm p. 225
Horse Thieves 2019
C-print su Fujiflex montata su Aludibond 95,5 × 250 cm
Collezione Gianfranco D’Amato, Napoli pp. 226-227
Bill Beckley e la Narrative Art
Il binomio parola-immagine e l’estetica del bello
Bill Beckley desidera ringraziare
Gianfranco D’Amato
David Carrier
Andrea Viliani
Pasquale Trisorio
Lucia Trisorio
Laura Trisorio
Paola Trisorio
Valeria Cacciapuoti
Laurie Johenning
Tristan Beckley
Liam Beckley
Copertina Hot and Cold Faucets with Drain
1975, particolare
Coordinamento editoriale ed editing
Studio Trisorio, Napoli
Progetto grafico e impaginazione
Paola Trisorio
Traduzione del testo di David Carrier
Gabriella Rammairone
Crediti fotografici
Nicola Amato, p. 107, 108
Amedeo Benestante, p. 109
Giuseppe Schiavinotto, pp. 125, 243
Francesco Squeglia, pp. 104, 105, 111, 112, 113, 122, 123, 124, 126, 127, 256-257, 260-261, 262-263
Responsabile editoriale
Marco Vianello
Coordinamento editoriale
Federica Boragina
Graphic Design
Angelo Galiotto
Redazione
Laura Guidetti
© Barnett Newman by SIAE 2022
© Bill Beckley, New York
© Gli autori per i loro testi
© Studio Trisorio, Napoli
© 2022 Electa S.p.A., Milano
Tutti i diritti riservati
www.electa.it
Questo volume è stato stampato per conto di Electa S.p.A. presso O.G.M. Spa, via 1a Strada 87, Padova, nell’anno 2022










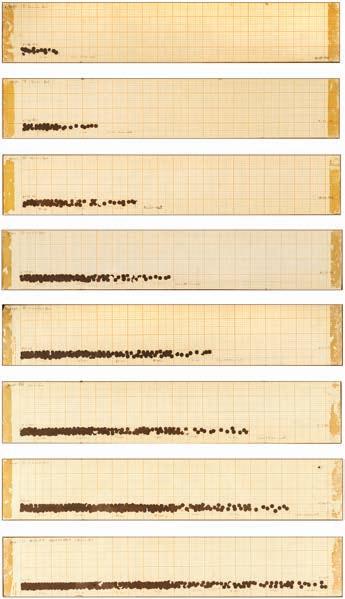

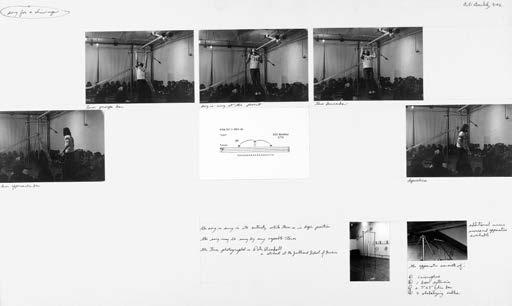

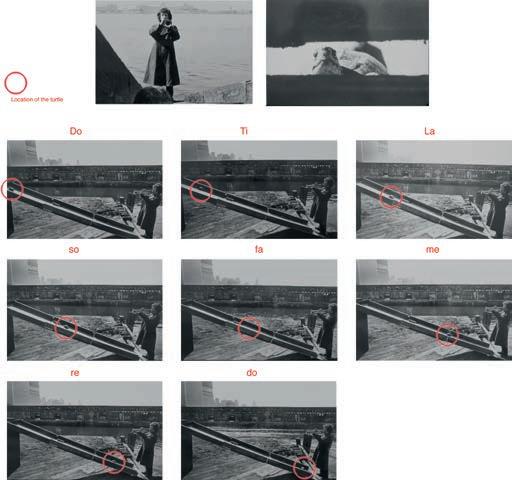



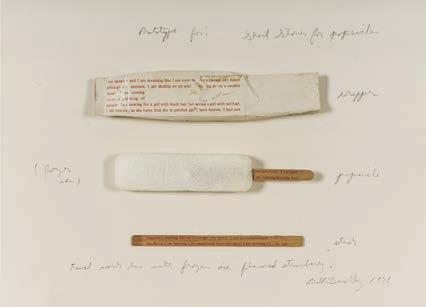



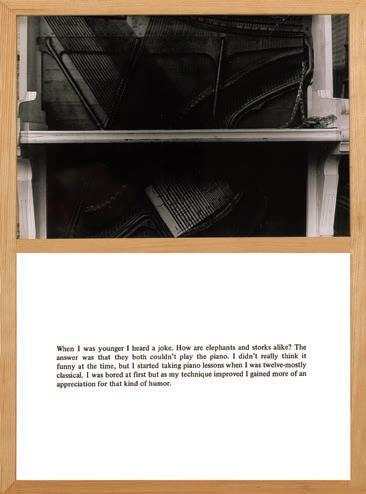
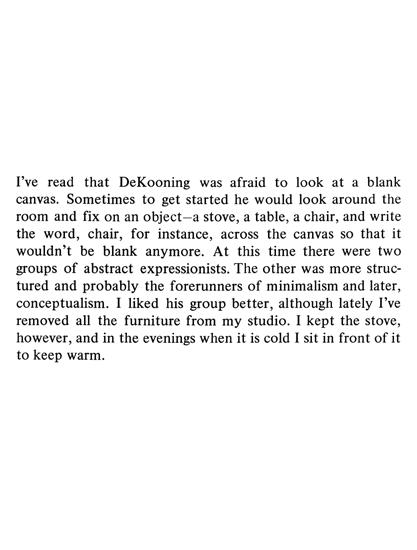


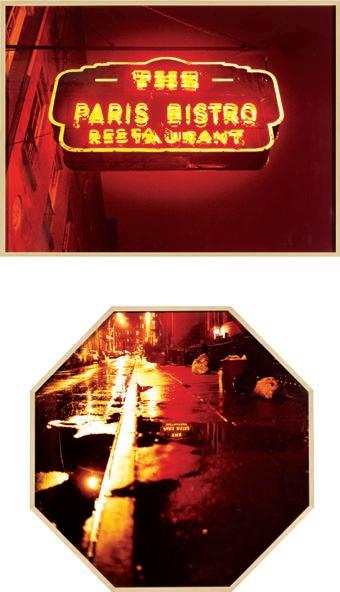
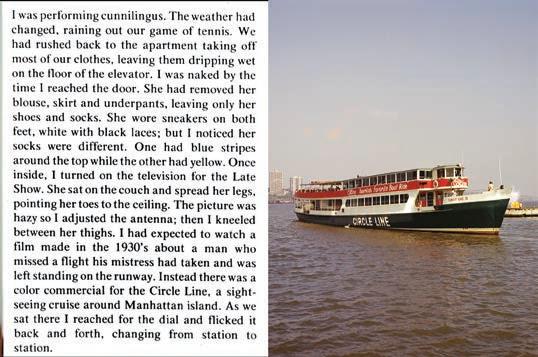
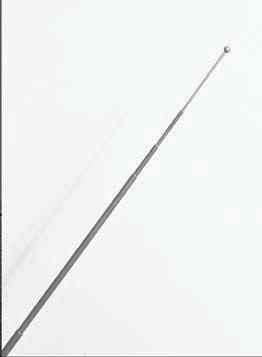


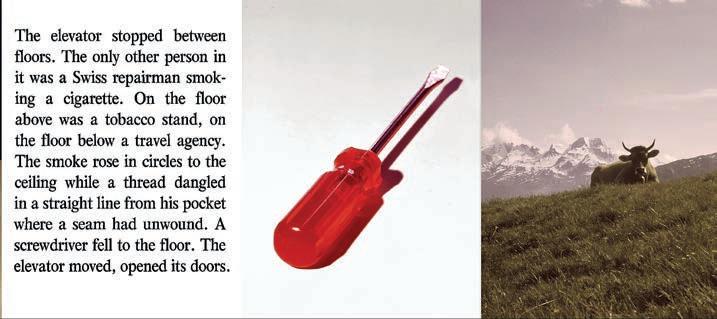
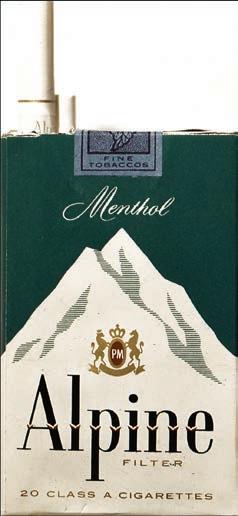
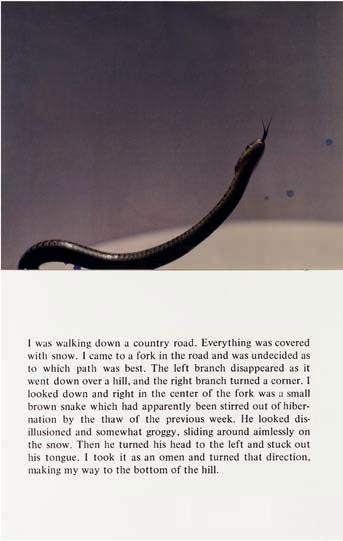



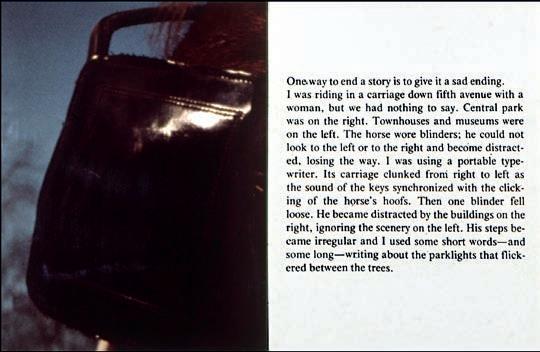



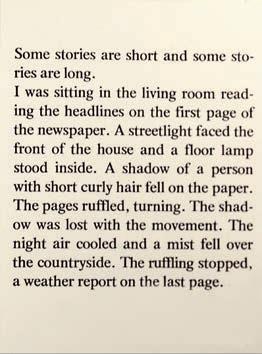
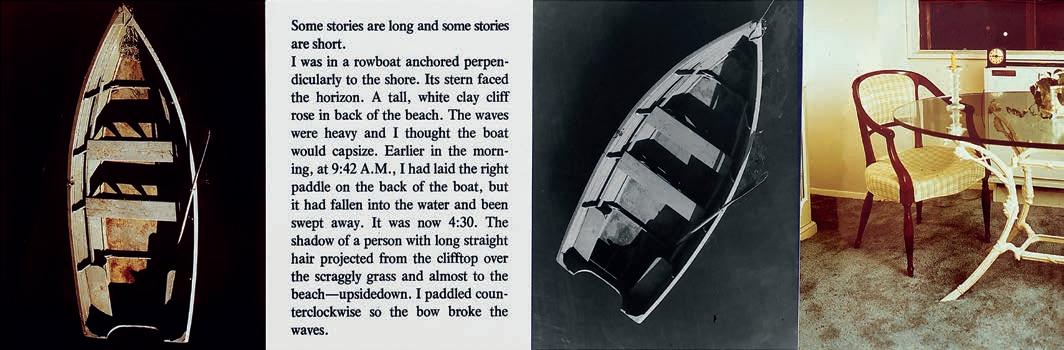










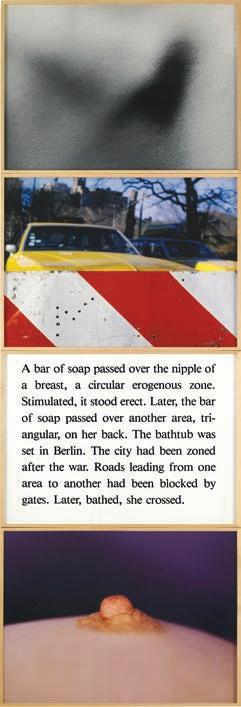
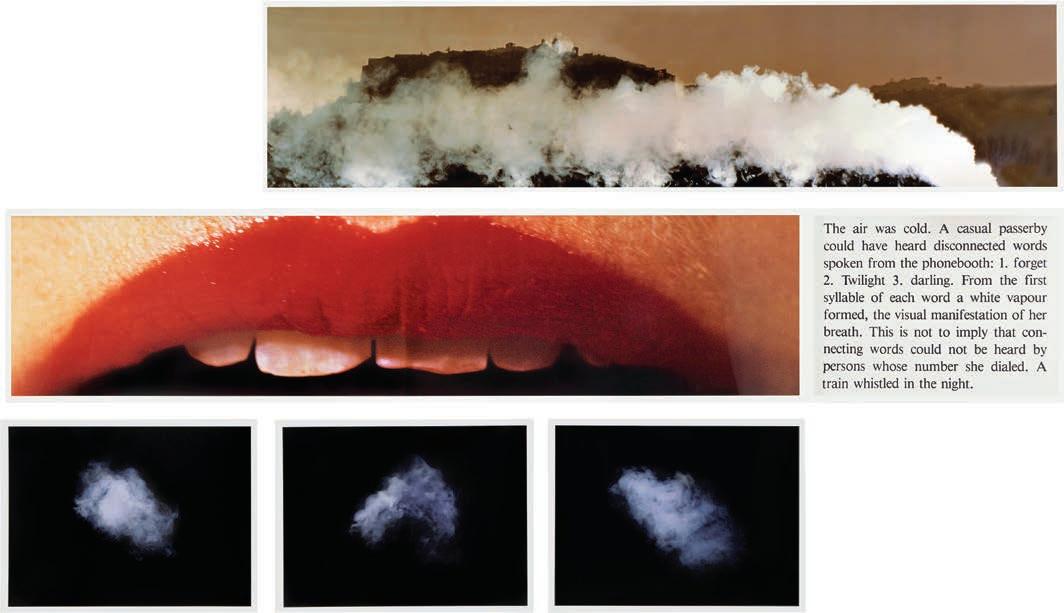


















































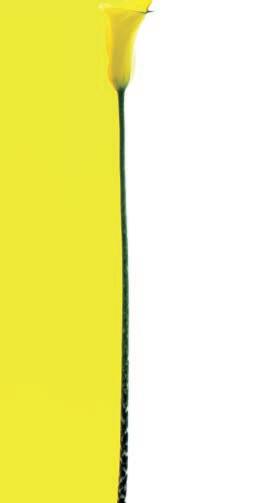























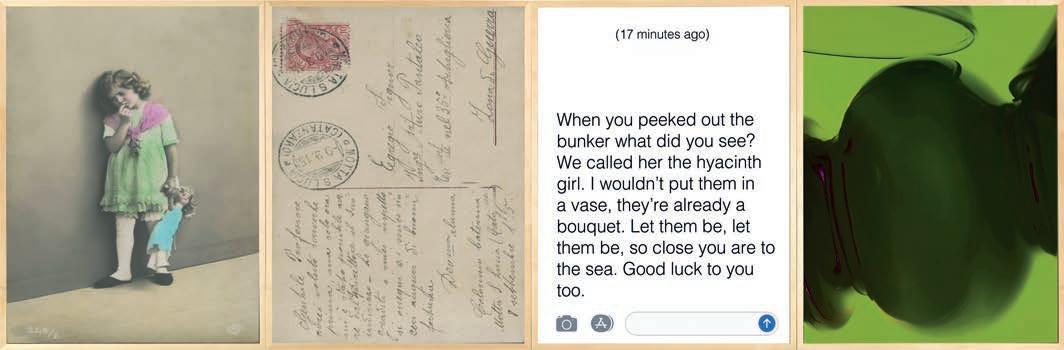


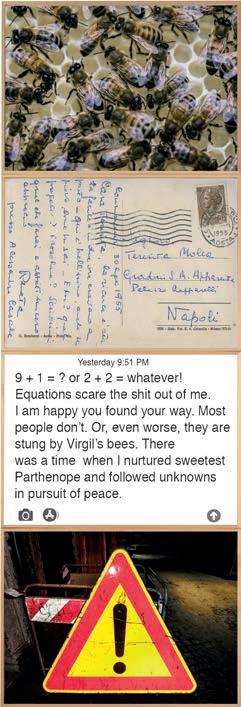

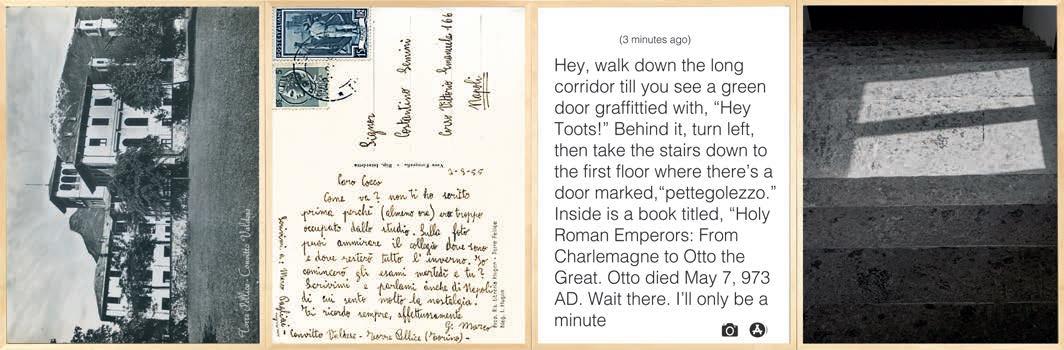
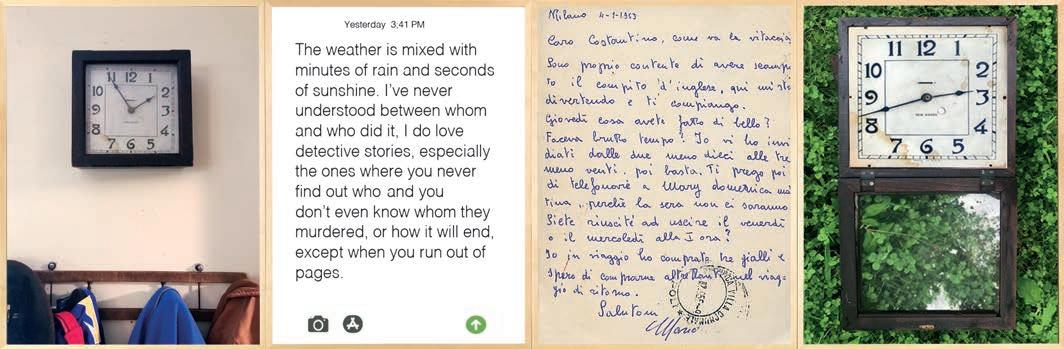

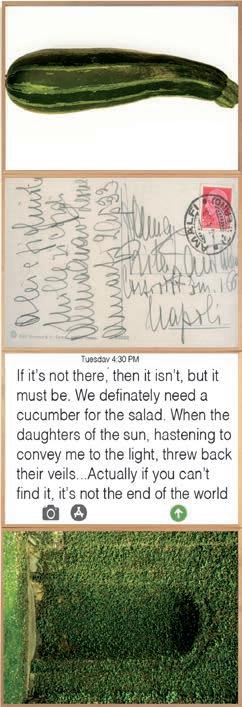
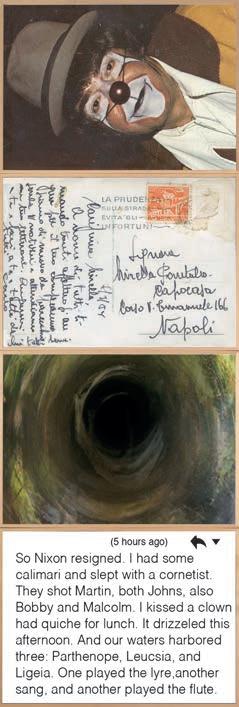
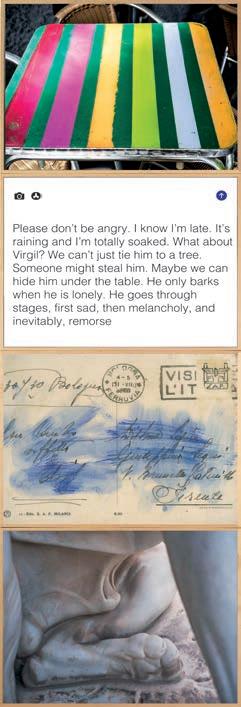
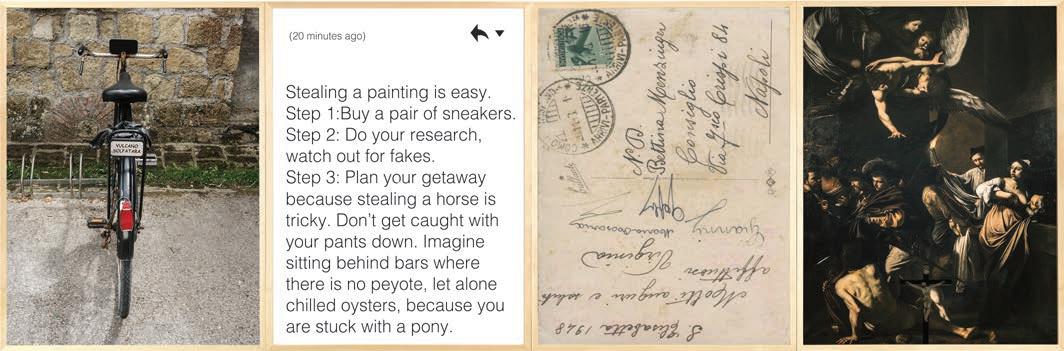










 Studio Trisorio, Napoli, 2016
Studio Trisorio, Napoli, 2016
 Studio Trisorio, Roma, 2006
Studio Trisorio, Roma, 2006
 Studio Trisorio, Napoli, 2019
Studio Trisorio, Napoli, 2019
 Bill Beckley, Studio Trisorio, Napoli, 2019
Bill Beckley, Studio Trisorio, Napoli, 2019