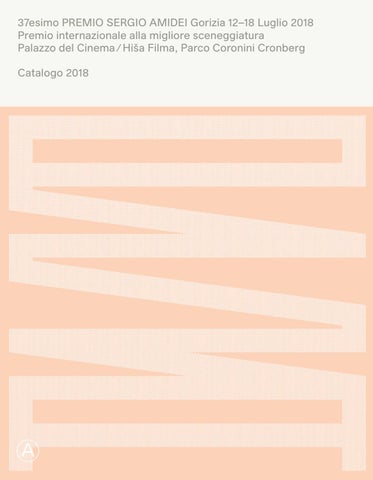37esimo PREMIO SERGIO AMIDEI Gorizia 12–18 Luglio 2018 Premio internazionale alla migliore sceneggiatura Palazzo del Cinema ⁄ Hiša Filma, Parco Coronini Cronberg Catalogo 2018
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.