87



Un approccio Student Voice per l’educazione alla lettura
a cura di Simone Giusti e Giusi Marchetta
Un progetto del Salone Internazionale del libro di Torino con il Centro per il Libro e la Lettura

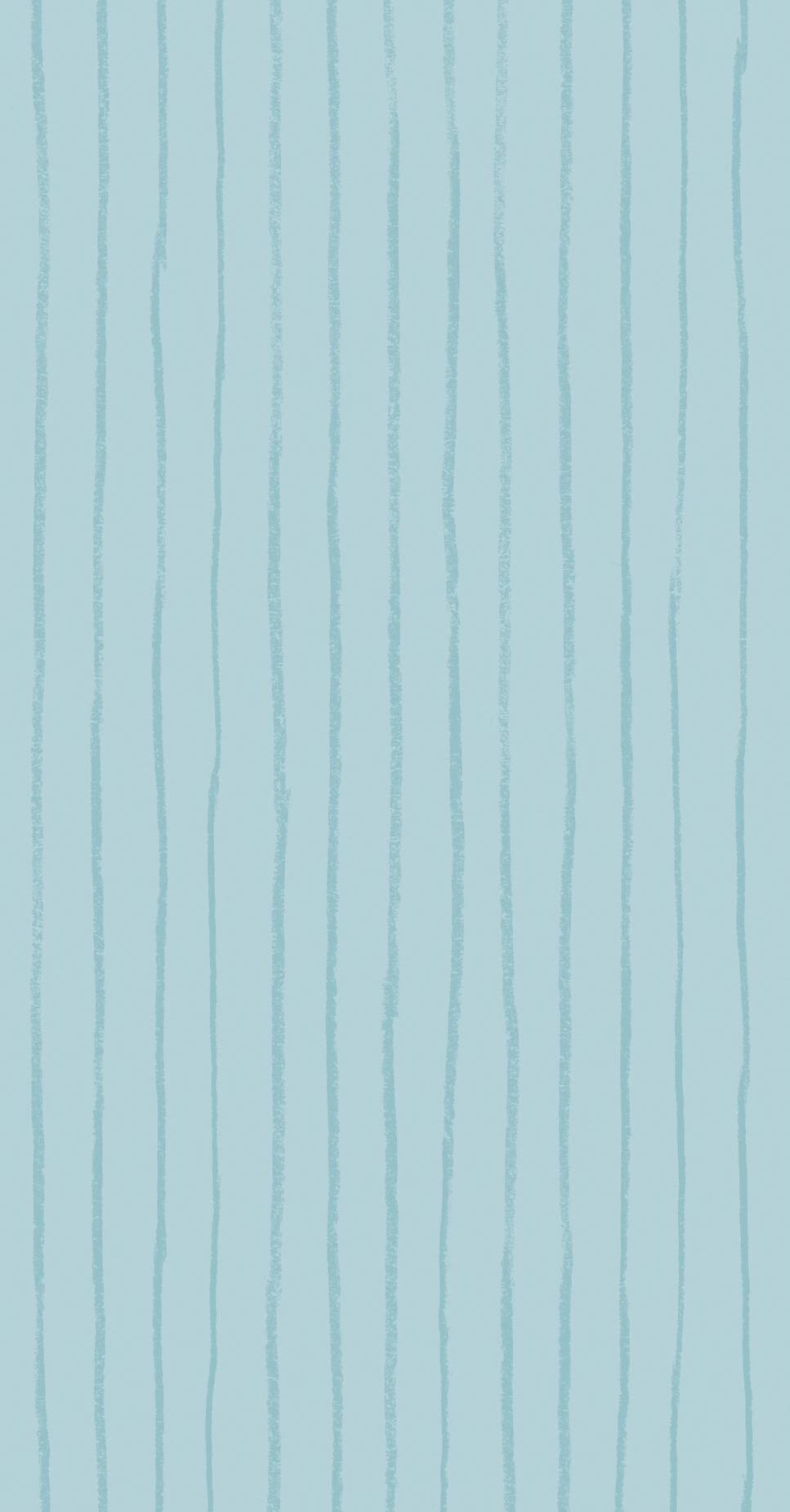
Un approccio Student Voice per l’educazione alla lettura
a cura di Simone Giusti e Giusi Marchetta
Un progetto del Salone Internazionale del libro di Torino con il Centro per il Libro e la Lettura
© Loescher Editore - 2025
Sede operativa Via Vittorio Amedeo II, 18 - 10121 Torino www.loescher.it
Diritti riservati
I diritti di pubblicazione, riproduzione, comunicazione, distribuzione, trascrizione, traduzione, noleggio, prestito, esecuzione, elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale e di adattamento totale o parziale su supporti di qualsiasi tipo e con qualsiasi mezzo (comprese le copie digitali e fotostatiche), sono riservati per tutti i paesi. L’acquisto della presente copia dell’opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.
Fotocopie e permessi di riproduzione
Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere efettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E. del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.Tali fotocopie possono essere efettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E.
Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale,economico,commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l’editore potrà concedere a pagamento l’autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del presente volume. Le richieste vanno inoltrate a Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (CLEARedi) Corso di Porta Romana, n. 108 - 20122 Milano e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org
L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale. La loro fotocopia per i soli esemplari esistenti nelle biblioteche è consentita, anche oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all’opera. Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, né le opere presenti in cataloghi di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi, la facoltà di cui all’art. 71 - ter legge diritto d’autore. Per permessi di riproduzione diversi dalle fotocopie rivolgersi a diritti@loescher.it Licenze per riassunto, citazione e riproduzione parziale a uso didattico con mezzi digitali La citazione, la riproduzione e il riassunto, se fatti con mezzi digitali, sono consentiti (art. 70 bis legge sul diritto d’autore), limitatamente a brani o parti di opera, a) esclusivamente per finalità illustrative a uso didattico,nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. (La finalità illustrativa si consegue con esempi, chiarimenti, commenti, spiegazioni, domande, nel corso di una lezione); b) sotto la responsabilità di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro,accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le parti di opere sono utilizzate; c) a condizione che, per i materiali educativi, non siano disponibili sul mercato licenze volontarie che autorizzano tali usi.
Loescher offre al mercato due tipi di licenze di durata limitata all’anno scolastico in cui le licenze sono concesse: A) licenze gratuite per la riproduzione, citazione o riassunto di una parte di opera non superiore al 5%. Non è consentito superare tale limite del 5% attraverso una pluralità di licenze gratuite, B) licenze a pagamento per la riproduzione, citazione, riassunto parziale ma superiore al 5% e comunque inferiore al 40% dell’opera.
Per usufruire di tali licenze occorre seguire le istruzioni su www.loescher.it/licenzeeducative L’autorizzazione è strettamente riservata all’istituto educativo licenziatario e non è trasferibile in alcun modo e a qualsiasi titolo.
Ristampe 6 5 4 3 2 1 N 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 ISBN 9788820139377
In alcune immagini di questo volume potrebbero essere visibili i nomi di prodotti commerciali e dei relativi marchi delle case produttrici. La presenza di tali illustrazioni risponde a un’esigenza didattica e non è, in nessun caso, da interpretarsi come una scelta di merito della Casa editrice né, tantomeno, come un invito al consumo di determinati prodotti. I marchi registrati in copertina sono segni distintivi registrati, anche quando non sono seguiti dal simbolo ® Nonostante la passione e la competenza delle persone coinvolte nella realizzazione di quest’opera, è possibile che in essa siano riscontrabili errori o imprecisioni. Ce ne scusiamo fn d’ora con i lettori e ringraziamo coloro che, contribuendo al miglioramento dell’opera stessa, vorranno segnalarceli all’indirizzo clienti@loescher.it
Loescher Editore Divisione di Zanichelli editore S.p.A. opera con Sistema Qualità certifcato secondo la norma UNI EN ISO 9001. Per i riferimenti consultare www.loescher.it
Il contenuto di questo libro non è stato approvato dalle Nazioni Unite e quindi potrebbe non rifettere la posizione ufciale di questa organizzazione.
Educare alla lettura - Leggere è partecipare è un Progetto del Salone del libro e del Centro per il libro e la lettura.
In collaborazione con DFCLAM Università di Siena
Coordinamento editoriale: Alessandra Nesti
Realizzazione editoriale e tecnica: PhP - Grosseto
Impaginazione: Silvia Filoni
Copertina: Visualgrafka – Torino
Progetto grafco interni: Fregi e Majuscole – Torino
Progetto grafco copertina: Leftloft – Milano/New York
Stampa: Gravinese Industrie Grafche S.r.l.,via Lombardore 276/F – 10040 Leinì (TO)
Diritto di TDM
L’estrazione di dati da questa opera o da parti di essa e le attività connesse non sono consentite, salvi i casi di utilizzazioni libere ammessi dalla legge. L’editore può concedere una licenza. La richiesta va indirizzata a tdm@loescher.it
A cura di Educare alla lettura
Durante l’anno scolastico 2023/2024 oltre seicento insegnanti delle scuole secondarie del primo e secondo ciclo sono stati coinvolti in un progetto di educazione alla lettura organizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dal Cepell che aveva per titolo Leggere è partecipare. Il progetto ha preso avvio dall’ipotesi che uno dei fattori che incidono sulla scarsa propensione alla lettura sia la mancata partecipazione attiva alla vita culturale, accompagnata dalla persistenza di stereotipi che delegittimano la lettura delle persone con basso livello di istruzione o la lettura di opere che non godono di prestigio nelle scuole e nelle università. Uno dei più autorevoli studiosi del fenomeno, Giovanni Solimine, ha descritto questo fenomeno in una sua interpretazione dei dati Istat del 2018, in cui si legge: «Azzardiamo l’ipotesi che i “lettori morbidi” si percepiscano come “lettori di serie B”, forse a causa del basso livello di istruzione e della debole qualità letteraria delle proprie letture. Questi italiani ritengono forse di non avere diritto di cittadinanza all’interno del circuito della partecipazione culturale e considerano il loro passatempo come qualcosa di diverso da una pratica culturale vera e propria».
Se così fosse, per ampliare la platea dei potenziali lettori e delle potenziali lettrici, occorrerebbe agire non solo per avvicinare le persone ai libri e alle pratiche di lettura, ma anche per favorire a scuola lo sviluppo di pratiche e atteggiamenti basati sulla partecipazione attiva, senza la quale rimane difficile acquisire un rapporto durevole e profondo con la lettura letteraria. Leggere letteratura, infatti, richiede una serie di comportamenti, uno stile di vita fondato sul desiderio di incontrare e di ascoltare gli altri, di condividere le proprie esperienze estetiche attraverso la conversazione e la scrittura, mettendo sempre in gioco le proprie risorse cognitive ed emotive. È necessario, quindi, agevolare la presa di parola da parte di ogni studente, che deve rendersi conto di avere la possibilità e la capacità di partecipare alla vita culturale da protagonista.
Per prevenire o vincere quel senso di inferiorità che caratterizza i cosid- 5
LeggeRe è PaRteCIPaRe
detti “lettori morbidi” e che è tipico delle fasce più deboli della popolazione scolastica (drop out, alunni e alunne a rischio dispersione, ripetenti), la proposta formativa ideata da Simone Giusti e Giusi Marchetta – responsabili scientifici del progetto – ha cercato di aumentare il livello di partecipazione nelle classi fornendo alle e ai docenti contenuti intellettuali e strumenti didattici che vengono adesso messe a disposizione di chiunque voglia metterli alla prova, con l’auspicio che contribuiscano a promuovere un’idea di lettura meno elitaria ed esclusiva.
Sono centinaia gli esempi, nella storia attuale e in quella passata, che illustrano la paura dei detentori del potere – politico, religioso, simbolico o familiare – di perdere il monopolio del senso.
Michèle Petit
Il dibattito pubblico sulla scuola si rianima, ciclicamente, grazie alle ondate di preoccupazione collettiva sollevate dall’episodio di cronaca nera con protagonisti giovani, o dall’interpretazione allarmante di qualche report sui risultati scolastici fornita da enti di ricerca internazionali. Negli ultimi mesi non si contano gli editoriali, gli articoli divulgativi, i post sui social in cui ci si è chiesti a turno cosa stiano imparando davvero a scuola ragazzi e ragazze di oggi. A questo proposito, colpisce quanto, per molte persone, l’immaginario della scuola resti ancorato a un passato privato: il quadretto della propria adolescenza ricordata con nostalgia e in qualche caso reinventata per aderire a una narrazione che ritiene la scuola di ieri più performante, più educativa e più colta di quella di oggi. Sebbene questa narrazione sia condivisa anche da una parte dei docenti, è evidente che il percorso che la scuola ha compiuto in direzione di una democrazia fattuale ha cambiato molte cose, mettendo a frutto anche se solo parzialmente le voci degli intellettuali (da Don Milani a Mario Lodi fino a Bruno Ciari per citare i più noti) che per una scuola democratica si sono spesi a lungo.
Se ripuliamo l’analisi della scuola del secolo scorso dall’alone di malinconia che avvolge il ricordo di noi tra i banchi e l’epica personale dell’avercela fatta nonostante la selettività del contesto, selettività che ci avrebbe spronato a dare il meglio di noi (una convinzione che già Tullio de Mauro ha contribuito a demolire con lieve autorevolezza), sarà facile individuare dagli anni Sessanta a oggi un progresso che riguarda, tra le altre cose, l’introduzione di una didattica inclusiva e la sostituzione dell’apprendimento mnemonico con lo sviluppo di competenze di cui servirsi in modo autonomo: l’idea di una scuola, insomma, che in modo lento e con diversi contraccolpi procede
LeggeRe è PaRteCIPaRe
nell’intenzione di considerare gli e le studenti come persone con una propria individualità e dei diritti, in una continua ridefinizione del concetto di istruzione.
Prendiamo il caso della literacy e delle linee guida ministeriali, che hanno da tempo eliminato i programmi scolastici e la loro dittatura, capace di risucchiare tutto il tempo a disposizione del docente, e sottolineato l’importanza di formare alla lettura in modo da sviluppare un’abitudine autonoma e duratura. Da anni su indicazione ministeriale si pone l’accento sulla necessità di progettare un’azione efficace di educazione alla lettura, finalizzata all’acquisizione di uno strumento utile al reperimento di informazioni, all’intrattenimento e soprattutto allo sviluppo del famigerato “spirito critico” – espressione che ritorna spesso tra gli obiettivi formativi delle progettazioni didattiche, ma che altrettanto spesso viene vanificata da pratiche che ristabiliscono la dinamica tradizionale dello studente a cui viene richiesto di restituire conoscenze e che, terminata la lettura del libro assegnato, non ha sviluppato la necessità o l’abitudine di cercarne un altro. È su questo punto che il discorso didattico e formativo ci sembra convergere con le istanze di democrazia incarnate dall’idea di una scuola progressista. Lo svolgimento del compito assegnato in modo diligente non dipende solo dalle caratteristiche individuali e dall’impegno profuso da chi studia: al successo formativo concorrono anche fattori sociali e ambientali, come ricorda la percentuale altissima di drop out (in particolare con background svantaggiato o migratorio), che ci colloca al fondo della classifica europea, tra i paesi con una più elevata dispersione scolastica.
Questa esperienza diffusa di esclusione da un percorso di istruzione non può che ingenerare una presa di distanza dall’istituzione, e in generale dall’idea di cultura su cui sembra imbastire tutto. Pensiamo ad esempio alla diffusione degli stereotipi sulle persone con un basso livello di istruzione o alla delegittimazione delle letture che non vengono considerate letterarie, e quindi dignitose. Nel 2018 Giovanni Solimine evidenziava la questione parlando di “lettori di serie B”, che si ritengono esclusi dal discorso della partecipazione culturale come se ne fossero estranei. Come se non ne avessero diritto. Cosa imparano, quindi, gli studenti nella scuola di oggi? A non essere protagonisti della loro vita culturale, e a rimanere ancora solo “assimilatori”, per di più selezionati dalla loro capacità di rapportarsi a un canone letterario definito altrove. La soluzione alla nostra carenza di lettori e di lettrici, quindi, può risiedere proprio nella possibilità per gli e le studenti di prendere la parola e di mettere in gioco le proprie risorse cognitive ed emotive per entrare in relazione col libro attraverso una pratica didattica che li faccia sentire coinvolti. Da questo assunto è stato possibile immaginare una formazione dei do-
centi della secondaria basata sull’approccio student voice, ovvero su pratiche didattiche incentrate sulla partecipazione attiva degli alunni.
Il corso, articolato in cinque incontri, ha coinvolto come formatori Matteo Lancini, Federico Batini, Vanessa Roghi e Cristiano Corsini, esperti nel campo del benessere degli studenti, dell’inclusione, della storia della scuola e della valutazione, i cui interventi sono riportati sinteticamente nella seconda parte del volume. Ai partecipanti è stata proposta, in seguito a ciascuno degli incontri, un’attività didattica da sperimentare in classe, e che avrebbe dovuto coinvolgere ragazzi e ragazze a partire da un’esperienza di lettura. Nella prima parte del volume è riportata una piccola parte dei materiali elaborati dalle classi coinvolte. Ogni insegnante che ha preso parte attiva al progetto ha consentito alle sue classi di esprimersi attraverso fotocollage, cartelloni, manifesti, schede, lettere e interviste, in formato analogico o digitale. I materiali, selezionati e accuratamente digitalizzati, sono stati caricati su uno spazio web condiviso e accompagnati da una breve relazione, che ha consentito di monitorare le attività e di avere un riscontro sull’esito dell’intervento.
Non siamo in grado di dire se l’intervento abbia inciso sui comportamenti di lettura, ovvero se i partecipanti avranno più possibilità di diventare, in futuro, lettori e lettrici per la vita. Quel che è successo è che molti studenti hanno avuto occasione di condividere, all’interno delle loro classi, alcune loro idee sulla scuola, e lo hanno fatto anche grazie agli stimoli ricevuti dalla lettura, insieme ai compagni e alle compagne, fidandosi dell’insegnante e degli organizzatori del progetto, che avrebbero poi letto i loro testi.
Questo libro non esisterebbe senza la partecipazione di centinaia di studenti e insegnanti che hanno realizzato le attività e ne hanno condiviso i risultati. A loro va il nostro ringraziamento, con l’auspicio e il desiderio di rendere un buon servizio alle scuole che vorranno proseguire il lavoro iniziato.
Su La ricerca online alla pagina di questo Quaderno è possibile trovare l’elenco completo delle scuole partecipanti: https://laricerca.loescher.it/i-quaderni-della-ricerca-87/.
QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 21, L.D.A.). ESCLUSO DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.

Un approccio Student Voice per l’educazione
La propensione alla lettura non dipende solo dalla capacità di decodifcare e comprendere i testi. Si leggono libri anche per partecipare alla vita di una comunità e per compiere esperienze signifcative, inseguendo il desiderio di incontrare e di ascoltare altre voci, di condividere altre prospettive sul mondo. Sono queste solo alcune delle motivazioni che hanno spinto il Salone Internazionale del Libro di Torino e il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) a realizzare il progetto di educazione alla lettura intitolato “Leggere è partecipare”, che nell’anno scolastico 2023/2024 ha coinvolto oltre seicento insegnanti delle scuole secondarie del primo e secondo ciclo.
Ricorrendo a tecniche didattiche basate sull’approccio Student Voice, che ritiene di migliorare l’efficacia dell’insegnamento grazie all’ascolto della voce dei ragazzi e delle ragazze, Giusi Marchetta e Simone Giusti hanno ideato e coordinato una serie di incontri su alcuni temi oggi fondamentali per la vita scolastica – il benessere, la dispersione, la partecipazione e la valutazione –, e li hanno accompagnati con kit didattici da usare in classe per sollecitare la riflessione personale, la discussione e l’interpretazione dei problemi.
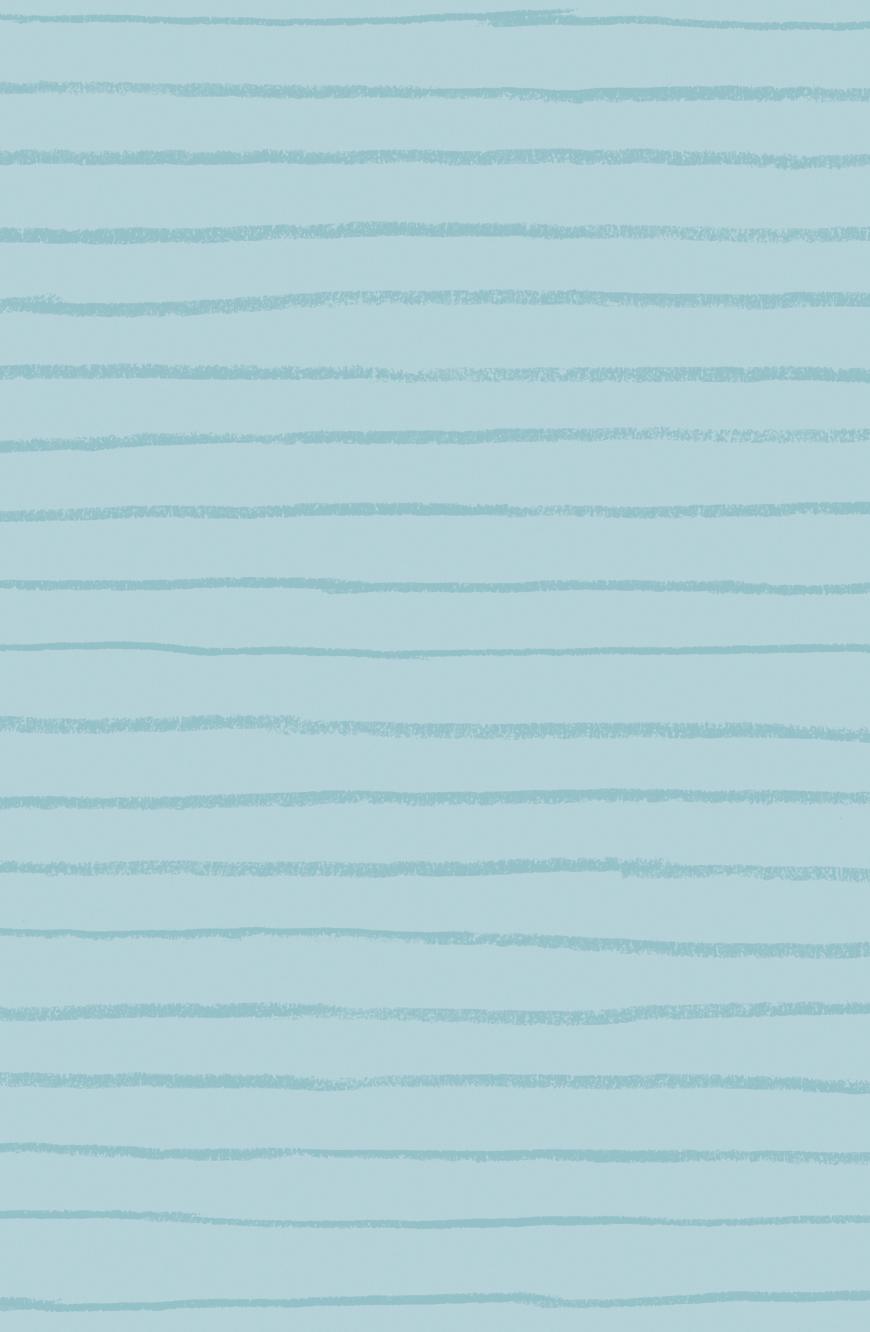
La parte didattica è introdotta da un estratto dei lavori dei relatori e della relatrice che hanno collaborato al progetto: Federico Batini, Cristiano Corsini, Matteo Lancini e Vanessa Roghi.
Simone Giusti insegna didattica della letteratura italiana all’Università di Siena, ed è autore di ricerche, studi e saggi sulla letteratura italiana, sulla traduzione, sulla lettura e sulla didattica della letteratura. Ha fondato la rivista «Per leggere», semestrale di commenti, letture, edizioni e traduzioni. Con Federico Batini organizza il convegno biennale “Le storie siamo noi”, la prima iniziativa italiana dedicata all’orientamento narrativo. Insieme a Natascia Tonelli condirige la collana scientifca QdR / Didattica e letteratura.
Giusi Marchetta vive a Torino, dove insegna. Ha pubblicato la raccolta di racconti Dai un bacio a chi vuoi tu (Terre di mezzo, 2008), vincitore del Premio Calvino, e i romanzi L’iguana non vuole (Rizzoli, 2011) e Dove sei stata (Rizzoli, 2018). Ha fondato e coordina il podcast del Tavolo delle ragazze (nato da Tutte le ragazze avanti!, Add editore). Per Einaudi ha pubblicato Lettori si cresce (2015) e ancora per Add il saggio Principesse. Eroine del passato, femministe di oggi sugli stereotipi di genere nella cultura di massa.
Un progetto del Salone Internazionale del libro di Torino con il Centro per il Libro e la Lettura
€ 7,70 3937 LEGGERE È PARTECIPARE
