Francesco Furci – Elisabetta Pozzi
Techno pass

· Didattica per competenze
· Compiti di realtà
· Flipped classroom · CLIL
· Educazione civica e ambientale
· Agenda 2030

IL TUO LIBRO DIGITALE
Strumenti per la didattica personalizzata, individualizzata, inclusiva, per la lezione in classe con la LIM e il ripasso a casa.

Il tuo libro si arricchisce di video di approfondimento, video lezioni, video tutorial, laboratori di ascolto, lettura dei testi, canzoni, mappe ed esercizi interattivi, audio CLIL in lingua inglese e tanto altro ancora. Puoi ascoltare l'audiolibro completo, letto da speaker professionisti, modificare il carattere dei testi, utilizzare il dizionario interattivo e la traduzione multilingue.
RAFFAELLO PLAYER
Per accedere ai contenuti e agli strumenti digitali, entra in Raffaello Player (rp.raffaellodigitale.it) o scarica l’applicazione Raffaello Player dal portale www.raffaellodigitale.it, da Google Play o dall’App Store e inserisci il codice di attivazione. Non è richiesta alcuna registrazione.
Personalizza i tuoi contenuti, allega file, crea nuovi documenti e condividili con gli altri. Connessione internet necessaria.
Inquadra e visualizza i contenuti presenti nel libro digitale. Connessione internet necessaria.
REALTÀ AUMENTATA
Installa l'app Raffaello Player e inquadra la pagina.

QR CODE
Inquadra i QR Code direttamente con la fotocamera oppure con un’app a tua scelta.
Collegati al portale www.raffaellodigitale.it per scaricare il materiale digitale extra e richiedere assistenza. Registrati per ricevere gli aggiornamenti del testo digitale.
CODICE DI ATTIVAZIONE
Francesco Furci – Elisabetta Pozzi
Techno pass
TECNOLOGIA
Il corso Technopass
Il volume Tecnologia del corso Technopass spiega e approfondisce gli interventi e le trasformazioni che l’uomo opera nell’ambiente per soddisfare i propri bisogni: materiali, agricoltura, territorio, energia, macchine, mezzi di trasporto e di comunicazione ecc. Il volume è scandito da numerosi momenti di approfondimento (Educazione ambientale, Educazione civica ecc.) e di verifica delle conoscenze (Per l’interrogazione, Verifiche) e delle competenze (Compiti di realtà).
Molta attenzione è posta all’inclusione, attraverso numerose pagine dedicate a tutti gli studenti per fissare i concetti principali, e alla conoscenza della lingua inglese specifica della disciplina (Glossario CLIL, Tech & CLIL).
A disposizione, il volume Domande e risposte per l’interrogazione, per un ripasso dei concetti principali a casa o a scuola.
Ogni Area si apre con un breve testo riassuntivo dei contenuti, una mappa riepilogativa e attività da svolgere in classe e a casa (classe capovolta).


Il volume si apre con un’utile cassetta degli attrezzi che fornisce alcuni concetti chiave per lo studio della disciplina.
Ogni Unità è introdotta da un riassunto per parole chiave.
Le Lezioni sono generalmente sviluppate su due o quattro pagine. Il testo è scandito in brevi paragrafi, con un linguaggio accessibile ma preciso e scientifico, e corredato di immagini, illustrazioni, box, rubriche, tabelle, schemi a blocchi, utili per chiarire o approfondire gli argomenti analizzati.

Il testo è completato da box che consentono di creare un collegamento tra passato, presente e futuro delle nuove tecnologie (Ieri –Oggi – Domani), che affrontano temi legati all’ambiente, all’ecologia, alla sostenibilità e al riciclo (Educazione ambientale), che offrono spunti di riflessione di cittadinanza (Educazione civica).

Pagine e box di Educazione ambientale affrontano i temi legati all’ambiente, all’ecologia, alla sostenibilità e al riciclo, per far sviluppare una maggiore consapevolezza circa le problematiche attuali.
Alla fine di ogni Lezione alcune domande consentono di effettuare un rapido ripasso dei concetti appresi. I termini specifici della disciplina sono tradotti in inglese (CLIL).
Sono presenti molti riferimenti agli obiettivi dell’Agenda 2030: sono indicati dall’apposita icona in alcune Lezioni e in apertura di Area. Inoltre, al termine di alcune Unità sono presenti spunti di riflessione collegati agli obiettivi dell’Agenda 2030.

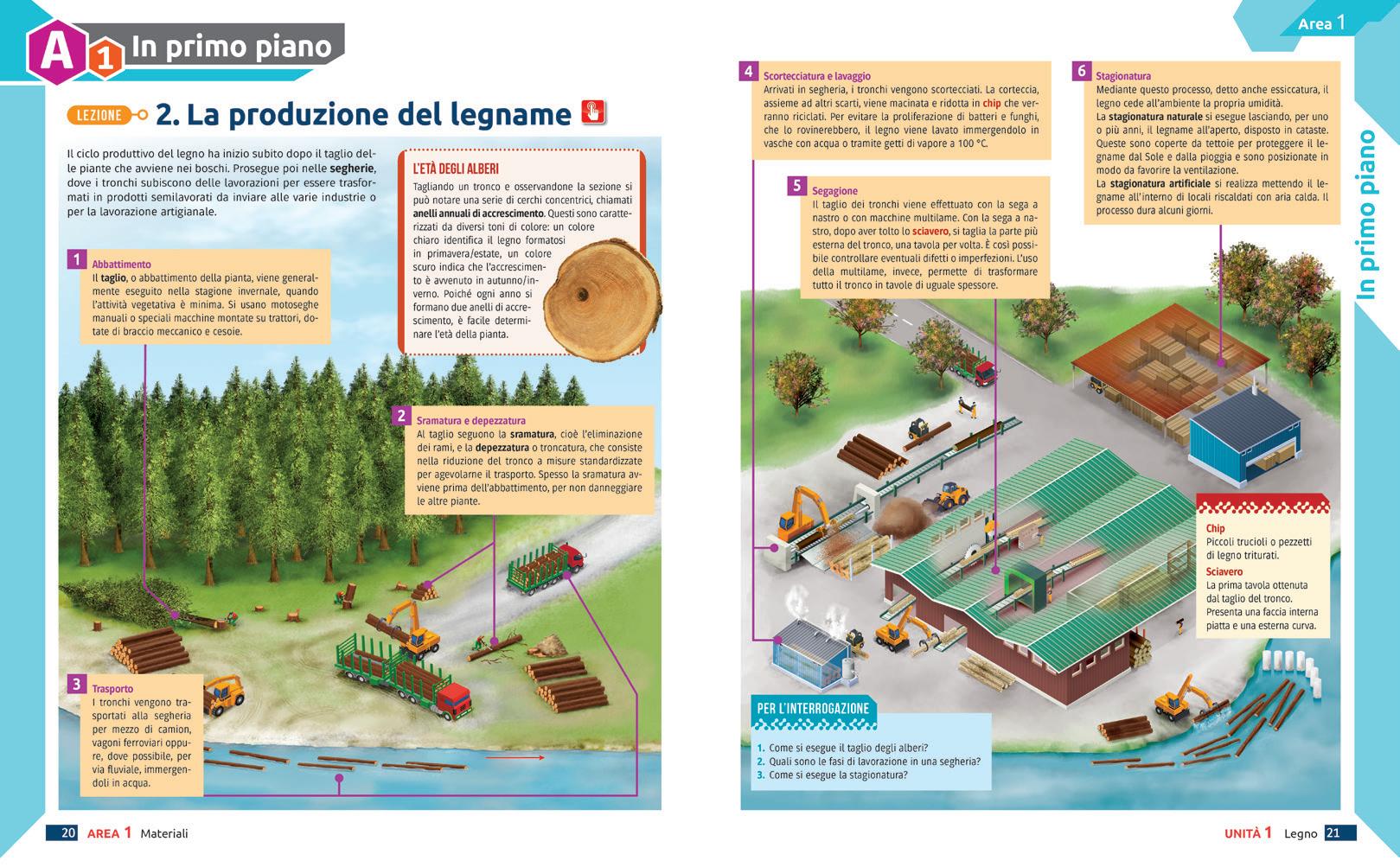
Le pagine In primo piano analizzano processi produttivi o elementi importanti della disciplina con grandi tavole illustrate ricche di particolari e dettagli.
Le Sintesi riassumono i concetti chiave affrontati nell’Unità. Sono stampate con un carattere ad alta leggibilità e corredate di audiolettura. In allegato anche le mappe concettuali dell’Unità. In alto nella pagina, un rimando al volume Domande e risposte per l’interrogazione, per il ripasso dei concetti principali.
Le Verifiche permettono di accertare le conoscenze acquisite nelle singole Lezioni dell’Unità. Tutti gli esercizi si possono eseguire anche al computer, con autocorrezione.
Tech & CLIL sono attività in inglese per favorire un percorso CLIL.


Al termine di ogni Unità sono presenti spunti per sviluppare le competenze tramite attività da svolgere in gruppo, al computer oppure per approfondire alcuni temi legati all’Agenda 2030.
Al termine di ogni Area sono approfonditi alcuni temi della disciplina in chiave di Educazione civica, con attività per sviluppare buone pratiche cooperative di senso civico.

Alcune attività si possono svolgere utilizzando i dispositivi elettronici personali (Kahoot!).
È inoltre possibile esercitare le competenze attraverso alcuni Compiti di realtà, articolati e trasversali, raccolti in fondo al volume.


La didattica inclusiva
Technopass è un corso pensato per garantire a tutti il diritto all’apprendimento attraverso molti strumenti specifici per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali ma rivolti a tutti, in maniera inclusiva.
La mappa concettuale (in digitale) permette di ripassare e di riorganizzare le idee
I testi sono organizzati in modo schematico ed essenziale
Le parole chiave sono evidenziate

Il libro digitale offre inoltre ulteriori strumenti per favorire l’inclusività.
• Audiobook Lettura integrale dei contenuti. Lettura lenta e scandita, adatta per studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento, delle pagine di didattica inclusiva.
• Alta leggibilità Visualizzazione del libro adattabile a ogni esigenza, grazie al formato ePub che permette di modificare il colore, lo sfondo e anche il carattere del testo (con la possibilità di scegliere anche la font leggimi, appositamente studiata per i DSA).
• Traduzione automatica È possibile selezionare parole e porzioni di testo e tradurle in altre lingue.
• Dizionario Utile per la comprensione delle parole e l’espansione del lessico.
Volume semplificato È disponibile il volume con lezioni semplificate, font ad alta leggibilità, audiolettura integrale, mappe concettuali ed esercizi semplificati, oltre a un glossario multilingue della disciplina.
Le risorse digitali
Technopass si sviluppa sul libro digitale: la versione multimediale, interattiva e aperta dell’opera che offre numerosi contenuti digitali integrativi al corso cartaceo.

Video
Filmati di approfondimento, utili anche per la flipped classroom, e video mappa di Area con commento audio.

Contenuti interattivi
Esercizi interattivi di diverse tipologie, con autocorrezione.


Galleria immagini
Galleria fotografica per un approccio visuale ai contenuti.

Learning object
Attività interattive e autocorrettive realizzate con le illustrazioni presenti nel volume.
Inquadra il QR Code con una fotocamera oppure con un’app a tua scelta: visualizzerai i contenuti presenti nel libro digitale.
Le attività indicate con l’icona Kahoot! permettono di utilizzare i dispositivi elettronici personali dello studente durante l’attività didattica in classe in maniera sicura, coinvolgente e collaborativa. B.Y.O.D. (Bring Your Own Device)

Risorse aggiuntive
Approfondimenti, ulteriori informazioni e curiosità relativi agli argomenti trattati.

Mappa
Mappa concettuale dell’Unità.
Tramite questo tasto potrai vedere le risorse legate alla pagina e quelle di tutto il volume. Risorse digitali

1 Clicca sull’icona Kahoot! Scarica l’app Kahoot! sul tuo dispositivo
2 Condividi il PIN con gli studenti Inserisci il PIN
3 Avvia l’attività Rispondi correttamente
La strumentazione
Il libro digitale è concepito per essere utilizzato in classe con la LIM e a casa dallo studente: è ricco di strumenti che permettono la creazione e la personalizzazione dei contenuti.
Alta leggibilità

È possibile aumentare la dimensione del testo e modificare il font (tra cui leggimi © Sinnos editrice, appositamente studiato per i DSA).
È possibile attivare la traduzione in altre lingue di tutto il testo o di alcune parti.
È possibile attivare il dizionario di italiano.
È ricco di contenuti digitali integrativi.




È dotato di una ricca strumentazione per la scrittura e per la consultazione.
Offre la possibilità di creare documenti, come presentazioni, linee del tempo e mappe concettuali, e condividere tutto il materiale con la classe.

13. Fibre chimiche
Le fibre tessili artificiali
Le fibre artificiali sono ottenute dalla trasformazione di materie prime naturali di origine organica. Si possono produrre fibre tessili a partire da proteine animali e vegetali, ricavate dai semi di molte piante, come la soia, l’arachide, il granoturco, il cotone e la canapa, oppure dalla caseina del latte, da cui si ricava il lanital, inattaccabile dalle tarme ma ormai fuori commercio. Dalla trasformazione chimica della cellulosa (legno, linters del cotone) si ottiene il Rayon, una fibra artificiale usata per la tessitura. A seconda della lavorazione e della materia prima utilizzata, si distinguono vari tipi di filati di Rayon: viscosa, cuprammonio, acetato.


Mappa concettuale Linea temporale
Audiobook
Ogni testo è stato letto, in tutte le sue parti, da speaker professionisti. Alcune parti sono facilitate, cioè sono audioletture lente e scandite per studenti con BES.
La realtà aumentata permette di attivare i contenuti digitali tramite il proprio device.
È possibile aggiungere dei collegamenti a risorse multimediali esterne al libro (documenti, immagini, video, audio, web link).
Collegandoti all’indirizzo raff.link/libro-digitale troverai la descrizione dettagliata di tutti gli strumenti.


Concetti chiave










Legno



















































46.
49.
2 Settore agroalimentare
































53.
54.
55. Un edificio speciale: la casa
56. Impianti
57.
58. La domotica
59. La bioarchitettura
60.
















Territorio










14
74.
75.
78.

nergia ed elettricità
















Energie rinnovabili 218










81.
82.
83.
84.









16 Macchine e motori





Mezzi di trasporto


Veicoli spaziali





















































Compiti di realtà
1. Tecnologia e materia
Dalla scienza alla tecnologia
L’uomo è da sempre stato un attento osservatore dei fenomeni che avvengono in natura e a questi ha sempre cercato di dare una spiegazione, interrogandosi di continuo sul perché avvengano determinati fenomeni. A dare delle risposte ci pensa puntuale la scienza, il cui termine significa appunto «conoscenza», che, con metodi rigorosi e scientifici, cerca sempre una risposta in modo oggettivo, misurabile e ripetibile. La scienza verifica un’ipotesi relativa a un fenomeno il cui risultato deve essere messo a disposizione di tutti; inoltre non entra mai nel merito etico di una ricerca giudicandola giusta o sbagliata, ma definisce se ciò che è stato osservato è vero o falso.

La tecnologia, invece, ha il compito di trovare soluzioni innovative per la produzione di dispositivi e di sistemi necessari per molteplici applicazioni: comunicare, curare le persone in modo efficace, spostarsi nel minor tempo possibile, migliorare la produzione industriale con nuovi materiali e macchine appropriate ecc. Possiamo quindi dire che scienza e tecnologia, pur essendo due discipline ben distinte, lavorano insieme per rendere le condizioni di vita migliori per tutti.
Studiare tecnologia
La tecnologia è la disciplina finalizzata alla progettazione e alla realizzazione di oggetti e macchinari utili alla vita dell’uomo.
Lo studio della tecnologia è molto importante perché aiuta a capire come l’uomo, facendo uso del sapere e del saper fare, riesca a realizzare tutto ciò che è necessario per le proprie esigenze quotidiane. Lo studio di questa disciplina permette anche di avere una visione più ampia e rispettosa nei confronti di ciò che la natura offre: da lei attingiamo le materie prime indispensabili per ottenere, con adeguate trasformazioni, prodotti di vario genere. L’evoluzione della tecnologia è frutto dell’incontro di saperi e discipline differenti: agricoltura, comunicazione, medicina, produzione energetica, informazione e trasporti sono solo alcuni dei settori dove il progresso tecnologico è costantemente presente e offre sicurezza, affidabilità e competitività.
Il progresso si basa sull’innovazione che introduce di continuo nuove tecnologie, permettendo di ottimizzare il tempo e i costi a favore di una maggiore crescita economica e sociale. In questi ultimi anni si sono fatte scelte più consapevoli delle materie prime, in base alla loro disponibilità e in favore della tutela dell’ambiente evitando, dove possibile, metodi estrattivi e produttivi che causino danni al suolo, all’acqua, all’aria e alla salute dell’uomo.
Studiare tecnologia vuol dire, pertanto, avere una maggiore consapevolezza di tutto ciò che avviene intorno a noi e scoprire cosa si nasconde dietro ai beni e ai servizi offerti ogni giorno alla collettività.
Materia prima
Qualunque forma di materia disponibile in natura dalla quale è possibile ricavare dei prodotti o dei semilavorati (minerali, alberi, vegetali, petrolio ecc.).

La materia
Con la formazione della Terra, avvenuta oltre 4 miliardi di anni fa, ha avuto inizio una lenta trasformazione chimico-fisica degli elementi che la costituivano e che hanno dato luogo alla materia, parola che deriva dal latino mater che significa madre, cioè l’origine di ogni cosa.
La concentrazione di molti elementi chimici, la presenza di elevate temperature e forti pressioni interne portarono alla formazione, per esempio, dei minerali di cui l’uomo si serve per ottenere alcune materie prime indispensabili per le proprie necessità. Ferro, oro, argento, uranio, sabbia, granito, argilla e migliaia di altri elementi sono utilizzati ogni giorno nella produzione industriale. La materia viene manipolata e trasformata dall’uomo con l’utilizzo di tecniche e tecnologie avanzatissime per ricavare nuovi prodotti, o per migliorare quelli già esistenti.
Gli elementi presenti sulla Terra, come l’aria, l’acqua, gli animali, i vegetali e i minerali, sono tutti costituiti da materia, che ha la proprietà di occupare uno spazio con una massa e un volume.
La materia è costituita da un insieme di particelle legate tra loro, le molecole, che a loro volta sono formate da un raggruppamento di altri elementi invisibili a occhio nudo, gli atomi.
A seconda della forza che tiene unite le molecole, la materia può assumere diverse forme:
• stato solido, per esempio legno, vetro, metalli, plastica ecc.;
• stato liquido, per esempio acqua, petrolio, bevande ecc.;

• stato aeriforme, per esempio ossigeno, anidride carbonica, gas metano ecc.
Materia e chimica
La chimica è la scienza che studia la composizione e le proprietà della materia esistente in tutte le sue forme. È grazie alla chimica che l’uomo, attraverso processi di trasformazione, può creare materiali innovativi utili per il progresso tecnologico. Nel quotidiano, tutti noi dipendiamo costantemente da questa disciplina. Infatti, la nostra vita procede per reazioni chimiche: i prodotti di cui ci circondiamo ogni giorno come cibo, acqua, medicine, materie plastiche, carta, metalli, vetro, combustibili, concimi, detersivi sono solo alcuni degli elementi alla cui base troviamo, come artefice, la chimica.
I principali materiali usati dall’industria si ottengono legando tra loro atomi o molecole di varia natura con modalità differenti.
PER L’INTERROGAZIONE
1. Perché è importante lo studio della tecnologia?
2. Su che cosa si basa il progresso tecnologico?
3. Da cosa è costituita la materia?
4. In quali stati si può trovare la materia?
EDUCAZIONE AMBIENTALE
La chimica verde

Un notevole contributo viene oggi offerto dalla Green Chemistry (chimica verde) il cui impegno è finalizzato a ottenere prodotti e processi che mirano a rispettare l’ambiente e la salute dell’uomo.
Questo tipo di approccio etico punta anche al risparmio energetico attraverso la creazione di materiali biodegradabili o con processi di riciclo più sostenibili.
CONCETTI CHIAVE
2. Risorse naturali e materiali
Le risorse naturali
L’uomo, dopo aver osservato che alcuni elementi presenti in natura potevano essere trasformati in materiali utili per la sua sopravvivenza, cercò di scoprirne di nuovi per migliorare sempre più le proprie condizioni di vita. Inizialmente non fu un’impresa facile, sia a causa della mancanza di strumenti e conoscenze appropriate, sia perché tali materie erano disseminate in punti diversi e spesso poco accessibili del pianeta. In seguito, però, grazie alla tecnologia e al contributo degli studi geologici e di speciali mezzi di ricerca, come aerei e sonde spaziali, è divenuto possibile conoscere l’ubicazione di molti giacimenti di risorse, che hanno determinato lo sviluppo della produzione industriale attuale.
L’attività di estrazione del carbone ha un forte impatto sull’ambiente.

Scarti che diventano risorse
La necessità di sviluppare nuove tecnologie per salvaguardare le risorse disponibili ha portato, e porterà sempre di più, al recupero degli scarti di molti materiali. Si considerano oggi risorse, per esempio, gli scarti delle attività agricole che, grazie alle tecnologie esistenti, vengono utilizzati per ottenere nuove materie prime da utilizzare in moltissimi settori. Non è escluso che la ricerca e il progresso tecnologico renderanno possibile anche lo sfruttamento futuro di risorse al momento impossibili da recuperare.
Geologico
Relativo alla geologia, la scienza che studia la storia, la costituzione e la struttura della crosta terrestre.
Le nuove ricerche e le accurate osservazioni del suolo hanno però anche rivelato, purtroppo, che i giacimenti di alcune materie prime stanno esaurendo le loro scorte a causa delle incessanti estrazioni: in un futuro prossimo sarà pertanto necessario sviluppare nuove tecnologie per poterle salvaguardare.
Risorse e riserve
Le risorse sono tutti gli elementi presenti nell’ambiente naturale che vengono usati dall’uomo per soddisfare i propri bisogni come, per esempio, i minerali, il petrolio, l’acqua, le piante, i prodotti dell’agricoltura, i prodotti ittici e quelli dell’allevamento e così via.
Le riserve sono costituite dall’insieme delle risorse effettivamente disponibili e di cui si conosce l’esatta collocazione, i cui giacimenti sono economicamente sfruttabili oggi e negli anni futuri grazie alle tecnologie a disposizione dell’uomo. Le risorse si possono classificare secondo due aspetti:
RISORSE
Secondo la loro origine
• Ambientali come acqua, Sole, vento…
• Minerarie come metalli, materie inorganiche…
• Biologiche come prodotti agricoli, materie organiche...
• Energetiche, ciò che permette di ottenere energia (fonti), come legno, petrolio, Sole, uranio, carbone…
Secondo la loro disponibilità
• Esauribili o non rinnovabili, la cui riserva è destinata a estinguersi a causa del continuo utilizzo, delle condizioni irripetibili e dei tempi lunghi necessari per la loro ricostituzione: minerali, combustibili fossili…
• Rinnovabili, la cui riserva è quasi infinita o può essere comunque ricostituita in tempi brevi: acqua, Sole, prodotti della Terra…
Dalla materia ai materiali
Ogni volta che l’uomo vuole produrre un oggetto ha bisogno di un materiale da cui partire: le risorse naturali vengono allora in suo aiuto offrendosi, direttamente o indirettamente, per i suoi scopi. Alcune epoche storiche devono il loro nome proprio ai materiali scoperti e usati in quel determinato periodo (età della pietra, età del bronzo…).
Si definisce materiale qualunque elemento fisico prelevato dall’ambiente naturale e impiegato dall’uomo per ottenere prodotti utili a soddisfare i propri bisogni.
In relazione all’origine dei materiali si può compiere una netta distinzione tra:
• materiali naturali, cioè quelli impiegati senza eccessive trasformazioni o sottoposti a minime lavorazioni finalizzate al loro impiego (acqua, pietra, legno, gas naturale ecc.);
• materiali naturali trasformati, quelli la cui materia prima si trova in natura ma necessita di processi industriali per ottenere i prodotti utili all’uomo (truciolato, vetro, ferro, carta ecc.);
• materiali artificiali, ottenuti da miscele di materie prime sottoposte a specifici processi industriali, trasformati con lo scopo di avere determinate prestazioni (conglomerati, gomme, plastica ecc.).
I materiali naturali, a loro volta, sono classificati in:
• materiali organici, ovvero di origine animale o vegetale, che si ricavano da organismi viventi in grado di riprodursi (legno, paglia, cotone, caucciù, sughero ecc.);
• materiali inorganici, ovvero di origine minerale, cioè composti naturali non in grado di riprodursi che si trovano sulla crosta terrestre (oro, argento, ferro, marmo, diamanti, sabbia ecc.).
PER L’INTERROGAZIONE
1. Perché alcuni giacimenti di materie prime si stanno esaurendo?
2. Come sono classificate le risorse?
3. Qual è la definizione di materiale?
4. Qual è la differenza tra materiale organico e inorganico?

Il legno è un materiale organico molto utilizzato dall’uomo.
I primi materiali
I primi materiali conosciuti e usati dall’uomo, in ordine di necessità, furono il legno e la pietra, perché erano immediatamente disponibili e facilmente reperibili. Seguirono l’argilla, le fibre tessili, i metalli e tanti altri materiali. Con il passare del tempo e con le nuove scoperte, l’uomo imparò a trasformare i materiali naturali in prodotti aventi caratteristiche diverse da quelle di origine. Primo tra tutti fu il vaso di ceramica, ottenuto con la cottura dell’argilla, poi fu la volta del vetro, che si ricava dalla lavorazione della silice
Roccia sedimentaria utilizzata nella realizzazione della ceramica e dei laterizi.
Silice
Minerale diffuso sulla crosta terrestre, utilizzato nella produzione del vetro.
3. Le proprietà dei materiali
Scegliere i materiali
La scelta di un materiale per produrre un bene è determinata dalla conoscenza di una o più sue proprietà perché non tutti i materiali sono uguali e, soprattutto, non tutti presentano le medesime caratteristiche. È necessario quindi conoscere la funzione che dovrà svolgere il prodotto e le sollecitazioni cui verrà sottoposto per poter scegliere il materiale più idoneo. Molto spesso, per ottenere materiali idonei a più scopi, vengono uniti più elementi: nell’acciaio, per esempio, una percentuale di carbonio unita al ferro ne influenza molto la durezza. O ancora, modificando la quantità di collante nel processo produttivo della carta, ne consegue una variazione dell’assorbimento finale dell’inchiostro; aggiungendo del piombo alla miscela di preparazione del vetro si ottiene una maggiore durezza e una migliore trasparenza, e così via Le proprietà dei materiali si suddividono in fisico-chimiche, meccaniche e tecnologiche.
Proprietà fisico-chimiche
Le proprietà fisico-chimiche sono proprie degli elementi che costituiscono i singoli materiali, ovvero si riferiscono alle caratteristiche generali della materia stessa. Le proprietà fisiche non alterano la composizione della materia, ma agiscono sulla forma e sul volume; quelle chimiche invece cambiano la composizione della sostanza. Le principali sono:
• conducibilità termica ed elettrica, la capacità di trasmettere calore o elettricità;
• resistenza all’ossidazione e alla corrosione, cioè al deterioramento dovuto ad agenti esterni;
• peso specifico, il rapporto tra il peso e il volume di un corpo;
• colore, la sensazione che dà all’occhio la luce riflessa dai corpi;
• temperatura di fusione, alla quale una sostanza passa dallo stato solido a quello liquido;
• dilatazione termica, la variazione del volume di una sostanza dovuta alla temperatura;
• igroscopicità o impermeabilità, la capacità o meno di una sostanza di assorbire acqua e umidità.

Igroscopicità. Temperatura di fusione.
Scheda 3
Proprietà meccaniche
Le proprietà meccaniche si riferiscono al comportamento dei materiali
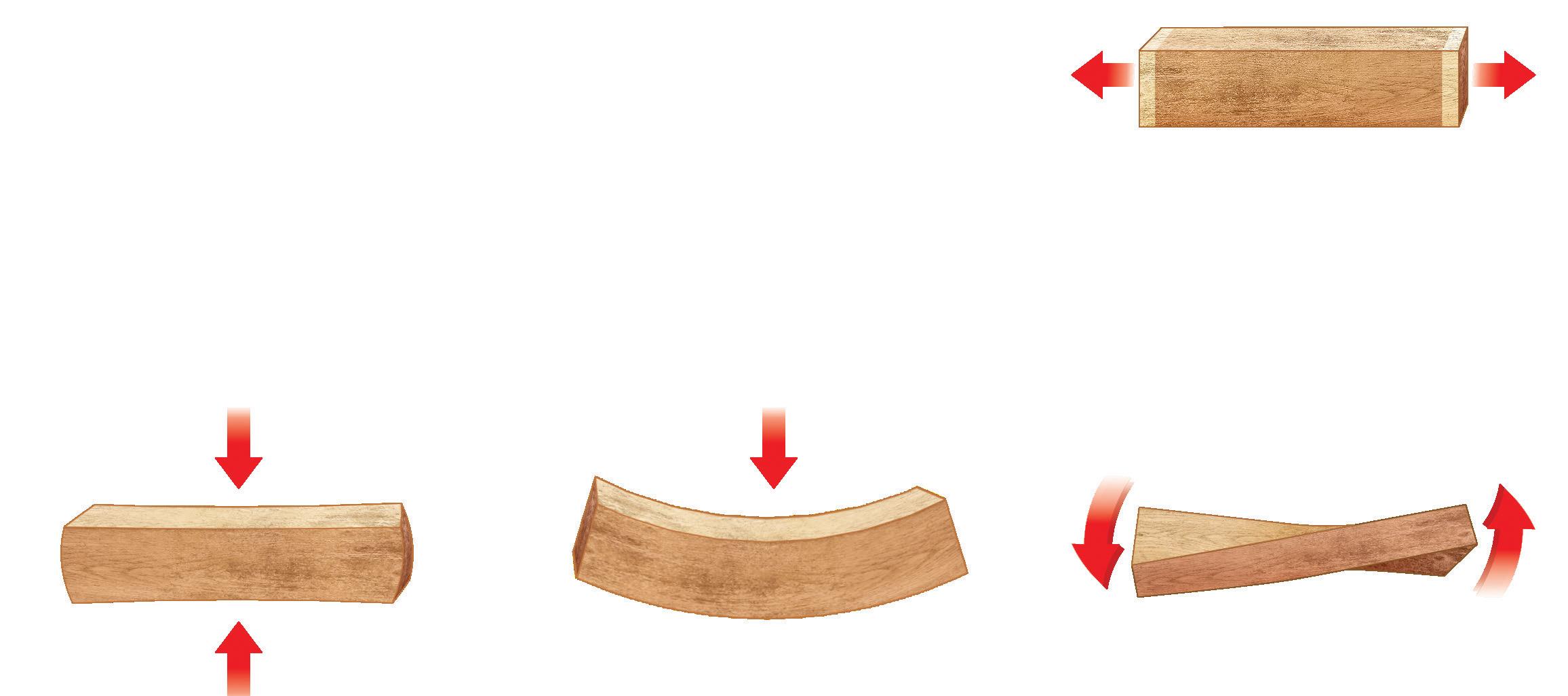
Compressione.
Proprietà tecnologiche
Le proprietà tecnologiche riguardano i materiali sottoposti a qualsiasi tipo di lavorazione e consistono nell’attitudine a lasciarsi modellare per ottenere una determinata forma finale. Le principali sono:
• malleabilità, la proprietà di un materiale di poter essere ridotto in lamine e lastre sottili;
• duttilità, la proprietà di un materiale di poter essere ridotto in fili;
• plasticità, la capacità di un materiale di cambiare forma in maniera definitiva;
• temprabilità, la capacità di acquistare maggiore resistenza attraverso la tempra, che consiste nel riscaldamento e nell’immediato raffreddamento del materiale;
• fusibilità, la proprietà di un materiale di fondere a determinate temperature;
• saldabilità, la capacità di un materiale di essere unito con altri costituendo un unico nuovo pezzo.
PER L’INTERROGAZIONE
1. Quali sono le proprietà dei materiali?
2. Che cosa sono le proprietà fisicochimiche?
3. A cosa fanno riferimento le proprietà meccaniche?
4. Che cosa sono le proprietà tecnologiche?

CONCETTI CHIAVE
4. Settori economici e industria
Dagli utensili in pietra alla robotica
La tecnologia fa parte a tutti gli effetti della cultura umana e, al pari di quest’ultima, si trasforma continuamente. L’arte di levigare gli utensili di legno e di pietra è stata tra le prime attività dell’uomo: questo modo di realizzare i primi rudimentali strumenti, che servivano per la caccia, era l’inizio di un processo tecnologico. In un primo tempo i manufatti si tramandavano così com’erano di padre in figlio. Successivamente prevalse la regola della modificazione: i prodotti tecnologici del passato erano presi come modelli da riprodurre, ma ogni volta si attuava una rigida selezione per stabilire quali servivano ancora e per scartare quelli di cui non si avvertiva più il bisogno. Ogni generazione proponeva così variazioni e innovazioni. Si cominciava a parlare, cioè, di trasformazioni tecnologiche. Comparve ben presto il concetto di accelerazione, ossia cambiamento continuo. L’accelerazione, associata alle scoperte scientifiche e all’industrializzazione con le sue macchine, si velocizzò ulteriormente sotto la forte spinta del computer, che negli ultimi decenni ha modificato l’organizzazione della società e del mercato. Il cammino tecnologico è continuato e continua ancora giungendo fino alla robotica che, in virtù della sua natura interdisciplinare, trova applicazione in molteplici contesti come quello medico (biorobotica), domestico (domotica), spaziale e industriale.
I settori economici
Ogni processo produttivo si lega inevitabilmente a quelli che l’economia definisce settori economici, ovvero la suddivisione delle attività produttive secondo caratteristiche comuni. In base a questa classificazione i settori sono distinti in primario, secondario, terziario e terziario avanzato
SETTORI ECONOMICI
Primario

Tutte le attività lavorative svolte per ottenere i beni primari indispensabili per la vita dell’uomo. Comprende l’agricoltura, la silvicoltura (coltivazione dei boschi per ricavarne legname), la zootecnia (allevamento del bestiame), la pesca e le attività estrattive (minerali, risorse energetiche).
Secondario

Tutte le attività lavorative finalizzate alla trasformazione delle materie prime in prodotti semilavorati o prodotti finiti. È strettamente legato al settore primario, poiché non avrebbe motivo di esistere se non vi fossero le materie prime da trasformare. Comprende l’industria e l’artigianato.
Terziario

Dai primi rudimentali strumenti per la caccia si arriva a oggetti microscopici dalle incredibili caratteristiche tecnologiche, grazie alle continue trasformazioni tecnologiche.


Tutte le attività finalizzate alla vendita dei beni prodotti e alla fornitura dei vari servizi, inclusi quelli di pubblica utilità. Questi servizi possono essere destinati alla vendita (per esempio i trasporti, il commercio, l’attività bancaria e assicurativa, il turismo), oppure non destinati alla vendita e generalmente a carico dell’Amministrazione Pubblica (per esempio la giustizia, la sanità, la sicurezza, l’istruzione).
È un settore di ultima generazione, definito anche quaternario, al quale appartengono le attività di ricerca scientifica e di sviluppo di programmi informatici, capaci di gestire le macchine per la produzione e che offrono un valido supporto nella gestione amministrativa delle società avanzate.

L’industria
L’industria è un complesso sistema di lavoratori e macchinari che, attraverso l’impiego di risorse naturali, finanziarie e tecniche, trasforma le materie prime in semilavorati e prodotti finiti destinati al consumo.
L’industria fornisce alla società prodotti di massa con l’aiuto di sistemi sempre più efficienti che sostituiscono, e in alcuni casi eliminano del tutto, il lavoro manuale. Talvolta, infatti, il compito dell’uomo all’interno di alcune tipologie di industria è divenuto unicamente quello di controllare che tutti i processi si svolgano secondo precisi e stabiliti schemi di lavorazione.
Ogni industria, operante all’interno di differenti settori produttivi, è organizzata con strutture e modalità di lavoro proprie, ma alla base c’è quasi sempre la ricerca di metodi di produzione e di tecnologie innovative necessarie per poter competere all’interno del mercato. La robotizzazione e la computerizzazione caratterizzano oggi molti
cicli produttivi: grazie a macchinari sempre più innovativi ogni prodotto viene controllato più volte e può uscire dall’industria solamente se non presenta imperfezioni. L’industria fa parte del settore secondario ma, come molte altre attività produttive, è connessa ad altri settori economici: reperisce le materie prime grazie alle attività svolte nell’ambito dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’estrazione dei minerali ecc., e utilizza servizi offerti dai settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, del commercio, della finanza ecc.
Gli impianti industriali
Gli impianti industriali sono costituiti dall’insieme di macchine, strumenti e servizi organizzati in uno o più spazi con lo scopo di permettere la messa in opera delle diverse fasi di un ciclo produttivo. Eseguono cioè il ciclo tecnologico del prodotto, ossia la sequenza delle attività necessarie per passare dalle materie prime ai prodotti finiti.
Ogni impianto ha una specifica capacità produttiva, ossia ha la possibilità teorica di produrre un certo numero di pezzi in una precisa unità di tempo.
Gli impianti industriali possono essere organizzati secondo due tipi di processi:
• processo di tipo continuo, che svolge un solo ciclo di lavorazione fornendo una sola varietà di prodotto; si basa generalmente sulla catena di montaggio, ossia la disposizione dei macchinari nell’ordine in cui si svolgono le fasi di lavorazione;
• processo di tipo intermittente, che svolge in modo alterno cicli di lavorazione diversi per ottenere differenti varietà di prodotti; le macchine uguali o simili sono riunite in reparti specializzati indipendentemente dall’ordine delle fasi di lavorazione previste.
Prodotti di massa
Prodotti industriali realizzati in grandi quantità e in serie, cioè tutti identici tra loro, in modo da soddisfare un alto numero di consumatori. Mercato Il complesso degli scambi economici.
L’ARTIGIANATO
L’artigiano è un imprenditore che esercita un’attività manuale non di serie, con l’utilizzo di appositi macchinari, lavorando da solo o con la collaborazione di familiari o di pochi operai.
Nel nostro Paese, l’attività artigianale ha sempre avuto un ruolo economico importante anche per l’offerta di posti di lavoro, legandosi ad attività diversificate come l’edilizia, i trasporti e molte altre (falegnami, imbianchini, idraulici, fabbri, meccanici, parrucchieri, sarti ecc.).
PER L’INTERROGAZIONE
1. Quali sono le principali attività che fanno parte del settore primario?
2. Che differenza c’è tra settore terziario e terziario avanzato?
3. Che cos’è la capacità produttiva di un impianto?
4. Come possono essere organizzati i processi industriali?

5. Ciclo produttivo e sostenibilità

Il ciclo produttivo industriale
Per dare vita a un processo industriale occorrono materiali offerti dalla natura: questi dovranno essere facilmente lavorabili e, soprattutto, economicamente convenienti da trasformare. Le risorse naturali che entrano nell’industria per essere immesse in un ciclo produttivo vengono chiamate materie prime. Esse subiscono una serie di trasformazioni che cambiano le loro caratteristiche rendendole adatte alle successive fasi del ciclo, divengono cioè materiali semilavorati. I semilavorati devono poi essere sottoposti a ulteriori lavorazioni, al termine delle quali diventano dei prodotti finiti pronti per la commercializzazione. Ogni prodotto è utilizzato dalle persone per un certo periodo di tempo, breve o lungo a seconda delle caratteristiche dell’oggetto stesso: questa fase viene chiamata consumo Quando il prodotto ha soddisfatto il bisogno per cui è stato realizzato, cioè quando è stato consumato, si trasforma in rifiuto e deve essere eliminato: si parla in questo caso di dismissione. Facciamo un esempio per illustrare il ciclo produttivo industriale.
Materie prime
Il cotone è una risorsa naturale adatta alla produzione industriale.

Prodotti semilavorati
Subisce una prima lavorazione che lo trasforma in filato, cioè in un semilavorato, e diventa una materia prima per il settore tessile. Il filato viene successivamente lavorato per ottenere un tessuto, ovvero un altro semilavorato.

Prodotti finiti
Saranno le successive lavorazioni a trasformarlo in un prodotto finito, per esempio in una T-shirt, pronta a soddisfare i desideri dei consumatori finali.

Consumo
Il prodotto ottenuto, la T-shirt, viene utilizzato.

Economia circolare: un ciclo industriale sostenibile
Nel momento in cui la T-shirt sarà consumata o rovinata, verrà dismessa. Dismissione


Nel corso dei millenni, l’uomo ha sempre utilizzato quanto trovava in natura per la propria sopravvivenza, senza mai preoccuparsi della gestione dei rifiuti che produceva. Era la natura stessa che provvedeva, in un tempo breve, a riutilizzare i rifiuti come parte integrante di un ciclo biologico. Ogni forma di rifiuto diveniva una risorsa indispensabile per altri esseri viventi: la nascita, la crescita, la morte e la trasformazione erano alla base di quello che si definisce ciclo naturale chiuso, ossia materia che si trasforma in altra materia. Con il tempo, però, le scoperte della chimica e il progredire della tecnologia hanno contribuito alla produzione di materiali sintetici che hanno apportato vantaggi nella vita quotidiana, ma i cui scarti non si sono mostrati adatti a essere smaltiti dalla natura: sono risultati cioè non biodegradabili. L’uomo ha interrotto il virtuoso ciclo naturale chiuso per dare vita a un ciclo aperto caratterizzato dall’estrazione delle materie prime, dalla loro trasformazione in prodotti e successivamente in rifiuti.
Lo smaltimento dei beni dismessi, pian piano ha portato con sé squilibri ambientali, con ripercussioni anche sulla salute dell’uomo. A queste problematiche si è aggiunta la consapevolezza di una progressiva diminuzione della disponibilità delle risorse naturali. Tutto ciò ha portato l’uomo a ripensare alle fasi del ciclo industriale tradizionale e a introdurre, anche se lentamente, un sistema industriale con ciclo chiuso. Esso prevede che il prodotto, dopo il consumo, torni al punto di partenza del ciclo industriale stesso divenendo nuovamente materia prima grazie al riciclo: partendo dalle bottiglie di vetro già utilizzate si possono per esempio ottenere nuove bottiglie di vetro e così via.
Attualmente gli Stati industrializzati stanno adottando sistemi innovativi per un’economia produttiva definita economia circolare, secondo la quale i rifiuti di origine biologica possono rientrare nel ciclo naturale che li reintegra come nutrienti per il terreno, mentre i rifiuti tecnologici sono rivalorizzati come risorsa per ottenere nuove materie prime.
Lo sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030

Nell’ultimo secolo ci si è resi conto che la Terra e le sue risorse sono in pericolo e si è pertanto cercato di trovare soluzioni alle diverse problematiche ambientali. Nel 1992 fu redatta la Dichiarazione di Rio, un codice di comportamento in cui sono fissati alcuni princìpi universali da realizzare su scala mondiale, nella quale si parla di sviluppo sostenibile. Il termine sostenibilità dello sviluppo indica una nuova modalità di vita e di progresso che presti maggiore attenzione alle risorse, basandosi sul giusto equilibrio tra crescita economica, inclusione sociale e tutela dell’ambiente Dal 1992 quasi tutti gli Stati del mondo tengono periodicamente incontri per tentare di convogliare i propri sforzi nella direzione di uno sviluppo sostenibile globale. Il 25 settembre 2015, in occasione dell’Assemblea generale dell’ONU, i governi dei 193 Paesi membri hanno presentato e sottoscritto l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, «un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità» volto al rafforzamento della pace universale e allo sradicamento della povertà in tutte le sue forme, prospettando un cambiamento di rotta dell’economia mondiale e spingendo alla collaborazione a livello globale
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile si compone di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e 169 target, o traguardi, che sono parte fondante dell’Agenda e dovranno essere raggiunti entro il 2030
All’interno di questo libro troverai molti riferimenti agli obiettivi descritti dall’Agenda 2030: li potrai facilmente identificare grazie all’apposita icona presente all’inizio di alcune Lezioni e in apertura di Area.
In fondo al volume, inoltre, è disponibile una descrizione degli obiettivi dell’Agenda 2030 presenti in questo corso.

Piatti e posate monouso sono oggi prodotti con materiali naturali.
PER L’INTERROGAZIONE
1. Che differenza c’è tra materia prima e semilavorato?
2. Cosa accade a un prodotto dopo il consumo?
3. Che differenza c’è tra ciclo industriale tradizionale e ciclo industriale chiuso?
4. Che cos’è l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile?

6. Rifiuti e smaltimento
Discariche e raccolta differenziata

Con l’industrializzazione le materie prime subiscono profonde modifiche e diversificati processi di lavorazione: si consumano moltissimi nuovi prodotti, ma aumentano di pari passo i rifiuti non biodegradabili.
Il territorio comincia allora a ospitare le prime discariche, ossia ampi territori o cavità naturali che accolgono tutto ciò che viene dismesso. Queste però si rivelano ben presto responsabili dell’inquinamento delle falde acquifere e dell’ambiente. Per arginare il problema vengono introdotte allora delle norme molto rigide per regolamentare la raccolta di rifiuti e per evitare il disperdersi degli inquinanti nel terreno: nascono le discariche controllate, luoghi dove avviene lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani dei quali non è possibile eseguire il riciclaggio.
Purtroppo ancora oggi nel nostro territorio vengono spesso scoperte discariche non controllate o abusive, all’interno delle quali vengono accumulati rifiuti spesso pericolosi, creando gravi problematiche di inquinamento del terreno e rischi per la salute dell’uomo. A quest’ultime si affiancano anche gli abbandoni nell’ambiente di elettrodomestici, pneumatici, mobili e materiali edili.
Fondamentale diviene quindi la raccolta differenziata, che ha come obiettivo il riciclaggio della maggior parte dei rifiuti al fine di salvaguardare l’ambiente e recuperare materie prime le cui riserve tendono pian piano a esaurirsi.
A questo progetto di ecosostenibilità dobbiamo partecipare tutti noi con azioni semplici e responsabili, attivandoci per incrementare il riuso, la riduzione degli scarti e la separazione attenta dei vari materiali per il riciclo, che permetta la successiva trasformazione in materia prima di seconda generazione, ovvero non derivante direttamente dalle risorse naturali.

Falda acquifera
Contiene l’acqua che si raccoglie nel sottosuolo e che torna poi a disposizione dell’uomo per i suoi bisogni. Stoccaggio
Conservazione di materiali in un deposito.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Le quattro R
Molto spesso sentiamo parlare di recupero, di riciclo, di riutilizzo e di riduzione: non sono sinonimi ma termini che si riferiscono a specifiche funzioni di gestione dei rifiuti, con l’obiettivo comune di favorire la sostenibilità ambientale:
• recupero si riferisce a una serie complessa di azioni (raccolta, trasporto, immagazzinamento) finalizzate alla valorizzazione dei rifiuti come risorse;
• riciclaggio indica il riutilizzo delle materie prime che costituiscono il prodotto al termine del suo ciclo di vita e che possono essere impiegate in un nuovo ciclo produttivo; i materiali comunemente sottoposti a riciclo sono i metalli, la carta, il legno, il vetro e parte delle materie plastiche;
• riutilizzo o riuso indica il nuovo utilizzo di prodotti senza che avvenga alcuna lavorazione; i prodotti sono talvolta impiegati con funzioni diverse da quelle originarie (per esempio trasformare una vecchia bottiglia di plastica in un vaso per i fiori);
• riduzione si riferisce alle azioni finalizzate alla riduzione effettiva dei rifiuti, come acquistare prodotti con poco imballaggio, utilizzare per la spesa una borsa in tela o acquistare solo prodotti effettivamente necessari.
I rifiuti
Si definisce rifiuto qualsiasi sostanza, oppure oggetto di scarto, derivante da attività umane o da cicli naturali, eliminato o abbandonato. Generalmente i rifiuti sono distinti in tre categorie principali:
• rifiuti urbani, provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili, oppure posti nei cestini su strade e aree pubbliche o private;
• rifiuti speciali, derivanti da lavorazioni industriali e da attività agricole, commerciali, artigianali; sono compresi i rifiuti ospedalieri, i materiali provenienti da demolizioni e scavi, quelli dai veicoli a motore, i residui di rifiuti solidi e i fanghi derivanti dalla depurazione delle acque;
• rifiuti nocivi, contenenti sostanze tossiche e nocive come, per esempio, amianto, arsenico, mercurio, piombo, solventi, scorie radioattive.
L’isola ecologica
L’isola ecologica, conosciuta anche con il nome di piazzola ecologica o ecocentro, è un’area presente sul territorio comunale nella quale i cittadini e le aziende possono portare i propri rifiuti ingombranti o non smaltiti con il normale sistema di raccolta porta a porta. Strutturalmente l’area è recintata per avere un maggior controllo sullo smaltimento dei rifiuti, suddivisi per frazioni omogenee nei vari cassonetti. Una volta riempiti i cassonetti si procederà al loro invio presso i centri specializzati per l’attività di recupero e trattamento. L’accesso all’area è generalmente ristretto e controllato.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il valore dell’umido
Nella raccolta differenziata l’umido, ovvero l’insieme di scarti alimentari e dei piccoli scarti del giardino, è raccolto in un sacchetto biodegradabile per essere inviato a un centro attrezzato di compostaggio. Da questi scarti si ottiene il compost, una sostanza per fertilizzare il terreno. Bisogna stare attenti a non confondere biodegradabilità e compostaggio:
• i materiali biodegradabili sono quelli che si degradano, in un tempo più o meno lungo, a causa di specifici batteri presenti nell’ambiente e alla fine del processo sono assorbiti direttamente dal terreno;
• il compostaggio è il risultato del processo di decomposizione dovuto all’azione di batteri e animali che avviene, in un tempo molto breve, sulle sostanze vegetali alla fine del loro processo vitale e dal quale si ottiene il compost, un ottimo fertilizzante per l’agricoltura.

I rifiuti ospedalieri vengono trattati con la massima cautela.
PER L’INTERROGAZIONE
1. Che differenza c’è tra discariche controllate e discariche non controllate?
2. Come si classificano i rifiuti?
3. Che differenza c’è tra biodegradabilità e compostaggio?
In ogni Comune italiano sono presenti i contenitori colorati per la raccolta differenziata dei rifiuti da avviare al riciclo: in gran parte dei casi la raccolta avviene col sistema «porta a porta», ovvero a domicilio.

7. Inquinamento
Inquinamento ambientale
L’inquinamento ambientale è inteso come un’alterazione del terreno, dell’aria e dell’acqua le cui cause sono dovute sia a fenomeni naturali che all’attività antropica (dell’uomo).
L’evoluzione dello stile di vita, con scarsa attenzione verso l’ecosostenibilità, ha contribuito enormemente ad aumentare l’inquinamento della Terra. Questo fenomeno, che peggiora sempre più velocemente, è causato in particolare dall’eccessivo consumo di combustibili fossili che vengono usati giornalmente per le centrali elettriche, per la mobilità e per le caldaie domestiche. I gas che si generano dalla combustione dei carburanti vengono immessi in modo incontrollato nell’ambiente causando forti squilibri sugli ecosistemi e sulla biosfera. Solo negli ultimi decenni moltissimi Paesi, presa coscienza dei pericoli che il progresso tecnologico sta causando, hanno iniziato a regolamentare tutto ciò che causa inquinamento.
Inquinamento del suolo
L’inquinamento del suolo è un’alterazione, più o meno permanente, dovuta alla presenza di composti chimici e materiali tossici provenienti dalle attività industriali, agricole e dai rifiuti urbani, con effetti negativi sui prodotti per l’alimentazione, sugli animali e di conseguenza sulla salute dell’uomo. Tale inquinamento, oltre a condizionare la produttività agricola, è responsabile della contaminazione dell’acqua che beviamo e dell’aria che respiriamo.
Inquinamento delle acque
L’inquinamento delle acque è causato da molti fattori legati a uno scorretto smaltimento degli scarichi urbani, industriali e delle attività produttive agricole. I componenti chimici presenti nei rifiuti generati da tali attività vengono trasportati nei fiumi e da questi al mare o nei laghi. Se, invece, vengono abbandonati sul terreno, si infiltrano negli strati profondi del sottosuolo inquinando le falde acquifere, con possibili conseguenze per la salute delle persone. L’acqua è un elemento fondamentale per la vita sul pianeta: nonostante sia disponibile in quantità enorme, solo una piccola parte (circa il 3%) è acqua dolce, necessaria alla vita. Purtroppo, una buona parte di questa viene sprecata o inquinata, mettendo a serio rischio la vita in alcune zone del pianeta. Un particolare inquinamento dei mari e dei laghi è l’eutrofizzazione, ovvero l’eccessiva concentrazione di elementi chimici, soprattutto fosforo e azoto, derivanti dai detergenti presenti nei reflui urbani e nelle concimazioni agricole che causano una abnorme crescita delle alghe e delle piante acquatiche le quali, sottraendo ossigeno, compromettono la vita del mondo ittico. Altro rilevante pericolo è dato dallo sversamento di petrolio in mare, causato da incidenti alle petroliere. Il petrolio, ristagnando per molto tempo sulla superficie dell’acqua, danneggia in modo rilevante gli ecosistemi e il più delle volte la fascia costiera. Inoltre, un problema oggi molto grave è dato dalla grande presenza di plastica e microplastica negli oceani (vedi p. 57).



Inquinamento dell’aria
L’inquinamento atmosferico si ha quando nell’aria si vengono a trovare delle alte concentrazioni di sostanze nocive per la salute dell’uomo, degli animali e delle piante.
I principali inquinanti provengono dalle attività industriali, dagli autoveicoli, dalle centrali elettriche, dalle caldaie domestiche e dagli impianti di incenerimento. Questi emettono nell’aria degli inquinanti: anidride carbonica (CO2), monossido di azoto (NO), biossido di azoto (NO2) e particolato o polveri sottili (PM10). Nell’aria si trovano anche concentrazioni di benzene, diossine e tanti altri elementi chimici che derivano dalle attività produttive quotidiane dell’uomo.
I danni all’ambiente provocati da tali inquinanti sono principalmente:
• piogge acide: si verificano quando anidride solforosa e ossidi di zolfo e di azoto, in particolari condizioni climatiche, ricadono al suolo sotto forma di neve, pioggia o nebbia provocando danni, oltre che alle opere d’arte esposte all’esterno, alle piante e agli animali privandoli delle loro protezioni naturali;
• buco dell’ozono: la diminuzione dello strato di ozono presente nella stratosfera, dovuta alle attività antropiche, causa una ridotta protezione dalle radiazioni ultraviolette del Sole che provoca danni ai viventi;
• effetto serra: le radiazioni solari, a causa della presenza di uno spesso strato di CO2 in atmosfera, dopo aver raggiunto la crosta terrestre non riescono più a disperdersi nello spazio, provocando l’aumento della temperatura e squilibri agli ecosistemi e al clima.
Riscaldamento globale e cambiamenti climatici
L’inquinamento e gli effetti che provoca sono alla base del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici in atto nel nostro pianeta. In particolare, l’effetto serra contribuisce all’innalzamento delle temperature medie, fenomeno ormai diffuso in molte parti del mondo negli ultimi anni.
Tutto ciò sta causando dei rapidi cambiamenti climatici, i cui effetti dannosi si stanno già mostrando:
• scioglimento dei ghiacciai con conseguente innalzamento del livello degli oceani, fattore che sta già minacciando territori costieri e sommergendo isole abitate;
• desertificazione di alcune aree, con conseguente riduzione delle foreste e delle aree coltivabili;
• riduzione delle piogge, con conseguente diminuzione della disponibilità di acqua dolce;
• estinzione di alcune specie animali e vegetali.

Fridays for Future
Greta Thunberg è una ragazza svedese che a 15 anni ha iniziato, prima da sola poi coinvolgendo migliaia di altri giovani, una lotta a favore dello sviluppo sostenibile e contro i cambiamenti climatici. Oggi è il simbolo di moltissimi studenti che hanno a cuore la salvaguardia ambientale. Per la sua battaglia è stata candidata al premio Nobel per la pace ed è stata ricevuta da alte personalità politiche e dal pontefice Papa Francesco.

PER L’INTERROGAZIONE
1. Cosa si intende per inquinamento ambientale?
2. Quali sono gli inquinanti del suolo?
3. In cosa consiste il processo di eutrofizzazione delle acque?
4. Da dove provengono i principali inquinanti dell’aria?
5. Quali sono gli effetti del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici?
AREA 1 Materiali
I materiali sono dei prodotti formati da una o più sostanze. Possono essere di origine organica (legno, carta, fibre tessili) oppure inorganica (materie plastiche, vetro, ceramica, metalli). Si utilizzano per ottenere oggetti o manufatti che presentano, in funzione al loro impiego, proprietà e caratteristiche proprie.
AGENDA 2030
Nell’Area sono presenti contenuti legati all’Agenda 2030:
• Lezione 5
• Lezione 9
• Lezione 19
• Lezione 24
• Lezione 32
• Educazione civica




Materiali

Materie plastiche







Flipped classroom
La carta e l’ambiente
In Italia si producono ogni anno moltissimi prodotti cartacei, sia con materie prime «vergini», sia con materie prime dette «seconde», ossia con la carta da macero. Ma... che tipo di rapporto c’è tra cartiera e ambiente?
IN AUTONOMIA



1 Guarda il filmato e scopri la storia dei fogli di carta. Scoprirai molte informazioni utili e interessanti sul processo produttivo della carta.
2 Analizza l’impatto ambientale delle diverse fasi produttive: scopri eventuali criticità e proponi adeguate soluzioni alternative.
Per farlo leggi la procedura di preparazione delle paste di cellulosa e dei fogli di carta (pagine 29, 30 e 31); poi cerca ulteriori informazioni visitando specifici siti internet. Prendi appunti ed eventualmente stampa il materiale che reputi interessante.
3 Approfondisci le tue conoscenze sul riciclo di questo materiale.
Leggi attentamente la scheda di educazione ambientale (pagina 33). Cerca in internet qualche video che mostri il processo di riciclaggio della carta. Annota le informazioni che reputi interessanti.
IN GRUPPO
Dopo aver formato dei piccoli gruppi in classe:
• confrontatevi su quanto ciascuno di voi ha imparato autonomamente a casa;
• esaminate appunti e materiale raccolto e discutetene tra di voi;
• preparate un documento nel quale, sulla base di motivazioni e dati certi, si definisca il rapporto tra cartiera e ambiente e la sostenibilità del riciclo della carta.

Questa è solamente una proposta di lavoro: potete esercitarvi con la classe capovolta anche con gli altri filmati presenti nelle Unità dell’Area.

Legno

Lezione
1. Il legno
Il legno è stato uno dei primi materiali utilizzati dall’uomo nella storia, sia perché molto presente in natura sia per le sue proprietà.
Proprietà fisico-chimiche
Colore e odore: caratteristiche per cui si distingue un legno da un altro.
Igroscopicità: capacità di assorbire acqua o umidità.
Ritiro e dilatazione: variazione delle dimensioni per effetto della perdita di umidità o dell’assorbimento.
Conducibilità elettrica e termica: capacità di opporsi al passaggio della corrente e del calore (il legno è un isolante).
Il tronco
Proprietà meccaniche
Durezza: resistenza alla scalfittura e all’abrasione.
Resistenza: capacità di opporsi a tutte le forze esterne come la trazione, la compressione, la torsione, la flessione e il taglio.
Elasticità: capacità di deformarsi temporaneamente per tornare poi alla forma iniziale.
Il tronco è la parte di albero che si trova tra la chioma e le radici. Al suo interno passano i vasi legnosi che servono per trasportare la linfa grezza dalle radici alle foglie, e i vasi cribrosi che, con un percorso inverso, trasportano la linfa elaborata. Analizzando la sezione di un tronco si possono osservare le diverse parti che lo compongono.
Proprietà tecnologiche
Plasticità: capacità di deformarsi sotto l’effetto di una forza esterna.
Curvabilità: capacità di assumere una forma curva e di mantenerla nel tempo.
Fendibilità: capacità di fendersi, cioè di lasciarsi spaccare nel senso della lunghezza delle fibre.
Attitudine al taglio: capacità di lasciarsi tagliare con gli attrezzi.
STRUTTURA DEL TRONCO
2 Durame, o legno propriamente detto. È la parte più vecchia del tronco e la più compatta, formata da cellule morte dove non scorre più la linfa.
1 Midollo. È situato al centro del tronco, è costituito da una sostanza spugnosa e nelle piante più vecchie tende a sparire.
Il legno è un materiale rinnovabile che si ricava dalle fibre vegetali situate sotto la corteccia del tronco delle piante.
Il legno nella storia
Fin dall’antichità l’uomo ha utilizzato il legno, impiegandolo nella costruzione di armi per la caccia e attrezzi per coltivare; utilizzandolo come combustibile inoltre, se ne servì per scaldarsi, cuocere i cibi, tenere lontani gli animali feroci e illuminare. Successivamente imparò a costruire piroghe e poi navi per scoprire nuove terre e scambiare le merci. Già gli antichi Egizi conoscevano la tecnica dell’impiallacciatura (vedi p. 22), i Romani usavano il legno per costruire le imponenti strutture ancora oggi visibili, nel Medioevo gli artigiani creavano svariati oggetti, da quelli più piccoli di uso quotidiano ai mobili intarsiati per arredare le case.

3 Alburno. È la parte di legno di più recente formazione, ricca di vasi legnosi.
4 Cambio. È uno strato elastico che rappresenta la crescita del tronco.
5 Libro. È uno strato sottile sotto la corteccia, all’interno del quale scorre la linfa verso le radici.

6 Corteccia. È lo strato superficiale, formato da cellule morte, che riveste il tronco e lo protegge dagli agenti atmosferici e dai parassiti.
La classificazione delle essenze
I legnami possono essere classificati in base alla regione geografica di provenienza: si distinguono in legnami di zone temperate (Europa e America) ed esotici, provenienti da zone tropicali. Un’altra classificazione è definita in base all’albero di provenienza: legname da latifoglie, alberi che hanno foglie larghe e caduche, e legname da aghifoglie, sempreverdi con foglie aghiformi. Infine, le essenze sono distinte in base alla loro durezza.
Legni teneri: pioppo, betulla, tiglio. Hanno una colorazione più chiara e un minor peso dei legni duri. Si lasciano scalfire facilmente anche con l’unghia.

Legni resinosi: pino, abete rosso, larice. Sono legni teneri che contengono all’interno una resina che protegge la pianta dagli attacchi dei funghi e degli insetti. La resina è molto utilizzata dall’industria chimica.

PER
Legni duri: faggio, frassino, noce, rovere, ciliegio.
Provengono da piante che crescono in climi temperati, il cui legno è duro e compatto; non si lasciano scalfire facilmente.

I difetti del legno
Legni esotici: mogano, teak, palissandro. Provengono da zone tropicali, dove esiste un’unica stagione e la crescita degli alberi è continua. I legni sono duri e compatti.

Essenza
Termine che indica le diverse tipologie di legno.
Resina
Sostanza appiccicosa e profumata prodotta da alcuni vegetali.
CLIL
Albero: tree
Legno: wood
1. Che cos’è il legno?
2. Da cosa è costituito il tronco?
3. Come vengono classificate le essenze del legno?
4. Quali sono i principali difetti del legno?
Il legno, in quanto materiale biologico, è soggetto ad alterazioni naturali che ne possono compromettere l’utilizzo e la lavorazione. I principali difetti sono quindi dovuti a malformazioni naturali del tronco.

Cipollature
Formazione di distacchi tra le fibre attorno agli anelli di accrescimento contigui, proprio come in una cipolla tagliata trasversalmente.
Fenditure
Distacchi tra le fibre che avvengono in modo radiale, dalla corteccia verso il midollo.
Eccentricità
Spostamento del midollo verso l’esterno.
Nodi
Inserzioni di giovani rami che non si sono sviluppati (nodi vivi) o punti di sviluppo dei rami che, staccandosi, lasciano buchi (nodi morti).
A 1 In primo piano
Lezione
2. La produzione del legname
Il ciclo produttivo del legno ha inizio subito dopo il taglio delle piante che avviene nei boschi. Prosegue poi nelle segherie, dove i tronchi subiscono delle lavorazioni per essere trasformati in prodotti semilavorati da inviare alle varie industrie o per la lavorazione artigianale.
1


3
Abbattimento
Il taglio, o abbattimento della pianta, viene generalmente eseguito nella stagione invernale, quando l’attività vegetativa è minima. Si usano motoseghe manuali o speciali macchine montate su trattori, dotate di braccio meccanico e cesoie.
L’ETÀ DEGLI ALBERI
Tagliando un tronco e osservandone la sezione si può notare una serie di cerchi concentrici, chiamati anelli annuali di accrescimento. Questi sono caratterizzati da diversi toni di colore: un colore chiaro identifica il legno formatosi in primavera/estate, un colore scuro indica che l’accrescimen to è avvenuto in autunno/inverno. Poiché ogni anno si formano due anelli di accrescimento, è facile determinare l’età della pianta.

2
Sramatura e depezzatura
Al taglio seguono la sramatura, cioè l’eliminazione dei rami, e la depezzatura o troncatura, che consiste nella riduzione del tronco a misure standardizzate per agevolarne il trasporto. Spesso la sramatura avviene prima dell’abbattimento, per non danneggiare le altre piante.
Trasporto
I tronchi vengono trasportati alla segheria per mezzo di camion, vagoni ferroviari oppure, dove possibile, per via fluviale, immergendoli in acqua.
Scortecciatura e lavaggio
Arrivati in segheria, i tronchi vengono scortecciati. La corteccia, assieme ad altri scarti, viene macinata e ridotta in chip che verranno riciclati. Per evitare la proliferazione di batteri e funghi, che lo rovinerebbero, il legno viene lavato immergendolo in vasche con acqua o tramite getti di vapore a 100 °C. 4
5
Segagione
Il taglio dei tronchi viene effettuato con la sega a nastro o con macchine multilame. Con la sega a nastro, dopo aver tolto lo sciavero, si taglia la parte più esterna del tronco, una tavola per volta. È così possibile controllare eventuali difetti o imperfezioni. L’uso della multilame, invece, permette di trasformare tutto il tronco in tavole di uguale spessore.
6
Stagionatura
Mediante questo processo, detto anche essiccatura, il legno cede all’ambiente la propria umidità.
La stagionatura naturale si esegue lasciando, per uno o più anni, il legname all’aperto, disposto in cataste. Queste sono coperte da tettoie per proteggere il legname dal Sole e dalla pioggia e sono posizionate in modo da favorire la ventilazione.
La stagionatura artificiale si realizza mettendo il legname all’interno di locali riscaldati con aria calda. Il processo dura alcuni giorni.

PER Chip
Piccoli trucioli o pezzetti di legno triturati.
Sciavero
La prima tavola ottenuta dal taglio del tronco. Presenta una faccia interna piatta e una esterna curva.
1. Come si esegue il taglio degli alberi?
2. Quali sono le fasi di lavorazione in una segheria?
3. Come si esegue la stagionatura? PER L’INTERROGAZIONE
Lezione 3. I derivati del legno

Il legname ricavato direttamente dal tronco dell’albero è detto massello. Oggi il suo utilizzo è molto limitato: diverse parti dell’albero, grazie alle loro buone caratteristiche, sono in grado di sostituire il legno naturale. Le moderne tecnologie, infatti, consentono di ottenere pannelli di legno come il compensato, il multistrato, il paniforte, il tamburato, il truciolato, l’MDF e il lamellare utilizzando i rami e altri scarti della lavorazione dei tronchi che altrimenti sarebbero destinati a divenire rifiuti.
I piallacci sono sottili fogli di legno che si ottengono con la sfogliatura, facendo ruotare sul proprio asse il tronco, reso cilindrico, contro una lama affilatissima chiamata sfogliatrice, che lo riduce a un foglio continuo. Oppure si ottengono tramite la tranciatura, realizzata bloccando il tronco mentre una lama, detta coltello, lo riduce in singoli fogli, la cui larghezza varia in base alle dimensioni del tronco. Per effettuare queste operazioni è necessario che il tronco sia reso morbido con il vapore.
I piallacci trovano impiego nella produzione dei compensati o per nobilitare, cioè rivestire, i pannelli con fogli sottilissimi di essenze pregiate. Questi prodotti si chiamano impiallacciati.
TRANCIATURA
CLIL
Legname: timber
Massello: solid wood
Una lama affilatissima sfoglia il tronco di legno.

I rulli fanno ruotare il tronco di legno.
Tronco di legno
I principali pannelli

Eventuale piallaccio con essenze pregiate
Compensato: si ottiene incollando, a caldo o a freddo, tre fogli sottili di legno. Per aumentarne la resistenza, lo strato centrale viene disposto con le fibre nella direzione opposta e in modo perpendicolare rispetto agli altri due strati. I due fogli esterni possono essere due piallacci di essenze pregiate. Lo spessore del pannello di compensato è di 3-5 mm.
Multistrato: è un semilavorato che si ottiene con la sovrapposizione di più strati di legno sfogliato, incollati tra loro con le fibre incrociate per migliorarne la resistenza alla flessione. Lo spessore può essere di 30 mm. Per la sua facilità di lavorazione e per le sue caratteristiche di resistenza è usato nell’industria del mobile e nelle lavorazioni artigia nali. In commercio si trova allo stato grezzo, impiallacciato, laccato e con finiture varie.

Piallaccio con essenze poco pregiate
Eventuale piallaccio con essenze pregiate

Piallacci con essenze poco pregiate
Paniforte: è un pannello ottenuto incollando tra loro dei listelli di legno a sezione quadrata o rettangolare, che ne formano l’anima, rivestiti con due fogli di piallaccio che possono essere di legno pregiato. Il prodotto così ottenuto non si deforma e si presta molto bene alla fabbricazione di porte, tavoli e mobili in generale.
Tamburato: si tratta di un pannello formato generalmente da due fogli esterni di compensato. La parte interna può contenere un’anima a nido d’ape di cartone oppure può essere vuota, e in questo caso è dotata di un’intelaiatura di legno per fissare i due fogli esterni. Il pannello risulta leggero e resistente, non si deforma e viene usato per la fabbricazione di porte e ante di mobili.
Truciolato: è il semilavorato più utilizzato, commercializzato sotto forma di pannelli. Si ottiene riducendo rami e scarti di lavorazione in piccoli trucioli di legno poco pregiati. Questi, dopo essere stati impastati con una resina che fa da collante, vengono stesi e compressi in casseforme. Lo spessore che si ottiene varia da 10 a 30 mm. Il suo basso costo e la sua versatilità ne fanno un prodotto di largo impiego, utilizzato sia allo stato naturale sia ricoperto con piallacci di essenze pregiate o laminati plastici colorati.
MDF (fibra a media densità): è un pannello costituito da una finissima fibra di legno mista a un materiale collante resinoso, il tutto adeguatamente pressato. Ricorda molto il truciolato, ma si differenzia per la facilità di lavorazione dei bordi e della superficie, simile a quella del legno massello. Lo spessore di questi pannelli è compreso tra 2 e 50 mm. La compattezza uniforme delle fibre lo rende un materiale omogeneo; può essere facilmente verniciato, laccato, impiallacciato o rivestito con laminati plastici colorati. Viene largamente usato nella costruzione di mobili.
Lamellare: si tratta di un insieme di listelli incollati e pressati tra loro, con i quali si realizzano travi e tavole. Risulta molto resistente alla flessione e viene utilizzato soprattutto per costruire grosse strutture portanti, come i ponti e le coperture degli impianti sportivi, con grandi luci e prive di pilastri.
LA MASONITE
La masonite, o faesite, è un pannello di legno ottenuto per cottura e pressatura, in vari spessori, di trucioli di legno. È usata soprattutto come parte posteriore di mobili e cassetti. I pannelli così ottenuti sono utilizzati anche come isolanti acustici ed elettrici. Le fibre di legno, normalmente, non sono mescolate con colle.
Piallaccio

Piallaccio
Listelli massicci di legno poco pregiato

Anima a nido d’ape di cartone Intelaiatura di legno



PER L’INTERROGAZIONE
1. Cosa sono i piallacci?
2. Quali sono i principali pannelli?
3. Qual è la differenza tra truciolato e paniforte?
4. Quali sono le caratteristiche del tamburato?
Lezione 4. Impieghi del legno

In passato il legno era impiegato solo come fonte energetica e per la costruzione di case e ponti, mentre oggi è uno dei materiali più usati e trova impiego in diversi settori.
L’edilizia
Al legno è stato restituito un posto di primo piano nel settore delle costruzioni edilizie. Questo materiale ha tra i suoi pregi quello di possedere una buona elasticità e di opporsi alla trasmissione del calore, per cui è un ottimo isolante termico oltre che acustico; inoltre viene utilizzato nella costruzione di edifici antisismici e nella maggior parte delle strutture dei tetti.
Oggi molti architetti tornano a utilizzare il legno anche per realizzare le strutture portanti, oltre che per le finiture estetiche degli interni.
L’industria del mobile
Per tavoli e sedie si usa il legno massello, mentre in genere i mobili sono fabbricati con semilavorati impiallacciati, dai costi inferiori. Per i mobili da giardino si utilizzano legnami provenienti da alberi a legno duro, come il teak o la quercia, molto resistenti.
L’industria cartaria
Fa un largo uso di legno tenero per l’estrazione di pasta di legno e pasta di cellulosa.
L’industria navale
Il legno galleggia e non arrugginisce. Al tradizionale impiego del legno massello, oggi riservato alle piccole imbarcazioni, si è affiancato quello del compensato marino e del lamellare incrociato, utilizzati per realizzare interni e arredi, paratie, sottofondo dei ponti e cabine sia su motoscafi sia per grandi navi.
L’industria musicale
Per la realizzazione di strumenti musicali come chitarra, pianoforte, oboe, violino, viola, si utilizzano legni di primissima scelta, con caratteristiche meccaniche particolari.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
La deforestazione e la certificazione del legno
La crescente richiesta di legno e di nuovi spazi da destinare alle attività commerciali hanno portato a un abbattimento eccessivo dei territori boschivi, causando il fenomeno della deforestazione. Gli alberi rappresentano il principale approvvigionamento di ossigeno e rivestono una funzione importante per il contrasto al cambiamento climatico. Proteggere le foreste vuol dire, quindi, salvaguardare l’esistenza futura del pianeta.
Al fine di garantire la sostenibilità delle foreste sono nate alcune organizzazioni internazionali che si occupano di certificare la provenienza del legno, attraverso i marchi PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) e FSC (Forest Stewardship Council).
Nel settore della carpenteria si usano principalmente travi, travetti, tavole per il tetto e travi in legno lamellare, ideali per strutture portanti e coperture.
Industria del mobile: furniture industry
Deforestazione: deforestation CLIL
Balconate e frangisole sono realizzati in legno massello, generalmente con essenze resinose.

Il parquet è una pavimentazione composta da legno massello con spessore di 10-22 mm, oppure ottenuta dall’assemblaggio di singoli elementi di legno nobile con spessore di 2,5 mm.
PER L’INTERROGAZIONE
Per i serramenti (porte e finestre) si utilizza prevalentemente il legno massello, ma anche il legno lamellare per infissi e scuri.
1. Quali sono i settori d’impiego del legno?
2. Perché il legno è particolarmente utilizzato nell’industria navale?
Lezione 5. Sostenibilità e riciclo

Il riciclo del legno è fondamentale sia per l’equilibrio ambientale sia per il risparmio delle risorse boschive, preziose per la vita del nostro pianeta.
RICICLO DEL LEGNO
2 Altri scarti più voluminosi provengono dalle industrie e dalla demolizione di edifici: travi, porte, finestre, pavimenti, mobili, scarti di lavorazione di mobilifici, pallet ecc.

1 Il legno da riciclare (imballi, cassette di frutta e verdura, piccoli mobili, ramaglie provenienti dalla potatura o dall’abbattimento di alberi ecc.) viene raccolto in apposite isole ecologiche.
6 I pannelli vengono utilizzati per realizzare nuovi mobili.
Con i chip, una volta amalgamati con resine e pressati, si producono pannelli di legno impiegati per la costruzione di mobili e rivestimenti e pellet per alimentare stufe.
Gli scarti industriali della lavorazione del legno vergine (segature, rifili, rimanenze da tagli) possono essere impiegati nella produzione di pasta di cellulosa per le industrie cartarie e blocchi di legno-cemento per il settore edile.
Quando il legno non è adatto al riciclo viene inviato agli impianti di termovalorizzazione e utilizzato per produrre calore ed energia elettrica; si tratta di un processo non ripetibile dato che la materia viene eliminata.

I pallet sono pedane di legno usate nei magazzini per facilitare le operazioni di carico e scarico delle merci, tramite l’uso di carrelli elevatori o gru.

3 Gli scarti vengono portati nei centri di trasformazione. Qui subiscono una prima fase di triturazione grossolana e un lavaggio per eliminare impurità e corpi estranei minori, come chiodi o sassolini; quindi vengono ridotti in chip.
4 I chip di legno vengono trasformati, a seconda della tipologia, in altri prodotti: pellet, pasta di cellulosa, compost.
5 Oppure i chip sono utilizzati per la produzione di pannelli di legno.
Il pellet è una biomassa secca, cioè un materiale organico da cui si ricava energia termica, ottenuta attraverso semplici lavorazioni meccaniche. Rappresenta un’alternativa ai tradizionali combustibili per il riscaldamento domestico: è pratico da trasportare, ecologico, economico.

1. Perché è importante il riciclo del legno?
2. Come avviene il riciclo del legno?
3. Che cos’è il pellet? PER L’INTERROGAZIONE



Ripassa i contenuti a pagina 9-10 dell’allegato.







Lezione 1 Il legno
Il legno è la parte di tronco situata sotto la corteccia di una pianta.
Il legno è un materiale resistente, è isolante acustico e termico, assorbe l’umidità, è infiammabile e ha una straordinaria capacità elastica.
Il tronco ha una sua struttura: all’esterno c’è la corteccia, che ha una funzione di protezione, verso l’interno si trovano l’alburno (il legno di nuova formazione) e il durame (lo strato più duro).
Le essenze si distinguono in base alla durezza e alla zona di provenienza:
• i legni teneri si lasciano scalfire con l’unghia;
• i legni resinosi contengono la resina, una sostanza che protegge la pianta;
• i legni duri sono molto resistenti;
• i legni esotici provengono da zone tropicali e sono duri e compatti.
Il legno può presentare difetti come malformazioni naturali o di lavorazione.
Lezione 2 La produzione del legname
La produzione del legname inizia con il taglio della pianta nel bosco e il successivo trasporto alla segheria. Qui si procede alla scortecciatura e alla segagione per trasformare il tronco in tavole; segue poi la stagionatura per far evaporare l’acqua.
A questo punto, le tavole sono vendute alle falegnamerie o alle industrie.
Lezione 3 I derivati del legno
I legni derivati sono i semilavorati ottenuti impiegando diverse parti dell’albero.
Il piallaccio è un sottile foglio continuo di legno che si ottiene facendo ruotare il tronco contro una lama. I piallacci vengono poi incollati e pressati tra loro ottenendo compensati e multistrati; con l’aggiunta di listelli di legno si producono paniforti e tamburati; con i trucioli di legno miscelati con colle si hanno i truciolati e l’MDF.
Lezione 4 Impieghi del legno
Il legno è utilizzato principalmente nel settore edile: per la struttura dei tetti (travi), per la costruzione di serramenti (porte e finestre), per parquet e scale.
L’industria del mobile e l’industria navale usano soprattutto il legno massello; l’industria cartaria estrae dal legno la cellulosa; l’industria musicale impiega legni di prima scelta per strumenti come chitarre e violini.
Lezione 5 Sostenibilità e riciclo
Il legno da riciclare viene raccolto nelle isole ecologiche e poi ritrasformato in semilavorato per la produzione di pannelli, con cui si realizzeranno nuovi mobili. Con la parte non riciclabile si produce il pellet, combustibile per le stufe a biomassa.

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. Il legno è un isolante elettrico. V F
2. Nell’antichità il legno era impiegato per cucinare i cibi e per scaldarsi. V F
3. I legni pregiati sono quelli provvisti di lunatura. V F
2. Scegli l’alternativa corretta.
1. Le fenditure sono dei distacchi di fibre dalla forma
A radiale B circolare C rettangolare
2. I legni resinosi sono legni
A duri B teneri C esotici
3. I legni esotici provengono da zone
A tropicali B fredde C collinari
3. Inserisci i termini mancanti scegliendoli tra i seguenti.
acqua – segheria – artificiale – legname – stagionatura –tavole – aziende
Una volta tagliati, i tronchi giungono alla dove inizia la segagione per trasformare il tronco in , che verranno accatastate lasciando degli spazi vuoti per favorire la ; tale processo, che può avvenire in modo naturale o , ha lo scopo di eliminare l’
In seguito, il può essere commercializzato dalle del settore.
4. Scegli l’alternativa corretta.
1. Dalla scortecciatura si ricavano
A chip
B legni masselli
C sciaveri
TECH & CLIL
Complete the sentences with the words from the box. deforestation timber tree wood
1. Wood comes from
2. derived directly from the trunk of the tree is called solid wood.
3. Tables and chairs are made of . 4. is caused by an excessive logging of woods.
2. Il processo di stagionatura naturale dura
A alcuni giorni
B due o tre settimane
C uno o più anni
5. Scegli l’alternativa corretta.
1. L’MDF è un pannello costituito da
A legno massello
B fibra di legno
C tavole lamellari
2. Per una struttura portante in legno è meglio utilizzare pannelli di
A paniforte B lamellare C MDF
3. I piallacci si ricavano dal tronco mediante una lama chiamata
A sfogliatrice B depezzatrice C massellatrice
6. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. Il legno è poco utilizzato in edilizia. V F
2. Per realizzare i mobili si utilizzano anche i semilavorati. V F
3. L’industria della carta utilizza la cellulosa del legno. V F
4. Il legno viene impiegato come materiale antisismico. V F
5. Il marchio FSC certifica l’ecosostenibilità del legno. V F
7. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. Il riciclo del legno è utile per l’ambiente. V F
2. Nella prima fase di riciclaggio gli scarti del legno vengono bruciati. V F
3. Il pellet è un combustibile ottenuto dal carbone. V F
4. L’unico legno che può essere riciclato è quello di essenze tenere. V F
5. Dal riciclo del legno si ottiene il massello. V F
6. Il pellet è utilizzato come combustibile. V F
COMPETENZE DIGITALI
1. Effettuate una ricerca in internet sull’importanza che il legno ha avuto per il progresso della vita dell’uomo e preparate una presentazione di sole immagini che illustrino il vostro lavoro.
2. Utilizzando un programma di presentazioni, spiegate: - perché il legno viene considerato una risorsa rinnovabile; - quali benefici porta la presenza degli alberi sulla Terra; - le conseguenze del disboscamento sul pianeta.






Carta
Lezione 6. La carta


La carta è il prodotto della lavorazione di fibre di cellulosa e di sostanze minerali tenute insieme da collanti.
La carta è adatta a molteplici usi e per ognuno di questi deve possedere una caratteristica specifica. Così, se la carta è destinata ad avvolgere alimenti deve resistere ai grassi; per l’industria grafica è indispensabile l’assorbimento dell’inchiostro; per le confezioni è richiesta una buona resistenza allo strappo; se invece è usata per le banconote non deve usurarsi facilmente.
Proprietà fisico-chimiche
Grammatura: peso della carta, espresso in g/m2 .
Spessore: misura dello spessore del foglio, espressa in mm.
Igroscopicità: capacità di assorbire acqua o umidità.
Opacità: proprietà di non lasciarsi attraversare dalla luce.
Proprietà meccaniche
Resistenza alla trazione: capacità di resistere a due forze uguali e contrarie.
Resistenza allo strappo: capacità di resistere alla rottura per lacerazione.
Resistenza alla piegatura: scarsa capacità di opporsi alla piegatura (la carta è facilmente piegabile, il cartone meno).
CLIL
Proprietà tecnologiche
Lisciatura: capacità di assumere un aspetto ruvido, liscio, satinato.
Stampabilità: capacità di assorbire prodotti per la stampa.
Collatura: proprietà che migliora la scrivibilità del foglio.
L’evoluzione della carta
Nel 3000 a.C. gli Egizi cominciarono a scrivere su rotoli di papiro, una pianta diffusa lungo il fiume Nilo, costituiti da striscioline pressate ed essiccate. Essendo però un prodotto di origine vegetale, il papiro era soggetto alla formazione di muffe e batteri che lo deterioravano. Nel III secolo a.C. nella città di Pergamo fu creata la pergamena, un sottile strato di pelle di ovini. Alla pergamena fece seguito la carta, inventata nel 105 a.C. in Cina, che usava come materia prima gli stracci di indumenti. Grazie agli scambi commerciali, la tecnica della fabbricazione della carta arrivò in Europa. Alcuni artigiani di Fabriano, nelle Marche, intorno al XIII secolo applicarono delle innovazioni, introducendo macchinari specifici e l’uso della colla animale, derivata dagli scarti delle concerie, che rese la carta più resistente all’attacco dei microrganismi.

PER L’INTERROGAZIONE
1. Che cos’è la carta?
2. Qual è stata l’evoluzione storica della carta?
3. Quali sono le materie prime usate per ottenere la carta?
4. Come avviene il processo di sbiancatura?
La materia prima: la cellulosa
La cellulosa è una delle componenti fondamentali delle piante a essenza tenera; è presente, per esempio, negli alberi di pioppo, ma anche nelle piante della canapa e del lino: per questo motivo anticamente la carta era ricavata dagli indumenti realizzati con queste fibre. Per utilizzare la cellulosa come materia prima è necessario estrarla dalle piante. Il metodo più tradizionale è quello di sottoporre il legno scortecciato all’azione abrasiva di una mola rotante che, in presenza di acqua, sottrae gran parte della lignina, la sostanza che rende duro il legno.
Si ottiene in questo modo la pasta meccanica, o greggia, di colore paglierino scuro, che presenta il vantaggio di sfruttare al 95% il legno; la qualità però risulta scadente. Trattando chimicamente questa pasta, si riesce a eliminare la lignina residua ottenendo la pasta semi-chimica Tutt’altro procedimento è riservato alla produzione della pasta chimica: in particolari autoclavi i trucioli di legno vengono sottoposti all’azione del calore dell’acqua e ai processi chimici che eliminano tutte le sostanze non cellulosiche. La pasta così ottenuta viene utilizzata dall’industria come cellulosa greggia, oppure può subire un processo di sbiancatura, che può avvenire con l’ossigeno, il cloro o l’acqua ossigenata, per rendere la cellulosa più bianca. Il cloro ha sempre dato ottimi risultati perché è in grado di dissolvere la lignina senza danneggiare la cellulosa; tuttavia, dal momento che questo elemento è molto inquinante, oggi si preferisce usare l’acqua ossigenata, che lo è meno e migliora anche la qualità della carta.

PER

I maggiori produttori di legna e cellulosa per carta sono i Paesi ricchi di foreste, come quelli scandinavi e il Canada. In Norvegia, per esempio, esistono delle speciali piantagioni a uso industriale dove vengono piantati alberi che crescono rapidamente, in circa 6-7 anni, e che hanno elevate rese produttive, come i pioppi e le betulle. Una volta tagliati per ricavare il legname utile, gli alberi vengono nuovamente ripiantati.
Sbiancatura Procedimento chimico che serve per rendere più bianca la cellulosa.
In autoclavi, recipienti ad alta pressione, le scaglie vengono bollite a 150 °C con prodotti chimici per eliminare la lignina.
I tronchetti di legno scortecciati vengono sfibrati tramite lame.
La pasta viene filtrata, ra nata, quindi resa più fine, sbiancata e lavata.
Viene poi tolta l’acqua (disidratazione).

Si ottiene la pasta meccanica.
Si ottiene la pasta di cellulosa. Confezionata in balle, viene venduta alle cartiere. Il composto viene filtrato, sbiancato e lavato.
Viene poi tolta l’acqua (disidratazione).
Lezione

7. La produzione della carta
Partendo dalla cellulosa si arriva alla carta attraverso una serie di processi di lavorazione automatizzati, eseguiti da apposite macchine: l’impianto di produzione della carta viene chiamato macchina continua
1
2
Magazzini della materia prima
Contengono le diverse paste per carta: pasta meccanica (A), pasta di cellulosa (B) e pasta semi-chimica (C).
Raffinatore conico
Le materie prime vengono miscelate nel raffinatore conico.
La pasta di cellulosa viene sminuzzata, in presenza di acqua. Le fibre, sotto l’effetto mescolante delle pale rotanti, si dispongono in modo disordinato intrecciandosi e aumentando la compattezza e la resistenza.


Vasca di afflusso
Nella vasca di afflusso l’impasto, costituito per il 95% da acqua e per la percentuale restante da fibre, viene distribuito in modo uniforme sulla tela. 4
Rulli
L’impasto viene posto su una rete metallica mentre una serie di rulli fa avanzare il foglio. Le fibre di cellulosa rimangono sulla tela e l’impasto si compatta mentre l’acqua filtra verso il basso.
Impasto
Per migliorare la qualità della carta, all’impasto si aggiungono minerali in polvere, come caolino, talco o polvere di marmo, che conferiscono peso, opacità e stampabilità al prodotto finito. Infine si aggiunge una colla di origine animale o sintetica, che serve per tenere compatta la pasta e regolare l’assorbenza dell’inchiostro.

Seccheria
Nella seccheria il sottile foglio passa attraverso una serie di rulli riscaldati che lo privano dell’acqua restante.
LA BOBINA DI CARTA
La bobina può raggiungere una lunghezza di 10 km e una larghezza di 10 m. Viene tagliata trasversalmente in bobine di dimensioni inferiori, della larghezza di 1 o 2 metri, che vengono poi inviate ad altre cartiere più piccole, che si occupano di ulteriori processi di lavorazione.

CLIL
Macchina continua: paper machine
Bobina: paper reel
Patinatura
È un trattamento che si effettua nella calandra. Per rendere la carta più brillante, sul foglio viene stesa una patina, una miscela di pigmenti.
Bobina
Il foglio, che esce dalla macchina continua alla velocità di circa 2 chilometri al minuto, viene avvolto in una bobina.
1. Come funziona la macchina continua?
2. Cos’è il raffinatore conico?
3. Perché è importante la calandratura? PER L’INTERROGAZIONE
Calandratura
Il foglio umido passa nella calandra, costituita da una serie di rulli che rendono la superficie liscia e lucida. La calandratura determina lo spessore finale del foglio e diminuisce la porosità della carta.
Lezione
8. I tipi di carta e gli usi
La carta viene impiegata per molteplici necessità quotidiane, che vanno dall’uso domestico all’uso industriale.
Le carte per stampare
• Carta da stampa: viene usata nelle tipografie e litografie e si adatta ai vari inchiostri specifici per la stampa; è impiegata per realizzare giornali, dépliant, libri, carte geografiche.
• Carta per quotidiani: di qualità scadente, non contiene sostanze collanti.
• Carta patinata: grazie alla sua caratteristica di buona resistenza viene usata per libri e riviste.
Le carte per disegnare e scrivere
• Carta da disegno: è prodotta con cellulosa pregiata, non contiene sostanze minerali e resiste molto bene alle cancellature. È impiegata anche per i lucidi da disegno.
• Carta da ufficio: è la carta utilizzata per stampanti, fotocopie, fax, buste.
• Carta per quaderni: viene realizzata con pasta di cellulosa ed è poco assorbente.
Le carte per alimenti e imballaggi
• Carta da forno: è una carta oleata e resiste alle alte temperature.
• Carta accoppiata: si tratta di una carta per alimenti, dotata di una protezione in plastica.
• Carta paglia: è usata generalmente per avvolgere alimenti quali carni e salumi, accoppiata a un sottile foglio plastificato. Per fabbricarla si impiega la paglia di grano.
• Carta kraft o carta per pacchi: di colore marrone, è molto resistente ed economica. Viene utilizzata per sacchetti, buste della spesa, fogli per rivestire i pacchi.
• Carta di riso: è una qualità pregiata, ottenuta dalla pianta del riso; è molto resistente allo strappo e molto sottile, per questo viene impiegata per realizzare volumi di migliaia di pagine.
Le carte speciali
• Carta assorbente: essendo priva di colla risulta molto assorbente e trova largo impiego nella realizzazione di fazzoletti e tovaglioli.
• Carta per uso domestico, igienico e sanitario: è usata per asciugamani, rotoli asciugatutto, lenzuola mediche.
• Carta per banconote: è di ottima qualità e molto resistente, presenta una filigrana ed è fabbricata esclusivamente dalla Zecca dello Stato.
• Carta decorativa, carta da parati, carta adesiva, carta per fotografia: si tratta di materiali accoppiati, che hanno un supporto di carta unito ad altre sostanze, come la plastica o la colla.
I cartoni
• Cartoni e cartoncini: hanno una struttura rigida e resistente e una grammatura più elevata della carta. I primi sono formati da due fogli spessi, incollati e distanziati da un foglio ondulato, e sono usati per realizzare scatole per l’imballaggio. Il cartoncino è utilizzato per biglietti da visita, flyer, cartellette, raccoglitori.
IL TETRA PAK®
Il termine Tetra Pak® indica un contenitore di cartoncino accoppiato con altri materiali, impermeabile all’aria. È costituito da una pellicola di alluminio e un cartoncino, pressati tra due rulli riscaldati, tra i quali è inserito un velo di polietilene che, sotto l’effetto del calore, fa da collante tra i due strati esterni. Il primo prodotto conservato in tale contenitore è stato il latte, mentre oggi vi si confezionano molti prodotti liquidi, come succhi di frutta o vino, e conserve.






PER L’INTERROGAZIONE
1. Come si suddivide la carta in funzione agli usi?
2. Come sono costituiti cartoni e cartoncini?
3. Cos’è il Tetra Pak® e da cosa è costituito?
Lezione
9. Sostenibilità e riciclo
Acquistare un prodotto di carta o cartone proveniente da foreste che non siano state tagliate illegalmente o in violazione dei diritti civili dei lavoratori è molto importante. Anche per la carta, così come per il legno, esistono marchi (FSC e PEFC) che certificano che la carta è stata realizzata con materie prime provenienti da foreste dove sono rispettati rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
La carta da macero
Carta e cartoni non più utili diventano rifiuti che possono essere riutilizzati per ricavare nuova carta. La carta recuperata prende il nome di carta da macero, dalla quale, attraverso diversi processi, si ottiene la carta riciclata.
L’utilizzo della carta da macero per produrre nuovo materiale comporta diversi vantaggi: si limitano il taglio di nuovi alberi, lo smaltimento nelle discariche e si risparmiano acqua ed energia elettrica.
Il riciclaggio ha inizio con la raccolta di tutti i prodotti a base di cellulosa, come gli imballaggi, i giornali, i quaderni, libri, cartoni ecc.
RICICLO DELLA CARTA

La carta e il cartone provenienti dalla raccolta di erenziata, dalla raccolta porta a porta dei Comuni e dalle isole ecologiche vengono portati presso i centri di raccolta.


8
2
1. A che cosa serve la certificazione della carta?
2. Perché è importante la carta da macero?
3. Come avviene il riciclo della carta? PER L’INTERROGAZIONE
3 1 In questi centri il materiale viene separato dai corpi estranei.
Il materiale filtrato viene compresso in balle.

4 5 Le balle di carta vengono acquistate dalle cartiere.
Le balle di carta vengono sminuzzate.
6
Il materiale viene immerso nell’acqua all’interno di uno spappolatore per ottenere un impasto.
7
Segue la depurazione, un processo mediante il quale le fibre, con l’ausilio di mezzi chimici o meccanici, vengono ripulite da residui di resine, collanti ed eventuali patinature.
Segue la disinchiostrazione, passaggio obbligato in quanto sia i quotidiani sia le riviste presentano alte percentuali di inchiostro di stampa, che deve essere eliminato per ottenere una pasta bianca, chiamata in gergo «pasta carta».
La pasta carta proveniente dalla carta da macero viene utilizzata da sola, o mista a pasta carta vergine, e trasferita nella macchina continua per produrre nuove bobine di carta. 9










Lezione 6 La carta
La materia prima utilizzata per la produzione della carta è la cellulosa, estratta principalmente da alberi a essenza tenera come il pioppo, ma anche da piante come la canapa e il lino. Dal legno si ottengono la pasta meccanica, mediante procedimenti meccanici, e la pasta chimica, tramite processi chimici.
Lezione 7 La produzione della carta
La produzione della carta avviene con la macchina continua, un grande impianto in cui viene inserito un impasto costituito per il 95% da acqua e in minima parte da fibre di cellulosa e da altre sostanze per migliorarne le caratteristiche finali.
L’impasto passa poi in una lunga serie di rulli che dapprima lo compattano, poi lo asciugano e, se necessario, rendono il foglio lucido; quindi viene avvolto su una grande bobina.
La bobina, lunga fino a dieci chilometri, verrà tagliata secondo le lunghezze commerciali e venduta alle varie tipografie o industrie del settore.
Lezione 8 I tipi di carta e gli usi
A seconda del tipo di impasto si possono ottenere diversi tipi di carta:
• la carta da stampa, sottile e con buona assorbenza agli inchiostri tipografici;
• la carta da disegno, prodotta con cellulosa di buona qualità;
• la carta per quaderni, poco assorbente;
• la carta per alimenti, resistente ai grassi;
• la carta per pacchi, resistente allo strappo;
• le carte speciali, come la carta per banconote, resistente all’usura nel tempo;
• i cartoni, costituiti da due fogli di carta spessa per garantire rigidità e resistenza, impiegati nella produzione di scatole per l’imballaggio.
Lezione 9 Sostenibilità e riciclo
La carta e i cartoni vengono raccolti dai Comuni e gestiti da centri specializzati che si occupano di recuperare le fibre di cellulosa per ottenere nuova carta. Il recupero di carta e cartone e il successivo riciclaggio evitano il ricorso alle discariche e agli inceneritori. Permettono inoltre di risparmiare acqua ed energia elettrica rispetto alle quantità impiegate partendo da materie prime. Evitano, infine, il taglio di nuovi alberi da cui ricavare il legno da destinare al ciclo produttivo.
1. Scegli l’alternativa corretta.
1. Tra le proprietà tecnologiche della carta vi è anche
A la stampabilità B la grammatura C l’opacità
2. Tramite la sbiancatura la cellulosa diventa più
A lucida B bianca
3. Fissando un peso a un foglio di carta si valuta la sua resistenza alla
A trazione B strappo C compressione
4. La pergamena fu creata nella città di
A Bergamo B Firenze C Pergamo
2. Completa le frasi scegliendo tra i termini seguenti. lignina – acqua ossigenata – cellulosa – essenza –pasta meccanica
1. Dalla sfibratura del tronco si ottiene la
2. La pasta chimica può essere trattata con l’ che la rende bianca.
3. I trucioli, ottenuti dall’azione abrasiva del tronco, vengono lavati per eliminare la , sostanza che rende il legno duro.
4. La cellulosa si ottiene da alberi a tenera.
5. I maggiori produttori di legna e per carta sono i Paesi ricchi di foreste.
3. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. La cellulosa è la materia prima da cui si ricava la carta. V F
2. Nell’impasto della carta si aggiungono dei minerali in polvere. V F
3. La macchina continua è formata da una lunga serie di presse.
F
4. La calandratura serve per amalgamare l’impasto nella vasca di afflusso. V F
5. La macchina continua serve per estrarre la cellulosa dalle piante.
TECH & CLIL
True or False.

4. Scegli l’alternativa corretta.
1. Le calandre della macchina continua sono rulli che
A impastano la cellulosa B lisciano il foglio
C spappolano la cellulosa D sfibrano il foglio
2. La carta viene prodotta tramite la macchina
A estrusiva B continua
C stampatrice D sbiancante
5. Completa le frasi inserendo il nome del tipo di carta.
1. La carta da viene usata in tipografie e litografie.
2. La carta viene utilizzata per libri e riviste.
3. La carta da è utilizzata per fotocopie e fax.
4. La carta ha un colore marrone, è molto resistente ed economica.
5. La carta trova impiego nella realizzazione dei tovaglioli.
6. La carta per è resistente e di ottima qualità.
6. Completa il testo scegliendo tra i termini seguenti. disinchiostrazione – pasta – fibre – estranei –spappolatore – continua – macero
La carta domestica e industriale viene trasportata presso appositi centri che si occupano del recupero delle dalla carta da . Dopo l’eliminazione dei materiali , la carta viene sminuzzata e messa in uno . Dopo le fasi di depurazione e si ottiene la carta, che viene inserita nella macchina per produrre carta riciclata.

V F
1. The first people who made paper were the Egyptians. T F
2. The creators of the first paper, as a material, were the Japanese. T F
3. The main raw material needed to produce paper is lignin. T F
4. Cellulose is a fiber present in the wood of trees. T F
COMPETENZE DIGITALI
1. Effettuate una ricerca in internet per approfondire lo sviluppo storico della carta. Preparate quindi una presentazione con immagini o video da presentare alla classe.
2. Effettuate una ricerca in internet sui risvolti negativi che il consumo della carta arreca all’ambiente. Realizzate una presentazione del lavoro, utilizzando grafici e immagini che troverete in rete.




UNITÀ

Fibre tessili

Lezione 10. Le fibre tessili
Le fibre tessili sono materiali di origine naturale, artificiale o sintetica che, filati e intrecciati, danno origine ai tessuti.
Tutte le fibre di origine naturale o chimica, per essere considerate tessili e quindi lavorabili al telaio, devono presentare alcune fondamentali caratteristiche che riguardano la lunghezza, la resistenza meccanica, la finezza, la lucentezza, la sofficità. Devono, inoltre, poter resistere al calore, all’azione dei solventi in fase di lavaggio e alle alterazioni dovute all’usura.
Proprietà fisico-chimiche
Igroscopicità: capacità di assorbire l’umidità.
Finezza: spessore delle fibre, espresso in micron (= 0,001 mm).
Inalterabilità: capacità di resistere alle muffe e alle sostanze chimiche.
Proprietà meccaniche
Resistenza all’usura: buona capacità di sopportare il logoramento.
Resistenza alla rottura: carico sopportato da un filo senza rompersi.
Resistenza al calore: capacità di resistere a certe temperature senza subire alterazioni.
Resistenza all’allungamento: capacità di resistere alla sollecitazione della trazione.
Proprietà tecnologiche
Lavorabilità: capacità di assumere nuove forme.
Attitudine alla tintura: capacità di assorbire un colore e di mantenerlo nel tempo.
Le fibre tessili nella storia
L’origine dell’uso delle fibre tessili si perde nel tempo. Non sappiamo con certezza dove e quando furono utilizzate per la prima volta. Sicuramente in un primo momento si fece uso delle pelli degli animali per ripararsi dal freddo. Da alcuni studi archeologici e dai dipinti rupestri, risulta che presso i popoli della Mesopotamia, circa 8 000 anni prima di Cristo, erano di uso comune tessuti di lino per abiti e teli, mentre il cotone fece la sua comparsa più tardi, in India. L’uomo, con l’ingegno e la fantasia, passò da una primordiale tessitura ai moderni telai ottenendo tessuti di un certo pregio.

Vegetali
Fibre di origine naturale
Animali
FIBRE TESSILI
Cotone


Minerali
Lino Canapa Juta



Filati di Rayon
Artificiali
Fibre chimiche




Sisal

PER L’INTERROGAZIONE
1. Cosa sono le fibre tessili?
2. Quali sono le proprietà meccaniche delle fibre tessili?
3. Quali sono state le prime fibre tessili utilizzate dall’uomo?
4. Cos’è l’amianto e a cosa serve?
Sintetiche





EDUCAZIONE AMBIENTALE
L’amianto
L’amianto è un minerale con proprietà ignifughe, cioè di resistenza al fuoco, costituito da fibre che si ottengono dalla frantumazione e dalla macinazione della roccia madre. In passato l’amianto è stato largamente usato, misto al cemento, nella realizzazione di lastre ondulate impiegate per la copertura dei tetti e per la fabbricazione di tubi (tra i principali produttori vi era la società Eternit). Nel tempo i manufatti di amianto tendono a degradarsi liberando particelle di fibre che, se inalate, si accumulano nei polmoni originando pericolose patologie respiratorie.
Valutati gli alti rischi, in Italia ne è stato vietato l’uso, pertanto tutti gli edifici e i manufatti che contengono amianto devono essere bonificati, esclusivamente a opera di ditte specializzate, dati i pericoli che si corrono a contatto con tale materiale.

11. Fibre tessili vegetali
Il cotone
Il cotone è una fibra tessile ottenuta dai peli che ricoprono i semi della pianta del cotone, contenuti dentro la capsula del fiore; quest’ultima, infatti, giunta a matu razione si apre lasciando fuoriuscire la bambagia. La pianta, originaria dell’India, si diffuse in Europa nel XIII secolo. Cresce allo stato spontaneo, ma per usi indu striali viene coltivata nelle zone calde e ricche di acqua. I maggiori produttori di cotone sono Stati Uniti, Cina, India e Pakistan. Attualmente, con una produzione di 15 milioni di megagrammi l’anno, è la fibra vegetale più diffusa al mondo. La raccolta del cotone avviene nel momento esatto della schiusa delle valve (le due parti in cui si divide la capsula del fiore, o baccello), per evitare che il vento o l’acqua le danneggino.


Finita la fase del raccolto, il cotone viene essiccato e sottoposto a sgranatura per separare le fibre dai semi. Seguono la cardatura e la pettinatura per eliminare le impurità. Dopodiché, nelle industrie per la filatura, con un processo di meccanizzazione si trasformano le fibre in filati e quindi in tessuti pronti per la confezione. I semi, separati durante la sgranatura, vengono usati anche per ottenere un olio impiegato nell’alimentazione umana e animale. Dalle capsule, lunghe circa dai 2,5 ai 10 cm, oltre alla peluria si ricava un sottoprodotto di scarto, chiamato linters, costituito dai peli corti che rimangono attaccati ai semi e vengono impiegati nell’industria delle fibre tessili artificiali.
PER
Prima della Rivoluzione industriale il prodotto nelle piantagioni di cotone veniva raccolto a mano.
Oggi lo stesso lavoro viene eseguito con macchine raccoglitrici, con un grande risparmio sui costi di produzione. Tuttavia, i mezzi meccanici non sono in grado di selezionare le capsule migliori e il prodotto finale è meno pregiato.
Le proprietà e gli impieghi
Il cotone ha una bassa elasticità, per cui risulta molto sgualcibile. Ha una buona lavabilità sia in lavatrice sia a mano, trattiene poco il calore, assorbe bene il sudore e difficilmente provoca allergie. Grazie a queste proprietà il cotone è la fibra più usata in assoluto nel periodo estivo. Oltre che per i capi di abbigliamento, inclusi per esempio i blue jeans, viene anche utilizzato per realizzare biancheria per la casa, come lenzuola, tovaglie, spugne.
I capi di cotone si lavano anche ad alte temperature (60-90 °C). Se i tessuti sono colorati è tuttavia consigliabile una temperatura più bassa, in modo da evitare che perdano la tinta e si rovinino.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il cotone organico o biologico
La coltura tradizionale del cotone è piuttosto dannosa per l’ambiente, a causa dell’impiego di una considerevole quantità di pesticidi e fertilizzanti chimici, che finiscono per contaminare l’acqua e hanno un forte impatto su flora e fauna. Il 25% di tutti i pesticidi prodotti nel mondo viene usato per coltivare il cotone.
Il cotone organico è un cotone coltivato secondo princìpi biologici, quindi ha un impatto ambientale inferiore rispetto a quello del cotone tradizionale, in quanto viene coltivato secondo metodi che prevedono l’assenza di tecniche di ingegneria genetica e di elementi tossici quali i pesticidi e un uso controllato di fertilizzanti. Inoltre è ipoallergenico, poiché non viene sbiancato né tinto con sostanze chimiche aggressive.
Bambagia
Fiocchi di cotone che ricoprono i semi.
Cardatura
Consiste nel districare le fibre del cotone, renderle parallele e pulirle dai materiali estranei.
Pettinatura
Consiste nell’eliminazione delle fibre più corte (stoppa) e delle eventuali impurità rimaste.

La mercerizzazione è un trattamento specifico riservato alle fibre vegetali, e in particolare al cotone, per renderle più lucide, resistenti e adatte alla tintura. Si esegue immergendo il filato in una soluzione di soda caustica. Il cotone mercerizzato è utilizzato nell’abbigliamento e nella biancheria per la casa.
Il lino
Il lino è coltivato in Italia, Europa settentrionale e nelle Americhe. Molti popoli antichi, tra cui gli Egizi e i Greci, usavano già le piante di lino per confezionare cordame, funi e tessuti. Per ricavare le fibre da cui ottenere il filato si utilizza il fusto sottile della pianta, composto da una quantità di cellulosa pari al 70%. Una volta matura, la pianta del lino viene estirpata ed essiccata, viene poi macerata in acqua per favorire il distacco delle fibre e subisce quindi un’operazione meccanica di sfibratura che serve a dividere la parte fibrosa da quella legnosa. Si ottiene in questo modo la filaccia, o lino greggio, su cui, con apposite macchine, si esegue la pettinatura per eliminare le fibre corte e l’impurità residua. Dopo queste fasi le fibre vengono ritorte, a secco o a umido, per ottenere il filo da tessere. Nel secondo caso, l’aggiunta di acqua permette di ottenere un filo più fine e resistente, usato per l’abbigliamento. I tessuti di lino si classificano, in base al grado di finezza delle fibre, in fini, mezzani e grossi.
Le proprietà e gli impieghi
Grazie al senso di freschezza che trasmette, il lino è considerato la migliore fibra per il periodo estivo. Viene utilizzato per produrre biancheria, lenzuola, asciugamani, capi di abbigliamento. Essendo una fibra rigida, i capi assumono un aspetto stropicciato, caratteristica principale che contraddistingue questo tipo di tessuti.
La canapa
La canapa è una pianta erbacea annuale la cui maturazione avviene nei mesi estivi. Per ottenere le fibre, il fusto viene fatto seccare e successivamente messo a macerare in acqua per una settimana. Il distacco delle fibre avviene per sfibratura meccanica o maciullatura presso i canapifici dove, dopo la pettinatura, le fibre vengono selezionate e divise secondo le caratteristiche di finezza, lunghezza e morbidezza. Vengono quindi sottoposte prima a filatura e poi a tessitura.
Le proprietà e gli impieghi
Data la sua elevata resistenza, la canapa viene utilizzata per produrre cordami, sacchi, stuoie, per la giunzione di elementi in ferro zincato, negli impianti idrici e come substrato per i tappeti.

Cotone: cotton
Lino: linen
Canapa: hemp
PER L’INTERROGAZIONE
1. Come si ottiene il cotone e quali sono le sue proprietà e i suoi impieghi?
2. Perché si utilizza il trattamento della mercerizzazione del cotone?
3. Come si ottiene il lino?
4. Quali sono le proprietà e gli impieghi della canapa?



La juta è una fibra vegetale che si ricava dalla corteccia macerata di piante erbacee tropicali, coltivate prevalentemente in Bangladesh e India. Viene utilizzata per produrre sacchi di imballaggio molto resistenti.
sisal si
Lezione 12. Fibre tessili animali
La lana
La lana è una fibra tessile ottenuta dalla tosatura del manto lanoso, chiamato vello, che ricopre gli ovini, i caprini e i camelidi. Il vello degli ovini è formato da tre strati: una parte esterna o cuticola, una intermedia e una zona interna o midollo. Alla base si trovano delle ghiandole sebacee che impregnano i filamenti di lana con il grasso. La qualità della materia prima dipende dalla razza, dalle condizioni climatiche, dallo stato di salute dell’animale e dalla parte del corpo che viene tosata. La tosatura si esegue in primavera con cesoie elettriche o, più raramente, a mano con forbici da tosa. La lana più pregiata è quella prelevata dal dorso dell’animale, che viene utilizzata esclusivamente per i filati, mentre un valore qualitativo minore è attribuito al vello della zona dell’addome e delle zampe, che viene impiegato per le imbottiture.
La produzione
Nei casi in cui, prima della tosatura, gli ovini vengano sottoposti a un lavaggio con acqua per eliminare parte della sporcizia e del grasso, si ottiene una lana chiamata saltata. Diversamente, se gli animali non vengono lavati, la lana tosata prende il nome di greggia, o sucida.
Dopo la tosatura la lana viene confezionata in balle e venduta ai lanifici, dove avvengono successive lavorazioni. Le fibre corte vengono lavorate con il sistema della cardatura, che dà un filo grosso e quindi filati più pesanti. Le fibre lunghe, invece, vengono pettinate ottenendo dei filati sottili e leggeri.
Le proprietà
La lana, composta da cheratina, una proteina che si trova nei peli, è un ottimo isolante termico, è igroscopica, cioè assorbe il sudore e l’acqua, è elastica e ingualcibile. Teme l’attacco delle tarme, che bucano i capi, e l’infeltrimento, cioè l’attorcigliamento delle fibre superficiali dovuto a una temperatura di lavaggio troppo alta.
Le lane speciali

Le modalità di allevamento degli ovini prevedono il pascolo allo stato brado, con stazionamento nello stesso luogo, oppure la transumanza, cioè il trasferimento di greggi da un pascolo a un altro, generalmente dalla montagna ai terreni vicini al mare.

La tosatura può avvenire con apposite forbici o con rasoi elettrici.
Merino: la lana prodotta dalla pecora di razza merino è di ottima qualità ed è usata soprattutto per l’abbigliamento. Questa razza è stata importata in Spagna dal Nordafrica e ogni capo di bestiame può produrre 10 kg di lana pregiatissima. Di minor pregio è la lana ottenuta da razze incrociate con la merino, utilizzata per produrre tessuti, coperte e tappeti.
Cachemire: è una fibra che si ricava dal vello di una razza di capra che vive nel Tibet. In primavera la morbidissima lanugine, che si è formata nel periodo invernale per proteggere l’animale dal freddo, viene raccolta con un particolare pettine. Sicuramente tra i vari tipi di lana è la più pregiata, al punto di essere definita l’oro dei tessuti. Ogni capra fornisce ogni anno circa 200 g di lana cachemire.
AREA 1 Materiali

La seta

La seta è una fibra tessile di origine animale che si ottiene dalle secrezioni della bava del baco da seta. È una fibra molto antica, prodotta per la prima volta in Cina intorno al 2600 a.C.
La bachicoltura
Alla schiusa delle uova le larve iniziano a mangiare le foglie di gelso e crescono, diventando bruchi. Dopo 40 giorni il bruco smette di mangiare e «sale al bosco», cioè si posiziona su un rametto; inizia quindi a secernere una bava vischiosa che solidifica a contatto con l’aria e in breve tempo si chiude all’interno di un bozzolo.
A questo punto i bozzoli vengono raccolti e messi in un forno a 70-90 °C (stufatura), per far morire i bruchi. Alcuni bozzoli, però, vengono salvati e dopo circa 20 giorni avviene la metamorfosi del bruco in crisalide e, infine, in farfalla.
Le filande acquistano i bozzoli dagli allevatori; dopo averli posti in acqua a 90 °C, con una macchina si esegue la trattura per ottenere un unico filo, che può essere lungo fino a 1 km.

Il baco da seta si nutre di foglie di gelso.
Le proprietà
Unendo più fili insieme si ottiene il filo di seta.
La seta assorbe facilmente il colore, è molto elastica, è anallergica, impedisce gli scambi di calore ed è molto leggera. I capi confezionati con questa fibra possono essere indossati in qualunque stagione. Se sottoposta a fiamma, la seta emana un odore simile a quello di capelli bruciati.
I materiali compositi
I materiali compositi derivano dall’unione di almeno due elementi che hanno caratteristiche chimicofisiche diverse ma che, combinati in modo sinergico e non fusi, acquisiscono delle proprietà non riscontrabili se analizzati singolarmente.
1. Quali sono le caratteristiche della lana?
2. Quali sono le lane speciali?
3. Come si esegue la bachicoltura? PER


Industrialmente i materiali compositi sono formati da una matrice e da uno o più rinforzi, tenuti assieme da additivi o resine. La matrice può essere metallica, ceramica e polimerica; tra i rinforzi maggiormente utilizzati vi sono delle fibre tessili molto particolari, le fibre di vetro e le fibre di carbonio. Con le fibre di vetro mischiate a resine plastiche si realizza la vetroresina, che viene utilizzata nella produzione di oggetti esposti agli agenti atmosferici: serbatoi, piscine, imbarcazioni, pale eoliche e attrezzi sportivi.
La fibra di carbonio è formata da atomi di carbonio e polimeri: i sottilissimi fili di carbonio vengono intrecciati in modo da creare delle strutture tessili. Le fibre di carbonio hanno proprietà eccezionali dal punto di vista della resistenza meccanica e della resistenza al calore e alla fiamma, sono leggerissime e offrono notevoli vantaggi sui costi di produzione. Vengono impiegate in campo aerospaziale, nautico, automobilistico, sanitario e sportivo. Le troviamo quindi nella realizzazione di manufatti dove il peso e la resistenza sono fattori fondamentali, come sci, canne da pesca, biciclette da corsa, canoe, racchette da tennis, caschi; inoltre nella componentistica degli aerei, delle sonde spaziali, delle auto e per le strutture di macchinari nelle sale radiologiche e negli apparecchi ortopedici.
Lezione
13. Fibre chimiche
Le fibre tessili artificiali
Le fibre artificiali sono ottenute dalla trasformazione di materie prime naturali di origine organica. Si possono produrre fibre tessili a partire da proteine animali e vegetali, ricavate dai semi di molte piante, come la soia, l’arachide, il granoturco, il cotone e la canapa, oppure dalla caseina del latte, da cui si ricava il Lanital, inattaccabile dalle tarme ma ormai fuori commercio.
Dalla trasformazione chimica della cellulosa (legno, linters del cotone) si ottiene il Rayon, una fibra artificiale usata per la tessitura. A seconda della lavorazione e della materia prima utilizzata, si distinguono vari tipi di filati di Rayon: viscosa, cuprammonio, acetato.
Le fibre tessili sintetiche
Le fibre sintetiche sono ottenute per sintesi chimica dai derivati del petrolio. Hanno caratteristiche di resistenza, sono termoisolanti perché trattengono il calore del corpo, non si stropicciano e non sono soggette al pilling (le palline che si formano sulla superficie del tessuto). Non essendo traspiranti hanno il difetto di provocare, a volte, reazioni allergiche cutanee. Diverse sono le fibre usate comunemente.
Poliestere (chiamato anche Terital o Terilene): è usato per confezionare impermeabili oppure, misto alla lana, per abiti e, misto al cotone, per camicie. Ha una scarsa capacità di assorbimento e una buona resistenza. Solo con l’usura forma delle palline superficiali (pilling) ed è ingualcibile.
Fibre poliammidiche (la più diffusa è il Nylon): sono filati che resistono all’usura e sono dotati di una particolare elasticità che permette loro di adattarsi a tutti i movimenti del corpo. Per queste caratteristiche tali fibre sono impiegate per calze, collant, guaine, costumi da bagno, tessuti per pantaloni da sci e rivestimenti per le giacche a vento.
Fibre poliacriliche (Leacril, Dralon, Orlon): sono tra le fibre tessili più leggere, in grado di conferire voluminosità e una discreta elasticità al filato. Si prestano per realizzare capi di maglieria.
Fibre poliviniliche (Movil, Rhovyl): sono prodotte sotto forma di fili continui o di fiocco (fibre corte). Possiedono una buona resistenza agli agenti chimici, all’abrasione e alle tarme, non assorbono l’acqua per cui si asciugano facilmente. Sono impiegate per la maglieria, per coperte, tappeti, tendaggi, tessuti industriali.
Fibre poliuretaniche (Elastan, Lycra): sono fibre artificiali molto elastiche. Il filo di Lycra ha eccezionale capacità di allungamento (può raggiungere 6-7 volte la lunghezza iniziale) e di recuperare la forma. Lycra è un marchio registrato DuPont.

Il Nylon fu la prima fibra organica interamente sintetica a essere prodotta su scala industriale nel 1938. Utilizzata nel campo dell’abbigliamento, in particolare per le calze, ebbe successo durante la Seconda guerra mondiale soprattutto per la fabbricazione dei paracadute.
Materie prime
Monomeri
Polimeri


Marchio registrato È il diritto d’uso esclusivo di un marchio, registrato insieme a un brevetto. PER
Le fibre sintetiche sono prodotte industrialmente a partire da sostanze semplici (monomeri) provenienti dall’industria petrolchimica.
Dai monomeri si ricavano i polimeri, che costituiscono la resina sintetica.
La resina viene scaldata e fatta passare attraverso i fori di una filiera per essere trasformata in un filo.
I fili vengono quindi stirati per diventare sottili.
Il filato viene avvolto in bobine oppure trasformato in fiocco.


Per i collant il numero espresso in denari, o den, indica la trasparenza, la leggerezza e il peso del filo. Più alto è il numero di den, maggiore sarà il peso della fibra.

Le fibre tessili di ultima generazione
Fibre comfort: sono fibre sintetiche. Trattengono l’umidità del corpo, che rilasciano successivamente in funzione della temperatura dell’ambiente esterno.
• Pile: è composto al 100% di fibre poliestere, derivanti spesso dal riciclo delle bottiglie di plastica. Ha un aspetto morbido, è leggero perché costituito per l’85% di aria e caldo perché l’aria riscaldata dal corpo vi circola liberamente all’interno. Il pile non è un tessuto, ma è ottenuto con una particolare lavorazione che lo rende voluminoso e soffice.
• Polartec: simile al pile, è capace di regolare il livello di calore fornito a seconda delle diverse condizioni ambientali e delle specifiche esigenze personali.

Microfibre: il termine microfibra non indica una fibra tessile, ma la microfilatura per estrusione di fibre acriliche, Nylon, poliestere o Rayon. Le microfibre sono molto sottili (due volte più fini della seta) e la loro estrema leggerezza rende i tessuti morbidi al tatto. Le microfibre sono state inizialmente sfruttate per produrre panni da pulizia, successivamente il loro uso è stato esteso a un gran numero di prodotti, soprattutto articoli sportivi, per i quali risultano fondamentali l’assorbimento del sudore e la capacità di traspirazione.
Tessuti multistrato: sono formati da una membrana di materia plastica molto resistente, posta tra due strati di fibre sintetiche: lo strato interno assorbe il sudore, quello centrale regola la temperatura intrappolando l’aria e la parte esterna è idrorepellente.
Molte fibre di ultima generazione sono marchi registrati.
• Teflon: si tratta di fibre che hanno subìto un trattamento protettivo per creare un’invisibile barriera in grado di proteggere il tessuto dalle macchie, anche quelle oleose, pur mantenendo la traspirabilità. Il tessuto così trattato non necessita di continui lavaggi e dura più a lungo. È un marchio registrato DuPont.
• Gore-Tex: è una membrana microporosa bicomponente (PTFE espanso e materiale oleofobico) che viene applicata sui tessuti per rendere i capi di abbigliamento, gli accessori e le calzature antipioggia, impermeabili al vento e resistenti, mantenendo la traspirabilità al vapore acqueo. Ciò è reso possibile dal fatto che le molecole dell’acqua sono più grandi di quelle del vapore acqueo, quindi le gocce di pioggia non riescono a filtrare dai pori della membrana, al contrario del sudore, che può fuoriuscire. Questo principio è adottato anche nelle suole delle scarpe traspiranti. È un marchio registrato W.L. Gore & Associates.
• Windstopper: sono tessuti con una membrana microporosa che rende i capi antivento, assicurando traspirabilità e minimo ingombro. La membrana viene aggiunta anche ai capi in pelle o in microfibra, oppure accoppiata al pile. È un marchio registrato W.L. Gore & Associates.
• Cordura: è una fibra di Nylon dall’aspetto naturale, molto resistente all’usura, allo strappo e all’umidità. Nei capi di abbigliamento sportivo viene utilizzata per rinforzare le zone a maggiore rischio quali spalle, gomiti, ginocchia. È un marchio registrato DuPont.
Le pezzette per la pulizia sono realizzate in microfibra.
La fibra Coex
Le nuove tecnologie hanno contribuito alla creazione di una nuova fibra cellulosica vegetale ricavata dal lino, dalla canapa e dal cotone che è stata resa ignifuga senza l’utilizzo di additivi chimici. I tessuti ottenuti vengono impiegati come rivestimento in campo domestico o dell’abbigliamento per potenziare gli standard di sicurezza per la protezione dalle fiamme. Questi tessuti sono morbidi, anallergici, biodegradabili e, soprattutto, riciclabili.
1. Qual è la differenza tra fibre artificiali e fibre sintetiche?
2. Quali sono le fibre tessili sintetiche più diffuse?
3. Quali sono le fibre tessili di ultima generazione?
I capi di abbigliamento sportivo sono studiati per essere particolarmente leggeri. Quelli per la montagna sono pensati anche per offrire protezione dal vento, dalla pioggia e dalle diverse condizioni climatiche.

Lezione 14. Filatura, tessitura e confezione

La filatura
La filatura industriale consiste in una serie di lavorazioni eseguite per trasformare le fibre tessili in filati. Da questo procedimento vengono escluse la seta, le fibre artificiali e le fibre sintetiche perché si ottengono direttamente sotto forma di filo continuo.
L’obiettivo principale della filatura è quello di ottenere un filato omogeneo nell’elasticità e nella resistenza alla trazione e all’usura.
Dopo la filatura può essere effettuata la tintura: quest’operazione permette al colorante di penetrare nella parte centrale del filato.
A questo punto i filati sono pronti per il processo di tessitura.
FILATURA

1 Con lo sfioccamento le fibre di cotone vengono aperte, scomposte e pulite per eliminare le impurità.
2 Le fibre sciolte vengono raccolte, creando uno strato sottile chiamato ovatta.
3 L’ovatta viene avvolta in rotoli.

Il primo attrezzo utilizzato per torcere le fibre tessili fu il fuso, costituito da un bastoncino infilato in un tondino. Facendo ruotare il bastoncino si torcevano le fibre attorno al fuso.
5 Con la cardatura le fibre vengono ulteriormente separate e disposte in modo regolare.
4 I rotoli di ovatta vengono portati sulla cardatrice.

10 Un’aletta rotante avvolge il filato, chiamato stoppino, su di una spola: facendo ruotare le fibre parallele e tese si ottiene un lungo filo.
8 Il nastro viene sottoposto a stiratura.
9 Nel banco a fusi il nastro viene ritorto e assottigliato.
11 Sul filatoio, per mezzo di rulli, lo stoppino viene stirato (allungato) e, mediante un anello, con movimento verticale viene avvolto e ritorto sul rocchetto. Si ottiene così il filato.
7 Si ottiene un nastro.
6 Segue la pettinatura, per disporre le fibre in modo uniforme secondo la lunghezza; quelle corte vengono eliminate.
La tessitura

La tessitura è un’arte finalizzata alla produzione di tessuti mediante l’intreccio di fili. La tecnica è molto antica: i primi telai impiegavano due tipi di fili, ordito e trama, intrecciati perpendicolarmente tra di loro con le mani o con un bastoncino. Successivamente il telaio cambiò struttura e forma introducendo il liccio e il pettine, che velocizzarono il lavoro. Il tessuto ha una larghezza definita in base al numero di fili dell’ordito, mentre la lunghezza è indefinita.
Sui due lati del tessuto, detti cimose, i fili dell’ordito sono molto più ravvicinati per aumentarne la resistenza. Sulle cimose si possono trovare impressi sigle, marchi di fabbrica o altri segni convenzionali. I tessuti più comuni e più diffusi sono quelli ortogonali, quali i tessuti per camiceria o biancheria per la casa; sono formati dall’intreccio dei fili di ordito, posizionati in senso longitudinale, e dei fili di trama, cioè quelli orizzontali, disposti perpendicolarmente tra di loro.
TELAIO PER TESSITURA
3 Il numero dei licci presenti nel telaio dipende dal tipo di intreccio che si vuole ottenere.
1 I fili dell’ordito sono avvolti su di un cilindro chiamato subbio
Rulli portafili

2 Il liccio ha la funzione di alzare i fili pari dell’ordito e abbassare quelli dispari, favorendo così il passaggio del filo di trama.


4 Il pettine ha una forma rettangolare allungata ed è provvisto di fessure al cui interno passano i singoli fili dell’ordito. Con un colpo secco, il pettine compatta il filo di trama a ogni passaggio.
5 Il passaggio del filo di trama avviene con l’ausilio della navetta
6 A mano a mano che la tela si forma, viene arrotolata su un altro subbio.
L’inserimento del filo di trama nei telai moderni
Nel corso degli anni, pur essendo stata modificata notevolmente la meccanica del telaio, la sequenza delle operazioni è rimasta invariata; ciò che invece si è evoluto riguarda soprattutto l’inserimento del filo di trama. Nei moderni telai questo avviene con metodi diversi, tramite:
• un getto d’aria, che fornisce la spinta alla navetta con il filo di trama;
• un proiettile, costituito da un’asta di acciaio e munito di una pinzetta che trattiene il capo della trama. Scorre in apposite guide e attraversa, a oltre 200 km/h, i fili dell’ordito;
• due pinze, «pattini» in metallo e resina sintetica, muniti di particolari pinzette capaci di trattenere la trama;
• un getto d’acqua che riesce a trascinare il filo di trama da un’estremità all’altra del tessuto, a oltre 300 km/h.

Oggi la tecnologia ha permesso di sostituire il lavoro del tessitore con l’automatismo dei telai meccanizzati. I processi di lavorazione vengono svolti da programmi computerizzati che gestiscono sia l’intreccio sia i motivi decorativi.
L’intreccio
I tessuti sono il risultato della lavorazione di intreccio tra i fili dell’ordito e quelli della trama ed è proprio l’intreccio, definito anche armatura, a caratterizzare il tessuto. Le armature si distinguono in diverse tipologie.
• Armatura a tela: è la più antica e semplice; consiste nel far passare un filo della trama prima sotto e poi sopra a quello dell’ordito. Il tessuto che si ottiene è molto resistente e non ha un dritto e un rovescio.
• Armatura a spiga o saia: ha come struttura il filo di trama che passa prima due volte sopra e poi una volta sotto ai fili dell’ordito. Il tessuto presenta un’evidente struttura diagonale a destra o a sinistra.
CLIL
Filatura: spinning
Tessitura: weaving
• Armatura a raso: è molto caratteristica perché si distinguono chiaramente il dritto e il rovescio. Il filo di trama passa da quattro a sette volte sopra e una sola volta sotto al filo dell’ordito.

La tessitura a maglia
I tessuti a maglia vengono realizzati utilizzando una serie di fili, i quali vengono intrecciati a forma di anelli concatenati tra di loro fino a creare una catenella. A seconda del modo con cui vengono uniti, variano sia l’aspetto estetico sia la struttura del tessuto.
La caratteristica che distingue il tessuto a maglia rispetto a quello che si ottiene con il telaio a fili ortogonali è una maggiore elasticità ed estensibilità, che comporta una migliore vestibilità degli abiti confezionati. L’impiego dei tessuti a maglia interessa principalmente i capi di abbigliamento, come T-shirt e indumenti intimi.
Il finissaggio
Il finissaggio consiste in una serie di operazioni di lavorazione che si applicano ai tessuti, allo scopo di migliorarne l’aspetto, le proprietà e le possibili applicazioni.
La tintura può essere effettuata durante vari stadi della lavorazione tessile, partendo dalle fibre fino ad arrivare al capo finito, passando dai filati e dai tessuti.
Un’altra operazione è la stampa, che permette di riportare un disegno, anche a più colori, su una superficie tessile.
Le operazioni di candeggio hanno lo scopo di eliminare eventuali impurezze colorate e ottenere bianchi puri.
Il trattamento ignifugo consiste nel rendere il tessuto antifiamma con l’aggiunta di apposite sostanze.
Altri trattamenti di finissaggio possono essere l’antimacchia, l’antinfeltrimento, l’antipiega, l’antipilling e l’antitarme.


Dal tessuto al capo di abbigliamento
Prima che un tessuto diventi un capo di abbigliamento sono necessarie altre operazioni, che un tempo erano eseguite semplicemente con ago, filo e qualche rudimentale strumento, mentre oggi possono avvalersi di numerose macchine computerizzate che riducono i tempi di lavoro e i costi della produzione.
Le principali fasi per la realizzazione di un capo di abbigliamento sono:
• la creazione;
• la preparazione dei modelli e il taglio del tessuto, cioè la modellistica;
• la confezione;
• la finitura.
La creazione è la fase più creativa e inizia con il disegno del capo da realizzare; il modello determina la natura del prodotto e il modo in cui esso verrà lavorato. Il disegno tiene conto delle tendenze della moda e dell’immagine di marchio del produttore. La modellistica determina il metodo di confezionamento e lo sviluppo delle varie taglie, che solitamente viene effettuato a computer e con specifici programmi di grafica: si realizzano così i tracciati. Realizzati i tracciati, si procede con la fase di produzione. Il tessuto viene predisposto a strati mediante una macchina, chiamata faldatrice, che crea un materasso di tessuto. Sul materasso vengono posizionati i tracciati e si procede con il taglio tramite taglierine meccaniche o mediante dispositivi a raggio laser. Questa operazione permette di tagliare contemporaneamente un elevato numero di parti.
La confezione dei capi consiste nel congiungere tra loro le diverse parti del tessuto mediante la cucitura. Le fasi di confezione possono essere diverse, dalla semplice cucitura dei tessuti alla realizzazione di tasche, occhielli, attaccature per bottoni.
La finitura consiste nel controllo del capo per individuare eventuali difetti e comprende tutte quelle operazioni che rendono l’abito idoneo alla vendita in termini di presentazione, cioè stiratura, piegatura e imballaggio.
I capi vengono quindi inviati al magazzino di stoccaggio e da qui alla filiera per la commercializzazione.
Gli abiti dell’industria dell’abbigliamento prendono commercialmente il nome di prêt-à-porter, che vuol dire abiti pronti da indossare, oppure sono definiti abiti griffati quando fanno capo a noti stilisti.


EDUCAZIONE AMBIENTALE
Riciclare gli abiti dismessi
Mettere i propri abiti usati nei cassonetti delle associazioni umanitarie, sparsi su tutto il territorio nazionale, non costa nulla e ha effetti benefici sull’ambiente perché evita il ricorso alle discariche. Dopo la raccolta viene effettuata una selezione del materiale: per il 60% si tratta di indumenti in buone condizioni che vengono rivenduti in Italia nei mercatini dell’usato oppure, se sono capi in buone condizioni ma non adatti al mercato nazionale, vengono distribuiti gratuitamente in Africa, Sud America, India, nel Sud-Est asiatico e nei Paesi dell’Europa orientale. Circa il 25% del materiale raccolto, opportunamente tagliato, viene ridotto in stracci, pulito e commercializzato per il settore delle imprese di pulizia e per le officine; una parte di questi tessuti riciclabili viene utilizzata per produrre materiale fonoassorbente. Solamente il 5% circa viene destinato alla discarica o all’inceneritore.
1. Come si eseguono la filatura e la tessitura?
2. Che cos’è l’intreccio o armatura?
3. Come avviene il finissaggio?
4. Quali sono le fasi di lavoro per creare un capo d’abbigliamento?










Lezione 10 Le fibre tessili
Le fibre tessili sono prodotti di origine naturale o chimica con i quali si realizzano i tessuti. Sono fini, soffici e resistenti.
Lezione 11 Fibre tessili vegetali
Le fibre tessili vegetali si ricavano dalle piante e sono:
• il cotone, traspirante, è usato per l’abbigliamento e la biancheria per la casa;
• il lino, molto traspirante, è usato per gli indumenti estivi e per la biancheria;
• la canapa, molto resistente, è utilizzata per produrre stuoie e cordami.
Lezione 12 Fibre tessili animali
Le fibre tessili animali si ricavano dagli animali e sono:
• la lana, ottimo isolante termico per il corpo perché assorbe il sudore e l’acqua; può essere di alta qualità (lana merino e cachemire) e si ottiene dal vello degli ovini;
• la seta, molto elastica e leggera, è prodotta con il filo del bozzolo di un baco.
Lezione 13 Fibre chimiche
Le fibre chimiche si ottengono attraverso reazioni chimiche e sono:
• le fibre artificiali, prodotte con la trasformazione di alcune materie prime organiche (per esempio il Rayon si ricava dalla cellulosa);
• le fibre sintetiche, resistenti e termoisolanti (per esempio il poliestere e le fibre poliammidiche come il Nylon), prodotte partendo dal petrolio;
• le fibre tessili di ultima generazione, che riescono a regolare il calore corporeo in funzione della temperatura esterna (per esempio il pile), hanno alta capacità di traspirazione (per esempio le microfibre) oppure sono altamente impermeabili (per esempio il Gore-Tex).
Lezione 14 Filatura, tessitura e confezione
La filatura consiste in una serie di lavorazioni per trasformare le fibre in filati.
La tessitura è finalizzata alla produzione di tessuti: i più comuni sono quelli ortogonali, realizzati con il telaio e costituiti dai fili dell’ordito intrecciati a quelli della trama, e i tessuti a maglia, che si basano su una serie di fili intrecciati a forma di anelli concatenati.
Per realizzare gli abiti, i tessuti vengono tagliati sulla base di modelli sviluppati nelle varie taglie.
Infine, le parti vengono cucite assieme nel reparto confezione.

1. Abbina le seguenti fibre alla giusta categoria. fibra di carbonio – fibre poliuretaniche – seta – lino –juta – poliestere – cotone – fibre poliviniliche – lana
1. Fibre vegetali: – –
2. Fibre animali: ........................................... – ...........................................
3. Fibre minerali:
4. Fibre sintetiche: – –
2. Scegli l’alternativa corretta.
1. Il sisal è una fibra
A sintetica B vegetale
2. Il Rayon è una fibra
A animale B artificiale
3. La resistenza all’allungamento è una proprietà
A meccanica B tecnologica
4. La fibra di vetro è una fibra
A minerale B artificiale
3. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. Le fibre del cotone si ricavano dal fusto della pianta.
V F
2. I tessuti di cotone sono poco elastici. V F
3. Dalla lavorazione del lino si ottiene la filaccia.
4. Le fibre di canapa sono usate per produrre cordame.
V F
V F
4. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. La lana si ottiene solo dal vello delle pecore. V F
2. La bachicoltura è la coltivazione di fibre tessili. V F
3. La fibra di vetro è utilizzata per realizzare oggetti esposti agli agenti atmosferici. V F
5. Scegli l’alternativa corretta.
1. Per realizzare un tessuto antimacchia bisogna usare le fibre di
A Teflon B Cordura
2. Nei tessuti multistrato lo strato interno A intrappola l’aria B assorbe il sudore
6. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. Le fibre artificiali si ottengono dai derivati del petrolio. V F
2. I tessuti Windstopper sono antivento. V F
3. Le fibre sintetiche sono di origine organica. V F
7. Metti in ordine le fasi di realizzazione di un capo, inserendo anche quella mancante. modellistica – finitura – creazione
1. 2. 3. 4.
8. Completa le frasi scegliendo tra i termini seguenti. subbio – trama – telaio – filato
1. Dalla lavorazione delle fibre tessili si ottiene il .
2. L’intreccio delle fibre tessili si esegue con il
3. La navetta serve per facilitare il passaggio dei fili di ..................................................................... nel telaio.
4. Nel telaio la tela che si forma viene avvolta
sul .
9. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. La filatura è un’operazione che segue la tessitura. V F
2. L’intreccio serve per conferire resistenza al tessuto. V F
3. I due tipi di filo usati dal telaio sono l’ordito e la trama. V F
4. L’intreccio tra i fili di trama e quelli di ordito caratterizza i tessuti. V F
APPRENDIMENTO COOPERATIVO

TECH & CLIL
1. Realizzate un cartellone con i nomi e le immagini delle fibre tessili riportate sulle etichette degli indumenti che usate abitualmente. Per ogni fibra spiegate quali sono le proprietà. Preparate dei grafici e delle tabelle che evidenzino la percentuale del loro utilizzo tra i vostri capi d’abbigliamento.
2. Spiegate perché, oggi come ieri, l’abbigliamento riveste un ruolo importante nella vita di ogni persona e può divenire anche un simbolo di appartenenza.





Materie plastiche e gomme

Lezione 15. Le materie plastiche
Le materie plastiche derivano da risorse naturali, in particolare petrolio e gas naturale, trasformate in resine sintetiche: la manipolazione in laboratorio delle molecole di queste sostanze permette di ottenere il materiale plastico, che non esiste come tale in natura. Così l’industria chimica è in grado di produrre dei materiali, sempre più complessi e avanzati, che si adattano a una vastissima gamma di applicazioni abbracciando tutti i settori della produzione. Il merito di tanto successo è dato dall’estrema adattabilità e funzionalità con cui si ottengono migliaia di prodotti in plastica, i cui utilizzi non conoscono confini. Infatti, grazie alle sue numerose proprietà, la plastica può essere resa flessibile, rigida, dura, morbida, opaca, trasparente, leggera, resistente alla corrosione, ai batteri e alle muffe; in campo alimentare e sanitario la plastica è compatibile con liquidi e alimenti.
Proprietà fisico-chimiche
Conducibilità elettrica: buona capacità di opporre resistenza alla corrente elettrica (la plastica è un isolante).
Comportamento al calore: la plastica può essere modellata una volta (termoindurente) o più volte (termoplastica).
Proprietà meccaniche
Durezza: buona capacità di resistere all’abrasione.
Elasticità: buona capacità di riacquistare la forma primitiva (per alcune tipologie).
Resistenza meccanica: buona capacità di resistere alle forze esterne.
La plastica nella storia
La scoperta e l’utilizzo delle materie plastiche è piuttosto recente: esse nascono sul finire dell’Ottocento con lo scopo di sostituire alcuni materiali naturali pregiati, troppo costosi e spesso difficili da reperire. Il primo materiale plastico che appare sul mercato è la celluloide, a cui seguono la bachelite e la fòrmica.
Le continue ricerche e le nuove tecnologie portano alla produzione, intorno agli anni Trenta, delle materie plastiche derivate direttamente dal petrolio, come il polistirolo o il Nylon
Intorno agli anni Settanta nascono materiali plastici a elevata tecnologia, chiamati di «terza generazione»: si creano, cioè, nuovi polimeri studiati appositamente per far fronte a specifiche esigenze nei più svariati settori.
Le materie plastiche sono materiali artificiali che, in determinate condizioni di pressione e di calore, possono essere facilmente modellate.
CLIL
Materia plastica: plastic
Resina: resin
Proprietà tecnologiche
Plasticità: ottima capacità di essere deformata da forze esterne.
Duttilità: buona capacità di lasciarsi ridurre in fili.
Malleabilità: buona capacità di lasciarsi ridurre in sottili lamine.

Tanti tipi di plastica


Quasi tutti gli oggetti in plastica riportano il simbolo . Per riconoscere in modo chiaro e immediato il tipo di plastica, sono stati pensati dei codici numerici validi a livello internazionale: i produttori sono obbligati a inserire tale numero all’interno del simbolo, sotto il quale generalmente è apposta la sigla del materiale. Le cifre da 1 a 6 identificano le plastiche che è possibile riciclare; le resine di tipo 7, invece, non sono riciclabili e vanno smaltite nel cassonetto dell’indifferenziato. Le plastiche più diffuse sono:








O
PE (polietilene): corrisponde a circa la metà di tutte le plastiche prodotte ed è usato per sacchetti, cassette, nastri adesivi, bottiglie, tubi, giocattoli;
01 PET (polietilene teraftalato): si utilizza in genere per le bottiglie di bibite, di acqua minerale e per la produzione di fibre sintetiche;
02 HDPE (polietilene ad alta densità): usato per i vasetti di yogurt o per detergenti;
03 PVC (cloruro di polivinile): impiegato per produrre contenitori per le uova, tubazioni e pellicole isolanti, porte, finestre;
04 LDPE (polietilene a bassa densità): usato per sacchetti e imballaggi;





05 PP (polipropilene): utilizzato per oggetti per l’arredamento, contenitori per alimenti, flaconi per detersivi, prodotti per l’igiene personale, mobili da giardino;
06 PS (polistirene, meglio noto come polistirolo): usato per produrre vaschette per alimenti, posate, piatti, tappi.
07 Altre plastiche: impiegate come isolanti nelle fibre di vetro e come polimeri per gli imballaggi; non sono riciclabili.
07 LA CHIMICA PER LA PLASTICA




Da quando Giulio Natta, negli anni Cinquanta, ha messo a punto il polipropilene, le nuove scoperte si sono susseguite senza sosta permettendo alle materie plastiche di essere oggi presenti pressoché in ogni attività umana.
La formazione della plastica è data essenzialmente dal monomero, costituito da una o più molecole, che attraverso una complessa reazione chimica riesce a saldarsi ad altri monomeri. Si forma così una lunghissima catena che prende il nome di polimero. Aggiungendo poi anche un solo elemento chimico, si ottiene una struttura finale che presenterà proprietà diverse.
I metodi utilizzati per far sì che i monomeri si leghino tra di loro sono diversi: uno di questi è il processo di polimerizzazione che avviene per l’aggiunta di un catalizzatore il quale, in presenza di calore controllato, innesca la necessaria reazione di coesione tra i singoli monomeri.
1. Cosa sono le materie plastiche?
2. Quali sono le proprietà delle materie plastiche?
3. Quali sono le plastiche più utilizzate? PER L’INTERROGAZIONE
UNITÀ 4 Materie plastiche e gomme
16. La produzione delle materie plastiche
Dal petrolio alle resine sintetiche

La produzione delle materie plastiche è molto complessa e prevede varie fasi di lavorazione. La risorsa che permette di produrre le resine sintetiche è la virgin naphta, ossia un prodotto della distillazione del petrolio, oppure si può partire dal gas naturale. Dalla virgin naphta, con un processo chiamato cracking (o reforming, che consiste in una scissione degli idrocarburi), si rompe una catena di molecole e si ottengono diverse molecole semplici, chiamate monomeri. Con il processo della polimerizzazione si ha l’aggregazione dei monomeri e si ottengono lunghe catene dette polimeri, ossia le resine sintetiche.
La trasformazione delle resine
Le resine prodotte, a seconda della natura o del tipo di accoppiamento dei monomeri che le compongono, si dividono in:
• termoplastiche, che hanno la proprietà di poter essere lavorate più volte per riottenere nuovi oggetti finiti e possono quindi essere riciclate;
• termoindurenti, che, una volta lavorate, non permettono più successive modifiche o nuove lavorazioni; questa caratteristica ne limita il riciclo.
A questo punto, per realizzare un materiale plastico, occorre unire alle resine sintetiche degli additivi, cioè sostanze che conferiscono al materiale particolari caratteristiche che ne migliorano l’aspetto e la resistenza meccanica. Le miscele così ottenute vengono poi trasformate in granuli, polveri o paste a seconda delle esigenze industriali.
La lavorazione delle resine

Le resine sotto forma di paste, granuli e polveri sono ora pronte a divenire, grazie a macchinari industriali, gli oggetti di cui ci serviamo ogni giorno. Le tecniche di lavorazione delle materie plastiche variano a seconda del tipo di prodotto finale da immettere sul mercato.
Lo stampaggio per compressione o termoformatura
È la tecnica generalmente utilizzata per la lavorazione delle plastiche termoindurenti, con cui si producono sedie e alcune parti di mobili.
Le resine, ammorbidite dal calore, sono compresse tra uno stampo e un controstampo dove, indurendosi, prendono la forma voluta.
TERMOFORMATURA
Pressa meccanica


Resina termoplastica: thermoplastic resin
Resina termoindurente: thermosetting resin CLIL

Lo stampaggio per iniezione
Con questa tecnica vengono generalmente prodotti piccoli oggetti, attraverso la lavorazione delle resine termoplastiche. I granuli di resina vengono inseriti all’interno di un iniettore cilindrico riscaldato in cui è presente una vite senza fine che, ruotando, spinge la resina, resa molle dal calore, attraverso un foro d’uscita. Quest’ultimo è collegato a uno stampo apribile, all’interno del quale i polimeri si raffreddano prendendone la forma.
INIETTORE CON STAMPO
1 Granuli di resina
2 La vite senza fine spinge la resina, ammorbidita dal calore, nello stampo.
4 Lo stampo viene aperto.
L’estrusione
Questa tecnica viene utilizzata sia per le resine termoplastiche sia per quelle termoindurenti, per la realizzazione di tubi e profilati. La resina riscaldata viene spinta attraverso una matrice, che contiene la sezione dell’impronta usata per stabilire la forma del profilato che si vuole realizzare. Una volta raffreddato, il profilato viene tagliato nei vari formati commerciali.
INIETTORE CON MATRICE
1 Granuli di resina

3 Elementi riscaldanti 5 L’oggetto finito viene estratto.
La soffiatura
Questo metodo è utilizzato per la produzione di oggetti cavi, come bottiglie, taniche e contenitori di piccole dimensioni. Il materiale riscaldato viene immesso nello stampo e sottoposto a un getto d’aria compressa, che lo fa aderire alle pareti dello stesso.
SOFFIATURA

1 Stampo in metallo
3 Viene iniettata aria compressa.
2 La vite senza fine spinge la resina, resa molle dal calore, attraverso la matrice.
5 Si ottiene il profilato finito, la cui sezione dipende dalla matrice.
2 L’oggetto in plastica con il collo già formato viene riscaldato.
4 La plastica aderisce alle pareti dello stampo.
5 Lo stampo viene aperto e l’oggetto estratto.
3 Matrice
4 Sistema di raffreddamento
La calandratura (o laminazione)
Il materiale riscaldato e pastoso viene fatto passare attraverso dei cilindri che ruotano in senso opposto diminuendone lo spessore.
Tra gli oggetti prodotti vi sono fogli, lastre sottili, laminati.
L’espansione
All’interno della massa di resina, resa morbida dal calore, viene immesso del gas che la fa espandere e la trasforma in una specie di spugna.
Si producono così isolanti termici, giubbotti salvagente, imbottiture per sedili, isolanti acustici.
PER L’INTERROGAZIONE
1. Come si ottengono le resine?
2. Qual è la differenza tra resine termoplastiche e resine termoindurenti?
3. Quali sono i diversi metodi per la lavorazione dei materiali plastici?
4. Come avviene la lavorazione con il processo di estrusione?
17. Usi delle materie plastiche
I prodotti ottenuti a partire dalle resine sono numerosi e diversificati, impiegati in quasi tutti i settori economici.
Edilizia: grazie alle sue proprietà isolanti, la plastica offre vantaggi in termini di durata, resistenza e risparmio energetico. È impiegata nella produzione di serramenti e profilati per finestre, tubature, isolamenti termici e acustici, pavimenti e rivestimenti murali, membrane e guaine per l’impermeabilizzazione.
Arredamento: con la plastica si realizzano contenitori da cucina e lampade, vasche e docce, imbottiture e oggetti di ogni genere. Il laminato plastico riveste buona parte degli arredi.

Elettronica ed elettrodomestici: la plastica è insostituibile nell’industria elettrica ed elettronica per la realizzazione di elettrodomestici, fibre ottiche, telefoni cellulari, computer, microchip.
Mezzi di trasporto: le materie plastiche rendono i paraurti capaci di assorbire i colpi e i serbatoi privi di rischio d’esplosione, hanno quindi contribuito a rendere i veicoli più sicuri; inoltre, le materie plastiche vengono impiegate per la realizzazione degli airbag e delle cinture di sicurezza. Un altro beneficio della plastica è dato dalla sua leggerezza, che consente un minor consumo di energia.
Agricoltura: serre e teloni permettono di coltivare prodotti anche fuori stagione; sistemi di tubature in HDPE consentono l’irrigazione dei campi; inoltre, anche le macchine agricole sfruttano i benefici della leggerezza e della sicurezza della plastica.
Imballaggi: è qui che le materie plastiche, grazie alla loro versatilità, leggerezza ed economicità, trovano il maggiore sbocco. Pellicole estensibili, shopper, bottiglie, contenitori alimentari, barattoli per cosmetici e detergenti sono solo alcuni degli oggetti che animano il mondo del packaging.
Sanità: la plastica è insostituibile nell’assistenza medica di base (sacche per il sangue, strumenti igienici monouso, fili da sutura) e viene usata in alcune tecniche chirurgiche (valvole cardiache, protesi per arti e articolazioni, filtri per dialisi). Gli imballaggi in plastica, inoltre, allungano la durata dei farmaci e ne migliorano le condizioni igieniche.
Musica: una grande rivoluzione nel campo musicale è stata l’invenzione dei long playing (LP) in vinile, poi delle audiocassette, dei CD e dei lettori ottici.
Inoltre, la plastica è ideale per realizzare caschi e tute per pompieri, piloti da corsa e astronauti, realizzati con materiali e tessuti capaci di resistere a temperature superiori a 350 °C.
È un materiale molto presente nei campi profughi e negli ospedali d’emergenza, si pensi ai serbatoi d’acqua, ai contenitori per cibi e vaccini, alle tende e alle attrezzature sportive.
Polimeri a memoria di forma
PER L’INTERROGAZIONE
1. Quali settori fanno uso delle materie plastiche?
2. Quali caratteristiche rendono le plastiche adatte a essere impiegate nel settore dei trasporti?
3. Cosa sono i polimeri a memoria di forma?
I polimeri a memoria di forma (SMP, Shape Memory Polymers) sono dei materiali che, sotto lo stimolo di un fattore esterno come la luce, il calore o altre forme di energia, sono in grado di trasformarsi temporaneamente per poi tornare allo stato permanente originale. In altre parole, è la possibilità che ha un corpo con una forma determinata di cambiarla, in presenza di particolari condizioni, senza per questo perdere la memoria della sua forma iniziale. Oggi disponiamo di polimeri a memoria di forma realizzati sia con materiali termoplastici che termoindurenti. Gli SMP sono molto utilizzati nel campo medico per interventi con il minimo impatto invasivo, in quello tessile per la realizzazione di indumenti con filati misti con cotone o lana che si rimodellano in funzione della temperatura esterna.
Lezione 18. Le bioplastiche
La plastica è resistente, versatile, leggera ed economica, tuttavia i tempi di decomposizione sono molto lunghi e, se non smaltita correttamente, può contaminare l’ambiente. Per questo motivo recentemente le innovazioni tecnologiche hanno portato all’introduzione di biopolimeri o bioplastiche, materiali organici con caratteristiche simili alla plastica ma considerati biodegradabili, cioè in grado di decomporsi nel terreno. Pur avendo le stesse proprietà di un materiale inorganico, le bioplastiche sono una materia organica, di origine vegetale.
Biodegradabile o compostabile?
Oggi sul mercato sono comparse decine di polimeri plastici ricavati, per esempio, dall’amido di mais, patate o frumento.
• Mater-Bi è il nome commerciale di una bioplastica brevettata dall’azienda Novamont e ricavata dal mais. Il Mater-Bi è utilizzato nella realizzazione dei sacchetti per la raccolta differenziata dell’umido, ma trova impiego anche nella produzione di giocattoli, stoviglie, imballaggi.
• Ingeo PLA (acido polilattico) è una bioplastica, anch’essa ricavata dal mais, brevettata dall’azienda statunitense NatureWorks. Si tratta di un materiale perfettamente trasparente, per cui viene utilizzata per la produzione di bicchieri e bottiglie per l’acqua minerale.
• La polpa di cellulosa si ricava dalle fibre della lavorazione di alcune piante, in particolare della canna da zucchero. Viene utilizzata per la produzione di piatti e bicchieri. Resiste alla temperatura di 200 °C e può essere utilizzata nel forno a microonde.
Questi prodotti sono considerati biodegradabili e compostabili (ossia utilizzabili per la raccolta dei rifiuti domestici dell’umido), in base a una normativa europea secondo cui tali materiali devono degradarsi del 90% in sei mesi. Tuttavia, perché la decomposizione si attivi è necessario che lo smaltimento avvenga in appositi siti di compostaggio: grazie alle temperature elevate e ai batteri presenti negli impianti di compostaggio, il materiale si decompone progressivamente, senza rilasciare sostanze nocive e trasformandosi in compost, utilizzato come fertilizzante.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Bioplastiche: pro e contro
Le bioplastiche ottenute da cereali come il mais o il grano oppure dalle patate hanno il vantaggio di essere biodegradabili e compostabili, ma la loro produzione desta qualche critica. Per ottenerle, infatti, vaste superfici vengono coltivate appositamente, impiegando energie fossili per azionare le macchine, acqua di irrigazione, diserbanti e concimi chimici, e sfruttando terreni che invece potrebbero essere destinati alla coltivazione di alimenti.

CLIL
Bioplastica: bioplastic
Biodegradabile: biodegradable
OGGI DOMANI
Il futuro della plastica
Il problema dello smaltimento della plastica impone soluzioni sempre più urgenti ed ecosostenibili. Per questo molti ricercatori lavorano assiduamente per trovare il modo di produrre plastiche al cento per cento biodegradabili e compostabili.
1. Cosa indica il termine bioplastica?
2. Come sarà il futuro della plastica?
3. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle bioplastiche?
4. Come viene utilizzato il Mater-Bi? PER L’INTERROGAZIONE
Un esempio sono le bioplastiche PHA e PHB: poliesteri prodotti attraverso la fermentazione batterica di zuccheri utilizzando scarti vegetali della lavorazione di barbabietola e canna da zucchero. Questo tipo di plastica è molto versatile e adatta a vari usi, grazie anche alle sue caratteristiche di stampabilità, flessibilità e resistenza. Una volta utilizzata, può essere compostata a temperatura ambiente con il solo intervento dei batteri presenti in natura, senza lasciare residui e in soli 10 giorni.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Lezione 19. Sostenibilità e riciclo
La combustione della plastica all’aperto senza controllo rilascia nell’aria sostanze molto inquinanti. Per esempio, il PVC oltre all’anidride carbonica rilascia acido cloridrico, diossine e furani, composti ad altissima tossicità.
Pertanto, al termine della loro vita gli oggetti in plastica dismessi devono seguire, come anche altri prodotti, trattamenti per il riuso, il riciclaggio e procedure controllate di smaltimento.
RICICLO DELLE MATERIE PLASTICHE
1 I Comuni effettuano la raccolta dei rifiuti in plastica da riciclare. Per ridurre il costo del servizio sarebbe bene schiacciare tutti gli oggetti, così che occupino meno spazio e servano meno furgoni per trasportarli.

2 In circa 35 impianti sparsi in Italia avviene una selezione delle plastiche più pregiate (PET, polistirolo, HDPE), separate in base al polimero di base e, in alcuni casi, al colore.
4 La plastica avviata al riciclo viene lavata e macinata; si ottengono granuli o scaglie di plastica che non sono più classificati come rifiuto ma come materia prima seconda.

Inquinamento da microplastica: microplastic pollution CLIL
3 Il materiale selezionato viene venduto: in Italia il 61% della plastica avviata al riciclo è recuperata, circa il 35% è utilizzata nei cementifici e per la produzione di energia elettrica, mentre solo il restante 4% finisce in discarica.

A livello nazionale, l’ente che si occupa del riciclo delle materie plastiche è il COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica).
Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in plastica coinvolge ormai la quasi totalità della popolazione.
Vi sono degli oggetti che, pur essendo fabbricati con plastiche riciclabili, in alcuni Comuni sono classificati come rifiuti indifferenziati o ingombranti. Ciò accade perché la normativa europea e italiana prevede l’obbligo di riciclaggio solo per i prodotti in plastica che rappresentano imballaggi. Tuttavia, dal maggio 2012, si riciclano anche piatti e bicchieri usa e getta in polistirene. Per favorire la sostenibilità ambientale, è necessario che i singoli cittadini privilegino l’acquisto di prodotti dotati di imballaggi con un esiguo contenuto di plastica: spesso, infatti, l’imballaggio è del tutto inutile, concorre all’aumento del prezzo del prodotto e comporta una maggiore quantità di rifiuti da smaltire.
5 Con la plastica riciclata è possibile realizzare qualsiasi tipo di oggetto.

Isole di plastica
La plastica è un materiale che giornalmente usiamo sotto tantissime forme: non c’è oggetto, infatti, che non sia composto da una percentuale più o meno alta di tale materiale. Questo produce inevitabilmente un accumulo di rifiuti plastici che devono essere riciclati e smaltiti nel rispetto delle normative. Purtroppo non sempre ciò avviene, per cui molti oggetti di plastica finiscono inevitabilmente nell’ambiente. In particolare i rifiuti di plastica si accumulano nei fiumi e nei mari e, assieme agli oggetti gettati in mare dalle navi e dai pescatori, hanno contribuito a creare una grave emergenza per l’ecosistema marino. Gli 8 milioni di megagrammi di plastica che annualmente finiscono nei mari si muovono per l’influenza delle correnti marine e stanno creando immensi raggruppamenti che assomigliano a isole. Le notizie della formazione di tali isole di spazzatura, chiamate isole di plastica (garbage patch), sono state confermate e rilevate con immagini. La più grande di esse, conosciuta come Great Pacific Garbage Patch, si trova nell’Oceano Pacifico, tra la California e l’arcipelago delle Hawaii. La sua estensione è di 1,6 milioni di km2, pari a tre volte la superficie della Francia, e il suo peso stimato è di 80 000 megagrammi.
Microplastiche
Gli effetti che queste masse di plastica stanno provocando sono devastanti anche perché, col passare del tempo, le radiazioni solari e l’acqua marina le sgretolano creando piccolissimi frammenti di diametro inferiore ai 5 millimetri. Queste briciole di materiale, conosciute con il termine di microplastica, rappresentano un «invisibile» inquinamento che va ad alterare gli ecosistemi e la biodiversità del mare e che, inevitabilmente, si ripercuote anche sulla salute dell’uomo. Infatti, rischiamo di nutrirci di pesci nei cui organi interni si trovano quantità variabili di microframmenti e nanoplastiche, che sono diventati un problema per la sicurezza alimentare. L’inquinamento marino da microplastiche viene anche alimentato dall’uso quotidiano dei prodotti per l’igiene personale e la cosmesi perché molti di questi articoli contengono microsfere usate come esfoliante che, date le ridotte dimensioni, non sono filtrabili con i normali sistemi di depurazione delle acque reflue. Altra fonte di inquinamento è causata dalle microfibre rilasciate durante il lavaggio di indumenti sintetici come il poliestere. Oggi, per limitare tale problematica, molti Stati impongono alle industrie la sostituzione delle microsfere di origine plastica con prodotti naturali.
Plastic free challenge
In Italia è stato da poco approvato il progetto Plastic free challenge che letteralmente vuol dire «liberi dalla plastica» e ha lo scopo di salvaguardare i mari e il territorio. Con tale iniziativa si vogliono sensibilizzare le Regioni, i Comuni, le varie associazioni territoriali e la catena della grande distribuzione affinché, spontaneamente e nei limiti delle loro competenze, aderiscano al divieto di utilizzo di oggetti di plastica usa e getta.
In molti hanno già applicato tale iniziativa, anticipando di fatto quello che per legge avverrà nel 2021 nell’UE e in altre nazioni, provvedendo a vietare di vendere e usare molti prodotti monouso di plastica come cannucce, piatti, bicchieri e altri. Al loro posto saranno prodotti e commercializzati oggetti simili ma biodegradabili.


PER L’INTERROGAZIONE
1. Come si creano le isole di plastica?
2. Perché le microplastiche sono pericolose per la salute dell’uomo?
3. Come si può limitare la presenza delle microplastiche nei mari?
4. Cosa prevede il progetto Plastic free challenge?
Lezione 20. Gomma naturale e sintetica
PER
La gomma è un materiale naturale o sintetico che sotto l’effetto di una forza esterna si deforma, riacquistando l’aspetto iniziale quando l’azione cessa. L’industria della gomma utilizza come materia prima sia il lattice prodotto da alcune piante (gomma naturale) sia i polimeri derivati dall’industria petrolchimica (gomme sintetiche).
Grazie alle sue caratteristiche di resistenza, flessibilità, elasticità e impermeabilità, la gomma è un materiale adatto a svariati usi e viene impiegata in diversi settori.
Proprietà fisico-chimiche
Conducibilità elettrica: capacità di opporsi al passaggio della corrente elettrica (la gomma è un isolante).
Igroscopicità: capacità di opporsi all’assorbimento dell’umidità.
Insolubilità: capacità di non formare soluzioni con l’acqua.
La gomma naturale
Proprietà meccaniche
Resistenza all’abrasione: capacità di resistere all’erosione, alla raschiatura.
Resistenza alla rottura: capacità di resistere alle forze che determinano una frattura.
Elasticità: capacità di deformarsi per poi riprendere la forma originaria.
La gomma naturale, chiamata anche caucciù, viene ricavata dal lattice dell’albero della gomma (Hevea brasiliensis); è costituita per il 35% circa da gomma e per il rimanente 65% da acqua e da piccole percentuali di proteine e grassi. Questo materiale si presenta infatti appiccicoso, colloso se riscaldato e duro se raffreddato. La tecnica di raccolta del lattice prevede l’incisione della corteccia della pianta. Il lattice raccolto, che mediamente si aggira attorno a 3 kg annui per pianta, viene versato in grosse vasche e fatto coagulare aggiungendo sostanze chimiche (acido acetico o formico).
Dopo la spremitura in una calandra, effettuata per eliminare la parte liquida, l’impasto si presenta in fogli. In seguito a un’affumicatura, che impedisce l’aggressione da parte delle muffe, i fogli essiccati vengono riuniti in balle per poi essere spediti alle fabbriche per la lavorazione e la trasformazione in prodotti finiti.
Vulcanizzazione
Procedimento mediante il quale la gomma diventa elastica.
Mescola
Miscuglio a base di gomma a cui sono stati aggiunti degli additivi.
Proprietà tecnologiche
Fusibilità: capacità di lasciarsi fondere.
Temprabilità: capacità di acquistare durezza sotto l’effetto del calore.

La gomma nella storia

I primi ad avere scoperto le straordinarie proprietà della gomma furono probabilmente gli indigeni del Sud America, che estraevano un lattice liquido e vischioso dalla corteccia dell’albero chiamato Hevea brasiliensis. Purtroppo il lattice presentava un grande limite: in poco tempo solidificava e non poteva più essere usato. La soluzione al problema arrivò nella prima metà dell’Ottocento, quando lo statunitense Charles Goodyear inventò il processo di vulcanizzazione della gomma, che migliorava le proprietà fisiche e meccaniche del materiale. Un secolo più tardi, chimici tedeschi misero a punto una gomma sintetica di buona qualità, chiamata Buna (Butadiene), migliorata nelle sue proprietà grazie a ricerche condotte nel corso degli anni seguenti. Nel Novecento, con l’avvio della motorizzazione, la gomma divenne quindi ricercatissima per fabbricare gli pneumatici delle auto.
La lavorazione della gomma naturale
Masticazione
La lavorazione della gomma comincia con la masticazione, che prevede lo sgretolamento della gomma greggia affumicata e l’aggiunta di additivi. Gli additivi rendono la pasta più plastica per la lavorazione, migliorano le proprietà meccaniche del materiale, impediscono l’invecchiamento, ne migliorano la lavorabilità e ne esaltano l’elasticità. Il prodotto così ottenuto prende il nome di mescola.
Formatura
Segue la fase di formatura, durante la quale si mette la mescola fusa dentro appositi stampi oppure si lavora il materiale con la tecnica dell’estrusione o lo si riduce in fogli sottili tramite la calandratura.

La gomma sintetica
Vulcanizzazione
Il processo di vulcanizzazione consiste nel portare il prodotto finito a una temperatura di 140-150 °C, per essere sottoposto a un trattamento con zolfo. Attraverso questo processo il caucciù, che generalmente è poco resistente e poco stabile agli agenti atmosferici e chimici, migliora le sue caratteristiche di elasticità, impermeabilità, resistenza agli sbalzi climatici e a molti solventi organici.
La gomma naturale è usata nella realizzazione di oggetti per uso medico, ospedaliero e per l’infanzia, equipaggiamenti sportivi, isolanti e suole per calzature, tessuti impermeabilizzati per l’abbigliamento, giocattoli, materiali vari per l’arredamento, prodotti per la casa, mastici e adesivi, guarnizioni.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Gomma: rubber Lattice: latex
Agli inizi del Novecento la quantità di gomma naturale sul mercato non riusciva più a soddisfare la richiesta di materia prima per gli pneumatici e si rese quindi necessario produrre nuovi materiali sintetici che sostituissero la gomma naturale. Rispetto alla gomma naturale, la gomma sintetica è più economica e maggiormente lavorabile.
Le più importanti gomme sintetiche che oggi si trovano in commercio derivano dal petrolio.
• Buna S (Butadiene-stirene): per la sua elasticità è molto usata nella realizzazione di cinghie e suole e nell’industria automobilistica per la produzione di pneumatici.
• Buna N (Butadiene-nitrile): gomma dura e resistente ai solventi, conserva una buona elasticità anche a basse temperature; si usa per realizzare recipienti, guarnizioni, tubi, cuoi artificiali, adesivi.
• Gomme siliconiche: resistono a temperature oscillanti tra –100 °C e +300 °C e vengono usate nell’industria elettronica per costruire guarnizioni, parti di aerei e missili.
• Neoprene: resiste all’invecchiamento, per cui si usa per prodotti esposti ai vari agenti climatici; difficilmente infiammabile, viene impiegato per tubi, guanti, abiti di protezione, cavi elettrici e altri materiali per l’edilizia.
Sostenibilità e riciclo
La gomma non è biodegradabile e il suo riciclo non ha un valore molto significativo perché il materiale che si ottiene è scadente. La gomma proveniente da prodotti usurati può comunque essere triturata e ridotta in granuli, che consentono un reimpiego nella mescola dei nuovi manufatti. Grazie alle nuove tecnologie i granuli si utilizzano nella produzione di guaine fonoassorbenti, nella messa in opera delle piste di atletica e per rendere meno rumorose e più drenanti le strade.
PER L’INTERROGAZIONE
1. Quali sono le materie prime utilizzate per produrre la gomma?
2. Quali sono le differenze tra la gomma naturale e quella sintetica?



Ripassa i contenuti a pagina 16-18 dell’allegato.







Lezione 15 Le materie plastiche
Le materie plastiche derivano da risorse naturali, come petrolio e gas naturale, trasformate in resine sintetiche. Queste, sottoposte a reazioni chimiche, vengono trasformate in materie plastiche utilizzate in tutti i campi.
Sono materie facilmente lavorabili, resistenti, economiche e leggere; non vengono attaccate dalle muffe né dai batteri e offrono un buon isolamento termico ed elettrico.
Gli oggetti in plastica hanno il simbolo con un codice che ne descrive le caratteristiche.

Lezione 16 La produzione delle materie plastiche
Le resine sintetiche si ottengono dalla virgin naphta, proveniente dalla distillazione del petrolio, o dal gas naturale. Le resine possono essere:
• termoindurenti se è possibile lavorarle una sola volta;
• termoplastiche se possono essere lavorate più volte.
Alcune lavorazioni della resina per ottenere gli oggetti in plastica sono lo stampaggio per compressione e per iniezione, l’estrusione e la soffiatura.
Lezione 17 Usi delle materie plastiche
I prodotti ottenuti a partire dalle resine sono numerosi e impiegati in quasi tutti i settori economici: nell’edilizia, nell’arredamento, nell’elettronica, nella realizzazione degli elettrodomestici e dei mezzi di trasporto, nel settore della sanità.
Lezione 18 Le bioplastiche
Le plastiche impiegano tanti anni per decomporsi e così di recente sono comparse le bioplastiche, materiali organici molto simili alle plastiche ma biodegradabili. Alcune di esse sono compostabili, cioè utilizzabili per la raccolta dei rifiuti domestici dell’umido.
Lezione 19 Sostenibilità e riciclo
Al termine della loro vita gli oggetti in plastica devono seguire trattamenti per il riciclaggio e procedure controllate di smaltimento.
Per favorire la sostenibilità ambientale, ogni cittadino dovrebbe privilegiare l’acquisto di prodotti dotati di imballaggi con un esiguo contenuto di plastica.
Lezione 20 Gomma naturale e sintetica
La gomma è un materiale naturale o sintetico che sotto l’effetto di una forza esterna si deforma, riacquistando la forma iniziale quando l’azione termina.
È resistente, flessibile, elastica e impermeabile.
La gomma naturale, o caucciù, deriva dal lattice estratto dalla pianta della gomma e viene impiegata per produrre oggetti per l’infanzia o di uso medico.
La gomma sintetica deriva dall’industria petrolchimica e viene impiegata, per esempio, per produrre pneumatici e tubi.

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. Le materie plastiche derivano da risorse naturali.
2. Le materie plastiche sono costituite da una miscela a base di fibra di vetro e un materiale rinforzante. V F
3. La malleabilità è una caratteristica meccanica della plastica. V F
4. Le plastiche di tipo da 1 a 6 sono riciclabili. V F
5. Il primo materiale plastico utilizzato dall’uomo è stata la bachelite. V F
6. Il polimero è formato da una lunga catena di molecole. V F
2. Scegli l’alternativa corretta.
1. La plastica termoindurente può essere modellata
A una volta B più volte
2. I materiali termoplastici possono essere fusi
A una volta B più volte
3. Completa le frasi scegliendo tra i termini seguenti.
cracking – virgin naphta
1. Le resine sintetiche si ottengono dalla
2. Per produrre le materie plastiche si spezzano le catene di molecole tramite un processo di
4. Individua l’intruso.
1. Quale tra i seguenti termini non si riferisce alle catene molecolari da cui si ricavano le plastiche?
A monomeri B biomeri C polimeri
5. Indica in quali settori industriali si utilizzano le materie plastiche.
TECH & CLIL
Choose the correct alternative and answer the following questions.
1. What is the raw material needed to produce most of plastics?
A Cellulose B Oil
2. Which plastics can be recycled?
A Thermoplastic B Thermosetting
3. Natural rubber comes from…
A Bamboo B Caucciù
6. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. Il Mater-Bi è un nuovo materiale che deriva dal carbone. V F
2. Tutte le plastiche biodegradabili sono compostabili. V F
3. PHA e PHB sono bioplastiche. V F
4. L’Ingeo PLA è una plastica perfettamente trasparente. V F
7. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. Tutte le materie plastiche sono riciclabili. V F
2. La combustione della plastica provoca l’emissione di composti tossici. V F
3. Le isole di plastica si trovano anche nel Mar Mediterraneo. V F
4. Il progetto Plastic free challenge limita l’uso quotidiano della plastica usa e getta. V F
8. Scegli l’alternativa corretta.
1. Il materiale plastico da riciclare viene
A ridotto in granuli B direttamente fuso
2. Con la plastica riciclata è oggi possibile ottenere
A solo alcuni tipi di oggetti
B qualsiasi tipo di oggetti
9. Completa il testo.
La gomma si può ottenere da una materia prima come il ............................................................... estratto da alcune piante oppure da prodotti derivati dall’industria
Per realizzare gli pneumatici delle automobili la gomma viene sottoposta al processo di , che ne migliora le proprietà di all’abrasione e al calore.
10. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. La gomma naturale è chiamata anche caucciù. V F
2. Il lattice si estrae tramite incisioni sulle radici della pianta. V F
3. Quando vengono allungati, gli elastomeri si deformano senza spezzarsi. V F
OBIETTIVO AGENDA 2030





1. Le isole di plastica presenti negli oceani sono una minaccia per la biodiversità. Spiegate con immagini e documenti come esse arrecano danni all’ambiente e alla salute dell’uomo.
2. L’inquinamento ambientale ha raggiunto livelli preoccupanti per il pianeta. Spiegate e illustrate quelle che secondo voi sono le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni al problema.

Vetro
Lezione 21. Il vetro

Il vetro è il prodotto della fusione della silice e di altri elementi che, solidificandosi, conferiscono la caratteristica della trasparenza.
Il vetro è un materiale che per le sue qualità, unite allo sviluppo dei metodi di produzione, si presta a essere usato in molti campi, da quello industriale a quello artistico; è impiegato in particolare nel settore alimentare, grazie alla sua capacità di non alterare gli alimenti. È un materiale duro, ma allo stesso tempo fragile; grazie allo sviluppo tecnologico è oggi però possibile produrre vetri infrangibili.
Proprietà fisico-chimiche
Conducibilità termica ed elettrica: capacità di opporre resistenza al passaggio della corrente e del calore (il vetro è un isolante).
Trasparenza: proprietà di un corpo che si lascia attraversare dalla luce.
Proprietà meccaniche
Resistenza alla trazione: scarsa capacità di sopportare la trazione. Resistenza alla compressione: ottima resistenza se sottoposto a compressione. Resistenza all’abrasione: buona capacità di resistere alle scalfitture. Fragilità: non sopporta gli urti.
Vetro: glass
Cristallo: crystal
Proprietà tecnologiche
Fusibilità: proprietà di fondere se sottoposto a 1 500 °C.
Duttilità: capacità di farsi ridurre in fili.
Malleabilità: capacità di farsi ridurre in sottili lastre.
Temprabilità: capacità di acquistare maggiore durezza se sottoposto a tempra, cioè a cicli di riscaldamento e raffreddamento.
La scoperta del vetro
Plinio il Vecchio racconta che il vetro fu scoperto da mercanti fenici: giunti sulle rive di un fiume, accesero il fuoco e accanto misero dei blocchi di nitrato che trasportavano come mercanzia. A mano a mano che il fuoco bruciava, i blocchi si scioglievano e, combinandosi con la sabbia del fiume, formavano un composto lucente e trasparente. Reperti archeologici farebbero invece risalire l’uso del vetro già al 3500 a.C. presso gli abitanti della Mesopotamia. Anche negli scavi di Pompei ed Ercolano sono stati rinvenuti oggetti in vetro. Nel 50 a.C. i Romani perfezionarono la tecnica vetraria, inventando la soffiatura e il modo di ridurre il vetro in lastre per schermare le finestre. Nel Medioevo alcuni artigiani veneziani affinarono le conoscenze della soffiatura, al punto che, per tenere segreti i processi di lavorazione, nel 1291 spostarono sull’isola di Murano tutte le vetrerie.

I tipi di vetro
In base alle proprietà che possiedono e secondo l’uso a cui sono destinati, si contano più di cinquanta tipi di vetro.
Il vetro comune





Il vetro comune è impiegato per la produzione di lastre e contenitori: bottiglie, bicchieri, vasi, oggettistica d’arredo e lampadari. Una delle sue caratteristiche è quella di offrire un’elevata inalterabilità chimica a contatto con gli alimenti e le bevande. In alcuni casi al vetro si aggiungono elementi che conferiscono una particolare colorazione.
Il cristallo
Il cristallo è un vetro caratterizzato dalla presenza di alte percentuali di piombo, che conferiscono all’oggetto una particolare brillantezza, oltre a una sonorità tipica. Si presenta con un taglio e una molatura (vedi p. 65) che gli attribuiscono riflessi lucenti come quelli dei diamanti. Tra gli oggetti prodotti vi sono la cristalleria da tavola, vasi, lampadari e svariati manufatti artistici.
Il vetro pirex
Il vetro pirex, tecnicamente conosciuto come vetro borosilicato, è ottenuto con l’aggiunta di boro e silicati vari alla sabbia silicea. È un materiale molto duro, capace di resistere agli sbalzi di temperatura. Questa proprietà lo rende un materiale idoneo per la cottura in forno degli alimenti. Può essere usato anche nel forno a microonde o per congelare i cibi nel freezer.
I vetri termoisolanti
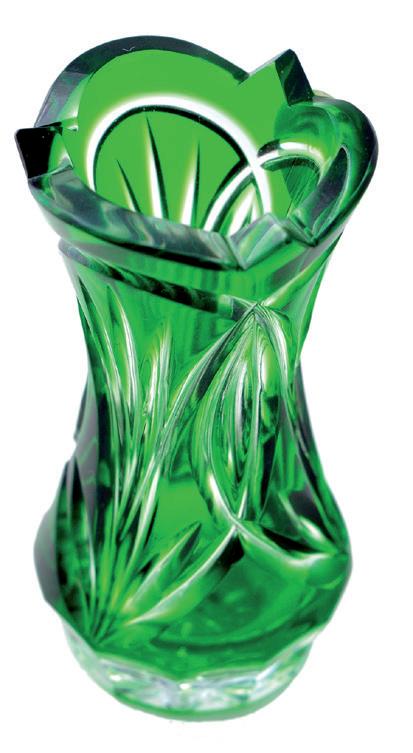

Il cristallo è stato sempre considerato un vetro molto pregiato e per questo ricercatissimo. Il cristallo più famoso è quello di Boemia, che fece la sua comparsa nel Seicento ed è considerato ancora oggi tra i più raffinati.
PER L’INTERROGAZIONE
1. Che cos’è il vetro?
2. Quali sono le proprietà fisico-chimiche del vetro?
3. Com’è stato scoperto il vetro?
4. Qual è la differenza tra vetro comune e cristallo?
5. A cosa serve il vetro pirex?
I vetri termoisolanti sono costituiti da due lastre di vetro mantenute a una distanza di 6-10 mm da una cornice. All’interno della cornice viene posto un gas isolante, costituito da aria o gas inerte. Il grado di isolamento termico dipende dallo spessore dei vetri, dalla quantità di isolante e dalla tenuta ermetica della struttura. Questi vetri trovano largo impiego nell’edilizia per la costruzione degli infissi, perché permettono un risparmio di energia oltre a proteggere gli ambienti interni dai rumori esterni.
Il vetro di sicurezza
Viene chiamato vetro di sicurezza quel vetro che, in caso di rottura, non rilascia frammenti pericolosi per le persone. Generalmente si ottiene incollando due lastre di vetro con una o più pellicole plastiche, in policarbonato o acrilico. Oltre a essere trasparente, questo vetro è dotato di grande elasticità e resistenza. In caso di urto il vetro si rompe, ma le lastre rimangono «incollate» alla pellicola di materiale plastico.
È utilizzato come vetro esterno in edifici adibiti ad attività sportive, in scuole, ospedali, nelle vetrine dei negozi ecc. Il vetro di sicurezza temprato è ottenuto portando il vetro a circa 700 °C per poi raffreddarlo. In questo modo si ottiene un materiale molto resistente agli urti, usato per porte, ripiani di tavoli e box doccia, vetrate e vetri per autovetture.
Lezione 22. La produzione del vetro
Le materie prime
La materia prima per fabbricare il vetro è la silice, un ossido di silicio che in natura si trova nelle rocce contenenti quarzo e viene estratta nelle cave di quarzite.
La produzione del vetro inizia preparando una miscela, composta prevalentemente di sabbia silicea a cui si aggiungono altri materiali:
• fondenti, per facilitare la fusione (carbonato di potassio oppure ossido di sodio);
• stabilizzanti, per impedire al vetro di perdere la trasparenza;
• soda, per rallentare la solidificazione della massa fusa;
• ossidi metallici, per ottenere una particolare colorazione;
• rottami di vetro, per favorire la fusione ed evitare l’utilizzo di materie prime.
La lavorazione del vetro
CLIL
Silice: silica
Stampaggio: molding
Float
Lastre di vetro sottile, usate prevalentemente in edilizia come vetro per le finestre.
Tutti gli elementi che costituiscono la miscela del vetro, detta anche carica, prima di entrare nel forno di fusione vengono frantumati finemente per ottenere un prodotto omogeneo. La carica, portata a una temperatura di 1 300 °C, inizia a fondere assumendo una consistenza pastosa, ma solo a 1 500 °C raggiunge il punto ottimale di fusione per la lavorazione. Durante il processo di fusione, che dura mediamente 24 ore, la carica sprigiona dei gas che formano delle bolle. Queste devono essere eliminate perché creano imperfezioni e determinano scarsa resistenza nei prodotti finiti.
La lavorazione industriale del vetro avviene utilizzando diversi metodi.
• Stampaggio: la massa ancora fusa viene messa in uno stampo e sottoposta a pressione, per cui è costretta a occupare tutti gli spazi vuoti dello stampo. Con questa tecnica si creano oggetti vari per l’arredamento.
• Pressatura-soffiatura: in uno stampo viene fatta cadere una goccia di materiale fuso, che viene poi sottoposta a un soffiaggio forzato in modo da far aderire il materiale su tutta la parete cava, lasciando la parte interna vuota. Con questo metodo si producono bottiglie e buona parte degli oggetti cavi.
• Float glass: cioè vetro galleggiante, è il metodo più usato per ottenere il vetro piano.
PRESSATURA-SOFFIATURA
1 Una goccia di pasta vetrosa, di dimensioni calibrate, viene fatta cadere in uno stampo. Si forma il collo della bottiglia.


4 Lo stampo viene aperto, la bottiglia estratta e posta su un nastro trasportatore.
2 Lo stampo viene aperto; un braccio meccanico trasporta la goccia di vetro con il collo formato in un altro stampo.

3 Lo stampo viene chiuso e viene immessa dell’aria.
La pasta vetrosa si espande aderendo contro le pareti dello stampo.
5 Le bottiglie entrano in un tunnel chiamato di ricottura, dove vengono raffreddate lentamente a temperatura ambiente.


2 Le materie prime, finemente macinate, sono poste nel forno.
3 Fusione
Il forno viene portato a una temperatura di 1 300 °C; il materiale inizia a fondere e diventa pastoso.
4 Affinazione e formatura
Una volta fuso, il vetro viene fatto colare su un bagno di stagno fuso. Qui si spande e forma una lastra piana e uniforme.
5 Ricottura
La lastra di vetro viene fatta passare in un tunnel, chiamato forno di ricottura, dove viene raffreddata molto lentamente.
1 Silos contenenti le materie prime
8 Controllo
Una macchina elettronica verifica le caratteristiche di dimensione, forma, spessore e integrità di ogni prodotto. I pezzi non conformi agli standard prefissati sono scartati e avviati alla frantumazione per essere nuovamente fusi.

6 Taglio
Una volta raffreddata, la lastra viene tagliata in altre lastre più piccole, nelle misure commerciali.
La finitura del vetro
Completato il processo produttivo, il vetro può essere sottoposto a ulteriori lavorazioni per esaltare determinate caratteristiche o per eliminare alcune imperfezioni.
• Molatura: una volta tagliate nelle dimensioni opportune, le lastre di vetro vengono sottoposte a molatura per evitare che la superficie dei bordi rimanga tagliente.
• Spianatura: è un’operazione di tipo meccanico che si effettua sulle superfici delle lastre per eliminare eventuali imperfezioni dai bordi.
• Foratura: per praticare fori nel vetro si utilizza un trapano con apposite punte diamantate, raffreddate con acqua.
• Lucidatura: ha lo scopo di rendere liscia e brillante la superficie vitrea, quando l’oggetto è finito. Il lavoro viene effettuato con acqua e speciali abrasivi molto fini.
• Sabbiatura: è un trattamento effettuato per opacizzare la superficie lucida del vetro e avviene con un getto, sotto forte pressione, di sabbia e acqua.
• Acidatura: si tratta di una tecnica basata sull’uso di un acido in grado di rendere la superficie satinata.
7 Tempra
Per aumentarne la resistenza, il pezzo finito viene prima portato a una temperatura di 700 °C, poi bruscamente raffreddato immergendolo in acqua fredda o esponendolo a correnti d’aria.

La molatura richiede l’utilizzo di acqua che raffredda i bordi ed evita tensioni nel vetro.
PER L’INTERROGAZIONE
1. Con quali materie prime si produce il vetro?
2. Con quali metodi si produce il vetro?
3. Quali sono le lavorazioni di finitura del vetro?
23. Altri impieghi del vetro
Il vetro artistico
Con l’introduzione di macchinari per l’attività industriale, verso la metà dell’Ottocento il metodo di lavorazione del vetro subì una profonda trasformazione. Questo, però, non modificò l’arte vetraria degli artigiani di Venezia, che continuarono a produrlo mantenendo inalterate le loro tecniche. Ancora oggi, il vetro viene lavorato con la canna da soffio: il materiale vetroso, reso fuso in un apposito forno, viene prelevato con la canna e soffiato a bocca. La lavorazione avviene utilizzando solamente delle pinze, la fiamma, esperienza e abilità. La fase di creazione dell’oggetto deve essere svolta velocemente per sfruttare la plasticità del vetro
La lana di vetro
La lana di vetro è un prodotto ottenuto facendo passare la massa di vetro fusa, sotto forte pressione, attraverso un dispositivo detto filiera dotato di buchi con dimensioni di 1 µm (pari a 0,001 mm). Si ricava quindi una fibra minerale simile a ovatta.
PER
I materiali in fibre di vetro trovano applicazione nel campo dell’edilizia come termoisolanti e fonoassorbenti, nel settore automobilistico come silenziatori nelle marmitte.
La fibra ottica

Un tipo particolare di fibre di vetro è rappresentato dalla fibra ottica, usata come guida di luce. Se si pone una sorgente di luce all’inizio della fibra, la luce si propaga lungo la fibra stessa.
Trova grande impiego nel settore delle telecomunicazioni: il segnale elettronico viene convertito in segnale luminoso, trasportato attraverso fibre ottiche e, infine, riconvertito in segnale elettronico. Rispetto ai cavi di rame, la fibra ottica ha il vantaggio di trasportare un numero di informazioni enormemente superiore a parità di diametro; inoltre, non risente di interferenze elettriche e magnetiche.
Il vetro ottico
Il vetro ottico si ottiene miscelando al vetro privo di impurità il piombo, l’arsenico, il potassio e il boro. La miscela viene poi fusa a circa 1 500 °C dentro speciali crogioli in platino. La massa viene spianata per formare una lastra uniforme e quindi raffreddata. A questo punto può subire la lavorazione di molatura, così da assumere la forma desiderata per produrre lenti per gli occhiali da vista, binocoli, telescopi, obiettivi per macchine fotografiche e microscopi.
Il vetro autopulente

Lana di vetro: glass wool
Fibra ottica: optical fiber
Crogiolo
Recipiente usato per fondere metalli, vetro ecc.
2. In quali settori viene impiegata la lana di vetro? PER L’INTERROGAZIONE
1. Come si produce il vetro artistico?
Il vetro autopulente è sempre stato un sogno irrealizzabile. Oggi, dopo programmi di ricerca e di sviluppo, è una realtà. Si tratta di un normale vetro con un rivestimento speciale sul lato esterno: uno strato sottilissimo di biossido di titanio che produce l’effetto autopulente attraverso due meccanismi:
• reagisce ai raggi ultravioletti della luce solare decomponendo e sciogliendo lo sporco organico;
• reagisce all’acqua che, invece di formare goccioline, si spande uniformemente sulla superficie del vetro e scivola via portando con sé le particelle di sporco. A differenza di quanto avviene con i vetri tradizionali, l’acqua si asciuga velocemente e non lascia macchie.
Lezione 24. Sostenibilità e riciclo
Il vetro è il materiale riciclabile per eccellenza, perché mantiene inalterate tutte le sue proprietà anche dopo essere stato sottoposto a numerosissimi trattamenti di riciclo. Per riciclare il vetro è necessario procedere alla fase di raccolta, prestando molta attenzione a non unirlo a vetri contenenti pericolosi elementi tossici, come lampadine, tubi al neon, vetri delle finestre, vetro pirex, vetro con etichetta «T» (tossico) o «F» (infiammabile). Questi ultimi, infatti, devono essere portati presso un’isola ecologica per essere trattati come RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi). Dopo la raccolta differenziata effettuata in ambito domestico e industriale, il vetro segue diverse fasi per il riciclaggio.
RICICLO DEL VETRO

2 Cernita
Ha lo scopo di separare il vetro da ceramica, plastica e altri corpi estranei.
1 Raccolta
Il vetro da riciclare, recuperato con la raccolta porta a porta organizzata dai Comuni, oppure stoccato in appositi contenitori che per la loro forma vengono chiamati campane, viene raccolto da ditte specializzate.
7 Uso e smaltimento
Dopo l’uso, il ciclo ricomincia con una nuova raccolta per un nuovo processo di riciclaggio.
3 Frantumazione


I rottami di vetro vengono frantumati grossolanamente. La massa viene sottoposta a un trattamento di aspirazione per eliminare corpi leggeri come carta, alluminio, legno, e poi all’azione di un’elettrocalamita per eliminare eventuali corpi ferrosi sfuggiti alla cernita.
Aspirazione
Elettrocalamita
4 Macinazione
I rottami di vetro vengono macinati finemente.
5 Fusione
Il materiale già macinato viene mischiato alla materia prima (silice) e fuso per ottenere nuovi prodotti.
Riciclare e utilizzare rottami di vetro per fabbricare nuovi oggetti ha numerosi vantaggi.
• Un minore impatto ambientale: non è infatti necessaria l’estrazione della materia prima (silice e altri minerali) in cave che deturpano il paesaggio.
• La riduzione dei consumi energetici: per la preparazione della materia prima occorre energia, che viene risparmiata se si parte da rottami di vetro; ciò significa che le fasi di lavorazione e trasformazione sono più economiche.
• La diminuzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera: se si utilizza meno energia, si ha una riduzione della quantità di polveri e fumi di combustione emessi nell’aria.
• La riduzione della massa complessiva di rifiuti da smaltire nelle discariche.
• Un minore inquinamento del terreno e delle falde acquifere: bisogna ricordare che il vetro abbandonato nell’ambiente impiega circa 400 anni per decomporsi.
PER PER L’INTERROGAZIONE
1. Come avviene il riciclo del vetro?
2. Quali sono i vantaggi del riciclo del vetro?
3. Quali sono i vetri pericolosi, contenenti elementi tossici?



i contenuti a pagina 19-20 dell’allegato.







Lezione 21 Il vetro
Il vetro è un materiale solido trasparente ottenuto dalla fusione della silice e di altri elementi. È un buon isolante elettrico e termico, è resistente alla compressione e all’abrasione ma è fragile (non sopporta gli urti). Esistono diversi tipi di vetro:
• il vetro comune, largamente impiegato nel settore alimentare grazie alla sua capacità di non alterare gli alimenti;
• il cristallo, che contiene alte percentuali di piombo che conferiscono brillantezza e sonorità tipica ed è usato nei settori industriale e artistico;
• il vetro pirex, resistente agli sbalzi di temperatura e utilizzato per la cottura degli alimenti o per congelare i cibi nel freezer;
• i vetri termoisolanti e di sicurezza, incollati con lastre plastiche per evitare la formazione di schegge in caso di rottura e utilizzati negli edifici.
Lezione 22 La produzione del vetro
La sabbia silicea impiegata per produrre il vetro viene estratta dalle cave. Alla sabbia silicea macinata finemente si aggiungono altre sostanze (stabilizzanti, fondenti) per migliorare la fusione, ottenendo una miscela detta carica. La carica viene portata a una temperatura di 1 300-1 500 °C, ottenendo una massa pastosa
La lavorazione del vetro avviene principalmente con metodi industriali:
• con lo stampaggio si creano oggetti di arredamento;
• con la pressatura-soffiatura in uno stampo, soffiando aria all’interno, si producono bottiglie e oggetti cavi;
• con il float glass si produce il vetro piano, come lastre sottili.
Si procede poi con la finitura del vetro per esaltare determinate caratteristiche o per eliminare alcune imperfezioni (per esempio spianatura, foratura, lucidatura).
Lezione 23 Altri impieghi del vetro
Come in passato, anche oggi la lavorazione artigianale del vetro artistico, praticata da abili artisti, si serve di pinze e canna da soffio per realizzare singoli oggetti d’arte. Il vetro può essere ridotto in sottilissimi fili: l’ammasso di fibre che ne deriva è chiamato lana di vetro e trova impiego in edilizia come materiale isolante.
Una particolare fibra di vetro è la fibra ottica, impiegata nel settore delle telecomunicazioni per trasferire enormi quantità di informazioni.
Lezione 24 Sostenibilità e riciclo
Il vetro è il materiale riciclabile per eccellenza perché può essere riciclato moltissime volte. Viene recuperato con la raccolta differenziata e ridotto in rottami di vetro. I rottami sono poi macinati finemente e miscelati con nuove materie prime; infine vengono fusi per ottenere nuovi oggetti.
ATTIVAZIONE DEI CONTENUTI DIGITALI
Con Realtà Aumentata
1 Scarica, installa e avvia l’app Raffaello Player.
2 Digita il titolo del volume da attivare oppure inquadra la copertina del libro.
3 Attiva il testo digitale con il CODICE DI ATTIVAZIONE che trovi sul retro della copertina del volume (va fatto solo la prima volta).
4 Clicca sull’icona Realtà Aumentata.
5 Inquadra la pagina e scatta una foto.
6 Dal menù «risorse digitali della pagina» seleziona il contenuto che vuoi visionare.

Con QR Code

1 Scarica, installa e avvia un’app in grado di leggere i QR Code.
2 Inquadra un QR Code presente all’interno delle pagine del libro.
3 Attiva il testo digitale con il CODICE DI ATTIVAZIONE che trovi sul retro della copertina del volume (va fatto solo la prima volta).
4 Dal menù «risorse digitali del libro» seleziona il contenuto che vuoi visionare.
Techno pass


Per lo studente
Tecnologia
• Disegno
• Competenze digitali

• Tavole per il disegno
• Domande e risposte per l’interrogazione



• DVD Libro digitale
• Volume semplificato (con CD Audiolibro MP3)
Codici per adozioni e pack vendita (modalità mista di tipo b - cartaceo e digitale)

Per il docente


• Guida per il docente
• DVD Libro digitale docente
• CD Audiolibro MP3
ISBN 978-88-472-3529-8 Tecnologia + Disegno + Tavole + Competenze digitali + Domande e risposte + DVD Libro digitale
30,90
ISBN 978-88-472-3530-4 Tecnologia + Disegno + Competenze digitali + Domande e risposte + DVD Libro digitale € 25,90
ISBN 978-88-472-3531-1
ISBN 978-88-472-3533-5
Tecnologia + Disegno + Tavole + Domande e risposte + DVD Libro digitale € 23,90
ISBN 978-88-472-3532-8 Tecnologia + Disegno + Domande e risposte + DVD Libro digitale € 21,90
Tecnologia + Competenze digitali + Domande e risposte + DVD Libro digitale € 18,90
ISBN 978-88-472-3534-2 Tecnologia + Domande e risposte + DVD Libro digitale € 16,90
ISBN 978-88-472-3501-4 Competenze digitali + DVD Libro digitale € 9,90
ISBN 978-88-472-3538-0 Edizione compatta + Tavole + Competenze digitali + Domande e risposte + DVD Libro digitale
ISBN 978-88-472-3539-7 Edizione compatta + Competenze digitali + Domande e risposte + DVD Libro digitale
ISBN 978-88-472-3540-3 Edizione compatta + Tavole + Domande e risposte + DVD Libro digitale € 22,50
ISBN 978-88-472-3537-3 Edizione compatta + Domande e risposte + DVD Libro digitale
8,90 Configurazioni di vendita
ISBN 978-88-472-3502-1 Volume semplificato + CD Audiolibro MP3
Il corso è disponibile anche nella modalità di tipo c (solo digitale) su www.scuolabook.it
Risorse digitali
Il testo è ricco di contenuti per la lezione in classe e a casa
Alta leggibilità
Alta leggibilità (formato ePub) con testo modificabile
Audiobook
Audiolibro integrale a cura di speaker professionisti
Attivazione delle risorse digitali tramite smartphone o tablet Prezzo di

