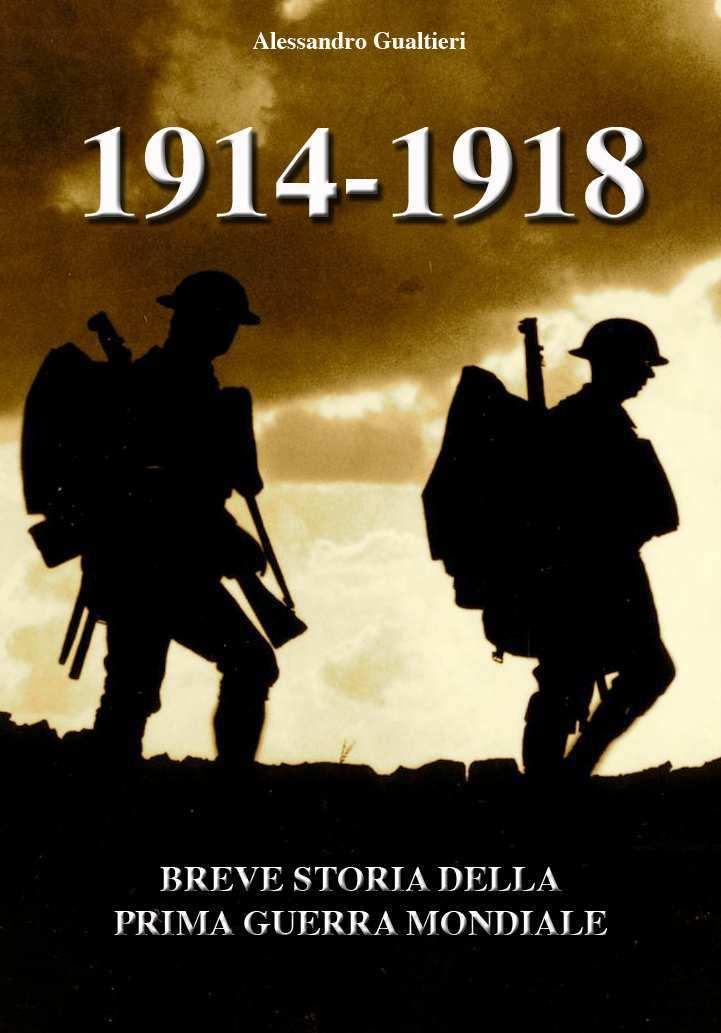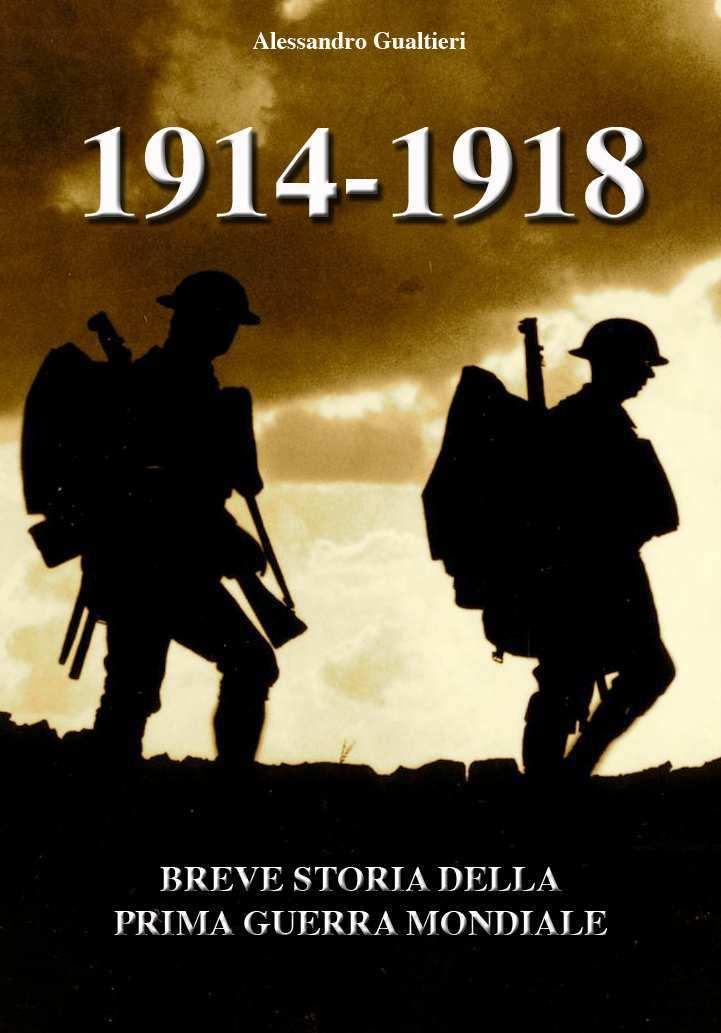
Alessandro Gualtieri 1914-1918 BREVE STORIADELLAPRIMAGUERRA MONDIALE 2
Copyright © 2011 by Alessandro Gualtieri
3
“… hai nascosto queste cose ai dotti e ai savi e le hai rivelate ai piccoli…
… perché così a te piacque.” Luca X-2I
Ho scelto di dare fuoco alle polveri di questo breve proemio con un brano di San Luca. Frase biblica quella dell’evangelista, come biblico è stato l’evento Grande Guerra. Il medico di Antiochia non ha mai conosciuto Cristo di persona, eppure le descrizioni ch’egli riporta sul Vangelo e sugli Atti degli Apostoli sono specifiche e quasi riservate per poterle considerare acquisite da terze persone. evidentemente usava bene le informazioni. Ebbene anche l’autore di questo volume è supportato da una profonda conoscenza della materia, dalla ricercatezza delle fonti, e con quest’opera porta a compimento una esegesi globale di ciò che fu la guerra 1914 – 1918. Cinque anni di ostilità che egli rivisita con originale spirito e doti di preziosa sintesi. Il tutto tradotto, comparato e rivisto col “senno di poi”, come è giusto che sia parlando di moderna archeologia. Come ebbe a dire Andrea Carandini (nell’introduzione a “I detective dell’Archeologia”): “La comparazione è il presupposto di ogni conoscenza e di ogni azione, nel senso che essa ci impone di considerare i fenomeni non per loro stessi, ma in relazione con gli altri fenomeni. Senza la conoscenza degli elementi banali delle grandi pianure della vita quotidiana non coglieremmo né misureremmo le vette degli avvenimenti eccezionali”.
Nel testo, dalla Dichiarazione di Guerra all’Armistizio, tutto sembra mirare al fine didattico di rendere noto, in cui ben si collocano a volte personalissime, a volte conclamate, ragionate conclusioni. Forse è questo l’obiettivo di Gualtieri, scrittore, ricercatore e autore di siti internet tematici: egli vuole divulgare, mettere in relazione l’enorme mole di testi e diari che parlano del conflitto, rendendo con ciò le nozioni alla portata di chiunque desideri sapere chi erano i Kaiserjager austriaci o le SturmTruppen tedesche, gli Alpini italiani e i Tommies di Sua Maestà britannica. Piccole grandi vicende vengono svelate, così come molte curiosità legate all’argomento trattato. Tra
PREFAZIONE
4
le pagine, che si parli di un fucile mod. ‘91 o della filosofia bellica di un secolo fa, l’attenzione del lettore rimane alta: i meriti vanno condivisi tra la bontà degli argomenti trattati ed un linguaggio ben levigato e scorrevole.
Ancora una volta è stato rispettato il testamento del tenente Adolfo Ferrero, caduto sul monte Ortigara. Egli rivolgendosi ai genitori interpretava le aspettative di ogni soldato gettato nella mischia del fronte: timoroso per l’assalto imminente e libero dall’idea di retorici eroismi. “Parlate di me ai miei fratelli – chiedeva l’ufficiale degli Alpini consapevole della fine imminente – parlate di me, morto a 20 anni per la Patria. Sforzatevi di risvegliare in loro il ricordo di me … chè è doloroso il pensiero di venire dimenticato da essi.” Ebbene, Granatieri Sardi del monte Cengio, Alpini del Grappa e dell’Altopiano di Asiago, Fanti del Carso, riposate in pace, perché ci sarà sempre qualcuno che parlerà di voi ai figli dei figli, e poi a quelli che ancora verranno.
Giovanni Dalle Fusine
5
Di vivo interesse per la Prima Guerra Mondiale si può forse parlare solo tra pochi “addetti ai lavori”, gli appassionati, i collezionisti e gli amanti della storia in generale. Purtroppo, la cosiddetta “Grande Guerra”, sembra essere stata dimenticata troppo in fretta e quasi “oscurata” dalla Seconda Guerra Mondiale (trattata, documentata e riproposta a oltranza dai principali Media). Ed è un grave peccato perché la Prima Guerra Mondiale ha gettato, guarda caso, proprio quasi tutte le basi della Seconda, creando i presupposti per la nascita di movimenti politici e vere e proprie “ritorsioni” in grande stile, di cui si parla ancor oggi, ogniqualvolta si tratta la figura delle dittature Italiane e Tedesche che hanno avuto un ruolo predominante dagli anni ‘30 fino al 1945. Per non parlare poi di ciò che i francesi chiamano “Le Tournant Du Siecle”, l’avvento del secolo scorso cioè, che ha assistito ed è stato direttamente interessato da un’infinita serie di sconvolgimenti, innovazioni, scoperte e mutazioni economiche, sociali e politiche catalizzate e apparse subito prima, durante o dopo la cosiddetta Grande Guerra.
Le nostre vie e le nostre piazze, cosi come accade in tutta Europa e anche oltreoceano, sono piene di monumenti e lapidi commemorative ai milioni di caduti di quella che sembra una “guerra dimenticata”. Semplicemente nessuno riesce a discernere, in un particolare architettonico o in una sontuosa facciata di un edificio, un memento deposto a testimonianza d’affetto, rispetto e amore per chi diede tutto per ideali tanto grandi, poco meno di un solo secolo fa. Per questo motivo, dopo aver letto innumerevoli scritti, saggi e trattati sull’argomento, mi sono prefissato, immodestamente, l’obiettivo di risvegliare o, meglio ancora, far nascere l’interesse non solo per accadimenti storici stranamente bistrattati dai media, ma soprattutto per le migliaia e migliaia di giovani vite che vennero così prematuramente e violentemente spezzate per gli stessi ideali di patria, libertà e democrazia che l’umanità insegue da sempre. Da molto tempo, le ricerche e gli sforzi in cui mi prodigo – primi fra tutti il sito Internet “La Grande Guerra 1914-1918” (www.lagrandeguerra.net) e il Centro Studi Informatico “La Grande Guerra” (www.csigrandeguerra.it) - sono ripagati dalla grande soddisfazione di poter contribuire, come dicevo poc’anzi, a non dimenticare tutti i nostri padri
INTRODUZIONE
6
spirituali e i loro immani sacrifici, che videro il mondo intero prima soffrire e subire una terrificante catastrofe, quindi piangere milioni di giovani vite spezzate.
Proprio in quest’ottica, ho deciso di sviluppare una vera e propria sintesi degli avvenimenti e delle principali connotazioni di questo conflitto, piuttosto che costringere il lettore all’immersione totale in un ennesimo, dettagliatissimo e omnicomprensivo trattato. Mi auguro dunque che la mia scelta editoriale, renda decisamente piu’fruibile l’approccio iniziale all’argomento o una sua eventuale, snella rilettura, anche per semplici e immediati riferimento di studio e di ricerca.
7
LE RAGIONI DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE
La Germania desiderava acquisire territori in Russia, temeva la superiorità navale britannica e, soprattutto, si sentiva minacciata e relegata all’isolamento dai Paesi confinanti;
L’Austria-Ungheria, considerandosi un’alleato di minore importanza nei confronti della Germania, nonchè direttamente minacciato dal desiderio di indipendenza delle proprie, molteplici minoranze etniche e dei Paesi confinanti, cercava un rafforzamento economico e diplomatico in Europa.
La Gran Bretagna, in seguito all’apertura del Canale di Kiev, temeva una costante e inarrestabile crescita della Marina militare e commerciale tedesca; inoltre si sentiva seriamente minacciata da una possibile invasione teutonica;
La Francia agognava riconquistare Alsazia e Lorena - perdute e concesse alla Germania nel 1870 - e temeva una crescente egemonia europea tedesca;
L’Italia, alla quale la Triplice Alleanza, stipulata in precedenza con Austria e Germania, risultava decisamente poco proficua - mirava ad acquisire territori austro-ungarici: in particolare, in Dalmazia e nell’Adriatico.
La Serbia cercava uno sbocco sul Mare Adriatico e avrebbe voluto condurre la rivolta delle popolazioni Slave nei Balcani ai danni dell’oppressione imperiale Austriaca;
La Russia condivideva gli interessi della Serbia - al fine di spezzare il giogo imperiale che gravava sulle popolazioni Slave - e temeva le mire espansionistiche pan-europee tedesche;
Nel 1914, nulla poteva evitare un conflitto mondiale. Grazie a un eccezionale sviluppo industriale, quasi tutti i paesi europei possedevano ingenti quantità di armi e flotte militari in costante accrescimento. Francia e Inghilterra cercavano un modo per bloccare l’espansionismo tedesco e la sua inarrestabile egemonia industriale e scientifica. La Francia cercava la
8
rivincita, dopo la clamorosa sconfitta bellica del 1870, e voleva riprendersi l’Alsazia e la Lorena. L’Austria e la Russia credevano di poter risolvere le loro difficoltà attuando una politica estera fortemente aggressiva ed espansionistica.
La crisi del 1914 può dunque essere definita come risultanza militare di una lunga tensione politica tra le grandi potenze europee, che si trascinava da almeno un decennio: una prima crisi risaliva al 1905, in occasione delle iniziative tedesche per arginare l’espansione francese in Marocco; nel febbraio-marzo del 1909, poi, con l’annessione della Bosnia Erzegovina da parte austriaca, si era riaccesa la rivalità austro-russa nei Balcani; nell’agosto del 1911, una nuova crisi marocchina portò a un nuovo confronto diplomatico tra Francia e Germania. Nel 1912-13, infine, ebbero luogo le due Guerre Balcaniche, che misero nuovamente in pericolo la pace tra Russia e Austria. Queste tensioni mantennero in costante stato di allerta le maggiori potenze europee e di conseguenza innescarono una inarrestabile corsa agli armamenti terrestri e navali. Contemporaneamente, il vento nazionalista aveva tenuto sotto pressione l’opinione pubblica alimentando un certo odio tra i vari popoli, sia in virtù del desiderio di onnipotenza della propria nazione, sia sotto forma di rivendicazioni etniche. La propaganda nazionalista, inoltre, aiutò molto i governi a giustificare dinnanzi all’opinione pubblica le ingenti spese per il riarmo e per le spedizioni coloniali. Alla base delle tensioni internazionali vi erano comunque importanti interessi economici e territoriali per il controllo degli scambi internazionali, direttamente in relazione con le reiterate crisi economiche avvenute tra il 1907 e il 1914.
Da parecchi anni, i vertici militari francesi e tedeschi si stavano preparando a una guerra che consideravano inevitabile. La Francia aveva irrobustito il confine con la Germania, mentre quest’ultima aveva pronto il “Piano Schlieffen”, per un attacco fulmineo che le permettesse di raggiungere Parigi in poco tempo - così come era già successo nel 1870 (durante la Guerra Franco-Prussiana). Appena dichiarata la guerra e iniziata la mobilitazione, il grosso delle truppe francesi venne dunque ammassato lungo il confine tedesco.
La mobilitazione delle forze russe si svolgeva, al contrario, molto lentamente per la scarsezza di mezzi di trasporto e l’insufficienza di vie di collegamento (strade e ferrovie). La Germania allora, pensò di concentrare tutte le sue forze
9
contro la Francia, di annichilire rapidamente quest’ultima e quindi rivolgersi contro l’impero russo sul fronte orientale. Per poter attuare questo piano di “blitzkrieg” la Germania doveva evitare a ogni costo le possenti fortificazioni francesi costruite sul confine: perciò si decise di invadere il Belgio, rimasto neutrale, per prendere alle spalle le truppe francesi. I tedeschi, dopo un mese di durissimi scontri, si spinsero fino a quaranta chilometri da Parigi, ma sul fiume Marna vennero fermati e respinti al termine di una battaglia di inaudita violenza. Dopo l’episodio della Marna, le truppe tedesche e francobritanniche si dovettero fronteggiare lungo una linea che andava dal canale della Manica fino alla Svizzera. La guerra di movimento si trasformò dunque in guerra di posizione. I soldati furono costretti a vivere dentro chilometri e chilometri di anguste trincee, nella sporcizia e sotto le intemperie, su un fronte divenuto pressochè immobile. Aquesto punto, l’imprevista guerra di posizione fece svanire l’illusione della guerra lampo di qualche mese prima. Questo accadde perché, rintanandosi nelle trincee e attendendo l’assalto del nemico, il difensore si ritrovò quasi sempre avvantaggiato sull’attaccante. Gli assalti, infatti, venivano impostati e concretizzati dai soli fanti armati di fucile e baionetta, che si scagliavano contro postazione avversarie ben guarnite, defilate, protette e quasi sempre dotate di letali mitragliatrici.
Gli stati europei si buttarono a capofitto nell’avventura bellica sottovalutandone tragicamente i costi economici ed umani. Affrontarono con estrema leggerezza un conflitto di tali proporzioni poiché erano certi di una guerra breve, analoga a quelle dell’800. Inoltre, erano fermamente convinti che la potenza delle nuove armi a loro disposizione avrebbe ulteriormente accelerato l’esito del conflitto. Un altro grave errore fu quello di credere che la supremazia militare in Europa avrebbe facilitato anche il dominio assoluto sul mondo intero, ma questa considerazione non tenne conto della nascita di due nuove superpotenze: gli USAe il Giappone, che uscirono fortemente rafforzate dalla Prima Guerra Mondiale, mentre l’Europa ne risultò gravemente indebolita, sia per le perdite umane che per i costi economici.
Le quattro principali cause dell’azzardata entrata in guerra del nostro Paese, al fianco delle forze dell’Intesa (Francia, Russia, Inghilterra e altri alleati minori), possono essere identificate in: a) desiderio di grandezza, b) rischio
10
di una crisi politica, c) errate valutazioni sull’importanza dell’impegno bellico, d) avidità di “facili espansioni territoriali”.
Il nostro Paese infatti, non voleva di certo entrare in guerra a fianco degli Austriaci, così come la Triplice Alleanza avrebbe previsto. In Italia predominava la corrente neutralista, ma un’arrabbiata minoranza interventista era assolutamente dell’avviso di cambiare addirittura alleanza e di schierarsi contro l’Austria. La stampa interventista, dal “Corriere della sera” all’”Idea nazionale”, si adoperava senza tregua per convincere l’opinione pubblica che, restando neutrale, il nostro Paese non sarebbe mai diventato una “grande potenza”. L’interventismo proponeva l’annessione delle terre cosiddette “irredente”, considerate italiane, ma ancora in mano straniera, quali il Trentino, la Venezia Tridentina, la Venezia Giulia, Istria, Fiume, Dalmazia, Nizza, Canton Ticino, Corsica e Malta. I territori considerati irredenti erano definiti tali in modo arbitrario: a volte si considerava il criterio etnico, ossia la presenza di italofoni, altre volte quello geografico, appartenenza ai confini naturali, altre ancora a quello storico, appartenenza del territorio, in passato, ad uno degli antichi stati italiani. I cattolici e buona parte dei socialisti si professavano dichiaratamente pacifisti e neutralisti. Giolitti, che da poco aveva lasciato la presidenza del consiglio, si era impegnato ufficialmente per cercare di garantire la neutralità italiana. Il famoso statista era convinto che gran parte del territorio italiano ancora occupato dall’Austria (“parecchio”, come lui stesso lo definì) potesse essere ottenuto con la diplomazia e non con la violenza. Di contro, il Ministro degli Esteri, Sidney Sonnino, e molti altri con lui, intendeva approfittare della guerra proprio per “spazzare via il parlamentarismo giolittiano”. Quest’ultimo era considerato una pratica di governo troppo trasformista, dedita a frequenti compromessi con il partito socialista dell’epoca e a una diretta manipolazione elettorale, che affidava i risultati delle urne alle intimidazioni dei prefetti e dei potentati locali. Una specie di prova generale di dittatura segreta. Giolitti, da parte sua, avrebbe di certo voluto sbarazzarsi dei membri di quel Governo interventista a lui tanto indigesto. Se, con i deputati a lui fedeli, Giolitti avesse continuato a opporsi all’intervento, l’Italia sarebbe andata incontro a una crisi istituzionale di proporzioni enormi e lui stesso ne sarebbe stato travolto. Appiattendosi sulle posizioni dei socialisti neutralisti e del Vaticano, non avrebbe più avuto davanti a sé una qualsiasi prospettiva di rinnovamento costituzionale e liberale.
11
Luigi Cadorna, capo del nostro tremebondo e antiquato esercito, riteneva le armi a sua disposizione sufficienti a capovolgere il rapporto di forza tra le parti belligeranti – nel dicembre 1914 egli osservava che: “La bilancia è oggi oscillante e piuttosto a sfavore degli Imperi centrali. Se un altro esercito viene gettato sul piatto avverso, dovrebbe traboccare”.
Infine, anche dall’estero non mancavano pressioni e il comportamento italiano non brillò certamente nell’ambito delle stesse rivendicazioni territoriali, avanzate prima con Austria e Germania, promettendo in cambio un rientro nella Triplice Alleanza, poi nei confronti dell’Intesa, quando il nostro governo non riuscì ad accontentarsi delle terre ebdelle ricompense economiche promesse dall’Austria stessa, in cambio della nostra neutralità! Dopo un lungo e tortuoso mercanteggiare, a Londra, nell’aprile del 1915, il governo italiano firmò un patto segreto con cui si impegnava a schierarsi in guerra al fianco di Francia, Russia e Inghilterra. Anche se il re si dichiarava a favore della guerra, il Parlamento, ancora contrario, fu in pratica costretto ad approvare il suddetto patto. Il 24 maggio 1915 anche l’Italia entrò in guerra a fianco dell’Intesa.
Degno di particolare menzione è il fatto che, al contrario di quanto recita il più famoso inno patriottico di quei tempi (peraltro scritto sul finire della guerra) - “La Canzone del Piave” - nel maggio 1915, l’Italia non subì alcuna invasione da parte degli Austro-Ungarici, ma cercò subito di violare i confini nord-orientali, nella speranza di raggiungere e conquistare con le armi Trento e Trieste “irredente”.
La Prima Guerra Mondiale vide impegnate ben ventotto nazioni. A contrapporsi, in quello che divenne il Primo Conflitto Mondiale, furono due grandi schieramenti: le Potenze Alleate, spesso identificate come “L’Intesa”, che comprendevano anche Gran Bretagna, Francia, Russia, Italia e Stati Uniti, e gli Imperi Centrali, Germania, Austria-Ungheria, Turchia e Bulgaria.
È bene inoltre ricordare che molte altre nazioni, allora appartenenti ai domini coloniali delle principali potenze europee, fornirono il proprio contingente militare in supporto dei rispettivi alleati e/o furono loro stesse teatro di scontri, perlopiù innescati per alleggerire e sbloccare la guerra di posizione sui due fronti principali pan-europei.
Imperi Centrali:
12
Tedesco, Austro-ungarico, Ottomano, Bulgaria, Libia
Potenze Alleate o “Intesa”
Francia, Gran Bretagna, Belgio, Portogallo, Russia, Romania, Serbia, Grecia, Italia, Giappone, Cina, Montenegro, Usa, Brasile, Perù, Bolivia, Panama, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Honduras, Equador, Liberia, San Marino.
13
CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI
AVVENIMENTI DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE
Cronologia del 1914
Il 28 giugno del 1914, il principe ereditario Francesco Ferdinando d’AustriaUngheria e la sua consorte venivano assassinati a Sarajevo, per mano di un gruppo anarchico-terrorista pro-Serbo. L’omicidio ebbe subito dei risvolti politici inaspettati e in breve le cose precipitarono esponenzialmente. Lo sgomento dell’Imperatore Asburgico Francesco Giuseppe, si trasformò in utile espediente al fine di permettere all’Austria-Ungheria di coronare il sogno di estendere il suo Impero nei Balcani. L’ultimatum del 23 luglio alla Serbia non fu altro che l’ennesimo escamotage da parte dell’Austria-Ungheria per giustificare la propria buona fede di fronte alle diplomazie europee. Il governo austro-ungarico infatti, accusava la Serbia di una complicità indiretta nell’organizzazione dell’attentato, poiché l’arma usata dall’omicida era risultata di fabbricazione nazionale (arsenale di Belgrado). Come garanzia, si chiedeva che alle relative indagini partecipassero anche le autorità austriache. In caso contrario, il Governo serbo sarebbe stato ritenuto complice e di conseguenza l’Austria avrebbe considerato l’attentato come un atto di ostilità nei suoi confronti. L’ultimatum aveva messo in guardia la Russia, che aveva prontamente schierato le proprie truppe sul confine con la Carinzia, minacciando di intervenire in caso di aggressione alla Serbia.
Trascorsa appena una settimana, il 29 luglio, giungeva puntuale la dichiarazione di guerra alla Serbia che faceva precipitare il mondo nel terrore. Il 30 luglio, i primi proiettili di artiglieria colpivano la capitale Serba. Alla notizia del bombardamento, la Russia dichiarò la mobilitazione parziale contro l’Austria. Da quel momento, tutti gli Stati Maggiori europei iniziarono i loro preparativi per la guerra. I tedeschi, per primi, avevano proclamato il “Kriegsgefahrzustand” (stato di pericolo di guerra). Si trattò, in realtà, di una sorta di paravento diplomatico che durò solo due giorni.
Il 31 luglio, di fatti, la stessa Germania inviava un ultimatum alla Russia per
14
costringerla a sospendere i provvedimenti militari contro l’Austria e intimava alla Francia di non intervenire in caso di conflitto russo-tedesco. Allo scontato “niet” dello zar, la Germania opponeva, il 1° agosto, la sua dichiarazione di guerra - il giorno dopo, chiedeva al governo belga il libero passaggio delle proprie truppe in caso di guerra contro la Francia; il 3 di agosto dichiarava guerra anche a quest’ultima. Anulla erano servite le precauzioni di Parigi, che aveva fatto ripiegare di dieci chilometri i propri soldati dalla frontiera, per evitare incidenti e così dare adito alla Germania per farsi una ragione sulla guerra. La possibilità di evitare il conflitto era stata auspicata dai francesi fino all’ultimo. Alla violazione della neutralità belga da parte dei tedeschi, la Gran Bretagna scioglieva anch’essa ogni riserva ed entrava in guerra a fianco dei francesi. L’Italia rimaneva temporaneamente neutrale.
28 GIUGNO:
Assassinio a Sarajevo dell’arciduca Francesco Ferdinando e della consorte Sofia; 23 LUGLIO: Ultimatum austro-ungarico alla Serbia;
15
28 LUGLIO:
L’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia;
1 AGOSTO:
La Germania dichiara guerra alla Russia;
2 AGOSTO: Dichiarazione di neutralità dell’Italia;
3 AGOSTO:
La Germania dichiara guerra alla Francia e invade il Belgio, attuando il piano Schlieffen;
4 AGOSTO: L’Inghilterra dichiara guerra alla Germania;
5 AGOSTO:
L’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Russia, il Montenegro all’AustriaUngheria;
6 AGOSTO: La Serbia dichiara guerra alla Germania;
12 AGOSTO:
L’Inghilterra e la Francia dichiarano guerra all’impero Austro-ungarico;
23 AGOSTO:
Il Giappone entra in guerra al fianco dell’Intesa;
16
26-30 AGOSTO:
La Germania, sotto la guida di Hindenburg e Ludendorff, travolge le armate Russe a Tannemberg; 9-15 SETTEMBRE: Nuova vittoria tedesca sui russi nella zona dei laghi Masuri; 3-13 SETTEMBRE: Battaglia della Marna, rimozione del Generale Helmuth Johann Ludwig von Moltke, sostituito dal Generale Erich von Falkenhayn; 8-12 SETTEMBRE:
Le armate russe, dopo aver sconfitto a Leopoli gli austro-ungarici, dilagano in Galizia; 29 OTTOBRE:
Gli ottomani, legati agli imperi centrali, attaccano la Russia; 2-3 NOVEMBRE: Le forze dell’Intesa dichiarano guerra alla Turchia; 6 NOVEMBRE:
Gli austro-ungarici entrano a Belgrado.
17
Cronologia del 1915
La strategia di Joseph Joffre, comandante il capo delle forze francesi, era molto chiara. L’intenzione era quella di cacciare i tedeschi dal suolo patrio, dopo aver stretto la morsa intorno al saliente di Noyon. L’attacco doveva essere condotto da due lati: Artois e Champagne. Joffre non prevedeva di sfondare in tempi brevi: “rosicchiando” la linea tedesca, sperava di logorare il nemico fino a far crollare il fronte. Questa azione di logoramento fu attuata per quasi tutto il 1915. Gli inglesi si adeguarono alla strategia francese pur avendo un esercito numericamente più piccolo. Così, con l’eccezione dell’offensiva tedesca a Ypres in aprile, la guerra sul fronte occidentale nel 1915 fu una serie di scontri destinati esclusivamente a indebolire le linee tedesche. Sulla carta la strategia di Joffre era valida; il comandante francese aveva tutte le ragioni di credere che la guerra di trincea non sarebbe durata a lungo. L’offensiva fu ripresa nella Champagne nel febbraio 1915. I successi, tuttavia, si misuravano esclusivamente in metri di terreno strappato agli avversari e le perdite francesi salirono a circa 240.000 uomini. Questo era lo scenario militare di quell’anno: battaglie costose in termini di vite umane, limitate avanzate e poche possibilità di sfondamento.
22 APRILE:
AYpres, sul fronte occidentale, i tedeschi utilizzano, per la prima volta, i gas asfissianti;
25 APRILE:
Fallimentare sbarco a Gallipoli delle forze dell’Intesa;
26 APRILE:
La delegazione italiana firma il patto di Londra, che prevede, in cambio di alcuni territori, l’entrata in guerra del nostro Paese al fianco dell’Intesa;
2 MAGGIO: 18
Gorlice-Tarnow gli Imperi Centrali travolgono le armate zariste;
7 MAGGIO:
I sottomarini tedeschi affondano il transatlantico inglese Lusitania. La Germania sospende la guerra sottomarina indiscriminata, temendo l’ingresso in guerra degli Stati Uniti, che avevano protestato per la morte dei cittadini americani che si trovavano a bordo.
23 MAGGIO: L’Italia dichiara guerra all’Austria;
24 MAGGIO:
Le truppe italiane si attestano sulla linea del fronte;
23 GIUGNO-7 LUGLIO:
Prima battaglia dell’Isonzo. Ne seguiranno altre undici;
A
19
18 LUGLIO-3 AGOSTO: Seconda battaglia dell’Isonzo;
21 AGOSTO: L’Italia dichiara guerra all’Impero Ottomano; 5 OTTOBRE: Reparti dell’Intesa sbarcano a Salonicco al fine di aiutare l’esercito Serbo. La Bulgaria si schiera con gli Imperi Centrali; 18 OTTOBRE-4 NOVEMBRE: Terza battaglia dell’Isonzo; 10 NOVEMBRE-2 DICEMBRE: Quarta battaglia dell’Isonzo; 10 DICEMBRE: Sgombero di Gallipoli; lo stato maggiore britannico sostituisce il Generale Sir John French con il Generale Douglas Haig.
20
del 1916
La guerra di trincea aveva creato fronti di guerra lunghi migliaia di chilometri, che occupavano centinaia di migliaia di combattenti. Ogni stato belligerante fu costretto ad adottare l’arruolamento obbligatorio. Milioni di donne furono impiegate nelle fabbriche - addette alla produzione di materiale militare - nei campi e ovunque si dovessero ricoprire ruoli, posizioni ed incarichi lasciati vacanti dagli uomini radunati al fronte. Le due grandi e sanguinosissime campagne combattute in Francia nella zona di Verdun e sulla Somme non servirono a far avanzare di un solo metro le linee dei belligeranti. Avvenne il terrificante esordio di nuove armi, peraltro ancora non decisive per gli esiti della guerra: gli aerei, i carri armati, i gas e i lanciafiamme. Gli aerei, in particolare, combatterono inizialmente tra di loro, mitragliando casualmente le trincee e ancor più raramente bombardando i centri urbani. Dopo l’unica grande battaglia navale della Prima Guerra Mondiale, quella dello Jutland, i tedeschi combatterono la guerra sui mari con l’esclusivo impiego dei sottomarini e con le navi “corsare”. Vittime dei sottomarini furono soprattutto i navigli di rifornimenti provenienti dagli USA e destinati alle forze dell’Intesa. Questo sarà uno dei motivi che, alla lunga, contribuirà all’intervento degli Stati Uniti in guerra.
9 GENNAIO:
Definitiva evacuazione di Gallipoli e dei Dardanelli;
21 FEBBRAIO: Comincia la battaglia di Verdun; 11-19 MARZO: Quinta battaglia dell’Isonzo;
15 MAGGIO:
Gli austriaci lanciano la Strafe Expedition, sul fronte italiano del Trentino. La spedizione, voluta per punire l’alleato traditore, sfonda il fronte ad Asiago, costringendo il nostro esercito a una disperata, ma efficace resistenza;
Cronologia
21
31 MAGGIO: Battaglia navale dello Jutland tra le flotte inglese e tedesca;
5 GIUGNO: I russi lanciano un potente e vittorioso attacco contro gli austro-ungarici; 16 GIUGNO: Vittoriosa controffensiva italiana sul fronte del Trentino;
1 LUGLIO: Battaglia della Somme; 4-8 AGOSTO: Sesta battaglia dell’Isonzo, che conduce alla conquista di Gorizia;
28 AGOSTO: L’Italia dichiara guerra alla Germania. La Romania si schiera al fianco dell’Intesa;
29 AGOSTO: Il Generale tedesco Erich von Falkenhayn, all’indomani del fallimento della grande offensiva a Verdun, viene sostituito dal Generale Paul von Hindenburg, alla guida dello stato maggiore.
14-17 SETTEMBRE: Settima battaglia dell’Isonzo;
22
16 SETTEMBRE:
Sul fronte delle Somme fanno la loro comparsa i primi carri armati, sviluppati dall’esercito britannico; 9-12 OTTOBRE: Ottava battaglia dell’Isonzo; 31 OTTOBRE-1 NOVEMBRE: Nona battaglia dell’Isonzo; 22 NOVEMBRE: Muore Francesco Giuseppe, imperatore d’Austria-Ungheria; gli succede Carlo I; 6 DICEMBRE:
La Romania viene travolta dai tedeschi che occupano Bucarest. David Lloyd Gorge diviene primo ministro inglese;
13 DICEMBRE:
In Francia, il Generale Robert Nivelle sostituisce il Generale Joseph Joffre nella carica di comandante dell’esercito.
23
Nel 1917, l’inutile strage era ormai sotto gli occhi di tutti e non si intravedevano sbocchi. Nulla riusciva a giustificare tanti massacri e indicibili, crescenti sofferenze. Papa Benedetto XV continuava a lanciare appelli per la pace e per far finire la guerra, definita una “vergogna dell’umanità intera”. La popolazione europea soffriva la fame e osservava attonita le migliaia di profughi, feriti, mutilati e caduti, il cui sacrificio non era valso a nessuno scopo. Mancavano i contadini nei campi e gli operai nelle fabbriche - le donne, i vecchi e i bambini dovevano occuparsi di tutto. Al malcontento dei familiari dei soldati si univa il morale bassissimo di questi ultimi, che trascorrevano il tempo nell’attesa di ennesimi, massacranti assalti che non portavano a nessun concreto risultato. Numerose furono le defezioni e gli episodi di automutilazione e di ammutinamento; inoltre, molti giovani richiamati si resero colpevoli di renitenza alla leva. L’estrema rigidità delle corti marziali e delle numerosi fucilazioni sul campo contribuirono a fiaccare ulteriormente lo spirito combattivo di tutti gli eserciti schierati.
In Russia, nella primavera del 1917, scoppiarono diverse rivolte che costrinsero lo Zar Nicola II all’abdicazione. L’esercito stanco e sfiduciato si sfaldava, i soldati tornavano a casa in massa. Verso fine anno, il partito bolscevico di Lenin prese il potere e Lenin firmò l’armistizio di Brest-Litovsk e quindi il trattato di pace con la Germania. La Russia usciva così dal conflitto perdendo Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia. Il ritiro della Russia sembrava aver dato un duro colpo alle speranze di vittoria del fronte anglo-francese-italiano.
Germania e Austria riversarono contro il fronte francese e quello italiano le truppe rese libere dal disimpegno della Russia. Aquesto punto, avvenne l’ingresso decisivo nel conflitto degli Stati Uniti d’America. Gli Americani erano rimasti molto colpiti dagli affondamenti delle navi civili, operate dai tedeschi e in particolare dall’affondamento del transatlantico Lusitania, che aveva provocato la morte di ben 124 cittadini americani. Nel mese di aprile del 1917, il governo USAdichiarò guerra alla Germania: ciò comportò l’arrivo in Europa non solo di truppe fresche, ma di viveri, materiali e ingenti prestiti finanziari. L’esercito italiano era logorato dopo ben dodici inutili assalti sul fiume Isonzo. Il comando Austriaco scagliò contro gli Italiani le truppe che tornavano dal fronte orientale. L’attacco sfondò lo schieramento
Cronologia del 1917
24
italiano a Caporetto tra il 24 e il 30 ottobre 1917. Tutto il fronte italiano dovette ritirarsi per evitare che parte delle truppe rimanessero accerchiate o isolate. Tale ritirata, mai programmata dai vertici militari italiani, si trasformò immediatamente in una disfatta. Furono perse intere divisioni e una quantità ingente di materiali. Migliaia furono i profughi civili costretti ad abbandonare le loro case. Fortunatamente, quando tutto sembrava perduto, il nostro Paese seppe reagire con fermezza. Il Generale Armando Diaz sostituì il Generale Luigi Cadorna e a Roma fu costituito un Governo di Solidarietà Nazionale, presieduto da Vittorio Emanuele Orlando. L’esercito fu riorganizzato rapidamente, l’avanzata austriaca fu bloccata sul Piave, sull’altipiano Asiago e sul Monte Grappa. Ormai per l’Austria e la Germania non c’erano più speranze di proseguire il conflitto vittoriosamente.
1
FEBBRAIO:
La Germania dichiara la guerra sottomarina indiscriminata;
3 FEBBRAIO: Gli Stati Uniti rompono le relazioni diplomatiche con il reich di Guglielmo II;
3 MARZO: Il Generale Arz Arthur von Straussenburg sostituisce il Generale Conrad von Hotzendorff alla guida dello stato maggiore austriaco;
8 MARZO:
In Russia comincia la rivoluzione;
15 MARZO:
Lo zar Nicola II è costretto ad abdicare;
25
2 APRILE:
Gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania;
12 APRILE-6 GIUGNO: Decima battaglia dell’Isonzo; 16 APRILE: Battaglia dello Chemin des Dames sul fronte occidentale; 29 APRILE: Il Generale Philippe Petain diviene capo di stato maggiore francese, al posto del Generale Robert Nivelle; 26 GIUGNO: Sbarco in Francia del primo contingente americano;
1 LUGLIO: Offensiva russa guidata dal Generale Aleksej Brusilov;
19 LUGLIO: Gli Imperi Centrali contrattaccano le armate russe che iniziano a sfaldarsi;
1 AGOSTO: Papa Benedetto XV lancia un appello per fermare “l’inutile strage”;
18 AGOSTO-12 SETTEMBRE: Undicesima battaglia dell’Isonzo;
26
24 OTTOBRE:
Un poderoso attacco austro-tedesco sfonda il fronte italiano a Caporetto;
6 NOVEMBRE:
I bolscevichi di Lenin conquistano il potere;
9 NOVEMBRE:
Il Generale Armando Diaz sostituisce il Generale Luigi Cadorna, alla guida dell’esercito Italiano;
7 DICEMBRE:
Gli Stati Uniti dichiarano guerra all’impero Austro-ungarico;
10 DICEMBRE:
MAS italiani, guidati da Luigi Rizzo, affondano la corazzata austriaca Wien;
15 DICEMBRE:
ABrest-Litovsk, Russia e Germania firmano l’armistizio.
27
Cronologia del 1918
Dal punto di vista esclusivamente militare, le cose per Austria e Germania non andavano male: le truppe austriache avevano raggiunto il Piave, la Russia si era ritirata con gravi perdete territoriali, il fronte occidentale era pressoché immobile. Ma dal punto di vista delle risorse, entrambe le nazioni non ce la facevano più: le campagne erano state abbandonate, le materie prime si erano praticamente esaurite, il razionamento alimentare gravava anche sulle truppe. Senza viveri e rifornimenti, Austriaci e Tedeschi furono costretti ad arrendersi. Nella primavera del 1918, gli Imperi Centrali fecero un ultimo, disperato tentativo di rovesciare il corso del conflitto. In Francia, l’esercito tedesco si spinse nuovamente fino alla Marna, ma fu definitivamente bloccato e ricacciato indietro, anche grazie al contingente militare USA, da poco sbarcato in Europa. L’esercito Italiano, con estremo coraggio e abnegazione, respinse le ultime offensive austriache e colse la vittoria decisiva nei pressi della cittadina di Vittorio Veneto. Gli italiani avanzarono finalmente alla volta di Trento e a Trieste, dove entrarono il 3 novembre. Il 4 Novembre, fu firmato l’armistizio con l’Austria. Il giorno 11 dello stesso mese la Germania, stremata, chiese la pace. L’imperatore tedesco e quello austriaco furono costretti ad abdicare.
3 GENNAIO: Il presidente americano Wilson enuncia i suoi “14 punti” per il mantenimento della pace mondiale;
3 MARZO: Trattato di pace di Brest-Litovsk tra Russia e Germania;
21 MARZO: Offensiva tedesca sulle Somme;
26 MARZO: Nomina del generale Foch a comandante supremo delle forze alleate;
28
8 MAGGIO:
Trattato di pace tra Intesa e Romania;
10 GIUGNO:
Luigi Rizzo, alla testa di due MAS, affonda la corazzata austriaca Santo Stefano; 15-23 GIUGNO: Battaglia del Piave: gli austro-tedeschi battono in ritirata;
16 LUGLIO:
Lo Zar Nicola II viene ucciso, insieme a tutta la famiglia, a Ekaterinburg;
29
15-26 LUGLIO: Seconda battaglia della Marna: i tedeschi vengono fermati;
8 AGOSTO: Inizia la battaglia di Amiens: il fronte tedesco viene sfondato; 9 AGOSTO: Volo di Gabriele D’Annunzio su Vienna, durtante il quale vengono lanciati manifesti tricolori di propaganda; 12 SETTEMBRE: Vittoria alleata a St. Mihiel; 29 SETTEMBRE: La Bulgaria si arrende; 24 OTTOBRE: Gli italiani trionfano a Vittorio Veneto; 30-31 OTTOBRE: La Turchia firma l’armistizio; 3 NOVEMBRE: Truppe italiane entrano a Trento e a Trieste; 4 NOVEMBRE: Armistizio, a Villa Giusti, tra Italia e Austria;
30
Il Kaiser Guglielmo II abdica;
11 NOVEMBRE:
Armistizio tra Intesa e Germania - è anche la fine del glorioso impero Austroungarico; GENNAIO 1919: Si apre la conferenza di pace di Versailles.
9 NOVEMBRE:
31
FRONTI DELLA
PRIMA GUERRA MONDIALE
Il Fronte Occidentale
Nel 1914, l’esercito tedesco aprì il fronte occidentale invadendo il Lussemburgo e il Belgio, poi controllando importanti zone industriali in Francia. L’invasione cambiò drammaticamente direzione con la battaglia della Marna. Le due parti si dovettero trincerare allora lungo una imponente linea di fortificazioni, che si estendeva dal mare del Nord fino alla frontiera con la Svizzera. Questa linea rimase pressochè invariata per la maggior parte della Grande Guerra.
Fra il 1915 e il 1917, su questo fronte si combatterono moltissime importanti offensive. Uno smodato e impressionante impiego di bombardamenti preparatori e ingenti quantità di fanteria concretizzarono appieno il concetto di “Guerra di Materiali”, nel tentativo di riprendere il conflitto di movimento con scontri frontali di inaudite e terrificanti proporzioni. Tuttavia, la combinazione di trinceramenti, nidi di mitragliatrici, filo spinato e altre difese, causò ripetutamente devastanti perdite agli attaccanti, senza offrire alcun successo degno di menzione. Per superare lo stallo, si introdussero nuovi strumenti d’offesa, tra cui le armi chimiche e i carri armati. Ma la situazione migliorò sensibilmente solo dopo l’adozione di tattiche migliori e l’arrivo dell’esercito statunitense in Europa. L’inesorabile avanzata delle armate alleate, iniziata nel 1918, rese palese ai tedeschi che la sconfitta era ormai inevitabile: il loro governo fu dunque indotto ad assoggettarsi alle pesantissime condizioni di resa che gli alleati dell’Intesa avrebbero dettato a Versailles. Il Fronte Orientale
I PRINCIPALI
32
fronte orientale era localizzato in Europa centrale e orientale. In seguito a pressanti richieste di aiuto dei francesi, raccolti a difesa di Parigi, i russi decisero di attaccare, a fine agosto del 1914, lungo il confine con la Germania e l’Austria-Ungheria. Il piano del granduca Nicola, zio dello zar Nicola II e comandante in capo dell’esercito russo, era quello di occupare la Prussia orientale e le fortezze tedesche di Thorn, Posen e Breslavia, per poi avanzare su Berlino. Tra il 17 e il 22 agosto 1914, due armate russe, al comando dei Generali von Rennenkampf e Samsonov, attaccarono la Prussia orientale, inducendo il comandante tedesco von Prittwitz a ripiegare dietro la Vistola. Prittwitz, a causa della sua scarsa combattività venne sostituito al comando dai Generali Hindenburg e Ludendorff, i quali elaborarono un ambizioso piano per fermare l’avanzata russa, attirando i russi in una trappola. Il 26 agosto, iniziò la Battaglia di Tannenberg: le truppe russe furono accerchiate e sconfitte. In seguito subirono un’altra disfatta nella Battaglia dei Laghi Masuri e furono respinte oltre la frontiera: Berlino era salva. Tuttavia, i russi si rivalsero contro gli austriaci a Leopoli, riequilibrando le sorti del conflitto. Dopo lo stallo dell’inverno 1914-1915, lo Stato Maggiore austriaco scatenò, con gli alleati tedeschi, l’offensiva in Galizia del maggio 1915; il successo fu clamoroso e l’offensiva terminò il 14 maggio con la riconqusita della Galizia e una situazione strategica fortemente favorevole agli Imperi Centrali. Nel 1916, il Generale Aleksej Brusilov lanciò un’offensiva che portò l’esercito russo a riconquistare la zona persa in precedenza. Tuttavia, la conquista tedesca della Polonia e l’atmosfera rivoluzionaria che iniziava a crearsi in Russia vanificarono questo risultato. Nel marzo 1917, scoppiò la rivoluzione di febbraio a San Pietroburgo – ciò costrinse ad abdicare lo Zar Nicola II, mentre il fronte si era ormai stabilizzato su una linea che andava dalla Lettonia al confine austriaco. Il nuovo governo russo, presieduto da Alexander Kerenskij, cercò ancora una volta di riprendersi la Galizia con le armi: disastroso fu il risultato e nell’ottobre 1917 scoppiò la Rivoluzione d’Ottobre. Il nuovo governo bolscevico, presieduto da Lenin, firmò il trattato di Brest-Litovsk il 3 marzo 1918: la Russia uscì definitivamente dal conflitto. Le ostilità sul fronte orientale cessarono per sempre.
Il
33
Le operazioni militari in Medio Oriente si svolsero in Mesopotamia, Palestina e Arabia, dove, nel giugno del 1916, scoppiò un’insurrezione contro il dominio ottomano, con l’appoggio degli inglesi. Per fomentare ulteriormente la rivolta araba, le forze britanniche in Egitto (l’E.E.F. – Egyptian Expeditionary Force) avanzarono verso la penisola del Sinai e la Palestina, conquistando alcune importanti roccaforti nei primi giorni del 1917. Nello stesso anno, l’impero turco venne sconfitto; ma gli arabi non ottennero l’indipendenza sperata, pur avendo combattuto con efficacia al fianco delle truppe inglesi e del colonnello T.E.Lawrence (il famoso “Lawrence d’Arabia”). Il principe Feisal, secondo figlio dello sceriffo Hussein, partecipò col colonnello inglese alla conferenza di pace di Parigi nel 1919, senza ottenere nulla di ciò che era stato promesso.
Il Fronte Italo-Austriaco
Il fronte italo-austriaco, durante la Prima Guerra Mondiale, era come una grande “S” rovesciata su un fianco; là dove l’ansa affonda in territorio italiano (nel Trentino), il Generale Luigi Cadorna dovette assumere ben presto atteggiamento difensivo; viceversa, dove l’ansa si protende verso nord (Isonzo e Carso) fu concentrato il maggior sforzo bellico. Proprio su quest’ultimo tratto del fronte si concretizzò la tattica cadorniana delle “spallate”: una serie di offensive – prive di alcun tipo di sinergia - intese a mettere gli Austro-Ungarici con le spalle al muro, in una guerra di materiali e di attrito. Un disegno strategico, di più ampio respiro e concezione, era infatti alieno al concetto all’impostazione stessa della guerra di trincea, anche su tutti gli altri fronti internazionali. Inseguendo le chimere della manovra di accerchiamento, dello sfondamento del fronte e della “corsa” inarrestabile verso Trieste e, addirittura, Vienna, gli attaccanti si trovarono sempre di fronte a molteplici e aspri rilievi, sui quali il
Il Fronte Mediorientale
34
nemico se ne stava ben trincerato e difeso, anche con forze notevolmente inferiori. Una situazione analoga a quella del terribile bastione rappresentato dal Carso. L’unico risultato di queste inumane carneficine, fu solo la conquista di pochissimi chilometri quadrati di territorio desolato e inospitale, di cui l’Italia poteva fare a meno e che resero sempre più difficile il mantenimento e la difesa delle prime linee, pericolosamente affondate in profondità nella cosiddetta “terra di nessuno”, tra i due fronti opposti. Come per tutte le potenze belligeranti, anche per l’Italia la guerra si tradusse in un logorante conflitto di posizioni, per di più affrontato in condizioni sfavorevoli in quanto gli austriaci controllavano le postazioni più elevate nel Trentino, nel Friuli e in Carnia. Nel 1916, gli austriaci allentarono la pressione italiana con una violenta controffensiva in Trentino (la Strafexpedition, la cosiddetta “spedizione punitiva”) i cui effetti risultarono più dirompenti sul piano psicologico e politico che non su quello militare: si spense allora la speranza, ancora diffusa in Italia dopo ben dodici mesi di guerra di posizione, di un’imminente vittoria. Nel quadro della complessa offensiva sul fronte Carsico invece, la 3a Armata Italiana, in particolare, assolse un compito particolarmente arduo e sanguinoso: i suoi uomini, guidati fino al termine del conflitto dal Duca d’Aosta, si coprirono ovunque di valore e di gloria, nella lunga e durissima lotta su un terreno molto difficile e contro un nemico particolarmente tenace, agguerrito e molto spesso disperato. Anche nelle tragiche giornate della ritirata al Piave, il comportamento della 3a Armata fu tale da farle meritare lo storico appellativo di “Invitta”. Alla 2a Armata invece, dopo un lungo periodo di relativa inazione, toccò l’onere di ricevere l’urto proveniente da Tolmino, Caporetto e Plezzo e, anche a causa di un comando che peccò di omogeneità e continuità, fu travolta e costretta ad arretrare drammaticamente nell’ottobre del 1917. Aquesto punto, il fronte Trentino e quello del Piave si ricongiunsero in un’unica linea di resistenza che, sensibilmente più corta dell’intero sviluppo del fronte sino ai giorni di Caporetto, si rivelò ben più consona ad arrestare l’invasione nemica e, in seguito, a ricacciarla sul finire del conflitto.
35
PRIMA GUERRA MONDIALE
Sun Tzu, autore del trattato “L’Arte della Guerra”, ha insegnato a combattere conoscendo bene il nemico, noi stessi e le condizioni in cui si svolge la lotta, affinché ogni gesto sia commisurato allo scopo e non provochi inutili perdite. Tuttavia, i Generali della Prima Guerra Mondiale sembrano aver saltato a piè pari qualsiasi tipo di insegnamento derivato dall’esperienza dei loro predecessori, essendo sprofondati tragicamente a nella devastante “materialschlacht”, o “guerra di materiali”, sperando di strappare facili vittorie con migliaia e migliaia di vite umane continuamente sprecate in un insensato tritacarne bellico.
Ciò che la scrittrice inglese Lyn McDonald ha sagacemente definito “la perdita dell’innocenza del 1915”, è proprio ciò che, bagnato dal sangue sacrificale delle masse ancora intimorite e giocoforza infatuate dei propri “infallibili” condottieri, diede vita a una variegata serie di concreti fenomeni di rivolta e diserzione, sul finire della contesa internazionale: tutto ciò avveniva ancor prima che qualcuno iniziasse a sventolasse la bandiera del revisionismo storico ben cinquant’anni dopo!
L’intera Europa del 1914-1918 era in fiamme e ben presto il singolo individuo si trovò a combattere semplicemente per portare a casa la “ghirba” e non più per inseguire un’ideale politico o economico. Ecco allora imporsi a imperitura memoria, l’inferno di Passchendaele, Ypres, Verdun, Caporetto, della Somme e via dicendo, reiterato scenario di incommensurabili carneficine dettate esclusivamente dall’ego e dall’ottusità di troppi scellerati “burattinai” ai vertici della contesa.
Il Piano Schlieffen
Il Piano Schlieffen era il disegno strategico dello Stato Maggiore Tedesco, attuato all’inizio delle ostilità, per conseguire la vittoria sul fronte occidentale
LE PRINCIPALI
BATTAGLIE DELLA
36
ai danni della Francia. Il piano militare prendeva il nome dal suo ideatore, il Generale Alfred Graf von Schlieffen. Quest’ultimo aveva previsto una rapida mobilitazione tedesca, l’inevitabile violazione della neutralità di Olanda e Belgio, quindi il rapido e massiccio dilagare delle truppe teutoniche attraverso le Fiandre e verso Parigi, facendo perno sulla debole tenuta dell’ala sinistra delle posizioni francesi in Alsazia-Lorena.
Sconfiggendo rapidamente la Francia, Schlieffen prevedeva di poter spostare l’attenzione tedesca sul fronte orientale. Il Generale aggiornò regolarmente i dettagli del suo piano con estrema dedizione, anche dopo essersi ritirato dallo Stato Maggiore tedesco, nel 1905; ma il suo successore, Helmuth von Moltke (detto “il giovane”) indebolì l’esecuzione del piano nell’agosto del 1914: all’inizio del conflitto, evitando l’invasione dei Paesi Bassi, fu così penalizzata l’ala destra dello schieramento tedesco, mantenendo un copioso contingente nella Prussia Orientale che era sotto minaccia.
La caparbia resistenza francese, coadiuvata dalla rapida mobilitazione della British Expeditionary Force (il contingente militare britannico inviato oltremanica), contribuì anch’essa al fallimento del piano nel 1914. Anche la caparbia resistenza dell’esercito belga, dalle forze francesi e di quelle britanniche, unita all’inaspettatamente rapida mobilitazione della Russia, sconvolse i piani tedeschi. La Russia attaccò la Prussia Orientale, attirando così le forze tedesche previste per l’invasione su larga scala sul fronte occidentale. La Germania, in seguito, sconfisse la Russia in una serie di scontri collettivamente noti come Battaglia di Tannenberg, ma questa diversione, permise alle forze francesi e britanniche di fermare l’avanzata tedesca su Parigi nella Prima battaglia della Marna (Settembre 1914). Da quel momento in poi, gli Imperi Centrali furono costretti a combattere la guerra su due fronti.
Anche se molti teorici e studiosi contemporanei sostengono che il piano sarebbe comunque fallito, a causa di gravi vizi intrinseci iniziali, una versione modificata dei concetti di Schlieffen si dimostrò efficace nello stesso teatro di battaglia, quando la Francia fu annichilità dai Panzer di Hitler nel 1940.
La
37
Marna
Dal 6 al 9 settembre 1914, le truppe francesi, disposte sul fiume Marna, a sud di Parigi (a estrema linea di difesa della Capitale), bloccarono la manovra di aggiramento attuata dall’esercito tedesco. Secondo i piani del Generale Schlieffen, la Germania aveva violato la neutralità del Belgio, ma si era anche indebolita a causa dell’eccessivo sviluppo in profondità delle vie di rifornimento; spingendo troppo in avanti le proprie truppe, l’esercito del Kaiser Guglielmo II° aveva perso di mira il suo obiettivo principale: la capitale francese.
La Francia riuscì a mobilitare ingenti quantitativi di truppe, ricorrendo addirittura a tutte le auto pubbliche di Parigi, che fecero la spola con il fronte, cariche di soldati, per giorni e giorni. Anche con il supporto della British Expeditionary Force, efficacemente mobilitata in poco tempo, la Francia riuscì ad arginare gli attacchi nemici e, poco dopo, a costringere l’esercito Tedesco alla “corsa verso il mare”: un continuo, infruttuoso tentativo di aggiramento del fianco sinistro avversario, che raggiunse in breve tempo le Fiandre e il Mare del nord.
In seguito alla Battaglia della Marna, la guerra di movimento si trasformò in guerra di posizione, con gli eserciti contrapposti bloccati in una lunghissima teoria di trincee e avamposti. Si formarono punti nevralgici e cosiddetti “salienti” su tutta la linea, ove tutte le fazioni in lotta si contesero costantemente pochi metri di terra, all’inaudito costo di migliaia e migliaia di vite umane.
Per ironia della sorte, sempre sulla Marna, ma nel 1918, si verificò anche una vittoriosa controffensiva anglo-francese. Quest’ultima, bloccò l’estremo tentativo tedesco di rovesciare le sorti del conflitto, spezzando il fronte nemico prima dell’intervento del corpo di spedizione statunitense.
38
Verso la metà del 1915, apparve chiaro a tutte le potenze coinvolte nel conflitto che la guerra di movimento aveva definitivamente ceduto il posto a quella di logoramento statico, in trincea. Ciò costrinse non solo a una lunga e dispendiosa revisione di tattiche, strategie e apparati logistici, ma anche alla spasmodica ricerca di un altro teatro di battaglia dove fosse possibile sbloccare, di riflesso, lo stallo Europeo.
Il Primo Lord dell’Ammiragliato Britannico, il giovane Winston Churchill, pensò di aver trovato la soluzione ideale, proponendo l’idea di un clamoroso attacco allo stretto dei Dardanelli. Liberando questa zona dal controllo Turco, le forze dell’Intesa avrebbero potuto rifornire liberamente la Russia dal Mar Nero, incrementando così la pressione dal Fronte Orientale ai danni di Austria e Germania. Lo Stretto dei Dardanelli era tuttavia ben difeso dall’artiglieria e dalle mine turche e, per liberarsi da queste ultime, la Reale Marina Britannica avrebbe ricoperto un ruolo predominante in tutta l’operazione. Il piano si concretizzò il 19 Febbraio 1915, ma la flotta inglese incontrò subito difficoltà insormontabili e delegò alle truppe da sbarco, composte perlopiù da “Tommies” Australiani e Neozelandesi, l’esclusivo e arduo compito di snidare le batterie costiere turche e le truppe arroccate a ridosso dello Stretto.
Fin dal primo giorno di combattimento, le spiagge della penisola interessata dallo sbarco si trasformarono in una specie di “prova generale” del D-Day della Normandia di un ventennio dopo. I “Tommies” britannici vennero inesorabilmente falciati a migliaia dai colpi avversari e da condizioni ambientali assolutamente deleterie (che provocarono dissenteria, colera, disidratazione). La decisione di porre fine ad un ennesimo, inutile massacro, fu presa dopo ben 259 giorni di inutile guerriglia e circa 205.000 caduti. Da quel giorno, la Penisola di Gallipoli è rimasta nella storia degli Australiani e dei Neozelandesi come il calvario di un’intera generazione, che non potrà mai essere dimenticato.
Gallipoli
Ypres 39
Sul finire del 1914, al termine della “corsa verso il mare”, la cittadina di Ypres (oggi Ieper), nelle Fiandre settentrionali, assunse il ruolo di ultimo caposaldo dell’esercito Inglese, prima della regione prossima alle coste del Belgio (completamente inondata all’inizio del conflitto, per impedire l’avanzata tedesca).
Il fronte pertanto, assunse una conformazione tipica di un saliente, con la cittadina di Ypres pericolosamente protesa a oriente e circondata su tre lati da modesti rilievi occupati dai tedeschi. Ben tre terrificanti campagne, con il concerto di un clima quasi perennemente piovoso, ridussero l’intera zona ad un paesaggio lunare e spettrale, dove moltissimi soldati furono vittima del fango e degli elementi naturali particolarmente avversi, ancor prima delle mitragliatrici e dei cannoni.
La prima battaglia di Ypres (22 aprile 1915) inaugurò, tra l’altro, un nuovo, tremendo sistema per cercar di aver la meglio sul nemico: l’uso indiscriminato di gas letali, tra cui il fosgene, il cloro e il solfuro dicloroetilico: non a caso, tutte queste miscele letali presero poi il nome identificativo generico di “Iprite”, dalla stessa cittadina Belga.
I gas aggressivi vennero prodotti e impiegati in grande quantità nella Prima Guerra Mondiale. Non ebbero tuttavia grande influenza strategica, salvo che in episodi locali, a causa dell’estrema sensibilità alle condizioni atmosferiche e la notevole difficoltà di impiego.
La British Expeditionary Force, solo a Ypres, registrò 5.000 morti e 10.000 intossicati dal 1915 fino al termine del conflitto. Nel 1917, lo stesso settore di Ypres fu teatro dell’ultima offensiva di Sir Douglas Haig, il Capo di Stato Maggiore britannico, che, convinto per l’ennesima volta di poter sconfiggere il nemico con la “guerra di materiali”, mandò allo sbaraglio migliaia di uomini per conquistare, in ben tre mesi di inutili massacri, solo qualche chilometro in più all’interno del saliente (Battaglia di Passchendaele).
Verdun
Recita una delle tantissime testimonianze dei soldati francesi, gettati nel diabolico tritacarne di Verdun: “Se non avete visto Verdun, non avete visto
40
niente della guerra”.
Alla vigilia di Natale 1915, Eric von Falkenhayn presentò al Kaiser Guglielomo II° un dettagliato memorandum per l’attacco a ovest. L’obiettivo sarebbe stato il tranquillo settore meridionale di Verdun, che la propaganda francese aveva dichiarato assolutamente inespugnabile. Il 21 febbraio 1916, l’artiglieria iniziò a martellare le posizioni francesi. Per tre giorni i tedeschi investirono le linee nemiche. Il morale dei soldati francesi subì un durissimo colpo, massacrato da circa due milioni di proiettili, lanciati solo nelle prime nove ore di bombardamento (in soli venti chilometri quadrati di zona di combattimento!). I tedeschi si lanciarono all’assalto provando, per la prima volta, tecniche di infiltrazione supportate da due terribili armi: i gas e i lanciafiamme (che fecero la loro prima apparizione proprio a Verdun). Il 25 cadde il bastione centrale delle difese di Verdun, il forte Douaumont (lasciato pressoché indifeso già dall’inizio della guerra, in seguito a una grave valutazione strategica).
Politicamente tuttavia, Verdun non sarebbe dovuta mai cadere in mano al nemico e proprio su questo si era basata la strategia del Generale von Falkenhayn: dissanguare l’esercito nemico, impegnandolo in un deleterio e inevitabile tritacarne bellico.
Lo Stato Maggiore francese decide di resistere a qualsiasi costo, affidando l’intero settore di guerra al Generale Philippe Pétain. Quest’ultimo lanciò una serie di furiosi contrattacchi, alimentati dai rinforzi che arrivano lungo la Voie Sacrèe (la “Via Sacra”): una strada battuta dall’artiglieria, ma unica via di collegamento al fronte, sulla quale sfilarono, per mesi e mesi, circa ventinila uomini al giorno e un autocarro ogni cinque secondi.
“Ils ne passeront pas” – “Non passeranno”, fu l’unica parola d’ordine di Petain: Verdun diventò allora il simbolo della Francia, del suo onore e della follia stessa della guerra. Lo scontro, violentissimo e senza quartiere (si arrivò spesso agli attacchi alla baionetta e a selvaggi confronti a mani nude) si protrasse fino all’ottobre del 1916, quando entrambe le fazioni si arresero di fronte al reciproco sfinimento e a circa 700.000 soldati caduti.
41
Conosciuta dalla storiografia italiana anche con il nome di Battaglia degli Altipiani, questa offensiva austro-ungarica fu voluta per punire il tradimento italiano alla Triplice Alleanza. Quando nel pomeriggio del 14 maggio 1916, un fuoco d’artiglieria, mai visto prima, si scatenò sulle posizioni italiane, e il mattino del 15 il XX° Corpo austro-ungarico mosse all’attacco, le prime rapide conquiste fecero temere e presagire un travolgente successo del nemico. L’attacco colse le truppe italiane troppo proiettate verso posizioni estremamente avanzate. L’intera massa di uomini dislocati a difesa del fronte continuò coraggiosamente e selvaggiamente a riconquistare qualsiasi posizione persa, fino a quando, abbruttiti e devastati dalla violenza degli attacchi, gli italiani dovettero necessariamente iniziare la ritirata. Sorpreso dagli avvenimenti, ma capace di un poderoso colpo di reni, Cadorna racimolò un numero sufficiente di divisioni di riserva e costituì la “miracolosa” Va Armata che segnò concretamente la fine dell’offensiva sugli Altopiani. Per costituire questa nuova arma d’offesa, Cadorna corse un notevole rischio: dovette infatti alleggerire le truppe dislocate sull’Isonzo, rischiando che un’offensiva nemica contingente gli strappasse di mano anche le poche e sudatissime conquiste su quel fronte. L’Austria si rese subito conto della minaccia e, dopo un ultimo tentativo di offesa ai danni delle difese del Lemerle e del Magnaboschi, cessò l’offensiva, con relativo importante arretramento delle linee raggiunte. Si concludeva così la prima grande battaglia difensiva dell’Italia, definitivamente “maturata” per la “guerra di materiali”, che l’avrebbe vista impegnare ingenti quantitativi di uomini, mezzi e risorse fino al termine del conflitto. Purtroppo durante questa sanguinosa e frenetica battaglia, il fatto di aver perduto terreno (la massima penetrazione austriaca si misurò su più di venti chilometri in profondità verso la pianura vicentina) relegò nell’ombra la ben più concreta vittoria difensiva italiana.
Lo Jutland
Dopo il 1900, l’artefice dell’espansione navale tedesca fu l’ammiraglio Alfred von Tirpitz, il cui chiodo fisso era la costruzione delle corazzate (le famose
La Strafe Expedition
42
“Dreadnought” inventate dagli inglesi). La sua filosofia navale era stata definita “la teoria del rischio”, costituire cioè una minaccia per la Royal Navy grazie a una flotta di corazzate che, pur non esattamente in grado di sconfiggerla, ne avrebbe limitato il potere, minacciandola con il pericolo di rovinosi attacchi di sorpresa. Il Kaiser abbracciò completamente le idee di Tirpitz. La Kriegsmarine tedesca, la seconda flotta più forte del mondo (dopo quella britannica), poteva vantare una sostanziale parità nei confronti degli avversari. La Germania poteva quindi tentare di rompere l’isolamento forzato con buone probabilità di successo. Nel maggio del 1916, la Hochseeflotte avrebbe simulato, con lo spostamento di poche unità, l’occupazione degli Stretti di Danimarca. La Grand Fleet britannica sarebbe caduta nella trappola e avrebbe inviato il grosso delle proprie forze verso gli Stretti: le navi tedesche, più leggere e manovrabili, avrebbero attaccato di colpo gli avversari, distruggendoli. L’Ammiragliato di Londra cadde in pieno nel tranello, ordinando a sei incrociatori di battaglia e quattro supercorazzate “Dreadnought” di dirigersi verso il punto dove riteneva si sarebbero trovati i pochi incrociatori tedeschi (lo Stretto dello Jutland). L’Inghilterra mise in moto anche ventiquattro corazzate semplici, altri tre incrociatori da battaglia, ventisei incrociatori leggeri e settantanove cacciatorpedinieri. La Germania schierava sedici corazzate, 1undici incrociatori leggeri, cinque incrociatori da battaglia e sessantuno cacciatorpedinieri. Lo scontro tra le due possenti forze avvenne il 31 maggio 1916: la battaglia navale sarebbe divenuta la più importante del Primo Conflitto Mondiale e una delle più importanti nella storia della marina internazionale. Dopo cinque ore, le due flotte si disimpegnarono, avendo entrambe subito gravi danni. Dal punto di vista del morale e delle perdite, risultava indubbia la vittoria tedesca; ma la Grand Fleet britannica non era di certo stata annientata. Ciò avrebbe avuto conseguenze pesantissime per lo svolgimento della guerra e per la Germania stessa. Il governo tedesco, disilluso fino alla paranoia nei confronti della propria flotta di superficie, decise di affidarsi all’unica arma capace, a suo dire, di garantire risultati strategicamente significativi: il sottomarino.
La Somme
Cinquantanovemila perdite, circa lo stesso numero di soldati scomparsi in
43
dieci anni di guerra in Vietnam, furono le perdite della British Expeditionary Force solo nel primo giorno di offensiva nel settore del fiume Somme, a sud di Ypres e a nord-est di Parigi.
Narrano le cronache dei testimoni oculari, che i mitraglieri tedeschi smisero ben presto di sparare, esterrefatti e allibiti dal terrificante tiro al bersaglio che venne loro offerto, la mattina del 1° luglio 1916. I soldati inglesi, convinti che una settimana di bombardamento di preparazione avesse annichilito qualsiasi tipo di difesa passiva, uscirono dalle trincee e marciarono incontro a morte certa, a passo rallentato, senza nemmeno imbracciare il fucile. I tedeschi, dal canto loro, usciti dalle “stollen” - profonde caverne studiate per sopravvivere anche ai cannoneggiamenti più intensi - si trovarono a sparare contro file inspiegabilmente compatte di bersagli, senza dover neanche prendere la mira. La Battaglia della Somme, voluta principalmente dalla Francia, per alleggerire la pressione su Verdun, testimoniò per la prima volta la caparbia testardaggine dello stato maggiore britannico, unitamente alla sua alta impreparazione ed immaturità nella prima offensiva di materiali dell’Intesa. Dal tragico risultato di questa campagna, l’esercito inglese non riuscì a trarre sufficienti insegnamenti per evitare, un anno dopo, un’analoga strage annunciata durante la Terza Battaglia di Ypres (Passchendaele). Arendere più amara l’inutile perdita di tante vite umane, contribuì poi la scoperta di moltissimi proiettili inesplosi e difettosi, che durante il bombardamento preparatorio avevano lasciato pressochè intatti reticolati, filo spinato e trincee avversarie. Con l’autunno, il campo di battaglia si coprì di fango. La pioggia trasformò le trincee in acquitrini, rendendo ancora più difficile la vita ai soldati. L’ultima fase della battaglia si svolse il 19 novembre. Da un punto di vista strettamente tattico si trattò di una sconfitta tedesca, ma il guadagno territoriale alleato rispetto a luglio precedente fu davvero minimo: un saliente profondo al massimo dieci chilometri, conquistato a carissimo prezzo: le perdite, tra morti e feriti, ammontarono a 620.000 per l’Intesa a e 450.000 per la Germania.
44
Nella seconda metà del 1917, l’esercito russo non aveva praticamente più capacità bellica: questo permise ai germanici di sottrarre al fronte orientale un cospicuo numero di divisioni. Date le pressanti richieste del nuovo imperatore d’Austria, fu creata un’armata agli ordini del capace Generale Von Below, allo scopo di ricacciare gli Italiani sulle posizioni del 1915. L’operazione fu preparata con grande cura e dispiego di mezzi. Per aprire la strada agli attaccanti nella conca di Plezzo, fu fatto arrivare al fronte anche uno speciale battaglione lanciagas, che piazzò centinaia di tubi lanciagranate di fronte alle linee italiane (i reparti che Cadorna avrebbe in seguito tacciato di codardia, erano già destinati a morire, in battito d’ali, per intossicazione da gas fosgene nemico). La mattina del 24 ottobre 1917, l’alta valle dell’Isonzo era piena di nebbia e il tempo era freddo e piovoso. Nonostante conoscessero l’ora d’inizio dell’attacco nemico, gli artiglieri italiani restarono immobili. Ben presto, una valanga di fuoco si abbatté sulle prime linee e poi avanzò a sconvolgere le retrovie, ma i vertici militari italiani erano stati chiarissimi, quando avevano imposto di non sparare fino a che ciò non venisse esplicitamente richiesto e autorizzato. Tuttavia, sotto un simile uragano di ferro, le linee telefoniche saltarono subito; i segnali ottici non servirono e i portaordini non riuscirono a recapitare alcun ordine, falciati ovunque dal fuoco nemico. In realtà, il tiro di contropreparazione sarebbe dovuto iniziare prima e non dopo quello austrotedesco (il che, quando accadde, come nella battaglia del Solstizio, azzerò le possibilità di successo dell’attacco), dato che tutte le informazioni indicavano un ammassamento di truppe d’assalto assai a ridosso della prima linea e, quindi, poco protette da un efficace sbarramento d’artiglieria. Il Generale Pietro Badoglio fu il principale esecutore dell’ordine che imbavagliò le artiglierie; il Generale Luigi Capello, dopo giorni di farneticazioni e preparazioni di controffensive strategiche, cadde malato: il caos totale regnava dunque sovrano e gli austro-tedeschi violarono e dilagarono facilmente per la val Natisone e la valle dell’Isonzo, in mezzo a isolate sacche di resistenza e a grottesche incapacità dei comandi italiani. La difesa si spostò dapprima sulla linea al Tagliamento e quindi sul Piave e sul Grappa (dove le truppe del neodecorato “Pour le mérite” Tenente Ervin Rommel, condottiero delle avanguardie austro-tedesche, ebbero poi modo di spuntarsi le corna contro i battaglioni degli Alpini). Qui e sull’Altopiano dei Sette Comuni, si combatté una terribile battaglia d’arresto, che durò, in pratica, fino al febbraio del 1918; infine, l’esercito italiano si ricompattò con
Caporetto
45
ritrovato fervore patriottico e riprese la pugna a oltranza. Dopo Caporetto, l’esercito italiano, tra il Brenta e il mare, poteva contare su non più di 300.000 uomini - ma erano uomini che la tragedia di Caporetto aveva profondamente cambiato e, in qualche modo, forgiato e preparato al ben più radioso futuro del 1918.
Il Piave
Dopo lo sfondamento di Caporetto, lo Stato Maggiore italiano decise di attestare la nuova linea sul Piave, ordinando nello stesso tempo l’arretramento delle proprie armate precedentemente impegnate sulla linea Giulia e quella Carnica. Il nuovo schieramento aveva al centro il cardine del monte Grappa sul quale, dopo la Strafe Expedition del 1916, erano state realizzate imponenti difese. La “Battaglia del Piave” fu dunque una serie di azioni di contenimento, difesa e contrattacco, che si susseguirono dal novembre 1917 all’estate 1918 e che precedettero la battaglia finale di Vittorio Veneto. Dopo il passaggio sulla destra del fiume della IIa e IIIa Armata italiana e la distruzione di tutti i ponti verso la riva sinistra, iniziò la disperata resistenza contro le truppe austro-tedesche, imbaldanzite dal rapido e inaspettato successo. Ma, dopo accaniti combattimenti, le avanguardie austriache, a causa di difficoltà logistiche e battute dell’artiglieria italiana, vennero accerchiate e catturate.
Durante l’inverno, l’Italia continuò l’opera di consolidamento su questa linea, mentre continuarono cruenti scontri sul monte Grappa. La battaglia riprese tra il 15 e il 23 giugno dell’anno successivo, quando gli Austro-Ungarici lanciarono una nuova grande offensiva su tutto il fronte dall’Altopiano di Asiago (Offensiva Radetzki) al Piave (Operazione Albrecht). Fu una delle più dure e sanguinose battaglie della Prima Guerra Mondiale. Ma la rete difensiva creata da Cadorna - migliorata secondo i disegni di Armando Diaz con veri e propri compartimenti stagni - riuscì a resistere a tutti gli ormai disperati urti del nemico.
I soldati italiani e in particolare la nuova classe chiamata alle armi - i ragazzi del ’99 - con il contributo di divisioni inglesi e francesi compirono veri prodigi di valore. Era questo il preludio alla prossima travolgente offensiva,
46
nota come Battaglia di Vittorio Veneto, che in pochi giorni sbaragliò il nemico, che già a giugno, perdendo sul Piave, aveva ricevuto un durissimo colpo.
La Primavera-Estate del 1918
Apartire dal 21 marzo del 1918, la Germania lanciò una serie di disperate offensive, nel tentativo di travolgere una volta per tutte le forze dell’Intesa, schierate a ridosso della famosa “Linea Sigfrido” (o “Linea Hindenburg”). Su quest’ultima posizione, l’esercito tedesco era infatti arretrato, per accorciare e consolidare il suo fronte, dopo l’ultimo grande attacco Franco-Inglese, comandato dal Generale Nivelle. L’Intesa versava in analoghe, stremate condizioni e le numerose defezioni dei “Poilus” francesi, uniti alla loro generalizzata deficienza combattiva, spinsero Hindenburg e Ludendorff a tentare il tutto per tutto.
L’11 aprile 1918, il Capo di Stato Maggiore inglese, il Generale Sir Douglas Haig, ordinò ai propri uomini, messi con le spalle al muro, di resistere fino alla morte, senza cedere un palmo di terreno. Il Generale francese Ferdinand Foch venne incaricato di gestire tutte le forze alleate, in qualità di Generalissimo – ma si trovò comunque costretto ad arretrare sotto gli urti dell’”Operazione Michael”, che portò la Germania ancora una volta ad un passo da Parigi e dalla vittoria finale. Ma l’arrivo dell’esercito americano (gli Stati Uniti entrarono ufficialmente in guerra il 7 aprile 1918), unito a gravi difficoltà logistiche nemiche, ribaltò le sorti del conflitto, a favore dell’Intesa. La prima vittoria ufficiale Americana avvenne il 28 maggio nelle vicinanze di Cantigny, alla quale fece subito seguito la conquista di Bouresches e del bosco di Belleau. Proprio in quest’ultima occasione, si distinse per tenacia e coraggio il corpo dei Marines Statunitensi, che facevano parte dell’American Expeditionary Force, appena arrivata in Europa. La strenua e disperata resistenza italiana sul Piave ebbe finalmente ragione dell’invasore Austriaco e lo travolse definitivamente nel cruento scontro di Vittorio Veneto, mentre a partire dall’8 agosto - la cosiddetta “giornata nera” dell’esercito tedesco - le vittorie alleate su tutti i fronti costrinsero Austria e Germania a capitolare con i successivi armistizi, del 3 e 11 novembre 1918.
47
48
Veneto
Dopo aver arrestato l’avanzata degli imperi centrali, con le truppe di questi ultimi ormai esauste e sulla difensiva (dopo la lunga marcia seguita allo sfondamento del fronte a Caporetto), tutto sembrava pronto per un attacco volto a riconquistare i territori occupati e a spezzare, definitivamente, le linee austro-tedesche, debilitate dalle paurose perdite subite nella battaglia del Piave e analogamente in difficoltà anche sul fronte occidentale. Anche a causa dalla difficile situazione militare, si inasprirono i contrasti multietnici dell’esercito asburgico (formato da molteplici etnie, comprendenti austriaci, ungheresi, croati, boemi, sloveni polacchi e bosniaci), provocando il progressivo sfaldamento dello stesso. I Comandi alleati, fin dal trionfo della resistenza sul Piave, continuarono a incentivare concretamente lo Stato Maggiore italiano a prendere l’iniziativa contro l’agonizzante nemico, finché, dopo vari ritardi, volti ad assicurare l’adeguata preparazione delle sue truppe, il Generale Armando Diaz decise di lanciare la controffensiva finale - a un anno esatto dalla disfatta di Caporetto. Al termine di due giorni di aspri combattimenti, i soldati italiani, dopo un primo momento di difficoltà, furono in grado di attraversare il Piave e di avere la meglio sulla vigorosa resistenza nemica. Il massiccio attacco in forze condusse l’esercito italiano fino a Vittorio Veneto, ove conquistò la vittoria decisiva, travolgendo e tagliando in due le armate di un impero che, di fatto, aveva già cessato di esistere come entità politica. Trento e Trieste furono liberate e, a un’AustriaUngheria ormai in piena dissoluzione, non restò altro che chiedere l’armistizio, firmato il 4 novembre a Villa Giusti, presso Padova. Come sentenziò il Generale Pietro Badoglio: “Per l’Italia fu la fine della guerra, per l’Austria fu la fine di un grande impero”.
L’armistizio
tra Italia e Austria-Ungheria
Dopo la disastrosa sconfitta di Vittorio Veneto dell’ottobre-novembre 1918, l’Esercito Austro-ungarico era allo sfascio. La débâcle militare si trasformò in una rotta non più arginabile e mentre le truppe tentavano di rientrare in patria, a Villa Giusti si firmava l’armistizio per far cessare il fuoco su tutto il fronte italiano. La popolazione italiana apprese il mattino del sabato 2
Vittorio
49
novembre 1918 l’esaltante notizia: “Travolto dall’esercito italiano, il nemico chiede a Diaz l’armistizio”. Il giorno 3, il Generale Badoglio, il Generale Scipioni, il Colonnello Gazzano, il Capitano Maravigli e il Comandante Accissi furono nuovamente a contatto con i parlamentari. Il colloquio durò a lungo, ma prima di uscire avvenne un risolutorio scambio di strette di mano: l’armistizio era firmato. Con lo strillo “L’Austria ha capitolato” il Corriere della Sera del 5 novembre pubblicava il famoso Bollettino della Vittoria, firmato dal Generale Armando Diaz.
L’armistizio finale
In quanto alla Germania, il 4 novembre il Generale Armando Diaz telegrafò a Parigi: “Se la Germania non sottostarà condizioni armistizio che le saranno imposte dagli alleati, l’Italia interverrà per costringerla alla resa”. Di fronte alla minaccia italiana alla sua frontiera meridionale, la Germania, ormai inesorabilmente sconfitta, dovette finalmente deporre le armi. L’8 novembre, fu annunciata l’abdicazione del Kaiser Guglielmo II°. I plenipotenziari tedeschi, guidati dal cattolico Erzberger, incontrarono il Generale Ferdinand Foch, comandante degli eserciti dell’Intesa; sul treno blindato, sul binario morto della linea Compiègne-Soissons - lo stesso su cui Hitler avrebbe imposto la resa alla Francia durante la Seconda Guerra Mondiale – venne firmato l’armistizio dell’11 novembre 1918, che pose fine alla Prima Guerra Mondiale.
La conferenza di pace si riunì, in seguito, a Parigi e portò alla firma dei trattati tra le varie nazioni belligeranti a Versailles con la Germania (28 giugno 1919), a Saint-Germain-en-Laye con l’Austria (10 settembre 1919), a Neuilly con la Bulgaria (27 novembre 1919), al Trianon con l’Ungheria (4 giugno 1920) e a Sèvres con la Turchia. L’imperatore Carlo I° d’Austria abdicò nello stesso giorno dell’armistizio.
50
GUERRA DI MATERIALI
La Prima Guerra Mondiale coinvolse tutte le maggiori potenze e tutti gli stati europei, a eccezione della Spagna, dell’Olanda, delle nazioni scandinave e della Confederazione Elvetica. Ancor più significativo, è il fatto che truppe provenienti dalle colonie d’oltremare vennero inviate, spesso per la prima volta, a combattere e a operare fuori della loro area geografica di appartenenza. Totale fu l’impiego dei mezzi e delle risorse a disposizione. Gli scontri che interessarono il mondo intero dal 1914 al 1918 impiegarono e annichilirono una quantità fino ad allora inimmaginabile di materiali e di risorse di qualsiasi genere. Da qui l’espressione tedesca “Materialschlacht” (“guerra di materiali”). Ma la Grande Guerra fu soprattutto un conflitto perlopiù statico e di posizione. Nella “terra di nessuno”, quello spazio che si estendeva tra le prime linee degli schieramenti, non solo erano cancellati i diritti elementari degli individui, ma persino la natura era orribilmente sconsacrata e violentata dall’uomo con le sue terribili attrezzature di morte e distruzione. Un’aberrazione topologica dunque, snaturata dalla tecnologia bellica più avanzata di quei tempi. La zona di guerra era il “regno della distanza” fisica e spirituale: la nuova e devastante tecnologia d’offesa dettava una condotta dei combattimenti a distanza, cioè senza che l’avversario dovesse essere necessariamente visibile. La tecnologia rese virtualmente invisibili le sue vittime, mentre ciò non accadeva quando, decenni prima, si sventravano ancora i nemici con la baionetta o li si inquadrava nel mirino del moschetto. Uccidere, ferire e menomare diventarono allora conseguenze remote del premere un pulsante, del muovere una leva o, ancor peggio, di ordinare il fuoco contemporaneo di migliaia di bocche da fuoco, standosene comodamente seduti davanti a una mappa, a centinaia di chilometri dal fronte. Anche l’inedita “democratizzazione” della guerra, che coinvolse direttamente e per la prima volta le masse, oltre che i professionisti dell’arte militare, incrementò il livello di barbarie e l’impatto psicologico e materiale del conflitto. Dal 1914, iniziò pertanto quel processo di smaterializzazione dell’avversario, che progredirà nel conflitto seguente con l’uso del radar e, ancor oggi, con le armi “intelligenti” - quelle cioè capaci di selezionare autonomamente il bersaglio da colpire - e gli strumenti di localizzazione e
LA
51
distruzione del bersaglio addirittura telecomandati.
La nascita delle prime tecnologie di sterminio in massa mise subito in mostra il suo carattere tipicamente industriale. L’avvento di nuove e potentissime armi ha infatti, da sempre, caratteristiche indiscutibilmente simili ad altri tipi di evoluzioni in campo industriale. Nella macellazione, ad esempio, la razionalizzazione dei procedimenti, l’organizzazione di tempi e spazi di lavorazione e la costruzione di appositi spazi, a distanze strategiche dai grandi centri urbani, possono facilmente essere paragonati alle varie fasi degli innumerevoli massacri del 1914-1918. La peculiarità dell’industria della macellazione, non a caso, è costituita dal fatto che la sua “produzione” passa attraverso la “distruzione” della vita. In modo analogo ed estremo, i campi di internamento e di sterminio dei nazisti (già apparsi proprio durante la Prima Guerra Mondiale, ma spesso taciuti dalla storiografia ufficiale) si potrebbero paragonare ai moderni sistemi di fabbrica: invece di produrre merci, impiegavano gli esseri umani come materia prima e sfornavano la morte a ciclo continuo, con quantità giornaliere preventivate e garantite. Proseguendo le analogie, è immediato realizzare quanto la dinamica fra produzione e distruzione, quint’essenza della moderna società industriale, sia un ben noto aspetto del sistema capitalistico. La realizzazione di nuovi beni di consumo è subordinata allo smaltimento rapido, vale a dire alla distruzione delle eccedenze dello stesso ciclo produttivo precedente. La Prima Guerra Mondiale fu dunque un’immensa occasione di “smaltimento”, incastonata in un tragico processo di spreco globalizzato. Con tutte le sue “rivoluzionarie” apparecchiature di distruzione, questo conflitto mutò i campi di battaglia in giganteschi sistemi di distruzione di massa – il tutto seguendo sempre le regole del sistema capitalistico, forse ancora più rigidamente che in tempo di pace.
52
LE TATTICHE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Quasi sempre, la risposta data ai molteplici insuccessi strategici del 1914-1918 addossa ogni colpa ai vertici militari, in quanto, anche come confermato da molti storici contemporanei, a quell’epoca gli eserciti si reputavano composti da “leoni comandati da asini”. Tuttavia, prima di pervenire a un giudizio circa l’effettiva competenza degli alti comandi nel periodo bellico 1914-1918, ci sono molti aspetti da prendere in considerazione. Era stato sostenuto che la guerra si basava su cicli tecnologici. Nel 1914 la tattica difensiva ebbe un temporaneo predominio su quella offensiva; una situazione che si sarebbe invertita tra il 1939 e il 1941. Ciò fu determinato soprattutto dagli sviluppi degli armamenti. Durante la guerra, le forze in campo non avevano grossi problemi nell’assalire le posizioni nemiche, usando l’artiglieria e la fanteria. Persino durante il famoso e atipico 1° luglio 1916 – l’inizio della Battaglia della Somme - le divisioni inglesi e le vicine formazioni francesi riuscirono a raggiungere tutti i loro obiettivi. La difficoltà non era irrompere nelle trincee nemiche, ma proseguire concretamente l’azione. Parlando in generale, era più facile per un difensore tamponare la breccia aperta nel proprio fronte, che per un attaccante far avanzare le proprie riserve per sostenere le prime ondate di truppe d’assalto, il cui slancio perdeva quasi subito impeto a causa delle inevitabili, pesanti perdite.
Adispetto dell’immagine pubblica dei comandanti della Prima Guerra Mondiale, visti come “asini” dotati di scarsa fantasia, tra il 1914 e il 1918 si verificò una concreta rivoluzione della tattica militare. La guerra del 1914 fu di tipo napoleonico, ma quella del 1917-18 ebbe molti elementi in comune con la Blitzkrieg del 1940. Le tattiche di infiltrazione, la guerra chimica, gli attacchi aerei, le azioni combinate di reparti di fanteria e mezzi corazzati, gli sbarramenti d’artiglieria accuratamente preparati: tutto ciò era ormai entrato a far parte della mentalità strategica del 1918. Caso strano, mentre vengono ricordate le nuove armi (come i gas e i carri armati), questo non avviene per le innovazioni tattiche. In altre parole, tutti gli eserciti avevano impiegato tattiche lineari di fanteria nel 1914, ma già nel maggio 1915 un ufficiale
53
francese, il capitano André Laffargue, stava iniziando a pensare all’addestramento di reparti d’assalto, che dovevano aprirsi la strada lanciandosi avanti in piccoli gruppi. Furono i tedeschi a sviluppare questo metodo, addestrando truppe scelte e bene armate a penetrare nelle posizioni nemiche, oltrepassando gli ostacoli e continuando ad avanzare sempre più a fondo nelle retrovie, lasciando ai rincalzi all’attacco il compito di annientare eventuali sacche di resistenza. Questa tecnica fu adottata a Cambrai e Caporetto nel 1917; inoltre, il suo impiego contro gli inglesi sulla Somme, nel marzo 1918, spezzò l’equilibrio del fronte statico, portando alla ripresa della guerra di movimento, in campo aperto. Indipendentemente dai tedeschi, sia i francesi che gli inglesi avevano abbandonato l’idea dell’avanzata frontale e adottato tattiche più flessibili basate sull’impiego di piccoli reparti. In modo analogo, le rigide tattiche difensive basate su tre linee di trincee furono sostituite dalla difesa in profondità, in gran parte conseguenza dell’esperienza tedesca sulla Somme nel 1916. Le truppe avanzanti dovevano allora fronteggiare una serie di avamposti iniziale e quindi una zona di combattimento protetta da capisaldi: questi ultimi, piazzati in modo da assicurarsi appoggio reciproco, avrebbero necessariamente diluito e rallentato le truppe d’assalto, permettendo di bersagliarle con maggior facilità. Anche le tattiche dell’artiglieria subirono un profondo cambiamento: i pedestri tentativi di distruggere le posizioni nemiche con migliaia e migliaia di proiettili con gittata fissa, furono sostituiti da tiri di sbarramento in grado di spostarsi con l’avanzare delle truppe in attacco (quello che gli inglesi chiamavano “Creeping Barrage” –“Sbarramento Strisciante”). L’embargo, che Inghilterra e Francia imposero alla Germania Guglielmina sin dall’inizio della Prima Guerra Mondiale, può essere considerato come lo strumento di offesa probabilmente più efficace per far sì che l’esercito del Kaiser venisse inesorabilmente costretto alla capitolazione. In seguito a tale strategia d’assedio operata dall’Intesa, la Germania dovette amministrare con infinita parsimonia le proprie risorse interne, nonché cercare comunque di rifornire lo sforzo bellico dei suoi alleati, analogamente stretti nella morsa dell’embargo. Quando iniziarono a tuonare quei tragici “cannoni d’agosto” nel 1914, le rotte commerciali tedesche furono immediatamente bloccate dallo sforzo congiunto dei due principali Paesi dell’Intesa. Un proclama reale britannico sancì il diritto incontrastato di impedire alla Germania qualsiasi scambio, commercio o contrabbando di ogni genere di merce, inclusi armi,
54
proiettili, esplosivi equipaggiamenti bellici. L’iniziale inarrestabile avanzata degli ultimi mesi del 1914, testimoniò perfettamente la supremazia incontrastata della macchina da guerra tedesca – tuttavia le mancava un importantissimo ingranaggio: il controllo e il dominio assoluto dei mari e delle relative rotte commerciali. Su tale lacuna si sviluppò immediatamente l’embargo dell’Intesa, anche se inizialmente la Germania riuscì in parte a mantenere rapporti commerciali con il resto del mondo (soprattutto grazie a un astuto permissivismo britannico, desideroso di far indebitare il nemico oltremodo, gettando le basi per una inevitabile crisi economica e finanziaria interna).
Si calcola che circa il 70% delle risorse tedesche fosse, fino ad allora, di importazione, contro un 50% nelle esportazioni. Nonostante i modesti risultati ottenuti nei primi mesi di embargo, la Germania e i suoi alleati dovettero presto costituire un nuovo tipo di economia centralizzata, di tipo autarchico, per ottimizzare la gestione delle risorse comuni. Molto presto la Germania si rese conto di non avere altra scelta se non quella di contrastare militarmente le soffocanti restrizioni economiche imposte dall’Intesa. Il Kaiser decise di ascoltare i consigli del suo Ammiraglio von Tirpitz e di lanciare la propria flotta di sottomarini contro le sentinelle dei mari dell’Intesa. Venne ben presto dichiarato, per la prima volta nella storia, questo nuovo tipo di guerra navale. Gli inglesi non si fecero tuttavia intimorire e rafforzarono controlli e blocchi navali. Appare sicuramente ironico che con l’impiego dei temuti “Untersee-Boat “(U-Boat) i tedeschi provocassero direttamente una recrudescenza dello stesso embargo, che li avrebbe poi costretti a una bruciante sconfitta. Con il procedere della guerra, la Germania decise comunque di investire ulteriormente nello sviluppo dell’arma sottomarina e ben presto si raggiunsero affondamenti pari a mezzo milione di tonnellate al mese, che fecero rischiare una pericoloso effetto “boomerang” dell’embargo ai danni della stessa Inghilterra.
Va da sé che la drastica riduzione di generi di conforto e soprattutto di alimenti e di materie prime, correlata strettamente ad costante degrado del livello di salute media, esacerbò i già crescenti malumori, prodromi di scioperi e manifestazioni sempre più violente. Il morale del fronte interno, così come quello dei soldati in prima linea iniziò a denunciare lo stesso comune denominatore della disperazione. La voglia di combattere e, in generale, di resistere oltremodo alle infinite e durissime prove di una lunga e devastante guerra, stava decisamente esaurendosi. Sul finire del 1918, i
55
soldati tedeschi, ormai stremati e quasi privi di cibo, armi e munizioni, arrivarono al punto di augurarsi un attacco di carri armati nemici perchè, come disse lo stesso Capo di Stato Maggiore Enrich von Ludendorff: “Dentro ad ogni carro si può sicuramente trovare del cibo”. La guerra non finì a colpi di cannone: il popolo tedesco e il suo esercito, entrambi stremati e disperati, abbracciarono di buon grado qualsiasi forma di armistizio che ponesse fine ai loro disagi. Si credette allora di potersi liberare dell’embargo, una volta firmate le pesantissime condizioni imposte dagli alleati per la resa incondizionata tedesca – in realtà il blocco commerciale non venne sollevato fino al 1930, rendendo ancor più amara la sconfitta alla Germania ed esacerbandone il già crescente desiderio di rivalsa e di vendetta. Partendo dall’esempio delle “Sturmtruppen” create dai tedeschi (una specie di “super fanteria” particolarmente veloce, agile e senza l’impaccio di zaini, pale, picconi e quant’altro sarebbe servito a chi, dopo di essa, si sarebbe dovuto insediare nelle postazioni conquistate), i Comandi italiani, fin dal 1915, considerarono la creazione di unità d’assalto o di cosiddetti “esploratori”. Il Colonnello Giuseppe Bassi fece dunque realizzare una specifica scuola d’addestramento a Sdricca di Manzano, in provincia di Udine, dove si inventò un particolare addestramento per i suoi “Arditi” fanti.
Il primo impiego ufficiale degli “Arditi” risale alla battaglia della Bainsizza, il 18 e 19 di agosto 1915. L’esito vittorioso catalizzò la nascita di ulteriori reparti e la direttiva ufficiale di costituire gruppi di “Arditi” in tutte le Armate italiane. Come accadde per ogni nuova arma o strategia, anche l’impiego di questa “super fanteria” non fu sempre indovinato. Spesso i reparti degli “Arditi” vennero impiegati come unità di fanteria in difensiva pur non avendone reali capacità.
In seguito al disastro di Caporetto, il nuovo Comando Supremo italiano dettò anche negli “Arditi” un riordino generale. Si cercò infatti di organizzare meglio le unità, ciascuna con organici, armamento, tecniche di impiego ed uniformi proprie; i reparti vennero quindi rinumerati e riassegnati ai vari Corpi d’Armata. Successivamente assunsero la numerazione del Corpo d’Armata di dipendenza e vennero ordinati in tre compagnie con tre sezioni mitragliatrici, sei sezioni pistole mitragliatrici ed altrettante munite di lanciafiamme. L’armamento individuale, inizialmente composto solo dal pugnale e dalla granata Thevenet, si arricchì del moschetto 91 TS, versione accorciata del fucile modello 91. L’uniforme rimase la stessa ma, per carenza
56
di materiali, venne introdotta la camicia grigioverde di flanella con cravatta e fez neri. Apparve anche uno zainetto d’ordinanza, un semplice tascapane cioè, che potesse contenere un minimo di cosiddetto sostegno logistico. Tornati in azione dal il 10 giugno 1918 in poi, ben nove reparti di “Arditi” vennero destinati alla costituzione della 1a Divisione d’Assalto, seguita quindici giorni dopo dalla 2a Divisione d’Assalto con la quale venne creato un vero e proprio Corpo d’Armata d’Assalto. Verso la fine della guerra le Divisioni d’Assalto vennero anche usate a guisa di arietie per la liberazione della cittadina di Vittorio Veneto. Nel più puro spirito anarchico belligerante, gli “Arditi” vennero spesso incaricati di azioni audaci, prive di una reale utilità militare, ma certamente altisonanti dal punto di vista della propaganda. Da queste formazioni di “nuovi combattenti” si crearono anche squadre destinate a operare nelle retrovie nemiche, raccogliendo informazioni e attaccando le linee di rifornimento – quello che oggi potremmo facilmente identificare con sabotatori e guastatori. Gli inglesi ci insegnarono anche a paracadutarci oltre le linee nemiche, per veri e propri scopi di spionaggio; gli “Arditi” allora si lanciavano con denaro italiano e austriaco d’occupazione, nonchè una gabbietta di piccioni per spedire messaggi ai loro comandi. Dietro le linee nemiche cercavano anche di sabotare ponti e ferrovie o addirittura di modificare le segnaletiche stradali, per gettare nel caos i trasporti nemici! A Gabriele D’annunzio, esteta primo del più puro spirito ardito, dobbiamo anche il più famoso motto di queste truppe speciali: l’indimenticabile “Me ne frego!” di cui in seguito, per scopi politico-propagandistici, se ne snaturò la vera essenza.
57
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
La trincea
Per i combattenti del 1914-1918, nulla fu più terribile della “vita” di trincea, che costrinse migliaia di uomini ad affrontare un’esperienza infernale, in grado di scoraggiare anche il più fervente patriota o interventista. Le milizie di tutti gli schieramenti si trovarono a convivere con lo spettro della morte, nelle interminabili ed estenuanti giornate di ozio apparente tra il fango e la sporciza, sprecate perlopiù a simulare una normalità soltanto apparente. Anche nel lasso di tempo che intercorreva tra le grandi offensive (la cui preparazione richiedeva spesso mesi e mesi di lavoro) il pericolo mortale era sempre in agguato: un cecchino, una granata, una raffica di mitragliatrice, un assalto improvviso, potevano improvvisamente spezzare la monotonia della vita in trincea. Rintanati come topi nelle viscere della terra, i soldati furono costretti a fronteggiare anche malattie, epidemie, denutrizione e sfinimento, costantemente esposti alle avverse condizioni atmosferiche e a un inevitabile, costante stillicidio di vite.
Per limitare le terribili perdite subite in campo aperto, durante i primi mesi di guerra, non si era potuto fare altro che scavare rifugi in profondità e rendersi dunque invisibili al nemico, ammassandosi come topi in angusti fossati o in anfratti naturali. Paolo Caccia Dominioni, ufficiale italiano sul Carso, cristallizzò l’orrore e il ribrezzo per la vita in trincea con le parole: “Trincea! Abominevole carnaio di putredine e di feci, che la terra si rifiuta di assorbire, che l’aria infuocato non riesce a dissolvere. Il tanfo di cadavere lo ingoiamo col caffè, col pane, col brodo!”
Le trincee, compatibilmente con la natura del terreno, erano state scavate quanto più possibile vicino a quelle dell’avversario: talora, la distanza tra le prime linee non superava qualche decina di metri, impedendo di fatto il tiro
ARMAMENTI E TECNOLOGIE
58
di artiglieria. I tedeschi si erano inventati particolari strutture realizzate in profondità e denominate “stollen”, dove riuscirono spesso a ricoverare e proteggere i loro soldati, durante gli intensi bombardamenti avversari prima dei grandi assalti. I ripari erano spesso insufficienti e le vedette dovevano scambiarsi i cappotti pesanti (distribuiti col contagocce) nei turni di servizio invernale - il “Trench Coat” (“cappotto da trincea”), il famoso impermeabile anglosassone, nacque proprio allora, per proteggere gli ufficiali dalle impervie condizioni atmosferiche sul fronte occidentale. Chi avesse spaziato con lo sguardo su una zona trincerata, a stento avrebbe notato segni di vita. Questa si svolgeva nel modo più attento e silenzioso dentro alla crosta terrestre. Dall’alto lo spettacolo era totalmente diverso e molto più simile ad un formicaio che a un insediamento umano.Di fronte al reticolato e alla trincea, in direzione del nemico, c’era soltanto la “terra di nessuno”, popolata dai cadaveri e dai moribondi di entrambe le parti.Questi ultimi squarciavano l’aria con grida di dolore, fino a quando non veniva tacitamente dichiarata una brevissima tregua per raccogliere morti e feriti o non sopraggiungeva la morte per sfinimento.
59
Anche se venne molto presto surclassata dall’artiglieria, per efficacia e potere offensivo, nonché dalle bombe a mano, dai mortai e dai gas venefici, tutti gli eserciti in campo continuarono ad adottare la baionetta fino al termine del conflitto - perlopiù per l’intrinseco potere di offesa squisitamente psicologico di quest’arma ormai vetusta. Molti reduci, intervistati ormai in età avanzata, hanno notevolmente ridimensionato l’immagine di un’arma tanto cruda e rozza - quanto devastante, se usata nel combattimento corpo a corporaccontando innumerevoli aneddoti su come la baionetta venisse impiegata quasi esclusivamente come un vero e proprio coltello da campeggio e niente più. Era l’ideale per abbrustolire le fette di pane sul fuoco, per aprire le lattine di carne in scatola e, vista la lunghezza, addirittura per rimestare il contenuto delle latrine o le braci di un focolare.
In pratica, la baionetta rimase un semplice coltello a lama lunga, innestabile sul fucile, improvvisato a guisa di lancia medievale per i combattimenti ravvicinati. Mentre i francesi si inventarono una lama cilindrica ad ago, ritenuta particolarmente devastante per infliggere gravi ferite ai nemici, i tedeschi introdussero la lama seghettata, quasi esclusivamente fornita e utilizzata dai genieri. Tale modifica strutturale venne pubblicizzata oltremodo e con grande sdegno dalle forze avversarie, per scopi propagandistici atti a denunciare la “brutalità” e l’inesauribile “sete di sangue” della Germania Imperiale.
Il fucile
Il fucile fu l’arma più utilizzata e preferita durante tutto il corso della Grande Guerra, nonostante le numerose innovazioni belliche, quali i numerosi tipi di granate, i gas, i carri armati, e mortai, ecc. Mentre la gran parte delle armi più potenti risultava particolarmente scomoda e poco maneggevole (si pensi alle pesanti mitragliatrici), il fucile permetteva maggior libertà d’azione offensiva e, unito alla baionetta, diventava indispensabile in occasione del combattimento corpo a corpo. Le pistole, dal canto loro, venivano distribuite soltanto agli ufficiali, pertanto il fante tradizionale si trovava sempre in compagnia del fidato moschetto, in qualsiasi situazione d’attacco o difesa. Stranamente, i modelli e le tecnologie impiegate per la produzione dei fucili
La
baionetta
60
non variarono minimamente durante tutto il corso della Grande Guerra – di contro, ogni altro tipo di arma fu soggetta a costante sperimentazioni e miglioramenti . Le prestazioni di ogni fucile, per ogni esercito, erano strettamente vincolate alla capacità dei caricatori, costituiti da semplici vaschette senza involucro esterno o contenitori estrusi da un unico blocco di metallo.
La figura del tiratore scelto, assunse grande importanza non appena la guerra di movimento lasciò spazio a quella di posizione, in trincea. Lo stillicidio giornaliero di vite, spezzate dall’implacabile grilletto dei cecchini, non avrebbe comunque mai potuto cambiare le sorti del conflitto. Ciononostante, da qualsiasi postazione o trinceramento, era facile aspettarsi il colpo ben assestato e quasi sempre infallibile dei tiratori scelti che, a volte semplicemente per noia, continuavano a cercare bersagli umani per ore ed ore. Quale miglior strumento di morte se non il fucile dunque, per accompagnare questa spietato tiro al bersaglio?
La pistola
L’avvento delle polveri da sparo senza fumo (cordite e balistite), avvenuta nel 1880, diede il via alla produzione di proiettili molto potenti, ma di dimensioni particolarmente contenute. Iniziò allora lo sviluppo del sistema di ripetizione semi-automatica, in cui l’energia cinetica del rincùlo serve per far arretrare il carrello-otturatore, che a sua volta espelle il bossolo vuoto. Contemporaneamente si riarma il cane/percussore e si introduce in canna una nuova cartuccia – tutto ciò con significativo aumento della rapidità di tiro. Molto presto apparvero le pistole moderne che sarebbero state impiegate nella Prima Guerra Mondiale, come la famosa Luger Parabellum 9mm. P08 (in Germania ne vennero fabbricate circa 2 milioni durante il conflitto, oltre alla più sofisticata Parabellum M17 ), la Colt Government 1911, la P.38 in calibro 9 parabellum e la F.N. Browning, Modello 1910 Calibro 7.65. La pistola standard dei soldati di sua Maestà britannica fu il revolver Webley Mk IV (circa 300.000 unità realizzate durante il conflitto). La Pistole Revolveur Modele 1892 (spesso ribattezzata “Lebel” o “Model d’ordonnance” ) fu invece il cavallo di battaglia dei «Poilus» francesi. L’esercito di re Alberto I del Belgio impiegò due varianti del revolver statunitense Browning, rispettivamente di 7.6mm e 9mm di calibro. L’Austria-Ungheria e la Romania adottarono la Steyer Automatic, in due
61
versioni, rispettivamente da 9mm. e 7.65mm. di calibro. L’esercito e la marina «a stelle e a strisce» utilizzò invece la Colt 0.45 (11.4mm., automatica o revolver) e il classico revolver Smith and Wesson, dotato del medesimo calibro. Quest’ultimo venne prodotto in circa 150.000 esemplari durante la Grande Guerra. L’esercito italiano adottò la Glisenti 9mm., che tuttavia non venne mai prodotta in quantità sufficienti a soddisfare l’altissima domanda. Venne quindi affiancata dal revolver Bodeo con calibro 11. e dalla Beretta 7.65mm. automatica (realizzata nel 1915). La Russia fu costretta a raccimolare qua e là armi e munizioni durante tutta la Grande Guerra, quasi sempre costretta a sottrarre armi al nemico per far fronte alla sua cronica penuria di materie prime.
La pistola, utilizzata inizialmente solo dalla cavalleria, venne in seguito concessa agli ufficiali di tutti gli eserciti, alla polizia militare, agli aviatori e ai carristi. Per questi ultimi, così come per gli equipaggi dei carri armati, la pistola si rivelò inoltre l’unica arma sufficientemente pratica, rispetto agli ingombranti fucili adottati da tutti i soldati semplici, soprattutto in relazione al modestissimo spazio vitale disponibile a bordo degli aeroplani e dei carri. Una semiautomatica F.N. Browning, Modello 1910 Calibro 7.65, fu la pistola che esplose “ufficialmente” i primi tragici colpi d’inizio della Grande Guerra: impugnata dall’anarchico insurrezionalista Gavrilo Princip, fu impiegata per freddare, a Sarajevo, il principe ereditario Francesco Ferdinando e la sua consorte Sofia.
La mitragliatrice
Regina incontrastata della Grande Guerra, anche se scelleratamente sottovalutata a oltranza dagli strateghi militari dell’epoca, la mitragliatrice pesava inizialmente fino a 60 chilogrammi ed era terribilmente ingombrante e poco pratica per gli attacchi della fanteria e della cavalleria. Per ogni pezzo, erano richiesti ben sei o sette serventi, incaricati del montaggio, del posizionamento e della costante manutenzione, oltre che dell’effettivo impiego dell’arma; inoltre, fino al termine della guerra, la mitragliatrice fu sempre soggetta al problema del rapido surriscaldamento, che ne limitò sensibilmente l’affidabilità. Durante i cinque anni del conflitto, si
62
impiegarono due tipi di raffreddamento: ad aria e ad acqua. Quest’ultimo, anche se più efficace, costringeva i serventi al pezzo a procurarsi e tenere sempre a disposizione grandi quantica d’acqua per garantire l’uso prolungato dell’arma. Era pertanto consuetudine urinare sulla mitragliatrice, una volta terminate le spesso scarsissime riserve di liquidi più consoni al suo raffreddamento – basti pensare alle aride doline del Carso o alle altrettanto aspre alture della penisola di Gallipoli! Non mancavano, infine, frequenti inceppamenti, anche nei modelli più avanzati alimentati con nastri automatici di cartucce. Per questa serie di motivi, si cercò sempre di impiegare le mitragliatrici in gruppi di unità vicine, in modo da sopperire all’improvviso malfunzionamento di ogni singolo pezzo.
Se è vero che la mitragliatrice fu per tutta la Grande Guerra un’arma prevalentemente statica, pertanto inadatta a seguire le truppe all’attacco, la tipologia stessa del grande conflitto statico di trincea ne sancì l’impiego ideale per difendere e rendere pressoché inespugnabile qualsiasi postazione. Con una capacità media di fuoco equivalente a circa 80-100 fucili, contro ogni tipo di mitragliatrice della Grande Guerra si infransero sanguinosamente tutti gli attacchi di fanteria e cavalleria, tanto arditi, quanto disperati e senza alcuna possibilità di successo. I Generali di ogni nazione belligerante, ad eccezione di quelli tedeschi, continuarono ostinatamente a mandare allo sbaraglio migliaia vite, pretendendo di contrapporre a centinaia di pallottole vomitate in ogni secondo dalle mitragliatrici, solo i coraggiosi petti dei propri fanti.
Il lanciafiamme
Questa terribile arma, che fu usata per la prima volta nel 1914-1915 dai tedeschi (adottata, ben presto, da tutte le fazioni in lotta), vanta plurisecolari origini. L’idea di lanciare sull’avversario proiettili incendiari o, più semplicemente, materiale combustibile in fiamme, risale infatti al quinto secolo avanti Cristo. Aquell’epoca, recipienti di varie fogge, riempiti con carbone o zolfo, venivano spesso catapultati contro ai nemici, a guisa di primitivi ordigni incendiari. Anche nelle battaglie navali, si adottò molto presto un analogo impiego di contenitori di terracotta, riempiti di petrolio e altre sostanze combustibili. La Germania Guglielmina fu la prima a impiegare questo terrificante strumento d’offesa (che fu quindi adottato anche da tutte
63
le fazioni in lotta): lo scienziato Richard Fielder, agli inizi del ‘900, ne inventò due modelli, battezzandoli “Flammenwerfer”. La versione più compatta e portatile, il “Kleinflammenwerfer”, poteva vomitare lingue di fuoco fino a 18 metri di distanza, mentre il “Grossflammenwerfer” necessitava di più di un operatore, offrendo una gittata quasi raddoppiata. L’esercito tedesco cercò spesso di utilizzare i lanciafiamme per terrorizzare e ripulire le prime linee avversarie, prima di lanciare le proprie fanterie all’attacco. Ben presto però, ci si rese conto dell’estrema vulnerabilità di quest’arma, che poteva facilmente sfuggire al controllo o esplodere anche a causa un ben assestato colpo di fucile. Un’arma scomoda dunque, molto pericolosa, anche se caratterizzata da un impatto psicologico devastante per il nemico.
Durante la preparazione dell’offensiva sulla Somme, nel 1916, gli inglesi approntarono quattro giganteschi lanciafiamme, del peso di circa due tonnellate cadauno, inserendoli nelle fortificazioni statiche di prima linea. L’artiglieria tedesca li mise tuttavia fuori combattimento, prima ancora che venisse lanciato l’attacco delle fanterie. Anche i francesi produssero la loro versione : si trattava del lanciafiamme Schilt, di cui la Germania copiò le notevoli innovazioni strutturali per sviluppare il suo nuovo modello Wex.
L’Italia costruì analogamente lanciafiamme portatili e da trincea. I primi furono dati quasi esclusivamente agli Arditi, mentre quelli statici (modello Herzent- Thirion) vennero impiegati in ricoveri blindati per scopi prettamente difensivi. Dai dati in nostro possesso, risulta che durante la Prima Guerra Mondiale i tedeschi lanciarono più di 650 attacchi supportati dai lanciafiamme, mentre non esistono dati per le altre nazioni belligeranti.
La bomba a mano L’arma impiegata per eccellenza negli gli assalti era proprio la granata o la bomba a mano. Baionette e fucili infatti, servivano quasi esclusivamente per proteggere i granatieri, almeno nelle prime fasi dell’attacco. Anche dopo un attacco vittorioso, i granatieri erano soliti ripulire i tortuosi tracciati delle trincee appena conquistate, impiegando notevoli quantità di ordigni esplosivi da lancio.
64
All’inizio della Prima Guerra Mondiale, la Germania poteva già disporre di circa 70.000 bombe a mano, e di 106.000 esemplari specificatamente realizzati per essere lanciati con il fucile. Le più note erano la Stielhandgranate (con l’impugnatura a bastoncino), la “Diskushandgranate” (a forma piatta), la “Eierhandgranate” (senza impugnatura) e la “Kugelhandgranate” (a forma sferica). I tedeschi si munirono anche di granate caricate con gas e composti chimici aggressivi.
Per affrontare la supremazia tedesca, dopo solo un anno di guerra gli inglesi si trovarono costretti a produrre quasi 250.000 bombe a mano alla settimana! La produzione industriale di granate sarebbe comunque continuata a crescere in modo esponenziale e, fino al termine del 1916, i “Tommies” di sua Maestà britannica dovettero comunque integrare le loro dotazioni standard con granate artigianali, realizzate con le lattine delle loro razioni.
Mentre le granate da lancio (con il fucile) vennero quasi subito abbandonate dai tedeschi, gli alleati dell’Intesa ne svilupparono versioni sempre più affidabili, le cosiddette “Cup Grenades”. Nel 1915, l’esercito inglese ricevette le bombe a mano Mills, efficaci, affidabili e dotate di pratico un rivestimento impermeabile. Nel corso della Grande Guerra ne vennero lanciate più di 70.000.
65
mazza ferrata
Questo antico strumento di barbarie medievale venne rispolverato durante la Grande Guerra e dunque impiegato soprattutto nei combattimenti corpo a corpo o per dare il colpo di grazia ai nemici feriti. Nelle trincee di tutta Europa, i soldati di ogni fazione impiegavano martelli, vanghe, coltelli e persino i classici «tirapugni» in ferro, ma l’avvento delle mazze ferrate si registrò in concomitanza con i primi lanci di gas letali. Del resto, già nella guerra Anglo-Boera in Sud Africa (1899-1902), gli Inglesi avevano già usato mazze di legno con borchie di ferro – le “Knob Kerri” - che vennero chiaramente adottate anche sul Fronte Occidentale del 1914-1918.
Tra i soldati che si arrendevano durante un attacco, chi veniva trovato in possesso di mazze ferrate veniva ucciso immediatamente. Lo stesso accadeva anche per tutti coloro che portavano alla cintura coltelli con la lama seghettata o analoghi artifici analogamente poco “cavallereschi” e particolarmente brutali.
Anche gli Italiani molto presto adottarono questo tipo di arma, tuttavia in modo meno generalizzato. Del resto fu il pugnale la vera peculiarità degli assaltatori italiani: un’arma che venne usata con estrema perizia dagli Arditi, unitamente alle bombe a mano.
La corazza
La corazza, un tragico paludamento di chiara memoria medievale, era la protezione prediletta dei fanti incaricati di spingersi, nottetempo, fino alle trincee nemiche e cercare di aprire varchi nei reticolati, impiegando cesoie o tubi di materiale esplosivo. Fu, in sostanza, una delle tante protezioni sperimentate nel corso della Prima Guerra Mondiale, per cercare di contrastare efficacemente il fuoco nemico. La corazza standard pesava circa dieci chilogrammi ed era costituita da un piastrone trapezoidale formato da più stradi di acciaio al cromo nichel, che raggiungevano uno spessore totale di circa sei millimetri. Paraspalle ed eventuali, analoghe protezioni per il ventre, potevano essere aggiunte al pezzo centrale della corazza, impiegando lamine metalliche di raccordo e bretelle in cuoio. Internamente, il pezzo
La
66
centrale della corazza era dotato di due bracciali, che ne avrebbero eventualmente permesso l’utilizzo anche a guisa di scudo. Con l’avvento delle bombarde e dei mortai da trincea, le compagnie tagliafili vennero impiegate sempre meno, relegando le corazze ad un più generico impiego come protezione per i franchi tiratori e le sentinelle, all’interno delle trincee.
I mortai e le bombarde
I campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale furono perennemente ricoperti da barriere di filo spinato e complesse, anche se temporanee, fortificazioni campali di ogni genere e tipo. Ogni singolo metro quadro del fronte venne costellato di trincee, ricoveri, osservatori, piazzuole d’artiglieria, ecc.
Mitragliatrici e trinceramenti ebbero un nefasto impatto sullo svolgersi della guerra, fino ad allora intesa come scontro di movimento, ma ora costretta a un costante stillicidio di vite umane, rintanate perennemente come topi nel fango ed esposte non solo alle frequenti tempeste d’artiglieria, ma anche a tutte le bizzarrie atmosferiche. Nella nuova guerra di logoramento e di posizione si dovettero studiare molteplici e bizzarri sistemi di tipo statico, per eliminare il nemico e, soprattutto, tutto ciò che lo proteggeva, al di là della «terra di nessuno».
L’invenzione più efficace, fu probabilmente la cosiddetta bombarda o mortaio da trincea. Una specie di mortaio, capace di lanciare potenti cariche esplosive a breve distanza. Molteplici tipi di proiettili, caricati spesso anche con gas venefici, potevano dunque essere lanciati contro le trincee avversarie, con effetti localizzati, ma senza dubbio devastanti. Le bombarde, come vennero quasi subito ribattezzati i mortai da trincea, conobbero una larga diffusione in ogni esercito e vennero presto affiancate anche dalla versione più leggera e portatile, in dotazione alla fanteria.
I tedeschi fecero uso del Minenwerfer, un esemplare che misurava inizialmente 25 centimetri di diametro (calibro) e pesava ben 95 chilogrammi. Vennero in seguito prodotti su scala industriale altri due modelli, rispettivamente con calibri da 17 cm. e 7,6 cm. L’Inghilterra, dal canto
67
suo,realizzò forse la versione più efficace e famosa di tutta la Grande Guerra: il mortaio Stokes. Quest’arma era in grado di sparare 22 proiettili al minuto con una gittata massima di circa un chilometro. Quasi contemporaneamente gli inglesi svilupparono anche un modello più pesante, i cui proiettili di 24 cm. di calibro vennero soprannominati «Maiali volanti». Il mortaio Stokes venne adottato anche dall’esercito francese, che congiuntamente agli alleati d’oltre Manica, continuò a perfezionarlo fino al termine della Prima Guerra Mondiale.
Un altro famoso tipo di mortaio in dotazione alle forze dell’Intesa era il Vickers da 1.75 pollici (circa 5 centimetri di calibro), ribattezzato “mortaio delle mele candite” (“toffee apple”). I suoi proiettili ricordavano infatti dei dolcetti dell’epoca, ottenuti caramellando una mela infilzata su uno spiedino. Il più famoso mortaio da trincea del nostro esercito fu certamente il Bettica. Considerando la sua estrema maneggevolezza, si dimostrò uno strumento di offesa particolarmente valido. Fu prodotto in alcuni modelli con calibri differenti, da 38 a 60 centimetri. Anche l’insolito mortaio Minucciani veniva impiegato dell’esercito italiano durante la Grande Guerra. Simile ai lanciapalle da tennis automatici dei nostri giorni, veniva caricato con un ordigno discoidale, offrendo una modesta gittata di circa 200 metri.
I carri armati
Non esiste nessun singolo inventore al quale poter riconoscere l’ideazione del carro armato. Aben vedere infatti, l’idea generica di un simile mezzo bellico risale addirittura al 18esimo secolo. Una lunga serie di esperimenti, astrusi prototipi e ardite sperimentazioni vennero infine riscoperte e riunite in un unico, concreto progetto, dall’esercito inglese (con l’insolita supervisione della marina militare britannica): per necessità si cercava infatti, disperatamente, l’arma segreta per uscire dalle trincee e schiacciare il nemico. Ribattezzato, per motivi di segretezza “Tank”, il primo prototipo di carro armato fu la naturale evoluzione dei veicoli militari blindati, già presenti in numerosi esemplari e modelli su tutto il Fronte Occidentale, sin dall’inizio delle ostilità. Là dove un normale autoblindo si fermava (terreno
68
estremamente inagibile e fangoso, trincee, scavi, particolari asperità del terreno, ecc.), sarebbe subentrato il nuovo, rivoluzionario mezzo da combattimento. Anche se il nemico fu colto di sorpresa e fuggì a gambe levate di fronte a questi mostri meccanici, l’esercito inglese si rese subito conto della notevole mancanza di affidabilità e controllo di questa nuova arma. In particolare, a causa della fretta con cui vennero mandati allo sbaraglio, quasi tutti i primi carri armati si impantanarono, caddero dentro alle trincee o, in generale, ruppero il motore, sollecitato oltremodo durante il combattimento. Inoltre, il calore prodotto all’interno dell’abitacolo risultò letale per l’equipaggio dei carri, così come i gas di scarico per i quali non era stato previsto alcun valido sistema di smaltimento. Solo l’eroismo e l’abnegazione dei primi carristi riuscì ad aver ragione di queste gravi lacune strutturali durante le prime sperimentazioni in battaglia. Il successo ottenuto in numerosi scontri seguenti riuscì comunque a far riacquistare la fiducia necessaria nell’ulteriore impiego e sviluppo dei carri armati, al punto che anche l’America, la Germania Guglielmina e molte altre nazioni belligeranti iniziarono seriamente le propria sperimentazione.
I gas
Come sappiamo, nel corso della Prima Guerra Mondiale si rispolverarono anche strumenti d’offesa impiegati nei secoli precedenti, ma ormai abbandonati, spesso a causa dell’estrema barbarie con la quale erano stati inventati e utilizzati. Già nel 1640, ad esempio, i Turchi avevano utilizzato proiettili fumogeni, caricati con olio di trementina, acido nitrico e paglia bagnata. Durante la Guerra di Crimea (1853-1856), in occasione dell’assedio di Sebastopoli, gli alleati europei si erano serviti di proiettili caricati contenenti ossido di caolite e derivati arsenicali, miscelati con zolfo bruciato, per creare gas e fumi tossici. Infine, durante la Guerra Franco-Prussiana del 1870, furono impiegati analoghi ordigni esplosivi, caricati con sostanze lacrimogene e starnutatorie. Si può dunque affermare che in varie epoche storiche antecedenti al primo ventennio del secolo scorso, si faceva già uso di armi chimiche, anche se le conoscenze scientifiche relative non furono mai in grado di sviluppare ulteriormente, perfenzionandolo, questo disumano
69
strumento d’offesa. A partire dagli ultimi decenni del 1800 e l’inizio del 1900 tuttavia, la sperimentazione e l’industria chimica furono in grado di fornire prodotti dalle straordinarie capacità, indispensabili al progresso tecnologico dell’umanità. Sintetizzate spesso per esclusivo impiego civile, molte sostanze rivelarono proprietà tossiche ben superiori ai prodotti normalmente usati in chimica industriale o come veleni per altri scopi ed applicazioni. Per esempio il gas Fosgene, impiegato sui campi di battaglia del 1914-1918, era già stato sintetizzato dall’inglese John Davy nel 1812, unendo cloro e ossido di carbonio utilizzati normalmente per la preparazione di vernici e la colorazione dei tessuti.
Anche il terribile gas “Iprite” (solfuro dicloroetile – ribattezzato dal nome di Ypres, dove fu impiegato per la prima volta), con terrificanti capacità aggressive e vescicatorie, era già stato ottenuto dal chimico inglese Guthrie nel 1860. Il cloro, che fu tra i primi tipi di gas impiegati a scopi offensivi durante la Grande Guerra, veniva già impiegato dal 1910 per la creazione di vernici e medicinali in Germania. In Europa dunque, la produzione di sostanze aggressive, con opportune modifiche, poteva raggiungere livelli di produzione giornaliera enormi, ottenendo così subito quantità notevoli di armi chimiche adatte all’impiego bellico. Durante il Primo Conflitto Mondiale, si giunse molto presto ad impiegare sostanze chimiche di tipo gassoso a scopi offensivi e, in particolare, non appena ci si rese conto di non poter riprendere la guerra di movimento, con tutti gli eserciti impantanati nelle trincee in trincea e senza disporre di altre armi più convenzionali ed efficaci. Contrariamente a quanto narrano viene molti storici contemporanei, non furono i tedeschi, bensì i francesi ad impiegare per primi i gas durante la Grande Guerra. Proprio sul finire del 1914 infatti, gli uomini di Joseph Joffre esplosero alcune cariche di gas lacrimogeno ai danni delle truppe tedesche in marcia verso Parigi. Si trattò tuttavia di un fatto decisamente casuale, al quale la Francia non diede alcun seguito in termini di ulteriore sperimentazione. Questa tragica eredità venne, al contrario, subito raccolta dalla Germania Guglielmina, che iniziò prontamente a studiare questo nuovo e subdolo strumento di offesa, sviluppandone – come abbiamo visto – versioni ben più letali e aggressive. Già durante l’assalto e la successiva conquista di Neuve Chapelle, nell’ottobre del 1914, i tedeschi lanciarono gas starnutente all’indirizzo del nemico e tre mesi dopo, nel gennaio 1915, analoghe sostanze irritanti fecero la loro comparsa sul Fronte Orientale, ai danni dell’esercito russo. Tuttavia, in quest’ultima circostanza, il gas non riuscì a vaporizzarsi
70
completamente a causa della temperatura troppo rigida. Si iniziò allora a capire che l’impiego effettivo di questa nuova arma era inscindibilmente legato alle condizioni atmosferiche (temperatura, umidità relativa, forza e direzione del vento, ecc.). Dopo il debutto ufficiale di questa nuova arma, avvenuto il 22 Aprile del 1915 a Ypres per mano degli uomini del Kaiser, tutti gli altri eserciti in lotta la aggiunsero al proprio arsenale. Gli inglesi furono i primi a restituire la tragica pariglia: la sera del 24 settembre 1915, circa quattrocento “proiettori” lanciagas erano pronti a vomitare una densa nube di cloro sulle trincee tedesche di Loos. L’attacco avvenne alle prime luci dell’alba del giorno seguente, con risultati a dir poco catastrofici: il vento contrario o non abbastanza forte, fece ristagnare gran parte del gas a ridosso delle linee inglesi. Anche in questa occasione le condizioni metereologiche intervennero direttamente sulla riuscita dell’attacco con i gas. Da quel momento in poi fu tutto un susseguirsi di ulteriori esperimenti e messa a punto di nuovi sistemi di lancio e dispersione di gas sempre più letali, per arrivare al terrificante “Gas Mostarda” o “Iprite”, introdotto dai tedeschi durante la battaglia di Riga, sul Fronte Orientale, nel settembre del 1917. Questo gas, oltre ad avere effetti vescicanti di inaudita potenza, ristagnava sulle divise, sull’intero campo di battaglia e persino nel sottosuolo, aumentando la sua potenzialità d’offesa per settimane e settimane. Italia e Austria-Ungheria non furono da meno nell’impiego di sostanze chimiche aggressive. Basti pensare allo sfondamento di Caporetto, riuscito in gran parte per merito di circa duemila proiettili caricati con Fosgene e lanciati contro gli ignari soldati italiani, nella conca di Plezzo, all’alba del 24 ottobre 1917. Quella notte, gli italiani non immaginavano che il nemico avesse deciso di farli morire così vigliaccamente. Acausa dell’umidità, le foglie ingiallite cominciavano già a cadere e il tanfo della putredine pervadeva ogni cosa. Somigliava all’odore delle bianche nuvole di gas che ricoprirono in pochi istanti l’intera conca di Plezzo. I soldati italiani respirarono solo una volta quel gas, che forse odorava di foglie morte e di erba marcia, ignorando la loro fine imminente! E’utile sottolineare che tutti i belligeranti del Primo Conflitto Mondiale impiegarono prodotti gassosi anche per creare semplicemente cortine fumogene e incendiarie. Questi prodotti risultarono spesso complementari dei gas velenosi, ogniqualvolta ci fu la necessità di creare confusione tra le file nemiche, accecare temporaneamente gli osservatori e creare una protezione per far avanzare truppe d’assalto, rese virtualmente “invisibili”. Nel saliente di Ypres ad esempio, gli inglesi adottarono proiettili caricati al fosforo, con notevoli effetti incendiari e un
71
fumo particolarmente denso in grado di mascherare i loro movimenti. Per uso prettamente offensivo, invece, tre distinte categore di sostanze aggressive vennero impiegate da tutti i belligeranti: gas volatili (molto tossici, ma estremamente fugaci, per permettere agli attaccanti di manovrare in profondità - Cloro, Fosgene, Bromo), gas persistenti (per inibire al nemico l’accesso a particolari zone campo di battaglia - Iprite, cloruri, bromuri) e gas molto persistenti (per rendere interi tratti del fronte completamente inagibili, per giorni e giorni (Iprite, Binitrobenzolo, prodotti fumogeni e nebbiogeni). I gas furono considerati una vera e propria arma segreta, anche dopo la loro ufficiale introduzione sui campi di battaglia del 1915.
Le Armi Batteriologiche
Numerose prove dimostrano che gli scienziati del Kaiser Guglielmo II° abbiano sviluppato un ambizioso programma di guerra batteriologica, sin dal 1914. La storia ufficiale non ne fa menzione, ma è sicuramente legittimo supporre che la nazione che diede alla luce gran parte delle moderne scienze microbiologiche, abbia almeno studiato tale possibilità di offesa.
Nel 1915, il Dottor Anton Dilger, oriundo tedesco, fu accusato di aver coltivato in casa sua, a Washington D.C., il bacillo dell’Antrace (Bacillus Anthracis) e del Cimurro (Pseudomonas Mallei) forniti dallo stesso governo del suo Paese. I bacilli sarebbero poi stati consegnati ad alcuni portuali di Baltimora, per inocularli a migliaia capi di bestiame (soprattutto cavalli, muli e bovini) destinati al fronte europeo (gli U.S.A., anche prima di entrare in guerra, rifornivano ufficiosamente e lucrativamente le forze dell’Intesa). Pare che anche qualche centinaio di soldati, esposti al contagio, caddero vittima di questa letale arma biologica. Dilger lasciò in eredità al suo governo i suoi complessi e approfonditi studi sulle armi biologiche, nonché molte raffinate tecniche di inoculazione sugli animali – sul finire della guerra, Antrace e Cimurro venivano addirittura nascosti in microfiale dentro alle zollette di zucchero per i quadrupedi. In particolare, vennero registrati casi di infezione di Antrace ai danni di molti cavalli venduti all’esercito francese dalla Spagna e dal Portogallo, nonché dall’Argentina, analogamente estranea al Primo Confitto Mondiale. Infine, i tedeschi provarono anche a diffondere il colera
72
in Italia, la peste a San Pietroburgo e lanciarono bombe “infette” sulla Gran Bretagna. Anche se non esistono prove di alcun genere, viene spontaneo chiedersi se lo stesso virus di influenza “Spagnola”, che decimò la popolazione europea sopravvissuta alla Grande Guerra nel 1918, non fu in realtà lo zenith raggiunto all’epoca delle letali manipolazioni microbiologiche delle Potenze Centrali.
All’inizio del Primo Conflitto Mondiale, il neonato aeroplano venne utilizzato soprattutto per la ricognizione, per controllare gli spostamenti delle truppe e per individuare linee di rifornimento; i primi caccia furono utilizzati come supporto agli aerei destinati alla ricognizione, che rimaneva lo scopo principale dell’aviazione militare. Solamente più tardi, ci si accorse che questo tipo di arma poteva anche essere usato per arrecare danno al nemico e disturbarne i movimenti, oltre che per controllarlo. Gli scontri aerei divennero sempre più frequenti e cominciarono a distinguersi i piloti migliori che presto entrarono nell’immaginario collettivo come degli eroi o, addirittura, come dei nuovi, romantici cavalieri. Del resto, lo stesso impiego dei primi prototipi di paracadute non era consentito ai piloti, ma solo agli osservatori che salivano in cielo a bordo dei palloni aerostatici. Potersi salvare, abbandonando il proprio aereo, non era considerato “cavalleresco” e leale nei confronti dell’avversario! I primi anni della guerra videro il netto predominio dell’aviazione tedesca su quella francese e inglese; la superiorità tecnica degli aerei tedeschi (realizzati grazie all’altissimo ingegno dell’olandese Antony Fokker) e la grande abilità dei suoi piloti, le garantirono la supremazia dei cieli, che sarebbe durata fino alla seconda metà del 1917. Con la comparsa degli S.P.A.D. francesi e dei Camel inglesi, l’aeronautica militare degli Alleati riuscì finalmente a spezzare il giogo tedesco che l’aveva costretta a subire gravissime e continue perdite, come nell’”Aprile di sangue” del 1917 (quando la vita media di un pilota era di circa 17 ore e l’aviazione alleata toccò il suo punto più basso di rendimento durante la guerra). I tedeschi furono anche i primi a inventare un sistema di sincronizzazione che permetteva di sparare senza timore che le pallottole distruggessero le pale dell’elica. Aquei tempi infatti, la mitragliatrice era posta sull’ala superiore o sulla fusoliera dei velivoli, dietro al motore. Nel
L’Aviazione della Prima Guerra Mondiale
73
primo caso il pilota era addirittura costretto ad alzarsi in piedi, manovrando la cloche con le gambe, per poter sparare qualche colpo a casaccio. Manfred von Ricthofen, passato alla storia come il leggendario “il Barone Rosso”, fu tra i primi a creare unità indipendenti, le “Jagdgeschwader”, che potevano essere riposizionate tatticamente in completa autonomia per servire più di un tratto di fronte. La stessa squadriglia Lafayette, prima di essere assorbita dall’aviazione francese, svolse un compito analogo, distinguendosi nei cieli di Verdun, così come su quelli della Somme. Ben presto ci si rese conto dell’estrema potenzialità degli aerei anche come strumento di disturbo e distruzione di massa, una volta dotati di corposo munizionamento da sganciare direttamente sulle linee avversarie. Comparvero i primi bombardieri che riuscirono persino a spaventare i londinesi, sulla scia delle incursioni dei famosi dirigibili Zeppelin. La prima difesa antiaerea era costituita da alcuni fucilieri appostati sui tetti delle case o da batterie antiquate e poco adatte al tiro contraereo. Tuttavia lo sviluppo di sofisticati strumenti di difesa contraerea non raggiunse mai un’efficacia analoga a quella della loro controparte volante, per tutto il corso della Guerra. Ci furono, ad esempio, casi eclatanti di rozza improvvisazione ancora nel 1918, quando, secondo alcune fonti ufficiali, un semplice fante australiano riuscì ad abbattere il mitico Barone Rosso, a colpi di fucile da una trincea!
La Marina Militare della Prima Guerra Mondiale Paragonata agli intensi e complessi scontri della Seconda Guerra Mondiale, la cosiddetta “Grande Guerra” del 1914-1918 si presentò come una specie di “prova generale”, nell’ambito dei combattimenti in mare aperto. Nell’agosto 1914, era opinione comune che tra le unità da battaglia inglesi e tedesche si sarebbe arrivati ad uno scontro senza precedenti nel mare del nord. Una volta conquistato il controllo, la marina britannica avrebbe potuto distruggere la flotta mercantile della Germania, costringendola alla resa a causa dell’Embargo. Gli inglesi tuttavia sarebbero rimasti delusi. Le strategie della loro flotta garantivano e miravano ad una seconda Trafalgar. La marina da guerra tedesca era numericamente inferiore a quella dell’avversario e per questo motivo i tedeschi evitarono accuratamente i grandi scontri, cercando invece di attirare gruppi di unità isolati nel mare del Nord per distruggerli
74
poco alla volta. Condussero pertanto una serie di azioni di disturbo lungo le coste occidentali dell’Inghilterra. Dal canto suo, l’Ammiraglio Jellicoe, comandante in campo della Royal Navy britannica, invece di cercare lo scontro diretto, adottò una strategia di blocco a distanza; un atteggiamento cauto ma efficace.
Anche la presenza di unità tedesche impiegate nella guerra “corsara” era un pericolo per le navi alleate in navigazione nell’oceano Indiano. In particolare, l’incrociatore Emden operò con notevole efficacia affondando 16 mercantili per un totale di 71.000 tonnellate, fino a quando il 9 novembre 1915 fu messo fuori combattimento dall’incrociatore australiano Sidney alle isole Cocos.
La squadra navale tedesca dell’ammiraglio von Spee, salpata da Tsingtao, in Cina, prima dello scoppio delle ostilità, ebbe anch’essa un breve periodo di supremazia nell’oceano Pacifico, distruggendo la squadra di incrociatori dell’ammiraglio inglese Cradock a Coronel, al largo delle coste cilene, il 10 novembre del 1915. La risposta della Royal Navy fu rapida. Una potente formazione navale sorprese von Spee nelle acque delle Falkland e mise fine per sempre alle sue scorribande corsare.
Le unità germaniche avrebbero inevitabilmente dovuto soccombere nelle zone in cui operavano, vista la presenza delle basi inglesi lungo le rotte principali utilizzate dai tedeschi. Essi non poterono nè rafforzarsi nè tornare a casa, a causa del suddetto Embargo. Se Kriegsmarine tedesca fosse riuscita ad aprirsi uno sbocco nell’Oceano Atlantico, tutte le rotte commerciali degli Alleati sarebbero state interrotte, con disastrose ed irreversibili conseguenze. Inoltre, la stessa identica minaccia fu costantemente concretizzata dai micidiali sommergibili tedeschi che, per quasi tutta la durata del conflitto, furono liberi di silurare qualsiasi vascello straniero incontrassero sulla loro rotta.
Dopo la firma del patto di Londra nell’aprile 1915, l’Italia stipulò con l’Intesa la Convenzione Navale di Parigi, in cui fu definita la collaborazione tra le flotte italiana, francese e inglese, con particolare attenzione al teatro di guerra dell’Adriatico. La marina italiana, alla cui guida era stato posto l’ammiraglio Paolo Thaon di Revel aveva le principali basi navali a Venezia e Brindisi, ma tra questi due punti la costa presentava fondali bassi ed era quasi priva di ripari naturali e di approdi difendibili, con la parziale eccezione di Ancona. Il grosso della flotta era concentrato a Taranto.
75
Gli austro-ungarici dall’arsenale di Pola potevano spostarsi al riparo delle isole della Dalmazia a Zara, Sebenico e Cattaro, fra l’altro base d’appoggio dei sommergibili tedeschi. In tal modo, in poche ore di navigazione erano in grado di attaccare dove volevano la costa italiana, lungo la quale correva sia la ferrovia sia la strada litoranea. Le forze navali italiane e alleate furono distribuite fra le varie basi, concentrando a Brindisi unità pesanti e sottili per assicurare il blocco del canale d’Otranto e impedire il passaggio di unità di superficie e subacquee degli Imperi Centrali verso lo Jonio e il Mediterraneo, e viceversa.
Gli impegni bellici navali delle principali Nazioni coinvolte nella Prima Guerra Mondiale furono i seguenti:
Mare del Nord: Marina Militare Tedesca contro Marina Militare Inglese
Mar Baltico: Marina Militare Russa contro Marina Militare Tedesca
Mare Adriatico: Marina Militare Austriaca contro Marina Militare Francese, Italiana e Inglese
Mare Egeo e Mar Nero: Marina Militare Tedesca/Turca contro Marina Militare Francese e Inglese
76
LA FINE DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE
La fine della Prima Guerra Mondiale lasciò irrisolti gravissimi problemi, che avrebbero gettato le basi del conflitto globale successivo. Gran parte degli Stati europei si erano ormai fortemente indebitati con gli Stati Uniti – in particolare, Gran Bretagna, Francia, Italia, Russia, Romania, Grecia e Cecoslovacchia avevano ottenuto prestiti in denaro durante il corso del conflitto, mentre Austria, Ungheria, Yugoslavia, Armenia, Polonia, Estonia, Lituania e Finlandia avevano impiegato fondi statunitensi per la ricostruzione, dal 1919 al 1925. I debiti di guerra sarebbero stati pagati agli Stati Uniti nel corso di ben 62 anni successivi al termine del conflitto. L’Armenia tuttavia, non si costituì come realtà nazionale, pertanto non saldò mai il suo debito con l’America. L’unica nazione che riuscì ad estinguere completamente il suo debito, fu la Finlandia nel 1969. Nel 1925 gli Stati Uniti cancellarono l’80% del debito italiano e l’anno successivo il 60% di quello francese. Il governo bolscevico russo non volle mai riconoscere i debiti contratti dal precedente regime Zarista.
Secondo le statistiche ufficiali, le vittime (tra i militari) della Prima Guerra Mondiale furono 37.494.186. Si parla di 8.538.315 morti, 21.219.452 feriti e 7.750.919 tra prigionieri e dispersi (il 57,6% degli uomini mobilitati, che furono 65.038.810). Sempre secondo le cifre ufficiali, il conflitto provocò almeno 680.000 morti tra i combattenti italiani.
La mancata vittoria completa ai danni delle Potenze Centrali, compromise, sin dall’inizio, la stesura del Trattato di Versailles. Avendo combattuto così a lungo per ottenere la resa incondizionata del nemico, la fine della guerra sancita da una semplice serie di armistizi, portò ad un trattato di pace tanto precario, quanto instabile per tutte le fazioni in causa. Gli Stati Uniti d’America si svincolarono subito dagli impegni sottoscritti in precedenza, con la seguente motivazione: nessun trattato che non fosse stato avvallato da quella che, nel frattempo, era diventata una potenza mondiale di prima
77
grandezza, avrebbe potuto rivelarsi efficace. Due grandi potenze europee e mondiali (la Germania e la Russia) erano temporaneamente escluse dai giochi di potere internazionali – entrambe si dovettero accontentare di un semplice ruolo di spettatrici alla stesura del trattato. Non appena almeno una di queste due nazioni fosse rientrata in gioco, qualsiasi di pace appoggiato solo dalla Gran Bretagna e dalla Francia (anche l’Italia si era dichiarata insoddisfatta e aveva analogamente abbandonato il tavolo delle trattative), non sarebbe potuto durare a lungo. Fu dunque un’imperdonabile leggerezza non considerare che, prima o poi, Germania e Russia, sarebbero prepotentemente riapparse sullo scacchiere internazionale. Infine, il debito imposto alla Germania per la ricostruzione e i danni causati dalla guerra, si rivelò tanto astronomico, quanto inverosimile, al punto da costringere, in qualche modo, i vinti a covare ulteriore odio e sete di vendetta e di rivalsa.
La maggior parte degli uomini che combatterono nel Primo Conflitto Mondiale, maturò un convinto odio per la guerra. Molti di loro tuttavia, soprattutto chi era riuscito a portare a casa la “ghirba”, realizzarono di aver sfidato e vinto una miriade di possibili morti atroci, provando così un fortissimo sentimento di selvaggia superiorità. Adolf Hitler fu uno di questi uomini, dominati dall’odio e dallo sprezzo per tutto ciò e tutti coloro che non avevano fatto parte della tremenda “esperienza formativa” del conflitto, vissuto in prima linea. Lo stesso Paolo Monelli e moltissimi altri protagonisti del conflitto, aveva intuito la pericolosità e gli effetti nefasti del ruolo di “assassini professionisti”, imposto così a lungo alle migliaia di combattenti. Certamente anche la reazione diametralmente opposta a questo comportamento autoritario e nichilista, dava luogo a conseguenze ugualmente negative. Dopo la guerra, i politici di tutto il mondo si resero conto che bagni di sangue come quelli del 1914-1918 non sarebbero stati più tollerati dai loro elettori. La strategia postbellica della Francia e dell’Inghilterra, si basò proprio su questo presupposto. Ciò aiutò i tedeschi a vincere, nel 1940, l’offensiva a ovest contro la Francia e contro l’Inghilterra, che volevano evitare a tutti i costi di impegnarsi in quel tipo di “guerra di materiali” che aveva decimato le proprie genti un ventennio prima. Non a caso, la Francia si piegò ad una sbilanciatissima pseudo-alleanza con i nazisti, formando la Repubblica di Vichy, sostanzialmente asservita alle decisioni di Hitler. Infine, vale la pena citare, ancora una volta, le parole del filosofo Eric Hobsbawm, che conclude “L’epoca della guerra totale”: “Guardando indietro, ai trentun anni che vanno dall’assassinio dell’arciduca d’Austria a Sarajevo fino alla
78
resa incondizionata del Giappone, si deve considerarli come un’epoca di strage rovinosa, paragonabile alla guerra dei trent’anni nella storia tedesca del Seicento.”
La Prima Guerra Mondiale non risolse nulla. Le speranze che essa generò furono subito deluse. Il passato era irrevocabile, il futuro era rimandato, il presente era particolarmente amaro. La Seconda Guerra Mondiale offì, invece, delle soluzioni sostenibili, almeno per alcuni decenni a venire. I drammatici problemi sociali ed economici che avevano afflitto il capitalismo, nella precedente “età della catastrofe” parvero scomparire. L’economia del mondo occidentale entrò in una fase particolarmente proficua; le democrazie politiche occidentali, sostenute da uno straordinario miglioramento delle condizioni materiali di vita, rimasero stabili; la guerra venne confinata alle aree del Terzo Mondo.
79
Il primo colpo esploso sul fronte italiano
Benché la data ufficiale dell’inizio delle ostilità tra Italia e Austria-Ungheria corrisponda al 24 maggio, 1915, esistono testimonianze che potrebbero indurci ad anticipare il fatidico evento. Nel pomeriggio del 23 maggio 1915, la motobarca che portava la comunicazione dello stato di guerra al distaccamento di Foce Aussa fu fatta segno a tiri dalla dogana austriaca di Porto Buso. Ma la tradizione vuole che il primo colpo di fucile della “Grande Guerra” sia stato sparato alle 22:40 dello stesso giorno, dal Finanziere Pietro Dall’Acqua, nei pressi di Cormons. L’Alpino Massimiliano Grendene invece, racconta che: “Il 23 Maggio 1915, alle 11 di notte, improvvisamente si sentirono colpi di cannone. Ebbi il presentimento che fosse giunta l’ora amara”.
I Pidocchi e le “Chat-Line”
Il “passatempo” preferito dei soldati in trincea, tra un combattimento e l’altro, era quello di spidocchiarsi, inventando sempre nuovi modi per cuocere, friggere o bruciare gli odiosi parassiti. Il fatto di conversare e chiacchierare amabilmente tra commilitoni (in inglese “to Chat”), impegnati a distruggere i parassiti, divenne dunque sinonimo di entrambe le attività, inscindibilmente unite.
Un fiammifero può costare la vita
Chi fuma sa che accendere più di due sigarette con lo stesso fiammifero porterebbe sfortuna. Ma potrebbe addirittura far perdere la vita! Ciò accadrebbe tuttavia, solo se vi trovaste in una trincea della “Grande Guerra” dove, l’accensione del fiammifero richiamerebbe l’attenzione di un eventuale cecchino, la seconda sigaretta accesa gli permetterebbe di inquadrarvi bene nel mirino e la terza gli darebbe il tempo di premere il grilletto senza rischio di sbagliare!
Tom & Jerry
I simpatici personaggi di una serie di cartoni animati tra le più rinomate nel
CURIOSITÀ SULLAPRIMAGUERRAMONDIALE
80
mondo, sono stati così battezzati e caratterizzati proprio in seguito alla “Grande Guerra”. Il fante inglese era soprannominato, infatti, “Tommy”, mentre il suo acerrimo nemico tedesco, al di là della terra di nessuno, “Jerry”. Frullatori o cannoni?
La tedesca Krupp, così come la Skoda e la Fiat, modificò le proprie attività industriali per la produzione in massa di armi e munizioni durante la Prima Guerra Mondiale. In particolare, la Krupp e l’austriaca Skoda furono in grado di produrre i famosi obici di grosso calibro (420mm. e 305mm. rispettivamente), impiegati con grande successo per abbattere la spessa muratura dei forti Belgi, Francesi e Italiani.
81
cavallino rampante di Francesco Baracca
Fu proprio Francesco Baracca, l’asso dei cieli italiano durante la Prima Guerra Mondiale, a scegliere, per primo, come proprio simbolo il famoso cavallino rampante. Enzo Ferrari racconta che, durante un incontro con la madre dell’eroico aviatore caduto sul Montello, fu proprio quest’ultima a suggerirgli di mettere sulle sue autovetture da corsa il simbolo scelto dal figlio durante la guerra.
In taxi al fronte
Nel 1914, durante la mobilitazione generale, l’esercito francese si trovò a corto di mezzi per trasportare tutti i soldati al fronte e arrestare in tempo l’avanzata tedesca. Furono dunque “reclutati” tutti i conduttori di auto pubbliche di Parigi che, animati da puro spirito patriottico, effettuarono innumerevoli viaggi al fronte senza far funzionare il tassametro! Analogamente, gli inglesi contribuirono a risolvere lo stesso problema, utilizzando i famosi “Double Decker”, gli autobus due piani londinesi.
Angeli in guerra
Nell’agosto del 1915, l’esercito inglese si precipitò in Belgio per bloccare l’avanzata tedesca verso Parigi. I “Tommies” britannici subirono gravissime perdite durante la battaglia della Marna, nella località di Mons, e i pochi superstiti dissero di essersi salvati grazie a una specie d’intervento divino. Sembra, infatti, che durante la ritirata, fossero apparsi degli angeli, vestiti come arcieri medievali, che impedirono un successivo inseguimento da parte del nemico.
Volete burro o... granate?
Sulle alture di Pozieres, sul Fronte Occidentale, nella notte del 26-27 luglio 1916, si combatté la più terribile battaglia a colpi di granate della “Grande Guerra”. Senza un attimo di sosta, australiani e inglesi lanciarono circa 30.000 bombe a mano contro il nemico, fino all’alba.
La commemorazione dei pompieri
Nel 1928, a Ypres, Belgio, si decise di far eseguire “The Last Post” (l’equivalente del nostro “Il Silenzio”), tutte le sere, in onore delle nazioni che tanto sacrificarono, in termini di vite umane, per difendere questa piccola
Il
82
nazione durante la “Grande Guerra”. Il privilegio di eseguire “The Last Post” fu affidato ai trombettieri volontari della stazione locale dei vigili del fuoco. Aeccezione del periodo della Seconda Guerra Mondiale, dall’11 novembre 1929 “The Last Post” è stato eseguito tutti i giorni fino ad oggi. La tradizione continua…
La cabala delle date
Atitolo puramente cabalistico è interessante sapere che la Prima Guerra Mondiale terminò con l’armistizio, firmato alle ore 11, dell’undicesimo giorno dell’undicesimo mese, nel 1918. Ore 11:00 del 11/11.. 1918!
I primi blitz su Londra
I primi bombardamenti su Londra non avvennero, come si crede, nella Seconda Guerra Mondiale, a opera della Luftwaffe – bensì già nel 1915, per merito dei mastodontici aerostati Zeppelin.Marmellata o cannoni?
Nel 1915, la penuria di munizioni interessava tutte le fazioni in lotta; gli inglesi decisero allora di utilizzare lattine contenenti marmellata di prugne per fabbricare rudimentali bombe a mano, mentre i tedeschi e gli austriaci si inventarono mazze ferrate e altri tremendi strumenti di offesa, di medievale memoria, per sopperire alla mancanza di armamenti.
Stakanovisti della guerra
Acausa di un’errata interpretazione dei soldati britannici, durante la “Grande Guerra” si sparse la voce che i mitraglieri tedeschi fossero incatenati ai loro strumenti di offesa, costretti così a combattere fino all’ultimo respiro, senza mai indietreggiare o fuggire davanti al pericolo. In verità, questi soldati utilizzavano speciali cinghie per trasportare e riposizionare più agevolmente le terribili mitragliatrici Schwarzlose, ma una volta caduti sui loro pezzi, diventava difficile interpretare il tragico insieme di carne, metallo, cinghie, nastri delle munizioni ed effetti personali, grottescamente inscindibile.
La leggenda di Enrico Toti
Enrico Toti, medaglia d’oro al valor militare, immortalato in divisa da bersagliere da una tavola celeberrima di Achille Beltrame mentre, privo di una gamba, lancia la stampella contro il nemico, non era un bersagliere e nemmeno un soldato! Aveva, in realtà, perso la gamba in un incidente sul lavoro, parecchi anni prima, e da allora sbarcava il lunario girando il mondo
83
con una bicicletta senza un pedale, esibendosi come fenomeno da baraccone. Si fissò, tuttavia, nella volontà di partecipare alla guerra e divenne una specie di mascotte delle truppe, tanto che gli fu data anche una divisa, ma senza mostrine, con la raccomandazione di non sostare in prima linea durante le azioni di combattimento.
Padre Pio in “visita” dal Generale Luigi Cadorna
Narra una leggenda che, all’indomani della rotta di Caporetto - nelle più cupe giornate del Regno d’Italia - una notte, entrò negli alloggi di Luigi Cadorna un frate cappuccino che, dopo un breve colloquio, riuscì a far desistere il Generale da presunti propositi suicidi. Nessuno vide, né registrò la presenza del sant’uomo al cospetto del Generale Cadorna, ma dopo molti anni, il graduato lo riconobbe con certezza vedendo una fotografia di Padre Pio –che peraltro non conobbe mai personalmente in tutta la sua vita!
Le prime divise alpine
Le prime truppe alpine utilizzate a spizzichi sulle altissime quote dell’Adamello, avevano, in parte, ancora le divise della Guerra di Libia, che, come facilmente si può immaginare, erano del tutto inadeguate a una primavera a 3.500 metri!
Gli zingari in guerra
Negli anni precedenti allo scatenarsi del conflitto, fu registrata una grande quantità di popolazioni gitane e zingare, di passaggio per le terre del Belgio. Tra le masserizie rivenute, dopo la loro partenza, molte furono identificate di fabbricazione tedesca. L’Intesa riuscì a ipotizzare che, tra i suddetti nomadi, si fossero celati molti soldati e ingegneri tedeschi, incaricati di compiere sopralluoghi e osservazioni topografiche dettagliate, al fine dettagliare e migliorare ulteriormente i piani d’invasione teutonici.
Concerto per cannoni e ottoni!
La notte del 26 agosto 1917, durante la lunga offensiva per lo sfondamento della Bainsizza, il morale dei fanti venne risollevato improvvisamente da una banda militare che dalla cima del Monte Santo intonò motivi patriottici e militari. La compaggine musicale, che si esibiva in un “teatro” davvero insolito, quanto improbabile, era diretta nientemeno che da Arturo Toscanini, gia’direttore d’orchestra di fama mondiale.
84
Il Capitano Martini invece, decise di far suonare la sua modesta compaggine musicale, arroccata sulle cengie del Lagazuoi, quando gli austriaci fecero brillare alcune mine, nel tentativo di far sloggiare gli italiani da queste ardite posizioni. Con una frenetica e quantomai ardita esecuzione, la banda italiana riuscì a trasmettere un chiaro segnale al nemico, che intuì immediatamente la vanificazione di tutti i suoi sforzi.
“Remembrance Day” – Il Giorno del Ricordo e il fiore di papavero
La relazione tra i papaveri e il Remembrance Day, celebrato in molti Paesi del mondo l’11 novembre, deriva dalla poesia “Nei campi di Fiandra”, dell’ufficiale medico canadese John McCrae. L’emblema del papavero venne scelto perché questi fiori sbocciavano in tutti i campi di battaglia delle Fiandre nella Prima Guerra Mondiale. Il rosso intenso dei papaveri apparve un simbolo particolarmente appropriato per significare l’immenso spargimento di sangue causato dalla terribile lotta in trincea.
85
GLOSSARIO DEI TERMINI
Durante il Primo Conflitto Mondiale nacque una nuova terminologia bellica in tutte le nazioni belligeranti. In seguito all’introduzione di nuove tecnologie, strumenti e modi d’offesa, usi, costumi e regole comportamentali dell’epoca, si rende spesso utile far riferimento a un glossario dei termini piu’ricorrenti nell’intera bibliografia di questo periodo storico.
A.E.F. American Expeditionary Force: L’esercito Americano che prese parte alla Grande Guerra dal 1918 fino al termine del conflitto.
ACROCORO: Altopiano molto vasto e accidentato circondato da burroni.
ALPEN-JAGER: Truppe da montagna austriache.
ANZAC: I soldati delle forze armate di Australia e Nuova Zelanda (ANZAC è l’acronimo di “Australia and New Zealand Army Corps”, “Corpo d’armata di Australia e Nuova Zelanda”).
B.E. British Experimental: La sigla assegnata a tutti I prototipi di aeroplani da caccia o da bombardamento, realizzati in Inghilterra durante la Grande Guerra.
B.E.F. British Expeditionary Force: l’esercito britannico inviato in Europa per combattere dal 1914 al 1918.
BALMA: Una grotta vasta e poco profonda, con la bocca a volte più larga del fondo.
BERTHA: La “Grande Bertha” era un obice da assedio particolarmente possente, prodotto dalla Krupp tedesca. Così battezzato in onore della moglie dello stesso Gustav Krupp, questo possente cannone sparava proiettili da 900 chilogrammi e necessitava di una squadra di 200 artiglieri per essere assemblato e utilizzato.
BOCIA: Il giovane alpino, in termini di esperienza e permanenza al fronte.
86
BORRI: Burroni, fossi scavati dalle acque in luoghi scoscesi.
BUSA: È su un altopiano quello che corrisponde a una Dolina sul Carso. Si tratta di una vasta buca di poca profondità, un avvallamento con i fianchi, e generalmente anche il fondo, rocciosi.
CACCIATORI: soldati a piedi o a cavallo armati e addestrati per la milizia leggera.
CAMEL: Aeroplano da caccia di fabbricazione Inglese.
CAMICE BIANCO: La tuta bianca che si indossava sopra l’uniforme, per mimetizzarsi con la neve.
CAPRONI: Aereo bombardiere pesante di fabbricazione italiana.
87
CASTAGNATO: In gergo studentesco di quel periodo significava “fregato”, “ingannato”
CAVALLO DI FRISIA: ostacolo mobile costituito da un telaio, generalmente in legno, con tavole o tronchi disposti a “x” ed armato con il filo spinato. Impiegato per lo sbarramento di strade, passaggi obbligati o varchi nei reticolati.
CECCHINO: Il termine “cecchino”, sinonimo di tiratore scelto o tiratore isolato che conduce una specie di guerra privata a metà strada tra l’imboscata e la caccia grossa, nacque durante la “Grande Guerra” sul fronte italiano. Così, infatti, i nostri soldati battezzarono quei tiratori scelti austriaci in scherno e disprezzo del loro vecchio Imperatore Francesco Giuseppe o, per dirlo all’italiana, “Cecco Beppe”, da cui “cecchino”.
CENTINA: struttura in legno o ferro disposta ad arco.
CIDOLO: Indica la chiusa che si costruisce lungo il corso di un fiume per chiudere il passaggio ai tronchi d’albero e altri detriti trasportati dalla corrente.
CINQUINA: Era la paga del soldato italiano, che percepiva 10 centesimi al giorno, più 40 di indennità di guerra, in un unico pagamento effettuato appunto ogni cinque giorni.
CONTRAFFORTE: sperone di muratura, addossato al lato interno delle mura, per rinforzarle e renderle più resistenti alle cannonate.
CORONARE UNABRECCIA: è l’azione compiuta dagli assedianti che, dopo aver conquistata la breccia, vi si trincerano nella parte più alta con gabbioni e opere in terra.
CORONARE UNATRINCEA: significa costruire la parte più alta del parapetto con fascine o sacchi di terra.
CORTINA: tratto di mura rettilineo, tra un bastione e l’altro ; cortina (6 - 7) significa cortina tra i bastioni 6 e 7.
CROCE BLU: Identificativo dei proiettili d’artiglieria caricati con gas lacrimogeno e irritante.
CROCE GIALLA: Identificativo dei proiettili d’artiglieria caricati con gas
88
Mostarda o Iprite (solfuro di etile biclorurato).
CROCE VERDE: Identificativo dei proiettili d’artiglieria caricati con gas Fosgene.
CROCIATI DI NERO: con l’insegna della Croce Gotica.
DIAGONALE: Era così chiamata l’uniforme grigioverde italiana da passeggio; si parla dell’uniforme degli ufficiali.
DOLINA: È sul Carso quello che corrisponde a una Dolina su un altopiano. Si tratta di una vasta buca di poca profondità con fianchi rocciosi.
E.E.F. Egypt Expeditionary Force: l’esercito britannico inviato in Egitto per combattere dal 1914 al 1918.
FANTACCINO: soldato semplice di fanteria.
FELD-JAGER: cacciatori austro-ungarici.
FICCANTE, FUOCO FICCANTE: fuoco diretto dall’alto verso il basso.
FIOCCHETTI DI LANA: in lontananza, le esplosioni dei proiettili di artiglieria producevano delle piccole nuvolette bianche, paragonabili a fiocchetti di lana.
FRONTE: Il fronte militare veniva chiamato “la fronte” ai tempi della Grande Guerra.
GABBIONE: Reticolato trasportabile, a soffietto. Si costruiva nelle retrovie e si trasportava, ripiegato, davanti alla prima linea.
GHIRBA: Parola di antichissime origini usata per l’otre o un analogo contenitore per liquidi, in pelle animale. I soldati italiani coniarono l’analogia tra contenitore in pelle ed il corpo umano, da cui il significato di “pellaccia”, “vita”, “esistenza” attribuito alla “ghirba”. Perdere la “ghirba” significava morire.
GIARONE: Dialettale per ghiaione, cioè una “pala” colma di sassi e di ciotoli.
GOLA: vedi Bastione.
89
GRAPPE: particolari in ferro di forme diverse, le cui estremità appuntite venivano piantate nelle travi o nelle tavole e servivano per tenere salde le diverse parti di baracche o delle fortificazioni.
GREPPO: fianco ripido della montagna.
HOTCHKISS: Mitragliatrice di fabbricazione francese.
INFILATA, FUOCO D’INFILATA: direzione del fuoco, quando coglie la linea nemica di fianco e senza ripari.
IPRITE: Volgarmente chiamato anche gas Mostarda (solfuro di etile biclorurato) - noto anche come “Croce Gialla” e Yprite; uno dei gas letali più temuti.
KAISER-JAGER: soldati scelti dell’Imperatore (Guardie Imperiali).
JAGDSTAFFEL: Termine usato dall’aeronautica tedesca per identificare un gruppo da combattimento, formato da più squadriglie di caccia. Abbreviato spesso in “Jasta”.
JASTA: Vedi “Jagdstaffel”
K.U.K. : Acronimo per kaiserlich und königlich, prefisso che precedeva tutti gli enti che facevano capo all’imperiale e regia amministrazione pubblica austro-ungarica.
90
KATZELMACHER: “Fannulloni”, “Buoni a nulla” - termine generico con il quale gli Austriaci definivano i soldati Italiani.
KRUPPS: Nota industria metallurgica tedesca, convertita alla produzione di obici d’assedio durante la Guerra.
LAND-STURM: milizia territoriale austriaca.
LAND-WEHR: milizia territoriale austriaca.
LAVANDAIO: I veneti usavano questo soprannome per un soldato particolarmente loquace e chiacchierone, proprio come le lavandaie.
LINEA, FANTERIADI LINEA: fanteria che adempie le normali attività belliche, distinte da quelle dei corpi specializzati ; 66° di linea significa 66° reggimento di fanteria.
M.E.F. Mediterranean Expeditionary Force: La spedizione militare anglosassone inviata a combattere nello Stretto dei Dardanelli (Gallipoli)
MAXIM: Mitragliatrice di fabbricazione tedesca
MEZZALUNAO LUNETTA: opera di fortificazione isolata, esterna alle mura, posta a difesa della cortina. È costituita da due pareti (facce) che si incontrano formando un angolo (saliente), rivolto verso la campagna.
MITRAGLIA: palla da cannone costituita da un sottile involucro di latta, ripieno di palle o schegge di ferro. Allo sparo, l’involucro si squarciava, e la massa di schegge si dilatava a formare una rosa di proiettili, micidiale per la truppa nemica.
MOCHENI: Gli Austriaci - così chiamati dalla pronuncia dialettale, tirolese, austriaca, di “machen”, il verbo fare.
MORTAIO: pezzo d’artiglieria a canna corta, caratterizzato da traiettoria di tiro molto curva. Sparava le bombe, che per effetto di tale traiettoria cadevano quasi verticalmente sul bersaglio
MUCH, MUC: Appellativo veneto per indicare I tedeschi.
NIEUPORT: Aeroplano da caccia di fabbricazione Francese
OBICE: pezzo d’artiglieria la cui traiettoria di tiro è compresa tra quella del
91
cannone e quella del mortaio.
PALA: Nelle Dolomiti, l’ultimo ripidissimo tratto di terreno erboso o misto d’erba, di terra e di sassi da cui si eleva la croda dritta e nuda. Si tratta di un vocabolo alpino e preromano.
PALETTO ACODADI PORCO: Paletto di ferro che terminava con un ricciolo al quale era più semplice e più sicuro agganciare il filo spinato.
PALUDAMENTI: coperture militari.
92
PARALLELA: trincea scavata dagli assedianti, il cui tracciato è all’incirca parallelo a quello del recinto difensivo, ma lentamente converge ad esso. Scopo della parallela è quello di portare gli assedianti più vicini alle mura restando al coperto
PIASTRINO: Il piastrino di riconoscimento era un astuccio di metallo che si portava cucito nella parte interna della giubba. Conteneva un foglietto di carta con il nome, la classe e la categoria del soldato. Serviva, com’è ovvio intuire, a identificare i caduti in battaglia. L’esercito inglese invece, utilizzò per tutta la Grande Guerra un semplice dischetto di cuoio (facilmente deperibile), che i “Tommies” portavano al collo a guisa di ciondolo.
PIAZZA: è così chiamata la città o fortezza assediata.
PIAZZOLA: spazio di terreno sistemato per piazzarvi un pezzo d’artiglieria.
PILLOLA: proiettile di artiglieria.
PINNACOLI: guglie a forma di piramide, sottili vette di montagne.
PIPA: Il cicchetto o rimprovero da un superiore.
RESERVESTELLUNG: trincea di riserva.
RIDOTTA: fortificazione di secondaria importanza, isolata o collegata ad altri sistemi di difesa.
SALIENTE: vedi Bastione,Mezzaluna
SBIBBOLE: Granate, bombe e shrapnels
SCHIAPPINI: soldati non troppo abili nello svolgere gli incarichi a loro assegnati.
SCOPERTO: essere allo scoperto significa trovarsi esposti al tiro del nemico senza alcun riparo.
SCRIMOLO: orlo, bordo, ciglio.
SCUDETTO: Scudo da trincea, con una feritoia per il fucile, utilizzato da vedette e tiratori scelti.
SERVENTI: militari incaricati all’approvvigionamento di munizioni o alla
93
pulizia dei pezzi di artiglieria.
SHRAPNEL/S: piccole sfere d’acciaio o di piombo contenute all’interno di alcuni tipi di proiettili d’artiglieria.
SIPE: La più comune bomba a mano di fabbricazione italiana. SIPE significa “Società Italiana Prodotti Esplosivi”.
SKODA: Nota industria metallurgica Austriaca, convertita alla produzione di obici d’assedio durante la Guerra.
SORTITA: attacco di sorpresa condotto dagli assediati contro gli assedianti.
94
SPAD: Aeroplano da caccia di fabbricazione Francese.
SPECCHI: Formulari già pronti, stampati, di cui la burocrazia militare abbisognava per complicarsi sempre più.
STELLETTE (TOCCARSI LE): I soldati italiani si toccavano contemporaneamente le stellette sul collo della giubba per scaramanzia, sostituendo, almeno in pubblico, altri gesti punibili dalla disciplina militare.
STREGHE (VEDERE LE) : Aver molta paura (gergo degli Alpini).
STURM-TRUPPEN: Unità tedesche o austro-ungariche molto agguerrite paragonabili ai reparti italiani degli Arditi.
TABIA’: Fienile isolato di una malga montana, a volte collegato ad una stalla.
TERRAPIENO: Nelle opere di fortificazione: terreno, naturale o di riporto, addossato al lato interno delle mura, e sopraelevato rispetto al piano di campagna. Veniva utilizzato per sistemarvi le postazioni difensive, soprattutto le artiglierie. Nelle postazioni per artiglieria : struttura per proteggere la postazione dai tiri nemici, realizzata con terra, legname, gabbioni e fascine
TRAVERSA: sbarramento interno alla trincea, disposto come protezione dal fuoco d’infilata.
VECIO: Il vecchio alpino, in termini di esperienza e permanenza al fronte.
VEDRETTA: Piccolo ghiacciaio, tipici della zona dell’Adamello ad esempio.
VOLTEGGIATORI: soldati di fanteria leggera;
ZEPPELIN: Dirigibile di fabbricazione tedesca, che prese il nome dal suo inventore, Conte Graf von Zeppelin.
95
L’autore ringrazia sentitamente per la collaborazione, la disponibilità e la preziosa amicizia:
Museo della Grande Guerra 1914-1918, Canove di Roana (VI), Museo Storico Nazionale degli Alpini di Trento, Museo della Grande Guerra 1914-1918 al Passo Fedaia in Marmolada Museo della Grande Guerra 1914-1918 a Punta Serauta in Marmolada Museo della Guerra Bianca in Adamello, Temù Associazione Nazionale Alpini, Gruppo Alpini Arcella PD Gruppo Alpini San Gregorio Magno PD Marco Ambrosini
Oscar Barcella Col.M.B.V.MStefano Basset Nicola Bultrini
Valerio Burattin Col. Franco Burei Romano Canalia Giovanni dalle Fusine Mario Fornaro Daniele Girardini Massimiliano Italiano Siro Offelli Pierluigi Scolè
Cristina Spagliardi Gen. di Brig. Tullio Vidulich Avv. Alberto Zanca
RINGRAZIAMENTI
96
NOTE BIOGRAFICHE E SITI
INTERNET
Alessandro Gualtieri è un formatore linguistico, accreditato presso molteplici, realtà didattiche ed enti di formazione nazionali.
Alessandro Gualtieri è inoltre, un appassionato storico e ricercatore milanese che da anni studia assiduamente la Prima Guerra Mondiale a livello internazionale. Nel 2010 ha pubblicato “La Battaglia della Somme” e “Verdun 1916”, mentre nel 2011 ha rilasciato una terza produzione editoriale sulle Battaglie di Ypres. Un saggio sulla condizione femminile durante la cosiddetta “Grande Guerra” è infinie di prossima pubblicazione.
Alessandro Gualtieri è anche l’autore di “La Grande Guerra 1914-1918 Percorso di Studio a Schede” , “Dal Piave alla prigionia”, “I Musei della Grande Guerra” e “Recuperanti”.
Di recente, ha anche tradotto “Dal Piave alla prigionia” , nella versione internazionale in lingua Inglese, intitolata “An Italian forever”, disponibile in tutto il mondo.
Autore e webmaster del sito internet www.lagrandeguerra.net, Alessandro Gualtieri è presidente, cofondatore e webmaster del “Centro Studi Informatico La Grande Guerra”, un’organizzazione creata per raccogliere e divulgare notizie, informazioni e iniziative inerenti alla Prima Guerra Mondiale (www.csigrandeguerra.it).
97
Alessandro Gualtieri fa anche parte dell’Associazione “Viaggi & Storia” , che desidera finalmente soddisfare chiunque voglia capire i fatti, scoprire i personaggi che li hanno determinati e soprattutto ritrovare ciò che oggi è rimasto ancora da vedere, senza trascurare l’altra parte eccitante di un qualsiasi viaggio.
98