
 UFFICIO STORICO ORESTE BOVIO
UFFICIO STORICO ORESTE BOVIO


 UFFICIO STORICO ORESTE BOVIO
UFFICIO STORICO ORESTE BOVIO


TLmi i diriui riservaLi Vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione © by Uffìcio Storico SME Roma 1996
FUSA Editrice S.r l. Via di Mal agrotta, 2 93 00050 Ponte Galeria (R oma)
Il 7 gennaio 1797 nella ciltà di Reggio Emilia, il Congresso della giovane Repubblica Cispadana, nata a seguito della travolge11te campagna militare napoleonica, deliberava l'adozione della propri.a bandiera, disponendo che "... fosse universale lo stendardo dei Lre colori, bianco, rosso e verde, e fosse segno di italianità e sovraniJà".

Il vessillo tricolore iniziava così, duecemo anni or sono, la sua gloriosa storia, marciando alla testa di quei primi soldati italiani che, pur tra le fila di un esercito straniero, alimentavano la fiamma spirituale, ormai accesa, del riscatto nazionale, prologo alla grande epopea risorgimentale.
Le idee ed i principi ispirati dalla Rivoluzione Francese e portati in Italia con ferrea determinazione dal giovane Buonaparte si esplicitavano 111.aterialmente nella trama tricolore. La storia italica stessa, antica e recente, il senso di rinnovamento sociale e politico, le aspettative per un futuro unitario e libertario avevano trovato, finalmente, il loro simbolo per eccellenza: la bandiera.
Successivamente, durante il Risorgimento, il Tricolore assurse ad emblema della lotta del popolo italiano per l'indipendenza na-;,ionale contro l'occupazione straniera, sventolando sulle barricate e sui campi di battaglia, da Milano a Porta Pia, nello spirito e nell'aspirazione dei più nobili ideali di democrazia e libertà. Principi, questi, che animarono ugualmente il riunifìcato popolo italiano ed il suo Esercito nei duri successivi cimenti: dalle trincee del Piave alle ferite dolorose del secondo confl.illo mondiale, dal riscallo nazionale attraverso la guena di liberazione alla rinascila de mocratica
Da due secoli il popolo italiano riconosce nel Tricolore il simbolo dell'unità e dell'indipendenza della Patria; concreta manifèstazione della sincera adesione del popolo all'idea di Stato ed espressione del carattere, delle Lradizioni e delle aspirazioni di tutta la Nazione, com.e solennemente sancisce la Carta Costitu-;,ionale .
Il volume "Due secoli di Tricolore" assume, quindi, un significato particolare, non solo per la sua valenza divulgativa e per il rigore formale, ma soprattutto per la dimensione del messaggio etico che riesce a trasmettere. Messaggio ulteriormente fortificato e vivificato anche dalla recente concessione all'Esercito della Bandiera di guena, glorioso simbolo e concreto riferimento per quanti in uniforme, in pace ed in guerra, hanno fornito un raro esempio di spirito di sacrificio e di disinteressata solidarietà umana in nome dell'Italia .
In un momento quale quello attuale in cui il Paese si sforza cli superare un'indubbia crisi di rifèrimenti morali e la scena internazionale è offuscata dal riaffermarsi di nazionalismi disgreganti, l'evocazione storica del Tricolore costituisce un forte richiamo all'emblema che, tra i più ricchi e carismatici, possiede un potendale unifìcante e rappresentativo impareggiabile.
Ne è prova il fatto che il_ vessillo tricolore, sbarcato oltremare nell'ambito di missioni umanitarie e di pace in luoghi spesso geografìcanzente e culturalmente lontani, ha saputo conquistare il cuore e la fiducia di quei popoli travagliati, assurgendo a immagine di solidarietà umana e di speranza nella possibilità di superare le devastazioni delle guerre, dei soprusi e delle persecuzioni.
Quest'opera ha quindi il pregio di riaffermare l'alto significato storico e spirituale del Tricolore, non già materia cli d iscussione politico-sociale, bensì oggetto di insostituibile culto civico e civile, a perenne ricordo che ogni conquista ha un cosLO, spesso doloroso, ma indispensabile per la reali~za~ione cli una Na~ione sempre migliore

IL CAPO DI S DELL 'ESERCITO Generale Bo nifazio NC I SA di CAM E RANA

Sotto il profilo strettamente lessicale, si può definire la bandiera come un drappo di fornza rellangolare, attaccato per uno dei lati più coni ad un'asta, e che porta i colori e per lo più anche Lo stemma dello Stato, cillà, corporazione, ecc , a cui appartiene ' , ma una definizione del genere lascia insoddisfatti perché trascura l'aspetto più caratterizzante di qualsiasi bandiera: quello simbolico. Lo stesso dizionario dal quale è tratta la precedente definizione, infatti , per esemp lificare il significato del vocabo lo simbolo non trova nulla di più appropriato c h e la bandiera è il simbolo della patria.
Per quanto da c.lue secoli soltanto - da quando cioè, dopo le rivolu zioni americana e francese, gli uomini hann o smesso di essere sudditi per divenire cittadini ciascun pop olo veda nella bandiera nazionale il simbolo dell'unità e della indi pendenza della sua patria, l'uso della bandiera come simbolo di potere, personale o di una ristretta cerchia di persone: tribù, clan, gens, casta, è antichissimo e molti sono g]i aut01i classici che ci hanno l a ciato testimonianze al riguardo. Sol o da qualche decennio 2, però, è sta to intrap reso un o st udio s ist emat ico e scien tifi co sull'or igine e sull'evoluzione della bandiera, approfondendo l'argomento anche sotto l'aspetto sociologico. Si è visto così che attraverso l'esam e delle band i e r e di un popolo è possibile giungere alla definizione , o trovare conferma di precedenti intuizioni, di alcuni particolari caratterizzanti della sua cultura, de l tipo di organizzazione politica c h e si era data e, persino, d e ll e sue condizioni economiche perché le caratteristiche formali di una bandiera so no molto spesso la concreta espress ion e della soc ie tà che si esprimeva lramit c quel simbo lo.
Fin dalla più r emota antichit à l'uomo sentì la necessità pratica di rendere facilmente visib il e il proprio potere ed inalberò una insegna 3, un qualsiasi manufat to c ioè che lo differenziasse dag l i altri uomini e lo facesse riconoscere a distanza.
Con il tempo le insegne rappresentarono non olo il singolo individuo, ma tutto il gruppo di persone a lui legate da rapporti di parentela o, comunque, di sudditanza. Spes so l'insegna rappresenta l'animale da cui il gruppo c r edeva di discende re, cioè il suo totem . Il senso di superstizioso terrore che legava al totem l'uomo primilivo, convinto di trarre da esso i suoi poteri, si trasformò presto in un se ntimento di venerazione per l'inseg na , alla quale fu attrib uito un carattere protettivo, dando così inizio a que l processo di sacralizzazione delJa bandiera di cui ancora oggi rimangono tracce evidenti in molto cerimonie.
F~mando Palani , N01·i.,;sil110 di::,io11ario della lingua italiana. edizione a cura di Gianfranco Folena, Milano, Fabbri Editore, 1974.
Il termine "vessi ll ologia", com unemente adottato per indicare questo nuovo sellore di studi, è stato usato ufficialmente per la prima , ·olta solo nel 1969 da Whitney Smith , direttore del Flay Rese arc h Cent c r di Win c hester (U SA).
1 Per insegna o ves s illoidc si intende comunemente un qualsiasi oggetto che, pur differendone nell'aspetto, espleti le stesse f umioni di una bandiera.
Solo in un secondo tempo le insegne ebbero una funzione militare, offrendo ai combattenti un punto di riferimento inequivocabile. E che il primitivo uso delle insegne non sia stato originato da esigenze di carattere bellicoso, ma piuttosto dall'intimo e profondo desiderio di ogni uomo di distinguersi dagli a] tri e di prevalere s ugli altri, è provato anche dal fatto che le insegne sono una caratteristica comune della nostra civiltà, presente presso tutte le razze e tutte le culture.
Sia pure differenziate nella foggia, tutti i popoli della terra hanno avuto le loro insegne , siano essi stati di natura bellicosa o di indole pacifica.
Molte fonti antichi lib1i sacri, pitture rupestri, affreschi tombali, vasi cultuali, altorilievi di monumenti ci permettono di ricostruire con buona approssimazione la fattura delle insegne presso i diversi popoli e di constatare le correlazioni esistenti tra la forma dell'insegna e la cultura de1 popolo che la innalzava: a pagina 7 sono state riportate alcune insegne tra le più significative: la testa d'animale, ingenua rappresentazione della generale credenza dell'uomo primitivo di poter recepire parte delle virtù dell ' ucciso; la statuetta egizia del dio Horus, materializzazione di quel rapporto tra uomo e divinità tipico delle società teocratiche, in cui l'ubbidienza al dio si trasformava automaticamente in ubbidienza al sovrano, incarnazione del dio in terra; l'aquila l egiona1ia, cosciente espressione visiva della potenza e della maestà dell'impero romano; il cinghiale, emblema di una tribù celtka; il labaro, insegna dell'impero romano ormai divenuto cristiano; il parasole, simbo lo politico di grande importanza nel s ud- est asiatico. Anche nella Bibbia vi sono molti accenni ad insegne ed a vessilli usati dal popolo di I sraele . Nel Libro dei Numeri si Jegge: "i figli di Israele si accamparono attorno al tabernacolo, ciascuno sotto il proprio vessillo p1incipale e sotto l'insegna della casa patema"; dal Genesi e dal Deuteronomio sj apprendono anche i colori di quei vessilli e le figure che li carica.vano: rosso con la mandragola per la tribù di Ruben; verde con l a città di Sachem per la tribù di Simeone; bianco, nero e rosso con il pettorale de] sacerdote per la tribù di L evi; azzurro con il leone, probabilmente rosso o violaceo, per la tribù di Giuda; nero con 1'asino per la tribù di Issachar; bianco con la nave per la uibù di Zabuilon; color zaffiro con il serpente per la tribù di Da.n; grigio con una tenda per la tiibù di Gad; rosa con una cerva per la tribù di Neftali; color acquamarina con l'olivo per la tribù di Asher; nero con un simbolo egizio per la tribù di Efraim; un vessillo multicolore con il lupo, infine, per la tribù cli B eniamino.

Quasi sempre le insegne ci appaiono innalzate s u un'asta e questa usanza comune è facilmente spiegabile con motivi pratid un'asta può essere facilmente reperita, trasportata, agitata e con considerazioni più sottili. Secondo un noto studioso", 'Tasta è un simbolo cli potere; corrisponde aUa mazza, alla spada ed ad altre armi, come anche all'itifallo, simbolo insieme della rigenerazione della razza e del predo minio del maschio sulla femmina, il prototipo del rapporto padrone-schiavo
Per la sua forma, inoltre, l ' asta esprime l'anelito verso il cielo degli uominj legati alla terra".
Il fatto che comunemente le insegne fossero realizzate in metallo, cuoio, legno e che l'impiego del tessuto fosse molto raro può essere spiegato razionalmente, se si pone mente alla circostanza che i popoli antichi sapevano tessere egregiamente, ma non colorare con altrettanto buoni risultati i tessuti.
4 Whitney Smith, Le bandiere Storia e simboli, Edizione italiana a cura di Aldo Ziggioto, Milano , Mondadori , 1975.Tavola I - Insegne (primitiva, egizia, romana di epoca repubblicana , celtica, asiatica, romana di epoca imperiale).


 __
__

L'esigenza bellica di rendere facilme n te riconoscibili a distanza le formazioni dei comba ltenti fece sco pri re presto l'utihtà delle insegne in campo mi litare.

Nell'esercito romano signa (raffigurazione di animali o di simboli sacri) e vexilla (lembi di stoffa colorata) furono regolarmente usati.
La tradizion e dice che l a prima in segna , data da Romolo , era cos tituita da una manciata di fieno legata in ci ma ad una lancia, donde sarebbero derivati prima il nome di manipulus ad ogni reparto che vi s i raccoglieva e poi l a trasformazione del segnale stesso in una m ano. Alt1i vuole c h e i l si mb olo sia stato fin dall'origine una mano aperta, c h e stava ad indi care il ges to imperioso co n cui il comandante accompagnava i suoi ordi ni ovvero intima va al n em ic o di non avanzare.
Successivamente la mano venne racchiusa in una cor ona d'alloro, so vrapposta ad una patera ombelicata c he conferiva all'insegna carattere s acrale , specialm ente a quelle dei reparti maggiori , come la leg i one
L'elevato grado di organizzazi one raggiunto dagli eserciti roman i produsse i suo i effe tti anche nel campo ve silJo log i co. L'evo luzione progress iva c h e, spec ie dopo il Mill e, trasformerà l' insegna in una ba ndi era era infatti già presente, a lm eno in nuce, nell'insegna romana , sia sotto l'aspetto formale sia sotto l 'as petto della sacra lizzazione.
L'inseg na della legione, infatti, era custod it a dalla prima coorte, la più forte per numero e p er valore di legiona1i , ed era costituita da un'aquil a, s imbolo di Giove, con le ali s piegate e co n il fu lmin e tra gli artig li.
L'as t a dell'i n segna era munita di puntale per essere piantata in terra e recava lungo il gambo i segni d e ll e onor ificenze di cu i il corpo era insignito e alc un e targhe su ll e quali erano apposte la sig la S .P. Q.R., ]e iniziali o l'immagine d e ll'imperatore che av ev a istituito la legione , e, infine, un qua d rato di stoffa di vario co lor e, che disting u eva le diverse legioni, il vexillum .
La cava ll eria romana, i noltre, ebbe una propria insegna, l a prima del genere in O cciden t e: un drappo quadrato , di solito ros so, con frange, attaccato ad una sbaITa fi ssata or izzon t almente, a guisa di croce, in cima ad un 'altra asta term in ante a lancia: il classico sten dardo di cavall eria, quindj, nato dalla necessità di non portare emblemi ingombranti o pesanti a cavallo.
Da l vessillo c h e li distin g u eva preser o poi il no m e di vex illatione s i distaccamenti di una o più leg ioni.
N e ll'accampamento le insegn e erano raccolte insieme n el p r etorio, i n apposita te nd a e ge losamente c u stodite. Si ce le brava in l oro o n ore una ri correnza fes tiva durante la quale esse venivano innovat e o riparat e. In tempo di p ace era n o conserva te ne lla sede d e ] pubblico erario sotto la vi gilanza dei questori.
"Nei confronti di tutte le inse gne i romani coltivarono profondo ris p etto eriverente attaccamen to , come al simbol o non solo dello spirito di corpo dell'esercito, ma anche d e ll a tradizione d el popo lo roman o. Il sacramentum veniva pronunzia to dava nti all'insegna, c h e era difes a fino a ll a morte; perde rla comportava l'ignomi ni a, tanto che le coorti le quali vi incorrevano, ven ivano punite facendole bivaccare fuori dall'accampame n to, senza le te nd e"'.
La ferrea organizzazione statuale romana trasformò l'insegna legionaria in simbolo dell"'imperium" di Roma e molti studiosi sono concordi neJ ritenere che l'aquila romana sia stata la prima bandiera del mondo, in quanto simbolo tangibile di uno Stato organizzato.
La caduta dell'impero romano d'occidente trascinò con sé anche l'idea dell'organizzazione statale e, quindi, l'evoluzione dell'insegna da simbolo personale o di gruppo a simbolo di tutto uno Stato si intem1ppe. Quando, con Carlo Magno, Ja ctùtura barbarica recepì quanto ancora rimaneva della lradizione romana, reinterpretandola beninteso alla luce delle proprie esperienze, le bandiere divennero il simbolo imperiale e feudale, cioè non ancora segno distintivo di una nazione o di uno Stato, n1a pur sempre simbolo di poteri organizzati nel sistema feudale.
L'evoluzione formale che trasformò in Europa la vecchia insegna, prevalentemente di legno e metallo, in bandiera di tessuto, fu dovuta principalmente ai contatti con i popoli orientali. Pare ormai accertato, infatti, che furono i Cinesi per primi, utilizzando le possibilità loro offe1ie dalla sericultura, ad introdurre due innovazioni fondamentali: l'anacco laterale del drappo all'asta e l'attribuzione del valore di simbolo più ai colori del tessuto che alla foggia dell'asta. Dalla Cina le bandiere passarono ne] Vicino Oriente e gli Arabi incominciarono ad usare bandiere policrome all'epoca di Maometto. I Francru diffusero in Europa quest'usanza, avendola appresa dagli Arabi appunto durante le guerre combattute nel VII e nell'VIII secolo.
Il generale rifiorire dei commerci dopo il Mille e sopratt.1.1tto le Crociate diedero un grande imptÙso allo sviluppo delle bandiere, a causa delle accresciute necessità militari e navali.
A questo proposito è necessa1io ricordare che alcuni autori sostengono che le bandiere sono nate sul mare, dove la comunicazione con mezzi ottici è stata per lunghi secoli l'unka possibile. Ad ogni modo, fin dal secolo XII le navi alzarono un vessillo per indicare il porto di provenienza, come risulta dai portolani del tempo. Per quanto riguarda l'Italia, Genova usò l'insegna di San Giorgo, bianca con la croce rossa, Pisa una bandiera tutta rossa, Venezia il vessillo rosso con il leone di San Marco, Amalfi una bandiera azzurra con la croce biforcuta bianca. Gli eserciti crociati, inoJ tre, per distinguersi a seconda della nazionalità, adottarono croci di diverso colore. Nel 1188 Filippo Augusto di Francia, Em-ico II d'Inghilten-a e Filippo di Fiandra decisero che le loro bandiere portassero, rispettivamente, la croce rossa in campo bianco, la croce bianca in campo rosso, la croce verde in campo bianco.
I.:Ordine dei Templari adottò pili tardi la croce nera in campo bianco, mentre le tn1ppe dell'imperatore Federico II spiegarono un vessillo con l'aquila nera su campo giallo.
Alla fine del Medio Evo e durante l'epoca moderna, vessillologia ed araldica furono strettamente coJlegate, in quanto, come abbiamo visto, le bandiere non rappresentavano simbolicamente il popolo ma iJ feudatario suo signore ed anche quando l'evoluzione della società feudale portò allo Stato unitario, questo fu con siderato giuridicamente come proprietà personale del monarca e fu, quindi, l'insegna personale della dinastia regnante ad assumere il valore di simbolo dello Stato.

Specialmente Je bandiere militari non erano all'epoca che "la trasposizione sistematica dello stemma del Signore che comanda gli armati combattenti"
0


L'uso sempre maggiore, a partire dal Medio Evo, delle bandiere presso i reparti militari, è documentato abbondantemente anche da alcune espressioni, usate ancora oggi si può dire in tutto il mondo: "abbandonare le bandiere" per disertare; "alzare la bandiera bianca" per arrendersi; "mutar bandiera" per cambiare opinione; "portare la bandiera", per essere il primo in qualche cosa; il vocabolo, "antesignano", che oggi è usato nel significato di precursore, ha la sua etimologia nei le gionari romani che combattevano ante signa, cioè davanti o nei pressi delle insegne per difenderle. Nel Medio E vo, inoltre, si denominò bandiera un numero deLemùnato di soldati raccolti sotto la stessa insegna; negli archivi dei grandi com uni italiani sono custodite ancora le convenzioni stipulate per assoldare bandiere di fanti o di balestrieri o di cavalieri ed in tutte si fa menzione di un ragazzo, destinato a portare l'insegna o bandiera del reparto.
Fino a Settecento inoltrato, dunque, la bandiera ebbe due funzioni: rappre sentare vis i vamente il potere e costituire un punto di riferimento per le tn1ppe in battaglia. L'Enciclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers afferma infatti che le drapeau, l'enseigne e l'étendard sono manufatti sotto i quali "i soldati s i raccolgono per combattere e per espletare gli altri compiti militari".

La rivoluzione americana, che portò nel 1776 alla formazione del primo nu cleo degli Stati Uniti d'America, originò anche la prima bandiera nazionale moderna. Dopo qualche anno un'altra rivoluz ione, quella francese, sostituì alla bianca bandiera borbonica il tricolore 7 , nel quale si rispecclùò lo spirito della Francia intera e che, portato dalJe armate rivoluzionarie e napoleoniche attraverso tutta l'Europa, fu considerato il simbolo della lotta contro l'assolutismo. Anche la foggia del tricolore francese, all'epoca poco comune, contribuì a colpire l'immaginazione dei popoli ed a favorirne l'imitazione .
Il seme rigeneratore della rivoluzione francese non morì nemmeno con la Restaurazione e nei p1imi decenni del secolo XIX i cittadini di tutti gli Stati cominciarono a riconoscere nella bandiera nazionale il simbolo della patria comu n e . Nacquerò cos1 in Europa e nelle Americhe, insorte contro la Spagna, le autentiche bandiere nazionali, concreta manifestazione della s incera adesione di tutto il po polo all' id ea di Stato come espressione del carattere, delle tradizioni, delle aspira zioni e dell'unità di tutta la Nazione
La storiografia degli ultimi decenni ha dedicato non poco spazio al problema delJa costituzione degli Stati nazionali, nati dall'iniziativa di élites politiche, mili tari e intellettuali e non certo frutto spontaneo di movimenti di massa.
"Non sono le nazioni a fare gli Stati , bensì il contrario", ha scritto Edward Hobsbawn s intetizzando il problema e non vi è dubbio che, accanto alle ferrovie, alle forze armate, alla scuola, anche la bandiera abbia avuto una parte non piccola nel processo di unificazione e di identificazione dei popoli. Lo stesso Bismarck,
7 Come noto, il tricolore francese deriva dall'unione dei colori di Parigi, bleu e rosso, con il bianco dei Borboni ed il suo primo patrocinatore fu iJ La Fayette.
uomo alieno da ogni suggestione retorica, comprese quanto fosse importante la scelta di una appropriata bandiera ed ideò personaln1ente il vessillo del rinato Reieh tedesco, unendo al bianco ed al nero degli Hohenzollern il rosso della Lega Anseatica.
La definitiva affennazione della bandiera come il più importante simbolo politico nazionale avviene però nel nostro secolo, come conseguenza del diffondersi prepotente, prima in Europa e poi in Asia ed in Africa, del nazionalismo Quest'ideologia , infatti, che identifica il popolo con la nazione e questa con lo Stato, pur avendo avuto origine dal pensiero di uomini del Settecento come Rousseau ed Herder, si sviluppò alla fine del secolo scorso con l'affermazione delle nazionalità italiana e tedesca e poi in questo, soprattutto con la caduta degli imperi austro-ungarico e turco e con la decolonizzazione dell'Asia e dell'Africa.
Sia pure molto brevemente, è necessario ricordare l'importanza assunta dalla bandiera come sin1bolo unificante anche nelle lotte politiche, basti pensare alla bandiera rossa, ormai pat1imonio ideale dei socialisti di ogni tendenza. Maurice Dornmanget nel suo interessante saggio Le drapeu rouge et la révolution de 1848 ha affermato infatti : "Fare, o meglio abbozzare la storia della bandiera rossa significa ripercorrere parzialmente la storia del proletariato. Ma significa delinearla da un punto di vista particolare, poiché il fatto d 'inalberare la bandie ra rossa è un tratto rivelatore di una certa maturità sociale, di un certo grado di coscienza sociale, di un sicuro istinto rivoluzionario o talvolta, più semplicemente, d'uno spirito di rivolta e len1entare. AJ tempo stesso, fare la storia della bandiera rossa vuol dire, in un certo senso, concretizzare la storia prol etaria e socialista, perché significa sce gliere in questa storia un oggetto reale che presenta, rispetto ad altre espressio ni dell'azione operaia, il vantaggio di essere misurabile e tangibile, il che evita grossi rischi d'errore . Vuol dire, inoltre, entrare nel campo del simbolismo proletario e rivoluzionario che merita attenzione e studio allo stesso titolo della simbolica reli giosa o nazionale. Mettere in evidenza il significato mentale, morale, socia le implicito nello spiegamento della bandiera rossa, penetrare l'anima di una collettività nella misura in cui si rivela con quest'atto, significa anche in larga misura prendere conoscenza della sua tradizione, individuare le sue consuetudini che rivelano tensioni intime e forze profonde molto meglio di quanto non facciano mozioni di club o congressi, o discorsi di leader". E uno storico italiano recentemente ha scri tto: "anche nel campo dei governati, dei dominati, dei subalterni, dei vinti , la bandiera è stata -e continua ad essere sia pure in varia misura un emb lema nel quale ci si riconosce come collettivo. Lo sa chi ha analizzato le vicende dei mo ti risorgimentali, le insorgenze contadine ed operaie, lo sa chi ha vissuto la guerra partigiana e, sebbene vaccinato dall'orgia dei drappi, dei gagliardetti, dei vessilli del Regime, ha dovuto riconoscere l'esistenza a livello popolare di un indistruttibile anche se discreto per non dire pudico desiderio, quando non amore, di bandiera", concludendo poi con questa affermazione "la bandiera è un documento non trascurabile della simbologia delle masse perché reca nei segni i motti e le figure diventati patrimonio di moltitudini"
• P er i popoH del Terzo Mondo, di più recente emanci pazione, per i quali occorreva creare rapidamente una salda coscienza di identità nazionale, la bandiera si è

rivelala il mezzo più idoneo per affermare la prem inenza dell'idea nazionale rispetto alla religione , alla tradizione tribale, alla lingua ed all'ideologia politica.
P er quanto il disegno ed i colori di ogni bandiera d er ivino dall e tradizioni e dalla storia, è molto difficile int erpretarne il significato perché, a differ enza dell ' araldica, dove i metalli ed i colori hanno un valore abbastanza preciso, in campo vessillologico ogni Nazione giustifica la scelta dei suoi colori in modo di verso.
I.:azzmTO, ad esempio, vuole simboleggiare il cielo nella bandiera cilena, il mare in quella del Gabon, il fi ume Gambia nella bandiera della Repubblica del Gambia, i nobi li ideali in quella filippina e, per finire, l'uguaglianza e la giustizia nella bandiera della Repubblica di Cina.
Il colore rosso rappresenta generalmente il sangue di coloro che sono morti per la Patria o il coraggio dei cittadini, ma può ugualmente indicare: l'ardore con il quale il popolo si impegna nel processo dinamico di costruzione del Paese ( Guyana ); il sole (Laos); la carità, la fedeltà e l'amore (Repubblica del Togo); lo splendore dei focolari alla sera (Principato di Liechtenstein); il fiume Volta Ro sso (R ep ubblica dell 'Al to Volla); oppure ricordare il colore tradizionale di un gruppo e lnico (g li Ha n, maggioranza della popolazion e cinese) o di una setta relig iosa (i musulmani Kharigiti dello Stato di B ahrein) o di un partito politico (partito liberale della Repubblica di Panama).
Così il colore verde, a volta a volta, è simbolo di speranza (R epubblica dello Zaire), di ricchezza agricola (R epubblica del Gabon) , di fede musulmana ( R egno dell'Arabia Saudita).
Anche l'interpretazione dei simboli più spesso usati nelle bandiere non è sem pre agevo le, in quanto ogni Stato è libero di attribuire ad essi il significato che più gli aggrada.

In linea generale, la croce indica l'appartenenza d e lla popolazione alla religio ne cristiana, ma vi sono delle eccezioni, nella bandiera giamaicana, ad esempio, l a croce di S. Andrea che vi campeggia vuo l e ricordare l'Union J ack britannica.
La stella vuole generalmente rappresentare l'indipendenza, come ad esempio nella bandi era del Ghana , ma può anche rappresentare i cinque continenti del mondo e quindi l'unità del genere umano, come nelle bandiere di molti P aesi comunisti E così un certo numero di stelle può indicare il numero degli Stati com ponenti una Federazione, come le 50 stelle della bandiera degli USA , ma anche avere un significato completamente d iverso, come nella bandiera della R epubblica Popolare Cinese, dove quattro piccole stelle accanto ad una più grande simboleg giano la guida del partito comunista sulle quattro classi sociali : gli operai, i contadini, i piccoli borghesi e d i capitalisti patriottici.
La mezzaluna è il simbolo della religione islamica e compare, infatti, in quasi tutte le bandiere degli Stati musulmani, ma nella bandiera marocchina tale religione è indicata invece con la stella di re Salomone.
Infine, un rapido scorcio sulle più diffuse combinazioni di colori usate in vessilogia.
I.:antico tricolore zarista bianco, azzmTO e rosso per quanto imposto da Pietro il Grande e non espressione di una tradizione, si integrò talmente nel simbolismo russo che nel XIX secolo divenne l'emblema del nazionalismo panslavo. Ancora oggi quei colori, chiamati appunto panslavi, compaiono nelle bandiere di numerosi Stati slavi.
I colori panarabi verde, bianco, rosso e nero hanno invece un'origine religiosa e storica Essi ricordano, infatti , le bandiere degli Ommayyadi (bianca), degli Abbassidi (nera), dei Fatimidi (verde) e degli Ottomani (rossa) e sono oggi ripresi, almeno in parte, in tutte le bandiere arab e .
Il verde, il giallo ed il rosso, colori della bandiera etiopica, sono invece considerati colori panafricani, perché colori dell'unico Stato africano da tempo imme morabile indipendente . Essi sono stati adottati da molti nuovi Stati, come il Senegal, il Mali, il Camerun, anche se ciascuno di questi Stati li ha giustificati con diverse motivazioni

"Come tutti gli altri tricolori, il tricolore italiano è una variante della bandi era della rivoluzione francese. Si formò in tempo non ancora ben precisato, con la sostituzione del verde all'azzurro; e perciò può considerarsi l'emblema più fedele dei principi della rivoluzione, perché il verde, secondo il simbolismo massonico eredi tato dai giacobini, rappresentava allora la natura e con essa l'acquisto dei diritti di natura : uguaglianza e ubertà", così Fausto Nicolini sulle pagine dell'Enciclopedia Italiana (voi. VI, pag. 77), ma l'autorevolezza dell'a u tore e del testo non esimono dall'aggiungere qualche precisazione .
Napoleone B onaparte, G enera l e in Capite dell'Armata d'Italia, il 17 vendemmiajo dell'anno V della R epubblica francese una ed indivisibile (]'8 ottobre 1796) scriveva all 'Amministrazione Genera le della Lombardia, l'organ ismo civile presieduto dal Sommariva che governava il ducato di Milano sotto l ' occhiuta tutela francese, approvando la costituzione di un reparto di volontari che si sarebbe affiancato alle truppe francesi nella gu erra contro l'impero asburgico. "La libertà della Lombardia, e la felicità de' loro compa t r iotti, sarà il premio de' loro sforzi, e d il frutto della vittoria" prometteva Napoleone che l'1 1 ottobre informava il Di rettorio c i rca la costituzione di una "Légion Lombarde. Les couleurs nationa1 es qu'ils ont adoptés son le vert, le blanc et le rouge"
Come ha notato il Glusi 1 , "tanto nell 'arte che nella r et torica si era allora in pieno classicismo, sembrava indispensabile 1icorrere alle memorie degli antichi Romani r i evocando per la denominazione dei primi corpi mobili itali ani quella suggesti v a di legione, la quale, anz i ché di battagHoni e compagnie, non poteva co mporsi che di coorti e di centurie".
La L eg ione Lombarda fu pertanto articolata in: sei coorti, ciascuna di cinquecento uomini suddivis i in cinque centurie; una divisione di artiglieria, una compagnia di cacciatori a cavallo . S econdo l'art icolato progetto elaborato dall' An1mini strazione G enerale della Lombardia ogni coorte avrebbe avuto "il suo S tendardo tricolorato Naziona le L ombardo d i stinto per n u mero, ed ornato dagli emblemi della Libertà".

In effetti il 6 novembre 1796 nel corso di una solenne cerimonia alle ore cinque pome ridiane sulla piazza del Duomo , come riportava il Corriere Milanese del giorno dopo, la prima coorte della Legione Lom b arda r i cevette la bandiera 2 • Nei giorni seguenti, senza particolari cerimonie pubbliche , anche l e resta n ti ònque co ort i ricev ettero la l oro bandiera .
1 Enri co Ghi si, Del tricolore ita liano, Torino, Fratelli Bocca Editori, I 912, pag. 30.
i La Leg io n e L om bard a, sotto il comando d e l milanese Giu seppe D e La H oz Ortis di fam ig li a or iund a spagnola g io va nissimo aveva militato co n o nore n e lJ' eserc ito austriaco d e l B eaulieu prese p arte alla battaglia di Arc o le (16 novembre 1796 ) contro g li Austriaci e, successivamente, allo sco ntro di Faenza (2 febbraio l 797) con le truppe pontificie comporta ndo si sempre molto di gnitosamente.
Queste sei bandiere, quasi incredibilmente sopravvissute a tanti sconv olgimenti militari e politici , sono ora custodite uell'Hures Museum di Vienna le prime cinque e nel Musée de l'Armée all'Hotel des Invalides a Parigi la sesta. Nel Museo del Risorgin1ento di Milano è invece custodiata la bandiera della compagnia cacciatori a cavallo della Legione, bandiera consegnata al reparto probabilmente in epoca successiva.
Queste bandiere non sono identiche, differiscono però per piccoli particolari per cui descriveremo per tutte solo quella assegnata alla 1a coorte.
Il drappo di questa bandiera, di seta, è alto 132 cm ed è composto da tre teli larghi 50 cm di cui quello verde è all'asta, quello bianco al centro, quello rosso al battente3. Sul lato dfritto del drappo , in alto al centro, è cucito un largo nastro svolazzante, ora di colore giallo, stù quale campeggia la scritta "Subordinazione alle leggi militari" in argento. Nel centro del drappo un berretto frigio di colore rosso, rivolto al battente, orlato in basso da una striscia bianca, rossa e verde. Sotto il berretto, 1a scritta in argento:
Ancora più sotto un simbolo massonico: la squadra con il pendolo , riprodotta nei colori naturali.
Una corona di quercia racchiude il tutto.
Su lato rovescio del drappo il nastro svolazzante reca la scritta "Eguaglianza o morte" mentre sotto il consueto cappello frigio, sempre rivolto al battente e sempre con la base tricolore, la squadra con il pendolo è fiancheggiata dai pugnali di Bruto e di Cassio che hanno il manico tricolore.
Anche nel lato rovescio il tutto è racchiuso da una corona di quercia.
L'asta, unita al drappo da una spirale di chiodi con la capocchia dorata, è sormontata dalla freccia a forma di picca, alta circa 18 cm, di metallo dorato. Completa la bandiera la cravatta tricolore, lunga circa 40 cm, annodata alla base della freccia.
Come ha notato il Ghisi "il tricolore della Legione Lombarda al suo apparire fu essenzialmente distintivo militare perché non si scambiassero dai nemici in campo aperto le milizie italiane per francesi e non restasse menomato il prestigio di queste ultime se per awentura alle prime non arridesse ]a fortuna delle armi".
Ineccepibile l'annotazione del Ghisi per quanto riguarda la natura del primo tricolore: bandiera militare e non bandiera di Stato. Lacunoso, invece, l'insigne ricercatore per quanto attiene alle motivazioni che fecero prescegliere il colore verde, e non, per esempio, il colore giallo per differenziare il tricolore lombardo da quello francese.
Come si è visto, Fausto Nicolini ritiene che il verde sia stato proposto ed accettato sulla base di una suggestione massonica che la presenza della squadra e del pendolo sulle bandiere della Legione Lombarda sembrerebbe confermare. Deve inoltre essere considerato come elemento a favore di questa ipotesi che la mas-
• Per quanto riguarda la terminologia della bandiera si r imanda all ' Appe ndic e al volume Ter minologia.

 Tavola IV Tricolore della Legione Lombarda.
Tavola IV Tricolore della Legione Lombarda.

soneria, con il suo programma di fratellanza universale e di impegno morale pe r il progresso dell'umanità, ebbe un peso notevole nell'affermazione degli ideali propri all'ill uminismo ed alla rivoluzione francese.
Altri studiosi ritengono che la scelta del verde sia stata suggerita dall'uniforme bianca e verde della milizia urbana milan ese, istituita fin dal 1633 dal governo vicereale spagnolo 4 •
La retorica romantica del Risorgimento, infine, rifiutando le ipotesi più razio nali , ha voluto accreditare la leggenda che il verde, jj bianco ed il rosso fossero sempre stati i colori italiani, ricercando le pretese origini dei nostri colori addirittura nella Divina Commedia, ricordando due terzine del canto XXIX del Purgato rio: "tre donne in giro, da la destra rota, / venian danzando: l'una tanto rossa, / ch'a pena fora dentro al foco nota; / l'aJtr'era come se le carni e l'ossa/ fossero state di smeraldo fatte; / la terza parea neve testé mossa".
Giovanni Berchet, infine, inspirato dalle rivolte scoppiate nel 183 1 a Modena ed a Bologna, nell' O de All'armi! All'armi! ha offerto dei tre colori un'interpretazione suggestiva che, pur essendo priva di riscontri documentali, per lungo tempo è stata accolta, se non dalla mente, dal cuore degli Italiani 5 :
"Dall'Alpi allo Stretto fratelli siam tutti/ Su i limiti schiusi, su i troni distrutti / piantiamo i comuni tre nostri color!/ Il verde, la speme tant'anni pasciuta;/ il rosso, la gioia d'averla compiuta; I il bianco, la fede fraterna d'amor" .
La reazione politica dell'Emilia all'invasione francese era stata molto vivace e Napoleone, deciso a dare gradualmente vita nell'I talia settentrionale ad un organi smo statale in grado di proteggere il fianco della repubblica francese e di costituire in poco tempo una base al suo potere personale da contrapporre al Direttorio, approvò le rivolte di Reggio e di Modena contro il regime estense ed incoraggiò gli approcci che i gove1ni provvisori di quelle città avevano stabilito con gli analoghi orga nismi sorti a F e rrara e d a Bologna dopo l'invasione francese degli Stati della Chiesa.

A Modena dal 16 al 18 ottobre 1796 si tenne un primo Congresso nel quale i d elegat i delle quattro città decisero di unirsi in una sola Repubblica, che fu stabilito di chiamare Cispadana, e di contribuire allo sforzo bellico francese contro l'impero d'Austria arruolando una Legione Italiana, forte di tremila volontari suddivi si in cinque coorti di seicento.
Il Congresso, particolare significativo, deliberò inoltre che ciascuna coorte avesse '1a sua bandiera a tre colori nazionali ita1iani ado1na degli emblemi della libertà" e che anche l'uniforme dei v olontari fosse dei colori "già amm ess i dai nostri confratelJi lombardi".
" Vds al riguardo quanto pubblicato da Vittorio Fiorini sulla Nuova Antolog ia alla fine dell'OtLocento (vol. LXVII (1897) pagg. 239-267 e 676-710).
' Ancora nel 1915 nel libro di lettura per i soldati Un anno di vita al reggimento, dovuto alla penna di Ettore Toschi maggiore nel 67° fanteria, come decimo ed ultimo comandamento del "Decalogo de l soldaLO" è scri.llo: "Rivolgi la mente alla tua bandiera. Essa esprime tutto quanto il Re e la Patria attendono: nel verde la speranza nel suo glorioso avvenire, nel bianco la fede n e' suoi figli; nel rosso l'amore di tutti verso di Lei".
Per la prima volta Italiani di due Stati diversi, e spesso in lotta tra loro, si dic hiaravano fratelli e proclamavano la loro volontà di far parte di un unico organis mo statuale! La grande importanza dell'evento fu efficacemente sottoli neata da Tommaso Casini e da Vittorio Fiorini che ne] 1895 , pubblicando per la prima volla gli Atti del Con gresso Modenese per la Federazione Cispadana, scrivevano: "Il Congresso di Modena fu il primo passo fatto dai nostri avi su lla via dell'unificazione nazionale. Ivi convennero ad affermarsi fratelli i rappresentanti di quattro nobili provincie, le quali nella loro s toria non avevano avuto più nulla di comune dopo i tempi di Federico Barbarossa; ed è si ngolare che in quel primo affratellamento il loro pensiero coITesse appunto alla Lega Lombarda, che significava tacilamente l'avversione agli stranieri; come non è senza un'alta significazione polilica l'appello che essi rivolsero , fosse pur sotto l ' impul so del Bonaparte, alle restanti popolazioni ilaliane, perché tutte si affrettassero a 1icongiungersi alla madre comune".
Al Congresso di Modena seguì, dal 27 dicembre 1796 al 9 gennaio 1 797 , il Congresso di Reggio Emilia che detl e completezza legale e cornice giuridica alle nobili aspirazioni dell'asse mblea modenese.
"Libertà Uguaglianza. Reggio, 27 dicembre 1796 ossia 7 Nevoso. Riuniti in Reg gio nel predetto giorno i deputati delle quattro popola~ìoni di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio si radunano nel luogo destinato alle ore undici antimeridiane"°, iniziano cos1 gli Atti del Congresso Cispadano che riuniva nel palazzo del Comune di Reggio Emilia 102 delegati , di cui 36 erano bolognesi, 24 ferraresi, 22 modenesi e 20 reggiani. Erano prese nti, inoltre, co me uditori i rappresentanti della Repubblica Transpadana. Nel corso della seduta inaugurale il delegato bolognese Vincenzo Brunetti presentò la mozione che avrebbe decretato la na scita ufficiale del primo Stato democratico unita1io italiano, proponendo "di convenire fin d 'ora nella massima di formare le quattro Popolazioni una Repubblica una ed indivisibile, dipendente però dalle condizioni, e dai modi da stabilirsi in appresso".
In un'atmosfera e di esultanza e di entusiasmo la proposta fu approvata all'unanimità, nacque così la Repubblica Cispadana.
Altra risoluzione significativa fu presa nella seduta de] 3 gennaio quando il Congresso adottò "per emblema della Repubblica un Turcasso con quattro frecce, attorniato dalla corona civica colla iscrizione Repubblica Cispadana una ed indivisibile. Tale sarà anche il sigiJlo della Repubblica".
Ma per quanto riguarda l'argomento di questo volume la seduta più importante del Congresso fu quella del 7 gennaio 1797, nella quale il delegato di Lugo di Romagna Giuseppe Compagnoni 7 propose, ed il Congresso approvò, "che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di tre colori Verde, Bianco e Rosso e che questi tre colori si usino anche nella Coc carda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti".

Villoria Fiorini, Gli atti del Congresso Cispadano nella città di Reggio (27 dicembre 1796 9 gennaio 1797), Roma, 1897.
Giuseppe Compagnoni (1754-1833) per la sua cultura giuridica offrì al congresso un rilevante contributo di pensiero e fu il proponente di numero se deliberazioni di grande importanza. Nella sua ampia produzione letteraria e giuridica un posto di rilievo spetta agli Elernenti di dirillo cosrituzio11ale democratico, ossia principi di giuspubblico universale, nei quali vengono fissali i principi statutari di quello che oggi si chiama diritto costituzionale, per la prima volta distinto dal giusnaturalismo o diritto cli natura nel quale era sempre stato compreso.
 Tavola V Bandiera del Rovatti.
Tavola V Bandiera del Rovatti.

Questa deliberazione del Congresso di Reggio è l'atto di nascita della Bandiera italiana in quanto per la prima volta il Tricolore è adottato come bandiera di Stato.
SulJ'esatta foggia del tricolore cispadano, soprattutto per quanto riguardava lo stemma centrale, le incertezze ed i dubbi sono stati molti, anche perché gli Atti del Congresso ci sono pervenuti senza alcun disegno.
Il sacerdote modenese Antonio Ro va tti nella sua diligente e puntuale Cronaca Modonese dell'anno 1797 vecchio stile e 1 ° della Repubblica Cispadana registrò la parata militare della Guardia Civica Modon ese del 12 febbraio 1797 e ne disegnò la bandiera, così descritta dal Ghisi: "L'asta è fittamente tricolorata a spirale coi colori italiani e termina con una lancia dorata da cui pendono tre cordoni con fiocch i, uno bianco, uno rosso ed uno verde. Il drappo s i compone di tre teli orizzontali : quello rosso, che è il primo in alto presso la lancia, porta in lettere d 'oro l'iscrizione:
Il telo bianco presenta nel mezzo il turcasso rosso orlato d'oro con quattro frecce, accerchiato da un serto verde, metà d'alloro e metà di quercia, ed ai fianchi le sigle in oro: R.C. , evidentemente "R ep ubblica Cispadana" . Il telo verde porta in lettere d'oro la scritta:
Anche il Fiorini ritenne che la bandiera disegnata dal Rovatti, d e purata dalle scritte, fosse quella ufficiale della Repubblica Cispadana, ma le approfondite e sagaci ricerche condotte da Ugo Bellocchi 8 negli anni sessanta di questo secolo hanno finalmente chiarito ogni dubbio ed hanno permesso di ricostruire con esattezza la veridi ca roggia della prima bandiera italiana di Stato.

Il drappo si componeva di tre teJi orizzontali, quello rosso in alto, quello bianco al centro e quello verde in basso, come nella bandiera della Guardia Civica Modonese disegnata dal Rovatti, la differenza è nello stemma dello Stato collocato al centro del telo bianco. Scrive il B ellocchi: ' Tarma della Repubblica Cispadana è racchiusa in un ovale che contiene, a s ua volta, la corona civica rappresentata dal le tradizionali fronde di alloro. Più al centro, un turcasso, a forma cU cono capovollo , con il vertice affondato in un trofeo composto di lanc e, di un fascio littorio, di due bandiere e di un cannone, ospita quattro frecce. Alla base del turcasso, un tamburo militare; ai lati le lettere RC (Repubblica Cispadana)" 9 •
Ci siamo dilungati, con molta pignoleria, forse troppa, sulle caratteristiche morfologiche della bandiera della R ep ubblica Cispadana, primo nucleo di uno Stato italiano a struttura unitaria e democratica, per un doveroso scn1polo di pre cisione . P er ravvivare l'interesse del lettore , il commento sull'importanza storica e politica dell'evento sarà pertanto affidato alla robusta arte oratoria di Giosuè Carducci, del qual e si riporta integralmente il discorso celebrativo Per il Tri colore, pro
' Ugo Bellocchi, li primo Tricolore. Reggio Emilia 7 gennaio I 797, R eggio Emilia, 1963.
• Ugo Bellocchi, la storia d' Italia na,rnta dal tricolore, 1796-1986, Reggio Emilia, Società Emiliana Editoriale, 1985, vol. 1, pag. l 16.
nunciato a Reggio Emilia il 7 gennaio 1897 in occasione del primo compleanno centenario de]]a nostra Bandiera: "Popolo di Reggio , Cittadini d'ItaHa, ciò che noi facciamo ora, ciò che da cotesta lapide si commemora, è più che un fatto. Noi celebriamo, o fratelli, il natale della patria. Se la patria fosse anche a noi quello che era ai magnanimi antichi, c ioè la suprema religione del cuore, dell'intelletto, della volontà; qui, come nelle so lennità di Atene e d'Olimpia, qui, come nelle ferie laziali, sorgerebbe, vampeggiante di purissimo fuoco, l 'altare della pania; e un Pindaro nuovo vi condurrebbe intorno i candidi cori dei giovani e delle fanciulle cantanti le origini, e davanti sorgerebbe un altro Erodoto leggendo al popolo ragunato l e istorie, e il feciale chiamerebbe a gran voce i nomi dell e città sorelle e giurate. Chiamerebbe te, o umbra ed etrusca Bologna, madre del diritto; e te Modena romana, madre della storia, e te epica Ferrara, ultima nata di connubii veneti e celti e longobardi s u la mitica riviera del Po E alle venienti ap1irebbe le braccia Reggio animosa e leggiadra, questa figlia del console M. Emilio L ep ido, e madre a Ludovico Ariosto, tutta lieta della sua lode moderna; ché "città animatrice d'Italia" la salutò Ugo Foscolo, e dal seno di lei canta il poeta d ella Mascheroniana
favilla scoppiò donde primiero
Di nostra libertà corse il baleno.
Ma i tempi sono oggimai sconsolati di bellezza e d'idealità: direbbesi che manchi nelle generazioni crescenti la coscienza nazionale, da poi che troppo i reggitori hanno mostrato di non curare la nazionale educazione. I volgh i affollantisi intorno ai baccani e agli scandali, dirò così officiali, dimenticano, anzi ignorano , i gior ni delle glorie; nomi e fatti dimenticano della grande istoria recente, mercé dei quali essi divennero, o dove va no divenire , un popolo: ignora il popolo e trascura, o solo se ne ricordano per loro interessi i partiti.
Tanto più siano grazie a t e, o nobile Reggio, che nell'oblio d'Italia commemori come nella sala di questo palazzo di città, or sono cent'anni, il 7 gennaio 1797 , fu decretato nazionale lo stendardo d ei tre colori . Risuonano ancora nell'austerità della storia a vostro onore, o cittadini, le parole che di poi due giorni il Congresso Cispadano mandava da queste mura al popolo di Reggio: "Il vostro zelo per la causa della libertà fu eguale al vostro amore per il buon ordine. Sapranno i popoli di Modena, di Ferrara, di Bologna qual sia il popolo di Reggio, giusto, energico, genero so; e si animeranno ad emularvi nella carriera della gloria e della virtù. L'epoca della nostra Repubblica ebbe il principio fa queste mura; e quest'epoca luminosa sarà uno de' più bei mo men ti della città di Reggio".
Il presidente del Congresso Cispadano dicea vero.
L'Assemblea costituente delle quattro città segnò infatti il primo passo da un confuso vagheggiamento di confederazioni al proposito dell'unità statuale, che fu il nòccio]o dell'Unità nazionale . Qu elle città che fin allora s'erano riscontrate solo su campi di battaglia con la spada calante a ferire, con l'ira scoppiante a maledire; che fino in una dissonanza d'accento tra ' fraterni dialetti cercavano la barriera immortale della division e e dell'odio; che fino inventarono un modo nuovo di poesia p er oltraggiarsi; quelle città si erano pur una volta trovate a gittarsi l'una d e ll e braccia dell'altra , acclamando la Repubblica una e indivisibile.

Quale spirito di Dio scese dunque in cotesta sala a illuminare le menti, a rivelare tutta insi e me la visione del passato e dell ' awenire, Roma che fu la grande , Ital ia che sarà la buona? Certo l' antico ed eterno spirito di nostra gente, che dalla fusione confluito delle varie italiche stirpi fu accolto e dato in custodia della Vesta romana dal cuore di Gracco e dal genio di Cesare , ora commosso dall'aura de' tempi nuovi scendeva in fiamme d'amore su i capi dei deputati cispadani, e di essi usciti di recente dalle anticamere e dalle segreterie de' legati e dei duchi faceva uomini pratici del reggimento libero, cittadini osservanti del giusto e dell'equo, legi slatori prudenti per il presente, divinatori dell'avvenire.
E già a Roma, a Roma, sì come a termine fisso del movimento iniziato, era volata nei discorsi e nei canti la fantasia patriottica; ma il senno ed i l cuore mirò da presso il nemico eterno nel falso impero romano germanico, instrumento d'infor me despotismo alle mani di casa d'Austria, sicchè prima a quei giorni ris u onò in Reggio la non mai fin allora cantata in Italia reminiscenza della lega lombarda e di Legnano; sicché impaziente ormai d'opere la gioventù affrettò in Montechiaru golo le prove di una vendetta di Gavinana. Per ciò tutto, R eggio fu degna che da queste mura si elevasse e prima sventolasse in questa piazza, segnacolo dell'unico stato e della innovata libertà, la bella la pura la santa bandiera dei tre co lori.
Sii benedetta! benedetta nell'immacolata ori gine, benedetta nella via di prove e di sventure per cui immacolata ancora procedesti, benedetta nella battaglia e nella vittoria, ora e sempre, nei secoli! Non rampare di aquile e leoni, non sormontare di belve rapaci, nel santo vessillo; ma i colori della nostra primavera e del nostro paese, dal Cenisio all'Etna; le nevi delle alpi, l'aprile delle valli, le fiamme dei vulcani. E sùbito quei colori parlarono alle anime generose e gentil i, con le ispirazioni e gli effetti delle virtù onde la patria sta e si augusta; il bianco, la fede serena alle idee che fanno divina l'anima nella costanza dei savi; il verde, la perpetua rifioritura della speranza a frutto di bene nella gioventù de' poeti; il rosso, la passione ed il sangue dei martiri e degli eroi. E sùbito il popolo cantò alla sua bandiera ch'ella era la più bella di tutte e che sempre voleva lei e con lei la libertà: ond'è che ell a, come là dice la scritta, Piena di fati mosse alla gloria del Campidoglio .
Noi che l'adorammo ascendente in Campidoglio, noi negli anni della fanciul lezza avevamo imparato ad amarla e ad aspettarla dai grandi cuori degli avi e dei padri che ci narravano le cose oscure ed alte preparate, Lentate, patite, su le quali tu splendevi in idea, più che speranza, più che promessa, come un'aureola di ciel o a' rnorienti e a' morituri, o santo tricolore E quando tu in effetto ricomparisti a balenare su la tempesta del portentoso Qua rantotto i nostri cuori a1la tua vista balzarono di vita novella: ti riconoscemmo: eri l'irid e mandata da Dio a segnare la sua pace co l popolo che discendeva da Roma, a segnare la fine del lungo obbrobrio e de] triste servaggio d'Italia. Ora la generazione che sta per isparire dal combattuto e trionfato campo del Risorgimento, la generazione che fece l'Unità, te, o sacro segno di gloria, o bandiera di Mazzini d i Garibaldi di Vittorio Emanuele, te commette alla generazione che l'unità deve compiere, che dee coronare d'idea e di forza la patria risorta.
O giovani, contemplaste mai con la visione dell'anima questa bandiera, quando ella dal Campidoglio riguarda i colli e il piano fatale onde Ro ma discese e lanciossi alla vittoria e all'incivilimento del mondo? o quando dalle antenne di San Marco spazia sul mare che fu nostro e par che spii nell'oriente i regni della commerciante e guerreggiante Venezia? o quando dal Palazzo de' P iori saluta i clivi a

cui Dante saliva poetando, da cui Michelangelo scendeva creando, su cui Galileo sancì la conquista dei cieli? Se una favilla vi resti ancora nel sangue dei vostri padri del Quarantotto e del Sessanta, non vi pare che su i monumenti della gloria ve tusta questo vessillo della patria esulti più bello e diffonda più lieto i colori della sua gioventù? Si direbbe che gli spiriti antichi raccoltigli intorno lo empiano ed inanimino dei loro sospiri, rallegrando ne' suoi colori e ritemperando in nuovi sens i di vita e di speranza l'austerità della morte e la maestà delle memoria.
O giovani, l'Italia non può e non vuol essere l'impero di Roma, se bene l'età della violenza non è 6nita pe' validi: oh quale orgoglio umano oserebbe mirare tant'alto? Ma nè anche ha da essere la nazione cortigiana del rinascimento, alla mercé di tutti: quale viltà comporterebbe di dar sollazzo delle nostre ciance agli stranieri per ricambio di battiture e di stragi? Se l'Italia avesse a durar tuttavia come un museo o un conservatorio di musica o una villeggiatura per l'Europa oziosa, o al più aspirasse a divenire un mercato dove i fortunati vendessero dieci ciò che hanno arraffato per tre; oh per Dio non importava far le cinque giornate e ripigl iare a baionetta in canna sette volte la vetta di San Martino, e meglio era non turbare la sacra quiete delle ruine di Roma con la tromba di Garibaldi sul Gianicolo o con la cannonata del re a Porta P ia. L'Italia è risorta nel mondo per sé e per il mondo: ella, per vivere, deve avere idee e forze sue, deve esplicare un officio suo civile ed umano, un'espansione morale e politica. Tornate, o giovani, alla scienza e alla coscienza de' padri, e riponetevi in cuore quello che fu il sentimento il vòto il proposito di quei vecchi grandi che han fallo la patria: L1talia avanti tutto! L'Italia sopra tutto!»
L'J l messidoro dell'anno V, il 29 giugno 1797, Napoleone, reso più ardito e più indipendente dal Direttorio dalla vittotia riportata sull'impero d'Austria, aggiunse un altro tassello al suo disegno politico ed annunciò la costituzione di un nuovo Stato: la Repubblica Cisalpina. "La Repubblica Cisalpina scrisse Napoleone nel proclama che dava vita al nuovo Stato stava da parecchi anni sotto il dominio della Casa d'Austria. La Repubblica Francese è succeduta a questa per diritto di conquista Essa vi rinuncia da questo giorno, e la Repubblica Cisalpina è libera ed indipendente. Riconosciuta dalla Francia e daU'Irnperatore, Ella lo sarà ben tosto ancora da tutta l'Europa . Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Francese non pago d'aver in1piegato la sua influenza, e le vittorie delle Armate Repubblicane per assicurare l'esistenza politica della Repubblica Cisalpina, spinge più lungi le sue sollecitazioni, ed essendo convinto, che se la Libertà è il primo dei beni, una rivoluzione sj trascina dietro il più terribile di tutti i flagelli, dà al Popol o Cisalpin.o la propria Costituzione : il resultato delle cognizioni della Nazione più illuminata . Perché questo passaggio possa farsi senza scosse, senza anarchia, il Direttorio Esecutivo ha giudicato dovere questa sola volta far nominare i Membri del Governo, e del Corpo Legislativo: di maniera che il Popolo non nominerà che dopo un anno alle piazze vacanti conformemente alfa Costituzione.
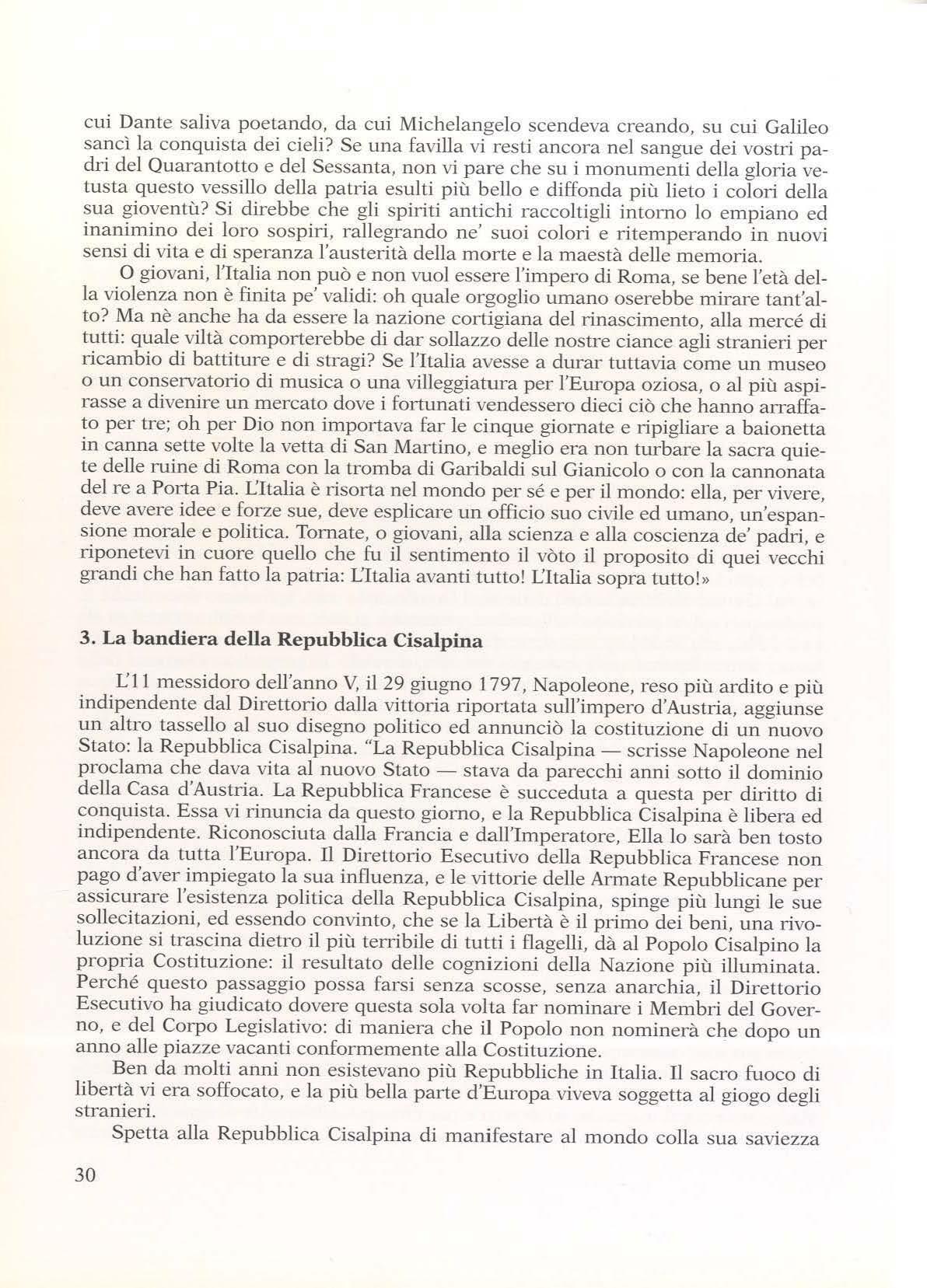
Ben da molti anni non esistevano più Repubbliche in Italia. Il sacro fuoco di libertà vi era soffocato, e la più bella parte d'Europa viveva soggetta al giogo degli stranieri
Spetta alla Repubblica Cisalpina di manifestare al mondo colla sua saviezza
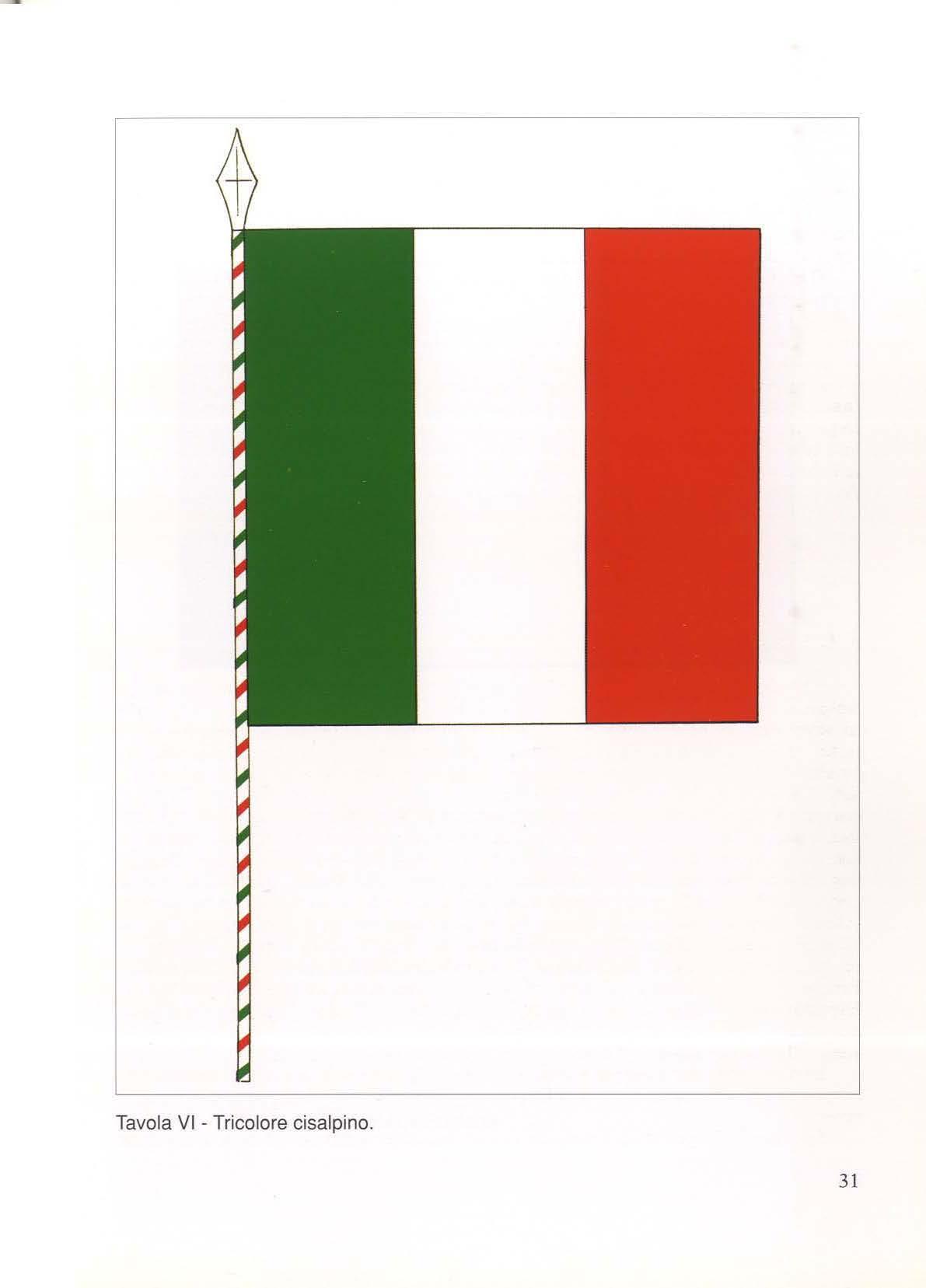 Tavola VI Tricolore cisalpino.
Tavola VI Tricolore cisalpino.

 Tavola VII a) Tricolore Repubblica Romana.
Tavola VII a) Tricolore Repubblica Romana.

 Tavola VII b) Tricolore Repubblica Partenopea.
Tavola VII b) Tricolore Repubblica Partenopea.

ed energ ia , e colla buona organizzazione delle sue Armate, che l'Italia moderna non ha degenerato, e ch'Essa è degna ancora della Lib ertà".
La Cisalpina quindi, secondo le intenzioni di Napoleone, doveva avere leggi francesi, essere governata da elementi ligi ai suoi vole1i e, soprattutto, contribuire a rafforzare l'esercito francese con nuovi corpi di truppe.

Tutlavia la R ep ubblica Cisalpina, comprendendo il t errit01io delle Repubbliche Transpadana e Cispadana, l e province già venete di Be rgamo, Brescia e Rovigo, parte della Valtellina, il ducato di Massa, il principato di Carrara e la Romagna, rappresentò con i suoi tre milioni e mezzo di abitanti l'embrione della futura nazione italiana ed anche la sua bandiera anticipò la foggia dell'attuale bandiera italiana.
Il 22 fiorHe dell'anno VI (11 maggio 1798 ), infatti, il Gran Consiglio della Repubblica Cisalpina dovendo definire la bandiera dello Stato "per uso della naviga z ion e, che per ogni altro pubblico segnale", deliberò finalmente : "w. Bandiera della Nazione Cisalpina è formata di tre bande parallele all'asta, la prossima all'asta verde, la successiva bianca, la terza rossa. L'Asta è similmente tricolorata a spirale, colla punta bianca".
Deliberazione importante e p er nulla scontata perché anche tra gli elementi riformatori più aperti alle nuove id ee i pareri non erano sempre concord i ed il particolarismo politico riaffiorava spesso sotto la pati na di una improvvisata ed imposta unità.
Nello stesso periodo altri Stati italiani , anch'essi nati all'ombra delJe baionette francesi, adottarono infatti bandiere nazionali di colori diversi: la Repubblica R o mana, in vita dal 15 febbraio 1798 al 29 settembre 1799, un t1icolore nero, bianco e rosso e la Repubblica Partenopea nella sua ancor più breve esistenza ( 22 gennaio 19 giugno 1799) ebbe si una "bandiera tricolore nazionale" ma blu, gialla e rossa .
La Repubblica Cisalpina, momentaneamente travolta dagli eserciti austro-russi, risorse dopo Marengo, ingrandita con la provincia di Novara e con quel1a di Verona fino all'Adige, e continuò a rappresentare un polo di riferimento per l'emer gente sentimento unitario che, sia pure con molti distinguo e con molte esitazioni, cominciava a fermentare n e ll'animo degli italiani.
Nel 1802 la R epubblica Cisalpina camb i ò finalmente nome, di ve nn e la R epu bblica Italiana con Napoleone P residente e Francesco M e l zi d'Eril Vice- P residente
Il clima politica n el frattempo era mutato, Napoleone non era più un cittadino genera le ma il P rimo Consol e e tutto doveva rientrare nell'alveo dell'ordine e della tradizione, dimenticando "gli eccessi della Rivoluzione" ed annacquando i principi dell'89.
Dopo l'abbandono del calendario rivoluzionario con conseguente ripristino di quello gregoriano (17 febbraio 1802), fu modificata la foggia della bandiera nazio nale. Il tri colore a bande verticali ricordava troppo l'origine rivoluzionaria e popolare dello Stato , il 20 agosto 1802 il Governo della Repubblica italiana deliberò la foggia de11a nuova bandiera: "un quadrato a fondo rosso, in cui è inserito un rombo a fondo bianco, contenente un altro quadrato a fondo verde".
P er rispetlo della verità occorre dire che il Melzi d'Eril avrebbe voluto elimin are il colore verde, mantenuto "per l'intervento di Napoleone e per le pressioni di forze morali massonico-democratiche", afferma ancora Fausto Nicolini.
Nel 1805 la R ep ubblica Italiana si trasformò nel R egno d'Italia, ingrandita con
Venezia e con il Tirolo. La bandiera del nuovo Regno non cambiò, almeno ufficialmente, perché ]e bandiere dei reparti del Regno d'Italia, infatti, erano di foggia diversa. Il rosso ed il verde erano disposti a triangolo attorno ad un rombo bianco che recava al centro un'aquila napoleonica di colore giallo. I.:asta, inoltre, era sormontata: da un'aquila di bronzo dorato se ]a bandiera era in dotazione ad un reparto della Guardia Reale, dal leone di San Marco se la bandiera era in dotazione ad un reparto di fanteria.
Un'ultima considerazione a chiusura del capilolo dedicato alle origini della bandiera italiana.
Se è vero che nella foggia e nei colori il tricolore italiano rivela una precisa derivazione da quello francese -e nelle pagine precedenti gli effetti della rivoluzione francese sulla società italiana dell'epoca non sono stati certo taciuti è anche vero che i giacobini italiani, ideatori del tricolore italiano, non furono soltanto amorfi esecutori delle volontà napoleoniche e pedissequi ripetitori di un verbo politico e sociale straniero.
Eredi spirituali del pensiero di Gaetano Filangieri e di Cesare Beccaria, i giacobini italiani furono in molte circostanze capaci di elaborare una autonoma proposta di riforme politiche, sociali ed economiche idonee allo sviluppo della società italiana e seppero inserire a pieno titolo nel nuovo clima ClÙturale europeo una nuova Italia, di cui il tricolore verde-bianco-rosso fu il simbolo.

Deve quindi essere condiviso il sereno e meditato giudizio di Benedetto Croce sui giacobini italiani:
« uniti coi loro fratelli di tutta Italia, trapiantarono in Italia l'ideale della libertà secondo i tempi nuovi, come governo della classe colta e capace, intellettualmente ed economicamente operosa, per mezzo delle assemblee legislative, uscenti da più o meno larghe elezioni popolari; e, nell'atto stesso, abbatterono le barriere che tenevano separate le varie regioni d'Italia, specialmente la meridionale dalla settenlrionale, e formarono il comune sentimento della nazionalità italiana, fondandola non più, come pri1na, sulla comune lingua e letteratura e sulle comuni memori.e di Roma, ma sopra un sentimento politico comune. Due ideali, dei quali il primo ora, dopo oltre un secolo che ha operato, si dice che sia invecchiato e da sostituire, e io non so cosa pensare di siffatti giudizi e delle congiunte aspettazioni, ma il secondo, per lo meno, è ancora vivo e forte Le supe1fi.ciali teorie di quei patrioti, la loro candida credenza nella nazione redentrice (la Francia, che di nuovo si presentava all'Italia e al mondo come quella della politica "generosa"), i loro errori di calcolo, la fanciullaggine di certi loro atti, i tentennamenti e le debolezze di alcuni tra loro, tutti questi aspetti negativi, sui quali si suole troppo insistere, sono un nulla a paragone dell'opera effettiva che con la loro fede veramente generosa essi compierono. Quando io ripenso a quei calabresi ed abruzzesi, basilicatesi e pugliesi, e napoletani di Napoli, che agitavano ardenti problemi politici nei giornali repubblicani della Cisal pina e in opuscoli e fogli volanti, che entravano nelle legioni italiane allora formate, che prendevano servizio presso i francesi o presso i nuovi governi democratici, e quando leggo i documenti delle relazioni e amicizie che essi allora legarono con lombardi e piemontesi e liguri e veneti, dico tra me: Ecco la nascita dell'Italia moderna, della nuova Italia, dell'Italia nostra».


 Tavola VIII b) Bandiera del Regno d ' Italia.
Tavola VIII b) Bandiera del Regno d ' Italia.

Ne] 1815 cadde con Napoleone anche l'ordine politico esistente nella penisola. "Sfasciatosi il Regno d'Italia che aveva raccolto in unità gran parte della prosperosa valle padana, g ià divisa fra cinque o sei padroni; discio]to l'esercito italico che, a giudizio anche di contemporanei e stranieri, era stato "il più grande awenimento storico della penisola negli ultimi secoli, l'inizio per l'Italia di un'era nuova" gli Italiani rientravano tutti nei quadri dei vecchi Governi restaurati, ma nel tempo stesso si mettevano al lavoro per creare, da sé, lo S tato nazionale". Così Gioacchino Volpe nella prima pagina della sua magistrale ltalia Moderna ' .
Ed anche il Pi eri iniziò la sua Storia militare del R isorgimento ricordando l'esperienza napoleonica: "Napoleone mai aveva voluto l'unità d'Italia, ma sotto il regime napoleonico l'Italia aveva pur ritrovato, dopo tanti secoli, una parvenza d'unità. All'infuori infatti della Sardegna , terra ospitale dei profughi re savoiardi, e della Sicilia, asilo dei Borboni e presidiata, insieme a Malta, dalla Gran B retagna, tutta l'Italia era francese e divisa in sole tre parti :
1) le province annesse alla Francia (Piemonte, Ligmia, Toscana, Umbria e Lazio), alle quali si potevano aggiungere le terre italiane facenti parte delle province illiriche, vera marca di frontiera del rinnovato impero di Carlo Magno (Gorizia, Trieste, fium e e la Dalma zia); 2) il Regno italico, unilo per unione personale all'imperatore dei Francesi e governato dal vicerè suo figliastro (Lombardia con Alessandria, Novara e la Valtellina, Veneto, Trentino, A1to Adige fin poco sopra Bolzano e Merano, Mod ena, Lega zioni e Marche); 3) il regno di Napoli dato al cognato di Napoleone, Gioacchino Murat.
E , in realtà, anche le parti in cui risultava divisa l'Italia erano fra loro ben poco separate; lo stesso sistema amministrativo: unità legislativa, uguag]ianza di tut ti i cittadini davanti alla Legge, libertà privata, libertà di coscienza in questioni religiose, secolarizzazione dei beni ecclesiastici; quesle caratteristiche del regime francese erano comuni alle varie parti d'Italia e indubbiamente avevano preparato il terreno all'unità politica vera e propria" 2 •

Certo il terreno era stato preparato, ma molto tuttavia era necessario fare. Citando a n cora il Volpe: "Il Risorgimento è una conquista de g li Italiani su se stessi, prima ancora che non sug] i stranieri Nulla di più falso di quella immagine oleografica, antica ma 1irnessa in grande circolazione gli ultimi tempi come d e bba essere ragione di vanto per noi, di un'Italia sempre, da secoli, fissa al pensiero dell'unità, fremente di spirito di indip endenza, ma sempre tenuta ferma, a dispetto di ogni suo diritto, dalle sue catene .
Si ebbero, su quella faticosa strada, tappe successive: ognuna più spedita e si cura di quella precedente" 3
•
1 Gioacchino Volpe , Italia modenza /815-1915 , voli. 3 , Firenze, Sansoni, 1946-1952.
2 Piero Pie1i, Storia militare del Risorgimento Guerre e insurrezioni, T orino, Einaudi, 1962, pag. 5.
' Gio acchino Volpe, op. cil., pag. 5.
La prima tappa fu coslituita dai moti carbonari di Napoli e di To1ino nel biennio 1820-1821, moti tendenti, soprattutto a Napoli, ad ollenere dai legittimi sovrani una costituzione, quella promulgata a Cadice dagli in sorti spagnoli ed accettata obtorto collo da re Ferdinando VIII , e non certo l'unità d'Italia. Ed il tricolore innalzato dai tenenti Morelli e Silvati a No la il 1° luglio 1820 fu, infatti, quello carbonaro, nero-rosso-turchino. La rivolta di Palermo, in disaccordo con Napoli ma anche con Messina e con Catania, dimostrò poi come il concctlo di It alia unita fosse ancora prematuro.
Anche nel Piemonte sabaudo l'obiettivo fu soprattutto la costituzione spagnola, so lo in seconda istanza la liberazione della Lombardia dall'oppressione austriaca. rl Pi eri afferma che sulla cittadella di Torin o i rivoltosi innal zaro no il tricolore carbo naro m entre su quella di Alessandria sventolava i l tricolore italian o verdebianco-rosso4, ma la notizia non appare certa. Il 1O marzo 1821 il colonnello Guglielmo Ansaldi della brigata Savoia, Presidente della "Giunta Provinciale Provvisoria di Governo", autonominatasi ad Alessandria', emanò il seguente proclama che rivendica infatti, innanzitutto, le libertà politiche;
"Cittadini!
Lo stendardo del dispotismo è per sempre curvato a terra tra noi. La Patria, che ha gemuto fi n ora sotto il peso di ob brobriose catene, respira finalmente l'aure soavi di fraternità e di pace.
Cittadini! l'ora dell'italiana indip endenza è suonata . La Co stituz ion e di Spagna che n e ll a notta del 9 cli questo mese è stata proclamata e giurata dal Reggimento Drago ni del Re, dalla Brigata di Genova, e dai Federati italiani, sarà l'unico statuto d'Italia, mercè di cui il R e, ed il Popolo uniti coi più san ti legami formeranno una so la famiglia.
Cittadini! n o n più ereditarie, o figlie dell'arbitrio, ma elettive saranno le dignità; non avrà in esse preminenza che il merito solo, e so lo nelle Leggi risiederà tulla la potenza dello Stato. Qu esto nuovo Codi ce di Patti Sociali, basato su lla Re li gione de' Padri nostri, sarà mallevadore alla Patria della di l ei interna sicurezza, e servirà di barriera imm ensa e stabile contro qualunque temerario tentativo di Straniere Falangi.
Cittadini! non la scia tevi traviare dai pochi sediz iosi nemici della pubblicità felicità, allontanale dal vostro cuore ogni sent im ento di ve ndetta , e gridate viva il R e, viva la Costituzione di Spagna, viva l'Italia".
Nessun proposito di guerra all'Austria per liberare il Lombardo-Veneto dunque, so llanto propositi di difesa.
Ll 1 marzo la Giunta poi emanò un prowedimento nel quale traspare Ja preoccupazione per un possibile intervento austriaco, del resto già in atto nel apoletano, tanto da decretare per J'esercito la som mini strazione di razioni di guerra:

"Considerando che coll'inalberare lo Ste nd ardo dell'Indipendenza la Nazione si è posta in stato di guerra contro l'Austria, e che essendo in questa att itudin e ostile i prodi che la difendono hanno diritto al trattamento delle genti di g uerra che trovansi in campagna, [la Giunta] ha decretato, e decreta quanto segue.
4 Piero Picri, op. cii., pag. 94.
' Gli altri membri della Giunta erano i capitani Barnnis e Palma, il tenente Bianco di Saint Jorioz, gli avvocati Liuzzi e Dossena, il medico Rattazzi ed il commerciante Appiani.
L'Esercito Italiano è costituito sul piede di guerra: e quindi da l giorno d'oggi in poi gli saranno somministrali li viveri di campagna".
Ancora difesa quindi di quanto è stato conseguito, non certo propositi di invasione dei domini austriaci! Anche l'affermazione che l'esercito si c hiama italiano e che è stato innalzato lo stendardo dell'indipendenza nazionale non deve trarre in inganno, si trattava infatti di reminiscenze napoleoniche che, tuttavia, hanno forse fatto erroneamen l e supporre al Pieri che il tricolore degli insorti di Alessandria fosse quello nazionale.
In realtà, come è scritto anche in un opuscolo cel ebrativo, pubblicato da] Comune di Alessandria il 10 marzo 1991 nel 170° anniversario dei moti e cw·ato da Giulio Massobrio, tutti i Lestimoni dei fatti del marzo 1821 ham10 lasciato testimonianze dell'esposizione del tricolore sulla cittadella occupata dai Dra gon i del Re la notte tra il 9 e iJ 10 marzo , ma non es ist e alcun accordo fra loro sui colori e sulla foggia della bandiera stessa.

Santorre di Santarosa, che peraltro la notte in questione non era in Alessandria, la descrive rossa, ver de e blue, il Beauchamp afferma invece che anche la bandiera alessandrina fosse nera, rossa e blue come quella innalzata a Tori no. Altre testimonianze, afferma sempre l 'op u scolo ci tato , sono altrettanto contraddittorie, se non ben più vaghe. "In ogni caso, certamente, il tricolore alessandrino non era quello, verde, bianco e rosso , che nel 1848 fu adottato dal R e gno di Sardegna e che si richiamava idealmente alla bandiera della Repubblica Cisalpina".
Come è noto la rivoluzione piemontese del 1821 durò soltanto un mese, soffo cata, come quella napoletana, dalle baionette austriache tra l'indifferenza popolare e l'ostili tà dell'alta gerarchia ecclesiastica. Il movimento democratico, a Torino come a Napoli, aveva evidenziato tutti i propri limiti ; molta strada doveva ancora essere percorsa per giungere alla rea lizzazione dell'unità nazionale in un quadro di lib ertà costituzionale, tuttavia, a differenza di quanto era accaduto tra la fine del S ettecento e l'inizio dell'Ottocento, la borghesia aveva dimostralo di saper prendere l'iniziativa del rinnovamento politico e sociale senza bisogno del soste gno di un esercito straniero. L'intervento repressivo austriaco contribuì, inoltre, non poco a diffondere il convincimento, almeno nel1e classi più colte, che la libertà non potesse essere disgiunta dall'indipendenza.
Nel luglio del 1830 la sollevazione del popolo parigino costrinse Carlo X a cedere iJ trono a Luigi Filippo d'Orleans, candidato della borghesia liberale guidata dal Thi.ers.
Le ripercussioni delJ'avvenimento in Europa furono notevoli, nell'agosto scoppiò la rivoluzione a Bruxel1es e nel novembre a Varsavia. La Francia, pro clamando il principio del non intervento, iiuscì a far riconoscere alle Grandi Potenze la secessione de] B elgio dall'Olanda, suscitando grande entusiasmo in Italia. Nel feb braio del 1831 scoppiò l'insurrezione a Modena, Reggio, Parma, Bo logna, Ancona. I1 duca di Modena dovette rifugiarsi a Mantova, la duchessa di Parma a Piacen za, i cardinah legati a Roma. L'insurrezione tuttavia, senza un v alido organismo direttivo che indirizzasse e coordinasse gli sforzi particolari di
ciascuna provincia e senza uomini di governo capaci ed esperti, fu facilmente soffocata dalle truppe austriache comandate dal Frimont, lo stesso generale che aveva sconfitto le truppe costituzionali napoletane nel 1821, nonostanle la valorosa resistenza opposta daj patrioti a Novi Modenese il 5 marzo e tra Sant'Arcangelo e Rimini il 25. La Francia di Luigi Filippo, infatti, soddisfatta dal successo ottenuto per il Belgio, aveva rinunciato al principio del non intervento per il caso italiano e l'Austria aveva subito ripreso il suo ruolo di zelante custode dell'assolutismo e di intransigente garante dell'assetto politico stabilito dal Congresso di Vienna.
Ma se i risultati raggiunti dalle insurrezioni furono modesti sul piano militare, furono notevoli sul piano politico. In tutte le sommosse il tricolore innalzato dai rivoltosi fu quello nazional e verde, bianco e rosso e la partecipazione ai moti dei ceti popolari fu, per la prima volta, di una notevole consistenza. E che il tricolore rappresentasse ormai il simbolo unificante di tutti gli Italiani è indirettamente provato dall'assurda durezza de ll a condanna, tre anni di reclusione, inflitta dal Tribunale Statario di Modena, alla contessa Rosa Testi Rangoni, colpevole di "aver cucita, di commissione del Capo Ribelle Ciro Menotti, una B andiera di seta, di color bianco rosso-verde, con scienza che la medesima dovesse servire alla Rivolta; e di non aver rivelato un si atroce delitto, diretto al pregiudizio di S .A.R. Fran cesco IV, nostro veneratissimo Sovrano"6 •
Nel giugno dello stesso anno a Marsiglia Giuseppe Mazzini fondava la Giovine Italia che, all'articolo 8 del suo statuto, stabiliva: "i colori della G i ovine Ital i a sono il bian co, il rosso, il verde. La bandiera della Giovine Italia porta su quei colori, scritte da un lato, le parole : Libertà, Uguaglianza, Umanità; dall'altro : Un i tà, I ndid ,, pen enza.
Il tricolore bianco, rosso e verde riceveva così il crisma definitivo che lo co nsacrava per il presente e per il futuro unico vessiJlo della libertà e dell'indipenden za d'Italia.
Gli evenb accaduti in Italia ed in Europa nel biennio 1848 1849 sono ben co nosciuti e, del resto, lo scopo ed i limiti di questo volume non ne consentirebbero una sia pur sommaria narrazione.

Saranno perciò 1icordati solo gli avvenimenti che ebbero un diretto r i flesso sulla definitiva affermazione del tricolore come bandiera nazionale.
U 12 gennaio 1 848 scoppiò a P alermo un moto insurrezional e con forti venature indipendentiste e, nel giro di un mese, le truppe borboniche, ad eccezione del presidio della cittadella di Messina, furono costrelte ad abbandonare la Sicilia . Q uasi contemporaneamente, il 25 ed il 26 gennaio, anche a Napoli si verificarono grandi ma1ùfestazioni popolari di protesta e re Ferdinando II, indubbiamente uno dei più retrivi sovrani dell'epoca, fu costretto a concedere l a costituzione, ricalcata sul modello francese del 1830.
• IJ fatto che Francesco TV, "vista ed approvata la sentenza", disponesse che la contessa Testi Rangoni scontasse la pena in un monasle ro e non in una fortezza non attenua la ferocia spropos itata della decisione del Tribunale.
3 . Il tricolore nel 1848-1849
La Sicilia, ferma nell'intenzione di ottenere la costituzione del 1812, si proclamò indipendente ed adottò, alla fine di marzo, come bandiera statale il tricolore italiano a bande verticali recante al centro del telo bianco la figura della Trinacria 7 •
Anche il nuovo governo di Napoli adottò una nuova bandiera, il 3 aprile dispose che la bandiera reale fosse "circondata dai colori italiani, si che formino un solo corpo di bandiera", in pratica un tricolore di foggia quanto mai inusuale: un rettangolo bianco, recante al centro lo stemma dei Borbone, racchiuso da una doppia bordatura, rossa quella interna, verde quella esterna 8
L'arrendevolezza alle richieste popolari di Ferdinando II costrinse anche altri sovran i italiani a concedere la costituzione.
Il 17 febbraio il granduca di Toscana promulgò la costituzione, seguito il 4 marzo da re Carlo Alberto di Sardegna ed il 14 dello stesso mese da Papa Pio IX.
Gli awenimenti italiani si ripercossero anche in Europa: il 2 l febbraio 1848 scoppiarono a Parigi disordini tanto estesi da travolgere la monarchia di Luigi Filippo; a Vienna il 13 marzo una rivolta, promossa inizialmente dagli studenti, co-
7 Trinacria, isola triangolare o terra dei tre capi , fu il nome della Sicilia fin dai tempi omerici e la triskelis, la figura umana con tre gambe, fu molto usata nell'antichità per indicare la Sicilia, tanto che il Governo Provvisorio dell'isola ne fece lo stemma dello Stato.
• Lo stemma usato a ll 'ep oca dai Borbone di Napoli era estremamente co mplicato. Di seguito la descrizione araldica, tratta dal volume L'araldica dell'esercito, edito dall'Uffici o Storico dello Sta to Maggiore Esercito nel 1985:
!'arme dei Reali delle Due Sicilie consisteva in uno stemma partito di quattro linee. Nel I grande partito: nel I O e nel 4 ° di oro, a sei gigli di azzurro, 1, 2, 2, 1 (Farnese); nel 2° e 3 ° di rosso, alla fascia d'argento (Asburgo), partito di Borgogna antica che è bordato d'oro e d 'az zurro con bordatura di rosso. Sul tulto del I grande partito: lo scudo di Portogallo di argento, con cinque scudetti di azzurro posli in croce, caricati di cinque bisanti di argenlo , segnati di un punto di ne ro, nel centro, messi in croce di S. Andrea, con la bordatura di rosso, caricata di sette castelli d 'oro, posti: tre nel capo , due ai lati e due inclinati a destra ed a s ini stra nei cantoni della punta. Nel II gran partito; spaccato di due: nel I inquartato: nel 1° e 4° di rosso , al castello in oro ton-icellato di tre pezzi dello stesso, finestrato aperto e aggiornato di azzurro (Castiglia); nel 2° e 3° d 'a rgento, al leone di rosso, coronato, lampassato e armato d'oro (Leon); innestato in punta d'argento, alla granata di rosso s tellata e fogliata di verde (Granala). Nel seco nd o di rosso, alla fascia di argento (Asburgo). Nel terzo spaccato: a) trinciato in grembo; nel I O centrato al triangolo grembiato di oro a quattro bande di azzurro bordato di i-osso (Borgogna antica); nel 2° d 'oro , al leone di nero, armato, lampassato e coronato dello stesso (Fiandra); b) d'azzurro, a nove gigli d'oro , 3, 3, 3, a l capo lambello di rossi di cinque pezzi (Angiò). Nel III grande partito, spaccato di due. Nel l O partito: a destra di oro, a quattro pali di rosso (Aragona); a sinistra inquartato in pila, nel capo e puma di oro a quattro pali di r osso : ai lati di argento, all'aqui la nera, co ronata dello stesso, dal volo spiegato (Aragona-Sicilia). Nel 2 ° d'azzurro, ad otto fiordaUsi di oro, 3, 2, 3, alla bordatura spaccata d'argento e di rosso (Borgogna moderna). Nel 3° spaccato: sopra tagliato in grembo, nel 1° di Nero, al leone d'oro passante (Brabante), nel 2° d'argento, all'aquila rossa, coronata deIJo slesso, dal volo spiegato (Anversa); sotto d'argento, alla croce d'oro scorciata e potenziata, accantonata da quattro crocette semplici dello stesso (Gerusalemme). Nel IV ed ultimo grande partilo: d 'o ro a sei palle , I , 2 , 2, l , la prima azzurra caricata di tre g igli d'oro, 2, 1, e le altre rosse (Medici). Sul lulto d 'az zurro, a lre gigli d'oro, 2, I , alla bordura di rosso (B orbone) . Lo stemma era fregiato degli O rdini cavallereschi di San Gennaro , San Ferdinando, Costantiniano di San Giorgio, del Toson d'oro, della Concezione, del Santo Spirito e cimato della corona Rea le con tocco rosso.

strinse Metternich a fuggire in Gran Bretagna; il 19 marzo fu la volta di B erlino ad insorgere.
In questo clima europeo scoppiò la rivoluzione italiana: il 18 marzo insorse Milano, il 22 insorse Venezia, l'ese r cito austriaco d 'occupazione fu costretto aritirarsi nelle fortezze del quadrilatero (Mantova, P eschiera, Verona, Legnago). Sollecitato ad intervenire dai moderati lombardi, che temevano l'Austria ma ancor più il trionfo delle correnti radicali, Carlo Aberto il 24 marzo varcò il Ticino e mosse guerra all'Austria. Ferdinando II, Leopoldo Il e Pio IX furono allora costretti ad intervenire nel conflitto per bilanciare l'egemonia del Regno di Sardegna . Questi awenimenti ebbero effetti rivoluzionari, è il caso di dirlo, anche in campo vessillologico.
Le carte costituzionali concesse in Toscana e nel Regno di Sardegna precisavano con molta chiarezza che il mutato assetto costituzionale dello Stato non avrebbe avuto riflessi sulla bandiera dello Stato. Lo Statuto toscano recitava, infatti, all'articolo 22 "lo Stato conserva la sua bandiera ed i suoi co lori " e quello sardo non era meno esplicito , l 'articolo 77 stabiliva che "lo Stato co n serva la sua bandiera; e la coccarda azzurra è la sola nazionale". Lo Statuto concesso dal Papa, infine, ignorava addirittura il problema. La guerra provocò un rapido cambiamento della situazione. Carlo Alberto, quando il 23 marzo decise di entrare in guerra contro Austria, ordinò che le sue Lruppe "entrando nel territorio della Lombardia e della Venezia portino lo Scudo di Savoia soprapposto alla Bandiera tricolore italiana".
La decisione sovrana prese alla sprovvista l'appena costituito ministero che, nella seduta de] 27 marzo, stabilì con molta precipitazione le caratteristi che della nuova bandiera dello Stato, come narra il Brancaccio nell'a ccurata rievocazione di quegli awenin1enli:
"Il modello della nuova bandiera ve nn e adottata in Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 n1arzo. Fu, in quel giorno, chiamato innazi al Consiglio un segretario del Ministro dell'interno, tal Bi gotti al quale si diede incarico di disegnare subito un modello di bandiera che fosse tricolore e con lo scudo di Savoia . Il Bigotti eseguì tre diversi disegni che presentò al Consiglio: nel primo lo scudo era di fianco, nel secondo era nella parte superiore e nel terzo nel mezzo. Dopo alcune esitazioni venne scelto il disegno neJ qual e la bandiera aveva lo scudo nel mezzo, e così largo da sovrapporsi alle bande laterali, verde erossa; ma in tal modo il bianco della croce si confondeva coJ bianco della banda centrale della bandiera, ed il rosso dei quarti di destra si confondeva col rosso del drappo. Rilevato tale inconveniente, si convenne nell'opportunità di c ircondare lo scudo con una orlatura di colore, in modo che potesse meglio risaltare. Qualche ministro propose che tale orlatura fosse gialla, quasi a rappresentare una cornice dorala; ma quel colore fu subito scartato perché ricordava il giallo delle divise austriache; il Bigotti suggerì allora di adottare il co lore azzurro, che era quello di Casa Savoia e tradizionale nel Piemonte. La proposta venne accettata e si deliberò inoltre che i nastri da attaccare qual cravatta alla bandiera fossero tre, uno per ogni colore della bandiera, e frangiati in oro. Quando ciò fu deciso , il Bigotti disegnò il modello definitivo, che il giorno stesso fu approvato dal Re.
La bandiera mod. 1848 ebbe dunque al centro lo scudo di Savoia, senza corona, di forma sannitica, con largo orlo azzurro, e di dimensioni tali da sovrapporsi

 Tavola IX a) Tricolore siciliano.
Tavola IX a) Tricolore siciliano.



 Tavola IX e) Stemma dei Borbone.
Tavola IX e) Stemma dei Borbone.

 Tavola X - a) Tricolore toscano.
Tavola X - a) Tricolore toscano.

 Tavola X - b) Tricolore piemontese.
Tavola X - b) Tricolore piemontese.

alle tre bande, bjanca, rossa e verde, del drappo. Tale sovrapposizione doveva simboleggiare l'unione delle idee e delle speranze italiche, sotto la guida della Casa di Savoia"9 •
Anche il granduca L eopo ld o II dovette prendere una decisione e d il 17 aprile firmò il decreto che modificava la bandiera toscana: "Noi Leopoldo secondo, per la Grazia di Dio Granduca di Toscana, ecc. ecc., ravvisando opportuno che le Nostre tntppe, le quali combatlono in Lombardia, militino sotto il Vessillo della Indip endenza italiana già adottato da due dei Nostri alleati , Sua Maestà il R e di Sardegna e Sua Maestà il R e del Regno delle Due Sicilie; e d 'altronde volendo prendere un provvedimento generale che serva ad ogni milizia ed alle marine; Sentito il parere del Nostro Consiglio dei Ministri; Abbiamo decreto e decretiamo quanto segu e:

Art. 1. AlJ'attuale Bandiera è sostituita come B andiera dello S tato, tanto per la truppa di linea quanto per i bastimenti da gue1Ta e mercantili, la B andiera tiicolore italiana, a cui verrà sottoposto lo S cudo granducale.
Arl. 2. L e Bandiere della Gu ardia civica porteranno sul fondo tri colore da una parte l o S cudo granducale , dall'altro ]'arme della Comunità alla quale appartiene il battaglione" 10 •
Pi o IX non volle rinunz iare ai tradizionali colori, bianco e giallo, della bandie ra pontificia , tuttavia , anche se molto a malincuo r e, acco ns entì che il ministro dell'interno il 18 marzo decretasse che: "udito il Consiglio de' Ministri; udito il volere di Sua Santità, la B andiera Pontificia b i anco-gialla sarà fregiata di cravatte coi colori italiani ".
Anche i ducati dell'Italia centrale, fuggiti i rispettivi sovrani, adottarono il tricolore come Bandi era dj Stato, così come i l governo P rovvisor io della R epubblica Veneta che il 27 marzo, pochi giorni dopo la cacciata degli Austriaci, decretava: "La B andiera della Repubblica Veneta è composta dei tre colori verde, bianco e rosso. Il verde al bastone, il bianco nel mezzo , il rosso pendente. In alto, in campo bianco fasciato dai tre colori, il Leone giallo. Coi tre colori comuni a tutte l e bandiere odi erne d'Italia , si professa l a comunione italiana. Il Leone è simbolo speciale di una delle italiane famiglie".
9 Nicola Brancaccio, Le bandiere del Regno di Sardegna dal 1814 al 1860, in Memorie storiche nziliLari, Roma , Ufficio Storico dello Stato Maggiore E serc ito, 1910, fascicolo 2°, pag. 193. L 'origine dello stemma sabaudo, croce d'argento in campo rosso, non è nota. Il Gerbaix de Sonna z ritenne che Pi etro II di Savoia, il primo conte ad innalzare tale insegna, essendo cong iunto di re Enrico III d'Inghilterra e fratello del beato Bonifacio, arcivescovo di Canterbury, avesse voluto assumere come propria J'insegna dei crociali inglesi di quel tempo. Recentemente si è però scoperto che Pi etro , non ancora conte di Savoia, era g ià tito lare di uno stemma "di rosso alla croce d'argento" come conte di Richmond.
10 Lo sc udo granducale era meno complesso di quello borbonico, ad ogni buon contro se neriporla la descrizione araldica, tratta sempre dal citato volume dell'Ufficio Storico:
Lo sc ud o era inquartato: nel 1°, partito di Ungheria antica (fasciato di otto pezzi d'argento e rosso) e di Ungheria moderna (di rosso alla doppia croce d'argento sostenuta da un monte di tre cime di verde coronalo d'oro); nel 2° di Boemia (di rosso al leone d'argento con la coda biforcuta, armato, linguato e coronato di oro); nel 3 ° di B orgogna ai due barbi d'oro addossati e accompagnati da quattro crocette ricrociate e fitte dello stesso, poste l , 2, 1). Sul tutto uno scudetto interzalo in palo: nel 1° di Lorena, nel 2° d'Austria, nel 3 ° di Medici. Lo scudo, c imat o dalla corona reale, era accollato da un trofeo di bandiere e di anni con i collari degli Ordini di Santo Stefano e del Toson d'Oro.
Si è riportato per esteso il decreto del Governo Pro w isorio Veneto perché c i sembra un esempio emblematico di quanto il sentimento unitario, nei patrioti del 1848, fosse ancora permeato di regionalismo.
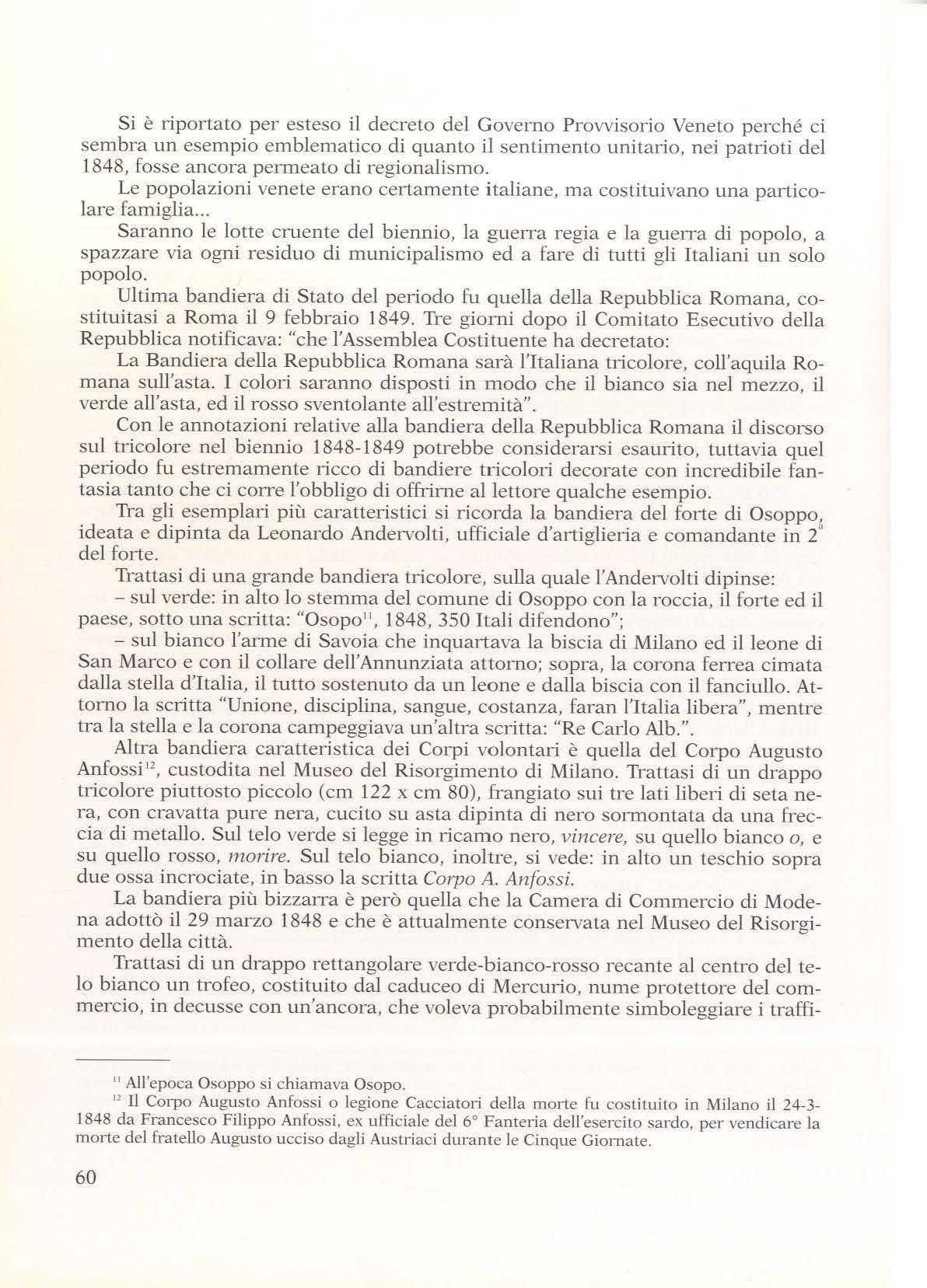
Le popolazioni venete erano certamente italiane, ma costituivano una particolare famiglia
Saranno le lotte cruente del biennio, la guerra regia e la guelTa di popolo, a spazzare via ogni residuo di municipalismo ed a fare cli tutti gli Italiani un solo popolo.
Ultima bandiera di Stato de] periodo fu quella della Repubblica Romana, costituitasi a Roma il 9 febbraio 1849. n-e giorni dopo il Comitato Esecutivo della Repubblica notificava: "che l'Assemblea Costituente ha decretato:
La Bandiera della Repubblica Romana sarà l'Italiana tricolore, coll'aquila Romana sull'asta. I colori saranno disposti in modo che il bianco sia nel mezzo, il verde all'asta, ed il rosso sventolante alJ'estremità".
Con le annotazioni relative alla bandjera della Repubb1ica Romana il discorso sul tricolore nel biennio 1848-1849 potrebbe considerarsi esaurito, tuttavia quel periodo fu estremamente ricco di bandiere tricolori decorate con incredibile fantasia tanto che ci corre l'obbligo di offrirne al lettore qualche esempio.
Tra gli esemplari più caratteristici si ricorda la bandiera del forte di Osoppo ~ ideata e dipinta da Leonardo Andervolti, LLEficiale d'artiglieria e comandante in 2 d e l forte.
Trailasi di una grande bandiera tricolore, sulla quale l'Andervolti dipinse: sul verde: in alto lo stemma del comune di Osoppo con la roccia, il forte ed il paese, sotto LLna scritta: "Osopo 11 , 1848, 350 Itali difendono"; sul bianco l'arme di Savoia che inquartava la biscia di Milano ed i] leone di San Marco e con il collare dell'Annunziata attorno; sopra, la corona ferrea cimata dalla stella d'Italia , il tutto sostenuto da un leone e dalla biscia con il fanciullo. Attorno la scritta "Unione, disciplina, sangue, costanza, faran l'Italia libera", mentre tra la stella e la corona campeggiava un'altra scritta: "Re Carlo Alb.".
Altra bandiera caratteristica dei Corpi volontari è quella del Corpo Augusto AniossiJ 2 , custodita n el Museo de] Risorgimenlo di Milano. Trattasi di un drappo tricolore piuttosto piccolo (cm 122 x cm 80), frangiato sui tre lati liberi di seta nera, con cravatta pure nera, cucito su asta dipinta di nero sormontata da una freccia di metallo. Sul telo verde si legge in ricamo n ero, vincere, su quello bianco o, e su quello rosso, morire. Sul telo bianco, jnoltre, si vede: in alto un teschio sopra due ossa incrociate , in basso la scritta Corpo A. Anfossi.
La bandiera più bizzarra è però quella eh e la Camera di Commercio di Modena adottò il 29 marzo 1848 e che è attualmente conservata nel Museo del Risorgimento della città.
Trattasi di un drappo rettangolare verde-bianco-rosso recante al centro de] telo bianco un trofeo, costituito dal caduceo di Mercurio , nume protettore del commercio, in decusse con un 'ancora, che vo leva probabilmente simboleggiare i traffi-
11 All'epoca Osoppo si chìamava Osopo.
12 11 Corpo Augusto Anfossi o legione Cacciatori della morte fu cosLituito in Milano il 24-31848 da Francesco Filippo Anfossi, ex ufficiale del 6° Fanteria dell'esercito sardo, per vendicare Ja morte del fratello Augusto ucciso dagli Austriaci durante le Cinque Giornate.
 Tavola Xl Tricolore veneto.
Tavola Xl Tricolore veneto.

 Tavola Xli - a) Tricolore romano.
Tavola Xli - a) Tricolore romano.

 Tavola Xli - b) Tricolore Osoppo.
Tavola Xli - b) Tricolore Osoppo.



 Tavola Xli d) Tricolore commercianti.
Tavola Xli d) Tricolore commercianti.

 Tavola Xli e) Tricolore mazziniano.
Tavola Xli e) Tricolore mazziniano.

ci marittimi. Al di sopra ed al di sotto del trofeo campeggia la scritta IL COMMERCIO AVVICINA I POPOLI.
Il vessillo cost ituisc e certa mente una sicura t est imonianza del patriottismo degli operatori di commercio modenesi ma, altrettanto certamente, testimonia la necessità del ceto imprenditoriale di operare in mercati più ampi, come quelli che avrebbe potuto offrire un' I talia unita.
Questa brevissima rassegna termina con la grande bandiera (cm 260 x J 45) che sventolò dal balcone del Campidoglio durante i giorni gloriosi della Repubblica Romana: un drappo tricolore che reca al centro la scritta DIO E POPO LO, estrema e vigorosa sintesi del pensiero mazziniano 13 •
Con la capitolazione di Venezia, 22 agosto 1849 , anche la storia del nostro tricolore sembrò finire.
Insieme con l'abrogazione delle prerogative costituz ion ali i vari Principi rimessi sul trono dalle truppe a us triache decretarono i l ritorno alle antiche bandiere dinastiche . Soltanto nel Reg no di Sardegna, nonostante l'infelice giornata delle armi sarde a Novara, il tricolore rimase a simboleggiare la volontà del popolo e della dinastia di non rinunciare né alla libertà né all'unità della Patiia.
Il trico lore concesso da re Carlo Alberto, mai chiaramente definito con un organico prowedimento legislativo , fu leggermente modificato negli anni precedenti la 2a guerra d'indip e ndenza. Come narra H Brancaccio, le bandiere distribuite ai reggimenti nel 1848, "confezionate, in causa dell'urgenza , con seta scadente, furono presto scolorite o ridotte a brandelli, sicché si dovettero sostituir tutte fra il 1850 ed il 1851. Non avendo i decreti del 1848, relativi alla loro adozione, specifi cato norme precise: non essendosi data pubblicità alla deliberazione del Consiglio dei ministri, od essendosi forse smarri to il disegno fatto dal Bigotti, il magazzino delle merci di To rino eseguì il rinnovamento delle bandiere, facendon e confezionare con indicazioni date volta per volta ai fabbricanti. P er cui, secondo l'epoca di fabbricazione, i corpi ebbero bandiere che differiscono non soltanto nelle dimensioni, ma anche nella forma delle singole parti; così, in tutt e l e bandiere rinnovate, l'orlo azzurro dello scudo non fu più sovrapposto, ma aderente ai colori laterali" Nel 1857 l'orlo azzurro dello scudo sabaudo fu rimesso in discussione nel Pa rlamento subalpino, discussione chiusa definitivam e nte dalle parole di Cavour:
"In questo S1ato, o signori, il colore azzurro non è nuovo; è un colore al quale una gran pa1"te dei nostri concittadini associa antiche, sacre e gloriose memorie. No, non si può dire nuovo un colore che risveglia così nobili ri membranze, e nel quale sono pure riposte grandi speranze; giacchè a rendere fruttifera la gloriosa bandiera italiana è necessario, è indispensabi le, che sia strettamente associata alle glorie dell'eterna e valorosa monarchia sabauda, rappresentata da questo colore tradiz.ionale " .
 11 La bandiera è attualmente conservata nel Museo del Risorgimento di Milano.
11 La bandiera è attualmente conservata nel Museo del Risorgimento di Milano.
Dopo la discussione parlamentare fu incaricata una speciale commissione di fissare definitiYamente il modello della bandiera, compito che la commissione portò a termine ma nessuna circolare ufficiale ne rese nolo i] lavoro, tuttavia, precisa sempre il Brancaccio, il modello proposto "se rvì da allora di norma al magazzino delle merci per la confezione delle bandiere da distribuire. In tale modello, lo sc ud o era staccato dalle bande laterali di colore e sormontato dalla corona reale" •~.
Il nuovo stemma dello Stato, infine scudo sabaudo, cimato della corona reale ed accollato all' Ordine de1l'Annunziata, uscente da un trofeo di quattro bandi ere tricolori in decusse contrib uì a rendere popolare nel giro di qualche anno il tricolore anc h e negli strati meno co lti della popolazione.
L'inizio della 2a guerra d'indipendenza, ed i] conseguente ritiro delle guarnigioni aus triache dietro il Mincio, fu salutato dalle popolazioni dei ducati e delle Legazioni con grande en tu siasmo, il Granduca di Toscana, la Duchessa di Parma ed il Du ca di Modena abbandonarono precipitosamente i loro Stati ed il tricolore nazionale ritornò a sventolare.
Nonostante le apparenze, infatti, il biennio 1848-1849 non era stato un fallimento, ma un'esperienza dura e salu tare, quan t o mai c hiarifi catrice e r i cca di fermenti per l'awenire. A commento di quel periodo il Volpe ha scritto: "Falll la cooperm~ione dei Pri ncipi , minata dal diverso atteggiamento loro di fronte alle nuove istituzioni liberali, dalla crisi interna di taluno dj queg)j Stati (1ivoluzione di S ic ilia), dal vero e proprio contrasto di interessi fra i Principi stessi di fronte a ll a guerra di liberazione. Si dimostrò utopistica, e non per ragioni con tin genti ma per una intrinseca contraddi zione, la speranz:a di un Papato nazionale e riforn1atore: cioè t ram ontò il neoguelfismo e fu colp il o a morte definitivamenle il P apato temporale . Caddero a terra il "Popolo", divinizzato dai democratici , ed il mito insurrezionale e rivoluzionario. Le varie costituz ioni non ressero a lla prova de] fuoco, né solo per colpa dei P ri nci pi. Litalia senza guida appanre un caos di virtù imp ote nti , di volo n tà incompiule, di passion i senza freno, di a n gusti egoism i, di c lemen ti incerti: tanto è vero c h e notevole parte della borghesia liberale, moderati o democratici c h e fossero, spaventati dal disordine popolaresco, non videro male la restaurazione e abbandonarono a se stesse le plebi in rivo lla. Ma alcun e semplici idee e m ersero sopra tanto naufragio: che il n emico era verament e uno solo, l ' Austlia, da affrontare n on su le piazze e le strade, non a Napoli o a Milano o a Firenze, ma sopra un piLL vas to camp o e u ropeo; c h e erano necessari un esercito rego lare e una diplomazia, anche per dare credito internazionale al movimen t o e disarmare le mjJle diffid enze accampate contro di noi dappertutto; che attraverso l'indipendenza avremmo raggiunti i liberi ordini, e attraverso J'unità o un programma unitario conquis tat o l'ind ip endenza, che si poteva in Italia, contar solo sul Piemonte e la s u a dinastia, i quali, appunto, eran o forti di un loro esercito e di una loro diplomazia, man tenevano in vigore la costituzione, realizzavano un pie n o affiatamento fra popolo e Principe, si muovevano per l'impulso di aJte ambizioni, avevano interess i veramente ant iaustr iaci , facevano una politica insieme conservatlice e rivoluzionaria" '\

., Nicola Brancacc io , op. c it. , pa g I 96 e pag. 199
1 ' Gioacchino Volpe, op. cit. , pag 19 e 20.
 Tavola Xlii - Stemma dello Stato italiano.
Tavola Xlii - Stemma dello Stato italiano.
La maturità politica raggiunta dal popolo italiano dette subito nel 1859 risultati concreti anche ne] campo vessillologico. Già 1'11 maggio il Governo della Toscana decretava:
"Art. 1. Tanto per l'esercito, quanto per la marina da guerra e mercantile, unica bandiera dello Stato sarà da qui innanzi la bandiera tricolore italiana.
Art. 2. I tre colori nazionali saranno disposti in liste verticali nell'ordine seguente: il verde all'asta, il bianco in mezzo, il rosso fuori.
Art. 3. I ministri della Guerra e degli Affari Esteri sono incaricati, per la parte che spetta ad ognuno, deU'esecuzione del presente decreto".
Il 29 settembre poi, il Governo toscano, con altro decreto stabiliva che "nelle Bandiere dell'Esercito e della Marina .MiJjtare e M ercantile dovrà porsi lo stemma della Casa di Savoia. Provvisoriamente nella Bandiera della Marina e dei Consolati toscani sarà aggiunto un leone bianco nell'angolo superiore della lista verde presso l'asta". IJ 13 giugno era la Commissione del Governo di Parma a disporre che: "La bandiera tricolare italiana con la croce di Savoia sarà inalberata nella real cittadella", lo stesso giorno anche a Modena la bandiera tricolore era innalzata sul palazzo ducale.
Il 1 ° ottobre infine il Governatore Generale della Romagna, Leonetto Cipriani , sanzionava con un decreto quanto era ormai in uso fin dal giugno: "Nelle bandiere dell ' Esercito e della Marina Militare e mercantile dovrà porsi lo stemma della Casa di Savoia".

I.:armistizio di Villafranca sul momento sembrò po1Te fine alle speranze di conseguire l'unità d1talia, ma quando dovette fermarsi l'azione del Governo entrò in campo l'iniziativa popolare ed il tricolore ancora vittorioso sventolò sui campi di battaglia.
r.;11 maggio 1860 Garibaldi sbarcava a Marsala e già il 25 giugno Francesco II, nel disperato tentativo di arrestare il moto rivoluzionario, proclamava: "Desiderando di dare a' nostri amatissimi sudditi un attestato della nostra Sovrana benevolenza, ci siamo determinati di concedere gli Ordini costituzionali e rappresentativi nel Regno in armonia co' principii italiani e nazionali, in modo da garantire la sicurezza e prosperità in avvenire, e da stringere sempre più i legami che ci uniscono a' popoli che la Provvidenza ci ha chiamati a governare. A quest'oggj siamo venuti nell e seguenti determinazioni.
1. Accordiamo una generale amnistia per tulti i reati politici fino a quesLo giorno.
2. Abbiamo incaricato il Commendatore D. Antonio Spinelli della formazione di un nuovo Ministero, il quale compilerà nel più breve termine possibile gli articoli dello Statuto sulla base delle istituzioni rappresentative italiane e nazionali.
3. Sarà stabilito con S.M. il Re di Sardegna un accordo per gli interessi comuni delle due Corone in Italia.
4. La nostra bandiera sarà d'ora innanzi fregiata de' colori nazionab italiani in tre fasce verticali, conservando sempre nel mezzo le Armi della nostra Dinastia.
In quanto alla Sicilia, accorderemo analoghe istituzioni rappresentative, che
 Tavola XIV a) Bandiere militari del Regno di Sardegna (modello 1848 e modello 1860).
Tavola XIV a) Bandiere militari del Regno di Sardegna (modello 1848 e modello 1860).

 Tavola XIV - b) Tricolore Marina toscana.
Tavola XIV - b) Tricolore Marina toscana.

 Tavola XV Tricolore borbonico mod 1860
Tavola XV Tricolore borbonico mod 1860

possono soddisfare i bisogni dell'Isola; e d uno de ' Principi della nostra Re a l Casa ne sarà il nostro Vicerè".
L'inefficacia dei pro vve dimenli di Francesco II apparve subito con grande evidenza. "Il richiamo in vigore della costituzione del 1848 ha scritto Pier Giusto J aeger non e ntu si asmava se non un a frangia di uomini di penna e di toga, di strat ti pe r ò , anche loro, dal suono delle armi oltre lo stre tto e dalle fitte manovre diplomatiche. L'amnistia richiamava in patria intellettuali di prestigio, che dell'odio verso i B orboni avevano fatto il loro principal e se ntim e nto, e che i con tatti avuti in Piemonte ed in Toscana con altri libe ra li italiani rendevano pronti a co llegarsi con questi per abbattere il "tiranno". La bandiera tricolore , con l'enorme e complicato stemma borbonico n e l mezzo, che copriva quasi del tutto la fascia bianca, sembrava un oggetlo strano e ripugnante tanlo ai patrioti quanto ai seg uaci dell'antico regime" 11'

In effetti i tardivi pro,Nedimenti adottati dal sovrano borbonico non riuscirono ad evitare il completo sfacelo del R ea m e : il 6 settem bre Francesco II lasciava Napo l i riparando nella fortezza di Gaeta; il 1° ottobre , al Volturno , l'esercito meri dionale garibaldino sconfiggeva definitivamente quello borbonico; il 21 ottobre un plebiscito decretava che "il popolo vuole l'Italia una ed indivisibile con Vittorio Emanuele com e re costituzionale per sé e per i suoi legittimi successori", come r e citava la formula con la quale l a popo l azione del Regno delle Due Sicilie fu chiamata ad esprimersi.
L'I talia, anche se priva ancora del Lazio e del Triv e neto, era finalmente unita Il 18 febbraio 1861 si riunì a Torino il primo Parlamento Italiano ed il 17 marzo fu promulgata la legge che sanciva l'avvenuta costituzione del Regno d ' Italia.
Il nuovo Stato adottò tacitamente come bandi era na z ional e quella d el Regno di Sardegna, con la foggia stabilita dal R. D 25 marzo 1860 , decreto che riprendeva le norme non pubblicate nel 1857. La bandiera del Regno d ' Italia portò quindi al centro della banda bianca lo stemma d e i Savoia, orlato d 'azz urro, distaccato dalJe bande laterali, con la parte inferiore a punta, sormonlato dalla corona rea le
16 Pi er Giusto Jacger, Francesco li di Borbone l'ultimo re di Napoli, Milano, Mondadori, 1982,
La proclamazione del Regno d'Italia, come si è visto nelle pagine precedenti, non determinò alcun prowed i mento legislativo a riguardo della bandiera nazionale. Tacitamente , con il convinlo assenso della classe politica, la bandiera del Regno di Sardegna divenne la bandiera del nuovo Stato.
Gli abitanti delle nuove province impararono presto a riconoscere nel tricolore con lo stemma sabaudo il simbolo dell'unità e dell'indipen d enza della P atria so prattutto per opera deJl'esercito.
L'esercito, infatti, contribuì moltissimo a rendere familiare l a bandiera anche nelle più i solate comunità montane sia direttamente, attraverso l 'opera educatrice quot idianamente svolta nei confronti dei giovani alle armi, attività che comprendeva non solo l'uso della lingua iLaliana 1 e l'albafetizzazione ma anche la cono scenza dell'ordinamento costituzionale dello Stato, sia indirettamente, con l'espo sizione della bandiera nazionale nelle caserme e con lo spiegamento delle bandiere reggimentali in occasione di parate e di riviste .
Che la bandiera rappresentasse un mezzo quanto mai incisivo per creare una cosdenza nazionale era ben noto anche all 'epoca.
Massimo d'Azeglio, pittore di talento, romanziere di successo, combattente valoroso, uomo di governo prudente ed assennato e, soprattutto, gran galantuomo ha scritto nei suoi Ricordi " ... siccome gli eserciti, i cannoni rigati, i monitors fioriscono più che mai , è bene che la nuova generazione si imprim a profondamente nell'anima il rispetto, i] culto, l' i dolatria e, se si v uole, la supers ti zione della propria b andiera ... Sia opera di tutti, giovani e vecchi, grandi e piccoli, di spargerne, di fondarne il culto. Sia sentimento di tutti che la bandiera rappresenta l'Italia, l a P atria, la libertà, l'indipendenza, la giustizia, la dignità, l'onore; che p er questo la bandiera non si a bb assa, n on si macch ia , n on si abbandona mai, e c h e piuttosto si muore" (I miei ricordi vol. II, cap XIX)

S embra pertanto opportuno r iportare in q u esta sede un ampio stralcio del regio decreto del 25.3.1860 che regolava dimensioni e fogg ia delle bandiere militari.
"
Art. 2 - La Bandiera si comporrà di: un'asta, un drappo, una fascia, un cordo ne, una freccia.
Art. 3 La freccia deve essere considerata come la parte importante e moral e della bandiera; su di essa saranno scolpiti il no m e del reggimento, l'epoca della sua creazione, delle successive sue formazioni ed ord i namenti , i fatti d'arme cui
1 In Italfa, negli anni dell'indipendenza politica, il dialetto siciliano suonava 'africanissimo' alle orecchie dei toscani, menlre, in qualche paese del Sud, la parlata di un settentrionale poleva es sere scambiata per inglese. Qui, del resto, su o lLr e venlicinque milioni dj anime, coloro che si esprimevano in itaJiano erano appena seicenlomila: il 2,5%" T u llio De Mauro, Storia linguistica dell'Jtalia unila, Bari, Laterza, 1976, Vol. I, pag 43.
prese parte il Corpo e quelle altre onorifiche indicazioni che siano per occorrere, secondo che verrà delerminato dal Nostro Ministro della guerra per speciale decreto.
Art. 5 Le bandiere dei reggimenti di fanteria saranno di stoffa di seta e di for1na quadrata, delle dimensioni cioè di metri 1,20 di lato, scompartibili in tre bande uguali portanti i colori nazionali verde, bianco e rosso, ciascuno della larghezza di metri 0,40. La parte bianca sarà nel mezzo.
Art. 6 Le bandiere per corpi di cavalleria saranno pure di seta, quadrate, della dimensione di metri 0.60 di lato e scompartite come sovra in tre bande uguali verde, bianco e rosso, cadauna di metri 0.20.
Art. 7 ... le bandjere ... porteranno improntate sul centro del campo bianco, ad uguale distanza dai lembi inferiori e superiori, lo scudo di Sa voia con croce bianca in campo rosso con contorno azzurro e sorn10:ntato dalla corona reale ricamata in seta ...
Art. 8 Le aste della bandiera per la fanteria sono della altezza di metri 2.50 compreso il calcio (O,l O) e la parte che si conficca nella freccia (0,10). Quelle per la cavalleria 1,8 (7).
Art. 9 Le aste delle bandiere saranno fasciate di velluto turchino azzurro, ornate di bullette di ottone poste a linea spira l e.
Art. 1O Le aste saranno sormontate dalla freccia, la quale ha nel centro lo stemma reale, e portante ]e iscriziom indicate al precedente art. 3.
Art. 11 Alla parte inferiore della freccia è awolta una fascia di seta di co lore turchlno azzurro a nodo con due strisce.
Art. 12 Saranno così pure avvolti due cordoni in argento delle dimensioni di mm 4 e della lunghezza totale cli m 1 .50 terminante con fiocchi ... " .
Qualche decennio dopo le esigenze della navigazione spinsero il Governo ad emanare un nuovo Codice di navigazione per la marina mercantile (regio decreto 24 ottobre 1877) nel quale era finalmente presa in esplicita considerazione la bandiera nazionale.
I.:art. 1O1 del Codice, infatti, prevedeva: "Le navi della marina mercantile inalberano la bandiera nazionale, seco ndo il modello, e nei casi stabiliti dal regolamento" e l'art. 172: "Le navi tanto all'arrivo quanto alla partenza dai porti o dalle spiagge dello Stato, dovranno avere la bandiera spiegata".
La materia era peraltro più comp iutamente esaminata e definita nel Regolamento per l'attuazione del Codice (regio decreto 20 novembre 1879).

:tart. 624 di esso contiene la d escrizione particolareggiata della bandiera della marina mercantile: "La bandiera nazionale da inalberarsi dai bastimenti della marina mercantile sarà composta dai tre colori nazionali disposti in tre campi verticali, ciascuno dei quali avrà una larghezza uguale al terzo di quella della bandiera. Il campo verde vicino all'asta, il bianco ne] mezzo ed il rosso all'esterno. La bandiera porterà sul campo bianco lo scudo di Savoia senza 1a corona reale. Le proporzioni ne saranno le seguenti: altezza della bandiera, uguale a due terzi deJla larghezza: larghe zza dello scudo, compreso il campo azzurro, uguale alla larghezza del campo bianco".
La bandiera nazionale poco alla volta divenne veramente per tutti i cittadini italiani, e non solo più per le classi politicamente più mature, un simbolo sacro, oggetto di venerazione e di rispetto.
 Tavola XVI Alfiere del Regno d ' Italia (1 ° reggimento fanteria).
Tavola XVI Alfiere del Regno d ' Italia (1 ° reggimento fanteria).

La tendenza a conferire aJla bandiera nazionale un carattere sacro ha profonde tradizioni in una Nazione cattolica, il rito della benedizione della bandiera è antichissimo e trova il suo fondamento nell'antichissima concezione della sovranità di diritto divino.
Lo Stato itaHano, per quanto rigorosamente laico, non volle rinunciare a quesla consuetudine e si trovò talvolta in contrasto con la Chiesa. Una equilibrata esposizione delle ragioni dell'uno e dell'altra si trova, sempre alla voce bandiera, nell'Enciclopedia Italiana: "Le speciali condizioni in cui lo Stato italiano venne a trovarsi dopo i] 1870 rispetto alla Chiesa cattolica e al papato, fino al trattalo lateranense del 1929 , fecero sorgere in vari punti del regno minacce di pericolosi conflitti e di aspre discussioni in merito all'ammissione delle bandiere nazionali nell'interno delle chiese e degli altri edifici destinati al culto. Si volle talvolta da alcuni ravvisare nell'opposizione dei parroci all'introduzione delle bandiere nelle chiese, in occasione di funerali o di altre pubbliche cerimonie, l'ipotesi dello sfregio al simbolo dello stato, reato previsto e represso dal codice penale .
Ma chi consideri la questione da un punto di vista strettamente ortodosso, deve riconoscere che al sacerdote cattolico, che si attenga strettamente ai precetti degh organi superiori della gerarchia ecclesiastica, non può essere fatta colpa del la stretta ossen,anza delle norme cui egli è tenuto ad obbedire. Difatti un decreto emanato dalla congregazione della Sacra Penitenzeria del 4 aprile stesso anno, stabiliva che non dovessero ammettersi in chiesa se non i vessilli delle confraterni te e quelle bandiere che fossero state precedentemente benedette.
D'altra parte, secondo lo stesso decreto del Santo Uffizio, la benedizione può essere accordata solo alle bandiere delle società private i cui statuti siano stati approvati dall'autorità ecclesiastica, e che contengano un qualche segno religioso, e nessun altro segno riprorevo]e. Questo divieto evidentemente non può colpire l e bandiere dell'eserdto e della marina militare, che sono poi le vere bandiere dello stato, giacché esse sono benedette col rito cattolico al momento della loro ufficiale consegna aJ reggimento e alla nave: né può colpire la bandiera dello stato in quan to tale, ma solo eventualmente quelle bandiere che, pur avendo i colori nazionali, costituiscano l'emblema di sodalizi privati, e per le quali non sia stata chiesta e ottenuta la solenne benedizione ecclesiastica.

L a questione fu anche dibattuta alla camera dei deputati nella tornata del 18 marzo 1899, in risposta ad analoga interrogazione degli on. Barzilai e B udassi, originata da alcuni incidenti verificatisi nella chiesa di S. Andrea delle Fratte in Roma. Il governo dichiarò doversi distinguere tra le bandiere appartenenti ad as sociazioni private e quelle dei corpi civili e militari dello stato, delle province e dei comuni, contro le quali solamente sarebbe stata abusiva una eventua l e esclusione dal recinto dei sacri edifici''.
il 1911 , celebrandosi il cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia e di Roma capitale, fatta nel P arlamento di T01ino nel marzo 1861, fu veramente un anno singolare per il nostro Paese, un anno di rievocazione del passato e di auspicio per l'avvenire.
Il 28 marzo, con solenne cerimonia, fu inaugurato "il grandioso monumento a
Vittorio Emanuele Il, ai pi edi del Colle capitoli no , che era poi il monumento all'llalia, unifi c ata d al la di scorde concordia di due generazioni di Italiani" 2 • Il 5 ottobre fu innalzato il tricolore s ui forti di Tripoli e d un'ondata di s incero en tusiasmo p ercorse tutta l a Nazione. P e r s in o un poeta sc hi vo e sommesso come Gim·an ni Pa scoli ce l eb r ò l a grande Proletaria c h e finalmente aveva r i so lto il problema d e ll' e migra z io ne mettendo a disposizione dei nostri lavoratori " una vasta region e ba g nata daJ nostro mare, verso la quale si prot e nd e impaziente la no stra isola grande; una vasta regione che già per opera dei nostri progenitoli fu abbondevole di acque e di messi, e verd eggiante di a lb eri e giardini ".
Gabriel e d ' Annunzio con le sue di ec i Can zoni delle gesta d'Oltremare, pubblica le s u un gra nd e quotidiano dall'8 ot t ob re al 7 dic embre 191 J , contribuì poi a diffon dere sent im e nti di esu lt a n za per la prova offerta dalle truppe e di fiducia nei destini d e lla Patria , ritornata grand e e vo litiva . Mai fors e una co nquista co loni ale is pirò tanto entus iasmo e tanta speranza e sulla sc ia di questi sent im enti un giovane lettera to , di ch i ara to non idoneo alla vi sita di leva , Giov anni Boine, pubblicò un s ingol a r e v olumetto , Di scorsi mibtari, "com e ad illud e rmi d 'ave r anc h ' io pagato il legittimo tributo che i g iovani d e lla mia leva hanno più concretamente pagato nelle caserme (e d in armi ) alla patria" com e scrisse n e lla prefazione 3 • E dopo le pagine dedicate all'onore mi/ilare ed a lla disciplina militare il Boin e scriss e s ulla bandiera del reggimento il di sco rso che riportiamo:
Bisogno umano del simbolo c ome eccitamento all'azione
Quando s 'è dis cors o dell'onore e d e lla disciplina, noi siamo, p er via di ragionam e nti , risaliti dalla spo ntaneit à del sent iment o e dalla pratica meccanica di ogni g iorno alla idea chiara, al concetto. Ci s iamo fatti un co n cetto di questo onore e di questa dis cip lina che erano g ià vivi in noi naturalmente o per ab itudin e contratta, perché , come abbiamo detto , è dove r e d 'ogni uomo ra g ionevole r e ndersi cosc ienle di og ni cosa c he è in lui e d 'ogni cosa c he fa; e perché , co n parol e del no s tro "R egolamento di disciplina": "megl io s'adempie c i ò di cui s i co nosc e la ragion e" .
Ma le rag ioni ed i concetti diventano as sa i spesso astrazioni un po ' a ride che non servo n o se non indirettamente all'agire e n o n sono in ogni modo l'a g ire, perché vo i potete sa pere p erfettame nt e che cos'è l 'o n està e n on e ssere ones ti , o cos'è p er esempio il risp e tto filiale e non averne in pratica, p er vostro padre, nessuno.
Gioacchino Volpe , op. cic., Yol. lll , pag. 347.
1 Gio vanni Boine (1887-1917). Scrittore e citico letterario di intensa spiritualità e di notevole acume, fu un a delle fi g ure più rappresentative di quella corrente mistico-modernista inseritasi alla fine dell'Ottocento nel mondo cuhurale italiano. Tra i fondatori del Rinnovamenw , la rivista del modenismo italiano, il Boinc collaborò anche alla Voce, dalla quale tuttavia si staccò nel 1913 in aperto dissenso con Giuseppe Preaolini. Già minato dalla tisi, si ritirò nella nativa Liguria e collaborò a ll a Ri viera Ligure, sulla quale tenne la rubrica Plausi e Botte co n la quale con t1ibuì a segnal are a l grande pubblico giovani poeti emergenti come R ebora, Campana, $barbaro. Nel 1914 pubblicò una raccol t a di racconti, li peccato ed altre cose e nel 1915 i Discorsi lllilitari, di cui riportiamo l'indice: l'onore militare, la disciplina militare, la banc.licra del reggimento, il giuramento militare, la P atria, lo Statuto, i fattori dell'unità italiana , i doveri del soldato in guerra, a pac e conc lusa. Un vero breviario laico, nel qua le la sp iri tualit à tormenta l a de ll'autore s i riflette con semplicità e con forza. Nel 1938- 1939 i suoi scritti furono ripubblicati in qualtro volumi a cura di M. Novaro.



Chi riflettesse troppo sull'onore, sulla natura dell'onore ed il fondamento della discip lina , chi rimanesse nell'astrazione riflessa di essi, sempre, a farvi su libri e discorsi, correrebbe il rischio di dimenticarsi della effettiva attuazione loro che è prop1io quel che di essi importa di più.
C'è in noi accanto al bisogno di ragionare, di chiarificare concettualmente le cose nostre, l'altro bisogno di realizzarle prontamente, di incitarci in esse, di agire. E per agire, per incitarsi all'azione, assai più che le astrazioni pensate servono le imagini ed i simboli, servono per esempio i motti brevi che comprendano tutta una lunga fatica di idee sistemate; o tutta una dura esperienza di secoli. S ervono i motti, gli imaginosi proverbi per esempio e le parole che infiammano; e servono le figure, gli oggetti che diciamo simboli . Simbolo è tutto ciò alla cui materialità p er convenzione o per naturale anal ogia di imagini, noi riattacchiamo un insieme di sentimenti o di id ee ad esprimere il quale bisognerebbe altrimenti un lungo sviluppo di discorsi . Avviene quasi sempre che il complesso chiaro e freddo delle idee s i restringa e dentro di noi si intensifichi un calore di sentimento; ed il sentimen to, quasi ancora si raccorci e si rassodi, nella forma del si mbolo , così che nella materialità del simbolo è da ultimo compresa la vitalità del sentimento e l'ampiezza complicata delle idee, come per pigliare un esempio che avete ogni giorno sot tocchi, nell'imagine deJla croce i cristiani compendiano la pietà dei loro vangeli e l'insegnamento dottrinale che ne hanno tratto i teologi.

Breve. Il s imbolo che ci infiamma, il simbolo dell'onore e della disciplina nostra è la nostra bandiera. Dire la nostra bandiera è dire l'onore della nostra patria; e perciò noi consuetamente parliamo come non ne parleremmo s'essa non fosse assai più di quel che l'occhio ne vede, dell'onore della nostra bandiera. La quale è anzitutto il simbolo nazionale dinnanzi a cui vi siete scoperti reverenti nelle solennità della pa tria anche quando non vestivate per nulla ancora l'uniforme che ora vestite . Giacché anche qui niente contrasta tra la condizione di cittadino e quella di soldato . E per sapere di che significato è piena anche pel cittadino comune l'imagin e di questo drap po tricolore spiegato in trionfo al vento, bisogna chiedere a chi ha viss uto fuor dal suo paese a lungo e l'ha scorto od in pieno oceano navigando , od in un lontano porto, od anche solo alle finestre di un Consolato nostro, d'un tratto col battito al cuore e con gli occhi umidi. Essa è pel cuore commosso, la Patria stessa: ed è più precisamente pel cittadino italiano l'Italia una, l'Italia unificata con cinquantanni di eroismi e di dolori sotto la gloriosa Monarchia di Casa Savoia.
La bandiera come simbolo dell'onore militare
Ma pel militare essa è qualcos'altro ancora. "Pel militare, dice il 'Regolamento di disciplina', la bandie ra oltre a ciò ch'essa ricorda al cittadino è anche un simbolo dell 'onore militare, e gli rammenta i fasti di guerra de1l'esercito cui ap partiene". Tuttociò in somma che s'aggiunge al concetto d e ll 'onore e deJla discipli na civile nel concetto specifico di onore e disciplina militare, va intimamente per noi unito all'imagine della bandiera nazionale in quanto è bandiera del nostro reg gimento .
Voi sapete che gli scopi grandi si raggiungono attraverso il minuto conseguimento degli scopi subordinati; che la disciplina dell'esercito ]a si fa con la disciplina di ciascun soldato; che si governa bene una città cominciando a bene governare la propria Famiglia; che si [a, s i costruisce i) valore di una nazione pro c urando che ne abbiano le singole citlà. Così ]a gloria della Patria, noi militari la facciamo la custodiamo attraverso quella dell'esercito e quella dell'esercito attraverso quella del nostro corpo e quella del corpo attraverso quella de) reggimento, di cui i nostri battaglioni, di cui le no stre compagnie, di cu i i nostri plotoni, e ciascuno di noi co me elemento, è parte.

P er una ragione umana, noi più attivamente amiamo c iò che a bbiamo intorno ed in mezzo a cui si svolge la vita no stra, che non ciò che direttamente non vediamo anche se materialmente o moralmente più grande. Allo stesso modo che, poniamo, noi siam disposti a dar una mano d'aiuto all'operaio che ci sta vicino di casa, più facilmente che non al dottore che conosciamo appena di nom e e sta in un'altra città. Questi sono esempi e, come tutti g li esempi, zoppicano.
Ma insomma voi sa pete bene che ciascun reggimento ha una s ua storia, come in uno stato ciasc una regione, e che questa particolare storia è proprio quella a cui ciascuno di noi è più particolarmente attaccato e ci eccita maggiormente all'emulazione. Noi ci gloriamo d egli ero ismi na z ionali ma ci raccontiamo con speciale fervore e piacere quelli di essi che s i debbono alla nostra regione. E c i esaltiamo a l ricordo d'una battaglia vittoriosa, ma cerchiamo fra gJi episodi di essa quelli che riguardano il reggimento, quelli che furono co mpiuti dal reggimento che è il nostro.
Il nostro reggimento a San Martino od in Libia non è noi che abbiamo questo o quel cognome e n ome, non è in verità la materiale persona ili questo o quel sold ato presente; ma lo sp irito di corpo ci accomuna n ell'imaginaz ione commossa a quelli che furono i nostri commilitoni di cinquant'anni fa, od a quelli dell'anno scorso. Lo sp irito ili corpo e l'umana simpatia ci fa quasi esser presenli alle gesta di cru ci ha preceduti nell'uniforme c h e ora è nostra, sentire lo sfo r zo eroico, la sofferenza fisica, l'abbattimento awilito della sconfitta e la delirante gio ia della vittoria. Ques ta storia di sconfitte e di vitt01ie, questa storia in ogni modo sempre di abnegazione e di ero ismo, è quella che svoltas i con questi e quelli ep isodi, in questo o quel luogo, in que sta o quella maniera , dà la particolare fisionomia a ciascun reggimento, che ne fa l'anima viva attraverso i] tempo. Noi ci sentiamo, attraverso quest'anima, emuli di chi ci ha preceduti; noi ce ne sentiamo vendicatori, pensiamo per essi alla rivincita, o p er essi pensiamo alla vittoria egualmente gloriosa.
Vogliamo com'essi, come sempre U nostro reggimento da quanto è creato, non esser da meno degli altri nell'esercito in cui militiamo, servire con vigore la Patria ed il Re.
Vogliamo che il nostro regg im e nto viva e co ns ervi la fisionomia sua come la s toria sua propda gliel'ha pian piano formata, come la sua anima s alda Jo vuole.
L'onore della patria attraverso l'onore del reggimento
 Tavola XVIII - Vittorio Emanuele lii annuncia la dichiarazione di guerra all ' Austria il 24 maggio 1915. (Tavola di Beltrame sulla Domenica del Corriere)
Tavola XVIII - Vittorio Emanuele lii annuncia la dichiarazione di guerra all ' Austria il 24 maggio 1915. (Tavola di Beltrame sulla Domenica del Corriere)

Sentimenti che deve suscitare la bandiera del reggimento
Storia , fisionomia, anima viva che è come segnata e fatta corpo nella bandiera intorno a cui si raggruppa.
Storia a cui la bandiera ha partecipato , presente dappertutto dove qualcosa di memorabHe il Reggimento ha compiuto, quasi giudice e guida di ogni atto.
Non c'è bisogno di ragionar molto in torno a cose come queste Quando il drap po tricolore co i suoi nastri e le sue medaglie vi s i spiega dinnanzi solenne nel sole, è come se il meglio dei molti che son stati prima di voi qui a servire, generosi e fedeli , umilmente o con g]oria di eroi, si levasse sere no e gagliardo, innanzi agli occhi vostri, a mostrarsi Voi salutate ed il cuore di commozione si gonfia Che se il drap po è antico e segnato di battaglia e di vittoria, un subito desiderio, un subìto impeto di dare nella mischia, ove occorra, il sacrificio del vostro corpo come nel giuramento giurato avete dato l'anima vostra, per emulazione vi prende.
E se il drappo è fiammante e nuovo, se è intatto come una giovinezza impaziente non a n cora provata, ecco che come un cruccio ed un'ansia vi afferra e quasi vorreste la prova, e quasi vorreste d'un tratto mostrare come anche voi siate capaci di entusiasmo e valore; vorreste che la vostra vergine bandiera fosse agitata nell'impeto del combattere e ne uscisse alto-levata coi fregi della gloria.
Vorreste che qualcosa di voi vivamente, come il sangue che sprizza, s'imprimes se in lei, poiché sentile che è in essa impresso il meglio dei vostri predecessori qui. E capite perfettamente come in qualche caso doloroso in cui il nemico asserragliò tutt'intorno le vostre schiere, anziché cedere la vostra bandiera, laceratala, coloro che la difendevano se la siano nascosta, come si racconta, a brani sul petto quasi per salvare ciò che restava di più vitale del reggimento distrutto. Quasi come una cosa sacra che non si permette sia profanata, quasi come se in avvenire dai bran i 1icuciti di essa, dovesse risorgere, anima viva di un corpo che pareva spento per sempre, l'assieme compatto ch'essa aveva sostenuto e che poteva ancora ricondurla alla gloria della vittoria.
E capite perfettamente ch'essa suscita in battaglia, l'accanimento con cui la seguita, la decisione di morire sott'essa piuttosto che vedervela tolta!
Essa è la presente imagine del vostro onore, essa è l'onore dell'esercito vostro che è per voi tutto l'onore; essa è il palpabile simbolo religioso di quella "Religione della Pa tria" che sta ora, in voi, innanzi ogni altra".
La pagina del Boine or ora 1iportata costituisce una sicura testimonianza dei sentimenti che nutrivano i giovani all'inizio del Novecento, sentimenti che furono veramente il supporto id eal e che fece loro affrontare, con una determinazione che s tupisce l'Italiano di oggi, le prove tremende della prima guerra mondial e .

Anche in quella guerra tanto dura e cruenta il tricolore rappresentò per tutti gli Italiani, neJ modo più sem plice ed immediato, il simbolo di quell'unità nazio nale non ancora completamente raggiunta e che si voleva final111ente portare a compimento.
Ed al tricolore fece riferimento Vittorio Emanu e l e III nel proclama rivolto alle Forze Armate all'inizio del conflitto: "Soldati di te1Ta e di mare! L'ora solenne delle rivendicazioni nazionali è suonata! ( ... ) A voi la gl01ia di piantare il Tricolore d'Italia sui terreni sacri che la natura pose a confine d ella Patria nostra".
La bella la vo la di Achille Beltrame su La Domenica del Corriere, raffigurante il sovrano che agita il tricolore dal balcone del Quirinale, documenta quanto grande
fosse la "presa" emotiva della bandiera nazionale sul popolo che si assiepava nella piazza.
Il proclama del sovrano ebbe poi un riscontro nel comunkato del Comando Supremo del 3 novembre 1918: "Le nostre truppe hanno occupato Trento e sono sbarcate a Trieste. il Tricolore sventola sul Castello del Buon Consiglio e sulla torre di San Giusto".
Nel 1923 , con i1 regio decreto legge del 24 settembre, l'uso della bandiera nazionale fu meglio definito.

Secondo quel decreto la bandiera nazionale si differenziava in: bandiera di stato; bandiera reale, diplomatica e governativa, bandiera del regio esercito e della regia marina; bandiera della marina mercantile; bandiera degli enti pubblici locali.
Lart. 1 del decreto recitava: "La bandiera nazionale è formata da un drappo cli forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso, col bianco coronato dallo Stemma Reale bordato d'azzurro.
Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti uguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura. La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlam ento, delle rappresentanze djplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale.
Lart. 2 confermava le disposizioni in vigore per le bandiere nazionali usate dal regio esercito, dalla r egia marina, dalla regia aeronautica e dalla marina mercantile.
L'art. 3, infine, stabiliva che le bandiere nazionali degli enti pubblici locali avessero lo stemma R eale senza corona.
Gli ultimi articoli del decreto disciplinavano la posizione della bandiera nazionale nelle cerimonie, la possibililà di esporre la bandiera a mezz'asta in segno di lutto, ]e pene per coloro che avessero trasgredito.
Un decreto finalmente esamiente e che definiva con termini appropriati dimensioni e foggia della baniliera nazionale.
Per quanto riguarda l'esercito occorre dire che il 7 giugno l 938 uno specifico regio decreto raccoglieva in un solo dispositivo quanto stabilito sja dal regio decreto 25 marzo 1860 sia dai tanti provvedimenti parziali adottati ne] dopoguerra.
Di seguito gli articoli più significativi.
"
Art. 1 È concesso a tutti i reggimenti bersaglieri, alpini e del gemo, esistenti e disciolti, l'uso della bandiera nazionale, in sostituzione del labaro attualmente ad essi affidato.
Le bandiere dei predetti reggimenti sono di stoffa di seta e di forma quadrata, come quelle adottate per i reggimenti ili fanteria, ma hanno le seguenti dimensioni: drappo, metri 0,90 di lato; larghezza delle bande portantj i colori nazionali, m 0,30; lunghezza dell'asta, esdusa Ja freccia, m 2,10.
 Tavola XVIII - Labaro del corpo automobilistico e del corpo di commissariato - Freccia mod. 1938.
Tavola XVIII - Labaro del corpo automobilistico e del corpo di commissariato - Freccia mod. 1938.

Art. 2 È concesso ai reggimenti di fanteria carrista l'uso dello stendardo, conforme a quello adottato per i regg im ent i di cavaUeria e cli artiglieria.
Art. 3 La freccia deJle nuove bandiere e dei nuovi stendardi concessi ad unità, corpi o istituti del Regio esercizo, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, reca nel centro l'aquila imperiale in luogo dello stemma reale.
Essa è conforme al disegno allegato al presente decreto.
Art. 4 L'8 ° reggimento genio continua a fare uso della bandiera dell'arma del genio affidatagli in base aU'art. 3 d el R eg io decreto 14 novembr e 1935 XIV, n. 2442

...
I labari attualmente affidati ai reggimenti bersaglieri alpini e del genio saran no conservati nei Musei d'arma stabiliti dal Ministt·o per la gueffa, non appena sostituiti dalle bandiere di cui al precedente art. 1.
Il
Anche nella 2a guerra mondiale il tricolore rappresentò per il soldato italiano un sicuro punto di riferimento, tanto nei gion1i radiosi della vittoria come in quelli grigi della sconfitta.
"Anche in guerre non conformi alle tradizioni civili ed umane del nostro P ae se, il tricolore indicò ai soldati italiani la via della lealtà: Francia, Jugoslavia, Grecia, Russia, Africa settentrionale. Ma fu proprio il tricolore nazionale a guidare quegli stessi soldati, nuovi combattenti della libertà, nella resistenza a l nazismo oppressore, a difesa dell'onore e d e lla lib ertà : Cefalonia, Creta, Corfù , Grecia, Divisione Garibaldi. E il tricolore fu l'unica bandiera del movimento patriottico nazionale della Resistenza, dalle formazioni partigiane all'esercito nazionale dello Sta to .
E quando la libertà fu riconquistata, mille e mille tricolori fiorirono sul territorio redento, sui campanili delle chiese, sulle torri dei comuni, sulle ciminiere delle fabbriche difese dagli operai, sulle torrette dei campi di concentramento e di sterminio le cui catene venivano spezzate a significare che l'Italia e ra , per opera degli Italiani, libera". Così Francesco Cossiga il 28 giugno 1984 nell'aula di Palaz zo Madama 4 •
A conclusione del capitolo si riportano alcune considerazioni di Giovanni Floris, poeta e scrittore di talento immaturamente scomparso, a commento del dipin to di Alvaro Giordano Alzabandiera in Russia 5 :
"
Di una bandiera potrebbe fare a meno (ma in pratica, no) solo gente che prega, che sa pregare perché crede veramente in Dio Ma chi non sa o non vuole pre gare; chi vive, combatte, vince, perde, spera, dispera prima di morire nel ventre della realtà effettuale, leva come orazione la sua Bandiera . Se la Fede è qualcosa di mitico, la Bandie ra è allora l'ostensorio della Fede, della Speranza e della Carità laiche, rigorosamente ma religiosamente umane. Non è materia di discussione po-
• Il 28 giugno 1984 nel co r so di una suggestiva cer im onia il ministro della difesa, senatore Giovanni Spadolini, offrì a nome delle Forze Armate al Senato della Repubblica la bandiera. Dopo aver collocato la bandiera nell'aula del S enato, Fran ce$CO Coss iga, allora presidente del Senato, pronunciò il discorso di cui si è riportato un brano.
5 Il dipinto si trova n e l Museo Storico della Fanteria in Roma Il Gi ordano figurava Lra g li espo i Lori a ll a " Prim a Mostra degli artisti italiani in anni" tenutasi a Roma nel 1942.
litico-sociale, ma di culto civico e civile. Se la Storia è l'unità progressiva di tutte le nostre ipotesi d'esistenza in cerca di verifica attraverso la morte, la Bandiera è il simbolo di tutti i problemi che da tale ricerca erompono e dei loro rispettivi valori. I.:alzabandiera è dunque la preghiera storica, laica, del cittadino, particolarmente del cittadino in divisa, del so ld ato: dove l'accentuazione della disciplina come obbedienza sostituisce l'adorazione, ma dove domanda e ringraziamento sono presenti nella lode. Ed è preghiera di unità: particolarmente in guerra, al fronte, quando, per la distanza spesso enorme dalla propria terra, l'unità è tutta dentro, e i segni che scandiscono lo spazio sono avversi, ostili" 0 •
6 Giovanni Floris, l'Esercito italiano nell'arte, Roma , Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito, 1979, pagg. 25 e 26.

li cambiamento istituzionale al vertice deJlo Stato determinò anche il cambiamento della foggia della bandiera nazionale.
Il 13 giugno 1946 Umberto II di Savoia, salito al trono per l'abdicazione di Vittorio Emanuele III il 1O maggio, lasciò l'Italia e già il 19 iJ Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi, esercitando i suoi pote1i di Capo prowisorio delJo Stato, firmava il decreto legislativo presidenziale n. 1 che così recitava: "Fino a quando non venga diversamente deliberato dall'Assemblea Costituente, la bandiera nazionale è formata da un drappo rettangolare, distinto verticalmente in tre sezioni uguali, rispettivamente dei colori verde, bianco e rosso. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, ed i colori verranno distribuib nell'ordine anzidetto, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura".
Il tricolore repubblicano è pertanto, come si dice in linguaggio araldico, puli to, nel senso che la bianca banda centrale è priva di simboli.
Accadde però che sul mare la bandiera italiana venisse confusa con quella della marina mercantile messkana, all'epoca verde -rossa-bianca senza alcun emblema. Il diritto internazionale, inoltre, non consente che due Stati facciano uso della medesima bandiera. Fu quindi necessario diversificare il nostro trkolore da quello messicano, il Capo Prowisorio dello Stato Enrico De Nicola il 9 novembre 1947 sanzionò pertanto il decreto legislativo n. 1305 che stabiliva: "È istituita per la Ma1ina militare e per la Marina mercantile una bandiera navale conforme ai modelli risultanti dalla tavola annessa al presente decreto, firmata dai Ministri per la Difesa e per la Marina mercantile.
Per la Marina militare, la bandiera navale è costituita da] tricolore italiano caricato, al centro della banda bianca, dall'emblema araldico della Marina militare, rappresentante in quattro parti gli stemmi delle repubbliche marinare (Venezia, Pisa, Geno va, Amalfi), sormontato da una corona tunita e rostrata.
Per la Marina mercantile, la bandiera navale è costituita dal tricolore italiano caricato, al centro della banda bianca, dallo stemma araldico indicato nel precedente comma, senza corona turrita e rostrata, e con il Leone di San Marco con libro, anziché con spada".
Per la precisione occorre dire che lo stemma di Venezia reca un leone alato d'oro in campo rosso, quello di Pi sa una croce a chiave d'argento pure in campo rosso, quello di Genova una croce rossa in campo argento e quello di Amalfi, infine, una croce biforcata o maltese d'argento in campo azzurro.
Come ha fatto notare Aldo Ziggioto , il maggiore esperto italiano in campo vessillo logico, la diversa foggia del Leone di San Marco, c h e nella bandi era della Marina militare impugna una spada ed in quella della Marina mercantile tiene aperto il vangelo, è in realtà un errore, dovuto alla falsa credenza che la Repubblica di Venezia usasse per le navi da guerra e per quelle mercantili due diverse bandiere.
Le bandiere dell'Esercito, dell'Aeronautica e dei reparti a terra della Marina erano già state definite dal decreto legislativo n. 1252 in data 25 ottobre 1947.


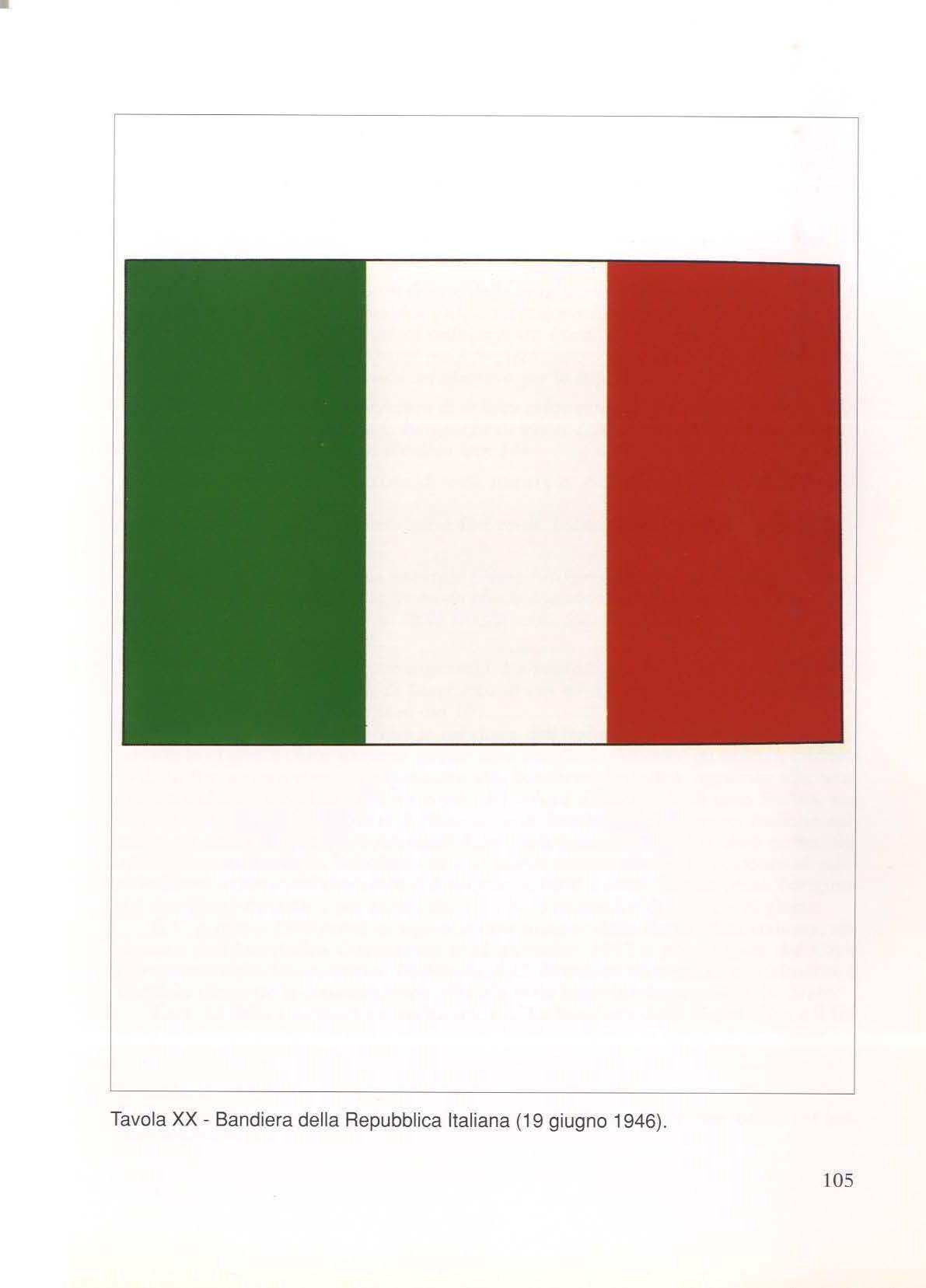 Tavola XX Bandiera della Repubblica Italiana (19 giugno 1946).
Tavola XX Bandiera della Repubblica Italiana (19 giugno 1946).

Il decreto recita testualmente:
"Art. l Per tutti gli enti dell'Esercito e dell'Aeronautica militare e per i reparti a terra della Marina niilitare, attualmente concessionari di bandiera, labaro o stendardo, è adottata una bandiera avente le caratteristiche di cui alla tavola annessa al pre sente decreto, firmata dal Minislro proponente.
Art. 2 Detta bandiera si compone di: una freccia, un 'asta, un drappo, una fa scia, un cordone.
Art. 3 La freccia è di ottone dorato della lunghezza complessiva di cm. 35. Su di essa sono incisi: il nominativo dell'Ente concessionario; l'epoca della sua creazione, delle successive sue formazioni ed ordinamenti; i fatti d'am,ze cui prese parte; le ricompense al valore di cui la bandiera è fregiata; tutte quelle altre onorifìche indicazioni stabilite con speciali decreti del Ministro per la Difesa.
Art. 4 L'asta è di legno rivestila di velluto color verde ed amata con bullette d'ot tone poste a linea spirale. Ha la lunghezza di metri 2,20 compresi il codolo (cm 10) che si conficca nella freccia ed il calcio (cm 10).
Art. 5 - Il drappo, intessuto di seta naturale, è di forma quadrata delle dimensioni di cm 99 per ogni lato. È suddiviso nei colori verde, bianco e rosso, ciascuno della lunghezza di cm 33.
Art. 6 La fascia è di seta naturale colore turchino azzurro. È fermata, a nodo, alla parte infèriore della freccia in modo che le due strisce che ne risultano siano del la lunghezza di cm 66 ciascuna . Dette strisce sono completate, all'estremità libera, da una frangia argenta di cm 8x8.
Art. 7 Il cordone, anch'esso argentato, è annodato alla base della freccia : i tratti liberi che ne risultano hanno la lunghezza di cm 67 e terminano ciascuno con un fìocco argentato della lunghezza di cm 1O ................................... ".
Non deve stupire il fatto che Je bandiere dell'Italia repubblicana abbiano co nservato le c r avatte color azzwTo. È pur vero che Carlo Alberto, quando fu costretto dalla forza degli eventi a rinunciare a ll a bandiera dinastica, aggiunse al]a bandiera tricolore i nastri azzurri a ricordo del colore tradizionale di casa Savoia , ma è altrettanto vero che l'azzurro è rima sto nelle bandiere d e ll ' E sercito italiano soltanto per simbo legg iare la continuità della tradizione militare . D a oltre un secolo, infatti, la cravatta della bandiera come il naslro azzurro delle decorazioni al valore militare, consacrati entrambi dal sangue di tanti caduti, hanno perso l'originario significato dinastico per assurgere a simbolo nazionale di onore e di g loria.
Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la costituzione della Repubblica I taliana, ap provata dall'Assemblea Cost itu ente il 22 dicembre 194 7 e promulgata dal Capo Pro wisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre successivo 1 e finalmente il Trico lore ricevette la consacrazione ufficiale nella l egge fon damental e dello Stato.
L' art. 12 della Costituzione recita infatti: "La bandiera d e1la R epubblica è il trico lore ital ia n o : verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di egual i dimensioni".
1 La Costitu:done è slala pubblicata nella Gazzetta Uflìciale del 27 dicembre 1947, n. 298 (edizione straordinaria).


 Tavola XXI a) Bandiera della Marina Militare.
Tavola XXI a) Bandiera della Marina Militare.

 Tavola XXI b) Bandiera della Marina Mercantile.
Tavola XXI b) Bandiera della Marina Mercantile.

La legge 27 maggio 1949, n. 260, definiva poi e regolava l'esposizione della bandiera nazionale sugli edifici pubblici in occasione delle feste nazionali.
Alcuni decenni più tardi si avvertì l'opportunità di regolare con maggiore precisione l'uso della bandiera nazionale da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e fu pertanto emanato, il 3 giugno 1986, uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Detto decreto non si limita a disciplinare con precisione i luoghi e le circo stanze di esposizione della bandiera, prescrive anche come la bandiera nazionale debba essere esposta, assicurando così, in ogni circostanza, aJ sacro simbolo della Nazione quel posto di assoluta preminenza che gli compete.

Le vicessitudini della 2"' guerra mondiale e la trasformazione i stituz ionale del lo Stato non hanno attenuato negli Italiani la devozione ed i l rispetto per il vess illo nazionale, simbolo dei sacrifici e degli ardimenti compiuti dal nostro popolo durante il primo ed il secondo Risorgimento.
Gli Italiani infatti, consapevo li che i due presupposti essenziali sui quali si fonda lo S tato moderno e democratico sono la relig ion e della libertà e la religione della patria, ricostruirono il tessuto morale della Nazione lacerato dalle dramma tiche esperienze della guerra civile riscoprendo il valore unificante del Tricolore.
Il 7 gennaio 1947 il 150° anniversario della nascita della bandiera nazionale fu ricordato con particolare solennità a R eggio Emilia, alla presenza del Capo Prov visorio dello Stato Enrico D e Nicola. Oratore ufficiale della cerimonia, Lui gi Salvatorelli pronunciò nella circostanza un forte e vibrante discorso di cui, a conclusione di questo lungo cammino rievocativo che ha ripercorso tutte le tappe della storia ormai bicentenaria del nostro tricolore, riportiamo ampi stralci.
Per comprendere appieno il significato del discorso occorre ricordare che, all'epoca, la Nazione, pur in mezzo a contrasti ideologici, era alla ricerca di una nuova dimensione mentre con costante, operosa, intelligente attività cercava di ricostruire quanto la guerra aveva distrutto. E Luigi Salvatorelli comprese che prop1io nell'amore e nella venerazione della bandiera nazionale il popolo italiano po teva attingere le energie spirituali necessarie per ricostruire una Patria giusta e umana:
«Il tricolore non è abbassato, non sarà abbassato. Esso è stato ribenedetto, iiconsacrato dalla insurrezione dei patrioti, dal sangue dei partigiani e dei soldati d'Italia combattenti contro il nazifascismo nella nuova lotta di lib erazione. Esso simboleggia ancora la persistente ragion d'essere dell'Italia una in un mondo rinnovellato : esso ci addita la via per la salvezza della patria. Nell'unità d'Italia è il presupposto della nostra soprawivenza, il segreto del nostro awenire . È salva l'unità teJTitorial e, anche se ai margini il sacro corpo della patria sanguina per dolorose ferite. È salva l'unità statale e sarà preservata, ne siamo sicuri, contro ogni pericolo dalla nuova costituzione repubblicana. Deve essere salva e da noi, da noi soli dipende che lo sia l'unità morale.
Cittadini di Reggio e d1talia!
I partiti sono necessari, i dissensi inevitabili, le lotte politiche feconde. Ma ad un patto: che al disopra di ogni partito, al di là di ogni dissenso, attraverso ogni

Tavola XXII Bandiera mod. 1947 per reparti dell'esercito.


lotta, il senso della patria, la coscienza dell'unità nazionale pennangano e sovrastino. O gni disputa è possibile, l ecita, utile, purché nei punti essenziali, nei momenti supremi si avverta il limite, oltre il quale la contesa offende la patria, si intuisca l'interesse nazionale che occo1Te rispettare. Hae c est Italia, Diis sacra: sacra agli Dei, e prima agli uomini, ai suoi figli. Raccogliamo , o cittadini, l' e redità del congresso di Reggio, l'eredità dei patrioti cispadani, cisalpini, partenopei. La nostra norma di condotta, il nostro grido di raccolta sia, oggi e sempre: Viva il tricolore italiano! Viva l'Italia , una e indivisibile!» 2
1 Cfr. Luigi SalvatorelJi, li Tricolore Italiano, in la Rassegna d' Italia, an n o TI, febbraio 1947 , pp. 95-100.


 Tavola XXIII Bandiera dell ' Arma di fanteria.
Tavola XXIII Bandiera dell ' Arma di fanteria.

Come si è visto, per lunghi secoli le bandiere hanno avuto una diretta derivazione araldica e, quindi, ancora oggi araldica e vessillologia hanno molti termini in co mune. "Conservatrice e tradizionalista per sua natura , l'araldica custodisce nel suo mondo rappresentativo un'infinità di concetti medievali e di conseguenza ne ha mantenuto anche le denominazioni" 1 • Denominazioni non sempre chiare al lettore di oggi e non sempre usate con il medesimo significato dagli studiosi.
2
1 · puntale a freccia (a pomo, ad alabarda ad emblemi vari); 2 · asta; 3 · cordon i; 4 • fiocchi; 5 · frangia; 6 · cravatta; AB lunghezza: BC · larghezza; AEGD · parte dell" asta o ghindante; EBCG · parie al battente;
AERH · cantone in alto all"asta: EBRF cantone In a lto al battente ; HRDG cantone In basso a l l'asta; RFGC · cantone in basso al battente; AJPQ • cantone Interno: AJDM • terzo all"asta: JK LM • terzo centrale; KBCL · terzo al battente; ABFH · alto; HFCD · basso;
Al fine di evitare qualsiasi confusione, si forniscono alcune definizioni tratte per lo più da un articolo del Bescapè 2 e dal già citato vo lum e del Neubercker alle quali l'autore si è attenuto nel corso della trattazione.

ACCANTONATO: si dice delle figure e in particolare della croce aventi nei cantoni dello scudo (da uno a quattro) altre figure di accompagnatura.
1 Ottfried Neubecker, Araldica, Milano, Mondadori, 1980.
2 Giacomo C. Bescap è, La 1er111inologia1 il linguaggio araldico, i simbo li in Araldica n. 910/ 1977 , R oma, 1977.
ADDOSSATO: attributo di due animali che si voltano il dorso e guardano i fianchi dello scudo .
ARME: complesso di determinate figure , effigiate secondo certi principi e cer te regole, che costituisce il contrassegno stabile di persone, o famiglie o enti . Ogni arme si compone di due parti principali: lo scudo e l'elmo, ma possono far parte dell'arme anche gli ornamenti. Talvolta l'elmo è sostituito da una corona.
ATTRAVERSANTE: è detto della figura o pezza araldica , generalmente lunga, che attraversa una partizione, un'inquadratura o l'intero campo.
BANDIERA: deriva da banda , di cui era l 'insegna (Paolo Diacono nell'Historia Langobardorurn , secolo VII, già parla di Bandonum vessillo del re degli Enùi) ed è un nome ge n erico usato per indicare termini più precisi propri di altre lingue, quali per esempio Banner o Panner; insegna di tipo araldico, anticamente rettangolare e attaccata all'asta dal lato maggiore; Fahne o Drapeau: bandiera usata prevalentemente a terra, in origine emblema soprattutto di guerra o di sovranità, qualunque ne fosse l'aspetto, al contrario di Flagge o Pavillon o Ensign: bandiera più moderna, in origine usata soprattutto in mare.
BORDURA: lista aderente ai lembi interni dello scudo, del quale segue la sinuosità, larga circa un settimo della larghezza dello scudo .
CAMPO: è il fondo dello scudo su cui sono poste le figure e le pezze.
CARICATO: si dke di tutte le pezze o figure che ne hanno altre sopra, spesso di piccole dimensioni.
CORNETTA: bandiera di dimensioni ridotte, a due punte, propria un tempo dei dragoni Da essa trassero origine i gagliardetti di cui appresso.
CRANCELINO: figura araldica formata da una mezza corona di foglia di ruta, di verde, posta in banda e attraversante.
FASCIATO: è così detto lo scudo caricato di fasce alternate di due smal ti in numero pari, da 4 a 8. Olh-e questo numero è detto "burellato".
FIAMMA: usato nel senso di bandiera, è termine che appare nel secolo VIII , ma ebbe particolare importanza soprattutto a Bisanzio, dove Flàmoulon dalla fine del Mille indicò comunemente la bandiera di gue1Ta. Sopravvissuto nelle Ungue romanze, il vocabolo indica l e lunghissime bandiere (ormai però di uso Hmjtato ) che le navi portarono dal Medioevo in poi in cima agli alberi. Con il termine fiamma si indi ca anche una bandiera di forma pentagonale un tempo usata dai reparti di cavalleria.

GAGLIARDETTO: originariamente bandiera a due punte issata sugli alberi delle navi, poi ad una sola punla o di forma quadrata , ma sempre di dimensioni ridotte.
GIGLIO: definito semplicemente "giglio", è il giglio araldico, il più nobile dei fiori balsone, ma rappresentato senza alcuna somiglianza con il fiore che esiste in natura, che viene pertanto chiamato "giglio naturale".
GONFALONE: dall'alto tedesco gunt{an (da gundja = guerra, e fahan = inse gna), il gonfalone indicò nell'Alto Medioevo la bandiera attaccata alla lancia porta ta dai cavalier. Aveva forma di rettangolo esteso in lunghezza e terminava co n punte, le cosiddette lingue o fiarnnze o code o fanoni, di solito tre. In questa forma e di co lor rosso, senza figure, il gonfalon e divenne insegna personale dell'imperatore. Mantenendo la sua forma originaria terminante in code e differenziandosi in
ciò dallo stendardo , il gonfalone fu usato dai Comuni medievali. Il cosiddetto gon falone papale era, invece, un ombrellone a strisce alterne, rosse e oro .
INSEGNA: vds. VESSILLOI DE.
LABARO: originariamente derivò, secondo alcuni, dall'aquila legionaria roma na e dallo stendardo della cavalleria; se ne hanno notizie al tempo dei primi impe ratori romani cristiani, quando fu sostitLùto all'aquila il monogramma intrecciato XP, iniziali della parole XPISTOS. È simile allo stendardo, pendente da un regolo orizzontale, ma di dimensioni minori.
LAMBELLO: pezza ara ldi ca simile ad una lista scorciata e munita di pendenti (o gocce) patenti e in numero normalmente di tre.

PASSANTE: attributo dei quadrupedi posti in atto di camminare, la zampa destra anteriore sollevata.
PATENTE: attributo - in particolare - della croce le cui estremità si allargano ai bordi dello scudo.
Q UARTO: quarta parte di uno scudo diviso in quattro pezzi . P er es t ensione si intende per "quarto" il campo di un'arme composta (e perciò costitue n te arme a sé) suddivisa in parti uguali da linee orizzontali e vert i ca]j in c r oc i antes i.
SCUDETTO: dicesi dello scudo posto sul tutto, ossia sopra un altro scudo (in quartato o altrimenti partito).
SEMINATO: è lo scudo (o la figura) cosparso di piccole e numerose figure (di solito gig li , stelle, api o rose).
SMALTI: sono i colori (rosso, azzurro, nero, verde, porpora) e i metalli (oro e agento) araldici
STENDARDO: con questo termine si intendono impropriamente e genericamente tutte le insegne usate nell'antichità, anche se in realtà non si trattava c h e di emb l emi, spesso di carattere religioso, i ssati per lo più in cima ad aste . La più antica, autentica, rappresentazione di uno stendardo risale a circa 2 800 anni avanti Cristo ed appartenne a una provincia egizia : la raffigurazione di un animale (una lepre) su un panno co lo rato, fornisce gli elementi dello stendardo quale fu usato poi nei secoli: l'asta che tiene alto e ben visibile i] drappo c h e, sventolando, attrae l'attenzione.
In campo militare lo stendardo è una bandiera di dimensioni ridotte usata da reparti di cavalleria o, comunque, montati.
SUL TUTTO: figura, in particolare scudetto, posto su un'inquadratura o altra partizione.
SUL TUTTO DEL TUTTO: si dice di uno scudetto posto a sua volta sullo scu detto figurante sul tutto.
VESSILLO/DE : un qualsiasi oggetto che, pur differendone nell'aspetto, espli chi le stesse funzioni di una bandiera.


AA.VV. , Un'alrra Italia nelle bandiere dei lavoratori, Torino, 1980.
B01NE Giovanni , Discorsi militari, Firenze, Libreria della Voce, 1915.
BOVIO Oreste, Le bandiere dell'Esercito, Roma, U lficio Storico Stato Maggiore Esercito, 1985.
BOVIO Oreste, L'araldica dell'Esercito, Roma, Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito , 1985 .
BELLOCCHI Ugo , Il tr icolore 1796 1986, Reggio EmjJfa, Società Emiliana Editoriale, 1986 .
BRANCACCIO Nicola, Le bandiere del Regno di Sardegna dal l 814 al I 860, in Memorie Storiche Militari., Roma, Ufficio Storico Stato Maggiore Eserc i to , 191 O.
DE MAURO Tullio , Storia linguistica dell'Italia unita, Bari, Laterza , 1976. Enciclopedia Italian a , voce Bandiera, voi. VI.
FIORA Paolo Edoardo, Bandiere in Piemon/e, Torino, Accademia di San Marciano, 1974.
GERBAIX de SONNAZ Carlo Alberto , Bandiere, stendardi, vessilli di Casa Savoia dai conti di Morianc.1. ai re d'Italia, T orino, R o u x e Viarengo , 1911.
GHISI E nrico , Il Tricolore italiano, Todno Roma, F ratelJi Bocca Editori, 19 12.
LONGO Angelo , La bandiera, in Rivista della Guardia di Finan za, n. 2/J 969, Roma, 1969.
MASSOBRJO Giulio (a cura di) , / moli del 1821 e la cittadella di Alessandria, Alessandria, Comune di Alessandria, 1991.
P IERI Piero, Storia militare del Riso,gimenw. Guerra ed insurrezioni, Torino, Einaudi, 1962.
RANGONI-MACHIAVELLI Luigi, La bandiera tricolore e gli Stati italiani del 1848-1849, in Rasse gna storica del Risorgimento, R oma, 1914.
SALVATORELLI Luigi , li tricolore italiano, in La Rassegna d'Italia, n. 2/ 1947, Milano, 1947.
SMITH Whi t ney, La bandiera. Swria e s imboli, Milano, Mondadori, 1975.
VOLPE Gioacchino, ltalia Moderna, volJ. 3, Firenze, Sansoni, J946 1952.
ZIGGIOTO A1do , Le bandiere degli Stati italiani, in Armi antiche, numeri unici 1970 e 1971, Torino, Acc a demia di San Marciano, 1970 e 1971.

Andervolti, Leonardo, 60
Anfossi, Augusto, 60 Anfossi, Francesco Filippo, 60
Ansaldi, Guglielmo, 44 Appiani, commerciante piemontese, 44 Ariosto, Ludovico, 28 Asher, personaggio biblico, 6 Azeglio, Massimo Taparelli d', 85
Baronis, ufficiale piemontese, 44 Barzilai, deputato italiano, 89 Beauchamp, Alphonse de, 45 B eccaria, Cesare, 38
B ellocchi, Ugo, 27 Beltrame, Achille, 95, 97
Beniamino, personaggio biblico, 6 B erchet, Giovanni, 23 Bianco, di Saint-Jorioz, Carlo, 44 Bigotti, 48, 73
Bismarck-Schonhansun, Otto von, 15 B oine, Giovanni, 90, 97 Bonifacio di Savoia, 59 Brancaccio, Nicola, 59, 73, 74 Brunetti, Vincenzo, 24 Bruto, Marco Giunio, 20 Budassi, deputato italiano, 89

Campana,Dino, 90 Carducci, Giosuè, 27 Carlo Alberto, re di Sardegna, 47, 48, 73, 107 Carlo X, re di Francia, 45 Carlo, Magno 12, 43
Casini, Tommaso, 24 Cassio, Longino Caio, 20 Cavour, Camilla B enso di, 73 Cesare, Gaio Giulio , 29 Cipriani, Leonetto , 76 Compagnoni , Giuseppe, 24 Cossiga, Francesco, 1Ol Croce, B enedetto, 38
Dan, personaggio biblico, 6
D'Annunzio, Gabriele, 90 De Gasperi, Alcide, 103 De La Hoz Orti s, Giuseppe, 19 De Mauro, Tullio, 85 De Nicola, Enrico, 103, 107, 113 Domman get, Maurice, 16 Do ssena, awocato piemontese, 44
Efraim, personaggio biblico, 6 Enrico II, re d1nghilterra, 12 Enrico TU, re d'Inghilterra, 59 Erodoto, 27
Federico I, imperatore, 24 Federico II , imperatore, 12 Ferdinando 11, re delle Due Sicilie, 46, 47 Ferdinando VIII, re di Spagna, 44 Filan gieri, Gaetano, 38 Filippo di Fiandra, 12 Filippo Augusto, re di Francia, 12 Fiora, Paolo Edoardo, 12 Fiorini , Vittorio, 23, 24, 27 Floris, Giovanni, 101, 102 Foscolo, Ugo, 28
Francesco II, re deIJe Due Sicilie, 76, 83 Francesco JV, duca di Modena, 46 Frimont, Johann Philipp von, 46
Gad, personaggio biblico, 6 Galilei, Galileo, 30 Garibaldi, Giuseppe, 29, 30, 76 Gerbaix de Sonnaz, Carlo Alberto, 59 Ghisi, Emico, 19 , 20, 27 Giordano , Alvaro , 101 Giove, 11
Giuda, personaggio biblico, 6
Herder, Johann Gottf,-ied, 16 Hobsbawrn, Edward, J 5
Issachar, personaggio biblico, 6
Jaeger, PierGiusto, 83
La Fayette, Marie Joseph Motier de, 15 Leopoldo Il , granduca di Toscana, 48, 59
Levi, personaggio biblico, 6 Liuz zi, avvocato piemontese, 44 Longo , Angelo, 11
Luigi Filippo, re dei Francesi, 45, 46 , 47
Maometto, 12 Massob1io, Giulio, 45 Mazzini, Giuseppe, 29, 46
Melzi d'Etil, Francesco, 37
Menotti, Ciro, 46
Metlernich Winneburg, Klemens Wenzel Lothar von,48
Morelli, ufficiale napoletano, 44 Murat Gioacchino , re di Napoli, 39
Napoleone I, imperatore, 23, 24 , 30, 37, 43
Neftali, personaggio biblico, 6 Nicolini, Fausto, 19, 20, 37 Novaro, Michele, 90
Palma , ufficiale piemonlesc, 44 Pascoli, Gio vann i , 90 Pi eri, Piero, 43, 45
Pietro il Grande, zar di Russia, 17 Pietro Il di Savoia , 59
Pindaro, 28
Pio IX, ponLefice, 47, 48 , 59 Prezzolini, Giuseppe, 90
Quazza, Guido , 16
Rattazzi , medico piemontese, 44 Rebora, Clemente, 90 Romolo, re di Roma , 11 Rousseau , Jean-Jacques, 16 Rovatti, Antonio , 27
Ruben , personaggio biblico, 6 Salvatorelli, Luigi , 113, 117 Santarosa, Santorrc De Rossi di Pomarolo di, 45
Sbarbaro , Camillo, 90 Silvali, Rodolfo , 44 Simeone , personaggio biblico, 6 Smith , Whitncy, 5, 6
Sommariva, giacobino lombardo, 19 Spadolini, Giovanni, 101 Spinelli, Antonio, 76
Testi Rangoni, Rosa, 46 Thiers, Louis Adolphe, 45 Toschi , Ettore, 23
Umbc1-to H , re d'Italia, 103

Vi tt01io Emanuele Il, re di Sardegna e re dltalia, 29,83,90
Vittorio Emanuele III, re d'Italia, 97, 103 Vo lpe, Gioacchino , 43, 74, 90
Zabuilon, personaggio biblico, 6 Ziggiolo, Aldo, 6, 103
pag.
Pre s enta zi o ne 3
1. O rigine e primitivo significato 5
2 . Funzione mili tare d e lla bandiera 11
3 L a bandi e ra nazional e 15
1. Origini del tricolore 19
2 L a pri ma band i era itahana 23
3. La bandiera della Repubblica Cisa lpina 30
1. I moti del 18 20- 182 1 43
2. I moti de l 1831 45
3. Il tricolore nel 1848-1849 4 6
4. Il tricolore nel 1859 73
5. L'I tal i a unita 76
1. Funzione unificante del Lricolore 85
2. Il tricolore di Vittorio Veneto 89
3. Il tricolore nella 2" guen-a mondiale 98
1 I.:aspetto normativo 10 3 2. I.:aspet t o simbo l ico 1 13
Appendice - TERMINOLOGIA DELLA BANDIERA 12 1 Bibliografia 125 Indice dei nomi 12 7

