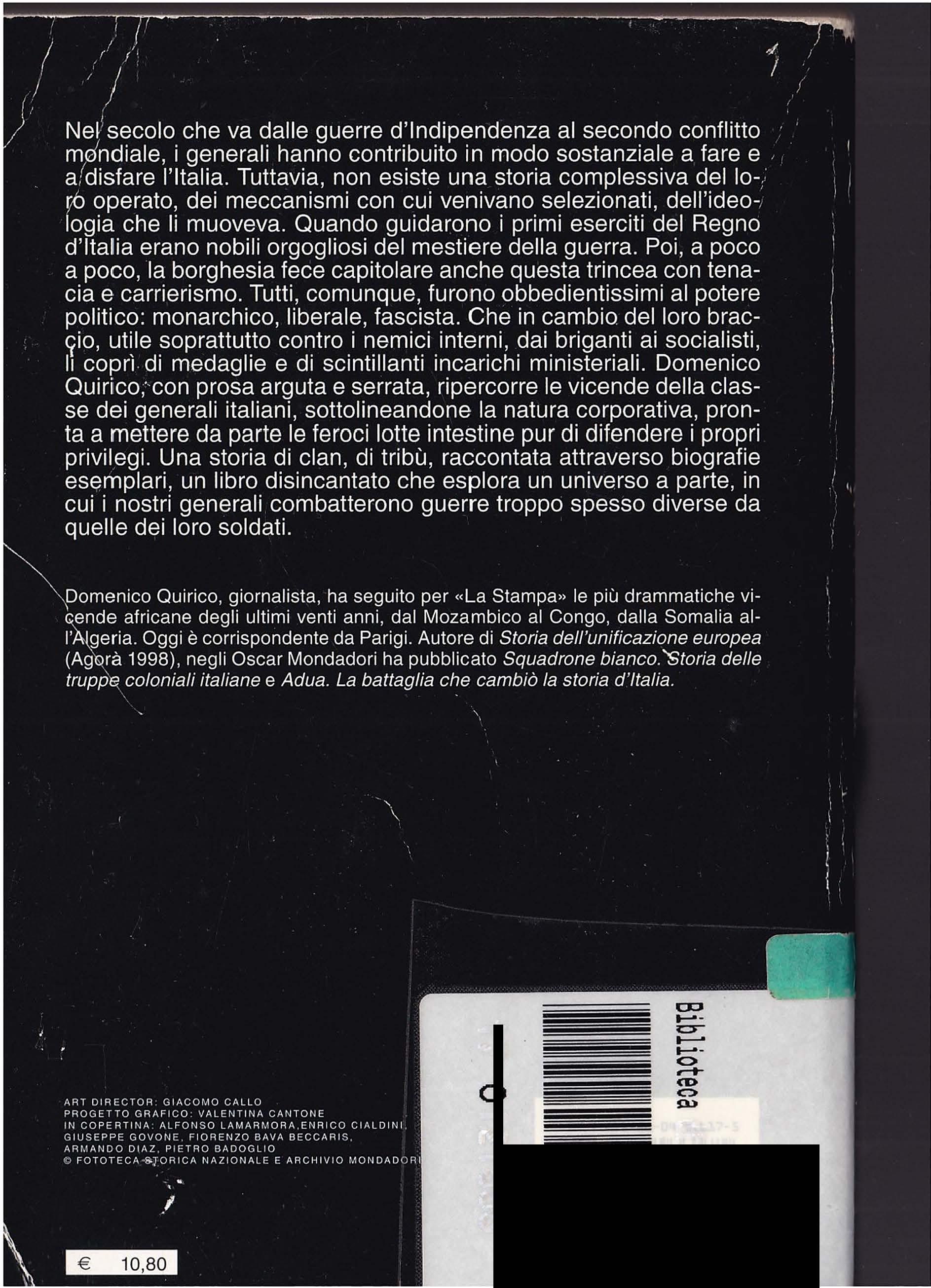Controstoria dei vertici militari che fecero e disfecero l'Italia
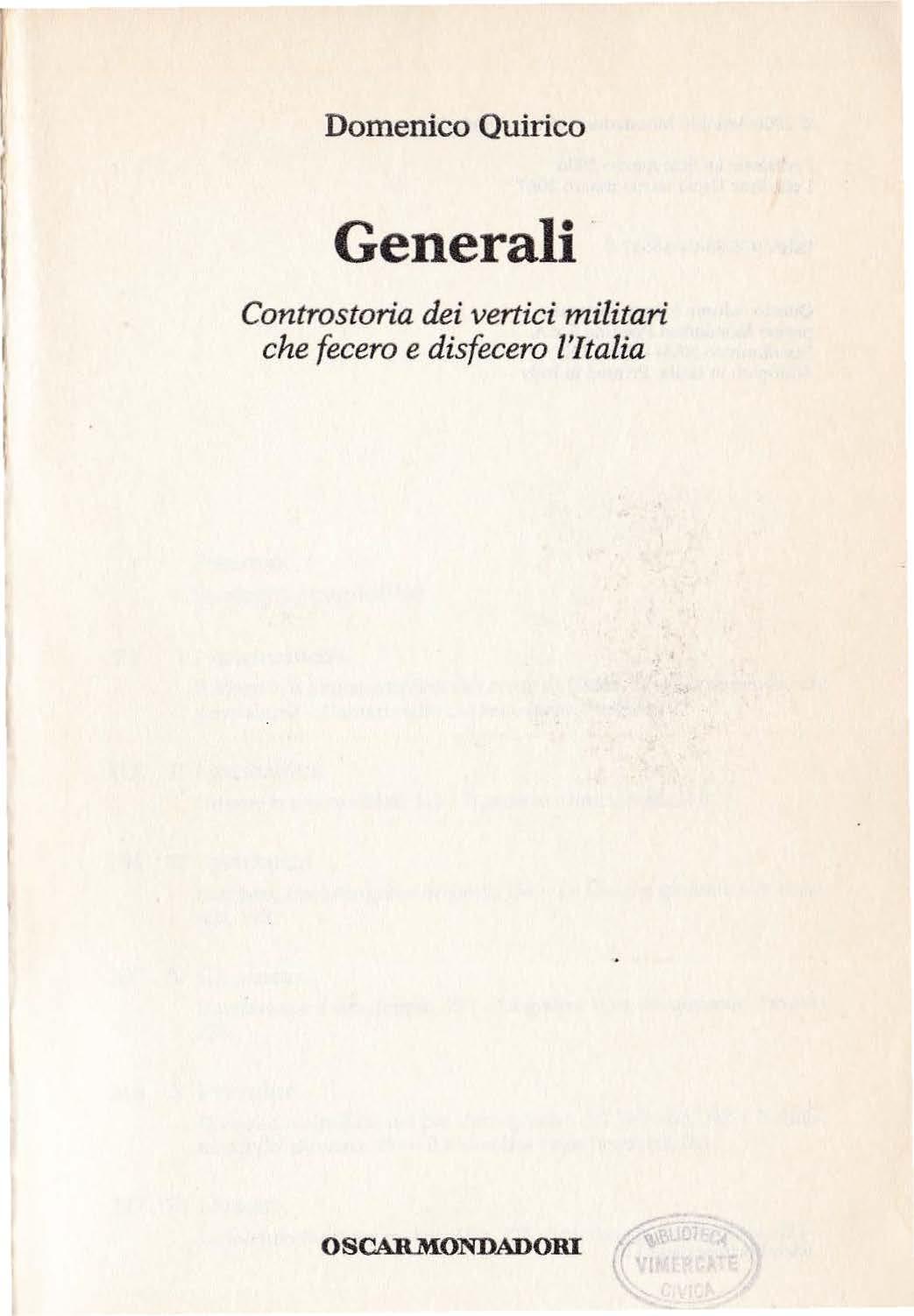

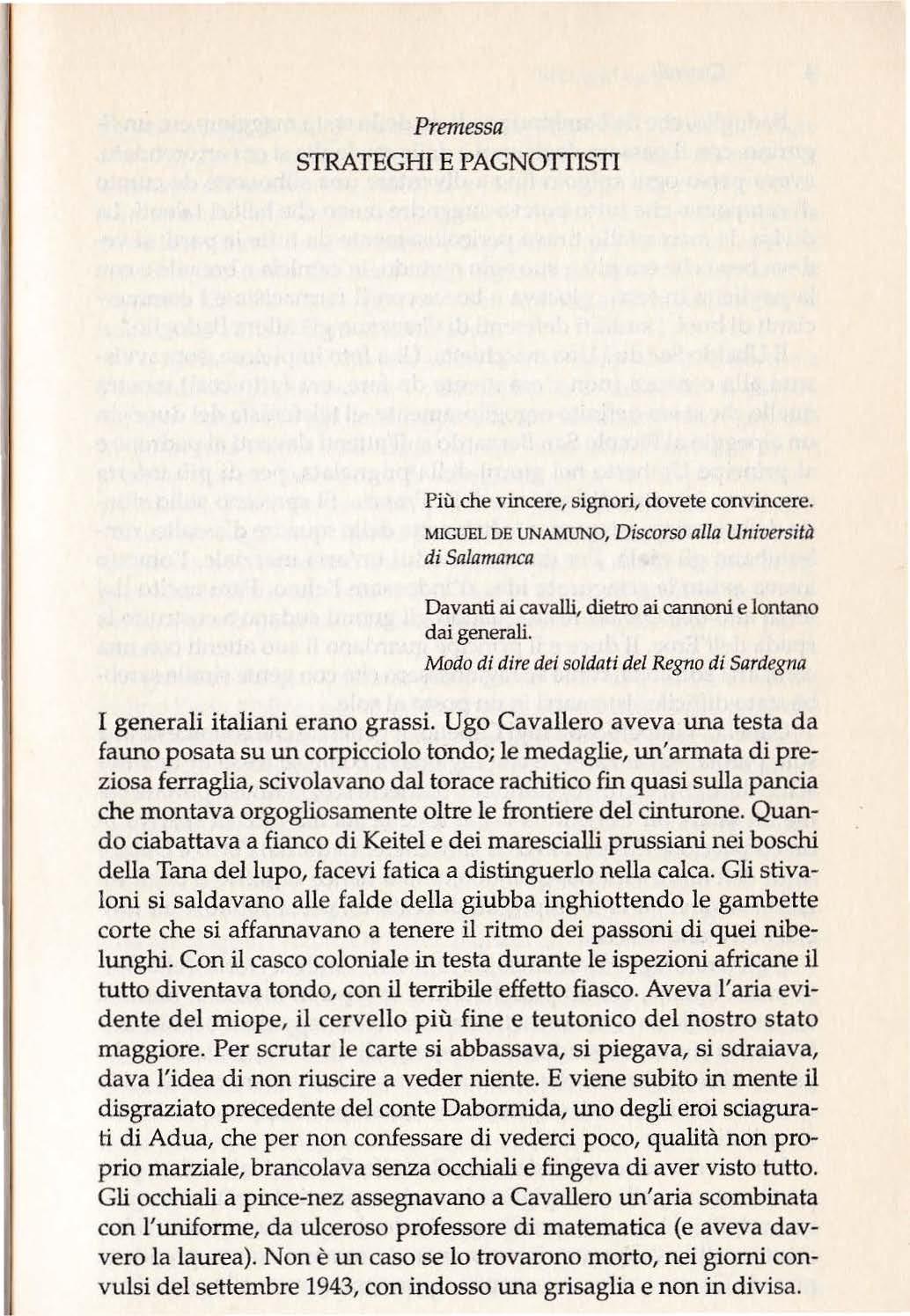
Più che vincere, signori, dovete convincere.
M1GUEL DE UNAMUNO, Discorso alla Univers ità di Salamanca
Davanti ai cavalli, dietro ai cannoni e lontano dai generali. Modo di dire d ei soldati del Regno di Sardegna
I generali italiani erano grassi. Ugo Cavallero aveva una testa da fauno posata su un corpicciolo tondo; le medaglie, un' armata di preziosa ferraglia, scivolavano dal torace rachitico fin quasi s ulla pancia che montava orgogliosamente oltre le frontiere del cinturone. Quando ciabattava a fianco di Keitel e dei marescialli prussiani nei b oschi della Tana del lupo, facevi fatica a distingu erlo nella calca. Gli stivaloni si saldavano a lle falde della giubba inghiottendo le gambette corte che si affannavano a tenere il ritmo dei passoni di quei nibelunghi . Con il casco coloniale in testa durante le ispezioni africane il tutto diventava tondo, con il terribile effetto fiasco . Aveva l 'aria evidente del miope, il cervello più fine e teutonico del nos tro stato maggiore . Per scrutar le carte si abbassava, si piegava, si sdraiava, dava l'idea di non riuscire a veder niente. E viene s ubito in mente il disgraziato precedente del conte Dabormida, uno d egli eroi sciagurati di Adua, che per non confessare di vederci poco, qualità non proprio marziale, brancolava senza occhiali e fingeva di aver visto tutto. Gli occhiali a pince-nez assegnavano a Cavallero un'aria scombinata con l 'uniforme, da ulceroso professore di matematica (e aveva davvero la laurea). Non è un caso se lo trovarono morto, nei giorni convulsi del settembre 1943, con indosso una grisaglia e non in divisa.
Badoglio, che da bambino prodigio dello stato maggiore era un figurino, con il passare degli anni e delle medaglie si era arrotondato, aveva perso ogni spigolo fino a diventare una silhouette da curato di campagna che tutto poteva s u ggerire meno che bellici talenti. La divisa da maresciallo tirava pericolosamente da tutte le parti; si vedeva bene che e ra più a suo agio quando, in camicia e bretelle e con la paglietta in testa, giocava a bocce con il farmacista e i commercianti di buoi, i sudd i ti deferenti di Grazzano già allora Badoglio.
E Ubaldo Soddu? Una macchietta. Una foto impietos a , sopravvissuta alla censura (non c'era niente da fare, era fatto così) mostra quello che si era definito orgogliosamente «il telefonista del duce» in un alpeggio al Piccolo San Bernardo sull'attenti davanti a l padrone e al principe Umberto nei giorni della pugnalata, per di più inferta con mano incerta, alla schiena della Francia. Si sprecano s ullo sfondo della g loriosa istantanea le baionette delle squadre d ' assalto, rimbombano gli alalà . Per darsi a n che lui un'aria marziale, l'ometto aveva avuto l a sciagurata idea d'indossare l'elmo. Pare uscito dal terzo atto dell'Oro del Reno, quando gli gnomi sudano a costruir e la spada d ell'Eroe. Il duce e il principe guardano il suo attenti con una certa aria sorniona, come se ragionassero che con gente simile sarebbe stato difficile sistemarsi in un pos to al sole.
Capello, l' impetuoso Luigi Capello, il generale che conosceva una sola parola, «avanzare», e che ragionava come se fosse in una mischia di rugby, è grosso, sformato, trichechesco, la divisa portata come un sacco, un Gargantua la cui testa acuta ma piccola spariva in un corpaccione da beccaio o da carrettiere. Cadorna, Porro e Diaz, il duca dell' unica v ittoria, quando erano a fianco di Joffre o degli ing lesi avevano l'aria di impiegati del catasto: pensi subito a un ufficio, non a una trincea.
E gli ammiragli? Domenico Cavagnari, l'Andrea Doria delle flotte mussoliniane, era un piccoletto che spariva in mezzo ai marinai schie rati sulle navi, un musetto da contabile; neppure il bel blu della marina riusciva a sradicare il sospetto di ulcere, di malattie di fegato e altri imba razzi che nulla avevano a che vedere con le to lde spazzate dai marosi degli oceani o con tempeste appena u scite dai r icordi di Ulisse .
L' unico che «aveva il fisico» era Rodolfo Graziani: alto e ben proporzionato, capelli scompigliati in onde sapienti che già sembra vano scolpite nel marmo, profilo gagliard o da console romano. E lui, a s tuto, coltivava queste rimembranze da romano antico, prendeva pose da Cesare e si fac e va sempre rappresentare a cavallo con a fian-
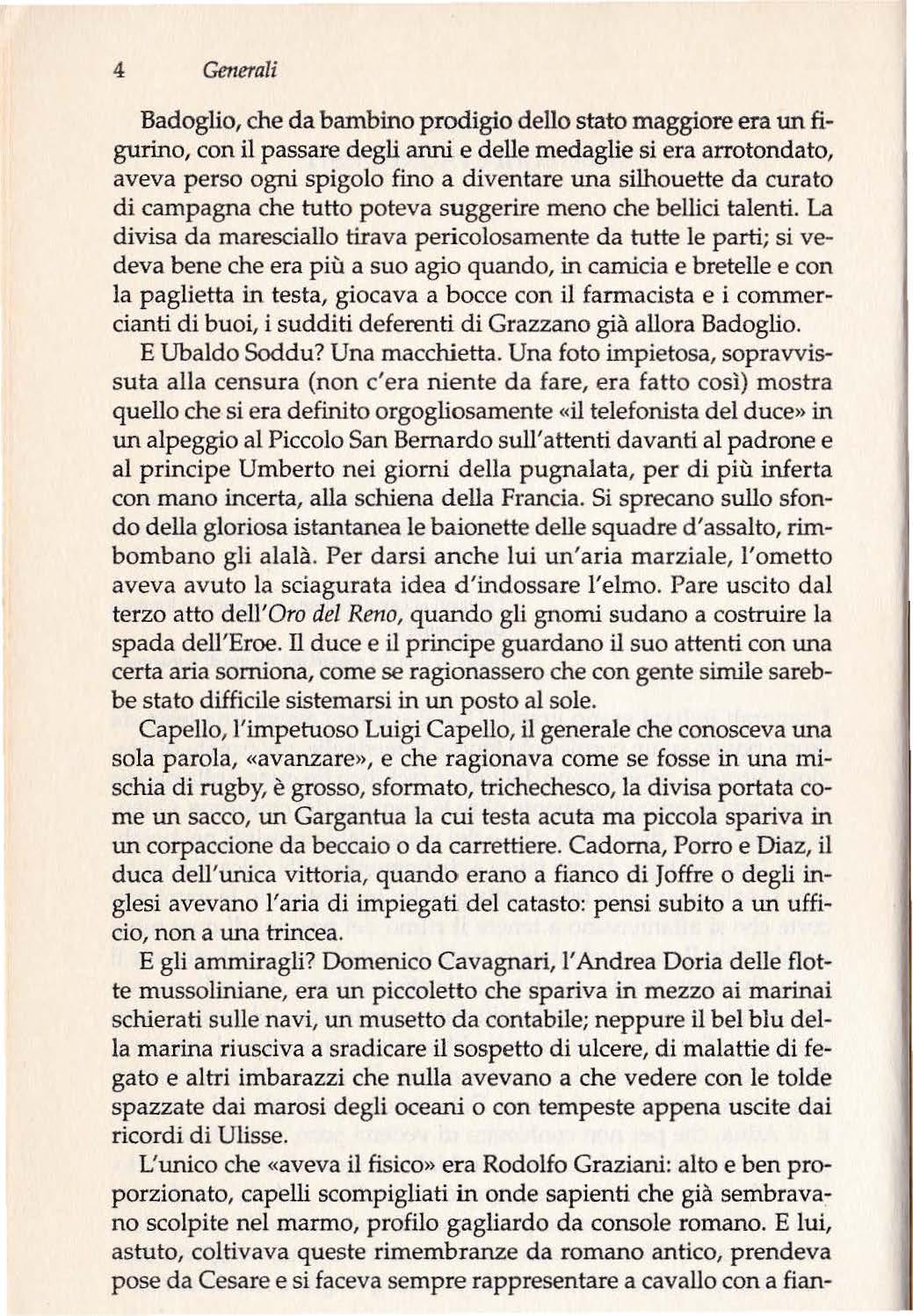
e pagnottisti
co personaggi di non poco conto: Marte, Scipione l'Africano, Augusto, che, guarda caso, sembravano usciti dal suo stesso stampo. Per mostrare che era ancora possente e integro, dopo un etiopico attentato, scandalizzò l'Italia distribuendo a destra e a manca fotografie in cui era ritratto nudo di fronte e di profilo: una prova estetica che il novanta per cento dei condottieri italiani non avrebbe superato. Il capitano Battista Pintus gli aveva dedicato un'ode da recitare con il sottofondo della Quinta di Beethoven.
Le divise non li aiutavano. Con la scomparsa del blu Savoia e l'avvento del grigioverde se ne era andata una bella fetta di eleganza; eran venuti in voga certi cappottorù che trasformavano i generali in grottesche statue ambulanti, sembravano goffi monoliti a cui lo scultore avesse dimenticato di scheggiare le gambe. E poi c'erano i pennacchi. Forse per renderli più alti e guerrieri, qualcuno sciaguratamente negli anrù Trenta pensò bene di aggiungere all'elmetto un fioccone spropositato che alle sfilate li faceva sembrare personaggi del melodramma, reclute dell'Aida in attesa di un Radames muscoloso che li guidasse dalla pausa pranzo sul palcoscerùco per il trionfo.
I generali italiarù soffrono più o meno tutti di qualche malattia, hanno l'aria giallognola di gente che sta per marcar visita, altro che vegliare insonrù sui destirù delle armate: le emicrarùe di La Marmora; le ulcere o peggio di Baratieri che, con notti insonrù e flussi dolorosissimi, prepara una battaglia, e che battaglia, contro tutte le selvaggerie dell'Africa; i malori di Diaz che, mentre sta sistemando i conti con l'Austria-Ungheria, dedica sempre metà delle sue lettere a casa a temperature corporee e flussi ; le asme di Badoglio che taglia la corda da Addis Abeba e dalle sue altitudirù lasciando i guai in eredità ai colleghi. Perfino De Bono, il quadrunviro che ha una salute di ferro e che verrà ucciso solo dal piombo del plotone di esecuzione (altrimenti sarebbe campa to altri cinquant'anni), è sempre in lista dal medico, immagina agguati clinici, ammonticchia sintomi misteriosi e micidiali. E non abbiamo perduto di vista il benemerito lacchè badogliano, il generale Quirino Armellirù, un Epaminonda che rifiutò di prendere il comando del Decimo corpo d'armata a El Alamein mentre la battaglia indiavolava sul filo della vittoria o della catastrofe dichiarando di avere «una colite in atto» .
Questo libro non vuole essere la storia dell'esercito italiano. Non potrebbe. Perché l e guerre dei nostri generali sono completamente diverse da quelle dei loro soldati. Abitudirù, aspiraziorù, idee, furori, tutto agli antipodi, paion popoli diversi che la Storia per caso ha
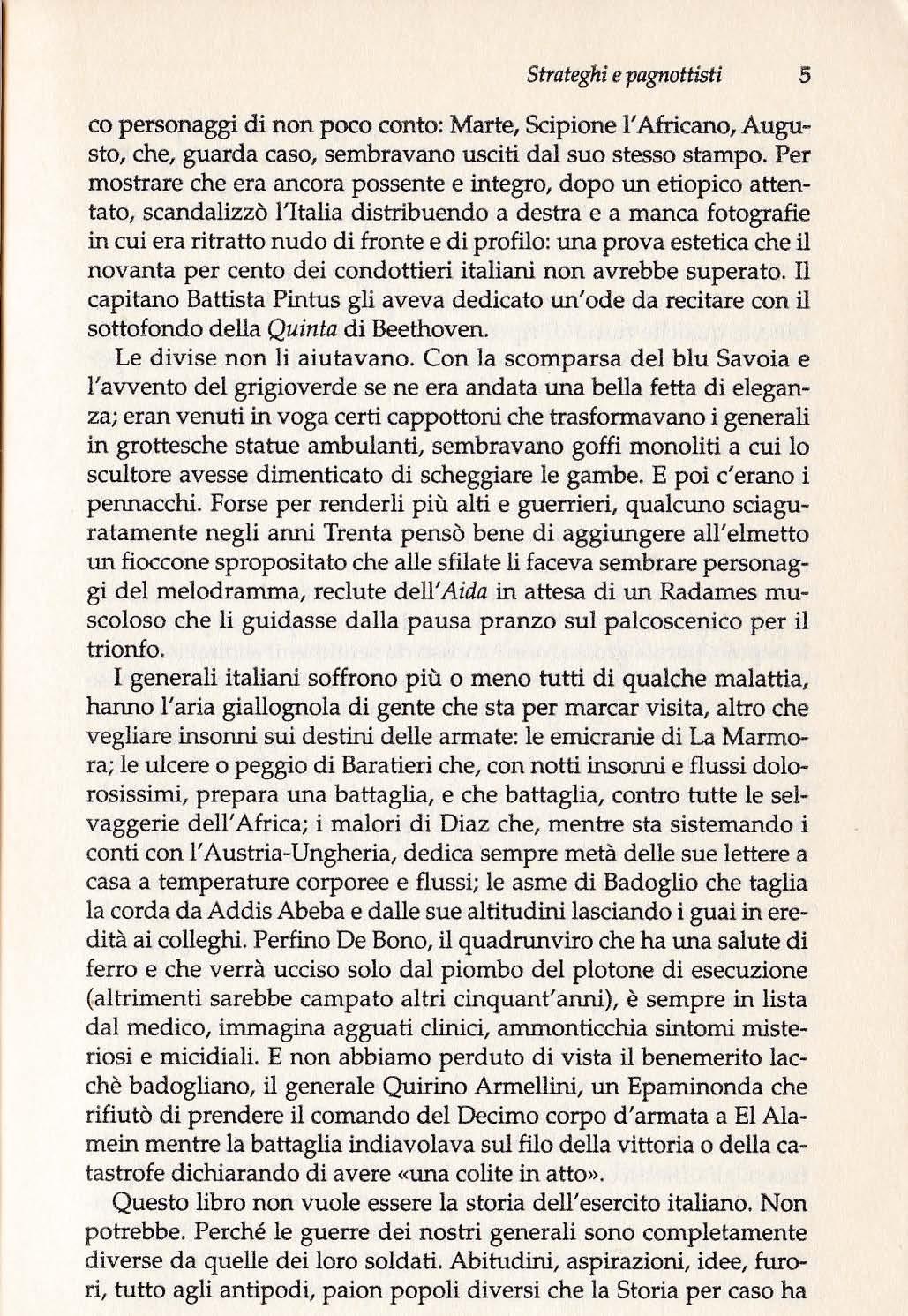
accampato a breve e sospettosa distanza reciproca. Anzi di più: i generali non conoscono i loro soldati. Da La Marmora a Badoglio li liquidano sbrigativamente come masse brute che bisogna sbozzare con l'accetta del regolamento e della disciplina fino a trasformarli in autorrù capaci di gettarsi in ogni mischia.
Il primo che ordina un trattamento degno di essere umani è Armando Diaz. Niente di rivoluzionario per carità: il pranzo caldo in trincea, qualche turno di riposo in più n ei frettolosi postriboli delle retrovie, la raccomandazione di non fare assalti inutili tanto per riempire le paginette stantie dell'ordine del giorno e dimostrarsi attivi e grintosi, un'assicurazione per le farrùglie, quattro lire in caso di morte del parente rrùlitarsoldato in modo da scongiurare la immediata indigenza. Eppure appaiono come intuizioni degne di Mosè, concessioni da pastore di uomini e l'autore - se ne parla con stupefatta commozione ancora dopo un secolo - ne ricava fama di santo, di palombaro delle coscienze e dei caratteri .
I nostri suprerrù comandanti rrùlitari sono rimasti con in saccoccia la psicologia e la mentalità immutate dei vecchi questori piemontesi. Il popolo, parola grossa, non è mosso da sentimenti aspirazioni idee: c'è solo la folla dei rivoltosi, dei sovversivi quando sono in borghese e dei renitenti e degli ignavi quando hanno addosso un'uniforme. Inizia la musica: Della Rocca, che reprime a schioppettate l a rivolta dei torinesi indisposti dal «tradimento» (il primo!) dei Savoia che hanno cambiato cap itale e largheggia con i plotoni di esecu zione nelle felici province meridionali del Regno per estirpare il brigantaggio come fosse la malaria . La sinfonia spetta a Bava Beccaris, il fucilatore di Milano cui hanno detto che c'è la rivoluzione e lui obbedisce rrùtragliando e deportando nelle latorrùe di Finalmarina, senza preoccuparsi di controllare se è vero. Non sta indietro la grancassa di Cadorna, che con la sua disciplina avrebbe messo volentieri due carabinieri dietro ogni fante per controllarne lo slancio. Chiude Badoglio, questurino insuperabile. Dopo aver restaurato la libertà statutaria, il marchese di Sabotino emana leggi draconiane, sembra accampato in un territorio straniero e che il suo vero nerrùco siano g li italiani. I suoi soldati girano con la baionetta in canna e con lo stato d'assedio nello zaino. Si schierano nelle piazze in linea pronti a far fuoco, gli ufficiali con l'elmetto calzato e il sottogola ben teso. Appena arrivano i tedeschi i soldati spariscono: «Evidentemente» commenta la gent e «erano armati contro di noi e non contro i crucchi».
E Mario Roatta? Diciamo la verità, gli dobbiamo delle scuse: in questo libro lo abbiamo trasc urato. Ma per una buona ragione: la
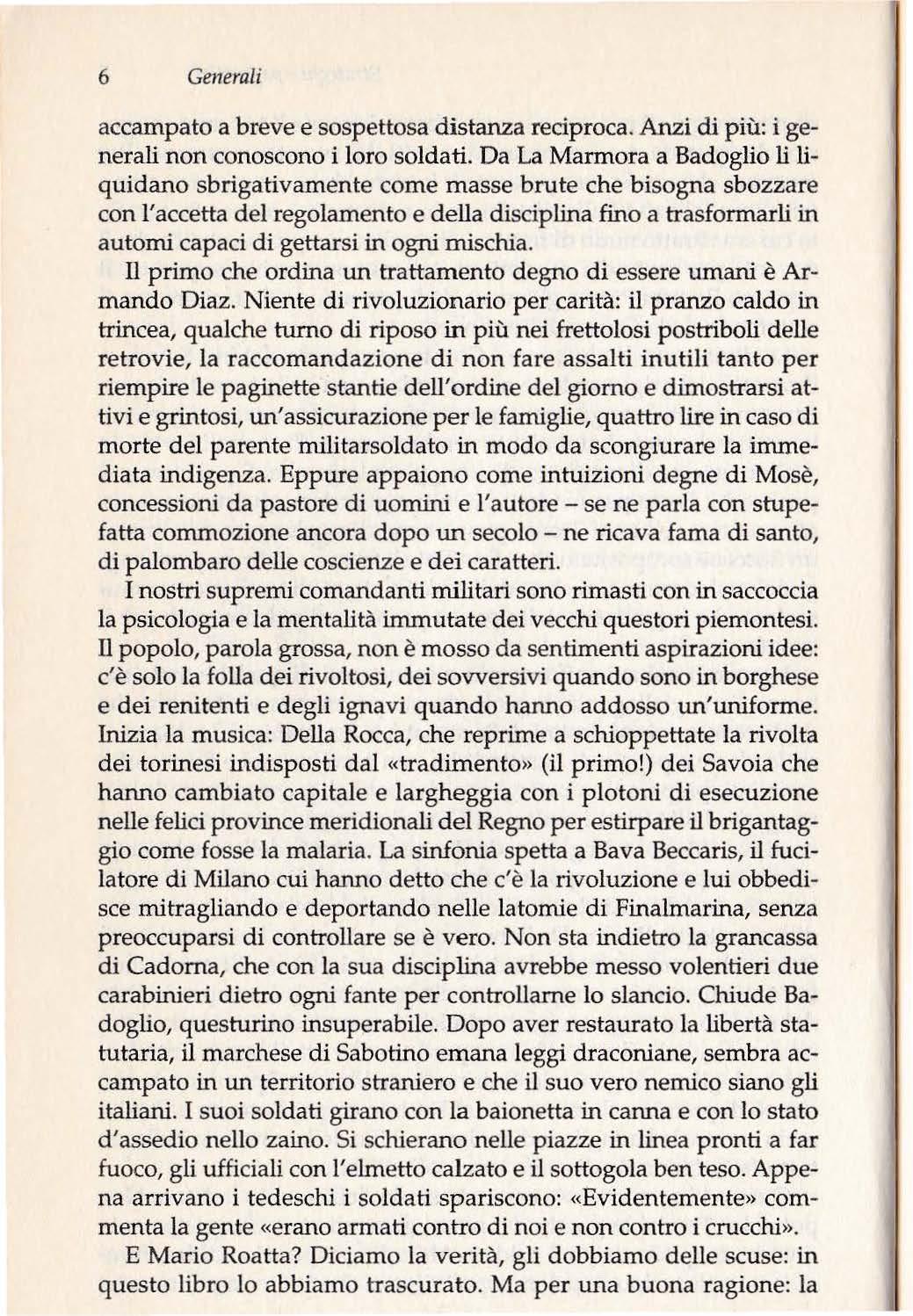
e pagnottisti
sua autobiografia di manigoldo in uniforme da generale rende inutili tutte le altre. Perché affannarsi a sollevare polvere negli archivi e disturbare il silenzio delle biblioteche? Non c'è difetto soperchieria carognaggine che non si riassuma comodamente nelle sue gesta . La guerra con le cannonate, gli assalti lo avevano appena sfiorato, quando era giovanissimo e, dice lui, faceva meraviglie con il contingente italiano sul fronte di Francia. E bisognerebbe indagare su tutti questi remoti eroismi. Poi diventa capo del Sim, lo spionaggio militare, sotto il fascismo. Era fino ad allora un'associazione di innocui incompetenti. I nostri agenti speciali erano ufficiali che venivano spediti in giro all'estero travestiti da turisti a spremere informazioni ascoltando le chiacchiere nelle osterie vicine alle caserme o girando in bicicletta sui sentieri che si accostavano alle frontiere in cerca di bunker e trincee. De Rossi, un bravo generale, racconta delle sue gite da autarchlca spia in Francia e in Austria (si avevano ancora idee un po' confuse su chi fosse il nemico), a controllare, cronometro in mano, gli orari dei treni che portavano verso il confine italiano. Sono gli anni in cui gli stati maggiori hanno l'ossessione dei tempi della mobilitazione, si ritiene che un treno in orario possa fare più che le astuzie di un Annibale e un capostazione inefficiente può costare la vita a un'armata. Ebbene Roatta ha il compito di trasformare quell'ufficetto in una congrega di rinomati criminali, diffondere la pratica del bastone del pugnale e del ricatto assassino anche al felpato mondo degli spioni. Ci riesce, diamogli atto, benissimo. Sono i suoi agenti a eliminare per conto di Mussolini il fastidio dei Rosselli e a seminare mezza Europa di delitti intimidazioni provocazioni. Non ha mai comandato un reggimento e lo spediscono a dirigere con un nome falso (usa quello della moglie, che sublime fantasia) come un ladro, greche di qua greche di là, le legioni di finti volontari che puntellano in Spagna la crociata contro il bolscevismo. Lì i metodi da camorra non bastano; persino Franco lo prende in uggia e lui si fa bastonare a Guadalajara dalle stracciate brigate internazionali. Carriera finita ? Niente affatto, Non ha nuociuto a sufficienza alle sorti patrie. Diventa ascaro, si fa per dire, di Vittorio Ambrosia, capo di stato maggiore dell'esercito; in Sicilia nel 1943 provvede a sabot are gli sforzi dei suoi soldati ordinando ritirate e distruzioni di depositi come nemmeno gli ing lesi più diabolici avrebbero immaginato. Ci mancherebbe, lasciatelo lavorare diamine! È un congiurato, prepara il tradimento. L'8 settembre, in borghese, si conquista, tenendo in spalla una mitragliatrice, come un guerrigliero di Pancho Villa,
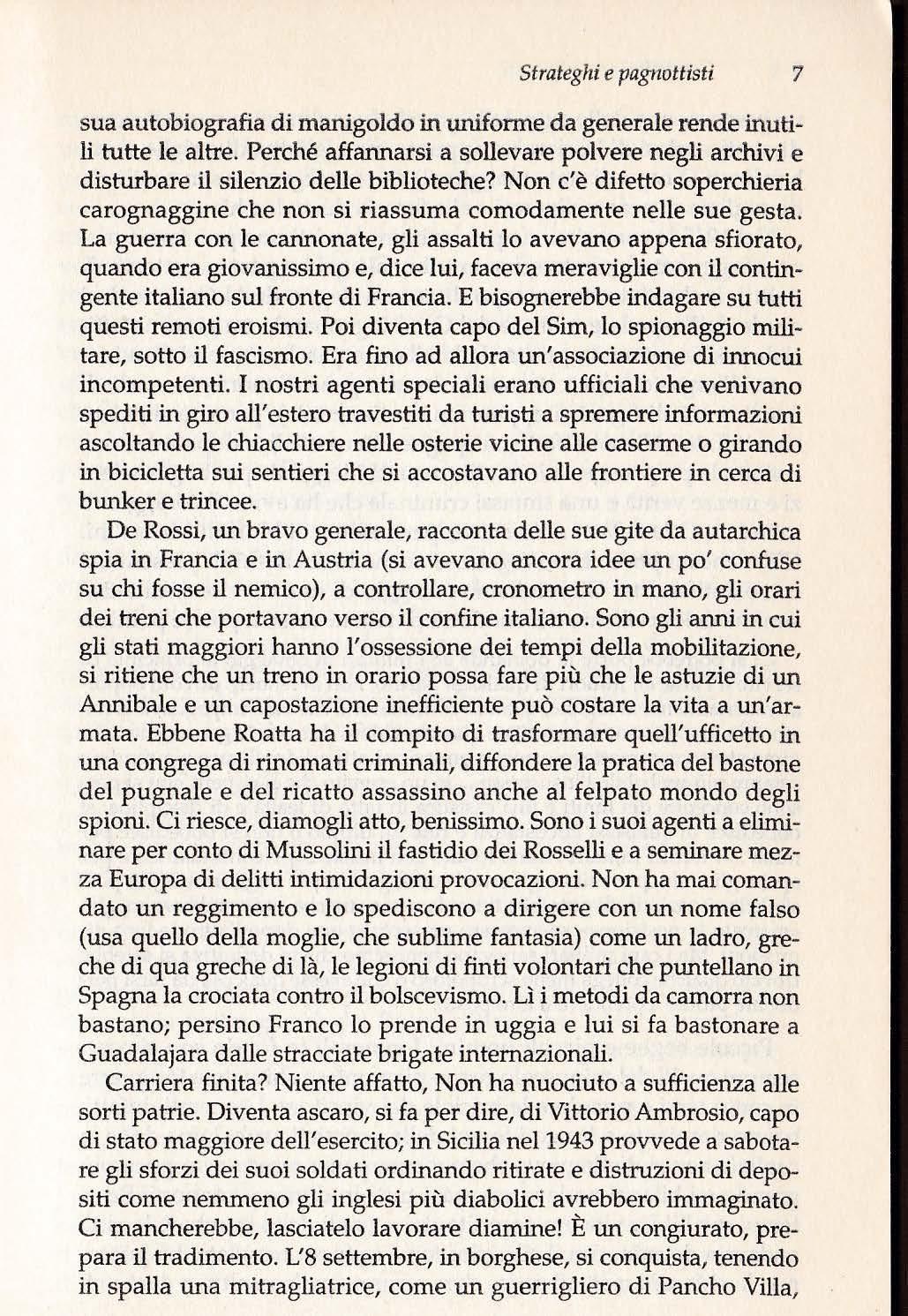
un posto su una delle auto della grande fuga dinastica verso Pescara dimenticandosi di lasciare un appunto, un biglietto, due righe ai subordinati (è capo di stato maggiore!) che consegna - e son centinaia di migliaia di persone inermi - alla ferocia dei tedeschi.
Nel 1945 la commissione per i crimini fascisti non può fare a meno di agguantarlo, lo trascina in tribunale gobbo per una caterva di delitti, inchiodato da un capo di accusa degno di Al Capone. Lui evade dall'ospedale militare del Celio ingannando un giovane ufficiale cosl ingenuo da prestar fede alla sua parola d'onore! Condannato all'ergastolo (peccato non ci fosse la pena di morte, Beccaria di fronte a simili figuri ci appare un sentimentale), pensate sia stato riacciuffato? Niente affatto: si spegne libero e felice dopo aver raccontato le proprie gesta in un libro quasi illeggibile per bugie, silenzi e mezze verità e una sintassi criminale che ha avuto il coraggio di intitolare Otto milioni di baionette, per irridere ai bluff di Mussolini. C'è mancato poco che ci regalasse anche lo sberleffo di presentarsi come antifascista! Gli rendiamo omaggio di una citazione, sintetica summa del servilismo dei condottieri italiani verso il potere politico:
Ci si potrebbe porre In domanda se i militari in omaggio al principio di servire il Paese all'infuori di qualsiasi partito, non avrebbero dovuto opporsi materialmente al regime, quando constatarono che esso impegnava la nazione in una guerra non sentita e quando videro durante la guerra che il regime stesso commetteva errori e omissioni atti ad accelerare e a rendere sempre più probabile l' insuccesso ... in un esercito che si rispetti non si possono concepire dei limiti e una casistica in fatto di lealtà e di disciplina: si obbedisce in qualsiasi circostanza e fino all'ultimo o non si obbed isce per nulla ... i tecnici militari hanno lottato con insistenza e continuamente per aprire gli occhi, per evitare gli errori contingenti e per migliorare il più possibile la situazione. Si potrebbe tuttavia osservare che essi avrebbero meg lio «marcato la posizione)) se avessero presentato uno dopo l' altro le l oro dimissioni. Ma i capi militari sapevano benissimo che in definitiva si sarebbe trovato qualche collega meno scrupoloso o che avesse qualcosa da farsi perdonare pronto a prendere il loro posto.
Piccole beghe e piccoli uomini. I generali in fondo son rimasti sempre quelli del minuscolo regno piemontese abituato a far guerre in conto terzi e prendere le briciole dal v incitore. I generali, infatti, hanno rimpianto a lungo i tempi della prussietta subalpina dove la capitale non si distingueva che per essere una caserma un poco più grande e i bilanci andavano quasi tutti in divise e cannoni. Beati tempi quelli! La vita era scandita dai segnali della tromba e la città andava a dormire con il silenzio, come se fosse arruolata. La guerra non la si faceva mru sul serio, e'e r a sempre qualcun altro a dare una

e pagnottisti
mano, e così non c' era bisogno di studiare aggiornarsi preparare gli uomini e le armi. Un bluff militare secolare ben oliato e noto a protagonisti e comprimari. Fino a Mussolini, che conosceva la lana dei suoi condottieri e aveva trasformato il colpo gobbo, la minaccia parolaia, l'approssimazione giornalistica in politica estera e militare. Ci volle l'energia spietata di un Cadorna, un Torquemada del militarismo, perché riuscissimo ad affrontare con un esercito degno di questo nome la prima guerra mondiale . Vent'anni dopo avrebbero dov uto, secondo i piani, provvedere i tedeschi. I generali, infatti, si offesero e cominciarono a incolpare Mussolini quando si accorsero che la situazione imponeva che la guerra la combattessimo anche noi. Ma come? Che pretese, noi eravamo già prontissimi, ma per la parata della vittoria. E, infuriati per lo sgarbo, lo fecero cadere dopo averlo incensato per vent'anni.
I generali hanno costituito la categoria che forse ha recato più danni nelle vicende di questo paese. Eppure non esiste una storia complessiva dei loro comportamenti, dei meccanismi con cui venivano selezionati, dell'ideologia che li muoveva. Sono state pennelleggia te con furore da menade le magagne dei politici, dei preti, degli insegnanti e dei filosofi, ma i generali niente, sempre al riparo nel loro cantuccio di professionisti naturalmente imparziali. Certo, sono uscite biografie anche recenti di singoli generali soprattutto dell'epoca del regime, qualcuna persino vagamente assolutoria che si è dannata l'anima a dimostrare come dopotutto anche loro cospirassero, anzi a dir meglio mugugnassero, contro il regime, ma non si poteva in fondo fare di più. Eh già, c'era il re che taceva: e come potevano i generali non obbedire al loro re? Seppure in termini numericamente ridotti i generali hanno costituito marxianarnente un ceto. Nel senso che si riconoscevano come espressione di un'unica «cultura», ben separata dalle miserie e dalle gozzaniane aspirazioni di borghesia e proletariato. Alla dichiaraz ione della prima guerra del Regno d'Italia, nel 1866, i generali di a rmata erano quattro per centomila uomini; negli anni Trenta per cercare, difficile impresa, di raddrizzare la schiena dell'Italia sempre proletaria ma anche fascista erano lo sciupio di seicento. Non bastavano. Questa identità così d ispettosa si era formata progressivamente annacquando i vecchi strati nobiliari, che avevano monopolizzato i posti chiave dell'esercito ancora nel periodo immediatamente successivo a l Risorgimento, con l'innesto prima tumultuoso dei detestati garibaldini, poi, con dosaggio alchimistico, grazie alle Accademie di Modena e Livorno fondate a questo scopo, della media e piccola

borghesia postunitaria. Le nuove reclute unirono alla vecchia boria la meschina avidità degli arrivati, ansiosi di mimetizzarsi tra coloro che li avevano preceduti.
I Badoglio Graziani Capello, un d emi-monde, si atteggiano a superuomini, iperbolizzano se stessi e la propria missione militare p e rché avvertono lo scetticismo ironico di chi n e intravede dietro le maschere la piccolezza d ei crani, la modestia delle idee. I tempi in cui si rischiava la pallottola risolutrice sono passati; adesso si fa lo stratega al calduccio dei comandi, si corre un solo pericolo: di essere scavalcati da qualche concorrente più filisteo nel rondò d elle promozioni per meriti sempre naturalmente «ecceziona li». Questi la guerra non la fanno, vi assistono.
Monolitici verso l'esterno, i generali si agitano all'interno del loro mondo come un mucchio di lucertole. Sono divisi, si odiano, costruiscono partiti e camarille, scelgono capi per conquistare il comando di una divisione, l'appalto delle carrette per i cannoni, un seggio senatoriale che non si nega quasi a nessuno. Si comincia con piemontesi contro napoletani . Parola, la prima, usata un po' alla larga: i piemontesi sono quelli arrivati da tutti gli Stati che il Piemonte ha ingoiato con cannonate e plebisciti . Conflitto complicato che dura forse quarant'anni. Poi segue la g u e rra con i garibaldini: mischia breve, le camicie rosse che bramano la legittimazione savoiarda non sono un fronte unico, sono ingoiati come i barbari nell'Impero romano. Infine incrociano le spade i «caporettisti » contro «qu elli di Vittorio Veneto». Quando il 10 giugno 1940 scendiamo in campo contro le d emoplutocrazie dell'Occidente i badogliani non hanno tempo per distrarsi perché fioccano le manganellate delle milizie di Graziani e dei pretoriani di Cavallero.
E sono scontri risse guerriglie. Le stra tegie, i mode lli di armata, i tipi di cannone sono scuse. Si battaglia per cose concretissime, come la gestione dei bilanci del ministero della Gu erra (non si ritenevano in questo campo ancora necessarie ipocrisie semantiche). Sono belle sommette perché v u ol dire, in tempi normali, quando non rullano i tamburi, il venti per cento delle entrate dello Stato. Facciamo dei numeri: n e l pacioso 1885 in cui tutto il mondo ci sorrideva sono duecentocinqu anta milioni di lire d i cui cinquanta, uno sproposito, di suggesti ve spese straordinarie!
E poi che grigiori questi baldi guerrieri. Daremmo un tesoro per incrociare la biografia di un Boulanger italiano, uno capace di morire di crepacuore, dopo aver sfiorato il trono, sdraia to s ulla tomba della bellissima amante. Ci accontenteremmo p e rsino di un Conrad,

e pagnottisti
l'arcinemico austriaco, che nelle pause dell'impegno diuturno per annientarci trovò il tempo di rischiare la carriera per contendere al marito, e con successo, una nobildonna triestina dalla bocca sanguigna. Niente. I nostri hanno biografie da mezze mruùche, tutti casa e ufficio, qualche palpito ce lo regala solo Bixio, ostinato frequentatore di bordelli ma che crepa sussurrando il nome della famiglia dilettissima come nei santini di don Bosco. Ci siamo avventurati, speranzosi, nella biblioteca di qualche generale dei tempi in cui eravamo una grande potenza . Molti classici della guerra, molto Napoleone, molto Clausewitz (per lo più intonsi, ahimè) e poi un po' di Carducci: non quello tribunizio e satanesco, ma quello dei tempi in cu.i faceva lo strillone della monarchia; d'Annunzio certo, Guido da Verona, romanzetti. Null'altro. Sfogliando i memoria li, i ricordi, i best seller di vittorie, sempre molto rare, con le firme di Della Rocca, Persano, La Marmora, Baratieri, Graziruù, Badoglio, si resta esterrefatti per la sintassi da rapporto poliziesco, il periodare che lampeggia di culture mediocri, di letture casermesche, le prose molli modeste umili nauseose. Non a caso nell'ese rcito italiano c'erano generali che sbattevano in fondo ai ruoli di merito gli ufficiali che sorprendevano con un libro in mano. Erano sempre profeti dell'accaduto, maniaci del presentimento . L'unico generale italiano che ha portato un contributo citabile alla scienza militare, Dohuet (ne maledicono il nome ancor oggi due tirannacci come il serbo Milose vié e l' iracheno Saddam che hanno avuto i regimi santamente schiantati dai bombardamenti a tappeto, previsti con intuito da profeta da quell'italiano, così poco rimunerato dai suoi connaz ionali), ebbe fama di bislacco e finl in fortezza! Per il resto si campava di quattro vecchie idee imbandite con la prosopope a di Aristotele; come tutti i mediocri si teneva conto dell'esperienza in modo arbitrario, si confondevano gli effetti con le cause.
Sono stati scritti dotti libri sulle dottrine strategiche dell' esercito italiano. Vogliamo fare gli iconoclasti. Dateci retta: ci sembra tempo prezioso sprecato, bastano due righe. Tracciamo un solco. Fino al 1896, la data infausta di Adua, tutto ruota intorno all'idea copernicana che bisogna attaccare a ogni costo e che le baionette fanno miracoli. Dopo la batosta i generali fanno dietrofront: scusate, ci siamo sbagliati , è la difesa la tattica che più si adatta alle caratteristiche antropologiche della razza guerriera italica, generosa, paziente come un mulo, ma che manca di quello che i latinisti chiamano il furore gallico. Salvo la parentesi di Cadoma - che infatti è un isolato, uno
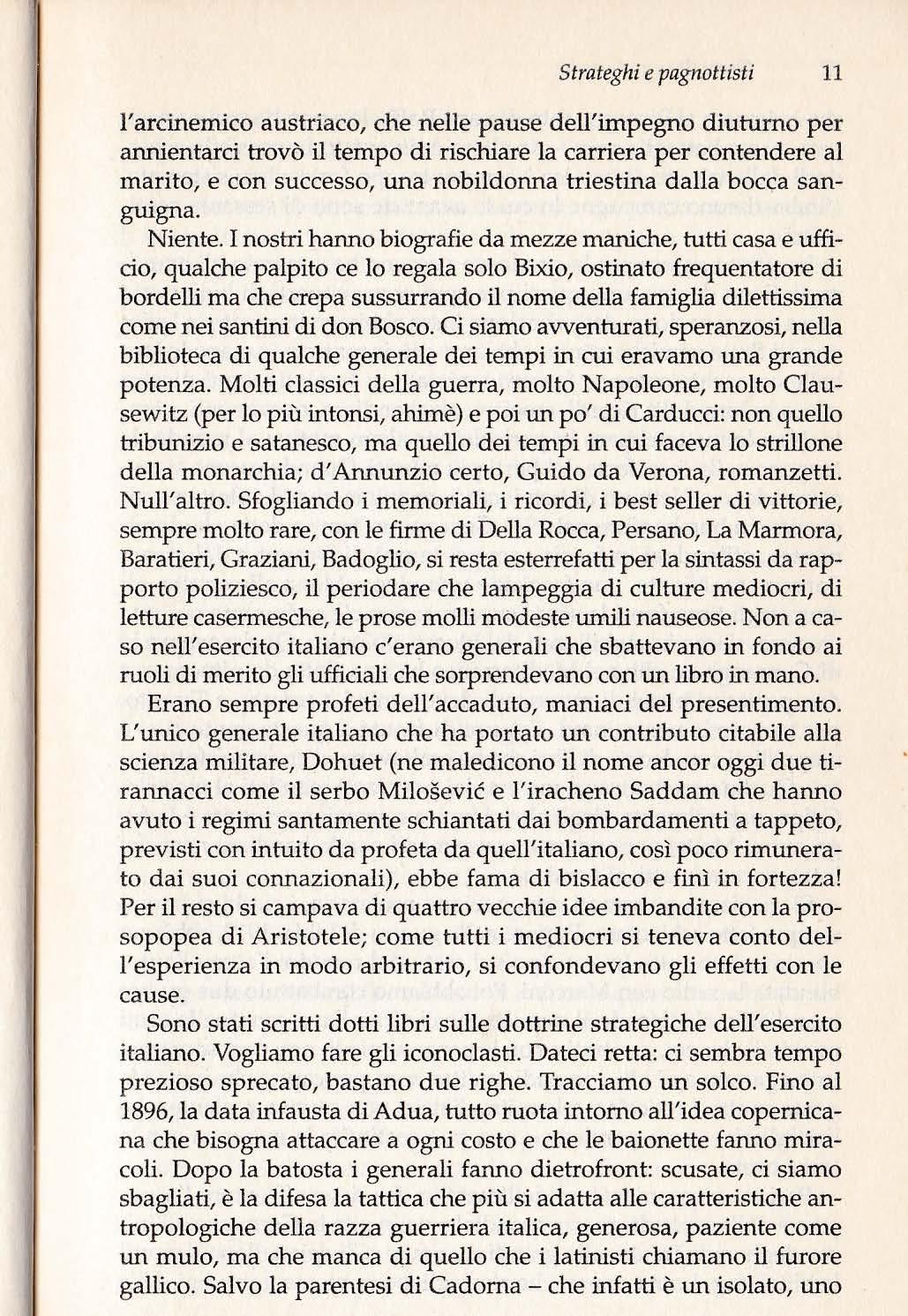
che è rimasto al Risorgimento di papà Raffaele e non ha mai partecipato a una battaglia vera - da allora è diventato impossibile schiodarli dalle trincee, il n emico è sempre troppo forte e ben sistemato, s'imbastiscono campagne in cui le avanzate sono di sessanta centimetri.
In questo amore per la prudenza nessuno ha superato gli ammiragli. Sono decine, uno quasi per ogni nave, coperti di bigiotteria presa non si sa dove, dato che dopo Lissa abbiamo imparato la lezione e di flotte nemiche non ne abb iamo più incontrate. Amano le loro belle corazzate come se fossero i cristalli di famiglia, ogni piastra evoca in loro dolci ricordi, crociere, alzabandiera, ricevimenti, parate . Non le metterebbero in pericolo per alcun motivo al mondo, le tengono nella cassaforte dei porti più muniti. Quando escono si raccomandano a Nettuno di non incrociare anima viva . La flotta nemica viene a bombardare nel 1941 Genova, un tempo detta «la dominante», sfilandoci in faccia come ai tempi di Dragut e del pirata Barbarossa. Niente, non facciamo una piega. Messi alle strette, gli ammiragli tiran fuori la scusa suprema: non c'è carburante per una crociera, siamo immobilizzati dal blocco albionico. Quel poveraccio di Cunningham che nel Mediterraneo ha una flotta da pitocco con due portaerei piene di rammendi deve venirci a cercare, a Taranto, per trovare le nostre navi. Eppure di fronte a questa gente ci si è scappellati con decine di libri che ne esaltavano «l 'eroismo sfortunato». Quello non mancava, ma era dei poveracci mandati al macello. Colpa, naturalmente, degli altri. L'unica operazione riuscita è la fuga, verso Malta, per andare a consegnarci con la bandie ra nera del lutto, ancora intatti, al nemico.
Si sa: siamo poveracci, una nazione proletaria, i ricchi ci hanno sempre fatto schiantare. Eppure nella guerra di Libia, 1912, abbiamo sperimentato tutto in anticipo sul resto del mondo: l'aereo l'autoblindata la radio con Marconi. Poi abbiamo combattuto due guerre mondiali maledicendo il nemico che ci sfracellava con quelle armi micidiali che noi, arretrati e con le pezze ai piedi, non conoscevamo. Impiegarono agli alti comandi quattro anni per capire che gettar la gente contro i reticolati e le mitragliatrici non serviva a niente, che l'artiglieria - gran parolone - non può sostituire la manovra con la forza bruta.
Pariani, riorganizzatore dell'esercito che deve affrontare l'aspra prova della seconda guerra mondiale, va in gita in Germania all'inizio degli anni Trenta, alle grandi manovre. Gli spiattellano davanti la blitzkrieg, i carri armati che sferragliano in massa, i prodigi delle

comunicazioni via radio che consentono di manovrare al centimetro su spazi giganteschi, gli romba in testa la Luftwaffe che apre la strada arando con le bombe il cammino dei carri d'assalto. Immaginatevelo: tronfio, il binocolo in mano, un sorrisetto scettico sotto i baffi, la faccia di chi ne ha viste di tutti i colori. Lui torna in Italia e ti sciorina «la guerra di rapido corso» fatta con «piccole masse» (l'espressione è sua) di carri armati da tre tonnellate, quelli che non fanno paura neppure ai guerrieri del negus d'Etiopia.
La fortuna dell'aeronautica è di esser finita nelle mani di ungerarca, Italo Balbo, che era capitano di complemento (lo fecero maresciallo, alla fascista), che aveva un talentaccio per l'innovazione e la modernità, raro nelle cabale di Palazro, che straparlava di ruralità e cercava di mettere i piedi sulle orme di Roma antica. Se fosse dipeso da certi generali, nel 1918 l'avrebbero abolita l'aviazione, perché faceva concorrenza e aspirava a essere autonoma. Comunque l 'idea di coordinare l'attività militare non venne mai messa in pratica: fa te la guerra vostra e non pestatemi i piedi!
Il problema non è: perché i generali italiani erano così mediocri? È: perché lo erano tutti? Gli incapaci li incontri in ogni esercito. I francesi hanno affidato milioni di uomini a macellai ottusi come Nivelle e ai capitolardi della seconda guerra mondiale che sciuparono il miglior esercito del mondo. Gli inglesi furono messi in fuga dalle zagaglie degli zulu e dai pastori afgani armati di catenacci e di antiche ferocie. A Gallipoli si fermarono ad ammirare le evoluzioni dei fantaccini turchi con la divisa a pezzi e capitolarono a Singapore facendosi prendere alle spalle da un'armata in bicicletta. I tedeschi hanno consumato generazioni nelle pianure d'Europa per accorgersi che per vincere non bastava una sbrigliata fantasia tattica e la fama di eredi di Arrn.inio. Per non parlare degli americani che sono ancora oggi, dopo la conclamata fine della Storia, alle prese con un rompicapo per loro inestricabile: come si fa a vincere quando n on basta rovesciare sull'avversario i rendiconti della superiorità di mezzi e materiale?
Ma erano eccezioni, storture che venivano rapidamente corrette, emarginate, sostituite. Da noi, invece, un secolo con molte canaglie molti scrite riati molti arroganti e soprattutto molti mediocri. Le guerre, si dice, cominciano sempre in tempo di pace. E questo paese sembra essere stato incapace, liberale o fascista, crispino o giolittiano, di esprimere in uno dei punti strategici dell'attività dello Stato - la sua difesa - un ceto all'altezza delle necessità. Anzi: ha provveduto, essendone consapevole, a perpetuare una selezione al contra-
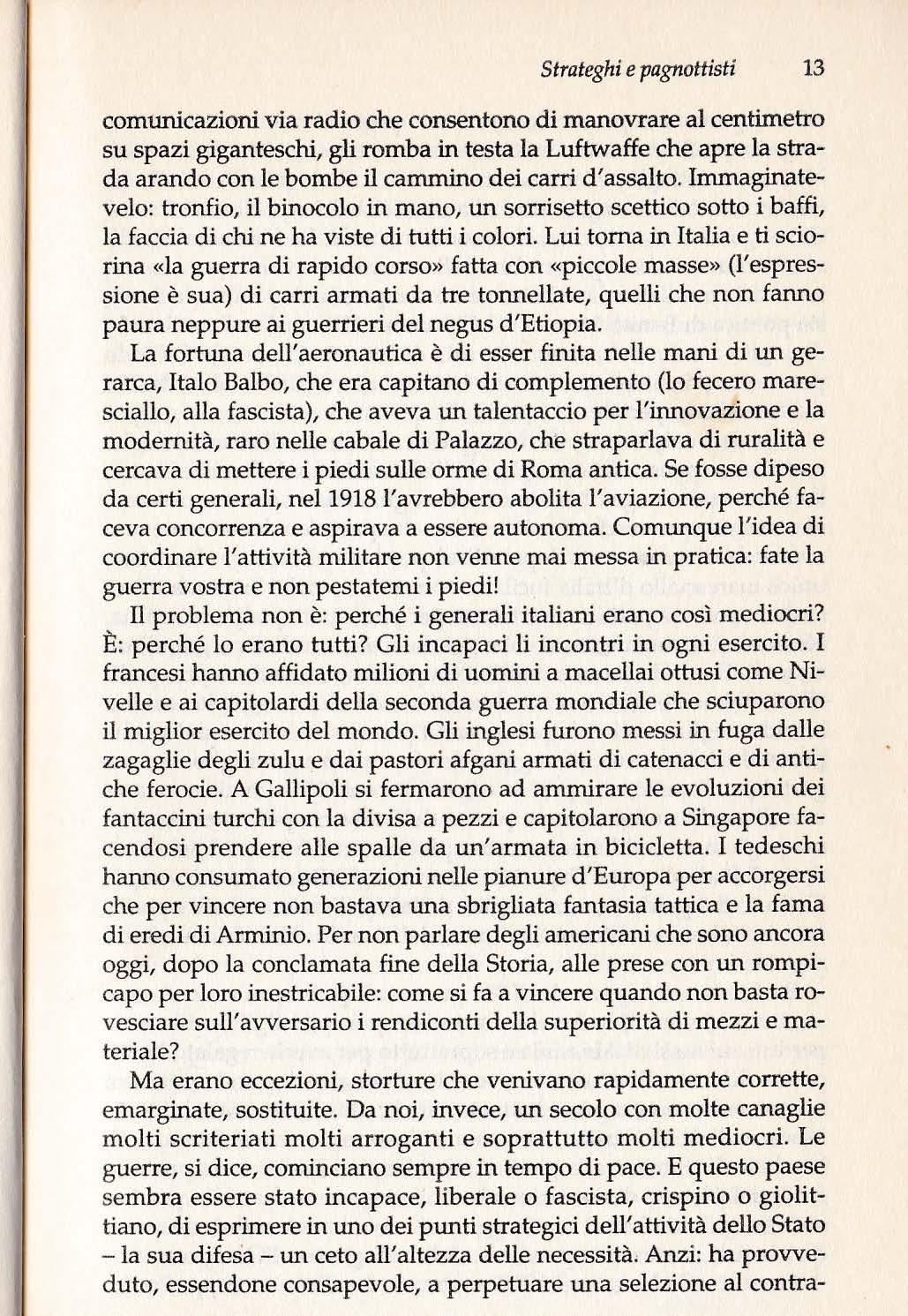
rio che portava ai posti chiave, dove si potevan fare terribili danni, proprio quelli che erano evidentemente meno meritevoli e capaci . Non sono dettagli per militaristi fanatici. Il Risorgimento: chi lo ha lasciato a metà consegnandoci alla necessità del macello del Carso? Ci vengono in mente, così alla buona, tre nomi: La Marmara Cialdini e Persano, che sciuparono una bella occasione a Custoza e Lissa. E la vittoria mutilata su cui ha lavorato con personale profitto la fantasia politica di Benito Mussolini? Chiedete a Diaz e al suo caudatario Badoglio a cui non bastarono le urla di Vittorio Emanuele Orlando per mettere insieme qualche divisione e correr dietro al fantasma dell'esercito imperiale.
Due dati colpiscono. In tutta questa via crucis di disastri fughe inefficienze penseresti che i plotoni di esecuzione e le forche abbiano lavorato come negri. Niente affatto. I giustiziati sono un polacco, mercenario sprovveduto, e Ramorino che pagò (evidentemente non aveva abbastanza santi in paradiso) per la fatai Novara. De Bono, unico maresciallo d'Italia fucilato, non conta, perché lo ammazzarono per vendetta politica e certo non per punirlo di qualche sconfitta. Nessuno dei vinti nostrani ebbe poi dalla sua condiz ione grandi incomodi. Forse Persano, cui tolsero la pensione, e sembrò provvedimento talmente mostruoso e draconiano da restare scolpito con un brivido negli annali e da provocare il pietoso intervento del re che p rovvide di tasca sua a foraggiare lo sfortunato ammiraglio. Finì ergastolano Capello, che pure si era esibito nel '22 in camicia nera in una di quelle sudamericane parate della Marcia p er antonomasia: ma pagò caro un dilettantesco complotto contro Mussolini e le vendette di Badoglio, non Caporetto. Quanto agli altri, funzionò semp re l'istituto del perdono, anzi meglio, della riabilitazione che li riportava trionfalmente all'onor (militare) del mondo. Noi italiani siamo pietosissimi.
Baratieri : nel marzo del 1896 una nazione intera , se lo avesse stretto tra le mani, lo avrebbe stritolato per quei figli inutilmente perduti sui sassi di Abissinia e sopra ttutto per averle regalato l 'antipatica dimostrazione di non avere le stimmate di grande potenza. Lo processarono a tambur battente, con i cadaveri ancora caldi sotto le acacie di Abba Garima, come non volessero concedere il tempo a lla rabbia di sfumare, alla pietà d'imbaldanzirsi. La forca era pronta, i fucili del plotone di esecuzione ben oliati: se ne uscì assolto per trascorrere gli ultimi anni a passeggio s ui s uoi monti trentini, chiamando in causa come corresponsabile d ella «disgrazia» l'Onnipotente.
Prendete Cadoma: nel 1918 sembrava dovessero accopparlo. Lo

avevan trasferito a Parigi si direbbe per sottrarlo al linciaggio dei «santi maledetti», giravano commissioni d'inchlesta feroci come turchl. Finì in niente. Mussolini-che era rimasto, come diceva lui, sempre il numero di piastrina 12467 - cancellò tutto e lo dichlarò, esagerato!, maresciallo d'Italia. A Verbania, la sua città, sudarono sangue per regalargli il conforto di una villa. Chiuse gli occhl pronunciando parole marmoree sugli immancabili destini della nazione finalmente restituita alla disciplina piemontese dal mascelluto ex sergente dei suoi bersaglieri . E Graziani? Sfuggito ai distributori di piazzale Loreto per un caso e alla giu stizia sbrigativa dei partigiani per l'unica manovra riuscita dell'esercito di Salò, sembrava il tipo ideale per un processo alle vigliaccherie militari, alle ferocie della guerra civile, al regime, al colonialismo, a tutto. Ha concluso la sua lunga storia come deputato dell a repubblica democratica e antifascista. E, dicono, stringendo l a mano in un comizio galeotto a uno dei padri putativi della rep ubblica, Giulio Andreotti. Giudici e politici, quando si tratta di generali sembrano prendere l 'evangelica pazienza dei confessori che demandano ogni punizione al superiore e futuro giudizio dell'Onnipotente e sanno come troppo spesso ci sfugga, nell a nostra umana modestia, il vero taglio delle cose e degli uomini. C'è dell'altro. In Italia, nonostante lo scorrere impetuoso dei regimi, è stato portato a conclusione un solo colpo di stato: quello del carognesco Badoglio, il 25 luglio. Ma era un golpe a metà, fuori ordinanza, che fa inarcare le sopracciglia ai puristi sudamericani. Perché il maresciallo si era mosso soltanto con tanto di ordine su carta bollata del re, supremo e ultimo depositario del potere come era scritto non proprio a chiare lettere sulla Magna Charta albertina. Di tintinnar di sciabole, di progetti, di discussioni, di caserme inquiete si è parlato, è vero, da quando l 'Italia si è proclamata una, fino ai tempi della prima repubblica e dei golpe naturalmente «bianchl». I militari, si sussurrava, erano stufi delle magagne dei politici, il paese andava a rotoli, era l'ora di rimettere le cose a posto: chiacchlere che circolavano, pensate un po', nella Firenze di La Marmora e di Giovanni Pascoli. Si temevano maggiormente, in tempi più recenti, le intemperanze dei colonnelli alla moda greca e sudamericana che quelle dei generali, pasciuti e soddisfatti dello stato delle cose. Su queste angosce, che non andavano oltre i bisbigli da salotto o da giornale, ha sudato e strepitato la sinistra fino all'altro ieri; perché non si è in fondo mai schlodata dalla retorica delle barrica te, dei patiboli di Thiers, il boia della Comune, e dei feuilleton del-

la biblioteca popolare Sonzogno in ari il generale è una belva assetata di sangue in servizio permanente e quando non trova nemici al1'esterno se li va a stanare nelle vie delle città.
Diamogliene atto: i generali italiani son sempre stati fedelissimi. Ben trincerati dietro lo slogan: l'esercito non si mischia con la politica perché in questo caso sarebbe minato dalle beghe e dalle ideologie.
In realtà questo lodevole agnosticismo puzza di copertura; i nostri generali si sentivano, per privilegi e considerazione, una scaglia di granito nel monumento della classe dirigente. E questa posizione dovevano difendere indipendentemente dalla forma tecnica che i padroni del vapore decidevano di adottare per tenere a galla il periclitante paese. Altro che storie, altro che adorazione per il monarca simbolo dell'Unità, antologia della Memoria civica . Lo avrebbero gettato a mare se necessario quello scorbutico numismatico che non ha certo lasciato solchi nella Storia. Nell'analisi di questa strategia di confortevole sopravvivenza ai vertici ci mettevano un'acutezza insospettabile. Si accorsero, per esempio, che la sinistra sulfurea che aveva sbalzato dai seggi governativi la destra storica protagonista del Risorgimento non aveva umori rivoluzionari o palingenetici, che Depretis era, se possibile, più malleabile e prudente di Ricasoli o di Quintino Sella il taccagno.
Con il fascismo furono per un poco prudenti, poi videro che quel Mussolini - che in gioventù sbraitava contro gli assassini in uniforme, voleva lasciare la Libia ai beduini e definiva il re «il più inutile dei cittadini» - non vedeva l'ora di accomodarsi negli scranni del vecchio Stato sabaudo. E il 28 ottobre, giudiziosamente per loro, non spararono. Leggete la biografia di Badoglio. Forse era distratto nel 1922, pensò che Vittorio Emanuele si sarebbe sbarazzato di quello sbraitante Mussolini e rilasciò dichiarazioni imprudenti: «Con quattro fucilate l'esercito delle camicie nere si disperderà», candidandosi già alle medaglie della repressione. Sgomento, stralunato si accorse che il rivoluzionario da osteria era andato, in frac, a stringere la mano del re al Quirinale ed era diventato onnipotente. Con una rapida virata il braccio armato della democrazia liberale divenne il gestore obbedientissimo della dittatura nelle caserme.
Certo non dicono bugie i generali quando s'iscrivono alla schiera biblica degli apolitici, ovvero nessuno versa l'obolo al partito crispino o giolittiano o infila nel portafoglio la tessera fascista (salvo che non sia ad honorem) . Fatica sprecata: i politici li avevano assunti e li ripagavano così bene da non avere la necessità di manifestare particolari entusiasmi. Restavano apolitici i soldati del re come ai tempi
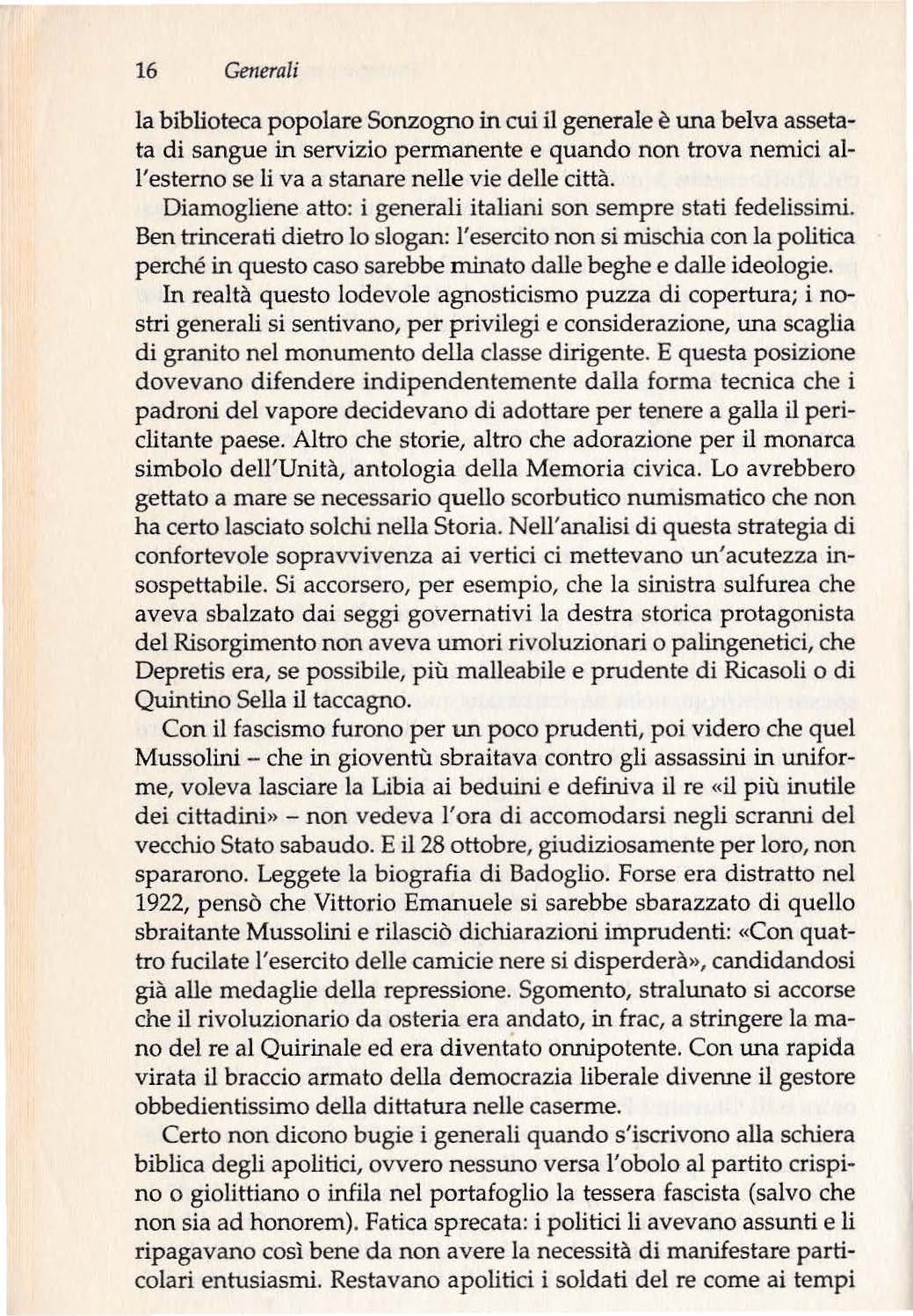
e pagnottisti
in cui la grazia di Dio non aveva dovuto rincantucciarsi per far posto anche alla volontà della nazione. Per questa utilissima finzione i generali rinunciarono sempre alla carica di comandante supremo e si accontentarono; persino Cadorna, che strinse in pugno un potere che mai nessuno ha avuto nella storia d'Italia, accettò di essere il capo di stato maggiore del sovrano. La finzione la spezzò quel guastafeste di Mussolini che si inventò la carica comica di primo maresciallo dell'impero e si tirò dietro la vendetta assassina di casa Savoia. Scorrete i nomi dei primi ministri da quando re Vittorio mise piede al Quirinale mormorando: «Finalmente ci siamo!». Sembra di essere in America Latina, i gallonati dilagano, è un continuo scambiare palandrana militare e stiffelius: La Marmora Menabrea Pelloux. Seguono in carovana lunghe file di ministri deputati senatori che impinguano le schiere dei governanti, trasformano il Parlamento in un'adunata di reduci. li baratto funzionava così. In cambio di una fedeltà gesuitica il potere politico offriva l'assoluta libertà di rimes tare nell ' organizzazione interna dell' esercito, che infatti fu sempre mostruoso, sproporzionato rispetto alle necessità e alle possibilità del paese. Gli otto milioni di baionette non le ha inventate Mussolini: erano il Corano di tutti i ministri della Guerra. L'esercito «di caserma», numerosissimo di reclute flosce e pitocco nei magazzini e nelle armerie, serviv a a moltiplicare divisioni e armate: tutte poltrone in più per i generali e una sbirraglia a basso costo per tenere sotto controllo le bizze del paese . Quando c' era da scendere in piazza per s mussare a cannonate le velleità delle plebi che chiedevano pane o riforme, i generali senza colonna vertebrale non avevano certo paura di sporcarsi le mani . Nel 1943 si misero sulle pedate del monarca e scuoiarono in cinque minuti Mussolini, non perché avevano nos talgia dell'Italia liberale che andava a votare ma perché si offriva loro una scorciatoia per salvare la faccia e conservare i privilegi azz erando la sconfitta. Loro, così pietosi quando si trattava di giudicare le re ciproche magagne, sapevano essere spicci . Badoglio raccomandò al comandante dei carabinieri Angelo Cerica, un tenebroso ca gliostro della Benemerita, di «far sparire» Mussolini: a Cerica mancò solo il tempo per obbedire. Spesso i generali e il loro esercito non parlano nemmeno la stessa lingua: ancora nel fango della prima guerra mondiale, per fraternizzare con certe divisioni siciliane o del Sud, i generali nelle loro (brevi) ispezioni dovevano utilizzare l' interprete, come nel Tigrai o in Somalia. I proclami alle truppe sono documenti sconce rtanti. Stendhal s p ergiurava di aver imparato lo stile leggendo le tirate di Napo leone.
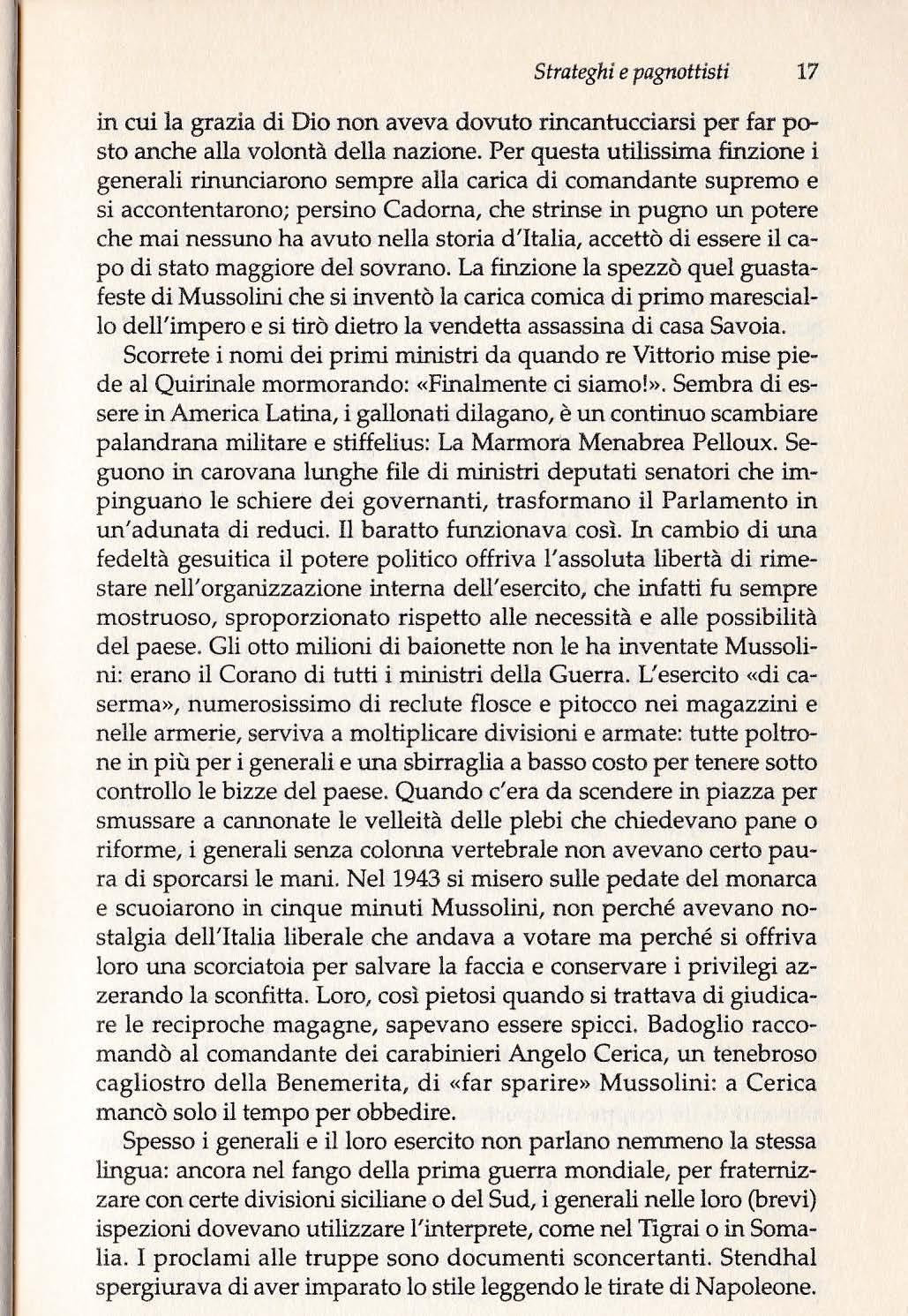
Qui non ci siamo: i n ostri attingono a una sottocultura classicheggiante, a un lessico che nessun fantaccino di Cialdini o di Diaz decifrava, i periodi e ran così lunghi che facevano venire l'asma. A quei contadini analfabeti rifilavano un campionario cattedratico risoluto, asfi ttico di paroloni come onore g loria dovere. I generali italiani vivono lontani dai soldati, anzi sembra che li evitino, ne abbiano istintivamente ripugnanza. Non appena gli eserciti si fanno giganteschi i quartieri generali arretrano, sbandierano la necessità, accolta con vero entusiasmo, che il capo non può affrontare il rischio di essere ucciso o ca tturato come un pedone qualsiasi. La geografia generalesca della prima guerra mondiale è un itinerario d ' arte: tutte le tappe dell'avventura architettonica palladiana vengono percorse, le ville e i manieri delle grandi famiglie venete non sfuggono alla requisizione dotta e patriottica, si tappezzano di targhe e lapidi che ricordano come in quei saloni, sotto le volte pennellate da artisti sublimi, si infervorò anche il genio militare di tizio e di caio. Durante la maramaldesca offensiva contro la Francia, ai tempi ancora beati d e lla guerra parallela, i comandi s tanno acquattati a chilometri dal fronte: il principe Umberto che guida un gruppo di armate senza capirne nulla è in v illa, a Pocapaglia, Graziani ha parcheggiato il treno comando su un binario morto nella stazione di Bra; sono zone di bolliti e di arrosti, ci si scambia visite, si degus tano vini che balzano fuori da cantine fornitissime. Insomma, non ci si annoia in attesa dell'inev itabile trionfo dei bollettini. In Etiopia, nel 1935, il genio non strappa solo grida di meraviglia per la perizia con cui fa sorgere dal nulla s tra de davvero romane : a De Bono costruiscono un posto comando con comod ità di doccia e water al centro dell' Africa dove son rimasti ai tempi di Salomone e della regina di Saba. Graziani in Libia, a Cirene, siamo n el 1940, per poter pensare in santa pace a come battere gli ingl esi, scende nelle frescure di un'antica tomba romana che ha fatto attrezzare con gusto architettonico e precauzioni modernistiche a bunker, capace di resistere all'urto di una bomba di aereo. Viene un sorriso a pensare a Rommel che voltegg iava con un aeroplanetto s ul campo di battaglia per decifrare i movimenti delle truppe o coperto d i polve re come un cammelliere sfrecciava s u un b lindato attrezzato a carro comando e prendeva animosamente la testa deg li assalti .
I generali non s i nutrono certo con il cibo dei soldati . I generali s tranieri in visita res tano ab bagliati, nel 1915 come nel 1940, dalla magnificenza rinascimentale delle nostre mense: cibi e vini son preparati e serviti come in un albergo da nababbi, le ispez ioni al fronte
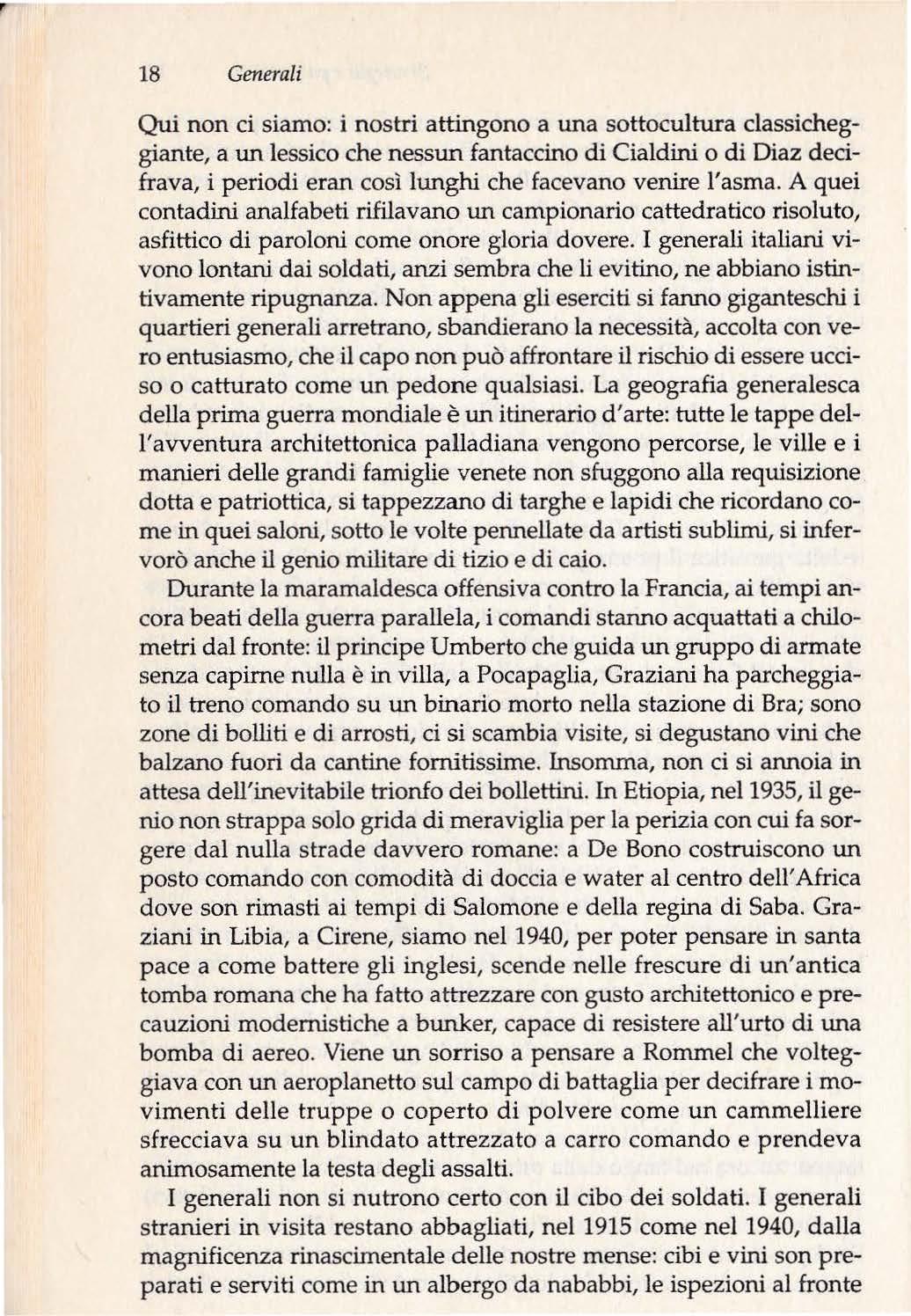
e pagnottisli
italiano sono tour gastronomici. Ah questi italiani! Della Rocca, la canaglia di Custoza, si imbosca, visto che non c'è di meglio, in una osteria di Villa franca e passa le ore in letizia sotto l'ombra fresca di una pergola. De Bono è popolarissimo, ben oltre i propri meriti, quando comanda una divisione nella prima guerra mondiale. Ha scovato nelle sue quadrate legioni un cuoco che ha servito sui transatlantici di lusso. Al suo comando superiori e pari grado fanno la fila per ispezioni e scambi di idee che coincidono di solito con pranzo e cena. Se lo porta dietro, il gourmet, pure in Albania. Sui maledetti monti di Grecia mille quadrupedi muoiono ogni mese per assicurare i rifornimenti in prima linea dove non ci sono strade. Quelli che erano someggiati con prosciutti vini e salse per le Eccellenze certo trovarono più lieve la pena perché arrivarono sempre a destinazione. In Africa settentrionale Rommel, sempre lui, quell'ossesso, mangia gallette e beve acqua nauseabonda a fianco dei suoi soldati. Quando si reca da Bastico e Messe e si aprono le cambuse crede di aver sbagliato guerra : si banchetta e si beve con classe. Le ritirate dei nostri alti comandi si lasciano dietro non baionette e spadoni ma forme di parmigiano, maccheroni, bottiglie di annate memorabili. Mai vi godreste con gli italiani una scena come quella di von Moltke che nel 1866, al crepuscolo della trionfale giornata di Sadowa in cui ha stritolato un impero millenario, mangia due fette di salame sul campo di battaglia a fianco dei suoi fanti!
Ci vogliono le immagini per imprimere bene nella mente la Storia. Per i generali italiani abbiamo scelto questa. Il 22 gennaio 1941 le radio della Settima divisione corazzata inglese lanciarono il messaggio in codice che tutti i soldati impegnati nella più sfolgorante campagna militare della storia aspettavano: «La volpe è stata uccisa in aperta campagna». La metafora della caccia alla volpe era venuta spontanea agli ufficiali durante la battaglia cominciata un mese prima nel deserto egiziano fischiettando Waltzing Matilda. li generale Wavell rastrellava ogni giorno nella sabbia frammenti giganteschi dell'esercito del maresciallo Graziani detto l'Africano. Egli proclamava che un'armata di duecentocinquantamila uomini e mille aeroplani lo stava martirizzando. Gli inglesi non erano più di trentamila . Aveva ragione Churchill: «Sembra che questi italiani siano grano preparato per la falce».
La volpe però sfuggiva sempre, era furba, guizzava fra le trappole, scompariva, le intravedevi solo la coda. La volpe era una buffa figura di generale, Annibale Bergonzoni, che i soldati italiani chiamavano affettuosamente «Barba elettrica». Se leggevi il curriculum

sembrava Marte in orbace: tutte le campagne coloniali, la Spagna, tenace e fascistissimo, temprato dalle sabbie d'Africa e dal vento del!' Andalusia . Poi, quando il comandante della piazzaforte «imprendibile» di Bardia saltava fuori dal bunker, t'imbattevi in uno di quegli strambi profeti che si trovano talvolta nelle osterie di paese e che cercano di convincerti che il mondo va a rovescio, realtà amara sulla quale sei pera l tro già documentatissimo. Magro, lungo, una doppia barbetta corvina e candidissima, occhi spiritati da rivoluzionario balcanico, la volpe aveva lasciato a Bardia uno sciupio di roba: settecento veicoli, centoventi carri armati e centoquaranta pezzi anticarro, alcune divisioni esauste. Ma lui era sfuggito come un Fregoli, su una Topolino, imboccando la via Balbia a tavoletta, lasciando gli inglesi immusoniti. Poi era rispuntato a Tobruk, altra piazza munitissima almeno nei proclarrù fascisti dove era promossa a tomba della protervia britannica. Il duce gli aveva mandato un messaggio affettuoso, dovendosi accontentare di questi maestri della ritirata: «Sono sicuro che Barba elettrica e i suoi bravi soldati resisteranno a qualunque costo, fedeli fino all'ultimo». Per gli inglesi agguantare il generale che loro chiamavano «Basette elettriche» era ormai un punto di onore sportivo.
A Tobruk non resistemmo fino all'ultimo, anzi bastarono poche ore perché trentamila uorrùni con tanti automezzi che nessuno riuscì nemmeno a contare, duecento cannoni, ottanta carri armati, diecimila tonnellate di acqua potabile, due mesi di cibi in scatola, conserve, casse di spaghetti, centinaia di tonnellate di farina e un impianto frigorifero colmo di carne, alzassero le braccia. Stavolta c'era anche il Bergonzoni. Ha appena firmato la resa che un ufficiale inglese tiene in mano. È un riassunto della disfatta: dei giorni buoni gli sono rimaste solo la barba (non ha più i gradi sul cappottone sgualcito da profugo), la bustina storta in testa, una coperta tenuta a mo' di tovagliolo, in mano ben stretta una borsa di quelle da avvocato di provincia. Se la portava dietro da mesi sulla Topolino: documenti segreti? memoriali esplosivi? No: tutto il nécessaire per la prigionia .
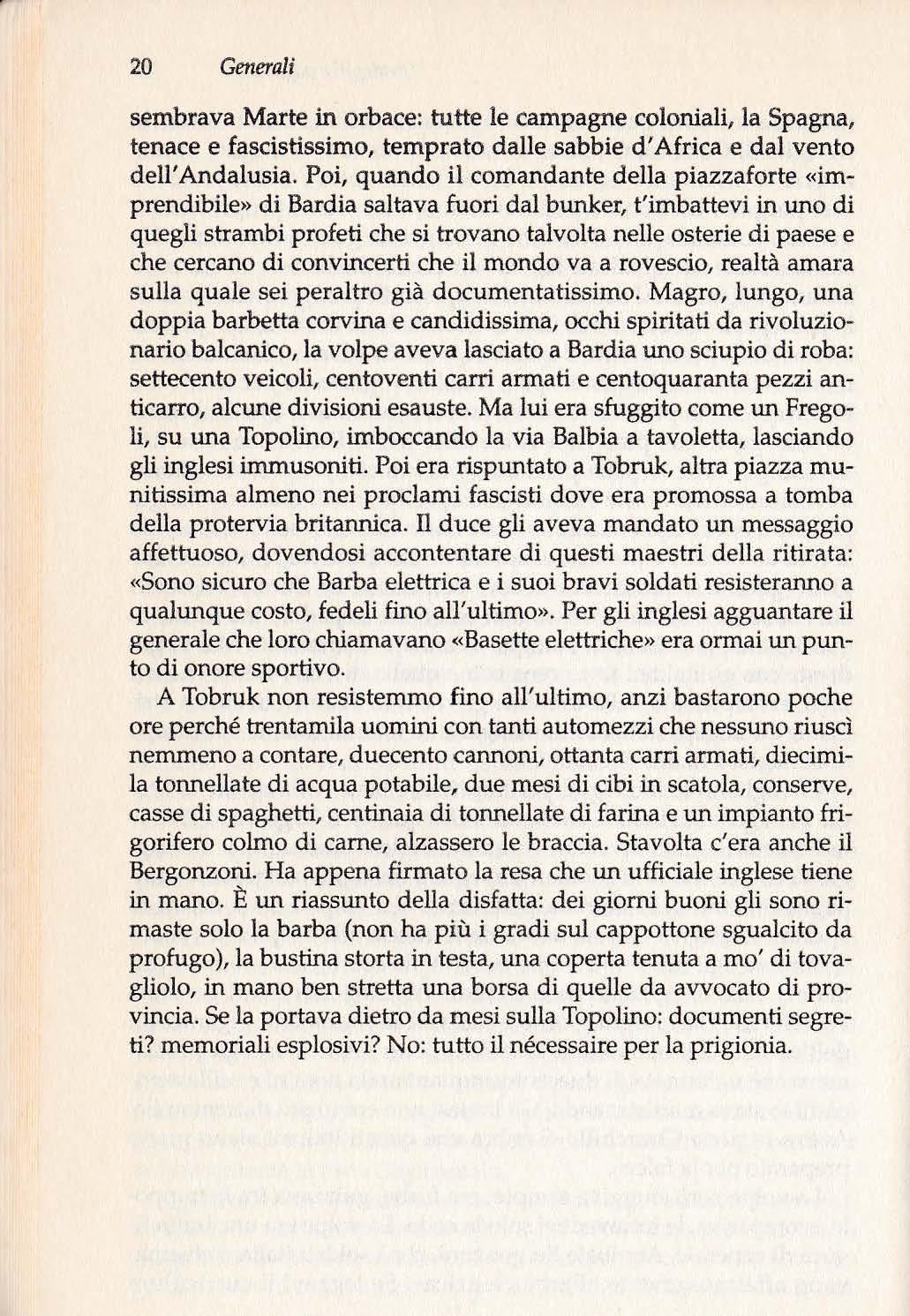
n Mago e la strana sconfitta del conte di Gaeta
«Setta: quantità di persone che aderiscono a qualcheduno, e seguitano qualche particolare opinione e dottrina politica, o regola di vita religiosa. Ma p er lo più ora ha mal senso.» Puntuale come sempre, il Tommaseo, nel suo dizionario con cui si affannava a dare all'Italia, finalmente una, la stampella di una lingua comune. E all'etimologia di «se tta» aggiungeva dotti esempi di quel «mal senso»: «Fazione, parte, congiura » aggiungeva «e ancora divisione, discordia: ma benché poi fossero le dette parti tra i nobili di Firenze e spesso si guerreggiassero tra loro come mini stati, ed erano in setta per le dette parti, e si tenevano insieme... ». Fino a concludere, con un lampo sulla nuova questione del secolo: «Pare setta .. . dicesi anche di operai che si accordino per fare sciopero».
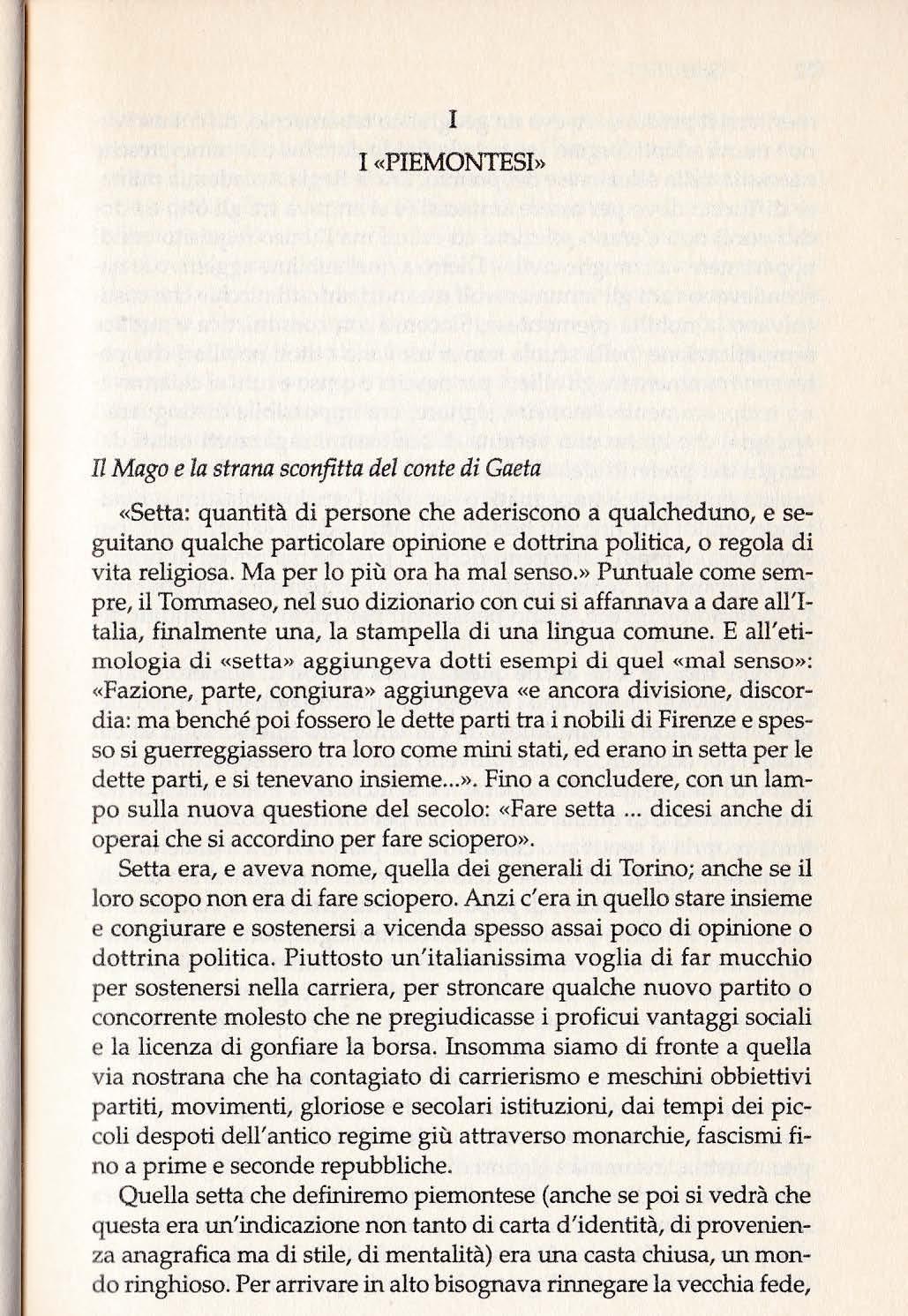
Setta era, e aveva nome, quella dei generali di Torino; anche se il loro scopo non era di fare sciopero. Anzi c'era in quello stare insieme e congiurare e sostenersi a vicenda spesso assai poco di opinione o dottrina politica . Piuttosto un'italianissima voglia di far mucchio per sostenersi nella carriera, per stroncare qualche nuovo partito o concorrente molesto che ne pregiudicasse i proficui vantaggi sociali e la licenza di gonfiare la borsa. Insomma siamo di fronte a quella v ia nostrana che ha contagiato di carrierismo e meschini obbiettivi partiti, movimenti, gloriose e secolari istituzioni, dai tempi dei piccoli despoti dell'antico regime giù attraverso monarchie, fascismi fino a prime e seconde repubbliche.
Quella setta che definiremo piemontese (anche se poi si vedrà che questa era un'indicazione non tanto di carta d'identità, di provenienza anagrafica ma di stile, di mentalità) era una casta chiusa, un mondo ringhioso. Per arrivare in alto bisognava rinnegare la vecchia fede,
meritarsi il perdono. Aveva un geografico tabernacolo, da cui uscivano i nuovi adepti forgiati secondo le rigide dottrine e le cameratesche necessità della selezione e del premio. Era la Regia Accademia militare di Torino dove per essere ammessi (e si entrava tra gli otto e i dodici anni) non c'erano selezioni ed esami ma l'unico requisito era di appartenere «a famiglie civili». Dietro a quel sublime aggettivo si nascondevano tutti gli innumerevoli meandri anfratti nicchie che costituivano la nobiltà piemontese. Siccome con comunistica e audace semplificazione, nella scuola non si usavano i titoli nobiliari che potevano frammentare gli allievi per nascita e censo e tutti si chiamavano reciprocamente «monsù», signore, era impossibile distinguere i «paggi», che erano una ventina di sceltissimi ragazzotti usciti dai ranghi dei preferiti del re -e che servivano a corte riducendo per questo onorevole e impegnativo servizio l'orario scolastico e risultando quindi alla fine più bestie degli altri - dagli «alunni» che, per mancanza di fondi dei parenti ricchi di passato ma poveri di futuro, si allietavano per veder pagata la retta , anzi la pensione, dal sovrano. I «convittori», invece, erano pensionati per conto e per rendita dei parenti.
Come tutte le sette anche questa aveva vincoli di numero: mai la scuola (dove si dividevano i discepoli in quattro brigate) superò, negli anni gloriosi e tumultuosi da cui emersero i personaggi di cui stiamo per occuparci, i duecentoventi allievi. Aveva soprattutto il legame di una lingua che separava e selezionava automaticamente tutti coloro che di quella conventicola per diritto di nascita o per volontà propria si sentivano chiamati a far parte. Ed era il dialetto piemontese. A quell'arduo esercizio dovevano rassegnarsi savoiardi, sardi, genovesi, il mazzo di popoli e di genti che casa Savoia in alcuni secoli era riuscita a riunire spesso controvoglia, sotto il suo scettro appuntito. E qui veniamo al primo capitale carattere: l'ideologia che riuniva questi distinti giovanotti e che doveva forgiare una ben quadrata legione protagonista (e che protagonista!) nientemeno che della storia prima del Piemonte e poi dell'Italia. Questa così eterogenea nobiltà si era costruita nei secoli all'ombra di quelle montagne e di quei fiumi impetuosi, ma ahimè non abbastanza per tener lontani gli eserciti di vicini tanto scomodi e molesti da chiamarsi Francia, Spagna, Austria, insomma i gig anti di un'Europa ancora litigiosa, rapace e felicissima di esserlo. Si era data un'immagine pubblica a cui era affezionatissima e che cantastorie e lettera ti si impegnavano a trasmettere e confermare: l'immagine, cioè, di un mondo di famiglie davvero «civili» perché legate ai loro duchi, per cui erano disposte a
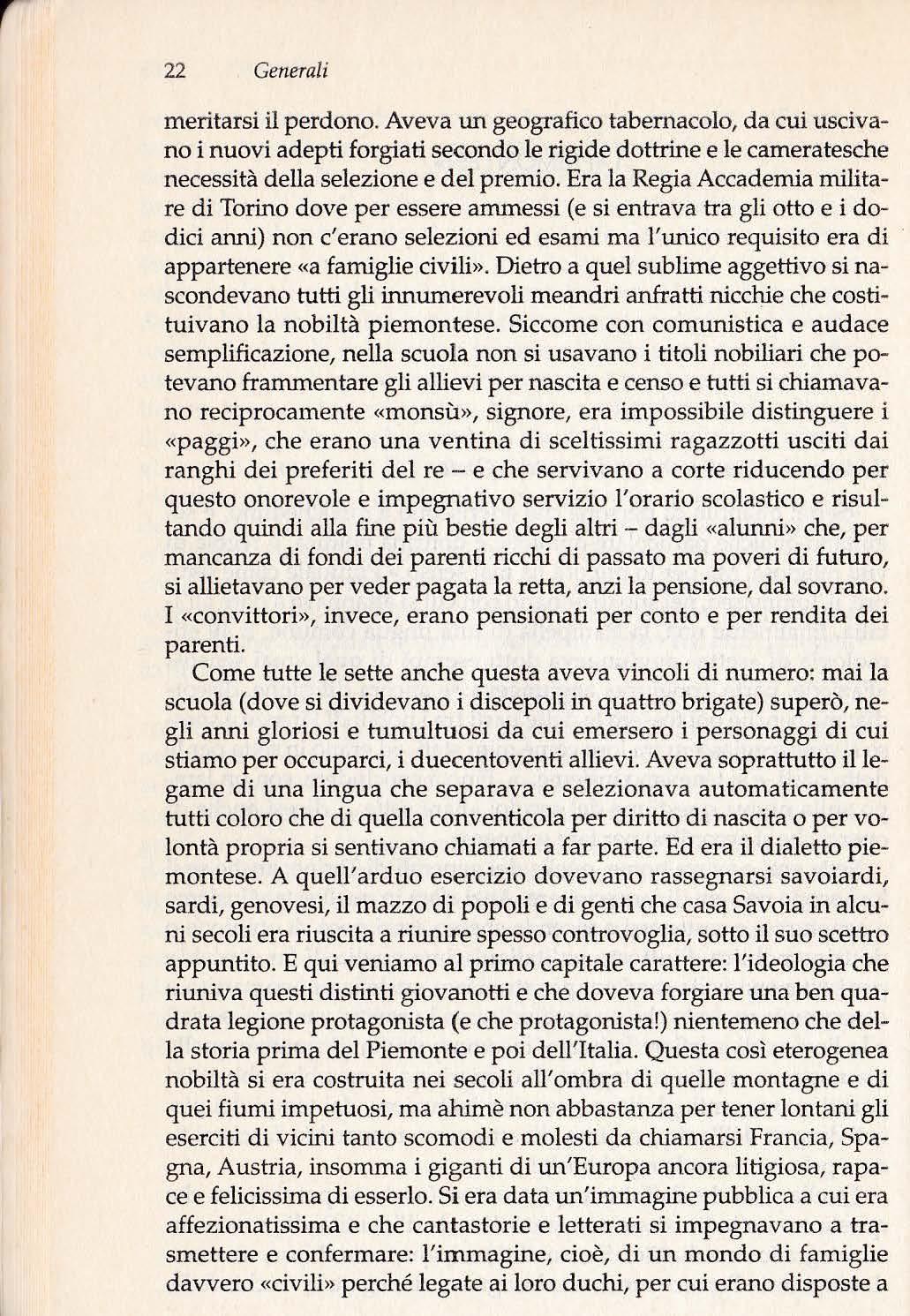
dare i soldi e la vita. Amminis trava con oculata parsimonia, retti cos tumi e affettuosa carità, distribuiva i suoi beni, accudita da contadini e borghesi fedeli e contenti del loro piccolo mondo ordinato, parco e tranquillo. Era il mondo dei Costa de Beauregard, buono, piccolo, affezionato alla sua penuria; dei bei tempi in cui re Vittorio Amedeo, quello della battaglia vittoriosa di Torino, aveva un solo cappotto foderato da una parte e leggero dall'altra che rivoltava a seconda della stagione. Era, come tutte le mitologie, a ben guardare, proprio una mitologia: quella nobiltà fedelissima sembrava ben disposta a lasciarsi sedurre, non appena si presentava l'occasione, dalle sirene di altri padroni; e senza guardar molto per il sottile.
Per esempio la marchesa Raffaella, distintissima madre di uno degli eroi della nos tra Storia, Alfonso La Marmora, vedova da poche settimane, incinta di sei mesi con sulle braccia oltre a sette figliole da accasare sette maschi di cui il più grande aveva diciassette anni e il più giovane meno di uno. Si era messa in fila, a Torino, nientemeno che davanti a una coppia smagliante di successo ma per altri versi assai chiacchierata: Napoleone e Giuseppina che, con in testa la corona imperiale appena cinta a Parigi, scendevano ad arraffare anche la annosa e un poco ossidata corona ferrea di sovrani d'Italia. La marchesa, che teneva a rispetto anche la prolifica Niobe, a cui non mancava il coraggio (semmai il patrimonio) per allevare quella strabocchevole famig lia e tenere, come si diceva, il decoro del casato, aveva chiesto e ottenuto di sistemare qualcuno di quei benedetti ragazzi nell'armata gloriosa, invincibile ma che mezza Europa si ostinava a chiamare usurpatrice: «Per diventare buoni soldati e seguire (a fianco dell'instancabile demolitore di troni) il cammino della glor ia s ui campi di battaglia ». Fiammiferi sparsi attendono solo chi ha voglia di accenderli. L'impe ratore non si fece pregare perché di carn e da cannone aveva sempre bisogno, e così tre dei La Marmora divennero rispettivamente tenente dei Cacciatori a cavallo, allievo del1 ' Accademia militare di Fontainebleau e paggio di corte, prima che la vendetta della vecchia Europa non si decidesse a cacciar via quell'usurpatore di corone.
A giurare fedeltà al nemico del suo amatissimo re e quindi a finir nella categoria dei voltagabbana, o, se vogliamo usare parole grosse, dei traditori, l'animosa marchesa Raffaella non era certo unica. L'epopea napoleonica si era popolata di piemontesi spediti in giro per i campi di battaglia d'Europa in quella guerra infinita che fu il periodo napoleonico: magari incrociando la spada e le schioppettate con altri connazionali che invece per menar le mani avevano scel-
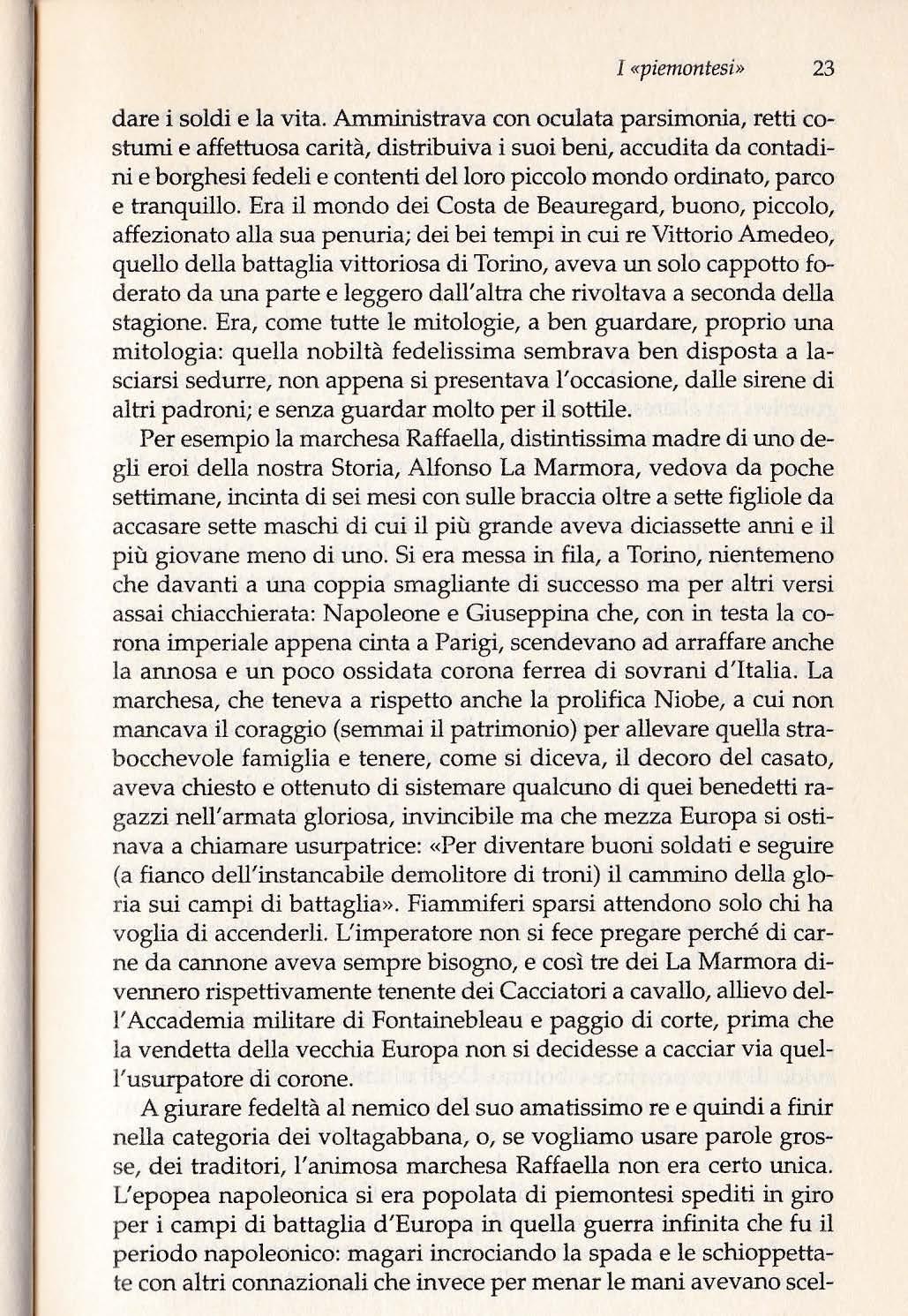
to le truppe del re di Prussia o addirittura del lontanissimo zar Alessandro. Ali'Accademia i nostri protagonisti potevano raccogliere la saggezza consumata di Cavagnero, un vecchio professore che aveva scontato sulla pelle tutte le campagne dell'impero e se le portava in giro come medaglie esibendo le innumerevoli ferite che vi aveva guadagnato; una vita, la sua, sollevata da terra, frenetica e furibonda.
Molto di leggendario c'era anche nella fama dei duchi che con faticosissimi scambi, guerricciole e tradimenti si erano portati a casa il desideratissimo titolo di re. Loro si presentavano come razza di guerrieri cavallereschi e animosissimi: i prussiani d'Italia, si diceva quando era appena sbocciata la gloria del grande Federico. Se poi si sfogliavano, senza farsi intimidire dagli aggettivi e dai punti esclamativi, gli annali del Regno, si scopriva che le glorie guerriere risalivano, e si fermavano, al duca Emanuele Filiberto detto «Testa di ferro», che quelle glorie si era procurato, fra l'altro, sotto le bandiere e con i soldati non suoi ma dell'imperatore. Messi da parte i primi mitologici fondatori del casato, il conte Verde e il conte Rosso, le cui imprese un po' brigantesche si perdevano nelle nebbie dei secoli di ferro, gli altri Savoia si erano distinti più per abilità nel barcamenarsi e nel tradire i vicini di Francia e di Spagna che per il talento nel condurre i propri soldati in battaglia. Soprattutto con i francesi avevano messo fantasia nel modo di cambiar casacca: nel bel mezzo d e lla gue rra, quando anche le loro quattro sca lcagnate legioni assumevano un peso qualche volta decisivo. E l' unico Savoia che per la mischia aveva colpo d'occhio e mestiere, il principe Eugenio, aveva dovuto cercare contratto lontano da casa, alla corte degli Asburgo d 'Austria.
Quanto agli affezionati sudditi, non ci mettevano nello schierarsi sotto le bandiere dei re di Sardegna molto entusiasmo: fino alla vigilia degli eventi che stiamo per raccontare, le loro armate eran formate soprattutto da svizzeri, arruolati nei cantoni più poveri di quel paese su cui invano i duchi per secoli avevano messo il loro sguardo avido di terre proviI)ce e bottino. Degli ultimi re tornati nei loro palazzi dopo che quell'invadente di Napoleone aveva dovuto sgombrare, Vittorio Emanuele I non aveva per l'esercito molta passione; forse per la scarsa fortuna che la casata aveva ricavato dall'accapigliarsi con il Gran Corso . E il successore Carlo Felice addirittura pensava di smontar tutto quell'apparato di cannoni e bandiere lasciando un'armata scenografica e di timorati scagnozzi: i generali gli sembravano, ansioso com'era di cancellare la parentesi napoleonica,

gente pericolosissima e contagiata dal veleno della rivoluzione. Risultavano molesti al sovrano soprattutto gli esponenti delle cosiddette armi dotte, come l'artiglieria, che lui cruamava «patriottiche»; capovolgendo il senso, non traduceva «patriottismo» con «entusiasmo genuino per il paese» e il sovrano, ma con «fellonesco» . Nonos tante questi distinguo, il re e i suoi nobili continuavano ad avere nelle corti d'Europa la fama di militaristi sempre alla ricerca di cau se buone o cattive per menar le mani in santa pace.
La nostra setta si divideva fin dall'inizio in due congreghe più piccole; una parte sceglieva la via più piana delle armi dette «comuni» e l'a ltra quella più accidentata delle armi «speciali». E speciale era davvero, se il corso di studio comprendeva matematica analitica e applicata (meccanica e idraulica), fisica e chimica, a rte militare o tattica, istituzioni di artiglieria, fortificazione passeggera e permanente, arcrutettura, geografia politica e fisica, storia del Medioevo e dell'età moderna, belle lettere e filosofia razionale . Aggiunge te a ques ta sfiancante galoppata nello scibile umano le qualità dei professori : per le matematiche, per esempio, a cui veniva destina ta la maggior parte del tempo, salivano in cattedra quelli dell'Università di Torino dove imperava un cattedratico cli nome Bidone, temutissimo, dalle cui grinfie ogni anno uscivano con la laurea non più che tre studenti. Ma anche per gli studi s i ripeteva il fenomeno della fama militaresca dei re: una cosa erano i programmi, un'altra era la pratica . Alla fine del corso che durava dieci anni, infatti, gli allievi si presentavano a una commissione nominata dal ministro della Guerra che doveva gi udicare se avevano meritato il posto e le spalline di sottotenente. Ebbene, un po' a causa dei cognomi degli alunni, un po' per na tural e tendenza alla mansuetudin e, i commissari non si mos travano mai molto severi, neppure con i praticanti d elle armi do tte. E quando mancava la volontà, entravano in gioco altri fattori: s i s tancavano di rimandare gli allievi agli esami, o arrivava la grazia sovrana, o c'era per qualche guerra in v ista un eccezionale bisogno di ufficiali da mandare al macello. Non parliamo poi delle armi comuni, dove solo una mostruosa predisposizione a finire n ella cosiddetta «squadra franca», quella delle punizioni, poteva evitare alle armate del re la sciagura di un altro poco dotto ufficiale. Nella squadra franca, in cui non era lecito parlare, la ricreazione si faceva stando in riga immobili o a spali' arrn con il fucile e si mangiava solo pane e acqua, era stata peraltro sopp ressa dal pietosissimo sovrano nel 1833. All'educazione delle recl ute de lla setta provvedevano, oltre che istitutori e ufficiali spesso

ignorantissimi, anche sacerdoti abatini e cappellani che sembrano usciti da un ex voto settecentesco. E qui severità e impegno erano controllati con maggiore attenzione: orazione mattina e sera in cappella, messa quotidiana (la domenica due, con l'uffiz io della Madonna e una predica al mattino), vespri e benedizione la sera. Ogni mese i futuri generali dovevano presentarsi al confessionale almeno una volta: in quaresima aumentavano giustamente le prediche, nell a settimana santa i futuri generali assistevano alle funzioni della Passione nella chiesa di San Filippo e, a Pasqua, comunione obbligatoria.
Come con questo calendario da abati uscissero poi dalla scuola fior di generali è mistero tutto da indagare. In ogni caso, della sollecita pazienza degli esaminatori attenti più ai titoli nobiliari che a quelli di studio, non ebbe certo bisogno Alfonso La Marmora che alle armi dotte si era dedicato, dicono gli agiografi, con studio e passione, ed era uscito da quell'austero palazzo diplomato a pieni voti con la qualifica di esperto cli artiglieria. L'ultima cosa al mondo che avrebbe desiderato era di esser considerato un dotto, qualità che valeva nell'esercito, prima sardo e poi italiano, diffidenza e risolini di scherno. Rischiava molto, perché alla perizia di bombarcliere aveva aggiunto la conoscenza, per l'epoca straordinaria, delle lingue straniere: il francese che era un po' l'esperanto della nobiltà, ma cianciugliava anche il tedesco. All'inizio questa scienza gli servì soltanto per i viaggi in Ungheria dove s i dedicava al s uo hobby: comprare cavalli a cui destinava le sue seimila lire di rendita con una passione e uno scialo che aprirono vasti vuoti in un patrimonio non proprio smisurato. Nel 1830, già presago delle future battaglie, beffò gli ufficiali austriaci assicurandosi il miglior puledro nelle aste di Mezohegyes dove accorrevano come attirati dal miele gli appassionati dell'intera Europa. Fu li che per tremila lire, un prezzo folle, soffiò a tutti uno splendido arabo di nome Ghidran che lo servì poi fedelmente per quindici anni. In sella a quel campione, a Venaria, dove erano le caserme del corpo di artiglieria, si diverti va a saltare improvvisate barricate che i compagni gli costruivano sulla strada. In occasione dell'asta il generale austriaco Hardegg, considerato il miglior cavallerizzo d'Europa, aveva masticato giaculatorie all'indirizzo degli ussari che si eran lasciati soffiare, «dall'italiano» poi!, quel meraviglioso purosangue: e a chi gli opponeva il prezzo folle pagato dal La Marrnora rispondeva: «Per un cavallo come questo un ussaro dovrebbe vendere il suo dolman». Munito di conoscenze linguistiche, La Marmora, un tipo tutto te-
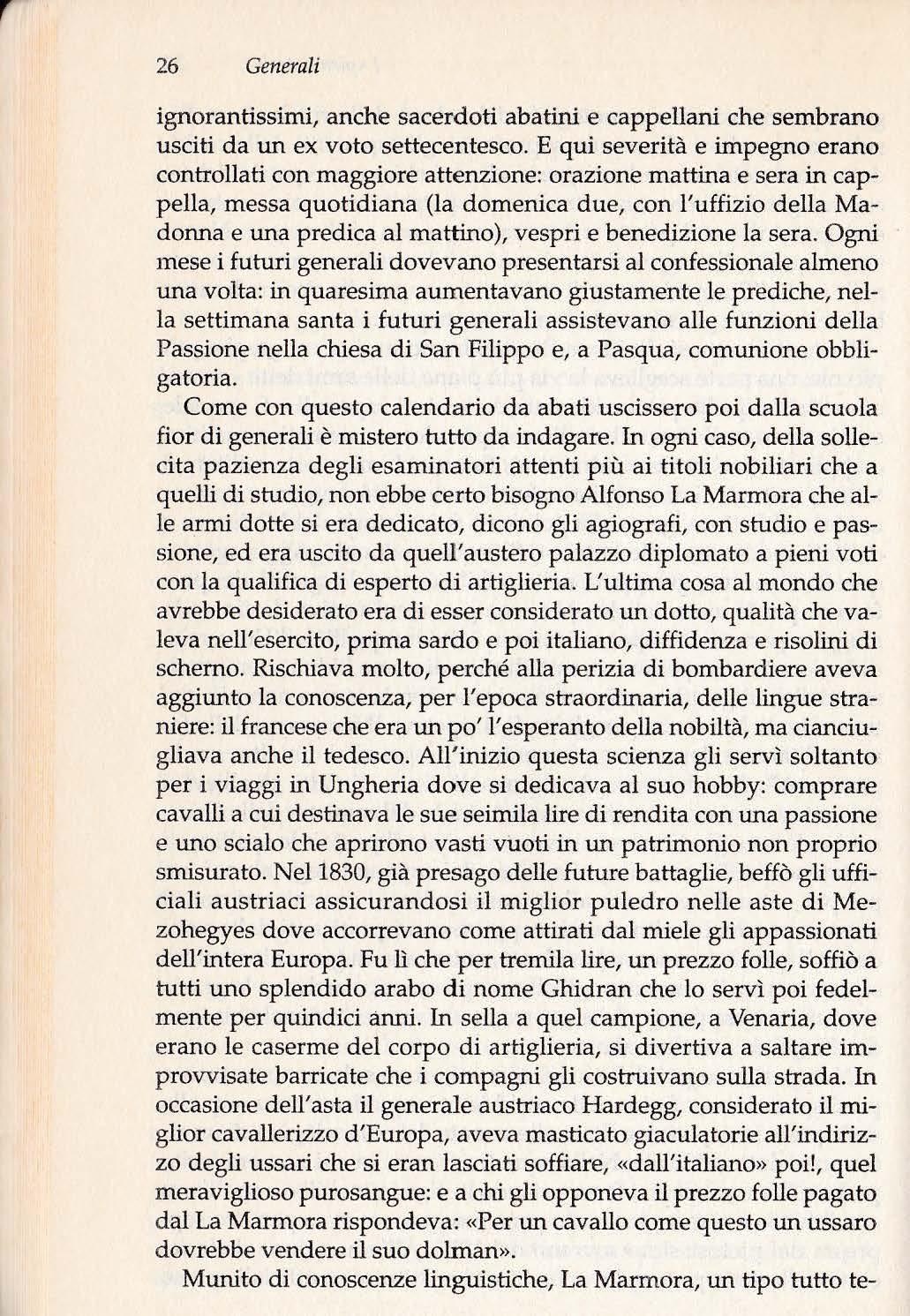
s ta ossicine e membrane come un pipistrello, aveva iniziato un Grand Tour che l'aveva portato a visitare mezza Europa alla ricerca di quei segreti che dovevano illuminare la via anche delle piccole ma ambiziose armate del re di Sardegna. Era stato anche in Prussia. Lì, dopo le vittorie su Napoleone, si stava forgiando quel congegno militare che l'avrebbe trasformata per un secolo e più, fino alla definitiva catastrofe, in spauracchio e miccia perennemente accesa sotto la pace del continente. Ebbene, il dotato ufficiale piemontese trasse da quella visita una passione per il prussianesimo: poteva render onorati servigi alla nostra arte della guerra che invece continuava a essere sedotta dallo stile francese. La si diceva scuola napoleonica, ma tutto era ridotto a una più elementare passione per l'urto e l'impeto che non era nemmeno l'abc dell'arte dell'imperatore. Il prussianesimo del La Marmora si alimentò con l'ammirazione del «buon contegno militare» esibito dagli individui di qualunque grado di quegli eserciti sia che fossero sotto le armi o fuori servizio nei caffè, nei pubblici passeggi, nei ritrovi sociali. Si affannò a indagare le cause di quell'educazione che faceva la gioia dei caporali di giornata, e la trovò negli «speciali ammaestramenti dati nelle scuole ufficiali e alle reclute con così rigida attenzione da diventare il contegno, un'abitudine». Se a questo aggiungiamo che al ritorno iniziò una campagna per la divisa ben portata e la pratica della ginnastica per le reclute che teneva «a freno le cattive abitudini del corpo che col progredire degli anni si cambiano in deformità» avremo nitido il risultato delle trasferte tedesche. Noi ci ostiniamo a vedervi anche il segno lasciato dai buoni abatini della Regia Accademia. La Marmora non si era nemmeno accorto del vero nocciolo di novità: la guerra co me scienza esatta, la scoperta del ruolo dell'organizzazione e di piani strategici, la meticolosa preparazione dei quadri e dell'armam ento, il legame tra industria e guerra che avrebbero fa t to della Prussia la signora militare d'Europa.
Tornò in Italia con questo bagaglio di precetti morali adatti a un sergente di giornata e si dedicò a lucidare le stantie glorie di quell'esercito «di caserma» dove, unico caso in Europa, occorse tempo per s trappare le reclute dal bigliardo della piazza d'armi fatto di manov re e contromanovre, incroci e simulati comandi. E dove, sembra incre dibile, si facevano le istruzioni a fuoco una sola volta l'anno! La su a guerra era quella del mercoledì in piazza Reale a Torino dove i reggimenti di presidio della capitale davan saggio di maestria compiendo movimenti che in guerra sarebbero stati impraticabili. Vedeva il mondo come una caserma un poco più grande, nutriva diffi-

<lenza per ogni lette ratura che non fosse il Regolamento. E faceva costruire le caserme senza scale così i soldati entravano e uscivano dalle finestre a forza di braccia. Silenzio, obbedienza cieca, nessuna infrazione alle regole, esattezza dei movimenti erano le qualità ch e il futuro generale cer cava nei suoi u omini, che dovevano esser simili agli automi del grande Federico. Posava a prussiano con la barbetta me tafisica, la divisa attillatissima. Comparve anche s ul palcoscenico d e lla corte con contegnosi silenzi che sembravano condurre agli scioglimenti dei mis teri eleusini. 1 sold a ti lo clùamavano «il Mago» per l' abilità che aveva di materia lizza rsi nelle camerate, m aga ri di notte, per scoprire la macchia dimenticata s ulla g iubba o lo zaino mal riposto; a cui seguiva il codazzo di relative p esanti puniz io ni. Indossava per quelle is pezioni un lungo pastrano bigio che lo avvolgeva, e alto e smilzo com'era do veva apparire a quelle recl ute terrorizzate come un 'app arizio n e un p o' diabolica e sopranna turale. Aveva una faccia che a forza di controllarsi finiva per non esprimere più nulla . Dalla Germania si era portato dietro anche una passione ca rtacea che lui conside rava un altro seg reto d e ll 'arma ta disegnata da Clausewi tz e compagni: l'incartamento era la s ua gioia, l' ordine cronologico, il riassunto, il qua dro s inottico le sue d elizie. Conti, registri, bolle, moduli, tutta la vita militare e dei reggimenti d oveva essere scandita d a una burocrazia maresciallesca piaga eterna d elle armate italiche. Consulente in artiglieria d ell'ambizioso, s fu ggente, to rme ntato re C arlo Alberto, La Marmora divenne a grandi falcate un'autorità nel mondo militare saba udo, costruendo a partire da Venarla una coorte di amici fedelissimi ch e n e avrebbero accompagnato la carriera scalando a balzi i gradi e le poltrone. Utilizzò i devoti pretoriani p er condurre una spietata battaglia (non dimenticlùamolo, sarà una d e lle caratteristiche e terne dei gen erali italiani) contro que llo che la setta considerava il nemico più pericoloso, molto più dell'avversario che si presentava davanti a lla bocca dei cannoni : l'innovatore. Questa funes ta figura che metteva in discu ssione equilibri radicati e carriere sicure s i m a teria lizzò dapprima n ella robusta figura di un a ltro generale, Giovanni Cava lli. Per l'epoca, Cavalli (che peraltro esibiva un pessimo carattere, ma come rimproverarlo se si tiene a mente la granitica ottusità dell'ambiente, uno dei più ingrati e pitocclù) era una rarità. Uno che praticava più ch e il campo di Marte le officine, che d e dicava tempo e ingegno a studiare le armi invece che accon tentars i della baionetta, ch e aveva capito che un' invenzione vale come mille carich e di cavalleria e che è meglio sempre cercare
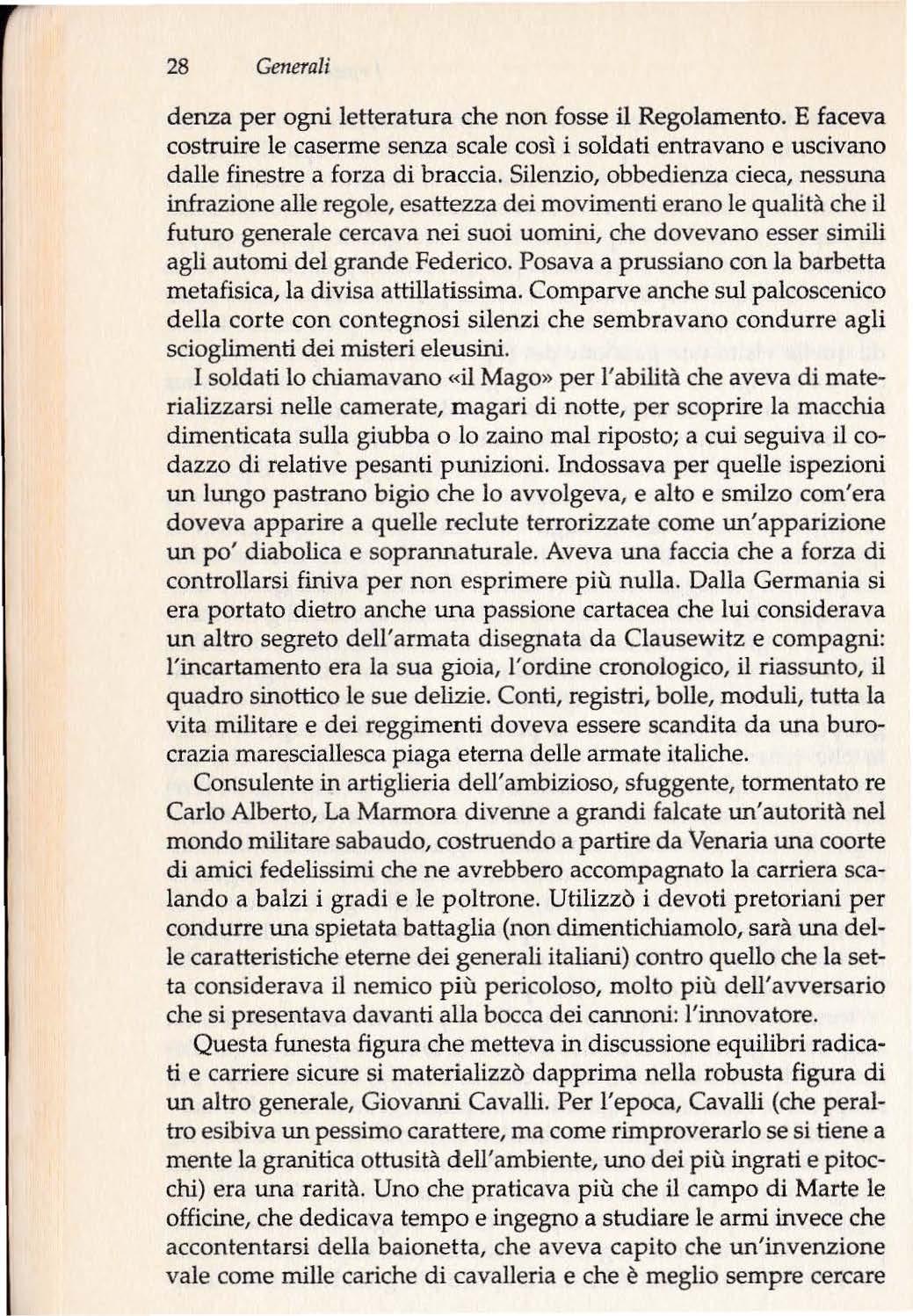
di combattere almeno con i materiali una guerra diversa dalla precedente. Aveva inventato un nuovo tipo di cannone che rivoluzionava in pratica le battaglie. Ai tempi napoleonici infatti con i modelli di cannoni ad anima liscia si sparava a mitraglia quando il nemico era ormai a un passo per frenarne l'urto. Il successo del tiro a distanza era affidato alla strage che i proiettili compivano rimbalzando sul terreno, segnando sanguinosamente le file compatte del nemico, che s toicamente attendeva come imponevano le leggi strategiche del tempo, a piè fermo . La Marmora aveva una memoria implacabile per tutto ciò che ne ostacolava la carriera; piccato per la bocciatura di un suo nuovo treno d'artiglieria dietro cui intravedeva le trame del rivale, dichiarò una guerra senza quartiere al fastidioso innovatore. Nel cuore di questa società militare così gentile, timorata, pedantescamente moralistica e virtuosa, ci si scontra con una totale insensibilità, una sorta di implacabile egoismo quando si tratta di cambiare. Difficile che potesse apprezzarne le doti un generale che scriveva stupidaggini simili negli «avve rtimenti » agli amici:
Guai se alla scienza so]a si sacrificasse lo spirito militare e la virtù che la costituiscono o se agli ufficiali di provata risoluzione o fermezza quando s iano dotati pure di sano criterio e buon senso se ne preferissero degli altri s olo perché più istruiti. Non si dubiti che le battaglie si vincono ass ai più, oserei dire per i nove decimi, per la solidità della truppa e per il buo n e semp io e la fermezza dei capi intelligenti anziché per co mbinazioni strategiche. G ià ebbi a ramm entare che durante le gue rre dell ' impero molti ge n e rali contribuirono alle g randi vitto rie di quell' epoca memorabile sebben fossero pochissimo istruiti e che nella mia lunga carriera ho avuto a che fare con tanti superiori, alcuni che sapevano tutto ciò che un uomo può imparare ed erano dei buoni a null a, vale a dire, non vi era mezzo di strappare loro una d ecis ione qualsiasi per quanta premura se ne avesse.
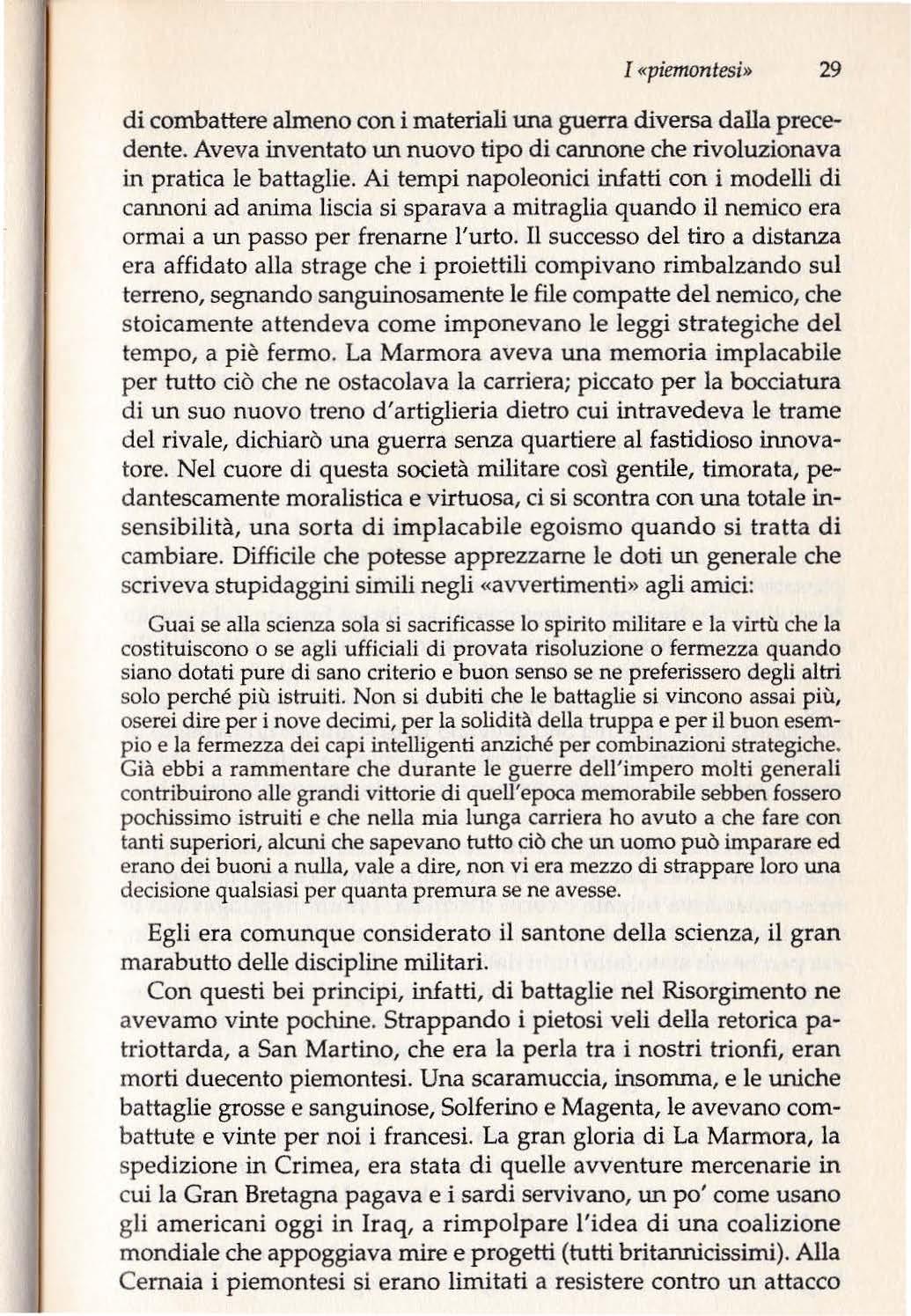
Egli era comunque considerato il santone della scienza, il gran marabutto delle discipline militari.
Con questi bei principi, infatti, di battaglie nel Risorgimento ne a vevamo vinte pochine. Strappando i pietosi veli della retorica patriottarda, a San Martino, che era la perla tra i nostri trionfi, eran morti duecento piemontesi. Una scaramuccia, insomma, e le uniche battaglie grosse e sanguinose, Solferino e Magenta, le avevano comb attute e vinte per noi i francesi. La gran gloria di La Marmora, la s p e dizione in Crimea, era stata di quelle avventure mercenarie in cui la Gran Bretagna pagava e i sardi servivano, un po' come usano g li americani oggi in Iraq, a rimpolpare l'idea di una coalizione mondiale che appoggiava mire e progetti (tutti britannicissimi). Alla Cernaia i piemontesi si erano limitati a resistere contro un attacco
dei russi che erano, se possibile, comandati da generali e nobilastri più ottusi e arretrati dei nostri. I nemici più insidiosi erano stati dissenteria, freddo e colera che avevano spedito all'altro mondo anche il fratello di La Marmara, Alessandro, passato alla storia per la non minuscola gloria di aver inventato i bersaglieri.
La volontà, la speranza si orientavano verso di lui come il ferro verso la calamita. A quest'uomo e alla setta che capitanava avevamo affidato nel 1866 il primo esercito dell'Italia unita. Il conte La Marmora poteva dirsi soddisfatto. L'armata per completare l'opera del Risorgimento e conquistare le ultime province sotto il tallone dell'imperial regio governo, come scrivevano i giornali, era nuova di zecca. Fresche di bucato le bandiere che portavano ben piantato nel tricolore il vecchio stemma dei Savoia, fresche e nuove di sartoria le uniformi anche se qualche criticone le trovava goffe, poco pratiche, che rendevano i soldati degli automi grassi con quel cappottane così imbarazzante, i pantaloni bianchi a sbuffo infilati nelle galosce; i passatisti già rimpiangevano il bel blu attillato d ell'esercito sardo. Nuovi anche divisioni e reggimenti; le cinque brigate del vecchio esercito piemontese che si erano sobbarcate l'immane fatica del Risorgimento erano diventate venti; ai vecchi nomi gloriosi si erano aggiunti i reggimenti che raggruppavano toscani lombardi ed ex borbonici. Ma le leve nel Sud avevano fatto scaturire un rivoletto di reclute e uno sconquasso di disertori che avevano alimentato le armate, quelle sì belle gonfie, della controrivoluzione sanfedista e b orbonica.
Ecco, i comandanti! Quelli invece erano vecchi e La Marmara per questo era ancora più soddisfatto: la immusonita camarilla piemontese comandava brigate e corpi d'armata. I nomi riepilogav ano le battaglie risorgimentali. Se mancava qualcuno, il Bava per esempio, era perché era stato fatto fuori dalla setta, colpevole di un reato assai peggiore della sconfitta: aver scritto articoli pe r denunciare dabbenaggini ed errori nel comando alla fatai Novara. Erano gente di fegato pronta ad andare in prima linea, a saggiare di p ersona il fuoco nemico, della famiglia che Napoleone chiamava «les muratiens», cioè come Murat, tutto coraggio cuore e niente testa. Qualcuno come il Durando, che aveva accumulato fin dal tempo della difesa di Venezia ferite e medaglie, aveva la fama di iettatore: a ogni suo eroismo era appiccicata una sconfitta e sembrava abbonato a perder battaglie. Ma quelli erano dettagli!
Non c'era da aspettarsi grande spirito d'iniziativa, era gente che le guerre le aveva sempre fatte agli ordini degli altri. Anche la cam-

pagna del 1860 era stat a comandata dai francesi e i generali italiani si erano arrangiati a portar soccorso, manovrare a comando, tenere impegnate le forze nemiche che è un bel modo per dire che i compiti importanti se li accollavano gli altri. Inutile fingere: il 1860 era stato un successo di Napoleone !Il, a Milano re Vittorio era entrato stando dietro all'imperatore e il prete, nel Te Deum di ringraziamento per la vittoria, si era persino dimenticato di citarlo! Per fortuna era almeno finito il tempo in cui i Savoia si affidavano a esperti stranieri: andavano di gran moda polacchi e ungheresi. Forse perché sempre impegnati a studiar rivolte, a innescare le micce della rivoluzione contro Austria, Prussia e Russia si pensava che fossero gente che andava a letto con la spada sguainata e viaggiasse con in valigia le micce per i cannoni.
A far la parte degli «stranieri» adesso c'erano i garibaldini: Cosenz Medici Bixio e Sirtori, che avevano da tempo scambiato la camicia rossa con il blu e le spalline; e soprattutto i due borbonici, Mezzacapo e Pianell, i «napulitan», soldati da corda e sacco come li chiamavano, quando non erano presenti, gli apostoli della setta. Quello che pomposamente continuiamo a definire il tribunale della Storia di solito non ammette che un unico argomento: il fatto compiuto. E le loro non erano vicende esemplari.
Prendete Pianeti. Persona ammodo, per carità. Colto certo p iù dei piemontesi; scriveva perfino dal campo di battaglia lettere dolcissime alla moglie e aveva impegnato, patriotticamente, nel prestito per armare il nuovo esercito dell'Italia, tutto il suo, tanto che non disponeva di tremila lire per comperare un buon cavallo che lo portasse in battaglia e doveva accontentarsi di ronzini e di bestie prestate dagli a mici . Ma quel generale che cosa faceva quando Garibaldi risaliva verso Napoli inghiottendo a bocconi le province del suo re legittimo, per cui aveva giurato, Francesco II detto Franceschiello? Era minis tro della Guerra. Non si pretendeva un nazionalismo permaloso. Le Due Sicilie, è vero, erano allo sfascio e perfino il re teneva sotto le finestre del palazzo un vapore pronto a scappare. Ma la truppa voleva battersi, tumultuava per le strade distribuendo bastonate ai «liberali»: e lui, il genera le, il ministro, l'ultimo baluardo di quella dinastia secolare, passava la serata ad alleviare la mente stanca afflitta da gravi pensieri leggendo, «con l'usato calore», i canti di Dante. E il suo aiutante di campo Ferrarelli lo ascoltava ammirato. Era stata, quella dell'agosto del '60 a Napoli, la prova dell'8 settembre italiano: generali che raccontavano favole, di difese strenue mai avvenute, travestendo un nemico in realtà coperto di stracci in

titano imbattibile per giustificare tradimenti e ritirate. Generali come il Via!, che avrebbe dovuto difendere la Sicilia e invece si era svergognato sottoscrivendo patti umilianti con Garibaldi ritirandosi con reggimenti e cannoni intatti. Appena sbarcato in Calabria aveva subito scritto quattro telegrammi al ministro, non per proporre controffensive o chiedere munizioni: il primo per i suoi averi, il secondo per la diaria, il terzo per l'ordinanza e il quarto per il figlio. Nella confusione generale, con la gente che scendeva in piazza a Napoli urlando contemporaneamente viva Mazzini e viva Francesco Il, come raccontava anni dopo quel curiosone di Alexandre Dumas, cosa faceva il Pianell, sollecito ministro della Guerra? Annunciava ogni mattino che sarebbe partito per le Calabrie per organizzare la battaglia finale con le truppe che imploravano un comandante decente per potersi battere, e poi la sera disfaceva i bagagli con la scusa che tutti lo volevano a Napoli per impedire disordini . Alla fine partì davvero. Ma per la Francia, dopo essersi accordato con una delle più singolari figure di doppiogiochista e traditore della storia d'Italia: Sua Eccellenza Liborio Romano potentissimo ministro dell' Interno del Borbone che aveva già indossato la coccarda dei Savoia quando ancora baciava la mano al suo re. Maramaldo al suo confronto può dirsi, senza esagerare, un gran signore. Portava in dote al nuovo padrone quegli sbirri che avevano fino al giorno prima dato la caccia ai liberali e ai filopiemontesi; erano già pronti a dedicarsi con lo stesso scrupolo a papisti e filoborbonici! Dopo un breve soggiorno a Parigi con signora, il bravo Pianell si era presentato a Torino dove aveva ritrovato, con una nuova uniforme, i più fidj amici di un tempo. In tre giorni, e in segwto a un colloquio con Cavour e Fanti che era ministro della Guerra e La Marmora che gli usò molte cortesie, tutto era combinato. Il ministro della Guerra del Borbone ricommciava la carriera con le spalline di tenente generale del Savoia primo re d'Italia! Gli mancava solo l'aureola.
Che cosa poi quel re pensasse dei suoi generali è tutto da indagare: non gli erano in fondo simpatici per una ragione semplicissima, egli stesso pensava dj essere un grande conduttore di uommj e non sopportava l'aria di superiorità che quelh si davano quando dispiegavano sul tavolo le carte. Lui, il re sergente, si piegava volenteroso su quelle carte ma non ci capiva davvero un'acca. Per il Savoia, a cul piaceva almeno quanto le contadinotte sudaticce e robuste, la guerra assomigliava a un'incursione di briganti: fucilate sciabolate assalti all'arma bianca, urla e fumo. Quando il fumo si diradava, lasciava intravedere il nemico in fuga e si poteva andare ali' osteria a far fe-

sta. Grandi e monarchiche risse, insomma, dove certo il re ci metteva un coraggio a tutta prova: la sua leggenda era legata a una mischia, a Palestro, quando violando ogni regola si era presentato in prima linea guidando un gruppo di z u avi francesi all 'attacco di una posizione nemica particolarmente ostina ta. Quei soldati che all'epoca avevano fama di magnifici combattenti tanto che eran copiati nelle pittoresche divise africane perfino in America, s i presentarono alla sera a l re per offrirgli i gradi di caporale. Forse era una favola, forse davvero per molti anni quel reggimento continuò nell'adunata mattutina a gridare il nome di Vittorio Emanuele, caporale, assente gius tificato perché re. Comunque, al Museo del Risorgimento di Torino sono rimasti ben custoditi filetti da caporale degli zuavi. Minuzie, episodi da libro di avventure che però il re scambiava per segno di abilità guerriera e guardava male quei generali che volevano tenerlo in seconda linea e temevano che la sua irruenza combinasse guai. Come il suo successore che portava il s u o stesso nome, ne intuiva la pochezza umana e il modesto talento professionale. Tra i generali che quel giorno si affannavano sulle dolci colline di Custoza e Villafranca amava soltanto Enrico Della Rocca, passato al setaccio di cento prove, generale e piemontese da capo a piedi. Non per l'episodio d i Magenta, quando, invocato dai francesi, che stavano crollando dopo ore di inutili e cadomeschi assalti alla baionetta, perché caricasse con i suoi reggimenti a cavallo aveva risposto, naturalmente in d ialetto: «Noi cariuma sempre!» (Noi carichiamo sempre). Ne apprezzava, s ussurrava qualcuno, la procace moglie che gli prestava in quel momento femminili e graditissime attenzioni.
La Marmara questa guerra si poteva dire che se l'era costruita di persona, a misura dei suoi talenti e delle sue bestialità. Prima di reindossare la divisa da generale si era cucito addosso la redingote di presidente del Consiglio. Intendiamoci: i generali italiani già all'ep oca, si può dire con il paese appena svezza to «dal secolare servagg io» , avevano subito sviluppato per la politica una sorta di naturale sosp e ttosità che resterà uno dei segni cromosomici di appartenenza . In Italia non sarebbe mai nato, non diciamo un Napoleone, per cari tà, ché ci volevano doti e ingegni che le nostre accademie proprio non avevano nel programma di studi, ma neppure un Washington o un De Ga ulle. La politica, i parlamenti, le elezioni, que l fuggente areopago lo guardavano con un misto di sospetto e di compassione. Serviva a fornire mezzi, denaro e occasioni di far guerra: poi non si dovev a impicciare . Loro, i generali, eran fedeli al re come a i tempi dei monarchi assoluti e se accettavano cariche di ministro era per la
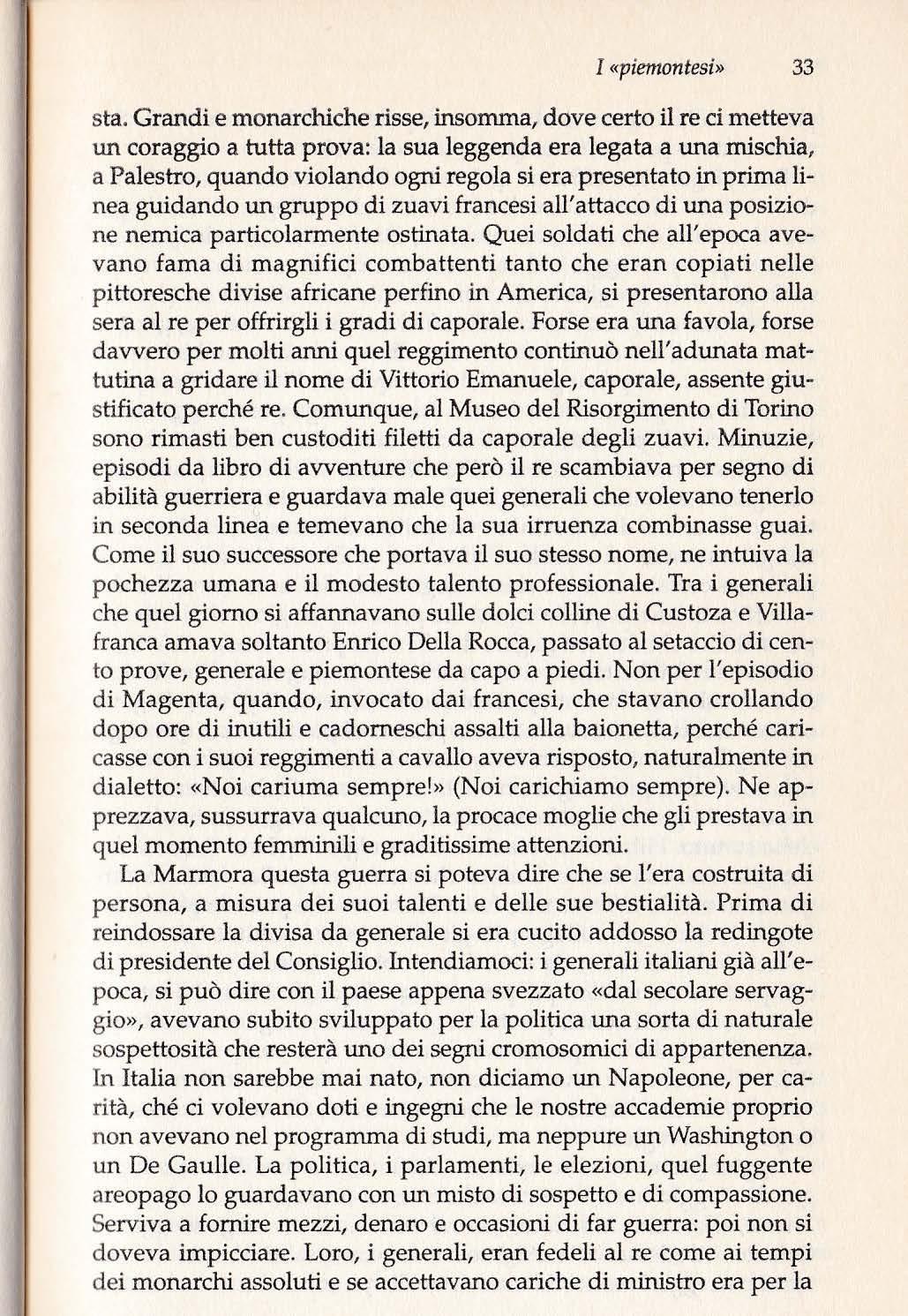
poltrona della G uerra che certo non s i poteva affidare a un civile. Sarebbe stato, e per molto tempo fu , uno scandalo. Per spiegare con efficacia questa insofferenza raccontia mo il modo in cui La Marmora acco lse la notizia che il Regno di Sardegna era diventato, da monarchia assoluta, Stato costituziona le: per realizzare que l passaggio dai cari v ecchi te mpi al mond o nuovo dei suffragi e d elle borghesie che non obbedivano soltanto ma decidevano e votavano, non erano s tati s ufficienti una ri voluzione, guerre, res taurazioni, ma si era fatto ricorso alla tentennante ambizione di un monarca . Nei primi giorni del 1847, quando l'Italia e l 'Europa si accendevano per inusi tati furori , e rano in fuga personaggi come Metternich e il papa diventato incredibilmente ri voluz ionario, La Marmora se ne stava come al solito a Venaria dove era acqua rtie rata l 'arti glieria s aba uda . Erano gli ufficiali r accolti al ris tora n te Moro, tenuto da una s i dice fascinosa vivandiera di n o me Lucia. Ma i titolati galantuomini s i sa rebbero affacciati al Caval lo bianco, dove la pens ione costava me no e che raccoglieva le modeste comod ità dei sottufficiali. Anche quella sera si era praticato un gioco di destrezza p e r stabilire chi doveva p a gare il caffè: una patata crud a veniva infilata su un forchettone e cia scun ufficiale, impugnando con la s inis tra un colte llo, d oveva spiccare una fetta netta di patata. Pagava chi non r iu sciva o fa ceva cadere la pata t a n el piatto. Erano questi g li usi degli uomini che han fatto l ' Italia! Ebbene, la conversazione infuriava sulla pro mulgazione delle riforme di Carlo Alberto a cui dopo pochi giorni sar ebbe seguito !' ancor più fragoroso irrompe re dello statuto. I liberali e i rea z ionar i nosta lgici di Carlo Felice s i accapigliavano con furore. L' unico che non disse nulla, come se l'argomento non lo inte ressasse, fu La Marmora che prese la parola solo per tacitare un collega più g iovane : aveva s alutato come un s u ccesso che l e faccende di ordine pubblico fossero sottratte alla competenza d ei militari per passare a quella degli sbirri. «Niente affa tto» contestò il con te, perché in quel modo s i toglievano attività agli ufficia li che s e mpre le avevano svolte con compe te n za e fed eltà. Come s i vede, una d e lle icone della rivoluzione italiana s i trovava benissimo, a lmeno fin o a quel m o m e nto, all' ombra domestica degli antichi reg imi.
Aggiungiamo un altro episodio ch e lo legò a due illustri comp ag n i di viaggio in contrati cas u a lm ente s u un vapo r e d e l Lloyd di Trieste, allora città au striaca, con cui tornava da un lungo v iaggio in Oriente. Ad Alessandria d ' Egitto con lui erano saliti a bordo due distinti passegg eri r ed u ci da una v isita alle p iramid i. I tre frate rnizza-
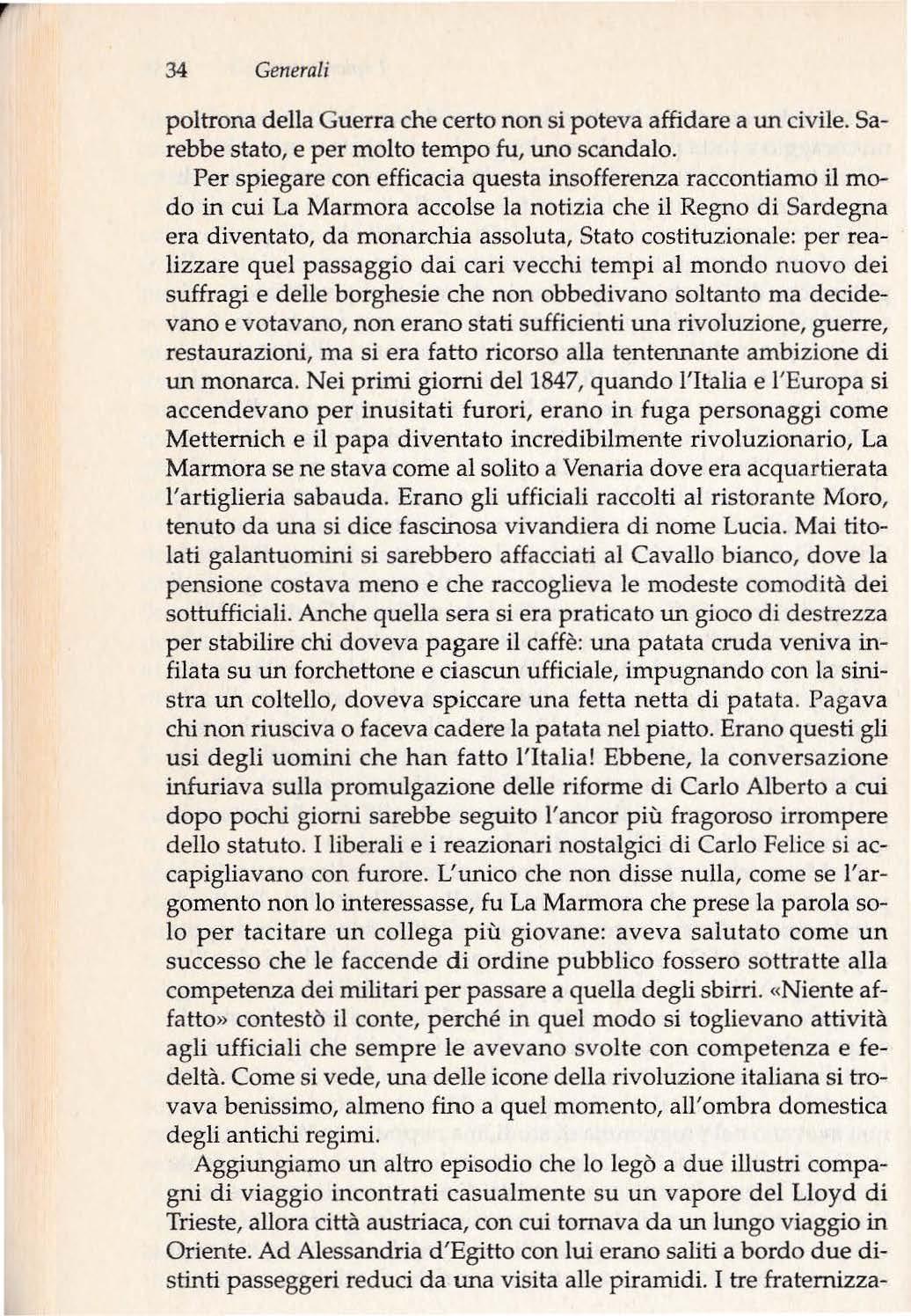
rono; La Marmora scoprì che si trattava del principe Colloredo e del conte Gablentz, alti ufficiali dell'esercito dell'imperatore d'Austria. A Corfù, dove non si poteva scendere a terra per non infrangere la quarantena, i tre compagni diventati inseparabili spedirono un servo perché comprasse viveri e tabacco e soprattutto si informasse di quanto era successo in Europa durante le due settimane di viaggio. «Il papa è morto» annunciò tra la costernazione generale il servo, aggiungendo che l'Italia era in ebollizione. I tre ufficiali continuarono amabilmente le loro conversazioni fino al porto di arrivo scambiandosi ogni tanto come un motto di spirito la battuta: «Vedrete che prima o poi dovremo tirarci delle cannonate». La Marmora li ritrovò infatti a Palestro come generali e nella guerra del 1866. Cavalleria da vecchia Europa delle corti, dove la solidarietà di classe e di buone maniere era più forte dell e ostilità tra le nazioni. Ma quanto erano lontani questi generali dai tempi nuovi.
Dopo iJ Cavour tutti i governi si affannarono in un'impresa disperata: trovare un altro leader che del conte avesse le stesse magnifiche qualità di astuzia e di manovra, che sapesse far combattere le guerre agli altri e portare un piccolo paese a discutere nel salotto buono dei g randi d'Europa, alla pari. Insomma, uno spericolato burattinaio che tenesse i fili di congiure e diplomazia, accendesse e spegnesse le guerre a suo piacere e talento, che parlasse con Garibaldi e mettesse paura a Napoleone li. Impresa impossibile per una semplice ragione, che un altro Cavour non esisteva. Gli eredi Urbano Rattazzi, Bettino Ricasoli, Quintino Sella eran tutti fior di politici, ma non avevano l'ingegno di quel gigante. Così La Marmora si era rassegnato a farsela lui la sua gue rra, a cercarsi gli alleati nuovi di zecca perché o rmai Napoleone, indecifrabile, umorale, qualcuno diceva ormai imbolsito dalla malattia e dalla senescenza, non bastava più . E l'aveva trovato, l'alleato, in uno che al Cavour proprio assomigliava, anzi era se possibile ancor più s pietato, mefistofelico e pronto a tutto: il conte Otto von Bismarck, che provava a fare in Germania quello che a l Cavour era riuscito in Italia. Sul n emico non doveva affannarsi: era sempre la stessa Aus tria arrogante e pasticciona, autolesionista come accade a tutte le creature storiche che il destino ha condannato a un declino tanto lento quanto inesorabile. La guerra era per gli Asburgo quello che i cosmetici rappresentano per le bellez ze in declino, un modo per prolungare brevemente l'apice dei successi. La Marmora era soddisfattissimo perché finalmente facevamo da s oli: niente alleati ingombranti, niente n ecessità di aspettare che un altro esercito arrivass e a dar man forte alle nostre divisioni minusco-

le. Il piano di guerra lo avevano disegnato apposta con pennellate sontuose: due annate che dovevano con annibalico estro circondare gli austriaci nel loro inutile quadrilatero di fortezze, sbarchi in Dalmazia e avanzata con la flotta in pugno fino a Trieste, un esercito dei soliti volontari dell ' animoso Garibaldi al galoppo verso il Nord Tirolo, e per non dimenticar niente, perfino una rivolu zione da far scattare in Ungheria in coincidenza con l'avanzata dei nostri. Si erano a questo scopo precipitati da La Marmara a Firenze torme di quegli arruffapopoli ungheresi che giravano l'Europa come commessi viaggiatori e che annunciavano a ogni primavera la certezza di insurrezioni mastodontiche d ei loro popoli ormai arcistufi degli Asburgo e della loro ben ordinata prigione. Chiedevano soltanto denaro e armi, naturalmente per accendere la miccia. Il risulta to era sicuro. Largheggiammo anche quella volta ma naturalmente non successe nulla . Anzi a Custoza ammirammo con s tupita rabbia la determinazione con cui i reggimenti ungheresi si scagliarono contro di noi, come se fosse la battaglia da cui dipendeva la loro sopravvivenza.
L'alleato, il bravo La Marmora non se lo era cercato; era venuto lui a cercare noi . La Prussia ci proponeva di saldare, insieme, i conti con Vienna. A noi sarebbero andate le province che mancavano per completare il nostro Risorgimento; a loro la supremazia necessaria in Germania per procedere alla riunificazione di quegli sparsi e litigiosi Stati. E iniziare (ma questo non potevamo saperlo) la rincorsa alla supremazia in Europa. Il «prussiano» La Marmora non aveva però una grande considerazione d e lla potenza prussiana; come sappiamo, ammirava più la marzialità e l 'educazione senza estendere la curios ità ai cannoni dei Krupp. Al suo inviato a Berlino per trattare l'alleanza con Bismarck, il generale Govone, che sarà uno dei nostri protagonisti, invece di dare disposizioni precise disse di non riv elar niente dei piani di guerra italiani e di non interessarsi a quelli prussiani: stabilito il bottino, il Veneto (al Sud Tirolo il preveggente Bismarck disse un risoluto no) ciascuno avrebbe marciato per il suo destino . Era la guerra parallela, come l' avrebbe definita Mussolini, che soddisfaceva il nostro orgoglio narcisistico e avrebbe dovuto evitarci brutte figure e impegni che sapevamo di non poter soddisfare. Govone penava a compie re la sua missione. Non disponeva dei pieni poteri e un negoziato parallelo, a sua insaputa, era condotto dall' ambasciatore conte di Barrat. Il cancellie re p en sò a un certo punto, per sondare i progetti di quegli strani e riservatissimi alleati, di spedire addirittura von Moltke (che non era ancora cele-

bre) a Firenze per consultazioni. Ma ricevette un cortesissimo diniego e un suo inviato meno prestigioso venne messo quasi alla porta con la scusa che non era all'altezza, per competenze militari, di discutere con i nostri napoleonici dirigenti. Alla fine firmammo il patto rifiutando sdegnosamente di accettare in dono il Veneto in cambio di una rinuncia alla guerra: era contrario all'ono r e militare, disse La Marmora che sognava cannonate e cariche di cavalleria. Per la prima volta cominci ammo ad abusare di quel sostantivo, «onore», la sola ricchezza dei poveri, che tornerà spesso nelle storie di questo libro.

Bismarck per parte sua aveva già capito tutto: gli italiani sarebbero serviti al massimo come secondo fronte. I nostri fantaccini, considerati poco bellicosi e svogliati, avrebbero immobilizzato qualche divisione austriaca. I conti li avrebbero saldati i prussiani in Boemia. La Storia non inventa niente: la stessa tattica l'avrebbe usata un altro tedesco, Rommel, in Africa nella seconda guerra mondiale: le divis ioni italiane facevano da materasso, subivano i colpi degli inglesi, lui con le sue divisioni corazzate poteva così compiere aggiramenti e manovre con comodo.
«Arrivederci a Vienna» e ognuno per la sua strada, aveva detto Bismarck tutto soddisfatto di averci coinvolto in quel pericoloso affare in cui aveva impegnato tutta la sua carriera e il futuro del suo paese. Per un attimo rischiò perfino di essere travolto a causa dei maneggi di Napoleone III; lasciandoci fra l'altro soli ad affrontare il non disprezzabile esercito di Cecco Beppe. Altro che Vienna! Il nostro problema era quello se s uperare o no il Po e il Mincio. Come accadrà sempre in tutte le nostre guerre più o meno sciagurate, al vertice militare era spuntato il micidiale veleno del dualismo: appena in Italia mette la testa fuori un protagonista, qualcuno che dimostra di avere qualità, immediatamente con antico gu sto ghibellino gli si contrappone un guelfo, si esasperano le rivalità, si prova gran gusto a porsi al lato della mischia per vedere chi vince, si aizzano i due ad azzanna rsi con impegno. La Marmora, il s ignor presidente del Consiglio, non aveva certo intenzione di pass ar i giorni di quella guerra così promettente, che rischiava di essere l'ultima del Risorgimento nazionale, in fegatose giornate di governo, a te nere a bada i chiacchieroni d el Parlamento temporaneamente parcheggiato a Firenze in attesa dei colli fatali di Roma. Voleva comandare le armate, naturalmente sotto la finzione nominale (molto nominale) del re, che non vedeva l'ora di fare a botte. Ma ahimè aveva un rivale, e che rivale! Enrico Cialdini duca di Gaeta.
Riveritissimo guerriero, Cialdini aveva un monumentale difetto: faceva parte della «setta» soltanto per successiva, benevola cooptazione; non era un piemontese. Non solo. Un secondo dettaglio biografico faceva germogliare nel La Marmara un'immediata sospettosità: proveniva dalle file dei quarantottis ti, di coloro che vivono e sognano e muoiono dietro alla barricata, che il generale avrebbe volentieri preso a cannonate con altrettanto entusiasmo di quello che destinava agli austriaci. Na to infatti in Emilia, scottatosi al fu oco dei moti del 1831 quando l'intera Italia complottava, anche se molto all'italiana cioè soprattutto con le intenzio ni e poco co n i fatti, aveva da quella esperienza rimediato la febbre dei pericoli e della gloria militare. La s ua scuola non erano sta ti naturalmente gli austeri e lucidi corridoi dell'acca demia di Torino, ma le tumultuose guerre carliste in Spagna. Si era infatti arruolato in quella specie di brigate internazionali di inquieti attaccabrighe e mezzi idealisti sopravvissuti ai tumulti di mezza Europa. Avevano attraversato, sempre sulla cres ta del caos, un inestricabile macello durato quarant'anni, un ginepraio di cui si ricordava solo l'inizio, il troppo esclusivo affetto che Ferdinando VII aveva manifestato per la figlia Isabella escludendo il fra tello dalla successione. Quanto bastava per produrre furiose battaglie e massacri, contadini inferociti e miserabili che approfittavano per saldare i conti, e idealisti che sognavano di trasferire la rivoluzione dalla Spagna al resto d'Europa, una specie di prova generale, confusissima e in fondo sterile, di quanto sarebbe successo sempre in Spagna ai tempi del golpe franchista. Cialdini, inseguendo il rumore delle fucilerie, cambiò casacca e bandiera. «Le sue» precisano gli agiografi «furono sempre quelle che meglio rappresentavano la libertà.» C'è da dubitarne vis to il profilo dei protagonisti e comprimari di quel guazzabuglio. Alla fine, visto che le braci in Spagna si s tavano spegnendo, passò in Portogallo dove invece l'incendio stava appena crepitando. Firù per essere assunto come ufficiale dei Cacciatori in un manipolo di disperati volo ntari messo insieme da un altro discutibile fuoriuscito e mercenario italiano, Gaetano Borso di Carminati, genovese, ex guardia del corpo del re di Sardegna, che aveva dovuto cercare arie meno pericolose quando n e l 1821 aveva provato ad anticipare troppo i sogni liberali dei suoi datori di lavoro . Borsa è un personaggio salgariano, in mezzo a quei golpe e ai disperati cambiabandiera, anneri to dalla polvere da sparo e con la spada storta per scaramucce e battaglie, si trovava a pennello. Al suo fianco come tenente c'era un a ltro italiano dai solidi destini, Manfredo Fanti: i due giovanotti impegnati a imparare la difficile arte del guerreggia-

re si batterono, assaltarono città, si accapigliarono con armate dalle pittoresche unifomù, dalla selvaggia violenza e tutte arcisicure di costituire l'esercito legittimo. Fecero collezione di medaglie croci benemerenze e cavalierati di cui quegli eserciti erano generosissimi quasi quanto i nostri.
C'erano in quelle guerre anche degli inconvenienti: il generale Borso che pure delle labirintiche oscurità della politica spagnola e ra espertissimo, fu licenziato in tronco perché non aveva obbedito all'ordine di fucilare un gruppo di nemici che si erano arresi sulla parola. Tra pronunciamenti e generali che cadevano al comando delle loro armate come sergenti qualsiasi, dopo aver partecipato alla presa di Madrid, gli venne un po' misteriosamente offerto il comando della guardia civile, un corpo mezzo di sbirri e mezzo di soldati che si stava costituendo. Lo spedirono a Parigi per studiare l'organizzazione della ben oliata e napoleonica gendarmeria. Un po' poco per quel giovanotto che sognava glorie altrimenti robus te; e così, appena era suonato il tamburo della prima guerra d'Indipendenza, era tornato al galoppo in Piemonte dove con Fanti aveva trovato posto nella piccola armata del re Carlo Alberto che provava a fare l'Italia. Dei giorni di Spagna a Cialdini erano rimasti un saldo coraggio personale di cui diede prova per esempio a Palestro, la spietata durezza necessaria per tener assieme truppe eterogenee (il suo primo reggimento piemontese era formato da vecchi sabaudi e giovanotti volontari che si guardavano in cagnesco), e soprattutto una mania per i proclami di stampo napoleonico che lo accompagnerà e tedierà i suoi eserciti per tutta la vita. Diamo la parola al generale, nella prosa c'è tutto l'uomo. Il 16 agosto 1855 i piemontesi si batterono con i russi alla Cemaia. Il Terzo corpo guidato da Cialdini però restò di riserva. Alla sera il generale non seppe resistere: lanciò un fiammeggiante proclama ai suoi soldati, che certamente ringraziavano Dio di averli tenuti fuori dal carnaio.
Fortuna ci tolse di prender parte attiva alla gloriosa battaglia. I vostri sguardi rivolti a sinistra esprimevano con quanta invidia miravate i prodigi dei battaglioni francesi e della nostra Seconda divisione. I vostri volti dicevano che non sareste stati minori ... Voi meritate un giorno di battaglia e Dio lo farà sorgere anche per voi.
Immaginate il gusto quando le cannonate potrà scambiarle davvero! Il 7 giugno 1859 i soldati della Quarta divisione di Cialdini passarono il Ticino assordati dall'inevitabile proclama:

Dalle rive del Ticino io voJsj ieri lo sguardo indietro e mirai con compiacenza il glorioso cammino da voi percorso ... Onome della Quarta di visione è sulle labbra di ognuno. O re ci onora di un lusinghiero ordine del giorno, l'esercito ci encomia, la patria ci applaude e ovunque vi volgete incontrate un sa luto, una stretta d i mano, un evviv a. Soldati! Da quanto faces te io traggo speranze di g randi cose ... p rosegu i te come avete cominciato e fra poco dai poggi di Verona griderete alle genti italiche: l'a us triaco sparì!
Purtroppo sei anni d o po, nonostante i roboanti proclami del generale, i poggi di Ve rona eran s e mpre occupati da g li austriaci ch e non avevano alcuna inte nzio ne di sparire. E bi sogn ava d i nuovo m arcia re e combattere e scrivere proclami.
M entre le sorti dell'unificazione erano m osse dalle arzigogolate arti del Cavour, Cialdini continuò ad aver fama d i generale di «sinistra» che contava amici in quel partito di azione che il conte torinese as tutamente mode llava alle s u e tra m e complesse. Tanto che il primo ministro faceva ricorso a lui quando doveva tenere i contatti con Gariba ldi. Non rischia va delusioni. Quei g iovani ex rivoluzionari orm a i e r a no saldamente inse riti n e ll a classe d irigent e piemontese: troppi vantaggi m edagli e sinecure per ritornare ai tempi incerti delle ba rricate e dei complotti. Sentite cosa rispose Cialdini alle sirene dell'eroe che, al contrario di Cavour, non con osceva bene i suoi int e rlocutori e tendeva ad attribuire a tutti quel fervore ch e invece app arte neva solo a se s tesso. Nel settembre del 1861, mentre Cialdini era luogotenente d el re a Napoli, gli proponeva di far causa comune, gettar la divisa alle o rtiche e te ntare una nuova impresa dei Mille, questa volta per prendere Roma:

Voi libero affatto di vincoli e di doveri verso il governo traete vita e forza dal popolo e da lla rivolu zione di cui siete capitano abilissimo e prod igioso ... ma io che rilevo autorità e grado dal re e dal governo, io che devo prestigio e fama all'esercito, fuori del quale nulla sono, se accettassi, se potessi associarmi al vostro progetto al tro n ome non meriterei fuorché quello di traditore. Ho inteso parlare di una nuova teoria in fatto di coscienza militare 1a quale a utorizzerebbe e legittimerebbe la diserzione e il trad imento perché consumati per il be ne della patria e nell'interesse della libertà . Amo patria e libertà grandemen te ..., ma confesso che la teoria a cui accenno non mi pers uade né punto né poco e che mi attengo al vecchio sistema d i fedeltà alla bandie ra che seguo e di religione al giuramento che prestai.
Era forse p e r una certa ve n a s pagnolesca ch e aveva acquistato durante i tumultuosi anni s pagnoli . O p er l'idea balzana che la fama di Napoleone era lega ta proprio ai suoi proclami e p e r una naturale t e ndenza di carattere. C ia ldini metteva una scrupolosa a tten z ione nella sua immagine pubblica . E aveva scelto per questo scopo un a t-
tento copione che prevedeva lo stile del generale cavalleresco: doveva essere implacabile ma nello stesso tempo pronto a esibire quel!'armamentario di galanterie, buone abitudini e gesti nobili che affardellavano lo zaino dei mai troppo rimpianti «guerrieri antichi». Amava aggiungere anche qualche mediocre e meschino sotterfugio, come diffondere la voce che era di origini nobili, un falso . Lo condizionava un caratteraccio; impegnato sempre nel recitare una parte, esercizio faticosissimo, esplodeva in collere memorabili che spesso mandavano all'aria i suoi luccicanti propositi di generosità. Purtroppo il generale aveva legato la sua gloria soprattutto a due discutibili campagne: l'una, la conquista degli Stati pontifici così mediocre da meritare presso gli addetti ai lavori che non fossero travolti da patriottica cecità o da una passione smodata per il generale, a mala pena il titolo di passeggiata. Nell'altra, la presa della fortezza di Gaeta, la soddisfazione del proscenio gli era stata sottratta, ahimè!, da una donna.
Per ricordare la battaglia di Castelfidardo il fervore postunitario e antipapesco ha eretto a monte Cucco un monumento spropositato, a ssirobabilonese, hollywoodiano, forse il più imponente mai messo in piedi in Italia e che anticipava quella mania del faraorùco con cui abbiamo compensato la minuzia delle nostre glorie. L'idea fu lanciata da un comitato, ali'alba del secolo XX, quando il gagliardo generale era già da tempo uscito dalle pene terrene. Alla riconoscenza n a zionale furono necessari ben dodici anni per raggranellare la somma necessaria a erigerlo. Sei metri per dodici, centocinquanta quintali di bronzo fuso, forse più di quanto sarebbe servito per dare al generale i cannoni necessari a strigliare il nemico, ventimila conifere nel parco, una montagna di centosessanta metri quadrati di massi di travertino per reggere con fatica decine di figure di soldati che, secondo un taglio cinematografico, diventano sempre più grandi e b en modellati via via che si fanno più vicini al generale. Lui, unico a cavallo, lo sguardo tranquillo del trionfatore, incita alla carica; l'emerito scultore Vito Pardo, che vinse l'appalto ed ebbe lavoro assicurato per dieci anni, non fece davvero risparmio di espressionismo: le facce dei soldati sono stravolte dalla foga inarrestabile della battaglia, i muscoli del cavallo che ha l'onore di sostenere il gagliardo coraggio dell'eroe sono così turgidi che il bronzo sembra sul punto di scoppiare . Dietro al monumento sistemò una cripta di stile assiro con decorazioni dei professori Giustini e Sollazzini di Firenze. Ebbene, bisogna dire con mestizia che al generale Cialdini il monumento s a rebbe piaciuto! La battaglia di Castelfidardo durò quattro ore,
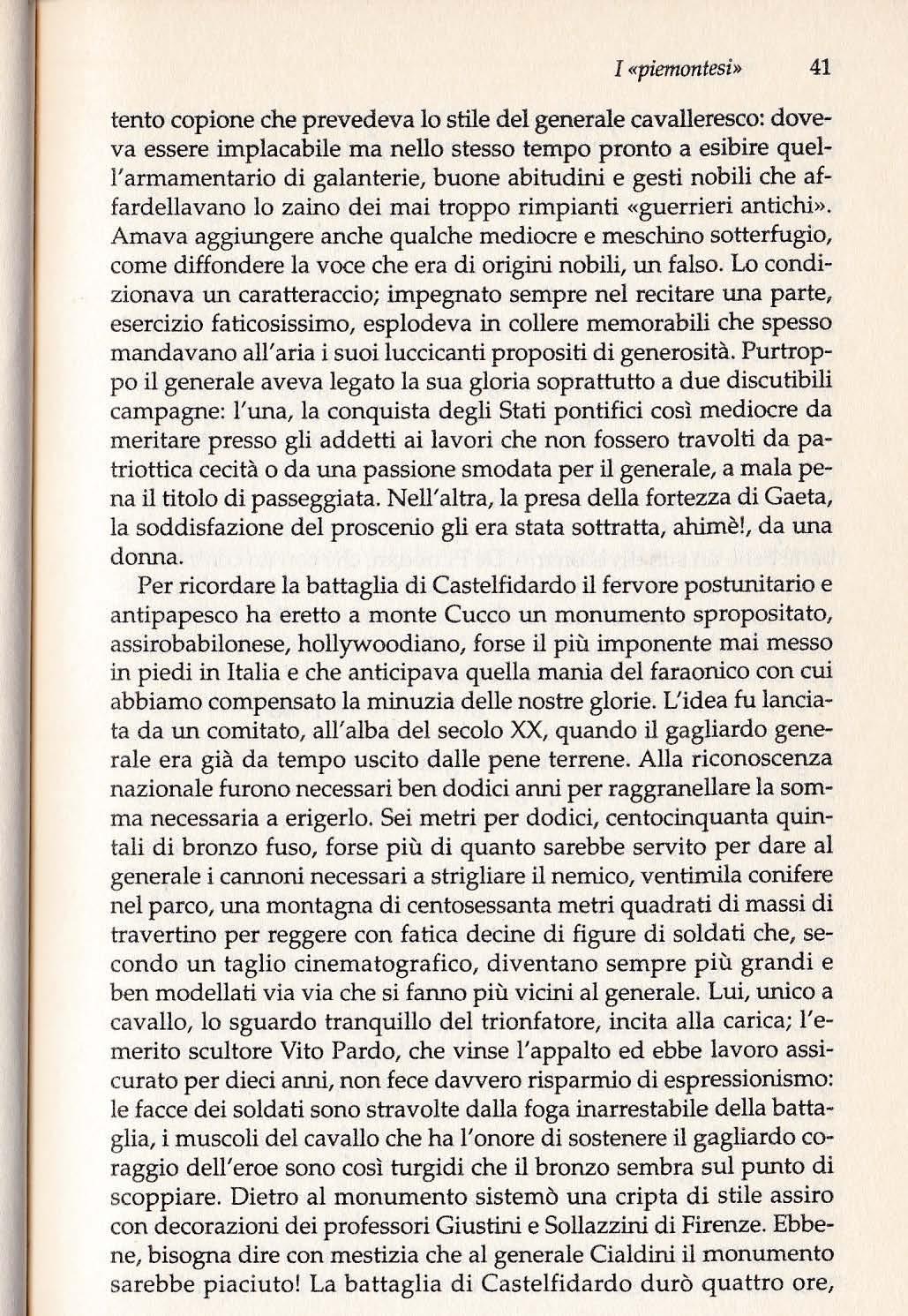
quanto bastò per scoperchlare il cosiddetto patrimonio di San Pietro ammantato da una polvere che risaliva a Carlo Magno. I morti del1'armata del papa furono ottantotto. Ancor meno, sessanta, i piemontesi. L'esercito di Pio IX era un'accozzaglia mal amalgamata di crociati della reazione accorsi da tutta Europa, giovanotti senza esperienza bellica che avevano abbandonato i banchl di scuola e i salotti incantati da una bella causa, mercenari che non aspettavano altro che incassare il soldo e darsela a gambe. Comandava un francese, de Lamoricière, mercenario pure lui, che non si sa bene perché godeva di una fama bellica fragorosa. Sotto ingaggio del papa era stato vanamente corteggiato dai Borboni di Napoli alla disperata ricerca di un generale che sapesse combattere. Francesco II risparmiò soldi. Il talentoso Marte pontificio mise fantasia bellica solo nel prelevare dal santuario di Loreto la bandiera di Lepanto per animare i suoi poco bellicosi soldati e poi scappare ad Ancona con la cassa . Si batté bene un suo divisionario, De Pimodan, che con un contrattacco mise i brividi a Cialdini; e infatti ci lasciò la pelle. Il generale modenese non perse occasione per dare una lustratina alla strombazzata fama di elegante inviando i suoi medici all'agonizzante avversario per tentare, invano, di tenerlo in vita.
Se Castelfidardo non era stato granché, ancor peggio avvenne davanti a Gaeta. Tutto poteva prevedere il futuro conte che a rubargli la gloria sarebbe stato non un altro generale ma lei, «la fulva donna, l'aquiletta bavara che rampogna», Maria Sofia di Baviera, la moglie di Franceschiello. Riuscirà nell'impresa di far avvampare le laudi di d'Annunzio; di quell'assedio che aveva cancellato un'altra bandiera dalla storia d ' Europa si ricordava solo la svelta silhouette di quella Lady D che aveva animato le stanche convulsioni di un regno agonizzante. A lui il «gran bombardiere», «l'italo duce» non era rimasta che l'ambigua gloria di avere sconfitto un esercito guidato da una madama! Un vero tiro mancino del demorùo. L'esercito borbonico aveva le più belle divise d ' Europa; le sue qualità si fermavano Il. Cacciatori e volteggiatori, granatieri della guardia con il berrettone di pelle d'orso (a Napoli poi!), le mille varietà della cavalleria. L'estro murattiano e la consumata abilità dei vecchi sarti delle armate settecentesche si erano uniti per schlerare splendenti reggimenti. Andavano bene solo per le parate. I soldati si dividevano in due categorie. I nazionali erano arruolati con il sistema d e l sostituto (chi aveva soldi spediva un poveraccio al posto suo); La Marmora, meno cavalleresco di Cialdini, li chiamava affettuosamente «carogne» e li descriveva così: «Son tutti coperti di ro-
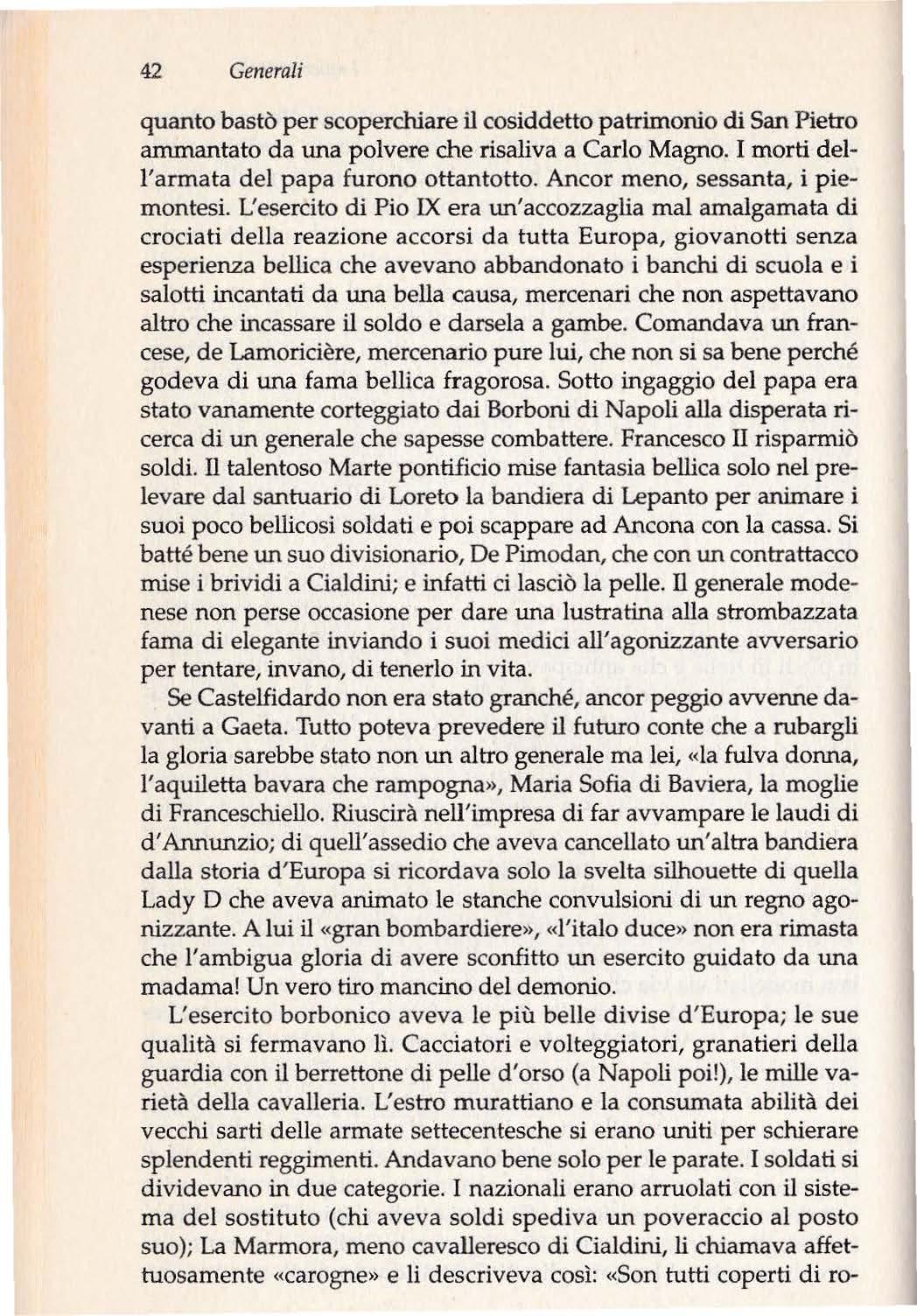
gna e di vermina, moltissimi affetti da mal d'occhi o da mal venereo, di milleseicento che ho prigionieri non arrivano a cento quelli che possono prendere servizio». 1 mercenari bavaresi e svizzeri, i rifiuti delle caserme d'Europa, erano una trista legione che svolgeva bene un solo compito, quello di schiacciare ogni moto o insurrezione interna con ferocia. In queste circostanze davano il meglio di sé: quando il padre del sovrano in carica, lo spiccio re Bomba, li aveva scagliati contro la sua capitale che si era ammantata di barricate e sproloquiava di costituzione, ci avevano messo l'impegno di una schiera di unni.
I generali eran peggio. Traditori come quelli che abbiamo già incontrato, vecchi rimbambiti che non vedevano l'ora di tornare a casa o sbruffoni incapaci: come Ferdinando Beneventano del Bosco che girava con al seguito ceppi con cui asseriva di voler portare a Napoli Garibaldi. Aiutato da malattie misteriose e tempiste, evitava di esser presente nei momenti chiave delle guerre. Il povero Francesco, invece di procedere con la pedagogia del plotone di esecuzione contro quella masnada e spronarla a difendere il Regno (un'armata normale avrebbe regalato ai Mille, nonostante il talento di Garibaldi, la stessa fine dei fratelli Bandiera), compativa, sorrideva, perdonava. E così si ritrovò assediato a Gaeta senza soldi, senza speranze e senza alleati.
Era ormai una tradizione che nella famiglia dei Borbone fossero le donne a mostrare grinta e carattere. In tempi di fughe ignominiose davanti ai giacobini la terribile moglie di Ferdinando I, Maria Carolina, sorella della sventurata Maria Antonietta, aveva tenuto testa con umore frenetico perfino all'usurpatore corso. L'avevano spedita a Vienna in fretta e furia perché era così reazionaria da stonare perfino alla corte borbonica. Maria Sofia, bellissima secondo i canoni del tempo, uscita da una famiglia che sfornava principesse da marito invece che gloria e cannoni, si trovò maritata a un principe che non le assomigliava certo: uno che si trovava a suo agio nella processione di san Gennaro piuttosto che sul campo di battaglia, che aveva preso i talenti della madre, una Savoia salita agli altari per beghinismo e cristiana rassegnazione. Era maturata a fianco del re Bomba che con le sue sanguigne e robuste pulsioni maritali l'aveva spedita precocemente al creatore e alla fama degli altari.
Francesco del padre, un reazionario astuto irriducibile spietato bestia nera di giacobini e patrioti , non aveva preso nemmeno la selvatica vitalità: alla debolezza del carattere si accompagnava, frutto delle sciagure a mitraglia che punteggiavano il suo regno

tarlatissimo, un'autolesionistica vocazione al martirio regale, alla bella fine che certo non aiutava le traballanti sorti di quella creatura politica cui solo un revisionismo impudente ha attribuito meriti e decenza. Inevitabile che la moglie n e prendesse il posto, invocando, senza fortuna, invece del «raggio di gloria» che illuminasse il crepuscolo, un poco di cuore nella difesa concreta del Regno, trasformandosi nell'anima di quella anacronistica resistenza a Gaeta. Incarnò poi il legittimismo fino a diventare più borbonica dei Borboni, una sorta di ossessione, uno iettatorio, lugubre rimprovero vivente per l'Europa dei troni fino alla prima guerra mondiale. Quando anche lei disparve con quel mondo di cui era stata la sfortunata eroina.
La regina infiammava i cuori degli uomini di tutto il continente, passeggiava sui bastioni e chiedeva di puntare di persona i cannoni, sognava infantilmente una bella ferita e aveva scambiato gli stucchi di Palazzo reale con una casamatta umida, buia e popolata di pidocchi . Il povero Cialdini poteva contrapporre ben poco per incantare l'immaginario collettivo. E pensare che il generale italiano ebbe la possibilità di sperimentare con mezzo secolo di anticipo le «meraviglie» della guerra moderna, forse di evitare che sul granito del Carso si dovesse pagare il sanguinoso dazio delle nuove armi. Attorno a Gaeta schierò proprio quelle meraviglie d e ll'artiglieria che erano uscite dalla fertile immaginazione del nemico di La Marmora, il generale Cavalli. Al contrario dei borbonici, che disponevano di cannoni (settecento) che avevano servito ai tempi del primo assedio napoleonico, di qualche pregiato obice che aveva stampato sul bronzo una data seicentesca e due addirittura che avevano visto i tempi delle compagnie di ventura e di Carlo vm, Cialdini metteva in batteria dei gioielli: i cannoni rigati con una gittata e una forza di penetrazione all'epoca sconosciute. Fragorosa smentita delle scuse che i generali italiani hanno sempre allegato a ogni sconfitta, a ogni guerra sventurata fino al 1940: comandiamo armate di pezzenti, abbiamo armi preistoriche, insomma facciamo la guerra della pulce contro l'elefante, come scrisse Graziani dopo la batosta in Africa settentrionale. I politici hanno sempre fatto finta di crederci, compreso Mussolini che infatti non lo fece fucilare. Davanti a Gaeta i piemontesi trascinarono due armi segrete, anticipazioni della Grosse Bertha tedesca che martellò Parigi o del supercannone sognato da Saddam: una batteria con due cannoni Cavalli da ottanta e quaranta millimetri caricati dalla culatta che eran costati ventimila franchi l ' uno, una enormità. Scaricavano addosso

ai difensori, a più di tre chilometri oltre la portata dei cannoni normali, proiettili mostruosi in grado di annichilire con il semplice effetto sonoro. Erano «mostri », e così li definirono gli addetti militari in visita reverente alle batterie italiane, che infastidivano Cialdini a cui quell'obbligo di scappellarsi davanti a svedesi, balcanici e danesi sembrava intollerabile: «Non mandatemi più forestieri anche se sono raccomandati dal Padre Eterno» sbottava con il ministero della Guerra, «ho la casa ingombra di indiscreti che vogliono vedere e saper tutto, che mi fanno perdere tempo e pazienza .. ». Fummo sul punto di gettare in campo un'altra arrna segreta, dal b uffo nome di brulotto minatore; era dawero un ordigno micidiale, una cannoniera riempita fino all ' orlo di dinamite che l'ideatore, un u fficiale precursore dei kamikaze, avrebbe dovuto far entrare nel porto facendola poi esplodere. Il crollo, apocalittico, si calcolava sbriciolasse mezza città. Ci fermammo all' ultimo momento non per pietosa attenzione alla sorte dei civili ma perché era necessaria troppa polvere! Incredibile e insospettabile: era già l'alba della guerra indus triale, awampava la forza meccanica in grado di sbriciolare le vecchie armate fatte di baionette e divise luccicanti come accadde nel 191 4. Nessuno in Europa fino ad allora lo aveva provato sul campo; nemmeno Cialdini, che pure esibiva con soddisfazione il suo arsenale terrificante, capì. Alcuni difetti, naturalmente e italianamente, immiserivano le nostre armi segrete. I mos tri si inceppavano in contin uazione perché la lubrificazione non era all'altezza della modernità dei congegni, sparavano solo quattro colpi l 'ora e senza precisione. Ma alle proteste d ei napoletani che esibivano le rovine degli ospedali e delle chiese protette dalla bandiera nera che ali'epoca faceva le veci di quella della Croce Rossa, Cialdini rispose con il fondo velenoso del suo carattere: «Le bombe non hanno occhi ». Dopo un centinaio di colpi i cannoni si ruppero e non se ne parlò più. Anche quell ' artiglieria che non aveva pretese di modernità fece spesso cilecca perché i proiettili risultarono con le spolette difettose (mal caricati o a ddirittura senza polvere!).
La miopia del generale non comprese i tempi nuovi e continuò a o rganizzare l'assedio scavando parallele, diagonali e brecce come ali 'epoca di Vauban; quando lo scopo era offrire ai difensori, che non chiedevano altro e non avevano quasi mai la propensione al martirio, una ragione per alzare bandiera bianca senza perdere la faccia. Condusse un assedio tradizionale con molto charme e qualche monumentale arrabbiatura . Più che i borbonici che tentarono un paio di s ortite e poi si limitarono a una difesa passiva e a farsi falcidiare dal
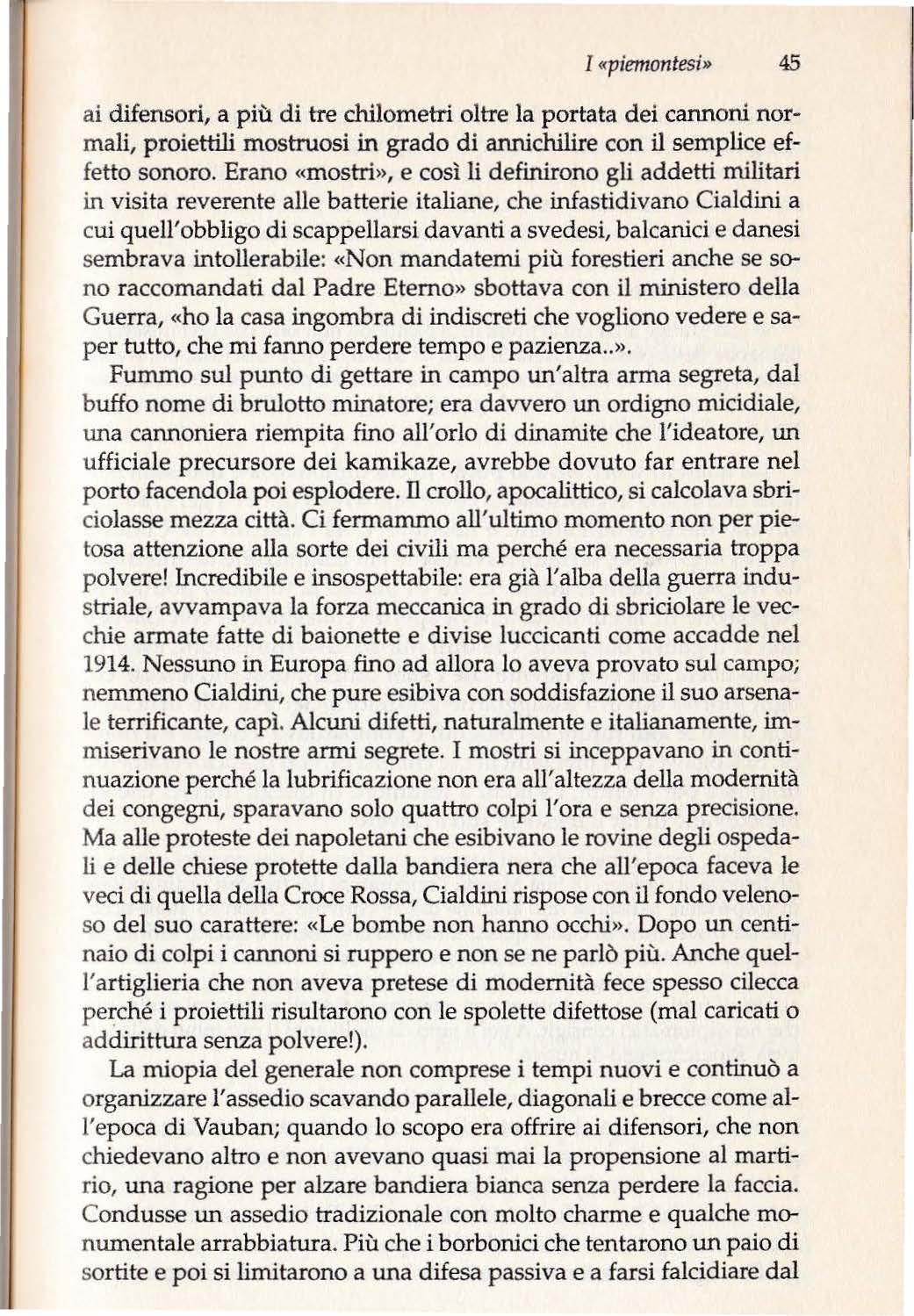
tifo, il suo nemico erano le trame dei politicanti, bestia nera dei nostri gen erali . L'assedio davvero è un'agonia tacihrrna, testarda. Cavour aveva probabilmente dei suoi gallonati collaboratori la s tessa considerazione del re; forse peggiore perché alcuni li aveva incontrati nelle camerate dell'Accademia di Torino. Però sapeva come blandirli. Senti t e cosa scriveva a Cialdini ch e a questa prosa era affeziona tissimo:
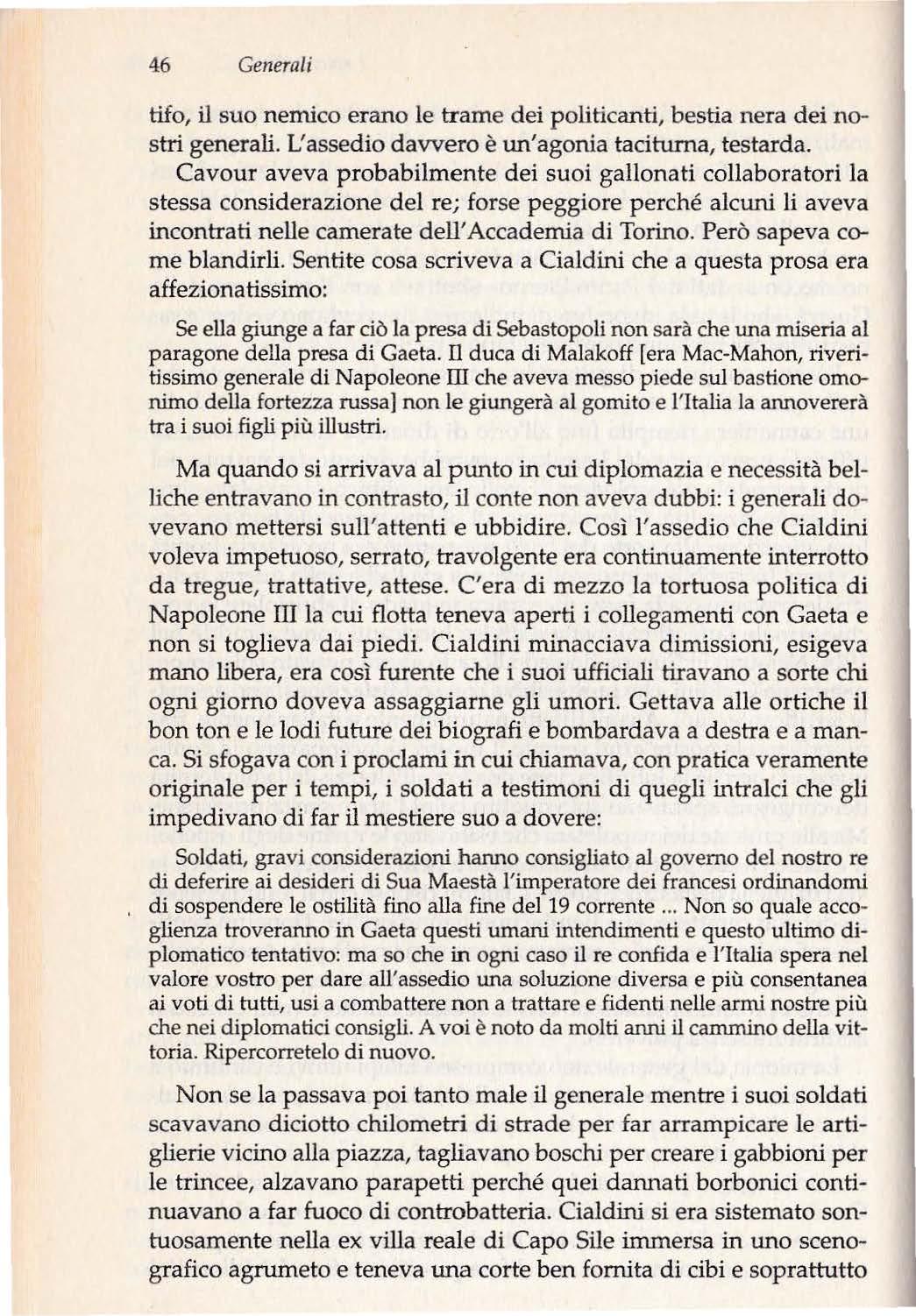
Se e lla giunge a far ciò la presa di Sebastopoli non sarà che una miseria al paragone della presa di Gaeta. Il duca di Malakoff [era Mac-Mahon, riveritissimo genera le di Napoleone ID che aveva messo piede sul bastione omonimo della fortezza russa] non le giungerà al gomito e l'Italia la annovererà tra i suoi figli più illustri.
Ma quando si a rrivava a l punto in cui diplomazia e necessità belliche entravano in contrasto, il conte non aveva dubbi: i generali d ovevano mettersi sull'attenti e ubbidire . Così l'assedio che Cialdini voleva impetuoso, serrato, travolgente era continuamente interrotto da tregue, trattative, attese. C'era di mezzo la tortuosa politica di Napoleone m la cui flotta teneva aperti i collegamenti con Gaeta e non si toglieva dai piedi. Cialdini minacciava dimissioni, esigeva mano libera, era così furente che i suoi ufficiali tiravano a sorte chl ogni giorno doveva assaggiarne gli umori. Gettava alle ortiche il bon ton e le lodi future dei biografi e bombardava a destra e a manca. Si sfogava con i proclami in cui chlamava, con pratica ve ramente originale per i tempi, i soldati a testimoni di queg li intralci che gli impedivano di far il mestiere suo a dovere:
Soldati, gravi consideraziorù hanno consigliato al governo del nostro re cli deferire ai desideri di Sua Maestà l' imperatore dei francesi ordinandomi di sospendere le ostilità fino alla fine del 19 corrente ... Non so quale accoglienza troveranno in Gaeta questi umarù intendimenti e questo ultimo cliplomatico tentativo: ma so che in ogrù caso il re confida e l' Italia spera nel valore vos tro per dare all'assedio una soluzione diversa e più consentanea ai voti di tutti, us i a combattere non a trattare e fidenti neUe armi nostre più che nei diplomatici consigli. A voi è noto da molti anni il camrrùno della vittoria. Ripercorretelo di nuovo.
Non se la passava poi tanto male il generale m entre i suoi soldati scavavano diciotto chilometri di strade per far arrampicare le artiglierie vicino alla piazza, tagliavano boschl per creare i gabbioni per le trincee, alzavano parapetti perché quei dannati borbonici continuavano a far fuoco di controbatteria. Cialdini si era siste mato sontuosamente nella ex villa reale di Capo Sile immersa in uno scenografico agrumeto e teneva una corte ben fornita di cibi e soprattutto
di vini con una cantina che esibiva i succhi delle terre testé redente al fianco del più tradizionale champagne. L'atmosfera di bisboccia era contagiosa. Si restava a tavola dalle dieci a mezzogiorno gustando spesso cacciagione che il re spediva al «suo caro generale»; al pomeriggio una trottata, alle cinque di nuovo a tavola e poi a letto. La tranquilla burocrazia dell'assedio continuava mentre i cannoni infierivano con la razione quotidiana di proiettili sulla città affranta dalle bombe ma soprattutto dal tifo, dalla sporcizia e dalle carogne di animali, incancrenita dall'umido di un inverno particolarmente piovoso. A infastidire il Cialdini e il suo umore dispettoso erano soprattutto le «ispezioni», perché considerava come affronti al suo orgoglio che qualche gallonato personaggio si facesse vedere dalle sue parti. Perdio, quell'assedio era suo e nessuno gli avrebbe rubato la gloria di entrare a Gaeta con le bandiere al vento! Quando si fece concreta la possibilità che gli venisse tra i piedi il nuovo luogotenente dell'ex Regno borbonico (sostituto del Farini che era diventato pazzo), per di più ammiraglio e soprattutto Savoia, Eugenio di Carignano, ne fece una malattia e minacciò dimissioni, rivolte, scandali. Con scarsa educazione mandò a dire che la reggia in cui abitava non aveva stanze disponibili per quell'ingombrante ospite ispettore. L'assedio, nelle pieghe di questi importanti affari, si può dire andasse avanti da solo. La piazzaforte che nei messaggi di Cialdini al Cavour appare «casamattissima» e quasi imprendibile, era in realtà s tata costruita «alla borbonica» (o all'italiana se volete aggiornare i tempi). L'artefice, l'illustre architetto Giacomo Guarinelli, infatti, a veva messo molto estro e fantasia nel disegnare polveriere, spalti e bastioni ma assai meno scrupoloso era stato nella realizzazione poi di quelle sue intuizioni belliche. Aveva insomma risparmiato su calce e mattoni mettendosi in tasca un gruzzolo così cospicuo che tutti a Napoli, a partire dal re, sapevano che si e ra costruito un leggendario e sontuoso palazzo. Tutti sapevano, ma come imponeva il copione nessuno aveva provveduto o era stato punito. Così la fortezza qualificata per «formid abile» in realtà si rive lò assai scadente. Le casamatte e le polveriere, sulla carta a prova di bomba, si sfasciavano al tremare del terreno. Guarinelli, vero cuore di coniglio, alle prime a vvisaglie della vittoria piemontese si era precipitato alla corte di Cia ldini guadagnandosi la qualifica di indegnissimo traditore; ma regalando al generale tutti i preziosi segreti della costruzione .
Il 5 febbraio una bomba scagliata dai piemontesi, forse agevolata dalle volte non proprio impenetrabili, scardinò una polveriera del bastione di Sant'Antonio s fracellando mezza città e seppellendo s ol-

dati e civili. Lo spettacolo di quell' immane esplosione n el racconto dei superstiti ha gli s tessi echi dell'll settembre di New York: I' oscurità causata dall'immensa colonna di fum o, i massi delle fortificazioni scagli ati in aria fino a ricadere in mare formando una diga, le strazianti lame ntazioni d ei moribondi e dei superstiti prigionieri delle case crollate. Cialdini tirò fuori il «modo feroce di far la guerra» che aveva imparato nei sette anni di Spagna e che l o faceva temere dai nemici disabituati a quei metodi: ordinò infatti di continuare a b ombardare i p overacci che cercavano di scavare, ancora sotto choc, tra le macerie, m entre i suoi ufficiali si gustavano lo spettacolo con grand i applausi e invocazioni di «Savoia» e «Italia». Sempre il 5 febbraio, dopo a ltri inutili lutti cau sati dai ritardi nella capitolazione (Cialdini e il comandante borbonico Giosuè Ritucci litigarono per il galateo dell'armistizio e il rispetto del medesimo) com e Dio volle, i due giovani ex sovrani partirono tra salve di cannone, hurrà e commozione generale. Gaeta si arrese al suo implacabile conquistatore, il quale per l'occasione, una volta tanto, trovò nell' inevitabile proclama alle truppe v ittoriose accenti meno retorici del solito:
Soldati, noi combattemmo contro italiani, e fu questo necessario ma do-lo roso ufficio; per ciò non potrei invitarv i a dimos trazioni di gioia, non potrei incitarvi agli insultanti tripudi del vincitore. Stimo più d egno di voi e di me il rad unarvi quest'oggi sull'istmo sotto le mura di Gaeta dove verrà celebrata una gran messa funebre. Là pregheremo pace ai prodi che durante questo memorabile assedio perirono combattendo tanto nelle nostre trincee quanto ai baluardi nemici: la morte copre di un mesto velo le d iscordie um a ne e gli estinti sono tutti ugual.i agli occhi dei generosi . Le ire nostre d'altronde non sanno sopravvivere alla battaglia. ll soldato di Vittorio Emanue]e combatte e perdona. Firmato Cialdini.
Che le sue ire non sop ravv ivessero alla pugna era vero solo in parte: n e sapeva qualcosa il genera le Gennaro Fergola che a Messina continu ava impavido a far sven tolare l' ultima bandiera borbonica del Regno. Furibondo perché doveva r itardare i festeggiamenti per il trionfo e raccoglie rne i frutti, infastidito dalla prospettiva di un altro assedio che s i ann u nciava l ungo e n oioso, Cialdini si sca tenò. Scrisse a l Fergola una nota che anticipa metod i di guerra davvero di a ltri tempi:
No n darò a lei e alla s u a guarnigione capitolazioni di sorta dato che cons idero la di lei condotta aperta ribellione al Regno d'Italia: dovrà arrendersi a discrezione. Se farà fuoco sulla città farò fucilare dopo la presa della cittadella tanti ufficiali e soldati quan te sar anno state le vittime causate dal s uo fu oco sovra Messina : e i beni di lei e degli ufficiali saranno confiscati per indennizzare i danni recati alle famig lie dei cittadini.
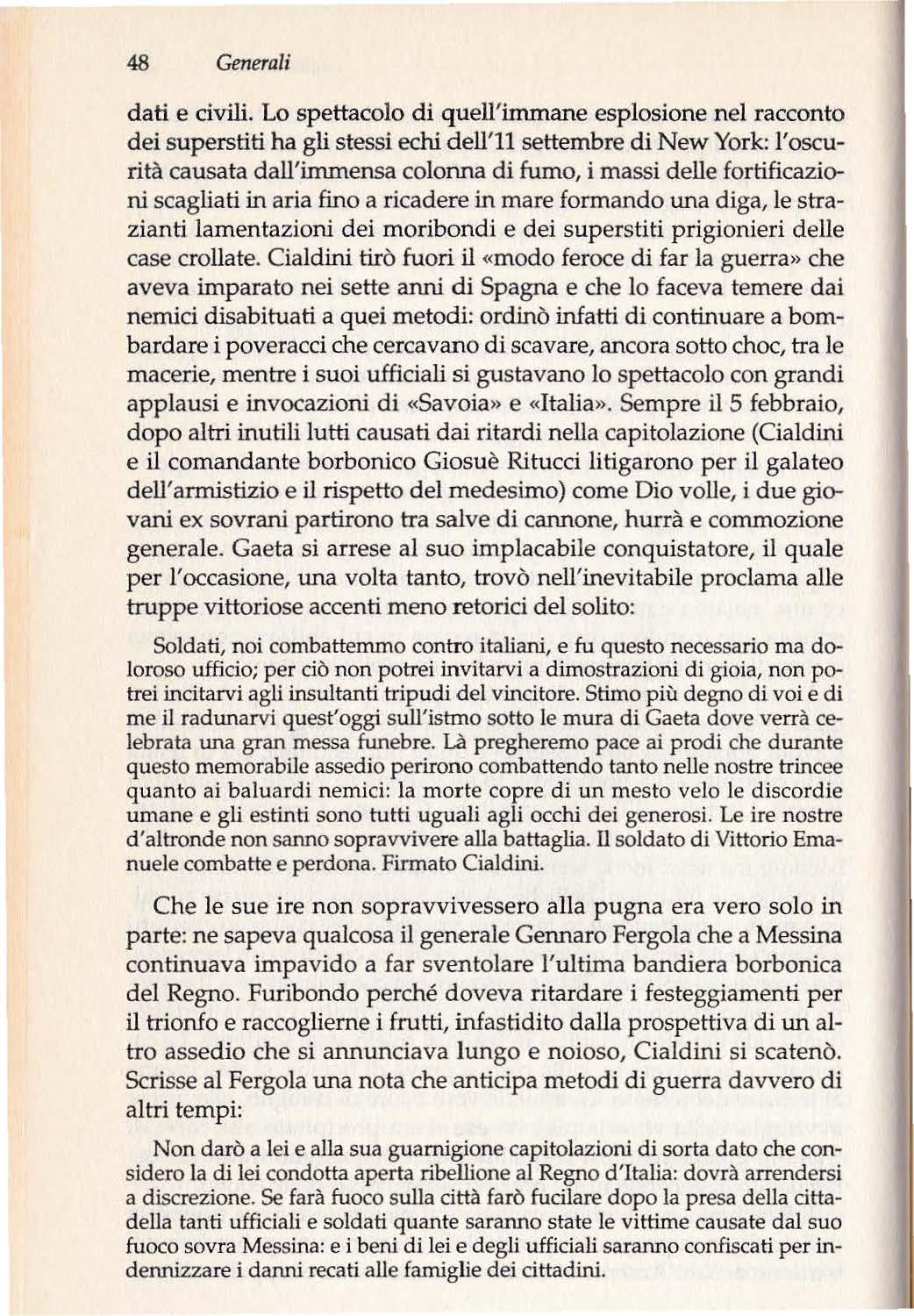
E aggiungeva che avrebbe consegnato il generale e i suoi subordinati al popolo evidentemente aspettandosi un linciaggio. Per fortuna il Pergola, forse sconcertato da tanta barbara ferocia, che era distante dai costumi delle paciose guerre borboniche, si arrese e non fu necessario che Cialdini si macchiasse di simili nazistici eccessì.
La vittoria gli rese, secondo la napoleonica usanza, il titolo di duca di Gaeta con tanto di stemma che portava disegnata una rocca e il motto «Caieta ltaliae resti tuta». Primo nucleo di quella geografia nùlitar-nobiliare un po' da operetta che da Gaeta attraverso Neghelli, il Sabotino e Addis Abeba sparirà nel giro di un giorno dalle pagine dell'araldica e d e lla Storia. Iniziava quell'abitudine tutta italica di esagerare nelle medaglie, nelle lodi, nella retorica marmoreo-funeraria che accompagnerà i nostri duci fino alla catastrofe del 1943. I giornali raccoglievano fondi per donargli spade d'argento e corone d'oro, poeti più o meno titolati lo salutavano incomparabile duce dell 'esercito, si sprecavano maiuscole e superlativi che tanto non cos tano nulla e fanno sempre bella figura . Gli dicevano che e ra giunta la sua ora, e lui se lo lasciava dire, e lo pensava anche. Con metodo aveva costruito in quegli anni un suo personalissimo partito che lo definiva, senza arrossire, «il Garibaldi in uniforme» ed esplicitamente puntava a contrapporsi alla setta nobiliare piemontese. Aveva scelto i suoi sostenitori spigolando tra i nomi più al tisonanti dell'aris tocrazia nùlitare di quell'altra Italia che, dai ducati alla Sicilia, era stata, come diceva il suo motto, a rditamente e non sempre a suo piacere restituita, più che alla patria, ai Savoia. Basta. È l'ora di riprendere la narrazione da quella primavera del 1866 in cui l'esercito italiano gonfio di uomini e cannoni si preparava a ripercorrere le strade che una pace venuta troppo presto gli aveva precluso sei anni prima. Al momento di cominciare a scambiar cannonate si era discusso, e con foga, su chi dovesse comandare l'esercito. I nonù non erano tanti: Cialdini, appunto, seguito come una cometa dal codazzo dei «cialdinisti» che gli attribuivano gran carattere e talenti da uomo for te. Non pochi lo proponevano a capo dell'esecutivo per far marciare diritto quel paese un po' zoppicante. Aveva titoli ma non possibilità Giovanni Durando, per quella fama di iettatore che in Italia avrebbe tagliato la carriera anche ad Annibale e Napoleone. A Custoza, puntuale, la sua cattiva stella gli tenne d ietro: si beccò una pallottola nelle prime fasi della battaglia e il comando della divisione che ebbe il poco ambito ruolo di protagonista passò ad altri. C'era Agostino Petitti di Roreto, modesto, grigio ma favoritissimo dal re che lo voleva perché così avrebbe comandato

lui. E poi La Marmora e la sua setta piemontese. Tutti i ministri della Guerra a parte il Fanti erano per principio sue creature, espressione del modo dj far la guerra del tempo dei padri . Il re non lo poteva soffrire, lo giudicava modesto s ul campo e poi troppo pieno dj sé per lasciar s pazio al suo sovrano. Ma aveva abilità nell' intrigo e considerava quella guerra un suo affare privato. Come fare allora per non scontentare nessuno e trovarsi con lo stato maggiore dilaruato dalle beghe e dai regolamenti di conti d elle «chiesu ole», come dicevan i contemporanei, dell'esercito? Fra l'altro i due sfidanti avevano presentato piaru opposti che rispecchiavano gli stili di guerreggiare: seguire la veccrua strada attraverso il Mmcio e le fortezze del quadrilatero verso nord , ingiungeva La Marmora , una v ia disegnata dalla geogra fi a per tutti gli eserciti che da sempre si scambiavano fendenti in quella zona. Oppure passare il Po animosamente in Emjlia e buttarsi a l galoppo a tagliar la ritirata dell'imperial armata, come suggeriva il CiaJdinj_ L'idea per la verità non era s ua, l'aveva rubata al collega di Spagna, Manfredo Fanti. Era lui l' uomo che aveva con pazienza come ministro della Guerra provveduto alla creazione dell ' esercit o italiano riuscendo in un ' impresa che, seduti in poltrona oggi, appare quasi sovrumana: innestare ne l! ' armata sabuada gli eserciti dei piccoli Stati, mescolare genti che parlavano dialetti tra loro q u asi incomprensibili, culture non solo militari spesso incompatibili, reclute e ufficiali che si guardavano in cagnesco. E per giunta, nel tempo libero, aveva provveduto anche a sistemare le fortificazioru al confine con l'Aus tria. Tutto tra bilanci striminziti, gelosie, poJemjche, guerre in corso. Certo, si criticò, aveva piemontesizzato, sollevando rancori ed esportando i dHetti dell 'armata sarda, che erano tanti. Ma lo sforzo fu titaruco . Proprio da Fan ti La Marmora aveva inizfoto a regolare i conti: e rano quelli che lw defiruva «poco più che avventurieri». CialdW era ormai il caposcuola, ritiratosi il Fanti dal prosceruo dopo la morte del Cavour di cui era una creatura, terrrunata l'immane impresa. State certi che lo avrebbe azzannato se già aveva giurato antipatia imperitura al Cavalli che pure era piemontesissimo; e per un problema di carriaggi e salmerie! Anche con il fondatore dell'esercito italiano lo scontro, ai non addetti ru lavori, poteva sembrare meschino. I due generali s i erano scannati perché Fanti n e l suo ordinamento aveva corretto una delle rusposizioru prescritte dieci anru prima dal La Marmora: i reggimenti di fanteria non eran più orgaruzzati su quattro battaglioru ma su tre e il battaglione su sei anziché su quattro compagrue. Apriti cielo ! Per La Marmora era s tato come se un nuo-
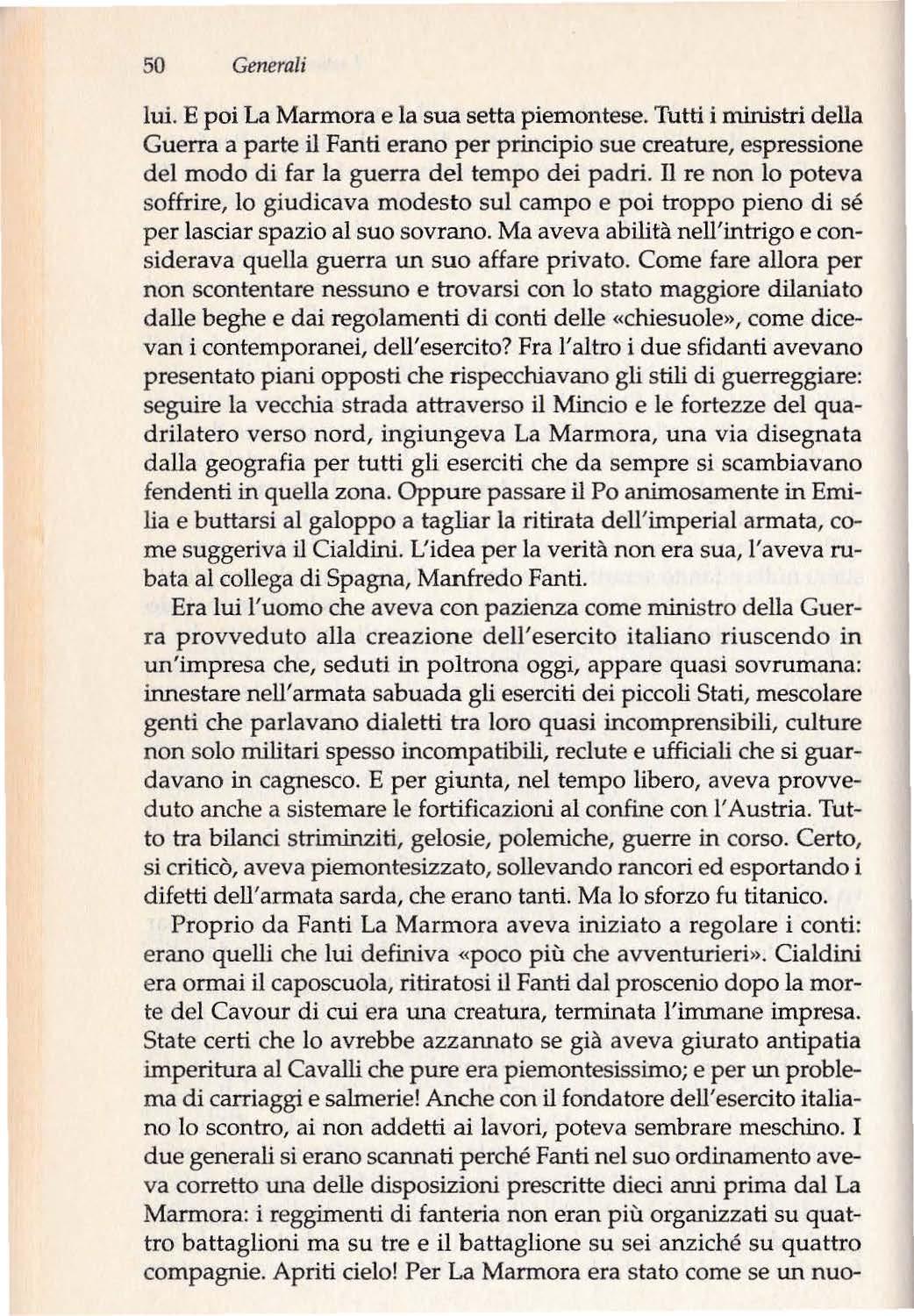
vo Lutero avesse appeso ai portoni delle caserme una rie<lizione militaresca delle sue tesi eretiche! Se proprio si vuole cercare un motivo di strategie dietro quel contrasto che incendiò il Parlamento italiano come era accaduto solo per la liquidazione dell'esercito garibaldino, si poteva mettere in campo la scelta di un esercito più agile e manovriero, alla francese, come lo voleva il Fanti, al posto di quello più pesante e metodico come lo aveva immaginato il La Marmora. Dettagli se vogliamo. Ma a far infuriare il piemontese era soprattutto la constatazione che si cercava di modificare il suo assetto, per questo da conside rare come intoccabile perfetto e quindi eterno. Marzo 1861: aveva aperto le ostilità il La Marmora con un' interpellanza che assunse, per i toni e la durezza delle argomentazioni, l'aspetto di un a ttacco personale.
Per talwù queste sono semplici insignificanti modificazioni ma per chi è al corrente delle cose dell'esercito (come è naturale che io lo debba essere) si rivela qualcosa di più, si rivela un cambiamento...

La Marmora cerca ev id entemente la rissa e ass ume il t ono del maestro alle prese con un praticante senza titoli che sta per commettere, per ignoran za, monumentali sciocchezze:
Mi lagno perché se qualcuno si fosse rammentato che io forse, mi si permetta che lo dica, più di ogni altro aveva viaggiato per istudiare le estere organizzazioni, se qualcuno dico fosse ricorso a me, io avrei probabilmente ris parmiato tante inesattezze che sono sfuggite in quella relazione e avrei forse anche provato che quelle che oggi l'onorevole signor ministro addimanda le sue idee, sono idee assai antiche, le quali in gran parte sono state abbandonate. Come per esempio quelle che per combattere un grosso battaglione ci voglia proprio un altro grosso battaglione quasi che due battaglioni piccoli che corrispondono alla s tessa forza n on s iano più acconci ancora.
Non c'è che dire: la guerriglia all'interno dei vertici militari era davvero senza esclusione di colpi. E non si fermava lì. Della Rocca, che era aiutante di campo del re, l' uomo che aveva acquisito meriti stroncando al prezzo di decine di morti l'insurrezione di Torino ecomandava una divis ione, aveva appena sfidato a duello il s uo comandante: vecchie ruggini ministeriali, La Marmora voleva infatti per scrupoli costituzionalistici (chissà che non c'entrasse anche qualche problema di pol trone) togliergli il comando della ex capitale. Era dovuto intervenire il re per evitare la vergogna di quello scontro che av rebbe fatto ridere l'Europa. E non dimentichiamo Giuseppe Sirtori, ex garibaldino ora con le spalline di generale che, probabilme nte vedendo la scarsa considerazione in cui lo tenevano i professionisti di Torino e per il suo caratteraccio, aveva litigato si può dire con tut-
ti, tra dimissioru denunce Iettere più o meno anorume ai giornali e naturalmente duelli che erano un po' la conclusione inevitabile di ogni divergenza militare.

I generali di Custoza non vennero sottoposti a corte marziale (al contrario dell'ammiraglio Persano che come vedremo pagò in parte per tutti). Troppo stretto era ormai il legame tra i condottieri e la politica: essi erano una parte costitutiva di quella gerontocrazia austera e paesana, metterli in discussione avrebbe inevitabilmente significato far tremare la struttura stessa dello Stato. Era ben avviato come abbiamo visto, il metodo pessimo di nominarli senatori e mirustri. Una pratica che, per esempio, nell'ammiratissima Prussia sempre si evitò.
Peccato per questa indulgenza. Alcuru dei generali ben avrebbero meritato il banco degli imputati e un paio anche il plotone di esecuzione che ne addomesticasse gli istinti. Così non si saprà mai esattamente come e su iruziativa di chi venne combinato il colossale pasticcio di dividere l'esercito in due per consentire ai litiganti, La Marmara e Cialdiru, di far ciascuno la sua guerra e in tutta comodità separati da almeno centocinquanta chilometri. Senza aver orgaruzzato, volontariamente, un sistema per coordinare il disegno strategico comune. Passata la buriana, e con pochi danru, per molto tempo i protagorusti di quella incredibile sconfitta continueranno a ingombrare il Parlamento, le tribune delle parate e le prime pagine dei giornali. La Marmara e Cialdiru inaugurarono un genere che è nostro come l'endecasillabo e il melodramma: il memoriale autogiustificatorio degli sconfitti. Con titolazioru che vanno dal mirumalista Un po' più di luce sugli eventi politici e militari dell'anno 1866 del La Marmara all'erculeo Ho difeso la patria di Graziaru, eguale è lo stile: curialesco, con la prosopopea avvocatesca della provincia, tipico di una cultura o incultura che dai nobili del Risorgimento alla piccola borghesia dell'ltalietta punta sullo spaccare il capello in quattro, sull'imbrogliare le carte, diffondere fumo fino a trasformare la colpa in difettuccio, in sfortunato accidente del destino. Con la chiamata a correo, naturalmente, nell'ordine, di politici incompetenti, soldati vigliacchi, colleghi infidi, miserie ataviche di un paese non all'altezza dei suoi immaginati destiru. Con salomoruca stupidità dividemmo la nostra schiacciante superiorità in soldati cavalli cannoru materiale in due: 120.000 uomini, 37.000 cavalli e 456 cannoni, due dei tre corpi d'armata restarono sotto la mano di La Marmara che era capo di stato maggiore del re, comandante solo nominale, accampati sul Mincio. Il Quarto corpo
toccò a Cialdini, ma così grosso (otto divisioni) e ben armato da pareggiare quasi quello del detestato rivale. Il r apporto così stretto con la politica lo si vedeva bene dal modo in cui quelle armate erano cos tituite: non c'era uno stato maggiore che preparava con burocratica dedizione la guerra. I generali scrivevano direttamente a presidente del Consiglio e ministri, esigendo, polemizzando, minacciando. Sembra una favola ma è s toria: Cialdini strappa al neoministro Pettinengo, che ha sostituito l'arruolato La Marmora, due d ivisioni «per fargli cosa gradita» ed evitar rogne. E vero: solo l'idiozia umana può dar l'idea dell'infinito. Con una forza così mostruosa, centoventi.mila uomini (non ha mai diretto eserciti così giganteschi) La Marmora si awia al fronte due giorni prima che le armate si mettano in moto verso il nemico. Come usava Napoleone. C'è da capirlo, bisogna dipanare l'ingarbugliata matassa delle faccende nazionali e internazionali. Fino all'ultimo d eve restare a Firenze a dettar te legrammi, sciogliere congiure ministeriali, impartire ordini ai fedelissimi Chlssà cosa frullava per la testa a La Marmora in viaggio verso il suo comando dove il Mincio si arriccia nella pianura . La dichlarazione di guerra era già stata consegnata d a un distinto ufficiale al comando austriaco, all' arciduca Carlo, figlio d'arte e ammalato di «Deutsche Siidselmsucht», la nostalgia tedesca per il Sud. L'aveva accolta, s i scrisse, senza pronunciar parola. Rimuginava mugugni e impuntature il generale che aveva deciso di fare una deviazione verso il Po dove si trovava il quartier generale di Cialdini. I testimoni lo descrivono depresso, stanco, logorato da quella diplomazia dei telegrammi che aveva fatto da penosa premessa alla dichiarazione di guerra. Per giorni infatti si era presentata la catastrofica possibilità che combattessimo come nel 1848 in disgraziata solitudine. Del rivale si sa cosa pensava; esattamente quello che un altro dei condottieri p iemontesi, Raffaele Cadoma, scriveva senza far ricorso alla metafora: Prepotente, sospettoso, di temperamento istabile, più pronto a comandare che a obbed ire, eppu r timoroso di una grande responsabilità, sempre pronto a evitare il comando supremo. In realtà non sapeva comandare e non s apeva obbedire.
Era, quasi, la verità. Cialdini nei suoi tortuosi rovelli aveva pubblicamente fatto il ritroso scrivendo a La Marmora il 1 ° maggio quando già si lucidavano i fu c ili e si oliavano i cannoni:
lo non accetto un comando maggiore di due o tre divisioni al più ... non mi sento forza né capacità di assumere comandi più importanti né di concorrere alla condotta generale della g u erra la cui responsabilità declino comp letamente.

Solo che poi aveva manovrato per averne otto, di divisioni. E si dichiarava fuori dalla mischia; il comando supremo voleva glielo offrissero gli a ltri. E state certi che avrebbe accettato! Anche i piemontesi avevano i loro difetti: arroganti, approssimativi, appiccicati al regolamento, privi di qualsiasi virtù che a ssomigliasse allo spiri to di iniziativa, umanamente meschini. Se un esercito si poteva improvvisare, e lo si e ra fatto con buoni risultati, i generali non si potevano certo inventare . Sul colloquio dei due quel 17 giu gno s i può solo congetturare: si misero d'accordo di non m ettersi d'accordo, di far ognuno la propria guerra fin gendo di coordinarla. Sulle tecniche da adoperare, la «macchia d'olio» o la «conquis ta fulmin ea», non si sprecarono considerazioni storicistiche. La spagnol esca cortesia dei messaggi che si scambiarono prima, durante e dopo la battag lia e che arrivavano quando già la situazione s ul campo e r a cambiata, serviva a occultare la reciproca indifferenza. La Marmara se la cavava così :
La nostra azione rispettiva er a troppo evidente perché fosse d'uopo di prendere accordi speciali . Ciascuno dalla parte sua avrebbe agito secondo le occorrenze con la massima energia in modo da battere o paralizzare il nemico attaccandolo ora da una parte o ra dall'altra
Bella q u esta immagine dell'austriaco sballotta to tra i fendenti delle due armate e opportunamente incapace di pensare qualsiasi piano che non fosse quello di farsi battere. E il 21 ribadiva:
Ella riceva am pia facoltà di cominciare e proseguire le operazioni di guerra in quel senso che le sembrer à più opportuno a seconda delle circostanze. Solo la prego di tenermi sempre al corrente di ogni cosa.
Tanto, dovevano esser si d e tti i due astuti stra tegh i, g li austriaci non aspettavano a l tro ch e chiudersi n elle fortezze e batter serla. li marchingegno per quel patto sciagurato lo trovarono in un sostantivo: «dimostra zione », des tinato a cospicue fortune nel l essico dei nostri genera li . La parolina la scovò il Cialdini in un teleg ramma del 21:
Il mio passaggio del Po deve essere preceduto da seria dimostrazione sul Mincio. Avvertitemi al più presto se pensate farla il 24.
Nel voca bolo c'è la chiave del trucco: se l'arma ta del Mincio fa una dimostrazione, che v uol dire una finta, allora significa che l'attacco vero, quello principale, t occa all'annata d el Po . Deve aver esulta to il Cialdini quando lesse il telegramma di risposta firmato dal capo di sta to maggiore Agostino Petitti:

La Mannora in giro per dare istruzioni. Frattanto credo di poterla assicurare che il giorno 24 sarà fatta dimostrazione sul Mincio secondo informazioni che si avranno sul nemico. Al ritorno di La Mannora maggiori schiarimenti
Passano poche ore ed ecco «gli schiarimenti»:
La Mannora ritorna to. Domani si passa il Mincio e la cavalleria perlustra il paese al di là.
La parola «dimostrazione» nella risposta del generalissimo era per la verità scomparsa; ma per Cialdini non era stata neppure respin ta e quindi se ne riteneva soddisfatto, anzi soddisfattissimo. E cominci ò a prepara re ponteggi e d ivisioni per la sua guerra principale.

Che volete, aveva un carattere difficile. Oppose un secco no alla richiesta di aggregare alle sue armate il principe ereditario Umberto spedito in campagna per cominciare a costruirsi una fama guerriera da Savoia : sapeva bene ch e aver tra i piedi il regale rampollo avrebbe costituito un bella preoccupazione e un 'eventua le disgrazia avrebbe certamente aumentato il mito savoiardo, ma distrutto la sua carriera. Cosi Umberto fuù con le colo1rne di La Marrnora e a Villafranca, impavido, dissero le cronache molto generose, resistette con i suoi quadrati alle cariche degli ulani austriaci: episodio marginalissimo della battaglia per la verità, che venne gonfiato per attenuare quelli grossi e sfortunati.
Soddisfattissimo era pure La Marrnora. A tutto pensava meno che a una finta così utile ad agevolare la gloria del generale-avventuriero. Il 24 infatti non si mossero poche truppe e molta cavalleria, quanto serviva per far credere al nemico che affrontava l'attacco principale rivolgendo la sua attenzione al fronte sbagliato . Si mosse l'intero l'esercito italiano. Ma lo fece con l 'allegra disinvoltura di una scampagna ta, senza un piano tattico, alla rgandosi senza prudenza in ogni direzione. La cavalleria che doveva esplorare non esplorò, restò dietro la fanteria che si muoveva tra polvere, soste nei paesi e nei fossi, canzoni marziali e una coda di carriaggi inutili, ingombranti e pericolosi. Tanto gli austriaci, tutti e ran pronti a giurarlo a cominciare dal generale in capo, non si sarebbero fatti vedere. Quel giorno La Marrnora scia lacquò il poco credito strategico che anche i su o i peggiori nemici gli concedevano: al momento in cui gli austriaci si abbatterono come un ciclone su una parte d elle sue sparse truppe perse le tteralmente la testa. Cominciò a galoppare a destra e a manca seguito penosamente dal re sempre più rabbuiato e critico che cerca-
va di fargli accettare consigli dettati dal buon senso e trasmettergli un po' della sua detenninazione, virtù che non gli faceva difetto. Per molte ore nessuno seppe più nulla di lui. Il comando supremo era evaporato, sparito, i generali dovettero rassegnarsi a decider d a soli o con il collega a cui davano il fianco, senza conoscere la situazione complessiva, ingannati da e pisodi isolati che facevano loro pensare che il disastro fosse molto più definitivo o che al contrario stessimo vincendo: vennero fuori i talenti di a lcuni (Govone, Bixio), l' inadeguatezza di altri, la maggioranza . È una disgraziata evenienza che si verificherà tante altre volte: quando si mette male i generali italiani, invece di pensare come Napoleone a Marengo che la battaglia n on è persa fino a quando c'è un battaglione intatto, scompaiono.

Il comandante in capo, mentre i soldati si battevan o con sorprendente determinazione per un esercito così fresco, si gettò nelle re trovie dando tutto per finito . Se invece s i fosse premura to di ascoltare i rappo rti si sa rebbe accorto che avevano combattuto ed eran o parzialmente disgregate solo cinque divisioni s u venti, che gli au striaci esausti, slegati, con perdite superiori, s tavano pegg io di noi e p ensavano solo a come rammendare il rito rno offensivo degli italiani. Emise ordini di ritirata gen erale, di far saltare i p o nti, di abbandonare al n e mico carriaggi cannoni divisioni intere che stavano consegnando posizioni intatte mugugnand o incredule, quasi sull 'orlo d ell'ammutinamento .
E Cia ldini? A un certo punto della giornata ricevette un telegra mma d el re in cui si annunciava che l'arma ta d el Mincio era impegnata non in una dimostrazione ma in una batta glia furibonda e gli ordinava di e ffettuar subito il passaggio del Po. Vittorio Emanuele, che pure non era stratega, aveva intuito: er a ormai sera, l'arciduca Alberto avvisato dei movimenti di quelle otto divisioni che ne insidiavano il fianco avrebbe dovuto riorganizzarsi e si poteva tentare la rivincita che avrebbe cancellato tutte le vergogne. Cialdini, a cui queste grandi notiz ie dovevano aver sollevato acute speranze, prudentemente si tenne fermo. Accamperà poi buone ragioni: i rischi di passare il fiume con tutte quelle armate avendo una sola e incerta via di ritira ta, la necessità di prendere tempo per far passare le artiglierie, l a na tura del terreno che fitto di fiumi e corsi d'acqua avreb be ra llenta to le manov re. Tutto vero, ma c'è da giurare che il duca d i Gaeta avev a già intuito ch e il s uo più p ericoloso avversa rio s i era e liminato con le propri e incapacità e la guerra s tava p e r diventare interamente s u a . Stette fermo e infatti gli a rri vò alle quattro e mezzo un second o te legramma, questa volta del sempre più imbambolato La Marrnor a:
Austriaci gettatisi con tutte le loro forze contro corpi Durando e La Rocca li hanno rovescia ti . Non sembra finora che inseguano. Stia quindi all'erta. Stato armata deplorabile, incapace agire per qualche tempo, cinque divisioni essendo disordina te.
Eran passa te undici ore dalla battaglia, il cielo s tava p e r spegnersi, n essun austriaco s i e ra fatto vedere verso le n ostre p osizioni. La Marmora raccontava falsità e si prep arava a ritirars i oltre l ' Adda: lo fermarono con m o di brusdù g li altri gene rali, sa re bbe stata la fine del Risorgimento. Cialdini invece riunì i suoi in un informale consiglio: cosi informale che, esposta la situazione o quella che si pensava, lasciò capire in modo esplici to che era deciso a ritirarsi dal Po per coprire Bologna. I gen erali, che per seconda re le volontà di quel dispotico comand ante avevano pre dis p osizi o n e, furono naturalmente tutti d 'accordo. Si fece marcia indietro. Nei misteri di Custoza c'è anche la d a ta d elle dimissioni di La Marmora: il 24 stesso dice qualc uno, il 26 sostiene lui. Dettagli. Cialdini divenne cosl il capo supr emo e si la nciò dopo due settimane verso nord insegue ndo un esercito che n o n c'era più. Gli austriaci avevano sposta to le truppe sul fronte prussian o dove von Moltke stava annie ntando l' intarmalito impero. li Veneto p erò non lo conquistò lui. Ci a rrivò d a Napoleone III e anzi rischiammo, quando la Prussia, egoista, fermò le operaz ioni senza aspettarci, di essere annienta ti dagli a u s tri aci che avevano le mani libere.
Il 13 settembre 1892 a Livorno la vita si fermò. Chius i gli uffici, i negozi, le v ie principali della città listate a lutto. Nella piazza Vittorio Eman uele mano v ravano per rendere gli o n o ri tre reggimenti di fanteria, il r eggim ento di cavalleria Catania, l 'artiglie ria e i reali equipaggi. Si rende vano g li ultimi o nori al genera le Cia ldini. La salma imbalsamata d ai professori Bracchini e Tedeschi, sommer sa da d ecorazioni medaglie ordini conquistati nel corso di un'interminabile ca rriera restò a lungo nella s tanza al piano terra d el modesto villino di vi a Carlo Bini. Il carro funebre si mosse poi verso Pisa dove la salma fu tumulata. Sull'affusto di cannon e che la trasportava, la grande corona del re ch e lui n on aveva voluto al s u o fianco ne lla sfortunata campagna del 1866: «Umberto I al prode soldato, a ll 'amico fedele» .

Come muore un generale
I t estimoni ch e, d ap prima s tupefa tti poi atterriti, avevano assistito a quello spetta colo magnifico e crudele con co rdavano tutti s u un fa tto: il s ilenzio. Sulla valle di Balaclava a due passi da Sebastopoli,
in Crimea, quando la cava lleria inglese aveva cominciato a muoversi prima al passo poi al trotto sull'erba bassa, e ra scesa una calma plumbea; qualcuno rammentò che si poteva persino sentire tintinnare le bardature dei cavalli. Poi il fra stuono d egli zoccoli come una sinfonia che cresceva via v ia che il passo d egli animali aumentava di frequenza e d ' intensità, s'impadroru d e lla valle. Tutto è nitido come fissato sotto una luce troppo cruda. In testa stava Lord Cardigan, uno di quei tipi dei quali si dice che n eppure il diavolo farebbe loro paura, con la scintillante uniforme dell 'Undices imo ussari, il suo reggimento privato: rosso, blu r ea le, pelliccia, la «petisse» portata non a tracolla ma come una gi ubba . Quell'uomo s tava conducendo seicento soldati alla morte e lo face va guardando fis so davanti a sé verso la collina in fondo alla valle dove u omini in pesanti cappotti grigi, i soldati russi, si affannavano atto rno ai cannoni confondendosi con il colore d ella terra. In un' incredibile sar abanda di equivoci, di ordini sbagliati, di ripicche personali (tutti gli eserciti in fondo si assomiglian o) g li aveva no ordinato di andare a riprendere i cannoni che i russi avevano strapp a to agli ingles i in una scaramuccia; lui con furo re autodistruttivo e s tupido eroismo s tava obbedend o. A costo di un massacro voleva cacciar via il nemico a p eda te d a quegli affus ti . Il buo n senso ha la ma rcia lenta e difficile.
Le divise d el Tredicesimo dragoni leggeri, dell ' Undicesimo u ssari e d e l Diciassettesimo lancie ri e r ano s piegazza te da quella g u erra crud e le dove i disagi il fango il cole ra facevano più vittime d elle battaglie. Lord Cardigan, che s i era posto alcuni metri da vanti alla p r ima linea d ei dragoni, con la spada sguainata e la voce ferma d ava gli ordini agli u o mini: p asso, trotto. C'era da completare, prima di arriv are ai cannoni, poco più di un chilome tro; tanto, troppo visto che altri cannoni erano piazzati ai lati della valle e avrebbero preso d'infilata quei temerari. Tra le divise sporche dei solda ti inglesi, in prima fila s e ne dis tinguevano due linde e di ve rse. Trottavano con bello stile cercando di s ta r dietro al ritmo allunga to di Cardigan che montava Ronald, il suo cavallo prefe rito, un sa uro di s traordinaria be llezza e potenza. Erano due ufficia li d e ll'esercito piemontese: il luogo ten ente Landriani, animoso ufficia le del Piemonte Reale e il maggiore G iuseppe Govon e, adde tto allo stato maggiore della coalizione che si b a tteva contro i ru ssi. Erano s u una delle colline che come una mano avv iluppavano q u e lla vall e senza a lberi . Potevano reci tar la parte di testimo ni perché in quella ass urda battaglia nata d a un puntig lio s uicida no n c'entravano niente. Ma quella carica era sembrata loro così scenografica, così irripetibile in un' epoca in cui orma i i can-
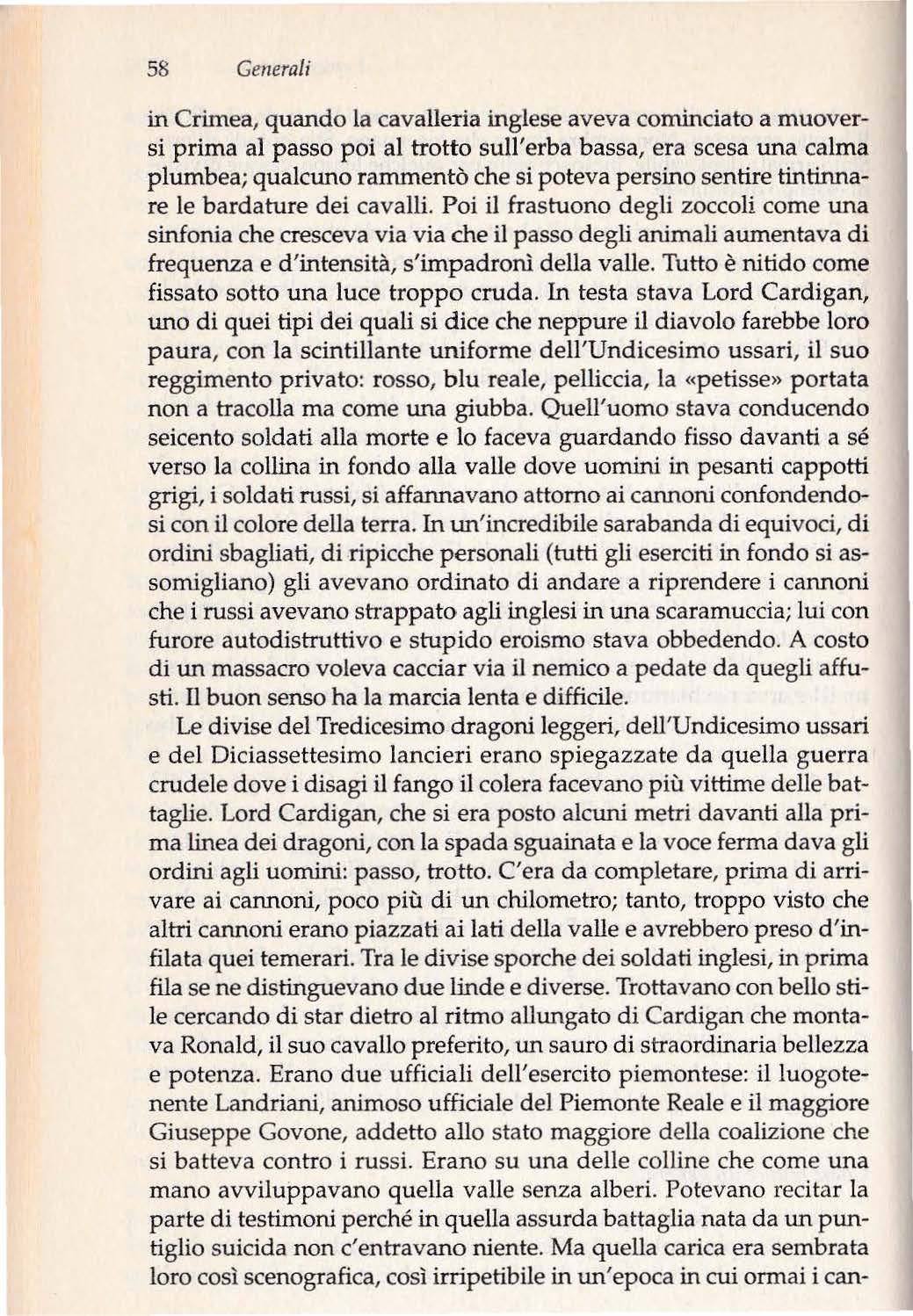
noni avevano costretto i cavalieri a metter prudenza e a rassegnarsi a fare gli esploratori, che non avevano voluto rinunciare. Accettare che i tempi sono cambiati è difficile, soprattutto se sono cambiati in peggio. Così si moriva per un puntiglio estetico. Si andava insieme all'inferno allegramente.
Si erano sistemati sulla estrema destra della prima linea insieme a un maggiore polacco (come poteva non esserci un rappresentante di quei folli cavalieri?) quando accadde qualcosa di inspiegabile che turbò l'ordine perfetto, da campo di manovra, con cui si stava svolgendo la carica non ancora infastidita dalle cannonate. I russi s tavano infatti prendendo la mira e controllando gli alzi dei cannoni. Un ufficiale, che i due italiani conoscevano benissimo, il capitano Nolan, una vita piena di rumore e di furore, grande esperto di cavall eria, si gettò galoppando come un pazzo davanti alla prima linea; sorpassò Cardigan e, con la spada puntata e urlando frasi incomprensibili in quel baccano forsennato, puntò obliquamente verso destra come se volesse tirarsi dietro la brigata . Cardi gan inferocito urlò: «Non così! Dobbiamo mantenere il passo». Aveva pensato che l'ufficiale avesse perso la testa e cercasse di ridurre, contro ogni buona regola, il tempo in cui sarebbero rimasti sollo il fuoco. Cosa cercasse di fare Nolan non s i scoprì mai. Della carica era il principale responsabile: era s tato lui a portare l 'ordine di attaccare, qualcuno dice che lo aveva modificato scambiando per e rrore le batterie russe che si dovevano conquistare. Una granata russa, una delle prime che fioccarono addosso agli inglesi lo colpì in pieno, il cavallo s i voltò e con l 'ufficial e sconciato rigido in sella, lanc ia ndo un urlo strazian te, cominciò a ga loppare nella direzione opposta a quella dell'attacco. Attraversò tutte le schiere inglesi prima che il suo cavaliere cadesse a terra fulminato. Adesso le granate di una trentina di cannoni fi occavano, i primi shrapnel a mitraglia passavano alti, poi cominciò a piovere piombo sopra le schiere fitte che avevano preso un galoppo leggero sempre tenute a bada dall'occhio severo di Lord Cardigan. Ogni colpo adempiva al s uo dovere di nuocere e sfasciava schiere di uomini e cavalli. Govone si era voltato verso il compagno per gridargli, in quel macello, «fa caldo!»; poi aveva spronato in direzione di quei cannoni che sembravano inawicinabili. Ma Cardigan teneva in pugno i suoi e rimandava indietro tutti quelli che cercavano di allungare il galoppo spezzando l'allineamento. Quando Govone si era volta to Landriani non c'era più, certo colpito. La mitraglia cadeva ormai come le gocce di un temporale e acciaccava percuoteva annichiliva la brigata che si raccoglieva come per trovar forza e andava
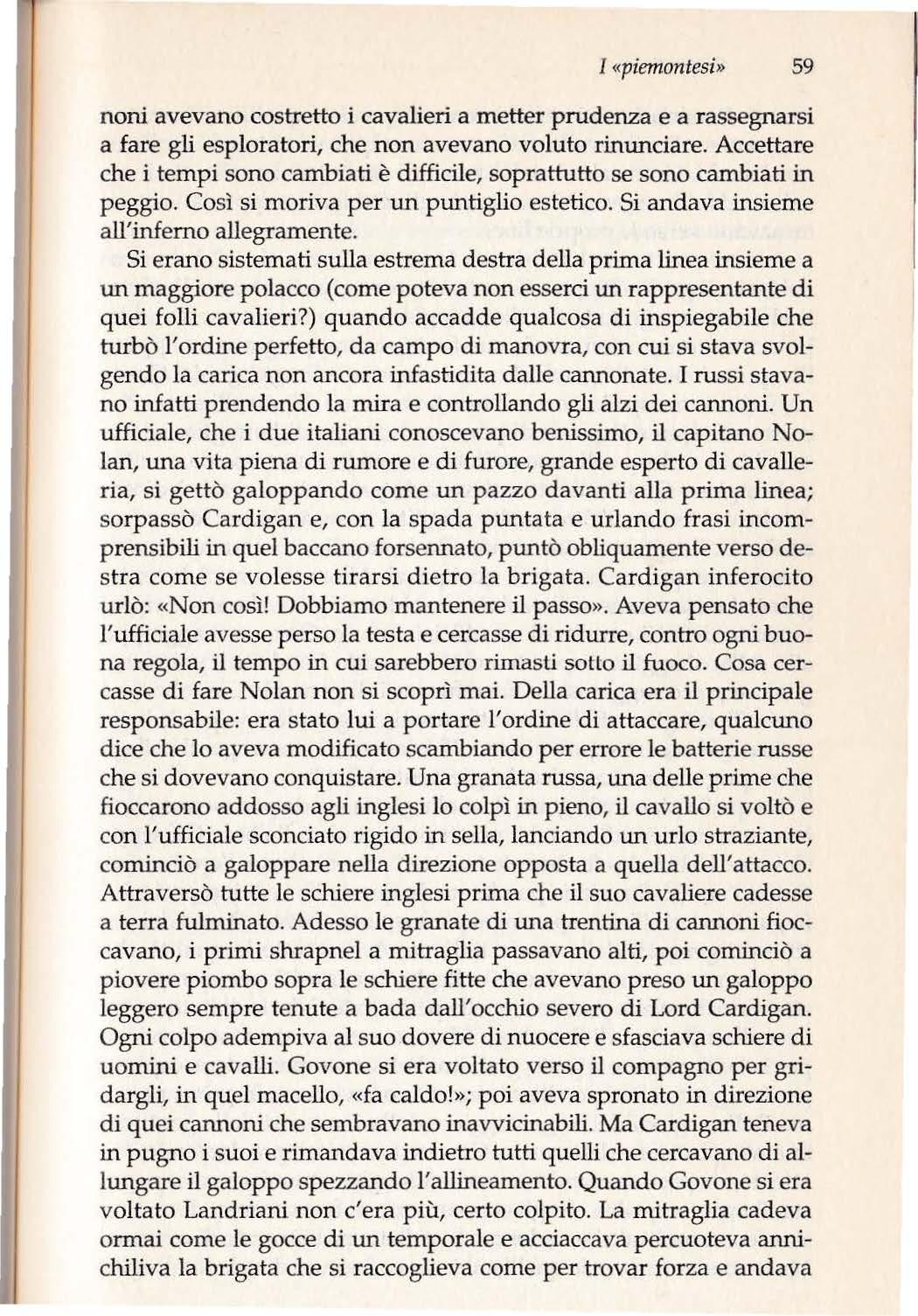
avanti. Persino i russi sembravano sorpresi di quella ostinazione senza senso. Poi il cavallo di Govone fu colpito ed entrambi crollarono al suolo. L'ufficiale s i rial zò cercò di rimontare in sella ma il cavallo cadde di nuovo. Allora si unl agli altri feriti e appiedati che ritornavano verso le proprie linee.
A venti passi v id e Landriani a terra, ferito, che si rialzò, lo riconobbe e gli gridò «Pippo». Govone rispose «viva il re!», poi l'ufficiale che aveva seguito la cavalleria inglese come volontario, ricadde. Lo catturarono i russi, ma la sua ferita era troppo grave e neppure l'amputazione della gamba lo salvò dopo una lunga agonia . Govone, ferito a una spalla, cercò di montare su uno dei cavalli scossi che correvano qua e là pazzi di paura s ul campo di battaglia, venne scambiato a causa della sua uniforme scura per un russo da un ufficiale inglese. Qu ell'ostinato voleva farlo prigioniero; si salvò dicendo che e ra ferito e l'altro, molto compito, se ne andò per le sue faccende. Dalle alture stava scendendo la cavalleria russa ansiosa di massacrare quanto restava di quei pazzi. Allora dimenticò il contegno e si mise a correre. Lo salvò un soldato inglese che stava riportando indietro il cavallo di un ufficiale morto. Govone si aggrappò alla sdla, si aggirò disperatamente cercando Landriani; poi rassegnato e pesto raggiunse le linee francesi. Il generale Canrobert e i suoi ufficiali gli si affollarono attorno, si congratularono per la bella carica e per essere sopravvissuto. Piovvero voti sinceri per il collega preso prigioniero. La carica dei piemontesi finì lì.
Da quella pianura bagnata da molta gloria ma da poco senno parte invece la carriera di uno dei nostri protagonisti, l'albese Giuseppe Govone. L'abbiamo finalmente trovato l'eroe modesto, l'eroe antiretorico, l'eroe dall'audacia ponderata. In questo libro di incapaci e infingardi in cui si inciampa a ogni piè sospinto, Govone è uno dei pochi veri generali della storia italiana. Aveva tutte le qualità che mancavano a i suoi più riveriti colleghi: la curiosità per esempio, la stessa che lo aveva portato a quella pericolosa audacia di buttarsi tra i cavalieri perduti di Balaclava. Ma non e r a ostentazione, passione per la bella morte e il gesto gratuito. Voleva sempre vedere, capire e per far questo i libri non bastavano. Occorreva osare in prima persona. Dalle ragioni del brigantaggio e della renitenza delle genti del Sud alla posizione del nemico, Govone faceva sempre domande, era attento, disposto a esaminare anche i luoghi comuni; cercava risposte. Furono le qualità che gli consentirono di fare carriera, di non restare come molti altri semidei con le stellette un burocrate di caserma. Ma lo condannarono, in quell'ambiente così saturo di veleni e pregiu-

dizi, anche all'isolamento e alla sconfitta. Era soprattutto un gen erale moderno, forse l' unico della nostra s toria d ove si tende va sempre, per limiti cultura li e radicata consuetudine, a restar abbarbicati a tre, quattro id ee con servate come dogmi . Sapeva o rganizzare; fin da quando er a giovane ufficiale aveva l'estro per la pianificazione, per risolvere rebus strategici o trasferire masse di u omini e mezzi da un luogo all'altro. Era insomma uno splendid o ufficiale di stato maggiore, mestiere ancora ai primordi soprattutto da noi, in un piccolo Stato dove il m aggior problema logistico era portare le truppe alle manovre a pochi chilometri di distanza e non farle morire di fame.
Era un' ab ilità che aveva svil uppa to con una carriera singolare p e rché semplice; capitano, «fu attaccato alle legazioni di Vienna e Berlino» come recitava il documento di nomina in qualità di addetto militare: anzi era q ualcosa di più. «Guardando il Dan ubi o n on perda di vista il Ticino» gli scriveva il già potente La Marmora con uno dei s uoi rarissim i lampi di prosa efficace. Venivamo da due sconfitte brucianti. Govone in caso di guerra, a To rino ci speravano eccome, doveva «guardare, intrigare e fars i accettar e come volon ta rio e semplice spettatore». Austria e Prussia rimandarono la sald a tura dei loro con ti tedeschi e finì sempre sul Danubio, ma molto più a sud, dove invece turchi e russi se le davano di santa ragione. Il resoconto epistolare di quella esotica guerra, decine di lettere e relazioni spedite a La Marmora son o uno dei documenti più v ivaci e godibili ancor oggi della nostra storia militare.
Govone era accreditato tra i turchi, i più deboli, condannati nella generale convinzione a subire catastrofiche sconfitte, a esser ricacciati nelle pianure dell'Asia e a dover rinunciare agli ultimi brandelli del loro impero e uropeo . Govone tifava per lo ro, per gente come il serraschiere Omar Pascià, croato di origine, svelto d i persona, indurito dalla fatica e dotato di un istintivo intuito stra tegico, a d orato da lla truppa, maestro di una guerra fatta di colpi di mano e piccole operazioni guid ate d all 'estro. Tifava per i piccoli soldati turchi, fantaccini affidati dopo la gran strage dei giannizzeri, agli ufficiali europei che avevano cercato d'ins tilla re loro principi nuovi: g li piacevano quei piccoli uomini sobri intrepidi e te naci, rassegnati a essere porta ti a l m acello da uffi ciali ignoranti e mediocri e d a un sistema politico dove l' unica ideol ogia erano corruzione e favoritismo. Al gran quartier gen er ale di Sciumla dove l'Oriente intero sembrava essersi dato app untamento come per una grande recita in costume, accorrevano d a tutta Europa ufficiali, avventurieri e mestieranti alla ricerca di ingaggi informazioni occasioni. Govone seguiva, annotava,

riferiva tutto. La dichiarazione di guerra era stata una recita sublime: Omar Pascià aveva spedito il proclama del sultano che ingiungeva ai russi di sgombrare i cosiddetti principati, terre dell'Islam. Il principe Gortschakoff aveva risposto con g rande degnazione che non aveva ordini dello zar in proposito e quindi restava dove era. Ma Govone non riusciva a mantenersi neutrale quando vedeva svarioni strategici o tattici mostruosi, e finì per diventare, con gaiezza sbarazzina, da spettatore protagonista. Quando ormai aveva ricevuto il richiamo perché sembrava che la guerra fosse finìta, g li giunse la notizia che invece i russi si stavano dirigendo con grandi forze contro la fortezza di Calafat. Ecco la sua lettera a La Mannora:
Ho letto ancora e riletto la di lei lettera di richiamo. Se potessi fare come ai tempi dell'antica Grecia, andrei e tornando le domanderei: in tali e tali circostanze un ufficiale sardo doveva andare? Ella signor ministro mi risponderebbe forse di sì e io potrei aggiunge re: ebbene io sono andato. Ma ora col te legrafo e coi vapori le notiz ie arrivano prima che io possa metterne la questione, conviene dire le cose prima di farl e. Onde oso scriverle che s tante il grande interesse d e lla circostanza non mi sono tratte nuto ... Se ho mancato mi dia signor minis tro, tre mesi di cittadella.
Arrivato a Calafat, visto che di arresti non si p o teva per r agioni pratiche parlare, scese in campo contro i russi: scrisse una lettera a Omar Pascià per segnalare i difetti delle fortifica z ioni e sugge rire piani di guerra meno strampalati di quelli d el generale turco a cui era affida ta la piazza. Govone era ovunque, se si perdeva una scaramuccia gli pareva di aver gettato via la giornata; tutti, turchi inglesi francesi (ormai la spedizio ne in Crimea era decisa) lo invocavano per avere informazioni e consigli, lo aggregavano agli stati maggiori : «insomma v e d e signor ministro che dico schiettamente tutto senza umiltà e che la fortuna mi perseguita ... » . Anche se stava per ris uonare !'«arrivano i nostri », aveva già capito che il d e stino dei turchi era segnato:
Questi turchi del po polo sono brava gente. Ma il povero impero n on potrà probabilmente rimettersi in piedi per l'immoralità dell' amministrazione e la mancanza di patriottis mo d e j grandi. Per esempio Mohamed Alì lasciando il ministero della Guerra po rtò via i pochi piani delle fortezze e si rifiutò di darli al s uo ri vale erede.
Omar Pascià era alle prese con una guerra che si era fatta improvv isamente complicata, gli era cresciuta tra le mani diventando una scaglia di malebolge. Ormai più che un semplice curioso lo considerava un membro dello stato maggiore, gli assegnava incarichi speciali, lo invitava ripetutamente a farsi turco per diventare generale

delle sue armate come avevano fatto molti altri ufficiali europei d i minor qualità che il piemontese. Lui s e la rideva e ne scriveva con granc:li p e nne lla te coloristiche al La Marmo ra facendogli ba lzare davan ti agli occhi in cronache gioconde il lento radunars i dell'esercito dei coalizzati, i tipi dei gen erali europei, l' ing lese Raglan, vecchio arnese d ell'età d i Wellingto n, i francesi irruenti e superbi nonos tante le scarse glorie di Napoleone il piccolo. In attesa che le armate occidentali si srotolassero sulle sponde del Mar Nero, la guerra da dispersa e confusa, come spesso accade, si era improvvisamente raggomitolata s u un punto, la fortezza di Silistria, s dra ia ta s tÙ Danubio, «non forte per natura e non forti ssima neppure per arte» come la d escriveva Govone. La guerra si era aggrappata a l terreno. E in ques to assedio cli un posto scon osciuto sembrò di colpo ch e tutto si dovesse decidere. Poteva mancare a questo appuntamento adesso che i cannoni russi tenevano sotto tiro i poveri turchi rannicchiati nelle trincee? Il 7 gi ugno il nuovo governatore Rifaat Pascià riusci con poche truppe fresch e a violare il blocco : a l suo seguito galo ppava n a turalmente il Go vone. Divenne l'animatore della resistenza: le batte rie russe erano a cento passi, i lor o cacciatori a trenta, le mine, vecchia astuzia d egli assedianti, s i mangiavano fette di fortifi cazioni, ing hiottivano cannoni e soldati. Govone aveva fretta, dopo pochi giorni sarebbe dovuto ripartire e allora suggeri al governatore di realizzare un ridotto interno, inespugnabile da apporre ai russi in caso di crollo dei bastioni esterni . L'idea fu accolta e il suo compito in teoria era finito: quella non era l a s u a g uerra . In vece si offrì di andare a tra cciare il nuovo trinceramento perché non s i fidava degli ufficia li turchi. Lavoro pericoloso tanto che un collega inglese si fece cogliere d al piombo.
lo che restai dritto come Wl palo per un 'ora a tracciare solo o con akuni solda ti non ebbi nulla; e qualcuno s i rallegrò dopo con me d ella chance. U n ufficiale inglese un p o' geloso mi disse con dispetto: «È una vergogna che voi e ques ta gente v i espon ete cosl. L'abc de l mestiere d ell 'ingegnere è di me tter s i a l riparo». Risposi: «E l'abc del mestiere del soldato è di mostrare alla truppa di avere san g ue freddo», feci ritornare i soldati e restai solo.

Quando i russi, come preved eva Govone, fecero crollare una parte di fortificazi oni entrando n ell'anello interno della città, si trovarono di fronte quella subdo la ridotta e furono respinti con dure p erdite: aveva ragione il governato re che cercò di trattenerlo in città e d isse «che la sua presenza valeva un corpo di armata».
Rispetto ai be i tempi in cui galoppava dietro al comando di Omar Pascià l'arrivo dei piem o ntesi di La Marmora, che sembrava preluder e a grandi imprese, s i rivelò una delusione:
Voi in patria fra g li amici e le b e lle dame dei vostri pensieri siete lieti e felici . Il sole s punta ridente, il tramonto è soave e amoroso. La vita è una fortuna. Noi s ia m o tra il colera e il tifo, desolati delle perdite dei nostri com pagni e contia mo i morti a un migliaio senza che la gloria del fuoco e de i comb attimenti compensi q u este tristezze...
Tutto sembrava kalabalik come dicono i turchl, guai e confusione, e invece di elencare vittorie ci si limitava a far l'elenco d elle malattie: febbri te r zane, febbri gastriche, febbri cerebrali, colera, tutte p i ù efficaci dell 'anna ta russa. L'alba del 16 agosto, quando le colonne russe si diressero verso le linee piemontesi alla Cernaia per dare battaglia, fu salutata come una liberazione: Govone fece a tempo a cor rere negli spalleggiamenti p e r vedere tra la nebbia che s i diradava le lunghe file d ei soldati nemici che respinti si ritiravano, decimate e disordinate. Per fortuna la gloria era arrivata.
La seconda guerra d ' Indipendenza fu raffazzonata a furia dai talenti diplomatici del Cavour; sul piano militare g li resse la penna il tenente colonnello Govone. I proclami dei sol oni che g uida va no l'eserci to facevano luccicare gli occhl agli entusiasti; intanto, s ilenz ioso discre to efficientissimo, questo giovane ufficia le da mesi faceva stud i, calcoli, piani per predisporre armamenti e le intese con gli indispensabili a llea ti francesi che aveva mo alla fine trascinato a comba ttere una guerra che in fondo serviva solo a noi. Ma ancor più delicato e d ecisivo era s tato il s uo lavoro, modernissimo, dell'organizzazione dello s pionagg io, della «inte lligence» come s i d ice oggi. Govon e, dal quartier gen erale d i Torino per mezzo di un reticolo d'informa tori arruolati tra la popolazione antiaustriaca sapeva ogni giorno le mosse delle guarnigioni nemiche, la loro consistenza, l'arrivo dei rincalz i e le abitudini. Accompagnò in p e rson a alla frontiera il barone di Klebelsberg e il conte Ceschl ch e e rano venuti a portare l' ultima tum fatale p e r i destini dell'imperial regio gove rno. Gli austriaci invasero senza fre tta il Piemonte. Govone aveva già organizzato una fittissima quinta colonna di carabinie ri : er an o piccoli nuclei di sottuffici ali e di marescialli che, indossati ves titi borghes i, dovevano la sciare ch e le truppe austriach e li scavalcassero per poi riferire movimenti numero piani a llo stato maggiore. In case dislocate s ulle grandi strade dovevano contare il numero delle colonne che a rrancavan o maledicendo il polverone e poi con l'aiuto di contrabb a nd ieri, borg h esi insospettabili e colombi viaggiatori, mandare s ubito le novità al comando. Rischlavano la vita p erch é i «cavallereschi» aus t riaci provavano un particolare fas tidio per le spie e fucilavano con grande p iacere. Ma la r ete funzionò a punti -

no. Giorno dopo giorno, mentre l'esercit o francese si raccoglieva a fatica a Genova o passava le Alpi, i generali piemontesi erano in grado di val utare consis tenze e mosse di quegli impacciati invasori. Avevano la possibilità di strangol are in culla l'unità d'Italia; abituati com'erano a una guerra pigra e incerta non colsero l' occasione. Pecca t o che i generali piemontesi non ne tennero conto, come racconta il colonnello Cecilio Fabris che di questi servizi segreti era un appassionato narratore:
Mai forse il comando di un esercito ebbe più chiare e precise informazioni e mai mostrò, come allora, di non valersene. Il fatto della ritirata alquanto precipitata di Acqui e l'andamento del piano di guerra eseguito e voluto da Napoleone mostra chiaramente come avrebbero potuto svolgersi al di fuori di qualunque informazione sul nemico.
Insomma Govone e i suoi carabinieri lavorarono con efficacia e dedizione, ma parlarono ai sordi. Non sarà l'ultima volta.
La campagna del 1859 Govone la passa a cavallo al seguito del re. Non per andare a pavoneggiarsi in uniforme ma per raccogliere informazioni, stilare relazioni, decifrare i movimenti del nemico e le contromosse più efficaci dei nostri. Il giorno dopo la grande battaglia di Solferino e San Martino, la chiusa a fanfara della campagna, una delle più sanguinose dell'Ottocento, sale a cavallo alle quindici e a mezzanotte è ancora per i campi, tra cumuli di feriti e di moribond i per raccogliere informazioni. Il giorno dopo alle cinque è già in piedi e ci resta fino a notte fonda per stilare il rapporto che vuole preciso e dettagliatissimo su quanto è s uccesso. Spera che serva per non commettere gli stessi errori, per assicurare alla battaglia l'ordine geometrico che è il sogno di ogni vero conduttore di uomini . Quel sanguinoso fatto d ' armi non poteva apparirgli che come un gigantesco sproposito, casuale e illogico:
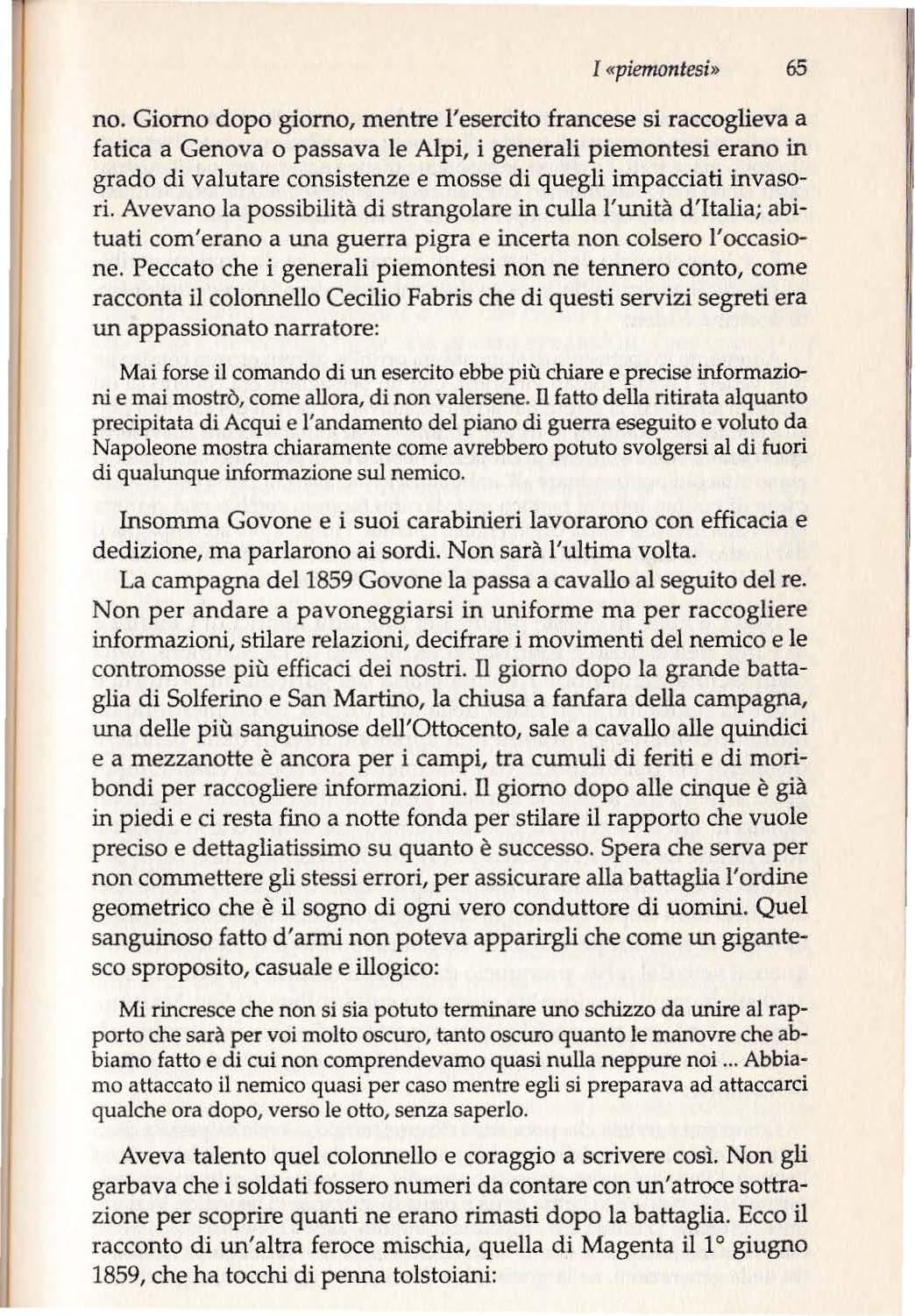
Mi rincresce che non si sia potuto terminare uno schizzo da unire al rapporto che sarà per voi molto oscuro, tanto oscuro quanto le manovre che abbiamo fatto e di cui non comprendevamo quasi nulla neppure noi ... Abbiamo attaccato il nemico quasi per caso mentre egli si preparava ad attaccarci qualche ora dopo, verso le otto, senza saperlo.
Aveva talento quel colonnello e coraggio a scrivere cosi. Non gli garbava che i soldati fossero numeri da contare con un'atroce sottrazione per scoprire quanti ne erano rimasti dopo la battaglia . Ecco il racconto di un'altra feroce mischia, quella di Magenta il 1° giugno 1859, che h a tocchi di penna tolstoiani:
È uno s pettacolo straziante l' indomani di una battaglia. Non si incontrano sulla strada che ca rri di feriti e di morenti mescolati spesso a disgra zia ti che sono g ià s pirati. Le chiese, le case sono piene anco ra stamane di austriaci, di zuav i e di sold ati n ostri che i chirurghi curano a modo lo ro, tormentandoli con le loro operazioni per vederli morire mezz'ora dopo.
E se lo s pe ttacolo delle vittime g li appare senza distinziorù orribil e, traccia il r acconto della gioia dei v incitori come la prepote nza fatta dottrina e idea :
Altrettanto lo spettacolo di s tamane era orribile, altrettanto era comico ieri di vedere i nostri soldati vittoriosi. Qui un bersagliere era coperto di un cappeUo austriaco, là alcuni fantaccini montavano i cavalli dei cannoni presi al nemico per condurli in trionfo a l campo, più lontano alcurù zuavi feriti erano seduti s ull'avantreno di un pezzo ne mico e sei prig ionieri austriaci vi erano a ttacca ti per trascinare all'ambulanza i vincitori. Gli zuavi con le mani p ie ne di bottino tolto a l n e mico guardavano facendo cerchio una carre tta messa alla rovescia senza capirci nulla . Quando l'impe ratore accompagnato d al nostro re andò a visitare il campo francese, un sold ato mi chiese: «È quello là il vostro impe ratore? Accidenti che bell'uomo...».
Non c'è nulla in ques te p agine d e i proclami retorici di Cialdini e di Fanti, d ell'astruso e soddisfatto tecrùcismo di La Marmara, d e lla compia ciuta esa ltazio n e ri voluz iona ria d ei garib a ldini. Vittoria e sconfitta sembrano specchiarsi nella loro tragica, incommensurabile incomprensibilità, gli uomini non appaiono avvolti d a lla bandiera degli eroi ma dal mediocre compiacimento dei sopravvissuti impegnati a riempirsi le tasche e a fare gesti infantili e inutili. È già un isolato in que ll'eserci to di gen erali un po' meschini ch e si avv iano a d a rraffare d ecorazioni e carrie re ora ch e la nazione, e non certo per merito loro, è dive ntata grossa e importante. Leggiamo il discorso che dieci anni dopo, quando le campagne del Risorgimento svicolavano nella r etorica patriotta rda e d era d iventato imposs ibile dis tinguere il vero dal falso, pronunciò davanti all'ossario p er i caduti senza distinzione di nazio nalità costruit o s ulla collina di San Martino. Govone è ancora p er poclù giorrù ministro della Guerra, sembra a ll 'apice d e lla carriera ma s ta per s profondare n ei gorglù della fo llia e della morte: Compagni e fratelli che poca terra ricopre; terra che avete calpestata dieci anni or sono al suono delle trombe guerriere, con voci d ' ira sul labbro, con l'amore d'Italia nel cuore, riposate tranquilli! .. . Il vostro cuore fu sparso utilmente per la patria e la patria gra ta e pie na di speranze vi benedice. Vi riammira l'esercito, vi saluta il re . Riposate tranquilli, alleati generosi che ci ave te dato la mano fraterna . Il ricordo dell'opera vostra non si dileguerà nella storia delle gene razio ni, nella gratitudine di noi e dei fig li nostri; segnerà una

era nuova di libertà per le nazioni del mondo. Nemici di un giorno, valorosi nemici! Il vostro sacrificio fu glorioso per il vostro paese. Se la vittoria non poté essere vostra, la mano di Dio e lo spirito dei tempi nuovi erano contro di voi; ma non rimpiangete la battaglia perduta perché l'odio di razza fu spento nei cuori; rallegratevi perché oggi i vostri compagni stringono la mano a noi, uniti tutti nella via comune della civiltà e della giustizia.
A quest'uomo che sapeva trovare per il nemico così inusitate parole di umana comprensione e che combatteva seppure con grande metodo e determinazione una guerra senza odio (per quanto sia possibile), veniva affidata nel 1862 una difficile missione: comandare una divisione in Sicilia dove cresceva una nuova forma di guerra sporca e subdola che avrebbe afflitto tutta la storia d'Italia fino a oggi, quella della mafia e dell'antistato. Il generale aveva fatto triste esperienza della lotta al brigantaggio, la repressione contro i nuovi sudditi del Sud che sembravano così riottosi a capire i vantaggi dell'Italia unita sotto i Savoia. I suoi colleghi erano ritornati da quella feroce campagna con il disgusto per «l'Africa di casa nostra», l'eterna Vandea di cui non volevano capire le motivazioni segrete e si accontentavano dell'elementare strategia della forca . Govone aveva trascorso sedici mesi nelle province napoletane prima, poi ali' Aquila in Abruzzo e a Gaeta, su quella frontiera pontificia così facilmente permeabile e dove passava una sorta di sentiero di Ho Chi Minh per le reclute e le armi che alimentavano la rivolta. Rivendicò il privileg io insolito per un generale di pensare ad alta voce. Compilò una clamorosa m emoria sulle cause del brigantaggio spedita all'inevitabile commissione di inchiesta che a Torino cercava di capire i misteri di quella incomprensibile rivolta: dopo pochi m esi g li era parso di trovare la spiegazione del brigantaggio «nella condizione sociale del paese e nel misero stato d e l proletariato». Nel nuovo incarico Govone m e tte la stessa puntigliosa tenace volontà di capire vede re controllare prima di formarsi dei giudizi: interroga i proprietari e scopre che la paga durante i mesi di lavoro è di circa sessanta centesimi di franco, quella delle donne che sudano nei campi dall'alba a l tramonto ancora meno:
Io vidi sovente manovali di campagna cibarsi di cocomeri crud i e fui una volta dolorosamente colpito da due donne che vidi far violenza alla sentinella per raccogliere sugli spalti di Gaeta erbe comuni per farsene cibo ... Taluno dei miei ufficiali mi narrò che alla stagione delle messi, avendo visto i lavoranti ton1are la sera al paese con covoni sulle spalle e chiesto che fosse ai proprietari, questi risposero: è roba rubata a noi, ma non possiamo porvi rimedio, questi lavoranti non guadagnano che pochi grani una parte dell'anno. Morirebbero di fame se non ci rubassero.
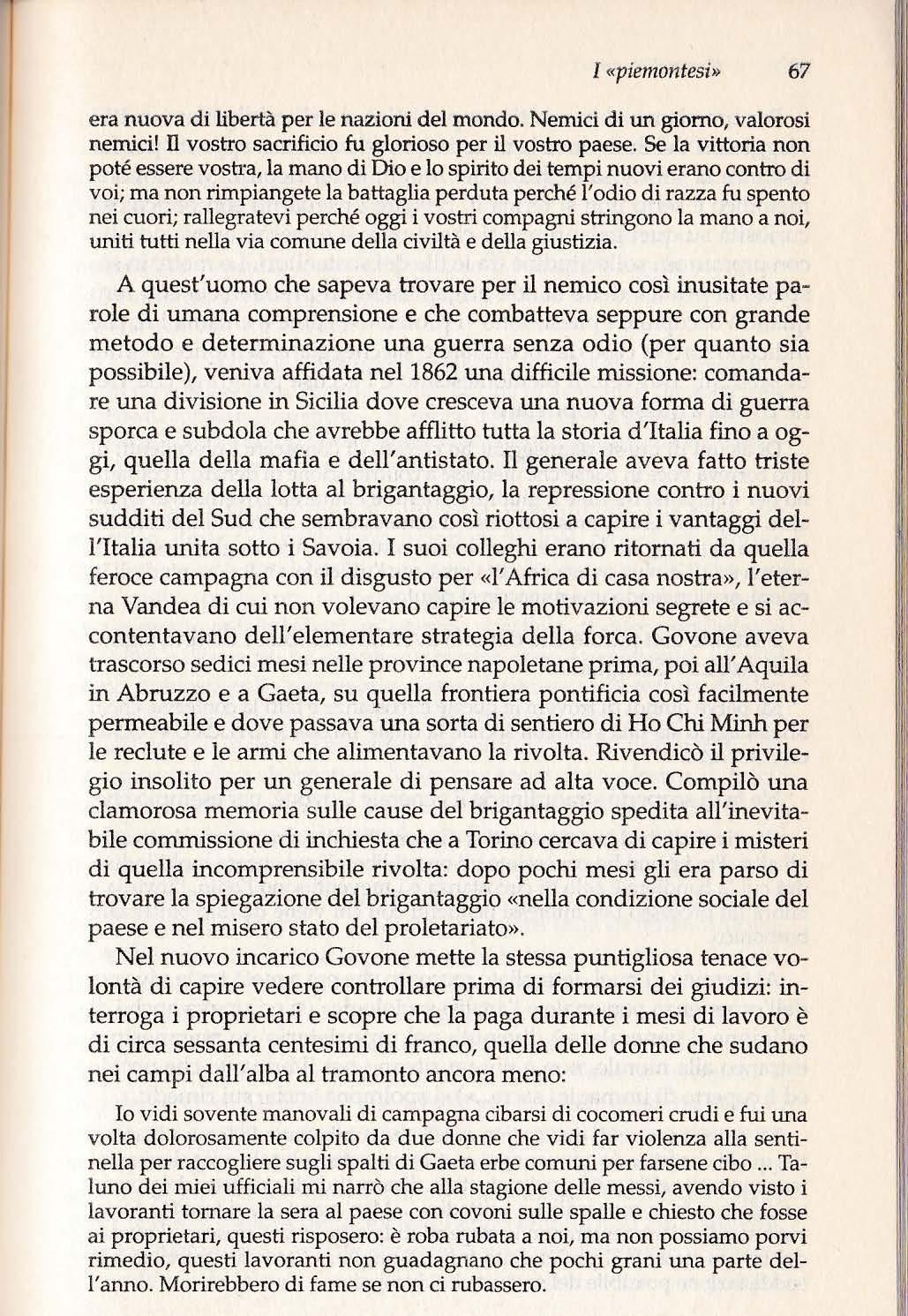
Per ora siamo al bozzettismo pietistico a cui indulgevano tutti i viaggiatori del Sud, dove la miseria sembrava messa apposta per far risaltare la sontuosa bellezza dei luog hi e dei ricordi. Ma Govo ne m e todico e serio non si fe rma lì. E volge lo sguardo con pe ricol osa curiosità su quei galantuomini che il nuovo governo aveva accolto co n premurosa sollecitudine tra le file dei sostenitori . Lo m e tte in sos petto la pratica delle bande brigantes che di prendersela co n loro quando occupano i paesi; sono «i proletari» , come li chiama lui, che indicano loro le case da incendiare e saccheggiare: semplice avidità di predoni? Davvero il piemontesismo è l 'accu sa più grave che v iene rivolta a questi proprietari?
Di alcuni di qu esti danneggiati ho cercato di conoscere i preced enti; di uno correva v oce in paese che mettesse a conhibuz io ne di denaro il contadino p er interporsi tra lui e il g iudice e fra lui e l'auto rità governativa. Di un altro seppi che era opp ressivo verso il contadino suo e un mio ufficiale mi riferiva appunto fra le altre cose che un contadino avendogli chiesto cinquanta scudi dovuti aveva risposto presente l' ufficiale: andrai a prenderli in galera, aggiungendo una minaccia al rifiu to.
E chiude con parole che devono aver fatto allibire i dis tinti signori di palazzo Carignano:
Mi parve quindi di trovare in queste circostanze e fatti la conferma che il brigantaggio sia una vendetta sociale la quale TALORA SI APPLICA CON QUALC HE GlUSTlZIA.
Ne fa di scoperte s traordinarie il generale Govone, per esempio che: alla rivo luzio ne i nuovi po tenti si dissero liberali e chiamarono bo rbonici gli altri. Fra i primi ho conosciuto g li onesti liberali ma ancora molti individui cui la bandiera è solo di circost anza e i moventi sono 1'odio, l'invidia e talora un processo p er interessi pendenti con chi viene d a loro battezzato borbonico.
Al termine di quel dettagliato racconto che era a metà tra la vivezza d e ll'esperienza personale e l'analisi sociologica (si occupava anche di religione il generale: «è dive nuta pel proprietario un p aga nes imo estraneo alla morale, non è p iù un ritegno per il brigante che uccide ed è coperto di immagini sacre... ») si spolmona anche sui rimedi: Mi paiono essere di due specie: quelli che combattano la fame e la miseria; quelli che facendo entrare ogni cosa in un sistema legale e regolare mantengano tutti nell' equità e nella giustizia disarmando le vende tte del povero e richiamando la concordia tra i cittadini ... Man mano che s i faranno ferrovie e s trade, si aumenteranno le sorgenti di lavoro, s i farà crescere il prezzo del l avoro s tesso e il prole tariato troverà mig lior esiste n za materiale e la soddisfazione possibile dei suoi assoluti bisogni.
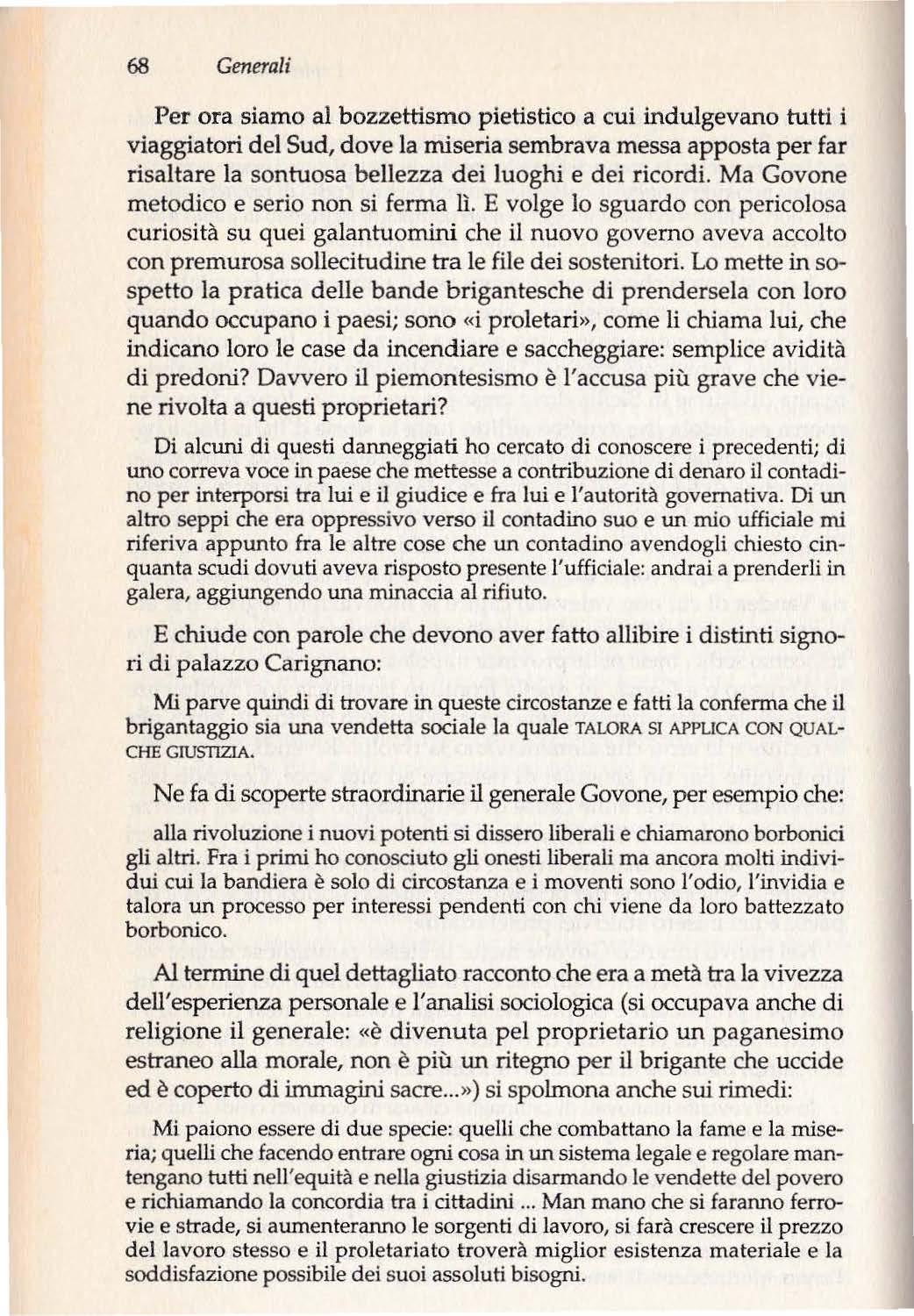
Se la sua relazione aveva sollevato curiosità nei commissari doveva essere rimasta ben sepolta nelle loro coscienze, perché i metodi con cui il brigantaggio fu sconfitto risultarono ben diversi, anzi opposti, a quelli proposti dal Govone.
La situazione in Sicilia si presentava diversa, non c'era un problema militare, nessuna banda di C r oceo o di Ninco Nanco faceva guerriglia sui monti. Anzi, scriveva il ministro della Guerra Della Rovere appena sbarcato a Palermo:
La Sicilia è in uno stato di perfetta tranquillità, i delitti sono diminuiti, i partiti non danno segno esterno di vita. La città di Palermo si presenta sotto la veste di Torino o poco meno ... Il peggio della Sicilia è la pessima amminis trazione, sono i disordini nell'amministrazione della giustizia, nel personale di pubblica sicurezza, nel personale delle prefetture.
Bene. Ma subito dopo c'è l'intoppo: la renitenza alla leva, per esempio, dove s'impastavano umori pericolosi. Non c'era comunque la nostalgia per il Borbone, il quale in Sicilia non aveva mai raccolto molti sostenitori. Le prime tre leve proclamate dal nuovo Regno avevano creato infatti un esercito parallelo di oltre ventiseimila renitenti e disertori; ne avevano arrestati tremilasettecento, gli altri erano nascosti nelle campagne, dove costituivano le reclute dell'armata della mafia e dei cosiddetti galantuomini. Servivano per le intimidazioni, il racket, le vendette nei confronti di chi non si arrendeva a questa legge alternativa. A Govone toccò di ascoltarne di tutti i colori. I delitti denunciati in due anni erano millecinquecento, l a maggior parte impuniti, ottanta cara binieri, simbolo detestato del nuovo potere, ammazzati, paesi interi scossi da faide feroci che portavano ad autentiche battaglie, zone dell ' isola dove alla legge era perfino vietato l'ingresso. E poi un'atmosfe ra fatta di mille diffidenze, mille tabù, mille pudori. Il generale fa tristi esperienze di quel1' antistato che comanda la Sicilia. Il sentimento dell'onore a cui si sottomettono principi e masnadieri della grande tradizione qui non ha corso. Il 10 giugno 1863 racconta al ministro Peruzzi come intende procedere con metodi nuovi per restaurare l'ordine pubblico. Il mandamento di Misilmeri, che sceglie per l'esperimento, ha fama di esse re uno dei più riottosi e pericolosi; le truppe che sono state messe di guarnigione res tano barricate in caserma e spesso devono sfuggire ad agguati, i renitenti vivono comodamente e ostentatamente fuori legge. I bulloni della società hanno cominciato ad alle ntarsi. C on tre battaglioni Govone procede a un rastrellame nto; il paese è circondato e isolato di notte, nessuno può uscire, inizia una perqui-

sizione delle millecinquecento case, duecento giovani vengono arrestati. Per avviare la ricerca dei renitenti si chiede aiuto alla giunta municipale, ma nessuno si presta temendo le vendette non appena i soldati abbiano svoltato l'angolo della strada.
Di più: se anche la truppa coglie un malvivente a casa, vi è assai più gente a testimoniare della onestà della persona che a riconoscere il colpevole. L'ostinazione a non aiutare le ricerche della forza pubblica sale qui all'eroismo. È una virtù che ha un nome speciale e si chiama nel gergo popolare omertà. Un individuo che ebbe il cranio fracassa to da una vanga in un campo a pochi passi da un mio ufficiale si rifiutò di dire chi fosse che l'avesse stramazzato a terra dei tre o quattro individui che erano vicini e pretendeva essersi rotto il capo cadendo. Tutti sono di un mutismo usuale. La piaga è profonda.

Non si riesce a scovare collaboratori, i galantuomini non ci sentono da quell'orecchio. Si cerca di incrociare le poche testimonianze con gli elenchi dello stato civile tenuti dai parroci . Ma il generale scopre che sono ancora quelli borbonici pieni di omissioni e talora di falsi. Bisogna liberare i sospetti. Govone, tenace, lascia le truppe in paese, ordina ogni notte di ripetere tre quattro volte i rastrellamenti, spedisce in campagna pattuglie che arrestano tutti i giovani in età pericolosa. Dopo due settimane, esausti per quella oppressione sono gli stessi notabili e i capi bastone a recarsi al comando distribuendo i nomi e le case dove prendere chi ha rifiutato la leva.
Il successo induce il governo a ordinare di ripetere l'operazione più in grande n ella provincia di Girgenti, altro enorme covo di banditi e disertori. Questa volta s i procede addirittura con venti battaglioni. Altro che poliz ia, è un'operazione militare: colonne mobili che setacciano questa Vandea siciliana con metodi implacabili come le perquisizioni di massa . La vita di una parte dell'isola è sconvolta da quell'uragano militare, cominciano a piovere sul ministero proteste dei galantuomini e di quei notabili che costituivano il presidio governativo nell' isola, e dal ministero cominciano ad arrivare al generale rabbuffi, inviti a non esagerare, ingiunzioni. Govone non ci sta; ha ricevuto una missione e il metodo dei ras trellamenti, certo poco democratico, gli sembra l'unico praticabile:
Riguardo ai renitenti ecco come procedono le cose n e lla ma ggior parte dei com uni. Va la truppa con una lista di cento renitenti. Si domanda alla a utorità di indicare le case, vi rispondono che non sanno. Si prendono le guardie municipali e gli uscieri vi si rifiutano. Si domanda nel paese, nessuno sa nulla. Si arrestano individui sospetti, nessuno vuol riconoscerli. Come può fare un comandante con una lista che contiene i due terzi di nomi di morti o espatriati o gente che non esiste? Ebbi deputazioni perché desistessi.
Vennero tre o quattro dopo ch e io ero qui. Una volta venne un deputato di Aragona dicendomi che avrebbe creduto di rivolgersi al ministro. Io risposi che lo facesse, che io non impegnavo la responsabilità ministeriale e che il ministro poteva a nche disapprovarmi. Ma che mi ricollegavo al patriottismo della popolazione. Che essi stessi avevano chiesto misure eccezionali, che si trattava di fare l'Italia ma non nn'Italia in mano ai ladri, che dovevano sopportare un incomodo temporaneo per avere un risultato utile.
I metodi erano brutali e lui stesso ne era consapevole, ma teneva sempre presente il non dover superare certi limiti. Govone non è, e non sarà mai, come certi suoi colleghi un ottuso poliziotto impegnato «a perseguitare opinioni». La sua parola non si è accovacciata sotto la disciplina della divisa. Quando lascia la Sicilia e ormai bron to la il cannone di una nuova guerra, i risultati sono evidenti: milletrecent ocinquanta ricercati per icolosi arrestati, mezzo milione di impos te recuperato, il nu mero dei renitenti che per la prima volta comincia precipitosamente a scendere. A Custoza l'unica medaglia d'oro concessa a un soldato semplice della s u a divisione t occò a un fantaccino siciliano .
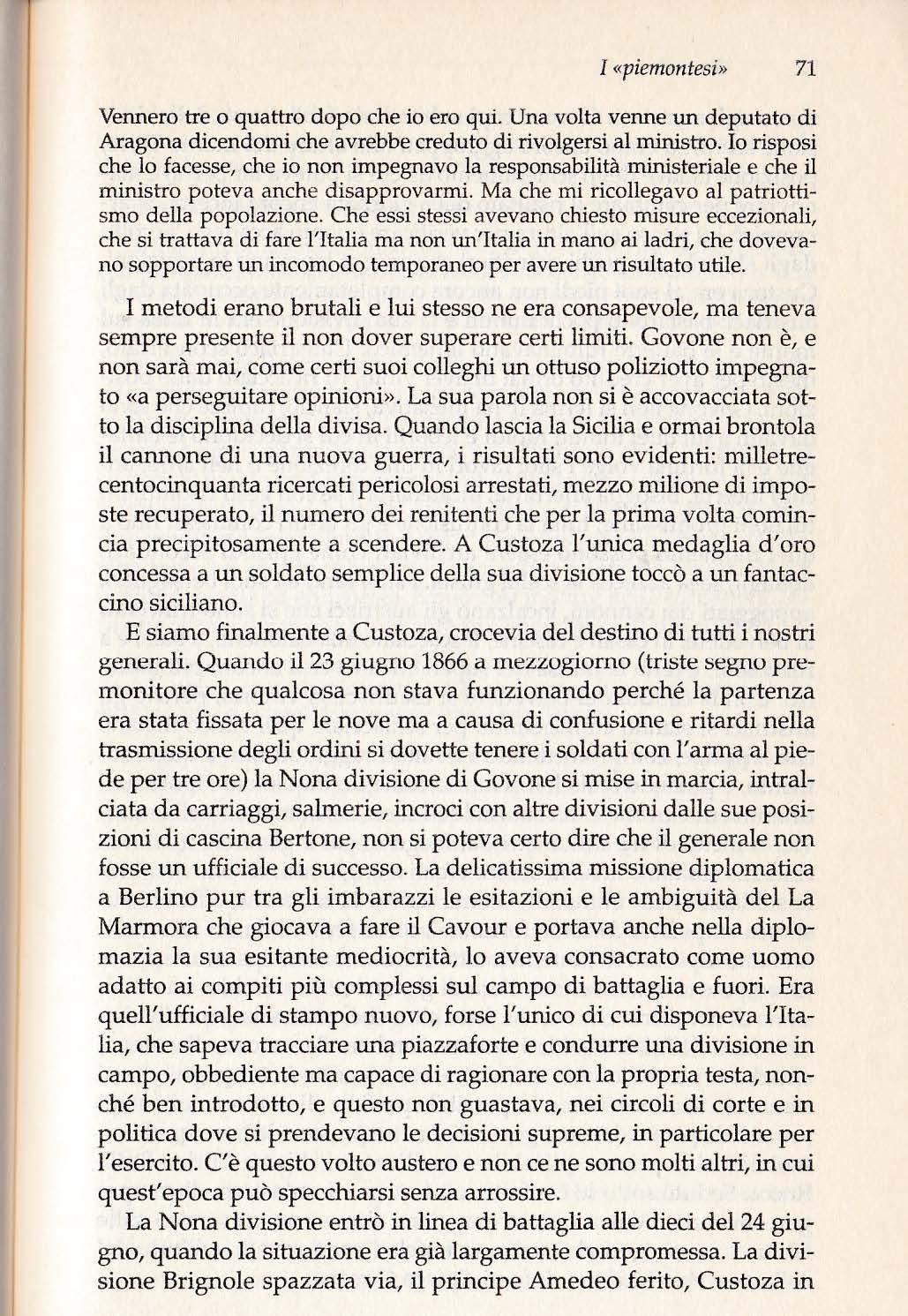
E s iamo finalmente a Cus toza, crocevia del destino di tutti i nostri generali. Quando il 23 gi u gno 1866 a mezzogiorno (triste segno premonitore che qualcosa non stava fu n z io nando perché l a partenza era stata fissata per le nove ma a causa di confusione e ritardi nella trasmissione degli ordini si dovette ten ere i soldati con l'arrna a l piede p er tre ore) la Nona divisione di Govone si mise in marcia, intralciata da car riaggi, salmerie, incroci con altre divisioni dalle sue posizioni di cascina Bertene, non si poteva certo dire che il generale n on fosse un ufficiale di su ccesso. La delicatissima missione dip lomatica a Be rlino p u r tra gli imbarazzi le esitazioni e le ambig uità del La Marmora che giocava a fare il Cavour e portava anche nella diplomazia la sua esitante mediocrità, lo aveva consacrato come u omo ada tto ai compiti più complessi sul campo di battaglia e fuori . Era q u ell'ufficiale di stampo nuovo, forse l ' unico d i cui disponeva l'Italia, ch e sapeva tracciare una p iazzaforte e condurre una divis ione in campo, obbediente ma capace di ragionare con l a propria testa, n onché ben introdotto, e questo non guastava, n ei circoli di corte e in politica dove si prendevano le decisioni supreme, in particolare per l'esercito. C'è questo volto au stero e non ce n e sono molti a ltri, in cui quest'epoca può sp ecchiarsi senza arrossire.
La Non a divisione entrò in linea di b a ttaglia alle dieci del 24 g iugno, quando la situazione era già largamente compromessa. La division e Brignole spazzata via, il principe Amedeo ferito, Custoza in
mano agli austriaci. Govone capì subito il da farsi: i resti della divisione sconfitta erano ancora aggrappati alle alture del monte Torre, posizi one chiave dello schieramento da cui si poteva far perno e manovrare per cambiare il risul tato della giornata ancora incerta. Si arrampicò lui stesso sull'altura per verificare quanto accadeva, accolto dagli «hurrà» dei pochi granatieri che ancora tenevano le posizioni. Custoza era ai suoi piedi non ancora completamente occupata dagli austriaci: bastarono pochi minuti e la sua divisione era in linea sul monte e le batterie fulminavano il nemico. L'austriaco sconcertato, mesto per aver creduto ormai di aver vinto, fu ricacciato dalle posizioni . Govone non si ferma lì: ha iniziativa, slancio, capisce che sono davanti a lui quei minuti rapidi e febbrili in cui si decidono le battaglie e la fortuna volge i suoi favori in una direzione o nell'altra, ancora incerta. Bisogna afferrarla, incatenarla a sé con gesti risoluti, intuizioni prontissime; tutta la confusione e gli errori commessi fino a que l momento possono essere archiviati come episodi secondari, dettagli, se si azzecca la scelta giusta. I suoi fanti e i suoi bersaglieri, appoggiati dai cannoni, incalzano gli austriaci che si sono trincerati al Belvedere, in casali e cascine; li scacciano alla baionetta, a balzi e a ruzzoloni, e tutta la massa dei superstiti si riversa ancora più indietro. Con Ja caduta del Bel vedere si esaurisce la vittoria, perché gli austriaci si s t anno ammassando per schiacciare quel cuneo italiano che li punge, compromettendo i risultati raggiunti fino a quel momento, e pesando sulla loro vittoria come un'inquietante ipoteca. Il dramma di Govone e dei suoi soldati si sta consumando nelle retrovie . A meno di tre chilometri dal luogo in cui il generale manovra rintuzza assalta e tiene in scacco croati e ungheresi, ci sono ventimila soldati italiani immobili - come scrisse la relazione ufficiale austriaca stupefatta da tanta fortuna -, come fermati da un incantesimo: due divisioni di fanteria intatte che non hanno sparato neppure un colpo e che non vedono l'ora di gettarsi nella mischia, una divisione di cavalleria che non ha fatto altro che trotterellare inutile dietro i fanti. Ufficiali e soldati sentono rombare il cannone, discutono, chiedono perché non si avanza per soccorrere i compagni che si stanno battendo. L'uomo impassibile perfino alle invocazioni sempre più disperate dei suoi generali mentre passano le ore e quell'immobilità si fa più inesplicabile e umiliante si chiama Enrico Della Rocca. Seduto sotto le confortevoli frasche di un'osteria di campagna circondato dal suo stato maggiore, riceve con un sorriso sulle labbra i messaggeri che arrivano trafelati con i cavalli sull'orlo del collasso e che chiedono rinforzi. Spiega Govone:

Per ora rispondo della posizione, ma temo un serio attacco perché vedo il nemico concentrarsi e prepararsi: per tale evenienza avrei necessità di rinforzo. Se sua eccellenza mi manda truppe rispondo della giornata.
Alle tre e mezzo il messaggio è diventato un'invocazione:
Le mie truppe hanno respinto per tre volte gli attacchi del nemico, da ieri non mangiano, sono spossate dalla fatica e da l lungo combattimento, non potrebbero resiste re contro un nuovo attacco. Ma se vostra eccellenza mi manda un rinforzo di truppa fresca mi impegno a dormire sulla posizione.
Enrico Della Rocca: anima molle, nera e fegatosa. Non è un generale, anche se ha combattuto tutte le guerre del Risorgimento: è un cortigiano; tutta la sua vita l'ha passata a fianco del re di cui è luogotenente e l'aver perso que lla carica, per i maneggi di La Marmora, lo ha gettato in una crisi depressiva. De l cortigiano ha i modi, le astuzie, le untuose strategie. Quando Cialdini rifiuta di aver tra i piedi il prin· cipe ereditario ingombrante e pericoloso, nocivo alla libertà dei comandanti, lui accetta subito con gioia, scrive a Vittorio Emanuele un biglietto servile ed entusiasta. E può così inserire nella corrispondenza una lettera del re che gli sembra più importante di una vittoria:
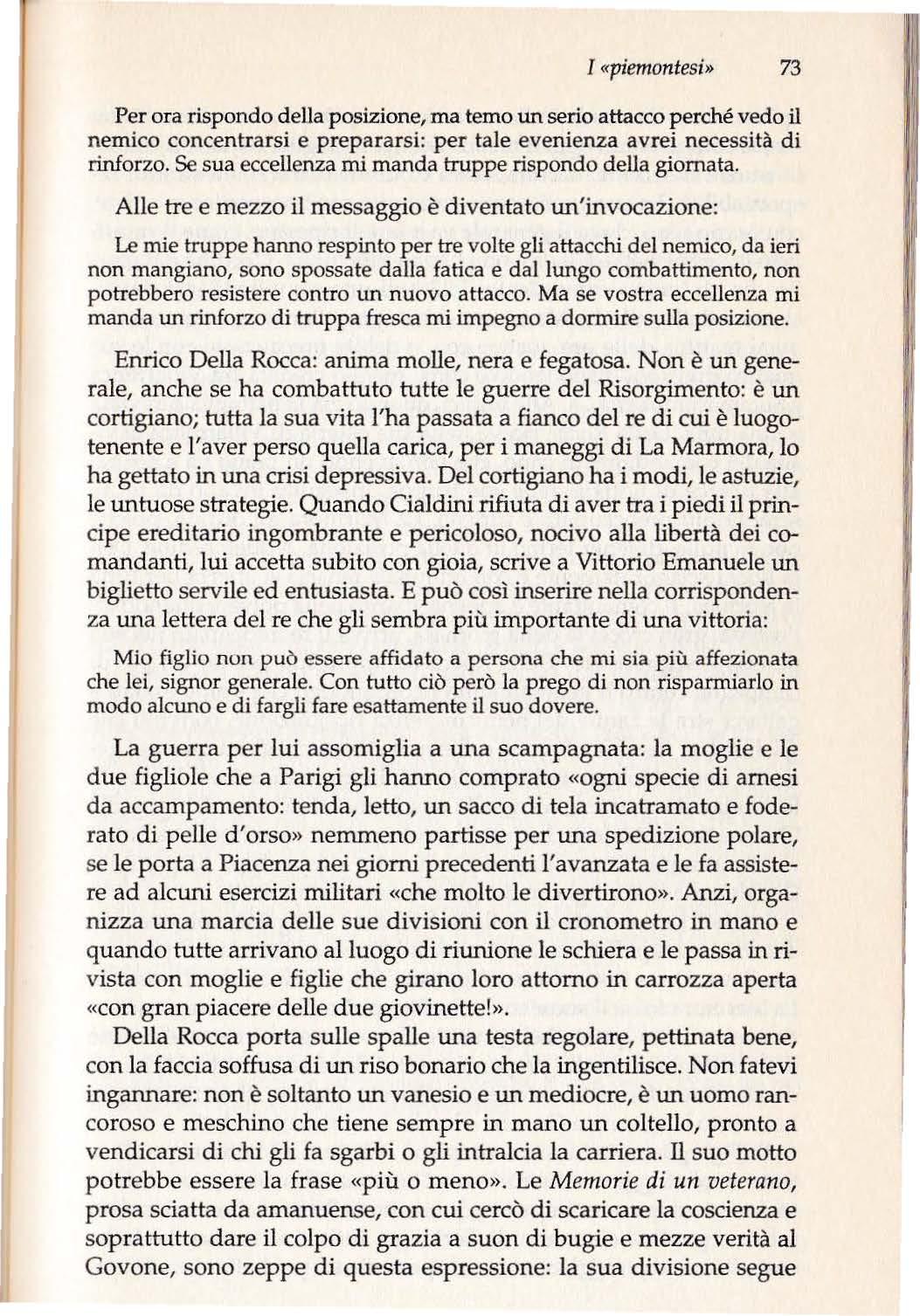
Mio figlio nun può essere affidato a persona ch e mi sia più affezionata che lei, signor generale. Con tutto ciò pe rò la prego di non risparmiarlo in modo alcuno e di fargli fare esattamente il suo dovere.
La guerra p e r lui assomiglia a una scampagnata: la moglie e le due figliol e che a Parigi gli hanno comprato «ogni specie di arnesi da accampamento: te nda, letto, un sacco di tela incatramato e foderato di pelle d 'orso» nemmeno partisse per una spedizione polare, se le porta a Piacenza n ei giorni precedenti l'avanzata e le fa assiste· re ad alcuni esercizi militari «che molto le divertirono». Anzi, organizza una marcia delle sue divisioni con il cronometro in mano e quando tutte arrivano al luogo di riunione le schiera e le passa in ri· vista con moglie e figlie che girano loro attorno in carrozza aperta «con gran piacere delle due giovinette!».
Della Rocca porta sulle spalle una testa regolare, pettinata bene, con la faccia soffusa di un riso bonario che la ingentilisce. Non fatevi ingannare: non è soltanto un vanesio e un mediocre, è un uomo rancoroso e meschino che tiene sempre in mano un coltello, pronto a vendicarsi di chi gli fa sgarbi o gli intralcia la carriera. Il suo motto potrebbe essere la frase «più o meno ». Le M emorie di un veterano, prosa sciatta da amanuense, con cui cercò di scaricare la coscienza e soprattutto dare il colpo di grazia a suon di bugie e mezze ve rità al G ovone, sono zeppe di questa espressione: la sua divisione segue
«più o meno» la strada indicata, arrivano «più o meno» all'ora s tabilita, le colline erano «più o meno» occupate dagli a ustriaci. E contali astuzie nasconde, occulta, cerca di divincolarsi dalle enormi res ponsabilità . Le s ue guerre sono concepite con burocratico m estiere, con orario fisso, dove il general e va a fare il riposino, come il capufficio la pennichella. G li eroi non hanno vita lunga. L'ordine del giorno che g li hanno comuni cato il 23 è di una sempli cità straziante, classico dello s tile La Marmora: «Vostra eccellenza si avanzerà domani mattina dalle ore quattro con le debite precauzioni con le s u e q u attro di visioni disponendole come meglio crederà tra Villafranca e Sommacampagna ...». Alle undici, quando già la battaglia è avviata e infiamma, Della Rocca riceve nella sua osteri a di Vill afranca la vis ita del comandante in capo, che non avendo un piano va a spasso alla ricerca d i notizie d e lle sue truppe, inseguito invano da un re sempre più preoccupato e furioso. La Marmora gl i o rdina, poiché non sa nulla, di tener fermo in q uella p osizione. A quell'ordine, Della Rocca sciaguratamente e con criminale tenacia si atterrà per tutta la giornat a. Il comandante è appena sparito ne lla polvere quando all'osteria, gran crocevia della giornata, arriva il re impegnato nel suo penoso inseguimento. Della Rocca ne approfit ta per far un po' di campagna contro il generalissimo ricordandogli ch e siamo andati a gettarci «tra le zanne del nemico» senza ricognizione, convinti che g li austriaci fossero a Verona e che non c'è traccia di un quartier generale dove rivolgere richieste di o rdini e comunicazioni. Incassata la solidarie tà sovrana, torna al l a sua immobilità . A lle richieste del Govone fa rispondere che tutto q uanto poteva mandare, una batteria di cannoni, ha mandato e che n on h a a ltre truppe disponibili. Ch e dunque s i arrangi con quegli aus triaci così molesti.
Perché? La condotta di Della Rocca non è spiegabile con una monumen tale stupidità o mancanza d'iniziativa, difetti in cui peraltro eccelleva . Della Rocca lo fece apposta. Era convinto che il posto di La Marmora fosse il suo e con infantile spirito di ri valsa sragionò così: avete voluto questo bel gen erale ch e va in giro a cercare n otizie della battag lia e non h a preparato nulla? Bene, tenetevelo. Mi h a ordinato di star fermo e io s to fermo. Questo dispetto di cortigiano deluso costò la vittoria a Govone e la vita a tanti suoi soldati.
Il 25 giugno, mentre s iamo in piena ritirata, La Marmora perde la testa, vuole fuggire indietro fino a Cremona. Govone arriva trafelato, furente dopo aver impedito quasi con la forza che venissero fatti saltare i ponti al comando di Cerlungo. Incontra l 'uomo ch e lo h a costretto a indietreggiare e che l o apostrofa un po' beffardo: «O bra-
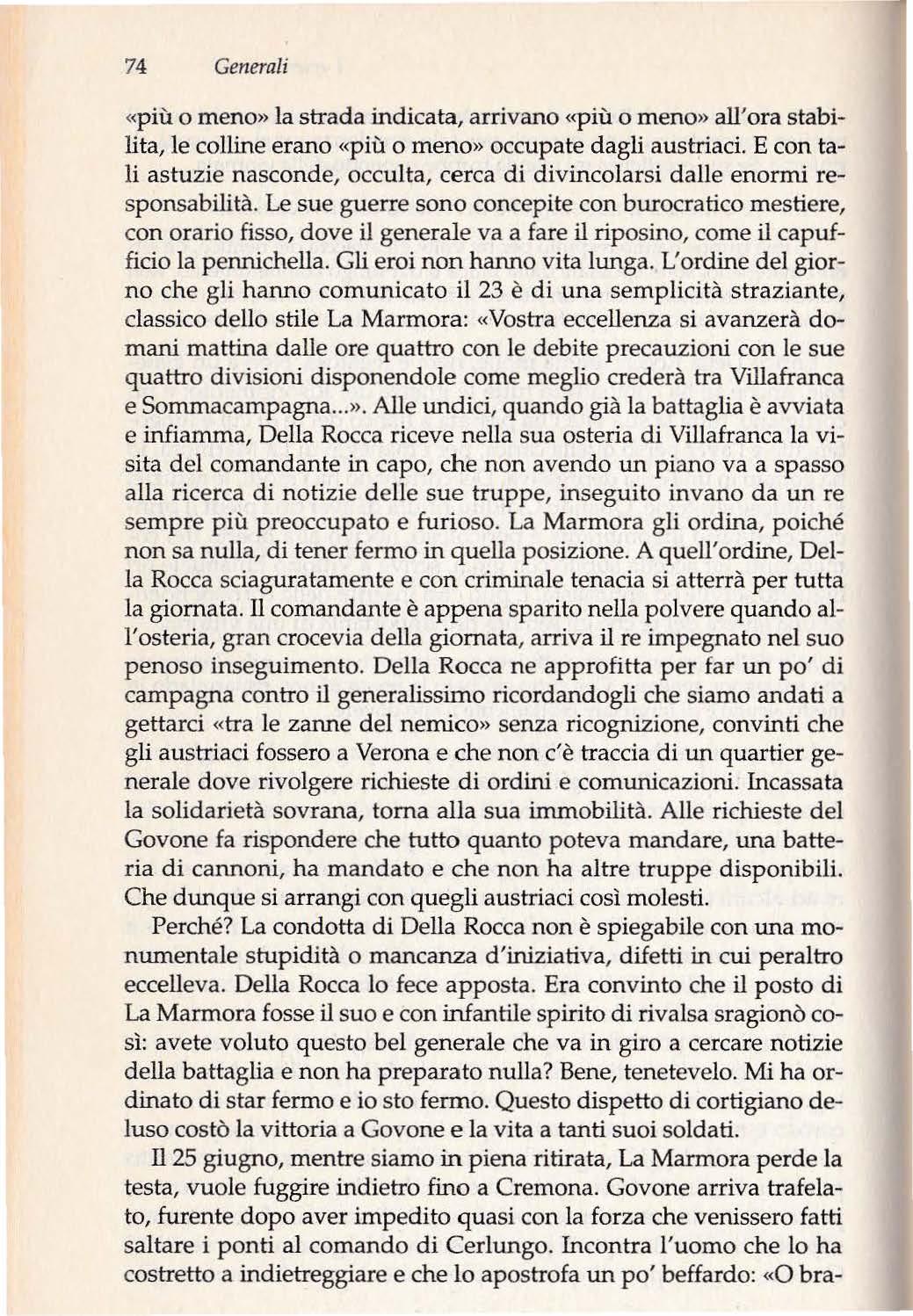
vo! Non sapevamo più d ove lei fosse», e che gli dà, dopo quel bell'incipit, l'ordine di fuggire, ritirarsi, distruggere ca rriaggi e cannoni, lanciando altre maledizioni e insulti contro La Marmora come se in quel disas tro ci trovasse soddisfazione. Govone stralunato chie de al s uo comandante perché lo aveva abbandonato n e l bel mezzo della battaglia , e quello, il cui italiano aveva molto del piemontese: «Bravo u chiel! E mi chi avia la cavalleria austriaca an facia?». Govone non era un diplo matico. Invece di t acer e risponde: «A me è stato d etto che v ' erano due squadroni di ulani contro due divisioni ». Da que l momento il d estino del genera le è segnato. Il 26 la sciagurata ritirata è d ecisa. Ha appena rice v uto notizie che gli austriaci non inseguono, anzi hanno ordinato di bruciare i ponti perché sono certi che g li italiani torneranno al contrattacco. Si precipita a Cerlung o, dove stanno già s montando tutto, con quelle notiz ie d ecisive. Della Rocca lo gela furente: «Insomma, non si dia l 'ari a di criticar tutto, la ritira ta fu d ecisa in consiglio di guerra. Ubbidisca!». Ha lavorato bene il cortigiano: Govone il rompiscatole, il primo d ella classe che crede di insegnar la guerra ai gen erali che hanno più gradi di lui, il p ericoloso criticone che sparla di tutti e segnala errori. Perfino La Marmora è s tato convertito. Govone va dal generalissimo per cercare di convincerlo, lo trova inesorabile sulla ritirata . Ha la voce rud e che convien e a l momento: «Ma è un errore fatale per carità, faccia venir qui Cialdini e ripassiamo il Mincio». La Marrnora si incollerisce, n ei suoi occhi sono g li smarrimenti dell'uom o abitua to a vagolare per lo spazio dei sogni celesti : «Insomma l ei v u o le ciò che vuole, ha idee eccellenti ma è peggio di Cialdini. Lasci fare un poco anche agli altri. Ha un carattere che guasta tutte le sue qualità ». Il giorno dopo la cavalleria scopre che Govone aveva ragione, di a ustriaci n on c'è traccia e la ritirata per for tuna si ferma. Ma quand o Govone t orna al quartier generale è già un uomo condannato:
Tutti mi vo ltano le spa lle. La prima volta che vado a Torre Malamberti, La Marmara che mi vede no n mi chiama. Petitti passa e finge di n on vedermi. Chiedo spiegazioni a Bariola, a d altri, mi d icono che la mia opposizione alle o perazioni era male interpretata. Paz ienza! Io non parlo per me ma per iJ paese per l'esercito rovinato da tanti e rrori.
Ecco il punto: sa la verità, è la m e mor ia vivente delle loro turpitudini. Per questo costituisce un pericolo che bisogna isolare e annichilire. I ricordi sono olio bollente. Il generale ha commesso forse invol o ntariame nte un a ltro errore . Su un giornale della «Es trema » (termine che dava subito l' idea d i barricadieri della penna, di gente

che mina le pubbliche istituzioni), «Il Sole» di Milano, esce un estratto del suo rapporto in cui si racconta senza polemica la verità, che cioè il mancato soccorso da parte del Della Rocca è costata la giornata. Per il cortigiano è un pericolo mortale. Odia, da buon reazionario, i giornalisti; i pochi che osano avvicinarsi ai suoi comandi sono spediti via con occhiate minacciose, e addirittura scrive alla moglie: «se avessi qualche migliaio di lire di troppo le impiegherei a far dare buone legnate a quei giornalisti che sono insolenti e schifosi».
A metà luglio quando, ritiratisi gli austriaci e vuoto il Veneto, finalmente decidiamo di marciare all'inseguimento, va da Petitti per sapere se andrà con Cialdini sulla strada di Vienna (figuriamoci!) e con La Marmara nel Tirolo ricevendo l'amara risposta: «Lei resta qui. Mio caro, lei si dà troppo movimento e più nessuno la v u o le ... Della Rocca h a chiesto che la tolgano dal suo corpo». Lasciamo la parola a Govone:
Qui debbo confessare che fui ferito. Capisco di essere per lui un rimorso, g li ho detto, dopo la battaglia, che non mi aveva soccorso e che l'aveva fatta perdere. Confesso questi torti ma è difficile contenersi di fronte a così gravi avvenim enti. Se il generale non mi vuole io sono contento di non essere più con lui in cui n on posso avere fiducia. Ma soggiunse Petitti.: e Della Rocca sa che lei ne sparla. E ha fatto pubblicare sul "Sole" una parte del suo rapporto del 24 ...». Replico che quanto a spa rlarne non lo faccio io ma la truppa, so di una divisione che non è la mia ove i soldati lo hanno battezzato il duca di Villafranca. S i deve riconoscere che è impossibile evitare la critica quando questa è meritata. Non c'è che un modo: chi ha una taccia deve togliersi dall 'esercito sub ito. Cosi fanno i francesi, cosi fanno gli austriaci. Petitti dice: «Ma con questa teoria si dovrebbe togliere il generale La Marmara poiché ha perduto la battaglia». lo taccio.
Non tace invece il Della Rocca. Archivia le proprie responsabilità con un autocelebratorio: «q uindi, per chi vede le cose in grande e non bada soltanto alla località sulla quale si trova, è cosa certa che io av rei commesso un grave sbaglio non tenendo fortissimo a Villafranca». E, come testimonia un suo complice, il generale Corvetta, si dà un gran da fare invece perché «il generale G... » (non ne mette neppure il nome nella sua corrispondenza tanto è l 'odio che gli porta) «che con le sue lettere ai giornali si è posto in un vespaio ne esca "malconcio assai"». È il curaro fatto carne e ossa, avvelena tutto ciò che tocca .
Emarginato, guardato di malocchio da una larga parte dei colleghi perché gli era rimasta la fama di aver tradito la disciplina e l'omertà corporativa, gli resta ancora un servizio da compiere, per quel dovere a cui era rimasto sempre febbrilmente fedele. Finita male la
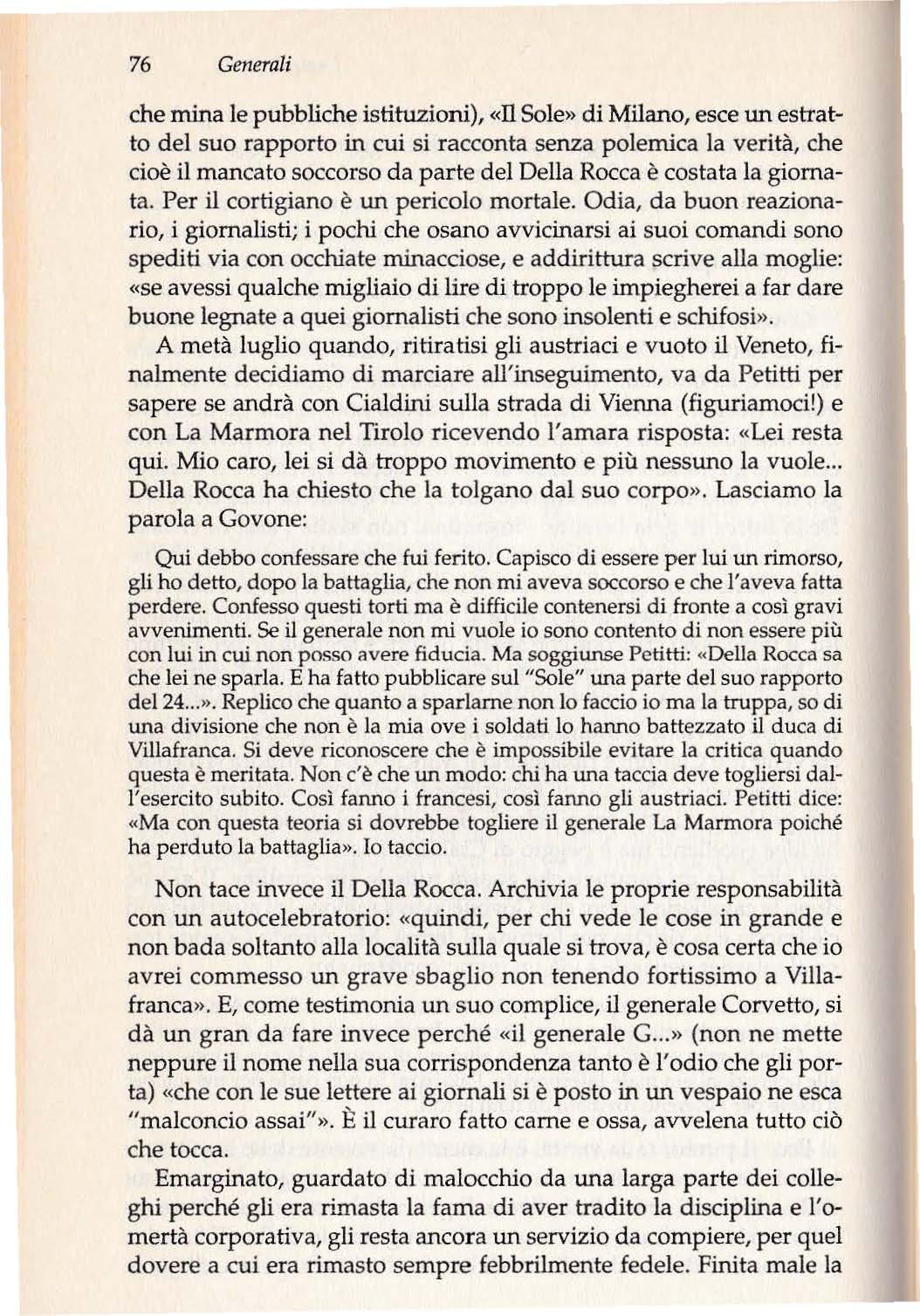
guerra c'era una nuova battaglia da combattere non meno insidiosa e complicata: quella contro il disavanzo. Mancano l'enormità di centottanta milioni ai bilanci dello Stato, c'è il rischio concreto di una bancarotta, così concreto che il re addirittura minaccia di abdicare per non essere travolto da quella vergogna. Giovanni Lanza cerca con i soliti maneggi, barcamenandosi tra destra e sinistra, di mettere in piedi un ministero disposto ad accettare e far accettare come già si diceva allora lacrime e sangue. Deve trovare un generale disposto a mettere la sua firma sotto un bilancio che taglia di venti milioni i fondi dell'esercito, sfidando la probabile rivolta dei colleghi. Si rivolgono naturalmente a Govone.
La crisi è di quelle italiane: nomi che vanno e vengono, portafogli che passano di mano dieci volte in una mattinata, candidati sicurissimi che spariscono in poche ore, mediazioni intrighi baratti. L'unico che fa davvero i conti è il generale, che si ingegna a tagliare tutto il tagliabile: riduce gli squadroni di cavalleria che ormai non servono più a niente, scioglie alcune batterie di cannoni, risparmia, arriva fino a dodici milioni, si accorge che di più non può fare. Alla fine il governo riuscirà, ma a pagar per tutti sarà come sempre Govone che si vedrà rovesciar addosso dai colleghi una nuova accusa: aver di nuovo rotto la solidarietà di classe e aver smobilitato l'esercito. Cialdini, il solito Cialdini, lo attacca alla Camera; Della Rocca continua metodico e silenzioso la sua campagna di calunnie, perfide ironie, veleni. La tensione nervosa di quell'incarico smisurato, più complesso che dirigere una battaglia (sono gli anni della conquista di Roma) sconvolgono la mente del generale. Comincia a dare i primi segni della malattia mentale che nel 1872 lo porterà alla tomba. Imp lacabile e feroce, l'odio di Della Rocca non si ferma neppure di fronte alla morte: «Lo sventurato aveva perso il ben dell'intelletto e saltava e ballava nel suo gabinetto ministeriale lasciando senza ordine i comandanti delle truppe accampate intorno a Roma o dandone di così strampalati che Cadorna se li doveva far ripetere e poi variarli». Ecce Homo!
L' ammiraglio che non sapeva nuotare Raccontano che il conte Carlo Pellion di Persano, ammiraglio di Sua Maestà il re d'Italia, poiché non sapeva nuotare tenesse sul ponte di comando sempre due robusti marinai che invece, in quell'arte che potremmo definire di minuta sopravvivenza marinaresca, erano i più sperimentati della flotta; nel caso di un malaugurato naufragio
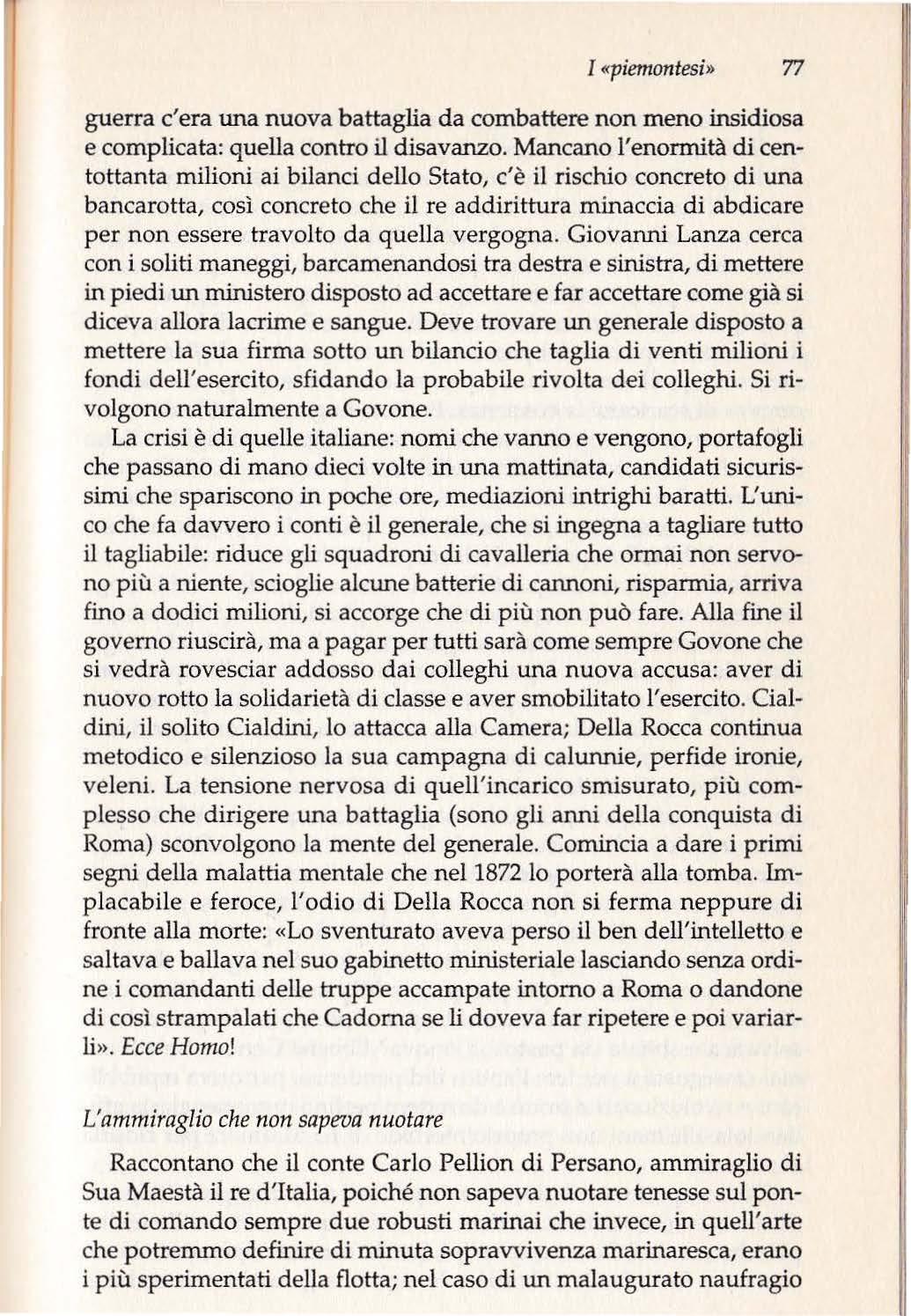
avrebbero dovuto preservare, tenendolo a galla fino al salvamento, quella fine mente di stratega indispensabile agli immancabili destini del Regno. Forse anche questa era solo una leggenda. Ne giravano tante sull'ammiraglio. Per esempio che fos se asceso al ministero della Marina e alle più alte cariche dello Stato soltanto perché era figlio adulterino di Carlo Alberto e quindi fratellastro del re galantuomo. E non se ne parlava solo nei caffè o nei salotti: questa leggenda la riportò perfino un fortunatissimo libello contro il vinto di Lissa quando la sopravvivenza del paese sembrava dipendere dall'annientamento di quell' uomo e con il processo la classe dirigente italiana cercava di scaricarsi la coscienza. Era una bugia, perché le date manifestamente non coincidevano e bastava andare a consultare l ' atto di nascita in ben tornito latino dell'illustre personaggio. Nella storia dei comandanti italiani è sos peso a mezz'aria. Appare a un tratto come nel vuoto, sembra agire senza alcun punto di appoggio o di sostegno visibile. Poi sparisce. Nella deprecazione universale. Il Persano era, verità questa incontestata, nativo di Vercelli, luogo del Regno che con le acque aveva molti punti di contatto ma certo non sufficienti per ispirare in un giovanotto gli orizzonti del navigatore e d e ll' ammiraglio. E pure non era facile avere quella ispirazione in un Regno che era quasi per tradizione terragno, con gli occhi rivolti alla Francia e alla Lombardia, abituato a fare i conti per difendersi e per sognare nuovi possessi con le montagne e, al massimo, i fiumi. Non c'era nulla da fare: ai Savoia il mare non diceva niente, c' erano arrivati quasi per caso, inseguendo con quel loro talento predone un' avidità di nuove terre che sfiorava l'anoressia. Di tutto ci si poteva accontentare; anche della contea di Nizza dove la famiglia di Persano era nata con il gusto del mare, prima di spostarsi per vicende di carriera e di feudi in terraferma. E perfino quando le vicende della Storia li fecero signori di Genova e della Sardegna, i duchi di Torino mantennero sempre per quei sudditi marinai una ben rodata diffidenza. La Sardegna la consideravano poco più che una colonia selvatica e abitata da pastori. Genova? Ebbene Genova non si era mai rassegnata a perdere l'antica indipendenza, partoriva repubblicani e riv oluzionari a frotte e dovettero perfino cannoneggiarla affidandola alle mani non proprio morbide di La Marmora per ridurla al silenzio.
C'è il sospetto che il giovane rampollo di nizzardi trasferiti in terraferma avesse scelto la carriera in marina invece che nell'esercito, più che per antiche consuetudini, per la concreta speranza che su una nave fosse facile abbordare le supreme gerarchie visto che la
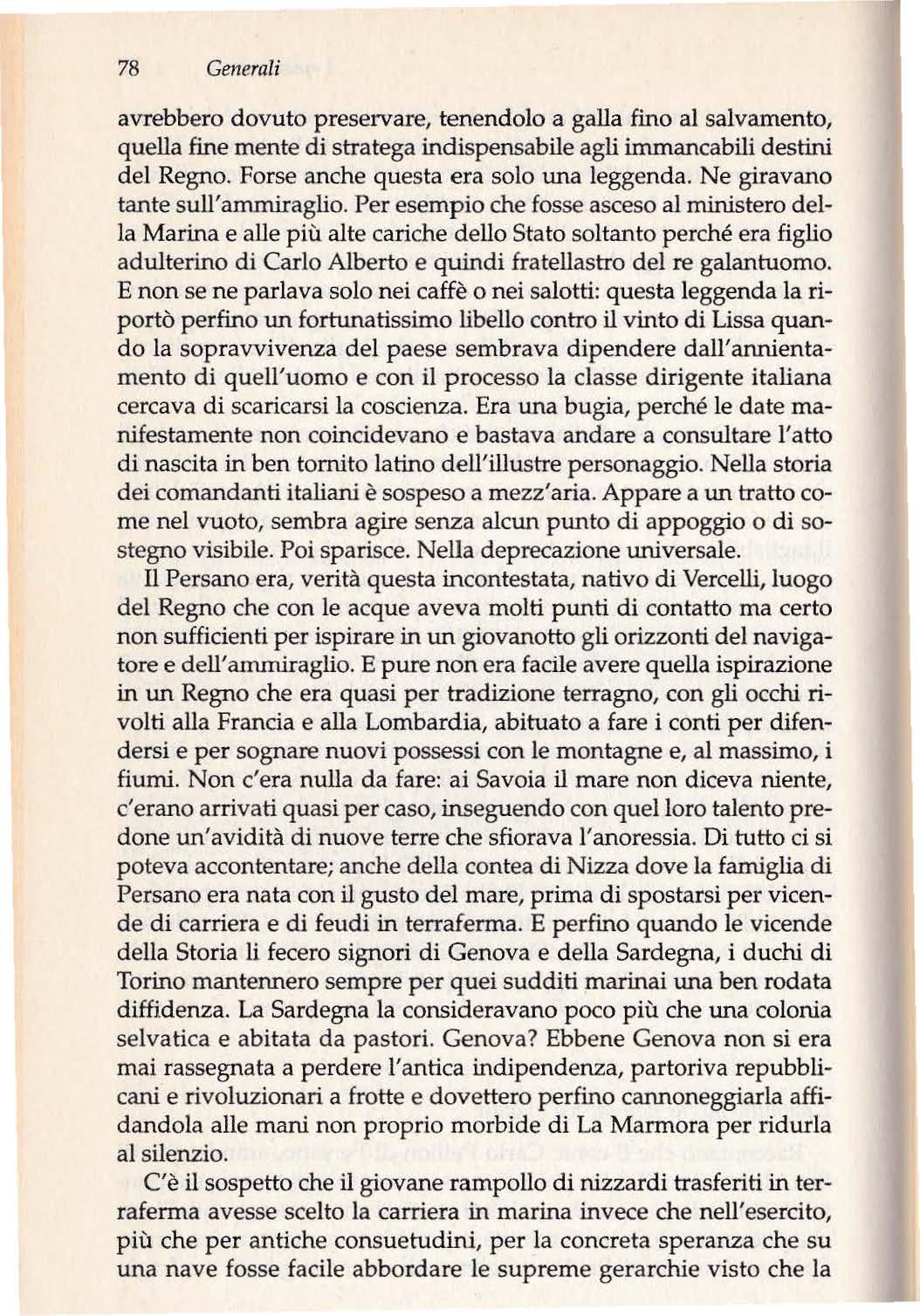
concorrenza era modesta . Per dirla chiara, la marina sarda semplicemente non esisteva, non aveva una storia. Era sempre stata formata da piccoli battelli che servivano soltanto per tener testa alle scorrerie dei pirati barbareschi. Nessuna grande battaglia: per molti anni era stata ricordata come impresa gloriosa la cattura di un bastimento tunisino; tanto che il nome della località per tradizione veniva data a una nave della flotta sarda. Nelle guerre del Risorgimento la marina aveva svolto una parte trascurabile: sette morti in tutto testimoniavano che gli eventi bellici non dovevano esser stati particolarmente grandi. Si era segnalata, per la verità, più che per le battaglie - che la sorte non le aveva concesso di combattere - per un ammutinamento: quello degli equipaggi spediti nel 1848 a pattugliare l'Alto Adriatico e che all'ordine, dopo la fatai Novara, dì tornare a casa, sì erano ribellati. L'Albini, che li comandava ed era il padre dì un protagonista di Lissa, non era riuscito a controllarli, anzi, impiegando a sproposito le buone regole dell ' educazione navale, andandosene aveva scambiato segnali di saluto con la flotta nemica. Apriti cielo! Gli equipaggi, già furibondi e sospettosi, ne avevano tratto la convinzione che dietro a tutto ci fosse un bel tradimento. Così al ritorno gli era stato tolto il comando. Episodio che certo non aveva contribuito ad alzare quella parte delle sue forze navali nella considerazione dei sovrani.
Era questa, comunque, una caratteristica anche delle altre marine italiane, che per trovar gloria dovevano risalire alle Repubbliche medievali. In Toscana ancora si parlava dell'unico vero bastimento dei granduclù che datava all'età dì Filippo II e che era stato appunto dagli spagnoli requisito con imperialistica arroganza e costretto a condividere la sorte del!' Armada non proprio invincibile. E ne erano seguiti per secoli processi, contese diplomatiche, riclùeste di risarcimenti. Sulla carta la marina napoletana, che avrà gran ruolo nella vicenda del Persano, era la più agguerrita d'Italia. Un poco perché in passato aveva con qualche tragedia manovrato a fianco o contro la sublime flotta di Nelson, e soprattutto perché Ferdinando II, il «re Bomba» attentiss imo a tutto ciò che poteva salvarne il declinante potere assediato dalla Storia più che dai rivoluzionari, ci aveva dedicato soldi e attenzione: cosicché disponeva di battelli modernissimi, a vapore, quando gli altri ancora arrancavano a vela come ai tempi di Ruggero di Lauria. Vantava anche una scuola per ingegneri navali e un bacino per riparar i motori delle navi. Quel che mancava erano però comandanti ed equipaggi con la sclùena dritta, insomma il morale .

Abbondavano per esempio tipi come Ferdinando Pucci, che era rimasto alle guerre del Settecento, invecchiato nel tranquillo trantran della marina di Napoli e che era conosciuto più che per l' abilità nel manovrare vela e cannone, per l'esercizio non solo tecnico ma anche pratico dell' arte gastronomica. A Napoli erano famosi i suoi manicaretti. Oppure Napoleone Scrugli di Tropea, calabrese che si dava grandi arie da liberale e murattiano (ma questo non era bastato perché i Borboni pazientissimi almeno lo togliessero dalle loro armate). Come nocchiero era citato soprattutto per aver portato a naufragio una fregata a ruote sulla bocca del Tronto. Non a Capo Horn. Con sussiegosa protervia aveva rifiutato i consigli dell'ufficiale di rotta . Eppure Francesco gli aveva offerto il comando della flotta. Erano state queste anime filistee a d istruggere la monarchia e a vendere, in cambio di sinecure e posti, la marina ai piemontesi. Di fronte a non proprio straordinari esemplari di navigatori, diciamo subito che il Persano faceva la sua bella figura. Perché era stato, ci viene il sospetto anche a causa del nome che portava, l'enfant prodige di quella marina lillipuziana grazie a un abbordaggio e a una crociera . L'abbordaggio, con una operazione che sembrava uscita dai tempi delle crociate e di Lepanto e invece risaliva al 25 settembre 1825, l'aveva compiuto a Tripoli, non ancora «bel suol d'amore» ma sempre luogo da cui partivano pirati e si acquattavano bey selvatici e prepotenti . Una decina di imbarcazioni armate del re di Sardegna - piccole navi, intendiamoci, brigantini e golette - era andata di notte con audacia da commando all'assalto della flotta altrettanto piccola del bey. Lo sconquass o serviva per risolvere una bega di tributi ma soprattutto di savoir-faire diplomatico; quell ' armatore di pirati giudicava il Savoia troppo secondario per rendergli omaggio come a una potenza europea. La sorpresa non riuscì ma il Persano, che a vent'anni comandava una delle navi assalitrici, riuscì a salire a bordo e a incendiare uno dei vascelli del bey il quale il giorno dopo, mugugnando, sparò ventuno salve di cannone in onore della bandiera sarda.
Maggiore notorietà gli diede la seconda avventura. Persano, che intanto era stato in lnghilterra a studiare le navi a vapore che quei cantieri stavano sfornando in anticipo sui tempi e vi aveva pure trovato moglie, ebbe il comando dell ' Eridano, trecentocinquanta tonnellate, un brigantino bell ' e nuovo con cui la marina sarda compiva la sua prima circumnavigazione del globo e metteva il naso fuori dalle domestiche e paludose acque del Mediterraneo. Tre anni durò il viaggio che diede al Persano la fama di novello Magellano, rotto a

tutte le più spericolate e complesse manovre alla vela. Perizia di cui lui cominciò a vantarsi a proposito e a sproposito, ordinando alle navi di cui aveva il comando passaggi arditi e inutili anche per entrare in un porto o per scivolare tra secche e scogli che si potevano benissimo evitare senza guai. Era vanitoso il futuro ammiraglio e non perdeva occasione per esibirsi: nel 1851 gli andò bene, perché rifiutò il pilota per risalire il Tamigi con la più moderna nave della flotta sarda causando, fra l'altro, un piccolo scandalo a Londra dove erano preoccupati che si potesse arrivare senza problemi con un ' imbarcazione da guerra fino alla capitale. L'ambasciatore sardo dovette smentire che la nave fosse davvero riuscita a risalire il fiume, procur andosi furibonde controsmentite da Persano offesissimo di esser stato privato del suo exploit.
Un'altra volta gli andò male quando, sempre in quell'anno, sulla sua nave salirono passeggeri di eccezione: il re, il duca di Genova e il principe di Carignano. Era una crociera innocua, un passaggio dato a quegli illustri personaggi che andavano in Sardegna per una partita di caccia, unico scopo per cui l'isola sembrava ai Savoia essere stata creata dal buon Dio. Il Persano, che era attentissimo a farsi propaganda, volle però approfittarne per mettersi in luce. Invece dj segujre la rotta normale si gettò audacemente tra gli scogli della Maddalena per «far guadagnare mezz'ora ai tre passeggeri» e soprattutto far vedere la sua abilità marinara. Il Governolo finì con lo scafo squarciato da uno scogHo che nessuna carta nautica indicava anche perché di lì non passava nessuno. Il re e i parenti non annegarono ma si dovette procedere a trasbordarli su un altro scafo. Persano fu spedito, come era logico, davanti al consiglio ili guerra e fu condannato alla perdita del grado per sei mesi. Doveva avere protettori potenti. Infatti in ltaHa, dove c'è sempre un appello che arriva a modificar e l'asprezza delle sentenze, tutto fu cancellato: colpa non dell'incauto navigatore ma delle carte che non segnalavano quello scoglio molesto e un po' repubblicano!
Ma questi erano dettagli. Il vero guaio dell' ammiraglio cui il Regno affidò la sua prima flotta da guerra, la «leggenda» che lo perseguitava e che a Lissa vide la più sanguinosa conferma, era che fosse un vigliacco. Per la verità, passato il bruciore della sconfitta e i furori del processo (raramente nella storia italiana si è assistito a una tale uniforme volontà di trasformare un singolo individuo in simbolo dei guru collettivi) Persano ha trovato difensori tenaci e animosi. Tra questi, un altro ammiraglio: Angelo Iachino, anche se il suo meticoloso libro sulla campagna di Lissa si può leggere più come un'auto-
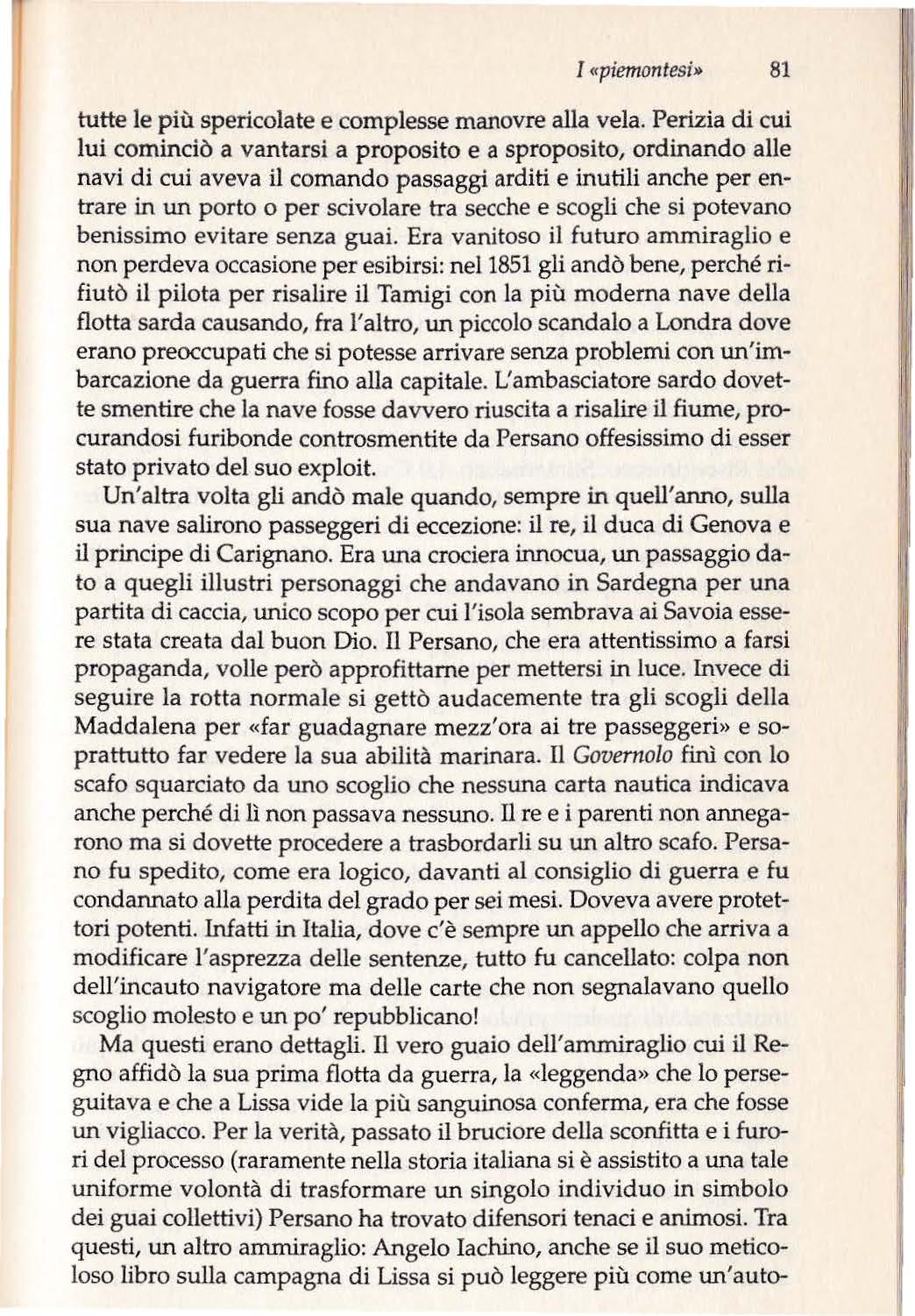
difesa che come un tributo alla memoria dell'ormai dimenticato vinto di Lissa e Iachino difende in realtà se stesso, i macroscopici errori della nostra flotta ne lla seconda guerra mondiale quando con belle navi come quelle di Persano non combinammo nulla e demmo la stessa prova di scarsa animosità e incompetenza di un secolo prima. Iachino non riuscì ad affondare neppure un cacciatorpediniere inglese, ma impavido sfornò volumi per dare lezioni postume a un secolo di guerra navale. Ecco un altro impudente chiacchierone per la nostra galleria degli orrori.
Quando il Persano con la sua flotta ormeggiò davanti ai muscolos i bastioni di Gaeta, per procedere al blocco della città e aiutare Cialdini a smontare l'ultimo pezzo dei Borboni, era già un protagonista del Risorgimento. Stimatissimo dal Cavour che lo aveva impiegato in quella operazione ai confini tra politica guerra e intelligence che era stata l'acquisto della flotta meridionale, si muoveva con la nonch a lance di un signore della guerra. Eppure il 22 gennaio la sorte d oveva riservargli qualche amarezza. «La piazza si tace» aveva scritto il giorno prima al s uo protettore Cavour che era ansiosissimo, chiedeva notizie di quell'assedio troppo lungo e complicato, «che gatta ci covi?» Era proprio così. All' improvviso i difensori scatenarono un fuoco d'inferno che coprì la lunga linea delle fortificazioni di una nube di fumo spessissimo, mentre gli a rtiglieri di Cialdini presi di sorpresa stenta vano a rispondere al fuoco. La flotta lasciò gli ancoraggi a Mola e s i diresse in linea di fila come prescrivevano i regolamenti verso la città per replicare. Francesco Il e la moglie animosissima con i loro ufficiali seguirono preoccupati le impeccabili manovre della squadra che scivolava nave dopo nave, scaricava i cannoni e poi lasciava il posto alle altre riprendendo con l'esattezza di un metronomo il suo posto nella fila. Ben presto i difensori si accorsero che i colpi finivano in mare sollevando immensi scenografici castelli d 'acqua (un'onda bagnò anche la regina, che si diverti moltissimo innalzando di qualche grado la sua fama di amazzone senza paura). La flotta italiana aveva inaugurato una delle s ue caratteristiche più solide e durature, far la guerra per finta tenendosi rigorosamente fu o ri tiro. I soldati napoletani celebraro n o la scoperta d a par loro: pernacchie, gestacci, ironici saluti con i fazzoletti rivolti alle navi italiane che continuavano impassibili a sprecare munizioni. La banda dei reggimenti caccia tori intonò l' inno borbonico (scritto da Paisiello) alternandolo con i valzer. Uno dei colpi degli italiani gettò sulla battigia una spigola, che un marinaio andò a recuperare offrendola al re tra gli applausi.
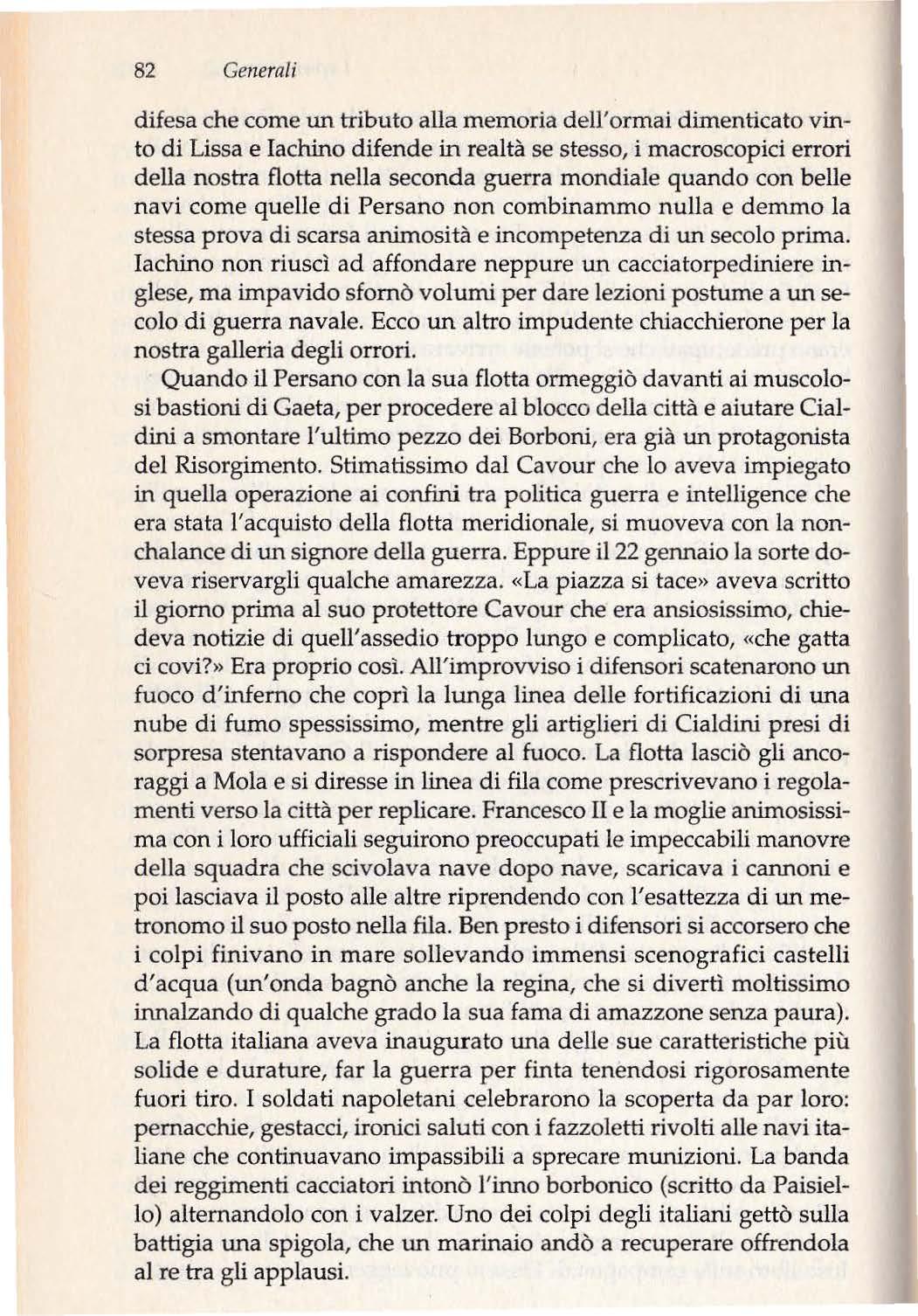
Proprio il giorno prima Cialdini aveva scritto al ministro della Guerra Fanti una lettera singolare: «Fammi sapere se è vero che Cavour ha ordinato a Persano di non esporre le navi al fuoco come dice lui. Tu sai che ho delle ragion.i per supporre che l'ammiraglio sia un falso coraggioso».
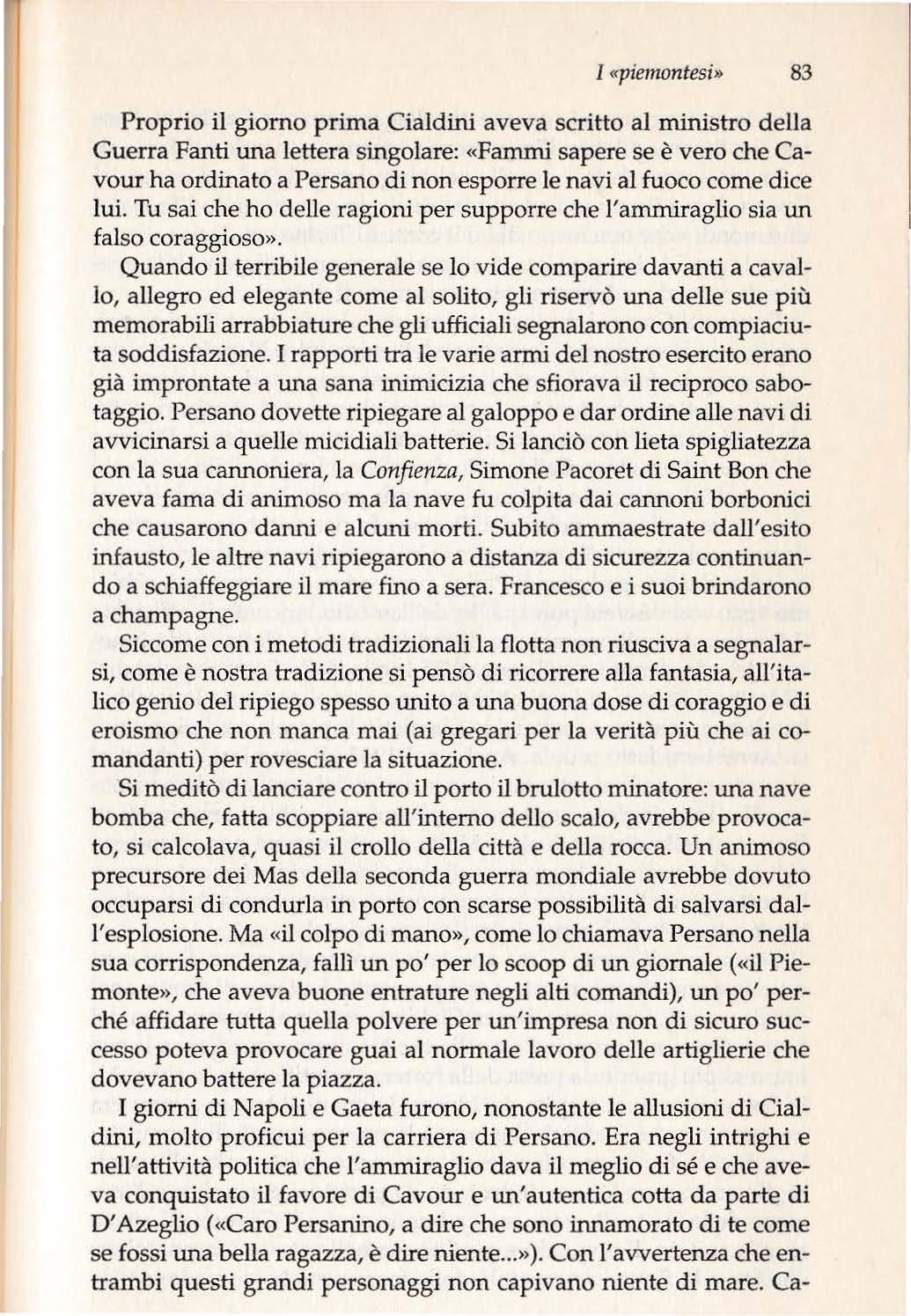
Quando il terribile generale se lo vide comparire davanti a cavallo, allegro ed elegante come al solito, gli riservò una delle sue più memorabili arrabbiature che gli ufficiali segnalarono con compiaciuta soddisfazione. I rapporti tra le varie arnti del nostro esercito erano già improntate a una sana inimicizia che sfiorava il reciproco sabotaggio. Persano dovette ripiegare al galoppo e dar ordine alle navi di avvicinarsi a quelle micidiali batterie. Si lanciò con lieta spigliatezza con la sua cannoniera, la Confienza, Simone Pacoret di Saint Bon che aveva fama di animoso ma la nave fu colpita dai cannoni borbonici che causarono danni e alcuni morti. Subito ammaestrate dall'esito infausto, le altre navi ripiegarono a distanza di sicurezza continuando a schiaffeggiare il mare fino a sera. Francesco e i suoi brindarono a champagne.
Siccome con i metodi tradizionali la flotta non riusciva a segnalarsi, come è nostra tradizione si pensò di ricorrere alla fantasia, all'italico genio del ripiego spesso unito a una buona dose di coraggio e di eroismo che non manca mai (ai gregari per la verità più che ai comandanti) per rovesciare la situazione.
Si meditò di lanciare contro il porto il brulotto minatore: una nave bomba che, fatta scoppiare all'interno dello scalo, avrebbe provocato, si calcolava, quasi il crollo della città e della rocca. Un animoso precursore dei Mas della seconda guerra mondiale avrebbe dovuto occuparsi di condurla in porto con scarse possibilità di salvarsi dall'esplosione. Ma «il colpo di mano», come lo chiamava Persano nella sua corrispondenza, falll un po' per lo scoop di un giornale («il Piemonte», che aveva buone entrature negli alti comandi), un po' perché affidare tutta quella polvere per un'impresa non di sicuro successo poteva provocare guai al normale lavoro delle artiglierie che dovevano battere la piazza.
I giorni di Napoli e Gaeta furono, nonostante le allusioni di Cialdini, molto proficui per la carriera di Persano. Era negli intrighi e nell'attività politica che l'ammiraglio dava il meglio di sé e che aveva conquistato il favore di Cavour e un'autentica cotta da parte di D'Azeglio («Caro Persanino, a dire che sono innamorato di te come se fossi una bella ragazza, è dire niente... »). Con l'avvertenza che entrambi questi grandi personaggi non capivano niente di mare. Ca-
vour lo aveva nominato agente di collegamento con Garibaldi, l'uom o che dove va pilotare l'impetuoso e ingenuo generale nel far larivoluzione senza farla, o m eglio nel conquistare il Sud n el nome d e i Savoia. E qui Persano diede prova dj classe convincendo l'Eroe d ei due m ondi «ch e non meno di lui il conte di Torino era d eciso a compiere la grande impresa, ma che per riuscire e ra indispensabile operare di concerto, ad op erand o tuttav ia m e toru d iver si».
Davanti a Gaeta incrociava poi una s quadra francese il c ui ammjra g lio, non si sa s e per le istruzioru d ell'erugmatico Napoleone o per estro proprio, faceva di tutto p er da re una mano a i due g iovaru sovraru e m e ttere i bastoru tra le ruote ai piemo ntesi; «tenga rispetto alle navi francesi il contegno più riserv ato» raccomandava a Persano il Cavour, che sudava freddo solo a pensare a un possibile incidente con quell' all ea to così ambiguo forse più per le proprie indecisioni che p e r vero disegno politico. E Persano fu riserva tissimo, aspettando co n pazienza che l 'ammiraglio «amko» s i a llontanasse, ricruamato infine d al s u o padrone di Parig i, per awiare le o perazioru, abbiamo visto così discrete pure quelle, dell'assedio. Anco ra più efficiente il Persano fu n e ll 'op erazion e di raddoppiare la flotta sarda innesca ndo, con denaro e p o ltrone, il 25 luglio d e lla flotta napoletana. Ammiragli e comandanti a bbassa r ono semplice mente la vecchia bandiera e vennero a m ett ersi in fila dietro le piccole na vi piemon tesi. Av re bbero fatto scuola. Anche nel 1943 gli ammiragli, che non avevano mai n a fta o estro ta ttico p er u scire dai porti e andare incontro alla flotta ing lese, copieranno g li impennacchiati ammiragli d i Francescruello d i rigendosi s u M al ta a tutto vapo re per a rrendersi agli inglesi e salvare le grech e sulle maruche: evid e nte m ente presso la nostra gente l 'autoaffondamento, eroico stra tage mma d e i p e rde nti per salvare la faccia, n on è pratica conosciuta! Siamo qui di fronte a una parola ingombrante: paura. È un conce tto ins ieme e troppo vas to e troppo stretto. La fama di fifone, anzi di fa lso coraggioso come diceva Cialdinj, veruva al P ersan o non dai fatti di Gaeta ma proprio da que lla che lui s tesso consider ava la s u a impresa più grande : la presa della fortezza pontificia di Ancona. Alla flotta toccava il compito del blocco dal mare, il lavo ro a te rra e ra nuovam e nte del Cialdinj, che faceva le prove generali di co nquistato r e di città . Sarà una coincidenza, ma anche questa vol ta all 'ammiraglio arrivarono le ttere di protesta da parte dei genera li per l ' inaz ione d e lla flotta. Persano aveva buone scu se: il Cavour g li aveva r accomandato di non subire p e rdite ma n e llo s tesso tempo voleva che fosse la flotta, cen e ren to la delle forze a rma te, a g u adagna r la

gloria della resa di Ancona. Persano che non aspettava altro che obbedire agli ordini risolse il problema mandando al bombardamento una na ve per volta. Come a l solito m anca va il carbone e c'era poco da far g li eroici. In quel modo non rischiava nulla ma l'assed io poteva durare secoli, mentre Cialdini aveva fre tta di correre a s ud p er, si fa p e r dire, «da re una mano a Garibaldi» . L'estro gli suggerì anche un'azio ne che, se riuscita, avrebbe audacemente antici pato qu elle d ei commando: caricare truppe da sbarco sulle lance delle navi e di notte scivolare fino all'imboccatura del porto, tagliare la catena che lo chiudeva e p oi, approfittando d e lla s o rpre sa, impadronirsi del m olo e della fortificazione (dal lugubre n ome di Lazzaretto) che la presidiava. Creato il p a nico tra i difensori, c'era forse m od o di sbarcar a ltri marò e dare l 'assa lto alle altu re della città. L' idea non e ra malvagia e forse si poteva anche riuscire; solo ch e Persano, per non d ividere la gloria, no n disse nulla a Cialdini: s i limitò a spedirgli poche o re prima un enigma tico biglietto in cui g li ann unciava «che si aspettasse per quella notte un tafferuglio ne l porto». Persano restò sull 'ammiraglia scrutand o n e ll'oscurità d opo ch e le barche deg li inc ursori g uidate d a un capitano Cerruti erano sco mparse n el buio. Urla s trepiti cannonate bagliori di scoppi: dalla Maria Adelaide p a reva che n ella vecchia fortezza pontificia fosse scoppiato l 'inferno. Già Persano esultava, quando Cerruti e i s uoi, mestam ente , riapparvero. La sorpresa non era riuscita e l 'animoso si era limitato a scambiar fucilate con i difensori rischiando anche di restare intrappolato. Il giorno dopo Persano ci riprovò con più barche e soldati e guidando di persona la spedizione: questa volta fu colpa della catena che n on si riuscì a spezzare con m ezzi inadeguati se si ri p e té il fiasco. Si d ovette, dopo aver gettato in a ria bestemmie scultoree, riprendere il no rmale bombardamento, e qui molti notarono e fecero notare che l'ammiragli a andava sempre ad attaccare i forti per ultima quando il fuoco dei difensori s i era fatto più fl eb ile e addirittura, nei pochi casi in cui s i avv icinò a distanza più efficace e pericolosa, l 'ammiraglio p e r varie ragion.i non e ra mai a bordo. Se le voci e i mormorii erano s ui moli, e sulle to lde delle navi odio in fermentazione, nulla naturalmente trasparve a livello come si dice, ufficiale. Anzi, Persano fu esa ltato come l'espugna tore di Ancona : Cavour era uomo che manteneva le promesse e o rdinò che la resa d el Lamoricière, ultimo generale d el papa, fosse firmata s cenograficamente proprio a bordo di quella Maria Adelaide che così ambiguamente aveva partecipato alle operazioni. Ne d erivò a l Persano la gran croce d ell'ordine militare dei Savoia: una robusta pennellata alla su a autostima vanitosa! E da
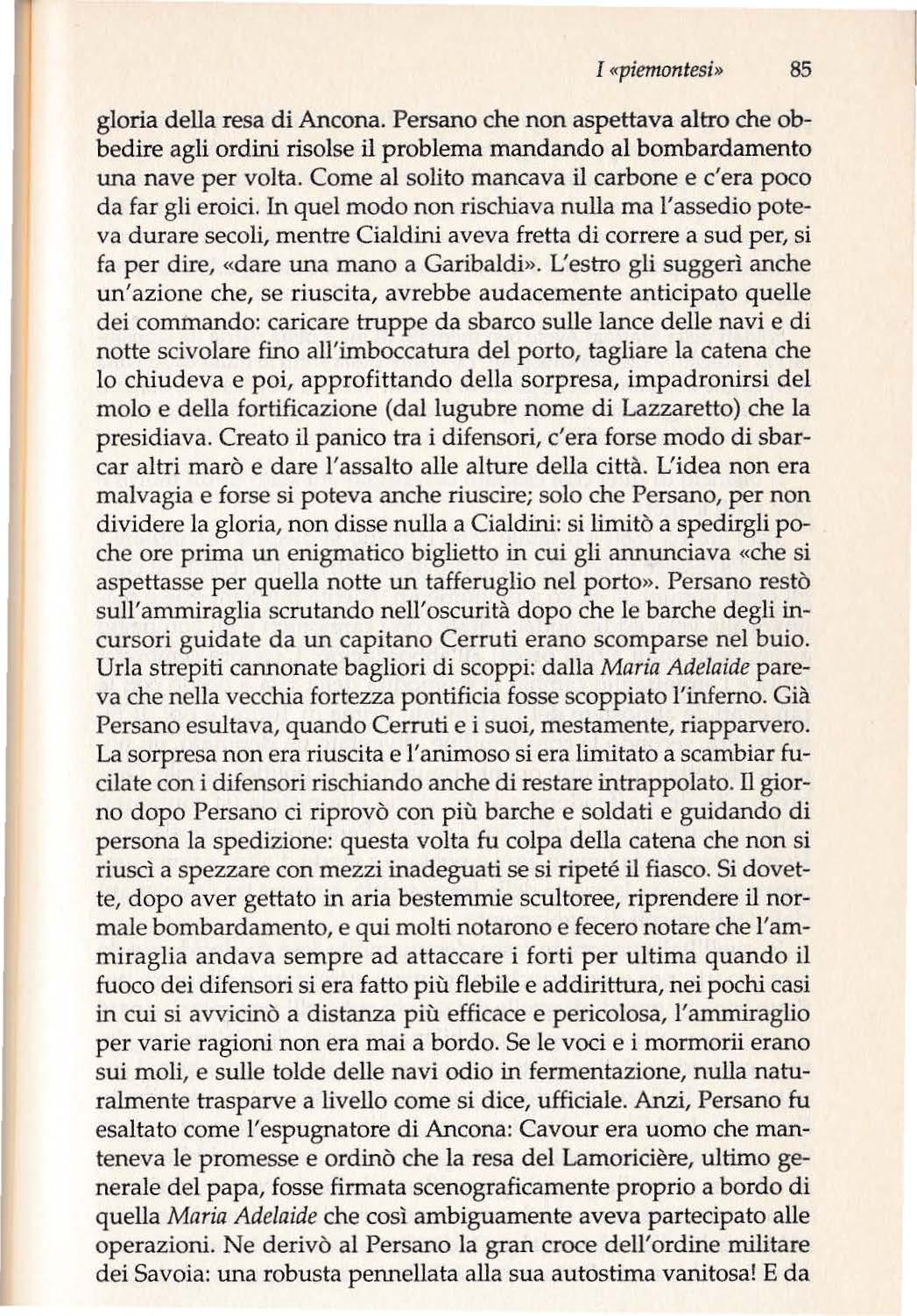
parte dei generali un astio e una voglia di rivincita che li portarono a torto perfino a rimproverargli lo stile con cui aveva ricevuto a bordo il vinto e a buttar benzina su quelle voci di scarso coraggio personale che da quel momento avrebbero perseguitato l'ammiraglio. L'interrogativo se si fosse trattato di vera gloria è di natura piuttosto accademica, soprattutto per l' interessato, il quale mandò alle stampe il solito orgoglioso proclama :
Soldati della Marina! Avete ben meritato di me e della patria [la scansione era indicativa del personaggio]. Le vostre gesta sotto le mura di Ancona sono degne degli eredi delle glorie di Pisa, di Venezia e di Genova. Soldati! La nazione vi guarda con orgoglio, il vostro re vi ringrazia. Sono grandi i destini della Marina italiana.
Il bilancio di quel così esaltato tafferuglio era stato di un morto e o tto feriti leggeri.
Tra l'eroico 1860 e il fatale 1866 Persano si diede a raccogliere i frutti dell'essere diventato un padre della patria; indifferente ai cipigli degli uomiru, si elevò a monumento. Niente più tempeste e manovre alla vela, addio audaci virate con i cannonieri e gli equipaggi a rrampicati sugli alberi pronti all'abbordaggio. L'e popea sembrava finita e l'ammiraglio cambiò le scomodità della vita a bordo con le più ovattate atmosfere del Parlamento prima di Torino e poi di Firenze. Era, secondo la consuetudine, diventato un deputato, un notabile rispettato per tutto quanto riguardava la politica navale. Ombroso e facile a offendersi e a dar mano alla pistola (si contarono nella sua carriera sei duelli), con i politici Persano era untuosissimo. Uomo avvezzo da lunghi anni a pensare a modo d'altri, a non muove re passo senza la scorta della legge scritta, a vivere tra i due guanc iali degli articoli di regolamento.
In quell'Italia ancora in fasce c'erano molte cose da decidere e da fare: i porti, per esempio, che bisognava attrezzare e allargare per flotte ben più grandi di quelle dei vecchi staterelli preunitari, e navi da ordinare costruire pagare con bilanci in rosso. Fra l'altro non c'erano cantieri in Italia adatti ai nuovi mostri di ferro che ormai costituivano le flotte straniere e bisognava ordinare in America in F rancia in Ing hilterra. Affari grossi, di milioni, con lobby che già si facevano voraci e pronte a tutto per ricavar spazio nei bilanci: si a ffollavano a quella greppia provvidenziale l'esercito e la marina in vivace concorrenza su chi dovesse spremere più soldi: navi o cannoni? La scelta dipendeva dal peso che Persano e La Marmora avevano n ei mirusteri e in Parlamento. Alla fine, come imponeva la logica,
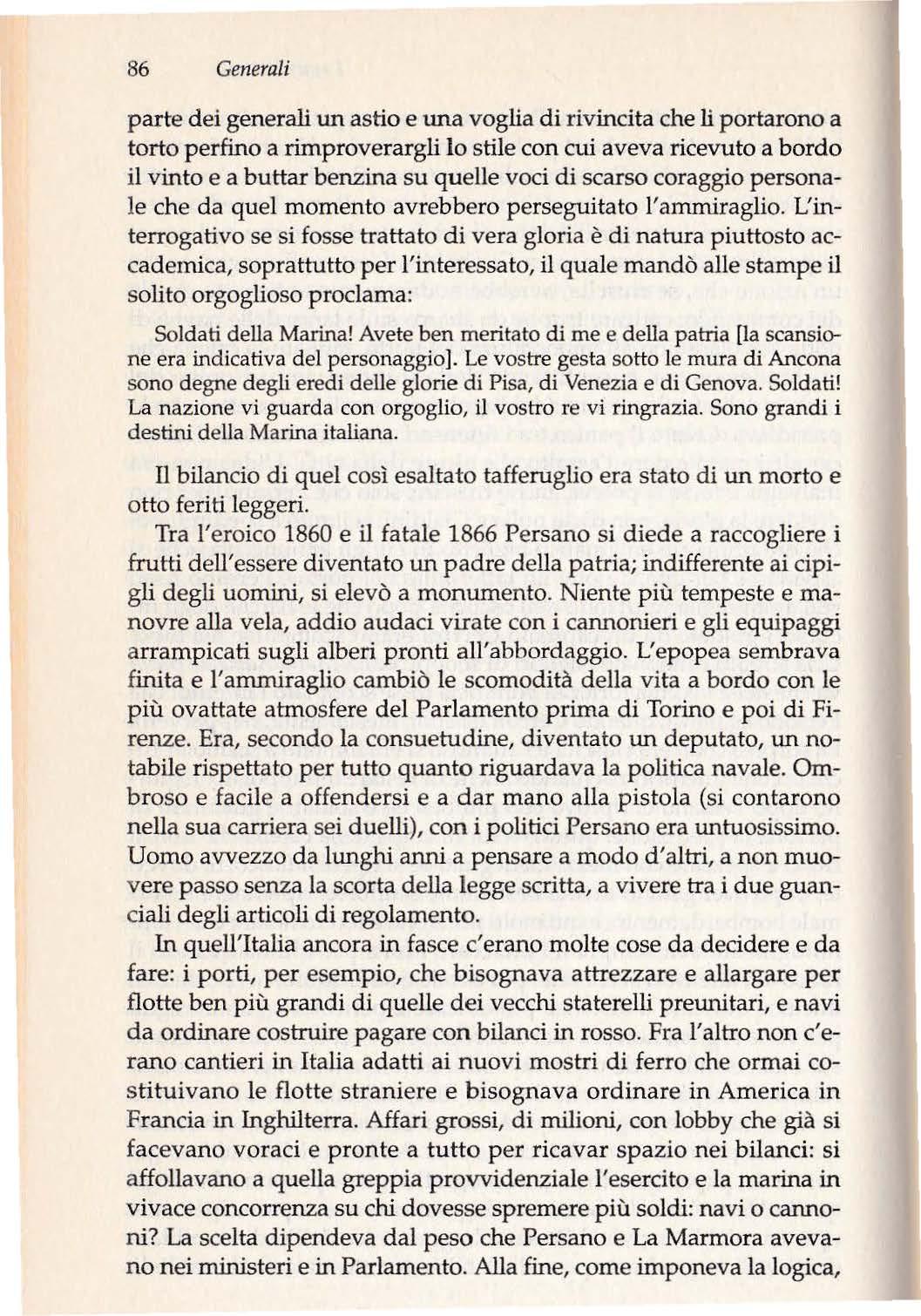
divenne ministro della Marina sotto quel governo Rattazzi che degli epigoni di Cavour era il meno talentoso. Aveva posto a base del proprio sistema filosofico il motto degli scolastici: «ornne quod est est» (ciò che è, è) e tirava avanti senza perdere il sonno. Le solite voci, con qualche postumo fondamento, sostenevano che a raccomandarlo era stata soprattutto la stupenda moglie del premier, Maria, nota per aver fatto strage di mariti e che era rimasta ammaliata dal suo stile di autentico lupo di mare. Stile non dimostrò il governo che prima di sciogliersi, travolto dallo scandalo di Aspromonte e delle fucilate a Garibaldi, in articulo mortis, lo nominò ammiraglio. Lui sostenne sempre che la decisione era stata presa a sua insaputa, il che è poco credibile . E probabilmente il suo stato di servizio lo rende va quasi obbligatorio. Resta il fatto che il modo serviva solo ad alimentare la musoneria nei ranghl navali. Era comunque rimasto cinque anni lontano dal ponte di comando di una nave. Un tempo lunghlssimo anche perché nella guerra marittima si stava verificando una enorme rivoluzione: era arrivato infatti il vapore che stava cancellando secoli di tattiche e di strategie per la guerra sul mare. E dal 1850, con l'introduzione dell'elica al posto delle vecchle pale laterali, la rivoluzione si era completata. Non solo: il cannone con l'anima rigata stava sostituendo quello ad anima liscia che aveva accompagnato gli ultimi secoli di battaglie e aumentava la penetrazione e la distanza in cui si poteva combattere. Si tirava ormai con efficacia a oltre mille metri, contro navi di legno anche di più; faceva capolino quella guerra condotta senza veder mai in faccia il nemico. Si moriva senza rendersi conto di chl fosse il proprio assassino, un' angoscia che la gente di mare scontò prima di quella di terra. Una quarantina di anni dopo avrebbe sconvolto le coscienza degli europei.
Scendeva in acqua un nuovo tipo di nave: la corazzata, che sembrava realizzare il sogno dell'inaffondabilità. Le prime prove, e clamorose, le aveva date durante la guerra civile americana, un brutto, sgraziato vascello sudista, il Virginia, a Hampton Roads; invulnerabile per le robuste placche di metallo, seminò il panico e la morte con il suo sperone e le cannonate nell' elegante flotta nordista fatta di navi di legno, sconvolta dalla sorpresa . Come accade in tutte le epoche di trapasso, le novità crearono disorientamento e nostalgia del passato, mentre le marine più importanti si affannavano a ricoprire le navi di piastre di ferro e a costruire motori a carbone che trasmettessero il movimento attraverso le eliche. Ormai le flotte nei progetti erano gigantesche acciaierie mobili. C'era chi restava risolutamente

affezionato alle vecchie navi di un tempo e sperava che le innovazioni avrebbero avuto vita brevissima. Incalzati dal progresso gli strateghi erano disorientati, l'occhio smarrito tradiva imbarazzo. Molti modernisti sostenevano che lo strumento bellico del futuro con l'avvento del vapore sarebbe stato lo sperone, come ai tempi di Caio Duilio, e annunciavano battaglie con mostri di acciaio che invulnerabili alle cannonate si lanciavano a tutta velocità contro il nemico fracassando le fiancate. L'era di passaggio era testimoniata anche dalla linea delle navi che erano un po' buffe, sgraziate. C'erano ancora le alberature dei secoli precedenti e le vele ma stavano piantate con in mezzo i fumaioli e le linee svelte degli antichi vascelli si erano fatte più gonfie e panciute a causa delle corazzature .
L'avvento di grandi novità poteva, per noi che avevamo una marina che nasceva si può dire dal niente, rivelarsi un gigantesco vantaggio. Non eravamo appesantiti dalla necessità di non gettar via il vecchio. Senza nostalgie potevamo iniziare da zero e subito con mezzi moderni ed efficaci. Persano è stato spesso pennelleggiato per un imbecille. Siamo onesti: riconosciamo che in questo non era giusto muovere appunti. Forse perché viaggiando in Inghilterra aveva visto le tendenze della prima potenza marinara del mondo, era diventato subito un fautore delle corazzate. Nei suoi anni «politici» aveva lavorato di gran lena per strizzare da bilanci sempre miseri il denaro necessario per ordinare ai cantieri di mezzo mondo splendide navi della nuova generazione. Esagerava un poco in senso opposto perché considerava le navi di legno ormai inutili e un peso per la squadra. Tendeva a tenerle fuori dai piedi: pensava che di fronte alle corazzate sarebbero andate a picco. Così a Lissa quattrocento cannoni rimasero a guardare senza sparare un colpo. In poco tempo era stato compiuto davvero un piccolo miracolo: disponevamo di una flotta molto più numerosa e moderna di quella austriaca che in quel momento era l'unico nemico alla nostra portata sia bellica che politica. Addirittura nei cantieri inglesi si stava lavorando, mentre i rumori del conflitto si facevano sempre più sonori, a un'arma segreta: un'unità di concezione rivoluzionaria su cui politici e ammiragli confidavano (a torto) come del colpo magistrale che avrebbe assicurato la vittoria. E c'era già chi gridava allo scandalo: non ci sono più ricognizioni, manovre di avvicinamento, assalti e inseguimenti. Non si combatte più, si fabbrica, si trasporta e si distrugge.
A partire dall'invenzione della polvere da sparo i guerrieri hanno sempre accettato l'arma più efficace a malincuore, perché guasta il gioco. Le novità tecniche portavano con sé anche molti guai: i moto-

ri a vapore erano delicatissimi e spesso lasciavano le navi in difficoltà. Motoristi e ufficiali addetti alle macchine, che erano neofiti privi di esperienza dovevano ancora allenarsi ai nuovi segreti dei loro mezzi. I marinai li guardavano con l'occhio sospettoso che le popolazioni primitive rivolgono ai fabbri, creature giudicate in contatto con materie sulfuree e demoniache. Era difficilissimo far viaggiare in formazione alla s tessa velocità una grossa squadra di navi a vapore: anche una manovra semplice come una conversione richiedeva infatti febbrili e complicati calcoli per accertare la pressione delle macchine necessaria per uniformarsi a l movimento della flo tta. Non è un caso che si verificassero spesso scontri di navi della stessa formazione e gli ammiragli terrorizzati tenevano le unità a distanza cercando di serrare sotto solo al momento dello scontro. Nascevano problemi complicati: mentre un tempo il vento che assicurava il movimento lo mandava gratuitamente il buon Dio e l'abilità dei comandanti al massimo lavorava al modo di sfruttarlo con più accortezza, ora le navi ingoiavano quantità gigantesche di carbone: che bisognava comprare (nuove spese ahimè nei bilanci), accatastare nei depositi in luoghi strategici dove rifornirsi, caricare sulle navi con grande dispendio di tempo. E il carbone causava nuove insidie. Stipato per mesi nelle stive - accanto ai depositi delle polveri - provocava fenomeni di autocombustione. Capitani ed equipaggi vivevano nell'angoscia che la nave saltasse in aria senza preavviso: fenomeno che accadeva spesso e ci causò anche a Lissa molti guai. Elevato un monumento al dio acciaio difettavano però le tattiche di battaglia. Ci si arrangiava cercando di modellare il passato al presente. Si guardava all'estero dove le flotte da più tempo si muovevano a vapore. Persano andava in giro con in tasca la cosiddetta «tattica supplementare», un volume scritto da un ammiraglio francese, Louis Edouard Bouet-Willaumez, proprio in quegli anni: un bignami per gli ammiragli con le corazzate. Ma Lissa fu il primo grande scontro tra navi a vapore della storia e non si sarebbe più ripetuto di fatto fino alla prima guerra mondiale. Altri tempi. Ma anche allora gli ammiragli ancora pieni di dubbi ebbero gravi difficoltà a stare al passo con i mezzi che le nazioni avevano messo con tanta passione e spreco di denaro a loro disposizione.
Se le navi erano, almeno sulla carta, all'altezza, vediamo gli ammiragli. Qui lo stantuffo della nazione restava paralizzato. Basti dire che il capo di stato maggiore D'Amico, meridionale, e l'ammiraglio, piemontese non si scambiavano parola e comunicavano tra loro (tale era il fastidio reciproco) attrave rso un giovanotto di cui le storie del-
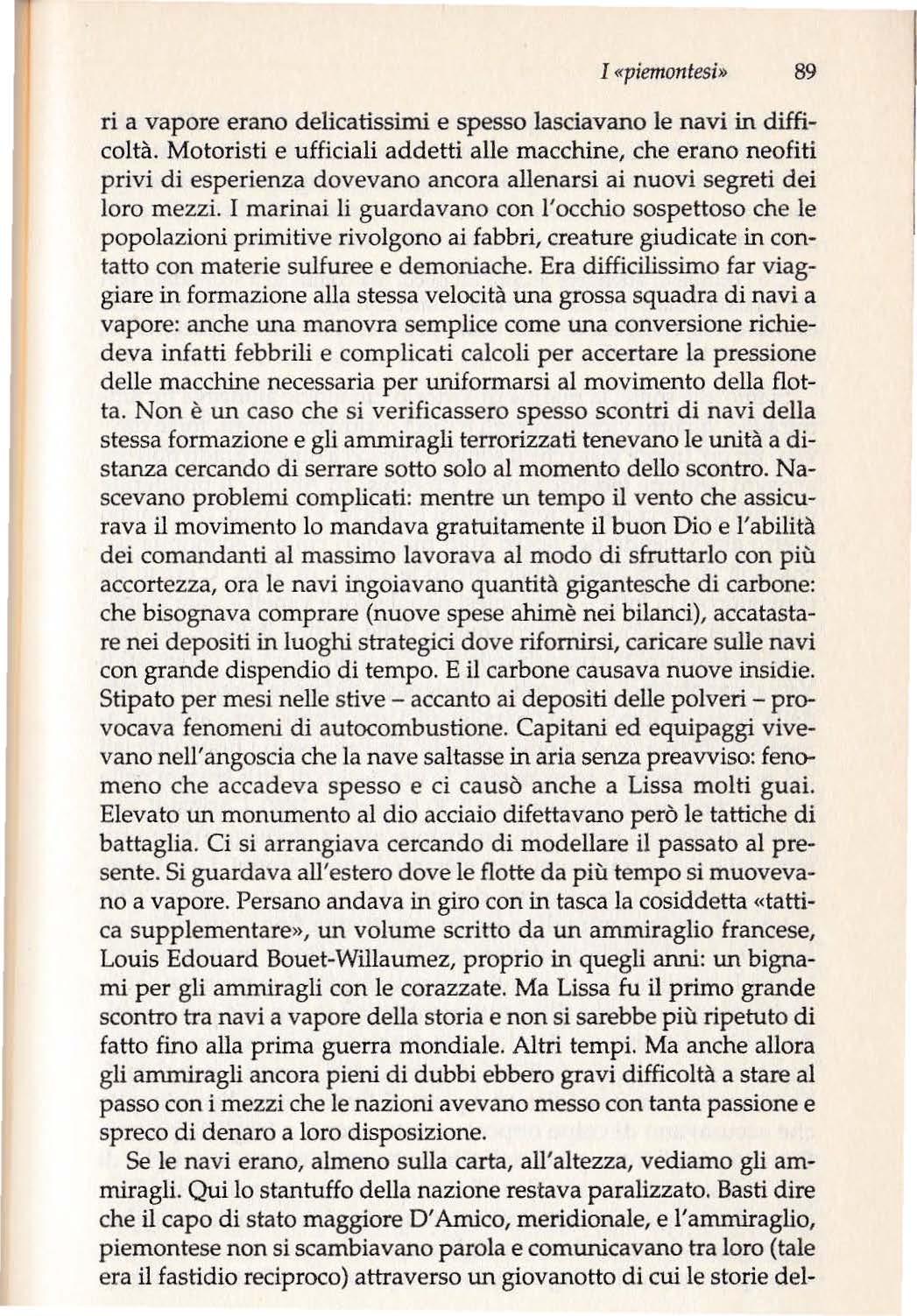
le miserie italiche hanno riportato anche il nome, Roberto De Luca. Lo stesso D'Amico, che pareva un Aronne, la barba folta e fluente, che doveva essere il principale sostegno e consigliere di Persano, il suo braccio destro, scriveva, tre settimane prima della battaglia a un altro ammiraglio, il Vacca che comandava una divisione:
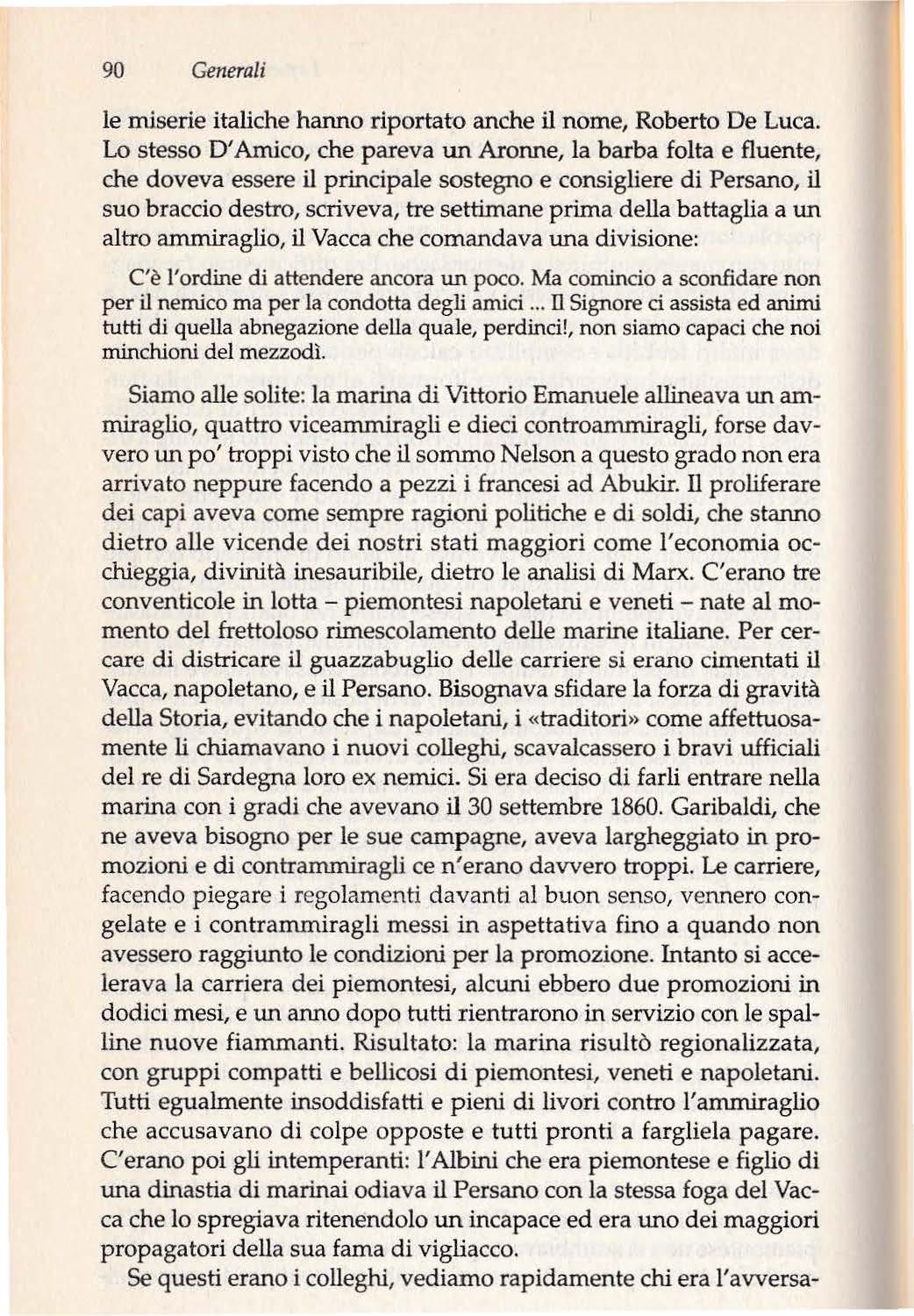
C'è l'ordine di attendere ancora un poco. Ma comincio a sconfidare non per il nemico ma per la condotta degli amici ... Il Signore ci assista ed animi tutti di quella abnegazione della quale, perdinci!, non siamo capaci che noi minchioni del mezzodì.
Siamo alle solite: la marina di Vittorio Emanuele allineava un ammiraglio, quattro viceammiragli e dieci controammiragli, forse davvero un po' troppi visto che il sommo Nelson a questo grado non era arrivato neppure facendo a pezzi i francesi ad Abukir. Il proliferare dei capi aveva come sempre ragioni politiche e di soldi, che stanno dietro alle vicende dei nostri stati maggiori come l 'economia occhieggia, divinità inesauribile, dietro le analisi di Marx. C'erano tre conventicole in lotta - piemontesi napoletani e veneti - nate al momento del frettoloso rimescolamento delle marine italiane. Per cercare di districare il guazzabuglio delle carriere si erano cimentati il Vacca, napoletano, e il Persano. Bisognava sfidare la forza di gravità della Storia, evitando che i napoletani, i «traditori» come affettuosamente li chiamavano i nuovi colleghi, scavalcassero i bravi ufficiali del re di Sardegna loro ex nemici. Si era deciso di farli entrare nella marina con i gradi che avevano il 30 settembre 1860. Garibaldi, che ne aveva bisogno per le sue campagne, aveva largheggiato in promozioni e di contrammiragli ce n'erano davvero troppi. Le carriere, facendo piegare i regolamenti davanti al buon senso, vennero congelate e i contrammiragli messi in aspettativa fino a quando non avessero raggiunto le condizioni per la promozione. Intanto si accelerava la carriera dei piemontesi, alcuni ebbero due promozioni in dodici mesi, e un anno dopo tutti rientrarono in servizio con le spalline nuove fiammanti. Risultato: la marina risultò regionalizzata, con gruppi compatti e bellicosi di piemontesi, veneti e napoletani . Tutti egualmente insoddisfatti e pieni di livori contro l'ammiraglio che accusavano di colpe opposte e tutti pronti a fargliela pagare. C'erano poi gli intemperanti: l' Albini che era piemontese e figlio di una dinastia di marinai odiava il Persano con la stessa foga del Vacca che lo spregiava ritenendolo un incapace ed era uno dei maggiori propagatori della sua fama di vigliacco. Se questi erano i colleghi, vediamo rapidamente chi era l'avversa-
rio con cui avrebbe dovuto scambiar colpi di cannone il nostro contestato ammiraglio. Non è che il tanto lodato Wilhelm von Tegetthoff fosse, per biografia, molto s uperiore al nostro vercellese. Tanto per cominciare anche lui era nato tra le montagne, in Stiria, e il m a re l'aveva scelto per volontà e passione: la sua fama di spericolato e straordinario stratega era dovu ta a una scaramuccia. Gli irriverenti sostenevano che era stata una sconfitta. Il nome di Helgoland al largo delle coste tedesche non sta certo tra le battaglie colossali della storia. Fu un piccolo episodio: l'austriaco, che non era ancora ammiraglio, con due modeste freg ate a e lica di una quarantina di cannoru e con tre ancor più minuscole cannoruere prussiane prive di qualsiasi abilità marinara, contro la flotta danese . L' Austria dava una mano alla Prussia impegnata nella rissa per i ducati . Alla fin e della sparatoria, settanta cannoru austriaci contro un centinaio d ei danesi che avevano fama di marinai esperti e animosi, la n ave di Tegetthoff e ra in fiamme . Ma qui emerse la s u a d o te principale: era un tipo animoso, d eciso, sperico lato, con una fede invulnerabile n e l proprio d estino. Si lanciò in m ezzo ai n emici per aprirsi un varco. La g loria a m a il trambusto; disorientò così profondamente l 'ammiraglio nemico che aveva invece la stoffa del Persano da indurlo, vincitore qual er a, a ritirarsi d a l campo di battaglia. Quanto a moderru tà di concezioni tattiche Tegetth off d enuncia va un'irrimediabile insignificanza, era un teorico d ello sperone. Ma aveva nelle ossa evidentemente mid ollo di leone, aveva quella grinta e quella volontà ostinata di conseguire la vittoria che può portare a grandi disastri ma talvol ta, se accompagnata dalla for tuna, rovescia le sorti d e ll e battaglie.
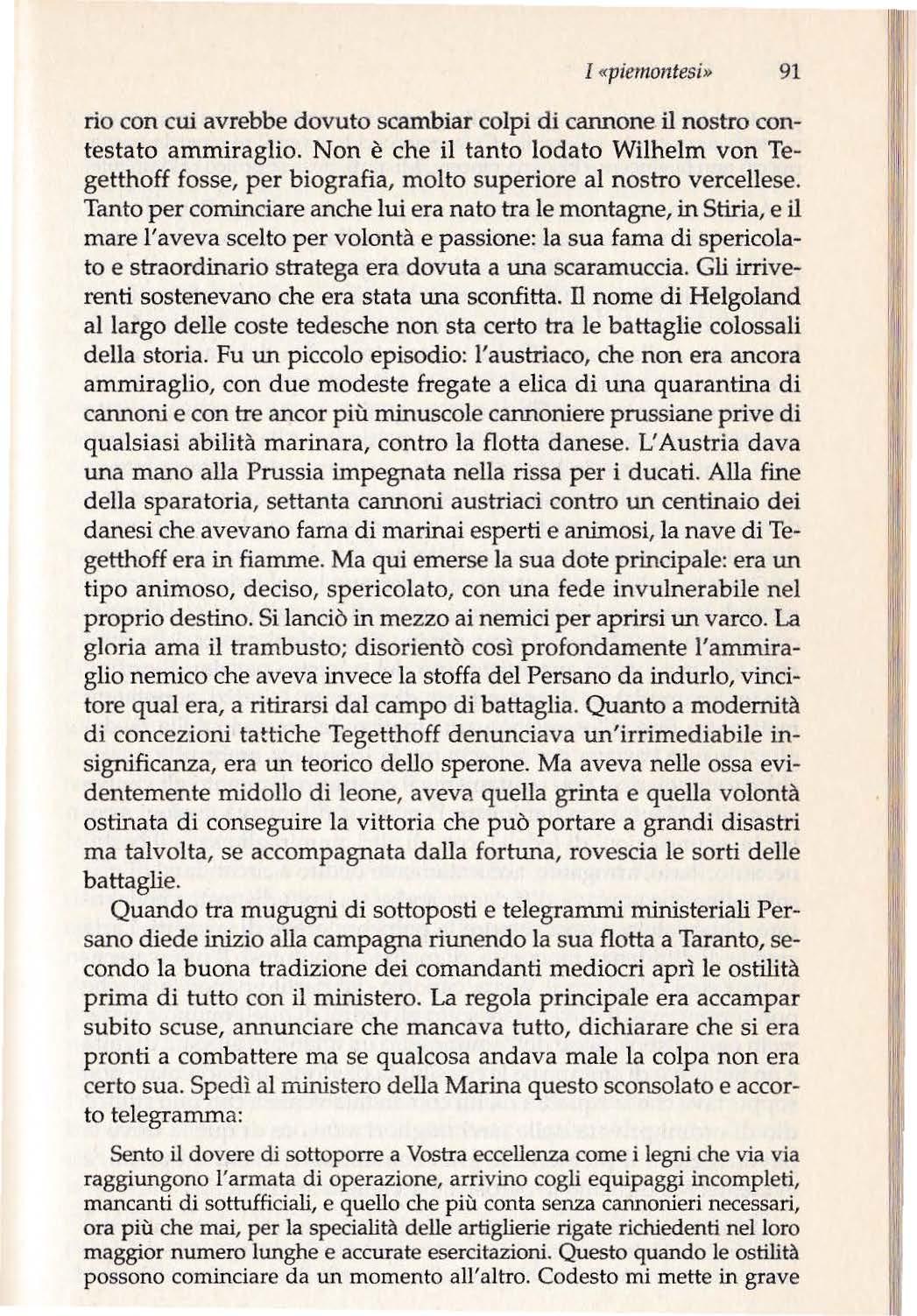
Qu ando tra mugugru di sottoposti e telegrammi ministe riali Persano diede inizio alla campagna riunendo la s ua fl otta a Taranto, se-condo l a buona tradizione dei comandanti m ediocri aprì le ostilità prima di t utto con il ministero. La regola p r incipale e ra accampar subito scu se, annunciare che man cava tutto, dichiarare che si era pronti a combattere ma se qualcosa andava male la colpa non era certo sua. Spedì al ministero d ella Marina ques to sconsolato e a ccorto telegramma :
Sento il d overe di sottoporre a Vostra eccellenza come i legni che via via r aggiungono l'armata di operazione, arrivino cogli equipaggi incompleti, mancanti di sottufficiali, e quello che più conta senza cannonieri necessari, ora più che mai, per la specialità d elle artiglierie rigate richiedenti nel loro maggior numero lunghe e accurate esercitazioni. Questo quando le ostilità possono cominciare da un mome nto a ll 'a ltro. Codesto mi m ette in grave
pensiero. La flotta non è pronta alla guerra. Ci vorrà almeno un mese per portarla a un punto tollerabile. Ci faremo uccidere per il re e per la patria, ma ciò non fa vincere e bisogna vincere. Mi aiuti, ne la supplico caldamente. Accanto a una cattiva retorica e a un brutto stile (a Persano e ai suoi scritti tocca uno degli ultimi posti nella graduatoria letteraria, peraltro non certo esaltante, dei nostri generali) l'ammiraglio usa l'astuto marchingegno di mostrarsi devotissimo al suo referente politico. A ricever la lettera c'era purtroppo un politico, Depretis, che ha lasciato nella storia d'Italia la pesante eredità del trasformismo. Era uno di quegli uomini di Stato che si restringevano al primo acquazzone come una stoffa di cattiva qualità anche se avevano fatto credere di essere tessuti con filo ben pettinato . Alla marina era arrivato naturalmente in base al classico principio dell'incompetenza assoluta (faceva l'avvocato ma il suo predecessore era un generale e di navi ne capiva ancor meno). Si barcamenava con lo stratagemma dei politici di affidarsi ai consigli dei tecnici che aveva al ministero; con tono pure lui servile scriveva al Persano lunghissimi predicozzi pieni di espressioni ammirate ma anche di consigli pratici; l' interlocutore intuiva subito che provenivano da marinai con cariche inferiori alla sua i quali approfittavano del ministro per dargli ordini. Era un accumulatore di appunti, un dipanatore di indizi, annotatore meticoloso fino ali'ossessione, un fanatico del rovescio della medaglia. Quanto bastava per solleci tame la irrequieta ombrosità gerarchica e stimolarlo a fare esattamente il contrario di quanto gli veniva suggerito. Mentre con il ministro Persano si dilungava in elogi ecomiche enunciazioni di fedeltà, con gli altri ammiragli usava il bastone: autoritario, arrogante, accuratamente dedito a circondarsi di una solitudine che scavava diffidenza anche tra i più disposti a collaborare. Guardatelo: aveva sempre la palpebra greve di sospetti, l'aria cattiva di diffidenza rancorosa, di maliziosi sottintesi. Il più scatenato tra i suoi critici era il Vacca, capofila del partito napoletano, che non sopportava di dover stare sotto gli ordini di quell'omino e vedeva in ogni disposizione dell'ammiraglio un attentato alla sua dignità e un tentativo di sminuirne le possibilità di gloria. In particolare non sopportava che la squadra da lui comandata venisse con uno stillicidio di ordini privata dell e navi migliori a favore di quella dove si pavoneggiava il piemontese gran comandante. C'era un piano, è evidente! Ma cediamo la parola al battagliero ammiraglio:
Qui il Persano fa il despota in tutto ed è singolare che noi che abbiamo fatto una rivoluzione e compromessa la nostra testa per combattere il dispotismo di un sovrano, ora dobbiamo tollerare quella dì un coglione! [Curioso
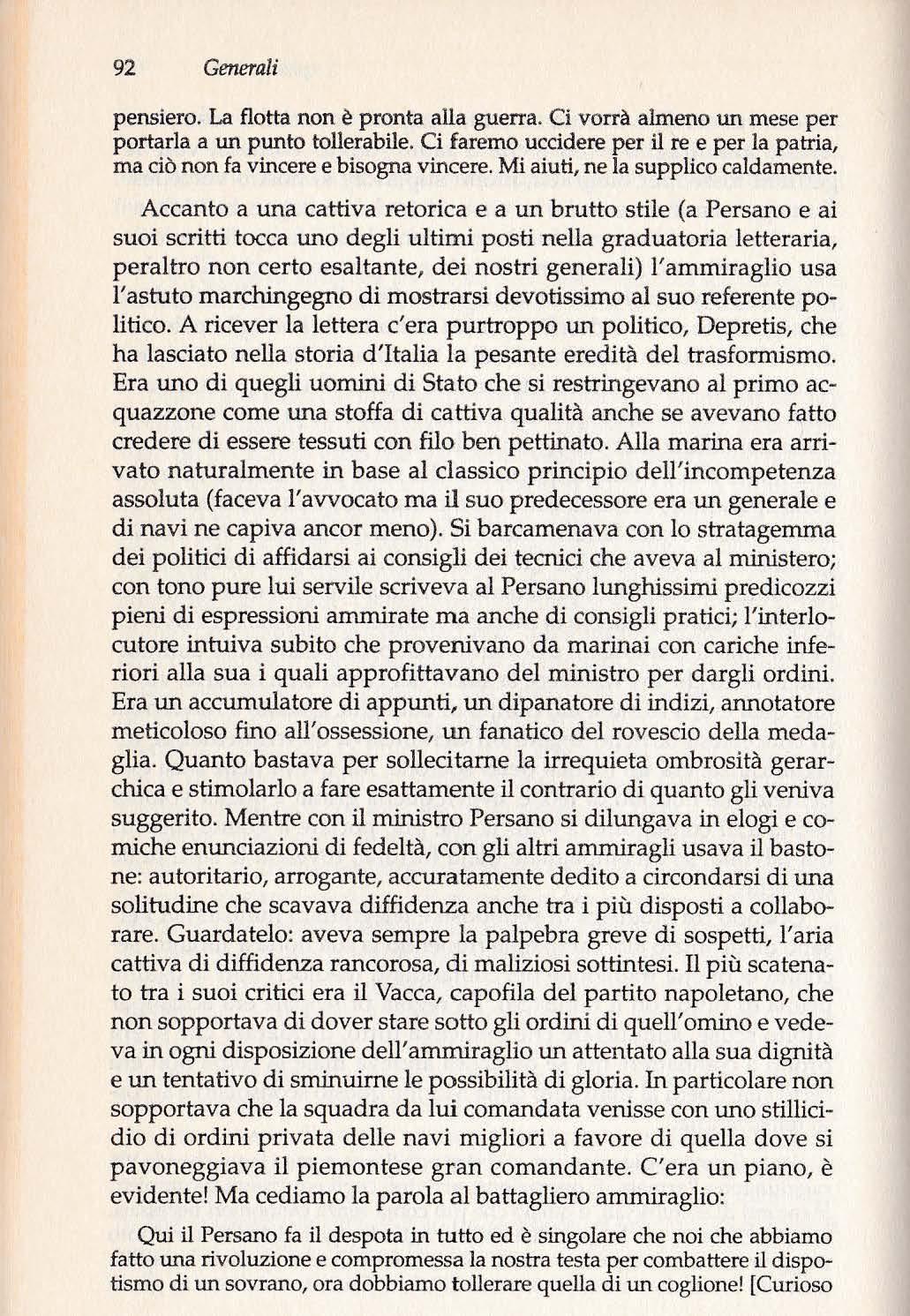
il modo in cui viene definito il tradimento degli ammiragli, in Italia la rivoluzione ha significati singolari.] Il Persano consacra il suo arbitrio alla barba mia, di D'Amico e del ministro! Voi siete annullati completamente ma quel che è peggio è che tutti qui si sono annullati in faccia alle stolte prepotenze e io prevedo grandi guai per l'avvenire, perché se questi fosse uomo da condurre da sé la lunga questione politica e militare, forse si potrebbe fidare in lui, ma qui non è il caso del Sessanta quando nella marina napoletana il Persano, in luogo di avere a combattere nemici, trovò adesioni e concorso a tut~ te le sue operazioni. Qui abbiamo una marina con sette navi corazzate pronte ad attaccarci e vi è bisogno di cuore e di mente.
In attesa di usare il cuore (che poi vedremo gli mancherà) il grande ammiraglio cercava di usare la mente. Molte delle cose che aveva denunciato al ministro erano vere: non avevamo una base organizzata in Adriatico, dove si doveva combattere la guerra, e lo si sapeva da anni; mancava il carbone, così la flotta che si riuniva a Taranto poteva far esercitaziorù col contagocce e sa Dio quanto ne avrebbe avuto bisogno. La leva navale, che durava la breve parentesi di quattro anni, frettolosamente proclamata non appena e ra venuto l'annuncio di possibili ostilità, aveva rie mpito i bastimenti di equipaggi raccogliticci che dovevano imparare molte cose della manovra di quelle navi nuove, tutte costruite all'estero. Su alcune unità i macchinisti erano francesi perché non si erano ancora addestrati adeguatamente g li italiarù. Molti cannorù erano ad anima liscia e bisognava procedere alla sostituzione se s i voleva combattere ad arrrù pari con l' avversario. Poiché come scrive con beata ingenuità il Persano, «non abbiamo precedenti da consultare» non si sa peva bene quale sarebbe stata la tattica di guerra.
Dalle tranquille rive dell'Amo Depretis dettava la linea e pretendeva: sbarazzare l'Adriatico dalla flotta nemica (in teoria giusto concetto, perché era necessario afferrare la superiorità navale senza cui non è possibile alcuna operazione); predisporre sbarchi sulla costa dalmata, difendere le nostre coste che erano sguarrùte e, perché n o, portare il terrore su quelle nemiche con l'eccezione di Venezia che non si poteva bombardare e Trieste, città imperiale. (Per ragiorù politiche non doveva essere sfiorata e comunque negli accordi con la Prussia ci era stata espressamente negata anche in caso di vittoria.) Insomma, Persano non aveva un attimo di respiro. Aleggiava, come si dice, «nel paese» l'impressione che almeno per quanto riguardava la guerra marittima l'es ito del conflitto fosse scontato tanto evidente era la superiorità numerica delle forze navali italiane. E poi, a competenti e orecchiatori di strategia sembrava mostruosa l'idea stessa che un paese senza tradiziorù marinare come l'Austria - dove la flot-
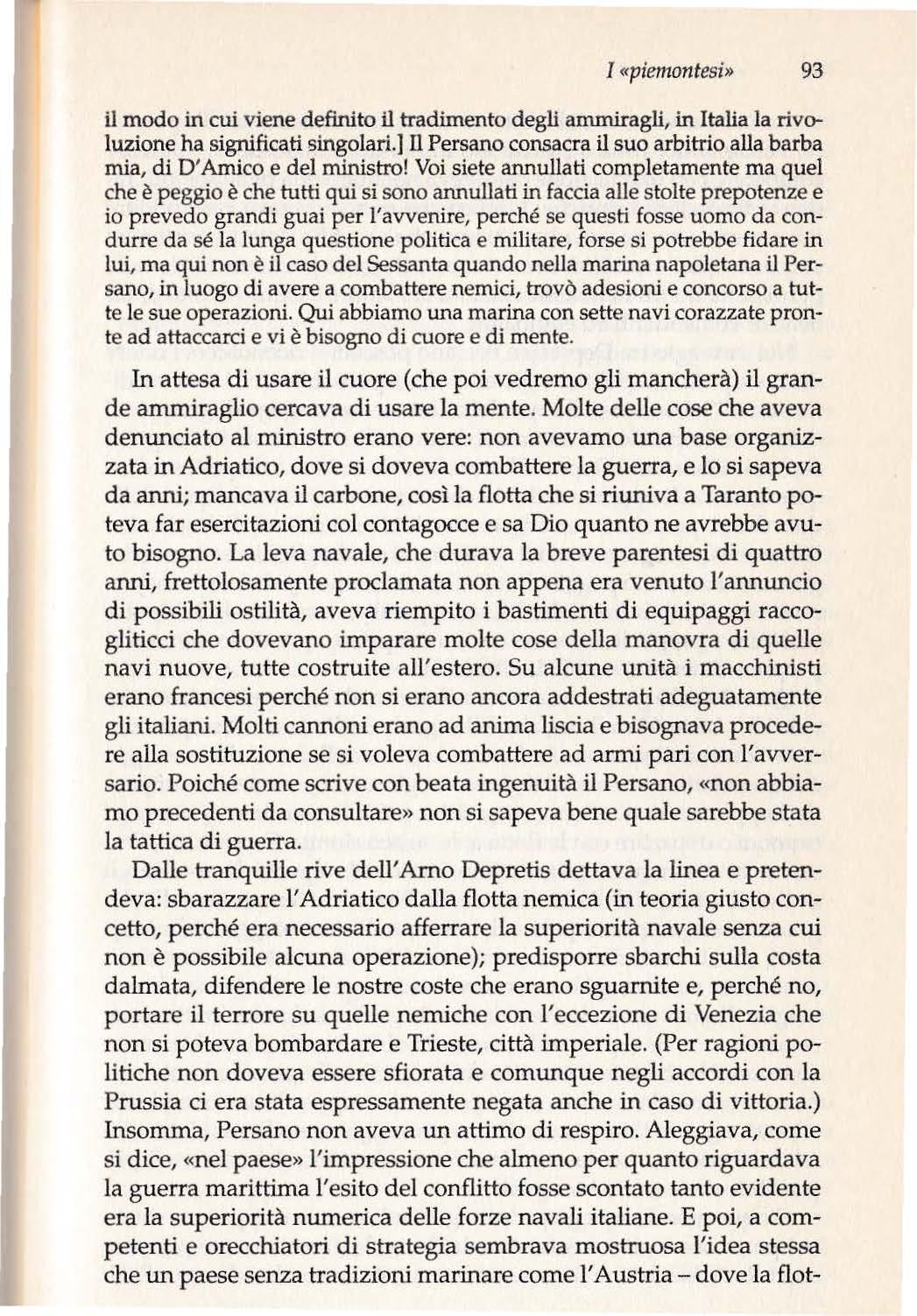
ta era stata inventata dall' abile ed entusiasta fratello dell ' imperatore, Ferdinando, futuro sfortunato imperatore messicano - potesse competere con una nazione che aveva nel mare una delle sue più radicate tradizioni retoriche. L'unico che non sembrava condividere tali certezze era proprio lui, l'uomo che avrebbe dovuto portare al successo quella costosissima armata, il quale però nascondeva le perplessità tra fiumi di assicurazioni del valore e della volontà di far bene di comandanti ed equipaggi.
Nel carteggio tra Depretis e Persano possiamo riconoscere l ' odore della stupidità di politici e generali. Il responsabile della marina dimostra all'inizio verso il capo della flotta ed ex collega di governo il timore reverenziale n ei confronti di un tecnico di cui sa di non poter capire il latinorum. Depretis ha una certa tenerezza dispettosa e inquieta, cerca di opporre ai dubbi che crescono con l' avvicinarsi della data delle operazioni non argomentazioni tecniche ma il classico italiano della denigrazione del n emico: «Ammiraglio, le assicuro che gli austriaci stanno peggio di noi». Ma astu tamente si cautela instaurando con i subordinati del Persano, peraltro contentissimi di poter scaricare i propri livori e rancori, un rapporto parallelo con cui si propone di tener d'occhio la situazione. Quando il 20 giugno arrivano a Taranto, il messaggio convenzionale «Sta bene. Viva il re», che è il segnale dell'inizio delle operazioni, e l'ordine di spostare la flotta ad Ancona, Persano dà un saggio della sua tattica: rimanda di giorno in giorno la partenza accampando l 'opportunità di attendere qualche unità in ritardo o di armare i cannoni o di partire con la flotta solo se ben riunita. Soprattutto, Persano, che era in questo astutissimo, las ciò nel vago chl doveva dargli ordini: il ministro della Marina che da Firenze lo tempestava di telegrammi sempre più impazienti, o il capo di stato maggiore La Marmora che, invece, dai suoi quartieri sul Mincio centellinava rarissime lettere molto vaghe e con inviti a far quello che gli sembrava meglio. Il gran generale considerava la guerra sul mare inutile e secondaria, non ne capiva nulla e non si voleva immischiare. L'austriaco lo avrebbe battuto lui con i suoi cannoni nelle pianure lombarde. Le navi a l massimo servivano a portare le truppe. Situazione ideale: si poteva giocar l'uno contro l' altro per raggiungere la vera intenzione de l Persano, non fare nulla e tenersi l ontano dal nemico il più possibile per non rischiar guai. Cinque giorni impiegò per giungere ad Ancona e appena arrivato nel porto cominciò .. . a smontare la flotta: le due corazzate pi ù possenti Re d' Italia, dove Persano aveva alzato la sua bandiera, e Re di

Portogallo, appena uscite dai cantieri rischiavano di esplodere per que l noto dife tto dei depositi di carbone. Si cominciò a vuotare le carborùere . Un'altra corazzata, Principe di Carignano, aveva in batteria cannorù lisci, che furono s montati per sostituirli con quelli p resi da un'altra n ave . E poi c'erano viveri riparazioni munizioni mille faccende, come se la flotta avesse traversato l'Oceano anziché poche miglia d e l placido Adriatico. Nessuno sapeva dove fosse l 'ammirag lio aus triaco e che intenzioni coltivasse, ma il porto era tutto un fervore di barche barchette pontoni, equipaggi a terra sostituiti da operai. li 25 ad Ancona piombò il minis tro che aveva attraversato l'Appennino al galoppo per un'ispezione; e non sarebbe stata che la prima, com e vedremo. Depretis a ppare ancora sotto l'effetto del fascino marinaro dell'ammiraglio, si a ffanna con caramellosa a dul azione a prome ttere che farà ogni cosa per soddisfare il cumulo di richieste indispensabili che il Persano g li ha sottoposto, si preoccupa soprattutto «ch e s iano sorveglia te le comunicaziorù d egli e quipaggi con le lo ro famiglie, non essendo improbabile che il partito retrivo cerchi di getta re qualch e elem ento di disordine n ella truppa di mare come ha tenuto in quella di te rra ». Eran o ques te le s uppe llettili di cui e ra ingombra la mente d el minis tro. L' elemento di disordine in realtà s i chiamava Custoza: p roprio il giorno prima le b e lle armate di La Marrnora avevano preso la fuga d avanti a ll'arcid uca Albe rto. La sconfitta fu salutata da Persano come la consacrazione definitiva della sua tattica «prudente». A essere audaci s i rischiava l a brutta figura, le guerre sono una espiazione.
Non s i sarebbe probabilmente più mosso d a Ancona se improvvisamente a lle cinqu e del mattino del 27 giugno l'avviso Esplorat ore, con le caldaie che scoppiavano p er il tentativo di sp remere la maggior v elocità e le bandiere di pericolo alzate su tutti gli a lberi, non avesse fatto irruzione nel porto con un annuncio incredibile: gli austriaci con le loro sette corazzate stavano dirigendo su Ancona. Incrociando al la rgo, la piccola unità le a veva scorte p er puro caso e s i era presa una prima raffica di cannona te .
Persano il prud ente si fece trovare in mutande: la s ua ammiraglia non poteva uscire perché quel maledetto carbone era sempre lì con il rischio di esplodere; la Re di Portogallo durante i lavori era sbandata imbarcando acqua nei cilindri e stava tutta p enosamente da un lato con i cannoni punta ti verso l 'acqua; la corazzata Ancona aveva il motore s m o ntato e a terra; l a Principe di Carignano era sempre senza cannorù, e su altre due corazzate i macchinisti francesi, sempre que lli , contratto in mano si rifiu tarono di accendere i m otori perché quel-

la era una battaglia e loro non c'entravano per nulla. Confusione ordini bestemmie febbrili lavori bettoline che si incrociavano e scontravano mentre gli equipaggi cercavano di ritrovare i posti di combattimento. Per tre ore il porto di Ancona sembrò un formicaio scoperchiato. Con il Persano che, miseramente costretto a trasbordare sul minuscolo Esploratore con il suo sta to maggiore, correva di qua e di là per esortare a far presto prima che cominciassero a piovere le palle a u striache.
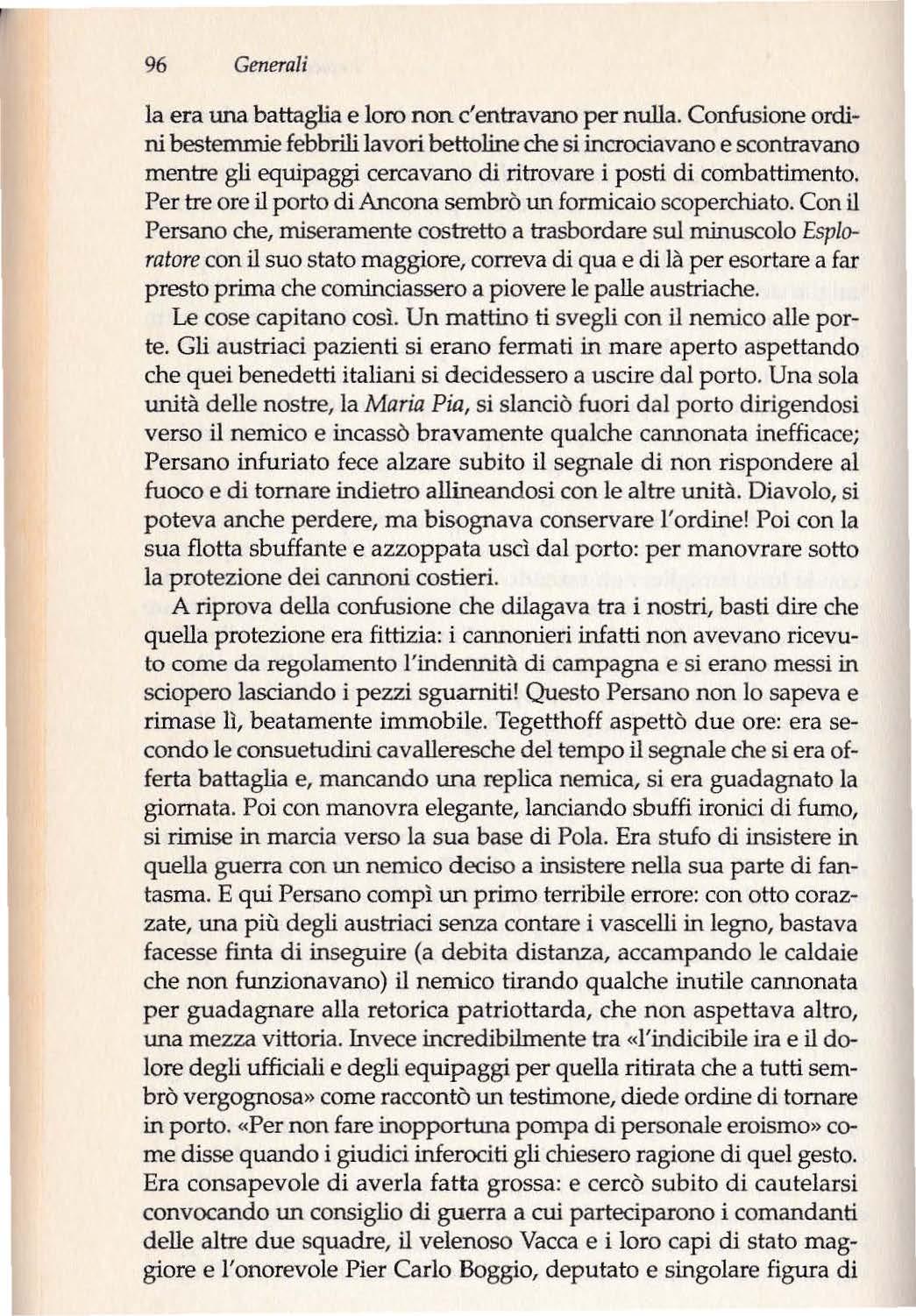
Le cose capitano così. Un mattino ti svegli con il nemico alle porte. Gli austriaci pazienti si erano fermati in mare ape rto aspettando che quei benedetti i taliani si decidessero a uscire dal porto. Una sola unità delle nostre, la Maria Pia, si slanciò fuori dal porto dirigendosi verso il nemico e incassò bravamente qualche cannonata inefficace; Persano infuriato fece alzare s ubito il segnal e di non rispondere al fuoco e di tornare indietro allineandosi con le altre unità. Diavolo, si poteva anche perdere, ma bisognava conservare l ' ordine! Poi con la sua flotta sbuffante e azzoppata uscì dal porto: per manovrare sotto la protezione dei cannoni costieri .
A riprova della confusione che dilagava tra i nostri, basti dire che quella protezione era fittizia: i cannonieri infatti non avevano ricevuto come da regolamento l'indennità di campagna e si erano messi in sciopero lasciando i pezzi sguarniti! Questo Persano non lo sapeva e rimase Il, beatamente immobile. Tegetthoff aspettò due o re : e ra secondo le consuetudini cavalleresche del tempo il segnale che si era offerta battaglia e, mancando una replica nemica, si era guadagnato la giornata. Poi con manovra e legante, lanciando sbuffi ironici di fumo, si rimise in marcia verso la sua base di Pola. Era stufo di insistere in quella guerra con un nemico deciso a insistere nella sua parte di fantasma. E qui Persano compì un primo terribile errore: con otto corazza te, una più degli austriaci senza contare i vascelli in legno, bastava facesse finta di inseguire (a debita distanza, accampando le caldaie che non funzionavano) il nemico tirando qualche inutile cannonata per guadagnare alla retorica patriottarda, che non aspettava altro, una mezza vittoria. Invece incredibilmente tra «l 'indicibile ira e il dolore degli ufficiali e degli equipaggi per quella ritirata che a tutti sembrò vergognosa» come raccontò un testimone, diede o rd ine di tornare in porto. «Per non fare inopportuna pompa di personale eroismo» come disse quando i giudici inferociti gli chiesero ragione di quel gesto. Era consapevole di averla fatta grossa: e cercò subito di cautelarsi con vocando un consiglio di guerra a cui parteciparono i comandanti delle altre due squadre, il velenoso Vacca e i loro capi di stato maggiore e l 'onorevole Pier Carlo Boggio, deputato e singolare figura di
commissario politico che era stato imbarcato sulla Re d'Italia per tener d'occhio l'ammiraglio e che sparì, al contrario del Persano, nei gorghl di Lissa. Non fu chlamato l' Albini, che trovò così un motivo in più per recriminare e odiare l'altro piemontese. Persano tirò fuori l'elenco delle magagne delle navi sostenendo che in quelle condiziorù avrebbe rischiato una disfatta correndo dietro agli austriaci. Poiché vedeva facce perplesse, aggiunse misteriosamente che non aveva potuto indebolire l' annata perché era destinata ad altre non meglio precisabili operaziorù belliche. Gli ammiragli di fronte a quel mistero, all'unanimità, ammisero che in simili condiziorù si doveva restare in porto. Poi tornarono alle loro urùtà e riurùti gli equipaggi cominciarono senza troppe perifrasi a raccontare che il Persano era un vigliacco. Il Boggio riferì le parole dell'Albini («Così non si fa la guerra») . L'ammiraglio convocò con un pubblico segnale il reprobo sulla sua nave sottoponendolo a una pubblica e umiliante lavata di capo. Fu un altro errore e da quel momento ebbe, naturalmente, un nemico mortale. Sui giornali uscirono nei giorrù seguenti fondi che inneggiavano alla pmdenza d e l Persano; era una teaùca consolidata quella di farsi le ragioni sulla stampa, già all' epoca asservita ai vari potentati militari e politici e influentissima. L'ammiraglio riprese come se nulla fosse la sua vera campagna: tener buono il sempre più sospettoso, impaziente ministro. Alternava efficacemente due registri con cui coloriva il suo piano: l'adulazione più smaccata («le vostre lettere riservate mi attaccano maggiormente a voi. L'armata ve ne dimostrerà la sua riconoscenza col fare il suo dovere. Vi ammiro, siete la fortuna della marina, siete un portento di attività») con sperticate dichlaraziorù di bellicosità puramente epistolare. Aveva scovato, ora che la flotta era riparata, un nuovo pretesto per differire la partenza per la poco sospirata battaglia: l'Affondatore, arma segreta della flotta italiana ormai sul punto di uscire dai cantieri inglesi e disporùbile per la zuffa decisiva. Era una nave di nuova concez ione. Lo dimostrava anche nelle linee sottili, con i cannoni disposti su due torrette in plancia e non più distribuiti sui fianchi come ai tempi di Nelson. Era il futuro che scendeva in mare. Ma come per tutte le innovazioni, si ponevano troppe speranze in quel congegno che presentava difetti nel motore e nel timone e che emergeranno impietosamente a Lissa . Persano affermava che quella nave s icuramente gli avrebbe dato la vittoria; gli sembrava prudente aspettare, per uscire in mare, di arricchire la flotta con quel vascello mirabile. Si sentiva un veggente in mezzo ai ciechl.
Non aveva compreso che la situazione era sul piano politico completamente cambiata e adesso gli interlocutori non avevano più pos-
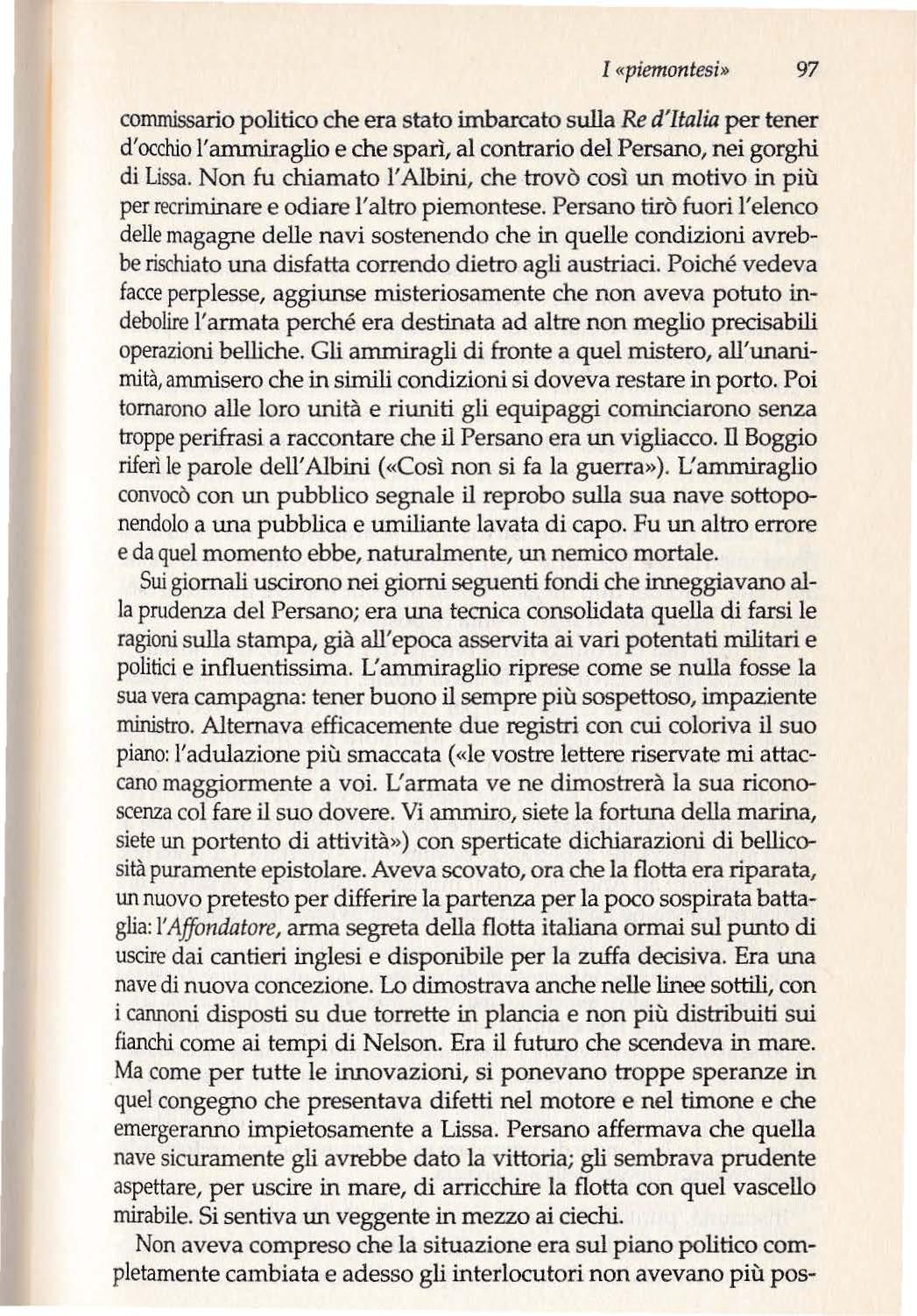
sibilità di attendere i suoi comodi. Si parlava di pace, l'Austria - ormai con al collo il laccio prussiano - sembrava disposta a cedere il Veneto alla Francia per liberarsi almeno di un nemico, bisognava evi tare la vergogna di finir la guerra senza vi ttorie accettando come pezzenti un regalo da Napoleone. Bisognava vincere, insomma, e alla svelta! I messaggi di Depretis cambiano to no, si minimizzano i complimenti e si moltiplicano gli appelli a tirar fuori quella benedetta flotta dal porto. 11 ministro è così disperato che a un certo punto sembr a accontentarsi p ersino che le navi escano in mare incrociando a consumar carbone. Ma Persano è implacabile: ancora un giorno per armare i cannoni, un altro se ne va con la richies ta di istruzioni più precise su che fare. «Domani credo che tutto sarà finito e correrò al mio dovere. Abbiate un momento di sofferenze per questo ritardo che d'altronde non viene da me.»
Quando gli mandano le istruzioni - sbarazzare l'Adriatico della flotta austriaca e bloccarla - lui risponde: «Ricevute ora istruzioni . Sta bene. Farò del mio meglio. Posso aspettare avere imbarcati cannoni? ». E aggiunge: «Prego pronta r isposta» .
C'è qualcosa d'ironico nelle lettere del Persano, che qua n do è messo alle strette cava fuori la carta finale, l'Affondatore: «Se posso aspettare Affondatore credo u tile per colpo ardito. Converrebbe se lei acconsente prevenire generale La Marmara che mi sembra impaziente si che lo sono anch'io ma il 24 mi è lezione». La citazione dello sfortunato episodio sembrava messa apposta per mandare in bestia Depretis: «Uscire dalla rada e dal porto con la flotta. State al largo sulle macchine aspettando bastimenti. Affrettate. La flotta non deve rimanere ad Ancona». Più il ministro insiste più Persano si tira indietro: adesso ne ha studiata un' altra per evitare lo scontro:
Sia persuaso signor ministro che uniformandomi ai di lei consigli e alle istruzioni del governo interamente dichiaratemi, io nulla tenterò che possa apparire improvvido e temerario [ma non è ironia questa!]; ma intanto la sola apparizione della flotta italiana sulle coste possedute dal nemico sul punto dove abbiano a convergere i nostri sforzi saranno un utile sussidio alle operazioni di terra. Che se alcuna favorevole opportunità si presenti di misurarmi col nemico ella può essere sicura che io non la lascerò sfuggire e lo s pirito dal quale sono animati tutti quanti ufficiali marinai e soldati a bordo della flotta che ho l' onore di comandare mi è garante che non andranno deluse le speranze riposte nella sua armata.
Insomma, punta sulla pace: con una «bella dimostrazione» - parola fatale-conta di arrivare alla fine delle operazioni con le navi intatte accon tentandosi di fare il gregario alle operazioni di terra (che
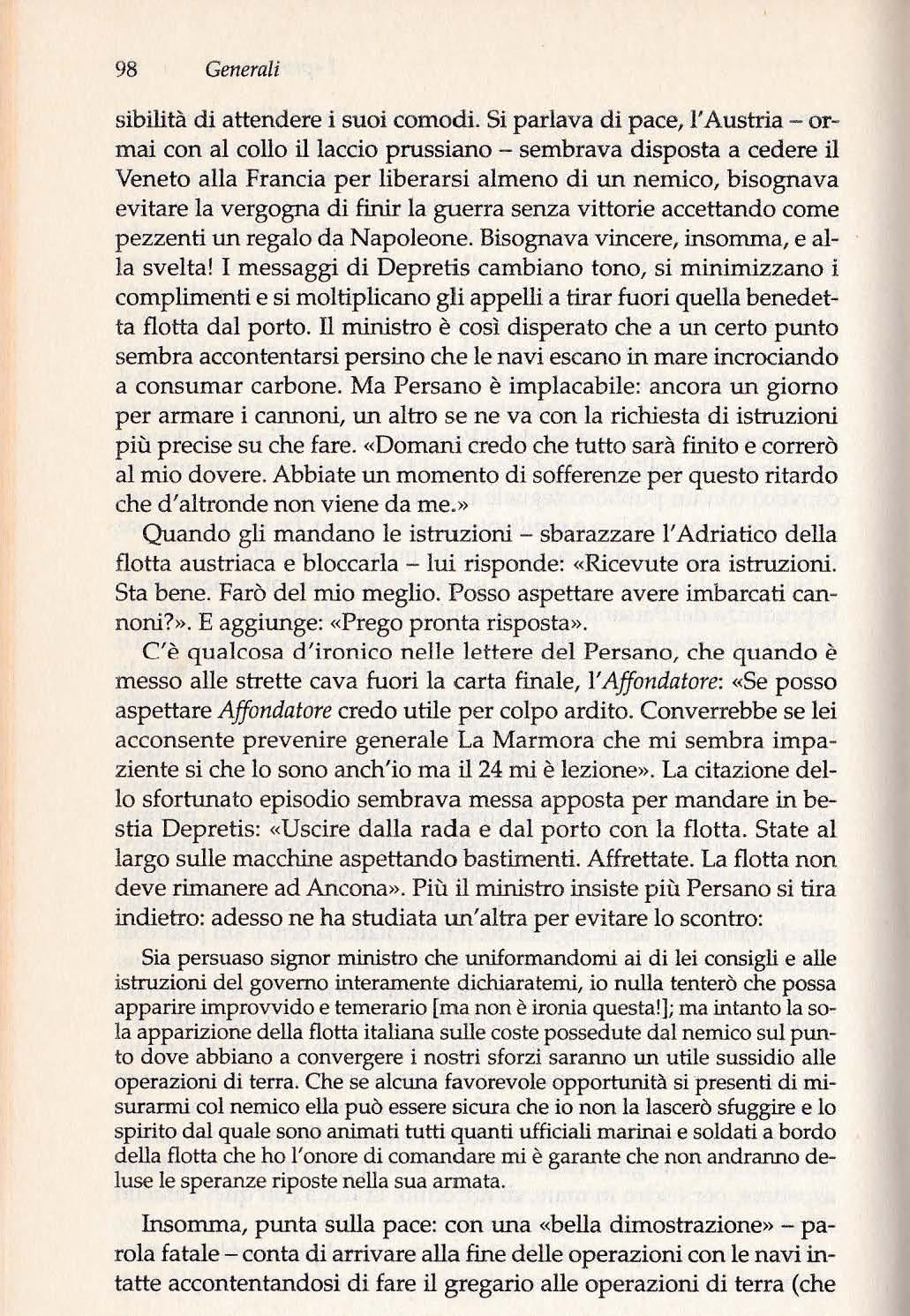
vanno malissimo). «Non è solo con l'impegnare battaglie navali che una flotta giova alla nazione» proclama con innocente sfrontatezza un articolo su «La provincia», ispirata da questo interessato precursore della flotta in potenza che tanto piaceva a Mussolini! Non aveva capito l' ammiraglio che il patto con i politici funzionava soltanto fino a un certo punto: e tale boa di non ritorno era costituita dal momento in ctù questi ultinu si accorgevano che stavano rischiando la carriera. Allora scattava il si salvi chi può, e i generali sfortunati o incapaci diventavano utilizzabili per un secondo scopo: quello di fornire il capro espiatorio da gettare in pasto ali' opinione pubblica per salvarsi.
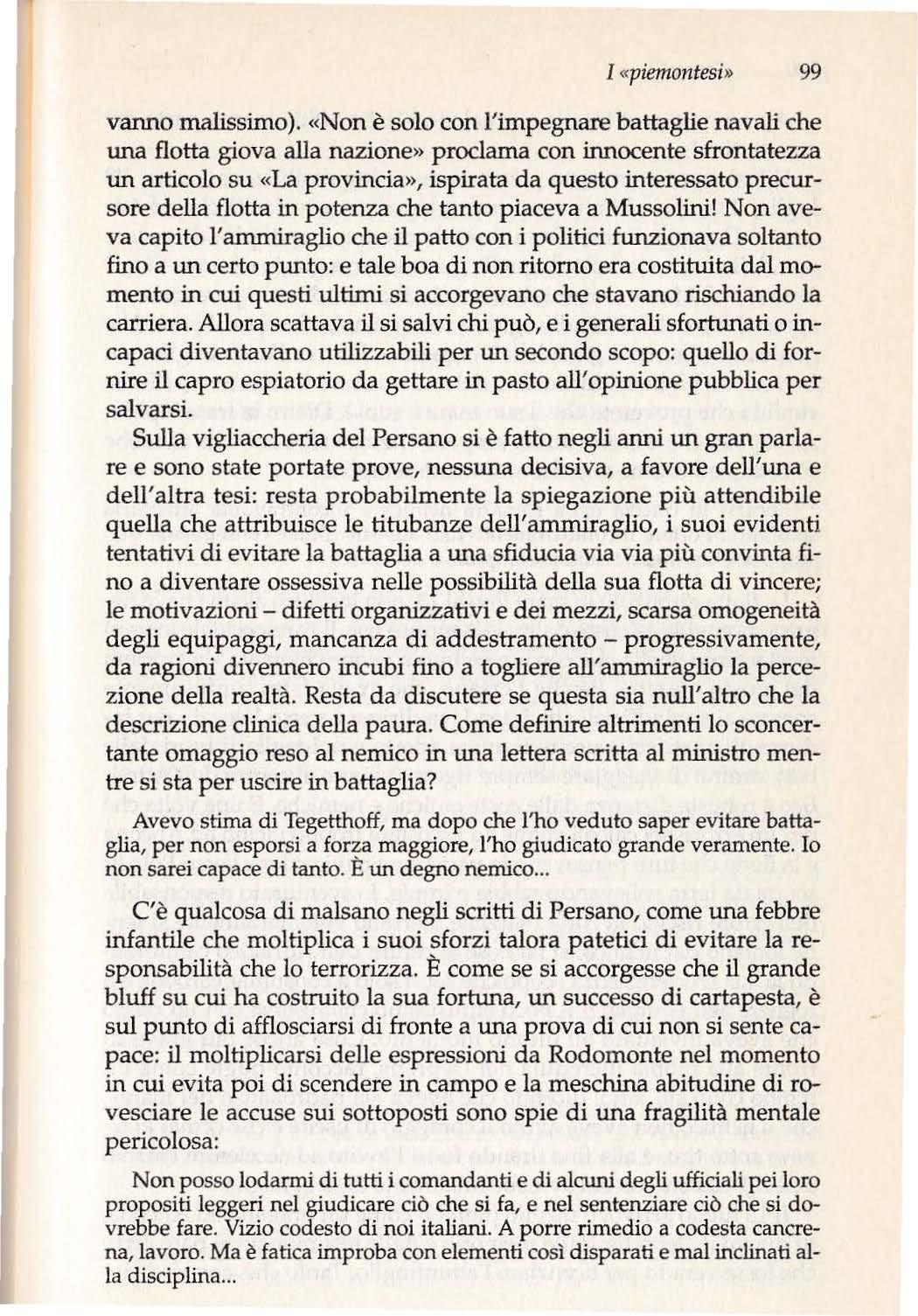
Sulla vigliaccheria del Persano si è fatto negli anni un gran parlare e sono state portate prove, nessuna decisiva, a favore dell'una e dell'altra tesi: resta probabilmente la spiegazione più attendibile quella che attribuisce le titubanze dell'ammiraglio, i suoi evidenti tentativi di evitare la battaglia a una sfiducia via via più convinta fino a diventare ossessiva nelle possibilità della sua flotta di vincere; le motivazioni - difetti organizzativi e dei mezzi, scarsa omogeneità degli equipaggi, mancanza di addestramento - progressivamente, da ragioni divennero incubi fino a togliere all'ammiraglio la percezione della realtà. Resta da discutere se questa sia null'altro che la descrizione clinica della paura . Come definire altrimenti lo sconcertante omaggio reso al nemico in una lettera scritta al ministro m entre si sta per uscire in battaglia?
Avevo stima di Tegetthoff, ma dopo che l' ho veduto saper evitare battaglia, per non esporsi a forza maggiore, l'ho giudicato grande veramente. Io non sarei capace di tanto È un degno nemico
C'è qualcosa di malsano negli scritti di Persano, come una febbre infantile che moltiplica i suoi sforzi talora patetici di evitare la responsabilità che lo terrorizza . È come se si accorgesse che il grande bluff su cui ha costruito la sua fortuna, un successo di cartapesta, è sul punto di afflosciarsi di fronte a una prova di ctù non si sente capace: il moltiplicarsi delle espressioni da Rodomonte nel momento in cui evita poi di scendere in campo e la meschina abitudine di rovesciare le accuse sui sottoposti sono spie di una fragilità mentale pericolosa:
Non posso lodarmi di tutti i comandanti e di alcuni degli ufficiali pei loro propositi leggeri nel giudicare ciò che si fa, e nel sentenziare ciò che si dovrebbe fare. Vizio codesto di noi italiani. A porre rimedio a codesta cancrena, lavoro Ma è fatica improba con elementi cosi disparati e mal inclinati alla disciplina ...
A un uomo così fragile e sgualcito l'Italia affidava una parte del suo destino!
Dilazionare a un certo punto divenne impossibile, era ormai 1'8 luglio, il tempo a Firenze scorreva a ben diversa velocità che ad Ancona e Depretis intravedeva il finale che temeva di più, diventare una delle facce simbolo di quella guerra senza gloria e onore. Si va? Non si va? Masse enormi di uomini, dì armi, dì cose parevano sospese al filo del dubbio. Bisognava rassegnarsi, a lasciare il porto che qualcuno chiamava già «della vergogna». Partiva l'ammiraglio con in tasca un biglietto particolare del suo ministro torturatore («l'Italia confida che proverete che il suo mare è suo»). Dietro la frase lapidaria sapeva che c'erano atroci sospetti che neanche stavolta avrebbe obbedito all'ordine napoleorticamente semplice:
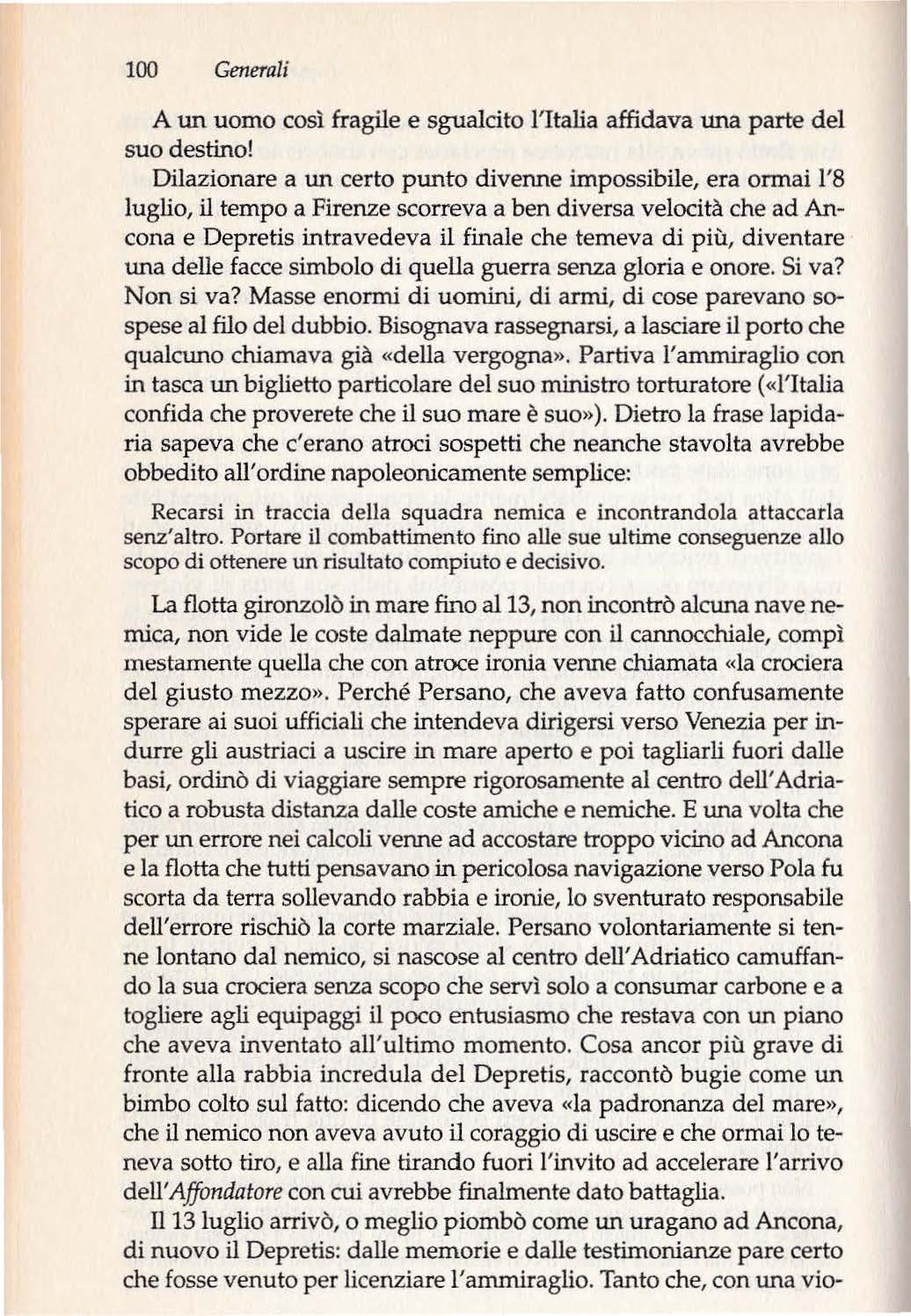
Recarsi in traccia della squadra nemica e incontrandola attaccarla senz'altro. Portare il combattimento fino alle sue ultime conseguenze allo scopo di ottenere un risultato compiuto e decisivo.
La flotta gironzolò in mare fino al 13, non incontrò alcuna nave nemica, non vide le coste dalmate neppure con il cannocchiale, compì mestamente quella che con atroce ironia venne chiamata «la crociera del giusto mezzo». Perché Persano, che aveva fatto confusamente sperare ai suoi ufficiali che intendeva dirigersi verso Venezia per indurre gli austriaci a uscire in mare aperto e poi tagliarli fuori dalle basi, ordinò di viaggiare sempre rigorosamente al centro dell ' Adriatico a robusta distanza dalle coste amiche e nemiche. E una volta che per un errore nei calcoli venne ad accostare troppo vicino ad Ancona e la flotta che tutti pensavano in pericolosa navigazione verso Pola fu scorta da terra sollevando rabbia e ironie, lo sventurato responsabile dell'errore rischiò la corte marziale. Persano volontariamente si tenne lontano dal nemico, si nascose al centro dell'Adriatico camuffando la sua crociera s enza scopo che s ervì solo a consumar carbone e a togliere agli equipaggi il poco entusiasmo che restava con un piano che aveva inventato all ' ultimo momento. Cosa ancor più grave di fronte alla rabbia incredula del Depretis, raccontò bugie come un bimbo colto sul fatto: dicendo che aveva «la padronanza del mare», che il nemico non aveva avuto il coraggio di uscire e che ormai lo teneva sotto tiro, e alla fine tirando fuori l'invito ad accelerare l'arrivo dell'Affondatore con cui avrebbe finalmente dato battaglia . ll 13 luglio arrivò, o meglio piombò come un uragano ad Ancona, di nuovo il Depretis: dalle memorie e dalle testimonianze pare certo che fosse venuto per licenziare l'ammirag lio. Tanto che, con una vio-
!azione clamorosa dell'etichetta, convocò per primo non lui ma i suoi bellicosi subordinati, Vacca e Albini, e il commissario politico Boggio che al termine della crociera aveva furiosamente litigato con l'ammiraglio. Al deputato confidò appunto i suoi piani: «La flotta non fa niente, il paese protesta, Persano non è più quello di prima, converrà surrogarlo». Invece non lo fece e commise l'errore più grande. A salvare Persano fu non tanto la mancanza di un sostituto, i critici erano prontissimi, né la convinzione che fosse pericoloso farlo nell'imminenza della battaglia (la visita lo aveva totalmente esautorato e umiliato). Lo trattenne la necessità di non violare delicati equilibri politici. Perché il gran protettore dell'ammiraglio era il presidente del Consiglio Bettino Ricasoli. Barone di ferro, come lo chiamavano i suoi ammiratori, o barone di latta come lo chiamava quel gran giudice di uomini che era il Cavour? Il dubbio è rimasto. Il nume tutelare del timido ammiraglio era proprio lui; che nei giorni in cui l'Italia in t era mormorava contro quell'inazione e gli equipaggi erano quasi all'ammutinamento gli scriveva affettuoso:
Tu mi dici che riunito l'Affondatore alla flotta saprai dare alla campagna di mare l'indirizzo che le compete e saprai compiere la tua missione. Grande consolazione mi ha recato questa risposta. Avrei un dolore indicibile se le cose andassero altrimenti e ne sarei in angoscia per il paese e per te... Io sono certo che tu sia nella stessa via in cui è il governo cioè che con l'audacia si debba vincere le difficoltà perché oggi l'audacia è prudenza. Altro non aggiungo e ti mando il più patriottico augurio che abbia mai fatto palpitare il mio cuore.
Depretis, che non aveva avuto il coraggio di sfidare il primo ministro e compiere l'unico gesto che avrebbe salvato la flotta, si precipitò a Ferrara a cercare alleati in quell'insensata diatriba. Li trovò in La Marmora, che dopo il balletto delle dimissioni aveva ripreso in mano come se nulla fosse il comando supremo, e nel re. Uscì da quel colloquio la più goffa delle decisioni: dare a Persano un ultimatum, che arrivò sotto la forma del celebre telegramma di La Marmora del 14 luglio, esempio mirabile che resterà nella storia dell'insipienza politico-militare: Questa mattina si è riunito un consiglio al quale oltre al generale Cialdini e io hanno assistito i ministri Ricasoli, Visconti Venosta, Pettinengo e Depretis. Questo consiglio è stato unanime nel deplorare che la flotta non abbia ancora trovato occasione di agire energicamente contro il nemico e in seguito a esso lo stato maggiore e il ministero mi incaricano di comunicare a vostra eccellenza l'ordine perentorio onde una siffatta negazione di risultati utili abbia a cessare al più presto. Non appena dunque l'Affondatore avrà raggiunto la flotta dovrà vostra eccellenza prendere il mare e iniziare sia contro la flotta nemica s ia contro l e fortez ze sia contro il litora le nemico

quelle operazioni che crederà più convenienti a ottenere un successo importante nelle difficili condizioni politiche in cui si trova attualmente il paese. Conviene assicurare uno di quei fatti compiuti che mettono nel caso di ac~ campare e sostenere le pretens ioni più estese possibili quando si verrà a trattative per la sistemazione definitiva delle cose.
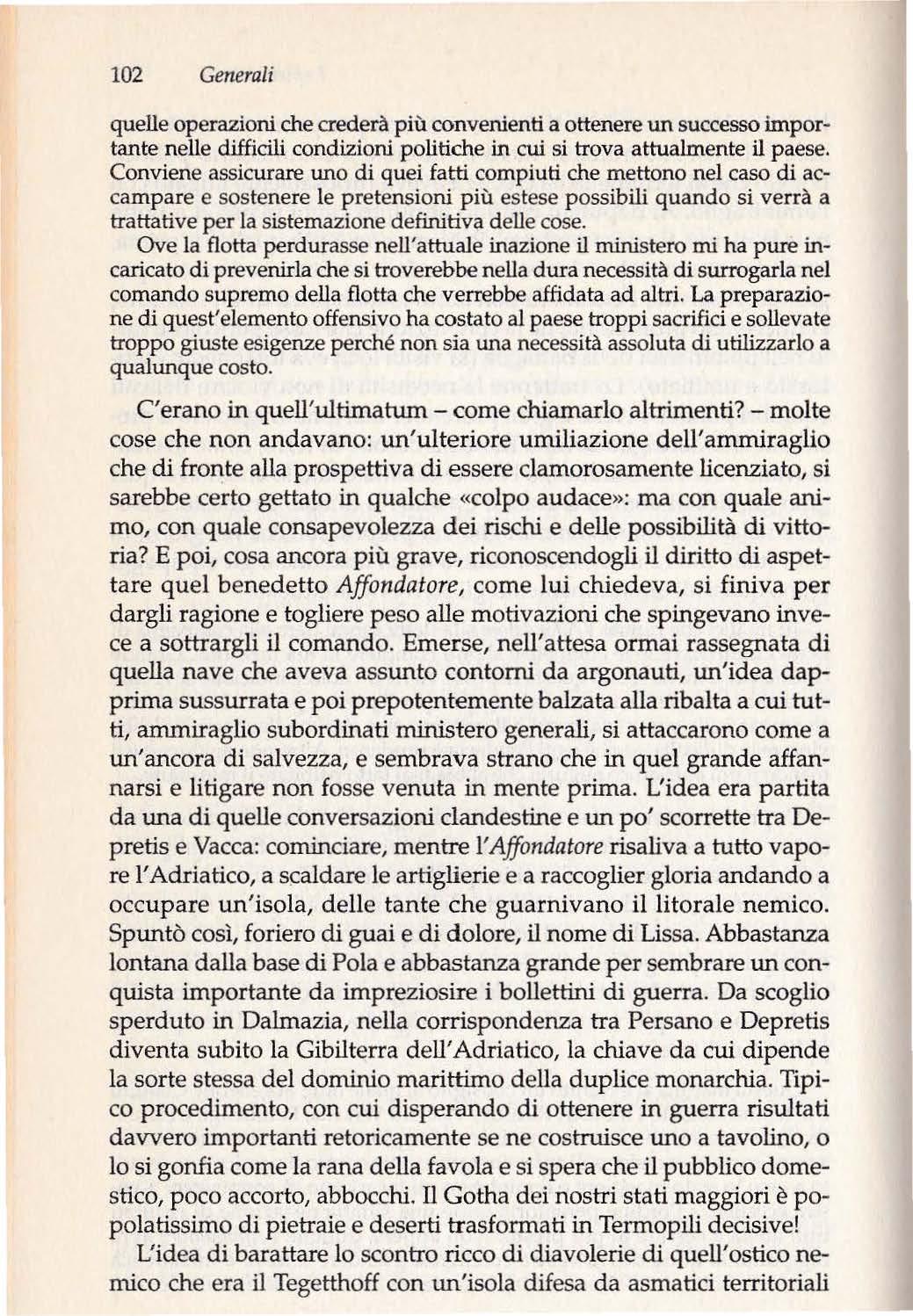
Ove la flotta perdurasse nell ' attuale inazione il ministero mi ha pure incaricato di prevenirla che si troverebbe nella dura necessità di surrogarla nel comando supremo della flotta che verrebbe affidata ad altri. La preparazione di quest'elemento offensivo ha costato al paese troppi sacrifici e sollevate troppo giuste esigenze perché non sia una necessità assoluta di utilizzarlo a qualunque costo.
C'erano in quell' ultimatum - come chiamarlo altrimenti? - molte cose che non andavano: un'ulteriore umiliazione dell'ammiraglio che di fronte alla prospettiva di essere clamorosamente licenziato, si sarebbe certo gettato in qualche «colpo audace»: ma con quale animo, con quale consapevolezza dei rischi e delle possibilità di vittoria? E poi, cosa ancora più grave, riconoscendogli il diritto di aspettare quel benedetto Affondatore, come lui chiedeva, si finiva per dargli ragione e togliere p eso alle motivazioni che spingevano invece a sottrargli il comando. Emerse, nell'attesa ormai rassegnata di quella nave che aveva assunto contorni da argonauti, un'idea dapprima sussurrata e poi prepotentemente balzata alla ribalta a cui tutti, ammiraglio subordinati ministero generali, si attaccarono come a un'ancora di salvezza, e sembrava strano che in quel grande affannarsi e litigare non fosse venuta in mente prima. L'idea era partita da una di quelle conversazioni clandestine e un po' scorrette tra Depretis e Vacca: cominciare, mentre l'Affondatore risaliva a tutto vapore l'Adriatico, a scaldare le artiglierie e a raccoglier gloria andando a occupare un' isola, delle tante che guarnivano il litorale nemico. Spuntò così, foriero di guai e di dolore, il nome di Lissa. Abbastanza lontana dalla base di Pola e abbastanza grande per sembrare un conquista importante da impreziosire i bollettini di guerra. Da scoglio sperduto in Dalmazia, nella corrispondenza tra Persano e Depretis diventa subito la Gibilterra del!'Adriatico, la chiave da cui dipende la sorte stessa del dominio marittimo della duplice monarchia. TI pico procedimento, con cui disperando di ottenere in guerra risultati davvero importanti retoricamente se ne costruisce uno a tavolino, o lo si gonfia come la rana della favola e si spera che il pubblico domestico, poco accort o, abbocchi. Il Gotha dei nostri stati maggiori è popolatissimo di pietraie e d eserti trasformati in Termopili decisive!
L'idea di barattare lo scontro ricco di diavolerie di quell'ostico n emico che era il Tegetthoff con un'isola difesa da asmatici t erritoriali
parve al Persano cosi bella, intelligente e a buon mercato che dimenticò tutte le sgarbe rie che gli erano state fatte e diede magnanimam ente la mano al ministro il quale, finalmente soddisfatto, venne a salutarlo prima della p a rtenza. Nessuno ne ll'euforia si preoccupò di prendere informazioni s ull ' isola: qua nte batte rie la difendessero e dove e quanti soldati fossero di g u a rnigione. Eppure c'erano sulle n avi nume rosi ufficiali ven eti che avevano prestato servizio non molti a nni prima nella marina austriaca e certo avevano visitato Lissa: n essuno li interrogò. Si disponeva di una carta idrografica d e lla zona ma neppure di una carta geogra fica e Persano gentilmente chiese per lettera al ministro di inviargliela. Depretis che, t e rrorizzato, intuì forse un'altra losca manovra per non partire, g li rispose brusco che non ne aveva di disponibili però lo autorizzava «se ne provvedesse a qualunq u e patto se può rinvenirla ad Ancona».
Ci volevano poi le truppe da sbarco: Persano, che ne aveva seicento, giustamente pensava fossero poche per ridurre alla ragione un'isola vasta e una guarnigione certamente più robusta. Anche per questo si rivolse a Depretis aggiungendo la domanda: «Ma chi comanderà la spedizione a terra?». «Oh bella! Un ufficiale superiore della marina» replicò il ministro. «Ma gli ufficiali di marina non sono capaci di ques te cose.. .» «Un ufficiale di marina deve anche sap er dire messa! » fu la replica finale e peren toria dell' impaziente Depretis. Andammo accompagnati dall'inevitabile proclama (con involontari accenti cornici e qualche bugia):
Dal primo aprirsi delle ostilità l'armata di operazione seppe mantenersi padrona dell'Adriatico. Circostanze da noi affatto indipendenti ci hanno finora impedito una maggiore iniziativa. Ora è venuto il momento di agire. Io sono lieto di annunciarvelo, e d i appagare così la vostra gi usta impaz ienza di combattere. Il nostro re ci ordina di farlo a oltranza. L'Italia ci guarda. Proviamo con i fatti che sappiamo superare la generale aspettazione.
La lettera sped ita invece a La Marmara aveva accenti assru più crepuscolari, e umili , s ingolari pe r un soldato che s t ava per affrontare la prova suprema:
Ricevo i rimproveri che Vostra Eccellenza mi manda per parte del ministro chinando la fronte come si add ice a un suddito fede le e umile subordinato. Ogni mia osservazione sa rebbe riprovevole. Vuole dire che avrò preso abbaglio nei miei giud izi e vedrò di saper far meglio.
A Ferrara, sede del gran q uar tier generale, si sarebbero dovuti s paventare a morte: era lo stile di un u omo rassegnato che non cred eva più a se s tesso e al proprio d estino.
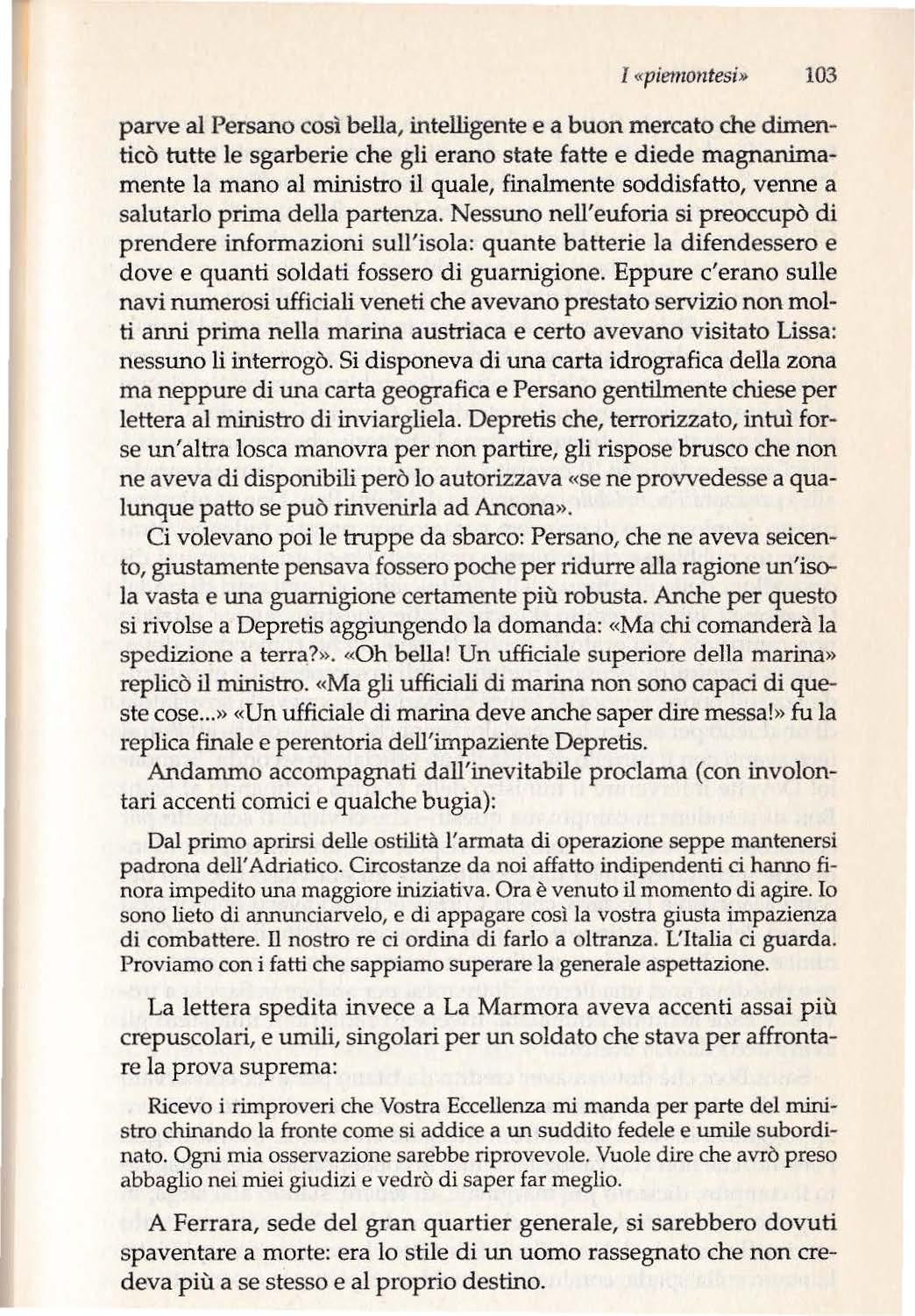
Per due gionù la flotta perse tempo in inutili bombardamenti attorno all' isola: le batterie erano, d ispettosamente, piazzate troppo di lato per l' alzo dei nostri cannoni e i tiri risultavano inefficaci; non sap endo nulla non potevamo prevedere. Impossibile quindi sbarcare. G li ammiragli, i so liti Albini e Vacca, facevano quel che pareva loro, spostandosi e rinunciando agli attacchi che e rano stati ordinati senza che Persano, ormai di fatto esautorato, dicesse nulla o minacciasse punizioni. Stringe il cuore a ricord are episodi che davano la misura dello stato degli equipaggi. Si maneggiava la v ita di uomini con sciagurata incoscienza. Nel tentativo di combinar qualcosa si decise di entrare animosamente nel porto di San Giorgio, il maggiore dell'isola, e annientare da breve distanza le batterie che continuavano a d a rci sommo fastidio. Il compito di g u asta to re era stato assegnato alla corazzata Formidabile comandata dal Sa int Bon. Due anni prima questo esimio uomo di mare era passato n on proprio indenne attraverso un pubblico e chiacchierato uragano. Un giornale, come si d iceva allora della «Estrema », «il Diritto», affidato agli estri d i un ta l Gi use ppe Civinini te nuto d'occhio dalle questure, aveva inizia to una campagna denigratoria contro la nave da lui comandata dove, s i faceva capire, qualcuno si metteva soldi in saccoccia. La gi urisprudenza sull'onore, ancora da tempi barbarici, imponeva la scorciato ia di un duello per sedare l o scandalo. Senonché invece del Saint Bon si fece avanti con il cartello di sfid a il suo ufficiale in seconda. Scandalo! Dovette intervenire il ministro della Marina o rdinando a l Saint Bon di scend ere in ca mpo: m a questi -che ci viene il sospetto per certe cose avesse c uor di coniglio - rispose con una lettera, ricordando che il comando della nave contestata g li era valso la croce dei Santi Maurizio e Lazzaro, che la Corte d e i Conti ave va approvato i bilanci della sua gestione e ch e non conosceva affa tto il signor Civinini; e quindi non vedeva m otivo per ammazzarlo o farsi ammazzare e chiedeva anzi una licenza di tre mesi per andare in Savoia a trovare la cara mamma ammala t a. Invece di r adia rlo il ministero gli aveva accorda to la licenza.
Saint Bon, che doveva aver credito da titano per aver conservato fa ma di animoso, s i gettò eruttando cannona te n el p orto. Doveva appoggiarlo il Vacca con a ltre tre fregate corazzate. L'ammira g lio Persano, che n on voleva toglier g lori a a i coll abora tori, si era ritagliato il compito, diciamo più marginale, di tene re, stando alla larga, in rispetto altre batterie austriache su lle colline . Piazz ato a trecento meri dalle batterie d e l cas tello, il Saint Bon, la zazzera scompigliata, la mano sulla spada, cominciò a scambiar colpi con le casematte a u -

striache. Sembravano due pugili che incrociano colpi furiosi senza badare a schivare e a difendersi aspettando solo che uno dei due crolli tramortito. Stava il Saint Bon ben ritto sul ponte di comando circondato dai suoi due ufficiali terrei per la paura e dava gli ordini per manovrare con eleganza mentre tutto attorno a lui era un inferno di fuoco fumo e spari. Quella vicenda giornalistica doveva però essergli rimasta sullo stomaco perché a un certo punto mentre la mischia si faceva feroce e fioccavano anche le fucilate disse: «Vorrei proprio vedere qui che figura farebbe quel signor Civi.niru ». Intanto il Vacca e le sue fregate erano a fatica entrate nell'angusto porto, all'ingresso misurava ottanta metri ma con la Formidabile davanti che eruttava cannonate e ne riceveva non si poteva combinare nulla; o almeno così raccontarono, lasciando il Saint Bon da solo a cavarsela. Le relazioni ufficiali non ne parlarono, ma l'equipaggio della Formidabile, che non aveva le manie del suo comandante, a un certo punto non ne poté più di pigliar cannonate e si ammutinò chiedendo di uscire dal porto . Saint Bon e gli ufficiali dovettero sguainare le sciabole per tenere l'equipaggio al suo posto. Insomma non si andava all'inferno allegramente.
Era proprio una crociera disgraziata . Mentre cercavamo di combinar qualcosa di buono per giustificare la giornata, arrivò «involto in una fitta burrasca» spuntando come una maledizione divina da un orizzonte grigio freddo gonfio di pioggia, Tegetthoff con le sue sette corazzate.
I testimoni della battaglia furono unanimi nel raccontare che quando fu alzato il segnale «nemico in vista» e apparve quel minaccioso ammassamento, «l'annunzio fu accolto dall'armata come s i accoglie l'annunzio di un pericolo impreveduto» . E questo da solo spiega molte cose di quanto avvenne quel giorno.
Comunque, in una gran confusione, la nostra flotta cercò di assumere uno schieramento in grado, secondo le buone regole, di reggere all'urto del nemico. Avevamo in mare dodici corazzate contro sette del nemico e anche nelle al tre categorie di navi il nostro vantaggio era n etto. Anche guardandola in quella luce scarsa del giorno piovoso sballottata dai marosi sempre più grossi, la prima flotta italiana faceva una gran figura: scafi dipinti in chiaro bianco-cenere, alberature ricalate e le coffe blindate con tutto quello che si era trovato, comprese le brande. Navi belle come sempre sono state le nostre, flotte estetiche, come gli incrociatori e le corazzate che invano fecero crociera nel Mediterraneo contro gli inglesi nella seconda guerra mondiale. La gente che era a bordo, magari raccogliticcia, magari

senza grandi tradizioni alle spalle, aveva voglia di battersi, andava incontro al nemico con animosità e speranza. Non che la truppa fosse assetata di sangue: al momento opportuno se ne cavarono ampiam ente e valorosamente la voglia. Avevano alzato secondo un vecchio costume il piccolo pavese perch é il g iorno di battaglia è un giorno di festa . Tutti si erano armati di spade e coltelli che li facevano sembrare pirati . Anche se le loro navi erano ormai corazzate nessuno a partire dai comandanti dubitava che lo scontro sarebbe finito con il classico abbordaggio di una nave nemica . I marò che e rano a bordo si disposero ai loro posti pronti a fulminare con una scarica di fucileria il nemico in coperta. Come scrisse l'inglese Wilson, ch e si intendeva di navi e di uomini.
Se gli italiani non sapevano battersi, sapevano almeno morir bene e in quel periodo di loro sciagura queste eroiche ges ta furono ricordate con amore dal popolo italiano. Erano valorosi i combattenti di Lissa ma il loro valore n on vince le battaglie.
Per capire perché perdemmo basta riesumare dai diari cosa fecero i due comandanti. Alle dieci e quindici, quando faticosamente le nostre navi avevano assunto la linea di fila che era stata scelta dal nostro ammiraglio per muovere contro il nemico, Persano fece alzare su lla Re d'Italia il segnale che ordinava all'Affondatore (era finalmente arrivata la meraviglia della flotta!) di avvicinarsi. Poi fece fermare la sua nave e con una lancia si trasferì definitivamente sulla corazzata con il suo vice D'Amico, un ufficiale di s t ato maggiore, due sottufficiali e il suo primo aiutante, il figlio Carlo. Tutto fu fatto con tale fretta che la lancia venne addirittura abbandonata. Poi sull'Affondatore venne al zata la bandiera di viceammiraglio (non si disponeva per la sorpresa dell'evento di quella di ammiraglio) e la Re d'Italia mes tamente abbassò la s ua insegna di nave che custodiva i destini del capo della flotta. Salendo a bordo, racconta un testimone, Persano disse: « Vengo al vostro bordo per essere certo di poter tirare la prima cannonata». Si riferiva probabilmente alla vel ocità della unità come avrebbe fumosamente spiegato nella sua au todifesa e al processo:
Era la prima volta che ci accingevan10 alla prova dei nuovi formidabili strumenti di una battaglia marittima, quindi e per il mio giudizio, e pel parere dei migliori autori delle tattiche navali mode rne, e per l 'autorizzazione che me ne davano i vigenti regolamenti della Regia Marina Italiana passai sull'Affondatore inalberandovi la mia bandiera di comando. A ciò mi deliberavo nell' intento di trovarmi su di un legno che tenevo per forte e veloce a un tempo. Sia per potermi condurre a piacimento nel fitto della misclùa o

per determinare la vittoria se vincenti, o per rinfrancare il combattimento se perdenti; sia perché meglio poteva muovermi e spiccar ordini con certezza di essere veduto.
Sarà: il fatto è che solo le navi più vicine si resero conto che l'ammiraglio non era più a bordo della Re d'Italia. Nella nuova guerra navale infatti oltre a cannoni e corazze era comparso un altro e lemento impreveduto, il fumo pesante e spesso che toglieva la visibilità. In un tempo in cui i segnali si facevano esclusivamente con bandiere quella cortina fumogena rendeva impossibile comandare efficacemente i complessi movimenti di flotte così grandi, un problema che era ancora irrisolto al tempo della battagHa dello Jiitland (nel 1916!), e che dovrà aspettare l'avvento della radio. Comunque il vero guaio è che Persano, saHto a bordo, si infilò dentro una delle due rivoluzionarie torrette corazzate dell'Affondatore. Nessuna altra nave quel giorno disponeva di qualcosa di simile: un locale alto due metri a sezione ellittica con pareti spesse cinquanta centimetri di cui dodici di corazza. Attraverso le feritoie larghe appena dodici centimetri cominciò a seguire la battaglia (ben poco perché non si vedeva nulla: a causa dj difetti al timone, «la meravigHa» era assru poco manovrabile) e di lì non si mosse più. Soltanto un evento imprevedibile a quel punto poteva metterne in pericolo la vita.L'Affondatore, che non affondò nulla, avrebbe dovuto essere ribattezzato l'Inaffondabile. Era inevitabile che quei pochl che si accorsero della manovra ne ricavarono una pessima impressione, e anche se essi non erano tra i molti nemjci dell'ammjragHo, era difficile non sospettassero che si trattasse di un espediente per restare al sicuro. Gli altri continuarono a pensare che la battaglia fosse diretta dalla R e d'Italia e cercarono invano sui suoi alberi comparire i segnali di movimenti e manovre. Certo qualcuno ne approfittò per aver un motivo legittimo di scuse per la inazione, o l'aperta disobbedienza . Come l'Albin;, che furibondo per dover guidare la flotta di legno che il Persano aveva sistemato in retroguardia considerandola inutile, per dispetto si mjse in sciopero e non partecipò alla battaglia: quattrocento cannoni che quel giorno non spararono un colpo e fecero solo da spettatori.
E l ' ammiraglio Tegetthoff? Lasciamo che racconti un testimone che era sulla sfortunata Re d ' Italia e che nella concitazione, nel fragore indiavolato della mjsch;a si vide venire addosso al massimo della velocità, undici nodi, proprio la Kai ser Max, ammjraglia austriaca. La Re d'Italia, sciaguratamente colpita al timone, era diventata ingovernabile e il comandante, con una decisione che sarebbe gentile definire stolta, aveva ordinato di fermare le macchine: una preda ghlotta,

quella gran nave immobile con la sua pancia bianca, per un teorico dello sperone come Tegetthoff. Il cassero era in fiamme, la tolda ricolma di gente pronta all'arrembaggio coperta di morti e feriti, un ufficiale già gridava: «Tutto è fuùto, ai vostri posti». Tonello Orsini, guardiamarina capocoffa, vide in una manciata di secondi interminabili in un mare che sembrava sgombro incredibilmente di navi, emergere quel terribile vascello che dirigeva verso di loro, immobili:
Due uomini solo si vedevano sulla coperta ed erano, lo seppi dopo, l'ammiraglio e il comandante... la nostra coperta era invece piena di sangue e di feriti che gridavano e gemevano che era una pietà. In questa il Max ci investi ìn pieno, un poco a prora: allora vidi l'ammiraglio nemico, bell'uomo con lunghe barbe nere, togliersi il berretto e dare un grido, a cui rispose un'eco lunghissima dalla sua batteria. Quel grido ci riempì l'anima di una rabbia atroce e tirammo su di lui colle nostre carabine, ma inutilmente.
La nave amnùraglia affondò in quattro minuti, risucchiando nel suo gorgo duecento marinai. Si salvarono solo centocinquantanove nuotatori provetti, i più forti e fortunati. Le zattere di salvataggio non esistevano ancora, furono inventate solo nel 1915. Lissa è tutta qui: venti minuti, non di più, di confusione, una nave persa e un'altra, la Palestro, che saltò in aria per un incendio che non si riuscì a spegnere. La scomparsa della carcassa squarciata della Re d'Italia in un duello identico a quello delle triremi greche e romane, segnò la nostra sconfitta. Infuriarono per mesi, per anni dotte dispute se la colpa fosse stata nell'aver il Persano scelto la linea di fila e il Tegetthoff aver invece puntato ingegnosamente sul cuneo. Vinse Tegetthoff e questo scioglie la disputa. Ma vinse perché aveva una qualità che Persano perfino ignorava: la grinta, la determinazione, la voglia di andare a cercarsi la fortuna a tutti i costi rischiando, che è l'unico modo per trovarla davvero. E per imprimere in chi combatte ai tuoi ordini la stessa forza di volontà; esattamente quello che i generali italiani non hanno mai esibito.
Eppure anche tra i nostri non erano mancati gli animosi: una unità austriaca, la Prinz Eugen, e la nostra Maria Pia comandata dal marchese Del Caretta accostarono fiancata a fiancata e si scambiarono cannonate e fucilate furiose da pochi metri. Il Del Caretta stava fuori dalla torre di comando con la pistola in pugno esposto al fuoco come un marinaio qualunque: vide sulla tolda della nave nemica il comandante austriaco Bary, si scambiarono un cortese saluto col berretto. Un beau geste. Dopo la battaglia divennero amici e le mogli si scambiarono lettere e visite di cortesia. Il Persano restò chiuso nella sua torre corazzata e riemerse solo dopo tre ore e mezzo quando

la flotta n enùca era sfilata tra le nostre navi malconce e disordinate e aveva r aggiunto ormai Lissa..
C'era tutto il tempo p er rimediare: anzi si doveva rimediare. Nonostante le due perdite dolorose avevamo ancora una netta superiorità in corazzate, mezza fl otta non aveva sparato un colpo e soprattutto il ne nùco era malconcio chiuso nel porto di Lissa: si aspettava l'ordine di muovere contro il nemico; invece, come a Custoza, Persano alzò il segnale di dirigere verso Ancona . Eravamo vinti soprattutto perché riconoscevamo d i esserlo. Sembra incredibile, ma alle prime notizie della b a ttag li a con fuse, contraddittorie a Firenze e a Vienna s i e ra fatto festa, convinti entrambi di aver vinto. E quando la flotta mestamente si avvicinò ad Ancona, la folla assiepata sul molo e s ull 'altura di San Ciriaco aspettava di veder comparire le na vi nemiche catturate. Quando si accorse che invece mancavano due navi n ostre cominciò a fi schiare e tumultuare. Non e ra che l ' avvisaglia di quanto sarebbe su ccesso n e lle settimane successive: la gran rissa tra i reduci, ognuno che accusava l' altro di essere il responsabile della disfa tta, magari dividendosi secondo le vecchie schiere regionali, napoletani con tro piemontesi, p iemontesi contro ven eti . Su una sola cosa tutti er ano d'accordo, pubblico, politici e colleghi sa lvo qualche rarissima eccezione: nel maledire il Persano. Mentre la burocrazia riprend eva i suoi fasti consueti (a un marinaio inghiottito dalle acque - il capo cannoniere della Re d'Italia - giunse la richiesta di una fattura per aghi con cui cucire le vele che mancava alla documentazio ne! ).
Iniziava la consueta tattica italica per asso rb ire le sconfitte. Il primo passo era quello di p roced ere alla falsificazione di quanto era s u ccesso lavorando s ulla leva d e ll'eroismo. Non bastava la ve rità, che n on era p oco: s i doveva inventare, n asconde re, celare, volgere in retorica. Si inventò che il comandante della Re d' Italia si e ra immolato sparandosi a lla testa quando aveva visto la sua nave ormaj perduta, per perire con i suoi marinai. Esistevan o invece testimo ni che avevano scorto il capitano Enùlio Faà di Bruno, il quale fino all'ultimo aveva dato o rdini, t ogli ersi i vestiti per gett arsi in mare con i s u o i uomini . E l 'aveva fatto davvero, perché alm lo scorsero nudo in acq ua d ove, poco esperto nuotatore com'era, tentava di avvinghiars i a qualche rottame . Forse glie lo impedì il risucchio d e lla n ave che andò a fond o portando con se molti suoi figli perduti. Vis to che un s uicidio solo n on bas ta va, se n e inven tò un altro ancor meno credibile, di massa. Alfredo CappelJinj e i marinai della Palestro in fiamme avrebbero volo n tariamente sacrifica to le loro vite per impedire che la nave cadesse in mano al n enùco. Così hanno stu d ia to generazioni

di bambini italiani sui libri di testo: quando invece fu l'esplosione della santabarbara per un incendio che i marinai non erano riusciti a bloccare a causare il disastro. Per di più avvenuto non in mezzo alle navi nemiche, ma al centro della nostra formazione quando la battaglia era ormai terminata.
Restavano da saldare i conti della sconfitta, con i morti, l'umiliazione definitiva di quella guerra sciagurata, i trecentosettanta milioni di lire dilapidati per una flotta che non era servita a nulla. Depretis piombò ad Ancona e parlò con tutti gli ammiragli, a eccezione del Persano che rimase solo sulla sua nave presentendo quanto lo aspettava: bastava leggere i giornali dove impazzavano accuse così mostruose e smodate da far sembrare irrilevanti le sue colpe reali. Ormai lo chiamavano «il conte bugiardo» e le allusioni alle sue vigliaccherie del passato e del presente erano esplicite e clamorose. Persano fidava però in quella solidarietà di clan e di mafia che ha quasi sempre funzion ato: se condannano me devono condanna re automaticamente anche i politici, Depretis Ricasoli, La Marmora che hanno colpe grandi quanto le mie. E per questo, con gesto suicida, chiese lui stesso di essere sottoposto al consiglio di guerra. Contava di essere prosciolto magari con una di quelle archiviazioni che in Italia così bene salvano la faccia . Errore fata l e! La classe politica aveva bisogno di un colpevole e chi meglio di lui, odiato sospetto poteva fornire il soggetto per la parte? Il materiale per le accuse e ra già pronto a vo1umi e ogni giorno lo fornivano g li altri ammiragli - 1 ' Albini e il Vacca in prima fila - che dovevano nascondere i loro errori e le loro plateali disubbidienze . E sopra ttutto non si era accorto che quanto s uccesso dopo Custoza non era un esemp io temibile: la setta dei generali era troppo forte per lasciarsi punire d ai politici, troppo salda la solidarietà orizzontale rispetto alle inimicizie, alle gelosie e agli odi in qualche caso che li separavano. Persano e ra, un po' per arroganza un po' per il suo ruolo, isolato, solo. I colleghi di terraferma consid eravano già allora la flotta un inutile sciupio di soldi ed erano dispostissimi a lasciarlo affogare. A un certo punto la sua tranquillità (erano passati nel frattempo due mesi e si era firmata la pace) cominciò a incrinarsi: i primi t e legrammi con cui Depretis s ubdolamente aveva accettato le sue g iustifica zioni e la sua versione molto ottimistica d e i fatti (Persano si ostinava a dire che era rimas to padrone del mare, beato lui) erano scoloriti. E, soprattutto, il giudizio s ul s uo operato era sta to trasferito, con sospetto scrupolo costituzionale, al Senato trasformato in Alta corte di gi ustizia. Fu un processon e. Presiedeva il t erribile tribunale il senatore Cel-

so Marzucchi, componenti Castelli e Chigi entrambi ex ufficiali di marina e un viceammiraglio: il De Ferrati. Persano, che nel frattempo era stato arrestato e si trovava agli arresti domiciliari in un alloggio nello stesso palazzo del Senato, nel leggere il capo di accusa certo sentì che la sua sorte era già decisa. Le imputazioni erano: alto tradimento, punibile con morte ignominiosa per aver scientemente fatto o omesso atti per cui fu impedito il buon esito di una operazione militare, in esecuzione di ordini in presenza del nemico [e qui si rischiava la fucilazione alla schiena], in esecuzione di missione per negligenza e imperizia [si rischiavano benignamente solo le dimissioni].
Se davanti a un tribunale militare aveva qualche possibilità, con i senatori che dovevano difendere evidentemente l'assoluta innocenza dei politici era già mezzo condannato. A complicar le cose si mise anche la sua sciocca volontà di confutare, di apparire protagonista che non lo abbandonò neppure nella disgrazia. Aveva infatti a tamburo battente fatto pubblicare un libretto, Jfatti di Lissa, in cui forniva la sua versione. Operina sciagurata scritta in un tono saccente, dove manca qualsiasi umile constatazione di errori (colpe sarebbe s tato chieder troppo), le omissioni e le inesattezze sono clamorose, e soprattutto si rov escia veleno sugli altri ammiragli da cui invece avrebbe dovuto cercar aiuto:
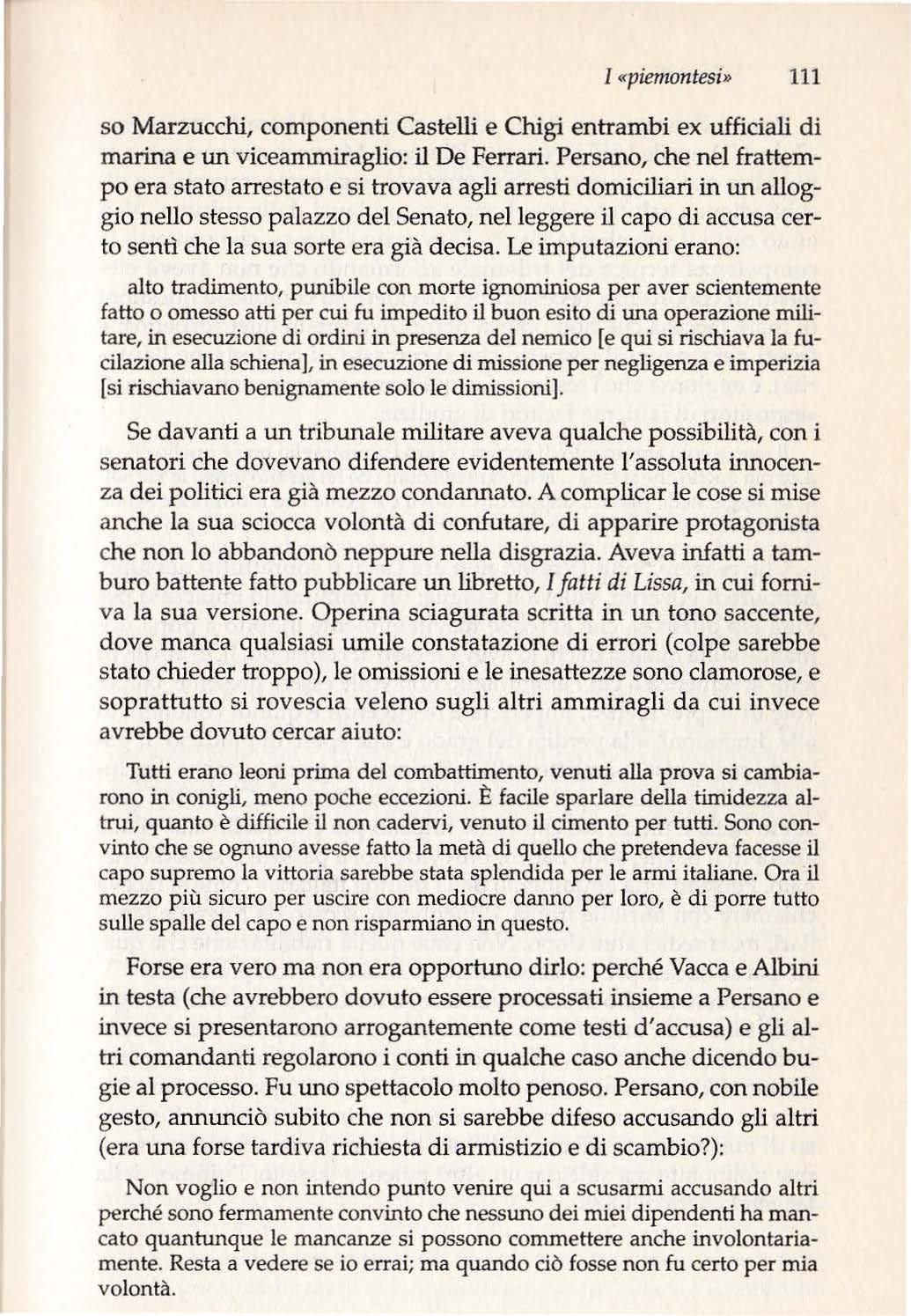
Tutti erano leoni prima del combattimento, venuti alla prova si cambiarono in conigli, meno poche eccezioni. È facile sparlare della timidezza altrui, quanto è difficile il non cadervi, venuto il cimento per tutti. Sono convinto che se ognuno avesse fatto la metà di quello che pretendeva facesse il capo supremo la vittoria sarebbe stata splendida per le armi italiane. Ora il mezzo più sicuro per uscire con mediocre danno per loro, è di porre tutto sulle spalle del capo e non rispa rmiano in questo.
Forse era vero ma non era opportuno dirlo: perché Vacca e Albini in testa (che avrebbero dovuto essere processati insieme a Persano e invece si presentarono arrogantemente come t esti d ' accusa) e gli altri comandanti regolarono i conti in qualche caso anche dicendo bug ie al processo. Fu uno spettacolo molto penoso. Persano, con nobile gesto, annunciò subito che non si sarebbe difeso accusando gli altri (era una forse tardiva richiesta di armistizio e di scambio?):
Non voglio e non intendo punto venire qui a scusarmi accusando altri perché sono fermamente convinto che nessuno dei miei dipendenti ha mancato quantunque le mancanze si possono com.mettere anche in volontaria· mente. Resta a vedere se io e rra i; ma quando ciò fosse non fu certo per mia volontà.
Povero P ersano, non aveva capito che ormai il baratto era impos· sibile. L'll a prile 1867 l' a vvoca to Diomede Marvasi, che sosteneva la pubblica accusa, chiese la condanna per negligente imperizia e disobbedienza s alutato da entusiastici app la u si dalle t r ibune. No n ai utò certo il suo cliente invece l' avvoca t o Giacosa, che contestò la compet enza tecnica del tribunale affe rmando che non aveva e lementi di conoscenza necessari per decidere su complesse questioni di mare (accusa che n on poteva n on provocare in quei sospettosi e tronfi personaggi il sospetto che si cercasse di contes tarne l 'auto· rità), e aggiunse che i t estimoni, e qui aveva ragion e, non erano stati «espositori di fatti, ma faci tori di giudizi»:
Il vero e solo argomento di accusa contro l'ammiraglio non è quello che si dice ma quello che s i tace ... le argomentazioni che ho sentito lungo le vie sotto le logge, nelle piazze, dappertutto dove c'è gente che mormora e schia· mazza, che deride e ride ... è necessario che un uomo muoia per il popolo.
C he esagerazioni! Persano non era Gesù e soprattutto nessuno, n eppure il governo, voleva il sangue: un ammiraglio impiccato per viltà era qualcosa che avrebbe inevitabilmente indotto a porsi do· mande s ulla qualità di chi lo aveva messo a l comando. Il 15 a prile fu letta la sentenza a cui l'ammirag lio n on volle essere presente: colpe· vo le di imprevidenza, imperizia e n egligenza e quindi con danna t o alle dimissioni, a lla perd i ta del grado e alle spese di giudizio. Il governo poco cris ti anamente volle infierire e vi aggiunse anche l'esclu· sione dalla pensione, poi confermata dalla Corte dei Conti. Ma q u es t o in Italia è un diritto che viene tutelato più che quello alla vita, e allora fu il re che, sotto banco, provvide poi a passare il sussidio nega to . Persano «già ammiraglio della marina italiana» come s i faceva chiam a re con t erribile ironia, dimentica to, scosso da tragedie familiari, morì sedici anni dopo. Non ebbe quella riabilitazione che q u es to paese ha sempre concesso anch e ai suoi colpevoli più t otali . Non andò meglio a l suo avversario, il fortunato Tegetthoff era già n ella t o mba da undici anni . Le sue proposte per potenziare quella flotta ch e così bene aveva servito i suoi padroni e rano s tate bocciate. Gli intralci non e rano meno astrusi di quelli che ingombravano l'Italia e lui u scì di scena tra molte a marezze e rimpianti, tanto che pres· so di noi, amara vendetta, si diffuse la voce ch e non fosse morto di una polmonite ma suicida: un a ltro pate tico tassello, l 'ultimo, della leggenda nera di Lissa.

Un eroe con le cambiali Nino Bixio aveva, per dirla con clùarezza, un diavolo per capello. Fin da quando gli avevano ordinato di andare con la sua Settima divisione a occupare la posizione delle Gonfardine aveva capito che quel giorno avrebbe dovuto eserci tare la virtù che meno gli era congeniale: la pazienza. C'erano mille cose che non gli piace vano in quella g u erra «stupida» . Si avanzava, per esempio, senza che la cavalleria che pure era mastodontica e molto riverita avesse, come si diceva in linguaggio tecnico, «riconosciuto» i luoghi: tanto il nemico, dicevano i suoi colleghi generali, era secondo la testimonianza della gente del luogo, oltre l'Adige. Quindi si poteva venir avanti a casaccio: ma lui il nemico lo sentiva, lo fi utava, sensibilità che aveva imparato alla scuola di Garibaldi quando un' intuizione ti poteva salvar la vita. E poi tra la sua divisione e quelle vicine, sulla sinistra c'era addirittura il principe Umberto, si allargavano grandi spazi vuoti dove il nemico se era in vista si sarebbe potuto insinuare. Al mattino aveva già dovuto manovrare per impedire che l'erede altrono venisse spazzato via da una carica di ulani un po' kamikaze che gli si erano gettati addosso. Ma da sei ore era completamente immobile, i cannoni puntati, i soldati con l'arma al piede mentre a destra sentiva che il cannone tuonava; e con che fragore e intensità, crescendo di ora in ora.
Era s ta to un bell'episodio che avrebbe giovato alla carriera e che lui, un talento nelle pubbliche relazioni, aveva subito sfruttato guadagnandosi un posto in tutti i sussidiari del Regno ancora per molti anni : «Altezza,» aveva detto al futuro sovrano «permetta che le stringa l a destra con sentimenti di patria gratitudine»; frase e posa ideale per quei bozzetti che immortalavano un'epoca: l'accordo sul

campo cli battaglia tra le due Italie, quella garibaldina e un po' briccona e quella monarchica ufficiale, nobile e posata. Ma Umberto lo congedò con un frettoloso grazie, perché era molto più serio di quanto l'antirisorgimen to lo ha clipinto dopo i fatti del 1898.

A volte in quelle sei ore gli venne voglia cli far finta di niente e buttarsi avanti, alla gariba ldina: con le camicie rosse avrebbe fatto così, il generale voleva iniziativa e alla fine invece di rimproverarlo gli avrebbe stretto la mano. Dietro di lui una rivoluzione vittoriosa che aveva preso una cattiva piega, diverse rivoluzioni mancate, un numero così grande di battaglie che dà un po' le vertigini. Ma adesso aveva addosso i gradi dell'esercito piemontese. Quel giorno il suo compito era dimostrare che sapeva fare il generale vero, non solo dei volontari combattendo alla s udamericana, lui che era ven uto «nella famiglia militare dal regno della rivoluzione». E il primo compito di un generale vero, regolare, era quello di obbedire agli ordini. Anche se volentieri li avrebbe mandati al cliavolo. L'ultima cosa che doveva succedere è che qualcuno alla fine della giornata potesse dire che lui, il pirata, l'avventuriero, non sapesse comandare una divisione davanti al nemico; lo sussurravano già i soloni della setta piemontese e non solo loro.
Non era più quello di Calatafimi e di Maddaloni. Allora usciva dalla tempesta, la tempesta era in lui . Adesso viaggiava in carrozza anche sul campo di battaglia come i veri generali, aveva messo s u pancia e per questo portava la pancera che gli permetteva cli esibire la bella silhouette di quando caricava ancora alla bai onetta, si tingeva i capelli. Così quando gli dissero che doveva ritirarsi a Staffalo per coprire la ritirata dell'ala destra obbedì. Bestemmiando, accigliandosi, martoriando il cavallo con gli speroni, gettando a destra e a manca quelle occhiatacce che terrorizzavano i sottoposti, ma obbedì. Cercò per la verità di guadagnar tempo spedendo un messaggio al quartier generale in cui assicurava ch e si era schierato sulla strada di Sommacampagna e che lì poteva resistere benissimo. «Si credeva in forze da tener l a posizione sino al riprendere dell'offensiva» scrisse. Povero Bixio! Si faceva ancora illusioni. Era sicu ro che la notte stessa, al massimo il mattino, completato quello che doveva essere soltanto un aggiustamento tattico causato dai primi scomposti movime nti della battaglia, saremmo andati avanti e al galoppo: eravamo o non eravamo più numerosi degli austriaci e con più cannoni? E invece no. Della Rocca, proprio lui, il nemico di Govone, un personaggio da salotto e da tranelli, gli spedì il capitano Farini con l'ingiunzione di andar ancora più indietro e di fretta. Quella era pro-
prio una ritirata. Per lui, abituato ad avanzare sempre, la d olorosa esperienza era ancora più complicata e pericolosa: si ripiegava sotto l'affanno di un nemico vittorioso che poteva esser vicinissimo mentre scendevano le ombre della sera, con i solda ti sfatti da quella inutile attesa, n e lle cui file il ritirarsi aveva trasformato l'entus iasmo in angoscia rabbia umiliazione. E infatti aveva appena dato gli ordini distribuendo presidi ai nodi delle strade, spedendo i bersaglieri a destra e a sinistra d el percorso che dovevano seguire, e piazzato le batterie laddove il sostegno poteva risulta r d ecisivo, che dall'oscurità ormai incombente emerse il rombo cadenzato che annunciava l'avanzare della cavalleria n emica . Erano già le sei di sera, si sentiva il sospiro lontano dei ca nnoni e non c'era più tempo di riparare al disastro.
Bixio aveva d is piegato la sua fanteria in linea con l 'ordine di accog liere il n emico a mezzo tiro dove i colpi sarebbero s tati più precisi e poi si pian tò tra le batterie fo rm a te da dieci cannoni dove voleva lui s tesso dar l'ordine d e l fuoco quando la mitraglia av rebbe seminato il maggiore sconqu asso. Forse la battaglia era p erd uta ma, perdio, av rebber o vis t o com e s i batteva un Bixio. Dalle file nemiche emerse, con l'atteggiamento del messo, un elegante ufficia le d egli u ssari. Divisa blu, pantaloni rosso fuoco, alamari dorati, n eppure la polvere di una giornata di battaglia aveva spento l'eleganza di quei gagà dell'esercito imperia le: gente di fegato che magari qualcuno avrebbe chiama to stupidi . Erano loro che a l mattino s i e r ano lancia ti senza costrutto e senza possibilità contro i fanti del principe Umberto e d erano stati massacrati dalle fucilate e dalla controcarica dei nostri s quadroni a cavallo. All'ufficiale che svento lava la bandiera bianca, Bixio mandò incontro il s uo capo d i s ta to maggiore, il capitano Busetto, che tutto il giorno aveva s fiancato il cavall o a portar ordini, fare ricognizio ni, riferire, e gli raccomandò che ordinasse ali' austriaco, prima di scambiar parola, di voltar la testa dall'altra parte per non osservare lo schie ramento italiano e usar queste notizie per dirigere il successivo assalto. Bixio era sempre Bixio anche se con i gradi piemontesi. Non resistette a vederli parlottare a lungo e animatamente. Spronò il cavallo e s i avvi cinò n o n v i sto ai due che un poco buffamente volgevano le spalle per quella ch e sembr ava una disputa a i soldati e ai cannoni. Cols e l 'eco di parole che si riferivano a unarichiesta di resa e non ci vide p iù, tornò a essere il garibaldino, lo sciabolatore, il fucilatore, il terribile. Gettò il cavallo contro lo sventurato parlamentare con la sua inutile bandiera bianca, lo affe rrò per l' uniforme e cominciò a scrollarlo urlandogli in faccia, raccontano le
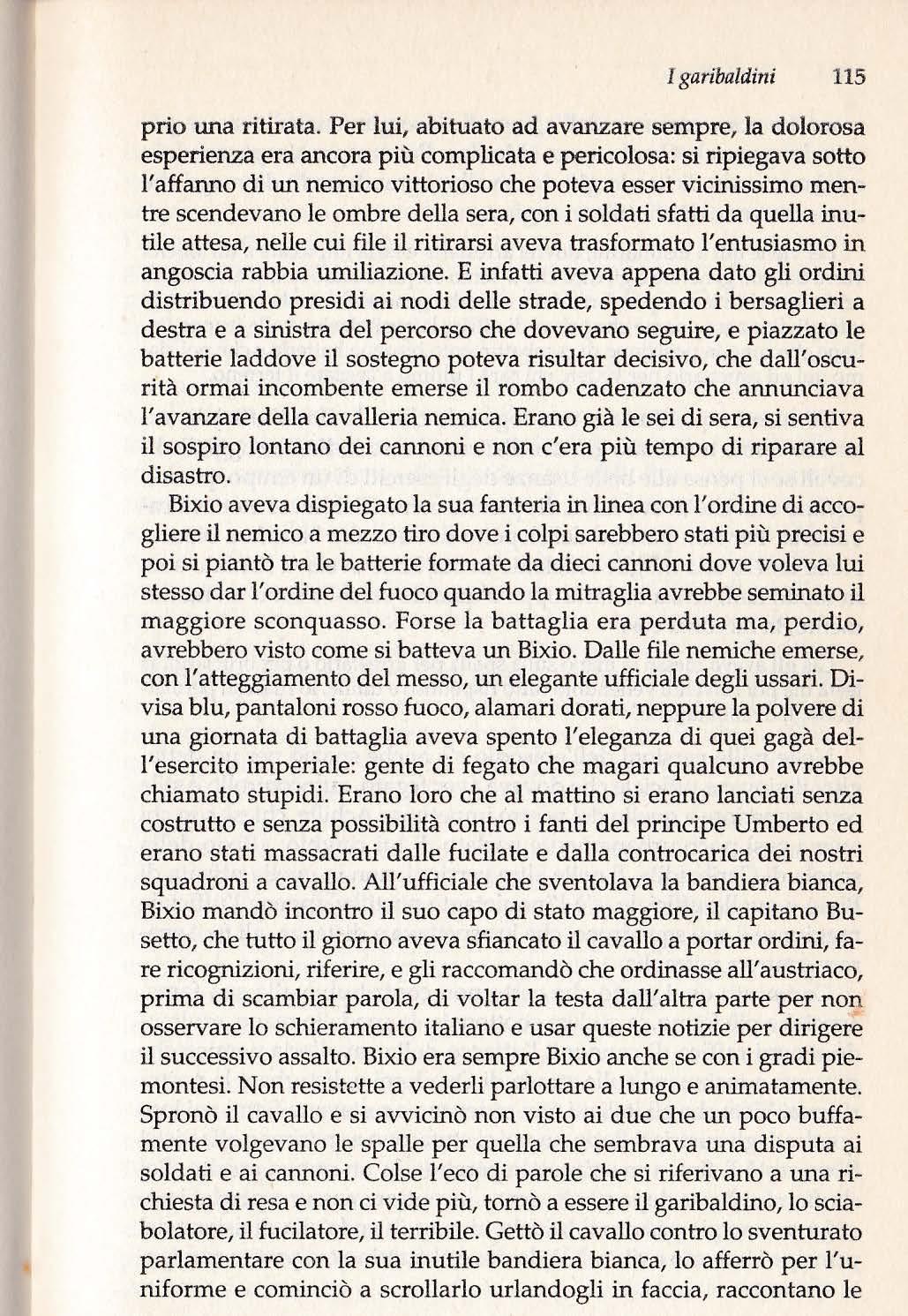
cronache non censurate dall'agiografia risorgimentale, la stessa parola del generale Cambronne: «Merda». Poi sempre str apazzandolo e minacciando di tirarlo giù da cavallo, i grandi occhi da mago che non cessavano di scintillare, aggiunse:
Lei viene qui a insultarmi, dovrei arrestarla e farla impiccare a un albero. Torni dal suo generale e gli dica che il Terzo corpo italiano non si arrende, fa arrendere chi viene a proporre delle cose del genere! Se vuole la libertà e la vita gli dica a mio nome che prima di offrire la capitolazione alle truppe italiane che sono in posizione di combattimento bisogna batterle e che noi siamo qui ad aspettarlo per vedere chi sarà l'ultimo a lasciare il terreno.
Ci mise in quell ' urlare una foga tal e che alla fine l'ufficiale austriaco venne trascinato giù di sella; erano cose si direbbe oggi disdicevoli se si pensa alle belle usanze degli eserciti di un tempo quando perfino uno che aveva fama di spietato come Cialdini ci metteva cavalleria. Per non parlare del rispetto dovuto alla bandiera bianca. Nelle lettere alla moglie Adelaide in cui Bix.io svelava l'animo suo, in modo nai:f, senza badar troppo a quando sarebbe stato un monumento, la racconta così:
Già gli avevo messo 1a mano sulla spalla per arrestarlo o per bruciargli la testa ma poi rinvenni vedendolo tutto rispettoso e umile, lo rilasciai permettendogli di allontanarsi.
Nelle mille versioni dell'episodio c'è anche spazio per un dettaglio: il giovane ufficiale che doveva aver fegato, autocontrollo e stile certo superiore a quello del nostro impetuoso Achille, chiese con chi aveva cosi poco urbanamente parlato. E lui ringhiò: «Bixio della scuola di Garibaldi!». E nelle altre versioni, non in quella privata di Bixio e quella ufficiale, c'è l'inquietante postilla: appena l'ufficiale raggiunse il suo squadrone, che lo aspettava a distanza, gli fece sparare contro a mitraglia.
Compiuto quel gesto che certo non contribuiva alla sua fama, aspettò a piè fermo, la giubba sbottonata, la spada in mano, esultando a ogni raffica di cannoni, l'attacco della cavalleria nemica che provava a insinuarsi sulla strada di Quaderni e disturbare la nostra ritirata. Visto che gli italiani non cedevano e restavano fermi nei loro quadrati, gli austriaci dopo un po' si stufarono e sparirono alla vista . Bixio restò lì fino a mezzanotte sperando in un nuovo assalto. Poi sbuffando, paese dopo paese, senza incontrare nessuno perché i nostri avevano già passato il Mincio, si mise in coda alla divisione del principe Umberto e ritornò là da dove al mattino era partito con tante speranze.

Siamo, con Bixio, arrivati alla seconda anima del nostro esercito e d ei nostri generali: i garibaldini. Perché se i piemontesi rappresentavano la scuola, il mestiere, il metodo (con tutte le eccezioni che g ià abbiamo incontrato p er s trada) i garibaldini sono l ' improvvisazione, l'estro, l'ard o r e, il far da sé con i mezzi c h e si hanno, inventando grandi imprese con niente, terrificante qualità che ha sempre accompagnato la retorica italica e i suoi più riusciti disastri. Occorre subito spiegare perché, com e sembrerebbe natura le nel parlar dei garibaldini, non si parte a ppunto da Garibaldi, che a guardar bene è l'unico u o mo di g uerra italiano ch e e bbe ai suoi t empi una consolidata e s incera fama all'estero; quando già l ' assioma «gli italiani non si battono» e ra noto un po' in tutto il mondo. Il fatto è che i garibaldini sono cosa completamente diversa da Garibaldi. Anzi, in alcuni casi risultano esser esattamente l 'opposto. E poi, e lemento da non trascurare, Garibaldi con l'esercito italian o non c'entra quasi nulla . È ve ro ch e almeno in tre ca mpagne gli misero addosso la divisa da ten ente generale, prima delle truppe sarde e poi, nel 1866, di quell'appendice del pian o annibalico che prevedeva - con i suoi vecchi Cacciatori d elle Alpi - di andare a disturbare gli austriaci addi rittura s ulla strada del Tuolo e, chissà!, fo rse di Vienna. Ma tutti sapevano, anche Ga ribaldi, che si trattava di improvvisazioni, che quella divisa se la ·sarebbe tolta non appe na si fosse s pe nta l'eco dell ' ultima fucilata. E i generali, quelli veri, i s u oi colleghi, passarono il tempo a spedirgli te legrammi per disciplinarne l' impeto, gli negarono i fucili e le scarpe che son o l 'unico modo di guadagnar v itto rie, e quando proprio non poterono fare di più esercitaron o l'arte della calunnia per s minuirne i già magri successi. Insomma Garibaldi non è mai stato davvero un generale ita liano: fu, e geniale, un guerr igliero, un cond utto re di band e, uno s tra tega della finta, dell'agguato, mosso da un'astuzia istintiva nel cogliere i mag istrali difetti dei generali (per sua fortuna sempre m ediocri q uando n on sci agu rati) che ebbe di fro nte. I suoi sfondi erano la pampa argentina con i r aid di cavalieri mai s tanchi e feroci ssimi. Fu per lui fa tale non aver accettato l 'offerta di Lincoln di comandare un'armata dei nordisti nell a guerra di Secessione. Il s u o sti le era perfetto per gli america ni, sarebbe diventato un eroe pronto per le sceneggia ture di Hollywood, un mito. Forse anche presidente. Invece di finire a Capre r a, solo e bizza rramente inquietante, a gua rdar crescere un' Italia che non gli piaceva e che ricompensava le su e imprese imbalsamandolo in un personaggio disegna to s ulla base delle necessità politiche dei suoi avversari . Anche la s u a impresa più grande, la conquis t a del tarlato regno bor-
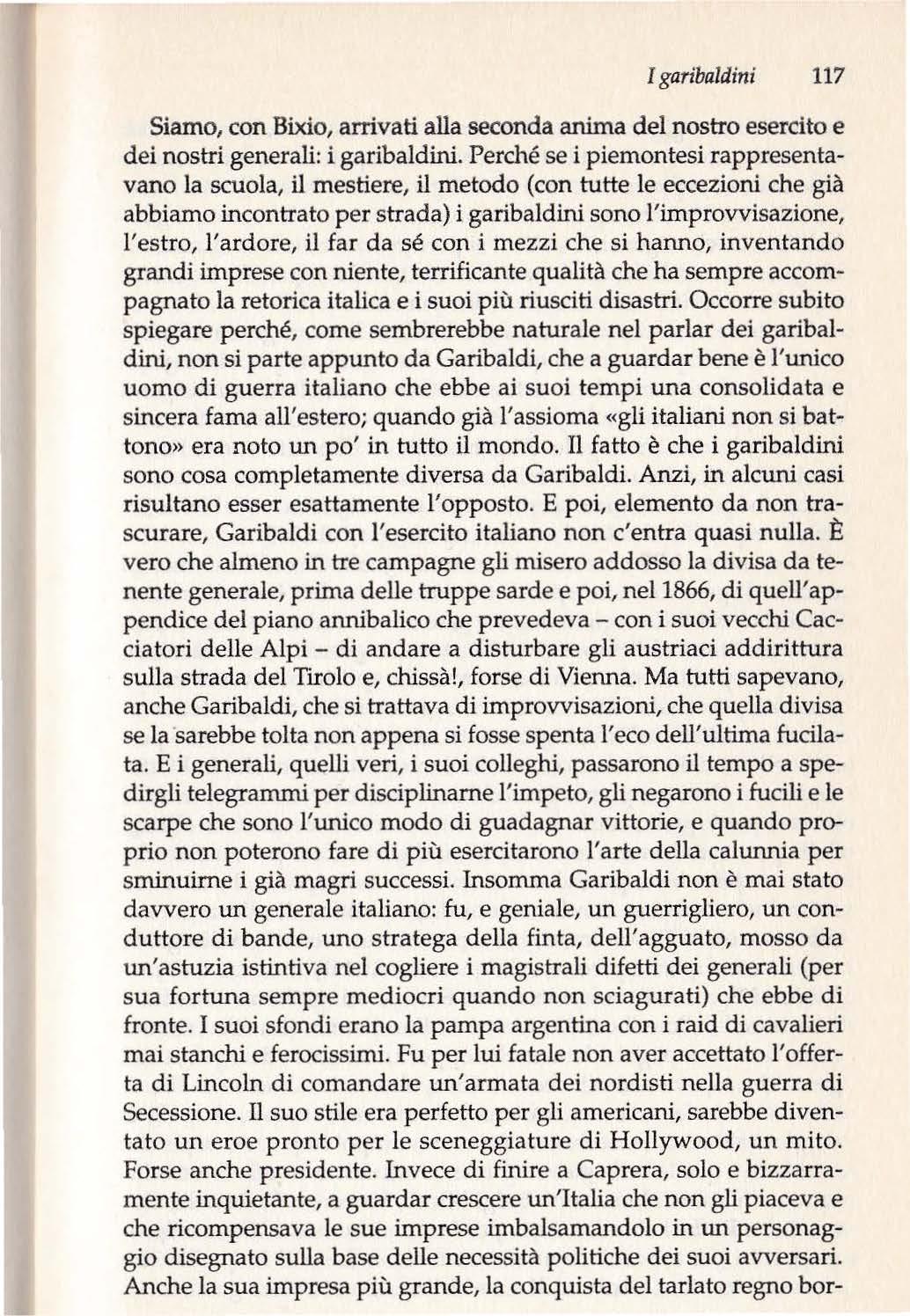
bonico, fu una gigantesca rapina coronata d a successo. Ma Garibaldi era unico, anche nel combattere. I suoi discepoli ne oreéchiarono lo stile ma mai seppero imitarne l'intelligenza, la misura . Quella l'aveva soltanto il vecchio condottiero sudamericano. A loro res ta il garibaldinismo che i gene rali italiani si portarono di etro fino alla seconda guerra mondiale, qualcuno dice anche oltre, quando le guerre non c'erano più o almeno si facevano per altri motivi .
Tutt'altra cosa erano invece i garibaldini: la storiografia ufficiale ne ha fatto l'es pressio ne di quell 'altro Risorgimento popola re gen eroso e rivoluziona rio che le astuzie di Cavour e delle classi dirigenti sempre perfidamente impegnate a divid e re, s offocare e s fruttare hanno tenuto in un angolo. Ai garibaldini è nuociuto anche l'esser stati adottati, a futura memoria, con le loro camicie rosse da una sinistra che per ideo logia e scopi in nulla a ssomigliava a quei mille saliti sui vapori Lombardo e Piemonte nel maggio del 1860.
Non erano i Mille, n aturalmente, tutti eguali. C'era all ' interno del nucleo d i generosi uno s pecchio molto va rio d e ll ' Italia di allora: idealisti a cui il Risorgimento non pareva mai finito e avevano passato, qualcuno a ddirittura dal 1821, tutte le guerre e le ri voluz ioni, e terni cospiratori che s'imbarcavano in ogni impresa e avevano s marrito p er strada fedi mazziniane e giacobinismi che già s fumavano nel socialismo. C'erano giovanotti magari di quarant'anni - perché n ell'era d e lle rivoluz ioni e d e lle controri voluzioni che fu l'Ottocento non c'era te mpo per invecchiare - che volevano solo m enar le mani e p e r i quali austriaci e borbonici erano la stessa cosa. Gli agi d e lla pace sembravano loro insipidi, indigesti. C'era poi un'élite che invece sapeva bene perché si imbarcava in un'impresa che ai meno attenti alle tortu ose combinazioni della politica di allora poteva sembrare una follia e roica; e invece partiva con scenari già disegnati, omertà e complicità precise, esiti quasi inevitabili vis to che il de proftmdis ai Borboni l'avevano cantato Francia e Inghilterra che a llora facev ano il bello e il cattivo tempo in Europa. Era il nucleo riunito ne lla Terza compagnia detta molto opportunamente «dei savi », tutta gente che sap eva bene che cosa voleva, o ltre naturalmente la liberaz io n e n aziona le: una carriera, una poltrona ministeriale, le spalline da gen erale vero, la ricchezza. Facevano un po' impressio ne perché in mezzo a quella bella gioventù erano tutti di m ezza età. E tu tti riuscirono infatti ne i loro scopi: Luigi Miceli, Vincenzo Carbonelli, Domenico e Raffaele Mauro tanto per far qualche nome, Cesare Sp rovieri, tutti poi ministri deputati sena to ri ben inseriti in quella élite che non aspettava altro che di as sorbirli e tra smetter loro gus ti, modi
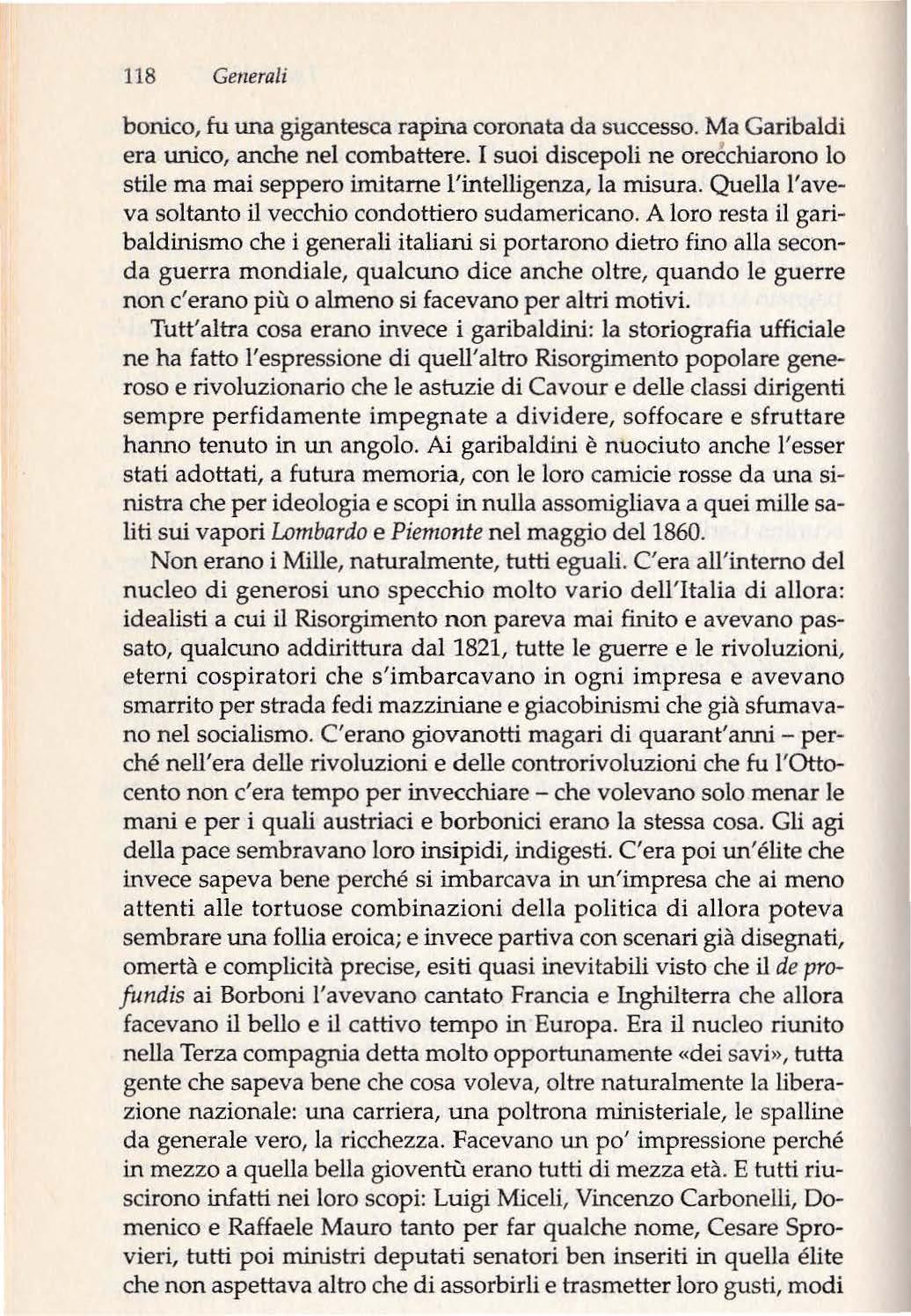
di far politica e finalità. Tra loro c'erano anche i generali: Bixio appunto, Sirtori, Cosenz, Medici tutti li troveremo ben infagottati nelle divise blu di Vittorio Emanuele e di Umberto, talvolta più piemontesi dei piemontesi, qualcuno persino con le greche della nobiltà . Certo non tutti erano così: gli idealisti restarono con un palmo di naso, con una mancia per l'impresa compiuta, molta rabbia e la voglia di ricominciare. E li ritroveremo ali' Aspromonte e a Mentana, sempre entusiasti anzi «irriducibili» come si chiamava la loro divisione quando sbarcò a Marsala. Raccontiamolo subito il modo in cui i primi vennero separati dai secondi e nell'esercito italiano venne, con giudiziosa parsimonia, inoculato un po' di quel siero guerrigliero e sudamericano, dopo averlo naturalmente così annacquato da renderlo ìnnocuo e insapore. Quell'l1 aprile 1861 al Parlamento subalpino c'era aria di battaglia, e di battaglia grossa. I campioni di destra e sinistra affilavano le armi per uno scontro ch e si annuncia va, come si dice, «decisivo per i des tini del paese». Le questioni d elle forze armate che oggi passano per inezie e che non innescano più grandi entusiasmi e irriducibili furori (la leva che ha accompagnato generazioni di italiani è stata cancellata in sedute frettolose e quasi senza contraddittorio, un tempo l'istituzione dell'esercito di mestiere avrebbe incendiato le piazze) allora e rano «la questione»: con l'unità nazionale ancora da finire, mezza Europa che ci guardava con odio e l ' altra metà che appena ci tollerava come d ei pezzenti, i bilanci che piangevano miseria e i briganti che controllavano spicchi interi del Mezzogiorno, l'esercito era la chiave di tutto. Anche perché la guerra dormiva con un occhio aperto. Si parlò molto in queg li anni di un partito militare; aveva ambizioni autoritarie e di gestione diretta del paese, faceva tintinnar le sciabole. C'erano eccellenze che pigiavano i tasti dello stato d'assedio a ogni soffiar di foglie e chiedevano di spedire lo statuto tra i cimeli storici. Fantasie: i generali non complottavano per la semplice ragione che sapevano b enissimo che nulla potevano ottenere più di quanto già avevano. In discussione c'era la liquidaz ione di quell'esercito m eridionale, i garibaldini per dirla in breve, considerato l'antagonista dell'esercito di caserma, burocra tico formalista e prussiano in anticipo. Il problema di che fare di tutta quella gente in armi si era manifestato quando ancora si s parava s ul Volturno e a Gaeta e quella armata «democratica» era parsa a tutti incompatibile con l'ordine e le finanze del nuovo Stato. Passate le febbri rivoluzionarie, si boccheggiava di fronte ad altre novità, si puntava all'ordine, alla organizzazione,
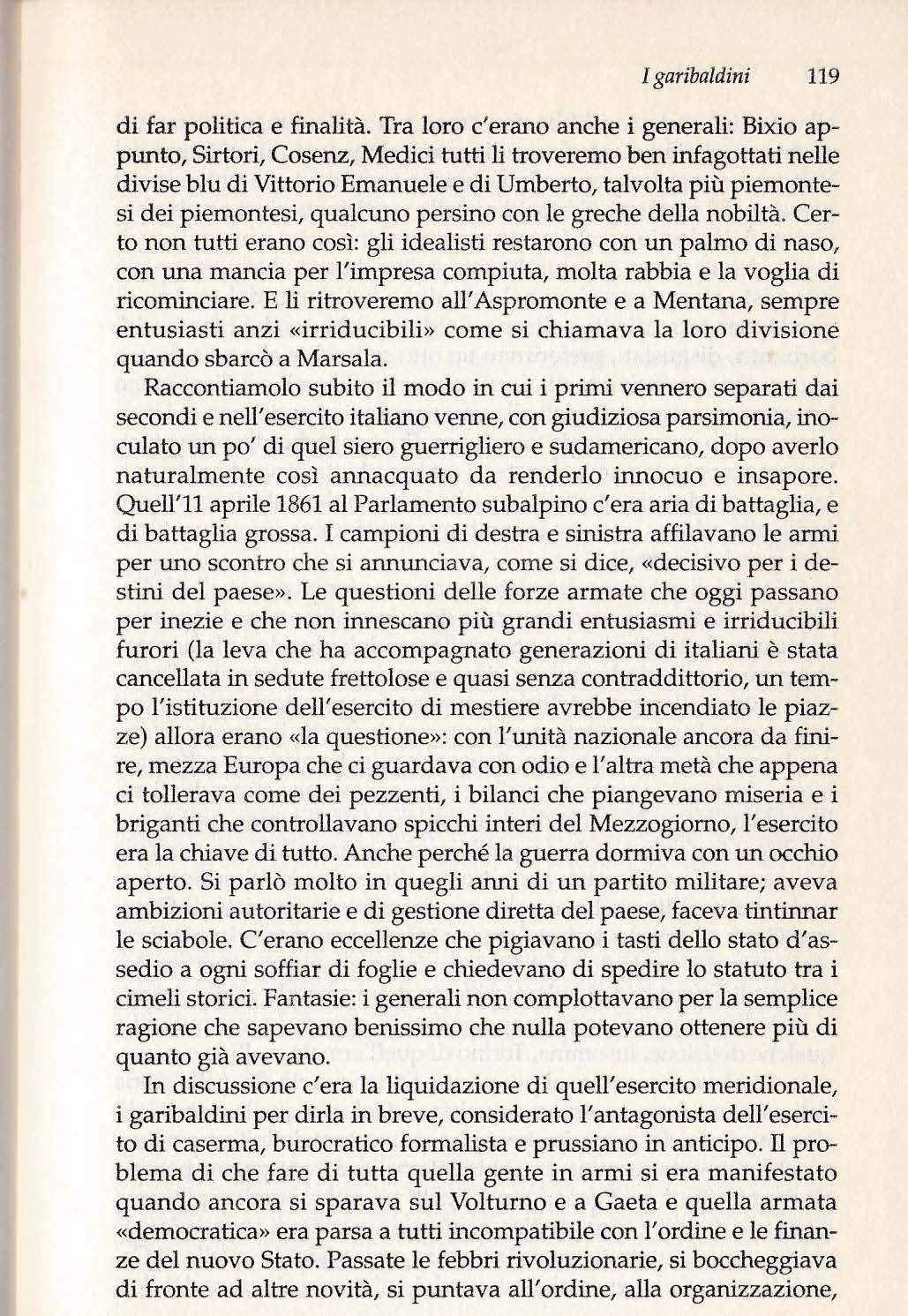
alla stabilità. Adesso i Mille non erano più mille: lungo la strada si erano arruolati in massa fino a diventare cinquantamila ai tempi del Volturno, progressione sospetta poiché seguiva come un'ombra il percorso dei vincitori. Garibaldini della venticinquesima ora, borbonici stufi di esserlo perché venivano meno sinecure e vantaggi, quelle élite locali voraci e naturalmente voltagabbana che avevano già intravisto nuove occasioni nel tumulto e nel mutar del regime di guadagnar terre diritti poltrone. Soldati pochi perché i fantaccini borbonici, disgustati, preferirono un otto settembre alle noie di una nuova divisa, ufficiali molti, i cui entusiasmi liberali e italiani erano inversamente proporzionali alla vergognosa incapacità con cui avevano tradito e macchiato la loro divisa. Era gente che alle prime fucilate era scappata a gambe levate, si era macchiata di saccheggi e violenze, si era dovuta spesso tener a bada e mandare all'attacco con il fucile alla schiena, ma che ingombrava pretendeva tumultuava per aver pensioni e gradi.
Gli ufficiali poi erano davvero troppi: a conferma che quella di Garibaldi era un'armata sudamericana dove le spalline non si negavano a nessuno. Settemila su cinquantamila uomini; quando i piemontesi, che pure erano quindicimila in più, non arrivavano a tremila. Che fare di tutta quella gente? A Torino, dove erano sospettosissirni e solo il re, che pur di aver soldati avrebbe arruolato anche il diavolo, tifava per le camicie rosse, sapevano bene che più che gridare «o Roma o morte» la maggior parte di quella gente sognava uno stipendio fisso. Impegnata a fare la rivoluzione, le era mancato il tempo di pensare ad altro . Ma c'erano anche i repubblicani e i mazziniani, «sovversivi» insomma che non as pettavano altro che dimezzare la miracolosa formula «Italia e Vittorio Emanuele» con cui avevano marciato da Quarto a Gaeta. E poi dove prendere i soldi per mantenere in piedi un esercito così sterminato? Nel 1865 con la guerra alle porte si era dovuto tagliare per dodici milioni e l'anno dopo, quando già il cannone si può dire tuonava, se ne erano andati in risparmi nove milioni e qualche divisione. Insomma, Torino di quell'armata malfida e personale si voleva sbarazzare al più presto. Si temeva ciò che nella storia italiana è una forza superiore a qualsiasi ideologia: quella cioè del diritto acquisito, del precario che aspira a diventare definitivo e perenne, che muove burocrazie, fa inchinar la politica, scompagina persino gli eserciti. Tutti quei generali colonnelli tenenti caporali aspiravano a passare di ruolo, come si dice, confermare e magari arrotondare le entrate con gli arretrati presso la finanza regia visto che quella di Garibaldi, precaria e generosissima perché attingente al tesoro d el Bor-

bone, aveva chiuso le casse cancellando emolumenti e pensioni integrative. L'Eroe, che propendeva per una matematica assai creativa, aveva proposto di trasferir tutti in un nuovo corpo d'armata di cinque divisioni con il vecchio nome semiufficiale di Cacciatori delle Alpi con cui aveva dato del filo da torcere agli austriaci in un paio di guerre. Era quell'esercito di popolo che sempre ha attraversato i sogni alternativi della sinistra italiana. Quando è sceso in campo in realtà ha rimediato per incompetenza e verboso entusiasmo solo mastodontiche tragedie. Si è sempre un po' confuso con l 'esercito di setta, di parte, di consorteria fino a quando il furbo Mussolini non riuscì davvero a realizzarlo e a usarlo per conquistare il vecchio stato dei re e dei generali piemontesi .
Il capofila dell'operazione di liquidazione delle camicie rosse fu proprio quel Fanti che pure una certa pratica di eserciti popolari doveva averla avendo militato tra le scalcagnate armate delle guerre spagnole.
Alle sue spalle per una volta la camarilla dei generali piemontesi si schierò unita: c'erano da difendere le carriere dall'invasione di petulanti concorrenti. Per capire che cosa pensasse dei garibaldini basta rileggere il battibecco tra il ministro della Guerra e Angelo Brofferio, uno dei capofila della sinistra parlamentare che lo aveva proprio su questo tema stuzzicato alla Camera il 23 marzo 1861 quando si discuteva della riforma dell'esercito:
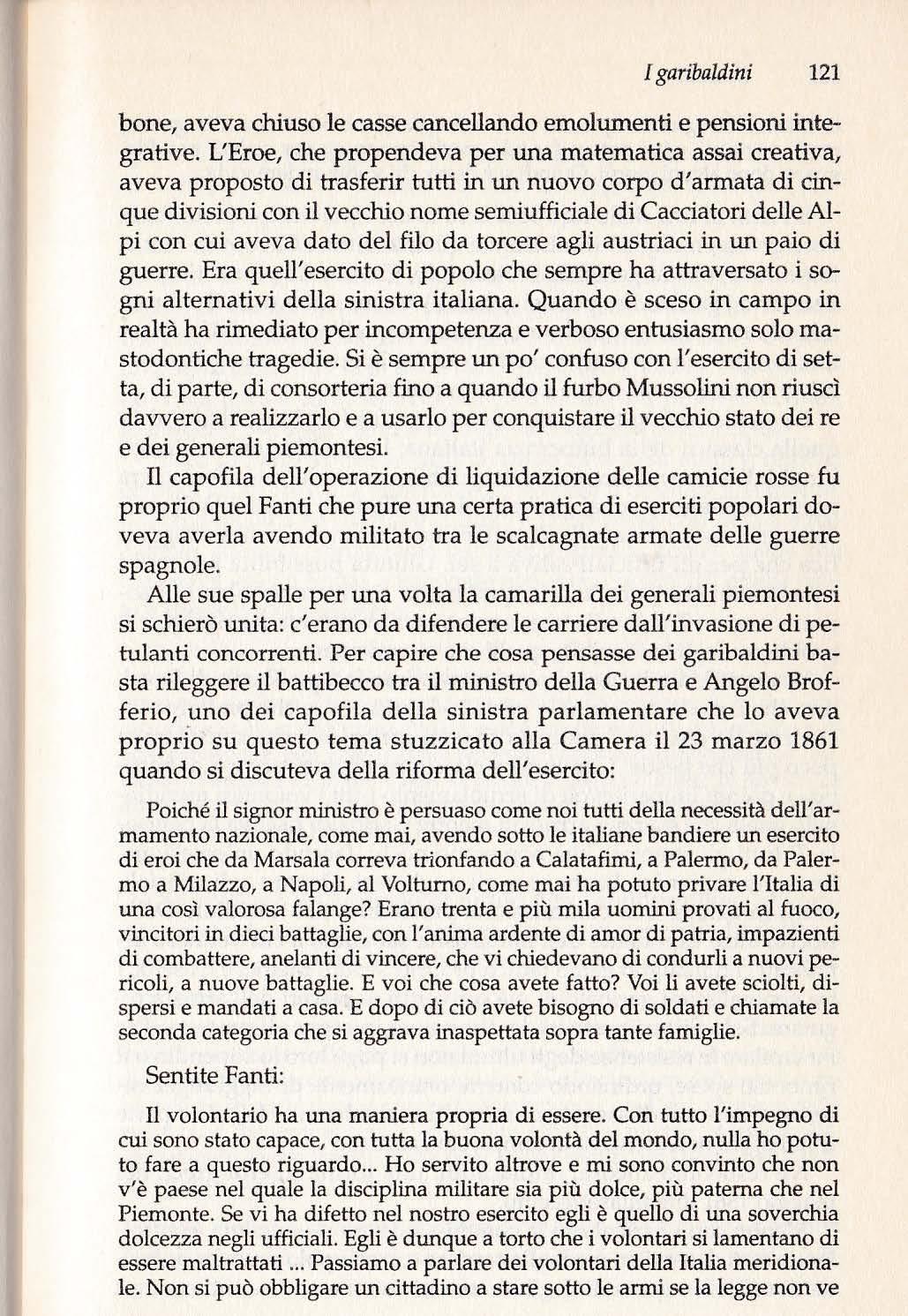
Poiché il signor ntinistro è persuaso come noi tutti della necessità dell'armamento naz ionale, come mai, avendo sotto le italiane bandiere un esercito di eroi che da Marsala correva trionfando a Calatafimi, a Palermo, da Palermo a Milazzo, a Napoli, al Volturno, come m ai ha potuto privare l'Italia di una così valorosa falange? Erano trenta e più mila uomini provati al fuoco, vincitori in dieci battaglie, con l 'anima ardente di amor di patria, impazienti di combattere, anelanti di vincere, che vi chiedevano di condurli a nuovi pericoli, a nuove battag lie. E voi che cosa avete fatto? Voi li avete sciolti, dis persi e mandati a casa. E dopo di ciò avete bisogno di soldati e chiamate la seconda categoria che si aggrava inaspettata sopra tante famiglie .
Il volontario ha una maniera propria di essere. Con tutto l'impegno di cui sono s tato capace, con tutta la buona volontà del mondo, nulla ho potuto fare a questo riguardo... Ho servito altrove e mi sono convinto che non v'è paese nel quale la disciplina militare sia più dolce, più patema che nel Piemonte. Se vi ha difetto nel nostro esercito egli è quello di una soverchia dolcezza negli ufficiali. Egli è dunque a torto che i volontari si lamentano di essere maltrattati ... Passiamo a parlare dei volontari della ltalia meridionale. Non si può obbligare un cittadino a stare sotto le armi se la legge non ve
lo chiama. Bisogna dunque che i volontari prendano una ferma. Bisogna armarli e vesti rli, né si poteva far tale gravissima spesa per vederli poi dileguarsi dopo alcuni giorni. Quindi si è detto: chi vuole andare vada.
E Fanti, in una delle rare occasioni in cui i politici lo videro far la voce grossa, minacciò dimissioni e qualcos'altro a Cavour se non si fosse dato retta ai generali. Protestando, Cavour (ma forse fingeva, detestava i garibal dini più dei generali) acconsentì. Anche il re brontolando rinunciò con molto rammarico a quell'esercito naif e di attaccabrighe con cui si riprometteva di far la guerra come piaceva a lui, guascona, cavalleresca e senza troppi studi.
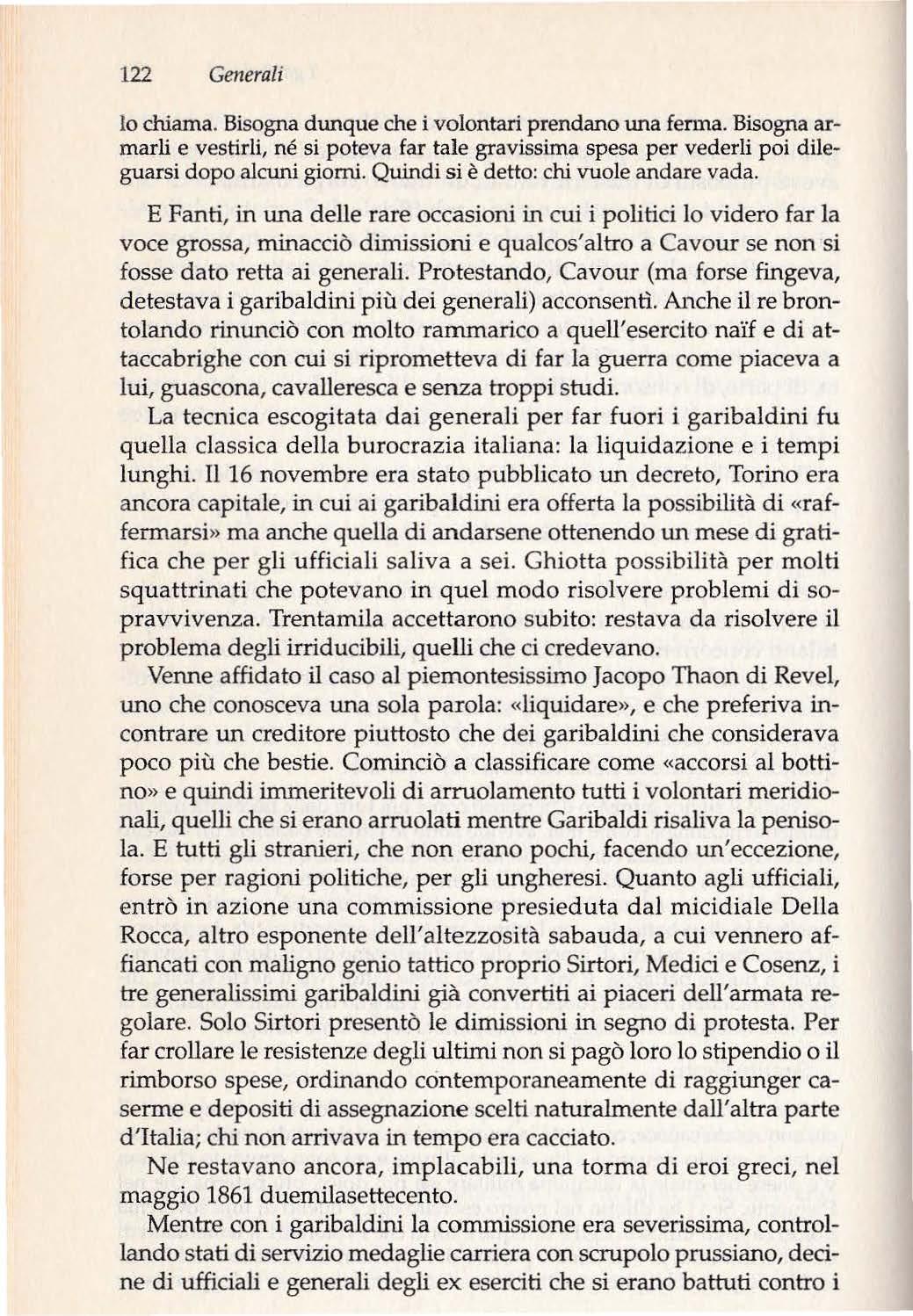
La tecnica escogitata dai generali per far fuori i garibaldini fu quella classica della burocrazia italiana : la liquidazione e i tempi lung hi . Il 16 novembre era s t ato pubblicato un decreto, Torino era ancora capitale, in cui ai garibaldini era offerta la possibilità di «raffermarsi » ma anche quella di andarsene ottenendo un mese di gratifica che per gli ufficiali saliva a sei. Ghiotta possibilità per molti squattrinati che potevano in quel modo risolvere problemi di sopravvivenza. Trentamila accettarono subito: restava da risolvere il problema degli irriducibili, quelli che ci credevano. Venne affidato il caso al piemontesissimo Jacopo Thaon di Revel, uno che conosceva una sola parola: «liquidare», e che preferiva incontrare un creditore piuttosto che dei gariba ldini che considerava poco più che bestie. Cominciò a classificare come «accorsi al bottino» e quindi immeritevoli di arruolamento tutti i volontari meridionali, quelli che si erano arruolati mentre Garibaldi risaliva la penisola. E tutti gli stranieri, che non erano pochi, facendo un'eccezione, forse per ragioni politiche, per gli ungheresi. Quanto agli ufficiali, entrò in az ione una commissione presieduta dal micidiale Della Rocca, altro esponente dell'altezzosità sabauda, a cui vennero affiancati con maligno genio tattico proprio Sirtori, Medici e Cosenz, i tre generalissimi garibaldini già convertiti ai piaceri dell'armata regolare. Solo Sirtori presentò le dimissioni in segno di protesta. Per far crollare le resistenze degli ultimi non s i pagò loro lo stipendio o il rimborso spese, ordinando contemporaneamente di raggiunger caserme e depositi di assegnazione scelti naturalmente dall' altra parte d'Italia; chi non arrivava in tempo era cacciato.
Ne restavano ancora, implacabili, una torma di eroi greci, n e l maggio 1861 duemilasettecento.
Mentre con i garibaldini la commissione era severissima, con trollando stati di servizio medaglie carriera con scrupolo prussiano, decine di ufficiali e generali degli ex eserciti che si erano battuti contro i
piemontesi e contro l'unità d'Italia entravano a frotte accolti a braccia aperte dai nuovi colleghi. Ce n'era abbastanza per scatenare la rabbia di Garibaldi e dei d emocratici che volevano regolare i conti con i moderati e si preparavano allo scontro. Il 18 aprile 1861 il deputato Garibaldi entrò nel Parlamento di Torino per dare battaglia ai generali (e a Cavour). Si presentò con il tale nto scenografico che non gli mancava ves tito da Garibaldi: poncho pantaloni grigi la berretta sudamericana che l' agiografia ufficiale del Risorgimento santificherà ma che suscitava sghignazzi tra i képi dello sta to maggiore. Cialdini, che qualcuno continuava a considerare il più garibaldino dei generali sabaudi, lo insolentì per quella te nuta definita «incongrua e pagliaccesca». Toccò al Fanti ap rire le ostilità; dopo aver reso ampi e retorici omaggi ali'ardire e a lla generosità, al proposito di unirsi alla grande famig lia italiana ed essersi inchinato a un'impresa così nobile e nazionale, cominciò senza tante perifrasi a sparare, contro quella che chiamava «bassa forza», cannonate non meno pesanti di quelle usate a Palestro e San Martino:
Ognuno sa quanto il volontario avversi ogni regola che lo assoggetti al quartiere, alla piazza d'armi, alla disciplina e a ogni cosa che possa contraddire i suoi desideri. I suoi operati son o mossi dalla passione di un fine, che quando non sia subito raggiunto, lo rende insofferente d ' ogni indugio e di ogni privazione. Egli guarda come schiavitù l'ordine, come pedanteria l'autorità; obbedisce all ' uomo e non al grado. È voglioso infine di novità. Se questo, signori, può essere un e lemento prezioso in date circostanze e condizioni egli d iventa molesto e sommamente dispendioso laddove non tuoni il cannone.
Qui abbiamo un assaggio. di futuro . Era l'enunciazione dell'esercito amato da sempre e per sempre dai nostri generali: disciplina e obbedienza. Agli ufficiali Fanti dedicava ancor maggiore attenzione:
Il loro numero e i favolosi avanzamenti che ave vano ricev uto e rano talmente fuori misura d'ogni paragone fino al di d'oggi in Europa che l' ammetterli senz'altro nella gran famiglia militare sarebbe stato, lasciate che lo dica, o signori, siccome voler pronunciare la dissoluzione dell'esercito nazionale. Se in pochl mesi si potessero raggiungere i gradi più eminenti della gerarchia a che servirebbero le accademie, gli istituti militari, le leggi sull'avanzamento, le condizioni di idoneità? Perché sacrificare i nostri figli a lunghi studt a discipline rigorose, a privazioni1 a spese?
Nella famiglia militare non c'era davvero molta simpatia per quei figlioli prodighi; non sembrava possibile trasfondere nei cuori e nelle menti le tradizioni di modestia valore patriottismo delle vecchie
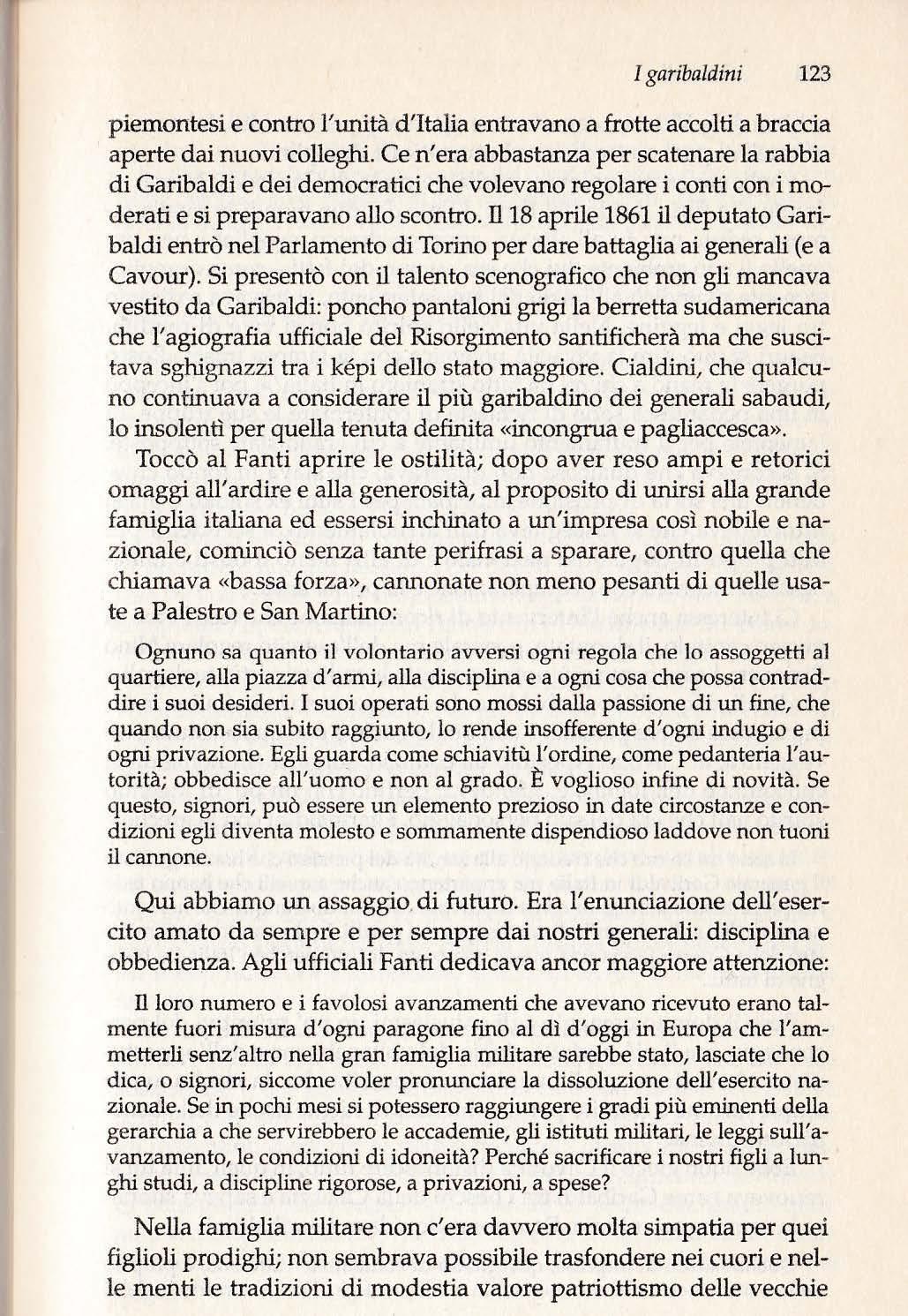
schiere di re Vittorio, come invece si tentava per i sudditi del nemico affratellati però da tradizione burocratica e disciplina.
Vogliamo essere spietati, parliamo male di Garibaldi. Messo di fronte alla furia lucida del Fanti, l'Eroe dei due mondi in quella famosa seduta non fu all'altezza, apparve stracco, svogliato: non era quello il suo ambiente; lui che era «uomo dei fatti», come orgogliosamente rivendicò all'inizio del suo intervento, si trovava a disagio tra leggi e leggine. Nella vita dello spirito non si vive di rendita. Esaurì si può dire la vivacità polemica con la famosa frase: «Posso porgere la mano a chi mi ha fatto straniero in Italia?»; poi s ' inceppò in una pedantesca serie di richieste di confermare le sue truppe, di lamentele per il trattamento umiliante a cui erano state sottoposte. Si accorgeva che qualcosa non quadrava, che stava in fondo chiedendo una sorta di pensione anticipata per i suoi ex soldati e già si intravedeva che si rassegnava dall'arruolamento, a scender a più miti propositi di guardia nazionale e di altri meno robusti e imbarazzanti incarichi che l'equiparazione e la prima linea.
Ci interessa anche l'intervento di riconciliazione che fece l'eroe di questo capitolo, il deputato, generale ma dell'esercito regolare Nino Bixio: era l' esponente più noto, con tutte le militari virtù, teologali e cardinali, di quell'ala garibaldina che aveva messo in naftalina la camicia rossa ed era passata, e con quale gusto e con quale astuta preveggenza, al Cavour. Apostolo da comizio, sorgeva «in nome della concordia e dell'Italia», e difendeva, perfino con un po' di ingenuo spirito nalf che era del suo personaggio, i garibaldini con le greche:

Io sono tra coloro che credono alla santità dei pensieri che hanno guidato il generale Garibaldi in Italia ma appartengo anche a quelli che hanno fede nel patriottismo del signor conte di Cavour. Domando dunque che nel santo nome di Dio si faccia un'Italia al disopra dei partiti. Io domando che il minis tro della Guerra faccia una massa compatta di tutti perché l'Italia ha bisogno di tutti ...
Reso il dovuto omaggio agli entusiasmi un po' primitivi del personaggio, era il più perfetto elogio del voltagabbana e dell'opportunista. Nascosto in quell'unanimismo ipocrita che da noi ha avuto ampie fortune e condito per non mancar di niente anche della benedizione di vina.
Ebbe buon gioco il Cavour a disinnescare tutto; in quell'aula lui si muoveva come Garibaldi tra i boschi della Calabria e sapeva suonare la zampogna unitaria. Ecco come liquidava i garibaldini:
Quella natura di imprese, quel modo di combattere tutto suo, è proprio della natura stessa del suo esercito in cui il prestigio, l' a zione individuale, il
magnetismo direi così tengono luogo della disciplina, delle regole, dei principi degli eserciti stanziali. Bisogna prender le cose come sono. L'esperienza ci ha dimostrato che vi possono essere dei corpi di volontari non legati con ferme regolari i quali possono in date circostanze operare cose grandissime, splendidissime. E noi ci siamo detti: conviene non disperdere questi elementi ma per conse.rvarli è d'uopo non mutare l'indole, bisogna in caso di guerra poter prendere tutte queste forze che non sono ordinabili con regole consuete un po' pedanti, degli eserciti stanziali. Il mantenere questi corpi obbligandoli alla ferma è voler snaturarli .

Insomma Garibaldi doveva capire: la spedizione dei Mille l ' aveva fatta con l'autoriz zazione e il sostegno del governo, adesso l'entusiasmo non serviva più, quella banda di giovanotti abituati a menar le mani poteva solo crear guai in un momento in cui non era opportuno provocar la guerra. Quindi dovevano star zitti e accontentarsi della pensione. Bisognava sagomare le coscienze.
Garibaldi si dichiarò «completamente insoddisfatto»: quel modo di procedere non era italiano, non degno della nazione. Raccoglierà solo 79 voti contro i 194 del documento governativo. Non restava, a completar l'opera, che saldar i conti con i 1740 ufficiali che erano entrati nell'esercito e che erano stati sistemati nel purgatorio dell' aspettativa e della disponibilità. Altre centinaia di rassegnati chiesero volontariamente il congedo. Per gli ultimi l'implacabile Thaon di Revel scriveva al fratello: «Le scorie che sono rimaste attaccate all' esercito saranno rimosse dai consigli di disciplina».
Non era certo il caso dei generali, che a pieno titolo erano approdati al nuovo esercito italiano e che gli porteranno in dote una caratteristica: il garibaldinismo, un po' mazziniano e molto squadrista che ne accompagnerà le sventure fin dentro il nuovo secolo. C'è un filo, spiace dirlo, che va da Bixio al quadrunviro Italo Balbo a cui in fondo assomiglia, dalla marcia gloriosa dei Mille a quella assai meno fulminea e altrettanto fatale, in treno, della rivoluzione fascista .
Scorza selvatica aveva questo figlio di un dipendente della Zecca abituato più all'aspra disciplina delle strade di Genova che alle aule scolastiche, e che girava scortato da un cane ferocissimo. Gli teneva compagnia nelle risse in cui lampeggiava spesso il coltello mentre gli insegnanti disperati lo definivano così: «Assiduità: assente; diligenza: nessuna, poca correttezza nei doveri religiosi, non meritevole di passare alle class i superiori» . Fino all'episodio citatissimo nelle aule scolastiche della nuova Italia: scaraventò un calamaio in faccia al maestro, il che lo fece uscire di gran fretta da tutte le scuole del Regno.
La soluz ione in una città di mare per quell'irriducibile discolo non poteva essere che il mare: Genova che, scialacquate le antiche libertà e dilapidate la rendite delle marinare ricchezze vivacchiava sotto l'unghia neppure tanto leggera dei Savoia, in quegli anni si ingegnava a recuperar rotte e quattrini. Armatori, che portavano in dote più coraggio che mezzi, andavano come bucanieri a caccia sui mari dove ormai dominavano i colossi, Francia Stati Uniti e soprattutto Inghilterra . Bi.xio, reprobo punito, finì come mozzo sul brigantino Pilade e Oreste del capitano Gioba tta Bennati: bella nave svelta e solida con un equipaggio di brontoloni, lupi di mare di Camogli ma che conoscevano velacci e gabbie come i viottoli della loro cittadina. Portava vino al ilio della Plata e poi bordeggiando sulle coste brasiliane fino a Pernambuco caricava pelli, zucchero, caffè e cotone per il ritorno. A bordo Bixio e ra il mozzo che «doveva pulire tutti gli angoli del bastimento nessuno eccettuato» come raccontava quando già era celebre e genera le, «sciacquare i piatti fare lo sguattero e il servitore di tutti e quando non facevo a modo il che mi accadeva s pesso erano scappellotti da rintontire». Se qualcuno p e rò lo prendeva in giro magari dandogli dello «sciuretto» che in dialetto vuol dire signorino per irridere alle sue origini borghesi e alla sua perduta fortuna, tirava fuori il coltello e guardava con certi occhi che inducevano quei coriacei lupi di mare a girare a l largo. Al ritorno (dopo tre anni!) volevano arruolarlo in marina anche per sgravare da quell'antipatico servizio il fratello, secondo un metodo che ancora tollerava la marina sarda. Lui preferì fuggir di casa e infrattars i nei vicoli più sordidi di Genova popolati di balordi, prostitute, gente di malaffare in cui il suo caratteraccio subito lo impose al ruolo di capo: forse non fece il macrò come un giorno gli av rebbe rimproverato in Parlamento il Bertani, vate della sinistra delusa del suo l egittinùsmo. Certo, su quell 'epoca della sua vita che molto entrava nella mitologia di abisso e redenzione così cara al romanzo ottocentesco, tante cose aveva da nascondere. La marina di Sua Maestà però aveva braccia e memoria lunga e lo agguantò per mettergli addosso la divisa con il frac nero e il cappello a cilindro. Quel mare che non gli era rimas to nel cuore quando viaggiava s ul brigantino del capitano Be nnati, cominciò ad amarlo sotto la ferrea bru tale disciplina savoiarda. Magro, ossuto, il viso duro come un p ersonaggio della danza macabra di Holbein, con il gusto della rissa che non gli venne certo meno: una coltellata gli attraversò un labbro tanto che dovette, per evitare la corte marziale, imbastire una bufala e fa r si crescere i baffi che portò poi per semp re p e r nascondere lo sfregio.
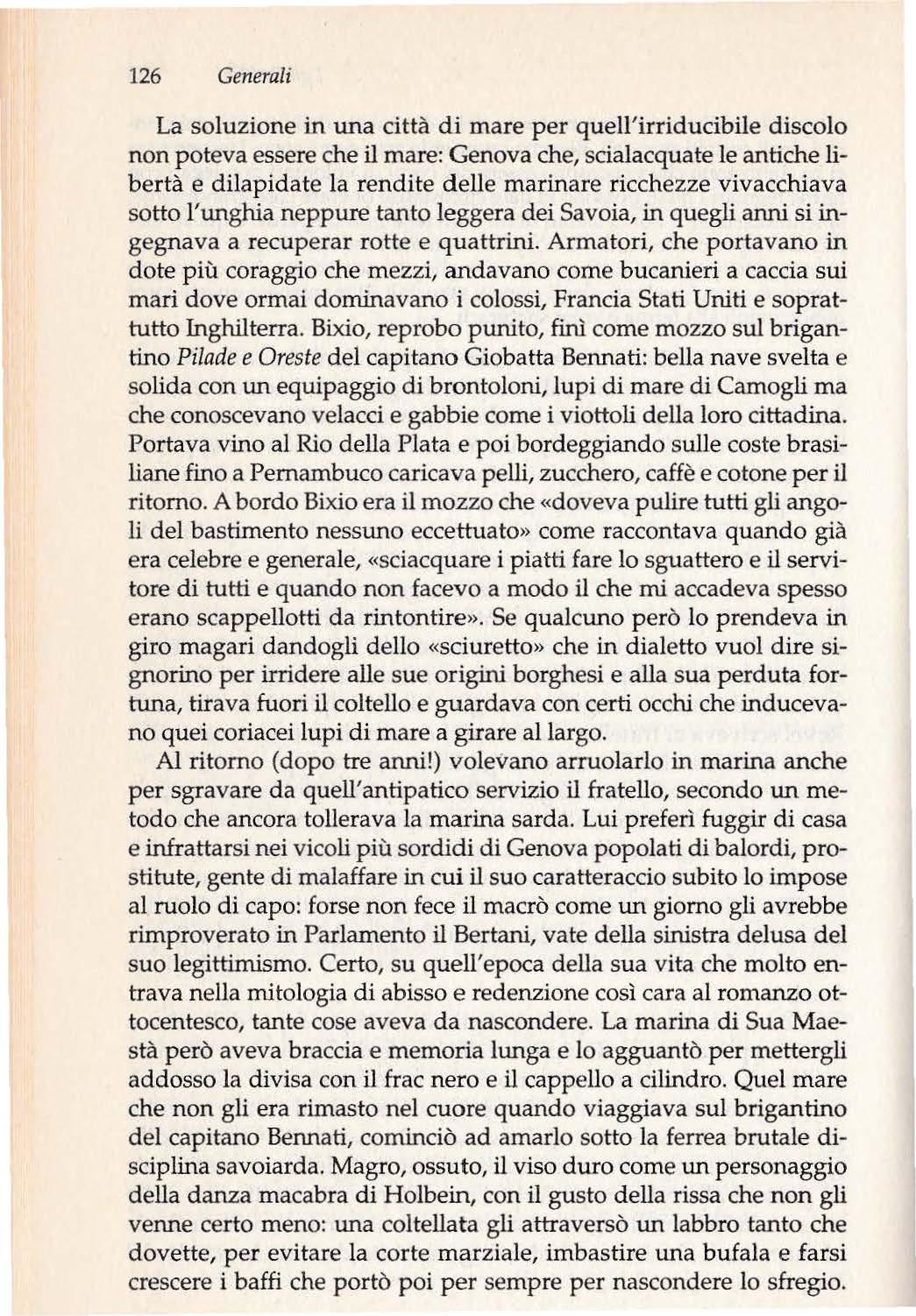
Sulle navi di Sua Maestà, come spesso accade, fu colpito dal tarlo del virus mazziniano e rivoluzionario che in quegli anni sembrava contagiar tutti.
In queste idilliche disoccupazioni morali gli resta v a il tempo p er un'altra incred ibile avventura marinara : un viaggio n e i mari d 'Oriente con un carico di p e p e. Ma il comandante non gli andava a genio: un quacchero a m e ricano che pre tendeva di navigare a furia di cerimonie religiose e digiuni. Con altri due compagni decise di disertare al largo di Sumatra: si gettarono in mare e dopo aver rischlato di annegare p erché, pur essend o forti nuota tori, avevano mal calcolato le distanze e la forza di que ll e acque dispettose, ve nne ro sa lvati dai malesi. La regina locale pare si fosse innamorata di Bixio e ai suoi rifiuti g li impose di adottare tutte le regole d ella fede musulmana. Li salvò il provvidenziale ritorno d el capitano quacchero ch e n on voleva rinunciare a quei tre figli perduti. Benedicendo l a sua ostinazi one ripresero la loro strada di triboli. Rientrato in Italia (ma vedremo che quei luoghi gli restarono n e l cuore e gli misero il tarlo di avventure che lo porteranno a ll a tomba) cominciò la sua carrie ra di rivoluzionario a tempo p ien o . È il 1848: l'Italia inte ra mod e rata e radicale scopre il piacere di scendere in piazza per chiedere, sollecitare, imporr e a papa re duchi. Si vuole di tutto: costituzioni, p ane, guerra allo straniero, legh e. Si r esu scitano le sopite energie, si a llineano schiere b a ld e e impetuose. Bixio è già Bixio, a Genova, dove le manifestazioni aggi ungono ai talenti risorgime ntali una buo na d ose di antipatia per quei Savoia ch e sono ultimi n el fervore rivoluzionario, sfida la cava lle ri a a mani nud e impugnando il tricolore. Con Mameli, poeta m ediocre m a fervido cospira tore, si arruola nei volontari per la guerra regale: il tempo per acco r ge rsi che c'è tempo solo per chiacchiere e per p rendere batoste . Quello no n è (ancora) il s u o mondo: c' è d a difendere Roma con Garibaldi e Bixio diventa se stesso; contro i francesi del generale O udinot, infatti, compie il primo gesto che segner à tutta la storia sua personale e dei garibaldini. I francesi, s icurissimi che gli italiani n on si b a tteranno, m arcian o su Roma. A Porta San Pan cr azio la composita armata dei difensori invece s i batte, e con furore: si spara, ci si accoppa alla baione tta, i francesi incredibilmente retrocedono. Solo un maggiore di n ome Picard con trecento soldati del Ventesimo s i impunta, si annida in alc une case, ricaccia i nemici che disordinatam ente lo inseguono. Allo ra Bixio a cavallo, che n a turalmente precede i com pagni e n on gli par vero di gettarsi s ull'avversario, s i lancia a l ga loppo s ul maggiore ch e incita e organizza lo sforzo dei s u oi. Lo

afferra per la giubba, lo strattona e trascinandolo come un gatto in mezzo ai soldati sbalorditi gli ordina di farli arrendere se non vuol morire: e quelli vistisi senza capo abbassano le armi. Possiamo scegliere tra due opzioni, entrambe allettanti. Questa è la versione italiana del fatto. Quella francese è un poco diversa: Bixio infatti subdolamente si sarebbe avvicinato al francese presentandosi come parlamentare, poi ne avrebbe approfittato per farlo prigioniero. Versione meno eroica, se volete anche un po' meschina, ma che rende quantomeno a Bixio doti di astuzia guerrigliera che faranno parte del suo personaggio. Una palla in corpo, presa difendendo Villa Glori, e la fama di congiurato di mestiere è quanto gli restò di quella difesa di Roma che militarmente fu una scaramuccia ma assurse a guerra grossa perché, grazie ai luoghi in cuj si svolgeva, pemùse agli italiani quello che riesce loro meglio: gonfiare con la retorica e i ricordi di un passato glorioso le miserie e la banalità del presente. Con il sentimento che la Storia sia una serie di gesti miracolosi.
Poi per anni Bixio fu soprattutto capitano e uomo di mare. Prima sotto a ltri, lungo quelle rotte sudamericane in cui Genova cominciava a metter le prore, e quindi con una nave sua, la Mameli, costruita inseguendo un progetto che vedremo meglio nella fase finale della sua vita portarlo alla morte, cioè l'attrazione per l'Oriente ma non legata a esotiche e salgariane curiosità. L'Asia e l'Australia lo seducevano con il profumo concretissimo di affari, business, commerci; voleva andare a guas tar le feste a inglesi e olandesi che lì si giovavano di un quasi totale monopolio. In Australia ci arrivò con il suo vascello carico di carbon fossile nel 1856, dopo quattro mesi duri di mare. Ma al ritorno il Capo di Buona Speranza, spauracchio dei marinai, quasi lo privò con un fortunale di nave e vita. Tornato ai moli domestici di Genova facendo i conti con i soci di quella spedizione su cui aveva riposto tante speranze, si accorse che non tornavano e che invece dei guadagni, tra naufragi , ritardi e riparazioru si era prodotto un bel passivo. I soci si volatilizzarono, la nave fu venduta. Non riuscì mai a scaltrirsi su que lle che si dicono le magagne del mestiere. Booo fu costretto a tirar fuori, mentre montavano rumori di nuove guerre, l' uruforme del guerriero e d e l rivolu zionario .
Le ideologie certo non lo imbarazzavano, le manovrava con un certo geruale disordine. Mentre sul Ticino si preparava la guerra, Bixio diede l'addio ai suoi amici di quegli anni, i mazziruani, arruolandosi con i seguaci di Cavour. La motivazione di quella birbanteria sbrigativamente la trovava n ella necessità di non causare di v i-
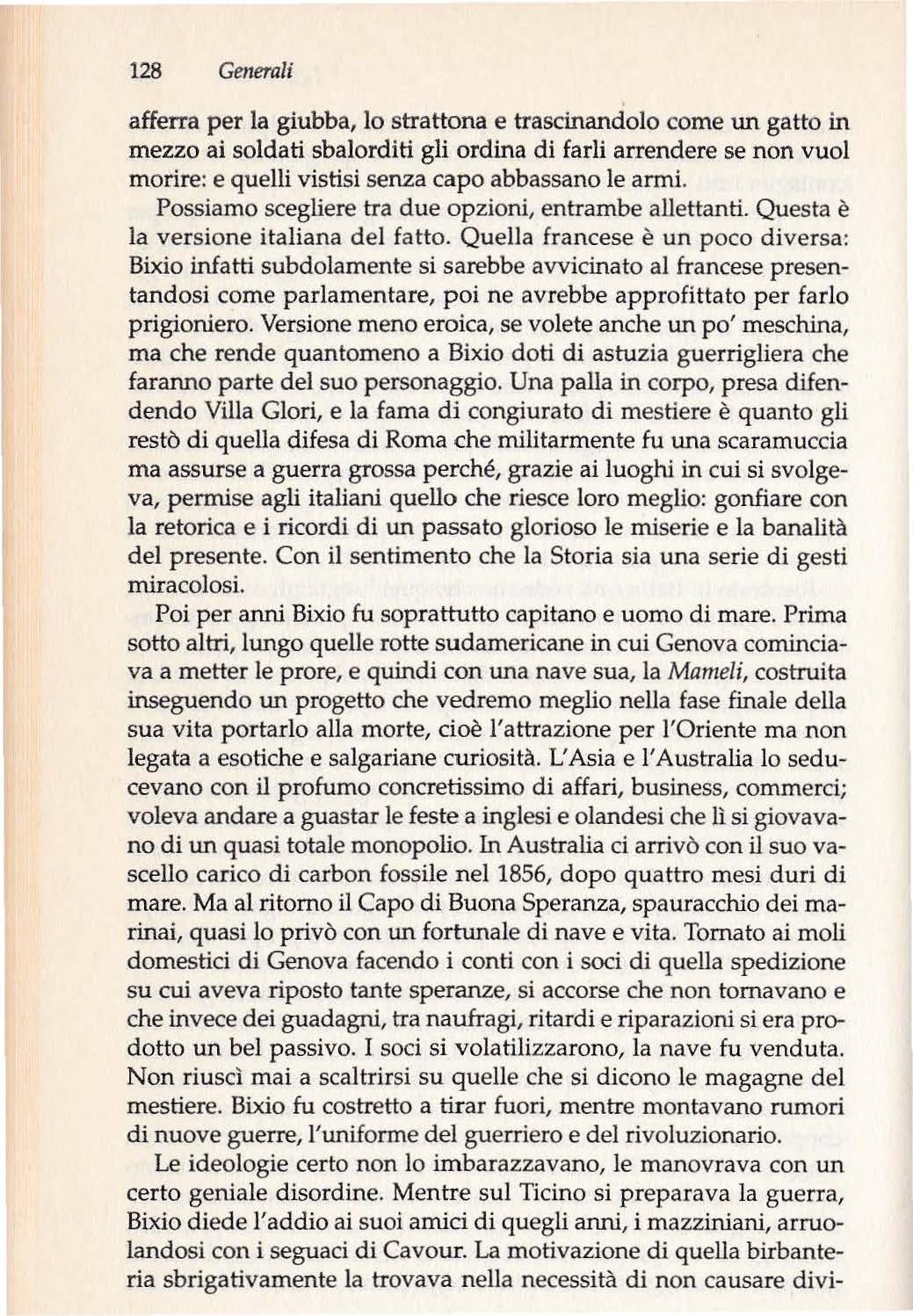
sioni nel momento in cui stava per riprendere il filo d i quella guerra che aspettava come una benedizione. Ma questo non impedl che i suoi compagni vi leggessero un assai meno onorevole voltafaccia, per d irla chiara: un tradimento. Il suo momento ancora non era venu t o: i mesi passati a comandare un reggimento nei Caccia to ri delle Alpi furono poco più che una prova. Non priva di qualche infortunio. Garibaldi gli aveva dato ordine di prendere con i suoi il for te di Laveno con un assalto notturno: era un'impresa alla Bixio, tutto coraggio e improvvisazione. Troppa ce ne mise il genovese, perché i difensori si accorsero dell'assalto e si dovette impiegare molta destrezza per tornare indietro sani. Insomma persino Garibaldi, come riconobbe Bixio in una lettera, fu costretto a rimproverargli «la sua chiamata temerarietà» . Ma lui guasconamente aggiungeva: «Del resto è la mia natura che lascio come sta». Ma se Bixio non trascurava la sua immagine già garibaldina, cominciava a lavorare per predisporre le credenziali per il gran salto che avrebbe segnato la sua carriera, quello tra i regolari, tra le éli te. Un po' istrione e un po' camaleonte. Il miglior modo per spegnere i sospetti di chi amava soprattutto ordine e disciplina era quello di mostrare più zelo e impegno dei padroni. E così l 'ardimentoso con smania e accanimento si diede a modellare il suo reggimento fino, ci dicono le cronache stupefatte, «a farsi la fama di casermiere, di pedante». Un bell'impasto di rivoluzione e bluff fu quell'impresa dei Mille che doveva dargli fama e gloria e un posto da generale. Dietro l'improvvisazione di Garibaldi - gettarsi con un pugno di giovanotti di fede contro un Regno dotato di eserciti flotte e saldi legami internazionali - in realtà c'era tutto un disegno ufficiale già ben autorizzato. Era quella rivoluzione con tanto di carta bollata, l 'unica che ci riesce benissimo. Far insomma la rivoluzione che non doveva parere rivoluzione. Infatti tutto era regolarmente concordato con Cavour, gli inglesi avvertiti benevolmente sovrintendevano, perfino il Rubattino, armatore a cui dovevano essere trafugati con patriottica ribalderia i due vapori necessari per il trasporto, si era cautelato, con tanto di assicurazione, nel caso l a fortuna e i borbonici che erano gli unici a non esser d'accordo avessero messo il bastone tra le ruote. Glieli pagarono più di settecentocinquantamila lire, il dopp io del loro valore; non c'è che dire: la rivoluzione rendeva!
L'incombenza di rubare spettò, come imponeva il copione, al Bixio, che in quel porto degli anni scapestrati aveva conservato salde e non presentabili amicizie. Anche se era tutto un bluff e i gendarmi stavano ben attenti a non accorgersi di nulla, la visse come un'fliade che gli
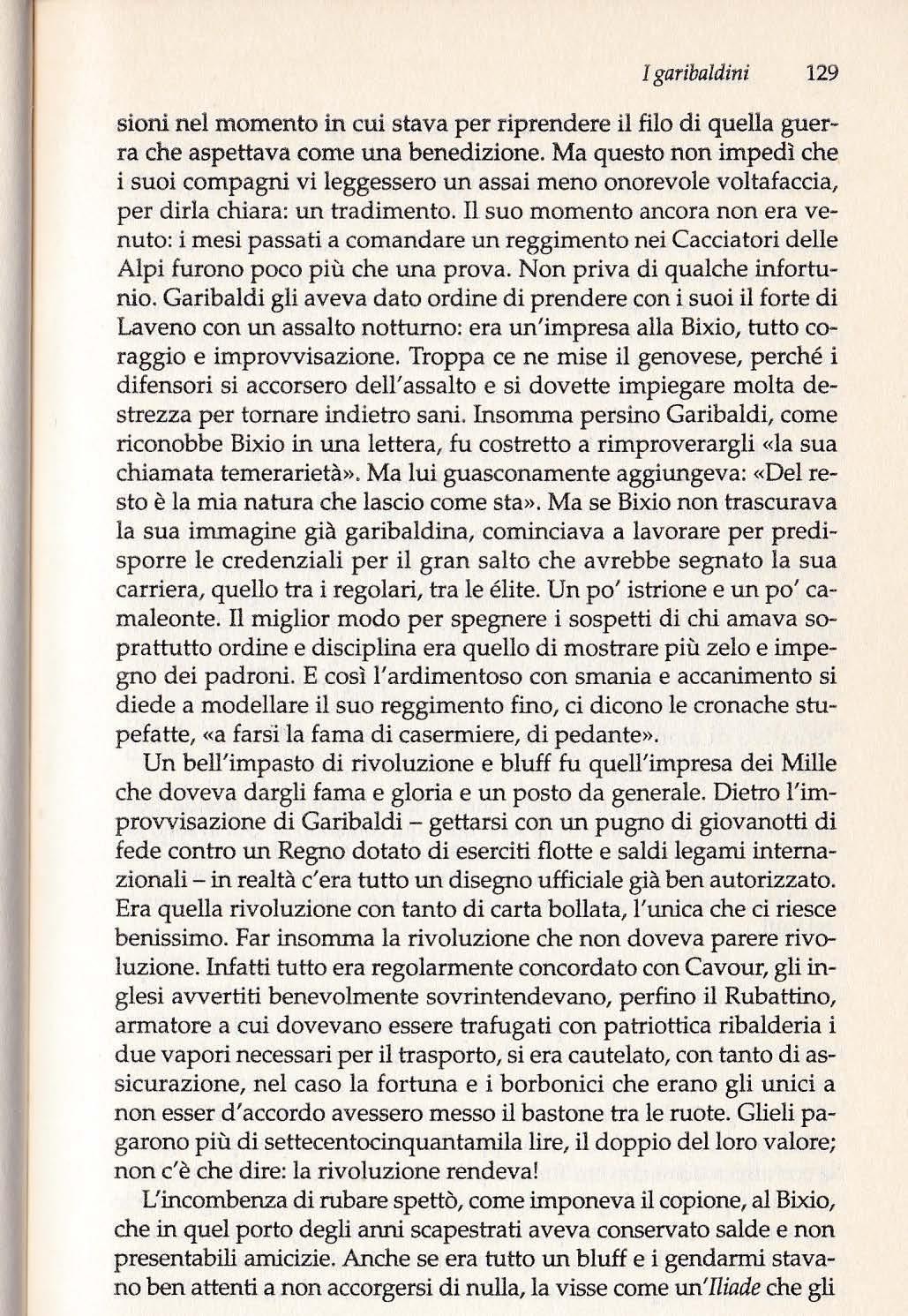
faceva perder il sonno e la fame. Dicono che girasse nei giorni che precedevano l'assalto come uno spiritato con un berrettaccio da tenente colonnello calcato in testa, aggirandosi in casa senza guardar né moglie né bambini. Alle nove e mezzo del 4 maggio il pirata e futuro generale poté pronunciare la frase storica che preferiva: «Signori, attenti, da questo momento comando io». E i suoi quaranta pirati volontari, gente di mano, scelta tra le sue ciurrne, che si erano nascosti in una vecchia nave in disarmo, si gettarono sul Lombardo e il Piemonte dove i marinai non aspettavano altro che arrendersi. Ma, beata imprevidenza italica, si era dimenticato un dettaglio: nessuno era fuochista tra quei baldi corsari e non si sapeva come accender le macchine. Mentre Garibaldi, sì, questa volta imprecava alla Bixio, si persero cinque ore per trovare dei macchinisti esperti e patriottici. L'epopea eroicomica rese mogio il futuro generale. Una piccola soddisfazione però gli restava. Garibaldi, che pure in mare aveva uno stato di servizio commendevole, aveva nell' ambiente fama di menagramo e di uno che portava i bastimenti nei guai. Così gli organizzatori della rivoluzione avevano preteso che la barca meno efficiente, il Piemonte, una carretta del mare che Rubattino aveva as tutamente affittato alla rivoluzione, venisse comandata proprio da Bixio.
Per far capire alle sue camicie rosse che tipo era, di fronte a un tentativo di ammutinamento per una violenza usata a uno di loro, balzò sul cassero e gridò alcuni aforismi energetici:

Io sono giovane, ho trentasette anni, e ho fatto il giro del mondo. Sono s tato naufrago e prigioniero ma sono qui e qui comando io. Qui io sono tutto: lo zar, il sultano, il papa, sono Nino Bixio. Dovete ubbidirmi tutti. Guai a chi osasse un'alzata di spalle. Guai a chi pensasse di ammutinarsi! Uscirei con la mia uniforme, con la mia sciabola, con le mie decorazioni e vi ucciderei tutti.
E li guardava in un modo che a nessuno venne il dubbio che potesse essere solo una vanteria.
Non è questo il luogo per raccontar l'impresa garibaldina. Si comincia in un tempio di Melpomene e si finisce nelle piazze a manganellate. I dettagli leggendari furono disegnati da una letteratura che gli stessi garibaldini imbandirono con acuta attenzione affidandola a Giuseppe Cesare Abba, a Giuseppe Bandi, a un servizio propaganda e comunicazione che era forse il più efficiente settore della spedizione. Bixio peraltro sfogliava di persona i petali della mitologia che lo riguardava, dal celebre «qui si fa l'Italia o si muore» di Calatafimi, di cui è lui s tesso il testimone o l'inventore, alla meticolosa contabilità delle sue ferite (quelle certo vere) che comunica ad Agostino Bertani:
I miei cavalli ricevettero dieci palle nemiche a Roma, diciannove a Reggio Calabria, tre a Maddaloni. Il mio corpo è s tato onorato da tre palle nemiche a Roma, da una a Palermo, da due a Reggio e da una rottura di gamba al passo del Volturno.
Al soU u cchero con cui riferiva ch e il corrispondete deU' «Illustration» inglese aveva chiesto un suo ritratto visto che anche n e Ua capitale dell a prima g lobalizzazione le sue gesta cominciavano a far notizia, aggiungeva con astuta modestia ch e g li elo aveva nega to: «Alla fine, se avremo fatto qualcosa di duraturo, allora vedremo».
Questo è un paes e in cui chi ha successo con le donne, soprattu tto se non sono la moglie, è guardato con affe ttuosa e inv idiosa tolleranza. Bixio, che certo e ra un bell'uomo, non trascurò nemm eno q u esto particolare per inzucch erare i d o lori della vi ta militare. Gli p iaceva n o alte vigorose di forme, ben provvedute, come confessò a un amico, «di c uscine tti adiposi» . P er scovarle n on s i limitava ai bordelli per ufficiali che all'epoca erano la regola e non sollevavano a lcuna rimostranza. Fece un viaggio in Inghilterra a spese del gove rno t irandosi die t ro una modista che poi lo abbandonò per la sua ligure ava ri z i a . C'era in mezzo ai s u oi rapporti con le donne un contorto affare. La moglie Ad elaide, leggera sventata mondanissima, lo tradiva : il selvaggi o Bixio ch e aveva sposato la guerra come diceva la moglie, e bbene, era confuso n e lla calca gelatinosa d e i cornu ti. Il rivale fo r tuna to, per genera le ammissione, s i chiamava Cesare Braico, un medico n apoletan o mondano e sciupafemmine che aveva per un certo p e riodo, e quando non c'era più pericolo, seguito l'avventura dei Mille . Lasciò la m oglie di Bixio, esibita a fest e teatri e concerti con scrupolosa invadenza, solo quando la scambiò con una nota cantante lirica. Il due llatore, l'uomo che p er uno sguardo troppo a u dace era disposto a incrociare la lama, subì. Si vendicava con una stra t egia che d arebbe lavoro a un allievo di Freud : scriveva chilometriche le ttere alla moglie in cui l e raccontava minuziosament e le avventure con le a manti, l a ripagava della stessa moneta s cendendo anche in particolari intimi con un contorto au to l esionis mo. Ogni tanto, secondo il costume ottocentesco, si garantiva la fed e ltà mettendola incinta. Morì come tutti i copioni borghesi dell'epoca im p o nev ano: invocando con accenti s tra zianti moglie e figli che aveva sempre n a turalmen te e disperatamente amato ! E pensare che i suoi fin troppo affettuosi biografi con erculea fantasia ne l odarono la p erfetta fedeltà domestica: «Quell'Ad elaide ch e forse fu la sola donna ch e da fidanzata e da sposa, abbia saputo qual gentile

cuore d ' amante fosse quel fiero uomo». Beata ingenuità di Giuseppe Cesare Abba!
I momenti più belli per lui vennero quando Garibaldi gli affidò l'ala d estra, una colonna che d a Corleone e Girgenti doveva salir s u fino allo Stretto per ras trellare quanto res tava d e i borbonici nell'isola e riunirsi alla colonna principale. Bixio aveva pieni poteri civili e militari: «Poteva requisire pigno rare levar soldi esercitar la giustizia e la polizia ». «Finalm ente sono davvero qualcuno» scriveva alla moglie con italianissima soddisfazione . La cosa più bella è che tutti i paes i facevano a gara a salutarne l'arrivo con balli e feste, e nessuno, visto che ormai il Borbone aveva p er so, si sognava di far resistenza. Il suo sogno, confessava, era una banda musica le con cui entrar nei paes i, ma visto che le sue truppe erano smilze s i trascinava dietro quelle di paese con cui assordava tutti e trasforma va l'operazio ne militare in un coloratissimo carnevale.
A Corleone si fe rmò dieci giorni attardato più che d alle necessità militari dai tre bordelli di quello che nelle lettere definiva «ospitale pa ese».

Qui a Corleone ci divertiamo molto; alla mattina s i fanno m anovre fino alle sette, alla sera ballo in piazza con la musica della brigata e poi ballo e canto con piano in case pa rticolari.
Insomma era una b e lla rivo luzione che permetteva anche di n ascondere un particolare poco gratificante: i fucili che e rano stati affidati ai «picciotti» li rubaro no di notte i ben p iù svegli bri ganti d e lla zona a cui d ella rivolu z ione non impo rtava nulla, gridavano «viva re Vittorio» e s i preparavano a gestire il dopo. A Catania l'entrata trionfale la pre parò p er gli inviati della stampa straniera:
Su uno sta llone nero come la pece che gli brillava sotto come una rondine, la faccia bruna incorniciata dal cappelluccio candido, pareva un emiro che to rnasse da una sped izione misteriosa nel deserto. Volteggiò spigliato, con gli ufficiali che aveva dietro si piantò in un punto d ella piazza in faccia all'elefante di pietra che sta là sonnolent o: a un s u o comando la fila s i spezzò, i battaglio ni piegarono, voltar ono rapidi gi usti e si fermarono in bell'ordine in colonna .
Anche qui s tava seguendo il rodato programma di cene e balli in una casa «particolare» quando gli giunse la n otizia che in vari paesi, soprattutto a Bronte sulle pendici dell'Etna, i contadini avevano impegnato una loro personalissima rivoluzione contro i galantuomini, massacrando famiglie di notabili, bruciando municipi e carte di proprietà, saccheggiando. Una frenes ia d a apocalisse. Come succedeva spesso,
nelle viscere delle società del Sud si mescolavano molte cose: volontà di rapina e lotta di classe, beghe privatissime e pubbliche nequizie, feudalità e rivoluzioni un po' marxiste. Insomma neppure i capi forse sapevano bene perché erano insorti. Infuriato per essere stato interrotto nella sua bella guerra, Bixio piombò su Bronte come una furia e con un solo battaglione. Nonostante le rivisitazioni cinematografiche recenti, lo spettacolo che si trovò di fronte era in grado di mozzare il fiato anche a chi, come lui, aveva per le popolazioni meridionali tutti i pregiudizi che appartenevano in parte aj «nordisti» e in parte al missionarismo risorgimentale: c' era infatti gente squartata abbandonata per le strade, una donna esponeva sconciamente i seni recisi (in un' altra versione, nell'ansia di mostrare come erano selvaggi gli insorti, uno di quell'orda è sorpreso mentre come un personaggio di Eschilo, in piazza poi!, rode il capezzolo di una sventurata vittima); ovunque distruzioni incendi saccheggi anche nei conventi delle monache.
Bixio non amava le popolazioni del Sud : era appena sbarcato e già scriveva a Adelaide di quella gente con i volti scavati e che parlava arabo, delle vie puzzolenti e piene di polvere.
La Sicilia non dà soldati, non paga impos te e se d e lle domande di impiego se ne facesse t e la vi sarebbe da coprire l' intera penisola.
L' odiato Giuseppe La Masa li presentava come entusiasti liberali e a lui sembravano invece briganti irrispettosi e indolenti, pronti sempre a voltar la schiena e scappare. Non si nascondeva certo dietro un linguaggio esopico:
Che paesi! Si potrebbe chiamarli veri porcili! Se io dovessi v ivere in queste regioni prefe rirei di bruciarmi la tes ta ti assicuro che ne lle province meridionali s i darebbe lavoro a metà della popolazione facendo spazzar le strade o quelle che qui chiamano strade. Prima che questi paesi giungano allo s tato di civiltà in cui s iamo noi abbisognano anni e lunghi anni i briganti sono la sola gente animosa ma con l'anima d e lla fiera coi d eboli e con g li ine rmi. Questo insomma è un p aese che bisogne re bbe distruggere o alm e no spopolare e mandarli in Africa a farsi civili!
Con i siciliani tutto era andato s torto fin dru primi giorni. A Palermo, davanti a Bixio che chiedeva a gran voce «chi comanda qui?», con un certo coraggio si era presentato un giovanotto avvolto in un mantello rosso da rivoluzionario d'opera : «Comando io che sono il generale La Masa ». Non aveva finito di parlare che al rivoluzionario siciliano arrivò in piena faccia una scudisciata e una frase «m a che generale La Masa! Lei è il generale La Merda!». Si rischiò una mischia generale tra liberatori e liberati. A La Masa restò quell' epiteto che aveva, si può dir,

meritato: perché era un gran venditore di fumo, un formidabile creatore di bluff a proprio vantaggio, vero esempio del rivoluzionario italico guascone. E anche fifone visto che spesso si nascondeva nelle case o, come accadde a Calatafimi, quando non trovava rifugi sveniva davanti al fuoco nemico. Ma finiti i combattimenti s i presentava sempre elegante e tirato a lucido «come una entrameuse», accampando miracoli di eroismo, come scrisse un testimone inglese di quei gloriosi fatti. Al conduttore dei picciotti e inve ntore della Sicilia garibaldina che non esisteva se non per un equivoco con scopi briganteschi, andò bene. Il giorno dopo, al bivio detto «della s taffa », quando i soli ti picciotti urlando come comari gli avevano fatto fallire l'assalto a sorpresa e causato diciotto morti tra i suoi carabinieri genovesi, dopo aver personalmente massacrato nove borbonici, Bixio aveva giustiziato con un colpo in testa un «partigiano che aveva visto intento a rubar g li stivali a un soldato morto». Bixio aveva fama di fucilatore, al minimo segno di disubbidienza o di ritardo negli ordini tirava fuori la pistola e il plotone di esecuzione, le sue truppe erano sempre sul punto di ammutinarsi per la violenza con cui distribuiva marce e scudisciate, se qualcuno faceva resistenza gli montava sopra con il cavallo. Si è spiana to il terreno davanti ai posteri con metodi spicci.

Adesso che gli avevano funestato «la serena letizia di quella patriottica corsa» Bixio era deciso a far piazza pulita: il 6 agosto dopo aver spedito in giro pattuglie con l'ordine di «percorre re il paese, impedire la circolazione, non lasciarsi avvicinare da alcuno, se viene trovato qualcuno arrestarlo e se resiste fucilarlo sul luogo » fece affiggere ai muri il famoso proclama:
Il generale Nino Bixio in virtù delle facoltà ricevute dal dittatore decreta che il paese di Bronte colpevole di lesa umanità è dichiarato in stato di assedio.
Nel termine di tre ore da cominciare alle ore dodici e mezza gli abitanti consegneranno le armi da fuoco e da taglio pena la fucilazione per i ritentori.
Il Municipio è sciolto per riorganizzarsi a termini di legge.
La Guardia Nazionale è sciolta per riorganizzarsi a termini di legge.
Gli au tori di delitti commessi saranno consegnati a l1e autorità militari per essere giudicati dalle commissioni speciali.
È imposta al paese la tassa di guerra di once dieci l'ora da cominciare alle ore ventidue del quarto giorno e da aver tennine al momento della regolare organizzazione del paese. Il generale Nino Bixio.
Forse è leggenda il racconto che vuole il terribile Bixio «con l'orologio in mano e la rivoltella sul tavolo» pronto a d ecretare lo scadere del terribile ultimatum. Forse è leggenda, come scrissero i giornali di Napoli ma anche mazziniani
quel demorùo rosso, bello elegante impeccabile che guida l'assalto alle case ribelli, fa spaccar tutto quanto, e non ha pace fino a quando ai muri viene appiccato il fuoco, che fa inseguire i ribelli che fuggono per i campi e li fa passare per le arrrù se armati e battere a sangue fino a quando non implorano pietà.
Non è leggenda che il 10 agosto i cinque capi della rivolta vennero fucilati alla schiena (uno di loro ebbe la forza di alzarsi e di chiedere di essere finito). Uno dei fucilatori, racconta l'Abba, vide Bix.io con le lacrime agli occhi per dover ordinare quella aspra punizione, e questa è probabilmente un'altra leggenda. Bix.io non poteva capire quella gente, in mezzo c' erano le sue convinzioni di uomo del Risorgimento per cui tutto quello che si frapponeva alla liberazione era borbonico, retrogrado, criminale. La pensavano così fior di intellettuali, figurarsi il soldato Bix.io che scriveva al consiglio municipale di Cesarò, altro paese in odor di controrivoluzione:
È necessario l'esempio e l' avranno tremendo. Che i buorù si serrino insieme, che le autorità siano vigili, che la Guardia Nazionale sia compatta, e la pace farà ritorno fra noi, e noi ritorneremo i soldati della libertà come siamo venuti. La Corte di Napoli ha educato una parte di voi al delitto e oggi vi s pinge a commetterlo. Una mano satanica vi dirige all'assassirùo, all'ince ndio, al furto per poi mostrarvi all'Ew·opa inorridita e dire: eccovi la Sicilia in libertà . Volete voi essere segnati a dito e dai vostri stessi nemici messi al bando della civiltà? Volete voi che il Dittatore sia costretto a prescrivere: stritolate quei malvagi? Con noi poche parole: o voi resterete tranquilli o noi in nome della giustizia e della patria nostra vi distruggiamo come ne rrùci della umanità.
Siamo sballottati tra l'estasi e la ripugnanza. Era un «tristo dovere» ma di sicuro il generale ci metteva un certo gusto e un grande impegno a compierlo! Intendiamoci, la sua non fu soltanto un'epopea di fucilazioni e repressione: la marcia dei Mille fu un'avventura e Garibaldi assomigliava più a Villa che al rivoluzionario Zapata. Erano tempi fatti apposta per approvvigionare i film e i libri di avventura. Ma Bi,do sapeva battersi. Garibaldi, pratico dei suoi umnini, lo usava come una specie di ariete, lo gettava laddove aveva bisogno di sfondare il nemico o resistere fino all' ultimo uomo perché sapeva che poteva fidarsi . Quanto a farlo generale ... Restò sempre colonnello perché Garibaldi ne aveva sperimentato i limiti. «Generale lo farà l'Italia » diceva, come avvenne. Conosceva bene i guai della nostra generosità nel largheggiare nei gradi. A Maddaloni durante la battaglia del Volturno che Bix.io considerò un trionfo suo, in realtà vinse un oscuro colonnello, Raniero Taddei, che tenendo il berretto sulla punta della spada si trascinò un battaglione a riprendere il monte Caro ai borbonici che stavano per avvolgerlo arrivando a Ca-
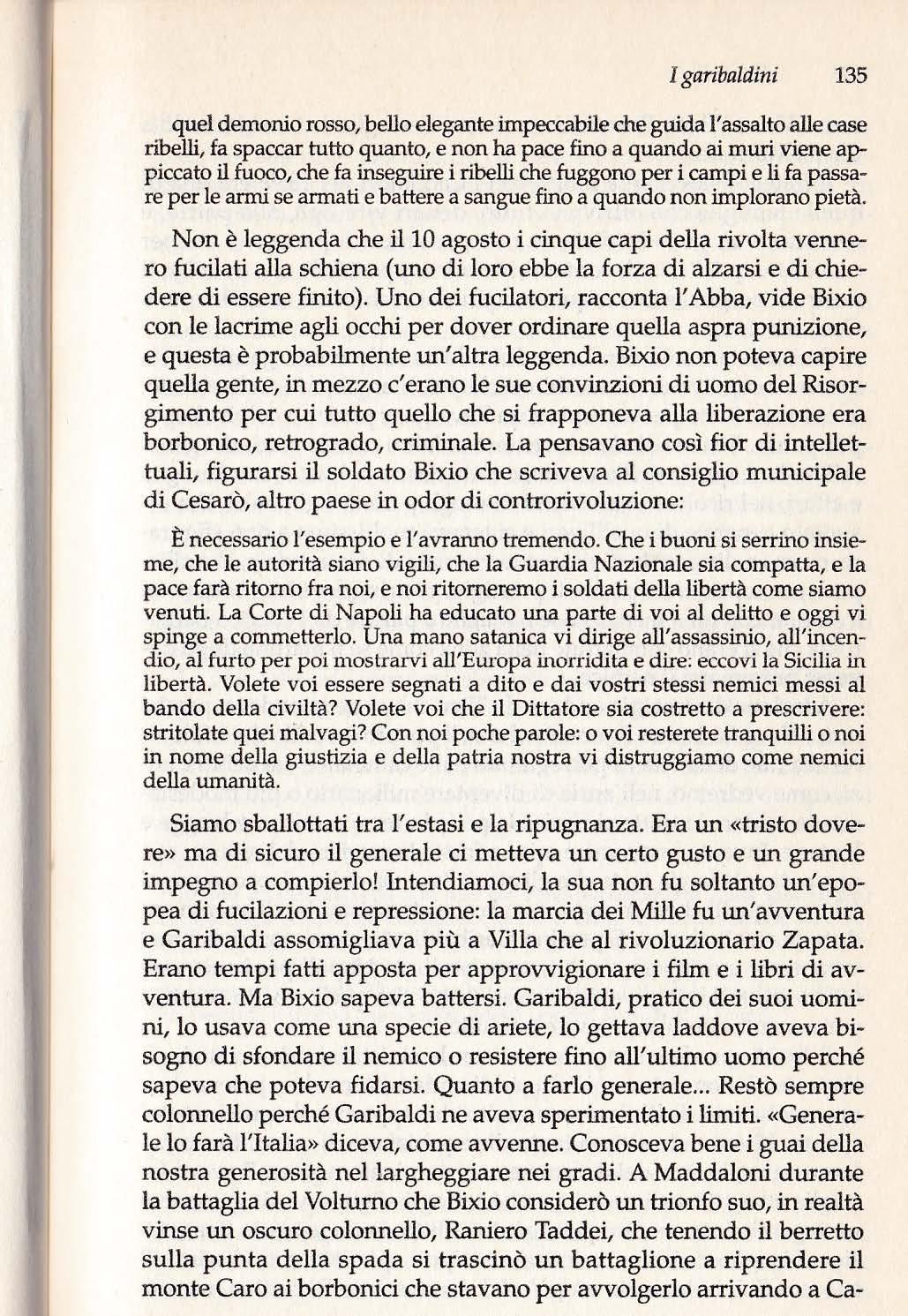
serta. Vinse Pilade Bronzetti con i suoi bersaglieri che si immolò a Castel Morrone.
Il fratello Narciso era morto con i Cacciatori nel 1859: era una di quelle famiglie che offrivano tutto, denari vite figli, alla patria, e sembrano un po' - lo diciamo non per amor di paragone ma per cancellare quell'aria di romanticheria insopportabile che avvolge il nostro Risorgimento -a quei martiri del nichilismo musulmano a Gaza o in Iraq.
Finì mestamente con un caduta da cavallo e una gamba rotta mentre inseguiva un fratacchione che lui, mangiapreti arciconvinto, aveva scambiato per una spia e un Ra vaignac pronto a colpire l'epopea patria. Bbdo si diede a inventare un'altra caratteristica dei generali italiani: quella dell'attenzione tutta nostra nel sistemare famiglia e affari, nel risolvere i problemi di mogli parenti figli amici. Era diventato generale di quelli veri e ci teneva moltissimo a non sfigurare: messo a dirigere la divisione territoriale di Alessandria, che all'epoca era considerata posto di prestigio, costringeva tutti i sottoposti a studiar con lui a menadito le battaglie a partire da Federico Barbarossa che si erano combattute nella zona come se il mattino dopo dovesse presentarsi il nemico.
A lezione di strategia andava da Tiirr, che se ne intendeva, perché non voleva far brutte figure. Anche se il povero secondo dei Mille sino alla fine della vita fu perseguitato dalle cambiali e dai debiti e anzi, come vedremo, nell'ansia di diventare milionario o più modestamente saldare le tratte ci rimise la pelle in terre esotiche selvagge e lontane. Inventò insomma e mise a frutto la carriera del reduce, con una notevole faccia tosta che gli attirò l'accusa dei suoi ex compagni (almeno quelli che non seguirono la sua stessa strada) di aver «venduto la rivoluzione». E persino Garibaldi, che pure non riuscì mai veramente a rompere con lui, se ne andò da Napoli per i suoi esili senza salutarlo. Il governo aveva intuito che quell ' eroe in servizio permanente effettivo poteva esser utile.
Il Bixio «prode e sanguinario» con la sinistra, i democratici, gli impazienti, non poteva più finger di andar d'accordo e poteva dare una spolverata di Iliade a un esercito che appariva ai vertici un po' spento. Viveva adesso con tanto di requisizione di un sontuoso palazzo naturalmente del defunto e non rimpianto regime. E aveva famiglia allargata, e di molto, perché a moglie figli servi si aggiunsero un ingombrante suocero pensionato afflitto da un rovescio finanziario e bisognoso di nuove fortune e nipoti spiantati e avidissimi. Il suocero finì, indovinate un po', dal riconoscente Rubattino, mentre

il fratello, oscuro travet di banca, divenne, con omaggio alla storia familiare, direttore della Zecca: per sé si era ricavato il posto di generale nell'esercito regio, naturalmente con le acquisite anzianità, un diritto che in Italia è più garantito e socialmente difeso che quello alla vita. E soprattutto, classica sinecura dei nostri gallonati condottieri, il seggio in Parlamento.
Tra i deputati Bixio ebbe sempre il ruolo, diciamo pure, un po' di macchietta. Nei suoi interventi in ctù mescolava lo stile che lo aveva reso celebre, affettava i modi napoleonici e presidiava due capisaldi: erano improntati a un così radicale allineamento sulle posizioni governative da sollevar imbarazzo anche se lui cercava di accreditarsi come uomo al di sopra delle parti, un patriota pronto a ogni mediazione per salvar la patria. Dalla biografia emerge un'anima inquieta. Ecco come presentava la sua posizione politica e ci vuol tutta l'amicizia del Guerzoni suo devotissimo per non coglier dietro la sincerità l'occhieggiare d el carrierismo: «Io sorgo in nome della concordia e dell'Italia [c'era stato uno scontro tra garibaldini e moderati]. Quelli che mi conoscono sanno che io appartengo sopra ogni cosa al mio paese».
Le cronache parlamentari riferiscono che le sue espressioni (come le già citate «Io sono tra coloro che credono alla santità dei pensieri che hanno guidato il generale Garibaldi ma appartengo anche a quelli che hanno fede nel patriottismo del signor conte di Cavour») che conciliavano l'inconciliabile furono accolte da boati e applausi vivissimi e prolungati: le convergenze parallele sono un mostro linguistico che ha vita antica n ei nostri parlamenti.
Io farò un discorso che non sarà del tutto parlamentare ... ma quanto agli uomini come il generale Garibaldi e come il conte di Cavour debbo dire che c 'è la disgrazia - e al mondo tutto non può andare bene - che si cacciano in mezzo a una infinità di altri uomini che mettono la discordia, questo non posso astenermi dal dirlo. Ebbene io ho una famiglia e darei la mia famiglia e la mia persona il giorno che vedessi questi uomini stringersi la mano.
Anche in Parlamento ci teneva comunque ad apparire Bixio, assumeva pose autoritarie, batteva il pugno sul tavolo, nell'ansia di far vedere il suo decisionismo e il cipiglio del guerriero, parlava a sproposito, la sua prosa inciampava in sgrammaticature che provocavano scoppi di risa. Aveva due fissazioni: costruire un esercito di quattrocentomila uomini con cui scendere il prima possibile in guerra, naturalmente per diventarne protagonista, e la potenza marittima; qui veniva fuori il suo vecchio mestiere di marinaro che gli aveva fatto aguzzar gli occhi sul gran bottino che altre potenze stavano già

mettendo proprio in quegli anni con furiosa invadenza nello zaino. Mentre Sella e Ricasoli avevano ancora un piede nelle mestizie della lesina, della tassa sul macinato e dei bilanci in rosso, già anticipando gusti e ambizioni che appartengono agli ultimi anni del secolo, lui aveva già sistema to il suo nell'era co lonialista e chiedeva retoricamente ai colleghi del Parlamento (vivacemente applaudito dicono le cronache):
Ma credete che passeranno molti anni che ci sia concesso il Canton Ticino che è nostro; senza che ci siano concesse le sponde dell'Adriatico sino al Quarnaro, che sono roba nostra; senza che ci sia concessa la Corsica che è roba nostra, e Malta che è nostra? Ma è cosa certa questa: l'Italia signori, non si ferma più... siamo noi i padroni del Mediterraneo, e lo siamo sempre stati.
Se aggiungete che già chiedeva a gran voce che si andasse «a disseppellire tra le sabbie della Libia la spada del centurione romano» avrete bell'e pronto il programma, la retorica e gli strafalcioni degli immancabili destini mussoliniani. In attesa di gettarsi sulla quarta sponda (ma l'Africa in quegli anni la rivendicava anche Mazzini!) trasformava il favore ministeriale in concreti vantaggi: per esempio salvò una seconda volta il Rubattino, che avrebbe dovuto davvero alzargli un monumento. Infatti aveva strappato per l'armatore patriota, ma anche pasticcione, una sovvenzione governativa di 211 lire per ogni lega marittima percorsa e un anticipo, se non bastasse, di due milioni rimborsabili senza interessi in sei rate: era di suo gusto l'inaugurazione di quella lobby affaristico-militare che avrebbe fatto lucrosi affari fino al fascismo. Per parte sua, era sempre perseguitato dai creditori, da certe cambiali che si tirava dietro da anni, dalle banche che concedevano prestiti all'eroe ormai abituato a un sontuoso tenore di vita che d escriveva come indispensabile al s uo decoro di soldato. Aveva quindici uniformi, due frac, quattro mantelle da sera, una trentina di paia di stivali e cento camicie di seta; aveva centomila lire di debiti ma si fece mandare, con la scu sa di una missione di studio, per tre mesi a spese del governo in Inghilterra dove intrecciò relazioni sentimentali e recitò la parte che gli piaceva di più, quella dell'Achille invitto. Tutto in cambio di una fedeltà governativa, lui che si proclamava a ogni piè sospinto indipendente e vincolato solo alla sua coscienza, così assoluta da meritarsi il nomignolo di uomo delle toppe che non votò mai contro un progetto del governo. È proprio vero che l'uomo bisogna prima sfamarlo e poi parlargli di virtù. Questa ferrigna fedeltà rischiò di costargli cara. Nell'ansia di compiacere, il 7 gennaio 1864, quando la ratifica della cessione di

Nizza come compenso a Napoleone infiammava il Parlamento e faceva gridare al tradimento, il prediletto di Garibaldi assordò tutti urlando: «Dichiaro che se fossi stato al Parlamento in occasione della cessione di Nizza l'avrei votata e voterei altrettanto oggi per la Liguria che è il paese dove sono nato» . Nella foga si era dimenticato che i suoi elettori non avrebbero apprezzato di poter diventare francesi e così alle elezioni successive fu battuto. Era un guaio ma erano tempi in cui agli errori degli elettori si poteva rimediare; e cos ì il governo, riconoscente, lo fece eleggere in un altro meno stizzoso collegio.

Dopo Custoza rischiò di diventare comandante supremo dell'esercito. L'idea venne a Della Rocca che, non contento di aver causato la sconfitta, si dedicava con tenace sollecitudine, forse per nascondere le proprie castronerie, a promuovere gli incapaci. Sostenne con Vittorio Emanu ele che Bi><io era davvero un gran generale, prode e «avveduto nella ritirata» . Può sembrare una maligna ironia, inv ece quello sciagurato voleva davvero fargli un complimento. Poteva essere l'erede di La Marmora: per fortuna il re non si lasciò convince re e gli diede del matto.
Il caso volle offrirgli per l'ultima volta una mano. Aveva fatto parte di quella pattuglia di uomini che per tutta la vita aveva sognato di prendere Roma e fame la capitale. La riv incita di Villa Glori gli fu concessa, come non avvenne per Garibaldi. L'ultimo suo comando fu per la spedizione d e l 1870, quella che venne chiamata senza paura di finir nel ridicolo «invasione»; ma sapendolo massone e mangiapreti, e per evitar schiamazzi rivoluzionari, lo sp e dirono a conquis tare Civitavecchia con la s ua divis ione. Non avevano tutti i torti. Pochi giorni prima di muovere aveva pubblicamente affermato che se fosse arrivato a Roma avrebbe provveduto a gettar cardinali e p a pa in Tevere . Sbruffona te; in realtà il Cadorna non lo poteva vedere, da buon piemontese, e non lo voleva tra i piedi. Fu per l' ultima volta Booo: al comandante d e lla piazza, rassegna to e pronto ad arrende rsi , s pedì un ultimatum dei tempi belli, scritto nell'orgasmo della lotta :
Ho dodicimila uomini di te rra, dieci corazza te, ce nto cannoni sul mare. Pe r la resa non accordo che un minuto di più di ventiquattro ore altrimenti d o m ani mattina s i chiederà dove fu Civitavecchia.
Per fortuna non ce ne fu bisogno, perché il condottiero papalino non aspettava altro che alzare bandiera bianca . Poi si diresse, in treno come tutti i co nquistatori recenti di Roma, fino a Ponte Galera, in periferia, e il 20 sette mbre a porta San Pancrazio riuscì a tirar qual-
che fucilata pure lui in quella scaramuccia. Anzi ne tirò troppe, perché nella foga di non perdersi l' avvenimento lanciò i suoi all'attacco senza precauzioni (subendo sette morti che per le battaglie risorgimentali erano una strage e infa t ti fu rimproverato dal Cadorna) e consumando più munizioni che tutto l'esercito. Andò in borghese e in incognito a visitare i luoghi della sua leggenda e questo è un gesto che gli fa onore. Ma il 23, quando in divisa si mise in prima fila per assistere con gli altri generali alla resa «con l'onore delle armi» dei pontifici, non seppe resistere. Di onore in quella vicenda ce n'era stato poco; i pontifici, mezzi mercenari e mezzi gaglioffi, si erano battuti vergognosamente, ma su questi dettagli che non costano nulla i nostri generali sono sempre stati molto generosi. Anche perché faceva loro comodo: quando gli sconfitti eravamo noi, e in modo altrettanto umiliante, l'onore serviva a salvar la faccia. Quando i papalini, mal vestiti con le divise trasandate, qualcuno ubriaco e con il sigaro in bocca, gli passarono davanti berciando e gridando per sfottere «viva il papa » e «viva la Francia», Bixio fece una delle sue celebri scena tacce. Cominciò a urlare insulti e a chieder loro perché facessero i coraggiosi adesso, mentre prima non si erano battuti. Senza l'intervento di Cadorna e degli a l tri si sarebbe scatenata una rissa poco commendevole con i gen era li pontifici . Bixio era uno che non si piegava alla turpe tentazione di porgere l'altra guancia.
La guerra gli aveva dato alla testa, si sentiva ormai alla pari con quella gallonata ed esclusiva consorteria in cui era stato issato solo per i propri meriti. Il pirata di Quarto, la cui filosofia m ilita re si esauriva in questa sintesi mirabilmente semplicistica che aveva e nuncia to alla vigilia di Custoza : «Ho undicimila uomini e qua lunque cosa avvenga sento che delle buone bastonate le darò anch'io. Al resto Iddio provveda », e ra nel pieno delle sue funzioni carismatiche. La fama lo bruciava senza scaldarlo, voleva la poltrona di minis tro della Guerra. Avviò con Cialdini una trattativa . Sentite come «la setta» lo mise a posto:

Mio caro generale, mi pare c h'Ella s ia ritornata alla Camera coi nervi troppo tesi. Ella ha l' istinto di ciò che scu ote le masse italiane e dal di Lei labbro sgorgano sempre ed esclusivamente parole patriottiche. Ma so ffra che io le dica che se ciò basta per un tribuno, non basta per chi ha la d.i Lei posizione e a buon diritto deve pretendere un portafoglio ministeriale.
Perfino Quintino Sella, così tutto di un pezzo, usò toni melliflui, contento di liberarsi di quel secca tore ormai inutile avviandolo verso divers i destini :
L'impressione che farai in Italia sarà grandissima. TI si paragonerà a quei grandi uomini di America che ieri vinsero in una lotta gigantesca e oggi dirigono una fabbrica e ai loro predecessori che vinta l'Inghilterra ridiventarono coloni . Senza complimenti, tu sei già grande in Italia ma un fatto come quello che hai in mente ti ingigantirebbe.
Quante cose scomodava l'inventore del macinato per un licenziamento!
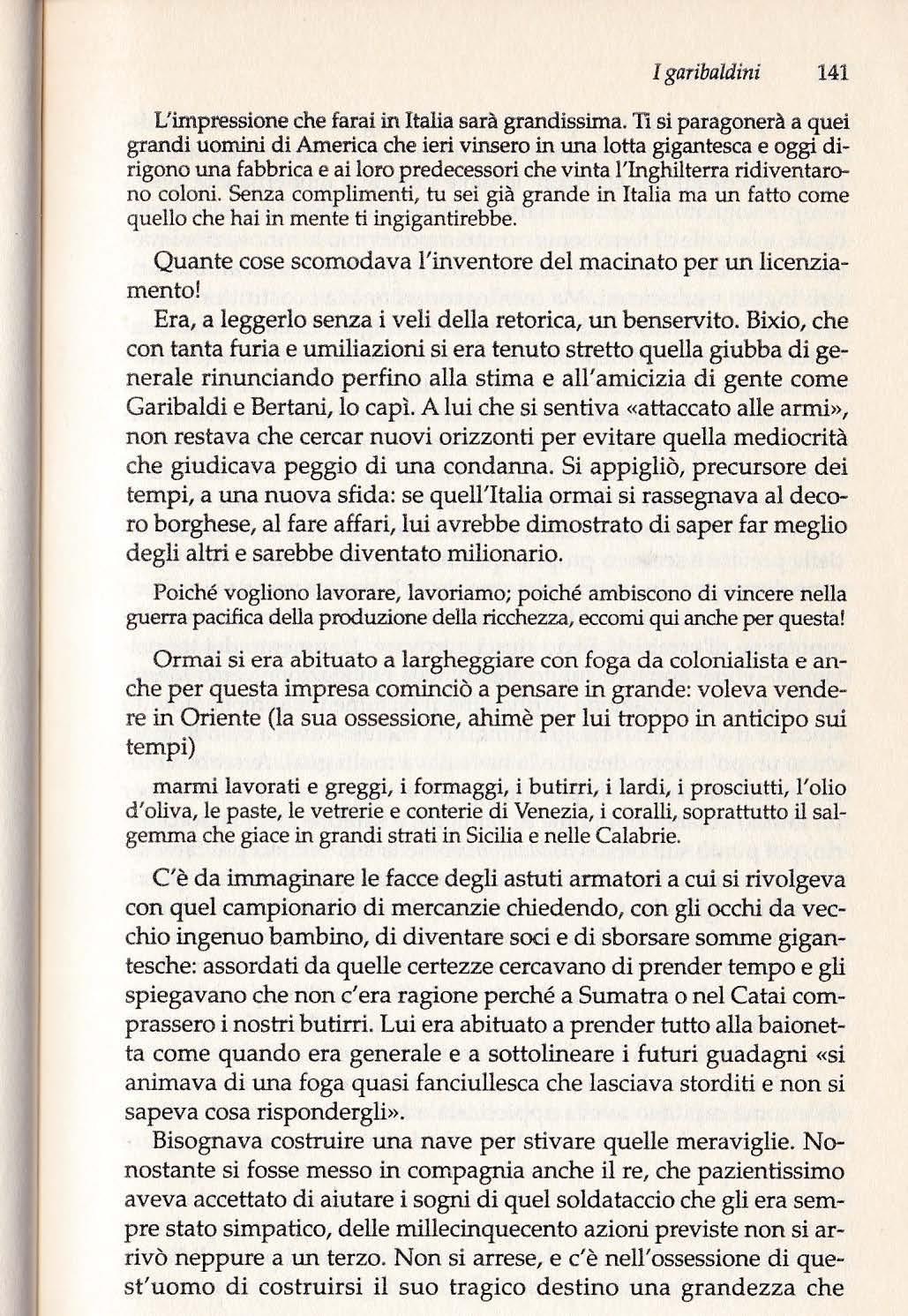
Era, a leggerlo senza i veli della retorica, un benservito. Bixio, che con tanta furia e umiliazioni si era tenuto stretto quella giubba di generale rinunciando perfino alla stima e all'amicizia di gente come Ga ribaldi e Bertani, lo capì. A lui che si sentiva «attaccato alle armi», non restava che cercar nuovi orizzonti per evitare quella mediocrità che giudicava peggio di una condanna. Si appigliò, precursore dei tempi, a una nuova sfida: se quell'Italia ormai si rassegnava al decoro borghese, al fare affari, lui avrebbe dimostrato di saper far meglio degli altri e sarebbe diventato milionario.
Poiché vogliono lavorare, lavoriamo; poiché ambiscono di vincere nella guerra pacifica della produzione della ricchezza, eccomi qui anche per questa!
Ormai si era abituato a largheggiare con foga da colonialista e anche per questa impresa cominciò a pensare in grande: voleva vendere in Oriente (la sua ossessione, ahimè per lui troppo in anticipo sui tempi)
marmi lavorati e greggi, i formaggi, i butirri, i lardi, i prosciutti, l'olio d'oliva, le paste, le vetrerie e conterie di Venezia, i coralli, soprattutto il salgemma che giace in grandi strati in Sicilia e nelle Calabrie.
C'è da immaginare le facce degli astuti armatori a cui si rivolgeva con quel campionario di mercanzie chiedendo, con gli occhi da vecchio ingenuo bambino, di diventare soci e di sborsare somme gigantesche: assordati da quelle certezze cercavano di prender tempo e gli spiega vano che non c'era ragione perché a Sumatra o nel Catai comprassero i nostri butirri. Lui era abituato a prender tutto alla baionetta come quando era generale e a sottolineare i futuri guadagni «si animava di una foga quasi fanciullesca che lasciava storditi e non si sapeva cosa rispondergli».
Bisognava costruire una nave per stivare quelle meraviglie. Nonostante si fosse messo in compagnia anche il re, che pazientissimo aveva accettato di aiutare i sogni di quel soldataccio che gli era sempre stato simpatico, delle millecinquecento azioni previste non si arrivò neppure a un terzo. Non si arrese, e c'è nell'ossessione di quest'uomo di costruirsi il suo tragico destino una grandezza che
mancò perfino nelle sue più celebrate battaglie. Accettando condizioni terribili che lo avrebbero reso schiavo per tutta la vita, strappò i soldi necessari per costruire la nave grande e moderna che aveva sempre sognato: la ordinò naturalmente ai cantieri inglesi a Newcastle, e la volle di ferro come ormai imponevano le innovazioni moderne, con un motore da duecento cavalli per tener testa ai futuri rivali inglesi e americani. Ma mentre ossessionava i costruttori, come un bambino viziato cominci ò a pretender miglioramenti e nuove caratteristiche sicché, inizialmente prevista di mille tonnellate (e sarebbe stata già un gigante), alla fine risultò di tre mila e il prezzo da trentottomila sterline salì a quarantatremila. Ma non fu la sua ambizione l'unico problema. Bixio, che fremeva perché vedeva passar il tempo e scivolar via anche i soldi, avrebbe volentieri fatti fatto fucilare gli operai inglesi, per dare l'esempio, come i caporioni di Bronte. Ma questi erano già entrati, e a passo di corsa, nell'era dei diritti e delle pretese e scelsero proprio quel tempo per scatenare una lunga serie di scioperi. Insomma, per comp letar la na ve e vararla ci volle ro due anni e due milioni di sterline. Che non si sa come, firmando montagne di cambiali, Bixio riuscì a trovare. L'aumento del tonnellaggio - come apparve subito chiaro nella navigazione verso Messina da dove con citazione gariba ldina il bastime nto avrebbe dovuto spiccare il volo verso i sognati mari d'Oriente - aveva reso le macchine un po' troppo deboli e la nave dava molti guai. Avrebbe voluto chiamarla Marco Polo per inneggiare al suo sogno d'Oriente, per un attimo accarezzò il nome di famiglia, e sarebbe stato straordinario, poi puntò s ull'eroico Maddaloni come la sua vittoria più famosa. Bixio con un ultimo saluto, in cui c'era tutta la s u a sfacciata ipocrisia, alla moglie che non e ra ven uta a Messina («Addio mia buona Adelaide, a mami che ti assicuro lo merito») diede forza alle macchine e partì, prima nave italiana a vapore che attraversava il canale di Suez. Aveva la stiva piena di carbone destinato a Singapore, l' animo gonfio di speranze e faceva finta di non sapere che a Genova tutti, nominando il suo Maddaloni, nonostante la modernità facevano gli scongiuri, perché dicevano che se come soldato non c'era nulla da ridire come capitano aveva appiccicata addosso la nomea di iellato. Infatti, entrand o nel canale a Porto Said dove bisognava disegnare una curva per cui occorrevano pratica, occhio e una buona esperienza, combinò un incidente che marchiò subito quella spedizione come sfortunata. Bixio, che si reputava un gran capitano (qualcuno aveva proposto di nominarlo ammiraglio nel 1866 a l posto di Persano!), volle far da sé rinunciando al pilota: tagliò in due una nave ci-

sterna, che per una serie di equivoci tentò di passargli a prora. Non si riuscì a fermar le macchlne di quel mostro e la nave finì a picco, per fortuna senza vittime. Verbale, inchiesta, multa di trentamila sterline perché nel canale vigevano regole severissime e non si guardava in faccia nessuno. Non era proprio così. Fu lo stesso Ferdinand-Marie de Lesseps, il geniale visionario che aveva presieduto l'impresa titanica ad abbuonargliela, forse perché sentiva affinità per quel temerario e soprattutto perché era stato amico del fratello che in Francia aveva fatto fortuna. Singapore, Batavia, Saigon, Pasauran, lo stretto di Malacca: acque insidiose e affascinanti; la Maddaloni e il suo frenetico capitano si lanciarono in crociere furibonde e disperate: riso, carbone, s'imbarcava di tutto perché le cambiali dall'Italia incombevano e Bixio si era accorto che le clausole che aveva accettato lo stavano strozzando. Fu per disperazione - lui che aveva sognato di diventar milionario e si vedeva davanti la vergogna del fallimento -che accettò di trasportare truppe al servizio dell'Olanda che dovevano andar a domare una rivolta scoppiata a Giava. L'erculeo Achille della libertà finiva traghettando mercenari che dovevano reprimere la rivolta di indigeni maltrattati in un'altra esotica prigione dei popoli. Beffe del destino! Il nolo, ventunmila sterline per tre mesi, era buono. Ma soprattutto lo attirò quel ritornare alla guerra, quel respirare di nuovo le atmosfere che erano state la sua vita. Nelle lettere piene di minuti particolari, l'orticello sul poggiolo, i prediletti colombi, la serva ubriacona e le preoccupazioni finanziarie, non ce n'è traccia ma non si fatica a pensare quali piani gli frullassero per il capo girando per le terre che sarebbero diventate tra poco salgariane. Sono gli anni in cui James Brook, inglese geniale, il «rajah bianco», si è da poco fatto r e del Sarawak. Bixio era il tipo adatto per imprese di questo genere. Se non fosse morto certo lo avremmo visto gettarsi in qualche avventura coloniale, scalare le ambe d 'Etiopia o scovare per l'Italia qualche dominio nei mari del Pacifico. Aveva l'estro, l'umore per simili cimenti, era la figura più adatta per diventare il Rhodes italiano.
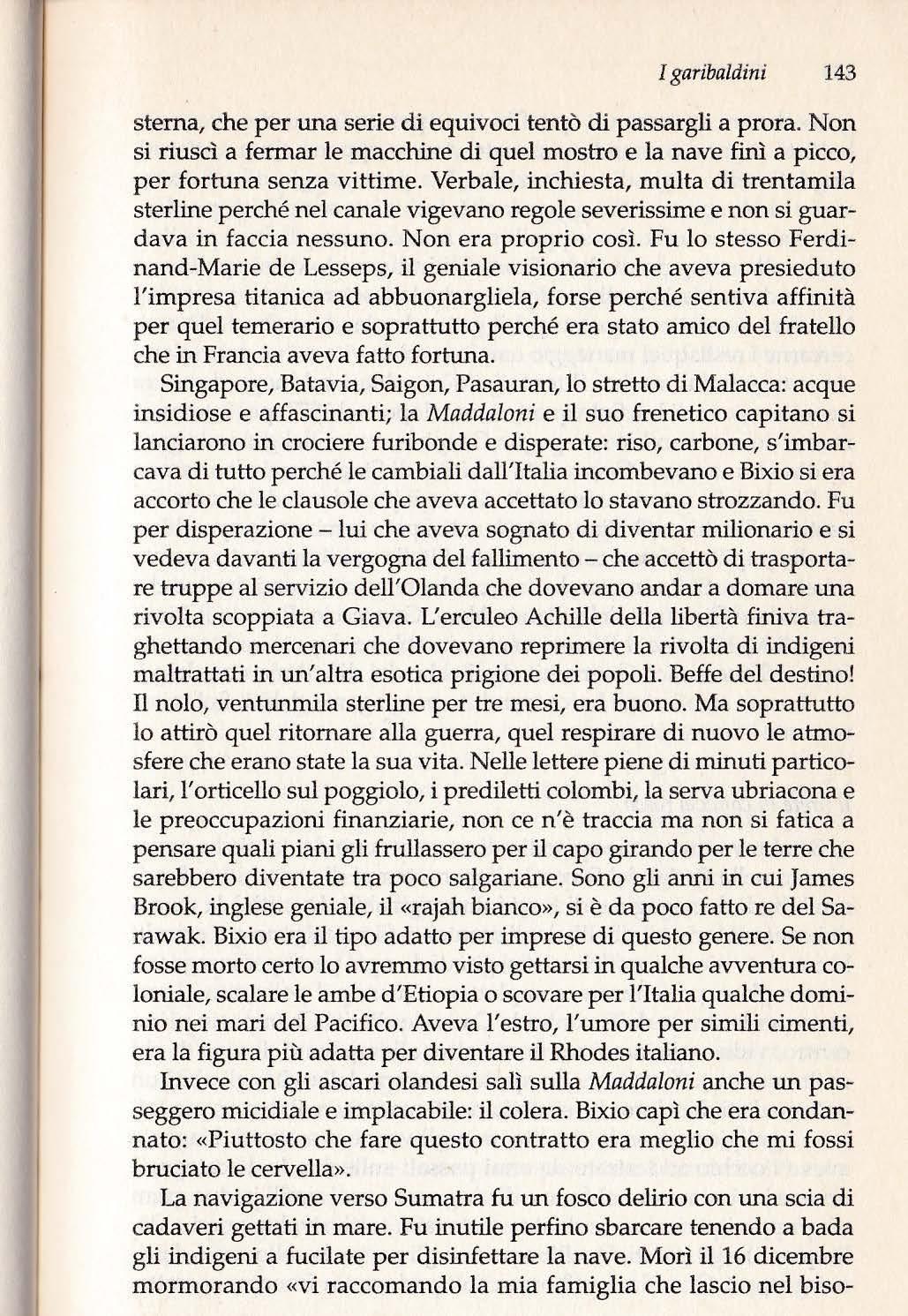
Invece con gli ascari olandesi salì sulla Maddaloni anche un passeggero micidiale e implacabile: il colera. BiJdo capì che era condannato: «Piuttosto che fare questo contratto era meglio che mi fossi bruciato le cervella».
La navigazione verso Sumatra fu un fosco delirio con una scia di cadaveri gettati in mare. Fu inutile perfino sbarcare tenendo a bada gli indigeni a fucilate per disinfettare la nave. Morì il 16 dicembre mormorando «vi raccomando la mia famiglia che lascio nel biso-
gno» che era davvero un epitaffio triste per un uomo che aveva abbattuto regni e comandato armate. Aveva appena cinquant'anni, bruciati nella storia di una nazione. Era pers ona ggio dibattuto tra vizi e virtù, spiritualità e g rossolanità, furbizia e semplicità, prudenza e sconside ratezza. Lo sepp ellirono in un cassone dj ferro p e r l'acqua, sulla spiaggia di Pulo Tuan. Gli indigeni lo disseppellirono pensando a chissà quali favolosi tesori e lo lasciarono poi insepolto. Macabra vendetta, come scoprì il generale olandese che andò a ricercarne i resti: quel maneggio empio costò la vita a due d e i violatori contagia ti dal morbo . Il terzo guidò i soldati s ul luogo d ove e ra quanto restava di lw . Solo qua ttro anni d o po, nel 1877, per interessamento d e l suo vecchio compagno Crispi, le ceneri del generale garibaldino tornarono a Genova. Al cimHero ili Staglie no si alternarono gli Ercoli della retorica nazio nale. C o me il pres idente del Senato Sebas tiano Tecchio: «O Nino, se tu non h ai potuto morendo specchiarti n ella pupilla d ei tuoi ca ri, sappi che l'Italia qui riunita tutta quanta ti benedice». Sulla s u a tomba invece che retorici enco m;, invece ch e scomodare Giovanni d e lle Bande Nere, Castruccio, Braccio il Piccinino, il Malatesta e il Ilinascimento, avrebbero dovuto scrive re una frase d e l s uo amjco G u er zoni: «Egli ebbe d e i difetti ma non d e i vizi». La sua amatissima bar ca, venduta p er pagare i d e biti, finì mjseramente in mano straniera.
Il prete in camicia rossa
Sembrava un banale episodfo ili cronaca, uno dei tanti che avvenivano nella Parigi del Secondo impero, tempi di a rricchiti e di miserabili, di demagogia e di lussi inìmmaginabili. La città è la m ecca dei contestatori, d ei ribelli, degli scontenti. Si raccolgono qui eremjti b izza rri e visionari er etici, mjstici giunti da ogni parte per insegnare, contemplare, p rofetizzare, complottare. Quando il poliziotto ili serviz io per le strade della contrada Croix des Petits Champs, in pie no centro, vide avvicinarsi un u omo alto, allampanato, il viso di chi molto aveva sofferto e molto sp e rava ancora dalla vita, g li abiti un po' sgualciti ili coloro ch e s i s forzan o ili mantenere il d ecoro m a lo ttano ogni giorno con le r e ndite, non gli vennero sospetti . L'agente aveva l'occhio addestrato da anni p assa ti sulle s trade, le categorie umane le riconosceva a l fiuto e dis tingueva i s uoi simjli in due grandi gruppi : i pericolosi (e d entro ci s tavano tutti, rivolu z ionari e d elinquenti) e g li o n esti . Quell'uomo n o n gli parve da collocare n el prim o gruppo. Quando ap rì bocca capì : pa rla va un francese corretto,

persino un poco affettato di chi ha fatto buoni studi, ma era uno straniero, un italien. Certamente uno di quei tanti fuorusciti delle rivoluzioni di quel paese che Napoleone ill - a cui piaceva fare il giacobino, il protettore dei deboli per omaggiare lo zio e per aver materiale con cui alimentare le sue tortuose trarne politiche - accoglieva con imprudente generosità . Il poliziotto non aveva prevenzioni per quei francesi di adozione: era gente, gli avevano raccomandato i superiori, che chiacchierava molto, passava le giornate nelle soffitte a poco prezzo a litigare s u rivoluzioni che erano già fallite o che non sarebbero mai state messe in piedi. Innocui chiacchieroni, teste bis lacche; ma non si sa mai. Chi maneggia le bombe, anche per le cause più esotiche e lontane, prima o poi, comincia a ricavarne una specie di assuefazione, una seconda natura che lo spinge a fame un comodo strumento di palingenesi universale.

Senza concitazione, con calma, l ' italiano gli chiese di intervenire: c'erano due mascalzoni che lo pedinavano ormai da parecchi giorni, e li indicò, erano all'angolo, di fronte a un negozio, e anche un bambino si sarebbe accorto che facevano finta di fare gli indifferenti e tenevano d'occhio proprio l'italiano che chiedeva aiuto. Sospetto confermato dal fatto che quando l'agente si diresse verso di loro per interrogarli fuggirono a gambe levate tra la folla.
Ma fu al commissariato, dove aveva accompagnato l'uomo per l'inevitabile denuncia, che il poliziotto ebbe la grande sorpresa: i due mascalzoni erano popolari tra le gerarchie poliziesche, perché erano due agenti impegnati in un servizio di sorveglianza debitamente autorizzato. Per l'imbarazzato l'agente di quartiere era il momento di uscire di scena, c'era nella vicenda qualcosa che evidentemente superava le sue modeste competenze; e infatti con una scusa tornò alle sue strade tumultuose lasciando l'italiano seduto in sala di attesa e invitandolo a incontrare il commissario per stendere il rapporto.
L'uomo della sala d'aspetto si chiamava Giuseppe Sirtori, strano tipo degno di Dostoevskij; era nell'ambiente convulso, sempre in bilico tra macchietta e tragedia dei fuorusciti italiani, un protagonista . Stava per iniziare per lui - che nella vita era destinato a superare molte volte delicate linee di confine, a lasciarsi dietro identità per calzarne altre con fatica e dolore - una parentesi drammatica che anticipava tragedie più moderne, realtà concentrazionarie e repressive che in quei giorni di metà Ottocento parevano ancora lontanissime e strane. Il rapporto sulla misteriosa persecuzione era destino che lo straniero non riuscisse a stenderlo mai. Perché l'atmosfera cambiò
subito con l'arrivo del commissario. Esperto di abitudini poliziesche che si assomigliano sotto tutti i regimi, un rivoluzionario particolarmente tagliato al lavoro cospirativo come Sirtori avrebbe dovuto fiutare il pericolo. Il testimone di un reato divenne con acrobatico colpo di scena un colpevole. Non aveva infa tti con sé alcun documento e a nulla valsero le affannose spiegazioni: il passaporto glielo aveva sequestrato proprio la poHzia quando era entrato in territorio francese e bastava mandare un agente a casa per aver conferma della sua identità.

Il calvario kafkiano cominciò a dipanarsi nelle sue stazioni inevitabili: prima al commissariato Haleau Blé poi a quello del Louvre, e sempre senza spiegazioni, senza che nessuno si decidesse a fermare gli ingranaggi per ascoltare le sue ragioni. Alle dieci di sera, dopo se tte ore, approdò al carcere della Prefettura dove la scrematura dei colpevoli era già stata fatta e nella rete erano rimasti solo quelli che dovevano discolparsi di delitti così interessanti da scomodare un giudice. Qui gli sequestrarono, segno che disponevano già di indizi pesanti, enormi, tutto ciò che aveva in tasca, ed era la miseria di tredici franchi. Gli diedero da mangiare solo nel pomeriggio del giorno s uccessivo, poi, senza che mai gli fosse concesso di chieder l'aiuto di amici o di un avvocato lo caricarono su un cellulare, che al galoppo come se ci fosse una pericolosa urgenza lo scaricò, era ormai il tramonto del secondo giorno, dopo aver attraversato tutta la città, in un enorme cortile. Lì i suoi custodi lo abbandonarono, sempre senza dire una parola di spiegazione. Sirtori si rivolse subito a quella gente per avere informazioni e notizie e con raccapriccio capì che quello non era un carcere, era molto peggio: il manicomio di Bicètre! Veneriamo questo momento. Siamo all'anticipazione del gulag più raffinato e feroce, l'ultimo tassello del mondo staliniano, la follia come manifestazione finale della devianza. Ma cosa aveva mai commesso di così atroce quel fuoriuscito per meritare una così moderna e inusitata punizione, qual era la follia di cui lo accusava un potere in fondo ancora abituato alla tradizionale repressione mediante la galera? Confessiamo una passione per la sua esistenza tumultuosa; lo abbiamo preferito ad altri generali garibaldini, cercavamo la prova che un secolo di rigide gerarchie come l' Ottocento, ancora tutto ben calato nel vecchio mondo, lasciava lo spazio a carriere straordinarie e velocissime. Era un uomo che non sapeva ridere. Si rivelò in ogni occasione geniale. E poi resta nella storia dei generali italiani un caso che non ha eguali.
La prima vita di Giuseppe Sirtori si era consumata placidamente
nelle atmosfere manzoniane della Brianza, all'epoca ancora pittoresca, un giardino di ville e paeselli non ancora ferito dalle tracce dello sviluppo e dell'industrializzazione. Negli anpi in cui Bixio disputava a coltellate nei vicoli malfamati di Genova, Sirtori passava «con molta diligenza» e la bella scritta «primus cum eminentia» gli esami al seminario di Monza. Ne usciva prete e parroco nella Milano austriaca, come lo aveva destinato la scelta di una famiglia di modesta agiatezza e di molti figli che forniva ministri alla Chiesa oltre che per cristiana passione anche per sbarazzarsi di troppi impegni economici che non poteva sostenere. Già a quel tempo gli amici lo descrivono nell' aspetto come apparirà ai garibaldini sugli spalti di Palermo o ai soldati tra le cannonate di Custoza : «Ritto, alto, labbra suggellate, occhi che guardano oltre gli oggetti su cui si fermano , mento inquisitivo». Non era un prete che attingesse, sempre per restare nella metafora manzoniana, allo stile di don Abbondio. Proclamava una strana e sospe tta interpretazione del magistero:
La mia religione sarà positiva come la matematica ma sentita e attraente come la poesia e le sue conseguenze saranno così inevitabili come quelle di una formula algebrica ma non dure anzi soavissime come è soave lo spirito cli carità .
Erano idee che potevano portare ingenuamente alla santità o, con maggiori probabilità, sulla via di «indo cili » e pericolosi p ensieri. Anche perché il parroco brianzolo frequentava coetanei che avevan o ben altre passioni, co me Cesare Correnti o i fratelli Carlo e Alessandro Porro che cominciavano negli anni Trenta del secolo, concitati da tante rivolu z ioni, a ragionare sul dominio austriaco e s ui destini d'Italia. In Francia il Sirtori e ra giunto una prima volta nel 1842 con tanto di regolare passaporto austriaco e licenza delle autorità ecclesiastiche Ci andava con scopi e volontà che non sono mai s tati interamente chiariti. Sciaguratamente le carte del Sirtori subirono, quando era già ce lebrato garibaldino e monumento della storia italica, un poliziesco filtraggio da parte di un parente, pure lui sacerdote, a cui i familiari le avevano consegnate per la censura prima di donarle agli archivi della memoria nazionale. E lui regalò alle fiamme tutto quanto non riteneva conforme all'immagine del santo e dell'eroe. Quel che è rimasto è una biografia ricchissima ma sghemba, dove manca per esempio qualsiasi cenno alle donne che g li riservarono affetti e qualcosa di più. E ce ne furono molte, a partire da una parigina, il petto vanitoso dei veni'anni, i fia nchi pienotti delle donne in fiore.
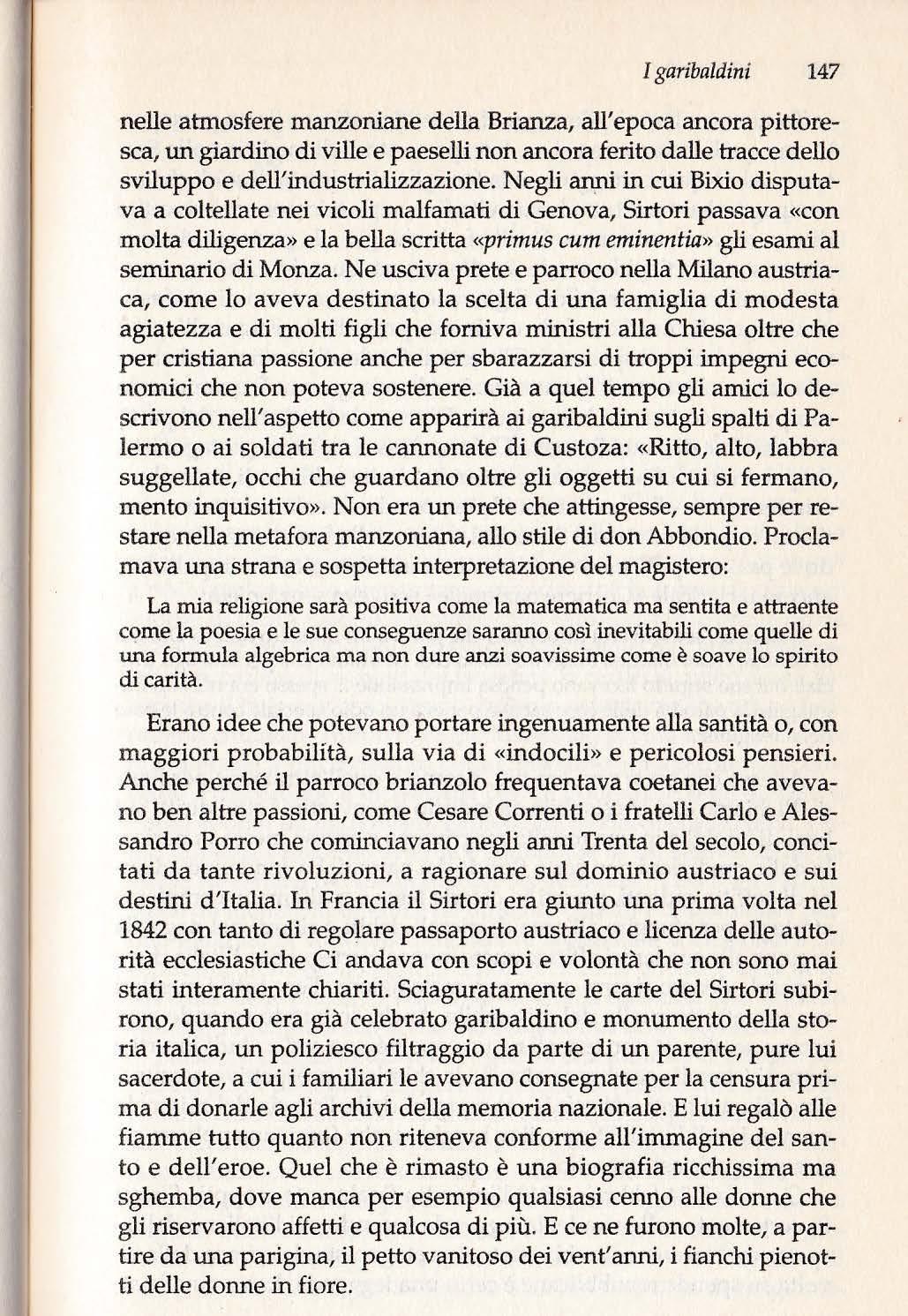
Torniamo a Parigi. «Per oggetti scientifici» diceva il suo passaporto, ma quali fossero non si sa. Intraprese studi di medicina alla Sorbona, iniziò quel carteggio con la famiglia alla ricerca di soldi che accompagnerà un po' tutta la sua vita fino a quando non sarà rivestito di una regolare uniforme. Quella fede che già alla partenza doveva essere strana e tiepida, tendente allo scisma, quando tornò era completamente scomparsa. Così il giovane parroco, armato di confusissimi sogni di conciliare fede e scienza, prese la decisione ali'epoca non certo facile di spretarsi. Gli restò il fondo di ascetica dedizione alla causa, che fosse il riscatto nazionale o la guerra. È quanto resta sempre attaccato a chi è stato prete. Divenne la bestia nera del partito clericale e di Santa Romana Chiesa, che se lo ritrovò protagonista, da pecorella definitivamente smarrita, nelle schiere di chi voleva scuoterne fino alle fondamenta le temporali e secolari certezze: venti anni dopo la morte del Sirtori, al volger della fine del secolo quando le passioni potevano essere se non cancellate almeno impallidite, ancora il clericale «Corriere nazionale» scriveva senza pietà:
È stato un settario cosl arrabbiato che pareva un ministro non di Dio ma di Satana, i suoi discorsi blasfemi erano così ributtanti che persino agli ufficiali del suo seguito facevano penosa impressione ... spesso era nel suo lin~ guaggio la parodia delle cose sacre e poneva un odio speciale contro le cose della religione.
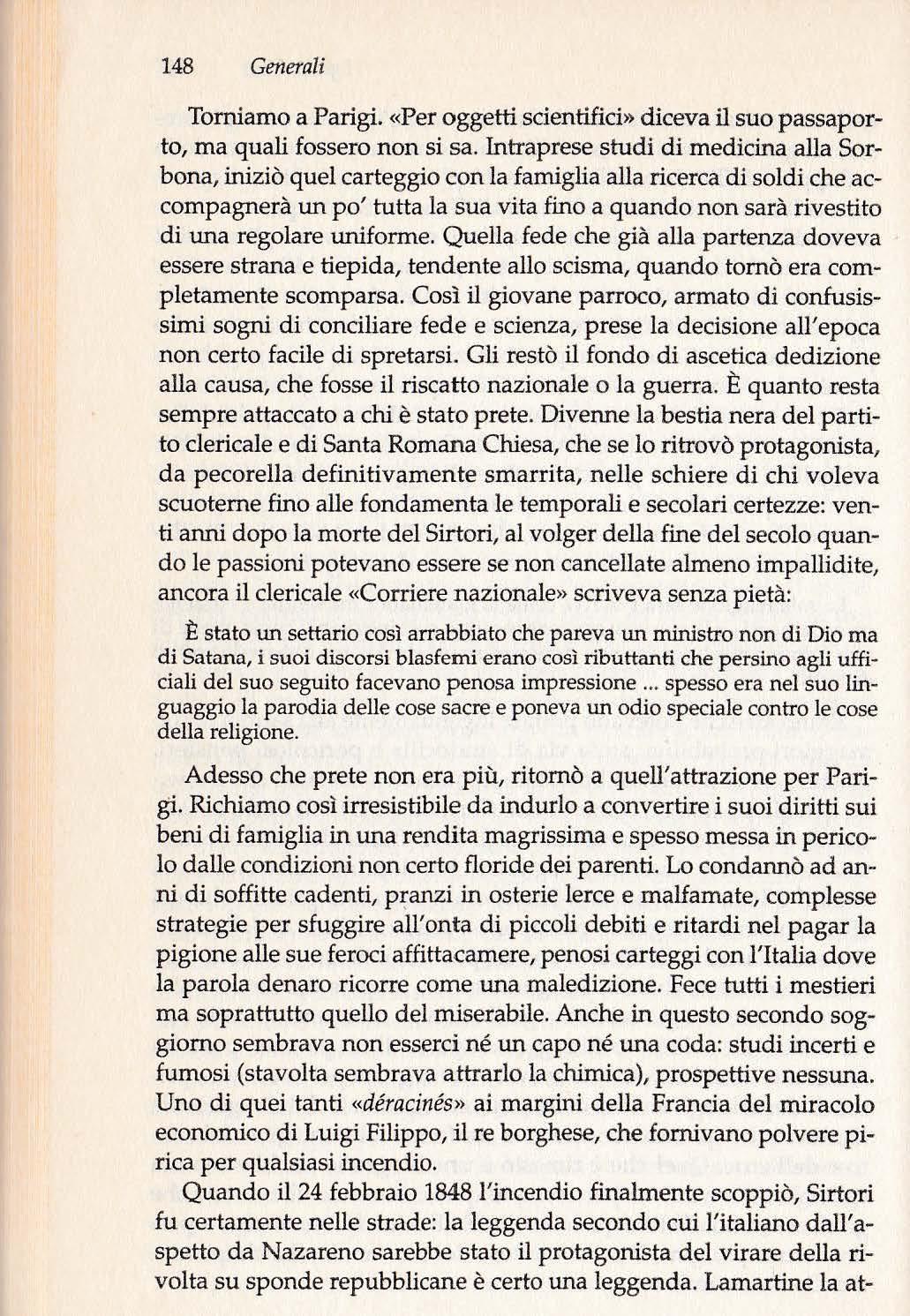
Adesso che prete non era più, ritornò a quell'attrazione per Parigi. Richiamo così irresistibile da indurlo a convertire i suoi diritti sui beni di famiglia in una rendita magrissima e spesso messa in pericolo dalle condizioni non certo floride dei parenti. Lo condannò ad anni di soffitte cadenti, ptanzi in osterie lerce e malfamate, complesse strategie per sfuggire all'onta di piccoli debiti e ritardi nel pagar la pigione alle sue feroci affittacamere, penosi carteggi con l'Italia dove la parola denaro ricorre come una maledizione. Fece tutti i mestieri ma soprattutto quello del miserabile. Anche in questo secondo soggiorno sembrava non esserci né un capo né una coda: studi incerti e fumosi (stavolta sembrava attrarlo la chimica), prospettive nessuna. Uno di quei tanti «déracinés» ai margini della Francia del miracolo economico di Luigi Filippo, il re borghese, che fornivano polvere pirica per qualsiasi incendio.
Quando il 24 febbraio 1848 l'incendio finalmente scoppiò, Sirtori fu certamente nelle strade: la leggenda secondo cui l'italiano dall'aspetto da Nazareno sarebbe stato il protagonista del virare della rivolta su sponde repubblicane è certo una leggenda. Lamartine la at-
tribtnva ai begli occhi della duchessa d'Orléans che avrebbe voluto diventare reggente. Un altro aneddoto agiografico lo vede a capo di una folla in tumulto ma ancora incerta su cosa fare, chiedere con piglio risoluto a un ufficiale che era a spasso per i fatti suoi di andare a prendere le armi. E alla risposta che le armi stavano in una caserma vicina l'italiano avrebbe assunto il comando di pochi animosi e avrebbe dato il la eroico uscendone con fucili e cartucce. Non ci crediamo. Anche perché i parigini erano così esaltati e nazionalisti da non aspettar certo uno straniero per rifinire la loro rivoluzione. Non era male comunque come debutto per uno che fino a poco prima era alle prese con ostensori e ostie.
Alla notizia dello scoppio delle Cinque giornate e dell'edizione italiana di quel Quarantotto si precipitò deciso a farsi valere. Non c'è pace, si sente odore di polvere e di rivoluzione, l'Italia ha sempre una nuvola nera in testa. Il 7 aprile era già a Milano dove il problema principale non sembravano gli austriaci, che pure stavano accampati a pochi chilometri e preparavano rivincite, ma la forma di governo: s udditi di Carlo Alberto o repubblicani? Sirtori diede le prime prove di quel bisogno di stupire e strafare che gli veniva dal!' abitudine prelatizia a parlare di assoluti (ne funesterà la carriera); unito a una natura che il linguaggio del tempo definiva ardente ma che noi preferiremmo chiamare sulfurea, dispettosissima, pronta a scambiar per offesa anche il più recondito cenno. Insomma un attaccabrighe ombroso e disponibile a incendiarsi per un nonnulla che gli scaverà il vuoto attorno tra mazziniani, garibaldini, monarchici e generali. Uomo di parte, bisognoso sempre e comunque di un nemico, della faz ione, fu l'anima del manifesto dei repubblicani, il falco tra i falchi. Tanto da mettere in ombra e far apparire tiepido e opportunista perfino Mazzini. Si votò sulla proposta di annessione al Piemonte e sul contromanifesto repubblicano: certo, con tutta la buona volontà di tener conto delle pressioni e dei limiti di quella consultazione, seicento vo ti contro seicentomila fanno pur sempre una bella impressione!
Forse era meglio dedicarsi alla guerra che incombeva sempre più serrata e l'ex prete fece regolare domanda di entrare tra i volontari: la mancanza di qualsiasi esperienza bellica, in quegli eserciti basati sull'entusiasmo, non era considerata un grave difetto; più importante la cultura, tanto che Sirtori venne subito eletto dai compagni capitano e il governo molto provvisorio gli rilasciò regolare brevetto con paga di otto lire al giorno. Alla sua bella truppa formata da «gioventù robusta inte lligente e piena di amor patrio» che difettava di uniformi ma «che diverrà elegante allorché sarà tinta di sangue te-
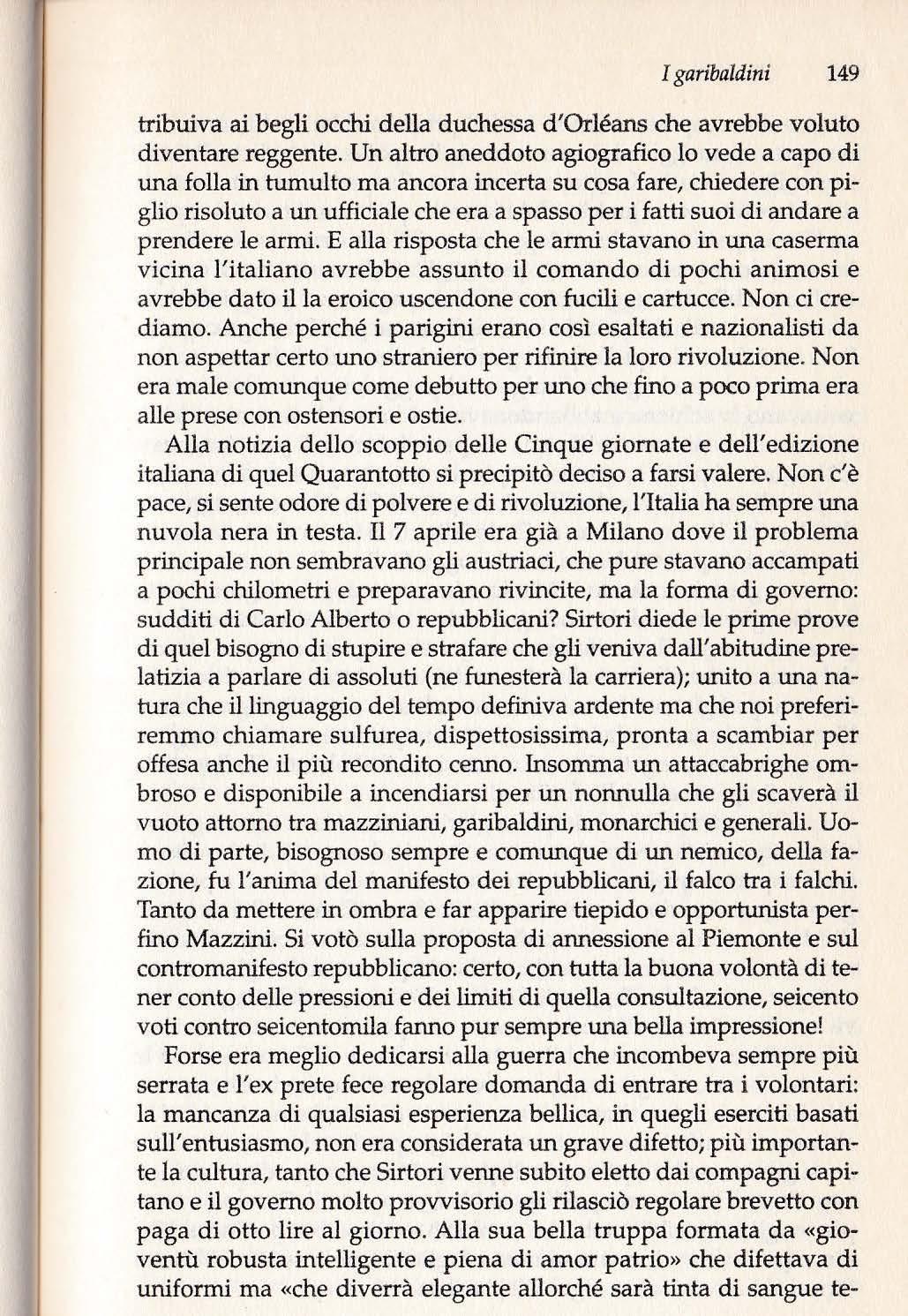
desco» il neocapitano rivolse un bel proclama che si chiudeva con un estremo omaggio al passato ormai alle spalle: «benedici o Patria i tuoi militi crociati». La gioventù robusta fu spedita in tutta fretta a difendere Venezia. Qualche dubbio sulle qualità militari del capitano Sirtori, partito con lo schioppo in spalla e la Gerusalemme liberata in tasca, doveva essere rimasto perché gli affidarono prima il compito di contabile del reggimento e ufficiale pagatore, e poi gli diedero un uncarico nella commissione di vigilanza ai panifici e agli ospedali. Lo tirò fuori da quella poco gloriosa burocrazia il furore rivoluzionario, mentre la guerra volgeva al peggio, i piemontesi battuti voltavano la schiena e abbandonavano i loro delusissimi sudditi; iniziava l'assedio reso celebre da «la peste infuria e il pan ci manca ». L'll agosto ai poveri commissari piemontesi che già si vedevano immolati alla rabbia popolare toccò, in piazza San Marco nereggiante di folla, dar l'annuncio che re Carlo Alberto li lasciava senza armi e senza flotta a provvedere ai loro bisogni. Dalla folla che cominciò a rumoreggiare invocando il Manin e la morte degli sciagurati saltò fuori un giovanotto dal viso angoloso in divisa dei volontari che, dopo aver arringato i manifestanti, ne guidò un gruppo su per le scale del palazzo ducale fino alla s tanza dei terrorizzati commissari. Di fronte a quel giovanotto «che era fuori di sé e a cui l'indignazione e l'ira soffocavano in gola la voce» deposero poteri e cariche e fuggirono prima d i essere gettati come minacciava il «bollente ribelle» dalla finestra in pasto alla folla furibonda.
La difesa di Venezia fu impresa gloriosa e inutile: il tipo di guerra che un tipo mistico ed esaltato come Sirtori adorava. Si distinse eccome! Proprio in quelle attività di commando che servivano a prolungare l'agonia ma non a cambiarne l'es ito finale. Come nell'incursione di Mestre : guidò duemila uomini all'assalto del sobborgo facendo scivolare i suoi nella fitta n ebbia e dando poi la caccia agli austriaci casa per casa. O al villaggio di Conche all'estremità della laguna, dove con cinquecento disperati riprese una posizione austriaca ricacciando il nemico per due chilometri verso Piove di Sacco. Scalava le cariche, Sirtori, era già maggiore, p oi colonnello quando diresse con mirabile tenacia la ritirata dall'avamposto di Marghera e i soldati lo chiamavano affettuosamente «san Luigi» per la calma serafica con cui si gettava nelle imprese più disperate. Ma non si prodigò solo n ella guerra: si batté anche nell'asse mblea, sempre ali' «Estrema», sempre tra gli irriducibili tanto che cominciò a dar ombra perfino al Manine passavano di mano in mano foglietti con la scritta «Volemo Sirtori abbasso Manin ». Ogni Silla ha il s uo Mario.
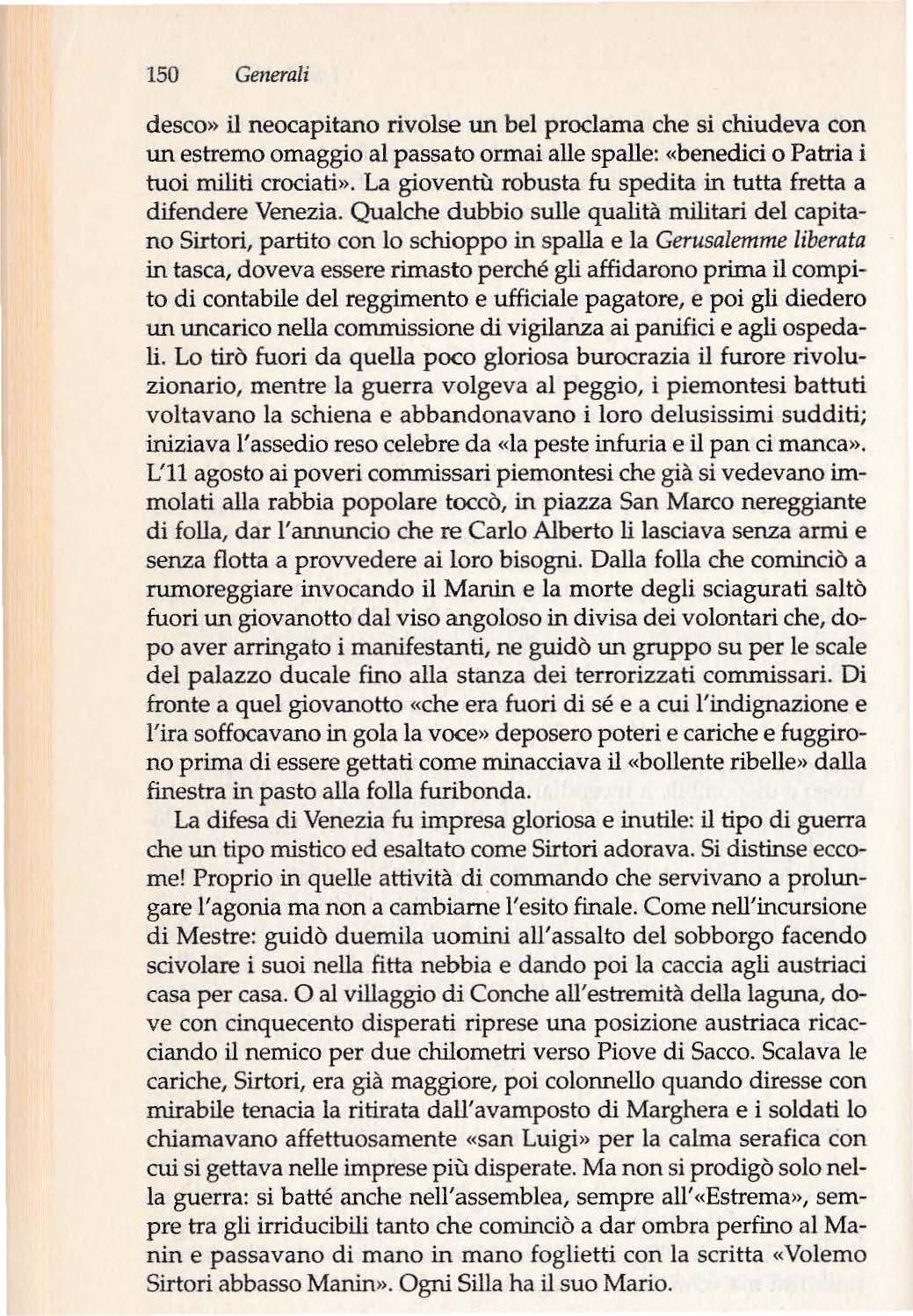
Erano inutili balletti sull'orlo del burrone: la città era stritolata dalla fame e dall'assedio, la gente cominciava a mugugnare perché la retorica di ultimo baluardo dell ' Italia libe rata non reggeva più. Circolavano manoscritti anonimi diffusi dai provocatori austriaci: «Forca al collo torto di Tommaseo o allo rinnegato Manine all'apostata Sirtori. Bricconi!. .. ». Peggio ancora minacciava il «cavalleresco» Radetzky, che tanto signore non doveva essere se lanciava proclami di questo tipo, esasperato dalle sortire di quel matto del Sirtori: «Ogni comune che vede avvicinarsi il nemico è obbligato ad avvisarne subito il nostro comando, se no il comune sarà trattato come traditore e sarà bruciato tutto il paese». Le usarono tutte gli austriaci per piegare quei pazzi di veneziani, perfino bombe legate a palloni aerostatici che dovevano annientare la città precipitando con l'esaurimento del combustibile. Aveva un bell'urlare il Sirtori che bisognava perire tra le rovine, la resa Vienna la voleva «piena intera e assoluta» e tra coloro che dovevano lasciare subito la città c'era anche nei primi posti dell'elenco un certo «Sirtori, prete lombardo». Dopo tanta truculenza s iamo così arrivati al terzo esilio parigino, quello segnato dalla prigionia nel manicomio di Bicètre. La mancanza di denaro, la miseria quotidiana (tanto che dalle sue lettere emerge chiara a un certo punto la volontà di uccidersi o il piano di andare in America a fare il contadino) non bastano per placare la sua selvaggia energia. Sirtori si getta con furia guerresca nelle beghe, litigi, rimostranze, regolamenti di conti che squassano la colonia dei fuoriusciti, un ambiente meschino, fatto di mafie private e di pubbliche enunciazioni di eroismo, retorica e bassi interessi mescolati senza ordine. Non guarda in faccia nessuno. Litiga con Mazzini scriven dogli cose peraltro vere che neppure i nemici più implacabili dell'apostolo h anno osato dirgli: «Mazzini è così impaziente di creare un popolo di Papa-Re che si fa insegnare come ognuno fa da papa e da re e proclama agli italiani: "o la mia credenza il mio simbolo la mia divisa o maledizione e scomunica ... " o falso profeta di Dio e del popolo» . Detto da un ex prete era certo vero, ma un po' forte. Ci si accapigliava, gli odi erano sanguinosi e malefici. Come nella vicenda che quasi certamente portò Sirtori in manicomio (sicurezze a distanza di più di centocinquan t'anni non ce ne sono). Brigava in quel periodo p er infilarsi n elle rivoluzioni d'Italia il principe Luciano Murat, figlio dell' eroe napoleonico; il Sirtori che si impicciava di tutto aveva pubblicato una lettera in cui non escludeva una soluzione murattiana come alternativa a quella dei Savoia . Erano scenari ancora totalmente ipotetici e con il Murat Sirtori , per

non smentirsi, litigò subito dopo. Apriti cielo: l'ambiente dell' emigrazione entrò in tempesta; perfino con Manin, con cui certo erano rimaste ruggini dai giorni di Venezia, iniziarono polemiche feroci, scambi di diffamazioni, oscure manovre p e r m e tte re l ' uno contro l'a ltro. A un certo punto Sirtori, che ved eva congiure e calunnie d a pp e rtutto probabilmente anche dove non ce n' erano, s pedì quattro cartelli di sfida , uno perfino a Murat che era cugino d ell'impe ratore. Poi un pome riggio scomparve . Con il passare delle settimane gli amici, sembra incredibile m a glien e resta vano e molti, cominciarono a preoccuparsi anche perché conoscevano le sue dispe rate condizioni economiche. Sottoposero a interrogatorio il padrone di casa che sosteneva che e ra partito per un viaggio. Incalzato, confessò che lo avevano trascinato al manicomio e costretto a raccontare a tutti quella pietosa bugia. Si precipitaro no, lo trovarono ormai allo stremo a vagare tra i pazzi. Solo dopo scenate e proteste ottennero un colloquio con il direttore che però, per dimetterlo, pretese che firmasse che era stato ricoverato perché afflitto da a lte r azion e cerebrale. Si temette lo scandalo; i congiurati a cui certamente era lega to il principe Murat e le sue aderenze a palazzo tremavano di fronte a quell'implacabile rivoluzionario, ce rcavano di cancellarne le tracce. Ci volle p azienza e chiasso per tirar fuori Sirtori dalle mura d el manicomio. A fe rmare commenti e accuse non bastò nemme no la scusa di un errore della po lizia. Pacata e a ttenta ai particolari, com e sempre, fu la versione fornita d al «Tunes»:
Uno dei più grandi patrioti italiani che si portò con sommo valore a Venezia, Giu seppe Sirtori, scomparve improvvisamente. Pare c h e s ia un deciso antimurattista e che abbia avuto un'aspra discussione con tre ca ldi aderenti del principe: Montanelli, Saliceti e Maestri. Solo dopo undici g iorni g li amici scoprirono il Sirtori nel manicomio di Bicètre. Si diressero allora alle autorità e fu liberato. Un certificato medico dichiarò che non c'era in lui ombra di pazzia. Eppure gli fu applicata per tre giorni la camicia di /orza. Si crede a un equivoco d i un poliziotto. Però simili violenze potrebbero realmente produrre la pazzia . Sopportò l'oltraggio con calm a padronanza di sé.
La s u a vita si esauriva in que l po' di gloria delle giornate del 1848. Di Parigi e della Francia ne aveva davvero abbastanza anche perché in Italia si riprendeva a m enar le mani. Partì. Era d estino ch e quella guerra non la dovesse combattere. Eppure aveva inviato appena arrivato a Torino una domanda di arruolamento al ministro d ella Guerra:
Desiderando di prender parte alla guerra d ell'Indipendenza nell e fil e dell 'esercito piemontese possibilmente nei ca va lleggeri domanda la dispensa relativ a a ll'età onde essere arruolato come semp lice volontario per tutto il te mpo della guerra in via di eccezi one a i regolamenti in vigore.

Evidentemente i regolamenti in vigore non tolleravano eccezioni perché nessuno gli rispose. Non lo vollero nemmeno tra i Cacciatori d i Garibaldi: non certo perché si riteneva poco opportuno arruolare un reduce dal manicomio ma p erché, si disse, il solito Murat che lo perseguitava con odio funes to a veva segnalato il suo nome al cugino Napoleone.
Si consolò facendosi eleggere deputato nel nuovo Parlamento italiano: evidentemente l 'eco delle sue imprese nel 1848 non si era ancora spento, ma lo assediava sempre quella cronica m ancanza di denaro. Al m o m ento d ella cerimonia di apertura d e ll e Camere non disponeva di un abito decente per partecipa rvi e fu costretto p e r l'ennesima volta a chiedere al fratello «qu a ttro, cinquecento lire p erché far debiti non posso né debbo in alcun mod o ... ».
Quando scoppiò il maggio radioso dei Mille, Sirtori aveva quarantasette anni ed era, diciamolo pure, un fallito . Eppure tra intrighi incertezze difficoltà organizzative bas tarono poche miglia di mare perché il pazzo di Bicètre diventasse il braccio destro d el generale. Garibaldi di animosi e s fegata ti ne aveva appunto mille, a lui non mancava l'astuzia tattica che è la dote migliore del guerrigliero; quello che non aveva era un organizza tore, un pianificatore di battaglie, un capo di s ta to maggiore insomma anche se la specialità di manager della guerra ancora non era stata inventata . Sirtori glie la offri e in questo senso fu davvero il primo dei Mille, come scrisse Garibaldi su un foglietto ancora conservato dove il suo nome compare in cima alla lista del gotha garibaldino. Val la p ena di riportare un brano della le ttera che Sirtori scriss e al fra tello il 5 maggio, mentre Bixio abbordava le navi d el Rubattino: Partendo per una impresa mo lto arrischiata ti scrivo due righe per raccomandarti ciò che ti raccomanderebbe un padre in caso simile. Tu pagherai i miei debiti con c iò che mi d evi. Se muoio il resto del mio poco avere è per te ... Onorate la mia memoria colla vostra onoratezza e con la vostra fraterna c o n cord ia . Ricordatevi che la probità vale più d e lla ricchezza, c h e la virtù è i l p rimo dei be ru e il solo che sia sempre in vostro p otere.
Inutile correre dietro ai mille episodi in cui Sirtori fu protago nis ta nella campagna del Sud. Con un frus tino in mano a Calatafimi q uando galoppava davanti alle linee tra un dilu vio di fuoco, e sopra ttutto ogni qual volta c'era in ball o qualche decisione difficile lui «con la voce sommessa e lo sguardo pietoso» come diceva La Masa ch e lo detestava, sapeva sempre portar Garibaldi verso le sue posizioni. G li scappava ogni tanto ne lle le tte re qualche tono un po' esagerato, la soddis fa z ione del proprio coraggio e, parliamoci chiaro, anche qualche bugia:

La nostra spedizione è una serie non interrotta di miracoli. Garibaldi è assai spesso più soldato che generale e si abbandona alla sorte col fa talismo di un musulmano. A Calatafimi fu per esser preso con la bandiera. Io salvai lui e con lui tutto il corpo di spedizione: fu il più bel giorno della mia vita! Egli dava a me la presa di Palermo. A Palermo quando già si trattava per l'armistizio fui ferito nel petto. La palla mi solcò le carni fino alle ossa senza offendere né quelle né le parti interne. Ora è quasi interamente guarita.
Di questo miracolo non esiste altra versione se non quella di Sirtori e viene da credere che se l'era proprio inventata. La fiducia di Garibaldi peraltro l'a veva guadagnata facendo sì che le camicie rosse (che erano diventate migliaia) potessero risa lire la penisola, attraversare lo Stretto, ogni giorno mangiare camminare combattere . Ma non e r a solo un pianificatore. Al Volturno fu lui che, bloccand o la colonna Perone, una scaglia dell'esercito napo letano che baldanzosa marciava ve rso Caserta e stava per realizzare un aggira mento, tenne fermo e guadagnò la v ittoria . Di lui il generale non aveva mai dubitato tanto che a chi gli prospettava a ll armato già il disastro, disse calmissimo: «Non preoccupatevi. A Caserta c'è Sirtori e bas ta».
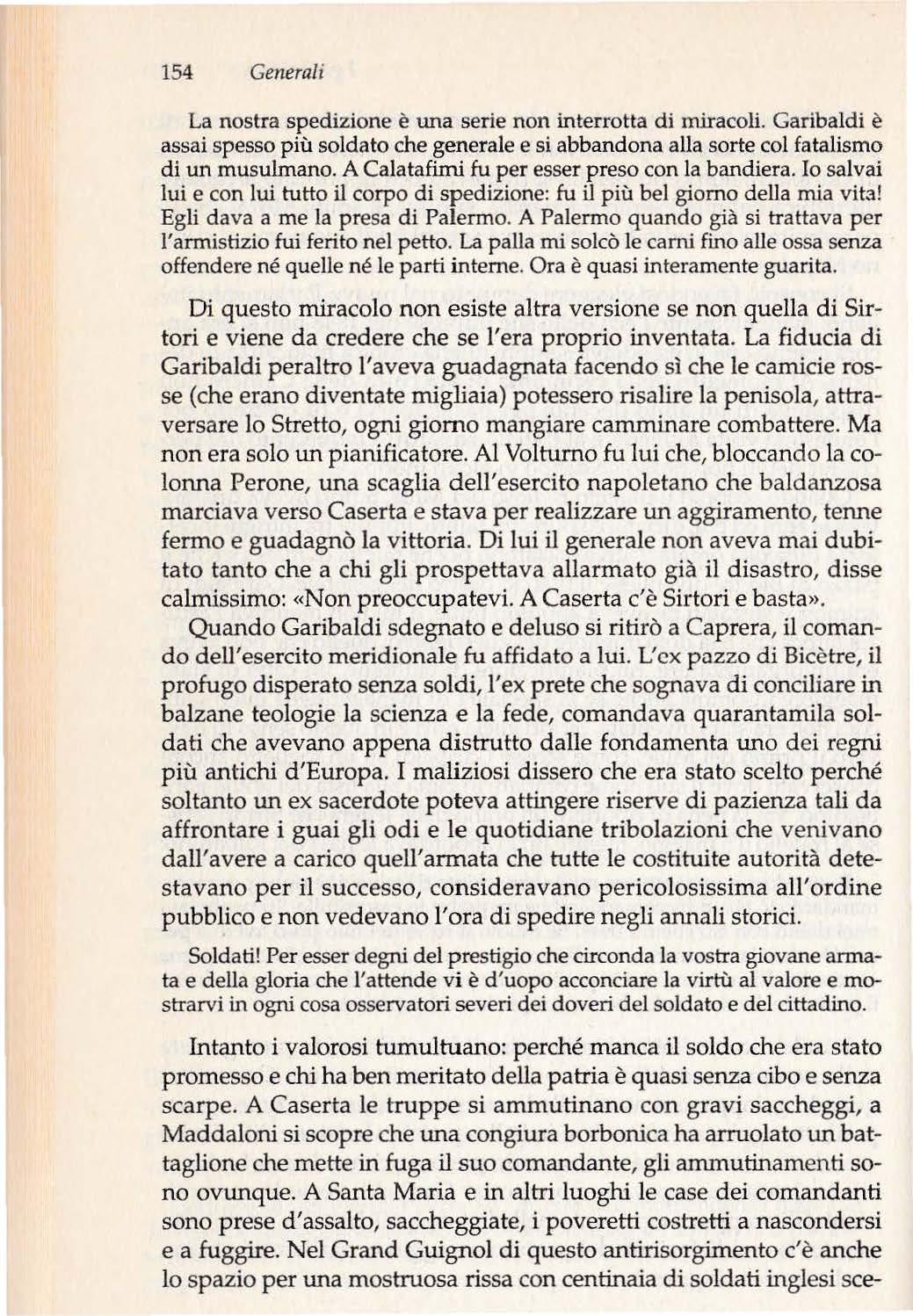
Quando Garibaldi sdegnato e deluso si ritirò a Caprera, il comando dell'esercito meridionale fu affidato a lui. L'ex pazzo di Bicètre, il profugo disperato senza soldi, l'ex prete che sognava di conciliare in balzane teologie la scienza e la fede, comandava quarantamila soldati che avevano appena distrutto dalle fondamenta uno d e i regni più antichi d'Europa. I maliziosi dissero che era stato scelto perché sol tanto un ex sacerdote poteva attingere riserve di pazienza tali da affrontare i guai gli odi e le quotidiane tribolazioni che venivano dall'avere a carico quell'armata che tutte le costituite autorità d etestavano per il successo, consideravano pericolosissima a ll 'ordine pubblico e non vedevano l'ora di spedire negli annali storici.
Soldati! Per esser degni del prestigio che circonda la vostra giovane armata e della gloria che l'attende vi è d'uopo acconciare la virtù al valore e mostrarvi in ogni cosa osserva tori severi dei doveri del soldato e del cittadino.
Intanto i valorosi tumultuano: perché manca il soldo che era stato promesso e chi ha ben meritato d ella patria è quasi senza cibo e senza scarpe. A Caserta le truppe si ammutinano con gravi saccheggi, a Maddaloni si scopre che una congiura borbonica ha arruolato un battaglione che mette in fuga il suo comandante, gli ammutinamenti sono ovunque. A Santa Maria e in altri luoghi le case dei comandanti sono prese d 'assalto, saccheggiate, i poveretti costretti a nascondersi e a fuggire. Nel Grand Guignol di questo antirisorgimento c'è anche lo spazio per una mostruosa rissa con centinaia di soldati inglesi sce-
s i a terra per la licenza, che per poco non si trasforma in sanguinosa battaglia. Ha ragione Sirtori nel suo ultimo proclama: «A voi soldati della Patria e della Libertà è forza essere eroi o non essere».
L'epopea è finita, tutti a casa. La liquidazione dell'impresa, latriste prosa dei sei mesi di indennità e dell'accasermamento quasi punitivo al Nord per scoraggiare i tiepidi e toglier energie anche agli entusiasti, insomma la grande epurazione burocratica a cui riesce quello che era fallito al cannone dei Borboni spetta a Sirtori e al suo implacabile rigore. Anche lui come Bixio adesso è luogotenente generale di quelli veri, anche se gli hanno affidato il comando di quell'armata di volontari, composta solo da ufficiali e senza soldati con cui hanno camuffato la liquidazione dell'armata garibaldina. Si è tirato dietro l'odio di tutti: dei ministeriali e dei generali di scuola che lo considerano un parvenu dalJa biografia sconcertante, e dei suoi ex colleghi che gli rimproverano di aver per ambizione preso la carica che solo Garibaldi aveva il diritto di avere. Medici e Tiirr, con i quali aveva diviso pericoli e battaglie, gli si voltarono contro. La t ensione era terribile e il generale nel quotidiano combattere sembrava perdere quel controllo di sé che aveva conservato perfino nelle orribili camerate di Bicètre. Tanto che durante un dibattito in Parlamento, era sempre deputato, gli scappò detto che l'esercito regolare era andato al Sud non per battere i Borboni «ma per combattere noi che eravamo l'Italia » e che «noi avremmo combattuto anche contro questo esercito. L'esercito che veniva contro di noi non poteva essere italiano». Forse era vero, ma non lo si poteva dire. Si scatenò un pandemonio e Sirtori fu costretto a ricorrere all'umiliante trova ta di affermare che era stato frainteso e a far marcia indietro. Restava però Sirtori. I soldi continuavano a non bas targli mai; quando ricevette il rendiconto degli arretrati che gli spettavano per la campagna del 1860 come prevedeva la nuova legge liquidatoria delle glorie garibaldine, si accorse sommando stipend i e indennità di campagna che le ventiduemila lire e rotte non erano cifra corretta, e inviò al ministero una lettera di correzione in cui fissava le sue spettanze a sole diciottomila lire! Già interame nte incassa te. E così ritornava per l'ennesima volta povero. Non era rose e fiori la sua nuova carriera. Anche perché la burocrazia ministeriale non perdeva occasione per tagliargli l'erba sotto i p iedi e fargli capire che le greche sulle maniche le aveva, ma era pur sempre un avventuriero capitato lì solo per necessità politiche. Lo s pedirono chissà quanto perfidamente in Calabria a combattere i briganti: non era una cattiva idea. Solo i garibaldini, che invece era-
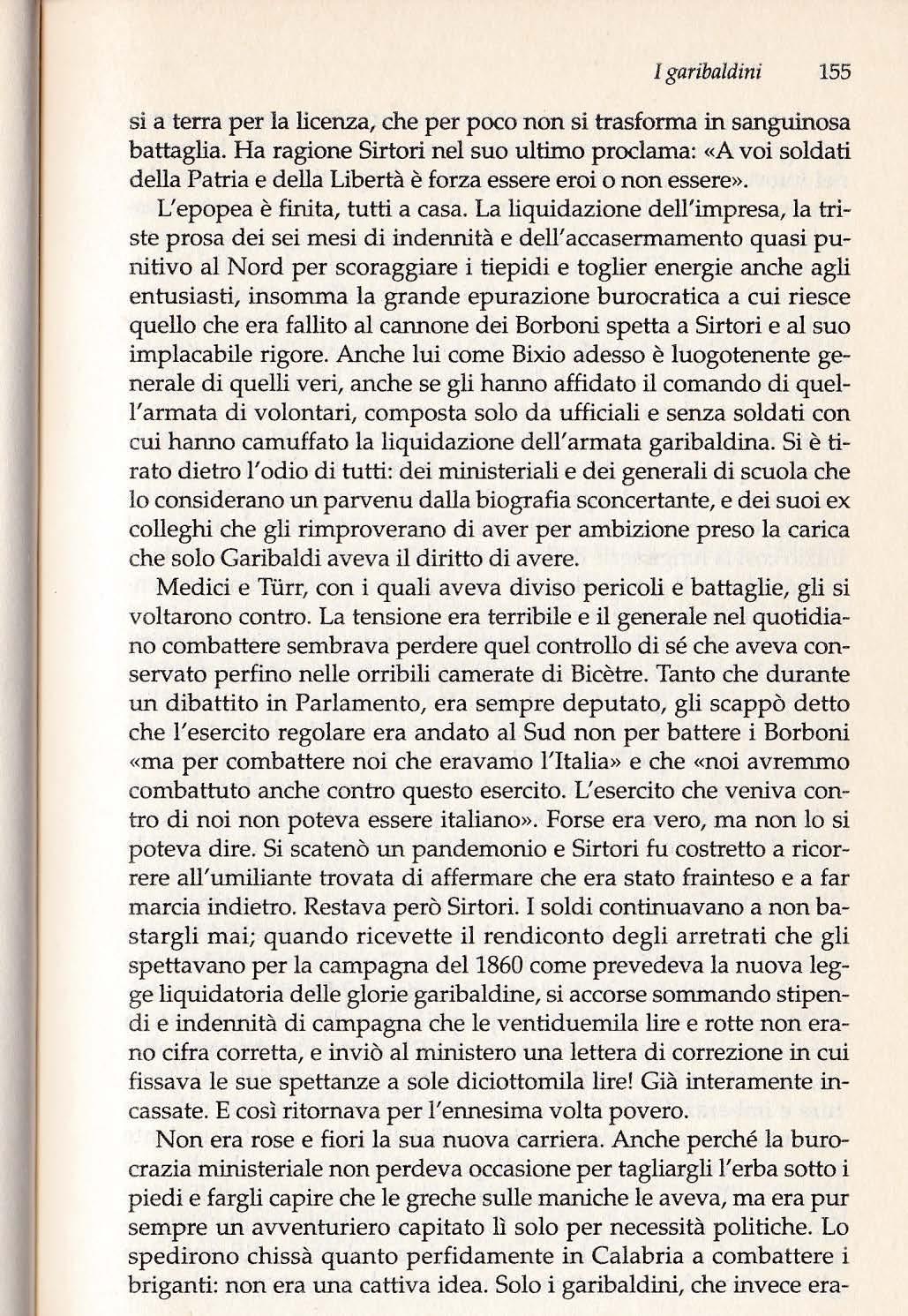
no stati manda ti a casa, si sarebbero battuti efficacemente contro quei guerriglieri. Lui si buttò, co m e era s uo costume, a lla baionetta n el nuovo incarico : redasse un appello ai briganti perché abbandonasse ro «il loro scellerato mestiere». Po i, come se fosse in s tato di assedio, prese in m an o tutti i poteri, scrivendo chiaro e tondo in una comunicazione ufficia le che «la camorra brigantesca ha radici in tutti g li strati sociali e oso dire in tutti i pubblici uffici » e convocò i nota bili a una sorta di summi t in cui annunciava l'istituzione d i un'assicurazi on e antiracket e la linea d ura nei confronti dei sequestri che erano la principale fonte di finanziamento dei briganti: chi pagava sar ebbe stato denunciato e lascia to a l s u o d estino. Erano idee mod erne ma gli costa ro no un rabbuffo furi oso d e l La Ma rmora, l a rivolta dei possidenti e la consta ta zione ironica di quelli che conoscevano bene il Sud e gli o pposero ch e i ricchi sarebbero sta ti i primi a quel punto a concertar r icatti coi banditi per dividersi i guadagni! Iniziò così la lunga serie delle sue dìrnissioni regolarmente accettate. Na turalme nte il giorno dopo la sua partenza i provvedimenti vennero imme diatamente revoca ti.
In attesa ch e anche Sirtori si ritrovi con tutti gli altri protagonisti sui fatali campi di C u s toza si può raccontare un piccolo episod io che spiega be n e qu a le fosse il clima tra i nos tri generali e com e l 'esito infaus to di quella battag lia n on fosse il frutto di sfortu na. Le manovre erano quell'anno, nel settembre 1864, fissa te al campo di Somma: appuntamento sempre delicato per un gen eral e perché di fronte al re era una buona occasion e per far be lla fi g ura e conquistare il sospirato «sca tto». Con p erfidia o ins ipie n za (forse più l a prima che la second a) il divisiona le Sirtori e ra stato messo agli o rdini di Alessandro Nunziante duca di Mign ano, ex luogote n ente di due re Borbone, uno di quegli abili traditori che avevano trova to casacca e riverite fortune sotto i Savoia. Come non prevedere che tra i due ex nemici non corresse buon san gue? Di più : a ca u sa d ell'alterigia di Sirtori s t agnava proprio un o dio feroce pronto a esplodere. Era il grande equivoco del Risorgimento che rampollava, dove si era fa tto tutto acconciando fingendo radd r izzand o s to rture e imbarazzi a furia di compromessi. I due litigarono subito e di brutto. Fece ro circol are storie di ufficiali prelevati dal Nunziante e che senza esperienza diretta di quanto dovevano fare sbagliarono manovre . Il Nunziante, a c ui non pareva vero di approfittarne e fo rse aveva costruito a pposta l'incidente, pubblicamente rimprover ò Sirtori, anche perché quella carriera così p oco edificante non g li ave va cambiato caratte re e conservava la prosopopea di quan-

do comandava le evoluzioni dell'armata napoletana. Sirtori non aspettava altro: era proprio come lo descriveva Petrucelli della Gattina, una sorta di Procopio di Cesarea dei retrobottega del nostro Risorgimento:
Parla poco e mai per non dire nulla. Ride di rado. Non conosce alcuno dei piaceri della vita e della giovinezza. Fu prete. La rivoluzione e l'Italia lo rapirono alla Chiesa. È adesso generale e capo di stato maggiore. Dovunque tuona il cannone per la patria, Sirtori si trova tra le prime file. Nell'esilio dove urtò con tutte le prove, morse a tutte le miserie degno partigiano disdegnoso. Il suo difetto è l'eccesso di coraggio. Su quella figura il destino ha impresso qualcosa di misterioso che colpisce l'osservatore e il superstizioso.
Era un bel modo per dire che molti con quell'aspetto ieratico lo prendevano per iettatore. Comunque aveva un brutto carattere. Scatenò un' offensiva a base di lettere al capo di stato maggiore, al ministero della Guerra, al re. Pretese, con una prosa davvero brusca e garibaldina per esser scritta da un subordinato, scuse pubbliche, come era stata l'accusa. Non si finì più: i comandi, stremati da ricevute in duplice copia, si videro arrivare addosso le inevitabili richieste di dimissioni di Sirtori che le aveva prontissime con annessi corte di disciplina, processi controaccuse. Pensarono di salvarsi respingendole e dandogli una licenza. Niente da fare : il tono con cui Nunziante gli aveva concesso la licenza non piacque al generale. Sembra va il licenziamento di un dipende nte, e annunciò che sarebbe andato al galoppo a Torino per inoltrare un reclamo direttamente al ministero. Alla fine gli diedero torto anche se, all'italiana, evitarono di prender provvedimenti. Difficile finisse diversamente poiché il ministro Petitti non aveva dimenticato che Sirtori nella foga di una disputa parlamentare aveva definito quel ministero «una sciagura nazionale»!

A Custoza comandava la Quinta divisione ed era ben deciso a usare anche quella volta come regola il suo motto «a ogni costo! ». La s ua guerra era già di quelle assolute, spirito del bene contro spirito del male. Nell'Ottocento non si usava ancora, dovremo aspettare il secolo delle idee assassine. Si incanalò subito in quel guazzabuglio con cui stavano dilapidando la nostra netta superiorità:
Il 6 maggio ero al mio posto. Ma al quartier generale del corpo di armata non trovai che due sottufficiali e al quartier generale della mia divisione n o n trovai né un ufficiale né un soldato! I vari uffici non furono costituiti che verso la fine di maggio; ancora a tale epoca si dovevano completare i servizi di stato maggiore, di trasporto, di sussistenza; mancavano ancora molti soldati delle classi in congedo che si presentavano alla spicciolata. Non fui al completo che pochi giorni prima della dichiarazione di guerra.
Gli diedero l'ordine di passare il Mincio la sera del 22 per il mattino seguente e soprattutto gli die d ero ordini molto, trop po vaghi: «Incontrando al caso forte resistenza non si deve insistere né ostinarsi soverchiamente». Che cosa voleva dire «soverchiame nte»? Anche se non aveva frequentato l'accademia bensì il seminario Sirtori, che per il di abolico aveva un certo orecchio, intuì subito che n ell'approssimazione genera le si lasciava volutame n te una grand e vaghezza: se fosse andata male la se tta piemontese avrebbe potuto, con qualche opportuna interp reta zione linguistica, rovesciare tutte le colpe s ui subordinati che avevano mal applicato il soverchio... Così la s ua divisi one avanzò prima animosamente ricacciando indietro anche gli austriaci p oi, tag liata fuori dal resto dell'esercito che erarimasto immobile o aveva rip iegato, dovette ritirarsi con alcuni rep arti s legati e in d isordine. A caldo, con la ritirata che gli infuriava alle spalle, commen tò cos ì:

Ve d evo tanti e rrori e tante colpe intorno a me che ogni sera dicevo con sollievo: «Anche oggi il n emico n on h a s aputo approfittarne» . Ricevetti l'ord ine di marcia il 23 poco prima di sera per m etterlo in esecuzione a lle qua ttro antimeridiane del 24 e pe r di più esso non conteneva nessuna is truzione n é indicazione precisa. E quel che è p eggio, n on parrebbe vero, è ch e n essuniss ima istruzione si ebbe ne l caso di un attacco nemico né di un insuccesso nostro. Fu d e tto p oi che fummo «sfortunati»! Noi invece fummo fortunatiss imi perché abbiamo pagato ancora a buon mercato assai, assai, l' ine sperienza me ravigliosa d e i nos hi superiori comandi.
E qui, nei superiori comandi, il d estino giocò un altro brutto tiro a Sirtori: la ferita ch e tolse di mezw Durando lo mise per la seconda volta sotto gli ordini di un «traditore» borbonico, il distinto Pianell. Tra napoletani e garibaldini la gue rra e ra dichiarata, e l'episodio di Somma aveva contribuito ad alzare i livori. Per di più Sirtori, che subodorava odore di frega tura, aveva dopo la battaglia ri volto ai s uoi ufficiali un ordine d el giorno di brutale semplicità: «Gli austriaci ci hanno dato una bella lezione e bisogna che n oi sappiamo approfittarne» . Per questo aveva chiesto rapporti chiari precisi senza reticenze, minacciando punizioni esemp lari a chi cercava scu se o dicev a bugie per nascondere g li e rrori commessi. Lo convoca ro n o al comando del Primo corpo di a rmata ins ie me agli altri di v is ionali . Il Pianell, con il s u o inte rcala r e n apoletano, invece di discute re della battaglia fece un fervorino risentito s ulla disciplina: «Ho notato un grande d isordine che mette a repentaglio l ' esistenza s tessa d ell' esercito. Fr a l 'altro alcuni soldati si perme tto no di sparare il fucile per ri-
p ulirlo .. . In nome del re io ordino che qualunque soldato sia colto a s parare venga immediatamente e senza processo fucilato».
Sirtori, che si aspettava ben altre discussioni e progetti magari di controffensiva, non ci vide più: ribatté che quegli ordini di fucilazion e erano illegali perché contrari al codice militare; per di più emanati in nome del re abusivamente e tali da rovesciare sul sovrano, che non sapeva nulla, la riprovazione per simili brutalità. Sirtori mise n ella replica quella foga che trasformava sempre i suoi rapporti con i s uperiori in un'avvisaglia di ammutinamento. Pianell la definì «dis cussione muliebre» e ribatté che, se proprio insisteva, poteva confermare l'ordine a nome proprio. La guerra era dichiarata, ed era solo la prova generale. Il 25 giugno, visto che La Marmara, impegnato in dimissioni e controdimissioni, non aveva rivolto alle abbacchiate truppe che invocavano la rivincita neppure un telegramma, si fece p render la mano e diffuse un roboante proclama ai soldati della Quinta:
Il 24 voi non foste indegni dei vincitori di San Martino. Respingeste e inseg uiste il nemico che vi era di fronte e già era assicurata e proclamata la v ostra vittoria quando io ordinai la ritirata1 perché la ritirata della Prima d iv isione della riserv a d e l Primo corpo di armata ci aveva scoperto interamente il lato sinistro e compromesso le comwùcaziolli con la riva destra del Mincio .. .
Noi teniamo come bibbia per questa battaglia il bel saggio che il generale Pallio dedicò a quei fatti quando i vapori delle polemiche erano spenti. Era una versione accettabile. Ciò che era sbagliato e p ericolosissimo era mettere nero su bianco in un proclama alle trupp e nomi e cognomi di colpevoli della sconfitta. La regola fondamentale tra i generali era il rispetto della più riguardosa omertà; non si mettevano in piazza gli errori: semmai la resa dei conti si faceva all' interno della setta. Con il cannone ancora caldo di raffiche e il nemico a pochi chilometri si rischiava di disintegrare la coesione di un esercito anche più solido del nostro. Ma questo forse avrebbe costituito una crisi definitiva e liberatoria; senza un dibattito sulle colpe della sconfitta si finiva per porre le premesse di nuovi errori. Sirtori fece leggere il proclama appena scritto al suo fedelissimo capo di s tato maggiore, il Moneta, che con mille riguardi, conoscendone il carattere, lo definì «un po' forte». Lo avverti che avrebbe sollevato guai. Per carità! A sentire l'odore della polvere gli era già venuta una gran voglia di buttarsi nella mischia con furore da martire. Delle polemiche non gli importava e con fare misterioso aggiunse che «il re sarebbe stato dalla sua parte». Il proclama appena diffuso fece più

effetto dell'attacco dei fanti dell'arciduca Alberto. Gli altri comandanti, soprattutto quelli così poco amichevolmente citati, si precipitarono da La Marmora, che prese carta e penna:
È con dispiacere e sorpresa che ho avuto partecipazione di un suo ordine del giorno alle truppe ... taH asserzioni sono vivamente combattute dai comandanti di tali truppe e non vi è ragione di prestar maggior fede alla signoria vostra; ma fosse pur vero quanto Ella asserisce, non può essere lecito a un generale spargere germi di scissura fra truppe che combatterono e torneranno a combattere insieme. Simile fatto è senza precedenti nell'esercito italiano e perciò le ri volgo severa ammonizione onde in avvenire ella non abbia più a scostarsi nelle parole che crederà indirizzare a lle sue truppe da quella formale riserva che sempre deve caratterizzare gli atti di chi copre un sì elevato posto nella militare gerarchia.
Si poteva ancora uscire dal guaio in cui si era infilato per via, diciamo, gerarchica: far ricorso al minis tro, chiedere un'inchiesta; tutto si sarebbe stemperato e sarebbe rimasto li, in que lla ammo nizione. Sirtori invece decise sciagura tamente di alzare la posta: il suo era un mondo di assoluti: verità contro bugia, torto contro ragione. Ma questa era l'etica, non il mondo dei generali. Così rispose direttamente, come se si fosse tra pari grado, al capo dell'esercito:
Ho la convinzione di non meritare l'ammonizione datami dall'Eccellenza Vostra con foglio del 3 luglio. Conosco le combriccole ordite per falsare la verità dei fatti del 24 giugno, ma confido nella forza della verità e nella lealtà dell'Eccellenza Vostra e del Re. Che se dovessi anche stavolta esser vittima degli intriganti come tante volte lo fui dal 1861 in poi, sono fermamente risoluto a chiedere le dimissioni dal militare servizio, perché vi sono nella lettera di Vostra Eccellenza alcune parole che io non posso lasciar passare inosservate. La parola di Giuseppe Sirtori non ammette dubbi da parte di chicchessia.
Era più che una lettera di sfida: era il manifesto di un ammutinamento. Un po' perché spiattellava l'esis tenza di combriccole che avevano interesse a tener nascosta la verità sulla battaglia, indicando quindi dei colpevoli e smentendo la versione ufficiale che s i stava faticosamente formando e che parlava di «giornata sfortunata»; e la sfortuna non ha padri. E poi perché tirava in campo il re chiedendogli di decidere da che parte stava la verità.
La Marmora colse subito il pericolo. E con sottile perfidia ordinò al Pianell, il superiore diretto di Sirtori, di rimuoverlo dal comando e ordinargli di res tare a Piacenza in attesa di disposizioni. In quelle ore, dopo aver salutato i suoi ufficiali «atterriti», Sirtori cominciò a capire che cosa stava per franargli addosso. I suoi nemici avevano intuito che se la sua colpa era stata di «etichetta militare» (essersi ri-
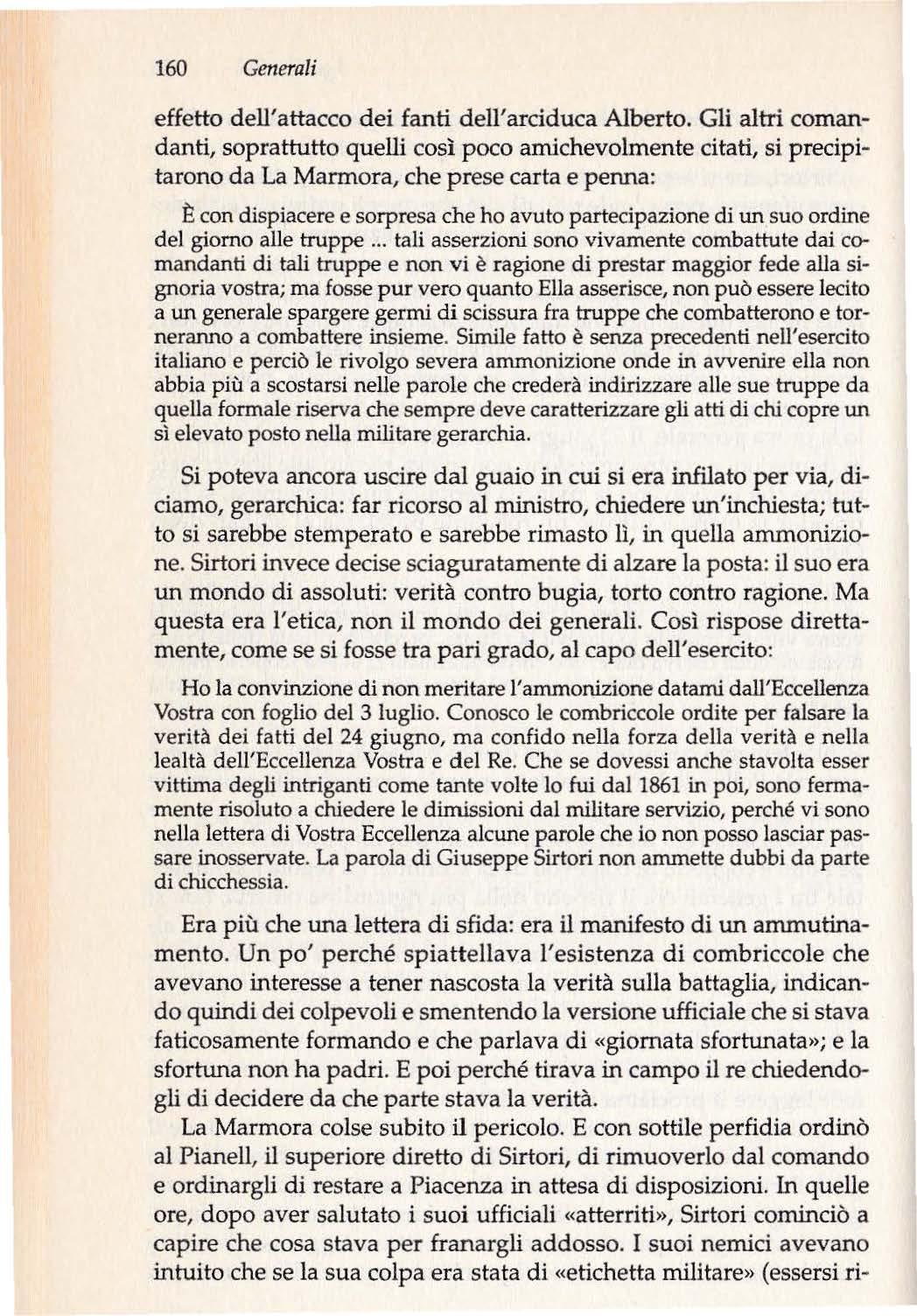
volto a un superiore senza stile e senza senso della disciplina), si poteva ben sfruttare l'occasione per vendicarsi rovesciandogli addosso utilmente altre e maggiori responsabilità. Così attorno all'ex garibaldino si scatenò sui giornali una vergognosa campagna diffamatoria ispirata dai colleghi che puntava a fame il responsabile della sconfitta: si disse che era stata la sua ritirata oltre Valeggio a scombinare le carte, che non aveva avuto né senno né coraggio.
La battaglia disperata e inutile di quell'uomo per difendersi cominciò con la richiesta al primo ministro Ricasoli di una commissione d'inchiesta che ne chiarisse le responsabilità e fissasse finalmente le colpe per quel giorno sciagurato:
Signor barone, l'ono re offeso e la vilipesa affezione del soldato non meno che la dignità di uomo e i doveri di cittadino mi obbligano a scuotere l' ignobile e iniquo giogo di La Marmara e compagni ... finché mi rimanga un alito di vita combatterò a oltranza l'infame camorra militare che offende l'esercito e il trono e perde e disonora l'Italia . Col profondo e incrollabile sentimento del dove re chiederò altamente, pertinacemente, irremovibilmente che il capo di stato maggiore e i comandanti dei prinù tre corpi di armata siano sottoposti a consiglio di guerra come veri e soli autori della disfatta del 24 g iugno
Soltanto chi avesse frequentato le vette sublimi del sacrificio cristiano poteva gettarsi in una battaglia del genere: solo, senza partiti alle spalle, chiedeva che la classe politica - che era complice e consapevole - mettesse sotto processo la classe dei generali in un autodafé da cui il paese e l'esercito dovevano uscire mondi da peccato! Era impossibile. Eppure lui si illudeva. Scriveva a Depretis, che gli era amico ma con le untuose prudenze che erano tipiche del personaggio, e infatti non fece nulla. Poneva domande che non potevano sembrare ingenue:
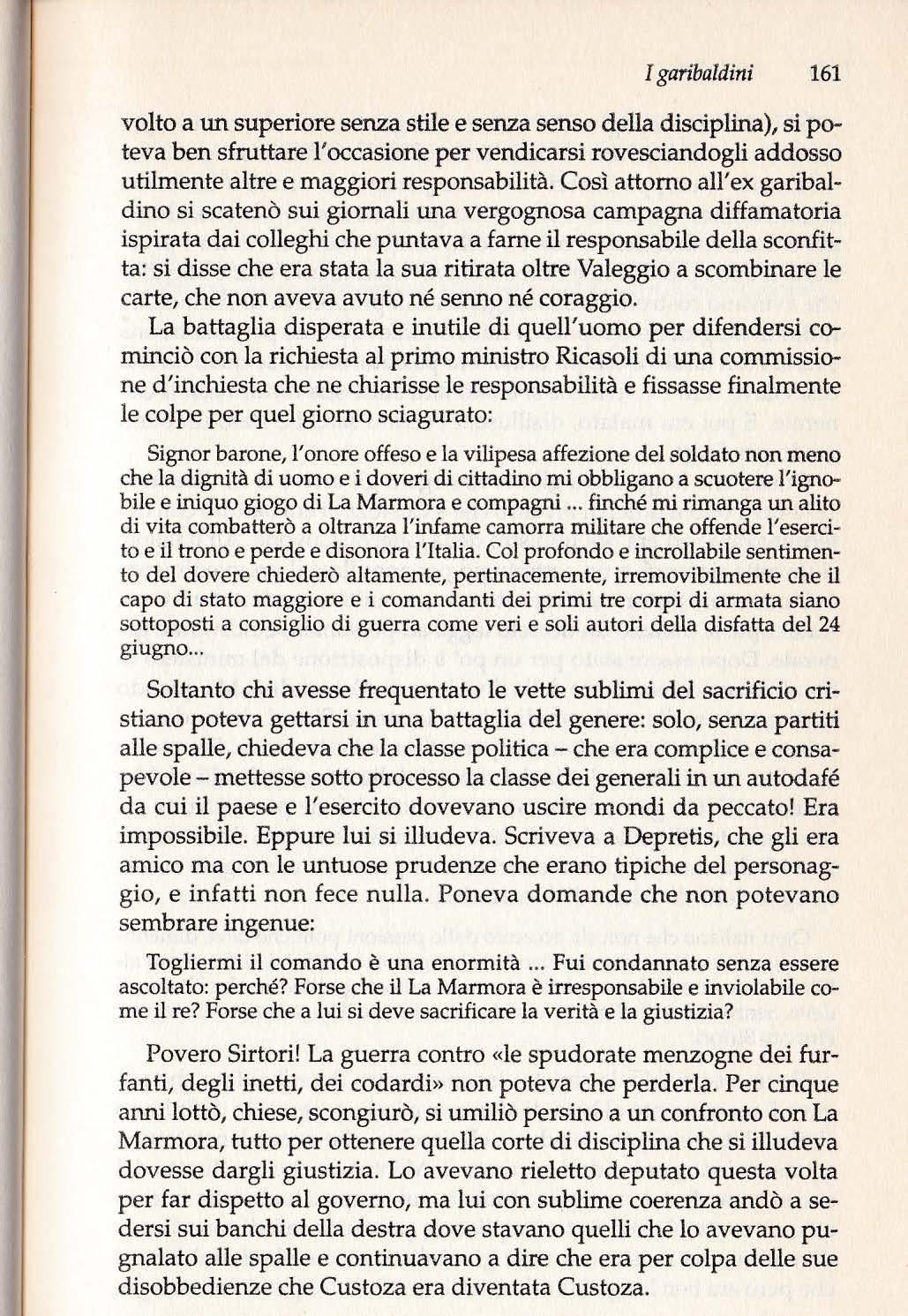
Togliermi il comando è una enormità ... Fui condannato senza essere ascoltato: perché? Forse che il La Marmara è irresponsabile e inviolabile come il re? Forse che a lui si d eve sacrificare la verità e la giustizia?
Povero Sirtori! La guerra contro «le spudorate menzogne dei furfanti, degli inetti, d e i codardi» non poteva che perderla. Per cinque anni lottò, chiese, scongiurò, si umiliò persino a un confronto con La Marmara, tutto per ottenere quella corte di disciplina che si illudeva dovesse dargli giustizia. Lo avevano rieletto deputato questa volta per far dispetto al governo, ma lui con sublime coerenza andò a sedersi sui banchi della destra dove stavano quelli che lo avevano pugnalato alle spalle e continuavano a dire che era per colpa delle sue disobbedienze che Custoza era diventata Custoza.
Nel '70, in campagna dove si era rifugiato e dove come sempre lottava con i debiti, arrivò dalla Francia un incredibile telegramma: «Generale Giuseppe Sirtori vuole compiacerci di venire a Lione o a Dole? firm a to Garibaldi». Il vecchio generale correva la sua ultima avventura combattendo con i vecchi nemici francesi contro i prussiani: erano i più deboli e l'Eroe restav a tenacem ente vicino alle idee che avevano costruito la s ua leggenda. Gli proponeva di riannodare il filo della grande e popea, di nuovo mille animosi per una buona causa. Non andò: il tempo ormai era passato, anche se quell 'offerta cancellava tutti i veleni che si erano fatti sulla sua rottura con il Generale. E poi era malato, disilluso ... P ecca to sarebbe stato un buon modo per finire. Quello che la giustizia g li aveva n egato g li arrivò il 12 dicembre 1871 per i buoni uffici di un altro che a Custoza si era battu to con determinazione ed era ora ministro della Guerra: Govone . All'italiana, si dove tte ricorre re a un sotterfugio per annullare il provvedimento e ria mmette re Sirtori nell'esercito con anzianità e gradi maturati nel frattempo: si utilizzò un decr e to legge ad personam, e ridivenne generale. Dopo essere stato per un po' a disposizione d el ministero lo nominarono comandante della di visione di Alessandria. Ma quando la disgrazia si dimenticava di lui e ra lo stesso Sirtori che andava a cercarla, faceva fuoco e fiamme per attirarne l'attenzione. Era morto in esilio, roso dalla m a lattia dai rimorsi dalle tragedie familiari, N apole one III. Un giornale lanciò una sottoscriz ione per costruire un monumento all' uomo che n el be n e e n e l male e ra stato decisivo per fare l ' Italia una. Al giornale arrivò tra i primi un messaggio con le insegne della divis io ne di Alessandria:

Ogni italiano che non s ia accecato dalle passioni politiche deve dimenticare ogni risentimento e ricordando solo i grandi benefici da lui arrecati all'Italia deve portare la sua pietra al monumento di gratitudine che l'Italia gli deve. Senza di lui l'Italia no n sarebbe ora nazio ne . lo sottoscrivo lire cento. Firmato Sirtori.
Fu uno scandalo: la sinistra insorse contro il garibaldino che pagava il monume nto al boia di Mentana e i più generosi lo definirono rimbambito rinnegato v enduto. «Il Secolo», che aveva lanciato una sottoscrizione per i caduti appunto di Mentana e che era diretto dal suo ex capo di stato ma ggiore Moneta, un tempo a lui fedelissimo, lo attaccò con v iolenza. Sirtori replicò, la pole mica salì di tono fino a dive ntare una mos truosa rissa giornalistica, come la definì Sirtori che però era ben lungi dal tirarsi ind ietro. Era «iniquissim a e sciagu-
ratissima». Ma quello era il suo elemento, ci si trovava benissimo, colpiva con la stessa durezza con cui aveva dato addosso a borbonici e austriaci:
Voi in nome dell'amore patrio e della severa morale insultate e maledite la sua memoria ed evocate i martiri dell'indipendenza italiana perché lo insultino e lo maledicano con voi! Io non vidi mai simile profanazione delle tombe, simile pervertimento del sentimento nazionale e del senso morale.
Morì due anni dopo, a Roma, dove lo aveva trasferito la commissione incaricata di studiare le nuove anni, si può dire alzando lavoce, impugnando la penna come una baionetta.


Lo confessiamo: con il generale Enrico Della Rocca pensavamo di aver già saldato i conti nella piana di Villafranca. Ci ripugna tirarlo di nuovo fuori dall'oblio; vanesio com'era, potrebbe pensare di essere davvero un protagonista, un guerriero del!' Ariosto o del Tasso. Ci eravamo dimenticati, in mezzo alla procella guerresca, che quando diede una mano agli austriaci era già un precursore, un pioniere. Chi meglio di lui poteva inaugurare la stagione dei fucilatori in uniforme, dei Pinochet s ubalpini? Nessuno.
Il generale ricevette la brutta n otizia alla stazione ferroviaria di Chivasso: fu quel 21 settembre 1864, per lui fertile di emozioni, discussioni politico-militari, storici enigmi. E di duro lavoro, ore e ore a cavallo, per esercitarsi a «finte battaglie», come si diceva a quel tempo, che si erano svolte a Cigliano. Stanco com'era, per tornare a casa, a Torino, era salito s ul treno, con il suo capo di stato maggiore e alcuni ufficiali . Era ormai l'imbrunire e s i pensava già alla minestra quando vide sotto l a pensilina il maggiore Corvetto, sottocapo di s tato maggiore, piombato lì evidentemente di gran fretta ad aspettarlo. Questo er a indizio sicuro di importanti e cattive notiz ie. Infatti l 'ufficiale salì nello scompartimento dove si era fatta subito l ' atmosfera del si salvi chi può. Raccontò che mentre Della Rocca manov rava nelle pianure di San Maurizio, la capitale del regno era in stato di rivolta. Anzi, la polizia annusava e presagiva la rivolu z ione. Folle imbestialite si erano raccolte in piazza San Carlo e avevano tentato di dare l'assalto alla questura e alla sede della «Gazzetta piemontese». Cose che non si erano mai viste, neppure al tempo dei giacobini, nella tranquilla città dei duchi. A provocare l ' agitazione omicida di quella buona gente affezionatissima fino a un minuto prima ai Sa-
voia, e che avrebbe dovuto esser soddisfatta per la conclusione della gran fatica unitaria, era stata appunto la lettura di alcuni giornali: «La Gazzetta», «L'Opinione» . Non scritti sobillatori. Tutti semmai accuratamente ministeriali e ben informati anticipavano l'incredibile: Torino non era più capitale d'Italia. Ma non per trasferire quell'onore pagato con tanti anni di sacrifici e battaglie a Roma, come era scritto nei dieci comandamenti del Risorgimento, bensì a Firenze. Dicevano i giornali che il 15, una settimana prima, il ministero retto dal Minghetti aveva firmato una convenzione con l'imperatore Napoleone III, grande difensore del papa: in cambio del ritiro della guarnigione francese da Roma il governo di re Vittorio accettava di s postare la capitale nell'ex città dei granduchi. Quello che i giornali non scrivevano era che si trattava nei progetti governativi di una grande finta, insomma molto machiavellicamente ci proponevamo di giocare un bel tiro a quell 'ingombrante e pretenzioso alleato: si andava a Firenze e poi, appena partiti gli zuavi, si sarebbe agguantata la prima occasione per metterlo davanti al fatto compiuto . I buoni torinesi, però, tutte queste ministeriali astuzie non potev ano saperle. Qualcuno provava a lenire la ferita ricordando che a desso lo Stato italiano contava ventisei milioni di abitanti e arrivava fino al mar d'Africa: quella capitale così isolata nel Nord era diventata dal punto di vista logistico e amministrativo troppo scomoda, una periferia. I più sofisticati, poiché la storia dell'inganno a Na poleone non poteva almeno ufficialmente consolare nessuno, provavano a ricordare che su quella famosa questione romana qualche novità bisognava comunque inventarla; quantomeno p e r frenare i bollori pericolosissimi di Garibaldi che con l'invettiva molto citata «Roma o morte» già aveva combinato i pericolosi disastri dell'Aspromonte e di Mentana. Niente: i bravi torinesi non si acquetavano, non gli veniva meno la voglia di rimboccarsi le maniche e darsi al lavoro della barricata. Per loro che da secoli v ivevano di corte e di burocrazia il trasloco della capitale, prima che una offesa morale, era un disastro economico che incubava passioni estremiste. Migliaia di persone e tutte ben disposte a spendere, soldati e funzionari, sarebbero partiti per ingrassare i sudditi dei g r anduchi e la città che aveva spremuto sangue e sudore per i Savoia sarebbe stata ridotta rapidamente al rango di un paesone pitocco e periferico. Meno male che soltanto i più ingenui e arrabbiati prestavano fede alla voce evidentemente propalata dai clericali che non vedevano l'ora di celebrare il De profundis di quello Stato che aveva commesso lo sproposito di portar via le terre al papa: secondo questi pessimisti il
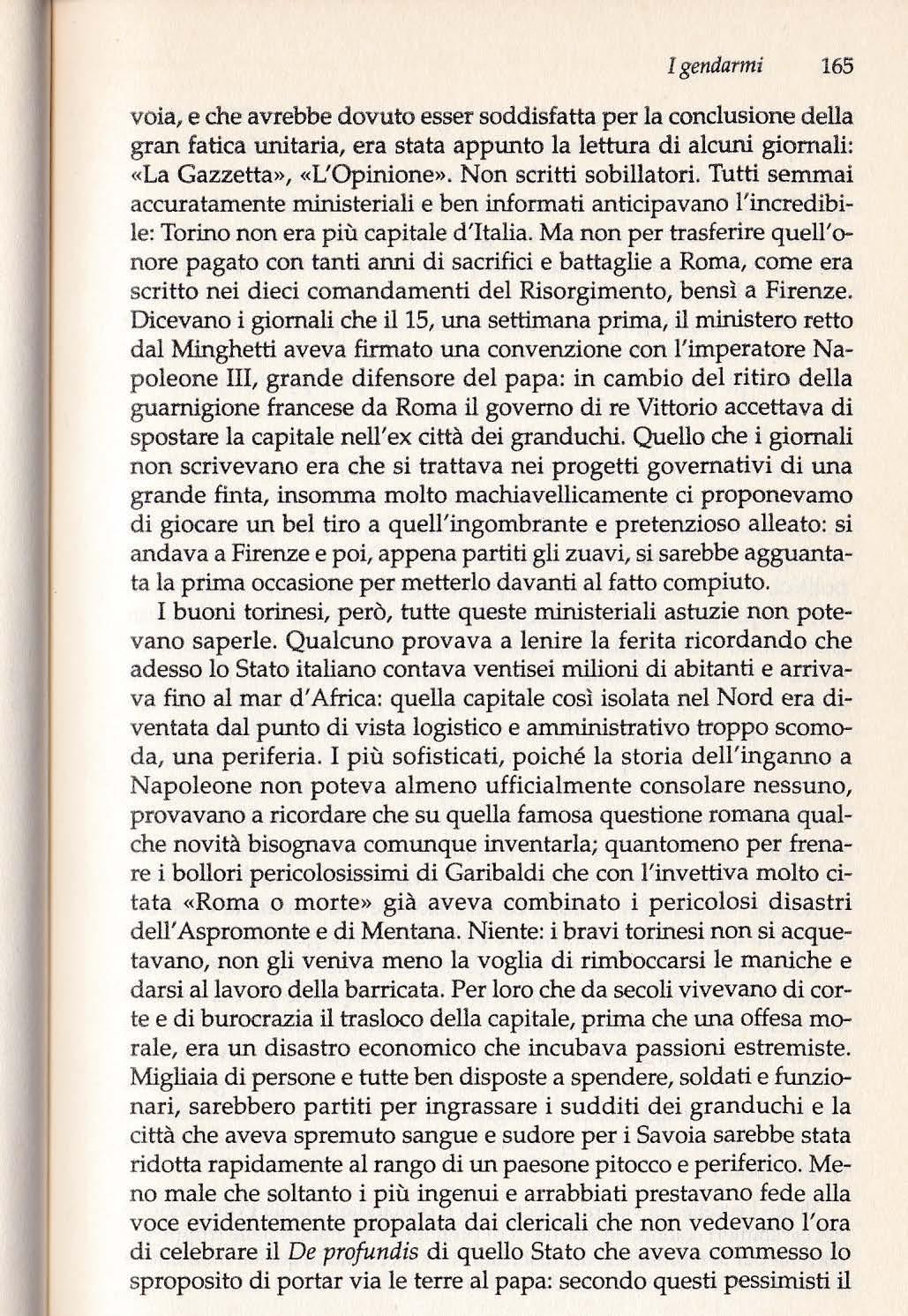
Piemonte intero era stato ceduto in regalo a Napoleone III! La dinamite per l 'esplosione c' era tutta. Alle incomposte vociferazioni da marciapiede aggiungete anche un po' di furo r e «nordista » contro quelli che fino al giorno prima erano s tati i nemici, borbonici e reazionari, e che adesso sciamavano già dappertutto, occupavano posti cariche scrivanie soprattutto nella pubblica amministrazione che si era fatta, da smilza, adiposa.
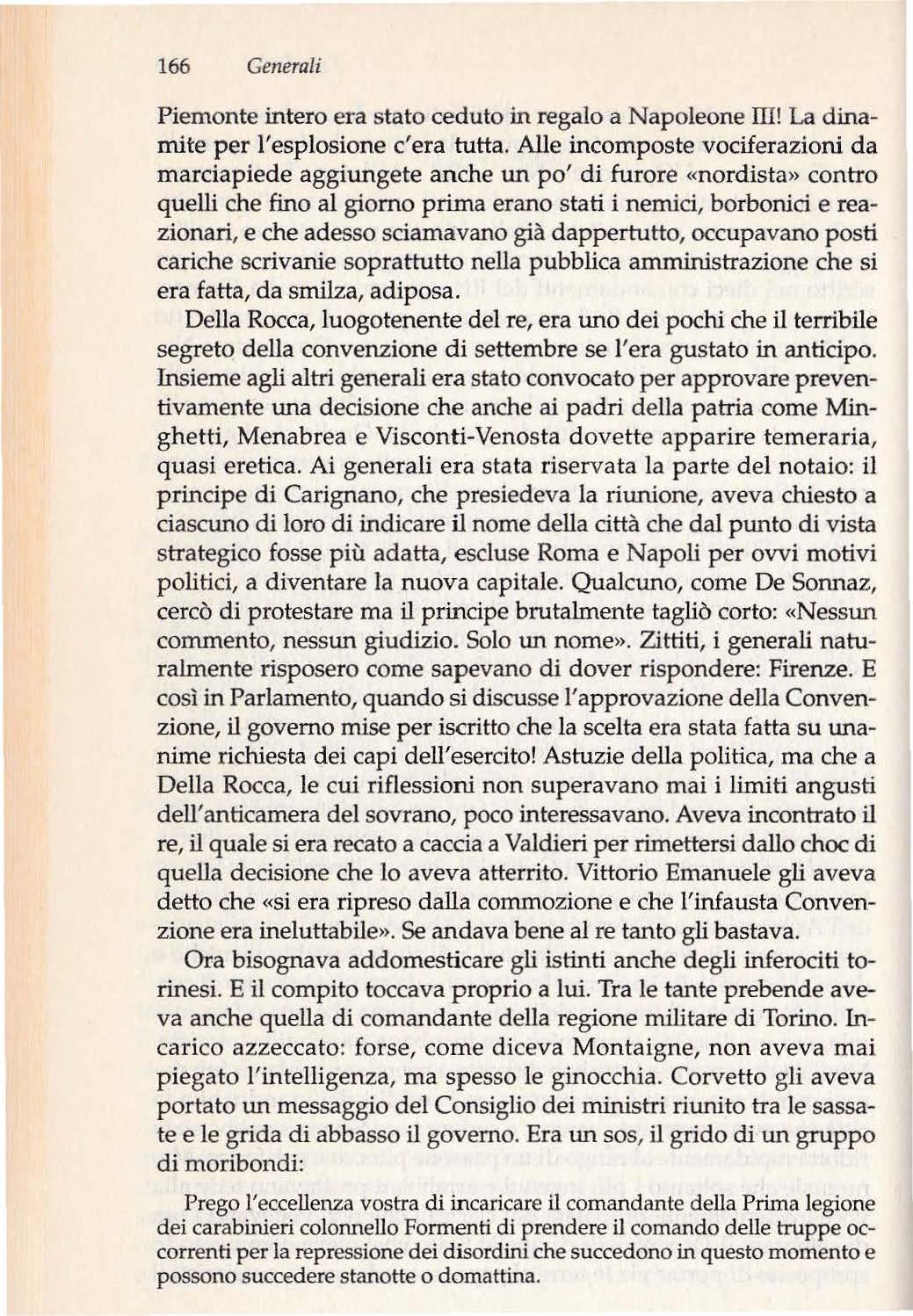
Della Rocca, luogotenente del re, era uno dei pochi che il terribile segreto della convenzione di settembre se l'era gustato in anticipo. Insieme agli altri generali era stato convocato per approvare preventivamente una decisione che anche ai padri della patria come Minghetti, Menabrea e Visconti-Venosta dovette apparire temeraria, quasi eretica. Ai gener a li era sta ta ri servata l a parte del notaio: il principe di Carignano, che presiedeva la riunione, aveva chiesto a ciascuno di loro di indicare il nome della città che dal punto di vista strategico fosse più adatta, escluse Roma e Napoli per ovvi motivi politici, a diventare la nuova capitale. Qualcuno, come De Sonnaz, cercò di protestare ma il principe brutalmente tagliò corto: «Nessun commento, nessun giudizio. Solo un nome». Zittiti, i generali naturalmente risposero come sapevano di dover rispondere: Firenze. E così in Parlamento, quando si discusse l'approvazione della Convenzione, il governo mise per iscritto che la scelta era stata fatta su unanime richiesta dei capi dell'esercito! Astuzie della politica, ma che a Della Rocca, le cui riflessioni non superavano mai i limiti angusti dell'anticamera del sovrano, poco inte ressavano. Aveva incontrato il re, il quale si era recato a caccia a Valdieri per rimettersi dallo choc di quella decisione che lo aveva atterrito. Vittorio Emanuele gli aveva d e tto che «si era ripreso dalla commozione e che l'infaus ta Convenzione era ineluttabile». Se andava bene al re tanto gli bastava. Ora bisognava addomesticare gli istinti anche degli inferociti torinesi. E il compito toccava proprio a lui. Tra le tante prebende aveva anche quella di comandante della regione militare d i Torino. Incarico azzeccato: forse, come diceva Montaigne, non aveva mai piegato l'intelli genza, ma spesso le ginocchia. Corvetto gli aveva portato un messaggio del Consiglio dei ministri riunito tra le sassate e le grida di abbasso il governo. Era un sos, il grido di un gruppo di moribondi:
Prego l'eccellenza vostra di incaricare il comandante della Prima legione dei carabinieri colonnello Fermenti di prendere il comando delle truppe occorrenti per la repressione dei disordini che succedono in questo momento e possono succedere stanotte o domattina .
Era l'ordine di procedere con l'esercito alla repressione di quella rivolta. La storia d'Italia iniziava per i generali nel più bello stile delle antiche e sgambettate autocrazie: fucilate agli insorti, caccia nelle s trade ai rivoluz ion ari. Bisognava metter la giubba del gendarme e del repressore.
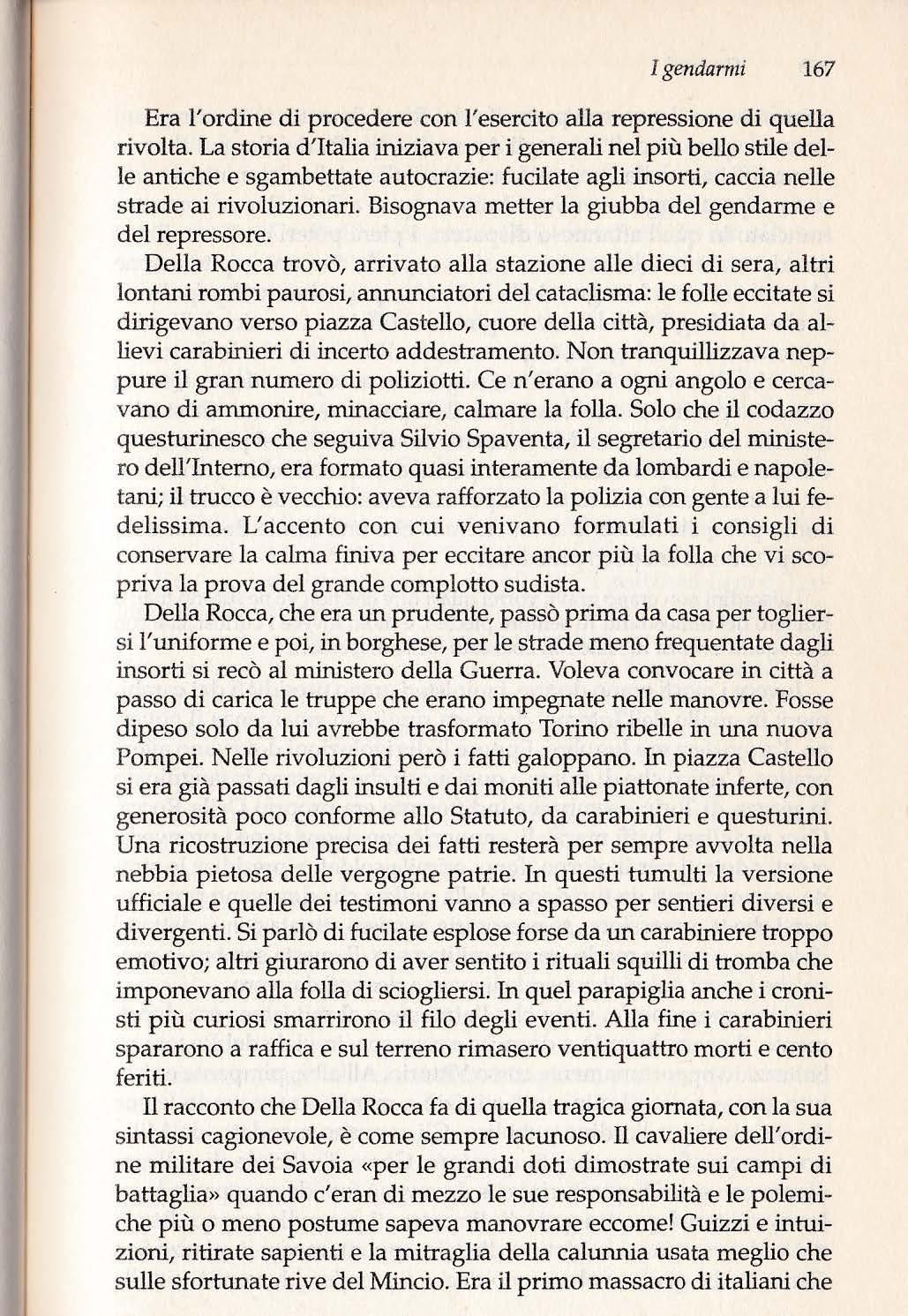
Della Rocca trovò, arrivato alla stazione alle dieci di sera , altri lontani rombi paurosi, annunciatori del cataclisma: le folle eccitate si dirigevano verso piazza Castello, cuore della città, presidiata da allievi carabinieri di incerto addestramento. Non tranquillizzava neppure il gran numero di poliziotti. Ce n'erano a ogni angolo e cercavano di ammonire, minacciare, calmare la folla. Solo che il codazzo ques turinesco che seguiva Silvio Spaventa, il segretario del ministero dell ' Interno, era formato quasi interamente da lombardi e napoletani; il trucco è vecclùo: aveva rafforzato la polizia con gente a lui fedelissima. L'accento con cui venivano formulati i consigli di conservare la calma finiva per ecci tare ancor più la folla che vi scopriva la prova del grande complotto sudista. Della Rocca, che era un prudente, passò prima da casa per togliersi l'uniforme e poi, in borghese, per le s trade meno frequentate dagli insorti si recò al ministero della Guerra. Voleva convocare in città a passo d i carica le truppe che e rano impegnate nelle manovre. Fosse dipeso solo da lui avrebbe trasformato Torino ribelle in una nuova Pompei. Nelle rivoluzioni però i fatti galoppano. In piazza Castello s i era già passati dagli insulti e dai moniti alle piattonate inferte, con generosità poco conforme allo Statuto, d a carabinieri e questurini. Una ricostruz ione precisa dei fatti resterà p e r sempre avvolta nella nebbia pietosa delle vergogne patrie . In ques ti tumulti la versione ufficiale e quelle dei testimoni vanno a spasso per sentieri diversi e divergenti. Si parlò di fucilate esplose forse da un carabiniere troppo emotivo; altri giurarono di aver sentito i rituali squilli di tromba che imponevano alla folla di sciogliersi. In quel parapiglia anche i cronisti più curiosi smarrirono il filo degli even ti. Alla fine i carabinieri spararono a raffica e sul terreno rimasero ventiquattro morti e cento fe riti.
Il racconto che Della Rocca fa di quella tragica giornata, con la sua sint assi cagionev ole, è come sempre lacunoso. li cavaliere d ell'ordine miHtare dei Savoia «per le grandi doti dimostrate sui campi di battaglia» quando c'eran di mezzo le sue respons abilità e le polemiche più o meno pos tume sapeva manovrare eccome! Guizzi e intuiz ioni, ritirate sapienti e la mitraglia della calunnia u sata meglio che s ulle sfortunate rive del Mincio. Era il primo massacro di italiani che
contestavano il governo partorito dal Risorgimento: in quattro aruù eravamo passati dall'età degli Apostoli a quella dei Borgia! Il resoconto ufficiale della strage afferma che il Consiglio dei ministri svol· tosi nel pomeriggio aveva attribuito proprio a Della Rocca, come annunciato in quell'affannoso dispaccio, i pieni poteri civili e militari per riportare la calma nella ormai ex capitale . Era una capitolazione clamorosa, c'era bisogno delle baionette per calmare il popolo. Si svelava la fragilità del nuovo regime e si offriva ai nemici dell'unifi. cazione, che eran legioni, argomenti per dimostrare che lo Stato sta· va andando a rotoli. Della Rocca negò, non ne sapeva niente. Questo è curioso per noi che abbiamo letto il dispaccio recapitato alla stazione della fatai Chivasso. Ma ammettiamo che fosse così poco curioso e fosse invece attentissimo a competenze, salamelecchi e attribuzioni. Ci insospettisce il fatto che per confermare la sua versione rac· contò poi nelle Memorie di un veterano che una simile decisione da tempi estremi era poco probabile:
i disordini non erano gravi; vorrei quasi dire che non ve ne furono mai; il numero dei dimostranti fu sempre piccolo, e molti invece i curiosi, che con due squilli e senza fucilate sarebbe stato facile disperdere.
Invece i morti erano decine, i ministeri erano presidiati dai carabi· nieri; in quello dell'Interno, dove era riunito in emergenza il gover· no, l'atmosfera era lugubre. Eppure lì di rivoluzioni dovevano avere pratica. L'unico che di fronte a quei morti che avevano insanguinato la piazza di Torino sembrava indifferente era proprio Della Rocca . Cera accigliata, baffi marziali, annunciò con degnazione i provvedi· menti adottati per il giorno dopo: seimila soldati a presidiar le stra· de accompagnati da funzionari della polizia che dovevano preoccuparsi che la repressione, se necessaria, venisse attuata con «i dettami di legge» e non in modo troppo militaresco. E questa sembra la prova che i pieni poteri il generale li avesse ricevuti davvero. Dopo mezzanotte, visto che l'atmosfera al ministero era depri· mente, il generale andò a dormire a casa sua, in viale del Re, ora ri· battezzato opportunamente corso Vittorio. All'alba, pimpante e risoluto, prese posto al ministero e iniziò a manovrare secondo le sue disposizioni per l'ordine pubblico. Gli avevano mandato, da Mila· no, come rinforzo anche un questore, Cossa, l' ufficiale di collega· mento con sbirri e questurini che dovevano fare da «supporto lega· le» ai militari. I quattro gatti di dimostranti per nulla tranquillizzati dal veder marciare i soldati, si diedero appuntamento in piazza San Carlo; anche questa volta erano decisi a prendersi le vendette sulla
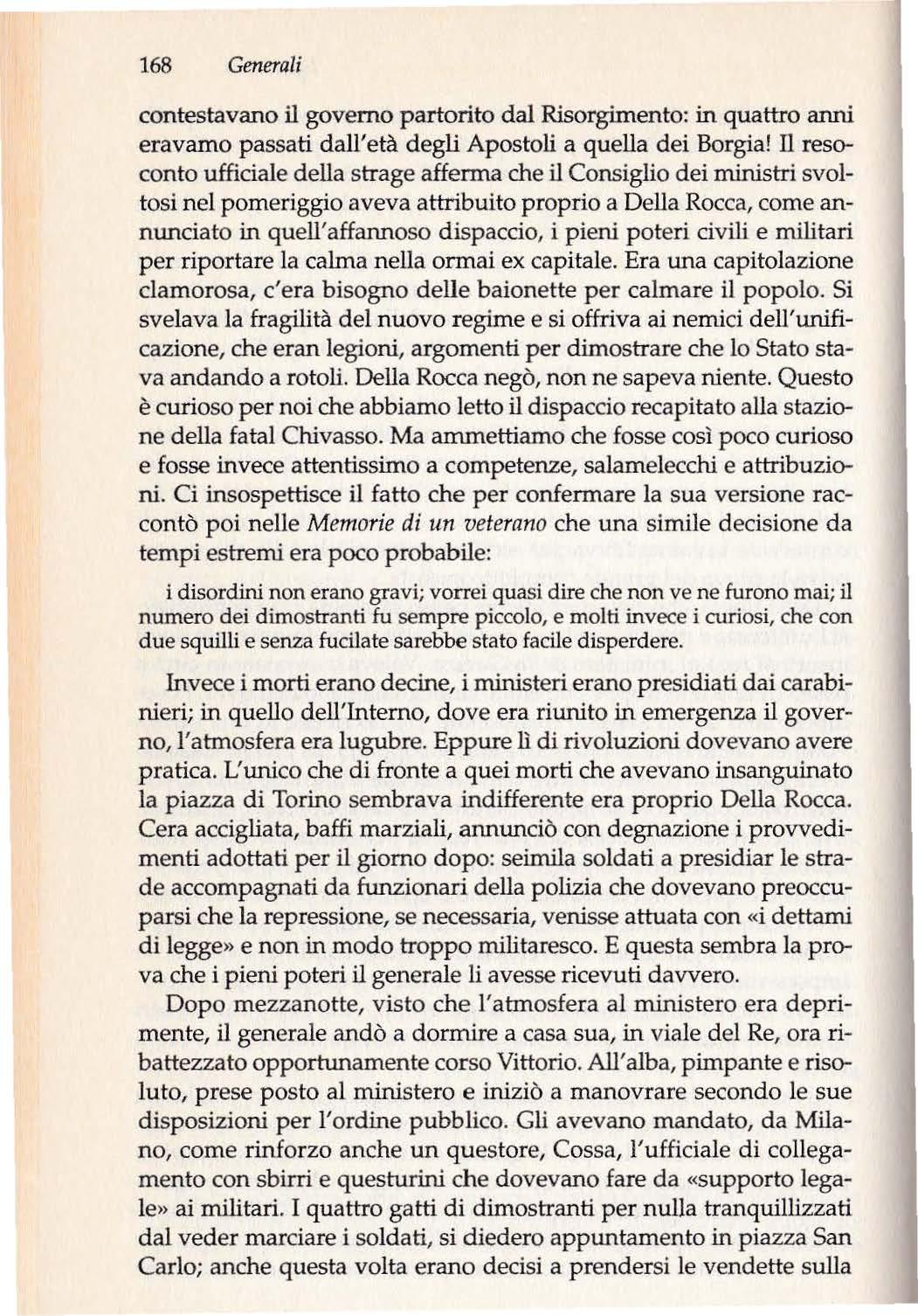
sciagurata «Gazzetta piemontese» a cui evidentemente si attribuiva non solo il peccato di diffondere notizie moleste ma addirittura di p rovocarle. Sassaiole, grida di abbasso i ministri traditori, «Roma o morte» che ormai era diventato per i torinesi un assoluto più pressante che per Garibaldi o Mazzini. Della Rocca era fermo alla sua teoria dei «quattro arruffoni» che si potevano disperdere con i birri solo se fossero stati capaci di fare il loro mestiere e non ex borbonici o asburgici un poco traditori. Diede la colpa di tutto quanto accadde al questore e ai poliziotti: conigli com'erano, spiegò, si erano spaventati per l' accorrere massiccio di gente dall'Arsenale e dalle vie vicine. Sotto i portici della questura fecero schierare contro la folla una compagnia di carabinieri accolti al grido non proprio amichevole di «sbirri, tenenti del boia! ». Si udirono come il giorno prima spari; la guerriglia ormai era di moda e i soldati, che erano stupidamente dis posti ai lati della piazza, cominciarono a tirare all'impazzata. Vennero colpiti molti dimostranti ma anche altri soldati che si trovavano sul lato opposto. Stramazzarono fra gli altri il portabandiera e il colonnello del Diciassettesimo reggimento di fanteria. Quando Della Rocca arrivò, trovò la piazza vuota perché tutti erano fuggiti . Il selciato era macchiato dai corpi di una trentina di borghesi uccisi e da a ltre decine di persone sconciate dalla fucileria. I soldati, che avevano perso il controllo, si affannavano a prestar assistenza solo ai loro compagni. Due morirono. Da quel momento Della Rocca decise che tutte le colpe erano di civili, governo e polizia e che lui non aveva mai avuto alcun potere nella gestione di quella triste vicenda. Altrimenti se ne sarebbero viste delle belle! Tranquillizzato, si precipitò al ministero e trovò il governo ancor più riunito in seduta di emergenza. Un governo in dissoluzione non cade, non crolla. Si accascia. Il ministro della Guerra, infatti, un altro generale, Alessandro Della Rovere, e ra già sdraiato in atteggiamento s offerente su un divano come se stesse per esalare l'ultimo respiro. Evento luttuoso differito solo di qualche giorno, circostanza che permise a tutti di scaricare opportunamente su di lui, che non poteva più s mentire, ogni responsabilità. Minghetti propose di votare lo stato di assedio; i due generali, Della Rocca e Della Rovere che ebbe un ultimo guizzo di vita, si opposero risolutamente. Intuivano che si stava cercando di passar loro la parte di protagonisti magari accusandoli del massacro. Minghetti ricordò a Della Rovere che era dimissionario per motivi di salute. Ormai la pietà era morta, si speculava sulle disgrazie. L'altro ribatté, emergendo si può dire dalle nebbie del coma, che visto il p ericolo corso dallo Stato, le aveva riti-
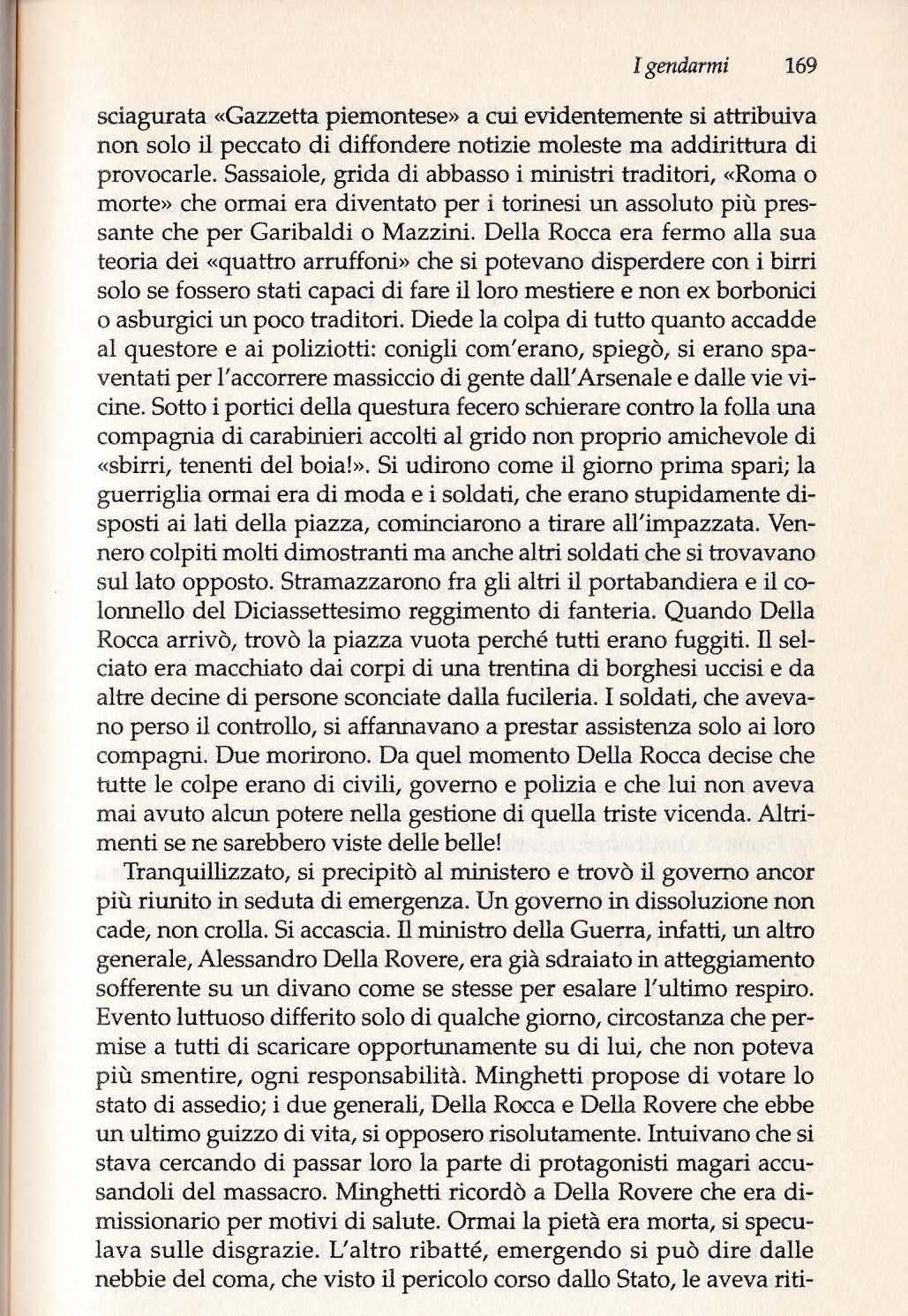
rate; non avrebbe consentito che Torino subisse un' offesa così grande dopo quanto già era successo. Si litigò allegramente con i ministri borghesi. Con fatti così tempestosi e risolutivi tutti manovravano per trasferire le colpe sul groppone cli altri. I militari erano gente d el mestiere, dei morti importava loro poco o nuJla; ma c'era da preservare la santità dell'esercito, davano addosso quindi al bersaglio dei politicanti che sollevano sempre, chissà perché, deprecazioni universali.
Un terzetto cli capetti lasciò il fortilizio ministeriale per andare a casa: Menabrea in via San Lazzaro, il Peruzzi in via Po - dove si ergeva il risorgimentale caffè Florio i cui vennouth avevano condito il Risorgimento- e Della Rocca in viale del Re . La camminata fece bene al generale, infatti, appena arrivato a casa, invece cli concedersi un sonno ristoratore dopo una giornata così piena e drammatica, si mise a scrivere al re. Non erano affettuosità di cortigiano: gli consigliava «francamente» di licenziare lo squinternato gabinetto, di attuare un mezzo golpe bianco. Conosceva gli umori del suo «Principale». I s uccessi gli avevano aguzzato la passione dell'impicciarsi nelle faccende dei ministeri; sparito Cavour di cui aveva paura gli semb ravano tutti retti da dilettanti pas ticcioni. 11 segretario di re Vittorio gli portò la risposta all'alba: il suo consiglio era manna celeste, ottima idea, via i ministri. Gli orclinava, con singolare procedura, di andare proprio lui e di furia a comunicare il licenziamento a l governo. Si può immaginare con quale gioia sollecita Della Rocca si mise all'opera. I crolli del barometro politico gli offrivano delizie inusitate. Piombò al ministero e intimò a i titolari, esterrefatti, la resa e l ' ordine cli far fagotto. Quale spontaneità di stratega, sembrava pronto a orclinare un nuovo Brumaio subalpino. Furibondo, il Minghetti - che allora non era proprio quel «figlio della paura» come lo insolentivano g li avversari - si rifiutò di ceder le armi in quel modo sud americano e anticostituzionale; pretese di ricevere una comunicazione scritta d el re da mettere agli atti della Storia. Dopo un'ora si presentò a Della Rocca che mordeva il freno per quelle lungaggini: «Ci ritiriamo dunque e rimettiamo a lei tutti i poteri civili e militari . Faccia lei, procuri di tranquillare gli spiriti e di prevenire nuovi disordini». Il generale non colse la maligna ironia: «Stia sicuro, non ve ne saranno più; forse ancora qualche dimostrazione tra un'ora o due, ma di carattere ben diverso». «Capisco» replicò il Minghetti, «saranno dimostrazioni cli gioia per la nostra caduta. » Altra giornata piena per il generale. G li restava ancora da comunicare al solito La Marmara, l'uomo dei momenti difficili, che gli era
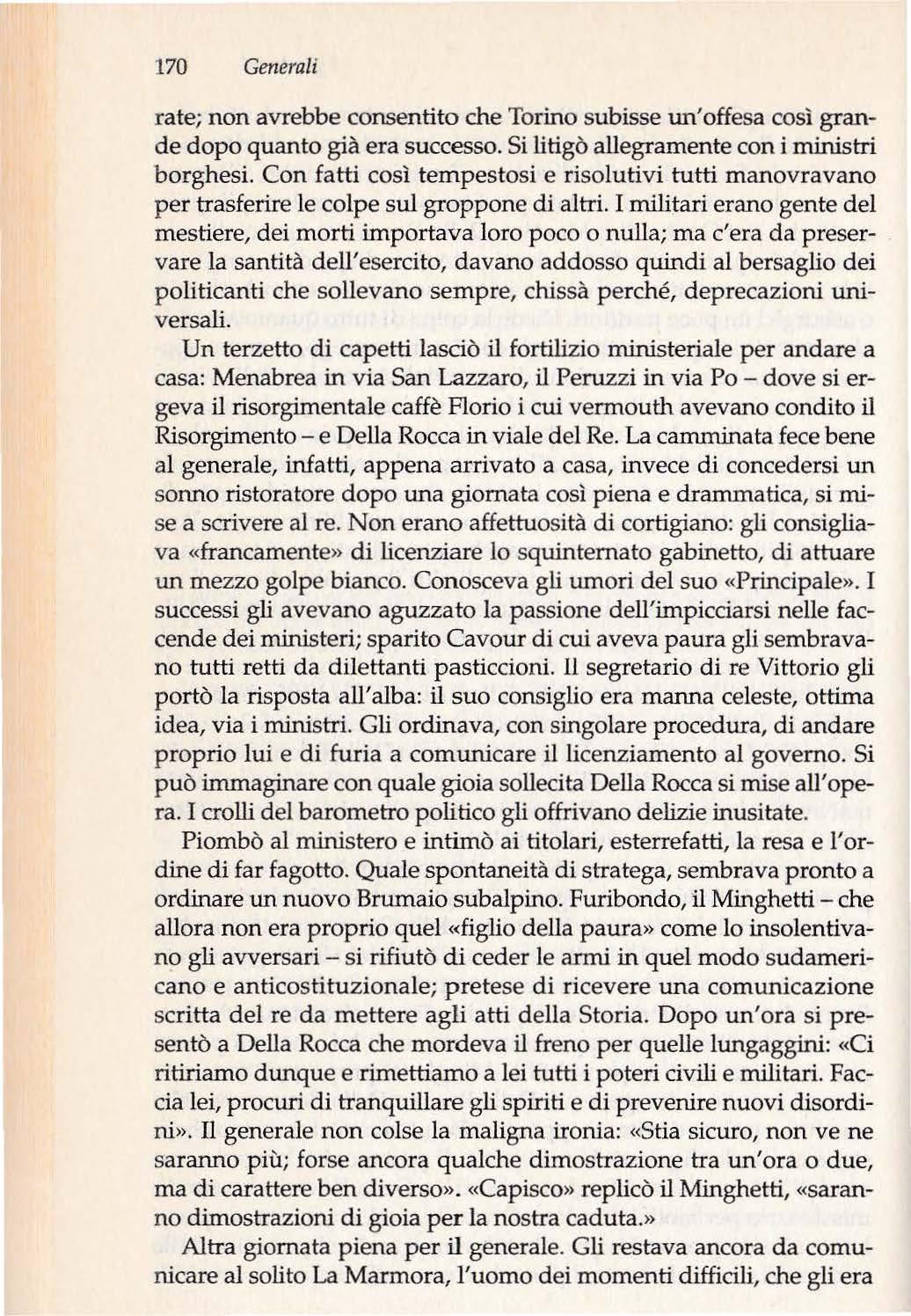
stato affidato il compito di formare il nuovo ministero. Lo trovò all'hotel Foeder più sicuro e presuntuoso che mai, appena arrivato dalla Svizzera. Impagabile la sua risposta che dovrebbe restare come l'epitaffio marmoreo del rapporto tra i generali «italiani» e i politici. «Già, già» sbuffò il cugino La Marmara (entrambi erano apparteneti al]'ordine del Collare dell' Annunziata, cui veniva riconosciuto il titolo di «cugini del re») con folte e minacciose sopracciglia, «si fanno le sciocchezze, poi incaricano me di ripararle!»
Dopo pochi giorni il governo uscì alla luce del mondo. I torinesi, che si accontentarono della caduta di Minghetti scambiandola per una compensazione dell'essere stati comunque decapitalizzati, tornarono al loro consueto tran tran di buoni sudditi. Ci fu qualcuno tra i consiglieri comunali che pensò di far affigge re sulla facciata del palazzo·comunale una lapide all' «eroe» di quei tragici giorni di rivolta e di intrighi: «Al generale Enrico Della Rocca per aver salvato dalle bombe ministeriali la città di Torino nei giorni 22 e 23». La discutibile inizia tiva per fortuna non ebbe seguito. Anzi, al Della Rocca ne vennero i guai e le amarezze che fece scontare come abbiamo visto ai suoi soldati e ai suoi colleghi due anni dopo nelle tragiche ore di Custoza. Un uomo in disgrazia è sempre noioso. Il Minghetti, tutt'altro che rassegnato a restare nella Storia ufficiale come il massacratore di Torino, chiese e ottenne una commissione di inchiesta, terreno su cui sapeva di poter, nel riscrivere i fatti, tener testa a ll'impetuoso generale. N e venne fuori una versione defirùtiva che esibiva la consueta serpentesca cautela di tutto ciò che in Italia ha il marchio dell'ufficiale e riguarda p ersonaggi altolocati: non si sa mai, le fortune e le sfortune sono transeunti. Ma accoglieva in sostanza la tesi della responsabilità dei militari n ella gestione di quelle poco lodevoli giornate.
Della Rocca strepitò, corresse, puntualizzò perché intuiva beniss imo, da consumato cortigiano, dove si andava a parare. Erano scene da congiura bizantina, diamine! La ferita era tutt'altro che sanata . Se ne accorse Vittorio Emanuele che subì a l teatro Regio, in occasione del tradizionale ballo dell'ultimo dell'anno, uno sgarbo davvero esecrabile. Lo fischiarono con una manifestazione di piazza. E uno sciopero dei notabili lasciò le sale tragicamente vuote. Intristivano abbandonati p ersino i banchi riservati alle eccellenze, le persone cioè addette alla corte. Delle mogli dei collari dell' Annunziata c'era solo la vecchia m a rchesa Mammina Spinola, una sopravvivenza patetica d el vecchio regime che vestiva per problemi economici gli abiti che s i e ra fatta confezionare ai tempi p er lei fausti d e lla res tauraz ione.

Da quel momento i Savoia persero la loro corte: dovettero sostituirla, sbarca ti al Quirinale, con il m al assortito «gen erone» romano. Il re s i inferocì più ch e per una b a ttaglia perduta: quella e ra la s ua città! Ne fece le spese il povero sind aco march ese d i Rorà. Accusato di non aver subito guidato una delegazione a chiedere scusa p er l'affronto, dovette fare la coda per settimane, vestito simbolicamente di corda e di sacco, a Firenze per ottenere il p erdono. Che non venne mai p ieno e definitivo. A De lla Rocca volevano toglier e p roprio quell ' incarico d el comando militare n ella vecchia capitale a cui tanto teneva . E la misura si presentava come una censura per quanto era s u ccesso. All' udienza dal re andò preoccupatissimo temendo di essere ricevuto in modo brusco; Vittorio, che sapeva come prend erlo, invece lo coprì di lodi, g li annunciò che, anche se avesse dovuto tog liergli la carica di primo aiutante, gli avrebbe con serva to gli emolumenti e un alloggio al p a lazzo. Gli chiese una prova di «deferenza» facendogli brillare future dorate ricompen se. Lui s tava z itto, un po' sulle sue. li re disse: «Là là, mio caro "Macigno" non facc ia l' imbecille sa?». Purtroppo al motto prussiano «io servo» non e rano con cesse eccezioni. «Macigno» non fece l'imbecille e ce lo ritrovammo a Custoza.
I generali hanno inciampato in quella ripugnante attività che è la repressione si può dire fin dai primi passi compiuti sotto le bandiere dell'esercito italiano. Da tenere a bada non c 'erano sol tanto i b ravi borghesi di Torino che non avevano certo la taglia leggera ma sicura d egli eversori della Bastiglia. Dovettero sbatte re il muso e affaticare le baionette in quella terribile guerra civile contro il brigantaggio nel Sud che durò quasi qua rant' anni sfior ando il volgere d el secolo. Le s tagioni più roventi e disperate furono in r eal tà que lle t ra il 1861 e il 1869, quando agli implacabili gene rali piemontesi buongustai delle battaglie affidarono le irrequiete province con la parola d ' ordine: ripulite e pacificate, altrimenti tutto il Risorgimento va a gambe all' aria. Conquistata a caro prezzo quella poco commendevole v ittoria, to rnò a essere un problema di questori e di sbirri. I dadi furono tratti quando ancora il cannone frugava gli spalti di Gaeta e Francesco II e la sua implacabile consorte custodivano concrete speranze di trarre ve ndette nibelung iche con qualch e colpo ben azzeccato delle soverchierie commesse dagli «i ta liani»: p arola da pronunciarsi con un accento di marcato disprezzo perché indicava i detestati settentriona li. Fu un incarico che assomigliava a un esilio, g uerra s p orca, così sfacciatamente pericolosa da ricordare la resis tenza spagnola contro Napoleon e , comb att uta fino alla classica
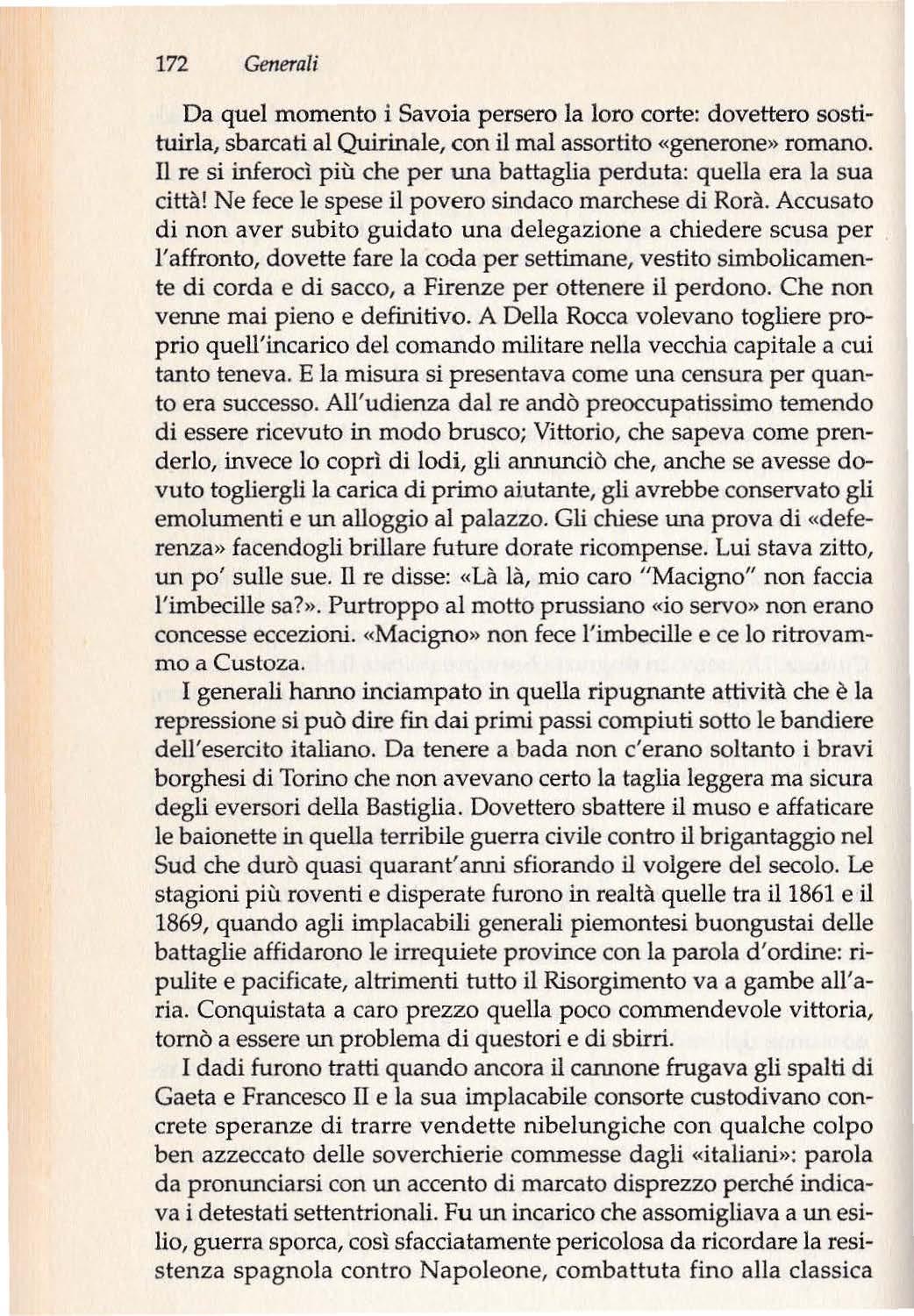
ultima goccia di sangue. Le torture furono inflitte dalle due parti con perversa raffinatezza.
Ma non era per motivi umanitari o di stile che i generali e tutti i grandi del Risorgimento, a cominciare da La Marmara, storsero la bocca nel metterci sbuffando le mani e sporcandosele non poco. Stonava, non era all'altezza l 'avversario che non sembrava proprio staccarsi da un verso del Manzoni o del Foscolo. Da sconfiggere infatti c'era gente di nome o soprannome: Croceo, Ninco Nanco, Chiavone, Tortora, capitan Teodoro, Diavolicchio, Pelorosso, Malacame, Bruciapaese, Culopizzuto. Spiritacci di tempi passati e futuri, sopravviss uti delle galere, briganti da passo, analfabeti, vestiti di pelli di pecora e con ai piedi gli zoccoli dei cafoni. I masnadieri nostrani non hanno nulla a che fare con quelli di Schiller. Anche se quelle epopee servivano a incrementare lo stato di servizio - perché i governi di Torino prima e di Firenze poi presero paura e apprezzarono quei successi quasi quanto quelli contro gli austriaci -, non erano certo allori da esibire in salotto. Ci siamo presi la briga di leggere carteggi e diari dove certi plutarchi ufficiali malati di retorica e di letteratura, talvolta, svelano anime in boccio. I modesti surrogati di generali furono tra i primi a segnalarsi per quel pregiudizio antimeridionale che scavò subito un solco tra le due Italie appena appiccicate, a tracciare quei paragoni arditi tra il nostro Sud e l'Africa selvaggia. Le sconfi tte coloniali aggiunsero all'arsenale già ricolmo solo modeste munizioni di pregiudizi e sciocchezze !ambrosiane.

La rivolta del Sud poteva essere un serbatoio di uomini di guerra, e poteva far nascere in qualche testa sveglia la smania di mettere in dubbi o ciò che prima e ra militarmente rispettato come dogma. Il programma prevedeva un mélange di agguati, imboscate, villaggi bruciati dagli uni per minaccia e dagli altri per vendetta, colpi di rasoio inferti da colonne costrette a mollar gli zaini e i bagagli per muoversi con rapidità e decisione. Non vi ricorda niente? Non è forse la lotta per conquistare i cuori e le menti? La controguerriglia era un'impresa i cui dettagli tecnici i condottieri di casa nostra avrebbero potuto attentamente studiare con utile anticipo. C'erano tutti gli elementi del Vietnam: con i san tuari della ribellione, la guerra sociale per annichilire le popolazioni prese in mezzo tra «regolari» e ribelli, il terrorismo spicciolo e i «sentieri» lungo cui correvano armi e uomini.
La chance di affrontare un avversario degnissimo che avrebbe tirato su lo spirito ai piemontesi all'inizio ci fu. Francesco Il, che aveva come sappiamo scrupoli un po' da santo (la moglie avrebbe detto
da minchione), era consapevole che i suoi bravi sudditi più impegnati nel guastar i conti al nemico erano quasi tutti usciti dalla scuola bellica delle galere. Non rinunciò per questo, quando la partita sembrava ancora aperta a ogni lusinghiero sviluppo, ad affidarsi ai regolari crismi di un generale diplomato. I suoi marcavano tutti visita, fuggiti a Torino o atterriti dalla prospettiva di cimentarsi con boschi umidi, pianure paludose e plotoni di esecuzione che non vedevan l'ora di provare polvere e micce. La copia in miniatura di Napoleone andò a cercarla nella terra dei don Chisciotte. Ci voleva uno spagnolo infatti per calarsi in quella bolletta generale: solo un inguaribile idealista avrebbe potuto prendere la guida di un'armata di briganti che difendeva i diritti di un re che tutta l'Europa aveva già affidato al plumbeo purgatorio dei pretendenti sfortunati. Il tramonto dei Borboni non ebbe neppure effimeri purpurei splendori. Fu un funerale di terza classe.
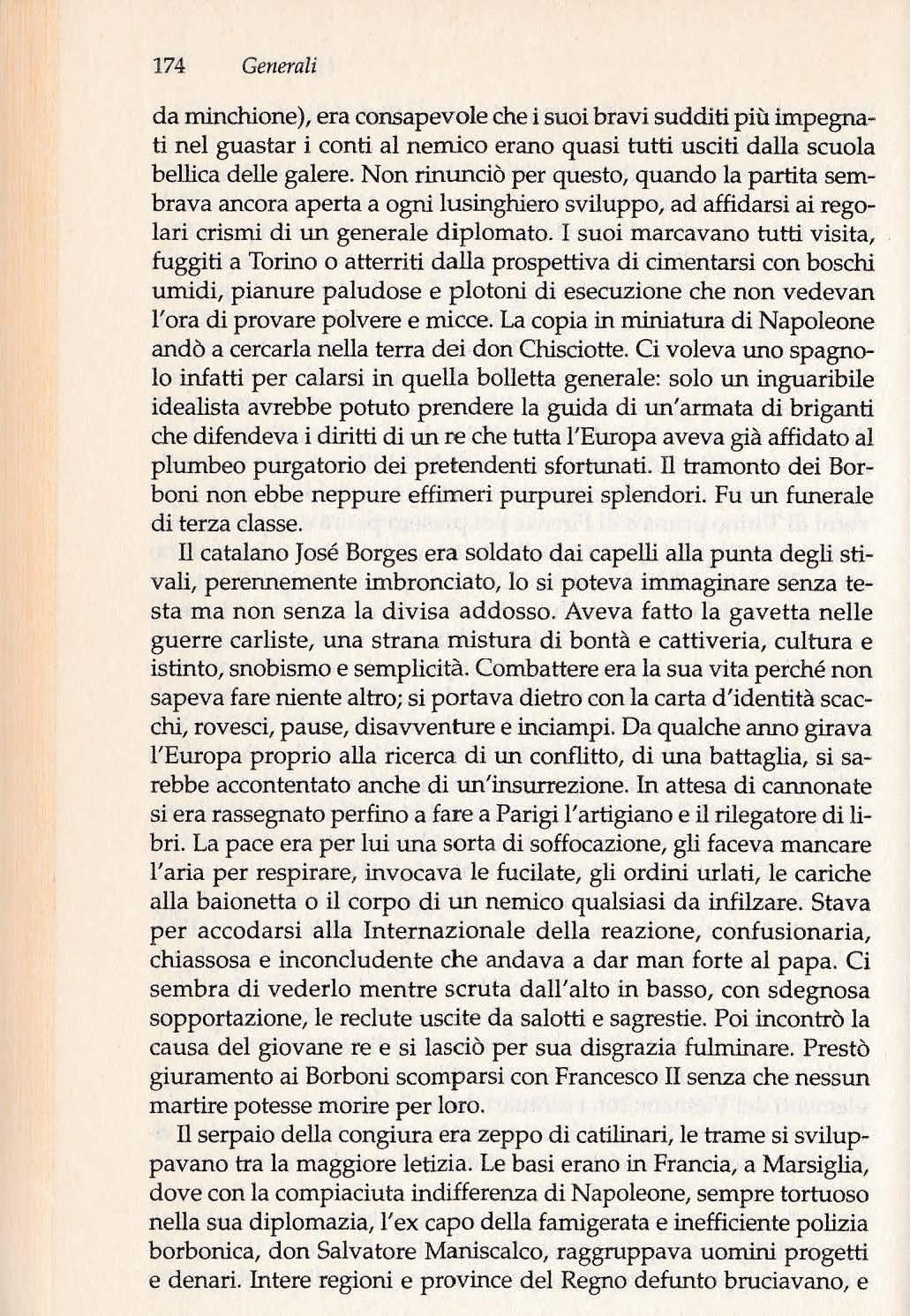
Il catalano José Borges era soldato dai capelli alla punta degli stivali, perennemente imbronciato, lo si poteva immaginare senza testa ma non senza la divisa addosso. Aveva fatto la gavetta nelle guerre carliste, una strana mistura di bontà e cattiveria, cultura e istinto, snobismo e semplicità. Combattere era la sua vita perché non sapeva fare niente altro; si portava dietro con la carta d'identità scacchi, rovesci, pause, disavventure e inciampi. Da qualche anno girava l'Europa proprio alla ricerca di un conflitto, di una battaglia, si sarebbe accontentato anche di un'insurrezione. In attesa di cannonate si era rassegnato perfino a fare a Parigi l 'artigiano e il rilegatore di libri. La pace era per lui una sorta di soffocazione, gli faceva mancare l'aria per respirare, invocava le fucilate, gli ordini urlati, le cariche alla baionetta o il corpo di un nemico qualsiasi da infilzare. Stava per accodarsi alla Internazionale della reazione, confusionaria, chiassosa e inconcludente che andava a dar man forte al papa. Ci sembra di vederlo mentre scruta dall'alto in basso, con sdegnosa sopportazione, le reclute uscite da salotti e sagrestie. Poi incontrò la causa del giovane re e si lasciò per sua disgrazia fulminare. Prestò giuramento ai Borboni scomparsi con Francesco II senza che nessun martire potesse morire per loro.
Il serpaio della congiura era zeppo di catilinari, le trame si sviluppavano tra la maggiore letizia. Le basi e rano in Francia, a Marsiglia, dove con la compiaciuta indifferenza di Napoleone, sempre tortuoso nella sua diplomaz ia, l'ex capo della famigerata e inefficiente polizia borbonica, don Salvatore Maniscalco, raggruppava uomini progetti e denari. Intere regioni e province del Regno defunto bruciavano, e
non solo metaforicamente, per l'attività di demiurghi rozzi e ignorantelli che i cospiratori dipingevano come fedelissimi al loro re spodestato e alla santa Chiesa. Ci voleva un miscredente per dubitare dell'esito quando l'alleato nella causa era il papa. Pio IX, guarito da tempo dalle mattane rivoluzionarie, assicurava lungo la permeabile frontiera con i suoi Stati libero passaggio a bande, emissari, spie, fuggiaschi. E i piemontesi non potevano che ruggire di rabbia e tacere. Anche il denaro, che ai tempi del Regno sembrava merce rarissima, tanto che il governo per mancanza di fondi si era rassegnato da decenni a fare nulla, sembrava scorrere a fiumi da sorgenti misteriose ma inesauribili. E poi c'era il passato che prometteva successo: contro quei partigiani avevano alzato bandiera bianca perfino le truppe della rivoluzione e di Napoleone Bonaparte. I legittimisti furono, alla moda borbonica, larghissimi di doni che non costavano niente e riuscivano in breve a far fiorire rigogliosi anche i timidi: gradi e commende per esempio. Borges divenne subito maresciallo di campo, e Gran Croce dell'ordine di Francesco I. Il comando si abbellì subito di uno stato maggiore che arruolò, fra gli altri, consumati reduci di tutte le guerre del continente; in maggioranza erano spagnoli come lui. La nota forte nella sinfonia la mise la promessa che, quando fosse sbarcato in Calabria imbracciando lo stendardo borbonico, moltitudini bibliche si sarebbero precipitate, con l'attenta regia d egli emissari del re, a sottoporsi ai suoi ordini. Già sentivi risuonare nei brindisi la marcia del cardinale Ruffo avviato su Napoli e dintorni. Borges voleva davvero combattere a qualsiasi costo. Impossibile non si accorgesse che dietro le scintillanti promesse c'era la secolare capacità dei Borboni di scambiare la fantasia per la realtà e una società intimamente guasta. Fece una tappa a Malta dove si sforzò di non vedere che la vantata organizzazione insurrezionale e ra una burl a. Tutti, in compenso, conoscevano la sua identità e il piano, segretissimo, della missione (quindi anche le torme di spie che i piemontesi avevano nell ' isola). Scienza e Provvidenza di miracoli ne fanno ancora, deve ave r pensato. Proseguì. Il 13 settembre 1861 sbarcò da una squinterna ta barchetta da emigranti, con cui aveva rischia to con lo stato maggiore di far naufragio a ogni miglio, e non trovò, delle proclamate armate sanfediste, nemmeno un uomo. I boschi e le paludi apparivano ostili e silenziose, i con tadini miserabili e spaventatissimi . Sui laghi di Galilea quando vi fiorivano le parabole di Gesù dovevano essere tutti così. Le s trade si presentavano come piste per capre e con polvere e fango ridussero in pochi g iorni a stracci le belle divise dello stato maggiore dell'in-

surrezione. Ci sono quelli nati apposta per fare da lente d'ingrandimento delle disgrazie. Borges non sarebbe stato uno spagnolo se avesse rinunciato: gettati via gli stivali sfondati e indossato un paio di zoccoli comprati da un contadino, dividendo con pastori tozzi di pane vecchio e formaggio, lo stato maggiore di Francesco II re di Napoli e di Gerusalemme avanzò con passo da funerale ma andò avanti. Era alla ricerca di un esercito per fare la guerra. I piemontesi, che sapevano tutto, gli erano già alle spalle. Per trovare soldati disposti a dargli retta impiegò venti giorni; si trascinò penosamente per tutta la Calabria, che assomigliava ancora a un'immensa foresta punteggiata da rare città e paesi simili a tiepidi presepi. Ogni giorno doveva sgusciare tra i piemontesi, gente che tende a strafare anche quando non è necessario.
Il bosco di Lagopesole, fitto e spaventoso, fu il palcoscenico adeguato per l'incontro. Non vi era posto che avesse dato un maggior numero di clienti alla galera. Il suo uomo era basso, muscoloso come un torello, un'aria rusticana, vegeto, con una faccia beffarda e feroce, modi che tradivano una educazione pessima. Si chiamava Carmine Croceo. Era un ex mandriano che aveva indurito la pelle nelle campagne borboniche, dove infuriava per trecentossessantacinque giorni l'anno la guerra per sopravvivere alla fame e alle sopraffazioni feudali. Ce le hanno descritte così le pagine straripanti di esecrazioni dei liberali; magari ci mettevano dell'interesse ma erano cronisti fedeli. Scuola crudele dove non c'era posto per i buoni sentimenti e si veniva su sempre con il coltello in mano, il libro delle ingiustizie quotidiane commesse dai birri, dai notabili, dai borghesi diventava in fretta enciclopedia. Croceo aveva dovuto pure indossare l'uniforme; per la regola non proprio davidica che lo imponeva ai poveracci in sostituzione dei ricchi che si comperavano il congedo. Raccontano le cronache giudiziarie, che guardano ai fatti e dimenticano le sfumature, che al ritorno aveva regolato i conti con un signorino . Aveva la colpa di aver insidiato le virtù della sorella; storia così esemplare da puzzar di falso. Comunque la severa sentenza lo trasformò definitivamente nella figura classica per cui il Sud è popolare tra poeti, annoiate damigelle e sociologi: il brigante. Taglieggiava paesi e passanti con un piglio così perentorio, un gesto così barocco da intenerire tutti i notisti in cerca di colore. Mise lo schioppo in soffitta per arruolarsi con Garibaldi. È storia comune a questi vandeani della grassazione. Chissà, sentivano qualche assonanza con le camicie rosse che un poco briganti erano anche loro. Il grande errore commesso dai piemontesi fu di licenziare quell 'esercito. Con i gari-

baldini Croceo quasi certamente sarebbe rimasto sergente e integrato nel nuovo ordine. Non ebbe invece altra possibilità che indossare di nuovo la vecchia divisa e andare incontro a quello strano generale che aveva bisogno di reclute . Solo le tragedie greche hanno qualcosa di cosi semplice e profondamente commovente. Nella verità sono complicate e senza palpiti . Prendete le reclute di Croceo: erano persone cui nella vita era mancata sorte migliore, incattivite, incarognite dalle prepotenze, spinte a gesti disperati. In quei boschi erano quasi imprendibili, si muovevano come nell'orto di casa. L'intendenza non costava nulla, avevano arruolato gli abitanti costretti un po' per simpatia e molto per paura a fornire cibo, rifugi, notizie. C'erano problemi di riverenze con Borges. Croceo era infatti pure lui un generale e i suoi luogotenenti, tra cui primeggiava la ferocia di Ninco Nanco, erano tutti almeno maggiori: gradi dati per burla ma a cui tenevano moltissimo. Rendeva meno gravi le loro miserie, scoloriva le colpe e la fedina penale: si sa, in guerra non si può andare con i guanti bianchi. Quella zona era ormai una terra liberata; i «partigiani» di Carmine, dopo aver messo in saccoccia borghi e frazioni sperduti tra i boschi e i monti, avevano perfino conquistato Melfi. E c'erano entrati tra gli archi trionfali che si tiravano su per la processione della Madonna, con il Te Deum in chiesa . Croceo aveva indossato per l'occas ione anche una stramba uniforme da generale e preso in mano la b a ndiera con i gigli. Quella era la vernice: dietro l'angolo i suoi sold ati si davano a fucilazioni saccheggi violenze per cui scartabellavano memorie secolari. I «liberali», che spesso non erano altro se non i n o tabili del vecchio regime passati a nuove passioni, arrivisti dai denti lunghi e dal sedere grosso, venivano giustiziati in strada, le figlie e le mogli stuprate; case e fattorie bruciate. La guardia nazionale che doveva battersi contro quei diavoli la scampava con la fuga. Pe nnaioli postumi hanno voluto, nonostante queste sconcezze, gus tare il piacere, caratteristico della nostra epoca, di conferire un alon e romantico ai mascalzoni.
Con questi galantuomini Borges iniziò la guerra contro i generali «italiani». Nonostante la lunga esperienza militare e le guerre spagnole, che come sappiamo non erano fatte per signorine o idealisti, s i accorse di avere molto da imparare. I briganti erano funzionari puntuali e zelanti del disordine. Avevano imbastito senza manuali, u s ando solo l'esperienza e l'astuzia contadina, una strategia efficacissima: non accettavano mai, con preveggenza maoista, il combattimento contro forze superiori, ma usavano il terreno per mettere il
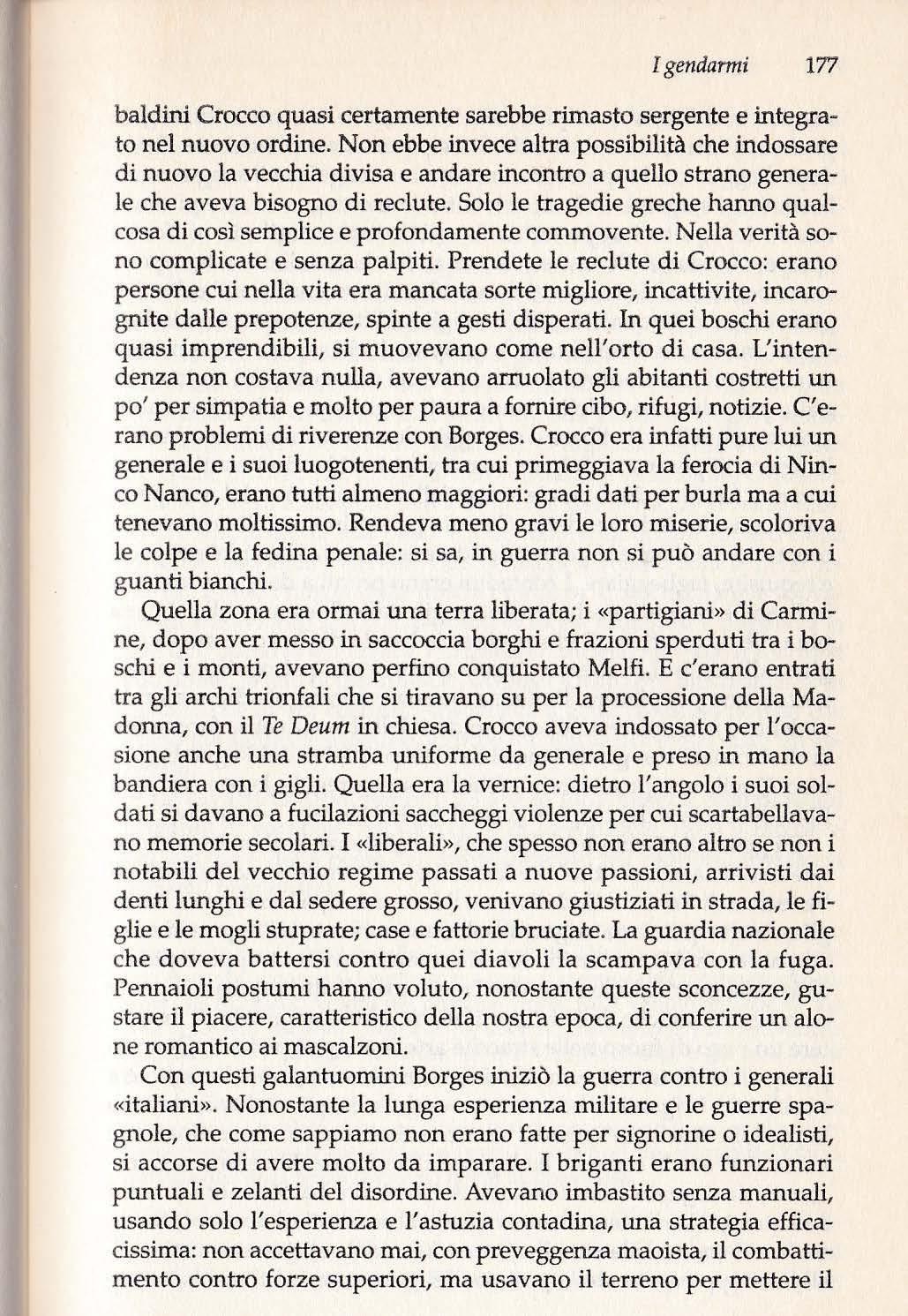
nemico in difficoltà e colpirlo nel momento in cui, smarrito in gole profonde, tormentato da bosclti fitti e pietraie, era più debole. E poi, dopo l'agguato- la sparatoria improvvisa che gelava il sangue e imbestialiva i sergenti - via di volata tra le montagne e i campi seminando inseguitori appesantiti da zaini uose artiglieria uniformi spesse e inadatte. Croceo schierava anche la cavalleria e la sapeva usare benissimo. Si teneva al fianco alcuni ex sottufficiali borbonici; gli avevano dato qualche utile consiglio militare e mettevano in battaglia una buona dose di rancore proprio di chi sapeva di esser stato sconfitto più dal tradimento dei capi e dal marciume del regime che dalle proprie colpe. Nelle bande tutti sognavano il bottino, molti amavano quella vita libera e selvaggia dove non mancavano i soldi, le donne si potevano palpare senza rischi saldando i conti magari con una fucilata , dove con la scusa della buona causa del re si potevano consumare le vendette. C'erano pane vino maccheroni ves titi oro, tutto quello che si poteva d esiderare; bas tava scendere nei paesi e requisire, taglieggiare. I contadini erano pronti a dare una mano, a indicare le case più ricche e a buttar giù dalle finestre quello che era più utile da arraffare. E vi stupite se la banda di Croceo contava migliaia di uomini? In mezzo c'erano anche feroci psicopatici che ammazzavano per piacere. Pazienza, questa era la regola di un mondo violento e nessuno certo di quei soldati della buona causa faceva finta di ricordare con grande mestizia i tempi infelici del Regno borbonico. Quella vita provvisoria e febbrile, senza regole, legata con ogni fibra del cuore e del corpo ai piaceri terreni bastava e avanzava. E i generali piemontesi? Esaurita la resiste nza borbonica, almeno quella ufficiale, con i timbri e le bandiere, sbarrate ormai le porte di Venezia e di Roma, il Sud divenne il loro principale campo di battaglia. Anche qui c'è da erigere il solito monumento all'imprevidenza. Apparvero subito s marriti, non si raccapezzavano: troppo rapide e abili nella guerriglia le forze dei Croceo e degli altri capibanda per le compassate tattiche delle truppe italiane. Non c'era modo di immettere un poco di fuoco nelle stracche arterie di quei pedanti . Quando per qualche fortunata combinazione si riusciva a parare l'assalto e a trascinare i briganti in uno scontro «regolare», gli «italiani» davano la pariglia. Anche se spesso il nemico si batteva con determinazione e non si a veva la certezza teologica della vittoria. Ma erano casi fortunati, da segnare sul calendario . A Cialdini e La Marmora (i nomi son quelli , il lavoro non mancava certo ai condottieri nostrani) toccava fare il conto delle cittadine incendiate, dei collaborazionisti uccisi. Purtroppo anche delle proteste dei galantuomini che si lamenta-

vano per essere s tati lasciati soli alle prese con i briganti. Incompre nsibile appariva a loro e ai politici di Torino, che le plebi libera te dal «serva ggio» si ostinassero a sputar sangue pe r i loro vecchi e feroci re . Si conclud eva sbriga tivamente che quelli erano «selvaggi». Avanti con lo stato di assedio, se non avete di meglio!
I p rimi successi contro i briganti li colsero così figure di irregolari, cavalieri di ventura della repressione. Ce n e sono s empre nelle guerre civili, ammazzare i compaesani aguzza virtù nascoste nel profondo. Già vivevano in tutt'altre s fere ai generali non ri velate . Per esempio n e ll a con s ta tazio ne che l'unico m o do p e r p revalere su que i giannizzeri era di u sare i loro stessi metodi. Erano strateghi spontanei. Soffermatevi s u Davide Mennuni; ci togliamo il cap pello, citando anche il borgo che lo regalò a lla ve trina d e l quotidiano, Genzano. Non si poteva essere più belva di lui nel d ar la caccia ai reazionari, aveva dup li cato l a sua p estifera dedizione in alc uni reparti della guardia n azionale a cavallo, fidati e decisi a ve nde r cara la pell e come lui. Erano i ranger della nostra Frontiera . Con i fuorilegge usavano g li st essi modi spicci. Gu ardavi in faccia Mennuni e trapelava la bile d e ll'uomo svalorizzato. I briganti si rintanava no solo a sentire il s uo nome, la rete di informatori, disposti a tutto per una manciata di denaro, che aveva costruito scod ellava a ge tto continuo notizie che e rano già sentenze eseguite . Eppure lui non sarebbe mai stato ungenerale.

La cava lleria di Menn uni il 23 aprile 1861 riuscì a piombare sui b riganti, di sorpresa, nel loro covo di Lagopesole. Ecco il raccon to del sangue e d ella peste del comba ttimento n el rapporto inviato ai generali piemontesi:
Ieri sera verso le ore 24 s i giunse in Forenza e stamane sul far del g iorno sono u scito con la detta cavalleria percorrendo il bosco grande dietro il paese, l ' Arenara, e poscia il Lagop esole . Quasi al termine dell'ultimo bosco esis tono gli agghiacci vernili del principe Doria. Mi è ve nuto il sospetto ch e colà c i fossero annidati i briganti. Mi son o diretto verso la parte del primo agghiaccio ove mi son o imbattuto in una ventina di essi; e già uno aveva impugnato il fucile p e r tirarmi; ma essendosi accort o che a lla punta dell' arma eravi lo s toppaglio si è accinto a levarlo, io più destro di lui l' h o disteso a terra con una fucilata. A questo colpo essi s i sono menati fuori, e la cavalleria ha energicamente s ostenuto un fuoco di circa due o re, ammazzando una trentina dell'orda senza ricevere i nostri alcW\a offesa.
Eran modi di guerra ignoti ai piemontes i. Dedichiamoci alle disavventure del gen erale De Sonnaz. Pochi come lui occupavano così s modatamente la vetrina del Risorgimento, era sempre in prima fila,
il temerario. Grigio: barba, capelli e il resto. Eppure troneggiava su ogni argomento, sapeva di tutto. Insegnava ogni cosa. Il suo avversario, che si era dato da solo ma meritatamente la qualifica di Gran Generale di tutti gli eserciti del Regno, era Luigi Alonzi. Il nom de piume guerresco, Chiavone, colpiva non proprio favorevolmente. Abbiamo l'incomoda abitudine di addentrarci nelle biografie: sono miniere. Era Chiavane un ex guardaboschi; occhi perduti nelle occhiaie fonde, che dardeggiavano lampi. La leggenda gli ha attribuito doti quasi animalesche di forza fisica e capacità di sopravvivenza. Insomma non moriva mai, risorgeva dalle ceneri. Pensiamo aggiungesse anche la capacità volpina di sfruttare le circostanze e un sesto senso per la politica. La sua banda operava saggiamente ai confini con lo Stato pontificio, terre benedette dall'abbraccio del Liri e dell'alto Volturno. Chiavone colpiva con la sua banda popolata cli guardaboschi e carbonai, tutta gente rude e incarognita da intemperie e miserie millenarie, febbri endemiche, fame implacata; poi, sfruttando la complicità di gendarmi venali e cardinali che vedevano la mano dell'Onnipotente in ogni guaio dei piemontesi, si rifugiava oltre confine. Con il tempo si era fatto audace, aveva addirittura liberato per alcuni giorni un grosso borgo come Sora . Erano state giornate indimenticabili quelle: si era insediato nel palazzo del governatore, aveva fatto bruciare pubblicamente i ritratti cli Vittorio Emanuele l'usurpatore e amministrato pomposamente la giustizia in nome del legittimo re Francesco II . Era diventato così famoso che il sovrano gli mandò un consigliere militare dal nome altisonante, il conte Théodule de Christen. Doveva coordinare la sua attività con i sempre confusi ma ambiziosi piani borbonici. Fu il conte, che senza essere un genio aveva l'istinto della propria grandezza, a suggerirgli di ripetere l'impresa di Sora, nel frattempo ricaduta sotto le criminali pretese piemontesi. Chiavone abolì per un attimo la sua scettica saggezza ed eseguì. Si ritrovò alle calcagna Maurizio de Sonnaz con una colonna di tremila piemontesi inferociti per il duplice affronto e soprattutto dotati di artiglieria . Questa volta volevano tagliargli gli artigli, fargli pagare le beffe. La banda, composta da circa ottocento briganti, sgusciando passò il confine pontificio trovando la calda accoglienza dei monaci dell'abbazia di Casamari, altri salvatori di uomini che avevano deciso di dare una divisa all'esercizio della carità cristiana. Salvavano solo i borbonici. Gli altri li consegnavano a Satana. Chiavane si abbandonava già alle stentate giaculatorie con cui festeggiava lo scampato pericolo. Ma il conte, nonché generale, questa volta si fece ardito fi-

no ai limiti della disobbedienza; avrebbe ignorato i confini e il diritto internazionale. Era stufo di mostrare i denti senza mordere, di farsi beffare da quei cafoni che se ne andavano carichi di bottino e con le bandiere al vento. Fronte bassa e avanti in colonna alla baionetta. La testa possibilmente non metaforica di Chiavone avrebbe zittito qualsiasi rimprovero dei superiori. Al mattino il brigante, sporgendosi dalle spesse mura della fortezza-convento, vide con gran sorpresa le divise blu dei piemontesi che lo assediavano come se fosse alla periferia di Torino. Ormai la guerra imbarbariva, avrà pensato, non erano più i vecchi tempi quando i confini erano sacri.
I monaci, che conoscevano a menadito la furia laicista e massonica degli assalitori, fuggirono inveendo contro le ladronerie da lanzichenecchi, le ferocie da vandali e le empietà da musulmani dei piemontesi, lasciando i borbonici alle prese con le legioni dei senza Dio. Chiavone, non si sa come, riuscì a sganciarsi mentre il convento andava a fuoco sotto le cannonate e il saccheggio dei piemontesi imbestialiti. Arrivò al paesone di Bauco aggrappato ai monti Emici, e difeso come nel Medioevo da mura un poco scalcinate ma ancora possenti. T1rò un sospiro di sollievo. Invece no. De Sonnaz, guidato da alcuni collaborazionisti che si ripromettevano dall'espugnazione della città privati e poco commendevoli vantaggi, era di nuovo lì, schierato con uomini cavalli e cannoni . Quell'uomo non aveva limiti: voleva inseguirlo fino all'altare di San Pietro, mettere a fuoco l'Europa cristiana . Visto che erano circondati, Chiavone e il conte-consigliere decisero che non c' era altra strada che difendersi. Guarnirono con attenzione le mura di tiratori scelti piazzati in case e posizioni da cui potevano infliggere al nemico costretto all'assalto i danni più gravi. De Sonnaz si affidò dapprima ai suoi quattro cannoni, che scaricarono per due ore palle e mitraglia sul paese ma senza ottenere visibili risultati: erano coriacee come i briganti quelle vecchie mura. Poi, dopo tutto quello scenografico baccano, il generale si stufò. In fondo aveva davanti quattro taglialegna, e lanciò all'assalto le colonne. Per entrare in quella stamberga di ribelli c'erano solo due porte; fanti e granatieri dovettero sottoporsi al pedaggio delle fucilate dei cecchini di Chiavone. Duro pellegrinaggio . La gragnola di piombo indemoniava. I briganti tiravano in uno sciupio di fumo asserragliati dentro un torrione, acquattati dietro un muro da dove, quando finivano le munizioni, replicavano agli assalitori con le pietre. Il capobanda e il conte correvano di qua e di là incitandoli, gridando che Dio e la Madonna e il buon re si battevano al loro fianco. Dopo ore di inutili tentativi egra-

vi perdite De Sonnaz si riconobbe battuto. Trattò con i briganti un accordo (che umiliazione per il generale!) che brandì poi come un certificato di assoluzione per lo smacco. Lui si sarebbe ritirato; in cambio quelli promettevano che non avrebbero più condotto incursioni oltre confine .
La vittoria fece perdere la misura a Chlavone. A ogni razzia si aumentava i gradi, si faceva chlamare comandante supremo della reali armi di Terra di l avoro e Molise. Adesso indossava anche quando andava a letto una uniforme molto sudamericana. Se proprio gli dobbiamo trovare un difetto, non era la crudeltà - pare esibisse con i prigionieri compassione e cavalleria -, aveva piuttosto la mania di imitare Garibaldi, in testa teneva ben calcato lo stesso zucchetto dell'Eroe. Voleva diventare celebre, gli piaceva la pubblicità. Poiché l'ortografia gli giocava spesso brutti scherzi, aveva affidato l' ufficio stampa e propaganda ad alcuni gesuiti. Quelli ripagavano dipingendolo anche fisicamente come un Gesù rusticano con i capelli fluenti e gli occhl magnetici. Corse rischi terribili pur di ospitare nei suoi covi una équipe di giornalisti e fotografi dell' «Illustration» . Nel 1862 fu uno scoop, che ripagarono facendo circolare una colorita serie di bugie ed esagerazioni. Chiavone divenne un Robin Hood vessato da invasori feroci. Al settimo cielo offrì pranzi pantagruelici con i migliori vini d'Abruzzo e Moet d'annata. Per la copertina scelse una foto che lo immortalava con gli zoccoli e in alta uniforme.
De Sonnaz non sarebbe mai riuscito a fargli tutto il male che si procurò da solo . Ora pensava in grande; era passato dalla rapina alla campagna militare. Tentò incursioni che diventarono ambiziose e irrealistiche e si concludevano in continui disastri. Poiché credeva davvero di essere diventato un generale, cercò di prendere Castel di Sangro, ben difesa da soldati e guardie nazionali. Fu un massacro da cui la sua banda uscì in p ezzi. I legittimisti, stufi di un brigante che non vinceva più, lo fucilarono alla chetichella.
I maggiori successi contro i briganti non furono opera dei bersag lieri, che pure seppero adeguarsi a quella guerra alleggerendo ulteriormente i loro bagagli e diventando veloci almeno quanto il nemico. Li ottennero invece le guardie nazionali, che riunivano i borghesi delle città; avevano aderito per convenienza più che per scelta ideologica al nuovo regime e avevano una gran paura dei taglieggiamenti e delle violenze. Vi intravedevano, a ragione, il riapparire della violenta protesta sociale, legata alla miseria e a l problema delle terre demaniali, uno sfogatoio dei rancori delle terre del Sud. Al loro fianco si sistemarono altri avversari assai pericolosi per i briganti: le

armate personali dei latifondisti, ex galeotti, uomini perduti e disposti a tutto, insomma della stessa pasta dei Croceo e decisi a usare gli stessi metodi. I «signori» infatti, di fronte ai ricatti di quei legittimisti così voraci, avevano gettato le simpatie borboniche ed erano diven tati grandi tifosi del re Vittorio. Furono loro a difendere i paesi, a tendere ai briganti imboscate sanguinose, a guidare le truppe nei santuari del nemico: sapevan bene di combattere per la vita o la morte, che in caso di sconfitta avrebbero trovato il palazzotto bruciato, la masseria sventrata, il bestiame «sgarrettato» . I generali «italiani» copiarono da quei maestri.
li più abile tra loro fu Emilio Pallavicini conte di Priola, un vero Alcibiade della controguerriglia . Riformò la struttura delle sue truppe aumentando per esempio i nuclei «mobili»; i suoi cavalieri infuriati divoravano la via appena arrivava una segnalazione utile sui movimenti del nemico. Soprattutto fu un focoso fautore di un nuovo istituto giuridico destinato a ingombranti fortune: il pentitismo. Le sghembe piroette della vita hanno fatto nicchiare Pallavicini tra gli uomini d'arme. Gli hanno fatto torto: era un filosofo. E della famiglia dei cinici. Per lui non c'era essere umano che potesse resistere alle lusinghe di una mancia, di una ricompensa in denaro. I trenta denari di Giuda erano il grimaldello con cui spiegava la vita. Non c'è che dire; era obbligato dalle sue funzioni ad avere una certa conoscenz a della miseria e della grandezza umana. Soprattutto della prima. Impugnando sal damente confessioni più o meno spontanee, pagate con la immunità e altri favori, sempre con il borsello in mano, nel 1863 cominciò a ripulire la Capitanata, poi la zona di Melfi infine il Vulture. Bande fino al giorno prima imprendibili evaporavano. Tradito da una spia, venne catturato e fucilato sul posto un capobanda celebre come Michele Caruso che aveva turbato i sonni di eserciti interi. Altri capi come Gennariello finirono poco gloriosamente sgozzati nel sonno, da gregari fedelissimi espugnati da una taglia di duecento lire.
li colpo più grosso di Pallavicini fu Ninco Nanco, il luogotenente di Croceo, «rozzo e tartaglione» come diceva il suo capo, ma considerato un maestro in ferocia e agguati. La faccia che era una ditta patibolare, gli occhi fondi di chi ha ficcato lo sguardo in delitti inenarrabili, questo selvaggio fu tradito da un pentito insieme al fratello Francesco. A leggere i verbali della sua fine ti viene in mente il giallo irrisolto di Salvatore Giuliano . I soldati di Pallavicini sorpresero i due briganti in una casupola vicino a Frusci dove si erano recati, ignari, per un incontro forse proprio con quelli che li avevano
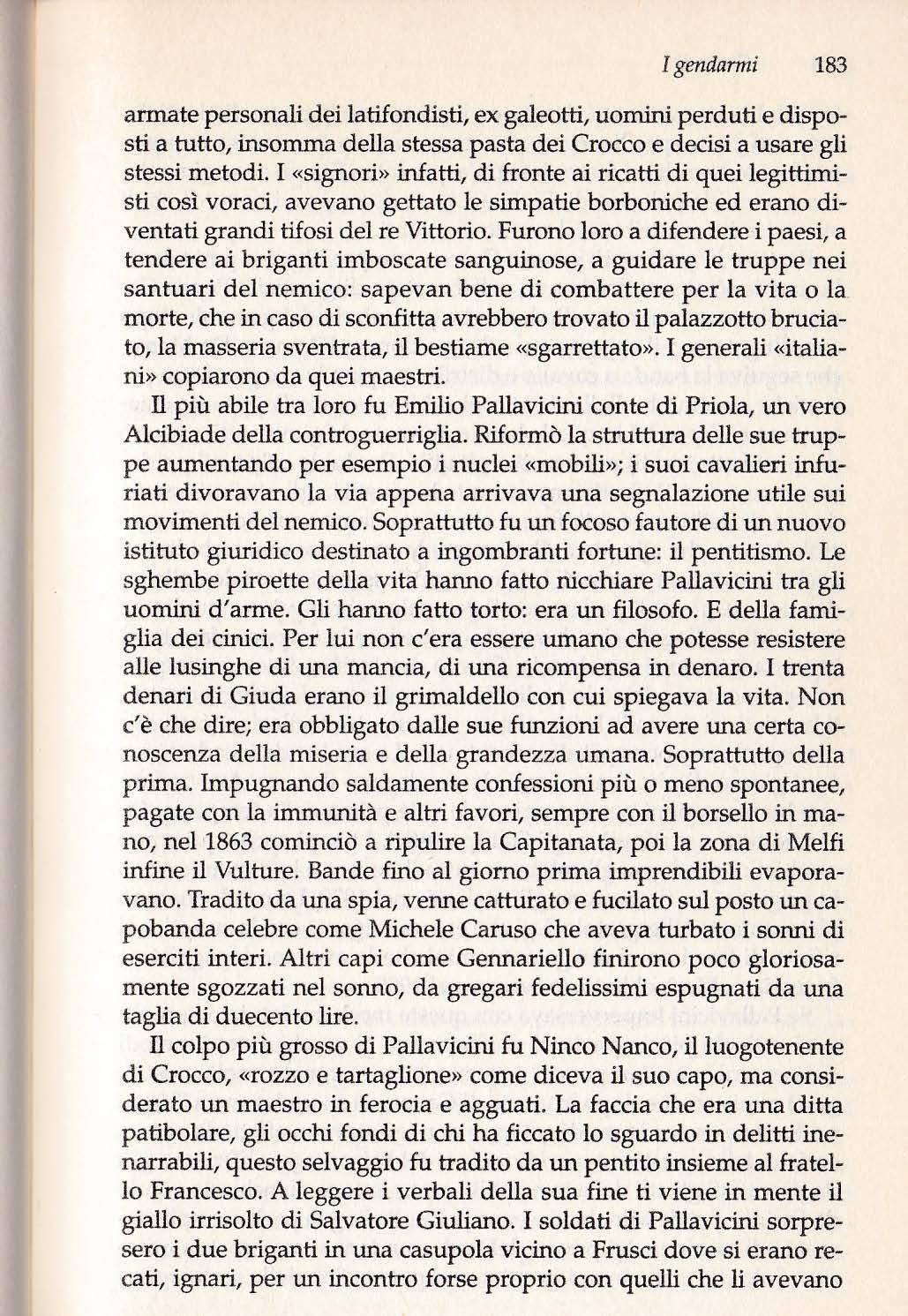
traditi. Li catturarono vivi, ma non li portarono in paese; li giustiziarono sul posto, poi li slegarono e prepararono una messa in scena per far credere che ci fosse stata un ' aspra lotta. Era un accorgimento, come accadde nel caso di Giuliano, per nascondere i nomi di chi li aveva traditi, e attribuire il merito ai soldati.
Restava la preda più grossa: Croceo, sempre libero e pericoloso. Lo inchiodò al suo destino un collaboratore di giustizia, Peppe Caruso. Si era consegnato alle lusinghe pecuniarie del generale dopo aver litigato con il capo a causa di una donna, Filomena De Marco, che seguiva la banda a cavallo e distribuiva pare le sue grazie un po' rustiche a entrambi. Pallavicini capì subito che «zio Peppe» (lo chiamavano così perché in quelle bande, formate da giovanotti, era uno dei pochi attempati) poteva essergli utile. Per lui la colpa e il perdono erano concetti elastici: nonostante la giustizia gli attribuisse una decina di delitti accertati, fece sì che lo condannassero solo ali'ergastolo invece che alla forca . Il carcere e le promesse ammorbidirono a nche la sua dura scorza di brigante, produssero il miracolo della redenzione. Chiese di parlare con il generale e si ritrovò a capo di una banda di tagliagole che dovevano precedere le truppe e fare terra bruciata attorno al capobanda. Croceo cominciò a diventare inquieto: i piemontesi adesso lo pedinavano come segugi, i rifugi eran tutti bruciati, di duemila briganti ne restavano, tra fucilazioni catture e rese spontanee, poco più di un centinaio. La s ua banda incadaveriva ogni giorno di più . Erano conti che fendevano il cuore. Aveva dunque buone ragioni per raccogliere le vele prima della tempesta . Licenziò tutti e si rifugiò n egli Stati pontifici. I tempi anche qui erano cambiati: i gendarmi gli rubarono tutto il denaro e lo dimenticarono in prigione. Lo ritrovarono gli «italiani» nel 1870. Lo condannarono pietosamente all'ergastolo. Lui che era un brigante con la sua etica si rifiutò di fare i nomi dei galantuomini che lo avevano ingaggiato e foraggiato. Morì, obliato, in carcere nel 1905.
Se Pallavicini imperversava con queste moderne intuizioni, molti suoi colleghi più impaz ienti si affidavano ai vecchi, buoni metodi dei governi autoritari per cui avevano, tutto sommato, molta nostalgia . I ministeri che dopo la morte di Cavour si succedevano a Torino e a Firenze con cadenze di galoppo non ignoravano affatto la natura sociale della questione meridionale e del brigantaggio. Tiriamo giù dag li scaffali gli atti della inevitabile commissione di inchiesta voluta da Farini e poi d a Minghetti: senza peli sulla lingua parlano esplicitamente di reazione dei poveri del Sud «condannati a perpetua miseria». Solo che erano tempi in cui non s i poteva fare della sociologia: i
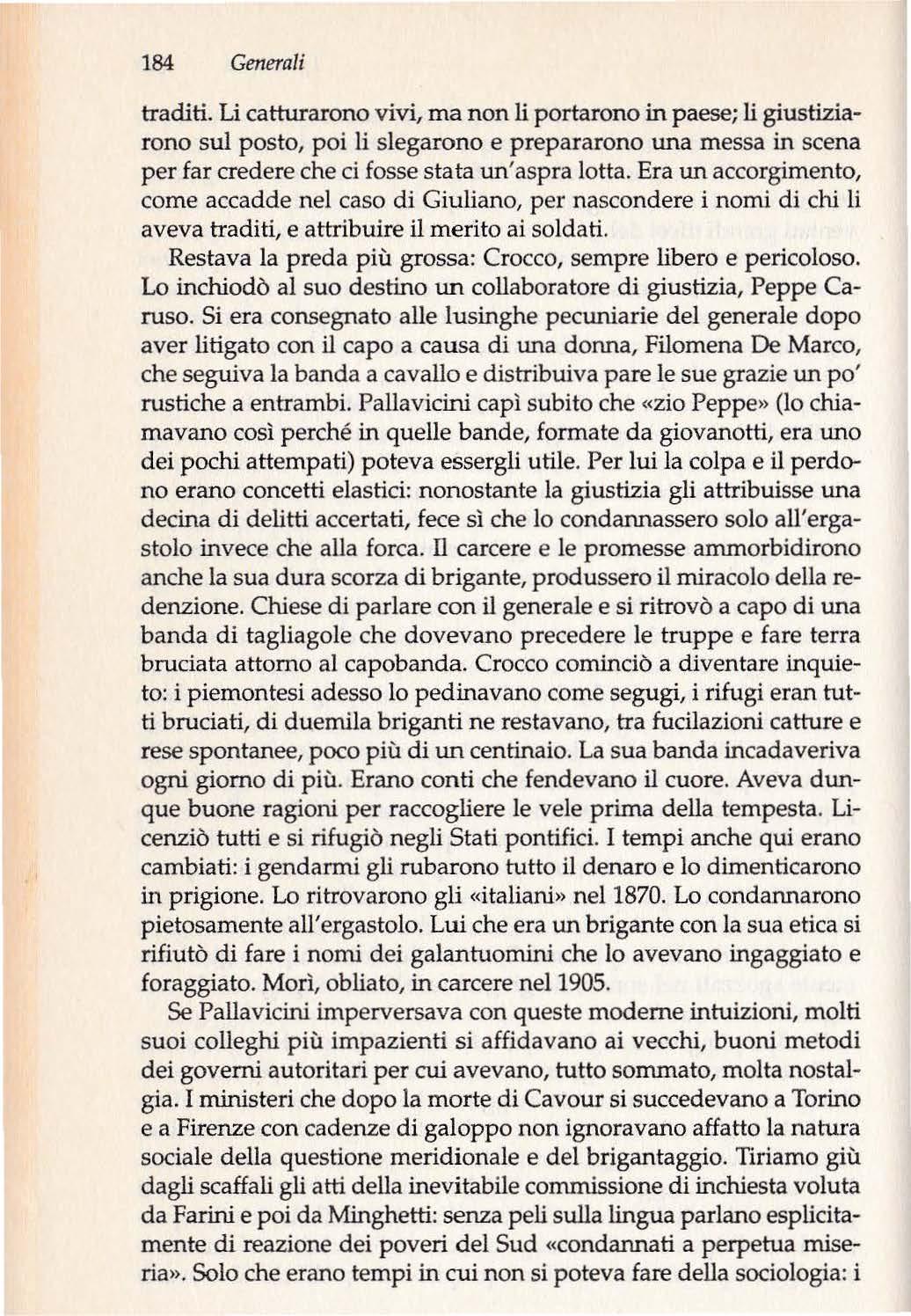
mezzi dello Stato erano modesti se non inesistenti, il complotto borbonico-austriaco-papalino contro l'Italia c'era eccome. Non si poteva perdere tempo. Si chledeva ai militari di eliminare quell'insidia alle r adici e con ogni mezzo. Poi si sarebbe pensato a riformare e arricchlre.
Le idee dei generali erano ricalcate sugli umori della folla liberale rannicchlata nel benessere . Non erano ciechl, vedevano attorno a sé facce che riassumevano secoli di patimenti. Ma badavano piuttosto ai numeri, quelli delle bande in armi, quattrocento, con almeno seimila briganti in attività che diventavano cinquantamila se si aggiungevano i complici, i sostenitori, i tiepidi. Era una colonia da conquistare.
Le cifre delle perdite subite dai soldati non sono mai state conteggiate ufficialmente e questo la dice lunga: erano così elevate che conoscerle avrebbe depresso l'umore nazionale. In quella guerra non si moriva da eroi. Perché quei simpatici briganti, che sono stati dipinti come personaggi di Byron, praticavano abitudini sel vagge. Ninco Nanco, già condannato per omicidio dai Borboni, era solito giocare a bocce con le teste degli ufficiali e dei soldati «italiani». Croceo, non è una leggenda, più volte seppellì vivi fanti e bersaglieri. Sarebbe ingenuo strabuzzare gli occhl e indignarsi se i plotoni di esecuzione non avevano il tempo di tirare il fiato. Alla fine, facendo calcoli accurati ma certamente al ribasso, il Molfese registra tra il 1861 e il 1865 oltre cinquemila fucilati. Gli zel anti estensori della leggenda borbonica e dell'occupazione coloniale piemontese giurano che furono almeno il doppio. È certo che spesso i generali dimenticavano di segnalare nei rapporti molti briganti fucilati quando il campo di battaglia non si era ancora r affreddato; preferivano, per non aver seccature ministeriali, inserirli negli elenchl dei caduti in combattimento.
Alle smanie repressive dei generali il governo aveva offerto un braccio giuridico di cui certo anche i più invasati non potevano lamentarsi: la legge Pica. Con tale spiccio strumento si istituirono i tribunali militari e si garantì loro il diritto di comminare la fucilazione immediata a chl era sorpreso con le armi in mano. Ma la vera novità di questo arsenale legislativo era nella strategia per togliere ai briganti collaborazioni, aiu ti, rifornimenti, informazioni. Riguardava chl veniva colto ad aiutare in qualsiasi modo i ribelli. Qui i giudici avevano mano libera di lasciar lavorare sospetti e fantasia senza farsi troppo condizionare da scrupoli legulei. La punizione era il domicilio coatto. Ai briganti che si presentavano spontaneamente si face-
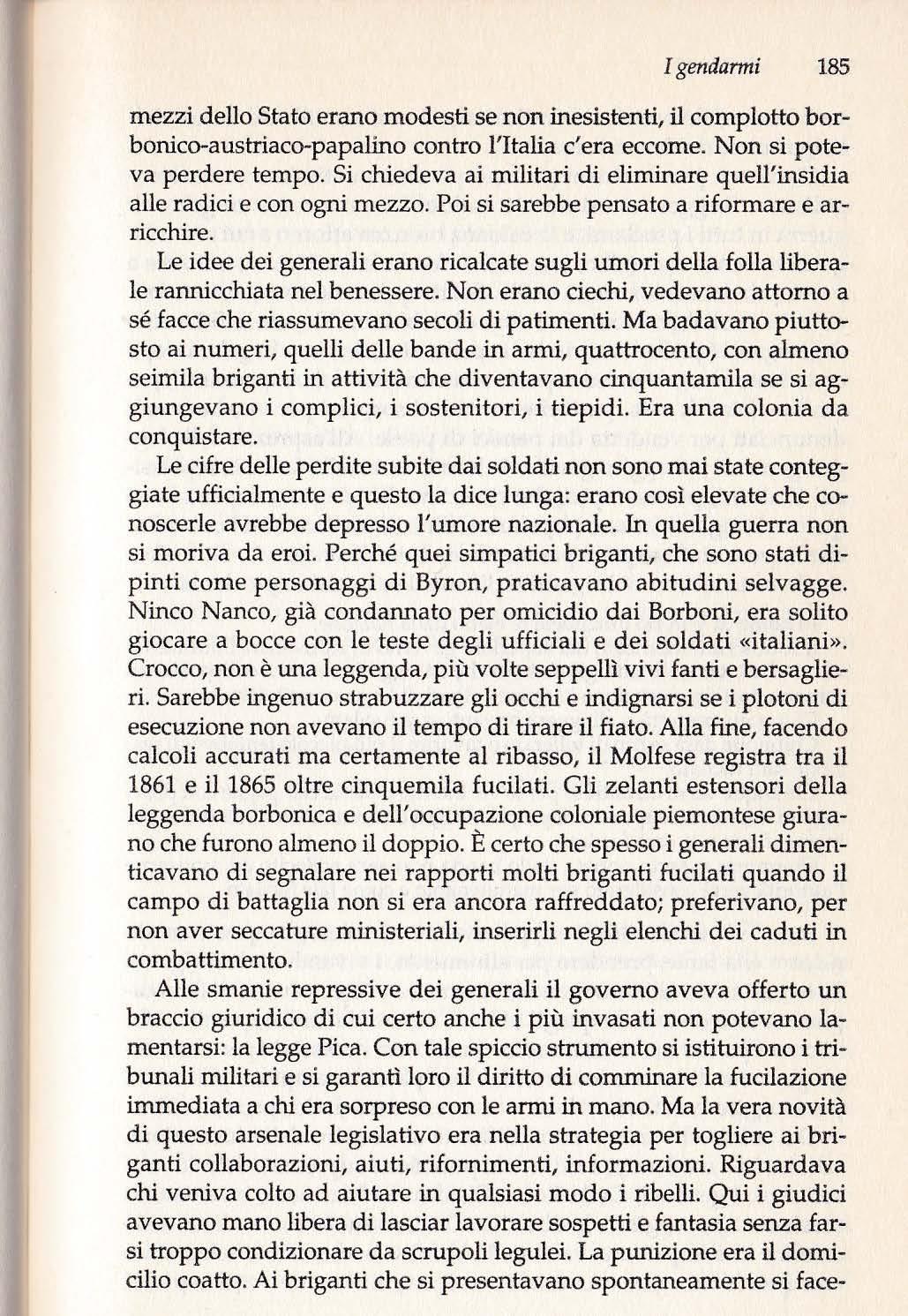
va balenare, invece che la fucilazione, il non scintillante futuro del!'ergastolo e dei lavori forzati.
C'era una parola che ai generali piaceva moltissimo: «manutengolismo». Leggendola si deve trasalire. Risuona come un grido di guerra in tutti i proclami, è la colonna bronzea attorno a cui si avvolgono sentenze esemplari, annunci di forche e fucilazioni, minacce a paesi, province e comunità ribelli. Si attruppavano con questo termine tutti i collaborazionisti: dentro ci dobbiamo ficcare le fidanzate dei briganti (qualcuna ci rimise la pelle, altre finirono in galera dopo esser state fotografate ed esposte alla curiosità dei benpensanti), parenti e vicirtl di casa, pastori e contadirtl sorpresi per via, innocenti denunciati per vendetta dai nemici di paese. All'asprezza della legge i generali poi aggiungevano la loro inesauribile fantasia repressiva. Cialdini, per esempio, che ricordava la Spagna e sapeva bene quanto i briganti fossero popolari, ordinò di fucilare tutti i contadirtl che fossero stati sorpresi per strade e sentieri con pane o altre cibarie. In tutte le terre di briganti si diffuse il suo celebre proclama:
In nome di Vittorio Emanuele re eletto dalla nazione, il sottoscritto incaricato dal superiore governo di ripristinare l'ordine avvisa indistintamente tutti gli abitanti che da oggi fino a nuove disposizioni saranno posti in esecuzione i seguenti rigori di legge eccezionale.
Chiunque tratterrà o alloggerà briganti sarà fucilato.
Chiunque darà segno di tollerare o favorire il più piccolo tentativo di reazione sarà fu c ilato.
Chiunque verrà incontrato per le vie inte rne o per la campagna con provvigioni alimentari superiori ai propri bisogni o con munizioni da fuoco per ingiustificato uso sarà fucilato.
Chiunque avendo notizie delle bande non sarà sollecito ad avvisarne l'autorità verrà considerato per manutengolo e come tale fucilato.
E cosl via fucilando. Si supponeva che si volesse in questo modo ridurre alla fame, prendere per sfinimento, i vivandieri dei briganti . Se ne andarono all'altro mondo, mentre invano cercavano di farsi capire nei loro dialetti da quegli ufficiali venuti da Torino, poveri cafoni che si portavano nella bisaccia quanto era necessario per una lunga giornata di lavoro lontano dai loro paesi arrampicati sui monti per sfuggire la malaria. Al solito si arrestavano amici, parenti, affirtl.
Dal ministero arrivavano, di fronte al numero delle fucilazioni, radi inviti a moderare, a ridurre la punizione suprema e definitiva ai soli capi. I generali, Della Rocca Cialdini La Marmara, inventarono un sistema per aggirare la direttiva. Ordinavano ai comandanti delle colonne che imperversavano nella Vandea borbonica di telegrafare con questa formula: «Arrestati con le armi in mano venti capi dei
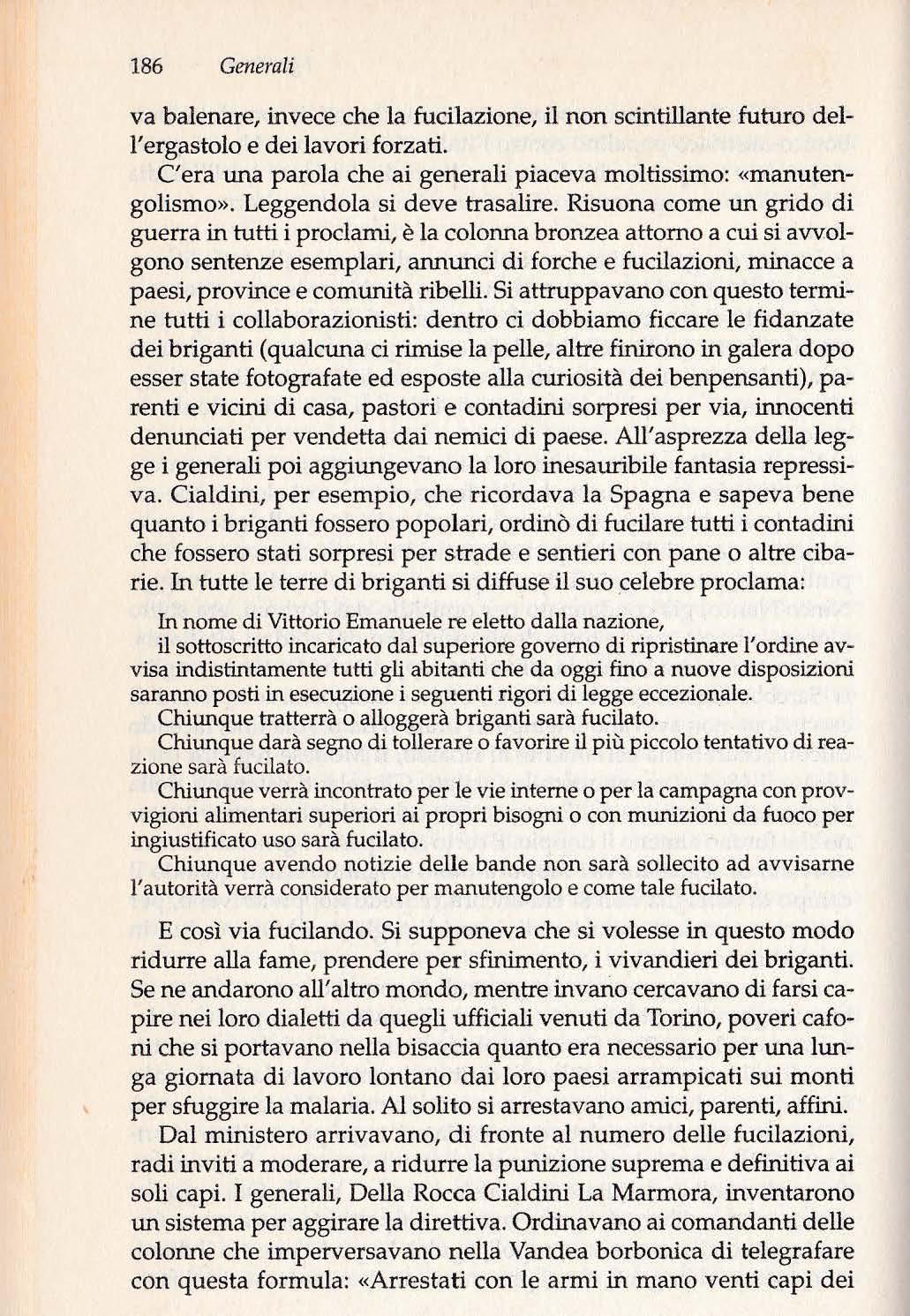
briganti». Dal comando si rispondeva: «Fucilate». Al Fanti, che comandava l 'esercito, dopo un po' questo numero straordinario di capi divenne sospetto; ordinò di sospendere le fucilazioni e di spedire in prigione g li arrestati. Dopo poche settimane carceri e caserme straripavano e si riprese con i plotoni di esecuzione.

Dove n on arrivava la fantasia dei generali prowedeva quella di colonnelli e maggiori: incaricati di riscuotere l 'imposta che, con la coscrizione, negli Stati borbonici era una sconvolgente novità, annunciarono che se i pagamenti non fossero stati effettuati entro quarantott'ore «si forzeranno i morosi inviando i soldati al loro domicilio che dormiranno in uniforme nei migliori letti del locale». Come a i tempi del fiscalismo di Diocleziano!
C'era anche chi, non corazzato dalla stessa anestesia morale, si smarriva. Il generale Pinelli, per esempio. Aveva baionettato l'Abruzzo Ulteriore, estirpato col ferro e col fuoco quella geldra cli criminali sbu cati dai sottosuoli. Venne preso in ostaggio con un tranello dal consiglio comuna le di un paesino reazionario e abitato da briganti. Non gli venne alcun male dal sequestro, si liberò subito . Ma incarognì lo stesso, aderì a un estremismo che si misurava coi punti esclamativi. Emise un proclama in cui, accusando l o Stato pontificio di dare mano ai ribelli, definl il papa «sacerdotal vampiro che con le sozze labbra succhia da secoli il sangue della madre nostra.. .». Apriti cielo! Era troppo anche per i mangiapreti che avevano fatto l'Italia. Fu necessario richiamarlo; minacciava di passare a fil di spada tutti gli abitanti del paese che avevano osato mettergli le mani addosso.
Quelli ch e scherzavano meno erano gli ex garibaldini: molti di quei briganti avevano indossato la camicia rossa, sfrigolava qualche rimorso e la voglia di dimostrare che non c'entravano nulla con l'epica impresa. Saremmo maliziosi a ricordare che Garibalcti aveva dato il cattivo esempio: s i era accordato con i camorristi napoletani. Assicuravano la città tranquilla in cambio di una compi acente indifferenza ai loro traffici! Torniamo sempre a quel punto, all' errore di aver sciolto l'esercito ga riba ldino. Aumentarono, con i reduci delusi e senza paga, le reclute dei briganti e mancò lo strumento ideale per la repressione. I metodi infatti avrebbero messo invictia a Torquemada. Quando fu spedito in Calabria, Sirtori appiccicò ai muri di Catanzaro w, proclama in cui diceva: «Il brigantaggio deve vincersi o con l'amore o con il terrore». Visto che d el primo c'era poca traccia si abusava del secondo. Avrebbe voluto trascinare i rivoltosi a Torino in catene per fame omaggio come gli schiav i etiopi dell' Aida. Con il
piombo si provvedeva agli uomini, ma non si dimenticavano neppure le cose quasi fossero anch'esse contagiate irrimediabilmente dalla peste brigantesca:
Tutti i pagliai devono essere bruciati e le torri e le case di campagna che sono abitate e conservate devono essere scoperchiate entro tre giorni e avere le loro aperture murate. Passato questo tempo saranno date al fuoco e inoltre saranno abbattuti tutti gli animali non protetti dalla forza pubblica.
Era la punizione cartaginese, si scomodavano le ferocie degli antenati . Gli ex garibaldini erano i più infiammati nel richiedere che per sgomberare le caserme dove si stava allo stretto gli arrestati venissero spediti in isole un po' fuori mano, il Madagascar, l'India portoghese o l'Australia, per definizione terra di galeotti . Si fece fatica a convincerli che nel nostro diritto non esisteva l'istituto della deportazione e soprattutto nessuno era disposto ad accollarsi quegli ospiti; anche se i tentativi con alcuni governi si fecero . Curiosamente, proprio la ricerca di una terra dove spedire i manutengoli a riflettere sui loro misfatti fu una delle ragioni iniziali della ricerca di una colonia. Bisogna dire che ad Assab per loro fo r tuna i banditi meridionali non traslocarono mai.
Quella che all'inizio sembrava una fastidiosa operazione di polizia si era trasformata in una guerra di lusso. Nella repressione i generali comandarono armate che nei momenti di maggiore attività arrivarono anche a centoventimila uomini. L'avventura repressiva, dapprima detestata, cominciava a piacere. Per la prima volta assaggiarono il frutto avvelenato del potere assoluto. Detestavano il controllo governativo più che i briganti; lì, nelle province ribelli, disponevano del diritto di fare quello che volevano : fucilare, cambiare sindaci e consigli comunali, mettere in riga i prefetti, fare la voce grossa nell' amministrazione e nell'economia. Erano governatori di colonie che il governo centrale trattava alla pari, per cui non valevano le norme dello Statuto . Un tenente poteva cacciare dalla sua poltrona un sindaco, qualche volta si preferì trascurare i briganti per avere mano libera sui liberali che avevano il torto di alzare la voce, scrivere articoli al cianuro, chiedere giustizia. Gente che si infuriava se un fior di galantuomo come il bandito calabrese Giosafatte Malarico, concordata la sua collaborazione, se ne stava libero e felice con dkiotto ducati al mese di pensione!
Chiudiamo con uno squillo di tromba . Tra tanti generali il cui lealismo trova le sue ragioni nel fatidico 27 del mese prendiamone uno di pasta diversa. È solo. È un titano, un gigante: Borges . Peccato, non

è nostro. Era come uno che avesse pronunciato i voti, aveva la vita dietro di sé. La convivenza tra quell ' asceta e l 'armata di straccioni feroc i durò poco. Lo spagnolo insisteva per darsi una regola da esercito vero, pretendeva discip lina almeno quando occupavano quei paesi ch e disp iegavano il vessill o borbonico (lo facevano tutti per salvarsi la pelle). Insisteva a combattere la sua guerra p u lita anche se soldi, uniformi e a rmi ormai dai borbonici non arrivavano più. I briganti invece erano affezionatissimi a vendette, stupri, taglieggiamenti, saccheggi, l'unica ragione per cui combattevano. Nei sogni di Croceo e Chiavone non c'era certo il desiderio che la questione sociale fosse risolta. In quel momento, infatti, a quali ricchi avrebbero ruba t o?
Le fortune militari dell'armata del Signore finiron o presto. Un fa llito assalto a Potenza fu l'ultima impresa con i crismi della grandezza. Emargina t o, guardato con sospetto, quasi prigioniero, Borges con il suo pugno di idealisti (una ventina) decise che ne aveva abbastanza e si diresse verso la frontiera pontificia per l'addio alle armi. Era inverno, i monti già coperti di neve. L'8 dicembre il gruppetto a cava llo, stremato, raggiunse Tagliacozzo ormai a un passo dalla sa lvezza. Soldati e guardie nazionali comandati dal maggiore Franchini li sorpresero nella cascina La Lupa . Quasi certamente un tradimento. Cinque li ammazzarono perché avevano cercato di reagire, g li altri si arresero. Borges volle consegnare la spada solo al maggiore e gli rivolse parole di lode per la bella impresa. Non aveva capito, c redeva di vivere ancora nelle guerre eleganti e educate. Franchini li legò e li trascinò a Tagliacozzo, il tempo di riunire il plotone e tutti vennero fucilati. Gli spagnoli chiesero ai soldati di mirare bene e attesero la scarica in ginocchio intonando funebri li t anie barocche. Si disse che Franchini aveva scelto questa conclusione sbrigativa e illega le perché si era impadronito del tesoro borbonico (è una leggenda che accompagna tutti gli scempi italiani) e perché aveva ricevuto da La Marmora l'ordine di dare un esempio che scoraggiasse altri tentativi di legittimare il brigantaggio. Ecco il rapporto che gli valse la medaglia d'oro:
Ventitré carabine, tre sciabole, diciassette cavalli, moltissime carte interessanti cadevano in mio potere, e bandiere tricolori con la croce di Savoia fo rse per servire di inganno, nonché lo s tesso generale Borges e gli al tri s uoi compagni ... e tutti traducevo a Tagliacozzo assieme ai cinque morti e facevo fucilare alle ore quattro pome ridiane per esempio d ei tris ti che avversano il governo del re e il risorgimento della nostra patria.

Il generale Fiorenzo Bava Beccaris aveva incontrato molti e coriacei avversari nella sua lunga vita di soldato: russi in Crimea, austriaci e ungheresi nelle campagne del '59 e del '66, la peste anarchica nel '98. Mai avrebbe immaginato che il più subdolo e pericoloso, quello che alla fine gagliardamente lo schiantò, sarebbe stato uno che non impugnava bombe e cannoni, e che si teneva ben lontano dalle prime linee dove invece impavido aveva dimostrato ampiamente di saper mettere il piede il generale. Era un nemico per definizione piuttosto proclive a star dietro ai fatti impugnando un'innocua matita, con la scusa di dover raccontare, e prontissimo se ne cessario a prendere di gamba buona le strade della ritirata e della fuga. Colui che lo fece a pezzi e ne lasciò fino a oggi frantumata la fama e la gloria, irrimediabilmente, era un giornalista . Noi che ci volgiamo indietro con la scienza già scritta sui libri possiamo dire che il generale aveva un presentimento. Infatti non accarezzava chi scriveva sulla stampa con la simpatia che d e dicava ad altre categorie sociali e dello spirito umano. Nel momento più fulgido della sua carriera cli giornali ne chiuse a decine, spezzò la voce con i sigilli giudiziari a spumeggianti cronisti e piccanti cantori della palingenesi politica e umana. Arrampicato a cavallo in piazza del Duomo a Milano, con grande soddisfazione e l'occhio fiero scrutò passare incatenati a due a due tra file di vigili, di carabinieri e di soldati decine di giornalisti a cui aveva tagliato gli artigli dell'editoriale e del fondo a più colonne. Avviati verso processi sommari e anni di galera non si sa quanto proficuamente scontati nel carcere di Finalborgo in Liguria che non era proprio una villeggiatura. Uno gli sfuggì. Era quello che aveva la freccia più intrisa di veleno.
Gli sembravano un'immensa tribù di galoppini e di zuavi professionali, col crepitare delle mitragliatrici si buttavano a terra e nascondevano la testa sotto la sabbia. Non ave va calcolato, quel conduttore di uomini, che presi singolarmente i giornalisti son gente innocua, spesso meschina, il più delle volte paurosissima e pronta a rassegnarsi al compromesso, ad accomodare i congiuntivi e a ta cere. Ma una volta che l ' articolo, come una mina, è uscito dalla loro penna, comincia a vivere di una vita propria, resiste ai secoli , continua a invelenire e arrugginire le gesta degli uomini senza che il passare degli anni gli inceppi il meccanismo. Così, uno come Bava Beccaris, che pure campò a lungo (morì nel 1923), con un quarto di secolo a disposizione per convincersi di essere veramente quello che il re

Umberto gli aveva scritto, cioè il salvatore d'Italia dalla rivoluzione, si ritrovò sul capo una condanna definitiva alla qualifica di fellone, belva, fucilatore di bambini, reazionario chimicamente puro. Sentenza talmente definitiva e non impugnabile che, mentre fior di canaglie come Belzebù e Giuda Iscariota hanno incontrato nei secoli belle penne disposte a raccontar le loro ragioni e a trovare metafisiche scuse per le loro malvagità, il generale Bava Beccaris da Fossano, provincia di Cuneo, è lapidariamente crocefisso alla colpa in saecula saeculorum.
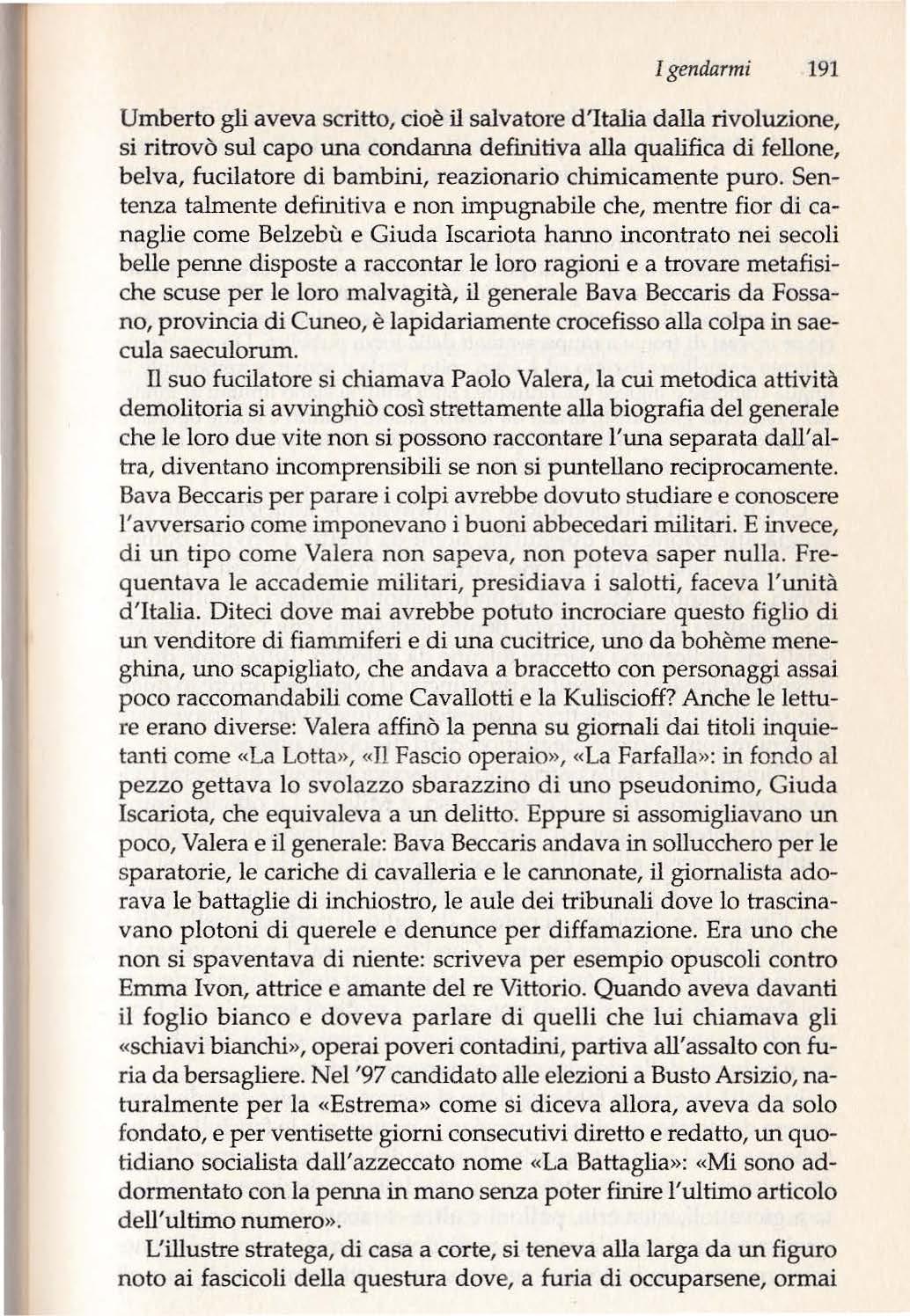
Il suo fucilatore si chiamava Paolo Valera, la cui metodica attività demolitoria si avvinghiò così strettamente alla biografia del generale che le loro due vite non si possono raccontare l'una separata dall 'a ltra, diventano incomprensibili se non si puntellano reciprocamente. Bava Beccaris per parare i colpi avrebbe dovuto studiare e conoscere l' avversario come imponevano i buoni abbecedari militari. E invece, d i un tipo come Valera non sapeva, non poteva saper nulla. Frequentava le accademie militari, presidiava i salotti, faceva l'unità d'Italia . Diteci dove mai avrebbe potuto incrociare questo figlio di un venditore di fiammiferi e di una cucitrice, uno da bohème meneg hina, uno scapigliato, che andava a braccetto con p e rsonaggi assai poco raccomandabili come Cavallotti e la Kuliscioff? Anche le letture erano diverse: Valera a ffinò la penna su giornali dai titoli inquietanti come «La Lotta », «li Fascio operaio», «La Farfalla »: in fondo a l pezzo gettava lo svolazzo sbarazzino di uno pseudonimo, Giuda Is cariota, che equivaleva a un delitto. Eppure si assomigliavano un poco, Valera e il generale: Bava Beccaris an dava in sollucchero per le sparatorie, le cariche di cavalleria e le cannonate, il giornalista adora va le battaglie di inchiostro, le aule dei tribunali dove lo trascinavano plotoni di querele e denunce per diffamazione. Era uno che non si spaventava di niente : scriveva per esempio opuscoli contro Emma Ivon, attrice e amante del r e Vittorio. Quando aveva davanti il foglio bianco e doveva parlare di quelli che lui chiamava gli «schiavi bianchi», operai poveri contadini, partiva all'assalto con furia da bersagliere. Nel '97 candidato alle elezioni a Busto Arsizio, naturalmente p er la «Estrema» come si diceva allora, aveva d a solo fondato, e per ventisette giorni consecutivi diretto e redatto, un quotidiano socialista dall'azzeccato nome «La Battaglia»: «Mi sono addormentato con la penna in mano senza poter finire l' ultimo articolo dell'ultimo numero».
L'illustre stratega, di casa a corte, si te neva alla larga da un figuro noto ai fascicoli della questura dove, a furia di occuparsene, ormai
era venuto in uggia, stufava, non sollevava più emozioni. Nel gennaio del 1898, pochi mesi prima dello scatenarsi degli eventi milanesi, un anonimo Plu tarco delle questure descriveva così questo nemico di classe: Nella opinione pubblica riscuote fama non solo di onest'uomo ma anche di individuo esaltato e anche un po' squilibrato di mente. f:. di carattere buono, che sente compassione per le sofferenze altrui, ma facile all'ingiuria specie per mezzo della stampa e capace anche di trascendere a vie di fatto specie se trovasi di fronte a rappresentanti della forza pubblica. Discretamente educato è intelligentissimo ed è assa i colto. Parla e scrive correttamente la lingua francese e ing lese quantunque i suoi studi si s ia no limitati al ginnasio. Frequenta giornalisti, artisti da teatro, pittori, scultori e anche operai. È iscritto alla setta anarclùca nella quale milita fino da i tempi in cui gli affiliati a essa chiamavansi Internazionalisti.
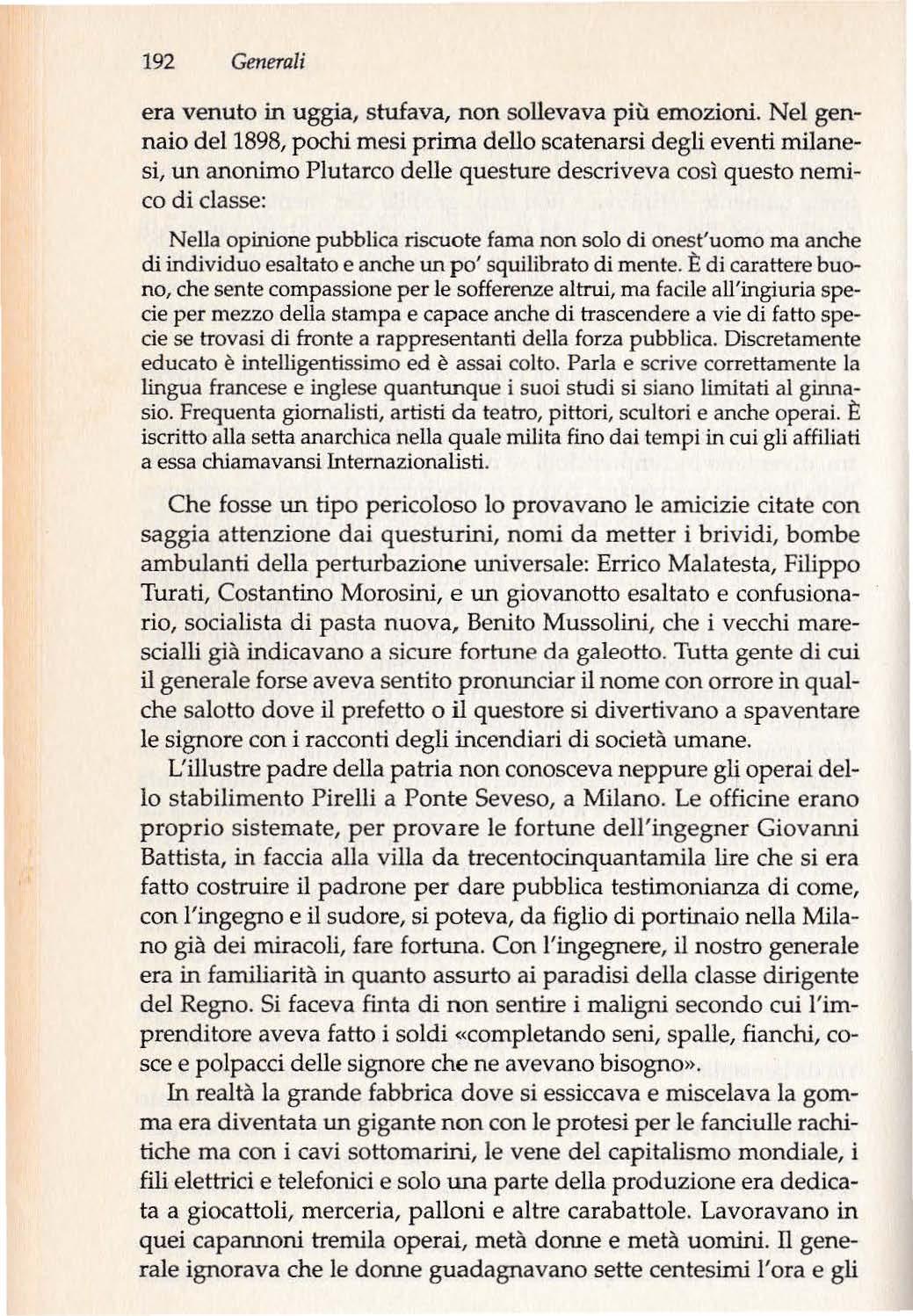
Che fosse un tipo pericoloso lo provavano le amicizie citate con saggia attenzione dai questurini, nomi da metter i brividi, bombe ambulanti della perhirbazione universale: Errico Malatesta, Filippo Turati, Costantino Morosini, e un g iovanotto esaltato e confusionario, socialista di pasta nuova, Benito Mussolini, che i vecchi marescialli già indicavano a sicure fo r tune da galeotto. Tutta gen te di cui il generale forse aveva sentito pronunciar il nome con orrore in qualche sal otto dove il prefetto o il questore si diver tivano a spaventare le signore con i racconti degli incendiari di società umane.
L'illustre padre della patria non conosceva neppure gli operai dello s tabilimento Pirelli a Ponte Seveso, a Milano . Le officine erano proprio s istemate, per provare le fortune dell'ingegner Giovanni Battista, in faccia alla villa da trecentocinquantamila lire che si era fa t to costruire il padrone per dare pubblica testimonianza di come, con l'ingegno e il sudore, si poteva, da figlio d i portinaio n e lla Milano già dei miracoli, fare fortuna. Con l'ingegnere, il nostro generale era in familiarità in quanto assurto ai paradisi della classe dirigente del Regno. Si faceva finta di non sentire i maligni secondo cui l' imprenditore aveva fatto i soldi «completando seni, spalle, fianchi, cosce e polpacci delle signore che ne avevano bisogno».
In realtà la grande fabbrica dove si essiccava e miscelava la gomma e ra diventata un gigante non con le prot esi per le fanciulle rachitiche ma con i cavi sottomarini, le vene del capitalismo mondiale, i fili e lettrici e telefonici e solo una parte della produzione era dedicata a g ioca ttoli, merceria, pallo n i e altre carabattole. Lavoravano in quei capannoni tremila operai, me tà donne e metà uomini. Il generale ignorava che le d onne guadagnavano sette centesimi l'ora e gli
uonùni il doppio. Gli orari erano ancora quelli un po' severi della rivoluzione industriale: dentro alle sette, una pausa di un'ora alle dodici e trenta per il pranzo (non c'erano mense, si mangiava all'aperto addossati ai muri sotto il sole e l'acqua quando pioveva); si usciva dopo undici ore. Eran regole dure, direte voi, impoltroniti da un secolo di battaglie sindacali vittoriose. Eppure la fila fuori dai cancelli per avere un posto era sempre sterminata . Per sperare di lavorare alla Pirelli bisognava adeguarsi a regole ferree, come «non mostrare g iornali sovversivi», non esibire fazzoletti rossi né calcarsi in testa berretti anarchici, indizi di brutte abitudini e non solo nella moda. Poteva anche non bastare. Perché se l' ingegner Perondi che presiedeva l'ufficio personale trovava la faccia dell'aspirante operaio un po' troppo truce, l'occhio indicativo di pericolose volontà di rivincita sociale, allora la fedina penale immacolata che questi teneva in mano non serviva a niente. Abbaiava con occhio sgembo «va bene, vi scriveremo» e significava che il poveretto poteva già cominciare a cercare un altro p osto per sopravvivere. Per chi ce la faceva a superare questo Caronte laureato, ogni quindici giorni c'era la festa della paga: insieme al libretto di lavoro davano un sacchetto con dentro il denaro spettante.
Il 6 maggio 1898 n ereggiava una folla di operai che marciava affannata verso gli ingressi degli stabilimenti d ella zona; c'erano, oltre alla Pirelli, l 'Elvetica, la Grondona, la Stigler. Su da via Galilei montava una eccitazione che non era quella solita del non arrivare in ritardo. L'Italia, infatti, era ormai da alcuni giorni, dal 25 aprile per la precisione, sottosopra, e circolava nelle prefetture, sicuro presidio del mondo ordinato e rispettoso, la terribile parola : rivoluzione. Circostanza doppiamente deprecabile. La coppia reale - Umberto e Margherita - era impegnatissima a preparar le feste per i cinquant'anni dello Statuto che alcuni politici vicini alla monarchia stava no pensando di stringere come una catena attorno al lassismo pericoloso dei tempi. Si assalivano mulini e dazi, colpevoli in simbolo della fame e del carovita, si tiravano contro guardie regie e carabinieri sassate ma anche con gli schioppi e le pistole. Avevano dato il la le solite teste calde di Faenza e di Ravenna, poi come un incendio era insorto il Sud, Secondigliano, Bari, Nocera in particolare, e quindi Napoli, dove dai bassi erano usciti cortei di menadi furenti che chiedevano il pane a trenta centesimi il chilo. Come se non bastasse e rano scese in strada tra cariche di cavalleria e fucilate anche le zone ricche come il cremonese e la Toscana. Il re era ad Asti dove passava in rassegna, imperturbabile, le quarantamila bottiglie della rassegna
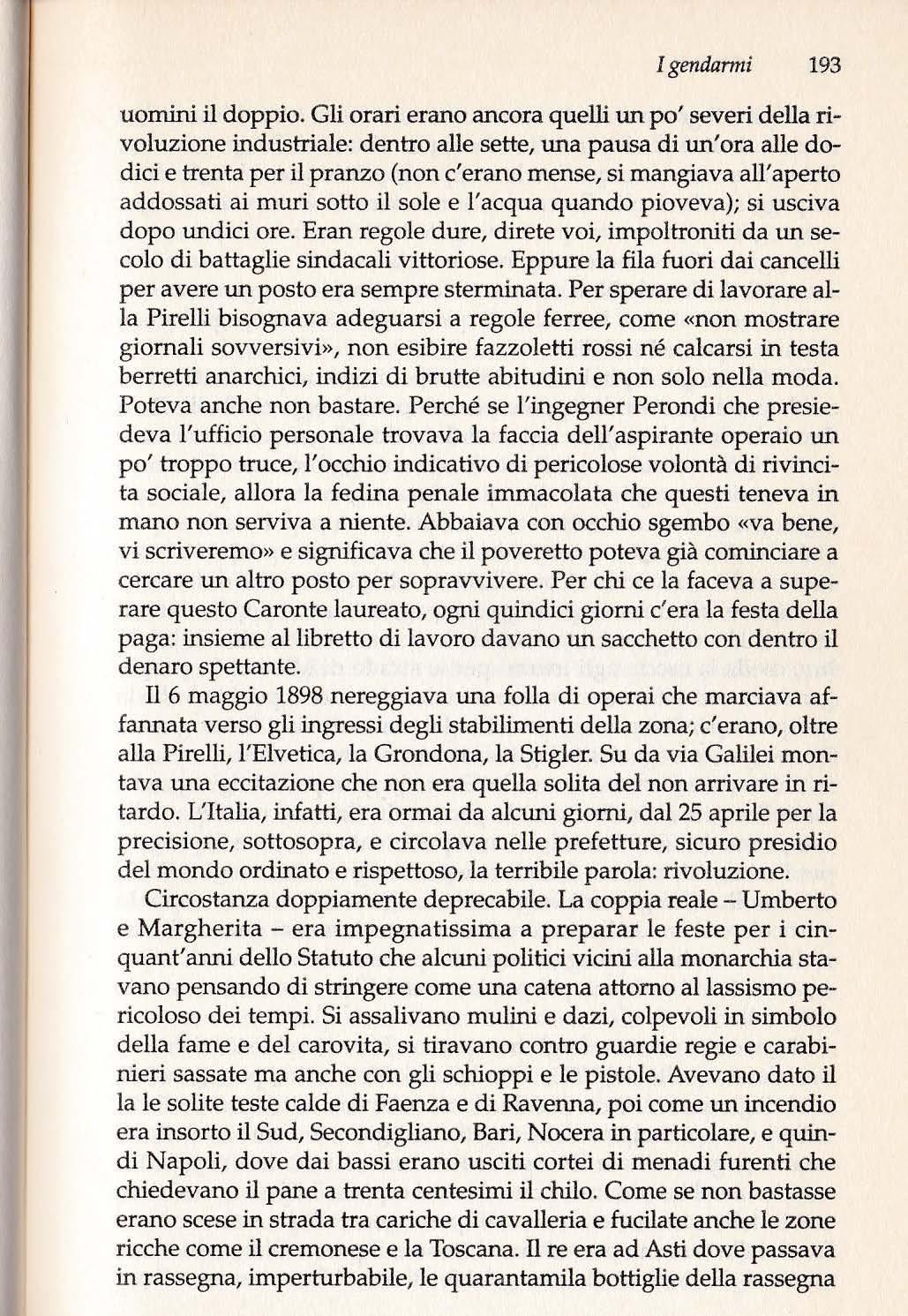
enologica. Il governo tentennava, offriva la mano tesa abbassando i dazi e calmierando il pane a trentacinque centesimi. Poi, per non dar l 'idea di aver paura, spediva la truppa. Soprattutto nei luoghi dove serpeggiava la rivolta fioccavano le nomine dei «commissari regi»: erano generali che avevano fama di fedeltà assoluta e di mano di ferro, gente che se necessario non avrebbe esitato, nomi come Pelloux, Mirri, Heusch. Non erano tutti feroci , anzi la maggioranza erano dei moderati; ma i membri di questa ombrosa compagnia mandavano in bestia i socialisti.
A Milano, già capi tale economica , spedirono un piemontese con cui la corte sperava di tappare per sempre la bocca ai ribelli, Bava Beccaris. Sotto le unghie dei suoi detrattori il generale cuneese è s tato dipinto come un travet dello s tato maggiore, uno che aveva fatto carriera con g li sca tti di anzianità, un signor nessuno. Tra i colleghi, pur essendo considerato una nullità, e ra popolarissimo: p erch é li invitava spesso a casa, e due o tre volte l'anno per pranzi sontuosi anche al ristorante Cova. Il ritratto di questo padre di famiglia esemplare, affettuoso e prodigo compagnone, servì per far contras to con il bieco massacratore, con la iena che, con il sorriso s ulle labbra, diede la caccia agli inermi per le strade di Milano. La propaganda fu così efficace e riscosse un tale s uccesso di pubblico che lo si dipinse persino come un mostro d a l punto di vista fisico: grasso, il n aso grosso e sgualcito degH ubriaconi, sformato come un sensale in uniforme e piazzato a cava llo. Erano in gran parte bugie: perché Bava Beccaris s i era battuto da par s uo in Crimea, nel '59 e nella campagna d el ' 66. Non solo. Aveva presentato una serie di progetti per la riorganizzazione della leva e per rend ere meno tragico il servizio militare a i giovani «regnicoli », come si diceva un tempo. In particolare si era dedicato con sincero entusiasmo ai guai delle sue reclute contadine, la maggioranza dei poveracci che insaccati in pesanti uniformi vedremo poi per le vie di Milano s parare a casaccio sulla folla.
Il governo, per non fargli mancare un braccio robusto, richiamò una classe, quella del 1873, sotto le armi. Non erano, per i generali , anni di gloria: lo sfregio di Adua lo ricordavano tutti, il nome di Bara tieri restava sco lpito nelle menti e s ui giornali come simbolo di una vergogna militare che nessuna successiva vittoria e neppure la retorica avrebbe addomesticato. Non si cap isce il '98 se non si tiene conto dello sconfinato rancore di questi generali che vennero tratti fuori dalle caserme per salvare il trono e il paese. Già, molti erano convinti che davanti alle canne dei fucili non ci fossero masse di po-
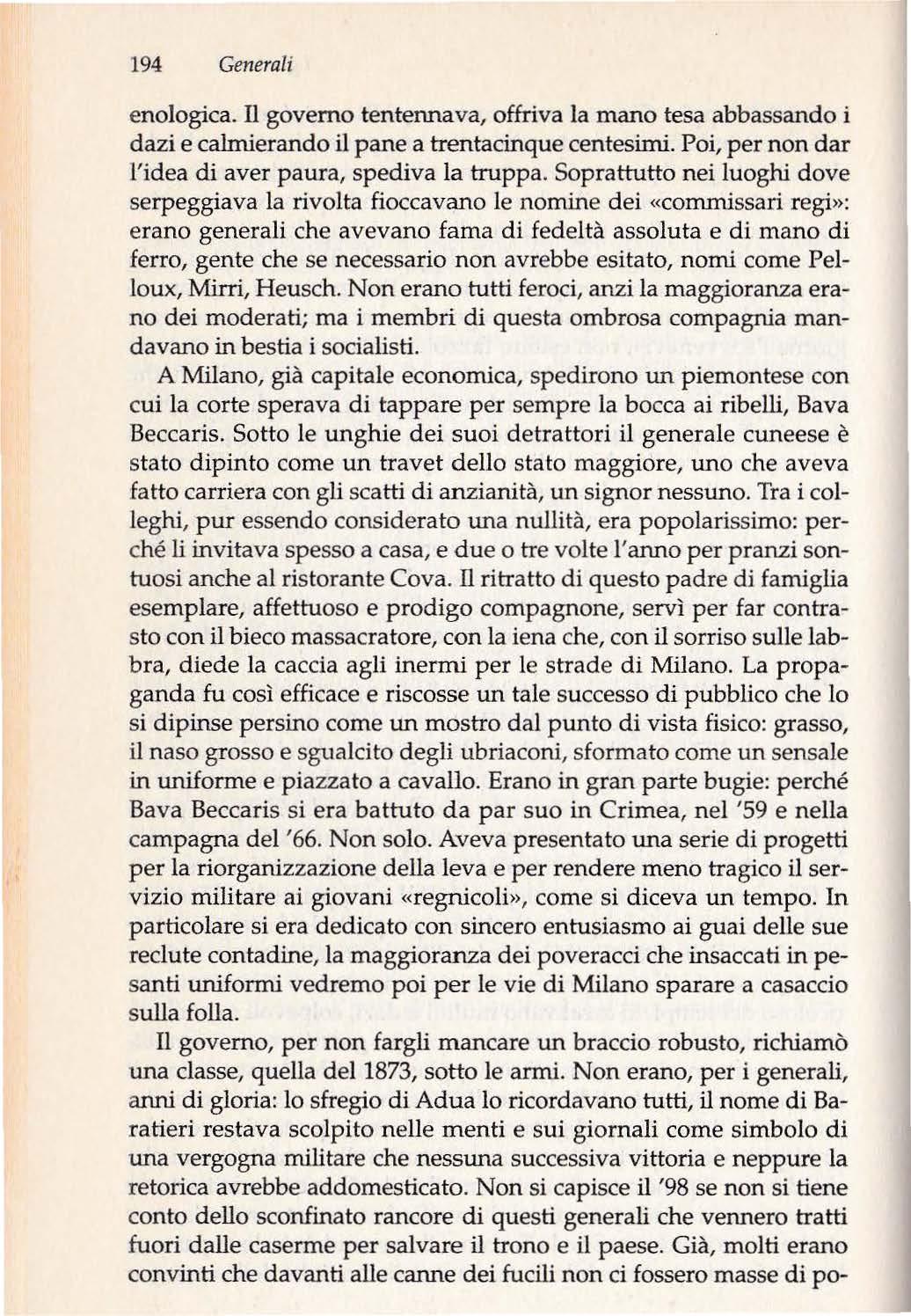
veracci affamati e alle prese con i conti di fine mese, ma rivoluzionari che si preparavano a dare la spallata definitiva alle istituziorù, a firùre il lavoro che nel '96, quando erano arrivate le notizie di Adua, era rimasto a metà. Il fermento sociale saliva come bolle di arùdride carborùca in una bevanda; bisognava dar prova di affidabilità, quella che era mancata sul campo di battaglia. Si offriva l'occasione di dare il benservito a quelli che due anrù prima erano andati in piazza per gridare «Viva Menelik!».
Re Umberto adorava i soldati, aveva indossato la sua prima divisa a quindici anni e si può dire che non se la fosse più tolta. Non mancava di coraggio personale e il bene dell'esercito era l'urùca cosa che lo interessasse: «Piuttos to che lasciare compromettere con la salvezza dell'esercito l'urùtà andrei a fare il signor Savoia» . Sotto il suo regno le spese militari lievitarono, si ingrossarono, strariparono. Nel 1866, e c'era la guerra, ammontavano a 165 miliorù, nel 1895 eravamo a 326. Ma erano quelle etichettate come ordinarie. Poi c'erano quelle straordinarie, per le fortificaziorù, le corazzate . Ci eravamo anche noi appassionati alle navi e la flotta era la terza del mondo dopo Inghilterra e Francia. Costavano anche gli impegrù della Triplice, che non erano registrati da nessuna parte ma indicati pudicamente come «impegrù personali tra due corone». Insomma esser pronti sul Reno a maciullare i francesi significò un quarto del bilancio statale che aveva un disavanzo di 234 miliorù. Era l'esercito dei dodici corpi d'armata che il re e i suoi generali difesero contro chiunque. L'idea che un politico potesse diventare ministro della Guerra scatenò subito la possibilità di una crisi dinastica . Era un esercito mostruoso, pletorico, di caserma; gli attendenti usati come servi di casa e bambinaie erano ventimila! Quello che su «Critica sociale» Arturo Labriola chiamò «un mostruoso e dificio di baionette». Politicamente Umberto, con una cultura zoppicante, si era subito abituato a l clima di espedienti che dopo le altezze sublimi della destra era stato inaugurato dai metodi disinvolti di Depretis . Non mancava di fiuto il sovrano. Lo prova la promozione pubblicitaria della monarchia che aveva avviato con la moglie, la seducente Marg herita . I due avevano poco in comune; il re l'aveva sposata dopo essere stato convocato da un telegramma dello sbrigativo padre: «Vierù a Torino che ti ho trovato la moglie». Lui s travedeva per l' implacabile arrampicatrice sociale che era la contessa Litta . Ma in pubblico, con la moglie che con il suo noiosissimo salotto aveva affascinato intellettuali e borghesia, recitava splendidamente il copione d el giovane sposo innamorato. Il passeggio al Pincio era ogni giorno un

trionfo, il calendario di inaugurazioni quasi sempre di monumenti dedicati a glorie vere o fittizie della casata e a un Risorgimento già dilavato da spunti polemici, erano un'alluvione. La regina , non meno militarista del marito, detestava «le idee aridissime del giorno presente», adorava le uniformi e sognava il regno trasformato in una ordinatissima caserma.
Al loro servizio un generale politico come Pelloux, chiuso in un radicalismo intransigente, era risoluto ad affidare la salvezza nel disordine anarchico repubblicano e socialista, all' unica forza sana del paese, cioè le fucilate . Mai come allora l'Italia fu vicina a un golpe. A sognarlo fu il re che voleva cambiar le regole del gioco facendo finta di rispettarle. La cricca dei moderati che soffiavano sulle sue propensioni autoritarie, da Parini a Sonnino, lo spingeva ad affidarsi a un generale che trasformasse il Parlamento in un ufficio del registro. Sulla piazza c'era Pelloux, il leader- provvidenza, il redentore. Pensava al governo innanzitutto come una pedagogia e parlava degli italiani come di una famiglia ingenua e turbolenta che ha soprattutto bisogno di imparare e ubbidire . Ecco l'occasione per il signor generale di aggiungere qualche nuovo ingranaggio alla macchina di potere. La plebaglia? Non le avrebbe lasciato altra libe rtà che ascoltare e applaudire.
Tutti, al governo e nei giornali della borghesia, il «Corriere d ella Sera » in testa, erano convinti che ci fosse, stesse crescendo, si addensasse e allungasse tentacoli mostruosi un complotto anarchico. Si ved eva, anzi intravedeva, ovunque la mano armata di pugnali pistole bombe congegni diabolici e mai usati che i giornali descrivevano con precisione fantasiosa . Volevano sgozzare i re perché, come diceva Giovanni Passanante, il cuoco che aveva cercato di pugnalare Umberto, «stavano bene e mangiavano troppo». Che i terribili vendicatori fossero vivacemente impegnati nella loro individualistica e inutile palingenesi a base di un selezionato esercizio del terrore non eran certo fantasie. Quello che i politici e i generali non coglievano era che i micidiali anarchici costituivano il passato. La minaccia per «l'ordine costituito» veniva semmai dalle file dei socialisti, dei cattolici, delle leghe, delle cooperative, delle camere del lavoro, esercito disciplinato con i propri giornali, deputati, agitatori infaticabili che si preparava a dare l ' assalto allo Stato borghese. Voleva impiegare metodi violenti? Non si può dire. Turati non m entiva quando al processo rivendicò orgogliosamente per il s uo movimento di «agire alla luce del sole» . Il complotto, se vogliamo identificarlo con un disegno articolato, alla Lenin, non esisteva. Erano state messe a punto, è ve-

ro, tecniche di disobbedienza, quasi di guerriglia, che dalle vecchie barricate risorgimentali erano passate a sfruttare donne e bambirù come scudi umarù e staffette. I generali, che erano sempre pronti per la guerra sbagliata, sapevano opporre solo le tradizioni del caro vecchio Radetzky: cannonate e fuoco a volontà. Siamo sempre in ritardo sui tempi!
Erano firmati dai socialisti i marùfestini che alcuni attivisti distribuivano quel mattino tra i diecimila che risalivano via GaWei pronti a essere inghiottiti dai portoni dei vari stabilimenti:
Cittadini lavoratori! La rivolta serpeggia nel paese. È la rivolta della fame e della disperazione. Il governo del re risponde al solito con l'eccidio scellerato dei supplicanti pane e lavoro, collo stato di assedio instaurato in quattro province, pronto in tutto il resto del regno; con provvedimenti di elemosina, figli della verde paura, insulto ai mali che pretenderebbe sanare.
L'aveva scritto l'estro tribunizio di Turati e si sentiva ancora molto brodo mazziniano in quella prosa. Bastava per infiammare l'arùmo di gente che magari non leggeva i giornali (peraltro faziosissimi) ma era ben informata su quanto stava avvenendo nel resto d'Italia. Per scatenare i grandi drammi ci vogliono degli incendiari. Domenico Viola detto il Calabrese era la persona adatta. Era uno sbirro che tutti descrivono come ardito implacabile coraggioso, uno che nella soppressione dei pericoli della società ci metteva estro e passione. Gli era stato conferito l'incarico di sporcarsi le marù perché altri le mantenessero pulite. Forse per questo era odiato come tutti gli agenti della Settima sezione, la «volante» della zona operaia. Quartiere dove inquietudine sociale e un po' di delinquenza si intrecciavano come sempre succede in latitudini così confuse e pericolose. Il Calabrese, immediatamente attratto dall'idea di afferrare un agitatore così provocatoriamente impegnato nell'opera sciagurata, ammanettò uno dei distributori degli incendiari manifesti: un ragazzo, Angelo Amadio detto il Pompierin, e pistola in pugno lo trascinò fino alla questura in via Torriarù. Non fu impresa facile perché la folla dei compagni dell'arrestato cominciò a far gruppo, a spingere e a gridare tanto che il Viola colpì brutalmente una operaia, tale Marianna, che con troppa foga gli sbarrava il passo. Il temporale divenne bufera: sassaiole contro la questura circondata da migliaia di persone inferocite che gridavano «assassini» e chiedevano la consegna dell'arrestato e del Viola per farsi giustizia, l'accorrere di deputati tra cui Turati che avevano intuito subito che stava maturando qualcosa di grosso e che pretendevano di trattare la liberazione, schierar-

si di soldati che presidiavano lo stabilimento Pirelli. A questo punto le indagini offrono scarso raccolto: Viola, si dice, innervosito dalla calca esplose alcune revolverate che atterrarono uno dei dimostranti. Al poliziotto non portarono fortuna; alla fine della sparatoria innescata dai primi colpi restò anche lui steso sul selciato . Ammazzato, questo pare accertato, dai suoi colleghi o dai soldati che avevano sparato, nel!' eccitazione, a casaccio.
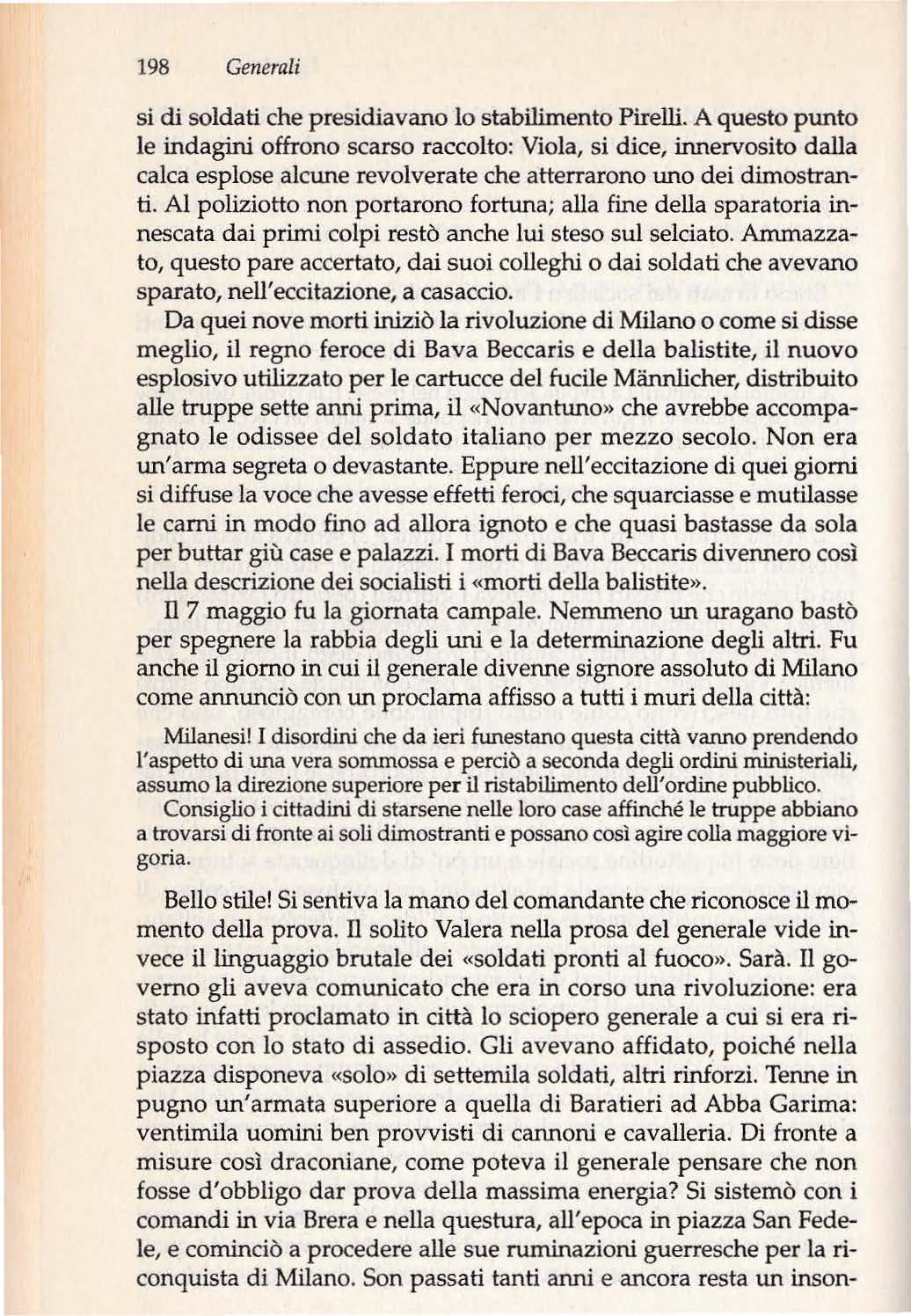
Da quei nove morti iniziò la rivoluzione di Milano o come si disse meglio, il regno feroce di Bava Beccaris e della balistite, il nuovo esplosivo utilizzato per le cartucce del fucile Mannl.icher, distribuito alle truppe sette anni prima, il «Novantuno» che avrebbe accompagnato le odissee de l soldato italiano per mezzo secolo. Non era un'arma segreta o devastante. Eppure nel!'eccitazione di quei giorni si diffuse la voce che avesse effetti feroci, che squarciasse e mutilasse le carni in modo fino ad allora ignoto e che quasi bastasse da sola per buttar giù case e palazzi. I morti di Bava Beccaris divennero cosl nella descrizione dei socialisti i «morti della balistite».
Il 7 maggio fu la giornata campale. Nemmeno un uragano bastò per spegnere la rabbia degli uni e la determinazione degli altri. Fu anche il giorno in cui il generale divenne signore assoluto di Milano come annunciò con un proclama affisso a tutti i muri della città:
Milanesi! I disordini che da ieri funestano questa città vanno prendendo l'aspetto di una vera sommossa e perciò a seconda degli ordini ministeriali, assumo la direzione superiore per il ristabilimento dell'ordine pubblico.
Consiglio i cittadini di starsene nelle loro case affinché le truppe abbiano a trovarsi di fronte ai soli dimostranti e possano cosi agire colla maggiore vigoria.
Bello stile! Si sentiva la mano del comandante che riconosce il momento della prova. Il solito Vale ra ne lla prosa del generale vide invece il linguaggio brutale dei «soldati pronti al fuoco». Sarà. Il governo gli aveva comunicato che e ra in corso una rivoluzione: era s tato infatti proclamato in città lo sciopero generale a cui si era risposto con lo stato di assedio. Gli avevano affidato, poiché nella piazza disponeva «solo» di settemila soldati, altri rinforzi. Tenne in pugno un'armata superiore a quella di Baratieri ad Abba Garima: ventimila uomini ben provvisti di cannoni e cavalleria . Di fronte a misure così draconiane, come poteva il generale pensare che non fosse d'obbligo dar prova della massima energia? Si sistemò con i comandi in via Brera e nella questura, all'epoca in piazza San Fedele, e cominciò a procedere alle sue ruminazioni guerresche per la riconquista di Milano. Son p assati tanti anni e ancora resta un inson-
dabile mistero come per cinque giorni si sia data la caccia a rivoluzionari che in realtà non esistevano, si sia sconciata una città convinti che crepitasse una rivolta micidiale di cui non c'era traccia. Siamo nel dominio della nevrosi più che in quello della politica. È vero: le rivoluzioni sono precedute da uno stato di esaurimento e contemporaneamente di violenta aggressività, il potere non sopporta più una nazione che gli dà ai nervi, il popolo non sopporta il potere che è già diventato odioso.
Certo, barricate furono alzate eccome: a porta Ticinese, in via Palermo, a porta Garibaldi, in via Mantegazza. Si utilizzarono materassi, masserizie, carretti, alcwù tram vennero rovesciati e incendiati. Ma erano, secondo le testimonianze generali, parenti poveri del 1848. Soprattutto i difensori non trovarono di meglio per tener lontani i soldati, i quali avanzavano arma al piede, o la cavalleria lanciata al galoppo, che salire sui te tti e bersagliarli con le tegole. Più efficaci risultarono l e strategie delle operaie del sigarificio di via Moscova che, tenendosi per braccio e cantando l 'inno dei lavoratori, sfidarono con un cordone compatto la truppa; coprendo di insulti le reclute e mostrando al loro imbarazzo seni e sederi per spregio.
Ma Bava Beccaris non scherzava: in piazza del Duomo c'è la rivoluzione, gli urla vano tutti, gli «accenditori» sono ovunque e scatenano la plebaglia. Non c'è tempo da perdere. Persino il sindaco, Giuseppe Vigoni, lo invitò a non avere la mano leggera e scrisse per ribadirlo un proclama, inventando uno slogan che sarebbe divenuto celebre:
Cittadini! Luttuosi avvenimenti hanno funestato la città. Milano che pensa e lavora non può essere solidale con coloro che obliosi di ogni dovere, attentano alla pubblica pace.
Si stringano i buoni tra loro e, rispettosi dei fratelli dell'esercito che sapranno difendere l'ordine pubblico loro affida to, facciano che Milano torni alla sua industre tranquillità che la rese fin qui rispettata e invidiata.
Milano che p ensa e lavora. .. C'erano evidente mente due nazioni impastate diversamen te, i cui orologi non segnavano da secoli la stessa ora. C'era anche una Milano meno eroica che scriveva. Al comando arrivarono a Bava Beccaris in quei giorni terribili trentamila lettere anonime: era lo scoperchiarsi di una cloaca di invidie private, calunnie, spiate, regolamenti di conti, tentativi di eliminare avversari antipatici, concorrenti molesti. Si saldavano le animosità di caseggiato quartiere ufficio alcova. Il generale le prese per buone, pensando che, se tanti erano gli avvisi, certo qualcosa di vero ci doveva essere .
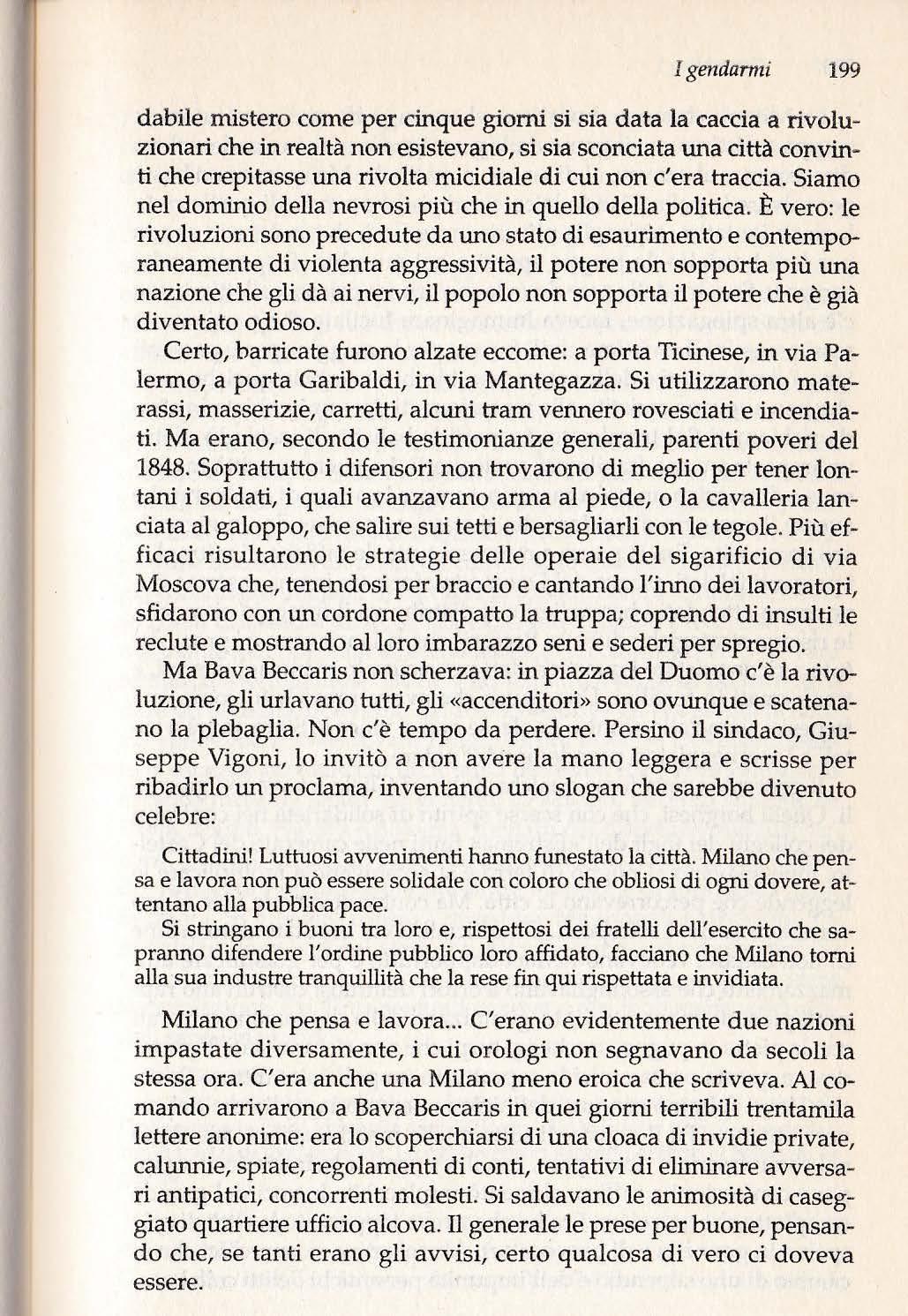
La Milano «buona», borghese, si sprangò in casa per aiutare la truppa a distinguere il grano dalla gramigna, uscire in strada voleva dire aspirare al carcere, a l disonore, a l patibolo. Ma spesso non bastò p er salvare la pelle. Dando la caccia ai pochi gauroche di quella rivoluzione ipotetica, teppaglia più che incendiari, che andava in strada per fare bordello, la truppa sparava nel mucchio. E spesso anche contro le finestre delle case dove la mostruosa psicosi collettiva, non c'è altra spiegazione, faceva immaginare fucilate che partivano e sassi assassini. Le v ittime civili furono per la maggior parte passanti ignari degli eventi e delle sommosse, bimbi e vecchi in qualche caso, che non avevano resistito alla tentazione di dare un'occhiata in strada richiamati dal trambusto. La perfida balistite li inchiodò dietro un'imposta troppo fragile per proteggerli. La guerra in città ingrossava e dimagriva un po' a casaccio, sempre in attesa di qualcuno che avesse il coraggio di gridare che si stava commettendo un gigantesco sproposito. Era la paura a muovere tutto: le raffiche di mitraglia, i passanti falciati, piazza del Duomo trasformata in una caserma dove erano attendati i bersaglieri e si distribuiva il foraggio ai cavalli, le riserve strategiche di Bava Beccaris che si lanciavano a spron battuto a riconquistare i quartieri dati per sicuro in mano agli insorti, e trasformati in fortilizi. Una paura che aveva preso tutti come una frenesia: siamo allo scontro finale, se non si vince lo Stato andrà arotoli e i saccheggiatori prenderanno il potere.
Il generale aveva forse qualche dubbio? Glielo levavano i giornali. Quelli borghesi, che con scarso s pirito di solidarietà nei confronti dei colleghi dei fogli dell' «Estrema» finiti nelle camerate del Cas tello, inneggiavano al pugno di ferro e si accanivano a moltiplicare le leggende che percorrevano la città. Ma confondevano le idee al governatore anche i sottoposti . G li ufficiali, a cui era stato dato ordine di non esitare, vedevano nemici dappertutto e per giustificare ammazzamenti che assomigliavano a errori delittuosi costruivano rapporti pieni di imboscate vinte, giannizzeri della rivoluzione catturati con la pietra in pugno, saccheggi turpi che non c'erano stati. Provvedeva a questa prosa omicida sop rattutto un poliziotto, Ettore Prina, che Turati fulminò con una definizione perentoria «odiatore del genere umano». Fu il regis ta di tutta quella m a cchinazione; insediato nel commissariato dove, pare, con il terrore e le maniere forti strappava confessioni a raffica, alime ntò implacabile le voci del grande complotto che non c'era. Era lui che aveva tappezzato la città di spie spesso in gonnella e di provocatori. Alcuni erano ex anarchici che in cambio di uno stipendio e dell'impunità per antichi delitti collabora-
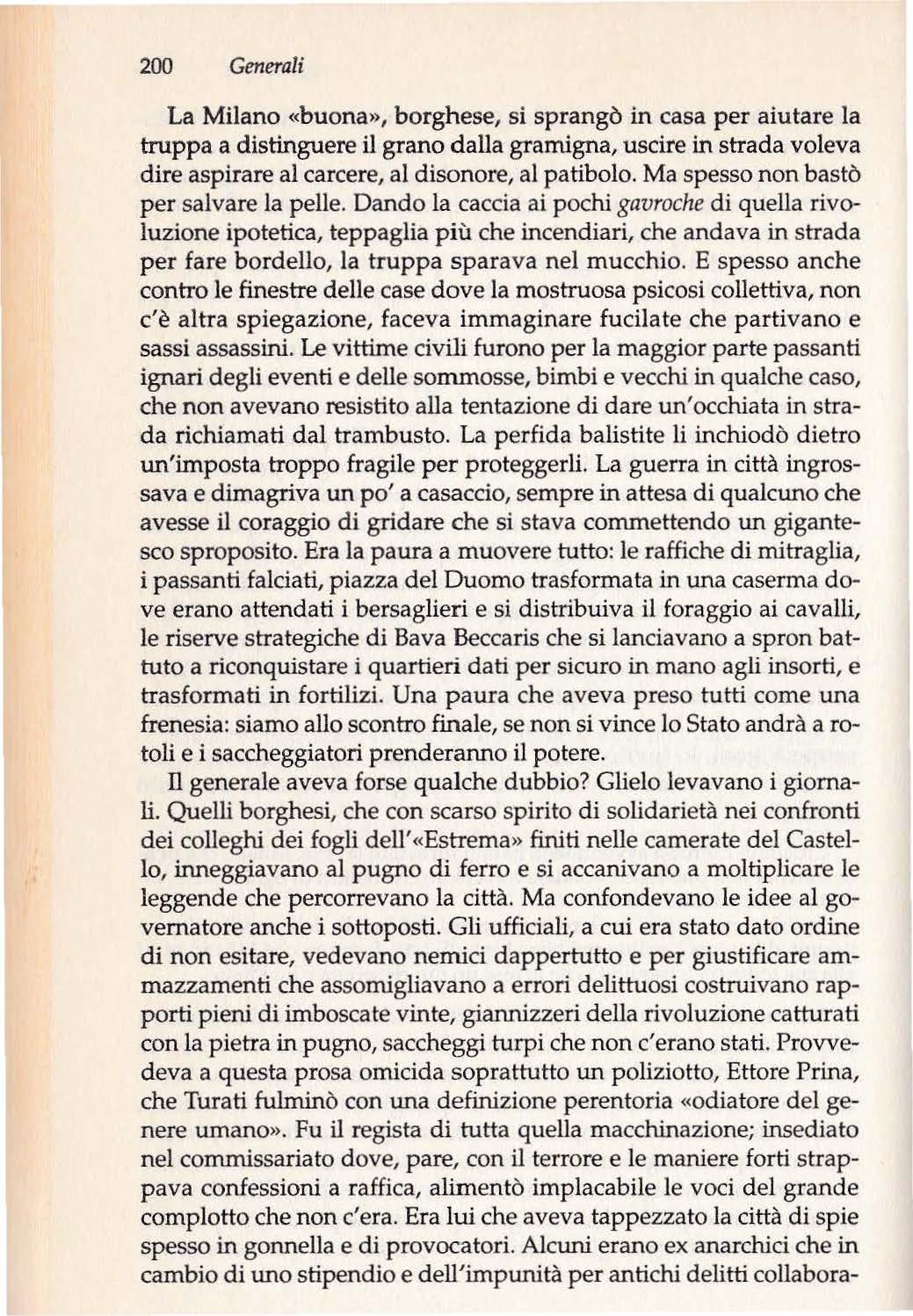
v ano con la polizia. Suggerivano i rastrellamenti e poi fornivano i capi di accusa ai tribunali militari che, siamo sinceri, nei casi più evidenti di falso non li ascoltarono.
In via Brera 15, dove era appostato Bava Beccaris, avevano, non c 'è che dire, l'occhio e la mano sicuri. Prendiamo un episodio famos o: l'assalto al convento dei cappuccini di corso Monforte. Era un e dificio spesso, circondato da un muro di mezza altezza dove ogni g iorno a mezzodì si radunava una folla di poveracci a cui i frati dis tribuivano pane e minestra. Erano uomini donne vecchi bambini, folla cenciosa che sembrava uscita ancora intontita e guasta dalle pa· g ine di Victor Hugo: alcuni seminudi, donne vizze esauste dalla quotidiana lotta per trovare cibo, bimbi che avevano dimenticato quando avevano cominciato a mendicare. La piazza era fin dall'alba presidiata da un forte nucleo di soldati, fanti e cavalleria; avevano piazzato anche due cannoni. Qualche cervello fine doveva aver capi to che quello era un posto da convulsioni rivoluzionarie. Avevano già consumato migliaia di cartucce sparando contro le finestre e verso corso Concordia dove, si diceva, erano annidati i rivoltosi. Il comandante d e ll 'operazione, eccitatissimo, tal colonnello Volpini, vera tempra di sterminatore, ordinò a un soldato dj salire su un carretto e dare un'occhiata all'interno del convento dove gli era giunta la notizia «potrebbero aver trovato rifugio alcuni insorti». Dovevano essere le estreme appendici di un'armata fantasma che per cinque giorni av rebbe turbato i sonni dei generali di Milano: seicento studenti <li Pavia, Torino, Padova e Bologna, monaili del disordine pubblico accorsi, pensate un po', in bicicletta per infettare ancor più il finimondo. A dar loro manforte era attesa un ' inv asione di incendiari dalla Svizzera. Si mossero contro l'invasione reggimenti e divisioni. La notizia fu presa così sul serio che Bava Beccaris, nel timore che i riv oltosi si servissero dei velocipe<li per portare ordini, ne fece vietare la circolazione. Quelli sequestrati venivano resi inoffensivi restituendoli senza manubrio:
Il regio commissario straordinario, in virtù dei poteri conferitigli, da domaru fino a nuovo ordine vieta nell'intera provincia di Milano la circolazione delle biciclette tricicli e tandem e s imili mezzi di loco mozione. I contravventori saranno deferiti ai tribunali di guerra .
Il generale nonostante l'età non verdissima sembra inesauribile, s ta a cavallo per ore, galoppa nei punti d ove i pericoli sono più alti. Commette, non si sa se per colpa sua o perché mal consigliato, errori

un po' ridicoli: fa arrestare un deputato, l'onorevole De Andreis; gli si trovano in tasca piante della città dove sono segnate aree con le sig le B e F: bombe e fuoco, traducono i sospettosi analisti dello stato maggiore, e invece sono gli idranti e le fognature che il deputato deve individuare perché è ingegnere del comune. Torniamo a corso Manforte. Come in un affretta to fotomontaggio, un caporale sale su un carro e getta un'occhiata all'interno del chiostro, vede la folla dei meschini appoggiata al muro in attesa della fratesca minestra. Gli pare di udire un colpo di fucile: si getta giù urlando «tradimento tradimento». Eccitato e assordato da ore di sparatoria contro le ombre ha scambiato i mendicanti per le armate della rivoluzione proletaria. Comunque si sca tena l' inferno. Sono tempi in cui i generali infliggono ai sottoposti la teoria dell'occhio nella schiena: il so ld a to deve sempre sentirsi controllato, deve vivere sapendo che qualsiasi suo gest o è tenuto sotto controllo e la minima esitazione gli costerà il plotone di disciplina o peggio. I soldati cominciano a sparare contro il convento, Volpini, a cui piacciono i metodi spicci e deve conservare molta ruggine laicista e liberale contro «i preti » di cui sospetta automatiche alleanze con la rivoluzione, fa entrare in azione il cannone. G li hanno dato gli obici, una sezione del Sesto artiglieria: perché non dovrebbe u sarli? «Cannonieri ap ritemi una breccia » grida, come se di fronte avesse le armate austriache. Due vampate buttan giù il portone dei poveri frati. I soldati si gettano dentro baionetta in canna come se dovessero espugnare il Quadrilatero . Frati e mendicanti, quelli almeno che non cadono falciati dai colpi o travolti dalla calca, gettano via scodelle e pentoloni, bes te mmiando o invocando i santi, si disperdono in chiesa nel refettorio in cantina braccati dai soldati ch e urlano «a rrendetevi ». Qualche anziano frate più malandato degli altri e che neppure le cannonate sono riuscite a tirar fuori da lla sua cella, viene afferra to, malmenato, tutti sono raccolti nel cortile dove un ufficiale che urla insulti e bestemmie già minaccia di passar tutti per le armi . Poi per fortuna un t enente, forse meno eccitato, si accorge che il covo dei ribelli non sembra così pericoloso. Una s taffe tta è partita al galoppo per piazza del Duomo e avverte Bava Beccaris che il covo dei ribelli è caduto. Diavolo! Si commenta tra gli ufficiali del comando : ecco pe rché non si catturava nessm10, erano nascosti da quei perfidi frati rivoluzionari!
C'è ancora un dubbio che turba i militari: il tunnel. Si dice che un passaggio segreto conduce dal con vento fino a piazza del Duomo e che è servito, «per linee interne» cita il rapporto scritto evidentemente da un militare con talento di romanziere, agli insorti per aggi-

rare le truppe e colpirle alle spalle. Il diabolico percorso sotterraneo altro non è che un innocuo passaggio che serve ai frati per arrivare a una loro proprietà sul lato opposto della strada. I soldati si affannano a cercare, baionettano tutto, esplorano persino un pozzo da cui tirano su soltanto un povero gatto morto.
Alla fine trascinarono via tutti, pitocchi e frati, facendoli sfilare, come era in uso, incolonnati tra due file di soldati che insultavano e minacciavano con i fucili. Li portarono come un trofeo alla prefettura, meta di tutte le brillanti operazioni di quei giorni. Qui passarono il confine amministrativo che li metteva sotto il controllo dei poliziotti, i quali certo non avevano una carità cristiana più sviluppata: li ammanettarono saldamente temendo chissà quali rivolte ed evasioni. Per loro fortuna incrociarono il prefetto, Winspeare, che, infastidito dall'esser stato completamente privato dei poteri dai militari, cercava per quanto gli era possibile di disfare quello che Bava Beccaris metteva in piedi. Fu lui che li fece smanettare e assistere fino a quando anche il generale si convinse che era stato preso un abbaglio e li rispedì al convento. L'll maggio arrivò ai superiori dell'ordine un biglietto con il timbro del tribunale militare:
Mi pregio informare la signoria vostra reverendissima che con mia ordinanza ho dichiarato non esser luogo a procedere in confronto di tutti i reverendi padri cappuccini del convento di corso Manforte. L'avvocato fiscale militare Scannagatti.
La leggenda dell'armata degli studenti però è dura a morire. L'Acquabella è una zona di cascine dove, dopo i casotti del dazio, Milano già sfuma nella campagna. A far compagnia a questi casolari sparsi, scanditi dai campi, uno stabilimento di caloriferi dell'ingegner De Francesci lungo la strada che porta al paesetto dell'Ortica. A questo paesaggio agreste aggiungete anche la ferrovia che porta a Venezia. Al mattino la gente sciama negli orti, l'armata dei lavandai, uomini e donne, che mitigano la fame lavando i panni dei milanesi, tirando a mano i carretti colmi di lenzuola e panni, arranca verso la città. Si diffonde la voce che l'armata degli insorti si è infrattata in questa arcadia dopo aver scelto come luogo di adunata l'Ortica. Sono cinquecento studenti e cinquemila contadini di un'improbabile ma ferocissima jacquerie che sta per abbattersi sulla città già in fiamme. Ci siamo. Si spediscono plotoni a piedi e a cavallo, la polvere comincia ad alzarsi lungo lo stradone sferzato dagli squadroni al galoppo con le spade sguainate. I lavandai, respinti dal cordone delle truppe come se fossero avanguardie dell'armata nemica, ripiegano

trascinandosi sulle spalle i panni lavati e l'angosàa per il guadagno perduto . Danno il primo avviso che sta succedendo qualcosa di spiacevole. I soldati avanzano lungo la ferrovia scaricando i fucili a ritmo accelerato, i campi e le facciate placide delle cascine sono sferzate, ridotte come dopo una terribile grandinata . Si comincia a sfondare i portoni, ricordo di tempi altrettanto tristi quando le armate dei lanzi andavan su e giù per la Lombardia. Son tornati i tempi di Renzo e dei bravi. Fucili in pugno, si ras trellano torme di mezzadri e contadini terrorizzati, infrattati n elle cantine e nelle stalle. Borghesi e passanti con spinte e minacce sono affastellati in mezzo alla strada. Si nascondono, è la prova che sono degli insorti. Nella rete restano impigliati anche padroni terrieri . Il proprietario dello stabilimento rischia la fucilazione : protesta per la brutta figura di esser finito in mezzo ai «rivoluzionari», lui distinto cittadino. All'osteria d e ll' Acquabella i soldati fanno il colpo grosso. L'oste Pietro Vittadini si è cos truito una buona fama soprattutto nella s tagione deg li asparagi, ha nel locale una brigata che ha pensato b ene di sceglier quel giorno per festeggiare con vino e salame, e poi giocatori di bocce, buongustai: un pienone. Quando arrivano i solda ti e trovano l' uscio incatenato e vedo no tutta quella gente riunita sotto la veranda, capiscono subi to che è la cupola criminale. Li trascinano via ammanettati ins ieme alle altre prede: duecento persone sotto choc che invocano pi età. Finiscono n elle camerate d e l Castello e davanti ai tribunali militari.
Alle 17.50 dell'B maggio Bava Beccaris spedì al presidente del Consiglio di Rudini il telegramma della vittoria:
Domata la ribellione che s i era accentrata ieri a Porta Ticinese, ritengo cessata ogni resistenza.
Il governo può essere tranquillo che la ribellione è oramai repressa. Ho ordinato che si riaprano tutti gli stabilimenti industriali.
Agli angoli delle strade, a l posto dei manifesti che promettevano forca e fucilate, era apparso un altro proclama:
Ufficiali sottufficiali e sold ati! Funzionari e agenti di pubblica sicurezza!
In questi tristissimi giorni, non badando a fatiche e a disagi, voi avete reso un grande servizio al re, alla patria, alla Civiltà . Per opera vostra la pace è restituita a questa grande metropoli la quale, cinquant'anni or sono, per virtù, va lore, per concordia di tutti i cittadini seppe risorge re a libera vita. l malvagi di ogni partito, concordi nel folle intento di sovvertire le istituzioni e di disfare l'Italia l'avrebbero ripiombata in una servitù peggiore della prima. Voi l' avete impedito! Nel nome del re e della patria vi ringrazio.
Il regio commissario straordinario tenente generale Bava Beccaris.
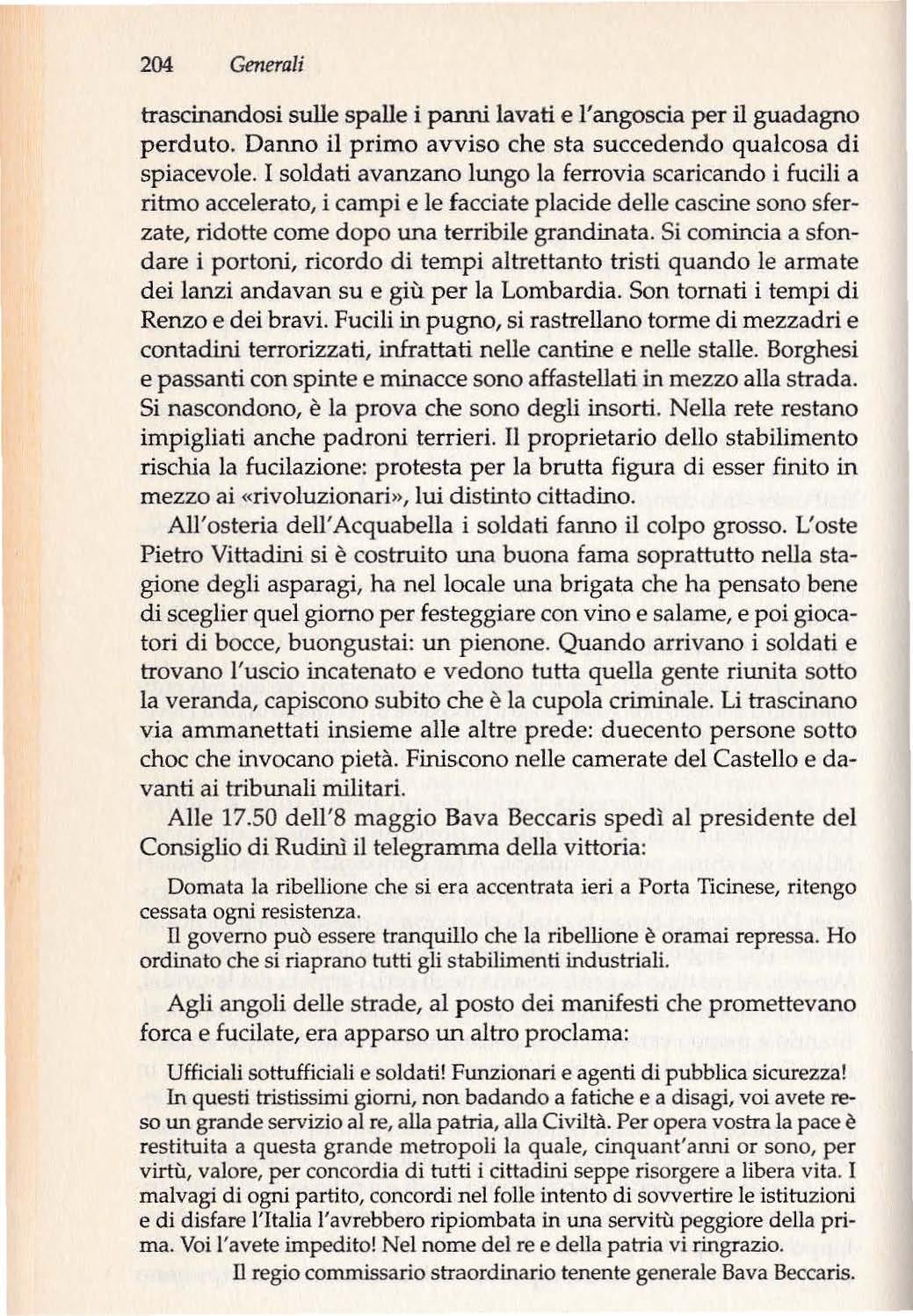
A Roma respirarono. Subito di Rudinl annunciò con grande enfasi al generale che per quella vittoria su altri italiani pestiferi e traditori si era guadagnato il seggio senatoriale e il collare dell'Annuziata che lo faceva cugino del re. L'aveva ben meritato: quando, proclamato lo stato di assedio, erano scattati gli scioperi e i ferrovieri si preparavano a bloccare i convogli dei rinforzi, li aveva militarizzati sottoponendoli al tribunale di guerra per diserzione. Come s crisse «L'Illustrazione italiana», breviario settimanale della borg hesia, aveva «stupito il mondo per la rapidità e l ' energia dei provvedimenti! ».
I giudici, non volendo essere da meno dei colleghi che avevano schiantato la rivoluzione, si scatenarono. Nel Castello funzionavano come una catena di montaggio due corti militari presiedute da tenenti colonnelli divenuti famigerati. Difendevano gli imputati alcuni giovani tenenti che comunque, sia detto a loro onore, si batterono sempre per quanto possibile per strappare assoluzioni o almeno riduzioni di pena . Si applicava il codice penale ordinario, ma con proced ura militare che prevedeva interrogatori spicci, nessuna arringa e processi a gruppi. Alla fine avrebbero affibbiato 1390 anni di reclusione, 90 di detenzione e 307 di sorveglianza. E la regina che si lamentava con Carducci pe r l'eccessiva tolleranza!
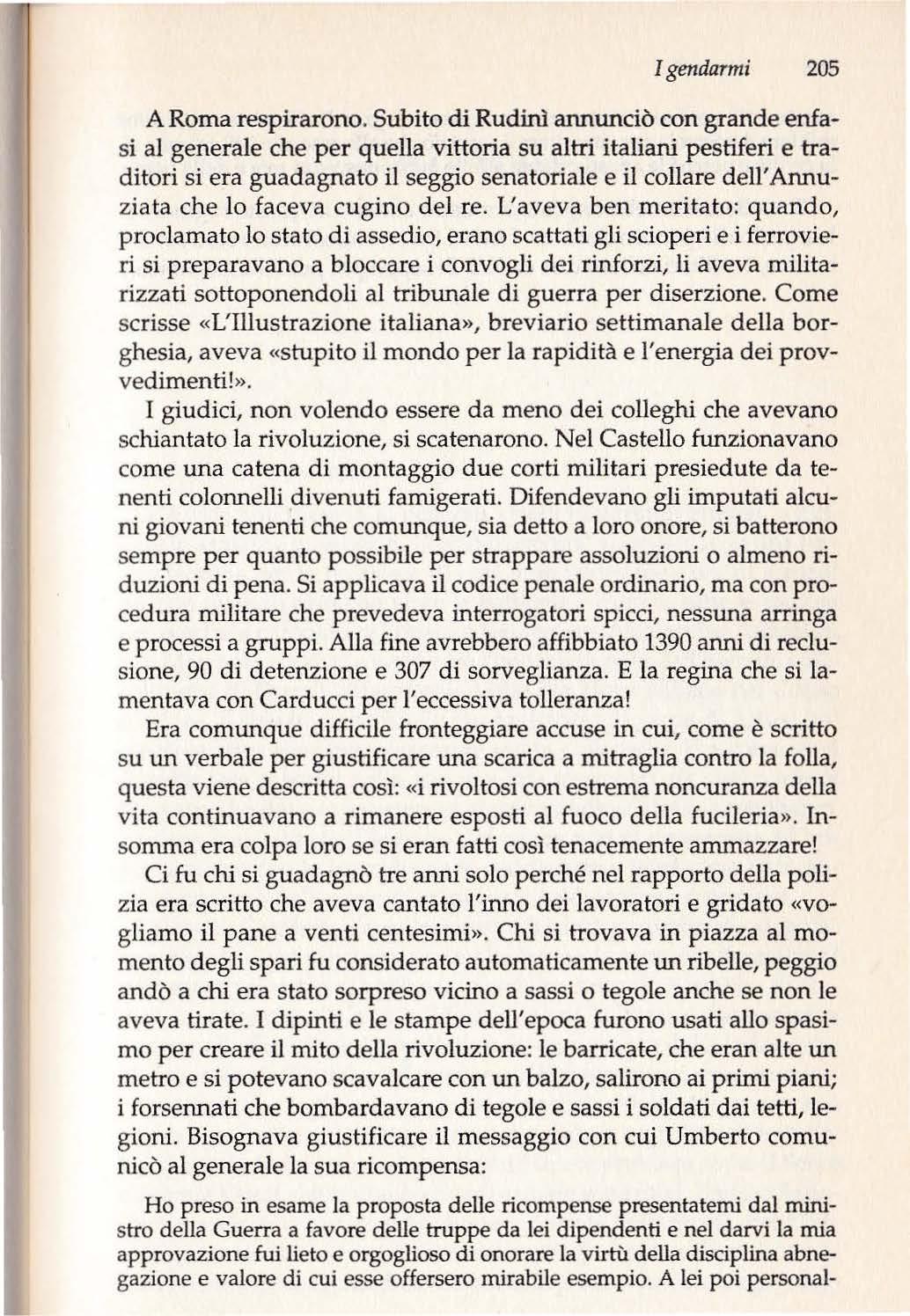
Era comunque difficile fronteggiare accuse in cui, come è scritto su un verbale per giustificare una scarica a mitraglia contro la folla, questa viene descritta così: «i rivoltosi con estrema noncuranza della vi ta continuavano a rimanere esposti al fuoco della fucileria» . Insomma era colpa loro se si eran fatti così tenacemente ammazzare!
Ci fu chi si guadagnò tre anni solo p erché nel rapporto della poliz ia e ra scritto che aveva cantato l'inno dei lavoratori e gridato «vog liamo il pane a venti centesimi». Chi si trovava in piazza al momento degli spari fu considerato automaticamente un ribelle, peggio andò a chi era stato sorpreso vicino a sassi o tegole anche se non le aveva tirate. I dipinti e le stampe dell'epoca furono usati allo spasimo per creare il mito della rivoluzione : le barricate, che eran alte un metro e si potevano scavalcare con un balzo, salirono ai primi piani; i forsennati che bomba rdavano di tegole e sassi i soldati dai t e tti, legioni . Bisognava giustificare il messaggio con cui Umberto comunicò al generale la sua ricompensa:
Ho preso in esame la proposta delle ricompense presentatemi dal ministro della Guerra a favore delle truppe da le i dipendenti e nel darvi la mia approva zione fui lieto e orgoglioso di onorare la v irtù della disciplina abnegazione e valore di cui esse offersero mirabile esempio. A lei poi persona!-
mente volli conferire motu proprio la croce di grand ' ufficiale e dell' ordine militare dei Savoia per rirneritare il servizio che ella rese alle istituziorù e alla civiltà e perché le attes ti col rrùo affetto la riconoscenza rrùa e della patria. Bava Beccaris nella risposta si mostrò almeno in questo ragion evole e parlò di «penoso dovere». I morti tra i rivoltosi erano stati settantanove, i militari ebbero due caduti. Si seppe poi per il fuoco amico.

L'austriaco e il suo doppio
L'Africa non piaceva ai generali, quelli importanti abituati a guidare le armate e gli eserciti. Ci andavano mal volentieri, con una furti va lacrima per la nostalgia cli casa, non vedevano l' ora di tornare perfino quando avevano vinto le battaglie e c'erano tutte le ragiorù p er restare a completare l'opera e festeggiare. Alessandro Asinari di San Marzano, spedilo a vendicare l'onore smarrito dall'esercito sulla collinetta di Dogali, una piccola Little Big Horn italiana nel Como d 'Africa, il sirùstro scricchiolio che anticipava la crepa di Adua, impiegò quattro mesi per percorrere trenta chilometri. Era come se si allontanasse di malavoglia, con una fitta reumatica, da quel porto di Massaua che doveva assistere al giorno gaudioso del suo reimbarco. Appena constatò che l'esercito del negus non si presentava all' app untamento con la battaglia partì soddisfatto e felicissimo ordinando al capitano della nave di spingere le caldaie fino a scoppiare. Antorùo Gandolfi, un colleziorùsta cli cariche e prebende, deputato generale e governatore, prese alla lettera le incaute affermaziorù del primo mirùstro, il siciliano marchese Antonio Starabba di Rudiiù, un altro che alla parola Africa storceva la bocca e che preferiva passare alla Storia con l'appellativo di «compagrùa della lesina» che gli incontentabili militaristi avevano affibbiato al suo mirùstero imp egnatissimo a tagliar spese, tutte superflue. Abolì allegramente il p rimo comandamento dei generali: mai cedere un palmo cli terreno. Gettò con la furia del prodigo al vento intere province come il Seraè e l' Oculè Cusai che ci erano costate astuzie e sacrifici. Perfino Badoglio, che vinse la più grande guerra colorùale d e lla Storia, nel 1936, a ll'Equatore dismetteva l'abituale sussiego e abbandonò in tutta fretta Addis Abeba quando il sudore non si era ancora asciugato sul-
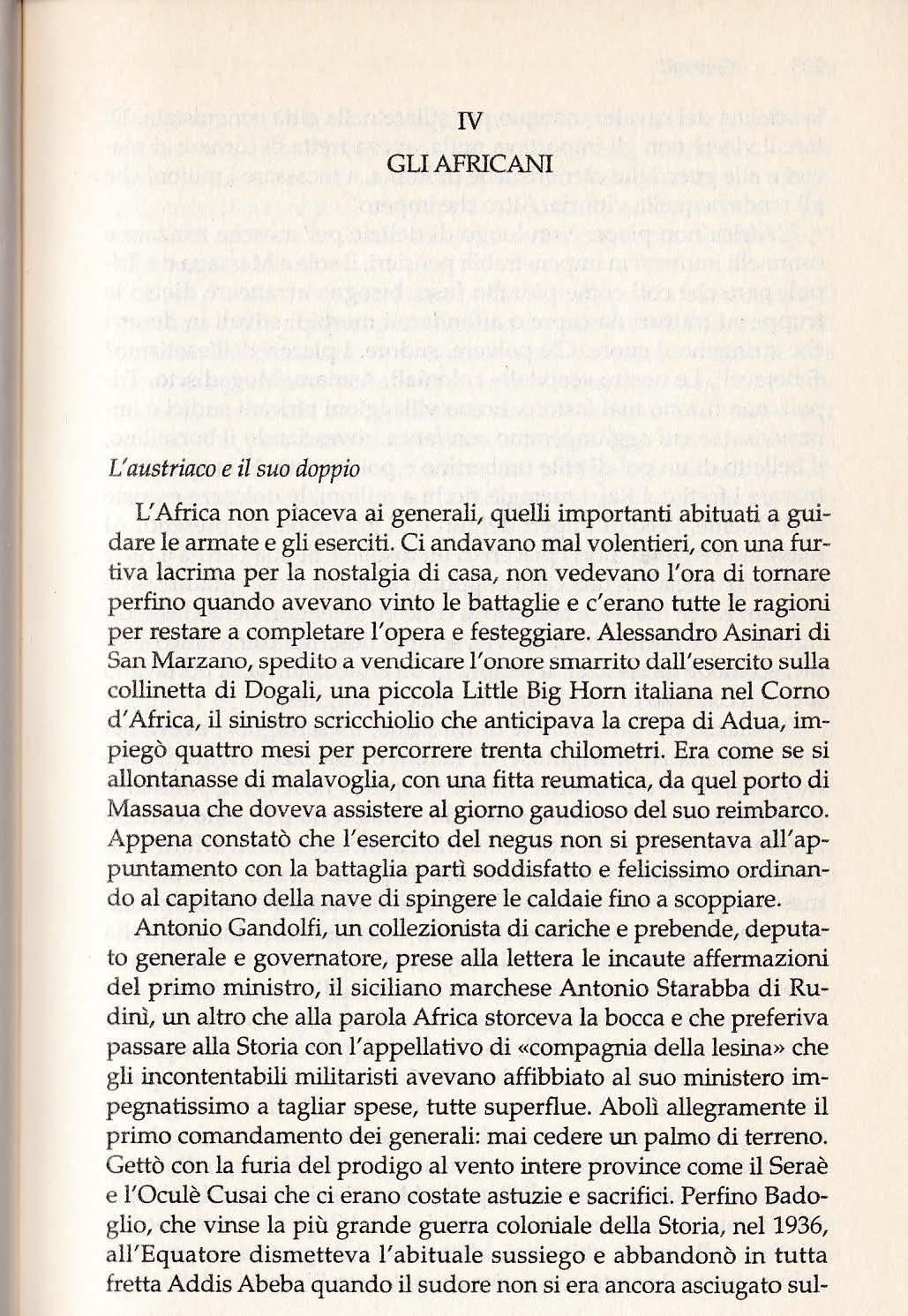
la schiena del cavallo montato per sfilare nella città conquistata. Di fare il vicerè non gli importava nulla, aveva fretta d i tornare ai piaceri e alle guerriglie carrieristiche di Roma, a incassare i milioni che gli rendeva quella vittoria. Altro che impero!
L' Africa non piace: è un luogo di delizie per mosche zanzare e cammelli immersi in impenetrabili pensieri, il sole a Massaua e a Tripoli pare che coli come piombo fuso, bisogna arrancare dietro le truppe su tratturi da capre o affondare i morbidi stivali in deserti che stringono il cuore. C'è polvere, sudore. I piaceri dell'esotismo? Teneteveli. Le nostre «capitali » coloniali, Asmara, Mogadiscio, Tripoli, non furono mai fastose. Erano villaggioni africani sudici e improvvisati a cui aggiungemmo con fatica , rovesciando il borsellino, il belletto di un po' di stile umbertino e poi fascista. Non sperate di trovare i fasti del Raj, i maragià ricclti a milioni, le dolcezze esauste dell'Oriente, l'eco di imperi defunti e di gradevolezze presenti. Al massimo vengono fuori i piaceri di un rosolio e di una partita a carte al circolo ufficiali in una calura appunto africana. Cose sgraditissime a clù invece in Italia era abituato ai concreti splendori della classe dirigente e che anc he alle manovre, sempre descritte come faticosissime, scomode da spezzar la tempra di un antico quirita, si portavano dietro il codazzo di mogli amanti e piaceri borghesi.
Il palazzo del governatore di Massaua, il «serraglio», aveva nel nome risonanze pruriginose, di harem e dolcezze orientali. Purtroppo eran solo risonanze: anche se spesso nelle corrispondenze giornalistiche dell' epoca il caldo dava alla testa e il goffo edificio lievitava a falansterio dove Shahràzàd incontentabili sfibravano governatori e guerrieri fino a un attimo prima erculei. Una bicocca messa in piedi dai turclù era. E tale restò fino a quando non ammainammo bandiera. Giacomo Belc redi, velenosissimo inviato della «Tribuna», ricordava con malizia giacobina il tempo in cui il generale Tancredi Saletta, primo governatore dell' Eritrea, l'uomo che aveva guidato lo sbarco primigenio in Africa, pranzava «sopra due pezzi di legno posati su delle casse vuote di petrolio e aveva per tovaglia una tenda». Beato lui che prima d i andare in India a imparare il mestiere del colonialista e tornare con un bell'elmo inglese e molta prosopopea, sapeva scherzare sopra questo esempio di «spartanismo». Quello era un contemporaneo di Licurgo. Poi peggiorammo. Non parliamo di Tripoli e Mogadiscio, suburbi della periferia musulmana sporchi e quasi inabitabili per un europeo distinto e dalle buone abitudini. Mettevano il disgusto a un generale solo a sfiorare la carta geografica coi polpastrelli. Quella delle «ma-

dame» è un'altra storia. I turgidi seni dalle erte punte e le reni feline avevano un bell'innescare languori. Ma erano delizie a cui si poteva dedicare, e lo faceva con furia, solo l'ufficialità di medio rango. Ai generali conveniva, purtroppo, per decoro spiare invidiosi, cercando di arrivare in fondo alla striminzita paginetta di affettuosità a lla moglie lontana .
E poi c'erano i nemici: coriacei e fanatici, disposti a battersi fino al sacrificio totale e quindi pericolosissimi, come da noi, addomesticati dalla civiltà dei Lumi, non avveniva più dal tempo dei Fabi. Era gen te che praticava tecniche belliche mai viste, scorrette, come l'imboscata, contro cui era facilissimo fare brutte figure. Ci siamo: per q uesto non piacciono le avventure africane. Una vittoria contro i «negri» rende poco, è considerata quasi obbligatoria vista la granitica convinzione della superiorità diciamo «tecnica» della razza bianca. Una sconfitta invece costa moltissimo, perché ha i contorni di vergogna continentale, accomuna nella deprecazione Milano e Londra, sta sullo stomaco all' intera Europa. E non dà diritto a quell'aura romantica che tocca al guerriero sfortunato riservato alle misclùe tra occidenta li, sicuro presidio dei gradi e della pensione. Per l'Africa si imbarcano volentieri, canticclùando, gli ufficiali inferiori, i tenenti, i capitani, perché vogliono far carriera attirati da epopee che in Europa non si possono più nemmeno immaginare. Il mo ndo qui è al rovescio: sono le paci infatti che durano trent'anni . Sba rcano con la faccia beata: i generali sono meno numerosi e poiché p referiscono starsene al fresco dei comandi non maramaldeggiano, r ivendicano il diritto alla pigrizia a n che nei confronti di ordini e contrordini, firme e controfirme. Si attenua la italica apoteosi delle scartoffie e dei lasciapassare. I pezzi grossi, anche i poclù che in Africa conquisteranno i galloni - per esempio Graziani e il funesto Baratieri, lo stravinto di Adua - s i porteranno quella qualifica di «coloniale» come una macchia sulla divisa: significa guerre da poco, scaramucce con popolazioni permalose e primitive. Sogneranno sempre di confermare le vittorie al cospetto di più titolati avversari. Quando Baratieri e Baldissera si incontrarono il 5 marzo 1896 tra le mura del forte che teneva d'occlùo gli umori di quella che era allora solo un abbozzo di città, Asmara, tracciato da approssimativi colpi di matita, tutto distingueva i due gen e rali. Antonio Baldissera asciutto, un corpo e un'anima che sembravano di porfido e di granito, indossava una divisa quantomeno sorprendente per un'epoca in cui allo stile i generali ci tenevano eccome: era una palandrana da soldato semplice a cui avevano cucito sopra, frettolosamente, i gradi

di generale e di governatore. Per di più appariva stropicciata, sgualcita, infarinata di polvere perché a cavallo, lavorando di sperone, aveva percorso la salita che portava da Massaua sul mare, dove era sbarcato alla capitale sull'altopiano. La strada buona moriva subito, il resto era una brocca tura di sassi.

Il collega che gli stava di fronte, invece, indossava una divisa fastosa e ben stirata, con tutti i gradi e le decorazioni al loro posto. Di medaglie e simboli di campagne ce n'erano forse fin troppi. Chi avrebbe detto che quell' impeccabile damerino, Oreste Baratieri, era reduce da una catastrofica ritirata e si era lasciato per strada tra le gole e gli aspri crepacci di Abissinia migliaia di soldati morti feriti prigionieri? Capita ogni tanto che la Storia smarrisca il filo e incroci con beffarda stramberia due destini: Baldissera era venuto a toglier il comando al vinto, a portargli, purtroppo in ritardo, un ordine umiliante di licenziamento; gli toglieva quel comando civile e militare per cui per anni aveva trapestato cocci utamente la via della carriera. La disdicevole trasandatezza di Baldissera nasceva proprio dall'aver viaggiato, per quel p erentorio appuntamento, in incognito, travestito da funzionario civile. Le machiavelliche, e inutili, astuzie della politica volevano che il licenziato nulla sospettasse fino al momento di trovarselo davanti, il suo s uccessore, armato della folgore di Giove della revoca. Troppo tardi. Ventiquattr'ore prima Baldissera a Massaua avrebbe incontrato una situaz ione ancora aperta su cui esercitare il suo pugno di ferro e mettere utilmente alla prova i piani che durante le settimane di navigazione nel Mar Rosso aveva elaborato per riparare, correggere, ribaltare una sconfitta in vittoria . Adesso doveva amministrare un disastro, il peggiore della s toria coloniale di ogni tempo, una batosta che faceva impallidire Lissa e Custoza. L'uomo che gli stava davanti era lo stesso che pochi mes i prima era venuto a Roma acclamato dalle folle e aveva pronunciato la famosa frase: «Datemi dieci milioni e vi porto in Italia il negus Menelik incate nato». I dieci milioni glieli avevano dati: Menelik s tava festeggiando la vittoria intonando il Te Deum ne lla chiesa di Adua. Si diventa filosofi a leggere certi sghiribizzi del fato.
Gli incontri tra generali, quando uno dei due è vinto, hanno spesso una straziante grandezza: le frasi di conforto pronunciate dai vincitori assordano le antologie e gli artisti si sono fatti tentare, grand i o modesti che fossero, dal tema plutarchiano dello sconfitto che consegna la s ua spada a ll'avv e rsario fortunato. Incroci di destini, grand ezze che appassiscono, la virtù della misura nel trionfo: sono le maree della s toria, il pennello e la macchina da scrivere vanno avan-
ti da soli. Quella volta ad Asmara si aggiungeva il dettaglio intrigante che i due protagonisti indossavano la stessa divisa e la sconfitta in un certo modo si riverberava anche su colui che era stato inviato per impedirla. Baldissera fece il possibile perché tutto sembrasse un normale avvicendamento e non una scena da tragedia greca. Si informò sui movimenti tattici della battaglia disgraziata, ma come se fosse una conversazione accademica, si parlasse di Waterloo e non di un posto in cui erano ancora caldi i cadaveri degli uccisi, i feriti rantolavano e i prigionieri gettavano guaiti da bestia . Si spinse impavido fino alla cortesia d i domandare qualche consiglio, lui che la colonia in pratica l'aveva montata pezzo su pezzo e se ne era andato per le solite polemiche col ministero e gli scandali che i gazzettieri delle retrovie solleticavano e qualche volta inventavano di sana pianta.
Non era la prima cortesia tra questi due generali così diversi. Il 19 aprile 1893 «Il Mattino» di Napoli riferiva ai suoi lettori di una proposta del governatore della colonia, l'ancora potente, riverito e presuntuoso Baratieri: aveva cltiesto, e naturalmente ottenuto, che venisse dedicato al Baldissera il forte Bet Macà il quale, fosco e sospettoso come la casa dell'Innominato, incombeva sul villaggio di Asmara che gli italiani avevano deciso con capriccio di conquistatori di trasformare nella loro capitale. Commentava il quotidiano, tra i più briosi nel1'accudire i nostri destini africani:
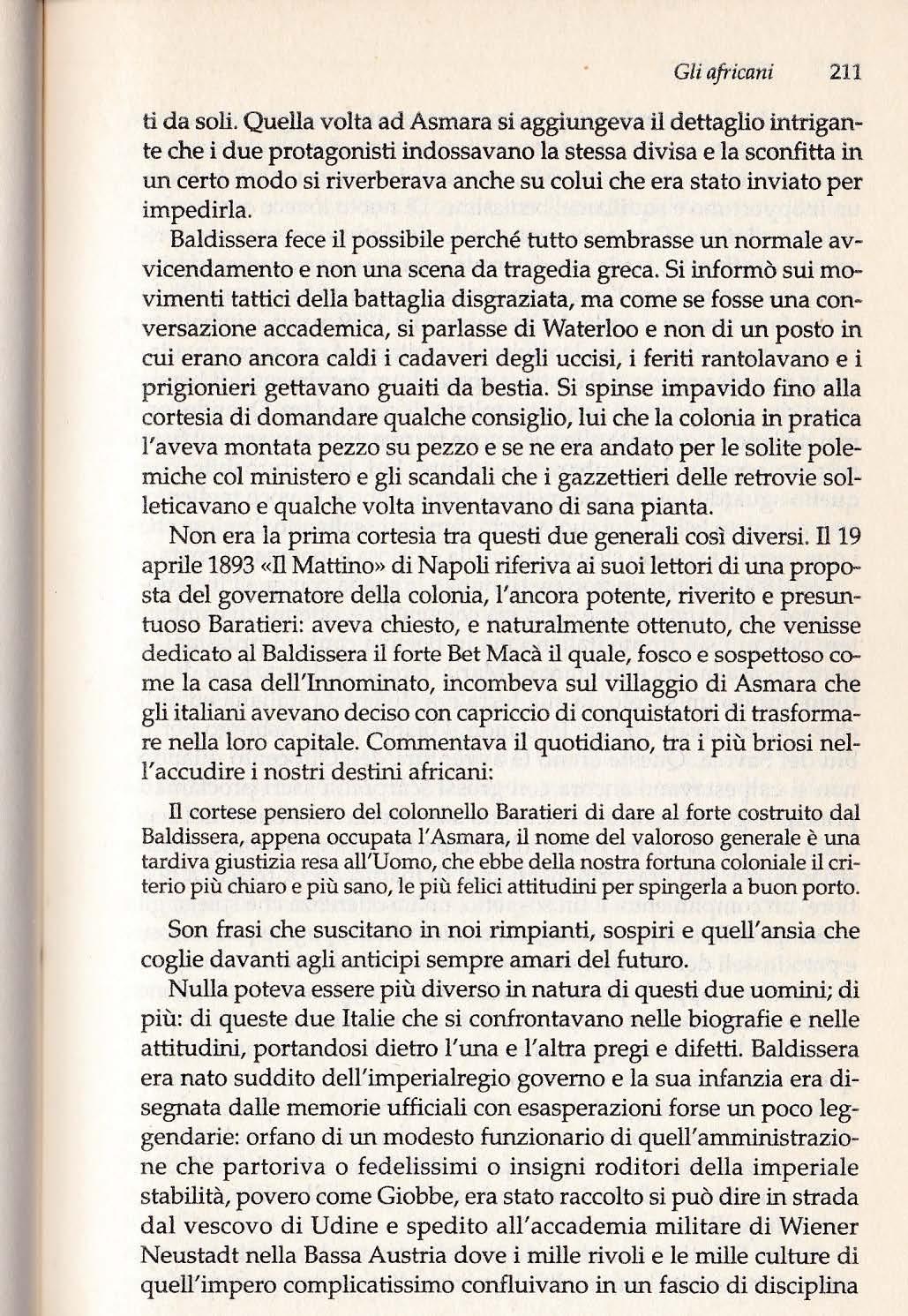
Il cortese pensiero del colonnello Baratieri di dare al forte costruito dal Baldissera, appena occupata l'Asmara, il nome del valoroso generale è una tardiva giustizia resa all'Uomo, che ebbe della nostra fortuna coloniale il criterio più chiaro e più sano, le più felici attitudini per spingerla a buon porto.
Son frasi che suscitano in noi rimpianti, sospiri e quell'ansia che coglie davanti agli anticipi sempre amari del futuro.
Nulla poteva essere più diverso in natura di questi due uomini; di più: di queste due Italie che si confrontavano nelle biografie e nelle attitudini, portandosi dietro l'una e l'altra pregi e difetti. Baldissera era nato suddito dell'imperialregio governo e la sua infanzia era disegnata dalle memorie ufficiali con esasperazioni forse un poco leggendarie: orfano di un modesto funzionario di quell'amministrazione che partoriva o fedelissimi o insigni roditori della imperiale stabilità, povero come Giobbe, era stato raccolto si può dire in strada dal vescovo di Udine e spedito all'accademia militare di Wiener Neustadt nella Bassa Austria dove i mille rivoli e le mille culture di quell'impero complicatissimo confluivano in un fascio di disciplina
ferrea e di valori condivisi. L'orfano era venuto su aggrottato, cattivo. Si raccontava che una volta, a un istruttore che gli chiedeva se sapesse nuotare, avesse risposto, conoscendo ancora male il tedesco, un inopportuno e squillante: benissimo. Di nuoto invece era assolutamente digiuno. Gettato in acqua !':tallo sbrigativo maestro aveva rischiato di affogare, ma la sua determinazione a non riconoscersi vinto e a non ammettere l'errore linguistico, grazie a sforzi inauditi, lo aveva fatto restare a galla . Nella guerra del 1859 aveva combattuto contro di noi e bene, con la divisa di capitano. Anzi, si era guadagnato i gradi proprio a Palestro a spese di un reggimento di bersaglieri che anni dopo gli sarebbe capitato di comandare. Quando, ormai italiano, si presentò alle sue nuove truppe, tutti stavano col fiato sospeso aspettandosi imbarazzi e abiure. Lui, imperturbabile, con quello sguardo severo che metteva soggezione e la voce tagliente, aveva tessuto le lodi dei suoi vecchi camerati esaltando il valore che i due eserciti avevano sfogato in quella gloriosa e lontana giornata. Nel 1866, per non incrociare di nuovo la spada con quell'incomoda prole della rivoluzione - era già colonnello -, ottenne di combattere non più sul fronte i taliano ma in Boemia contro i prussiani, e portò a casa la croce militare di Maria Teresa. A riparazione di un torto durato un secolo, la sua terra era diventata italiana ed egli chiese di cambiare divisa, lasciando il bianco degli Asburgo per il blu dei Savoia. Queste erano le avventure dell'Ottocento quando non si calpestavano ancora con grossi scarponi i sacri proclamati principi e gli irredentismi andavano a braccetto con l'onore del servizio. Gli rimasero, tra i suoi colleghi perfidi, il soprannome «l'Austriaco», che non era certo, negli anni di martiri ancor freschi a Belfiore, un complimento. E un sospetto, un'insofferenza che spiega gli inciampi della sua pur prestigiosa carriera. Tra le pagine più curiose e paradossali del Risorgimento e delle sue confusioni c'è l'immagine di Baldissera appena promosso nello stato maggiore della divisione di Chieti che passa interminabili serate a scambiare racconti e ricordi con Nino Bixio, il luogotenente di Garibaldi, ora comandante di quella divisione, il sovversivo che aveva dedicato la vita a cercare di scuotere il trono degli Asburgo. E ci piacerebbe che qualcuno dei due, il rivoluzionario genovese che sognava ormai nuove glorie marinare ed era un po' stufo di epopee, e il brillante ufficiale dell'odiata Austria ancora all'inizio di carriera, ci avessero lasciato un resoconto di quelle conversazioni.
Anche Baratieri era un suddito della monarchia austriaca, ma aveva fatto subito altre scelte: la carriera l'aveva imboccata indos-
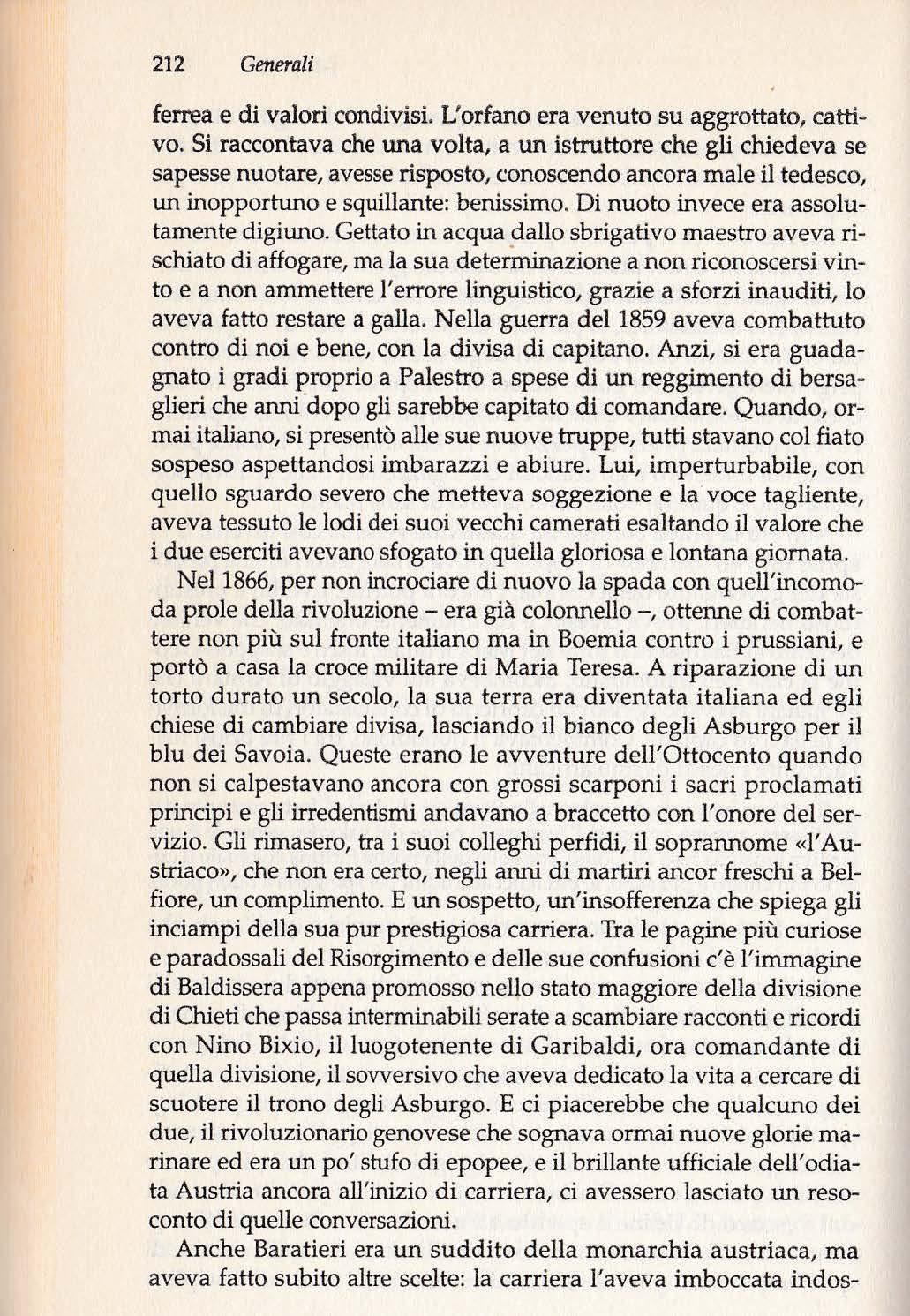
sando la camicia rossa, arruolandosi in quel gruppo di garibaldini ambiziosi e gagliardi che su quell'impresa avevano scommesso non solo per fornire un grande dispiacere ai Borboni ma soprattutto perché sarebbe stata un lasciapassare per il potere nella nuova Italia . Baratieri era uno di quelli che aveva azzeccato quell'azzardo: con la tessera garibaldina e un gran talento di acrobata della politica aveva scalato i gradi dell'esercito italiano, carriera a cui certo non lo destina vano attitudini militari. Quando Baldissera sudava sui manuali di Montecuccoli e del principe Eugenio, Baratieri manovrava nei corridoi romani tra le fila di quella sinistra che finalmente aveva arraffato il potere . In attesa di schiantare i nemici in corpore vili sui giornali impa rtiva aforismi e ramanzine sulle battaglie dell'antichità e su quelle poche che si combattevano in Europa; edificava la fama di stratega nelle aule del Parlamento dove, deputato, Crispi lo aveva sempre provvidenzialmente vicinissimo per sostenerlo in que lla scabrosa materia.
Ali'Africa era arrivato in queste estenuanti metamorfosi carrieris tiche perché aveva intuito che lì i salti di carriera erano più clamorosi, facili e repentini e si poteva speculare utilmente su un certo gusto esotico e imperialista che s i veniva piantando ogni anno sempre d i più nella vita di quell'Italia dalle mille delusioni e dai centomila r ancori. Abituato com'era all'immagine di primo della classe, di secchione, s i era anche dato il colorito da rodato coloniale partecipando a d alc une esplorazioni, di gran moda presso gli snob, nella vicina Tunisia. Era ancora senza padrone in quell'epoca; l'avevamo a un p almo; poi la Francia astutamente ce la soffiò relegandoci alle pietrose periferie del Corno d'Africa . Ne era tornato naturalmente sommergendo il pubblico di articoli e di libri dove sembrava, grazie al tono saccente, che null'altro avesse fatto in vita sua che attraversar dese rti, dar nomi a montagne e discutere con selvaggi sciaguratamente poco ansiosi di diventare civili. Insomma : il generale Baratier i era in realtà un giornalista geniale, un astuto politicante di un'Italia rapidamente convertita dai rigori un po' luterani della destra storica al governo rapace e sprecone d ella sinistra: uno che nelle cose militari andava a orecchio e credeva bastassero un paio di citazioni per vincere una battaglia . Baratieri non avrebbe mai commesso l 'errore di Baldissera che, promosso colonnello, alla richiesta se volev a far cancellare dallo stato di servizio il periodo in cui aveva militato nell'esercito austriaco, aveva risposto con un secco no. Lui si lavorava il Crispi, cercava di entrare in tutte le combinazioni dei ministeri. Ci volevano le acrobazie perché, anche allora!, cadevano e

venivano rimontate con i fragili puntelli di alleanze sempre provvisorie e infide. Scavava, ufficiale dello stato maggiore in Africa, sotto le fondamenta della statua del suo superiore, il governatore Orero, altro esempio di arrogante che si sentiva ridicolo con i gradi di governatore di quella rachitica colonietta.
Se Baldissera la scuola militare tedesca l'aveva frequentata da vvero, anche se nella versione casereccia dell'esercito austroungarico, per Baratieri il prussianesimo era diventato un dogma per scelta. Non perché avesse studiato con particolare attenzione le teorie strategiche che andavano di moda a Berlino, m a perché dopo la guerra del '70 fare il Moltke e ra diventata nelle caserme italiane la prova di modernità. Tutti fino al giorno prima omaggiavano Napoleone e i suoi s fioriti eredi come Mac-Mahon o Bazaine. Improvvisa era spuntata la passione per quei burberi vincitori di Metz e di Sedan: pianificazione, organizzazione, armate c he manovravano con l' orologio in mano. Di colpo era cambiato il vocabolario e Baratieri lo sfogliava furiosamente . Quanto poi al fatto che questa teori a fosse applicata o applicabile alle truppe da lui comandate... Ah, qui la faccenda si imbrogliava. Restava tutto sommato un giornalista approssimativo e abituato a spacciare per cultura profonda ciò che era solo un'infarinatura superficiale.
«L'Austriaco» aveva scoperto l' Africa n el 1887 e per dovere, non certo per accorti calcoli di carriera . Era sbarcato con quella spedizion e di San Marzano che doveva vendicare Dogali. Le sue lettere, dove l'arcigno ufficiale dismette l'aria di alma sdegnosa e si rivela a rguto spiritoso disincantato su uomini e cose, scoperchiano gli armadi retorici di quella spedizione. Baldissera ha capito tutto. Da Roma l'armata, che come un guizzo di folgore avrebbe dovuto incenerire il vile abissino, è partita con l 'ordine tassativo di evitare anche l'ombra di tm pericolo «per risparmiare ogni nuova commozione all'opinione pubblica in Italia tanto morbosamente sensitiva ». E allora, invece di impegnarsi nella caccia agli eserciti del negus, non è difficile trovarli perché sono immensi, si scava, si fortifica , si trincera, si costruiscono strade e ferrovie per assicurare ai diciassettemila uomini del corpo di sped iz ione l ' assoluta sicurezza. Comandando un'a rmata di t e rra zzieri impegnatissimi a portar pietre e a tirar su muri a secco, Baldissera può dedicarsi dalla Piana delle scimmi e (nome buHo per una poco marziale spedizi one) a raccontare: Massaua è Wla assai graziosa e interessante città~d ove s i mang ia s i beve e allegri s i s ta È provvis ta di ogni ben di Dio, perfino di belle signore, eleganti e bianche, in numero di undici: tuttavia preferisco e di gran lunga la mia

tenda e respirerò il giorno in cui non ci arriverà più regolarmente né il pane né l' acqua ho al mio servizio due giovani sudanesi nerissimi, Hidriz e Ibrahim, che mi fanno da scorta d 'onore, da guardie notturne, da binocolo portavoce postini fattorini ecc. ecc. E tutto ciò consumando solo mezzo litro d'acqua e due gallette al giorno. Il bello è che essi non nù comprendono e io non capisco loro e pure ci intendiamo tutti a meraviglia. Del resto qui io nulla trovai di sorprendente; mi immaginavo uomini e cose esattamente come lo sono in realtà, e fin dal primo giorno mi pareva di esservi nato e cresciuto, anzi, ci rimasi non poco di non essere molto più nero di quanto non sono.
Sempre in attesa d e ll'ordine di marciare in compatte schiere, o che il prudente negus Giovanni si d egnasse di scendere alla Piana delle scimmie per farsi bastonare, Baldissera e i suoi compagni videro con grande delusione la campagna finire . Quella volta non c'era nessun granellino di incenso da bruciare. Asinari di San Marzano, che tutti indicavano come un grullo bellicoso, era uno di quei soldati abituati a sentire l'odore della polvere senza il condimento del piombo. Il governo, a parole, faceva la voce grossa ed esigeva di vendicare l'onore d'Italia; in realtà si preoccupava solo di non avere un supplemento di guai. Anche una campagnetta minuscola come quella poteva bastare. Scriv eva questo filosofo mancato:
Non è soltanto al fuoco che si riprova la bontà degli eserciti, ma bensl anche a sopportare con animo sereno e v iril e perseveranza le privazioni, i disagi del clima, nell'abnegazione di ogni maniera, nel sentimento, nella religione del dovere; è in questo credo che le nostre truppe meritano le più grandi lodi.
Non gli venne da quella battaglia mancata un nocumento alla carriera. Anzi, gli avvenimenti non avevano certo imbronciato il giornale dell'esercito che riguardoso lo accolse sotto la sua ala protettrice:
Se all'Italia è mancato il successo delle amti perché il nenùco non ha ardito affrontarle, ha dimostrato peraltro di possedere un organismo nùlitare capace di lanciare senza nessuno sforzo un corpo di truppe considerevole nel Mar Rosso e in imprese di questa natura non è certo questo il punto meno importante.
Siamo nel 1888, i soldati spediti in Africa per vendicare i compagni si reimbarcano più abbronzati, ma di sicuro non più entusiasti per quella strana guerra senza fucilate. Baldissera invece resta, e con la carica addirittura di «comandante superiore». Definizione un po' g e nerosa visto che il suo esercito africano era costituito da qualche migliaio di mercenari arruolati ai quattro angoli del continente e la cui fama guerriera per ora si stemperava n e ll 'affettuosa definizione di «zucche v u o te». In realtà i suoi poteri erano ben ampi; si estende-
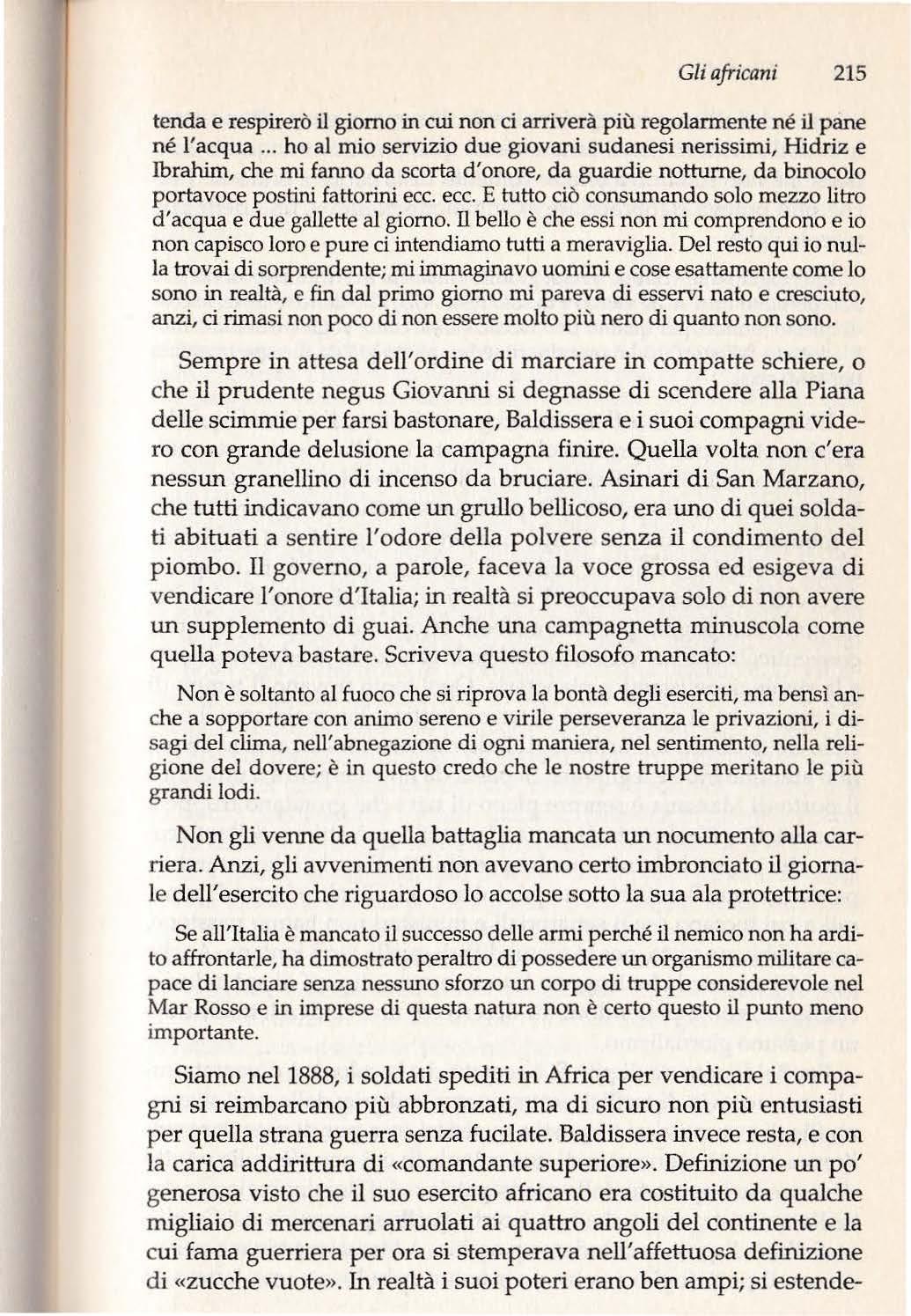
vano anche all'amministraz ione civHe. Insomma, era padrone assoluto d e ll 'Africa italiana. Stranamente quel fanatico tra nquillo e infl essibile n o n sembrava affatto contento d ella carica e n o n solo p erché non poteva riabbracciare «l'a n giol e tto biondo», un a delle s ue piccole figlie:

Interrogato due volte se avessi gradito rimanere in Africa risposi no. Ciò non pertanto tutti se ne vanno e io solo resto. Già, l'ho detto sempre, le cose di questo mondo, per quanto uno faccia, vanno come vogliono andare: inutile lottare. Mi s tordirò lavorando, rimedio questo già da me sperimentato per tanti anni.
È strana questa insofferenza d e i gen erali verso l'Africa. È qui che sperimentano per la prima volta nella s to ria della nostra casta milita re una possibilità esaltante, quella di eser citare un potere assoluto. In Eritrea s i è scelto infa tti, più p er n ecessità ch e p er ragionamento, il modello d e lla colonia di tipo militare. Le ragioni non sfuggono: s iamo avvinghiati a quella striscia di costa, sovrastati da mo ntagne e da esercit i con cinque, sei zeri, in contin uo stato di mobilita zione, ci t engono compagnia predoni e ribelli e ti opi, i dervisci, la fanatica conventicola che nel v icino Sudan ha inventato la jihad permanente e la rivoluzion e is lamica planetaria. Ogni tanto tro vano il tempo di rovesciarsi su di n oi in cerca di terre e bottino. Per molti anni il nocciolo d ella d ottrina, l'articolo di fede numero uno sarà combattere, non amministrare e legiferare. Si passa da un'emergenza a un'a ltra e il porto di Massaua è sempre pie no d i navi che grondano truppe e cannoni. Quell'ebbrezza d i comandare tutto può a ttirare soltanto coloro che in pa tria hanno poche possibilità di scalare le gerarchie, parvenu come Baratieri tanto per int enderci. Gli altri, i grandi genera li a cui toccano seggi sen ator iali e ministeri non hanno passione, come abbiamo vis to, per le scomodità di quella terra lontana. Anche perché i rapp orti che leggono loro n o n son o dipin ti di sp lend o ri e ricchezze, come pret endono di descrivere una cattiva letteratur a e un pessimo giornalismo.
Per Baldissera c'è di più. Si è accorto che la colonia è diventata subito un crocevia di traffici, sottogoverno, ruberie; dalle navi sbarcano file di avventu rieri disposti a qualsiasi cosa pur di s peculare sull' unica attività economica d i una colonia in cui non c 'è nulla e tutto deve essere importato dalla mad repatria o d ai domini inglesi, e d ove l'amministrazione, che non è certo quella s paragnina dei Quintino Sella, è disposta a chiudere un occhio. A Massaua arrivano persone con il portafoglio vuo t o, un passato n ebuloso e una l e ttera di
raccomandazione del ministro o del potente romano. Dopo pochi mesi fanno costruire palazzi, traslocano nelle antiche case dei mercanti arabi, ottengono posti e commende. Disprezzati in Italia, appena arrivati ad Asm ara sono fatti baroni. Scrive Baldissera n e ll '89 a un amico:
li assicuro che s i s ta bertissimo e sotto ogrti rapporto; e se ciò pensando io insisto per vertirmene via la ragione è che la rrtia bambina ha bisogno di me, ch'io o rmai son logoro dell'eccessivo e mai interrotto lavoro e soprattut~ to sono stanco di lottare tutti i giorni e tutte le ore, con fornitori disonesti e ladri Sostenuti e favoriti da deputati e ministri; non occorre che aggiunga che i citati lad ri sono tutti commendatori e cava lieri. Faccio punto, mi arresto, v isto che ho posto pi ede sopra un terreno fangoso.
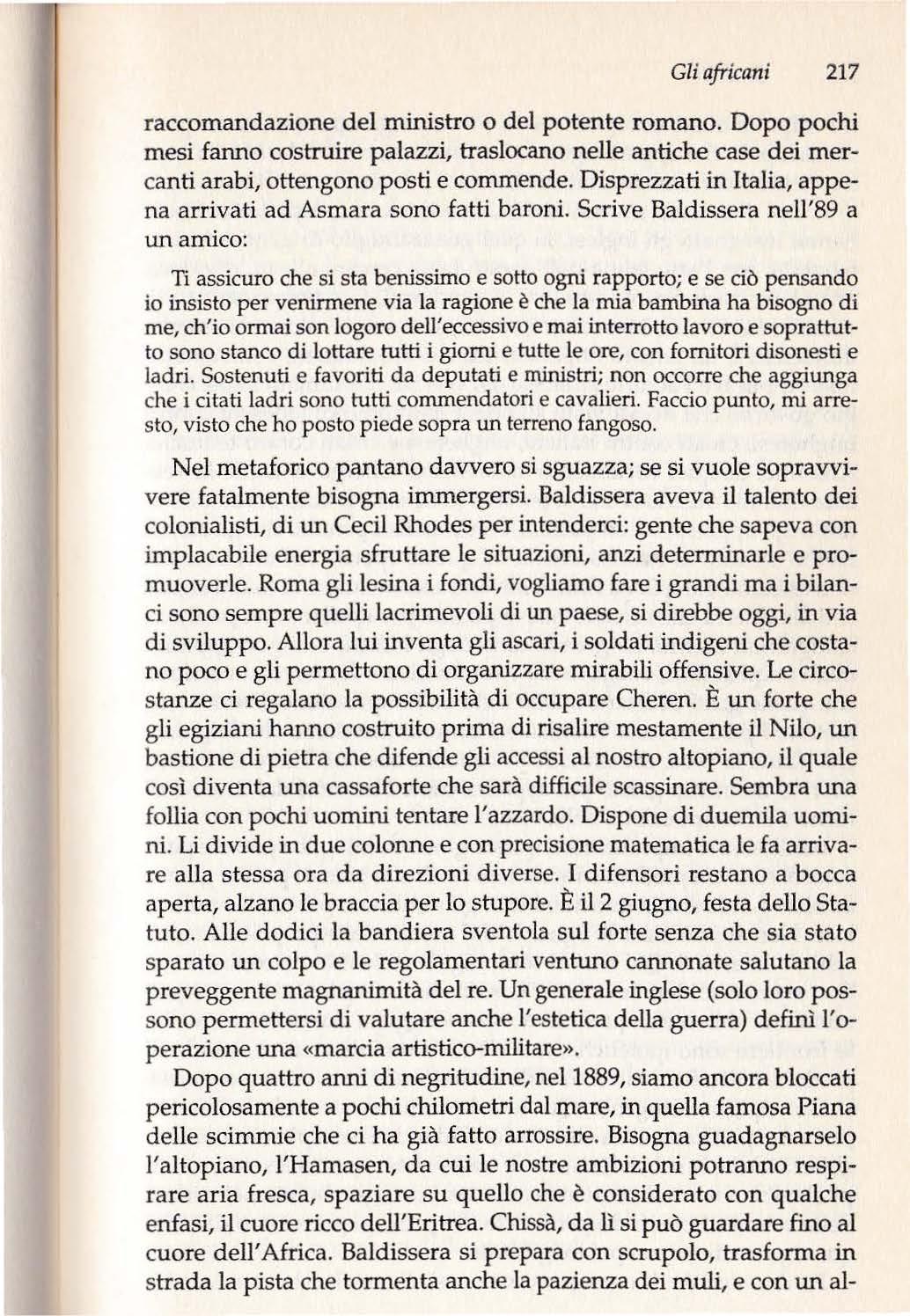
Nel metaforico pantano davvero si sguazza; se si vuole sopravvive re fatalmente bisogna immergersi. Baldissera ave va il talento dei colonialis ti, di un Ceci! Rhodes pe r intenderci: gente che sa peva con implacabile energia sfruttare le situazioni, anzi d e te rminarle e prom u overle. Roma gli lesina i fondi, vogliamo fare i grandi ma i bilanci son o sempre quelli lac rimevoli di un paese, si direbbe oggi, in via di sviluppo. Allora lui inventa gli ascari, i soldati ind igeni che costano poco e gli pe rm ettono di organizzare mirabili offensive. Le circos tanze ci regalano la p ossibilità di occupare Cheren. È un fo rte che gli egiziani hanno cos truito prima di risalire mestamente il Nilo, un bastione di pi etra ch e difende gli accessi al nostro altopiano, il quale così diventa una cassaforte che sarà difficile scassinare. Sembra una follia con pochi u omini tentare l'azzardo. Dispone di duemila uomini. Li divid e in due colonne e con precisione m atematica le fa arrivare a lla stessa ora d a direzioni diverse. I difen sori res tano a bocca ape rta, alzano le braccia pe r lo stupore. È il 2 gi ugno, festa dello Statuto. Alle dodici la bandiera sventola s ul forte senza che sia sta to s parato un colpo e le regolamen tari ve ntuno cannonate salutano la preveggente m agnanimità del re. Un generale inglese (solo loro possono permettersi di valutare anche l'estetica della guerra) defuù l'operazione una «marcia artistico-militare».
Dopo qua ttro anni di negritudine, nel 1889, siamo ancora bloccati pericolosamente a pochi chilometri dal mare, in que lla famosa Piana delle scimmie che ci ha g ià fatto arrossire. Bisogna guadagnarselo l'altopiano, l' Hamasen , d a cui le nostre ambizioni p o tranno respirare aria fresca, spaz iare su quello che è considerato con qualc h e enfasi, il cuore ricco d e ll'Eritrea. Chissà, d a lì si può guardare fino al cu ore d ell'Africa. Baldissera si prepara con scrupolo, trasforma in s trada la pis ta ch e torme nta anche la pazienza dei muli, e con un al-
tro colpo di mano occupa Asmara. Fioccano gli applausi, sono quattro casupole che appartengono a un predone, ras Alula . Ma da quel momento resteremo incatenati ali' Africa per altri quarant'anni.
I colpi di audacia sono soltanto una voce del suo repertorio. Come hanno insegnato g li inglesi, in quel guazzabuglio di genti è fondamentale, con l'arte felina dell'onesto Jago, cercare alleati, dividere, arruolare, trasformare i predoni in gendarmi, fare promesse a tutti, seminare zizzania, tenere sempre accuratamente accese le antiche inimicizie. È un talento imperialistico che a Baldissera veniva natura le. Applicava l'accorta strategia del vecchio consumato imperialregio governo che aveva visto a ll'opera dall'interno: tedeschi contro ungheresi, croati contro italiani, ungheresi e croati contro tedeschi. Alla fin e, da quel vociamento indiavolato, emergeva solida la vecchia tirannia austriaca che si portava nelle ossa il tarlo sordo dell'odio degli oppressi. I fieri patrioti, i nazionalisti pensosi che gli storici hanno creduto di riconoscere fin da queste epoche remote, in realtà non esis tono; Etiopia ed Eritrea devono accontentarsi di loschi signori della guerra che cercano nuove pedine per spellare con profitto i compatrioti inermi. La grande carta degli italiani è di non apparire mai conquistatori, coagulando l'automatica e fervente avversione che quelle genti dedicano subito a chi dà l'impressione di voler loro mettere i piedi in testa. Mettiamoci comodi. Lasciamo che litighino, che alzino la voce, che tirino fuori coltelli e bastoni . Tireremo il naso fuori al momento giusto per apparire com e liberatori dal tiranno di turno e farlo ripiombare nella m ediocrità. Baldissera si impratichisce, questo gioco è ambiguo sporco e pericoloso. Assolda predoni e regala loro fucili e le patenti per far guerra ad altre bande che in quel momento g li sembrano più ostili e pericolose. Non si può alzar lo sguardo dal mazzo delle proprie cart e, rischi di smarrirti. Qui non ci sono regole di lea ltà o riconoscenza . Con seimila soldati deve tener l'ordine in una colonia d i centoquarantamila chilometri quadrati dove si viaggia a dorso di cammello, le frontiere sono ipotetiche, non c'è un'amministrazione, bande di predoni e alleati armati fino a i denti di dubbia fedeltà vanno a spasso con cipiglio arrogante. Quando s i profila un pericolo Baldissera procede spietatamente a eliminarlo affidando il compito ai suoi irregolari. Anche la sola intenzione di tradire basta per una sentenza capitale di cui naturalmente non resta traccia ingombrante nei verbali della colonia . Spaziando per il cielo dei principi potremmo dire che qui v ige un diritto un po' l ongobardo. Fu il materiale di una operazione così disinvolta, lo scandalo Li-

vraghi, che opportunamente manovrato dai s uoi nemici a Roma come in colonia rischiò di tra volgerlo. Raccontiamolo, ci pare che assomigli a qualcosa. Dario Livraghi è un ufficiale dei carabinieri a cui Baldissera h a affidato il compito di t enere i collegamenti con i capi indigeni arruolati n e lle ban de irregolari. Tipo svelto, disinvol t o di modi e di scrupoli, Livraghi s i tira dietro un Leporello indigeno, un sottuffici ale, Adam Agà, che ha gi urato fedeltà più al s uperiore che al re moto re d'Italia. La s ulfurea coppia finisce per prendere passione a qu el doppio gioco, si ingegna a rende rlo triplo, quadruplo, m e tte su una privata organizzazione parallela in cui utilizza i s uoi collaborazio ni sti per estors ioni, rica tti e omicidi. In ques ti t empi di s ospetti b as ta la minaccia di un'accusa d i tradimento p er a prire gli animi e le b o r se. Le lis t e dei clienti lievitano come to rte, acchiappano anche r icchi m ercan ti e n o tabili che ci dedicano il loro affetto senza secondi pensieri. Chi non p aga viene eliminat o, «so ppresso» com e scrive la burocra zia coloniale, e tutto finisce nelle cifre della proficua lotta contro i tradi tori. I s uperiori del Livraghi strabuzzano gli occhi per tanta irriconoscenza indigena e passano a d al tra pratica. Quando il feroce Adam Agà è esausto o la vittima è davvero importante, è lo s tesso Livraghi ch e si sporca le mani dopo aver tra scinato il m alcapitato in qualche tratturo alla periferia di Massaua. La colonia è minuscola e molti sussurrano di queste pratiche così poco ortodosse. Anzi, il termine «livragheggiare» è s ta t o coniato per descrive re la sparizione repentina e misteriosa di qualche n o tabile chiacchierato (o troppo ricco). A M assaua s i strizza l ' occhio e si fa fin ta di nulla. Il capitano e il socio livragheggiano indis turbati . Ma nell' Italietta di Um berto rimasta n elle memorie patrie p e r essere autoritaria, dispotica e biliosa, la stampa come quarto pote re funziona, eccome. In colonia piombano torme di g iornalis ti in cerca di colore e d i scandali, gli inviati d e i fogli della sinistra sono famelici, documentati e curiosissimi. N on sono g iornali, sono barrica te. Così «la Tribuna » pubblica in prima p agina la storia e scoppia la scandalo. Di che t empra era fatto Baldissera lo si scoprì proprio in quelle circos tanze. Livraghi, fuggito opportunamente in Svizzera come un bancarottie re qualsiasi, tempesta i giornali di memoriali rica tta tori in cui minaccia ri velazioni da far crollare la colonia il governo il trono. Vuole per «collaborare» l ' immunità e r ovescia tutto s ui s uperio ri. Baldissera, processato per il teorema ch e «non poteva n on sapere» (e infatti sa peva benissimo), reagisce a fronte a lta assumend osi la responsabilità di una p ar te delle esecuzioni:

Se avessi lasciato correre mi avrebbero un giorno o l'altro trucidato qualche plotone ... senza farlo giudicare dai tribunali di guerra. L'Africa non si può regolare con le norme consuete dei paesi civili. La nostra sicurezza era seriamente rrùnacciata; trattavasi della salvezza della colonia. Il governo voleva mantenere tale sicurezza: io mi ero assunto la responsabilità di farlo e agii unicamente in questo senso.
Lo assolsero. Gli esperti di colonie con meraviglioso candore non persero un grammo di ammirazione per lui e continuarono a chiamarlo «il generale» come se fosse l'unico in quella infilzata di ufficiali tutti croci e galloni. Non riuscì invece a schivare l'infuocata antipatia della sinistra nei suoi confronti, che sarà appannata solo dall'imbattibile concorrenza di Bava Beccaris, l'assassino di Milano. Nel coro di strilli si distingueva Turati; lo chiamava per esempio «quel cane di Baldissera» accusandolo di aver portato in Africa «orrori e nefandezze»; come se quelle non fossero già U, ben presenti e vive da ere immemorabili.
Il suo tempo sotto i riflettori era inesorabilmente scaduto. A Roma era salito finalmente al potere un uomo, Francesco Crispi, che ai generali non voleva certo lasciare le redini così sciolte; era convintissimo che nessuno meglio di lui sapeva far la guerra visto che aveva tenuto a balia un praticante come Garibaldi. Affiorava forse per la prima volta qualche viscerale pregiudizio tra politici e militari. Fino a un minuto prima andavano così bene a braccetto con la puntigliosa attenzione alle reciproche competenze e il tacito accordo di non pestarsi i piedi. Adesso, in mezzo al rombo delle lodi, si avvertiva tendendo l'orecchio il ronzio della critica. La tattica fatta di audacie e di astuzie non piaceva ai governi della sinistra che si erano fatti tentare dalle sirene di Menelik: lo avevamo fatto diventare da oscuro ras di periferia negus d'Etiopia offrendogli cartucce, fucili e milioni; sicuri che ci avrebbe regalato per riconoscenza quello che era così per noi faticoso conquistare.
Era il contrario della politica di Baldissera, che invece voleva alimentare il caos nell'immenso impero, appoggiare qualcuno solo fino a quando non diventava troppo potente, essere indispensabile a tutti e non a uno solo. Se ne andò sbattendo la porta e con il viatico che non si negava a nessuno di un commenda dei Savoia. Tornò in Italia ad amministrare la noia di reggimenti di provincia. La motivazione ufficiale era una diplomatica «malattia agli occhi». Quella vera il trattato con cui regalammo a Menelik quattro milioni per comprare le cartucce e i cannoni con cui ci massacrò poi ad Adua; in cambio di

una promessa di protettorato che fu una beffa ben giocata dal negus ai nostri diplomatici malaccorti e creduloni.
In Africa era arrivata l'ora di Sua Eccellenza Oreste Baratieri! Era convintissimo, arpionando con il piede la soglia del Palazzo di Massaua, che la Storia lo avrebbe proclamato con parole da incidersi nel granito. La carica di governatore gli s pettava si può dire come una compensazione p e r un incarico ben più prestigioso. L'aveva solo s fiorato per quelle che si potrebbero definire ragio ni di alta politica. Infatti stava per diventare addirittura ministro degli Esteri. Alla poltrona si era avvicinato con anni di accorta propaganda di se stesso e delle proprie qualità di analista p olitico e militare. Non c'era salotto in cui non comparisse la sua felpata pinguedine, il grasso aveva già inghiottito i lineamenti un tempo severi. L'a vevano con rammarico boccia to come minis tro: era nato n ei domini austriaci e un irredento era l'ultima pers ona a cui il nostro alleato nella Triplice voleva stringer la mano .
Che s ciagura: fu preso p er quel che pretendeva di essere. Il primo provv edimento che adottò appena sbarcato in colonia fu di imporre il «Sua Eccellenza» nella corrispondenza ufficiale. Il predecessore Gandolfi se ne andò senza salutarlo, tanto lo disprezzava; dove va esser così la corte di Atreo . Baratieri, che conosceva Cris pi fin da quando entrambi erano vestiti di una sdrucita camicia rossa, sapeva perfe ttamente cosa voleva il suo capo a Roma: vittorie. Accontentiamolo! Il presidente d e l Consiglio era affaccendatissimo a reprimere rivolte; di più : quasi rivoluzioni in Sicilia e in Lunigiana; le plebi erano impermalite pe r tasse e balzelli e si ostinavano a non farsi condurre verso quella grandeur che a lui sembrava così indis pensabile e a portata di mano . I g enerali lo assis tevano, per tener l'ordine non bastavano gli s birri. Arrivò un telegramma che annunciava la presa di Cassala e la sconfitta dei dervisci, noti fanatici sudanesi, primi a voler tagliare con un colpo netto la testa dell'arrogante Occidente. A Roma si fes teggiò con luminarie e proclami; poi ci si chinò s ulla carta geografica a cercare dove fosse questa Cassala: la trovarono con fatica, era un posto talmente periferico rispetto alla nostra colonia che ci costringeva ad allungare pericolosamente le linee e a ingoiare altri milioni . Strepitò la sinistra estrema, che era davvero incontentabile: «Una creazione megalomane pagata col sangue dei nostri giovani e valorosi soldati e con le decine di milioni di cui si sente bisogno negli uffici del palazzo delle Finanze».
Nessuno ebbe cuore di ricordare che dervisci e seguaci del Madhi, peraltro defunto, erano lontani parenti di quelli che avevano mozza-
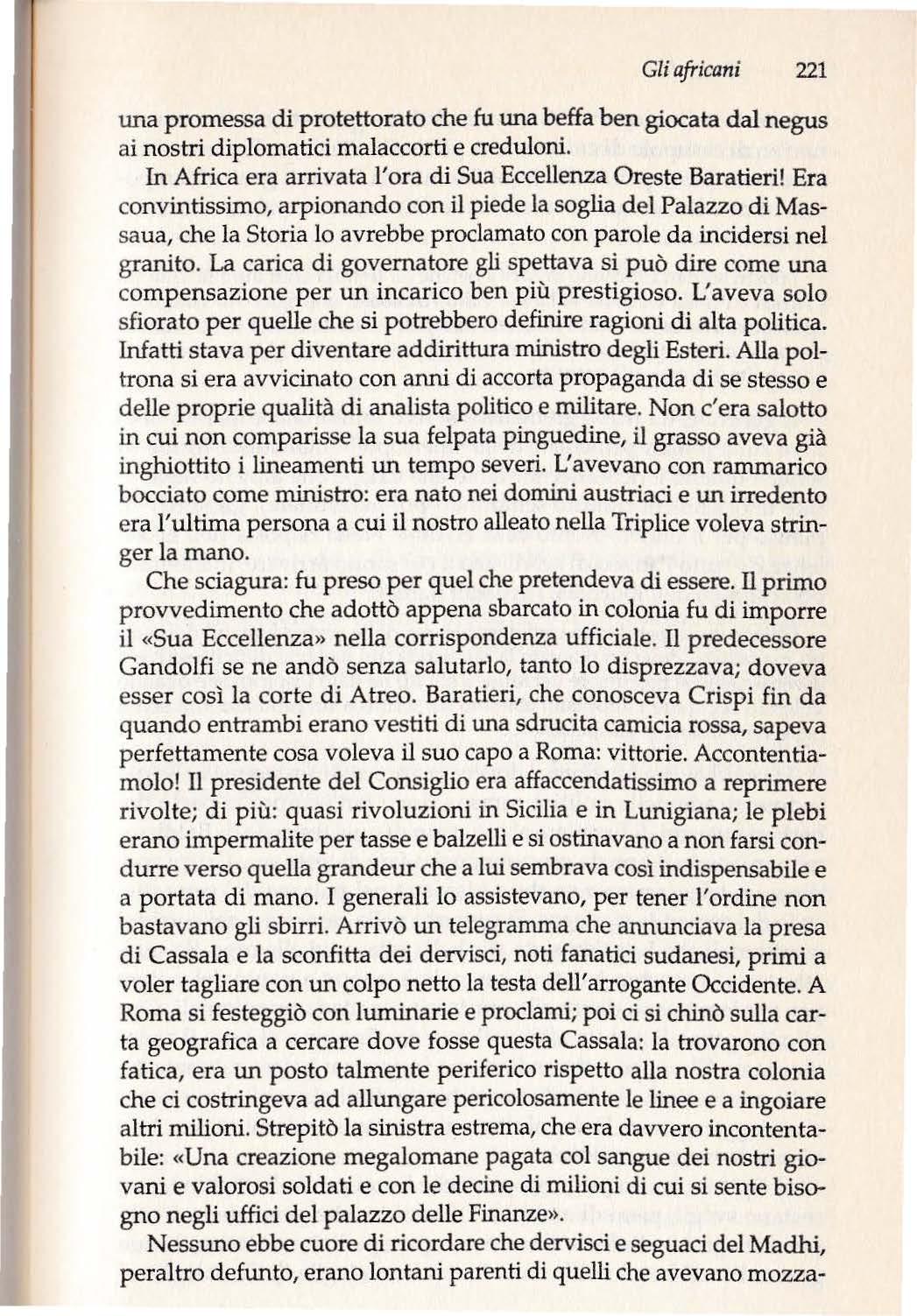
to la testa a Gordon Pascià e che la città conquistata era il consueto mazzo di casupole d i cui avevamo già una collezione. Era una vittoria e tanto bastò per attribuire al Baratieri la fama di genio. Non potevi mica d e ludere uno come Alfredo Oriani, s trampala t o vate italico, che seriveva:

I nostri soldati ritornano in Africa perché da tremila anni dura la lo tta tra l'Africa e l'Italia e l'Italia vi ha già vinto Annibale, imprigionato Giugurta, sottomessi i totomei, vinti i saraceni, dissipati i barbareschi. I nostri soldati ritroveranno su quelle are ne le orme degli antichi padri. L'Africa destinata alla civiltà è votata alla sconfitta.
Il generale, da furbo giornalista, si fece immortalare mentre liberava sulla piazza principale della «metropoli » mahadista t orme di schiavi dolenti e riconoscenti. Tanto ch e Crispi, ch e almeno nelle tirate retoriche era rimasto sempre un po' mazziniano, g li spedì «il plau so per il nuovo trionfo della civil t à» . Nella risposta dell'Eccellenza c'è tutto l 'abisso di servilismo a cui sanno arrivare, manovrando i cannoni dell'ipocrisia, i generali ita liani:
Chiedo scusa per il tono confidenziale, ma dalle rovine fuman ti del campo mahadista, dove ho p iantato la mia tenda, mi sarebbe difficile scrivere diversamente al precursore dei Mille, a chi mi ha dato l'ispirazione quando volendo occupare l'altopi ano abissino ha scritto a un ministro (<mi sento nelle ven e il sangue garibaldino)) . .
Tra garibaldini funziona il dovere reciproco di sostenersi nelle paludose strade della politica romana dove fan sempre la par t e dei barbari invasori. E Baratieri, al contrario di quel testardo di Baldissera, non è certo il tipo da procurar guai o fare di test a sua. Crispi spedisce un telegramma e sa ch e a Massaua n el palazzo del se rrag lio, sede dei comandi, si esegue. Si sussurra nelle caserme e nei corridoi ministeriali che Baratieri si dà alla bella vita, anzi alle orge. Su questa storia la tenebra è fitta. Il generale è troppo amante del potere per perdere tempo dietro alle pur fascinose madame coloniali . Con g li altri generali non va affa tto d 'accordo . Con uno di loro, il rodomontesco G iuseppe Arimo ndi, s iamo in guerra: lettere calunnie insulti precisazioni disobbedienze richies te di dimissioni al minis tero che viaggiano ve rso Roma al ritmo di sventagliate di mitraglia. Ambiente da vvero procelloso!
Crispi no n fa una piega, g li piace che i s u oi generali litig hino, così res tano svegli, pieni d i ambi z ioni. Baratieri, che gen erale lo è solo per l'anagrafe e l'ufficio cassa e non per qualità e dottrina, la sua guerra l'avrebbe g ià bell'e finita lì, con le m edaglie di Cassala. È ve-
nuto in Italia proprio per assaporare il dolce sapore della vittoria e della notorietà: banchetti, folle strabocchevoli che bloccano il suo treno alle stazioni, il re che lo abbraccia, il Parlamento in cui è naturalmente deputato che si alza in piedi al suo ingresso. Persino l'Aiace della sinistra estrema, il fustigatore implacabile di ministri e generali, Felice Cavallotti, gli stringe la mano. Crispi, ch e sull'Africa ormai punta tutte le sue senili rivincite di statista bronzeo ma frustrato dalla miseria della materia che è costretto a plasmare, gongola. Una sbonùa di meeting banchetti serate di gala, una tournée che gli fa attraversare a l galoppo tutta Italia; è una stella, può chiedere ciò che vuole, l'avrebbe. Di Menelik, il subdolo sovrano appollaiato sulle sue ambe inospitali, si è completamente dimenticato.
La scomoda realtà non è certo nascosta dietro tortuose congiure: basta leggere i giornali . Le corrispondenze dalla colonia, al contrario delle immancabili veline distribuite dal ministero che parlano di un Menelik moribondo e di un impero atterrito di fronte alla potenza italica, sono informatissime. Il negus sta raccogliendo schiere apocalittiche di soldati, un esercito immenso si muove come un leviatano v erso l a nostra fragile colonia. Il cannone già scuote l'aria. Per esempio Edoardo Scarfoglio, che ha raccontato la colonia in documentati e poco graditi reportage, scrive sul «Mattino»:

Menelik si prepara alla guerra da poco meno di un anno e noi non sappiamo ancora precisamente quanti cannoni, quanti fucili e quante lance abbia raccoIto ai nostri danni.
Eppure sul posto un generale di riserva c'è e per di più titolatissimo: Giuseppe Arimondi, un tipo tutto scatto brio spavalderia e slancio che la truppa adora. Offensivista convinto, grazie a un paio di battagliole contro dervisci ed etiopi non poco strombazzate, ha ottenuto gradi medaglie e una fama di attaccabrighe che copre l'ignoranza strategica e la pericolosissima tendenza a strafare. Inevitabile che i due si detestino, anzi la rivalità di mestiere, come succede sempre tra i nostri primi attori, si è trasformata in odio. Arimondi cerca di annientare il governatore con i suoi stessi mezzi, conducendo cioè campagna di denigrazione sui giornali. Sulla «Stampa » escono trafil e tti a l cianuro sul comandante in capo che lo accusano esplicitamente di codardia e incapacità, oltre che di abitudini sessuali sconvenienti. La malafemmina rientra sempre benissimo nell'identikit dello scioperato. Sono inezie di cui potrebbe con gusto occuparsi una corte marziale se non funzionasse la censura che i militari impongono su quelli che considerano affari interni della l oro casta.
Non basta; tutti gli ufficiali che arrivano in colonia devono subire dall'inferocito Arimondi un corso accelerato di denigrazione del governatore. Circoli e caserme a Massaua sono tutto un chiacchiericcio impastato di insulti, veleni, aneddoti veri o falsi, insinuazioni. La stampa ripre nde e moltiplica con gioioso furore le lettere di delazione: sono il suo cibo quotidiano, tanto che a un certo punto il governatore ne vieta la distribuzione in colonia.
Non siamo riusciti a capire il motivo per cui Baratieri non chiese a Crispi di liberarlo di quel concorrente molesto, magari con la tartufesca accortezza di una promozione e di una medaglia in più. Escludiamo che fosse, come scrisse il futuro maresciallo d'Italia Enrico Caviglia che prestò servizio da giovane ufficiale al loro fianco, perché «era di buon cuore». Forse considerava meschino l ' indispensabile accorgimento o era consapevole che, anche con un altro meno pestifero di Arimondi, l ' ostilità e il pregiudizio dei militari di carriera e di scuola pie montese nei suoi confronti non sarebbero mai venuti meno.

Con in gola il boccone dell' ultimo trionfale banchetto, il governatore dovette partire in gran fretta per la colonia dove Arimondi proclamava, con feroce soddisfazione immaginiamo, che tutto stava precipitando. Non c'era in Italia un solo pess imista inguaribile che avesse dubbi sugli inevitabili trionfi che attendevano il governatore. Ci correggiamo: c'era Filippo Turati, leader di una sinistra già allora risolutamente pacifista che per demolire la cricca reazionari a al pote re con sollecitudine leninista si augurava in Africa «una batosta sintetica e risolutiva». Tifava insomma per Menelik da cui, pensate un po', si aspettava la scintilla che incendiasse le intorpidite masse pro letarie italiche . Le masse italiche nelle persone dei soldati di rinforzo che Baratieri si portava dietro invece non vedevano l'ora di suonargliele, a quel buffo Menelik e alla mitica regina Taitù; e cantavano: «o Menelicche ! Le palle sono di piombo e non pasticche.. .».
RisaJendo i sentieri di Abissinia non ancora trasformati in strade (mancavano i soldi), il governatore avrà rimuginato su un altro dei suoi errori: per non disturbare il suo capo romano alle prese con i bilanci aveva accettato di ridimensionare le richieste di rinforzi . Il negus lo poteva battere benissimo con quello che aveva, in colonia tutto andava alla perfezione . Per la miseria di tre, quattro milioni andammo incontro alla catastrofe di Adua.
Di fronte a una guerra complicata come quella che si annuncia con il gigantesco esercito del negus, centomila uomini contro sedicimila e p er di più raccog liticci e a disagio in quelle latitudini, Baratie-
ri si rivela per quello che è: un incapace, un dilettante di strategia, assillato dalla paura di commettere errori e di fare un passo falso. Gli hanno messo attorno altri quattro generali, una enormità, e lui si sente sgradevolmente sotto esame. Nelle schermaglie sfortunate che precedono l 'alba fatale d e l 1° marzo ad Adua quella tensione lo fa ammalare, deperisce, ingiallisce, è travolto dal pessimismo e dall' umor malinconico. Sono sparite le pose napoleoniche che piacevano tanto. Se ne accorge perfino Crispi che dapprima ha pensato di guidar la guerra con i telegrammi sottoponendolo a una doccia s cozzese di o rdini di prudenza seguiti da p erentori inviti a osare. «Cod esta è una tisi militare» gli scrive a un certo punto con stile già mussoliniano, «non una guerra. Piccole scaramucce nelle qua li ci troviamo s empre inferiori di numero dinanzi al nemico, sciupio di eroismo s enza successo.» È uno sproposito che ci mette sullo stomaco dell ' altra indignazione. I telegrammi vengono dis tribuiti ai giornali per dimostra re che il governo sa cosa vuole e danno g li ultimi scossoni alla già traballante fama dell'invincibile Scipione. Una meteora salita così rapidamente a llo zenit non poteva non precipitare in fiamme . Alla fine Crispi, che comincia a sentire o dor di bruciato, decide di getta re a m are la zavorra di quel su o ossequiente servitore. Si è convint o che in Africa, per raddrizzare g li eventi, ci vuole un general e fatto di acciaio e si è rassegnato a passar sopra anche alle sue impuntature e a l ca ratteraccio: Baldissera.
Ma per concretizzare una decisione gi usta si sceglie il modo sbagliato: quello impiegat o da Rattazzi con Persano che già ci è costato il disastro di Lissa. Si avve rte con parole minacciose Baratieri che se continue rà nella s u a inerzia verrà licenziato. Poi, con una procedura da opera buffa, si fa p a rtire Baldissera, tra ves tito, con falso passaporto su una n ave ing lese. Si pensa ch e il nuovo gen erale piomberà a Massaua com e un «happy erid » e dopo a ver mostrato le credenziali al s uo predecessore procederà a d are una d e finitiv a lezione a quel fastidiosissimo negu s . Come all'opera insomma, dove però il n ernico s ta sempre dietro le quinte e al m assimo s i fa sentire con una melod ia di tamburi.
Baratieri, impie trito dalla prospe ttiva di chiudere così ing loriosamente una carriera, sceglie sciaguratamente di sostituire la tragedia a lla farsa e s i getta alla ricerca di un walha lla africano contro il n e mico, come si dice, «soverchiante». Al calore della battaglia il suo esercito s i fu se come cera . Adua fu una sconfitta talmente colossale, così imprezios ita da errori, inefficienze e incapacità, da ris ulta re, n o nos tante l' affannarsi di d ocumentati analisti, ancora oscura . Senza di-
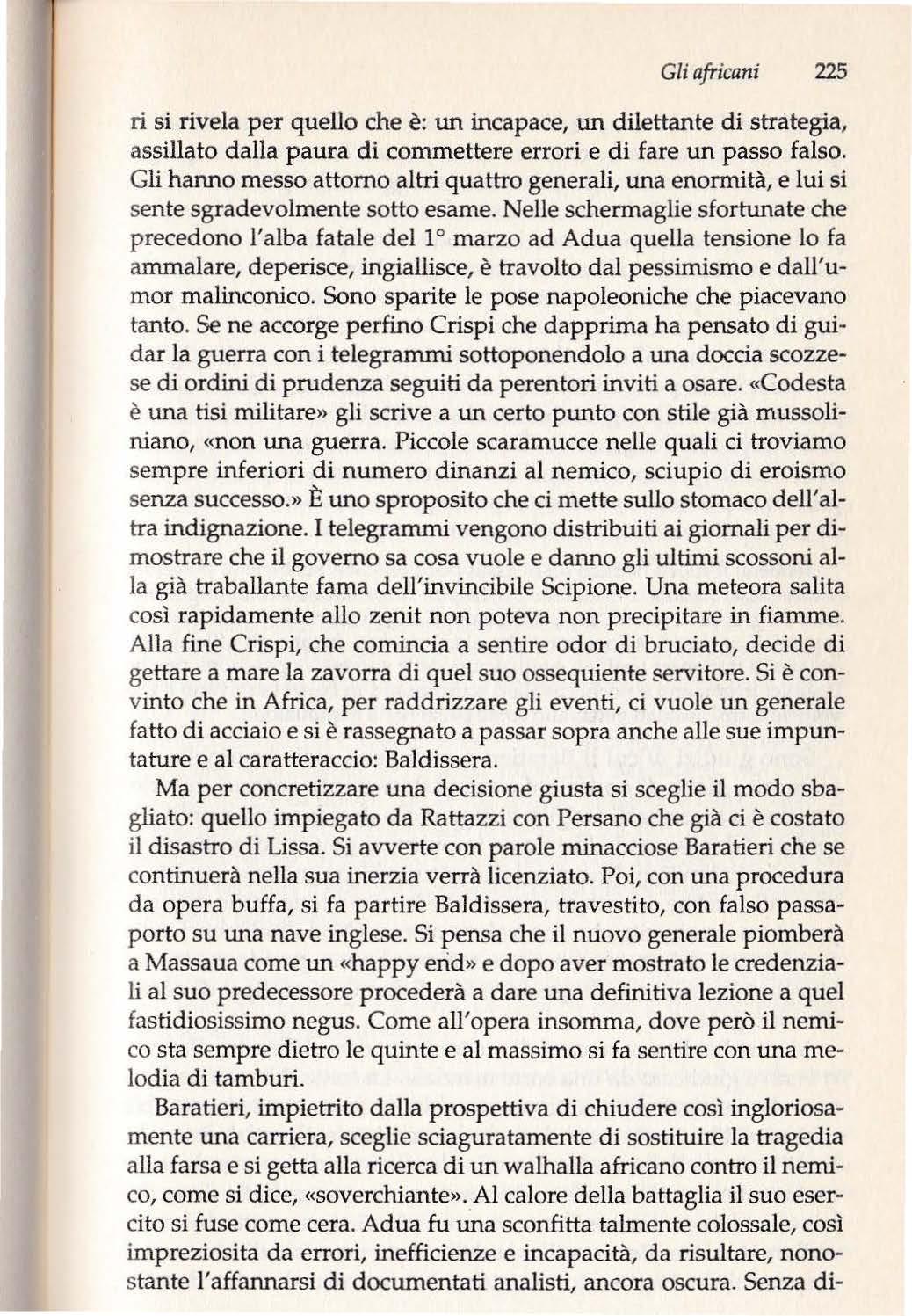
menticare che per compilare una versione ufficiale di meno di ventiquattr'ore di cannonate ci sono voluti quarant' anni, per una spiegazione che non va oltre un prudente omaggio ai luoghi comuni na· zionali, che «alla fede non corrispondevano i mezzL E fede e valori prodigati generosamente non bastarono a compensare». Una verità molto rimpicciolita; restavano da spiegare le ragioni di quello che, dimostrando poco sangue freddo il vicegovernatore, generale pure lui, nel primo sintetico rapporto definl «immane disastro».

Baratieri, che dalla mischia riemerse vivo al contrario di migliaia di suoi soldati, p e r giustificarsi scelse un'a ltra strada. Quella di imputare proprio alla vigliaccheria dei suoi fanti una catastrofe firmata dall' incapacità d e l generale. È proprio vero che la memoria è una delle attività più creative dell'uomo! Lui, che era sempre stato rimproverato per essere prudente, spedì appena rientrato dietro le solide mura dei nostri forti un telegramma sciagurato:
Sebbene il fuoco nemico fosse assai poco efficace, sebbene le posizioni nostre fossero buone e dominanti, le truppe si lasciarono subito impressionare da gruppi di nemici che profittando di angoli morti s i riunivano e cercavano di aggirarci. Allora non valse alcun ritegno. Invano g li ufficiali cercavano di trattenere i soldati su qualcuna deUe s uccessive posizioni, perché i nemici irrompenti e pochi cavalieri scorrazzanti in basso bastavano a travolgere tutto. I soldati gettavano come pazzi fucili e munizioni ...
Sono giudizi di cui il Baratieri non si pentì mai . Anzi nelle sue memorie, piene di omissioni e scandalosamente autoassolutorie, continuò a lavorare di artigli e di inganno, a dare la caccia a p olitici e soldati. Adua, secondo lui, era da imputare ai governi che gli avevano les inato i milioni (ma con il suo entusiastico consenso perché altrimenti avrebbe dovuto confessare che le sue vittorie erano di cartapesta) e a un esercito che non valeva nie nte: «Non illudiamoci sulla costituzione del nostro esercito e teniamo conto, grande conto, del bisogno che abbiamo di quadri saldi, di ferma disciplina, di consistenza organica».
Mentre Baldissera cercava di mettere rappezzi al disastro, Baratieri ve niva giudicato da una co rte marziale. La fretta di inchiodarlo ai suoi demeriti sarebbe stata e ncomiabile se fosse stata sincera. Ne u scì incredibilmente assolto, anche se umiliato sul piano personale. Era il debutto della nostra filosofia che impone di non condannare mai nessuno per le sconfitte, di considerarle sempre figlie di un destino crudele o di una somma di tante piccole incapacità che si annullano tra loro. Restò n e ll'a ula della corte marziale di Massaua il sospetto che in fondo ci fosse stato un ben articolato bara tto: Baratie-
ri tacque sugli errori dei suoi amki politici in cambio di un' impurùtà da cui si aspettava fo r se perfino una chance per la rivincita. Lui non ebbe la rivincita ma il s is te m a, direbbero gli antichi marxisti, res tò invece ben sald o. Scarfoglio commentò cosi la sentenza: «Il Bara tieri e ra w1 u omo impari a ll ' impresa, e ch e sa re bbe sta to ingius to condannare a morte o alla reclusione militare. È un genera le colpevole solo di inettitudine». Si resta stupefatti un secolo dopo di fronte a q u el «solo».
Era d estino ch e neppure Baldissera riuscisse a riconquis tare un .ritorno a casa con le fanfare . Eppure con p ugno di fe rro aveva dimostrato che si poteva ristabilire la s ituazio ne . Er a pur sem pre, a nche se con poche truppe umiliate, il «gen era le e mbesser», il gener a le leone. L'esercito del negus, esa us to per le p erdite, con il fiato cor to per le sue stesse dime n s ioni, non tentò neppure l' invasione d e lla colonia acconten tandosi di un successo che lo promuoveva tra le grandi potenze e m etteva definitivamente il bavaglio ai s uoi pericolosi oppos ito.ri interni. Baldissera libe rò il forte di Ad igrat assediato, evitando una replica degli ambigui eroismi di Macallè.
A Roma spirava p erò un'altra aria. L'Africa portava male, meglio disfarsene. Così comprammo con ve nti milioni cli lire la pa ce dal negus, sui vecchi confini d ella colo nia precedenti la battag lia . Ci ritiran11110 p e rfino d a Cassala, dove n essuno s i sognava di venirci a dis turbare, regalandol a ag li inglesi stupefatti. Baldissera, che cercava di manovra re d i nuovo con le su e truppe indigene a basso costo, rivisse giorni amari. Prevalevano le trame cli un altro diplo m a tico a utoproclamatosi africanista, Cesare Nerazzini, che fece credere che pagare Menelik fosse una buona soluzione p er evitare a ltre sciagure. Scriveva Baldissera:
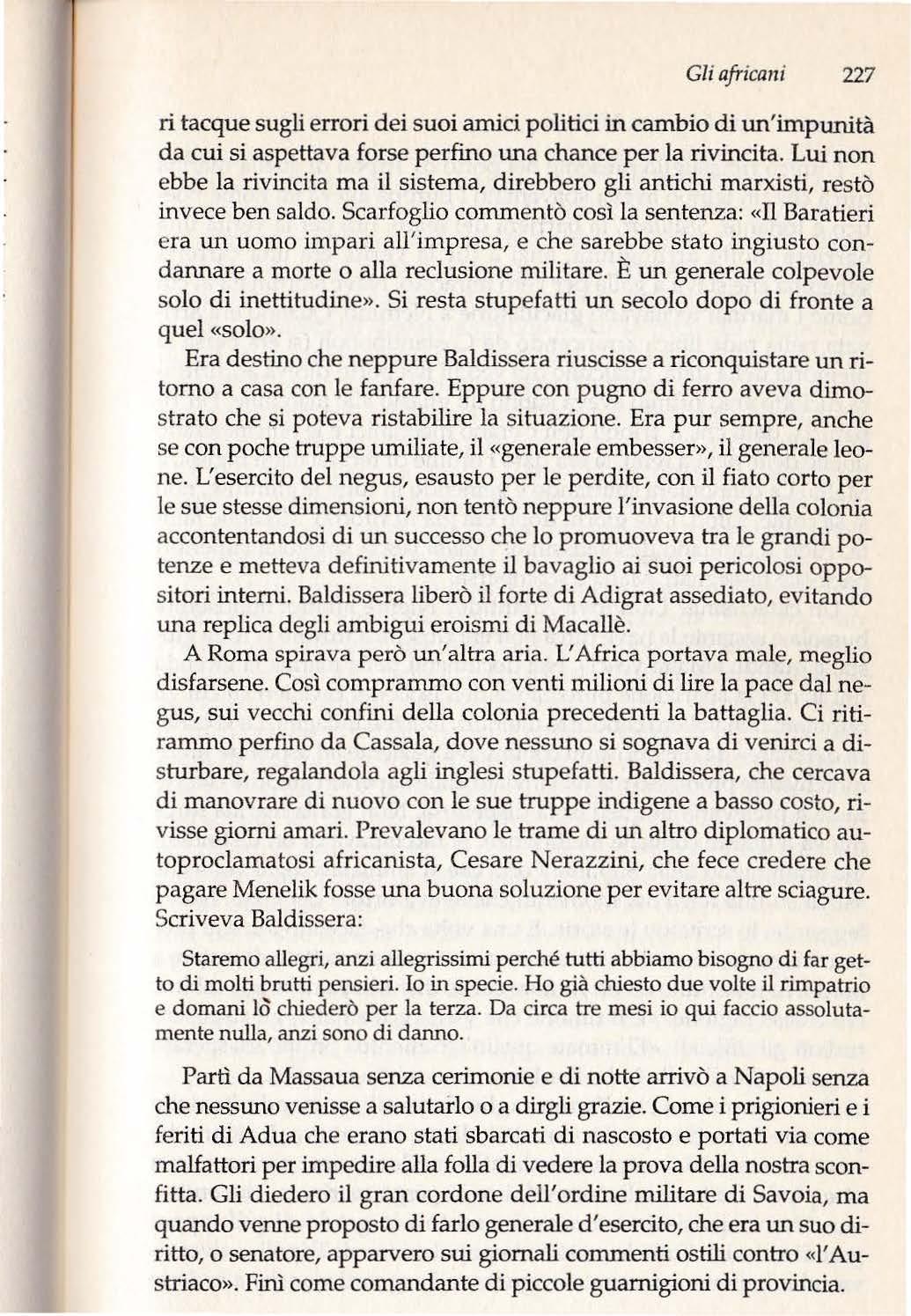
Staremo allegri, anzi allegrissimi perché tutti abbiamo bisogno di fa r getto di molti brutti pensieri . lo in specie. Ho già chiesto due volte il rimpatrio e domani Iò chiederò per la terza. Da circa tre mesi io qui faccio assolutamente nulla, anzi sono d i danno.
Parti da Massaua senza ce.rimonie e cli notte arrivò a Napoli senza che nessuno venisse a salutarlo o a dirgli grazie. Come i prigionieri e i fe riti di Adua ch e erano stati sbarcati di nascosto e portati via come malfatto.ci per impedire alla folla cli vedere la prova della nostra sconfitta. Gli djedero il g ran cordone dell 'ordine militare di Savoia , ma quando venne propos to cli farlo generale d'eserci to, che era un suo diritto, o senatore, apparvero sui giornali commenti ostili con tro «l ' Austriaco». Firù come comandante di piccole guarrugioni di provincia.
la guerra ricca del generale Cane-va

L'unico rimasuglio presente nel porto di Tripoli di quella marina turca che un tempo aveva spaventato l'Europa a veva un nome poetico e tonante: Sedulbar, la barriera del mare. Era per la verità una barriera molto arrugginita, anzi a dir la verità era una carretta sghemba che stava a galla per vero miracolo . Nave sfortunata al cui nome i marinai recitavano giaculatorie a Nettuno. Quando era arrivata nella rada libica arrancando da Costantinopoli (si era persa la memoria della data, qualcuno dei vecchi nel porto diceva addirittura diciotto anni prima) aveva subito un guasto alJe macchine. Per ripararla, dato che a Tripoli non c'erano meccanici e le officine erano quelJe delJe na v i a remi, si era dato l'ordine di recarsi dagli inglesi, a Malta. La cannoniera sbuffando e gemendo in tutte le giunture, non si sa come, salpò. Due giorni dopo era già di ritorno. Missione fallita, riferì il capitano desolatissimo: «Malta yosc!» spiegò ai superiori paciosi e rassegnati, Malta è scomparsa. Un cataclisma? La nuova Atlantide? Niente affatto: nonosta nte bussola e sestante la nave turca non era riuscita a trovare la rotta gius ta, e quindi: «Malta yosc!». Nei documenti delJa marina la vicenda fuù lì, con la s parizione burocratica dell'isola dei cavalieri su cui gli ottomani non vollero condurre ulteriori, faticose indagini . La «barriera del mare» da diciotto anni continuava paziente ad aspettare un rimorchiatore promesso ma mai inviato dalJe superiori autorità che venisse a prelevarla in quell'isola dispettosa. Non era la marina turca nuova a queste comiche inefficienze. Si raccontava di un distintissimo ammiraglio delJa Sublime Porta che si ammalava ogni volta eh.e saliva su una nave dal momento che aveva orrore del mare. Non è leggenda, lo scrivono le storie. E una volta che, facendo forza al proprio disgusto, con eroica determinazione aveva accettato di restare a bordo, fu infastidito da un rumore che lo disturbava nelJa sua cabina. Ne chiese ragione: «È il timone che viene governato» gli risposero turbati gli ufficiali. «Eliminate quelJo strumento» ordinò esasperato l'ammiraglio. Il bello è che l'ordine venne subito eseguito.
Erano problemi che l'ammiraglio Faravelli, comandante delJa possente Seconda squadra navale italiana, non aveva di sicuro. Le navi che comandava erano rombanti e modernissime corazzate con «tre pipe», tre fumaioli, come si dice in gergo marinaro, che eruttavano fumo densissimo e usavano motori in grado di sviluppare grandi velocità. Tutte le mattine la popolazione di Tripoli si riversava sul lungomare ammirata e aguzzava lo sguardo: anche a vederle
da lontano facevano davvero paura, i profili giganteschi e i cannoni delle torrette corazzate che alzavano le dita mostruose verso il cielo. La flotta scivolava avanti e indietro come se il suo compito fosse di ara re il mare con grandi unghiate: Garibaldi, Varese, Ferrucci, Coatit a cui si erano aggiunte Carlo Alberto, Sardegna, Sicilia, Umberto, Benedetto Brin su cui si alzava la bandiera dell'ammiraglio. Erano cattedrali di acciaio appena sfornate dai cantieri, con cannoni da trecento millimetri capaci di sparare a grande distanza proiettili che potevano far stramazzare intere città. Accanto a quei giganti scivolavano ossequiosi i cacciatorpedinieri, veloci ed efficienti, che da soli sarebbero bastati per polverizza re la vecchia cannoniera della Mezzaluna. Signori, siamo una grande potenza. Sono gli anni in cui la forza di una nazione si misura a flotte, i Grandi si rincorrono a colpi di corazzate, la potenza è n e lle colate delle acciaierie. Basta con il genio italico del ripiego, nelle navi da guerra avevamo messo tutta la nostra voglia di rivincita e la fresca gloria di nazione industriale. C'è da commuoversi di quell'entusiasmo: tutti i bambini della buona borghesia andavano vestiti con il costume da marinaio, e anche il piccolo Vittorio Emanuele, l'erede al trono, inteneriva i sudditi con la divisa bianca a righe azzurre e il basco con la scritta «Regia nave Duilio». Le signore passavano il tempo a cucire enormi bandieroni tricolori che dovevano garrire come insegne di battaglia sulle unità da guerra, e non c'era settimana in cui a Genova o a Napoli non si procedesse tra feste e discorsi al varo di qualche nuovo gioiello d'acciaio. Era una febbre, delle navi si faceva collezione. Insomma, se i ricordi di Adua non erano cancellati (non sarebbe stato possibile visto che e rano passati soltanto quindici anni) il paese era completamente cambiato. Alla marina toccava il gradito compito di compensare con le sue corazze lucide e i cannoni spropositati le miserie di quell'esercito che si era fatto battere, e in che modo, dai negri. Quella flotta e ra così impressionante che le autorità turche avevano diffuso con astuzia paesana tra le masse di Tripoli la voce che le navi erano inglesi o turche. La bugia aveva buone possibilità di essere creduta tanto era stravagante e inverosimile che un paese sgangherato come l'Italia, una nazione di poveracci scappati davanti alle orde del negus Menelik, potesse disporre di una simile potenza. Non avevano torto, ma per sfortuna dei turchi, nel nuovo tentativo coloniale, avevamo fatto scialo di mezzi e di determinazione. Su quella sperduta provincia che a Istanbul ricordavano solo per spedirvi i funzionari più incapaci a meditare sulle impazienze dei sultani e per controllare che beduini e pastori venissero tosati fino all'ultima pia-
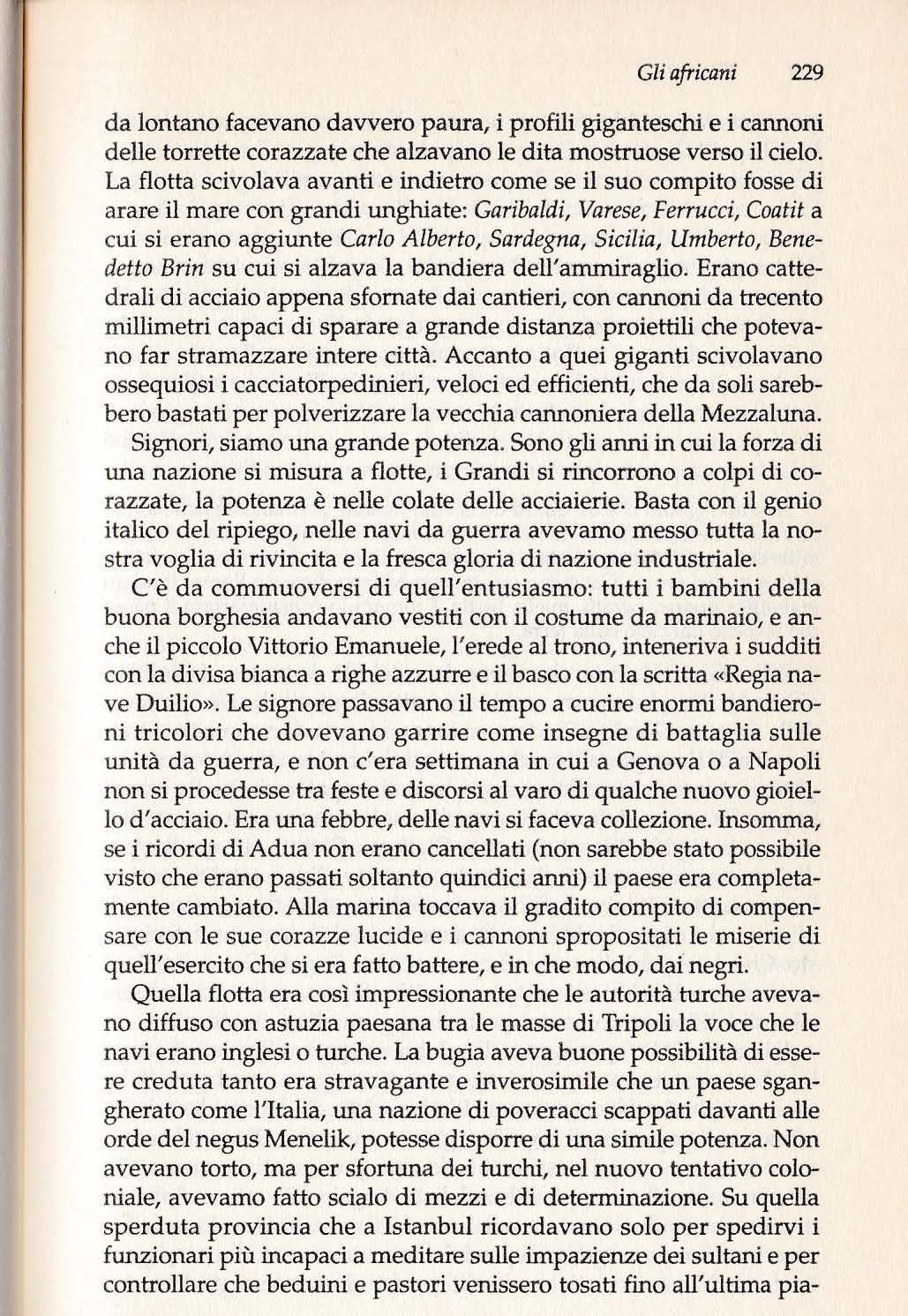
stra, si stava per abbattere un uragano. Volevamo strappargli la pelle, a Tripoli! Ci attirava l'odore insipido del sangue. Era il prototipo, per potenza e modernità, di quanto messo in piedi dagli Alleati per lo sbarco in Normandia nel 1944. Era il nostro «giorno più lungo» sontuoso, micidiale, senza scampo per il nemico. Lo sbarco in massa dai tempi di Agamennone è il vezzo dei conquistatori; c'eravamo anche noi, che per secoli avevamo ammirato gli sbarchi degli altri. Fu un acuto assordante, non lo ripetemmo mai più.
Le ragioni per cui la flotta incrociava impaziente nella rada e decine di migliaia di soldati stavano affardellando gli zaini e infilando in testa il casco coloniale in tutte le caserme italiane, secondo i giornali dell'epoca e i documenti dei politici, erano innumerevoli. Perché avessimo sopportato per tanto tempo senza agire, un mistero: Nessuno ignora che tre quarti della emigrazione permanente nelle lontane Americhe è composta da meridionali, mentre la Tripolitania estesa per mille chilometri di costa resta con qualche milione cli abitanti pressoché incolta a tredici o re da Catania quasi quanto Milano dista da Roma! Pindaro magnifica donne, cavalli, miele, frutta . I romani lo considerarono il paese più favorito dal cielo s ulla te rra.
Felice Giuffrida, uno che aveva dato del filo da torcere a Giolitti e ai carabinieri, dava voce con l 'ingenuità degli umili alle speranze della sinistra. Grazie a Pindaro e ai romani, non di conquista si trattava ma di riconquista. I turchi, a mazziniani ed eredi più o meno legittimi, stavano antipatici: corrotti, brutali, impalatori. Quello era un impero da tempo defunto, comunichiamolo a cannonate e procediamo con la civiltà. Più sobriamente Giovanni G iolitti, che quella spedizione aveva inventato, diceva che si andava lì per fa talità s torica. E tanto basta. Si doveva dimostrare di poter stare degnamente nell'Europa dei signori; abbiamo finalmente titoli e cannoni, fateci posto . Che il bel suol d 'amore su cui esercitava l' ugola Gea della Garisenda fosse di sabbia lo sapevano tutti e facevano finta di credere alle odi di Pindaro come se fossero il rapporto di un economista. E i generali? Be', pe r i generali la Libia era pari all'Eritrea. Andava loro benissimo la favola che si stava per distruggere «quel covo di ladroni, ciò che farebbe rientrare nell'orbita della civiltà occidentale innumerevoli popolazioni oppresse: greci come serbi, albanesi, cretesi, macedoni, armeni, gli stessi arabi e le altre genti asiatiche vinte» . Sono parole, sentite un po', del socialista Angelo Olivetti, scolpite su una rivis ta r ivoluzionaria e rossa come «Pagine libere» . Le crociate piacciono sempre ai generali perché danno una mano alla propaganda. Si rischiava, avvertivano i soliti profeti di sventure, di dare uno
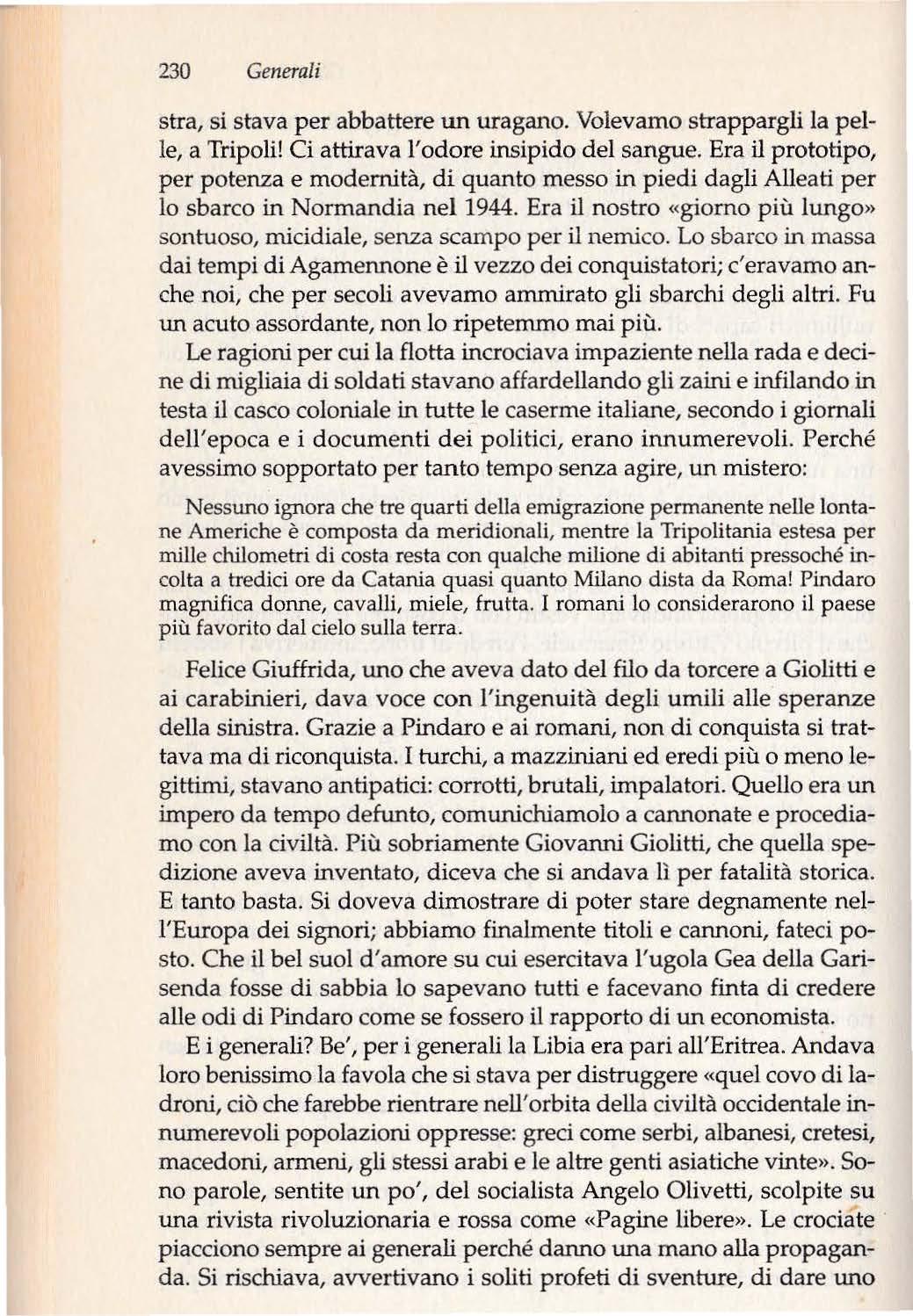
scossone a una costruzione tarlatissima provocando uno sconquasso politico che non si poteva controllare; poteva venir giù con i calcinacci la pace di tutta l'Europa, altro che Giugurta e Pindaro. Quello era affare per Giolitti. Se ne occupasse la volpe di Dronero. Loro non avevano tempo, affilavano le lame che avrebbero piattonato le schiene dei turchi in una rissa casalinga. Pronte le armi, i denari, i piani, mancavano i capi. C'era da stabilire chi avrebbe comandato le muscolose esibizioni in quel mare della Sirte dove «le Sirene chiamavano i naviganti con la voce armoniosa» come scriveva il dotto deputato De Marinis. Due alla fine erano rimasti in lizza: Carlo Caneva e Luigi Cadoma. Erano loro ad avere i titoli e la carriera necessaria. E infatti avevano comandato i due schieramenti, il rosso e l' azzurro, alle ultime grandi manovre svoltesi due mesi prima tra le vigne del Monferrato. L' aveva spuntata Caneva con le a rmate «rosse». Gli azzurri le avevano, come si diceva in gergo, «prese)), e sonore. Le evoluzioni del Cadoma, che peraltro aveva un caratteraccio ed era considerato sussiegoso e intrattabile, erano state seppellite sotto critiche feroci anche sui giornali. Lui disse ispirate dai suoi nemici allo stato maggiore, ne aveva a legioni. Era la grande occasione di Caneva. I superstiziosi traevano fausti auspici dalla sua biografia; era infatti il contrario del garibaldino Bara tieri (al risuonare di quel nome nei saloni degli alti comandi si facevano platealmente ancora gli scongiuri). Era nato a Udine sotto l'impero austriaco ma senza trame particolari furori contro il destino e aveva partecipato alle campagne d'Africa un anno dopo Adua per mettere insieme i cocci . Baffi che sembravano sempre sul punto di diventare baffoni, mass iccio, una di quelle facce che sembra abbiano calcato il berretto militare sin dall'infanzia e che in borghese non riconosceresti. Era soprannominato tra i colleghi, come sempre ferocissimi con chi aveva fortuna, «il Baldissera al frigidario » per la s ua freddezza che assomigliava secondo molti ad assenza di vivaci tà e di stile. Frigidario o meno, l'importante, pensarono i politici, e ra la riconosciuta somiglianza con Baldissera, visto che l'unico gen e rale nostro che in Africa aveva rimediato successi era stato proprio «l'Austriaco» . Qui ci voleva appunto uno che arrischiasse tutto il suo denaro in una puntata sola, affidandola al rosso o al nero. La p osta era grossa.
Il Baldissera al frigidario doveva comunque mettersi in coda. La prima parte della guerra era tutta della marina e delle sue freschissime glorie indus triali. Scordate le bestialità di Persano si aspettava s o lo un degno avversario per dimostrare che stavolta non eran di

ferro solo le navi ma anche gli uomini. Anche Canovetti doveva dar prova di pazienza. La dichiarazione di guerra all'impero turco era del 28 settembre, motivazione ufficiale la situazione di grave rischio per la comunità e gli affari italiani dovuta all'imperizia del governo ottomano. Una scusa, lo sapevano tutti, anche le grandi potenze. Non fu un'aggressione e la proclamammo tale, doveva essere una scampagnata e la intorbidammo con un colpo di cannone. La flotta davanti a Tripoli era pronta a radere al suolo la città ma era in attesa dell'arrivo del mostruoso convoglio che trasportava ottantamila uomini, l'esercito di occupazione. Si limitava a scambiar messaggi con i turchi asserragliati nel castello e dietro fortificazioni di cartone con cannoni che a parte qualche Krupp, erano vecchi di secoli. A scambiare due chiacchiere con Betir, il bey che ricopriva la carica di deftardar, custode del tesoro di Tripoli, l' ammiraglio aveva spedito il suo capo di stato maggiore, Thaon di Revel; portava in tasca una richiesta di resa e la minaccia di sbriciolare la città con i suoi cannoni. Vero modello del funzionario turco indolente e astuto, il bey aveva risposto con molta gentilezza: «L'Italia è grande e forte, la potenza della sua flotta evidente». Ma poiché non aveva istruzioni del suo governo, il cavo telegrafico con Istanbul era stato tagliato, doveva consultarsi con i superiori prima di decidere. Quindi chiedeva tempo con cortese sollecitudine. Canovetti cominciava a innervosirsi e a sentir aria di beffa. Già aveva dovuto subire un terribile rabbuffo per la beffa del Derna. Nella notte del 27 settembre, infatti, la corazzata Roma che incrociava davanti a Tripoli in agguato, aveva avvistato un piroscafo che viaggiava a fari spenti a tutta forza verso la città. Il ministero della Marina aveva segnalato che navi corsare turche erano salpate nei giorni precedenti con carichi di armi dirette verso la Libia. Bisognava prestar attenzione soprattutto a un certo vapore, il Derna, che si sapeva stracarico e pilotato da un capitano astutissimo. La corazzata accos tò fino a sovrastare il mercantile; poi l' intimazione di Alt! mentre i riflettori di bordo frugavano impudicamente tra le lamiere sospette. Comparvero allora una bandiera tedesca e due marinai che, parlando la lingua di Goethe, declinarono il nome Tormak. Il capitano Giovanni Lovatelli che comandava la corazzata doveva essere un buon marinaio ma poco esperto delle astuzie a cui troppo spesso gli uomini si abbassano. Come le bugie per esempio. Lasciò partire l'imbarcazione con tante scuse e senza fare altre indagini. Pochi giorni dopo il console italiano segnalò che il Derna, ammainata la bandiera tedesca e cancellato il nome Tormak, stava scaricando
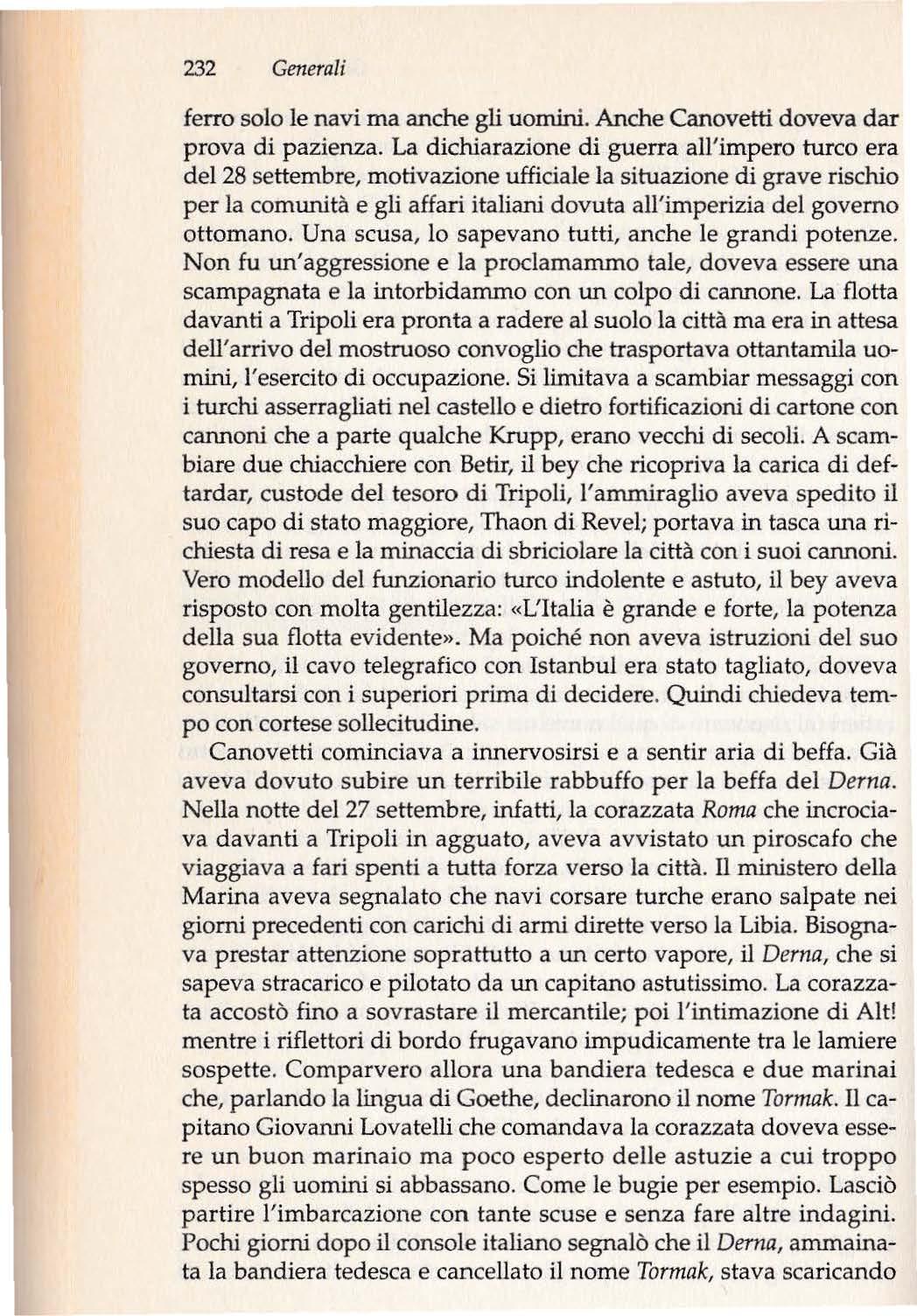
casse e casse di fucili Mauser nuovissimi e quintali di munizioni. Un bel colpo, molto garibaldino, che i turchi avevano messo a segno e che ci bruciava doppiamente: quella era la guerra a cui eravamo abituati noi!
La possente flotta incrociava ormai da sei giorni davanti a Tripoli, «i giorni di aspettazione» come li chiamavano i giornalisti sempre più esasperati a cui sembravano davvero troppi. Qui si perdeva la faccia! Così la marina decise di fare un brutto scherzo ai colleghi dell'esercito. Dopo un'ultima generosa proroga, l'ammiraglio ordinò di procedere al bombardamento. Le fortificazioni avevano nomi suggestivi: «Sultania», «Del molo»; ma a parte i temuti cannoni Krupp non potevano dare problemi. Alle tre suonò il segnale di «pronti al combattimento»; con emozione religiosa gli ammiragli avevano estratto, dalle cassette dove venivano conservate, le bandiere di combattimento. Grande lavoro degli addetti ai telemetri, cigolare di artiglierie che nelle torrette corazzate cercano implacabili il loro bersaglio. Dopo mezz'ora di comodi preparativi la prima bordata della Benedetto Brin diede il segnale che l'inedita guerra italoturca era cominciata. La salva scagliata da novemila metri cadde corta, in mare, sollevando una montagna d ' acqua. Poi un'apocalisse di fuoco si abbatté sempre più precisa sui forti, striati da fumate pesanti, inghiottiti da una tempesta di polvere. Le navi con placida sollecitudine si avvicendavano per cambiar murata e tirare con maggior comodo. Fino a sera, quando il fuoco dei turchi, all'inizio vivace anche se impreciso, taceva da ore. Delle mura restava ormai solo uno scempio di rovine e anche il vecchio faro aveva pagato, purtroppo per lui, il prezzo di quell'inutile resistenza. Il mattino del giorno successivo, con ferocia da secoli bui, venne completata l'opera giustiziando anche gli ultimi muri sopravvissuti. Il porto era dopo quel fracasso wagneriano tutto un silenzio. Si decise un'azione di commando. Su una lancia salì agilmente insieme a un manipolo di animosi un fegataccio, il capitano Pietro Verri, veterano d'Africa e della spedizione contro i Boxer in Cina. Tripoli la conosceva bene perché venti giorni prima vi era sbarcato travestito da ispettore delle poste e aveva osservato, rilevato, spiato mettendo a profitto la perfetta conoscenza della lingua araba. La pattuglia sbarcò sul molo, si aggirò tra cannoni abbandonati, cortili devastati, palmizi infranti. C'erano pochi cadaveri, soldati «territoriali» che non avevano avuto l'astuzia di scappare in tempo. La guarnigione si era volatilizzata, i forti erano vuoti, si poteva sbarcare. Alle sei e trenta i marine di Faravelli, con la loro divisa bianca e azzurra, su

battelli e lance, misero gli s carponi sul bel suol d ' amore. All'inizio si mossero con circospezione tra le ridotte smantellate, nel forte di Gargamesh vuoto; al Sultania, d ove non c'era un'anima viva, due cannoni m oderniss imi e rano ancora in buone condizioni, il forte Rosso che da lontano sembrava inespugnabile era atterrato, qualche colpo arrivato lungo aveva scoperchiato le case che si appoggiavano alla costruzione. Dagli spalti la città, candida con i minare ti, la grande moschea dei Ramanti con i portici avvolti da un' ombra deliziosa, apparve ai marinai tranquillissima e piena di gente. Solo in lontananza una s paratoria intermittente lasciava intravede re minacce per ora inesplicabili e remote.
A mezzogiorno, con opportuna puntualità, sul forte Sultania venn e innalzata un' immensa bandiera ita liana . Le navi risp osero con ventuno colpi, gli ufficiali si abbracciar ono mentre saltavano i tap pi delle bottiglie di ch a mpagne tenute in serbo per l'occasione. Verri, che non riusciva pro prio a star fermo, fu il primo a lanciarsi dalle fortificazioni per que lla che era la sua specialità : un'altra a rdita ricognizione in città. Città che si e ra peraltro scrupolosamente preparata all'evento di finir n egli artigli di queg li infedeli . La passione p er noi fu come uno di que i fiori che sbocciano nel giro di una notte . Fin dal mattino le v ie erano in fermento per far sparire tutte le bandiere turche e pavesare strade e piazze con quelle italiane; una delegazione di notabili salì a bordo d e ll'ammiraglia dichiarando che era venuta a fare a tto di sottomission e. Sollecitava un'occupazione rapida della città: dove erano finiti i soldati del re d'Italia? E i turchi? Chiese a sua volta l'ammiraglio che n o n sapeva darsi ragione di quella fortun a. Spariti scomparsi fuggiti : dissero i bravi cittadini, verso Gargamesh e i margini di que lla immensa oasi che racchiudev a la città, forse pe rfino nel d eserto sulle orme d e lle carovane cariche di armi e munizioni che e r a no partite gi à n e i g iorni precedenti . Il sindaco Hassuma Kara manli, la nos tra quinta colonna, il n ostro collaborazionis ta di turno, aveva ormai preso il potere e invitava a fare pres to. A Faravelli quella ritira ta così precipitosa e tota le appariva un bel mistero. Intravedeva una strategia d ai contorni pericolosi. Ma a quel punto non ci si poteva tirar indie tro, bisognava procedere all'occupazione senza aspettare l'arrivo d e ll'esercito e d ei s uoi lentissimi convog li. Il capitano di vascello Umberto Cagni, cuore di acciaio, uno ch e era arrivato qua si al Polo No rd, fu incaricato di comandare la spedizione. Aveva con sé la miseria di millesettecento marinai. Decise di moltiplicarli con un'astuzia. Per due ore, divisi in piccoli gruppi, i m arinai fecero ginnastica per le vie di Tripoli do ve

la popolazione si spellava le mani per dimenticarsi il vecchio padrone. Le squadre si scambiavano le posizioni come in una pellicola accelera ta: da un forte all'altro, dai Marabutti a l porto, dalla caserma a lla dogana ai pozzi, su e giù sempre di corsa cantando. Passavano venti compagnie ed era sempre la stessa . Alcune dopo essersi nascoste dietro le rovine di un forte si reimbarca vano e mettevano piede a terra da un'altra parte dove erano ancora facce sconosciute. Era immenso questo esercito italiano, p ensavano i buoni libici. Fu un piano ardi to. E una sudata terribile nell'aria caliginosa per il calore. Cagni aveva avvertito i suoi : «Ci sarà da camminare», e quelli impavidi avevano rispos to: «Cammineremo». Quel trucco di passare e ripassare sempre n egli s tessi posti andò avanti per giorni e con grande s uccesso. Tutti si erano orrnai convinti che la città fosse gremita di armati. L'occupazione sembrava davvero un'allegra passeggiata, di turchi nemmeno l'ombra. Si era invece presentato l'a stuto Hassuma in alta uniforme da sindaco, con altri dodici notabili, per far atto di sottomissione. Sulla scalinata del palazzo del governo s i dichiarò lietissimo di veder sventolare finalmente la bandiera italiana.
Erano scesi dalle navi anche i giornalisti; poterono scalpellare in prosa la resa del deftardar che consegnò le chiavi del palazzo. Eravamo passati in poche ore dalla guerra a lla fes ta, la breve epopea declinava già verso pranzi e simposi. Cagni aveva emesso un decreto: prometteva due talle ri a chi consegnava il fucile prima di mezzanotte e la confisca gratui ta a chi se lo faceva trovare addosso o in casa. Sempre con il trucco di sistemare i marinai a rotazione lungo le strade, si era allestito anche lo sbarco del nuovo governatore provvis orio, il contrammiraglio Borea Ricci d'Olmo, tipo d ecorativo con una gran barba mosaica e una divisa che tintinnava p er le medaglie.
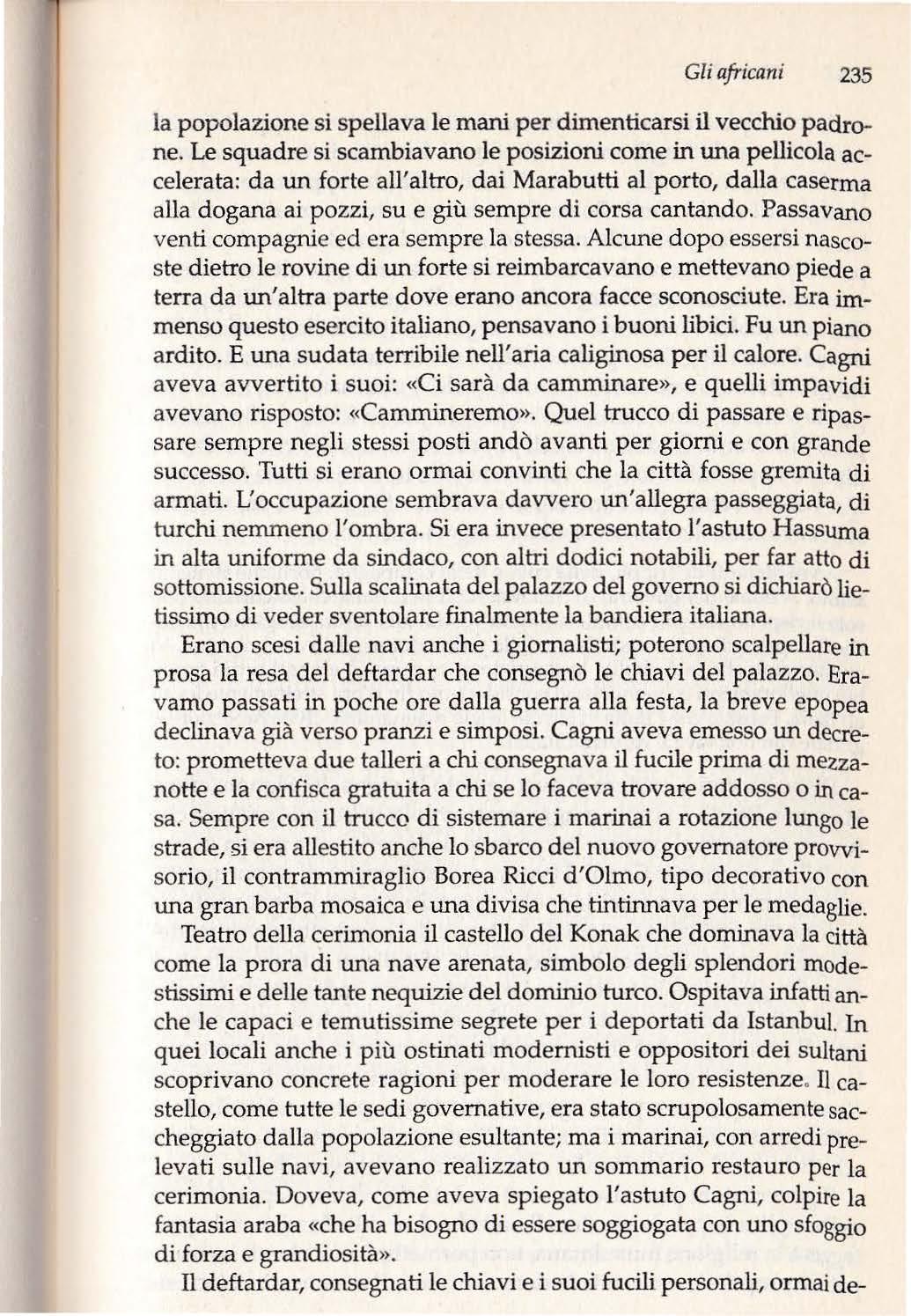
Teatro della cerimonia il castello del Konak che dominava la città come la prora di una nave arenata, simbolo degli splendori modestissimi e delle tante nequizie del dominio turco. Ospitava infatti anche le capaci e temutissime segrete per i deportati da Is tanb u l. In quei locali anche i più ostinati modernisti e oppositori dei sultani scoprivano con crete ragioni per m oderare le loro resistenze. li castello, come tutte le sedi governative, e ra sta to scrupolosa me nte saccheggiato dalla popolazione esultante; ma i marinai, con arredi prelevati sulle navi, avevano realizzato un sommario restauro per la cerimonia . Doveva, come aveva spiegato l 'astuto Cagni, colpire la fan tasia araba «che ha bisogno di essere soggioga ta con uno sfoggio di forza e grandiosità».
Il deftardar, consegnati le chiavi e i suoi fucili perso nali, ormai de-
nudato del potere, si era penosamente ritirato nei suoi appartamenti a meditare sulle fragili sorti degli imperi. I marinai avevano scovato per la cerimonia anche una vecchia carrozza che apparteneva a una famiglia di ricchi ebrei. Borea Ricci e ra un robusto marin aio d i Albe nga ch e aveva fatto all'inizio del secolo il giro del mo ndo, aveva partecipato al blocco d el Venezuela e a l salvata ggio d ei naufraghi russ i delle corazzate Variag e Koreetz nella guerra con il Giappo ne. Salì con qualche fati ca sul landau seguito, a piedi , dagli ufficiali in divisa bianca di gala e spadino. Cagni sovrin tendeva a cavalJo mentre gli ottoni riversavano la marcia reale. I marinai, presentate una prima volta le armi, correvano tagliando per i vicoli a schierarsi un poco più avanti. Onde fervid e di popolo sotto un cielo che sembrava dipinto a pplaudivano e poi tornavano alJe loro misteriose faccende. L'avveduto bando che Faravelli aveva fatto affiggere fin dal mattino solle vava come lievito irresistibile l' a nima della folla:
A voi abitanti di Tripoli, della città e della campagna, portiamo il nostro saluto. A no m e del governo di Sua Maestà il re d'Italia vi assicuriamo non solo il rispetto alla più completa libertà vostra, a lla vostra religione ma anche il rispetto di tutti i vostri beni, d elle vostre donne, dei vostri costumi. Vi annunciamo che sarà abolita l a coscrizioner vi saranno e la rgiti tutti i possibili miglioramenti economici e vi consideria m o fin d'ora strettamente lega ti all' Italia. Pensate che l'Italia vi stende la s ua magnanima, civile protezione e grid ate con noi: viva il re, viva l 'Italia!
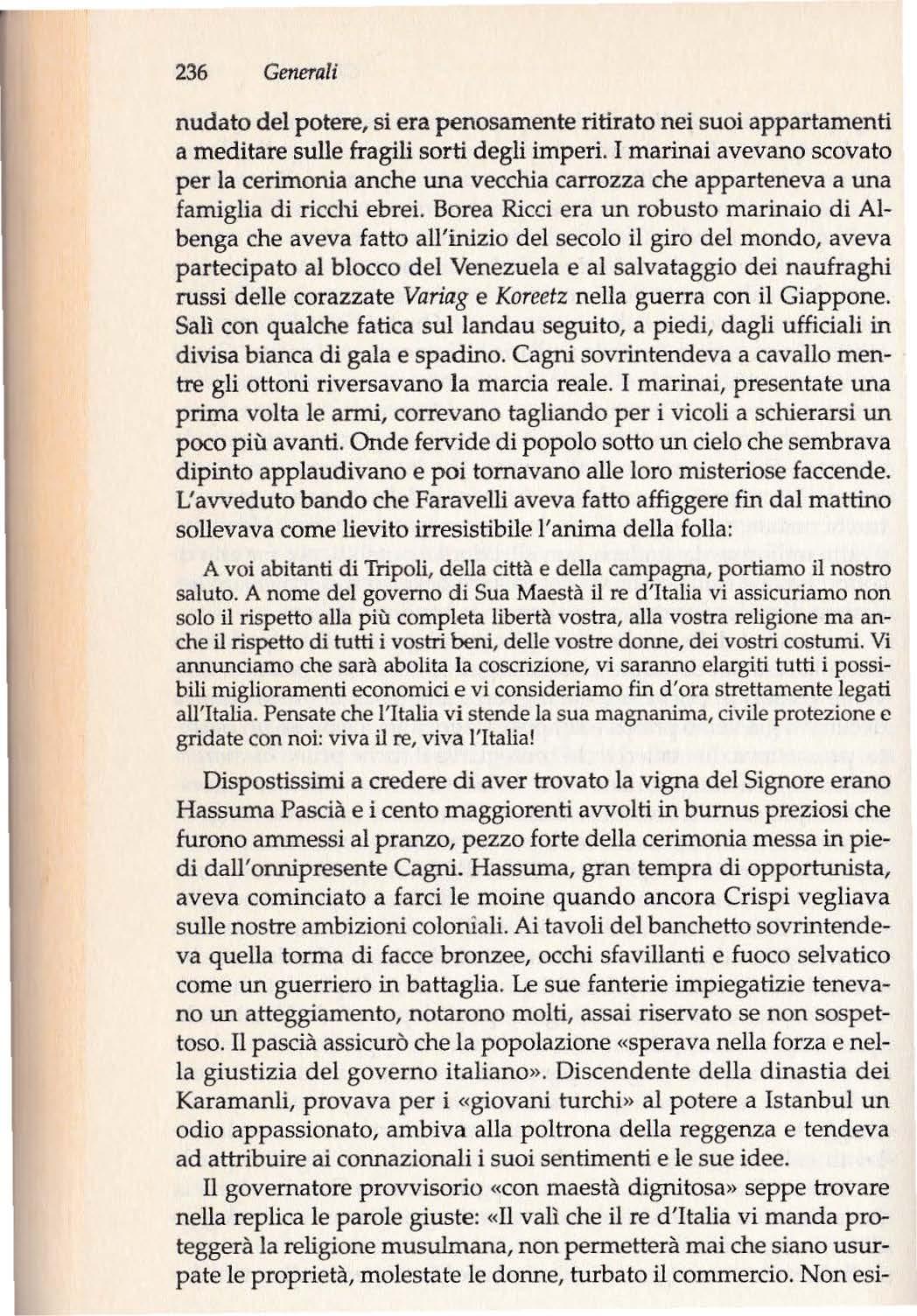
Dispostissimi a credere di aver trovato la vigna del Signore erano Hassuma Pascià e i cento m aggiorenti avvo lti in burnus preziosi che furono ammessi al pranzo, pezzo forte d ella cerimonia messa in piedi d a ll 'onnip resente Cagni. Hassuma, gran tempra di opportunista, aveva cominciato a farci le moine quando a ncora Crispi vegliava sulle nostre a mbi zioni coloniali. Ai t avoli d e l banchetto sovrintendeva quella torma di facce bronzee, occhi sfavillanti e fuoco selva tico come un guerriero in ba ttaglia . Le s ue fante rie impiegatizie te n evano un atteggiamento, notarono mol ti, assai riserva to se non sospettoso. Il pascià assicurò che l a popolazione «sp e rava ne lla forza e n ell a giustizia d el governo italia no». Discendente della dinastia dei Karamanli, prova va per i «giovani turchi » al pote r e a Istanbul un o dio appassionato, ambiva alla p o ltrona d e lJa reggen z a e tende va ad attribuire ai connazionali i suoi sentimenti e le s ue idee.
Il governatore provvisorio «con maestà dignitosa» seppe trovare nella replica le parole giuste: «Il valì che il re d ' Italia vi manda proteggerà la religione musulmana, non permetterà mai che siano u surpate le proprie tà, m o lestate le donne, turbato il commercio. Non esi-
gerà tributi senza bisogno». All 'ulema che faceva parte della delegazione pittoresca con il suo turbante verde, conquistato con il pellegrinaggio alla Mecca, regalò le dodicimila lire che, disse, erano state ritrovate nelle casse turche. L'ulema si mostrò felicissimo di quella for tunata combinazione. Anche il resto della delegazio n e, che v i scorse prospettive rosee, accolse con visibile soddisfazione il sa luto e da quel momento si lanciò sulle p ortate con vigore implacabile. E Caneva? Chiediamo scusa, lo abbiamo perso di vista. Mentre i ma rinai banche ttavano e scambiavano rare fucilate con questo n em ico evanescente e m is terioso, il comandante in capo e ra, come scrisse il suo capo di s tato maggiore Gastaldello, «fuori dalla grazia di Dio». La marina infatti gli aveva rubato il palcoscenico. I suoi soldati, che stavano faticosamente affluendo su mille tradotte a Napo li per imbarcarsi, sarebbero arrivati a Tripoli quando tutto era già concluso. Anche il s uo piano di guerra ch e prevedeva due sbarchi, in modo da afferrare la città libica e chiudere in una morsa i turchi prima che si organizzassero o tagliassero la corda, ormai era finita n elle carte s toriche dello stato maggiore. Questo fu l'errore fo ndame ntale della campagna, ci hanno poi spiegat o gli s tra teghi d el giorno dopo. Perché l'iniziativa baldanzosa dei marinai consentì ai turchi di sganciarsi e di organizzare la guerriglia assediando la città. Noi ci acconten tiamo delle carte e della voce dei protagonisti. Ci pare che la furia di Caneva derivasse più dalla g loria sfumata che da considera zioni tattiche. Tra la m arina, che godeva come si è visto del tifo popolare, e l 'esercito, che invece aveva a ddosso la macchia recentissima di Ad ua, c'erano s morfie e bisticci che nessuno si preoccupava dinascondere. La foto dei marinai schierati sul castello di Tripoli (questa fu la prima guerra nos tra scrupolosamente documentata dai report er) fu un grande colpo pubblici ta rio per gli ammiragli. E poi, per un generale che aveva in t asca ordini d e l governo come al solito confusi e contrastanti, trovars i tra i piedi anche le iniziative d e i colleghi no n doveva essere piacevole. La memoria governativa che g li attribuiva il comando infatti e ra una generica missione da tempi biblici:
Il decreto firmato da Sua Maestà il Re lissa le attribuzioni di sua Eccellenza il tenente generate Can eva e g li dà ampi poteri affinché egli possa in breve tempo far opera grande e benefica per quelle immense regioni che vogliamo occupare e per l' Italia.
Questo era per la Storia. Le istruzioni private che gli aveva affidato Giolitti invece erano più sfumate e complesse. Lo statista piemontese, che n on amava i s uperlativi, gli a veva raccomandato d i «far la

guerra sulle uova ». Sapeva benissimo che attaccando così brutalmente il grande mala to d'Europa, l'impero turco, rischiavamo di fare la parte degli incendiari. le a ltre potenze, che avevano accettato bon g ré mal gré quella guerra, erano pron t e a mettersi in mezzo schiacciandoci sotto nuove umiliazioni. Per cercare il genio di Caneva ci vuole la lente di in grandimento, infatti non si accorse che il nocciolo della questione era contenuto in tre piccole parole: «in breve tempo». Bisognava vincere alla svelta per far ingoiare la conquista, con l'eterno diritto del fatto compiuto, ad amici (che erano pochi) e nemici (che erano tantissimi).

Il 9 ottobre, finalmente, hanno inizio sotto il Vesuvio le operazioni d'imbarco in un'atmosfera d i isterico ottimismo che rimanda più a una g ita che a una operazione bellica. I muri della città sono tappezzati di proclami; quelli del sindaco che non si è lasciato sfuggire l'occasione dilagano:
Sulla vicina terra d'Africa bagnata dal mare nos tro la bandiera della patria, pe r il valore dei marinai d ' Italia, già segna l'ora dell'ade mpime nto [pensate alle smorfie di Caneva!]. Ai soldati che partiranno per consolidare il nos tro pieno e incontrastato dominio su quella regione che vide i voli della vittoria latina e conobbe la incontrastata civiltà di Roma, Napoli esprime nella pienezza del suo animo esultante l'aug uri o di luminosi ed eccelsi trionfi.
Era arrivato anche il re. In piazza del Plebiscito, che rischiava di esplodere per la folla immensa e si intravedeva appena sotto le bandiere, poté con compiacimento verificare la popolarità di quella guerra che cancellava i brutti ricordi dei tempi in cui la folla gridava «v iva Menelik». Sfilarono persino cento garibaldini in camicia rossa superstiti, ancora baldanzosi nonostante l'età , di quell'epopea sempre a portata di citazione. Caneva, che per i proclami aveva predisposizione, cercò consolazione in una raffica di ordini del giorno rivolti a «ufficiali e sottufficiali, caporali e soldati » ma in realtà già pronti per la pubblicazione sui libri di storia:
Noi sa lpiamo dai lidi della Patria accompagnati dall'unanime consenso e dai fervidi voti del popolo nostro, il quale fermamente vuole che anche sulle spond e opposte del mare Mediterraneo sia rispettato il nome italiano e con esso la dignità nazionale e i vitali interessi della nostra gente: ... noi portando in Tripolitania le armi italiane non moviamo al danno della terra e delle popolazioni tripolitane; queste e quella devono invece per opera italiana e non comune beneficio essere redente a nuova civiltà e a nuova ricchezza ... Alla tutela dei diritti nazionali provvederà la virtù delle nostre armi ... la diligenza della preparazione, la larghezza dei mezzi, la superiorità del numero e d ella militare istruzione, la vostra disciplina e il vostro valore so-
no arra sicura di prospero successo ne lle operazioni di terra ... Alla redenz ione civile delle nuove genti provvederanno la umanità, la moderazione, la giustizia che sono retaggi antichi e mai offuscati di nostra stirpe ... In quelle terre ove portiamo ora il vessillo della nuova Italia, in quelle te rre che o ra sono scadute per lunga barbarie e per incivili reggimenti, in quelle terre fu un tempo Roma con le sue aquile vittoriose e con la sua civiltà redentrice. Ricordiamo e il ricordo s ia fiamma alle anime nostre.
Dall'involuta sin t assi del Caneva sbucano molti e aggrovigliati e lementi: gli interessi vitali, concetto che avrà fortuna anche in epoche s uccessive, la «barbarie di incivili r eggimenti» da emendare; e, soprattutto, gli italiaiù brava gente, archetipo che guiderà il nostro colonialismo fino alla disfatta finale e anche oltre nel giudizio degli storici e dei politici. Alle lapidarie m otivazioni ufficiali Caneva, prudentissimo, aggiungeva poi un ordine del giorno interno, alla «diligente attenzione» della truppa. Dava istruzioni di comportamento, visto che stavamo per venire a contatto con popolazioni che, imbarbarite o no, avevano le loro abitudini. Il generale ribadiva lo scrupoloso rispetto della proprietà privata di qualsiasi specie, specialmente che non venisse arreca to alcun danno agli alberi di palma per cui aveva una passione da giardiniere. E il rispetto della religione; l e esperienze in Abissinia ci avevano insegnato che esplosiva miscela fosse l'Islam quando si mescolava alla lotta per l'indipendenza e alla politica.
Sono necessari il massimo rispetto e la tolleranza più deferente verso tutto ciò che concerne i riti musulmani. Nessuno scherzo, nessun dileggio è ammissibile sulle manifestazioni esterne d e lla fede islamica perché la libertà delle credenze e delle pratiche religiose deve essere pienamente garantita per tutti ... Nelle moschee è proibito l'ingresso.
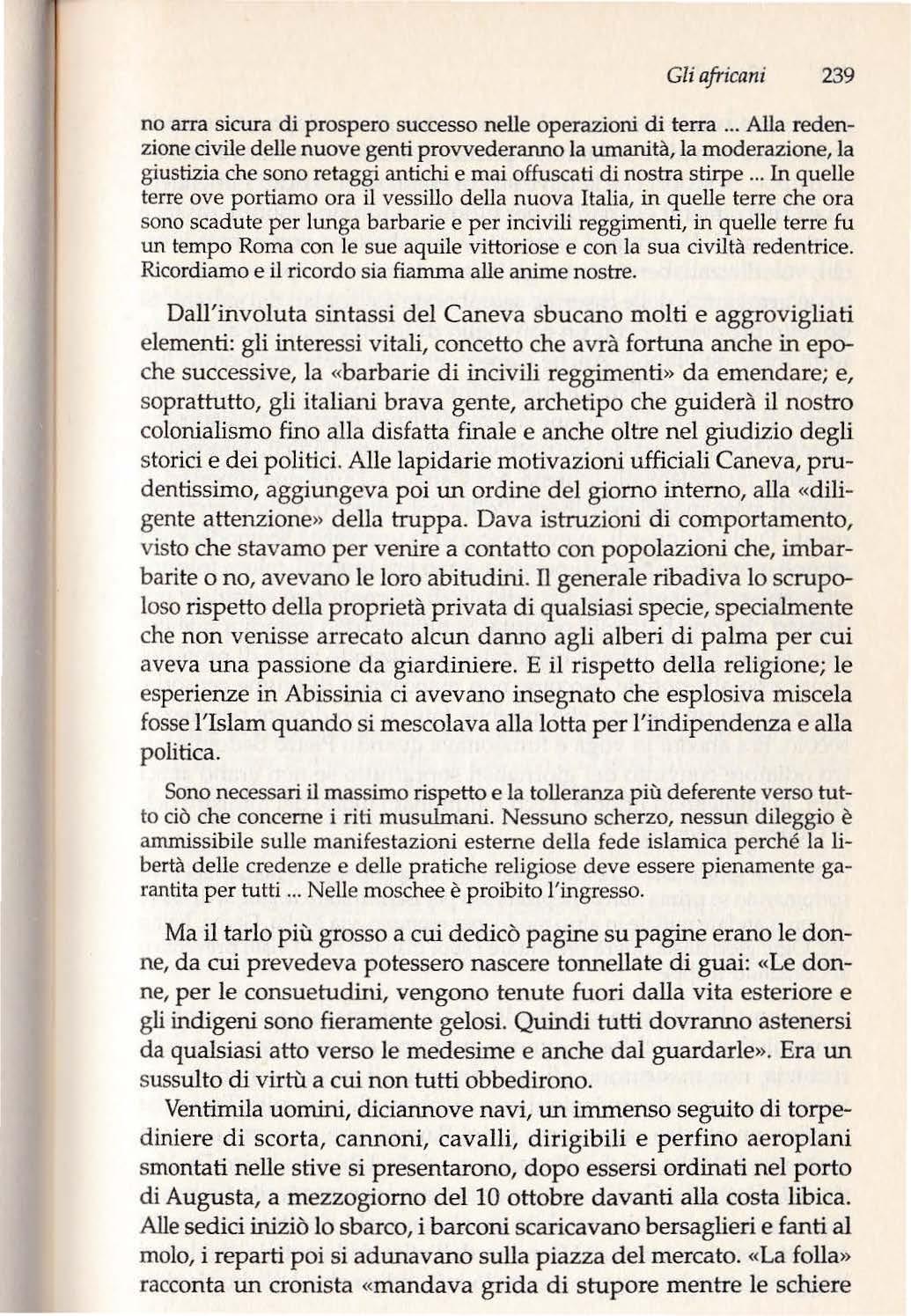
Ma il tarlo più grosso a cui dedicò pagine su pagine erano le donne, da cui prevedeva potessero nascere tonnellate di guai: «Le donne, per le consuetudini, vengono tenute fuori dalla vita esteriore e gli indigeni sono fieramente gelosi . Quindi tutti dovranno astenersi da qualsiasi atto verso le medesime e anche dal guardarle». Era un s ussulto di virtù a cui non tutti obbedirono.
Ventimila uomini, diciannove navi, un immenso seguito di torpediniere di scorta, cannoni, cavalli, dirigibili e perfino aeroplani s montati nelle stive si presentarono, dopo essersi ordinati nel porto di Augusta, a mezzogio rno del 10 ottobre davanti alla costa libica. Alle sedici iniziò lo sbarco, i barconi scaricavano bersaglieri e fanti al molo, i reparti poi si adunavano sulla piazza del mercato. «La folla » racconta un cronista «mandava grida di stupore mentre le schiere
passavano con le bandiere al vento. » Due giorni dopo un secondo convoglio, con altri diciannove piroscafi, scaricò una nuova ondata di truppe. Si scoprì ch e la nave s u cui erano s tati caricati l'intende nza e i rifornimenti e ra p artita per ultima. Ci furono rabbuffi, disagi e contratte mpi. Ma in quel m omen to si comb a tteva non contro i turcru, volatilizzati, bensì contro g li insetti che avevano preso possesso, e con a rroganza, delle caserme sgomberate dai soldati d e l s ultano. Si d ovette p rovvedere con un convoglio di insetticida fatto arrivare a tutta fo r za da Napoli. Anche Caneva era alle prese con nemici imprevedibili: i giornalisti. La spedizion e era «coperta», come si dice in gergo di r ed azion e, da decine di grandi firm e, quasi tutte disposte a suonare la grancassa d e l patrio ttis mo trionfante. Difficile te m ere tradime nti, pugna la te alla s crue n a. M a Caneva e i s uoi due supe rio ri, il cap o di stato maggiore Alberto Po llio e il ministro della Gu e rra generale Paolo Spingardi, a v evano scoperto una verità scomoda: che i singoli giornalisti, presi di persona, son o tipi innocui, talora folclo ris tici, s p esso can aglie. Ma un a rticolo di giornale può seminare più disastri che una battaglia perduta. Si affannarono quindi a manifes tare la lo ro scarsa fid u cia nella categori a alzando mura di protezione intorno alle n otizie. Siccome non mancavano di acume censorio, inventarono un sist ema che avrebbe fatto il suo dovere per m ezzo secolo. Era ancora in voga e funzionava q u ando Pietro Badoglio, altro odiatore convinto dei giornalisti soprattutto se non erano amici suoi, lo impiegò in Etiopia. Ecco l'illuminato ukase d el ministro della G u erra Spingardi:
Nessun g iornalista sarà autorizzato a corrisponde re per mezzo d e l cavo sottomarino se prima non avrà promesso per iscritto sotto la parola di onore di non mandare notizie in altro modo, per esempio, via Malta, Gerba, Egitto ecc . Ogni giornalista dov rà presentare i su oi dispacci per il visto preventivo a l Comando Truppe.
Siccome l ' Ita lia non sarebbe l' Italia e i giorna li s ti non sarebbero giorna lis ti se n on ci fosse sempre qualcuno ch e pratica le v ie d e lla furbizia, non mancarono g li aggirame nti, g li scoop, le notizie scom ode a rriva te nelle redazioni con macruavellici circu i ti. Tanto che perfino un mostro sacro come Lu igi Ba r z ini , che app unto u sava la vieta v ia di Malta, riscruò l'espulsione dalla Libia. Federico De Maria d el «Resto del Carlino» fu arres ta to per aver insaporito un report age con un 'aggressio n e s ubita da alcuni arabi r isulta t a in seguito quantome no esagera t a. Al Caneva, dell 'etica della notizia, dei lettori buggerati, non importava niente; lo infasti diva che dalla bugia s i ri-
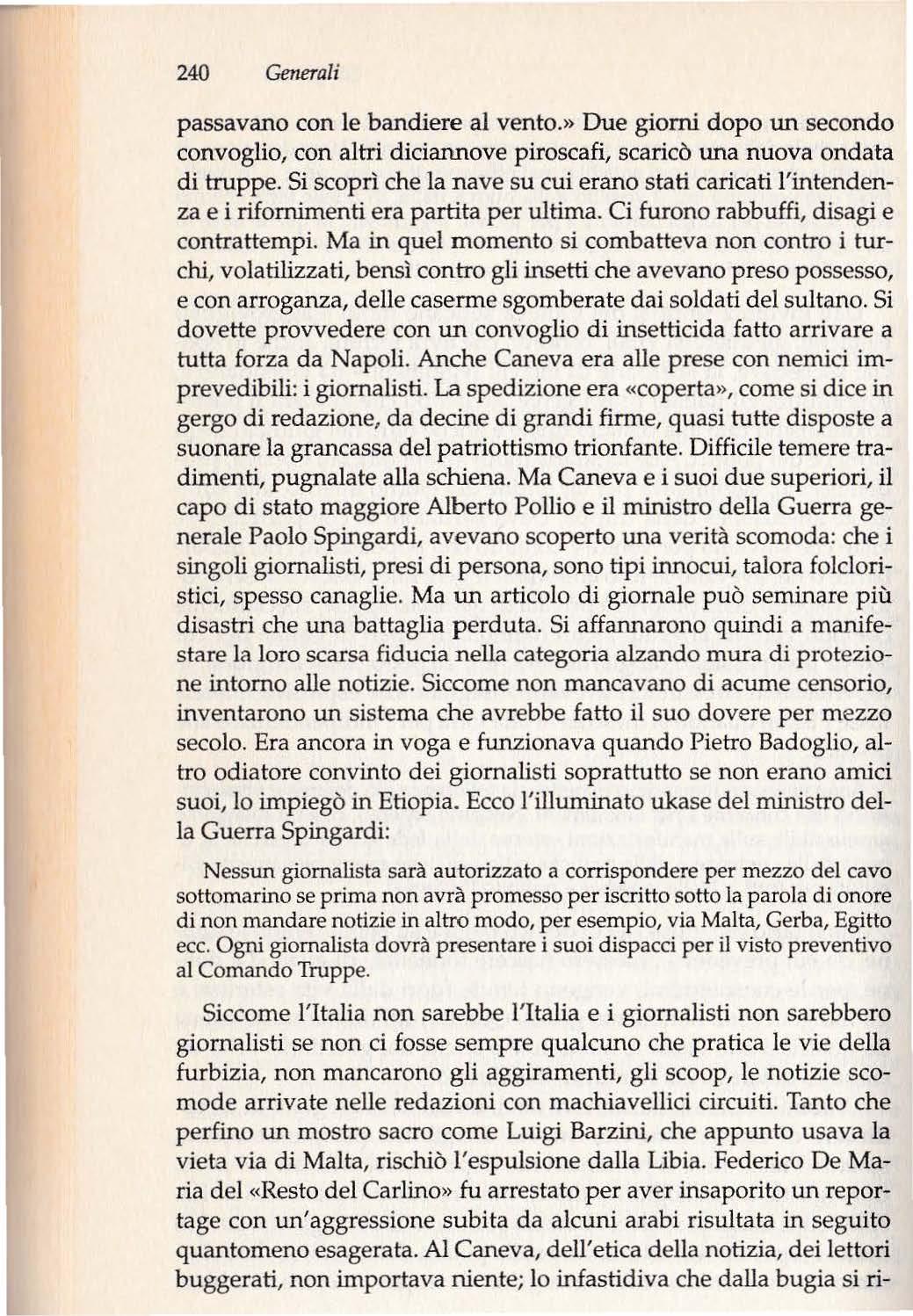
cavasse l'impressione che la normalità vantata dai bollettini ufficiali in real tà non esisteva o era molto fragile. Se ci amavano, chi erano q u esti che distribuivano bastonate? Eretici? E i turchi? Ness uno si occupava più di loro; la vita era torna ta in città «ben difesa e s icura». Aveva riaperto il Banco di Roma, grande burattinaio per inte ressi suoi d e ll'occ upazione d e llo scatolone di sabbia, le moschee officiavano ringraziamenti ad Allah, i mu ezzin si sgo lavano sui minareti a lanciare il richiamo d e lla preghiera, anche ai pigri e agli scettici che sono in ogni parte d e l mondo. Arrivavano letter e e te le grammi, il cavo sottomarino, perverso strumento d egli agguati giornalistici, era s tato ripara to. Era tempo di rimandare i molesti anche se utilissimi m a rinai alle loro salde navi con tanti elogi e medaglie. Caneva, subentrato come governatore ora che la guerra era finalmente d ell 'esercito, p rovava a far esercizio nei proclami di citazioni dal Corano:
Popolazioni d ella Tripolitania Cirenaica e regioni annesse! Ricorda te ch e Dio ha de tto ne l <<Libro)): «A coloro i quali no n po rtano la guerra religiosa e non v i caccia no dai vostri p aesi v oi d ovete fa re de l bene e proteggerli perché Dio ama i benefattori e i protettori)) . Ricordate che sta scritto pure nel t< Ll~ bro»: (<Se essi inclinano alla pace accetta tela voi pure e abbia te fiducia in Dio».
Forse in base queste così azzeccate citazioni (ma s i sa, i libri sacri s ono fatti per tro va rci que llo di cui uno ha bisogno) d egli arabi non s i preoccupava nessuno. Non e ravamo forse ve nuti per sottrarli a l giogo nefas to d ei corrotti turchi ? Come a vrebbero potuto i liberati ribella rsi ai liberatori? En-oretto, questo, in cui sono incorsi perfino gli americani in Vietnam o in Iraq: figuriamoci il povero Caneva di Ud ine! Il governatore aveva il s uo daffare a dis tribuire, davanti al governa tora to, ai pove ri d e lla città - categoria purtroppo fortem ente rap presentata nella sociologia libica - r azioni di farina pane g allette e pesce s alato. Gli aiuti alimentari erano arrivati con il trasporto Ga rigliano insieme al corpo di spedizione . Dovevamo dimostrare ai nuovi sudditi che eravamo altra gente rispetto ai p ezzenti e avidissimi t urchi , «dominazione deprimente e d emora lizzatrice» . Esibivamo molta moneta, s mente ndo le voci ch e sempre acco mpagnano le nostre spedizioni oltremare, che siam o dei poveracci resi ancor più poveri d alle s trane pretese di mostrarci una potenza . I libici sembravano credere alle nostre promesse perché le torme di miserabili in fila per la distribuzione non avevano fine, riempivano la piazza del merca t o. I questuanti si s dra iavano a terra, baci avano le mani d egli ufficiali ch e si ritraevano da quell'accattonaggio disgustoso e dolo-

roso insieme. Era una folla cenciosa, famelica, che già aveva imparato la prima parola italiana storpiata e terribile, che ripeteva come un rosario: «mangeria».

Ci eravamo distratti. Promettere il paradiso va bene, ma n on bisogna mai fissare scadenze. Eppure qualcosa di molesto si stava preparando: spa r atorie notturne agli avamposti, piccole punture di spillo, agguati a soldati ch e si spostavano da soli nell'oasi dove i muretti a secco, i giardini, i labirinti delle case tutte uguali sembravano fatti apposta. Si davano da fare soprattutto le spie, gli ufficiali turchi travestiti che controllavano la disposizione del nostro schieramento. Ce n'erano molti, riferivano i nostri informatori libici passati a noi per amore di guadagno, anche tra i mendicanti che s i affollavano attorno a Can eva. Uno di loro fu sorpreso mentre usciva dalla città sotto un intangibile burqa femminile. Si scoprì che un ufficiale medico venuto a chiedere rimedi per i s u oi feriti e cavallerescamente scortato fino alle linee, era un maggiore del Centoventisettesimo fanteria turco noto per la brutalità con cui aveva in passato diretto i tribunali indigeni, fanatico della jihad contro gli italiani a cui aveva promesso terribili punizioni per l'invasione. Al mercato si discuteva apertamente sul fatto che i turchi stavano ammassandosi non tra le p ietraie del lontano Garian, come pretendevano informatori ansiosi di compiacerci, bensì ai bordi della grande oasi dove avevano nascosto nei ventiquattro giorni di tempo che avevamo concesso loro, ventimila fucili Mauser nuovi di zecca e milioni di cartucce trasbordati dalle navi corsare sulla costa. Per cercare il nemicosi alzarono in volo persino gli aerei dell'animoso capitano Carlo Piazza, che instillarono terrore e ammirazione negli arabi. Sotto di loro scorreva la «mescia», il giardino, la caten a di oasi che circondava la città . Un giardino era davvero, con un milione di palme che la proteggevano dalla sabbia del deserto e che facevano velo e ombra a lle piantagioni di orzo, di alberi da frutta, cotone, a laghetti e pozzi; un giardino così fitto da risultare impenetrabile. Terra affascinante per il pellegrino ma adatta a ben più prosaici agguati. Gli aerei svolazzarono cinquanta minuti a bassa quota sull'oasi, non videro nulla e lasciarono al nostro esercito intatta l' illusione di essere al sicuro.
Alle otto del mattino del 23 ottobre anche Caneva rischiò la sua Adua tripolina. Come partoriti dal deserto, reparti turchi a piedi e a cavallo cominciarono ad attaccare il centro e l 'ala destra delle nostre trincee attorno alla città: s paratorie, assalti, contrattacchi, sembrava seppur scenografica, una grande inutile dimostrazione. Invece era una finta : i turchi non volevano spaventarci, volevano annientarci.
L'attacco principale avvenne sul lato orientale della città, a Tagura, nel sobborgo di Sciara Sciat dove erano di guarnigione i bersaglieri dell'Undicesimo comandati da un colonnello, Gustavo Fara, che aveva gustato i fanatismi musulmani nella battaglia contro i dervisci ad Agordat, in Eritrea. Mentre i bersaglieri cercavano di salvare la pelle e scuotersi di dosso gli assalitori che li avviluppavano sfruttand o, per avanzare, gli orti e i giardini, fulminandoci al riparo dei muri a secco, saltando giù dalle case preparate con cura per l'agguato, «i nostri fratelli arabi ansiosi di giustizia e di affetto» come li clùamava Caneva nei suoi rapporti al miele, ci attaccavano alle spalle lavorando di cecchini e di sgozzamenti. Fara si salvò sclùerandosi a quadra to attorno alla moschea dove lo prelevarono a sera le truppe di rinforzo e le cannonat e sparate dalla flotta. Ma il reggimento fu q uasi annientato, cinquecento caduti . Alcuni si suicidarono per non cadere in mano al nemico, decis ione terribile ma giustificata dalla s coperta di quello che avevano subito i prigionieri, ritrovati tra le d une e i campi dell' oasi orrendamente mutilati e tagliati a pezzi. Sono orrori di cui non trove rete traccia nel rapporto di Fara :

Notte tra nquilla. Ieri co ntegno truppe ammire vole . Perdite Undicesimo bersaglieri: ufficiali, due morti, dieci feriti, truppa, non ancora precisate. Riserva nti trasmettere nomi. Nemico completamente respinto con perdite rilevanti, si d ove tte procede re alla fucilazione di parecchi rivoltosi. Dei numerosi arrestati alcuni saranno sottoposti al giudizio d el tribunale di gue rra. Faccio imbarcare gli altri che sono parecchie centinaia .
Cane va aveva pianificato lo sbarco senza documentarsi sul nemico . Si era accontentato della relazione s e gre ta redatta dallo stato maggiore per il preside nte del Consiglio:
Le popolazioni della Cirenaica e della Tripolitania non saranno risolutamente avverse alla occupazione perché stanche del malgoverno dei turchi. Pertanto no n è infondata l' opinione comune che non incontreremo molte d ifficoltà dal momento che ci presentiamo come liberatori.
Dopo Sciara Sciat il generale cambiò umore, venne colpito da quella che definiamo la sindrome di Adua, che contagerà i nostri comandi fino alla seconda guerra mondiale: la paura di esporsi, che qualsiasi azione offensiva possa trasformarsi in un disastro, la preferenza per una guerra di p osizione, di difesa passiva fidando sul terreno e il numero dei soldati impiegati come masse s tatiche che contano per il loro peso. Diamo l ' addio senza rimpianti all'audacia, ai blitz, alle manovre che implicano risclù esiziali per la carriera. Meg lio non combinar nulla che finire come Baratieri. Tra quelle propen-
sioni avaramente difensive o prodigalmente offensive che venivano considerate proprie dei diversi temperamenti naturali, avevamo optato per le prime con risolutezza. Caneva vi aderì con totale determinazione. Addirittura, lui che aveva uomini e cannoni in abbondanza rispetto al nemico, abbandonò alcune posizioni attorno alla città che riteneva troppo esposte. Si rincantucciò sotto la protezione dei cannoni delle navi alla fonda. Dopo aver per settimane esecrato la viltà e l'incapacità militare dei turchi che impedivano alla sua bella armata di annientarli, adesso nei rapporti orchestrava lodi iperboliche alle qualità del nemico. Non era il caso proprio di avventurarsi nel deserto dove i soldati sarebbero stati inghiottiti dalla capacità del nemico di colpire e scomparire come una maledizione. Giolitti, che cominciava a essere assediato dalla diplomazia europea per cui il tempo concesso era scaduto, e aveva fretta di chiudere la guerra, cercò di rafforzare gli umori del suo generale spedendogli rinforzi. E non lesinò, visto che richiamò alle armi una classe intera e inviò a Tripoli altre due divisioni; e poi ancora alpini cavalleria fanti venti batterie da campagna otto da montagna e sette da fortezza. Insomma, alla fine cinquantacinquemila uomini, centocinquanta cannoni, ottomila quadrupedi e millecinquecento carri da trasporto. C'era di che attraversare l'Africa combattendo, non certo fermarsi nelle caserme di Tripoli!
Per Caneva invece ogni operazione era troppo audace, la sabbia del deserto troppo fine e le dune troppo alte per i nostri cannoni, le truppe poco addestrate e gli arabi troppo subdoli e astuti. Chiedeva sempre nuove divisioni. Aveva contagiato perfino i suoi divisionari. Briccola, per esempio, che aveva fama di animoso quand'era partito dall'Italia e che invece scriveva:
Mai la tattica di Quinto Fabio apparve più opportuna e più consigliabile dato che ogni giorno che passa segna per se stesso un aggravamento per le condizioni del nemico, ne assottiglia le file, ne indebolisce le forze ...
Ad assottigliarsi era soprattutto la pazienza di Giolitti:
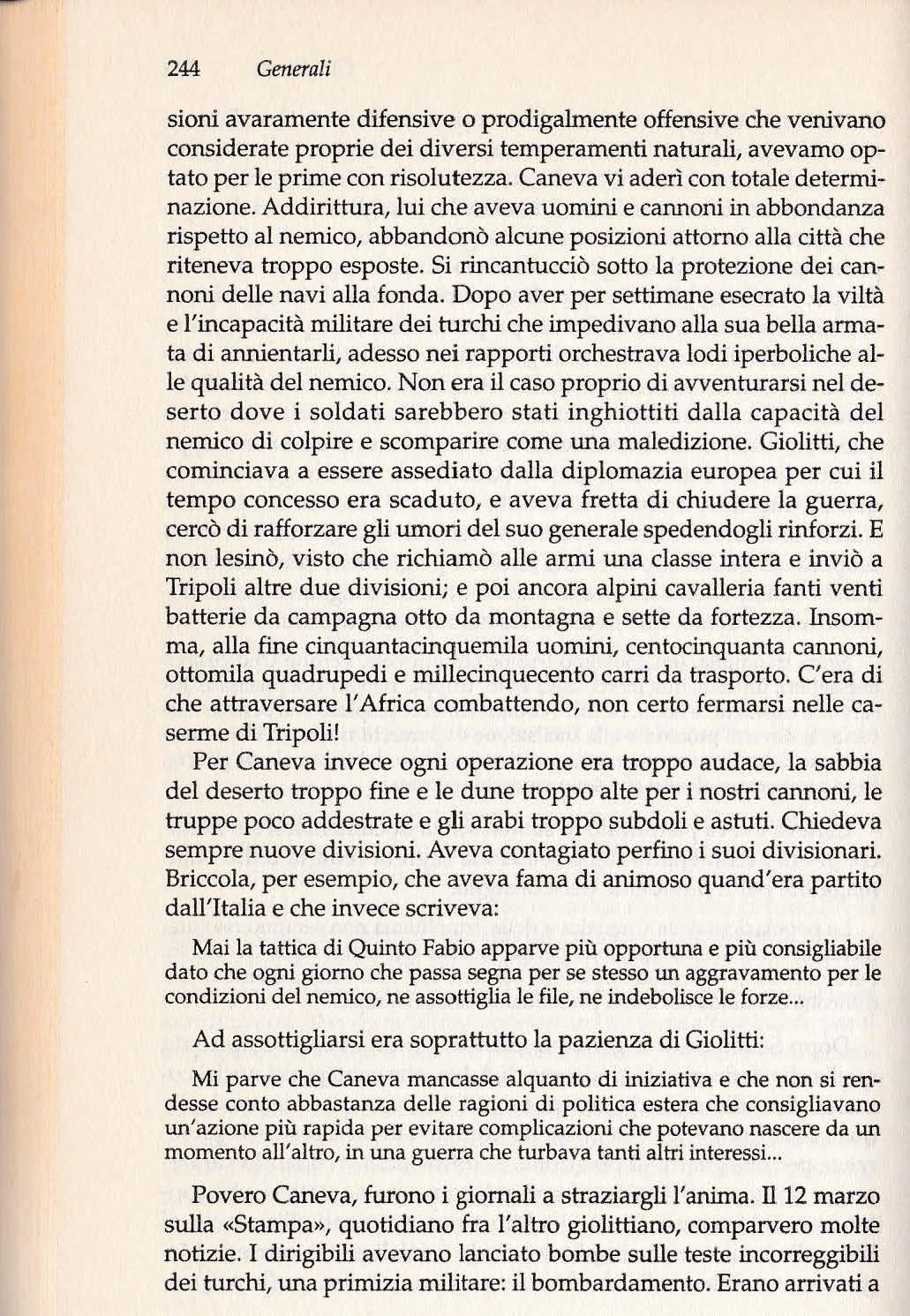
Mi parve che Caneva mancasse alquanto di iniziativa e che non si ren~ desse conto abbastanza delle ragioni di politica estera che consigliavano un'azione più rapida per evitare complicazioni che potevano nascere da un momento all'altro, in una guerra che turbava tanti altri interessi...
Povero Caneva, furono i giornali a straziargli l'anima. Il 12 marzo sulla «Stampa», quotidiano fra l'altro giolittiano, comparvero molte notizie. I dirigibili avevano lanciato bombe sulle teste incorreggibili dei turchi, una primizia militare: il bombardamento. Erano arrivati a
Tripoli, per passare alla cronaca, venti vetture e venti cocchieri siciliani: «Una vera manna per quanti si trovavano in città per ragioni di lavoro e non trovano mai vetture disponibili. Soprattutto i cocchieri arabi saranno costretti a diminuire le tariffe esorbitanti e a vestire decentemente».
Ma colpiva una pagina intera, a dir poco sorprendente per il lettore anche più affezionato del quotidiano. Conteneva, a fatica, viste le dimensioni, uno scoop: il memoriale che il generale Guglielmo Pecori Giraldi, comandante della Prima divisione del corpo di spedizione libico aveva inviato alle superiori autorità dopo il rientro in patria. Richiamato per motivi di salute, diceva la motivazione ufficiale; silurato da Caneva e collocato a riposo, scoprirono gli sbalorditi lettori d e lla «S tampa » per aver rischiato una seconda Sciara Sciat.

Abbiamo commesso in questo libro molti peccati di omissione; ci siamo lasciati alle spalle impuniti centinaia di generali che avrebbero meritato lo sberleffo seppure postumo, la citazione a disonore. Lo confessiamo, erano troppi, seguirli tutti ci avrebbe sfiancati, occorreva la capacità catalogatoria del Mahabarata. Con Pecori Giraldi facciamo una sosta, non vogliamo farcelo scappare. Era la prima volta che un documento così delicato e segreto veniva offerto all'opinione pubblica per vie traverse, per alimentare la guerriglia tra i generali. Pettegoli, sospettosi, malvagi, invidiosi, portinaie gallonate: eccola la pugnalata stampata sul piombo e ripetuta in decine di migliaia di copie. Segno che i veleni cominciavano a corrodere la corazza delle solidarietà corporative.
Trasferiamo armi e bagagli a Bir Tobras, sempre nei sobborghi della città da dove non ci volevamo muovere. I ribelli, che praticavano la guerriglia in tutte le sue infinite partiture, avevano sequestrato alcune famiglie di collaborazionisti per seminare una salutare paura tra chi stava dalla nostra parte. Pecari Giraldi, che nella guerra sporca ci sguazzava a piacere, aveva pensato di fare la voce grossa e proclamare ai quattro venti che comandavamo noi. Fu individuato il villaggio dove erano tenuti i prigionieri e il boia già affilava il coltello. Bel colpo! li più era fatto. Audacia, velocità, una buona pianificazione e sarebbero stati liberi . Entrò in campo un altro elemento, decisivo, catalizzatore direbbero i chimici: la bestialità di Pecori Giraldi, un giocatore d 'azza rdo di mestiere, d a lla mano svelta, dalle parole vuote, dalla smisurata ambizione. Sbagliò tutto: spedì troppi uomini ma con poca artiglieria (temeva affondasse nella sabbia); soprattutto calcolò male i tempi, cosicché le truppe arrivarono sul luogo dell'im-
boscata a g iorno fatto quando gli arabi erano pronti e ben svegli. Per scialare e completare l'opera non disse nulla a Caneva riservandosi di informarlo a cose fatte; probabilmente per non dover dividere i complimenti per un successo che pensava sicuro. Gli incursori furono circondati, si dovette impegnare una colonna di soccorso, e rob usta, per toglierli dalle mani dei turchi. Passarono agli annali anche scene poco dignitose con soldati che gettarono le scarpe per fuggire più rapidamente, molti morti e feriti.
Pecori Giraldi, che aveva una be lla faccia tosta, ammise quando fu convocato da Caneva solo «alcune manchevolezze» e scaricò le colpe s ui subordinati che n on avevano eseguito bene il suo piano. Scuse: ch e non lo s alva rono dall'esonero e dalla pessima iniziativa di me ttere tutto p er iscritto sul giornale. N o n dove tte attendere molto per gustare la vendetta. La Libia s tava irrobustendo la sinistra fam a di tomba dei generali. Giolitti era esasperato per le proposte dello stato maggiore: g li propo nevano co m e scorcia toie per la vittoria s trampal a te o pe razioni, come invadere la Turchia e catturare il sultano. Si a ffidò anche ai metodi cris pini spedendo un telegramma furibondo il 10 novembre 1912:
Governo mi ordina di r appresentare a Vostra Eccellenza grande necessità politica che collima perfettamente esigenze militari impadronirsi tempo relativamente breve tutta oasi di Tripoli per cancella re l'impressione che s iamo costà costretti a rimanere sulla difensiva e che quindi la proclamazione d ella sovranità italiana sopra la Tripolitania è una finzione .
Caneva rispose facendo tradurre in versi da un giornalista, p e r fortuna rimasto anonimo, alc une strofette di raccomandazioni alle truppe, s tampate e distribuite ai re parti:
Il fucil e non trascurare / esso sol ti può salvare.
Spara poco, punta assai / e il nemico colpirai.
Serba l'acq ua , non sprecarla / ch'è difficile trovarla.
Sii prudente e coraggioso / ma non troppo fiducioso .
Le loro d o nne e an che Allah / lascia s ta r p er carità .
Oltre all' essere deriso / se tu scappi sei ucciso.
Sul cammino dell'onore / segui sempre il s uperiore.
Vince un solo coraggioso / uno stuolo numeroso. Il nemico fe rmo aspetta / u sa allor la baionetta.
Era la g uer ra fa tta con il «Corriere dei Piccoli ». C ane va amava scrivere proclami e aveva subit o adottato il tono messianico che cons iderava adatto agli umori d e i s udditi arabi. Que l briccone di Enver, il bey che guidava con luciferina astuzia la resistenza, diceva, beffard o, che ave vano ammazzato più turchi le tonnellate d i carta lanciate
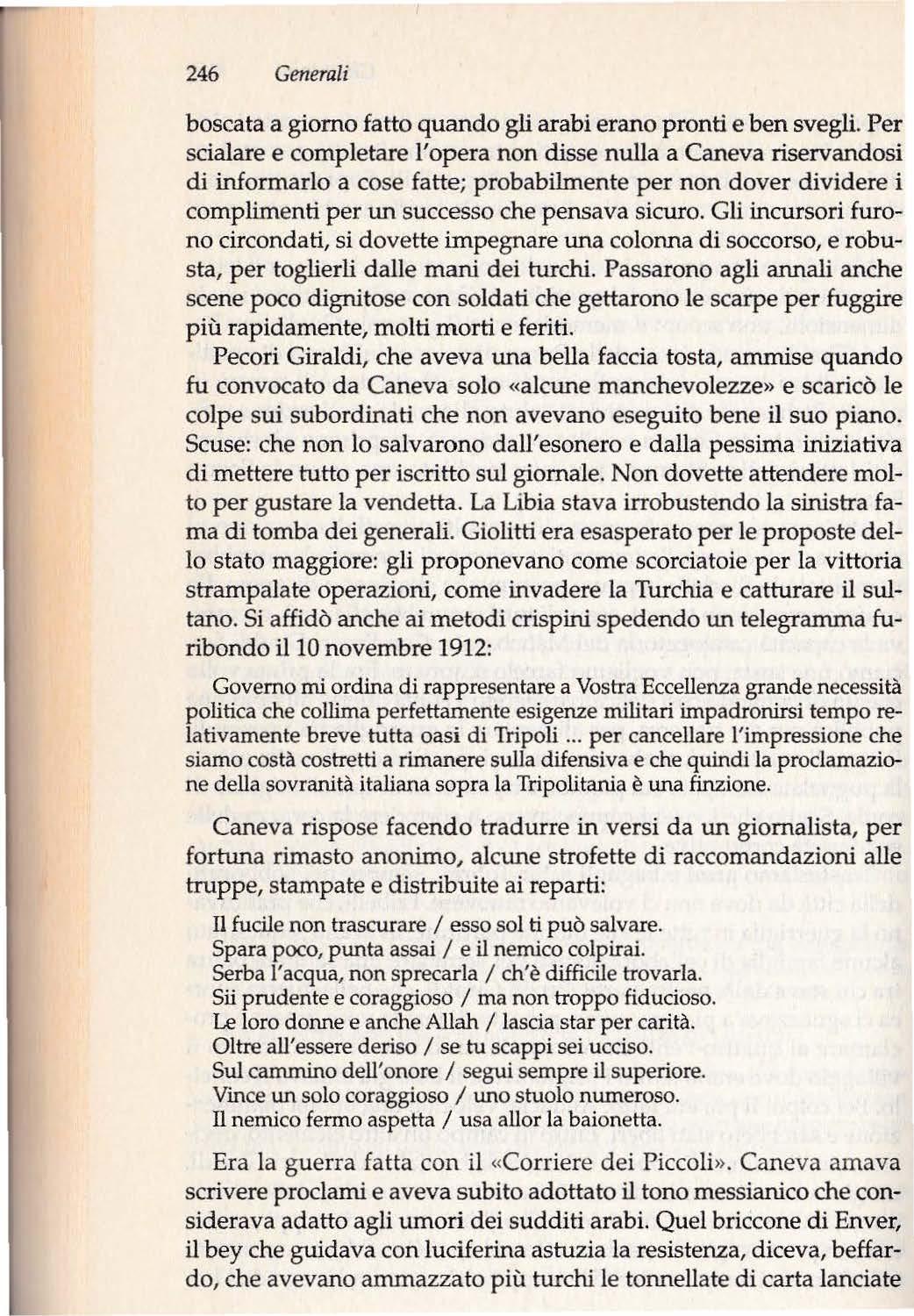
da dirigibili e aeroplani che le bombe italiane. Giolitti era un uomo paziente ma aveva la consapevolezza che il sublime scivola rapidamente nel ridicolo. Nel 1914, quando diecimila schiamazzatori professionisti gli chiedevano di gettarsi contro l' Austria, era ripensando a quelle strofette che rispose: «Ma quale guerra! Se non abbiamo nemmeno un generale che valga una lira!». Cominciò dopo quella degli sbarchi l'era dei reimbarchi. Dapprima venne il turno di Frugoni, l 'esaltatore di Fabio Massimo; poi toccò a Caneva . A cui venne regalato il solito comunicato ricco di lodi sperticate e chiaramente false: «Aveva condotto» si diceva «con felice esito a compimento la prima fase delle operazioni militari in Libia colla effettiva e salda occupazione dell'ampia distesa della cos ta ...». Divenne generale d'esercito, senatore, cavaliere della gran croce dell'ordine militare di Savoia. Tutti sapevano che in realtà era stato liquidato. Provvide Cadorna, che non aveva dimenticato la bocciatura per quelle sfortunate manovre, a tirarg li il calcio maligno: «La campagna di Libia ha prodotto effetti non buoni nella compagine morale dei corpi e non ne ha avvantaggiato la istruzione». La nos tra Africa finì lì per altri vent'anni.

Un vo lto scalpellato nel più duro gran ito del Verbano
Il palazzo della prefettura di Udine fu per tre anni, tra il maggio del 1915 e l'ottobre d el 1917 quando si dovette sgomberare di furia con le baionette tedesche e croate alle calcagna, la capitale d ' Italia . Il colosso, con quell'aria soda che avevano gli edifici pubblici d e ll' Antico Regime che sembravano aver sfidat o i secoli insieme alle idee, era accuratamente isolato con guardie e filo sp inato; mese dopo mese, anno dopo anno, cominciò ad a llargarsi come tocca quasi inevitabilmente a lle regge che dapprima minute dilagano con l a bulimia costruttiva e le esigenze sempre più fastose dei loro padroni. Intendenza amministrazione aerostatica si presero altri edifici usando la comodità e la larghezza consueta a chi sa di essere importante. Tutto suggeriva, al contrario di quanto uno immaginerebbe per un comando militare, l'idea della stabilità, del definitivo, d el p ermanente. Diamine, che non si intrufolasse l'idea che con il mutevole s tato delle operazioni belliche un giorno tutto quel ben di Dio si sarebbe spostato, magari in avanti alle terga delle truppe vittoriose. Quelli erano mll!'i dove la gente era per restarci per sempre. Come se la guerra fosse eterna e immobile, un esercizio biologico che s i ripe te n ella sua perfezione circolare.
A chi entrava in quella Città Proibita, se era un comune mo rtale, toccava subito l ' impressione di valicare la soglia di un ministero o di una cattedra le in convulsione vulcanica, affaccendata nelle s ue sacre funzioni. Tutto era ordinato secondo la ripartiz ione delle burocrazie cementate dal culto della minuziosità: uffici all'infinito, quasi l'anagrafe militare riuscisse ad assorbire tutti i casi della vita, frecce che spingevano diligentemente il visitatore verso il porto impiegatizio pronto ad accoglierlo, piantoni u scieri marescialli a ca terve, a mazzi,
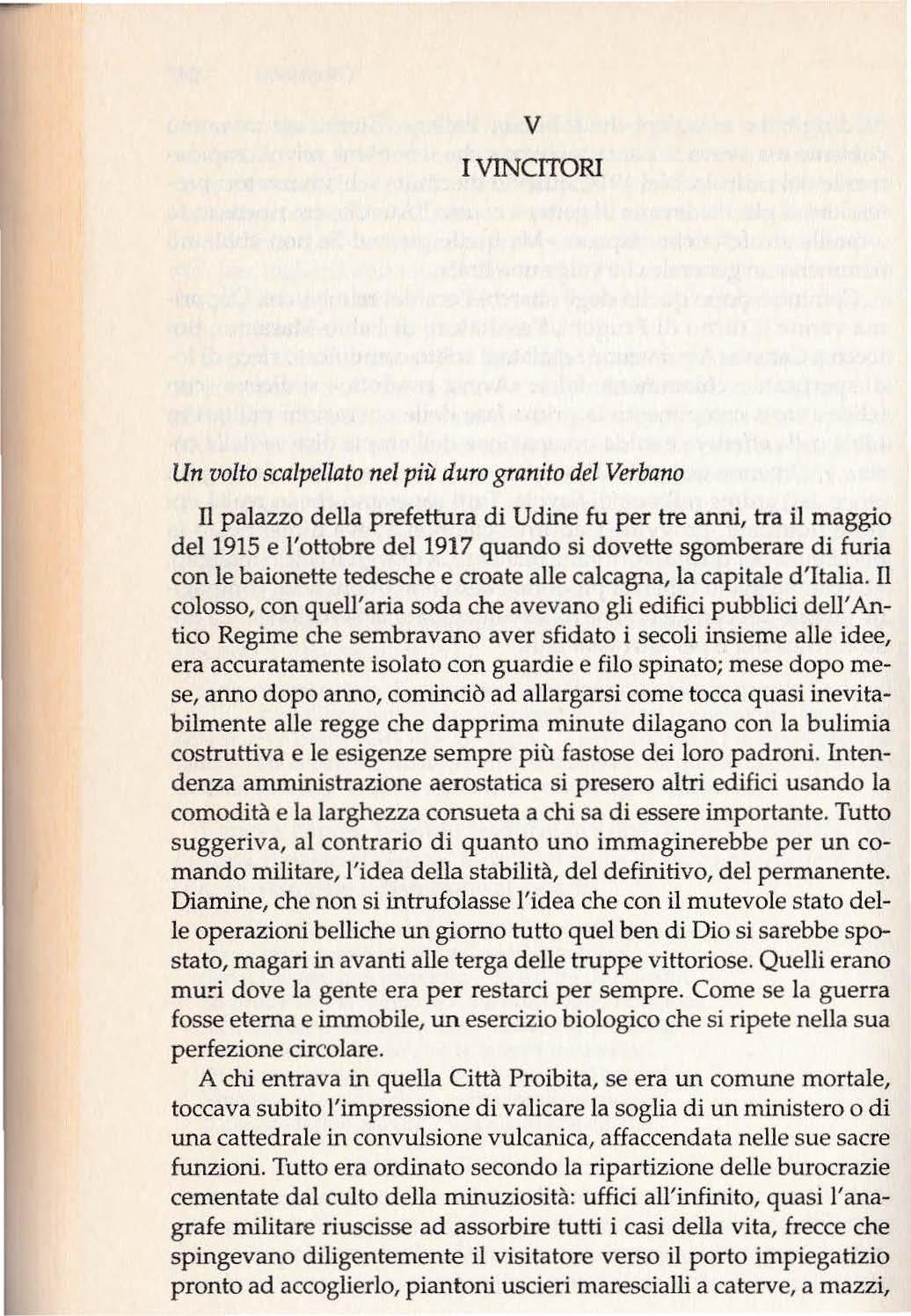
a grappoli, tutti con le loro scrivanie le penne i faldoni le evidenze ben ordinate. Su quel mare in tempesta vegliavano, aggirandosi con un sorriso e un sigaro in mano, i papaveri dello stato maggiore che coltivavano una Weltanschauung di paciosa moderazione sotto i portici freschi o presidiavano le loro poltrone come sentinelle vigilissime. Questo Vaticano militare aveva anche il suo riverito pontefice, il focoso barnabita padre Giovanni Semeria, oratore tribunizio e mangiatore formidabile. Un giorno il frugale Cadoma, impressionato dal monumentale piatto di spaghetti che stava davanti al frate e si preparava a una fulminea capitolazione, scherzosamente gli chiese: «Ma lei, padre, non ha fatto voto di povertà?»; e quello, pronto: «Sì, ma non di miseria». Modernista, erede dell'animoso manipolo di sacerdoti che avevano gettato alle ortiche l'armamentarìo di scomuniche del mondo moderno e della politica, era stato introdotto al comando supremo dalla figlia del generale Carlo Porro che al contrario del padre, un mediocre, era donna impetuosa e di grande carattere. Aveva la sua presenza nella cittadella delle virtù militari sollevato, natura lmente, i sospetti e le paure di laici liberali e massoni che vi intravedevano chissà quali velenose influenze del Vaticano sull'animo del generalissimo, per parte sua cattolico austero e rigoroso. Paure naturalmente spropositate dal momento che l'unico a subirne terribili conseguenze fu il povero frate che di fronte a quel macello smarrì quasi la ragione.
Nella capitale militare d'Italia di cui molti criticarono la posizione periferica, assai distante dal fronte (a Udine proprio per queste ragioni in tempo di pace non era dislocato neppure un comando d ' armata), a poco a poco traslocarono le prerogative del governo di Roma. Tutto ormai partiva e arrivava lì: permessi e ordinazioni g igantesche per l' industria, passaporti e inchieste giudiziarie e di polizia. Le penne fini del giornalismo avevano lascia to i corridoi di Mo ntecitorio come una città morta. Il pigia pigia e la mischia degli interessi politici avevano fatto fagotto. Tutta Italia ogni giorno aspettava con il fiato sospeso il bollettino del comando supremo, unica ve rità declina bile sulle operazioni militari a cui era addetto un ufficio fitto di accorti alchimisti della propaganda. A Udine accorrevano ambasciatori e ministri, uomini di affari e trafficoni, spie e intermedia ri. Le porte si aprivano ai giornalisti ammessi perché giudicati fedeli al verbo de! Capo, in prima fila sempre il direttore del «Corriere», Luigi Albertini, che serviva a Cadoma come messo per dettare la linea all'ormai esautorato governo di Roma. Costretto a occuparsi
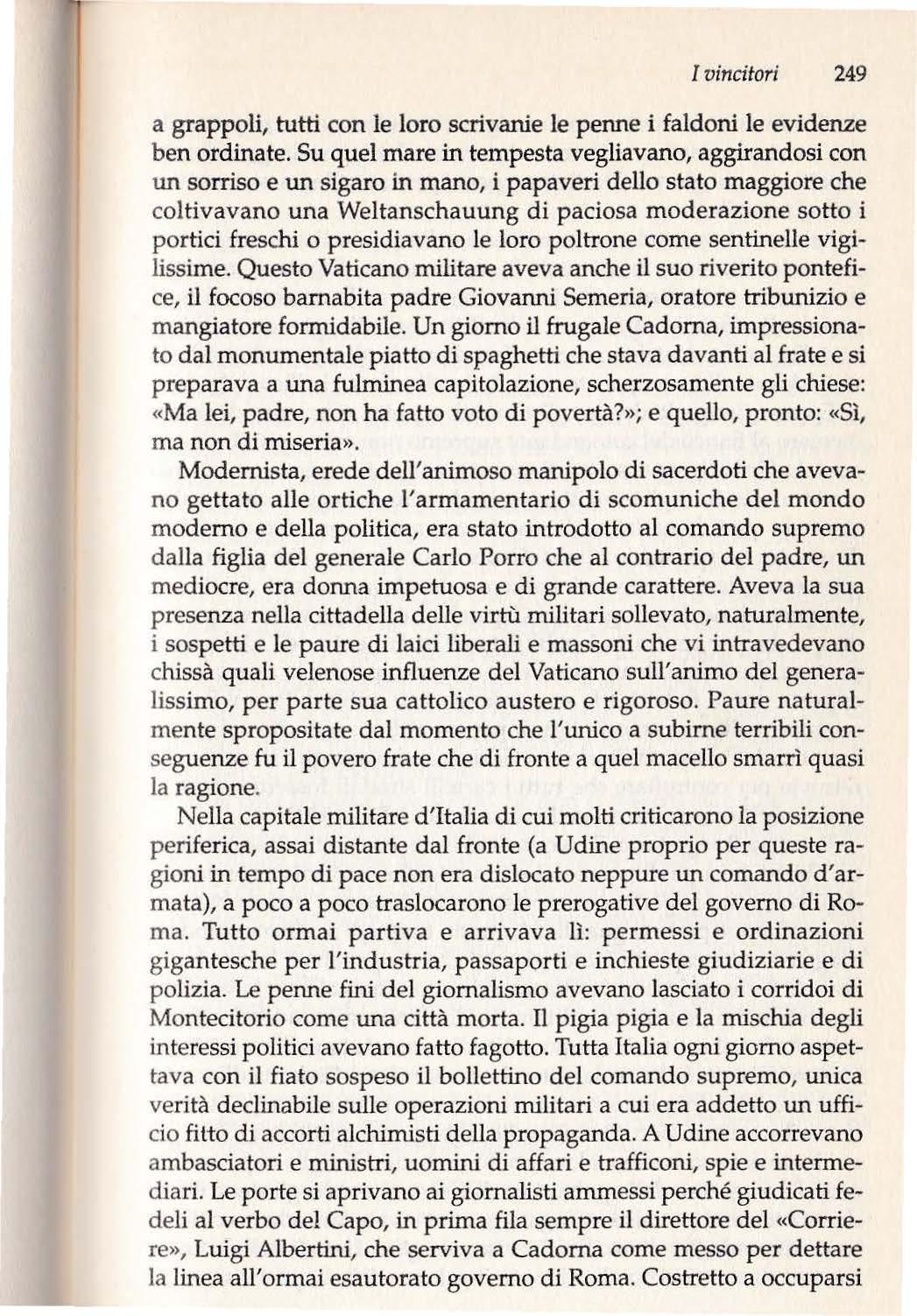
del!'ordinaria amministrazione anche Sal andra, uomo rispettabile ma a cui mancava quella forza interiore che ispira la grandezza, aspettava ogni giorno il bolle ttino per sapere se rallegrarsi o mettersi in gramaglie.
Attorno al comando, come avvien e n elle appendici di regge e caserme, la città si era trasformata in un'immensa sfrigolan te retrovia, in cui orari abitudini e affari erano regolati sulle necessità di quel popolo di ufficiali e attendenti. Gli affitti degli alloggi erano saliti alle stelle, caffè e teatri facevano affari d'oro, le s ignorine di modeste virtù davano il loro ripagato contributo allo sforzo bellico del paese. Eppure, in quell'alveare gli uomini, a poter affermare di essere davvero al fianco del comandan te supremo non erano più di cinqu e o sei. Lui infatti aveva scelto di non avere in anticamera, come ormai era in uso in tutti gli eserciti, un grande stato maggiore che ne alleviasse la quotidiana fatica di mandare avanti un esercito di milioni di u omini e a rimorchio l'Italia. Cadorna non voleva che gli scompigliassero i piani e i pensieri. Parlava e decideva per tutti. Era la sua interpretazione demiurgica del Capo che tutto deve vedere e prevedere e che per contratto è obbliga to all'isolamen to dell'idolo. Sopportava sbuffando il suo vice Porro, ma solo perché lo aveva scelto apposta per la fedeltà e le scarsissime virtù militari. Porro! Soffermiamoci sulla sua sm orta figura per un attimo: uno che nei giorni frenetici dell'attacco vittorioso a Gorizia andava in giro in auto nelle retrovie per controllare che tutti i cartelli stradali fossero a posto e non si verificassero errori nell'indicazione delle località.
Poi c'era il segretario, il colonnello Leone, che non lo lasciò mai, di un'obbedienza pavloviana dal momento che, con misurate parole, definiva il suo superiore «un prisma cristallino che manda bagliori da qualunque parte si guardi». A questo tirapiedi si affiancavano un maggiore e tre capitani molto giovani che sbrigavano il lavoro burocratico. Scrivani insomma. Il comando supremo italiano, la versione nazionale del pensatoio militare di Hindenburg e Ludendorff, era tutto Il . Era il senso di questa solitudine assolu ta ne ll 'autorità che spesso sfumava in testardaggine che consentiva a Cadorna di mantenere la celebre limpida serenità, di dominare le situazioni p iù terribili con il sorriso imperturbabile sulle labbra e che costituiva il lato più evidente del suo fascino. Non tributò un batter di ciglia neppure allo scoppio fragoroso della polveriera di Udine che ebbe gli stessi effetti di un terremoto e mise in fuga a gambe l evate lanzichen ecchi con tanto di medaglia d'oro. E a Treviso, nei giorni mesti della ritirata, mentre gli austriaci bombardavano il palazzo del suo provvisorio co-
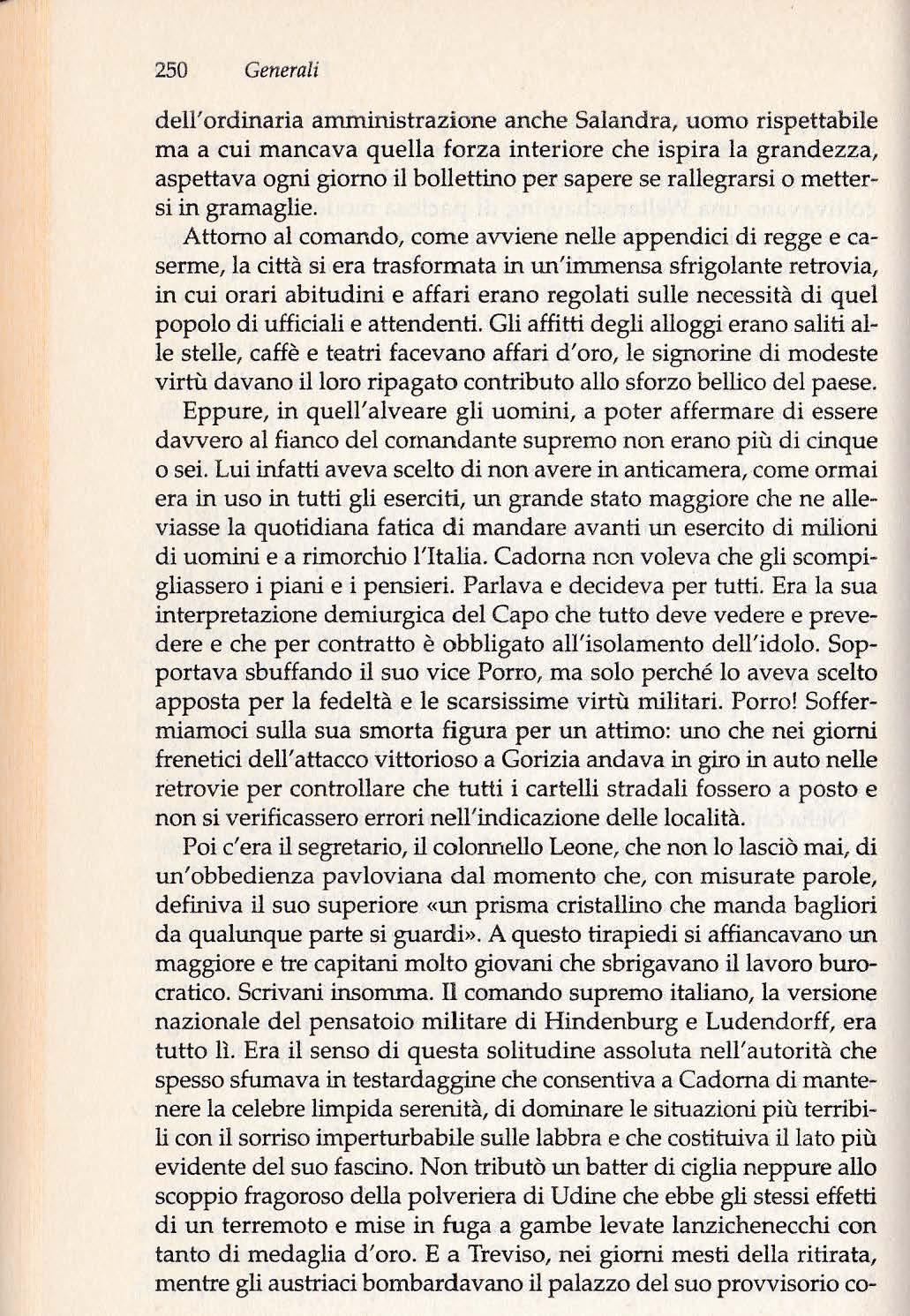
mand o, chiese agli ufficiali che gli stavano intorno di verificare come il s uo cuore non segnasse n eppure un battito in più. Sublime!
Era nato per l ' autorità. Ma purtroppo, come acca d e a tutti i demiurghi, predicava l'immobilità: il rea le doveva m odellarsi su ll o s tampo delle sue idee, pratica che sp esso comporta spiacevoli sorprese. Cadorna per tre armi regnò sul paese come un sovrano assoluto, designando i mmistri della Guerra che trattava come attendenti, organizzando la produzione industri ale e gli approvvigionamenti, licenziando d ecine di generali, trattando direttamente con gli allea ti. Nessun capo militare e n essun p olitico, con l'eccezione di Mussolini, ha m ai avuto in pugno un p o tere così vasto e indiscusso in questa p laga di disobbedienti. Ci and ò bene: er a uno che si acconte ntava de lla sensazione inebriante d el potere. Un altro avrebbe trasformato il paese nella Babilonia di Nabucodonosor.
Accusa to d ai d enigra tori di essere ancora un generale dell'Ottocento, aveva ben compreso ch e il primo vagito della guerra tota le aveva, purtroppo, asso rdato così fragorosamente il proscenio della Storia. E imponeva che tutte le en e rgie del paese venissero sottopos te al contro llo di una volontà ferrea che le incanalasse verso la produzio ne indus triale della v ittoria. La volontà, m eglio ripeterlo per i distratti, era la s u a. E pensare che eravamo entrati in guerra con un mmistro d e lle Finanze che s i affannava a far sì che le spese non superassero il bilancio ordina rio !
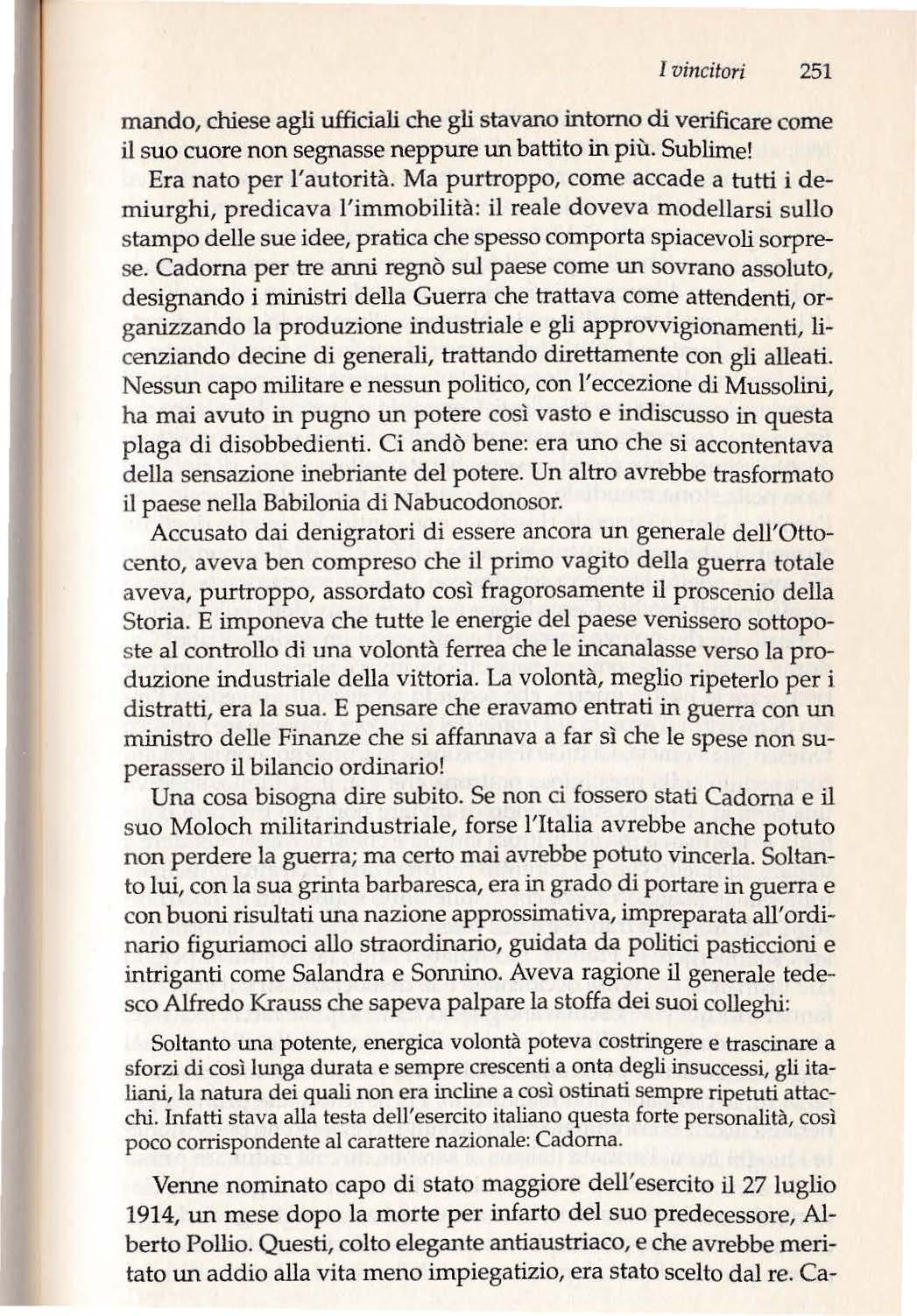
Una cosa bisogna dire s ubito. Se non ci fossero stati Cadoma e il suo Moloch militarindustriale, forse l'Italia avrebbe anch e potuto non perdere la guerra; ma certo mai avrebbe potuto vincerla. Soltanto lui, con la s ua grinta barbaresca, era in grado di portare in guerra e con buo ni risultati una naz ione approssimativa, impreparata all'o rdinario figuriamoci a llo straordinario, guidata da politici pasticcioni e intriganti come Salandra e Sonnino. Aveva ragione il generale tedesco Alfredo Krauss che sapeva palpare la stoffa dei s uoi colleghi:
Soltanto una pote nte, en e rgica volontà poteva costringere e trascinare a s forzi di così lmlga dura ta e sempre crescenti a onta degli insuccessi, g li italiani, la natura dei quali non era incline a così ostinati sempre ripetuti attacchi. Infatti stava a lla tes ta d e ll 'esercito italiano q u esta forte personalità, così poco corrispondente al carattere nazionale: Cadoma .
Venne nominato capo di s ta to maggiore d ell'esercito il 27 luglio 1914, un m ese dopo la morte per infarto del suo predecessore, Alberto Pallio. Questi, colto el egante antiaustriaco, e che av rebbe m eritato un addio alla vita meno impiegatizio, era s tato scelto dal re. Ca-
doma lo pretesero i vertici militari. Scavandosi la fossa . Aveva part ecipato con il padre a lla presa di Roma ma a n essuna campagna colo niale: tutta la s ua esperienza e r a frutto di d ottrina, scartoffie ed esercita z io n i ne ll e gra ndi manovre. Il giorno dopo la nomina, gli scriteriati governanti di Vienna, decisi a imboccare una sanguinosa scorciatoia p er tener e in piedi il traballante impero, consegna rono la dicltiarazione di guerra a lla Serbia accoppando con un pezzo di carta la storia secolare dell'Europa. N essuno allo ra era in grad o di p revedere la durata e l 'entità della catastrofe: m eno di tutti Ca doma, a cui nessuno disse che a Roma s i stava congiurando per evita re di scendere in campo con g li a lleati, Germania e Austria. E pensare ch e fin o a quel mo mento ci avevano consentito, bene o ma le, nonostante costituissimo la più piccola e sgangherata delle p otenze, di ficca re il naso ne lla s t or ia mondiale . C'è d a chied ers i per quale miracolo dell'acustica il gran generale riusciva a n on sentire lo strepi to d egli interventisti che presidiavano le piazze e il falsetto di d'Annunzio ch e g ià aveva ap erto la guerra re torica con «l'austriaca carogna», e aveva afferrato il veccltio Cecco Beppe con le ganasce della sua p oesia. Beato lui che poteva var care il confine con un end ecasillabo! Cadoma, sosp irando come un capoufficio, invece si mise al lavoro p er preparare la nostra guerra, che secondo g li accordi prevedeva l'invio di tre corpi d ' armata s ul fronte d el Reno per appoggiare l'attacco tedesco alla Francia. Ci mise il suo consueto impegno: non si era ancora seduto s ulla prestigiosa p o ltrona che g ià, il 31 luglio, spediva una nota al governo suggerendo di inviare non solo tre corpi d 'arm ata in Germania ma addirittura cinque e che si dovesse « tendere a inviare su quello che nel conflitto rappresenterà il teatro principale tutte quelle maggiori forze che ris ulteranno esuberanti ai nostri bisogni alla fro ntiera francese e nell' interno... ». Insomma, Cadoma voleva sommergere la Francia, incendiare Parigi, fame strazio peggio che Bismarck. La civiltà occidenta le e le d em ocrazie su cui si e ra affannato Tocqueville rischiavano grosso. Chissà quale faccia fece il re, c he s tava dirigendo dietro l e quinte il ribaltone delle alleanze, nel leggere il be llicoso programma del suo capo di sta t o maggiore. Se farsa fu, le comparse n o n mancarono. Poche settimane p rima il gen eral e Zuccari si era china to pensoso sulle rive del Reno per visionar e i luoghi in cui l'armata italiana si sarebbe dovuta radunare prima di azzannare i francesi . E dalla colonia libica un altro generale, Garioni, che evidentemente non ne aveva abbastanza dei guai che gli da va no i ribelli appiccicosi com e mosch e, scriveva ch e tutto era pronto per d are il fatto loro ai francesi della vicina colonia tunisina.
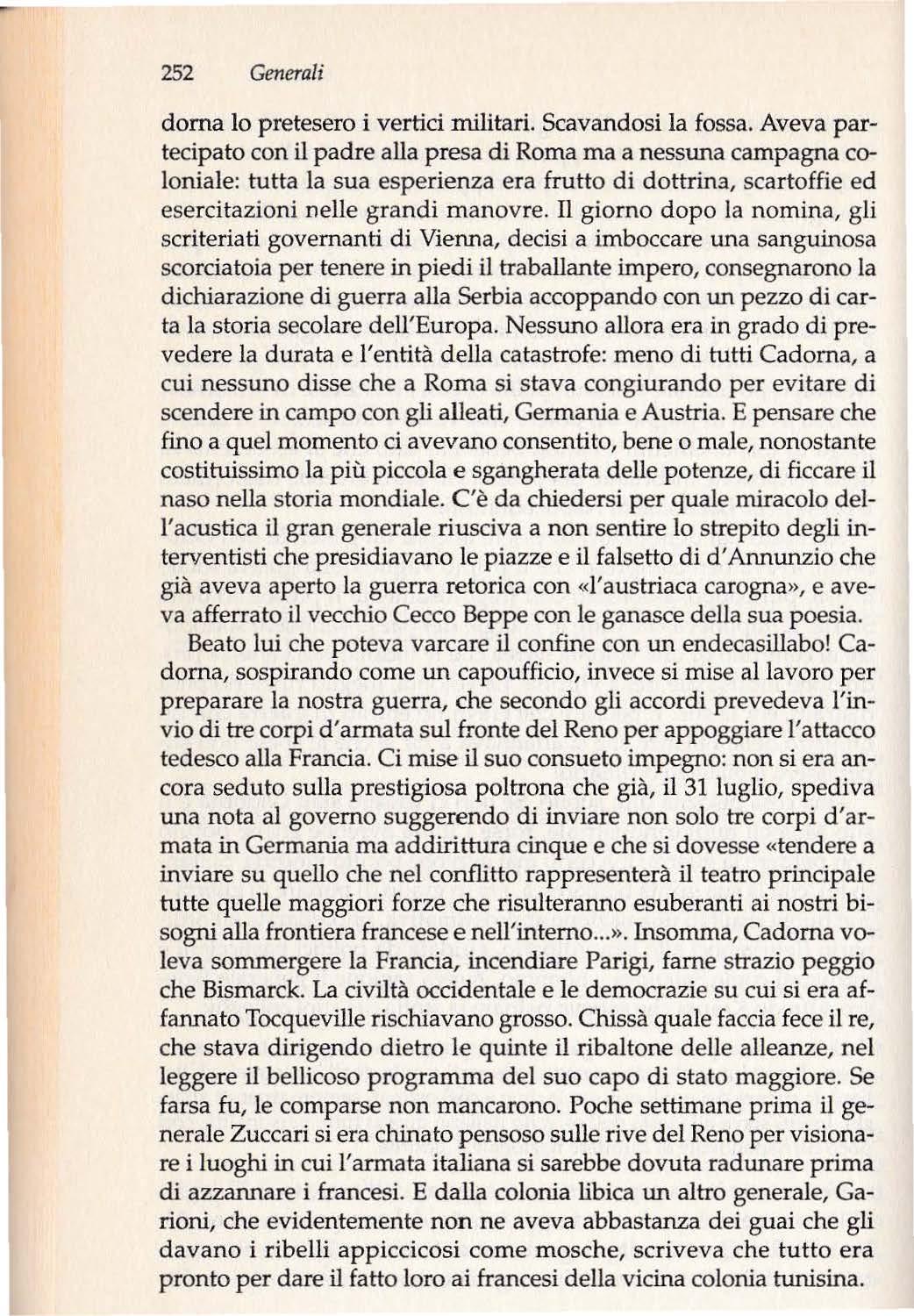
Il carteggio che corse in quei giorni tra Franz Conrad von Héitzendorff e Cadoma appartiene al repertorio grottesco della storia nazionale. L'austriaco, che aveva dolcezze di acciaio, chiese al collega di comunicare benevolmente quali forze destinasse al soccorso del!'Austria-Ungheria «in base agli accordi verbali che aveva già intavolato in via del tutto confidenziale con Sua Eccellenza il generale Pollio, ora defunto». Imbarazzatissimo Cadoma, che intanto aveva scoperto che l'Italia aveva proclamato la neutralità, fu costretto alla machiavellica tattica di guadagnar tempo: «Mi trovo nella impossibilità di rispondere in merito all'argomento di cui Vostra Eccellenza s i compiacque intrattenermi nella pregiatissima lettera sopra citata. Prego quindi» aggiungeva con la cortesia delle persone bene educate «di voler gradire i sensi della mia più alta stima e considerazione mentre mi riaffermo di Vostra Eccellenza devotissimo». Le cannonate alla prossima puntata.
Sembra incredibile, ma non gli dissero nulla neppure del patto di Londra i cui tortuosi accordi prevedevano il bottino (avaro) concesso all'Italia e pure costituivano un elemento non proprio secondario nel fissare i nostri obiettivi di guerra . Sonnino e Salandra erano proprio due mediocri politici che cavalcavano a fatica la rabbia interve ntista di una minoranza sempre più furibonda e invelenita, afflitti da una presunzione e una permalosità non inferiori a quelle del generalissimo. Con l'aggravante che non ne possedevano le qualità.
Adesso la situazione diplomatica si era sgarbugliata. Si faceva sul serio e la parola passava ai guerrieri. Cadoma doveva soltanto riscrivere i piani per disintegrare l'Austria. Era come chiedere a un impresario pronto a mandare in scena il Barbit?re, all'alzar del sipario, di scodellare l'Aida! Ma il suo motto non era forse «con energia e con fede »? Le sorprese non erano ancora finite: oltre a dover cambiare avversario Cadoma scoprì che, al contrario di quanto pensava, non eravamo affatto pronti alla mischia: i magazzini erano vuoti di vestiario e di armi, l'esercito in quegli anni si era trasformato in una retrovia della guerra in Libia che ingoiava miliardi e battaglioni . Le forze militari erano state sciupate ed esaurite. Lui sintetizzava così quella penuria: «La deficienza delle dotazioni normali di mobilitazione, l'assoluta mancanza degli equipaggiamenti invernali, la mancanza di un parco di assedio ... ». Eravamo, insomma, nudi e ben lontani dalla meta.
Basta, non aggiungiamo altro al nostro e suo legittimo sdegno. Per fortuna, viene da dire, si sparava. La grande impresa di Cadoma fu quella di costruire in quei mesi in cui la guerra era già alle costole

della vecchia Europa ma l'Italia restava a guardare, quello che appunto divenne l'esercito di Cadorna . Eppure, nonostante lo sforzo davvero titanico, entrammo in battaglia con trecento mitragliatrici in tutto (il comandante dell'esercito inglese a cui ci eravamo rivolti per una commessa di duecentocinquanta pezzi presso la Maxim rispose che prima di mandare mitragliatrici in Italia voleva essere ben sicuro contro chi avrebbero sparato'), non c'erano bombe a mano, l'artiglieria campale era rachitica per battere un fronte di seicento chilometri e aveva poche munizioni. Lo stesso Cadorna, tratteggiato dagli invidiosi come crudele, pietoso inveì: molti buoni soldati e ufficiali pagarono con la vita restando crocifissi sui reticolati perché non avevamo in magazzino oggetti così semplici e poco costosi come le forbici tagliafili. E da un anno gli eserciti di cinque nazioni erano interrati in trincea!
Con queste premesse non c'è da stupirsi se il generale ebbe con i politici Salandra e Boselli rapporti tesissimi: tanto che al suo colonnello medico Piero Casali confessava con parole asprigne, più con astio che con ironia: «Mi dà meno da fare Boroevic col suo esercito che il nostro governo. Certo è che io mi trovo tra due fuochi». Cadoma, non è un mistero, amava i governi forti, più Crispi di Cavour per intenderci. E con il fascismo si trovò benissimo e non soltanto perché Mussolini gli regalò la riabilitazione. Ma una volta che il cannone aveva tuonato, per lui il governo doveva tacere e inabissarsi nelle retrovie pronto solo a dire sì a tutte le necessità belliche. La sua bestia nera erano i consigli di guerra dove i politicanti, pantofolai infingardi e subdoli, si immischiavano nelle faccende militari, pensavano di poter dire la loro. In tre anni non ne concesse neppure una di queste passerelle; e anche a quella che gli costò il posto, a Rapallo, dove c' erano i vertici militari alleati, a cui si dovette rassegnare visto che era uno sconfitto, preferl non partecipare. Basta un esempio per tutti di come sapesse tenere al guinzaglio i ficcanaso di Roma. Il 24 maggio 1916 Salandra, di fronte alla situazione grave- gli austriaci dilagavano nel Trentino impegnati con entusiasmo ditirambico a punirci per lo sfacciato «tradimento» - gli chiese di organizzare, a Padova, un consiglio con i quattro comandanti di armata, il suo vice Porro, i due ministri militari e due deleg ati del Cons iglio dei minis tri «per esaminare a fondo s otto ogni aspetto la situazione militare onde il governo potesse farne base delle sue successive deliberazioni e assumere la responsabilità che gli spettava di fronte al Parlamento e al paese». Cadoma rispose così:

I consigli di guerra nelle circostanze difficili non servono colla diversità d ei pareri che creano le incertezze, dividono le responsabilità e inducono a temporeggiare mentre si riclùede fulminea la decisione. Finché avrò l'onore di godere della fiducia di Sua Maestà il Re e del governo la responsabilità è mia e l'assumo interamente.
Se proprio i ministri avevano bisogno di informazione, aggiungev a ironico il generale, oltre al quotidiano bollettino, potevano venire nella sua residenza privata a Villa Camerini presso Vicenza e avrebbero amabilmente conversato.
Ammettiamolo: il governo politico lasciò troppo potere al Cadorna, tanto che s i è parlato di un'autentica «infatuazione», fino ad ass umere i contorni di una rinuncia ai propri poteri. La guerra venne appaltata a quell ' uomo con il ghiaccio nell'anima, per di più prima che il generale avesse compiuto gesta m e morabili. Ancor più cattivo su questa dittatura fu Caviglia:
Nessun comando supremo dalla parte dell'Intesa ebbe la libertà di azione accordata dal governo italiano a Cadoma. Questo merito non si può negare ai capi del governo nostro come non si può negare che essi abbiano spremuto dal nostro paese tutte le risorse in uo mini e mezzi materiali. Erano diventati i furieri infaticabili e obbedienti di quella fabbrica di morte a ciclo continuo. Fu l'arrendevolezza dei politici a indurre il generale a occuparsi di materie che esulavano dai suoi compiti, a dettare lezioni anche in tema di politica interna e disciplina delle masse. Siamo qui giunti ai famosi quattro documenti contro il disfattismo che scrisse nel fatidico 1917 e a cui il governo non rispose. Formeranno il nucleo d ella teoria sullo «sciopero militare» con cui volle, non senza fondamento ma con eccessiva assolutezza, mettersi al riparo dal disastro che aveva combinato. Documenti in cui attaccava «l' opera n efasta che il partito socialista sta compiendo a danno dell'esercito e della patria», dove bollava con parole che il governo non avrebbe dovuto tollerare le scelte dell' esecutivo: «debbo dire che il governo italiano sta facendo una politica interna rovinosa per la disciplina e per il morale dell' esercito, contro la quale è mio stretto dovere di protestare con tutte le forze dell ' animo», proponeva, con esempi per di più, («la rivolta della brigata... è stata sanguinosamente repressa con la fucilazione sommaria di 28 militari e con la denuncia di altri 123 al tribunale di guerra») le draconiane misure per ristabilire il morale del fronte interno. Cadorna voleva trasformare l'Italia intera in una caserma, il paese era in preda a una lasciva pigrizia . E allora, ruggiva, sospendiamo la vita normale per rimaneggiarla ai fini della Vittoria, as surta ormai a categoria metafisica.

Diciamoci la verità: l'uomo faceva paura, aveva qualcosa di torbido nello sguardo, una sorta di vibrazione fredda che incuteva timore, instillava in chi lo incontrava quella reverenza che promana dalle personalità più forti. Era, forse, un timido ma anche un alchimista del materiale umano capace di nascondere la propria debolezza e di sedurre anche gli uomini dalle menti più acu te e più dure. Metteva la tremarella anche agli altri generali che si comportavano come scolaretti di fronte al maestro. Non avevano torto a temere: dei quattro comandanti di armata con cui iniziammo la guerra, Brusati Frugoni Zuccari e Nava, tutti considerati strateghi di genio e scrittori militari citatissimi, non se ne salvò nessuno, bocciati agli esami del maestro severissimo, defunti amministrativamente al servizio della patria. Un centinaio di generali e colonnelli caddero sotto il fuoco implacabile dei siluramenti di Cadorna.
Non sorprende allora che un generale di corpo d'armata, Ruggeri Laderchi, nel 1916 proclamasse davanti ai suoi ufficiali che se avesse ricevuto da Cadorna l ' ordine di piantare un chiodo nel muro e non avesse avuto il martello avrebbe utilizzato pur di obbedire anche l'orologio!

Al comando supremo nell'ufficio personale era appeso un enorme tabellone che costituiva lo spaur acchio di tutti i comandanti. I nomi dei generali e dei colonnelli infatti risultavano scritti a matita perché, come spiegava il burbero capoufficio gestore d i quella ufficialesca anagrafe, si cancellavano facilmente e si evitava di dover rifare, quasi ogni giorno visto qual era il movimento frenetico dei «siluri», il tabellone.
Cadorna è passato alla Storia patria come l'esempio del militare non inceppato da sentimenti morali, uno con il volto di quei re assiri scolpiti nei bassorilievi per cui i soldati altro non erano che carne da cannone da gettare nella fornace della guerra. È vero o no che questo Moloch li stimava numeri che la sua gloria implacabile inghiottiva senza sosta? Era o non era l'uomo delle spallate ostinate inutili sanguinose contro le gobbe del Carso il quale combatteva una guerra che era la ricapitolazione del passato? Il ritratto contiene ahimè alcuni e lementi di verità. Per lui in fondo il popolo italiano non esisteva, era riassunto e comp letato nelle armate che gli erano state affidate per vincere la guerra, non lo conosceva . Era una psicologia e una cultura che esaurivano l'umano e il divino nell'orizzonte militare (anche se Cadorna era personalmente uomo colto e di vasti interessi per es empio in campo artistico): questo era il limite, pericoloso e decisiv o, della sua personalità.
Aveva avuto a disposizione quasi un anno per scrutare le caratteristiche della guerra nuova, l'emergere delle trincee, della forza micidiale dell'artiglieria, della difficoltà di svolgere quella manovra di prepotenza tutta napoleonica che era l'abbecedario di ogni generale. Non valeva per lui, insomma, la giustificazione, che potevano accampare gli altri condottieri, di essere fuùti sotto il tiro del cannone con i concetti ereditati dai padri e dai nonni. «Non combattiamo da quarant'anni» strepitavano Conrad, Moltke il piccolo e Joffre, «come pensate potessimo aggiornarci?» A Cadoma bastava scomodarsi a s pinger lo sguardo oltre le Alpi per trovare le novità. Invece i suoi piani fluttuavano in un limbo di irrealtà, incapaci di scuotersi dal cuore le ceneri della nostalgia. Aveva a disposizione in tutto trenta chilometri di pianura e un impressionante paesaggio di alture selvatiche: escogitò un piano di guerra che prevedeva in tre mesi di essere a Vienna, e dove alla cavalleria era assegnato il compito di risalire a l galoppo la valle della Drava per sciabolare gli austriaci già scompigliati dal primo urto. Il suo piano di battaglia era ricalcato, con la carta carbone, su quello del Primo Console di un secolo prima: Napoleone aveva scritto che il Trentino, anzi il Trrolo del Sud, era troppo aspro e ingobbito per consentire un attacco. Bene: Cadorna lo cancellò dalla carta geografica nonostante la via più corta per Vienna pass asse di lì e continuò impavido, per tre anni, a guardare ai lontanissimi irraggiungibili obiettivi di Trieste. «Fin qui arrivò mio padre» aveva detto a una delegazione della sua città venuta a rendergli omaggio nei primi mesi di guerra, indicando l'Isonzo «e io devo arrivare fin qui», segnando un arco che partiva da Trento e g iungeva a Trieste.
Le incertezze, le meschine furbizie dei politici ci portarono in guerra nel momento sbagliato. E pensare che la scelta dell'ora è la prerogativa dei traditori. Gli Imperi Centrali, infatti, nel maggio del 1915 trionfavano: la pestifera Serbia sparita di scena, i russi massacrati che cominciavano a contare i morti a milioni e a mugugnare, gli inglesi, perfino gli inglesi, umiliati a Gallipoli e bastonati nell'Artois. Non era difficile capire che con quell'alleato di granito che era il Carso l'esercito della duplice monarchia sarebbe stato in grado di o pporre una resistenza fanatica. Niente affatto: per lui era sempre un'armata debolissima che un semplice tocco poteva far crollare. L'abc tattico di Cadoma era la famosa «Libretta rossa», un volumetto scritto da lui anni prima e che il Pollio aveva duramente stroncato, dal titolo Attacco frontale e ammaestramento tattico . Se pensate che i libri in fondo non uccidono chied e te a seicentomila cristiani che,
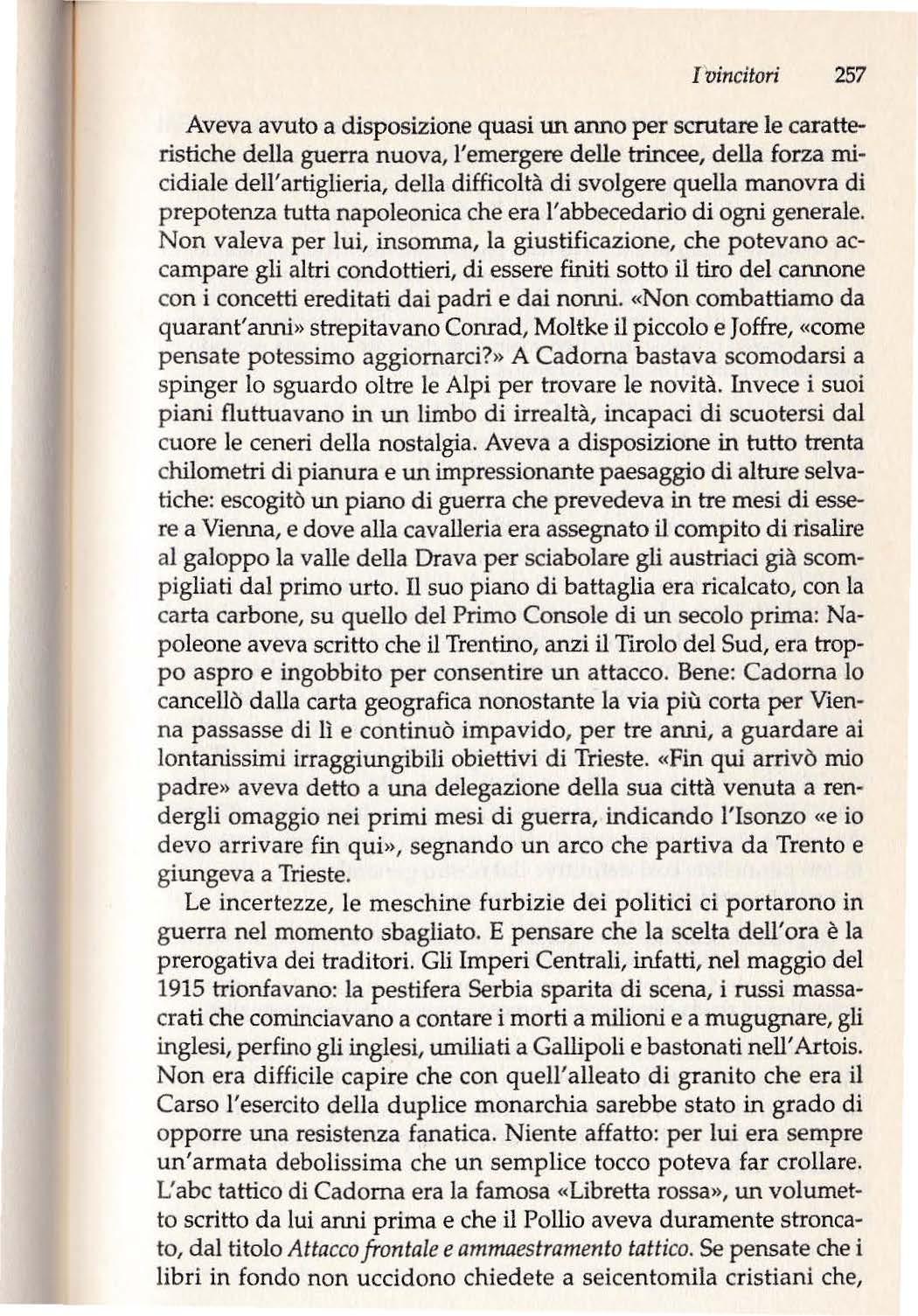
n o n avendone m ai letto una riga, pagarono lo stesso con la vita. Sul frontespizio, «Attacco frontale» e ra scritto a caratteri cubitali e per tutti fu noto con questo nome, distribuito per volontà del co mandante in migliaia di esemplari con l 'ordine perentorio:
Esso d eve al più presto diventare patrimonio intellettuale comune dei nos tri quadri . Tutte le manovre dovranno essere svolte d'ora in poi secondo i p recetti in esso contenuti; tutto ciò che nei vari regolamenti tattici fosse per contrastare a quanto è de tto nel p resente fa scicolo deve intendersi per abrogato. lo stesso mi assicurerò p ersonalme nte che tutto p roceda secondo gli intendimenti sin qui espressi. Firmato Cadoma.
Era il Talmud, la Bibbia, il Corano, il libretto cli Mao. Il culto della per sonalità accudito dai p lotoni di esecuzione.
La dottrina scritta con questo pennino di acciaio forse sarebbe stata eccellente, anche se zavorrata dal solito difetto cadontiano d ell'assolutistico e d e l semp lificatorio, nel 1885 q u ando l ' a ve va pubblicata per la prima volta. In q u e i trent'anni e rano sopravvenute inezie come il fucile a tiro rapido, nuovi micidiali tipi di cannone con calibri degni cli Polifemo, le mitrag liatrici, i mezzi m eccanici, i reticola ti, gli aerei. Insomma, il m o ndo mod e rno e l 'indu stria si erano sbizzarriti a complicare i metodi per scannarsi s ul campo di battag lia. Ma non bastava : la guerra del 1870 tra Francia e Prussia, saccheggiata per cos truire lo schema d e ll'opera, era sfumata nel ricordo senza che il mondo app re ndesse l'arte di stare in pace. Si e rano aggiunti all' elenco della ferocia umana altri conflitti, da que llo russo-giapponese a quelli b a lcanici, p e r non contare g li scontri coloniali e quelli n e lle Americhe che avevano complicato n on poco il p aesaggio tratteggiato con pennellate così definitive dal nos tro generale . Lui, a l contrario, di U non si era mosso:
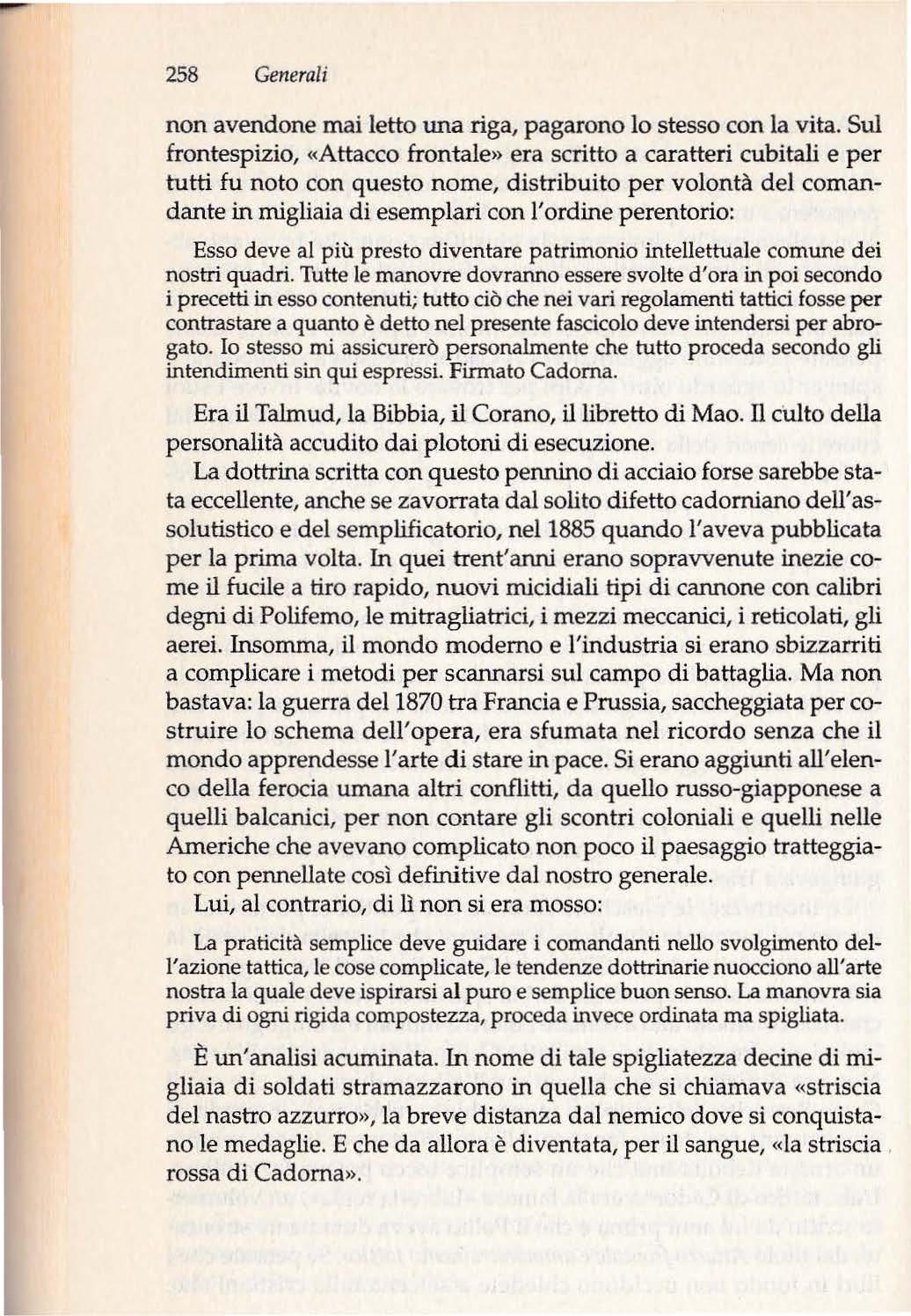
La praticità semplice d eve guidare i comandanti nello svolgimento dell'azione ta ttica, le cose complicate, le tendenze dottrinarie nuocciono all'arte nostra la quale deve ispirarsi al puro e semplice buon senso. La manovra sia priva di ogni rigida compostezza, proceda invece ordinata ma spigliata.
È un'analisi acuminata. In n ome di tale spigliatezza d ecine di mig liaia di sold ati stramazzarono in quella che s i chiamava «striscia del nastro azzurro», la breve dis t anza dal nemico d ove si conquistan o le medaglie. E che da allora è diventata, per il san gue, «la striscia . rossa di Cadoma».
All'alba del 23 ottobre 1918 un u omo alto che il pastrano militare rendeva ancor più massiccio scrutava immobile, quasi confuso con la roccia grigia d el monte, le rive d el Piave già rimaneggiato a liquida leggenda. Le alture p a reva n o generare nuvole e n ebbia a getto continuo. Il cielo p lumbeo, l'acqua che cadeva fastidiosa, gli antri in cui si annidavano pauros i o inferociti migliaia di uomini, davano un'uggia, un senso di sospensione sgomenta. Il paesaggio della battaglia sembrava il n egativo di una fotografia, tutto bianco grigio e nero. Tra le colline z uppe la striscia del fiume con i s uoi isoloni punteggiati di vegetazione quas i sommersi, ostaggio d ell 'acqua che s i era annessa bancal e di riva e di campi, la intraved evi appena, ti guidava m eglio la sua voce for te per il gorgogliar e rombante della piena . I t empi son p assa ti, la leggenda si è ap pannata, o ra possiamo dirlo: il Piave er a proprio un postaccio. Si capiva che l' uomo a lto, circondato da a ltri ufficiali che gli erano per l'ossequio d ei gesti sottoposti, con un bastone si sforzava di decifrare oltre il corso d'acqua le alture di San Salvatore. Tutto in lui er a lento, quasi felino: passo, modo di esprimersi, gesto . Intuivi uno di quegli insoppor tabili che conservano il sangu e freddo n el momento in cui tutti s i lasciano trascinare dalle e mozioni. Sapeva bene, perché l'aveva scrutata mille volte, che dopo essere s tato schiacciato dalle montagne, oltre l'ansa che compie t ra le due rive, il Piave sguscia v ia come un rettile pigro. I s ud ari di nebbia fanno sembrare minacciose e misteriose p ersino quelle umili gobbe di pietra che stanno di fronte. Il paesaggio s i divide in que l punto di osservazi one: d a una parte la lunga sclùena dei monti die tro cui il Piave definitivamente si n ascond e e d all'altra, a destra, ampia, morbida di campi e villaggi, l a pian ura che si avanza placida d a Conegliano a Vittorio Veneto.
Gli austriaci stavano trincerati tra il piano e il monte da quando si era esaurita, per fortun a nostra, l'ultima p agina di Caporetto. Da allora grandi masse di arma ti avevano piantato radici sempre più profonde le une di fronte alle a ltre e si s tudiavano e si tastavano in brevi assal ti . Fallita l'offe n siva per sca rdinare le linee italiane, il grande impero moren t e si era acqu a ttato ascoltando preoccupato il battito del suo cu o re esa us to ch e cominciava a ritmare sempre più flebilme nte. Se ne erano andati gli arroganti reggimenti te d eschi con l e loro nuove tattiche di g u erra che ci a veva no fatto tanti g ua s ti. Avevano tirato un sospiro di sollievo anche g li austriaci che si ved e-
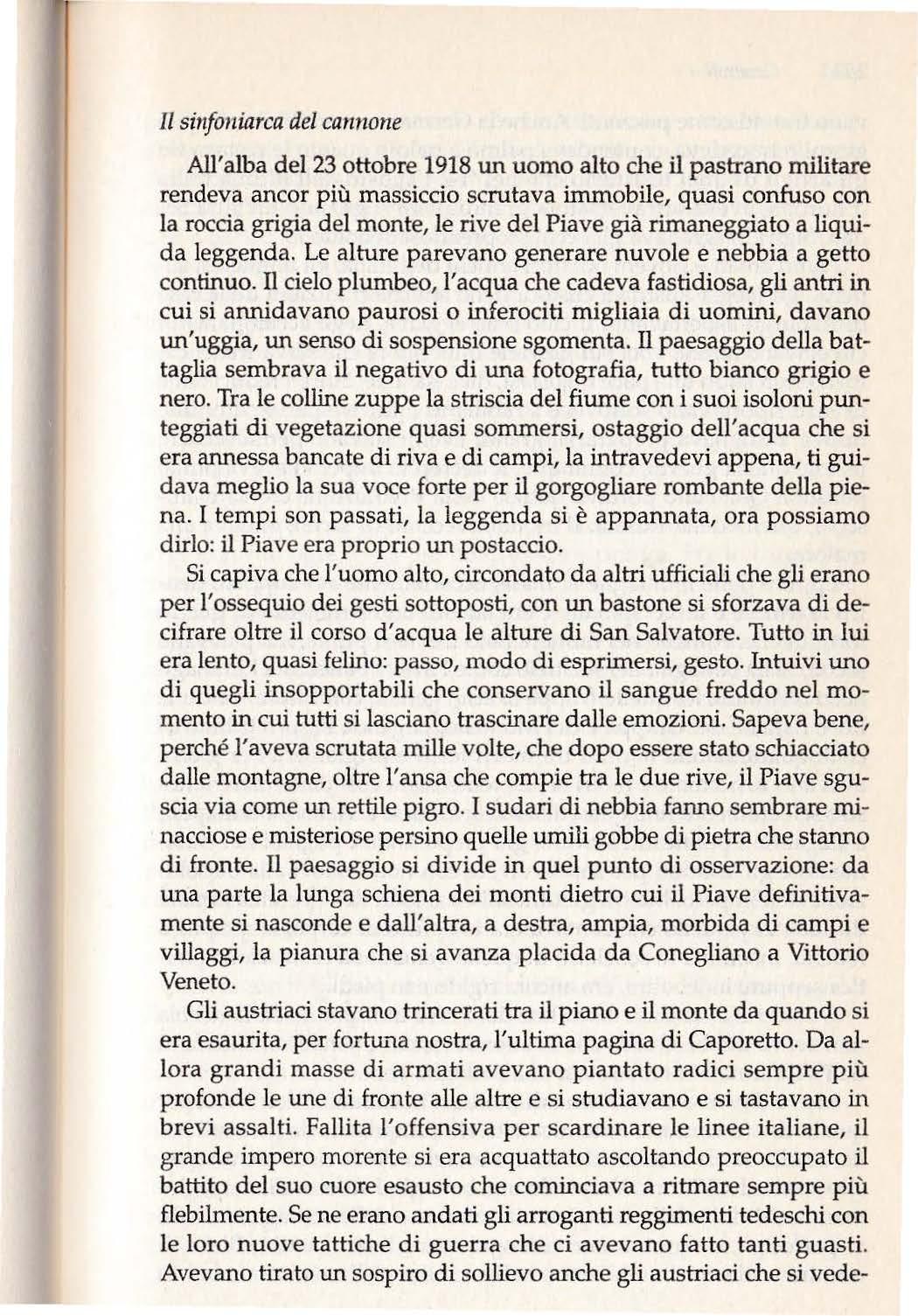
vano trattati come pezzenti . Anche la Germania, incredibile!, in quei giorni retrocedeva, contendeva palmo a palmo quanto le restava tra gli artigli di quel territorio che nel '14, l'agosto dell ' ultima follia d'Europa, aveva attraversato a grandi passi sognando un'altra Sedan. Sigfrido sgranava gli occhi scoprendosi deboluccio.
I fanti croati e sloveni odiatori antichi dell'Italia, gli ungheresi superbi, gli Jaeger austriaci custodi delle antiche tradizioni della casa di Asburgo aspettavano. Il cibo scarseggiava, negli accampamenti circolavano strane voci sul giovane imperatore che stava freneticamente cercando una pace qualsiasi, da casa le reclute e i reduci dalle licenze riportavano sottovoce strabilianti e furtive parole d 'ordine nuove: bisognava prepararsi, grandi eventi stavano per succedere perché quella guerra, comunque, il decrepito impero l'aveva ormai perduta. Qualcuno portava notizie della Rivoluzione con la maiuscola, quella della Russia. Il mondo, vecchio di secoli, andava alla malora.
Eppure dalle montagne al mare, accortamente avviluppato dentro le trincee e il filo spinato, c'era ancora uno s trumento di guerra formidabile. Almeno nei numeri. Solo tre mesi prima, ma parevano secoli, nella battaglia del solstizio come l'aveva battezzata l'immaginoso d'Annunzio, quelle truppe s i eran gettate con furore contro le linee italiane del Grappa e del Montello, pagando l'aspro tributo di centoquarantamila uomini tra morti feriti e prigionieri. Per giorni avevano rosicchiato i metri senza tentennare così da tendere il nostro schieramento fino quasi alla rottura . Forse a Vienna, a Budapes t, a Zagabria i politicanti stavano già preparando i pugnali del tradimento e gli antidoti per sopravvivere con nomi nuo vi alla dissoluzione dell'impero. Ma tra gli ufficiali e i soldati della vecchia armata di Radetzky quello che contava era lo spirito di corpo, la reciproca fedeltà . Insomma lo scheletro di quella veneranda costruzione politica seppure indebolito, era ancora rigido e in piedi.
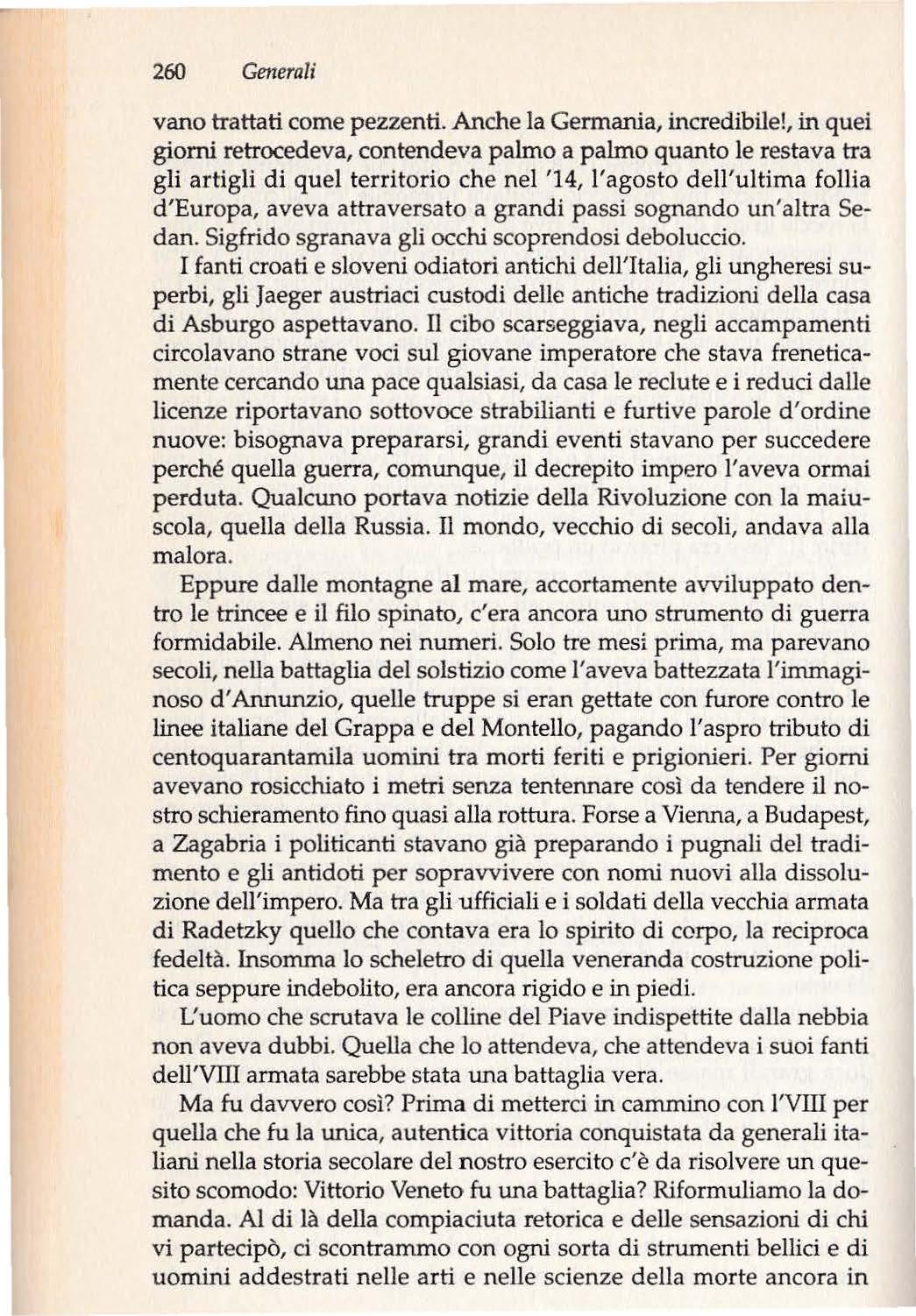
L'uomo che scrutava le colline del Piave indispettite dalla nebbia non aveva dubbi. Quella che lo attendeva, che attendeva i suoi fanti dell'VIIl armata sarebbe stata una battaglia vera.
Ma fu davvero così? Prima di metterci in cammino con l' VIIl per quella che fu la unica , autentica vittoria conquistata da generali italiani nella storia secolare del nostro esercito c'è da risolvere un quesito scomodo: Vittorio Veneto fu una battaglia? Riformuliamo la domanda. Al di là della compiaciuta retorica e delle sensazioni di chi vi partecipò, ci scontrammo con ogni sorta di strumenti bellici e di uomini addestrati nelle arti e nelle scienze della morte ancora in
grado di combattere o soltanto con un organismo esausto, minato dalla tentazione di arrendersi, immelanconito dalla constatazione che la causa fosse ormai perduta? Certo è che avevamo di fronte un esercito affamato. Nei tre mesi che precedettero la zuffa finale i soldati austriaci avevano trovato nelle gavette pane, legumi e caffè di cattiva qualità. E null'altro. Dimenticati carne o grassi: esaurito il bottino di Caporetto, svuotati i nostri magazzini che avevamo per la fretta di sgomberare il passo lasciato sciaguratamente ricolmi, l'unpero non era stato più in grado di rifornirli. Intere regioni come le bisbetiche province slave e la Romania asburgica scrollarono le spalle e fecero le avare, spedendo solo quantitativi minimi di derrate: anche i civili ormai ruminavano il famigerato pane K in cui la farina era, appunto, una infarinatura. Commercianti senza scrupoli che fiutavano vicina la fine della cuccagna imboscavano e rivendevano a caro prezzo il grano a una struttura statale che sembrava aver esaurito ogni forza per controllare e punire. Fra le truppe la mancanza di cibo scatenò lo spirito di rivolta e interi reggimenti si assentavano dalla pruna linea per dedicarsi a razzie nelle retrovie. Reggunenti ungheresi, già tradizionalmente riottosi, avevano organizzato sistemi di rifornunento paralleli e spesso un pochino criminali. Ma nonostante questo, il peso medio dei soldati nei reggunenti Honved non superava i cinquanta chili! Era unpalpabile, longilinea l'ultima armata della duplice monarchia: non c'erano obesi, nessuno marcava visita per indigestione. Per infiammare i soldati nell'ultima offensiva si erano lanciati proclami pantagruelici, in cui si promettevano decorazioni di vino e prosciutti; i comandi avevano predisposto squadre di requisizione dotate di appetiti formidabili che dovevano ripulire magazzini fattorie e negozi dei borghi e delle città conquistate. E nessuna pietà per i maledetti e grassi italiani, raccomandavano i marescialli.
Non erano migliori le condizioni delle uniformi. Non c'erano più ricambi, i soldati erano avvolti di stracci che cadevano a pezzi; si vedevano sentinelle coperte pudicamente solo dalla mantellina mentre s ul fronte montano non si distribuirono più le divise invernali. Affamati, stracciati, gli austriaci erano quasi immobili. I cavalli, che cos tituivano la forza motrice dell'esercito, erano ridotti a metà e il Parlamento, triste segno dei tempi nuovi, aveva rifiutato di concedere il foraggio . La cavalleria ormai era appiedata, ulani e dragoni avevano buttato via gli stivali per andare in ciabatte (alcuni reparti demoralizzati saranno i primi a sfasciarsi sul Piave) e peggio ancora l'artig lieria era runasta senza traini per i carichi di munizioni. Restavano

mobili solo i pezzi, ma sulla carta: c'erano batterie con al massimo cinque cavalli e in qualche caso addirittura con uno solo. Queste miserie che, bisogna d irlo a merito di ufficiali e gen erali di quell'esercito, avrebbero ammutolito anche il coraggio degli spartani, tenevano mano alla spessa ragnatela delle voci che costituiva il vero sabotag· gio s trategico. Nel composito mosaico di truppe e di popoli che rappresentava nelle trincee la sbiadita, opaca e declinante Austria, Radio fante riscriveva ogni giorno a s uo comodo la storia: s i assicurava che in Boemia era stata proclamata la repubblica, ma no! sciocchezze; era l'Ungheria che si era separata dall'Austria. Burle' La vera notizia veniva da Vienna: l'imperatore aveva accettato il piano di Wùson che era una specie di testamento funebre dell'Austria e stava per firmare la resa. Tutti i mormorii eran d'accordo su una cosa: ovunque stava maturando la rivoluzione. Parola magnifica, rivoluzione. Ognuno ci mette dentro quello che vuole. I comandi erano alla disperazione. Le licenze erano state sospese e la posta bloccata per arginare la marea della chiacchiera che scalpellava giorno per giorno la fiducia . Ma ungheresi slavi cechi erano a conoscenza che nei rispettivi paesi si stava preparando la resa dei conti. Sembrava stupido farsi ammazzare proprio allora per un imperatore licenziato dall a Storia.
Eppure i rapporti che gli ufficiali di collegamento delle armate del Tirolo e del Piave, guidate dalle due vanitose primedonne Conrad e Boroevic (si odiavano come tra stelle dell'Opera), pur non nascondendo la difficile realtà, ancora ai primi di ottobre erano ottimistici:

L'armata è rimasta sinora solida nel morale e continuerà a esserlo se verrarmo migliorate le condizioni materiali e s i provvederà a ristabilire l 'ordine nel paese ... sono convinto che l 'esercito continuerà a combattere nudo e affamato, purché abbia la sensazione, confermata da fatti concreti, d i non rapp resentare un peso inutile per l ' ordinamento statale e per il proprio popolo.
Spun tava il vecchio orgoglio degli ufficiali imperiali che neppure gli eventi avevano spiegazzato per aver creato in quel guazzabuglio medievale una struttura più forte delle gelosie tra i popoli che obbedivano agli Asburgo e che trovava all'in terno di se stesso, nel forte spiri to di corpo, nella disciplina e nelle tradizioni, motivi di coesione solidissimi. Ma era l' ultima vo lta che la ragione si arrendeva alle emozioni e che questi, votati a una sorta di Graal personale, compivano il miracolo. I sol dati e gli ufficiali si rendevano conto che stavano combattendo per qualcosa ch e in realtà non esisteva più. La guerra è un campo semantico minato in cui basta sbagliare nell'ap·
poggiare un piede per saltare in aria . La parola te rribile e ra stata pronunciata, il mondo era cambiato e non si poteva più tornare ind ie tro.
Il 23 ottobre, mentre gli italiani avevano ormai calzato l 'elmetto, Boroevic avvertì il comando generale che i reparti d elle varie nazionalità non volevano più combattere in Italia ma solo n elle rispe ttive patrie che rischiavano l ' invasione. Compa gnie inte re, rume ne, ung heresi si allontanavano e c'era bisogno di piazzare mitragliatrici e plotoni tedeschi per ferm arle. Era lo sciopero d e i soldati, qualcuno che aveva combattuto s ul fronte russo, inorridito, v ide già il modello leninis ta con i solda ti che gettavano i fucili e m a rciavano s ul Palazzo d i Vienna. Le agitazioni e i tumulti raggiunsero anche i repa rti di prima linea considerati più battaglieri e determinati. Il proclama ai soldati che l'imperatore Carlo, uno sventato, un vanesio com e tutti coloro a c ui tocca di svendere patrimoni s t orici ingombrantissimi, aveva lancia to proprio quel giorno nonostante i consigli contrari dei generali, e ra stato letto da molti come il testamento della monarchia e il riconoscimento ufficia le ch e la guerra o rmai era finita. Difficile dar loro torto:

Soldati, si avvicina il giorno della pace e del ritorno a lle vos tre case. I compiti che dovre te ancora assolvere s ino a que l m o mento sono particolarmente difficili, le vostre virtù militari e lo spirito di sacrificio p ossono decidere oggi pi ù che mai del futuro di tutti i popoli della Monarchia senza eccezioni e distinzioni ... Viviamo in un periodo di g rav i turbamenti, ma questi n on si devono estendere all'esercito e alla flotta. I vos tri doveri sono chiari e semplici come il g iura mento che avete p restato all'Onnipotente.
Avevano ragione i vecchi bronto loni: l 'ultimo Asburgo era s ta to l' antipaticissimo Francesco Ferdinando, ottuso e d eterminato come un sergente maggiore. Lo studen te serbo aveva capito tutto que l giorno a Sarajevo!
Tutti sap evano che il giovane impe ratore aveva malaccortamente già preso contatto con g li alleati e chiesto al papa di suggerire agli italiani di non attaccare per evitare una strage inutile vis to che la pace ormai e ra vicina . Il fatto che migliaia di soldati abbiano n onostante tutto accetta t o di uscire dalle trincee e fars i ammazzare è una cosa che trascende la nostra allenata immaginazione. Dobbiamo dirlo: era l 'odio e il disprezzo per gli italiani che riuniva in un unico affeziona t o partito g li umori di s lavi e austriaci ad animare l e trincee, non certo la p assione di combattere insieme. Insomma ci azzuffammo contro un fantasma che si ag itava e ogni tan-
to lanciava uno s tanco ruggito ma no n sapeva di essere già defunto. Vittorio Ve n eto fu un'ombra di battag lia.

Solo quando si accor geranno di essere un'armata morta i popoli d ella babel e cominceranno a guardarsi in cagnesco e crolleranno.
Per ques t o Enrico Cav ig lia, convocato ad Abano Te rme al comando supremo del genera le Diaz, ha insistito fino alla noia che questa volta bisogna combattere una battag lia diversa. Non contano le centinaia di metri rosicchiati al nemico, si deve punta r e a ll ' annientam ento d e ll'avversario, a distruggerlo, con una manovra, sul campo, tog liend ogli la possibilità di ripren d ersi. Basta con le vecchie offensive cadomiane, q uand o, conquistate alcune trincee con sacrifici immens i, quasi increduli d el successo, i fanti s i trinceravano nei piccoli sali enti e asp e ttavano rassegnati la controffensiva avversaria . Ci s i acco ntentava, le vittorie eran fatti morali . Questa volta bisogna fare i gen e rali s ul serio, manovrare, parola ch e al Caviglia p iace moltissimo, gettars i a destra e s inistra, prendere alle spall e le trincee n emiche dilagando senza fa re avarizia di rincalzi attraverso la prima breccia, gettare avanti la cavalleria, tira ta fuori dalla naftalina dopo quattro anni, e le a uto blinde. Finora queste d elizie dell 'offensiva hanno fatto, in una guerra da minato ri, la parte umiliante d ei testimoni. Audacia, aggr essiv ità escono d a l dimen ticato io: parole ch e impreziosiscono la guerra di quell'uomo imponente. Da vivo sembrava già una statua. Nelle trincee d ell'VIlJ armata lo vedono tutti i giorni, interroga i comandan ti, anche quelli impacciatiss imi di plotone, controlla, stimola , corregge i dubbiosi e gli indifferenti. Non sono le impettite ispezioni di Cadoma, cap aci di metter la tremarella anche a un cuo re cosacco ma che non servivano a nulla. Questa Eccellenza sfiora la sup erficie dei problemi con la s u a mano patrizia e professorale e lascia il segno. Ha un app untame nto d'onore, il gen erale: con il sindaco di uno di quei paesini attraversati dall' umiliant e cal vario d ella ritirata del '17. L'uomo vedeva partire le ultime divisioni italiane lacere, flagellate dalla pioggia e dalla vergogna, sapeva che era l' inizio di una lunga quaresima di umiliazioni e di dolore p er lui e la s u a gente. Caviglia gli aveva baldanzosamente dato l'arrivederci per il giorno, ch e sentiva non lontano, in c ui s i sarebbe ripresentato n el suo piccolo paese ma questa volta m arciando in sen so inverso per rendere la pariglia, far assaggia re agli austriaci la s tessa minestra .
Non si ripe t er à stavolta, l'ha giura t o, quello che è successo alla Bainsizza insanguinata in q u e l 1916 che pare ormai lon tano diecimila anni: lui, Caviglia, aveva aperto la breccia nelle arm a t e austriache,
bastava battere sull'incudine della vittoria con foga per smagliare tutto il tessuto delle loro trincee, delle fortificazioni, un ordito formidabile ma che si reggeva perno su perno. Gli spedirono complimenti e medaglie invece che le truppe necessarie per sfruttare il successo. L'austriaco, maestro nel rimediare all'esiguità del numero con la cattiveria, si ricompose, rimaneggiò, divenne di nuovo insuperabile. La Bainsizza adesso era ben lontana, dietro la nuova linea della battaglia che stava per iniziare. Se avessero vinto, le sue truppe avrebbero dovuto galoppare prima di rivedere quei sassi e i campanili dei paesi, ripercorrere tutte le undici battaglie che avevano combattuto sull'Isonzo dal maggio del 1915, inutili sanguinose estenuanti, gettate via a Caporetto in poche ore di follia e di stolta incapacità militare. Ad Abano nell'ultima riunione del 29 settembre a fianco di Caviglia sono gli altri tre generali che devono mettere insieme quella rivincita: Diaz, il comandante in capo che aveva fatto, come gli imponeva la sua interpretazione del ruolo, da segretario, mediando, tirando le somme, smussando i contrasti; il colonnello Cavallero, un giovane stratega dello stato maggiore che ha preparato i piani di attacco e che tutti indicano come un genio della guerra da tavolino; e Badoglio, il solito invadente.

Aleggia una fresca aria di temporale ogni qual volta i due, il ligure Caviglia e il monferrino Badoglio, si incontrano, e avviene spesso, visto che occupano due posti chiave nell'esercito risorto dalla truce stagione di Caporetto. 1 due si detestano. Si sbirciano con sopportazione. Badoglio tratta l'altro con quel tipo di ostilità con cui Erode ascoltava le prediche di Giovanni Battista. Nessuno meglio di lui sa recitare la parte dell'ipocrita gentile e bene educato . L'altro frigge, si contiene, si vede che stringe le manone per non scoppiare. Se non ci fosse l'educazione militare e la confidenza obbligatoria di chi si batte fianco a fianco sentiresti volare paroloni. Se la loro carriera si incontrerà ancora ne vedremo delle belle . Il piemontese è il ritratto dell'Italia che è: furba carrierista e crudele. L'altro, il ligure, di quella che avrebbe potuto essere e non riuscì dalle mani un po' goffe dei modellatori: seria rigorosa e previdente.
Come tra gli amanti, tra questi due condottieri c'è di mezzo un segreto di troppo: Caviglia sa ma non può dire, non si può macchiare la fama di Badoglio che è come quella della moglie di Cesare, intangibile, a prescindere. Così quel silenzio invelenisce, decuplica lo sdegno. Il segreto ministeriale ha messo sotto chiave le ore che precedettero e seguirono lo sfondamento di Caporetto: ma il giudizio di Caviglia sul collega si è già formato e non cambierà più fino a11'8 set-
tembre del 1943 e oltre, sarà solo il caso di arricchire raccontare ribadire. Badoglio era uno dei maggiori responsabili di quel disastro, si era reso colpevole non solo di mostruosi errori tattici e di imprevidenza ma di vera e propria codardia lasciando per ore le sue truppe senza ordini, scomparendo in cerca di salvezza dal campo di battaglia. E qui c'era già materia per una bella fucilazione. Se poi la legge avesse potuto aggiungere all'inevitabile semplificazione dei codici anche un pizzico di esecrazione morale, se fosse stato possibile metterci, nella fucilazione, un poco di rabbia in più, si poteva raccontare il dopo delitto: le tresche, le amicizie massoniche chiamate in campo a sopire e cancellare, facendosi forza in modo licattatorio delle stesse colpe, la corte marziale cancellata; pazienza, anche altri meno colpevoli di lui l'avevano scampata bella, ma addirittura il far carriera diventando il numero due dell' esercito! Doveva esser ben annichiHta l' Italia per ingoiare tutto questo. Il raduno di Abano e i giorni di Vittorio Veneto sono l ' ultima occasione in cui i due generali si battono fianco a fianco. Poi galopperà il reciproco odio che attraverserà i successivi vent'anni d e lla storia d ' Italia. Pier Paolo Cervone, in una bella e soda biografia, ha fatto di CavigHa l'anti-Badoglio. Ci vien voglia di gridare che il generale di Finale Ligure non lo merita : essere l' anti immiserisce una figura che ci permette di non lasciar vuota e coperta di ragnatela la galleria che dovrebbe ospitare i valenti condottieri della stolia d'Italia (Garibaldi, ribadiamo, era un guerrigliero: è fuori classifica). A Caviglia, che peraltro sovrastava il collega nell ' abilità militare, mancava tutto quell'armamentario che faceva di Badoglio un politico scaltro e senza scrupoli: il carrierismo fanatico, l'abilità di genuflettersi al potere politico sacrificando tutto (efficienza dell 'esercito, sorte del paese) che non fosse il suo immediato vantaggio contato in onorificenze soldi potere. Badoglio fu uno Jago dell'epoca delle ideologie e dei partiti di massa, nemmeno Shakespeare avrebbe avuto animo di dipingerlo, così canaglia gli sarebbe sembrato poco credibile, una macchietta sulla scena. Se scrivi una sua biografia ti vien subito voglia di passare allo stile del capo di imputazione. Lo rincontreremo: per ora teniamoci stretti a Caviglia, un uomo che n e lla dedizione assoluta al proprio paese possiede una generosità e una nobiltà che non appartengono al XX secolo ma all'Ottocento, che ha una dote piuttosto rara in un'epoca ormai già avviata alle fertili pianure dell'indulgenza: un inflessibile rispetto delle regole. Ma i tempi dell'odio sono ancora lontani in quell'autunno cosl gravido di speranze e di timori del 1918. Ad Abano Caviglia ha ot-
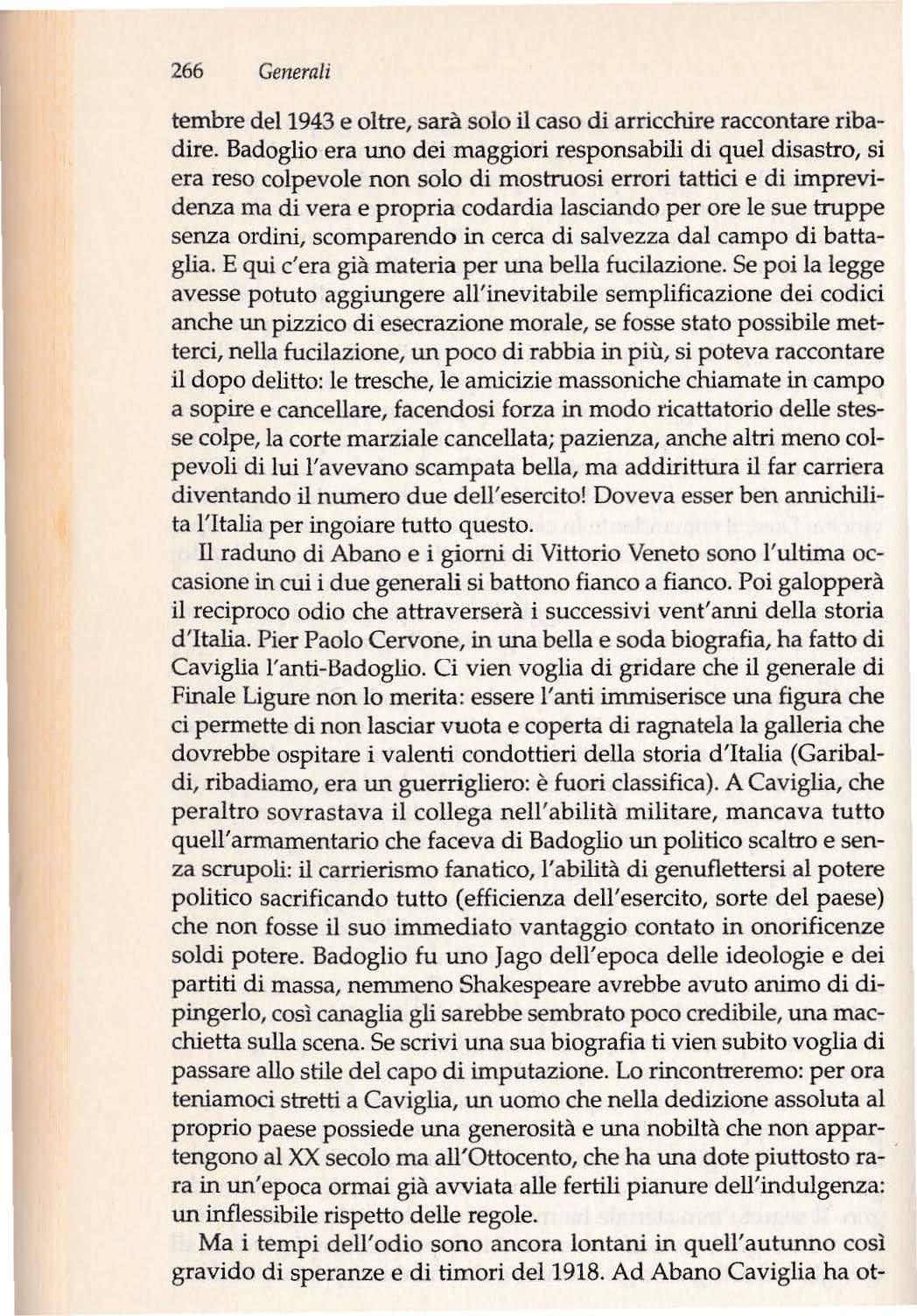
tenuto quanto voleva, le due divisioni di assalto formate dagli arditi per rinforzare la sua già affilata, implacabile VIII. Piacciono gli arditi a Caviglia . Sono gente che sa fare la guerra nuova che hanno mostrato i tedeschi, hanno il «mordente» come si dice n egli alti comandi, la fantasia per inventare le mosse sul campo di battaglia, non l'anonima rassegnata carne da cannone che serve solo al macello quotidiano, come sono diventati gli eserciti europei dopo quattro anni di guerra. Si combattono infatti, vista la vastità biblica delle armate, due guerre: quella delle squadre d 'assalto, degli specialisti, delle élite, dei demolitori implacabili di trincee e ridotte, gente che va in giro con il fucile come noi con gli occhiali; e qu ella della fanteriaccia, borghesi stralunati che non hanno mai sparato un colpo e servono per riempire le trincee e fornire bersagli alle artiglierie. In realtà, più che ai commando assomigliano a qualcosa di molto italico, le squadracce di fegato e coltello delle eterne risse medievali nostrane. Toglietegli la divisa e il maglione nero e vi trove rete davanti le bande dj Corso Donati e di Lorenzaccio: beffe e sgozzamenti, omeriche bevute e spedizioni punitive. Le guerre sono cose sentimentali come le canzoni: ogni popolo ha i suoi talenti e le sue passioni.
Per la verità altre decisioni di Diaz, che ha fatto senza batter ciglio ancora un volta il ragioniere, non sono piaciute a Caviglia. Alle ali distese sul fiume gli hanno sistemato altre due armate; la X è mista, formata da due divisioni inglesi e due italiane. Comanda Lord Frederic Rudolf Mambart, conte di Cavan, un tizio che si guarda intorno come se fosse tra i bantu e non vede l'ora di tirar fuori il bricco del tè. Caviglia lo conosce bene. A giugno, durante l'assalto a u striaco, M;lord presidiava una montagnaccia, il Ghelpac, che il buon Dio aveva opportunamente sistemato sulla linea di avanzata degli austriaci. I soldati di Sua Maestà se l'erano data a gambe e g li austriaci, giudiziosi, si erano buttati nel varco. Allora Caviglia, che aveva ben studiato le carte (era la sua qualità), aveva ordinato all'artiglieria dj s parare proprio s ul monte trasformandolo in un inferno di fuoco. Sconcerto e terrore nel comando, dove si passarono minuti terribili : quell'ordine che ap pari va inumano preludeva a un mostruoso incidente diplomatico. Come convincere gli inglesi della bellezza di quel sacrificio involontario? Anche perché il comando britannico cominciò a strep itare al telefono, furibondo, convinto che Caviglia avesse sbagliato il tiro: «Sta te cannoneggiando i nostri!» sbraitarono gli alleati; «No, gli austriaci» rispose implacabile Caviglia. Lord Cavan, che se l'era cavata per un pelo solo grazie al fuoco amico, venne

poi a stringergli la mano. E il «Tunes» aveva citato, rendendolo popolare nell' isola e nell'impero, la preveggenza del generale italiano. A quel tempo eran cose che contavano, meglio dell ' ordine di San Maurizio.
A sinistra gli hanno piazzato il borioso Graziani, che in alterigia non era secondo neppure a Napoleone senza avvicinarne la genialità. Le premesse della vittoria mutilata, dei micidiali mugugni che avrebbero trasformato il nostro dopoguerra in una seconda piagnucolosa tragedia erano lì. Con quella trovata, se avessimo vinto il successo sarebbe stato attribuito agli alleati. Ancora oggi riveriti storici inglesi e americani (sì c'erano anche loro sul Piave, uno scombinato inesperto battaglione di fanteria, quanto basta per dar diritto anche a loro di mettere il naso) sfornano libri in cui la guerra sul fronte italiano da Caporetto all ' Armistizio è spiegata come un trionfo delle truppe alleate che, nonostante i difetti dei padroni di casa, seppero alla fine aver ragione degli austriaci.
Li ha addestrati bene gli uomini delle sue divisioni, il generale Caviglia. Perché attraversare un fiume è una operazione militare delicata, pericolosissima come ai tempi in cui Cesare gettava orgogliosamente i ponti per le sue legioni sulle acque ben altrimenti furibonde del Reno. La tecnica non ha fatto, rispetto a quei tempi remoti, molti passi avanti. Bisognava, in faccia al nemico che sorvegliava e mitragliava, portare tutto il materiale di nascosto fino al luogo del guado. Se non vi avevano sfracellato pontieri e barche si poteva cominciare a piantare i pali nella corrente dispettosa del fiume e a ssicurarli mentre il nemico si ingegnava a nuocerti. Arrivato sull'altra riva eri solo all'inizio dell ' impresa: se il ponte crollava i soldati che avevano passato il fiume si potevano considerare morti o prigionieri.
Caviglia li vede i suoi soldati: aggrappati alla riva del Piave, curvi e incappucciati, i fucili girati verso il basso per proteggerli dalla pioggia , sembrano una colonna di gobbi penitenti. I fanti non amano passare i fiumi: loro sono abituati ad avere la terra sotto i piedi, a sentirla crocchiare, ad appoggiarsi, a scavarla per fame un rifugio, magari p e r morire. L'acqua li inquieta, mobile, perennemente infida, che gioca a favore del nemico. I luoghi dove avevano scelto di gettare 1ponti, a Fontana del Buoro e alle Grave d1 Papadopoli, erano fatti ad arte per aiutare quel passo pericoloso: la riva destra più alta di quella austriaca, il fiume che forma un solo canale e non si divide in molte vene da scavalcare, la trincea austriaca che corre più arretrata a causa della piena del fiume e lascia spazio per me tter piede a terra e attestarsi.
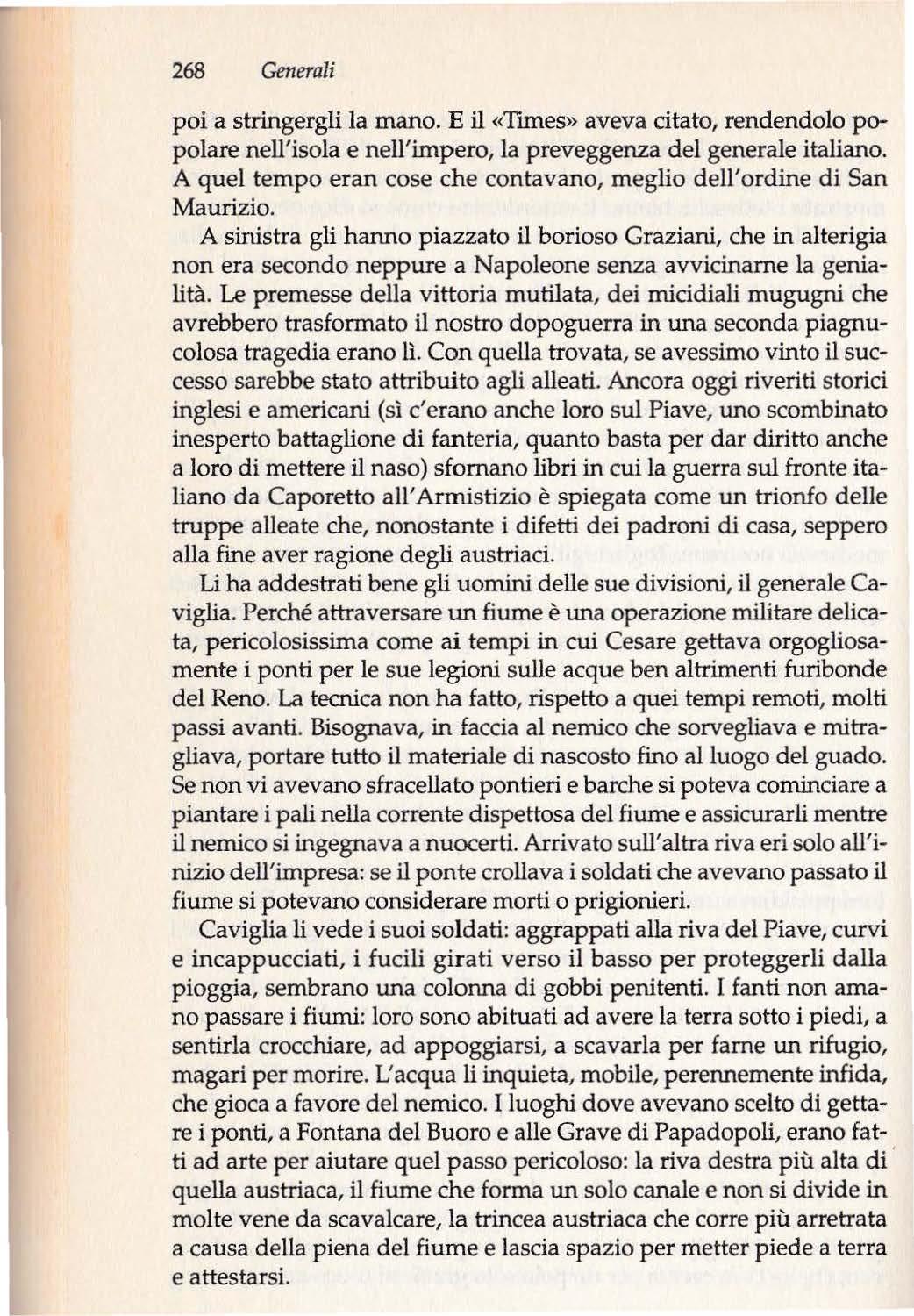
Una volta tanto in un esercito abituato ad affidarsi allo stellone e all'improvvisazione, la preparazione era stata meticolosa. Caviglia ci aveva messo la sua maniacale professionalità. E aveva un po' co· piato: gli erano infatti rimaste nella memoria scene viste nel 1905 ai tempi di una sua avventurosa rrtissione in Oriente come interessato osservatore della guerra russo-giapponese, un conflitto periferico ma che, a chi aveva acume, sapeva rivelare in anticipo molte delle lezioni tragiche della prima guerra mondiale. Sperare che servisse da ammonimento era un po' troppo, dato che gli eserciti si rassegna· no a cambiare tattiche e usanze solo quando ne hanno provato la necessità sulla propria pelle. Ebbene, i generali Kodama e Kuroki, a colazione gli avevano amabilmente raccontato quante pene avesse loro riservato il fiume Yalu in Corea alla vigilia della decisiva batta· glia di Mukden da cui cominciò, davvero alla lontana, il declino e la caduta dell'impero zarista. Dieci giorni li aveva bloccati la piena con sbalzi d'umore da bella donna. E alla fine avevano dovuto montare i ponti di giorno sotto il fuoco dei russi che, scalcinati com'erano, non avevano saputo approfittarne.
Tutto era pronto per domarlo quel bizzoso Piave: c'erano venti equipaggi da ponte, quasi cinque chilometri di passerelle e di mate· riale per mettere insieme passaggi di fortuna, un rrtigliaio di imbar· cazioni di tutti i tipi che avevano vuotato le rive di fiurrti lagune e canali di tutto il Nord Italia. I pontoni erano stati fatti scivolare di notte lungo mulattiere scavate al riparo dalle sentinelle nerrtiche fa. cendoli scorrere su cilindri di legno perché non facessero rumore. Poi i reparti del genio si erano sbizzarriti a nasconderli dietro gli ar· gini o nelle case distrutte, coprendo tutto con frasche e rarrti. Ma non bastava. Dopo i ponti era la volta delle artiglierie che, sempre di notte, avevano guadagnato le posizioni avanzate. Erano state masche· rate le piazzole cli tiro. Per aggiustare la mira e le distanze senza che il nemico si insospettisse cli tutto quel movimento di granate, altri trucchi, altre scappatoie.
I comandi austriaci erano convinti che gli italiani non avrebbero attaccato: al massimo una offensiva locale per strappare un po' di terreno e tacitare gli ' alleati. Si aveva scarsa considerazione per le fanterie italiane ritenute paurose, si temeva solo la superiorità nel· l'artiglieria che era ormai schiacciante. Tutto invece era pronto.
La parola a Caviglia:
Quando la battaglia è vicina il comandante deve dedicare ogni giorno qualche ora alle prime linee. Sono bagni morali di grande valore. Il soldato ha bisogno di vedere nel bianco degli occhi il suo comandante, sentirne la

voce calma, bonaria e affettuosa, di vedergli prendere qualche decisione dì particolari, rapida e pronta; di sentire un parere riassuntivo e conciso, detto così per caso, o uno scherzo. Tutto ciò fa rapidamente il giro delle trincee, rincuora ed esa lta.

Quelli non e r ano più i santi maledetti del '17, gente inve lenita dalle spallate, resa ottusa dall 'odio p e r una condizione che sentiva bes tiale e soprattutto inutile: era una nuova Italia, arrivata in trincea forse m eno baldanzosa di quella del ' 15 e delle radiose giornate, che si fidava meno della r etorica bolsa dei cantori d ella guerra, ma che in compenso voleva fare il suo dovere, bene e fino in fondo. Il patriottis mo, santi tempi, era una passione come l'amore per la famig lia, non una dottrina .
Caviglia fiutava quell'atmosfera che i condottieri respirano una volta nella vita: quando i soldati, scordate le sconfitte, i regolamen ti idioti, le wniliazioni del servizio e della trincea, lo squallore di una guerra senza colore e senza gloria, v ibrano d e lla tensione estrema del combattimento e sono pronti a eseguire come se fossero un prolungamento della volontà di chi li guida. Era invece il fiume a non da r re tta né cenno di calare. Voleva offrire, il m aledetto, un ultimo appiglio a quel n e mico che si sentiva ormai sconfitto nell' animo prima che nelle forze. Dodici ore, soltanto dodici o re di tregua nella pioggia bastavano per gettarsi oltre il Piave e scompaginare lo schieramento avversario. Caviglia aveva insistito fino alla n a u sea con i suoi ufficiali: appena giunte s ull'altra riva, le truppe d'assalto non dovevano limitarsi ad avanzare fino alla trince a n emica e assestarsi dopo averla conquistata. Dovevano guadagnare terreno anche a d estra e a sinistra per allargare la falla e agevolare gli altri reparti che traghetta vano s ui ponti vicini. Soprattutto, il loro obiettivo non erano le trincee gonfie di fanterie, b ensì le ba tterie di cannoni piazzate subito dietro. Senza quel braccio l'esercito a ustriaco sar ebbe crollato come un castello di carte.
Caviglia sa perfettamente cosa s uccede quand o un' armata r esta bruscamente priva di un puntello così d ecisivo, quando il fante curvo sotto i proiettili d el n emico sente alle spalle il silenzio. Bestemmia, si deprime, scappa. L'aveva vis to ad Adua nel 1896, quando era g iova nissimo uffici a le della brigata Dabormida. Tagliato fuori d al resto della p icco la armata italiana, per s tupidità e incomp etenza, quel grup po di uomini fino a un momento prima in grado d i muoversi come un corpo solo, baldanzoso e micidia le, si e ra trasformato in una turba di gente terroriz za ta, che gettava via i fu cili e cercava solo di fu ggire, ascoltando imbambolata g li ordini dei propri uffici a-
li. Il 25 novembre 1917 in piena fuga da Caporetto, a Lovice, ben ritto sulla massicciata della ferrovia, le aveva viste sfilare le brigate malmenate del suo Venticinquesimo corpo, le uniche a ritirarsi trascinandosi dietro i cannoru, i fucili ben saldi in mano. Gli altri erano la turba ormai senza anima dei sopravvissuti a un terremoto, laceri, privi di armi e zaini, anruentati prima nell'animo che nelle forze fisiche, pronti alla resa.
Eran passati pochi mesi e il generale avvertiva la differenza: quelli che si preparava a gettare oltre il Piave erano ormai soldati diversi. Operosi, tumultuanti, temerari. Gli austriaci non se ne erano resi conto, avevano in quei giorru inondato le trincee di manifestini in cui inneggiavano alla pace e invitavano gli italiani a dare una scrollata al governo dei guerrafondai: che iniziasse trattative e ponesse fine al macello. Erano rimasti ai giorni grami dello «sciopero militare». L'espressione se l'era inventata il maggiore responsabile, Cadorna. Allora sì che esausti soldati avevano invocato la fine di quelle inutili battaglie simili a un mostruoso suicidio di massa. Caviglia aveva replicato distribuendo a sua volta manifesti in cui diceva: «Baionette pronte! Tra poco voi gli darete la risposta » ed erano stati accolti con mormorii di approvazione e di entusiasmo. Buon segno!
L'unico che testardamente in quel 24 ottobre sembrava non volersi allineare ai ben oliati disegru era il Piave: pioveva con cupa ostinatezza e il fiume correva verso il mare alla velocità di quasi due metri e mezzo al secondo, che era il limite oltre il quale i gerueri disegnavano scenari apocaHttici di passerelle spazzate via insieme alla vittoria. Anzi, il fiume sempre più gonfio già passava all'attacco: dilagava oltre le rive zuppe e costringeva alcuni reparti più avanzati a riguadagnare il monte. Si dovette ordinare un rinvio di due giorru. Caviglia fremeva. Sapeva che gH inglesi e i francesi, rotta finalmente la grarut:ica invulnerabilità delle armate di Hindenburg, formicolavano oltre le vecchie trincee che li avevano inchiodati per anru nel fango delle Fiandre e del Brabante. L'impero tedesco per la prima volta scricchiolava, era sul punto di afflosciarsi . Guai se la pace ci avesse colti ancora lì, abbarbicati alle rive del fiume santo per il martirio ma con province intere occupate dal «vinto» e alle spalle una orribile sconfitta. Caviglia riesaminò per l'ennesima volta i grafici delle piene del fiume nell'ultimo mezzo secolo che si era fatto redigere dal suo stato maggiore. Mai in tutto questo lungo arco di tempo la piena era durata più di tre giorru. Al lato dell'Vlll armata la X aveva già avviato il passaggio grazie al fatto che alle Grave di Papado-
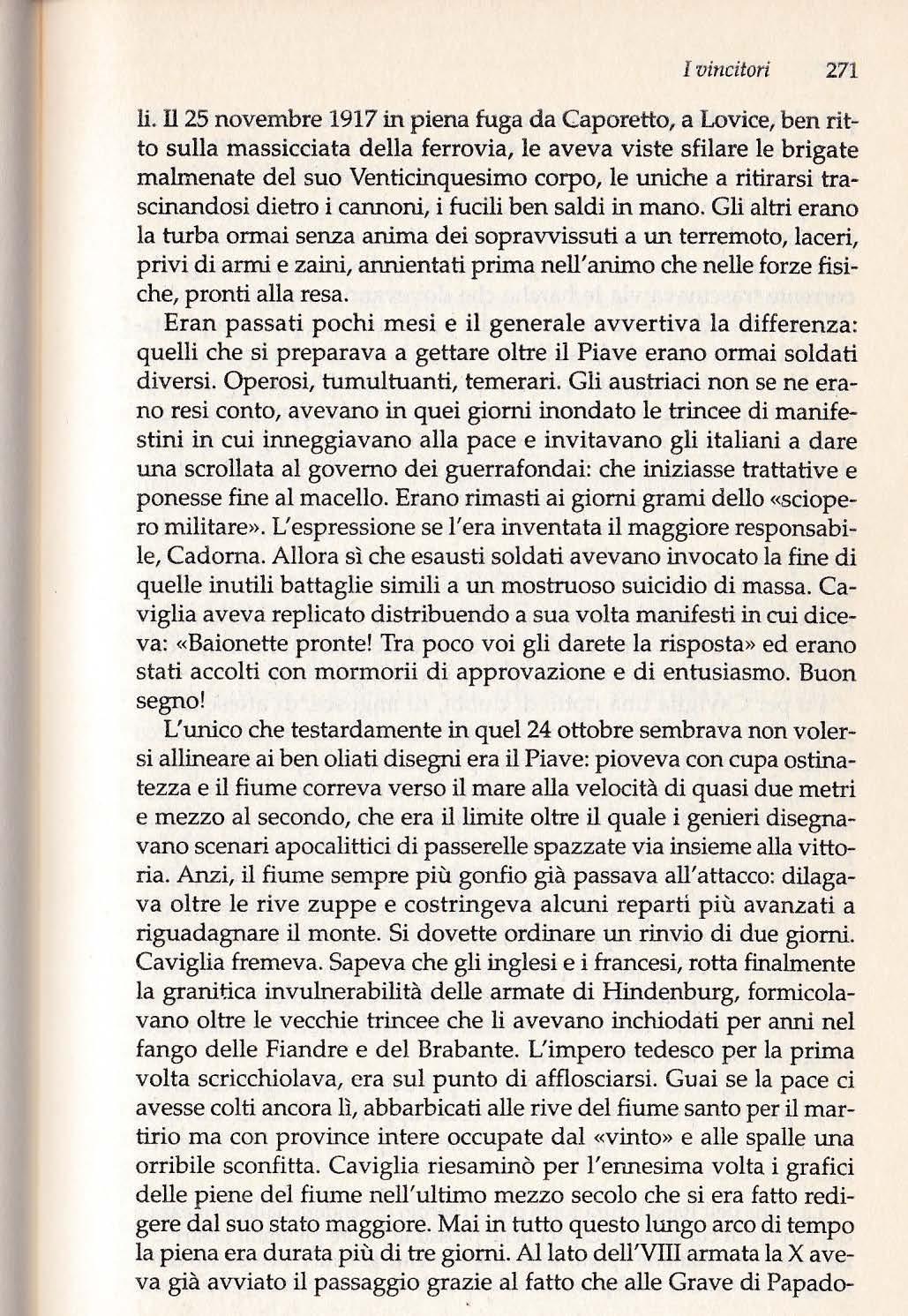
poli il corso d'acqua era più largo e quindi affievoliva la furia della corrente. Il 26 ottobre, un'ora dopo il tramonto, quando dall'altra riva gli austriaci ormai non riuscivano che a scorgere vaghe ombre, Caviglia diede l'ordine: attaccate . A Fontana del Buoro e a Nervesa i pontieri, nel più assoluto silenzio, cominciarono a trascinare i barconi in acqua . Era lavoro penoso, ci si affaccendava con poco sugo. La corrente trascinava via le barche che dovevano tra sportare al di là due divisioni di assalto destinate alla prima testa di ponte, a piantare saldamente un piede sull'altra sponda su cui l'intera armata avrebbe dovuto poggiarsi per compiere il salto. L'acqua spazzava i pali che i pontieri cercavano di fissare nel fondo. Sembrava che la natura desse una mano al nemico, come in quelle battagli e descritte da Omero in cui una forza misteriosa, una dea infuriata e dispettosa caccia indietro le schiere che sembrano vittoriose. A un certo punto, dopo una notte infervorata , fu necessario ritirare le passerelle a Pederobba e a Fontana del Buoro. A difend ere le divisioni passate cli là rimase vigile l' artiglieria, che teneva lontani con unghiate di acciaio gli austriaci. Quelli avevano ormai compreso la vastità della nostra offensiva, si riunivano, cercavano di schiacciarla sul nascere con i pochi mezzi che restavano loro prima che si ingrossasse.
Fu per Caviglia una notte di dubbi, di angosce, di attese impazienti. Soltanto se fosse riuscito a traghettare la sua armata l'attacco sarebbe diventato quello che aveva progettato: una grande manovra di migliaia di uomini che dov evano annientare l'esercito nemico una volta per tutte. Si confortò con un precedente illustre; anche Napoleone nei giorni della battaglia di Wagram aveva visto inceppata la sua implacabile intelligenza per i ponti gettati a Lobau sul Danubio in piena. A lungo era sembrato ai suoi marescialli atterriti che non ci fosse nulla da opporre al fiume incattivito che li aveva sconfitti. Il genio lucido dell'imperatore non aveva invece mai dubitato, era rimas to implacabile, fedele al suo piano e alla fine aveva vinto. Avrebbe provato a fare il Napoleone: al diavolo, non si cambiavano progetti, l'offensiva era confermata.
A mezzogiorno del 28, il momento più duro, la battaglia e ra ancor a in gioco, le premesse di una vittoria appena sbozzate. Caviglia colmò quell'attesa con un proclama alle truppe, di quelli scritti con il suo stile secco:
La storia dell'Italia futura forse per un secolo dipende rà dalla fermezza e dal fervore cli cui saranno capaci ne lle prossime 24 ore gli animi nostri ... È necessario che stanotte i ponti siano nuovamente gettati. È necessario che il maggior nume ro di unità passino sulla sponda sinistra del fiume . È necessa-

rio che le truppe che si trovino oltre il Piave attacchino violentemente, tendano con ogni ardore al raggiungimento degli obbiettivi prefissi. È l'Italia che l'ordina. Noi dobbiamo ubbidire.
Aveva appena finito di stilare l'ordine che un colonnello portò la notizia: sui monti a nord da alcune ore aveva smesso di piovere, rapidamente la piena del fiume sarebbe calata. Al comando arrivò, come sempre silenzioso ed enigmatico, con la sua faccia da ispettore delle ferrovie, il re. Caviglia gli annunciò che la vittoria era sicura. Non era arroganza, nibelungica scommessa sul destino. Era la razionale preveggenza del matematico, l'equazione dello stratega. La sua filosofia restava sempre racchiusa in una frase semplice:
Tutta l'arte della guerra è basata sul buon senso. La parte geniale sta nell'intuire il momento opportuno, in specie il momento morale, e nel prevedere ciò che vorrà fare il nemico per neutralizzarne gli sforzi e paralizzarli. Tutto il resto è volontà.
Fu nella notte tra il 28 e il 29 ottobre che l'impero austriaco, dopo una secolare esistenza, entrò in agonia. Le truppe che Caviglia, con fervore infaticabile, spediva al di là del Piave si gettavano attraverso i campi come un fiume straripato premendo sui fianchi dello schieramento austriaco, sgretolato dall'artiglieria, sconcertato da quella ta ttica che non era più la tradizionale pressione ostinata verso un unico punto. Le armate del giovane imperatore iniziarono a scomporsi. Era la manovra di Caviglia che per la prima volta sorretta dalle artiglierie, guidata dal suo pugno implacabile, si dispiegava. I reparti d 'assalto piombavano nelle retrovie, si incuneavano come il generale aveva previsto tra la montagna e la pianura, separavano i reparti, smagliavano filo dopo filo sempre più rapidamente la cotta di ferro stesa lungo il fiume. Era Caporetto, ma questa volta alla rovescia.
Dal suo comando il generale coglieva, nel fluire dei rapporti, la cadenza che a veva imparato a conoscere nei giorni tristi del '17. Le artiglierie all'apparire del nemico tacevano, cercavano di ritirarsi affannosamente, lasciavano le prime linee nude, scoperte. Sulle strade si formava la lunga coda dei cannoni, dei traini a cavallo e motorizza ti; agli incroci e s ui ponti tutto si ingarbugliava in mostruosi ingorghi che paralizzavano il movimento e rendevano vani gli ordini. Poi il panico contagioso travolgeva i servizi, l'enorme massa dell'intendenza che nelle seconde e nelle terze linee fino a un momento prima si era sentita al sicuro. Anche loro, i marescialli panciuti, gli scrivani arroganti, si buttavano sulle strade, ingolfavano con i loro

carri e gli archivi di carta inutile il movimento delle riserve che, fucile in mano, affluivano verso la prima linea; tutto diventava caos, confusione, paura.

Poi toccava ai generali e ai loro comandi: si scoprivano nudi nelle ville dove fino a un minuto prima avevano distribuito ordini con tranquilla sicurezza, salivano sulle auto e si mettevano avventurosamente per strada ma in direzione opposta alla battaglia. Cosi i telefoni tacevano, nessuno rispondeva più alle disperate richieste di rinforzi informazioni materiale che arrivavano dai reparti che ancora si ostinavano a combattere. Quando, dopo ore, riemersi dal caos delle strade, i generali cercavano di recuperare il controllo del loro esercito, tutto era inesorabilmente disintegrato, il copione della battaglia era loro sfuggito dalle mani.
Caviglia vigilava ben desto s ui rantoli di questa agonia; s u un fronte di centinaia di chilometri gli arrivavano i segnali di come quell'enorme costruzione messa in piedi per anni con pazienza e abilità cominciasse a non rispondere più agli impulsi della mente centrale, si decomponesse, andasse in pezzi. Era il momento di lanciare nella mischia la cavalleria e le autoblinde, lo strumento a cui aveva affidato il compito di dare il colpo di grazia. Alla sera del 29 gli austriaci e rano ancora aggrappati a un canale vicino a Conegliano, a dieci chilometri dal Piave . Ma nella pianura la resistenza era ormai cessata: i cavalleggeri e i fanti italiani correvano a riagguantare le località che un anno prima si erano lasciati penosamente alle spalle in ritirata.
Era il momento: l'esercito nemico, spezzato tra le Preal pi e la pianura, era defunto. Caviglia vide sulle strade il segno inequivocabile della disfatta: decine di rnigliaia di prigionieri si avviavano lentam e nte come greggi verso le nostre linee. E qui si rivela la grana diversa del vincitore:
Essi, g ià così spavaldi, che ostentavano disprezzo per noi e un giorno vittoriosi, a grandi urla esaltavano il loro odio trionfante contro di noi, ora passavano avviliti, laceri, affamati, demoralizzati come suini, umili e abbietti, gettando le armi. Tutto il mio octio per il nemico ereditario svaniva e non provav o pe r quelle pove re creature umane che una immensa profonda pietà.
Caviglia aveva vinto: u sando il nostro umile, paziente, solido fantaccino che nulla domanda, nemmeno che siano riconosciuti i suoi sforzi e i suoi sacrifici e applicando la buona regola di g uerra : «Attaccare il nemico, demoralizzarlo e abbatterlo con il minimo dispendio di forze». Gli aveva fatto da copione un'antica manovra provata
nel 1901 quando era un giovane ufficia le dello stato m aggior e: «C'è da diffidare di tutti i metodi tattici costanti e generali. Un buon metodo è quello che tie n e conto d ei nostri difetti e delle qualità del n emico che si combatte». Per arri va re a questo geniale buon senso avevamo impiegato quattro anni e sprecato seicentomila v ite umane .

È il momento d olce del trionfo m a per Caviglia è, come accade a tu tti i vincitori, venato d a un sottile, inarrestabile r impianto : lui è uno di quelli ch e vorrebbe prima di firmare la r esa del nemico arrivare fino a Vie1ma, intuisce che quella vittoria in cui sono gli alleati a detta rci le condizioni è macchiata già da tutti i crismi del grande pas ticcio. E perché sa che m ai n ulla n ella sua vita, come racco ntò un giornalista che fu vicino in quelle ore febbrili al suo comando, potrà eguagliare le vette sublimi d i Vi ttorio Ven eto:
Ora mi domando - egli mi dice - quale opera può riserbarmi l'avvenire, qualunque mi s i presenti di poter reggere al paragone della mia soddisfaz ione di oggi. Io cap isco come certe esistenze possano a un certo momento penare della super ficialità dei propri giorni quando tutto intorno a l oro, occasioni e opere, necessariamente non possono far a meno d i decadere. Io capisco fatte le proporzioni, il vuoto che si dové sentire den tro Garibaldi nel momento che donò a Vittorio Emanu e le il regno conquista to.
Era destino che il dopoguerra del v inci to r e, con siderato a ci nquantasette anni uno dei grandi generali d'Europa, non fosse imbas tito di cerimonie e di d omestici piaceri nella sua campagna di Finale Ligure. Non ci fu nemmeno il tempo d i t irare il fiato . Incombe quel dopoguerra così avvelenato di recriminazioni, ingiustizie, colossali debiti da pagare, frustrazioni . C'è soprattutto l ' immane problema dell a srnobili tazione. Tra soldati sotto le armi e p rigionieri si arriva a quattro milioni di uomini ch e bisogna svestire dell' uniforme e ricon segn are a lla v ita civile, s i fa per dire: perché g ià frigge nelle piazze e nei palazzi la r esa d e i conti tra chi la vittoria l'ha conquistata e chi se n e vuole impadronire. Qui ci vuole dell'eroismo amministra ti vo. C h e non inturgida certo il cuore di Vittorio Emanuele Orlando. Il primo ministro ha la testa a Versailles, una riunione di retori e di affa ris ti dove i gr andi, quelli veri, scorgono nell'avvocato s ictùo i tratti del parente povero venuto a molestare la loro avarizia. Affida a Caviglia il ministero della Gu e rra: hai vinto l ' aquila bicipite, ar rangiati con questo gigantesco guaio della smobilit azione.
In fondo n o n è un'idea sbilenca: solo un uomo deciso e universalmente ri spe tta to come lui può affrontare iperboree zone amminis trative dove però s i celano le attese e le rabbie di uomini da anni
abituati alla dura scuola delle trincee e alla regola un po' bisbetica che la ragione corre con la traiettoria delle cannonate. Materia ostica per il presidente del Consiglio che ne ha già abbastanza dei dispetti di Clemenceau e dei furori missionari dell'americano Wilson, che lo guarda in cagnesco come un eretico capitato alla mensa dei santi. Nei suoi quattordici punti, all'Italia son dedicate meno di due righe. Non ci può essere niente di certo in queste autopsie in materia storica, ma bisogna rassegnarsi: Caviglia non aveva capito quasi nulla dei problemi nuovi che la guerra aveva innescato. Non era il solo, per carità. Anche menti politiche assai più allenate della sua si trovarono impacciate a cercar strade in un paesaggio politico, ma soprattutto spirituale, che la carneficina aveva totalmente stravolto. Nulla, dannazione!, assomigliava a prima . Di fronte a quell'enorme guazzabuglio fece come consiglia Eraclito: aspettò che ciò che si oppone, componendosi, si ponesse eternamente. Parlò ai reduci di ritorno alla terra, e agli operai ricordò che la guerra aveva costituito per loro che avevano spesso evitato le trincee e ottenuto alti salari, una grande occasione di miglioramento economico e sociale. Accontentatevi insomma. A tutti distribuì lezioncine di una saggezza un po' ingenua che certo non accontentava bestiali furori e monumentali attese. Vi sorprende che di fronte a queste ottocentesche semplicità i suoi discorsi pubblici spesso fossero accolti con mugugni e silenzi ostili?
Un paese che lavora ordinatamente e seriamente come una casa commerciale seria e ordinata ha credito all 'estero. Dove non si lavora, dove si è in continua agitazione e l'ordine sociale è sempre minacciato non si può avere credito...
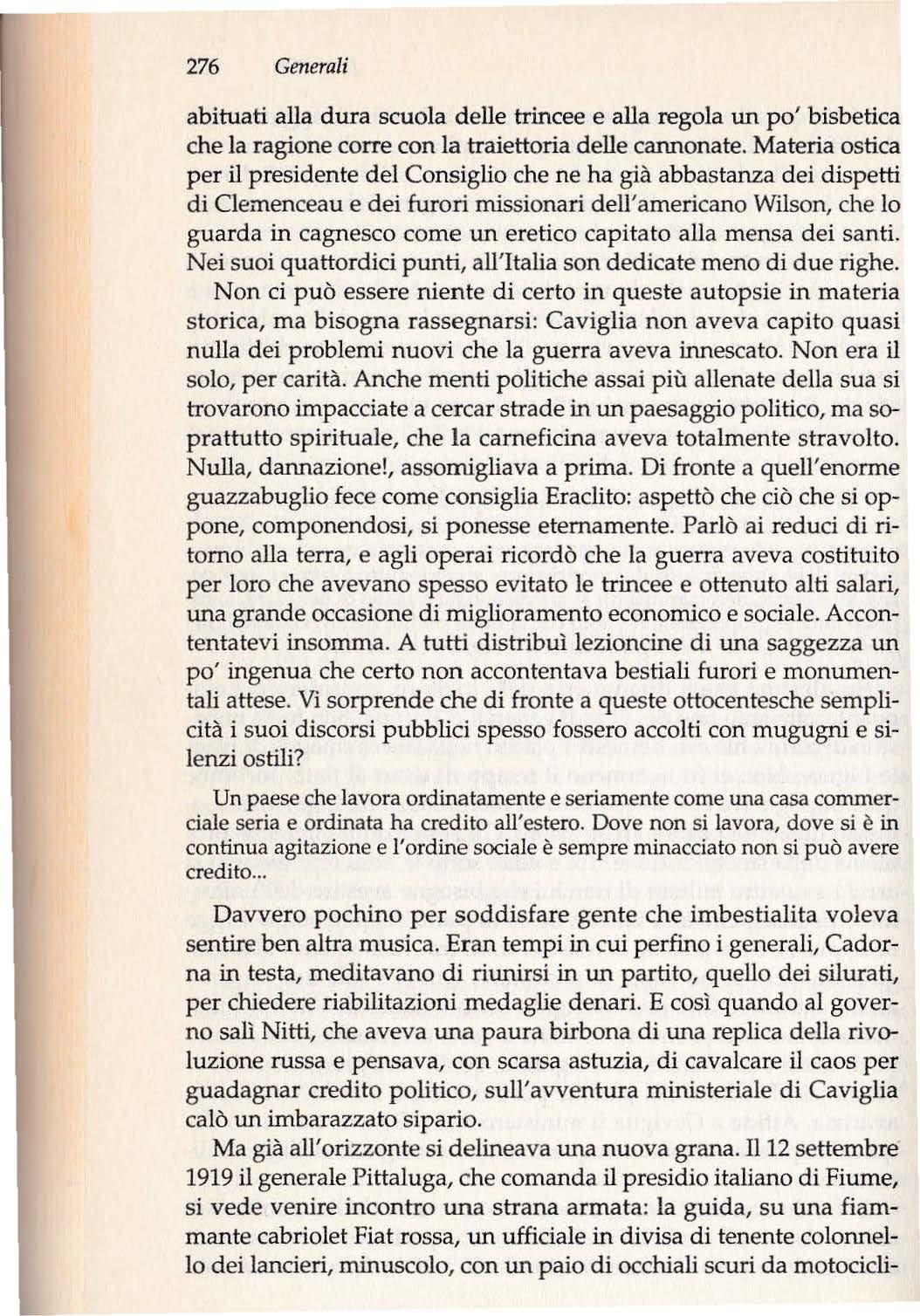
Davvero pochino per soddisfare gente che imbestialita voleva sentire ben altra musica. Eran tempi in cui perfino i generali, Cadorna in testa, meditavano di riunirsi in un partito, quello dei silurati, per chiedere riabilitazioni medaglie denari. E così quando al governo salì Nitti, che aveva una paura birbona di una replica della rivoluzione russa e pensava, con scarsa astuzia, di cavalcare il caos per guadagnar credito politico, sull'avventura ministeriale di Caviglia calò un imbarazzato sipario.
Ma già all'orizzonte si delineava una nuova grana.1112 settembre 1919 il generale Pittaluga, che comanda il presidio italiano di Fiume, si vede venire incontro una strana armata: la guida, su una fiammante cabriolet Fiat rossa, un ufficiale in divisa di tenente colonnello dei lancieri, minuscolo, con un paio di occhiali scuri da motocicli-
sta per ripararsi dalla polvere, frenetico, che sembra agitato da una perenne scarica elettrica. Dietro di lui camion arrancano carichi di centinaia di soldati, soprattutto granatieri, sgommano le autoblinde, giovani ufficiali dei reparti di assalto su auto borghesi sono eccitati come per un incontro galante, civili e curiosi sciamano e complicano il corteo. È l'esercito del Poeta, del vate d'Annunzio che marcia su Fiume, città italianissima che il presidente Wilson, in nome del s u o pasticciatissimo principio di nazionalità, non ci vuole concedere. La s tupidità del governo e gli ardori del nostro nazionalismo insoddisfatto hanno trasformato quel porto adriatico nel simbolo pulsante e pericoloso della colossale truffa consumata ai nostri danni dal trattato di pace. Ci e r avamo messi a desiderare la Dalmazia dopo aver avuto Trieste, incontentabili per colpa della geografia! Stavamo ancora meditando sulle dimensioni del nostro Lebensraum, lo spazio vitale, e gli al tri avevano g ià deciso per noi. Dateci almeno Fiume, gag lioffi sazi d i mille pasti!
Son tempi torbidi, si parla apertamente di rivoluzione e alcuni generali, con in testa il solito duca d'Aosta, meditano neppur troppo di nascos t o di marciare: ma non su Fiume, su Roma. Pittaluga, onesto p iemont ese finito in un ginepraio p iù grande di lui, chiede al poeta dove stia andando cosi appesantito di u omini e cose. Domanda un po' ingenua visto ch e , con futuristica lena, la colonna ha appena s briciolato, lanciandole contro a tutta velocità un'autoblindata, la sbarra di confine che segna a Cantrida quanto ci tocca. È scritt o così sull'armistizio e sul patto di Londra che quando lo abbiamo firmato nel 1915 ci sembrava un banchetto da incontentabili. Adesso lo spreg iamo come elemosina per i pezzenti.
La scena ha un bel taglio teatrale, gli esclamativi si sprecano, sono figure in cui il poeta dà il meglio di sé, dove è la vita che sembra copiare il brogliaccio d i un romanzo: «A Fiume!» . «Le ordino di tornare indietro» esclama il generale certo non abitua to a quelle tipologie tra il sudamericano e il balcanico. «Non prendo ordini da nessuno» ribatte quello strano colonnello alla minaccia di far seguire all'ordine le fucilate. D'Annunzio recita la scena madre con la stessa veemenza con cui lasciava in lacrime le amanti: «Generale, in questo caso lei h a due bersagli a cui mirare: la mia medaglia d'oro e la placca di mutilato. Dia l'ordine di sparare». Da buon decadente privo di forza spontanea, ha il culto della forza altrui.
Al povero generale forse non sembrò una cosa abbastanza seria per convertirla in tragedia. O ebbe il timore di finire nei libri di storia non per la diligenza con cui si era battuto sul Carso ma per aver

fucilato un poeta. E che poeta ingombrante! Non sparò e cominciò così l'avventura di Fiume. Gli storici non hanno rossori: capovolte le premesse, ricominciano da capo; l' hanno definita una sciagura n az ionale, la prova generale di a ltri e più ventennali sconquassi. Noi confessiamo invece una passionaccia per qu ei mesi fium ani, uno s trano ins ie me di violenza e carnevale. In una sto ri a patria che è o funebre o grottesca è una b e lla pennellata di epop ea. Fu infatti un happening rivoluz ionario di ineguagliabile fascino, l'unica vera rivoluzione capitanata d a un a rtista. Mescolate ins ieme colossali scemenze come il p rogetto di costituire una repubblica delle tre Venezie con Fiume e la Da lmaz ia e con presidente il duca d'Aosta (lo s ta to maggiore della !Il armata ci pensò davvero ed elabo rò con diligenza i relativi piani) e vera tragedia. Suscitò l'attenzione di un rivoluzionario impermalito come Lenin che la cons id erò l'unica concorrente in Europa alla s ua primizia bol scevica. A Fi ume fu inventato il terzomondismo e l a guerra contro la g lobalizzazione. Che Guevara avrebbe dovuto rilegger s i lo s ta tuto d e lla lega dei p opoli oppressi contro il trus t mondiale d egli Stati ricchi, av rebbe evitato molti errori. Sfilavano sul lungomare in quei mesi confu si ed elet trizzanti, quando tutto il mo ndo chiedeva notizie di Fiume con il fiato sospeso, rivoluzionari e truffatori, cocotte di alto bo rdo e vestali pure della rivoluz io ne come la marchesa Incisa di Cameran a che s i proclamava «tenente degli arditi di d'Annunzio», il nipote di Bakunin e scrittori come Paolo Comisso e l ' ungherese Garvay. Il governo Nitti h a bisogno dei soldi e del g rano americano ma non vuo le p erd ere la città perché l ' umiliazione rischia di travolgerlo: si p u ò fo r se sopportar e la fame, non le umiliaziorù. Allora complotta, ma second o lo stile d ell'opere tta, cercando di non prender d ecisiorù, facendo la voce grossa con la «repubblica del Carnaro» e nello s tesso tempo scambiando con il p oeta trattative consigli a iuti . In quella confus ione fioriscono voci in cui è difficile distinguere il vero dal velleitario: per esempio, l'ipotesi di marciare da Fiume s u Roma facendo insorgere le ribollenti Romagne dove i Savoia hanno fama di usurpatori e canaglie, per ab batte re la m o n arc hi a e creare una s pecie di re pubblica dei sovie t in salsa n ostra n a. L' idea di ques ta Marcia, insomma, girava da tempo. Il primo ad ave rla comunque fu davvero lui, Mussolirù, che all' epoca n o n s i era ancora elevato d a lla prosa del politicante di seconda schiera. Ne parlò riverente al poe ta, si fecero i n o mi dei generali già contattati, fo rse coinvolti come Gaetano Giardino e Cavig lia . Erano quasi certamente chiacchiere. Anche perché qualsiasi gi udiz io Caviglia avesse su Fiume, e ra condiz iona-
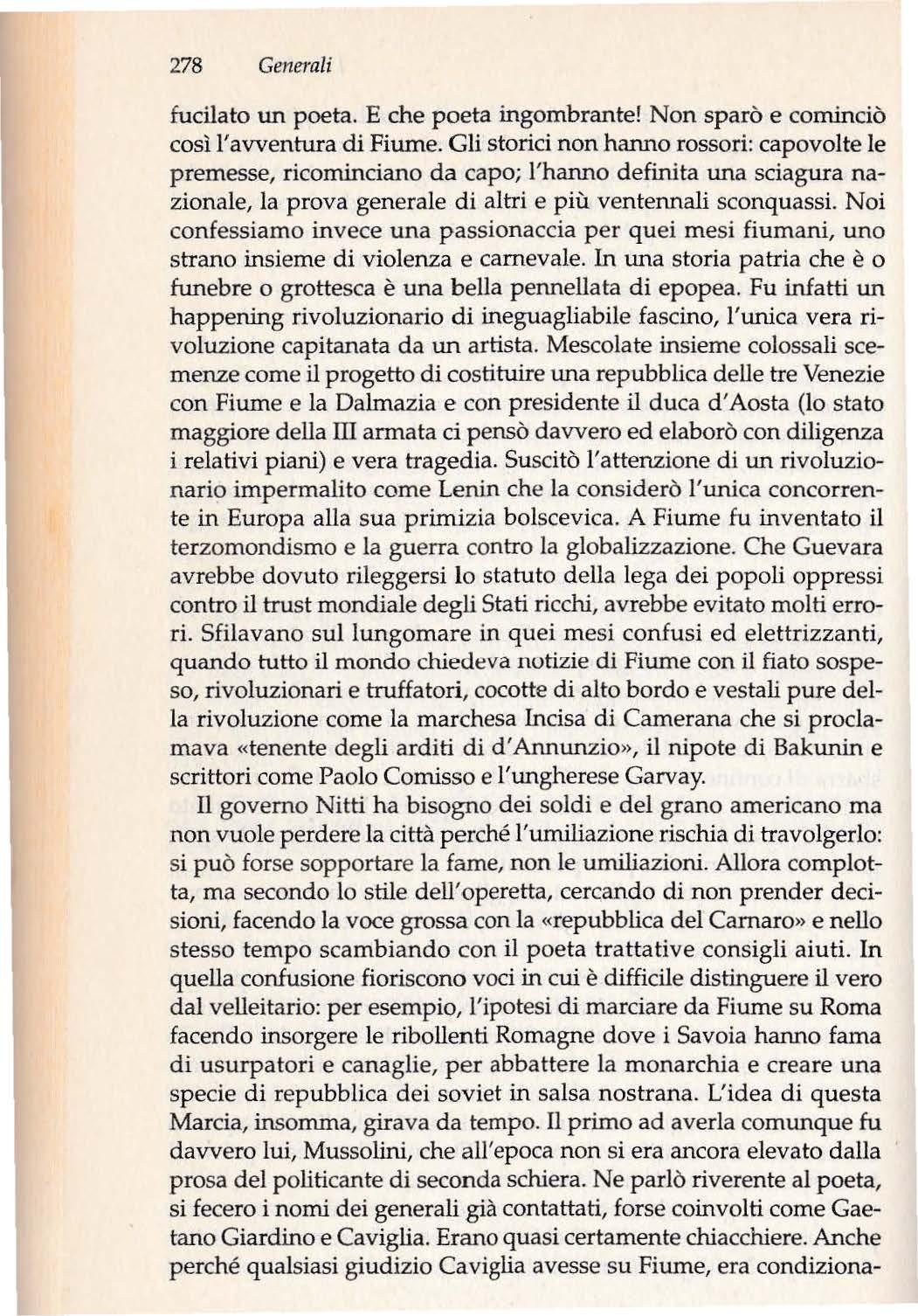
to da un elemento per lui decisivo: a Fiume si agitavano soldati che si erano ribellati al governo legittimo. E questo, qualunque fossero le motivazioni, lo riteneva inaccettabile. Lo scrisse anche a Nitti, di cui seguiva con rassegnato disgusto la tattica furbesca e dilatoria:
Il governo deve pretendere dalle truppe l'obbedienza assoluta, continua, immediata. Quando le truppe non sono sempre pronte a ubbidire non hanno il diritto di esistere. La responsabilità diretta di questo elementare dovere è delle alte autorità militari ... Esse avrebbero già dovuto presentare le dimissioni e avrebbero dovuto essere accettate e imposte; i corpi che direttamente o indirettamente hanno preso parte alla defezione dovrebbero già essere stati sciolti e tutti gli ufficiali che sono fuori della legge, cancellati dai ruoli.
Parole chiare, ben diverse dal comportamento del capo di stato maggiore, Badoglio (ancora lui), che ha amministrato la politica ambigua di Nitti con d'Annunzio trovandola assai vicina al suo stile falso e attendista. Ma ora, con le elezioni che hanno dato una grande vittoria a popolari e socialisti, e con gli alleati, impazienti, che minacciano ritorsioni, bisogna cambiar musica: basta con la reggenza del Carnaro e il suo carnevale rivoluzionario. A Badoglio, che comanda l'esercito, toccherebbe dare gli ordini della repressione, compito pericoloso che rischia di inimicargli una parte del paese e dei colleghi. È un brutto affare: sparare contro altri italiani per di più coperti di medaglie e di glorie militari. In questo paese mal governato, riflette il marchese del Sabotino, c'è una specie di scala sulla quale il legittimo, di gradino in gradino, diventa illegittimo. Domani quelle fucilate possono trasformarsi in una macchia sulla carriera. Meglio tenersene fuori. Con perfidia cortigianesca Badoglio scrive a Nitti suggerendogli, per non crear fastidi al comando supremo che deve essere al di sopra delle parti, di incaricare proprio Caviglia di riportare l'ordine a Fiume. Così evita un compito pericoloso e discusso da cui, comunque vada, non possono venire vantaggi, e mette nei guai un rivale di cui vede la popolarità e conosce il giudizio ferocemente ostile. A Caviglia il simpatico marchese del Sabotino riserva insomma lo stesso destino di Cialdini, costretto a sparare a Garibaldi sul1' Aspromonte.
Caviglia è convocato a palazzo e una delegazione di ministri gli presenta la catastrofica situazione di Fiume annunciando che lo prega di sostituire Badoglio per «ristabilire la disciplina e risolvere la questione». Il generale non può rifiutare anche se intuisce che dietro la scelta e'è un astuto accordo massonico per tirare fuori dai guai «il fratello Badoglio». Le settimane che intercorrono tra l'assegnazione

dell'incarico e la conclusione della vicenda sono confuse, ambigue. Caviglia non ama d'Annunzio, lo considera un attore fuori dalla sua parte, non può apprezzare, lui soldato così cartesianamente professionale, le sceneggiate militari del poeta indaffarato a dar fuoco al mondo intero. Il Vate lo lusinga, all ' inizio gli invia recensioni in perfetto stile dannunziano di alcune pubblicazioni del vincitore di Vittorio Veneto:
Mio generale, leggo con crescente fervore di spirito le sue pagine. Non è vero che non cantino. Vi è, tra pausa e pausa, un canto senza lira .. . con qualcosa di senofonteo che mi lascia indovinare gli occhi cesii della Pallade conduttrice di schiere.
Ma è difficile trattare con un uomo che vive quella contrastata pagina di storia come un avvenimento letterario. Seppure deciso a imporre la disciplina con rigore anche spietato, Caviglia è convinto del diritto dell'Italia a conservare Fiume e piuttosto che far qualcosa per sacrificarla, scrive: «Darei le dimissioni da generale dell'esercito italiano e andrei a fare il contadino in un angolo ignorato della Sardegna».
Il poeta e il generale si incontrano ripetutamente ed è davvero una strana coppia: quel generalone che indossa la divisa come una corazza e lo scrittore circondato da una coorte di giovani efebi in uniforme che lo adorano come un dio: «Mi venne incontro cortesemente ma io non potei trattenere un sorriso nel vederlo così mingherlino, vestito da ardito, col cappello piumato, il piccolo petto coperto di nastrini, di coccarde, di cordoni d'oro. Pareva un tenorino pronto per la rappresentazione» .
È proprio qui il guaio: d'Annunzio ci ha preso gusto. Dove troverà mai un altro palcoscenico simile sul quale inventare la Storia a suo piacere, disegnare uniformi, accogliere a palazzo fanciulle e madame pronte a tutto, veramente a tutto, per l' eroe? D'annunzio recita e comincia a credere che la finzione sia realtà. Non ascolta però le lus inghe di chi gli suggerisce di trasferire la compagnia e il palcoscenico su uno scenario più grande, a Roma, di fare la rivoluzione. Forse intuisce i pericoli, forse si accontenta del suo staterello personale dove non ha rivali. Chissà quale sarebbe stata la sorte dell' Italia se invece del giornalista Mussolini a Roma ci fosse andato con la Marcia per antonomasia lo scrittore d'Annunzio.
Comunque le trattative con Caviglia vanno male, i rapporti tra i due peggiorano di giorno in giorno, sbucano due ltalie destinate a non capirsi. Caviglia ha elaborato un piano per Fiume, che dovrebbe diventare uno Stato libero con ferrovia e porto, e la Dalmazia, auto-

noma sotto il protettorato italiano. Non è certo una soluzione sfavorevole ai legionar i anche perché i fiumani dapprima entusiasti cominciano a tro va r e la poesia di d 'Annunzio, che ha portato con il blocco fame e miseria, un poco indigesta . Ma come s i fa a trattare con gente che h a organizzato un ufficio «colpi d i mano» guidato d a due matti, Romano Manzutto e Gualtiero Covi che compiono arrembaggi di navi e città e pretendono come riscatto valigie piene di milioni? E poi su Fiume soffiano troppi congiurati e partiti che vogliono usarla per tener ca lda la cenere della protesta e crearsi occasioni per scalar e il potere. L'ambiguo Nitti non c' è più, il governo Giolitti firma l 'accordo con la Iugoslavia e ordina a Caviglia di clùudere la vicenda . Anche Mussolini, che segretamente tem e la concorrenza di d ' Annunzio, lo h a mollato. Caviglia incontra per l'ultima volta il poeta e per ore cer ca di convincerlo «a non costringerlo a demolire il s uo prestigio». La risp os ta del Vate è d a vate:

Con ligure cando re il generale Caviglia minaccia di scacciarmi. Ecco la mia risposta. È necess ario insorgere contro questi tradi to ri d ementi. I fasci dovranno fare le barricate, se occorre, e assediare il buon generale mai sazio di g lori a. Io mi farò ammazza re con tranquillo disprez zo e n on invidierò i s upe rs titi . La parola di Cambronne è la sola degna di questa can aglia stipendiata. A noi.
La canaglia stip endia ta risponde agli ufficiali con un d iscorso mis urato s incer o esemplare:
lo sono un soldato e qualunq ue possa essere la mia meditazione e il mio pensiero devo ubbidire. Il vedere continuame nte in ognuno che si ribella un e roe e un martire è segno di profonda inferiorità . Popoli forti e dominatori s ono que lli che riconoscono la ragione di Stato e a essa si inchinano Non q uelli ch e per vano sentimentalismo esal tano come eroico il gesto ribelle.
Lo stillicidio di diserzioni (perfino tre navi d a guerra si uniscono alla flo tta degli uscocchi d i Fiume) si fa così allarrnante da piegare anche le incertezze e le complicità del governo. Il 17 dicembre Caviglia dà, finalm e nte!, l ' ultimatum a d'Annunzio: quarantotto ore per uscire dalla città, poi entrerà in vigore il blocco totale. Lo fa commette ndo l'unico sciagurato e rrore d i sintassi della sua dignitosissima carriera di scrittore: «Sar à proceduto secondo le leggi interna zionali e i trattati in vigo re e con qualsiasi mezzo contro clùunque il quale te nte rà di vio lare d etto blocco». D' Annunzi o poteva sopportare le cannonate ma no n g li errori di grammatica : emette subito un proclama alle truppe in cui definisce Caviglia «colui che passerà nella storia d e lla ferocia s gra mmaticata sotto il nomignolo di ch iunqu e il
quale». La parola d'ordine per i legionari djventa, al nome Caviglia, la risposta «canaglia» .
È la vigilia di Natale ma a Fiume gli italiani si sparano addosso, si muore, è il «Na tale di sangue», il «Natale funebre». Sono paroloni ma certamente si consuma una tragedia. D'Annunzio, nonostante la buona prosa («resistiamo disperatamente, uno contro dieci, uno contro venti [è una bugia, ha più soldati dj Caviglia], nessuno passerà se non sopra i nostri corpi e domanj alla prima luce del giorno speriamo di guardare in faccia gli assassini della città martire») non riesce a trasformarla, come sognerebbe, in un'apocalisse wagneriana. L'Italia, ormai distratta da altri problemi, fa finta di non vedere. A mezzogiorno del 26, Caviglia, che ha pazientato anche troppo, ordina alla corazzata Andrea Daria di tirare contro il palazzo della reggenza, dove un frenetico, febbricitante d 'Annunzio straparla, scrive proclami, recita poesie, annuncia ecatombi purificatrici . Un soldato muore, il poeta, meno definitivamente ferito, è solo pesto per i calcinacci che gli cadono in testa. Questa volta è davvero la fine. Anche perché i fiumani non hanno nessuna intenzione di iscriversi al martirio letterario dell'esagerato personaggio. C'è tempo per un ultimo proclama contro l'ormai odiato Caviglia:
La granata d el glorioso cannoniere poteva decapitarmi e risolver d 'un tratto ogni controversia e liberare d'ogni molestia il buon governo del re. Per sfortuna la testa di ferro è stata solamente incisa. O vigliacchi d'Italia sono tuttora vivo e implacabile.
Proprio implacabile no, perché accetta la resa sicuro che quella vittoria nuocerà al suo avversario a cui resta una gloria ambigua e incivile mentre a lui, lo sconfitto, sarà facile accudire ormai al monumento di se stesso:
lo non temo l'ingiustizia dell'oggi, non chiedo la giustizia di domani; mi basta di ardere e se anche Fiume si spegnesse ... la mia anima arderebbe sempre per lei ... Viva l'amore. Alalà.
Chl in quei giorni incontrò Caviglia, «il sinfoniarca del cannone», vide un uomo invecchlato precocemente, come uscito da una malattia mortale. Era stata davvero breve la gloria di Vittorio Vene to.
La storia di Caviglia finisce lì, con le cannonate che sbrecciano il bel palazzo di Fiume. La lunga stagione del fascismo in cui restò, comunque, uno dei monumenti militari del paese fu un lungo pensionamento in cui non svolse alcun ruolo di rilievo. Si è molto scritto di un antifascismo di Caviglia. Certo Mussolini e la sua corte dei miracoli non gli piacevano, anzi li detestava, come era log ico per un uo-

mo di qualità e di cultura qual era: per lui erano «rivoluzionari di princisbecco», ciarlatani che pretendevano di muovere armate e di decidere la politica militare. Ma la sua era una fronda che si manifes tava molto poco eroicamente nelle lettere private e nelle conversaz ioni di salotto che l'Ovra riferiva naturalmente al duce. Proprio per l'a ssoluta mancanza di pericolosità resteranno sepolte, senza conseguenze, negli archivi. La sua posizione rimase quella tradizionale, agnostica che fissò in una lettera scritta al «Messaggero »:
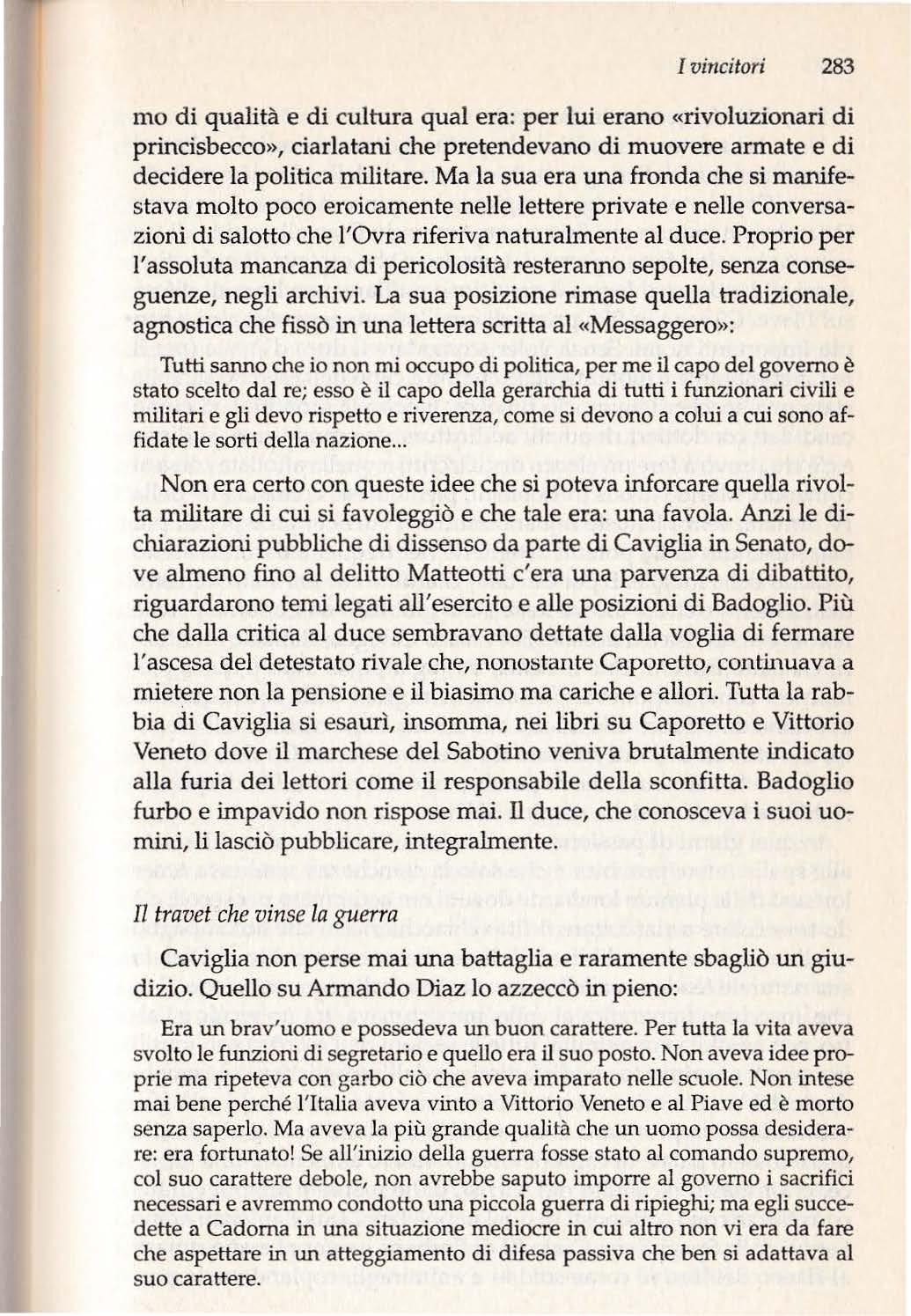
Tutti sanno che io non mi occupo di politica, per me il capo del governo è stato scelto dal re; esso è il capo della gerarchia di tutti i funzionari civili e militari e gli devo rispetto e riverenza, come si devono a colui a cui sono a ffidate le sorti della nazione...
Non era certo con queste idee ch e si poteva inforcare quella rivolta militare di cui si favoleggiò e che tale era: una favola . Anzi le dichiarazioni pubbliche di dissenso da parte di Caviglia in Senato, dove almeno fino a l delitto Matteotti c'era una parvenza di dibattito, riguardarono temi legati all'ese rcito e alle posizioni di Badoglio. Più che dalla critica al duce sembravano dettate dalla voglia di fermare l ' ascesa del detestato rivale che, nonostante Caporetto, continuava a mietere non la pensione e il biasimo ma cariche e allori. Tutta la rabbia cii Caviglia si esa url, insomma, nei libri su Caporetto e Vittorio Veneto dove il marchese del Sabotino veniva brutalmente indica t o a lla furi a dei le ttori come il responsabile della sconfitta . Badoglio furbo e impavido non rispose mai . li duce, che conosceva i suoi uomini, li lasciò pubblicare, integralmente.
Il travet che vinse la guerra
Caviglia non pe rse mai una battaglia e raramente sbagliò un giudizio. Quello su Armando Diaz lo azzeccò in pieno:
Era un brav'uomo e possedeva un buon carattere. Per tutta la vita aveva svolto le funzioni di segretario e quello era il suo posto. Non aveva idee p roprie ma ripeteva con garbo ciò che aveva imparato neUe scuole. Non intese mai bene perché l 'Italia aveva vinto a Vittorio Veneto e al Piave e d è morto senza saperlo. Ma a veva la più g rande qualità che un uomo possa d esiderare: era fortunato! Se all'inizio della guerra fosse stato al comando supremo, col suo carattere debole, non avrebbe saputo imporre al governo i sacrifici necessari e avremmo condotto una piccola guerra di ripieghi; ma egli succedette a Cadorna in una s ituazione mediocre in cui altro non vi era da fare che aspettare in un atteggiamento di difes a passiva che ben s i adattava a l suo carattere.
Era, detta ferocemente, la verità. Uno dei misteri irrisolti della prima guerra mondiale, oltre al comportamento di Badoglio nelle ore terribili dello sfondamento nemico a Caporetto, avvolge le ragioni che spinsero il re e il governo Orlando a nominare un tipo come Armando Diaz alla guida di un esercito in rotta, fatto a pezzi dal nemico e che cercava di imbastire, quasi sfidando ogni logica e previsione militare, una linea di difesa sul Piave. C'erano in fila, prima di quell'oscuro generale, altri e ben più importanti nomi. Senza voler scomodare il duca d'Aosta (per il re l'ingombrante e monumentale cugino a capo dell'esercito sarebbe stata una specie di annuncio funebre, meglio la sconfitta), si erano candidati condottieri rinomati; addirittura una quindicina, si disse, e c'è chi provò a fare un elenco degli iscritti a quella affollata corsa al comando. Mario Nicolis di Robilant, piemontese, comandante della IV armata, senza batoste imbarazzanti nel curriculum e per di più ben sostenuto dalle potenti artiglierie del frequentatissimo salotto romano della moglie. E poi Gaetano Giardino che era stato ministro della Guerra e che si diceva fosse stato giubilato da Cadorna perché non aveva un fisico marziale. Poi Enrico Caviglia, Raffaele Montuori, Giacinto Ferrero. Una mischia, un pigia-pigia. Tutti o quasi piemontesi come imponevano le antiche ragioni della setta; quando avevamo dato fuoco alla miccia alle sei massime cariche dell'esercito, di «straniero» c'era soltanto il fiorentino Pecori Giraldi, che comandava la l armata e che fu peraltro uno dei più furibondi quando si diffuse la notizia della nomina di Diaz.
In quei giorni di passione, con il tedesco che si era ormai lasciato alle spalle intere province e che solo la stanchezza sembrava tener lontano dalle pianure lombarde dove si era accampato per secoli, c'è da trasecolare a riascoltare il fitto chiacchiericcio che accompagnò quella nomina «incredibile». Si disse che aveva giovato al Diaz la sua naturale tendenza alle buone maniere e alla conversazione. Il re che, macchina fotografica al collo, importunava, tra un picnic e l'altro, con assoluta equanimità, tutte le sezioni dell'esercito con inutili ispezioni, era rimasto soddisfattissimo dall'accoglienza del comandante del Ventitreesimo corpo. Abituato a facce scure, occhi grifagni, ordini dati alla prussiana come schiaffi e soldati gettati al macello quasi fossero palate di carbone che dovessero alimentare una fornace, era rimasto incantato dai sorrisi, dalle maniere affabili e dalla correttezza con i sottoposti di quel napoletano . I suoi antenati erano venuti dalla Spagna con Carlo ID di Borbone e sempre erano rimasti al fianco dei loro re come soldati e arnrniragli, copiandone la pro-

gressiva napoletanizzazione. La maggioranza erano patetiche macchiette, l'eccezione i seri e gli efficienti.
Qualcuno più maligno sosteneva invece che fosse stato il siciliano Orlando a pretendere un non piemontese. Il presidente del Consiglio, che aveva un caratteraccio e posava a Clemenceau italico, non ne poteva più dei tipi alla Cadoma: gente che quando lui arrivava al comando supremo non si faceva vedere. «Siamo impegnatissimi» facevano dire dai tirapiedi e lo ammettevano all'ufficio di qualche sottocapo di stato maggiore. Anzi, quando Orlando era andato a Udine nella Città proibita, d o ve l'entourage militare e giornalistica del Capo distillava dai suoi alambicchi la Verità, lo avevano affidato al simpatico Diaz, che era al1ora capo del servizio operazioni, come dire un illustre signor nessuno. Di fronte a quell'intrattabile e terribile Cadoma il potere politico aveva per tre anni alzato bandiera bianca limitandosi a piegar la schiena sotto i rimbrotti e a firmare note spese. Orlando, adesso che quell'energumeno era stato per fortuna affossato definitivamente dagli alleati che ne avevano preteso la tes ta, voleva mescolare qua e là qualche goccia d'acqua al vino troppo forte del comando supremo. Voleva un generale che non gli rimproverasse le colpe per il crollo morale del paese e la tolleranza verso «i sovversivi e i pacifisti traditori». Diaz andava benissimo.
Non si sa quando per la prima volta fu fatto circolare il suo nome. Siamo sinceri: a imporre la decisione furono gli al1eati al convegno di Rapallo. All'hotel Kursaal i capi civili e militari dell'Alleanza dovevano tratta re alcune questioncelle accessorie: valeva la pena spendere ancora soldi e soldati nell'Italia rovesciata a Caporetto? L' atmosfera era lugubre: i nostri rappresentanti politici sembravano avviati a un funerale, qualcuno, come Bissolati, cercava di tirar su il morale parlando di farsi «saltare le cervella», scenograficamente lì, in anticamera. Un primo errore lo compì Cadoma che, come sappiamo, non si presentò: con la motivazione apparentemente solidissima che «lasciare la prima linea in quel momento voleva dire disertare». Fece di peggio: spedì il suo vice Carlo Porro, l'incapace per fama universale che in quegli anni aveva apposta utilizzato solo come accompagnatore e uomo di pubbliche relazioni da lui considerate moleste. Porro non sapeva nulla, visto che pensava a tutto il generalissimo, sbagliò il numero delle divisioni nemiche che moltiplicò per dieci, diede ai generali e ai politici a lleati l'impressione, già coltivata per conto loro, che il comando italiano fosse nel caos . Così dopo aver fatto attendere i padroni di casa in anticamera per discutere tra loro («ci hanno trattato come servitori» si immusonì Orlando), comuni-
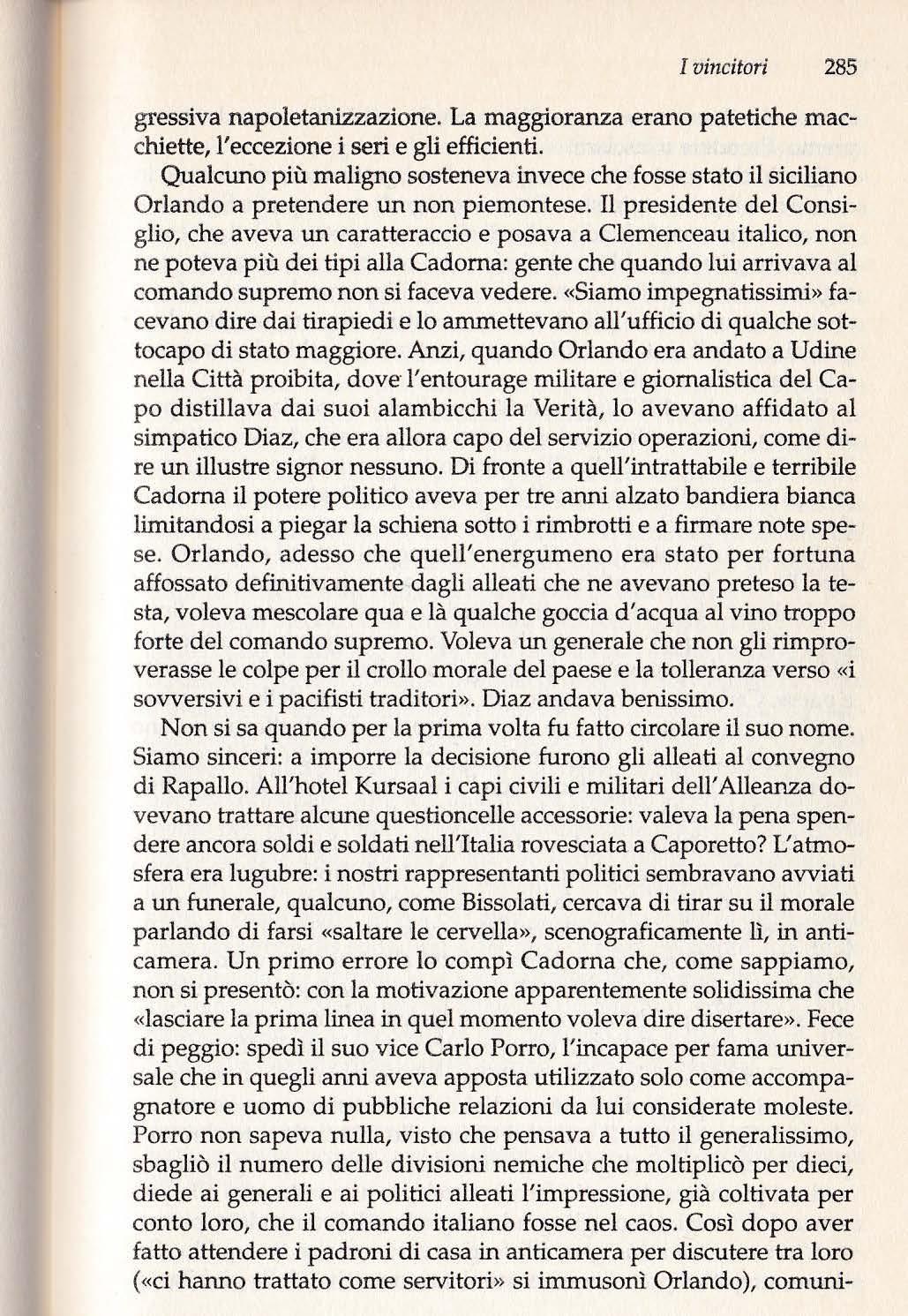
carono che il soccorso era condizionato al cambio di comandante supremo. Prendere o lasciare!
Quello che è certo è che a secernere l'indigesta decisione furono ir due, il re e il primo ministro. Forse a spingerli verso quella figura così sconosciuta e così sbiadita, che di sicuro non poteva iniettare entusiasmo negli animi abbacchiatissimi dei combattenti, fu anche una segreta e machiavellica cautela: nel caso il Piave non bastasse e fosse necessaria un'altra e più dolorosa sostituzione, era meglio che i grandi generali restassero di riserva, senza la macchia di una anco, più catastrofica sconfitta.
Il 9 novembre 1917 l'agenzia Stefani diede la notizia che l' impossibile era successo: lui, Cadoma, non era più capo dell'esercito italiano. Il paese ammutolì. Gli avevano assegnato l'incarico di rappresentante italiano presso l'alto comando alleato, una funzione decorativa visto che si precisava che aveva soltanto poteri consultivi. Eravamo diventati una colonia, stavamo s ull 'a ttenti a ricevere ordini . Persino la scappatoia per toglierlo dai piedi era stata inventata dagli alleati e imposta ai nostri politici, la classica promozione finta, per evitare, in quel momento che era davve ro supremo, la necessità di inchieste che potevano minare il già traballante morale di esercito e paese. Cadoma aveva reagito con una scena taccia delle sue, urlando che lo trattavano come un usciere. Sapeva che gli alleati avevano preteso la sua tes ta e sospettava una ripicca perché lui la guerra coordinata con le altre potenze non l'aveva mai voluta: diamine, non aveva voluto cedere parte dell'autonomia di comando.
A far da cerimoniere al cambio di generali, che avveniva si può dire sotto il rombare del cannone, con le strade invase da fuggiaschi e da rinfor zi che si incrociavano e si ostacolavano a vice nda nella palpitante confusione delle ritirate, era stato inviato il colonnello Rota dello stato maggiore. Uomo adatto alle tragedie, visto che era brutto di aspetto e ricoperto di improba bili medag lie, conquistate non si sa dove poiché non aveva mai comandato neppure un reggimento sul campo. Cadoma stava barricato a pa lazzo Dolfin nel centro di Padova: un ripiego immobiliare che straziava il cuore ripensando ai tempi glor ios i e metodici di Udine che erano ormai un ricordo. Qui r egnava il caos e il colonnello aveva dovuto sbraitare perché i carabinieri di guardia, evidentemente nervosi e preparati" a vedersi piombare davanti i feroci crucchi, lo ammettessero alla presenza del licenziato con gli sgradevoli ordini del comando supremo.
L'incontro tra i due generali fu riservato ma non tranquillo. Cadoma strepitò e pretese una comunicazione scritta della giubilazio-
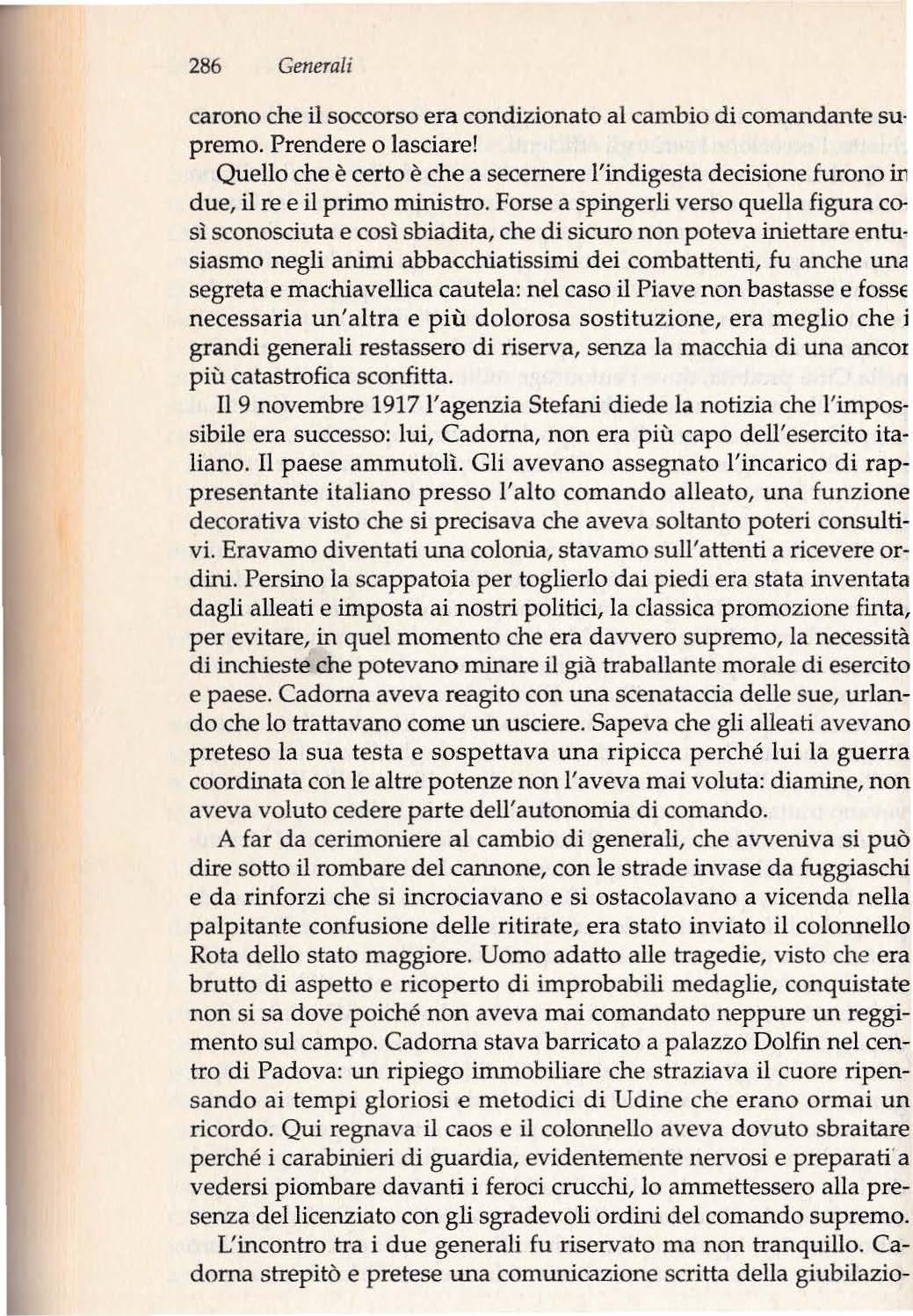
ne. Si sarebbe infuriato ancora di più se avesse saputo che quando gli avevano consegnato il decreto di nomina Diaz aveva sussurrato: «L'arma che sono chiamato a impugnare è spuntata. Bisognerà presto rifarla pungente. La rifaremo». E che il su o s u ccessore giunto a Padova era andato già a cena in un al bergo dopo aver fatto una vista di cortesia al duca d'Aosta, suo superiore fino a un'ora prima. Il duca, si disse, era stato gentile ma aveva lasciato capire che non aveva proprio esultato per quella repentina fortuna del sottoposto. Si dovette insistere perché Diaz sedesse di nuovo a cena con Cadoma nel grande salone della villa: bisognava imbastire per i libri di storia un cambio di consegne alla Plutarco. L'atmosfera era lugubre ma Cadoma, rendiamo onore, fu all'altezza. Animò la conversazione con una spettacolare carrellata sulle bellezze artistiche delle città che voleva visitare da pensionato e nel dopocena incantò i commensali con una lezione su Desiderio da Settignano e la scultura fiorentina del Settecento. Poi, come narrano i cronisti, dopo aver fatto gli auguri a Diaz all'esercito e all'Italia uscì dalla villa e dalla Storia .
In queg li incontri così circospetti e forbiti tra spiriti magni non era certo il caso di dire quanto pensava del suo successore che conosceva benissimo. Noi non abbiamo più que l dovere di riservatezza. Ecco qui il brogliaccio adeguatamente avvelenato: un mediocre, uno scribacchino «che non conosce il teatro di guerra, gli infiniti lavori di difesa esegu iti e il loro valore, né tiene né può tenere le numerose e intricate fila del comando». Amen . Cadoma era spieta to e certo in quel momento non poteva essere un giudice imparziale: ma per molti aspetti aveva ragione. Diaz, che per il colorito scuro i colleghi chiamavano «il turco» e forse c'era anche una venatura di settentrionale disprezzo verso il «napulitan», aveva per anni consumato le su ole degli stivali nelle segreterie del sottocapo e del capo di stato maggiore. Era un lavoro delicato, intendiamoci, e fondamentale per un esercito che ormai aveva assunto caratteristiche moderne per mezzi e strutture. Lavoro faticosissimo, come raccontava con pazienza alla moglie che gli rimproverava qualche ritardo nella corrispondenza domestica:
Passo le mie giornate e spesso anche la sera tra le carte, i lavori e gli studi che non mi danno tregua e mi occupano tanto che persino nei momenti di libertà, rarissimi, penso a quel che debbo scrivere ... Sono proprio legato al mio posto...
Nel 1911, quando Diaz fu promosso colonnello, non aveva ancora comandato un plotone sul campo e la sua carriera era stata tutta cartacea, riassumibile in faldoni annientati, pratiche che si erano arrese
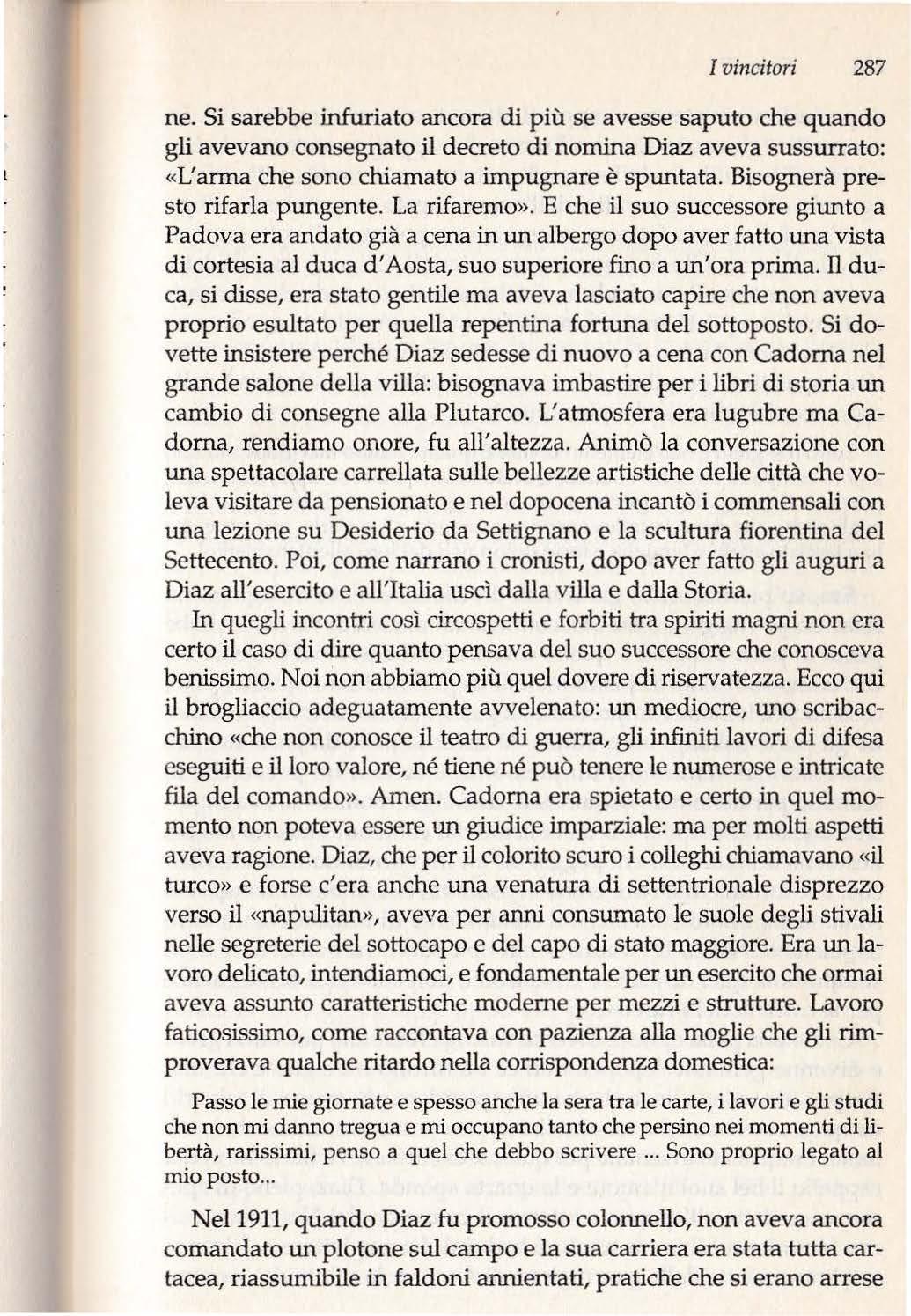
dopo furiose resis tenze e rapporti atterrati con zelo implacabile. Le prospettive di carriera, in un'Europa che appariva ancora imbalsamata n ell'equilibrio delle grandi potenze, potevano, gettando l o sguardo o ltre le erte pendici dell'avanzamento per anzianità, dopo vent'anni di marcia faticosa, scorgere una poltrona di sottosegretario alla Guerra. Glorie insomma ministeriali . Gli avevano affidato, come imponeva il curriculum, finalmente il comando di un reggimen to; si conquistò tra i soldati la fama di comandante se non preparato almeno buono e paziente. Lo aiutava una mericlionale, istintiva capacità di guardare alle cose con realismo, così lontano dalle asprezze abitudinarie dei piemontesi:
Tutto il segreto è nell'elemento uomo. E quanto hanno mal giudicato fino a poco tempo fa il nostro soldato. Questo io lo ripeterò sempre, altamente, perché è il vero .. . È un piacere comandare questi uorrtini che ti guardano negli occhi, che dopo la fatica sorridono quando gli si parla, essi pure che han lasciato affetti e famiglia e forse dolori nati dal loro allonta namento!
Era, su piccola scala, già il metodo Diaz: secondo un'agiografia forse un po' esagerata ma che contiene un nucleo di verità, avrebbe posto in parte rimedio a quella catastrofica eclisse del buon senso che erano stati i nostri primi metodi di guerra. Erano queste, però, cose ancora lontane e imprevedibili: per ora il suo metodo così umano gli portò soltanto un giudizio da cavar la pelle da parte del suo successore al Ventesimo, un piemontese tutto d'un pezzo che lo scambiò per bonomia pasquinesca: defini «borbonica » la sua impostazione del comando. Un eufemismo dal contenuto incerto ma funesto. Solo l'omicidio era peggio su un libretto di note caratteristiche. Per fortuna di Diaz c'erano consorterie e scambio di favori non soltanto tra i nordisti. Perché il comandante di brigata era un altro napoletano, Nico la D'Avanzo, a cui non parve vero di evitare a un compatriota quel dispiacere e l'episodio non ebbe così conseguenze per la carriera del «Turco» .
Come una palla di neve diventa valanga lui rotolò per tutti i gradi e divenne generale. Epopee non ce ne furono o meglio c'era una epopea di seconda linea che ha uno splendore più opaco. A salvarlo da queste burocratiche turpitudini ci pensarono naturalmente le colonie. Erano state inventate per questo. Giolitti aveva tirato fuori dal cappello il bel suol d ' amore e la quarta sponda. Diaz, pieno di speranze, credette all'epopea e ottenne il comando del Novantatreesimo fanteria in Libia tra turchi e beduini . Le sue lettere «africane» sembrano scritte dalla guarnigione cli Ancona: la salute che va sem-

pre benissimo, i bravi soldati, le minute faccende di tutti i giorni, una mediocrità, un grigiore da alzar le bracàa. Vien voglia di correre a sfogliare le missive sgrammaticate e faticose dei suoi fanti che spalancano gli occhl su quelle pericolose meraviglie saracine:
Cari genitori, se Dio mi guarda io sono buono di portare una africana per moglie perché qui le donne sono molto mercate ... Voi non potete saper e quante bellezze ha questa africana! Ha la testa come un toro, ha il naso cer me un !ione, ha la bocca come una tigre, li labbra rossi come il foco, ha la prisintata come un diavolo che esce dall'inferno! Se la porto faremo il teatro. L'occasione di imbattersi, finalmente!, nella gloria arrivò il 29 settembre 1912, quando a l grido di «bara taliani» (fuori gli italiani), torme di libici imbizzarriti si lanciarono all'attacco precipitando giù dalle dune che sovrastavano le nostre linee nell'oasi di Zanzur. Immensità avvampate da un sole infuocato. Fu una battaglia grossa, tutti si batterono con ardore, quasi con furore : alla fine un migliaio di quei fanatici guerrieri restarono sul terreno. Appesi come eravamo a una sottile linea di sabbia sulla costa rischiammo il disastro. Venne fuori un altro Diaz: l'uomo delle scrivanie, sempre impeccabile e con gli stivali lucidissimi si trasformò in un conduttore di uomini, li guidò alla carica . Un Aiace, un Astolfo: da non credere, anche i s uoi soldati sgranarono gli occhi. I giorni che precedettero il combattimento non furono tranquilli: la truppa mugugnava, c'era aria di ammutinamento. Era arrivata la notizia che gli anziani in attesa del congedo, al contrario degli imboscati della stessa classe rimasti nei reggime nti metropolitani, non sarebbero stati rimpatriati. La guerra, infatti, non andava bene e c'era bisogno di veterani che conoscessero le tattiche di quei guerrieri insoggiogati e insoggiogabili. Diaz, applicando il suo metodo, parlò ai «ribelli», al contrario di qualche collega che avrebbe scomodato con prontezza le pratiche del consiglio di disciplina; e per dare un segnale ch e si fidava di loro assegnò la bandiera del reggimento proprio alla prima compagnia dove s i annidava no i più scontenti e rivoltosi. A mezzogiorno, dopo ore di sparatorie e cannoneggiamenti, l'esito d ella zuffa era ancora incerto. Era una battaglia strana . I battaglioni sparivano negli avvallamenti di quel mare di sabbia in perenne tempesta, ricomparivano sgranati sulle creste delle dune, i nemici si vedevano a un passo e poi un minuto dopo erano già scomparsi, mobili e imprendibili. Diaz portò all'attacco le sue compagnie «con bello slancio», come si compiacciono di riferire i rapporti, salvò due batterie che erano sotto il fuoco nemico, manovrò come se avesse sotto il naso il manuale tattico per

la fanteria. Poi alle .tredici e quindici mentre si arrampicava s u una duna, venne colpito a una spalla . Restò sul campo, puntiglioso, fino alle quattordici continuando a dare ordini e a corregge re il tiro. Quando alla fine si rassegnò a farsi trasportare nelle retrovie, sicuro che ormai la situazione sul campo era ben assestat a, si alzò dalla truppa un rumore. Erano i renitenti che stavano per lanciare un micidiale sciopero militare? Il dubbio durò solo p ochi istanti. Un sottufficiale, una testa calda, il capo dei rivo ltosi, ordinò di portare avanti la bandiera «perché il colonnello possa baciarla » e po i di presentare le armi al ferito. Episodio ancora ottocentesco che i giornalisti al seguito delle truppe (erano legioni e affamati di scoop e di colore come cavallette) scoprirono ed esaltarono. Non era passione letteraria : le operazioni, nonostante le continue e magnificate vittorie, ristagnavano sempre a pochi chilometri dalla costa, la Turchia non si arrendeva. Insomma c'era bisogno, e urgente, di eroi. Diaz, il burocrate convertito dall'Iliade sabbiosa, andava a pennello. Al ritorno a Napoli, dove fu curato all'ospedale militare, gli resero visita generali ministri principi . Divenne insomma un personaggio dell'lta lietta guerriera che un po' s i formava e un po' si r ivelava a se stessa. Ma quando scopp iò la p rima guerra mondiale lo avevano già rimesso in «fureria» a mandare all'a ttacco pratiche e faldoni. E lì sarebbe rimasto se le potenze centrali non gli avessero dato una mano. li panorama militare che si presenta davanti al generale è un immenso quadrato di rovine. Tra quelle che erano le nostre prime linee di un paio di settimane avanti, da dove ancora sognavamo di dilagare verso Trieste e Vienna, e il Piave dove a fatica si sta completando la fuga degli ultimi reparti, era rimasto impigliato un esercito di seicentocinquantamila uomini: trecentomila tra morti, feriti e prigionieri, e trecentocinquantamila superstiti della lunga marcia all' indietro che sono in gran parte disperati spesso senza il fucile, e nessuno sa se possono costituire ancora un esercit o efficiente. Nelle mani degH austriaci sono rimasti cinquemila tra cannoni e bombarde, cinquemila mitragHatrici, trecentomila fucili, incalcolabili le perdite di viveri, cavalli, automezzi. Quasi un'apocalisse in sordina. La II armata che aveva smarrito la forza cozzando contro la porta di ferro del Carso non esiste più. Sul Piave i superstiti stanno imbastendo l'estrema difesa. Il fronte che dobbiamo difendere si è accorciato di trecento chilometri, un van t aggio per le nostre divisioni assottigliate, scarse di artiglieria e di mezzi che abbiamo lasciato ben stipati nei magazzini sull'Isonzo a disposizione d e i vincitori. Ma nessuno, a Roma e a Padova, può garantire che in quel punto potremo davvero

tenere. A Peschiera gli alleati hanno annunciato che le loro truppe resteranno in seconda schiera sul Mincio dove, in caso di nuova sconfitta, si dovrà imbastire l'estrema linea di difesa, quella davvero l'ultima. È un'idea che da sola mette l'angoscia, è come se il Risorgimento fosse stato cancellato!
Al fianco gli hanno messo un generale, Badoglio, raccomandato da Bissolati e dalla massoneria che, a sentir le voci e non solo quelle, comandava proprio il settore del fronte dove si è verificato lo sfondamento austriaco. E i suoi cannoni misteriosamente non hanno sparato . È meglio dire subito che con il miracolo del Piave Diaz non c'entra quasi niente. Che su quel fiume corresse il sottile filo che ci divideva dalla sconfitta definitiva, lo aveva deciso, e fin dal 29 ottobre, Cadoma . Non era solo una scelta tattica obbligata visto che altre barriere dietro cui ammassarci la natura non ci aveva regalato. Già nel 1916 quando l'attacco austriaco nel Trentino aveva fatto cigolare le nostre difese e c'erano state le prime prove generali di una Caporetto, il generalissimo, che non era uno stupido, aveva fatto predisporre un nucleo di difesa fissa che comprendeva il Grappa e il cosiddetto campo trincerato di Treviso, dizione un po' pomposa ma che si estendeva giudiziosamente alle rive del fiume e al Montello. Erano state tracciate mulattiere, si erano lanciate teleferiche, si era scavata una strada, la cosiddetta strada Cadoma, che rendeva agevoli i movimenti dei difensori e anticipava già con sapienza lo scenario su cui si sarebbe poi impegnata la battaglia. Il 7 novembre Cadorna, interrompendo la sciagurata serie di telegrammi al governo macchiati di pessimismo e di meschinità, aveva dato alle truppe con un proclama il senso morale della mischia che si stava per accendere: Noi siamo inflessibilmente decisi: sulle nuove posizioni raggiunte, dal Piave allo Stelvio, si difende l'onore e la vita d ' Italia. Sappia ogni combattente qual è il grido e il comando che viene dalla coscienza di tutto il popolo italiano: morire, non ripiegare.
Tutto era già stato predispos to, non c'erano alternative: Diaz non poteva far altro che sperare che la diga tenesse. Aveva ragione Albertini che scrisse:
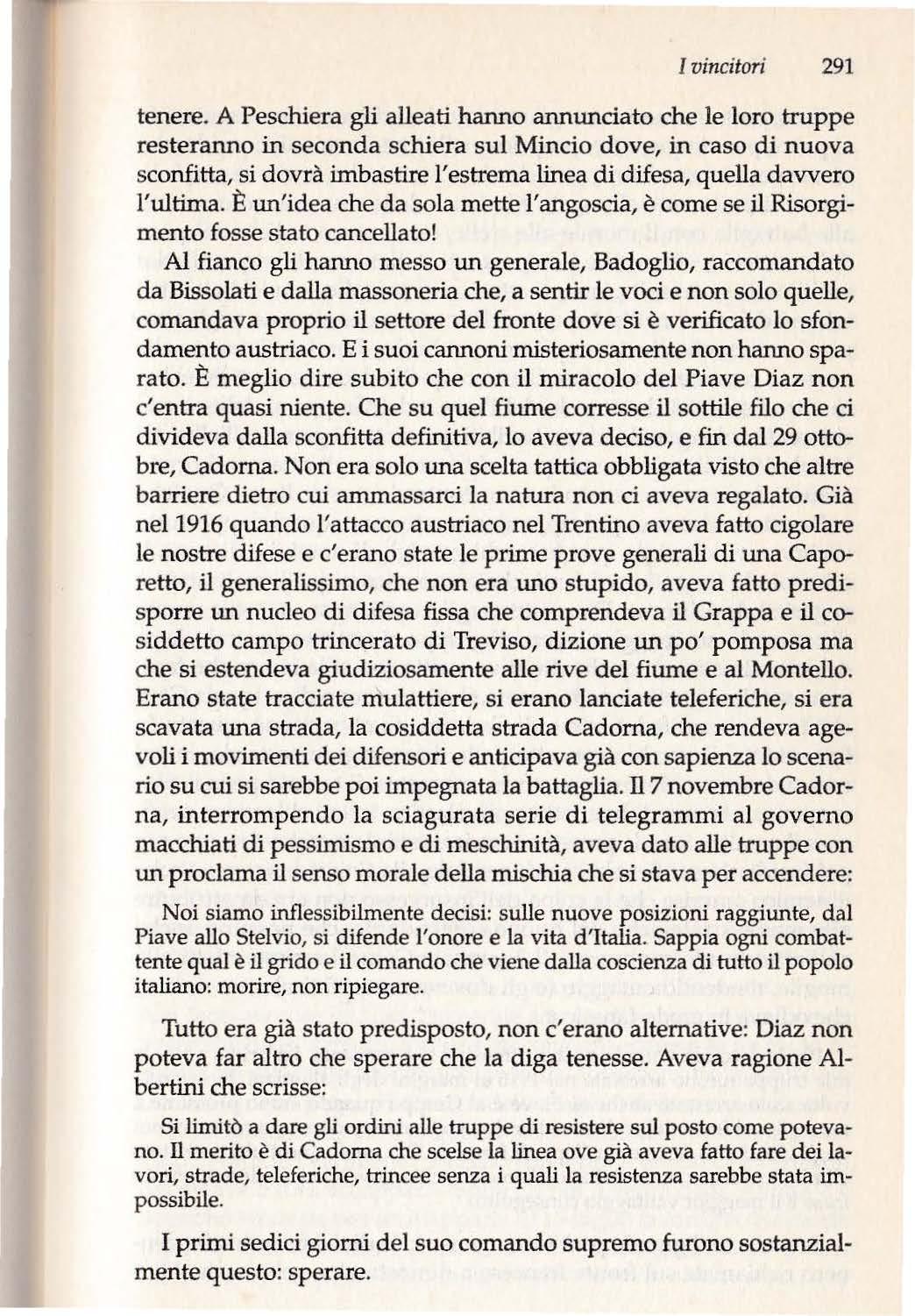
Si limitò a dare gli ordini alle truppe di resistere sul posto come potevano. Il merito è di Cadoma che scelse la linea ove già aveva fatto fare dei lavori, strade, teleferiche, trincee senza i quali la resistenza sarebbe stata impossibile.
I primi sedici giorni d e l suo comando supremo furono sostanzialmente questo: sperare.
Il rapporto numerico tra gli attaccanti e i difensori era favorevole ai primi per cinque a tre, proprio quello che i manuali considerano ideale per vincere; le truppe tedesche e austriache, anche se con le linee di rifornimento allungate e la fatica della rincorsa, accorrevano alla battaglia con il morale alle stelle, non ancora tediate d al peso della vittoria, sicure che i dis prezzati italiani sarebbero crollati e usciti dalla guerra. Il piano di attacco era semplice e micidiale: stritolare i difensori nell'abbraccio delle armate che stavano sugli altopiani e di quelle che irrompevano sul fiume. L'unico elemento che nessuno conosceva, neppure Diaz, era quello decisivo: cosa avrebbero fatto i soldati? Il miracolo del Piave e del Grappa si delineò con chiarezza solo quando, dopo terribili quarantasei giorni, all'alba del Natale 1917, il cannone tacque sul fronte, con gli attaccanti ormai esausti dopo aver cozzato invano contro le nostre linee. Qualche volta retrocedemmo, poi riprendemmo terreno, quasi dappe rtutto uscimmo vincitori da quei barocchi grovigli di uomini e di armi. Il miracolo lo fecero loro, i fanti, che e rano ancora quelli maltrattati e angariati da Cadoma . Diaz, a cercargli meriti, mise uno stile nuovo cli comando: un maggior lavoro di gruppo al quartier generale, la riduzione drastica di quelle direttive scritte con stile feroce che facevano sentire i generali sotto esame, il clima nuovo cli cui parla Gatti che pure era un fedelissimo di Cadorna. Si abbandonò, questo fu importante, il vecchio concetto d e lla difesa rigida, testarda, in cui non si doveva cedere neppure un centimetro di terreno pena il siluramento, a favore di una tattica più elastica, in c ui si lasciava avanzare il nemico dove la pressione era irresistibile e costava troppo per poi insidiarlo s ui fianchi costringendolo alla fine a desistere. Anche il nemico ammise che la colpa dell'insuccesso non era da attribuire alle magie strategiche del nuovo comandante, che nessuno anche s ull'a ltro fronte conosceva. Il 3 gennaio Conrad scrisse infatti alla moglie, rendendo omaggio (e gli doveva costar fatica) a un nemico che odiava in modo fanatico:
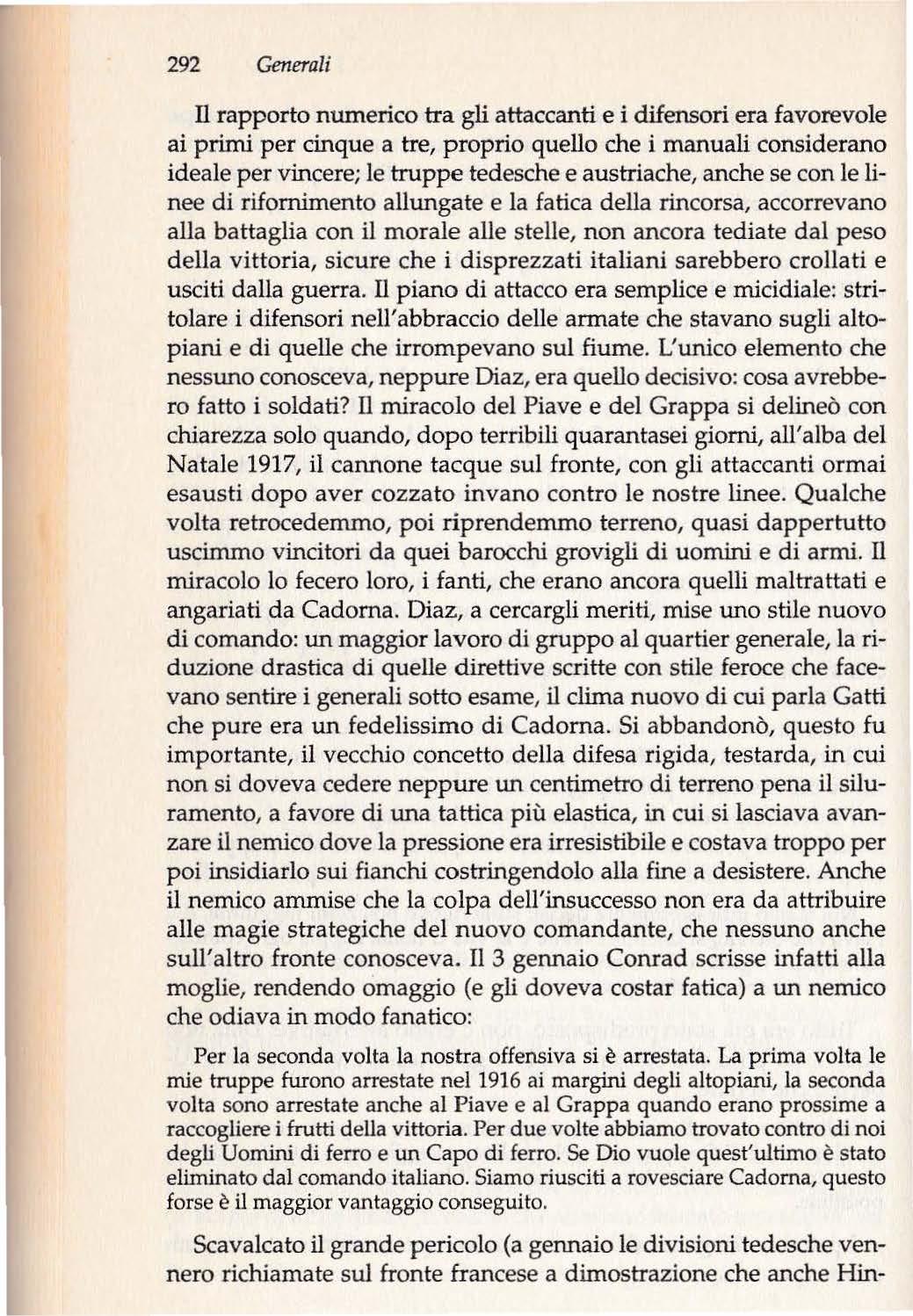
Per la seconda volta la nostra offensiva si è arrestata. La prima volta le mie truppe furono arrestate nel 1916 a i margini degli altopiani, la seconda volta sono arrestate anche al Piave e al Grappa quando erano prossime a raccogliere i frutti della v ittoria. Per due volte abbiamo trovato contro di noi degli Uomini di ferro e un Capo di ferro. Se Dio vuole quest'ultimo è sta to eliminato dal comando italiano. Siamo riusciti a rovesciare Cadoma, questo forse è il maggior vantaggio conseguito.
Scavalcato il grande pericolo (a gennaio le divisioni tedesche vennero richiamate sul fronte francese a dimostrazione che anche Hin-
denburg si era rassegnato a non veder l'Italia cancellata dalla guerra), Diaz poté dedicarsi alla ricostruzione dell'esercito: era il compito in cui il vecchio uomo d'ufficio si sentiva più abile. Anche perché inaugurava con il governo uno stile di convivenza che era esattamente il contrario di quello satrapesco di Cadoma. Diaz ascolta sempre, spesso consulta, qualche volta obbedisce. Scende per qualche mese il potere della nomenklatura piemontese che pure tiene al comando due esponenti come Giardino e Badoglio, scendono quasi a zero i siluramenti (anche se Diaz licenziò un fedelissimo come il generale Pennella che sul Montello non si era dimostrato all'altezza); non si consumano più forze né si fanno vittime inutili in piccoli assalti e dimostrazioni che tanto piacevano a Cadoma. Affluiscono al fronte nuove divisioni di ragazzi entusiasti, altro che sovversivismo!; aumenta la produzione di proiettili, cannoni, uniformi, cibo. I soldati italiani sembrano i veri vincitori; gli austriaci, malvestiti e denutriti, i vinti.
Lo stile e i meriti modesti di Diaz sono tutti contenuti in una lettera che scrisse alla moglie il 18 giugno 1918 mentre sul Grappa infuriava l' ultima disperata offensiva dell' impero austroungarico, l'operazione Radetzky. Nei piani si voleva completare l'opera e schiacciare la perfida nemica; era la carta disperata con cui Boroeviè e Conrad cercarono di afferrare il fantasma della vittoria. Il comando è affidato all'imperatore come si conviene a un'impresa che mette in ballo il destino del regno . «Come sempre mi accade nei momenti solenni» scrive Diaz «sono calmo e influisco sugli animi oltre che con dare mezzi, con l' inspirare fiducia che è tanta parte di ogni resistenza... » Era un uomo per le battaglie disperate, quando ci si affidava oltre che al cannone alla Divina Provvidenza, che ci diede una mano con una piena che spazzò via i ponti gettati dagli austriaci sul fiume. Aveva una gran fortuna, riusciva a intenerire lo stellone italico come nessun altro. La guerra offensiva, le grandi manovre strategiche, diciamoci la verità, non facevano per lui. Era il generale adatto all'esercito di un piccolo paese che quasi a dispetto delle scempiaggini commesse da chi lo dirigeva era diventato una grande potenza. E conservava in molti suoi uomini (e non i peggiori) il senso della fragilità della sua posizione. Nell'autunno del 1918 la guerra però è cambiata, i fronti si rimettono in rapido movimento. Adesso non è più il tempo degli eroismi, del «Piave o tutti accoppati». Spira da noi il vento della vittoria e ci vogliono strategie per acchiapparla. Il 15 luglio la fortuna decide definitivamente di lasciare il fianco del potente signore della guerra Ludendorff, che perde trentamila uomini in un'avanzata senza sue-

cesso. Il 20 agosto le armate alleate passano al contrattacco e comincia per i tedeschi una ritirata che non si fermerà più. Adesso i politici, che hanno capito come sia scomoda la posizione italiana che rischia di presentarsi al momento impegnativo degli armistizi con intere province ancora invase dal nemico «vinto», chiedono l'offensiva a tutti i costi. Bisogna avanzare e in fretta perché la situazione sta precipitando. Qui Diaz mostra tutti i suoi limiti. Per lui quelle sono «spiegabili impazienze» degli «strateghi di Roma», non si sente sicuro, annuncia a Orlando che lo tempesta di telegrammi, che sta elaborando un piano di attacco, ci mancherebbe!, ma ci vorrà tempo, cautela, organizzazione. Il 6 settembre, a riprova che non vuole impegnarsi, va in Francia e chiede a Ferdinand Foch e John Joseph Pershing, il comandante del contingente americano, uno sproposito: venti divisioni per condurre l'offensiva principale sul nostro fronte. Insomma, francesi e americani dovrebbero spostare la guerra d a noi per eliminare l'Austria. Alla Germania si penserà poi, con comodo: tanto tutti dicono che nel 1919 saremo ancora in trincea. La pace è una cosa cosl antica che ormai nessuno pensa che ritorni. È una di quelle classiche richieste all'italiana presentate per farsi affibbiare un profittevole rifiuto. Cosi, ritornato in Italia tra gli sghignazzi degli alleati, affida a Ugo Cavallero, enfant prodige dello stato maggiore, il compito di preparare, senza fretta, l'attacco finale all'Impero. Sono andate perdute quattro settimane che costeranno all'Italia una pace sbagliata, catastrofica.
Diaz fra l'altro scoprì improwisarnente le delizie del condottierismo. Non informò il governo delle caratteristiche del piano di attacco, da loquace si fece misterioso come un dio etrusco, anzi cominciò a dire le bugie. Per ragioni di segretezza, spiegò poi, per il timore che i politicanti spifferassero tutto, in particolare Orlando, awocato e logorroico, e venisse meno la sorpresa strategica che preparava agli austriaci. Una scusa che soltanto i suoi agiografi più tenaci hanno accetta to e che comunque dimostra la considerazione veramente modesta dei generali per i politicanti romani. Comunque Diaz rischiò grosso. Perché Orlando fu a un passo dal licenziarlo in tronco. Il 1° ottobre, infatti, il primo ministro piombò come una furia al comando supremo. Oltre che lo sco rrere dei g iorni e l'ormai chiara agonia degli imperi centrali lo preoccupavano le insistenze degli alleati che chiedevano, invocavano, pretendevano un attacco italiano. Che l'idea di sostituire Diaz non fosse soltanto una chiacchiera di cor ridoio lo dimostra il fatto che Orlando convocò Giardino e gli chiese un parere sulla «situazione generale». Era la mossa burocrati-
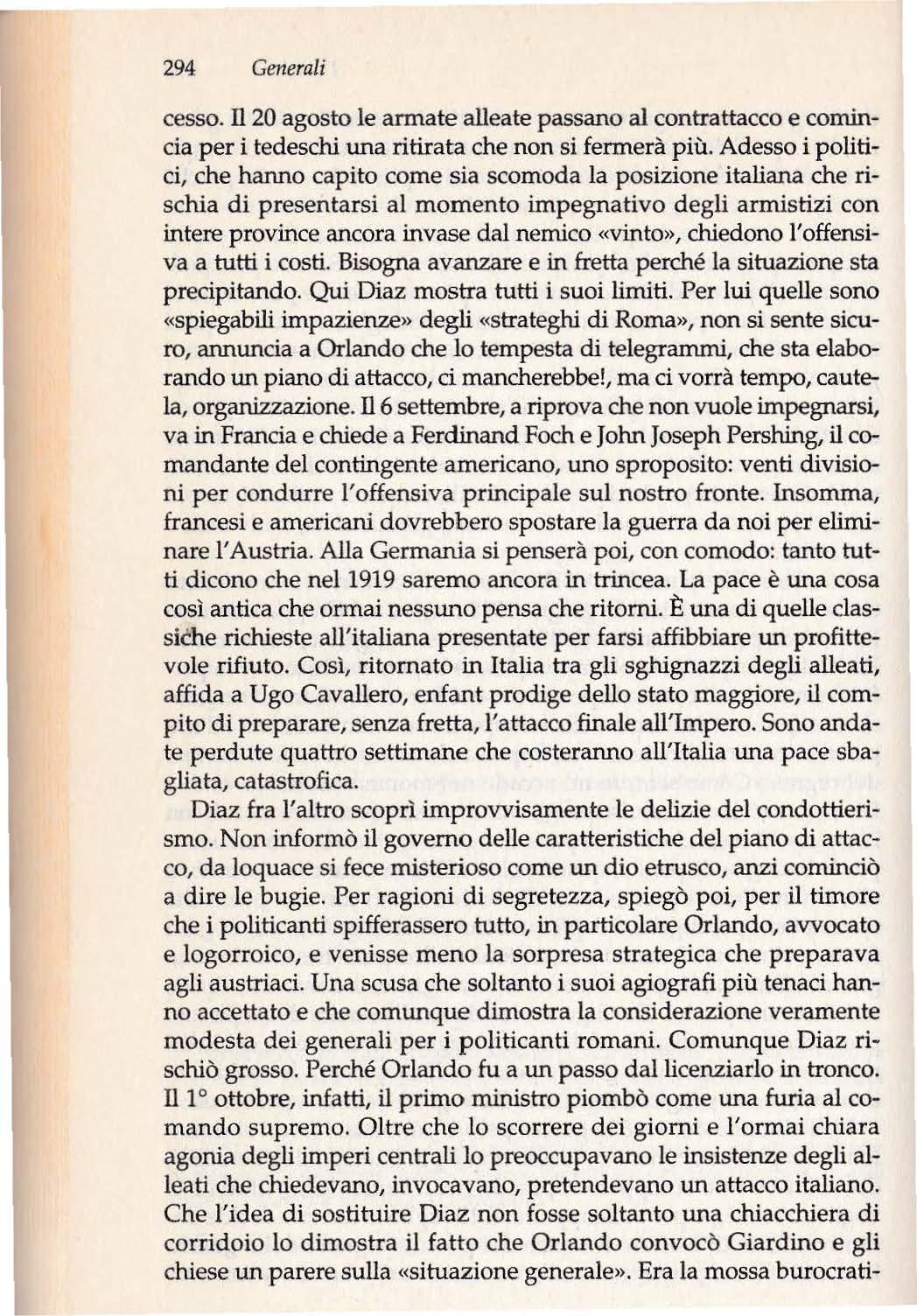
ca che precede le giubilazioni. Giardino, braccio destro di Diaz, non sapeva nulla, poverino, di questo fantomatico piano di attacco in ges tazione (e ciò dimostra che non doveva essere in fase m olto avanzata). Ma capì subito lo scopo di quella inusuale e gerarchicamente scorretta richiesta: se si fosse pronunciato per la poss ibilità di un'offensiva il comando sarebbe stato suo. Prudentemente preferì te nersi s ulle generali dicendo che per attaccare occorrevano dieci divisioni a lleate, altrimenti sarebbe stato m eglio rimandare tutto alla primave ra successiva quando il contingente americano sarebbe stato al completo. È un miracolo se Orlando non lo degradò!
Il primo ministro, rimasto senza munizioni di riserva, si presentò così al colloquio chia rificatore con Diaz, accompagnato per la circos tanza da Badoglio. Evidentemente chiamato a fare da testimone e da spalla in un confronto che si annunciava burrascoso. E burrascoso, oltre ch e ancor oggi incerto n ello svolgimento e nei contenuti, fu. O rlando chiese bruscamente di attaccare per tener fed e agli impegni con gli alleati, impegni di onore, disse, per sollecitare un tasto a cui i due gall onati dovevano esser sens ibili . Diaz, che non fece cenno al mitico piano (la segretezza ha i suoi penosi d overi), secondo alcune versioni offrì le dimissioni, secondo altre pretese un ordine scritto. In questo mod o si ca utelava nel caso di una sconfitta: l'unico responsabile diventava il governo che gli aveva imposto la sciagurata iniziati va. Si parlò anche d i un pugno su l tavolo, ma battuto da Badoglio; anzi n e parl ò proprio lui, che nella s ua versione del colloquio, si ritagli ò il ru olo di protagonista a fian co di un Diaz silenzioso e inerte. Fu con que l pugno fuori o rdinanza che avrebbe messo in fuga Orlando, gridando «allora dia l 'ord ine di a ttaccare e saprà in quanti minuti darò le mie dimi ssioni ». C'è da giurare che sono bugie: le dimissioni Badoglio le dava solo quando gli conveniva! Minacciarle mai : s i rischiava ch e ve nissero accettate. Della testa (m etafori ca) di Diaz s i parlò pure n el Consiglio d e i ministri d el 14 ottobre m a alla fin e preva lse il timore di combinare guasti ancora maggiori e lui r imase a conquis tarsi il titolo di duca d ella vittoria. Il gen erale confidò che la crisi al comando supre mo e'e ra s tata e si era sfiorata una nuova Caporetto a i ver tici d e ll 'esercito: «Due settimane fa m e ntre mi at taccavano da tutte le parti in Consiglio dei ministri si è p e rfino discussa la mia sostituzio ne che, oltre le opposizioni sorte, è fallita p er non saper eh.i porre al mio p osto».
Il 4 n ovembre 1918 quando un paese che non esisteva più, l'Aus tria-Ungh eria, chiese l'a rmistizio gli toccò raccontare l' ultima bugia della guerra a fferm ando n e l b o lle ttino della vi ttoria che l'esercito

italiano era stato «sempre inferiore per numero e per mezzi», evento che mai si era verificato. Era ormai asceso all'empireo dei notabili, un monumento, ma nel dopoguerra non fu all'altezza della fama che gli era piovuta addosso. Nonostante il collare dell'Annunziata, il titolo di duca, il ruolo di vincitore in servizio permanente che gli veniva assegnato in ogni cerimonia, non riuscì a crearsi nell'esercito un proprio partito che ne sostenesse le idee e la politica. Erano i tempi verminosi di Badoglio e del suo clan che, infatti, riuscì rapidamente a scucirgli la carica di capo di stato maggiore. Faceva semmai il consulente del re, gli avevano lasciato un ufficetto e anche lo stipendio di diciassettemila lire l'anno che non gli consentiva di largheggiare. Raccoglieva francobolli, girava i mercatini, rifilava implacabile ai visitatori il disco dove aveva fatto incidere il proclama della vittoria . Un pensionato, un travet quale era sempre stato. Il 28 ottobre 1922, caso strano, era di passaggio a Perugia dove si trovava il caotico quartier generale della marcia mussoliniana. Assomigliava molto a un' ispezione ordinata dal re per controllare se le camicie nere davano garanzie di fedeltà monarchica. Il suo parere, evidentemente, fu positivo e Mussolini gli doveva un favore. Il fururo duce era avaro e avrebbe volentieri fatto finta di niente. Fu lo stesso re che pretese il duca della vittoria nel primo governo fascista come garante. Fu ministro della Guerra. Poi mori.
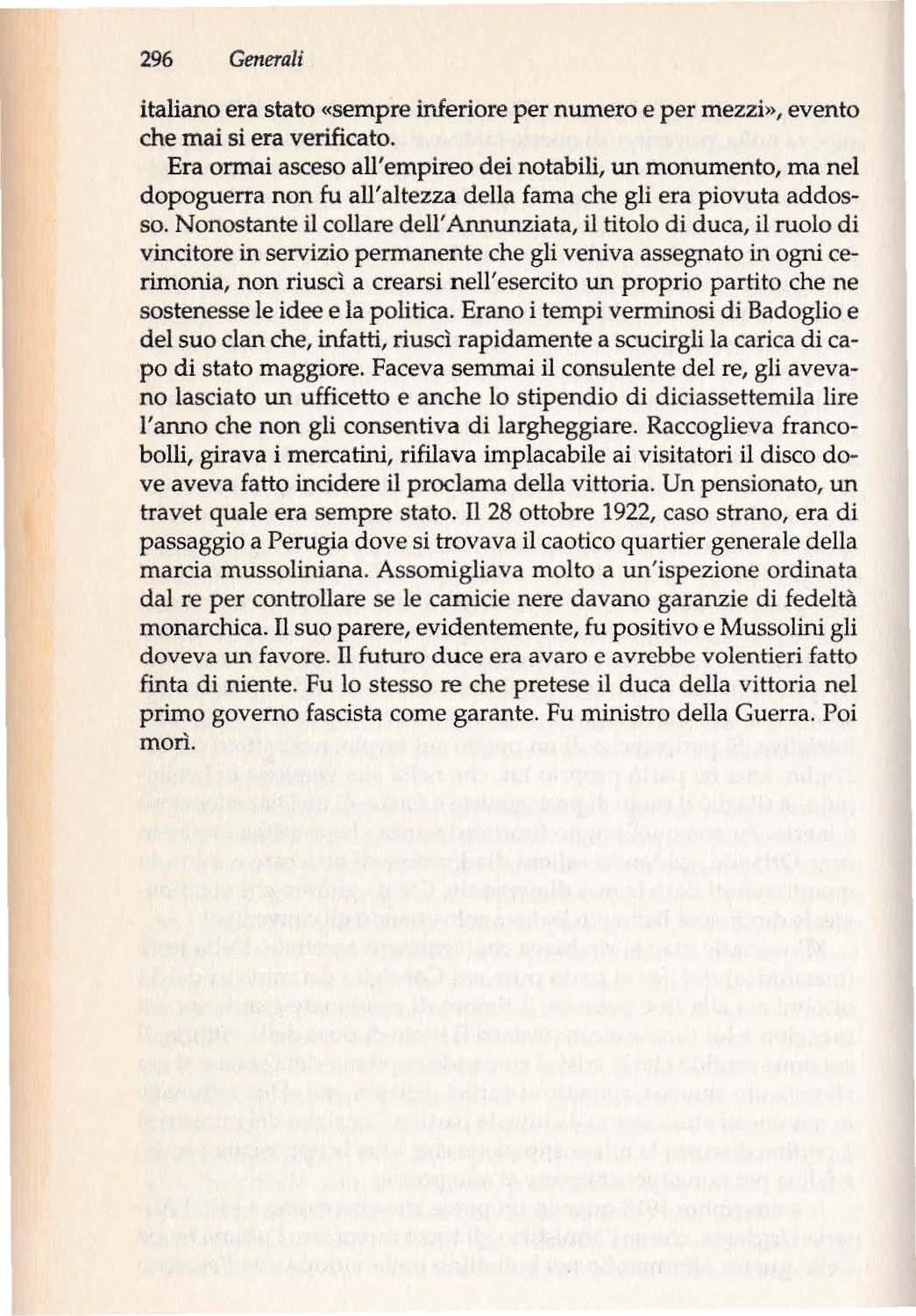
Un generale, famoso, chiuso come una corteccia nel suo abito di soldato, il fascismo l'aveva: eccome! Soltanto che non avrebbe mai potuto esibirlo proprio a causa del suo nome. Si chiamava Emanuele Filiberto duca d'Aosta ed era il cugino del re . Nel 1918 non c'era una persona in Italia che non lo conoscesse, lui, il comandante invitto della IIl armata, l'unica del nostro esercito che nei giorni cupi dello sfascio di Caporetto aveva ripiegato con le bandiere al vento, in beli'ordine e tenendo a distanza di rispetto il nemico. Al convegno di Peschiera, quando gli alleati erano venuti a controllare se l'Italia fosse ancora in grado di combattere, l'inglese Wilson e il francese Foch avevano fatto pressioni perché fosse nominato comandante dell'esercito al posto di Cadoma diventato antipatico, anzi insopportabile. Ma il re, quando voleva, sapeva essere implacabile; pur in quelle circostanze così drammatiche e penose, quando tutti pensavano che gli austriaci sarebbero arrivati come al tempo di Radetzky in piazza del Duomo a Milano, aveva resistito. «È un buon comandante» aveva detto con il tono di chi pensa il contrario «ma non ha abbastanza scienza militare p er condurre centinaia di migliaia di uomini.» Come tutti i piccoletti, Vittorio aveva nei confronti dell'ingombrante cugino, che invece era un omone «alto bello e affascinante», un comp lesso di inferiorità che si trasforma va in livore. Ma soprattutto covava con cura il sospetto dinastico che un giorno il ramo cadetto della casa, perennemente alla ricerca di un trono, potesse riuscire a far traslocare quello principale dal Quirinale. L'aspirazione certo non mancava: a tenerla bella desta accudiva Elena di Francia, l'ambiziosissima moglie del duca, che infatti, tanto per non perdere l'esercizio, fin da bambino aveva chiamato il figlio, il futuro eroe sfor-

tunato dell'Amba Alagi, «il mio piccolo re». Per una beffa del destino quel ragazzino allampanato anni dopo, nel 1941, finito prigioniero degli inglesi, ebbe davvero la possibilità di diventare re: g lie la offrirono i vincitor i che pensavano di seminare zizzania creando una dinastia antifascista. Ma lui, un po' per coerenza e molto per l'anima tentennante che stava nei cromosomi della casata, rifiutò.
Sarà per il brutto scherzo di Peschiera, che si era naturalmente risaputo, sarà per propensione naturale , l' infervorata e augusta coppia era subito approda t a a simpatie fin troppo esplicite nei confronti di quell'ex socialis t a di nome Mussolini e del suo movimento in camicia nera. Il duce, che non era ancora tale, astutamente dava loro corda, lisciav a quella passione, dimostrava nei confronti della coppia «reale» reverenza e simpatia, esattamente il contrario di quanto riservava invece ai Savoia, diciamo così, in carica. Qui tirava fuori dal cassetto e spalancava, con scarsa educazione rivolu zionaria, non si sa quanto fo nda te idee repubblicane .

Non c' era s filata di reduci e di camicie nere a cui i due, soprattutto Elena che era in questo ancor più esagitata e perent oria del marito, non presenziassero: era andata, sollevando scandalo, persino a Fiume, dove le e ra parso che il Vate fac e sse n1aturare con il ~uo estetismo rivoluzionario stuzzicanti chance aggiuntive per la casata. C'è sempre, nella preparazione delle rivoluzioni, qualche principe che si illude che i rivoluzionari lavorino per lui. Si era diffusa così la voce, ai tempi della famosa marcia, che Musso lini si preparasse a offrire la corona dell a sua rivoluzione proprio al duca, icona del buon veterano, pensionando il «re soldato ». E pensare che Vittorio aveva passato la guerra a scattare fotografie mentre il cugino prendeva Goriz ia e difendeva il Piave. Voci a cui il re era attentissimo (forse ad alimentare il sussurro era stato lo stesso Mussolini da buon giornalista ) riport avano che il duca d ' Aosta aveva raggiunto a Perugia i quadrunvi ri per mettersi alla t esta delle scalcinate arma te rivoluzionarie. E forse fu per questo che si decise a spedire il celebre telegramma convocando il capopopolo, che non ved e va l' ora di assumers i la croce del potere, a palazzo invece che alla caserma dei carabinieri.
Qua lunqu e fosse la verità , si e ra rapidamente convertita da cronaca in storia: il fascismo adesso e ra installato ai v e rtici d ello Stato e, impegnatissimo a farsi riconoscere come legittimo occupante dello s t esso, la g loria militare del duca (costretto a r assegnarsi al ruolo fo lcloristico di reduce di lusso) non gli serviva più. Nel 1922 i rapporti tra l ' esercito e il regime che non era ancora tale non si ispiravano all'idillio: i generali - la cui cricca era, nelle mani già deboli di Diaz e
in quelle di acciaio di Badoglio, la vecchla setta piemontese un po' allargata per tener dietro alle «circostanze» - non avevano certo sprecato fatica per stroncarne la marcia verso il potere. Anzi c'erano state connivenze, per omissione, e non solo, con i tempi eroici del!'olio di ricino e del manganello. Sono vicende che gli storici hanno cucinato e riscaldato innumerevoli volte: la neutralità dei vertici militari era stata inventata per mettersi alla finestra e monetizzare privilegi e potere corporativo. Suvvia: la guerra era finita, erano tempi di pusillanimità. Mussolini sapeva benissimo come il duca della vittoria aveva risposto, con un capolavoro di ipocrisia, al re che gli chledeva cosa avrebbe fatto l'esercito se avesse dovuto sparare sulle camicie nere: avrebbe come sempre obbedito, maestà, ma era meglio non metterne alla prova la fedeltà. Il generale Antonino Di Giorgio deputato nazionalista che non poteva certo dirsi un nemico dei fasci (e sarà infatti ministro nel primo governo Mussolini), aveva o non aveva dichiarato: «L' esercito se sarà impiegato farà il suo dovere»? Il sovrano si accontentò appunto della dichiarazione. A Mussolini i generali, quelli veri con le greche non quelli sudamericani che avevano guidato la finta marcia su Roma, stavano antipatici. Senza dimenticare che, con quell'intuito che costituiva la sua maggiore qualità politica, giustamente non si fidava. Confluivano in quel!' antipatia molti elementi: la vecchia ostilità del socialista rivoluzionario verso la camarilla militare dei tempi in cui si incatenava ai binari per fermare le tradotte della guerra libica e li chiamava affettuosamente «sicari del capitalismo». Hai un bel diventare interventista, compiere svolte montecitoriali: la ruggine delle invettive contro i generali massacratori e braccio della borghesia assetata di sangue non la limi via con gran facilità! Un uomo non dimentica mai sino in fondo le parole d'ordine di cui si è imbevuta come una spugna la sua giovinezza anche quando indosserà ventiquattr'ore al giorno una rodomontesca uniforme e si crederà un nuovo Cesare! Per di più c'era di mezzo quella bagatella della guerra: forse il futuro duce non era il mezzo eroe che gli sembrò giusto accreditare ai tempi del potere ma in trincea da bersagliere c'era stato, aveva respirato l'angoscia la rabbia l'indignazione per quella mischia zoologica, per lo sciupio scriteriato e criminale con cui i generali pigri infidi traditori e sanguinari avevano riempito lapidi e ossari con centinaia di migliaia di nomi. Adesso quei generali se li trovava davanti sempre impennacchiati e sussiegosi come se nulla fosse successo. Come si poteva dimenticare?
Non era certo a loro, a quella ghenga monarchica, che il regime
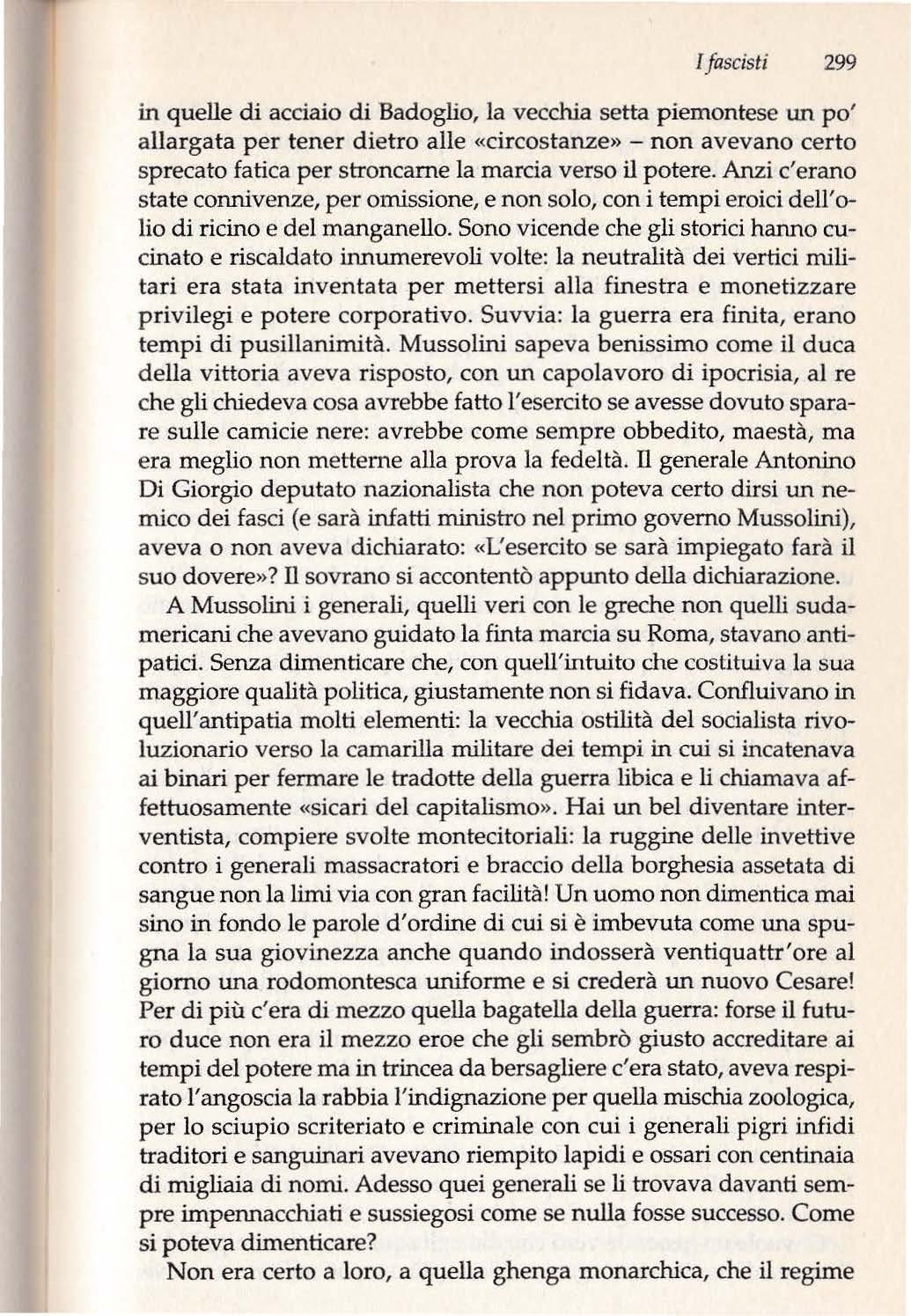
poteva rivolgersi sperando di far breccia nelle forze armate. Negli anni confusi del manganello, quando spediziorù brigantesche e malavitose, quali bruciare giornali o picchiare sindacalisti, erano presentate come il seguito delle battaglie d e l Carso, ci si accontentò di nomi davve ro un po' miseri : G usta vo Fara, Sante Ceccherirù, Asclepio Gandolfo. Erano stati certo valorosi combattenti d ella G rand e guerra, bersa glieri e arditi soprattutto con quel tan to d i canagliesco che b e ne si apparentava con lo «stile» ruv ido dei manipoli squadristi. Ma non erano g iganti , fra l' altro proprio p er le loro scelte p olitiche e rano con sidera ti da gli alti gradi dei p e r sona ggi pittoreschi, squalificati e p ericolos i come teppis ti. Ci voleva tempo perché funz ionassero con quei n otabili le due molle del conforrrùsmo: il posto e la paura.
Bisognava inventars i un generale fascis ta, un s imbolo del regime che s i immaginò sempre erede della Vittoria e battagli os issimo. Il Principale (così De Bono defini va Mussolirù) a Milano aveva irùzia to un contraddittori o con questo incipit: «Fascis ti, fu ori le ri volte lle». Mussolirù si impegnò per vent' anni. Invan o. Poi il duce si rassegnò e sciaguratamente pretese di ess e r lui l' urùco vero cervello militare del regime. Siamo qui ancora intontiti per qu es to equivoco disgrazia to. Per le minute incombe n ze fu cos tre tto a serv ir si proprio di quei generali monarchici infidi e inefficienti, figure da bestiario medievale, che aveva sempre disprezzato. La ricerca di un fascis ta con le greche irùzia ancor prima d ella presa d el potere, nei mesi febbrili ch e precedono il fatidico 28 ottobre 1922. Nel quadrunvirato c' è da sistemare infatti un militare di prestigio che affianchi nella urùve rsalis tica catalogazione della società italiana il s indacalista Miche le Bianchi, il monarchico Cesare Maria De Vecchi, lo squadrista Ita lo Balbo. Quest'ultimo e De Vecchi per l a verità hanno un p assato militare di tutto rispetto e p osson o es ibire sulla camicia nera, senza essere pres i a sassa te, m ed aglie d 'argento ben merita te. Ma sono ufficiali di complemento, sarebbe un po' comico presentarli co me strateghi. Arriveremo anche a quell o, più avanti, p er dispe ra zione, senza paura d el ridicolo con Balbo, da capitano addirittura maresciallo e comandante d e ll' aeronautica. Nella storia militare d ell'umarùtà soltanto un altro caso fece tremare con altrettanta foga le caten e dell ' incredibile. Quello dell'americano John Joseph Pershing: da capitano a gen erale con un balzo solo. Il presidente aveva bisogno di un favore! Ci vuole un generale vero che dia agli squinternati marùpoli d ell' armata di p a rtito una organizzazio n e più o meno militare e una vi-

sibilità propagandistica. Il merito o la colpa, fate voi, di aver suggerito a Mussolini la soluzione lo si deve attribuire a un colonnello dei bersaglieri, Francesco Sacco. Era presente a una delle tumultuose riunioni alla sede del partito a Milano in cui si mettevano a punto i dettagli dell'organizzazione dell ' armata fascista, scamiciata mal armata manesca indisciplinata e, secondo concordi testimonianze, anche sudaticcia e puzzolente. Non erano più i tempi di via Paolo da Cannobio, tra le strettoie e i muri cadenti manzoniani del Verziere: il movime nto di quel rovesciatore di regimi aveva già centomila apos toli. Sacco tra la curiosità generale fa un nome e lo propone come comandante ideale per la milizia: Emilio De Bono. Stupore, curiosità, scetticismo: non lo conosce nessuno . Generale lo è d i sicuro e con una carriera regolare, ha comandato un corpo d 'arma ta nelle giornate decisive del Grappa e ha sul comodino una collezione di medaglie d'argento e citazioni su.i bollettini di guerra da spaventare Diomede. Qualcuno nella stanza comincia a ricordare: è forse quel vecc hietto con la barba caprina, i capelli completamente bianchi, piccoletto, le gambette rachitiche avvolte nelle fasce mol!ettiere, i pantaloni grigioverde che sembra non si tolga mai d'addosso, un petto ingombro di medaglie che da un paio di mesi si mescola alle s filate delle camicie nere pe r le vie di Milano e dei paesi de] Bresciano? Proprio lui! Un generale, perbacco, chi l'avrebbe detto! Qualche bello sp irito, ai raduni, lo aveva scambiato per uno di quei reduci garibaldini che affollavano la storia d'Italia crescendo di numero e di pretese via via che l'epopea dell'Eroe dei due mondi sfumava in leggenda. Si chiedono notizie: disponibile lo è di sicuro, garantisce Sacco, e a qualsiasi cimento; no n ha nulla da fare visto che è disoccupato. Ha fregato anche lui, il complicato dopoguerra. Si è licenziato due anni fa dall'esercito, intristito dal fatto che il suo corpo d'armata s i è raggrinzito sotto i tagli delle spese di quel poco eroico periodo. Si è fatto sedurre dai vantaggi economici offerti ai prepens ionati, trappola antica con cui i governi sfoltiscono i ranghi impiegatizi e affollano quelli d e i gabbati. Sacco, che di De Bono è stato una specie di segretario in uniforme, lavora per il Principale e si guarda bene dal raccontare che prima di indossare ossessivamente la camicia nera su suggerimento di un cognato maneggione e astuto, ha cercato di gettarsi n egli affari sperando di lucrare sulle be nemerenze belliche; e poi ha fatto anticamera cercando uno stipendio e una poltrona proprio da quei partiti popolare e socialista che i fascisti stanno cercando di annientare a colpi di manganello. Anzi, qualcuno potrebbe raccontare di averlo v isto sgattaiolare nel palazzo dei portici setten-
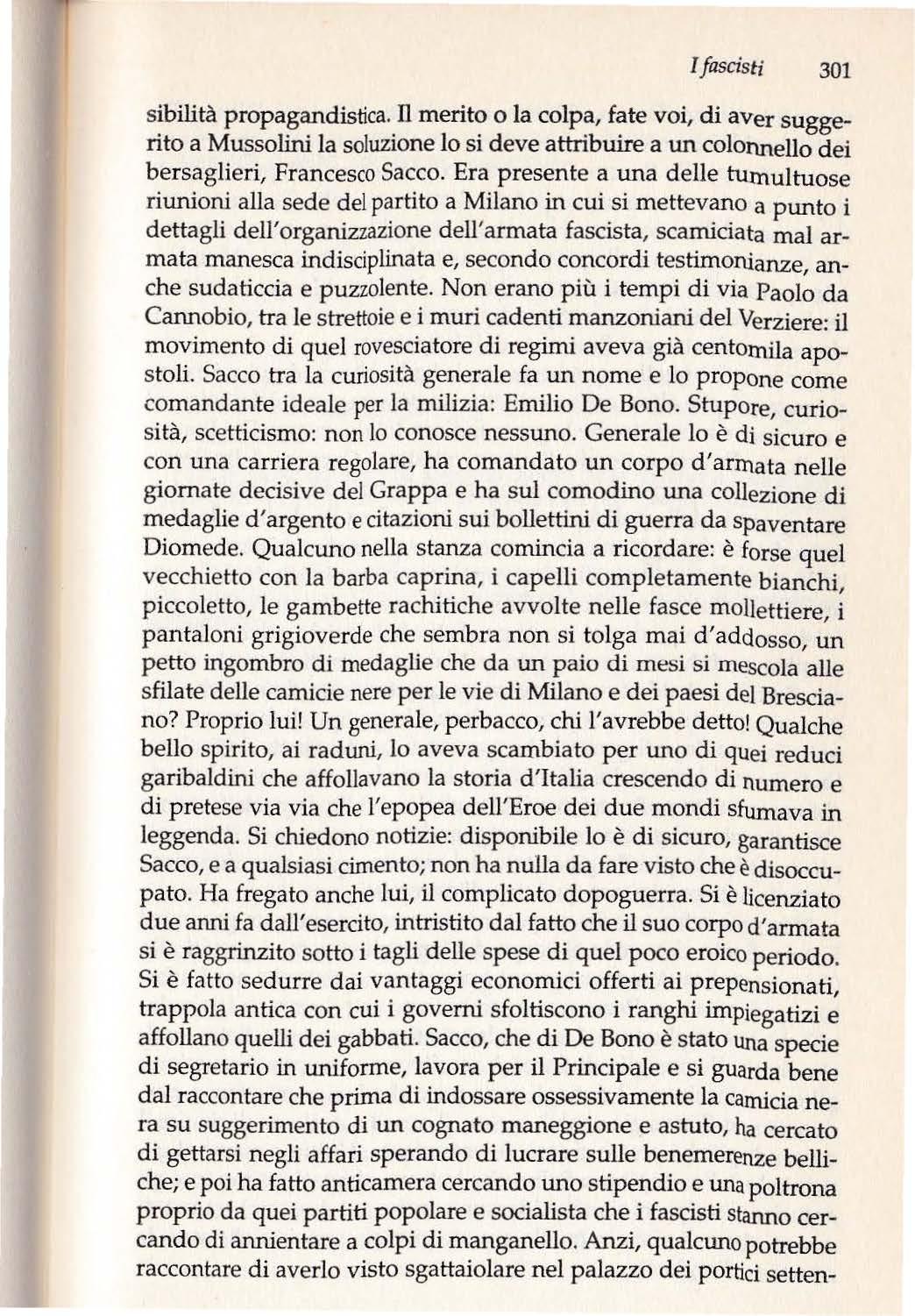
trionali in piazza Duomo 23 dove abita lo stramaledetto Filippo Turati. Avrebbero volentieri fracassato i randelli su quella giacchetta scura e il cappello floscio. C'era andato, pensate un po', per chiedere se per caso cercassero un candidato al ministero della Guerra (eterna fissazione della sua vita). Nei ritagli che gli lasciavano queste frequentazioni aveva collaborato come analista militare al «Mondo», altra parola che faceva storcere il naso ai fascisti. Ma qui ci entrava anche la necessità di uno stipendio perché il generale aveva la pensione assassinata ogni fine mese dall'inflazione .
Per la verità quello squadrista con la barba bianca ai raduni è considerato più che altro una macchietta, un personaggio folcloristico ed è così poco conosciuto che la gente inclicandolo lo chiama Del Bono o De Bonis. Povero generale, l'autorevolissimo «Corriere della Sera», breviario della borghesia non solo lombarda, quando diventerà ispettore generale della polizia lo additerà come Camillo dedicandogli in tutto dodici righe! L'unica benemerenza squadristica bisogna estorcerla con fatica ai biografi più scrupolosi: nell' anniversario della vittoria ha invitato alcuni commilitoni nella sua casetta di Bassano per celebrare. Le nequizie dei tempi pacifisti e bolscevichi e della vittoria mutilata però hanno consegnato quella data a un disclicevole silenzio. Perfino la baldoria militaresca tra quattro mura domestiche appare ai caporettisti feroce provocazione. Un gruppo di facinorosi assedia la casa dove il generale ha esposto fragorosamente il tricolore. Vuol finire il lavoro che gli austriaci hanno lasciato a metà. Lui, richiamato dal tumulto, ancora il tovagliolo al collo, la pasta fumante abbandonata nel piatto, esce impugnando in mancanza di strumenti più mortiferi la pistola giocattolo del nipotino e con aria fierissima mette in fuga precipitosa que i tiepidi estremisti. Non sono referenze da epopea: ma insomma, cercate un generale? Eccolo. È uno che crede al corpo dei bersaglieri come i gesuiti alla Chiesa cattolica. A menar le mani è capacissimo visto che non ha fatto altro in vita sua. Pazienza se sembra uno che cerca uno stipendio più che una rivoluzione. Lo squadrismo si porta sempre dietro qualche scoria. Il consiglio di Sacco è accolto senza troppe discussioni: gli eventi incalzano, i detta gli sono poco rivoluzionari e fanno perder e tempo. Siamo già a metà agosto, il capo ha ordinato di riunire il comando perché presto ci sarà da «marciare». L'ultimo esame al generale lo fa l' ex capitano Balbo che lo trova simpaticissimo (poi gli entusiasmi reciproci si raffredderanno anche se i due cercheranno cli non perdersi di vista in quella grande giungla arrivista che sono le retrovie del regime):

Aperto brillante. Ha uno charme particolare, unico, che conquista di colpo. Uno spirito fresco ricco di arguzie incisive.... Larga conoscenza della vita, memoria di ferro. Spira energia e umanità.
Assunto. Così i triunviri divennero quadrunviri.
De Bono accampò poi, nei suoi libri e nei suoi ricordi, preveggenti meriti fascisti che fece risalire agli anni della guerra quando il duce era un giornalista che aveva annegato nell'interventismo le sue colpe «bolsceviche», mutando il sottotitolo della bibbia quotidiana dei socialisti in quello di «Giornale dei combattenti e dei produttori» . Citava una lettera scritta a un amico il 19 luglio 1917 dove addirittura il nome di Lui era già vergato con monumentale preveggenza tutto maiuscolo:
Non abbiamo uomini, non abbiamo saputo far la réclame all'estero della nostra guerra ... Fa niente: faremo la rivoluzione poi. Quella ci darà l'Uomo, o gli uomini. Sai chi è il più sincero di tutti? BENTIO MUSSOLINI! Mi pare di averti già detto che io chiamerei fin d ' ora lui al governo... mettiamoci, o caro, neJJe mani di Dio visto che non possiamo metterci ancora in quelle di Be~ nito Mussolini, l' unico Uomo che sarebbe realmente capace di fronteggiare la situazione.
Ai meriti di quella stupefacente saggezza politica che si tingeva delle virtù della Sibilla aggiungeva anche una meno verificabile relazione epistolare di cui però non restano, purtroppo, confortanti tracce. Fu così che il generale a riposo dall' aspetto persino più vecchio della sua età divenne comandante dell'esercito privato di un partito che al giovanilismo mezzo rivoluzionario e mezzo marinettiano ispirava tutto il suo bagagliume retorico e iconografico . Se Mussolini aveva sperato per un attimo che De Bono gli portasse aderenze negli stati maggiori dovette subito rassegnarsi. Il suo uomo, eroico e simpatico e così fascisticamente entusiasta dell'impiego, non era la persona giusta. Pochi giorni prima che la marcia scattasse, infatti, De Bono ricevette una sgradita convocazione al ministero della Guerra . La poltrona era occupata, ancora per pochi giorni, dal generale Marcello Soleri. In quella compagine ministeriale segnata dalla paura e dalle complicità a cui dava una faccia appropriata il debolissimo Luigi Facta («nutro fiducia» era il suo motto salgariano), costituiva l'unica persona decisa e che detestava il fascismo e la sua baraonda. Aveva infatti ordinato di tener d'occhio i depositi perché tutti face vano finta di non sapere che dalle armerie del1'esercito uscivano ben oliate le armi dei fascisti. Soleri, con l'aria risoluta da usciere giudiziario, fece una solenne sfuriata a De Bono. Era ancora un generale effettivo dell'esercito, gli ricordò, anche se
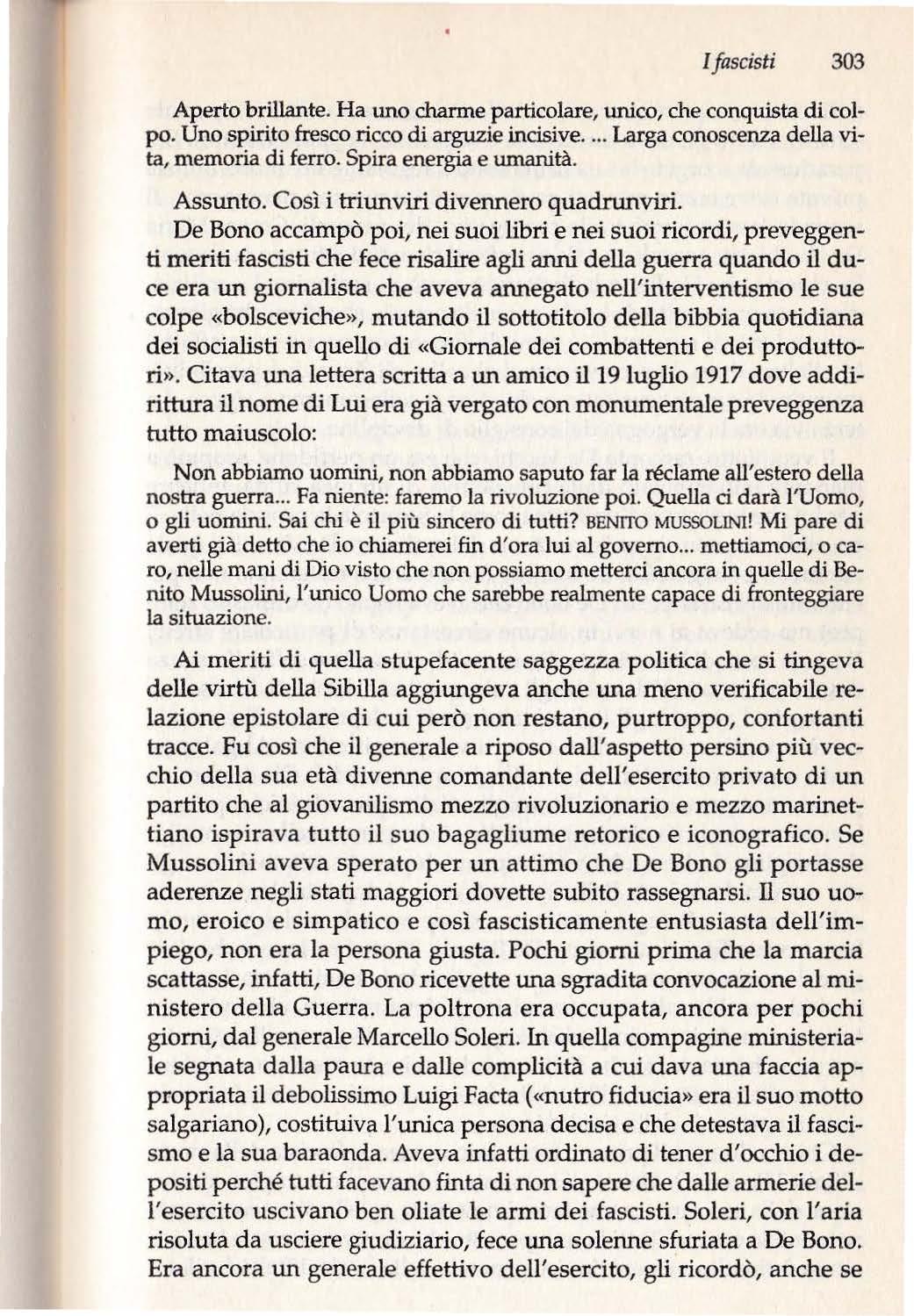
nella retrovia amministrativa della Posizione Ausiliaria Speciale (che fra l'altro gli dava diritto a uno stipendio, seppure ridotto). Era paradossale scorgere la sua firma sotto il regolamento di una milizia privata dove erano previsti gradi compiti e persino ricompense. Il secondo lavoro non è tra le prerogative dei generali . Cesare Maria De Vecchi, che raccolse a caldo i sofferti ricordi del futuro maresciallo, riporta che De Bono balbettando cercò di sminuire. La milizia, disse, era un esercito da burla, gente da osteria, sbruffoni che giravano con bastoni e pugnali, e armi da fuoco non ne avevano affatto. Ma l'altro, duro, lo serrava ormai al collo: gli dava due possibilità: smentire quanto aveva fatto o chiedere il collocamento a riposo. La terza via era la vergogna del consiglio di disciplina.
Il vecchietto, racconta De Vecchi, che era un perfidone, scoppiò a piangere imbambolato dalla prospettiva di un mea culpa, funebre per lui che indossava l'uniforme come la lucertola la propria pelle . È possibile che non sia un' invenzione del malizioso De Vecchi, il quale adorava i pettegolezzi. Le lacrime facili erano e resteranno una peculiarità del carattere di De Bono che aveva fegato (lo dimostrò sempre) ma cedeva ai nervi in alcune circostanze di particolare stress. Era una sorta di bovarismo, di nevrosi di chi sente e soffre l'assenza di un vero amore. Voleva che gli volessero bene, i soldati, Mussolini, la moglie, l'amante, gli italiani: a ltrimenti si deprimeva. Il generale cercò una diversione, chiese un rinvio per riflettere. Al galoppo andò a cercare conforto dai colleghi quadrunviri. Gli dissero di prender tempo accettando il consiglio di disciplina. I cinici sapevano benissimo che le rivoluzioni son fatte anche per cancellare i consigli di disciplina. Lui eseguì. Qualche paura dopo aver saltato il fosso gli era rimasta, lo rodeva. Balbo raccontava anni dopo, tra le risate, che nelle riunioni a Perugia mentre non si sapeva se le «colonne» avrebbero trovato fiori o cannonate, De Bono, il 28 ottobre, invece che dirigere il movimento rivoluzionario scagliando fulmini contro il tarlato pachiderma liberale, marcava visita. Voleva ritirarsi, abbandonare tutto sperando in un improbabile perdono reale per quella gigantesca sciocchezza; tanto che l'altro quadrunviro fu costretto a rinchiuderlo nella sua stanza all'hotel Brufani, poco eroico ma confortevole quartier generale della rivoluzione. Chi era dunq ue il primo e forse unico generale fascista della storia d'Italia? Povero De Bono, gli è rimasta addosso per la tragica conclusione della sua carriera una fama immeritata, quella di essere un monumentale cretino . Tutti hanno pensato che doveva essersela ben cucita se è riuscito a essere l'unico generale della storia d'Italia fucilato!
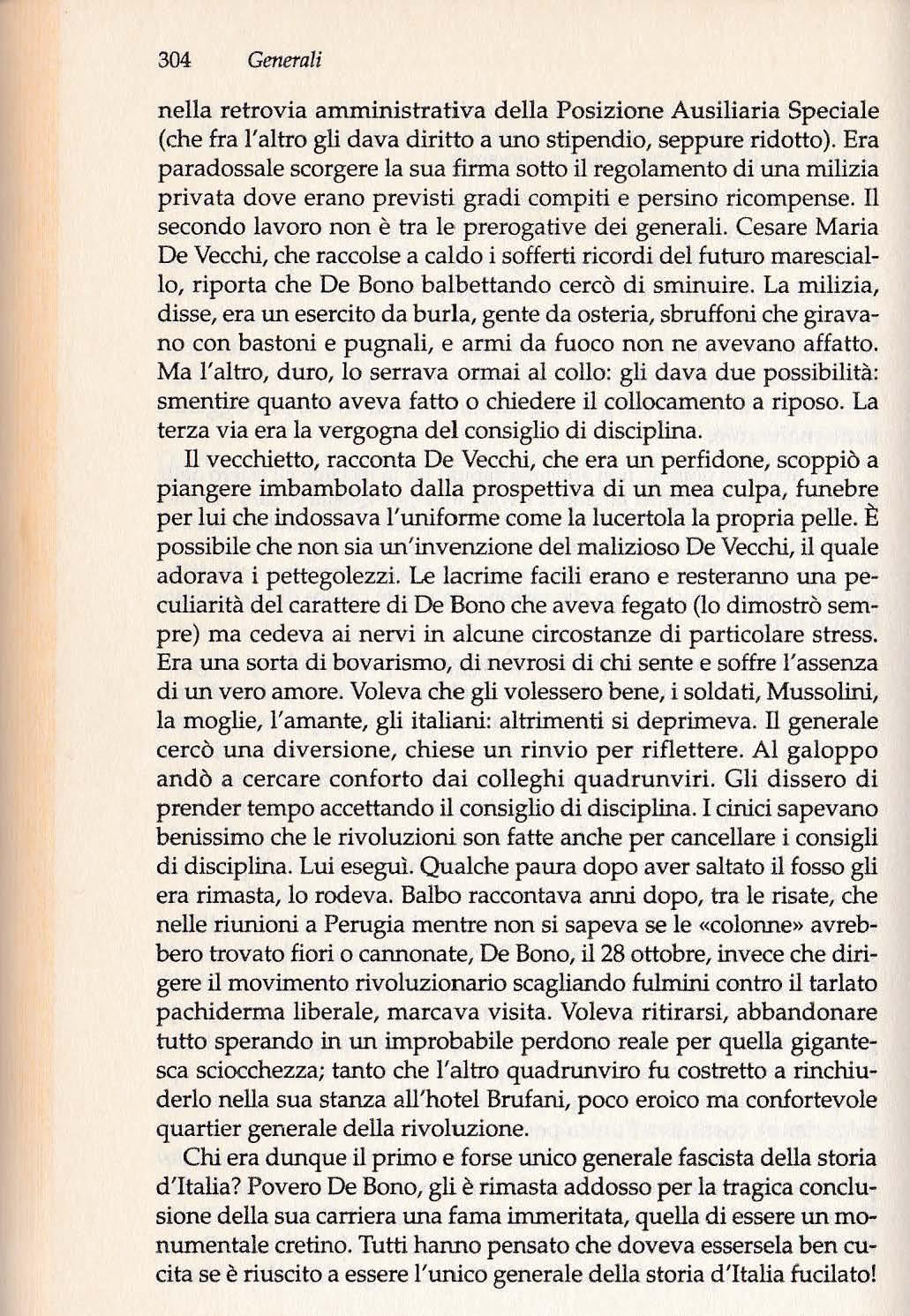
A costruirgliela è stato soprattutto il Principale, il Capo come lo chiamava nelle lettere, il demiurgo a cui doveva la carriera. Benito Mussolini, che fu sempre bruta le e maleducato con i suoi sottoposti esibendo l'arroganza del parvenu che si crede geniale, distribuiva disprezzo a piene maru: «È un vecchio cretino. Non a causa degli anni che possono rispettare l'ingegno, se c'è stato, ma perché è sempre stato cretino e ora è anche invecchiato». Non era facile essere mussoliruaru! Il duce in fasce avrebbe voluto muovere già allora uomiru e cose, fare tutto in un attimo sopprimendo il dazio del tempo. Era questa fregola che gli faceva sembrare tutto lento, malfatto, per cui ogru tanto maltrattava i s uoi fidi strumenti. Fra l'altro di De Bono lo irritava perfino la barbetta risorgimentale. Era noto a tutti che il duce detestava le barbe. Se così parlava il capo figuriamoci gli altri.

E invece De Bono forse non lo meritava. Aveva almeno capacità militari che tutti gli negavano, a cominciare dal suo arcinemico Badoglio, che faceva finta di non avere le vergogne di Caporetto e guidava una claque mafiosa di insopportabili mediocri. Veniva il patriarca da quella classe piccoloborghese (il padre era un militare di grado intermedio) che cominciava a sostituire a poco a poco anche negli alti gradi i nobili che avevano monopolizzato il posto sino alla fine del secolo. I lombi delle grandi famiglie si erano esauriti a fornir i figli stupidi, come diceva Giolitti, al cannone nemico. Adesso era ora si facessero sotto gli altri.
La calunnia, e l 'invidia, hanno perseguitato De Bono, con metodo, fin dalle prime pagine della biografia: nel Ventennio, nei corridoi degli alti comandi circolò sempre la leggenda (diffusa, non c'è mai suspence, dagli ambienti che erano vicini a Badoglio) che fosse stato un allievo mediocre se non un asino, tanto da esser bocciato alla Scuola di guerra. Era sicuramente una calunnia. Certo la sua carriera non fu folgorante: fra un passaggio di grado e l'altro intercorse sempre il meditato decennio necessario perché scattasse la lodevole ma non certo eroica promozione per anzianità. De Bono, lo racconta nei suoi diari, assomigliava a molti giovanotti di quell'Italia che mostrava i muscoli, non vedeva l'ora di menar le maru e far scatti a colpi di medaglie. Aveva scelto apposta il corpo dei bersaglieri, che erano un po' la Delta Force del nostro esercito; ma firuva sempre all'intendenza o allo stato maggiore lontano dalle cannonate. Passarono sedici anru perché trovasse finalmente un posto, la Libia, dove la mitraglia nemica se lo trovò di fronte. Per questo gliene venne un umore perennemente tendente al nero. Si considerava sfortunatissimo. Vedeva nei colleghi che lo sorpassavano nella corsa alle medaglie agli or-
dini militari alle promozioni una perenne congiura, li squadrava in cagnesco, sospettava agguati di sette perfezionatissime e costituite, chissà perché, per nuocere a lui e alla nazione tutta. Era avarissimo, qualità certo non indizio di grandezza, i suoi diari sono pieni di lamentele: lo stipendio da generale non ha voci e integrazioru fuori busta che ingrassano altri parigrado. Strepita per lo straordinario, il rimborso spese, il forfait. Gli riconoscevano una sola prodigalità, per i vestiti che si faceva confezionare da Caraceni ed erano già allora carissimi. Per il resto, milionario come era, viveva da povero, in questo appoggiato e benedetto dalla moglie che era più tirchia di lui. Per diventare colto non aveva speso molto tempo. I suoi diari sono pieru di strafalcioni di latino, torturava la prosa con gli arnesi tipici della mezza cultura di una borghesia pretenziosa e approssimativa. Anche se come scrittore le sue rievocazioni degli anni della caserma sono spesso godibilissime, affollate di personaggi e di storie. Il suo catastrofismo lo spingeva a temere sempre a ogni dolorino l'assedio di malattie terribili. Invece, a dispetto di un fisico non certo marziale, godette, si può dire fino al plotone di esecuzione e nonostante i bellici strapazzi, di una salute di ferro. Semmai le angustie gli veruvano da una moglie precocemente alcolizzata e imbarazzante. Si mormorò per anru di una relazione con il capostazione di Bassano durante le lunghe assenze di servizio del marito, e la tresca, vera o finta, non poteva certo contribuire alla credibilità del medesimo. Ripagava e restaurava con non troppo segrete avventure con donne del demi-monde, (di «contesse» improbabili abbonda la sua biografia) dall'aspetto giunonico e dai non purissimi interessi. Quando scoppiò la Grande guerra, che nessuno all'epoca sapeva ancora sarebbe diventata tale , De Bono fu tra gli entusiasti, i lodatori di una frizzante avventura di cui non si intuivano i rischi e la ferocia inumana. In fondo lui dichiarava di adorare la guerra senza tante perifrasi, il macello ha d egli svantaggi ma accelera la carriera. A dimostrazione che non era un folle sprovveduto denunciò subito nei diari che c'erano magagne e molte: due mitragliatrici per reggimento, le bombe a mano erano ignote e mancavano persino le uniformi con il nuovo colore grigioverde mimetico. Gli bastarono pochi giorru per esclama re sul diario: «Questa è guerra, altro che Libia!» e accorgersi che le manovre di Ca doma erano «una fesseria». Ma di fronte all'azione, alle bombe e finalmente a un comando scordò tutto e si gettò nel fragore della battaglia. Aveva fame di pericolo, difficoltà, violenza.
Gli hanno affidato la brigata Trapani, formata da siciliani, che ha
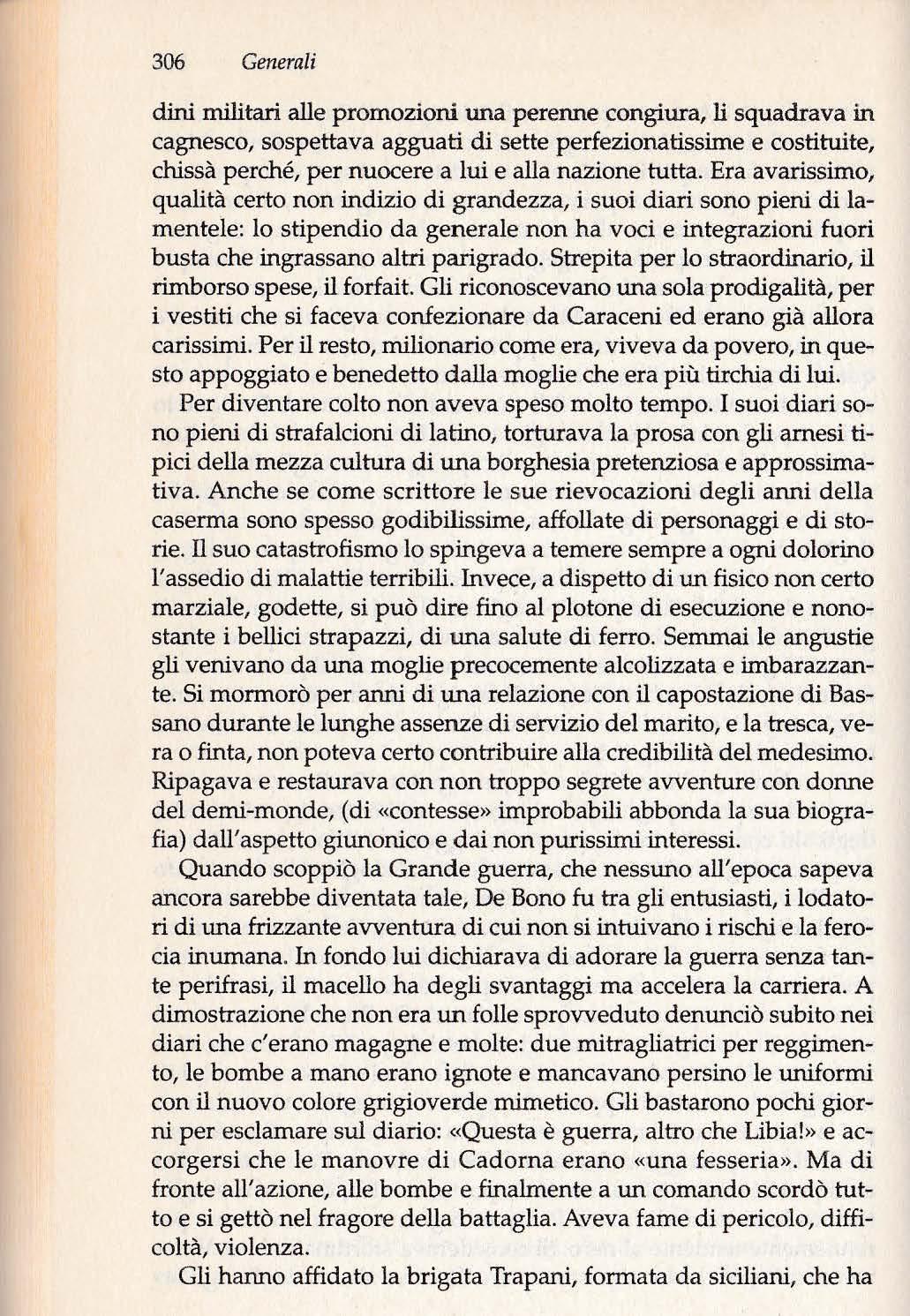
una fama pessima, forse per vederlo nei guai. Sono quasi tutti analfabeti, gente capace di una sopportazione infinita ma con cui è necessario parlare attraverso gli interpreti, neghittosa e rassegnata. De Bono si dimostra quello che è: un eccellente organizzatore. In epoca di ferocie cadorniane, cura il rancio facendo arrivare nelle gamelle gli amati spaghetti; riveste i soldati poiché alcuni si portano tutto addosso, divise estive e invernali, beni, armi, unico modo per evitare che siano subito rubati; fa concedere le sospirate licenze. A qu el vecchietto dall'aspetto poco marziale ma che ha fegato e sembra inesauribile i soldati vogliono bene. Lo ripagano al Sabotino dove sono protagonisti della vittoria che resterà nella Storia, invece, come sappiamo, legata ad altri nomi. Sono mesi duri anche per uno che ha fatto collezione di medaglie e di citaziorù sul bollettino di guerra. È popolarissimo presso gli altri generali grazie al cuoco che ne cura i pasti. Quest'ultimo prima di essere arruolato lavorava sulle navi da crociera e nel suo mestiere ci mette dell'arditismo, forse persino esagerato. Sotto il Sabotino si spinge per esempio fino ai reticolati p er pescare e portare in tavol a del pesce. Insomma a ndare a pranzo da De Bono diventa una leggenda. Ospite fisso è anche d'Annunzio che, immaginifico come al solito, ha defirùto il cuoco «il cordon bleu di De Bono» e si rifà dei pranzi da monastero della Quaran tacinquesima divisione. A far sudare e a togliere il sonno provvedevano non solo gli aus triaci ma soprattutto i colonnelli e i generali:

Avevano la preoccupazione del nemico che era davanti e spesso avevano quella maggiore del nemico che avevano di dietro: il superiore . Con ciò troppe volte erano portati a operare non secondo le circostanze e condizio ni del momento, ma cercando di indovinare i desideri del superiore.
Dal 1916, dal momento in cui la guerra e la retorica della vittoria si erano immalincorùte nelle trincee, il verbo più usato nei rapporti è «silurare» che ha preso il posto del canorùco «esonerare dal comando». Si silurava a tutto spiano, qualche volta perché c'erano ragiorù, qualche volta per dimostrare energia a spese dei sottoposti e non essere a propria volta silurati. Insomma la conseguenza era che i soldati, sp ettatori esterrefatti di quella serie ininterrotta di bocciature accuse pensionamenti, cominciarono a pensare giustamente di essere guidati come diceva De Bono da «fessi». De Bono si dimostrò un rissatore incorreggibile, ma dai suoi racconti ne emerge il lirrùte, lo stesso di quas i tutti i generali italiani e non solo di quella guerra dannata: è partito per un conflitto complicato con idee semplici, co-
me il suo aspetto fisico è fermo al secolo precedente, alle mischie del Risorgimen to. E con la consueta innocenza lo confessa: «Eravamo ancora spaesati, la guerra che si combatteva non era quella che ci avevano insegnato».
Basta leggere il racconto della sua prima azione come comandante di brigata . Arriva in trincea che è buio pesto e assiste allo sfilamento dei suoi soldati e al rientro in retrovia di quelli a cui danno il cambio: facce felici si incrociano con sguardi cupi, battute con silenzi impregnati di preoccupazione. Poi entra nella buca da dove deve dirigere l'azione e si accorge, stupefatto, che non vede niente. Era rimasto alle battaglie tripolitane con il comando su una duna, il galoppare delle staffette, gli ordini tattici dati in presa diretta guardando le mosse del nemico. Ma Il le trincee nemiche sono a cinquanta metri, solo una linea scura dove si intuiscono mitragliatrici uomini fucili. «Non c'era che da cacciarsi sotto e poi ... e poi si sarebbe visto.» Quando arrivavano gli ordini di attacco salmodiando non c'era che tirar fuori il vecchio regolamento: «L'obbedienza deve essere pronta rispettosa e assoluta» (avevano tolto il cretinissimo aggettivo «cieca» dopo il 1870, ma se si volevano evitare guai era sempre meglio non dimenticarlo). Alla fine di quel 1916 così ricco di soddisfazioni arriva la grana: la Trapani cozza contro un ostacolo troppo solido anche per lei: il Veliki, un'immensa banchina di muri compatti e grigi, percossa dai bolidi infuocati da «130»; la terra sussulta, schizza pietrame e fango. Non si passa. Il generale Luigi Capello, cento dilli di pura cattiveria, riserva un cicchetto al generale Venturi, superiore di De Bono, per lo scarso mordente nell'attacco, e lui lo gira come da regolamento al sottoposto. Con dieci giorni di arresti: uno schiaffo .
Gli tolgono il comando della Trapani. E mentre già si abbandona alle lacrime e considera defunta la carriera gli arriva il colpo di fortuna: cercano generali anche in naftalina per un fronte secondario, balcanico, l'Albania, terra di fango, briganti e minareti dove siamo andati a ce rcar di salvare il collo agli alleati serbi. De Bono che pur di comandare qualcosa andrebbe tra i tartari, accetta: è la sua fortuna. Evita così di finire nell'ingranaggio tritagenerali di Caporetto. Quella è una guerra da burla contrapposta al Carso con la sua enorme imposta di sangue e di dolore: si combatte più contro il freddo e la pioggia che contro gli austriaci, qui particolarmente dis creti e tranquilli. De Bono trova il tempo persino per darsi alla sua passione più sciagurata, la letteratura. Scrive infatti due testi teatrali - un dialogo veneziano (Minuetto) e una rivista (L'Albaneide)- che vengo-

no rappresentati, dice lui, con enorme successo e attori tratti dai reparti territoriali a Draisciovitza tra il pubblico giubilante fra cui sono segnalati anche ufficiali inglesi e francesi di passaggio. L'Albaneide, di cui pare fosse orgogliosissimo, la mandò in scena la sera del 15 marzo 1917 alla vigilia del suo ritorno sul fronte italiano, presenti il comandante del corpo d 'armata e «tutti i soldati che erano a portata in città! ... Fu un vero e clamoroso successo». Peccato non sia rimasto nulla dei due testi; sappiamo abbastanza delle sue composizioni poetiche, scriveva anche versi, nulla ci è risparmiato per dover temere pericolosi attentati alla settima musa. De Bono infatti aveva un talento speciale n el martoriare l'italiano, ci metteva gusto, fantasia, tanto che Mussolini rifiutò alcw'li suoi articoli con la dizione perentoria di «impubblicabile». E certo non per le idee antifasciste. In compenso, tra quelle montagne balcaniche le notizie della disfatta, delle armate liquefatte sull'Isonzo e il Tagliamento, dei generali cacciati con ignominia gli arrivano attraverso le soffiate degli runici dello stato maggiore. Gli altri crollano, lui fa carriera con una guerra, questa sì, da operetta.
I vuoti creati dai siluramenti aprono nuovi posti da generale e le disavventure del Veliki in quel disastro sono ormai divenute bagatelle. Gli assegnano addirittura il comando d el Nono corpo di armata sul Grappa. Arriva sempre un po' in ritardo De Bono. L'epopea del Piave si è già conclusa. Riesce ad acchiappare ancora l'offensiva Radetzky, ultimo guizzo dell ' imperialregio esercito ormai morente. De Bono se la cava in modo gagliardo, nonostante sul suo tratto di fronte si sia precipitata l'offensiva nemica più indiavolata . Si cuce sul berretto la corona dorata di tenente generale.
Ma il suo contributo più rilevante alla vittoria resterà quello della Canzone del Grappa. È storia curiosa. Raccontiamola. Si era diffusa, come accade nei momenti di forti emozioni, la voce che nei territori invasi la gente cantasse per dar spazio alle proprie speranze una canzone che cominciava con le parole «Monte Grappa, tu sei la mia patria ». Una leggenda dei tempi di guerra. I contadini del Piave avevano ben altro a cui pensare che inventare canzoni patriottiche. E gli austriaci riveriti oggi come gran signori erano abbastanza irnmalvagiti per destinare sbrigativamente a un muro chi fosse stato sorpreso a intonare questo m o tivetto. Il comando supremo che ora punta alla guerra propagandistica esige di avere testo e musica della patriottica canzone. Non vuole intendere ragioni: tutti dicono che esiste e quindi c'è. Trovatela. De Bono, strimpellatore a orecchio (non conosce le note) e poeta impavido (ha letto i suoi versi pure a d' Annun-
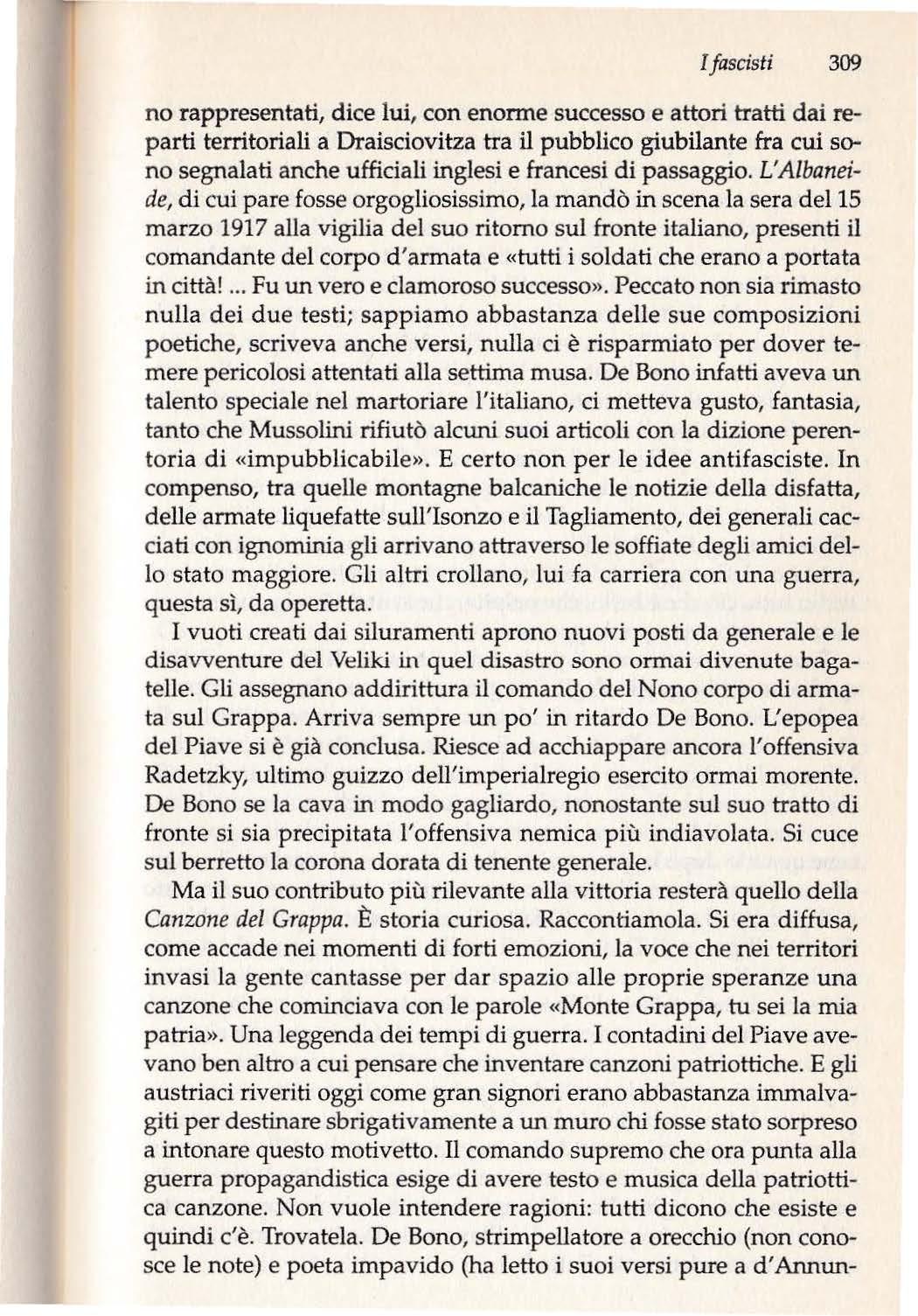
zio, il Vate fu grande a non stramazzare), si mette una sera al pianoforte che presidia un salone della splendida villa Dolfin dove ha sede il suo comando e inventa lì per lì la Canzone del Grappa. Alla musica provvede un ufficiale del Novantunesimo, tale Antonio Meneghetti, che di mestiere faceva davvero il musicista. Il motivo è spedito al comando che finalmente soddisfatto, diffonde. Tra le risate di De Bono e dei suoi camerati che sanno la verità.
Poi accadde l'ultima cosa che un soldato spera possa accadere e la prima di cui ha timore: la pace. La fine della guerra è per De Bono una tragedia e non soltanto per le turpitudini e le miserie della vittoria mutilata. Lui si è divertito: «Da che ho comandato il reggimento su su fino al corpo di armata io mi sono sentito e sono effettivamente sempre stato "il Signore". Mi sentivo "Io"».
Il suo inno alla strage non è marinettismo di recupero, è la frustrazione di uno che è nato con la divisa e sente di aver perso l'impiego: «Fine dunque; fine definitiva ... magari sono io un anormale; anzi certo è così. Coraggio. Addio mia bella vita passata; addio emozioni; addio tutto ciò che è bello, che palpita, che sente! Viva la guerra, perdio, viva solo e sempre la guerra».
È arrivato il momento di parlare del fascismo di De Bono. Cosl liquidiamo anche quello degli altri generali. La sua decisione, ripetiamolo subito, non è affatto ideologica: delle astruserie politiche del Principale non sa nulla, si tiene alla larga. A De Bono l'università di Milano ebbe il coraggio incivile di attribuire una laurea in filosofia (ne rideva pure lui); ma certo le riflessioni politiche non erano la sua passione quotidiana. Anzi detestava la politica, cominciò a occuparsene quando dopo la guerra vide che ai disertori si regalava il congedo con la menzione di merito come a quelli che avevano arrancato nelle trincee. Il suo fascismo è fatto di rabbia contro i politici (chiama Giolitti «il porco di Dronero»), di umiliazioni: lui, generale con tre medaglie d'argento, per campare si è visto offrire il posto di direttore del servizio taxi di Napoli! Era stato collocato a riposo, sentite un po', a causa di un'astuzia con cui aveva cercato di fare la guardia ai depositi di armi. Gli mancavano le sentinelle: allora aveva fatto scrivere giganteschi cartelloni «pericolo di morte, non avvicinarsi» con cui pensava di tener a bada i ladri. Del mondo a lui interessava soltanto l'esercito, l'unico orizzonte della sua vita. Alla svolta della caserma si estinguevano esseri umani emozioni pensieri. Nel '20, di fronte allo sconquasso del regime liberale e agli insulti dei rivoluzionari, la retorichetta fascista che parlava del Piave e della vittoria mutilata gli sembrò un sentiero noto. Tutto lì .

Anche il suo rapporto con Mussolini fu tutt'altro che idilliaco. Il vecclùo quadrunviro non risparmiava le critiche al duce, cui verùvano prontamente riferite da spie e sicofanti. Ma riguardavano solo il modo in cui il regime gestiva e guidava le forze armate. Oltre quelle terre a lui farrùliari e calpestate non si spingeva. Erano i confini della fronda di tutti i generali, Badoglio compreso, che considerava il dittatore «un sergente», «un orecchiante», come diceva, di strategie e che commetteva fesserie proprio perché non lasciava fare ai tecrùci (cioè a lui). Quando De Bono gli votò contro il 25 luglio e lo fece crollare, il suo progetto era di togliergli il comando militare, non certo di abbattere il regime in cui si trovava benissimo. Non avrebbe potuto essere diversamente. Ai generali non interessa che al governo ci sia Mussolini o un altro. L'esame al nuovo padrone lo faranno con la stessa domanda con cui hanno giudicato gli anrù della d estra e della sinistra: siete disposti a concedere l 'a utonomia corporativa nella ges tione del pletorico esercito di caserma, e i privilegi, gli stipendi alti, qualche guerricciola non troppo risclùosa per accelerare la carriera, la lucrosa gestione dei rapporti con l'industria degli armamenti? Con questi denari i condottieri hanno gavazzato per tutta la storia del Regno d'Italia . Intendiamoci, questo non vuol dire che non fossero fascisti: anzi lo erano tutti e con grande impegno. L'idea mussoliniana di un esercito da parata, scenografico anche se inefficiente, ma che s i poteva ben utilizzare per i bluff di politica estera, a loro andava benissimo. La guerra, quella vera, quella grossa, ai generali italiarù non è mai piaciuta. A far la voce burbera, ad andare in piazza a sognar le m edaglie e a esigere le cannonate erano i tenenti, i capitarù e i poeti come d'Annunzio. Ai generali piaceva il Iran tran di caserma, le manovre di fine anno con il re e l'atmosfera da scampagnata innocua. Erano ben insediati nella classe dirigente del paese: perché risclùare?
Tutto ques to venne bene in primo piano non appena il fascismo salì al potere e si dovette affrontare la grana della milizia, ovvero l 'esercito alternativo che Mussolini inizialmente fece guizzare davanti agli occhi preoccupati dei generali. Era la vecchia tecrùca mussolirùana: insediato anche lui nel vecclùo Stato autoritario e conservatore, firmati gli accordi di buona conv ivenza con gli industriali la monarchia la Chiesa i notabili, ogrù tanto faceva lampeggiare l'arùma rivoluzionaria, sovvertitrice, di «sinistra», del regime minacciando s fracelli e palingenesi. Perché, come diceva De Bono, «in fondo Mussolini era rimasto nell'animo un po' bolscevico e sovversivo».
Nella vicenda d ella milizia lui fu un protagorùsta. Mussolini sa-
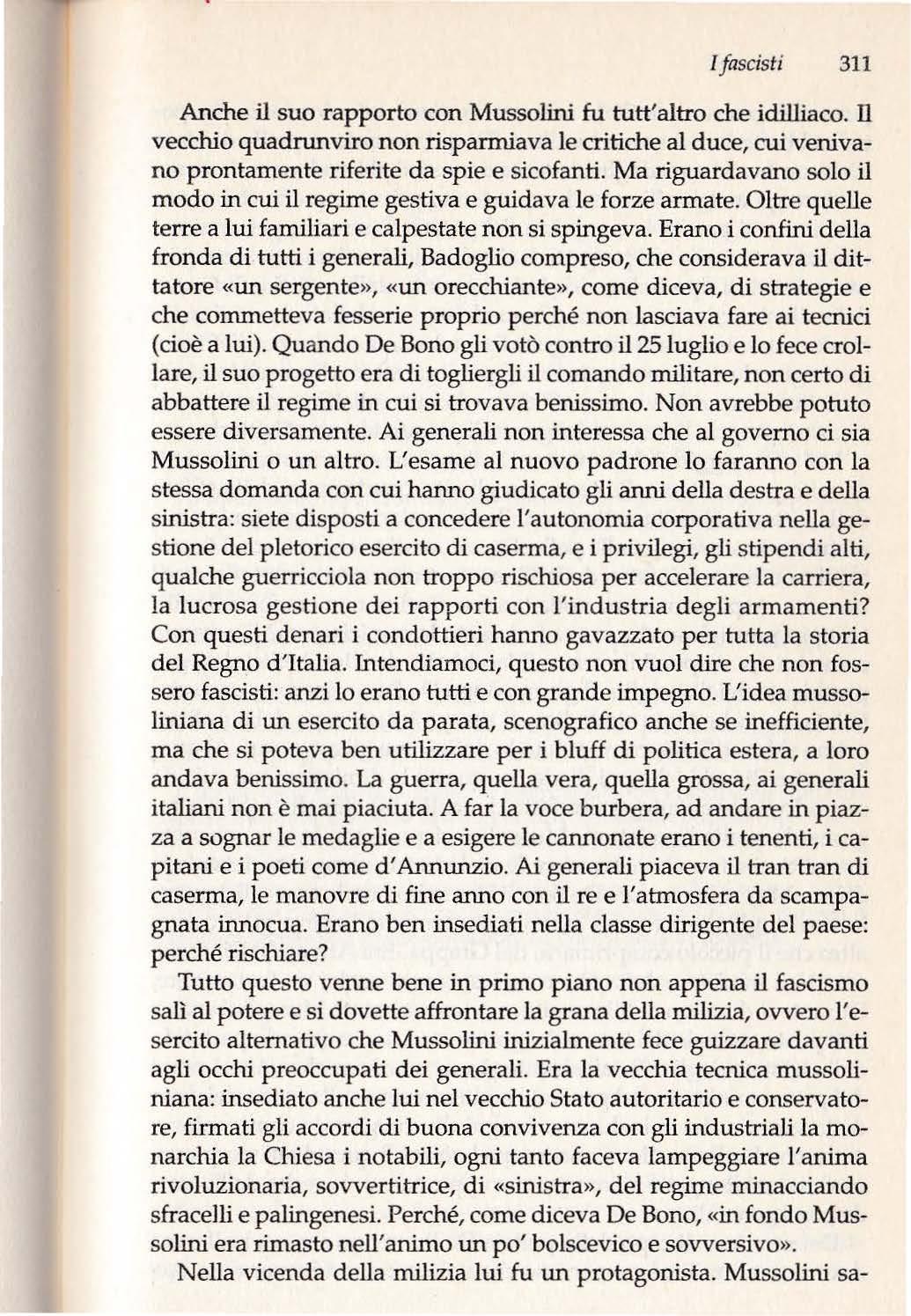
peva che, costruito lo Stato autoritario, c'era un'wùca forza che poteva abbatterlo, ed erano i militari. Di q ui, accanto a quella di blandirli con favori e m edaglie, la tentazione mai abbandonata di smussar loro gli artigli affiancando un eserci to privato, quello ch e aveva assicu rato a l p artito la conquista del potere. G ireranno per anni ma mai saranno realizzati progetti di abbellire le divisioni con i commissari politici di tipo bolscevico tratti appunto dalla milizia. Si faceva delle illusioni: la sua arma ta di squadristi e randellatori non riuscì a trasformarsi in un'autentica guardia pretoriana anche per l 'efficace guerriglia che le fecero i gen erali. E per il carattere di scorciatoia carrieris tica con cui la vissero ufficiali e reclute. Alla fine, come previs to, sarà p roprio l 'esercito d ei generali p iemontesi ad abbatte rl o.
Nel pomeriggio del 31 ottobre De Bono era sceso in strada imbaldanzi to per mettersi alla testa con gli a ltri quadrunviri della sfila ta della vittoria. Quell'om etto tascab ile con un'aria da domatore in miniatura non stava p iù nella pelle. Era sicuro di ave re in tasca il decreto di nomina a ministro dell a Guerra, coronamento metafisico di una vita. Aspirazione una volta tanto realistica: n on era forse il militare più prestigioso che aveva indossato la camicia n era? E nessuno come lui era disponibile a fare il lacchè d ei desideri bellici del n eopresidente del Consiglio. Il giorno dopo De Bono ricevette una sciabolata, neanche tanto simbolica: si ritrovò infatti capo della polizia, p r imo sbirro d'Italia come subito lo definirono gli avversari. Al quadrunviro Bianchi (che poi d iede per questo le dimissioni, un suicida secondo il commento esterrefatto dei colleghi) che gli chiedeva ragione di quella bocciatura, Mussolini rispose con la sua consuet a brutalità che faceva intravedere le maleducate arroganze del futuro duce: «Ma chi lo conosce De Bono? L'esercito non lo ama». li generale vero s ug li altari e con l'aureola astutamente l' aveva già trovato, altro che il piccolo comprimario del Grappa. Era Armando Diaz, che accettò il ministero della G u erra. Così faceva anche un favore al re. Durante il discorso dell' investitura ostentatamente Mussolini cedette il posto centra le del banco del governo a Diaz; e quando partendo dalla tribuna degli ufficiali si scatenò una ovazion e che univa i n omi del primo ministro e d el genera le molti scor sero s ulla faccia d e l duca d ella vi ttoria che s i inchinava i segni di una grande commozione. Altro che De Bono di cui ancora quel giorno i quotidiani s t o rpiavan o il n ome! Il regime s i inaugurava appunt o con la recita dell'accordo con i generali.
Del mestiere di capo della polizia De Bon o non sapeva nulla; era davvero un'umiliazione per uno che voleva com andare arma te. Ac-

cettò perché era avido di cariche e prebende, temeva sempre di n on riuscire ad arrivare al ventisette. Lo convinse, sopra ttutto, la possibilità di ottenere insieme alla ca rica di supersbirro quella di comandante d e ll'a ppe na cos ti tuita milizia. Era proprio ques to il compito delicato che gli aveva affidato il duce, che già cominciava a trovar a ntipatici o ingombranti gli altri due quadrunviri-guerrieri De Vecchi e Ba lbo. Erano solo ufficiali di compleme nto e farli generali sembrava d a vvero un po' tro ppo!
De Bono, a cui anche Mu ssolini rendeva il merito di essere un organizza tore implacabile e giudizioso di strutture d estinate a portare uo mini davanti alla morte, doveva procedere a un compito delicatissimo: no rmalizzare la squinternata, disobbediente, v io le nta armata dei r as; anzi «le armate d e i ras» come sc riveva il «Popolo d'Italia»:
Lo squadrismo non può e non deve mo rire, sarebbe pe r noi un vero s uicid io, la milizia deve essere trasformata ... le s quadre cesseranno di essere o rgano di un partito per diventa re o rgano dello Stato. Militarizzato lo squ ad rismo cesserà il p e rico lo di Wla concorrenza tra esso e g li altri corpi a rmati della nazione.

Che stessero zitti mentre «si spennava la gallina senza farla gridare troppo».
Era preludio di quella s tatalizzazione e di que ll ' inqua dramento ch e infa tti , due anni dopo, avrebbe portato quei maneggia tori di bombe e di pugnali a giurare fede ltà anche n ei confronti del re.
Il tempo delle spedizioru punitive è sorpassato . Lo s quadrism o è una orgogliosa memoria: ma pecca di assoluta incomprensione politica chi creda d i rinnovare oggi le vecchie gesta squadristiche e pecca contro la p a tria chi con il pretesto del rinnovato arditismo sfoghi i s u oi personali rancori e commetta comunque per priva to interesse soprusi e violenze. La milizia ha una ferrea d isciplina ch e d eve essere scrupo losamente rispetta ta, chi n o n la ris p e tta è fuori dalla legge. Non tollero deviazioru da questa linea di condotta.
Fulminava la prosa mussoliniana: il carnevale era finito, lo Stato ora è mio, guai a chi lo t occa.
Erano paro le forti: ma non sempre s paventavano coloro a cui erano rivolte. Perché a mettersi in riga d ovevano essere proprio quei capipopo lo che con le s quadre, gli incendi, le devas ta zioni, i delitti avevano seminato il t erreno d ella v i ttoria fascista. Lo scontro più duro il norma lizza tore De Bono l 'ebbe con Roberto Farinacci, cremonese, il teorico (e lo fu fino alla con clusion e dell'avven tura fascista) della seconda o ndata, d e lla rivoluzione permanente. Fosse sta t o p e r lui si sarebbe accampato con l'olio di ricino a damigiane fuori da tutti g li uffici pubblici, la camicia n e ra non la t oglieva m ai neppure a
letto: c'era ancora molto da fare. Ma «l ' Onorevole tettoia», che durante la guerra si era imboscato nelle ferrovie guadagnandosi quel fe roce soprannome, non aveva titoli per r esistere al generale De Bono e si piegò.

Più efficace era la guerriglia che gli opponevano gli altri generali, quelli che cons ide ravano De Bono un ex poco frequentabile e i suoi militi scioperati p ericolosi. Povero quadrunviro: lui cercava di rnig lio rarne la qualità e la disciplina e in un anno radiò rnillecinquecento militi e ben cinquecento ufficiali, predicando la ginnastica per diminuire le pance, disegnando uniforrrti e decorazioni che alzano il mora le, occupandosi anche del taglio dei capelli che esi geva corti («le belle chiome dello squadrista sono il più comodo albergo per i pidocchi...»).
Ai generali e a l loro foglio serniufficiale che si chiamava «L'esercito italiano» la milizia stava proprio sullo stomaco. Un'armata politica che tog lieva loro il monopolio della forza, che rispondeva direttamente a Mussolini: e r a un p e ricolo . Si dovette sudare a lungo p e r averne ragione. Fu una battaglia in cui il s uperuomo sacrificò alcune pedine come De Vecchi; il quadrunviro era considerato un nernico d e ll'ese rcito perché scriveva a rtico li in cui ricordava ai generali le magagne e le vergogne d el 1915 e del 1917 e p er gente come Badoglio quelle erano strazianti coltellate. Il gerarca narcisista e chiacchierone fu spedito in esilio nella selvaggia e sernidoma ta Somalia. A lla fine anche i generali accettaro no il compromesso, il «m ale minore» come ha giustamente detto Rochat. La milizia restava, minaccia g iammai cancellata, ma rido tta n el numero e con compiti di difesa dell'ordine pubblico (cioè di lotta contro i n e mici del regime) e di istruzione premilitare. Così si poteva far finta che si fo sse inse rita senza far troppi danni n ella vecchia o rganizzazio ne rnilitare d e llo Stato.
Le pene maggior i per De Bono vennero non dai ras ma proprio da quella carica di capo della polizia che al momento del delitto Matteotti rischiò di spezzarne, e definiti vame nte insieme al fascismo, la ca rriera : che s ia sop ra vvissuto lo si deve quasi esclusivamente al controllo già ferreo che il fascismo aveva ormai sullo Stato anche in alcuni organi chiave. Non certo all 'a iuto d i Mussolini, che il caro quadrunviro avrebbe lasciato volentieri inchiodato al ruolo di capro espiatorio p er un delitto compiuto in suo nome. De Bono non ebbe comunque alcuna responsabilità p ersonale nel crimine e di questo era convinto anche un osservatore non certo imparziale come Salvemini: nel senso che non lo ordinò materialmente; certo conosceva l'esistenza, all'interno dell' organizzazione da lui dire tta, d e lla fanti-
gerata «Ceka» che svolgeva i bassi servizi per il regime. Amerigo Dumini, losco figuro che si prese ntava con il biglietto da visita «otto omicidi», gli era poi notissimo, non uno sconosciuto come ingenuamente cercò di far credere. Fece anche s parire alcune prove imbarazzanti e cercò di aiutare i colpevoli per soffocare lo scandalo. Un complice, che fece tutto questo in modo così maldestro da finire d avanti all' alta corte e con acc use che lo rendevano al ruolo di possibile istigatore. Vennero alla luce, di sghimbescio, alcune storie di intra llazzi con i residuati bellici d el primo dopoguerra che n e angustieranno la lunga veccltiaia. Alla fine ne uscì con una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove (in particolare per il reato di favoreggiamento) che come tutti sanno, compreso De Bono, è lo strumento giuridico con cui il diritto italiano riesce a rendere permanenti e subdole le condaru1e, nel momento stesso in cui le esclude.
Da quella «su ccessione di strazi» come li cltiamava, e sappiamo dal s uo diar io che ne soffrì davvero atrocemente, De Bono emerse a sorpresa, n on giubilato ma con un doppio scatto di carriera: prima governatore della Tripolitania e poi comandante supremo d ella più grande impresa bellica del fascismo, la conquista dell ' impero etiopico . Per il primo incarico c'è da sosp e ttare che Mussolini gli facesse un dono avvelenato. La Tripolitania era infatti un indomato deserto dove guerriglieri feroci t enevano in scacco con grande vergogna i nostri milita ri . Forse il duce sperava che quel «veccltio mai sazio» perdesse d efiniti va mente la faccia contro qualche b ellicoso capo tribù (sono anni in cui al duce delle colonie n o n importa ancora nulla) . De Bono, ingenuo, non se n e avvede, ma cominciano, singolare coincid enza, in quegli anni le sue n otazioni nel diario contro Mussolini capo militare. Contro i ribelli u sa una guerra molto semplice: «Non ci sono le legna te che valgono ... se si ritirano li tempesto di bombe con gas asfissianti »; lo fece davvero, inaugurando i m ezzi con cui poi Graziani, allora suo subordinato completò il sublime eufemismo d ella «p acifica zione».
Per l'Etiopia invece le ragioni erano altre. N o n quella che a De Bono il duce volle sempre bene, come sostengono alcuni biografi (se gli avesse voluto bene non lo avrebbe fatto fucilare!). Ma bisognava p agarne il silenzio nell'affare Matteotti. Lo rivelò a De Vecclti: «Che tipo quel De Bono, mi ha ricattato e continua a ricattarmi ... ». E soprattutto il duce voleva che quella fosse una guerra, e una vittoria, fascista ; e di generali fascisti in giro, anche se erano ormai passati s ull ' Italietta liberalmona rcltica dieci anni di Uomo Nuovo, c' era ahimè sempre solo quel settantenne vitalissimo e con la barbetta.

Mussolini cominciò a pensare all'Etiopia nel 1931 quando De Bono, tornato dalla Libia, era ministro delle Colonie. Lo spedì per un'ispezione, che in realtà doveva servire a preparare i piani per attaccare l' impero del negus. Il duce aveva intuito: il regime ristagnava dopo le trombonate dei primi anni, la crisi economica internazionale tagliava i redditi anche da noi, nonostante l'invenzione di una versione del welfare in chiave fascista, e di trionfi internazionali non c'era traccia. La soluzione poteva arrivare da un clamoroso successo propagandistico. In fondo l'ltalietta liberale aveva conosciuto due umiliazioni, Caporetto da cui in qualche modo si era usciti, e Adua: che invece era rimasta invendicata. Ecco: il fascismo avrebbe con una guerra tutta sua vendicato quell'affronto. Sarebbe stata la prima guerra delle nuove generazioni mussoliniane condotta con metodi innovativi, tutto slancio squadrista e vittorie, divisa a metà propagandisticamente tra il passatismo romaneggiante e il modernismo industriale e tecnologico che il duce aveva appiccicato al suo regime senza mai scegliere fra l ' uno e l'altro. La designazione come capo della futura spedizione coloniale De Bono, nel libro che scrisse dopo gli eventi (dove naturalmente non c'è traccia della guerra furibonda che gli fecero gerarchi e generali), la racconta così: lo ritenni di non perder tempo e un bel giorno dissi al Duce: «Senti, se ci sarà una guerra laggiù lu, se mi ritieni degno e capace, dovresti concedere a m e l'onore d i condurla». Il Capo mi guardò fissamente e mi disse subito: «Certamente». Io soggiW1Si: «Non mi credi troppo vecchio?,>. «No» ris pose lui «perché non bisogna perdere tempo. »
De Bono ebbe anche il compito di convincere il re, ostilissimo all'impresa, a dare il suo consenso. Era e restò per sempre monarchico, ma del re sapeva vedere i difetti: la meschineria, la scarsa intelligenza, il carattere vendicativo. Lo «lavorò» comunque a dovere accompagnandolo in tre visite alle colonie che ne sollecitarono le ambizioni . Ma i guai gli arrivarono da colui che fin dagli anni della Libia era diventato il suo nemico numero uno: Pietro Badoglio, capo di stato maggiore dell'esercito e capo della cricca militare. Era uno con cui si poteva andare d'accordo solo se si accettava di diventare un gregario. E talora non bastava nemmeno quello. Badoglio manovrava da par suo: fece redigere il parere sul piano di guerra messo in bella copia da De Bono al suo fedelissimo Alberto Bonzani, piemontese ultramonarchico e, si dice, anche un poco antifascis ta . Era un siluro in piena regola. Tutto veniva accuratamente s montato, i piani definiti irrealizzabili e pericolosi. Era, seppure già così sferzante, solo la ver-

sione diplomatica di quello che Badoglio andava dicendo in giro sul comando affidato a De Bono: lo definiva generale esonerato dall'esercito e ne ricordava impietosamente l'età, sessantasette anni. Da quel momento diventò nelle lettere e nei diari «quel porco» e «una mente anchilosata». Badoglio fremeva perché si era accorto che quella non sarebbe stata una guerricciola bensì una epopea con seicentocinquantamila uomini e due milioni di tonnellate di materiale e buone prospettive di finire in un trionfo; che rischiava di sfuggirgli. L'approssimazione era quella consueta, mezza italica e mezza fascista. Una guerra che poteva mettere in pericolo il futuro del paese e trascinarci in un catastrofico conflitto (Hitler in quel momento parteggiava per gli etiopi a cui vendette pure armi) era condotta come una birbonata a due voci: il capo e il suo arzillo generale. La coppia tramava, complottava, organizzava, disponeva, litigava a colpi di reciproci telegrammi che avevano sempre la sigla MPA (massima precedenza assoluta). Siccome a un certo punto l'urgenza a furia di proclamarla si stemperò nella normalità, le sigle vennero cretinamente raddoppiate e diventarono: massima precedenza assoluta di tutte le precedenze assolute. Sicché, come racconta Paolo Cesarini, i telegrafisti, capita l'antifona, finirono per infischiarsene e fecero marciare quei napoleonici messaggi al ritmo normale. Forse fu un bene per De Bono che con «bella irnmortal benefica Fede ai trionfi avvezza» come racconta, al capo rispondeva sempre un consueto laconico «sta bene». Un telegramma secco secco che sembrava l'avesse scritto Tacito. Anche perché Lui, a un certo punto, arrivò a ingiungergli il sublime: «Rispondi con un monosillabo»!

Altro che monosillabi, c'era da pronunciare requisitorie. Di guai ne aveva a bizzeffe il quadrunviro africano. Asmara all'epoca del suo arrivo era abitata da 3875 metropolitani e non c'era assolutamente nulla:
In Eritrea non c'era niente che non fosse l'indispensabile per la vita della poca popolazione metropolitana, della piccola forza armata e degli indigeni, parchissimi. Voglio essere esatto: esisteva una certa dovizia di carne bovina e anche ovina, principale ricchezza del paese.
Il generale, che anche qui si rivelò organizzatore tenace, con baldanza fascista si mise all'opera: costrul strade dove prima erano tratturi da capre, aeroporti modernissimi con hangar fatti arrivare prefabbricati dall'Italia, magazzini e attendamenti dove dovevano trovare posto decine di nùgliaia di soldati disabituati al clima africano. Ingrandì collegò costrul sempre lottando con il capo che gli stava ad-
dosso e gli riduceva i tempi ordinando brutalmente che doveva essere pronto. I trabocchetti si nascondevano spesso dove meno se li aspettava, non dagli abissini ma dagli italiani. Gli operai spediti da Roma, per esempio, ventitremila che costituivano un problema per lui che deve «pensare a curarli nutrirli e tenere a posto quarantaseimila mal di pancia». Quelle legioni di braccia italiche eran mosse più che dalla baldanza colonialista dalla voglia di guadagno e dai mugugni di un sindacalismo che nella madrepatria non si potevano permettere. Fioccavano infatti le proteste per le dieci ore di lavoro, il vitto scadente, l'obbligo di sudare anche di domenica, le ore perse e il salario dimezzato per la pioggia, il divieto di uscire dai campi di sosta. La meglio gioventù fascista si era presentata, non si sa se per subdolo sabotaggio o consueta inefficienza, assai dimessa e in cattivo arnese: tra quella punta di diamante della classe operaia d el regime c'erano pochi stakanovisti, in compenso si contarono «una quantità enorme di sarti, calzolai, camerieri, diversi sagrestani e scaccini, dei gobbi deformi, dei cardiopatici e degli epilettici, dei mutilati di gamba e uno perfino mancante di un braccio». Non parliamo delle camicie nere a cui Mussolini aveva riservato il ruolo di protagonisti della guerra: «Quelle porche camicie nere,» ringhia De Bono nel diario «furti e violenze alle donne! Ma li faccio castrare come è vero Iddio! Li metto al passo».
E poi ci sono i figli di Mussolini, e Ciano, il genero, venuti a raccogliere medaglie, fastidiosi arroganti maleducatissimi. E i gerarchi di tutti i tipi che hanno fiutato gloria a bu on mercato, perfino l'accademico Marinetti futuristicamente sbarcato portando come unico b agaglio una cartella da avvocato. E tutti bisogna ospitare, riverire ed equipaggiare. Senza dimenticare che non doveva farsi irretire dalle direttive strategiche di un comandante in capo la cui dottrina sbrigativamente si esauriva nella frase: «L'essenziale è di fare presto e picchiare sodo». Ecce homo!
Aggirati gli agguati di Badoglio e le trombonerie di Mussolini, all'alba del 2 ottobre 1935, con il cruccio di non essere riuscito a strappare al capo l'agognata designazione a generale di armata (resta «designato d'armata» e per di più, poiché non ci sarà dichiarazione di guerra, senza la cospicua indennità) il vecchio generale mette su casa con il suo stato m aggiore nella confortevole baracchetta allestita a Coatit, località di confine scelta per seguire il primo balzo. Non c'erano evidentemente stù posto superstiziosi; il luogo presentava lo iettatorio precedente di essere stato sede di analoga funzione ai tempi del maledetto Baratieri n el 1896.
A rivedere le fotografie di quei giorni, mentre caracolla a cavallo,

o impegnato a dire bravo ai ras che fiutando la malaparata Si precipitarono da noi, con pacchi di decorazioni già pronte per gli eroi, sembra veramente un uomo della guerra di altri tempi. Non colpisce tanto l' aspetto fisico. Tra i piccoletti ha buona compagnia. Pietro Maravigna, un altro gen erale italiano, era «non più alto di ttn fiammifero». È la s ua aria assonnata che insospettisce, come se non vedesse l'ora di scappare a riposare in qualche tucul e le litanie di attendenti e colla boratori lo stordissero. Lo sforzo logistico compiuto da De Bono gli aveva succhiato le forze. Infatti fu titanico e riconosciuto come tale anche dagli osservatori militari stranieri a CUi ce rto non mancava la buo na volontà di cogliere le pecche nella. nostra bellica attività . Riuscì a far muovere decine di mig liaia di uomini con i loro mezzi e le indispensabili salmerie p er la sopravvivenza in un ambiente così scorbutico, d i fronte a un nemico che invece su quel terreno correva beni ssimo. De Bono quando si comincia a sparare ha sonno, è stanco, sbadiglia . Cadute Adua e Axum, d1.1.e trionfi s imbolici che il reg ime magnifi cò anche se non ci costaron o ness un co mbattimento, gli etiopi s i erano ritirati. Ad Adua entrò un reparto del genio credendo che la città fosse stata già occupata, m a rciarono fis chietta ndo come se fosse lo struscio serale, ci volle del cordiale p er rianimarli quando appresero la verità . In meno di quindici giorni di avanzata il primo balzo è compiuto e De Bono, che seg ue i princ ipi della vecc hia scuola militare, dà l 'ordine di «rafforzarsi sulle posizioni occupate». Bisogna spostare i d e p ositi, costruire le strade, procedere ai collegamenti telegrafici, esplorare. Altrimenti si rischia di replicare g li errori di Baratieri sconfitto dai rifornime nti più che da Menelik.
Sono saggezze ch e mandano in bestia il caporale Mussolini che conosce una sola parola: avanzare, e che vorrebbe già essere a Addis Abeba. In realtà De Bono non ha capito le mire d el duce; pensa con la mentalità delle guerre coloniali dei tempi di Crispi, epoca a cui in fondo appartiene: guadagni territoria li alla frontiera, correzioni di confini, soddisfazioni diplomatiche, prestigio ma senza correre troppi rischl. Le s ma rgiassa te fasciste n on gli hanno fatto perdere una buona d ose di sano rea lismo piccolo bor ghese. Capisce i pericoli, quando va a v isi tare Adua: nel g hebì imperiale devastato sono rimasti solo alcuni polli in cortile e fa il suo ingresso a cavallo fra ali di p opolazione fes tante. Ma lui aggiunge: «Era sta ta istruita p erch é app laudisse. Non ero tanto ingenuo da ritenere quei p lausi sinceri».
Ha capito tutto invece Badoglio, che è più furbo e più avido. n duce vuole fare il colpo grosso, non sogna la rivincita di una vecchia

sconfitta, vuole addirittura un impero. De Bono è uno «uso a non creare difficoltà» e a rispondere senz'altro sì anche alle richieste più sgarbate. Ma su un cosa si imputa e sa opporsi anche al capo: sulle questioni militari, dove ha capito che è arrivato il momento di «frenare». Ha una linea di operazione ormai lunga cinquecento chilometri di cui un quinto è reso insicuro dalla guerriglia etiopica e non basta l'aviazione per garantirlo da brutte sorprese. Qui vien fuori l'orgoglio corporativo, infernale di tutte le aristocrazie militari che lo spingerà nel corso degli anni a criticare perfino il rozzo Mussolini e a chiedersi se per caso non porti «a remengo l'Italia» . Cominciano a comparire quei vocaboli, «incompetenza», «orecchiantismo» che con il passare degli anni diventeranno nel diario la scorta di qualsiasi riferimento alle attività (militari) del duce, asceso tra l'indignazione dello stesso De Bono, da caporale onorario della milizia alla carica di primo maresciallo dell'impero. Orgoglio professionale che gli suggerirà il voto al Gran consiglio e gli costerà la vita. Nasce, grazie alle resistenze del quadrunviro che almeno momentaneame nte ha detto basta con l e avanzate, la congiura di Badoglio che per altro trovò in Mussolini una sponda già convinta. Il primo scricchiolio il vendicatore di Adua lo avvertì quando, ancora fresche le bandiere sugli spalti di Makallè, che era la tappa successiva, ricevette l'annuncio che stavano per piombare in colonia il ministro Alessandro Lessona che De Bono considerava, sbagliando, un amico e l'odiato Badoglio. L'obbedientissimo generale era furibondo e osò scrivere al capo cose inusuali negli anni del regime:
Ora ti dirò con la mia solita franchezza che se [Badoglio] verrà qui per ficcare il naso in quello che ho fatto o intendo fare, pianto qui ogni cosa e me ne vengo via. Tutto ha un limite, a un certo segno anche il senso di disciplina diventa supina fesseria.
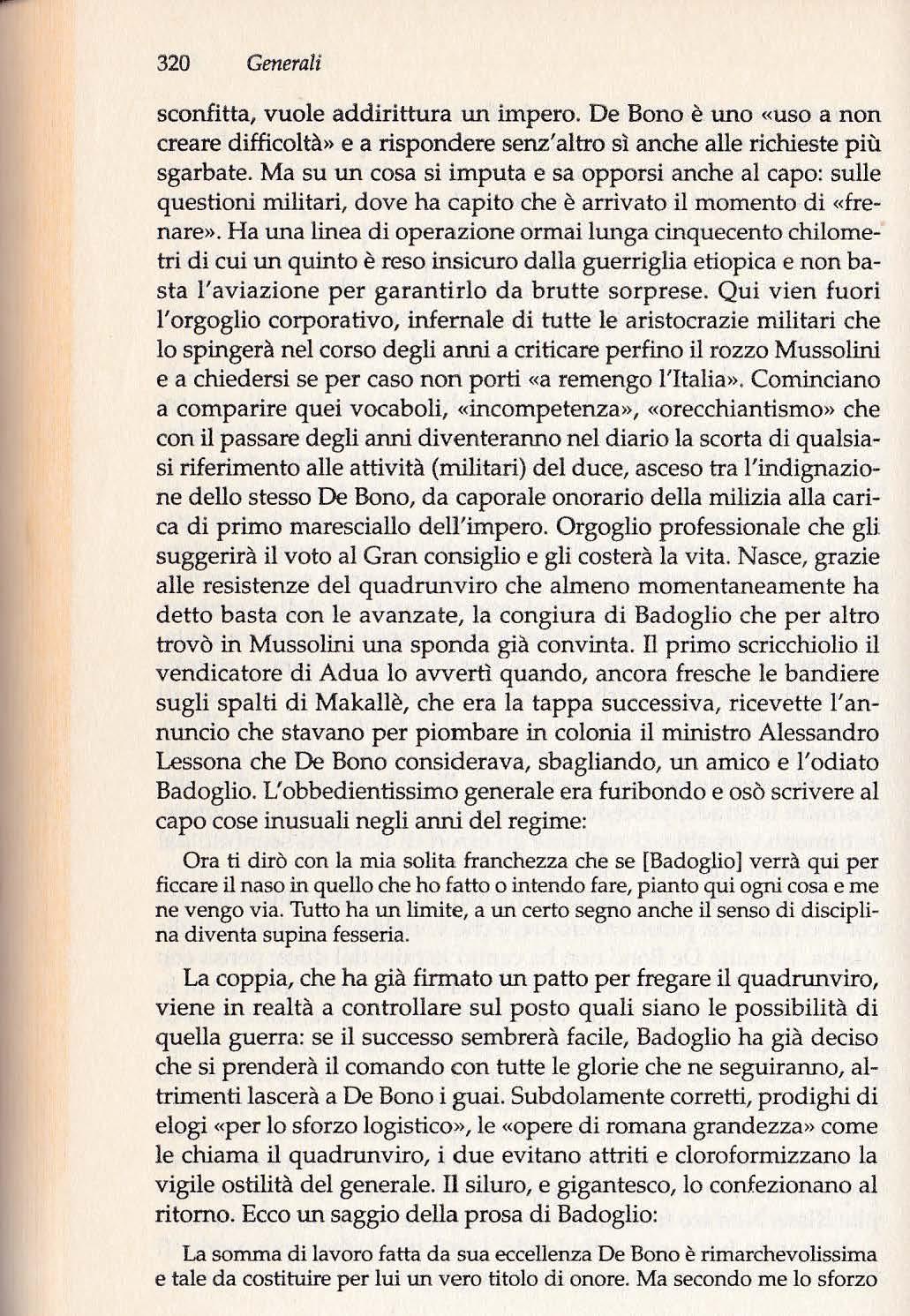
La coppia, che ha già firmato un patto per fregare il quadrunviro, viene in realtà a controllare sul posto quali siano le possibilità di quella guerra: se il successo sembrerà facile, Badoglio ha già deciso che si prenderà il comando con tutte le glorie che ne seguiranno, altrimenti lascerà a De Bono i guai . Subdolamente corretti, prodighi di elogi «per lo sforzo logistico», le «opere di romana grandezza» come le chiama il quadrunviro, i due evitano attriti e cloroformizzano la vigile ostilità del generale. Il siluro, e gigantesco, lo confezionano al ritorno. Ecco un saggio della prosa di Badoglio:
La somma di lavoro fatta da sua eccellenza De Bono è rimarchevolissima e tale da costituire per lui un vero titolo di onore. Ma secondo me lo sforzo
fatto ha non poco esaurito le su e riserve. A vederlo in molti, troppi momenti dà l'impressione di un uomo stanco, quasi sfinito. Questo suo s tato si riperc uote ovviamente sulla sua capacità volitiva ... si dice dappertutto più o meno apertamente che il comando non si sente...
Lo vediamo s igillare il verbale omicida con il sorriso piacente d ella locusta c he ha appena rovinato il raccolto. E l'amico Lessona? A lui Badoglio ha lasciato il compito di vi brare il maramaldesco colpo d i grazia:
Il genera le De Bono ha da to orma i tutto quanto poteva dare per il trionfo della causa che gli era stata confidata e sa rebbe prudente sottrarlo a nuove e p iù grandi responsabilità d i fronte alle quali egli potrebbe sventuratamente o ffu scare le moltissime benemerenza acq uis tate verso la patria e il fascismo .. . Se mi po ngo l'ansioso e assillante interrogativo: ha De Bono ancora tutte q uante le q ualità necessarie pe r comand are in una grande battaglia decisiva l'esercito nostro contro un potente e s uperiore per numero esercito abissino? Rispondo senza esita zione e in piena coscienza no ... Ho d'altronde riportato la precisa impressio ne che ormai se potesse o ttenere il rimpatrio con un al to riconoscimento del suo operato, ne sarebbe lietissimo.

Così s i u ccidevano i generali sotto il fascismo! La sorte di De Bono è segna ta; Mussolini, che è diventato dopo il rapporto ancor più maleducato ed esigente, h a bisogno soltanto di un pretesto. Glielo offrirà una località, l' Amba A lagi che r is ulta davvero incrostata di sorte fa ta l e p e r i nostri gen e rali, da Toselli ad Ame d eo d ' Aosta, e s u cw, non si sa perché, nonos tant e la s ua assoluta inutilità milita re si incaponiranno le nostre strategie. Il duce esige ch e venga occupata p e r vendicar e l 'onta d e l 1896, De Bono rifiuta perché giustamente h a capi t o che n o n serve ed espone il fianco a una manovra nemica . Infatti anche Badoglio rifiuterà di pre nd e rla. Il 15 novembre, al rito rno d a un'ispezione, trova un telegramma naturalm e nte segreto e personale che però s tavolta non ha ingiunzioni s tra t egiche:
Con la riconquista di Makallè considero ultimata la tua missione nel!' Africa Orientale, missione che tu hai svolto in circostanze estremamente difficili e con ris ultati che ti additano nel presente e nell'avvenire alla gratitudine d e lla nazione . ... Ti comunico che qual e tu o s uccessore ho scelto il maresciallo Badoglio ... Tu sai per esperienza che ogni ciclo di attivi tà a un certo punto deve essere concluso, che un po' di riposo ci v uole e che non bisogna esigere troppo dalla fortuna qua ndo sia s tata per un certo tempo propizia.
Parole s u cui il duce avrebbe forse dovuto m e ditare, anche p e r se s tesso. Il giorno dopo a De Bono arrivò la consolazione: la comurucazio n e che e ra stato p rom osso m ar esciallo d ' Ita lia
Il quadrunviro sapeva bene ch e cosa c'era die tro la fine prematu-
ra del suo «canto del cigno» . Se fosse stato un grande avrebbe respinto la promozione. Invece sul tavolo di Mussolini arrivò un telegramma molto fascista: «Sono felice che sia da te riconosciuta la mia opera di vecchio soldato e di fascista. Affettuosa devozione» . Ad avvelenargli la pensione e le giornate nel confortevole e inutile studio al Palazzo dei marescialli (non comanderà più nessun esercito in guerra anche se nel 1940 incredibilmente circolarono voci che gli assegnavano un'armata, e lui ci credette) resterà Io scandalo degli appalti in Abissinia. Fu un fastoso affaraccio di regime che coinvolse gli Scalera, potenti costruttori di cui De Bono quasi certamente se. za accorgersene era stato lo strumento per mostruosi arricchimenti. Finì naturalmente in un nulla di fatto, ma il maresciallo ne trasse nuovi motivi di amarezza e di rancore verso il regime. Comincia, con l'avvicinarsi della guerra e le nuove alleanze con i tedeschi che il soldato del Grappa detesta, la sua storia di frondista. Il Principale diventa «il capoccia» e «il padrone », un grosso guaio dal punto di vista militare e guerresco, un borghese rincappucciato . Si aggiunge all ' odio per Badoglio da lui plutarchescamente definito «uno che mette le mani avanti per cadere bene». Ma Io stesso De Bono è il primo ad ammettere che sono critiche da operetta («Io sono un servaccio»), non vanno mai oltre l'orizzonte militare in cui difende la sua competenza e non sfiorano le scelte politiche del duce. La grancassa della propaganda non lo inganna: sa benissimo che l' esercito è floscio, che i nostri armamenti sono roba da fonderia; ma in politica dove si definisce «ignorantissimo », il capo geniale e previdente resta sempre Lui. Nel chiacchiericcio ridicolo del frondismo di regime, tra i Ciano e i Farinacci, De Bono è comunque uno dei pochi sinceri. E fu suo il voto negativo al Gran consiglio d e cisivo per la caduta dell'uomo che il generale comunque più ammirava.

Sarebbe stato un gesto degno di Shakespeare . Peccato che De Bono non avesse capito niente. In quel sottile ordito di perfidie, bindole rie e di meschini e abbietti artifici che fu la congiura del re e del suo maggiordomo Grandi, lui poverino si confuse e si perse. Prese la parola e votò l'ordine del giorno Grandi perché voleva difendere l' esercito dalle critiche di tradimento e incapacità peraltro meritatissime . Pensav a che s i p o tesse sottra rre al duce, il dilettante di strategia, il comando delle forze armate senza far precipitare il regime. Spostò una tegola, e il tetto gli crollò in testa. Era un sempliciotto, uno che si portò in tasca quella sera invece che due granate, come pare fece Grandi, il santino di San Giuseppe!
Dopo 1'8 settembre non scappa, non fa nulla, continua le sue pas-
seggiate con la vecchia bicicletta da bersagliere. Il capo della polizia della Repubblica Sociale appena emersa alla Storia, Tullio Tamburini, lo convoca e senza ta nti giri di p arole gli s u ggerisce d i trasferirsi da Roma a Bergamo. Non è un domicilio coatto, la frontiera svizzera è a due pass i, insomma lo invita a scapp are dato che tedeschi e s uperfascisti si preparano a fargli l a pelle. Lui stupido o ingenuo non capisce niente . È tranquillo, si sente innocente. Nessun tribunale in tempi n o rma li av rebbe emesso una sentenza di morte. È vero . Purtroppo per lui, i tempi n on sono normali. Lo fucilano alla schiena, l ui vecchio gen erale tutto di un pezzo, nel p oligono di Verona insieme a Ciano e altri. Accudisce l'omicidio camuffato d a giustizia un gruppo di reclute affrante e tremebo nd e che confessano poi al cappellano di aver spara to alto per non giocarsi il paradiso.
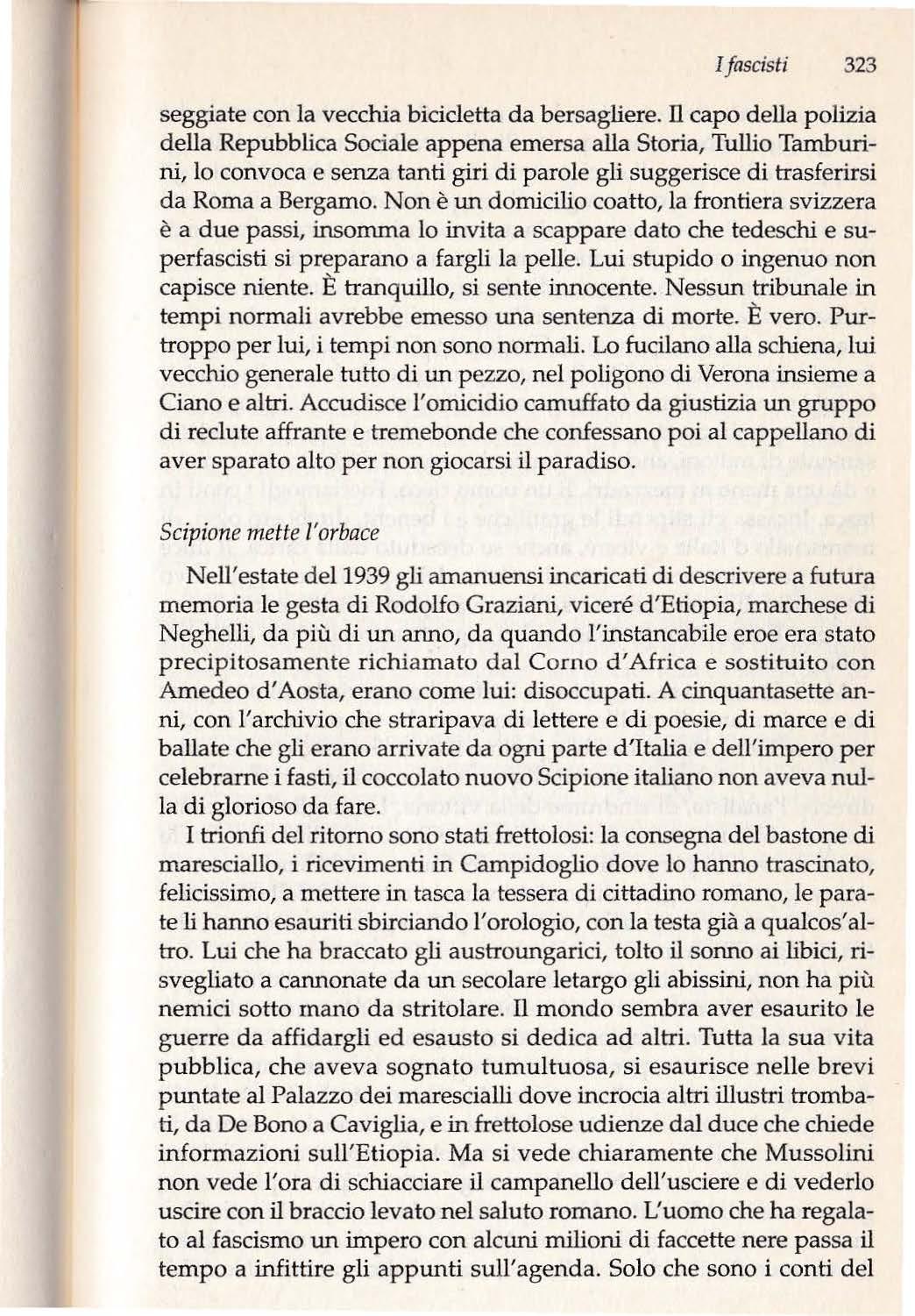
Nell 'estate del 1939 gli amanuensi incaricati di descrivere a futura memoria le gesta di Rodolfo Graziani, viceré d ' Etiopia , marchese di Negh elli, d a più di un anno, d a quando l 'instancabile eroe era s ta to p r ecip itosamente richiamato dal Corno d 'Africa e sostituito con Amedeo d'Aos ta, erano come lui : disocc upati. A cinquantasette anni, con l 'archivio che stra ripava di le ttere e di p oesie, di marce e di ballate che gli erano a rri vate da ogni parte d'Italia e dell'impero per celebrarne i fas ti, il coccolato nuovo Sci pione italiano non aveva nulla di gl o rioso da fare.
I trionfi d el ritorno sono stati frettolosi: la consegna del bastone di maresciallo, i ricevimenti in Camp idoglio d ove lo h anno trascina to, feliciss imo, a mettere in tasca la tesse r a di cittadino romano, le parate li hanno esauriti sbirciando l'orologio, con la testa già a qualcos'altro. Lui che h a braccato gli austroungarici, tolto il sonno ai libici, risvegliato a cannonate da un secola re letargo g li abissini, non h a più nemici sotto mano da stritolare. Il m o nd o sembra aver esaurito le guerre da affidargli ed esausto si dedica a d altri. Tutta la sua vita pubblica, che aveva sognato tumultuosa, si esa urisce nelle brev i puntate al Palazzo dei marescialli dove in crocia altri illustri trombati, d a De Bono a Caviglia, e in frettolose udienze d al duce che chiede informazioni sull 'Etiopia . Ma s i vede chiaramente che Musso lini non vede l'ora di schiacciare il campanello d e ll 'usciere e di v ederlo u scire con il braccio levato nel sal uto romano. L'uomo che ha regalato a l fascism o un impero con alcuni milioni di facce tte n ere passa il tempo a infittire gli appun ti sull'agenda . Solo che son o i con ti del
fattore, le date delle semine, la monta delle miglirua di pecore del suo gregge. Imbarazzanti queste iliadi agrarie di un contadino aggrappato alla tenuta di Arcinazzo sui colli romani dove i Muzi e gli Scevola ritempravano le voglie di conquistatori universali. Manca decisamente l'atmosfera eroica in un casale ribattezzato col nome di Casa! Biancaneve e che anticipa maestosamente l'orrido architettonico del!'abusivismo del secondo dopoguerra. Il padrone ha un bel1'affannarsi a tirare in ballo con l'immancabile citazione classica, è una mania, l'esilio operoso di Cincinnato. Del console romano così frugale non c'è traccia. Quello arava per metter le fave nella scodella, lui quando arrivano le cineprese dell' Istituto Luce. La proprietà è immensa, trabocca di animali e attrezzature moderne, puzza vistosamente di milioni, anche se Graziani spesso si rimbocca le maniche e dà una mano aj mezzadri. È un uomo ricco. Facciamogli i conti in tasca. Incassa gli stipendi le gratifiche e i benefit, direbbero oggi, di maresciallo d'Italia e viceré, anche se decaduto dalla carica. Il duce gli ha garantito, come segno di affetto della patria, un aggiuntivo «stipendio di riconoscenza», si chiama proprio così, di ventimila lire al mese. E sono i tempi delle celebri sognate astronomiche mille lire della canzone.

Ma il denaro, si sa, non è tutto. Soffre, il maresciallo: di non poter menare le mani, di quell'accantonamento che rimprovera a invidie congiure livori. Resusciterebbe perfino il Gran Senusso che ha sudato anni ad acchiappare pur di disporre di un avversario . È malato, direbbe l'analista, di sindrome della vittoria. La moglie Ines, come sempre affettuosissima, cerca di colmare il tedio militaresco con le visite dei vecchi pimpanti camerati del Carso e del Gebel: sono tristezze, grandi mangiate di prodotti veraci tirati fuori dalla dispensa e che fan metter su pancia; serate sciupate a giocare a tressette che fan stringere il cuore .
All'inizio di quella estate maledetta è svanita anche l ' ultima speranza: nell'infornata di nuovi senatori il nome del maresciallo non c'è. E per una buona ragione amministrativa: la legge, infatti, impone di aver compiuto, per ottenere il laticlavio, i sessanta anni. Altro che congiure! Si tratta di attendere. Ma Graziani, che è stato il più giovane colonnello della storia dell'esercito italiano, ha costruito la sua carriera sulle eccezioni non sulle regole. Si aspettava che il duce, solerte, si uniformasse. Nell ' elenco degli ottimati per di più si scorgono i nomi di Mezzetti e Nasi, due suoi subordinati in Etiopia, due mezze calzette del napoleonismo. Nella sua autobiografia fa il grandioso: «per me non chiesi nulla», e passa ad altro capitolo. Ne dubi-
tiamo. Intuì che non tirava più aria buona e prese la decisione che avrebbe, forse, trasformato la sua vita: decise di andare in Somalia dove i tempi gloriosi e convulsi della guerra non gli avevano fatto dimenticare una concessione per la miseria di cinquemila lire. Erano cinquecento ettari a Chisimaio dove la savana si arrende al verde del Giuba al confine del Kenia britannico, terra ricca di piantagioni e dove solo i neri restavano in miseria. Il maresciallo, ammalato di ricordi classici, era un collezionista di terre. Ovunque lo aveva portato la sua spada, come i generali romani, recintava, bonificava, piantava orti. Cento ettari a Bu Maad in Cirenaica che aveva pacificato con il ferro e il fuoco e anche qualche forca, quattrocento ettari in Abissinia nel territorio degli arussi, una elemosina per aver cancellato l'ultima schiavitù africana. Ora voleva andare a fare il colono, a seppellire le medaglie nella terra, fertile, della sua concessione. Chiese udienza a Mussolini e, racconta lui, gli parlò con la franchezza abituale del guerriero:
Non nominandomi senatore mi avete estromesso dall'unica forma di partecipazione alla vita pubblica. Io non vi chiedo il perché: capisco che su di voi agiscono tutti i riflessi delle varie situazioni. Ne avrete le vostre ragioni; ma poiché non mi si dà un impiego nell'ambito militare né altrove, ho deciso di recarmi in Somalia per dirigere personalmente la mia concessione.

Come gli amanti innamorati che si fanno i dispetti ma sono sicuri dei sentimenti, si aspettava naturalmente una offerta del duce che lo costringesse a rinunciare a quel progetto che privava la patria del suo grande generale. Il duce ascoltò, approvò e lo congedò. Dicendo: «Vi raccomando di coltivare molte banane, il nostro mercato ne ha sempre bisogno» .
Se Graziani «astro tramontato» fosse uscito da palazzo Venezia e si fosse imbarcato sulla prima nave per il Como d'Africa sarebbe rimasto nella storia italiana come un protagonista di due guerre in posti esotici. Invece, siccome di partire non aveva affatto voglia e quella recita con Mussolini era una scenata di gelosia, restò. Molti gli ricordavano che sull'Europa si stavano addensando nubi guerresche e i tedeschi di Hitler erano in grandi faccende per incendiare tutto il continente. Quella era gente che non si lasciava sfuggire per nulla al mondo una battaglia. E se si marciava, la rissa sarebbe stata così grossa che ci sarebbe stato posto anche per lui. Così sui libri di storia è rimasto, ma come uno sconfitto per antonomasia e l' ultimo vero generale fascista.
E pensare che, anche lui, fascista non lo fu mai. De Bono almeno
aveva marciato in camicia nera agli sgangherati radwù delle truppe di Mussolini. Graziani era, nel 1922, da un anno nei deserti libici a dar la caccia alle imprendibili anguillesche armate di Omar il ribelle . Ltù stesso s i raccontava politicamente così: «Nutro sentime nti monarchici, non sono mai s tato massone, credo di essere s ta to fascista dalla nascita, inconsciamente !». È la migliore definizione del modo in cui tutti gli ita liani o quasi aderirono n e l Ventennio scomodo e crud e le. Sublime innocenza di un uomo a cui mancava, oltre ad altre qualità no n di dettaglio, l'astuzia. Dei tre s tadi d e llo sviluppo: is tinto, sentimento, pensiero era fermo al primo. So lo lui, per stupidità ripicca livore, poteva allinearsi tra i fascisti quando quelli veri, quelli «consci», gettavano v ia la camicia nera n e i to mbini e s i travestivano nelle schiere d e i delusi, dei pentiti o degli ipocriti! Disegna bizzarri arabeschi il destino: quando nel 1904 s i preparava a sostenere gli esa mi per l'ammissione a ll'accademia militare prima degli orali fu sorpreso da un ufficiale a leggere !' «Avanti!» erischiò l' espuls ione. Se avessero indagato, gli esamina tori avreb bero scopert o altre magag ne: che quell 'a llampanato aspirante ufficiale aveva partecipa to anche a una marcia di protesta davanti all'ambasciata russa ai tempi in cui lo zar era alle pr"5t'. con le prime sfortunate prove di rivo luzion e, naturalmente inneggiando agli insorti . Abbandonate queste fisime comunarde, il figlio del povero medico di Arcinazzo che per mancanza di soldi non aveva potuto iscriversi a li'Accademia militare di Modena e si era rassegna to a studiar legge, aveva trovato ospitalità nella ca tegoria immen sa dei difensori d e ll'ordine costituito; ch e non si ponevano troppe domande su chi in q u el particolare momento l'ordine incarnasse. La carriera se l'era cos tru ita davvero con le proprie manone; non aveva frequentato la scu o la di guerra e Badoglio ne conserverà sempre velenoso il ricordo quando lo d efiniva «un o ttimo co manda nte di battag lione» e chiedeva polemicamente che cosa avrebbe combinato con l'improvv isazion e .
Era entra to nel fracasso d ella prima guerra mondiale come tenente ed era tornato a casa n e l 1918 come colonne llo: una ca rriera s trao rdinaria costrtùta tutta con eroismi colpi di mano assalti spregiudi ca ti, lavorando di spad a e di pugnale nel corpo d ei propri simili seppur v estiti con altra uniforme. Era la nuova guerra aspra inesora b il e durissima: ma pura. Q u e ll a che i vecchi barbogi dello s tato maggiore non sapevano più fare, convertiti al fatturato sanguinario del cannone. E che Graziani metterà s ul biglietto da visita fino a quando no n s 'imbatterà, nel des erto egiziano, in solda ti e gen e ra li di
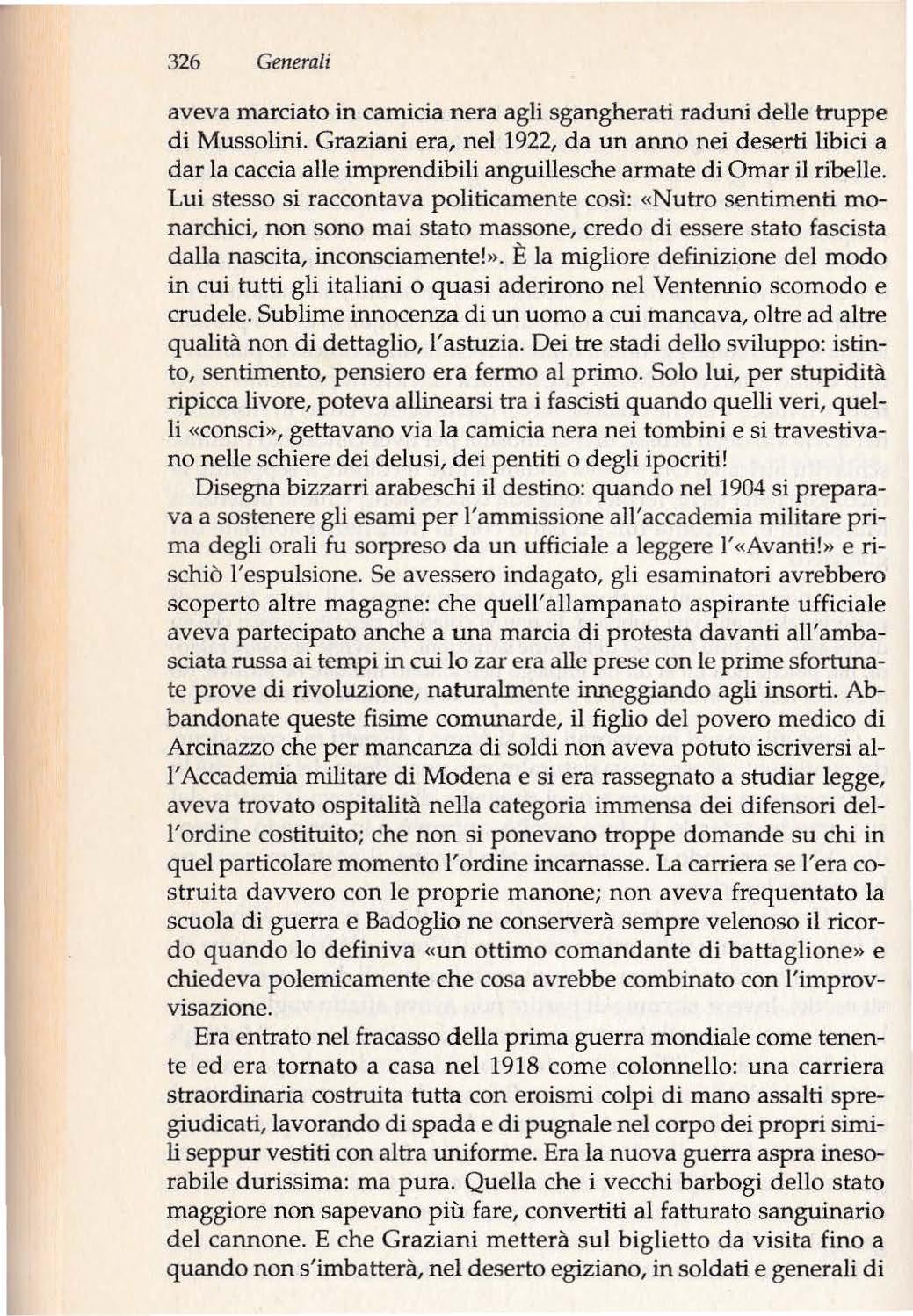
altra stoffa. Che non fosse fascista lo dimostra il comportamento che tenne quando rientrò nel 1919 a Parma dove era di stanza il suo reggimento. Era la Parma rivoluzionaria della «settimana rossa», nell'Oltretorrente friggeva una replica del ' 17 sovietico e sembrava di varcar le porte di una San Pietroburgo padana. Tutti i giorni c'erano assembramenti, tumulti, clamori, abbaruffamenti con gendarmi carabinieri guardie regie. Agli ufficiali era dato l'ordine di farsi vedere in giro il meno possibile, di fare vita ritirata e nel caso una passeggia ta fosse proprio necessaria, di lasciare nel cassetto le decorazioni. Per non accendere gli animi che già lo erano abbastanza da soli. Si rischiavano bastonate e sputi. Graziani qualcosa di peggio. Per una sciagurata omonimia si era diffusa la voce che fosse figlio del generale che dopo Caporetto era diventato ce lebre per la disinvoltura con cui faceva lavorare i plotoni di esecuzione contro disertori, panciafichisti, tiepidi o presunti tali . Nonostante una lettera di smentite su q u ella poco profittevole parentela, doveva star trincerato in casa; veniva accompagnato da una scorta in caserma come un malfattore e si temeva a ogni momento l'agguato, la fucilata vendicatrice. Se fosse stato fascista avre bbe preso la tessera e si sarebbe subito unito alle bande dei bastonatori in camicia nera che avevano preso in affitto l'onore dei reduci . Qualche offerta certo la ebbe, lui preferì chiedere una nuova destinazione in Oriente.
Nessun ge nerale ha meglio di Graziani incarnato non ciò che il fascismo era (non bisognava affaccendarsi molto) ma ciò che voleva essere: un incrocio tra Giulio Cesare e Macigno, il personaggio dei fumetti che anche n e ll'as p e tto fisico al generale sembra ispirarsi, la risposta autarchica a g li e roi delle strisce ame ricane: faccia da antico romano, braccia d i acciaio, posa energica, citazione la tina sempre pronta. Spesso la consecutio e le declinazioni zoppicavano. Ma non importa, la citazione è la versione giornalistica, portatile e veloce di una ver a cultura. Mussolini fu per molti anni affascinato da quel fegataccio: piaceva soprattutto la sua brutalità, la determinazione feroce con cui portava a termine il compito asseg nato. Era uno che non doveva prepararsi ali' a vanti-marsh. Era sempre con lo zaino affardellato. La chiamavano fermezza ed era un pregio che il fascismo poteva permettersi solo nella propaganda, ché poi la sua politica in tutti i campi era ammansita dalla necessità del compromesso. La s to r ia p ersonale di Graziani era diversa da quella dei generali del re, tondeggianti untuosi scettici e senza spigoli che avevano preso le greche e i gradi a scuola, con la pagella. Era il vero fascista in uniforme che usava s ul campo di battag lia i m etodi brutali dello squadrismo.

Ne scoprì i talenti ai tempi della «pacificazione» della Libia e gli piacque subito. Ne dubitate? Cosa c'era di più scenograficamente mussoliniano di un militare che appena arrivato in quella sgangherata colonia, dopo aver fiutato il vento che tirava, cioè un rassegnato tran Iran, il lazzaronjsmo di adeguarsi a vergognosi compromessi con gli arabi, aveva fatto affiggere alla porta del suo ufficio un cartello: «Presso questo comando non c'è cassaforte»? Già, perché la carica di colonizzatori la compravamo con moneta sonante. Negli anni duri della guerra quando Cadorna, che detestava le colonie, aveva fatto rientrare tutte le truppe avevamo temprato fino alla solidità del bronzo la pazienza. In Libia si può dire comandavano i libici, noi eravamo arroccati nelle città della costa protette dai cannoni delle navi, più o meno come ai tempi dello sbarco dj Caneva. Anzi, per evitare di essere annientati spesso ci piegavamo a pagare l'affitto. Addirittura esisteva un Parlamento libico, altro che dominio indiretto! Abbiamo inaugurato il postcolonialismo. Spalleggiato da un altro ambizioso a tre cotte, il conte Giuseppe Volpi in carica come governatore, Graziani cominciò a far nel deserto la guerra degli arditi. Preceduto da un fascistissimo gagliardetto con la scritta «Audacia vinci!» tendeva imboscate, msegwva, colpiva. Spariva nel polverone con colonne mobili dotate di cammelli e camion p er portare il materiale e l'acqua, costringeva i libici che ne erano disgustatissimi ad acciuffamenti quotidiani . Il deserto davanti a cw i vecchl comandanti italiani si ritraevano spaventati era diventato un mare in cui navigava con una determinazione e una sicurezza da far invidia ai senussi. Sconcertati da quello scombinamento di regole i nemici non sapevano più come reagire: l' italiano faceva la guerra come loro. I villaggi e le oasi, magari a giorni ru marcia dall'ultimo pozzo dove fino ad allora vivevano senza disturbo, erano diventate insicure. Le piste del deserto bengasino e d el roccioso Gebel, il Garian intontito dal sole, Kufra impalpabile e lontana come un miraggio, si popolavano di colpo, erano affollate da colonne formate da altri libici, i collaborazionisti, spietati implacabili inesauribili. Fermarsi a preparare un tè o a riempire gli otri di acqua melmosa a un pozzo poteva significare la morte. «Il governo della notte» come si faceva chlamare la Senussia con baldanzosa arroganza si intiepiruva, era costretto a retrocedere sempre più nell'interno, perdeva il fascino della invincibilità che è l'arma migliore delle guerriglie . Il comandante degli italiani era spietato, era un tormentatore implacabile dei propri simili. Giosc era una delle capitali dei ribelli: dopo una marcia nel deserto di ventidue ore con una temperatura di cinquanta gradi che rischlò di con-

vertirsi in tragedia, il forsennato Graziani piombò su Giosc e la rase al suolo, i ribelli furono falciati con le mitragliatrici: «Alzammo la bandiera italiana » scrisse nel suo successivo e quasi insopportabile Pace romana in Libia «sulle rovine».
Mussolini ancora in frac aveva bisogno di personaggi per la sua nuova Italia, adesso che rivaleggiando con la Genesi aveva deciso di creare l'uomo nuovo. Graziani, alto, leonino, faceva per lui. Lo nominò generale e gli spedì la tessera ad honorem del partito di cui quello non si era mai sognato di fare richiesta . Soprattutto ordinò a una troupe cinematografica di seguirlo. Si faceva proiettare i filmati a villa Torlonia, roteava gli occhi, e poi tirava via, rappezzava aggiu· s tava mondava, insomma faceva il montaggio lui stesso con la sinfonia delle sequenze che gli sembravano più adatte a mettere i muscoli e il buon umore alla fantasia popolare. Graziani, per carità, non si tirava indietro, non faceva il modesto. Montava sul cavallo bianco che aveva trovato un giorno per una strada di Tarhuna, vecchio covo ribe lle riportato alla quiete fascista; il destriero di nome Uaar, ov· vero «il difficile», era scenograficamente inquieto, Graziani replica· va le pose di Rodolfo Valentino. Se era il caso saliva in gobba a cammelli corridori, ordinava agli meharisti cariche con la spa da sguaina ta. Insomma recitava benissimo la parte del terrore dei be· duini, d ello Scipione, del fracassatore: tutti soprannomi che la stam· pa estasiata gli affibbiò. Mussolini rimase ammaliato soprattutto da un fotogramma: Graziani altissimo con in testa il vecchio chepì che era ancora quello della prima guerra mondiale, è avvolto in un man· tel10 che lo copre completamente; davanti a lui un libico, antico, omerico, vestito di bianco, raggrinzito dall'età risponde alle sue domand e guardandolo di sotto in su. Sullo sfondo le dune e la luce chiara del deserto. Diverrà l'immagine simbolo del colonialismo fa. scista, il civilizzato e il barbaro, il mondo nuovo e quello antico e destinato a inchinarsi e obbedire. Basta così, ce n'è d'avanzo. Purtroppo a Graziani piaceva anche scrivere. Collaborava ai gior· nali locali, la «Gazzetta di Bengasi», con lo pseudonimo di Gebeli· cus . Immaginava di essere un Lawrence italico. E infatti conosceva l'opera dell'inglese che consigliava come lettura edificante ai suoi ufficiali. Ma ahimè, se forse il suo amore per il deserto era pari a quello dell'autore dei Sette pilas tri della saggezza, non cosi era per lo s tile. Pochissimi sono stati i generali italiani, l'abbiamo detto, in gra· do di alzar la testa dal periodare dei rapporti di fureria. Ebbene Gra· ziani è uno dei peggiori del plotone degli altri: un periodare intermi· nabile, le subordinate che gli scappano come squadroni di cavalleria,
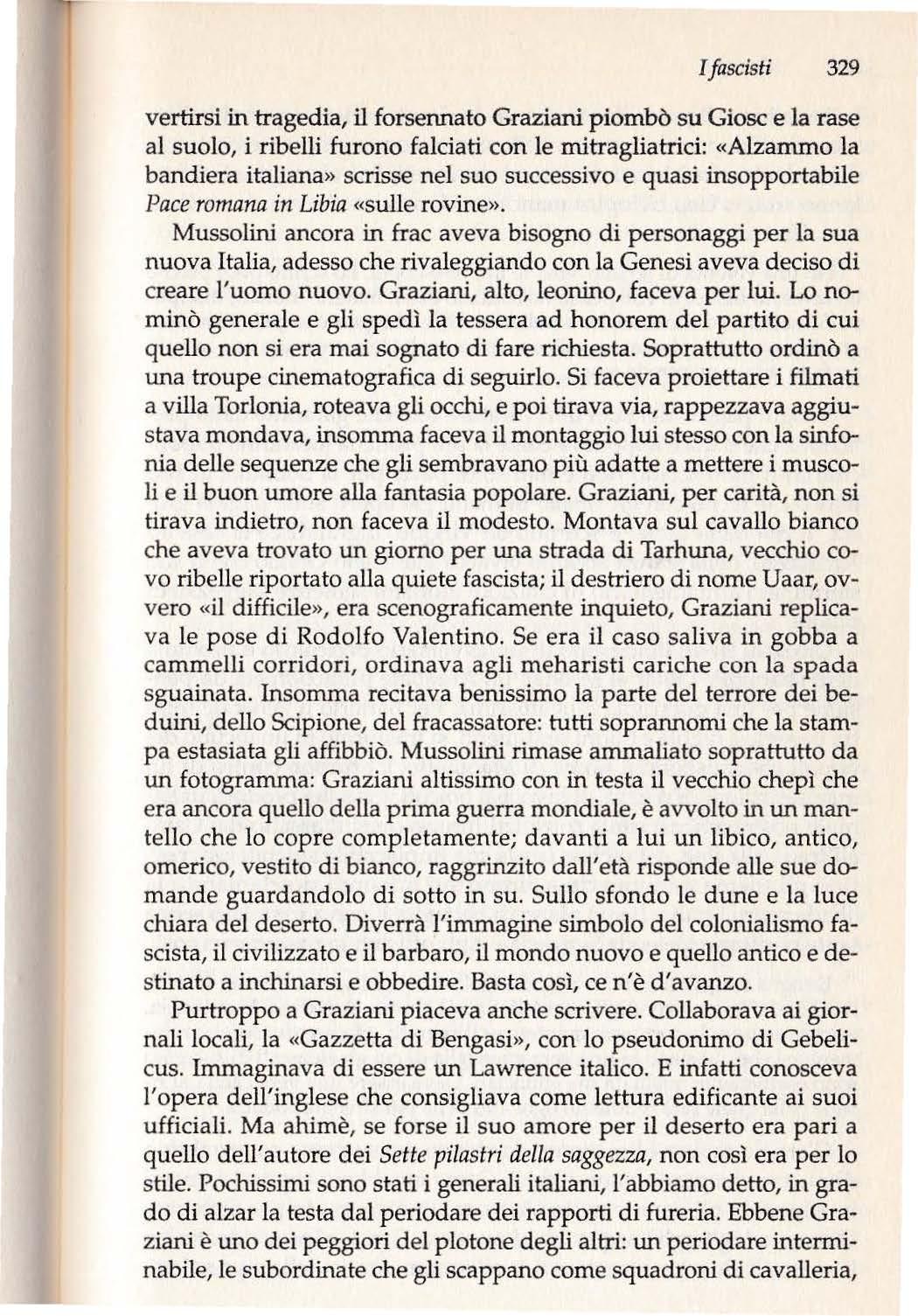
la fissazione di puntellar tutto con la citazione latina per abbellire secondo il deprecabile vezzo della nostra scuola ottocentesca; un io debordante, strafalcioni di sintassi che marciano su.i congiuntivi e ne fanno strage. Una ciclopica mancanza di rrùsura che non lo mollerà mai. Un esempio:
Ho una volontà di acciaio, amo le imprese nobili, ho scritto poco perché ho lavorato molto. In compenso ho studiato assai: materie militari, discipline filosofiche ed economiche e politiche. Dice Pitagora che nella vita bisogna fare un figlio, piantare un albero, scrivere un libro, costruire nna casa. Io ho fatto tutte e quattro le cose ...
In ogni pagina dei suoi libri (tirature bibliche garantite dalla prefazione che il duce apponeva come la più proficua locandina pubblicitaria) il maresciallo non è maj solo: parte per la Somalia, al suo fianco c'è Tacito con gli Armali in mano già aperti sulla pagina giusta. Torna dalla Libia. È scortato da Virgilio. Ingrandisce la casa ad Arcinazzo, nella stanza accanto bivacca mansueto Orazio con il suo sterrrùnato armamentario di citazioni aforisrrù sentenze saggezza in pillole.

Graziani trovò l ' inciampo di un avversario pericoloso e pronto a ogni sbaraglio, Omar el Muktar, un Annibale punico in età da pensione per una guerriglia giovanissima. Per batterlo il generale rrùse tra parentesi regole e buoni sentimenti, si trasformò in un incubo dei popoli che sillabano il nome di Maometto. Ci furono contro di lui manifestazioni di piazza, si invocò il boicottaggio dei prodotti italiani, le nostre ambasciate e consolati furono presi d'assalto dal Cairo all'Iraq. Alla fine, sotto choc per la sua implacabile spietatezza, perfino gli ulema e i muezz in salirono sui minareti proclamando la jihad contro l'Italia. Il suo piano di battaglia l'aveva intitolato senza tante perifrasi «Delenda Senussia». Agli ufficiali lo riassumeva così: Bisogna frugare il terreno a ogni angolo e in ogni senso. Cercare i rivali, stanarli dai loro nascondigli, ucciderli uno al giorno, impedirne la radunata, cercare sempre la sorpresa, mantenere il segreto, giocare di astuzia, rammentarsi che qui siano in una vera guerriglia di cui gli elementi di successo sono esattamente quelli da me enunciati. Deve essere una vera caccia al ri· belle nella quale sarà redditizio ogni atto della più sfrenata audacia.
C'era da rabbrividire ma era la chlave del successo contro il tipo di guerra che praticavano i libici. Come avrebbero capito i francesi in Algeria e gli americani in Vietnam, l'unico modo per soffocare Omar era togliergli l'acqua in cui nuotava. Graziani provvide. Fu un lavoraccio; dovette inventare tutto l'armamentario delle repressioni,
delle pulizie etniche, d egli olocausti. Fece spuntare nei deserti giganteschi campi di concentramento in cui come masse di armenti le tribù dei nomadi dell 'altopiano macchiato dalla rivolta vennero trascinate s popo lando la si rtica e il b engasino. Friggeva, il terrore gli sembrava le nto, compassato. Ecco allora i tribuna li volanti (no n era un' immagine retorica, i giudici come arcangeli del patibolo si spos ta vano infa tti in aeroplano): «La giustizia italiana scende dal cielo come una s pada » scrisse. Quei forsennati sfornavano sentenze a catena, non c'era provincia o ciuffo di p alme che fosse al riparo: l'accertamento delle colpe era spiccio, m e no di tre ore sentenza ed esecuzione compresa. Il m otore dell'aereo già rombava: avanti un altro. Rinchiuse persino il deserto che era senza frontiere dai tempi d e l Deuteronomio. Dall'Egitto filtra vano le a rmi e i rifornimenti per il senusso? Bene: ecco un muro di fil o spinato di migliaia di chilometri, che lasciò la ribellione affran ta, senza reclute armi e cibo.
Graziani era consapevole che i s u oi massacri erano ormai un volume . Rispondeva così:
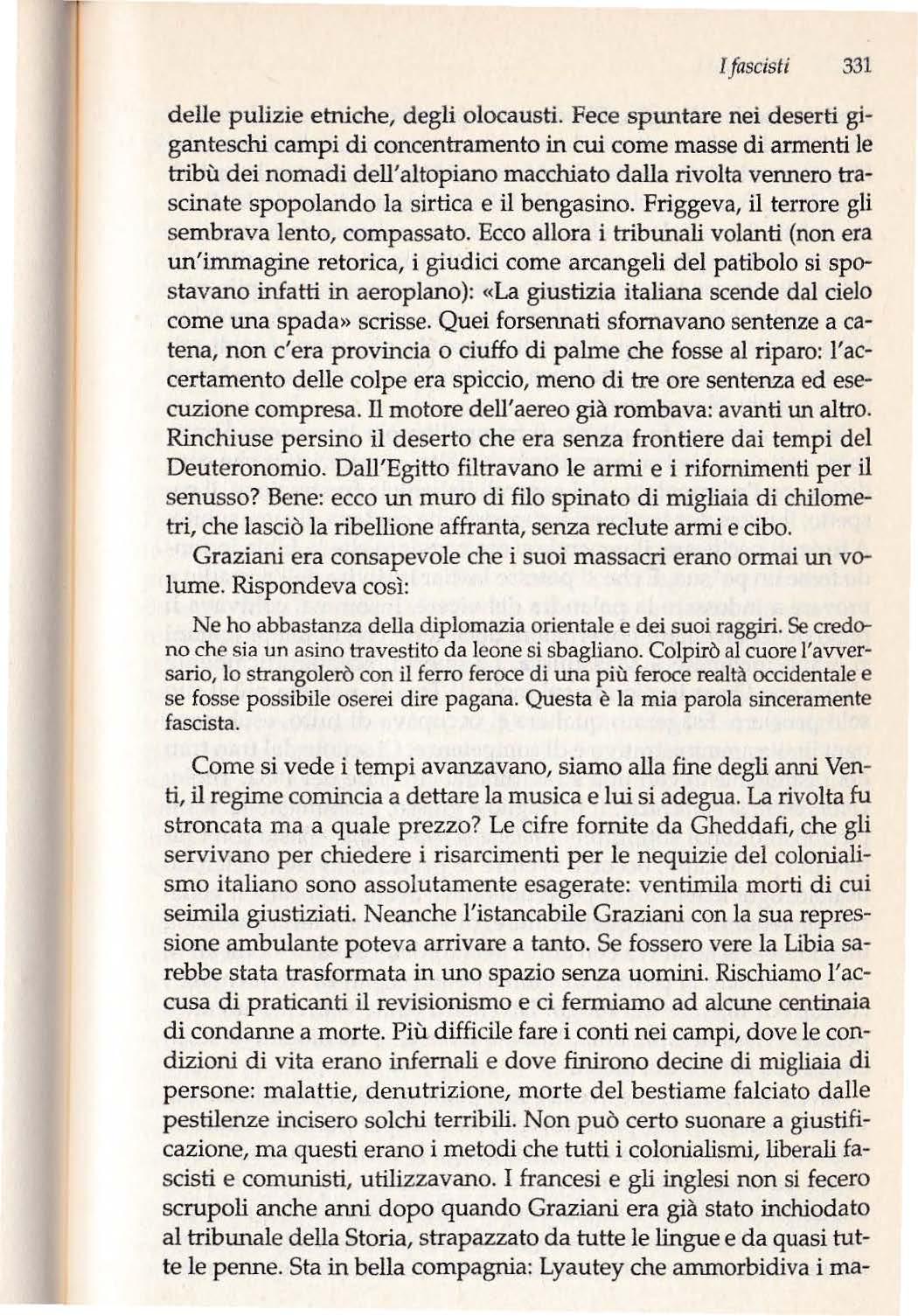
Ne ho abbas tanza deUa diplomazia orientale e dei suoi raggiri. Se credono che s ia un asino travestito da leone s i sbagliano. Colpirò al cuore l'avversario, lo strangolerò con il ferro feroce di una più feroce realtà occidentale e se fosse possibile oserei dire pagana. Questa è la mia parola sinceramente fascista.
Come si vede i tempi avanzavano, siamo alla fine degli anni Venti, il regime comincia a dettare la musica e lui s i adegua. La rivolta fu stron cata ma a quale prezzo? Le cifre fomite d a Ghed dafi, che gli servivano per chiedere i ris arcimenti p e r le nequizie del colonialismo italiano son o assolu tamente esagera te: ventimila morti d i cui seimila giustiziati. Neanch e l'istancabile Graziani con la sua repress ione ambulante poteva arrivare a tanto. Se fossero ve re la Libia sarebbe stata trasformata in uno spaz i o senza uomini. Rischiamo l'accusa di praticanti il revisionismo e ci f ermiamo a d alcune centinaia di condanne a morte. Più difficile fare i conti nei campi, dove le condizioni di vita e rano infernali e dove finirono decine di migliaia di persone: malattie, denutrizione, morte del b estiame falciato dalle pestilenze incisero solchi terribili. Non può certo s uonare a gi u s tificazione, m a questi e rano i m etodi che tutti i colonialismi, liberali fascisti e comwùsti, utilizzavano. I francesi e gli ing lesi non si fecero scrupoli anche anni d opo quando G r aziani e ra già stato inchi oda to a l tribunale della Storia, s trapazzato da tutte le lingue e da quasi tutt e le p enne. St a in b e lla compagnia: Lyautey che ammorbidiva i ma-
rocchini con la mitraglia, Rhodes poco pensoso delle sorti di zulu e boeri, Pershing l'americano che non riusciva a capire la freddezza dei filippini per le stelle e le strisce, Massu così impaziente con la casbah dispettosa. Fermiamoci. In quella folla rischiamo di perderlo di vista. Infatti il generale ne ebbe applausi non soltanto da Mussolini, De Bono e Badoglio che erano i suoi diretti superiori e lo invitavano a darci dentro con le esecuzioni, e se possibile a esser ancor più spiccio e implacabile. Furono i colleghi stranieri che ne ammirarono l'abilità nel districarsi da quel tipo di guerra che più creava fastidi agli eserciti europei. Certe strade una volta imboccate sono come binari senza scambi. Non se ne esce.
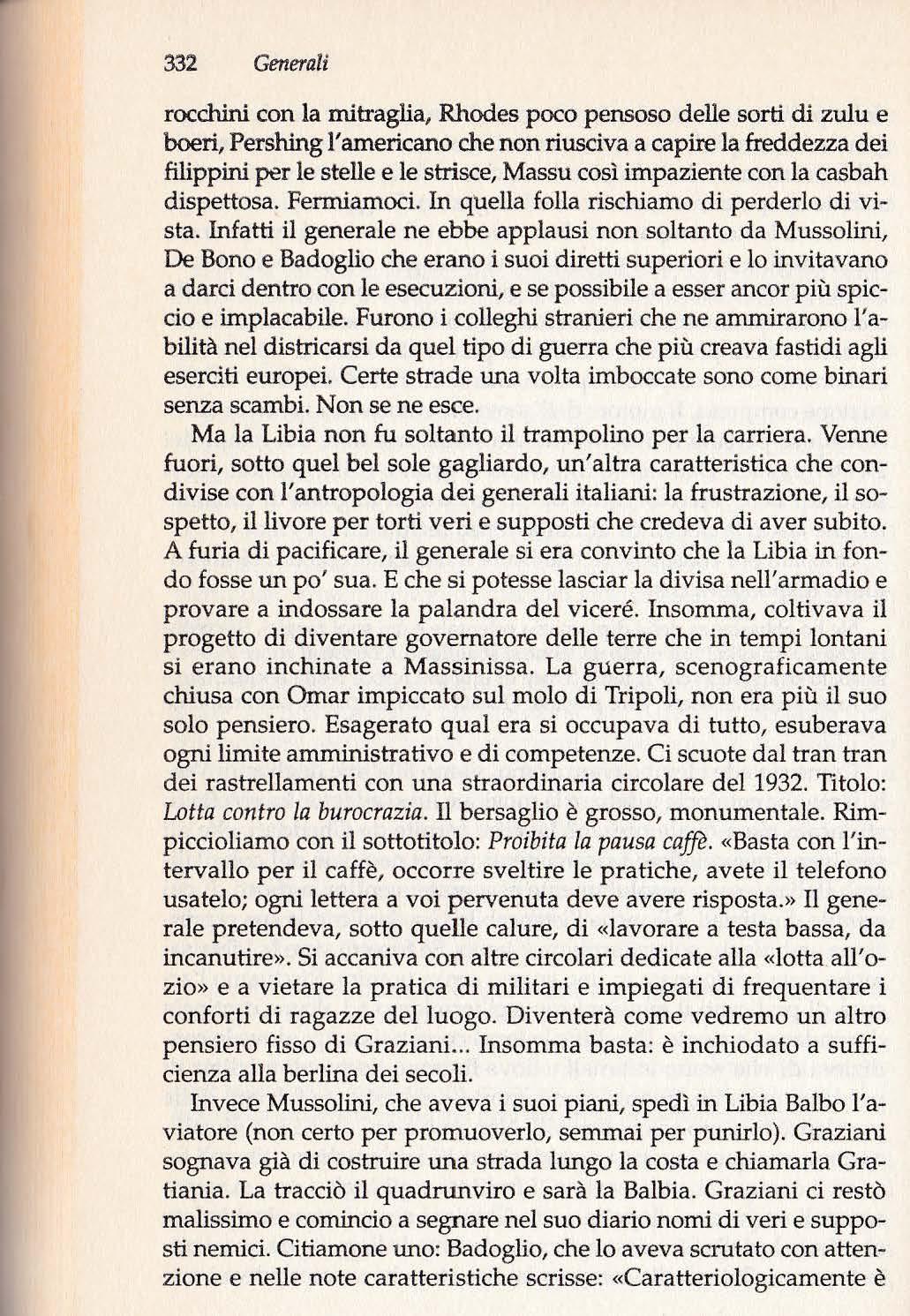
Ma la Libia non fu soltanto il trampolino per la carriera. Venne fuori, sotto quel bel sole gagliardo, un'altra caratteristica che condivise con l'antropologia dei generali italiani: la frustrazione, il sospetto, il livore per torti veri e supposti che credeva di aver subito. A furia di pacificare, il generale si era convinto che la Libia in fondo fosse un po' sua. E che si potesse lasciar la divisa nell'armadio e provare a indossare la palandra del viceré. Insomma, coltivava il progetto di diventare governatore delle terre che in tempi lontani si erano inchinate a Massinissa. La guerra, scenograficamente chiusa con Omar impiccato sul molo di Tripoli, non era più il suo solo pensiero. Esagerato qual era si occupava di tutto, esuberava ogni limite amministrativo e di competenze. Ci scuote dal trantran dei rastrellamenti con una straordinaria circolare del 1932. Titolo: Lotta contro la burocrazia. Il bersaglio è grosso, monumentale. Rimpiccioliamo con il sottotitolo: Proibita la pausa caffè. «Basta con l'intervallo per il caffè, occorre sveltire le pratiche, avete il telefono usatelo; ogni lettera a voi pervenuta deve avere risposta.» Il generale pretendeva, sotto quelle calure, di «lavorare a testa bassa, da incanutire». Si accaniva con altre circolari dedicate alla «lotta all'ozio» e a vietare la pratica di militari e impiegati di frequentare i conforti di ragazze del luogo. Diventerà come vedremo un altro pensiero fisso di Graziani ... Insomma basta : è inchiodato a sufficienza alla berlina dei secoli.
Invece Mussolini, che aveva i suoi piani, spedi in Libia Balbo l'aviatore (non certo per promuoverlo, semmai per punirlo). Graziani sognava già di costruire una strada lungo la costa e chiamarla Gratiania. La tracciò il quadrunviro e sarà la Balbia . Graziani ci restò malissimo e comincio a segnare nel suo diario nomi di veri e supposti nemici. Citiamone uno: Badoglio, che lo aveva scrutato con attenzione e nelle note caratteristiche scrisse: «Caratteriologicamente è
un sospettoso, soffre di mania di persecuzione e di conseguenza pensa male del prossimo».
Lo sgambetto il generale riusci a intravederlo anche quando si scatenò la guerra di Etiopia. Tutti sapevano che, secondo i piani, la battaglia vera si sarebbe combattuta al Nord, lungo le vecchie strade di Baldissera e Baratieri. E 11 comandava De Bono, il vecchio raggrinzito generale che aveva meriti fascisti certamente superiori ai suoi. Graziani, nuotando tra le voci, i sussurri e i pettegolezzi che costituivano il preludio delle imprese fasciste, si era convinto che gli avrebbero assegnato il comando del corpo d'armata eritreo, un'affilata avanguardia che avrebbe deliziato con le sue qualità riconosciute di «africano» e di offensivista. Invece gli arrivò la lettera che annunciava la sua destinazione: Somalia, con l'incarico doppio di governatore e comandante delle truppe. Lesse l'organigramma dell'armata, si incupì ancora di più: duecento autocarri da museo, trenta cannoni e aeroplani della prima guerra mondiale più pericolosi per i piloti che per il nemico. E la colonia? Una piaga che ci ulcerava da anni. Sabbie e acacie moribonde, non c'era un porto, bisognava trasbordare tutto su zattere sballottate dai marosi, una stagione delle piogge da marzo a ottobre che aggiungeva maledizione a maledizione e trasformava la sabbia in fango e i rigagnoli in fiumi in piena. Le tribù incarognite, selvatiche e neghittose fornivano i ventimila indigeni che con i dodicimila nazionali della «Peloritana» costituivano le sue fanterie. Dall'altra parte ras Destà, un fedelissimo di negus Ailé Selassié con un paio di armate zeppe di uomini e un consigliere militare di buona fama internazionale il turco Wehib Pascià. C'era davvero da lavorare a testa bassa.
A far infuriare Graziani fu soprattutto l'ordine delle operazioni: lui, il terrore dei beduini, doveva costruire un grande campo trincerato vicino a Mogadiscio, chiudersi dentro e tenersi rigidamente sulla difensiva . Graziani non sarebbe stato Graziani se non avesse coltivato altre idee, che coincidevano con quelle di Mussolini: il duce ormai si considerava un fior di generale e un altro capitolo, fascista, di quella impresa non gli dispiaceva. Ricevette Graziani per il commiato e quando il generale uscì impettito e bersaglieresco le direttive strategiche di De Bono erano già finite nei cassetti. La scena nel s uo best seUer Fronte Sud la racconta così:
Chi ha avuto la fortuna di incontrare qualche volta Mussolini nel salone di lavoro a palazzo Venezia davanti al suo tavolo e poi si volge per andarsene, sa che per giungere a lla porta di uscita è come se facesse un chilometro invece di cinquanta passi, che non finiscono mai. Sentite die tro di voi lo

sguardo magnetico dell'uomo che vi segue e vi misura. Quando finalrnent, giunto alla porta vi voltate per salutare romanamente, allora, dallo stesse sguardo del capo potete comprendere se siete stato giudicato bene o meno. Quel giorno i suoi grandi occhi brillavano verso di me, come fari lucenti ... Uscii con la sensazione che l'anima d e l Grande mi sa rebbe s tata vicina, e con Ja convinzion e che no n sarei rimasto in difensiva.
Non era certo uno abituato ai voli dello spirito ma stavolta aveva ragione. Doveva essere un comprimario, presidiare un fronte che avrebbe partorito guai vista la sproporzione di forze. Divenne anche nella fantasia della gente un protagonista. L'esperien za libica gli aveva insegnato che in territori desertici l a mobilità è tutto. Armate gigantesche costrette a marciare sotto baldacchini di p o lvere trasci· nandosi dietro con fatich e immani acqua e cibo sono v ulne rabili. Quando si subisce una sconfitta tra le sabbie, anche le armate più robuste si disgregano. La vittima delle cabale di palazzo con la sua zazzera a l vento n o n aveva automezzi. Li comprò. È il più grande blitz amministrativo e contabile d ella patria: rimborso spese e fattura. Con i fondi d el governatorato aggirando le s anzioni societarie si fece spedire da Aden cinquanta erculei caterpillar della Ford che potevano trascinare su qualunque terreno l 'equivalente del carico di mille autocarri. Mussolini, che non badava a spese per la vittoria, non solo autorizzò ma app laudì alla scorciatoia fascistissirna.
I suoi generali, a nord, anche il sussiegoso Badoglio, andavano a rilento con la loro guerra vecchio tipo (e pensare che disponev ano di trecentomila u omini!), sbuffavano a sentire sol tanto la parola attac· co. Quel Graziani, invece, correva. Ques ta volta non usammo il nu· mero, la nostra atomica umana . Tirammo fuori dall'arsenale i gas. Graziani aveva chiesto l'autorizzazione, Mussolini concesse «per gravi ragioni difensive», nella carognaggine avevamo dunque ancora qualche scrupolo e vergogna. Non era il caso del generale di Arcinazzo che allegramen te bombardò. Fece spallucce p er le !amen· tazioni di francesi e inglesi che appartenevano più alla politica che all'etica. Quanto agli etiopi con le loro artigianali ferocie, le evirazioni, gli scannamenti bestiali dei ca tturati, offrivano al duce la scusa per dimenticare le regole. A Addis Abeba cominciaron o a sfruttare i «proiettili usati dai demoni venuti dalle nuvole» che cadevano in tes ta ai loro soldati com e s cusa per tutte le sconfitte, anche quelle in cui i gas non c'entravano per niente.
Graziani arrivò trafelato con una gal oppata attraverso l' incubo desertico dell'Ogadèn , a Neghelli. Lo fecero m archese d ella ci ttà come a i te mpi dei paladini. Il re, che apriva con fastidio i batte nti del

Gran Magistero degli ordini cavallereschi, sarebbe scoppiato a ridere se avesse saputo che quella gloriosa conquista era un mazzo di tucul di fango e c'erano soltanto due edifici in muratura, la chiesa copta e la palazzina dove gozzovigliavano i consiglieri militari belgi del n egus. Accarezzò il sogno di tagliare per primo il traguardo nel c uore dell'Etiopia battendo sul tempo il prudente Badoglio. Mussolini non gli aveva forse scritto: «Vostra eccellenza troverà a Harrar il bastone da maresciallo»?
Era ormai famoso Graziani, famoso e temuto e non soltanto dagli abissini. Tanto che contro di lw venne utilizzata l 'arma sottile emicidiale della calunnia. Comparve infatti su alcuni giornali arabi stampati al Cairo e fu ripresa in mezzo mondo la notizia che era di religione ebraica. Non correvano ancora i tempi sciagurati delle leggi razziali ma, impegnato com'era in una guer ra a capo di truppe musulmane e con sudditi che tendevano al fanatismo, era un proclama di ribellione. Come sempre esagerato per tutto quello che riguardava la sua immagine e il suo onore - parolona che declinava in modo ossessivo - cominciò a tempes t are ambasciate, redazioni di giornali, consoli con la richiesta di smentite, scuse, rettifiche. Sistema perfetto per far sì che la falsi tà si allargasse e diventasse nella convinzione comune verità certificata. Alla fine, per dare dimostrazione piena della sua rive renza verso Allah andò, come imponeva la l egge, a prostrarsi poco dignitosamente nella moschea di Mogadiscio. Strano destino il suo: ritornò a galla in quei mesi un'altra leggenda che spiegava con il taglio di un romanzo di appendice la sua «ferocia» nelle guerre coloniali. Già in Libia circolava una voce priva di qualsiasi fondamento e nata non si sa come: che G raziani odiasse gli africani perché quando era bambino i suoi genitori erano stati trucidati dagli abissini di Menelik. Correvano si diceva i tempi di Adua o giù di lì. Polpettone truculento con infinite e imprevedibili variazioni: che la madre era stata violentata dagli indigeni, che lw st esso aveva dovuto dare il colpo di grazia per sottrarli a bestiali torture o risparmiare loro le sofferenze. Fino ad arrivare alla ancor più stupefacente appendice che non dei geni tori si trattava ma della moglie e della figlia del generale, sottoposte a bestiali e africane lussurie. Erano favole mal combinate, la ferocia di Graziani non aveva bisogno di simili fanfaluche. Ma il generale imbestialito, furibondo perse la testa e costrinse il duce a ricevere le due donne in udienza ufficiale per poter dar con grande rilievo l a notizia.
Di un'accusa non si diede mai pensiero, neppure in quel libro Ho difeso la patria con cw, sempre zavorrato da uno stile dannunziano
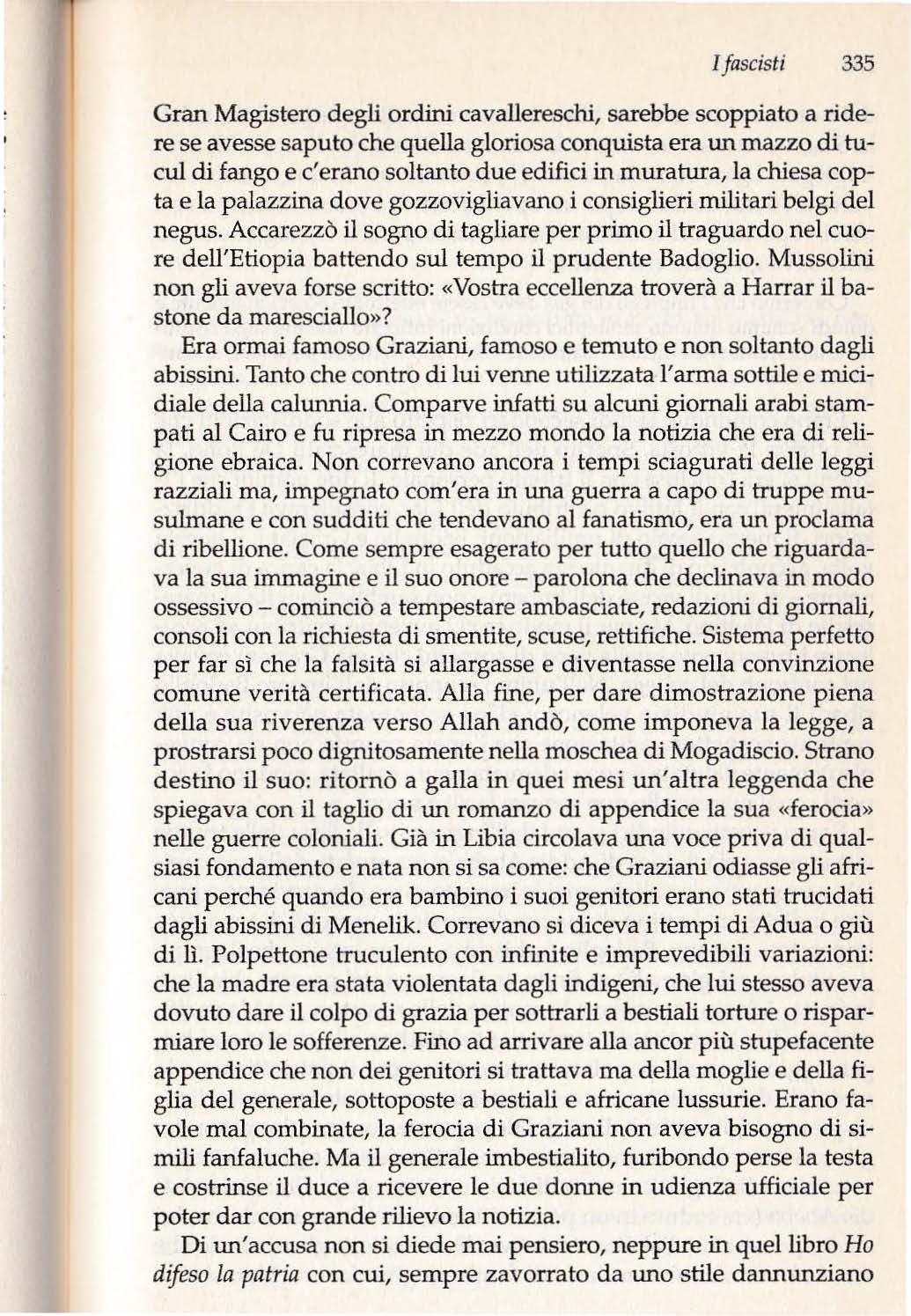
del tutto fuori tema in un libro dove cercava di apparire vittima della Storia e mansueto, scrisse la sua autodifesa. Era l'accusa di aver impiegato i gas. Come la pensava lo aveva scritto in una direttiva inviata all'aeronautica dopo un'oper azione di bombardamento con aerei vaporizzat o ri trasformatasi in fiasco perché la s tag ione secca attenuava gli effetti del ve leno:
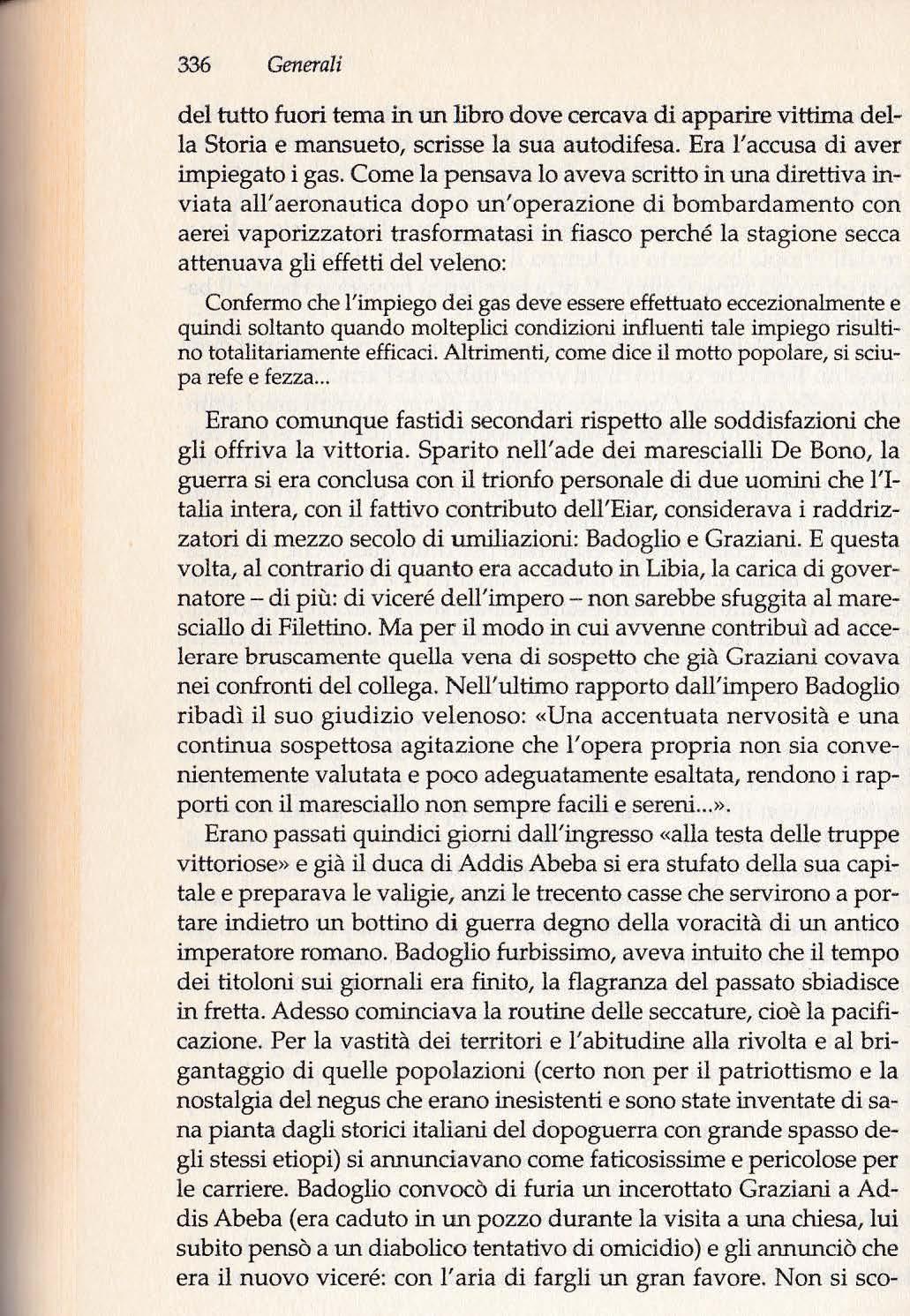
Confermo che l'impiego dei gas d eve essere effettuato eccezionalmente e quindi soltan to quando molteplici condizioni influenti tale impiego risultino to talitariamente efficaci . Altrimenti, come dice il motto popolare, si sciupa refe e fezza
Erano comunque fa s tidi secondari rispetto alle soddisfazioni che gli offriva la v ittoria . Sparito nell'ade dei marescialli De Bono, la guerra si era conclusa con il trionfo p ersonale di due uomiru che l'Italia intera, con il fattivo contributo dell'Eiar, cons iderava i raddrizza tori di m ezzo secolo di umiliazioni: Badoglio e Graziani. E questa volta, a l contrario di quanto era accaduto in Libi a, la carica di governatore - di più: di viceré dell'impero - non sarebbe sfuggita al maresciallo di Filettino. Ma p er il modo in cui avvenne contribuì ad accelerare bruscamente quelia vena di sosp e tto che già G raziani covava nei confronti del coliega. Nell'ultimo rapporto dall'impero Badoglio ribadì il s uo gi udi z io velenoso : «Una accentuata n ervosi tà e una continua sospettosa agitazione che l'opera propria non sia convenientemente valu ta ta e poco a d eguatamente esaltata, rend ono i rapporti con il marescialio non sempre facili e sereni ... ».
Erano passati quindici giorni d a ll' ingresso «alla testa d e lle truppe v itto riose» e già il duca di Addis Abeba si era stufato d e lla s ua capitale e preparava le valigie, anzi le trecento casse che servirono a portare indietro un bottino di guerra d egno della voracità di un antico imperato re romano. Badoglio furbissimo, aveva intuito ch e il tempo dei titoloni s ui giornali e ra finito, la fla granza del passato s biadisce in fretta. Adesso cominciava la routine delle seccature, cioè la pacificazione. Per la vastità dei territori e l 'abitudine alla rivolta e al brigantaggio di qu elle popolazioni (certo non p e r il patriottismo e la nostalgia del n egus che erano ines istenti e sono state inventate di sana pianta dagli storici italiani d el dopoguerra con grande spasso d egli stessi etio pi) si annunciavano come faticosissime e p ericolose per le carriere. Badoglio convocò di furia un incerottato G ra ziani a Addis Abeba (era caduto in un pozzo durante la v isi ta a una chiesa, lui s ubito pensò a un diabolico tentativo di omicidio) e gli annunciò che e r a il nuovo viceré: con l 'aria di fargli un gran favore . Non s i sco-
modò a fornirgli un quadro preciso della situazione, aveva fretta perché l'aereo lo aspettava con il motore acceso e l'altitudine gli accentuava l'asma. Con italica approssimazione gli predisse che lo aspettava «un bienrùo duro e poi le cose si assesteranno. Voi saprete superare tutto perché siete abituato alle situazioni difficili». E saltò agilmente sull'aereo: non aveva forse scelto come motto nobiliare un impegnativo «Veni vidi vici»? Che il re gli bocciò. L'ultima confidenza a un rabbuiato Graziani fu che partiva non per riposarsi ma per nuove battaglie: «Il sottosegretario alla guerra Baistrocchi durante la campagna ha cercato di farmi la forca, ma la pagherà. lo i miei nemici li strangolo lentamente, così, con il guanto di velluto». E mimò il gesto minaccioso. Era qualcosa di più di un monito a un collega che non faceva parte della setta e poteva montarsi la testa. Anticipo. Corro troppo. Ma quando spunta Badoglio, e succede a ogni cantone nella storia di questa sciagura nazionale che fu il condottierismo nos trano, ti viene voglia di corrergli dietro, di non fartelo sfuggire, di inchiodarlo a una forca storica visto che a quella non metaforica è sfuggito allegramente da un pezzo . Non c'è disgrazia nazionale, complotto, intrigo, vigliaccheria dove non si incontri il suo muso di violento e atrabiliare, diffonditore di veleni, demolitore di uomini e aggressore di gente a colpi di bugie.
Basta, torniamo a Graziani che aveva altri tormenti. Se lo avevano scelto immaginando che convertire gli abissini alle delizie di Roma sa rebbe stato complicato, avevano fatto bene i calcoli . Alle prese con ribelli, renitenti, guerriglieri, popolazioni brusche di modi e traditori si trovava come a casa propria tra i campi e i p ascoli di Arcinazzo. Era li che poteva applicare i suoi consolidati metodi questurineschi: ferro, fuoco, plotoni di esecuzione e forca. E li usò senza paura di staccare assegni a vuoto. Alla periferia della capita le allestì briose fi. le di patiboli cui s i preoccupava di fornire continuamente il loro misero carico umano. Chi entrava in città e magari non era ancora giudiziosamente rassegnato all'ordine nuovo traeva motivi urgenti di riflessione. Per questo Graziani avrà una nicchia sua nelle memorie dei non e roi dell' insensato XX secolo.
Si affannava a impiccare anche perché Mussolini, per cui l'Etiopia era un capitolo chiuso e in modo trionfale, non voleva essere infastidito con notizie spiacevoli. Nelle simpatie era incostante come nei rancori . Arduo spiegargli che quando l 'aereo di Badoglio si era allontanato in un rombo verso l'Italia, la capitale era in pratica assediata dalle bande dei ras trasformatisi in banditi, mestiere che riusciva loro meglio che quello di generale. Le comunicazioni con Asmara

e il Sud di fatto erano interrotte. I convogli della ferrovia Gibuti-Addis Abeba viaggiavano come nei film western, con i soldati ai finestrini, i fucili puntati, e spesso non bastava. Non c'era giorno senza qualche imboscata sulle strade, e sempre sanguinosa . Graziani scelse la via più complicata: poteva affidarsi ai capi collaborazionisti per il lavoro sporco, in cambio della conferma del potere sarebbero stati dispostissimi a diventare ultraitaliani, a ripulire l'Etiopia dagli etiopi se proprio non volevano intendere ragione. Invece li eliminò, qualcuno fisicamente, altri spedendoli in Italia al confino, altri ancora trasformandoli in inutili soprammobili per le cerimonie del regime. Cancellò insomma la vecchia Etiopia feudale facendo al negus un regalo di cui avrebbe dovuto essergli riconoscente. Poi fece il Graziani, piacere che non avrebbe delegato a nessun altro: flagellò fino a sradicare l'idea stessa della rivolta.
Il 19 febbraio 1937 il viceré, che amava le cerimonie coloniali in cui faceva la parte del negus, era impegnato a distribuire talleri ai poveri e a mostrarsi al popolo con fasto; era diventato massiccio, la divisa candida che scricchiolava sotto medaglie nastrini greche decorazioni. Era l'occasione scelta dagli etiopi che, ormai alla disperazione, avevano fatto ricorso all'estrema arma dei poveri: il terrorismo. Un attentato con bombe a mano doveva uccidere Graziani. Contemporaneamente le bande degli insorti si sarebbe ro lanciate all'assalto di Addis Abeba. Era una trama micidiale ma organizzata all'etiopica, fondata cioè sull'ingenua supposizione che bastasse uccidere una persona per far crollare tutta l'impalcatura del potere italiano. Graziani, colpito da decine di schegge, coperto di sangue ma vivo e vitalissimo fu trasportato all'ospedale. Subito si scatenò la reazione brutal e e apocalittica degli italiani. Si rimboccarono le maniche non tanto i militari e i carabinieri che per la verità in quei minuti di caos persero l a testa . A massacrare provvidero i fascisti locali: una sbirraglia abietta e ligia appena piombata in colonia e che agli ordini del federale Cortese bivaccava al bar della piazza già ribattezzata del Littorio. Furono loro che, in camion come ai bei tempi in cui crepitavano le leghe e i giornali socialisti, scatenarono una forsennata caccia all'uomo, trucidando bastonando bruciando. Andò a fuoco perfino la chiesa di San Giorgio, con libri e arredi venerandi, con la scusa che nascondeva armi. Gli etiopi terrorizzati non credevano ai loro occhi: altro che europei, erano ritornati i tempi sanguinari del negus. Graziani, dal letto di dolore, si guardò bene dal fermare quei forsennati: perché da Roma giungevano telegrammi urgentissimi che certo non spingevano a dis tinguere nei sudditi cospiratori e innocenti: «Tutti i

civili e i religiosi comunque sospetti devono essere passati per le armi e senza indugio. Attendo assicurazione. Mussolini».
Fu una strage i cui contorni numerici restano ancora sconosciuti; nessuno perse tempo a contare chi c'era nei tucul dati alle fiamme e si spiega solo con una reazione disperata di gente che era certa di trovarsi di fronte a una possibile replica della notte di San Bartolomeo degli italiani. Graziani, a cui lo scampato pericolo certo provocò uno choc nervoso, spediva al duce telegrammi a ritmo di catena di montaggio; mescolava la contabilità della repressione con le informazioni sulla sua t e mperatura corporea. Se l'era vista brutta e non solo per le bombe che avevano rischiato di spedirlo nel paradiso degli eroi fascisti anzitempo. L'attentato poneva un gigantesco punto interrogativo sulla s ua opera di viceré, immiseriva i rapporti in cui aveva garantito che i simpatici etiopi stavano ormai avviandosi, salvo pochi ostinati, a una rassegnata e talora entusiastica vita da sudditi italiani. Insomma, era un bell 'impiccio per la carriera. Era un generale carismatico, la sua fortuna valeva quanto la sua ultima impresa. Solo così si spiega il massacro di Debra Libanòs di cui Graziani porta tutta intera la responsabilità e che materialmente venne eseguito da un suo fedelissimo, il generale Pietro Maletti.
Era il convento più antico e venerato dell'Etiopia, spesseggiava sempre di pellegrini accuditi da trecento monaci e duecento diaconi. Un rapporto dei ca rabinieri redatto nelle ore convulse dell'a tte ntato lo indicava come possibile rifugio degli attentatori prima dell 'a ttacco al ghebì. Un collaborazionista, forse per ingraziarsi il maresciallo, confermò i sospetti. Non era molto. Si brancolava, come dicono i cronisti, nel buio. Bastò. Graziani telegrafò: «Ordino di passare immediatamente per le armi tutti i diaconi di Debra Libanòs meno i ragazzi. Assicuri con parola "LIQUIDAZIONE COMPLETA"». Male tti eseguì: con le mitragliatrici, altrimenti avrebbe impiegato troppo tempo. Sopravvissero solo trenta ragazzi. In Ho difeso la patria garbatamente n o n fa cenno a questo «episodio» s piacevole .
Dei monaci non g li importava nulla, li trovava subdoli e puzzolenti forse per quell' incidente della caduta in chiesa. Tutta la sua attenzione era dedicata ai p e ttegolezzi che arrivavano dall'Italia : si raccontava che una scheggia lo avesse evirato. Non c'era solo quello. Gerarchi e generali (il solito Badoglio) criticavano i suoi metodi spicci e si cominciava a guardare con occhio meno entusiastico alle meraviglie del fronte Sud.
Graziani impazzisce. Esige s mentite, rettifiche in prima pagina, comunicati ministeriali, punizioni esemplari dei calunniatori. Lesso-

na, ministro delle Colonie, esterrefatto risponde: «Sono voci anonime, come si fa a punire?» . Al ghebì vicereale il fracasso aumenta . Graziani ripete ossessivamente che distribuirà ca lci nel sedere di tutti quelli che lo criticano compreso Badoglio non appena tornerà in Italia. È una litania anche durante le cerimonie ufficiali. A una p ar a ta militare tra l' allibita stupefazione dei presenti, indigeni e non, si mette a danzare per dimos tra re che non è m enomato. Esige che i giornali pubblichino due foto della incredibile esibizione. Si fa fotografare nudo di profilo e di fronte a supporto d; un referto medico che ne dichiara la perfetta idoneità al servizio. Poi spedisce le foto a mezza Italia, Mussolini compreso. Il dittatore, sembra incredibile, prese nota ma fece finta di ni ente. Gli serviva in Etiopia un uomo che elimmasse le ultime bande di ras ribelli. Graziani eseguì. Non accorgendosi che in quel modo elimmava anche l' unica ragione per cm lo lasciavano come viceré. L'll novembre 1937 arrivò il temuto telegramma:
Con la liquidazione ormai sicura e prossima dei conati di rivolta nelw l'Amhara e nello Scioa ritengo che il suo compito sia finito. Ho scelto quale suo successore Sua Altezza Reale il d uca di Aosta ...
Era una mossa astuta: di fronte a una personalit à regale anche Graziani avrebbe dovuto inchinarsi e non mugugnare. Invece il maresciallo non sapeva d avvero perdere con stile. Scrisse volumj di lette re a tutti i gerarchi parlando di «indegna manovra», mjse insieme un dossier in cw notabili abissinj invocavano che restasse perché solo la s u a personalità poteva impedire ch e «la rivolta r iprendesse forza». Graziani, come ormai dicevano a Roma, aveva perso la testa: n o n aveva fo r se preteso per la celebrazione del primo anniversario dell'impero, poiché non poteva s filare tutto impennacchiato a i fori imperia li con Badoglio e De Bono, che alla cerimonia partecipasse il s uo cavallo? Siamo a deliri catilmari. Si offrì a ddirittura al duca come capo di s tato maggiore per aiuta rlo con i s uoi consigli a tenere in pugno la d ifficile situazione. Fu tutto inutile. Mussolini gelido pos tillò un liqwdatorio «stia ca lmo.. .».
La s toria di Graziani il vittorioso finiva Il, con la fastosa partenza dall' Etiopia che organizzò come un pellegrinaggio sulle strade del nuovo impero pacificato. Le guerre a s u a mjs ura di generale erano finjte. Quando sciaguratame nte il regime lo tirò fuori dalla naftalina p e r sp edirlo in Libia contro gli ing lesi, lo mjse di fro nte a un compito più grande di lui. I suoi avversari erano stati i libici e gli etiopi, guerriglie ri e bande senza aviazione, cannoni, carri a rmati. Non aveva scuola; comandare armate contro eserciti moderni era un compi-
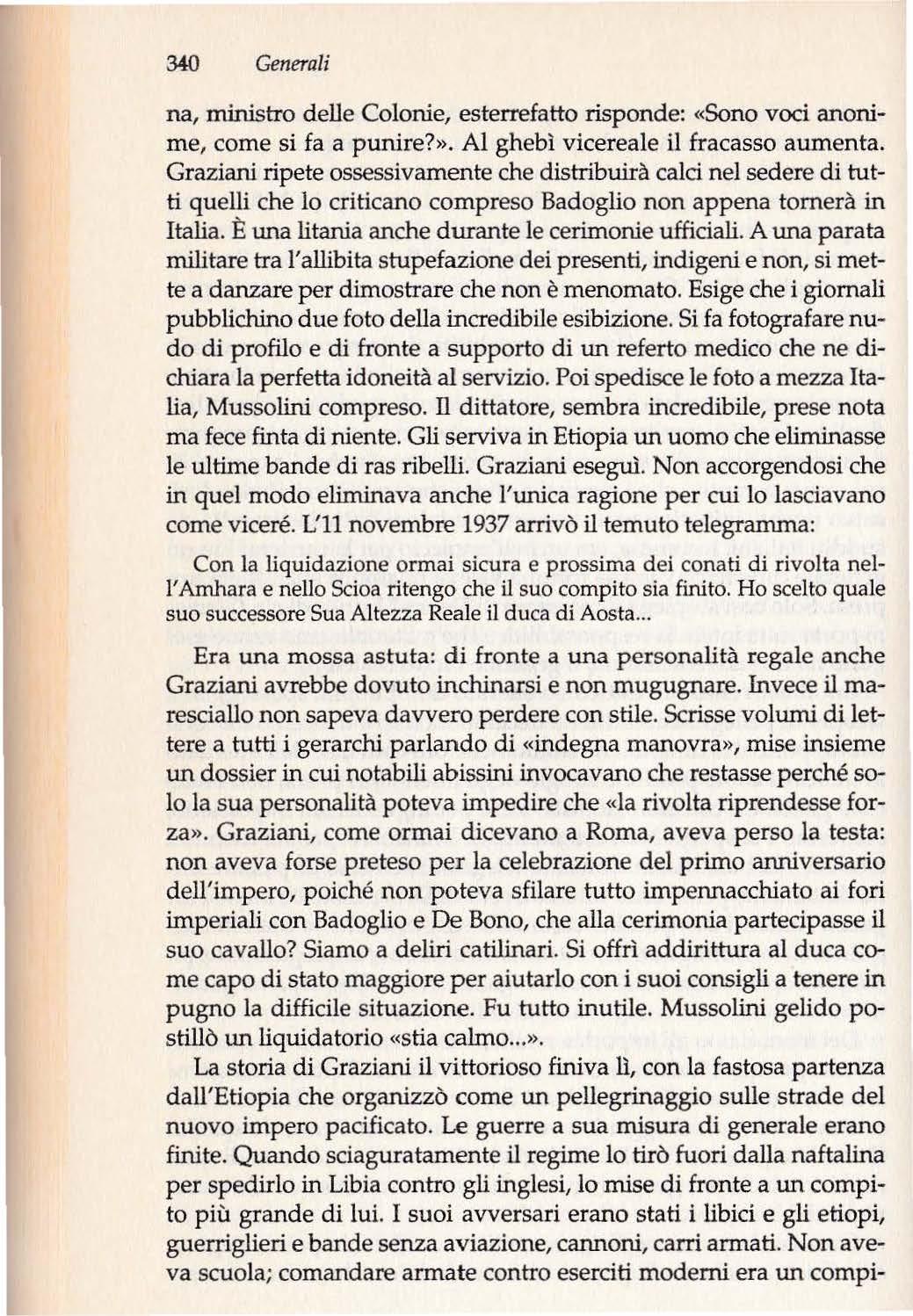
to che superava le sue capacità. Il comandante dell'armata del Nilo che fu il suo liquidatore, Sir Archlbald Wavell, un tipo inglese fino quasi a sembrare una caricatura, non lo conosceva. Altrimenti non lo avrebbe definito un pericoloso stratega in grado di inventare diavolerie sul campo di battaglia.
In quel dicembre 1941 era nervoso, inquieto; rimuginava sugli avvenimenti degli ultimi mesi e sempre più si convinceva che questa volta, per le solite note congiure, stava rischiando grosso. Se fosse stato superstizioso avrebbe, per esempio, cambiato posto di comando. Perché se ne stava sprofondato trenta metri sottoterra in una tomba dell'epoca tolemaica che il genio aveva ispessito con cemento armato fino a renderla resistente anche alle più grosse bombe di aereo allora disponibili? Il maresciallo scendeva direttamente nell'ingegnoso ma iettatorio bunker dal villino dove abitava nei momenti di tranquillità. I reperti che dovevano allietare il sonno del vecchio proprietario della tomba erano stati spostati con lodevole cura archeologica in un piccolo museo dove, naturalmente, campeggiava già il busto in bronzo del maresciallo. Lo potevi scambiare, se non fosse stato un po' troppo lucido, per uno di quegli antichi notabili romani che lì avevano trovato definitiva dimora. E pensare che Graziani per tutta la vita fu convinto di avere tra le sue qualità quella di ricevere misteriose premonizioni: quel fluido lo aveva sempre guidato sul campo di battaglia e mentre era in Italia gli aveva annunciato che Omar el Muktar era stato catturato ed era arrivato il momento, finalmente!, della feroce vendetta. Questa volta la premonizione non funzionò. Avrebbe dovuto spiegargli che stare a cinquecento chilometri dalle trincee di Sidi el Barrani dove i suoi soldati si affannavano con poco sugo contro gli inglesi non poteva certo giovare alla sua fama di condottiero. Infatti i rapporti riservati che giungevano sul tavolo del duce prima di trasformarsi in chiacchiere dei salotti romani esageravano e parlavano di un Graziani pauroso che non usciva mai dal bunker. Non era vero. Tra gli infiniti difetti dell'uomo anche dopo l'attentato-di Addis Abeba che ne sconvolse qua· si certamente l'equilibrio mentale, la paura non ci fu mai. Piuttosto, come aveva scritto nei suoi best seller sulle guerre nei deserti (e che altro mai aveva fatto in quegli anni se non guerre per conquistare deserti?), restare fermi con sterminate linee di rifornimento, privi di mezzi rapidi per spostarsi e battere sul tempo l' avversario, equivaleva al disastro. Questa volta gli avversari non erano gli appiedati etiopi ma un esercito che disponeva di carri armati, camion, aerei, autoblinde; un esercito che viaggiava a cinquanta chilometri l'ora ti-
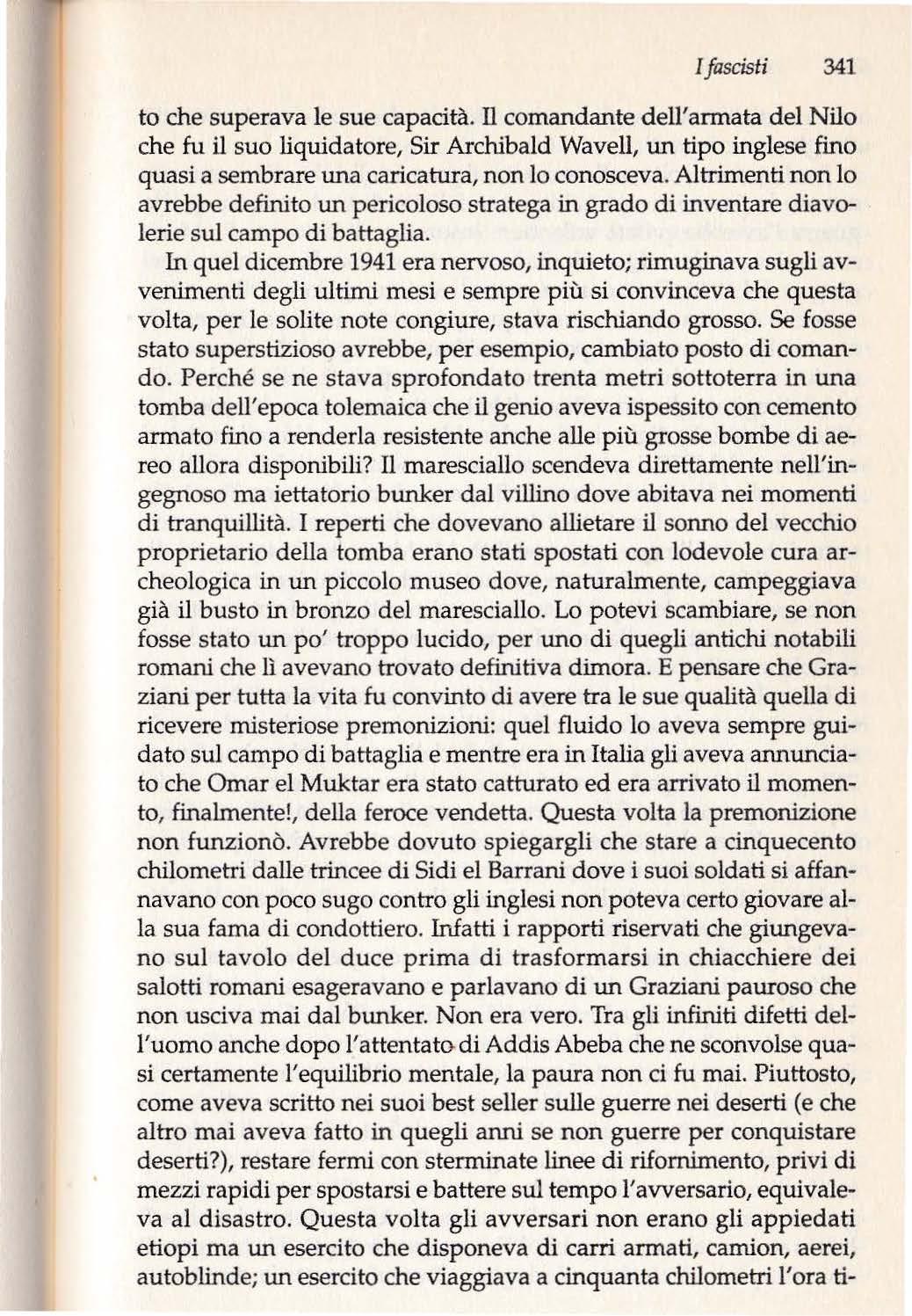
randosi dietro ciò che gli serviva e triturando con i cingoli tutto ciò che gli stava davanti.
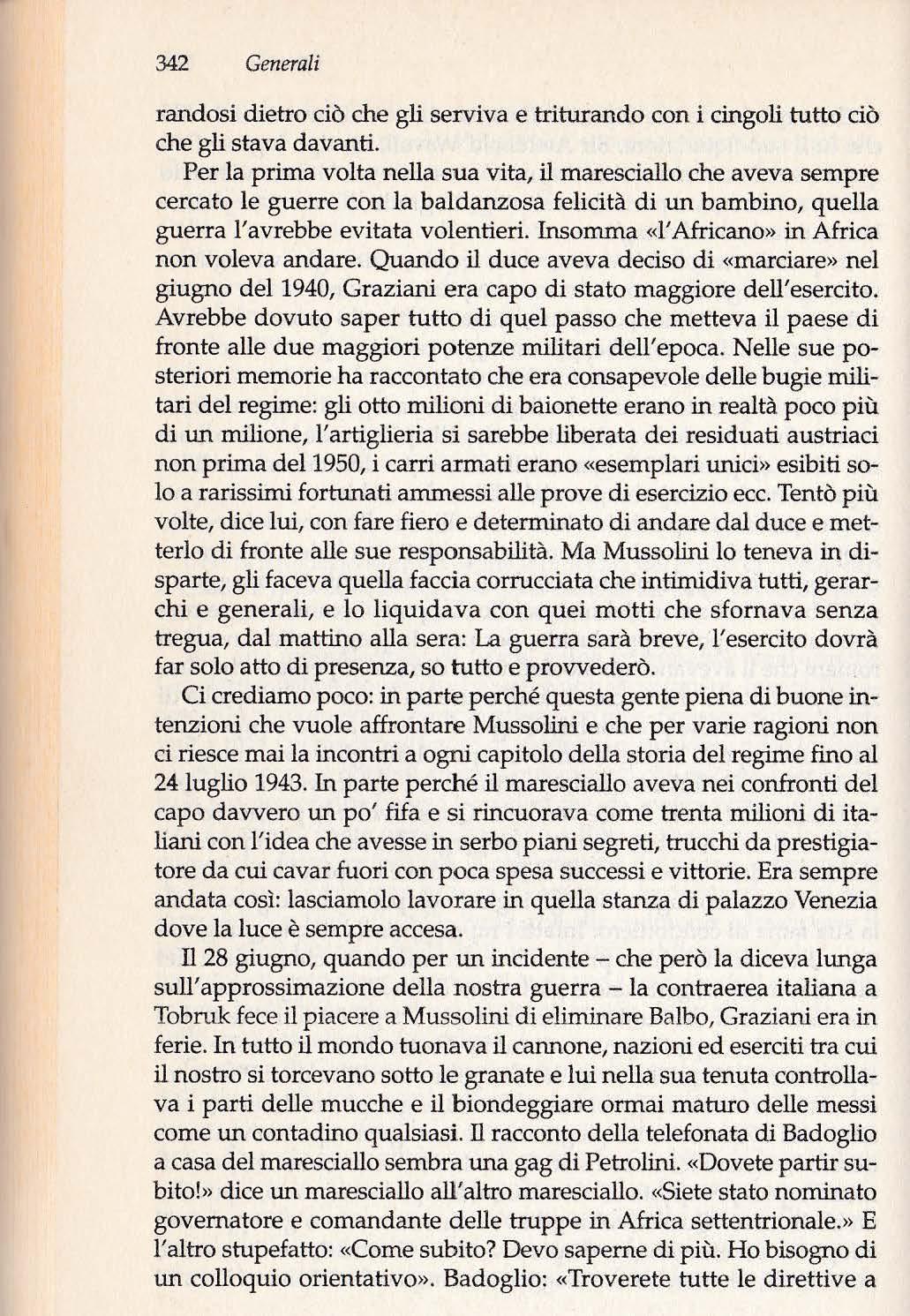
Per la prima volta nella sua vita, il maresciallo che aveva sempre cercato le guerre con la baldanzosa felicità di un bambino, quella guerra l'avrebbe evitata volentieri. Insomma «l'Africano» in Africa non voleva andare. Quando il duce aveva deciso di «marciare» n el giugno del 1940, Graziani era capo di stato maggiore dell'esercito. Avrebbe dovuto saper tutto di quel passo che metteva il paese di fronte alle due maggiori potenze militari dell'epoca. Nelle sue posteriori memorie ha raccontato che era consapevole delle bugie militari del regime: gli otto milioni di baionette erano in realtà poco più di un milione, l 'artiglieria si sarebbe liberata dei residuati austriaci non prima del 1950, i carri armati erano «esemplari unici» esibiti solo a rarissimi fortunati ammessi alle prove di esercizio ecc. Tentò più volte, dice lui, con fare fiero e determinato di andare dal duce e metterlo di fronte alle sue responsabilità. Ma Mussolini lo teneva in disparte, gli faceva quella faccia corrucciata che intimidiva tutti, gerarchi e generali, e lo liquidava con quei motti che sfornava senza tregua, dal mattino alla sera: La guerra sarà breve, l'eserci to dovrà far solo atto di presenza, so tutto e provvederò.
Ci crediamo poco: in parte perché questa gente piena di buone intenzioni che vuole affrontare Mussolini e che per varie ragioni non ci riesce mai la incontri a ogni capitolo della storia del regime fino al 24 luglio 1943. 1n parte perché il maresciallo aveva nei confronti del capo davvero un po' fifa e si rincuorava come trenta milioni di italiani con l'idea che avesse in serbo piani segreti, trucchi da prestigiatore da cui cavar fuori con poca spesa successi e vittorie. Era sempre andata così: lasciamolo lavorare in quella stanza di palazzo Venezia dove la luce è sempre accesa.
Il 28 giugno, quando per un incidente - che però la diceva lunga sull'approssimazione della nostra guerra - la contraerea italiana a Tobruk fece il piacere a Mussolini di eliminare Balbo, Graziani era in ferie. In tutto il mondo tuonava il cannone, naz ioni ed eserciti tra cui il nostro si torcevano sotto le granate e lui nella sua tenuta controllava i parti delle mucche e il biondeggiare ormai maturo delle messi come un contadino qualsiasi. Il racconto della telefonata di Badoglio a casa del maresciallo sembra una gag di Petrolini. «Dovete partir subito!» dice un maresciallo all'altro maresciallo. «Siete stato nominato governatore e comandante delle truppe in Africa settentrionale.» E l'altro stupefatto: «Come subito? Devo saperne di più. Ho bisogno di un colloquio orientativo». Badoglio: «Troverete tutte le direttive a
Tripoli, partite domarli ». Il capo di stato maggiore dell' esercito non sa nulla, sembra un impiegato spedito per una trasferta fastidiosa che cerca di guadagnar tempo . Graziani corre a Roma in auto, tagliando le curve. Ma Mussolini è in giro di ispezione. Allora si attacca al telefono. «Graziarli che volete?» gli chiede quello sull'infastidito (la Libia in quel momento è il n ostro fronte principale, ci lavorano due armate!). Lui si affanna, insiste con quello sciagurato conce tto del colloquio orientativo. L'altro risponde da duce: «Partite» con sette punti esclamativi. «Non ci sono aerei pronti, potrei aspettare un giorno.. .» azzarda b a lbe ttando il marescia llo che sembra uno scolaretto in cerca di giustificazione p er scansare l'esame . Infervorandos i, continua a parlare «fino a quando » racconta «mi accors i che dall 'altro capo d e l filo non c'era più nessuno. Mussolini, stando alle sue abitudini, a veva buttato gi ù la corne tta lasciando l'interlocutore a conversare nel vuoto come un imbecille»!
Le p e rplessità divennero m ontagne quando n ei famosi o rdini trovò la categorica imposizione di procedere a un a ttacco gen erale contro le forze ing lesi occupando parte d el terri torio egiziano. Veneriamolo, Graziani. Con s imili piani alla guerra poteva dedicare g li strapagli di tempo. Il resto era a ss orbito dalla d e tta tura dei telegrammi .assurti a lung h ezze prous tiane dove elencava a Badoglio e Mussolini tutte l e cose ch e n o n a n da vano, m e tteva le mani avanti per mostrare che neppure Annibale sarebbe riuscito a combattere così. Ci siamo immersi in questi Gu e rmantes della letteratura militare. L'impressione è ch e il generale fosse alle prese per la prima volta con una problema che s upe rava le sue p ossibilità e conoscenze. Lo dimostra il m eschino tentativo che fece ve rso metà agos to, quando l 'offensiva di o rdini del duce cominciava a farsi irresistibile. Mussolini affranto piega l a s ua prosa m etallica alle dolcezze riservate a uno scolaro teston e: «lo n on pretendo la conquista di Alessandria d 'Egitto che dista seicento chilometri dal confine, non vi ho mai impos to un obiettivo territoriale . Mi accontento che attacchiate».
A Tripoli si organizzò, come ai tempi di Baratieri, una sorta di consiglio di amministrazion e di generali; accorsero i mediocrissimi Ga riboldi e Berti che com a nda vano le cosiddette «grandi unità ». Grazia ni chi ese loro di so ttosc ri vere un pa rere m otivato sulla ric hies ta offensiva. Per uno ch e era impaziente di muover s i a briglia sciolta nelle plaghe soli ta rie d e l gerlio militare era una sorta di autoumiliaz ione! Spedì il tutto con una re la zion e sufficientemente catas trofica a Mussolini e una postilla in cui, con un tortu oso stile burocratico, m etteva «l a sua persona a completa disposizione delle

superiori autorità qualora ciò possa essere ritenuto utile» . Non erano furbescamente le dimissioni. Un generale italiano, si sa, si limita solo a minacciarle, ma non molla mai un incarico che potrebbe finire ad altri rivali! Servivano comunque per dire in caso di sconfitta che lui aveva avvertito Mussolini ma non gli avevano dato retta. E infatti non appena gli confermarono l'ordine dell'offensiva a tutti i costi l'eroe di Neghelli rispose con il classico «gli ordini saranno eseguiti». Arrivò cigolando, con la gola arsa e i serbatoi vuoti fino a Sidi el Barrani, desolato villaggetto nel deserto che gli inglesi avevano volontariamente sgomberato. Poi, compiendo una monumentale stupidaggine strategica, si trincerò, dedicandosi alla costruzione di strade e acquedotti, mentre gli inglesi trascorrevano il tempo loro concesso a mettere insieme un'armata spizzicando da tutte le parti dell'impero. Le striminzite possibilità che Graziani aveva di abbatterli quando erano in pratica privi di un esercito evaporarono, e la sconfitta, per gli insabbiati in que lla località esposta ai quattro venti del deserto, divenne certa. Si prese tutte le lodi esagerate per l'avanzata e fece finta di non sentire le critiche talora feroci che accompagnavano la sua successiva immobilità. Ormai gli inglesi li aveva dimenticati, non gli interessavano più. Aveva trovato il nemico aperto e dichiarato: Badoglio. Qualsiasi contrarietà l ' appiccicava alla diuturna attività della cricca di Roma che pareva impegnata ventiquattr ' ore su ventiquattro a nuocergli. Sembrava che la guerra in Africa l'avessero escogitata solo per sporcargli il pedigree di generale invitto. Perfino il fatto, abbastanza marginale, che il capo di stato maggiore del regio esercito gli desse sempre del voi, confermava che lo consideravano un parvenu, un estraneo alla crema dei vertici militari.
Ma l'episodio che scatenò la sua furia fu l'annuncio dell'attacco alla Grecia che lui apprese dalla radio come un italiano qualsiasi! Non era tanto lo sgarbo, pure enorme, quanto il fatto che, soprattutto dopo che la Grecia apparve assai poco disposta a farsi spezzare le reni senza farci dannare, l'Africa non era più il fronte principale . Declassavano un Graziani, e qu esto era insopportabile. Neppure le dimissioni del nemico Badoglio travolto dallo scandalo ellenico furono sufficienti a fargli tornare il buon umore. Con brontolii e segnali sempre più sinistri si annunciava la risposta inglese . Sbagliò tutto: non si preparò a manovrare, puntava sulla grinta dei suoi coloniali come Maletti, il fucilatore di Debra, che fu spazzato via con i libici in pochi minuti. Non aveva capito che ormai bastavano pochi carri usati come avevano fatto i tedeschi in Francia per scardinare qual-

siasi linea difensiva affidata alle prodi fanterie . Anche dopo il primo urto si poteva ancora riparare, concedendo spazio per guadagnare tempo. Wave ll non e ra Rommel, andava avanti lentamente e aveva paura, sembra incredibile, di Graziani. Invece il maresciallo, come s i dice, crollò. S pedì a llo s tato m aggio re un te legr a mma forse uni co nella storia militare di tutti i tempi : «Minaccia ravvo lgimento intero fronte cirenaico è palese ... » e dopo questa mazzata da lasciar intontiti proseguiva annunciando di volers i ritirare di centotrenta chilometri, a Tripoli : Riterrei mio d overe anziché sacrificare la mia persona su l p osto, portarmi a Tripoli se mi riuscirà, per mantenere alto almeno su quel castello vessillo d'Italia, a ttendendo che madrepatria mi metta in condizione di operare. Da me fino all' ultimo soldato abbiamo coscienza di aver fatto ogni sforzo pe r resistere dopo que lli compiuti per far comprendere a Ro ma qua.li fossero reali condiz ioni di questo teatro d i operazioni e mezzi necessari per poterle fronteggiare senza mettere l'u omo col fucil e e con scarsissimi mezzi anticar· ro in condizione di sosten ere la lotta della pulce contro l'elefante. Sia detto a mia m e m oria testamentaria.
Se il fascismo fosse stato un regim e serio Graziani sarebbe s tato immediatamente d estituito e fucil ato. Anche perché il te legramma non era s tato distrutto a bbas tanza rapidamente d a impedire ch e si d iffo ndesse tra tutti quelli che contavano, scatenando la rabbia e il panico. Alcuni esagi tati negli ambie nti del partito, che e bbe n e ll'occasione l' ultimo ra nto lo di attività, m e ditarono p er vende tta di darg li una lezion e radendogli al suolo l'am atissima tenuta di Arcinazzo. Invece s talle e casa li restarono in piedi . Pazientemente Mussolini non solo n on died e il via libera a così sudam ericane ve nde tte ma lo lasciò al comando, sperando che sapesse risollevarsi. Annotò solo con r a bbiosa ironia ch e l ' u o m o che parlava di lotta della pulce contro l' e lefan te aveva a disposizione un mig liaio di canno ni per ferm are il n emico e n o n e rano certo tutti r esidua ti b e llici. Fu un erro-r e : Graziani era militarme nte defunto. G uarda va immobile i solda ti inglesi c h e mi e t eva n o «cinque ac ri d i ufficiali e duecento ac ri di trup pe».
Non e r a più un gen e r ale, e r a un filosofo stoico, un compilatore di bollettini sulle miserie d e lla ritirata. Aveva guizzi polemici soltanto per incredibili m essaggi a l duce in c ui triturava tutta la s u a politica, r equis itorie ch e m e ttevano i briv idi ai gera rchi n on a ncora a bituati n e ppure a ll ' idea che Lui potesse essere criticato. Ci buttava d e ntro, con quello stile pomposo da m e lodra mma, rec rimin azioni personali e s t occa te politico-militari:

Non nù avete ascoltato. Non mi avete concesso di parlarvi direttamente. Avete continuato ad ascoltare chi o vi ingannava deliberatamente o vi illudeva ... Tutto conosco, fatti e nomi ... Ora duce non c'è più che un arbitro, il destino, alle cui forze superiori non posso opporre quelle mie umane. Sconto un passivo creato non da mia cecità o volontà ma da quelli che vi hanno tradito miseramente e con voi l'Italia.
Insomma sembrava che Graziani per vent'anni non avesse fatto altro che il mestiere dell'oracolo e della Cassandra, e non l'incensatore.
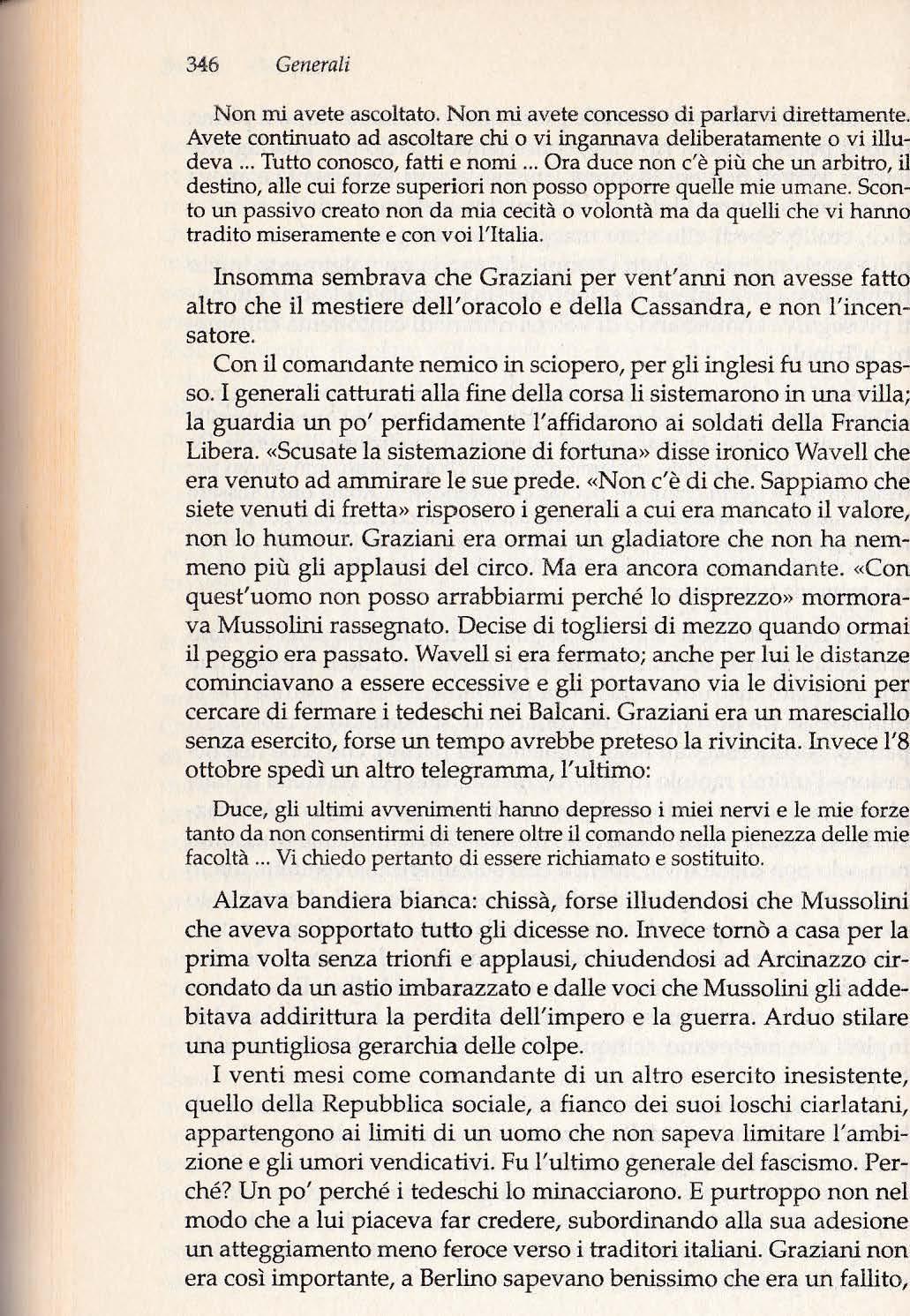
Con il comandante nemico in sciopero, per gli inglesi fu uno spasso. I generali catturati alla fine della corsa li sistemarono in una villa; la guardia un po' perfidamente l'affidarono ai soldati della Francia Libera. «Scusate la sistemazione di fortuna» disse ironico Wavell che era venuto ad ammirare le sue prede . «Non c'è di che. Sappiamo che siete venuti di fretta» risposero i generali a cui era mancato il valore, non lo humour. Graziani era ormai un gladiatore che non ha nemmeno più gli applausi del circo. Ma era ancora comandante. «Con quest'uomo non posso arrabbiarmi perché lo disprezzo» mormorava Mussolini rassegnato. Decise di togliersi di mezzo quando ormai il peggio era passato. Wavell si era fermato; anche per lui le distanze cominciavano a essere eccessive e gli portavano via le divisioni per cercare di fermare i tedeschi nei Balcani. Graziani era un maresciallo senza esercito, forse un tempo avrebbe preteso la rivincita. Invece 1'8 ottobre spedì un altro telegramma, l'ultimo:
Duce, gli ultimi avvenimenti hanno depresso i miei nervi e le mie forze tanto da non consentirmi di tenere oltre il comando nella pienezza delle mie facoltà ... Vi chiedo pertanto di essere richiamato e sostituito.
Alzava bandiera bianca: chissà, forse illudendosi che Mussolini che aveva sopportato tutto gli dicesse no. Invece tornò a casa per la prima volta senza trionfi e applausi, chiudendosi ad Arcinazzo circondato da un astio imbarazzato e dalle voci che Mussolini gli addebitava addirittura la perdita dell'impero e la guerra. Arduo stilare una puntigliosa gerarchia delle colpe.
I venti mesi come comandante di un altro esercito inesistente, quello della Repubblica sociale, a fianco dei suoi loschi ciarlatani, appartengono ai limiti di un uomo che non sapeva limitare l'ambizione e gli umori vendicativi. Fu l'ultimo generale del fascismo. Perché? Un po' perché i tedeschi lo minacciarono. E purtroppo non nel modo che a lui piaceva far credere, subordinando alla sua adesione un atteggiamento meno feroce verso i traditori italiani. Graziani non era così importante, a Berlino sapevano benissimo che era un fallito,
un s o ldato tag liato su mis ura p er una guerra perduta. L'ottuso maresciallo era convinto che lo avessero tirato fuori da Arcinazzo perché serviva loro un grande generale. Illuso! Ne avevano a bizzeffe e i tedeschi di lui n on sapevano che farsene. Serviva loro piuttosto un massacratore, un uomo specializza to n ella rancida e sanguinosa o rganizzazione della repressione. Graziatù aveva fatto benissimo con libici e d etiopi, perché non provarlo con i fastidiosi partig iaru ? Lui continu ò a pensare che invece, un giorno, lo avrebbero messo a capo di armate modernissime, quelle che n on aveva mai avuto, per prendersi la rivincita sull 'odia to Badoglio. Che infatti aveva scelto l 'al tra parte, quella vincente. Se non fu fucilato d eve dir grazie a Mussolini: il duce, ch e lo sopportava, r assegnato ad ave re ormai a l fian co g li scarti del r egime, una pattuglia di falliti ch e cianciavano di bella morte e di d ottrine socialisteggianti, affidò la repressione all 'esercito privato cli Pavolini. Così quando lo processarono, dopo settantanove udienze fu condannato «solo» p e r «collabo r azionismo» a diciannove anni. Lo vedete sepol to dalla vergogna in una galera? Niente affatto. I miracoli del diritto i taliano con sconti e amnis tie lo fecero uscire s ubito dal car cere. Tentò anche un' ultima avve ntura politica com e senato r e del Movimento soci a le. In un' Italia ancora marchiata dalle ferite e dai ricordi sembrò ai dirigenti d e l partito una buona bandiera da sventola re. Commisero l'errore di tanti che li avevano p receduti: pensare che G raziatù potesse avere una qualsiasi idea politica che n o n fosse la celebraz ion e di se stesso o la vendetta p er i to rti s ubiti. Un giorno che l'ex maresciallo andava a spasso per i casi s uoi ad Arcinazzo incrociò un com izio d e lla Democrazia c ri s tiana con Andreotti e un altro dirigente che e r a s ta to con lui in Africa. Chiese la parola e tessé un e logio di De Gasperi che stava «rimettendo in piedi la nazione e l'esercito». Della presunta stretta di mano con Andreotti nulla si sa di sicuro ed entra in quella serie di misteriose affettuosità ch e hanno punteggiato la lunghissima carrie ra del leader democristiano creandogli molti guai. È certa invece la rabbia del p ar tito che chiese spiegazioni. Lui s i dimise da d eputa to e presid ente onorario. Morì p oco dopo. Senza tessere. Per la m em o ria n on esis te prescrizione, e allora vale la p en a sbarazzarsi, dopo i generali, anche di quel!'esercito cli camicie nere in cui il duce, prima di venir disarcionato d ai propri errori, aveva ripos to tante speranze. Con le sue mattie cli futurismo militare le mescolò con abbondanza come carne d a cannone per inve lenire tutte le sue g u erre d a l! ' Abissinia alla Spagna. Qualche reparto si segnalò per ardore, la m aggio ranza erano svogliati e privi di a utorevole co-
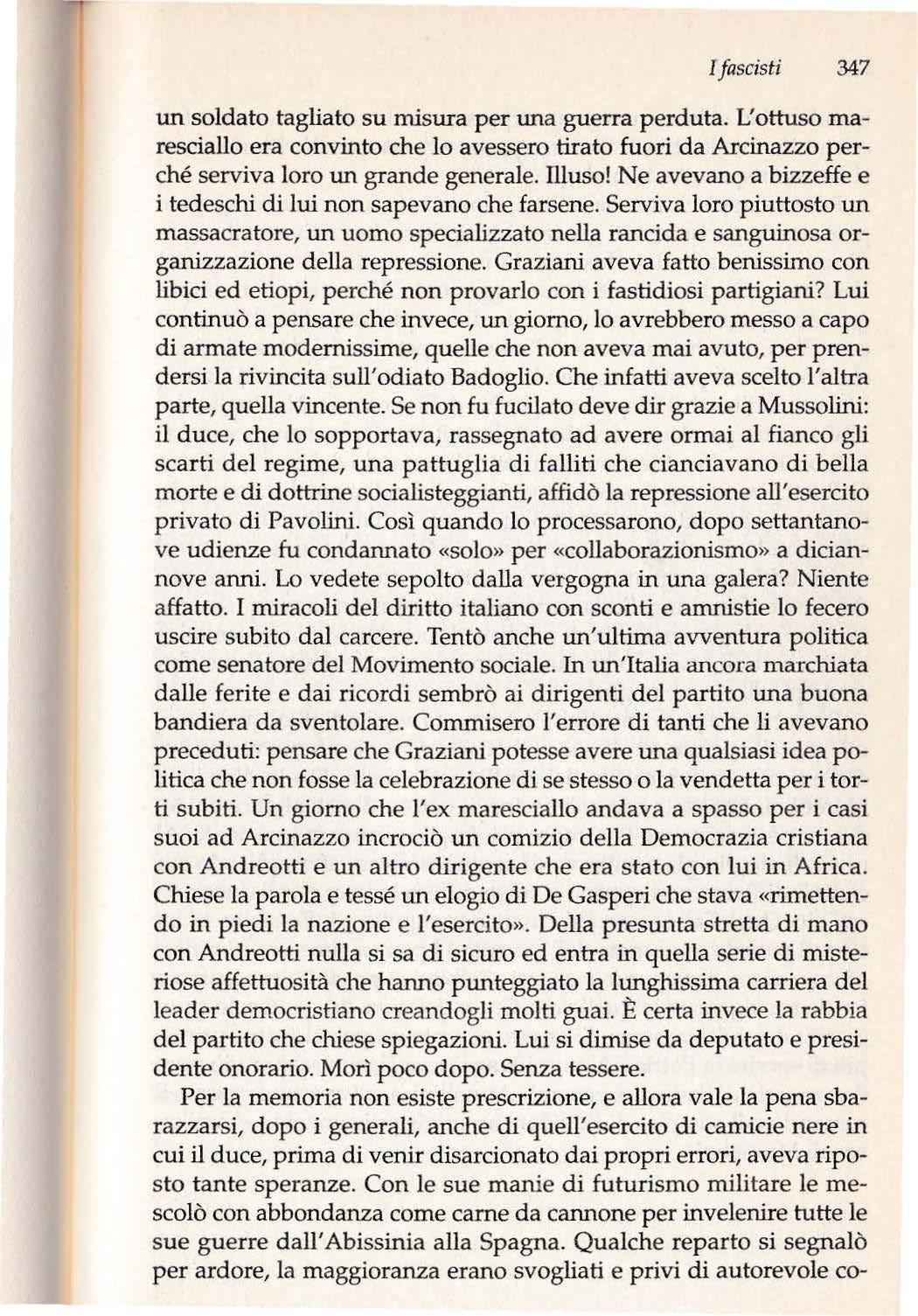
mando. Non si lasciarono mai sorpassare nelle ritirate nonostante i comunicati nello stile di Plutarco parlassero sempre di vittorie e non si facesse risparmio di medaglie.
Restava appiccicata alla milizia, nonostante fosse una compagine percorsa da pochi fremiti guerreschi, l'ipotesi che coltivasse il sogno di una seconda ondata fascista: fu una specie di ultima Thule del Ventennio. Si chiacchierò di un reggimento di camicie nere impegnate in Spagna che avrebbe giurato di fare piazza pulita al ritorno a casa. Voci, ma che suscitarono l'interesse perfino del duca di Aosta che a soffiare il posto al cugino Umberto ci pensò eccome. Al ritorno i focosi catilinari si dispersero per bordelli e osterie. Nel luglio del 1943 comunque alcune divisioni della milizia si trovavano accampate fuori Roma in addestramento sotto il comando del generale Enzo Galbiati. Faccia angolosa da faina, fama di fondamentalista mussoliniano, un comando guadagnato, si diceva, gettando bombe a mano e lavorando di coltello sui monti fatali di Grecia, toglieva il sonno ai cospiratori sparpagliati tra reggia , salotti e comando supremo più del feroce Kesselring. Sulla carta quel Saint-Just in camicia nera comandava alcune centinaia di migliaia di uomini. Ma la matematica bellica sotto il fascismo era una scienza molto nebbiosa. Forse non erano più di alcune migliaia.
Preoccupava però una divisione rimasta negli artigli di quel generale che alle parate con le sue occhiatacce feroci confermava che l'odio è il più comunicativo dei sentimenti umani. Era la divisione Mussolini, corazzata con una decina di panzer donati al duce dai tedeschi per garantirne la sempre più fragile sicurezza personale. Al re e a Badoglio già sembrava di sentirli arrivare sferragliando sui ciottoli di Roma non appena si fosse diffusa la voce che il duce non era più. Quel Galbiati era un fanatico tranquillo e inflessibile, in lui c'era il passato a garanzia dell'avvenire! I panzer rimasero in rimessa, non accesero neppure i motori. Galbiati si precipitò per primo a far da protagonista in quello che Croce definiva «lo spettacolo ripugnante dei voltacasacca». Si arrese, pensate un po', al «sacro principio di servire la Patria». Non coltivava rancori, anzi, abbracciò pure il segretario di Badoglio, generale Armellini, a cui avevano passato il comando e il compito di liquidare amministrativamente i «kamikaze» di Mussolini .

Il 15 ottobre 1940, centovettisettesimo giorno di guerra per l'Italia ancora per pochi anni fascista, a Roma fu una giornata fresca, punteggiata da brevi e frequenti scrosci di pioggia. Chi aveva ascoltato il bollettino delle ore tredici non aveva maturato il sospetto che dovesse succedere qualcosa di straordinario. I fronti militari sembrano ispirarsi a quella che la gente chiama la guerra «mollacchiona». In Africa dove abbiamo conquistato con grande furore di campane e di trombe un posto sconosciuto che si chiama Marsa Matruch c' è il solito movimento di pattuglie in cui naturalmente i nostri prevalgono sugli inglesi. Il bollettino ha mantenuto un silenzio di acciaio sul ben più vivace scontro telegrafico tra il duce e sua eccellenza Graziani «l'Africano» che non sente ragioni e non vuole procedere verso gli immancabili destini, in attesa con i piedi a mollo sulle rive del Nilo. Secondo lui sono ancora troppo lontani. Anche dagli alleati tedeschi poche novità: rovesciano le solite quantità record di bombe sull'Inghilterra e qualche pericoloso pessimista comincia a chiedersi, naturalmente sottovoce, come questa possa resistere sepolta sotto quella quantità di tritolo. La guerra impastata con la fame, i bombardamenti, le stragi quotidiane per la maggior parte degli italiani arrivava come un attenuato scrosciare di risacca; come in quelle tragedie ben costruire dove l'autore per i primi atti gira intorno ai personaggi, crea l' atmosfera mentre l'araldo che deve portare le notizie terribili che faranno precipitare gli eventi sta ancora dietro le quinte a prepararsi e a ripassare la parte. Politicamente viaggiamo con il vento in poppa, quanto basta perché il notiziario resti sulla stagionata notizia: il vertice al Brennero di undici giorni prima tra Hitler e Mussolini, tre ore in cui sono state

disegnate le future linee dell'Europa e del mondo poiché il patto dal buffo nome di Ro-Ber-To (Roma-Berlino-Tokyo) smarrendo quel famoso buon senso, ha sgarbati progetti anche sull' Asia e gli altri continenti. Ci sono le prove che tutto va per il meglio e, come ha previs to la mente del duce, la guerra è una finta di breve d ura ta: abbiamo apperia smobilitato seicentomila soldati rimandando a casa tre classi, una vicenda che non ha eguali nella storia delle guerre né antiche né moderne.
Il bollettino, subendo un'ultima metamorfosi nell'ufficio censura, non ha raccontato che Mussolini è tornato dal Brennero immusonito, ripetendo ai suoi che i «tedeschi dopo aver occupato un paese gli mandano un telegramma». Hitler, come d'abitudine nel suo lussurioso messianismo, ha parlato quasi sempre lui, e il duce, che non osa confessare di capire male il tedesco strascicato dell' ex imbianchino austriaco, ha colto solo una parola qua e là. Nell'assordante mitragliata retorica tornava spesso la Romania, dove re Caro] ha abdicato e al potere è salito un p iccolo Mussolini balcanico, il maresciallo Antonescu. Il fondatore del fascismo ha tratto, chissà perché, la conclusione che il signore della guerra di Berlino vuole metter le mani su quel paese danubiano stracciato e con gli zoccoli ai piedi. Inutile per qualsiasi operazione salvo che per i pozzi petroliferi che alimentano i serbatoi dell'attività bellica tedesca. Questa volta il duce ha deciso che non lascerà i tedes chi senza risposta e piazzerà un fragoroso colpo di quella che secondo i suoi ordini doveva essere una guerra «parallela»: una vittoria a te e un'altra a me fino a q uando il carciofo del conflitto non sarà completamente sfogliato.
Questi son o gli antefatti quando, quel famoso mattino, un corteo di auto con le sigle dello stato maggiore entra a palazzo Venezia facendo scattare il saluto dei moschettieri del duce. Nella sala delle riunioni plenarie consacrata alla toponomastica eroica del regime, sei personaggi prendono posto attorno a l lungo tavolo dominato dallo sguardo accigliato di Mus solini . Raccontarono i protagonisti che Lui era nervosissimo, si rivolgeva ai generali con un tono brusco quasi scortese. Era l'atmosfera da «decisioni irrevocabili», fiutarono subito quei consumati cortigiani . Si viene cioè a prendere gli ordini, persino i garbati avvertimenti sono vietati. Bisogna prepararsi: il capo dispone di loro a suo arbitrio, li dirige, li rabbuffa e li atterrisce. È successo centinaia di volte nel ventennio . Gli sguardi si fecero acquosi. Quegli uomini in uniforme erano dispostissimi a adeguarsi. Come sempre. Attorno al tavolo c' erano oltre al ministro degli Esteri e genero

del duce Galeazzo Ciano e il suo proconsole in Albania, Francesco Jacomoni, astuto, sornione, subdolo, erbaccia che verdeggia sotto tutti i regimi, quattro generali, Pietro Badoglio, Mario Roatta, Sebastiano Visconti Prasca e Ubaldo Soddu, strizzati nelle loro uniformi appesantite da greche e medaglie. Guardiamoli, questi figli prediletti di Marte. Viene in mente la frase acida del re che riferendosi a Badoglio e ai suoi vassalli aveva detto: «Pensare che è con queste facce di curati e di notai che Mussolini sogna di fare la guerra ... ». Peccato che il re questi giudizi così efficaci se li tenesse per il suo diario! Proprio una guerra, una bella piccola guerra vuol decidere quel mattino Mussolini con i suoi massimi condottieri. O meglio, più che decidere c ' era soltanto da certificare secondo il sistema italiano e ducesco per cui una cosa determinata sulla carta era già fatta: bastava a ttendere che la realtà naturalmente più lenta del pensiero dell ' Infallibile cigolando si adeguasse. Non aveva forse gridato con il titolo del primo fondo del suo giornale: Audacia? Raramente personaggi così funesti per il paese, che per d eprecabili circostanze era costretto a servirsi delle loro coloss ali incapacità, sono stati riuniti dalla Storia. Erano dei complici in un delitto ma si odiavano. Roatta definiva Visconti Prasca ùn «imbecille». E questi replicava dandogli del «mentitore abituale». Soddu diceva di Visconti Prasca che era un «esaltato». L'altro gli dava dell'«ambizioso» e aggiungeva per buon peso al ludibrio anche il figlio dicendo che «il padre lo inviava a far tappezzeria in tutte le campagne di guerra coloniali per riportare a casa numerose ricompense al valore. C'erano a ruolo nel 1939 la bellezza di s eicento generali, uno ogni trentacinque ufficiali tanto che come racconta uno di loro, Giacomo Zanussi, l ' annuario con i nomi prestigiosi veniva tenuto segreto. Non si volevano dare al nemico punti di riferimento? No. Semplicemente si aveva vergogna a metterlo in piazza «a causa del ridicolo che tanta abbondanza di nomi tra tanta pochezz a di uomini non avrebbe mancato di suscitare». L'abitudine di insultarsi a vicenda era peraltro diffusa visto che il capo di stato maggiore d e ll'esercito, Graziani, definiva il suo superiore Badoglio «traditore e versipelle» e questo replicava dandogli del «mediocre» e d el «codardo ». Con Soddu ce l ' avevano in parecchi forse per una carriera che aveva mosso pochi e incerti passi sui campi di battag lia ma a veva consumato i tappeti dei ministeri. Zanussi lo inchiodav a all'ete rnità niente meno che con cinque impegnativi aggettivi: «as tuto ambizioso demagogo intrigante arrivista». Il solito Graziani si accontentava di un «musicomane insignificante» (scriveva infatti nel tempo libero colonne sonore per film) Il musicomane
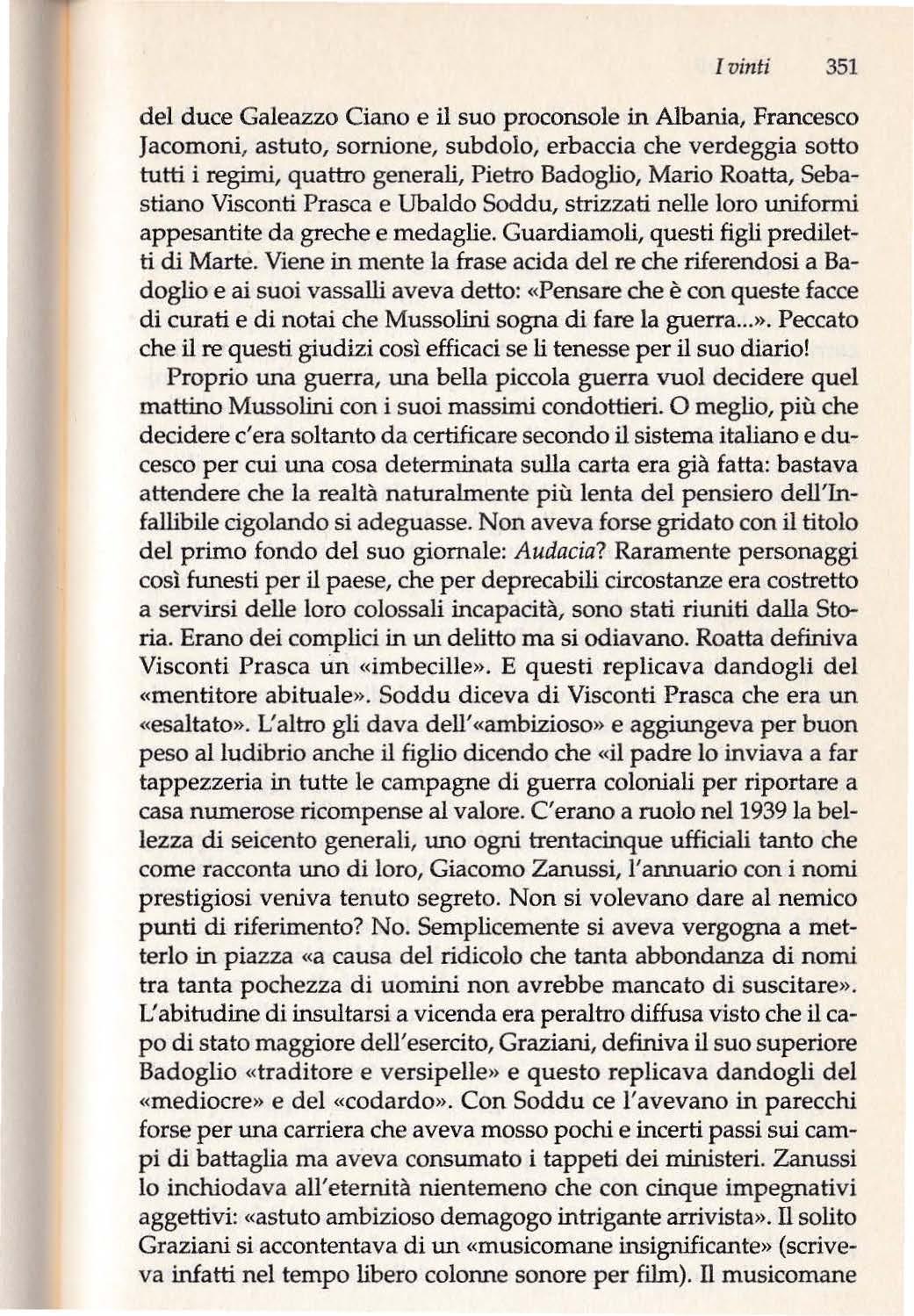
replicava per le rime: «imbelle» all'uno, «avanzo delle patrie galere» all'altro. Con la stessa determinazione e fantasia applicata ai campi di battaglia saremmo arrivati a Londra e ad Atene in un b a ttiba le no! La guerra l'avevano prepa rata tre tipi ameni di ques ta galleria d el ridicolo militare. Alfredo Pariani, milanese, apparteneva a que l modello di generale che aveva la guerra allegra: sempre sorridente, bonario, ottimista. Aveva buone ragioni. La guerra vera l'aveva conosciuta p er tre mesi nel 1915 comandando un reparto d i a lpini. Poi la carriera l'aveva portato a m a rciare n el tepore d ello stato maggiore d ove era più facile scavalcare i gradi p er meriti eccezionali ma misteriosi. Dal 1936 al 1939 ne fu il capo; vis to che il ministro delle Forze armate era Mussolini, che il regime costringeva ai lavori forzati perpetui, a lui toccò il ruolo di tecnico della preparaz ione militare dell'Italia al grande e inevitabile cimento. Pietro Gazzera, cuneese, la voce del buon senso e d e lla logica, ultimo soldato d e lla vecchia Italia, l'avevano fa tto fuori con quattro righe: «A ttendo le s u e dimiss ioni da ministro d ella G u erra». Lui aveva risposto: «Sono un sold ato e mi onoro d i obbedire». Sublime! Ebbene, il simpatico Pari ani si gettò s ulla riorganizzazione dell ' esercito, che certo era un'arma un po ' arrugginita ma aveva quantomeno una solida organizzazione, come un bambino che ha avuto il consenso di smontare un grande giocattolo e di rimontarlo a suo piacere. Sembrava impazzito, indannunziana to: le idee più strampalate, le riforme più r adicali gli parvero gustosissime, passò con un furore iconoclasta su reggimenti e divisioni che portavano nomi secolari, ricombinò, ribattezzò come un alchimista ch e h a smarrito volontaria m ente la formula dei propri intrug li e avanza a tentoni combinando gli ele menti a caso. Volgeva l 'esercito in una grande sagra paesana. Con il decreto numero 2095 del 22 dicembre 1938 compì la più straordinaria operazione di prestigiatore della storia militare: riuscì cioè a raddoppiare, senza spendere un sold o e senza arruolare un soldato in più, l'esercito italiano. La trovata, che incantò Mu ssolini, non a caso un giornalista cresci uto n el culto dell' improvvisazione, consisteva n el ridurre da tre a due i reggimenti di una divisione. Con una firma sotto un pezzo di carta magica mente l' Ita lia si ritrovò n egli annuari con cinquantuno divisioni di fante ria, venti in più di quelle precedenti assurgendo almen o numericamente a mass ima potenza mondiale. Che fantasia! Che bonaria intransigenza ! Che misero e g lorioso sotter fugio! Vi indignate? Lo scetticism o è un vizio da mediocri, l' arma dei fiacchi e d eg li inetti. Non c'era in fo ndo niente di m ale, è una piccola cabala di caserma: il capo del governo e ministro della Gu e rra non procla ma-
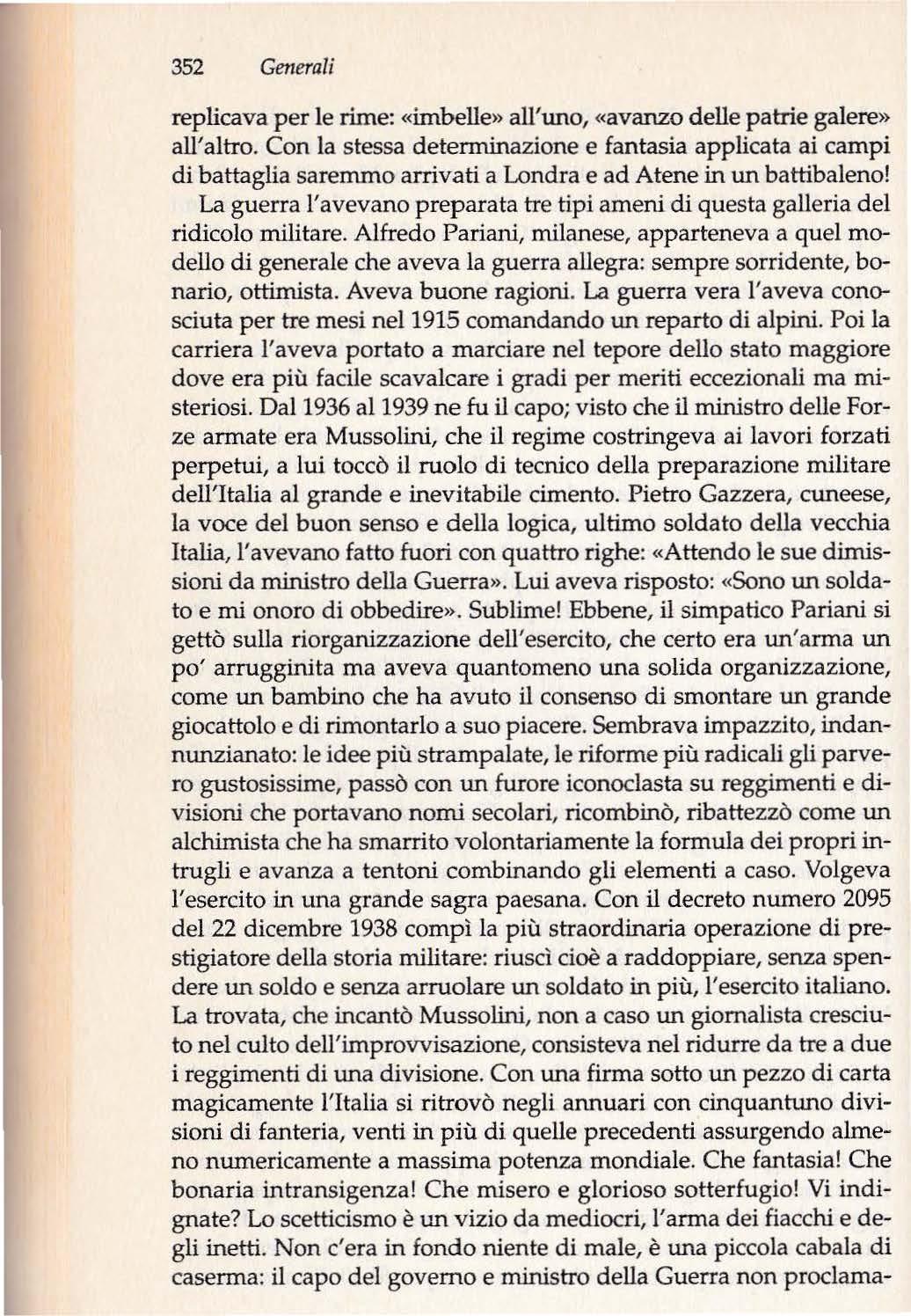
va forse in ogni discorso che disponevamo di otto milioni di baionette quando a mala pena arrivavamo a un milione? Pariani, bel talento di cortigiano, applicava alla lettera il principio mussoliniano secondo cui il numero è potenza. Lui era il suo Giovanni Battista. Che poi alla prova d ei fatti quelle divisioni così magroline risultassero, contrapposte a quelle del nemico, indebolite e inefficienti era un particolare secondario. Pariani si era cautelato, non si sa mai, spiegando al duce che per dare ordine a quella colossale trasformazione ci volevano almeno dieci anni. Le nuove divisioni bisognava addestrarle e soprattutto dar loro più armi e cannoni per bilanciare il numero ridotto. Nessuna paura, avrebbe risposto il duce secondo la versione che fornisce il generale: prima del 1943 non saremmo scesi in campo e c'erano fondi straordinari per riempire i magazzini ancora vuoti dopo le guerre di Etiopia e di Spagna. La nostra troppo celebrata genialità e la potenza taumaturgica dei nostri nervi da improvvisatori aveva messo tutto a posto .
Le spore di questo imbroglio matematico non infastidivano un'altra folta schiera di plaudenti: tutti quelli, ed erano migliaia, che da quella bufera traevano vantaggi. Se si moltiplicavano le divisioni e le armate, crescevano anche i posti da generali, colonnelli, maggiori, capitani e il ruolo delle carriere cominciava a procedere a una velocità che nemmeno la divis ione alleggerita di Pariani avrebbe potuto imitare. Un esercito intero si aggiunse i gradi, procedette all'autopromozione. Così che entrammo in guerra con una classe di ufficiali il cui livello medio era drasticamente calato. Per le necessità di organico, parola chiave nella storia d'Italia, si era proceduto a scatti ingiustificati, affidando incarichi complessi a uomini impre parati. È davvero un tipo ameno il buon Pariani, ha la fede leggera di un novello argonauta : nel suo piano e negli interventi con cui lo illustra al Senato, naturalmente tra gli applausi di quella non certo scorbutica assemblea, spreca una parola che gli piace, «alleggerimento ». Vuole soldati che marcino svelti come impone il pensiero fascista. Tutto quell'apparato che si portava dietro la vecchia divisione gli sembra un impaccio. Il suo modello è la guerra di Etiopia dove però anche l'avversario andava a piedi, anzi era senza scarpe, e quanto a potenza non disponeva di artiglieria, di carri e tantomeno di aviazione. Gli automezzi per portare a spasso quei soldati e rifornirli non ci sono. Pazienza, argomenta il generale, «tanto le prossime guerre, grazie alla sapienza politica del duce, si svolgeranno in colonia con avversari altrettanto alleggeriti». La sua bestia nera erano i carri armati: proprio non poteva digerirli quegli sgraziati mezzi

meccanici che appesantivano le sue belle manovre. Chissà, forse li trovava poco estetici!
E pensare che quando convocò nel 1937 una riunione di colleghi per parlare di questo non secondario argomento, tutti gli eserciti europei, con tedeschi e russi in testa, si dannavano a costituire divisioni corazzate. Certo gli osservatori spediti alle manovre degli altri, amici e nemici, dovevano aver riferito di questa barbara e incomprensibile tendenza. Pariani in persona aveva assistito anche alle manovre tedesche del '35 e aveva visto ali'opera le divisioni di Heinz Guderian. Al tavolo della riunione sedeva un testimone diretto, che poteva raccontare quanti guai potessero combinare quelle scatole di ferro adesso che si muovevano assai più rapidamente e agilmente che nella prima guerra mondiale. Ettore Bastico era appena tornato dalla vittoria di Spagna. Ce li aveva negli occhi i mastodonti russi che avevano messo una gran paura ai suoi legionari. «I nostri piccoli ridicoli carri "veloci"» raccontò «si fermavano davanti a un torrentello, erano lenti, vulnerabili, non avevano autonomia, erano un tormento per chi li guidava... insomma non facevano paura a nessuno.»

Non facevano paura neppure a Pariani, che liquida con un'alzata di spalle tutte le teorie moderne mettendo in un mazzo Basi! Liddell Hart, Guderian e De Gaulle. Lui ha la inveterata tendenza a giudicare gli altri a seconda della misura in cui riescono ad assomigliare a noi. Il carro va bene per azioni di rottura su esigui tratti di fronte, sentenzia, e quindi sono inutili le formazioni corazzate dotate di cannoni e trasporti truppe. Meno male, perché non disponiamo di nulla di tutto questo. La fanteria, proclama il novello Napoleone nostrano, deve co mbattere a piedi e i carri devono essere impiegati (gustoso ossimoro) a «piccole masse». Che l'aviazione possa dare una mano, trasformando l'attacco dei carri in una meccanica cavalcata delle valchirie, non gli passa neppure per la testa. Per la sua guerra va benissimo il carro «veloce», che è stato ideato per la montagna!, e quindi boccia gli studi per un nuovo mezzo più potente. Siamo finiti in mano di uno che non crede nel progresso, tira il freno di allarme quando si delineano novità. Gli è sgradevole perfino l'idea del cannone posto su una torretta girevole. Grazie ai suoi fantasiosi menu strategici entrammo in guerra senza carri armati; impiegammo tre anni, inutilmente, per correre ai ripari e costruire un mezzo in grado di non far sorridere gli avversari e non trasformare l'equipaggio in una versione italiana dei kamikaze.
Uno che invece di corazze pensava di intendersene era il corrispettivo di Pariani per la marina, l'ammiraglio Domenico
che come sottosegretario e capo di stato maggiore dal 1933 al dicembre del 1940 portò la flotta a schiantarsi come un pezzo di pane. Spigolando tra gli opuscoli a comporre un florilegio dj svarioni dell'ex caporale autoproclamatosi primo maresciallo dell'impero si rischia di perdere il sonno. Tra le tante bestialità militari attribuite a Mussolini c'è l'affermazione secondo cui l'Italia non aveva bisogno di portaerei: il buon Dio, prevedendo le ambizioni fasciste, l 'aveva sdraiata nel cuore del Mediterraneo trasformandola in una gigantesca seppure immobile unità porta aeroplani. L'analfabetismo del duce aveva un suggeritore: appunto questo ammiraglio fanatico della disciplina e dei bottoni ben lucjdati, arrogante e scorbutico con gli inferiori e perfetto gentiluomo nei rapporti con i potenti che gli servivano per fare carriera. L'imperialismo smargiasso del regime, i suo i proclami sul Mare nostrum e la Quarta sponda, gli anatemi contro Suez e Gibilterra che ci stritolavano, erano la s ua minestra quotidiana, le accarezzava come l'allea to preferito per masticare le scombinate formule della sua guerra navale. Questo ingegno tirchio e rugginoso adorava le corazzate: gli piacevano quei mostri quando tagliavano il mare con i cannoni puntati come ruta minacciose contro il nemico, quando manovravano seguite dalla muta degli incrociatori e dei caccia come cortigiani obbedienti. Sulla plancia ili comando ili giganti come la Giulio Cesare e la Littorio si poteva sognare di essere più potenti di Nelson; un ordine urlato nel megafono e a distanza ili chilometri con una salva ben assestata trasformava il nemico in uno scheletro annerito dagli incendi.
La corazzata era la nave idea le per le parate navali, quelle che piacevano tanto a Mussolini: erano l'esibizione ili una potenza senza rischi, allo stato appunto virtuale. Fatte in serie per gli orgasmi ili un'Italia casereccia, da capomastro, per un'Italia da dopolavoro. Quel che serviva per attizzare le braci della politica estera dove l ' esibizione dei muscoli e la retorica tenevano il posto del rischio calcolato e della forza vera.
Cavagnari sogna battaglie classiche: ammiragli sulla tolda ili enormi cattedrali ili acciaio che si scambiano monotone cannonate come a Tsushlma o al largo dello Jutland. Grazie alle corazze sempre più spesse e alle artiglierie contraeree le nuove insidie come il siluro e l'aereo saranno ridicole punture di insetti. Purtroppo non è solo un sogno. Gli danno carta bianca per costruirsela la flotta per questa sua ipotetica, scenografica battaglia navale. L'importante è averne tante ili corazzate. Ma non può usare lo strumento genialmente matematico del suo collega Pariani, ili farle nascere solo per decreto. Si getta sulla
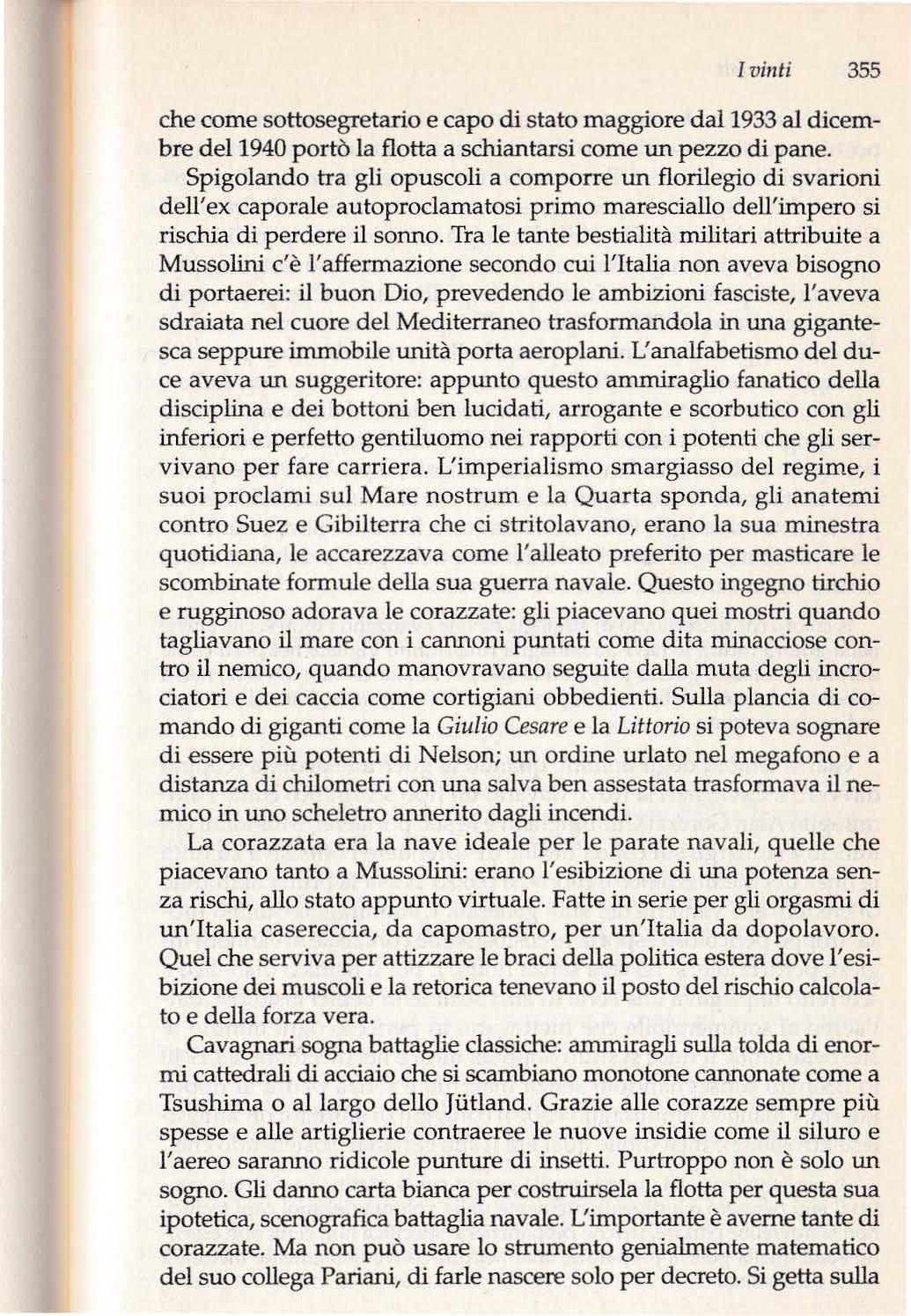
strada di chi ha volontà ma non i mezzi: l'ammodernamento. Mentre i nostri avversari costruiscono flotte e dottrine navali totalmente nuove, dilapidiamo gli anni Trenta a ritoccare come carrozzieri di periferia antiche reliquie della prima guerra mondiale, la Conte di Cavour, la Giulio Cesare, la Andrea Daria e la Duilio già vecchie ai tempi dell'impero austroungarico. Ingombrano i cantieri per un costoso restyling. Siccome non si possono fare, i cannorù di quelle veterane vengono come si dice «ritubati», da 305 millimetri a 320 quando ormai va di moda il 381 e in un ipotetico scontro le nostre belle navi farebbero la parte dei bersagli. La consolazione di Cavagnari sono le tre «trentacinquemila», Littorio, Vittorio Veneto e Roma. Assorbe i bilanci della marina come una spugna, con il risultato di trovarsi all'entrata in guerra con le navi ancora in cantiere o in fase di addestramento, e privo di tutte quelle altre urùtà come le scorte per i convogli che si rivelano fondamentali per le nostre strategie. Belle erano davvero le nostre navi e tanto bastava all'amrrùraglio che si accontentava della parola del duce citata in tutte le conversaziorù come l'ite missa est:
A coloro che dissertando di strategia navale avanzano l'ipotesi che anche nella guerra futura le navi da battaglia rimarranno vigilate nei porti come durante la Grande guerra io rispondo che per l'Italia ciò non avver rà; non è questione del costo delle navi; è questione della tempra degli uomini e degli ordini che ricevono.
Già, la tempra degli uomini: quando la guerra maledetta scoppiò davvero e Cavagnari si trovò davanti un tipo scorbutico come l'ammiraglio Alan Gordon Cunrùngham e le sue portaerei, Mussolirù cominciò a soffiargli sul collo l'ordine di «prendere l'offensiva su tutta la linea del Mediterraneo e fuori». Il pazzo aveva la brutta abitudine di credere alle vanterie dei suoi generali. L'amrrùraglio cambiò prosa: troppo pericoloso esporre le costosissime corazzate ai cannorti inglesi; perdendole, si restava senza flotta. E poi il nemico diabolico e scorretto impiegava una serie di altri strumenti bellici insidiosi, dall ' aereo al sommergibile che mettevano in pericolo ogrti minuto le sue belle urùtà . Il duce si stufò dopo sei mesi e nel dicembre del 1940 lo licenziò consegnandolo senza macchia e senza paura a l dopoguerra. Quando l'ammira glio ebbe il coraggio di sfornare un'autodifesa arrogante e incredibile qual era il suo carattere sost enendo che di preparazione alla guerra, quella guerra cui la marina fu costretta contro il suo pensiero e indipendentemente dalla volontà dei suoi capi tecnici, non si dovrebbe parlare, perché preparazione specifica non ci fu, non essendo stata quella guerra preparata, anzi neppur convenientemente meditata come tutti sanno.
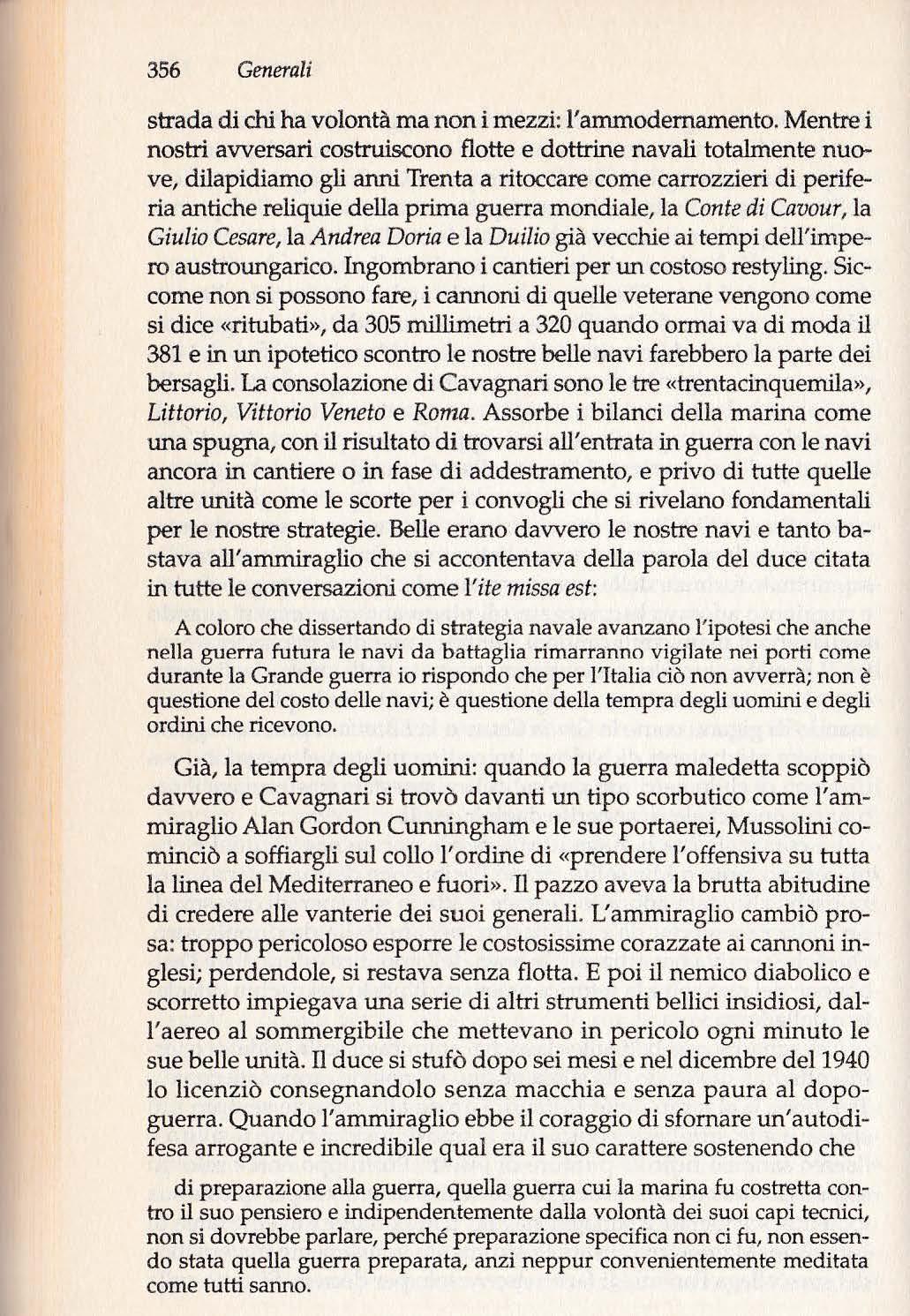
Questo incredibile ammiraglio da ricevimento combinò co n il suo collega dell 'aviazione Giuseppe Valle uno dei più esilaranti pasticci della storia militare . II 26 maggio 1939 i capi di stato maggiore si riunirono in un'assemblea che doveva dare i ritocchi decisiv i al nos tro appara to militare . Era un bel colpo d'occhio: si potevano addita re le medaglie come i venditori ambulanti m ostrano la m erce nelle fiere. Le poltrone cigolavano sotto il p eso d e ll e vittorie in tutte le guerre del Novecento. In un a rruffio rabbioso l'Europa non sparava ancora, ma aveva ormai le micce accese, i fucili puntati. Le promesse mussolinian e di una guerra non prima del 1943 potevano essere s mentite anc he dal più sprovveduto lettore di g iorna li. Si parla di siluri: a Fiume una società che si chiama White head produce modelli che sono conosciuti dagli s tati maggiori di tutto il mondo e dove fa compere p erfino la Germania hitleriana. C'è da pagare una ordinazione (la prima!) di trenta pezzi con cui pensiamo di incrementare la nostra potenza contro il n avi glio nemico. II problema è: chi paga? La m a rina che ne ha bisogno o l'aeronautica che d ovrebbe trasportare quei micidiali congegni sui s u oi aerei? I due comandanti alzano la voce, s i scatena una rissa. Valle ha la masce lla quadrata, tenace, testard a. Si inalbera e ribadisce che di quella roba non sa che farsene, contro le grandi navi è assai più efficace il b o mbardamento «orizzontal e». E poi di aerosiluranti n o n ne ha neppure uno, p er ragioni di economia non ne farà costru ire. I nostri equipaggi sono così bravi che possono fa r tutto: bomba rda re spezzonare s ilurare mitragliare la caccia nemica. La vera paura di Valle è di dover cedere aerop lani alla marina perdendo il monop olio della specialità.
Quella d e ll'auton omia era l'unico credo s trategico di Valle, eredita to da Italo Ba lbo, quadrunviro aviatore che, n e l bene e soprattutto nel male, aveva costruito l 'aeron autica ita liana modellandola s ulla base dei suoi indubbi ma pericolosi talenti di gerarca rinascimentale. L'aviazione era l ' ultima arrivata anche se la più fa scista delle specialità militari e ci teneva con la luciferina arroganza dei cadetti a non essere considerata di rango inferiore.
Quanto alle d ottrine, Valle è l'unico d ei capi militari del fascismo che poteva dichiarare, senza temere di essere smentito, di ave r d e tto con chiarezza a Mussolini, e nel 1939, che e rava mo impreparati ad affrontare il nemico! U n 'affermazione coraggiosa che sembra stonare con il fa tto che proprio lui, solo tra i costruttori d ella nostra impotenza militare, fuù davanti a un tribunale con l'accusa di aver fascistizza to le forze armate ed essersi illecitamente arricchito. La scusa che Valle presentò a l duce (senza essere fucilato) fu che in tutti q ue-
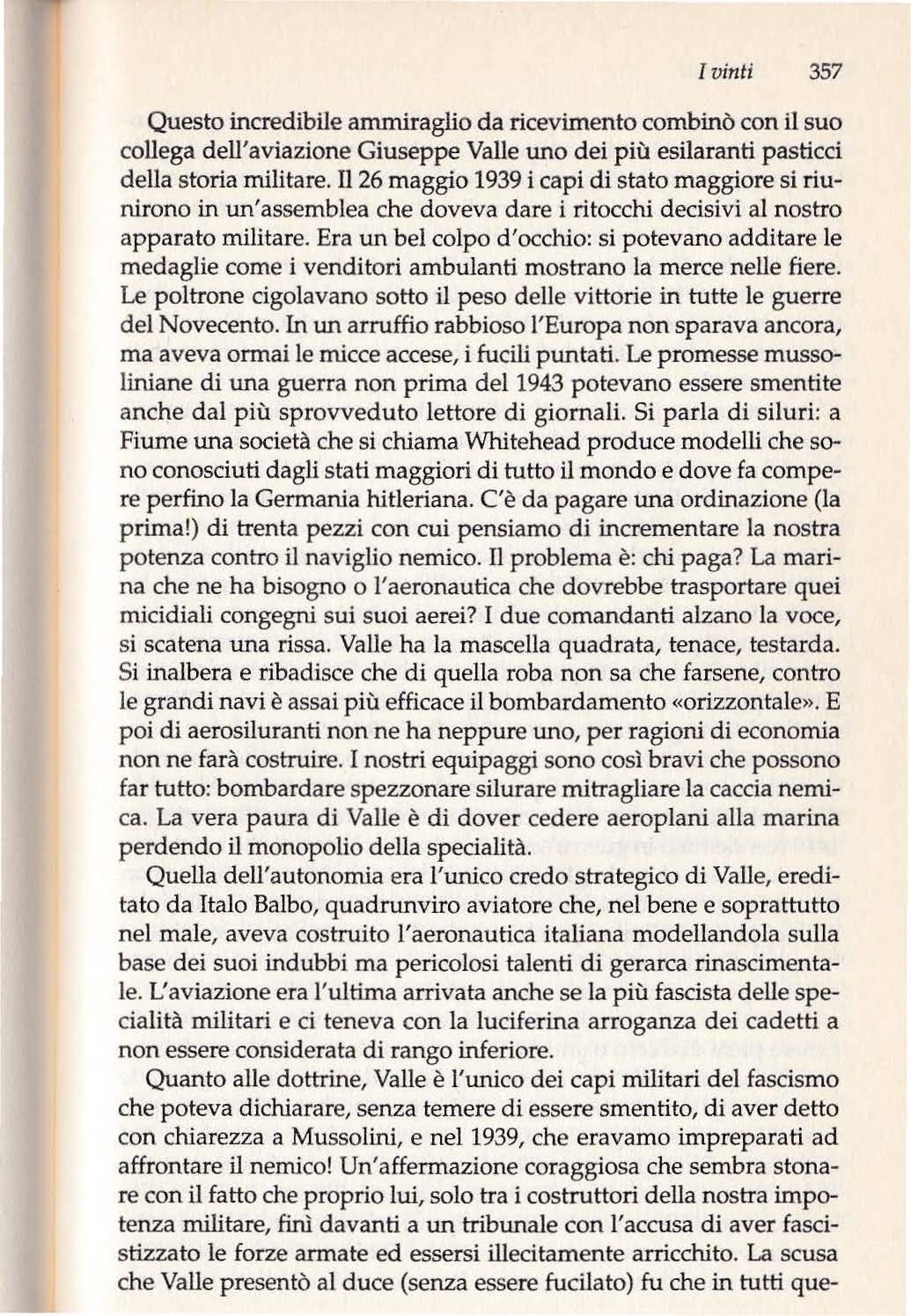
gli anni in cui era stato a capo dell' Ala Littoria aveva perseguito, sono parole testuali, «criteri di pace»! E tutte le adunate in cui il dittatore prefigurava flotte aeree che schiacciavano come insetti sotto grappoli di bombe gli innumerevoli nemici della grandeur fascista? Non era forse Valle sempre in prima fila con il naso in su a guardare i suoi bombardieri di tela e cartone? E un paio di guerre vere seppure periferiche l 'Italia le aveva combattute. Secondo il suo comandante il compito fondamentale dell'aviazione in quegli anni era sta to quello di vendere aerei ad altri paesi incamerando la indispensabile valuta estera!
Insomma, un piazzista di velivoli che aveva utilizzato i trionfi sportivi - le famose trasvolate che incenerivano di invidia Mussolini - del suo predecessore come una efficace pubblicità internazionale. L'ultimo ordinativo, quattrocento SM-79, il mulo tuttofare della nostra aviazione, era appena arrivato dalla Iugoslavia, paese contro cui era quasi certo che avremmo scambiato cannonate, visto il passato burrascoso e le mire del duce sui Balcani. Neppure la guerra incombente riuscì a fermare la commessa lucrosa!
Qui non si può raccontare. Si allargano le braccia, si osserva il religioso silenzio che accompagna l'insondabile. Valle, il piazzista che i giudici pietosi assolsero, aveva le id ee così chiare sul ruolo del!'aeronautica in una guerra moderna che rifiutò l'offerta americana di costruire su licenza le «fortezze volanti», i bombardieri che vinsero la seconda guerra mondiale. E pensare che sosteneva di essere il fedele d iscepolo delle teorie del bombardamento strategico! Il 10 giugno 1940 scendemmo in guerra senza bombardieri pesanti che avrebbero dovuto radere al suolo gli apparati industriali del nemico. Per non stonare mancavano anche un modello di caccia accettabile (il biplano Fiat piaceva ai piloti perché era acrobatico ma era già vecchio al tempo della guerra di Spagna) e un aereo per l'attacco al suolo, necessario per dare una mano ai colleghi appiedati dell'esercito.
La sua era un'aviazione arlecchinesca, con decine di modelli, in genere pieni di difetti o antiquati. Non era solo un problema di incapacità da parte della commissione guidata da Valle che sceglieva le proposte delle industrie. I generali sapevano benissimo che quei modelli erano inadeguati e che da quattro anni pe r esempio l a Raf disponeva di un gioiello come lo Spitfire. O che i tedeschi avevano e labo rato nuove tecniche di attacco con modelli come lo Stuka. Era una scelta deliberata, si sbagliava sapendo di sbagliare . Non si voleva scontentare nessuna delle industrie, Fiat in testa, che rivendicavano il diritto ad avere commesse. Pazienza poi se i piloti dovevano
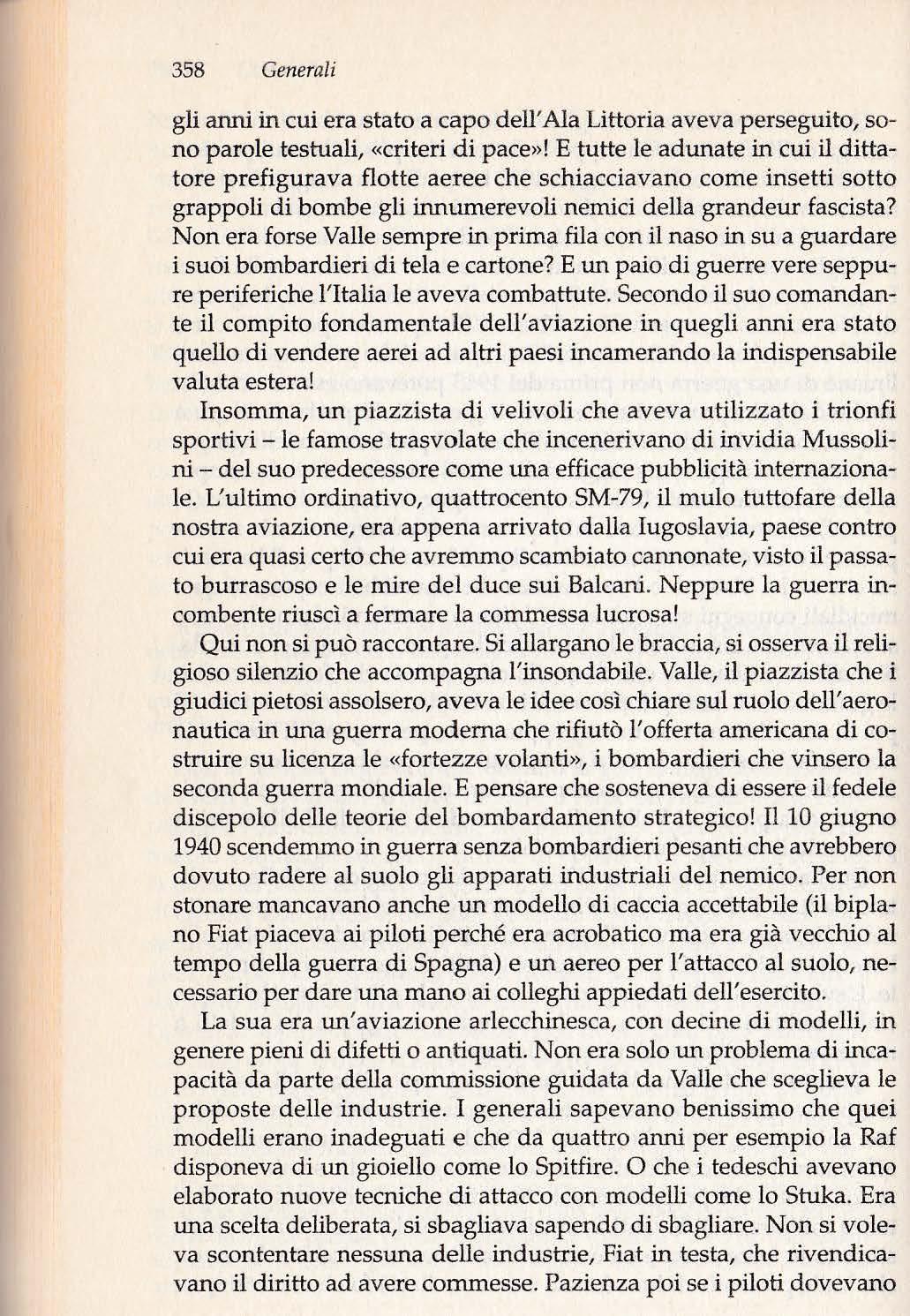
risdtiare la pelle su m odelli ormai da museo. Irùziammo e finimmo la guerra senza disporre di un motore di aereo da caccia all' altezza d egli avversari. E pensare che sarebbe bastato copiare dai camerati germani ci. Insuperabili in quella che è s tata defini ta l'arte d eUa sconfitta , l' unica vittoria che i generali italiani hanno conseguito nella seconda guerra mondiale è p ostuma . Non è avvenu,ta s u uno d e i molti campi di battaglia che hanno avuto a disposizione, inneva ti e sabbiosi, pian eggianti e irti di montagne. Hanno reso indiscutibile e definiti va l' idea che non potevamo v incere. Poiché e ravamo e ntra ti in guerra con un esercito rid icolo, un'aviazione primitiva e navi senza carburante contro eserciti m odernissimi, agguerriti e tecnologicame nte avanti di un secolo, l'esito dello scontro era già segnato. La bestiale avven tatezza di Mussolini che s i era legato al carro di Hitler e pretend eva di sfidare Inghilterra, Russia e Stati Uniti con le scatole di sardine da due tonnellate e il vecdtio fucile 91 (per citare due classici d e ll a n ostra saggistica militare) avrebbe reso inutile anche l'arte di un Napoleone o di un Clausewitz! Si pensa che si possono ingannare tutti per un certo tempo o si p ossono ingannare alcuni per tutto il tempo, ma non tutti per tutto il tempo. Ebbene i gen er ali hanno smontato questo pregiudizio. Invece di finire d avanti alle corti marziali nel dopoguerra hanno continuato a percepire grasse pensioni e a scrivere libri dove scaricavano sempre s ugli altri le colpe di sconfitte naturalmente «inevitabili». Inchiniamoci a uno dei pilastri del nostro astuto pensiero militare: giudicare l ' entità della propria forza in base a valori assoluti e non al rapporto con le circostanze strategiche, politiche e a l vigore dell'avversario. Torniamo a palazzo Venezia. I piani di guerra si spartiscono città e regioni della Grecia con svelta noncuranza. Visconti Prasca dà prova di animosità inventando una nuova strategia militare. «Ho dato ordine che i battaglioni a ttacchino sempre, anche contro una divisione!» Lo sproposito passa in un a ustero s ilenzio. C'è una stranezza . Il comandante dell'impresa alla proposta di avere più truppe nicchia, si ritrae, s i affanna a garantire ch e è fornitissimo: venti divisioni? N o , sono troppe, ne bastano cinque o sei. Generale di corpo d ' armata e di fresca nomina, temeva di essere scavalcato da colleghi più anz iani e titolati se il corpo di spedizion e fosse diventato e lefantiaco! Sospetto ben riposto. In una letter a scritta dal duce podti giorni prima ch e il balzo iniz iasse c'è tutta la ricattatoria doppiezza di cui era condita l a nostra teoria militare:
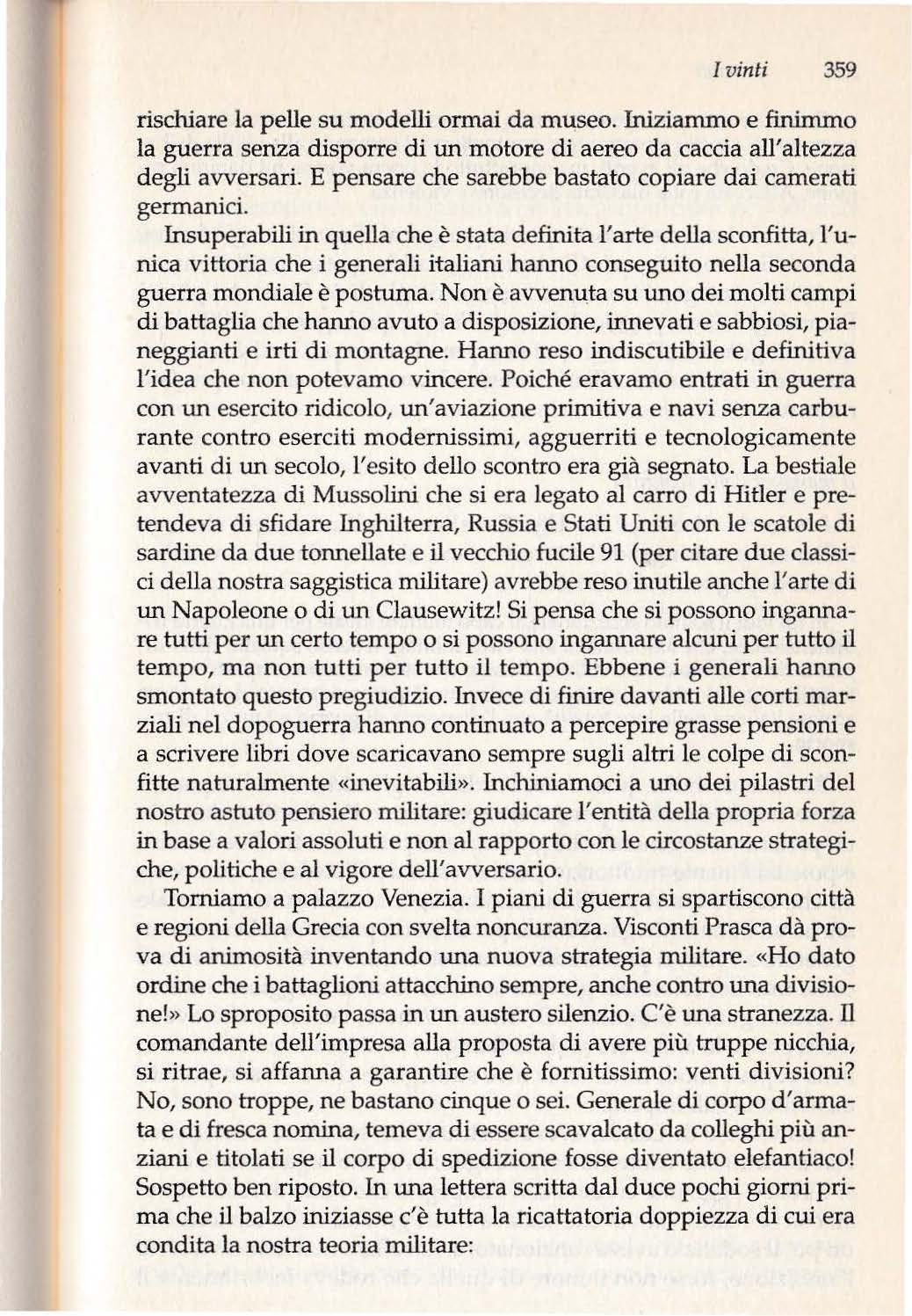
Caro Visconti, voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico adesso, che mi sono opposto a tutti i tentativi fatti per togliervi il comando alla vigilia dell'azione. Credo che gli eventi, ma soprattutto la opera vostra, mi daranno ragione. Attaccate colla massima decisione e violenza.
Prosa da boss mafioso. Dopo cinque giorni Visconti era già fermo, immobilizzato dai greci. Ci siamo logorati in questo terribile accumulo di montagne buone per le scene da giudizio finale dei pittori fiamminghi. Sono peggio del Carso. Finisce qui la guerra dell'Italia e dei suoi generali. D'ora in poi non prenderemo più decisioni autonome, diventeremo ausiliari dei tedeschi, carne da cannone per fare numero.
I tedeschi dicevano che Ugo Cavallero era l'unico vero stratega italiano. Kesselring, addirittura, davanti al tribunale militare italiano nel dopoguerra si sbilanciò:

In lui vidi il soldato eccezionale, il capo militare ideale per una guerra tridimensionale, che assommava alla virtù militare il senso squisito della diplomazia e l'uomo di alta cultura: l'uomo che se fosse stato tempestivamente utilizzato avrebbe potuto armonizzare il potenziamento delle forze armate italiane nella loro totalità con l'economia di guerra e i mezzi di trasporto.
Resta da stabilire quale fosse l'ordine degli addendi nell'equazione: se cioè lo dicessero perché era considerato l 'unico filotedesco in un panorama di generali che giudicavano prima che mediocri, infidi e potenzialmente traditori; o perché, essendo filotedesco, non poteva che essere quasi per illuminazione spontanea e consequenziale anche un buon stratega. Almeno per il nostro paese Cavallero era un generale atipico, il precursore di uno stile nuovo. Aveva debuttato come uno dei colonnelli giovani leoni dello stato maggiore durante la prima guerra mondiale. E Vittorio Veneto, successo che aveva molti padri, lo annoverava nella famiglia; si diceva avesse messo in bella copia e modi canonici le idee strategiche che avevano portato alla vittoria sull'impero.
P iemontese di Casale, aveva costituito un sodalizio carrieristico con un altro suo conterraneo, Badoglio; avevano organizzato, come si direbbe oggi, una cordata con l'impegno che l'uno avrebbe tirato su con sé l'altro via via che scalava i vari gradini della carriera. Per un po' il sodalizio aveva funzionato; a Cavallero non mancava certo l ' ambizione, forse non minore di quella che rodeva febbrilmente il
suo socio. Ma era un'ambizione di grana diversa che non si esauriva nella uniforme militare. Al contrario di Badoglio, ciarlatanesco e nefasto intrigante mascherato da dottrine pompose, Cavallero scandalizzò i «piemontesi»: era disposto a mollar, seppure per periodi non definitivi, la divisa per raggiungere altri traguardi. Per esempio nel mondo dell'industria, cui aveva scoperto si applicavano a meraviglia le sue indubbie qualità di organizzatore di uomini e le ideine imparate sudando sui banchi della scuola di guerra e dello stato maggiore. Cavallero era un eccellente manager e decise di rinverdire anche al tavolo di un consiglio di amministrazione le vittorie che aveva conquistato come generale. Andava e veniva dalla caserma impugnando l'aspettativa. Rivestito di buoni panni borghesi si concedeva i presentat'arm ai vertici dell'Ansaldo e della Pirelli.

Era un mondo in cui Badoglio si sarebbe smarrito con il suo dialetto; restò sempre, anche con tre greche sul berretto, un travet, un impiegato dello Stato, uno con lo stipendio milionario ma fisso. Secondo alcuni Cavallero era così tentato dall'industria anche per una certa avidità. Lo mormoravano i suoi critici nell'esercito che erano centinaia. Ah, Cavallero, non era mai sazio. Metteva a frutto nella sua attività di manager i vantaggi che gli derivavano dall' essere anche generale e dal conoscere le pieghe e gli interstizi di un'amministrazione con cui si potevano far buoni affari. Insomma un contratto a una ditta che aveva il generale, il conte Cavallero, in consiglio di amministrazione non si poteva certo rifiutare. Anche i controlli sulle forniture garantite da un simile potente padre della patria erano come si dice di routine. Anzi forse non erano affatto. Il conte ne guadagnava utili giganteschi, scrivevano nei rapporti le spie dell'Ovra che nel verificare questi mercanteggiamenti esplicavano un fiuto quasi pari a quello messo nello svelare le iliadi nelle alcove dei gerarchi. Comunque si sa che le spie esagerano; l'inevitabile processo, come si conviene a un paese in cui la ferocia e la minuzia del diritto e delle pene è inversamente proporzionale alla sua applicazione pratica e sembra fatta per agevolare il ricatto del potente, firù con una trionfante assoluzione.
Siamo testardi, non molliamo. Si mormorò molto negli anni Trenta di piastre per corazzate che avevano passato i controlli ma che con altrettanta facilità erano state trapassate dalle cannonate. Se il nostro esercito si presentò così mal ridotto alla prova non sempre dunque era colpa di ottusità. Spesso collaborarono anche mazzette, corruzione, lassismo ben ripagato. A ogni modo gli eredi del maresciallo hanno smentito con risolutezza. E di questo ci accontentiamo;
essendo morto non possiamo disporre delle smentite che più servirebbero, cioè quelle dello stesso Cavallero.
I due, comunque, Badoglio e Cavallero, al di là dei gusti, non erano nati per intendersi. Lo stato maggiore era un posto troppo piccolo per contenere le loro ambizioni. I rapporti franarono trasformandosi in ostilità scoppiettante quando nel 1925 Badoglio, dopo una breve eclisse, venne nominato onnipotente capo di stato maggiore generale e Cavallero era sottosegretario alla Guerra . Sembrava il compimento della scalata mano nella mano. Ma Cavallero voleva diventare mini s tro della Guerra. Fulminato da quella tromba di Geova che lo chiamava non fece caso che avrebbe così scavalcato il collega. Erano cose che con Badoglio non andavano fatte. Non ci riuscì e l'alleanza si spezzò. Quando clamorosamente litigarono sul palco di una sfilata militare alla presenza del re per uno sciocco e meschino cavillare l ega to a precedenze erano già come Ettore e Achille. I cuori dei leccapiedi e dei colleghi vacillarono, alcuni cervelli fini facevano già i conti su chi sarebbe stato il vincitore. Quando il 30 novembre 1940 Mussolini lo convoca a palazzo Venezia per affidargli la carica di Badoglio che è stato finalmente messo da parte, la sorpresa è generale. Anzi, più che la sorpresa monta l o sdegno. Dei badogliani, che si vedono orfani del capo. Badoglio è un monumento, non si licenziano i monumenti, argomentano con le lacrime dell'indignazione agli occhi. E poi restano affidati a uno che considerano ormai un ex che ha tradito per far d enaro . L'unico contento, si tramanda, fu il re che commentò con un s intetico: «Il nuovo ci sa fare». Mah ! Dietro i silenzi e le mezze frasi del sovrano molti biografi hanno intravisto chissà quali acutezze di giudizi e capacità di penetrare sotto lo scorza degli uomini. A noi pare piuttosto la ritrosia dietro cui i mediocri nascondono la incapacità di capire. Nel suo diario Cavallero evita di farne cenno ma la convocazione non gli arrivò inaspettata. Da settimane, da quando cioè la guerra di Grecia che doveva essere una passeggiata militare si era trasformata in un incubo, a suo favore lavorava uno sponsor: il ras di Cremona, la «suocera del regime», sua eccellenza Roberto Farinacci. Che Cavallero non ne parli non deve essere motivo di meraviglia. Farinacci, che era stato ferocemente ribattezzato «il Capostazione» perché si diceva che avesse evitato le trincee della prima guerra mondiale imboscandosi nelle ferrovie (era vero solo in parte, alle battaglie partecipò seppure in ritardo pure lui e pare si facesse onore), era uno dei personaggi più sgradevoli, rozzi e volgari del regime. Anzi di questa canaglieria squadristica si era fatto una bandiera politica promuo-

vendosi a campione dell'ala rivoluzionaria o sarebbe meglio dire piazzaiola, violenta e arrogante che il regime aveva messo in sordina se non cancellato. I suoi tempi, i mesi di Salò e del ritorno alle camicie nere e ai teschi, sono ancora lontani. Ma la guerra che non va bene svela i bluff di Mussolini, ridà fiato alle sue invettive contro la vecchia Italia dei notabili e dei generali impennacchiati che Farinacci non ha mai potuto soffrire e che lo tiene ai margini come personaggio sconveniente . Badoglio poi è la sua bestia nera: lo considera, e qui ha ragione, un subdolo, un traditore, un fascista per carrierismo. Lo vorrebbe fucilato. La suocera del regime adora il Terzo Reich, ammira Hitler che ha saputo fare piazza pulita e comanda da solo, senza la necessità di far riverenze al re e ai vecchi padroni. Vorrebbe farsi tedesco, far la guerra ai loro comandi così spietati. Punta per questo su Cavallero che i tedeschi considerano un mezzo parente militare. Tra loro c'era, pare, un'antica amicizia legata a conoscenze dj famiglia. Come il generale, laureato in matematica e considerato un intellettuale della guerra, e il Capostazione assurto per meriti fascisti al ruolo di avvocato potessero formare un' affiatata camarilla appartiene ai misteri del regime e dell' anima italica perennemente capace di stupire.
Gli incontri tra Mussolini e i suoi generali hanno sempre qualcosa che fa pensare al copione di un film in costume. Il duce li tratta come se fossero servitori tenuti alla mano in anticamera. Come racconta Bottai li chiama «i miei generali» con il tono soddisfatto di chi ha fatto carriera e adesso comanda. Sqwlla un campanello, si apre la porta e il generale, che magari è in disgrazia da anni, viene spedito ai quattro capi dell'impero a combattere pacificare resistere. Soddu ha saputo, nel 1939, che deve invadere i sassi del!' Albania alla stazione, chiacchierando con un collega incontrato casualmente; nessuno ha perso tempo ad avvertirlo. Ricordate il colloquio con Graziani frastornato e partente per l'inferno libico? Immaginiamo Cavallero insaccato nella divisa con gli occhiali da contabile abituato a srotolare pacchi di bigliettoru, infilzati sul nasone. Davanti a lui un duce con la barba in disordine, stranamente trasandato, diverso da quello che tuonava dal balcone che ormai da mesi resta inesorabilmente vuoto perché c'è poco da festeggiare e proclamare. Eppure il duce nella penombra sovrasta quell'ommo a cw adesso deve affidare le sue speranze di salvezza militare. Già, in Grecia dopo un mese siamo al disastro. Soddu, un altro piccoletto, faccia da oste della Luna piena, lanciato in un'avventura più grande di lw ha appena telegrafato che dobbiamo rassegnarci alla ritirata. Settanta chilometri addirittura, fi-

no ai bastioni del Gor Topit e al Tomori e qui bisogna metter su ur altro Grappa sperando che il fango dell'Epiro stavolta ci faccia il pia cere di rallentare l'avanzata dei greci. A un certo punto Soddu, eh, sembra aver perso la testa, telefona al comando supremo e annunci, che non ha alcuna sicurezza di poter resistere neppure con l'eroismc di Epaminonda. Quindi suggerisce l'opportunità di un «interventc diplomatico»: insomma di chiedere la pace ai greci! Potevamo affer mare con lo humour del buon soldato Schweyk di progredire lenta· mente verso la sconfitta.
Mussolini, è Cavallero che racconta nel suo diario, esordisce cor parole «affettuose, generiche». Poi gli sottopone il verbale della riu nione del 15 ottobre facendogli notare l'a utorevolezza delle firme ir calce al documento. Cavallero coglie e si lancia con tono professora· le in una critica al cianuro sul modo in cui la campagna è stata irnpo· stata e condotta. Son parole dolci per chi crede che la guerra può essere ridotta a geometria. Mussolini sgrana gli occhioni, si agita mussolineggia, mostra meraviglia . «Ma voi conoscete anche quest problemi?» con il tono di chi con l'acqua alla gola ha visto all'operi uno che cammina sulle acque . Risposta molto fascista: «Ho sempn sentito il dov,ere di tenermi pronto a servire il mio paese» . Il duce sembra aver scoperto che aveva un genio in casa e non ne tenev, conto. Chiama Sorice, il capo della polizia, uno che veglia da diec anni sui sonni tranquilli del regime: «È venuto Cavallero, ma quelle conosce l'Albania come il suo domicilio!».
Non c'era bisogno di altre ricognizioni e tasteggiamenti. C'è l'uo· mo giusto. Il posto di Badoglio è suo, basta aspettare che la decisione venga comunicata al rivale. Il giorno dopo altra udienza, sentii parlare il generale di come schiaccerà la Grecia è un lenimento alle cattive notizie, pare di aver già vinto. Questa volta il tono è ancm più affettuoso. «Così riprenderemo a lavorare insieme» dice e sem· bra che parli di un amico che torna dalle vacanze. Enuncia idee nuove per lo stato maggiore che dovrà uscire dal suo «assenteismc musulmano», riunioni tutti i giorni, basta deleghe ai militari, ora si fa sul serio questa guerra. Ha già concluso un allegro armistizio cor ogni forma d i preoccupazione. Acqua in bocca, ripete, prima che il minicondottiero di consigli di amministrazione esca con grandi sbracciamenti: l'etichetta impone che prima Badoglio sia avvertito, In anticamera tre -ministri sono in attesa del loro turno da Mussolini; appena vedono il conte scattano sull'attenti: «Ecco il nostro comandante». Questa era, approssimativa comare e scalcagnata, l'Italia fascista.
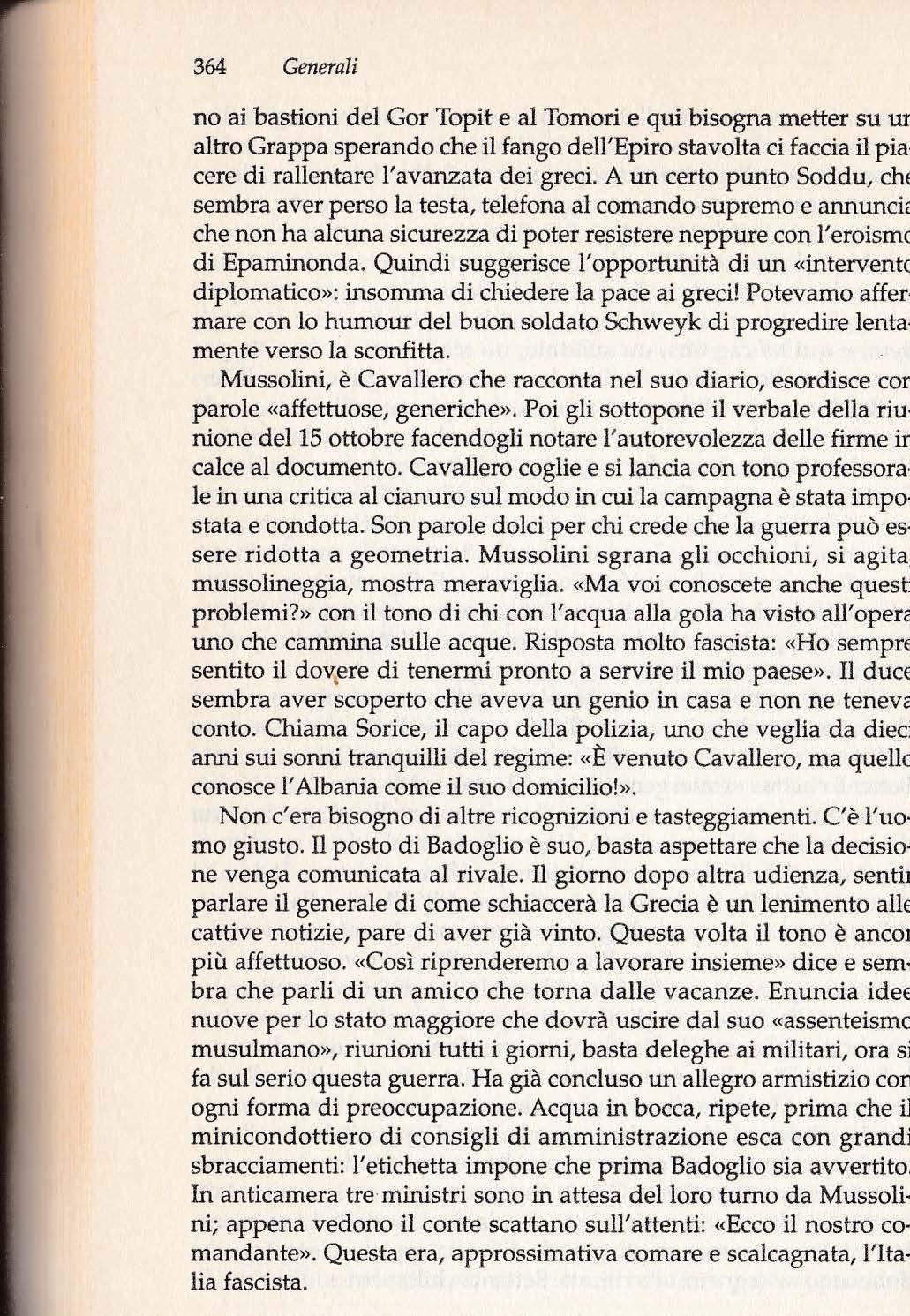
Passano tre giorni e come all'opera, arriva un'altra telefonata del duce: «Venite subito, l'aereo è già pronto a partire». Cavallero si ritrova a Erbasan nel regno fangoso di Albania e seconda linea di un disastro. La Maginot di Soddu, dove a fatica abbiamo attuato l'eufemistico ripiegamento, sta per crollare. Siamo appesi al sacrificio di alcuni reparti alpini che vengono gettati al massacro per rallentare la pressione dei greci. Altri ostacoli naturali a cui attaccarci non ce ne sono, n eppure la natura ci dà una mano, l' Undicesima armata ha già ricevuto l'ordine di ritirarsi. I siciliani della Piemonte hanno fatto miracoli lasciando il sangue su quelle montagne disgraziate sfracellati dai mortai da 81 che noi abbiamo venduto ai greci quando quel paese copiava la rivo luzione di Mussolini. Soddu e Mario Vercellino, il generale che comanda la IX armata, quella più strapazzata dagli attacchi nemici, sembrano due scampati a un naufragio. «Dopo questa ritirata» dice il secondo a Cavallero «avremo degli eroi maridotti allo stato di larve .» Soddu dedica le ultime energie a invocare un paio di divisioni per tenere Tuana e Durazzo ma solo «per scrupolo di coscienza, se i greci avanzano noi non molliamo». Poi si lancia in una tirata contro l'aeronautica che «è un bluff e pensare che l' artiglieria nemica appena ved e un aereo sta zitta!» .. C'è il rischio che se quegli indemoniati dei greci non si fermano festeggeranno il Natale a Tirana . Per Cavallero iniziano novanta giorni di fuoco . Rinforzati dagli aiuti inglesi che hanno messo il naso nei Balcani per colpa nostra, i greci di Papagos scattano all'attacco tra la Vojussa e Desnizza, poi nel settore dell'aspro monte Golico. Indietreggiamo di quindici chilometri, sotto nevicate furibonde, intirizziti da albe gelate. Con cappottoni che ostacolano i movimenti e non tengono lontano il freddo, i soldati di Cavallero resistono. In ogni pagina dei resoconti si muore da eroi: come sempre si spreca il fattore umano; come ammette il generale, «il trenta per cento dei proiettili da settantacinque restano inesplosi per cause non accertate». Lui si limita a disciplinare con metodo l'invio dei rinforzi, solo al momento in cui la crisi sarà superata si potrà pensare a manovrare, s i potrà cercare di «non prete ndere che i nostri soldati siano degli eroi permanenti e sfortunati»: «Tenere per arrivare al momento in cui avrò molto da spendere. Questo è il mio compito».
Le re trovie non lo aiutano in questa impresa così complicata. Invece delle divisioni e delle artiglierie arrivano le «eccellenze», i gerarchi che il fascismo ha spedito p e r far vedere che il regime non mette su pancia e che quando c'è da morire sono in prima linea . Per

molti catapultati dalle confortevoli retrovie della falsa guerra romana al gelo della prima linea è un risveglio brusco. Sono partiti con il viatico di una frase sciaguratamente storica che Mussolini ha regalato loro nel corso di un oceanico raduno di federali. In giacca di orbace e pantaloni grigi ha prima rivolto loro una domanda retorica: «Camerati, c'è qualcuno tra voi che ricorda il discorso di Eboli che pronunciai prima dell'inizio dell'impresa etiopica?». Silenzio generale e accorta pausa colmata di densi sguardi saettati sull'uditorio: «Dissi che avremmo spezzato le reni al negus. Ora con la stessa certezza assoluta, dico assoluta, dico che spezzeremo le reni alla Grecia». Acclamazioni.
Facendo uno sforzo per dimenticare che sullo sfondo ci sono tredicimila morti, cinquantamila feriti e venticinquemila dispersi, si dovrebbe ridere rileggendo le telefonate che il duce fa al suo comandante in Albania. Per lui «bisogna legnare, sfondare, contrattaccare, ricacciare, non dare tregua». Cavallero abbozza, acconsente, getta covoni di ottimismo e qualche volta cerca di far capire all'interlocutore qual è la vera situazione: «Il materiale è quello che è» dice riferendosi non ai cannoni ma alle fanterie che il duce continua a ritenere le regine delle battaglie. Qualche volta, ma sono poche, si ribella e bruscamente pone il Principale di fronte al ricatto della fiducia, ricordandogli che gli è stata concessa «assoluta».
L'unico sbarco gallonato che ha fatto piacere a Cavallero è quello di Farinacci, tirato fuori dalla naftalina perché rianimi le divisioni di camicie nere che, a parte alcuni episodi naturalmente molto lodati dalla stampa, stanno dando pessima prova. «Sono sfessate» le ha definite Starace, un altro ripescato, dopo un'ispezione. Non è solo per colpa di ras e gerarchi che le retrovie sono quelle solite delle guerre italiane. Durazzo e Valona, i porti della costa, sembrano la Tortuga. Arrivano navi cariche di materiali che nella confusione febbrile di quei giorni finiscono nella rete stesa da una coorte di affaristi, commendatori, appaltatori e impresari che fanno affari d'oro spesso esibendo certificati di merito del partito. Rimase celebre l'episodio di Durazzo. Per un errore degli operai, dal verricello di una gru che stava provvedendo al carico di un mercantile si staccò una cassa enorme su cui era scritto: «Urgente. Da maneggiare con cura contiene materiale radiotecnico che richiede revisione». Nella caduta il legname si sfasciò: ne uscirono a fiotti prosciutti e insaccati che alti ufficiali attraverso un ufficio preposto al saccheggio avevano dirottato verso le loro famiglie in Italia. Intanto i soldati di Cavallero difendevano affamati e con divise di stracci l' ultima scaglia di fronte verso Tepeleni.

Esaurita la spinta nemica, superata bene o male la bufera, il 5 marzo 1941 Mussolini fece irruzione in Albania. Adesso voleva la controffensiva, la vittoria che lo riscattasse da quei mesi di sofferenza. E voleva dirigerla lui la battaglia, assestare la legnata che schiantasse finalmente i greci. Toccò a Cavallero fare da cerimoniere a quella rara apparizione in prima linea. L'altra fu in Africa settentrionale: obiettivo partecipare alla parata della vittoria ad Alessandria d'Egitto, che non ci fu . Il duce guadagnò la pericolosissima fama di iettatore che ne distrusse forse definitivamente il favore popolare.
La sua arma prediletta, la propaganda, si era spuntata. I bollettini del quartier generale in questa guerra non contavano più del pane come avveniva nell'altra, non ci credeva nessuno.
La visita del capo era per Cavallero davvero una seccatura, tanto che nel diario ne fa solo un vago cenno, quasi nell'economia della guerra fosse stata un episodio minore. Invece per tre giorni a T,rana fu costretto con gli uomini dello stato maggiore a piegarsi sulle carte sotto l'occhio indagatore del duce per imbastire un attacco nel settore di Tepeleni dove ci eravamo salvati per un miracolo imbastito di migliaia di morti . Nella faccia del duce si intravede lo sguardo del cassiere a cui non piace la firma sul!'assegno intuendo già che è senza copertura. Bisogna sorbirsi interrogatori insulsi: «Vi sono lavori già fatti?», «Ave te notizie dell'atteggiamento dei greci?». E lui risponde: «Per ora niente ma sto sempre attento» . «E il genio?» si incuriosisce il superuomo un po' stropicciato. «Lavora! » Sembra di leggere Tacito. La conoscenza per sentito dire è davvero il grado più basso del sapere. Bisogna sorbirsi anche teologiche lezioni di questa natura: «Qui è in gioco l'onor!=' militare della nazione che di fronte al mondo è l'unico onore che 'fa nazione ha ... Al soldato dobbiamo sempre dare la sensazione che siamo vittoriosi, quando non si ritira il soldato deve sempre considerarsi vittorioso ... È inammissibile che non siamo capaci di dare una legnata ai greci...». Sul piano più strettamente tattico l'apporto più originale è questa frase: «Anche quando si perde terreno bisogna che il successo nemico non possa prendere nome di vittoria di una determinata località» . Era la lezione del caporettesco Badoglio!
A fatica si imbastisce l'attacco mussoliniano e 1 ' 8, all'alba, il duce raggiunge la sede del comando d'armata alpino. Le visite a reparti opportunamente ripuliti dal fango e dalle scorie del ripiegamento lo hanno riconfortato: temeva mugugni, ammutinamenti, sguardi torvi e bestemmie. Gli hanno dovuto strappare i soldati dall 'auto per frenarne l'entusiasmo, la gente lo invoca, lo tocca come un feticcio, ha

sentito parlare solo di vittoria, vendetta, massacri da compiere su quei greci dannati. Qualcosa è stato messo su da Cavallero, ma il resto è genuino. L'italiano è cosl malleabile. Con passo bersaglieresco, con il pastrano da primo maresciallo dell' impero che lo impiccia, seguito a fatica da Cavallero afflitto da gambe corte e pancia, il duce si arrampicò fino all'osservatorio di Narka: vista splendida sul fronte di attacco, un balcone sulla battaglia. Infatti era stato costruito apposta per lui. Gli sembrava di essere ritornato il «trincerista» del primo conflitto mondiale. Era di buon umore, il duce. Stringeva mani con familiarità da parenti che si rivedono dopo molti anni a ufficiali che gli erano totalmente sconosciuti ma avevano tirato fuori il distintivo rosso da squadrista. Tutto intorno già strombettava la retorica. Distribul frasi già pronte per un muro: «Vi sono momenti in cui tra libro e coraggio b isogna scegliere il coraggio». Non trascura la truppa: hanno distribuito sul sentiero alcune compagnie di bell'aspetto e lui stringe mani, si informa con l'aria di uno che in quel posto ha passato l'inverno. Non sa che con l'ironia che non è mai mancata al popolo di Pasquino hanno ritirato fuori una canzone dell'Etiopia:
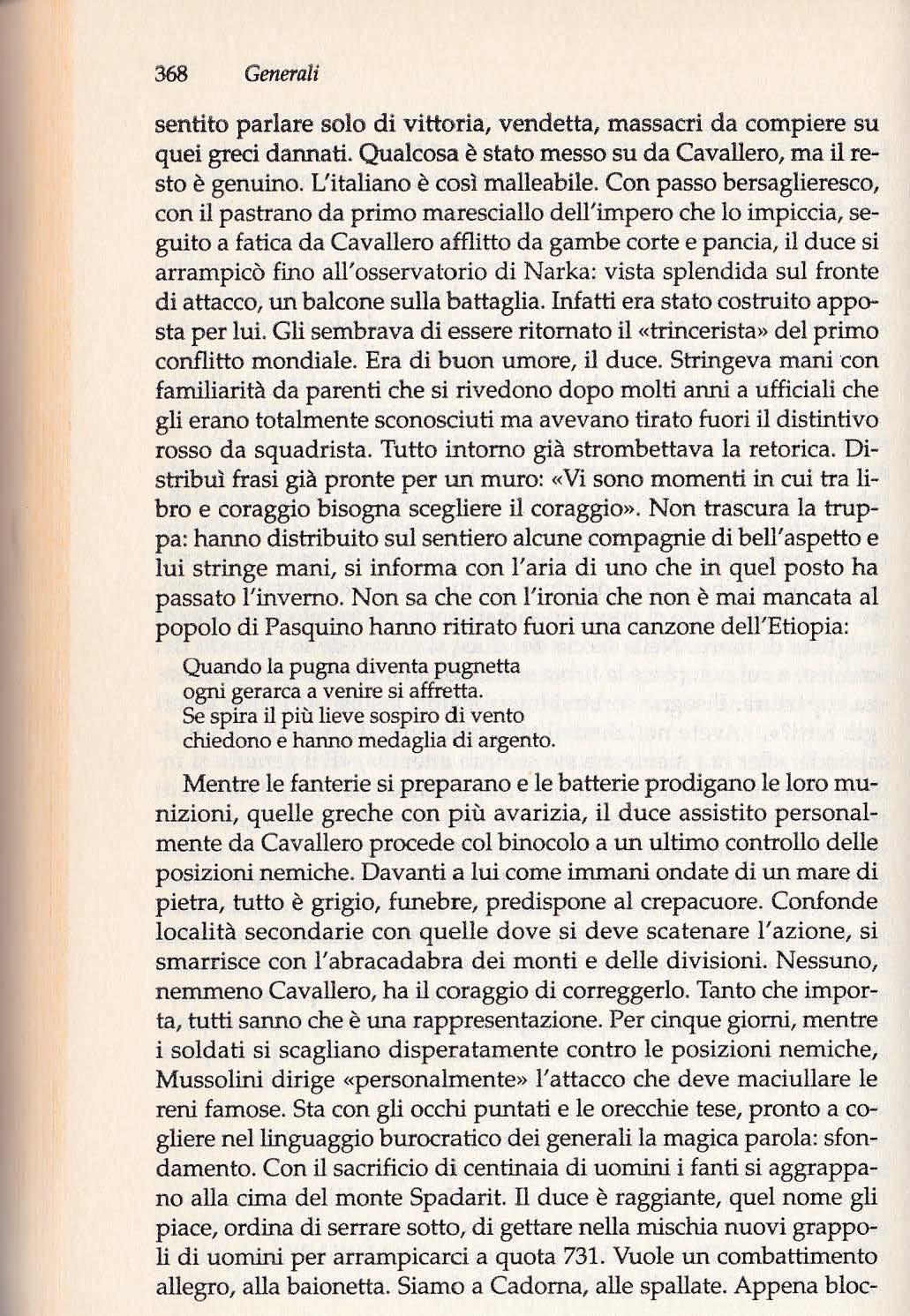
Quando la pugna diventa pugnetta ogni gerarca a venire si affretta. Se spira il più lieve sospiro di vento chiedono e hanno medaglia di argento.
Mentre le fanterie si preparano e le batterie prodigano le loro munizioni, quelle greche con p iù avarizia, il duce assistito personalmente da Cavallero procede col binocolo a un ultimo controllo delle posizioni nemiche. Davanti a lui come immani ondate di un mare di pietra, tutto è grigio, funebre, predispone al crepacuore. Confonde località secondari e con quelle dove si deve scatenare l'azione, s i smarrisce con l'abracadabra dei monti e delle divisioni. Nessuno, nemmeno Cavallero, ha il coraggio di correggerlo. Tanto che importa, tutti sanno che è una rappresentazione. Per cinque giorni, mentre i soldati si scagliano disperatamente contro le posizioni nemiche, Mussolini dirige «personalmente» l'attacco che deve maciullare le reni famose. Sta con gli occhi puntati e le orecchie tese, pronto a cogliere nel linguaggio burocratico dei generali la magica parola: sfondamento. Con il sacrificio di centinaia di uomini i fanti si aggrappano alla cima del monte Spadarit. Il duce è raggiante, quel nome gli piace, ordina di serrare sotto, di gettare nella mischia nuovi grappoli di uomini per arrampicarci a quota 731. Vuole un combattimento allegro, alla baionetta. Siamo a Cadoma, alle spallate. Appena bloc-
cati, proviamo da un'altra parte nella speranza di trovare a tentoni una crepa in cui infilarsi. La montagna nereggia per le ondate di fanti ingoiate dal fuoco nemico. Alla fine la quota resta ai greci. Sono azioncine slegate, velleità tragiche finite con migliaia di morti. Dallo Spadarit ci hanno ributtati due giorni prima. Il 15 marzo la breve guerra del generale Mussolini è finita. Stravolto, cupo, il duce ridiscende verso Tirana ma prima di imbarcarsi sul!'aereo che lo riporta a Roma tiene rapporto agli alti gradi dell'armata: «Per conto mio, egregi signori, vi dirò che certi insuccessi prima o poi me li aspettavo."i-lo sempre avuto più fiducia nei caporali che nei generali». È vero: la sua era stata l'Italia dei sottufficiali, dei treni popolari, casereccia accaldata e paesana. Ma doveva affidarsi ai generali. Alla fine la vittoria a Cavallero la regalano i camerati tedeschi che, infuriati, sono scesi nei Balcani per toglierci dai guai. Ora può finalmente manovrare visto che i greci si stanno ritirando sotto l ' urto teutonico, lancia all ' inseguimento le sue, diciamo cosl, d ivis ioni celeri: «Nella piana di Korcia » racconta al duce «hanno trovato q ualche ostacolo: interruzioni e campi minati . I bersaglieri sono scesi dagli autocarri e hanno proseguito in bicicletta». Il 22 aprile, finalmente!, passiamo di nuovo il vecchio confine. Il generale Gastone Gambara alle sei e venti del mattino sul ponte di Perati, diventato celebre per una canzone alpina, incontra, sgradita sorpresa, un ufficiale tedesco. C'è una grana e grossa : i greci hanno chiesto l' armistiz io e si rifiutano di arrendersi a noi che non li abbiamo battuti. Ai tedeschi in fondo la nostra umiliazione fa piacere, il comandante della Settantatreesima divisione germanica ferma gU italiani sulla via di Jannina. Bisogna spedire un generale, Enea Navarrini, a chied e re umilmente il passo. Alla fine vinciamo anche noi la guerra ma dobbiamo, per convincerli a firmare, mettere in rilievo il valore dell 'esercito greco nei bollettini «con aggettivi superlativi». L'ultima notaz ione del diario di Cavallero in Albania riguarda la sfilata d e lla v ittoria ad Atene: «Il reggimento di formazione sfilerà su autocarri per analogia con truppe tedesche. Per eventualità di sfilata a piedi i granatieri, i fanti e la milizia devono conoscere il passo romano».
La Grecia è solo il preludio. In Africa le ambizioni evaporano definitivamente e inizia, nell ' inferno di El Alamein, il terribile atto finale. Cavallero, che scodinzola alle spalle del duce in tutti i vertici sempre più imbarazzati e penosi con il camerata tedesco, trov a il tempo di raccogliere il bastone di maresciallo, conferitogli perché altrime nti sarebbe in sotto rdine rispetto a Rommel, e di litigare con il collega. Il «condottiero d ella guerra tridimensionale» per Rommel è un soldato
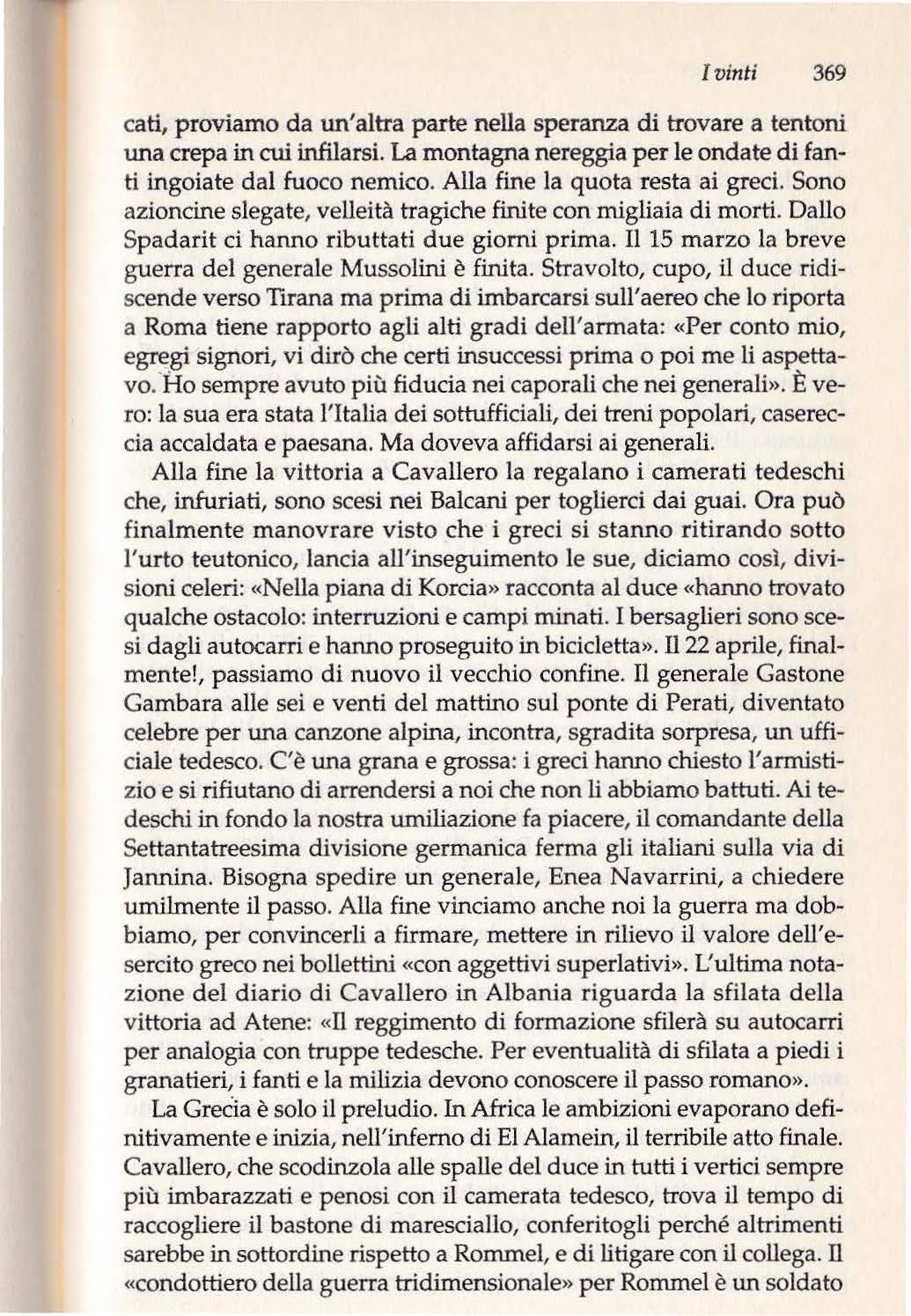
da tavolino. Cavallero invece giudica il fulmineo a tleta della blitzkrieg con la degnazione dello studioso: «Un ardito e avventuroso comandan te di reparto che tendeva a dilatare i successi tattici in sviluppi strategici la cui portata sfuggiva alla sua percezione».
Tra questi inutili e reciproci mugugni la battaglia va avanti per la sua strada e gli inglesi arrivano inesorabilmente in Tunisia. Cala s u di lui una seconda eclisse, deve cedere «il compito sovrumano». Sulle circostanze della sua morte esistono versioni opposte . Qualcuno vi ha scorto il primo segno di quella opposizione ai tedeschi che avrebbe portato poi a molte pagine gloriose della Resistenza. Cavallero cioè, sarebbe stato «suicidato» perché aveva rifiu tato di assumere il comando dell'esercito fan toccio che i tedeschi volevano ricostruire in Nord Italia sotto Mussolini. Vi sono strane lacune s toriche in cui i fatti spariscono come in un abisso. Questa versione francamente non ci convince. Cavallero era un personaggio che negli intrighi si muoveva benissimo. Ma non riusciamo a immaginarlo nei panni dell'eroe da tragedia greca che preferisce pagare con la vita piuttosto che tradire il suo re. Che fra l'altro lo aveva fa tto cacciare in prigione come un criminale comune dopo il 25 luglio. Molti hanno negato che a decretare l a s ua morte sia stato il cosiddetto «memoriale» in cui ammetteva di aver tramato contro Mussolini per sganciare l'Italia da una guerra ormai perduta. Badoglio lo aveva volontariamente dimenticato sul s u o tavolo di lavoro al Viminale appunto perché i tedeschi lo ritrovassero. Un generale non si sarebbe mai macchiato di una simile bassezza nei confronti di un collega, schiamazzano i badogliani. E sbag liano: l'uomo dell'8 settembre aveva la mentalità e lo spirito vendicativo per combinare anche di peggio.
Se i tedeschi avessero offerto davvero a Cavallero di diventare la bandiera militare del nuovo fascismo, avevano i mezzi per convincerlo. Q u ando puntarono su Graziani si sbarazzarono delle perplessità del maresciallo in pochi minuti con un a ben orches trata messinscena. E poi non avevano certo bisogno di un genio militare ammesso che ancora credessero Cavallero inserito in questa ristretta categoria . L'esercito che vol evano costruire infatti sarebbe stato comunque sotto il loro totale comando e sarebbe servito per operazioni di polizia e repressione. Non certo, come sognavano a vanvera gli uomini di Sa lò, per improbabili riscatti dell'onore nazionale. E se davvero glielo avessero chiesto, vanitoso come era, quasi certamente avrebbe accettato.
La verità è scritta davvero in quelle paginette di confessioni che il

maresciallo, trascinato a forte Boccea su ordine di Badoglio dopo il 25 luglio, aveva annunciato al carabiniere che lo arrestava come «importantissime e inaspettate». Badoglio spedì Carboni, uomo dei servizi segreti, a lui fedelissimo, a interrogare l'antico rivale ormai con le spalle al muro. Gli raccomandò con una perifrasi pietosa «di cavargli il sangue»! Carboni, congiurato di bassa lega ed eccessive ambizioni, ne cavò una confessione così spropositata e strumentale da risultare per molti aspetti poco credibile. Un Cavallero singhiozzante, spaventato, che invocava il nome della moglie (altro che eroe già in marcia verso il suo destino di patriota!) spiattellò i contorni di una congiura contro Mussolini. L'aveva, secondo le sue parole, imbastita sin dal novembre del 1942 quando si erano diffuse le voci, probabilmente vere, di una gravissima malattia del duce e le difficoltà della guerra gli apparivano ormai insormontabili. Cavallero avrebbe insomma progettato in anticipo quel golpe monarchico messo poi in atto nella primavera successiva dal re. Citava alti ufficiali a cui avrebbe commissionato la preparazione tecnica, un giurista a cui aveva chiesto un parere costituzionale sull'aggrovigliata vicenda e un amico, l'industriale Luigi Burgo, che si era offerto di finanziare la congiura con la bellezza di cento milioni. Il terrore fisico in cui sembrava caduto il maresciallo doveva avergli fatto perdere le doti di astuzia che tutti, amici e nemici, gli avevano sempre attribuito. Ripetutamente affermava di aver costruito tutta quella impalcatura sediziosa per trasferire il potere al maresciallo Badoglio «ai cui ordini ci saremmo messi tutti quanti». Come poteva pensare che il suo areinemico credesse a una simile favola? Che con l'odio che li divideva Cavallero, a furia di contorcersi, si sarebbe messo al suo servizio, avrebbe rischiato la testa per dare il potere proprio a lui?
Cavallero aveva congiurato; non ci sono dubbi. Era diventato nell'Italia infiacchita dalle disfatte e in mano a un potere che sembrava esausto, quasi uno sport nazionale. Nell'anonimo si son fatti tutti leoni, tutte bestie feroci. Aveva congiurato non con l'ambiente monarchico e badogliano che lo guardava con sospetto come sostenitore della lotta a oltranza, fino alla morte a fianco dei tedeschi; ma proprio con quell'amico, Farinacci, che lo aveva portato al comando supremo. Il ras cremonese era un tipo che girava con una pistola nascosta nella giarrettiera, gonfio di rancori, che praticava la tecnica inventata per i raid degli squadristi: «Attacco fulmineo e rapida ritirata». Dai tempi della Grecia aveva capito che il regime stava andando a rotoli, che i «molli» che aveva sempre odiato stavano prendendo la mano a disubbidire e meditavano clamorose capriole. All'inizio scel-

se di denunciare tutto al duce. Il dossier che presentò era da atterrire: il generale Vittorio Ambrosia, erede di Cavallero, sfarfalleggiava dicendo che la guerra era perduta e che bisognava chiudere bottega; una parte del fascismo, nomi come Dino Grandi e Galeazzo Ciano stavano tramando con il re. Erano informazioni di prima mano, si scorgevano tra le cose machiavellici nessi. Aveva portato a palazzo Venezia proprio una lettera di Cavallero dove si prevedeva che i congiurati fascisti alla fine sarebbero stati beffati dalla casa reale e dal suo scaltro manovriere, Pietro Acquarone. Il duce aveva irriso la sua mania di persecuzione, da suocera, e si era detto sicurissimo dell'affetto del re.
Allora maturò in Farinacci e nel suo socio l'idea di ammutinargli contro il fascismo: sostituire Mussolini che sembrava loro ormai svampito e spento, rimettere in sella l'ala dura del regime naturalmente guidata dallo stesso Farinacci e impegnarsi in una battaglia per la vita o per la morte al fianco dei tedeschi. Era tra tutte le opzioni la più complicata. Il primo passo era mettere in piedi una notte di San Bartolomeo dei gerarchi sciupati dal potere, dei militari accusati di tradimento e soprattutto dei Savoia, che avevano sabotato la guerra fascista e ridotto il regime a una larva. Cavallero doveva diventare il capo militare della riscossa italiana . Erano fantasie con scarse basi nella realtà? Con ogni probabilità sì, un fascismo senza Mussolini non poteva esistere e Farinacci, uno cui pareva energia la bestemmia e l'ingiuria, si faceva illusioni su un partito formato da vivacchiatori e ascari. Ma aveva quasi certamente cercato e trovato sostegno in Germania dove era stato inviato per alcune missioni. Doveva addolcire, pensava Mussolini, con il suo fanatismo protedesco gli aculei e le delusioni dell'alleato. Hitler non aveva prestato attenzione al pittoresco personaggio. Era di gusti difficili e bastava una occhiata per capire che quell' italiano frequentava più le osterie che l'Olimpo ariano. Maggiore attenzione gli avevano prestato Hirnmler e Goebbels con cui aveva da sempre affettuose relazioni. Era gente che metteva le mani anche in bassi servizi, viveva serenamente tra i delitti come un altro tra i debiti, si accontentava. Levanterie dell'anticristo Farinacci riferite in un «riservato al duce» della polizia secondo cui i tedeschi erano pronti a mettere in castigo Mussolini per puntare su di lui, erano appunto vanterie. Alla ambasciata tedesca a Roma Farinacci era di casa, entrava e usciva ogni giorno. Qui si spalancavano le porte dell'ufficio del messo segreto di Himnùer, l ' affabile colonnello Eugen Dollmann. Alcune volte per far bella figura e aumentare la sua qualità di congiurato con quei baffi
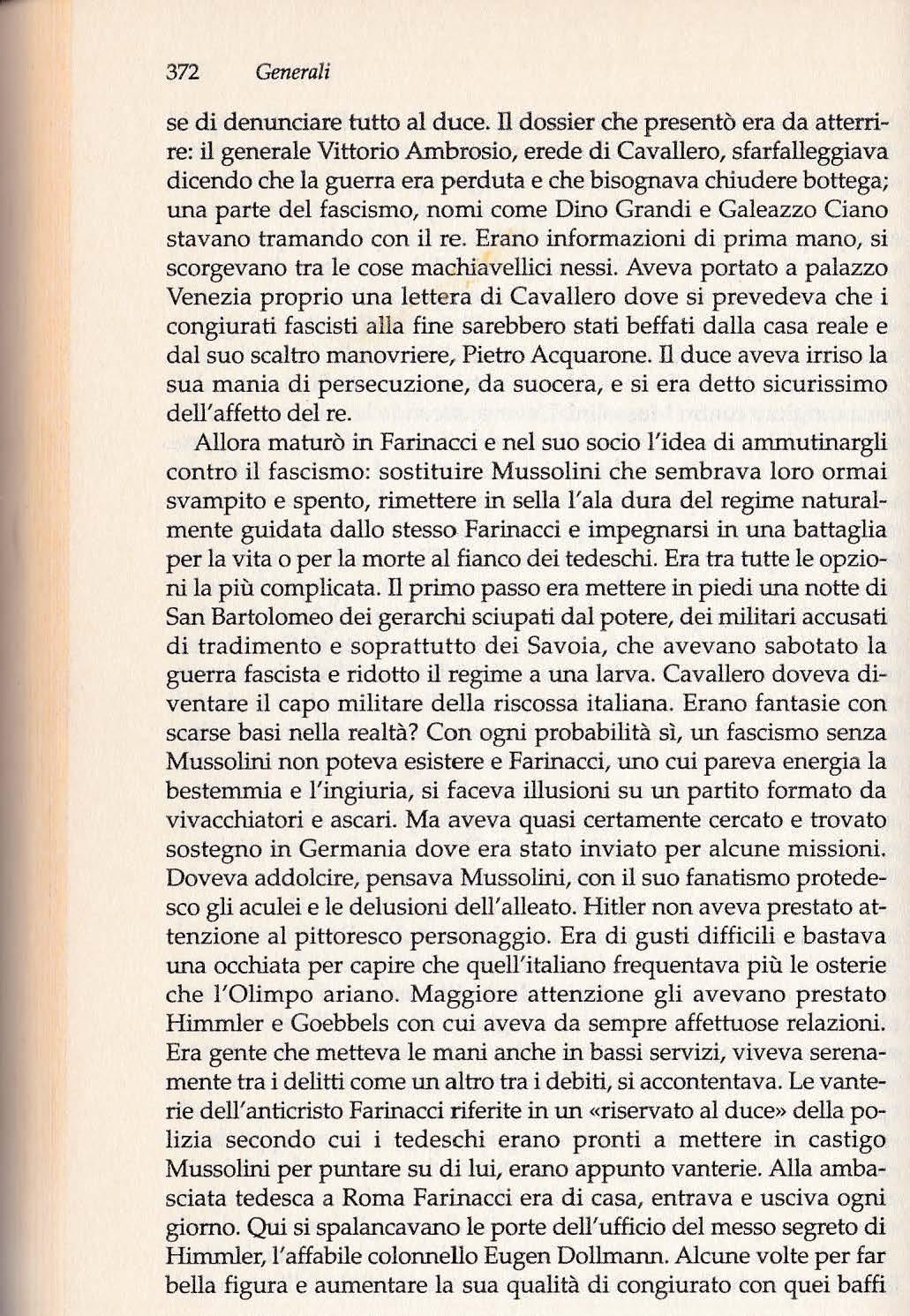
da attaccabrighe si portò dietro Cavallero. Davanti al panciuto maresciallo Farinacci attaccò brutalmente Mussolini definendolo «una sciagura per il regime»; gli stessi tedeschi d ovettero invitarlo a una maggiore cautela almeno verbale. Macché, la prudenza era scomparsa. Un mondo ormai tremava sui cardini: gli incauti prevalevano, la passione forzava la ragione. Il padrone di Cremona convocò l'adunata dei gerarchi che costrinsero Mussolini a convocare il Gran consiglio. Il capitombolo del dio ci fu, ma la conclusione come si sa fu ben diversa.
Per ritrovar Cavallero nello sconquasso dobbiamo correre al 12 settembre e affidarci al racconto del maresciallo Caviglia che assisteva all'apocalisse come un educato turista inglese a una corrida. C'è una Roma strana, sospesa davanti a noi; i tranvai funzionano regolarmente ma in periferia brontolano sparatorie e cannonate. I ministeri sono vuoti, abbandonati come gusci da gerarchi e generali. Al Quirinale sono spariti anche i carabinieri. A custodire le glorie d ei Savoia sono rimasti soltanto g li uscieri. Eroici. Disfatti i comandi e lo stato m aggiore. Come nei golpe dei sa trapi africani i generali e i ministri hanno dato l'ordine di sciogliersi e di tornare a casa . Lasciando come ultimo regalo per quel fe rragosto fuori stagione la possibilità di sacchegg iare i magazzini. E così vedi la capitale affollata da soldati ormai senza fucile, qualcuno già con la divisa a m e tà, che trascinano sacchi, valigie e cavagne colme di tutto quel ben di Dio che nei rapporti ufficiali è sempre stato indicato come tragicamente assente per lo sforzo militare del p aese. Caviglia che non ha incarichi, se non portare in giro la sua gloria, si è dato da fare per mettere un p o' d'ordine, garantire la s icurezza e le scorte alimentari, cercare di arginare la probabile furia vendicativa dei tedeschi. Graziani che lo ha importuna to a lungo per d escrivergli la sua difficile situazione economica, gli ha segnalato che i gerarchi fatti imprigionare da Badoglio sono adesso liberi all'ambasciata tedesca. Il vincitore di Vittorio Veneto decide di incontrarli e sale alla villa insieme all'arzillo De Bono. Quegli uomini s i presentano abbandonati sulla scalinata, lucertole che cercano un poco di v ita sotto il sole ancora tiepido. Sono i rottami di un naufragio, entrano in scena in massa come i coristi di una tragedia: Teruzzi, Cavallero, Buffarini, quas i n essuno scamperà a una sorte tragica. Hanno mille ragiorù p e r essere un po' bisbetici, portano vistosi i segni di una prigiorùa non dorata, abiti straccia ti, lo choc per il precipizio che separa i saloni di palazzo Venezia dal bugliolo della cella comune. Qualcuno bizantin eggiava di rivincite e invocava con il viso di chi sta per avventarsi
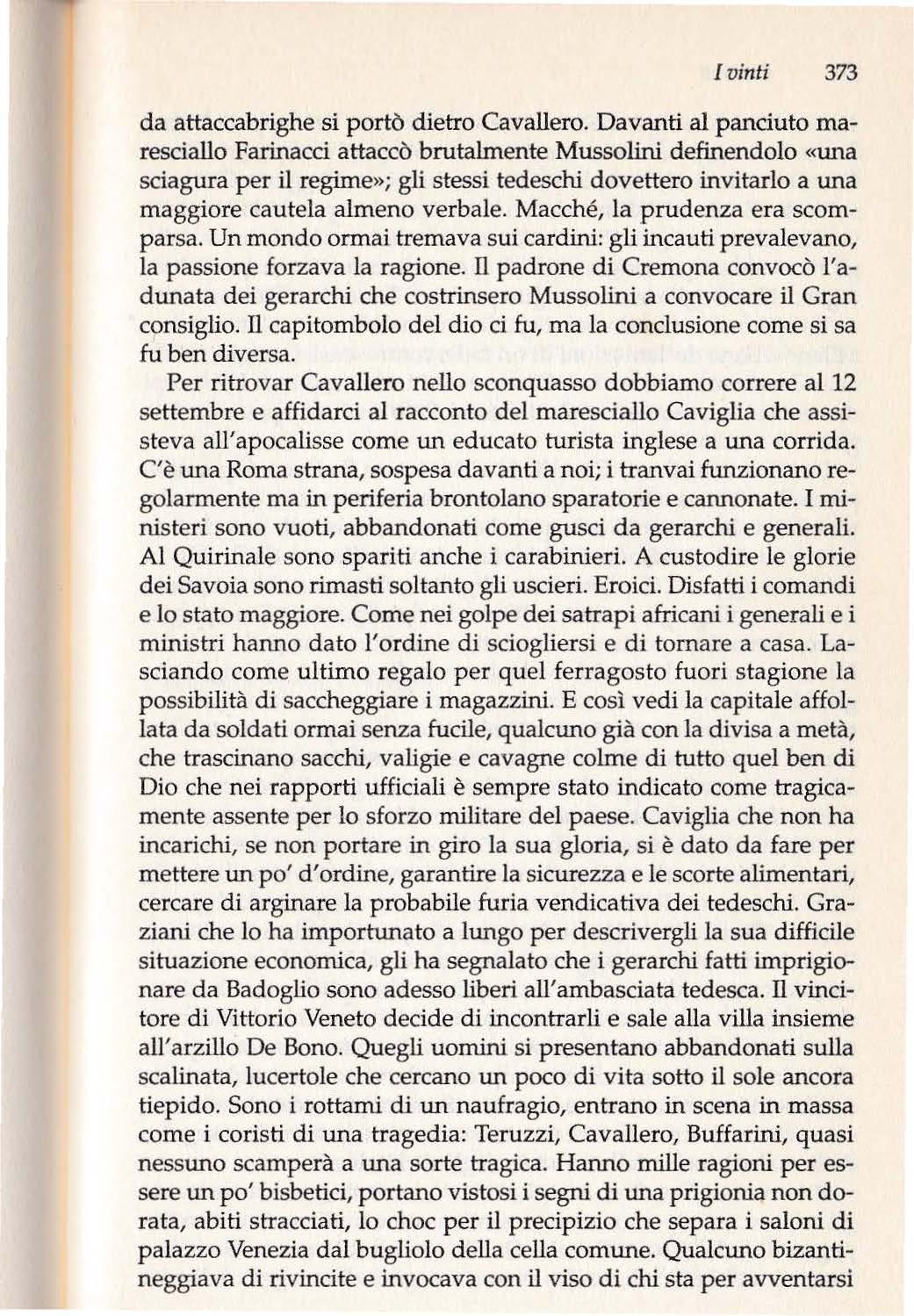
sul nemico Mussolini che intanto è stato liberato dai ceppi del Gran Sasso. La maggioranza ha mente ormai solo per i casi propri. Come Cavallero che è rimasto lo stesso che ha pennelleggiato Carboni: sull'orlo di una crisi di nervi, con la lacrima che spunta dalla pupilla . Ricorda a Caviglia Vittorio Veneto e la lettera che il maresciallo gli ha mandato per ringraziarlo di quanto aveva fatto in quella battaglia: «Non voglio andare in giro profugo. Tornerò in Piemonte dove mi spetta il comando dei corpi di armata di Torino, Alessandria e Milano». Sono declamazioni di un folle, controsensi. Caviglia lo frena: «Cavallero, se ne vada a Casale e curi i suoi interessi. I tre corpi di armata sono sequestrati dai tedeschi. Solo i tedeschi possono dargliene il comando».
L'ultima volta in cui Caviglia lo vide v ivo fu il giorno dopo, sempre nell'ambasciata tedesca dove era andato a incontrare l'ambasciatore Rahn. Terminato il colloquio, l'auto del maresciallo scende lungo i viali del giardino ed è bloccata da Cavallero e da Soddu in evidente aggua to . Il primo sale, si getta nell'auto e abbracciando l'anziano collega gli sussurra all'orecchio piangendo : «Sono prigioniero, domani mi portano a Frascati, mi mettono una palla in testa. Mi ammazzano». L'uomo è evidentemente fuori di sé; a Caviglia che gli chiede informazioni, notizie su quel delitto annunciato ripete come un automa: «mi ammazzano, mi mettono una palla in testa». Poi scende come se raccontare la sua sorte lo avesse tranquillizzato e si allontana, curvo, nel giardino con il suo compagno di sventura. Non fu il solo incontro che il morituro ebbe quel giorno: aveva ottenuto infatti dai tedeschi, che fra l'altro gli avevano anche riconsegnato la pistola, di visitare la moglie ricoverata in una clinica in città. A lei annunciò invece che i tedeschi volevano portarlo il giorno dopo in Germania da Hitler dove doveva prendere il comando dell'esercito fascista, ma aggiunse che non avrebbe mai accettato. Si mormorò anche di una cena ancor più funebre e barocca. Cavallero che, di fronte ai gerarchi furenti, invitato dai tedeschi a brindare al nuovo capo dell'esercito fascista con aria da antico romano rispose: «Io brindo al mio re». Scena improbabile visto che i tedeschi lo avrebbero immediatamente arrestato. Sembra più accettabile la versione che lo descrive invece mentre si allontana in silenzio inseguito dalle maledizioni e dalle minacce degli al tri italiani.
Il terrore di Cavallero era giustificato, non nasceva da un travaglio di coscienza per un atto che sentiva come tradimento al suo impegno di fedeltà con i Savoia . Quello era un dilemma che vissero semmai molti ufficiali, risolt o spesso con gesti di coraggio e dignità

p aga ti con la vita . Il maresciallo sapeva cosa aveva scritto nel memoriale e sapeva che gli altri, i fascisti, sapevano. Durante i giorni cli prigionia i gerarchi avevano cerca to di far giustizia sommaria p e r il tradimento ed era s ta to salvato da Soddu e Buffarini. Anche se il documento accusatore non e r a stato ancora trovato (lo rinvenne probabilmente Kappler) non c'erano dubbi che i fascisti avrebbero informato i tedeschi di che stoffa era fatto l' uomo caduto nelle loro mani. Il mattino dopo secondo la versione tedesca, l'unica disponibile, fu trovato s u una sedia in giardino, vestito con una grisaglia bo r g hese, un filo di sangue che usciva dalla tempia d estra dove s i era sparato con la pistola di ordinanza. Scena che Dollmann, classicista appassionato, riporta alla Winkelmann, con il cadavere rivolto verso la città di Roma ch e l'alba co lora di tinte rosate. A poca distanza il g ruppo dei gerarchi macchiò q ues ta bella morte gioend o sconci ame nte p er il d estino del traditore. Dopo l ' autop sia all'ospedale militare del C elio lo s eppellirono frettolosamente. Durante la cerimonia rese gli onori un reparto della Wehrmacht. Sulla bara tre coron e di fiori con i n omi di Hitler, Keitel e Kesselring.
Il generale Alberto Cavaciocchi era un omone tagliato nel bronzo . A settant'anni sembrava ancora piantato nel terren o come se da quello gli salisse una forza, era il gigante Eretteo. Gli occhi fulminavano gli inte rlocuto ri come se stesse s crutando il n emico in a ttesa del momento più adatto per massacrarlo con la mitraglia. Insomma: gli avresti dato trent'anni, crivellava di quotidiane invettive la mediocrità dei tempi e c'era da giurare che as pettava solo un' a ltra guerra per tog liere medaglie a palate alle s peranze di conco rrenti più giovani. Ebbene, il 4 maggio 1925 si esercitava in palestra con la s pada dando addosso all'avversario con il furore di un pe rsonaggio d el Tasso. Un a tte ndente in una pausa si avvicinò per dargli la n o tizia che era s t a ta annuncia ta ufficialmente la nomina di Pietro Ba dog lio a capo di stato maggiore dell ' esercito. Il generale, che era sopravvissuto alle insidie di Cus toza e che aveva, senza batter ciglio, osservato gli austriaci che avanzavano verso le sue trincee sul Grappa, alzò le braccia, lanciò un urlo: «Quel traditore! », e crollò a terra stroncato da un infarto. I contemporanei restarono, g iustam ent e, este rrefatti.
Ma chi era questo Badoglio a cui Mussolini affidava, in un momento decisivo dell'edificazione della dittatura, l'unica forza capace

di abbattere con un soffio il suo potere non ancora vigilato dalle invincibili sentinelle della Provvidenza? Purtroppo lo conoscevano tutti. Le biografie dei generali cominciano sempre con le loro avventure di ragazzi, chini sui libri della scuola di guerra o con le umili iliadi dei tenenti impegolati in qualche guerricciola per convincere gli indigeni ad assaporare i piaceri della civiltà occidentale . Badoglio no. Lui è come Atena, balza già armato di tutto punto dal capo del padre Giove. Ci spunta davanti infatti coperto di greche, medaglie, gradi come se avesse iniziato la carriera direttamente dalla poltrona di generale.

Nella storia dei grandi uomini ci sono dei vuoti, degli intermezzi più o meno lunghi, interrogativi irrisolti a cui è spesso collegata con fili tenaci la loro grandezza. Ebbene, nella biografia del maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, marchese del Sabotino, duca di Addis Abeba, mancano almeno due giorni. E che giorni! Sono quelli che coincidono con la catastrofe di Caporetto, la sconfitta più apocalittica subita da un esercito al cui confronto episodi come Canne e Stalingrado sembrano dei calchi.
San Tommaso e Ludovico Muratori non hanno scritto quanto i memorialisti di questa tragedia. Ha indagato una commissione d'inchiesta severissima. Ma ancor oggi circolano testi in cui viene definito «sorpresa strategica» quanto subimmo a opera dei nibelungici austrotedeschi. Niente affatto: dell' offensiva nemica sapevamo tutto. Il punto in cui sarebbe stata condotta, le armate che ne avrebbero curato l ' esecuzione, gli obiettivi che i generali del kaiser, prestati al povero cugino Carlo d'Asburgo, si ripromettevano di raggiungere. Perfino l'ora in cui sarebbe iniziato il cannoneggiamento. Notizia non secondaria poiché le battaglie allora si costruivano con il cannone. Era stata portata in regalo dal solito traditore, un ufficiale cecoslovacco che saldava così i conti con quelli che considerava gli invasori del suo paese. Il punto in cui sarebbe stato esercitato il massimo sforzo era un saliente, una gobba rimasta in eredità dall'ultima spallata di Cadoma che il ne mico poteva utilizzare, lo dicevano i generali italiani, come una piazza d'armi per manovrare contro di noi. È la zona presidiata dal Ventisettesimo corpo comandato dall'enfant prodige dell'esercito italiano, Badoglio. Ha quarantasei anni; significa, per l'esercito presidiato da vecchioni, aver copiato la carriera di Napoleone. E infatti la lista di coloro che ha scavalcato sulla strada delle promozioni è molto più lunga di quella percorsa dal nostro esercito dal maggio radioso del 1915. Ha cominciato la guerra come sottocapo di stato maggiore della II armata.
Si è lavorato il suo comandante, il tenente generale Pietro Frugoni, così bene che questi ne parla con tutti come di un miracolo della scienza militare: «Questo Badoglio è come Napoleone» dice. «Come lui è artigliere, anche lui diventerà un grande condottiero.» Frugoni, un mediocre che cadrà tra i primi, aveva sfidato il ridicolo e le convenienze proponendolo dopo sei mesi per una promozione a colonnello. Più che una relazione quella spedita alla commissione avanzamento è un encomio:
Questo distintissimo ufficiale superiore ha dato prove talmente evidenti del suo intuito tattico, della sua capacità di organizzatore, della sua tenace volontà e della sua forza di carattere da farlo assolutamente eccellere fra gli ottimi ufficiali del suo grado e di qualsiasi arma.
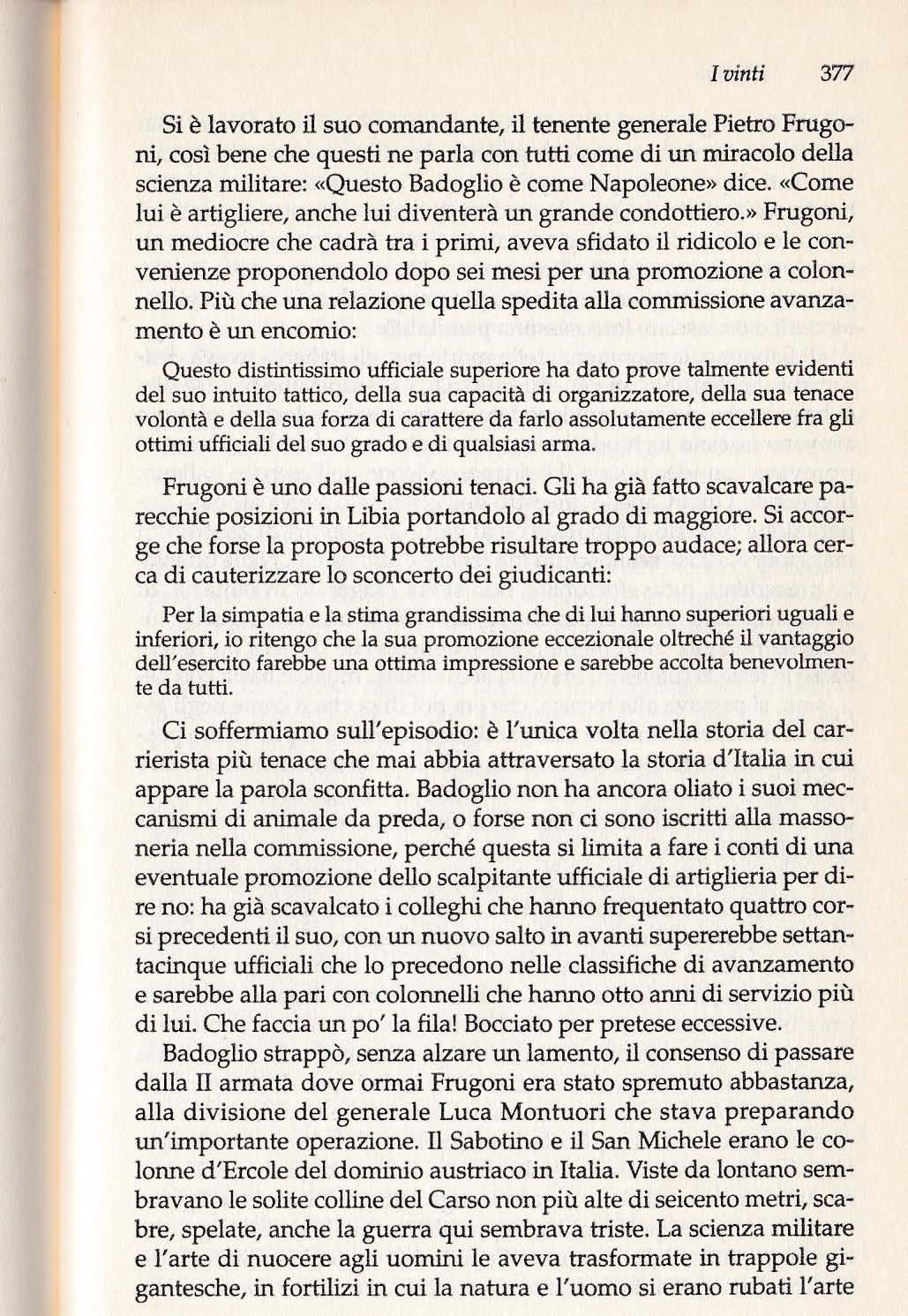
Frugoni è uno dalle passiorù tenaci. Gli ha già fatto scavalcare parecchie posiziorù in Libia portandolo al grado di maggiore. Si accorge che forse la proposta potrebbe risultare troppo audace; allora cerca di cauterizzare lo sconcerto dei giudicanti:
Per la simpatia e la stima grandissima che di lui hanno superiori uguali e inferiori, io ritengo che la sua promozione eccezionale oltreché il vantaggio dell'esercito farebbe una ottima impressione e sarebbe accolta benevolmen· te da tutti.
Ci soffermiamo sull'episodio: è l 'unica volta nella storia del carrierista più tenace che mai abbia attraversato la storia d'Italia in cui appare la parola sconfitta. Badoglio non ha ancora oliato i suoi meccanismi di animale da preda, o forse non ci sono iscritti alla massoneria nella commissione, perché questa si lirrùta a fare i conti di una eventuale promozione dello scalpitante ufficiale di artiglieria per dire no: ha già scavalcato i colleghi che hanno frequentato quattro corsi precedenti il suo, con un nuovo salto in avanti supererebbe settantacinque ufficiali che lo precedono nelle classifiche di avanzamento e sarebbe alla pari con colonnelli che hanno otto anni di servizio più di lui. Che faccia un po' la fila! Bocciato per pretese eccessive. Badoglio strappò, senza alzare un lamento, il consenso di passare dalla Il armata dove ormai Frugorù era stato spremuto abbas t anza, alla divisione del generale Luca Montuori che stava preparando un'importante operazione. Il Sabotino e il San Michele erano le colonne d'Ercole del dominio austriaco in Italia. Viste da lontano sembravano le solite colline del Carso non più alte di seicento metri, scabre, spelate, anche la guerra qui sembrava triste. La scienza militare e l'arte di nuocere agli uomini le aveva trasformate in trappole gigantesche, in fortilizi in cui la natura e l'uomo si erano rubati l'arte
nel rendere ogni passo aspro, faticoso, letale. Qui non c'erano solo trincee, ma bunker in cemento, gallerie che affondavano nella roccia, reticolati doppi tripli quadrupli protetti d'infilata da cannoni, bombarde, mitragliatrici. Quando credevi di essere arrivato alla fine del martirio eri invece solo ai primi contrafforti. Bisognava sfogliare altre trincee, altri reticolati, altre caverne. Un monte guardava l'altro, gli prestava le artiglierie e la mitraglia per prendere in mezzo gli attaccanti, non lasciare loro nessuna possibilità.
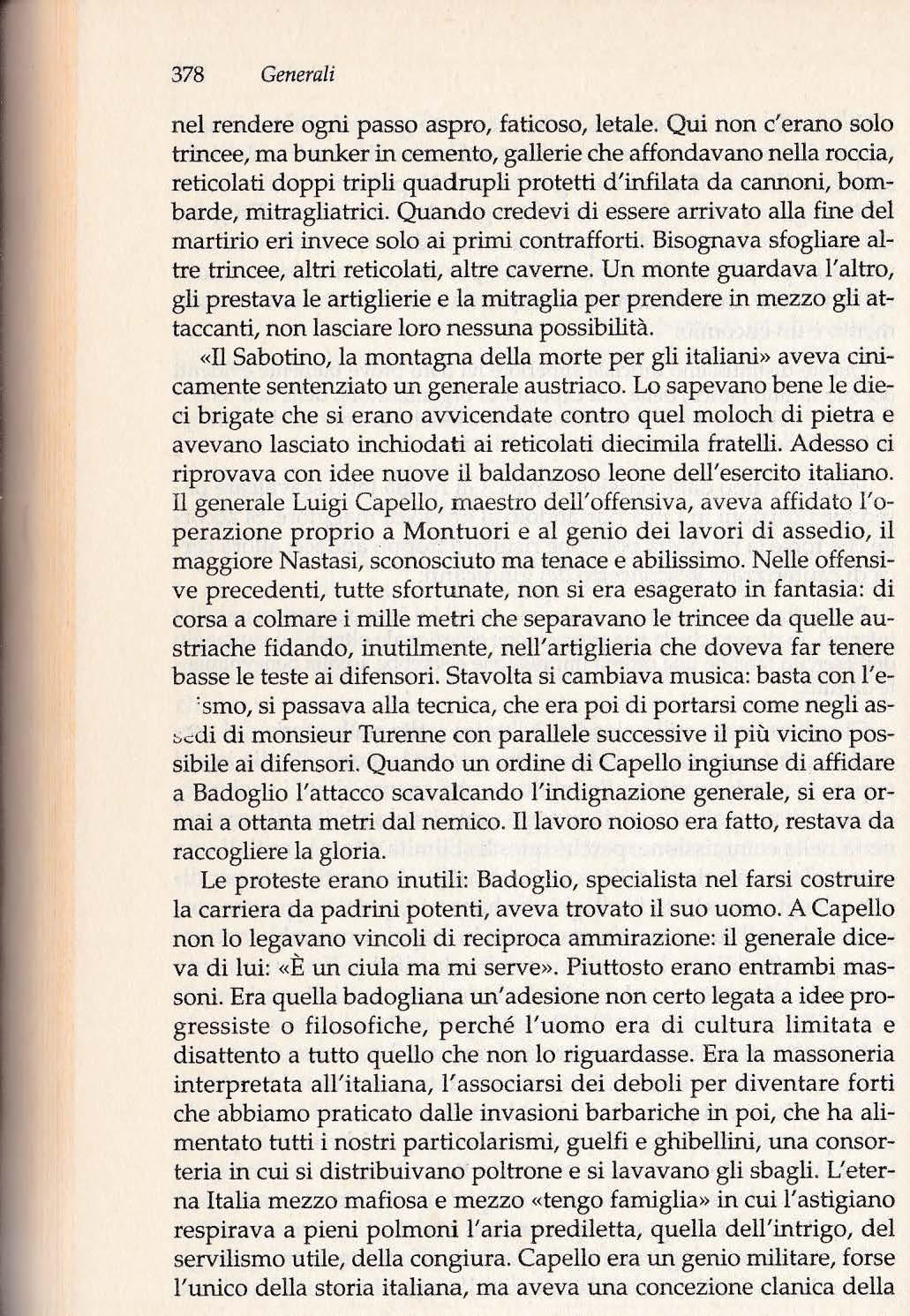
«Il Sabotino, la montagna della morte per gli italiani» aveva cinicamente sentenziato un generale austriaco. Lo sapevano bene le dieci brigate che si erano avvicendate contro quel moloch di pietra e avevano lasciato inchiodati ai reticolati diecimila fratelli . Adesso ci riprovava con idee nuove il baldanzoso leone dell'esercito italiano. Il general e Luigi Cape llo, maestro dell'offensiva, aveva affidato l'operazione proprio a Montuori e al genio dei lavori di assedio, il maggiore Nastasi , sconosciuto ma tenace e abilissimo. Nelle offensive precedenti, tutte s fortunate, non si era esagerato in fantasia: di corsa a colmare i mille metri che separavano le trincee da quelle austriache fidando, inutilmente, nell'artiglieria che doveva far tenere basse le teste ai difensori. Stavolta si cambiava musica: basta con l'e'smo, si passava alla tecrùca, che era poi di portarsi come negli ass edi di monsieur Turenne con parallele successive il più vicino possibile ai difensori. Quando un ordine di Capello ingiunse di affidare a Badoglio l'attacco scavalcando l'indignazione generale, si era ormai a ottanta metri dal nemico. Il lavoro noioso era fatto, restava da raccogliere la gloria.
Le proteste e rano inutili: Badoglio, specialista nel farsi costruire la carriera da padrini potenti, aveva trovato il suo uomo. A Capello non lo legavano vincoli di reciproca ammiraz ione: il generale diceva di lui: «È un ciula ma mi serve». Piuttosto erano entrambi massorù. Era quella badogliana un'adesione non certo legata a idee progressiste o filosofiche, perché l'uomo era di cultura limitata e disattento a tutto quello che non lo riguardasse. Era la massoneria interpretata all'italiana, l'associarsi dei deboli per diventare forti che abbiamo praticato dalle invasioni barbariche in poi, che ha alimentato tutti i nos tri particolarismi, guelfi e ghibellini, una consorteria in cui si distribuivano poltrone e si lavavano gli sbagli. L'eterna Italia mezzo mafiosa e mezzo «tengo famiglia » in cui l'astigiano respirava a pierù polmorù l'aria prediletta, quella dell'intrigo, del servilismo utile, della congiura. Capello era un genio militare, forse l'unico della storia italiana, ma aveva una concezione cianica della
solidarietà militare. Piazzava promozioni e incarichi a seconda delle sue necessità e Badoglio, pupillo delle gerarchie massoniche, gli era indispensabile.
Il Sabotino cadde. B'adoglio si mosse con determinazione feroce, riconosciamolo. Ma aveva talento soltanto quando era sotto la guida di un altro, era un perfetto esecutore. Come stratega rimase un sorpassato, credeva esclusivamente nella potenza dell'artiglieria e ancora nel 1940, a Balbo che invocava il soccorso di carri arma ti per poter affrontare gli inglesi nel deserto egiziano, rispose ch e li avrebbe frantumati con i cannoni. Cadde anche Gorizia, l'impero a u stroungarico tremò dalle fondamenta, g li alleati si s tupirono e per la prima volta l'Italia assaporò, in quella guerra così grigia e amara di lutti, il sapore della vittoria. li falso mito di Badoglio cominciò qui. Aveva r agione chi diceva che gli entrava in testa solo un'idea per volta. Badoglio, che era saltato in scena a lla vigilia dell'azione, si prese tutti i meriti di quella battaglia e divenne generale per meriti di guerra. La proposta di promozione la scrisse Capello di suo pugno e aveva toni che s i apparentavano a i commentari di Cesare: «Preparò e condusse a compimento la conquista del Sabotino che aprì la via alla vittoria di Gorizia. Questo motivo è tale che mi dispensa da l presentare qualsiasi rel azione a corredo». «Preparò»: Capello, non c ' è che dire, aveva nel mentire un bello stile.
L'equazione ormai era scoperta: mettere il suo protetto a capo di una operazione immediatamente alla v igilia assicurandogli così il merito dell'eventuale vittoria e sottraend olo alla deprecazione della sconfitta che sarebbe finita sulle spalle di coloro che l 'avevano preparata. Si ripeté nella decima battaglia dell'Isonzo che aveva come ambiziosi obiettivi il Vodice e il monte Santo sulla via, ahimè a noi sempre preclusa, di Trieste. Al Secondo corpo di armata toccava il compito di prendere il Kobilek e il Vodice, montagne maledette, che promettevano di ingoiare cadaveri almeno quanto il Sabotino . L'assa lto era sta to imbastito dal generale Garioni, sperimentato conduttore di u omini. Per s u a sfortuna l 'operazione sollevò le ambizioni di Badoglio che ormai non aveva più freni, voleva sa ltare le tappe come se avesse gli stivali delle sette legh e, si credeva il Napoleone del XX secolo. Questa volta volle sbriciolare il libro dei reco rd: tre avanzamenti di carriera in una sola volta, con un colpo di biliardo. C hiese a Cap ello. Ottenne. «Per imprevedute circostanze» fu scritto nel rapporto a lla vigilia dell'azione «rimase scoperto il comando del corpo di armata a cui era affidato il compito più arduo.» Garioni fu

spedito nelle retrovie mentre i suoi soldati si può dire stavano ormai in trincea con lo schioppo carico e le bombe a mano in tasca.
Era anche fortunato il nostro carrierista. Imbarcato in operazioni di cui non sapeva nulla, trovava sempre sottoposti encomiabili che poi naturalmente venivano dimenticati nei resoconti, gente eroica che faceva il lavoro, si sacrificava sui reticolati. Sul Vodice toccò al generale Maurizio Gonzaga dimostrarsi erede non immemore di una stirpe di condottieri e di santi guidando fanaticamente la sua divisione per consentire a Badoglio di salire ai fasti di generale comandante di corpo di armata. Anche qui il suo Tirteo fu naturalmente Capello; ci adesca ancor oggi con la sua prosa, noi che sappiamo: «Ogni parola di elogio mi sembra superflua poich é tutte le qualità di un comandante di grande valore si sono riunite in lui, in una felice fusione».
Ecco la vigilia del 24 ottobre 1917, sentiamo sull'Isonzo gli scricchiolii della catastrofe. Qui ci dovremmo fare profeti e aedi per vituperare a sufficienza, vendicare almeno a parole le vittime dell'assassino. La memoria è la nostra unica arma; lui ha cercato di strapparcela . Il generale che secondo Capello disponeva «dell'illuminato coraggio morale che affronta sereno le più grandi responsabilità» disponeva anche di una straordinaria abilità nel riscri vere la storia a suo uso e consumo. Lui, che coltivava le sue virtù militari fuori moda e si faceva un dovere di essere antiquato, qui era modernissimo, un precursore. Come gli antichi despoti del Nilo si esercitava a scalpellare i cartig li incisi sulla pietra per lasciare ai secoli solo la sua definitiva versione dei fatti e far scomparire nel silenzio chi poteva dargli torto. Nel primo dopoguerra affidò questo delicato compito a un'opera, l..a guerra sul fronte italiano, curata dall'ufficio storico dello stato maggiore, peraltro autore di studi serissimi e meritori, che doveva essere la Treccani della nostra vittoria. Collaborava anche a fornire la vulgata aristotelica e definitiva, per i secoli a venire, dei nostri sublimi quattro anni la prefazione di un combattente di rilievo: Benito Mussolini. In quel periodo Badoglio era il potente capo di s tato maggiore. Un dettaglio decisivo, voi capirete, per giungere all'assoluto e radicarsi. Ne venne fuori un'opera dove il suo ruolo scavalcava quello di Cadorna, Diaz e di tutti gli altri vincitori . Facciamola breve: per tutti, la guerra mondiale l'aveva vinta lui. Mentre ci metteva le mani, Badoglio provvide a una correzione topografica destinata ad avere fortuna. Gli bastò per cancellare d'un sol colpo la scomoda verità che il disastro si era verificato proprio nel settore del fronte che era affidato ai guizzi della sua «me nte chia-

ra equilibrata e precisa nutrita da solidi studi tecnici e raffermatasi alla viva pratica delle cose».
Oggi Caporetto, Plezzo, Tolrnino hanno nomi diversi e piange il cuore g irare in quei luogru che non sono nemmeno più italiani pensando a quanti ciclopici e inutili sacrifici sono costati a una generaz ione che si accinse all'opera con incrollabile entusiasmo. Anche se poi hanno cercato di attribuirle dubbi e resis tenze, quasi il patriottismo fosse una colpa. Confessiamolo: era comodo dare addosso al solito Cadorna, come si faceva fino a ieri. Le prove s ono scruaccianti. Il crollo avvenne tra Plezzo e Tolmino dove stava appunto il Ventisettesimo corpo di armata di Badoglio, con le mostrine di genera le ancora luccicanti. Apertasi la strada n ella vall e dell'Isonzo, le armate a u strotedesche dilagarono poi verso Caporetto e presero alle spa lle il Quarto corpo di armata di Alberto Cavacioccru. Fu proprio Badoglio che suggerì, anzi impose ai compilatori del libro, di cruamare Caporetto la battaglia che gli austriaci definiscono dodicesima battaglia dell'Isonzo. Tale rimase nei secoli allontanando il suo nome da così spiacevoH e pericolose circostanze. Cavacioccru con quel macigno sulla schien a finì davanti alla commissione d'inchiesta e fu condannato, Badoglio, come vedremo, divenne v icecapo di stato maggiore dell'esercito ed entrò a vele spiegate nel pantheon dei vincitori . Non ha fo rse definito la Treccan.i questa disfatta come «un r ipiegamento affrettato»? Nessuno ha sintetizzato come il genera le Angelo Gatti con tanta efficacia l'imbroglio:
Due uomini sono p osti a guardia d i una stanza, uno alla porta, l' a ltro alla finestra : mentre quello alla finestra si difende come può dagli assalti della strada, il compagno d ella porta lascia e ntrare il ne mico che butta nella via l'affaccendato difensore della finestra; e questi ha il danno e le beffe, e l'altro le lodi e gli onori. Tale è in breve la curiosa storia dei generali Badoglio e Cavaciocchl, che ha da to orig ine a molti scritti, e sarà giudicata quando la storia prenderà il pos to d e lle commissioni di inchiesta.
Ancora una volta, dunque, a BadogHo era toccato di trovarsi nel cuore della battaglia . Poteva raccogliere nuova gloria, dobbiamo invece seguire una s t oria di tristi vergogne, di piccole vil t à. In mano, per scongiu rare quello che sa rebbe diventato il «dì nefasto», aveva una forza imponente: q u attro divisioni, una add irittura rinforzata quasi a sfiorare da sola il corpo di armata (ottantaduemila soldati e duemilasettecento u fficiali) , gente solida, ve t e rani, e ben ottocento cannoni, i suoi amatissimi cannoni . Sapeva il pericolo che stava per avventarsi addosso alle sue Hnee e le contromisure giust e. La prima circolare di Capello che lo invitava a riconoscere le posizioni difensi-

ve in vi sta di un possibile attacco dalla testa di ponte di Tolmino è del 30 settembre . Il 9 e il 17 ottobre gli spiegarono a menadito lo svolgimento dell'assalto nemico «con carattere probabilmente risolutivo». Lo portarono per mano risalendo valle dopo valle, monte dopo monte, i luoghi che il piano tedesco trasformò poi nella nostra disfatta . Cadoma e la II arma ta lo avevano colmato di messaggi con le disposizioni tattiche: spostare le forze sulla destra dell'Isonzo per sbarrare la strada nel punto di pressione dell ' avversario ed evitare che cadessero in trappola. Soprattutto rispondere con il tiro di controbatteria fin dal primo rombo del cannone nemico in modo da inchiodare le divisioni di assalto, acquattate in prima linea, prima che potessero saltare fuori dalle trincee. li messaggio che Capello scrisse a Badoglio il 23 poteva firmarlo lo stratega tedesco che stava m ettendo le virgole ai piani di attacco:
Sembra accertato che il nemico dopo quattro ore di ti.ro con gas asfi ss ianti eseguirà un'ora e mezza circa di fuoco tambureggiante. Per sferrare l'attacco dopo cinque ore e mezza di fuoco le truppe nemiche devono essere molto serrate nelle prime linee. Noi terremo presente questa circostanza per aprire un fuoco di contropreparazione appena il nemico accenni a muoversi o meglio appena si abbia indizio che il nemico accenni a muoversi.
E Badoglio? li 19 ottobre arrivarono al suo comando due colonnelli, Testa e Calcagno, spediti dal comando supremo per controllare. li generale ostentò lo scetticismo insofferente del grande stratega. Secondo lui l'offensiva nemica era più nelle voci che nelle intenzioni degli austriaci. Comunque era tranquillissimo. Gli austriaci li voleva perseguitare, tiranneggiarli, chiuderli in un vicolo cieco, costringerli a percorrere tutte le fasi dell'agonia. «Tutto quanto aveva richiesto gli era stato dato subito ed era molto soddisfatto dello stato morale delle truppe. » Al massimo se proprio avanzavano mitragliatrici da altri fronti le mandassero! I due colonnell i tornarono al comando sfregandosi le mani e riferirono che a Tolmino c'era una roccia. Di Il gli austriaci non sa rebbero certo p assa ti. Badoglio lo aveva ripetuto anche a una compagnia dei suoi soldati, incontrata per strada. Aveva dato l 'alt, passato in rivista e poi aveva annunciato che gl i austriaci li avrebbero tra breve attaccati: «Ma niente paura r agazzi! Gliele daremo secche. Ho tanti cannoni da fracassarli prima che arrivino a lle nostre linee». E un caporale si era fatto avanti g ri dando: «Generale, l asci perdere i cannoni. Bastiamo noi con le mitragliatrici». Poi, nell'ordine del giOfflO distribuito alle truppe, aveva aggiunto una notizia: correvano voci che fossero arrivati sul fronte italiano anche soldati tedeschi : «Questo significa che ci sarebbero stati anche
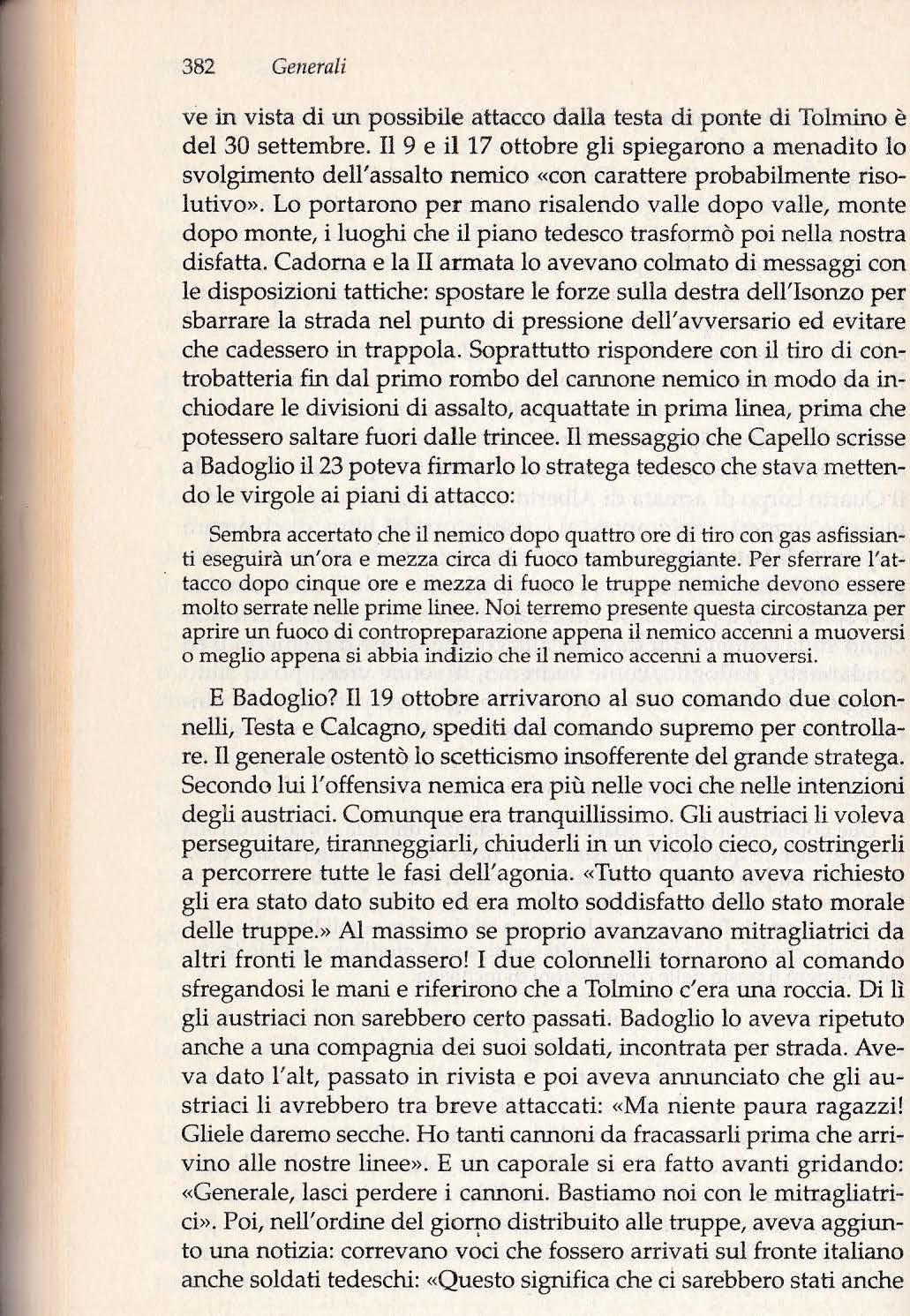
i berretti rossi dei crucchi tra i prigio nieri» . E il previdente generale, che pensava in grande, aveva già predisposto ampi alloggiamenti!
Nella g iovinezza il v incitore del Sabotino dove va aver letto il Manzoni e il s uo corp oso romanzo. G li era rimasta ben impressa la figura di quel condo tti ero, il Condé, ch e la sera prima della battag lia, infallibilmente andava a dormire e russava tranq u illo fino all 'alba, come se lo aspettasse una giornata in ufficio. A Badoglio era sembra ta una bella immagine da consegnare agli estensori delle sue biografie. Aveva copia t o. Alle dieci ogni sera riponeva sulla sedia medaglie e ch epì, affidava g li stivali all ' atte ndente e ovunque fosse si metteva sotto le coperte. Visto che era sicuro dj v incere applicò la ferrea liturgia del pisolino anche quel 23 ottob re. Non senza aver prima disobbed ito al comand o un paio di volte . Lasciò le truppe s ulla riva sinistra d e l fiume e intimò al capo della s u a artiglieria che, sembr a una barzelletta, si chiamava Cannoniere, cli non fa r nulla fino a quando lw stesso, Badoglio, non aves se o rdinato cli dar fiato al coro degli ottocen to cannoni!
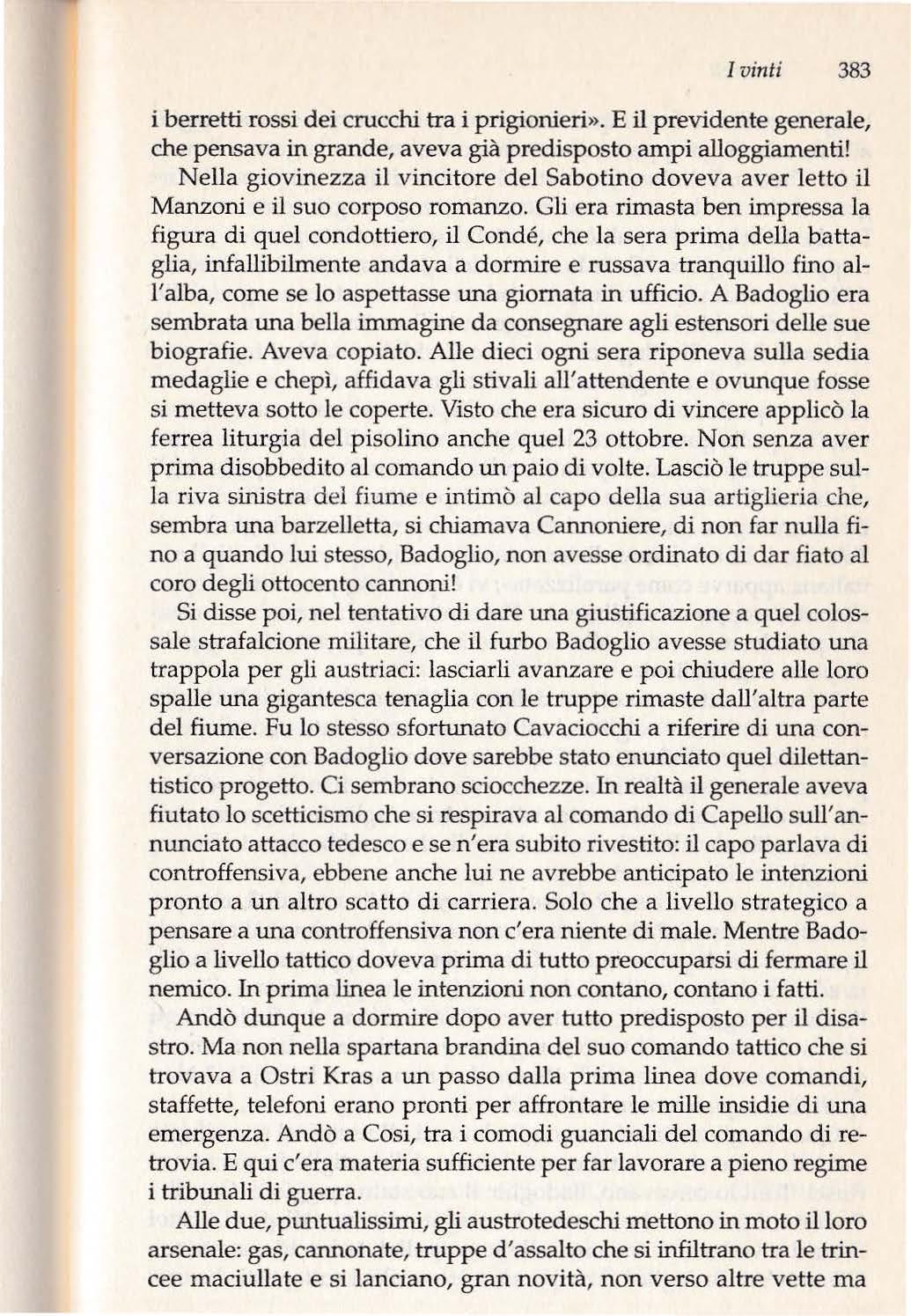
Si clisse poi, nel tentativo cli dare una giustificazion e a quel colossale s trafalcione militare, che il furbo Badoglio avesse studiato una trappola per gli austriaci: lasciarli avanzare e poi chiudere alle loro spalle una gigan tesca tenaglia con l e truppe rimas te dall'altra parte del fiume . Fu lo stesso sfortuna to Cavaciocchi a rife rire di una conve r sazion e con Badoglio dove sarebbe stato enunciato quel clil etta ntistico progetto. Ci sembrano sciocchezze. In realtà il generale aveva fiutato lo scetticismo che si respirava al comando di Capello s ull'annuncia to attacco tedesco e se n 'er a subi to rivestito: il capo parlava di controffensiva , ebbene anche lw n e avrebbe anticipato le intenzioni pronto a un a ltro sca tto di carriera. Solo che a livello strat egico a pensare a una controffensiva non c'era niente cli male. Mentre Badog lio a livello tattico doveva prima cli tutto preoccuparsi di fermare il nemko. In prima linea le intenzioru n on contano, contano i fatti.
Andò dunque a dormire dopo aver tutto preclisposto per il dfaas tro. Ma non nella s p ar tana brandina del s u o comando tattico che si trovava a Ostr i Kras a un passo d alla prima linea dove comandi, s taffette, telefoni e r ano pronti p er affrontare l e mille insidie di una emergenza. Andò a Cosi, tra i comodi guanciali d el comando cli retrovia . E qui c'era materia sufficiente per far lavo rare a pieno regime i tribunali di guerra.
Alle due, puntua];ssirni, gli au strotedeschi m ettono in moto il loro arsenale: gas, cannonate, truppe d ' assal to che si infiltrano tra le trincee maciullate e si lanciano, gran n ovità, non verso altre vet te ma
lungo le valli che fino a quel momento erano riservate ai carriaggi e alle furerie. Si galoppa, si divora la strada, sembra la guerra di una volta: Plezzo, Tolmino, Caporetto, la stretta dj Foni e il passo di Zagradan che sembravano inavvicinabili vengono giù come cartone. Perché la brigata Napoli è stata mal disposta, tutta protesa per la trappola badogliana. Cade la testata dello Judrio e ormaj le divisioni dello sfortunato Quarto corpo, condannato a morte, sono prese alle spalle con il chlodo su cui si regge tutto il nostro schleramento, la stre tta di Saga. Si dilaga ormai verso Cividale, i soldati ingoiano i chllometri, le dita degli austriaci affondano nel burro e si chledono se è vero quello che sta succedendo. Già, si è verificata una cosa mai vista in quella guerra in cui le artiglierie sono l'alfa e l'omega . I cannoni i taliaru non hanno sparato e adesso sono ormai alle spalle degli attaccanti : inutilizzati. Lo stratega di Caporetto, il tedesco Krafft von Dellmensingen, ancora anni dopo non sapeva farsene ragione: «A Tolmino il fuoco ili interdizione mancò completamente, l'artiglieria italiana apparve come paralizzata»; vi è quasi troppo ordine, troppo silenzio, troppo raccoglimento. Raccontava con un mezzo sorriso che per alcune ore davvero aveva temuto una gigantesca trappol a da parte degli italiani.
Invece gli ottocento ottoni della mortifera orchestra ili Badoglio rimasero zitti come se gli orchestrali avessero Wziato uno sciopero. Il silenzio, ecco il silenzio di Caporetto: come disse con ingenuo stupore un testimone all'imbarazzata commjssione di inchlesta: «Silenzio assoluto, impressionante delle nostre artiglierie di grosso e di medio calibro» . Altro che controbatteria che avrebbe dovuto fracassare gli incauti assalitori.
Che cosa era successo? Forse una formidabile assurdità, una parossistica anomalia? Con le cannonate austriache erano saltati i collegamenti con le prime linee, e Cannoniere, che apparteneva alla folta schiera di quei militari che hanno bisogno per pensare di aver l'ordine, magari scritto, si attenne all'intimazione che Badoglio gli aveva dato con quel tono arrogante e sussiegoso che assumeva quando si vestiva da condottiero: «Lei non spari, ha capito? Non spari fino a quando non lo dico io!».
Quando gli austriaci erano già davanti all'uscio del suo rifugio cercò di mettersi in contatto con il titano delle artiglierie, ma non ci riuscì. Tutti lo cercavano, Badoglio: il suo stato maggiore, Capello, Cadoma, i generali che avevano la sciagura dj essere disposti ai suoi fianchl e vedevano arrivare, alle loro spalle!, tedeschl e austri aci. Già, dov ' era Badoglio? Scomparso, introvabile. I sottoposti che era-
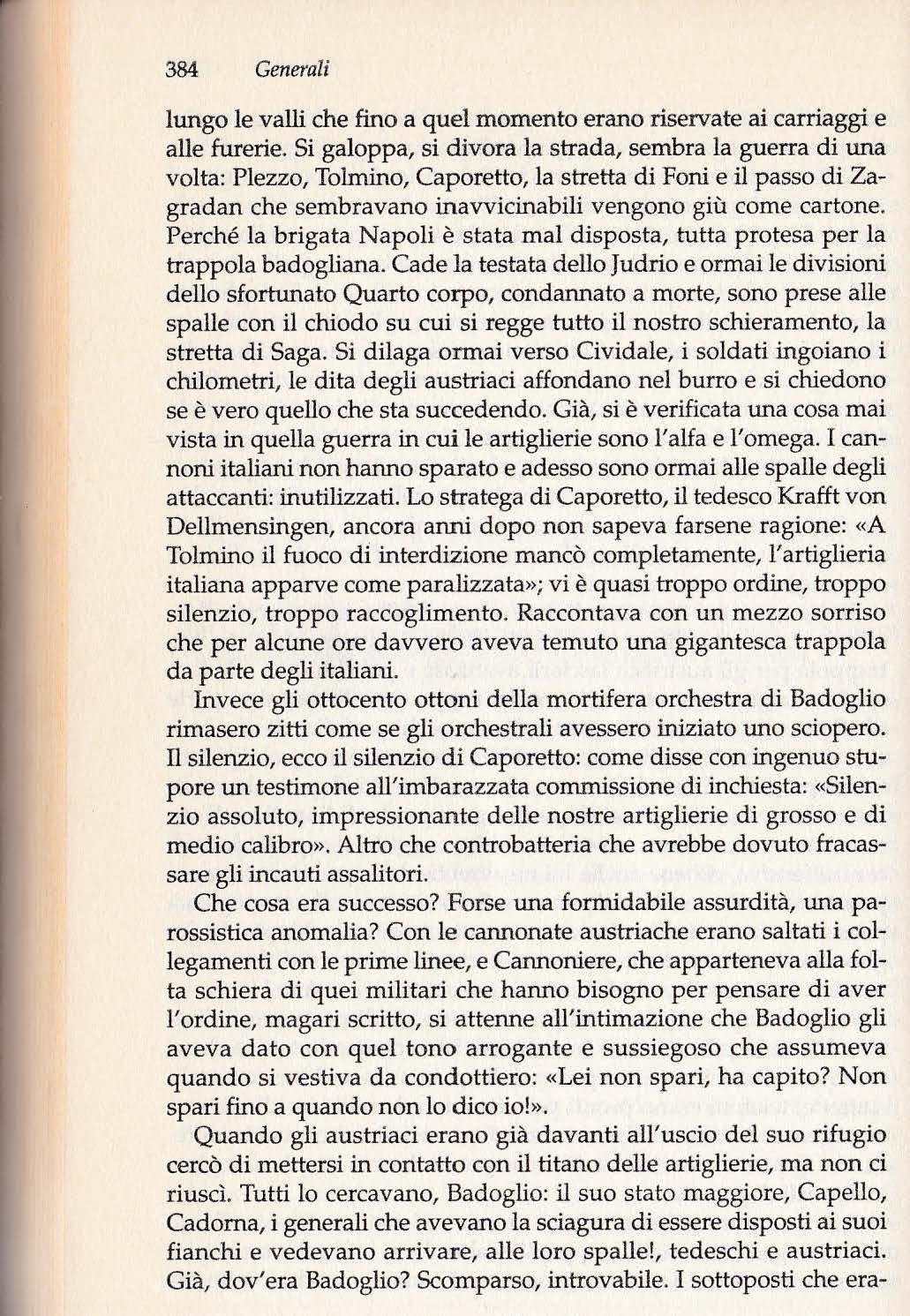
no già sotto le bombe non sapevano che fare, come impiegare le riserve, le notizie dalle divisioni arrivavano già gonfiate da voci, dicerie incontrollate, leggende. Si parlava di reggimenti che si erano arresi in massa (e non era vero), di altri che contrattaccavano nel vuoto o si facevano massacrare sul posto (ed era vero); che il quartier generale del Ventisettesimo corpo «aveva tagliato la corda» (ed era verosimile). A un certo punto i comandanti di divisione e di reggimento chlesero a Caviglia di essere incorporati nelle sue truppe e fecero bene; quel generale li condusse, combattendo e manovrando, quasi intatti fino alla linea di resistenza.
Badoglio, come tutti i colpevoli dei delitti perfetti, è riuscito a distruggere le prove. Sono state stralciate e strappate su ordine del governo le pagine della commissione d'inchlesta che lo riguardavano. Le ha fatte sostituire nel dopoguerra con la leggenda diffusa da alcuni sicofanti che aveva passato alcune ore a raccogliere i fuggiaschl con la pistola in pugno (c' era il famos o sciopero militare) guidando eroicamente i contrattacchl.
Siamo diventati, ripercorrendo un secolo di turpitudini, più asciutti e più duri. Si è già formato un callo. Non ci accontentiamo. Dopo una notte spaventata da raffiche e solcata ormai dal nemico, dilapidata ad abbaiare ordini a telefoni che restavano muti e a spedire ufficiali che non tornavano indietro, alle dieci si mise in marcia verso il suo comando, quello ormai sommerso dalla piena d e i fuggiaschl e dei vincitori. L'auto si ammazzava di fatica, a un certo punto fu necessario abbandonarla; piovevano cannonate e la via era ingombra di reparti in ritirata. Il gruppetto di alti ufficiali aveva perso lo stile e la baldanza, si immergeva a ogni curva un poco di più nel disastro. Si chledevano informazioni ai fuggiaschl ed erano stilettate, annunci funebri: reparti massacrati, fughe in massa, paesi già nelle mani del nemico, cannoni abbandonati con il proiettile in canna che non si era nemmeno fatto in tempo a rendere inutilizzabili. I superstiti, con la mania di quelli che sono sfuggiti a una grande disgrazia, sembravano metterci impegno nel colorire i particolari, nel trascinarli di fronte a ecatombe e vergogne. Badoglio isterico ogni tanto urlava il nome di qualche località dove erano, una volta, comandi di divisione. Il gruppo si incamminava come fosse sta to pronunciato il nome della salvezza . Si aggiravano in quelle onde in traccia dj una direzione. Pochl me tri e poi si era bloccati dalla piena, dall' interminabile traffico di armati e disarmati. A un certo punto tirò fuori davvero la pistola per fermare un gruppo di sbandati. Uno di loro senza degnarlo nemmeno di uno sguardo gli urlò: «Va' a morì ammazza-
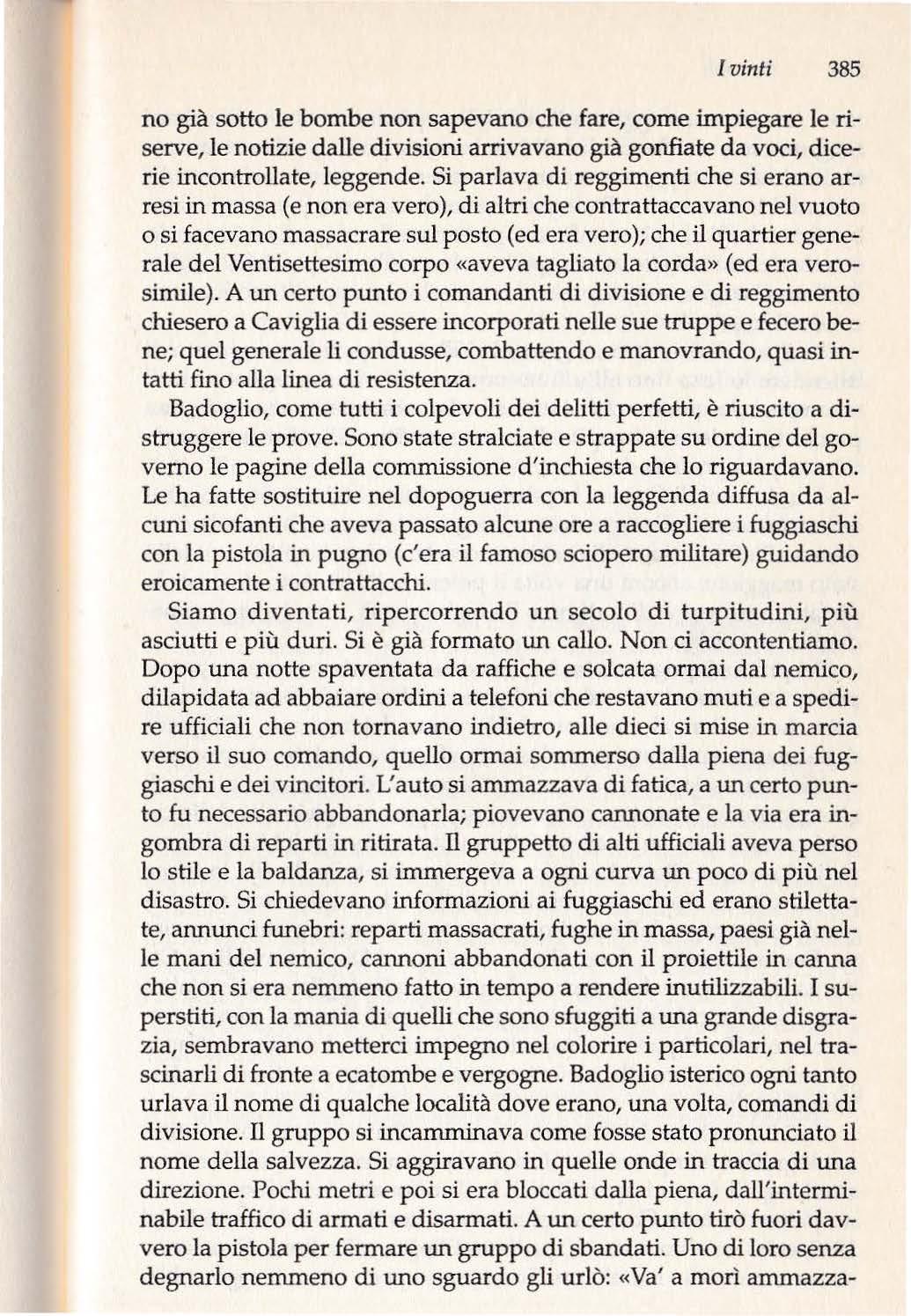
to». L'autista era fuggito, gli ufficiali appiedati anche nell ' animo, raggiunsero a sera la località di Lambresco e poi Liga, dove trovarono finalmente truppe ancora orgaruzzate e contatti con armate e divisioru. Lì, si racconta, Badoglio che sembra avesse perso nel trambusto anche il chepì, si inferocì: pensava alla «figura» non per lo strazio dei soldati che aveva spedito al macello ma perché Caviglia, l'odiato Caviglia, aveva preso il comando dei superstiti e li aveva condotti in salvo!
Per il suo divisionario, il generale Villaru, che gli aveva giurato di difendere lo Jeza fino all'ultimo uomo e che rimase tagliato fuori, sommerso da quattro divisioni nemiche, non spese nemmeno una parola. Quando aveva capito di essere sconfitto Villaru si era sparato in testa per non arrendersi.
«L'indomaru di Canne» lo passò a scatenare i talenti d e i suoi protettori massoruci. Emerse da quei negoziati, invece che con la condanna alla fucilazione alla schiena, con la carica di sottocapo dello s tato maggiore: ancora una volta il potere politico, sotto choc per la disfatta, non seppe dire di no e Badoglio passò, armi bagagli e medaglie, tra i vincitori.
Del primo dopoguerra badogliano basta ricordare come seppe sup erare manovrando con abilità il pericolo di una Caporetto carrieristica che lo sfiorò al momento dell'avvento del fascismo. Nei giorru della marcia su Roma si era lasciato sfuggire qualche espressione malaccorta, assicurando che se il re l'avesse ordinato, con un paio di schioppettate l'esercito avrebbe messo a posto la plebaglia delle camicie nere. Frase che ne aveva fatto subito agli occhi di Mussolini un pericoloso oppositore. La carica di ambasciatore in Brasile lo tenne per un poco al riparo da quei chiari di luna da cui riemerse trionfalmente come capo dell'esercito e garante della sua mussolinizzazione. Era inevitabile. Il duce, allora, aveva per i Diaz, i Caviglia, i Cadoma le tirrudezze della recluta. Intuiva che Badoglio era di un' altra pasta: servile, obbediente fino a quando i suoi interessi coincidevano con quelli del padrone, soprattutto ricattabile. I dossier su Caporetto che conosceva alla perfezione erano sempre pronti per renderlo malleabile.
Così il marchese del Sabotino si accomodò nel regime con sontuosa magruficenza ripromettendosi di sfruttarne con scrupolo le corruzioru, i goffi furori imperialistici, le sbruffonate che si fermavano a un passo dai fatti. Come un parassita, secondo i vecchi metodi del 1915, rubò un' altra vittoria, quella in Etiopia, a De Bono. Si colgono strane simmetrie. I suoi anru Trenta sono poco altro. Bisognerebbe

citare conti in banca, cariche, stipendi, buoni del Tesoro, investimenti . Era un milionario di regime. Inventò, nell'infinita galleria della burocrazia italiana, una nuova versione, maggiorata, del cumulo delle cariche. Ogni volta che veniva destinato a un nuovo incarico, pretendeva di conservare anche gli emolumenti di quelli precedenti. Alla fine i suoi stipendi erano antologie. Quando venne nominato maresciallo d'Italia si portò dietro a catena il gruzzolo milionario di governatore della Libia, l' indennità di capo di stato maggiore generale e ancora, dice qualcuno, persino il gruzzolo di ambasciatore. Sinfonia sublime dei diritti acquisiti! Ragionava con l'avarizia del verghiano don Gesualdo, con l'avidità del contadino piemontese che vive con il terrore di una grandinata che gli distrugga la vigna e l'orto. Eppure guadagnava un milione al mese. Ai tempi in cui mille lire erano l'ammontare dei sogni da lotte ria.
Le lettere al duce sono l' abc d el cortigiano, sempre stracolme della «più completa e a ssoluta devozione». I piaceri che chiede sono invariabilmente d ello s tesso tipo:

Mi sono p ermesso di rivolge rmi alla Eccellenza Vostra p e rché mi proponesse a Sua Maestà il Re per la concessione di un titolo nobiliare estensibile ai figli e riferentesi a lla mia azione sul Sabotino. Sarei gratiss imo a Vostra Eccellenza se mi volesse confermare quanto io ho l ' onore di scriverle in questa lettera.
Lo ebbe, il titolo, e anche case e proprietà che gli venivano regalate dalla «riconoscenza del paese». Caviglia, invece, il palazzo a Finale se lo comprò con i risparmi e poi dove tte anche raccomandarsi all ' ufficio delle tasse affinché, rimasto senza una lira, non lo stritolasse! A Badoglio in realtà l e m e daglie non interessavano, erano patacche. Quello che voleva erano soldi, conti in banca, milioni. Dopo la conquista di Addis Abeba, iniziò una battaglia non meno aspra di quella condotta con il negus p er ottenere una lussuosa residenza a Roma di cui sembrava avesse bisogno come un profugo. Questo è l' uomo che ebbe il coraggio di scrivere a proposito dell ' ingresso in guerra dell ' Italia nel 1940: Così, con l'animo straziato da funesti presentimenti, iniziai la dura via d e l mio calvario che disgraziatamente era pure il calvario di tutta la nazione. Proprio lui che aveva sempre approvato tutte le decisioni del duce «con spirito fascista », salvo poi subdolamente irriderle ma soltanto nelle conversazioni con i suoi fedelissimi. Non si sa mai! Era il violinismo: esagerare nel dire bene, e il male lo si dice in sordina, che è peggio.
Alle otto del mattino del 25 luglio 1943 Badoglio accompagnato da un altro generale, uno di quelli fedelissimi, Valenzano, è nello studio del re a Villa Savoia. Il suo «calvario» sta per finire; purtroppo non quello d ell' Italia, che è appena all' inizio. Da tempo, da quando Mussolini lo ha licenziato esasp erato per la grottesca sconfitta in Grecia, non indossa più la divisa e ha messo su pancia. Nelle memorie descrive rà così il momento supremo:
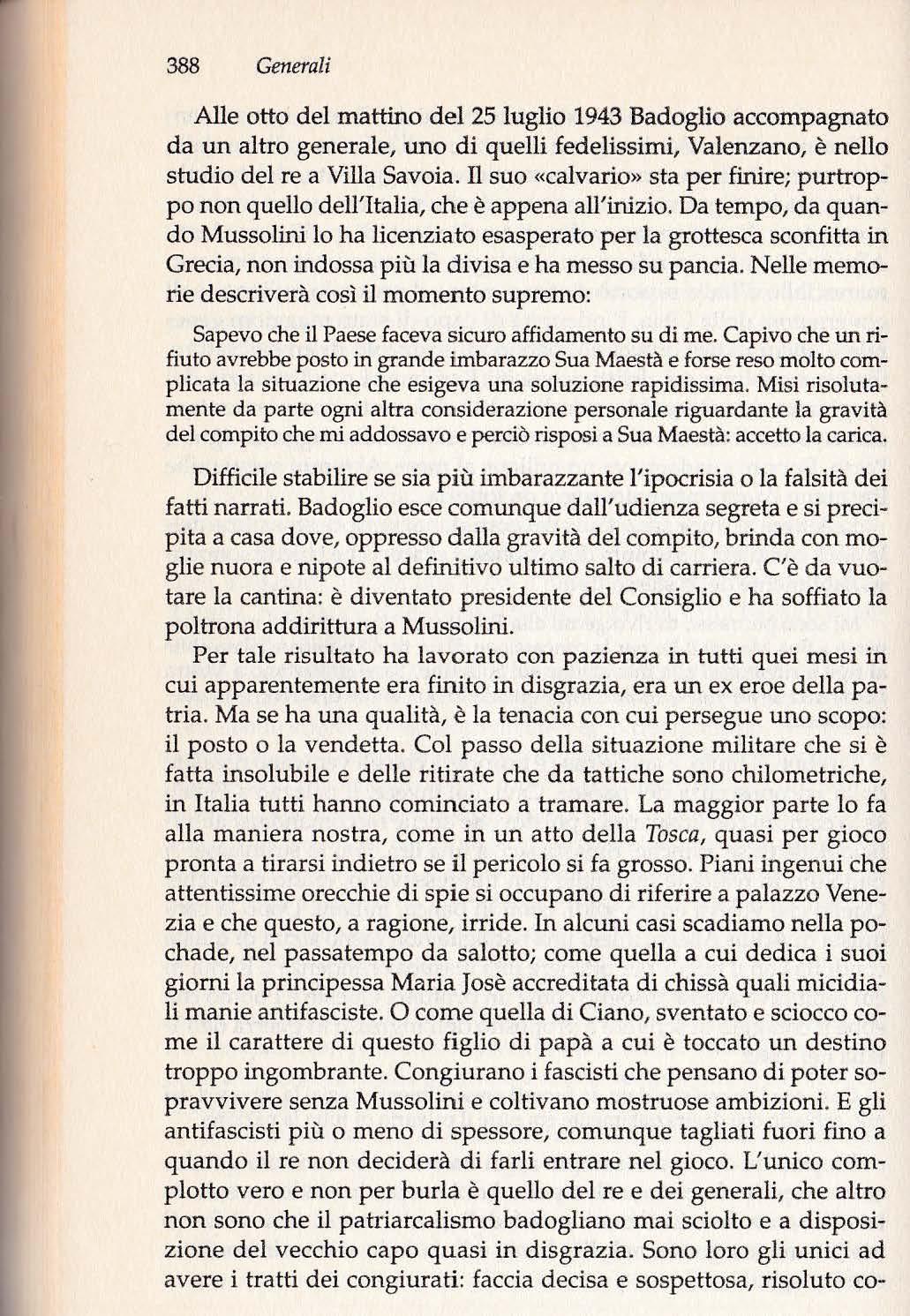
Sapevo che il Paese faceva s icuro affidamento s u di me. Capivo che un rifiuto avrebbe posto in grande imbarazzo Sua Maestà e forse reso molto complicata la s itua zione che esigeva una soluzione rapidissima . Misi risolutamente da parte ogni altra considerazione personale riguardante la gravità del compito che mi addossavo e perciò risposi a Sua Maestà : accetto la carica.
Difficile s tabilire se sia più imbarazzante l 'ipocrisia o la falsità dei fatti narrati. Badoglio esce comunque dall'udienza segr eta e s i precipita a casa dove, oppresso dalla gravi tà del compito, brinda con mog lie nuora e nipote al definitivo ultimo salto di carriera. C'è da vuotare la cantina: è diven t a to presidente del Cons ig lio e ha soffiato la poltrona addirittura a Musso lini .
Per tale ris ultato h a lavorato con paz ienza in tutti quei mesi in cui apparentemente era finito in d isgrazia, era un ex eroe della patria. Ma se ha una qualità, è la tenacia con cui persegue uno scopo: il posto o la vende tta. Col passo della situ azione militare che si è fatta insolubile e delle ritirate che da t a ttiche sono chilometriche, in Italia tutti hanno comincia t o a tra mare. La maggio r parte l o fa alla maniera nostra, come in un a tto della Tosca, quasi per gioco pronta a ti rarsi indietro se il pericolo s i fa grosso. Piani ingen ui che attentissime o recchie di spie s i o ccupano di riferire a palazzo Venezia e che questo, a r agione, irride. In alcuni cas i scadiamo nella pochade, n el passatempo da salotto; come q u e lla a cui dedica i s uoi giorni la principessa Maria Josè accreditata di chissà quali micidiali manie antifasciste. O com e quella d i Ciano, sventa to e sciocco come il carattere di questo figlio di papà a cui è toccato un destino tro ppo ingombrante. Congiurano i fascisti che pensano di poter sopravv ivere senza Mussolini e coltivano mostruose ambizioni. E g li a ntifascisti più o m eno di spessore, comunque tagliati fuori fino a quand o il re non deciderà di farli entrar e n e l g ioco . L'unico compl o tto vero e non p er burla è quello del re e dei generali, ch e altro n o n sono che il patria rcalismo badogliano mai sciolto e a disposiz io n e del vecchio capo quasi in disgrazia. Sono loro g li unici ad ave re i tratti dei con giurati: faccia decisa e sospe ttosa, risoluto co-
raggio, implacabilità nelle decisioni. Il maresciallo ha detto loro quando è entrato in quella che lui chiama la «morta gora»: «Voi preparate tutto agendo come una carboneria, e pensate a me come Capo». Quando le cose vanno male è all'esercito che si dà la colpa, quando vanno molto male è l'esercito il rimedio. Le cose per noi andavano malissimo. I nomi di questo serpaio sono noti : il generale Gustavo Pesenti, per esempio, uno che aveva suggerito al duca d'Aosta già nel 1940 di passare agli inglesi e di marciare su Roma con le nuove bandiere, e non aveva mosso un dito per difendere la Somalia, badogliano fervidissimo. Si racconta che quando gli inglesi travolse ro le nostre truppe sul Giuba il comandante, che le aveva abbandonate al loro destino senza ordini in stile Caporetto, fu l'ultimo che venne a saperlo. Non lo hanno fucilato, purtroppo. Come una formica allignò e prosperò in ogni teoria cospirativa, come in una s erra; tenne contatti con Vaticano, Alleati, vertici militari, con il maresciallo Caviglia che avevano tirato dentro il complotto solo per poterne spendere l' autorità ma già decisi a scaricarlo al momento giusto: temevano la concorrenza . Salendo più in alto c'è Vittorio Ambrosio, militare tutto di un pezzo anche quando è in pigiama dice qualcuno, in realtà autentica tempra del congiurato. Ha garantito poche settimane prima a Mussolini che chiunque si azzarderà a sbarcare in Sicilia «avrà le mani stroncate e che anche se l'e sercito dovesse ridursi alla Pianura Padana continuerà a combattere con ferocia». Sta lavorando come un forsennato per attuare un gigantesco sciopero militare: in Sicilia la maggioranza dei reparti italiarù si arrende senza combattere, generali lasciano i tedeschi da soli e corrono ad arrendersi . Augusta non viene difesa, una vergogna militare, Palermo e Trapani cadono senza combattere, armi e muniziorù vengono distrutte nei presidi quando il nemico è ancora lontano. La marina ormai rintanata nei porti stranamente viene ignorata dall'aviazione nemica attivissima a sbrindellare le città italiane. A riprova che i sospetti di intese e tradimenti forse non furono solo fantasie di fissati della dietrologia. Ambrosio viene nominato capo di stato maggiore, al comando dei carabinieri su richiesta di Badoglio arriva un suo ex sottoposto della campagna d'Africa; Giacomo Carborù, nominato sul tamburo generale di corpo d'armata, prende l'incarico della difesa di Roma. Tutti i tasselli sono a posto. Alle diciassette e venti del 25 luglio la congiura trionfa con l'arresto di Mussolirù. Urùco piccolo neo lo sdegno della regina a cui forse non hanno spiegato le disinvolte abitudini dei Savoia quando devono salvare pelle e trono. Quello che il re defirùsce
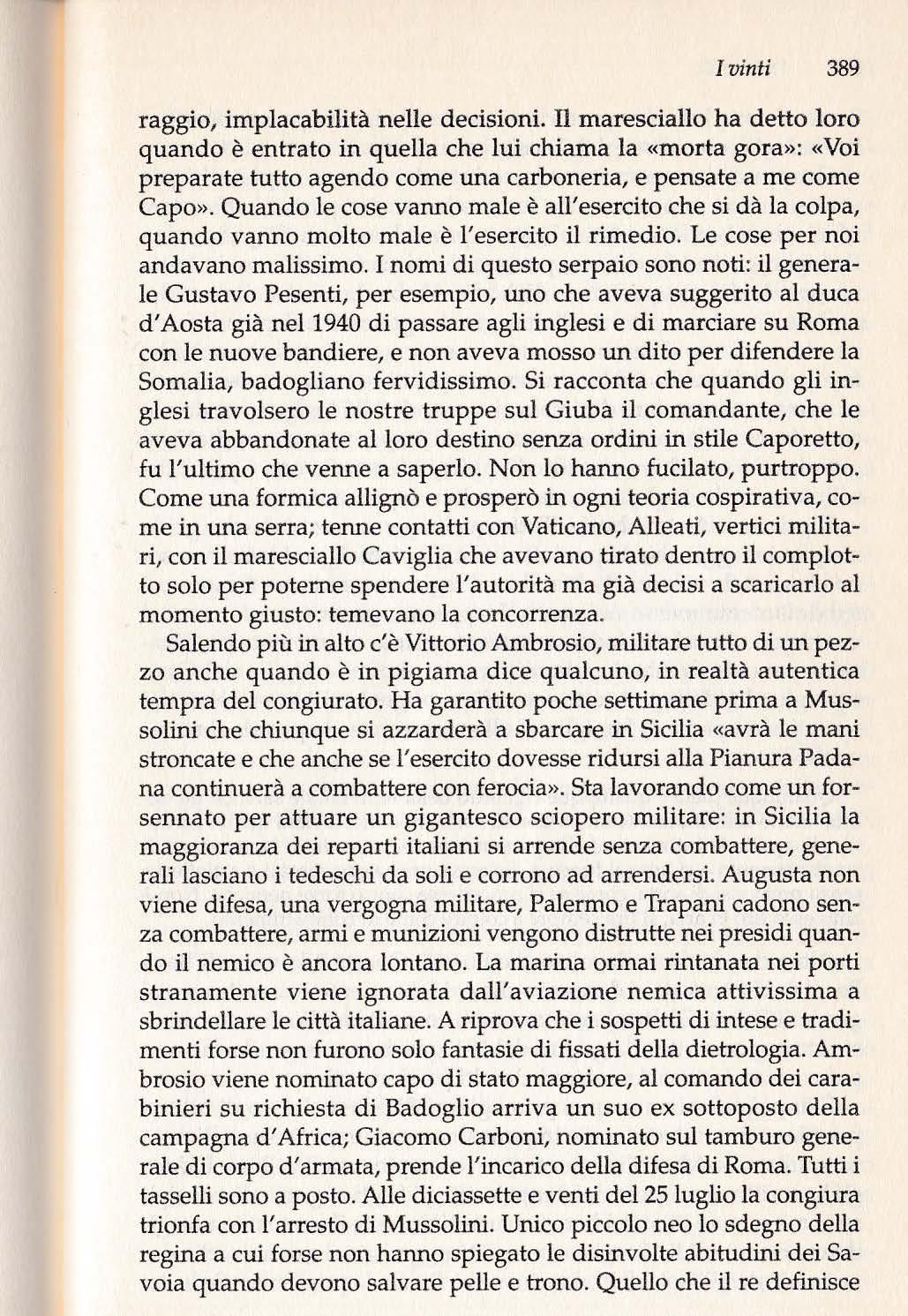
il suo diciotto brumaio partorisce sua eccellenza il maresciallo d'Italia Badoglio presid ente del Consiglio; anzi di più: nuovo dittatore. Gruppi di immemori che la caduta d e i tiranni applauditi per vent'anni non può essere una festa, sciamano in piazza a devas tare uffici e bruciare labari fino al giorno prima benedetti. Si grida «viva Badoglio»; viene da ridere a pensare che si sia formato così in fretta un partito del conquistatore di Addis Abeba. Lo s mantellatore del regime riceve compiaciuto l'omaggio d e i gerarchi e degli antifascisti, che si danno il cambio in anticamera cercando rassicurazioni e favori. Poi dà subito un luminoso esempio di come concepisce itempi nuovi, una circolare diramata ai comandi il 26 luglio, quando ancora l'eco dell'annuncio storico non si è spento e mezza Italia si guarda allo s p ecchio cercando di capire, adesso che non è più mussoliniana ma badogliana, se deve esultare o preoccuparsi.
Il primo ministro sbuffa. Tutta que lla gente in strada che grida strepita inneggia chiede punizioni non gli piace. Il problema non sono i fascisti, la volontà di difendere il regime e vendicare il capo così subdolamente messo nel sacco. L'apparato guerriero e feroce del ventennio si è sciolto indecorosamente con le ultime note di Giovinezza suonate da una banda militare in piazza la vigilia del Gran consiglio. I fed e lissimi tutto mascella e pugnale si sono rivelati dei sensatissimi padri di famiglia. E allora con chi se la prende il maresciallo?
Qualunque pietà e qualunque riguardo ne lla repressione sarebbe un delitto. Siano assolutamente abband onati i sistemi antidiluviani quali i cordoni, gli squilli, le intimazioni e la persuasione. Si proceda in formazione d i combattimento e si apra il fu oco a distanza, anche con mo rtai e artiglierie, senza preavvisi di sorta, come se si procedesse contro forze nemiche. N on è ammesso tiro in a ria, si tira sempre a colpire come in combattimento.
Altro che democraz ia, altro che libertà. Questa è la voce di Bava Beccaris che scavalca i decenni e che evidentemente è rimasta cara ai generali del re. D'altra parte un uomo come Badoglio che era rimas to strategicamente alla guerra del 1915, anche come gend arme non poteva aver fatto, n el ventennio, molti passi avanti.
È impegnatissimo in quei primi g iorni di potere. Prima di tutto a prendersi le vendette, come impone il suo carattere che non dimentica nulla. Con Mussolini, per fare un esempio, usa il velluto. Il duce gli ha scritto una lettera deferente in cui gli fa gli auguri e dà consigli s u come salvare l'Italia. I benefici lucrati durante il ventennio n on gli danno rimorsi. Alla Borgia, con levità suggerisce al gen erale, che d eve condurlo all'isola di Ponza dove si è fissata la prigionia: «Se le ca-

pita dia una spintarella a Mussolini, una spintarella potrebbe risolvere tutto». Con altri invece tira fuori il ghigno feroce: Cavallero, abbiamo visto, lo fa subito arrestare e precisa che pur essendo un maresciallo d'Italia lo vuole a Regina Coeli con i ladri e gli assassini e non a Forte Boccea. Va ancora peggio a Ettore Muti, fascista ma di talento, eroe di guerra con medaglie vere, tipo pericoloso perché popolare e ben informato sui vizi dell'eroe di Caporetto. Lo fa ammazzare d u rante un «tentativo di fuga», messinscena mal recitata da carabinieri fedelissimi.
Queste sono le incombenze importanti. Gli restano in quei quarantacinque giorni che lo separano dal disastro finale compiti secondari: come trovare un modo per cavarsela dai tedeschi e come uscire dalla guerra. I generali golpisti per conto del re infatti si erano illusi che, come succede ali' opera, compiuto il colpo di scena finale, immediatamente venisse giù il sipario e si potesse andare a casa. Invece subentra lo sgomento. Gli Alleati, che non vogliono fare sconti e non si fidano, scatenano una terribile offensiva aerea sulle città; i tedeschi che si fidano ancor meno della parola del camerata Badoglio stanno con evidenza preparando la vendetta. Il re «di complemento», come è s ta to definito, deve dedicarsi ora ali ' operazione più difficile: ingannare i tedeschi e passare armi e bagagli agli Alleati per poter assaporare i frutti della vittoria. Sarebbe, se riesce, l'apoteosi del saltafossi, la guerra classica dei Savoia di tutti contro tutti, una guerra in cui si fanno promesse solo per non mantenerle e della quale Machiavelli è il santo patrono. Come diceva il figlio di Badoglio, «un lavoro di ricamo». Arduo ma il padre, purtroppo, provò. Quali fossero i metodi lo mostrò nei primi due rammendi vibrati con mano sicura . Spedi Blasco Lanza d' Ajeta, ex tirapiedi di Ciano m a per ragioni di parentela in buoni rapporti con gli inglesi, a Lisbona. Il suo compito era scritto con la maiuscola: sdraiato su una carta geografica enunciò la dislocazione di tutte le divisioni tedesche che si trovavano in Italia e che gli era stata svelata dal generale Giuseppe Castellano prima della part enza. Aggiunse anche una primizia: le truppe italiane che presidiavano le coste erano state ritirate e concentrate per la difesa di Roma. Insomma: accomodatevi. L'ambasciatore Campbell non mosse un muscolo. Rivolse molte domande, ottenne dall' italiano, ansioso di collaborare, altre precisazioni, poi lo cacciò via dicendo che agli Alleati quelle notizie non servivano e che poteva riferire una sola richiesta: resa incondizionata. Nelle stesse ore in cui regalavamo notizie così riservate, Giuseppe Ambrosio a Tarv isio affrontava senza batter ciglio gli s guardi so-

spettosi di Keitel. Siccome si temeva s i tradisse, era un animo semplice, toccò a Raffaele Guariglia, ministro degli Esteri, napoletano e abilissimo attore, recitare la parte principale nella commedia: «La prima cura di Sua Maestà e del maresciallo Badoglio è stata quella di dichiarare che l'Italia continua la guerra mantenendo fede alla parola data. Questa dichiarazione pubblica formulata da grandi soldati come il re e Badoglio non è da mettersi in dubbio, altrimenti il paese si sentirebbe profondamente ferito nel sentimento dell'onore». Ad Ambrosio toccò «solo» il lieve compito di manifestare indignazione perché di fronte a tanta fedeltà la Germania continuava a spedir truppe nella penisola!

C'erano altre questioncelle da risolvere, come riportare indietro le divisioni dalla Francia e dai Balcani per evitare che fossero ingoiate dai tedeschi. Il re seguiva con sempre maggiore inquietudine l'azione del suo generale, cominciava ad avere dubbi sul 25 luglio. Badoglio aveva paura : una paura terribile dei tedeschi che per lui erano rimasti quelli di Caporetto. Più si avviluppava nel suo sconclusionato tradimento e più tremava per la possibile punizione : «Finiremo tutti così» diceva ai collaboratori e faceva il gesto dello sgozzamento. A Carboni che si precipitava ogni mattino per il rapporto, con un sospiro ripeteva: «Anche stanotte è andata bene, non mi hanno portato via». Come re Lear, in quei frangenti non era che l'ombra di se s tesso. A Bonorni confessò che attorno alla sua residenza aveva fatto piazzare decine di cannoni anticarro. A quel punto non aveva scelta; doveva sviluppare «il bellissimo inganno» e fidare nello stellone che lo aveva sempre aiutato. Come garanzia stringeva in mano questa bella frase: «Gli inglesi mi vogliono bene e tutto andrà a posto, senza danni e con GRANDI VANTAGGI».
Il compito è d elicato ma viene affidato a personaggi incapaci o di modesto livello, come Alberto Berio, diplomatico di scarso rango, console a Tangeri, scelto forse perché quella è una città ideale per tramare. A Guariglia è stato detto che è una persona seria, non si sa da chi. Firma una resa senza condizioni con la prosopopea che essendo «uno degli ultimi grandi marescialli d 'Europa», gli Alleati non vedono l'ora di farlo accomodare al tavolo dei vincitori. Anzi pone condizioni e offre consigli. Ci sono in giro i tedeschi che non vedono l'ora di sgozzarlo, non potrebbero gli angloamericani organizzare un bello sbarco a La Spezia, in Provenza o nei Balcani tanto per «succhiare via » alcune divisioni di quei maledetti? I negoziatori alleati che non hanno un soldato a disposizione, mancano di portaerei e stanno sudando per metter su un secondo fronte in Normandia,
strabuzzano gli occhi, sghignazzano e poi decidono di dare corda a quello strano traditore. Fino all'ultimo i capi alleati furono convinti che Badoglio, ultimo Machiavelli, stesse preparando una grande trappola, pronto a rivendere le divisioni appena sbarcate ai tedeschi per ingraziarseli. Coniarono per il giocatore da bocce astigiano un neologismo, «to badogliate» che significava passare da una parte all'altra. Come esempio delle impressionanti prove di ingenuità cospirative nostrane abbiamo scelt o il generale Giuseppe Castellano, l'uomo della resa. Impomatato, aria da faina, inconcepibile su un campo di battaglia pur essendo figlio prediletto del marchese del Sabotino, è stato magistralmente descritto dagli ufficiali americani che se l o trovarono davanti durante le trattative per l'armistizio: «Sembra il proprietario di un ristorante italiano di Soho o dell'East Side». Nello spumeggiare di iniziative tutte egualmen te sbilenche che la combriccola allestisce per passare nel campo alleato prima o poi si doveva arrivare a questo goffo personaggio. Non sapeva una parola di inglese ma questo era considerato un dettaglio. Castellano è l'unico generale della storia la cui massima aspirazione professionale fosse firmare la resa! Prendete il suo libro: Come firmai l'armistizio di Cassibile. Duecento pagine insipide, scritte da un furiere. La guerra, le battaglie viste dallo «spioncino del rrùo osservatorio» dice il modesto, filano via nella prefazione. Si vede che al generale non interessano. Se la prende con Mussolini ma ritualmente. Leggete questo passaggio:
I generali avrebbero potuto e dovuto ribellarsi (pacificamente, si intende) e lasciare ad altri il posto di comando; ma su questo argomento non compete a me il severo giudizio.
Il suo sogno è un altro: «fare fessi» gli angloamericani ed entrare nella storia come l'uomo che ha messo la firma sotto il più iperbolico cambio di alleato che si ricordi. Fu per questo che il 3 settembre 1943 nella piana di Cassibile si mise il vestito buono: completo nero scarpe nere lucidissime cappello nero. Sembrava un contadino di Verga che andava a un matrimonio. Era una giornata di sole accecante color platino, da forno di acciaieria. Castellano sudava. Il suo compito invece era firmare la resa totale del suo paese. Sorrideva il generale. Aveva passato il giorno prima ore di angoscia. Quando avevano saputo che non disponeva dei pieni poteri per la firma dell'arrrùstizio, tutti, inglesi e americani, prima cosi gentili, avevano corrùnciato a guardarlo storto. Nessuno lo salutava più nonostante lui scattasse
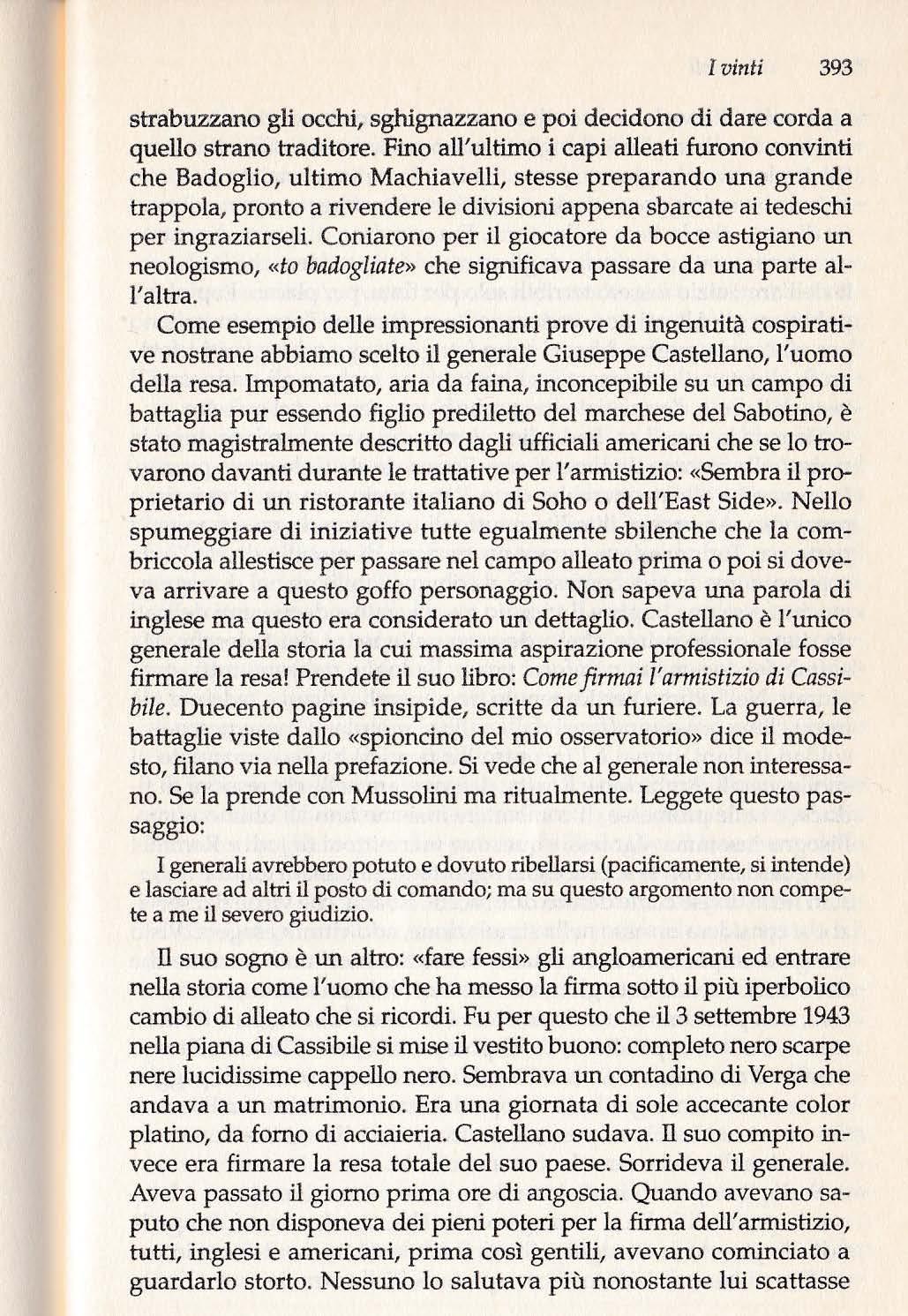
ogni volta che vedeva una divisa nemica; lo avevano chiuso in una tenda, a meditare. Così abbigliato entrò nella mensa ufficiali e si infilò tra le divise angloamericane. La foto lo ha immortalato così: con un'aria bonaria e domenicale, mentre amorevolmente osserva il pezzo di carta che lo ficca nella storia. Era convinto di essere diventato ora un camerata dei vincitori: gli avevano fatto credere che le clausole del!'armistizio fossero terribili solo per finta, per placare l'opinione pubblica: gli Alleati non vedevano l 'ora di avere l'apporto italiano per vincere la guerra. Non ci sono fotografie quando, spariti i fotografi, a llontanatisi i gen erali, gli mettono in mano e gli traducono il testo della resa, l'armistizio lungo che hanno tenuto nel cassetto.
Firmata la resa il re, Badoglio e Ambrosio come bambini dopo la marachella cercano di dimenticare. Eppure le clausole erano precise. Il comando alleato avrebbe dato l'annuncio con un brevi ssimo preavviso. Ambrosio, il militare tutto di un pezzo, in quei frangenti pa rte per Torino; «deve curare un trasloco di mobili» dice! C'è da sperare, come ha poi confessato al tribunale militare nel dopoguerra, che fosse una bugia e il viaggio fosse legato a documenti delicati da distruggere prima che cadessero nelle mani dei tedeschi. Ma ahimè dei documenti non forrù prove. Badoglio rassicura tutti i congiurati. Nell'ultimo vertice tenuto tra generali italiani e tedeschi già in un clima t esissimo (fuori dalla villa si guardano in cagnesco ss e soldati italiani, ormai è l'incontro tra nemici) ha raccomandato ai suoi generali, Ambrosio e Roatta, di esagerare nelle espressioni di fiducia e nelle promesse di combattere insieme fino all'ultimo uomo. Bisogna insomma «far fessi» quei due marmittoni di Jodl e Rommel che guardano con le sopracciglia aggro t tate gli italiani tondi e imbustati nelle divise come dentro due sacchi. Roatta, che viene dai servizi e si considera un asso n ella simul azione, addirittura esagera. Visto che gli esempi s torici non costano niente tira fuori una citazione che deve lasciar senza fiato gli interlocutori: «Noi non siamo come i sassoni, non passiamo al nemico mentre è in corso la battaglia». Il riferimento è alle truppe alleate di Napoleone che nel 1812 lo beffarono mentre il cannone tuonava a Dresda . Noi avevamo fatto di peggio: avevamo fornito, e gratis, la mappa del comando tedesco a Frascati. Gli americani bombardarono, Kesselring r estò illeso; morirono centinaia di italiani che non c'entravano niente.
Badoglio ripeteva in dialetto dopo cena prima di mettersi a letto con la puntualità di un impiegato: «Se Kesselring non mi rompe le uova lo prendo in castagna». Si era finalmente messo il cuore in pace. Ormai, nero su bianco, faceva parte dell 'alleanza dei potenti v in-
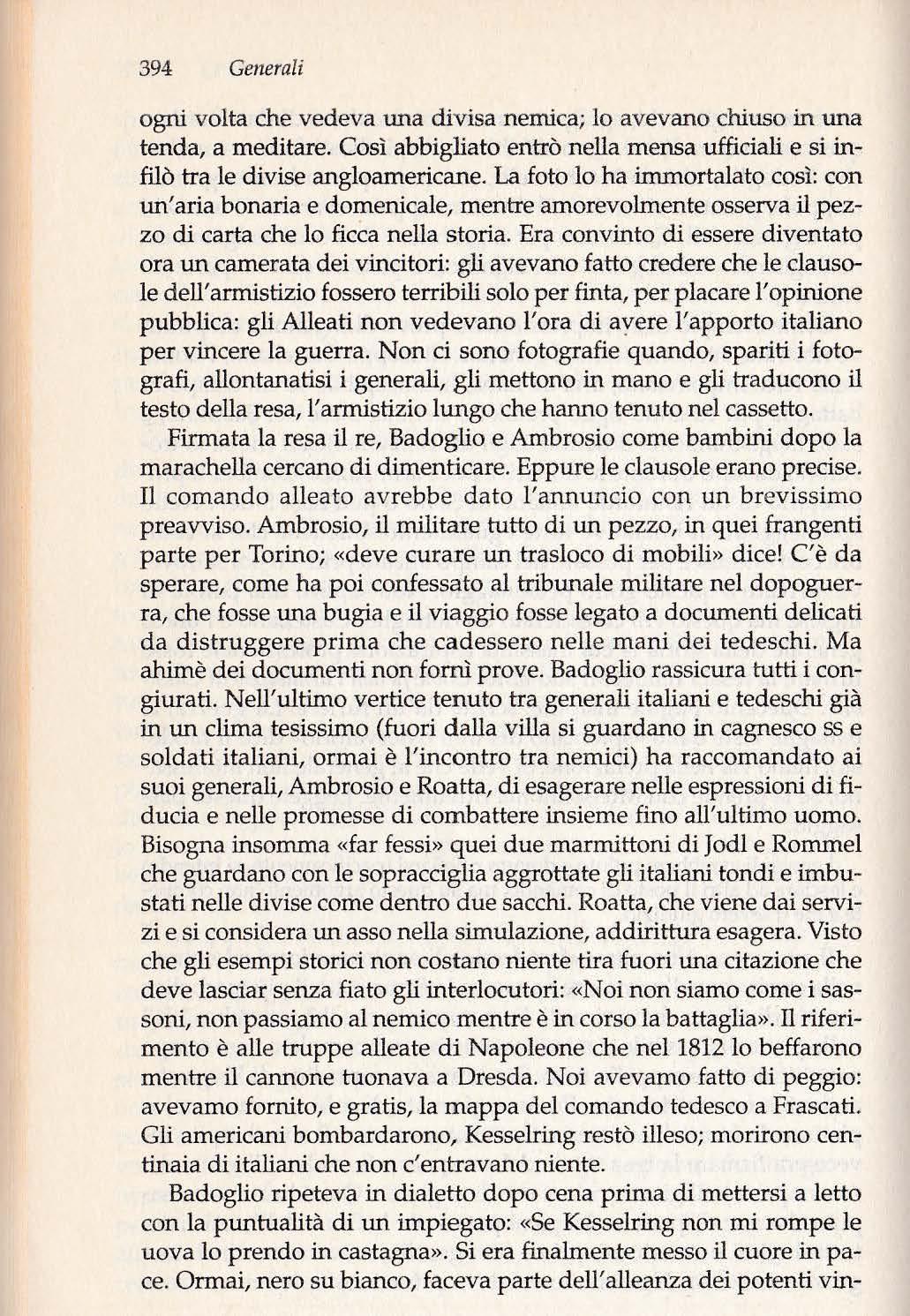
citori. Ci avrebbero pensato loro a tenere a bada quell'Hitler e i suoi unni fanatici. Già si immaginava a fianco di Alexander e Eisenhower sui Fori, naturalmente non più imperiali (ma non si può avere tutto), mentre assisteva alla sfilata delle truppe italo-anglo-americane vittoriose.
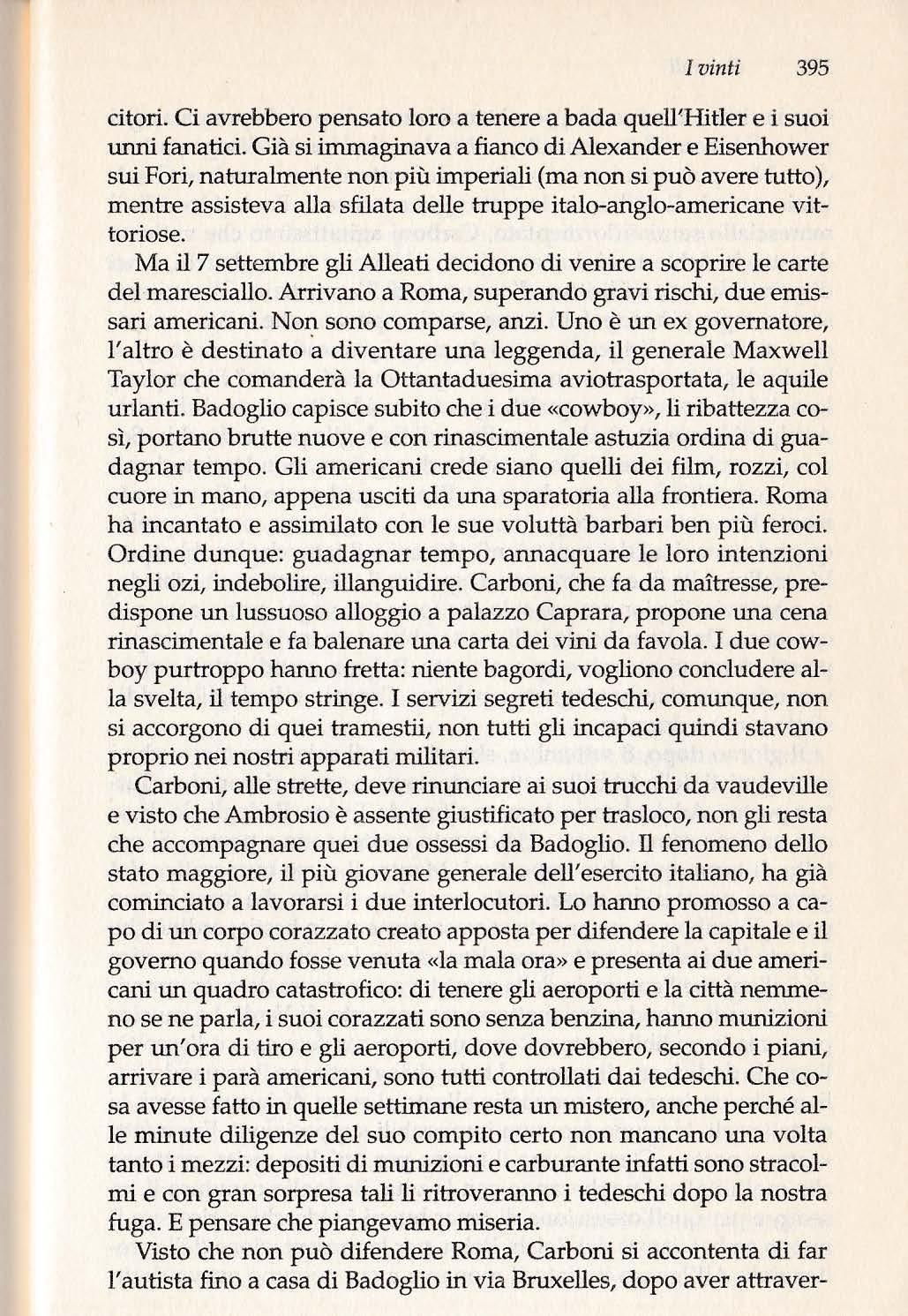
Ma il 7 settembre gli Alleati decidono di venire a scoprire le carte del maresciallo. Arrivano a Roma, superando gravi rischi, due emissari americani. Non sono comparse, anzi. Uno è un ex governatore, l'a ltro è destinato a diventare una leggenda, il generale Maxwell Taylor che comanderà la Ottantaduesima aviotrasportata, le aquile urlanti. Badoglio capisce subito che i due «cowboy», li ribattezza così, portano brutte nuove e con rinascimentale astuzia ordina di guadagnar tempo. Gli americani crede siano quelli dei film, rozzi, col cuore in mano, appena usciti da una sparatoria alla frontiera. Roma ha incantato e assimilato con le sue voluttà barbari ben più feroci. Ordine dunque: guadagnar tempo, annacquare le loro intenzioni negli ozi, indebolire, illanguidire. Carboni, che fa da maitresse, predispone un lussuoso alloggio a palazzo Caprara, propone una cena rinascimentale e fa balenare una carta dei vini da favola. I due cowboy purtroppo hanno fretta : niente bagordi, vogliono concludere alla svelta, il tempo stringe. I servizi segreti tedeschi, comunque, non si accorgono di quei tramestii, non tutti gli incapaci quindi s tavano proprio nei nostri apparati militari. Carboni, alle strette, deve rinunciare ai suoi trucchi da vaudeville e visto che Ambrosia è assente giustificato per trasloco, non gli resta che accompagnare quei due ossessi da Badoglio. Il fenomeno dello stato maggiore, il più giovane generale dell'esercito italiano, ha già cominciato a lavorarsi i due interlocutori. Lo hanno promosso a capo di un corpo corazzato creato apposta per difendere la capitale e il governo quando fosse venuta «la mala ora» e presenta ai due americani un quadro catastrofico: di tenere gli aeroporti e la città nemmeno se ne parla, i suoi corazzati sono senza benzina, hanno munizioni per un'ora di tiro e gli aeroporti, dove dovrebbero, secondo i piani, arrivare i parà americani, sono tutti controllati dai tedeschi. Che cosa avesse fatto in quelle settimane resta un mistero, anche perché alle minute diligenze del suo compito certo non mancano una volta tanto i mezzi: depositi di munizioni e carburante infatti sono stracolmi e con gran sorpresa tali li ritroveranno i tedeschi dopo la nostra fuga. E pensare che piangevamo miseria.
Visto che non può difende re Roma, Carboni si accontenta di far l'autista fino a casa di Badoglio in via Bruxelles, dopo aver attraver-
sato la città con i due americani terrorizzati e la pistola pronta a ogni posto di blocco. Il maresciallo, naturalmente, dorme. Bisogna attendere. Non può scendere in pigiama cli fronte ai due «nemici». O «alleati », clùssà. Il co lloquio lo tratteggia con ironia Paolo Monelli: il maresciallo semiaddo rme nta to, Carboni agitatissimo ch e vaticina disastri, la riclùesta ai due americani cli bloccar tutto, s barclù, lanci cli paracadutis ti, addirittura l ' annuncio dell'armistizio. Gli e missa ri sono sempre più s tupefatti e sospettosi; sapevano che le navi americane s i s tavano dirigendo ver so Anzio e i paracadutisti erano già a bordo d egli aerei. Come non pensare a un tradimento? Si propone loro cli fe rmarsi a Roma qualche giorno, così la situazione si clùarirà. A colpirli è soprattutto la paura fisica di Badoglio per i tedesclù: «Sono un vecchio maresciallo, ho vinto due guerre, n o n lascia teci soli con i tedeschi. Se ci prendono... ». Ripete quel gesto d ello sgozzam ento ben noto ne l suo quartier generale. Aggiunge, o rmai s proloquiando, citazioni dei su oi trionfi africani e il fa tto che ha abbattuto Mussolini . Alla fine accettarono di spedire il telegramma che chiedeva un rinvfo; Taylor pretese solo che fosse tolto ogni cenno a un s u o consenso. Un alto ufficiale italiano sa rebbe s tato inviato con loro per p rend ere nuovi accordi e spiegar tutto. Poi con grandi saluti e riverenze furono riaccompagnati a palazzo Caprara e Badoglio soddisfatto tornò a dormire.
Il g io rno dopo, 8 settembre, sbocciò con il sole e un motto che i protagonisti della febbrile nottata ripe tevano senza risparmio: «Tutto a posto». Ad Ambrosio, tornato alfine da Torino, Badoglio lo disse con un to no compiaci uto: «Ho dovuto m ette r tutto a posto». Si era to lto di tomo quei due importuni . Mentre il ca rro burocratico del governo proseguiva rasserenato, non c'era nie nte che fosse a l s uo posto. Eisenhower era anda to sacrosantemente in b estia; ordinò che a p arte l' avi osbarco tutto procedesse secondo i piani. Per avvertire gli italiani che l'ann unci o della resa stava per essere dato, era previs to ch e radio Lond ra trasmettesse un concerto di Verdi. La musica partì, m a increclibilmente a Roma nessuno o ci fece caso o l'ascoltò. Erano le doclici: ora di pranzo. I tedeschi avvertirono il comand o italiano che un immenso convoglio alleato s i stava dirigendo verso le coste laziali. Nessuno fece non impossibili supposizioni. Era infatti «tutto a posto». C'era anco r a il tempo per un ' altra recita grottesca ch e molti italiani pagh eranno con la vita. Badoglio convinse il re, sempre per quell'ossessione di ten e r buoni i tedeschi, a ricevere il nuovo a mbasciatore del Reich, Rahn, per la presentazione delle crede nziali. All'ignaro inviato il monarca a cui nessuno aveva de tto

nulla di quanto era successo nella notte regalò un pezzo di savoiarda doppiezza: «Dica a Hitler che l'Italia è legata alla Germania per la vita e per la morte».
Alle cinque e mezzo il testo del telegramma di Einsenhower arriva sul tavolo di Badoglio: qualcuno ha tagliato bruscamente la matassa degli inganni. La Reuters ha già dato l ' annuncio dell'armistizio. La scena la racconta Carboni, a cui il maresciallo cercò di rifilare la colpa della mancata difesa di Roma: il segretario e il nipote sono in lacrime, lui ansimando appoggiato a un tavolo ripete come una giaculatoria la frase: «Siamo rovinati». Non si osa più ficcare gli occhi nel futuro, non si spera più nulla. Ci si trasferisce tutti, mesto convoglio di dolenti, al Quirinale per un consiglio della corona. Arrancano anche Roatta, Carboni e gli altri scialbi protagonisti del pasticcio: Acquarone, valletto addetto ai bassi servizi reali, Sorice capo della polizia a cui si nasconde, ancora!, che la resa è stata firmata cinque giorni prima, l'ammiraglio De Courten e l'aiutante di campo generale Paolo Puntoni. E il maggiore Marchesi, unico a conservare i nervi saldi ma che ha il compito mediocre di stenografo. Carboni propone di compiere una follia: dare la colpa di tutto a Castellano, smentire l'accordo e rinegoziarlo con un governo diverso. Marchesi cerca di leggere il testo della resa scandito alla radio da Eisenhower, nessuno gli bada. Si moltiplicano le sciocchezze: Badoglio accusa gli americani di averlo tradito. Alla fine Marchesi, esasperato di tanta stupidità, prende la parola e spiega che a quel punto bisogna annunciare l'armistizio: la vergogna sarebbe enorme, anche perché non si potrebbe smentire l'operato di Valenzano e c'è il rischio di dover subire le rappresaglie dei tedeschi e contemporaneamente degli americani. Sarebbe la catastrofe, quella ormai scontata, e in più il disonore.
Ora che qualcuno aveva avuto il coraggio di dire la verità, la turba si placò e si decise senza più drammi di procedere. Badoglio, poiché nessuno aveva predisposto l'operazione, dovette andare all'Eiar per leggere a sua volta la dichiarazione di resa. Si rassegnò ad attendere, senza mugugnare, le sette e un quarto quando c'era il notiziario. Il re e la regina per sicurezza furono accompagnati al ministero della Guerra giudicato più difendibile. Li parcheggiarono, lui con una borsa da avvocato, lei in gonna lunga, nell'appartamento sfitto da anni del ministro. Li dimenticarono lì, con i due corazzieri davanti alla porta, seduti su una poltrona mentre l'oscurità scendeva nella stanza. «Due poveri vecchietti» disse Monelli, simbolo del crepuscolo di una dinastia che aveva conosciuto lampi gloriosi. Bado-

glio consumò dopo aver letto l'indigesto messaggio, una frugale cenetta condita con parentali complimenti per il tono usato alla radio. Poi alla solita ora, in dialetto, disse: «Mi ai vadu a dourmi». E andò a dormire.
Lasciamolo qui, il maresciallo, il marchese di Sabotino, il duca di Addis Abeba, con questa frase storica . Si fugge per categorie, prima i grossi poi i piccoli manigoldi. La rotta vergognosa della Baionetta ve r so sud, l'avverarsi della profezia di Caviglia, «quest'uomo distruggerà l'Italia e la dinastia», un esercito abbandonato al caos e alla vendetta nemica, sono una replica del Badoglio di Caporetto. Solo che questa volta il maresciallo non riuscì a far calare il segreto su altri giorni della sua vita.

Gli ultimi
Con 1'8 settembre finisce l'esercito italiano. E dovreb bero finire anche i generali. Dopo una catastrofe come quella, la realtà avrebbe dovuto costringere tutti all'apostasia. Correndo loro dietro per ministeri e campi di battaglia ci si sono ingrigiti i capelli, siamo stanchi, non ne possiamo più. Eppure abbiamo sfol tito, raggruppato, cercato dei simboli per non correr dietro a tutti, impresa impossibile. Adesso non si combatte più. Almeno noi. Gli Alleati ci usano come portatori, facchini, come succedeva agli ascari di un tempo. Non s i fidano, ci compatiscono. Lo stesso fanno i tedeschi sull'altro lato del fronte. Le battaglie dal 1943 le combattono i soldati senza divisa, i partigiani. Eppure nel dopoguerra i generali, che immagineresti dopo quelle ignominie una categoria estinta, un mestiere del passato, ritornano in scena, rifioriscono. La Guerra fredda regala loro una chance. Certo tutti sanno che la sicurezza della patria è affidata agli arsenali di altri. Ci usano come ripostiglio delle armi vecchie, ci infagottano nelle divise e ci schiacciano in testa gli elmetti che gli americani non sanno dove gettare, un'enorme discarica militare. In alcuni momenti strategicamente la Thailandia o la Somalia sono più importanti di noi. Eppure i generali sono di nuovo lì e accudiscono lo spropositato esercito di caserma che a loro è sempre piaciuto. Si sfila, si urla, s i gioca alla guerra che per fortuna non si farà . Sono cose antiche, che confortano il cuore. I generali e gli ammiragli del dopoguerra, spesso persone pregevoli, ben pre parate, colte, ormai equivalgono ai capi divisione delle ferrovie, burocrati di a lto rango che guidano un servizio che ingoia milioni. Neppure i gazzettieri più spregiudicati
sono riusciti a dar pennellate di epopea a coloro che hanno comandato le operazioni di «peace keeping». Facciamo i gendarmi agli ordini degli altri, si fa fatica a mettere insieme un mazzo di compagnie presentabili, bisogna rastrellare il meglio qua e là come ai tempi in cui andammo in Cina a dar la caccia ai Boxer. Eppure b as ta perché qualche soldato che è accorso per una paga migliore e le indennità di trasferta, purtroppo, ci rimetta la pelle.
Non ci interessano questi generali. Vogliamo chiudere con un' ultima pennellata, anzi un colpo di spatola. Sono rimasti nell'ombra i generali dei servizi segreti, quelli della guerra nascosta fatta di colpi di mano ladreschi, bugie sapientemente diffuse, congiure. Con una avvertenza: che da noi una cosa segreta in quanto tale è immediatamente nota a tutti. Creati dopo la terza guerra d ' indipendenza, questi servizi hanno sempre funzionato malissimo: un fittissimo armamentario ternico, scientifico, spionistico destinato all' unico scopo di pescare gli oppositori e difendere i dirigenti. Nella prima guerra mondiale gli austriaci, con una formidabile operazione di sabotaggio, fanno saltare in aria due supercorazzate, depositando comodamente nella santabarbara miccia ed esplosivo nascosti nelle ceste della verdura. Trama fitta che unisce le solite belle donne che lussureggiano nei complotti, come la marchesa Frida Ricci Pozzoli amica dell'ex regina di Napoli (ah, che lontani fantasmi), a deputati ed ex preti neutralisti. Non abbiamo talento per queste cose: ci piace pavoneggiare; ai generali finire in queste nebbie dove bisogna nascondersi, fingere di essere altri, s piace. Come si può rinunciare a cuor leggero al proscenio, alle parate?
Di servizi si occupava l'ultimo generale che è riuscito a infilarsi un po' di sghimbescio, come si conviene a chi di segreti si occupa: Giovanni De Lorenzo. Ma dobbiamo tornare all'inizio degli anni Sessanta, cavar fuori dagli archivi nomi impolverati: Moro, Taviani, la pillola fa ancora paura e se ne discute con furore, l'Italia del Cantagiro e della Graziella . Ci siamo capiti. Fuori d al tempo sembra anche lui, il generale: con il monocolo come nell'Ottocento, la divisa ben stirata, una prosa anacronistica che lamenta un secolo di aggiornamento sintattico e grammaticale mancato. Comanda i carabinieri ma si compiace di tenere, come riserva privata, il Sifar, ultima versione dei vecchi sgangherati servizi dal 1956 a l 1962. Sono anni tempes tosi ma ormai gli uragani ci scavalcano. Non h a molto da fare . Impiega il tempo a schedare, registrare, spiare, ammonticchiare doss ier. Ne colleziona centocinquantasettemila, un gigantesco archivio di chiacchiere, di sentito dire, di scandaletti di paese, di presunti figli illeg ittimi di
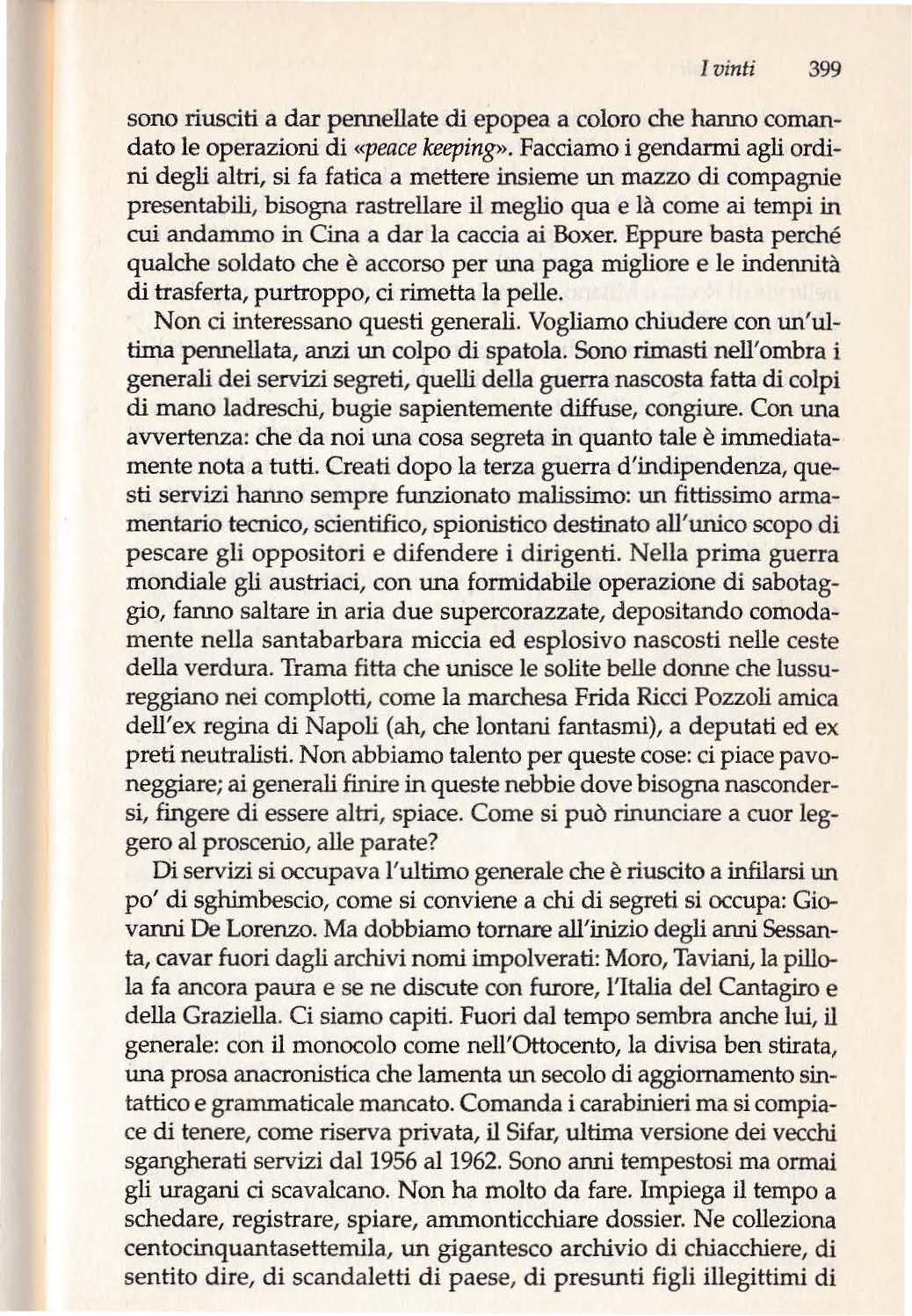
quelli che ancora non si chiamavano vip. Nei ritagli di tempo il generale, uno dei tanti a cui l'Italietta andava stretta, fece predisporre anche un piano detto «Solo» (perché avrebbe dovuto essere affidato solo ai fidati carabinieri) in cui si descriveva, come in un libro giallo, un golpe militare in caso di un precipitare della situazione politica: tutto completo, con i politici trascinati via, i carri armati che avanzavano nelle vie di Roma e Milano, i campi di concentramento per gli irriducibili agenti di Mosca .
I golpisti del Sifar sembrano i primi a non crederci, hanno tirato giù sommariamente, si vede la fretta e la noia a ogni punto a capo. Eppure bastò una delle tante crisi di governo, solo un po' più nervosa, perché la notizia che l'Italia aveva rischiato nel 1962 un colpo di stato militare finisse su «L'Espresso» e nella Storia . In realtà restò un sogno della sinistra che ha sempre aspirato al brivido delle barricate, alle furie della Comune, agli assalti al palazzo d ' Inverno, alle Tuileries, al Viminale.
Fu un bluff. Sipario appropriato per far uscire i generali dalla storia d ' Italia.
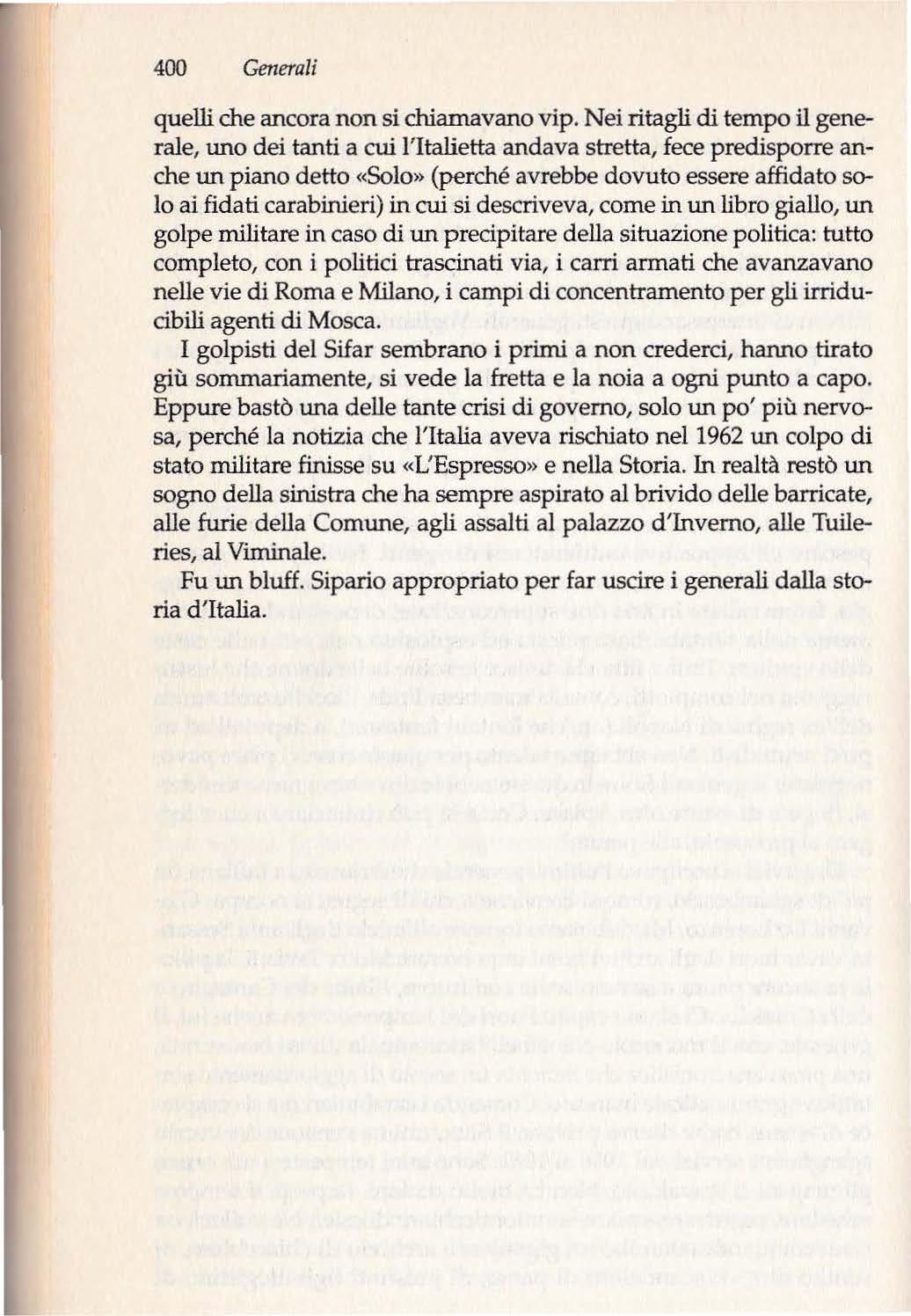
AAVV, Cronaca della guerra italo/urca e della conquista della Libia, Milano, Sonzogno, 1912.
AAVV, L'ammiraglio Persano nella campagna navale dell'anno 1866, Torino, Monitore delle strade ferrate, 1872.
Abba, Giuseppe Cesare, Vita di Nino Bixio, Bergamo, Moretti e Vitali, 1990.
-, Da Quarto al Volturno, Bologna, Zanichelli, 1963.
-, Storia dei Mille, Firenze, Bemporad, 1902.
Adamoli, Giulio, Da Sa11 Martino a Mentana . Ricordi di un volontario, Milano, F.lli Treves, 1892.
Agrati, Carlo, I Mille nella storia e nella leggenda, Milano, Mondadori, 1933.
-, Giuseppe Sirtori, il primo dei Mille, Roma-Bari, Laterza, 1940.
Armellini, Quirino, Diario di guerra, Milano, Garzanti, 1946.
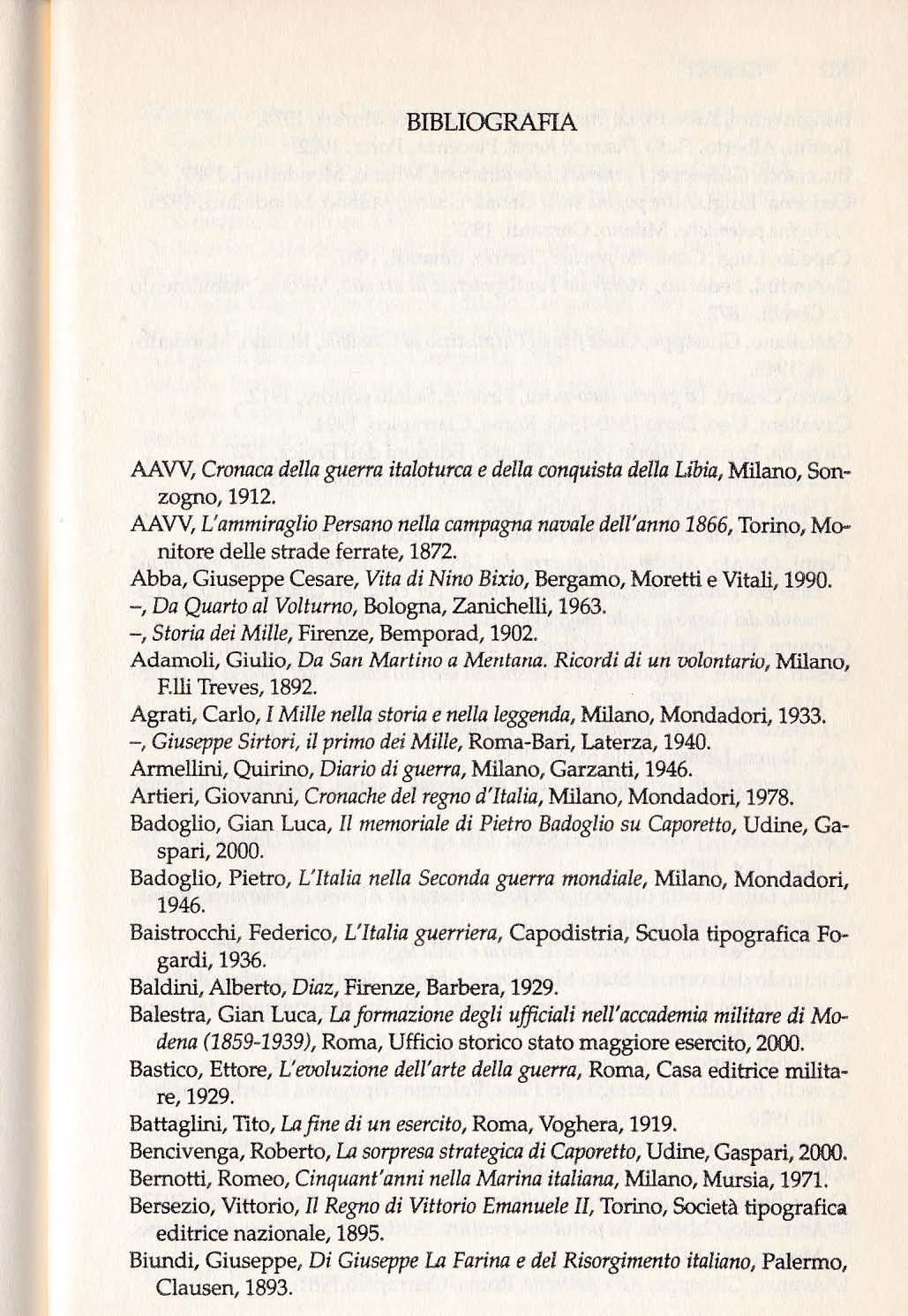
Artieri, Giovanni, Cronache del regno d'Italia, Milano, Mondadori, 1978.
Badoglio, Gian Luca, Il memoria le di Pietro Badoglio su Caporetto, Udine, Gaspari, 2000.
Badoglio, Pietro, L'Italia nella Seconda guerra mondiale, Milano, Mondadori, 1946.
Baistrocchi, Federico, L'Ita lia g uerriera, Capodistria, Scuola tipografica Fogardi, 1936.
Baldini, Alberto, Diaz, Firenze, Barbera, 1929.
Balestra, Gian Luca, La formazione degli ufficiali nell'accademia militare di Modena (1859-1939), Roma, Ufficio storico stato maggiore esercito, 2000.
Bastico, Ettore, L'evoluzione dell'arte della guerra, Roma, Casa editrice militare, 1929.
Battaglini, 1ito, La fine di un esercito, Roma, Voghera, 1919.
Bencivenga, Roberto, La sorpresa strategica di Caporetto, Udine, Gaspari, 2000.
Bemotti, Romeo, Cinquant'anni nella Marina italiana, Milano, Mursia, 1971.
Bersezio, Vittorio, Il Regno di Vittorio Emanuele II , Torino, Società tipografica editrice nazionale, 1895.
Biundi, Giuseppe, Di Giuseppe La Farina e del Risorgimento italiano, Palermo, Clausen, 1893.
Bongiovanni, Alberto, La fine dell'impero, Milano, Mursia, 1974.
Bottini, Alberto, Paolo Thaon di Revel, Piacenza, Porta, 1922.
Bucciante, Giuseppe, I generali della dittatura, Milano, Mondadori, 1987.
Cadoma, Luigi, Altre pagine s ulla Grande Guerra, Milano, Mondado ri, 1925.
-, Pagine polemiche, Milano, Garzanti, 1957.
Capello, Luigi, Caporetto perché?, Torino, Einaudi, 1967.
Carandini, Federico, Manfredo Fanti generale di armata, Verona, Stabilimento Civelli, 1872.
Castellano, Giuseppe, Come firmai l'armistizio di Cassibile, Milano, Mondadori, 1945.
Causa, Cesare, La guerra ital<>-turca, Firenze, Salani editore, 1912.
Cavallero, Ugo, Dario 1940-1943, Roma, Ciarrapico, 1994.
Caviglia, Enrico, Vittorio Ver,eto, Milano, Edizioni dell'Eroica, 1920 -, La dodicesima battaglia (Caporetto), Milano, Mondadori, 1933., Diario 1925-1945, Roma, Casini, 1952.
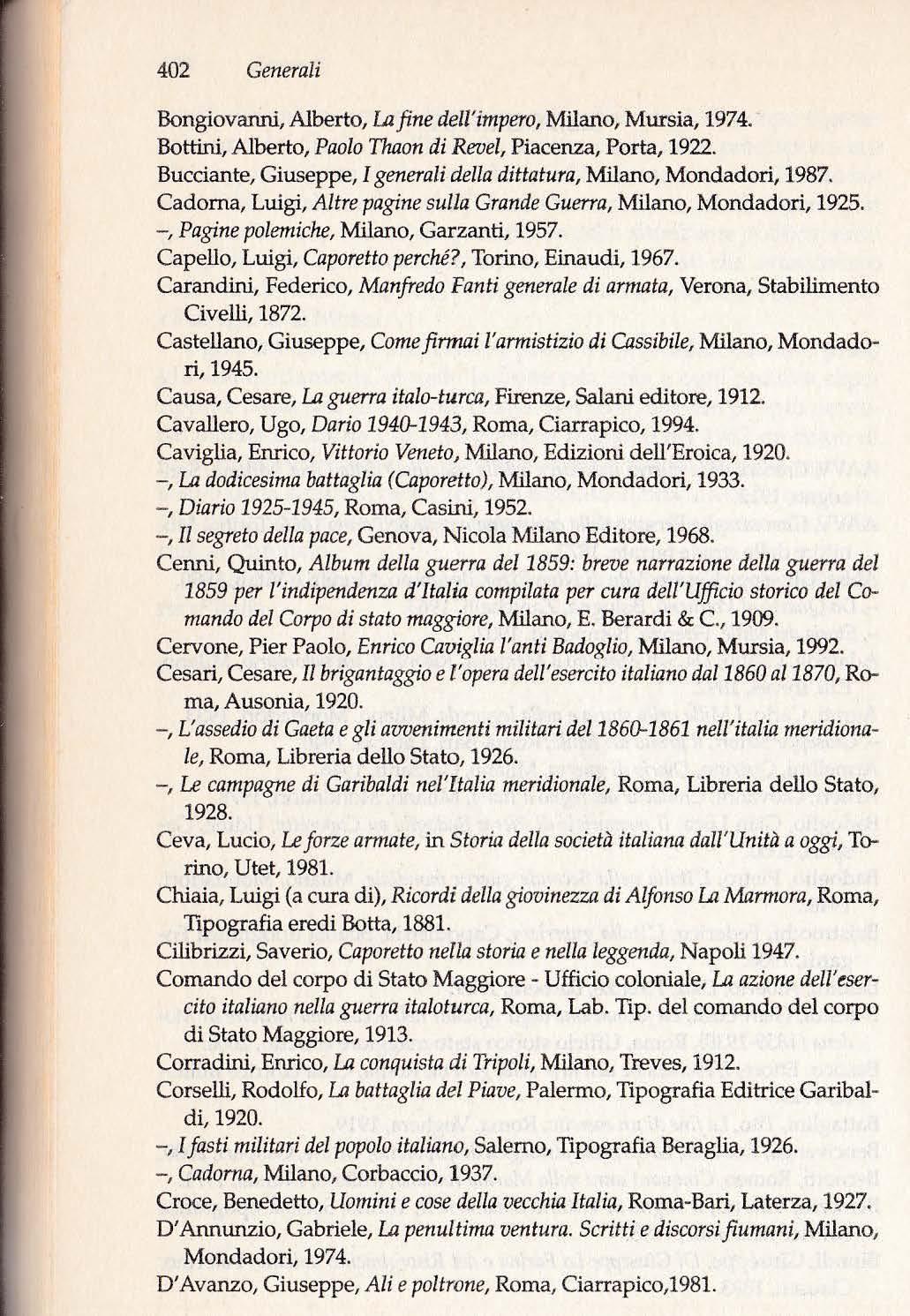
-, Il segreto della pace, Genova, Nicola Milano Editore, 1968.
Cenni, Quinto, Album della guerra del 1859: breve narrazione della guerra del 1859 per l'indipendenza d'Italia compilata per cura dell'Ufficio storico del C<>mando del Corpo di stato maggiore, Milano, E. Berardi & C., 1909.
Cervone, Pier Paolo, Enrico Caviglia l'anti Badoglio, Milano, Mursia, 1992. Cesari, Cesare, Il brigantaggio e l'opera dell 'esercito italiano dal 1860 al 1870, Roma, Ausonia, 1920.
, L'assedio di Gaeta e gli avvenimenti militari del 1860-1861 nell'italia meridionale, Roma, Libreria dello Stato, 1926.
-, Le campagne di Garibaldi nel 'ltalia meridionale, Roma, Libreria dello Stato, 1928.
Ceva, Lucio, Le forze annate, in Storia della società italiana dall ' Unità a oggi, Torino, Utet, 1981.
Chiaia, Luigi (a cura di), Ricordi della giovinezza di Alfonso La Mamwra, Roma, Tipografia eredi Botta, 1881.
Cilibrizzi, Saverio, Caporetto nella storia e nella leggenda, Napoli 1947
Comando del corpo di Stato Maggiore - Ufficio coloniale, La azione dell'esercito italiano nella gi1erra italoturca, Roma, Lab. Tip. del comando del corpo di Stato Maggiore, 1913.
Corradini, Enrico, La conquista di Tripoli, Milano, Treves, 1912.
Corselli, Rodolfo, La battaglia del Piave, Palermo, Tipografia Editrice Garibaldi, 1920.
-, /fa sti militari del popolo italiano, Salerno, Tipografia Beraglia, 1926.
-, Cadorna, Milano, Corbaccio, 1937.
Croce, Benedetto, Uomini e cose della vecchia Italia, Roma-Bari, Laterza, 1927.
O'Annunzio, Gabriele, La penultima ventura. Scritti e discorsi fiumani, Milano, Mondadori, 1974.
O'Avanzo, Giuseppe, Ali e poltrone, Roma, Ciarrapico,1981.
D'Azeglio, Massimo, Lettere a Carlo Persano nel decorso di 19 anni, Torino, Condeletti, 1878.
De Biase, Carlo, L'otto settembre di Badoglio, Milano, Il borghese, 1968.
De Bono, Emilio, U2 preparazione e le prime operazioni, Roma, Istituto nazionale fascista di cultura, 1937
De Marsica, Alfredo, 25 luglio 1943, Roma-Bari, Laterza, 1983.
Di Persano, Carlo,/ fatti di Lissa, Torino, U tet, 1866.
Dollmann, Eugen, Roma nazista, Milano, Longanesi, 1949.
Douhet, Giulio, Il dominio dell'aria, Milano, Mondadori, 1932.
-, La guerra integrale, Roma, Campitelli, 1936.
Faldella, Emilio, L'Ital ia nella seco nda guerra mondiale. Revisione di giudizi, Bologna, Cappelli, 1960.
Farirù, Domenico, Diario di fine secolo, Roma, Bardi, 1962.
Favagrossa, Carlo, Perché perdemmo la guerra, Milano, Rizzali, 1945.
Gatti, Angelo, Nel tempo della tormenta, Milano, Mondadori, 1923.
Ghio, Giuseppe, La guerra dell'anno 1866 in Germania e in Italia, Firenze, Ademollo, 1887.
Giardino, Gaetano, Piccole fauci nella bufera, Milano, Mondadori, 1924.
-, Rievocazioni e riflessioni di guerra, Milano, Mondadori, 1929.
Giolitti, Giovanni, Memorie della mia v ita, Milano, Treves, 1922.
Govone, Uberto, Il generale Giuseppe Govone. Frammenti di memorie, Torino, Fratelli Bocca, 1929.
Grandi, Dino, L'evitab ile Asse, Milano, Jaka Book, 1984.
Guerrini, Domenico, Lissa 1866, Torino, Casanova, 1907
Iachino, Angelo, La campagna navale di Lissa 1866, Milano, Il Saggiatore, 1966. Labriola, Arturo, Lo guerra di Tripoli e l'opinione socialista, Napoli, Morano, 1912.
La Marmora, Alfonso, I segreti di stato nel governo costituzionale, Firenze, Barbera, 1887.
, Carteggi di Alfonso La Marmara, Torino, Chiantore, 1928.
-, Un po' più di luce sugli eventi politici e militari dell'anno 1866, Firenze, Barbera, 1973.
La Masa, Giuseppe, Sulla guerra in surrezionale in Italia tendente a conquistare la nazionalità, Torino, Botta, 1856
Lumbroso, A lberto, La battaglia di Lissa nella storia e nella leggenda , Firenze, Quattrini, 1910.
Maltese, Paolo, La terra promessa, Milano, SugarCo, 1968.
Mangone, Angelo, Luigi Capello, Milano, Mursia, 1994.
Maravigna, Pietro, Come abbiamo perduto la guerra in Africa, Roma, Tosi, 1949.
Marazzi, Fortunato, Splendori e ombre della nostra guerra, Milano, Casa editrice Risorgimento, 1920.
Marotti, Gi u seppe, Il generale Enrico Cialdini duca di Gaeta, Firenze, Barbera, 1891.
Monelli, Paolo, Roma 1943, Roma, Migliaresi, 1945.

Monnier, Mare, Histoire du Brigandage dans l'Italie Meridionale, Paris, Miche! Levy, 1862.
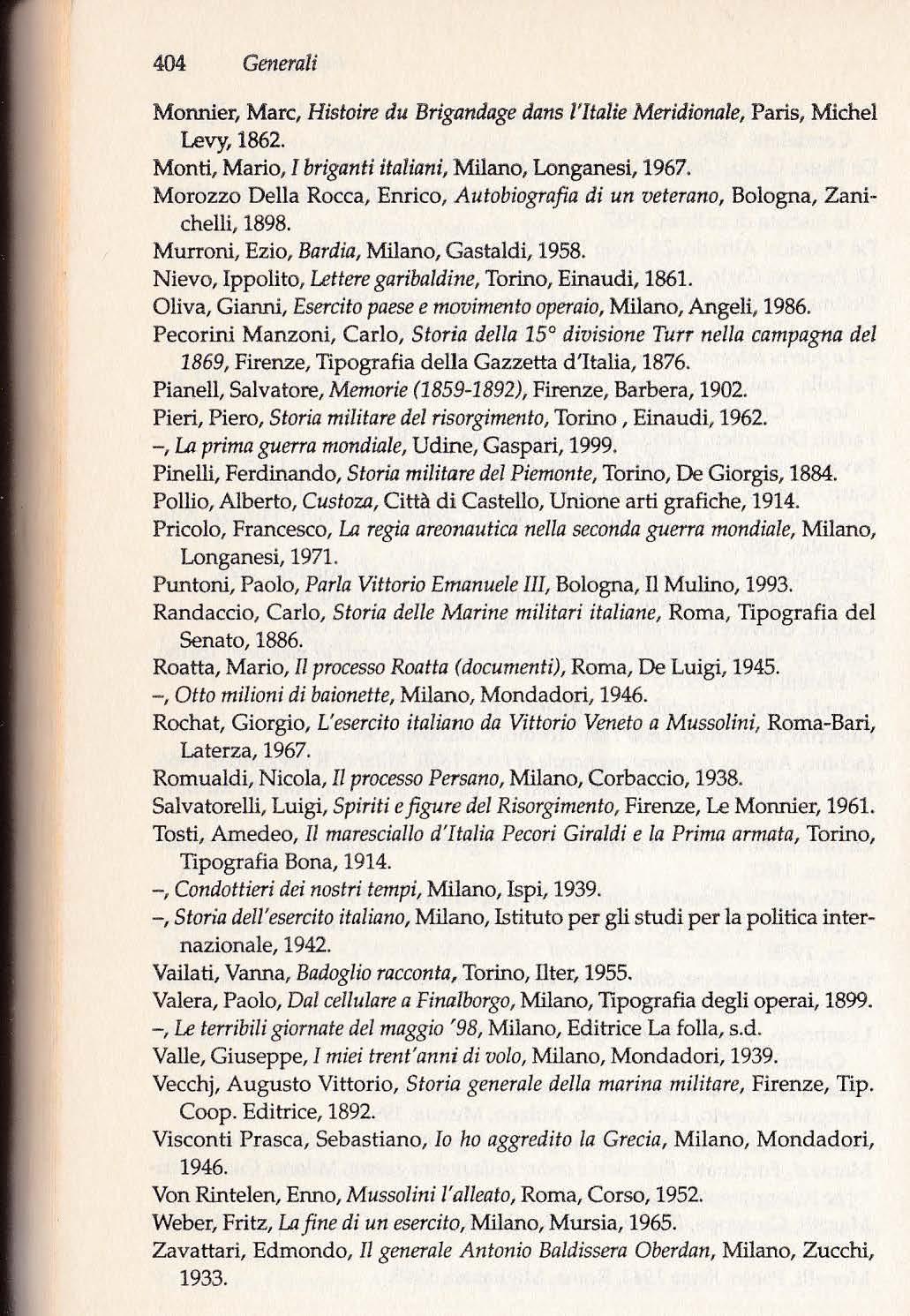
Monti, Mario, I briganti itaTiani, Milano, Longanesi, 1967.
Morozzo Della Rocca, Enrico, Autobiografia di un veterano, Bologna, Zanichelli, 1898.
Murroni, Ezio, Bardia, Milano, Gastaldi, 1958.
Nievo, Ippolito, Lettere garibaldine, Torino, Einaudi, 1861.
Oliva, Gianni, Esercito paese e movimento operaio, Milano, Angeli, 1986.
Pecorini Manzoni, Carlo, Storia della 15° divisione Turr nella campagna del 1869, Firenze, Tipografia della Gazzetta d'Italia, 1876.
Pianell, Salvatore, Memorie (1859-1892), Firenze, Barbera, 1902.
Pieri, Piero, Storia militare del risorgimento, Torino, Einaudi, 1962.
-, La prima guerra mondiale, Udine, Gaspari, 1999.
Pinelli, Ferdinando, Storia militare del Piemonte, Torino, De Giorgis, 1884.
Pollio, Alberto, Custoza, Città di Castello, Unione arti grafiche, 1914
Pricolo, Francesco, La regia areonautica nella seconda guerra mondiale, Milano, Longanesi, 1971.
Puntoni, Paolo, Parla Vittorio Emanuele /TI, Bologna, Il Mulino, 1993.
Randaccio, Carlo, Storia delle Marine militari italiane, Roma, Tipografia del Senato, 1886.
Roatta, Mario, Il processo Roatta (documenti), Roma, De Luigi, 1945.
-, Otto milioni di baionette, Milano, Mondadori, 1946.
Rochat, Giorgio, L'esercito italiano da Vittorio Venet o a Mus solin i, Roma-Bari, Laterza, 1967.
Romualdi, Nicola, Il processo Persano, Milano, Corbaccio, 1938.
Salvatorelli, Luigi, Spiriti e figure del Risorgimento, Firenze, Le Monnier, 1961.
Tosti, Amedeo, Il maresciallo d'Italia Pecari Giraldi e la Prima armata, Torino, Tipografia Bona, 1914.
-, Condottieri dei nostri tempi, Milano, !spi, 1939.
-, Storia dell'esercito italiano, Milano, Istituto per gli studi per la politica internazionale, 1942.
Vailati, Vanna, Badoglio racconta, Torino, Ilter, 1955.
Valera, Paolo, Dal cellulare a Finalborgo, Milano, Tipografia degli operai, 1899.
-, Le terribili giornate del maggio '98, Milano, Editrice La folla, s.d.
Vall e, Giuseppe, I miei trent 'a nni di volo, Milano, Mondadori, 1939.
Vecchj, Augusto Vittorio, Storia generale della marina militare, Firenze, Tip. Coop. Editrice, 1892.
Visconti Prasca, Sebastiano, lo ho aggredito la Grecia, Milano, Mondadori, 1946.
Von Rintelen, Enno, Mu ssolini l'allea to, Roma, Corso, 1952.
Weber, Fritz, lA fine di un esercito, Milano, Mursia, 1965.
Zavattari, Edmondo, /I generale Antonio Baldissera Oberdan, Milano, Zucchi, 1933.
Abba, G i useppe Cesare, 130, 132, 135 Acquarone, Pietro, 372, 397
Agà, Adam, 219
Ailé Selassié, 333 Albertini, Luigi, 249
A lberto d'Asburgo, a rciduca d 'Austria, 56, 95
A lbini, Giovan Battista, 79, 90, 97, 101, 104, 107, llD-111
Alessandro I Romanov, zar di Russia, 24
A lexander, Harold Rupert, 395
All, Mohamed, 62
A lo nzi, Luigi, v. Chiavone Amadio, Angelo (Pompierin), 197 Ambrosie, Giuseppe, 391-392, 396 Ambrosie, Vittorio, 7,372,389,394
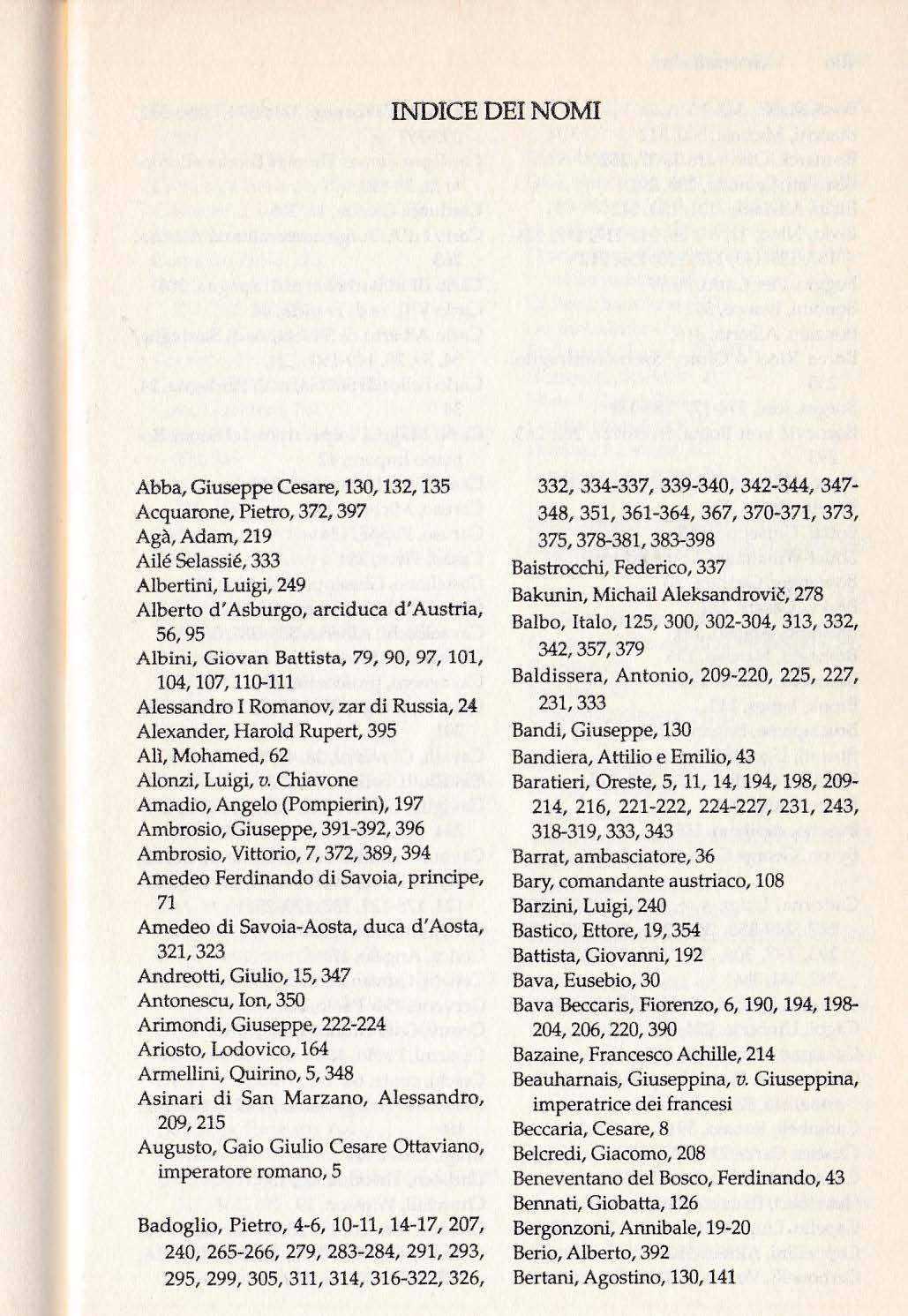
Amedeo Ferdinando di Savoia, principe, 71
Amedeo di Savoia-Aosta, duca d 'Aosta, 321 , 323
Andreotti, Giulio, 15,347
Antonescu, Ion, 350
A rim oncli, Giuseppe, 222-224
Ariosto, Lodovico, 164
Armellini, Quirino, 5, 348
Asinari di San Marzano, Alessandro, 209,215
A ugusto, Gaio Giulio Cesare Ottaviano, imperatore romano, 5
Badoglio, Pietro, 4-6, 10-11, 14- 17, 207, 240, 265-266, 279, 283-284, 291,293, 295, 299, 305, 3ll, 314, 316-322, 326,
332, 334-337, 339-340, 342-344, 347348, 351, 361-364, 367, 370-371, 373, 375, 37S-381, 383-398 Baistrocchi, Federico, 337 Bakunin, Michail Aleksandrovit, 278 Balbo, Italo, 125, 300, 302-304, 313,332, 342, 357, 379 Baldissera, Antoni o, 209-220, 225, 227, 231,333
Bandi, Giuseppe, 130 Bandiera, Attilio e Emilio, 43 Baratieri, Oreste, 5, li, 14, 194, 198, 209214, 216, 221-222, 224-227, 231, 243, 31S-319, 333,343 Barrat, ambasciatore, 36 Bary, comandante austriaco, 108 Barzini, Luigi, 240 Bastico, Ettore, 19, 354 Battista, Giovanni, 192 Bava, Eusebio, 30 Bava Beccaris, Fiorenzo, 6, 190, 194, 19g... 204, 206, 220, 390 Bazaine, Francesco Achille, 214 Beauhamais, Giuseppina, v. Giuseppina, imperatrice dei francesi Beccaria, Cesare, 8 Belcredi, Giacomo, 208 Beneventano del Bosco, Ferdinando, 43 Bennati, Giobatta, 126 Bergonzoni, Annibale, 19-20 Berio, Alberto, 392 Bertani, Agostino, 130, 141