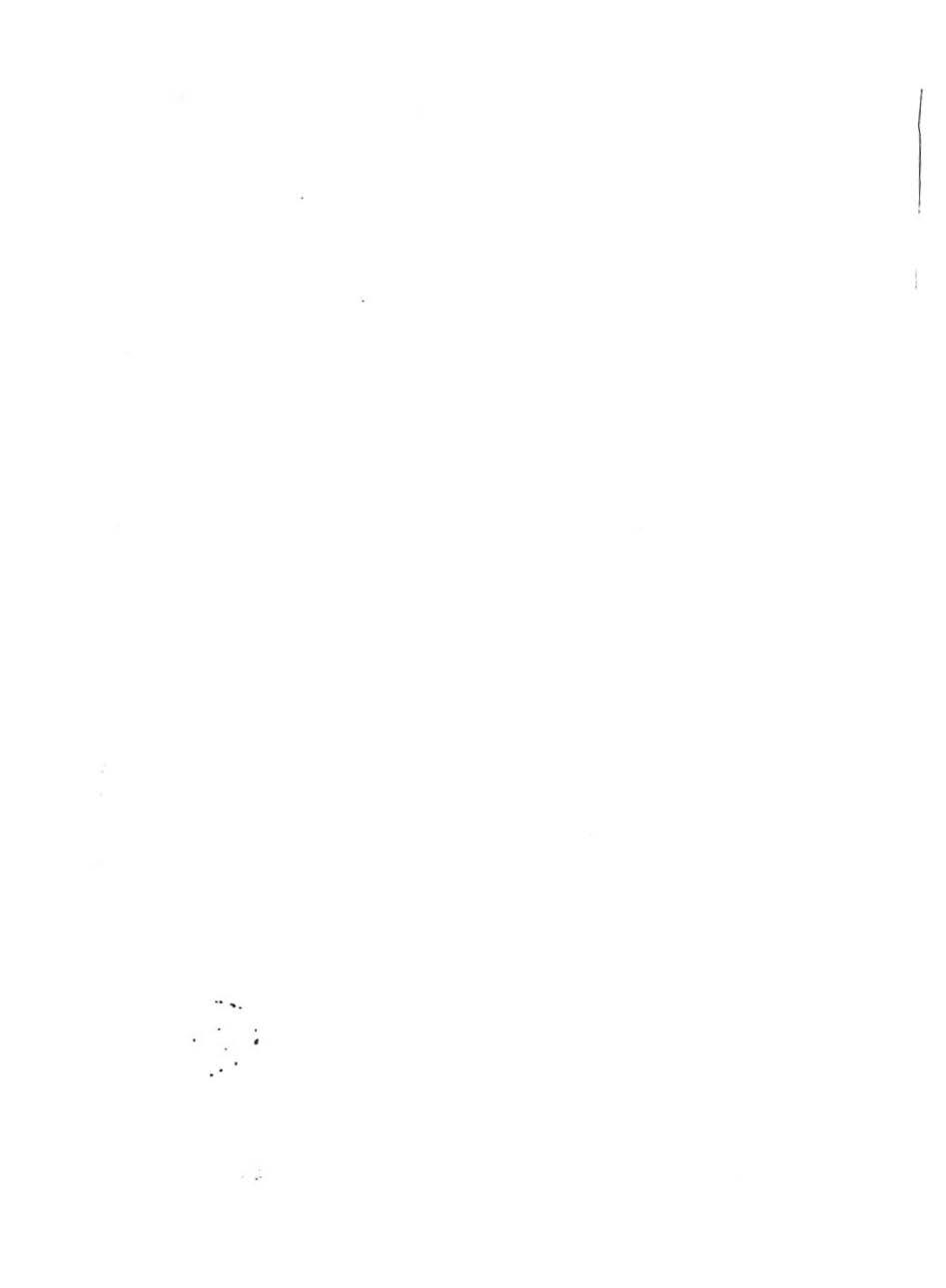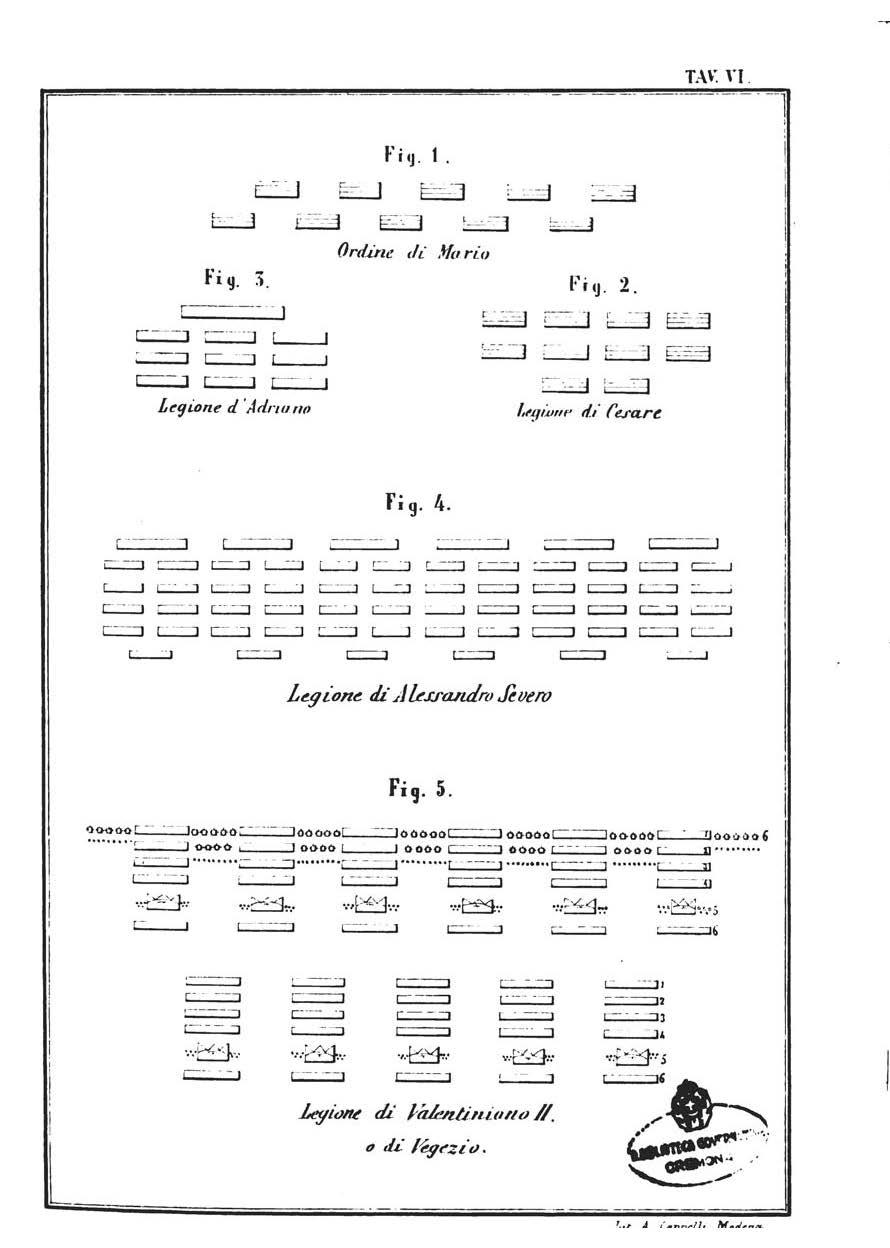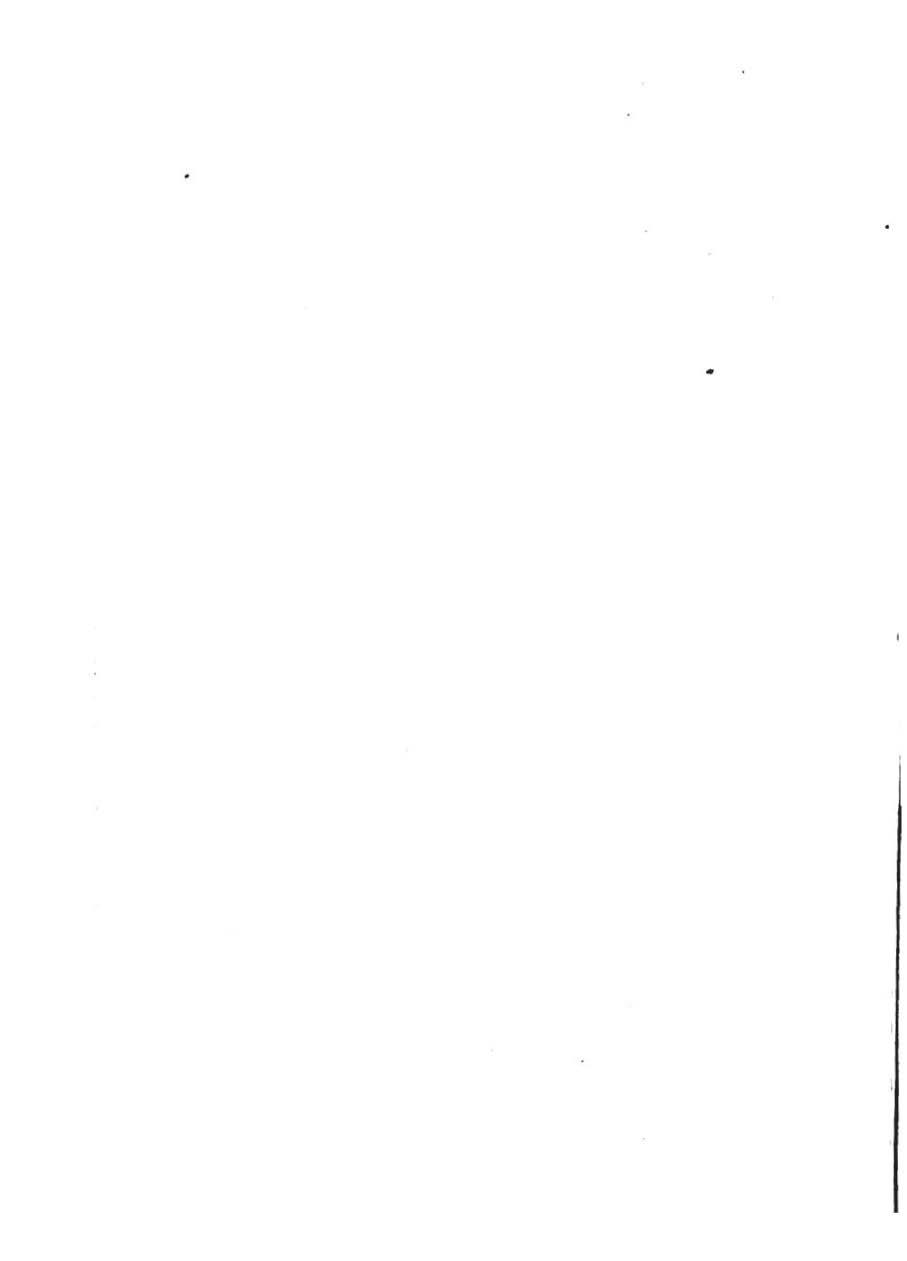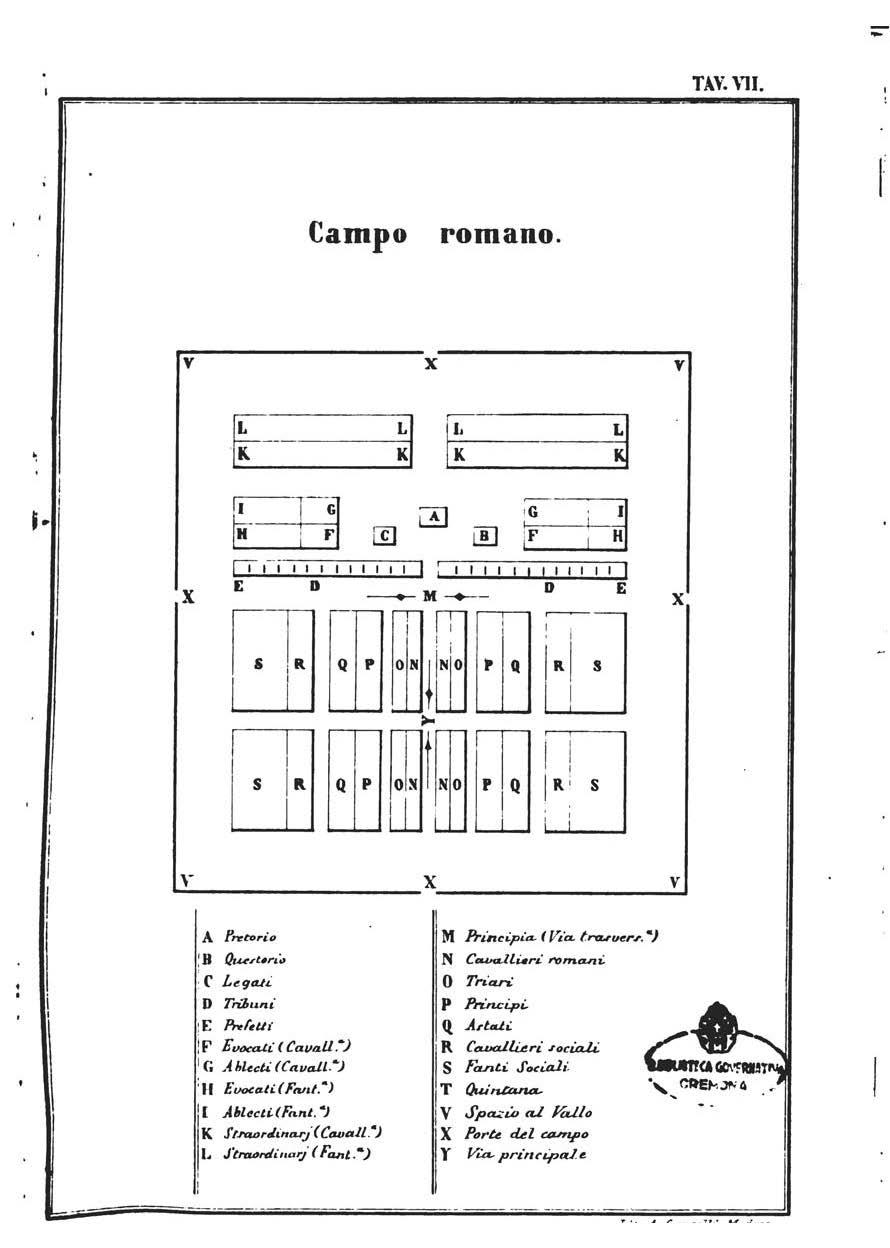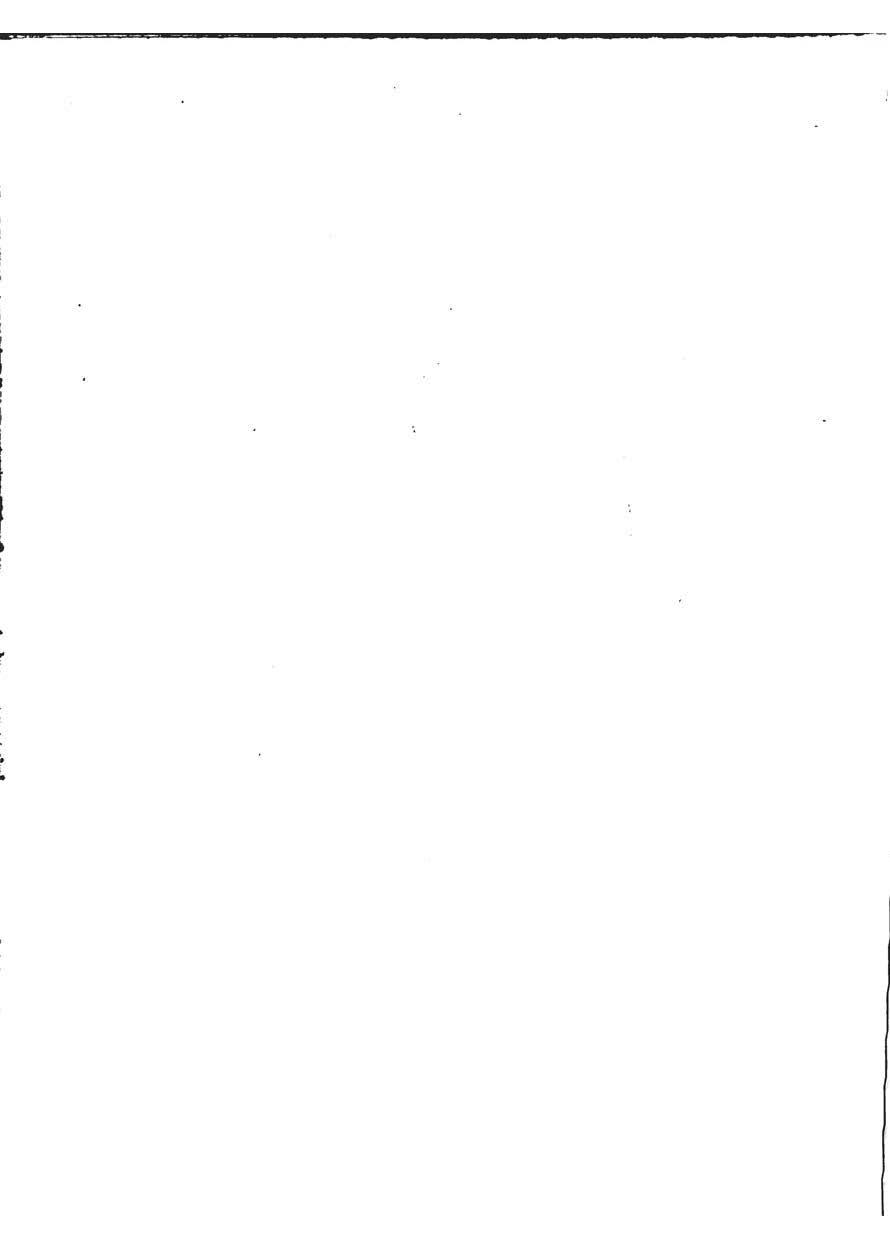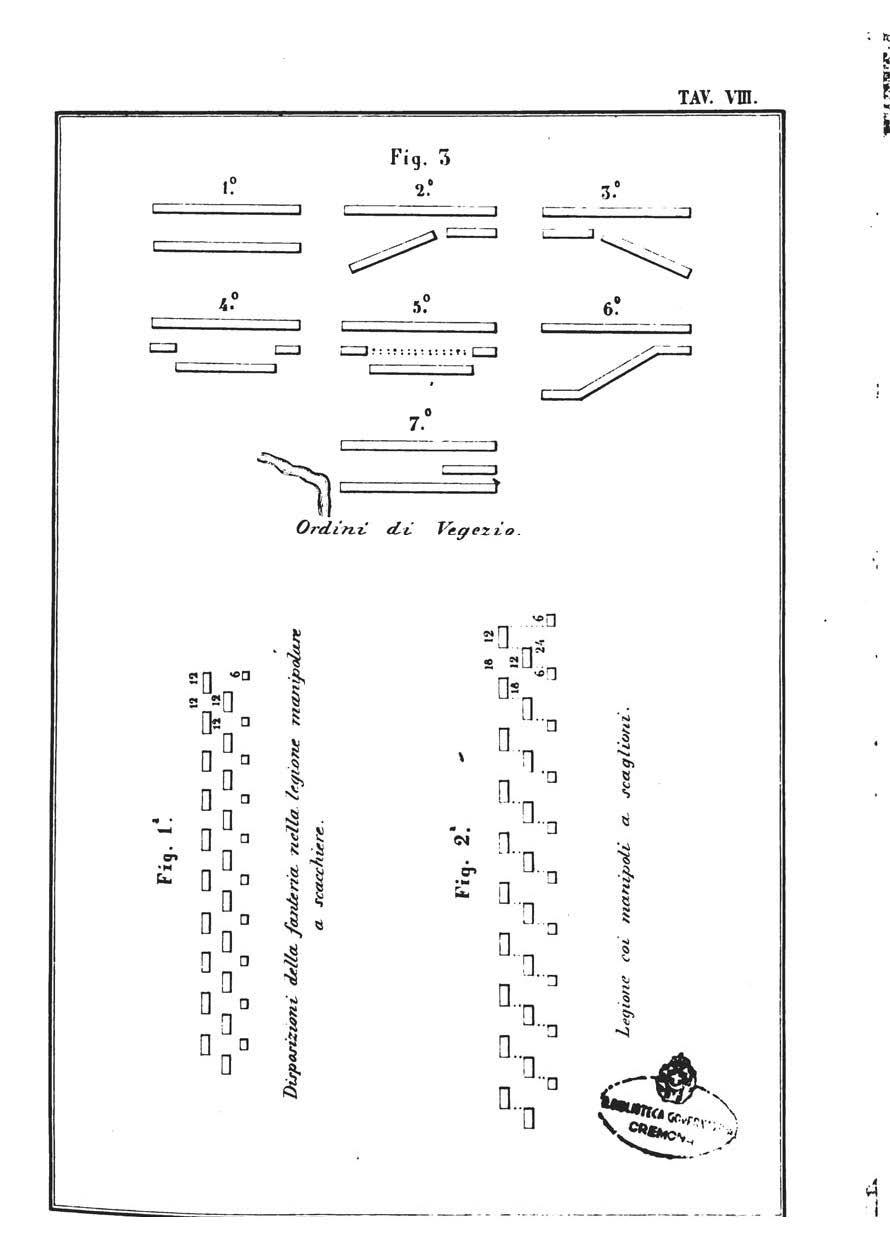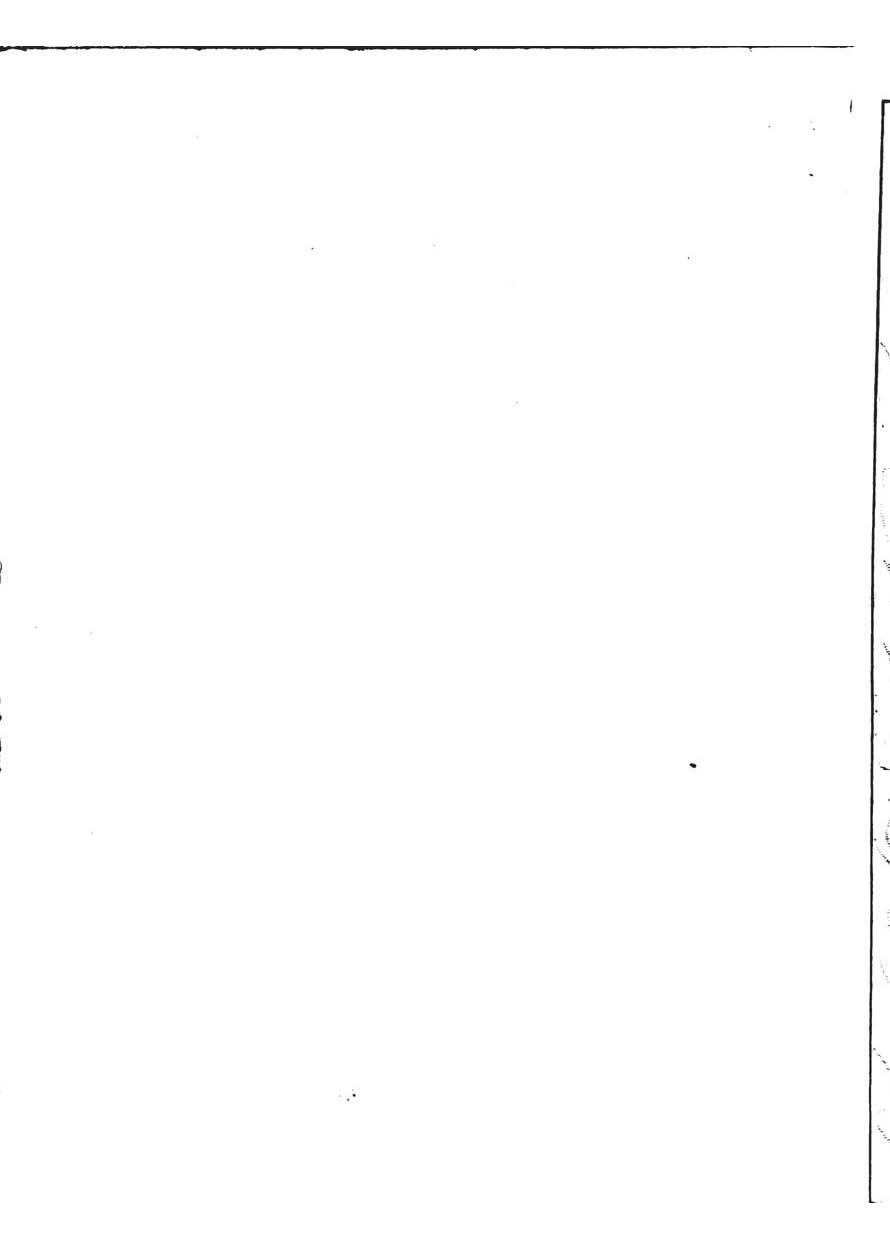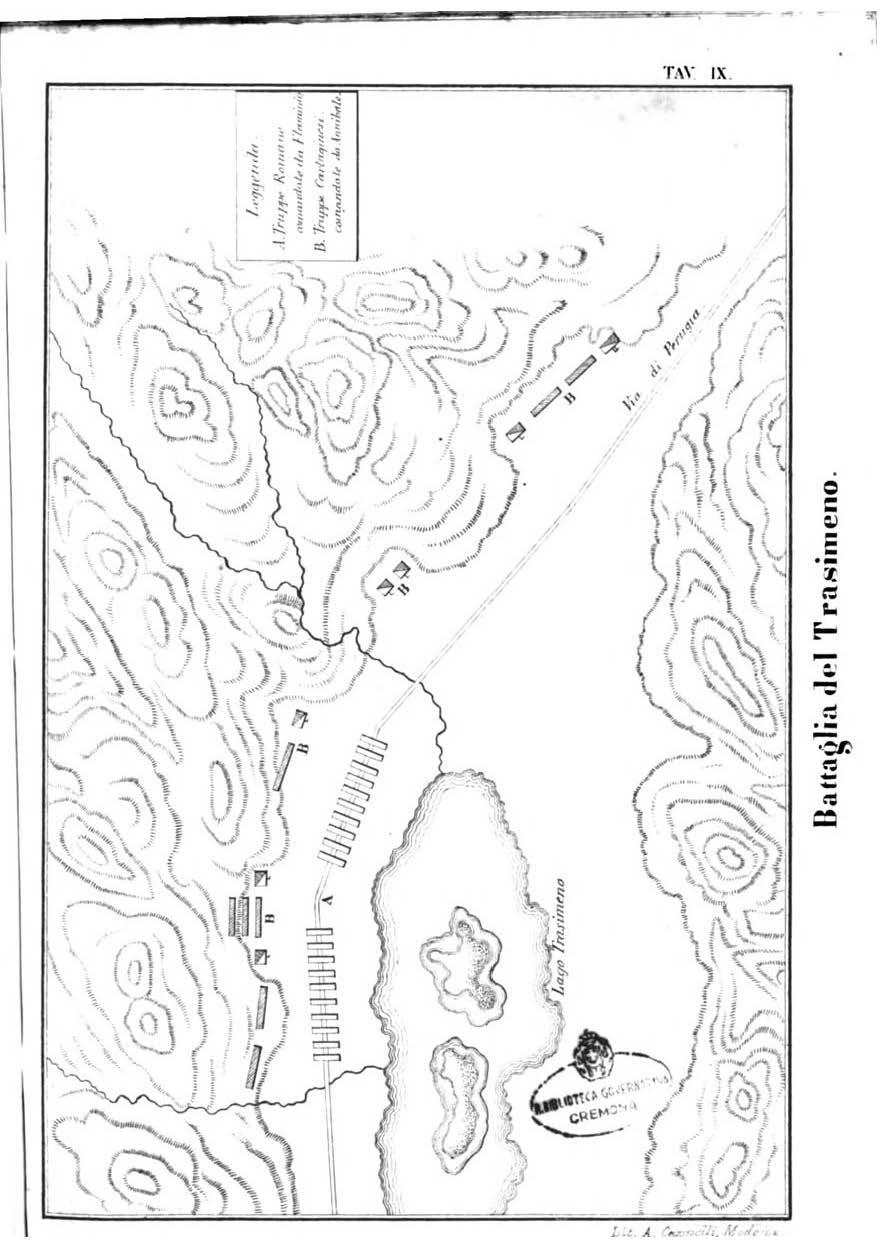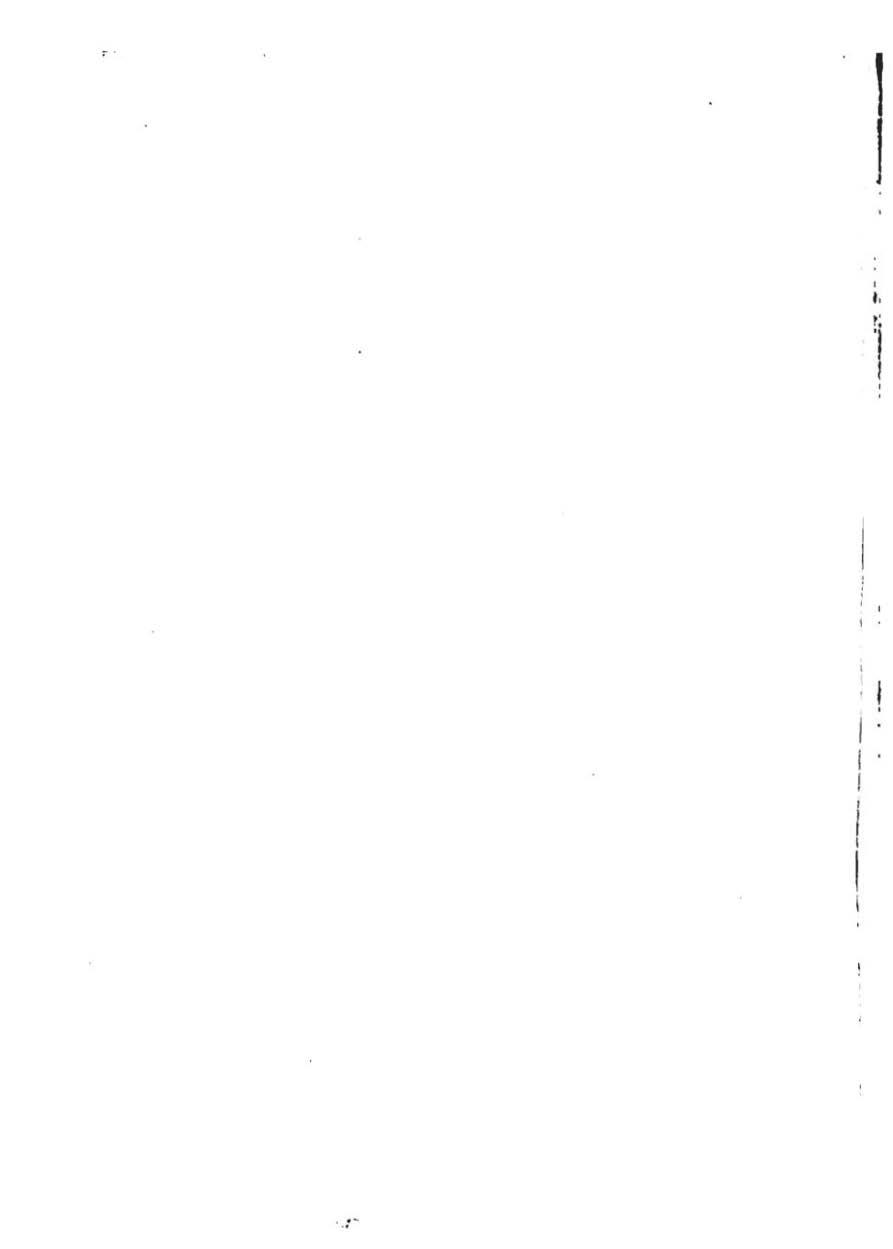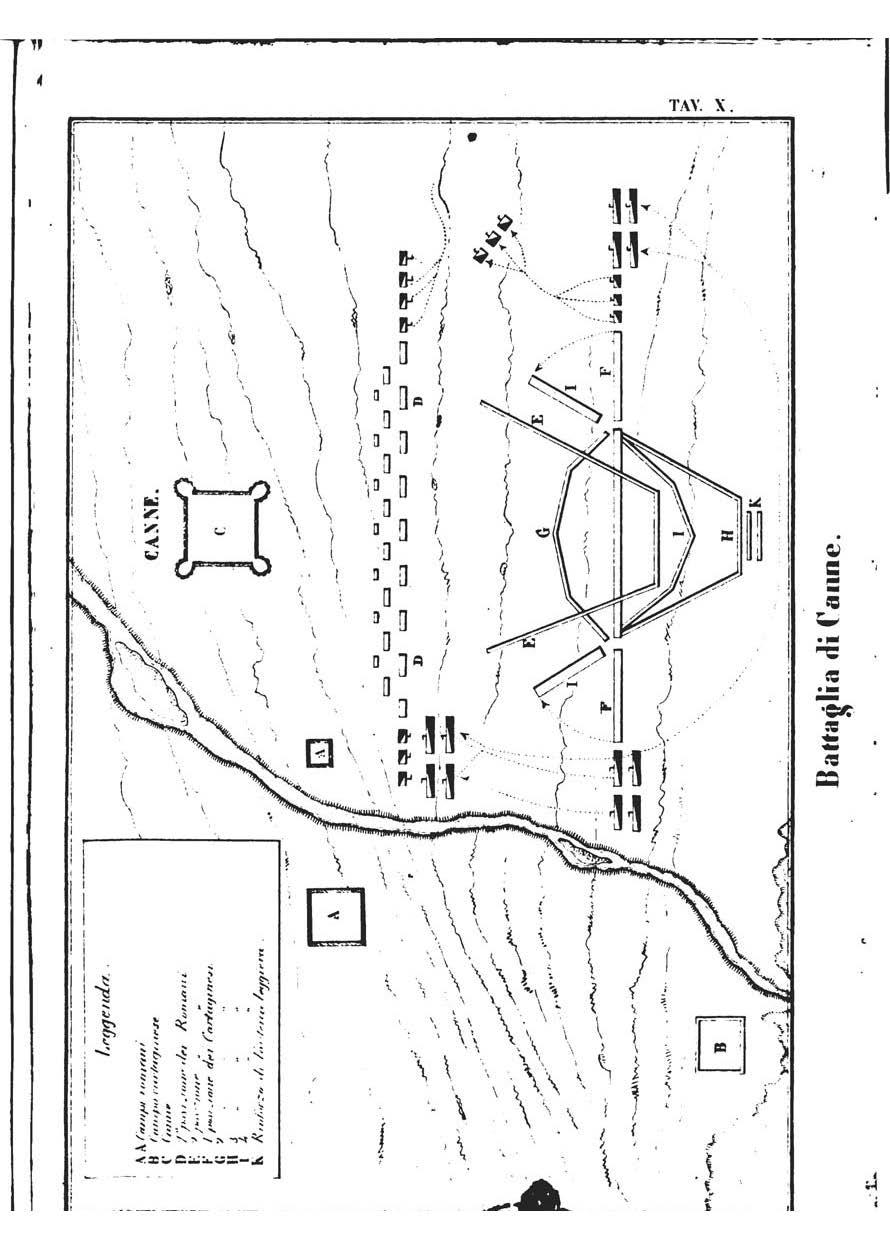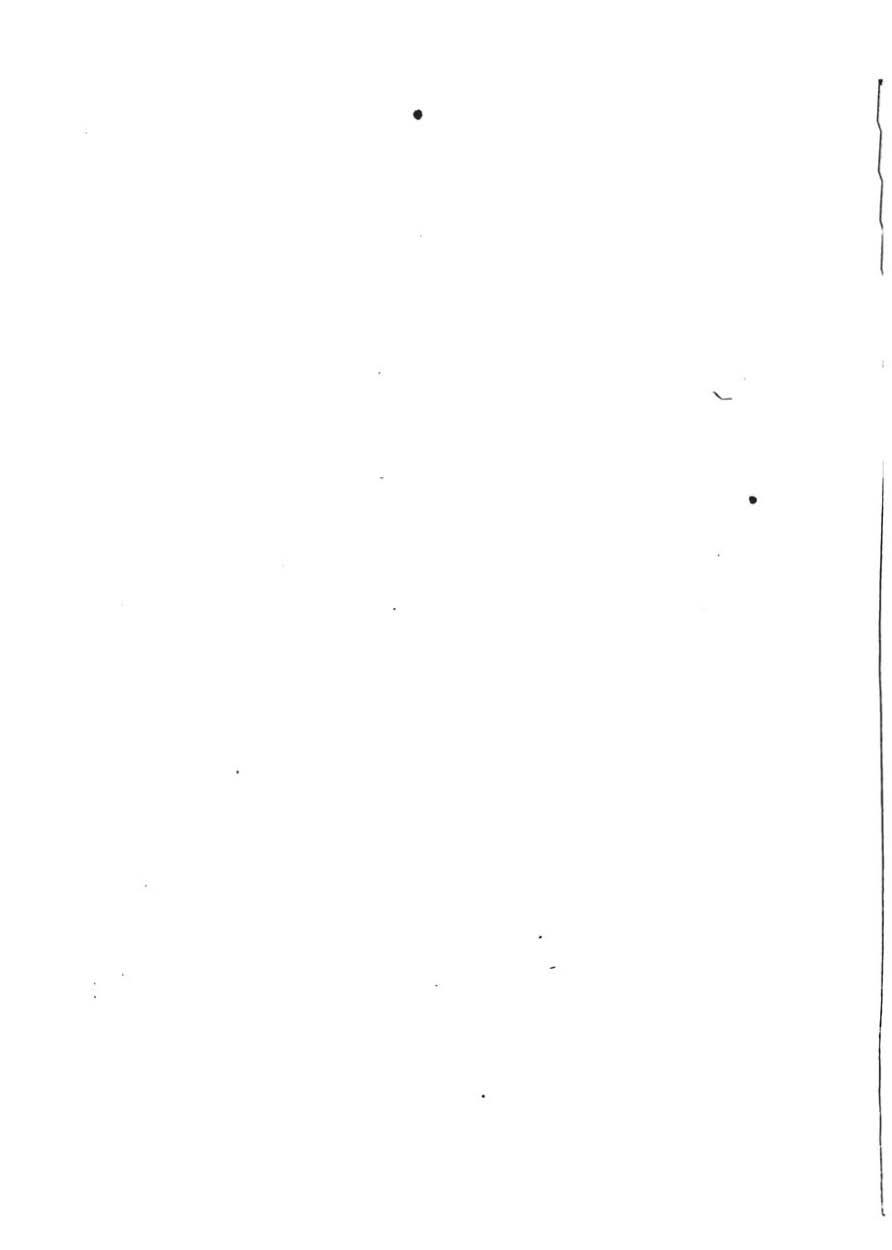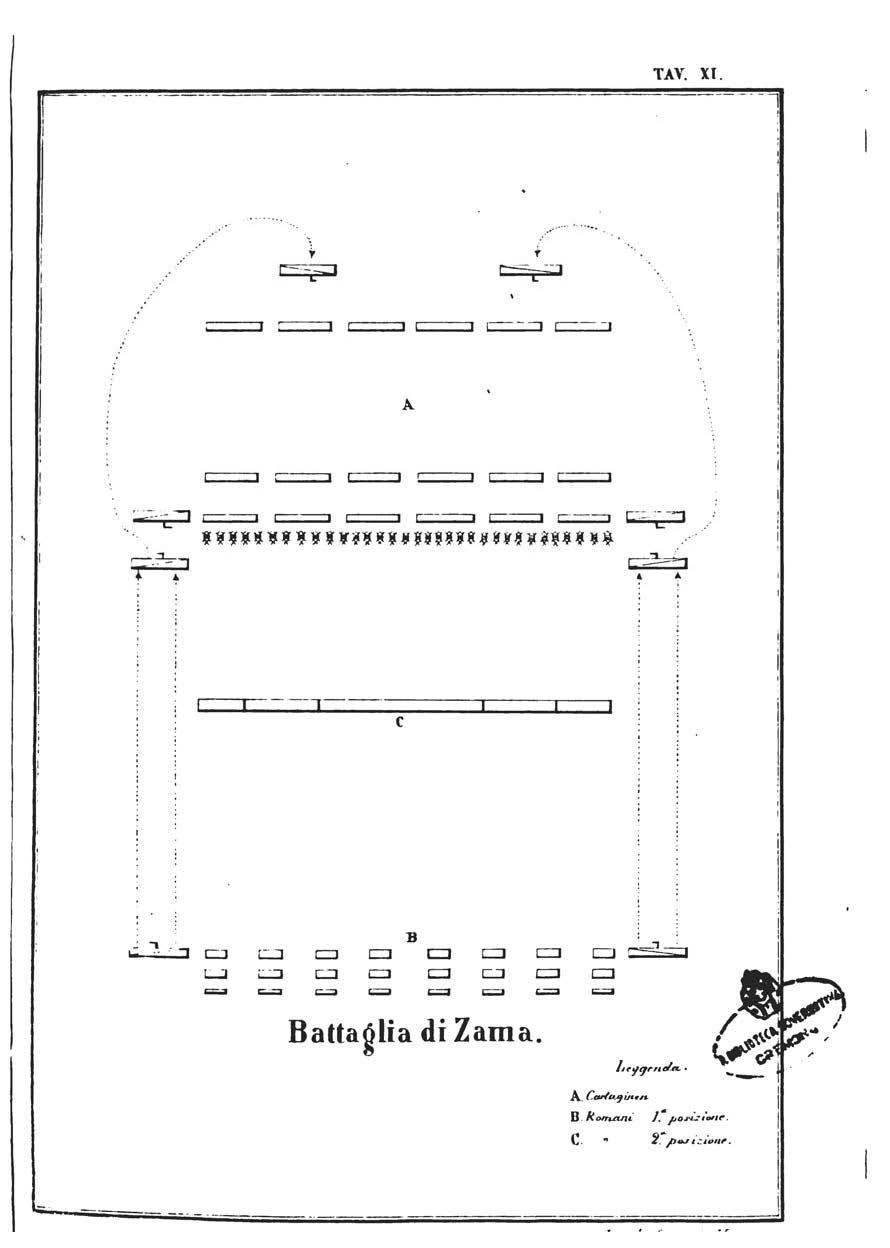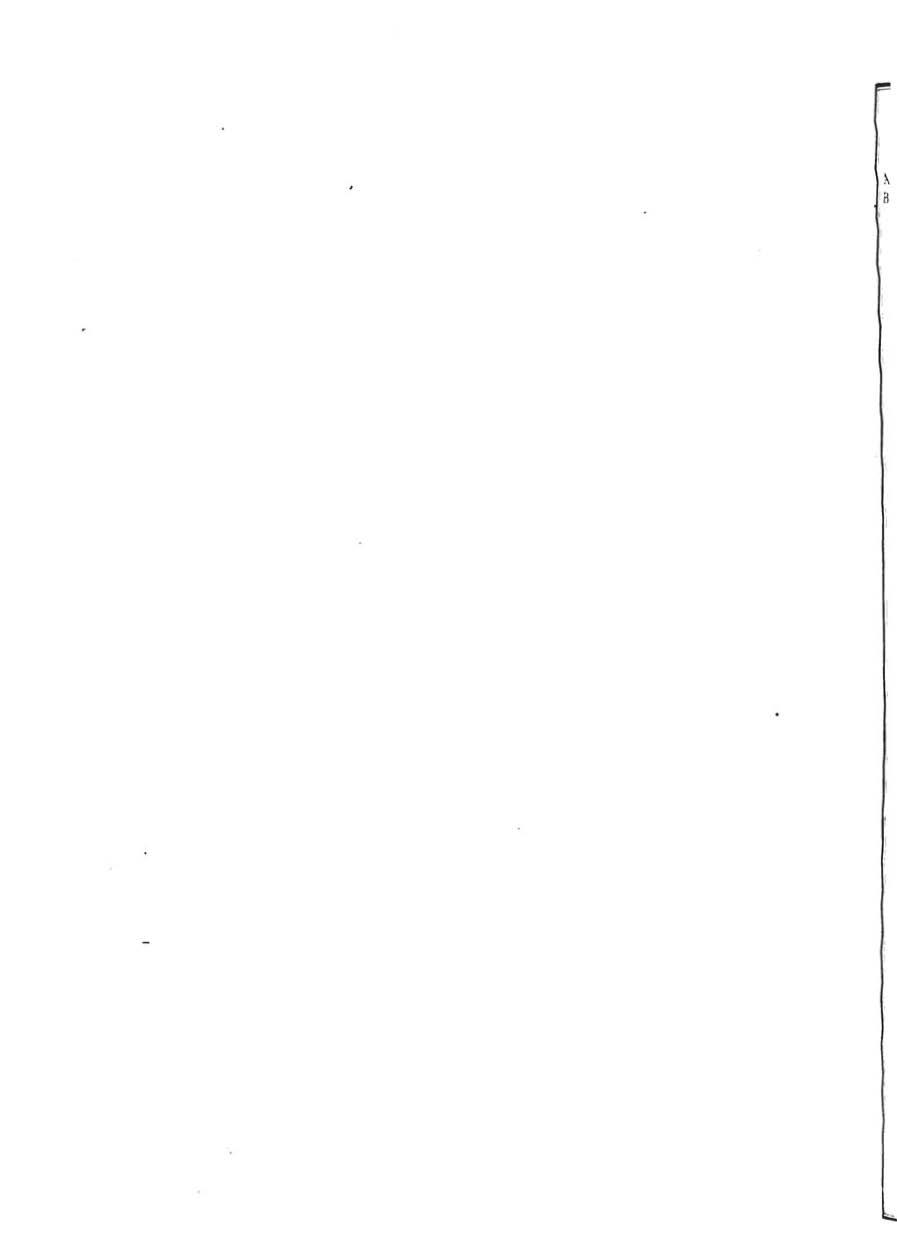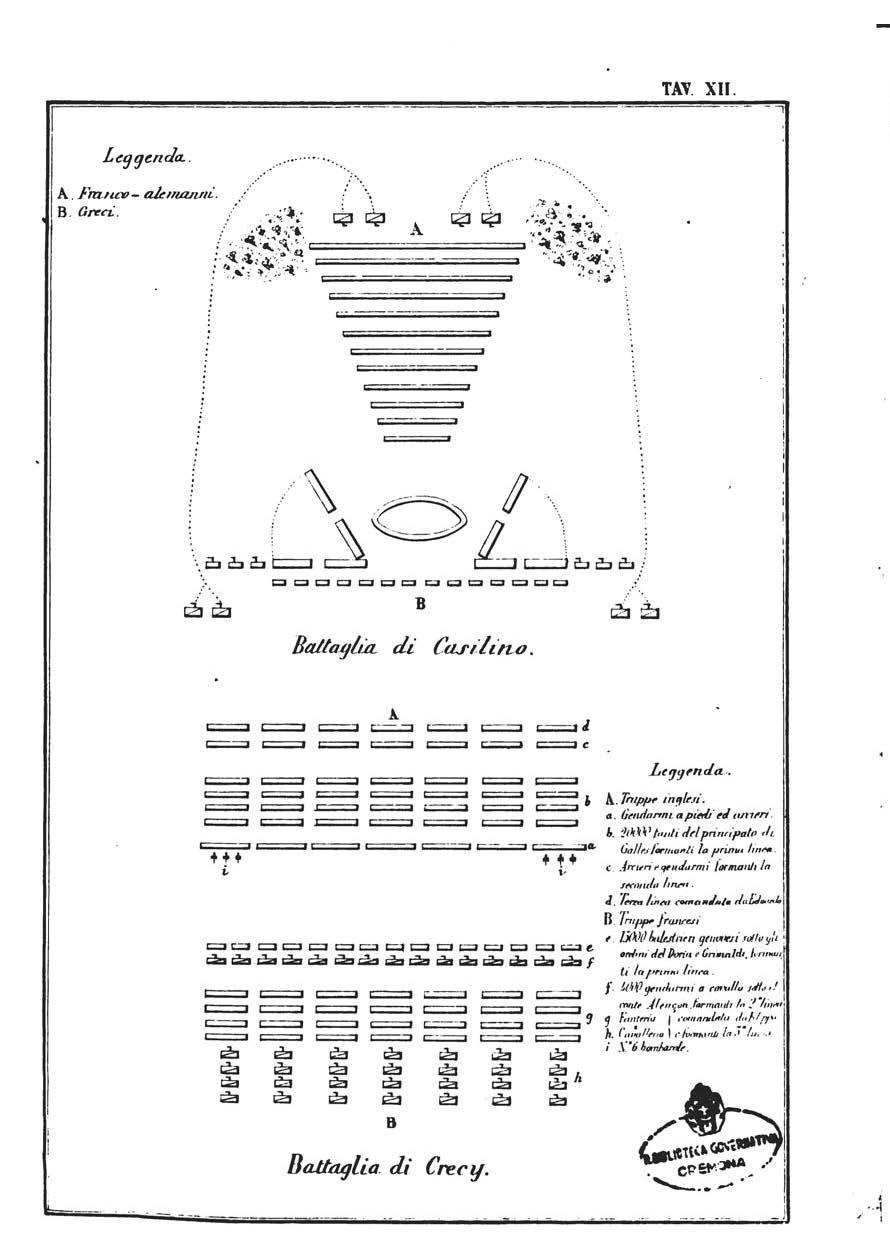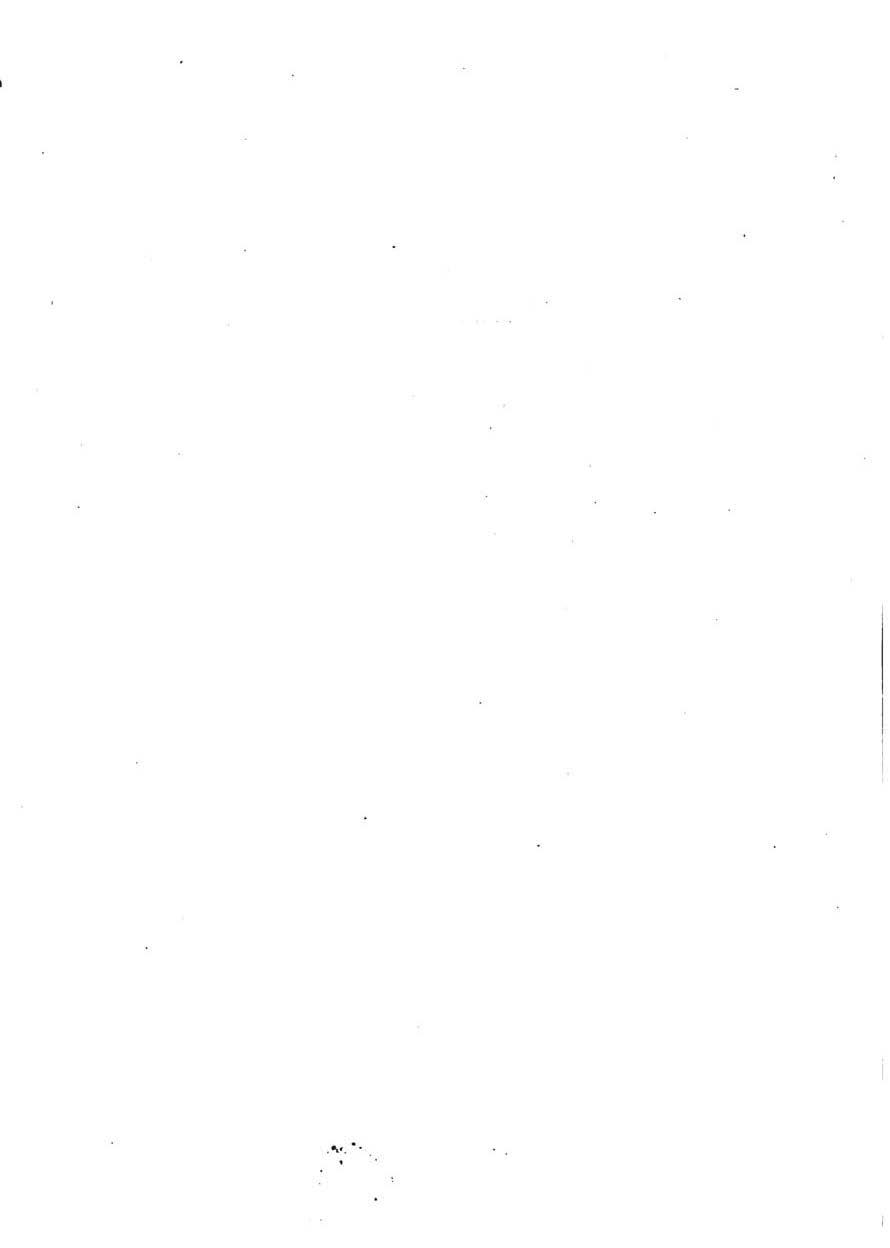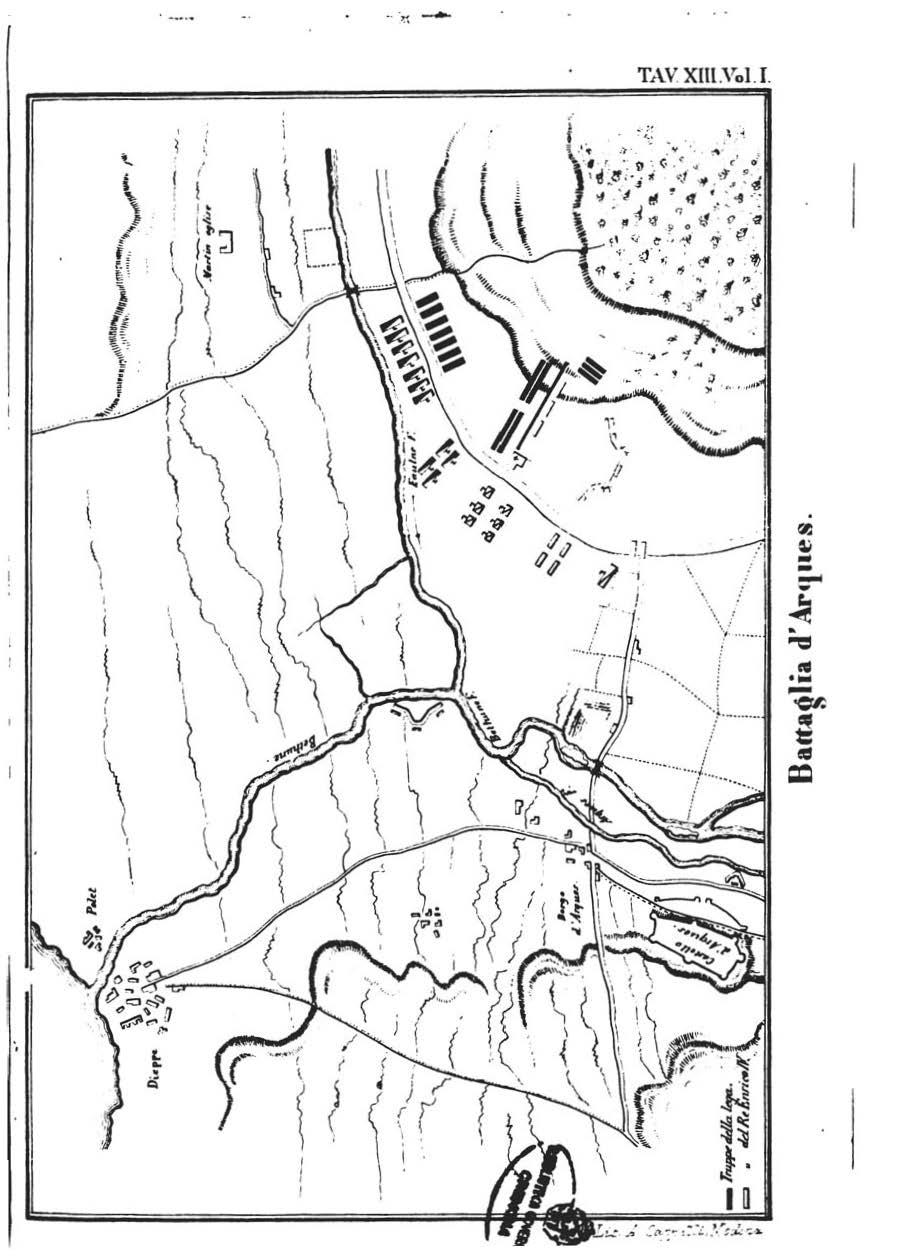DELL'ARTE MILITARE







Storia della 3." Divisione dell' esercito sardo nella guerra del t 859 • t vo'l. con due ritratti e 4 la· vole • Tori11o , Unione tipografico ·editrice· 1860. L. 5, 011. ' Lezioni d'arte e stori11 militare • Modena, Tip. Cap pe lli . 1867.
Biografia del duca di Genova • Tori11o, Unione tip
· ed il. • t 862. •
.
Biografia del genl'rale Cialtlini • Tori11o, Unione tipu · grafico • Pdilrice
O, 50.
O, 50. lliografla del generale Alfonso Lamarmora • Tori11o, Ti· pografla subalpina 1856
1861
Hiogralia del generale Ignazio Ribotti - Torirto e Fi· Tip. Cassone e Comp. • 1866. Sull' ordinamtnlo tlelta mihzia nazionale Tori11o, Ti· Aroaldi 1857 (esa urita ).
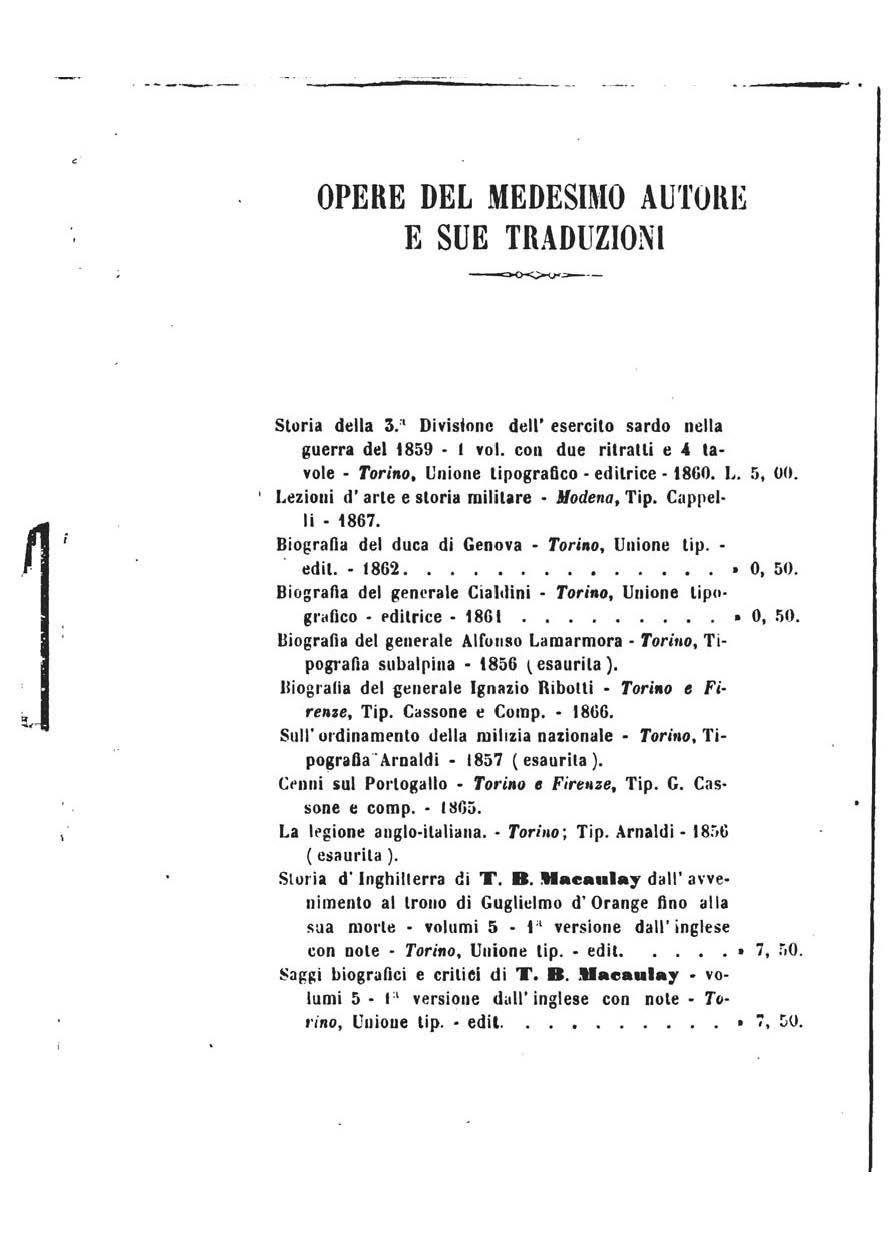
Crnni sul Po•·togallo • Tori1to e Fire11ze, Tip. G. Cassone e com p. • 1!IG5. La li'gione auglo·ilaliaua Tori11o; Ti p Arnaldi • t8r.tì (esaurila ). Storia d" Inghilterra èi T. B. llaea•alay dall' aHe· nimenlo al trouo di Guglielmo d' Orange fino alla sua morte • volumi 5 • t " versione dall'inglese con oote • Torino, Unione ti p. ed it.
.
.
7, ;,o. biografici e critici di T . B. Haeaulay . volumi 5 • l" versione d ttll' inglese con nole • To · r·in o, Uuioue tip • edit. ,
7,
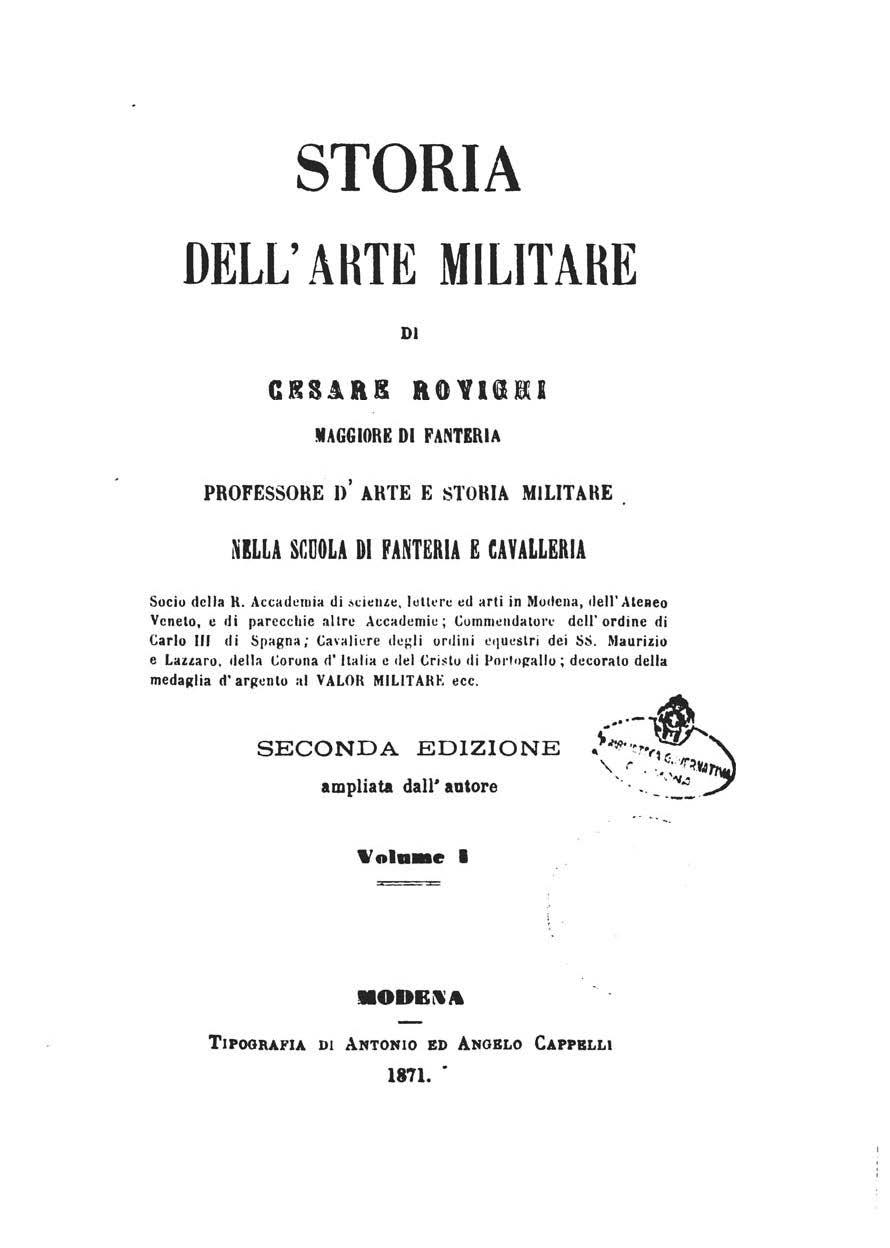
Soc io della l\. t! i oci•nLt. lullcrc in tlell' ,\leAeo Vene to, c di parecchie :tllrc Accademie; dell'ordine di Carlo 111 di Spagna; t:avalicre urtlini dei SS. Maurizio e Laztaro tlella t:oruna Il' Italia c tld tli J•or l••l!alfo; dccouto della meda11lia d'arjl c nto al VALOJt MJLITAHE
TIPOGRAFIA DI AMTONIO ED ANOBLO
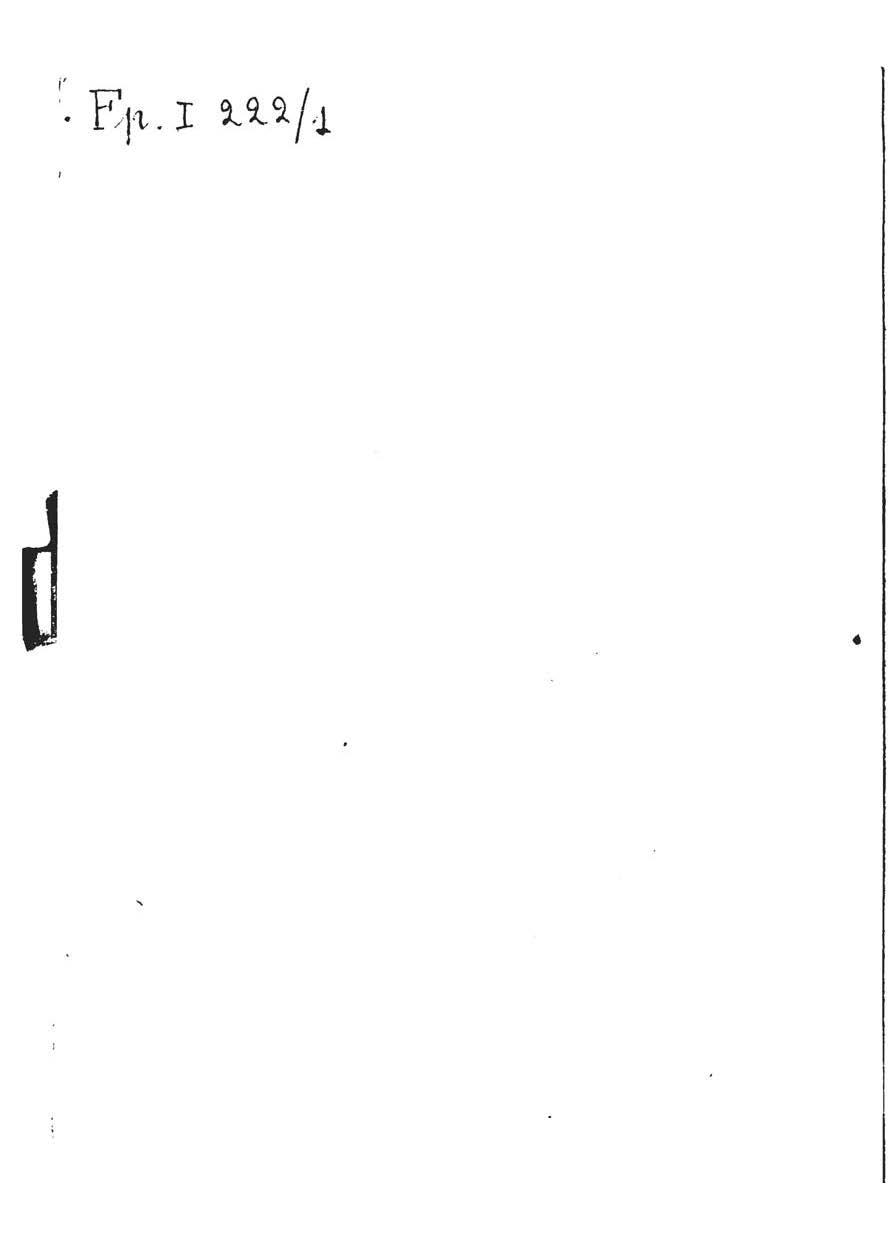
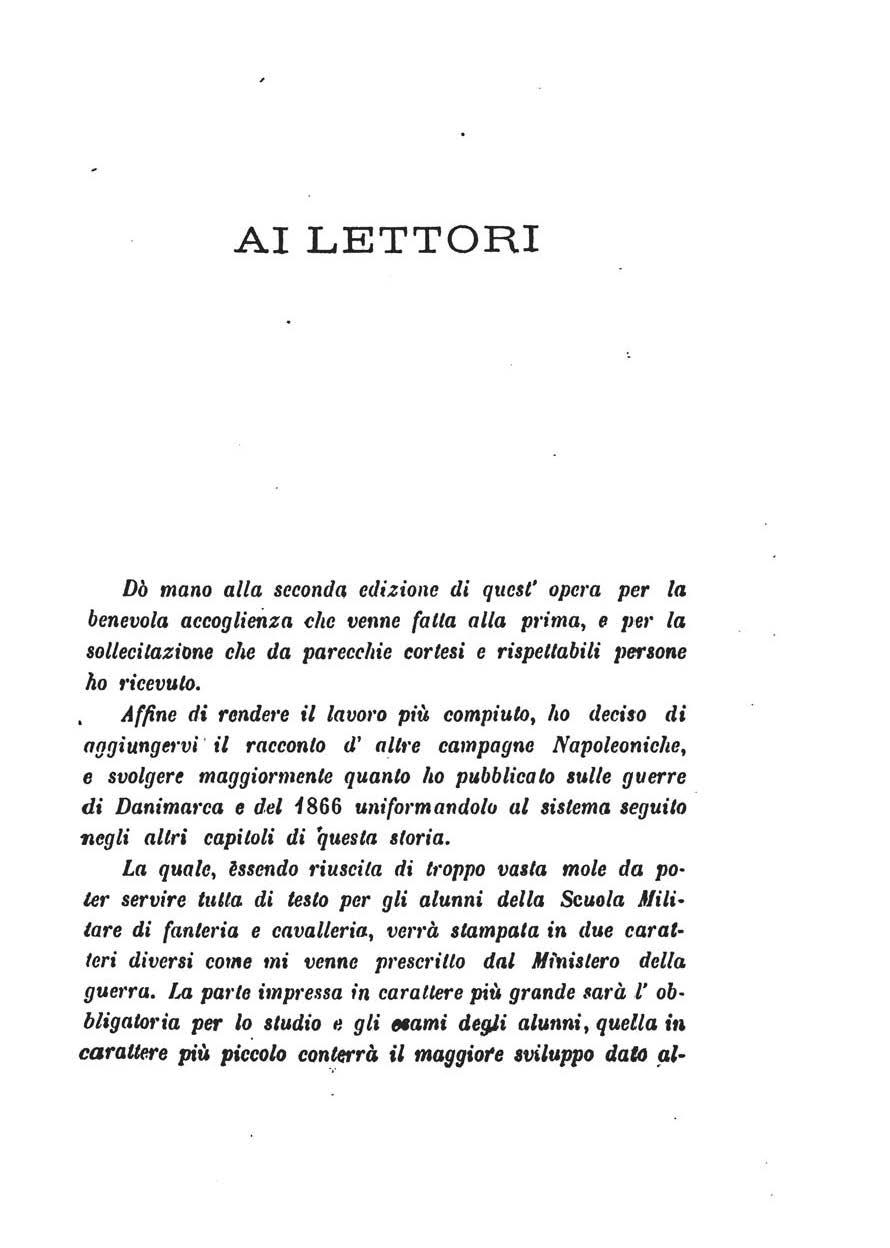
Dò mano alla seconda edizione di que&t' opera per la benevola accoglienza clw venne fatta alla pt'ima, e 1Jer· la sollecitazione elle da parecrllie cortesi e rispettabili 1Jeraone ho t•icevuto Affine di ronder·e il lavol'o più compiuto, Ilo cleci1o di a!}giungtt·vi · il racconto d' a.ltt•e campagne Napoleoniclte, e svolgert maggiormente quanto Ilo pubblicato aulle guerre di Danimarca e del -f 866 unifor·m an dolo al si&tema seguito negli altri capitoli di questa atoria.
La quale , riu&cita di ttoppo val/a mole da po· ler servire tulla di te&to per gli alunni della Scuola A/ili· tare di fanteria e cavalleria, verTà stampata in clue caratteri diversi cor11e mi venne pr·escritto dal Mr"'nislero della guer·ra. /..a parto ;n carattere più grande Jtarà .l' obbligatot·ia per lo_ studio e gli degli alunni, quella in carattere più piccolo conterrà il maggiote aviluppo dato pl· ,·
l' opera e non farù Jlm·te integratlle del scolaslir.o elle mi è affidato.
Ilo pt·ocurato di tellel' linguaggio elle possa essere com· preso da tutti. In questi tempi in cui le armi non coslitui · scono una professione od un mestiere serbati ad un celo sepa·, mio della ' .wzione, tutto quanto tende a divulgare le cogni z ioni che si riferiscono a cose militari ha scopo utile e patriotico; imperocchè si può rirucit·e in tal ad ispit·m·e viemmeglio i cittadini a senti;nenti marziali, si può concorrere ad intJogliare l' universale agli stuclii bellici, e acl alimentm ·e cosl quel sentimento che dù forza alle na· iioni, e le mantiene libere perci1è t·ispettate, indipendenti pere/tè lenudn.
Non voglio ristarmi clal dichiarare, come feci nella pt·ima edizione, elle avendo rieorso pet· questo lavoro a moltiuimi libri antichi e moderni, vi Jw talvolta riporta ti in-
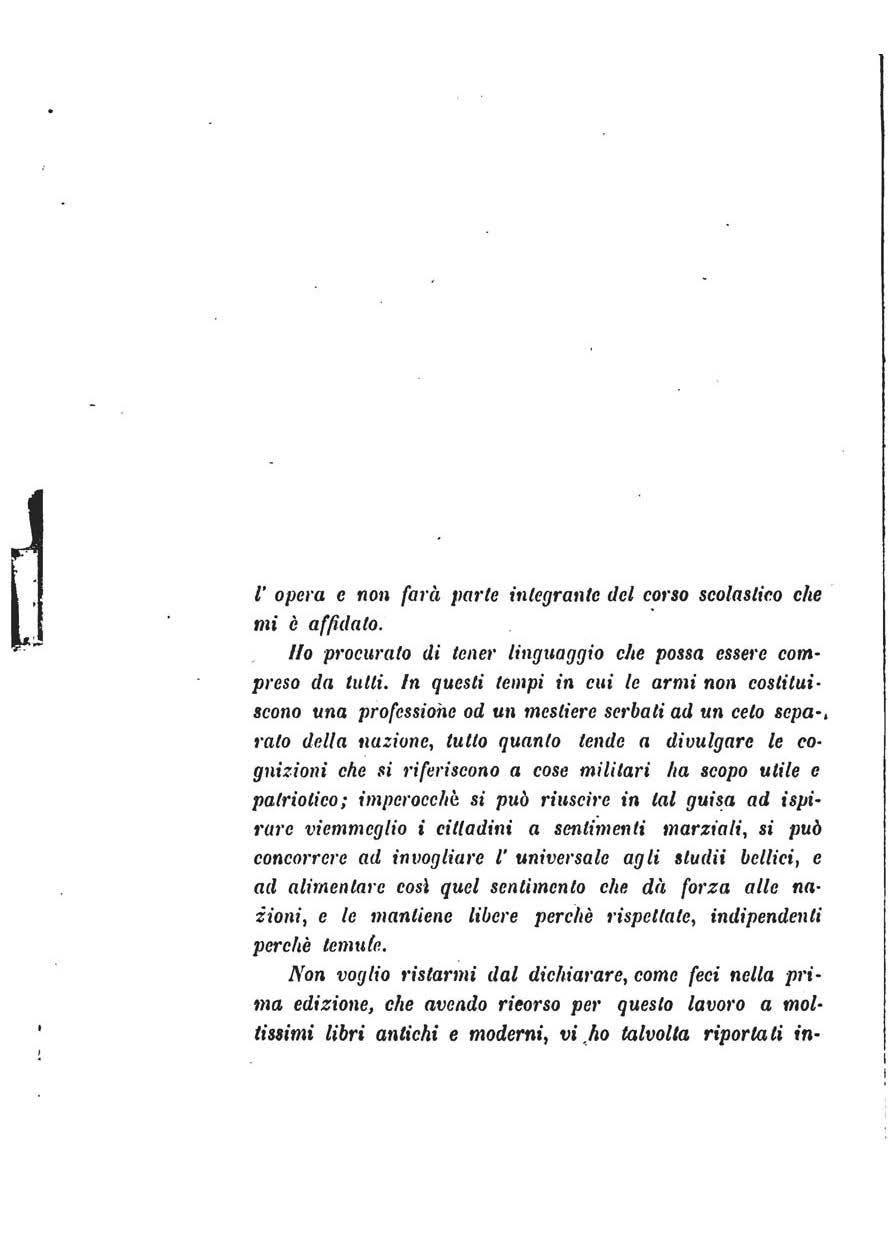
teri brani di oper·e altrui, qualor·a lw mvvisalo clte ciò si potesse fare senza turbare l' armonia dell' insieme, e fosse atto a portare a meglio la de' miei concetti. Quindi, non volendo opJH'oprinrmi le altrui cose citerò, le fonti a Citi attinsi.
&Jotlcma - Dicem br e 1870. ,
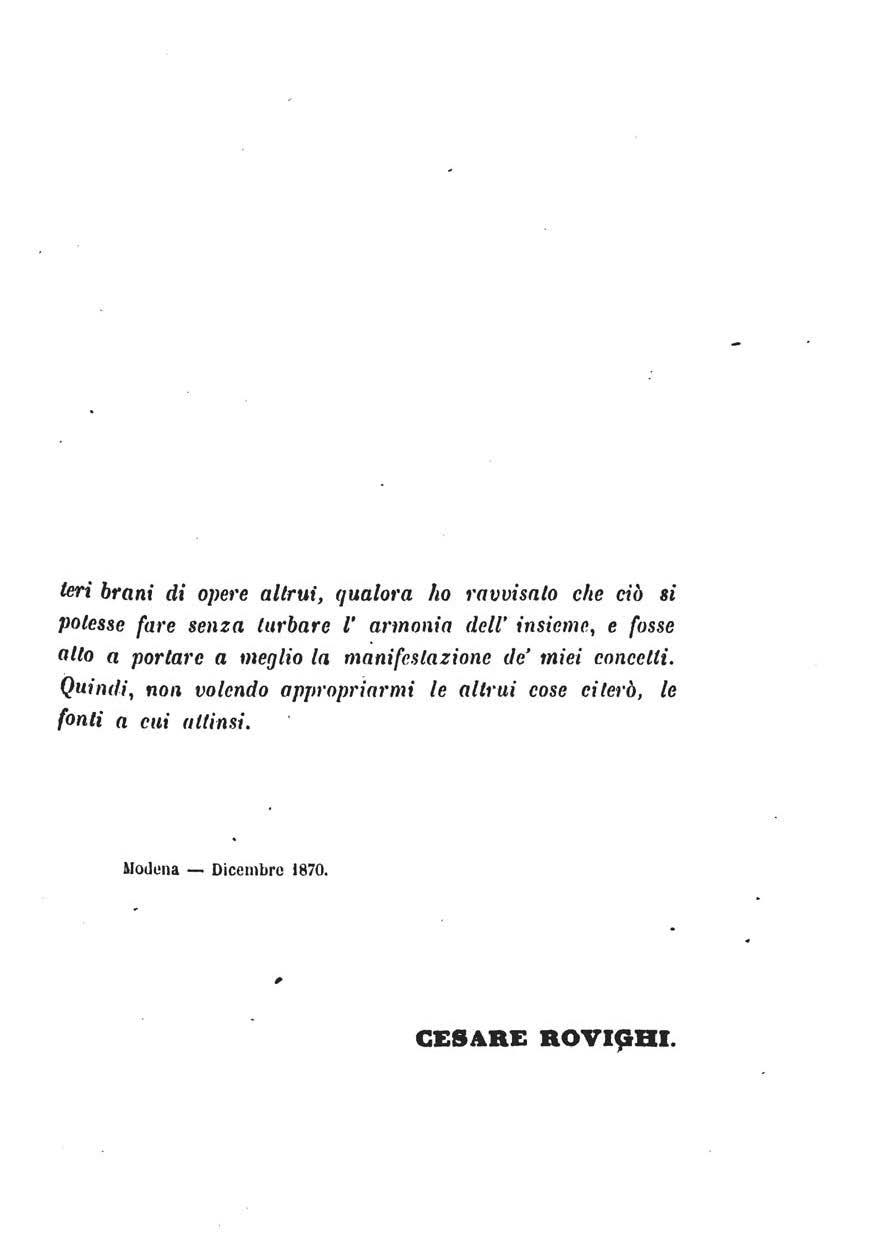
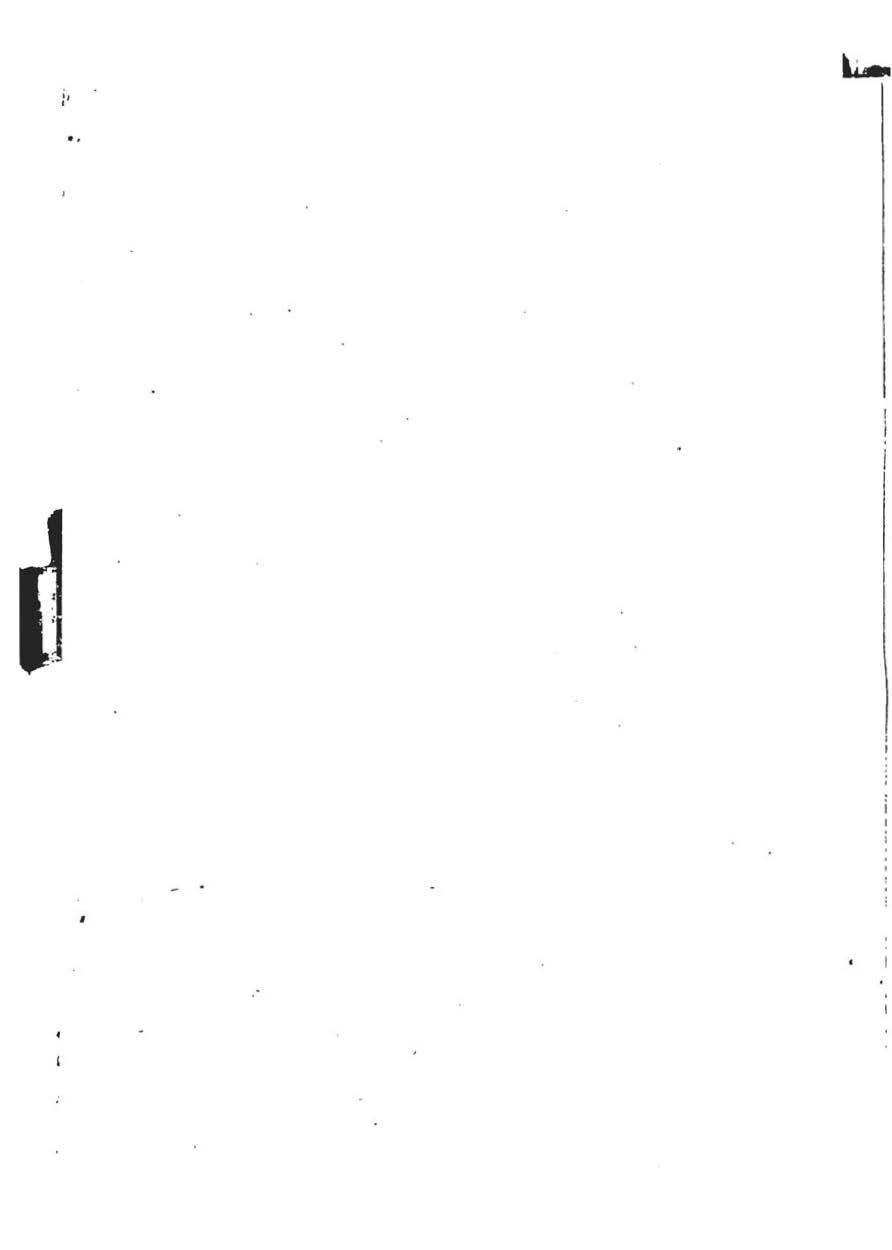
l. Definizioni dell'arte mili tare IJ . In che consista la Storia dr.ll' arto militare III. Utilità d ella Storia dell'arte milit:1rc IV . Cost ituzione degli eserciti V. L' ordillliiiiC11lO VI. L'azione- VII. l"bp porti dell'arte mili tare collo stato sociale, colle scienze, colle lettere, c collo arti VIII. Da qual punto si d eve incominciare la Storia mil it are IX. Idee sull'origine c sui primorrlii dell' arte X. Gli esercit i antichi: drgli egiz i: degli assi r·ii: di altr i popoli: dei grec i : dci romani XI. l te mpi di mezzo- X II. l tempi moderni XIII. Programmo dell' insr g namcn to X IV. Come verrà sviluppato -.
l. L' arte militare va soggetta a moltissime definizioni ; ma siccome il trattenersi a lungo intorno :1tl esse, cd alla _discrepanza che su tal e oggetto regna tra scrittori di • cose di .guerra, avrebbe caratll'rc di vana discu ssione nccndcmica, dalla quale nulla sca turirebbe di ut ilit t\ 111'11' atto pratico, così ci limitiamo ad accennare qu ella che più di
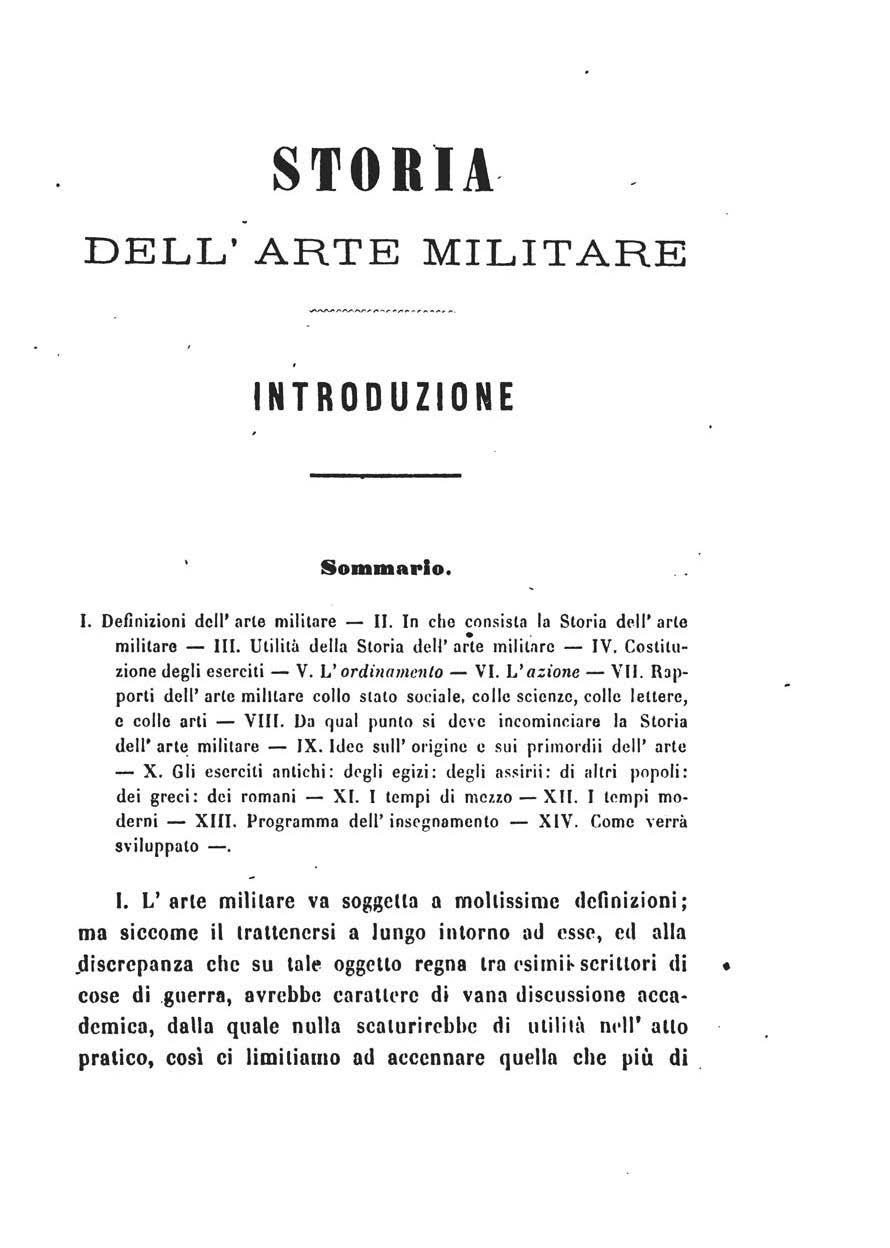
8ogni nltra ci sembra a proposito per servire di norma e di guida al metodo c he intendiamo seguire nello sviluppo di questo lavoro.
L' nrle militare consiste nel modo di ordinare gli eserciti e di f:u·Ji agire convenientemente cd utilmente.
Le parti principali adunque che formano il soggetto dell' arte militare sono: l' ordinamento c l ' azione.
Il. L' esposizione del modo di ordinare c di agire dai rem o ti tempi. fino a noi, costituisce l' oggctlo della Storia clell' arte militare.
111. Ma quale utilità havvi nello studio di questa sto· Non sarebbe per avventura una fatica da serbarsi ni dotti cd ai Ctll'iosi, anzichè da t·ichictlersi alla generalità dei cullori dell' arte l primordj, lo sviluppo, il progresso, il perfezionamento di ogni scienza. c di pgoi nrte, e delle singole parti di cui c qu ella si compogono, interessano talmente chi si dedico allo studio di esse ùa farci tro vare in ogni prcc!puo stabilimento d' istruzione una cattedra speciale, apposita. mente destinala n spargere lumi sull' origine, sulle vicissituùini, sull' andamcnlo di una data pnrte dello scibile umano. Quindi vediamo, a cagione d' esempio, nelle università l' insegnamento della Storia della mcdicitla pcgli studiosi dell' al'tc salutare, quello della Storia de.,l di,·illo pegli studiosi delle um:mc le ggi.
E che bisogno sarebbèvi , potrebbe dire tnluno, di confonder e la testa dci giovani coll' esporre i metodi ed i prc· celti d' lpocrale, di Galeno, di Averroc, mentre tonti rimedj eroici, tnnti sistemi felicemente sperimentati, erano total· mente ignoti o quelle antichità della scienza, sicc hè i tempi
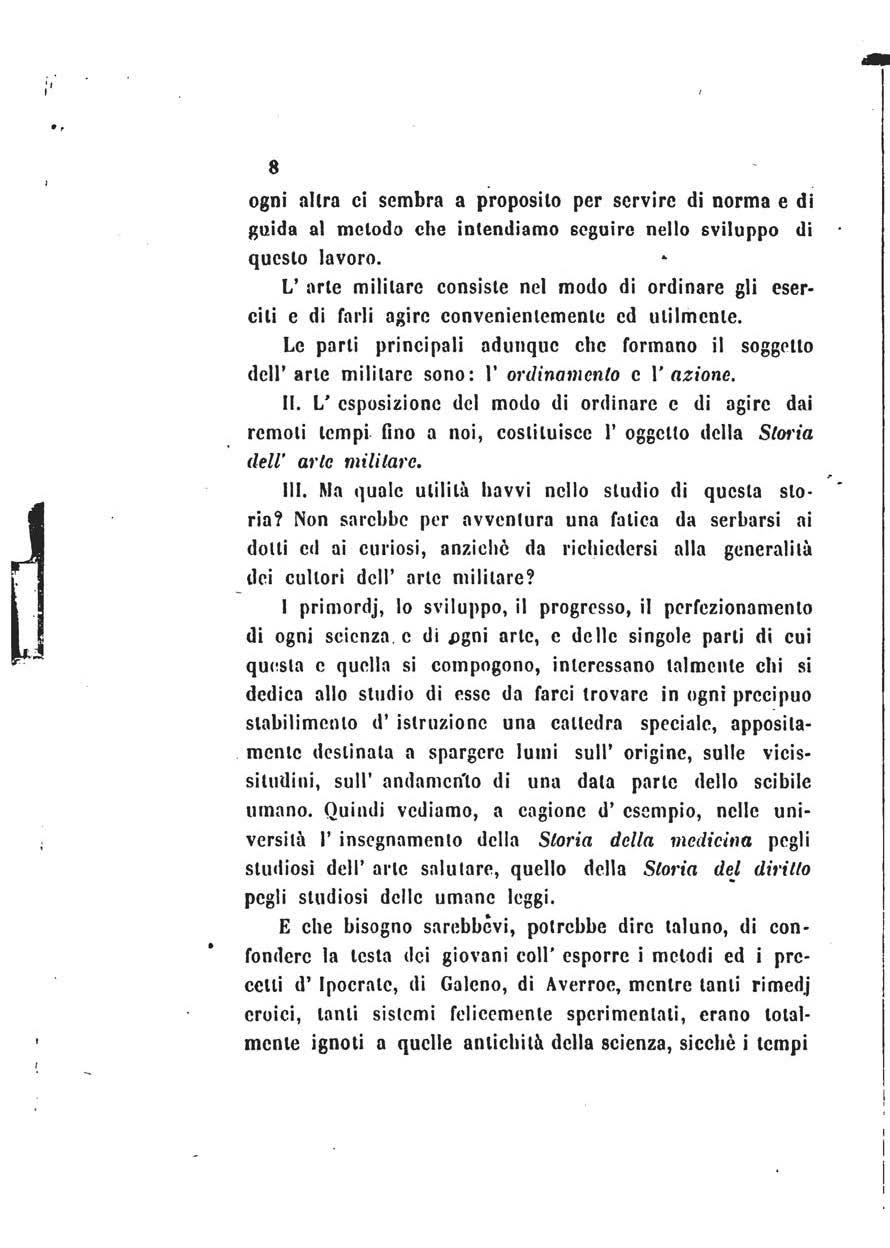
moderni si . possono considerare totalmente separati dai . più remoti? basta occuparsi della medicina oggitlì attuata, lasciando i n ·paec l' ombra dci greci antichi e degli arabi del medio evo?
Che bisogno sarebbevi d' infastidire le menti col nar· rare in lunga litania il succedersi d(!gli avvenimenti precipui .che mutarono alla scienza del diritto il principio c l' cssenza,non che i cambiamenti che tullo il sistema del giure medesimo ha subito? Non basterebbe il codice che si tro\oa attualmente in vigore, senza imbarazzarsi di ciò che si faceva ai tempi dei romani c dci barbari del settentrione?
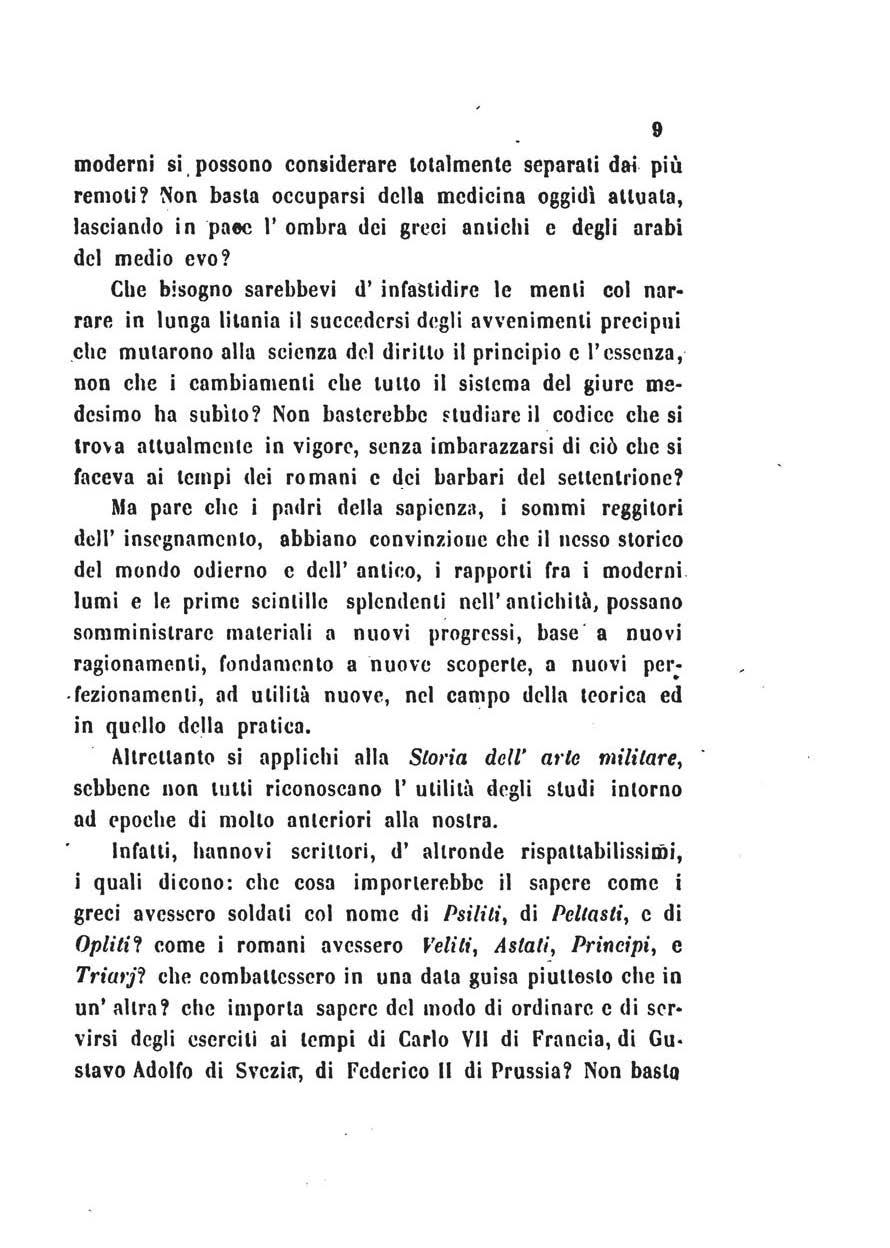
Ma pare che i padri della sapienza, i sommi reggitori dell' insrgnamcnlo, abbiano convinziouc che il ne sso storico del mondo odierno c dell' anli(:o, i rapporti fra i moderni. lumi e le prime scintille splendenti nell'antichità, possano somministrare materiali a nuovi progressi, base · a nuovi ragionamenti, fondamento a ·nuove scoperte, n nuovi per; . rezionamcnti, ad utilità nuove, nel campo della teorica ed in quello della pratica.
Altrettanto si applichi alla Storia dell' arte militare, sebbene non tutti riconoscano l' utilità degli studi intorno ad rpoche di molto anteriori alla nostra.
Infatti, hannovi scrittori, d ' allronde rispntlabilissimi, i quali dicono: che cosa importerebbe il sapere come i greci avessero soldati col nome di Psilili, di Pellasti, c di Opliti? come i romani avessero Velili, Astati, Principi, e che combattessero in una data guisa piutl6slo che in un'altra? che importa sapere del modo di ordinare c di S('r• virsi degli eserciti ai tempi di Carlo VII di Francia, di Gu. stavo Adolfo di Svczi:r, di Federico Il di Prussia? Non basto
t O
sapere dell' oggi e del jeri, o tutto al più, di quanto i nostri vecchi, viventi ancora, videro nell'epoca di Buooaparte su tanti campi di vittorie e Ili sconfitte? Qual uopo havvi di fermarsi a parlare degli scudi, delle sarisse, dei pili, degli arieti, delle catapulte, mentre l' applicazione della pol· vere separa intieramcntc gli usi, i costumi, le operazioni della guerra nostra da quanto greci e romani solevano pra· ti care?
Usi c costumi sì, sono diversi, risponderemo noi; grandi precetti no; imperocchè l' arte e la scienza della guerra hanno principj generali che restarono immutabili col succedersi Ilei secoli; c che se sembrarono scompnrsi, od almeno decaduti al sommo, io un' epoca trista nella quale tutlo quanto vi era di granrle scomparve o decadde, pure rivissero col rivivere delle ahre parti dello scibilc, cd offrirono ai· moderni i tesori dell' antichità da cui si estras&&ro materiali preziosi pel nuovo ellifizio che si andnva ad erigere.
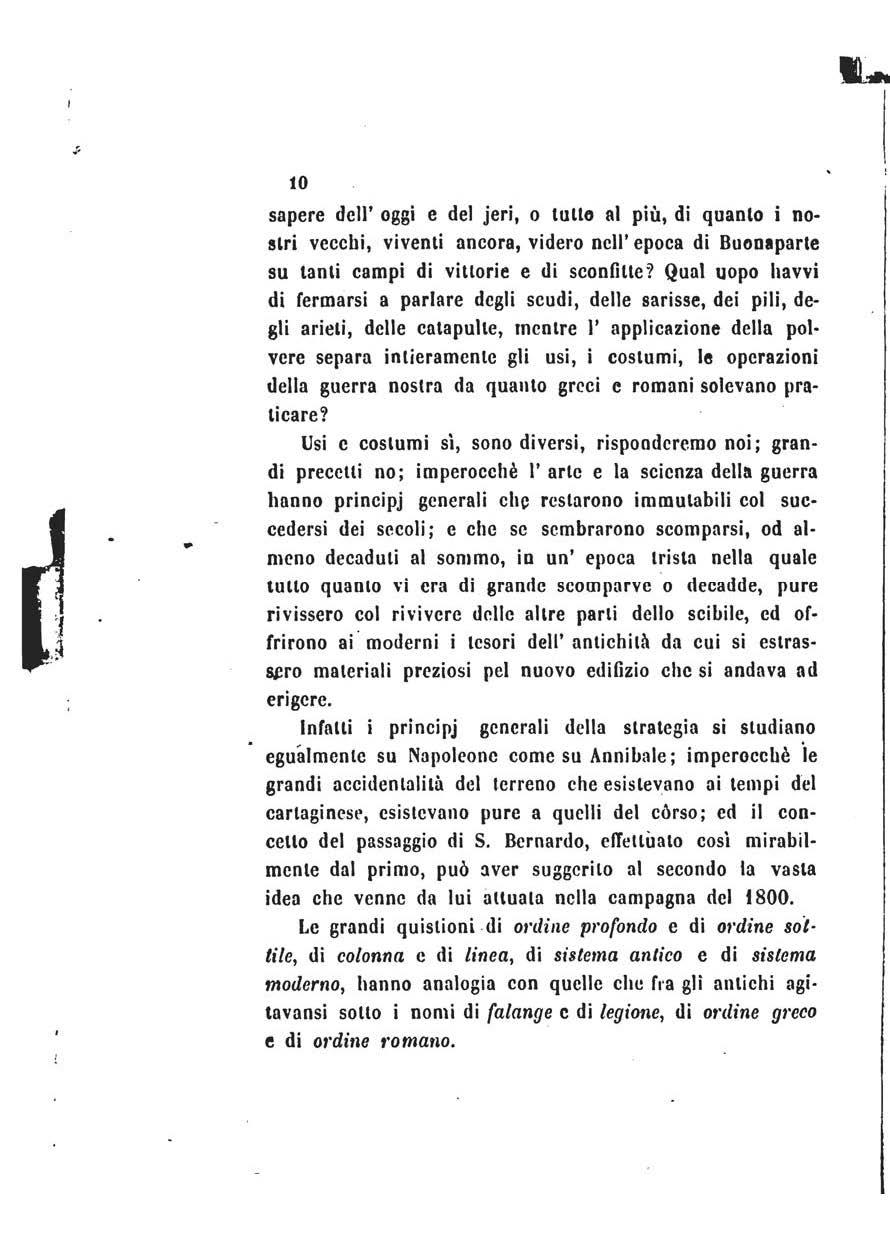
lnrntti i princlpJ generali della strategia si studiano egualmente su Napoleone come su Annibale; impcrocchè ie grandi accidentalità del terreno che ai tempi del cartagi nest•, esistevano pure a quelli del còrso; cd il concetto del passaggio di S. Bernardo, cfTcttùato così mirabil· mente dal primo, può aver suggerito al secondo la vasta idea che venne da lui attuata nella campagna del t 800.
Le grandi quistioni -di ordine profondo e di ordine soi· ti/e, Ili colonna c di linea, di sistema antico e di sistema moderno, hanno analogia con quelle che fra gli antichi agi· tavansi solto i nomi di falange c di legione, Ili orcline greco e di ordine t'O mano.
tt
Il sistema di reclutamento, che forma base 'precipua della bontà di un esercito, venne dai mC?derni informato al sran prmc1p10 che dirigeva così fatta operazione fra i greci ed i romani. Inraui, greci e romani stabilirono che ogni cittadino è obbligato a concorrere alla difesa della patria, ed ebbero quelle falangi che salvarono la Grecia a Maratona, quei soldati che_seppcro morire alle Termopili, quelle legioni che portarono l' aquila vincitrice nell' emula Cartagine. Ma t1i mano in mano che negli eserciti di Grecia o di Roma s' introdussero schiavi, stranieri, mercennrj d' ogni quegli eserciti crebbero bensì ael numero d' armati ma diminuirono di erlìcacia, finchè In corruzione fini di sciogliere ciò che dapprima era cementato soltanto · dall' amore della propria patria. Il medio evo 'che rovesciò ed annientò tutto quanto esistevo di buono nel mondo antico ,. cangiò pure totalmente, e in peggio, il sistema di raccogliere gli eserciti; ed ebbe per coo)bauenti, o cavallieri che guerreggiavano per sè, o turbc di villani senza ordine e Sfnza onore, o mercenarj che si . vendevano al primo o migliore acquirente. E, con poche eccezioni, si ebbero guf!rre misernbiJi, senza finezza di arte, senza vastità di concetti, senza grandezza di risultamenti. Risorta la civilià, si rontinuò per secoli a ricorrere all' opera dei mercenarj, pericolosa talvolta, incerta sempre; si richiese alcuna fiata, cd in limiti ristrelli e mal regolati, il braccio del .cittadino, ma non si ebbero veri cscrcili di cittadini; finchè negli ultimi tempi, ispirandosi ·a quanto di sublime nvcvano gli antichi nelle istituzioni loro, si adouò ampiamente cd esclusivamente il nobile ed utile principio dei greci e dei romani che ogni cittadino è obbligato a concorrere alla difesa della patria;
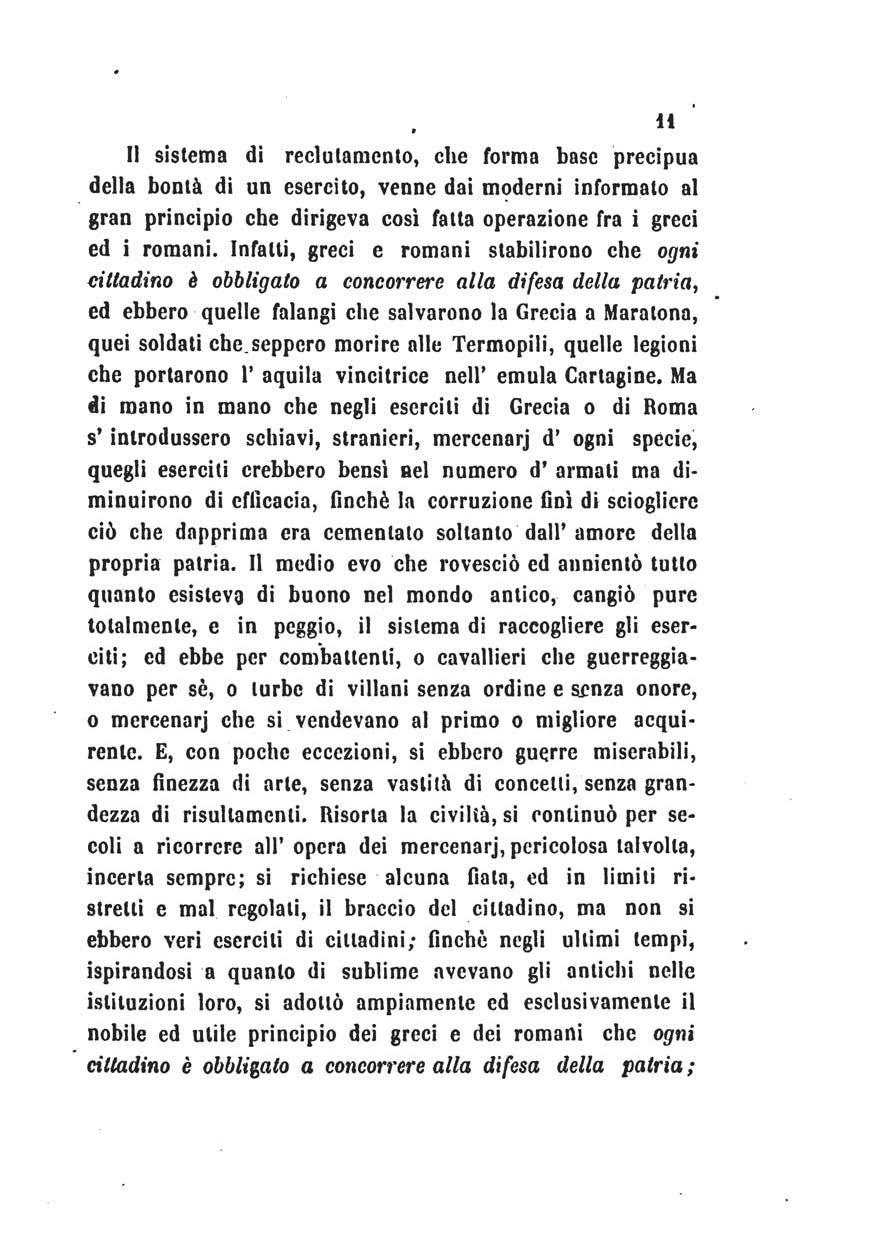
e si ebbero quegli eserciti di Francia che respinsero tulla Europa riunita a d_anno della loro repubblica. Ora, fu lo studio della Storia dell' arte militare ar1tica che suggerì agli uomini della rivoluzione francrse la più ampia applicazione del principio di reclutamento che vigcva fra i primi due popoli dell'antichità, c che produsse quel bene che invano si sarebbe sperato attingendo a fonti più mod erne si, ma as s ai più impur e.
Un altro esempio. Fino ai tempi poco discosti dai nostri, fu generale l' opinione dci governi che per aver soldati capaci di cieca obbedienza fosse mes tieri lo averli ignoranti. Non così la pensavano i · romani: essi insrgnarono ai cittadini a servire nell ' esercito prr amore drlla patria e della costei grandczz11; cd aflìnchè pot ess l·ro bene comprendere qut>sto sentimento, la r e pubblica cer.cò di sviluppare le loro intelligenze coHo studio c cogli utili ammaestromcnti; dile legio ni che ·Jibl'rarono la patria dalle invasioni punichc , c portarono tanto lungc le loro conquiste, componcvnnsi di quanto vi era distinto per intelletto nel paese. Vari stati togliendo guida dagli antichi romani, vogliono che i loro eserciti s i facdano di soldati intelligenti , c ne svi lup pano la mente coi metodi più appropriati d' inse· gnamento; patria, gloria, onore, s'imprimono nei cuori dopo aver passato il crogiuolo del rngionamento; c ragiona sano la mente illuminata, c. non la mantcnula nelle tenebre del · l' Così facciamo anche noi nel nostro giovane esercito italiano; imitnnùo gli antichi, vogliamo lo sviluppo dell ' intelligenza nei soldati, ed· in ispecial modo in chi esercita o deve esercì ln r c un comando sop1·a di essi; c speriamo di averli tali da f<lr tri()nfare, nelle prove che ci fossero serbate, il vessillo della nostra nazione.
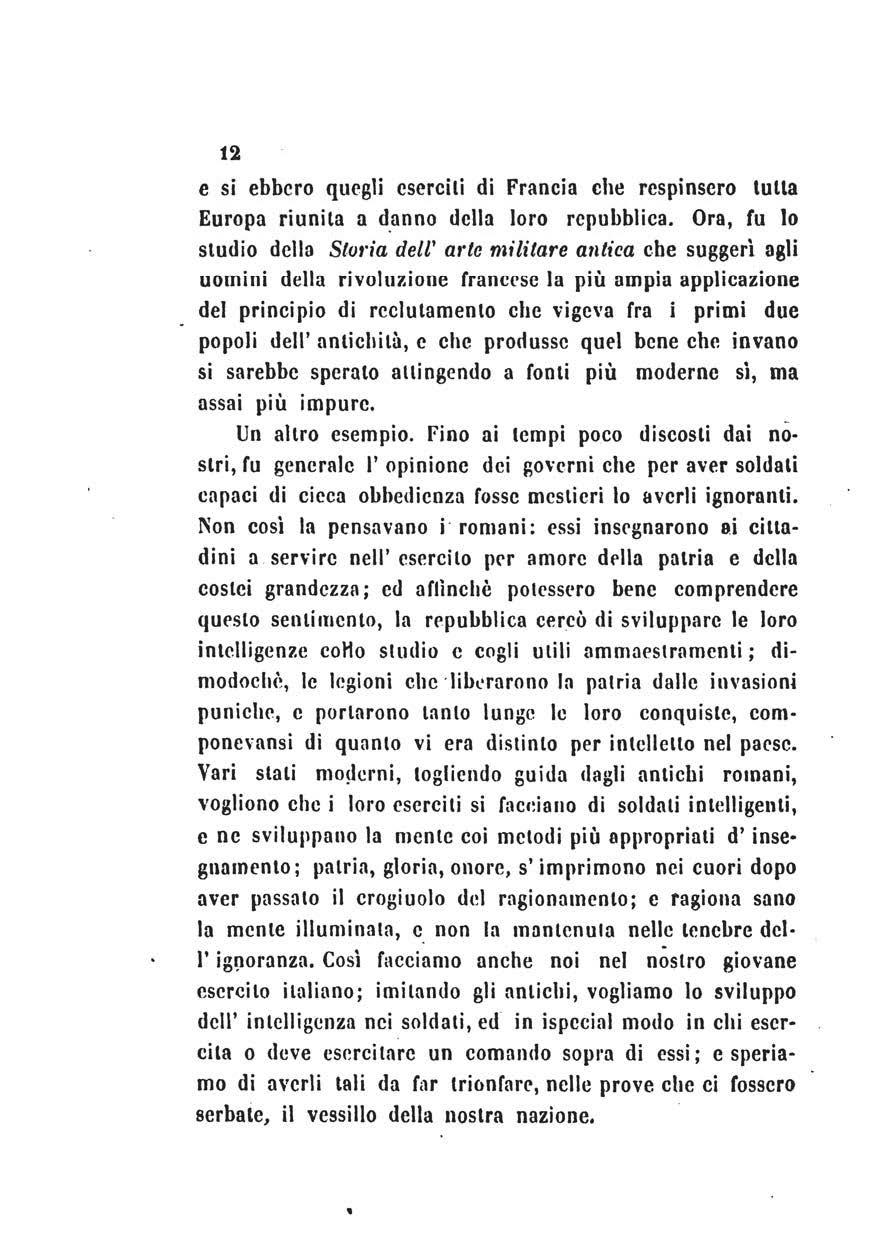
Lo studio adunque della Stor·ia dell' arte militare antica ha diretto i moderni nell' educazione degli eserciti.
Noi osserviamo inoltre che tutti i sommi fra i capilani e gli scrittori militari trassero 6cmpre i loro consigli dallo studio di quanto i predecessori loro a veva no operato. 1\facchiavelli cercò negli anticbi i metodi per orgonare c muovere le masse; Francesco I di Francia, c Gusta,·o Adolfo di Svezia, studiarono cd adouarono in certa parte l ' ordinamento dei romani; che più? Napoleone l istesso non riconosce apertamente l' utilità di cercare negli antichi gli ammaestramenti da cui si può cavar tesoro pci casi odierni, allorquando si dedica con tanta cura allo studio delle guerre di Cesare?
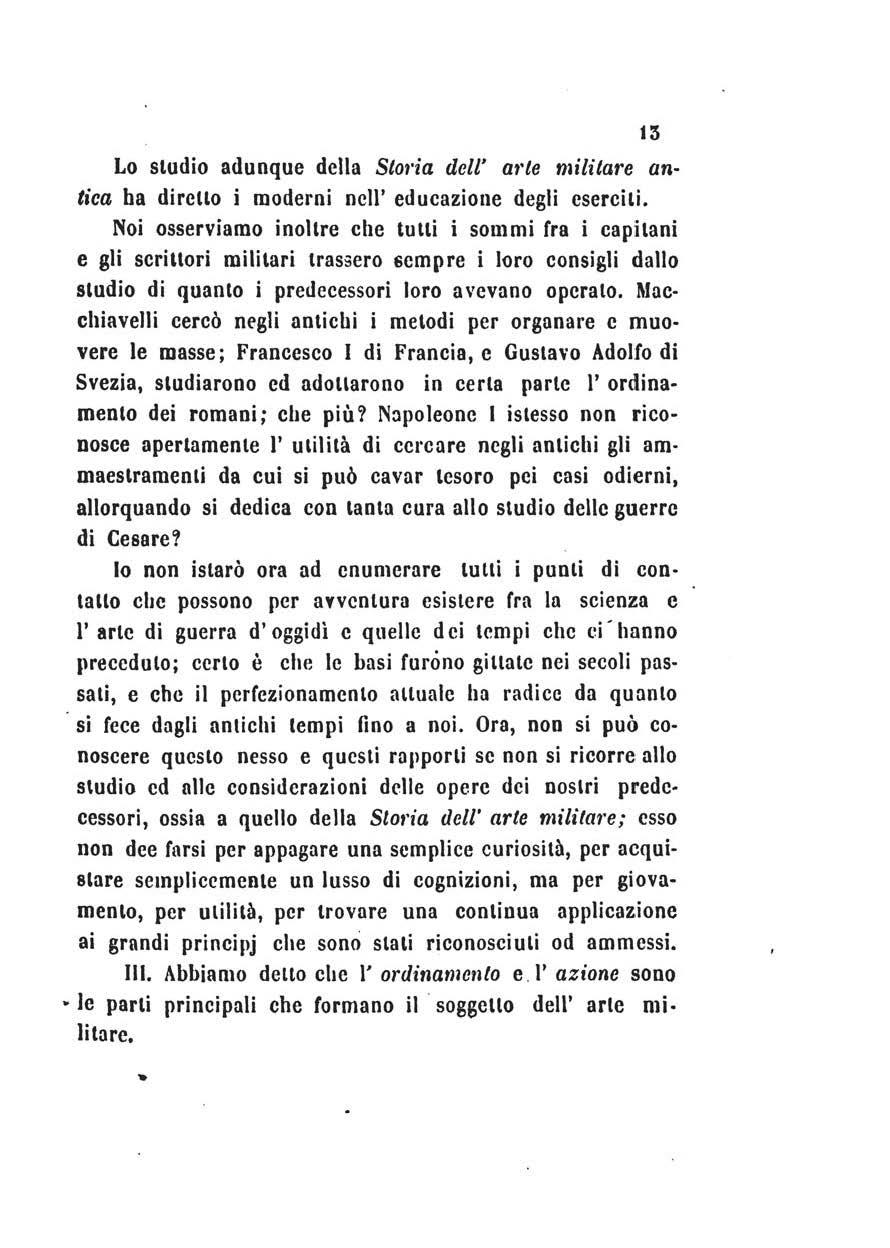
lo non istarò ora ad enumerare tutti i punti di contatto che possono per avventura esistere fra In scienza c l' arte di guerra d'oggi dì c quelle d ci tempi che l!i' hanno llreccduto; certo è che le basi furono gittate nei secoli passati, e che il perfezionamento auualc ha radice da quanto si fece dagli antichi tempi fino a noi. Ora, non si può conoscere questo nesso e questi rapporti se non si ricorr e allo studio cd nllc considerazioni delle opere dci nostri predecessori, ossia a quello de Ila Storia dell' arte militare; esso non dee farsi per appagare una semplice curiosità, per acquistare semplicemente un lusso di cognizioni, ma per giovamento, per utilità, per trovare una continua applicazione ai grandi principj che sono stati riconosciuti od ammessi.
111. Abbiamo detto che l' ordinamento e . l' azione sono ·le parti principali che formano il · soggcllo dell' arte militare.
Riguardo all' ·ordinamento, · esso si occupa delle due grandi categorie di agenti che compongono gli eserciti: il personale ed il materiale.
Il personale si compone• del contingente d' uomini per · la cui volontà, obbedienza, vigoria, e risolutezza, viene eseguito ogni ordine.
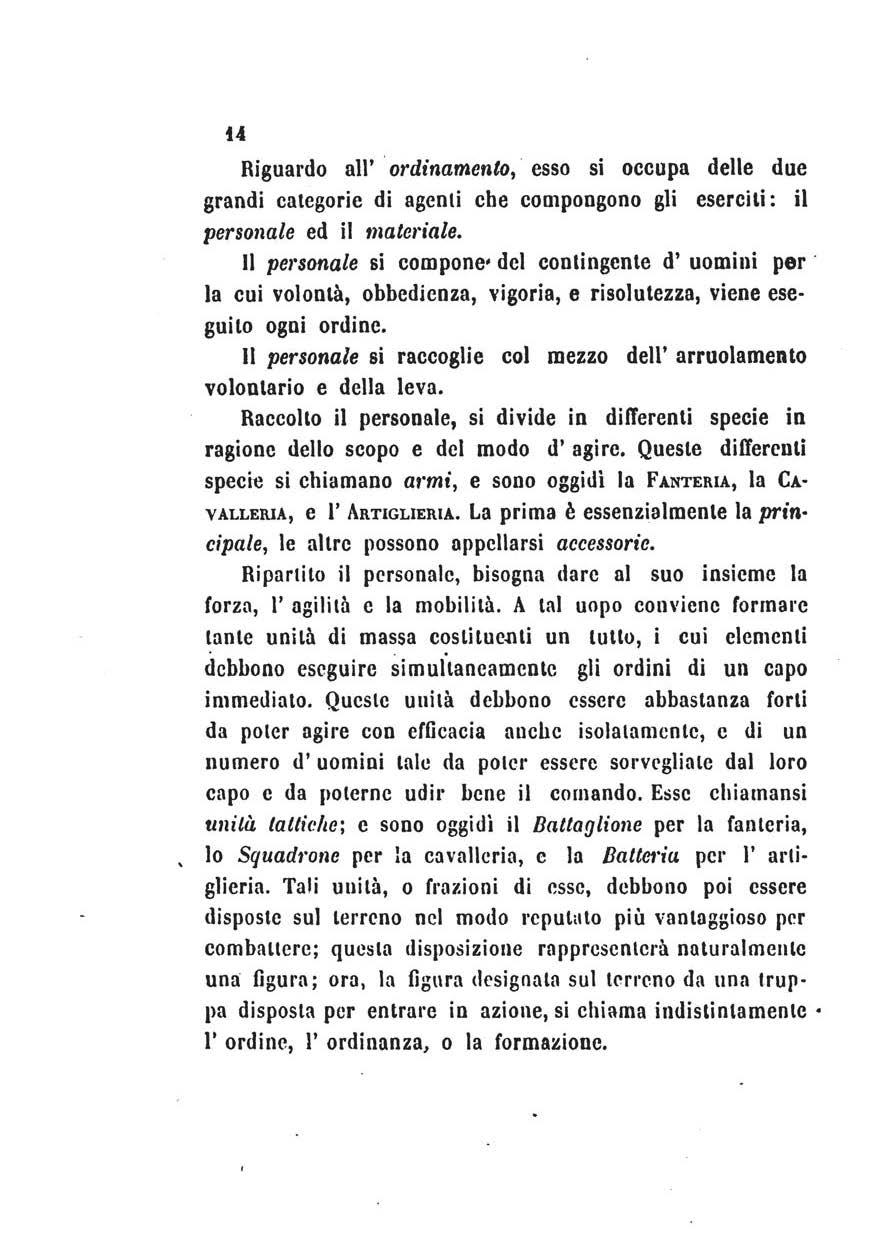
Il personale si raccoglie col mezzo dell' arruolamento volontario e della leva .
Raccolto il personale, si divide in differenti specie in ragione dello scopo e del modo d' agire. Queste differenti specie si chiamano at'mi, e sono oggidì la FA.NTERIA, la CAVALLERIA, e l'ARTIGLIERIA. La prima è essenzialmente la principale, le altre possono appellarsi accessorie.
Ripartito il personale, bisogna dare al suo insieme la forza, l' agilità c la mobilità. A tal uopo conviene formare tante unità di massa costitue.nti un lutto, i cui elementi debbono eseguire simuùancamcotc gli ordini di un capo immediato. Queste unità debbono essere abbastanza forti da poter agire con efficacia anche isolatamente, c di un numero d'uomini tale da poter essere sorvt'gliate dal loro capo c da poterne udii· bene il comando. Esse chiamansi unità latlil.·!tc; c sono oggidì il Battaglione per la fanteria, , lo Squadt'orJc per la cavalleria, e la Batle1·iu per l' artiglieria. Tali unità, o frazioni di esse , debbono poi essere disposte sul terreno nel modo reputato più vantaggioso pr.r combaucrc: questa di s posizione rappre se nterà naturalmente una figura; ora, la figura designala sul tcrr·cno dn un n trup· pa disposta per entrare in azione, si chiama indistintamente • l' ordine, l' ordinanza, o la formazione.
t5
L'ordinanza più naturale è·quclla di mettere gli uomini a fianco l' uno dell' altro formando la riga, e dietro l' un_o all' altro formando la fila. L' insieme delle righe e delle file costituisce un rettangolo le cui dimensioni furono delle ricerche dei taltici di tutti i temp i. Quando · le righe sono poche si aumenta la mobililè' a spese della solidità; quando sono molle si acquista in solidità c si perde in mobilità..
A seconda di questo numero di l' ordinanza è detta sottile o profondct. Mediante poi le suddivisioni delle unità si può ·passare dall' una ordinanza all' altra per supplire ai bisogni ed alle eventualità dellu guerra. '
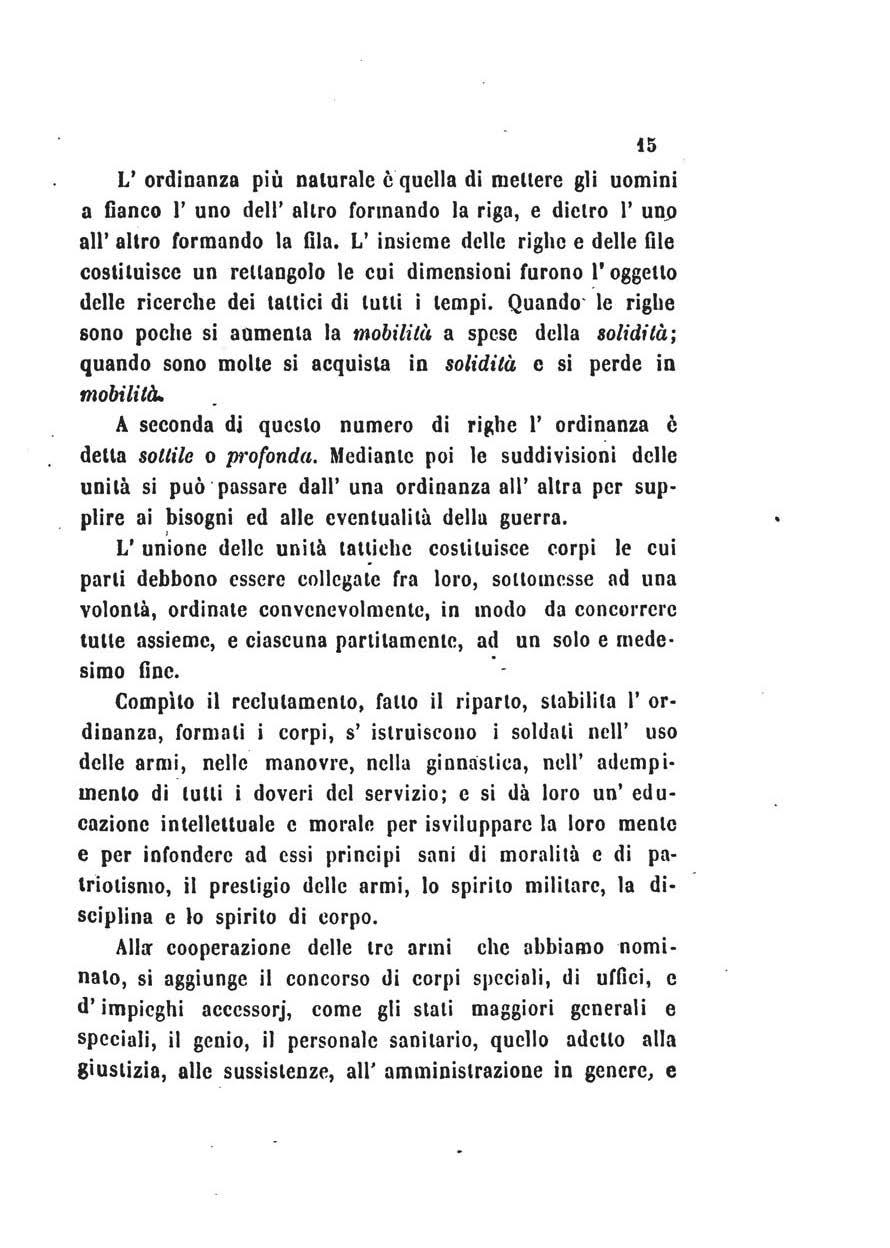
L' unione delle unità costituisce corpi le cui parti debbono essere collegate fra loro , soltomcsse ad una volontà, ordinate convenevolmente, in modo da concorrere tutte assieme, e ciascuna partilamcntc, ad un solo e mede· simo fine. ·
Compilo il reclutamento, fallo il riparto, stabilita l' or dinanza, formati i corp i, s' istruiscono i soldati nell' uso delle armi, nelle manovre, nella ginnastica, nell' adcmp i· mento di tutt i i doveri del servizio; e si dà loro un' ed ucnzionc intell eltua le c morale per isvilupparc la loro mente e per infondere ad essi principi sani di moralità c di patriotismo, il prestigio delle armi, lo spirito militare, la disciplina c lo spi rito di corpo.
All:r cooperazione delle tre armi che abbiamo nominato, si aggiunge il concorso di corpi spccioli , di uffici, c d' impieghi acccssorj, come gli stati maggiori generali e speciali, il genio, il personale san itario , quello adctto alla giustizia, alle sussistenze, all' amministrazione in genere, e
t6 quello che fa parte del treno pel trasporto degli oggetti nencccssarj al servizio militare c che non possono essere portati dai soldati.
Contullociò l' esercilo non è compito; vi vuole il materiale.
· Il materiale si può distinguere in due ·categorie principali; in quello che è portabile o Labile, ed io quello che non è nè portabile nè trasportabile: in alLri . termini, in materiale mobile ed in materiale stabile.
Nel materiale mobile si comprendono:
1.0 Le armi e quanto ad esse concerne
2. 0 Il vestiario od equipaggiamento
5.0 l mezzi di trasporto
4. 0 Le sussistenze
5. 0 l matrriali varj, ossia iJ materiale da ponte, gli strumenti neccssarj per riattare o rompere, aprire o cbiu· ùcre strade cd accessi, per assicurare gli accampamenti, per er igere fortificazioni io .campagna, per provvedere alla oppugoaziooe o alla difesa delle piazze, ed altri mohi che sono necessarj nl buon andamento della guerra.
Il materiale fisso o stabile, a cui abbiamo accennalo comprende le piazze forti, gli arsenali, i polverificj, le fon derie, le caserme, i magazzini, e tuui quei fabbricati che sono esclusivamente destinati ad uso militare.
IV. Questi sono gli oggetti principali che si riferiscono alla prima parte dell' arte militare ossia all' ordinamento degli eserciti; cd esponendoli per ordine di operazioni, essi consistono:
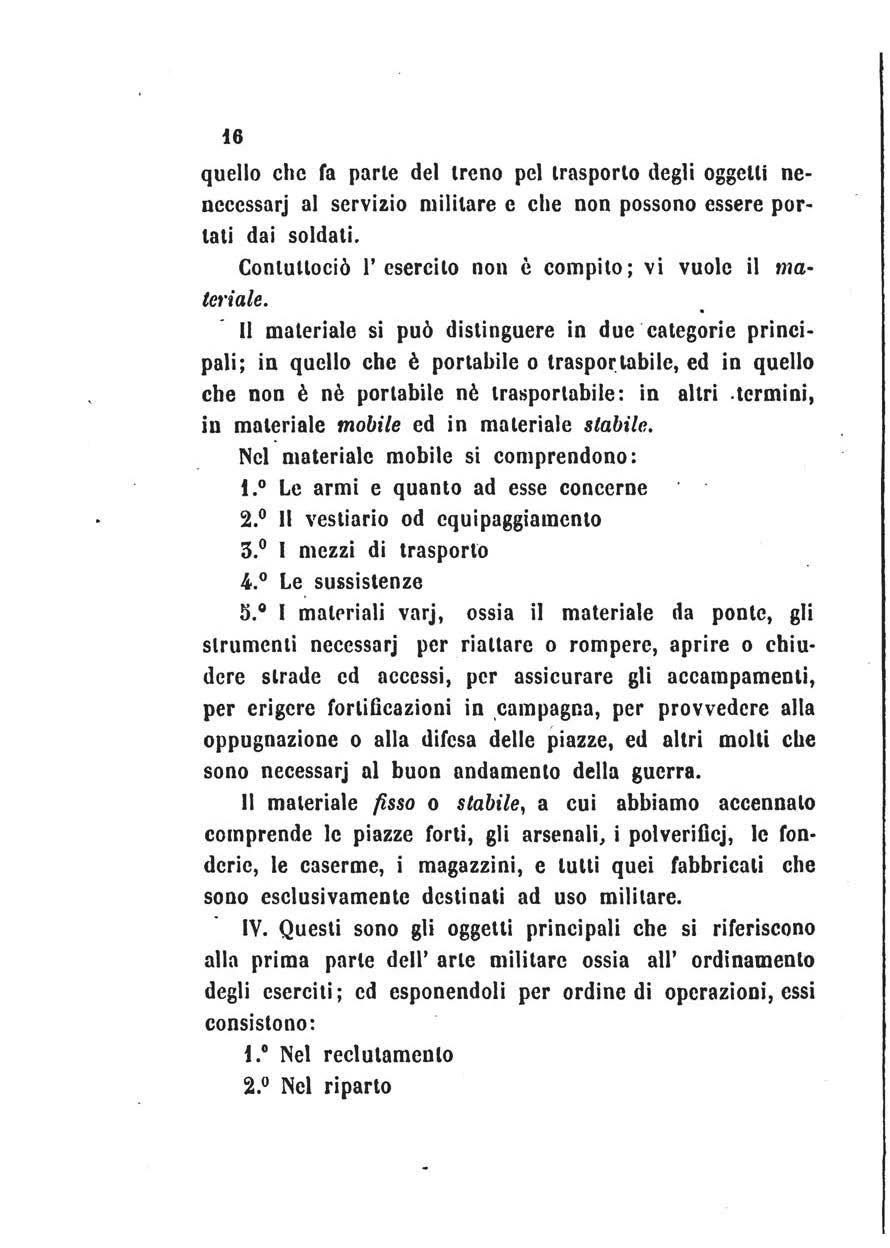
t . 0 Nel reclutamento
2.0 Nel riparto
3.' Nell' :umamcnto e ''estin•·io
4.u formazione od ordin.anza
5.' Nell' istruzione c nella disciplina
6 u Nell' amministrazione c servizii diversi.
VI. Rispetto alla seconda parte dell' arte militnre che si rifel'isce all'azione, ossia al modo di far agire gli escr· citi convenirntemente t!d utilmente, essa abbraccia i sommi precetti dello strategia, della grande tattica, della logistica, le cognizioni gcogrnfichc c topografichc, c quell' abilità spe· ciale di un supremo comandante la quale si sottrne ad ogni legge stabilita c non si acquista se non che pe1· dono di natur.a, e nella quale consiste la molla cd il scgrclo principa le della vittorin; la conosct'nza cioè dell'animo. del dato, e In maniera di saper approfittare delle sue tendenze.
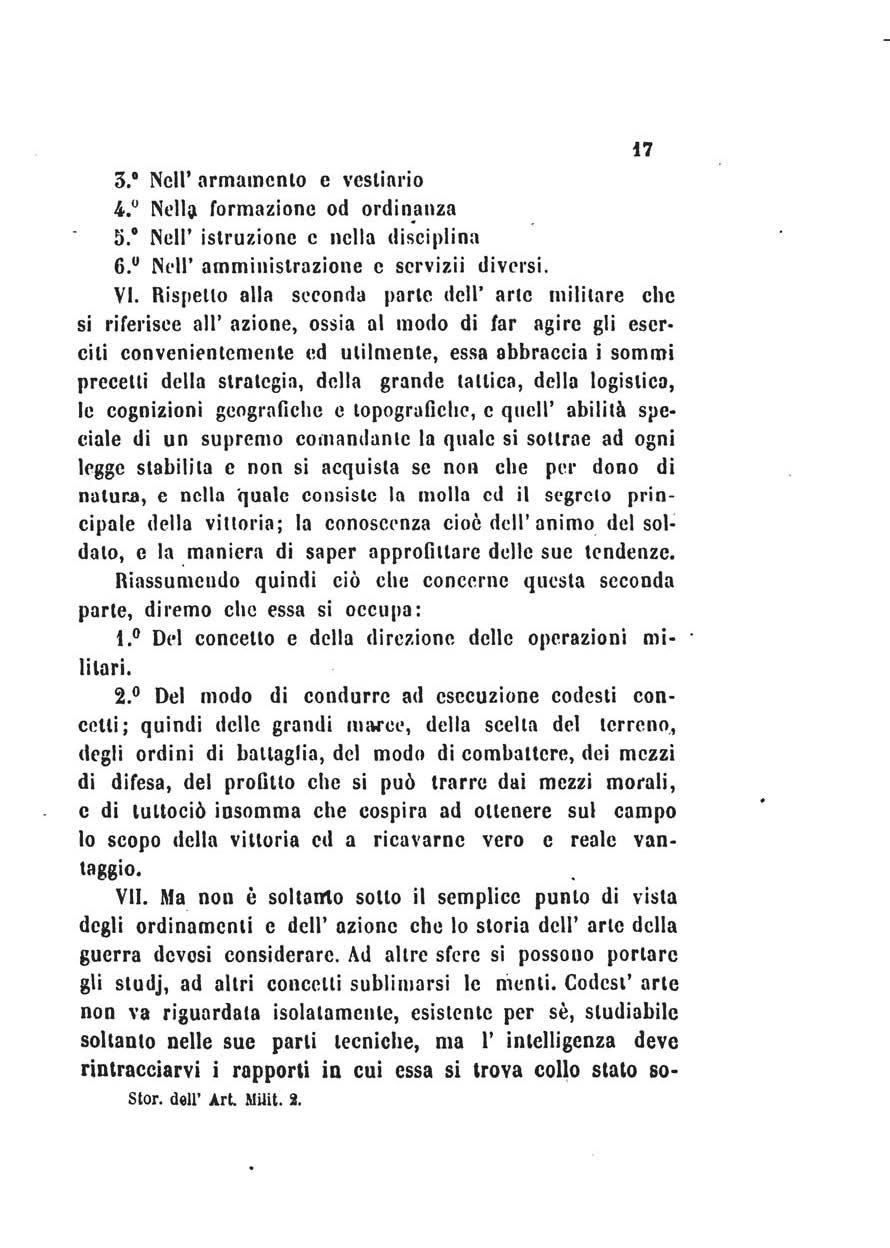
Riassumendo quindi ciò che concerne questa seconda parte, di1·emo che essa si occupa:
1.0 Dt•l concetto e della dirc?.ionc delle operazioni mi· litari.
2.o Del modo di condurre ad esecuzione codesti con· ccui; quindi delle grandi marce, della scelta del terreno., degli ordini di battaglia , del modo di combattere, dei mezzi di difesa, del profitto che si può trarre dai mezzi morali, c di tuUociò iosomma che cospira ad ottenere sul campo lo scopo della vittoria cd a ricavarnc vero e reale vantaggio.
VII. Ma _ non è soltamo sotto il semplice punto di vista degli ordinamenti e dell' azione che lo storia dell' arte della guerra devesi considerare. Ad allrc sfere si possono portare gli studj, ad altri conccLli subii marsi le n'lenti. Codest' arte non n riguardata isolatamente, esistente per sè, studiabilc soltanto nelle sue parti tecniche, ma l' intelligenza deve rintracciarvi i rapporti in cui essa si trova stato sostor. dell' .Art. MUit. i.
t8 ciale, colle scienze, colle leUere, colle bc11e arti, con tulto quanto insomma costituisce le condizioni di Ci'\iltà di un popolo o di un'epoca.
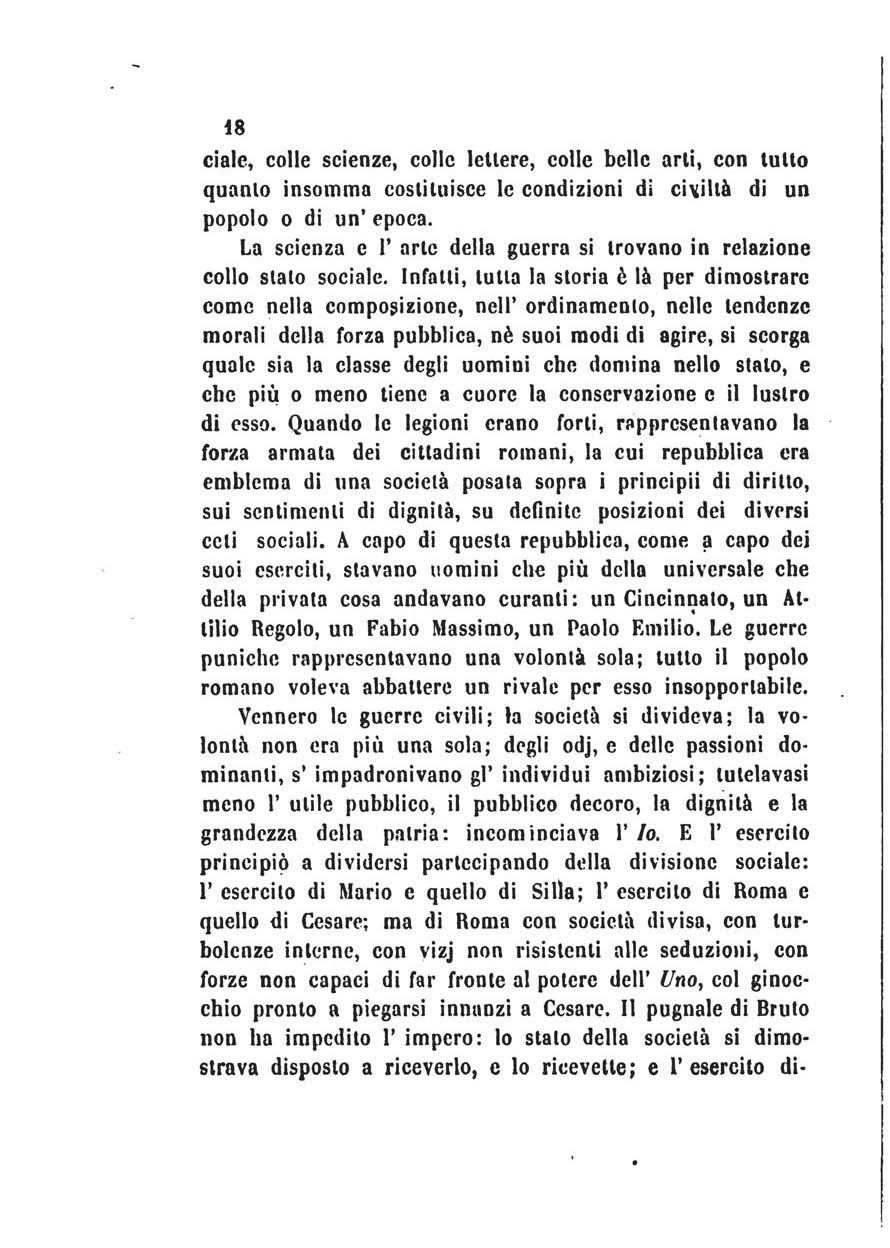
La scienza c l' arte della guerra si trovano in relazione collo stato sociale. Infatti, tutla la s toria è là per dimostrare come nella nell' ordinamento, nelle tendenze morali della forza pubblica, nè suoi modi di agire, si scorga quale sia la classe degli uomini che domina nello stato, e che o meno tiene a cuore la conservazione c i1 lustro di esso. Quando le leg ioni erano forti, la for-1.a armata dei cittadini romani, la cui repubblica era emblema di una società posata sopra i principii di diritto, sui sen timenti di dignità, su definite posizioni dei divt>rsi ceti sociali. A capo di questa repubblica, come !l capo dci suoi eserciti, stavano uomini che più della universale che della pt·ivatn cosa andavano curanti; un Cincin9ato, un Al· tilio Regolo, un Fabio 1\lassimo, un Paolo Emilio. Le guerre punichc rappt·esentavano una volontà sola; tutto il popolo romano vole\'a abbattere un rivale per esso insopportabile.
Vennero le guerre civili; la società si divideva; la vo· lontà non era più una sola; dc gli odj, e delle passioni do· minanti, s' impadronivano gl' individui ambiziosi; tutelavasi meno l' utile pubblico, il pubblico decoro, la dignità e la grandezza della patria: incominciava l' lo. E l' esrrcito principi9 a dividersi partecipando della divisione sociale; l' esercito di Mario e quello di Silla; l' esercito di Roma e quello di Cesare; ma di Roma con società divisa, con tur· bolcnze in.tcrnc, con vizj non risistenti alle seduzioni, con forz e non capaci di far fronte al potere dell ' Uno, col ginoc· chio pronto a piegarsi innnozi a Cesare. Il pugnale di Bruto non ha impedito l' impero: lo stato della società si dimo· stra va disposto a riceverlo, c lo ricevette; e l' esercito di·
t9 venne quello dell' uomo. La semplicità diè luogo al fasto; l' amor delle ricchezze a quello della glori a; l' egoismo al patriotismo; gli stipendj agli onori.
La corruzione imputridì coi secoli il colosso un tcm(IO ingigantito dal potere della virtù; In società vi rapprescn· lava sfacelo; c sfacelo vi presentò l' ese•·cilo non più capace di resistere all' irruzione dei barbari.
Nei tempj moderni, la società corrotta di Francia vi davn gli eserciti tli Luigi XV, imbelli in aperto campo, appena capaci di resistere dietro posti fortifìcati: la società risorgente della repubblica·, vi dava i figli della patt·icr, scuotcntisi dai vizj dci padri loro, cd esponenti i pelli a difcsn della patria loro. L' esercito vi rappresenta la virtt't nascentè, e la virtù rinasccva efTcuivamcntc nella società. l..a scienza e l' arte della guerra di quell' epoca \'i dimo· stra bensì lo stato con\'ulsi,•o della sociale convivenza, mn vi dimostra pure com' esse n pari passo della società cam· minassero poi nd nn riordinamento che consact·ava vittorie sul campo, ordine e potenza nell' interno nello stato.
Per ultimo osserveremo come il modo di fare la guerra ritragga perfettamente dell' indole sociale di chi la combatte. Guerre di saccheggio e di rapina,. sono per lo più fatte dai popoli poveri per di agricole od indu· strinli; saccheggiavano e rnpivano i bnrhari che abbandonavano i lori terreni ingrati per cercare dimora io più ridenti paesi. Guerre di rovine c di distruzione, dai popoli ignoranti_ accesi infuocate C pregiudicate passioni : rO\'Ì· navano, c distruggevano, i combnucoti le guerre fatali di religione.
Ma il progredimento della civiltà, rendendo più chiaro e diffuso il sentimento del giusto e dell'ingiusto, c più miti Ili animi umani, fece sì che le guerre divenissero più rare
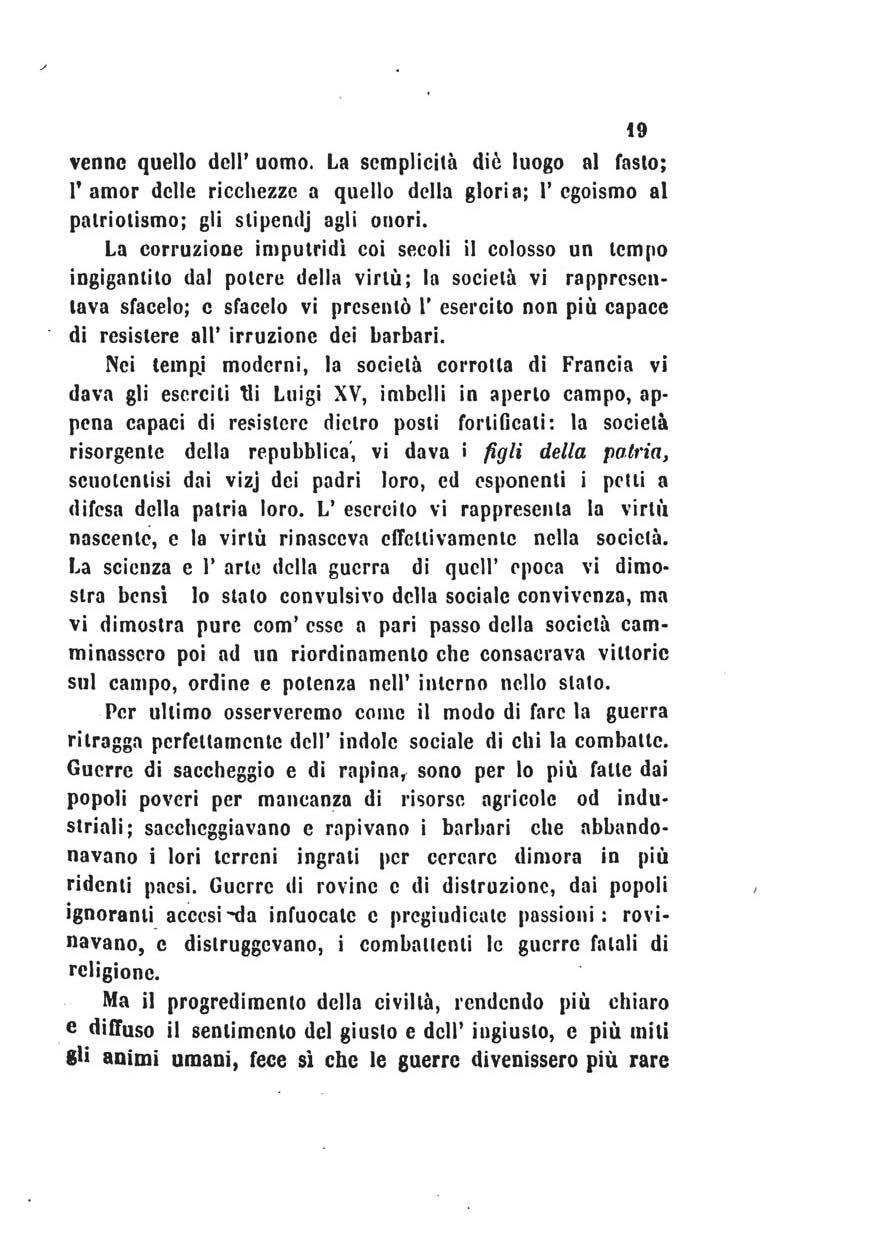
e meno feroci, per cui le delle odierne sono di gran lunga meno fat.ali di quelle delle antiche; imperocchè la guerra rilrac sempre il caraUcre suo dal grado di civiltà in cui si trova la nazione )oliante. Infatti, le guerre sono divenute più rare perchè le nazioni, dipendendo meno dall' arbitrio di go,·crnanti, che dispoticamrnte reggevano un tempo i pubblici destini, servono ora meno ai capricci di costoro; c, consultan!lo piullosto i pubblici interessi che l'ambizione individuale, gettano nella bilancia quel numero di voti che fa contrappeso alla passione personale e la supera c la vince; e siccome gl' interessi pubblici, dell'agricol&ura, del commercio, delle arti, dt>lle industrie, si sono nssni gcn<'ralizzati, c non vogliono ostacoli al loro sviluppo nè prricolo nel loro andamento, così si calcola assai prima di decidere o meuervi un incaglio che è conseguenza indispensabile delle guea·re: ceco il motivo pcrcui queste si sono fole più rare. Il sentimento poi dell' umanità, della giustizia, dell' equità, dell' interesse medesimo dei combattenti, le ha rese, come dicemmo, meno feroci: imperoc· chè rispellnodo le popolazioni nelle persone e negli averi, si crea minor numero di nemici, minor opposizione nel· l' eseguire i disegni preconcelli, maggior facilità ad ottenere i mezzi per sostenere gli eserciti c per aver notizie intorno all' armeggiare del nemico. Da ciò deduciamo che la guerra sLa in rapporta collo stato sociale e col suo grado di ci· \'Ìhà •
A rendcrla anche meno fatale, concorre in gran parte la brevità a cui ora si vn riducendo; e questa brevità è pure dovuta allo stato sociale. Una Yolta cranvi despoti cd eserciti merccnarj: quindi guerre lunghe c desolatrici. Ora sonovi nazioni ed eserciti cittadini; quindi guerre brevi e meno dannose. Fra gli esempi antichi, abbiamo le guerre
.
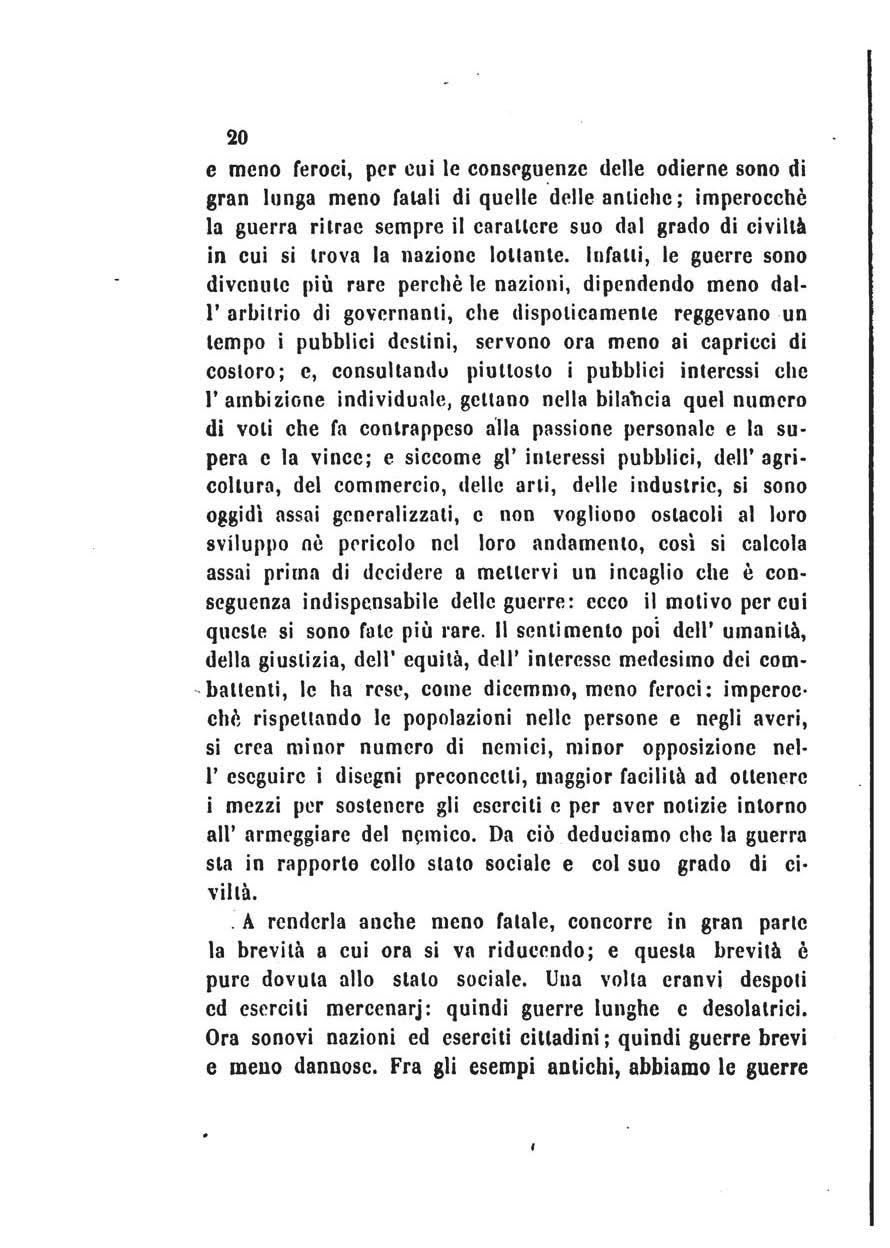
dei trent' anni, quelle di Luigi XIV, qUP.lla dci sette anni: fra i modenti, la guern di Crimea, quella del t 859, c quella del 1866. ·
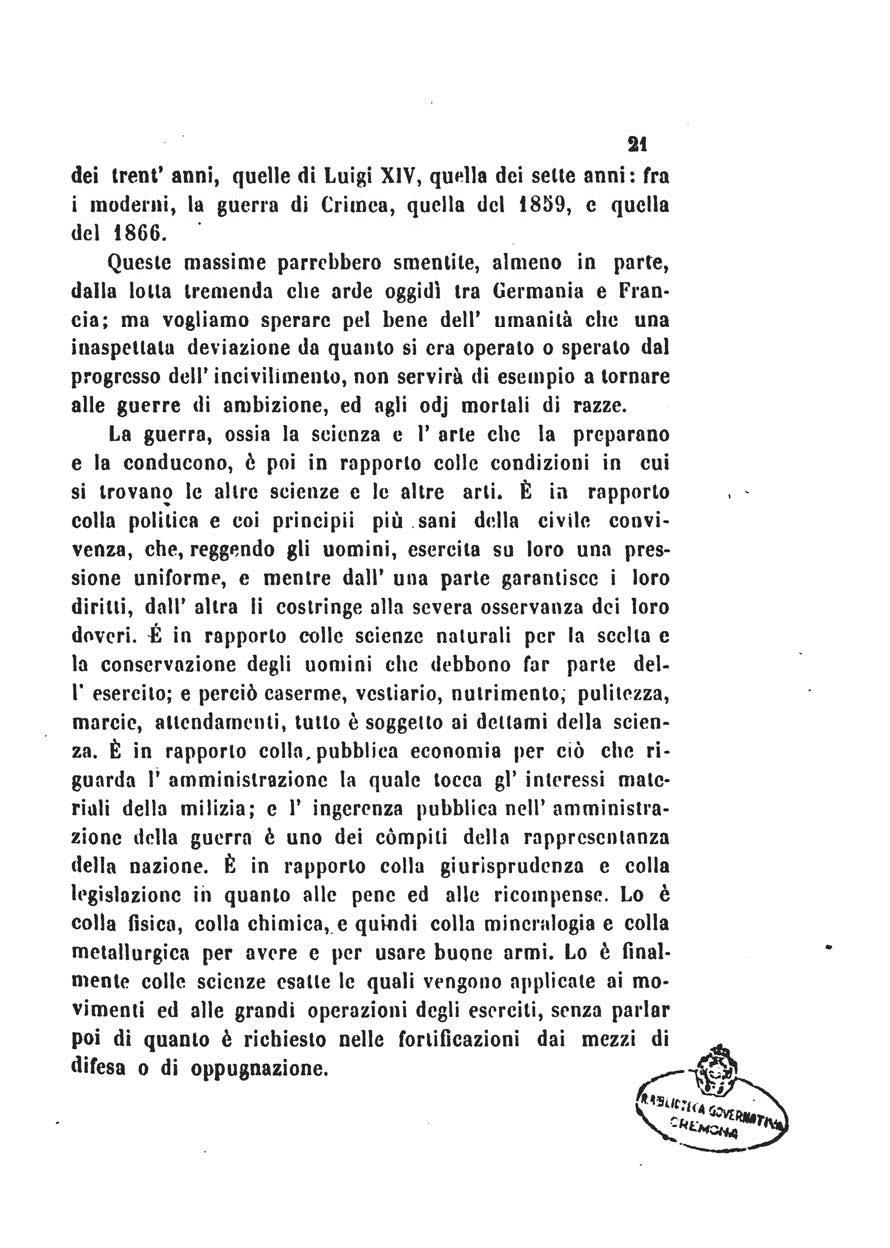
Queste massime parrebbero smentite, almeno in parre, dalla loLla tremenda che arde oggidì tra Germania e Fran· eia; ma vogliamo sperare pel bene dell' umanità che una inaspettata deviazione lla quanto si era operato o spet·ato dal progresso dell'incivilimento , non servirà di esempio a tornare alle guerre di ambizione, ed agli odj mortali di razze.
La guerra, ossia la scienza c l' arte che la preparano e la conducono, è poi in rapporto colle condizioni in cui si le aht·c scienze c le altre arti. È iil rapporto colla politica e coi pt·incipii più . sani ddla civile convivenza, che, reggP.ndo gli uomini, esercita su loro una pressione uniforme, c mentre dall' una parlc garantisce i loro diritti, dall' altra li costringe alla severa osservanza dci loro d(\vcri. -É in rapporto colle scienze naturali per la scelta c la conservazione degli uomini che debbono far parte dell' esercito; e perciò caserme, vestiario, nutrimento; pulitczza , marcie, tutto è soggetto ai dettami della scienza. È in rapporto collo. pubblica economia per ciò che riguarda l; amministrazione la quale tocca gl' intt•ressi matcrittli della milizia; c l' ingerenza pubblica nell' amminisu·azionc tlr.lla guerra è uno dei compiti dclln rapprescntnnzn della nazione. È in rapporto colla giurisprudenza c colla lt•gislozionc iil quanlo alle pene ed alle ricompense . Lo è colla fisico , colla chimica, _ e quindi colla minct·alogia e colla metallurgica per av<'re e per usare buQnc ormi. Lo è finalmente colle scienze csallc le quali vrngono applicate ai movimenti ed alle grandi operazioni degli esC'rciti, senza parlar poi di quanto è richiesto nelle fortificazioni dai mezzi di diresa o di oppugnazione.
'ffi'
In qual <'Osa al decadere delle allre arti c delle nlla·e scienze deve pure decadere l ' arte e la scienza della guerra, al fiorire di quelle Ùcn dietro immancabilmente il prospcramento di queste.
Anche colle lettere c colle arti belle la scienza di guerra tiene rappoa·ti (l).
La poesia fu spesso invocata per eccitare le necessarie 111 buon esito di un n lotta; e lo fece collo stimolare l' amor proprio, il sentimento patrio, l'odio al ne· mico; col canlarP. lP. gesle degli nntichi, effetti della vittoa·ia c quelli della sconfìua . l greci avevano i loro canti di guera·a; gli e i Bardi presso gli scandipavi e le popolazioni celtiche orientali, provano la nostra asserzione. Che più Y Anche nelle no s tre società civili, anche ai tempi nostri, abbiamo veduto in Prussia, in Francia, in Italia, molle composizioni poetiche ad uso degli eserciti. Di guisa che la gnrrra scuote le mus<', e le muse scuotono alla gucra·a.
L'eloquenza produce gli stessi effetti della poesia, cd eccita gli animi alla guerra. Dalle orazioni e dai discorsi dei capitani antichi, fino agli ordini del giorno dei moderni noi vediamo l' eloquenza tendere al medesimo scopo della poesia.
Nè fa mestieri il dire come le composizioni storiche, descrivendo le azioni degli uomini celebri, · concorrano nel medesimo fine rnggionlo dai poeti, specialmente nelle prime epoche della vita dci popot1. Erodoto, padre d"lla storia 1 compose il suo racconto che lesse in unn solennità nnzio-
(f) V. BLAN r.u Della scir n:a militare consitlem la 11e' suoi l'apporli collt scien;,• c col sislt•ma
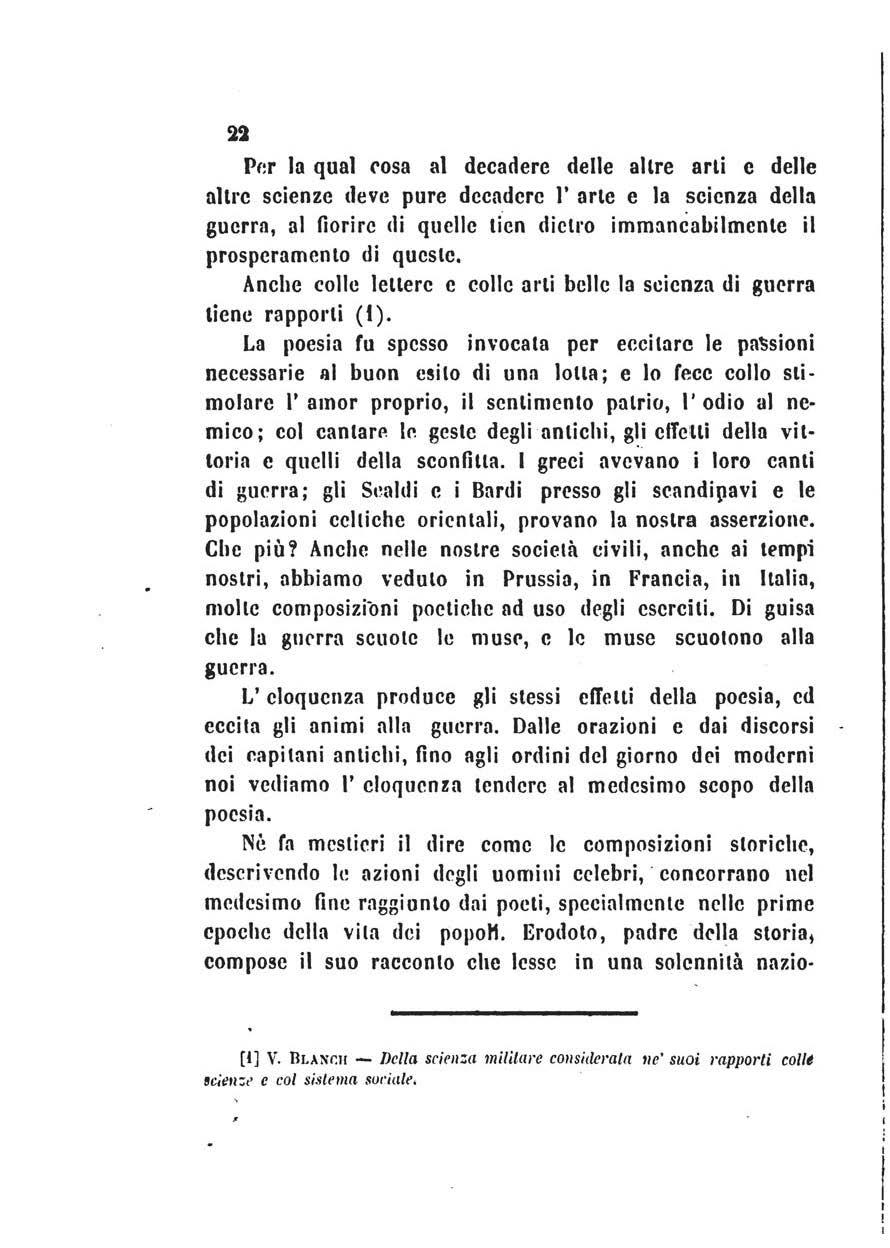
nole, per descrivere la lolla sproporzionata in cu1 1 greci trionfarono dci pcrsiaui, l' Europa dell' Asia, e la civiltà che progredisce con quella che sta ferma.
Anche le arti belle tendono le molle volle al medesimo scopo di eccitare e rilnigorirc le passioni. La musica serve ad animare i tumulti di &uerra od a scgnnre un ordine nella confusione; la pittura e la scultura servono a per · petuare la memoria dei sentimenti di amore o di odio, e di tutti gli nvv,.nimr.nti più celebri che ne sono derivali per lasciare esempio ed impulso alle future generazioni.
VIli. La storia dell' artè si occuperà dunque delle due parli, Ot'dinamento cd azione, c delle suddivisioni di esse che abbiamo accennato, come· pure dei ·rapporti che l'arte bellica ha collo stato sociale e con diverse parti dello sci· bile umano; ma dove avrò dcssa principio?
IX. La guerra, o per dir meglio la lotta fra gli uomini , è antica quanto l' umanità. Non appena vediamo du e uomini sulla terra li troviamo a cozzo fra loro ; uno uccide l' altro; e la morte di Abele è la prima goccia di quella lunga striscia di sangue che si è perpetuata colla vita delle nazioni.
Le prime guerre si fecero da uomo ad uomo; lutto vi era mosso dalla passione; tutto appop:giato alla forza brutale; poscia vi s ' introdusse una prima arte che fu quella del pugilato; e quest' arte fu tenuta in tanta onoranza da essere ammirata come un'istruzione emanata degli Dei. ·
Questi combattimenti individuali trallvano la loro origine dalla mal a tendenza ossia dal vi zii degli uomini ( l ); il tristo , che lÌ sentiva più forte, voleva dominAre e si faceva temere dai suoi simili. Allora i deboli cercarono di porre un argine alla prepo· lenza far.endo ricorso alla buona tendenza ossia alla virtù degli uomini; implorarono cioè l' aiuto di coloro che all' amore del-
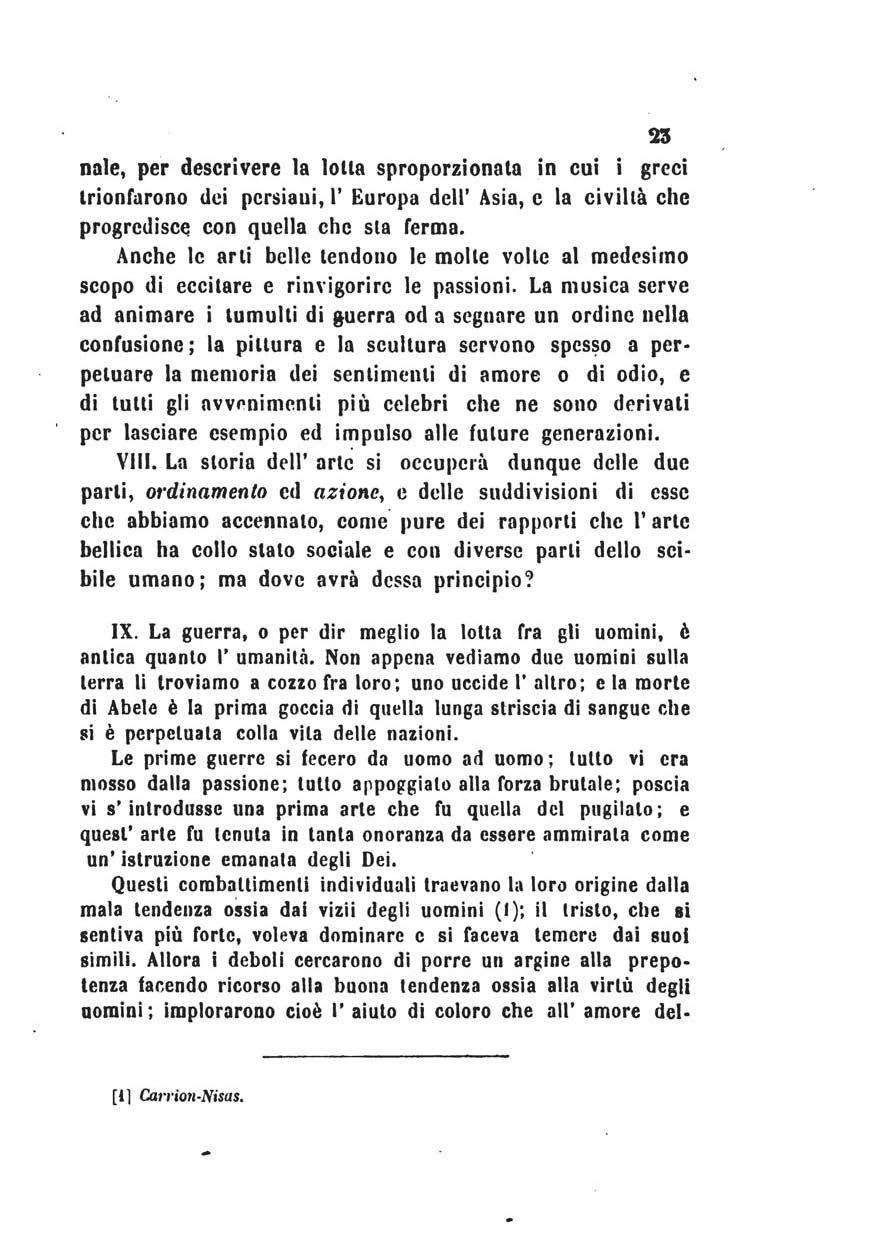 (l] CaiTÌOII·Nisas.
(l] CaiTÌOII·Nisas.
l' ordine ed all' orrore pel delitto aggiungevano il dispreuo del pericolo, la forza, e la destrezza; le popolazioni si raccomandarono alle loro braccia ed alla loro clava: e ciò formò la gloria ' degli Et·coli e dei 'fesei, o piullosto dei primi eroi elle loro servirono di modello.
Riuniti momenlaneameule od alleali per un certo tempo pa·· recchi combattenti coll' intendimento di . assalire o difendersi, sentirono il bisoguo di accordarsi per !stabilire un ordine· od un assetto qualunque; e per mantenere quesl' ordine e questo assestamento riconobbero la necessità del comando e dell' oLbe· di enza.
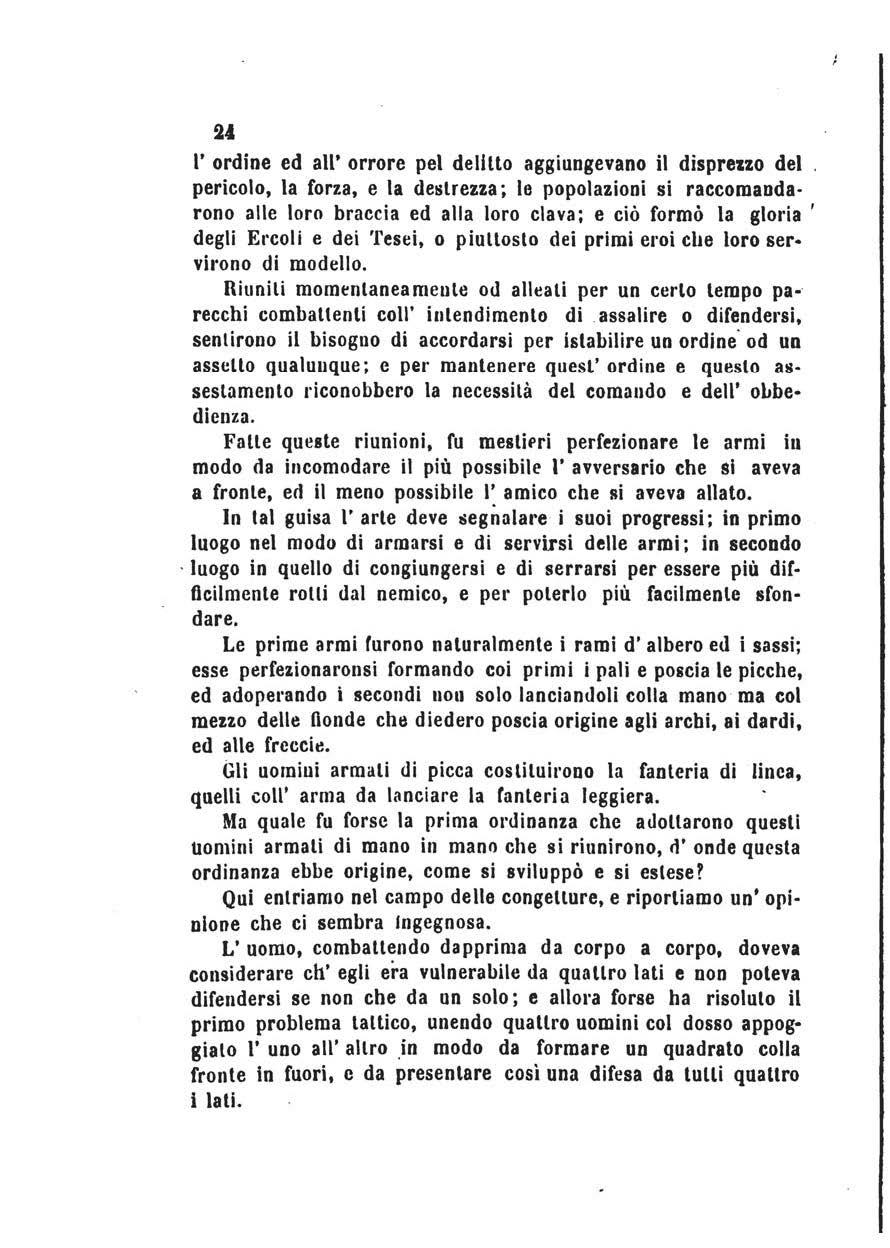
Falle queste riunioni, fu mestiPri perfezionare le armi iu modo ila incomodare il più possibile l ' avversario che si aveva a fronte, ect il meno possibile l ' amico che 11i aveva allato.
In tal guisa l'arte deve gegrHl lare i suoi progressi; in primo luogo nel modo di armarsi e di servirsi delle armi; in secondo · luogo in quello di congiungersi e di serrarsi per essere più difficilmente rotti dal nemico, e per polerlo più facilmente sfon· dare.
Le prime armi furono naturalmente i rami d'albero eù i sassi; esse perfezionaronsi formando coi primi i pali e poscia le picche, ed adoperando i secondi non solo lanciandoli colla mano ma col meno delle fionde diedero poscia origine agli archi, ai dardi, ed alle freccie.
Gli uorniui armali di picca costituirono la fanteria di linea, quelli coll' arma da lanc iare la ranleri a leggi era.
Ma quale fu forse la prima o1·dinanza che adollarono questi uomini armali di mano in mano che si riunirono, d' onde questa ordinanza ebbe origine, come si sviluppò e si estese?
Qui entriamo nel campo delle congetture, e riportiamo un'opi· olone che ci sembra Ingegnosa.
L' uomo, combattendo dapprima da corpo a corpo, doveva considerare cb' egli era vulnerabile da quattro lati e non poteva difendersi se non che da un solo; e allora forse ha risoluto il primo problema tattico, unendo quattro uomini col dosso appog· giato l' uno all' altro .in modo da formare un quadrato colla fronte in fuori, c da presentare cosi una difesa da tulli quattro i lati.
Questi quattro uomini non erano se non cbe il contingente di una o due famiglie.
Allorchè si raunarano selle od otto famiglie. numero che fu probabilmente quello della prima gente la quale abbandonò la vita errante dei cacciatori e Ilei pastori per le arti sedentarie dell' agt·icoltura, e stabilì la sua dimora intorno ad una fontana o sulle rive di un ruscello, il contingente dei combattenti che codeste ramiglie poterono somministrare fu naturalmente mag· giore; e f11tto il calcolo approssimativo su due uomini per ciascheduna, vi sarebbel'o stati d circa sedici uomini . Ora , par· tendo dallo stesso principio di difendersi da lulle le parli, è pos· sibite che il primo quadrato di quattro abbia servito di nucleo, di radice, al qua rlra t o più grande di sedici; il quale, armato di pali, o1ft·in la facoltà a gli nomini centro di servirsi della loro arma per pr.oteggere sè medesimi e coloro cbe li cuoprivano (t).
Aumentando ancora il numero delle famiglie riunite sino alla formazione di piccole città, queste poterono certamente f1no dalla loro orii(ine raunare maggiore quantità di combattenti, tanto più quand' esse erano collegate ad altre città con vincoli di alleanza per iscongiurare un pericolo comune. E siccome la esperienza avrà ben presto insegnato che l' energia· di una .truppa si fonda sull' unione de ' suoi elementi, cosi inYece di formare tanti piccoli quadrati isolati, ai pensò di combinal'e un tutto del cootin· geute di venuto più numeroso, e farne quadrati più grossi. Il per. fezionamento del palo che divenne lunga picca a punta di ferro, facilitò la difesa ad un maggior numero di righe che componevano l' ordin3nza: la quale però, divenendo vieppitì profonda, dovè contenere un numero di uomini che non poteva prendere parte al combattimento pcrcbè la loa·o arma non era bastante· 'mente lunga da poter oltrepassare le prime rigue ed agire attivamente prt!sentando la punta al nemico. Questi uomini potevano servire a due scopi: 1" a rendere più solida l' ordinanza collo impedire di disordinarsi e retrocedere a quelli che aveano innanzi
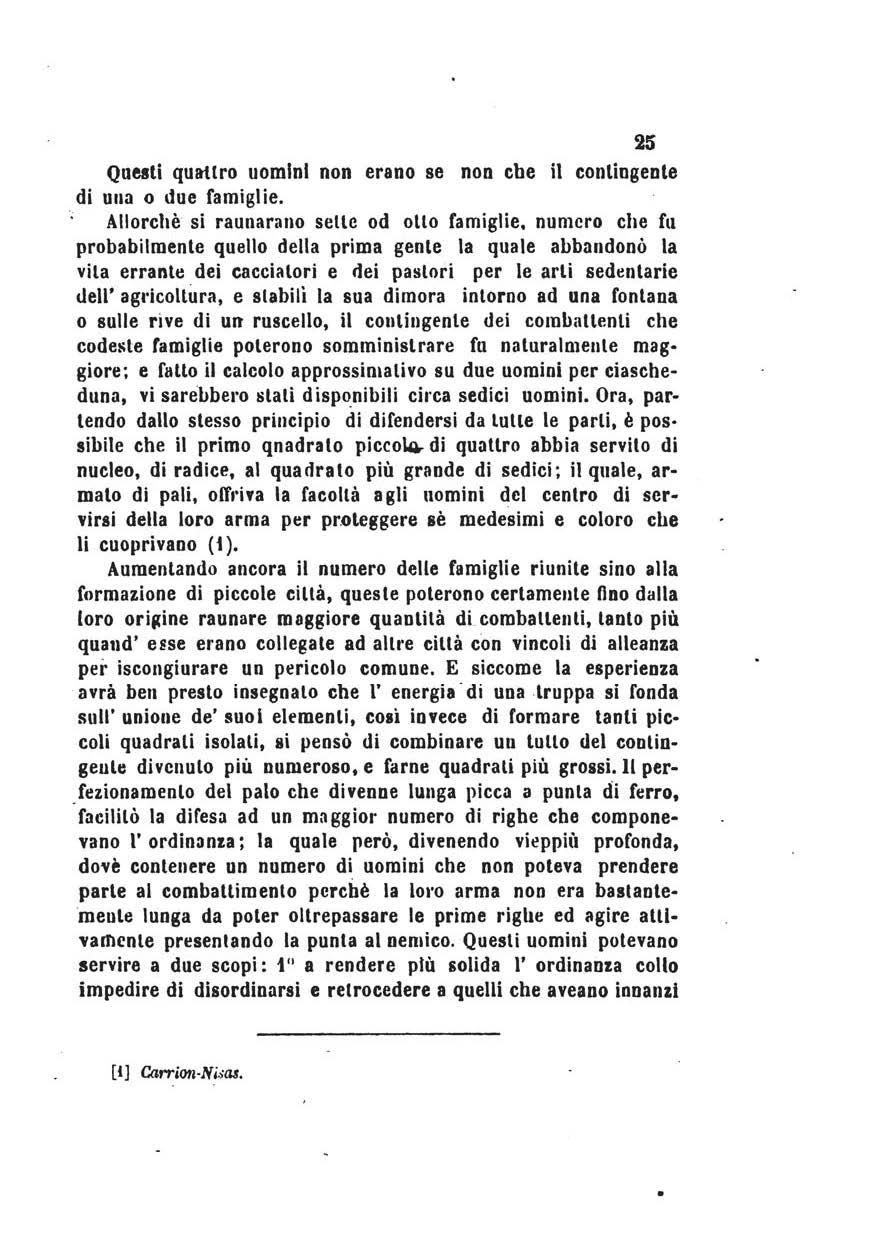
a sè: 2' a riempiere i vuoti che le ferite e le morti cagionavano: in questo secondo caso compievano l' ufficio di riserve di cui offrivano la prima idea ed! il primo germe.
Questi quadrati si componevaqo naturalmente di tante piccole unità, aventi ì loro capi, e rappresentate dai tenui -contingenti delle diverse adunanze o borgate primitive; unità che nnivano a costituire le suddivisioni dell' insieme divenuto numeroso e forte.
All' influito e soverchio ingrossamento di questi quadrati conveniva porre un limite; e ciò si potè eseguire allorquando si trovò un altro mezzo di proteggere le spalle ed i Oanchi delle truppe riunite in un sol corpo. L' invenzione delle armi da lan· ciare, della fionda cioè, dell' arco, e delle freccie, compiè la bi· sogna. L' uso di queste armi richiedeva movimenti liberi negli uomini che le maneggiavano, i quali per conseguenza non potevano essere introdotti nelle file serr'ale di coloro che portuano la picca; quindi per associa re l' azione dei primi con quella dei secondi, i frombolieri e gli arcieri ebbero il loro posto naturale sulla fronte, ai fianchi, ed alle spalle dei quadrati; potendo gio· vare in quest' ultima posizione, coi loro liri inarcali, ad offen· dcre il nemico.
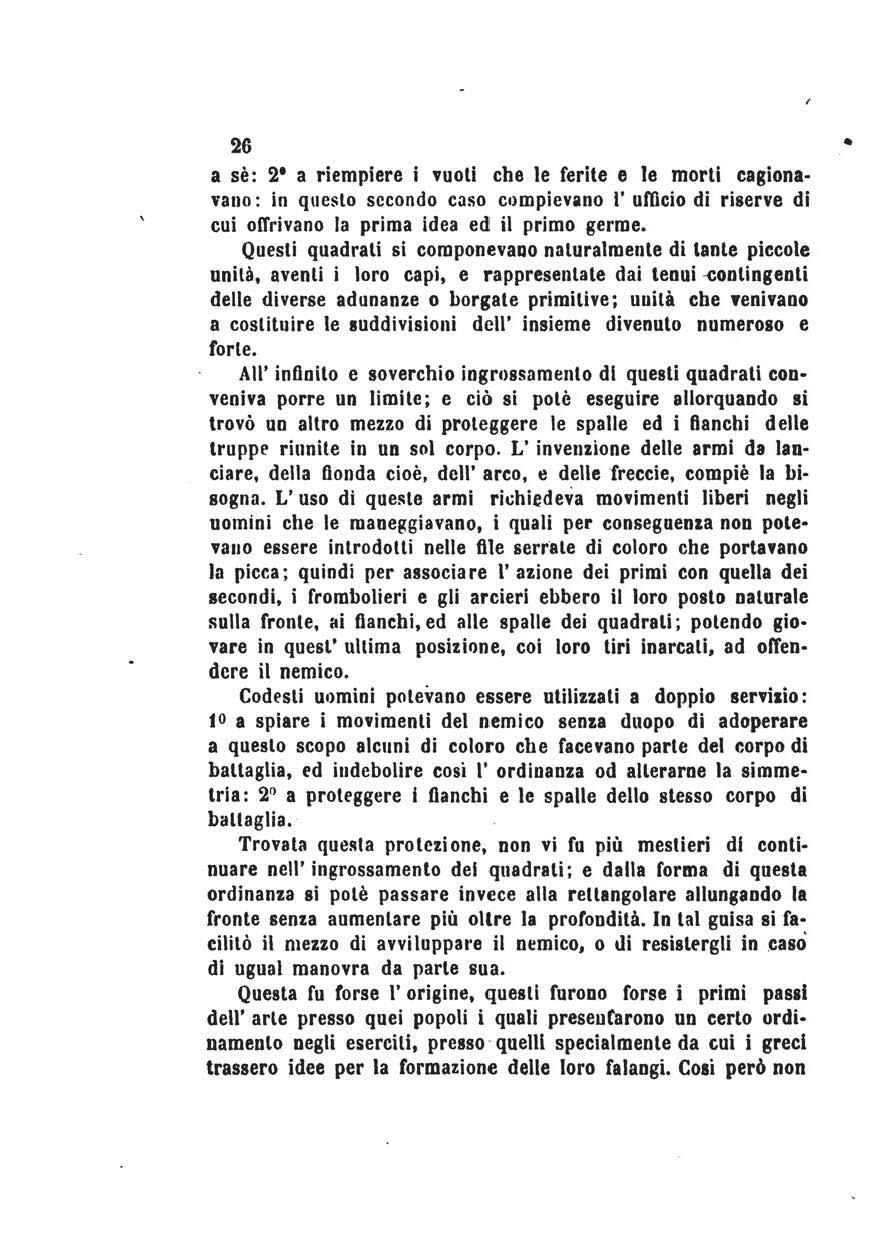
Codesti uomini potevano essere utilizzati a doppio servizio: to a spiare i movimenti del nemico senza dnopo di adoperare a questo scopo alcuni di coloro che facevano parte del corpo di battaglia, ed indebolire cosi l' ordinanza od alterarne la simmetria: 2° a proteggere i fianchi e le spalle dello stesso corpo di ballaglia.
Trovata protezione, non vi fu più mestieri di conti· nuare nell' ingrossamento del quadrati; e dalla forma di questa ordinanza si potè passare invece alla rettangolare allungando la fronte senza aumentare più oltre la profondità. In tal guisa si fa· cilitò il mezzo di avviluppar·e il nemico, o tli resisttrgli in .casò di ugual manovra da parte sua.
Questa fu forse l'origine, questi furono forse i primi passi dell' arte presso quei popoli i quali preseuCarono un certo ordinamento negli eserciti, presso · quelli specialmente da cui i greci trassero idee per la formazione delle loro falangi. Cosi però non
2'7 dev' essere ancnuto in ogni luogo ; perchè la riunione di moltitudini a rmate, non rette da principii · d' ordine e di ragiona t o meccanismo, non meritano il nome di ese rciti nè un' accurata investigazione sulla loro origine e sul loro accrescimento.
Finora abbiamo parlato dell' istituzione della fanteria; ci re· sta a dire da che ebbero origine la cavalleria, le macchine da guerra che s' introdussero negli eserciti per combattere io campo aperto, gli ostacoli elevati a diCesa, ed i mezzi immaginali per l' oppugnazione.
L' or igine della CIIYalleria, più o meno ordinata, si perde in mezzo alle favole della mitologia . L'uomo a cavallo vi è sentato dal C<'ntauro, il quale, formando nn tutto dell'animale e dtl cavalliere, dimostra come sino dai più remoti tempi si pensasse che per ottene re un buon cavaliere dovesse l' uomo, per cosi dire , identificarsi coll ' animale su cui montava. l mitologi hanno tentato di spiegare io diverse maniere l ' origine e la natura dei centauri che essi facevano nasc ere da una nuvola; e la piìt ragionevole sarebbe quella che li considerasse come una tribù prima domatrice dei cavalli (t).
L' antichità di queste favole provert:bbe quella della cavalle· rta ; ma non abbiamo alcun lume che ci rischiari la progressiva riunione di uomini armati a cavallo, l' òrigine della loro formazione ed ordinanza , ed il loro accoppiamento alla fanteria nella costituzione degli eserciti. Diodoro accenna ad una pietra acuita sulla tomba d' Osimandia, su cui era rappres entata la guerra che questo re d' egitto fece ai ribelli della Battriaoa, e dice che in quella impresa conducesse seco ventimila cavallieri. Tra Osiman dia e Sesostri, vissuto lungo tempo innanzi all' assedio di Troja , Diodoro conta "enlicioque generazioni; sarebbe adunque una cavalleria istituita pochi secoli dopo l' epoca che vien detta dlluviana . Ma tulli gli storici si accordano nel riferire al tempi di Scsoslri l' uso negli eserdti di cavalleria regolare e ben distinta . dai carri armati, della qual cosa terremo discorso fra breve.
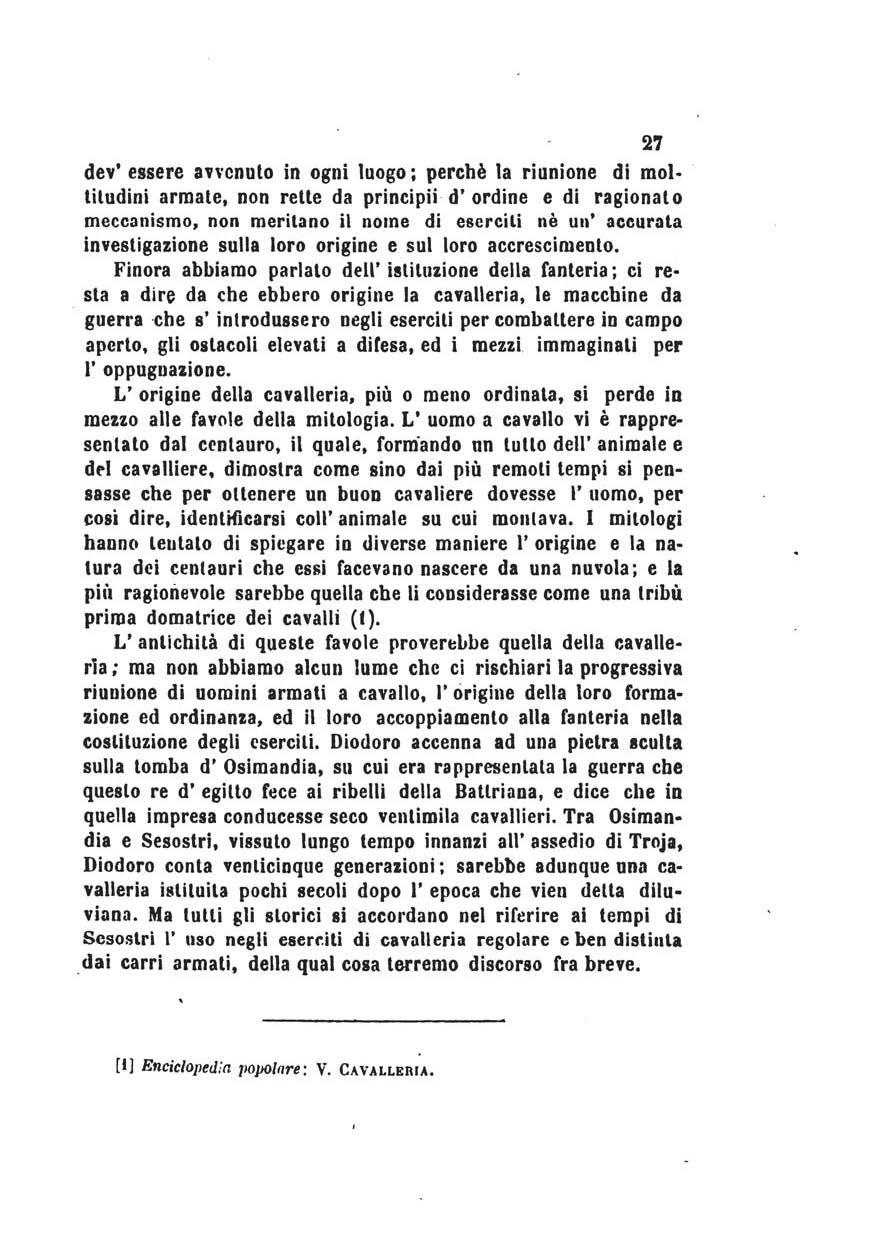
Non si sa bene quando i carri da commctassero ad usarsi: portavano lame ta glieuti alle sale ed nIle ruote; vi stavano cavalli vigorosi, e menavano strage nell' esercito nemico. Molte nazioni ne disputarono l' invenzione all'Egitto : ma Senofonte ne fa autore Ciro, Cte s ia Semiramide, ed allrl un re macedone. Comunque siasi, è certo che i carri armali .precedettero alla cavalleria; e che fu.l'ono tra le macchine più antiche le quali s' introdussero io ca10po (l) .. Le altre macchine trasci · nate al seguito degli eserciti sono di origine meno remota; tuttavia non abbiamo dali prech;i •:he c' inducano a determinare positivamente a quali epoche ed a quai popoli si d ebba attribuirne l' invcnzionr.. La loro fo r za motrice era tratta ordinar iamente dalla l'laslicità dei legni, come avveniva nei semplici archi.
Rispetto all ' origine degli ostacoli elevati a difesa e dei immaginali per l' oppugnaz ione, osserveremo eme, non appena cominciarono le prime tolle, il debole avrà sentito il bisogno di meli ere un ostacolo fra sè ed il suo nemico; mentre questi, dal canto suo, avrà dovuto cercare lutti i mezzi per distruggere que sti ostacoli. Le prime di difesa furono senza dubbio alçuni pali od un fosso di piccole dimensioni; i primi mezzi di oppu· gouione saranno slali na t uralmente la scalata e la &appa .
L' nrle delle fortificazioni adunque avendo per iscopo di porre H debole in condizione di resistere al forte, le sue prime appli· cazioni risalgono all' origine d elle società ; imperocchè sino da quando le popo lazioni si sono agglomerate, le riunioni meno numerose hanno dovuto pensare ai mezzi di sollrarre i frulli del loro lavoro alle tlcpredazioni di vicini più potenti. Le difese si sono regolate a DOI' ffia delle arm i ch'erano in uso. Allorquando gli aggressori arrivavano con grossi bastoni, con ascie di pietra, con .freccic e con giavellotti, la cùi punta era indurita al fuoco, o guernila d ' osso e di resta di pesce, un baluardo di terra, sor· montato da una linea di palizzate, o da una siepe viva, formava un trinceramento rispettabile. La terra del baluardo era quella che si otteneva scavando un fosso davanti alle palizzate od alle
(l J Ell cic/OjiCdia p opolare: V. CARRI.
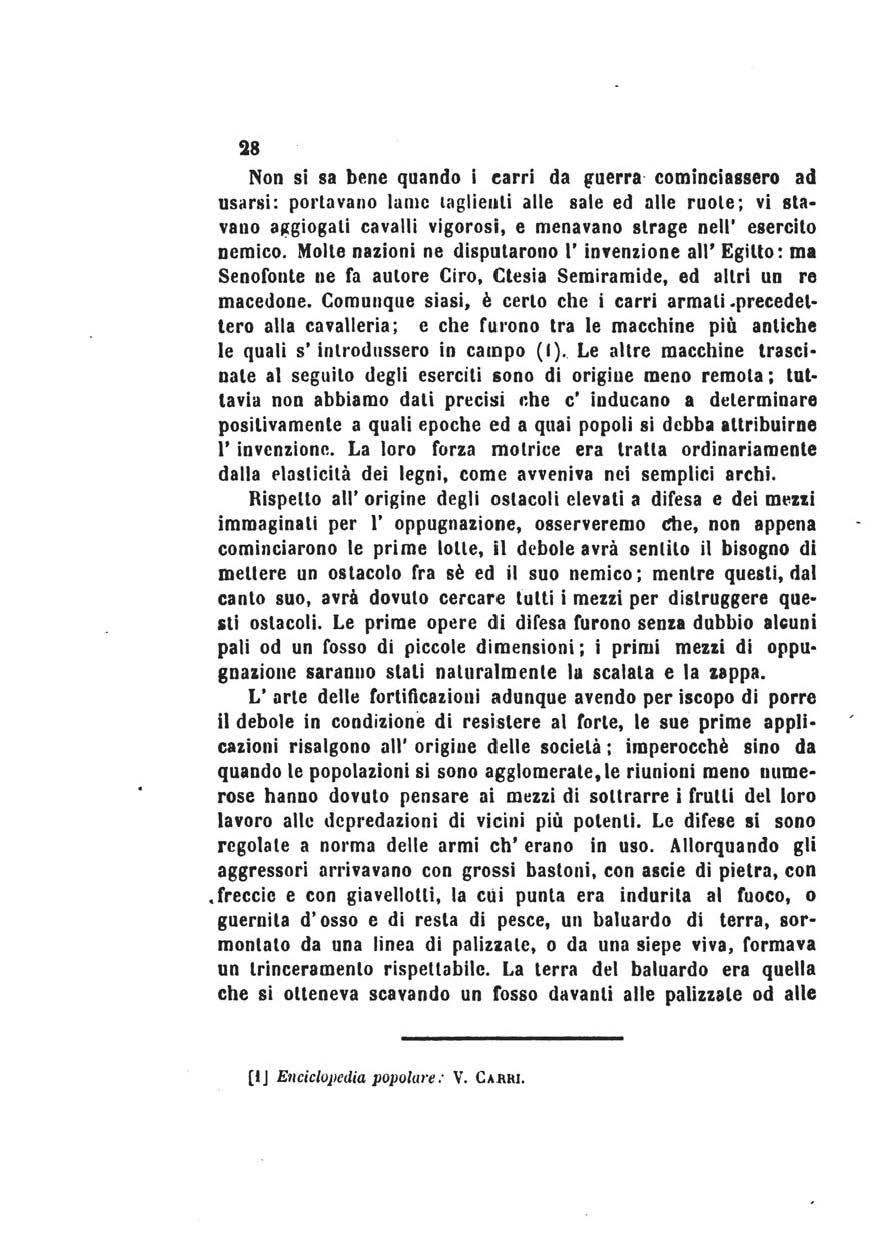
siepi vive per impedit·e eh e fossero tagliate otl arse; e questa terra, gellata all' iodittro, formava uua specie di piallaforma su cui montava il tliftnsorc per dominare l' assalitot·e e gt!ltargli dardi o piett·e per disopra alla lin<•a dci pali o dP.i rami. Tale è la fortificazione presso tutti i popoli primitivi, tale ci è rappresentata «!,a tutti gli autori :antichi, tale fu trovata negli ultimi secoli pres1:1o i popoli selvaggi dell' America (t).
Ditfuaasi l ' arte di lavorare i mttall i, queste fortificazioni perdellero assai del loro vaiQre, imperoccltè i pali e le siepi non presentavano più un ostacolo insormonlabile a strumenti di metallo ta glienti e temprati. Laoode, sino dai tempi più remoti, vidersi i popoli ergere moli di terra e di malloni, mnri di quadrelli colli al sole o di pietre dure, affine di pt·eservarc le loro abitazioni ed i loro campi dalle incursioni dci neruit:i. Questi muri seguirono la forma generale del recinto delle città; più alti e grossi erano dessi e meglio raggiungevano lo scopo pel quale ve\}ivano costrutti; la loro altezza li guarenti va dalla scalata e indeboliva l' effello delle armi da lanciare, quand' a nco non li avesse preservati iutieramente; la loro grossezza prel!entava un sito vantaggioso pel combattenti i c ui proiellili erano tanto più formidabili quanto da più alto partivano; oltre a ciò, qilanto maggiore era la grossezza loro altreuanlo più difficile il forarli sia di fronte ·cbe di sotto, qualora si fosse tentato dal nemico di aprir breccie o di cavar mine (2).
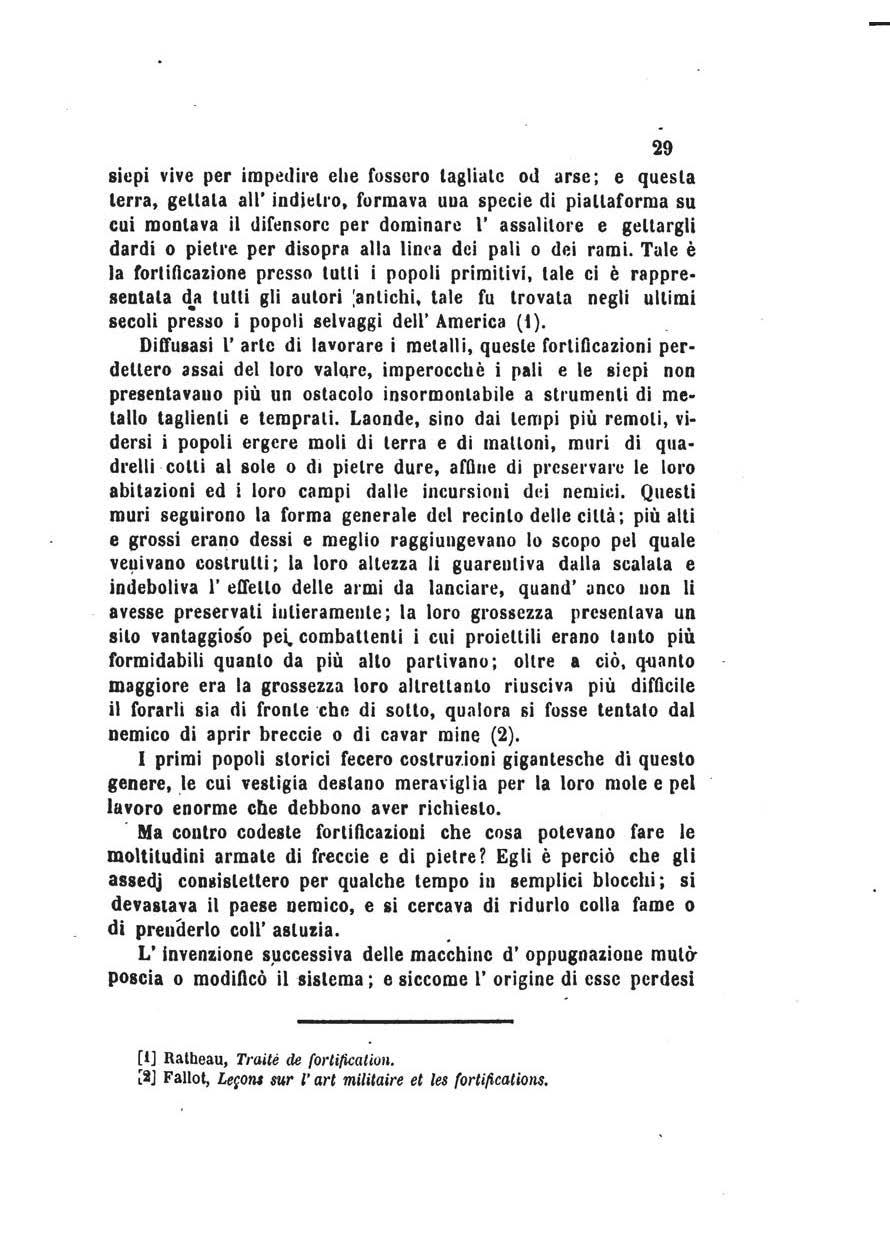
l primi popoli storici fecero costru1.ioni gigantesche di questo genere, .le cui vestigia destano meravigli a per la loro mole e pel lavoro enorme cbe debbono aver richiesto.
· Ma contro codeste fortificazioni che cosa potevano fare le moltitudini armale di freccie e di pietre? Egli è perciò che gli assedj conllistellero per qualche tempo in semplici blocchi; si devastava il paese nemico, e si cercava di ridurlo colla fame o di prenderlo coll'astuzia.
L' invenzione delle d' oppugoazione mutir poscia o modificò il sistema; e siccome l' origine di esse perdesi
[i] Ratbeau, Trailè de (orlifìcation.
Le,om mr l' art mililaire et /es (orti{lcations.
fra Je caligine <lei lempi; così non è dato allo storico di poter ragionare se non che sulle loro applicazioni e sui loro perfczionamenli, non sulle epoche o sui luoghi in cui fua·ono inventate.
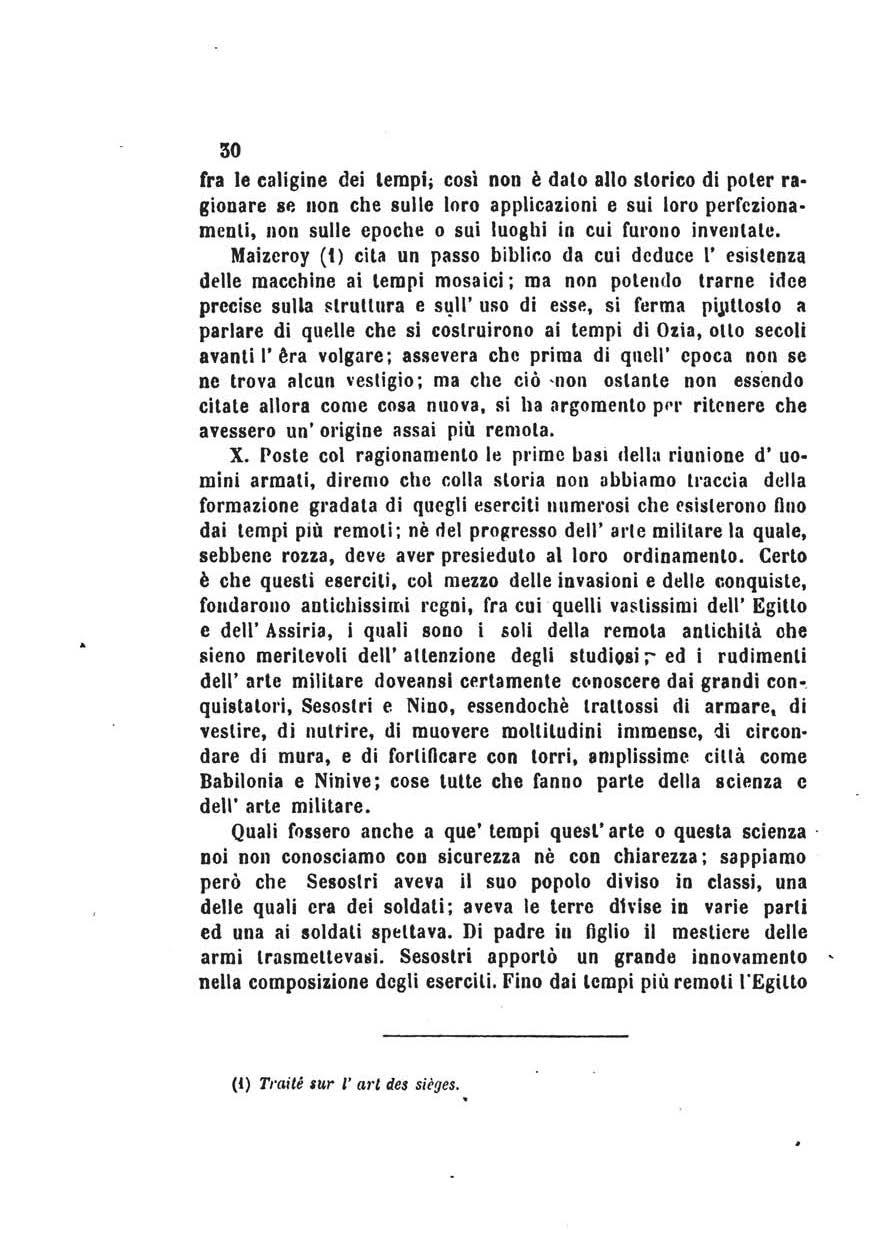
Maizcroy (t) cita un passo biblir.o da cui deduce l' esistenza delle macchine ai tempi mosaici; ma non potendo trarne idee precise sulla struttura e S(!ll' uso di esse, si ferma pijlllosto a parlare di quelle che si costruirono ai tempi di Ozia, ollo secoli avanti l' èra volgare; assevera che prima di q nell' epoca non se ne trova alcun vestigio; ma che ciò non ostante non ess·endo citate allora come cosa nuova, si ha argomento P"l' ritt>nere che avessero un' oa·igioe assai più remota.
X. Poste col ragionamento le pl'imc basi della riunione d' uomini armati, dia·emo che r.olla storia non abbiamo traccia della formazione gradata di quegli eserciti numet•osi che esisterono fluo dai tempi più remoti; nè rlel progresso dell' at·le militare la quale, sebbene rozza, deve aver presieduto al loro ordinamento. Certo è che questi eserciti, col mezzo delle invasioni e delle conquiste, fondarono antichissimi regni, fra cui quelli va!'tissimi dell' Egitto e dell' Assiria, i quali sono i soli della remota antichità che sieno meritevoli dell' attenzione degli studiosi;-- ed i rudimenti dell' arte militare dove11nsl certamente cc•noscere dai grandi con-. quistatori, Sesoslri e Nioo, t>ssendochè trallossi di armare, di vestire, di nuttire, di muovere moltitudini immense, di circon· dare di mura, e di fortificare con torri, amplissime cillà come Babilonia e Ninive; cose tutte che fanno parte della scienza c dell' arte militare.
Quali fossero anche a que' tempi quest ' arte o questa scienza · noi non conosciamo con sicurezza nè con chiarezza; sappiamo però che Sesostri aveva il suo popolo diviso io classi, una delle quali era dei soldati; aveva le terre dh'ise in varie parli ed una ai soldati spettava. Di padre iu figlio il mestiere delle armi trasmelleva11i. Sesoslri apportò un grande innovamento , nella composizione degli eserciti. Fino dai tempi più remoti l'Egitto
(t) Tmité sur l ' at't des sièges.
teneva in armi un corpo di truppe il quale, alla foggia di tutti gli eserciti primitivi, era composto di fanteria. Sesostri v' intro· dusse la cavalleria . L' arte dell' equituione, inventata in Egitto in epoca non bene determinala, ebbe utile applicaz.ione in quella di cui parliamo; ed i cavalli, che dapprima venivano ado· perali soltanto a trascinare i carri armati, costituirono un' arma novella.
1- carri di guerra tormavano grande fona degli antichi eser· citi; e gli egizj ne io molta quantità, come risulta dal viaggio di Dénon in Egitto nella circostanza dell' impresa di Buonapa•·te.
Le prime armi offensive degli egizj non sono ben note; certo è che nelle più antiche pillure e bassi rilievi . si vede il guerriero già munito delle ft·cccie, della lancia, del giavellotlo, dell'accetta, e della faretra. Nei sepolcri del re di Tebe si trovano dipinte altre armi fra cui la sciabola ed il pugnale. Le difensivo furono· primieramente le spoglie degli animali, le pelli cioè dei leoni e dei tori, lo scudo, che gli egizj (secondo Platone) pretendono aver inventato. Nelle pillure dci nominati sepolcri di Tebe si trovano pure il giaco di maglia e l' elmo.
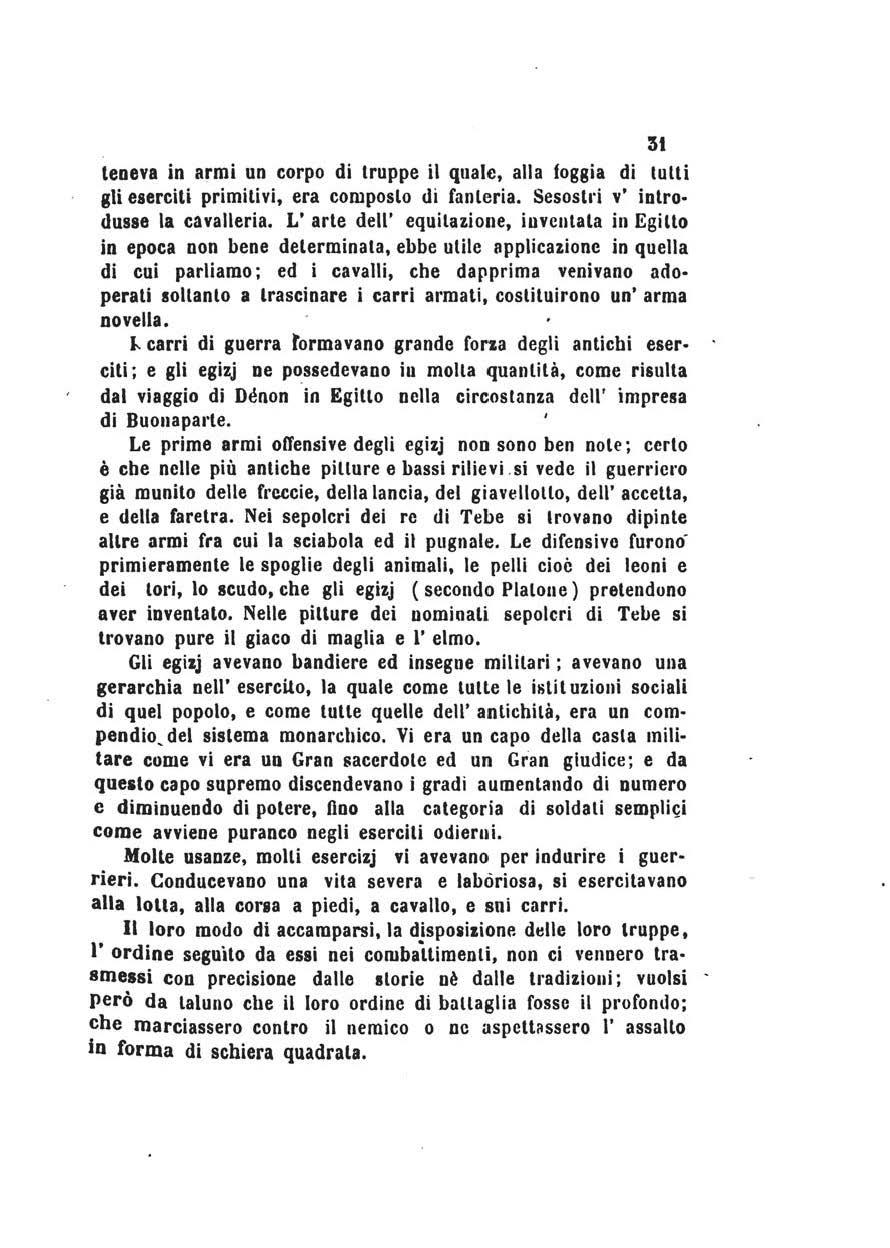
Gli egizj avevano bandiere ed insegne militari ; avevano una gerarchia nell' esercUo, la quale come tutte le uzioni sociali di quel popolo, e come tutte quelle dell' antichità, era un com· pendio, del sistema monarchico. Vi era un capo della casta mili· tare come vi era un Gran sacerdote ed un Gran giudice; e da questo capo supremo discendevano i gradì aumentando di numero e diminuendo di potere, fino alla categoria di soldati sempliçi come avviene puranco negli eserciti odierni.
Molle usanze, molli esercizj vi avevano per indurire i gucr· rieri. Conducevano una vita severa e labòriosa, si esercitavano alla loUa, alla coru a piedi, a cavallo, e sni carri .
Il loro modo di accamparsi, la disposizione dt:lle loro truppe, l' ordine seguito da essi nei corubaÌ.timenti, non ci vennero tra· smessi con precisione dalle storie nè dalle tradizioni; vuolsi però da taluno che il loro ordine di ballaglia fosse il profondo; che marciassero contro il nemico o ne l' assalto in forma di schiera quadrata.
Nemmanco si conosce fino a qual punto gli egizj antichi, s'intendessero della guerra d' asseùio, sia per l' assalto sia per la difesa. Essi hanno negletto l' arte delle fortificazioni; e la storia oon vanta punto le mura di Tebc o di Memfi come quelle di Ba· bilonia e di Ninive.
Le militi!! el(izlane si dividevano in due corpi: Cclcsirii ed Ermotibii, giusta la provincia in cui soggiornavano o piuttosto secondo la diversa forma abili lor·o. Vuolsi che le provin· cie dei primi pote"sero sBmministrare 250,000 uomÌJli, e quelle dci sccon1li 160,000. Mille uomiui nll' anno il st'rvizio presso il re e ricevevano soldo e razioni.
Rigullrdo .alla disciplina, gli storici nntichi ci fanno sapere soltanto che i soldati i q10ali abbandonavano il posto, o disoiJ· bcdivano al corr.andantP, o davano prova di codardia, erano puniti coi solisegni d' infamia; arg(lmeuto irrecnsab ile del sentimento d' onore militare.
Passando dagli egizj agli assirj, troviamo Nino che, a capo di sterminato numero di guerrieri (vuolsi d'un milione), compi le imprese meravigliose narrate dagli storici classici ed estese fino nell'Egitto e nell'India; troviamo molla conformità nel ai· stema militare dei due popoli, imperocchè gli antichi egizj e gli assirj del primo impero hanno brillalo qello stesso periodo.
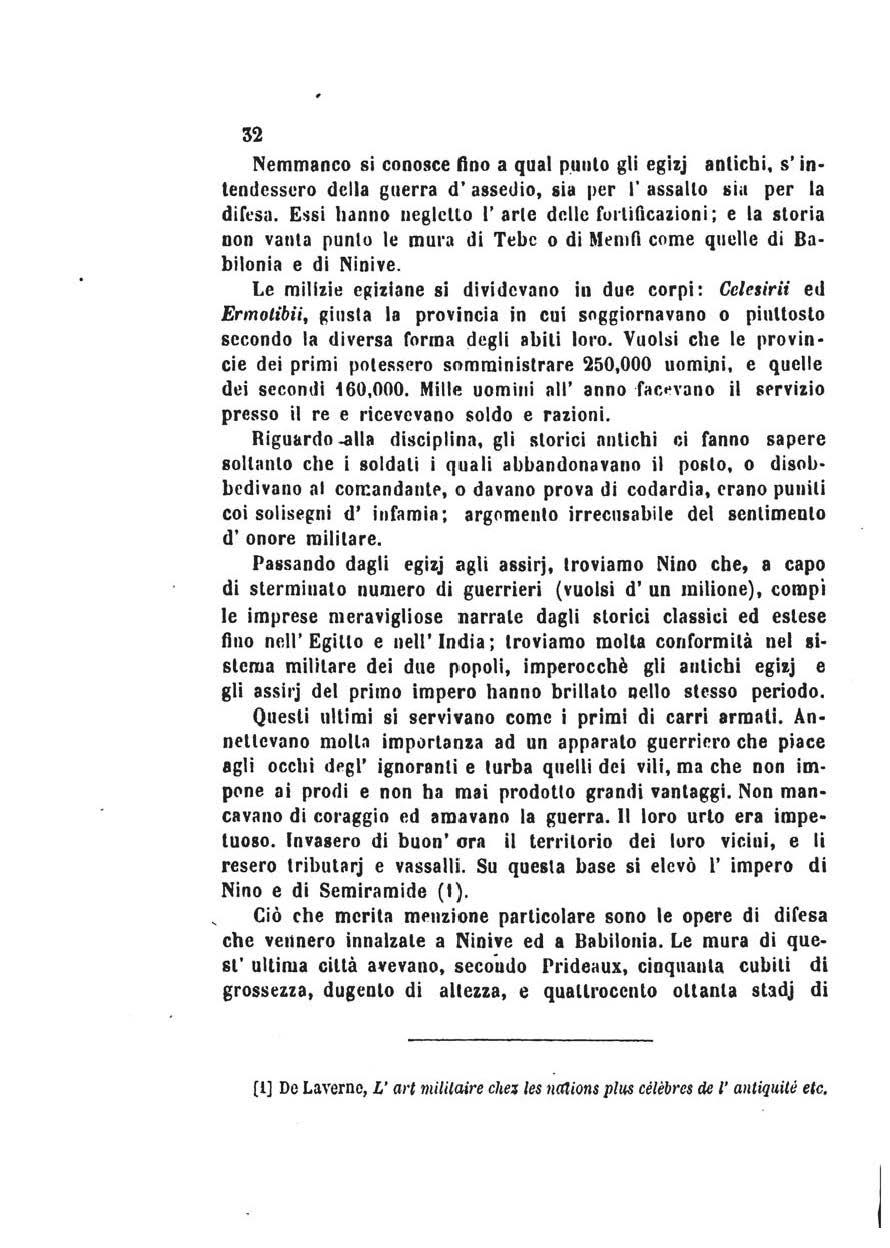
Questi ultimi si servivano come i primi di carri armali. An· nellevano molla importanza ad un apparato guerriero che p;ace agli occhi dr.gl' ignoranti e turba quelli dei vili, ma che non imp<'ne ai prodi e non ba mai prodotto grandi vantaggi. Non man· cavano di col'3ggio ed amavano la guerra. Il loro urto era impe· tuoso. Invasero di buon' ora il territorio dei loro vicini, e li resero tribulArj e vassalli . Su questa base si elevò l' impt>ro di Nino e di Semiramide (1}.
Ciò che merita menzione particolare sono le opere di diresa che ve11nero innalzate a NioiYe ed a Babilonia. Le mura di quest' ultima città uevano, secoiuJo Prideaux, cinquanta cubiti di grossezza, dugeoto di allena, e qualll·ocenlo oltanla stadj di (l] Dc La\'erne, L' at·t mililaire clle:s les 11afions plus célebl·cs de l' autiquité etc,
33 circonferenza, che corrispondono a circa ventiquattro leghe. Formavano un quadrato· perfetto, erano f.tbbricale di larghi matco nn essi per mezzo di bitume, allorniate da un gran fos!'o pieno di acqua e rivestito di mattoni in tulli i lati: l a terra cavata per profondarlo servi a fare i mattoni del suo rivestimento e quelli di cui erano costruite le mura. Ciascun lato del qua· drato aveva venticinque porte di bronzo massiccie, e fra le porte ed i lati del quadrato erano molte torri più alle dieci piedi delle mura.
Ma se gli antichi assirj ·erano molto innan zi uella costruzione delle opere di d1fesa, non pare che lo fossero' altrettanto nei mezzi e nei metodi di assa Ilo delle fortezze; le circostanze d el· l' àssedio di Baltro ( oggi Blak ), il più aulico della storia, fallo da Nino e dal suo esercito innumerevole, prouno come i primi assirj non fossero tt·oppo abili nell' arte di prendere una . città (i).
Altri popoli antichissimi ebbero eserciti, istituzioni mililari, imprese; fra questi si notano i chinesi, gl' indiani, gli ebrei.
Voolsi che esistesse un' arte militare in Ch ina ventisei secoli avanti l'éra cri stiana. Narrasi che venti secoli prima di Cristo i chinesi avessero eserciti con suddivillioni, ed ogni sezione fosse guidata da un vessillo di colore particolare. La cavalleria e i carri da guerra manovravano nella China in grandi masse. Vi si costruh·ano piazze forti e si praticavano gli assedj . Undjci secoli avanti Cristo 11i di:oponevano su di una sola linea ad intervalli, formala di cinquè quad1·ati uguali. Quattro secoli prima dell' èra volgare conoscevano la polvere da fucile, ma se ne servivano per fuochi d' artifizio: no o ebbero però bocche da fuoco se nun che in tempi più vicini a noi.
Gl ' indiani possedevano sino dai tempi più remoti d ella loro storia cel'le armi che lanciavano projellili col mezzo di uoa combinazione chimica in cui entrava il uilro; ma pare che l' uso e la conoscenza di questa combinazione siansi perduti coll' an· (Il lJc-Luvenw.
Stor. dell' Art Milit. 3.
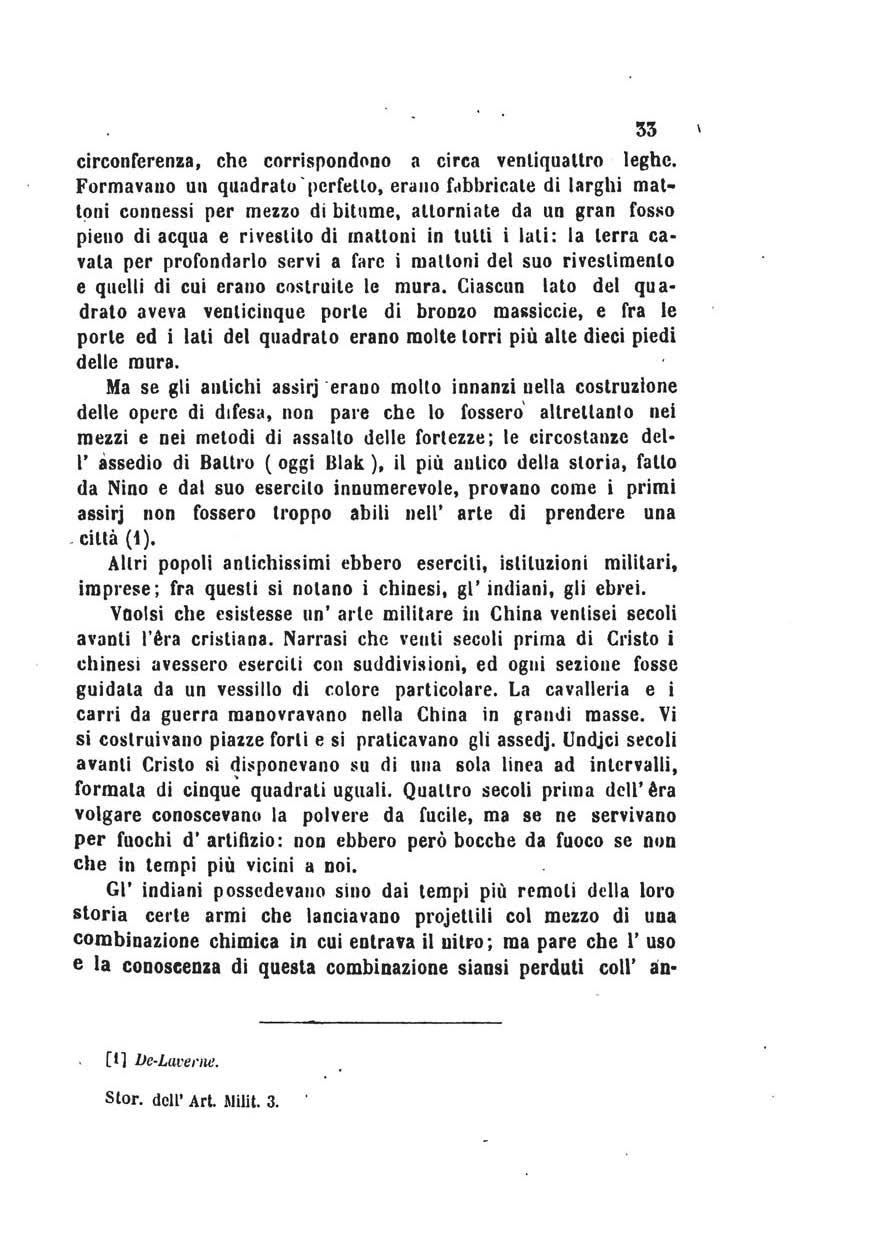
dare del tempo. Una classe d' uomini si dedicava alla guerra .
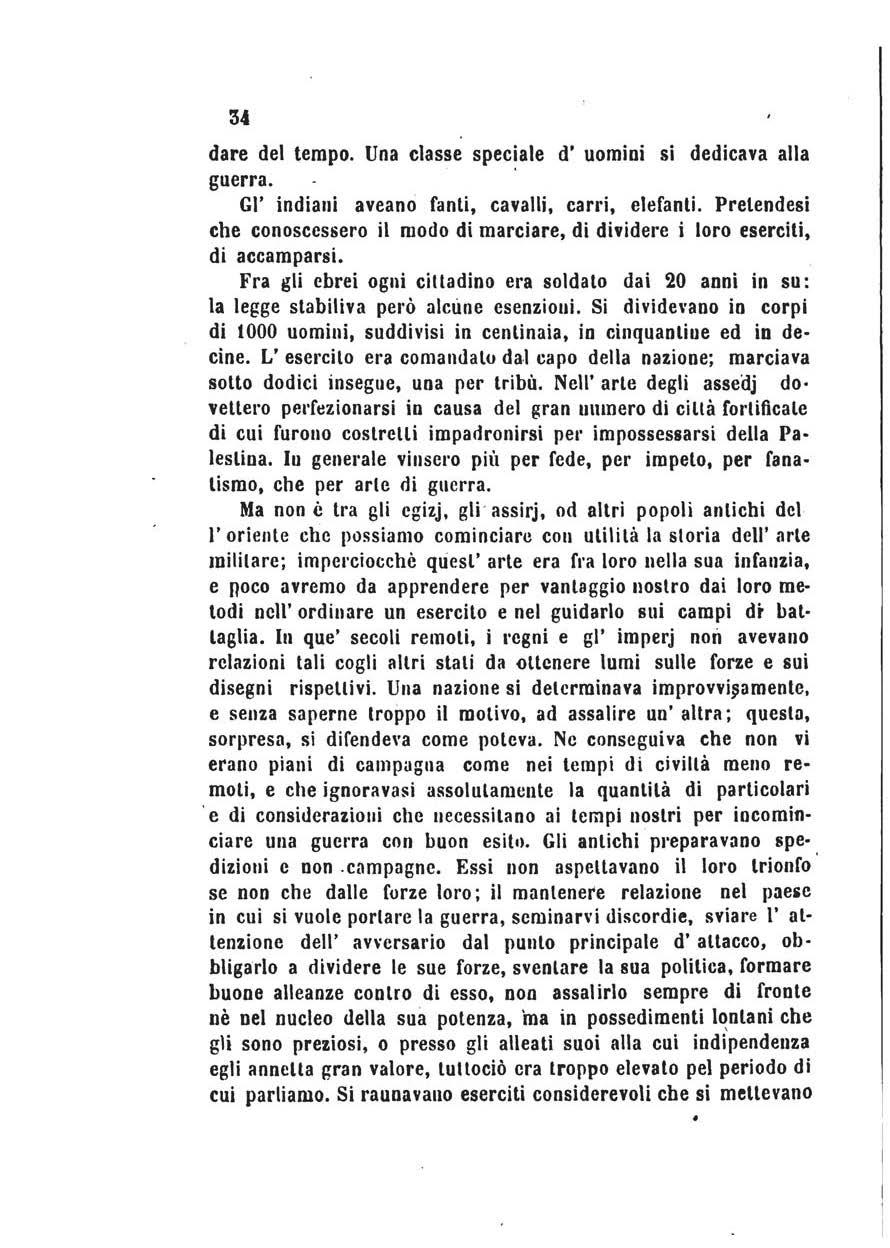
Gl' indiani aveano fanti, cavalli, carri, elefanti. Pretendesi che conoscessero il modo di marciare, di dividere i loro eserciti, di accamparsi.
Fra gli ebrei ogni cilladino era so ldato dai 20 anni in su : la l egge stabiliva però alcùoe esenzioni. Si dividevano io corpi di t 000 uomini, suddivisi in centinaia, io cinquantine ed in de· cine. L' esercito era comandalo dal capo della nazione; marciava sotto dodici insegue, una per tribù. Nell' arte degli asseaj do · vellet·o pea·fezionarsi io causa d el gran unmero di cillà fortificale di cui furono costretti impadronirsi pea· impossessarsi della Pa· lestioa. lu genel'a le vinsero più per fede, per impelo, per fanatismo, che per arte di guerra.
Ma non è tra gli egizj, gli · assirj, od altri popoli antichi del l'oriente che possiamo cominciare con utilità la storia dell'arte militare; imperciocchè qùest' arte era f1 a loro nella sua infanzia, e noco avremo da apprendere per vantaggio nostro dai loro me· todi nell'ordinare un esercito e nel guidarlo sui campi dr bat· taglia . In que' secoli remoti, i acgni e gl' imperj non avevano relazioni tali cogli altri stati da ottenere lumi sulle forze e sui disegni rispettivi. Una nazione si determinava improvvi§amente, e senza saperne troppo il motivo, ad assalire uo' altra; questo, sorpresa , si difendeva come poteva. Ne conseguiva che non vi erano piani di campagna come nei tempi di civiltà meno remoti, e che ignorava!'i assolutamente la quantità di particolari ·e di consiùerazioui che necessitano ai tempi nostri per iocomin· ciare una guerra con buon esitn. Gli antichi p1·eparavano spe· dizioni c non . campagne. Essi non aspettavano il loro trionfo se non che dalle forze loro; il mantenere relazione nel paese in cui si vuole portare la guerra , seminar"i discordie, sviare l' at· tenzione dell' avversal'io dal punto principale d' auacco, ob· bligarlo a dividere le sue forze, sventare la sua politica, formare buone alleanze contro di esso, ooo assalirlo sempre di fronte nè nel nucleo della sua potenza, ìna in possedimenti che gli sono preziosi, o presso gli alleati suoi alla cui indipendenza egli annclta gran valore, tuttociò era troppo elevato pel periodo di cui parliamo. Si rauoavano eserciti considerevoli che si mettevano
:15
in· movimento lulli in una volla ed in massa, c<l innondando per un punt o solo il p!lese che volevano assoggeltare.
La divisione dell' esercito in più colonne, le quali marcino ù' accordo per avviluppare ed invadere un territo rio, ed abbiano punti di corrispondenza c di riunione, non era maggiormente conosciuta dai guerriet·i di que ' tempi remoti di quanto lo fosse l' urte delle ricognizioni militari o quella delle es plorazioni, la scelta delle direzioni , delle pos izioni, e dei terreni; imperocchc tutte queste op erazioni non pussono essere, in caso di guerra, se non che frutto di lunga esperi enza , di premeditato, e di conoscenza perfetta dci paesi in cui si portano le proprie armi. Qu r. gli eserciti marciavano innanzi in una sol massa, non assumevano informazioni sulle località che dovevano percorrP.re se non che a misura che si avanzavano ; portavano s cco loro viveri pet· un certo tempo, ma non fa 'cevano magazzini di armi nè di munizioni da bocca; saccheggiavano il paese nemico giorno per giorno. I.e batta glie erano d' inrontro ; gli . eserciti si urla· vano e si uccidevano senza misericordia. Primi a dar la carica erano i carri falciati, poi il re,;to dell' esercito. Colui che trovavasi costretto a difendersi non poneva maggior arte nella sua condotta.
l.a ritirata era una rotta completa; l' incontro di un Oume era il colpo di morte pei fug giaschi; il monarca od il generale vinto passava il ponte ( se ve n' era uno pr eparato ) col sno corte ggio; 1!, per me glio assicurare la !'ua fu ga, lo faceva tagliare · t.Jiclro a sè, abbandonando la sua truppa all:r rabbia nemica (1}.
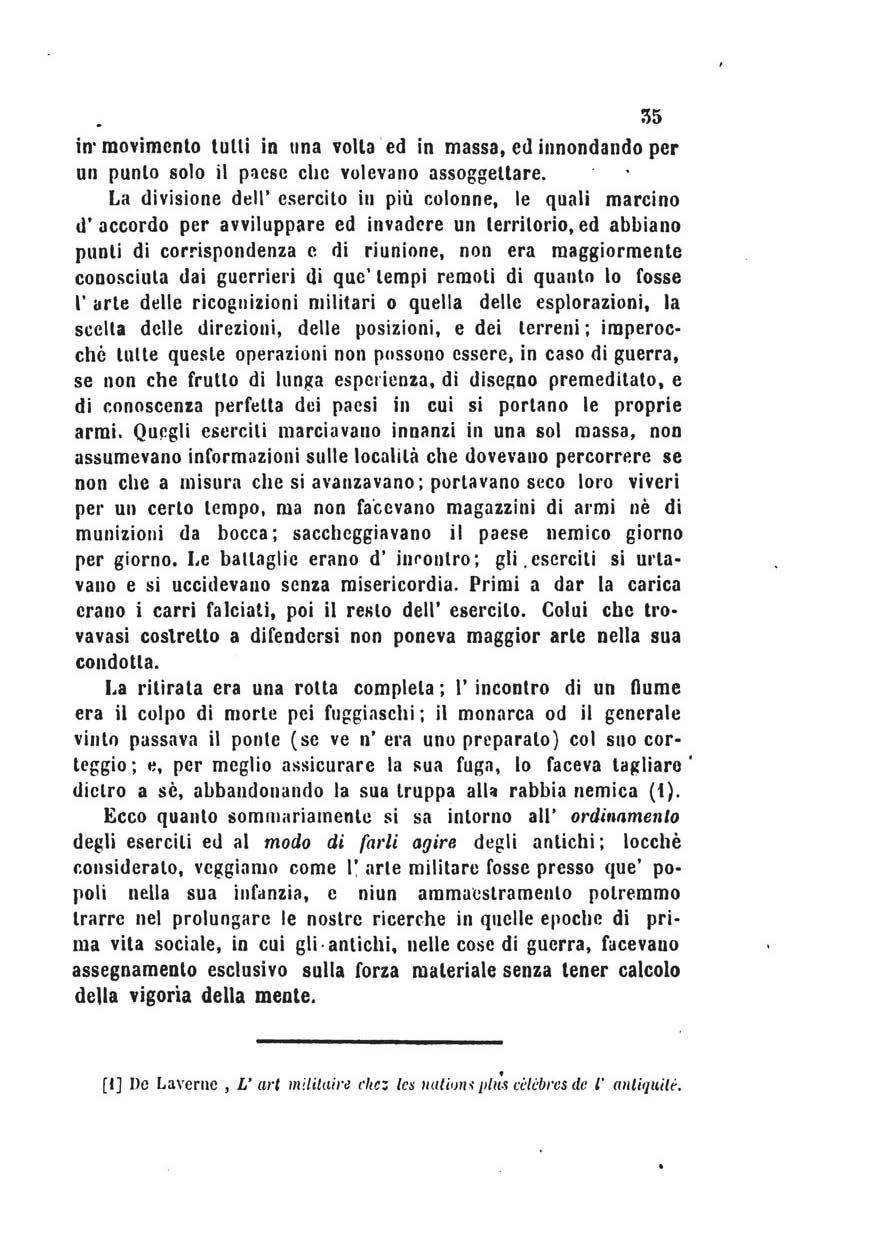
Ecco quanto sommariamente si s a intorno all ' ordinamento degli eserciti ed al modo di farli agire degli antichi ; locchè r.onsiderato, vcg giamo come 1 : arte militare fosse presso que' po· poli nella su a infanzia , c niun amm at slramenlo potremmo trarre nel prolun gare le nostre ricerr.he in quelle epoche di pri ma vita sociale, io cui gli . antichi, nelle cose di guerra, facevano assegnamento esclusivo sulla forza materiale senza tener calcolo della vigoria della mente.
( l] ne La \'crnc , L 'ar t cltc : Ics ci:li:brcs e t c l' alltiqui t r.
Qualora vogliamo rinvenire un felice àccoppiamcnto del raziocinio, dello studio, e dell' csverienza, coi mezzi fi. sici che sono a nostra disposizione, affine di rendere 'questi più ertìcaci srnza d' uopo di adop<'rarli in numero sterminato, noi siamo ohblignti a fermarci alla Grecia, O\'e troviamo l' arte della guerra fondata sopra sani principj e ricca di utili risuhamcnti. l greci, in guerra difensiva coi persiani, mercenaria sotto Ciro, civile fra loro, offensiva e conquistatrice sotto Alessandro, pensarono b<'n presto agli rsrrciti loro, e crea· rono educazione militare, armamento, amministrazione, ordinanza, manovre, disciplina, igiene, unn tattica di forma· zione che soppravisse alla distruzione delle loro falangi.
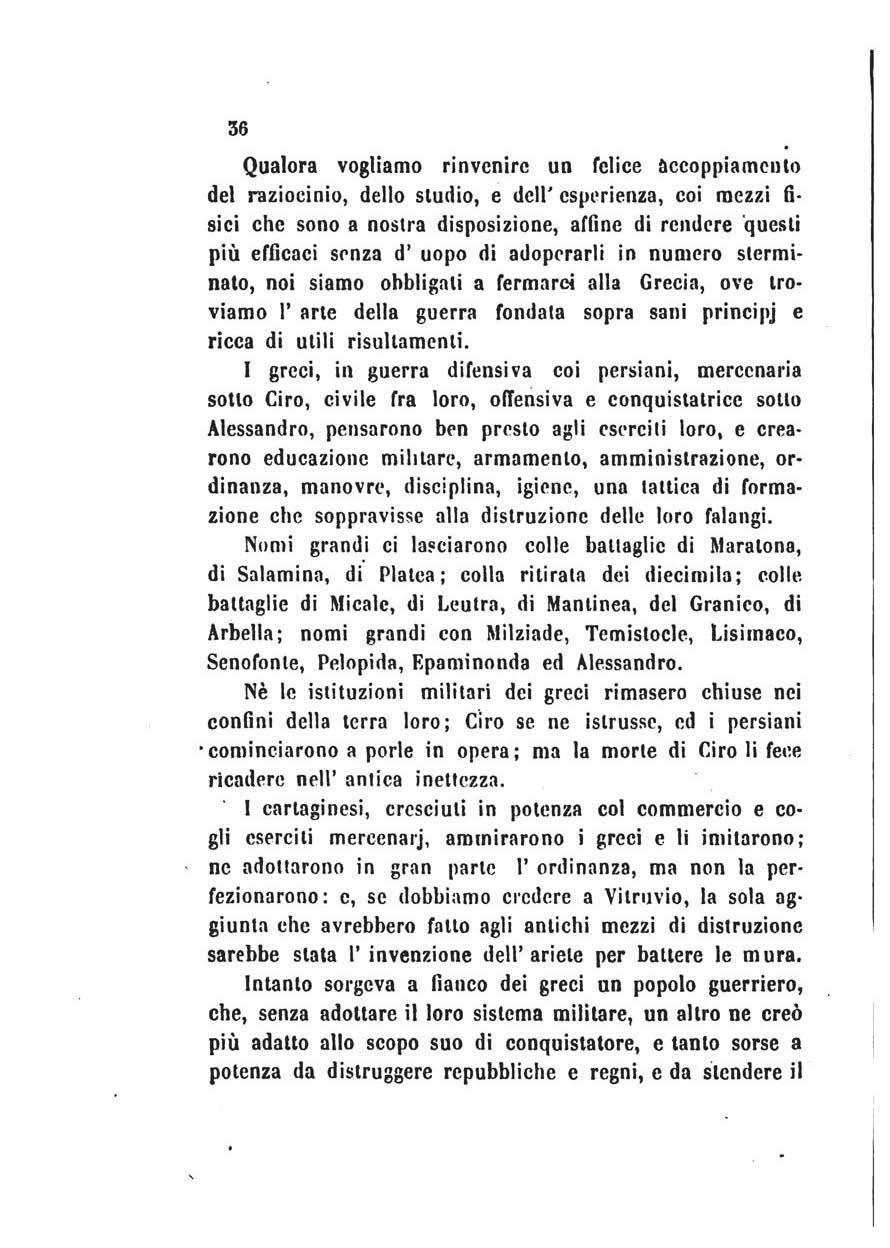
Nomi grandi ci la!lciarono colle battaglie di Maratona, di Sala mina, di. Platea; colla ritirata dci diecimila; battaglie di Micalc, di Lcutrn, di Mantinea, del Granico, di Arbella; nomi grandi con Milziade, Temistocle, tisimaco, Senofonte, Pelopirla, F.paminonda ed Alessandro.
Nè le istituzioni militari dci greci rimasero chiuse nei confini della terra loro; CÌro se ne istrussc, cd i persiani ·cominciarono a porle in opera; ma la morte di Ciro li ricnllerc nell' antica inettczza . l cartaginesi, cresciuti in potenza col commercio e cogli eserciti merccnarj , ammirarono i greci e li imitarono; ne adottarono in gran parte l' ortlin:mza, ma non la per· fezionarono: c, se dobbiamo ct·ctlcre a Vitruvio, la sola ag· giunta che avrebbero fallo agli antichi mezzi di distruzione sarebbe stata l' invenzione dell' ariete per battere le mura.
Intanto so•·gcva a fianco dei greci un popolo guerriero, che, senza adottare il loro sistema militare, un altro ne creò più adatto allo scopo suo di conquistatore, e tanto sorse a potenza da distruggere repubbliche e regni, e da stendere il
suo dominio sulla massima parte del mondo antico. l ro mani, ordinale le loro legioni, mostrarono fior d' arte e di saper militare in tutte le parti dell' orgaoamento, io tolte quelle dei cooccui e delle esecuzioni ; solidità e mobilità, saggiamente combinate, diedero . alle loro schiere una. superiorità assoluta sugli allri sistemi; essi ruppero le fnlangi, conquisero le masse innumerevoli di nemici meno istruui di loro, e lasciarono monumenti preziosi di sapienza militare i quali allestano quanto conoscessero l' arte della guerra e qual vi abbiano recato.
Xl . L' invasione dci barbari, precipitando i popoli nell' ignoranza, e gettando nel bu io tuue le arti e le scienze antiche, offuscò anche l' arte e la scienza militare con tanto onore e profitto i greci ed i romani avevano coltivato. l barbari portarono seco loro il sistema feudale, in cu i gli eserciti , composti principahncnte di cavalieri bardati di ferro , si distinguono sopraltuto per la prodezza, la forza fisica, e te azioni individuati; nulla per l'ordine e per l'insieme. Le guerre di Carlomagno, le invasioni dei Normanni, le ero· ciatc, le guerre per fondare doruinii stranieri nella penisola italica, sono le imprese più notr.voli dei tempi di mezzo. Xli. Fra le grandi scoperte che apersero la via al rinnovamento delle scienze e delle arti, e che separarono totalmente il medio e,·o dai tempi moderni, una ve n' ba che appartiene intieramente alla categoria militare. Vo' dire la scoperta, o, piunosto, l' uso della polvere; c col volgere degli anni tu no subisce il più esenziale mutamento; armi, Vtstiorio, ordinanza, tutto è cambiato; la cavalleria non è più la dominante negli eserciti; la fanteria riprende ili posto e r iacquista la considerazione ch.e godeva già frà greci e romani; la picca sparisce a poco a poco, c la I.Jajonenn
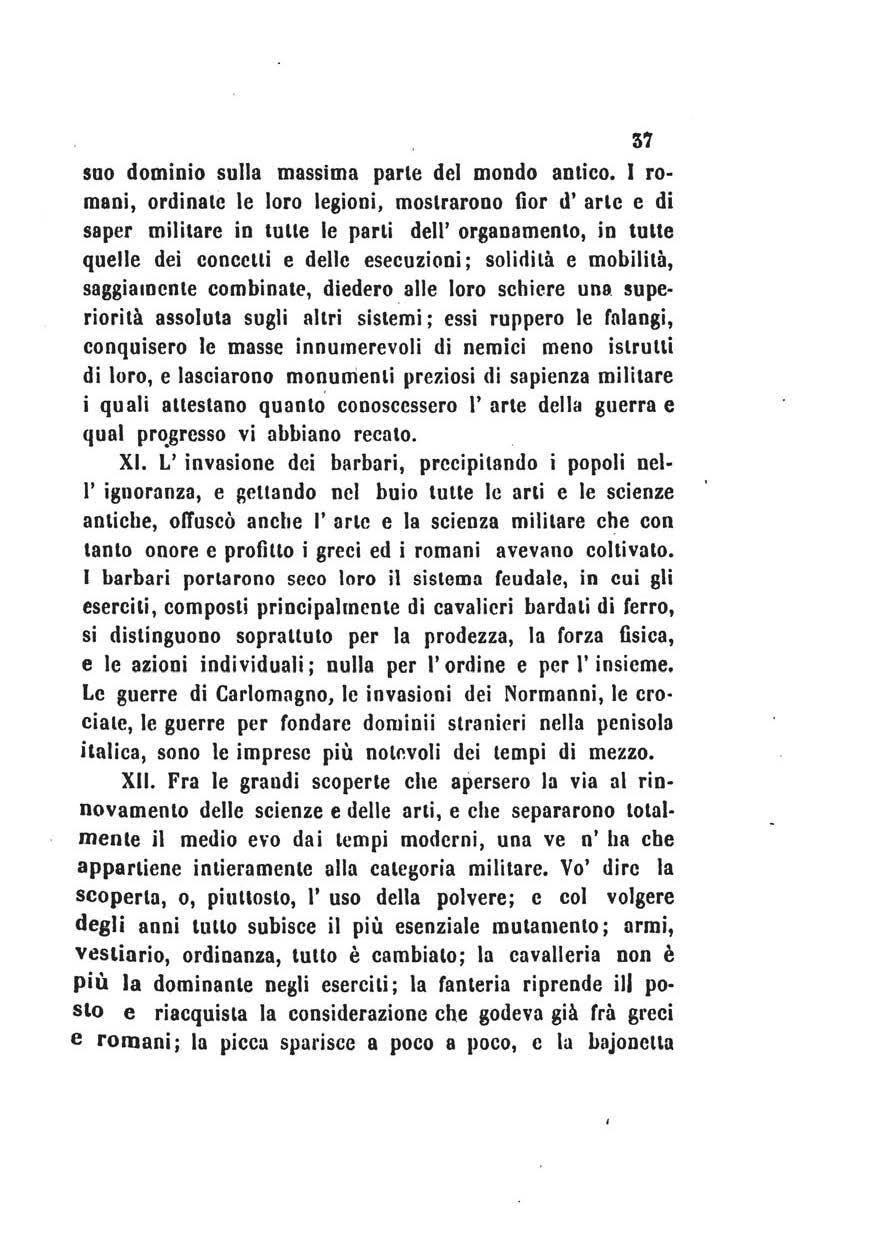
unita al fucile forma un' arma di doppio uso, da giuo e da urto; i classici di Grecia c di Roma vengono studia ti; e l' arte militare acquista un impulso e fa un progresso che le barbarie de l medio evo aveva arrestato.
Grandi avvenimenti c uomini grandi cbbimo in quest' éra novella. Carlo VIli scende in Italia cor. numero e pezzi d' artiglieria non mai veduti ; Emanuele Filiberto, ristabilito il fulgore della sun dinastia, instaura eserciti nazionali c cilladini; Enrico IV contro la lega cattolica, Mau' rizio di Nassau contro gli austro-ispanici, Gustavo Adolfo a capo dei protestanti nelle guerre di religione , Luigi XIV in quelle d' ambizione e di preponderanza, Torrenn, Mon· tecuccoli, Condè, il principe Eugenio di Savoia, il maresciallo di Sassonin, e al disopra di tutti Federico Il e Napoleone il grande, segnarono epoche nelln storia dell' arte militare le quali non si confondono con (1hclle di certe gcstc clamorose, di certe ardimentose imprese, che nulla influiscono sulla scien za; ma si svolsero in esse tutti i tesori che arricchirono di tanta sap ienza l' nrte della guerra da portarla al punto di altezza a cui oggi dì si · trova collocata.
l perfezionamenti recati alle al'mi in questi ultimi tempi hanno portato e porterano ultc'r iori mutamenti all' arte militare; le armi rigate, la forma c la mole dci projcuili, il tiro a favolose distanze, J' ago applicato ai fucili, l' alleggerimento e la semplificazione di tutto il materiale di guerra, la mobilità ognor crescente che si vuol dare nlordinanza, i progressi di tutte le arti e di tutte le scienze che hanno relazioni più o meno dirette colle cose di gucr· ra, ci costringono a studiare di continuo perchè le oppli· cazion i pratiche vadano di pari passo co lle elucubrazioni teoriche .
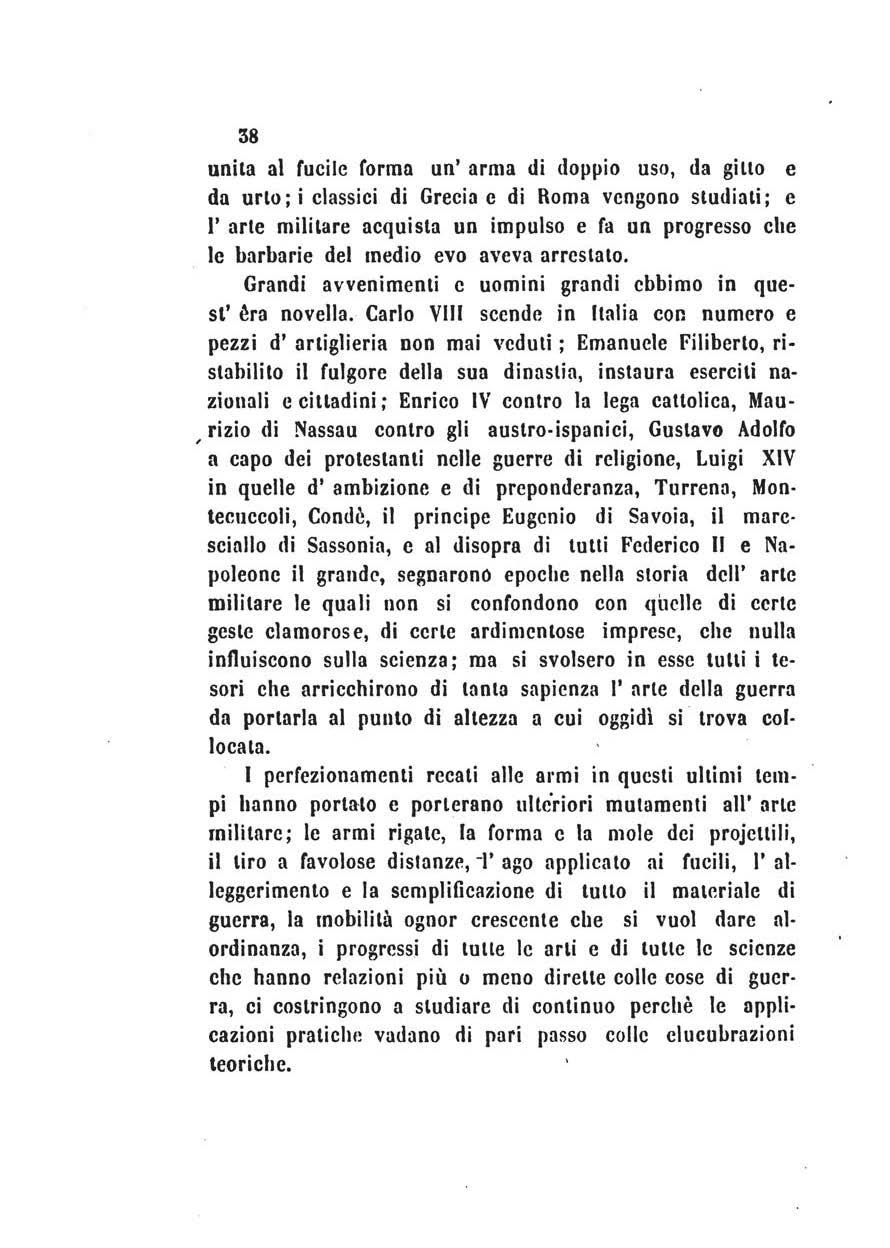
La Prussia ha riconosciuto più d' ogni altra potenza questa verità; e ne ha raccolto e raccoglie i frutti nelle grandiose e spedite sue guerre e suoi strepitosi trionfi . Non è io essa il genio di un uomo che opera prodigj, è il genio di una intiera nazione che ha compreso la foria del progresso.
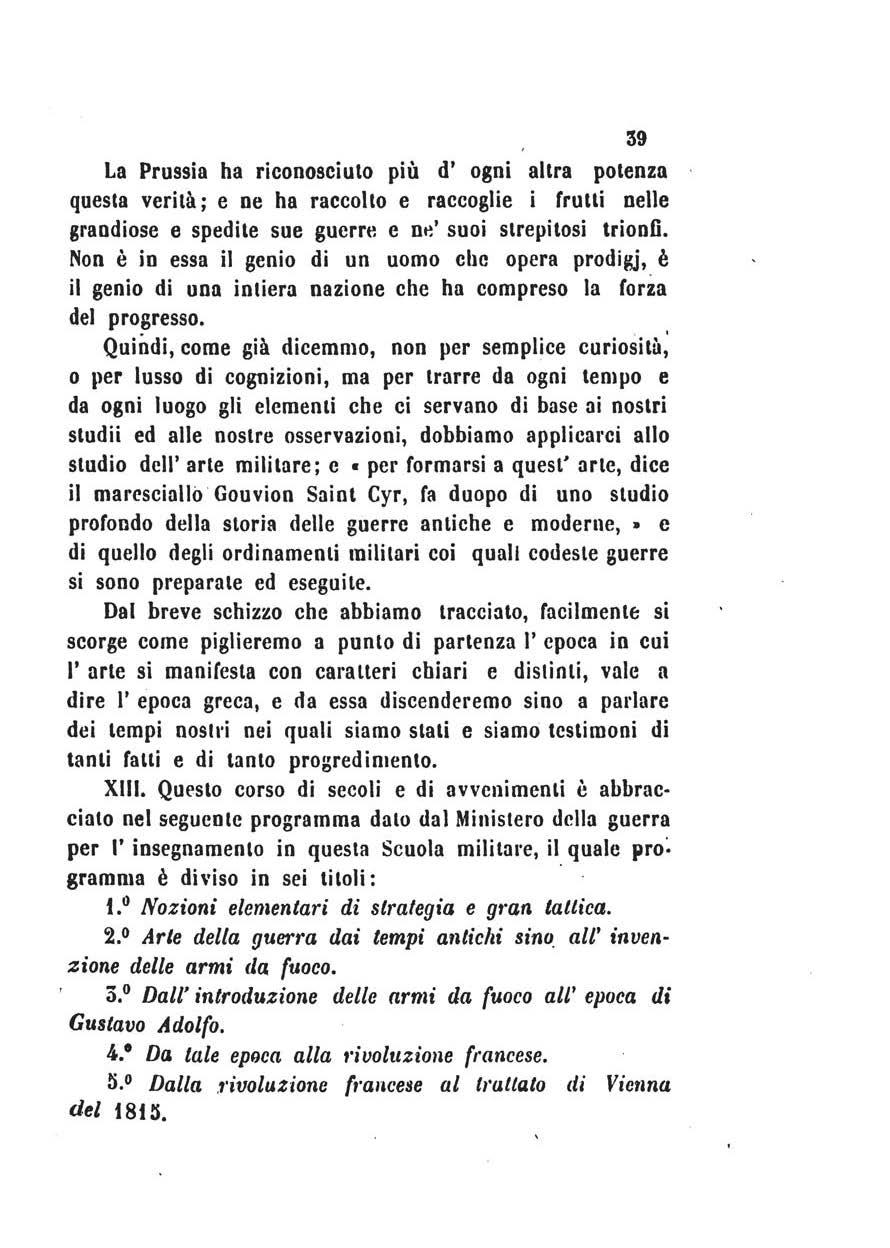
Quindi, come già dicemmo, non per semplice o per lusso di cognizioni, ma per trarre da ogni tempo e da ogni luogo gli elementi che ci servano di base ai nostri studii ed alle nostre osservazioni, dobbiamo applica1·ci allo studio dell' arte militare; c • per formarsi a quest' arte, dice il maresciallo ·Gouvion Saint Cyr, fa duopo di uno studio profondo della storia delle guerre antiche e moderne, " c di quello deg li ordinamenti militari coi quali codeste guerre si sono preparate ed eseguite .
Dal breve schizzo che abbiamo tracciato, facilmente si scorge come piglieremo a punto di partenza l' epoca io cui l' arte si manifesta con caratteri chiari e distinti, vale a dire l' epoca greca, e da essa discenderemo sino a pal'lare dei tempi nostl'i nei quali siamo stati e siamo testimoni di tanti ratti e di tanto progredimento.
Xlii. Qut'sto corso di secoli e di avvenimenti è abbrac· ciato nel seguente programma dato dal Ministero della guerra per l' insegnamento in questa Scuola mililal'e, il quale pro: gramma è diviso in sei titoli: ·
t . 0 Nozioni elementari di strategia e gran tattica.
2.0 Arie della guerra dai tempi anticlti sino. all' inven· zione delle armi da fuoco .
3.0 Dall' introcluzione delle nrmi da fuoco aU' epoca di Gustavo Adolfo.
4.• Da tale epoca alla f'ivoluzione francese.
Dalla .rivoluzione france:Je al ttallato eli Vicnna del i8HS.
0 Dal t 815 al f 866 .
XIV. Ecco quanto prescrive il programma mioist•·iale: come intendiamo noi di sviluppnrlo! .
Ciascun titolo si suddividerà in capitoli.
Ciascun C!lpitolo, traon.e quelli del 10 Titolo, consterà invariabilmente di tre parti principali.
Nella prima daremo un brevissimo Sunto storico ddle guerre fatte nel luogo c nel tempo a cui accenna il titolo del capo. In questa guisa sarà più facile al lettore il mel· tere nel loro posto cronologico quei fatti che nel resto dello svolgimento del capitolo si dovranno esplicare o citare.
Nella seconda parleremo dell' Ot·dinamento degli eserciti a quel tempo cd in quel luogo medesimo, ed alle diverse operazioni di cui si occupa, c che abbiamo già esposto per ordine in queste pagine.
Nella terza ci tratterremo in torno al modo di adoperare quegli eserciti, ossia al modo di agire, vale a dire all' Aziotle. Poscia daremo esempii, talora di concetti strategici, tal altra di concetti e di tattiche , sia nelle guerre combat\ute sui campi di battaglia, sia in operazioni eiTet· tuate in qualche grande assedio.
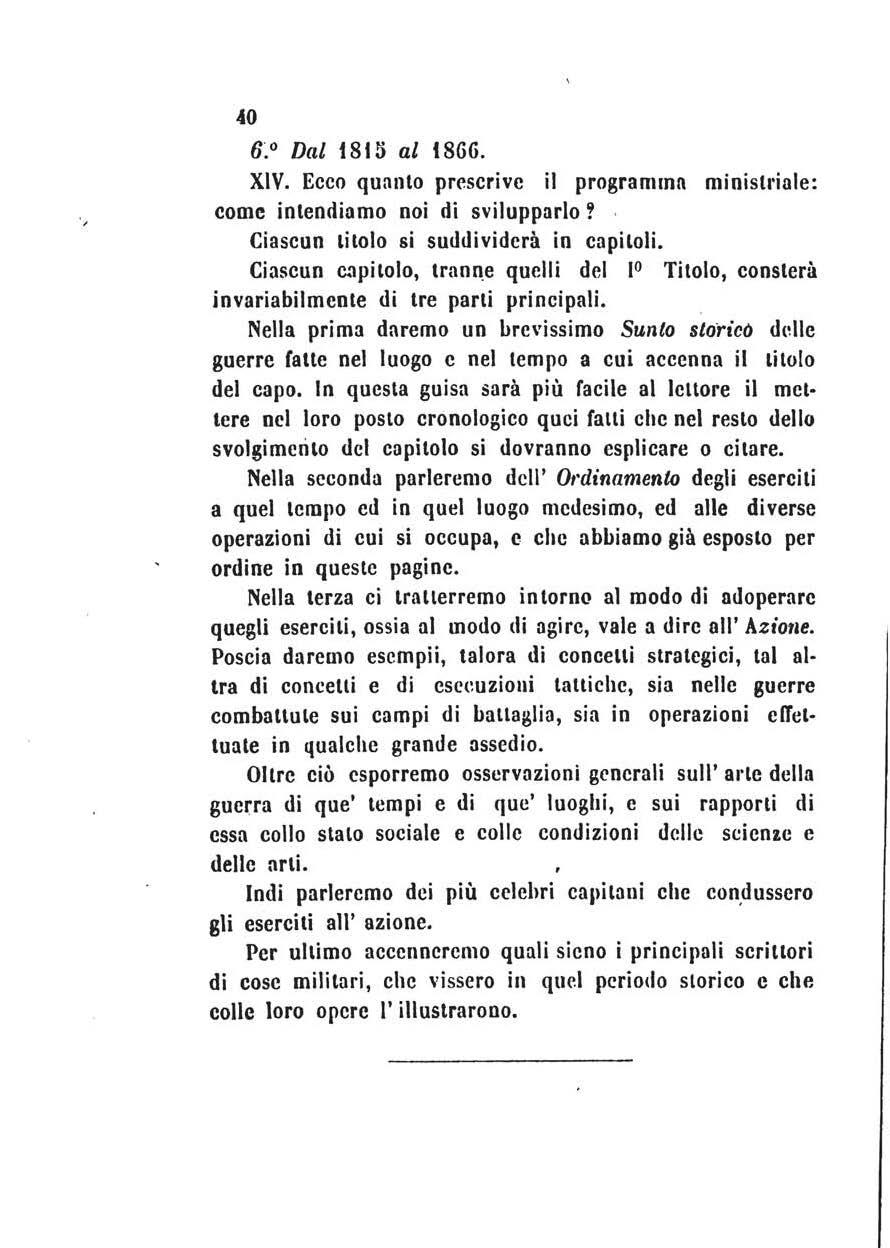
Oltre ciò esporremo osservazioni generali su ll' at·tc della guer:ra di que' tempi e di quc' luoghi, c sui rapporti di essa collo stato sociale e colle condizioni delle scicn1c e delle arti.
Indi parleremo dci più celebri ca11itnni che con dussero gli eserciti all' azione.
Per ultimo accenneremo quali sicno i principali scrittori di cose militari, che vissero in quel pcriotlo slorico c che colle loro opere l' illustrarono.
J. Definizione della gnerl'a Il. Distinzioni III. Scopo della guerra IV. 1.' esercito V. Il terreno VI. Teatro dello 'guerra e politi ca della guerra - VII. Teatro delle operazioni e strategia VIII. Campo di hattoglia, e gran tattica IX." Ba$e di operazioni X. Punti strategici: obùiettivi.;.... Xl. Linee di operazioni- XII. Linee di comunicazioni, di operazione, fronte strategi ca, linea . di diresa, punti ùi rifugio - Xlii. La logistica - XlV. Della guerra o>fTenSi\·a, della guerra difensiva e della ofl'ensivo-difensi\·a XV. Còmpito del Generale in capo XVI. Marcie strategiche XVII Andamento di una guerra. ·
l. La guerra è la lotta materiale di eserciti nf'mJCJ per terminnre e decidere colla ro rza lr. controversie dei potcn· tali che non si possono o non si vogliono dccitlere colla ragione.
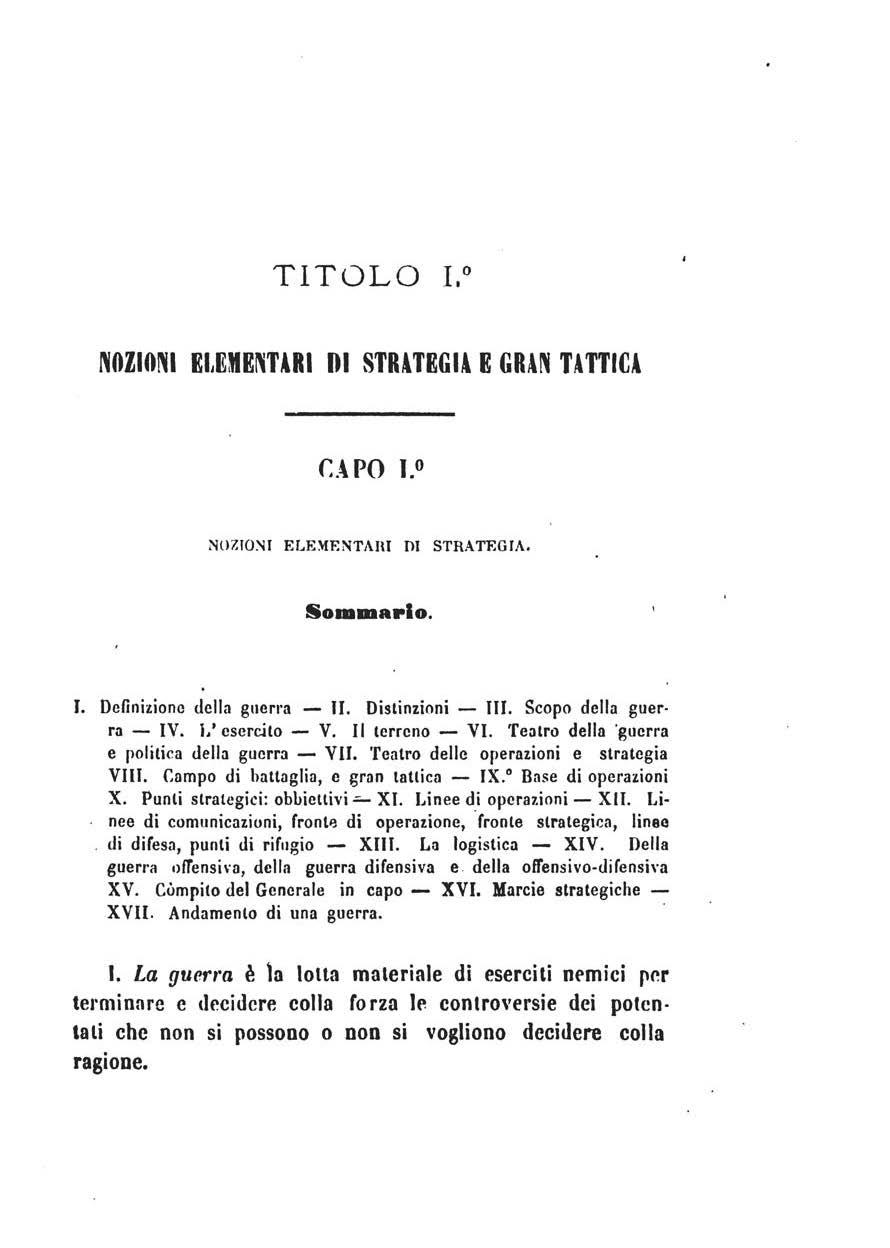
Il. La guerra si distingue secondo la causa che l'ha prodona in:
t . 0 Guerra d' invasione per conquista, mossa dall' am. bizione o dalla · cupidità di dominio. Esempj: in Alessandro, Cesare, Carlomagno, Luigi XIV, Federico Il, Napoleone.
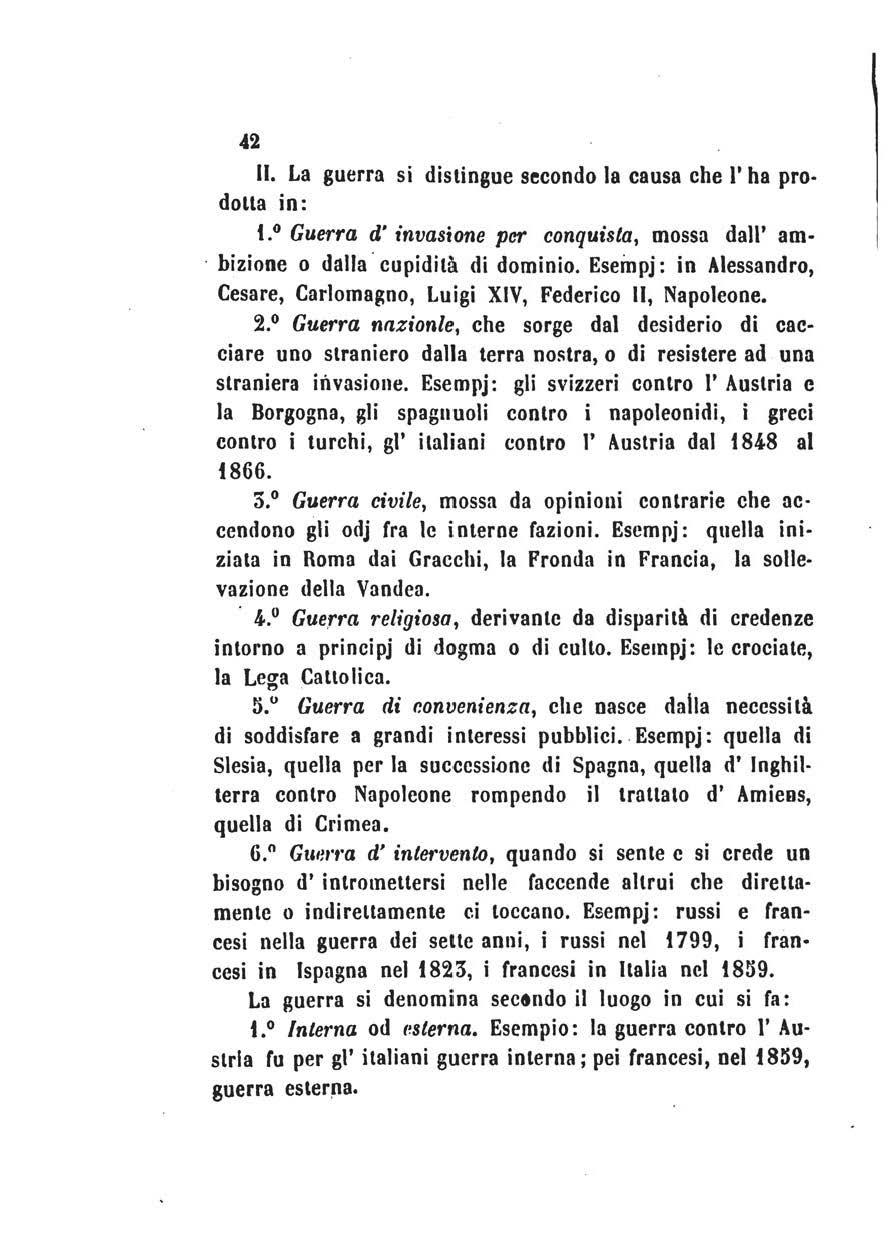
2.0 Guerra nnzionle, che sorge dal desiderio di cacciare uno straniero dall a terra nostra, o di resistere ad una straniera invasione . Esempj: gli svizzeri contro l' Austria c la Borgogna , gli spagnuoli contro i napoleonidi, i greci contro i turchi, gl' italiani contro 1' Austria dal t848 al t866.
5.0 Guerra civile, mossa da opinioni contrarie che accendono gli odj fra le i nteroe fazioni. Escmrj: q nella iniziata io Roma dai Gracchi, la Fronda in Francia, la sollevazione della Vandea . ·
4. 0 Guerra religiosa, derivante da di credenze intorno a principj di dogma o di culto. Esempj: le crociate, la Lega Cattolica.
!>.0 Guerra di r.onvenienza, che nasce dalla necessità di soddisfare a grandi interessi pubblici. . Esempj: quella di Slesia, quella per la successione di Spagnn, quella d' Inghilterra contro Napoleone rompendo il trattato d' Amiens, quella di Crimea.
6. 0 Gwwra d' intervento, quando si sente c si crede un bisogno d' intromettersi oe11e faccende altrui che direttamente o indireuamente ci toccano. Esempj: russi e fran· cesi ne11a guerra dei sette anni, i rus si nel t 799, i francesi in lspagna nel t 82 3, i francesi in Italia nel t 8a9.
La guerra si denomina secendo il luogo in cui si fa:
L 0 Interna od t!slerna. Esempio: la guerra contro l' Austria fu per gl' italiani guerra interna; pei francesi, nel t guerra es ter,na.
2. 0 Alarittima o terrestre. E!lt'mpj: guerre venete mari t· timc, gurrre !\ntichc e recenti terrt' s lri.
Finalmente si classifica secondo il modo di farla in: f. o Offensiva. Esempio: Federico Il invruJen<Ìo la Slesia .
2.0 Difensiva. Esempio: i l\ussi contro Napoleone nel t8t2.
Hl. Scopo della è di ott<'nere Ja vittoria, vale n dire di obbaUere le forze dell' avversario in modo da costr in gerlo a desistere da un'impresa od a subire la nostra volontà.
Affine di conseguire la vittoria fa mestieri adoperare t uni i mezzi materiali ed intrllettuali che sono in nostro potere per ben regolare le forze dt•l paese delle quali pos siamo disporre, c dar loro la maggiore efficacia.
IV. L' insieme delle forze del paese costituisce l' Eset·cilo.
L' esercito adunque è costituito dall' insieme · di tutti i mezzi e di tutte le fòrze tanto offensive quanto difensh·c di cui un paese disporre. Riunito in un tutto assoluto, sottoposto ad una soln volontà, esso rappresenta l'unico agente esecutivo in guerra.
V. Per far muovere l'esercito convenientemente ed utilmente, fa duopo conoscere il tP.rreno su cui devesi operare e sapersenc approfittare; fa duopo conoscere il Teatro della guerra, il Teatt·o delle operazioni, il Campo di hattnglia.
VI." Il teatro della guerra comprende tutti i pnt'si su cui due o più potenze nemiche possono incontrarsi, tanto sul proprio territorio quanto su quello tli allrnti o di potenze secondarie che trascinassero nel conflitto per timore o per interesse. Se la lotta si complica con operazioni marittime, allora il teatro della guerra non si limita soltanto· alla frontiera di uno stato.

Il teatro di guerra può quindi avere un' immfmsa, perchè . ha un significato vago e dipendente dagli avvenimenti (1).
Il modo · di ripartire le forze combattenti sopra questo teatro, c di fissare i grandi principj arfinchè gli sforzi parziali convergano allo scopo proposto nella lotta, appartiene al governo, ed entra nel dominio della Politica della guet"ra .
VII. Il teatro delle operazioni ha limiti · più ristretti. una superficie geog rafica, hacino di un gran fiume o versante marit\imo, li m iiata da grandi ostacoli naturali, o dalla frontiera di un paese neutro, e sulla quale hanno luogo tutte le opcrazioui di una campagna per mezzo di uno stesso est'rcito, e al !li là della quale queste operazioni non potrebbero ragionevolmente estendersi.
Il teatro della guerra può quindi contenere parecchi teatri d' operazioni, su ciascuno de' quali agisce un esercilo distinto e indipendente.
L' arte di disporre e !li fnr muovere le troppe sul teatro deJle operazioni, vale a dire una vasta superficie geogratìca, a portata del nemico, ma fuori del raggio visuale , entra nel dominio della strategia, ed appartiene al generale in capo.
Vl ll . Il campo di bnUaglia è una superficie di terreno che comprende le posizioni di due eserciti i quali si trovano a fronte tra loro, e sono pronti ad attaccarsi.
Il teatro delle operazioni può quindi contener un gran numero di campi di battaglia.
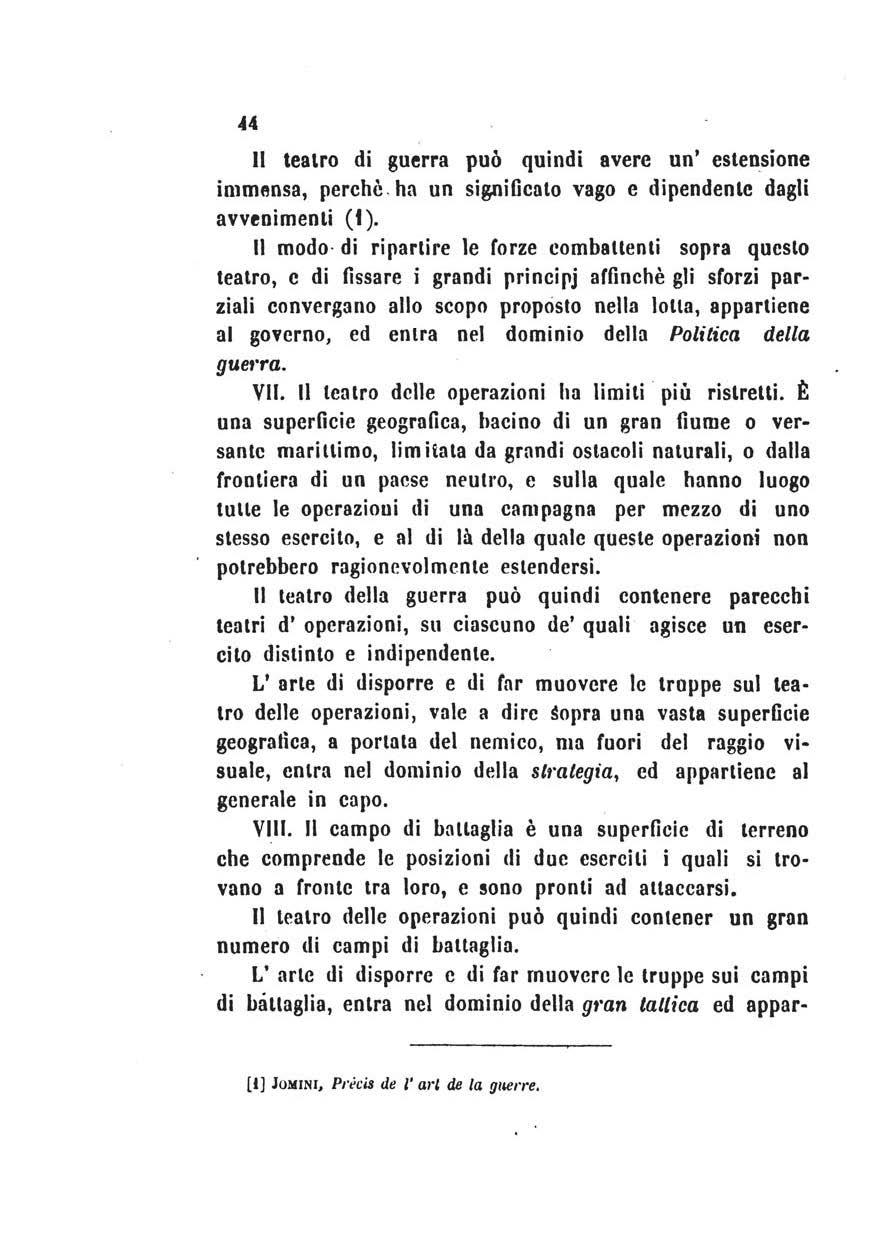
L' arte !li disporre c di far muovere le truppe sui campi di bauaglia , entra nel dominio della gmn tattica ed appor-
[l) J oMIN I, de l ' arl de la !}tten·e.
tiene al generale in capo ed ai comandanti di gl'osse mnsse tattiche (t).
Altre definizioni si diedero alla strategia ed alla gran tauica.
la Strateg;a si ré consistere nr.t conccllo t' nella direzione delle grandi operazioni militari; la Gran Tattica nel modo in genere di condurre ad esecuzione i concetti strategici.
La §trateg;a, si disse, è la tlir<'zione impressa ai movimenti militari in un circolo più esteso di quello che l' occhio può abbracciare; la G,:an Tattica è la direzione data alle truppe nella sfera del raggio visuale.
la Strategia è la tallica di un immenso spazio di terreno che si chiama Teall'o della guetra; la Gran Tattica è In strategia di uno spazio di terreno più ristretto che si chiama Campo di battaglia .
• La Strategia, dice l' arciduca Carlo, è quel t amo dèll' arte militare il quale insegna quali siano i punti più utili ad essere occupati io un teatro di guerra, c tluali sicno le linee più utili a percorrersi per passare dall' uno all' altro di questi punti • .
Per conseguenza, intraprendendo una guerra, }aisogna · considerare il luogo da cui si muove, il luogo a cui si tende, le vie che coRtlucono dnl luogo da cui muove a quello a cui si tende.
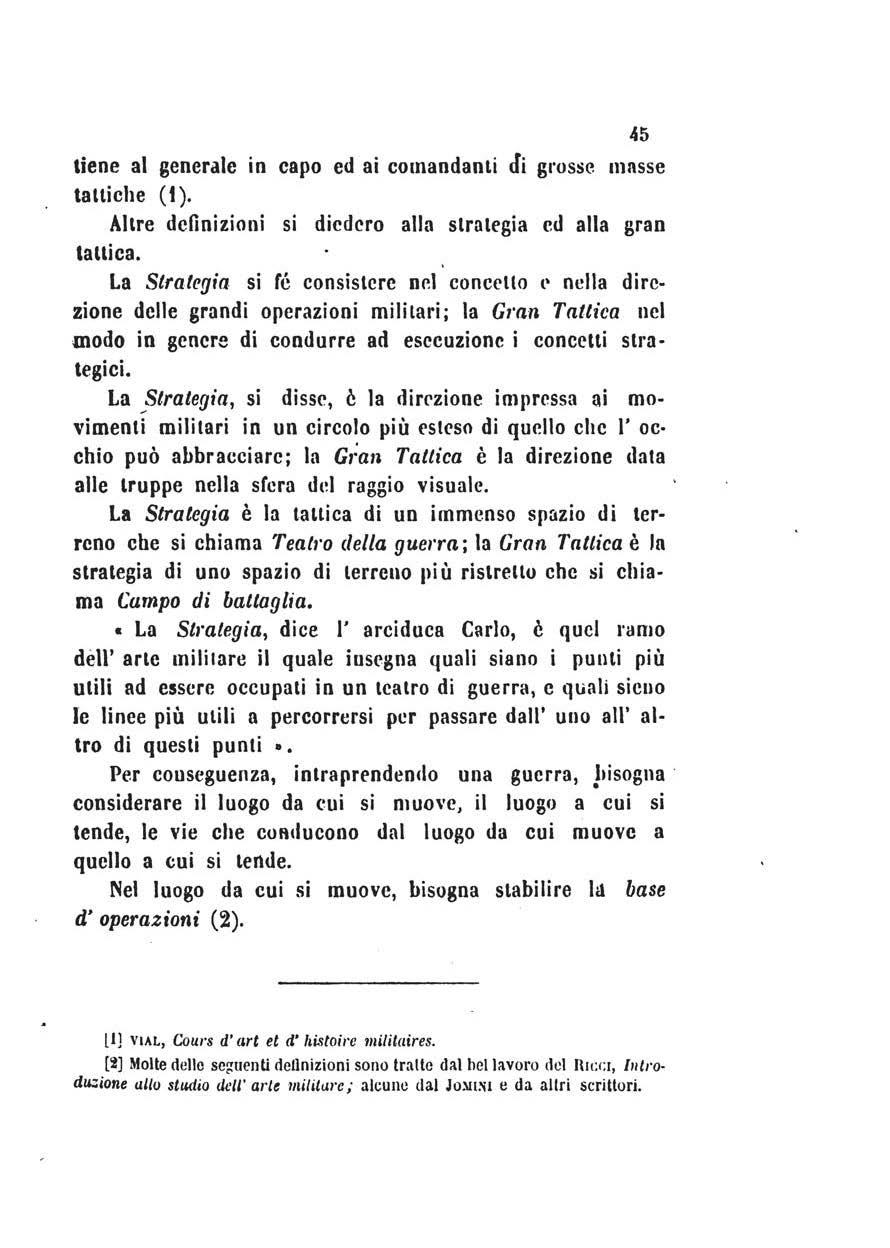
Nel luogo da cui si muove, bisogna stabilire 1<1 base d' operazioni (2).
[ l] VIAL, Cours d'art et d' liistoirc mililaires.
(i] Molte dello dcllnizioni sono tratte d:\1 hcii:\Voro tlcl R1 cr:r, illtro· du:ione «Ilo studio de/l" arte militu1·c; alcune dal e da a liri sc rittori.
IX. La base d' oper·azioni è una linea, o una combinazione di lince, costituita da varii punti strategici sui quali un esercito si appoggia nella difensiva, c da cui nell'offensiva trae i mezzi che gli sono neccssarii. D.alla definizione dato, risulta l' importanza soLio varii rapporti, offrendo punti d'appoggio c un rifugio in caso di rovescio, sia dal punto di vista amministrativo, fornendo i viveri e i rinforzi all' esercito; pcrlocchè è anche della base di approvigionamento. Ne viene per un éscrcito la necessità di mantenersi costantemente in comunicazione collQ propria base d' operazioni. Da ciò due principj fondamentali per la strategia: operare nella offensiva in modo da tagliare l'armata avversaria dalla sua base d' approvigionamcnto; operare nella difensi\'a nel senso del primo principio ora stabilito, impe· dendo che il nemico possa fare altrettanto a nostro danno. Da questi principii vengono determinate riguardo alle basi:
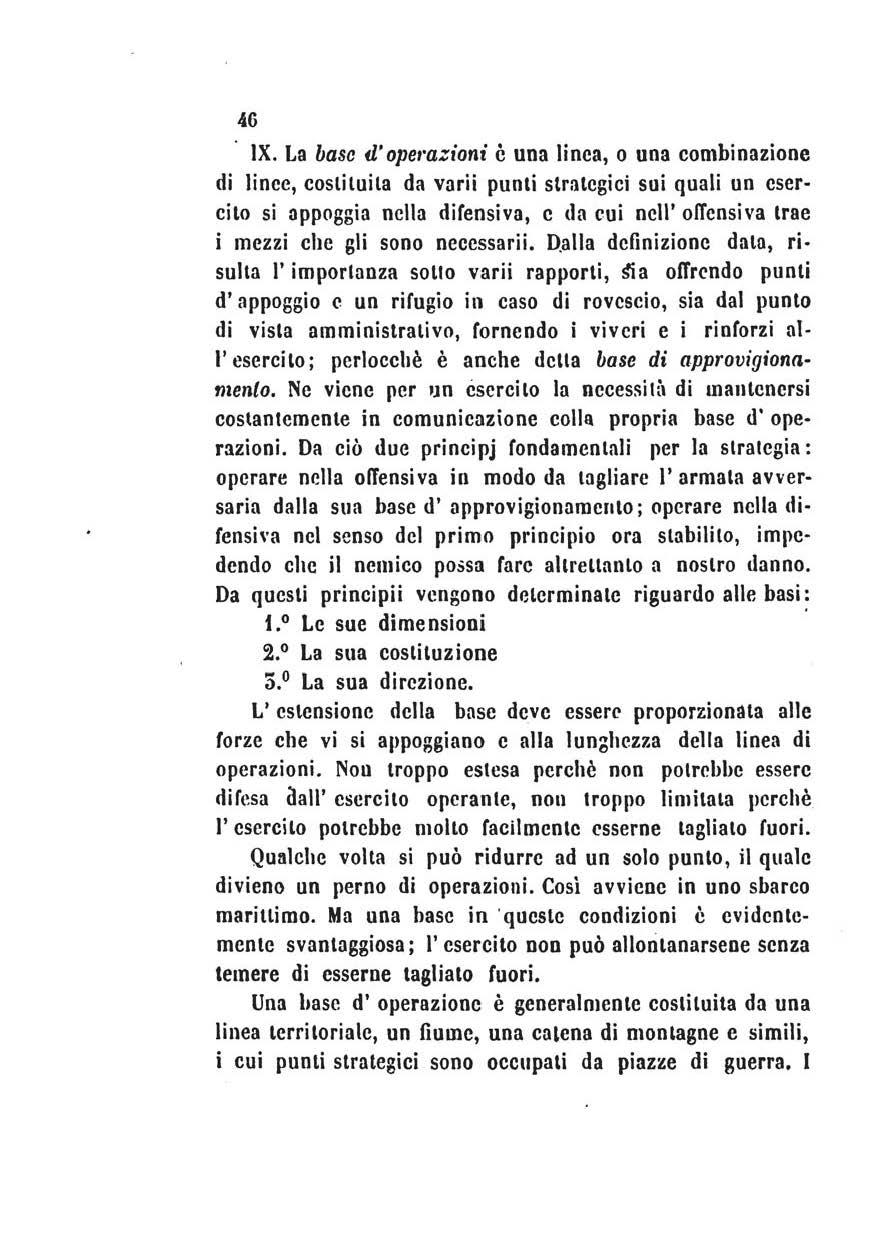
1.0 Le sue dimensioni ·
2. 0 La sua costituzione
5.0 La sua direzione.
L' estensione della base deve essen• proporzionata alle forze che vi si appoggiano c alla lun 0hczza della linea di operazioni. Nou troppo estesa pcrchè non potrebbe essere aall' esercito operante, non troppo limitata pcrchè l'esercito potrebbe molto facilmente esserne tagliato fuori. Qualche volta si può ridurre ad un solo punto, il quale divieno un perno di operazioni. Così avviene in uno sbarco marittimo. Ma una base in ·queste condizioni è evidentemente svantaggiosa; l'esercito non può allontanarsene senza temere di esserne tagliato fuori.
Una hasc d' operazione è generalmente costituita da una linea territoriale, un fiume, una catena di montagne e simili, i cui punti strategici sono occupati da piazze di guerra. l
suoi fianchi sono generalmente appoggiati a grandi ostacoli territoriali come il mare o un paese neutro, in modo che non possa venire aLtaccata di rovescio. l JlUnti che costituì· scono la base devono essere fortificati affine di potcrli ab· bandonarc a sè, senza paura di pc1·dere i magazzini c senza bisogno di difenderli con distaccamenti che indeboliscono l'esercito. De\·ono inoltre essere legati fra loro con comun.icazioni praticabili.
La sua direzione può essere o parallela a quella del nemico o inclinata fino a divenire perpendicolare; come pure può essere formata da due linee che si tagHano ad angolo più o meno aperto, ed in tal caso si dice avvilup· pante, mentre si dice avviluppatu quella dell' avve•·sario la quale si trova in condizione inverse di essa.
Se la linea di operazioni si allung!l di molto, allora . ( perchè gli approvigionamenti, le sussistenze, ed i soccorsi giungano in tempo e sicuri all'esercito) si stabiliscono varie basi successive lungo la linea d'operazione medesima. Esse diventano altrettante ·basi seconda-rie, ossia nuovi punti d'appoggio c nuovi centri d' amministrazione . Anche queste basi secondarie devono riunire possibilmente le qualità volute dai principj supremi della strategia.
X. Punti strategici sono quelli In cui occupazione può riuscir utile ed esercitare notabile influenza sulle operazioni; e sui quali deve per conscg.ucoza rivolgersi e basare la conquista e la difesa d' un paese.
Le qualità caratteristiche del punto strategico sono: f.0 Che cuopra ed assicuri la comunicazione che vi conduce. 2.° Che offra probabilità di poterlo sostenere. 5.° Che non possa essere oltrepassato impunemente dal nemico. 4.u Cbe ad facciano capo diverse strade c tlirezioni.
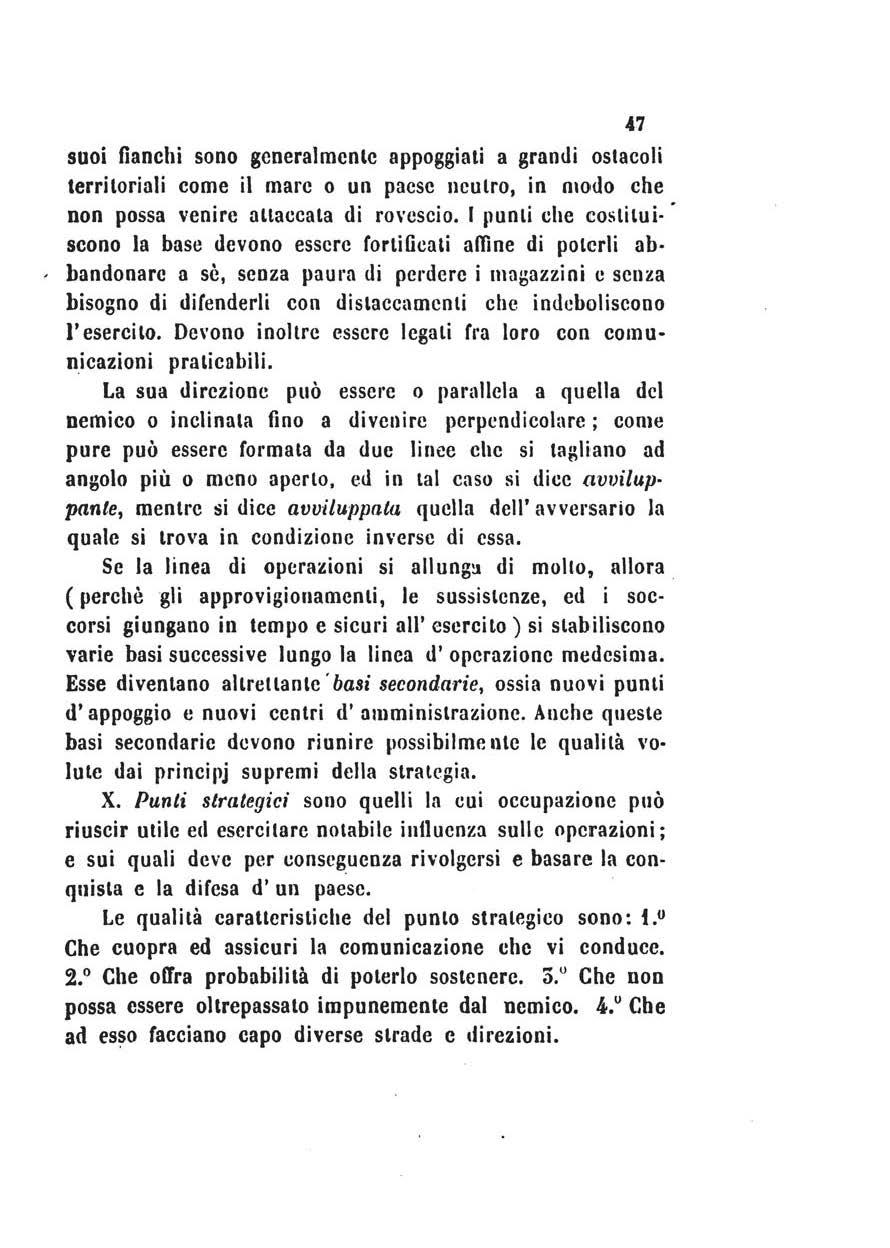
Sono punti strnlegici di primo ordine le capitali, pt'rchè centri tli azione, di mt•zzi, c di rit't:lll'zza. Gli cs<'rciti vi trovano ,.i\'t'ri, oggetti, dt•narn; c il loro possesso, o!trc che perm ette di utilizzare i mezzi lutti dd p:wsc, oltre che di· sorga11izza la •·esistenza tld nemico, est'rcita anche una in· flueoza morale considerevole su lla maggior degli nbi· tanti. Sono p.unti stratl'gici le città situate al confluente di J\ÌÙ Humi o che ne dominano il corso: cosi Alcssantlrin al confluente della Bormida col Tanaro tlommante la valle del Po; quelle situate dietro gli stret ti ovc congiungonsi le direzioni tli più vallate; quC"IIe che stanno n<'ll' int<·rscca· mt•nlo di più strade, come Bologna. Si tro\'ano ancora punti stt·att•gicì nei luogh i elevati do\'C sì congiungono din•rsi gio· ghi di montagne. Il cot·po che li occupa può scegliere la dil·<'zìone che gli conricnc discendere. Il S. Got· tardo è un punto di questo Esso domina ad un tempo i bacini del neno , del Rodano, della Rcus, dell' Aar c dd Ticino.
Oltre a questi punti pcr111ancnti il cui , ·alor c è intrinseco, la cui impnrtanza 1\ dipendente dalla. loro po· sizione c dalla configurazione del territ orio, e che pt·rciò si di· cono punti strale!Jici assoluti, letTiloriali o geoymfici, vi sono altri punti che, non imp or tanti per sè, lo diventano unicamente per la posizione del nemico c per ciò che si \'uol tentare contro di esso; c questi si dicono punti stra· le!Jici t:elativi, evenltmli, d i mrrno11•·a. Così quello locali ti\ o il cui possesso permetterà di battere il ccnu·o del nemico c dividerlo in due, o di girare una delle sue ali per impadronirsi delle sue comunicazioni, sarà punto strategico relativo o di manovra, perchè la sua importanza è eventuale, subordinata cioè alla posizione dell' avversario.
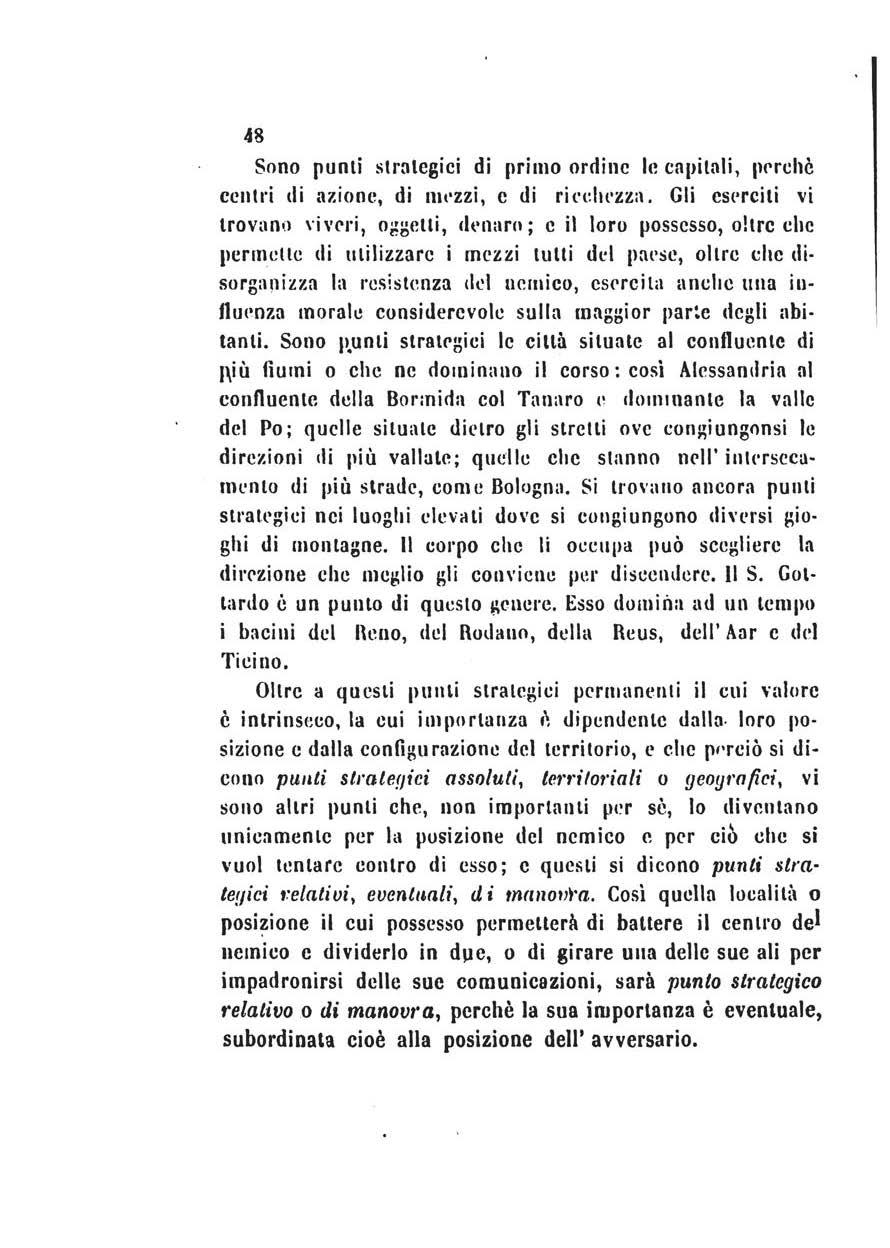
.t9
Non tutti l amo ti strategici sono eguale importanza. L'occupazione di alcuni è di effetto secQndario, d' allri è capitale, c questi dicoosi decisivi. l punti decisivi che sono lo scopo particolare delle opcr31.ioni chiamansi obbietli tJi.
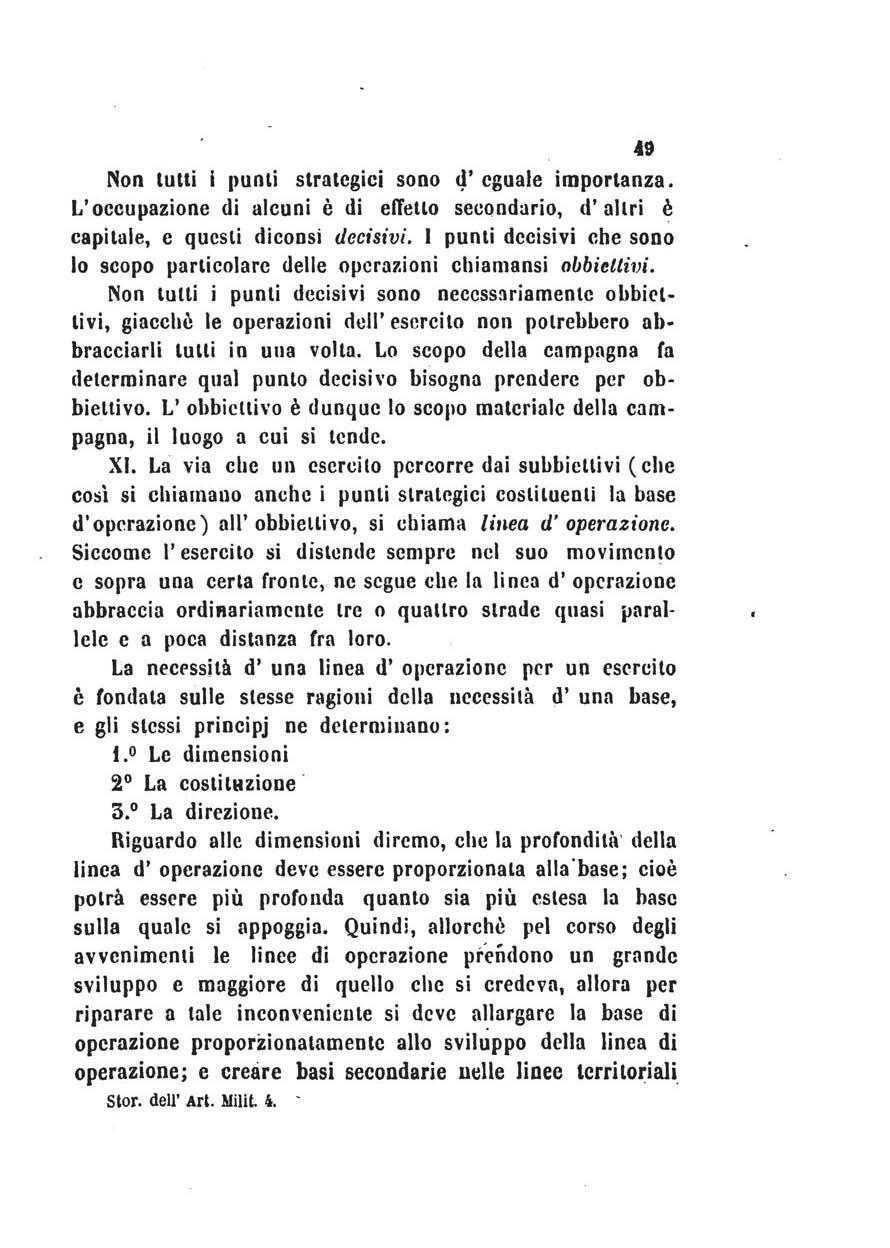
Non tutti i punti decisivi sono necessariamente obbictLivi, giacchè le operazioni dell'esercito non potrebbero abbracciarli tutti in una volto. Lo scopo della campagna fa determinare qual punto decisivo bisogna prendere per obbiettivo. L' obbictti\' Oè dunque lo scopo materiale della campagna, il luogo a cui si tende.
Xl. La via che un esercito percorre dai subbicuivi (che così si chiamano anche i punti strategici costituenti la base d'operazione) all'obbiettivo, si chiama linea d'operazione. Siccome l'esercito si distende sempre nel suo movimento c sopra una certa fronte, ne segue che In li oca d' operazione abbraccia ordittariamente tre o quattro strade quasi parallele c a poca distanza fra loro.
La necessità d' una linea d' OflCrazionc per un esercito è fondata sulle stesse ragioni della necessità una base, e gli stessi priocipj ne determinano;
1.0 Le dimensioni 2° La COSLÌLHZiooe . La direzione .
Riguardo alle dimensioni diremo, che la profondità· della linea d'operazione deve essere proporzionata alla'base; cioè potrà essere più profonda quanto sia più estesa la hase sulla quale si appoggia. Quindi, allorchè pel corso degli avvenimenti le lince di operazione prendono un grande sviluppo c maggiore di quello che si credevn, allora per riparare a tale inconveniente si deve allargare la base di operazione proporzionatamente allo svilÙppo della linea di operazione; e creàre basi secondarie uelle linee
Stor. dell' Art . Milìt. i. ·
50 che s' incontrano mau mano che si avanza nell' offensiva.
Riguardo alla costituzione della linea di operazione di· remo che essa può essere semplice o doppia.
È semplice quando l' esercito percorre una linea la quale abbraccia un fascio di strade più o meno · parallele, la cui distonza fra loro è tale che i corpi i quali le percorrono possono prestars i un mutuo appoggio ed essere efficacemente sotto lo stesso comando.
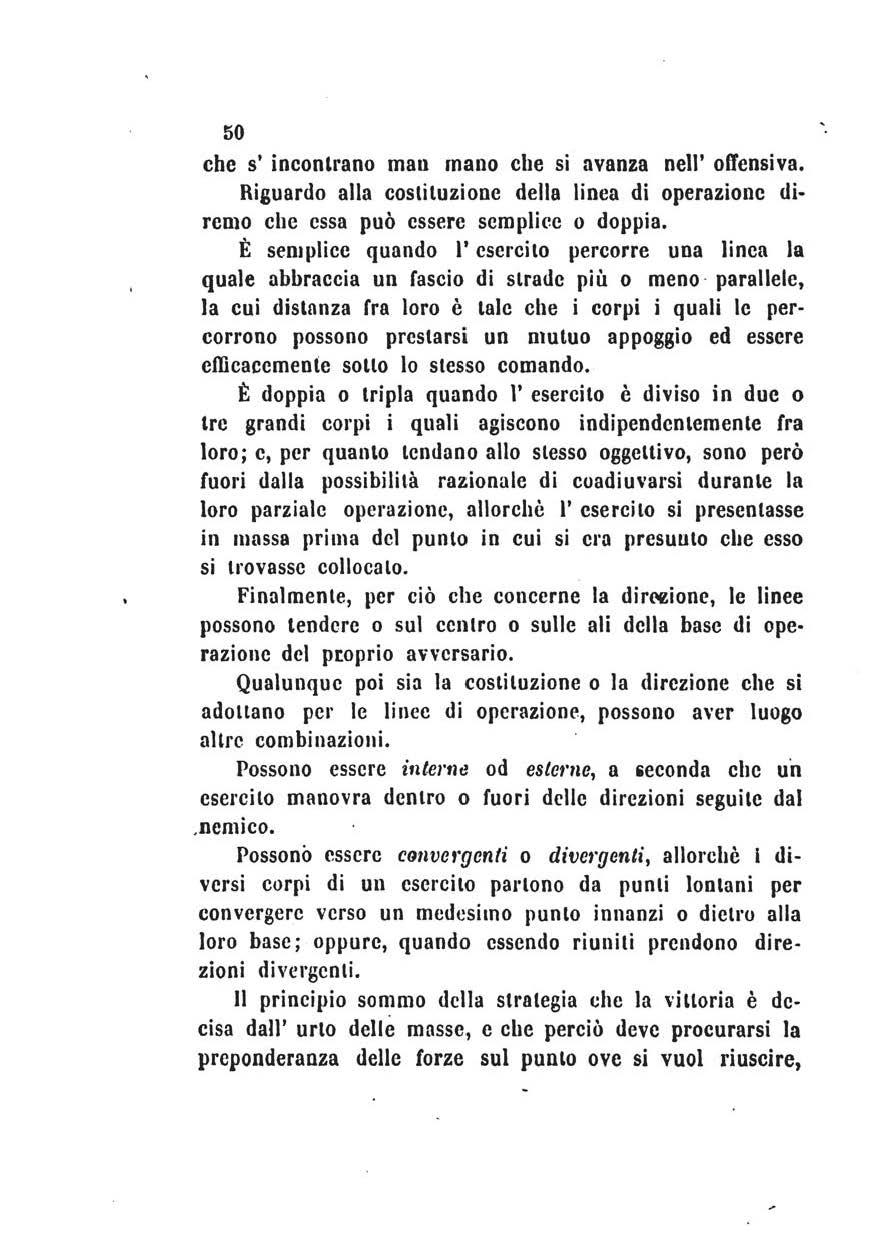
È doppia o tripla quando l' esercito è div iso in due o tre grandi corpi i quali agiscono indipendentemente fra loro; c, per quanto ten!lano allo stesso oggettivo, sono però fuori dalla possibilità razionale di coadiuvarsi durante la loro parziale ope1·azionc, allorchè l' esercito si presentasse in massa prima del punto in cui si era presuuto che esso si trovasse colloca lo .
Finalmente, per ciò che concerne la le linee possono tendere o sul centro o sulle ali della base di ope· razione del proprio avversario.
Qualunque poi sia la costituzione o la direzione che si adottano per le linee di operazione, possono aver luogo altre combinazioni.
Possono essere inten1e od eslet"ne, a che un esercito manovra dentro o fuori delle direzioni seguite dal .nemico.
Possono essere convergenti o divergenti, allorcbè i diversi corpi di un esercito par tono da punti lontani per convergere verso un medesimo punto innanzi o dietro alla loro base; oppure, quando essendo riuniti prendono direzioni divergenti.
Il pr incipio sommo della strategia che la viuoria è dceisa dall' urto dellè masse., c che perciò deve procurarsi la preponderanza delle forze sul punto ovc si vuoi riuscire,
applicalo alle lince d' operazione, dà la preferenza alla linea unica in confronto delle doppie , alle interne sulle esterne, alle convergenti sulle divergenti; pcrchè quelle offrono maggiore facilità alla concentrazione delle forze.
La linea di operazioni deve riunire certe condizioni; c, principali fra queste, la facilità e comodità delle vie, la sicurezza e la ricchezza; vale a dire che il paese t•·aver· salo offra tutti quc' mezzi che sono ncccssarj alla sussistenza delle truppe.
È inutile dire cho deve essere legata alla base d' operazione.
La linea di operazioni è sempre il punto debole di unn posizione; deve dunque essere coperta c assicurata; c perciò possibilmente perpendicolare alla fronte di opcrazio.ni.
La scelto delle Jincc di è uno degli oggetti più importanti della stra tegia, dipendendone essenzialmente l' rsito della guerra. A questo proposito Jomini dice: «Se l' orte d<'lln guerra consiste a mcllerc· in aziont! le maggiori forze possibili sul punto decisivo, la sct'lta della lincu di operazione, esse ndo il primo mrzzo per :u·ri\·arvi, può essere considrratn come la base d' un buon piano di campagna. Spesso un generale, costretto da circostanze imprc' ' iste c dagli avvenimenti n modificare il piano Jlrimiti\'o di campagna, cambia linea d' operazioni. •
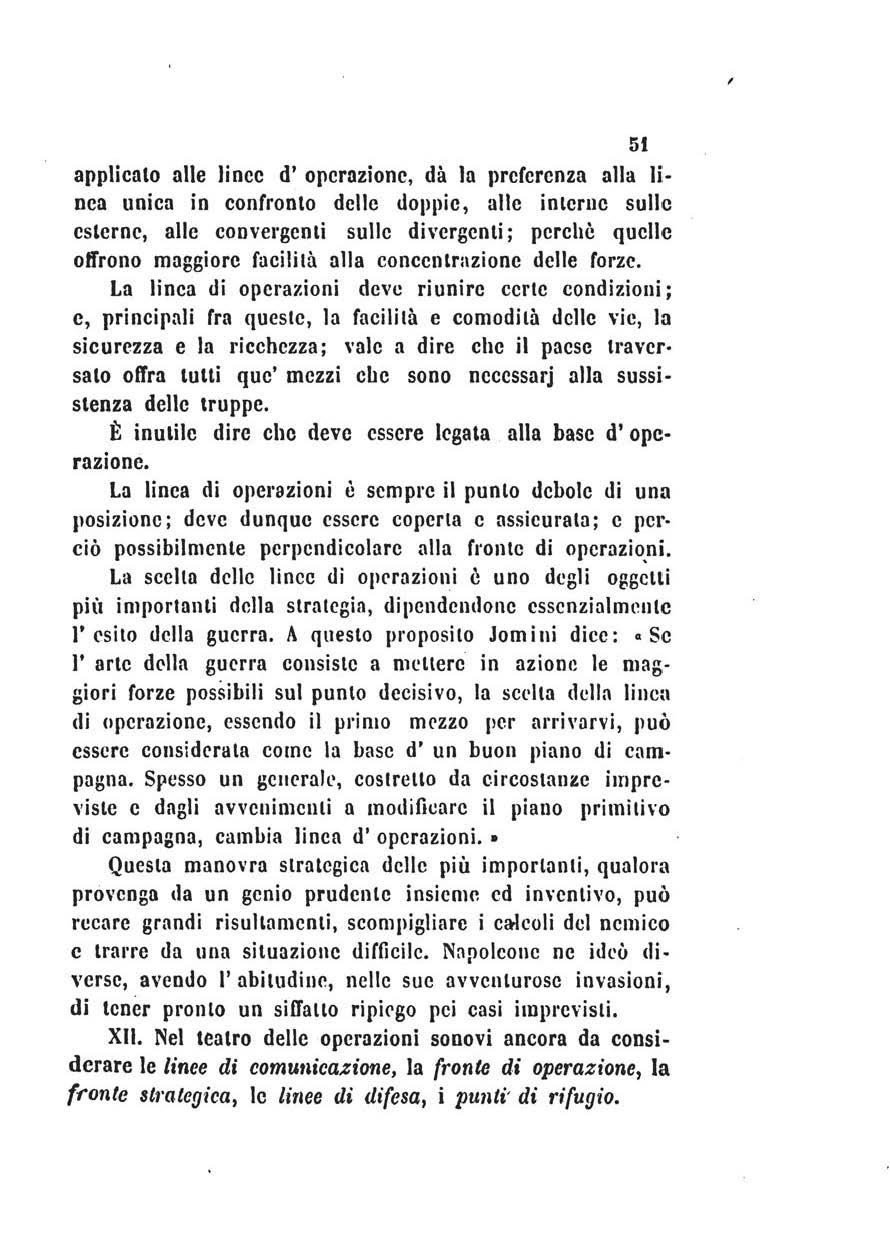
Questa manovro strategica delle più importanti, qualora pro,•cngn da un genio prudente insieme cd in\'Cnti\'o, può recare grandi risultamcnti, scompigliare i ca.Jcoli del nemico c lral'fe da unn situazione diCfìcilc. ne ideò diverse, avendo l'abitudine, nelle sue avventurose in vasion i, di tener pronto un sifTaLto ripirgo pci casi imp•·c...-isli.
Xli. Nel teatro delle operazioni sonovi ancora da considerare le linee di comuuica.zione, la fronte di operazione, la f-ronte strategica, le linee di difesa, i punti' di rifugio.
Linee di comunicazioni sono quelle strade particolari che legano fra loro i differenti corpi dell' esercito, i quali percorrono le principali linee di operazioni.
Si dice Fronte di tlperazione )a li nea che passa tangente alla testa dell e colonne jn marcia di un esercito e rappre· senta lo spazio sul quale può urtarsi coll' armata nemica. Regola fondamentale intorno all' estensione · della fronte di operazione di un' armata si è che deve essf're proporzionata alla fronte di spiegamento dell' esercito stesso. Ordinariamente la sua direzione è perpendicolare alla linea di operazioni. Però può avvenire che per evitare un movi· mento d' attorniamento del nem ico un esercito cambii fronte d' operazioni. Tali cambiamenLi di fronte sono manovre strategiche importantissime, giacchè, formando una perpendicolare colla propria base, si riesce come se si avesse una base d' opcrazioni è facile, eseguendo un tal movimento, RVVl'ntnrare la propria linea di operazione.
Non bisogna confondere le fronti di operazione colle fronti strategiche.
Allorchè un esercito è disposto sulla zona che esso vuol abbracciare, sia per assalire, sia per difrndl·rsi, occupa or dinariamente posizioni
L' estensione della fronte che queste posizioni abbracciano, è che è volta dal lato de l nemico, si chiama la (t'onte strategica: mrnlre, come dicrmmo, la fronle d' operazione e quella parte di terreno per la quale il nemico potrà presumibilmcntc giungere in una o due marcie sulla nostra fronte strategica.
In altre parole, il nome di Fronte st..ategica conviene meglio a designare quella delle posizioni reali occupate dall' esercito; mentre che il nome di Fronte operazioni ,designa meglio quello spazio che separa i due eserciti,
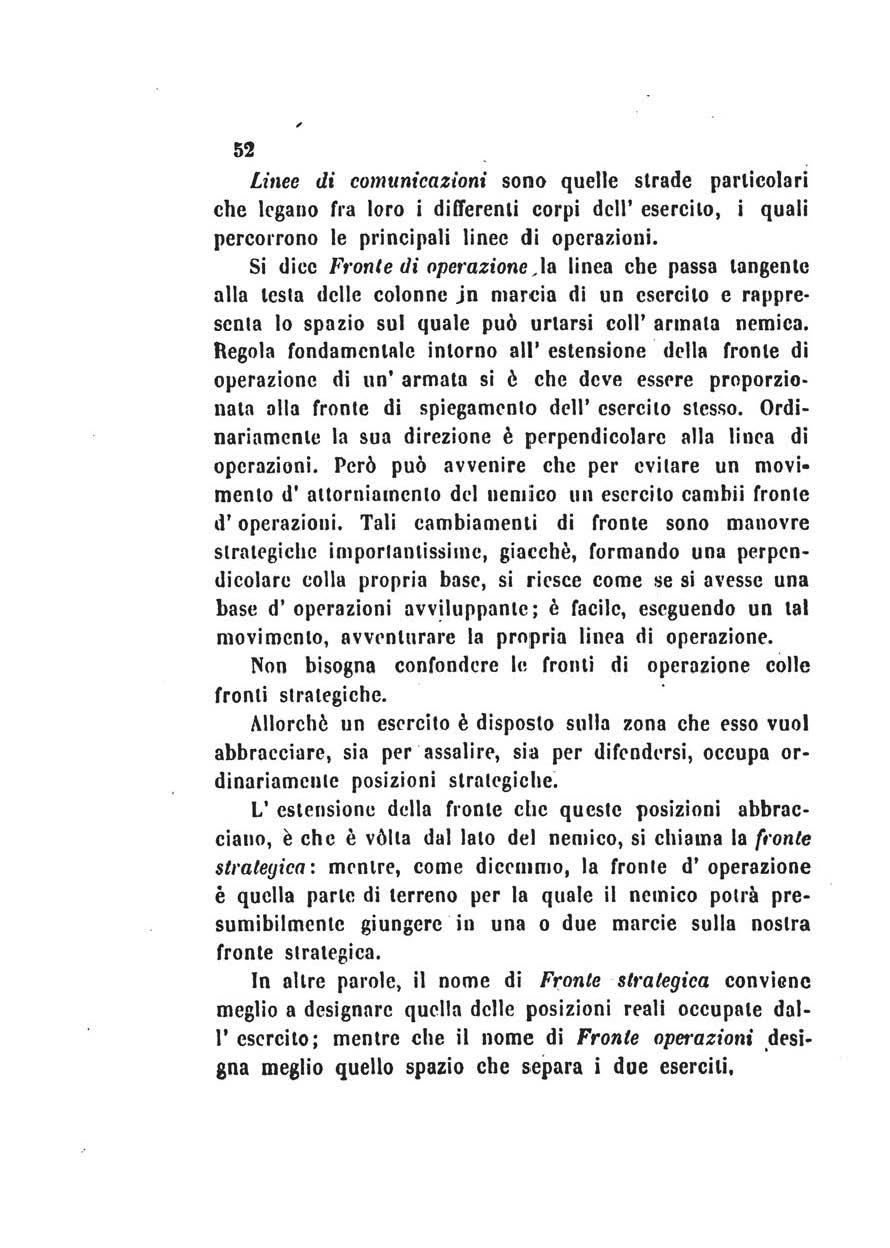
Le linee di difesa sono di diverse specie: ve ne sono di strategiche, e ve ne s,ono di permanenti e di eventuali. Le sono destinate al sistema di difesa dello stato, come le linee di frontiere fortificate, ed n cagione di esempio la catena delle Alpi Ira il · Piemonte c la Francia. Le eventuali si rif!!riscono sollanto alla posizione passeggera in cui si trova un esercito.
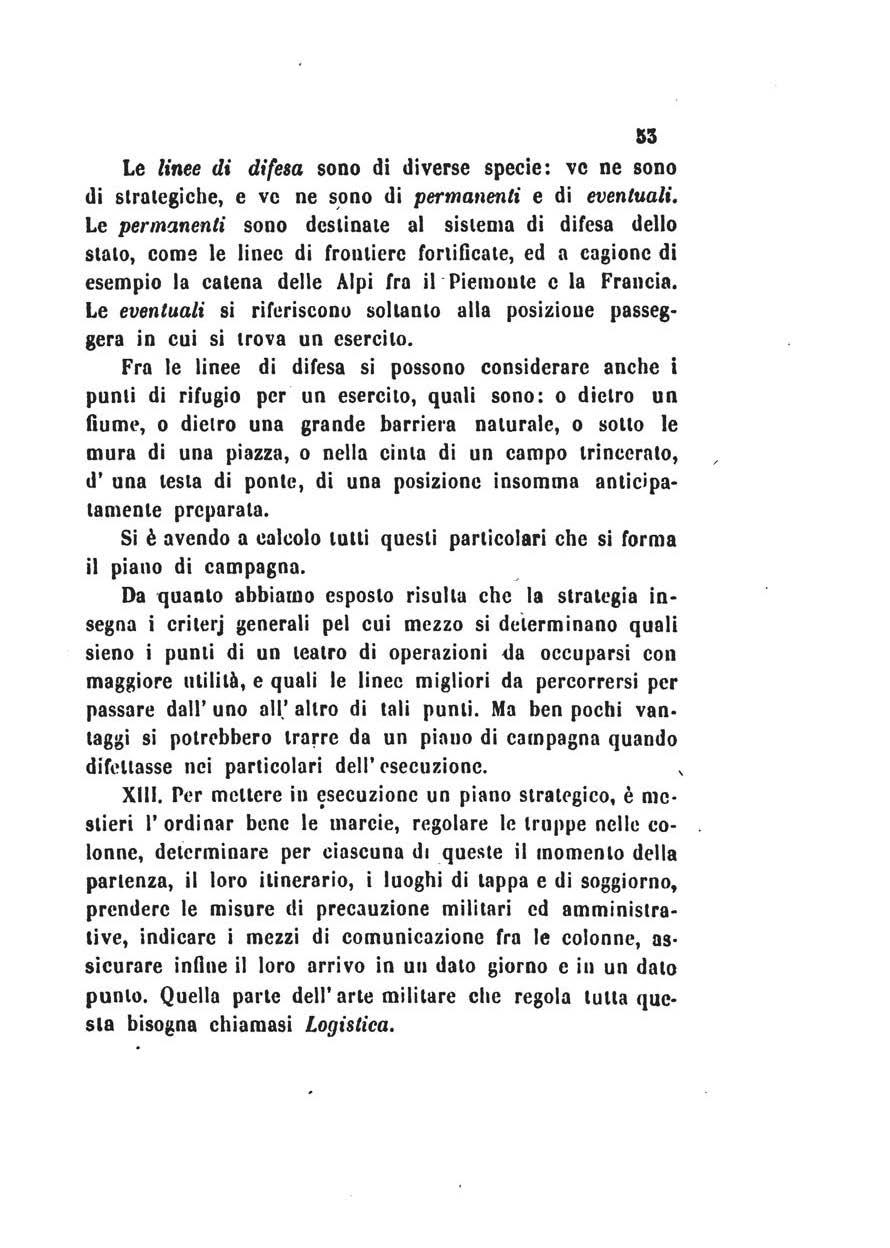
Fra le linee di difesa si possono considerare anche i punti di rifugio per un esercito, qunli sono: o dietro un fiume.>, o dietro una grande barriet·a naturale, o solto le mura di una piazza, o nella cinto di un campo trincerato, d' una testa di ponte, di una posizione insomma anticipa· tamente preparata.
Si è avendo a calcolo tuui questi particolari che si forma il piano di campagna. J
Da -quaato abbiamo esposto risulta che la strategia in· segna i criterj generali pel cui mezzo si dcierminano quali sieno i punti di un teatro di operazioni tla occuparsi con maggiore utilità, e quali le linee migliori da percorrersi per passare dall'uno ali.' altro di tali punti. Ma ben pochi van. taggi si potr<'bbero trarre da un piano di campagna quando difdtasse nei particolari dell' <'Secuzione.
Xlii. Per meucre in çsecuzionc un piano stratc>gico, è mestieri l' ordinar bene le marcie, regolare le truppe ncll!! co lonne, determinare per ciascuno d1 queste il momento della partenza, il loro itinerario, i luoghi di tappa e di soggiorno, prendere le misure di precauzione militari cd amministrative, indicare i mezzi di comunicazione fra le colonne, ns· sicurare infine il loro arrivo in un dato giorno c in un doto punto. Quello pat·te dell'arte militare che regola tutta C(UC· sta chiamasi Logistica.
XIV. Decisa la guerra, la prima cosa da determinarsi si è di sapere se essa essere offensiva o difensiva. E, innan zi tullo, convicn definir bene che cosa s' intenda con queste parole. ( f )
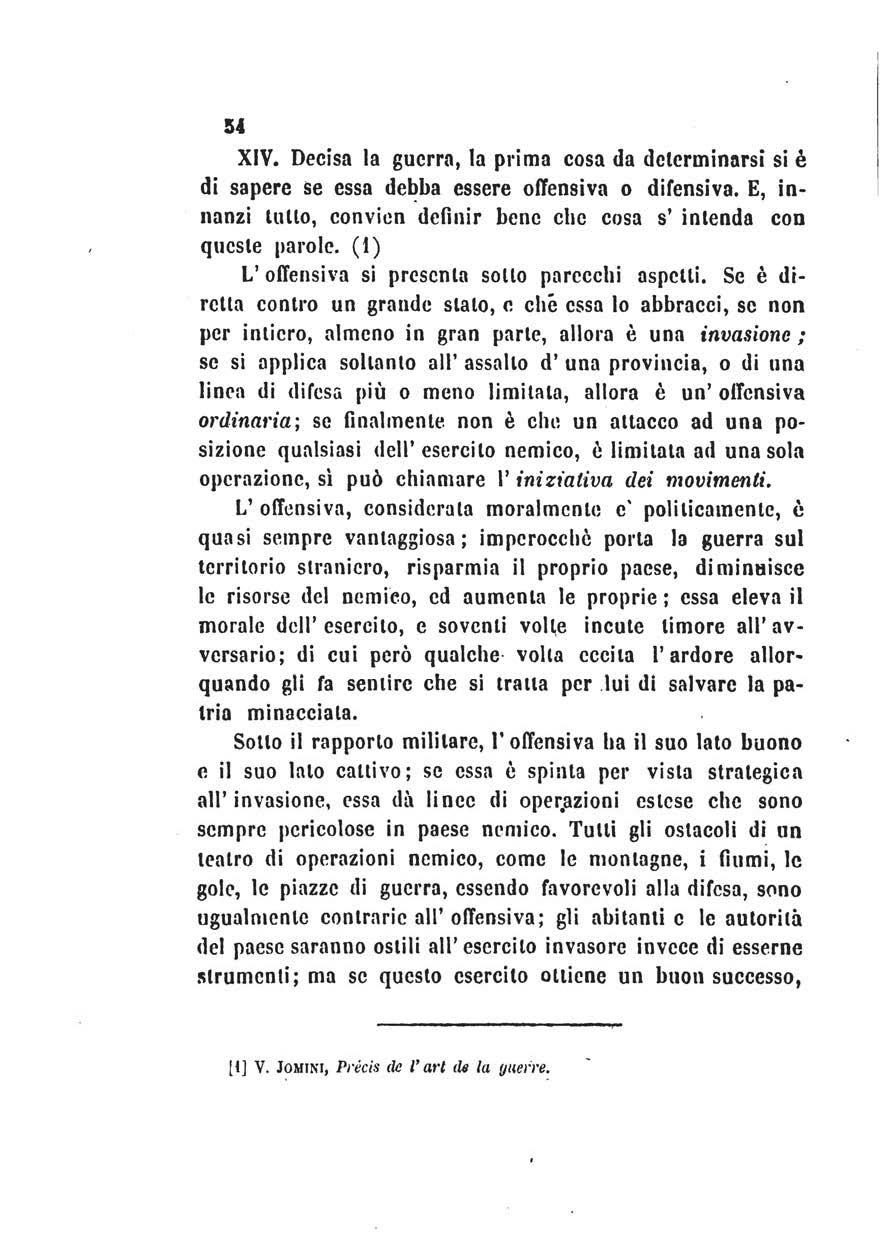
L'offensiva si presenta solto parecchi aspclli . Se è diretta contro un grande stato, c ché essa lo abbracci, se non per intiero , almeno in gran parte, allora è unn invasione; se si applica sollanto all'assalto d'una provincia, o di una lim•a di difcsli ()ÌÙ o meno limitata, allora è un' offensiva ordinat'ia; se fin almente non è che un attacco ad una posizione qualsiasi dell 'ese rcito nemico , è limilata ad una sola operazione, sì può chiamare l'iniziativa dei movimenti.
L' oiTI:!nsiva, considerala moralmente c' politicamente, è qua si sempre vantaggiosa; imperocchè po1·ta la guerra sul territorio straniero, risparmia il proprio pae se, di minttiscc le risorse del ocmi"eo, cd aumenta le proprie ; essa eleva il morale dell ' esercito, c sovcnti incute timore all' avversario; di cui però qualche · volla eccita l'ardore allorquando gli fa sentire che si trana per .lui di salvare la patrio minacciata.
Sotto il rapporto militare, l'offensiva ha il suo lato buono c il suo lato cattivo; se essa è spinta per vista strategica all'invasione, rssa dà li n ce di oper.azioni estese che sono sempre per icolose in paese nemico. Tutti gli ostacoli di. llD teatro di operazioni nemico, come le montagne, i fiumi, le golr, le piazze di guerra, essendo favorevoli alla ctifcsa, s0no ugualmente contrarie all'offensiva; gli abitanti c le autorità clel paese sara nno ostili all'esercito invasore invece di esserne ma se questo esercito ouicne un buon successo, [ l ] V. J ? MJJSJ, Précis c/c l' at'l le' (IIW ' re:
esso colpisce la potenza nemica fino al cuore, la priva de' suoi mezzi di guerra, e può condurre ad un pronto scioglimento deJla lolla.
Applicata ad una semplice operazione passeggera, vale a dire considerato. come iniziativa dei movimenti, l' offensiva è quasi sempre vantaggiosa, nella strategia. Infalli, se l' arte della guerra consiste a portare le proprie forze nel punto decisivo, si compren·de come il primo mezzo di applicare questo principio sarà di prendet·c l'iniziativa dci movimenti. Quegli che ba preso questa iniziativa, sa anticipatamente ciò che fa e ciò che vuole, ed arriva colle sue masse nel punto in cui gli convien colpire. Quegli che attende, _è · prevenuto dapertullo; il nemico si getta su frazioni del suo esercito; egli non sa dove l'avversario voglia portare gli sforzi, nè conosce i mezzi che gli deve opporre.
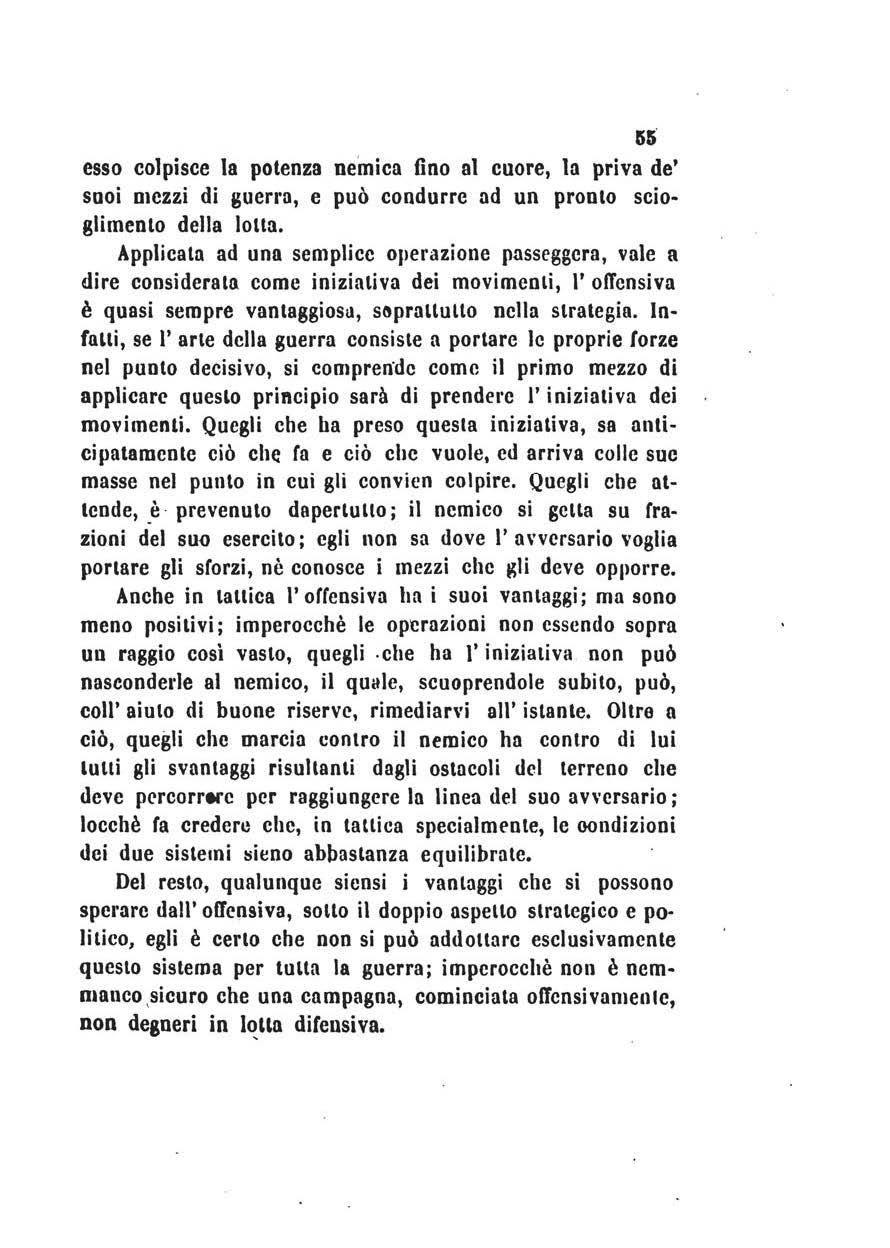
Anche in tauica l'offensiva ha i suoi vantaggi; ma sono meno positivi; imperocchè le operazioni non essendo sopra un raggio così vasto, quegli -che ha 1' iniziativa non può naseonderle al nemico, il quale, scuoprendole subito, può, coll'aiuto di buone riserve, rimediarvi all' istante. Oltre n ciò, quegli che marcia contro il nemico ha contro di lui Lutti gli svantaggi risultanti dagli ostacoli del terreno che deve percorrere per raggiungere In lin ea del suo anersario; locchè fa che, in tattica specialmente, le oondizioni dei due sistemi sicno abbastanza equilibrate.
Del resto , qualunque sicnsi i vantaggi che si possono sperare dall'offensiva, sotto il doppio aspetto strategico e po· litico, egli è certo che non si può nddottarc esclus ivam ente questo sistema per tulln la guerra; impcrocchè non è neromanco ,sicuro che una campagna, cominciata otTcnsivamenlc, non degneri in difensiva.
La guerra difensiva, come abbiamo dello, hn pure t suoi vantaggi quando è saggiamente combinata. Essa è di due specie: la difesa inerte o passiva, e la difesa attiva con ritorni offensivi. La prima è sempre perniciosa; la seconda può procurare grandi Lo scopo di una guerra difensiva essendo quella di cuoprire pel maggior tempo possibile la parte del territorio minaccia.la dal nemico, ·è evi· dente che lulle le operazioni debbono avere per iscopo di rita1·dare i suoi progressi, di contrariare le sue imprese mol· tiplicando le difficohà della sua marcia, senza pertanto impegnare seriamente il pro p rio esercito..Colui che si decide all' invasione lo fa sempre in conseguenza di un ascendente qualsiasi; e deve cercare fino da quel momento uoo scioglimento il più prooto possibile. Il difensore, al contrario, deve allontanare codesto scioglimento fino a che il suo avversario sia indebolito in causa di distaccamenti lasciati o mandati p.er necessità in diversi punti, in causa delle marcie, delle fatiche, delle privazioni, . ecc. e.cc.
Un esercito non si riduce ad una difen siva se non che in seguito di rovesci o di una inferiorità troppo sensibile; in questiJ caso, esso cerca coll' appoggio delle piazze, e col favore delle barriere naturali od artificiali, i di ri s tabilire l' equilibrio delle probabiJità, mohiplicondo gli. ostacoli che esso può opporre al nf'mico.
Questo sistema , allorchè non è troppo spinto, presenta pure condizioni favore\·oli, ma solo nel caso in cui il generale che si crede obbligato a ricorrervi, avrà il buon senso di non ridursi ad una difensiva inerte, vale a dire di aspt!llare senza muoversi, nei posti fissi, tutti i colpi che il nemico vuoi portargli; bisognerà anzi cb' egli si applichi a raddoppiare l' attività delle sue operazioni, ed a cogliere tutte le occasioni che si presenteranno per precipitarsi sui punti deboli del nemico prendendo l'iniziativa dei movimenti.
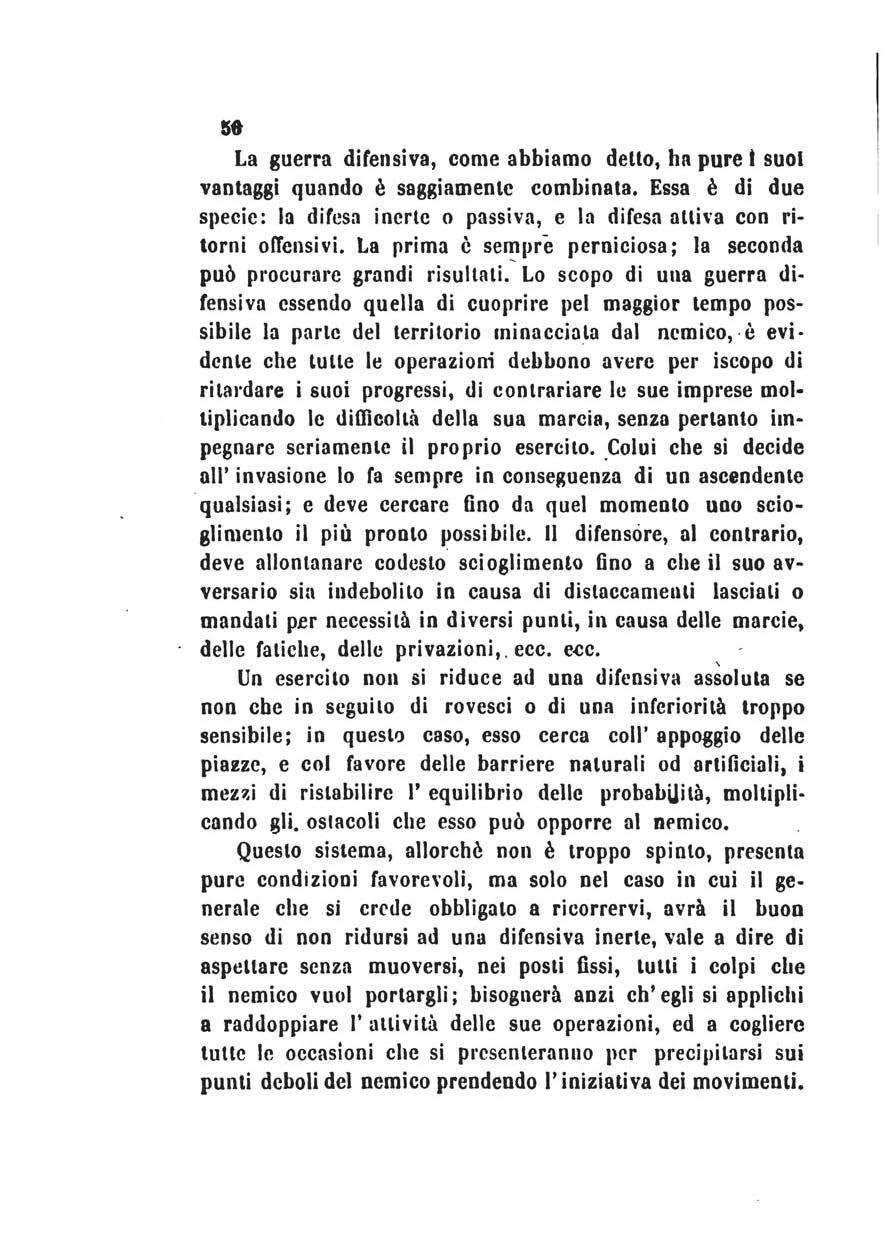
Questo genere di guerra, che Jomini chiama Ja Difensivaoffensiva, e che altri dicono Difesa attiva, può essere _ va n· taggiosa tanto in istratf'gia quanto in tallica. Operando in tal guisa , si pig lia i . vant:1ggi dei due sistemi, imperocclre si hanno quc11i dell' iniziativa, e si è più padroni di co· glierc l' istante io cui con,·icnc eo l pi rf', allorquando si nspella l'avversario in n)ezzo ad un terreno preparato prima od centro delle risorse e degli appoggi del suo proprio paese.
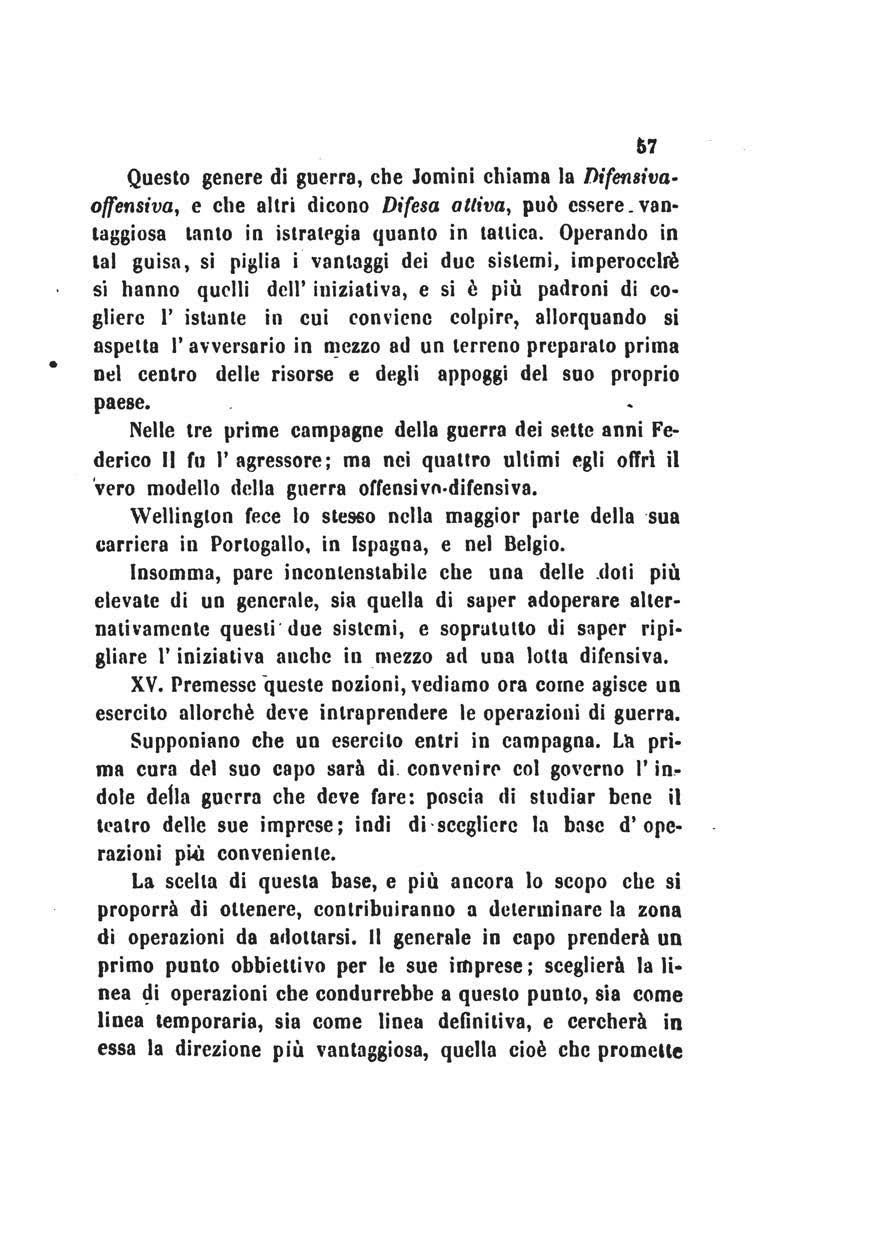
Nelle tre prime campagne della guerra dei sette ann i Federico Il fn l' agressore; ma nei quattro ultimi egli offrì il 'vt>ro modello della gnerra offensivo-difensiva .
Wellington fece lo stesso nella maggior parte della ·sua carriera in Portogallo, in lspngoa, e nel Belgio.
Insomma, pare ineontenstabile che una delle .doti più elevate di un generale, sia quella di saper adoperare alter· nativa mente questi · due sistemi, e soprututlo di saper ripi· glinre l' iniziativa anche in mezzo ad una Joua dift.>nsiva .
XV. Premesse queste nozioni, \'ediamo ora come agisce un esercito allorchè de\"e intraprendere le operazioni di guerra. Supponiano che un esercito entri in campagna. L'Il pri· ma cura dt>l suo capo sarà di. convt>ni r(' col go,•crno l' in,. dole defla gurrra che deve fare: poscia di studiar bene il tl•atro delle sue imprese; indi di ·scegliere Ja base d' ope· razioni pi.ù conveniente.
La scelta di questa base, e più ancora lo scopo che si proporrà di ottenere, contribuiranno a determinare la zona di operazioni da a•louarsi . Il generale in cnpo prenderà un primo punto obbiettivo per le sue imprese; sceglierà la li· nea operazioni che condurrebbe a qur.sto punto, sia come linea lemporaria, sia come linea definitiva, e cercherà in essa la direzione più vantaggiosa, quella cioè che promcate
maggior probabilità di buona riuscita senza esporre a gravi pericoli.
L'esercito, marciando su questa linea di operazioni avrà una fronte di operazioni c una fronte strategica; dietro a questa fronte, sarà bene che abbia una linea di difesa per servil'c d'appoggio in una circostanza. Le posizioni passeggere che i suoi corpi d' armata prenderanno sulla fronte di operazioni o sulla linea di difesa, saranno posizioni strategiche.
XVI. Ma ponendosi in movimento per entrare in campagnll, esso penetra in paese sospetto, e marcia circondato da nemici di cui non conosce la po sizione.
Allora si ndollano precauzioni particolari, e si applicano i principj seguiti per l' esecuzione delle marcie straltgiche (t).
Diconsi marcio slrategiclle quelle che hanno luogo sul teatro di operazioni. Set·vono ad eseguire le combinazioni strategiche, le manovre giranti, i movimenti retrogradi ec. Si dividono in:
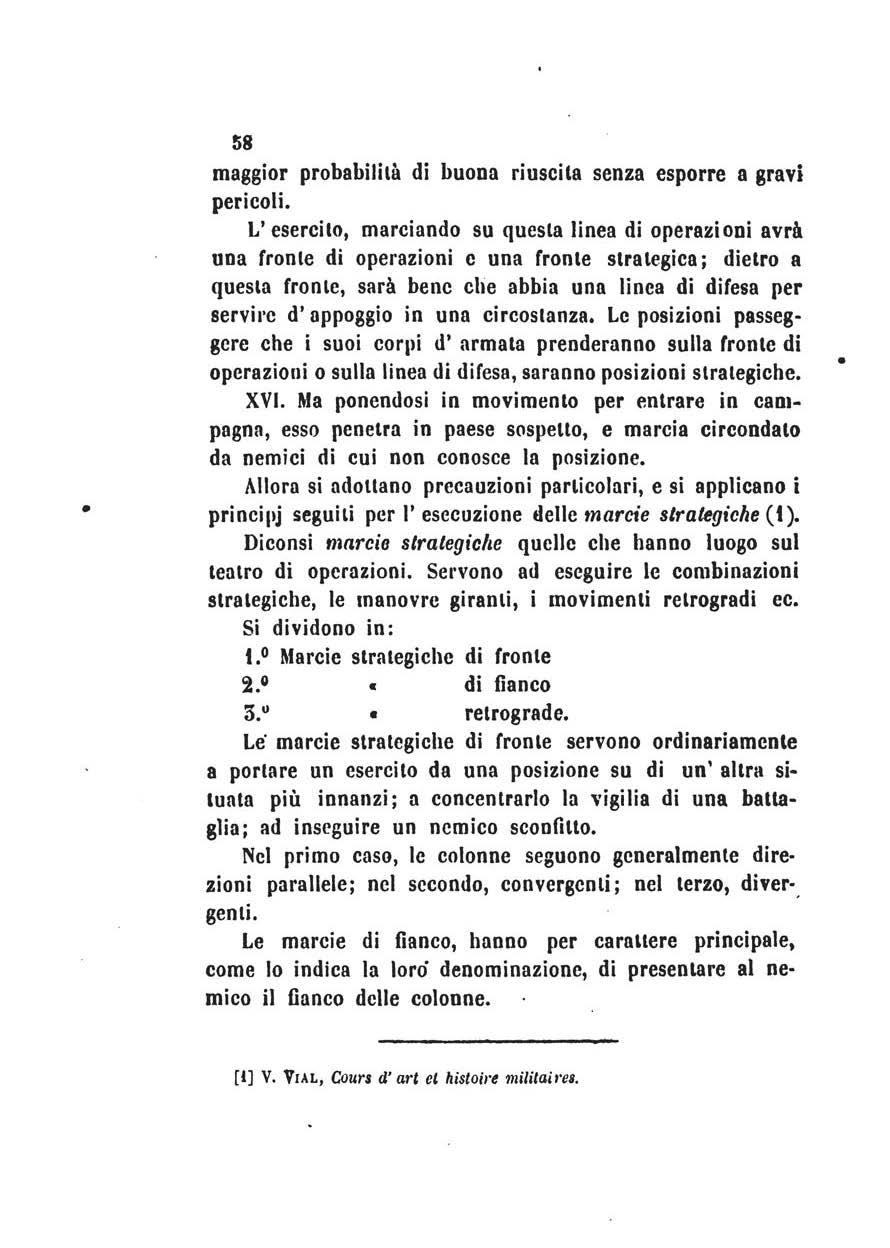
t.0 Marcie strategiche di fronte 2.o • di fianco 5." • retrograde.
Le· marcie strategiche di fronte servono ordinariamente a portare un esercito da una posizione su di un ' altra sitonta più innanzi; a concentrarlo la vigilia di una battaglia; ad inseguire un nemico sconfitto.
Nel primo caso, le colo nn e seguono generalmente dire· zio n i parallele; nel secondo, convergenti; nel terzo, diver·. genti.
Le marcie di fianco, hanno per carauere principale, come lo indica la loro denominazione, di presentare al ne· mico il fianco delle colonne.
[t) V VIAL, Cour1 à' art et histoire militai1·e•.
l loro inconvenienti sono:
t. 0 Di scuoprire le linee di ritirata dell' esercito;
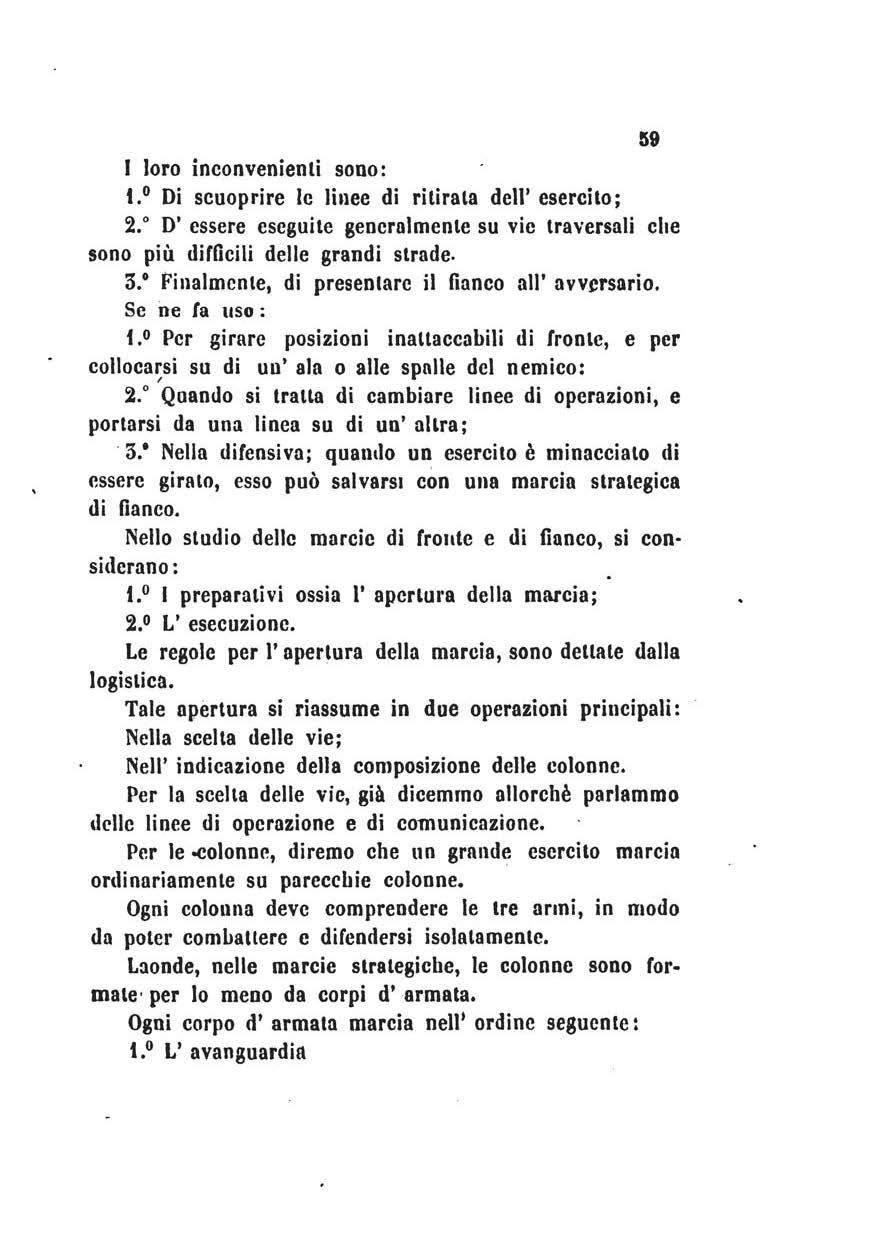
2. 0 D' essere eseguite generolmente su vie traversoli che sono più dirtìcili delle grandi strade.
5.' Finalmente, di presentare il fianco all' avversario. Se ne fa uso:
i . 0 Per girare posizioni inattaccabili di fronte , e per su di uu' aln o alle spalle del nemico:
2. 0 Quando si tratta di cambiare linee di operazioni, e portarsi da una linea su di un' allra;
· 5.' Nella difensiva; quando un esercito è minacciato di essere girato, esso può salvarsi còn una marcia strategica di fianco.
Nello studio delle marcic di froute e di fianco, si con· si<lerano:
t. 0 l preparativi ossia l' apertura della marcia; 2.o L' esecuzione.
Le regole per l'apertura della marcia, sono dettate dalla logistica.
Tale apertura si riassume in due operazioni principali: Nella scelta delle vie; Nell' indicazione della composizione deJie colonne. Per la scelta delle vie, già dicemmo allorchè parlammo delle linee di operazione e di comunicazione.
Per le -colonne, diremo che no grande esercito marcio ordinariamente su parecci..Jie colonne.
Ogni colonna deve comprendere le tre armi, in modo do poter combattere c difendersi isolatamente.
Laonde, nelle marcie strategiche, le colonne sono (or· mate · per Jo meno da corpi d' armata.
Ogni corpo d' armato marcia nell' ordine seguente: t . 0 L' avanguardiA
2. 0 Il corpo di battaglia
3 . 0 La retroguardia
4. 0 l fiancheggiatori.
A sollecitare immensamente i movimenti delle truppt>, concorrono oggidì in grandi proporzioni le strade ferrate .
XVII. Allorquando l' escrciio arriverà presso. al suo primo obbietlivo , ed il nemico comincierà ad opporsi alle sue imprese, esso lo assalirà o manovrerà per costringerlo alla ritirata. A tal uopo adotterà una o due linee strategiche di manovre, quali, essendo tempor arie, potranno deviare, fino ad un certo punto, dalla linea gt> nerale delle operazioni colla quale no n bisogna confonderle (t).
Per legare la fronte strategica alla . base, si formerà , a misura che si procede iooanzi, la linea di tappe, le lioee di appr.ovigionamenlo , e quelle di depositi.
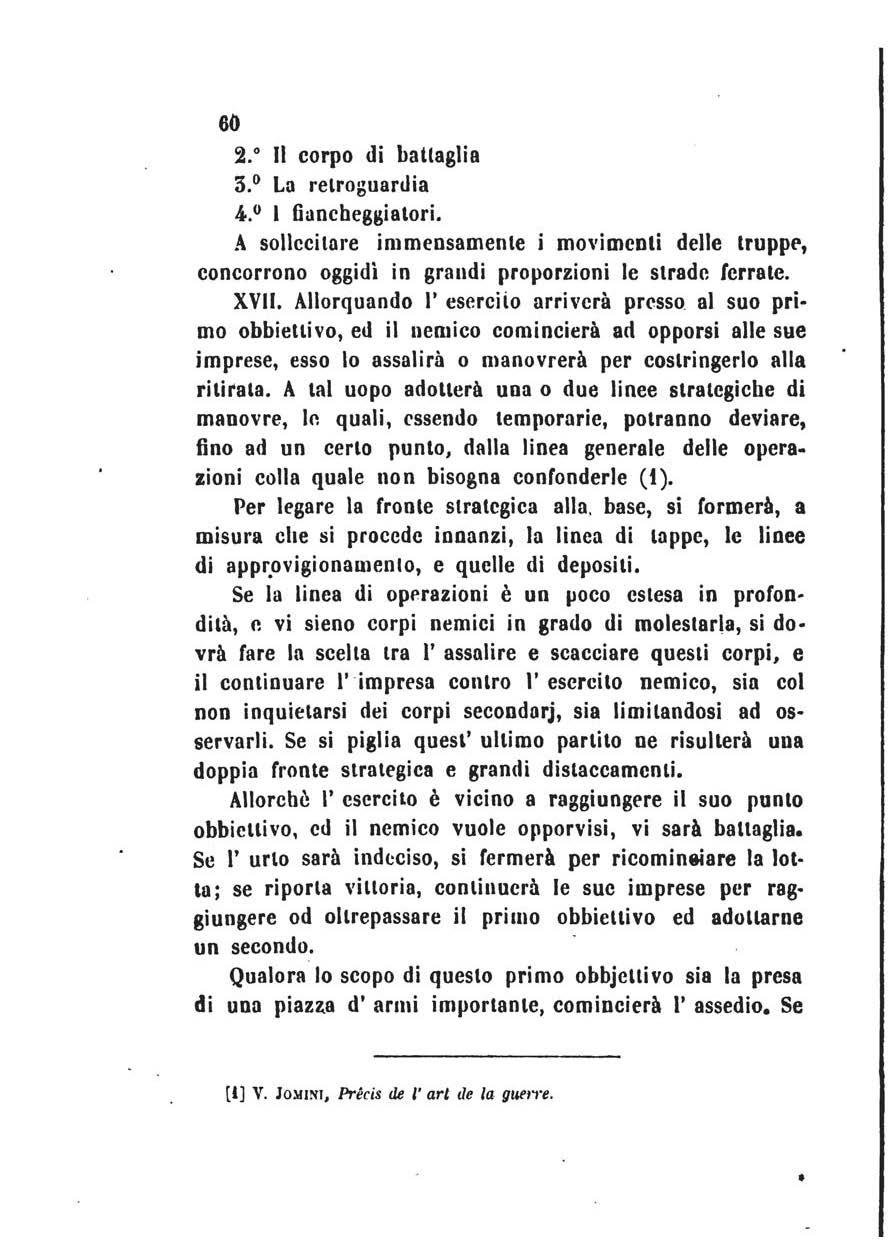
Se la linea di opr.razioni è un poco estesa in profondità, c vi sieno corpi nemici in grado di molestarla, si dovrà fare In scelta tra l' assalire e scacciare questi corpi, e il continuare l' ·impresa contro l' esercito nemico, sia col non inquietarsi dei corpi secondorj, sia limitandosi ad osservarli. Se si piglia quest' ultimo partito ne risulterà una doppia fronte strategica e grandi distaccamenti.
Allorcbè l'esercito è vicino a raggiungere il suo punto obbiettivo, cd il nemico vuole opporvisi, vi sarà battaglia. Se l' urto sarà indéciso, si fermerà per ricomineiare la lotto; se riporta vittoria, continuerà le sue imprese per raggiungere od oltrepassare il primo obbiettivo ed adottarne un secondo.
Qualora lo scopo di questo primo obbjettivo sia la presa di una piaz1.a d' armi importante, comincierà l' assedio. Se ( l) V ] OYINI, Précis de l' art ùe l a
l' esercito uon è abbastanza numel'oso per continuare la sua marcia lasciando un corpo d' assedio dietro a sè, sceglierà là vicino una posizione strategica per mantenere l' asst'dio medesimo. Se al contrario l' t'Sercito ha forze surtìcienti per trarre maggior frullo della sua vittorio, op· pure se non vi è alcun assedio da farsi, l' esercito mede· simo marcia innanzi per raggiungere un secondo obbjenivo ancor più importante del primo. Se qul'Slo punto si trova ad una certa distanza, sarà urgente procurarsi un punto d' appoggio intermedio; si formei'Ù quindi una base e\'en· tuole col mezzo di una o due città al sicuro da ogni offesa che si saranno certamente occupate; in caso contra· rio, si formerà una piccola riserva strategica che cuoprirà Je spalle e proteggerà i g•·a ndi depositi con opere passcg . gere. Se l' esercito passerà fiumi considerevoli, vi si co· slruiranno sollecitamente teste di ponte; e se i ponti ·si trovano in città chiusé da mura, s'innalzeranno alcuni trincicramenti per aumentare la difesa di' qul'sti posti e per raddoppiare così la solidità della base eventuale o della riserva strategica che vi si porrebbe.
Se al contrario la battaglia è andata perduta, avrà luogo la ritirata, affine di approssimarsi alla base c ricavarvi nuove forze, sia pei che si raccoglierebbero, sin per Je piazze e pei campi trincicrati che arrcstcreb bcro il nemico c l' fJbblighercbbcro a d·ividcrc le sue forze.
Tale è l'andamento gènerale ed ordinario di uoa guerra•
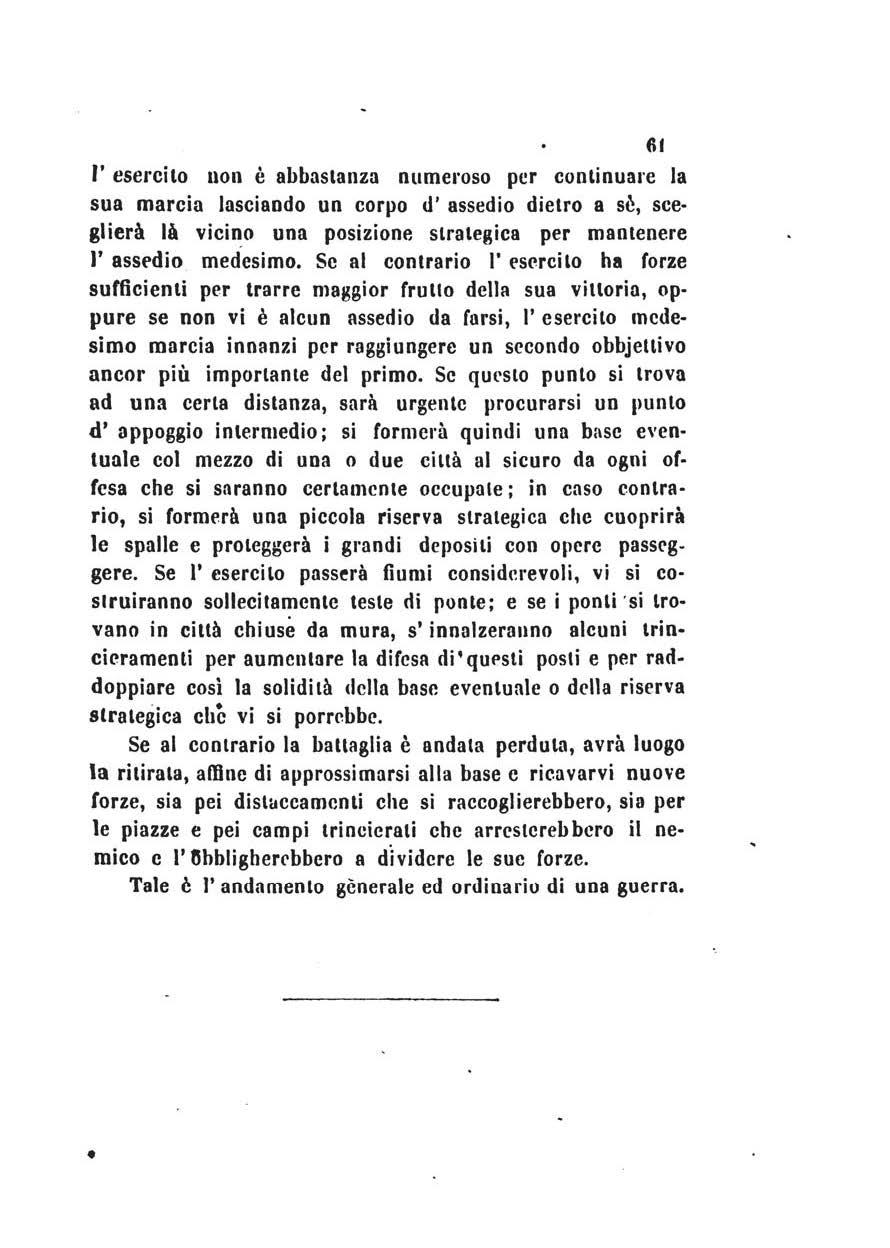
I. La gran tattica 11. Le posizioni militari 111. l'osizioni olfcnsivc, difensive c olfensivo-difcnsi, c -IV. I posti V. Parti principali di una posizione- VI . Punti dcholi c punti forti VII. Ca. rallcri di una posizione ' ' antaggiosi c svantaggiosi VIli. Marcio tattiche IX. Mnrcie lallichc di fronte X. Marcio lattiche di fianco- Xl. Ordini di battaglia X II. Ordine offensivo Xlll. Ordino difensivo - XIV. Dcsctiz.ione di una Laltoglia. •
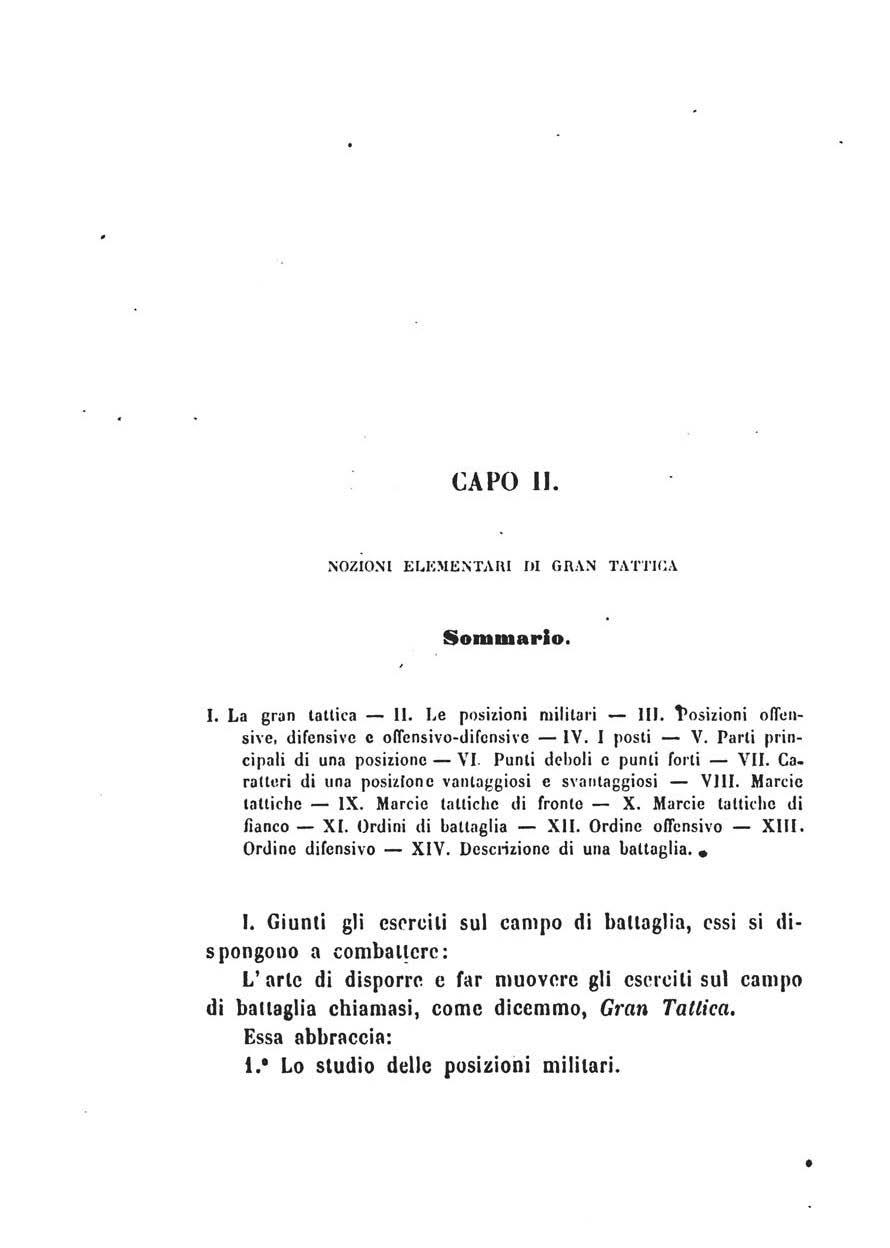
l. Giunti gli csr.rcili sul campo di battaglia, essi si dispongono a L'arte di disporre e far muovere gli eserciti sul campo di battsslia chiamasi, come dicemmo, Gran Tattica.
Essa abbraccia: t.• Lo studio delle posizioni militari.
2.o Quello delle marcic tattiche.
5.0 Quello degli ordini di bauaglia.
4°. Quello delle battaglie.
Il. La posizione militafe è quel tratto di terreno la cui occupazione offre vantaggi ad una truppa allo scopo di fer· marvisi e combauere. E siccome ciascun'arma ha uno tattica · particolare adauata alla mnnicra di combattere che le è propria, cd alla parte ch'essa deve prendere in un combauimento, ne viene di conseguenza che la natura del terreno può contrariare o favorire i suoi movimenti c la sua azione. .
III. È cosa dunque della più alta importanza il sapere scegliere una posizione la quale sia conforme alle viste del generale cd agli clementi di guerra di cui egli dispone. Ora, le viste che determ inano la scelta di una posizione sono: di difendersi; o di assalire; od aneo e di difendersi c ·di assalire talora simultaneamente, tal' altra allcr.nativamente o successivamente. Di qui vengono tre specie di posizioni: t.0 Le posizioni offensive . 2. 0 Le posizioni 3.0 Le posizioni difcnsivo -offcnsiv<', delle ancora posizioni miste.
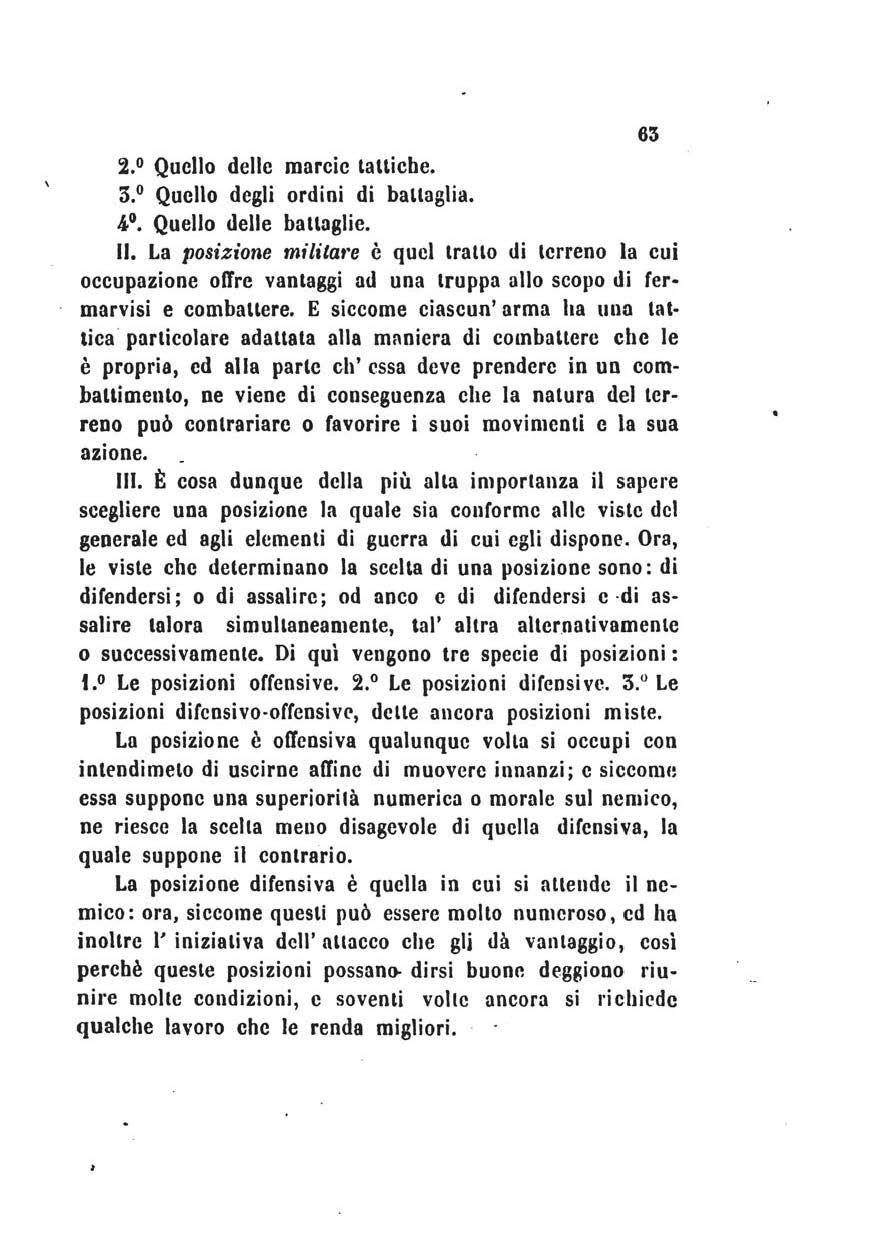
La posizione è offensiva qualunque volta si occupi con intendi melo di uscirne affine di muovere innanzi; c siceomf! essa suppone una superiorità numerica o morale sul nemico, ne riesce la scelta meno disagevole di quella difensiva, la quale suppone il contrario.
La posizione difensiva è quella in cui si attende il nemico: ora, siccome questi può essere molto numeroso, cd ha inoltre l' iniziativa dell'attacco che gli dà vantaggio, così perchè queste posizioni possano- dirsi buonr. degg iono riunire molte condizioni, c so venti volte ancora si ri c.hicdc qualche lavoro che le renda migliori.
6.1
Le posizioni miste sono. quelle che offrono il \'antaggio di potersi difcntlc.rc in alcuni punti e di alLuccnrc iu alcuni ahri.
IV. È mestiere osservare la differenza che si annette, fra In parola posizione c la parola posto .
Per posiz;o,e si vuoi intendere il vasto tratto di terreno su cui accampano gli eserciti od i grossi corpi tli esercito.
Per posto quel luogo più ristretto a ricc\'cre distaccamenti o corpi meno numcl'osi. Talvolta nella scelta di un posto si ha per iscopo di cuoprirt! una truppa la quale veglia alla sicurezza dell'es e rcito; tal' allra di tenere in iscacco il nemico col minrtcciarne i fianchi, le vie di cooppure di chiudergli qualche sbocco importante. Una posi zione sarebbe difettosa se l'esercito vi _ si trovas!le chiuso da ogni parte; un posto, per lo contrario, qualunque sin il fine per cui viene scelto, non potrebbe offr ire altrimenti resistenza suf6ciente, imperoeehè il su11 debole presidio deve fronteggiare forze molio superiori . l posti drst inati a tt'nere viva l'esplorazione debbono conservarsi uno via di ritirata libera c sicura; isolati, invece, non sono riputati mai troppo inaccessibili su tulli i punti.
·v. Si distinguono in uno posizione le seguenti parti P.riocipali: gli accessi, la fronte, i fianchi, l' interno, le spallr,_ la chiave.
VI. Ogni posizione pa·cscnta punti deboli e punti (orti. Sono deboli, generalmente parlando, i punti dominnti, ossia quelli che sono esposti ad essere bnttuti da truppe che si trovano in un terrcoo più elevato; i salienti, pcrchè possono essere battuti non solamente di fronte ma anche ai fianchi; i punti di facile aec('sso, perchè il nemico non avrebbe a lottare con altro ostacolo che con quello ·ctcl Cuoco del difensore; i punti che sono mascherati da località, come boschi, burroni,
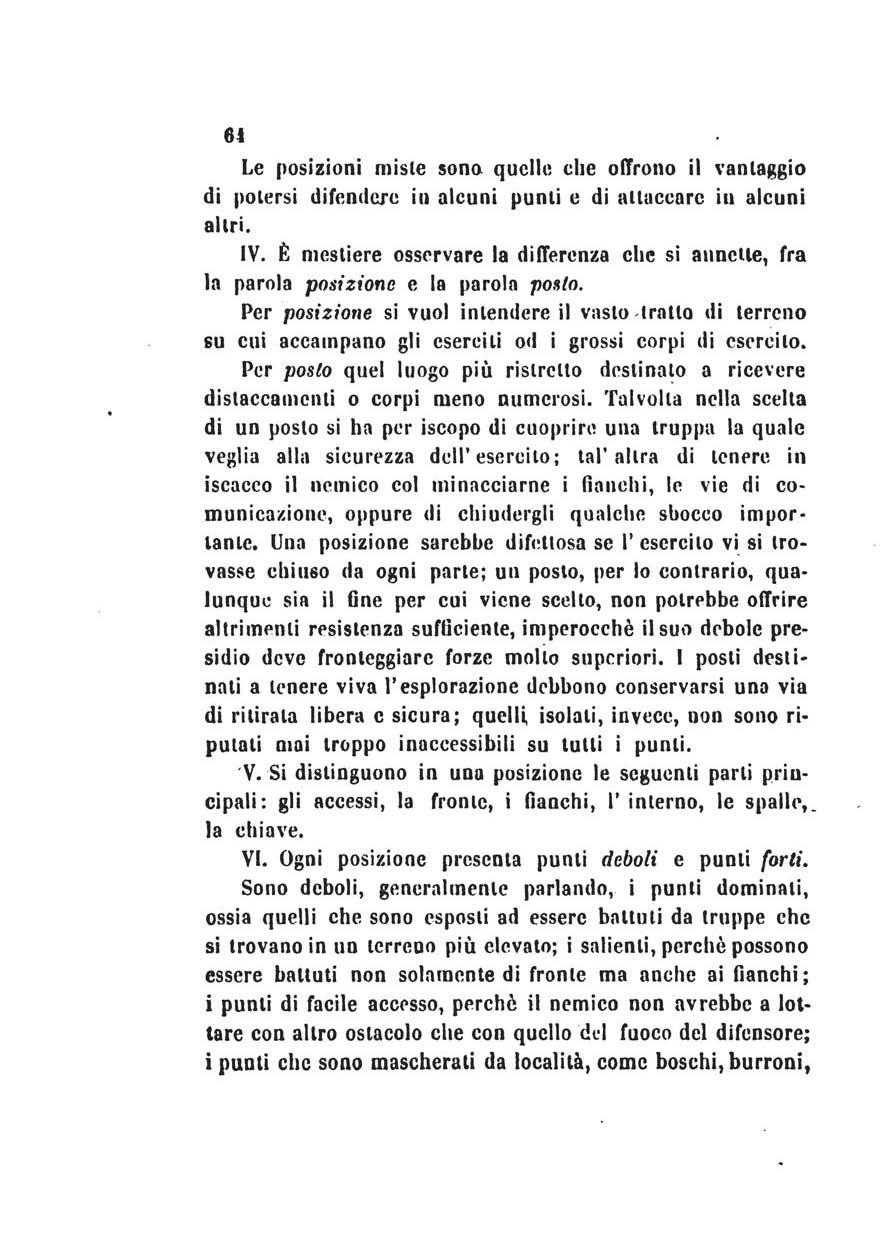
dighE!, caseggiati cc. pcrchè sono atti n cuoprire i movimenti del nemico, perchè, cioè, il nemico riparato da quegli osla· coli può avvicinarsi inpunemcntc al punto in discorso.
Sono forti' i punti che presentano carallcri contrnrj a quelli che abbiamo assegnato ai deboli; sono forti quindi i punti dominanti, pcrchè di là si vcd ono i movimenti fatti nei luoghi sollostanti c di là si fa uso dci fuochi con maggiore libertà c quin.di con utili là !Tiaggiorc; sono forti i rientranti pct:chè l' assalitOJ'C viene aci esporre In sua fronte cd i finn· chi suoi ai fuochi della difesa; sono forti i luoghi di diffi· cile accesso per l'inimico, perchè questo avrà a lollnrc non solo C!.Hltro i fuochi della difesa ma puranche contro gli osta· coli che il terreno gli oppone; sono foa·ti finalmente tuUc le località, come villaggi, masserie, cc.Jifizj, boschi, c pcrchè possono servire di utile occupazione al difcn sorc il quale può battl!rc il nemico slantloscnc al coperto.
Fra i varj punti forti della posizione, havvcné uno il qunk, pe1· l'importanza relativa che esercita, domina tutti gli altri cd è più forte di essi. Dall' occupazione di ques to punto dipende non so lo il possesso dell'intera posizione, mn bcnanco una vittoria completa. Esso chiamasi il punto decisivo, la chiava clelia posizione. La e/dava della posizione è dunque quel punto dalla cui occupazione dipende non solo il possesso dell' inticra posizione, ma bcnanco una vit· tori a com pleta . Non bisogna confoDllcre il punto decisivo, _ la chiave della posizione col punto debole. La disposizionn delle truppe, il ll'ovnrsi in poco numero o mal collocate in un dalo luogo, la natura del terreno, bastano soventi ,·oltc a costituire un punto clebole ossia quello che presenta rninoJ'C resistenza; ma la conquista di esso non procaccia se non che un successo parziale, il cui risultato può bensì obbligare il nemico a battere in ritirata, ma non
Stor. dell' Art. Milit. 5.
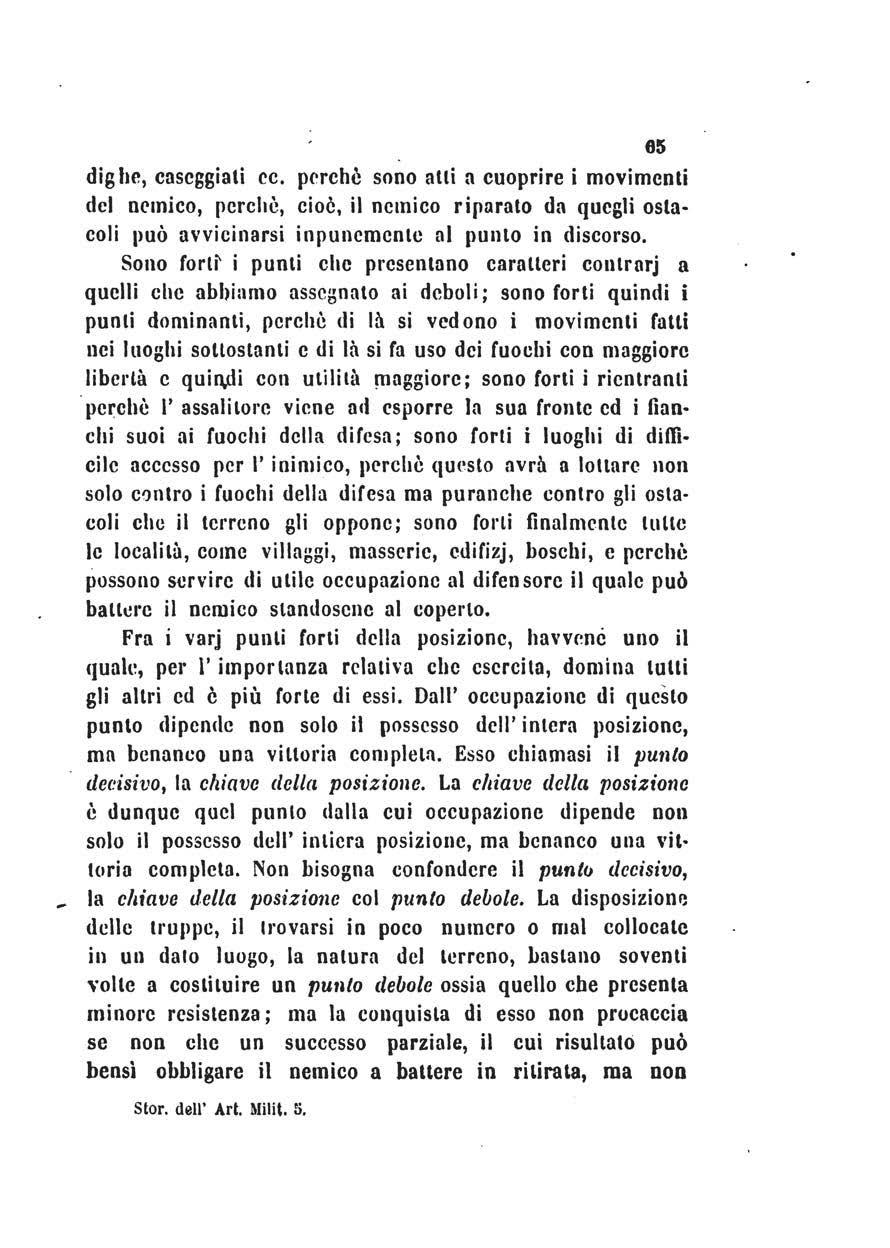
produce un gran ri s ultato sopra l' insieme delle operazioni di guerra. Al cont•·ario, il punto decisivo, ossia la chiave della posizione, si è quello il cui possesso ingenera la separazione completa delle forze nemiche, oppure è quello la cui occupazione obbliga non solo l' avversario a bauerc in riti•·ata, ma taglia inoltre il suo esercito dalla sua base d' operazionr, vale a dire da quc' luoghi da cui trae le sue risorse nel marciare all' offensh·a o su cui SÌ• appoggia per resistere nella difensiva.
Aggiungeremo ancora che il punto debole di forza quasi sempre s ulla fronte della posizione, è sempre compreso in essa, mentre il decisi vo può cssrrc so venti volte alle spalle della posizione, c più indietro di essa . Per conseguenza la comlizionc più favore\·olr, quando si ha l' iniziativa dci mo\'imcnti, si .è di combattere un nemico tanto irripcrito da prP.scnta•·e insieme il punto debole c il punto decisivo . Pcrchè l' insiçmc di una posizione possa dil'si vantaggios!l, occorre: t .° Che le truppe vi si possano muovere liberamente in tutti i sensi.
2 .° Che l' interno non possa rssrre battuto immediatamente dall' avversario; vale a dire che non sia dominato da qualche punto più elevalo a portata di cannone.
3.° Che la sua r stcnsionc sia in rapporto alla ft>rza dell' esercito che la deve occupare.
4.u Che i suoi fianchi, se non sono inaccessibili per ostacoli naturati, come boschi, ciUà, vill11ggi trincerati c non trincerati , corsi d' acqua, luoghi scoscesi, ccc. o che possono almeno essere ridotti inaccessibili con opere di arte. Ogniqualvolta non si possa appoggiare tln fianco , si dice che q'uesto è per aria, ed io tal caso conviene raccoglicrvi molle truppe affine di compensare questo grave ineon venicn te.
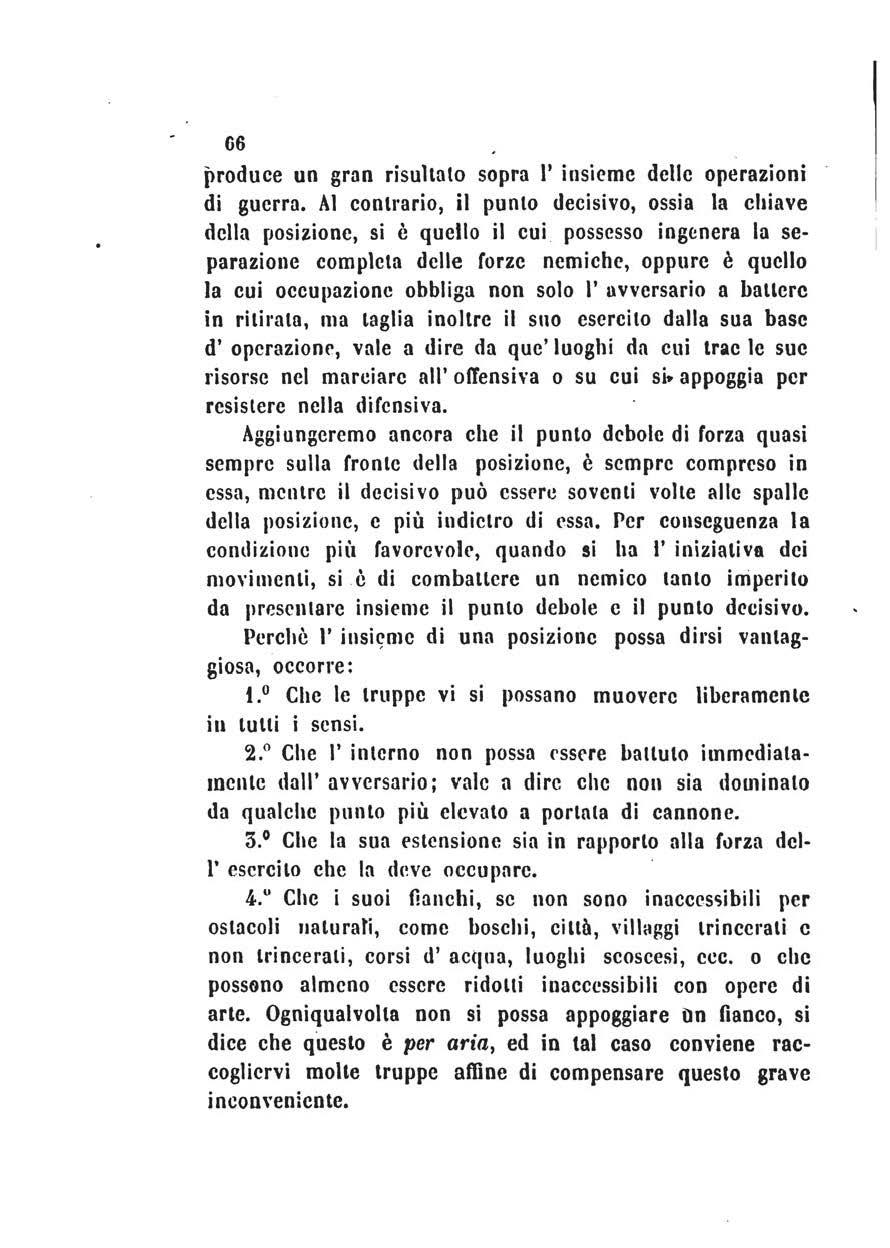
5.° Che la fronte presenti al nemico ostacoli da superare, senza però riuscire danosi ai difen sori opponendosi ai movimenti offensivi che volessero fa1·e: villaggi, masserie, boschi , vigneti, cd in generale tulli i luoghi di ricevere e ripararvi truppe, c che lasciassero fra essi degli spazj liberi di qualche ccntinajo di metri per potcn-i far uso efficace dei fuochi, sono buoni ostacoli per proteggere c cuoprire la. fronte di una posizione. Questi ostacoli esteriori e distaccati riunirebbero miglfori proprietà, qualora . fossero tulli dominati dalla fronte della posizione, c poi f1·a c.li essi si dominassero gli uni cogli altri, vale a tlire che ve ne fosse una serie di più bossi, dominaLi da un' ultra serie; e così via via, fino o giungere solto il comando della fronte 'ùclln posizione. Se il nemico s ' impadronisse dci primi, sarebbe cspo.sto ai colpi efficaci dci secondi.
6.° Che le della posizione siano libere; c non vi si debbano trovare delle streuc per cui sia mestieri pas- . sare ritirandosi.
7.° Che la linea di ritirata sia coperta.
8.° Che il nemico non pos sa girare la posizione senza tema di essero tagliato fuori, lui medesimo, dalla sua base d' operazioni. • .
9.° FinaJmcnte conviene che nella posizione si trovi acqua, paglia, e legna, od almeno che se ne trovi poco !ungi c che il nemico non 110ssn intcrdirnc l' uso. Qualora le truppe dovessero soggiornare sulla sarà vantaggioso che il paese circostante sia fertile c possa prov· vedere ai bisogni dell' esercito.
Una posizione sarà poi svanlaggiosa:
t.0 Quando essendo dominata da alture a portata di cannone, è veduta in tutti i · sensi .
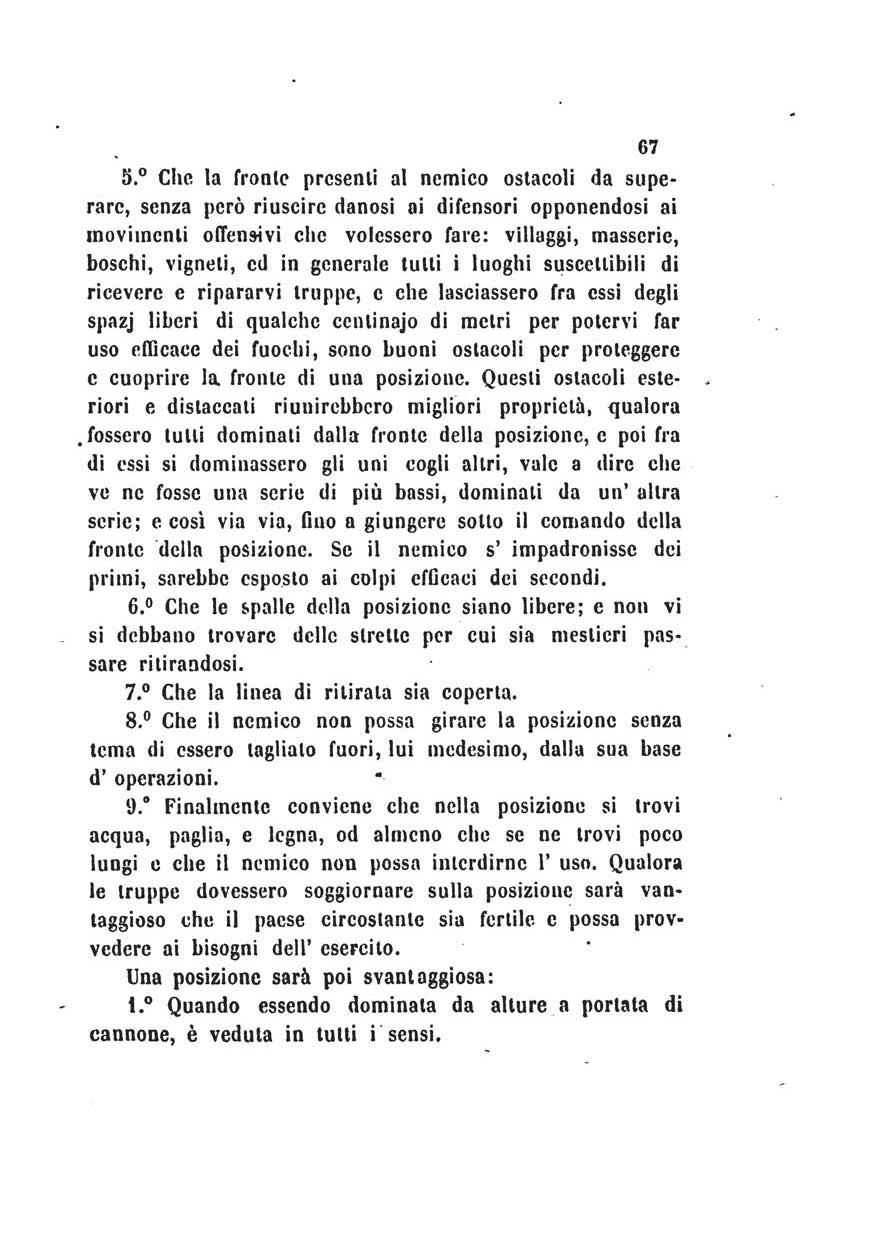
2.• Quando è intt·nlciala da pn1Ut1i, da fiumi, da burroni, c da gole di ogni s1•ccic, in modo da incagliare i movimenti delle truppe, cd nnche da porsi in mezzo tra diverse frnzioni rl.i esse in .guisa da dividerle; c da fnr sl, che non potcndosi soccorrere vicendevolmente possano essere scparatamente hallutc.
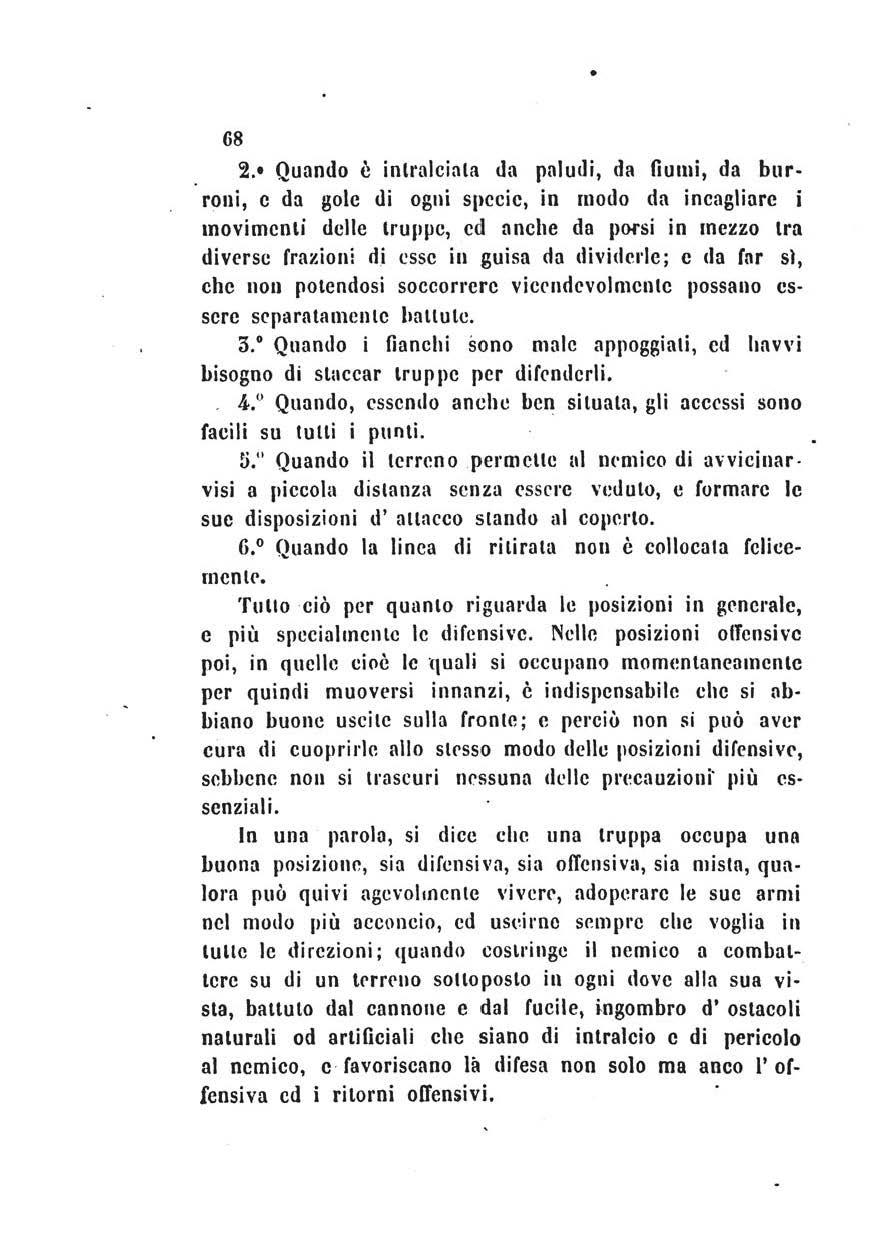
5." Quando i fianchi sono male appoggiati, ctl hnvvi bisogno di staccar truppe per difenderli. .
4. 0 Quando, essendo anche ben situata, gli acces si sono facili su tutti i punti.
ti." Quando il terreno permette al D<'mico di avvicinarvisi a piccola distanza senza essere Yt!dulo, c formare le sue disposizioni d' attacco stando al coperto.
6. 0 Quando la linea di ritirata non è collocata fclicernent<'.
Tutlo ·ciò per quanto riguarda le JlOsizioni in grnc•·alc, c più specialmente le difensive. Nelle posizioni offensive poi, in quelle cioè le ·quali si occupano momentaneamente per quindi muoversi innanzi, è indispensabile che si abbiano buone uscite sulla fronte; c perciò non si può aver cura di cuoprir lc allo st<'sso modo delle posizioni difcnsivr, sebbene non si trascuri nr.ssunn delle più essenziali.
In una parola, si dice che una truppa occupa unn buona posizione, sia difcnsi va, sia offensiva, sia mista, quaIom può quivi agcvol,ncntc \' iver<', adoperare le sue armi nel modo più acconcio, cd useirno scmp•·c che voglia in tutte le direzioni; quando cosu·ingc il nemico a combattere su di un t<'rr<'IIO sottoposto in ogni dove alla s ua vista, battuto dal cannone e dal fucile, ingombro d' ostacoli naturali od artificiali che siano di intralcio c di pericolo al nemico, c · favoriscano la difesa non solo ma anco l' offensiva cd i ritorni offensivi.
VIli. Diciamo ora alcune parole sulle marcie. .
Un. esercito si può muovere perpendicolarmente alla sua fronte o pa•·alcHnmenle ad essa; laonde le marcic manovre, o marcic tattiche, avuto riguardo alla fronte otl nlla linra di . battaglia, non che alla posizione del vengono distinte in due specie:
1.0 Marcie tattiche di fronte:
2. 0 Marcie tattiche di fianco .
A queste potrchbcrsi nggiungcre le marcic retrograde; ma siccome sono applicabili nd esse le no1·me che regolano le rnarcic tattiche di f•·onte, così tralnscinmo di tcnerne speciale argomento.
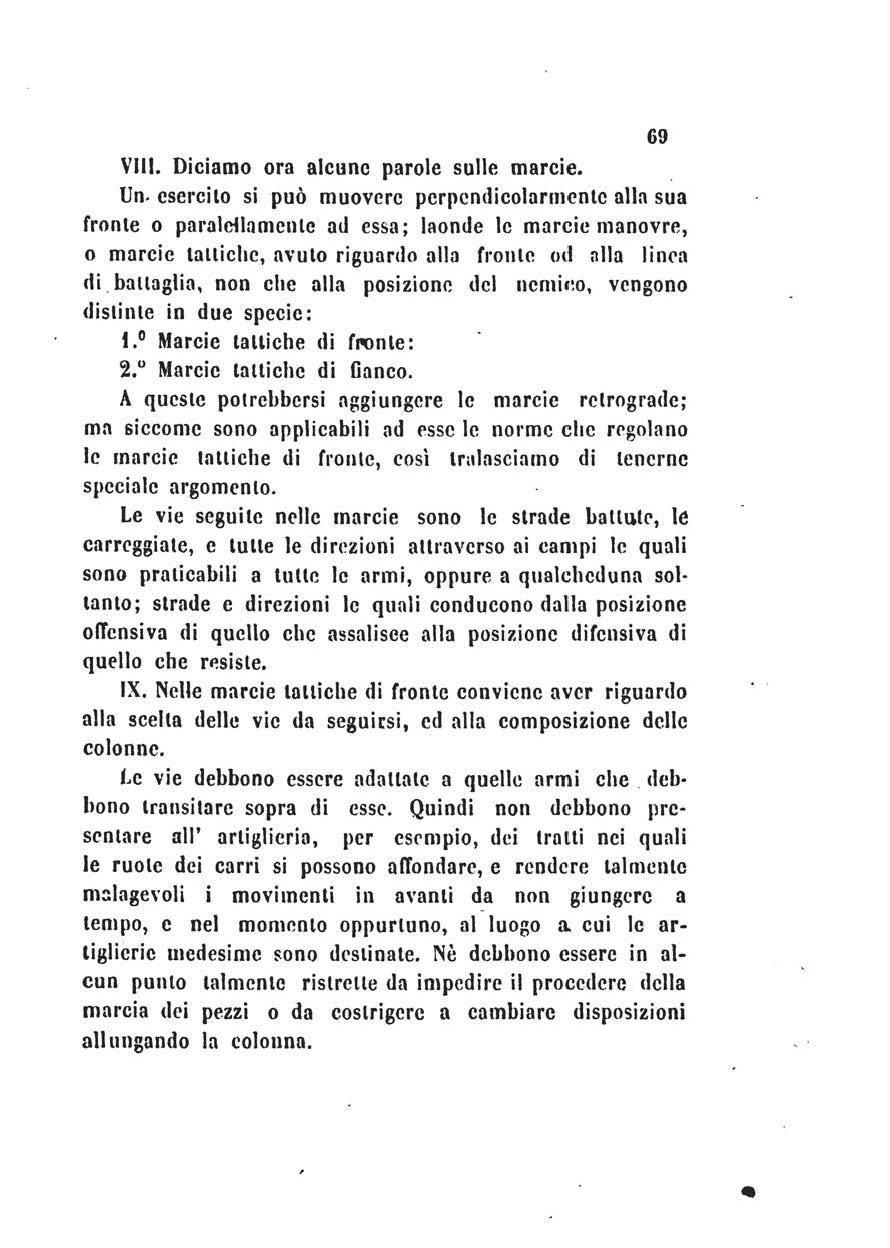
Le vie seguite nelle marcie sono le strade battul<', le carreggiate, c tutte le direzioni attraverso ai campi le quali sono praticabili a tutte le armi, oppure a qualcheduna soltanto; strade e direzioni le quali conducono dati a posizione offensiva di quello che assalisce alla posizione difensiva di quello che rP.siste.
IX. Nelle marcie tattiche di fronte conviene aver riguardo alla scelta delle vie da seguirsi, cd alla composizione delle colonne . te vie debbono essere adattate a quelle armi che . dcb· bono transitare sopra di esse. Quindi non debbono presentare all' artiglicrin, per cs<'mpio, dci trotti nei quali le ruote dci carri si possono affondare, e rcnde·re talmente i movimenti in avanti da non giungere a tempo, c nel momento opportuno, al luo go a. cui le artiglierie medesime !'ono destinate. Nè debbono essere in alcun punto talmente ristrette da impedire il procedere della marcia dci pezzi o da costrigere a cambiare disposizioni allungando la colonna.
Nemmanco debbeno essere tra eli loro divise da tali ostacoli che fossero capaci di tagliAre quel lt>game deve csistel'e fnt le diverse parli dell' esercito, in 8"isa che l'una, snpat·ata dall' nltrn, o altre, si possa trovare compromessa. Lnondc non dcbbonsi losciarc fra le colonne ostacoli forti come boschi, pendii scoscf.si, paludi, fiumi, n meno che il fiume non presenti mol .. ponti c guadi. l fianchi d ell' insieme delle colonne marcianti debbono essere protcLLi da osta coli estc1·ni; c per re nd ere più si eu ra In marcia si fa fi;mchcggiat·c dn distaccamenti in qut•IJa parte od in quelle parti per . le quali il nemico potesse presentarsi all' improvvi so.
Dccsi schivare, per quant' è possibile, le vie troppo incassate, come burroni, valloni ecc., a meno che non siano fiancheg giate da località impcnclrahili; se ciò non fosse, Jc colonne corrcrcbcro il pericolo di essere annientate qualora il nemico s i potesse prescnta1·e al loro

Sarà bene che innanzi alla fronte della marcia esistano ostacoli favorevoli, come tratti di boschi, masserie, allure, ondulazioni di terreno, che proteggano gli spit>gamenti c favoriscano gli attacchi.
In quanto alla composizione delle colonne, sia nel numero, sia nella fol'za, dipende dal numero, dall' ampiezza, e dalla natura delle \·ic; c siccome la marcia lallica conduce per ultima fine alla fo•·mnzionc di un ordine 11i battaglio, così gl' intervalli fra le colonne debbono per quanto è possibile, uguali ngl' di spirgnmento. In ogni però In della mnrcia dcv ' essere · presso a poco uguale aHa fronte ord !ne di battaglia; vnle n dire che lo spa:tio di terreno occupato in larghezza dall' ultima estremità destra delle colonne ·di morcia fino all' ultima estremità di sinisLra delle colonne medesime , dev' essere uguale,
7i o presso a poco uguale, alla linea che le stesse colonne occuperebbero se fossere od occuperanno spiegao. dosi. Se le colonne fossero disperse su di un:1 fronte troppo grande, si correrebbe pericolo allo spiegarsi di avere dci VU(Iti in cui il nemico si potrebbe cocciare, separore in frazioni l' esercito nostro, c batterle scparatameote. Se per ovviare i vuoti si estendesse la lioea con poca profondità, non appoggiata da altra linea o da riserve; si prcsentereb· bero puilli deboli che dal nemico potrebbero essere sfondati. Di più : la lunghezza della linea impedirebbe i rapidi con· cenlrameoti su di un dato punto; c le manovre per raccogliere forze superiori affine di abbattere con queste alcune parli della linea nemica, non potrebbero aver luogo con quella facilità che in simili casi viene richicsia.
SP. al conta·ario le colonne marciano troppe vicine le une alle altre, allora vi saranno inconvenienti negli spiega· menti; le truppe non potrebbero, ncmmnnco quelle di una stessa linea, prender parte tutte al combattimento, oppure essere in circostanza e disposte in modo da potl!rvi tutte prendere parte; e finalmenlf! non si avrebbe il vantaggio di poter con facilità oltrepassare la linea nemica, e girarne il fianco.
Nelle marcie touichc, di cui parliamo, si 1)rocura, per quanto è possibile, di conservaa·e una rch\zionc colla disposizione delle truppe in ordine di bauaglia.
In genernle le colonne del centro sono formate dai corpi di fanteria colle ·loro rispettive batterie. Quelli di cavalleria formano le colonne esterne, o marciano in seconda linea in guisa da fQrmare riserve.
Le truppe marciano per sezioni, determinate dalla lar· ghezza delle strade. Le colonne marciano a distanza intiera, a inezza distanza, otl anche St'fl'ate, a norma delle circostanze.
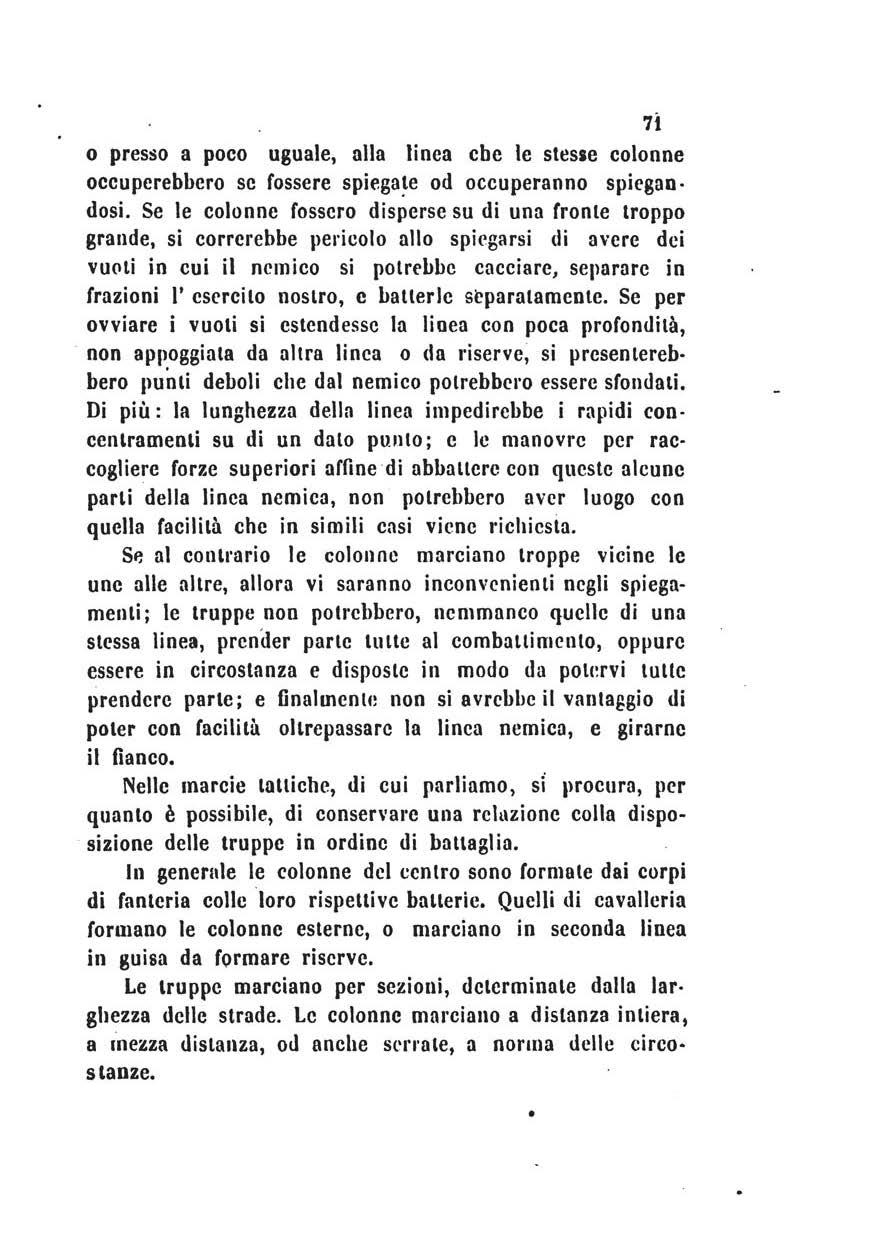
Le leste di colonna possono essere alla medesima altezza, possono essere scaglionate su una delle due oli, e possono ess ere scaglionate centro: ciò dipende dal modo con cui si ha intenzione di dare la battaglia .
X. Passiamo ora- ad esaminare le marcie tattiche di fianco, ossia quelle in cui l ' esercito, muovendosi paralelJnmente alla sua fronte, presenta al nem ico il . fianco delfe sue colonn e. Si fanno nell' offensiva per girare la linea nemica; nella difensiva ilCt' llppot·si n un movimento girante. In teoria , nulla havv i di più semplice e di più pronto del meccanismo di una marcia di questo gcnct·e, perchè si tratta soltanto di rompere: in colonna, con una semplice conversione delle suddivisioni, ciascuna delle lince sulla quale si trova schierato un esercito o un corpo d' esercito; poscia, per rimettersi da questa disposizione a un ordine di battaglia sul fianco della marcia, bas ta far eseguire conversioni inverse. Ma se è facile, astrazione fatta degli ostacoli presentati dalla natura del terreno, il trasportare lateralmente, e lutto ad un tratto, un ordine di batlaglia tutto intiero, non è questo però il solo caso che si possa presentare. Il nemico che dapprima ·si vedeva o si sapéva sul fianco, può aver fatto correre innanzi alla lesta deW esercito marciante un corpo considerevole per chiudere la via alle colonne di esso; cd in questo caso sarebbe giuocoforza di spiegare avanti codeste colonne in tutto od in parte; loe-· cbè non è tanto agevole pei motivi seguenti;
t •0 Perehè il numero delle colonne è determinato dal numero delle lince dell' Ol'dine di battaglia; cd essendo ristretto questo numero, le colonne sono molto profonde; ed essendo molto proronde, questa profondità rende difficili gli spiegamenti .
2. 0 Perchè non banno fra esse gl' intervalli richiesti per spiegarsi.
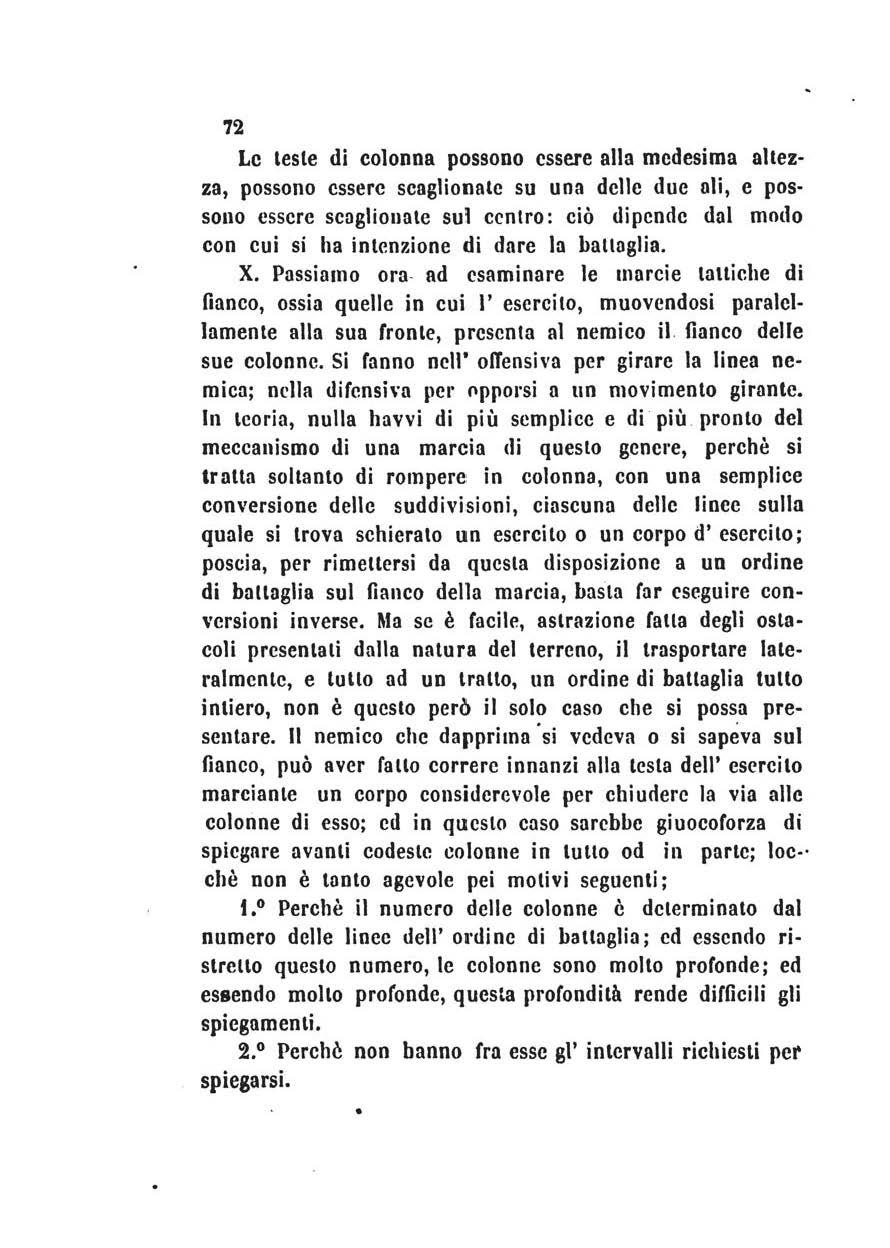
·
5.o Perchè se la conservazione delle distanze è dWi ri le ad ottencrsi in piccoli corpi di truppe, lo è più ancoro colonne numerose; c l' irr('golnrità delle distanze influisce sulla sollecitudine e regolarità degli spicgamcnti,
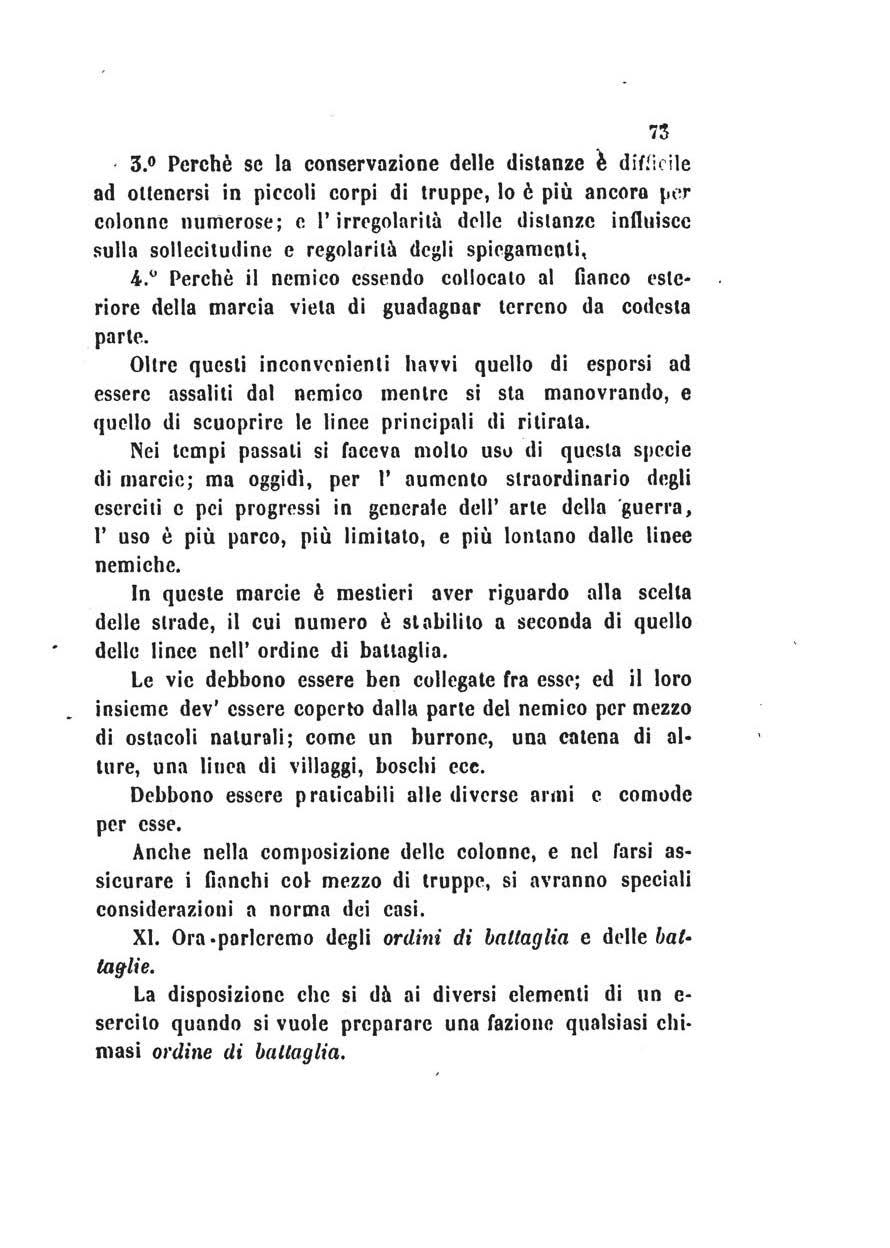
4. 0 Perchè il nemico essendo collocato al fianco este· riore della marcia vieta di guadagnar terreno da codesta parte.
Oltre questi inconv('nienli havvi qu ello di esporsi ad essere assaliti dal nemico mentre si sta manovrando, e f(UCllo di scuoprirc le lince principali di ritirata.
Nei tempi passati si facevo molto us1.1 di questa specie di marcic; ma oggidì, per l' aumento straordinario dc!gli eserciti c pei progressi in generate dell' arte della ·guena, l' uso è più parco, più limitato, e più lontano dalle linee nemiche.
In queste marcie è mestieri aver riguardo alla scelta delle strade, il cui numero è stnbilito n seconda di quello delle lince nell' ordine di battaglia.
le vie debbono essere ben collegate fra ess('; ed il loro _ insieme dev' essere coperto dalla parte del nemico per mezzo di ostacoli naturali; come un burrone, una entena di al· tnre, una linen di villaggi, boschi cee.
Debbono essere praticabili alle diverse a l'mi c comode per cssr.
Anche nella composizione delle colonne, e nel farsi as· sicurare i finnchi col mezzo di truppe, si avranno speciali considerazioni a norma dei casi.
Xl. Ora .parleremo degli orditli di battaglia e delle bat· taglie .
la disposizione che si dà ai diversi clementi di un esercito quando si vuole preparare unn fazione qualsiasi chi· masi Ol'dine di battaglia.
Prlma di passare agli ordini di battaglia reali c pratici, si traccia il cosi dello ofdine pt·imitivo di battaglia; esso costituisce un tipo il quale si applica ad un terreno nudo e perfellamcntc orizzontale; un Lipo che forma una di s posizione di aspcllati va, una dispo sizione di organamento, di accampame nto, e che si modifica poscia a seconda della disposizione dell' avvc1·sario, della composizione del suo esrrcito, delle forme di terreno, drllo scopo propo!lto, c dei diversi auacchi che si vogliono trnlarc o respingerr. Le modificazioni principali, .subite da questi ordini primitivi, sono le SC{l.UCnti:
1.0 Gli nlineamcnti in linl'n relta che abbiamo sui terreni di manovra, o in rasa pianura, si possono ben. rare volte ottenere in guerra; soprauutto nelle esten sioni di terreno rich ieste dai numero si esercì Li odici'Oi. La fronte di bauaglia dovril dunque s eguire le sinuosità del terreno. Se si dovesse far dipendere dall' alincamcnto la disposizione delle u·upJH', queste sinuosità polrrbbero impedire l' efTetLo delle armi, o sottomettere la truppa ai fuochi dominllnti del nt'mico. mestieri quindi di romp e re la linea di battaglia a seconda drgli accidenti del terreno. Ques ta.. linea presenterà dei punti più innanzi c dci punti più iildictro, ossia dei salienti c dci rientranti; que s te sinuosità della linea fanno sì ne ri s ultino fianchrggiam eoti sui punti d' attacco.
2. 0 Il parallelismo d1•1lc lince d<'ll' ordine di bauoglio non viene osservato rigorosl\mcnte. l.a 2/1 lio<'a si allontana o si appros s ima alla prima secondo i ripori ch'.cssa trova. Essa è più o meno obbliqua seconda le rorme del terreno. Ma pr escindendo da queste modificazioni, malgrado le quali l' ordine primitivo resterebbe sempre come tipo, altre di s posizioni mutano forma dell' ordine di battaglia;
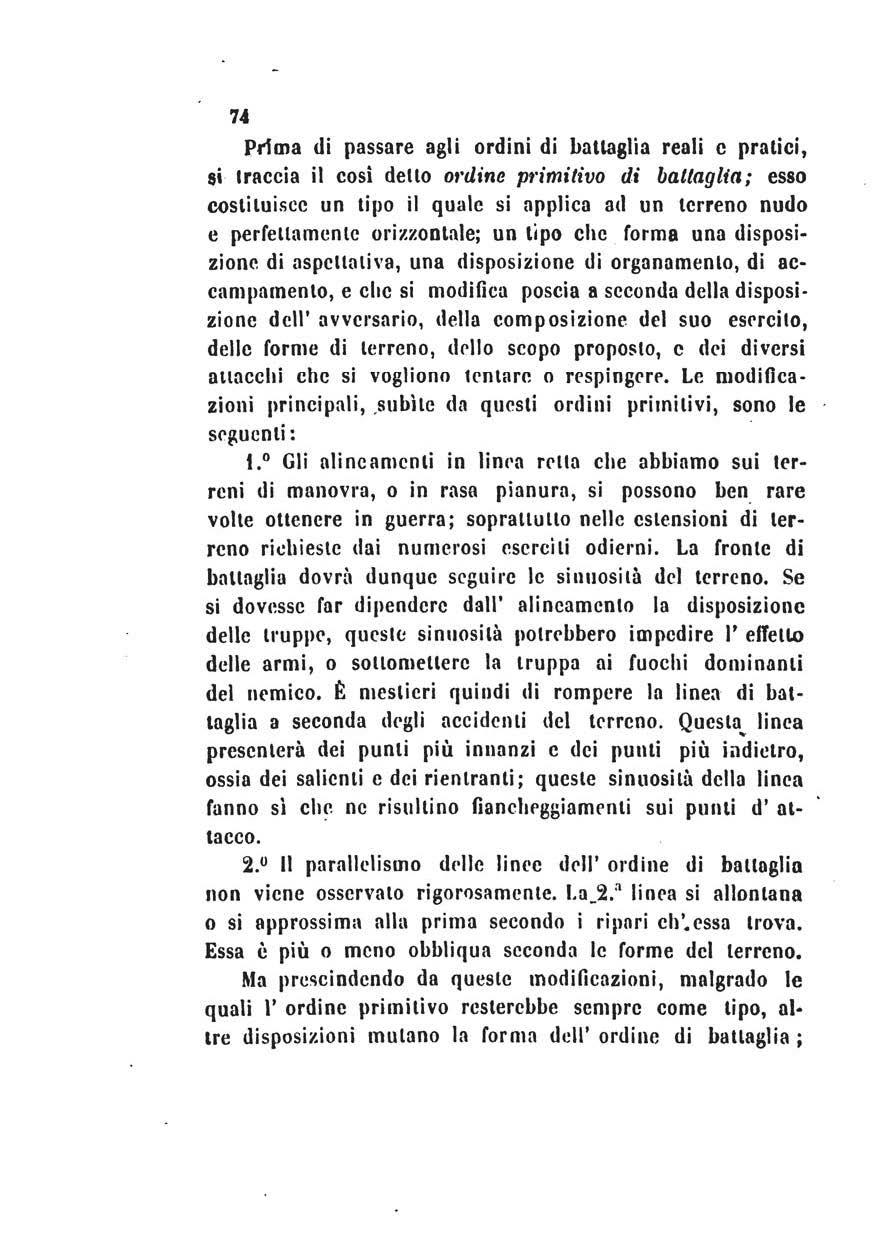
ed i tattici le raccolgono sotto categorie che vcngonc. da essi c.lassifìcatc. Forse, c certo, havvi in classificazioni; tuttavia non mancando esse di un certo i nteresse dal lato cicli' crmlizionc, esporremo sommar iamente quello che ,·ic n f11t1a dal Jomini.
Gli anticlii ammcuevono 7 ordini tli battaglia: Vcge:tio li ha esposti; la stt>ria dell' arte militare li ins<'gna. Nei tempi moderni, Jomini ·conta 12 specie di ordini. di battaglia; t.• L'ordine parallelo semplice. 2. 0 l'ordine pa. rnllclo con martello offensivo c difensi\'o. 5.0 l' ordine rinforzato su di una o due ali . 4. 0 l' ordine rinforzato sul centro. 5.0 l' ordine obbliquo semplice o rinfo1·zato sull' alla assalitrice. G.o c 7.• l' ordine perpendicolare su di una o sulle due ali . 8.0 l' ordine concnvo. 9. 0 l' ordine convesso. t o.• l'ordine scagl ionato _su una o sulle due nli. f 1. 0 l' ordine scaglionato sul centro. t 2.u L' ol'lline com bi· nato di un forte uttncco sul centro c su una delle estremità nel medesimo tempo. (V. Tav. l. )
Ciascuno di questi ord ini , dice il Jomini, può essere ndoUato semplicemente od essere combinato colla manovra di una forte colonna destinata a girare la linea nemica. .
Dopo aver parlato di questa classifìcazionc degli ordini di battaglia, fa duopo osservare che questi differenti ordini non si debbono pigliare alla lettera come ,·cngono indicate dalle fisu re geometriche. Un generale che volesse stabilire la sua linen di battaglia colla medcsimn regolarità che si fa sulla cartn o , iu una piazza d' armi, sarebbe immoncabil· mente deluso nella suo aspeUativa, c battuto, specialmente col metodo attuale di fare In guerra. Ai tempi di Luigi XIV c di Fe<l<'rico Il di Prussia, allorquando gli cs<'rciti si tro. vavnno parecchi giorni in faccia al nemico, allorquando
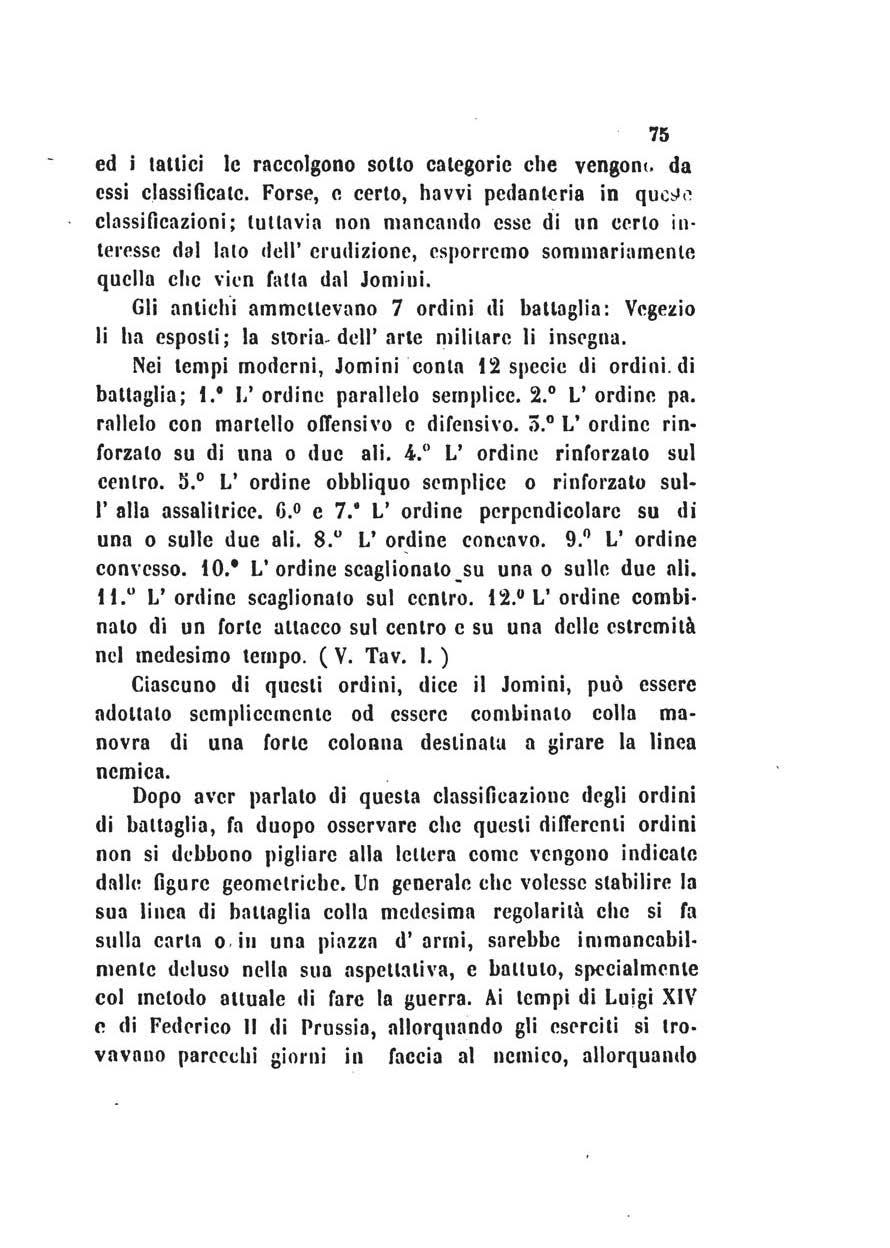
si arcva comoclo di aprire vie simmetriche per far arrivare Jr colonne a di stanze uniformi , nllora si poteva fot·se formare una litwa di batt ag lia che si avvicinasse iii più nllc figure trncciatè. Ma al dì d' oggi in cui gli eserciti sono resi più mohili dalla loro organizzazione in parecchi corpi, oggidì che si scontrano in seguito di ordini dali fuori dal raggio \'isuale c volte senza aver avuto il tempo di riconoscere esattamente la posizione del nemico, oggidì finalmente che le div<'rsc armi si trovano mescolate assie me nella linea di baltaglin, lulli gli ordini disegnati col compasso debbono nec(' ssar iam c nte trovat·si difettosi. In ogni modo però que ste specie di figure non hanno mai servito ad altro se non che ad indicare una disposizione approssimativa.
Altri uomini della sc ienza riducono a minori proporzioni il numero di questi ordini, c li limitano a tre principali:
t. 11 All' ordine di battaglia parallelo
obbliquo
E qui ripetiamo che usrmllo delle parole pat'allelo cd oiJbliquo applicali ad un ordine di bnUaglia, non bisognn aurilmirc a tali espressioni il loro valore geo mctl'ico, rna conviene consiclt•ral'lc come termini presi a prestitf' dalla geometria pc·r esprimere certe lince che più o meno si avvicinano n qu elle dai term ini metl<'simi.
L' o•·dinc di hallnglia parallelo è il più semplice di tutti; è l' ordine di battaglia dd prim,i popoli dell' anli· chità, presso i quali l' nt·tc della gucl'ra era poco perfezionata, avcmlo per risultato eli far urtar e su tutta la loro fronte i due eserciti che si condmllono; è In negazione di ogni id ea c di ogni combin:.zionc tattica.
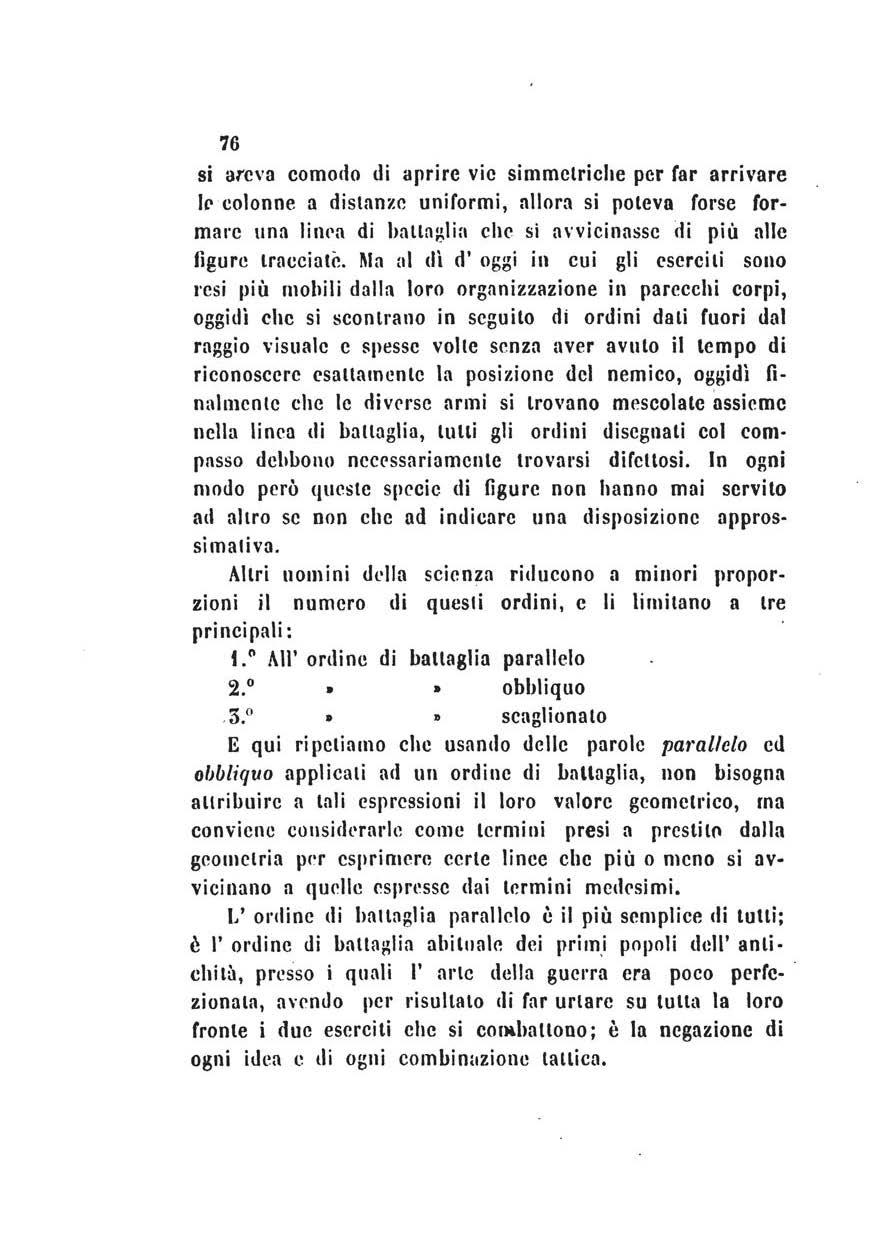
L'ordine di battaglia obbliquo si coi principj sistematici, quello in cui l'a ssol i t ore aHmzn un' alo c ri· fiuta l' altru.
In pratica, esso è quell' ordine pel qunle portando lo sforzo principale su di un punto solo, e riduc('ndo nll' ina· ,· zionc mediante dimostrazioni il rimanente della linea nemica , si ollcngono grandi vantaggi c probabilità di succcs.so, . quando il punto di attacco sia sc<'lto razionnlm cntc.
L'ordine di battaglia scaglionato, lasciando piena ·libertà d' azione sino al punto d' impegnarsi seriamente, offre van· taggi , a chi snppia nbilmcntc prevalersene; esso però è piuttosto un ordine per così dire prepaa·atorio anzichè definitivo; e. qunodo poi si deve impegnare seriamente l' azione, è necessario scegliere fra i due ordì n i di battaglia parallelo od obbliquo.
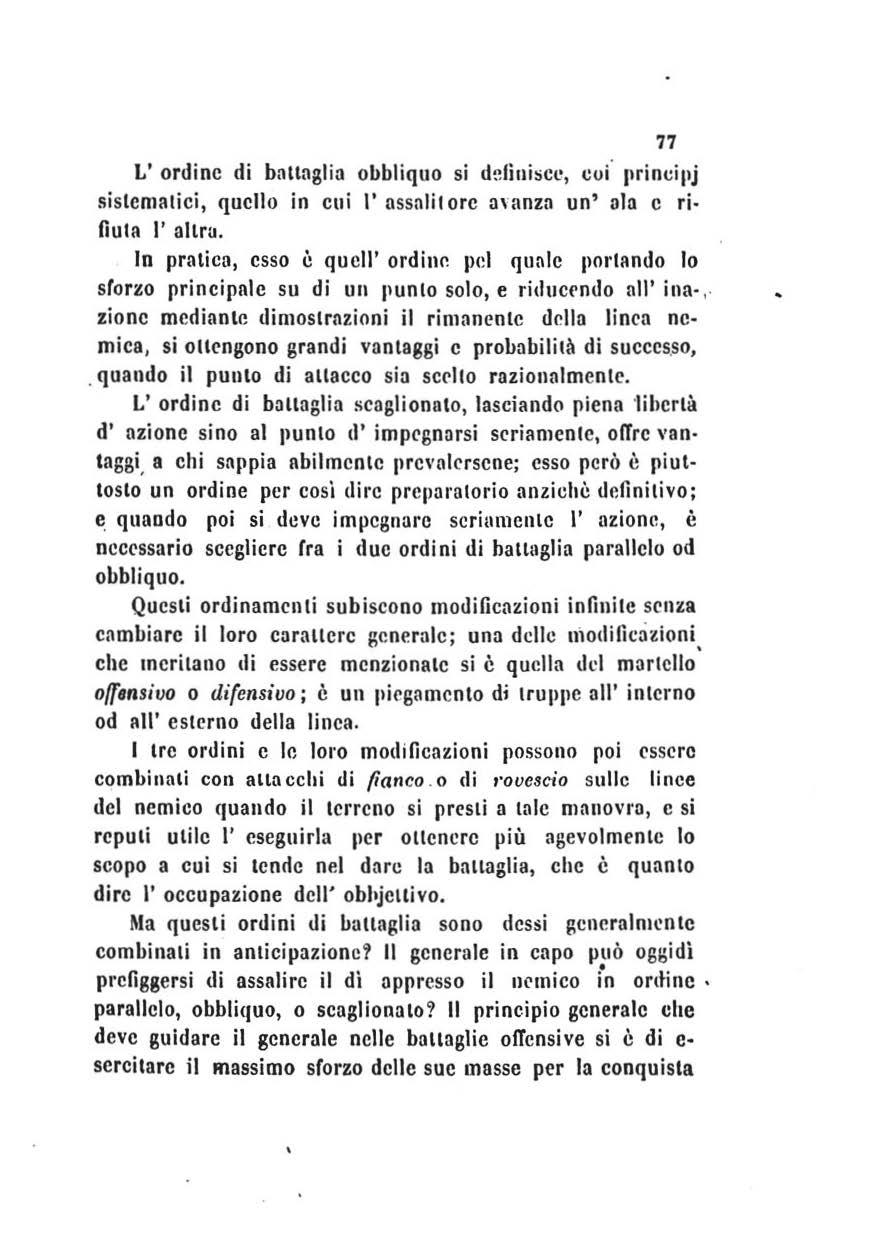
Questi ordinamenti subiscono modifi cazioni infinite se nza cambiare il loro carattere generale; una delle n1odifìcàzioni che meritano di essere menzionate si è quella del offsnsivo o difensivo; è un picgamcnto di truppe all' interno od all' esterno della linea.
l tre ordini c le loa·o modificazioni possono poi essere combinali con alla echi di fianco . o di t·oucscio s ulle lince del nemico quando il terreno si presti a tale manovro , c si reputi utile l' eseguirla per ottenere più agevolmente lo scopo a cui si tende nel dare la battaglia, che è quanto dire l' occupazione dell' obhjettivo.
Ma questi ordini di battaglia so no dessi combinati in anticipazione? Il generale in capo può oggidì •prefiggersi di assalire il di oppresso il nrmico in orttine • parallelo, obbliquo, o scaglionato? Il principio generale che deve guidare il generale nelle batt:lglie offensive si è di C· sercitarc il Rlassimo sforzo delle sue masse per la conquista
del prmto decisivo; difensive si è di . contrnstare al nemico col massimo delle sue forze la conquista di questo punto. Ora, qursti ot·dini di bauaglia non nascono per capr iccio del generale, ma per la necessità del terreno, tlclla disposizione delle forze nemiche, c dello scopo lattico del momento .
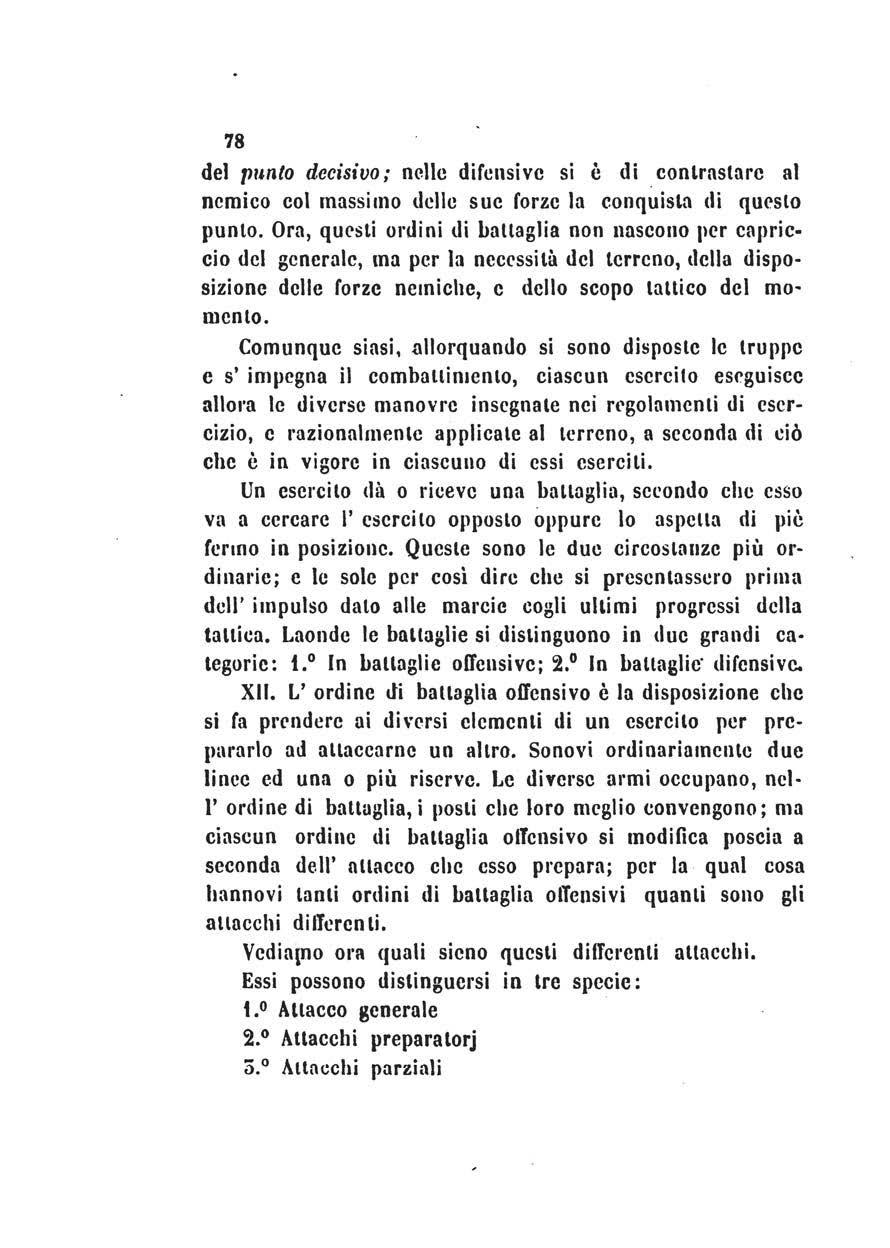
Comunque siasi, allorquando si sono disposte le truppe c s' impegna il combauimento, ciascun cscrcilo esr.guisce allot·a le diverse manovre insegnate nei rt'golrunenli di esercizio, c t•nz ionnlmentc applicale al terreno, n seconda di ciò che è in vigore in ciascuno di essi eserciti.
Un cset·cilo dà o riceve una bauoglia, secondo che esso va a cercare l' esercito opposto oppure lo aspella di l)iè fcrtno in posizione. Queste sono le due circostanze più ordinal'ic; c le sole per così dire che si presentassero prima dell' impulso dato alle marcie cogli ullimi progressi della talliea. Laondc le battaglie si distinguono in due grandi categorie: 1.0 In ballaglic offensive; 2.0 In balta6iic· difensive.
Xli. L' ordine tti batlaglia offensivo è la disposizione che si fa prrndcrc ai di\·crsi clementi di un esercito per prcpararlo ad allaccarne un altro. Sonovi ordinariamelllc due lince ed una o più riserve. Le diYct·sc armi occupano, nel· l' ordine di battaglia, i posti che loro meglio convengono; ma ciascun ordine di battaglia oiTcnsivo si modifica poseia a seconda dell' nllaceo che esso prcparn; per la qunl cosa hannovi tanti ordini di battaglia oiTensivi quanti sono gli allocchi diiTcrcnli.
Vcdin1no ot·a quali sieno questi difTct·cnli altncchi. Essi possono distinguersi in tre specie:
Allacco generale
Attacchi preparalorj
Attacchi parziali
Questi attacchi parziali Gi suddividono poi in:
t.• Attacco d' ala
2. 0 Auacco centrale
3.0 A uacco di . fianco
4.0 Attacco di rovescio.
Gli attacchi parziali si possono combinare a due a due e le combinazioni di cui si trova il moggior numero di esempj sono le seguenti:
1.0 Auacco sulle due ali;
2.0 Auacco centrale combinato con un attacco di ala;
5.0 Auacco di ala combinato con un o.\lacco di
4. 0 Attacco di ala o di fianco combinato con un auacco di rovescio (f).
In un auacco generale lutti gli clementi dell'esercito van· no ad urtare comemporancamcntc gli elementi dcW esercito nemico.
Questa è l' infanzia dell' arte. Così combattono le tribù selvagge nelle quali ciascuno vuoi prendere pal'tc al combattimento.
Così combattevasi nel medio e\·o, in cui i cavallieri non avevano fiducia se non che nella forza c dcst1·czza in. dividualc.
Le due truppe si sc hierano in allora in ordine parallelo; ciascuno cerca il suo avversario; è una serie ·di duelli.
Oggidì s' inizia generalmente un' azione campale mediante attacchi prepaf'atorj fatti dall' avanguardia o da corpi sccondarj, c che hanno per iscopo:
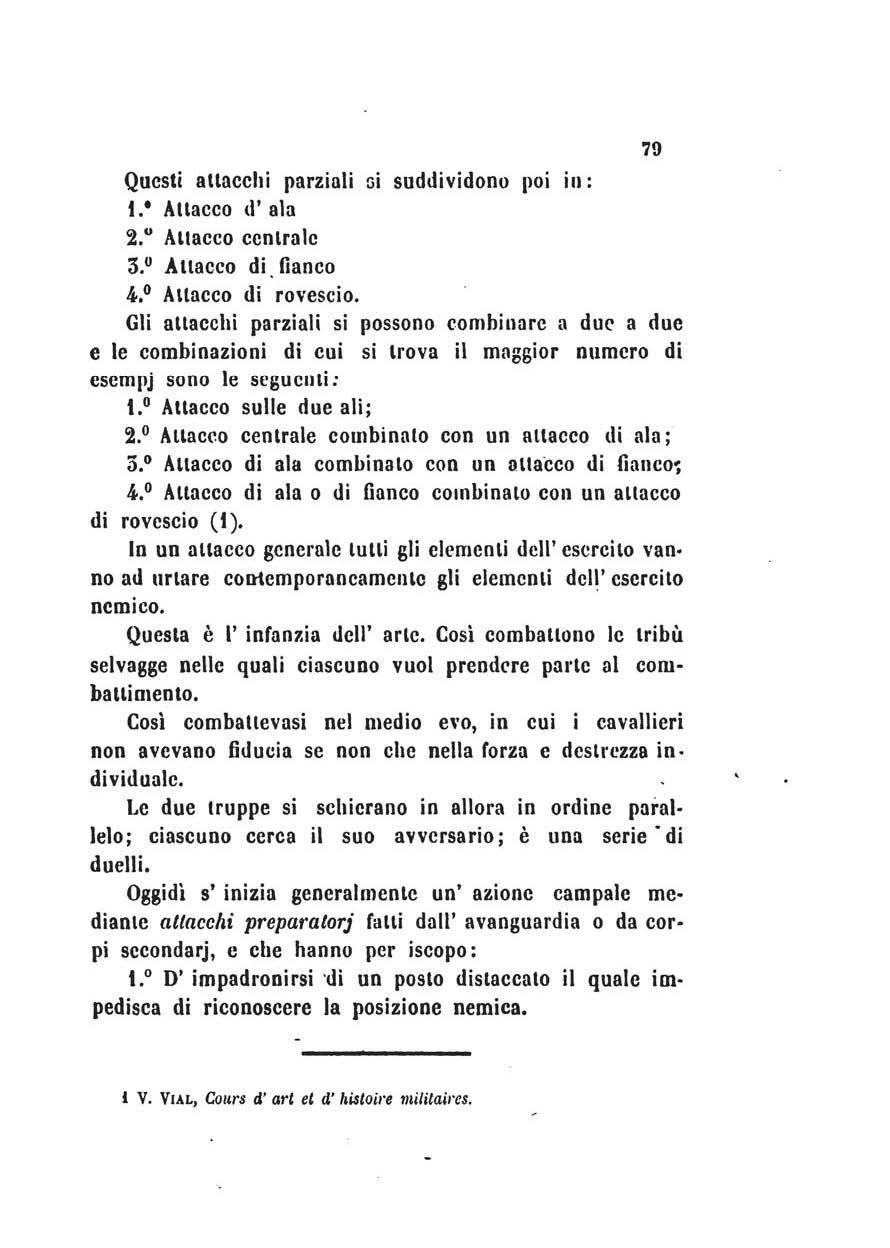
f. 0 D' impadronirsi ·di un posto distaccato il quale impedisca di riconoscere la posizione nemica.
l V. VJAL, Co11rs d' art et cl' hist oire militaii 'CS.
Di aUirarc l' attenzione dell' avversario sopra di un punto diverso dal \'ero pt.mlo d' auacco.
5.'' Di pr<'Jlnrarc alcune volte un attacco parziale.
Gli attacchi pnrzinli che vengono · in seguito sono .eseguiti da una delle ·grandi frazioni dell' ordine di hallaglia, da un' aln, dal centro, o da un corpo distaccato.
Finalmente, quanrlo gli attacchi parziali sono riusciti, si passa allora oli' attacco ' géncrnle.
Le condizioni generali n cui debbono soddisfare tuui gli ordini di battaglia offensivi sono le seguenti:
t." Saronno formate le lince c le riserve. Gencrnlmenie parlando, e senza tener calcolo delle circostanze porziali, si formano due linct•, le riserve parziali, c una riserva se · nera le.
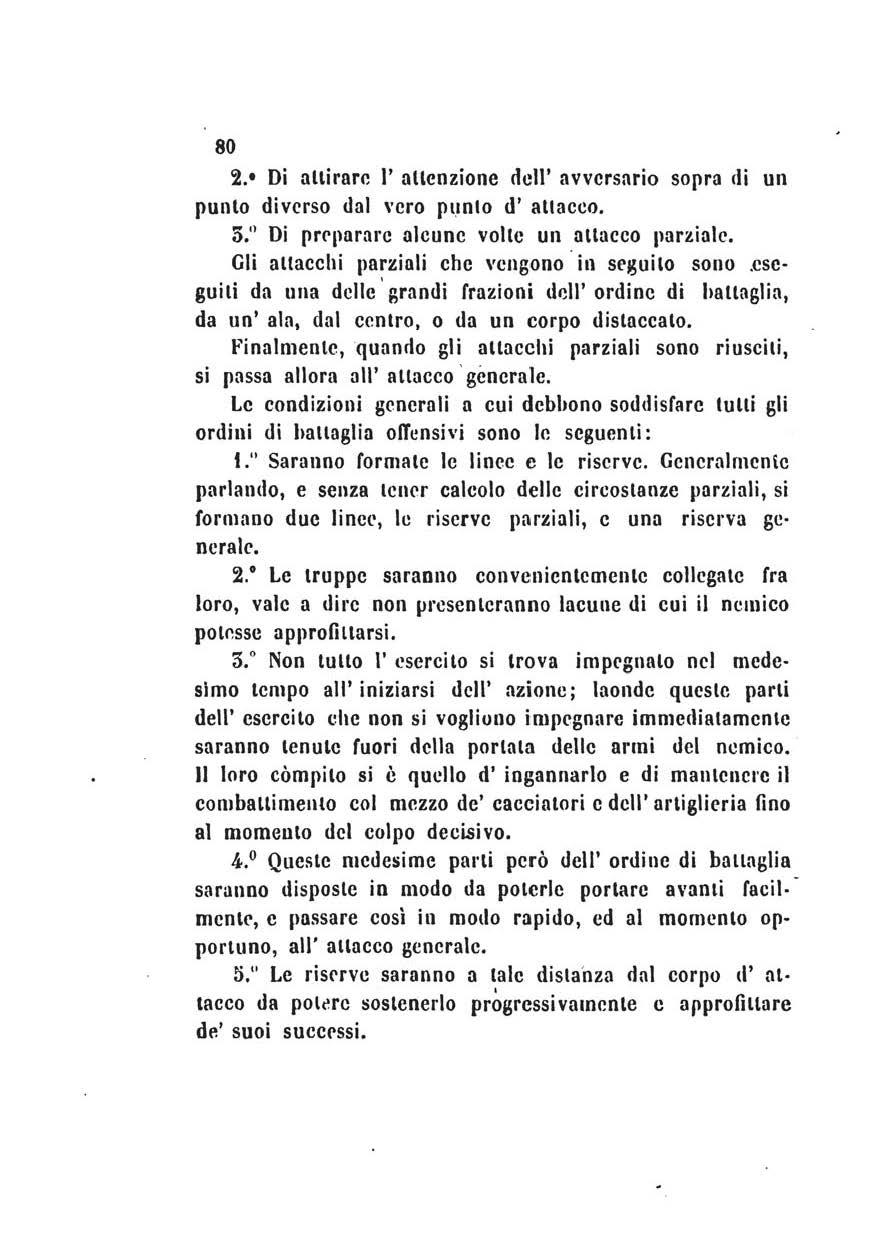
2.• Le truppe saranno convenientemente collegate fra loro, vale a dire non presenteranno lacune di cui il nemico approfillarsi.
5.0 Non tutto 1' esercito si trova impegnato nel medesimo tempo all' iniziarsi dell' azione; laondc queste parti dell' esercito l!ltc non si vogliono impegnare immediatamente saranno tenute fuori della portata delle armi del nemico. Il loro còmpito si è quello d' ingannarlo e di mantenere il combattimento col mezzo de' cacci ntori c dcii' artiglieria fino al momento del colpo decisivo.
4. 0 Queste medesime pa1·ti però dell' ordine di battaglia saranno di sposte in modo da potcrlc portare avanti facil· mente, c pnssare così in motlo rapido, ed al momento opportuno, all' attacco generale.
5." Le risrrvc saranno a tale distanza dnl corpo d' nt· tacco da sostcnerlo progressi vamcnte c approfillnre dr.' suoi succrssi.
6. 0 L' aspetto generale dell' ordine di battaglia offensivo dev' essere tale che il nemico non posso distinguere immediatamente il punlo su cui si vogliono dirigere gli sforzi.
7.° Finalmente il corpo d'attacco avrà dl"t;li elementi di superiorità sulla paa·tc corrispondente dell' ordine di battaglia del nemico.
Scelto il punto d' attacco, fa mestieri di formare un corpo il quale sia incar icato di dirigere i suoi sforzi contro di esso e .di impatlronirscoe; impcrocchè, come dicemmo, non tuuc le forze s' impegnano o si possono impegnare contro un dnto punto: questo corpo è il corpo d' attacco . Esso dev'essere costituito in guisa da soddisfare allo scopo pcl quale viene formato .
In quanto alla sua composizione diremo che il .corpo di attacco si compone delle tre armi le quali sono necessarie pel . meccanismo del combattimento, e che formano colla loro combizionc, lo strumento di guerra più perfeLto e più completo .
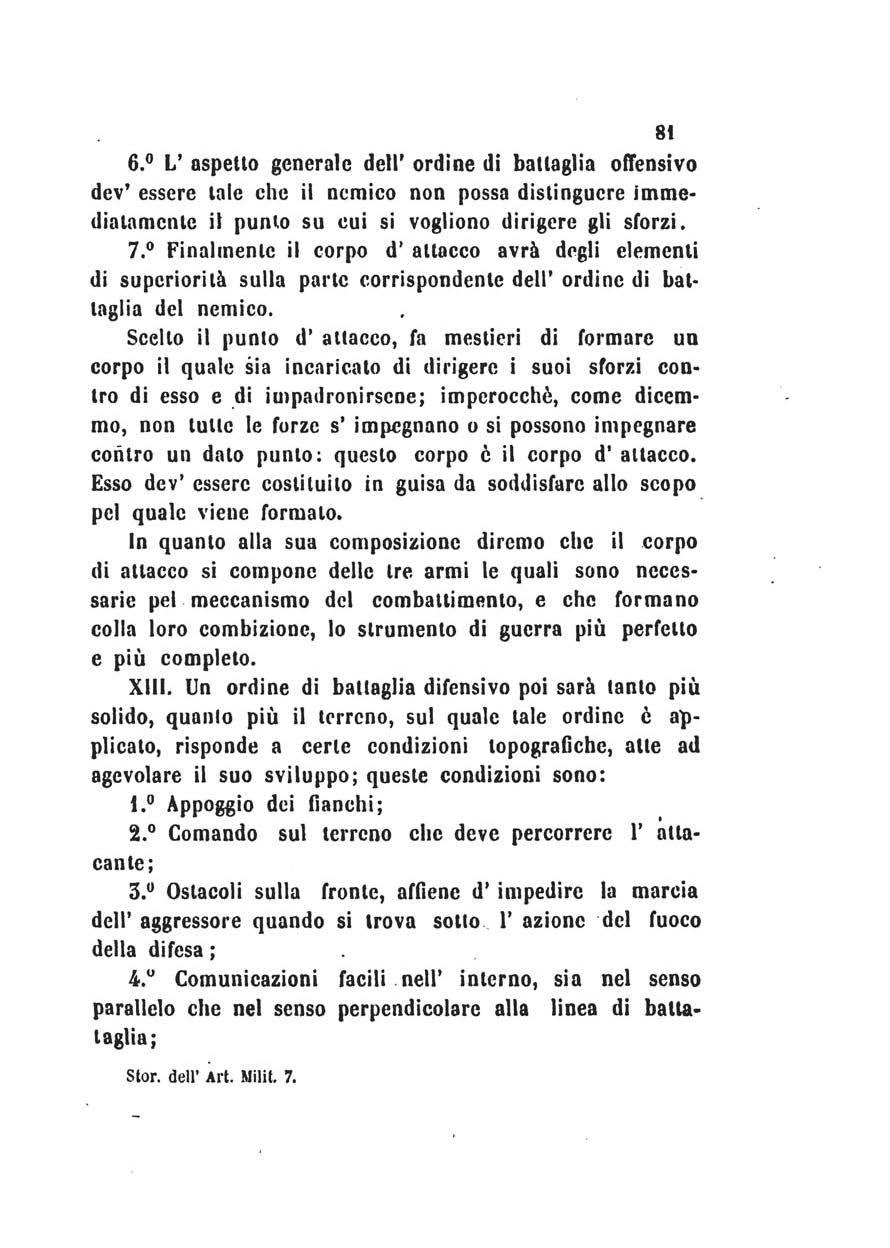
Xlii. Un ordine di battaglia difensivo poi sarà tanto più solido, quanto più il l<'rrcno, sul quale tale ordine è applicato, risponde a certe condizioni topografiche, atte ad agevolare il suo sviluppo; queste condizioni sono: t. 0 Appoggio dci fianchi; .
2.° Comando sul terreno che deve percorrere l' ollncante;
3.0 Ostacoli sulla fronte, affiene d' impedire la marcia dell' aggressore quando si trova soLto .. l' azione ·del fuoco della difesa ;
4.11 Comunicazioni facili . nell' interno, sin nel senso parallelo che nel senso perpendicolare alla linea di battataglia;
Stor. dell' Art. Nilit. 7.
ts. 0 Una profondità sufficiente per poter manovrare agevolmente.
6. 0 Una via di ritirata, per quanto possibi1e, al coperto dag1i attacchi del ncmieo e difesa d(d complesso delle forze difensive, ciò che. equivale a dire; l' oggettivo ossia il punto strategico in buone condizioni difensive.
Quando taluna delle condizioni ora enumerate fa difello, e si ha il tempo necessario per riparare a tale inconveniente, l' arte della fortificazione campale è chiamata a cercare o completare ciò che manca, sempre che il farlo non ollrapassi i limiti dei suoi mezzi.
XIV. Ci resto per ultimo la descrizione di una battaglia; c ad eseguire questo còmpito ci serviamo delle parole stesse de1 Dc Cristoforis, nella sua au1·rn opera • Cltc cosa sia la guerra. •
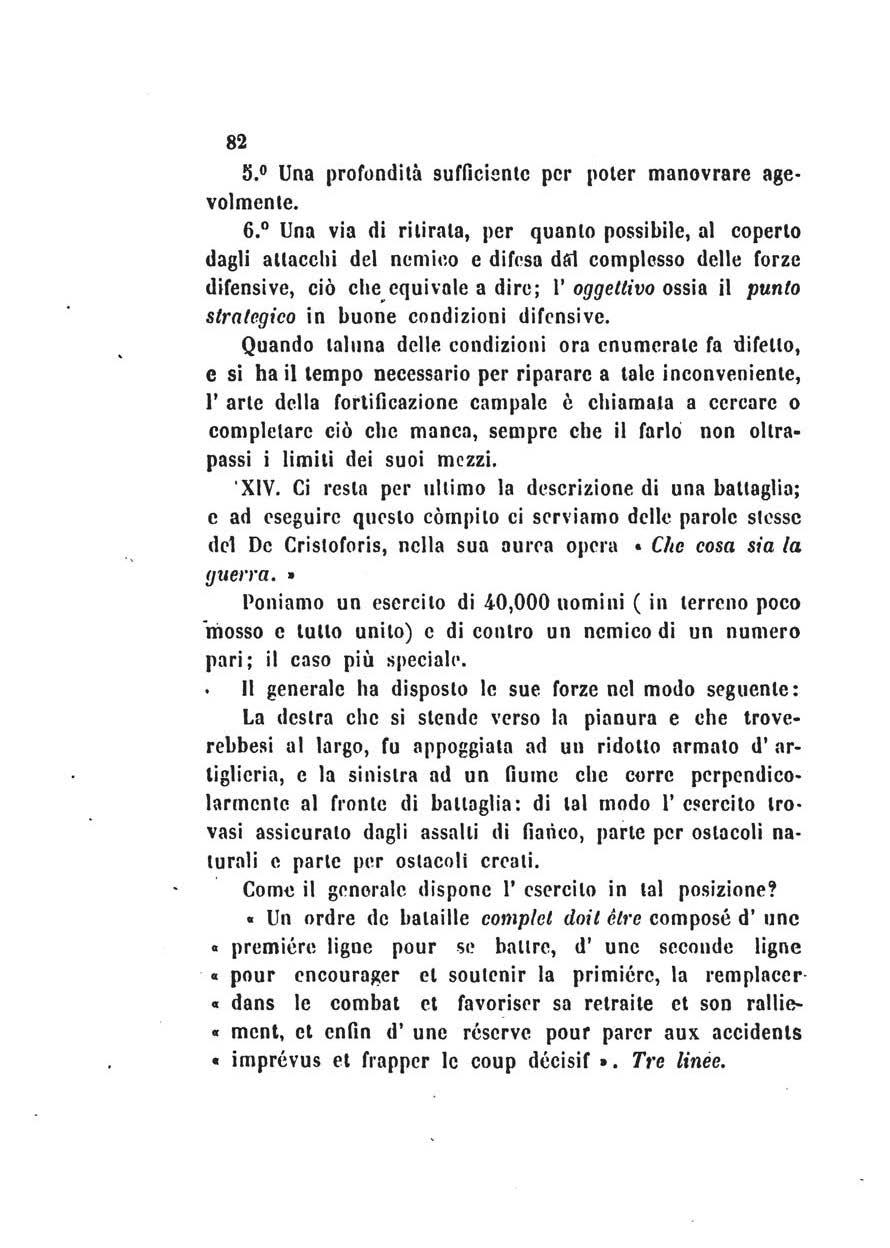
Poniamo un esercito di 40 ,000 uomini ( in terreno poco -n'tosso c tutto unito) c di contro un nemico di un numero pari; il caso più special1•.
Il generale ha disposto le sue forze nel modo seguente:
La destra che si stende verso la pianura e che troverebbe!li al largo, fu appoggiata ad un ridotto nrmnto d' artiglieria, c la sinistra ad un fìumc che corre pcrpcndicolarmcnlc al fronte di battaglia: di tal modo l' C!lcrcito tro· vasi assicurato dngli assnlti di fìaoco, parte per ostacoli naturnli c parte per ostacoli creati.
· Come il gr.noralc dispone 1' esercito in tal posizione?
• Un ordre dc bataille complct doil étre composé d' une • prcmiére ligoe pour !ie hnttrc, d' une seconde ligne • pour cncourager et soutcnir la primiérc, la J'emplncer·
• dans le combat et favoriscr sa retraite et soo rallie• ment, et enfìn d' une réservc pour parer aux accidents • imprévus et frappcr le coup décisif •. Tre linee.
Così ha suggerito al nostro generale l' autore delle Considéralions sur l' at't de la guerre, ma Napoleone ha risposto:
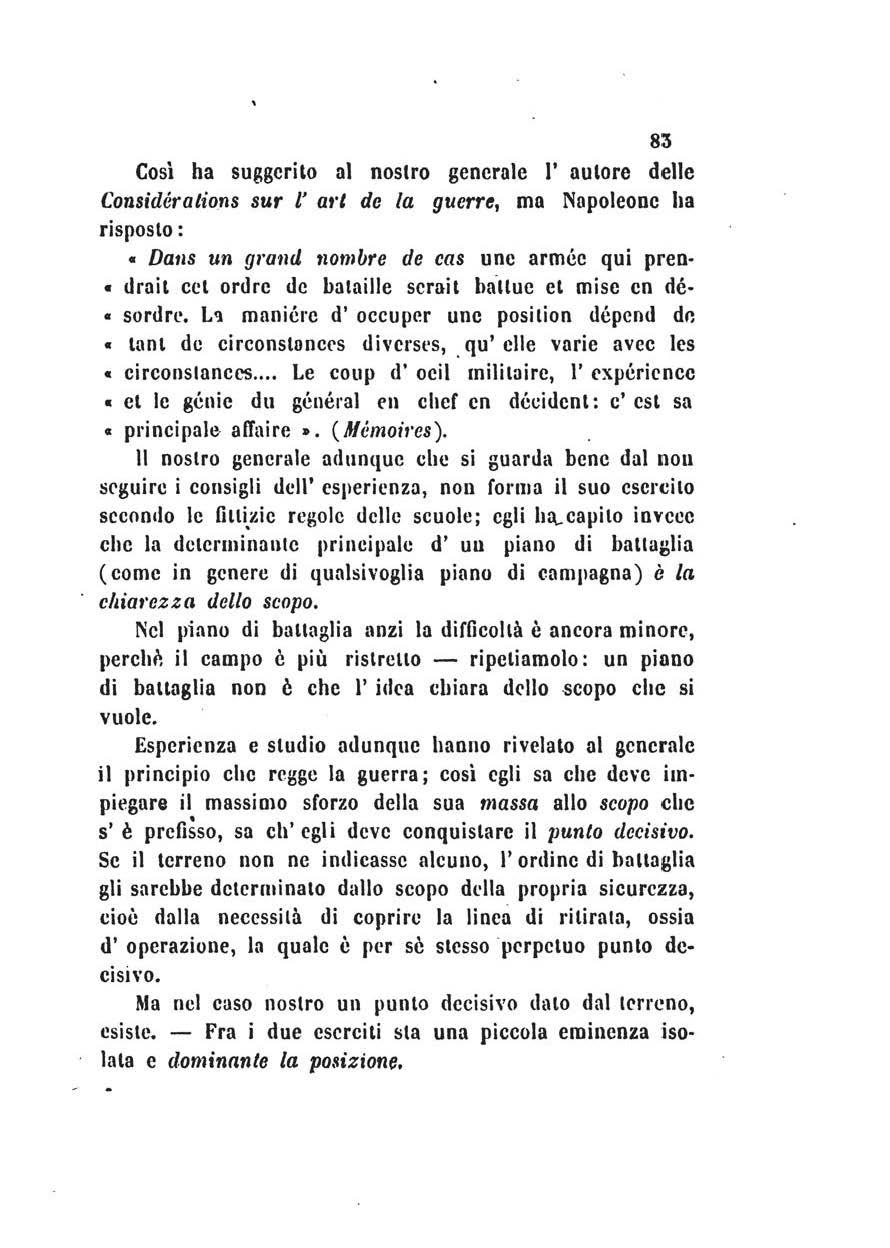
• Daus un grand tlombre de cas une arméc qui pren·
drait cct ordrc dc bataille scrait ba.lluc el mise co dé-
sordre. L'l mnniérc d' occuper une position dépend
tant dc circonstoncrs divet·st•s, . qu' elle varie avcc Ics
circonslanccs.... Le coup d' oeil militaire, l' expériencc
et le génic du général en chef cn décidcnt: c' est sa • principale atTaire •. (Mémoif'es).
li nostro generale adunque che si guanla bene dal non srguirc i consigli dell' esperienza, non forma il suo csct·cilo secondo le fiui.zic regole delle scuole; egli ha_capito invece che la determinante principale d ' uu piano di (come in genere di qualsivoglia piano di campagna) è la cllia,.ezz a dello scopo.
Nel 11iano di bauaglia anzi la difficoltà è ancora minore, perchil il campo è più ristretto - ripcLiamolo: un piano di battaglia non è che l' idea chiara d<'llo .scopo che si vuole.
Esperienza e studio adunque hanno rivelato al generale il principio che regge la guerra; così egli sa che dc•;c impiegare il massimo sforzo della sua massa allo scopo <:he s' è prefisso, sa ch' egli deve conquistare il punto decisivo. Se il terreno non ne indicasse alcuno, l'ordine di gli sarebbe determinalo dallo scopo dl'lla propria sicurezza, cioè dalla necessità di coprire la linea di ritirata, ossia d' operazione, la quale è per sè stesso ·perpetuo punto dccisJ\'O.
Ma nel caso nostro un J.lUlllO dccisi\'o dato dal terreno, esiste. Fra i due eserciti sta una piccola eminenza isolata e dominante la posizione.
Egli è adunque evidente che colui che ne rcslt>rà definitivamente padrone avrà acquistato un ''antaggio sì grave, da esserne decisa . ln bilancia della giornata, Lo scopo è adunque la conquista della collina; il piano della battaglia ne sarà allora d<'finito.
Dodicimiln uomini spiegnti sul fronte di btlltaglin tengono il nemico io rispetto, c sono sostenuti o l<!J'go, quà e là secondo le opportunità del. terreno, ( l in colonne per divisioni o per compagniE>, da altri dieci mila (_tan ti ne comporta il terreno).
Sono altrettante riserve parziali. La distanza di qucile truppe di sostrgno, se al tra ragione non esis te, è detenninata dalla velocità della loro marcia; abbisogna alla cavallerin un mezzo minuto per percorJ'I!rc 200 metri, c ne ab· bisognano due alla fante ria. · Un corpo di 8,0{)0 uomini è incarico lo dell' assalto dt'l monticello; sta a 500 passi dietro le prime truppe, in colonnr per divisioni. Una riserva. generale dci rim:menti tO ,OOO uomini sta dielro, tutti a 250 passi, in colonne di compagnie; là si è posta perchè un rialzo del terreno la dai colpi diretti dd nemico. Esso rimane immediatamente solto gli ordini a sola disposizione del generale in capo ; nessun altro, per nessuna nece ssi ta, può usarne un sol battaglione, una sola compagnia: comprende tutta la pesante c tutta l'artiglieria da posizione. Ogni divisione si trova intera in prima linea o nella ris<'rva . Tutti i corpi sono composti delle tre armi. Lo scopo massimo della battaglia è comunicalo ai generali sulJnltcrni che guideranno alla lotta le va•·ie masse; quei generali sanno che le grandi divisioni dell' esercito sono sol\oì:ncsse al piano, e le piccole alla condotta del è adunque loro concessa una certa latitudine di libera azione.
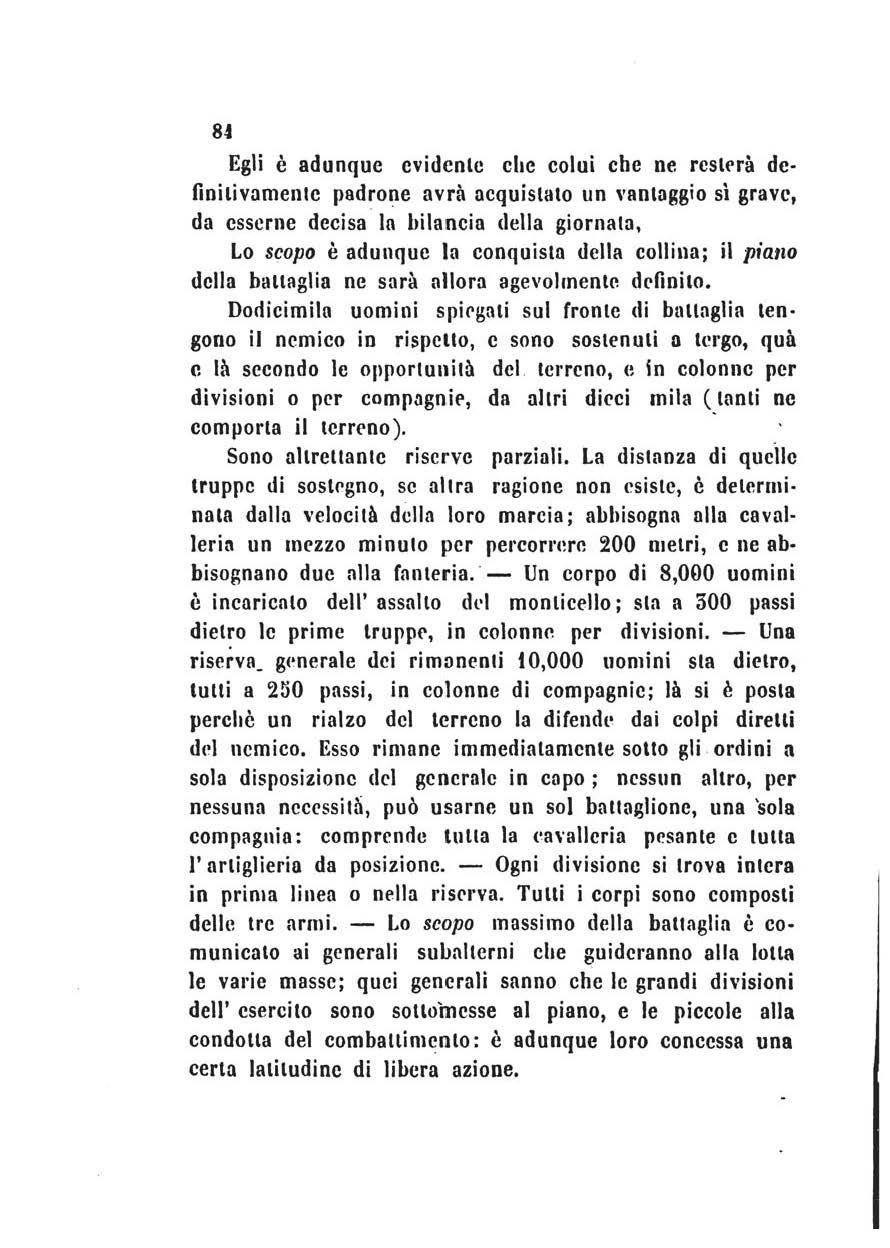
Il soldato è già impaziente di vedere il combattimento e di prendervi parte.
L'attacco comincia. L'artiglieria divisionale postasi in con,·eniente posizione comincia a battere obbliquamentc quella pal'te del corpo nemico che tiene il basso dell'eminenza; un nu,•olo di truppe legg ere si stende in ordine sparso; .e dietro, frattanto, marciano le colonne d'assalto per divisione, pronte n spi<>garsi in un baleno nl primo istante favorevole, e dietro loro le riserve immediate e parziali. La cavalleria alle nli tiene in rispetto il nemico che vorrebbe caricar di finnco li assalitori c non osa· c si rigira come impaziente.
Se l' impresn riesce, i1 nemico, reso già titubante dal fuoco dei nostri cannoni, cede nll' aspetto della terribile bojonetta; il generale dà ordine alla prima linea intero di avanzarsi e di proseguire il primo vantnggio ottenuto;ecco, gli umziali portatori dell' ordine attraversano in ogni senso il campo di battaglia, la Alat·cia in battaglia si spiega • in tutta la maestà della guerra • fa tremare il suo lo c i cuori nemici, e dal monticello cosi conquistato comincia a folgorare la nostra riunita .
Se la resistenza nemico sul punto decisivo è inv<>ce più forte di quello si fosse preveduto, se le nostre giovani truppe non hanno ancora tutta l ' audacia ·c la ferm ezza d i vecchi soldati, le risr.rve parziali accorrano sui punti oscil.lanti; tutta la prima linea che allora s i trova impf'gnota nella lotta ne è a t empo soccor sa; la battaglia diventa gcncrnle, e la prossima speranza rionimnndo i nostri, rende allora irresistibile il loro urto; In massa formidabile si ricompo ni!, i nemici sulle prime righe incessanlc ruoco, ma non mancano \'alorosi capi e disperati s<'guacii, c tutto ciò che vive s' nvnnzn; - inlìn c il tlr.lla
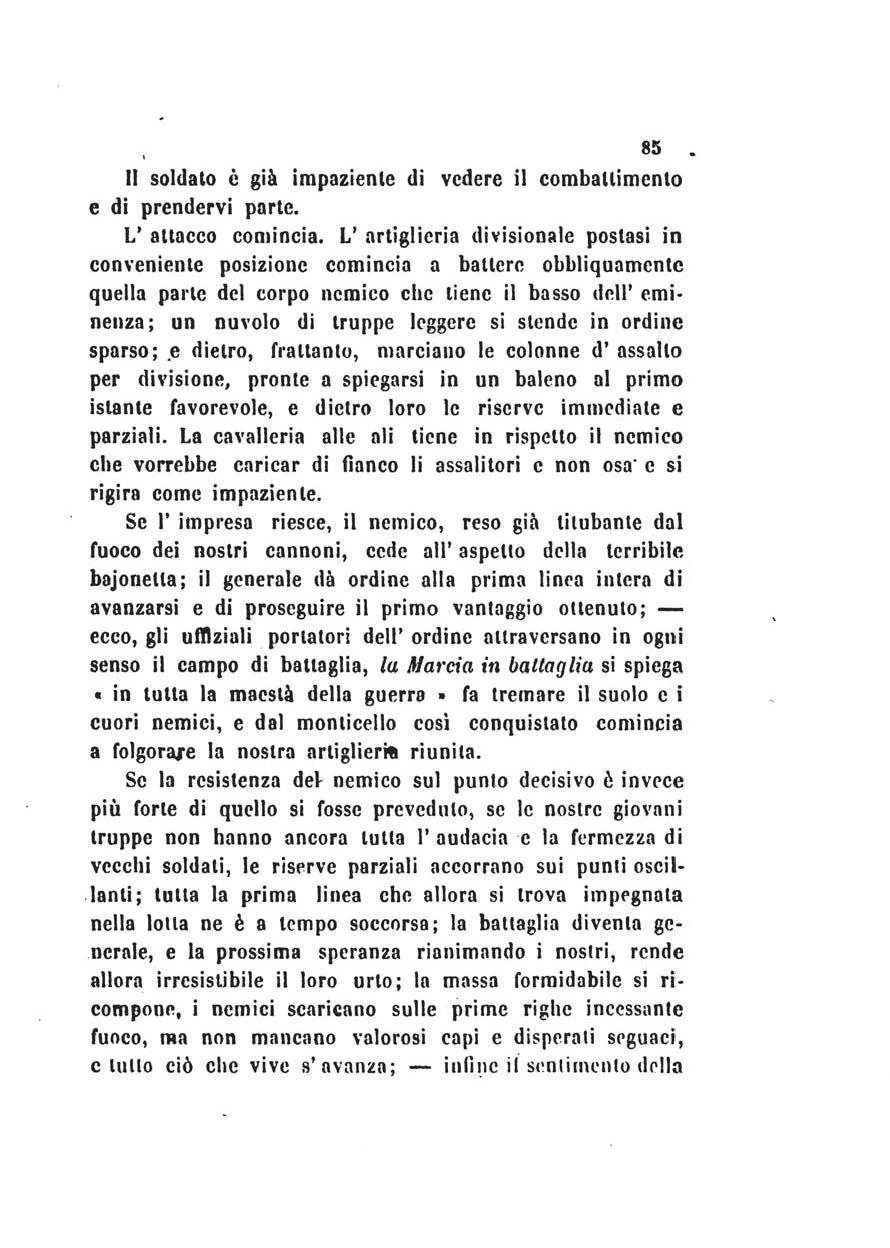
sua inferiorità decide il nemico alla ritirata prima che la grossa riserva, che E'gli dn longi già vede avanzarsi, abbia riuscito a cambinr In sconrìlln in disllstro.
La sera è giunta, le tincc sono in pieno movimento o retrogrado, od · in avanti, c la nostra cavalleria sfondando gli ultimi quadrati, O\'C il nemico valo roso tenta l ' ullima disprrata che salvi, se non la .vi ttoria, almeno l' onore del vinto, raccogliendo prigionieri, impnd•·oncntlosi di cannoni e bandiere, ammassa i frutti utili c gloriosi della ballagli a; la rnvallrria leggera alfine in· comincia il lun go inseguimento; i rimbombi del cannone si allontanano, c vincitori e vinti, gli uni sull' orma degli nltri, scompajono nlln nostra vista dietro le ondulazioni del terreno. Le prime titubazioni dci nostri giovani soldati sono dimenticate nelle esullanzc della villorin.
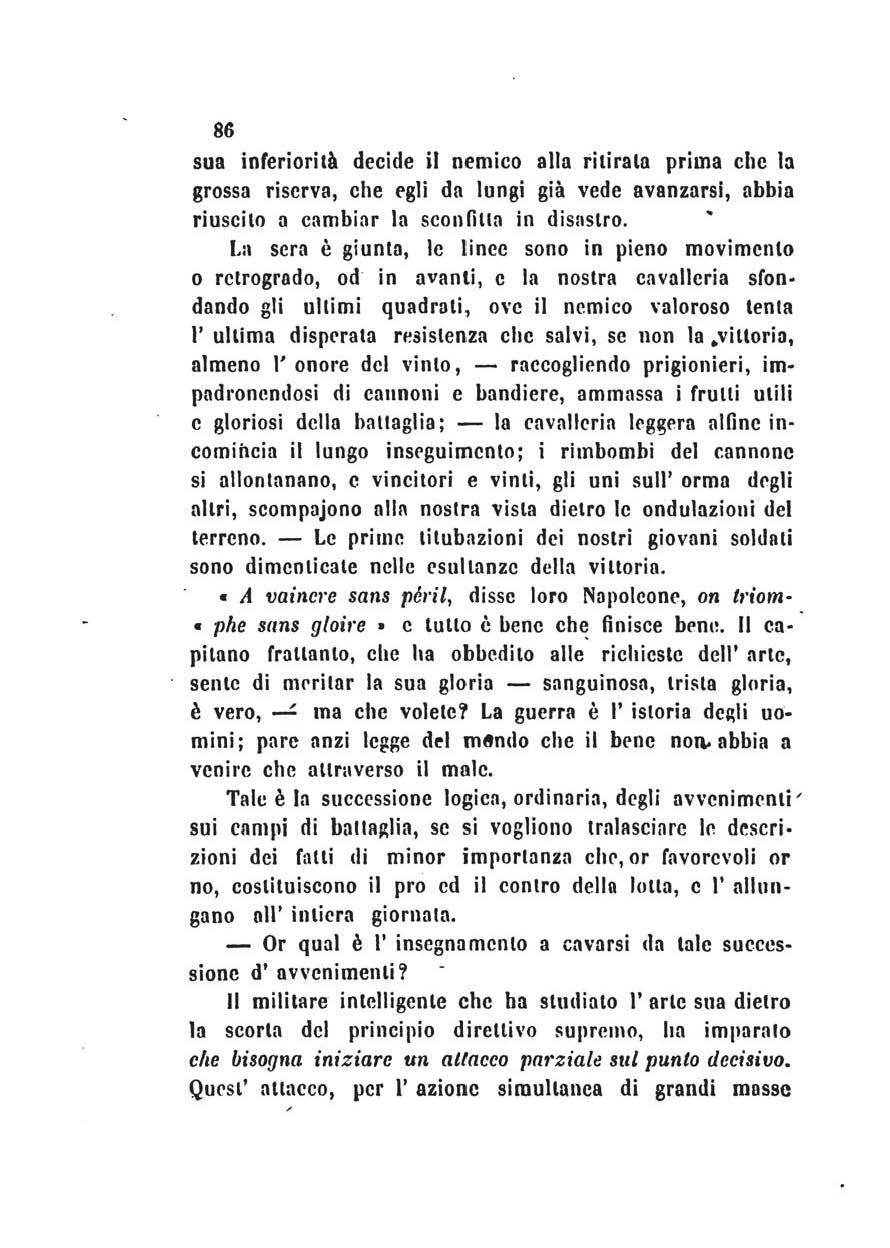
• A vaincre sans péril, disse loro Napoleone, on tfiom• phe SftnS gioire • c tullo è bene finisce bene. Il capitano frattanto, che ha obbedito alle richieste dell' arte, sente di mrritar la sua gloria - sanguinosa, trista glnria, è vero, ma che voletc't La guerra è l' istoria degli uomini; pare nnzi legge del mttndo che il bene non. abbia a venire che attraverso il male.
Tale è la successione logica, ordinoria, degli avvenimenti' sui cnmpi di se si vogliono tralasciare le descri· zioni dci falli di minor importanza che, or favorevoli or no, costituiscono il pro cd il contro dellt1 lotta, c l' allungano oll' inticra giornata.
- Or qual è l' in seg nam ento a cavarsi da tale successione d' avvenimenti?
Il militare intelligente che ba studiato l' arte sua dietro la scorta del principio direttivo supremo, ha imparato elle bisogna iniziare un attacco pm·ziale sul punto d ecisivo. Quest' attacco, per l' azione simultanea di grandi mosse
sopra un · tal punto, dà un successo probabile c •·code così probabile anche la buona riuscita dell' attacco generale che è fatto tosto dopo, con tu forze.
Ecco a che si riduce ogni c qualunque ordine di battaglia: prelude1·e all' azione gt.•ncrnlc ·c.on un allocco pnrzialc sul punto decisivo. Si capisce in tal modo co1nc ogni ordine possibile di ballaglia nnsca naturalmente dalle circostanze del terreno o dalla disposizione delle truppe nemi· che; se il punto decisivo trova si al centro, ne nascerà .. quello che nelle scuole è · chiamato attacco in ordine con· vcsso, se trovasi verso un ' ala, un. attacco obliquo, ccc:. ccc. e tutto ciò per forza. di cose, non per geome'tria di gabinetto, perchè mentre il corpo d' attacco parziale s' avanzerà più che il resto (e dietro a lui parte delia prima linea al suo soccorso), 1• altre parti della linea non s'impegneranno in combauimcnti compromettenti, c tenendo il nemico occupalo in lotte lontane di artiglieria c di truppe legger e, aspetteranno più da lungi l'esi to dt•ll' attacco sul punto decisivo, per avanzarsi poi alla loro volta con pro. .. bnbilità di succe sso totale.
È così che tutte quelle classific:azioni scolastiche ,che ci pongono innanzi una dozzina di ordini possibili di bat· taglia, non sono che espedienti, simmetrie fittizie, divenute necessarie a porre un qualunque nella · materia, poichè non si sa farlo nascc•·c dalla natura stessa delle eosr, cioè da un fatto unico ed univer sale n da un principio genetico semplice e chi{lro . - Il princi]Jio è che ln preponderanza della mnssa decide della vittoria. - /t fatto è l' nltncco parzinle, conseguenza nE'ccs sn rin di quel principio.
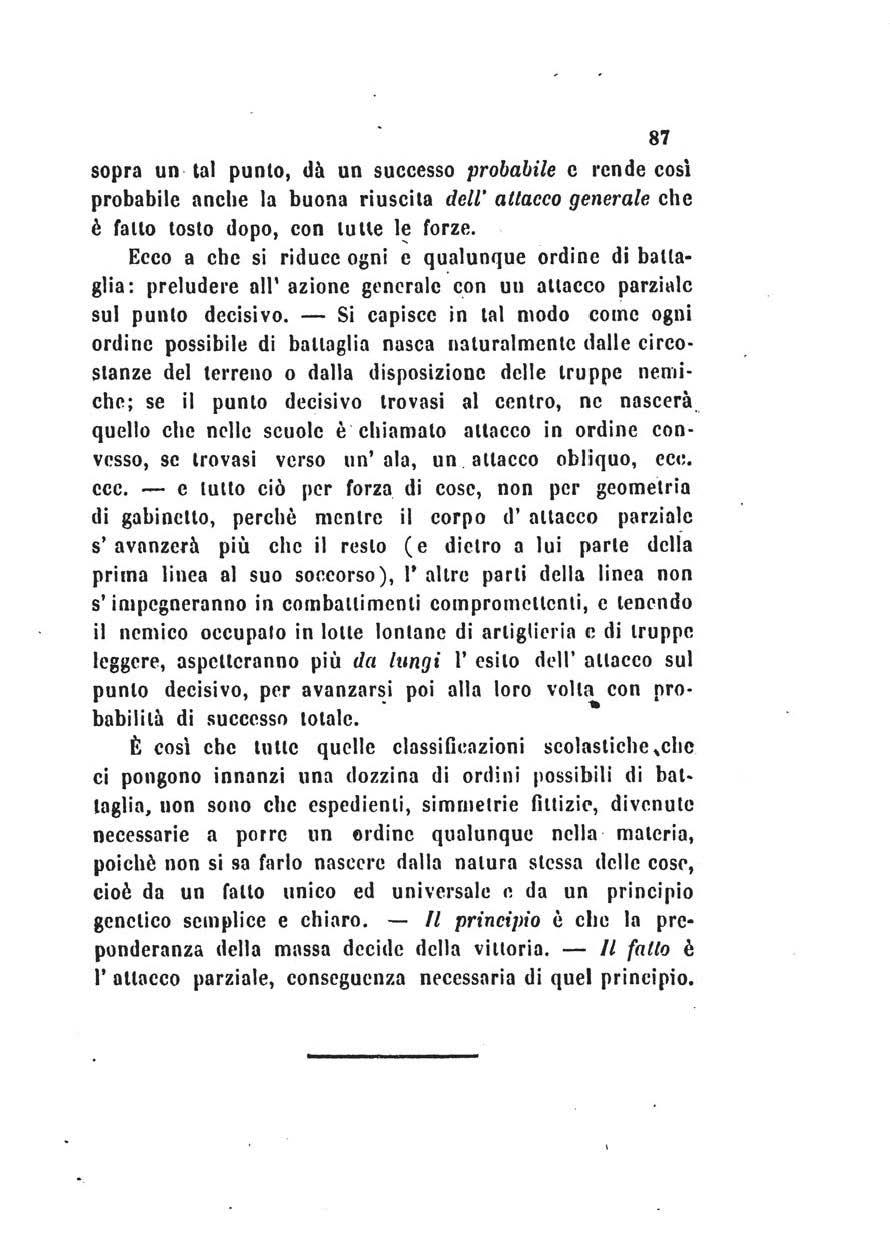
La Grecia, comprendeva una quantità di piccoli regni e di piccole repubbliche, quasi" sempre in guerra tra loro, e che non facevano alleanza se non che per respingere il nemico comune.
La prima spedizione della Grècia fu quella degli argonauti che nel t 550 A. G. C. andarono alla conquista del vello d' oro: esso resta pressoccbè intieramentc nel dominio della mitologia.
La prima guerra di qualche importanza fu quella di Tcbc nel t 515 A. G. C. delta ancora dci Sette Capi, in cui Polinice con Adrasto cd nltri cinque principi andò aJia conquista del trono di Tcbc, da cui era stoto escluso da suo fratello Eteocle. L' operazione principale fu l' nssedio di quclln ciltà.
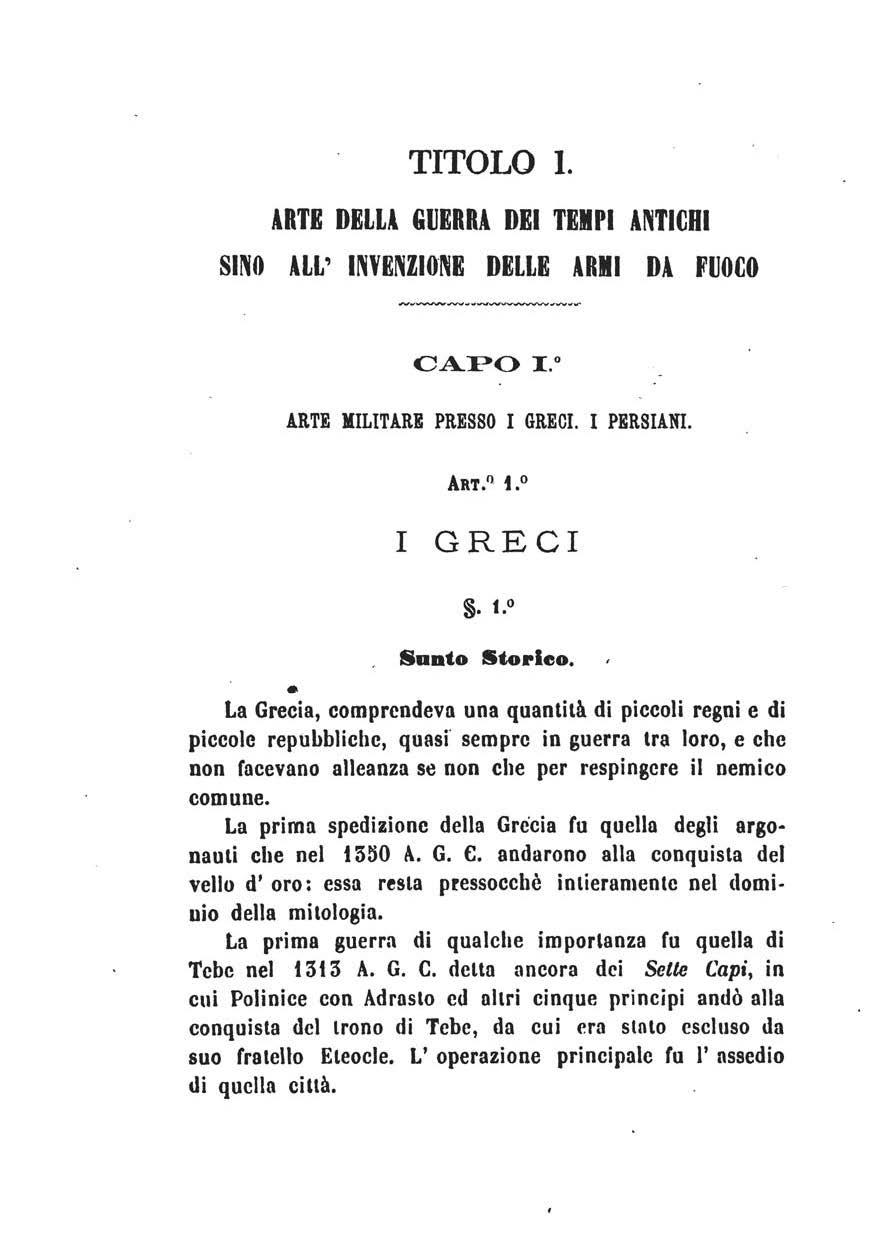
8t Riù turdi, nel t270, ebbe luogo 1' assedio di Troja elle durò dieci anni, e finl coll' incendio della cillà e la di · struzione del •·egno. Fu guerra di gelosia. l popoli che rappresentarono la .prima parte in Grecia furono gli spa1·tani e gli ateniesi.
Vicino alla Laconia, di cui Sparla era capitale, trovavasi la Messenia, paese fertile che faceva singolare contrasto col suolo arido di Laconin. Gli spartani, sotto pretesto di vendicare ·un insulto che forse non avevano ricevuto, dichiararono la guerra ai messenj , e Ji soggiogarono. Fu guerra di preponderanza; guerra civile.
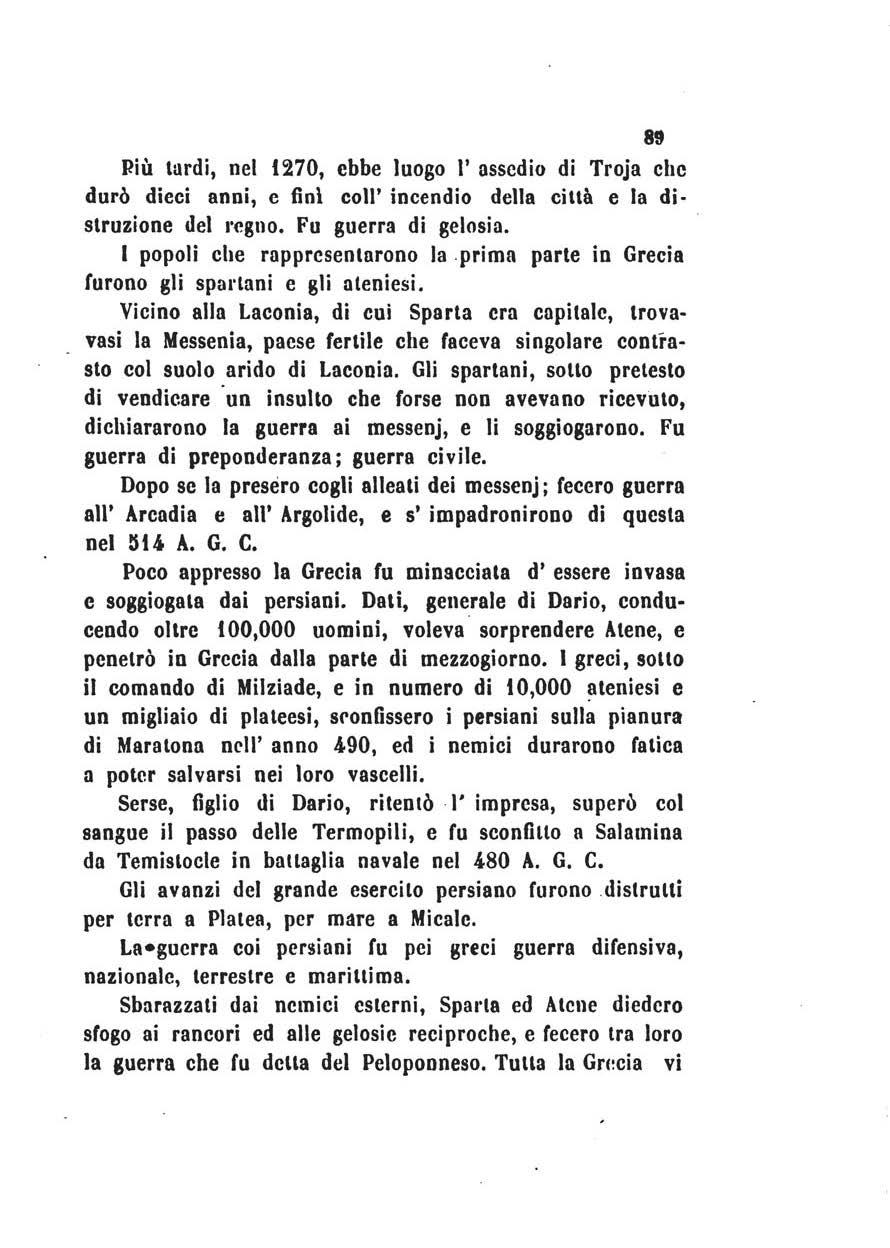
Dopo se la presero cogli alleati dei messenj; fecero guerra all' Arcadia e alt' Argolide, e s' impadronirono di questa nel !SU A. G. C.
Poco appresso la Grecia fu minacciata d' essere invasa e soggiogata dai persiani. Dati, generale di Dario, conducendo oltre f 00,000 uomini, voleva · sorprendere Atene, e penetrò in Grecia dalla parte di mezzogiorno . 1 greci, solto il comando di Milziade, e in numero di 10 ,000 e un migliaio di plateesi, sronfissero i persiani sulla pianura di Maratona nell' anno 490, ed i nemici durarono fatica a poter salvarsi nei loro vascelli . Serse, figlio di Dario, riteotò ·l' impresa, superò col sangue il passo delle Termopili, e fu sconfitto a Salamina da Temistocle io battaglia navale nel 480 A. G. C.
Gli avanzi del grande esercito persiano furono .distrutti per terra a Platea, per mare a Micalc.
La•gucrra coi persiani fu pci greci guerra difensiva, nazionale, terrestre e marini ma.
Sbarazzati dai nemici esterni , Spa1·ta ed Atene diedero sfogo ai rancori ed alle gelosie reciproche, e fecero tra loro la guerra che fu della del Pelopooneso. Tuua la Gn:cia vi
prese parte ; chi con lsparta, chi con Atene. Si diedero molle bauaglic, frR cui la prima di Mantinea tra gli argivi c i lncedcmoni comandati da llrasida c da Agid1•. Finì la guerra colla peggio di Atene alla bnllnglia di Egospotamos, dopo aver durato dal 405 al 45t ossia per lo spnzio di 26 anni. Fu guerra civile, terrestre c marittima.
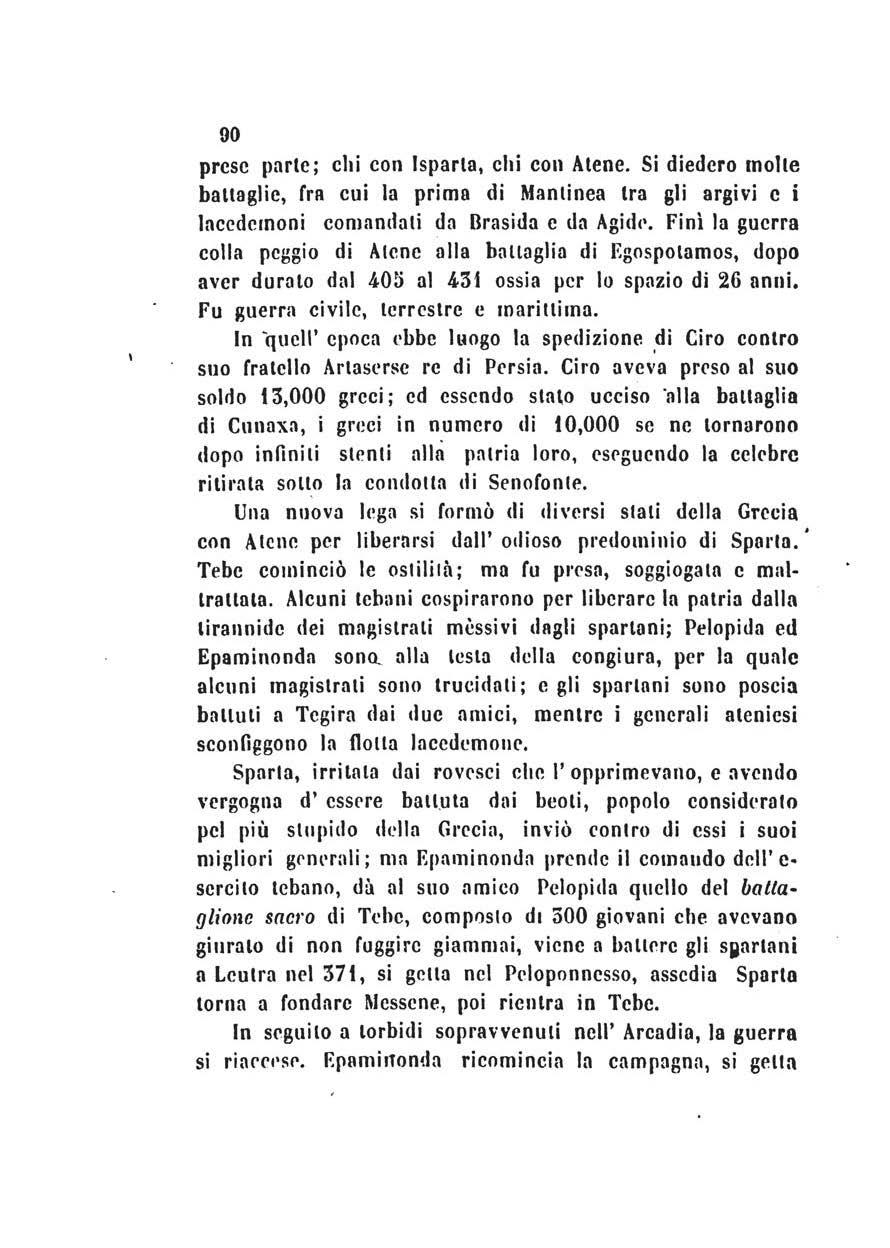
In quell' epoca l'hbc luogo la spt>dizione ,di Ciro contro suo fratello Artnscrgc re di Pcrsin. Ciro aveva prrso al suo solrJo t 3,000 greci; cd essendo ucciso ·alla battaglio di Cnnnxn, i greci in numero di tO ,OOO se ne tornarono dopo infiniti str.nti nllà patria loro, esrgucndo la celebre ritit·ata solto In condotla di Senofonle.
Una nuova lt!g a si formò di cli\'crsi slati della Grecia con Atene per lib unrsi dall' 01lioso pt·edominio di Spot' lo.' Tebe cominciò le ostililà; ma fu pt·csn, soggiogatn c mnllrauota. Alcuni tchani cospirnrono per liberare In patria dalla tirannide dei magi s trati mèssivi dagli spartani; Pelopida ed Epaminondn sonQ alla lesta della congiura, per In qunlc alcuni magistrati sono trucidati; c gli spartnni sono poscia bnlluli a Tcgira dai due amici, mentre i generali ateniesi sconfiggono la flolla laccdcmonr.
Sparla, irritata dai rovrsci che l'opprimevano, c nHndo vergogna d' cssrre ball.ula dni beoti , popolo consid(•r111o pcl più stupido dl.'lla G1·ccia, inviò contro di essi i suoi migliori grm•rali; ma Epnminonda prende il comnudo dell' C• sercito tcbano , dà al suo amico Pclopida quello del batta glione sncro di Tchc, composto dt 500 giovani che avevano giuralo di non (oggirc giammai, \' iene O ballrre gli sgarlani n Lculra nel 37 t, si getta nel Prloponncsso, assedia Sp11rto torna a rondare Mcssene, poi rientra io Tcbe.
In seguito a torbidi sopraHenuti nell' Arcadio, la guerra si ri:H'<'t'sr. Epnmittonda ricomincia In campagna, si gella
9l di nuovo nel Prloponneso, nss<'dia Sparla, ma Agcsilno lo costringe n retroccdert>, e l' croP- tcbano termina la sua carriera vincendo contro il V<.'cchio re lac cde mone In seconda battaglia di Mantinca nel 565, rimancndovi però ferito mortalmente.
l.n potenza di Tcbc cadde col suo' eroe sul campo• di Mantinea: quella d'Atene era caduta ud Egospotnmos; Sparla decade va giornalmente.
Un' allra potenza sorgeva allora a dominare sulla Grecia. Filippo, re di MacPdonia, "ducatos i n Tcbc alla scuola di Epaminonda, crea In falange macrdont', si fa capo delle guer,.e sacre contro i foçrsi dapprima, i locresi sost<'nuti dagli e dai tcbani dappoi, vince a Ch eronea c di · viene signore della Grecia . Fino n lui i maccdoni vennero da' greci repulpli come barbari, ossia stranieri; solto di lui si effettuò l' unione dc' due popoli, sicchè il primo entrò nella gran famiglia del seco ndo, e d'allora in ·poi ne free parte intrgrnnte. Alla testta dci greci, fa disegno di andare in Asia pt•r distruggrre l' impero persiano, ma è ucciso da Pausania a tradimento.
Alessandro suo figlio gli succede. Dopo aver punito di ribellione alcuni popoli, fra c.ui i tcbani, ed aver distrutto Tcbe, si pose a capo della spedizione greca contro Dario re di Persia, si fa nominare generalissimo dd n<'ll' ns· scmblcn da lui convocutn in Corinto, ' ' incc al Grnnico e possa il fiume, vince ad Isso c fa prigione llJUa la famiglia di Dario; s' impadronisce di Dnmasco, di Sidone, di Tiro che assedia p"r sette mrsi, va contro s' impadronisce di Gaz:1, c quindi va in Egitto, ovc sotto · melle Menfi e getta le fondamento di Alessandria.
Dario nve,·n radunalc nuove forze, ma Alessandro le finccò ad Arbclla; Babilonia , Susa, c Perscpoli, cadono in
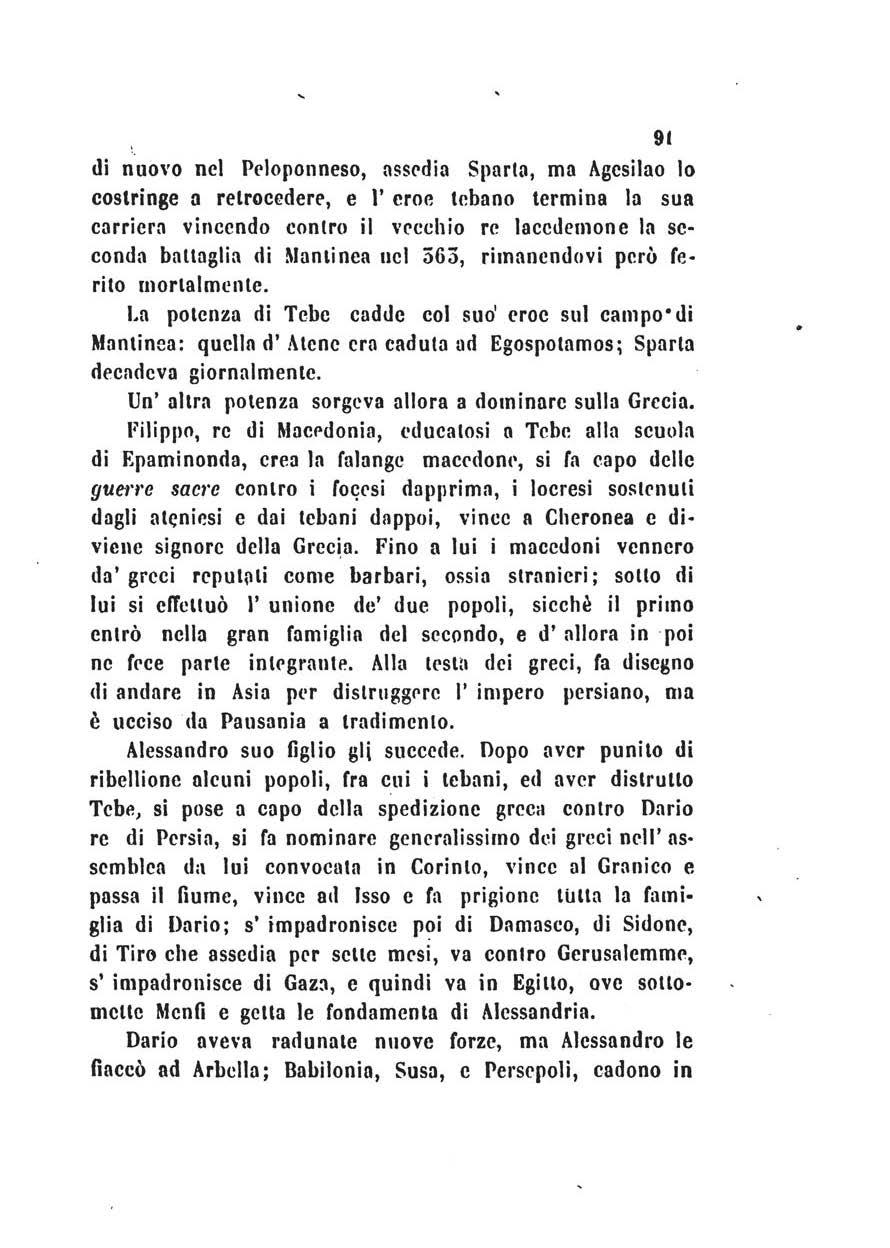
potere del vincitore; gli sci ti sono di là del Jaxartc. Alessandro va poscia allo conquista delle Indie, balte il re Porro, indi torna a Babilonia ovc muore d' intempcranzo.
l! impero d' Alessandro si sfasciò colla sua morte. 'l greci avevano formato una lega che si chiamava Achea; e siccome gli spartani volevano domil)arla, così vi furono parecchie battaglie, fra cui la terza di Mantinea vinta da Filopemene capo della lega contro Maccanidn tiranno .lli Sparla.
l romani, cresciuti in potcnzn, assalgono i re di Macedonia; le loro lrgioni rompono le falangi greche a Cinocefale nel t 97 e a Pidna nel 168 A. G. C.; indi battono e distruggono la lega Achea, e finiscono col ridurre la Gre('ia a loro provincia sotto il nome di Acaja. § 2.0
L' ·ordlnamcato.
Reclutamento. Tuni i eiuadini erano obbligati a servire nelle milizie in ogni stato della Grecia; cd il sistema di reclutamento noo offriva grande diversità fra l' una e l'a ltra delle repubbliche.
Non bastando i ciuadini si ricorreva, in Atene e Sporto, ad altri clementi: ai tlomiciliati, agli emnncipati, e persino agli schiavi, persino ai mcrccnaJ·j stranieri.
Parlando · di quelle due repubbliche, che furono le principali, diremo che gli ateniesi erano divisi in dieci tribù, e restuano ascrilli pel servizio militare dai diciolto ai quaranl' anni. l registr·i per la coscrizione erano tenuti da ufficiali eletti dal popolo. i quali chiamavano al l oro tribunale tutti i cittadini che si trovavano in tlà di portare le armi. Talvolla il governo fissava l' età deHe:: nuove leve, ese ntandone i più giovani ed i più at-
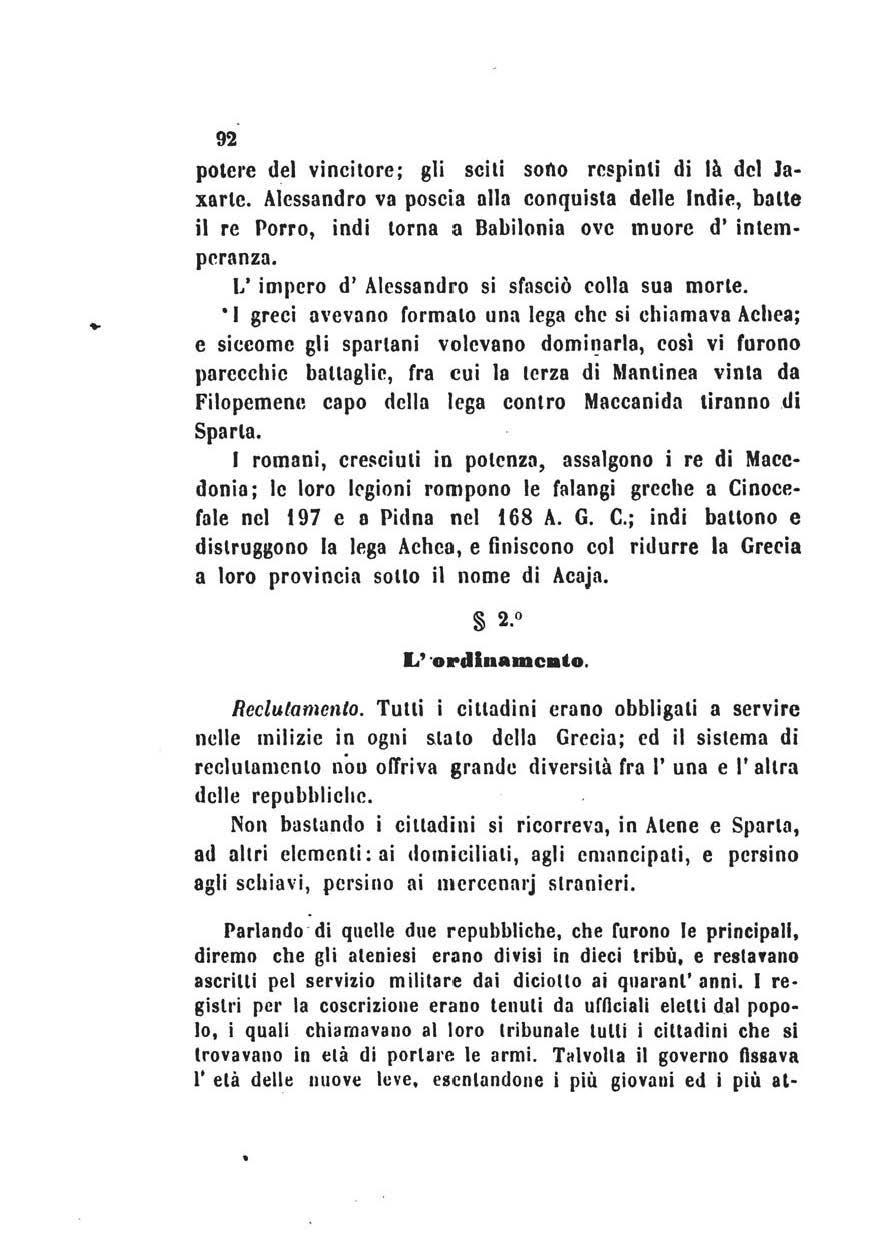
tempati; tal' aUra 11i traeva a sorte so lutti gl' isca·illi. Qualora il numero rlei cittadini non fosse stato bastevole alla cil'coslanza, si chiamavano sotto le armi, come dicemmo, i fol'eslit>ri domiciliali in Atene, gli emancipali, c perfino gli schiavi; si ar· ruolavano pur anco mel'cenarj stranieri; ma questi casi fnrono rari e l'esercito ateniese era per lo più composto di cittadini. Sparla era divisa in cinque tribù, in ognuna delle quali si teneva un regi11lro di tutti i cittadini che ne facevano pnrtc; nel giorno della leva, i magistrali decretavano quali tribù dovevano somministrare uomini per l'esercito. l cittadini erano obbligati a servire dai venti ai scssanl' anni ; ed a seconda del bisogno si chiamavano successivamente le classi. Non vi era più limite di età qualora il nemico fosse entrato nella Laconia di cui Sparla era capitale. Siccome poi gli spartaoi propriamente delli erano io piccolo numero, così ciii ama vano in aiuto i ci l· tadini del resto della Laconia i quali non godevano i medesimi privilegi degli spartaui, gli. emancipati, gli stranieri elle abitavano in lsparta, e nelle crisi straordinarie armnrono persino gli iloti loro schiavi. ·
Il reclutamento del rimanente della Grecia, ca·a presso a poco alla guisa di quello tlci due popoli suacccnnati, l' ate· nicse e lo spartano .
. ' 11 reclutamento ora descritto presentavasi però sotto due Casi, o, per meglio dire, i greci andavano soggetti a due requi· silioni. Alla prima nell'età di qu11ttordici anni; e questa non era Be DOD che un' iacriziooe SUi ruoli ; se non compievano questo dovere pagavano ammende ed erano sottoposti alla E quando una seconda volta il banditore pubblico chiamava co· loro ch' erano giuoli all' età del combattere, quale abbiamo aé· ceooala, ogni gionne cittadino che tardava a · presentarsi era punito di morte.
Prestavasi giuramento. lp Atene, p. e., il generale riceveva in un tempio codesto giuramento imposto alle truppe. A lui si presentava ogni
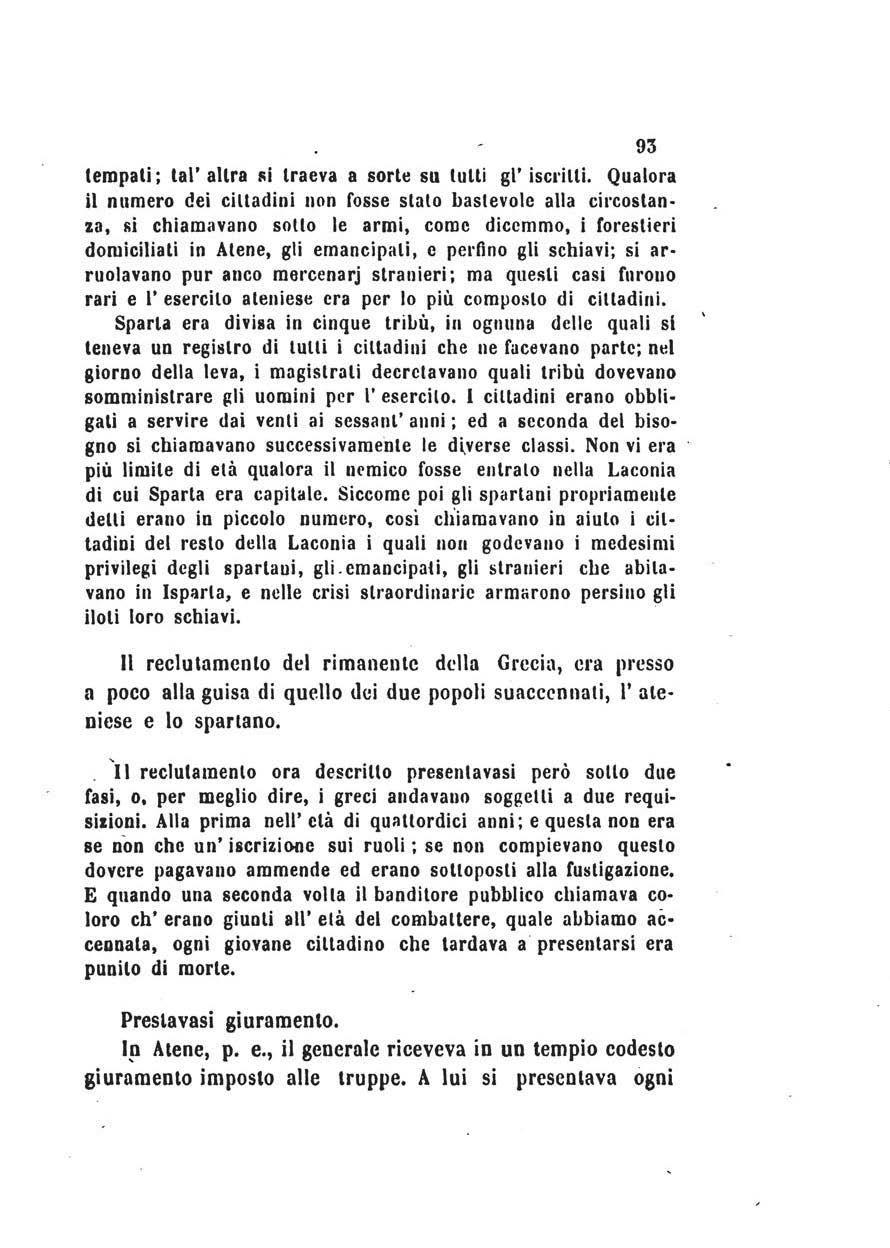
soldato, cd eg li faceva la scelta; i più fo1·ti erano mandati alla frontiera , i più drboli venivano destinati alla difesa delle mura.
La formola del giuramento ea·a la seguente: c Giuro di non disonorare la professione delle armi, di non salvat·e la mia vita con una fuga vergognosa, e di combattere fino all' ultimo respiro insieme a' miei conciltadiui, c, se fa duopo, da me solo, per la difesa della mia patria.
La formola era diversa ne' diversi luoghi della Grecia. A Lacedemonc, per esempio, l' esca·cito giurava obbedienza al suo generale; cd ogni soldato giurava a' suoi compagni di non ab· han donarli.
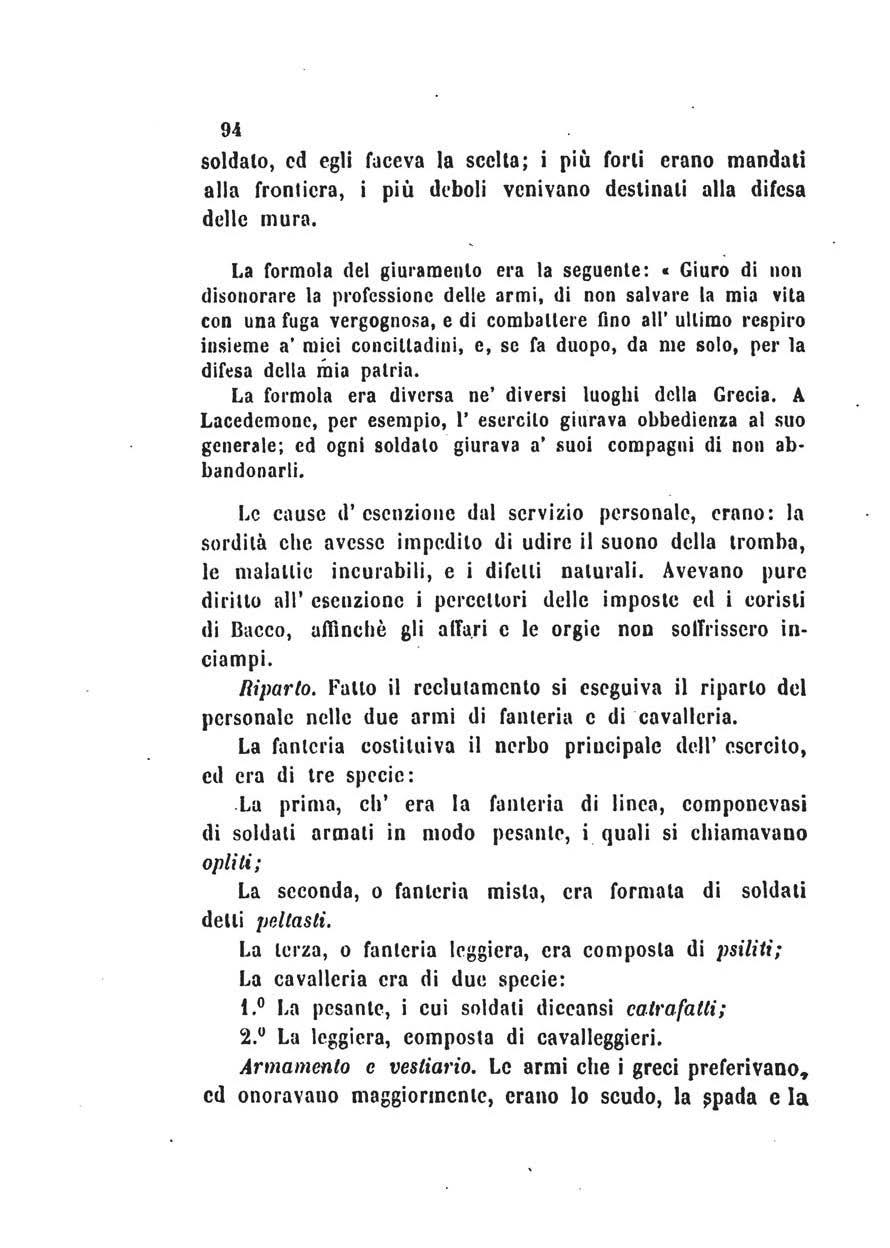
Le cause d'esenzione dal serv iZIO personale, crnno: la sordi tà che avesse impedito di udire il suono della tromba, le malattie incurabili, e i difetti naturali. Avevano pure diritto nll ' esenz ion e i pct·ccttori delle imposte ed i coristi di nacco, affinchè gli aiTa.ri c le orgie non sotTrissero inciampi.
Riparto. Fallo il reclutamento si eseguiva il riparto del personale nelle due armi di fant eria c di ·cavalleria.
La fanteria costituiva il nerbo principale dell' esercito, cd era di tre specie:
.La prima, ch' era la fanteria di linea, componcvnsi <li solda ti armali in modo pesante, i quali si chiamavano opliti;
La seconda, o fanteria mista, era formata di so ldati delli tJeltasti.
La terza, o fanteria leggi era, era composta di 1Jsiliti; La cavalleria era di due specie:
t . 0 La pesante, i cui soldati diceansi ca.tmfatti;
2. 0 La lcggicra, composta di cavalleggieri.
Armamento c vestiario. Le armi che i greci preferivano., cd onoravano maggiormente, erano lo scudo, la $pada e la
95 sarissa. L' oplita, il quale era il solo che da princ1p10 venisse onorato del nome di soldato, era quello che riceve,·a e sosteneva l' urto; ed aveva per armi difensive l' elmo, la corazza, lo sc udo o\oalc, e gli stivalètli foderati di !aminella di ferro; per otTcnsi ve, la spada è la sarissa. Era quest' ultima una picca che variò nella sua lunghezza , ora essendo di quattordici ora di sedici piedi c più ancora. La spada del laccdcmone era Stlecie di pugnale piut· tosto grande che si portava alla cintura.
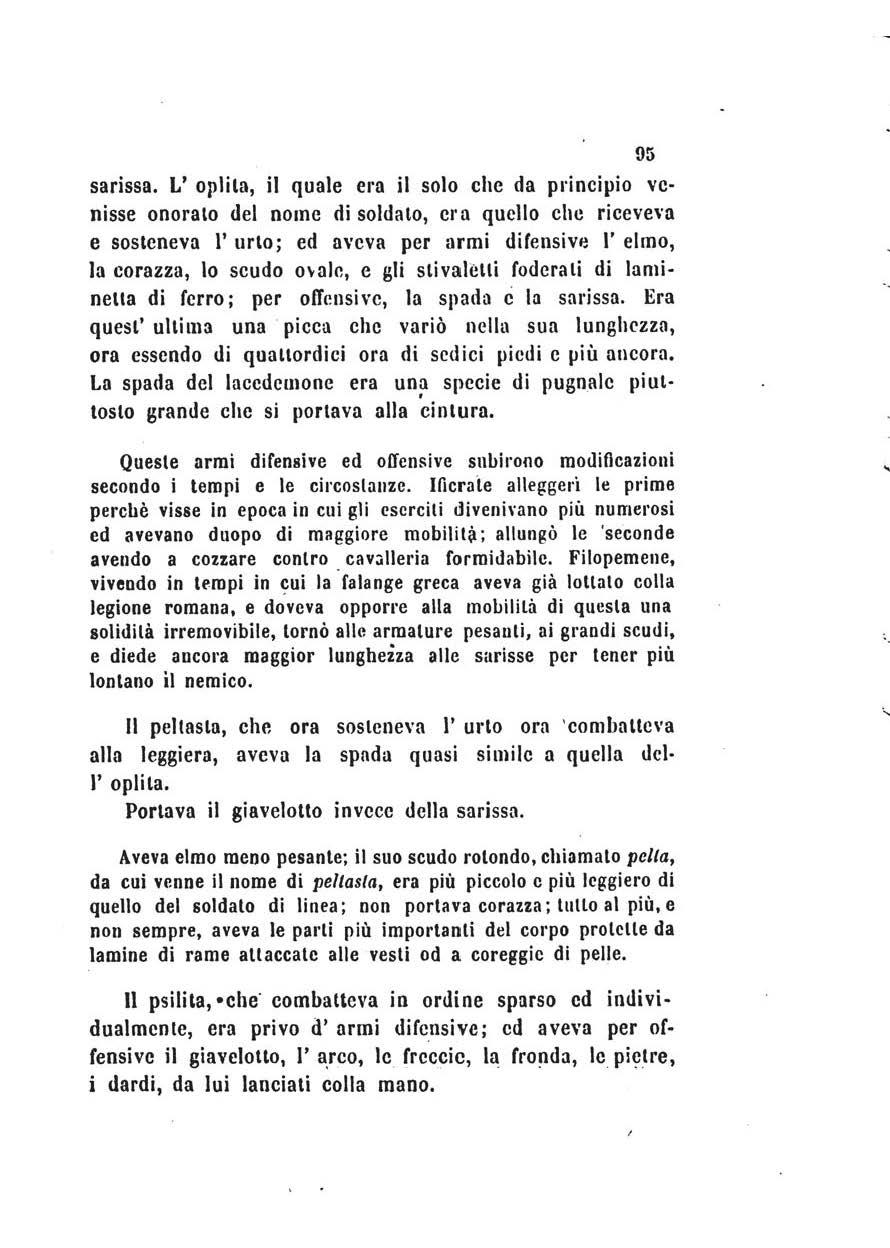
Queste armi difensive ed ofJen!'ive subirono motlificazioni secondo i tempi e le circostanze. Itìcrai.e alleggeri le prime percbè visse in epoca in cui gli eserciti diveni,·ano piu numerosi ed avevano d uopo di maggiore mobili allungò le 'seconde avendo a cozzare contro . cavalleria formidabile. Filopemene, vivendo in ltmpi in çui la falange greca aveva già lottato colla legione romana, e doveva opporre alla mobilità di questa una solidità irremovibile, tornò alle armature pesanti, ai grandi scudi, e diede ancora maggior lungheiza alle surisse per tener più lontano il nemico.
Il pcltasla, eh., ora sostcne\'a l' urlo ora ' combaltC\'a alla leggiera, aveva la spada quasi simile a quella del· l' oplita.
Portava il giavelolto invece della sarissa.
Aveva elmo meno pesante; il suo scudo rotondo, chiamalo pella, da cui venne il nome di peltasfa, era più piccolo c più lcggiero di quello del soldato di linea; non portava corazza; tullo al più, e non sempre, aveva le parti più importanti del corpo prolelle da lamine di rame attaccate alle vesti od a coreggie di pelle.
Il psilita, •che· combatteva io ordine sparso cd individualmente, era privo d'armi difc.nsivc; cd ave\·a per offensive il giavelotLo, l' a.rco, le frcccic, la fro!lda, le piçtre, i dardi, da lui lanciati colla mano.
..
I catafraui avevano per armi difensive: un elmo, che scendeva. sino alla metà del viso c difendeva in questa guisa dai dardi che cadevano in iJUrabola, c non incomodnva il comballcnte il quale non aveva da guardare se non che dall' nllo al basso. Il catofrnllo portava al b;.accio sinistro una specie di piccolo scudo clastico di forma rotonda; il braccio drillo era protello da bracciali di cuoio con lamine di rame. Ugual difesa aveva alle coscic. Portava inoltre stivali di cuoio armati di speroni.
Lt! armi offensive dei catafratti erano In lancia, la spada, spesse la chiavcrina, che è un' orma in asta luuga e sollile tla lanciare colla mano.
La cavalleria lcggiera, che non combatteva in massa, aveva archi oppure lancie.
l gt·cci non avevano nè s elle nè staffe.
Riguat·do al vestiario, sappiamo di particolare che le truppe spartane indossavano. vesti rosse.
Formazicmc. Raccolti io questa guisa , cd armati i soldati, dccsi necessariamente passare alla formazione dell' esercito.
Le milizie si formavano a falange; la falange ern composta di 8 t 94 uomini; metà opti ti, un quarto peltosti, un ouavo psiliti, un ouavo cavalleria.
Gli opliti della falange formavano 256 file su t 6 uomini di profondità. Vi erano divisioni c suddivisioni sino alla fila semplice.
Si dividevano io due merarchie di t28 file ciascuna:
La 1\lerarchia in due Chlliarcbic di fl4 file.
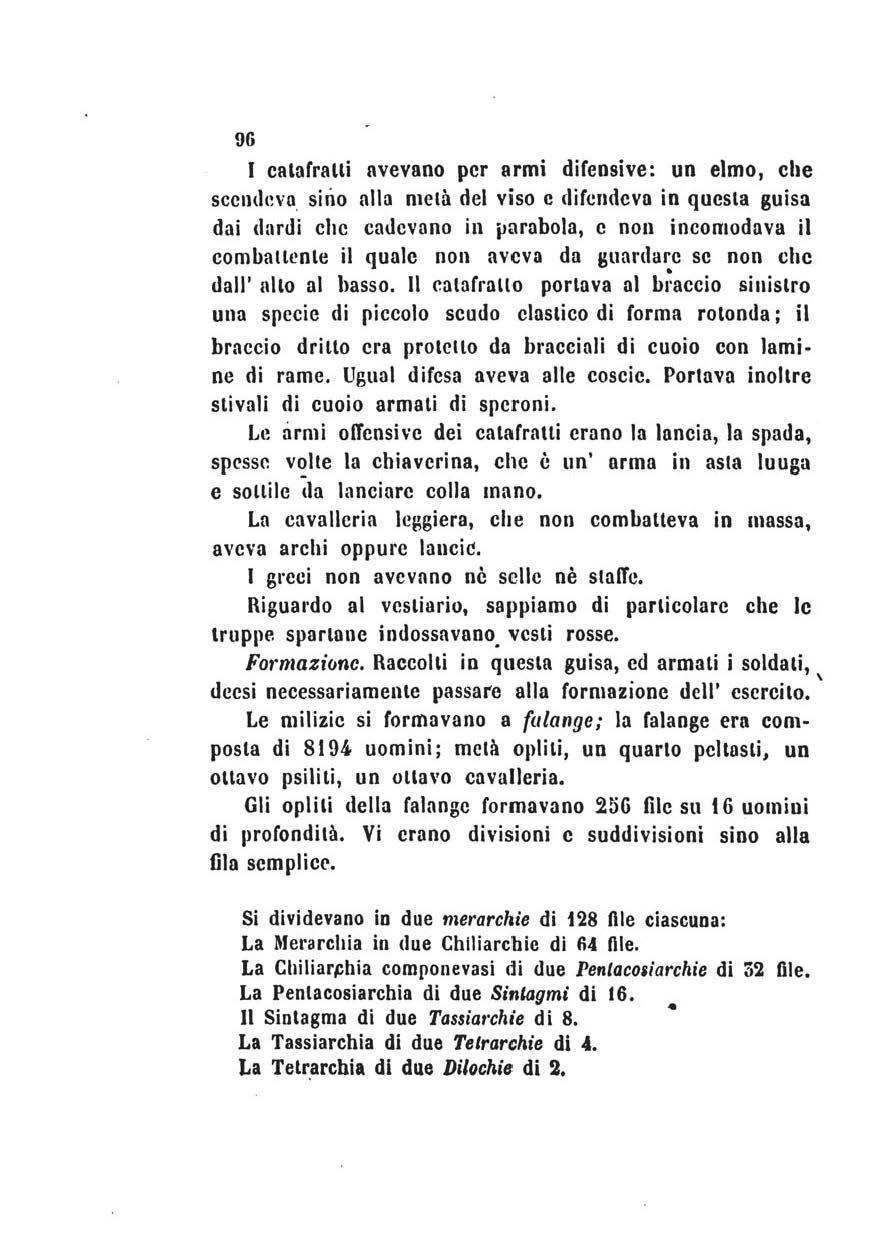
La componevasi di due Pentacosiarchie di 32 file .
La Penlacosiarcbia di due Sintagmi di 16. •
Il Sintagma di due Tassiat'chie di 8.
La Tassiarchia di due Tetrarchie di .t.
La Telr.arcbia dl due Dilochitt di 2.
\
La Dilocbia di due Locho1 ossia di 2 ftle. Finalmente eravi il Lochos o la ftla semplice.
Il Lochos si d ividcva, nella sua profondità, in due Dimerie; la Dimeria in due EuomoJitJ.
Ogni so ldato poi portava ' un composto che gli ricordava di conliuuo il suo posto c le sue funzioni nella riga e uella tlla.
Il primo uomo di ciascuna ftla era ad un tempo Loçhagos, Dimerila, ed Enomotarca, vale a dire comandante della fila, capo della prima Dimeria e dellà quarta Enomozia.
Gli uomini della 1" e 2' riga erano sem·plicemente Enomo-
Il t 6." e·ra Urago• o serra file, ed inollrc era invece del t2.• (V. Tav.n Il.').
Il primo uomo di ciascuna fila impari era Dilochita, o capo della Dilochia, senza venir mrno ai gradi che aveva già nel suo lochos.
Il primo uomo ·di ogni tetrarchia era Tetrarca o capo della tetrarcbia.
Il Ta s1iarca, o capo della tassiarchià, era il primo ufficiale che stesso fuori delle file; esso JlOncvasi innanzi al centro della sua truppa . ·
Il o comandante di sintagma, slava innanzi alla fronte del suo sintagma, avendo a sinistra un ajutante incaricalo di portare i suoi ·ordini. Dietro al sintagmatarca, e su di una medesima linea , erauvi tre. ufficiali, cioè: un portainsegna nel mezzo, un araldo d' armi a drilla per ripetere i comaudi, un trombella a sinistra per dare i segna li. L' uno li d••va per la vista, abbassando od innalzando l' insegna secondo i modi convenuti, l' altro colla voce, il lt>rzo col suo no o strepito di guerra.
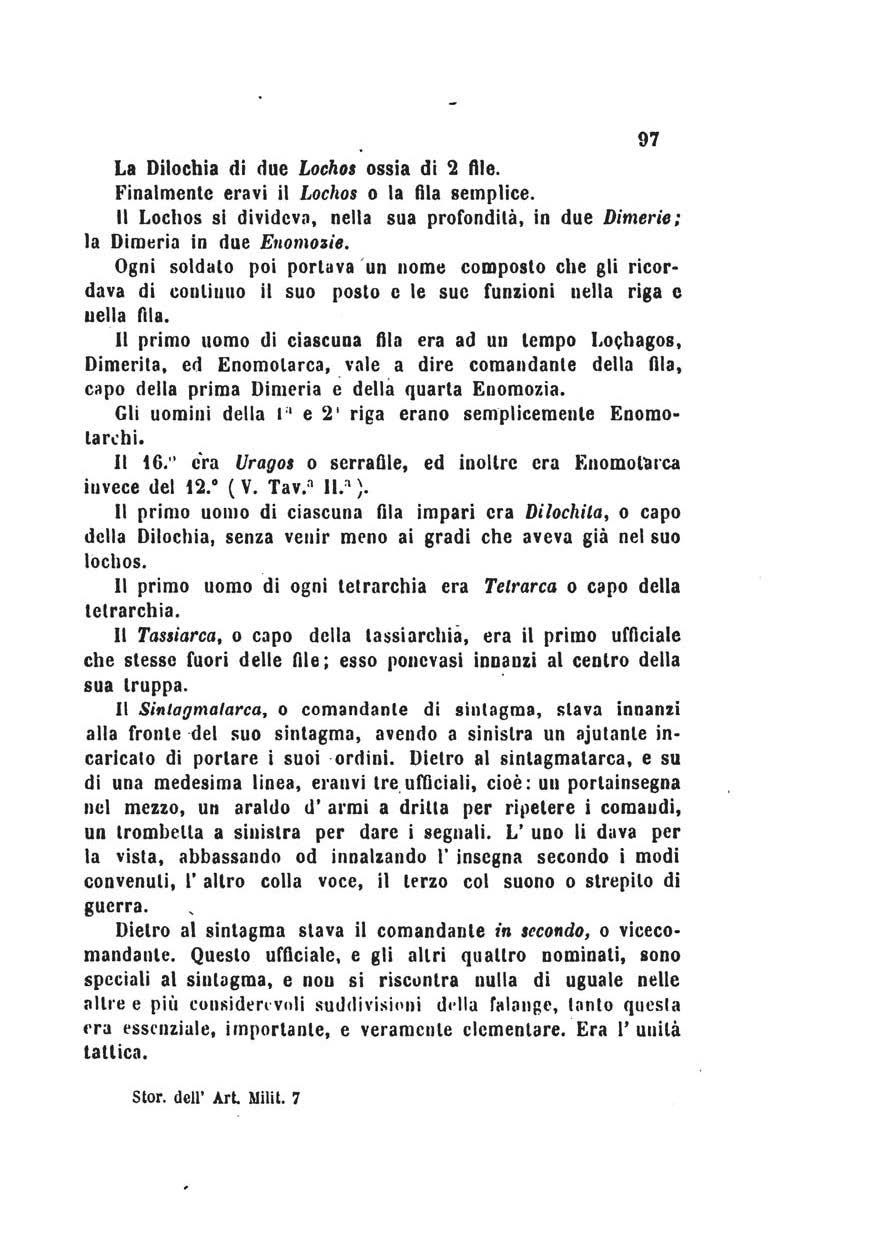
Dietro al sintagma slava il comandante in 1ccondo, o vicecomandanle. Questo ufficiale, e gli altri quallro nominati, aono speciali al siutagma, e nou si riscontra nulla di uguale nelle altre e piÙ COIIIiiderrvnli SUtJ!IivisÌI•IIÌ dt•Jia rèllangc, tnnto questa rra l.'ssrrn.iale, i mportante, e veramente clcmenlare. ·Era l' uni là tallica.
Stor. dell' Arl Milit. 7
l capi delle altre suddiYisioni del sinlagma, e il comandante della falange, si tenevano all' infuori e verso la dritla della loro truppa. (V. Tu.3 11. •)
Confrontando queste d i visioni alle nostre formazioni odierne, troveremo che la dilochia ( file) equivarrebbe alla .nostra sezione; la tetrarchia ( 4) al pelotone; la tassiarcbia ( 8) alla compagnia; il sintagma (t 6) al battaglione, uni tè. tattica; la chiliarcbia ( 64) al reggimento; la merarchia (t2i) alla brigata; la falange (256) •nessa, al completo dalle altre truppe, corrisponderebbe alla di visione.
l 2048 pehasti componevano l' Epixenagia. ·
L' unità di forze dell' epixcnagia, corrispondente al sintagma, chiamavasi Ecatontarcllia.
L' cpixeoagia subiva tutte le suddivisioni a cui era assoggetlata la falange degli opliti, ma con nomi diversi.
l t 024 psili\i stavano io ordine sparso, combaLLendo fuori di linea.
La cavalleria suddividevasi in /S()/e. L' Isola era 1' unità tattica; componevasi ordinariamente di t 6 cavalli di fronte e di 4 di profondità. Qualche volla formavasi pure su 8 di fronte e 8 di profo ndilà; tal' altra con 8 di fronte c 4 di profondità. l cavalleggieri stavano in ordine sparso.
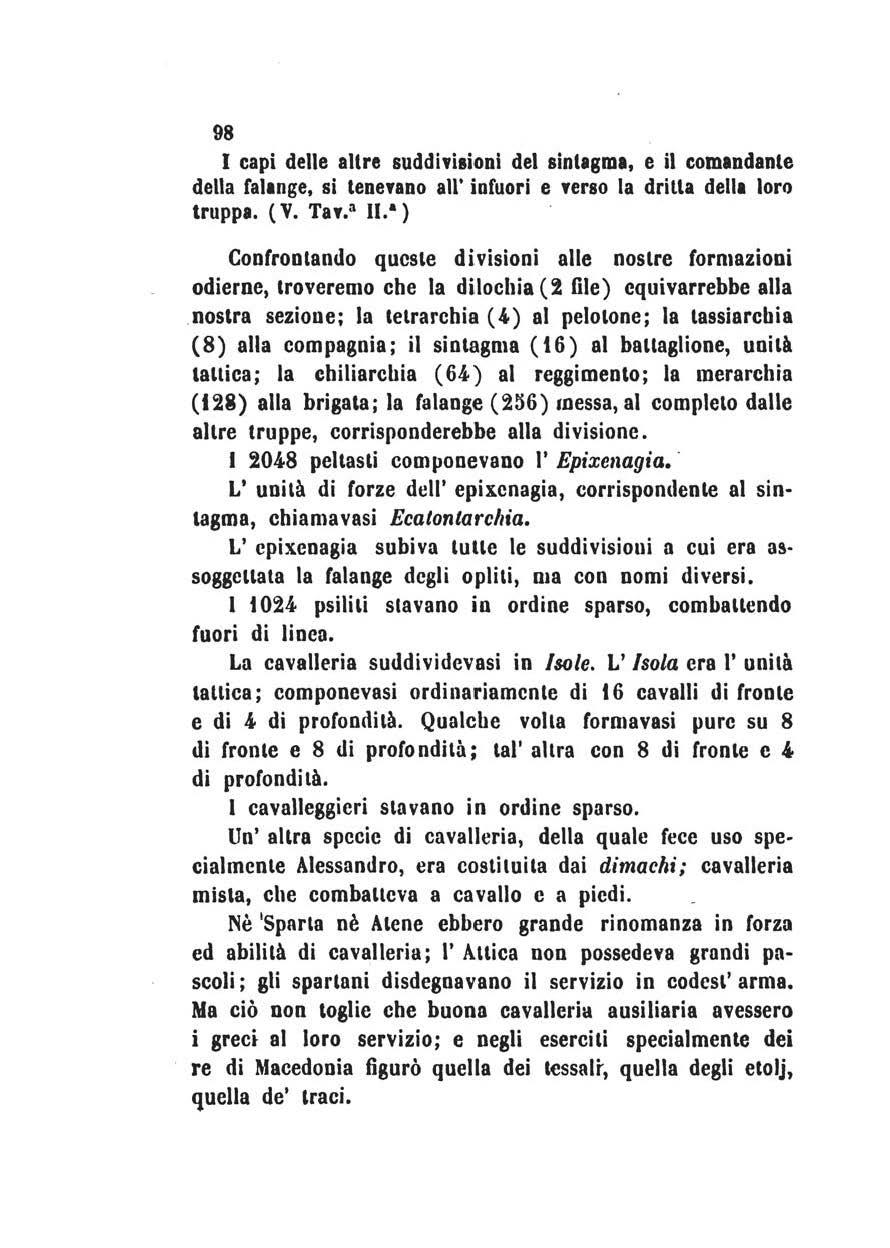
Un' altra specie di cavalleria, della quale fece uso specialmente Alessandro, era costituila dai di ma chi; cavalleria mista, che combatteva a cavallo c a piedi.
Nè 'Sparla nè Atene ebbero grande rinomanza in forza ed abilità di cavalleria; l' Attica non possedeva grondi pascoli; gli spartoni disdegnavano il servizio in codest' arma. Ma ciò non toglie che buona cavalleria ausiliaria avessero i greci al loro servizio; e negli eserciti specialmente dei re di !\lacedonia figurò quella dei tessalr, quella degli etolj, quella de' traci .
99
Tutto ciò costituiva la falange 8emplice o falange ele· rnentare.
Ma quando codesto ordinamento toccò il massimo della sua forza regolare, allora, e fu ai tempi di Alessandro, si videro quauro falangi semplici riunite che componevano In Tetmfalangarcliia. In essa, il complesso Jella cavalleria ·costituiva l' Epitagma.
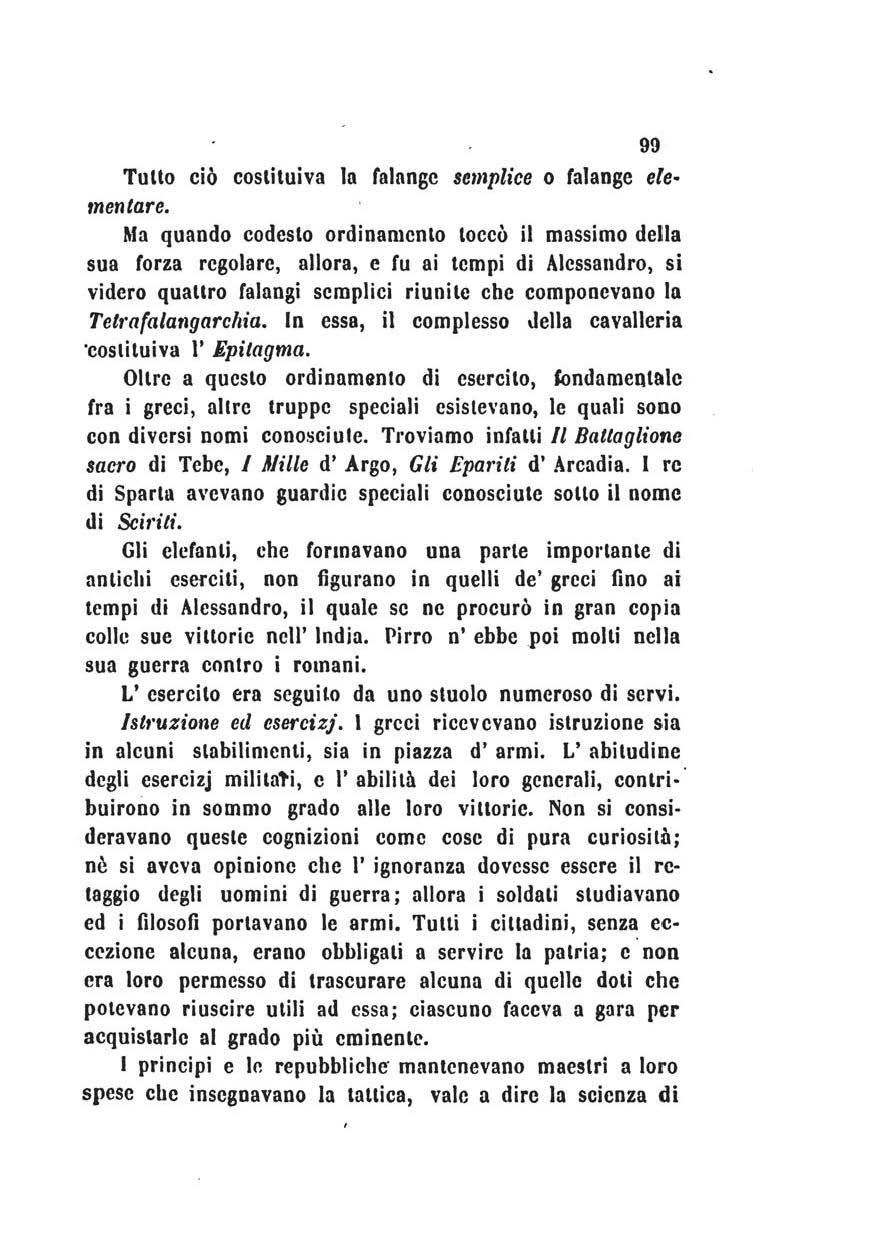
Oltre a questo ordinamento di esercito, londamenttlle fra i greci, altre truppe speciali esistevano, le quali sono con diversi nomi conosciute. Troviamo infatti Il Battaglione 8acro di Tebc, l Afille d' Argo, Gli Epa7'iti d' Arcadia . I re di Spartu avevano guardie speciali conosciute sotto il nome di Sciriti.
Gli elefanti, che formavano una parte impo1·tante di antichi eserciti, non figurano in quelli de' greci fino ai tempi di Alessandro, il quale se ne procurò in gran copia colle sue vittorie nell' India . Pirro n' ebbe poi molti nella sua guerra contro i romani.
L' esercito era seguito da uno stuolo numeroso di servi. lst,·uzione ed csercizj. l greci ricevevano istruzione sia in alcuni stabilimenti, sia in piazza d ' armi. L' abitudine degli esercizj milita1'i, c l' abilità dei loro generali, contribuirono in sommo grado alle loro vittorie. Non si consideravano queste cognizioni come cose di pura curiosità; nè si aveva opinione che l' ignoranza dovesse essere il rctaggio degli uomini di guerra; allora i soldati studiavano ed i filosofi portavano le armi. Tutti i cittadini, senza cc· cczione alcuna, erano obbligati n servire la patria; c ·non era loro permesso di tra scura re alcuna di quelle doti che potevano riuscire utili ad essa; ciascuno faceva a gara per acquistarle al grado più eminente.
l pr incipi e le repubbliche· mantenevano maestri a loro spese cbc insegnavano la tattica, vale a dire la scienza di
tOO ordinare le truppe e addestrarle alte diverse evoluzioni militari. ·A Pella, capitale della Macedonia, eravi un gran numero di tnuici che ricevevano stipcndj considerevoli; e questa liberalità dei principi contribuì mollo alla gloria che i mncedoni si sono acquistati.
Sparla cd Atene ebbero ginnasj militari, ove si faceva uno studio particolare dell' arte della guerra. Vi si eseguiva· ogni specie .di evoluzione con molta precisione, vi s' imparavano gli csercizj della fanteria c della cavalleria, vi si faceva il volteggio su cavalli di legno. In queste scuolr. s' insegnava tutto ciò che potevasi applicare sul campo di battaglia. S' insisteva particolarmente sulla teoria delle distanze e s ul tempo necessario a ciascuna evoluzione. · l corsi erano pubblici. Atene restava aperta a tulli i popoli. I greci non temevano di svelare i segreti della loro forza militare, tanto era gt·ande, la loro superiol'ità sugli stranieri.
Venivano inoltre abituati a molti e frequenti esercizj ginnastici. Fra questi è da notarsi la danza pit'rico, la quale facevasi colle armi indosso e la spada alla mano. Si esercitavano a correre, a saltar fossi, a lanciare proiettili, ad arrampicarsi su alture. S' insegnava lero a marciare con regolarità di passo cd al suono di strume nti musicali, locchè era necessario per l' indole intrinseca deJla falange. Infatti, nella descrizione della prima ballaglia di Mantinea, Tucidide scrive: • Era nvi flauti frammisti alle schie•·e, non per cantare l' inno di guerra e fare uno strepito vano, ma allo scopo di marciare con un passo ugualt e perfino in cadenza, per timore di rompere le l'ighe come accaJc per solito ai grandi eserciti. •
Allorquando volevasi piegare la colonna per marciare io di· rezione perpendicolare alla linea di baltaglia, si stabiliva l' eslen-
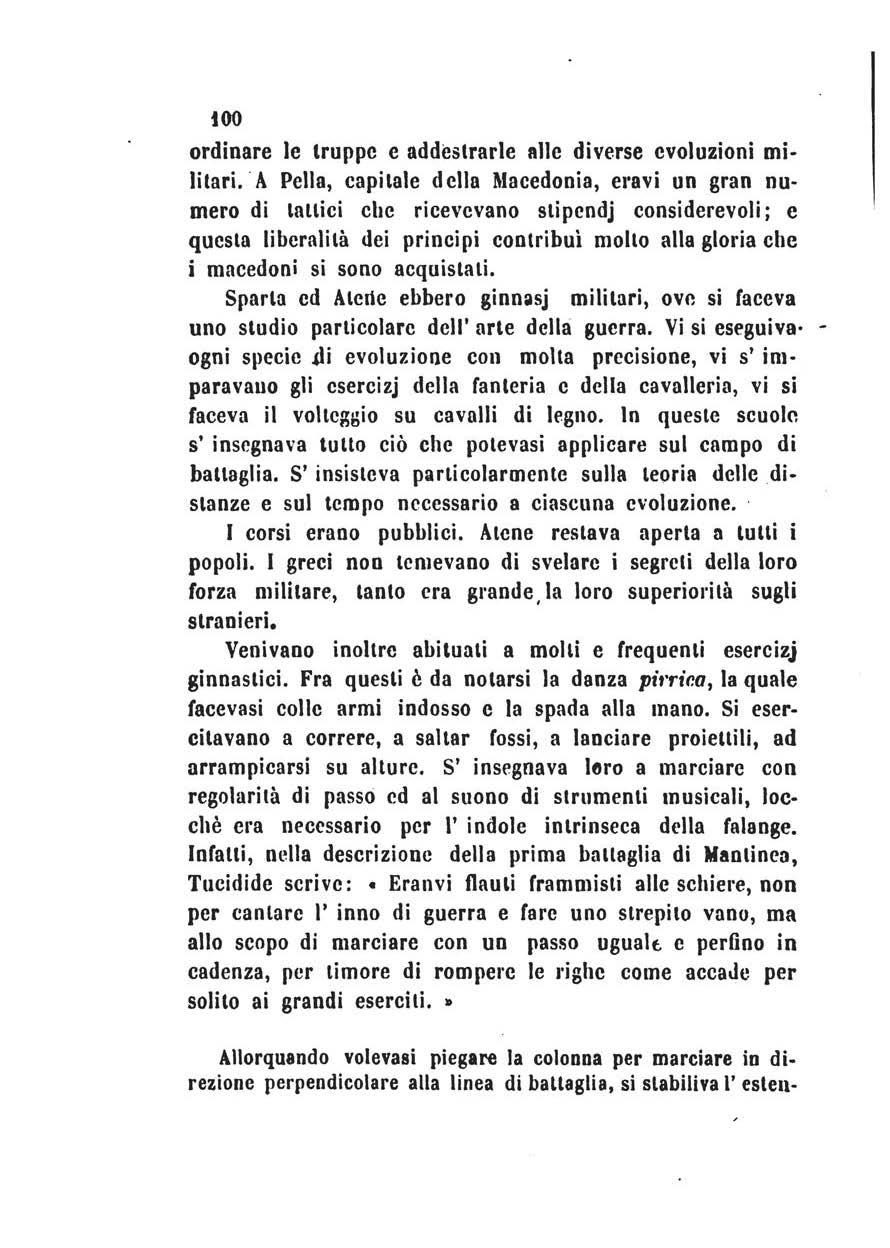
tOt • sione della fronle della colonna che si doveva formare; e desti· nata la suddivisione che doveva servire ·di base, tutte le altre suddivisioni analoghe si portavano con una marcia di fianco innanzi o dietro ad essa. Questo movimen lo perpendicolare alla linea di battaglia chiamavasi epagogo.
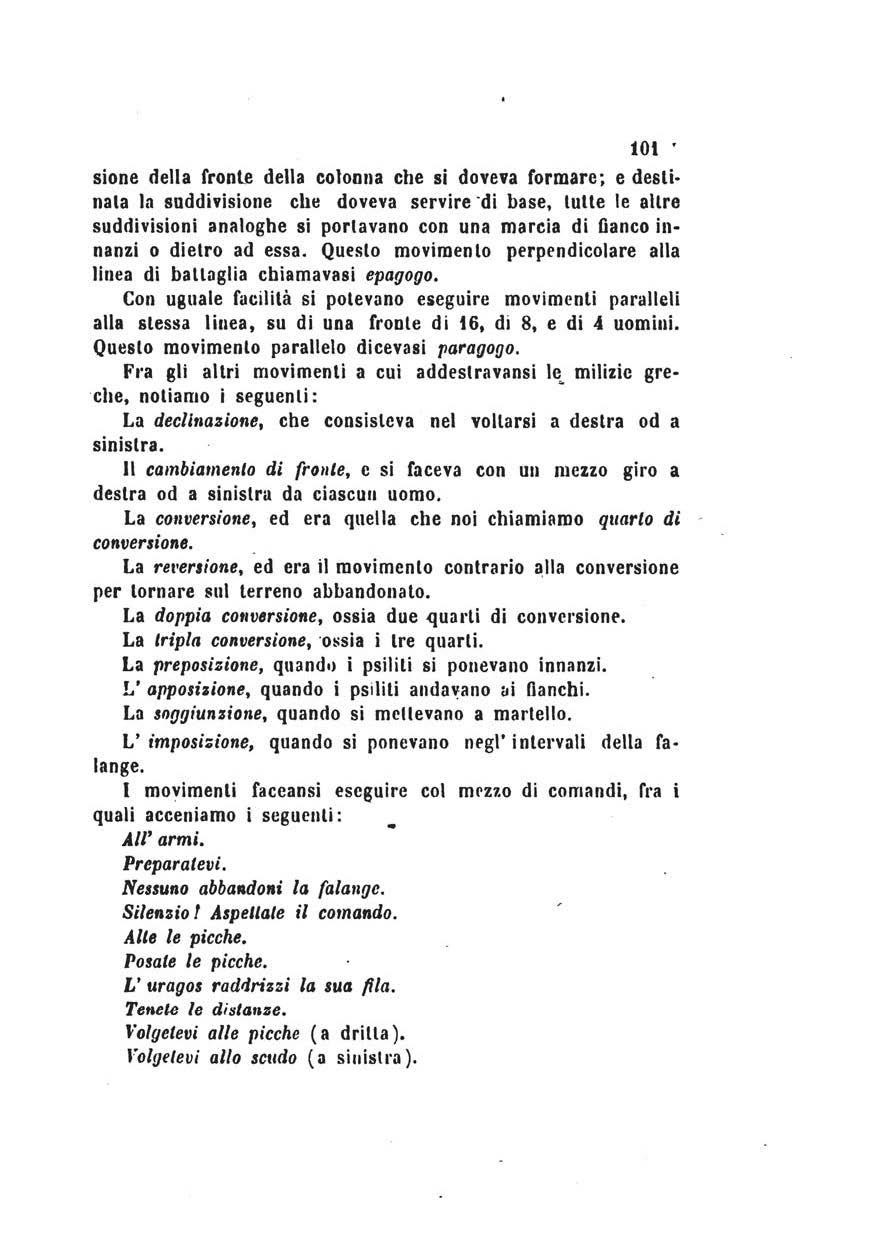
Con uguale facilità si potevano eseguire movimenti paralleli alla stessa linea, su di una fronte di 16, di 8, e di 4 uomini. Questo movimento parallelo dicevasi paragono.
Fra glì altri movimenti a cui addestravansi le. milizie grecbe, notiamo i seguenti:
La che consisteva nel voltarsi a destra od a sinistra.
Il cambiamento di fronte, c si faceva con un mezzo giro a destra od a sinistra da ciascun uomo.
La cot1versione, ed era quella che noi chiamiAmo quarto di conver1ione.
La rer•er1ione, ed era il movimento contrario conversione per tornare sul terreno abbandonalo.
La doppia conversione, ossia due quarti di convcl'siont>.
La tripla conversione, ·ot>sia i tre quarti.
La preposizione, quand•J i psiliti si ponevano innanzi.
L' apposiJione, quando i ps ilili 11i fianchi.
La sn{JgiunJione, quando si mettevano a martello.
L' imposizione, quando si ponevano nt>gl' i ntervali della fa· lange.
l movimenti faceansi eseguire col mrz1.o di comandi, rt·a i quali acceniamo i scguenli:
All'armi.
Preparatevi.
Nessuno abbat«<orai la falange.
Silenzio t Aspellate il comando.
Alle le picche.
Posate le picche.
L' uragos radtiriui la 1ua fila.
Tertekl le distanze.
l'olgetevi alle picch e (a dritta).
Folgetevi allo scudo (a siu istt'a ).
102
Raàcloppiale la profondità, Rimettetevi.
l cavallicri cscrcitavansi a motllarc c a discènderc da cavallo; cd a que' movimenti che portavano nlle formazioni che in seguito cliremo.
DisciP,linn: pette e t"icompense. La disciplina c•·a Jnantcnuta con pene c ricompense.
Le pene servivano a reprimere i disordini, le ricompense a stipolare il valore.
Il generale convinto di tradimento era punito di morte. ugual pena subiva colui che avesse, senza ordine, invaso le terre di un' altra repubblica.
In Atene, ogni generale doveva rendere conto della sua condotta e delle sue operazioni finila la campagna. Se non veniva approvato, lo si poteva condannare a multa ed anco a prigionia. Milziade ne offrì tristissimo esempio.
A Sparla, veniva punito di morte ogni comandante di posto o di fortezza che si fosse reso al nemico quando non poteva aver perduto ogni speranza di soccorso.
Chiunque non si presentato alla leva ·nel giorno fissato, od avesse abbandonato le llla. durante il combattimento, od avesse gettalo o ceduto le armi, o soprattutto avesse perduto lo scudo, veniva coperto d' infamia, era privato del diritto di cittadino, diventava ineapnce di compiere pubblici ufflzj, e gli restava inlert.lello l' ingresso nei templi.
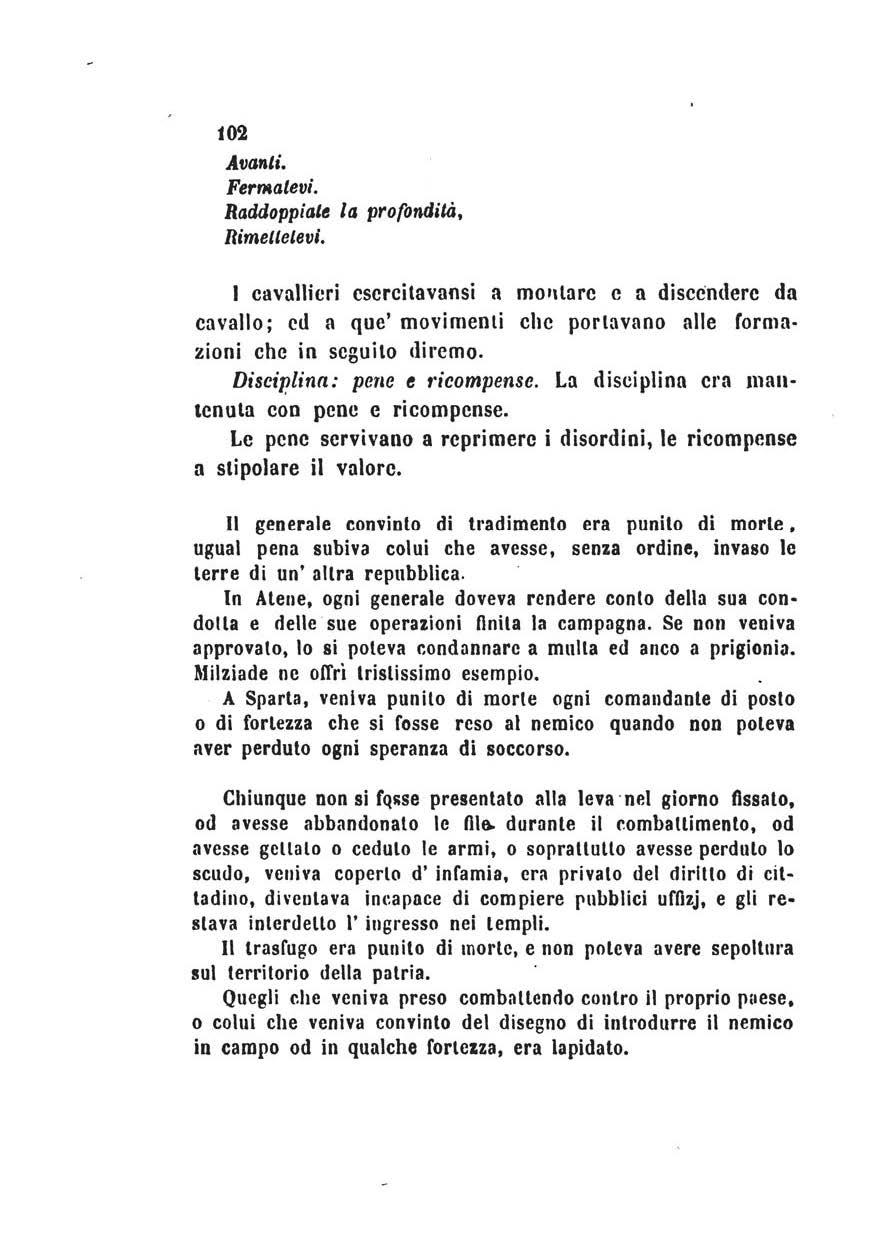
Il trasfugo era punito di morte, e non poteva avere sepoltura sul territorio della patria.
Quegli che veniva preso combattendo contro il proprio puese, o colui che veniva con vinto del disegno di introdurre il nemico in campo od in qualche fortezz a, era lapidato.
/
103
In Tebe, i generali che ritenevano il comando oltre un anno, erano puniti di morte. Poco mancò che Epaminonda non ne desse un esempio io sè medesimo.
Le ricompense erano più onorifiche che lucrative.
Una colonna che portava i nomi dei caduti per la patria, come a Maratona, una dichiarazione di benemerenza al popolo che aveva reso grandi servigi alla Grecia, come fece la Grecia intera verso Atene nella guerra contro i persiani, erano ricompense generali. Le personali, cunsistevano, come io Atene, nella promozione a grado superiore, nella proclamazione io feste pubbliche, nel dono di armature complete, in corone, in istatue .. in monumenti.
Pronìaioni · alimentarie assegnavansi a spese del tesoro ai feriti inabili al servizio; i quali avevano io oltre un posto distinto nei giuochi pubblici (t) .
Amministrazione. Riguardo nW amminis 'trazionc, i greci, le cui invenzioni sono tutte immortalate dai loro storici, idearono senza dubbio poche cose per l' approv igionomenlo degli eserciti; imperocchè gli annali non si · guari su questo argomento. Solo sappiamo che in Atene gl' intendenti dell'esercito portavano un nome che significa Conservato,.;, che le loro funzioni consistevano nel porre grani nei magazzini, nel somministrarli alle truppe, e nel venderli al popolo in tempi di carestia.
Per lungo tempo, i loro generali, nomati Strategi, riunirono nella città la suprema magistratùra e l' edilità, e negli eserciti il comando c l' amministrazione . Più tardi vennero divisi in Strategi militar·i o gt>nerali dell' esereito, ed in Slrategi que&tot!i ossia intendenti di guerra.
·In ogni modo però non bisogna speral'e di trovare negli
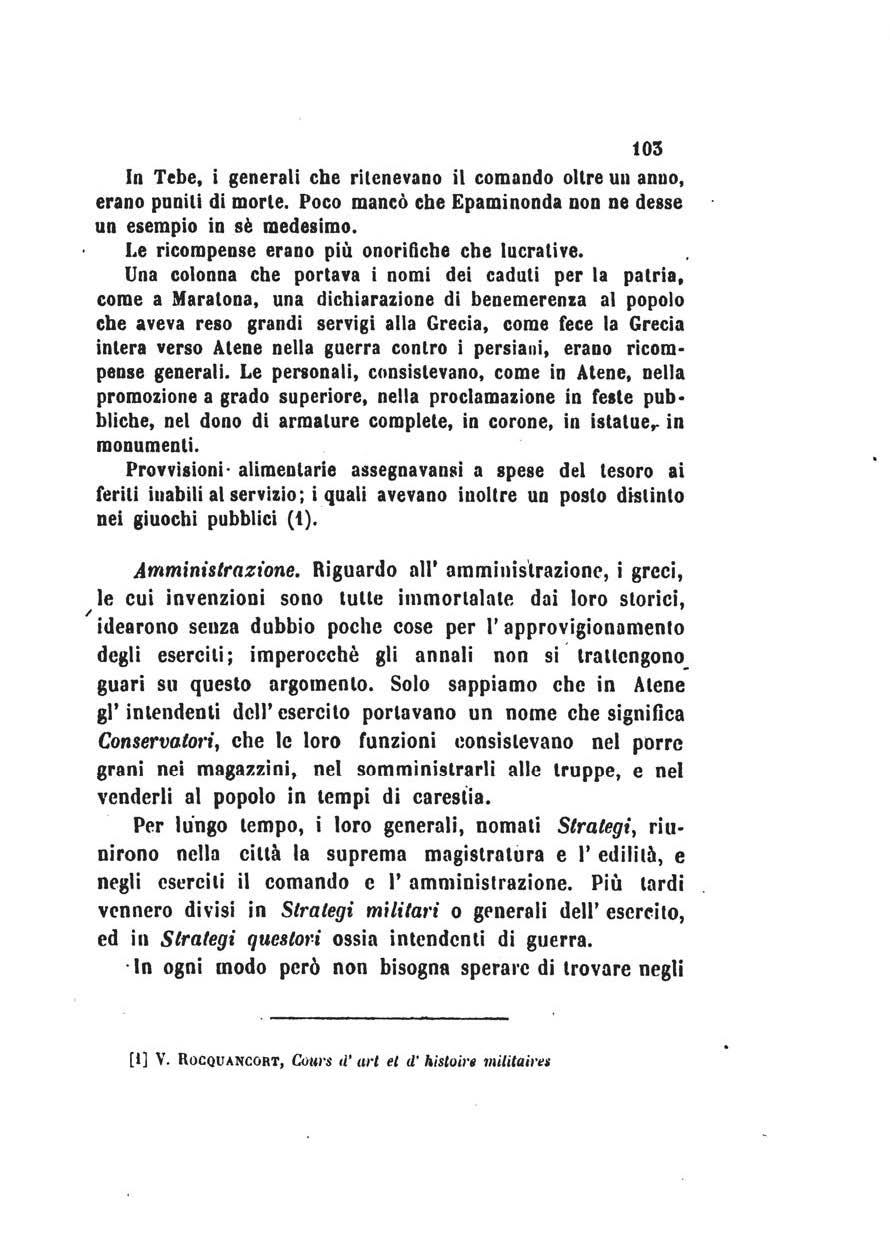
i04 storici della Grecia gli elementi amministrativi.
Un oilro ramo di saggia amministrazione militare si è quello del servizio sanitario; e non è nè a credersi nè a pretendere che in quelle epoche remote venisse coltivato colla rrgolurità e la sufficienza che oppena appena sono state introdolle in tempi a noi vicini. Tuttavia, troviamo che gli storici di Alessandro celebrarono i medici dell' e. sercito di Filippo, Cretobulo c Cristolene. Essi d!cono pure che Alessandro, il quale, ad istigazione di Aristotele, &\·eva studiato la medicina, la 'praticò sovente nell' esercito. Egli rese responsabili i medici della vita dci fe_rili; c guai a coloro i quali non ave ssero, secondo lui, adoperati tutti i mezzi della loro arte! Efestionc morì; c toslo Glauco, suo medico, fu condannato a scguirlo nella tomba.
Riguardo al soldo, non eraovi fra i greci che tre sole classi:
t.' Il Generale, o Stratega, che comandava la falange o l' armata.
2.0 Il Ccntul'iune o Tassiat'ca, primo ufficiale fuori di riga, che comandava a due tctrnrchie.
3.0 Il semplice soldoto, od oplilo, ch'era il soldato per eccellenza, il solo a cui si desse questo nome. La paga dei soldati di minore considcrazi.one era più piccola c variabile ; quolchc volta restava a carico dell' oplila ch' essi servivano come scudieri.
Tutto era ordinato in una di queste Lr;! categorie. Gli ufficiali ch' erano nelle file ricevcnlno paga uguale al soldftto; gli altri , Hno olio slTatega, qucUa del tassiarca.
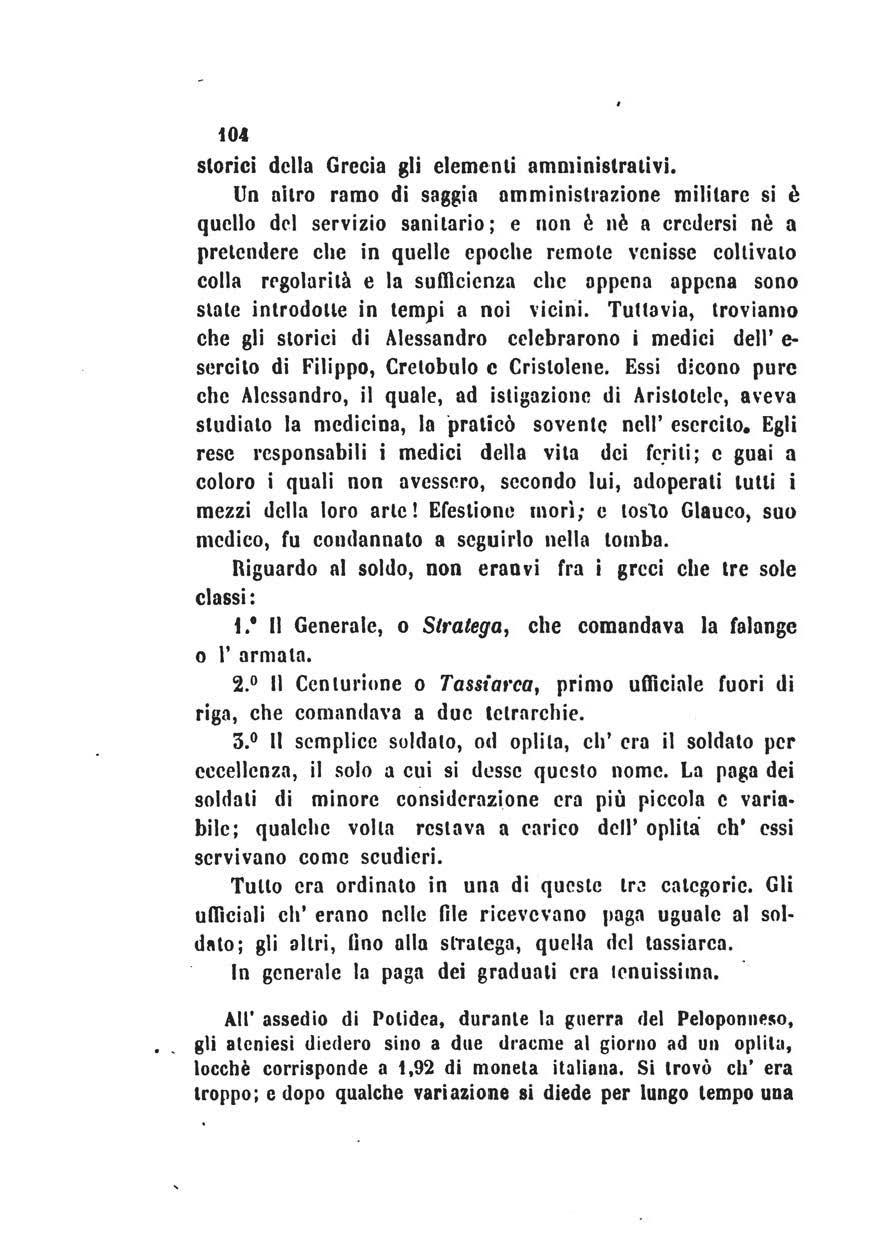
In generale la paga dei graduati era l<'nuissimn . ·
All' assedio di Polidea, durante la guerra del PeloponnP.!'iO, gli ateniesi diedero sino a due t.h·acme al giorno ad un oplil<t, locchè corrisponde o 1,92 di moneta italiana. Si trovò cb' era troppo; e dopo qualche variazione si diede per lungo tempo uoa
t05 dracma al giorno : Alla flne si ridullse il soldo a due leni di dracma, ossia a 64 centesimi al giorno.
L' ufficiale fuori di riga ne aveva il doppio. Il generale il quadruplo.
La pnga del ca\'allicrc in tempo di guerra variava se· condo le circostanze. Talvolta il doppio, tal volta il triplo cd anche il quadruplo eli quella del funte.
La paga cessn\'u per tutti in tempo eli pnce. Si tluvn però al ca\·alirre t6 dracme al mese, ossia t!i,36, pcl mantenimento del cavn llo.
t1·auavasi di certe spedizioni, diminuh·asi la paga· in conshlernzionc dt·l bollino presunto.
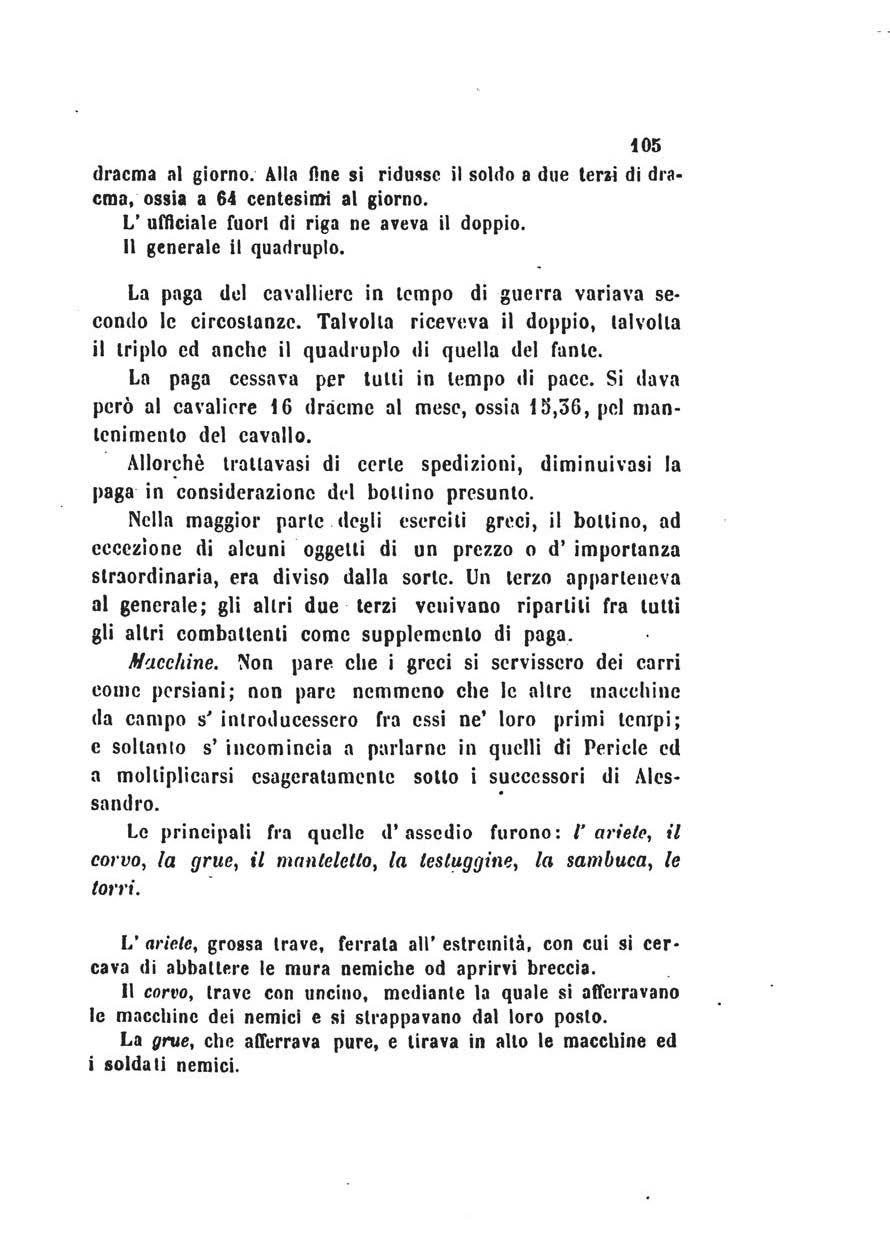
Nella mnggiot· parte . degli eserciti greci, il bottino, nd eccezione di a lcuni · oggetti di un prezzo o d' importanza s lrlordinaria, era diviso dalla sorte. Un terzo apparteneva al generale; gli altri due · terzi venivano ripartiti fra tutti gli altri combattenti come supplt>mcnlo di paga. M'.J.cclline. Non che i greci si serv issero dei carri come JH'rsinni; non pnrc nemmeno che le altre ma cchi ne da campo s'introducessero fra essi ne' loro primi tempi; e soltnnto s' incomincia n parlarnc in quelli di Pericle cd n moltiplicarsi esageratamente sotto i successori di Alcssnndro .
Le principali fa·n quelle d' assedio furono: l' il corvo, la grue, il mrmteletlo, la tesl!Jggine, la sambuca, le torri.
L' m·ielc, grossa trave, fenala all'estremità, con CUI SI cer· cava di abbattere le mura nemiche od aprirvi breccia .
Il corvo, lravc con uncino, mediante la quale s i afferravano le macchine dei nemici e si sl l' appavano dal loro posto.
La grue, che atterrava pure, e tirava in allo le macchine ed i solda li nemici.
106
Il ma,.ultllo, che difendeva i lavoratori nelle opere d; astediG.
La tuluggine, che aveva il medesimo scopo dell'antecedente.
La sambuca, colla quale dalle torri si abbassava il ponte sulle mura della città combattuta. Era chiamala pure con questo nome una scala che si ammaniva sulle navi per iscalare le mura delle città marittime. ·
Le torri, poste su ruote, e falle per andare in pi1no sui muri delle cillà assediate mediante un ponte che da esse si abbassava. Tah·olla portavano al basso un forte ariete. Erano costrulle di varii palchi con fi{lestre a'd ogni lato.
Fra le macchine da tiro, notavansi gli scot'pioni le catapulte, gli onagri, c le baliste. Lanciavano proiellili di \'Il· rii generi.
Su questo argomento torneremmo parlando dei romani.
Fortificazioni. Le ciltà greche, ad eccezione di Sporta, erano fortificate; In bnse delle loro fortificazioni erano mura fiancheggiale da torri. Talvolta le cinte erano doppie c triplr. Erano circondate dn ln.rghissimi fossi. · Avevano palizzatr, trincieramrnti dietro b:..luardi, c cortine dlètro alle torri.
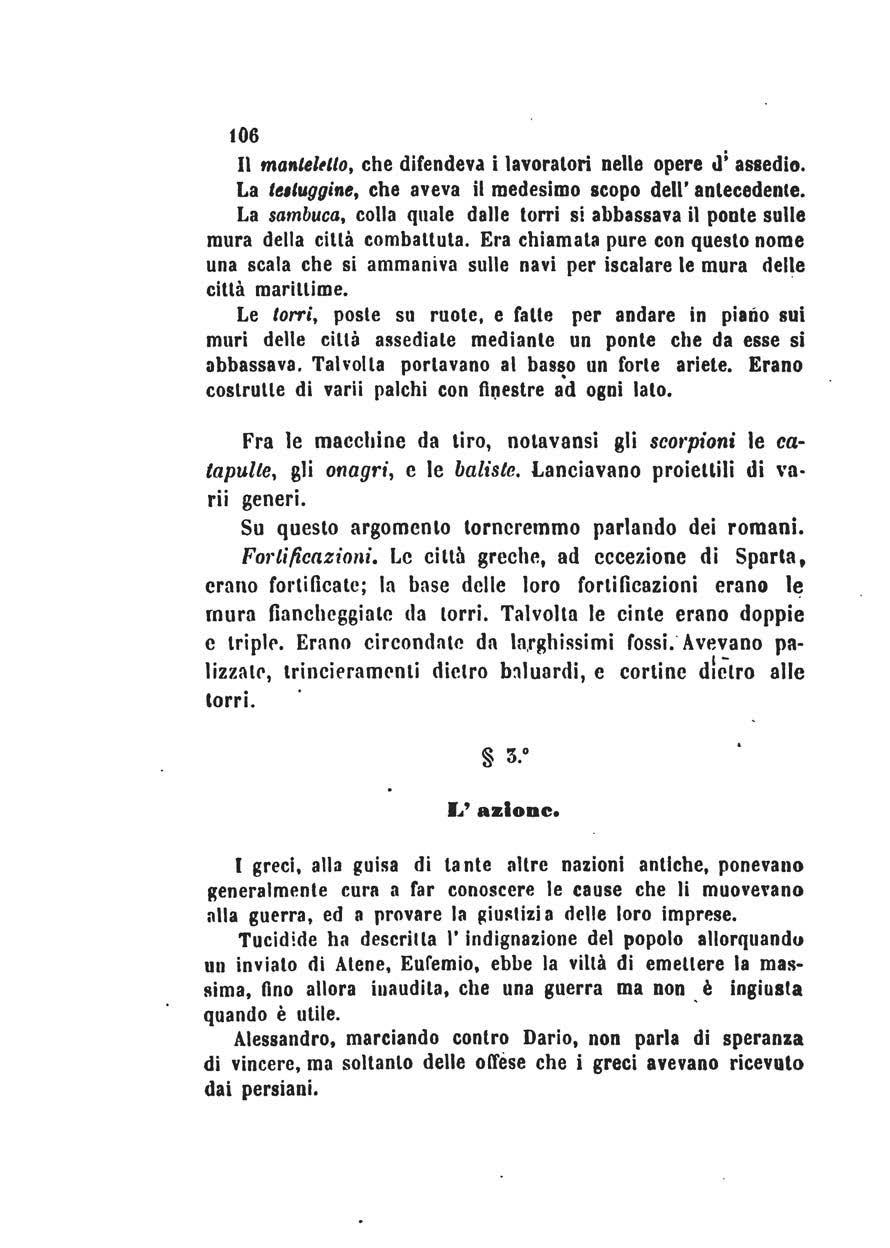
l greci, alla guisa di la nte nltre nazioni antiche, ponevano generalmP.nte cura a far conoscere le cause che li muovenno guerra , ed 11 provare la a delle loro imprese. Tucidide ha descrilla l'indignazione del popolo allorquandu un inviato di Atene, Euremio, ebbe la viltà di emettere la masRima, flno allora inaudita, che una guerra ma non è ingiusta quando è utile. '
Alessandro, marciando contro Dario, non parla di speranza di vincere, ma so ltanto delle oll'ése che i greci avevano ricevuto dai persiani.
'
tll7
Decisa In guerra, i greci sruditwano · le posizioni militari; ed è certo che qu es to srudio decsi aggiungere a tutte le cause che li fecero trionfare di eserciti innumerevoli. Essi combnHcvano nel loro paese; conoscevano quindi e sceglievano bene tnue le loro posizioni; e quaotlo Alessan· dro fece loro nbbandoonre il sistema della guerra difensiva c li trnscinò !unge dnl loro paesE>, l' nvcvn abili ingegneri geografi che misuravano le morciP, levavano le corte dci paesi sui quali si voleva portare il teatro della guerra, c tracciavano le strade.
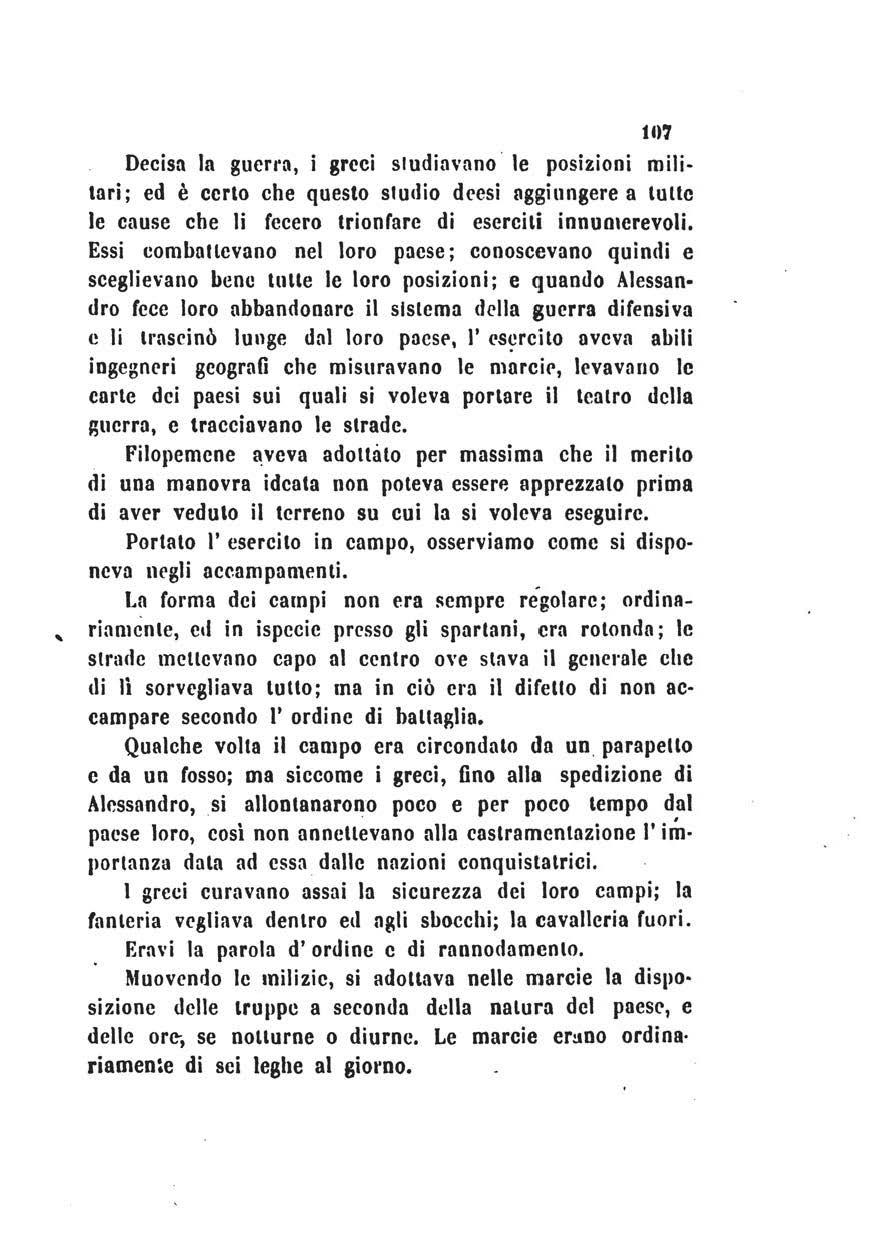
Filopemene adottàto per massima che il merito di una manovra ideata non poteva esserP. apprezzato prima di aver veduto il terreno su cui la si voleva eseguire.
Portato l' esercito in campo, osserviamo come si disponeva negli ocr.ampamenti.
La forma dci campi non era semp re régolare; ordinariamènte, cci in ispccie presso gli spartani, era rotonda ; le str<ulc mettevano capo al centro ove stava il gcnet·ale che di li sorvegliava tutto; ma in ciò era il difetlo di non accampare secondo l' ordine di battaglia.
Qualche volta il campo era circondnto da un . parapetto e da un fosso; ma siccome i greci, fino alla spedizione di Alessandro, .si allontanarono poco e per poco tempo dal paese loro, così non annettevano alla castramcntazione l' im· portanzu data ad essa dalle nazioni conquistatrici.
1 greci curavano assai la sicurezza dei loro campi; la fanteria vegliava dentro eli ngli sbocchi; la cavalleria fuori.
Ern,·i la parola d'ordine c di rannodamcnto.
Muovendo le milizie, si adottava nelle marcie la dispo · sizionc delle Lruppc a seeontla della nalura del paese, e delle ore-, se nouurne o diurne. Le marcie er!lDO ordina· di sci leghe al gioa·no.
ORDisponendo le truppe in ord ine primitivo di battaglia, si formavano in due linee; nella prima stendevasi la falange oplitica con file e t 6 righe; nella seconda l' e· pixenagia dei pellasti con 2o6 file e 8 righe. l psiliti stavano Cuori di linea ed in ordine sparso, o dinanzi alla Crontr, o disposti ai fianchi, o dietro alle lincr, o fra gl'in· terstizii della ca La cavalleria stava alle ali (V. Tav.1 Jll.a ).
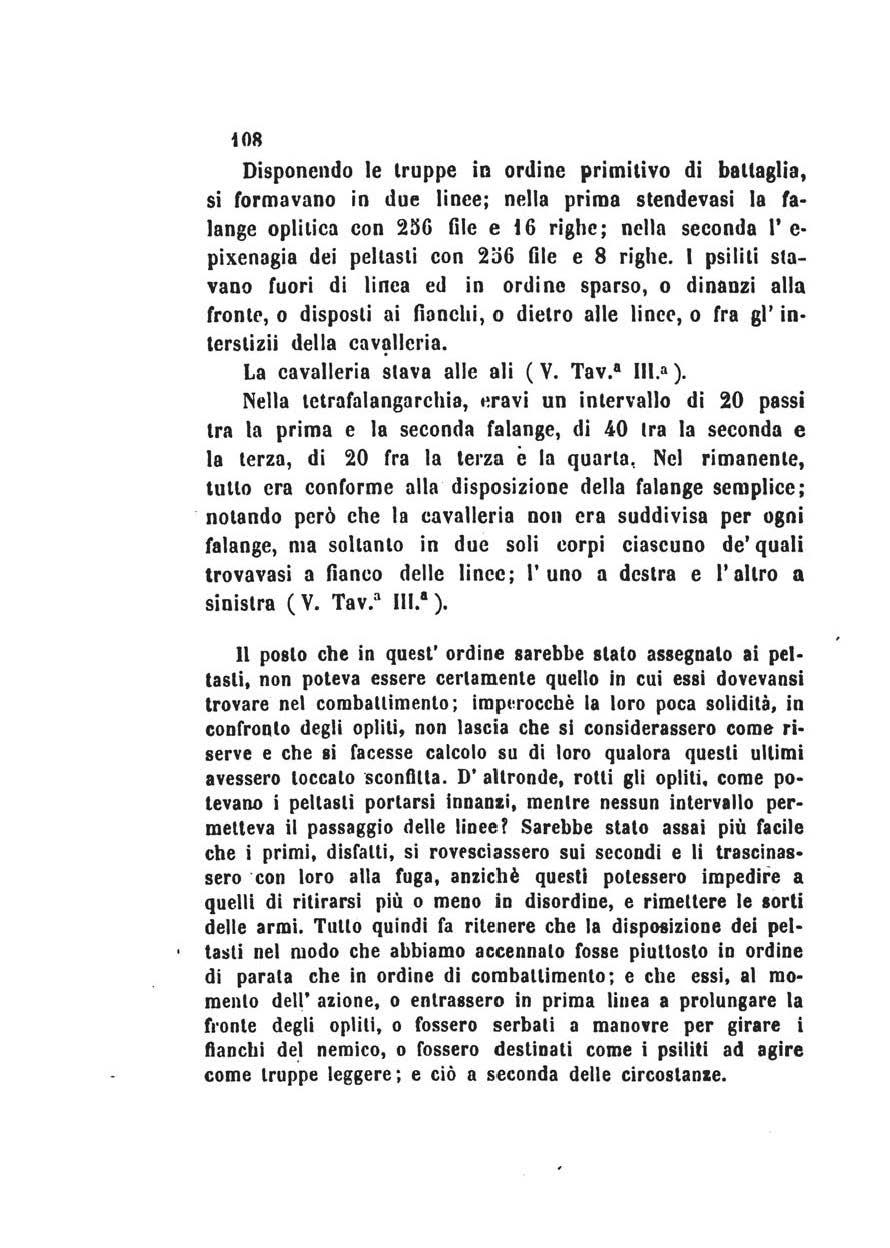
Nella tctrafalangarchia , un intervallo di passi tra la prima e la seconda falange, di 40 tra la seconda e la terza, di 20 fra la te•·za è la quarta, Nel rimanente, tutto era conforme alla disposizione della falange semplice; · notando però che la cavalleria non era suddivisa per ogni falange, ma soltanto in due soli corpi ciascuno de' quali trovavasi a fianco delle linee; l'uno a destra e l'altro ll sinistra (V. Tav.a 111.1 ).
Il posto che in quest' ordine sarebbe stato assegnato ai peltasti, non poteva essere certamente quello in cui essi dovevansi trovare nel combattimento; impt!roccbè la loro poca solidità, in confronto degli opliti, non lascia che si considerassero come ri serve e che si facesse calcolo su di loro qualora questi ultimi avessero toccato ·sconfitta . D'altronde, rotti gli opliti. come potevano i pellasti portarsi Innanzi, mentre nessun intervallo permetteva il passaggio delle linee f Sarebbe stato assai più facile che i primi, disfalli, si roVt'sciassero sui secondi e li trascinassero ·con loro alla fuga, anziché questi potessero impedire a quelli di ritirarsi più o meno io disordine, e rimettere le sorti delle armi. Tutto quindi fa ritenere che la disposizione dei pel· • tasti nel modo che abbiamo accennalo fosse piuttosto io ordine di parata che in ordine di comballimento; e che essi, al momento detr azione, o entrassero in prima linea a prolungare la f• ·onte degli opliti, o fossero serbati a manone per girare i ftancbi nemico, o fossero destinati come i psiliti ad agire come tr uppe leggere; e ciò n seconda delle circostanze.
L'ordine di cui abbiamo parlato, muta vasi, a norma dei casi , nella profondità e nella forma.
Qttalche volta la profondità ratJdoppinvasi, c poa·tavasi a 52 righe; qualche allra si riduceva alla metà e rimaneva di 8 righe. Nè a ciò solo limitavansi le variazioni che _ nel numero delle righe si portavnno nella falange .
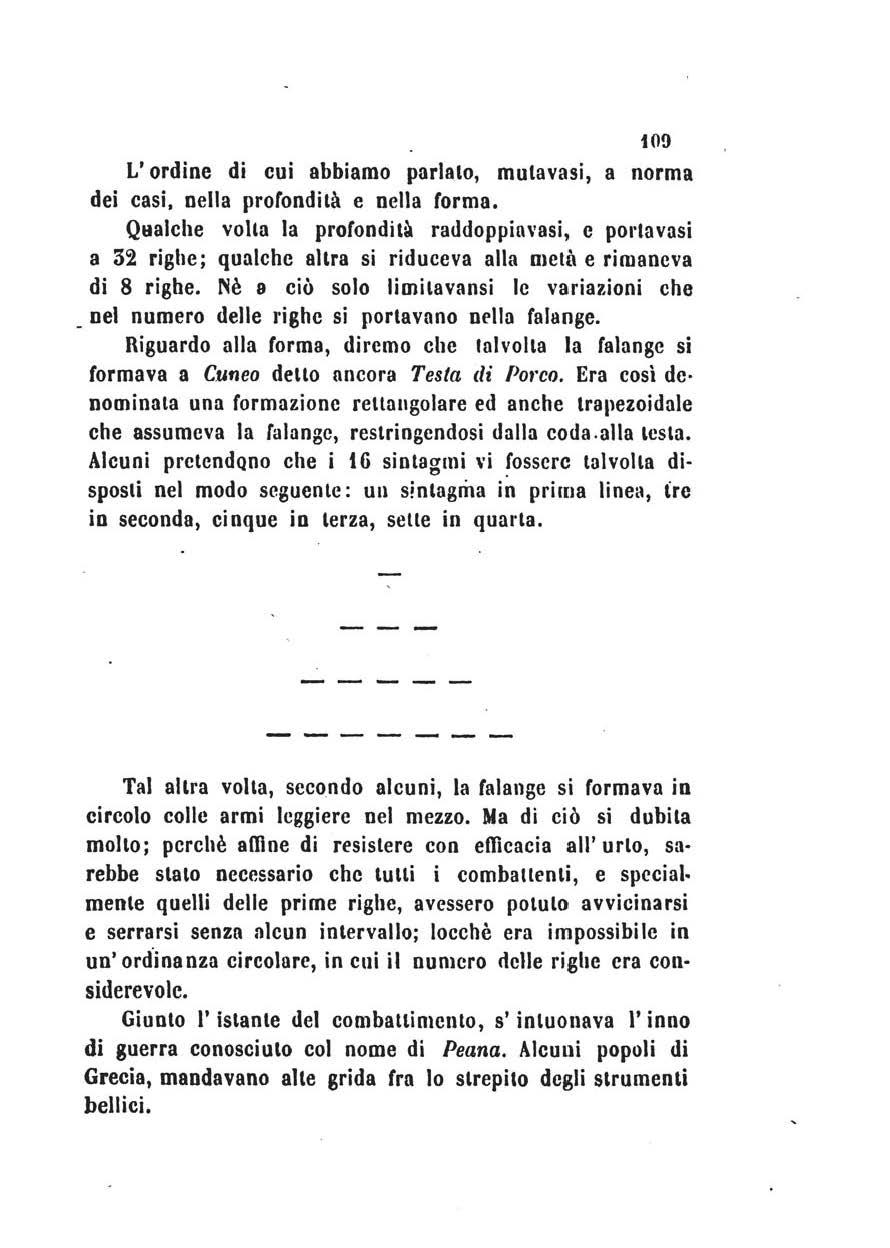
Riguardo alla forma, diremo che lalvolla la falange si formava a Cuneo detto ancora Testa eli Porco. Era così dc· nominata una formazione reuaugolare ed anche trapezoidale che assumeva la falange, restringendosi dalla coda .alla testa . Alcuni prctcndQno che i t 6 sintagmi \' i fosse re talvolta disposti nel modo seguente: un s!ntagma in pri([)a linea, tre io seconda, cinque io terza, sette in quarta.
Tal altra volta, secondo alcuni, la falange s i formava io circolo colle armi lcggiere nel mezzo. Ma di ciò si dubita molto; perchè affine di resistere con efficacia all'urlo, sa· rebbe stato necessario che tutti i comballenti, e spccial· mente quelli delle prime righe, avessero potuto avvicinarsi e serrarsi senza alcun intervallo; locchè era impossibile in un' ord.inanza circolare, in cui il numero delle era considerevole.
Giunto l' istante del combattimento, s' intuonava l'inno di guerra conosciuto col nome di Peana. Alcuni popoli di Grecia, mandavano alte grida fra lo strepito degli strumenti bellici .
Venendo alle mani, ei combatteva nel modo seguente. Le truppe lcggicrc iniziavano la lolta; poi scoprivano la fronte, e l' urto era dato o ricevuto dagli opliti; sei righe tenevano la sarissa orizzontale, le altre verticale perchè non avrebbero potuto sopravanzare la prima riga: così servivano a dare maggiore solidità all' ordinanza, cd a surrogarc i morti ed i feriti formando in tal guisa una specie di risl'lrva.
Se il nemico girava la linea , le sci ullimc righe presentavano la fronte indietro, e sostcn\!vano dal canto loro il com balli mento.
l pcllasti in modo misto, c talvolta servivano a prolungare la ·fronte della falange oplila.
La cavalleria molestava i fianchi del nemico, e si lanciava nei vuoti che si formavano nel della lotta.
In caso di villoria, gli uomini armati alla lcggiera insrguivano i vioLi per farr. prigionieri.
Finila la lotta, s' innalzavn un trofeo provvisorio, e di nuovo cantavasi un inno.
L'ordine para11clo era molto usato; ma si adottò anche il concavo , il convesso e l' obbliquo. Quest' ultimo, di cui fra breve parleremmo, fu adoperato con buon esito da Epaminonda cd anche da Alessandro il . grande.
l greci conobbero l' arte degli assedj, c quella della difesa delle piazze. Gli assedj di Alicarnasso e di Tiro falli da Alessandro il grande, quello di Rodi da Demetrio Poliorcetc, quello sostenuto da Siracusa contro i romani, ne danno prova. Ma di quest'arte tratteremo ragionando dci romani, essendovi in ciò molla analogia fril que' due popoli dell'antichità.
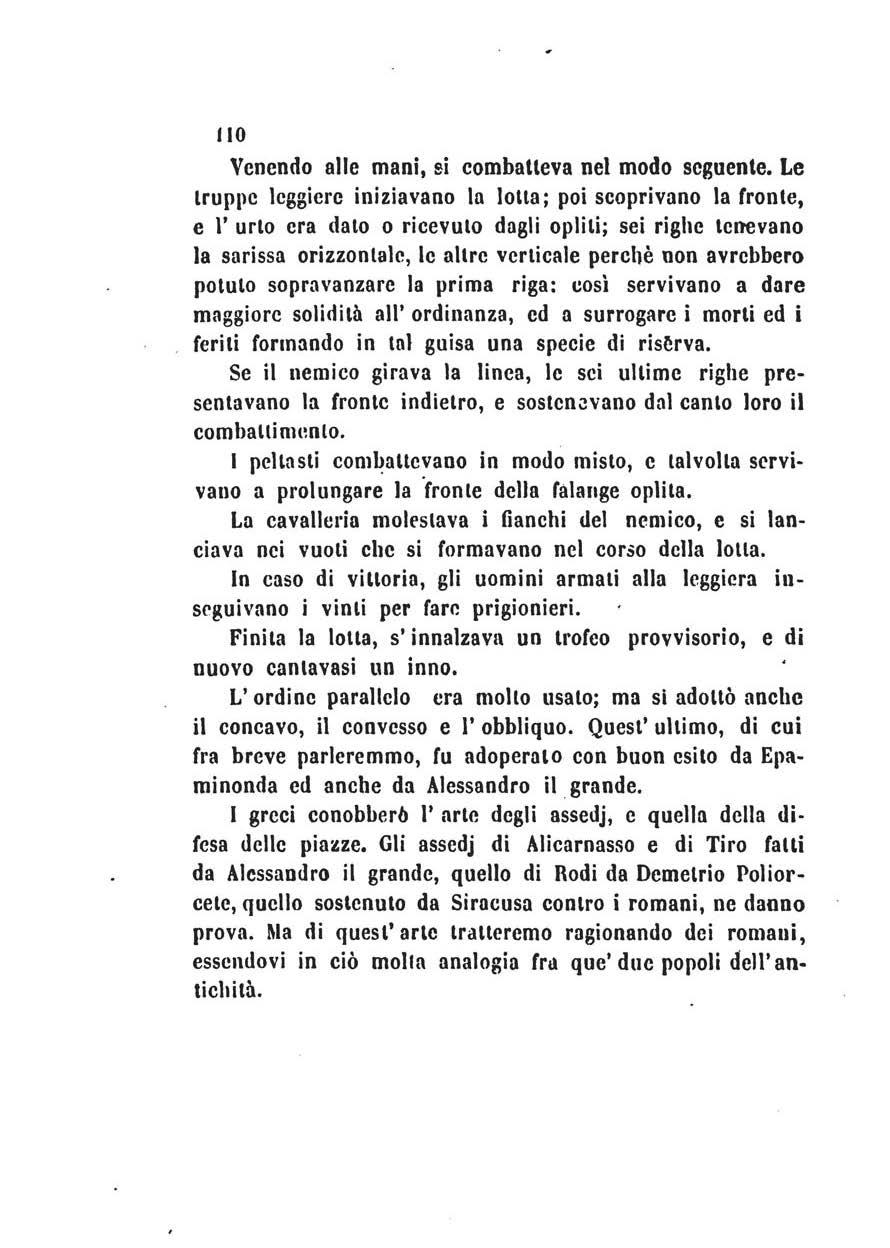
s. 4.0
Ceaal blo«ra8el e blbllo«raOcl.
n principio che alla formazione della falange fu quello lli costituire un corpo solido che resistesse all'urto tumultuario dei nemici.
La parola resistere implica difesa; c difcnsi\'a in prin· cipal modo era l' istit•JZionc della falange, come risulta evi· denlemente dalle sue nrmi, dalla sua ordinanza, dalla sua compattezza.
L'arme dell' oplita, elemento fondamentale della falange, era la lunga sa rissa. La lunghezza di quest'arma in ordinanza profonda e serrata, indica l' idea di tener lontano il nemico, d' impedire cioè che il nemico si avvicini ed offenda. È quindi arma essenzialmente difensiva. Altrettanto indicano Ja .difesa gli scudi del soldato medesimo.
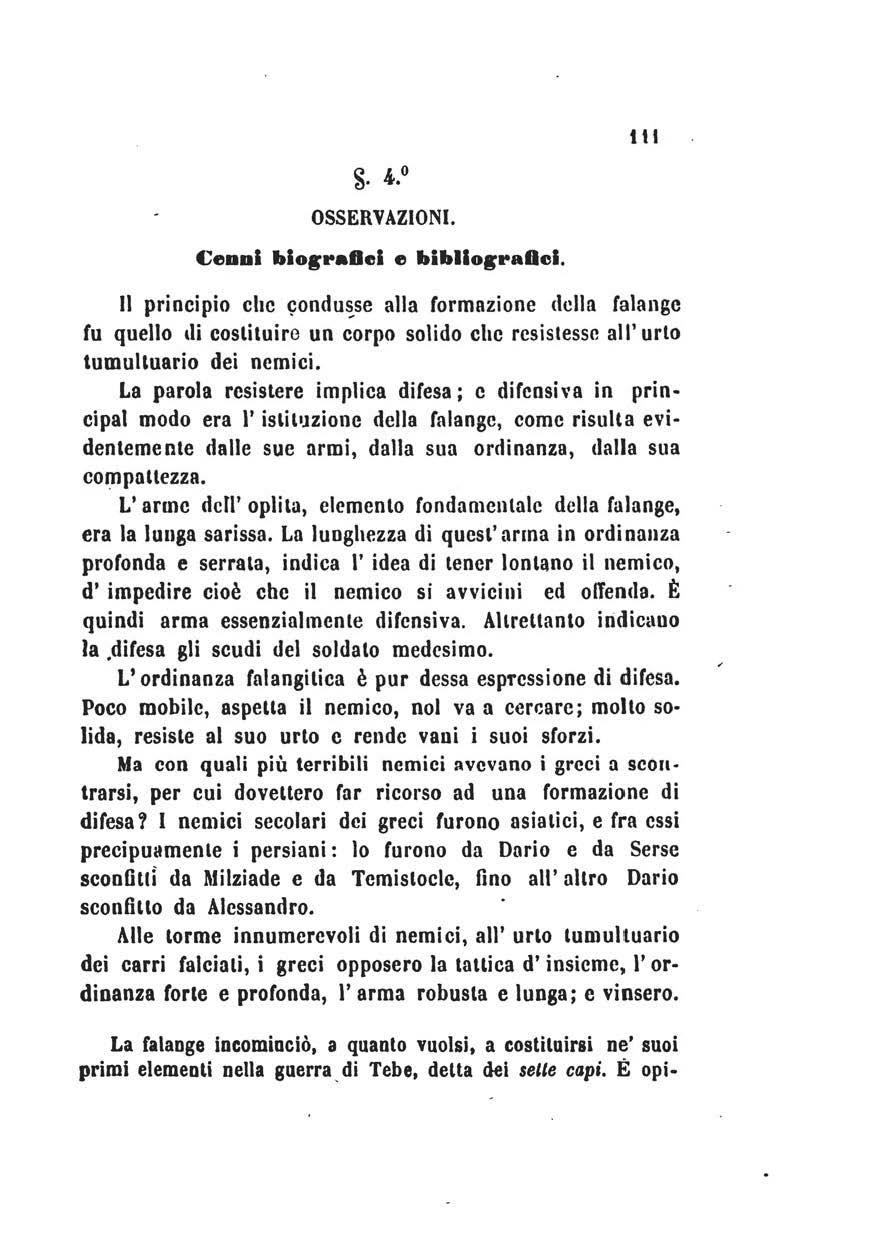
L'ordinanza fnlangilica è pur dessa espressione di difesa. Poco mobile, aspeua il nemico, noi va a cercare; mollo so· lida, resiste al suo urlo c rende vani i suoi sforzi.
Ma con quali più terribili nemici avevano i greci a scontrarsi, per cui dovettero far ricol'so ad una formazione di difesa? l nemici secolari dci greci furono asiatici, e fra essi precipuamente i persiani: lo furono da Dario e da Serse sconfitta da Milziade e da Temistoclc, fino alt' altro Dario sconfino da Alessandro.
Alle torme innumerevoli di nemici, all' urto tumultuario dei carri falciati, i greci opposero la tnUica d' insieme, l' ordinanza forte e profonda, l'arma robusta e lunga; e vinsero.
La falange locomiociò, a quanto vuolsi, a costituirsi ne' suoi primi elemeoli nella guerra . di Tebe, delta del sette capi. E opi-
l
H2 nione che in quella r.ircostanza si formasse la pe,tlacosiarchia, come quella che in un assedio aveva fronte abbastanza estesa da impedire l' uscita ai nemici p er le pot·te della cillà; imperoecbè, sebbene si voglia scorgere in codestà guerra ·qualche principio d'ordì ne e di disciplina, e qualche concello sufficientemente eseguilo, nulla meno l'arte dell' oppugnazione delle .piaz1.e non vi era di ce rto mollo avanzata, e tutto lo sforzo dei capi si dirigevo ap· punto contro le porte. .
Progredendo nel suo incremen Lo e nel suo perfezionamento, pare che la falange semplice si formass e nelle pianure della 'froade. Achille g iunse innanzi a Troja con 50 vascelli, su ciascuno de' quali aveva 50 uomini; di questi 2500 uomini formò 5 corpi e li pose sotto il comando di cinque capi diversi. corpi, di 500 uomini ciascuno, rappresentavano ancora la pentacosiarchia, il doppio sintagma, chr. corrispondeva o 512 uomini.
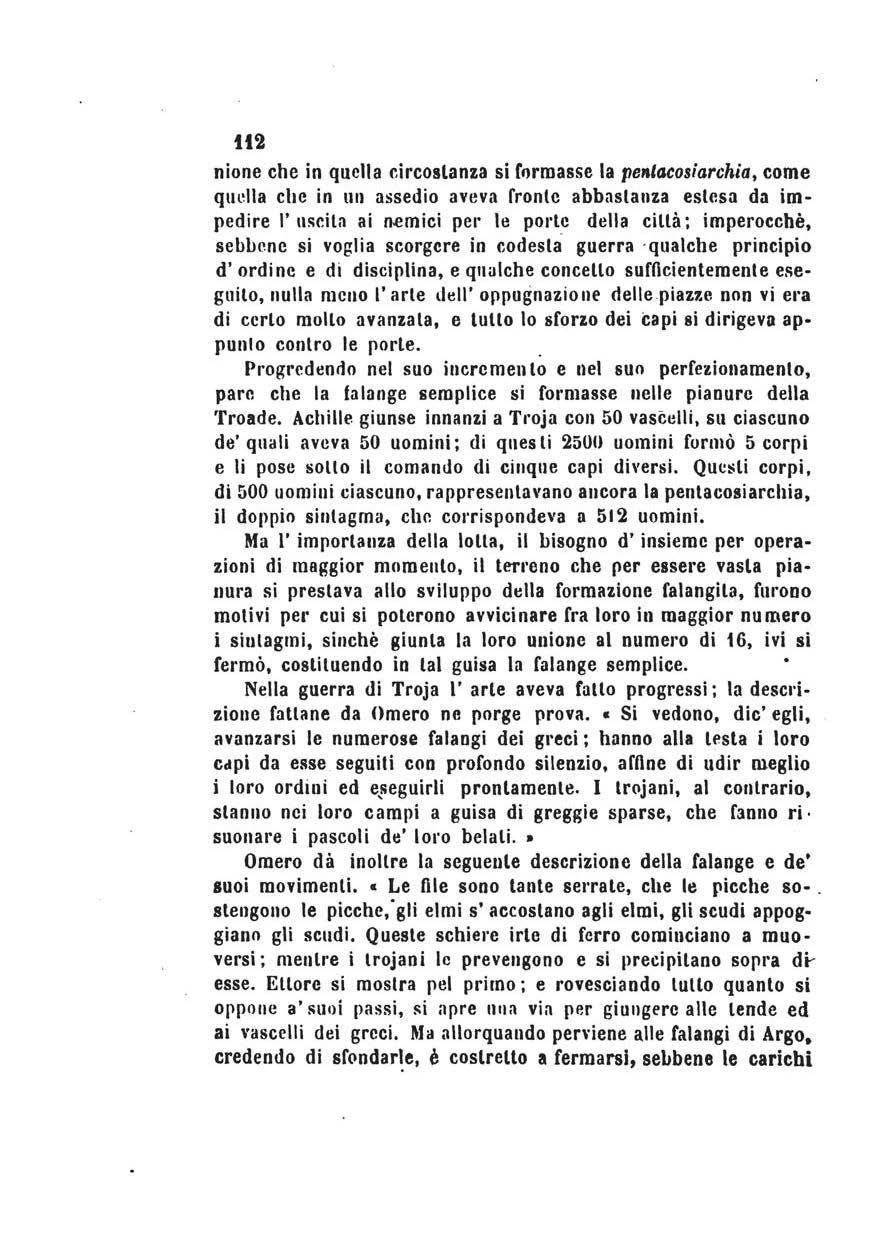
Ma l' importanza della lotta, il bisogno d' insieme per operazioni di maggior momento, il terreno che per essere vasta pianura si prestava allo sviluppo della formazione falangita, furono motivi pe1· cui si poterono avvicinare fra loro in maggior numero i siutagmi, sinchè giunta la loro unione al nume1·o di 16, ivi si fermò, costituendo io tal guisa la falange semplice.
Nella guerra di Troja l' arte aveva fallo progressi; la desc•·izione fattane da Omero ne porge prova. • Si vedono, dic' egli, avanzarsi le numerose falangi dei gt·eci; hanno alla Lesta i loro cc1pi da e11se seguiti con profondo silenzio, artlne di udir meglio i loro ordini ed e,seguirli prontamente. I t rCijani, al contrario, stanno nei loro campi a guisa di greggie sparse, che fanno ri . suonare i pascoli de' loro belali. •
Omero dà inoltre la seguente d esc rizione della falange e de• suoi movimenti. • Le file sono tante serrate, che le picche sostengono le picche,'gli elmi s'accostano agli elmi, gli scudi appoggiano gli scudi. Queste schiel'e irte di ferro cominciano a muoversi; ment•·e i trojani le prevengono e si precipitano sopra di-esse. Ellorc si mostra pel primo; e rovesci ando tutto quanto si oppone a' suo i passi, si apre nn a via per giungere alle tende ed ai vascelli dei greci. Ma allorquando pen·iene alle falangi di Argo. credendo di sfCindar!e, è costretto a fermarsi, sebbene le carichi
H5 con impelo furioso: impca·occhè codesti greci intrepidi lo ricevono senza rompersi, e lo respingono a colpi di picche è di spade. •
I greci adunque erano arrivali innanzi a 'froja colla penta· cosiarchia, e ne ritornarono .colla falange.
La falange si formò per obbligare ·t' impeto lumulluario a rompersi contro masse serrate e ferme; si formò nelle pianure della Troade, innanzi ai carri dei trojani, e contro · gli sforzi di una fanteria disordinala ma pt• ode: ed al cui impeto tnmulluario doveva appunto opporsi un' ordinanza solida e profonda .
Ma percbè la fa lange si limitò alla riunione di 16 sintagmi, e uon progredì aumentandone il congiungimento in numero maggiore?
Per ragioni parziali e riferibili a quell ' epoca , e per motivi generali che io ogni tempo sussisteranno e di cui deesi tenere gran calcolo anche ai dì nostri.
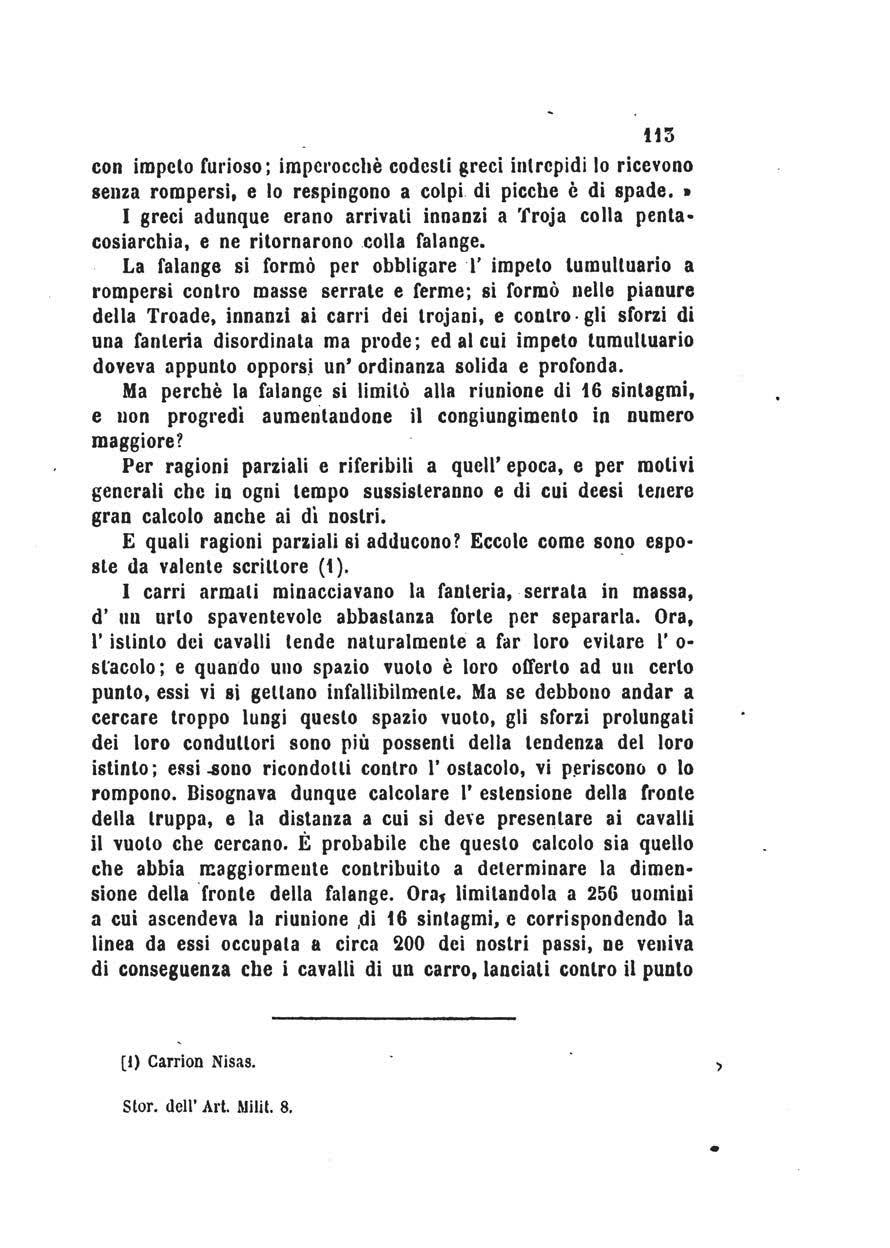
E quali ragioni parziali si adducono? Eccole come sono espo· ste da va lente scrittore {1 ). · l carri armali minacciavano la fanteria, .serrata in massa, d' 1111 urlo spavenlevolc abbastanza forte per separarla. Ora, l' istinto dci cavalli tende naturalmente a far loro evitare l' ostacolo: e quando uno spazio vuoto è loro offerto ad uu certo punto, essi vi si gellano infallibilmente. Ma se debbono andar a cercare troppo lungi questo spazio vuoto, gli sforzi prolungati dei loro conduttori sono più possenti della tendenza del loro istinto: eRsi ..sono ricondolli contro l' ostacolo, vi o lo rompono. Bisognava dunque calcolare l' estensione della fronte della truppa, e la distanza a cui si de\'e presentare ai cavalli il vuoto che cercano. È probabile che questo ca lcolo sia quello che abbia maggiormente contribuilo a determinare la dimensione della ·fronte della falange. Ora1 limitandola a 256 uomini a cui ascendeva la riunione ,di 16 sintagmi, e corrispondendo la linea da essi occupata a circa 200 dci nostri passi, ne veniva di conseguenza che i cavalli di un carro, lanciali contro il punto [l) Carrion Nisas.
St or. dell' Al't. Milit. 8.
il .t centrale. non avevano bisogno che di una deviazione di 100 passi per evitare l' urlo contro una falange isolata. E se la fa· Jange era combinata con altre truppe. i cavalli coi carri sarebbero passati pe1· gl' intervalli fra .due falangi. il minore dei quali era di 20 passi; ed allora . arrivando dietro la linea. sarebbersi trovati probabilmente perc.luti. essendo in balia di soldati che combattevano ' iso l alamcute intorno · alla falange, o delle truppe accessorie da cui era·
Riguardo ai motivi generali, essi risultano dalla necessità di non comporre masse troppo pesanti. perchè la troppa solidità andrebbe poi a grave scapito della mobilità. É questione agitata anche oggidi della limitazione delle unità lattiche. e dei corpi in genere; del maggiore o iuinor numero di compagnie tli cui dev' essere composto il battaglione, del maggiore o minor numerO"' di battaglioni di cui dev' essere composlll il reggimento; e così via via, sino alle formazioni di masse di maggior momento.
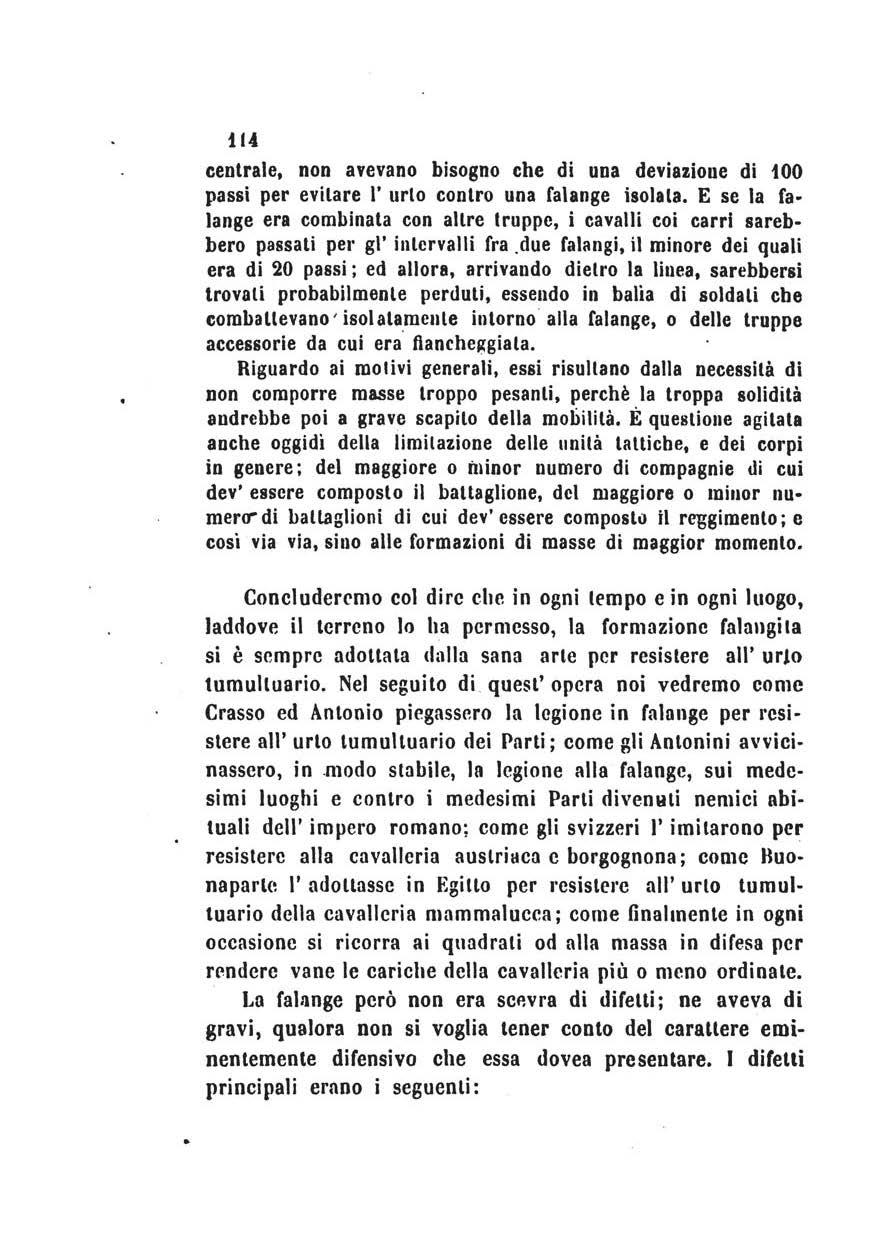
Concluderemo col dire che in ogni tempo e in ogni luogo , Jaddove il terreno lo ha permesso, la formazione falaugita si è sempre adottata dalla sana art e per resistere all' urto tumultuario. Nel seguito di. quest' opera noi vedremo come Crasso ed Antonio piegassero la legione in falange per •·esistere all' urto lumulluario dei Parti; come gli Anlonini avvici· nassero, in .modo stabile, la legione alla falange, sui medesimi luoghi e contro i medesimi Parli diventHi nemici ahi· tuali dell'imp ero romano; come gli svizzeri l'imitarono per resistere alla cavalleria austriaca c borgognona; come l\uonaparte l' ndouassc in Egitto per a·csisteJ'C nll ' urto tumultuario della cavalleria mammalucca; come finalmente in ogni occasione si ricorra ai quadrati od alla massa in difesa per rr.ndcrc vane le cariche della cavalleria più o meno ordinate.
La falange però non era scP.vra di difetti; ne aveva di gravi, qualora non si voglia tener conto del carattere emi nentemente difensivo che essa dovea presentare. l difetti principali ernoo i seguenti:
t 15
t .• Essa non poteva ogirc a perfezione se non . che in un terreno piano, unito, scoperto, senza fossi, senza pantani, senza gole, senza eminenze, senza fiumi; cd è difficile trovare un terreno esteso che non offra alcuno di tali oslncoli.
2. • Essa non era dotata di grande mobilità.
5.° Forma,·a una sola linea di bauaglia; imperocchè, rotta una \'olta la falange degli opliti, la linea dci peltasti non poteva rimcuere il comballimento, impedendo il loro organamcnto che essi, truppe più lcggicrc, serv issero di riserva a truppe più solide c pesanti. D' altronde, nell'ordine di battaglia, non si scorge come si potessero effettuare i passaggi delle lince.
A questi difetti si rimediò in circostanze speciali, allorquando il terreno lo ebbe richiesto: la falange fu spezzata, o, per meglio dire, spartita nelle sue divisioni c sudd iviper nelle marcic , cd anche per vantaggio nei comballimcnti. Senofonte la ruppe per adattarla al terreno nella ritirata dei diecimila, come vedremo negli csempj che addurremo; Pirro la ruppe dopo avere combattuto per qualche tempo nei te rreni ineguali cd interscrati dell' Italia. Continuando le nostre osservazioni sul progresso dell' arte militare in Grecia, diremo che nelle guerre persiane troviamo a Maratona brillate il gt'nio greco per la tattica &ulla scelta della posizione, c sul distribuin·}... le truppe, fo•·matc a Difcilangarclda, ossia in due falangi . Alle Tcrmopoli si ammira l' abnegazione di Leonida, ma in via d' arte la palma spella a Mardonio che ha giralo a' suoi fianchi.
Nella guerra del Pelopònncso non si hanno se non che operazioni abortite, lunghissimi assedj, e spedizioni abbandonate appena intraprese. Un bel concetto si fu la divcr·
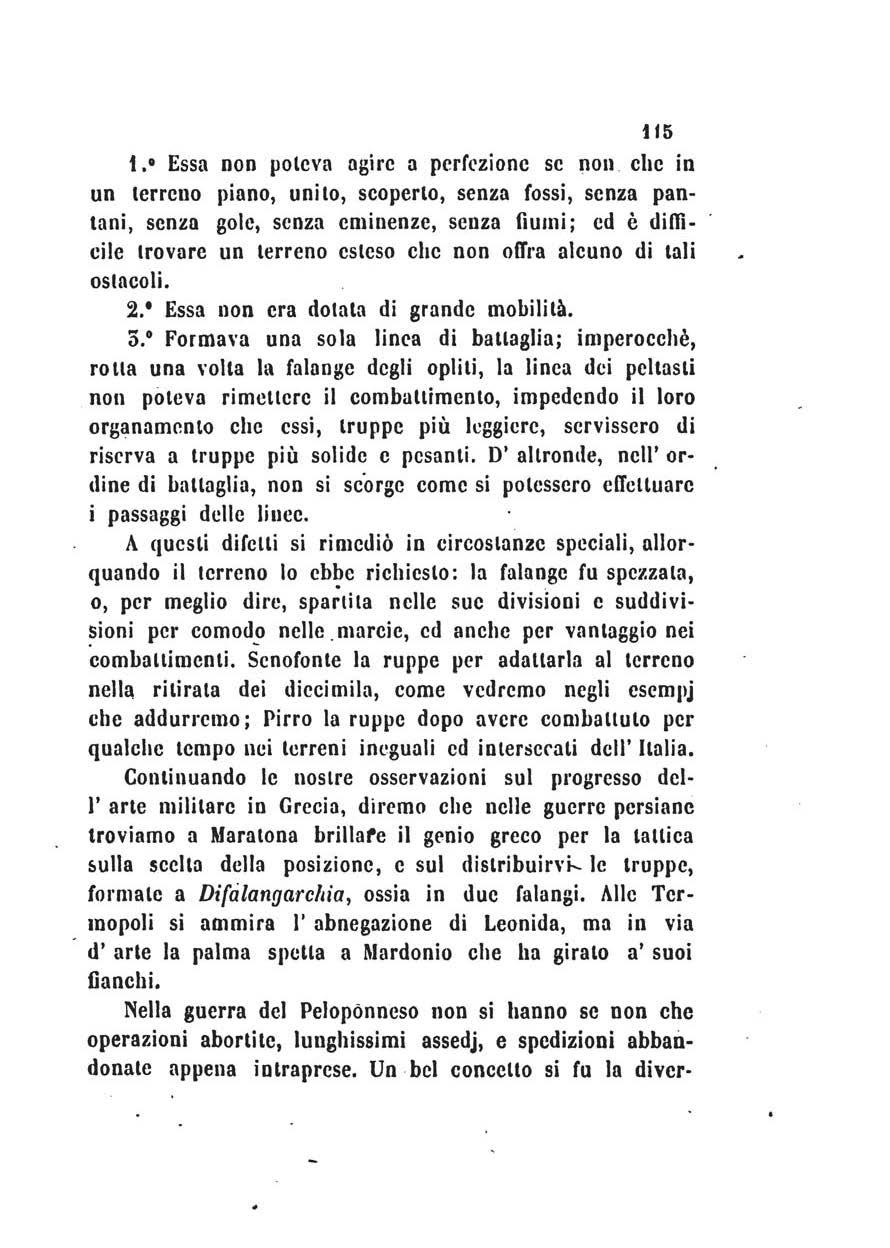
U6 sione in Sicilia immaginata da Periclc, ma fu male eseguita da Nicia.
Nella ritirata dci diecimila, Senofonte, come ·dicemmo, impresse mobilità n<•gli eserciti greci. Fu egli che tracciò ad Alessandro le strade dell' Asia maggiore.
Nella guerra trbana, Epaminonda perfezionò la grande tauica. Inventò, od usò splendidamente, l ' ordine obbliquo, cioè la disposizione colla quale si fa forza sopra uno o due punti con superiorità d' azionr, qualunque poi sieno la natura degli agenti e il genere della manovra di cui si fa uso.
l.' ordinamento della tctrafa,angarcbia fu opera di Filippo di Macedonia, cd Alessandro suo figlio ne trasse il profitto che tutti sanno. Alessandro fu tra i greci il primo cd il più grande nei concetti strategici. Prima d' internarsi nel continente asiatico, s' impadrouì, éome vedremo, delle cillà marinime, c con ciò rimase legato alla sua base d'o· pt>razione, c im11edì al nemico di equipaggiar flotte che potessero ta&liarlo fuori da questa base.
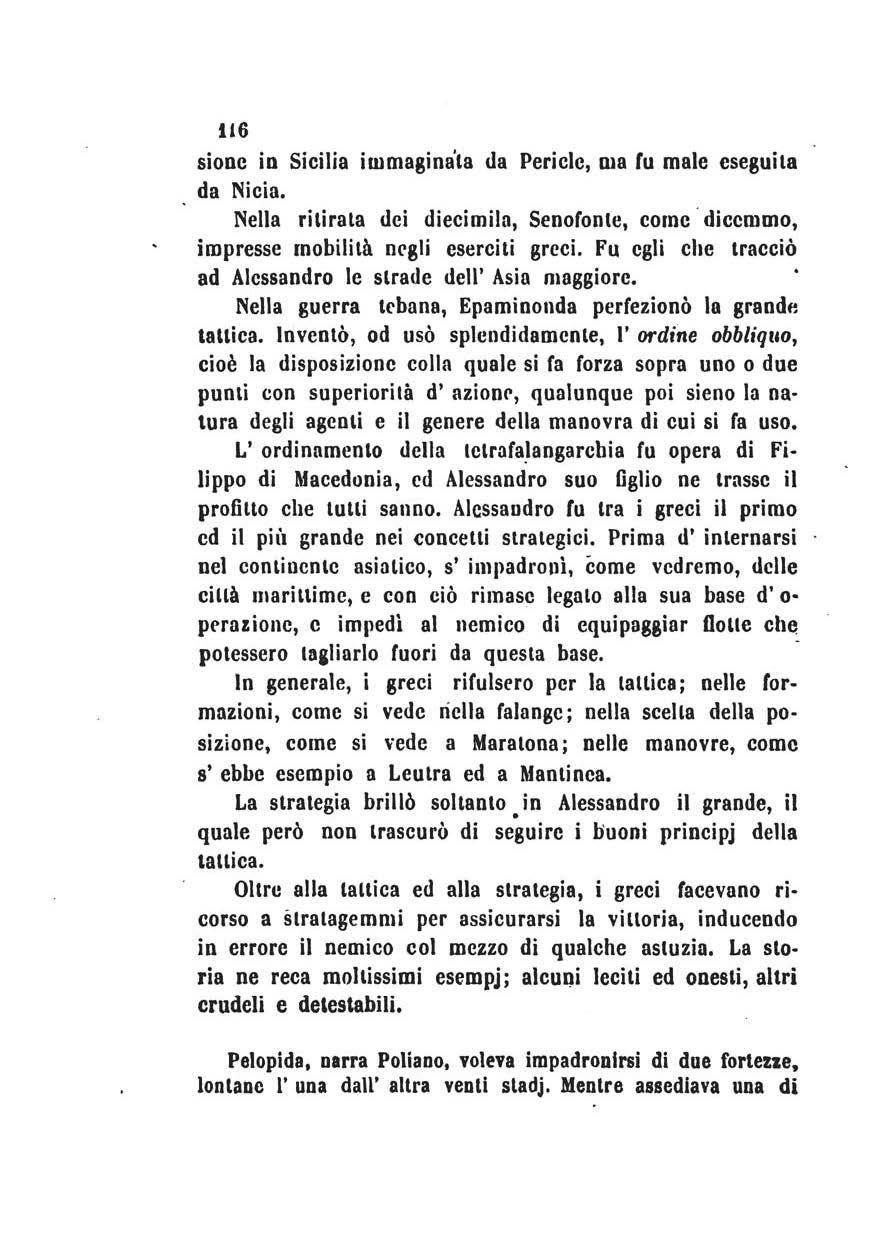
In generale, i greci rifulsero per la tattica; nelle formazioni, come si vede nella falange; nella scella della posizione, come si ,·ede a Maratona; nelle manovre, come s' ebbe esempio a l.eutra ed a Mantinca. l.a strategia brillò soltanto. in Alessandro il grande, il quale però non trascurò di seguire i liuoni principj della tattica.
Oltre alla taltica ed alla strategia, i greci facevano ri· corso a stratagemmi per assicurarsi la vittoria, inducendo in errore il nemico col mezzo di qualche astuzia. l.a storia ne reca mollissimi esempj; alcuni leciti ed onesti, altri crudeli e delestabili.
Pelopida, narra Poliano, voleva impadronirsi di due fortezze, lontane l' una dall' altra venti sladj. Mentre assediava una di
tl7 queste, die' ordine 11 quattro cavallieri di venire a briglia sciolla, con corone in testa, ad annunciargli la presa dell' altra città. A tale notizia, egli condusse le sue truppe innanzi alla città che si dir.eva caduta; e quando fu davanti alle mura, fece accendere un gran fuoco il cui fnmo fu veduto da quelli dell' altra cillà, i quali credettero che Pelopida l' avesse data in preda alle fiamme; ebbero paura di .essere trattati allo stesso modo, e si arresero a Pelopida. Questi aggiunse alle sue le forze che trovò nella città vinta; e si presentò innanzi all' altra, che, non avendo il coraggio di resislergli, gli apri le porte. Questo fu stratagemma leeilissimo.
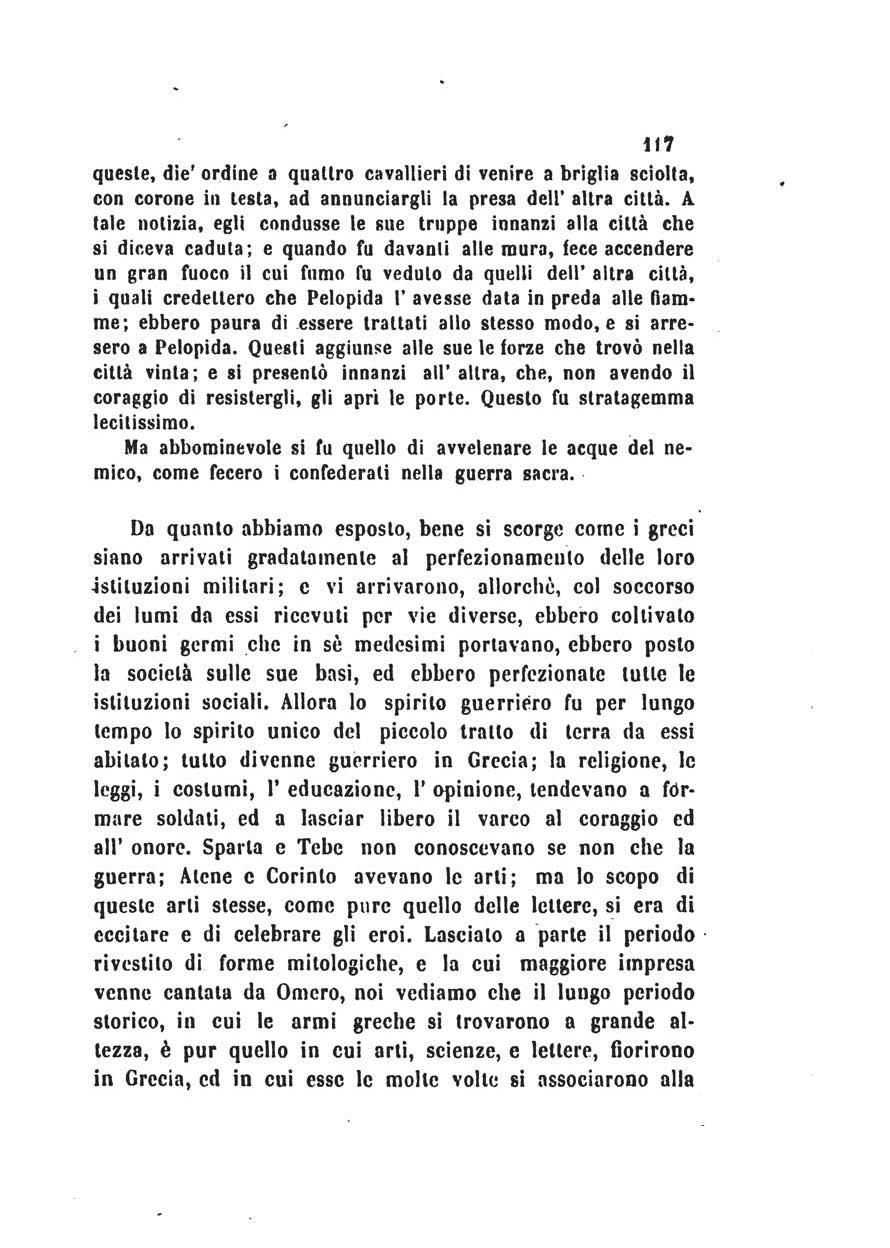
Ma abbominevole si ru quello di avvelenare le acque del nemico, come fecero i confederati nella guerra sact·a. .
Do quanto abbiamo esposto, bene si scorge come i greci siano arrivati gradatamente al perfezioname1Ùo delle loro c yi at·rivnrono, allorchè , col soccorso dei lumi da essi ricevuti per Yie diverse, ebbero coltivalo i buoni germi .che in sè medesimi portaYnno, ebbero posto la società sulle sue basi, ed ebbero perfezionate tutte le istituzioni sociali . Allora lo spirito guerriero fu per lungo tempo lo spirito unico del piccolo tratto di terra da essi abitato; tutto divenne guerriero in Grecia; la religione , le leggi, i costumi, l' educazione, l' opinione, tende\·ano a for· mare soldnti, ed a lasciar libero il varco al coraggio cd all' onore. Spa1·ta e Tcbc non conoscevano se non che la guerra; Atene c Corinto avevano le arti; ma lo scopo di queste arti stesse, come pure quello delle lettere, era di eccitare e di celebrare gli eroi. Lasciato a ·parte il periodo · rivestito di forme mitologiche, e la cui maggiore impresa venne cantala da Omero, noi vediamo che il luogo periodo storico, in cui le armi greche si trovarono a grande al · tezza, è pur quello in cui orti, scienze, e lettere, fiorirono in Grecia , cd in cui esse le molle volle si nssociarooo alla
H8
buona riuscita delle armi c ntl eternarne i trionfi. Tirtco co' suoi canti ispirò il cornggio, col suo esempio insrguò a vincr.re. Il poeta Eschilo, dopo aver combattuto nelle battaglie di di Salamina , di Platea, compose sulla prima di esse un poema il èui piano era stato concrpito sul campo stesso; il tragico Sofocle aveva diviso con Pcriclc il comando dell' esercito; Erodoto, combnllè contro il tiranno di Alicamasso, r., qual padre della storia, narrò le gcstc dei greci che difendevano la patria contro gli eserciti innumerevoli di Persia; Tucidide, combattè e scrisse In guerra del Peloponneso; Senofonte, conduuore dei diecimila, descrisse le vicende della sua impresa; e dalla sua descrizione si scorge come la guerra si conduca in conformità del carattere della nazione, dello stato sociale di essa; impcrocchè vi si rileva la superiorità degli "ord ini civili c il genio flessibile dr.i greci, che sperimentano, .variano non cedono nllc prime contrarietà, mentre i persiani non r:ulunnndosi che per. In p•·osperità, c continuando negl' immobili disegni, soccombono .
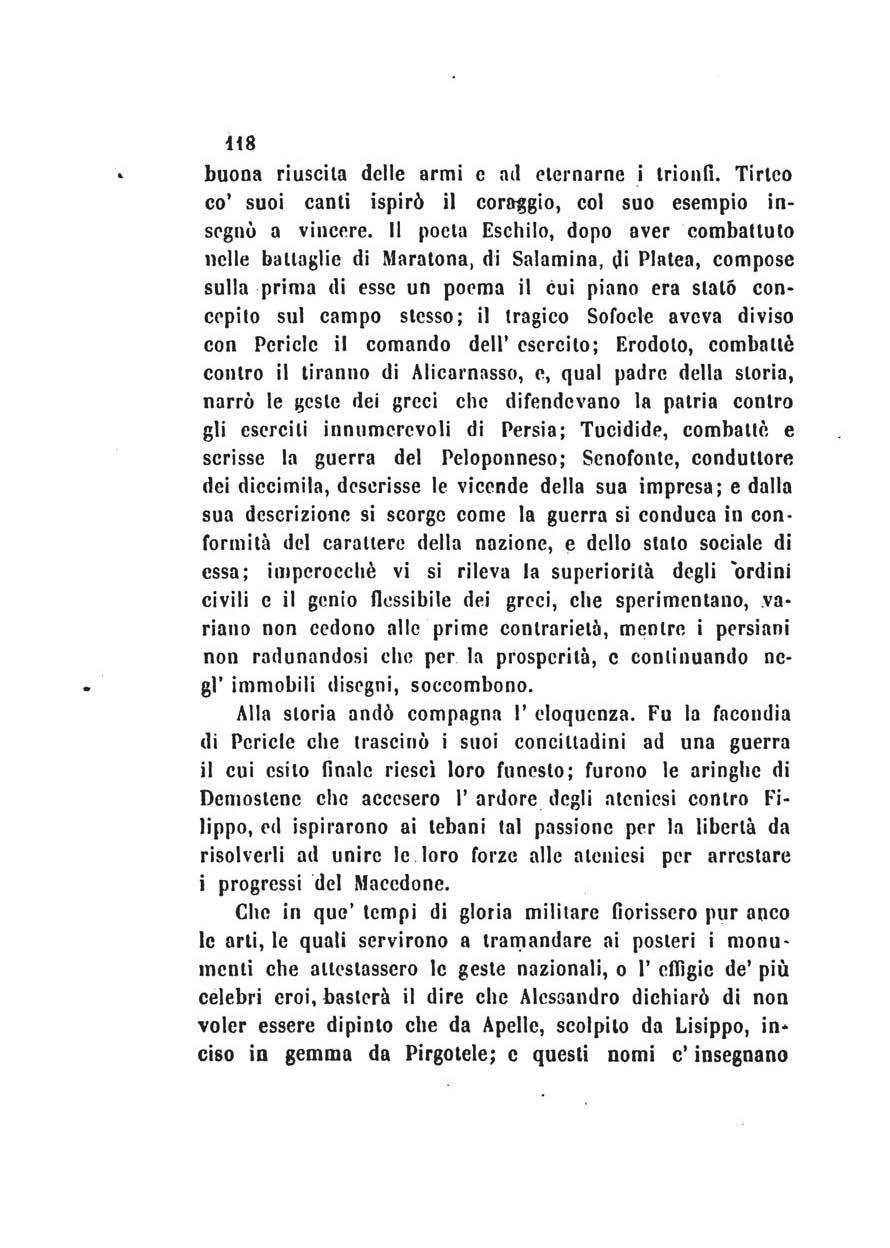
Alln storia andò compagna l' eloquenza. Fu la facondia di Pcriclc che trascinò i suoi concilladini ad una guerra il cui esito finale riesci loro funesto; furono le aringhe di Demostenc che accesero l' ardore . degli ateniesi contro Filippo, ed ispirarono ai tebani tal passione per In libertà da risolverli ad unire le . loro forze nllc ateniesi per arrestare i progressi 'del Maeedone.
Che in qui!' tempi di gloria militare fiorissero pur aoco le arti, le quali servirono a tra O) andare ai posteri i monumenti che all<'slassero le geste nazionali, o l' effigie de' più celebri eroi, basterà il dire che Alesoandro dichiarò di non voler essere dipinto che da Apelle, scolpito da Lisippo, in• ciso in gemma da Pirgotele; c questi nomi c'insegnano
. H9 come alla gloa·io della spada andasse in Grecia la maestria somma nello scalpello, nel pennello, e nel bolino.
In mt!ZZO n tanta sapienza e n taoia abilità, le menti greche, illuminate dalla filosofia, crnno oscurate dallà superstizion('. Dalle minime cose trnevnnsi buoni o funesti. Prima di cominciare un' impresa, si sacrificavano villime, e se ne consultnvano le viscere. Gli sparLani non si ponevano in marcia prima .del plenilunio; e ciò tolse loro la gloria di combattere a Maratona.
Qu<'slo misto di sapienza c ù' ignoranza imprimeva na· un carallcre specinlc alle risoluzioni ed all'andamento delle imprese .
Ci resta ora ad esporre, come promettemmo, un cenno biografico dei prlncipalì guerrieri che rifulsero nell' epoca gloriosa della Grecia, ed indicare alcuni autori principali che di questa si occuparono.
Troppo Jungo sarebbe il voler parlare di lutti i grandi capitani; il nominare Mil zia de, Cimone, Senofonle, Lisandra, Epaminonda, Filippo . di Macedonia, Alessandro, Filope· mene, basta ad indicare qual campo fecondo presentino que'tempi alla meditazione d el guerriero. Ci limiteremo quindi ad una scelta fr.a essi; e la facciamo .;adere su Senofonte, Epaminonda, ed Alessandro, che ci sembrano i "più meritevoli di essere intimamente conosciuti.
S1Norons. Nacque in Atene nel .u5 prima dell' èra voi· gare. Fu discepolo eli Socrate. Combattè nella battaglia di Delio, e posteriormente venne fallo prigione dai beoti. Continuò poi a !lervire la patria nella guerra peloponneslaca, ed a questa scuola ·pratica ar.qÙist.ò le profonde . cognizioni d' arte militare di cui diede pr11ve si lumino se nella ritirata dei diecimila. È in questa operazione militare, ammirabilmente condotta, che si è fatto un nome imperituro nella storia dell ' arte della guerra; ed è perciò che di essa terremo in seguito apposito discorso.
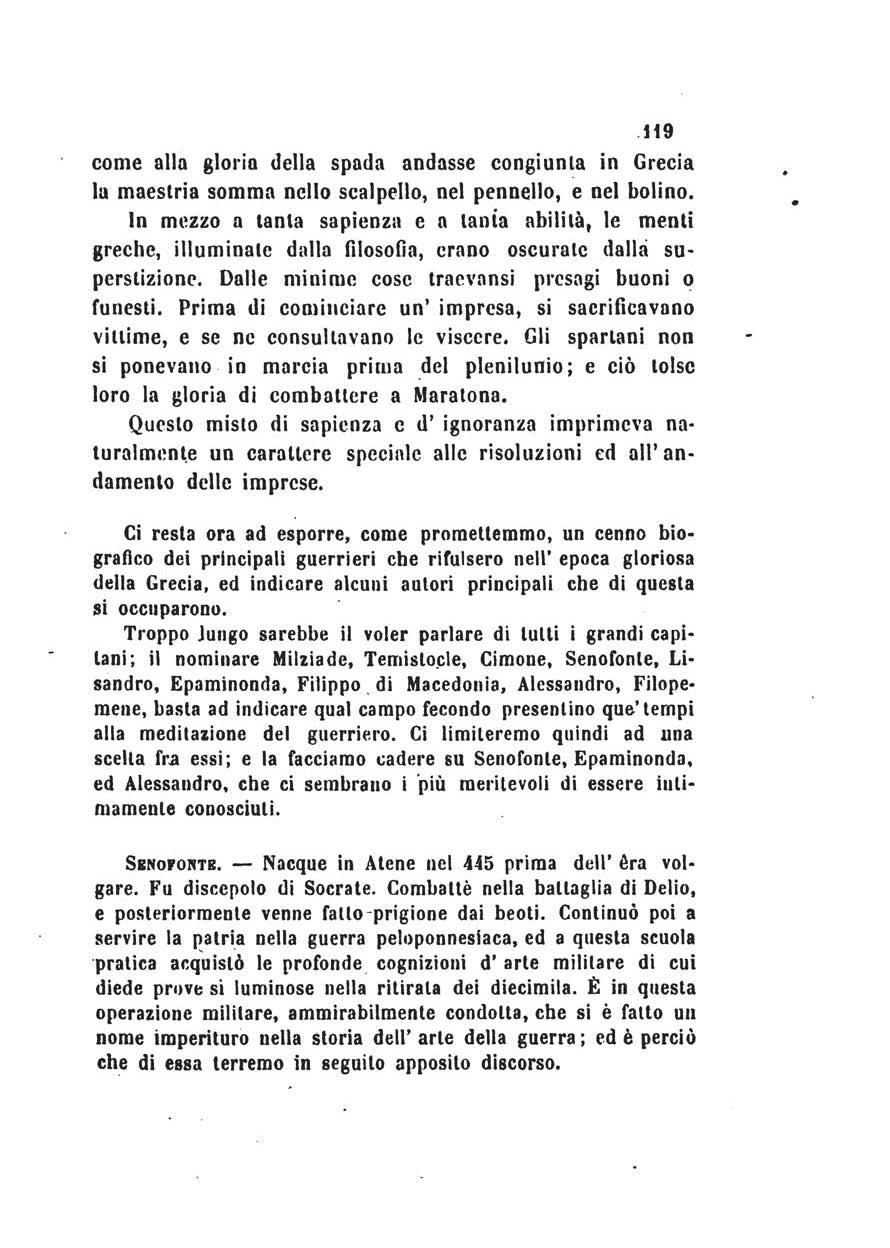
t20
Ritornato in patria, vi cadde in sospetto come amico di Socrate ch' era già stato dannalo a morte. Legatosi io amicizia con Agcsilao, andò a raggiungerlo in Asia, quando quel re v' intraprese la sua spedizione. Allora i suoi compatrioti, indispettiti nel vederlo .p o co r.a ldo d i amore di patria in guisa di ammirare e st>rvire gli stranieri, lo punirono di esiglio, ed egli trovossi contro loro alla battaglia di Coronea a fianco di AgesiIso. Gli spartani invece, in segno di riconoscenza, gli conferirono onori e gli regalarono casa e terre in Elide, ove si ritirò, con moglie e figli, stanco dellt' fatiche della guerra. Studio, caccia, cd amici, furono i suoi passatempi. Ma coslrello ad abbandonare la sua dimora per oslilità drgli elei contro gli spartani, tlni collo stabilirsi a Corinto, ove pare che rimanesse sino a Ila morte, sebbene gli ateniesi gli avessero rimessa la pena. Gradì tanto però questa spontanea resipiscenza della ·patria, da dartene prova col mandare i suoi due figli in Atene ad arruolarsi nell' esercito che marciò iu ajuto di Sparla, e combattè a Manlinea nel 362.
L' -illustre vecchio ollantcnne o[eriva un sacrificio, quando vennero a dirgli che un suo figlio era mol"lo nella battaglia. Allora si tolse la corona; e siccome il figlio defunto fu procla· mato non solamente valoroso, ma fortunato per avere ferito mortalmente Epaminonda, se la ripose in capo senza versare una lagrima, e si limitò a dire: • Sapeva ben io che mio figlio era mortale •.
1\lorì a novanl' anni; e fra le ultime pagine che scrisse, si leggono queste parQie: • Possa io almeno, priola discendere nella vedere la mia patria lJ·anquilla e fiorente l •
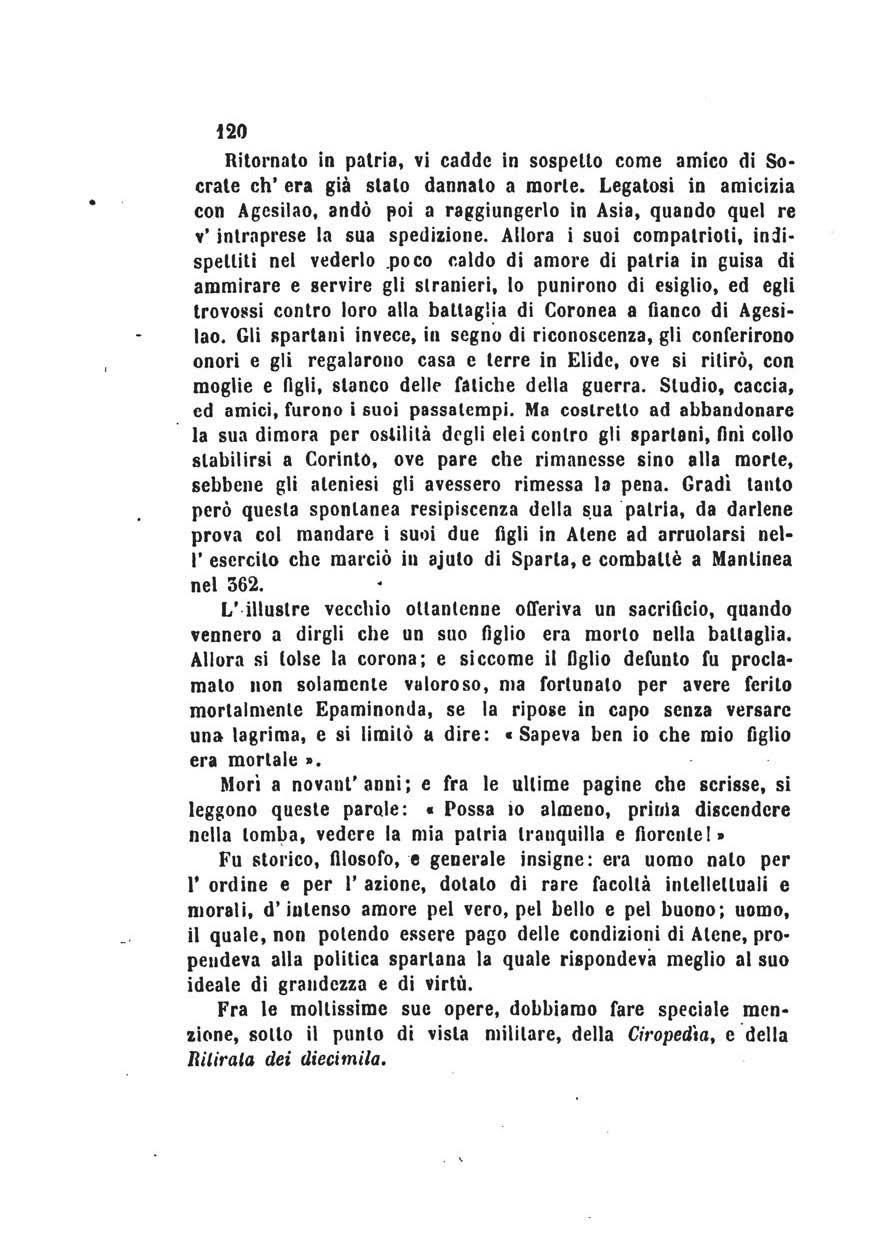
Fu stoa·ico, filosofo, e geoenle insigne: ea·a uomo nato per l' ordine e per l' azione, dotalo di rare facoltà intellelluali e mora l i, d' intenso amore pel vero, pel bello e pel buono; uomo, il quale, non potendo ellsere pago delle condizioni di Atene, propendeva alla politica spartana la quale rispondeva meglio al suo ideale di graudczza e di tirtù.
Fra le moltissime sue opere, dobbiamo fare speciale men· tione, sollo il punto di vista militare, della Cil·opedìa, c ·della Rilirala dei diecimila.
Tt·br, città principale drlla Béozia. ebbe il vanto P- .la forttJnll di verler nascr.rc sommo r.Rpilano nel quarto secolo pri•na dell' èra ca·istiana. Liberata giogo spar· tann col mezzo di una congiura, fra' cui capi era Pelopida, Tcbc si tro\:Ò in gucna cou Sparla, ed Epamioonda ebbe il comando delle sue lruppr Jr'u allora che si combattè la battaglia di Leu· Ira che noi drscrivert'mo in questo capitolo, e che diede tanto l usi ro al nome del generale le bano per la tattica con cui seppe condurla.
Questa villoria ispirò ad Epaminonda il disegno di rovesciare la supremazia di Sparla, e por Tebe a capo delle costituzioni tlcmor.ratiche della Grecia. Entrò nel Pel(•ponneso con parecchi alleali nd 5G9 A. G. C., invase c mandò a guasto gran parte della l.aconia, favori il ritorno io patria di mollissimi iloti nella e, rienlr;ato .in Trbç, venne chiamato in giudizio per avere tenuto il comando per quattro mesi oltre il tempo pre· scrillo dalle leggi. Egli consenti coi giudici sulle imputazioni fallcgli; indi soggiunse: • La legge mi condanna; merito la mor· le: ma chiedo per graz.ia che sia dichiaralo nella seutenza essere io slalo punito per nverc comballuto c vinto a Lculra, salvata Tt'be, rirlonata la libca·Là alla Gt·ecia, assedialo Sparla, rifalln Mcssenc. • l tebani applaudirono ed i giudici non osarono con· dannarlo.
Arruolatosi soldato in una guerra fatta per. liberare l' nmir.o suo l'elopida, che era ritenuto prigioniero da Alessandro tiranno di Fera, assunse poi il comando in capo d ell' esercito che era stnlo ballulo, e che fu da lui condotto a Tcbe, poi ricondoUo a comballet·c ecl a vincere.
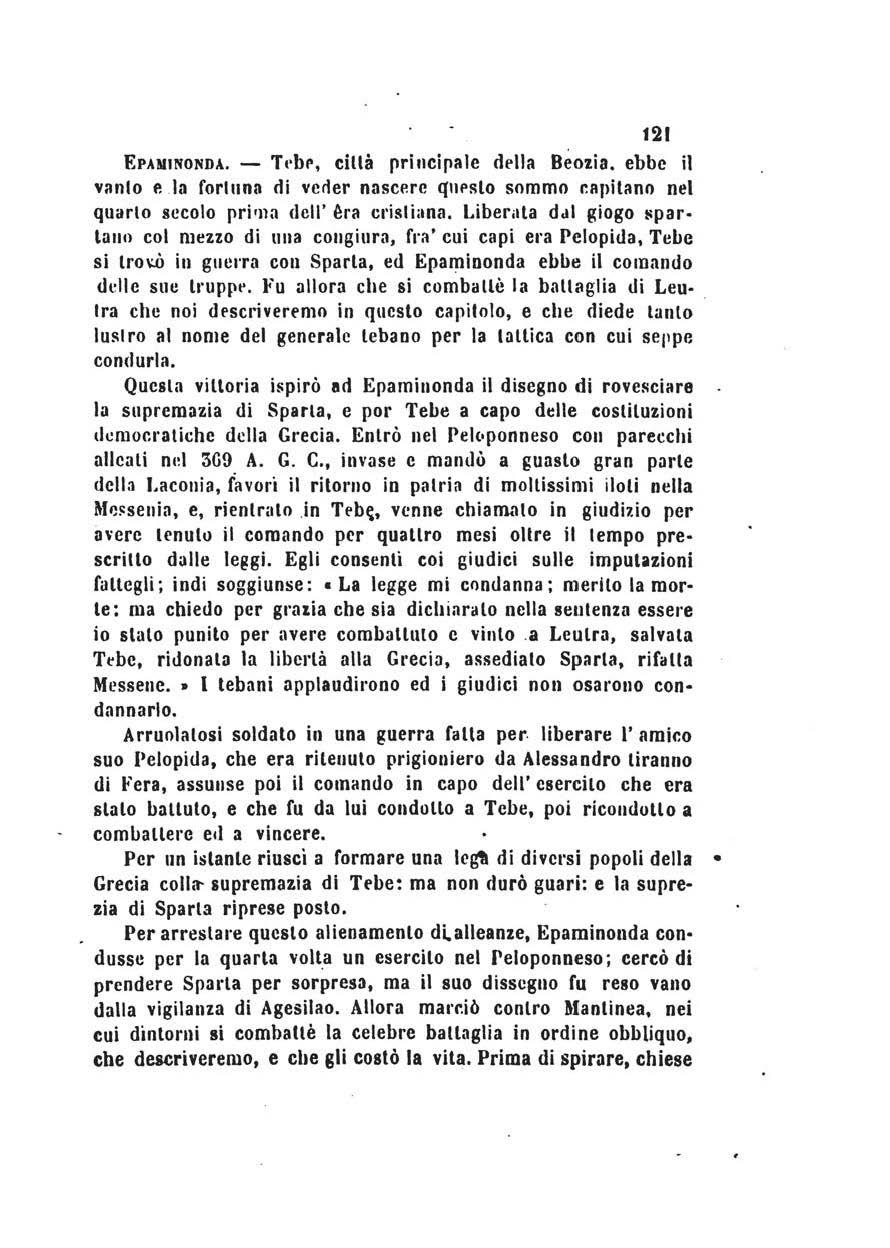
Per nn istante riuscì a formare una lcgt di divct·si popoli della • Grecia colla- supremazia di Tt>be: ma non durò guari: e la supre· zia di Sparla riprese posto.
Per arrestare questo alienamento di. alleanze, Epaminonda con· dussc per la quartn volla un esercito nel Peloponneso; cercò di prendere Sparla per sorpresa , ma il suo disscgno fu reso vano dalla vigilanza di Agesilao. Allora marr.iò contro Miantinea, nei cui dintorni si combattè la celebre ballaglia in ordine obbliquo, che deJCriveremo, e che gli costò la vita. Prima di spirare, chiese
122 di Deifanto e Sollida, da lui giudicali per soH degni di surrogarlo; ed essendogli stato riferito cb' erano morti • Allora, disse persuadete i tebani a concludere la pace. • Mori il t.t luglio dell'anno 362 A. G. C.
Tre città di Grecia si disputat·ono il tristo onore di aver dalo i natali al soldato che vibrò il colpo fatale all'eroe tebano.
Lui mancato, Tebe ricadde tosto nella primiera oscurità.
Il suo carattere è uno de' più belli che si riscontrino nella storia della Grecia. Amò sincet·amcnte la patria, e le rese i più emiftenti servigj. È sentenza di Cicerone che Epaminonda sia stato il più grand' uomo che la abbia prodollo; nè si saprebbe tli11convenire cb' egli rappresenta uno dei modelli più pcrfelli del gran capitano, dell' onesto cittadino, e dell' uomo llapienle ( 1). · • .
AussANDRO . - Figlio di Filippo il Macedone, nacque nel 556 A. G. C
Sino da fanciullo diè segni di canltere elevatissimo. Aristo· lite ne fu il principale educatore, e lo ammaeatrò in tulli l rami dello scibile , studiandosi specialmente di coltivare iu lui le doli di un capitano, essendo la Macedonia circondala da nemici pe· ricolosi.
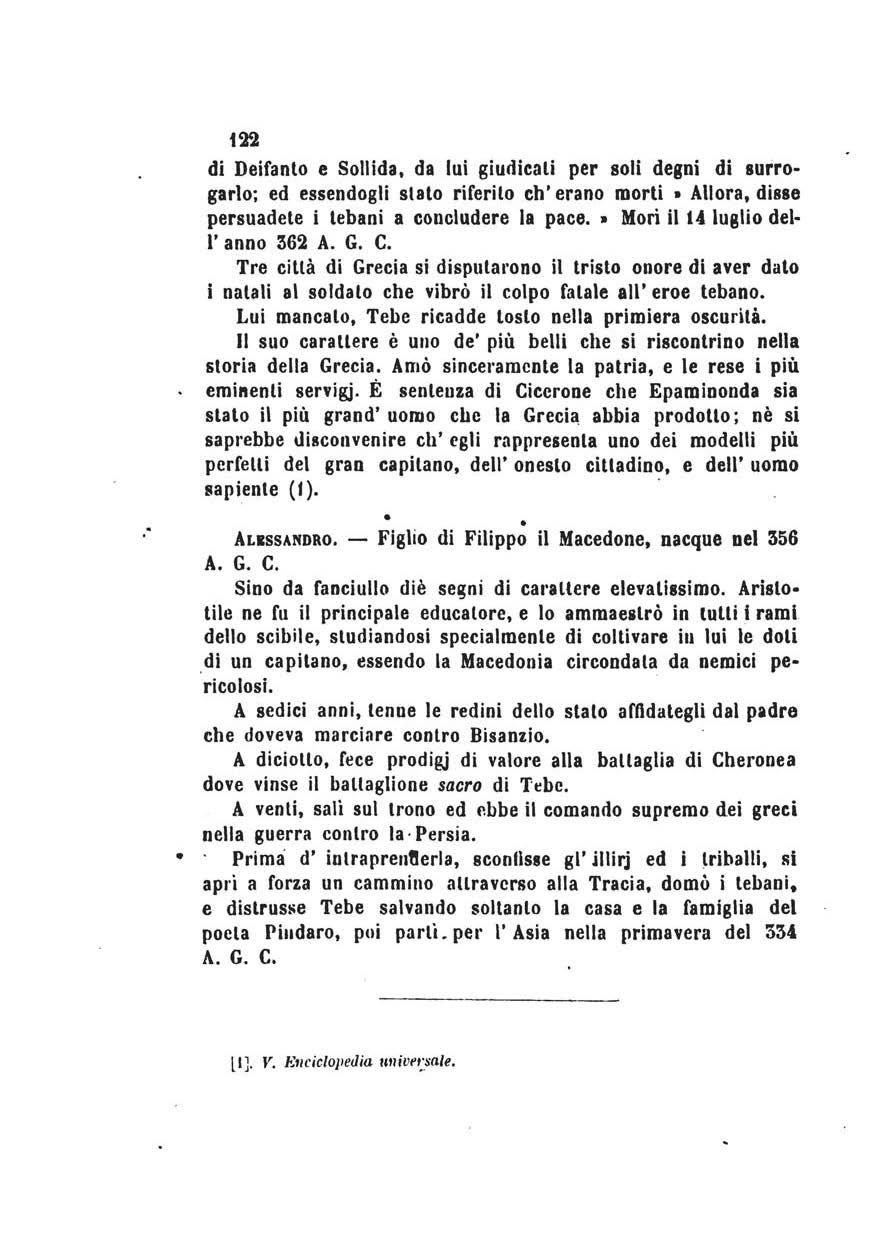
A sedici anni , tenne le redini dello stato affidategli dal padre che doveva marciare contro Bisanzio.
A diciollo, fece prodigj di valore alla battaglia di Cberonea dove vinse il ballaglione sacro di Tt:bc.
A venti, salì sul trono ed ebbe il comando supremo dei greci nella guerra contro la · Persia . • · Prima' d' iolrapreneerla, sconllsse gl' mirj ed i sl apri a forza un cammino allraverso alla Tracia, domò i tebani. e distrusse Tebe salvando soltanto la casa e la famiglia del poeta Piudaro, pui parli. pea· l' Asia nella primavera del 354 A. G. C.
[ l}. l ' J.: u c i c/ o)leùia
Passato il Granico, debellò 20,000 i; e, tranne Milt·to ed Alicarnasso che resistettr.ro più a lungo, quasi tutte le città dell'Asia 1\linore gli apersero le porte. Conquistò poi la Licia, la Jonia, la Caria, la .Pauftlia e la Cappadocia; e si avanzò poscia verso gli stretti della Cilicia ove Dario Re di Persia si era imprudentemente riparato con imm enso esercito inYl'CC di attendere l' aHersal'io uelle pianure dell' Assil'ia. lvi t·bbe luogo la seconda battnglia prt•sso l'Isso, fra il mar·c e le montagne.
Vincitore ad Isso, trattò con molta generosità la famiglia 1lel re vinto; poi si rivolse vèrso ia Celesiria e la Fenicia; s' impadronì di Damasco, distrusse Tiro e fondò Alessandria.
Di questa spedizione, tratteremo iu seguito solto il punto di vista dell'arte della guerra.
Tornato contro Dar·io che avcv;t messo insieme un allro esercito nell'Assiria, lo battè vicino ad Arbella; Babilonia, Susa, e poscia Persepoli, ca.ddero in suo potere.
Da questo momento la gloria d'Alessandro comincia a dccii· narc. Padrone del più grande imper·o della terra, divenne schiavo delle proprie passioni; si abbandonò all' ar·roganza e alla dissolutezza; si sconoscentoe e crudele; e in srno ai piaceri sparse il sangue de' suoi più prolli capitani. Sobrio e moderato per lo addietro, questo eroe che si sfonava di uguagliare gli Dei, si abbassò al grado degli nomini volgari. In un momento di ubl1riaehezza arse Persepoli, mat'aviglia Ilei montlo. , ·
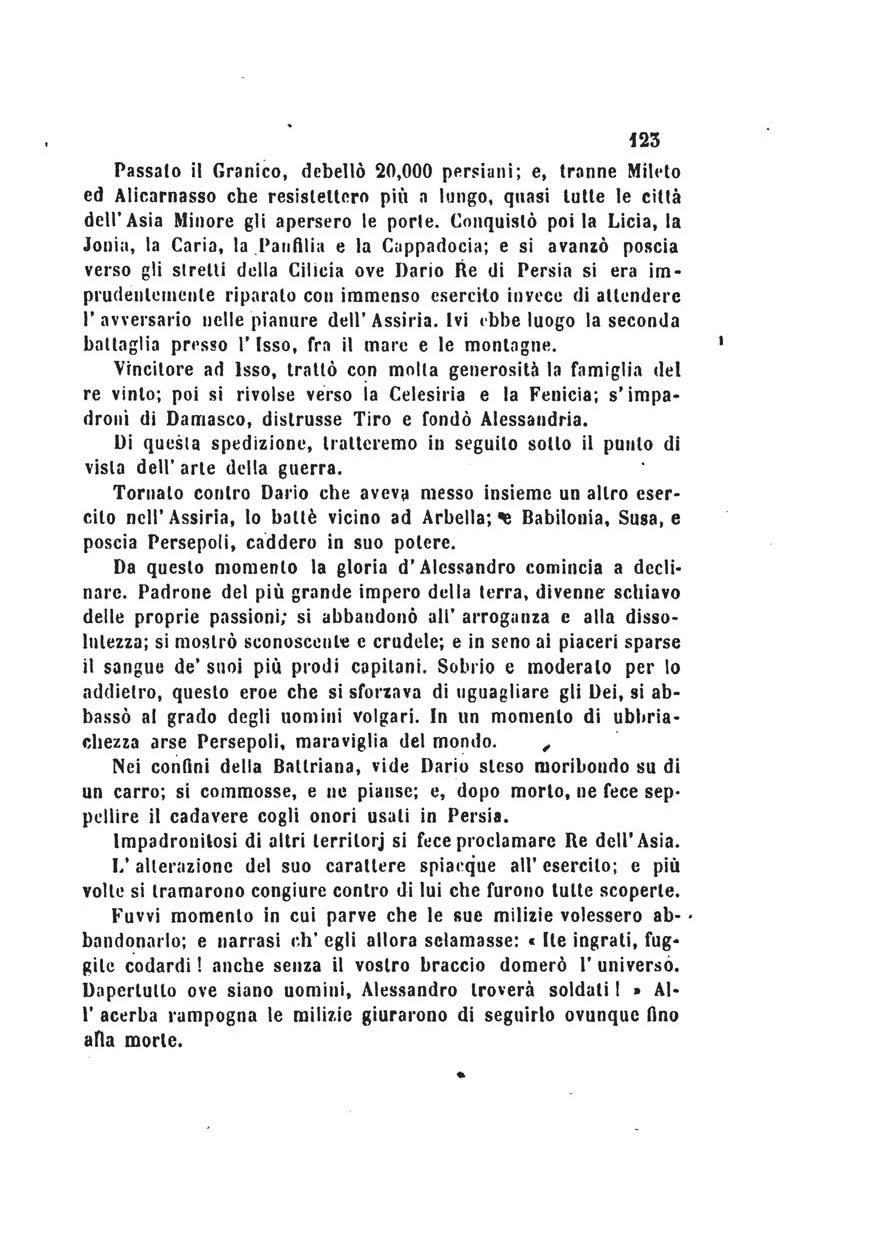
Nei confini della Ballriana, vide Dario steso ruoribonflo !!U di un carro; si commosse, e ne pianse; e, dopo morto, ne fece sep· pellire il cadavere cogli onori usati in Pet·sia.
lmpadronilosi di altri terrilorj si fece proclamare Re dell'Asia.
L'alterazione Ilei suo carattere spiaeque all' esercilo; e più volle si tramarono congiure contro Ili lui che furono tutte scoperte.
Fuvvi momento in cui parve che le sue milizie volessero ab- · bandonarlo; e uarrasi c:h' egli allora scia masse: c Ile ingrati, fug· gite codardi! anche senza il vostro braccio domerò l' universò.
ove siano uomini, Alessandro tro\'erà solduli l • Al· l' acerba rampogna le mili1.ie giurarono di seguirlo ovunque Ono ana morte.
Dopo esserai insignorito dell' loilia, tornò io Babilonia, ove ammalò tutto ad un tratto dopo un banchetto e in breve morì nel 323 A. G. C.
Cosi fini questo conquistatore, all 'e tà di 32 anni, dopo averne i 2 e 8 mesi. La sc iò dietro di un Immenso impero ehe divenne dì guerre continue. ebb e sete d i gloria e di dominio. Lo spronavano l'esem pio paterno c l' iunala cupidigia; c 11trumento delle sul' conquiste s'ebbe un popolo il quale, già uso al giogo di assoluto signore. fac endosi rarte cipe alle sprendi<le geste, veniva a rP.ndersi più lieve e indccorosa la servitù.
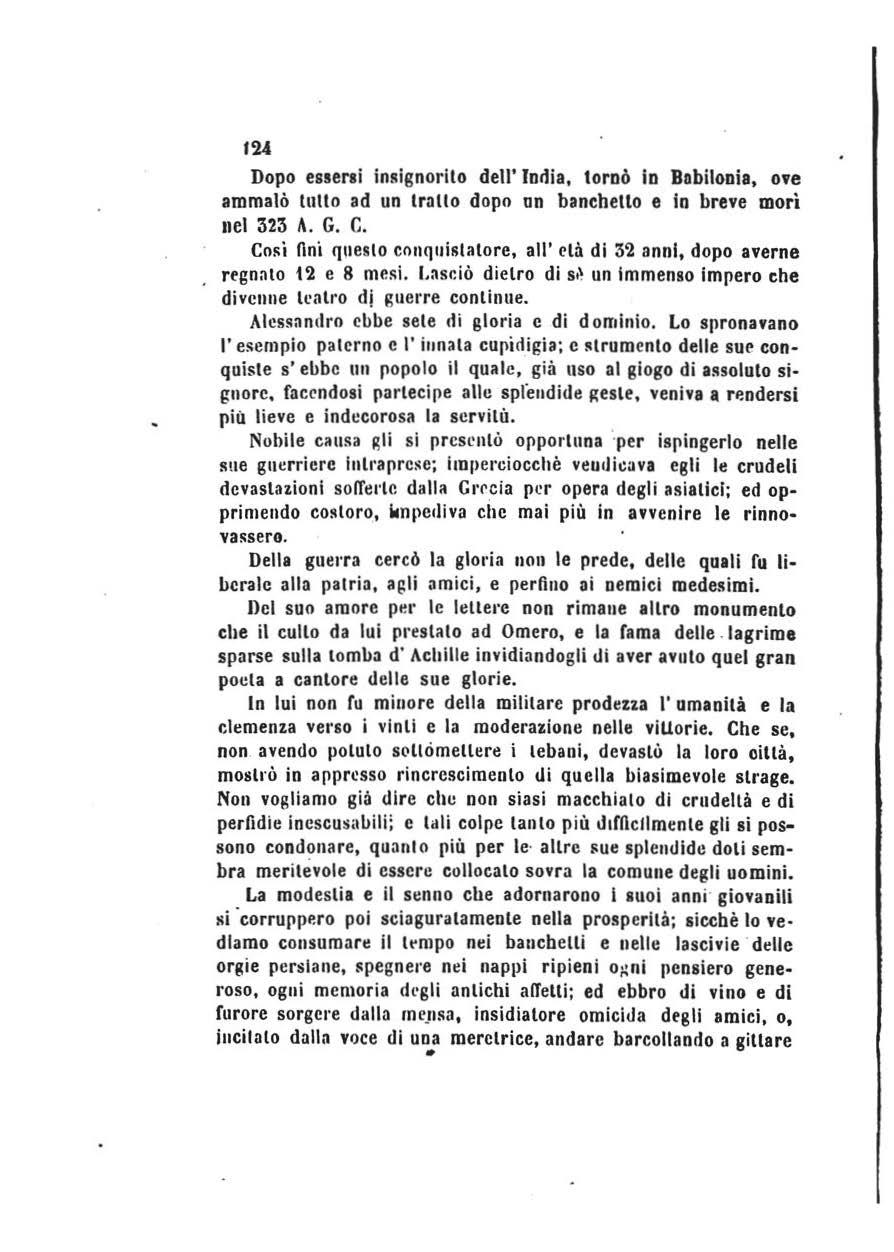
Nobile causa gli si presentò opportuna ·per ispingerlo nelle 11ue guerriere lnll'aprese; itn(lCI'ciocchè veutlil:ava egli le crudeli devastazioni so ffel'lc dalla Ga·rcia per opera degli asiatici; ed opprimendo costoro, Mnpellivn CÌtc mai più in avvenire le rinnovassero.
Della guel'ra cercò la glol'ia non le prede, delle quali fu liberale alla patria, amici, e perfino ai nemici medesimi.
Bel suo amore le lettel'e non rimane altro monumento che il cullo da lui pa·estato ad Omero, e la rama delle . lagrime sparse sulla t omba d' Achil le invidiandogli di aver avuto quel gran poeta a cantore delle sue glorie.
In lui non ru minore della militare prodezza l'umanità e la clemenza veno i vinti e la moderazione nelle viUorie. Che se, non avendo potuto S(ltiOmetlere i tebani, devastò la loro città, mostrò in appresso rincrescimento di quella biasimevole strage. Non vogliamo già dire che non siasi macchiato di crudeltà e di perfldie incscusabi li ; c tali colpe tanto p iù •.larllcllmente gli si posson o condonare, quanto più per le· altre sue splemlidc doli sembra meritèvole di esse r e collocalo sovra la comune degli uomini.
La mode stia e il senno che adorn a rono l auoi anni giovanili si 'corruppP.ro poi sciaguratamente nella prosperità; siccbè lo vediamo consumare il trmpo nei bancbelli e nelle lascivie delle orgie persiane, l'pegnere nd napt>i ripieni pensiero generoso, ogni memoria drgli antichi affelli; ed ebbro di vino e di furore sorgcl'e dalla rn eJ asa, insidìalore omicida degli amic i, o, incitato dalln voce <li una meretrice, andare barcollando a gillare •
l'incendio nella reggia assira . Poi, Callosi banditore superbo delle proprie geste, moltiplica i trofei lungo la via corsa nelle Indie, sè stesso esalta di risi bili cncomj, e con puerile jatlaoza, velata di umiltà, va mercando lodi dagli ateniesi . Ucciso dall' intemperanza, terminò sul fiore dell' età con . un abbietto Ooe la sua mortale carriera dopo una vita gloriosa; e ciò non ostaote lasciò una memoria egualmente dai macedoni e dai persiani compianta (1) .
Con ciò poniamo fine ai cenni biografici; e prima di passare agli esempj, menzioneremo alcuni autori ed alcune opere di que' tempi che hanno relazione coll'argomento di cui abbiamo trat· lato io questo capitolo.
011no, Iliade, ed Odis1ea.
Eaonoro, Delle guerre dei greci e dei per11 . Fu il primo che abbia el evato la cronaca a storia.
TucaDtD&, Storia della guerra peloponnesiaca . Il soggetto p d'io· teresse minore di quello di Erodoto; ma il racconto procede gra· ve; e la storia è separata dalla poesia.
La Ciropedia, romanzo storico, sempre morale se non 1empre fedele.

ID. La ritirata dei diecimila, in cui brilla la chial'ezza o il sentimento m•1rale, ed io rilevasi la superiorità degli ordini civili e il genio flessibile dei greci.
persiani avevano t 00,000 uomini dì fanteria t 0,000 di cavalleria :
( l) PLVTARC O, Vita à' .Aiessalldro.
l greci erano: ateniesi 9,000 di fanteria pesante platcesi t ,000 id.
Il campo di ballaglia di Maratona era un terreno che andava salendo leggermente dal mare fino ad una catena di monticelli che l'esercito ave\'a di.cLro a sè: i persiani al contrario erano addossati al mare (t).
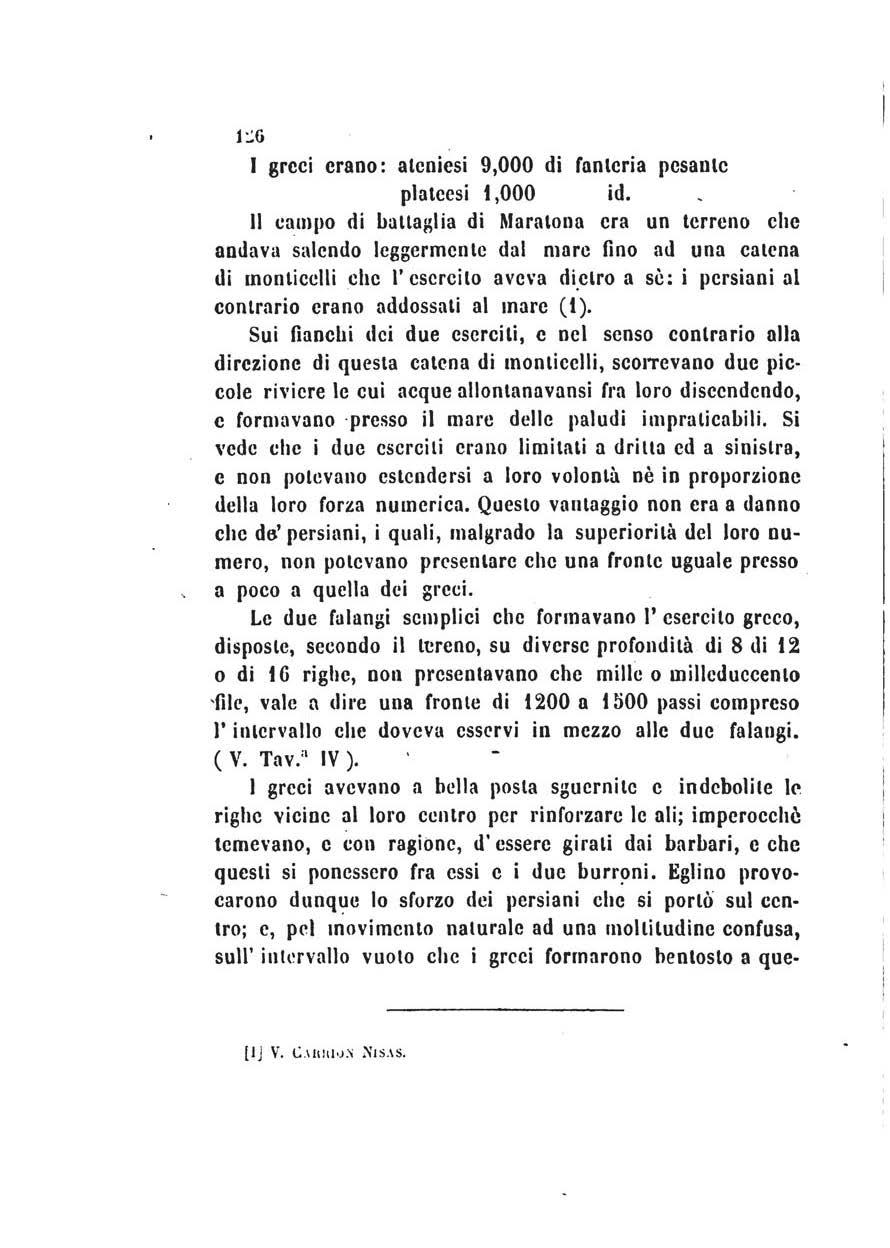
Sui fianchi dci due eserciti, c nel senso contrario alla direzione di questa catena di monticelli, SCOJTevano due piccole ri\•icre le cui acque allontanavansi fra loro discendendo, c formavano ·presso il mare delle paludi impraticabili . Si vede che i due eserciti erano limitati a drilla cd a sinistra, c non potevano estendersi a loro volontà nè in proporzione della loro forza numerica. Questo vantaggio non era a danno che d6' persiani, i quali, malgrado la superiorità del loro numero, non potevano presentare che una fronte uguale presso a poco a quella dci greci.
Le due falangi semplici che formavano l'esercito greco, disposte, secondo il tcreno, su diverse profondità di 8 di 12 o di tG righe, non presentavano che mille o milleduecento ·file, vale n dire una fronte di 1200 a t 500 ()ass i compreso l' intervallo che doveva esservi in mezzo alle due falangi. (V. Tav." IV ).
l greci avevano a bella posta sguernitc c indebolite righe vicine al loro centro per rinfo1·znre le ali; impcrocchè tcmC\'a no , C COil ragione, d'essere girali dai barbari, C che questi si ponessero fra essi c i due Eglino provocarono donq':lc lo sforzo dci J>Cr siani che si porlo sul centro; c, pcl movimento naturale ad una moltitudine confusa, sull' vuoto che i greci formarono henlosto a que-
(I j V. C .\ ll ll i •J:\ XlS.\S .
sto cen&ro; questo intervallo si allargò prontamente; IlA quando una parte dci barbàri fu passata per questa specie di imbuto, le due falangi ravvicinarono di nuovo i fianchi, e tagliarono così io due la colonna disordinala che si era introdotta nel loro intervallo.
Le due falangi si erano conservate io ordine, c non erano state inquietale nè di dietro nè ai fianchi perchè si erano appoggiate alle riviere.
Quc' prrsiani che si trovavano ancora fra i greci cd il mare, si precipitarono alloro verso i loro vascelli; quelli ch'erano corsi verso In ahurr., non poterono giungere ai loro legni che per mezzo di lunghi giri.
l pt!rsiani perdeuero 6:SOO uomini, i greci t 92.
La campagna fu vinta dai greci, i quali appr('st•ro allora come bastassero a un• invasione nemica.
Le cause che condussero a questo risultato furono: i . 0 L' ordinamento dei greci nelle due falangi, compatte e ferme. "
La scelta del terreno per parte di Milziadc . 3.o La taLLiea di rinforzare le ali, e l' astuzia di lasciar più debole il centro per adescare il nemico a preeipitar\'isi.
Questa bau aglia fu C(lmballuta il 29 settembre del 490 A. G. C.
Battaglia di Ler4lra (t).
l lebaoi aveva oo; 6000 uomini armali pesantemente 1500 • • alla leggera 500 cavallieri tessali.
Erano comandanti da Epaminonda
[lJ v. ROCQ UANCOURT
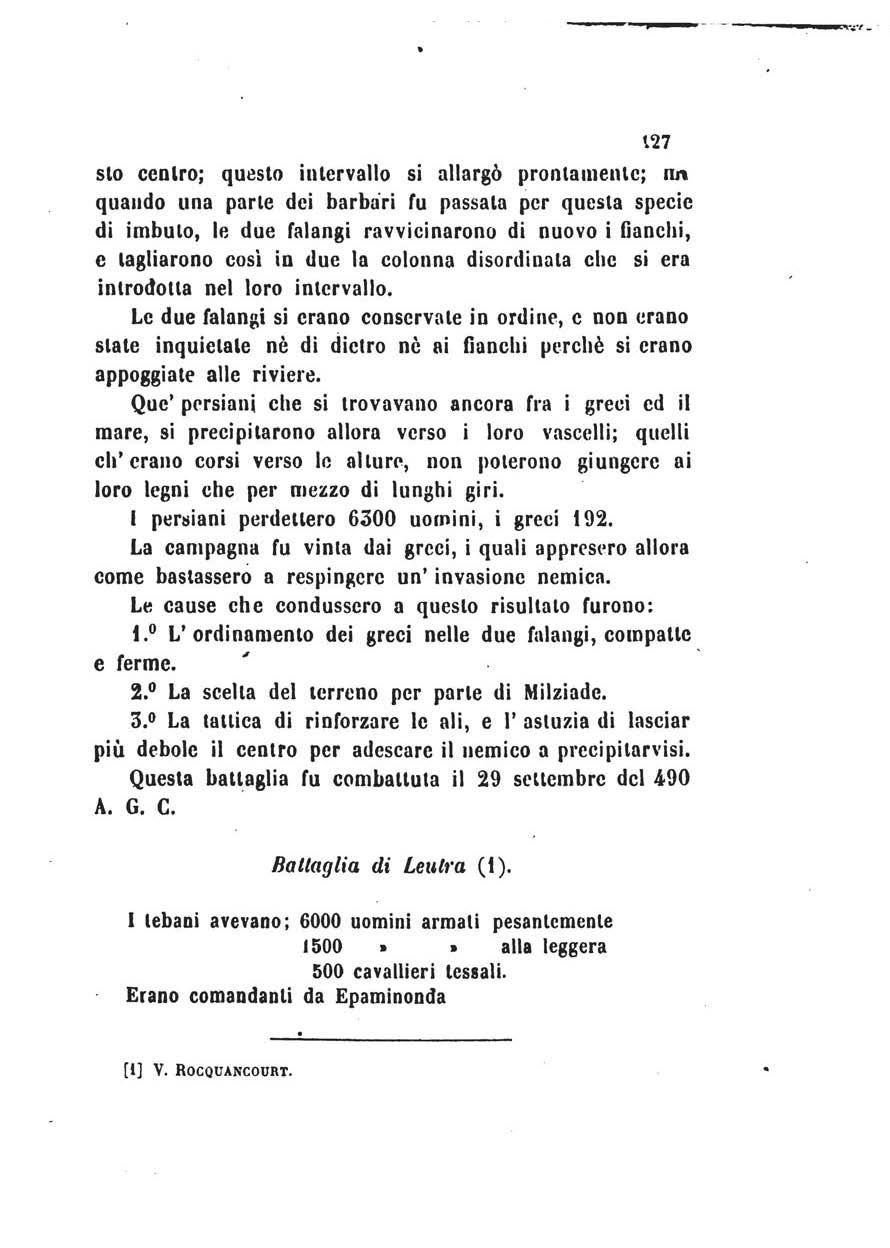
t28
l lacedemoni avevano 12,000 uomini circa la ca·· valleria.
Erano comandati da Cleombrolo.
l iebani erano disposti come segue:
t) In prima ·linea la cavalleria lessata perrhè Cleombroto aveva pure collocata la sua in prima liuea.
2) Dietro ad essa la fanteria lebana sopra un a profondità di 8 e di t2 uomini.
3) All'ala sinistra un cuneo quadrangolare su 50 uomini di profondità.
4) Dietro alla falange il battaglione sacro solto gli ordini di . Pelopida.
l lacedemoni avevano :
t) In prima linea la cavalleria lacedemone.
2) In seconda lin ea la fanteria. ·
Il terreno era una rasa pianura.
Le truppe cominciavano a distendersi in ordine parallelo; ma Epaminonda, vedendo tullo il pericolo di un assalto generale di fronte contro forze doppie, prese la risoluzione di non attaccare il nl!mico che colla sua estrema sinistra, lenendo loutauo il sto della 11ua linea . Volendo d'altronde assicurarsi la superiorità sul punto d' allacco, formò sull' estremità di questa sinistra un enorme cuneo quadrangolare di 50 uomini di profondità facendo màrciare per fianco sinistro le ulliroe eoomozie del suo centro e della sua dritta.
Il ballag lione sacro rinforzava l'estrema sinistra. (V. Fig. a IV).
Epaminonda frammischia nella sua cavalleria della fanteria armala alla leggicra, assale la cavalleria lacedemoue e la rigetta sulla seconda linea che è messa in disordine .
Il cuneo tcbauo, col battaglione sa ero, si avanza contro l'ala drilla del nemico, men.tre il resto della fanteria tebana eseguisce in avanti una conversione a drilla. Altri pretendono che questo resto di fanteria si avanzasse a scaglioni.
Cleombroto fa io avanti una conversione a dritta colla sua ala sinistra, mentre l' estrema dritta minaccia il Oanco del cuneo te: bano che si avvicina.
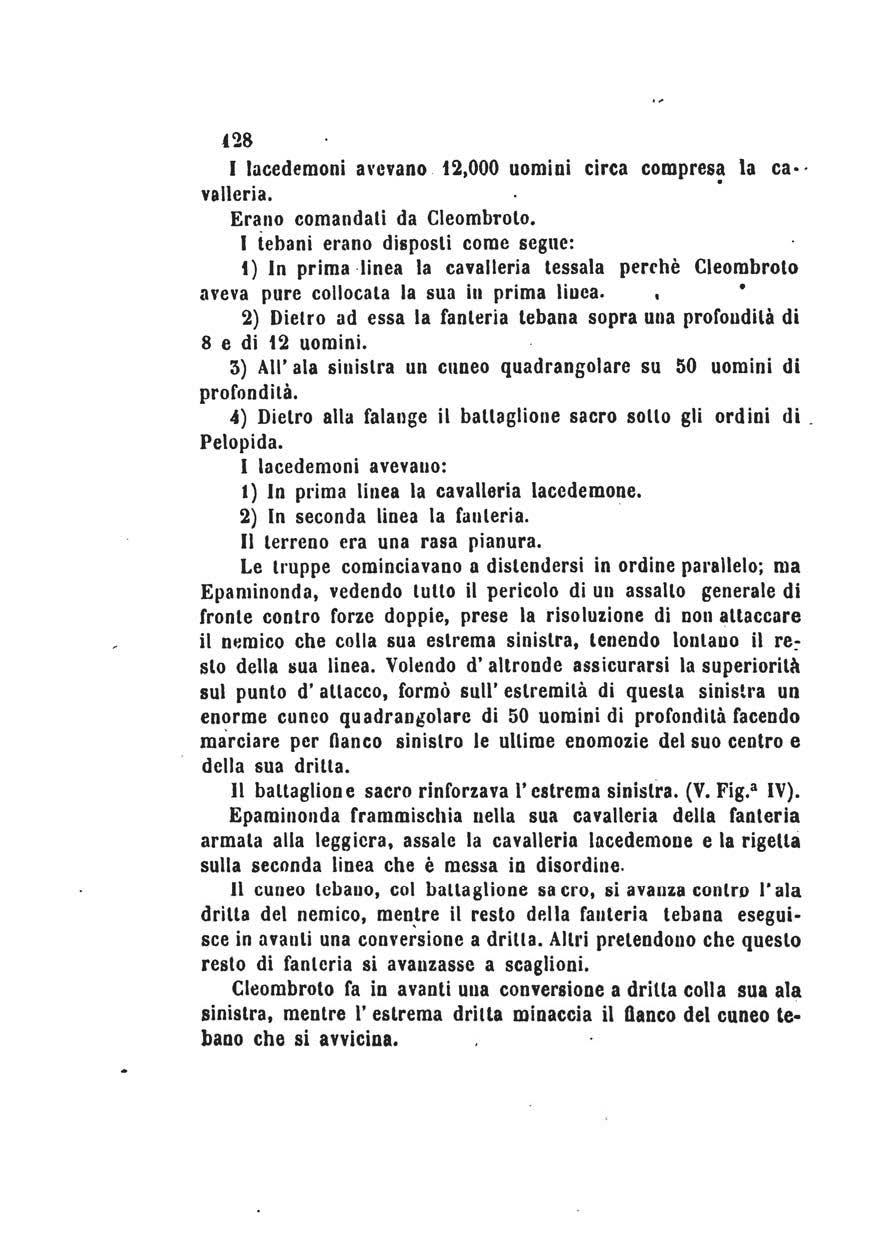
t29
Un ast>allo di fianco, fatto dal baUaglione sacro, ed i progressi del cuneo tebano che da nulla può essere arrestato, costringono i alla ritirata.
1 lacedemoni perdellero il loro Re Cleombrolo e circa f 000 combattenti; il loro paese rimase aperto alle invasione dei tebaoi e dei loro alleali.
Le cause del risultato furono:
1.0 La posizione viziosa io prima linea da!lla cnalleria tacedemone sulla quale non si poteva fare assegoamenlo.
2.0 La posizione obbtlqua ed inattesa, congiunta all' attacco eseguilo io forma di cuneo sull'ala dritta del nemico per parte , di Epaminonda.
3 .• La morte di avvenuta troppo presto.
Questa battaglia ebbe luogo nel 37t A. G C.
Seconda Battaglia di Alantinea.
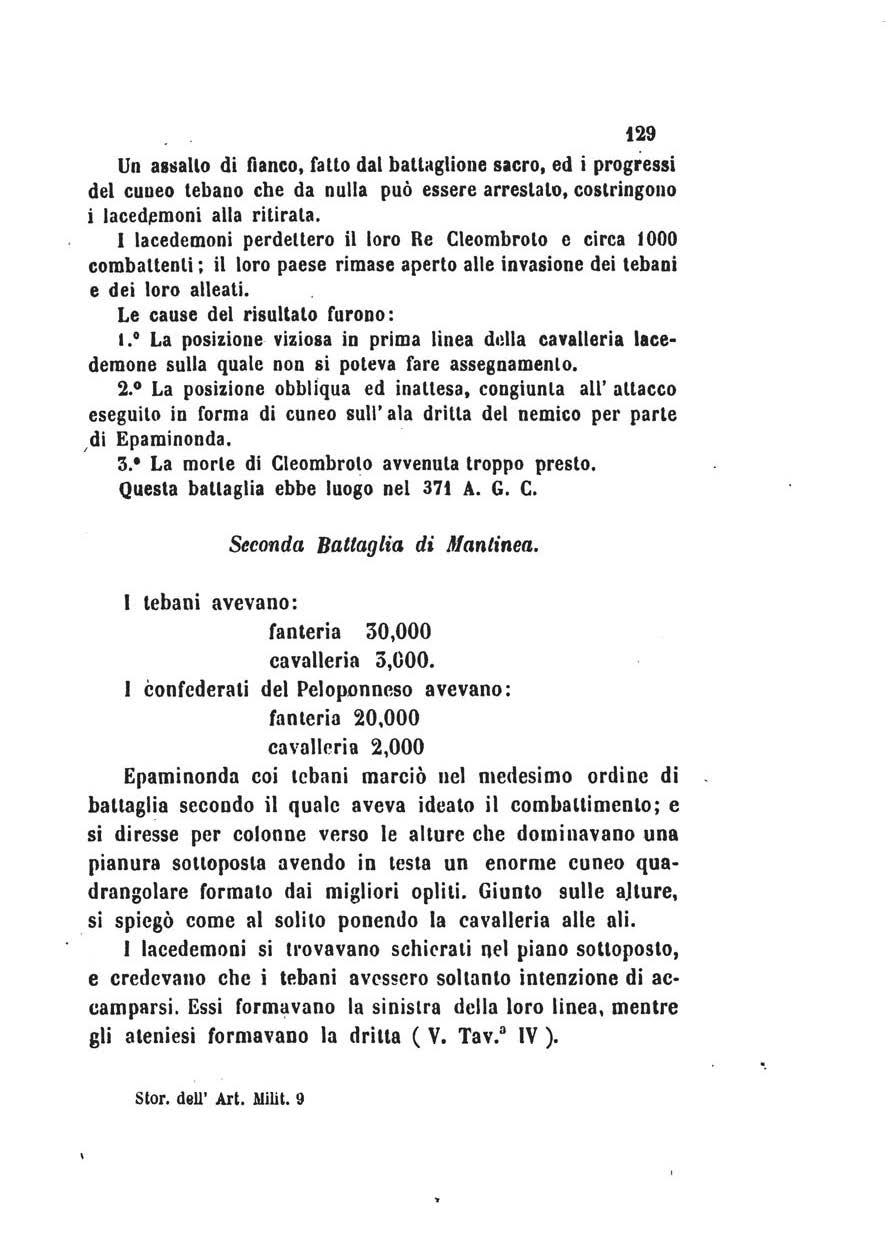
l tebani avevano: fanteria 30,000 cavalleria 5,000.
l èonfcderati del Peloponneso avevano: fanteria 20,000 cavalleria 2,000
Epaminonda coi tcbani marciò nel medesimo ordine di battaglia secondo il quale aveva ideato il combattimento; e si diresse per colonne verso le alture che dominavano una pianura sottoposta avendo in testa un enorme cuneo quadrangolare formalo dai migliori opliti. Giunto sulle aJture, si spiegò come al solito ponendo la cavalleria alle ali. l lacedemoni si u·ovavano schi<.'rati oel piano sottoposto, e credevano che i tebani avl.'sscro soltanto intenzione di accamparsi. Essi forml;lvano la sinistra della loro linea, mentre gli ateniesi formavano la dritta (V. Tav. 3 IV).
Stor. dell' Art. Alilit. 9
t30
Epaminonda discende al piano ed ordina alle ;ue ali di avvicinarsi alla cavalleria e tenerla in rispetto, mentre egli fa eseguire un movimento di conversione a sinistra per presentare la sua driua, rinforzata , sul centro dei la· cedemoni . Fatta la conversione, il cuneo si precipitò di sbieco sulla falange laccdemone, la sfondò e la divise in due.
La cavalleria ateniese alla destra non osò misurarsi colla tebana e stelle inerte in tutto il combattimento. La spartana, alla sinistra, fu posta in roua dalla tebona.
Anche questa bauaglia si 'diede da Epaminonda in Ofdine obliquo.
l tebani restarono del campo, ma perdettero E· paminonda che venue feri.to mortalmente.
Ambo le parti però si attribuirono la vittoria .
Il numero dei morti c dei feriti non è indicato in alcun luogo.
La baUagJia di Mantinea non portò alcun mutamento nelle cose di Gr'ecia.
Fu combauuta nel 362 A. C.
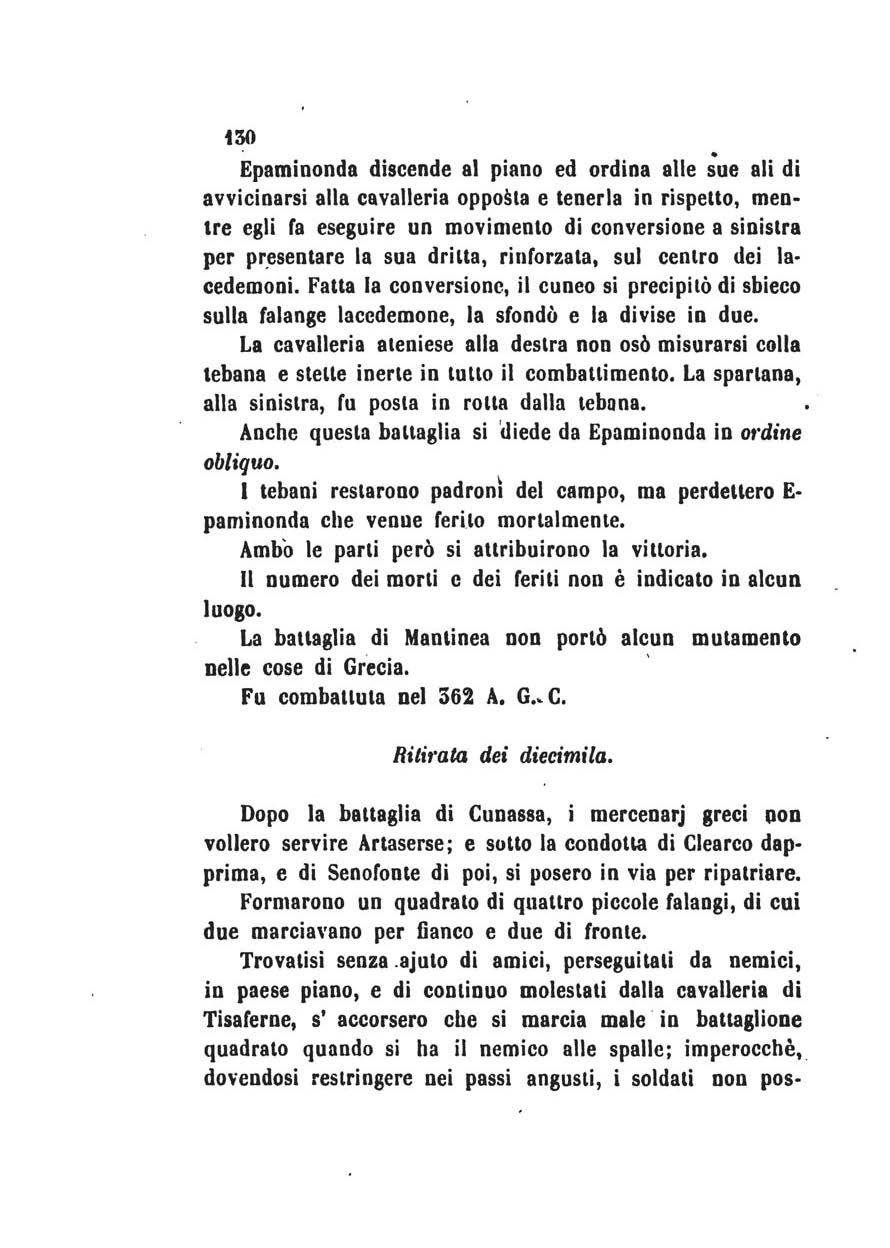
Ritimta dei diecimila.
Dopo la battaglia di Cunassa, i mercenarj greci uon vollero servire Artaserse; e sotto la condotta di Clearco dapprima, e di Senofoote di poi, si posero in via per ripatriare.
Formarono un quadrato di quattro piccole falangi, di cui due marcia\'ano per fianco e due di fronte.
Trovatisi senza .ajuto di amici, perseguitati da nemici, in paese piano, e di continuo molestati dalla cavalleria di Tisaferoe, s' accorsero che si marcia male · io battaglione quadrato quando si ha il nemico alle spalle; imperocchè, . dovendosi restringere nei passi angusti, i soldati non pos
t3t sono tenere il loro posto, nè riprenderlo ordinatamente quando fossero costreui a lasciarlo momentaneamente. Al· tora s1 formarono sei drappelli di cento uomini, che riparavano al disordine occupando i vuoti. Questa mobilità impressa alla colonna dei greci, ed loro ordine di battaglia, fu ad essi di gran giovamento nel passaggio delle montagne: per cui ·vi diedero maggior estensione formando ottasata drappelli di f 00 uomini, e separando in tre gli "Brmati alla leggiera e gli arcieri,
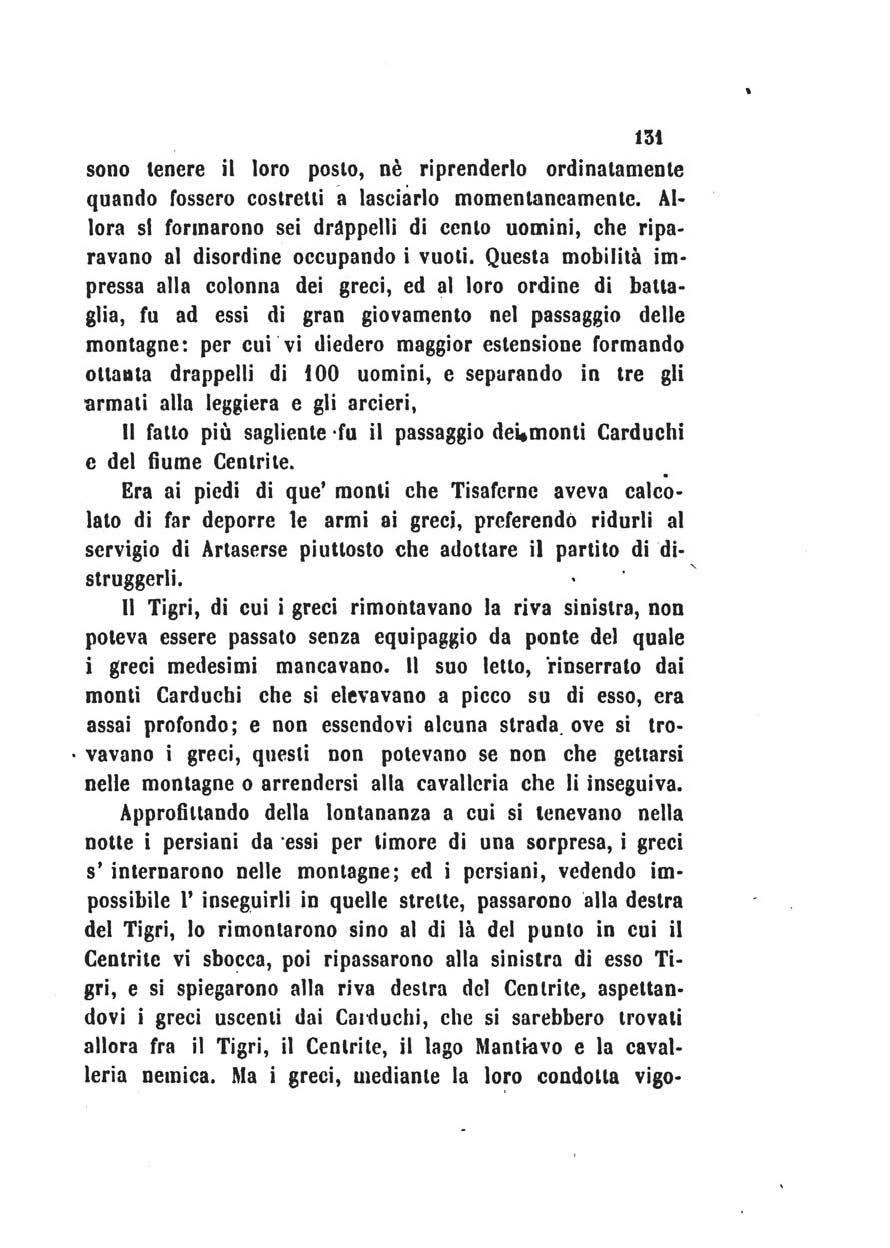
Il fatto più sagliente ·fu il passaggio dei.monti Carduchi e del fiume Centrite.
Era ai piedi di que' monti che Tisaferne aveva calcolato di far deporre le armi ai greci, preferendo ridurli al servigio di Artaserse piuttosto che adottare il partito di distruggerli.
Il Tigri, di cui i greci rimoòtavano la riva sinistra, non poteva essere passato senza equipaggio da ponte del quale i greci medesimi mancavano. Il suo letto, 'rinserrato dai monti Carducbi che si elevavano a picco su di esso, era assai profondo; e non essendovi alcuna strada . ove si tro. vavano i greci, questi non potevano se non che gettarsi nelle montagne o arrendersi alla cavalleria che li inseguiva.
Approfittando della lontananza a cui si tenevano nella notte i persiani da ·essi per timore di una sorpresa, i greci s' internarono nelle montagne; ed i persiani, vedendo im· possibile l' inseguirli in quelle strette, passarono ·alla destra del Tigri, lo rimontarono sino al di là del p,unto in cui il Ceotrite vi poi ripassarono alla sinistra di esso Tigri, e s i spiegarono alla riva destra del Ccntrite, aspettandovi i greci uscenti dai Cuduchi, che si sarebbero trovati allora fra il Tigri, il Centrite, il lago Mantiavo e la cavalleria nemica. Ma i greci, mediante la condoua vigo-
t32 rosa, le loro astuzie di guerra ben caloolate, l' unione intima dei loro capi, e le loro abili manovre, riuscirono a sventare il disegno dei nemici, e poterono proseguire la ritirata senza ulteriore persecuzione.
In queste marcie l' esperienza insegnò a Senofonte di far occupare le cime da armati alla leggiera per osservare il nemico, e tenerlo lontano in guisa che i· dardi non giungessero a colpire la falange; poi di accampare regolarmente, di scegliere posizioni vantaggiose, di marciare in ordine per non cadere alla spicciolala in mano del nemico; di rispar•miare i viveri che trovavano e portarne per più giorni; tener fuochi; pigliare le spie del nemico per farseue guide; girare .le posizioni; c mme altre cose che la lunghezza e la difficoltà della marcia posero sott' occhio in moltissime occasioni. l greci provarono freddi rigidissimi in Tracia, e Senofontc prende in questo caso una maggior cura pel nutrimento del soldato, essendo d' avviso che io tali circostanze si muore più· d' inopia che di freddo. Finalmente, Senofonte trovò conveniente nelle marcie uotturne di mettere innanzi la fanteria pesante, poi la leggiera, indi la cavalleria, percbè così trovati assieme al sopraggiungere del giorno; mentre se la cavalleria .avesse preceduto, sarebbesi al far del giorno trovata avanti per un gran tratto.
Ed in Senofoate, e nell'esercito suo, si ravvisa il tipo dei condottieri e mercenarj del medio evo, e particolarmente di quelli d' Italia.
(t) Per quanta imperizia si voglia auribuire ai generali (t) V. LISJ\.BNNE ET SAUVAN1 Bib liothèque historique et militaire, TOllE l. a-
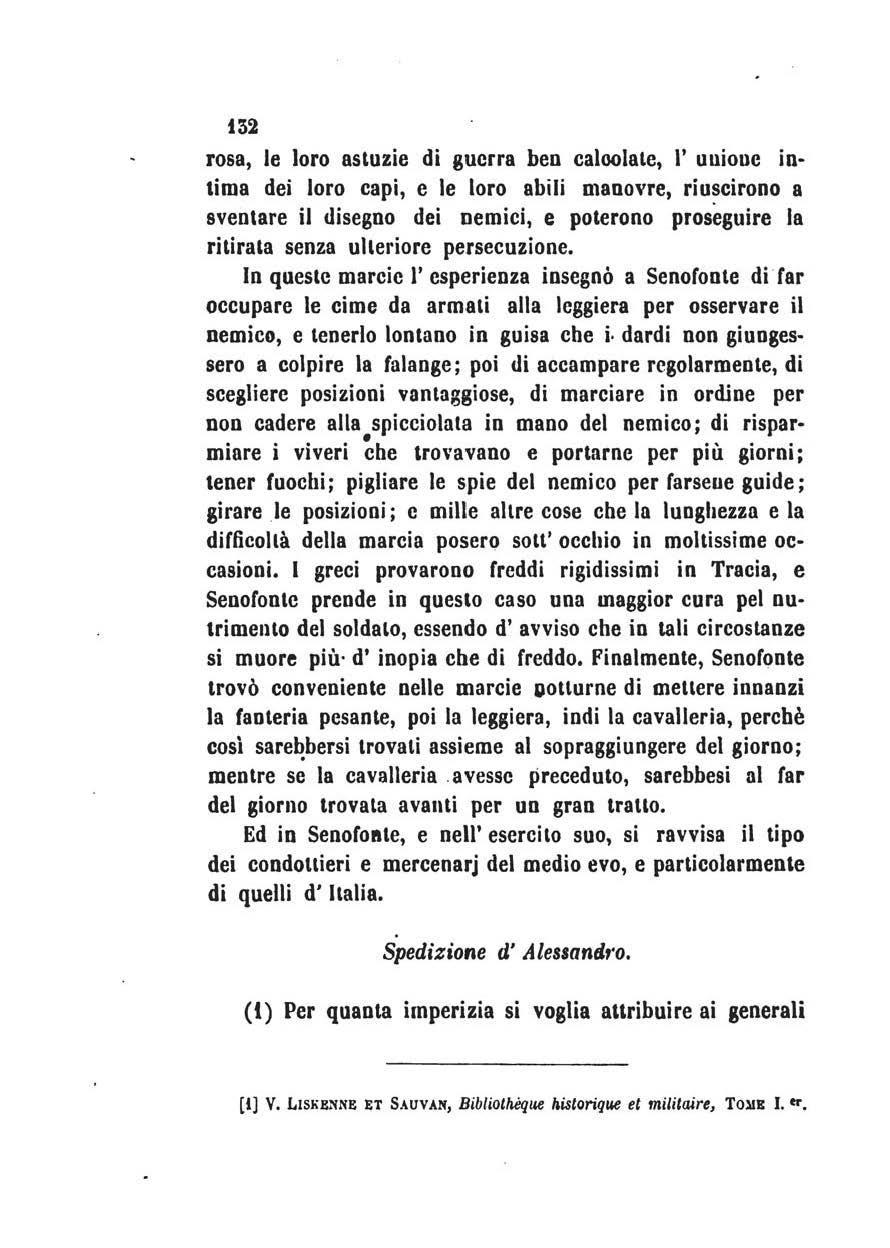
i33 di Dario , e per quanta abilità nella tattica si supponga in Alessandro, non si può ammettere che questo . eroe av_rebbè conquistato J' Asia con uomini qualora non avesse stabilito un piano generale d' invasione misurato sull' estelfsiooe del suo genio, e dal quale non siasi mai dipartito .
Questo piano strategico cominci.a · a svilupparsi dopo il passaggio dell' Ellesponto. Allora si vede Alessandro occuparsi della conquista di tutte le città maritLime delle coste dell' Asia e dell' Egitto, affine di togliere ai ,persiani il potere di equipaggiare una flotta nel Mediterraneo . D'altronde Alessandro doveva trarre soccorsi dalla Grecia per sovvenire ai hisogni delle sue truppe, ed assicurare in tal guisa le sue comunicazioni.
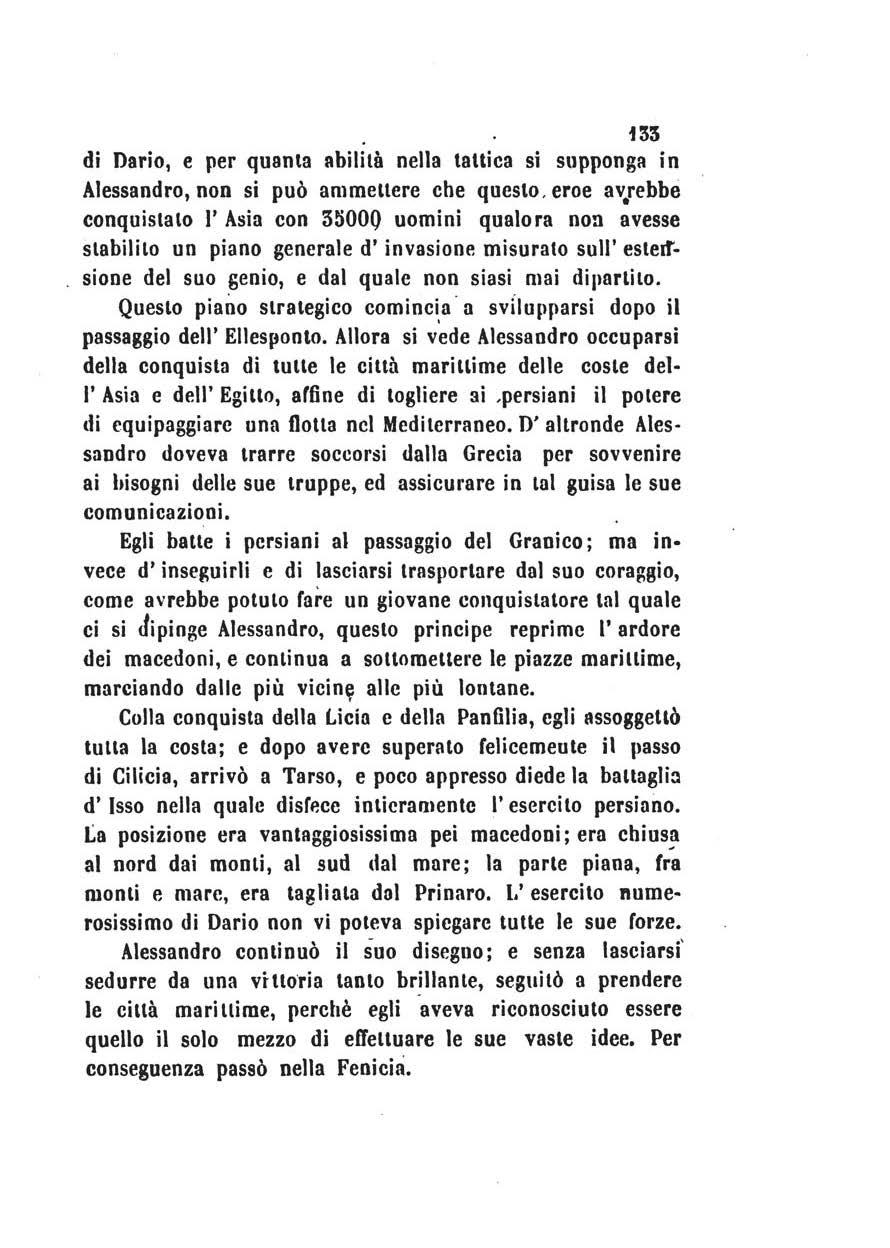
Egli batte i persiani al passaggio del Grani co; ma in· vece d' inseguirli e di lasciarsi trASJlOrtare dal suo coragsio, come avrebbe potuto rare un giovane conquistatore tal quale ci si dipinge Alessandro, questo principe reprime l' ardore dei macedoni , e continua a sottomettere le piazze marittime , marciando dalle più alle più lontane.
Colla conquista della Licia c della Panfilia, egli assoggeuò tutta la costa; e dopo avere superato felicemeute il passo di Cilicio, arrivò a Tarso, e poco appresso diede la d' Isso nella quale disfP.ce inticrafl)entc l'esercito persiano. la posizione era vantaggiosissima pei macedoo i ; era chius? al nord dai monti, al sud dal mare; la parte piana, fra monti e mare, era tagliata dal Prinaro. l.' esercito numerosissimo di Dario non vi poteva spiegare tutte le sue forze . Alessandro continuò il suo disegno; e senza lasciarsi' sedurre da una vrtto'ria tanto seguitò a prendere le città mari uime, perchè egli aveva riconosciuto essere quello il solo mezzo di effettuare le sue vaste idee. Per conseguenza passò nella Fenicia.
Ecco tutto i1 segreto della spedizione d' Alessandro. In tal guisa egli potè portare il suo esercito nelle regioni più lontane; le. sue spalle, e le sue comunicazioni colla Grecia, erano sempre assicurate.
Dopo l' assedio di Tiro c di Gaza , Alessandro rivolse le sue armi verso l' Egitto.
l tirj gli avevano data un' alta idea dei mezzi che possono essere forniti dal commercio; perciò risolse di loglierli ad essi fondando una città rivale. Egli scelse il sito della sua nuova città con un discernimento tanto maraviglioso, dice nobertson, ch' essa divenne una delle piazze di commercio più dell' antico mondo; e malgrado le conti.oue, essa non cessò di essere, per diciotto secoli, la sede principale . del commercio dell'India .
. Le bocche del Nilo non offrivano alcuno di questi vantaggi; la sola situazione conveniente era- distante dodici legt,e , dal fiume c nel centro del deserto. Gli antichi re di Persia avevano costume di mantenere una guarnigione in quel La nuova città, fo':'dala da Alessandro, aprì l' Egitto nel luogo medesimo io cui i re suoi predecessori avevano una chiave per ' chiuderlo.
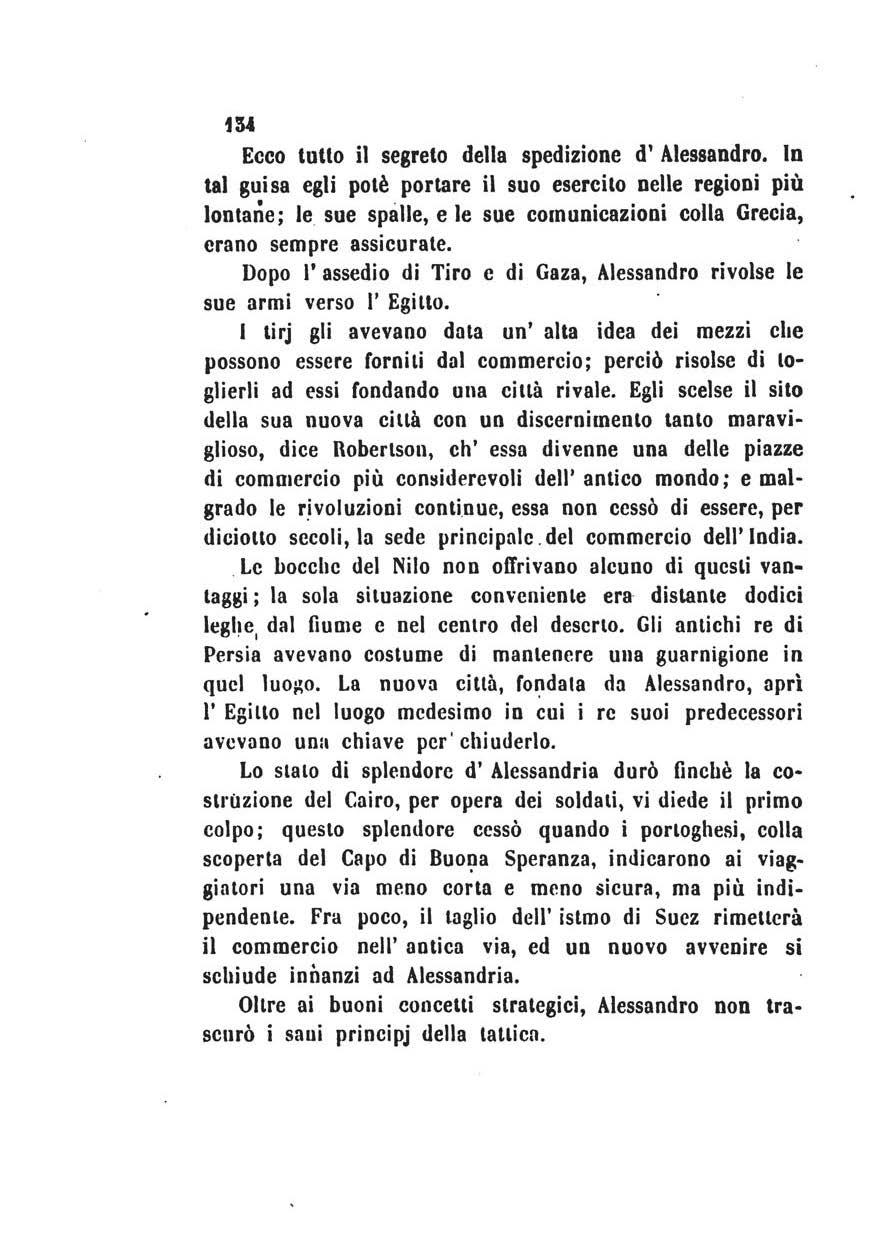
Lo stato di splendore d' Alessandria durò fincbè la co · struzione del Cairo, per opera dei soldati, vi diede il primo colpo; questo splendore cessò quando i portoghesi, colla scoperta del Capo di Speranza , indicarono ai viaggiatori una via meno corta e meno sicura, ma più indipendente. Fra poco, il laglio dell' istmo di Sucz rimellerà il commercio nell' antica via, ed un nuovo avvenire si schiude inòanzi ad Alessandria.
Oltre ai buoni concetti strategici, Alessandro non trascurò i saui principj della tatlicn.
i35
Nella scelta delle posizioni; noi lo vediamo abbandonare le pianure, porP.arsi sulle alture rapidamente, impadronirsi delle. gole, inseguire, schiacciare un nemico il quale non sa come rannodarsi e non osa collocarsi su punti che presentano spazio troppo piccolo al suo gran numero. Così sì è vtduto alla battaglia d' Isso; sebbene una pane della gloria sia dovuta a Parmenione, generale di Alessandro, il quale persuase il suo re ad aspettare Dario in un luogo streuo; in tal guisa riuscì tanto agevole il bauerlo, come sarebbe stato facile a Dario lo esterminat'e l' esercito di Alessa odro se questi si fosse portato io vaste pianure.
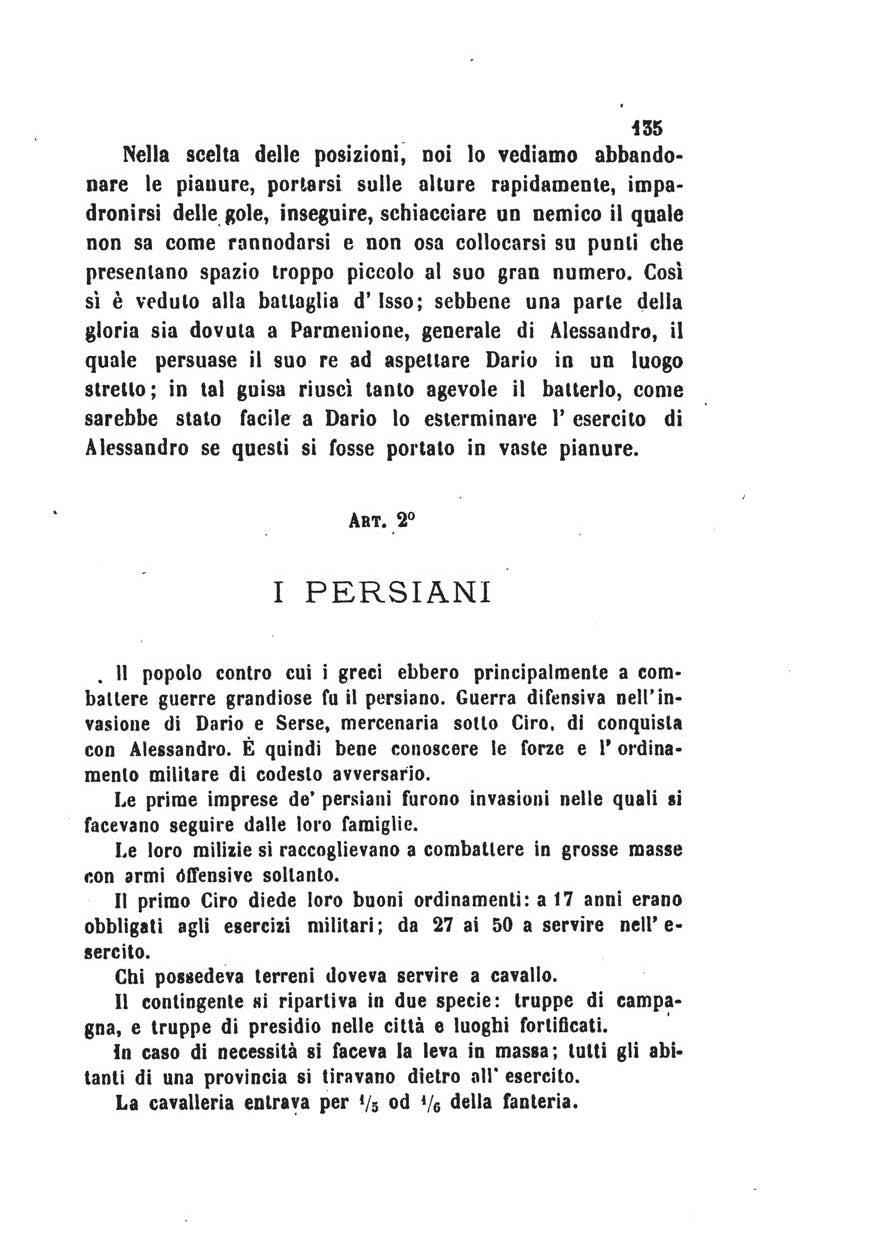
.
Il popolo contro cui i greci ebbero principalmente a comballere guerre grandiose fu il persiano. Guerra difensiva nell'invasione di Dario e Serse, mercenaria sotto Ciro, di conquista con Alessandro. È quindi bene conoscere le forze e l' or·dinamento militare di collesto avversario.
Le prime imprese de' persiani furono invasioni nelle quali si facevano seguire dalle loro famiglie.
J.e loro milizie si raccoglievano a combattere in grosse masse r.on armi difensive soltanto.
Il primo Ciro diede loro buoni ordinamenti: a 17 anni erano obbligati agli esercizi militari; da 27 ai 50 a servire nell' esercito.
Chi posaede.va terreni doveva servire a cavallo.
Il contingente Ki ripartiva in due specie: truppe di campagna, e truppe di presidio nelle città e luoghi fortificati. '
In easo di necessità si facna la leva in massa; tutti gli abi· tanti di una provincia si tiravano dietro all' esercito.
La cavalleria per •;5 od •;6 della fanteria.
.,
Alle armi oft'enaive Ciro aggiunse le difensive.
Le truppe erano divise e suddivise io corpi di iO,OOO uomini, di t 000, di t 00, di. t O con capi corrispondenti.
La profondità dell' ordinanza venne ridotta a 12 righe.
Le trùppe facevano esercizj frequent.i: il re passava la rivista una volta all' anno: erano esenti dalla rivista quelle che presidiavano i luoghi forti.
La disciplina era, per quell' epoca e per que' popoli, suffi· cienlemenle curala.
Il manteoim eolo pesava sui tributi della provincia od era a . carico dei satrapi: io guerra stava a danno dei paesi occupati; una parte però si portava dall' esercito, pel caso che non se ne fosse trovato subito sul suolo nemico.
Ciro apportò miglioramenti alla costruzione dei carri.
Grandi e minute prescri&ioni per gli accampamenti si trovano date da Ciro nella Ciropedia; e queste riflettono la di1posizione délle tende, delle armi diverse, delle singole nazioni, dei dift'erenli servigj, della sicurezza del campo.
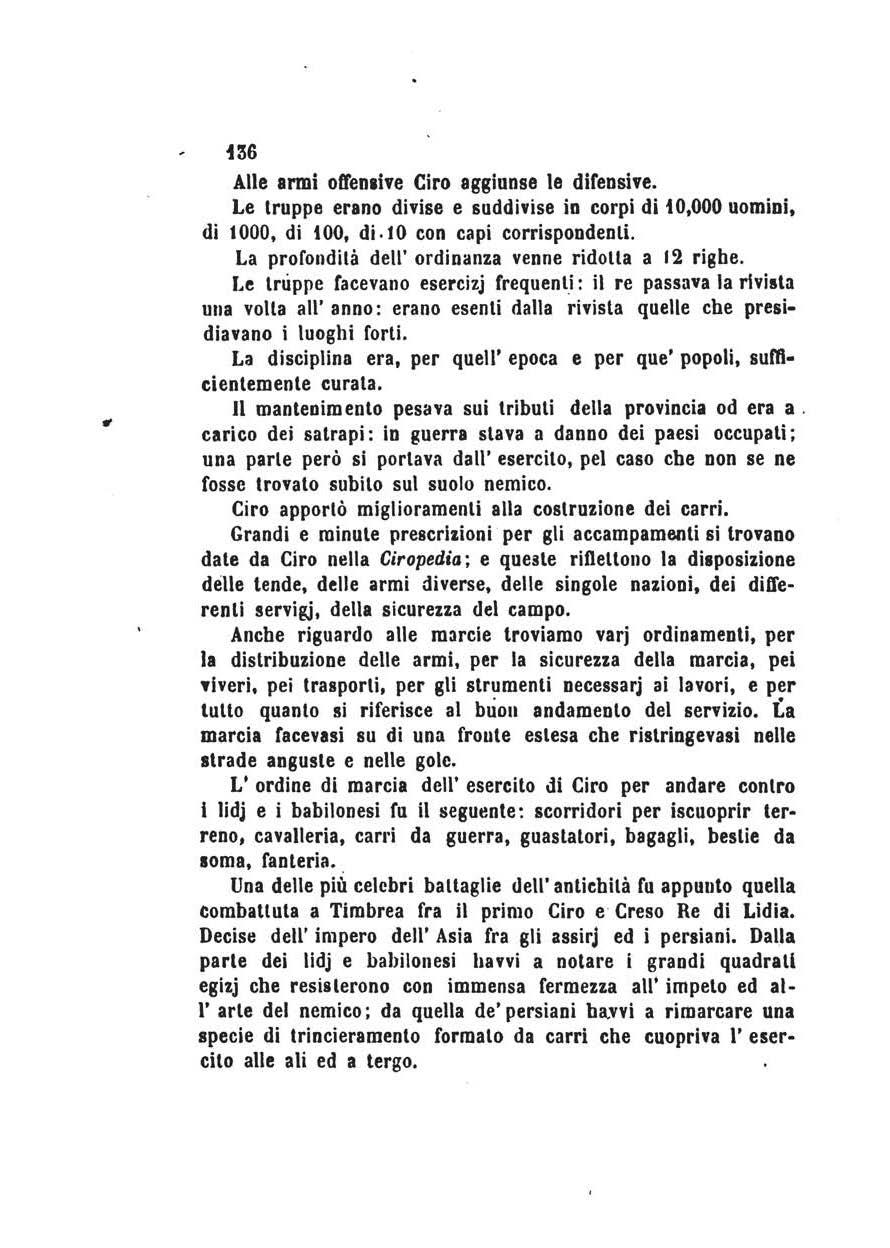
Anche riguardo alle ro3rcie troviamo varj ordinamenti, per la distribuzione delle armi, per la sicurezza della marcia, pei viveri, pei trasporti, per gli strumenti necessarj ai lavori, e per lutto quanto si riferisce al buon andamento del se"izio. La marcia facevasi su di una fronte estesa che rislringevasi nelle strade anguste e nelle gole.
L' ordine di marcia dell' esercito di Ciro per andare contro i li dj e i babilonesi fu il seguente: scorri dori per iscuoprir terreno, cavalleria, carl'i da guerra, guastatori, bagagli, bestie da 1oma, fanteria . .
Una delle più celebri battaglie dell'antichità fu appunto quella combattuta a Timbrea fra il primo Ciro e · Creso Re di Lidia. Decise dell' impero dell' Asia fra gli assirJ ed i persiani. Dalla parte dei lidj e babilonesi havvi a notare i grandi quadrati egizj cbe resisterono con immensa fermezza all' impelo ed all' arte del nemico; da quella de' persiani havvi a rimarcare una specie di trincieramenlo formalo da carri che cuopri•a l' esercito alle ali ed a tergo.
L' esercito di Creso si ra ascendere a 42(1,000 uomini, quello di Ciro a t !)6,000.
Vinse quesl' ultimo.
Dopo Ciro, i persiani si corruppero, fidarono nel numero, trascurarono la disciplina, poscia assoldarono mercenarj, diedero lulta l' importanza alla cavalleria, e finirono facile preda del genio di Alessandro.
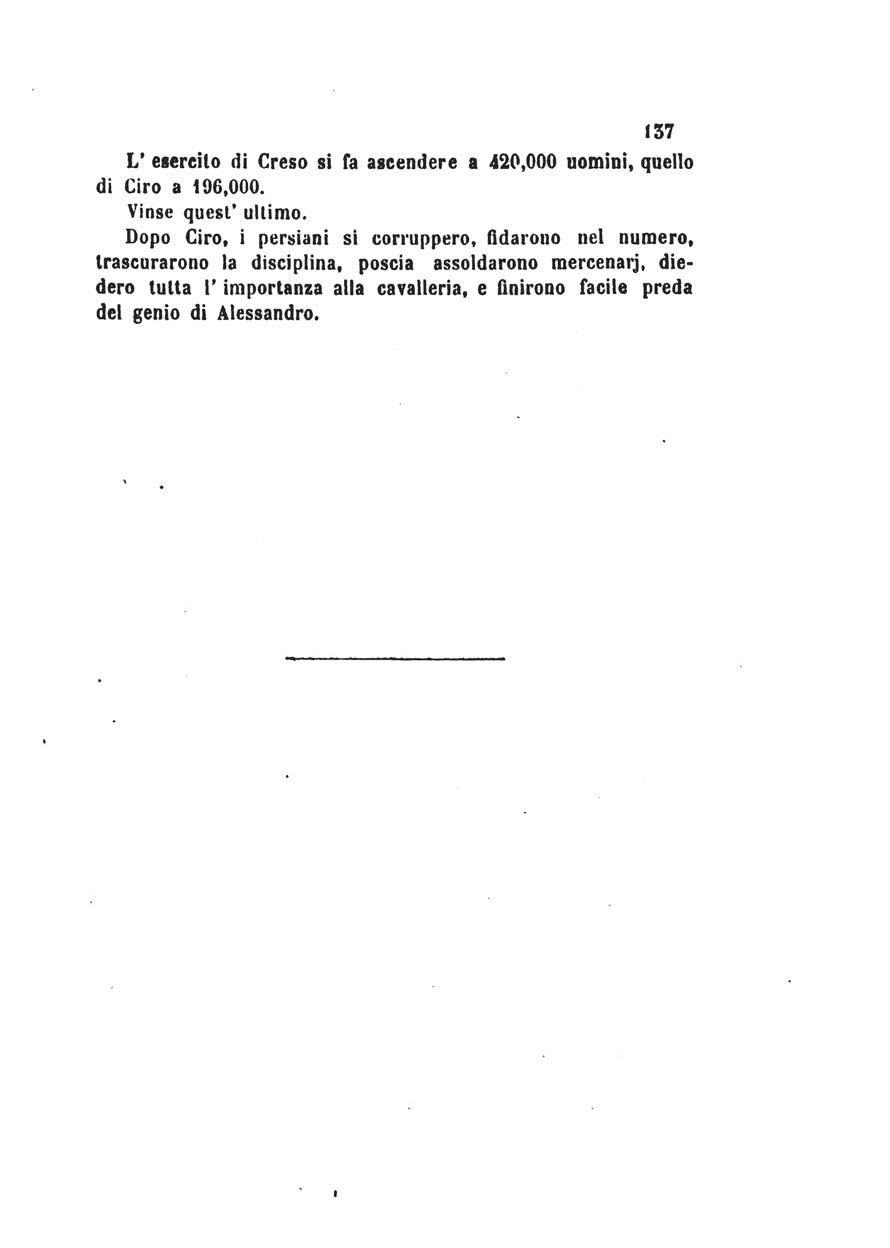
§, f.O
Narrano le storie, sebbene ora v' abbia chi neghi fede a quanto si nora fu ·scritto di Roma regia, che Romolo e Remo , discendenti per linea femminile da Enea, abbiano raccolto intorno a sè grosso numero di compagni, affine di rimettere sul trono d'Alba i1 loro avo materno Numitore che n' era stato espulso dal fratello Amulio. Riusciti nell' impresa, risolvettero di fondare una città per ricettare tuui coloro che avevano sotto i loro ordini. ·
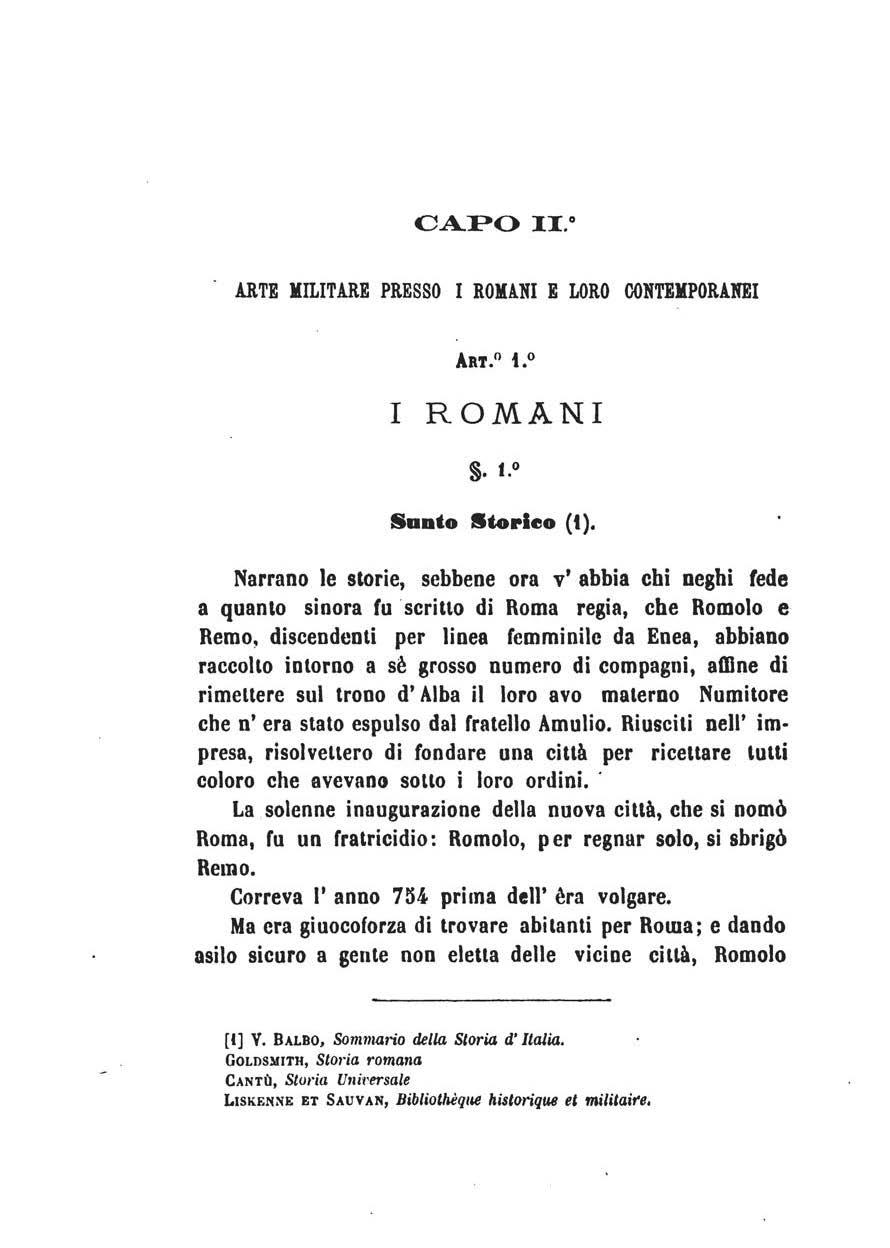
La solenne inaugurazione della nuova ciuà, che si nomò Roma, fu un fratricidio: Romolo, per regnar solo, si sbrigò Remo.
Correva l' anno 1M prima dell' èra volgare.
Ma era giuocoforza di trovare abitanti per Roma; e dando asilo sicuro a gente non eletta delle vicine città, Romolo
(l) V. BALBO, Somm4riO della Slori4 d'Italia.
GoL DSlllTH, Slo1·ia roman4
CANTil, Slorin Ullit•trsale
LI SKENNE ET SAUV AN, BibliOlhèQilt hislOriQUI el mililair'e,
t39 si trovò a capo di una popolazione maschile piuttosto ·numerosa.
Occorrevano donne; i romani ne chiesero ai prossimi sabini che le rifiutarono. Allora non si diedero più l' io· comodo di insistere . sulla domanda o di rivolgerla altrove: le rubarono. E da ciò venne la prima guerra di difesa fatta dai romani contro i sabini, che finì per intercessione delle donne rapite.
Bentosto passarono aHe conquiste: e le prime furono di piccole città distanti poche miglia dalla rutura metropoli llell' universo. Le vittorie riportate sui volsci, sugli equi, e i fidenati, furono i loro primi trionfi.
Sotto il terzo re Tullo Ostilio fecero la guerra impor· tante cogli albani per la supremazia del Lazio. Finì col certame degli Orazj e de' Curiazj, ed Alba si soUomise a Roma . Fu guerra di preponderanza.
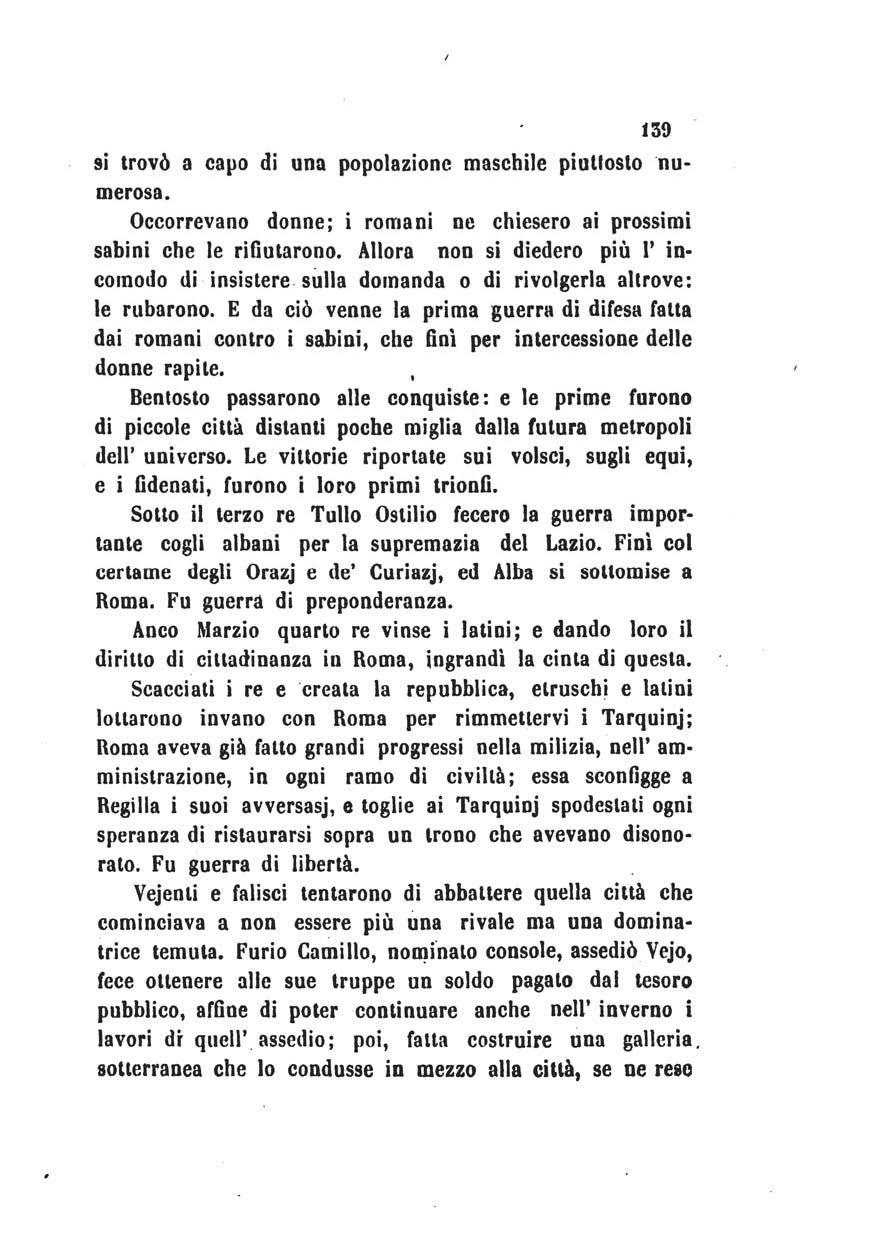
Aoco Marzio quarto re vinse i latini; e dando loro il diritto di cittadinanza in Roma, ingrandì la cinta di questa. Scacciati i re e ·creata la repubblica, etruschi e latini louarono invano con Roma per rimmetlervi i Tarquinj; Roma aveva già rauo grandi progressi nella milizia, nell' amministrazione, in ogni ramo di civiltà; essa sconfigge a Regilla i suoi avversasj, e toglie ai Tarquioj spodestati ogni speranza di ristaurarsi sopra un trono che avevano disonorato. Fu guerra di libertà.
Vejenti e falisci tentarono di abbattere queHa città che cominciava a non essere più una rivale ma una domina· trice temuta. Furio Camillo, nomfnato console, assediò Vejo, fece ottenere alle sue truppe un soldo pagato dal tesoro pubblico, affine di poter continuare anche nell' inverno i lavori dr quell' . assedio; poi, fatta costruire ùna galleria. sotterranea che lo condusse io mezzo alla ciuà, se ne reso
uo padrone con questo mezzo nel 594. Due anni dopo ebbe Falerio capitale dci falisci. Fu guerra di libertà; offensiva e difensi\·a.
Poco appresso i galli sennoni, dopo essersi stabiliti nel bacino del Po, s'erano trovati in territorio troppo angusto per loro; ed nell' Etruria, domandarono terre a Chiusi che ne aveva di troppo e non poteva coltivare. Gli abitanti di Chiusi respinsero la domanda dei galli, e chiesero soccorso ai romani che loro lo accordarono. Brenno marcia contro i romani, vince all' Allia, giunge a Roma, vi trova pochi putrizj che uccide, e tenta invano una sorpresa notturna al Campidoglio ove la gioventù si era rifuggiata. Allora assediò il Campidoglio per seue mesi; e quando i romani stavano per comperare la pace a peso d' oro, Furio .Camillo, esule io Ardea, · tornò nell' ingrata patria, roppe il disonorevole contralto, battè ed inseguì i vincitOI'Ì predoni e li ricacciò per allora alle loro sedi.
Fu guerra oiTensiva, di conquista, d' pei galli; difensiva e nazionale pei romani.
Il terrore prodotto dall' invasione dei galli era stato tale, che si stabili un speciale per far loro la guerra; e si decise, che nel caso di novelle invasioni cesserebbe ogni esenzione d' arruolamento, dal momento cbe venisse dichiarato il tumulto gallico.
· Due guerre sannitiche tennero dietro alle galliche. La prima percbè i popoli bellicosi del Sannio invasero la Campania alleata di Roma; la seconda perchè Roma cercò. impadronirsi di quella Carnpania stessa che dapprima aveva protetto. l romani vinsero la prima: vinsero anche la seconda, ma dopo aver subito un rovescio nelle gole delle Forche caudine, e l' umiliazione del giogo. Queste guerre, che incominciarono nel 543 prima dell' éra cristi&na,
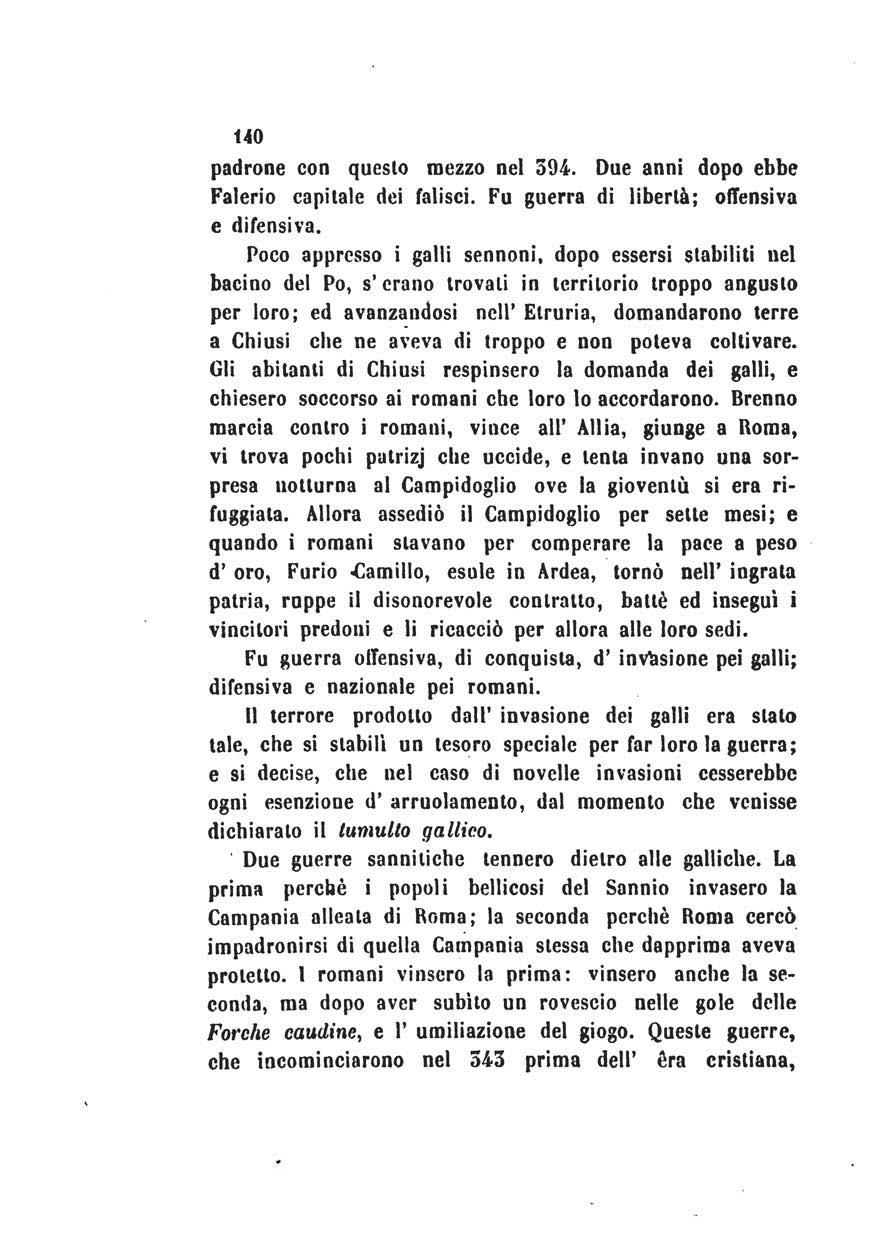
Ut durarono 47 anni. Furono di convenienza, di prepondcranze .
La potenza romana stendrvasi allora nella parte meridionale della penisola ove i greci avevano inviato gran numero di colonie le quali avevano dato al paese il nome di Magna Grecia. Una ve n' crn fra queste che aveva fondato la ciuà di Taranto; e siccome i tarentini paveotavano la vicinanza della repubblica ambiziosa, chies ero ed ottennero nel 283 il soccot·so di Pirro re dell ' Epiro.· Pirro, al quale erano stati dipinti i rornoni come barbari, rimase maravigliato di trovarli tanto abili. Vinse la battaglia di Eraclea in causa de' suoi eleranti, ma le perdite sofferto furono tali da spaventarlo della sua vittoria. A sua volla è battuto ad Ascoli, è battuto a Benevento da Dentato, che s' impadronisce del suo campo, e lo costringe ad imbarcarsi per la Grecia. t romani ebbero il buon senso di togliere da Pirro parecchi usi deJla tonica greca, mentre egli medesimo non isdegnò di pigliare da loro molte pratiche utilissime . l/ aspetto di un campo abbandonato da quel re, insegnò ai romani la castramentazione, e la teoria delle posizioni artificiali, nella quale divennero in ·seguito val enti maestri. Fu suerra d'intervento, offensiva per parte di Pirro; difensiva dal lato romano .
Intanto i mamf!rtini, specie di briganti selvaggi, s' im· padronirooo di Messana, ora Messina; e per guarentirsi dai cartaginesi, che avevano molte pretese sull' isola, si posero solto la protezione dei romani. Cartagine, fondata parecchi secoli prima di Roma , già colonia de' fcnicj o pomi di Si· done, già regno, poi repubblica indipendente, aveva estese le proprie colonie e il dominio ·io tutta 1' Africa occidentale, io Jberia, ed in Sicilia. Tali imprese e lati vittorie aveva effettuÌllo ed ottenuto col mezzo di eserciti mercenarj, tolti
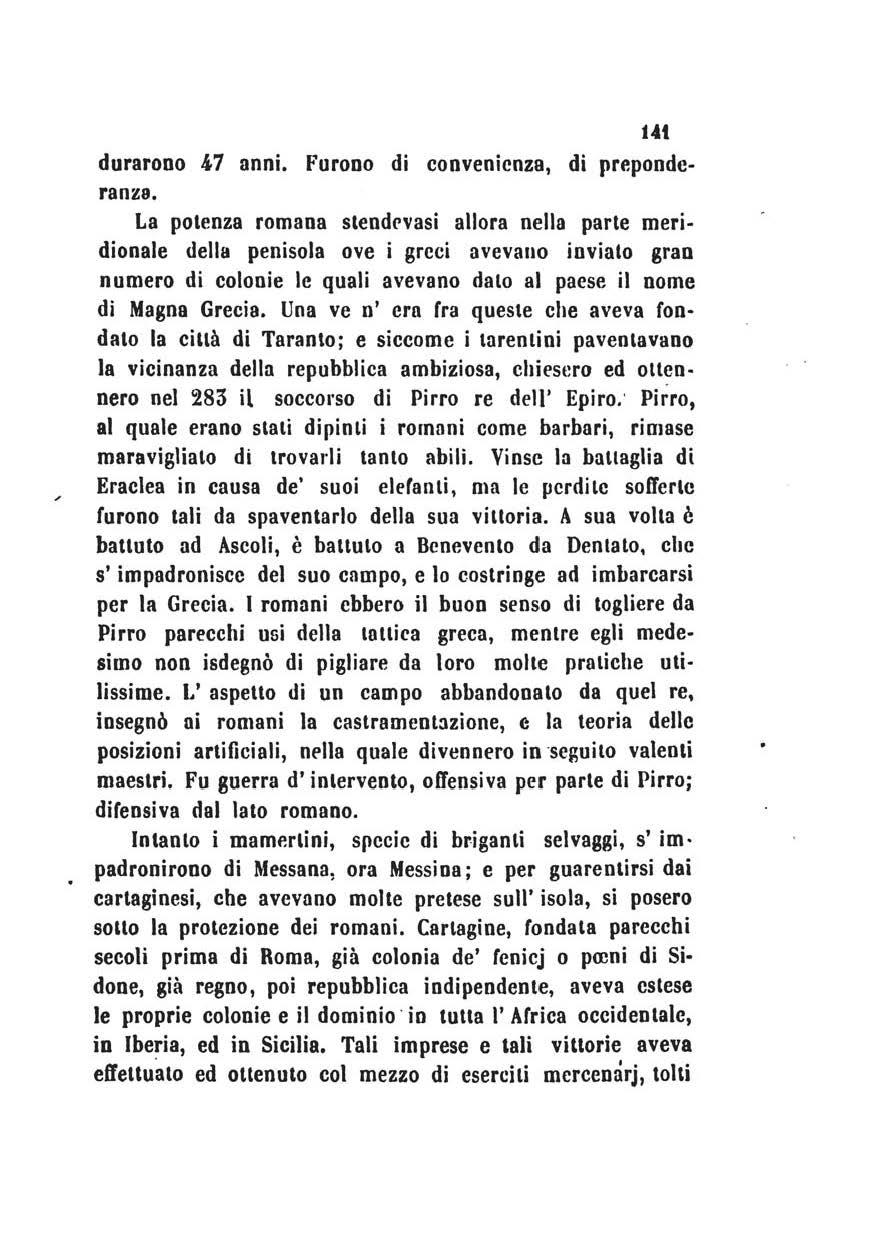
14'2 da tutle le nazioni: essendochè il popolo cartaginese , de1lito al commercio, pagava l' esercito, non vi serviva. Roma , cittaduzza Ialina, aveva sancito trattati di navigazione con Cartagine nel :S08; Roma, già potente, li aveva rinnovati nel 34:S. Ma Roma, cresciuta in signoria ed ambizione, ascoltava la ,·oce dei maruertini ed occupava Messina nel 264. Cartagine noi patì, e la guerra diventò insieme terrestre e marittima. l romani armarono Oouc alla cartaginese, diventarono potenza di mare, e vinsero due grandi battaglie navali all' abordaggio. Quindi passarono in Arrica per ferire il nemico al cuore. Ma furono vinti; c vi rimase pt·igione quell' Attilio Regolo che, rimandato in patria per negoziare, si fece immortale tornando 'ai ferr"i per morirvi e éosì lasciar Roma libera al suo costume di perdurare finchè vincesse. Roma vinse di nuovo io mare ed in terra, e compiè la conquista della Sicilia; allora fè pace escludendo la rivale dall' isola, e dando termine in questo modo alla prima guerra punica nel 241.
Dopo ciò Roma aggiunse in una ventina· d' anni al suo esteso impero, la Sardegna e la Corsica; guerreggiò, vinse nell ' lllitio, e si approssimò alla Grecia'; ed allora tutta la penisola riconobbe la dominazione dei figli di Romolo tranne la Gallia cisalpina. l romani si fecet·o riconoscere colle armi alla battaglia di Telamooe; i galli furono forzati a soLto· mettersi; e tutta Italia trovossi nel 222 sotto la dipendenza di Roma.
Nel 2 t 9 scoppiò la seconda guerra punica. Cartagine tene\'a la Spagna sino all' Ebro coll' obbligo di rispettare Sagunto alleata dei romani. Annibale, generale cartaginese, che ave,·a giurato odio implacabile a Roma , medita la rovina della ri\•alc della sua patria, e vuole giungere al suo scopo coll' assalirla nel cuore stesso de' suoi dominj italiani.
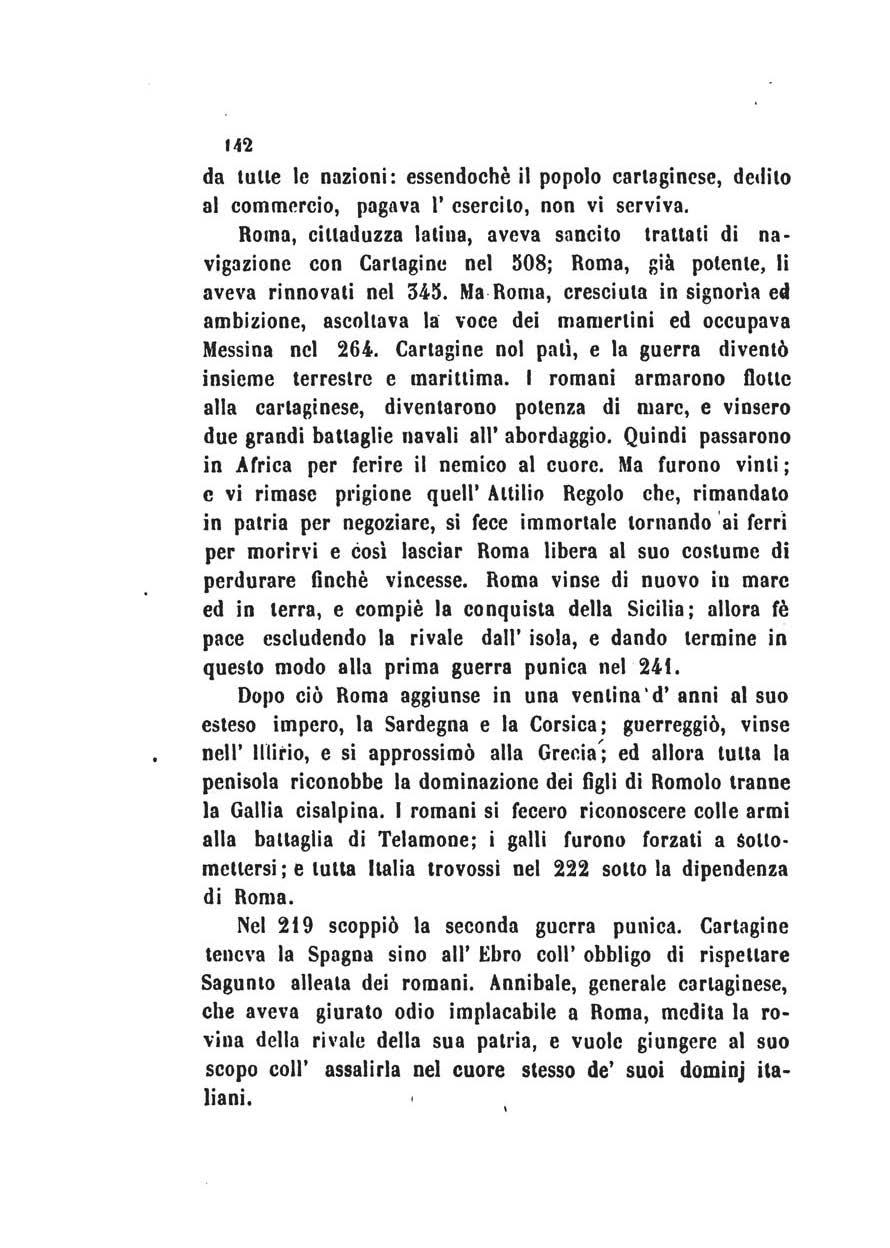
U3
Rotti i trattati coll' assedio e la presa di Saguoto, Annibale passa l' Ebro, valica i Pirenri, domo le popolazioni galliche che trova sul cammino, e giunge alle rive del Rodano la cui profondità e la cui rapidità spaventano esercito, che non ' di meno tenta il passaggio difeso da un esercito gallico., Dopo aver passato il Rodano, ingannando due eserciti romani che- lo inseguono, arriva al piede delle Alpi. Dove le abbia varrate non è b1mc stabilito: chi vuole dal Monginevra , chi dal Piccolo e chi dal Gran S. Bernardo. Comunque siosi le passò, scese ne' taurini, vinse i romani prima al Ticiuo, poscia alla Trebbia; varca gli Appennini, , attraversa le maremme di Chiusi e batte i romani al Trasimeno. La prudenza di Fabio gl' impedisce il progresso delle sue geste, l' imprudenza di Varrone gli oll're la batta· glia e la vittoria di Canoe. Ma non volendo forse affrontare il pericolo d' occupare una grande capitale, o impotente a ciò, girò intorno a Roma , poi si diresse verso Capua e la prese; ed ivi, e nella meridionale comunicante colla patria, colla Sicilia, e con Filippo re di Macedonia nuovo allealo suo, stabilì la sun bsse di ope· razioni.
Roma è grande in queste immense sventure: la terra popolata in origine da malfattori, è diventata una terra di eroi che ergono il capo non abbattuto dall' eccesso e daJia sequela delle avversità. Marcello vince tre volle i cartaginesi a Nola, passa in Sicilia, assedia Siracusa e la prende. Gli Scipiooi rimettono ed èstendono in lspagna la potenza romana. Il console Nerone sconfigge ed uccide Asdrubale al Metauro, venuto da Spagna in soccorso del fratello dopo essere sfusgito' agli Scipiooi; il più giovine de' quali, fatto console, neglige la guerra di Annibale io Italia, passa io Africa, e con Massinissa alleato, vince due battaglie contro
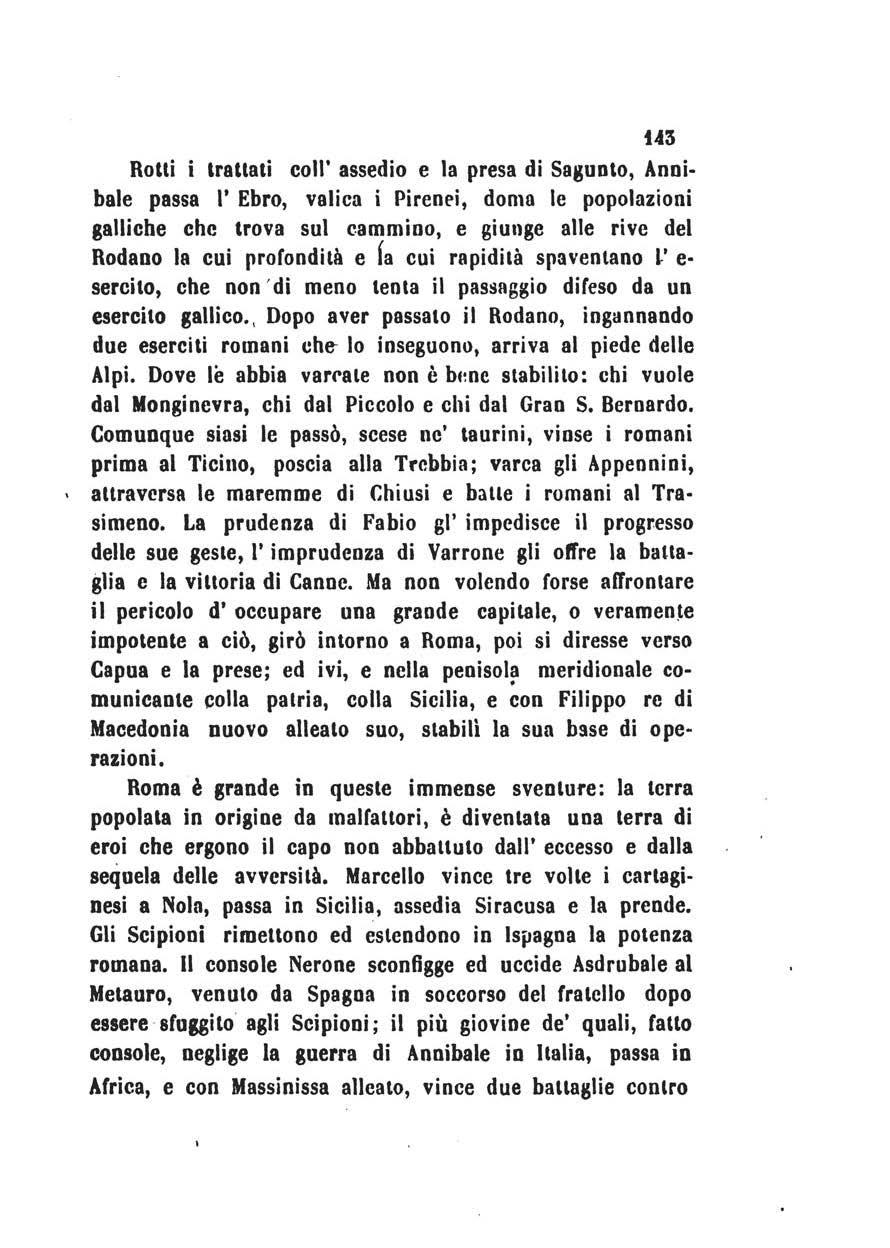
IU
i cartaginesi e Sifacc, ed una terza ed ultima a Zama nel 202 contro Annibale sforzato ad accorrervi. Cartagine domata, dovè rare una pace che può dirsi una capi.tolazionc; fu mollata, spogliata di sue navi c dc' suoi elefanti, rislrclla all' Africa; ivi diminuita a pro di Massinissa, ed impegnata a non guerreggiare se uon conseuzienle Roma ; ridotta insomma a poco più che provincia.
Negli anni successivi, Roma estese la sua potenza dall'Allantico all' Eusino. Bauè Filippo di Macedonia a Cinocdale e lo ridusse a pace umiliante. Ballè Antioco 1\e di Siria a Magnesia · ; bauè c sottomise i galati, colonia gallica stabilita in Asia; guerreggiò c vi nsc in Jspngna, io Liguria, in Sardegna_, in Corsica, in lstria e nell' lllirio; c, sconfino Perseo re di Macedonia a Pidna, lo trasse in trionfo tra le sue vie .
Era scorso più di mezzo secolo dacchè Cartagine era stata lìaccata a Zama; rinvenuta alquanto, destò la gelosia di Roma che la volle distrulla. Scipione Emiliano io una terza guerra punica 1' assediò e la distrusse nel 146 a. l' era cristiana.
Rallentate le conquiste, incominciarono le guerre civili. l Gracchi ne furono le prime viuime, c poscia Mario e Silla continuarono l' uno contro l' altro per· ambizione personale la lo\la della plebe e del patriziato.
Mario fece guerre e riportò villorie contro Giusurta io Numidia , contro i teutooi ad Aix, i cimbri a Vercelli; Silla contro gl' ilalici che volevano la cittadinanza romana, e contro re del Ponlo i cui eserciti furono balluti in Grecia a Cheronca e ad Orcomeoc.
Nella lotta ciuadina tra Mario e Silla, il primo rimase soccombente; il secondo, Tincitore fortunato, fece scaÌmare a mille a mille i partigiani del rivale; e, creandosi di \latore perpetuo, gettò le prime basi dell' impero.
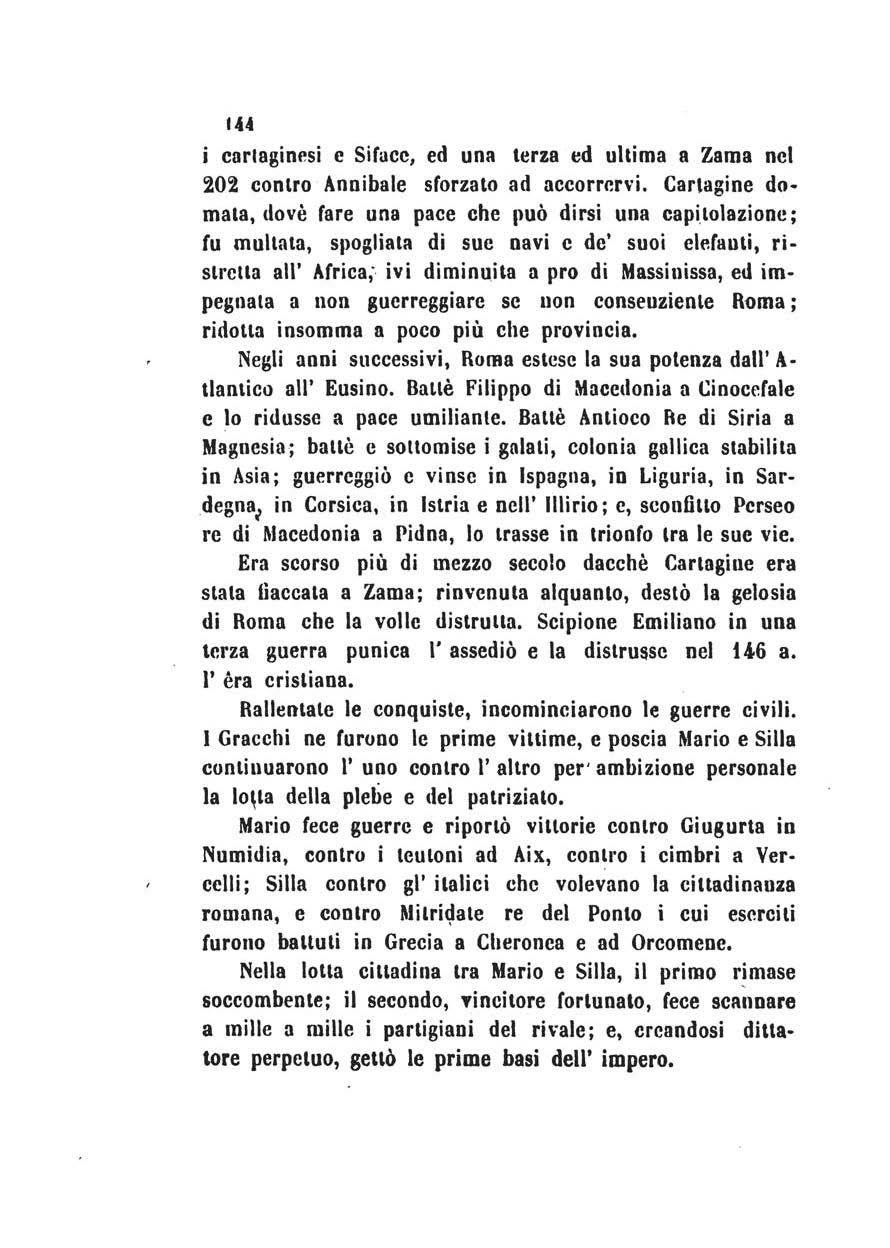
145
Morti Mario e Silla, la parte popolare fu sostenuta in lspagna da SerLorio, . che fini per tradimento. Pompeo, 'te· mendo di non venirnc ad una con avversario tanto formi· dabile, ne mise la testa al prezzo di oltre mezzo milione • delle lire nostre e 20,000 jugeri di terreno: e trovò in Perpeona chi preferì il mezzo milione e i 20,000 jugcri di terreno, ai principj dell' onore , ai dcuami della coscienza, ed alla testa· di Scrtorio.
Appena finilo questo ne sorse nn altro colla rivolta degli schiavi capitanati da Spartaco. Fu soffocata nel sangue, da Crasso prima, da Pompeo poscia. Poco vi pcrdeuero gli schiavi: rimanere uccisi dalla spada dei le· gionarj, o ' squarciati nei circhi dalle belve per dar gusto ai loro tiranni, era ·tutto morire: solo, la prima fine era gloriosa, la seconda più incresciosa.
Poi Catilina formò il tristo di soggiogare la repubblica; e per meglio riescirvi tramò di trucidare il seBato c di abbruciarc Roma. Vinto ed ucciso presso Pistoja, finì con lui la congiura non i disegni liherticidi.
Il sessantesimo anno A. G. C. si formò in RomR una lega di tre che si divisero il governo della repubbJica; e Co questa che costituì il primo triumvirato di Cesare, Pompeo e Crasso. Le provincie furono spartite fra i triumviri; Spagna ed Africa a Pompeo; Siria, con la guerra coot.ro ai parti, a Crasso; Illiri o e le due Gallie; colla guerra che vi sorgeva da un' invasione di teutoni che a chiamarsi Germani, a Cesare. Il solo governo tranquillo fra i tre era quello di Pompeo, il quale se ne stelle a Roma. Crasso andò contro ai parti e fu sconfitto ed ucciso. Cesare diedesi Lullo alle Gallic in cui scorgeva occasione di gloria e di potenza militare, strumenti massimi ad occupare la repubblica. Volò oltre Alpi; respinse i germani elvetici; si
Stor. dell' Art. .Milit. 10.
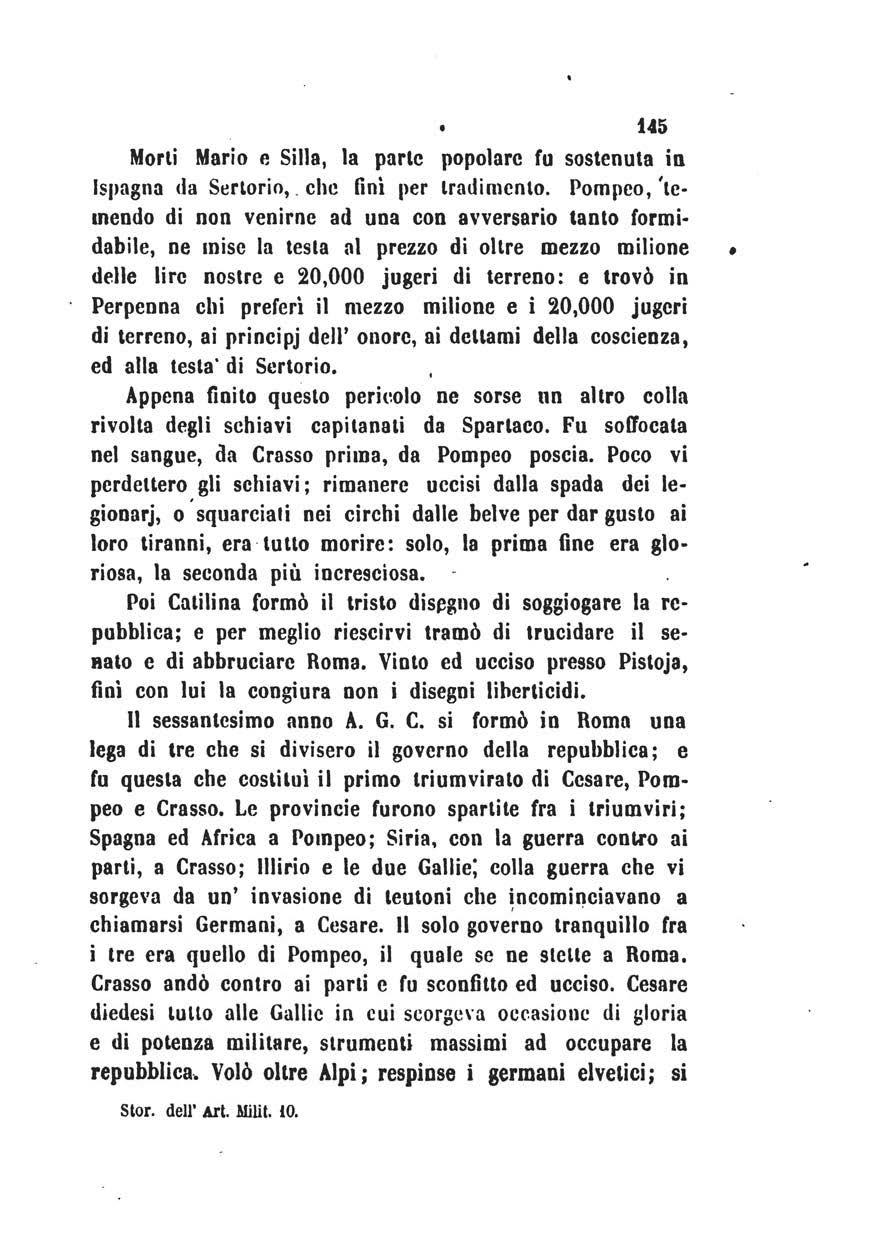
frammischiò alle parti, alle contese inlerne delle genti gal· liebe; vinse i belgi e gli aquitani; e, ·già domata tutta la Gallia, passò in Bretagna ed io Germania oltre Reno; tornò
• sui galli risollevati tl ridomolli.
1\lorto Crasso, il triumvirato si ridusse a duumviralo e non durò. Ciascun duumviro volle dominar solo, e scoppiò guerra tra essi. Cesare entra io Roma; insegue Pompeo; lo trova nell' Epird, sui campi di Farsaglia, e lo ·sconfigge.
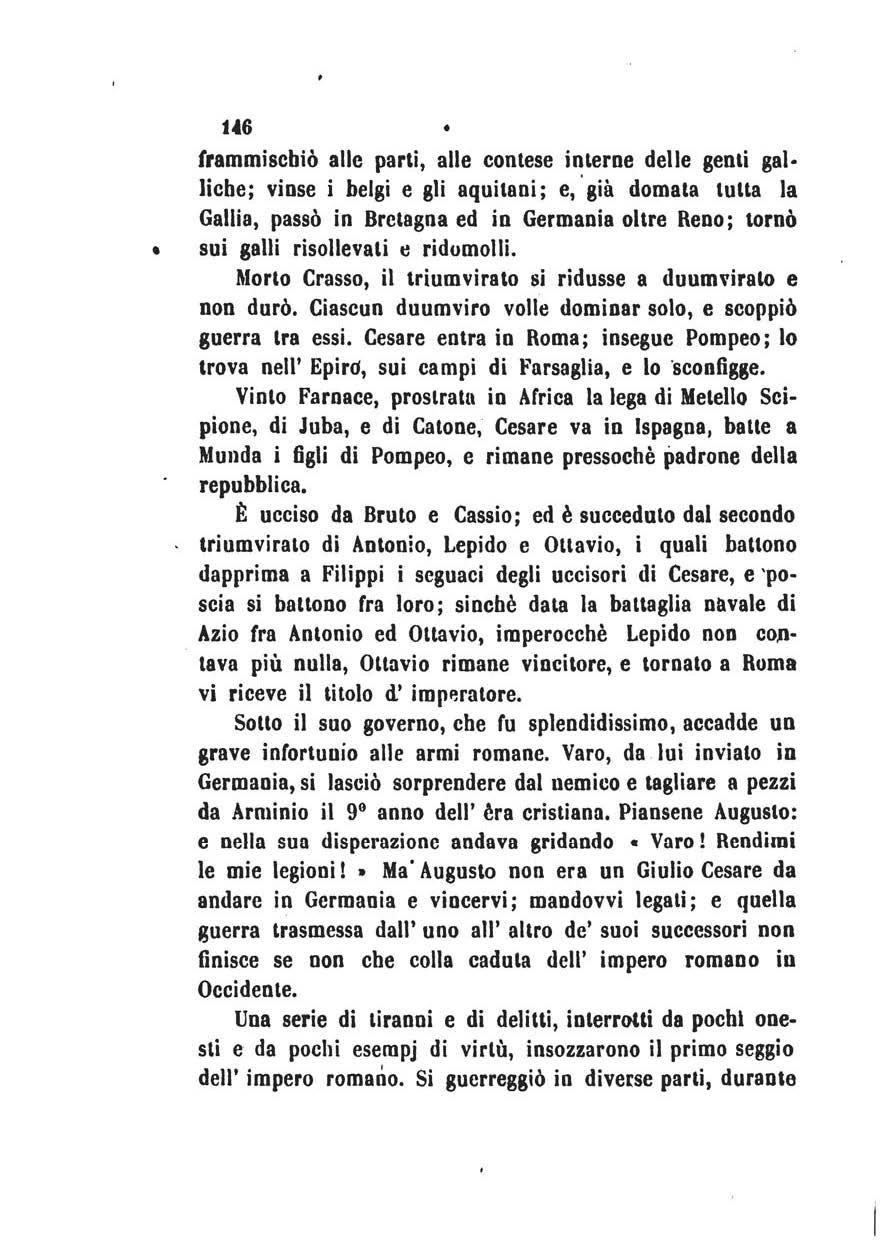
Vinto Farnace, prostratu io Africa la lega di Metello Scipione, di Juba, e di Catone, Cesare va io lspagoa, batte a Monda i figli di Pompeo, e rimane pressochè padrone della repubblica.
t ucciso da Bruto e Cassio ; ed è succeduto dal secondo triumvirato di Antonio, Lepido e Ottavio, i quali battono dapprima a Filippi i seguaci degli uccisori di Cesare, e 'poscia si battono fra loro; sinebè data la battaglia navale di Azio fra Antonio ed Ottavio, imperocchè Lepido non co.ntava più nulla, Ouavio rimane vincitore, e tornato a Roma vi riceve il titolo d' impP-ratore.
Sotto il suo governo, che fu splendidissimo, accadde un grave infortunio alle armi romane. Varo, da lui inviato io Germania, si lasciò sorprendere dal nemico e tagliare a pezzi da Arminio il 9° anno dell' cristiana. Piansene Augusto: e nella sua disperazione andava gridando • Varo ! Rendimi le mie legioni! • Ma ' Augusto non era un Giulio Cesare da andare in Germania e vincervi; mandovvi legati; e quella guerra trasmessa dall' uno all' altro de' suoi successori non finisce se non che colla caduta dell' impero romano in Occidente.
Una serie di tiranni e di delitti, interrotti da pocbl onesti e da pochi esempj di virtù, insozzarono il primo seggio dell' impero romano. Si guerreggiò in divetse parti, durao&e
U7 il regno e sotto quello di Claudio si fece la conquista della G.rao Brcuagna il '1 anno dell ' èra cristiana. Migliorata on po' la razza dei Cesari, vennero Vespasiano e Tito, che proseguendo la guerra in Oriente finirono coll' impadronirsi della Palestina.
Trajano vinse i daci nel principio del secolo; e la colonna che porta il suo noine fa ancora superba mostra fra i monumenti di Roma.
Adriano che gli successe, fu pinltoslo ordinatore dell' impero che d'ordine aveva somma la necessità; e coll' impero modificò pure l' ordinamento dell' esercito.
· Continuaronsi le guerre di quà ·e di là più per consèrvare che per ampliare l' impero; era anche troppo vasto da potersi tenere assieme, e già stava per isfasciarsi. l barbari avevano comincialo a minacciarlo.
Alessandro Severo, che visse nel· 3° secolo, operò mutamenti nell' esercito: fece guerra ai persi , e vinse.
Aureliano sconfiss.e tre volle i germani, una volta, e per sempre , Zenoh-, regina di Palmira, che, dopo avere con· quistate parecchie provincie dell ' impero romano , si faceva chiamare Regina d' Oriente. ·
Proseguirono i suoi successori l' opera di contrastare ai barbari l' invasione dell' impero. Probo battè i germani nel 377; Massimino domò i franchi, i borgognoni, e gli alemanni. Diocleziano respinse i persiani ed i snraceni; e Costantino, forse per odio a Roma pagana, o forse per avere una residenza opportuna affine di resistere ai barbari, trasportò la sua sede a Costantinopoli.
Sotto i suoi successori si divise l' impero in quello d' Occidente ed in quello d' Oriente; i costumi orientali finirono di corrompere la società, e di dare il crollo all' esercito. Pei barbari non furonvi più barriere: invasero, e distrussero. l
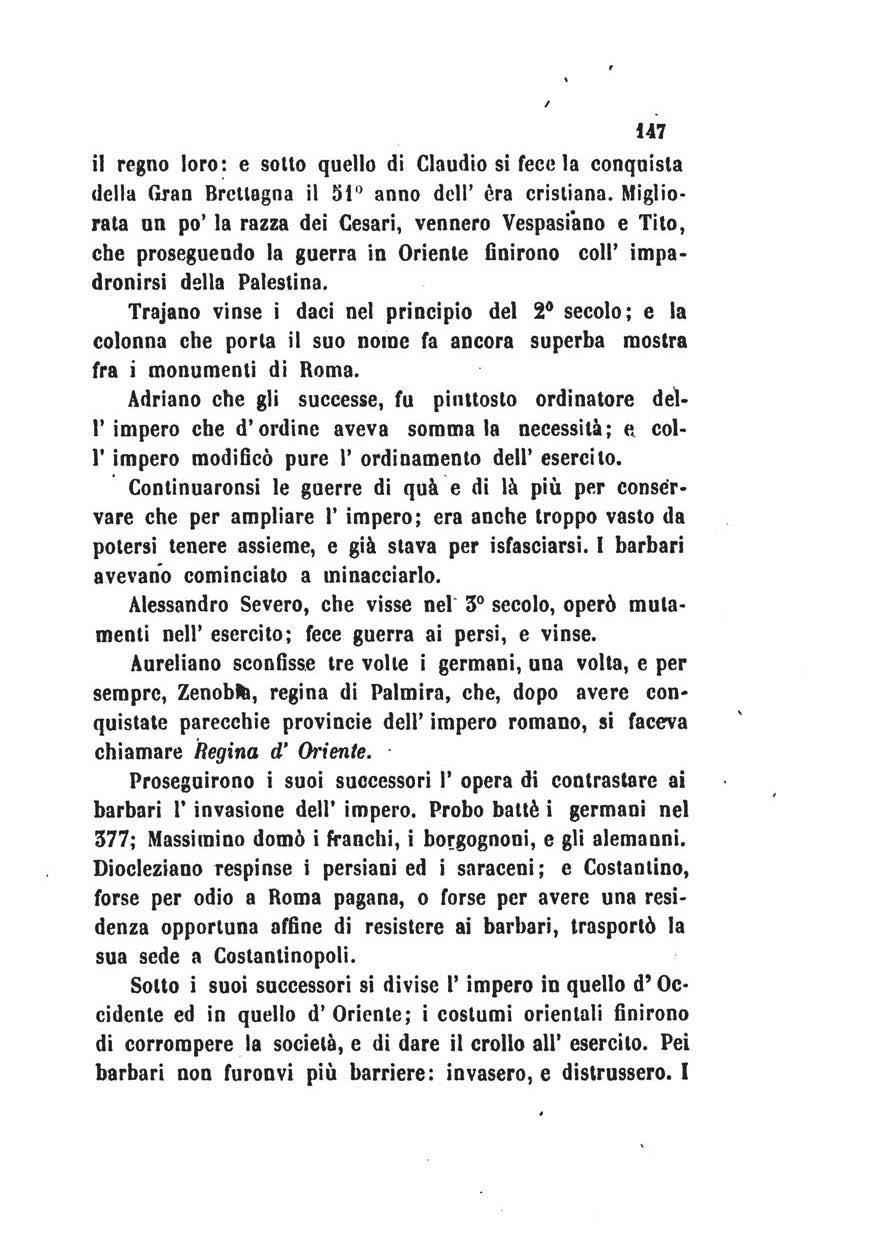
U8 vandali con Genserico entrarono in Roma nel .455, e ventun' anno dopo finiva l' impero d' Occidente colla deposizione di Au"gustolo; i barbari se lo divisero e formarono le diverse nazioni che furono stipite agli stati moderni di Europa.
Quello d' Oriente, invaso da altri barbari, andò lentamente estinguendosi; sinchè la scimiLara turchi finì di &agliare l' ultimo filo che legava al nome d' impero gli avanzi cadenti di una potenza vasta e corro t la. §. 2.o
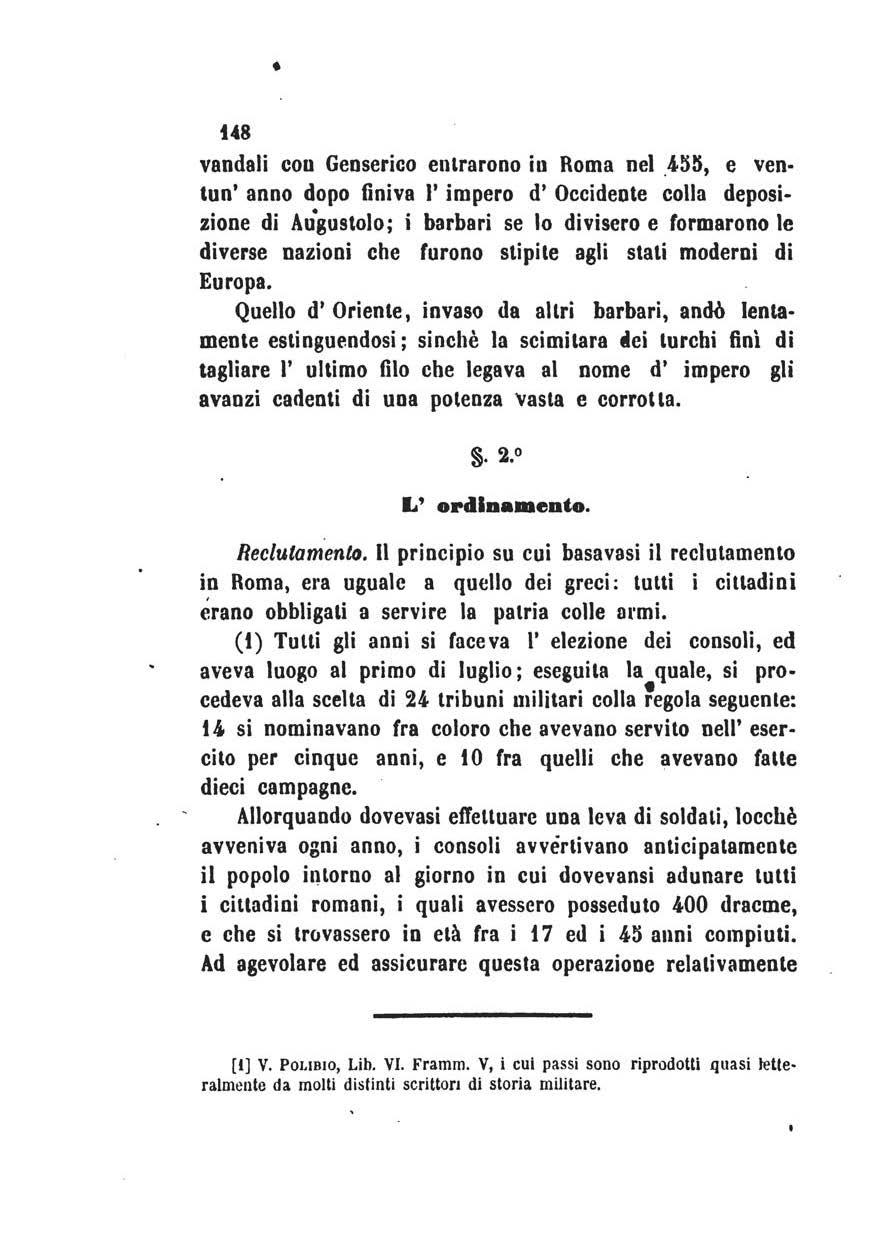
L' •••llaaMeato.
Reclutam.ento. Il principio su cui basavasi il reclutamento io Roma, era uguale a quello dei greci: tulli i ciuadini érano obbligati a servire la patria colle nt·mi.
(t) Tutti gli anni si faceva l' elezione dei consoli, ed aveva luogo al primo di luglio; esesuila la quale, si procedeva alla scelta di 24 tribuni militari colla 1egola seguente: t4 si nominavano fra coloro che avevano servito nell' esercito per cinque anni, e t O fra quelli che fatte dieci campagne. ·
Allorquando dovevasi effettuare una leva di soldati, locchè avveniva ogni anno, i consoli avvértivano anticipatamente il popolo iqtorno al giorno in cui dovevansi adunare tutti i cittadini romani, i quali avessero posseduto 400 dracme, e che si trovassero io età fra i t 7 ed i 45 anni compiuti. Ad agevolare ed assicurare questa operazione relativamente (l] v. POI.IBto, Lih. VI. Framm. V, i cui passi sono riprodotti .quasi lette· ralmcnle da molti distinti scritton di storia mili tare.
U9 all' età dt>i cittadini, concorrevà etficacemente un' antichissima legge che si auribuisce oi tempi di Tullo Ostilio, in virtù della quale dovevasi tenere un registro delle nascite e delle morti, contribuendo in tal guisa i provvedimenti per la coscrizione militare alla successiva istituzione dei registri per lo stato civile.
La riunione aveva luogo per solito al Campidoglio ; qualche volta al campo Marzio; ed ivi inalberavasi il vessillo consacrato all' operazione del reclutamento.
Ne' primi tempi si estraevano a sorte le tribù che dovevano somministrare il contingente; ma più tardi la leva si operava su tutta la popolazione col concorso di tutte le tribù. Questa modificazione venne portata in conseguenza dei lamenti delle tribù urbane che attribui vano ai consoli tristi maneggi per far cadere la sorte a danno loro, ed a vantaggio delle tribù forcsi più devote al patriziato.
l tribuni dividevansi in tanti drappelli in numero uguale n quello delle legioni che si volevano levare; e siccome ogni esercito consohre componevasi di quattro legioni, cosi, per mettere assieme uno di codesti eserciti, i tribuni si formavano in quattro gruppi che costituivano quattro giunte distinte .
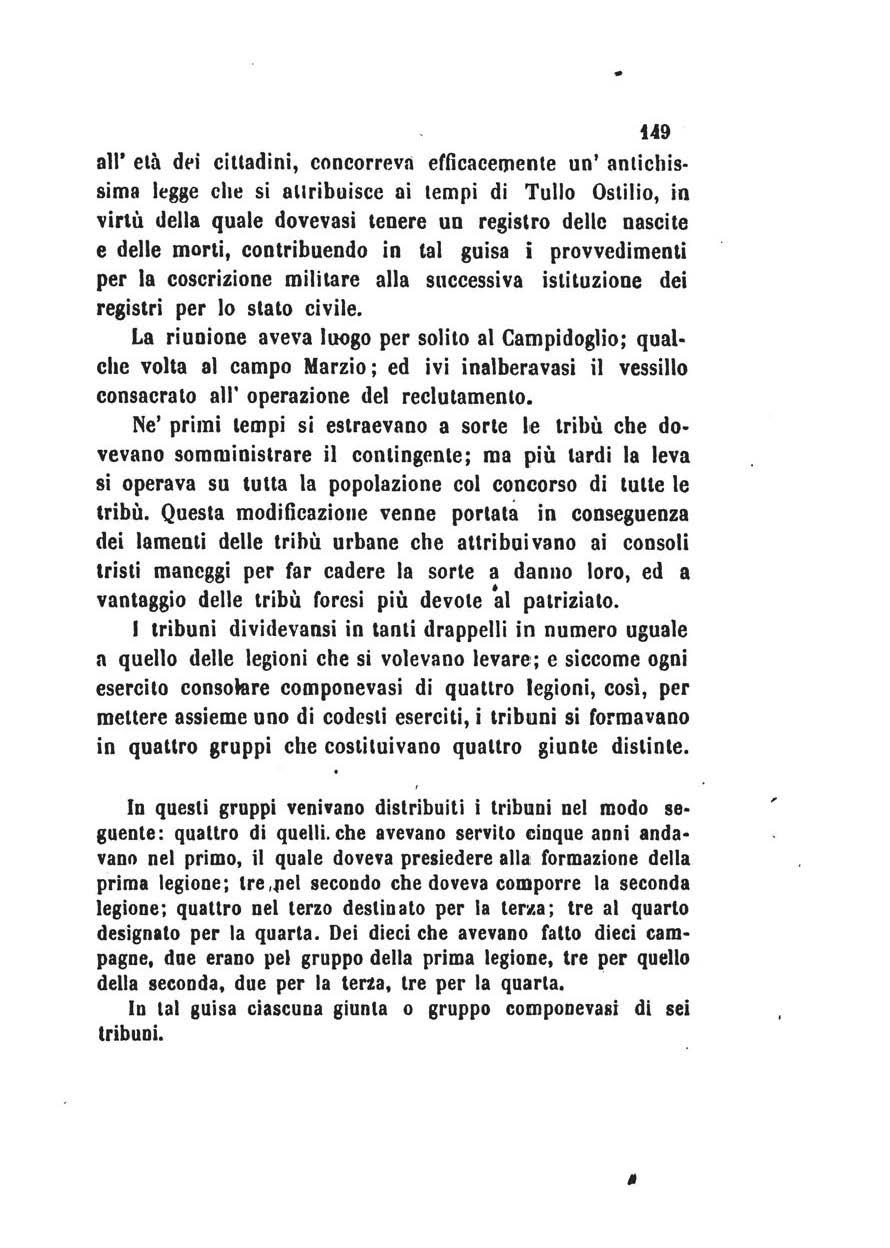
Io questi groppi veni•ano distribuiti i tribuoi nel modo se · guente: quattro dì quelli. che avevano servito eioque anni andavano nel primo, il quale doveva presiedere alla formazione della prima legione; tre , f) el secondo che doveva comporre la seconda legione; quattro nel terzo destinato per la terza; tre al quarto designato per la quarta. Dei dieci che avevano fatto dieci campagne, doe erano pel gruppo della prima legione, tre per quello della seconda, due per la terta, tre per la quarta. ·
Io tal guisa ciascuna giunta o gruppo componevasi di sei tribuni.
50
Falla questa opt>razione, si chiamavano, nell' ordine indicato dalla sorte, tutte le tribù, l' una dopo l' altra; e, fra esse, sceglievansi quattro uomini uguali, il più che fosse possibile, per istatura , per età, e per forza . Fottili avvicinare alle giunte, i tribuni della prima legione faceano per primi la loro scelta di uno di essi, poscia la facevano quelli della seconda, indi quelli della terza, e per ultimi quelli della quarta .
Dopo· questi quauro ciltadioi , si sceglievano altri quattro pure uguali fra loro; ed allora i tribuni della seconda legione erano i primi a prendersi il coscriuo, quelli della terza i secondi, quelli della quarta i terzi, e per ultimi quelli della prima.
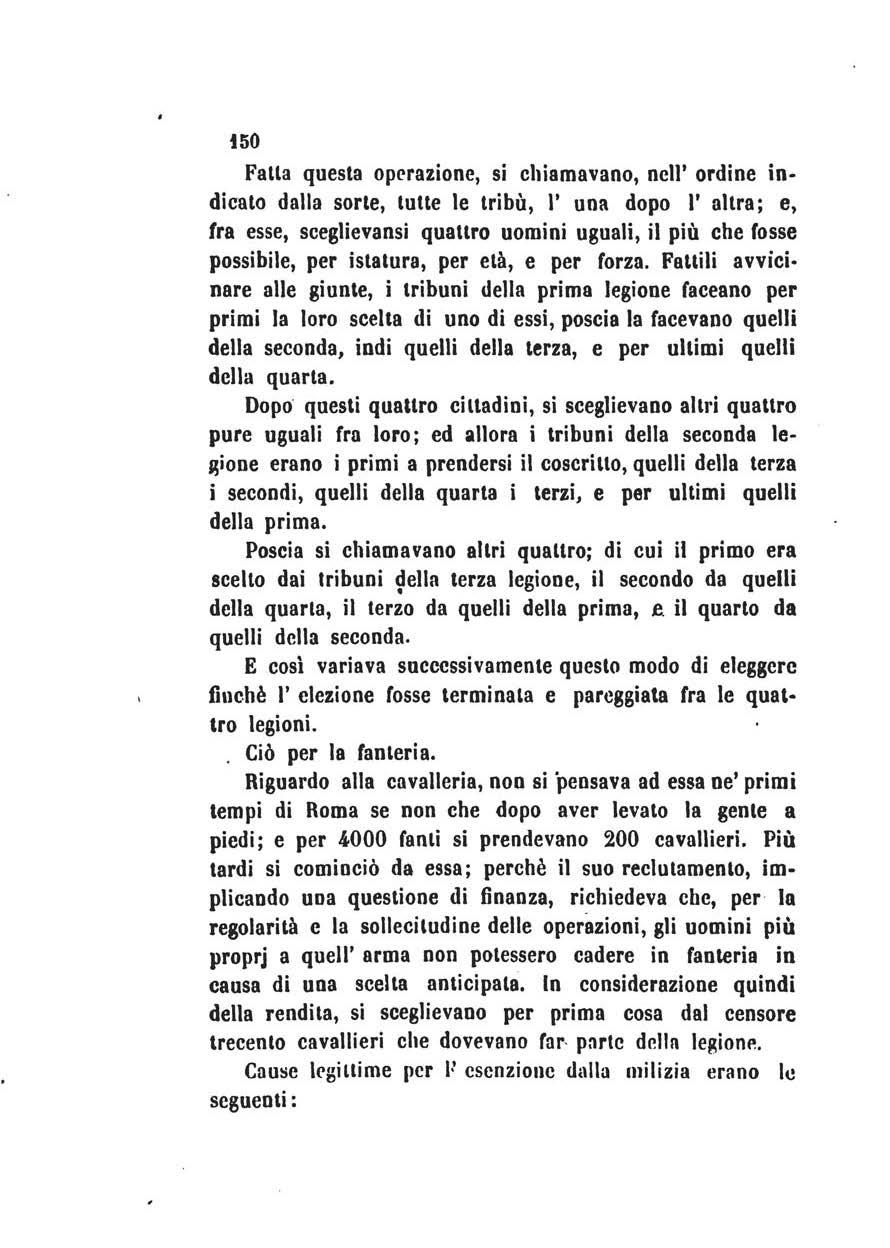
Poscia si chiamavano altri quattro; di cui il primo era scelto dai tribuni terza legione, il secondo da quelli della quarta, il terzo da quelli della prima, e.. il quarto da quelli della seconda.
E così variava successivamente questo modo di eleggere fiochè l' elezione fosse terminata e pareggiata fra le quat· tro legioni.
.
Ciò per la fanteria.
Riguardo alla cavalleria, non si pensava ad essa ne' primi tempi di Roma se non che dopo aver levato la gente a piedi; e per 4000 fanti si prendevano 200 cavallieri. Più tardi si cominciò da essa; perchè il suo reclutamento, im· plicaodo uoa quest ione di finanza, richiedeva cbc, per · la regolarità c la sollecitudine delle operazioni, gli uomini più proprj a quell' arma non potessero cadere in fanteria in causa di una scelta antic ipata. In considerazione quindi della rendita, si sceglievano per prima cosa dal censore trecento cavallieri che dovevano far- parte dr.lln legionP..
Cause l('gillime per P esenzione dalla milizia erano le seguenti:
i5t
t.' Ragioni di età, cariche di magistratura, esercizio del sacerdozio, o privilt•gio concesso dal sennto o dal popolo.
:! ." Il compimento di lodevoli servigj militari .
5.0 Una grave infe'rmità o difello ' fisico, come la sordità, l' eccessiva miopìa ecc.
La durata dell' iscrizione ai ruoli ero, come dicemmo, dai i 7 ai 45 anni compiuti. Ogni cittadino, entrando nel 46° anno, doveva avere servito 16 aoni in fanteria, o fO io cavalleria. Era chiamato interpelatamen te a seconda dei bisogni. Tale disposizione, per la quale il cavalliere stava sotto le armi meno del fantaccino, era dovuta al motivo delle maggiori spese a cui quello più di questi· andava soggetto.
Aseconda di questa regola generale,, gli eserciti romani furono quasi sempre esclusivamente di cittadini che avevano qualche agiatezza e godevano qualche considerazione; ma pei casi straordinarj, eziandio nei ttmpi migliori, si reclutarono di quà e di là i mercanti al minuto, gli emancipati di fresco, gli dei mestieri reputati scrvili, tutta gente esonerata ordinariamente dalla milizia, e r.he non vi era chiamata se non che per eccezione. Questa eccezione si estese fino agli schiavi dopo il disastro -di Canne. Nello stesso tempo che si eseguivano le leve a Roma, i consoli fJcevano conoscere ai magis:rati delle città alleate d' Italia la quantità di truppe che dovevano somm•mstrare, indicando loro il giorno ed il luogo di assembramento. Le leve si effettuavano alla stessa foggia di Roma.
La fanteria degli alleali o socj era uguale per. numero alla fanteria legionaria di un esereilo consolare ; ma la loro cavalleria era il doppio di questa. l. romaui non ebbero per 500 anni gli ausiliarj propriamente detti; ossia i soldali tolti dalle ci llà e dalle nazioni
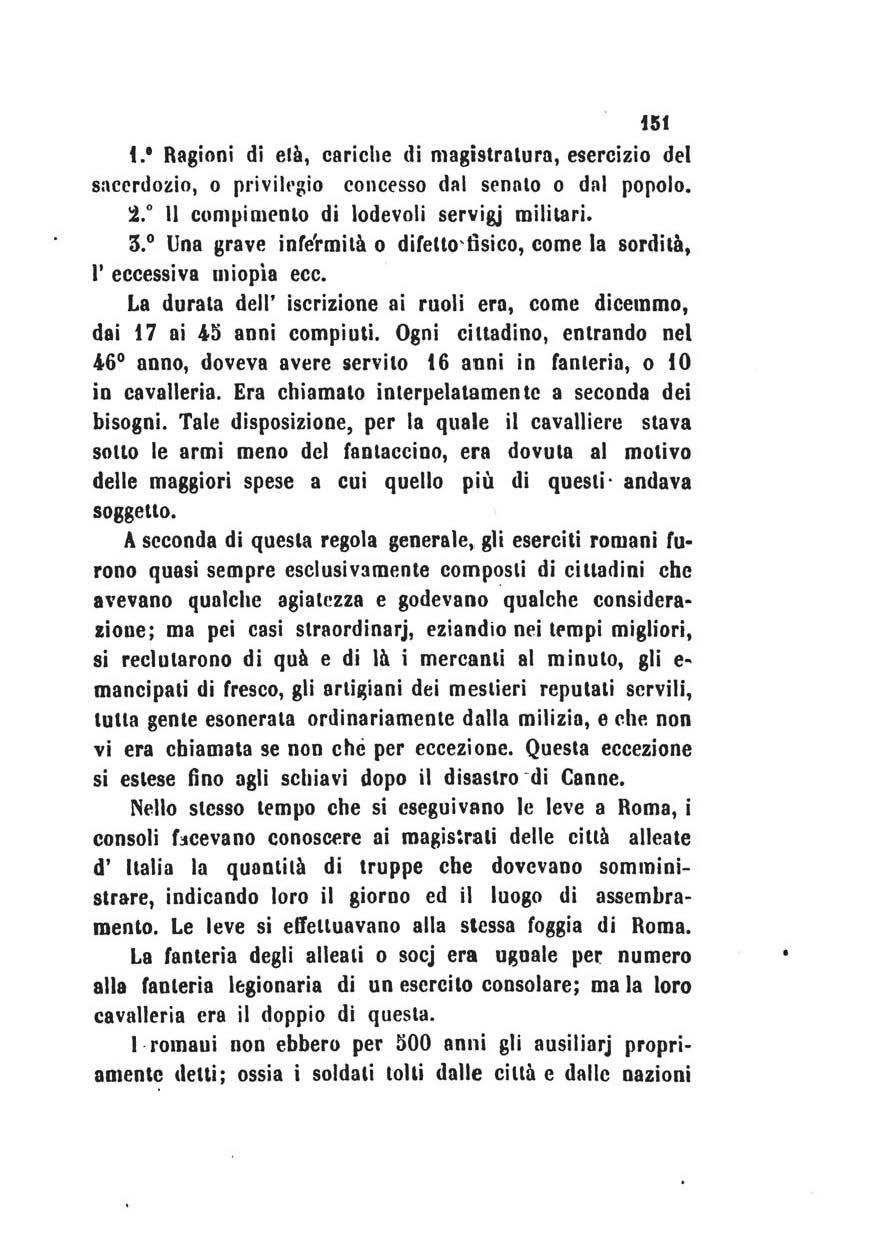
situate fuori d' Italia; quando li ammiseto, ebbero nel cuore dell' esercito un elemento di corruzione.
Oltre ai soldati di leva, i romani avevano anche i volontarj ossia gli Evocati; erano militi veterani i quali, compito il loro tempo di servizio, si ascrivevano di nuovo volontariamente nella milizia; essi erano tenuti io grande onore, e dalle infime fatiche esenti.
In caso di urgente bisogno, e quando il tempo mancava alla lenta scelta, si pigliavano i ·militi alla rinfusa, ed allora si chiamavano Militi subitarj o tumultuarj. Era que sta la leva in massa ; e ne abbiamo esempj di alcune fatte per ordine di Roma dagli Eroici, dai Latìni, e dalle colonie di Anzio.
Fatla la coscrizione, si passava al giuramento militare. Esso era semplice, e consisteva nel promettere di obbedire con ogni possa agli ordini degli umciali. Questo giuramento veniva · pronunciato da un soldato tenuto fra i più bravi; ciascun legionario lo ripeteva individualmente passando dinanzi ai tribuni .
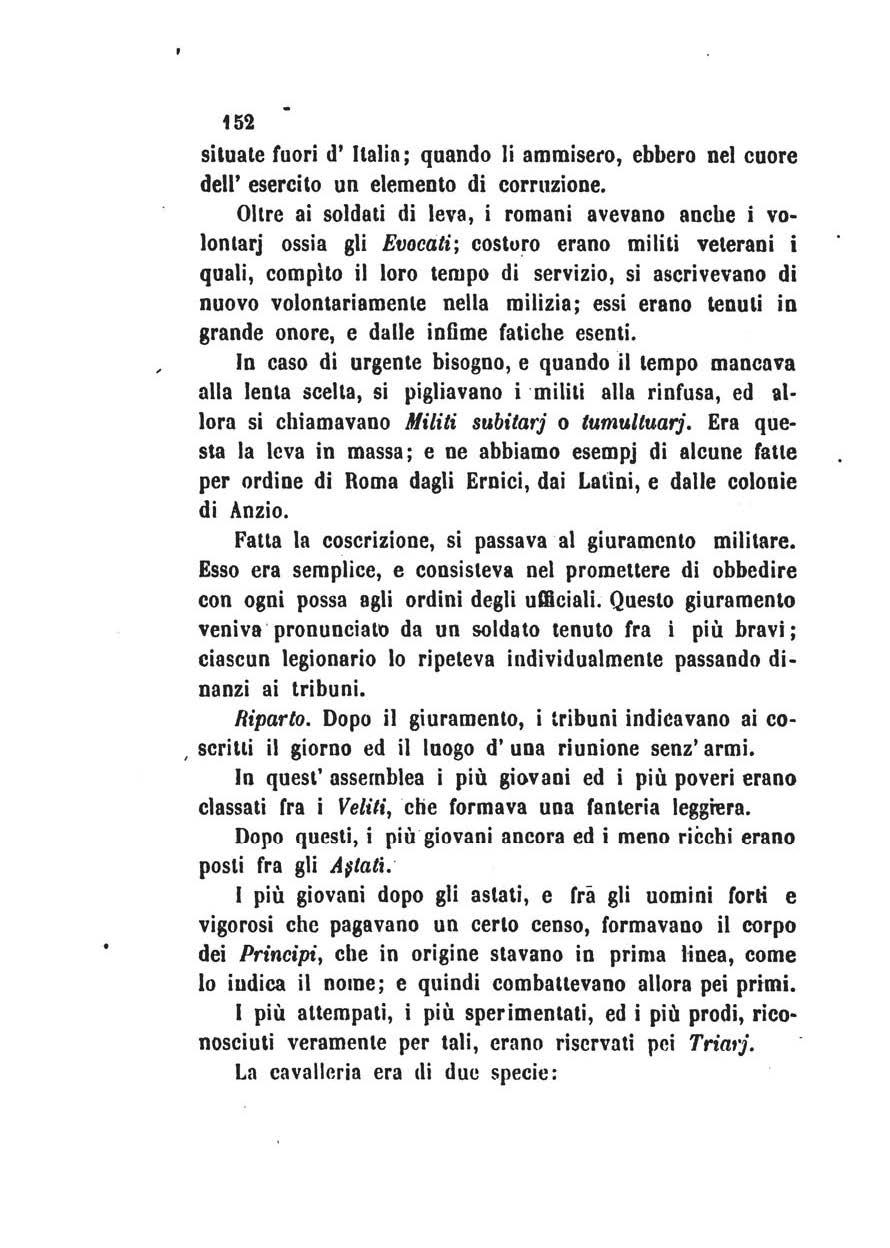
Riparto Dopo il giuramento, i tribuni indicavano ai co, scriUi il giorno ed il luogo d' una riunione senz' armi.
In quest ' assemblea i più giovani ed i più poveri erano classati fra i Velili, che formava una fanteria leggrera.
Dopo questi, i più .giovani ancora ed i meno ricchi erano posti fra gli A1tati; l più giovani dopo gli astati , e fra gli uomini forti e vigorosi che pagavano un certo censo, formavano il corpo dei Principi, che in origine stavano in prima Hoea, come lo iudica il nome; e quindi combattevano allora pei pri-mi.
l più attempati, i più sperimentati, ed i più prodi, rico· nosciuti veramente per tali, erano riservati pci Triat'j.
La cavalleria era 11i due specie:
55
f .° Cavalleria di · linea. Cavalleria leggiera.
Ln fanteria della legione era dunque di quattro specie di soldati, tre delle quali combaucvano oeJle file cd . una fuori.
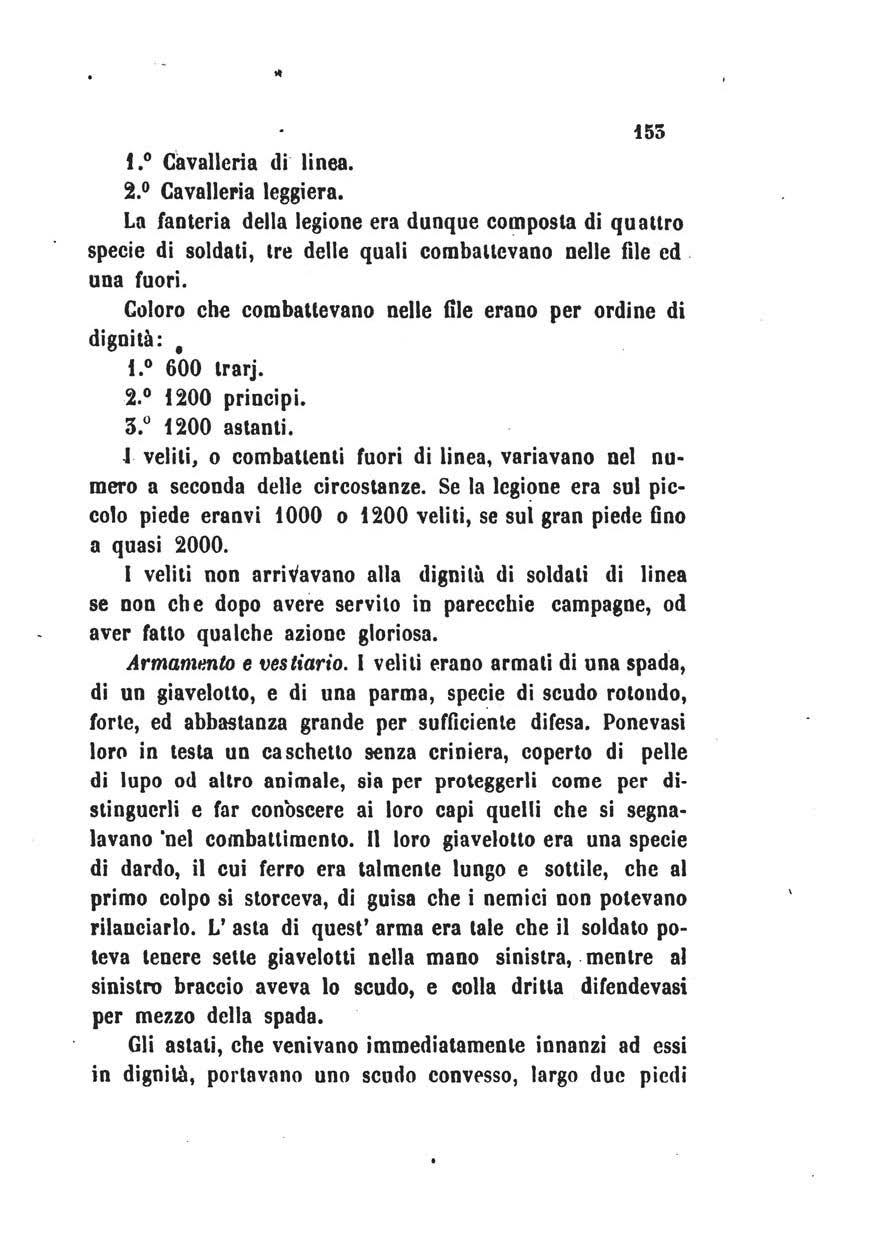
Coloro che combaUevano nelle file erano per ordine di dignità: , 1.0 600 trarj. 1200 principi. 3 . 0 f200 astanti.
J. veliti, o combattenti fuori di linea, variavano nel numero a seconda delle circostanze. Se la era sul piccolo piede eraovi 1000 o t 200 veli ti, se sul gran piede fino a quasi 2000.
l veliti non arrivavano alla dignità di soldati di Jinea se non che dopo avere servito io parecchie campagne, od aver fallo qualche azione gloriosa.
Armamento e vestiario . l veliti erano armati di una spada, di un giavelotto, e di una parma, spec.ie di scudo rotondo, forte, ed abbastanza grande per sufficiente difesa. Ponevasi loro in testa un ca schetlo senza criniera, coperto di pelle di lupo od altro animale, sia per proteggerli come per distinguerli e far conoscere ai loro capi quelli che si segnalavano 'nel combattimento. Il loro giavelotto era una specie di dardo, il cui ferro era talmente lungo e sottile, che al primo colpo si storceva, di guisa che i nemici non potevano rilaociarlo. L'asta di quest' arma era tale che il soldato poteva tenere sette giaveloui nella mano sinistra, . mentre al sinistro braccio aveva lo scudo, e colla driua difendevasi per mezzo della spada.
Gli astati, che venivano immediatamente innanzi ad essi in dignità, portavano uno scudo convt>sso, largo due piedi
54
e mezzo e luogo quattro, per proteggere la loro persona e la loro armatura. Questo scudo era coperto all' esterno di cuojo di vitello; in alto ed io basso era guernito di ferro affincbè l' umidità ·della terra non potesse farlo marcire, ed i colpi di taglio non lo rompessero. La sua eonvessità era pure coperta d' una lastra di ferro per parare i colpi di pietra! di picca, o di sarissa. Avevano la spada chF dava di punto e di taglio: sul fianco destro portavano uno stiletto. Avevano il pilo cb' era una specie di picca. Portavano gambiere ossia stiva letti; quello della gamba dritta era meglio difeso e guernito di làmine di rame , essendo più esposto nel combattimento di piè fermo, specialmente quando il -gi nocchio sinistro era in terra . La loro testa era coperta tla un elmo sorra cui portavano un pennacchio di tre penne dritte che dava loro un aspetto mat'stoso e formidabile.
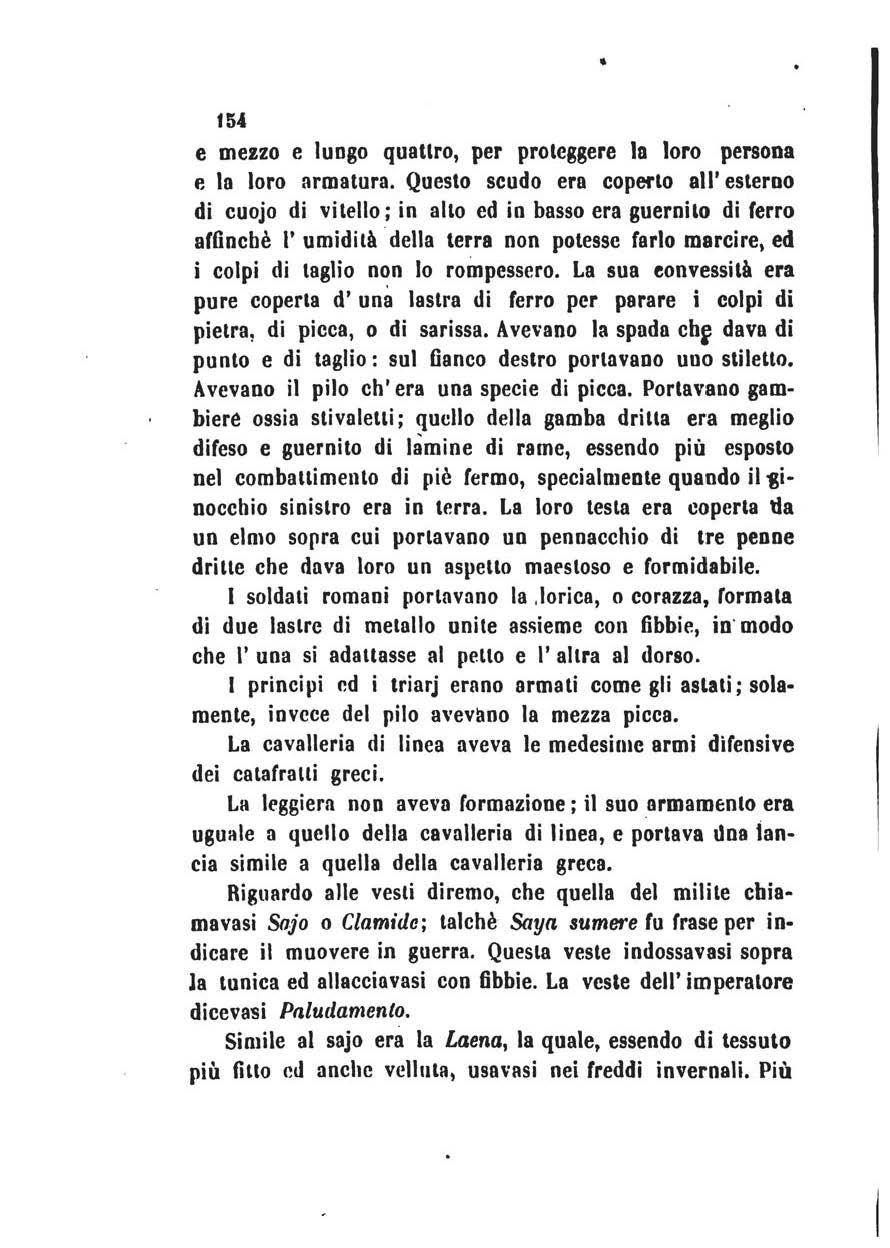
l soldati romani portnv:mo la .lorica, o corazza, formata di due lastre di metallo unite assieme con fibbie, io·modo che l' una si adattasse al petto e l' altra al dorso.
l principi cd i triarj erano armati come gli asLati; solamente, invece del pilo nevano la mezza picca.
La cavalleria di linea aveva le medesime armi difensive dei catafratti greci.
La leggiern non aveva formazione ; il suo armamento era uguale a quello della cavalleria di linea, e portava dna lancia simile a quella della cavalleria greca.
Riguardo alle vesti diremo, che quella del milite chiamavasi So.jo o Clamide; talcbè Saya &umere fu frase per indicare il muovere in guerra. Questa veste indossavasi sopra la tunica ed allacciavasi con fibbie . La ves&e dell'imperatore dicevasi Paludamento.
Simile al sajo era la Laena, la quale, essendo di tessu&o più fitto cd anche velluta, usavasi nei freddi invernali. Più
i 55 lunga ancora, e più atta a riparare ·dal rigore delle stagioni, era la Lo.cerna, cui poscia si aggiunse il Cucullus o cappuccio. Ordinanza. Raccol&i i militi, divisi nelle di verse categorie, vestiti ad armati a seconda della classe a cui erano destinati, si formna la Legione.
Il nome di legione veniva dal verbo leget·e che vuoi dire scegliere, pe.rchè la legione era composta di uomini scehi fra quelli sortiti per legge alla milizia.
La legione si formava su tre linee : la prima componevasi di astati, la seconda di principi , la terza di triarj. l veliti e la cavalleria occupavano ordinariamente i fianchi .dell'ordine generale di battaglia.
Ogni manipolo delle due prime linee, l' di astati e l' altra di principi, constava di t 20 combattenti. Ogni manipolo della ultima linea, ossia !ei triarj, componevasi di 60 combattenti. ·
Ognona delle tre linee della fanteria di linea di una legione dividevasi in dieci manipoli i quali cosi chiamavansi perchè nei primi tempi della repubblica portavasi dinanzi a ciascuno di essi un manipolo di fieno a guisa di segno o vessillo.
n manipolo era l' unità tattica della legione.
Ogni manipolo dividevasi in due centurie, e disegnava sul terreno un piccolo rettàngolo di tO uomini di profon· dità e di t 2 di fronte se il manipolo era di astati o di principi, e di 6 uomini di fronte, con tO sempre di profondità, se era di triari. (V. Tav.• V. Fig.• f.a)
La distanza fra un uomo e l' altro, ossia lo spazio tra la punta dei piedi di quello che è di dietro ai talloni di quello che è davanti, e l' intervallo fra uomo e uomo, ossia lo spazio preso da fianco a fianco, era uguà lmente di tre piedi.
La distanza fra le linee non è bene determinata ; ma pare che fosse di M a 60 metri.
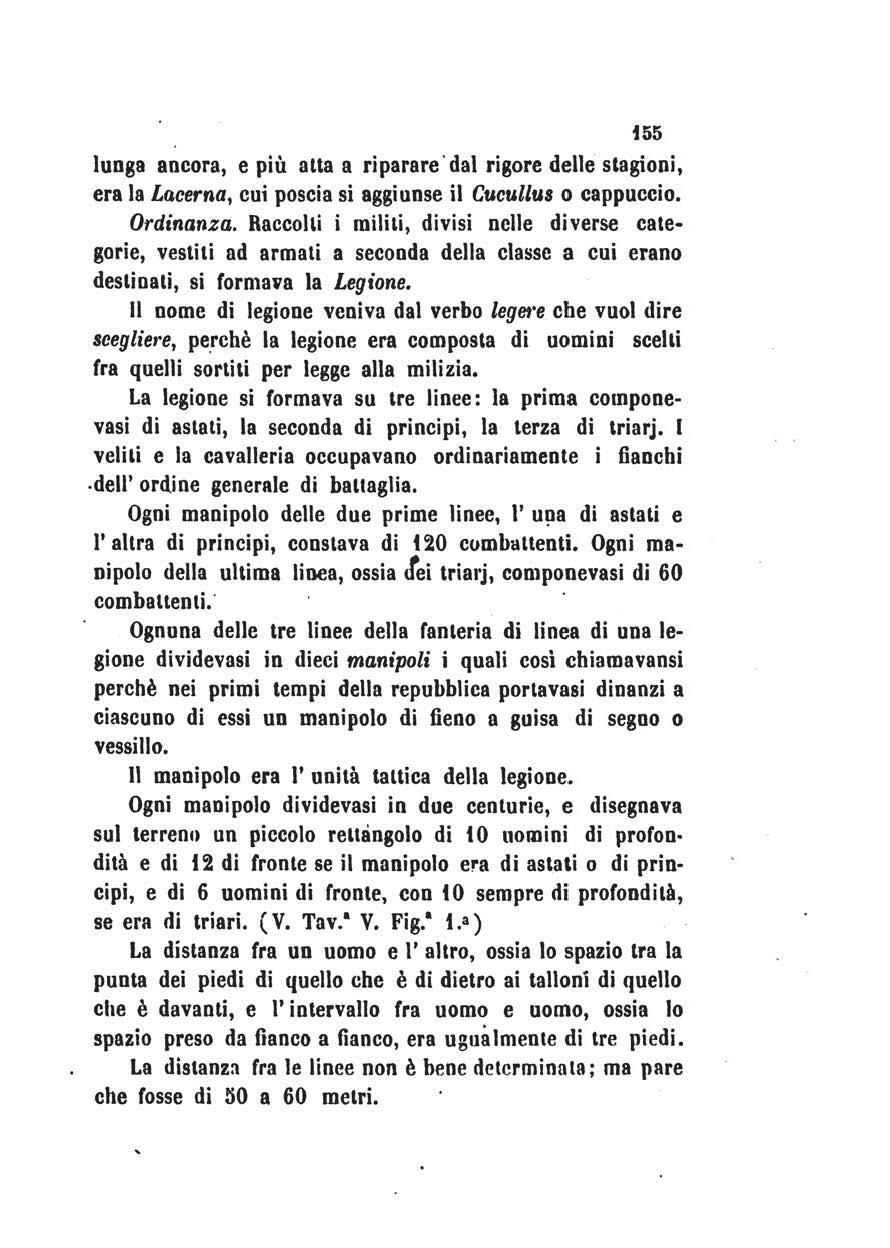
L' iQtervallo fra un manipolo e l' altro era uguale alla fronte di un manipolo.
l dieci manipoli della 2.• linea corrispondevano ai lasciati fra quelli della t •; i dieci della 31 corrispondevano ai vuoti lasciati fra quelli della 2 3 ed nUo spazio occupato da quelli della ta. .
l romani cominciarono ad accorgersi dell' importanza dello cavalleria quando ebbero a combattere colla cavalleria tessala che serviva nell'esercito di Pirro; tutlavia la loro tu poco numerosa e temibile fino all'epoca io cui conobbero la numida sul cui modello Scipione si diede a disciplinarla.
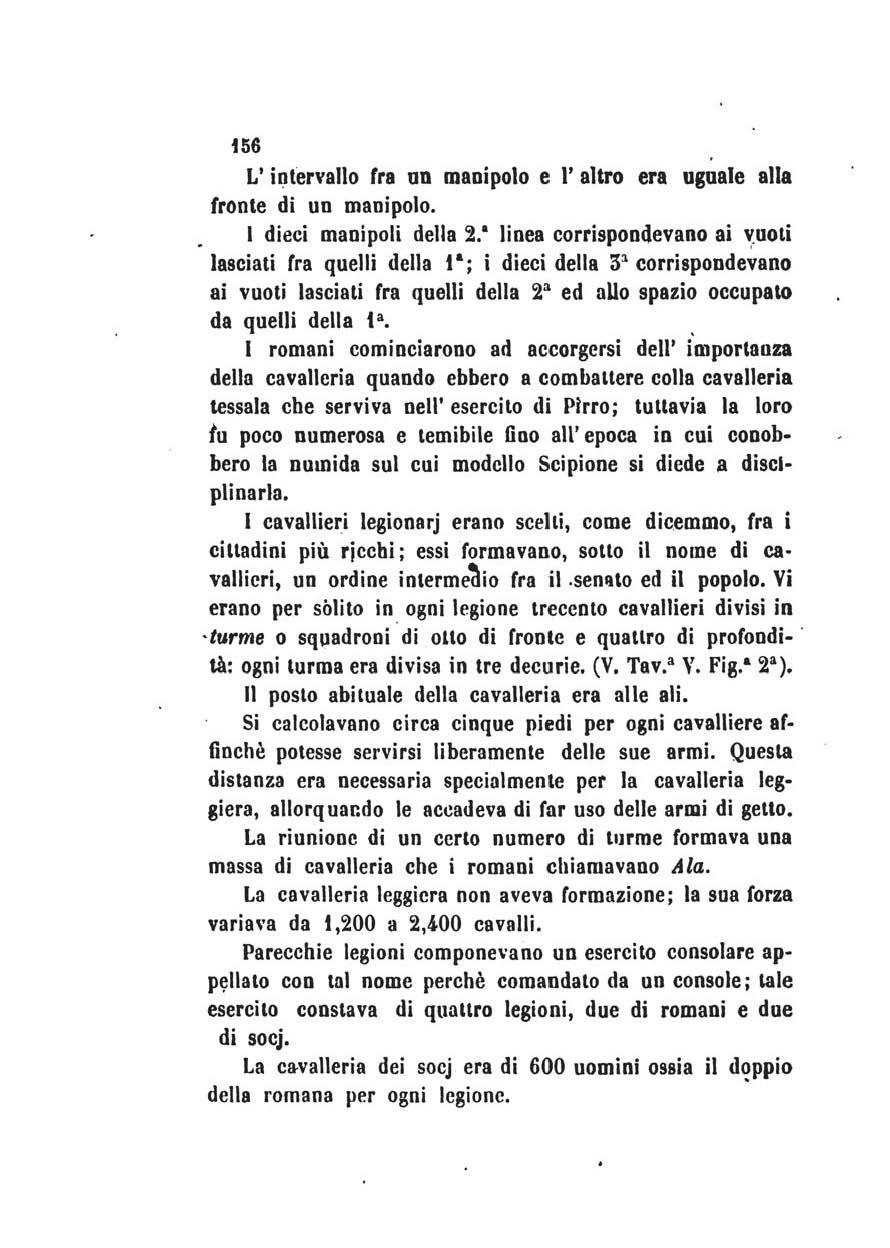
l cavallieri legionarj erano scelti, come dic.emmo, fra i cittadini più rjccbi; essi formavano, sotto il nome di cavallicri, un ordine fra il .semlto ed il popolo. Vi erano per solito in . ogni legione trecento cavallieri divisi in ·turme o squadroni di ono di fronte e quattro di profondi- · tà: ogni turma era divisa in tre declllrie. (V. Tav.a V. Fig.• 23 ).
Il posto abituale della cavalleria era alle ali.
Si calcolavano circa cinque piedi per ogni cavalliere affinchè potesse servirsi liberamente delle sue armi. Questa distanza era necessaria specialmente per la cavalleria leggiera, allorq uacdo le accadeva di far uso delle armi di getto.
La riunione di un certo numero di t11rme formava una massa di cavalleria che i romani chiamavano Ala.
La cavalleria leggicra non aveva formazione; la sua forza varia\·a da t ,200 a 2,400 cavalli.
Parecchie legioni componevano un esercito consolare appt;!llato con tnt nome perchè comandato da un console; tale esercito constava di quattro legioni, due di romani e due di socj.
La ca-valleria dei socj era di 600 uomini ossia il della romana per ogni legione.
Nell' ordine abituale di battaglia, le due legioni di fanteria romana stavano ol centro, avevano a destra , una lesione di socj ed a sinistra un' allra, poi alle ali la cavalleria, metà a manca e metà a dritta. Questa disposizione era fatta dai romani con doppio intento sagacissimo: t." Perchè l'esperienza aveva loro insegnato che quando il centro si avanzo ardito e valoroso, o in altri termini quando l'ordine di battaglia presenta una linea convessa, le due eli seguono l'impulso e· la vittoria è quasi sicura; mentre il contrario dee dirsi quando la linea per lo arrestarsi del centro impaurito resti concava; epperciò serbavano il centrò alla stirpe quirita di cui erano sicuri.
Perchè essendo le forze ·dci romani unite , e quelle dci socj divise, potevano le prime dominare queste più agevolmente e richiamarle all' ordin•e quando avessero tramata qualche pericolosa novità.
Fra i cavollicri sociali sccglicvansi dugento pel servizio personale dei consoli e si chiamavano Straordinarj; da questi nuovamente prendevas·i una torma di 40 Ablecti, ossia uomini scelti, i quali ad un tempo .fossero guardia consolare ed ostaggi, che solto gli occhi del capitano stessero colle loro persone garanti della buona disciplina dci loro compagni. Fino ai tempi di Mario, la legione non subì .variazioni se non che leggiere ed accidentali. Noi parleremo qui soltanto di quelle della . fanteria , impr.rocchè la cavalleria ne ebbe meno, e meno importimti.
La fanteria romana di uno lcgione .era abitualmente, prima di Polibio, di 5000 soldati di linea, C di l 000 o 1200 VCJ liti. Al tempo di Polibio nscesc al numero di 5000.
S'incominciò coll'aumentare il numero degli astati e dei principi ·di i 00 uomini per ogni corpo; i veli li ed i triarj rimasero quali erano.
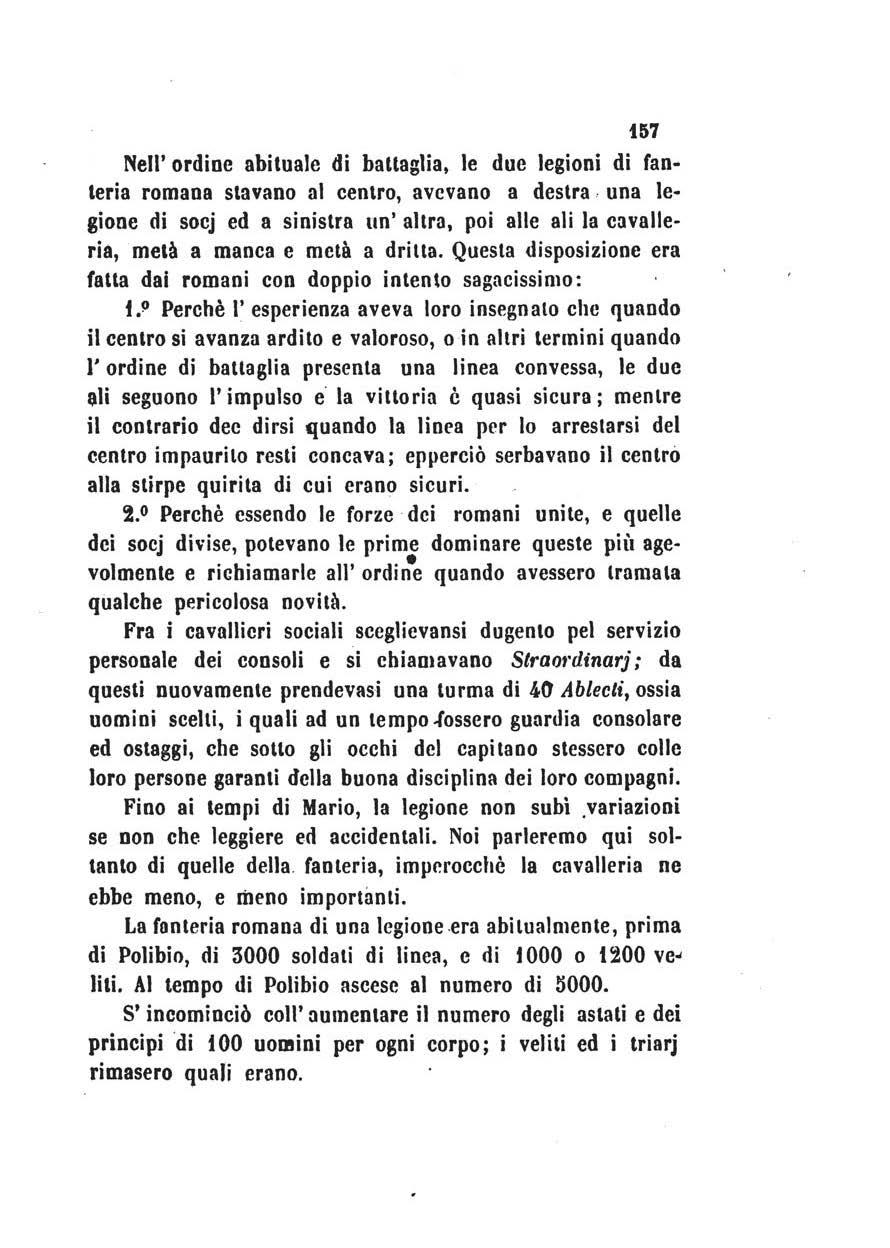
58
Poi, portando la legione a uomini, gli astati furono i 600, altrettanto i principi, cd il numero dei veli ti e dei triarj restò ancora inalterato.
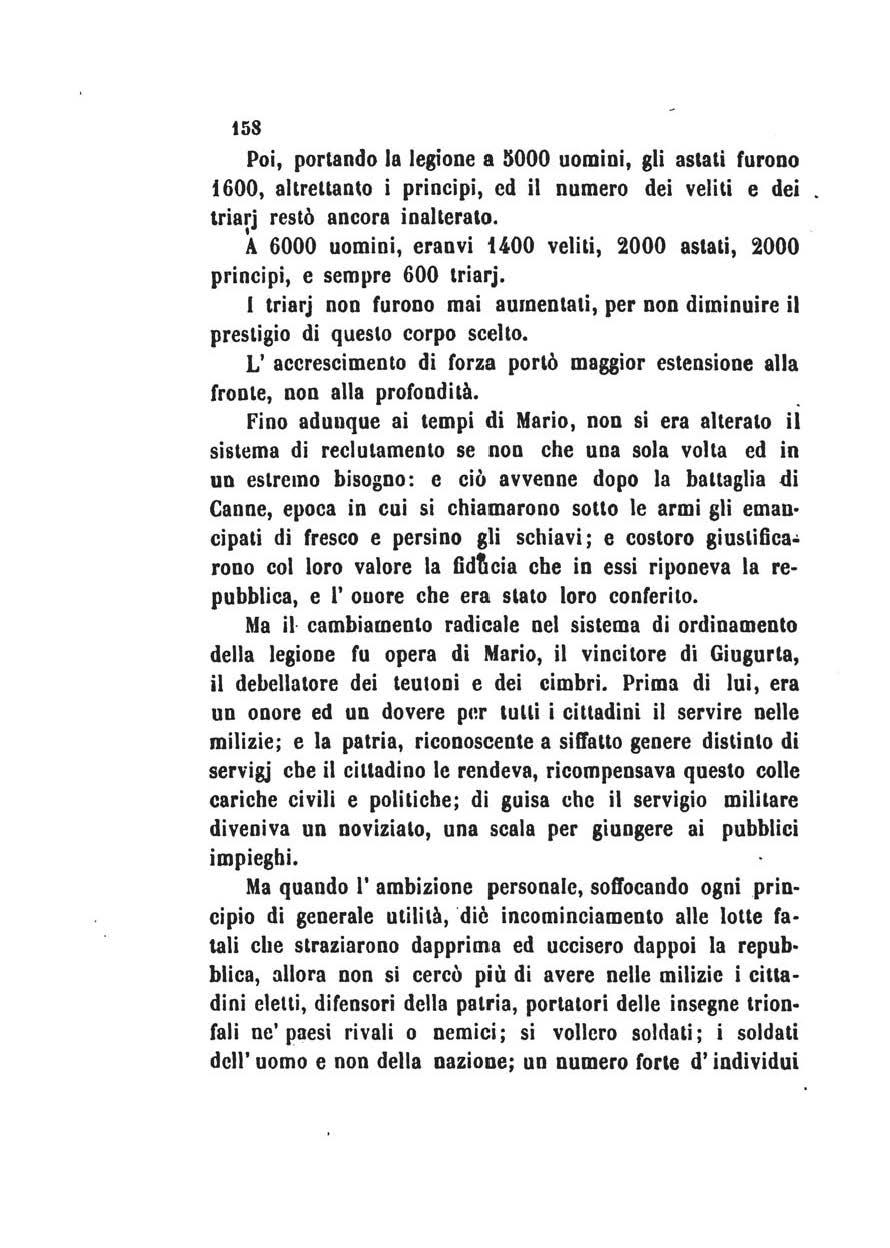
l
A 6000 uomini, eranvi UOO veliti, 2000 astati, 2000 principi, e sempre 600 triarj.
l triarj non furono mai aumentati, per non diminuire il prestigio di questo corpo scelto.
L' accrescimento di forza portò maggior estensione alla fronte, non alla profondità.
Fino adunque ai tempi di Mario, non si era alterato il sistema di reclutamento se non che una sola volta ed in uo estremo bisogno: e ciò avvenne dopo la battaglia di Canne, epoca in cui si chiamarono solto le armi gli eman· cipati di fresco e persino g1i schiavi; e costoro giustifica.; rooo col loro valore la fidflcia che io essi riponeva la repubblica, e l' onore che era stato loro conferito.
Ma il· cambiamento radicale nel sistema di ordinamento della legione fu opera di Mario, il vincitore di Giusurta, il debellatore dei teutoni e dei cimbri. Prima di lui, era un onore ed un dovere tulli i cittadini il servire nelle milizie; e la patria, riconoscente a sifl'atto genere distinto di servigj che il cittadino le rendeva, ricompensava questo colle cariche civili e politiche; di suisa che il servigio militare diveniva un noviziato, una scala per giungere ai pubblici impieghi.
Ma quando l' ambizione personale, soffocando ogni principio di generale utilità, 'diè incominciameoto alle lotte fatali che straziarono dapprima ed uccisero dappoi la repub· blica, allora non si cercò più di avere nelle milizie i cittadini eletti, difensori della patria, portatori delle inst>gne trionfali ne' paesi rivali o nemici; si vollero soldati; i soldati dell'uomo e non della nazione; un numero forte d'individui
t59
per resistere ad altro numero forte o per abbauerlo. Non · era più esca l'onore ma H soldo; laonde ad ogni ceto sociale, e più basso tanto meglio, si fece ricorso.
Fu allora che Mario, arruolò indifferentemente ogni specie d'uomini, ricchi c poveri, buoni e cattivi ciuadioi: tanto nella fanteria quanto nella cavalleria. Ben tosto s' occorse che questa truppa, questa agglomerazione di gente non animata e non sostenuta da alcuna forza ·ID(Irale, infiammata in un istante da passioni brutali e scorraggiata colla medesima rapidità, questa moltitudine infine senza virtù non era più propria all'ordinanza che aveva fatto trionfare gli escrcili di cittadini; e giudicò che il manipolo di f 20 uomini circa, o di t 50 nel plù alto piede della legione, era troppo debole. Allora riunì i tre manipoli di triarj, di principi, e di astati, e ne formò la Coorte. In essa i soldati restarono, sotto il rapporto amministrativo, uniti ·alla coorte come prima lo erano al manipolo; ma il nome dei tre ordini dci soldati Jegiooarj si perdeue; la legione fece un passo notevole verso la falange; c non tornò più a quell' ordine che fino allora aveva formato la sua gloria cd i suoi trionfi.
La legione si trovò per tal guisa composta di dicci coorti. L' su dicci righe fu conservata; e pare che sul principio di questo ordinamento, gli astati formassero le prime righe, i principi le quattro st>gucnti, cd i Lriarj le due ultime; ed a tollo questo nuovo sistema, a ,,uesta modificazione cioè dell'ordinanza primitiva della legione, si diede il nome di Ordine di Mario.
Se dal lato del reclutamento l'ordine di Mario riuscì fu· oesto alle istituzioni militari dei romani, conviene però riconoscere che la coorte godeva come il manipolo delle qua· li essenziali a tutte le unità di forza tattica; che essendo più forte del manipolo presentava . maggiore solidità senza
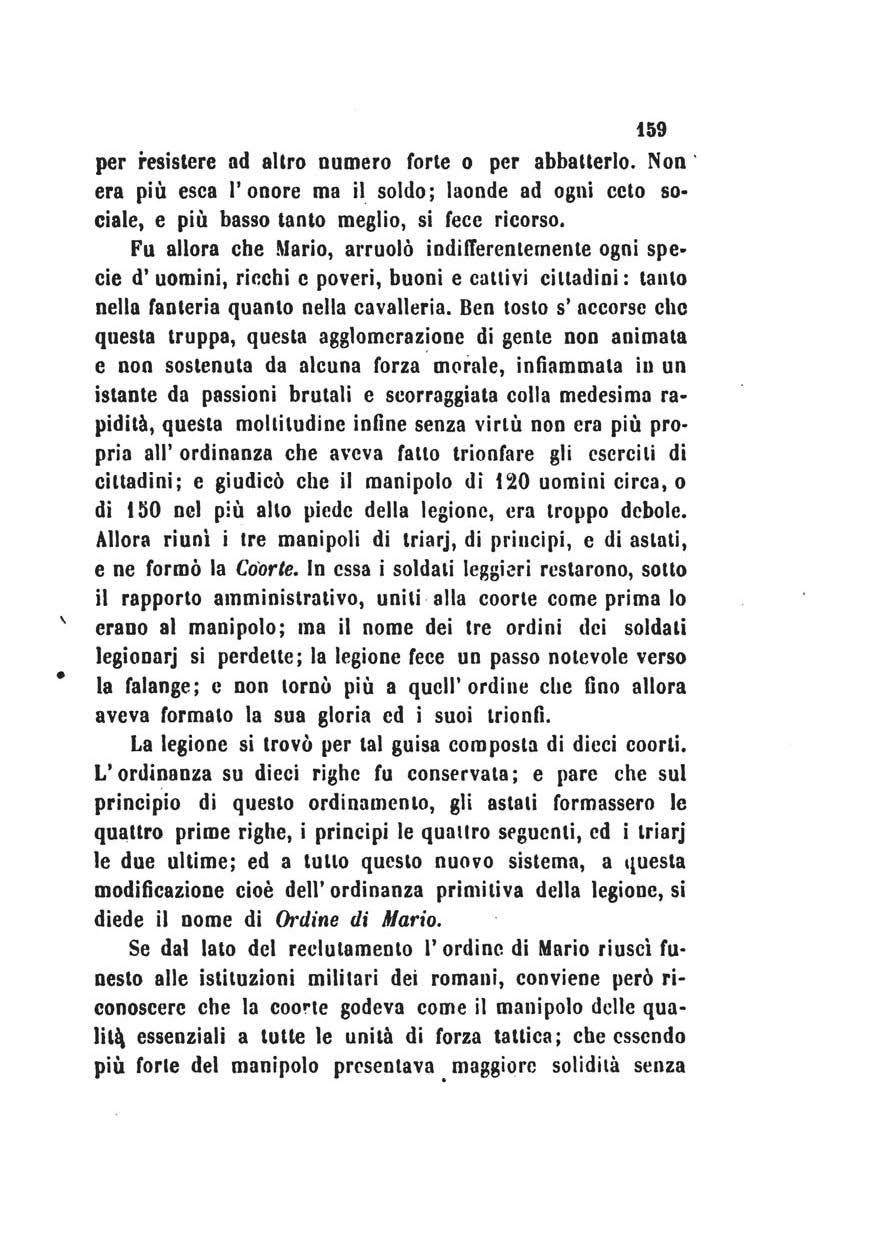
che ne potesse venire immenso danno a11a mobilità; E! che finalmente l' ordinamento per coorti offriva maggior sicurezza di quello per manipoli, essendocchè diminuendo il numero de11e unità tattiche ed l'estensione dc11a loro fronte, si diminuiva il numero dei fianchi i quali formano il lato debole delle ordinanze. (V. Tav .a VI . Fig.a t. 8 )
Cesare migliorò l'ordinanza di Mario: la terza linea fu ristabilita per servire di riserva; e soventi le coorti combatterono serrate senza intervalli fra loro. (V. Tav .• VI. Fig.a 2.a)
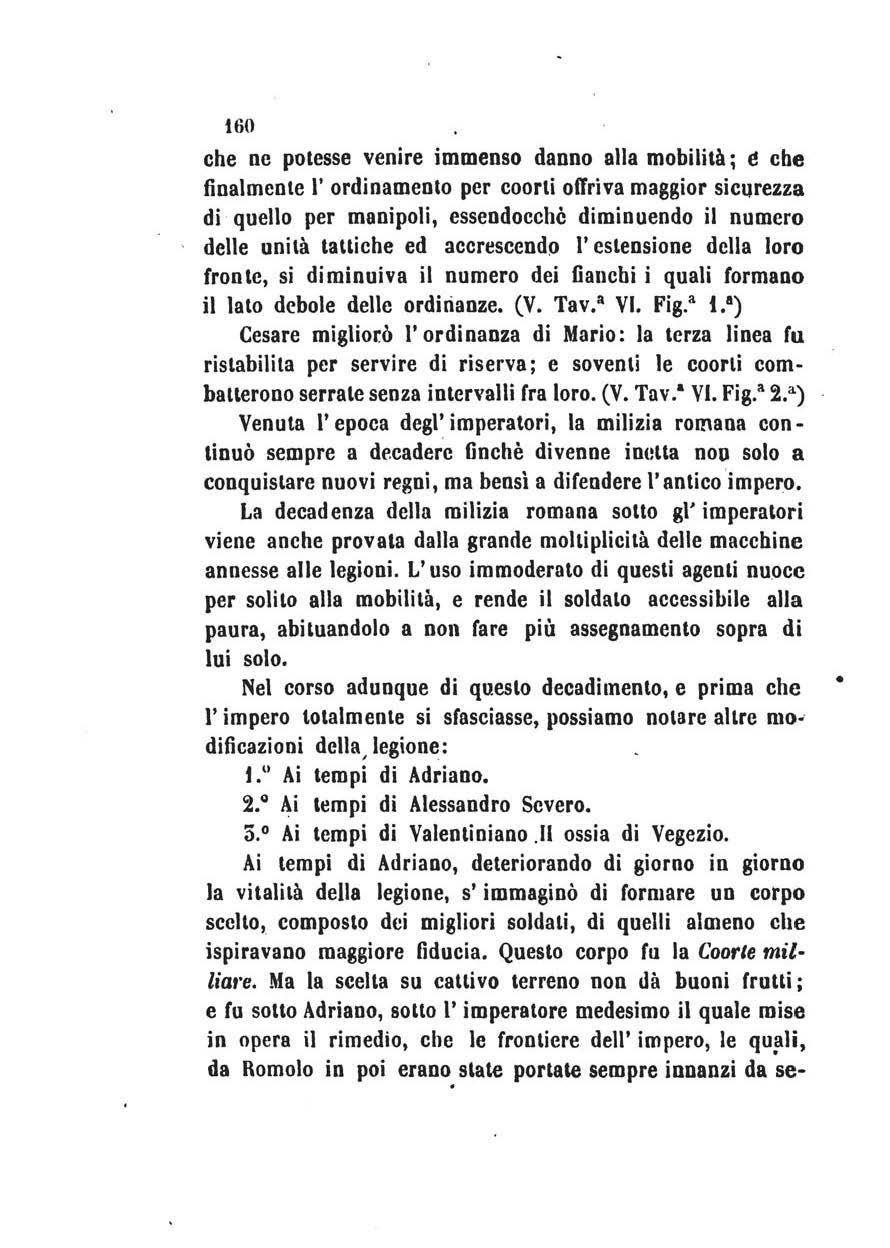
Venuta l'epoca degl'imperatori, la milizia romana contiouò sempre a decader'e finchè divenne iDlllta noo solo a conquistare nuovi regni, ma bensì a difendere l'antico 'imper.o. La decadenza della milizia romana sotto gl' imperatori viene anche provata dalla grande moltiplicità delle macchine annesse alle legioni. L'uso immoderato di questi agenti nupcc per solito alla mobilità, e rende il soldato accessibile aJJa paura, abituandolo a non fare più assegnamento sopra di lui solo.
Nel corso adunque di questo decadimento, e prima che l'impero totalmente si sfasciasse, possiamo notare altre mo ... dificazioni della , t •11 Ai tempi di Adriano.
2. 0 Ai tempi di Alessandro Severo.
5. 0 Ai tempi di Valentioiano .11 ossia di Vegezio. Ai tempi di Adriano, deteriorando di giorno io giorno Ja vitalità della legione, s' immaginò di formare un corpo scelto, composto dci migliori soldati, di quelli almeno che ispiravano maggiore fiducia . Questo corpo fu la Coorte milliafe. Ma la scelLa su cattivo terreno non dà buoni frutti; e fu sotto Adriano, sotto l'imperatore medesimo il quale mise in opera il rimedio, che le frontiere dell' impero, le qu!lli, da Romolo in poi erano. state portate sempre innanzi da se-
16t colo in secolo, furono ricondouc aW indielro, e che il Dio Termine dei romani rincul.ò per la prima volla.
Niuno storico ci indica io IllOdo positivo e preciso il ·luogo e il senizio della coorte ;milliare, sia all' epoca della sua creazione, sia luogo tempo dopo. Solo si sa che in principio questo corpo scelto non fu doppio e non si divise in due parti, per . rinforzare ugualmente le ali, como avvenne parecchi secoli più tardi; e cb' esso non era ripartito fra le due o tre linee della legione.
Alcuni sono d'avviso che il posto occupato dalla coorte milliare fosse alla testa della legione; percbè qualora fosse stata collocata tutta intiera alla destra od alla sinistra, avrebbe alle· rato tutte le proporzioni, essendo essa per lo meno il doppio delle altre, ed elevandosi qualche, volta al numero di t200 uomini . Collocata alla testa, e seguita dalle altre nove coorti su tre linee, cuopriva la fronte della terza coorte ed i due intervani fra la 2a colla 5• e la 5• colla 41 ; allora non restava più alcun vuoto sulla fronte per cui la cavalleria potesse penetrare. E siccome questo fu lo scopo per cui venne ·Creata, così si ac· carezza questa ipotesi di collocamento, la quale dà alla truppa scelta l' incarico di sostenere il primo urto del nemico, e di proteggere ed infondere coraggio alle altre masse.
Altri invece suppongono che si tenesse dietro alla legione, sotto gli ordini medesimi del generale, pronta a recarsi ove il pericolo fosse divenuto più imminente (V. Tav.a VI. Fig.a :v).
Ai tempi di Alessandro Severo si ravv i vò più che mai la tendenza al sistema della milizia greca, e quel giovane imperatore lo favo.rì con molto ardore. Adottale alcune modificazioni nell' armamento dei soldati, e specialmente nelle corazze, · negli elmi e nelle picche, si formò una specie di grande falange, 'o Legione falangila come dice taluno; la quale, composta di sei legioni coutigue, uguagliava ed anco sorpassava il numero più elevato a cui era giunta l' antica falange greca, sommando assieme le tre · specie di Stor. d ell' Art. Milit. H .
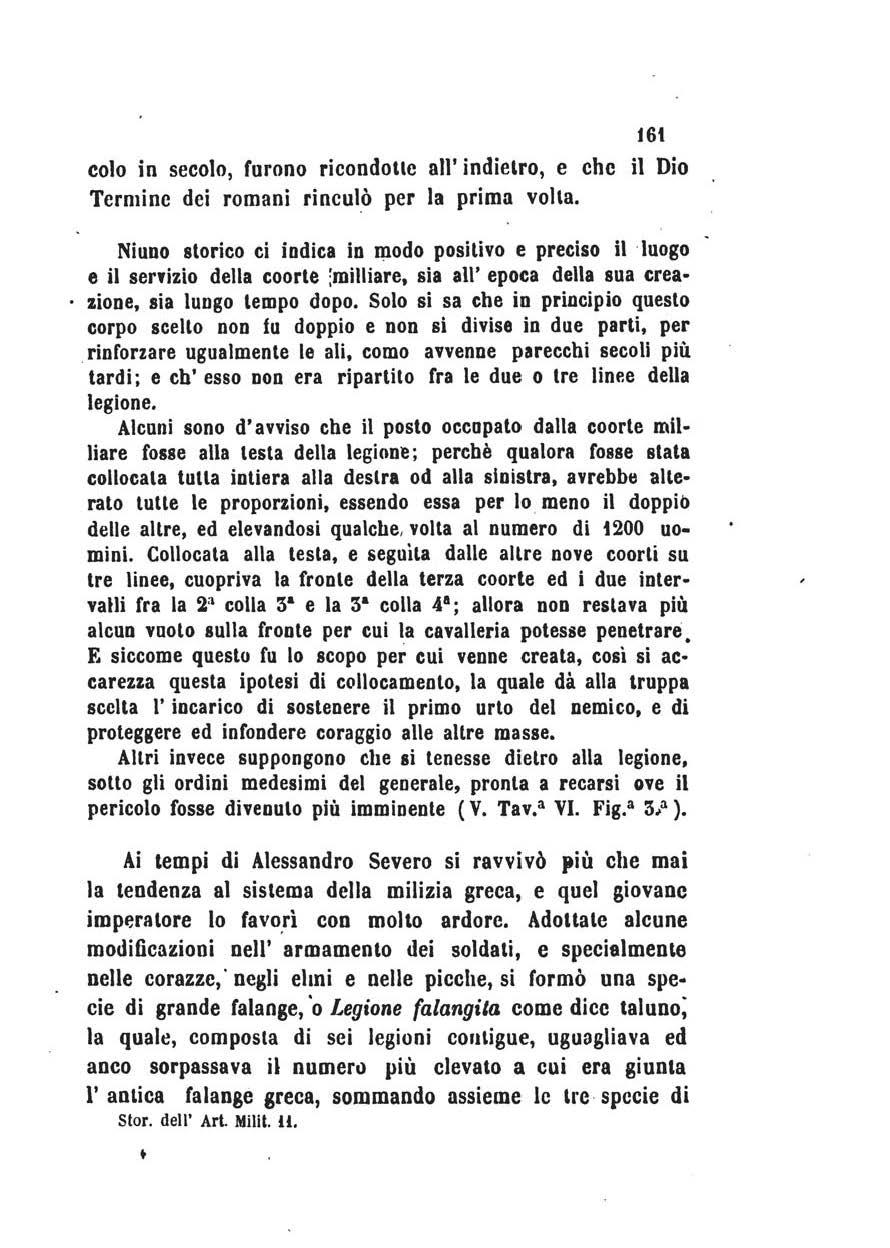
soldati Opliti, Pellasti e Psilili. Così la milizia non fu pm ilè greca nè romana , nè falange nè legione ( V. iav'\ VI. Fig,a 4.a ).
Ai tempi di Vegezio, ossia soLto il regno di Valentiniano Il, la legione era formata di coorti, ciascuna delle quali componcvasi di cinque righe di combauenti, t'd una di macchine.
La t.• riga era composta di soldati cbe assomigliavano agli antichi Principi; erano uomini armali pesantemente, soldati eletti, quali potevano restare dopo fatta la scelta di coloro che corrispondevano agli antichi triarj, e sopratutto dopo composta la coorte milliare.
La 2. • riga formavasi di arcieri, corazzati, armali di giavelotti e di lancie, considerati essi pure soldati scelti, ma che si anitinavano alla specie d' uomini degli antichi astati.
La 3." e 4. 1 componevansi d' un nuovo genere di ve\iti. destinali ad uscire dalle file, ed a spargersi, secondo la circo. stanza. davanti alla rronte e sui fianchi.
Poscia veniva, cosa sconosciuta nell'antica milizia, una 6.a riga di macchine da guerra fra cui si ponevano frombolieri e balestrieri di ogni specie, e giovani soldati, quasi senza armi, che lanciavano giavelolli, sossi, od anco pietre. colla mano. Costoro erano specialmente destinati a difendere l' accesso delle macchine. Quest' ordine di macchine gettava projettili io para-. boia al di sopra delle righe situate innanzi a loro. Erano dette Onagri o Grandi balille.
Finalmente viene la 6.a riga, composta di soldati che corrispondevano agli anticbi triarj.
Fra gl' intervalli delle coorti , e sorra due righe, stavano gli Scorpioni o Piccole bali1te che gettawano i loro projellili oriz· zontalmenle.
TuUo ciò era disposto su due linee uguali, ad eccezione della coorte milliare e degli' scorpioni che faceaoo parte soltanto della prima (V. Tav. 3 VI. Fig. a 5.3 ).
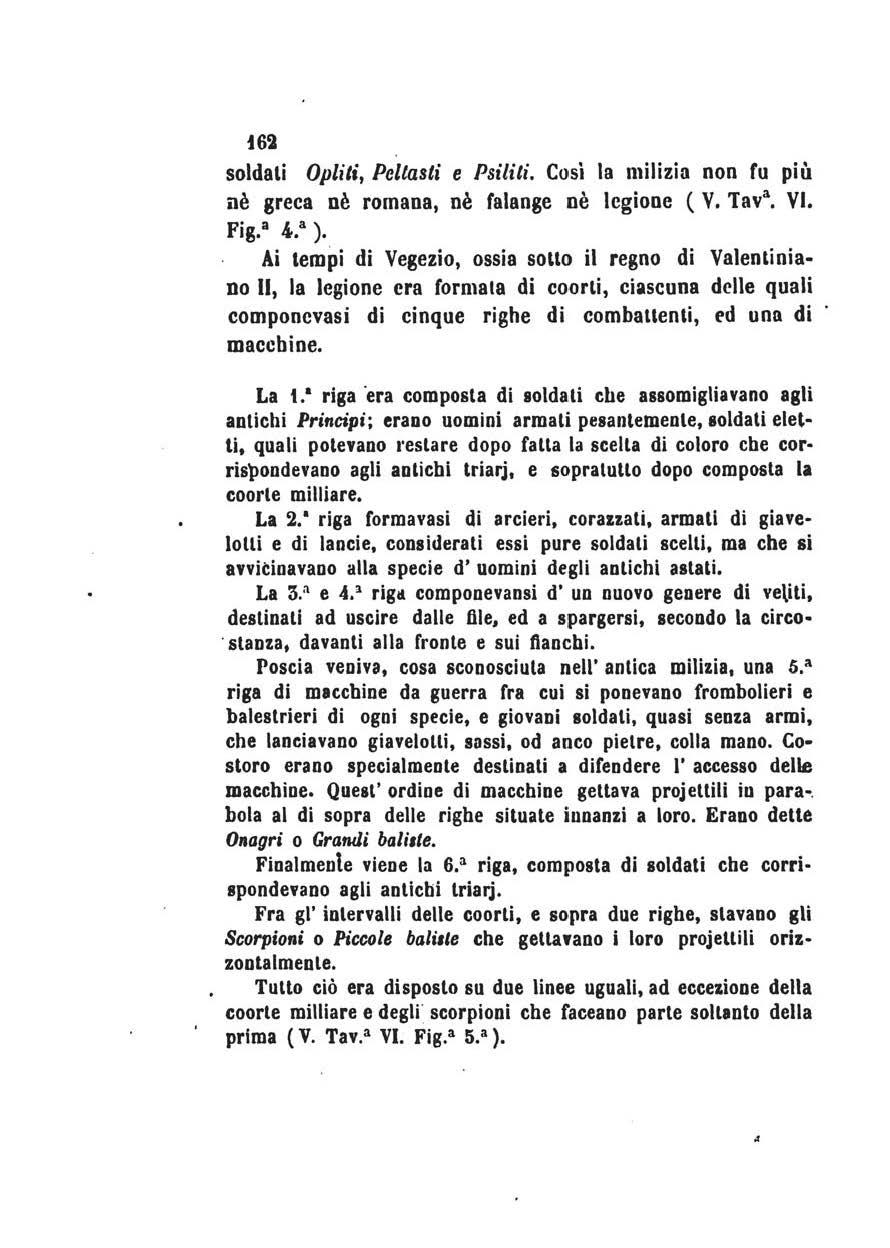
i63
Tale fu r ultimo stadio della legione, ugu31mentc incapace di solidità e di legg erezza: in questa condizione essa perì contro il vigore e la mobilità dei barbari.
Parliamo ora dei gradi e della gerarchia in queste legioni. Eranvi: il duce, in5ignito talvolta del titolo d' Imperatore, Legati, i Tribuoi, i Centurioni , i souoceoturioni , i Decani, Portabandiera.
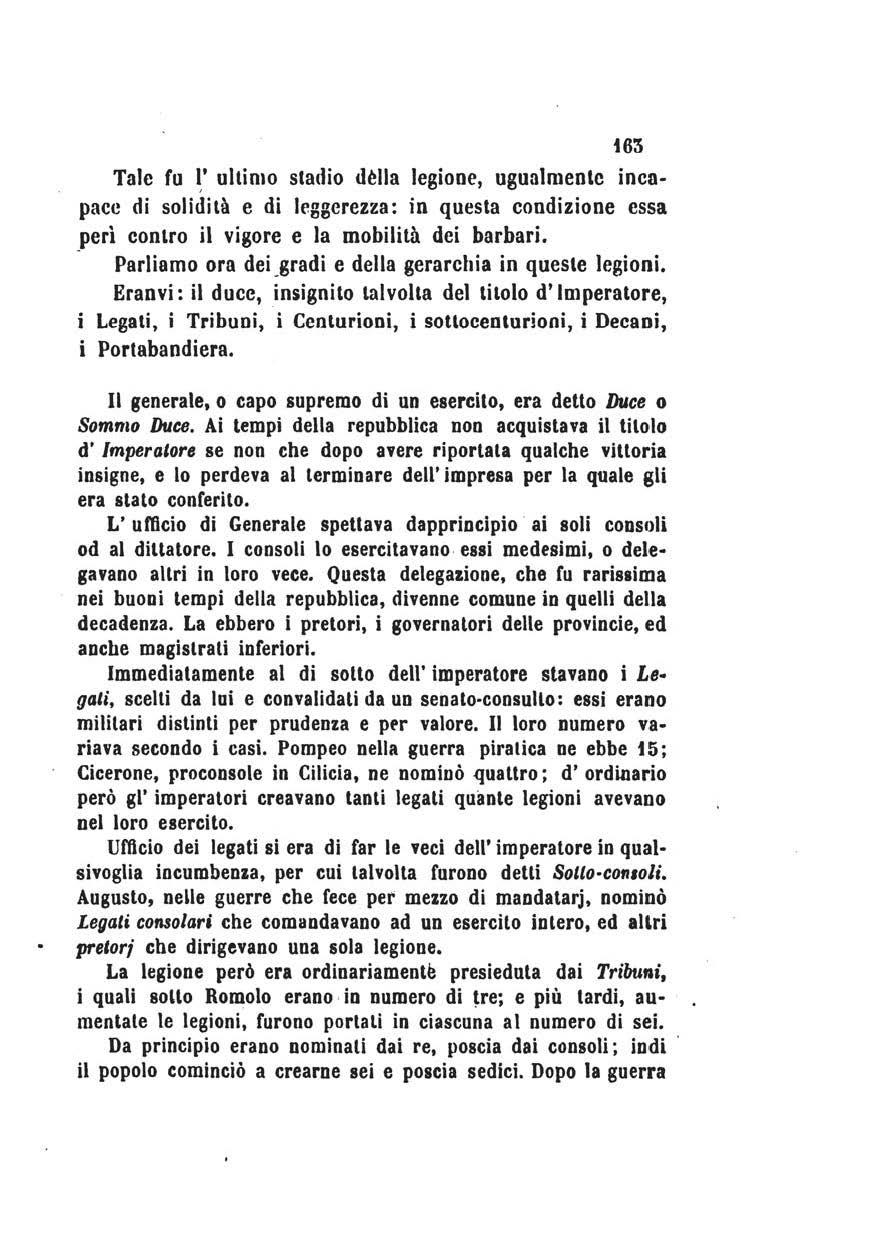
Il generale, o capo supremo di un esercito, era detto Duce o Sommo Duce. Ai tempi della repubblica non acquistava il titolo d' lmperator6 se non che dopo avere riportata qualche vittoria insigne, e lo perdeva al terminare dell'impresa per la quale gli era stato conferito.
L' ufficio di Generale spettava dapprincipio ai soli consoli od al diUatore. I consoli lo esercitavano . essi medesimi , o delegavano altri in loro vece. Questa delegazione, che fu rarisaima nei buoni tempi della repubblica, divenne comune in quelli del.la decadenza . La ebbero i pretori, i governatori delle provincie, ed anche magistrati inferiori.
Immediatamente al di sotto dell' imperatore stavano i Le· gati, scelti da lo i e convalidali da un senato consulto : essi erano militari distinti per prudenza e ptr valore. Il loro numero variava secondo i casi. Pompeo nella guerra piratica ne ebb e t5; Cicerone, procoosole in Cilicia, ne nominò quattro; d' ordinario però gl' imperatori creavano tanti legali quante legioni avevano nel loro esercito.
Ufficio dei legati si era di far le veci dell' imperatore io qual· sivoglia incombenza, per cui talvolta furono detti Sotto·COflloli. Augusto, nelle guerre che fece per mezzo di maodatarj, nominò Legati coruolarl che comandavano ad un esercito intero, ed allri pretori che dirigevano una sola legione.
La legione però era ordinariamente presieduta dai Tributai, i quali solto Romolo erano ·io numero di tre; e più tardi, aumentale le legioni, furono portali in ciascuna a l numero di sei.
Da principio erano nominati dai re , poscia dai consoli; indi · il popolo cominciò a crearne sei e poscia sedici. Dopo la guerra
i64 contro Perseo, re di i consoli ed il popolo ne elegevano in numero In seguito oe furono nominati sul campo di battaglia dai consoli e dai proconsoli; ed il loro numero si accrebbe solto gl'imperatori, i quali si creavano in tal modo maggiore quantità di aderenti. ·
Il loro còmpito si era di consP.gnare agli ufficiali, delegati a portarle, le insegne traMmesse dall'imperatore; di curare le munizioni, i viveri, e gli esercizj. I sei tribuoi imperavano sulla legione a due per volla, a giorni alternali , e . per lo spazio di due mesi; talchè io UQ esercito consollwe erano sempre io attività di servizio almeno quattro tribuni. Quelli cbe avevano esercitalo il lribuoato militare erano reputati cavallieri e portavano l' anello d' oro. ' •
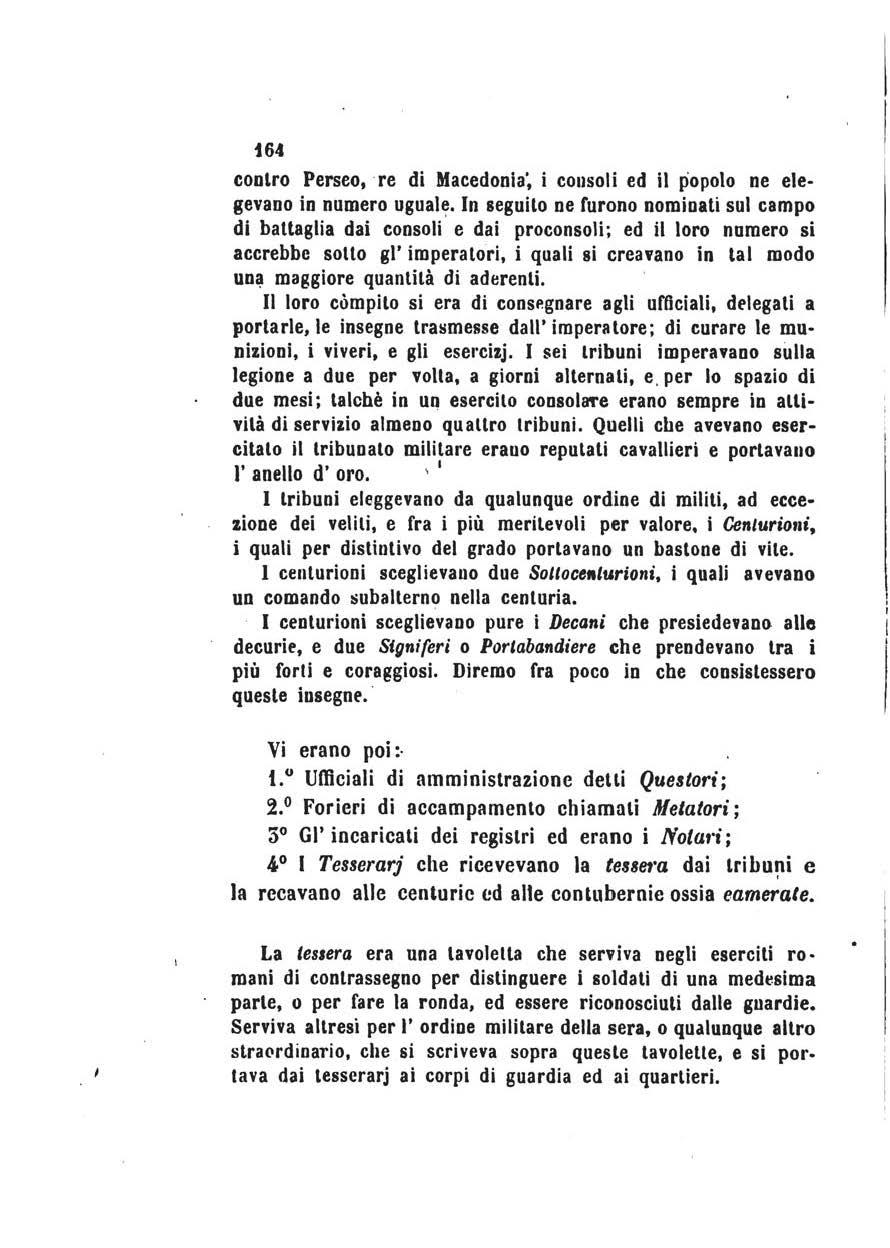
I tribuoi eleggevano da qualunque ordine di militi, ad eccezione dei velili, e fra i più meritevoli per valore, i Centurioni, i quali per distintivo del grado portavano un bastone di vite.
l centurioni sceglievano due Sottoce11turioni, i quali avevano un comando subalterno nella centuria.
l centurioni sceglievano pure i Decani che presiedevano alle decurie, e due Stgniferi o Portabandiere che prendevano tra i più forti e coraggiosi. Diremo fra poco io che consistessero queste insegne. ·
1. 0 Ufficiali di amministrazione detti Que&tori;
2.° Forieri di accampamento chiamnti Metatori;
3° Gl' incaricati dei registri ed erano i Notat·i;
4° l Tesserarj che ricevevano la te&set·a dai e la recavano alle centurie cd alle contubernie ossia eamerate.
La teuera era una tavoletta che serviva negli eserciti ro · mani di contrassegno per distinguere i soldati di una parte, o per fare la ronda, ed essere riconosciuti dalle guardie. Serviva altresì per l' ordine militare della sera, o qualunque altro stra<'rdioario , che si scriveva sopra queste tavolette, e si portava dai tesscrarj ai corpi di guardia ed ai quartieri.
t65 ts 0 l Alinisterj.
Posti gli alloggiamenti, due astati e due prmcap1 veninno incaricali di mantener monda e pulila la •ia principale. Sceglie· •ansi poi tre altri militl di ogni manipolo, per fissar le tende, prender acqua o legna.
Aur.o i oavallieri ave•ano per inservienti i ttiarj a loro più incaricali di pulirne i cavalli. Chiamavansi Excubire.
7° l Vigili. Erano i custodi e le guardie delle porte del campo e dei luoghi principali.
L' ordine dei quadri e delle promozioni era cosi fatto , che nella coorte il decimo astaro, ossia il centurione del decimo manipolo degli astati, passava al grado di decimo prin· cipe, e quindi a quello di decimo triario . Procedevasi quindi nel triarj nell' ordine inverso dei numeri nono, ottavo, settimo ecc. tlncbè si diventava primo pilo dei triarj; il che avveniva ad età avanzata come è agevole vedere.
Eccelsa era quindi la dignità del Primopilo, il quale, insieme coi tribuni, siedeva a consiglio dell' Imperatore. A lui era io ispecial modo afftdata la custodia qdl' aquila, a lui la direzione e il comando di tulli i centurioni, a lui spellavano le insegne eque.stri come ai tribuni.
La cavalleria non aveva un comaodaotc supremo suo proprio tranne quando la guerra veniva diretta dal dittatore, nel qual caso il duce supremo vi delegava un Mastt·o dà c.. cavallet'ia che era come il luogotenente del dittatore medesimo da cui solo dipendeva. l capi della cavalleria erano dunque, nei tempi ordioarj, tulli subalteroi, ed obbedivaoo al sommo imperante dell'esercito come quelli dello fanteria •
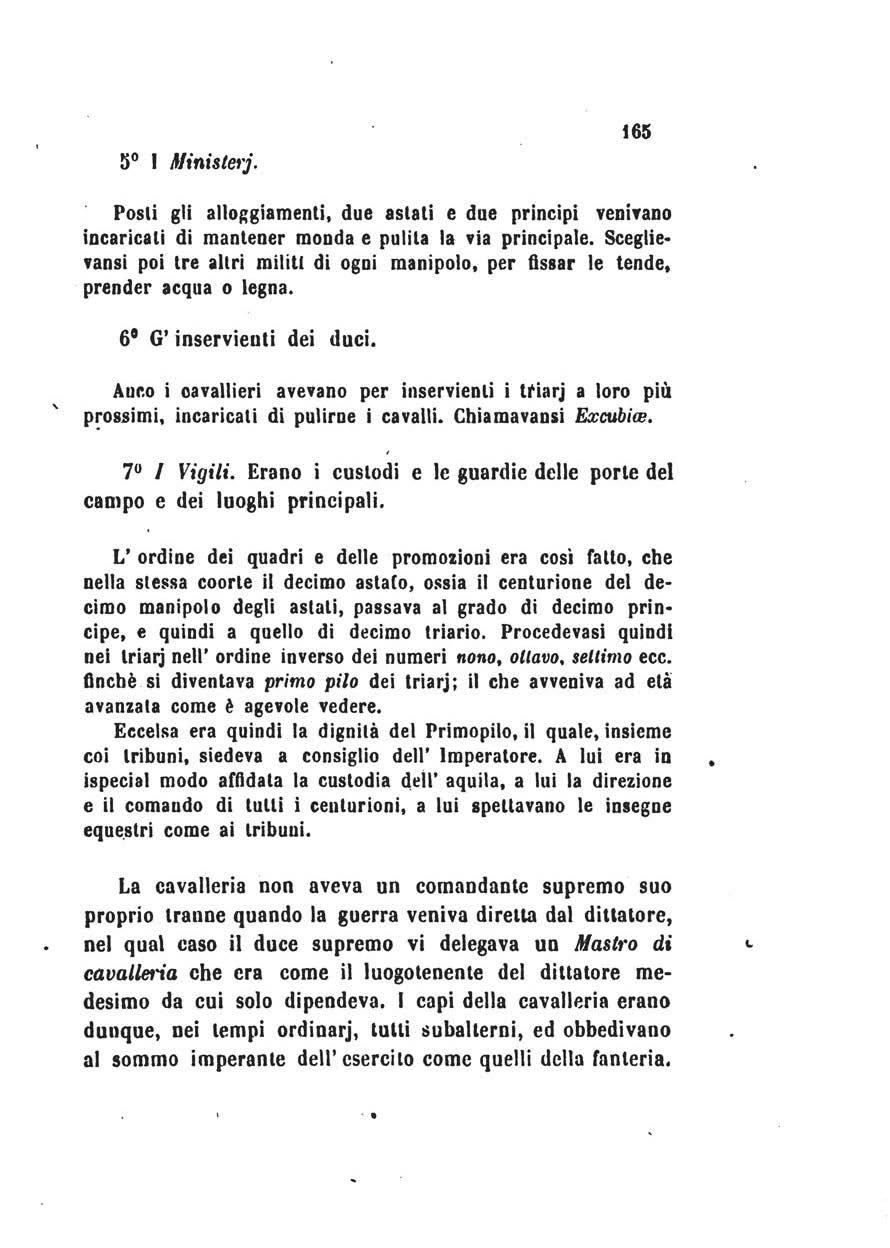
166
Erano di due specie: i Prefetti, due in ogni legione, che pre· siedcvano · alle ali dei cavallicri; e i Decurioni, in numero di 30, cbe dirige\·ano le decurie. Laonde in ogni turma vi erano tre decurioni, dei quàli il primo eletto, oltre alla speciale direzior:te della sua decuria, &\'eva quella · eziar1dio di tutta la turma, c perciò dicevasi Duce della turma . Ciascuno dei decurioni eleggevasi un luogotenente, pari al sotto centurione dei fanti.
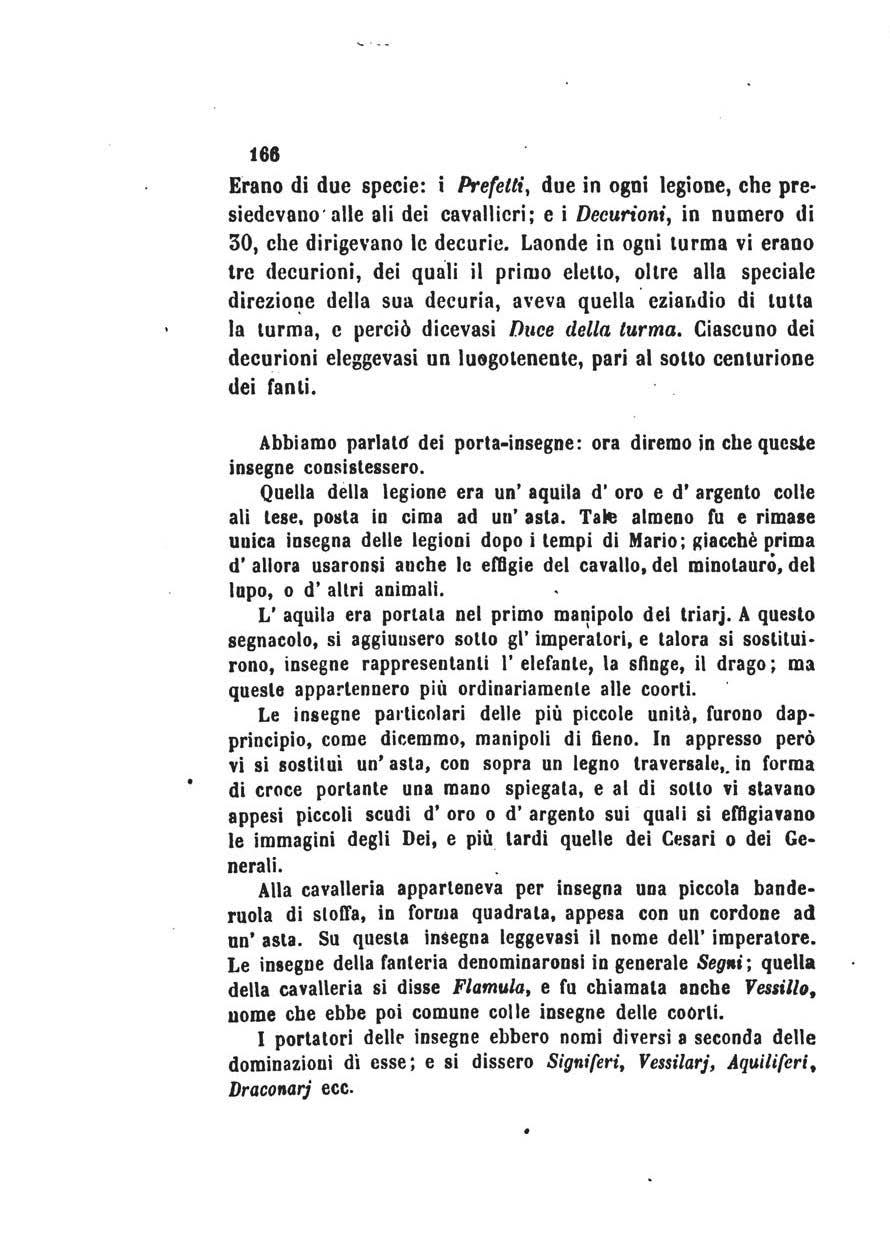
Abbiamo parlato dei porta-insegne: ora diremo in che qucsle insegne consistessero.
Quella della legione era un' aquila d' oro e d' argento colle ali tese, po11ta in cima ad un' asta. Tale almeno fu e rimase uuica insegna delle legioni dopo i tempi di Mario; giaccbè prima d' allora usaronsi anche le emgie del cavallo, del minotauro, del lupo, o d' altri animali.
L' aquila era portata nel primo maqipolo del triarj. A questo segnaeolo , si aggiunsero solto gl' imperatori, e talora si sostituì· rono, insegne rappresentanti l' elefante, la sfinge, il drago; ma queste appartennero più ordinariamente alle coorti.
Le insegne pal'ticolari delle più piccole unità, furono dap· principio, come dicemmo , manipoli di fieno. In appresso però vi si sostituì un'asta, con sopra un legno traversate,. in forma di croce portante una mano spiegata, e al di solto vi stavano appesi piccoli scudi d' oro o d' argento sui quali si emgianno le immagini degli Dei, e più. tardi quelle dei Cesari o dei Generali. .
Alla cavalleria apparteneva per insegna uoa piccola banderuola di stoffa, in forma quadrata, appesa con un cordone ad no ' asta. Su questa insegna leggevasi il nome dell' imperatore. Le insegne della fanteria deoomioaronsl io generale Segrai; quella della cavalleria si disse Flamuw, e fu chiamala anche Vessillo, nome che ebbe poi comune colle insegne delle coorti.
1 portatori dellr insegne ebbero nomi diversi a seconda delle dominazioni di esse; e si dissero Signi{eri, Yes silarj, Aquiliferi • Draconarj ecc.
t67
In occasione del conOitto, le insegne poneansi ne\le prime file: negli accampamenti piantavansi in terra.
Sacre P.rano desse e come diYinità si venera uno; e tale era il culto che per esse avevano i romani , che talora fu buono ed sfficace artifizio, per vincere una battaglia, il gettarle nella mischia , amncbè i più valorosi viemmeglio alla pugna sl animassero per andarle a riprendere di mano ai nemici.
Esercizj. Gli esercizi vennero considerati di tanta i mportanza che dal loro nome venne quello di Esercito. Essi si riferivano: •
1.0 Agli oneri
2.o Alle opere
5.• Alle armi.
Per gli oneri s'intendevano i tra.sporti. Il soldato romano era carico d'immenso peso, essendocchè portava il suo cibo per i :S giorni e tal volla anche di più. Cesare diè ordine a' suoi legionnrj di provvedersi di grano per 20 giorni; Scipione, secondo Tito Livio, ne avrebbe fatto prendere a' suoi per 50 giorni. Oltre a ciò il sold11to portava le armi e gli utensili, cioè la scure, la vanga ecc. alle armi difensive, come lo scudo, la corazza e )'elmo, P.gli non le calcolava qual parte del suo carico più di quanto lo fossero le sue braccia, le sue spalle, e la sua testa, imperocchè considerava sitTaue armi come membri del suo corpo. .
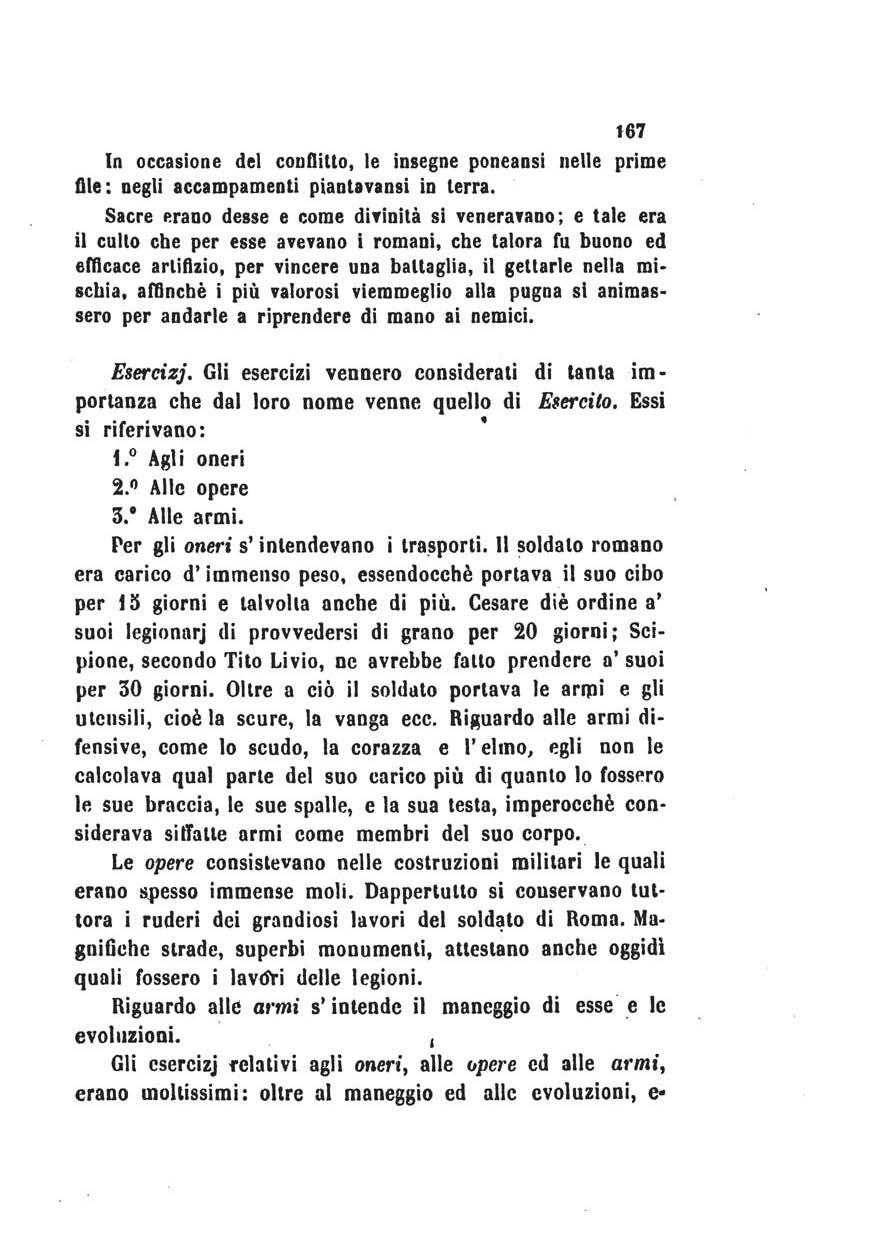
Le opere consistevano nelle costruzioni militari le quali erano s.pesso immense moli. Dappertutto si conservano tuttora i ruderi dci grandiosi lavori del di Roma. Magnifiche strade, superbi monumenti, attestano anche oggidì quali fossero i lavd'ri delle legioni.
Riguardo alle a t'mi s' intende il maneggio di esse · e le evoluzioni. ·
Gli cscrcizj rel:ltivi agli oneri, alle fJpere cd alle at•mi, erano moltissimi: oltre al maneggio ed alle evoluzioni, e•
t68 ranvi le passeggiate, la ginnastica, il nuoto, il salire per luoghi erti c difficili, il portar pesi, insomma tutto ciò cb' era necessario a rendere allo il milite ad istruirsi nel mestiere, ed a compiere agevolmente i doveri.
La legione aveva strumenti militari, ed erano la tromba, cornetla, la bucioa o corno.
La tromba suonava la carica e la ritirata. Suonava, allorchè i soldati, comandali per qualche lavoro, sortivano senza insegue. Al suono della tromba •i montavano e discendevano le guardie ordiuarie e le grandi guardie fuori del campo, si facenno le riviste, ed i soldati si regolavano a seconda di ciò che veniva suonato. .
La cornetta suonava per far marciare le insegne e farle arrestare.
Nel momento dell' azione, le trombe e le cornette suonavano assieme.
La buccina o corno chiamava all' assemblea, e suonava innanzi al generale qualche segno di comando.
U suono solenne di tutti gli strumenti militari della lesione, chiamavasi qassico. Con esso si dava il segno della ballagli a e s'infiammavano gli animi dci soldati a combaltcre, con esso si punivano esemplarmente di pena capitale i soldati sediziosi. Il Classico era segno di podestà imperatoria e si suonava avanti alla tenda del generale od imperatore · avendo egli solo l'autorità di ordinare che si eseguisse• . Amministrazione. l viveri del soldato romano consistevano io Carina o biscouo, in carne salina, ed io aceto che si mescolava coll'acqua.
Un Prefello dei viveri sopraintendeva alla sceglievasi pei soldati il miglior grano; e im fante ne riceveva 4 misure .al mese, che fanno più di 28 oncie al giol'oo; il cavalliere roJDano 12; quello degli ausiliari 8, perchè doveva mantenere
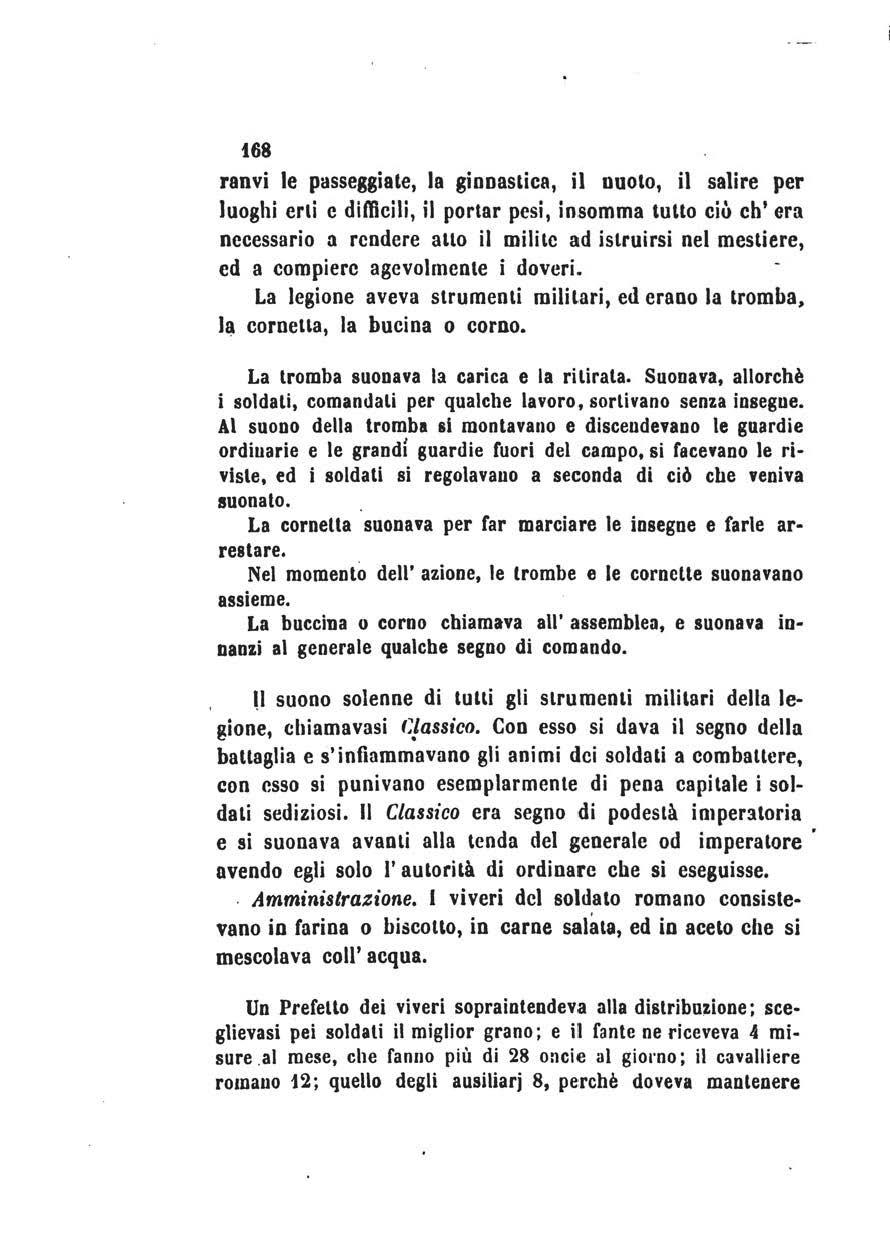
. 169
un valletto solo, mentre r• altro dovea maotenerne due. Macina· vano da sè il gnmo con uoa pietra dopo abbrustolito; più tardi si portava una macina in ciascuna decuria e si dava il pane. L' ora e la forma del pasto erano regolate. Nei giorni ' di bat· taglia asciotveasi la mattina; la cena, che era il pasto priocl· pale. alle 4 o 5 della sera; i generali, e ftoo gl' imperatori, ma o· giavano io pubblico per esempio di sobrietà.
Il servizio sanitario non aveva alcun organamenlo bene re· golato. Fuvvi però epoca in cur si addissero medici alle legioni. È degna di menzione l' usanza di distribuire miele ed olio ai soldati; il miele per mescolar\ o alle bevande a scopo igenico;. l' olio per le unzioni, che mantenevano l' agilità delle membra, e venivano con11iderate come un preservativo di molte malattie contagiose.
Il soldo accordato dalla repubblica incominciò solamente nel 4. 0 secolo dopo la fondazione di Roma all' occasione dell' assedio di Vrjo, la cui durata costrinse per la prima ' volta ad una campagna d'inverno. Dapprincipio venne fissato a poco più di tre soldi di nostra moneta, c variò a vantaggio delle truppe secondo i tempi c le imprese. Cesare per affezionarsi vie_mmagg10rmente il soldato lo portò a dieci. Ai tempi di Vespasiano era di 26; a quelli di Dominazio trenta. l dieci soldi che il legionario riceveva ai tempi di Cesare, aVI'ebbero costituito una ·paga assai. superiore alla. nostra in proporzione del prezzo delle derrate; ma sopra di essi ritcnevasi una parte pel nutrimento, pc) vestiario, per le nrmi c per le tende.
l centurioni ed i cavallieri avevano circa il doppio dei legionarj.
l tribuni avevano il quadruplo.
Oltre alla paga eravi il bottino, che secondo certe regole e formalità veniva poi diviso fra la lruppa.
I consoli, i proconsoli, i prelori, ed iu generale gli ufficiali generali della legione non rh:evcvano nllra ricompensa
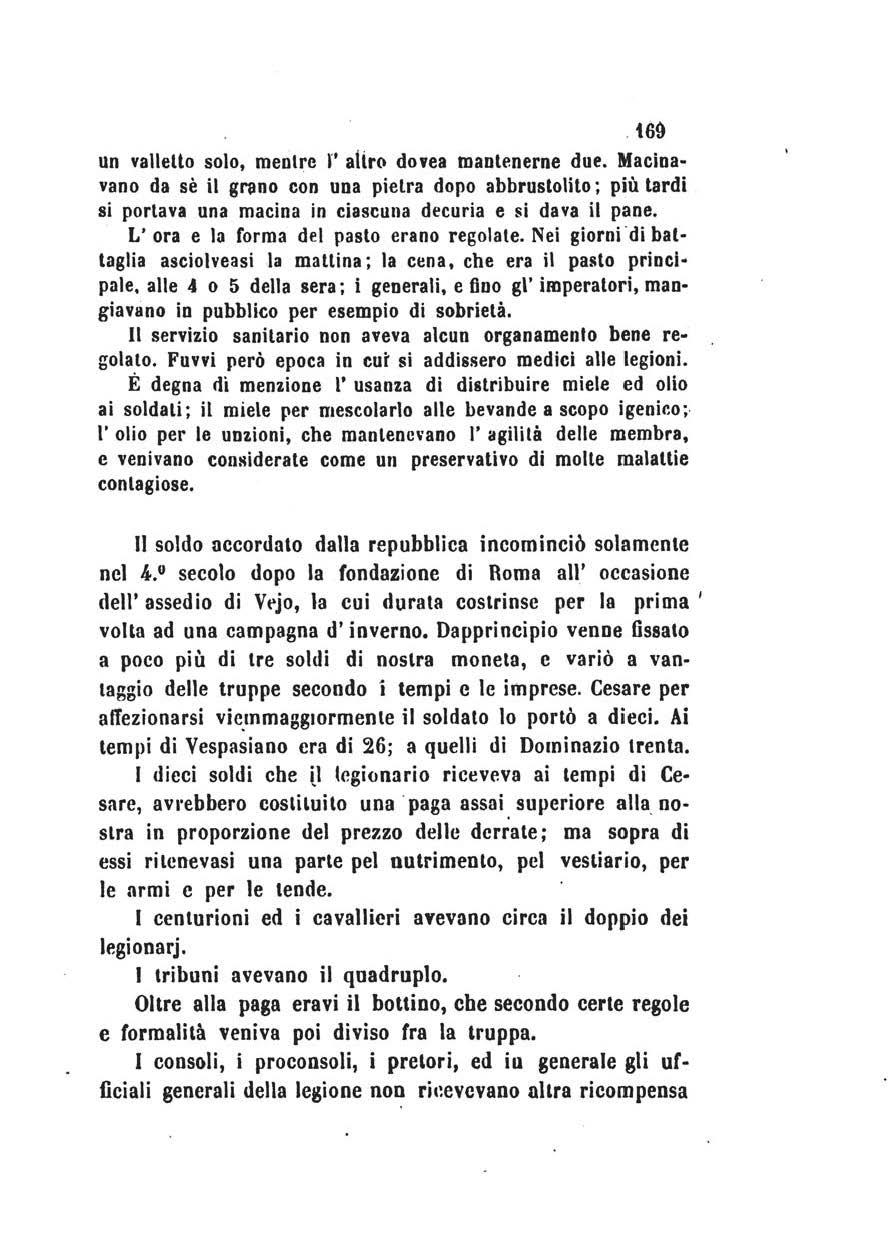
no dei loro servigj se non che l' onore. La repubblica però so· slcneva le spese necessarie all' esercizio delle loro funzioni cd ai loro equipaggi. Essi avevano inoltre un numero de· terminato di schiavi.
(f) Disciplina-Pene e ricompense. l romani ·erano estremamente severi per ogni infrazione di ' disciplina. Le pene erano inflitte in ragione dei delitti, ma si teneva sempre conto delle circostanze attenuanti od aggravanti nelle quali erano stati commessi.
Quando l' esercito era messo assieme, il generale· aveva pieno potere di vita e di morte; le sue decisioni erano senza appello; tuttavia egli ricorreva ordinariamente al giudizio di un consiglio di guerra .
Pei lievi falli, il soldato era obbligato a stare per un tempo prescritto in una posizione molesta; od a scavare un fosso di date dimensioni; oppure a far servi!lj straordinarj per l' approvvigionamento o la del campo.
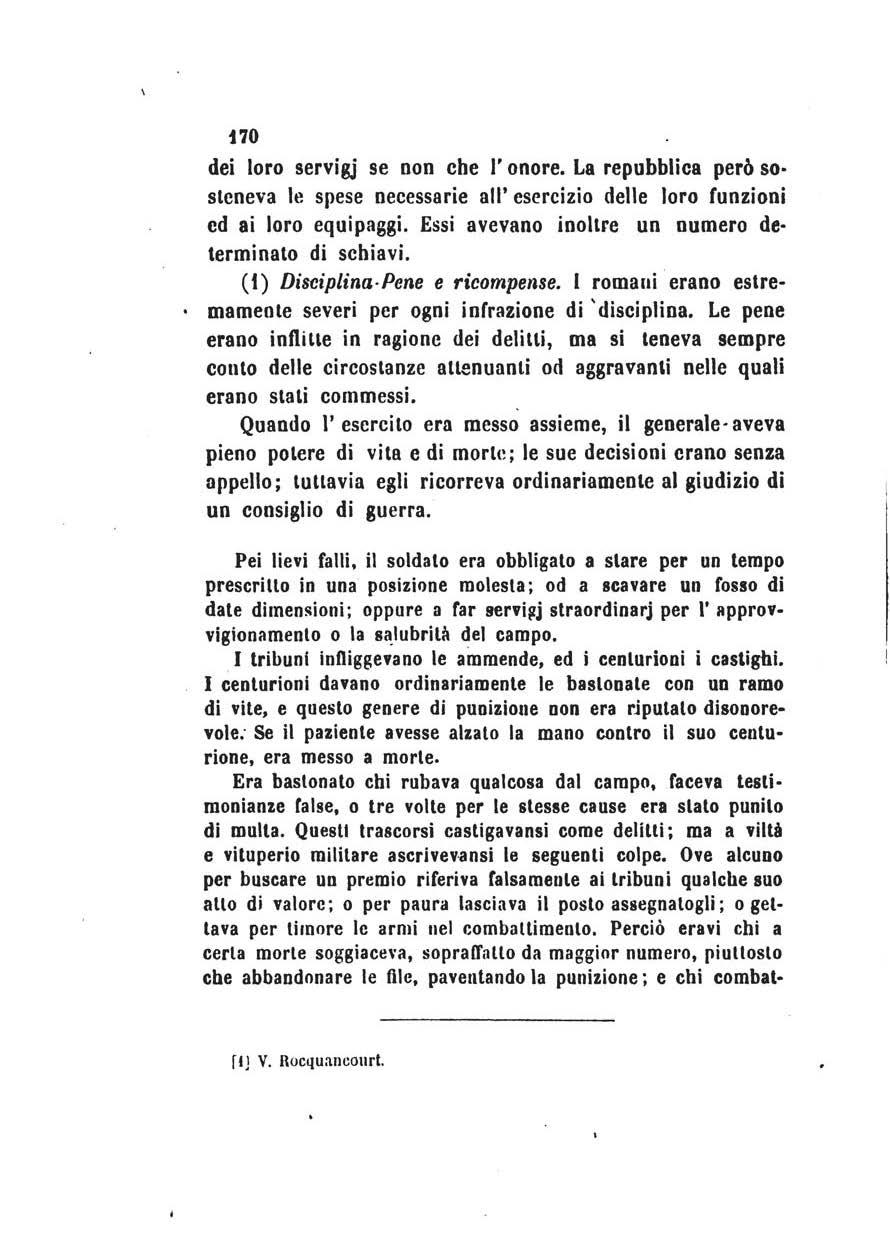
l tribunl inOiggenno le ammende, ed i centurioni i castighi. l centurioni dnaoo ordinariamente le bastonale con un ramo di vite, e questo genere di punizione non era dputalo disonore· vole ; Se il paziente avesse alzalo la mano contro il suo centurione, era messo a morte.
Era bastonato chi rubava qualcosa dal campo, faceYa testi· monianze ralse, o tre volte per le stesse cause era stato punito di multa . Questi trascorsi castigavansi come delitti; ma a viltà e vituperio militare ascrivev ansi le seguenti colpe. Ove alcuno per buscare un premio riferiva falsamente ai lribuni qualche suo allo di valore; o per paura lasciava il posto assegnatogli; o gettava per timore le armi nel combattimento. Perciò eravi chi a certa morte soggiace\·a, sopraffatto da maggior nume•·o, piuttosto cbe abbandonare le file, paventando la punizione; e chi combat-
fi J V. Rocquan co nrt.
t71 tendo si era lasciato cadere lo scudo, la spada o allr' arma, si lanciava temerariamente fra i nemici, per riacquistar .il pea·duto, o schivare, morendo, maniftlsla vergogna e gl' insulti de' suoi.
l fitlori addelti alla persona del generale . erano incaricali dell ' esecuzione della sentenza di morte ; prima battevano il condannalo colle verghe, poi si servivano della scure.
Allorquando un corpo di truppa aveva compromesso @.l ' in· teressi dello stato colla sua disobbedienza o colla sua viltà, il generale ne conduceva a morte una parte: se era la decima, la pena dicevasi decimaaione; se la ventesima vigesimaaione; se la centesima cente1imasione Crasso fece decimare un distaccamento tlel esercito per essere fuggito innanzi alle truppe di Spar; taco. Cesare si servì di questa pena pt>r arrestare la rivolta delle truppe ch' egli comandava in Italia; Augusto per punire una legione che nella guerra d' Illiria aveva abbandonalo vilmente il suo posto;. Antonio per castigare due coorti che non avevano saputo guarentire il suo campo dall' insulto dei Parli.
La legge delle dodici tavole infliggeva la pena di morte a coloro che avevano suscitato nemici allo stato; a coloro • che combattevano senza averne ricevuto l'ordine, oppure non obbe·· divano 1111' ordine o ad un segnale dato; a colui. che abbandonava il suo posto o la sua insegna; a quegli che gettava o vendeva le sue armi; a quegli che eccitava una sedizione, e finalmente ai transfugi. 11 lrausfugo era colui che passava o tentava passare al campo nemico. Era riputato transfugo quegli che si ' allontanava tanto dal campo da non udir più il suono delle trombe.
Oltre alle pcM corporali, ernnvi anche le pene morali delle Ignominiose.
Erano di questo genere il dover occupare un posto vile int una fazione, il vestire il colpevole di abito umile e discinto, n farlo da un grado più elevato di milizia ad uno meno alto, come dai triarj negli astati o nei veliti.
l romani erano altreuanto siusti e pomposi nel retribuire lr. belle azioni quanto severi nel punire le malvasie
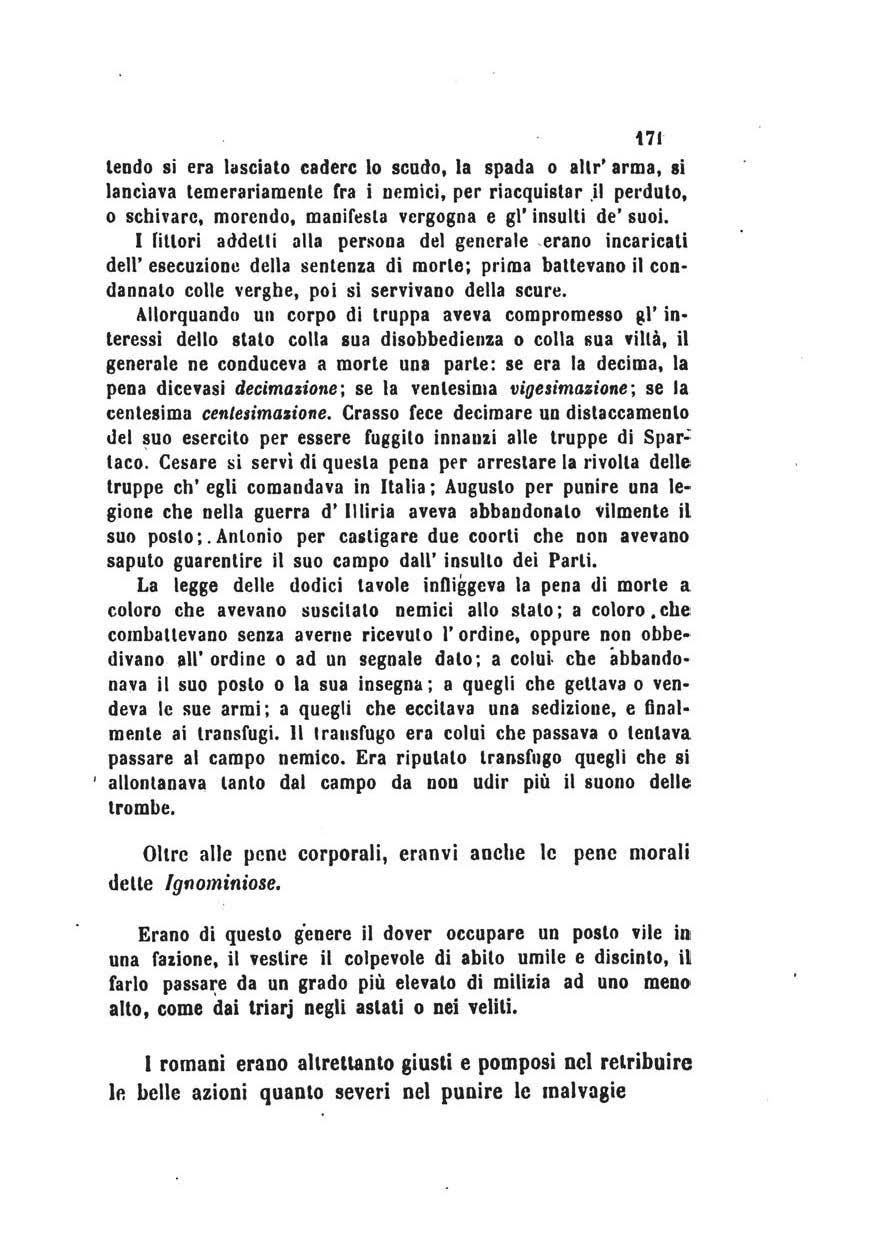
Le ricompense èhe davano, consistevano nei privilegi spe· ciali dei militi , e nei premj propriamente detti.
Tra i privilegi ve n' erano due notabilissimi; il primo di non poter essere costretti a litigare fuori del loro accan· looamento; l'altro di poter te stare del loro preculio castrense .
l premj ai valorosi davansi solennemente io presenza dei commilitoni dopo avere invocato gli Dei; essi erano di due specie: Alinori e Alag fliori.
Erano premj minori p: e: il dono di un' Asta p ora cioè non ferrata, In quale davasi al milite che avesse percosso il nemico io singolar certame; l'armilla, o braccialetto, a quel pedone, c la collana a quel cavalliere, che nel cimento avesse abbattuto inlieramcnte l' avversario e riportatene le spoglie.
l premj maggiori consistevano in corone di vario genere.
La trionfale, quella che si portava dagt• imperatori nel trionfo; era d' oro, e nei primi tempi di lauro.
L' o11iclionale , quella di cui l r.ittadini di una terra assediata presentavano il capitano che gli aveva liberato dall' assedio; era di gramigna, e falla con quella stessa gramigna cresciuta nella città durante d'assedio. ·
La Civica o Civile, quella che si assegnava a colui che aveva salvato in guerra un cilladino romano; era di fronda di quercia.
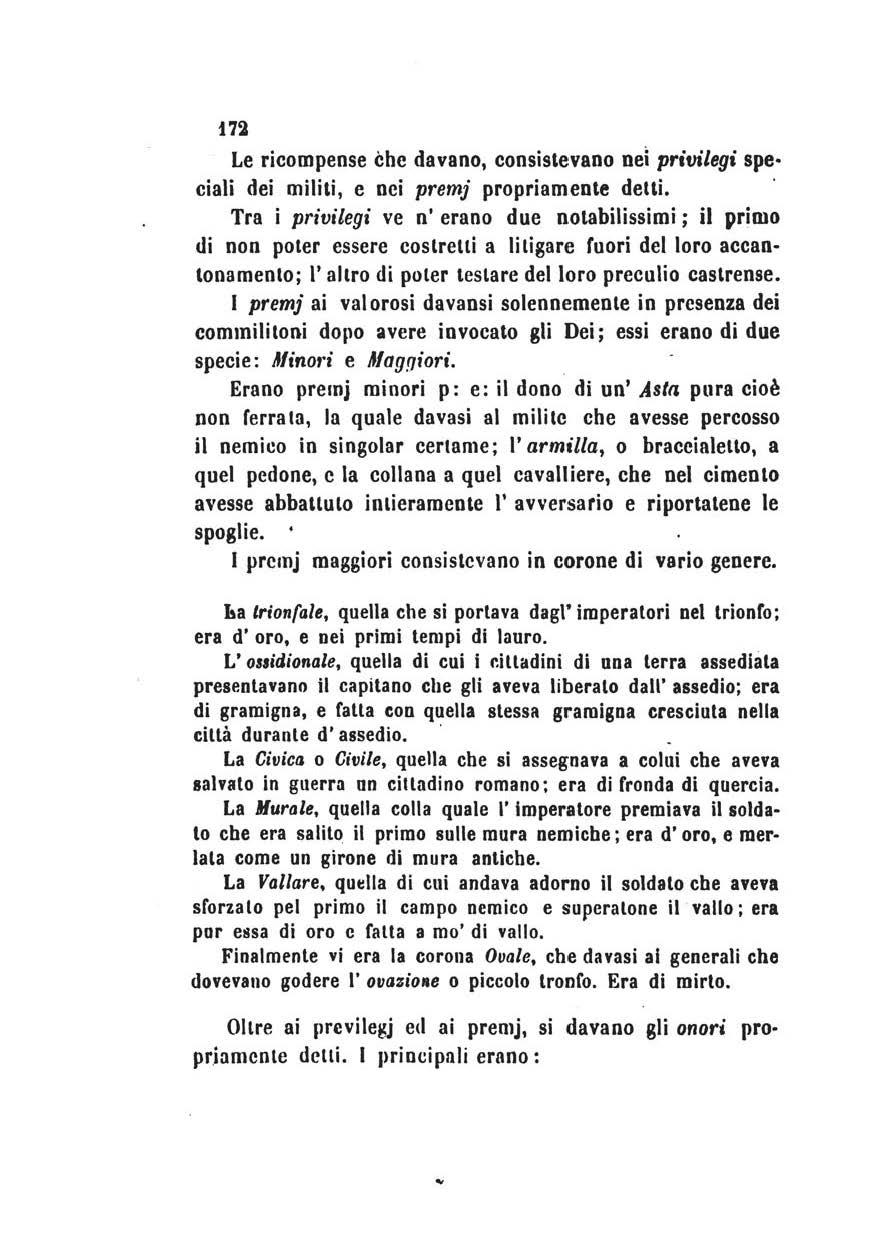
La Jlurale , quella colla quale l' Imperatore premiava il soldato che era il primo sulle mura nemiche; era d'oro, e merlata come un girone di mura antiche.
La Val/are , di cui andava adorno il soldato che aveva sforzato pel primo il campo nemico e superalone il vallo; era por essa di oro c falla a mo' di vallo.
Finalmente vi era la corona Ovale, che davasi al generali che dovevano godere l' ovazio11e o piccolo tronfo. Era di mirto.
Ollre ai previlegj ed ai premj, si davano gli onori pro· prjamcote detti. l principali erano:
i73
t.• La nomina d' impefatore, quando cioè ·t' esercito dava questo tatolo, che doveva poi essere confermalo dal senato. • La •upplicazione, che era un solenne decreto del senato col quale rendevansi pubbliche grazie votive agli Dei per una vittoria da taluno riportata.
5.0 Il trionfo, il quale era il più grande c solenne di tuui gli onori bellici; · concedevasi dal senato a quel duce che in giusta e legittima guerra, in una sola campagna, avesse ucciso più di cinquemila nemici, e colla sua vittoria il romano impero.
Macchine. l romani adottarono le macchine guerresche dei greci, e le perfezionarono; e fra le principali che essi adoperarono, deggionsi notare le catapulte o grandi baliste, e gli &carpioni o piccole baliste.
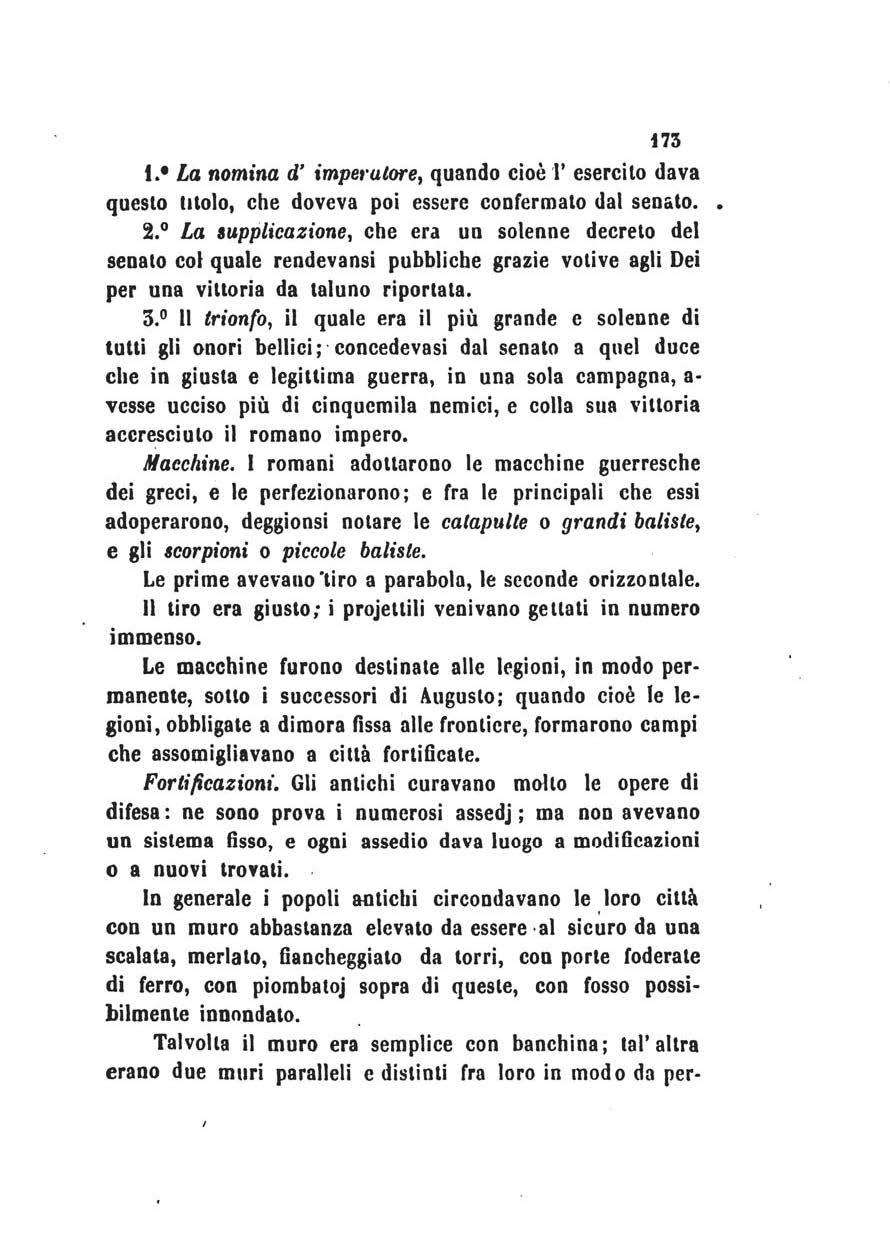
Le prime avevano 'liro a parabola, le seconde orizzontale.
Il tiro era giusto; i projellili venivano gettali in numero immenso.
Le macchine furono destinate alle legioni, in modo permanente, souo i successori di Augusto; quando cioè le legioni, obbligate a dimora fissa alle frontiere, formarono campi che assomigliavano a città fortificale.
Fortificazioni. Gli antichi curavano molto le opere di difesa: ne sono prova i numerosi assedj ; ma non avevano un sistema fisso, e ogni assedio dava luogo a modificazioni o a nuovi lronti. .
In generale i popoli a-ntichi circondavano le loro città con un muro abbastanza elevato da essere ·al sicuro da una scalata, merlato, fiancheggiato da torri, con porte foderate di ferro, con piombatoj sopra di queste, con fosso possibilmente ionondato.
Talvolta il muro era semplice con banchina; tal' altra erano due muri paralleli e distinti fra loro in modo da per-
f74 mcllcrc che si facesse un rarn11aro proporziomuo all' orùi• nanza dei difensori. Le mura di Nioi\•e, di Babilonia, c di altre antiche ciuà erano immensamente larghe. Nei casi di queste immense larghezze, altri muri si costruivano fra il primo ed il secondo per lcgarli fra loro e dare ad essi maggiore solidità.
La resistenza delle cinte veniva aumentata con travi collocati nella grossezza del muro e che servivano da travetti e da puntelli.
Le torri erano piene o vuote, con una piattaforma superiormente ove si ponevano le macchine. Talvolta, nelle vuote, si facevano due o tre piani inf<'riori e si aprivano feritojc nel muro.
Ciò per le costruzioni in generale.
Ma venendo applicazione per parte dci roman i, diremo che la scienza delle fortificazion i era poco necessaria ne' tempi dei loro maggiori trionfi. Allora non si mante.nevano guarnigioni nelle città; eserciti occupavano un dato punto; il· paese conquistato era conservato da colonie: e qualche volla stabilivansi torri quà e là che servivano da caserma per le truppe che fossero distribuite lungo una linea, p: ·e: fluv iale. Fu Augusto che tracciò linee di difesa alle frontiere; queste si col progredire del tempo, e il loro numero aumentò sempre nella stessa progressione dell'affievolimento dell'impero; 6nchè giunse .epoca in cui quasi tutte le piazze vennero forlific:ate.
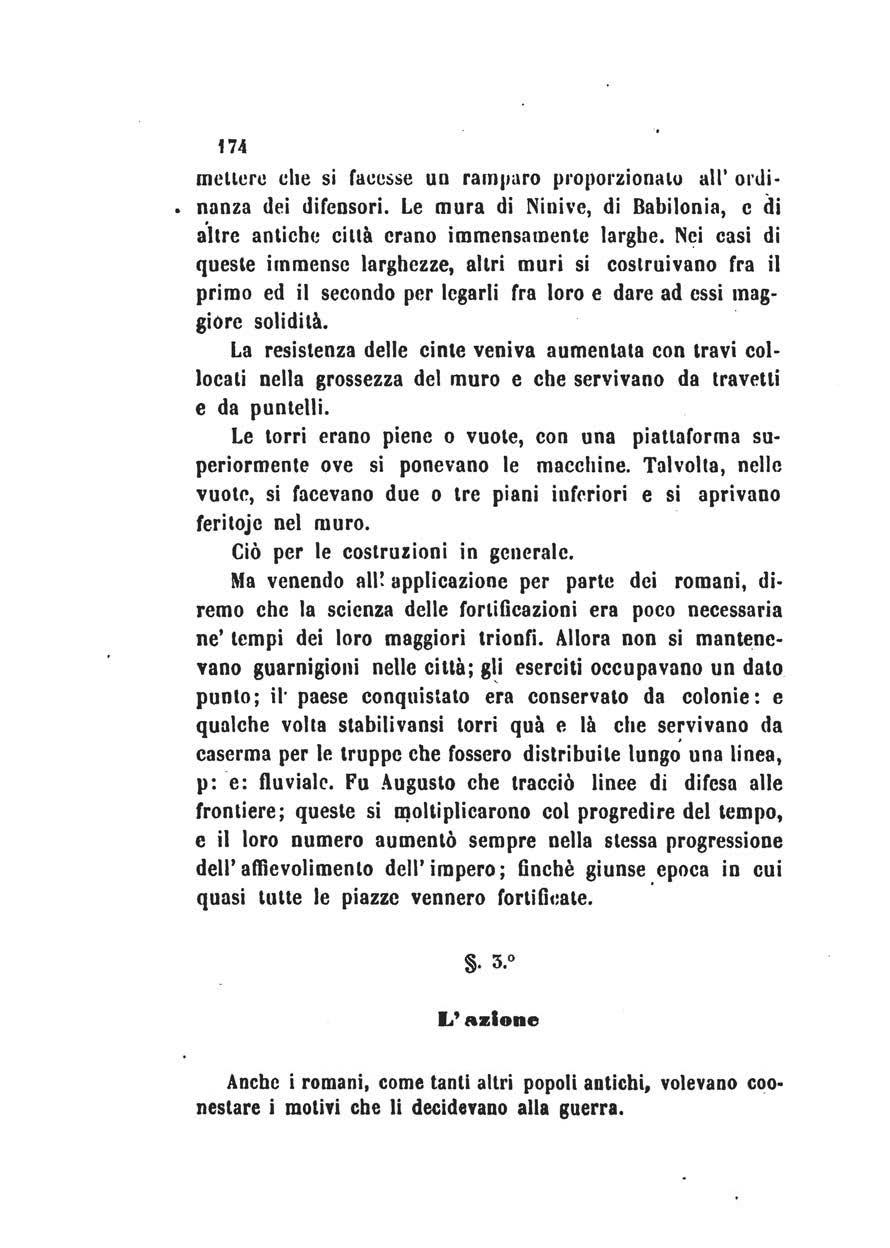 §.:;,o
§.:;,o
Anche i romani, come tanti altri popoli antichi, volevano nestare i motiYi che li decidnano alla guerra.
Ogni qualvolta la republ>lica avesse avuto da rinveadicare uoa terra, o da vendicare uo Insulto, o da punire un nemico, i romani venivano chiamali ad emettere la loro opinione sulle ragioni per le quali si proponeva la guerra, e la esprimevano con ooa formola che doveva dichiarare la guerra medesima giusta e senza macchia.
Ottenuta l'autorizzazione, si mandavano i feciali od araldi d' armi alla frontiera del popòlo minacciato; vi pubblicavano Il loro manifesto nelle città e sulle piazze; invocavano l'equità dei popoli e il soccorso degli Dei; e qualora non avessero ottenuta giusta risposta, chiamavano gli Dei in testimonio della offesa recata al pf?polo romano e se ne partivano. I re nei primi tempi, po· scia i consoli, domandavano il voto del senato; quindi, risoluta la guerra, rimandavansi i feciali a dichiararla ai confini, collo scagliare un dardo sul territorio dello &lato nemico. ·Quando però l'impero s'ingrandì oltre misura e si guerreggiò con lontanissime nazioni, di guisa cbe codesta cerimonia non avrebbe più potuto compiersi materialmente, la si faceva per simulacro in un campo vicino a Roma, detto perciò Campo ,o•tile.
Non è a credersi che i romani, i quali portarono tan· t' ohre le proprie conquiste quanto altro popolo non arrivò giammai, procedessero alla guerra ciecamente senza preconcetti piani di guerra; e senza essere forniti di cognizioni topografiche. La diversione falla da Scipione su Carta· gioe, per obbligare Annibale ad abbanclonarc l'Italia, dimostra luminosàmente a quanto di altezza si portassero le idee strategiche. Nella prima guerra punica, Attilio Regolo battè i cartasinesi, percbè, eccellente conoscitore del terreno, pervenne lungo le gole con una parte delle truppe sulla cima di una montagna da dov' essi credcvaosi inespugnabili, e li assalì alla testa, mentre il resto del suo esercito li attaccò alla coda. Fabio Massimo, limitato ad una guerra difensiva, combatteva su di un teatro, le cui posizioni gli erano tutte famigliari. Se Sertorio potè vincere le di Pompeo,
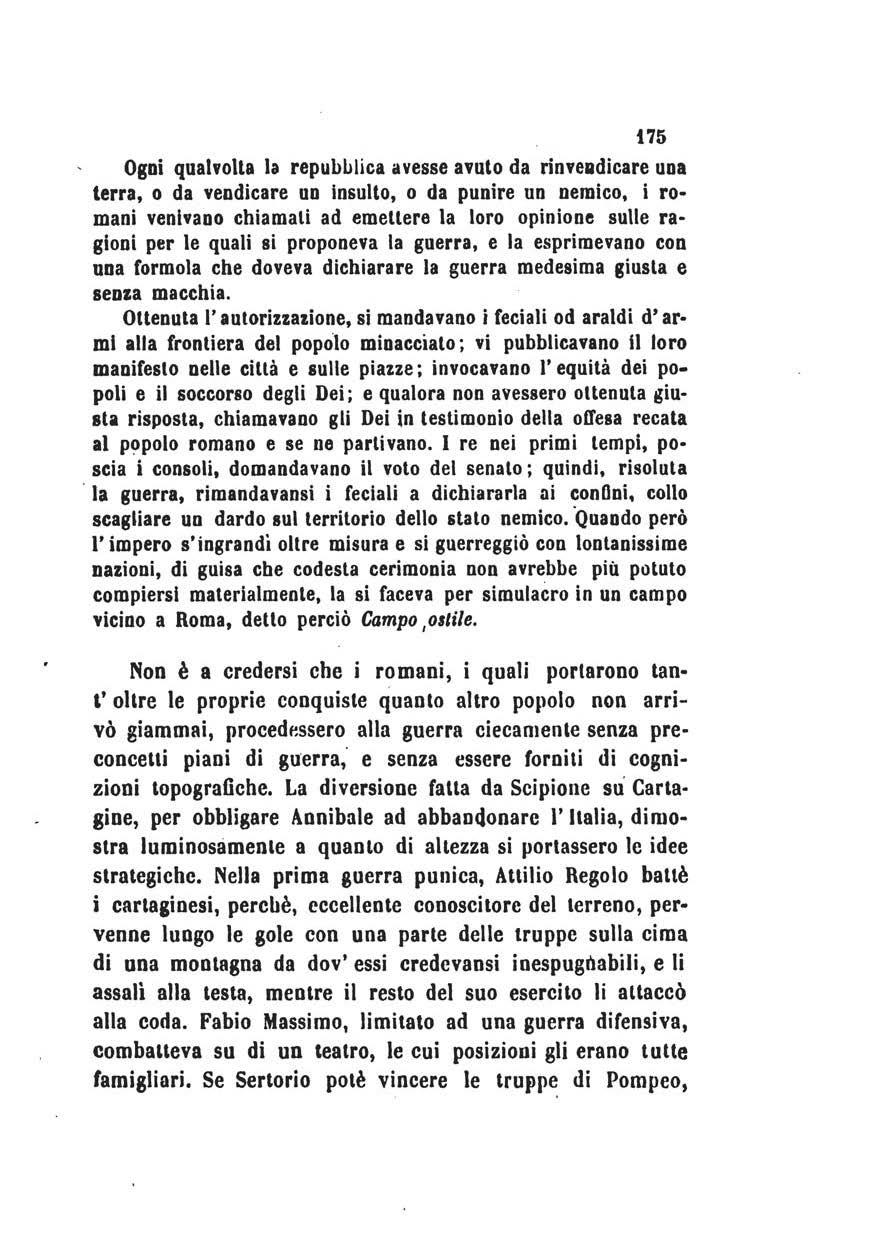
17G dcbbonsi llriocipalrucnw ascrivere le ·sue vittorie alla cono· scenza ch' egli aveva del tc1·rcno. Le marcie, gli Jlccampameoti, le sorprese, le battaglie, tutte le azioni, denotano sempre, e chiaramente, quanto Cesare negli studj topografici fosse versato. l suoi Commentatj provano quanto egli, appreizasse la scit>nza.
Decisa la guerra, seguiamo il nostro studio sull' cserci&o portato in campo ed esaminiamo il suo modo di agire. le truppe nelle categorie che abbiamo l'assemblea veniva congedata. Ciascun console detcrmina\'a il luogo in cui dovevano poi adunarsi definitivamente quelle che gli erano destinate; e, 'venuto i1 giorno per tale riunione, rutti i militi doveano trovarsi al pQsto c null' nltro potea dipensarli se non che gli auspici e le diffieultà assolutamente insormontabili. Quando tutti questi soldati erano adunati nel luogo stabilito, sì formavano le legioni, le turme, e J' esercito intiero.
Regolato tutto ciò, conducevansi le truppe nel luogo de· stinato al loro accampamento.
l romani dovettero la costanza della loro fortuna all'uso di chiudersi ogni notte in un campo fortificato, ed al non dar mai battaglia senza avere n tergo un ricovero trincerato, che ricettasse le proyvigioni, i bagagli ed i feriti.
L' arte della castramentazione era dunque l' oggetto di diligentissime cure. Quasi sempre ed uniformemente gli 1\C· campamenti furono quadrati. Distinguevansi però gli Estivi dagl'Invernali. l primi, ordinati meno accuratam ente , si dicevano Al.ansioni quando facevansi per uso di una sola notte; e Alloggiamenti quando si facevano per tempo maggiore.'
Più accuratamente eretti in ogni parte crono i quartie· ri d' inverno; ed è noto che parecchie città come Colonia e Passavia debbono la prima loro origine a questa specie di accampamenti.
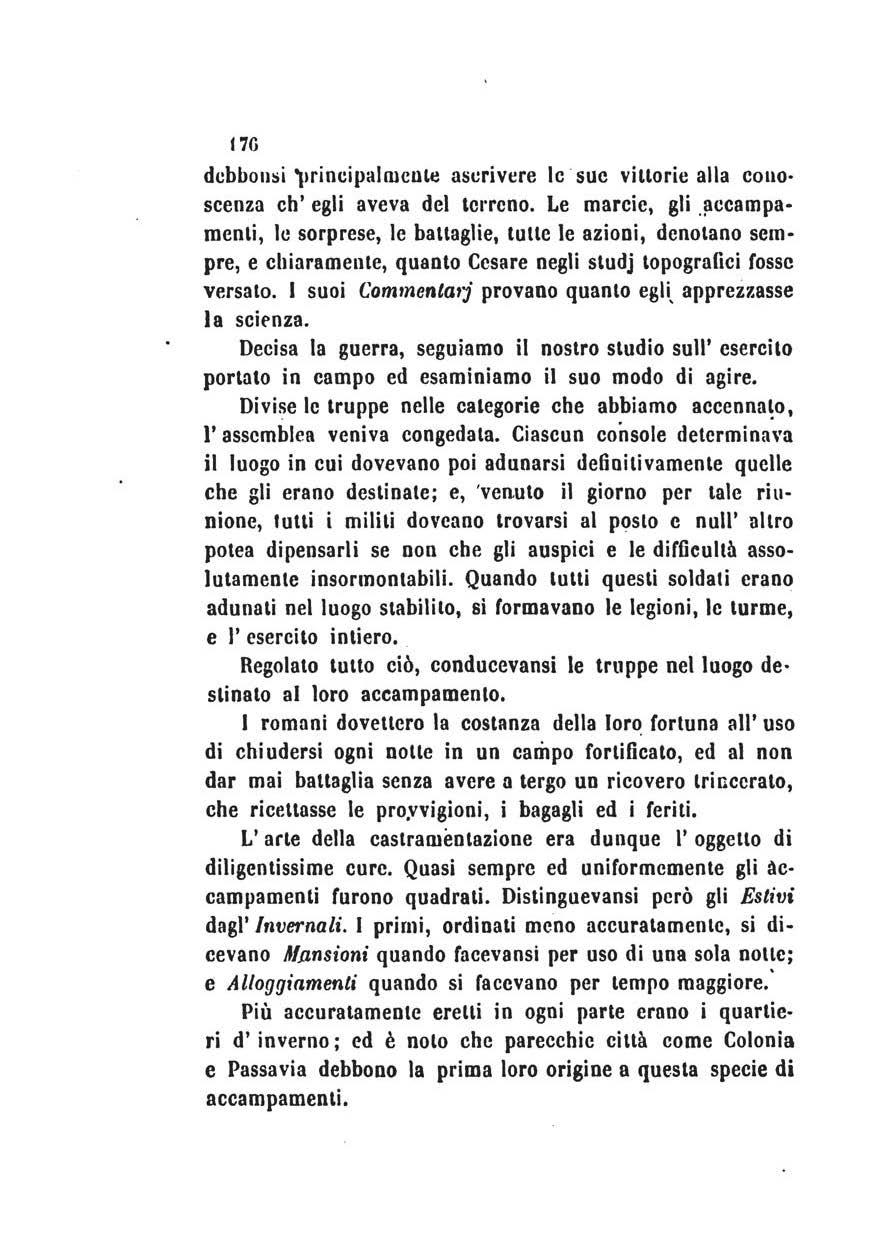
Due principali considerazioni, al dire di Machiavclli, avevano i romani nella scella del sito in cui ponevano il campo. L' una di mettersi iu luoghi sani, fugv;endo i palu· dosi od esposti a venti nocivi; l'altra dove il nemico non potesse assediarli, e torre loro ogni via dell' acqua c delle viuovaglie.
Determinato il luogo per porvi il campo, un tribuno ed alcuni centurioni vi andavano un po' prima delle truppe; sceglievano il posto più elevato c più comodo pel Pretorio, ossia il padiglione del console, vi piantavano un' insegna, ne piantavano altre di un colore differente nei principali angoli del campo, e segnando con giavelotti le divisioni più pie· cole, tracciavano l'accampamento che i soldati dopo giunti erigevano.
La forma ordinaria dell'accampamento romano è qnalc si trova nella tavola che abbiamo quì annessa (V. Tav.• Vll.:1 ).
Da questa tavola si scorge che il campo era dhiso da una strada maggiore in due parti; superiore cioè cd infe· riore. Nella superiore stava primo il Prctorio, ossia il padiglione del console ovvero il tabernacolo dell' lmpcralore. A destra del pretorio trovavasi il Questorio, a sinistra le tende dei legati. Davanti a tutte queste costruzioni era uno spazio destinato a ricevere gli ambasciatori ed alle riunioni. l tribuni erano collocati dietro al pretorio. Quindi in questa stessa parte superiore dell'accampamento stavano gli Evocati, gli Ablecti, e gli Straordinarj.
La parte inferiore del campo dividevasi in due altre parti da strada intermedia, ad ambi i lati della quale stavano i cavallieri delle legioni e dietro ad essi e nella stessa area i triarj; quindi, interposta nuova via, i pr;ncip; c gli a& tali; . poseia, .dietro nuovo intervallo, i cavallieri ed i pedoni dei socj.
Stor. dell' Art. Milit U.
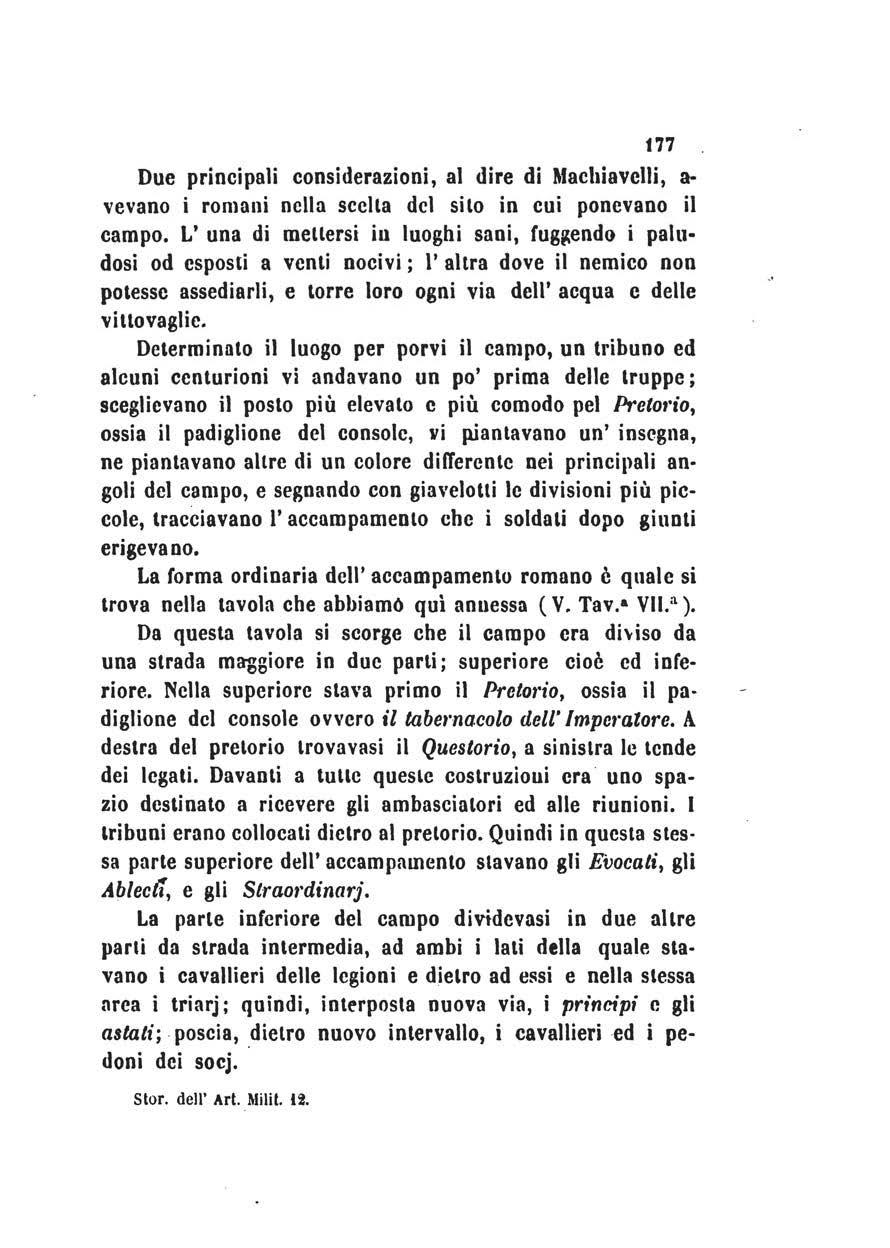
t78
l veliti erano ripartiti, per vivere ed accamparsi, nei tre ordini dei soldati di linea.
In ogni tenda capivano dieci militi col loro Decano.
All' intorno del campo era un Vallo che stava piedi distante dogli attendamenti, allo tre o quattro piedi , o più ancora se il nemico minaccian: era grosso 12 piedi . Una grande fossa della profondità di nove piedi, e della larghezza di dodici, circuiva il vallo..
Le porte del campo erano quattro: la prima, d'ordinario vòlta verso il nemico, era la Pretoria detta ancora Straordi· naria. Opposta ad essa stava la Decumana, perchè le stavano presso le decime coorti; cd ai lati le due delle Principali .
Le vie del campo erano tre Tt·asver&e e cinque Direllt; la prima delle trasverse era dinanzi al pretorio; l' ultima tagliava in mezzo le coorti ed era delta Quintana; quella di mezzo era nominata Principia, ed era luogo sacro e celebre negli accampamenti siccome quello in cui i tribuni pronunciavano le loro sentenze; dove sorgevano le are• i simulacri degli Dei, le immagini dei principi, le insegne principali delle legioni. lvi si prestavano i giuramenti; ivi s' infliggevano i supplizj; ivi custodivasi la pccunia depositata dai militi. ·
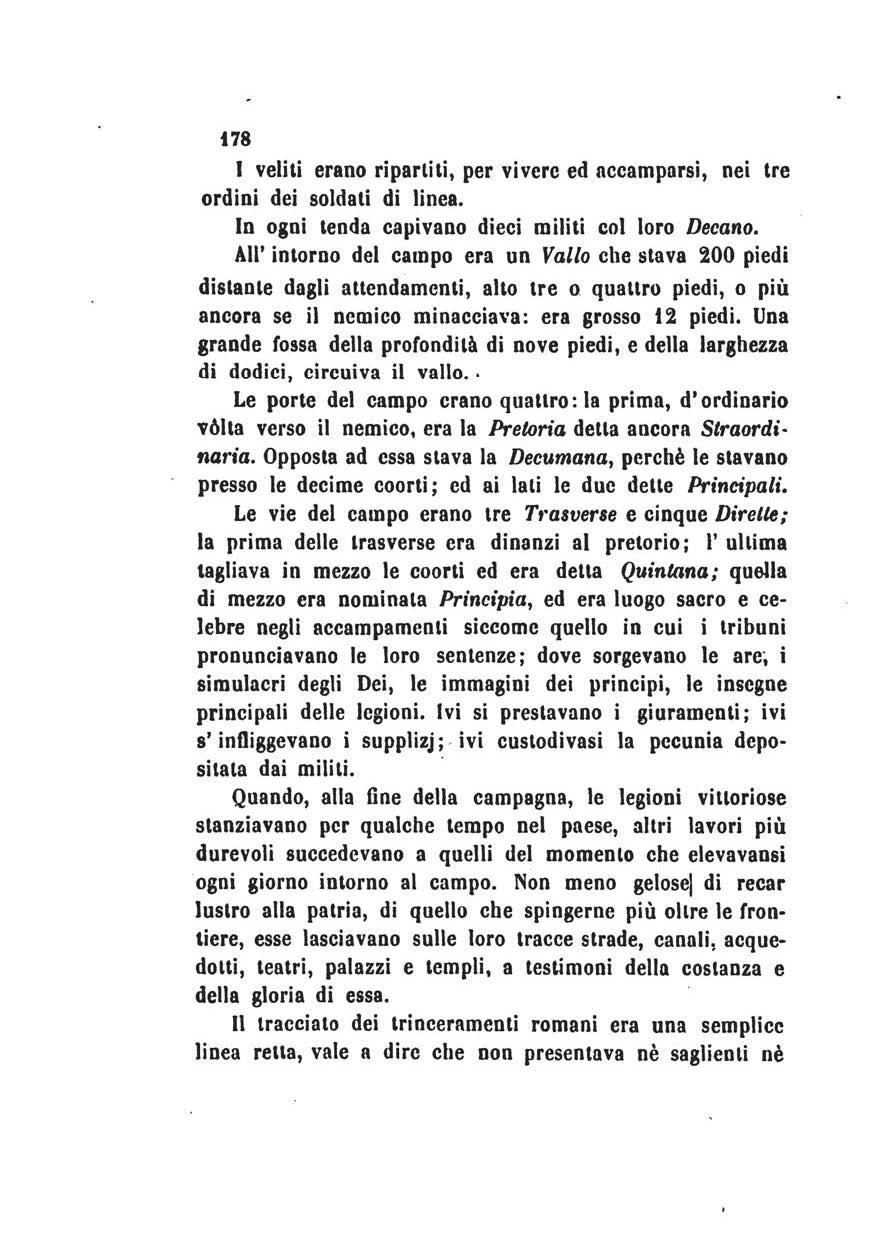
Quando, alla fine della campagna, le legioni vittoriose stanziavano per qualche tempo nel paese, altri lavori più durevoli succedevano a quelli del momento che elevavansi ogni giorno intorno al campo. Non meno gelose! di recar lustro alla patria, di quello che spingerne più ohre le frontiere, esse lasciavano sulle loro tracce strade, canali, acquedoni, teatri, palazzi e templi , a testimoni della costanza e della gloria di essa.
Il tracciato dei trinceramenti romani era una semplice linea retta, vale a dire che non presentava nè saglienti nè
...
rientranti. Il rilievo era debole quando ·non si aveva a le· mere un serio attacco per porte del nemico; mn in caso contrario si rinforzavano le dimensioni tlel profilo. Il pa· rapelto era fallo tli strati alternati di fascine e di terra.
Si rinforzavano anche i trinceramenti piantando sull'orlo esterno del parapetto le palizzate che portavano i soldati.
Alle volte si elevavano nel grosso del parapeUo alcune torri di legno a due o tre piani, per aver comando sulla campagna e vederé nel fondo del fosso.
Cesare, in circostanze difficili contro Vcrcingetorige, circomlò le sue linee con una rete di buche di lupo , e con un secondo fosso munito di creste d' alberi piantate verticalmente e lrgate insieme.
Alle volte, per meglio sorvegliare · il nemico, si occupa· vano alcune sommità intorno al campo col mezzo di pie· coli campi o forti , in cui pooevansi truppe; e si univano al campo principale col mezzo di una specie di capponiera o strada coperta.
Supponiamo che qur.sto campo sia levato e che 1' esercito si ponga in marcia.
Al primo segnale, dice Polibio, si spiantano le tende e si fa fagouo, cominciando da quelle del console e dei 'ribuni; imperocchè non permesso di piantare e spiantar tende se queste già non lo sono. Al secondo segnale si mettono i hal!agli sulle bestie da soma, ed al terzo tutto il campo si muove.
.L' avanguardia è la maggior parte delle volte composta di straordinarj. Dopo questi, viene l'ala dritta degli alleaLi che è seguita dai bagagli suoi e da quelli degli straordinarj. Indi una delle legioni romane, col ·suo bagaglio addietro. l.' altra legione vico dopo, seguita dal suo bagaglio e da quello degli alleati che marciano dietro ad essa; imperocchè
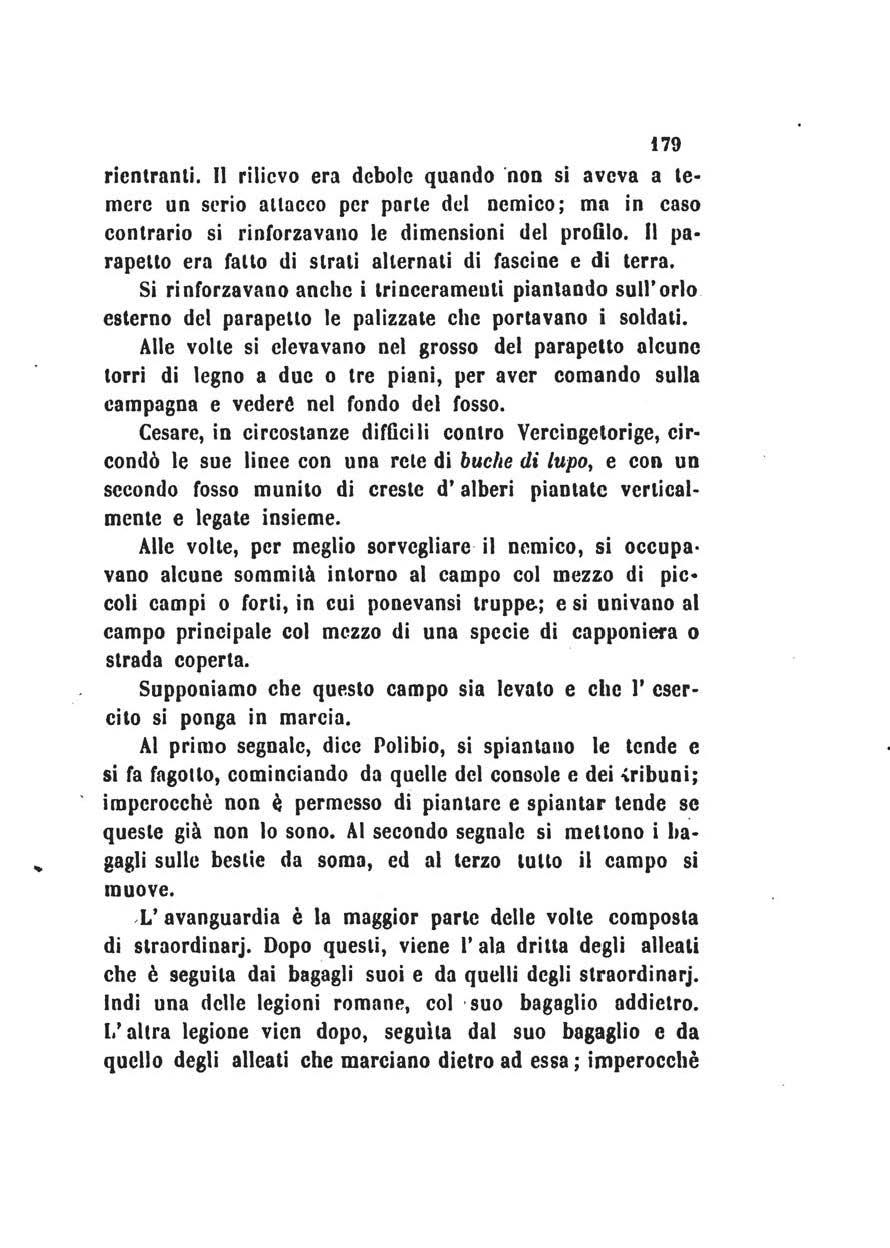
t80 io marcia è l' ala sinistra degli alleati che fo•·ma la retroBUardia. La cavalleria marcia talvolta alla retroguardia del corpo di cui fa parte, tal' altra a fianco delle bestie da soma per metterle al coperto da ogni insulto. Quando vi ha luogo a temere per là retroguardia, si fanno passare dalla testa alla coda gli straordinarj degli alleati, senza cambiar nulla nel resto. Le legioni romane e quelle degli alleati cambiano di ordine alternativamente, marciando un giorno alla testa e il dì seguente alla ·coda, affìnchè tutte ·approfittino ugualmente dell' acqua c dei viveri che si trovano luogo il minQ. Se si teme di essere assaliti, e se si marcia in terreno scoperto, si· ra uso di altra disposizione: gli astati, i Jlrincipi ed i triarj, marciano per manipoli in tre colonne a distanze uguali; ciascun manipolo ha i suoi bagagli innanzi a sè. Se il nemico si presenta, sia alla sinistra, sia alla dritta, si fa volgere i corpi dove il nemico si mostra; gli equipaggi restano indietro; cd in un istante e con un solo movimento tollo l' esercito è schierato io battaglia.
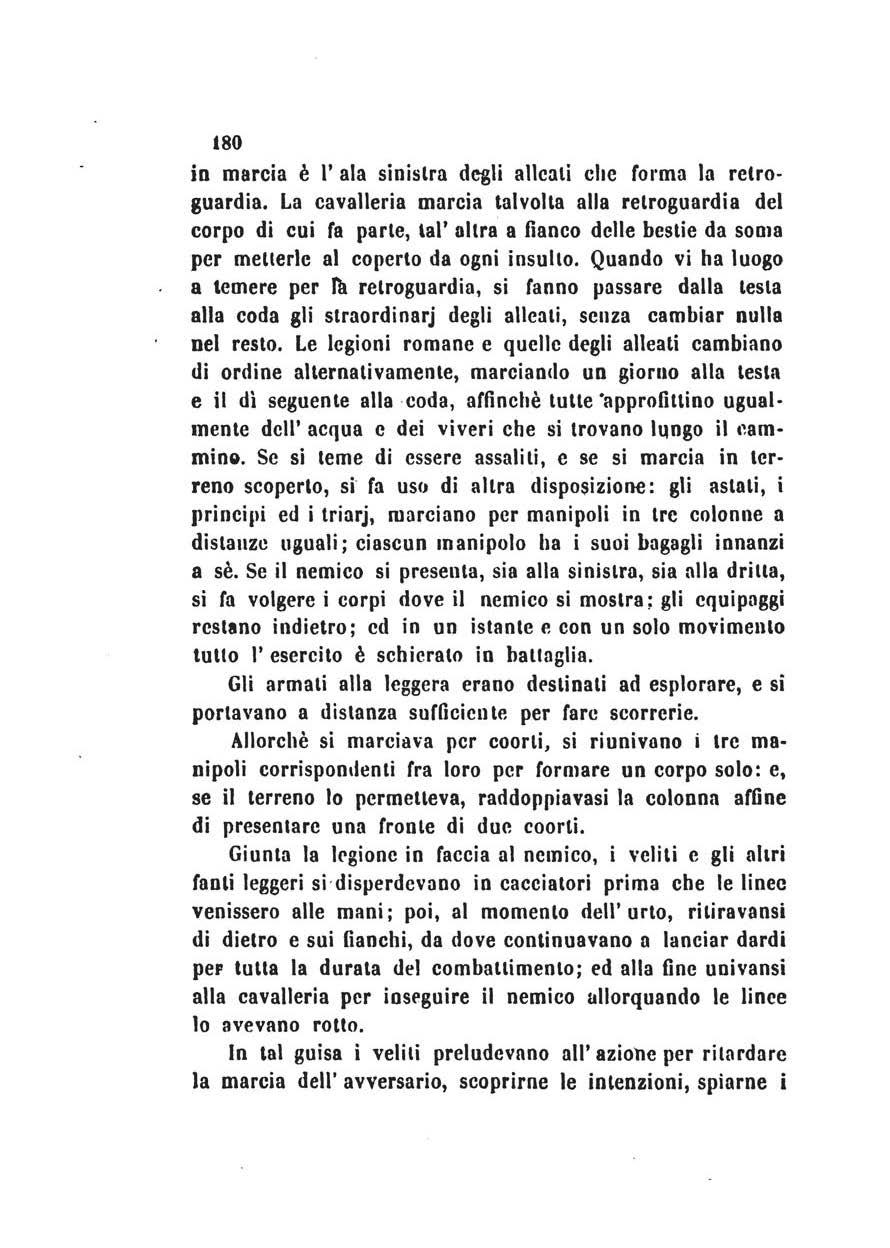
Gli armati alla leggera erano dt>stinati ad esplorare, e si portavano a distanza sufficicn te per fare scorrerie.
Allorchè si marcilna per coorti, si riunivano i tre manipoli corrispon1lenti fra loro per formare un corpo solo: e, se il terreno lo permetteva, raddoppiavasi la colonna affine di presentare una fronte di due coorti.
Giunta la l<'gione in faccia al nemico, i \'eliti c gli ahri fnoti leggeri si ·disperdcvaoo io cacciatori prima che le linee venissero alle mani; poi, al momento dell' urto, ritiravansi di dietro e sui fianchi, da dove continuavano o lanciar dardi per tutta la durata del combattimento; td alla fine uoivansi alta cavalleria per iosE>guire il nemico allorquando le linee lo avevano rotto.
In tal guisa i veliti preludcvano alt ' azione per ritardare la marcia dell' avversario, scoprirne le intenzioni, spinrne i
t81 mo vim<'nti , mascherare quelli dell' csl!rcito, e dar .tempo a questo di pigliare i suoi provvedimenti.
Questi soldati di leva combattevano in prima linea , solto gli occhi di tutto l' .esercito, pro1to ad applaUtdirli od a biasimarli. Il loro onore era quindi impegnato al primo esperimento che davano del loro valore.
Falli i primi colpi dai veli ti, gli . astati ingaggiavano la lotta.
1\larciavaoo colla spada nel fodero, tenendo un pi.lo in ogni mano : arrivati a dodici o quindici passi a distanza dalla linea nemica , lanciavano un primo pilo , e tosto , sgua iinaodo la spada, combattevano alla foggia dei gladiatori, col piè destro i o avanti, braccio sinistro sostenente lo scudo: non si privavano mai del secondo pilo, essendo esso il solo mezzo di resistere alla cavalle ria contro la quale se ne servivano a guisa di picca.
Qualora non avessero potuto rompere la linea nemica, e fossero stati re spinti, i principi, soldati di età più maturn c più aggncrriti di essi, li facevano passare dietro sè per gl ' intervalli dei loro manipoli e si battevano in luogo loro; allot·a gli astati li seguivano.
Intanto i Lriarj restavano sotto le loro insegne con un ginocchio a terra e colle pichc appoggiate nl suolo n punta alla simili a paliz1.ate sulla fronte della linea . Se la fortuna si dichiarava anche contro i principi, qu esti ritiravansi a poco a poco dalla prima linea fino ai triarj: c di là venne il prov e rbio la facenda è ridotta a; trinrj, per deoota•·c una situazione critica. Allora i triarj, vecchi ed esperimentati guerrieri, si alzavano tuuo ad un tratto; rannodavano a sè i principi e gli astati; li riccvcvnnt.l negl' in· tervalli delle loro righe, c formavano così nna sola linea pienn c continua colla quale piombavano sul nemi co; questa
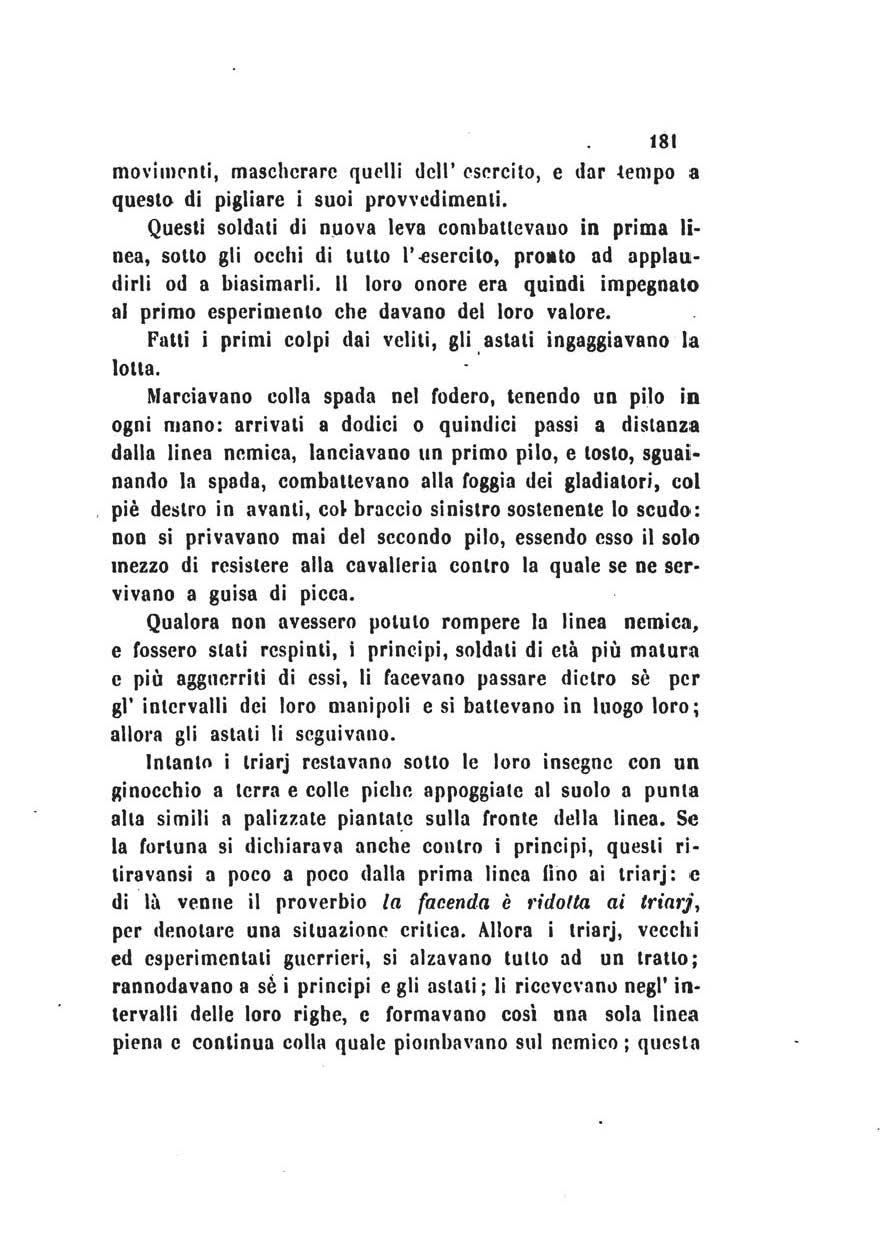
era 1' ulliina speranza. Nulla di più terribile agli occhi di un nemico, che credevo di non aver più altro a fare se non che da inseguire i vinti, di questa nuova linea la quale più numerosa c più terribile che mai elevavasi improV\'isameutc innanzi ad esso.
Varie sono le spiegazioni che si danno intorno alla formazione di questa linea conlinua. Gli astati ed i principi uniti assieme, rendono già per sè medesima piena la linea e non vi sarrebbe posto pel triarj.
Dicono alcuni che essendo la fronte dei manipoli degli astati e del principi neces sar iamente diminuita dopo una doppia battosta, sarebbesi l'i slretta al punto da permettere di schierarsi con loro i manipoli dei trial'j senza che alcun' alterazione si fosse po rtata negli' intervalli.
Altri suppongono invece che l' intervallo fra i manipoli delle due prime linre fosse di una volla e mezzo la fronte di essi, e quello fra i manipoli dei triarj fosse quadruplo della loro fronte. Che in prima linea adunque stessero gli astati coi manipoli ad intervalli uguali ad una volla e mezzo la loro fronte; in seconda linea i principi facendo corrispondere perpendicolarmente la pri· ma Ola di dritta di ciascun manipolo coll'ultima fila di sinistra del manipolo di astati posto davanti; finalmente in terza linea l triarj , coll' ultima fila sinistra del primo manipolo corrispondente a Ila prima di dritta del primo degli asta li, e colla prima Ola di dritta di tutti gli manipoli corrispondente all' ultima di sinistra di quello dei principi che gli slna dinanzi .
In tal modo la disposizione sarebbe riuscita a scaglioni invece di essr.re a scacchiere come si afferma che fosse (V. Tav.a VIli. Fig.c t,' e 2_.),
Questa seconda spiegazione non è che una semplice ipotesi, ma pare che debba avere qualche fondamento se osserviamo che negli esercizj dei romani, i quali dovevano essere come i nostri la rappresenlazionè di ciò che de\·e accadere sul campo di . battaglia, sarebbe stato impossibile, sçnza la condizione accennala, di riuscire in quesla manovra che d' allronde era una delle più rimarchevoli ed imporlanti della legione.
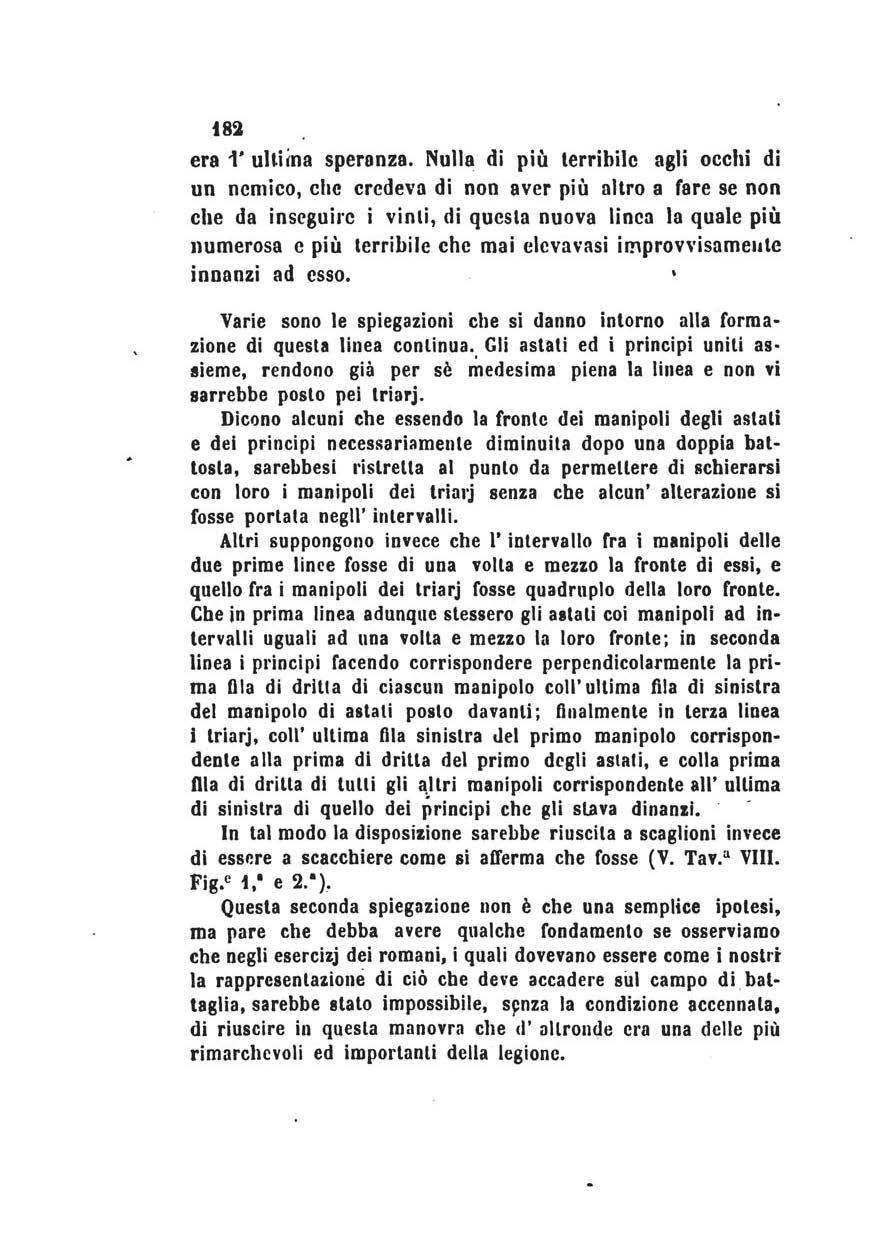
t83
Abbiamo detto che i nllti univansl alla cavalleria per inaesuire il nemico; ed ecco in qual modo spiesa Tito Livio che ciò avvenisse. • Ciascbeduo cavalliere, dic' egli, prende un velite ip groppa dietro a sè. Questi fant•ccini, sono abituali a saltare a terra al suonare della carica, a correre innanzi alla cavalleria, a lanciare i loro dardi, a rientrare fra i cavallieri, ed a rimettersi in groppa. •
l romani andavano al combauimento in ordine ed in silenzio, e non alzavano grido di 1uerra se non che al momento dell' urlo, per il nemico cd animare sè medesimi.
Dopo la vittoria, aveva luogo l' inseguimento dietro l'e sercito nemico.
Tale fu la prima costituzione legione nei tempi migliori di Roma . Il che offriva questo ordinamento era l' immensa mobilità la quale non impediva però che in dale circostanze, formando delle tre linee una assumesse la solidità della falange senza gl' inconvenienti di questa.
Altro vantaggio offrivano i vuoti lasciati fra manipolo e manipolo: essi permettevano il passaggio . delle linee che coll' ordinanza 1rcca non si poteva effettuare•
.Dalla esposizione che abbiamo V'Ho del modo di combauere dei romani, risulta che ci siamo semplicemente fer· mali su quell' ordi.ne di battaglia che si chiamo diretto o parallelo , quando cioè i due eserciti si urtano schierati sopra una fronte parallela e su parecchie linee, considerandolo tale rispettivamente al nemico qualora queslo trovisi ugual· meute disposto sopra di unu linea retta. Parlando però dei greci, abbiamo notato che Epaminooda, nelle due battaglie di Leutra e di Mantineo, si è servito dell' ordine obliquo. Ma non limilansi a questi dne gli ordini tlrgli antichi; e Vegezio ce ne descrive sette (V. Tn v. VIli. Fig.• ).
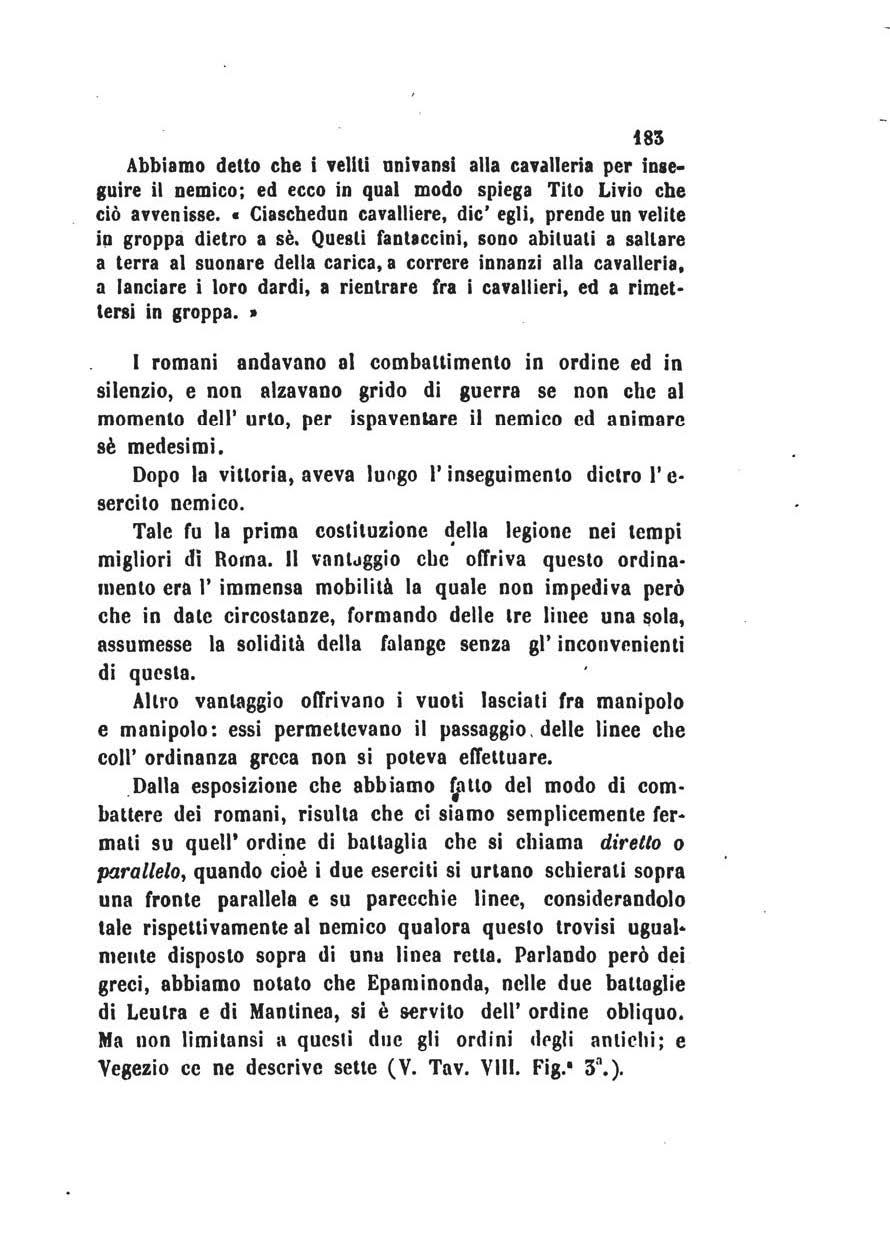
t84
Nel to l 'ese rcito conserva la primilin simmetria e sta parallelo al nemico; disposizione senz' arte e calcolo; possibile, quando si ,·oglia attaccare tulli i punti della linea opposta. Grande strage verrebbe da questo affrontarsi di due eserciti in. tutta la lunghezza, se pur l' uno, più prode c numeroso, non involga l' altro da ogni parte, terminando di colpo la lotta. Ma anche quando uno si senta superiore, deve evitare questo modo, il quale obbliga una marcia generale eli fronte, semp·re difficilissima anche in paese piano.
Il 2° r.onsiste nel collocare a destra le migliori truppe, assalire con queste, tenendo momentaneamente la sinistra fuori dal tiro .
Il 50 fa lo ste5so colla sinistra; attacco più debole, perchè questa è più scopcr.ta, aueso l' uso degli scudi, i quali, imbracciali al lato sinistro, lasciano indifeso il destro, che resta esposto marciando per compiere la manovra.
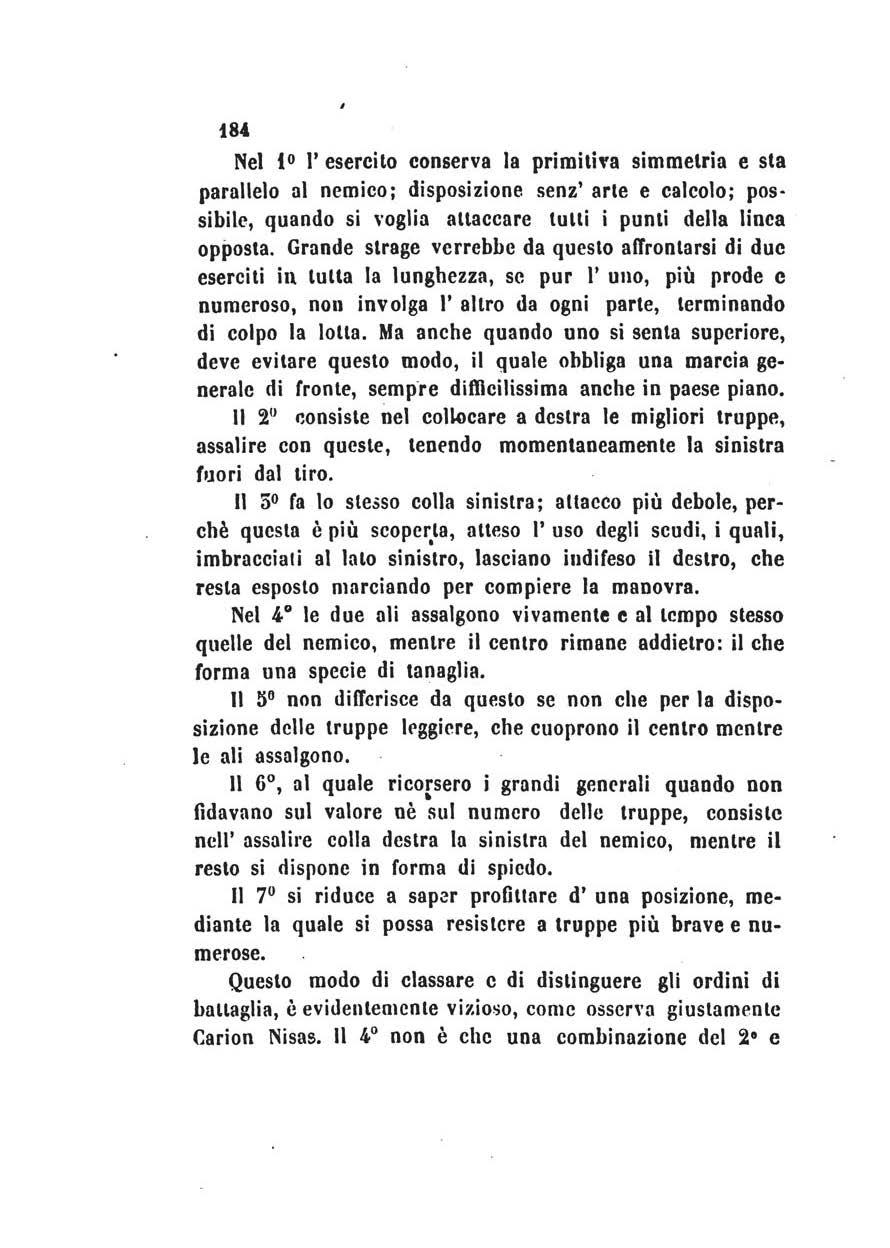
Nel 4° le due nli assalgono vivamente e al tempo stesso quelle del nemico, mentre il centro rimane addietro: il che forma una specie di tanaglia.
Il 5° non differisce da questo se non che per la disposizione delle truppe lt>ggicre, che cuoprono il centro mentre Je ali assalgono.
Il 6°, al quale ricorsero i grandi genl'rali quando non fidavano sul valore oè sul numero delle truppe, consiste nell' assalit·e colla destra la sinistra del nemico, mentre il resto si dispone in forma di spiedo.
Il 7° si riduce a sapar profittare d' una posizione, mediante la quale si possa resistere a truppe più brave e numerose .
Questo modo di classare c di distinguere gli ordini di bauaglia, è evidentemente vizio!;o, come osscn·a giustamente Carion Nisas. Il 4° non è che una combinazione del 2• e
t85 del 3°; il t; o non è che il 4• più compiuto; il 6° non è· esso pure se non che un ordine obliquo; il 7° non è un ordine, ma un at.lauamcnto alla posizione.
Altre formazioni speciali si adouarono pure dalle legioni iff parecchi casi.
A testuggine per l' assalto dci trinceramenti,.ed anco per la difesa in rasa compagna. In questa formazione si avvicinavano e disponevano gli scud i in guisa da cuoprirsi tutto aW intorno dn una specie di corLiaa di ferro, affine di ripararsi per alcun tempo dal saeuamento del nemico.
In orbe, ossia in rotondo, per resi stere ad un assalto avviluppante di fanteria o di cavafleria.
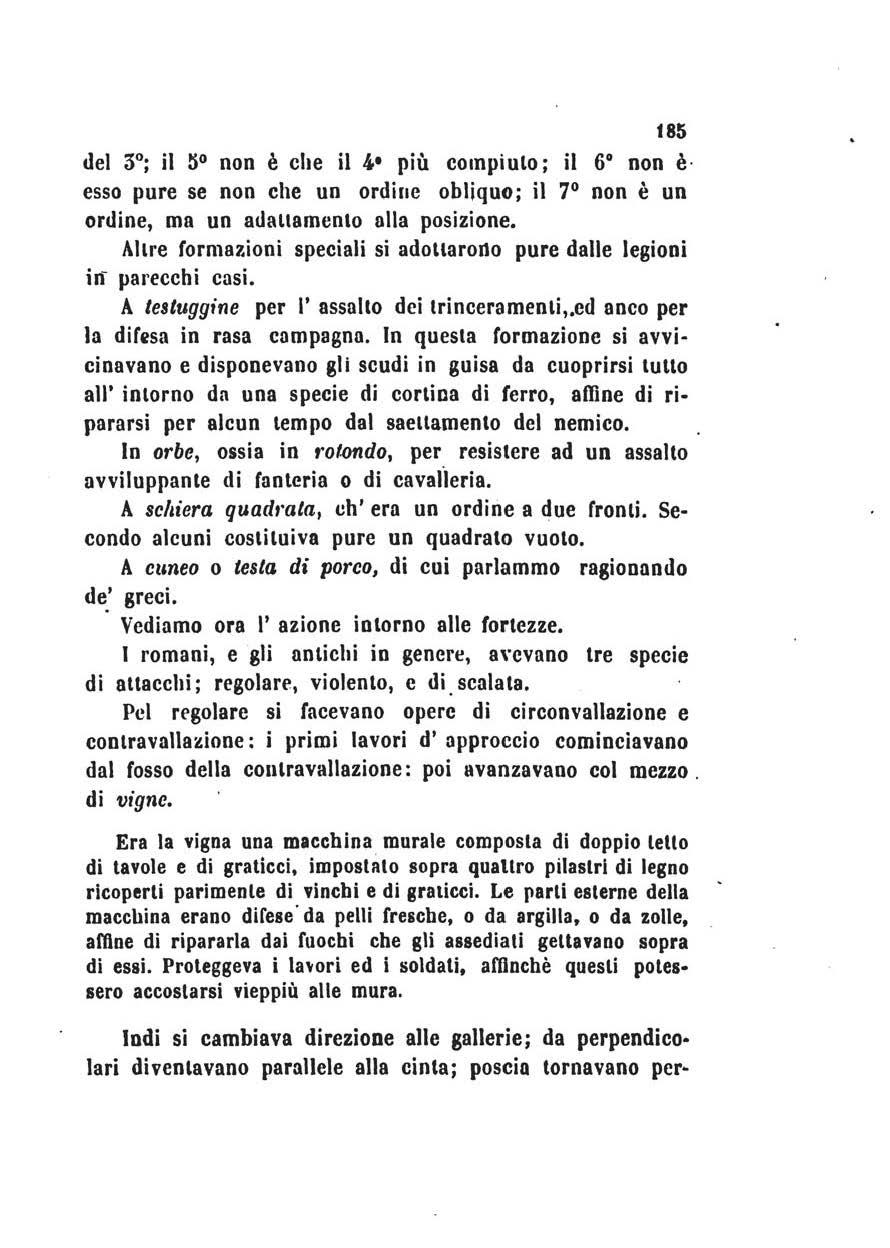
A schiera quadrata, ch' era un ordine a due fronti. Secondo alcuni costituiva pure un quadrato vuoto.
A cuneo o testa di porco, di cui parlammo ragionando de' greci.
· Vediamo ora l' azione intorno alle fortezze.
l romani, e gli antichi io genere, 8\'evano tre specie di attacchi; regolare, violento, e di. scalata.
Pcl regolare si facevano opere di circonvallazione e coatravalla:done: i primi lavori d' approccio cominciavano dal fosso della contravallazione: poi avanzavano col mezzo . di vigne.
Era la vigna una macchina murale composta di doppio tetto di tavole e di graticci , impostàto sopra quattro pilastri di legno ricoperti parimente di vinchi e di graticci. Le parli esterne della macchina erano difese· da pelli fres che, o da argilla , o da zolle, affine di ripararla dai fuochi che gli assediati gettavano sopra di essi. Proteggeva i lnori ed i soldati, amnchè questi potessero accostarsi vieppiù alle mura.
lodi si cambiava direzione alle gallerie; da perpendico· lari diventavano parallele alla cinta; poscio tornavano per-
iSG penclicolari: s1 nempiva il fosso, si appianava il terreno per facilitare il trasporto delle torri nelle quali stavano arcieri e macchine per geuarc projcltili, c quello delle testuggini coll' ariete per battère in breccia.
Oltre a ciò si faceva uso del tollenone, macchina colla quale si alaavn e trasportava sulle mura nemiche un cassone pieno di armati. Si adoperavano anche torri con ponti levatoj i. quali si gettavano sulle mura. Qualche volta si usava la mina, scavando, e 'appiccando fuoco con cataste di legno .
In caso di eccessiva solidità deiJe mura, si costituiva un terrazzo per mettervi macchine od uomm1, c favorire l' avvicinamento dci mezzi coi quali si dovevo tagliare il muro al piede.
L' assediato gettava dardi, fnceva sortite, poneva quà c là materassi c travi per rendere vana l' azione dell' ariete,. e col mezzo di argani aggrappava uomini . e macchine che si trovavano ·al piede dello muraglia. Costruivansi anche trinciernmenti dietro alle breccie; e si facevano talvolta torri di legno altissime per mantenere dominio sull' assr.diante.
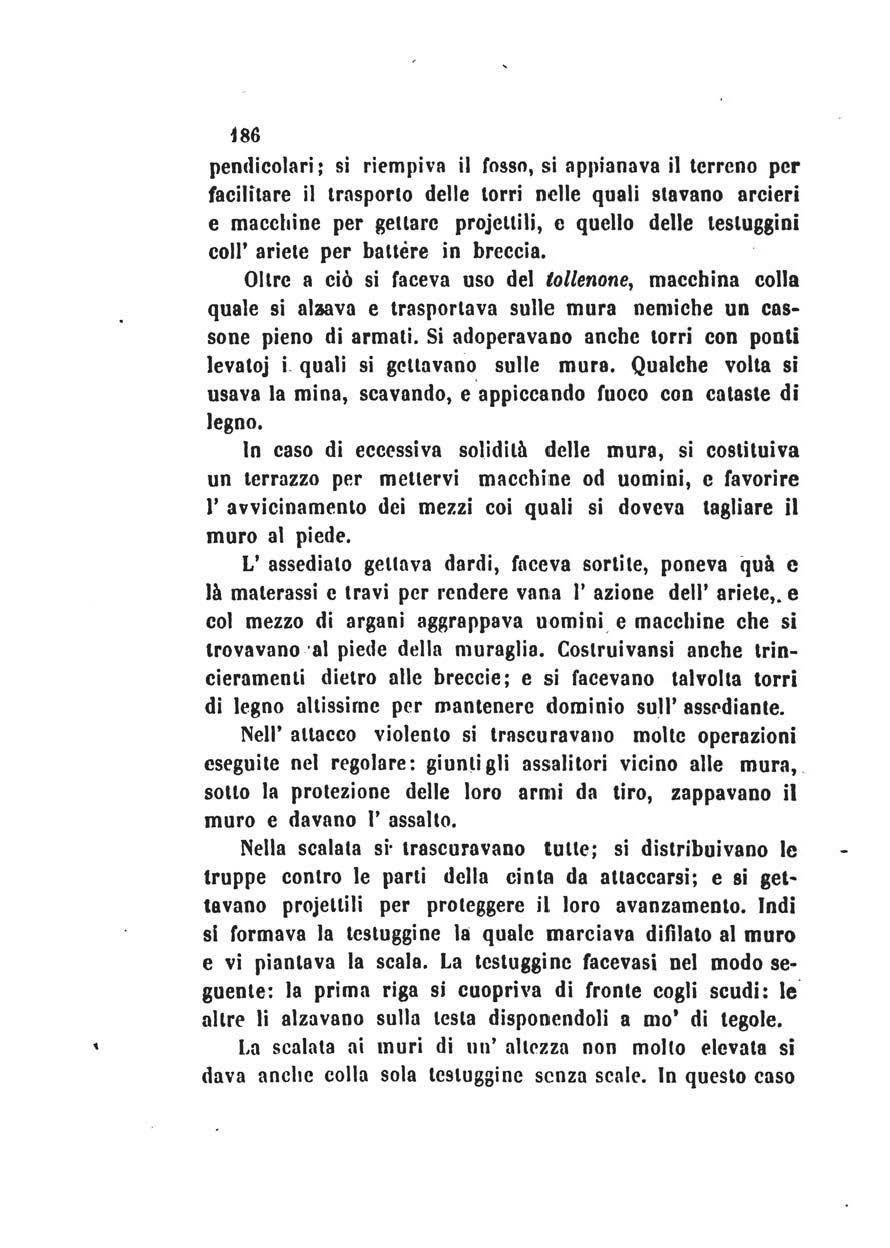
Nell' attacco violento si trascuravano molte operazioni eseguite nel regolare: gli assalitori vicino alle mura, . sotto la protezione delle loro armi da tiro, zappavano il muro e davano l' assalto.
Nella scalata si· trascuravano tutte; si distribuivano le truppe contro le parti della cinta da auaccarsi; e si get· tevano projetlili per proteggere il loro avanzamento. Indi si formava la testuggine la quale marciava difilato al muro e vi piantava la scala. La tc stuggi ne facevasi nel modo seguente: la prima riga si cuopriva di fronte cogli scudi: le· altr(' li alzavano sulla lesla disponendoli a mo' di tegole.
La scalata ai muri di nn' allczzn non molto elevata si dava anche colla sola tcslugginc senza scnlt>. In questo caso
t87 si abbassavano gradatamente gli scudi in modo da formare un piano inclinato sul quale ascendevano gli assalitori.
Prima di terminare questo paragrafo, diremo alcune parole sui segnali con cui in guerra si comunicavano gli ordini e gli ' avvisi, e sui meni che sl adoperavano pel passaggio dei numi. Discurreodo de ' primi, diremo, che quando trallavàsi di truppe le quali fossero state in grado di udirli o di averli vicino alla vista, i segnali davansi colla voce , o col mezzo delle trombe, o muovendo in diversi sensi le insegne. Ma quando voleansi mandare lontano le noli1ie della situazione, la cosa diveniva più dif· · flcile. Tuttavia troviamo antichissimi i segnali trasmessi mediao · te i fuoclli. Vuolsi inoltre, elle Decimo Bruto, assedialo in Modena da Antonio, desse avviso della sua condizione attaccando lettere ai piedi di parecchi piccioni. In ogni modo, l'uso dei segnali di· minuì allorquando il perfe1iooameoto delle strade rese le comu· nicaziooi meno penibili, e permise di portarsi più rapidamente a gra.od i distanze; vantaggio a cui io allo grado contribuirono i romani.
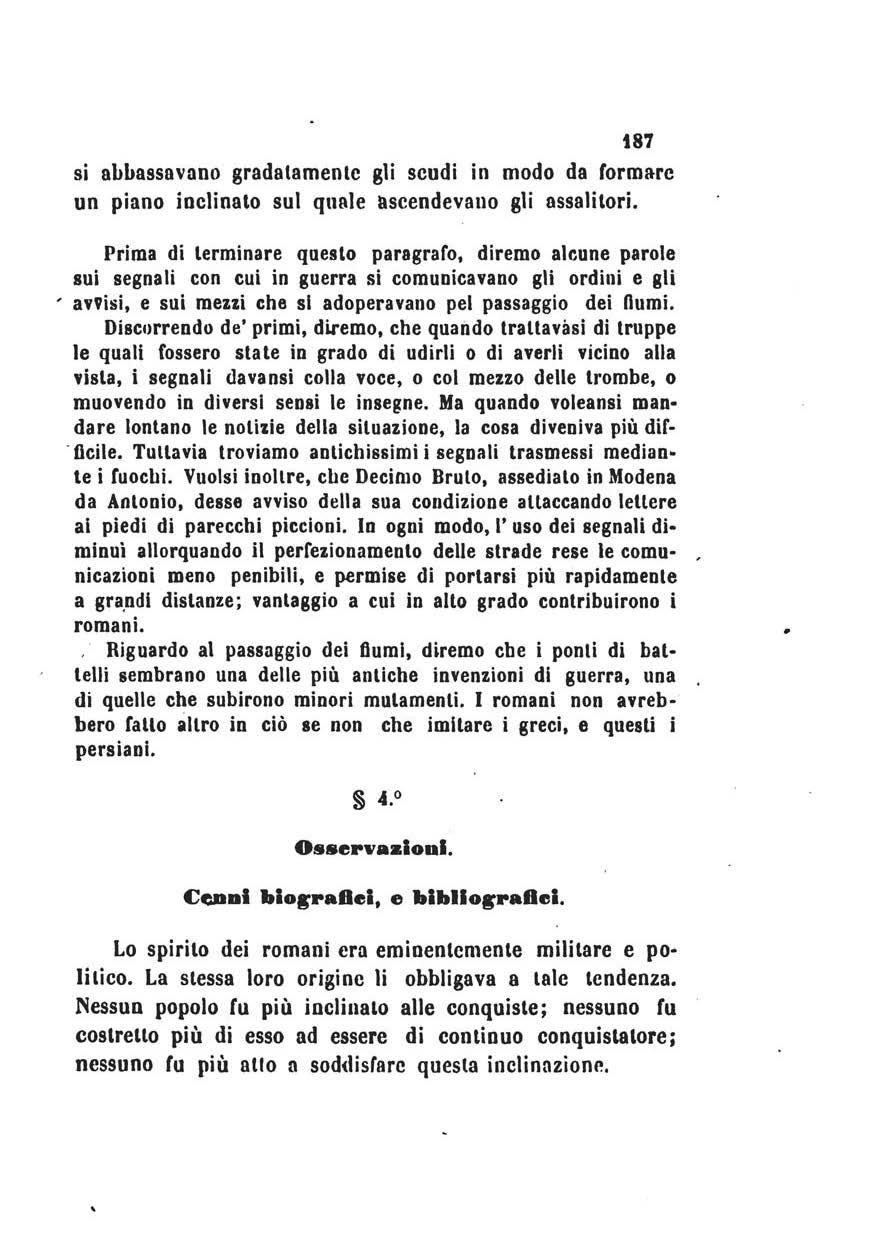
.
Riguardo al passaggio dei ftuml, diremo che i ponti di bat· telli sembrano una delle più antiche invenzioni di guerra, una di quelle che subirono minori mutamenti. l romani non avrebbero fallo altro in ciò se non che imitare i greci, e questi i persiani.
Lo spirito dei romani era eminentemente militare e politico. La stessa loro origine li obbligava a tale tendenza . Nessun popolo fu più inclinato alle conquiste; nessuno fu costretto più di esso ad essere di continuo conquistatore; nessuno ru più allo n soddisfare questa inclinazione.
t88
Ne veniva di conseguenza che se i greci per .la ditesa dovettero. ricorrere ad un ordinamento militare che tenesse ·fronte agl'i nemici invasori, e resistesse al loro urlo tumul· tuario, i romani invece dovevano adottarne un altro che permellesse loro di assalire gli avversarj, con so,lecitudine, con energia, con efficacia; c che assicurasse loro la vitto· ria la quale etTeuivamente abbandonò di rado le loro bandiere. Aspettare; era l'espressione dell' ordinanza falangitica compatta· , e delle lunghe sa risse: andare; era l' espressione della formazione mobile legionario,. e della spada dei quiriti.
In forza della mobilità della legione, i romani 'poterono portare le loro conquiste nelle regioni più remote; in virtù della perfezione della loro ordinanza poterono quasi sempre eooquidere i loro némici..
Non è però a credersi che essi non siensi trovati nella circostanza di dovere talvolta modificare i loro ordini di battaglia, e trovare il mezzo, l' espediente almeno, di resistere all' urto tumulluario o di renderlo vano.
Regolo si trovò a fronte gli elefanti alla battaglia di Tanisi. Allora mutò l' ordine a scacchiere, e pose l' uno die· &ro all' ·altro, io colonna, i manipoli degli astati, dei prin· cipi, e dei triarj. Con ciò voleva creare un passaggio per gli .elefanti. Ma non aumentò gl.' intervalli ordinarj fra i ma· nipoti. Egli li unì nella loro profonditil col disporre i veliti nelle distanze; e questi veli ti erano incaricati di balestrare gli elefanti. Ma gl' intervalli fra queste linee perpendicolari non essendo stati punto allargati, gli elefanti non trovavano nè a destra nè a manca aie un' uscita; e non avendo innanzi' ad essi, ovunque si fossero vòlti, se non che un' apertura insufficiente, gettavano il disordine e la confusione . nelle file romane. Per tal guisa la disposizione di Regolo,
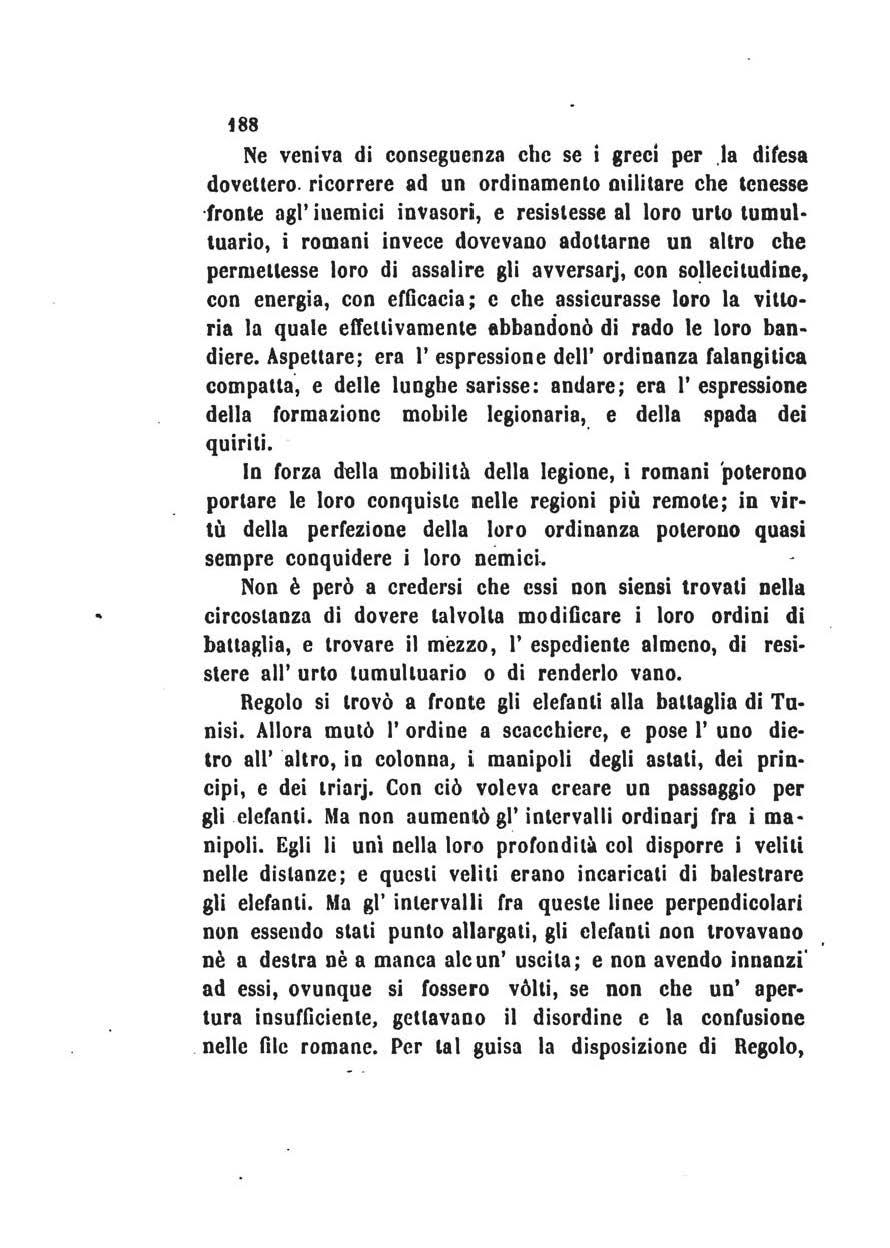
t89 la cui · idea era saggia, riuscì a suo danno nel risulta· mento.
Era il caso per Regolo, che si trovava sulla spiaggia unita dell' Africa , di avvicinarsi all' ordine della falange; egli poteva eseguire la manovra, per giungt>re a qu esta forma· zio ne, la quale venne effettuata con disècrni mento da Scipione nella battaglia di Zama. Per meglio compre ndere questa manovra giudiziosa di Scipionc, è mestieri gettare un colpo d' occhio retrospettivo sulla falange greca.
La falange era disposta in modo da non lasciar penetrare nè i carri armati di falci , nè gli elefanti; e di tener sempre distanti gli uni -c· gli altri col mezzo delle sarisse mentre i fanti leggi eri erano inearicati di dirigerli, provocandoli, o sui fianchi della tctrafalangarchin, o in uno dei tre inter· valli che abbiamo accennato .
Le armi dei romnni non ('Sscndo, sotto questo rapporto, simili o quelle dei greci, ed i loro mezzi per tener lontani gli elefanti cd i carri non essendo gli stessi, sia per causa della diversità nen' ordinanza, sia di quella dell e armi, Sci, pione giudicò che faceva duopo di aprire in ogni senso larghi passaggi agli elefanti, i quali non si potevano nè sviare nè respingere da vicino .
Perciò a Zama sopra un campo di bullaglia dello stesso genere di quello di Tunisi, egli mise prima di tutto, come aveva fatto Regolo a Tunisi , i manipoli de,gli astati, dei prin· , cipi, e d('i triarj, uni dietro gli altri, ma con distanze più grandi fra loro, c con più grandi intervalli fra queste linee perpendicolari.
Con questo mezzo adunque sii elefanti trovando dapertutto, a dritta , a manca, e dinanzi ad essi , molti vuoti c molte aperture, circolarono in questi spaz;j liberi, senzo far danno alcuno , non si urtarono nè contro le fronti, nè con-
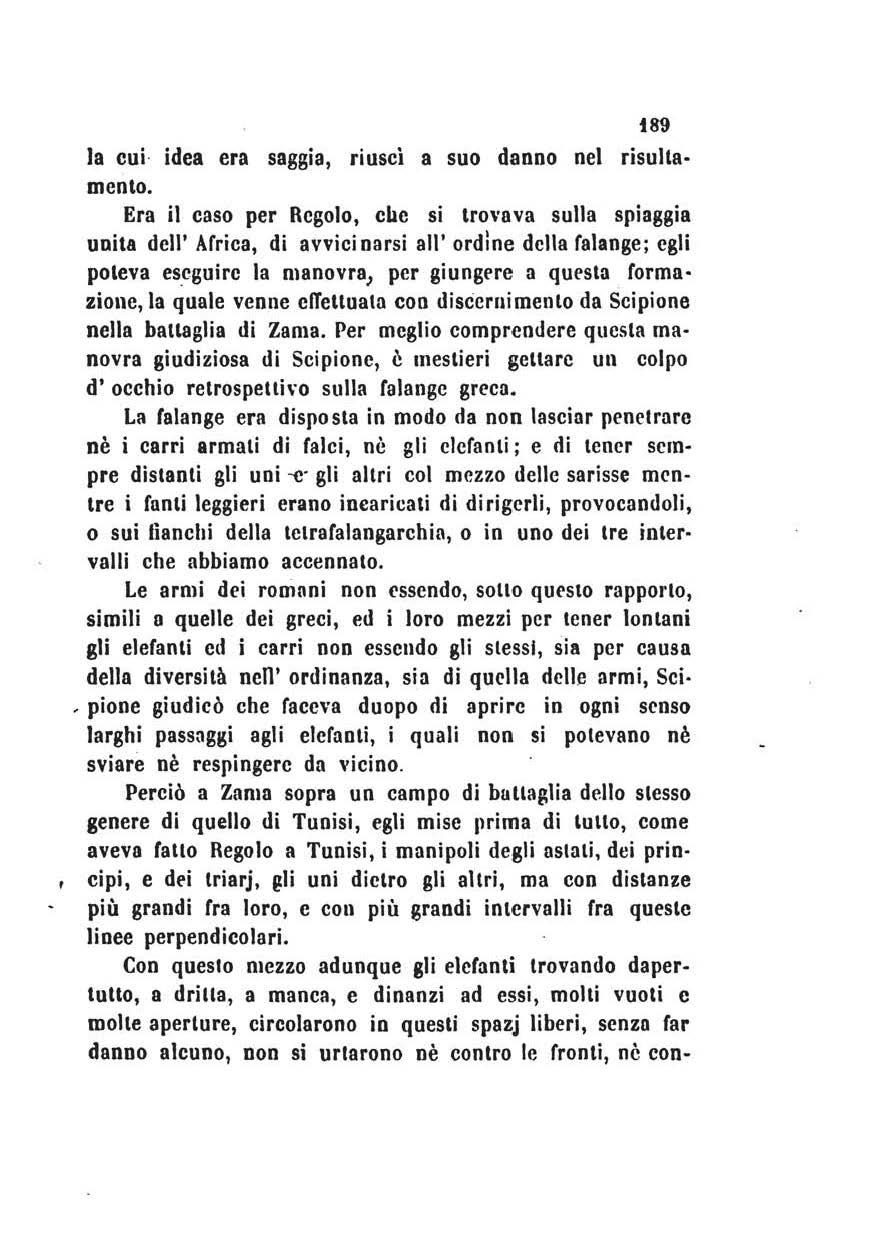 Hl O
Hl O
tro i fianchi, c si tro\'arono pn·sto alle spalle dell' cserci to romano, che allora marciò serrando il suo ordine; c si al· tribuiscc a tale preveggenza la vittoria riportata in questa battaglia importante (t).
Due imitazioni della falange ebbero luogo per opera di Cras:;o c di Arttonio.
Nella ritirata di Crasso, i romani videro un monticello di sabbia abbastanza elevato e vi si"ritirarono; posero i loro cavalli nel mezzo, e si fecero all' intorno una specie di cinta coi lo1·o scudi per trincerarsi, spt>rando che questa disposizione Jcl terreno li avrebbe ajutati contro i Parti che li inseguivano; ma avvenne tutto al contrario. La disposizione ad anfiteatro lasciava scoperti i militi ed esposti ai dardi dei nemici. Crasso fu battuto.
Antonio serrò a falange la legione per resistere aJI' inst>guimento dei Parti; poi asp ettò che costoro scendessero da cavallo per venire a tenzone, c allora li combattè alla legionaria e li vinse.
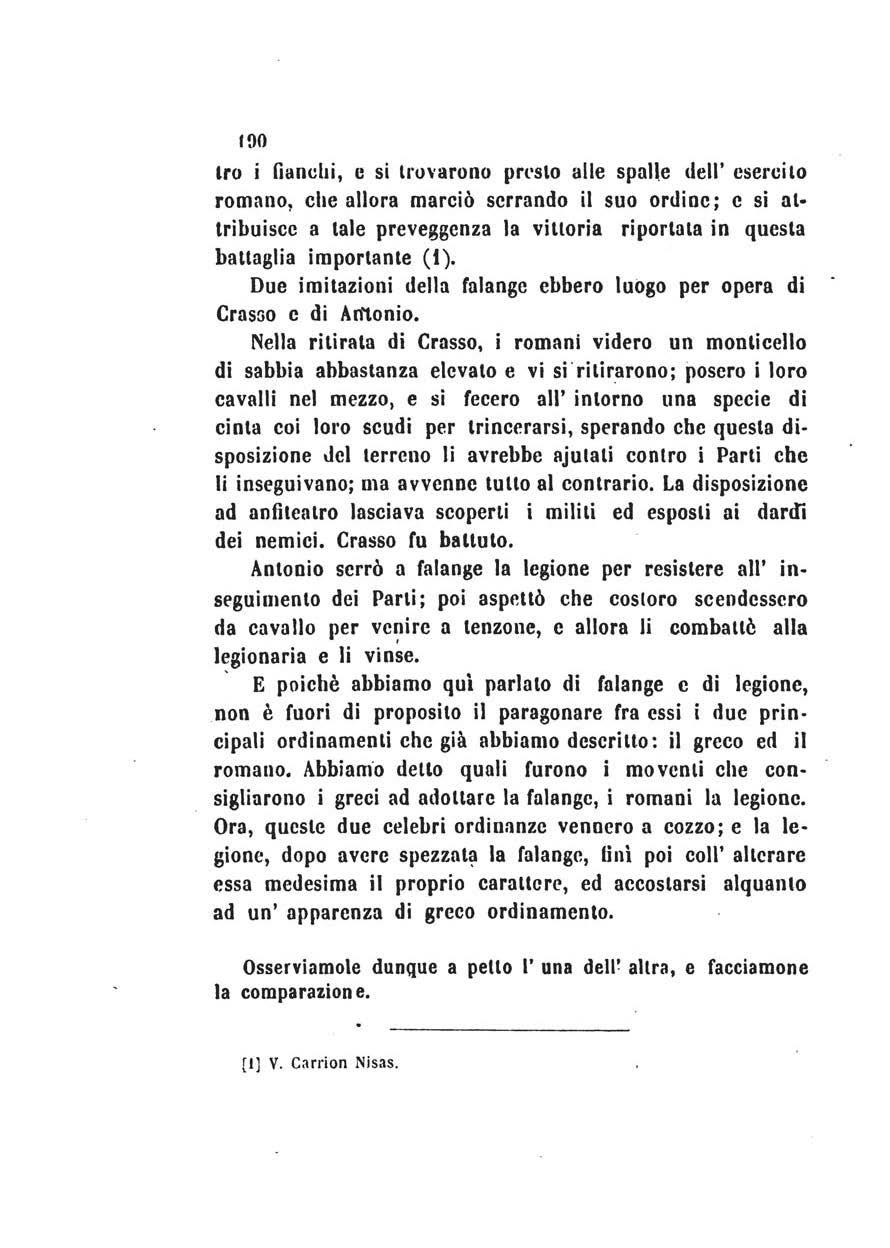
' E poichè abbiamo qui parlato di falange c di legione, non è fuori di proposito il paragonare fra essi i due prin· ci pali ordinamenti che già abbiamo descritto: il greco ed il romano. Abbianio dello quali furono i moventi che consigliarono i greci ad adottare la falange , i romani la legione. Ora, queste due celebri ordinanze vennero a cozzo; e la le· gionc, dopo avere la falange, tini poi coll' alterare essa medesima il proprio carattere, ed accostarsi alquanto ad un' apparenza di greco ordinamento.
Osserviamole dunque a petto l' una delt! altra, e facciamone la comparazione.
( l ) V. Ca rri on Nis a s.
t9l
In tempi in cui la legiouu una già ottenuto tutta sua forza, Paolo nella sua battaglia contro Perseo, trovò tolta la falange. La resistenza ostinata dei greci, dice Plotarco , mostrò cb' essi non avevano ancora meritato di decadere dalla loro antica ripotazlone. Il grande urto fu contro questa falange macedone, irta di picche, e ch' era ·quasi impossibile sfondare, tanto i soldati erano abituati ad unire tutti assieme i loro scudi ed a presentare al nemico una specie di muro di ferro .
Paolo Emilio confessava in appresso che questo baluardo di metallo, e questa selva di picche, lo avevano riempiuto di ·meraviglia e di timore; e che, per quanto si mostrasse tranquillo ed ilare, non aveva potuto sulle prime impedire a sè medesimo di provare q•talche dubbio e qualche inquietudine sull' ea;ilo del combatLimento. Infatti, tutta la sua prima linea di astati essendo messa in disordine, la seconda de' principi cominciava essa pure a piegare. '
Il console si accorse che l' ineguaglianza del terreo o obbligava le falangi a lasciare nelle loro fronti a lcune aperture cd alcuni intervalli; allora divise le sue truppe in piccoli drappelll, e comandò che i soldati si avventassero separatameote negli intcrstizj e nei ncui della falange avversaria, facendo cosi non già uu solÒ as· iallo o comòaUimento contro tutto il corpo della gente nemica, ma molli e da varie parli in un tempo . medesimo. Avendo Emilio dato un tal comando ai centurioni ed i centurioni ai militi, appena si furono i.nsinuali e penetrati f•·a le armi dei nemici, si posero a ferirne alcuni dt Oanco dove non erano coperti, altri alle spalle dove nel girare inloruo venivano colti; per la qual cosa, scompaginatasi cosi la falange. venne subito a mancare ogni suo.. potere, e quell' effetto che si produceYa dallo starsene unita. Combattendosi pertanto lesta a lesta , e da pochi con pochi, i macedoni, che avevano spade corte. altro non facevano che percuotere cou esse gli scudi dei romani cb 'erano saldi e che cuoprivano tutta la persona; e per contrario mal potendo coi loro , che erano leggieri, resistere alle spade dei romani medesimi, le quali, ·essendo gravi e calando con impeto, foravano qualunque armatura, e penetravano nei corpi, restarono alla One rovesciati. La fu immensa; imperocchè vuolsi che de' macedoni perissero

ffl2
Questo combattimento di Pidua fu l' ultimo slorzo e nome l' ullimo respiro della falange.
La falange era forte per la sua solidità, per In sua com· pattczia; opponeva due uomini c dodici punte di sa risse ud ogni legionario; ma non poteva combattere se· non elle in un terreno piano cd unito, ed io niodo solo; non aveva una riserva; non u.n passaggio di linee; non poteva muoversi a ritirata o ad inseguimento senza scompaginarsi; una volla cbe àvessc presentato intcrstizj, si gettavano fra questi i legionarj, come fecero a Pidna, e comballevano col vantaggio dell' arma corta contro soldati estremamente pc· santi.
La legione aveva per distintivo la mobilità; mn godeva anche di solidità, sia formando una linea sola, sia ordi· nandosi a coorti; aveva due linee e la riserva dci triarj; aveva il passaggio .di linee; combatteva su tutti i terreni; si adauava a qualsiasi marcia: combatteva ugualmente coll' esercito intiero o con qualcuna delle sue parti ridotte alle lliccole frazioni, cd anchn da uomo a uomo.
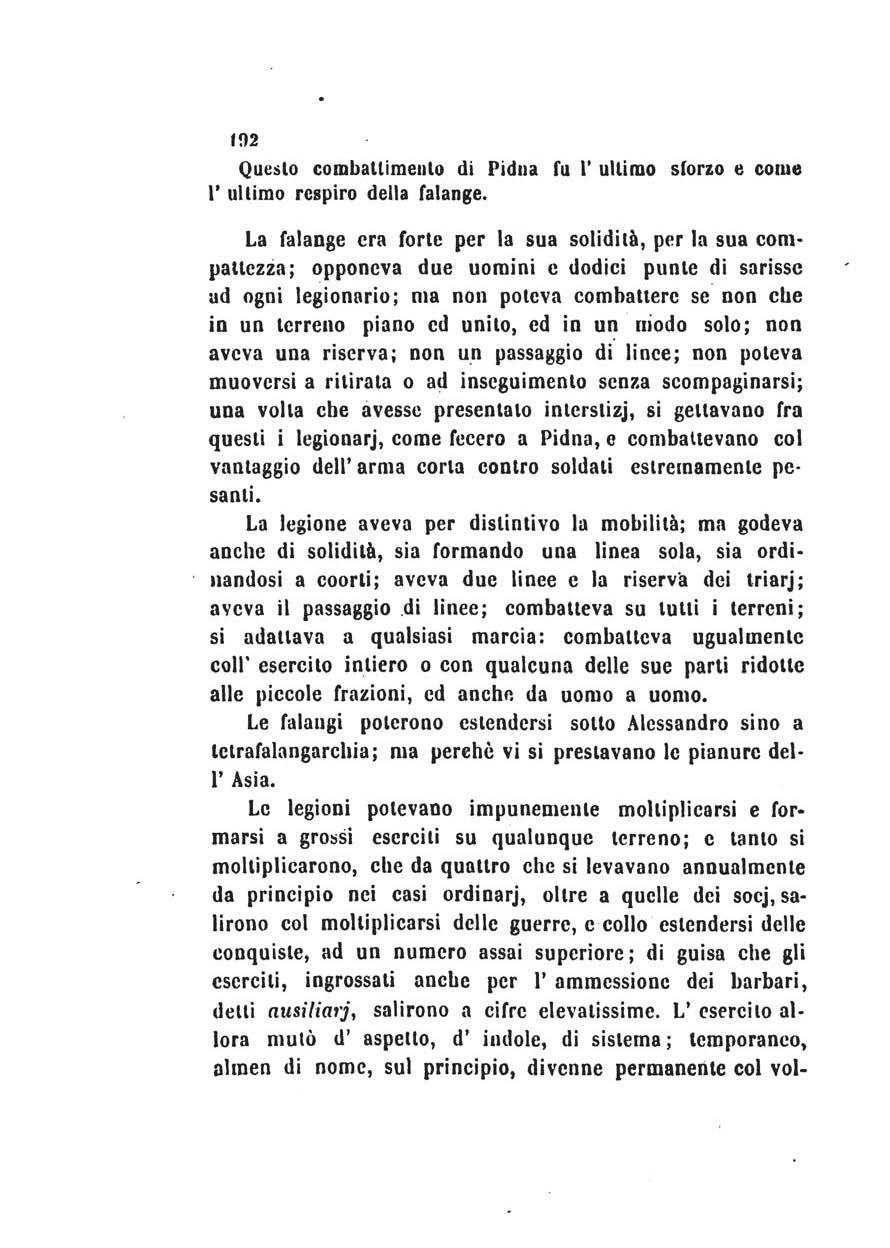
Le falangi poterono estendersi sotto Alessandro sino a tetrafalangarchia; ma perehè vi si prestavano le pianure dell' Asia.
Le legioni potevano impunemente moltiplicarsi e formarsi a grossi eserciti su qualunque terreno; c tanto si moltiplicarono, cbe da quattro che si levavano annualmente da principio nei casi ordioarj, oltre a quelle dci socj, salirono col moltiplicarsi delle guerre, c collo estendersi delle conquiste, ad un numero assai superiore; di guisa che gli eserciti, ingrossati anche per l' ammcssionc dei barbari, deui ausiliatj, salirono n cifre elevatissime . L' esercito allora mutò d' aspetto, d' indole, di sistema; temporaneo, almen di nome, sul principio, divenne permanente col voi-
193 gere del tempo. E fuvvi epoca in cui la Spagna ebbe n guardia legioni, quattro la Germania superiore, allrettanto l' inferiore, due la Dalmazia, tre la Polonia, due la Mesia, quattro la Siria, due l' Egillo, e una l' Africa. Sebbene questa distribuzione variasse iu diversi tempi, pure il nerbo maggiore delle milizie stanziò sempre nell' epoca degl' im· peratori sui confini delle nazioni più bellicose, al Reno, ·all' lstro, ed all' Eufrate. Vegliava così, in uno colle armate navali, a difesa dell' impero. .
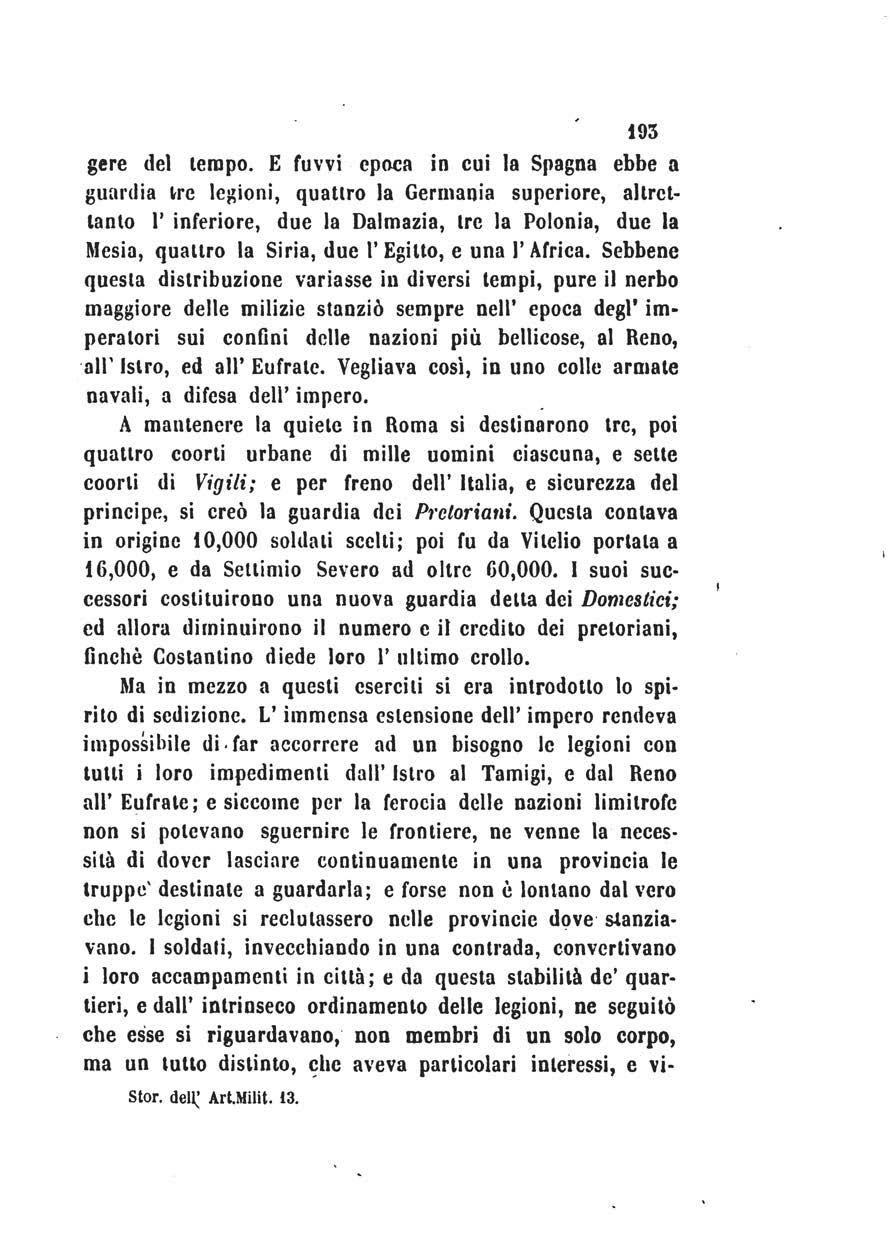
A mantenere la quiete in Roma si destinarono tre, poi quattro coorti urbane di mille uomini ciascuna, e selle coorti di Vigili; e per freno dell' Italia, e sicurezza del principe, si creò la guardia dci P1'cloriaui. Questa contava in origine tO ,OOO soldati scelti; poi fu da Vitelio portata a t 6,000, e da Settimi o Severo ad oltre 60,000. l suoi successori costituirono una nuova guardia detta dci Domestici; ed allora diminuirono il numero c il credito dei pretoriani, fine hè Costantino d ied e loro l' n ltimo crolJo.
1\fa io mezzo a questi eserciti si era introdotto lo s pirito di sedizione. L'immensa estensione dell'impero rendeva impossibile di . far accorrere ad un bisogno le legioni con tuui i loro impedimenti dall' lstro al Tamigi, e dal Reno all' Eufrate; e siccome per la ferocia delle nazioni limitrofe non si potevano sguernirc le frontiere, ne venne la necessità di dover lasciare continuamente in una provincia le truppe ' destinate a guardarla; e forse non è lontano dal vero che le legioni si reclutassero nelle provincie vano. l soldati, invecchiando in una contrada, convertivano i loro accampamenti in ciltà; e da questa stabilità dc' quartieri, e dall' intrinseco ordinamento delle legioni, ne seguitò che esse si riguardavano; non membri di un solo corpo, ma un &uuo distinto , C?hc aveva particolari interessi, e vi stor. ArlMHit. t3
veva in opposizione e rivalità cogli allri corpi. La nomina contemporanea di più imperatori, falla da diverse legioni, . ne è una prova.
Quanto dicemmo accenna ad un decad i me,nto delle mi lizie ; e questo decadimento avvenne col volgere dei fiochè giunta per esse la pienezza dei tempi non poterono più servire di base al colosso che sostenevano.
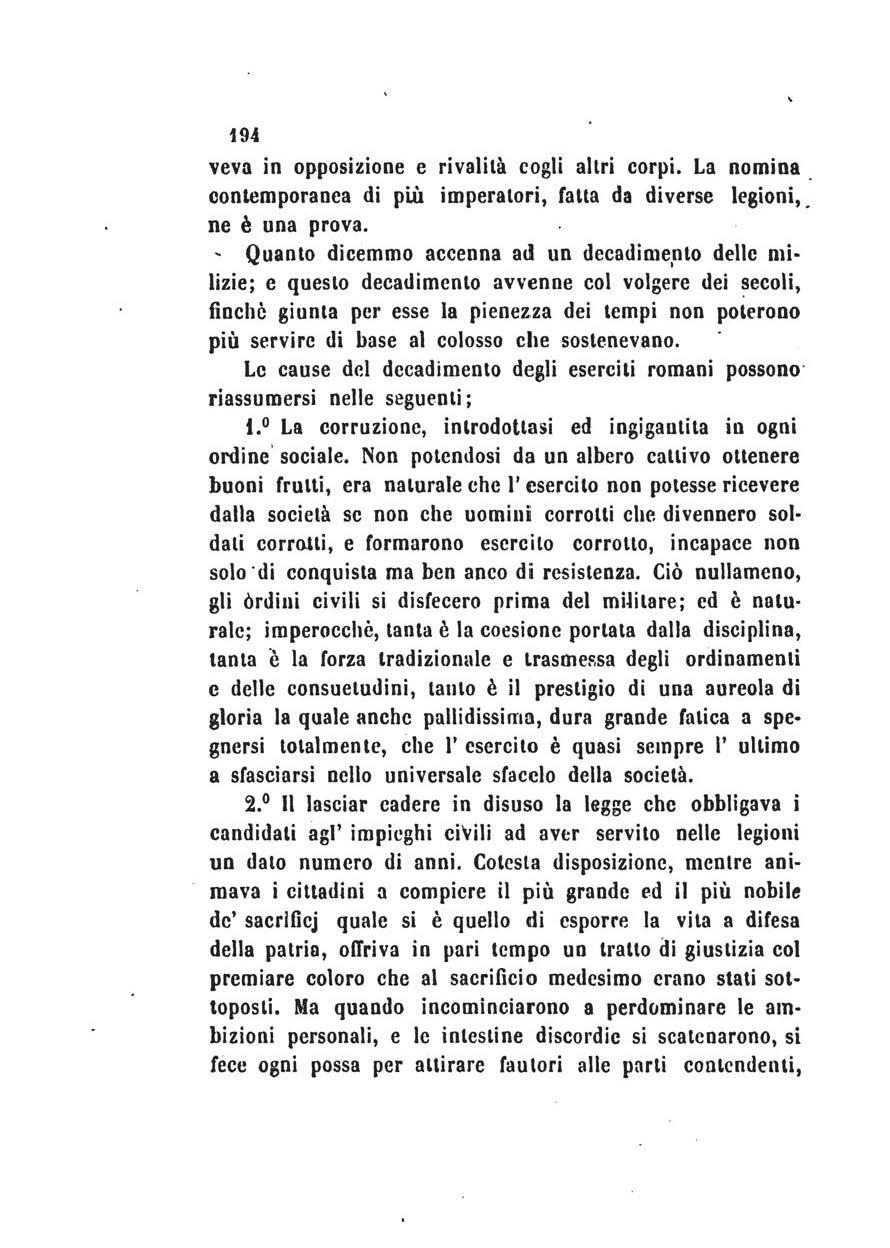
Le cause del decadimento degli eserci ti romani possono · riassumersi nelle s eguenti; t. 0 La corruzione, introdottasi ed ingigantita io ogni ordine' sociale. Non potendosi da un albero cauivo ottenere buoni frutti, era naLurale che l'esercito non potesse ricevere dalla società se non che uomin i corrotti che divennero soldali corro.lti, e formarono esercito corrotto, incapace non solo ·di conquista ma ben anco di resistenza. Ciò nullameno, gli òrdiui civili si disfecero prima del militare; cd è noto· ralc; imperocchè, tanta è la coesione portata dalla disciplina, tanta è la forza tradiz ionule e trasmessa degli ordinamenti e delle consuetudini, tanto è il prestigio di una aureola di gloria la quale anche pallidissima, dura grande fatica a spegnersi totalmente, che l' esercito è quasi sempre l' ultimo a sfasciarsi nello universale sfacelo della società.
2. 0 Il lasciar cadere in disuso la legge che obbligava i candidati agl' impieghi civili ad avtr servito nelle legioni un dato numero di anni. Cotesta disposizione, mentre animava i ci ttadini a compiere il più grande ed il più nobile dc' sacrlficj quale si è quello di esporre la vita a difesa della patrio, offriva in pari tempo un tratto ai gi ustizia col premiare coloro che al sacrificio medesimo erano stati sottoposti. Ma quando incom i nciarono a perd(lminare le ambizioni personali, e le intestine discordie si scatenarono, si fece ogni possa per auirare fautori alle parti conLcndenti,
-f95 e si diedero onori, cariche, ricchezze, a chi, senza aver ratto il tirocinio sul campo, senza essersi nllontanato dai proprj lari , aveva prestato braccio, od era stato strumento d' intrighi, pcl trionfo di parte, od anco si era soltanto umiliato a vili corteggiamenti. Ciò disgustò le milizie; ciò le indispose al servizio . l militi non vedevano più l' onorato e cornotlo riposo dopo le ratichc, le privazioni ed i pericoli.
L'opera di Mario, e la continuazione di essa, di ammeLterc nell' esercito gli emancipati di rresco e gli schiavi; e, peggiorando, di accogliervi i popoli vi nti, i barbari stranieri all' Italia. Mario, come dicemmo, ru tratto alla modificazione della legione ingrossandone di molto i manipolit ossia le unità tattiche, cd avvicinando con ciò aJJa forma falangi ti ca, per questi due motivi speciali:
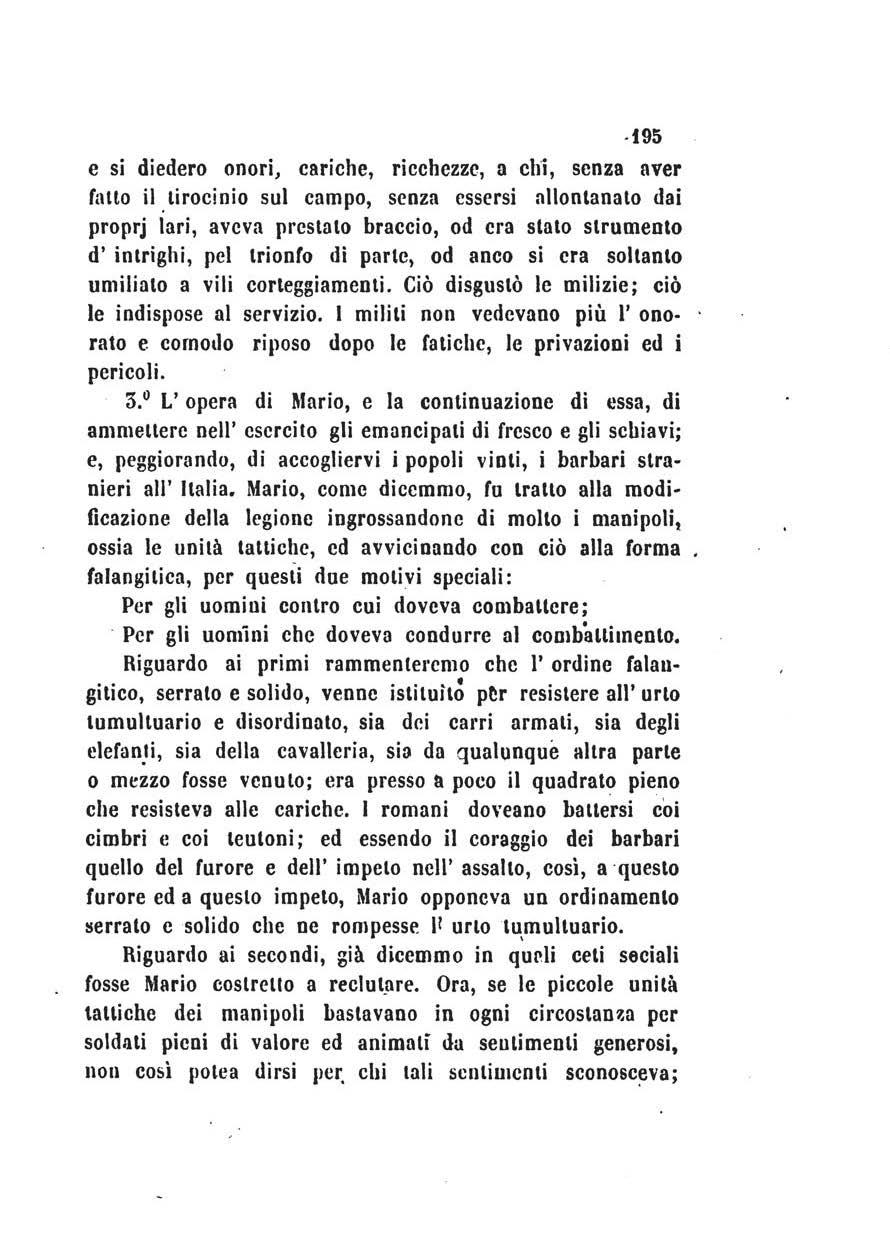
Per gli uomini contro cui doveva combaUcre;
· Per gli uomini che doveva condurre al combauimeoto.
Riguardo ai primi rammenteremo che l' ordine falaugitico, serrato e solido, venne istituito resistere aJJ' urto tumultuario e disordinato, sia dci carri armati , sia degli cleran.ti, sia della cavalleria, sia da qualunque altra parte o mezzo rosse venuto; era presso a poco il quadrato pieno che resisteva alle cariche. l romani do\'eano baue.rsi coi cimbri c coi teutoni ; ed essendo il coraggio dei barbari quello del rurore e dell' impeto nell' assalto, cosi, a ·questo furore ed a questo impeto, Mario opponeva un ordinamento serrato c solido che ne rompesse Il urto tu,multuario.
Riguardo ai secondi, già dicemmo in qur.li celi seciali fosse Mario costretto a reclul,!lre. Ora, se le piccole unità tallichc dei manipoli bastavano in ogni circostan1.a per soldnti pieni di valore ed animati da seutimenli generosi, non così polea dirsi per. chi tali sentimenti
1!)6 codesti uomini, individualmente considerati, avevano mestieri di trarre dal numero quel coraggio che in sè non po· levano avere io grande misura; riuniti in 300 si sentivano più forti che in t20; ed ecco une dei motivi per cui Mario li riunì in 300 piuttosto che in no; rormò il battaglion«! coll' unione di · tre compagnie; sacrificò un poco alla mobi· lità per ottenere la solidità; senza però che questo sacrifizio riducesse pressochè al nulla la mobilità come av,•eniva nella falange greca.
Continuando tale sistema di reclutamento, peggiorando di assai col volgere del tempo, deperì lo ·spirito militare che aveva formato la rorza degli eserciti, ·quando non furono più tuU' uno il cittadino ed il soldato. Ne vennero allora • due ·ceti distinti; nell' uno de' quali i soldati, senz' altro · sentimento che l' avidità del guadagno, riuscirono formidabili agl' imperatori stessi da cui erano sti pendiati, e li fecero e disfecero a capriccio, moltiplicando gl' impacci e la guerra civile.
È facile poi lo "immaginare le conseguenze che derivarono dall' avere ricorso a marcenarj barrbari per contenere e respingere i barbari . .
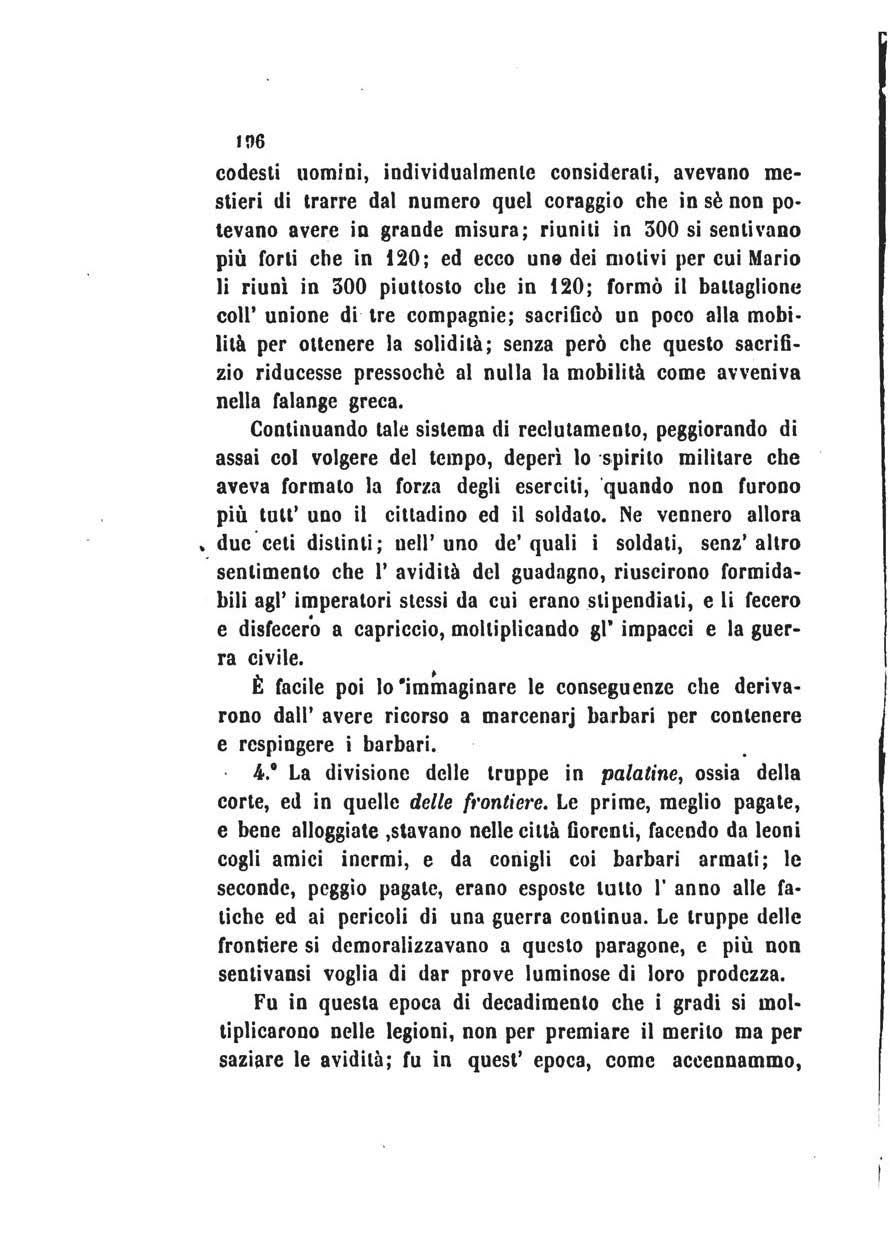
4.• La divisione delle troppe in palatine, ossia della corte, ed in quelle delle fi·ontiere . Le prime, meglio pagate, e bene alloggiate ,stavano nelle ciuà fiorenti, facendo da leoni cogli amici inermi, e da conigli coi barbari armati; le seconde, peggio pagate, erano esposte tutto l' anno alle fa· tiche ed ai pericoli di una guerra continua. Le truppe delle frontiere si demoralizzavano a questo paragone, e più non sentivaosi voglia di dar prove luminose di loro prodezza.
Fu io questa epoca di decadimento che i gradi si moltiplicarono nelle legioni, non per premiare il merito ma per saziare le avidità; ru in quest' epoca, come accennammo,
t97 che si adrlissero e crebbero a gran numero le macchine nelle legioni. La delle macchine porge segno di minore fermezza individuale dr.l soldato; quando la specie di uomini, di cui si compone un esercito, deteriora in forza ed in l' uso delle macchine si moltiplica; perchè è giuocoforza di supplire colla confidenza che il potere di queste armi ispira alle truppe, alla fede che il soldato non ha più in sè medesimo .
Fu pure in quest' epoca che si moltiplicò la fanteria lcggiera. Questa combatteva con armi da tiro, m'e ntrc la lcgionaria di linea combatteva con arma da taglio; la prima indica il combauimento da lonl.ano, la seconda il combat.timcnto di corpo a corpo; l' aumento di numero della prima in proporzione della seconda, dimostra come il pugnare da vici no riuscisse meuo accetto alle mi tizie degenerate.
Da tutto <JUanto abbiamo esposto, chiaramente emerge come tutto il sistema militare abbia sempre avuto' in Roma uno stretto legame colle condizioni della società. Forte e robusto. nei tempi di virtù; fiacco e debole in quelli di corruzione.
Seguendo il sistema da noi adottato, vèdiamo ora come si trovassero le lettere, .le scienze, e le urti, in questo continuo succedersi di guerre secolari che costituiscono 1' espressione principale della vita romana.
Nella pienezza tumultuosa di questa vita, gli studj fu· rono riguardati dai romani meno come occupazione da uomo, cbe come distrazione od abbellimento. Campo. loro era lo sviluppo pratico della vita umana, p:rrticolarmente nella politica; e in tal senso era dircua la loro coltura. Per penetrare nella fastosa arisLocrazia, molto giovavano la nascita e gli avi gloriosi, molto In ricchezza; . ma · più di lutto i ta· lenti la guerra, e quelli pel governo, che dovevano conservare la dominazione acquistata colle armi.
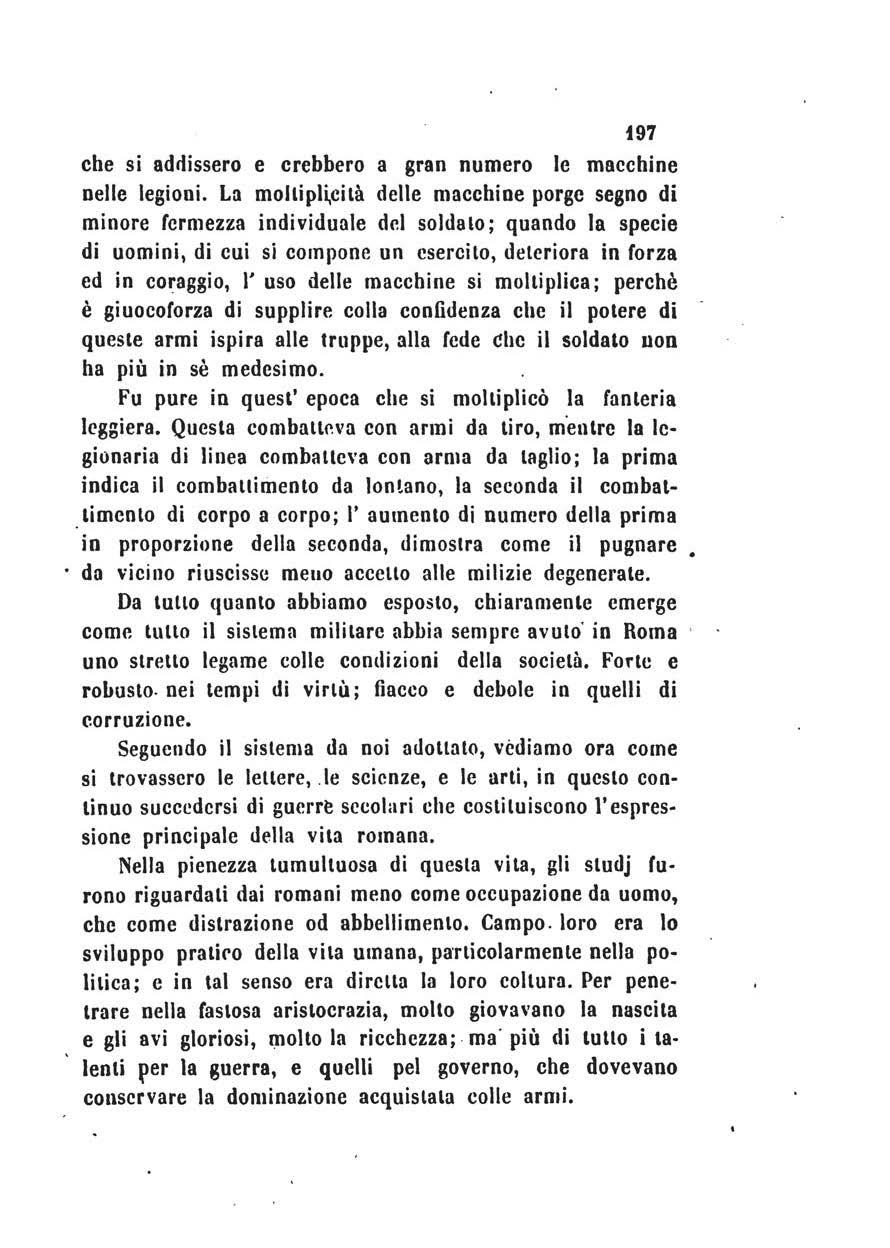
i98
Tanto maggwrc mera\•iglia desta il trovare insignì letterati in uomini assorti nelle pubbliche faccende, e che ci si mostrano più compiuti perchè chiamati ad ogni cosa. In Roma, l' uomo stesso era sacerdote, oratore, lcgista, magistrato, guerriero; il pretore rendeva giustizia i n città, fuori comandava le armi; il questore amministrava in pace le rendite civili, e approvigionava gli eserciti io campo; il console olfriva sacriftzj, delibcrnva in senato, convocava adunanze, soggiogava i nemici, ordinava le provincie. Cesare, il maggior èapitano del suo secolo, sarebbe stato il maggior oratore se l' avesse voluto; dal conquistare le Gallie, ve niva a fare i ·sacrifìcj; dal discutere una cnusa, a compilare il calendario e riformarlo. Egli, più d' ogni al tro informato • delle forze e de i vizj del suo tempo c del suo paese, narrò grandissime geste in piccolo volume; la cui naturale semplicità, e In limpida etl evidente concisione che non . dice una parola più nè meno di quel che impo1·ta, già erano in delizia ai più savj suoi contemporanei. Cicerone, eloquente, poeta, filosofo, stotista, giureconsullo, finanziere,. uomo d'alTari c di slutli, e primo o dci primi a trattar cause, di· rige lungo tempo il senato, combnllc i Parti, e dai soldati che guidò alla vittoria è acclamalo imperatore.
Non è costume annoverare i romani f1·a gli artisti, avt'ndo essi trovato più comodo e più dignitoso l' arricchirsi delle spoglie di allri paesi. Pochissim i artisti romani sono accennati da Plinio; e V.irgilio concede facilmente agli stranieri la gloria «ti ben dipingc1·e, scolpire, astrologare, e fin dell' arr ingare, purchè si serbi a. Roma il vanto di domar popoli e dar lt'ggi •
. Guerra e politica, ecco l'occupazione principale dei romani : ed ceco il perchè le arti non ebbero frll essi il mas· simo sviluppo nè ati allo lustro si portarono.
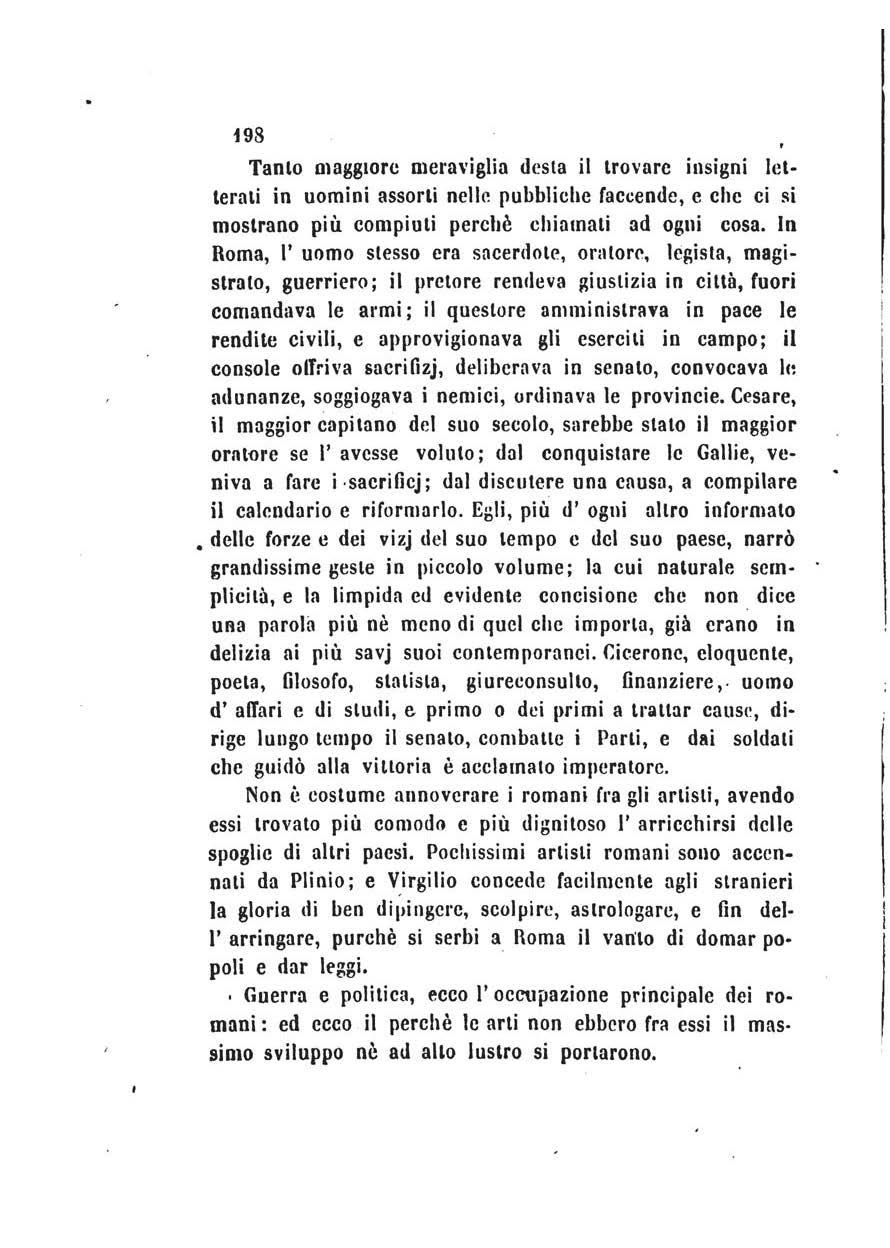
t99
Ma se non grandeggiarono per arti belle , eccelsero però io opere pubbliche di somma utilità, quale la costruzione delle E queste specialmente si collegano allo spirito militare e politico, e n e sono lo più alta espresione. Servivano a condurre ai paesi da conquistarsi e conquistati, ed a mantenersi in comunicazione con essi; per dominare ed unificare.
l romani riful sero io molle circostanze , come già dicemmo , pei felici con cetti strategici dei loro uomini tli guerra . Ardito, ma sfortunato, fu quello che condusse Regolo in Ml'ica; sagace e coronato da buon esito, fu quello cbe vi condusse Scipione.
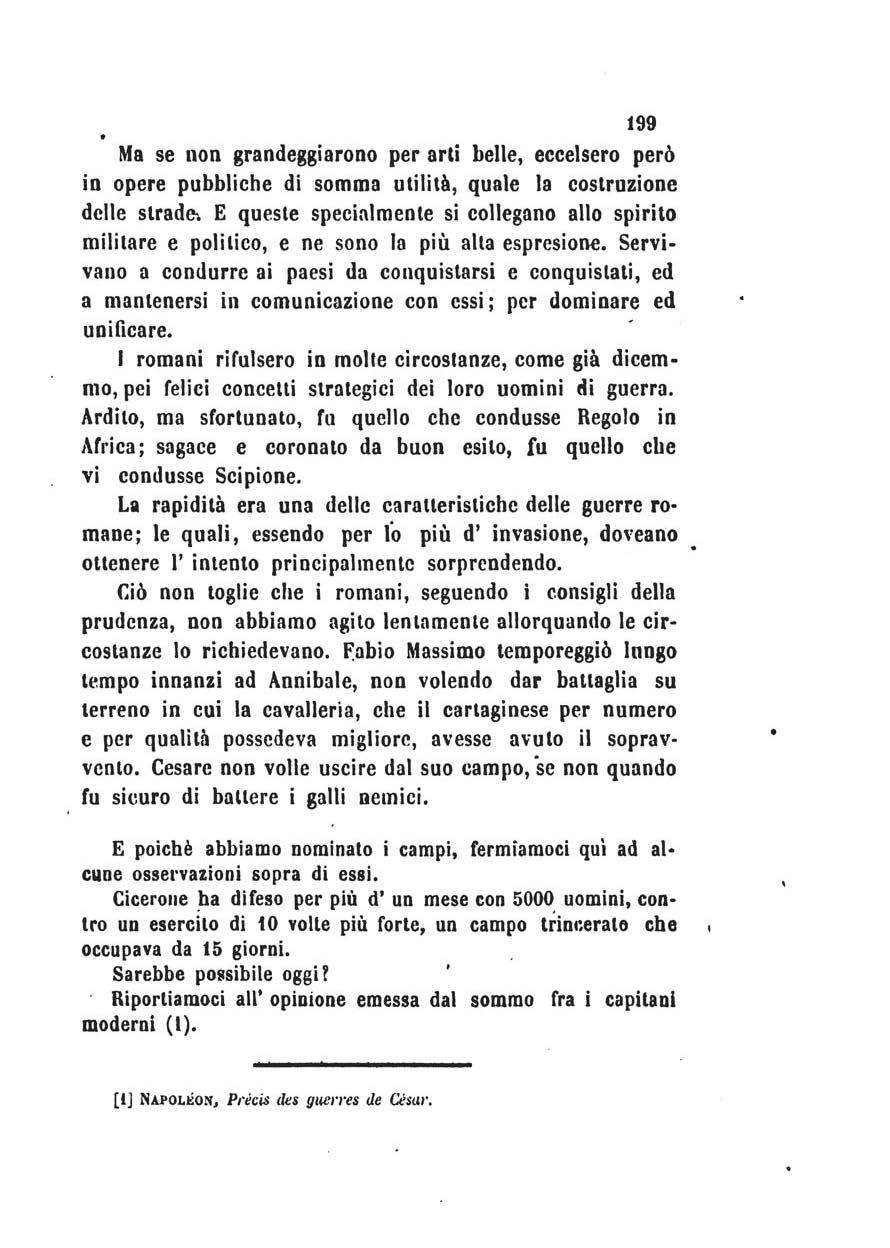
La rapidità era una delle caratter istiche delle guerre ro· maoe; le quali, essendo per lo più d ' invasione, doveano ottenere l' intento principalmente sorprendendo.
Ciò non toglie che i romani, seguendo i consigli della prudenza , non abbiamo agito lentamente allorquando le circostanze lo richiedevano. F:abio Massimo temporeggiò lnogo tempo innanzi ad Annibale, non volendo dar battaglia su terreno in cui la cavalleria , che il cartaginese per numero e per qualità po ssed eva migliore, avesse a vuto il sopravvcnto. Cesare non volle uscire dal suo campo, se non quando fu sicuro di battere i galli nemici.
E poicbè abbiamo nominato i campi, fermiamoci qui ad al· cune ossel'Vazioni sopra di essi.
Cicerone ha difeso per più d' un mese con 5000 uomini, con tro un esercito di 10 volle più forte, un campo che occupava da 15 giorni .
Sarebbe possibile oggi f
· Riportiamoci all ' opinione emessa dal sommo fra i capitani moderni (l).
(t j Ptéc is des g1uwr es de Césw·.
200 ·
Le braccia dei nostri soldati, dice Napoleone, hanno forza e gagliardia pari agli antichi romani; i nostri arnesi da pioonieri o zappatori sono gli stessi; ma abbiamo un agente di più che: è la polvere; talcbè possiamo alzar ripari, scavar fosse, tagliar abbattute, fabbricar torri, in poco tempo e bene, quanto essi; ma le armi offensive dei moderni banno tutt' altra potenza, e operano io maniera differente atfatto da quelle degli antichi .
La natura delle armi in quei antichi era tale che i romani stavano nei loro campi non solo al coperto dagl' insulti di un esercito uguale, ma ben anco di un superiore; erano padroni di combattere, o di aspettare miglior occasione. Mario, assalito da un nugolo di cimbri e di teutoui, si chiude nel campo, vi rimane Ono al giorno in cui l'oc cas ione gli si offre favorevole, ed esce preceduto da Ila vittoria. Cesare, in si mil guisa, arriva vicino al campo di Cicerone; i galli, quattro vo !te più numerosi, abbandonano quest'ultimo, e mà rciano contro Cesare. Il quale, in • poco d' ora, prende posizione, fortifica il campo, tollera paziente gli scherni e le provocazioni di un nemico cui non vuole combattere; ma l' occasione non tarda; esce allora da lulle le parli ed i galli sono vinti. ·
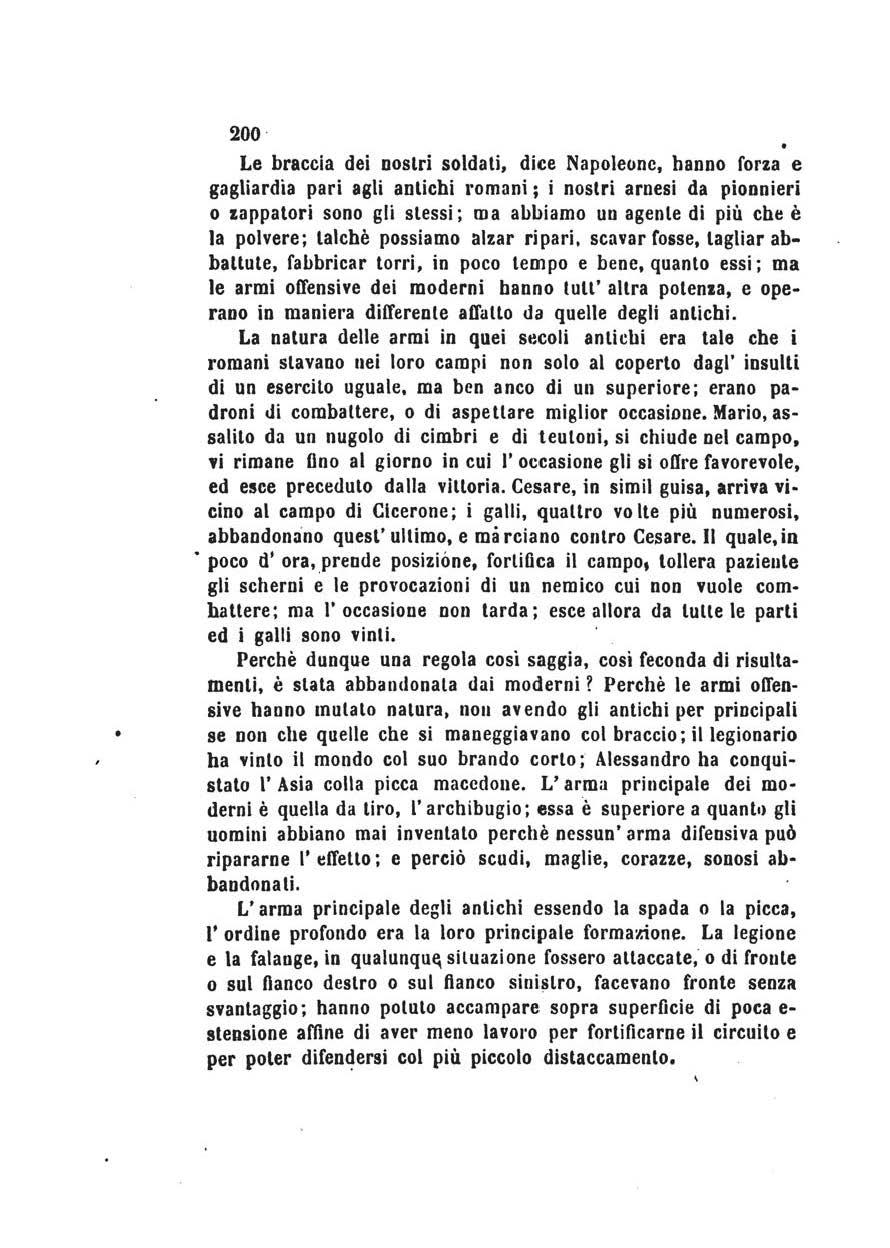
Perchè dunque una regola cosi saggia, cosi feconda di risu ltamenti, è stata abbando nata dai moderni? Perchè le armi offensive hanno mutato natura, non av endo gli antichi per principali se non che quelle che si maneggia vano col braccio; il legionario ba vinto il mondo col suo brando corto; Alessandro ha conquistato l' Asia colla picca maccdone . L'arma principale dei mo· dernl è quella da liro, l'archibugio; essa e superiore a quant•l gli uomini abbiano mai inventato perchè nessun'arma difensiva può ripararne l' c:tTetto; e perciò scudi, maglie , corazze, sonosi abbandonati.
L'arma principale degli antichi essendo la spada o la picca, l' ordine profondo era la loro principale formazione. La legione e la falange, in situazione fossero attaccate; o di froule o sul fianco destro o sul fianco sini!l tro, facevano fronte senza svantaggio; hanno potuto accampare sopra superficie di poca estensione affine di aver meno lavol'o per fortificarne il circuito e per poter col più piccolo distaccamento.
20t
L'arma principale dei moderni essendo da liro, il loro ordine abituale dev'essere più minuto e so.ltile, il quale permette di va· lersi di tutte le macchine da lanciaa-e. Con qneste armi, che col· piscono a grande distanza, i moderni traggono precipuo vantaggio dalla posizione che occupano; se essi dominano, se disordinano o ritardano il nemico, hanno il loro intento. Un esercito moderno deve dunque evitare di essere scomposto, avviluppato, e circon· dalo; e perciò occupare un campo che abbia una fronte estesa quanto la sua linea di battaglia; che se occupasse una superficie , quadra e un .. fronte insufficiente a dislendrrsi, verrebbe preso in mezzo da uu esercito di forza eguale, ed esposto a lutto il fuoco nemico che colpirebbe in lutti i ponti del campo, senza ch'esso potesse rispondervi se non che con piccola parte del suo. In questa posizione sarebbe maltrattato, malgrado le trincere, da un esercito uguale, ed anche inferiore. Il campo moderno non può essere difeso che dallo stesso esercito; c, in mancanza di questo, non polrebb ' esserlo da un piccolo distaccamento.
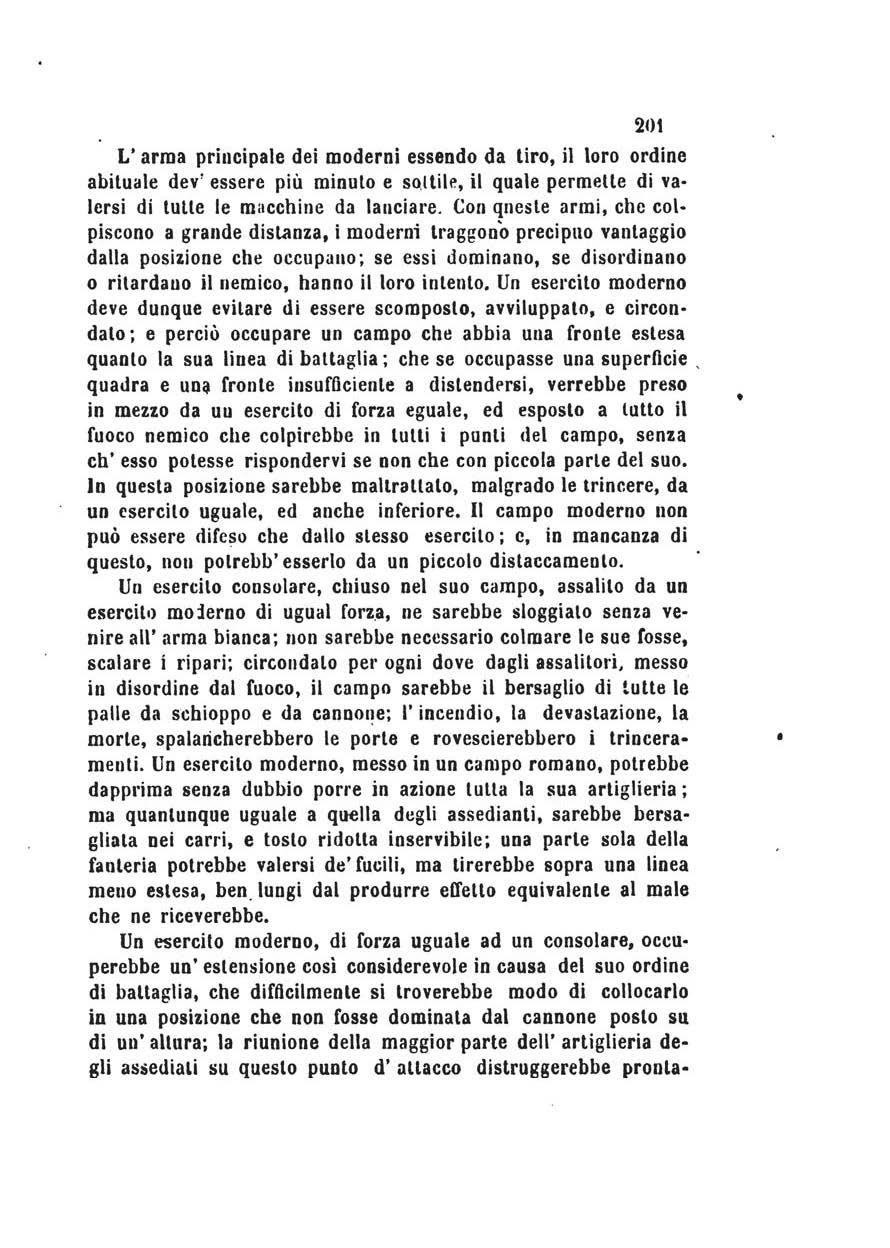
Un esercito consolare, chiuso nel suo campo, assalito da un esercito mo:lerno di ugual forz.a, ne sarebbe sloggiato senza ve· nire all'arma bianca; non sarebbe necessario colmare le sue fosse, scalare i ripari; circondato pet· ogni dove dagli assalitori, messo in disordine dal fuoco, il campo sarebbe il bersaglio di tutte le palle da scbioppo e da cannot!e; l'incendio, la devastazione, la morte, spalancherebbero le porte e rovescierebbero i trincera· menti. Un esercito moderno, messo in un campo romano, potrebbe dapprima senza dubbio porre in azione tutta la sua artiglieria ; ma quantunque uguale a quella degli assedianti, sarebbe bersagliata nei carri, e tosto ridotta inservibile; una parte sola della fanteria potrebbe valersi de' fucili, ma tirerebbe sopra una linea meno estesa, ben. longi dal produrre effetto equivalente al male che ne riceverebbe.
Un esercito moderno , di forza uguale ad un consolare, occu· perebbe un'estensione cosi considerevole io causa del suo ordine di battaglia, che difllcilmeole si troverebbe modo di collocarlo io una posizione che non fosse dominata dal cannone posto su di un'allora; la riunione della maggior parte dell' artiglieria degli su questo punto d' attacco distruggerebbe pronta·
mente i lavori di campagna che formano il campo. Tulle queste considerazioni hanno deciso i condollieri moderni a rinunziare al sistema dei campi tt·inccramcnti nel senso antico della parola, per supplirvi con quello delle po1i1ioni naturalt bene scelte.
Un campo romano era messo dovunque si fosse, purcbè go· desse le proprietà salubri; percbè tutte le località erano buone per eserciti che riponevano la loro forza nell'arma bianca; non importava nè colpo d'occhio, nè (lenio militare, per beo accampare; mentre la scelta delle posizioni, il modo di ol:cuparle e di disporre le armi differenti, profittando delle circostanze del terreno, è parte del genio di un capitano moderno.
La tattica dei moderni è fondata su due principi: 1° Che gli eserciti debbano occupare una fronte che loro permetta di mettere in azione con vantaggio tutte le armi da projetto: 2 11 Ch' essi debbano preferire il vantaggio d' occupare posizioni d' oade dominare da parte le linee nemiche, a quello di essere coperti o da un fosso, o da un parapetto, o da altra fortificazione da campagna.
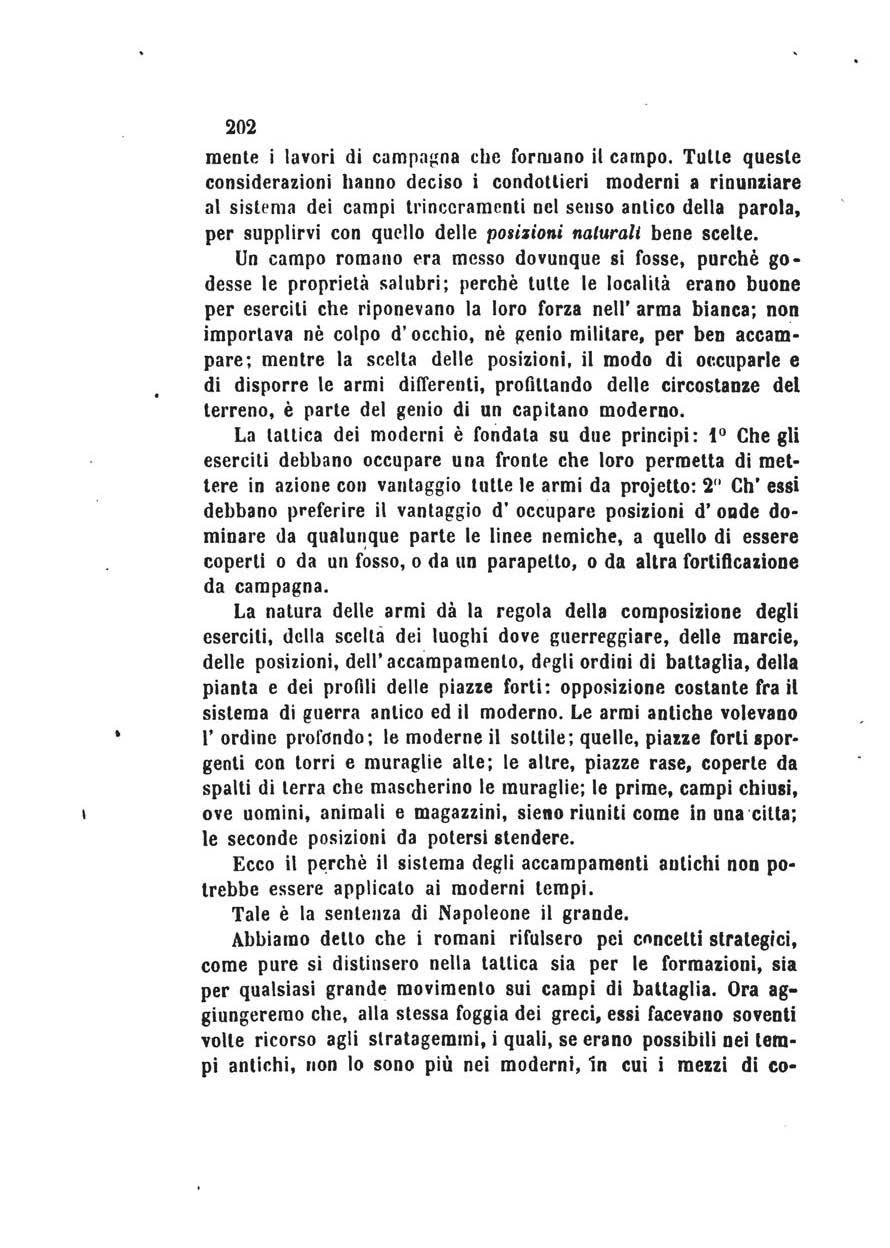
La natura delle armi dà la regola della composizione degli eserciti, della sceltà dei luoghi dove guerregg iare, delle marcie, delle posizioni, dell'accampamento, dPgli ordini di battaglia, della pianta e dei profili delle piazze forli: opposizione costante fra il sistema di guerra antico ed il moderno. Le armi antiche volevano l' ordine pt•ofondo; le moderne il sottile; quelle, piane forli sporgenti con torri e muraglie alte; le altre, piazze rase, coperte da spalli di terra che mascherino le muraglie; le prime, campi chiosi, o ve uomini, animali e magazzini, sieno riuniti come In una citta; le seconde posizioni da potersi stendere.
Ecco il il sistema degli accampamenti aulichi non po· trebbe essere applicato ai moderni tempi.
Ta le è la sentenza di Napoleone il grande.
Abbiamo dello che i romani rifulsero pci cnncetti strategici, come pure si distinsero nella lattica sia per le formazioni, sia per qualsiasi grande movimento sui campi di battaglia. Ora aggiungeremo che, alla stessa foggia dei greci, essi facevano soveoti volte ricorso agli stratagemmi, i quali, se erano possibili nei tempi antir.hi, uon lo sono più nei moderni, In cui i mezzi di co·
..
municazione, d' infot·mazioni1 ed il modo di combattere, sono tali, da rendere impossibile di -condurre il nemico agli stessi errori ed alle medesime illusioni. ·
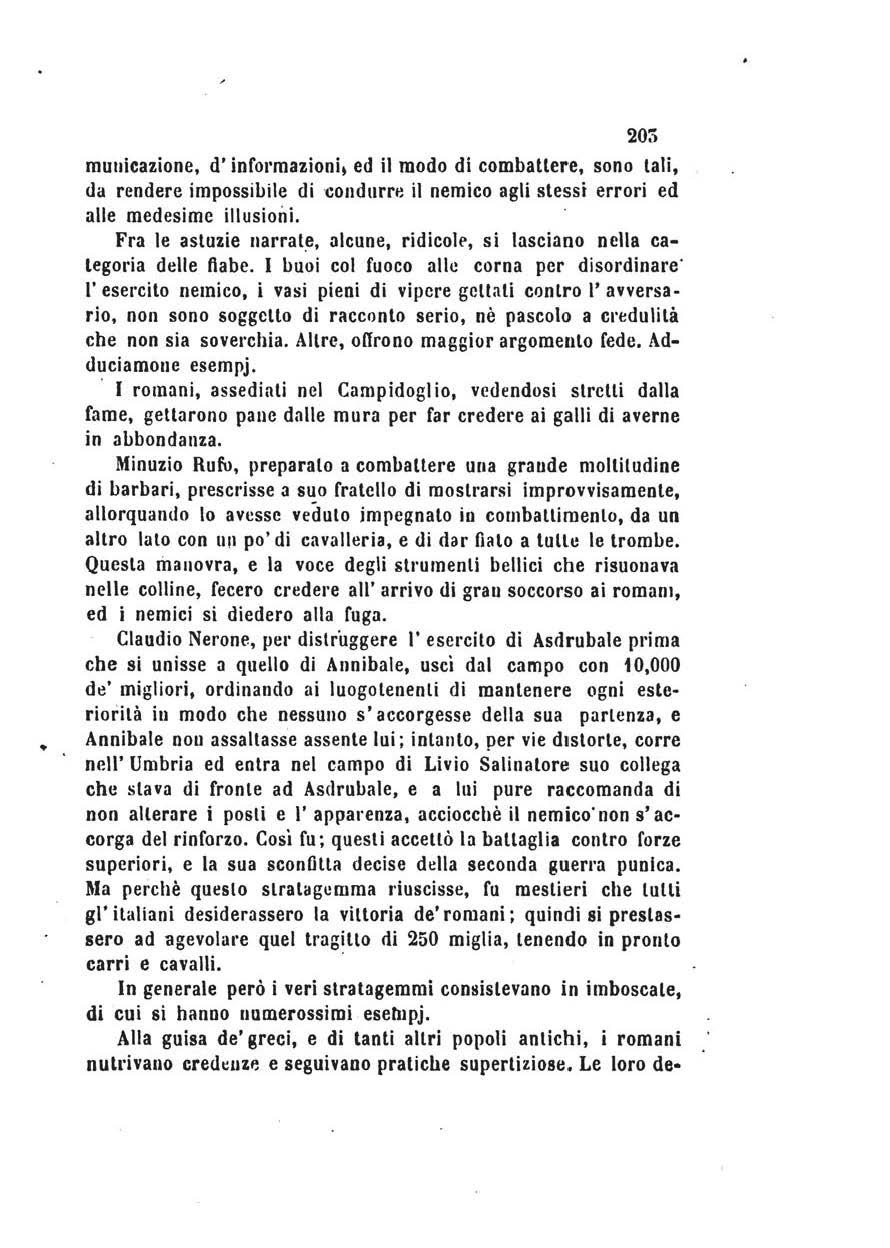
Fra le astuzie alcune, ridicolt>, si lasciano nella categol'ia delle fiabe. l buoi col fuoco alle corna per disordinare· l' eset·cito nemico, i vasi pieni di vipere gettali contro l'avversario , non sono soggetto di racconto serio, nè pascolo a ct·edulità che non sia soverchia. Allre, offrono maggior argomento fede. Adduciamoue esempj.
· l romani, assediati nel Campidoglio, vedendosi stretti dalla fame, gettarono pane dalle mura per far credet·e ai galli di averne in abbondanza.
Minuzio Rufo, preparato a combattere una grande molliludine di barbari, prescrisse a suo fratello di mostrarsi improvvisamente, allorquando lo avesse veduto impegnato io combattimento, da un altro lato con Ull po' di cavalleria, e di dar flato a tutte le trombe. Questa manovra, e la voce degli strumenti bellici che risuonava nelle colline, fecero creder·e all' arrivo di grau soccorso ai romam, ed i nemici si diedero alla fuga.
Claudio Nerone, pet· distruggere l' esercito di Asdrubale pt·ima che si unisse a quello di Annibale, uscì dal campo con 10,000 de' migliori, ordinando ai luogotenenli di mantenere ogni esteriorità in modo che nessuno s'accorgesse della sua partenza, e Annibale non assaltasse assente lui; intanto, per vie d ts torte, corre nell' Umbria ed entra nel campo di Livio Salinatore suo collega che stava di fronte ad Asdrubale, e a lui pure raccomanda di non alterare i posti e l'apparenza, acciocchè il nemico' non s' accorga del rinforzo. Cosi fu; questi accettò la battaglia contro forze superiori, e la sua sconfitta decise della seconda guerra punlca. )la perchè questo stratagemma riuscisse, fu mestieri che lutti gl'italiani desiderassero la vittoria de' romani; quindi si prestassero ad agevolat·e quel tragitto di 250 miglia, Lenendo in pronto carri e cavalli. ·
In generale però i veri stratagemmi consistevano in imboscale, di cui si hanno uamerossimi eseh1pj .
Alla guisa de' greci, e di tanti allri popoli antichi, i romani nutrivano credcuzP. e seguivano pratiche supertiziose. Le loro de·
liberazioni, sulle Imprese e la condotta di guerra, ea·ano subor· dinate alle sentenze degli auguri. Da fatli improvvisi ma natutali,' da fenomeni che facevano eccezione alle regole generali, traevano felici o funesti pt·esagi. Il volo d'uccelli,_ le ecclissi, le pioggie colorate, i caratteri delle viscere degli animali, senivaoo ad essi di consiglio e di guida per tentare o per desistere.
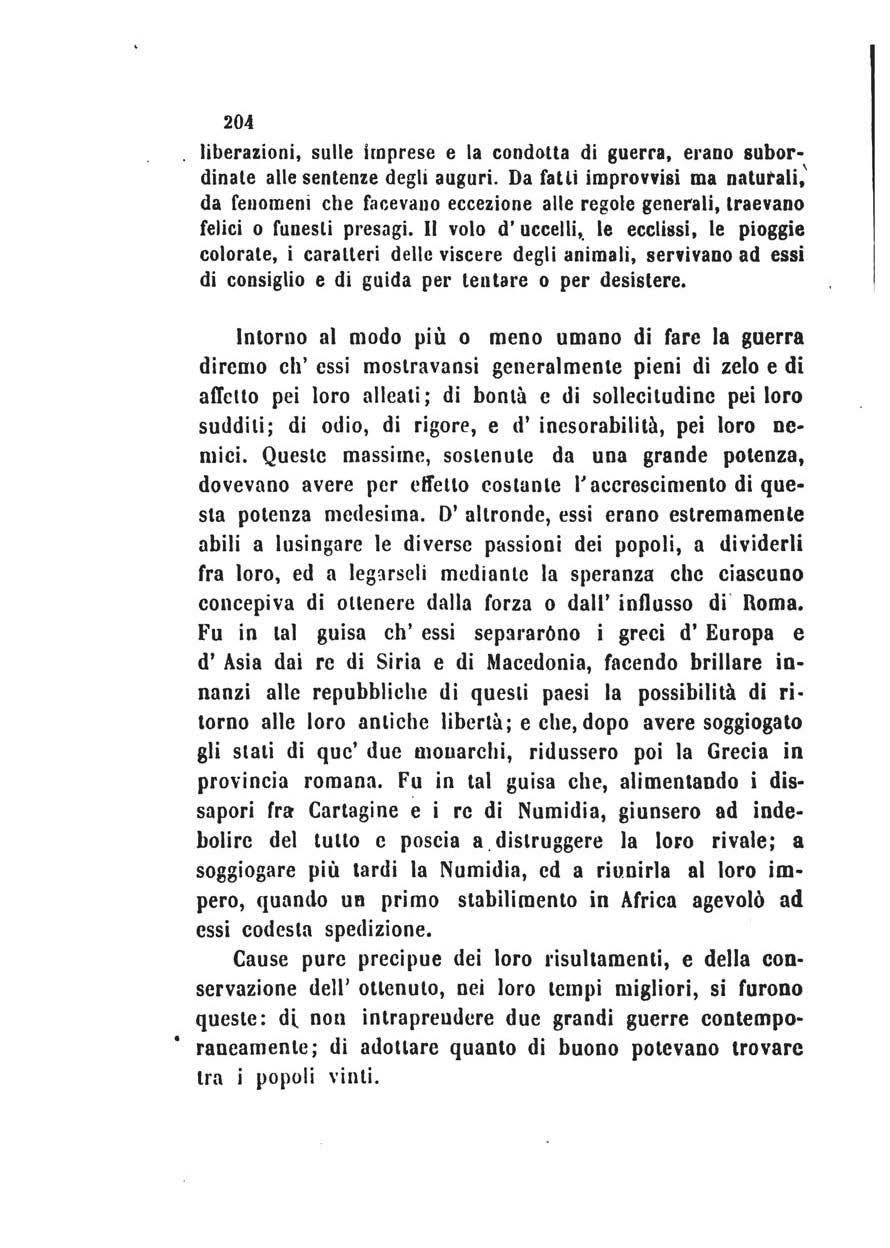
Intorno al modo più o meno umano di fare la guerra diremo ch' essi mostravansi generalmente pieni di zelo e di atrcuo pei loro alleati; di bontà c di sollecitudine pei loro sudditi; di odio, di rigore, e d' inesorabilità, pei loro nemiei. Queste massime, sostenute da una grande potenza, dovevano avere per ctfello costante l'accrescimento di questa potenza medesima. O' altronde, essi erano estremamente abili a lusingare le diverse passioni dei popoli, a dividerli fra loro, ed a leglrs e li mediante la speranza che ciascuno concepiva di ottenere dalla forza o dall' influsso di . Roma . Fu in tal guisa ch' essi sepaa·arOno i greci d' Europa e d' Asia dai re di Siria e di Macedonia, facendo brillare innanzi alle repubbliche di questi paesi la possibilità di ritorno alle loro antiche libertà; e che, dopo avere soggiogato gli stati di quc' due mouarchi, ridussero poi la Grecia in provincia romana. Fu in tal guisa che, alimentando i dissapori fra Cartagine e i re di Numidia, giunsero ad indebolire del tulto c poscia a . distruggere la loro rivale; a soggiogare più tardi la Numidia, ed a rio.oirla al loro impero, quando un primo stabilimento in Africa agevolò ad essi codesta spedizione.
Cause pure precipue dei loro l'isultamenti, e della conservazione dell' ouenuto, oei loro tempi migliori, si furono queste: dl non intrapreudcre due grandi guerre contempo· raocamente; di adouare quanto di buono potevano trovare tra i popoli vinti.
205
Passiamo ora, secondo il nostro sistema, a tracciare al•:uni cenni biografici di qualche grande capitano. E siccome la romana ci presenta tanti nomi insigni da renderei mollo incerti nella scelta, cosi, per ristrettezza dei limiti impostici, lasciamo da oo lato q nello d i Paolo Emilio, di Fabio Massimo, degli Scipioni, di Mario, di Silla, di Sertorio, di Pompeo, di Cicerone, di Antonio, e ci fermiamo soltanto a quello di Cesare, che fu il sommo fra lutti, il romano per eccellenza , il genio di Roma nella sua grandezza, nel ·suo orgoglio, nella sua audacia, o ella sua acutezza, nella sua magnanimità; e nel tempo stessonell' avidità sua, nella frenesia bellicosa, nella sete di potere, nell' allerigia, nell'ambi· zione.
CAJo G1uL10 CESARE. Nacque l' anno di Roma 654, un se· colo avanti l' era volgare, da famiglia patt·izia, che preten·. deva discendere da un lato da Vencre c dall' al .tro da Anco Marzio re di Roma. Era nipote di !\lario per pa1·te di zia.
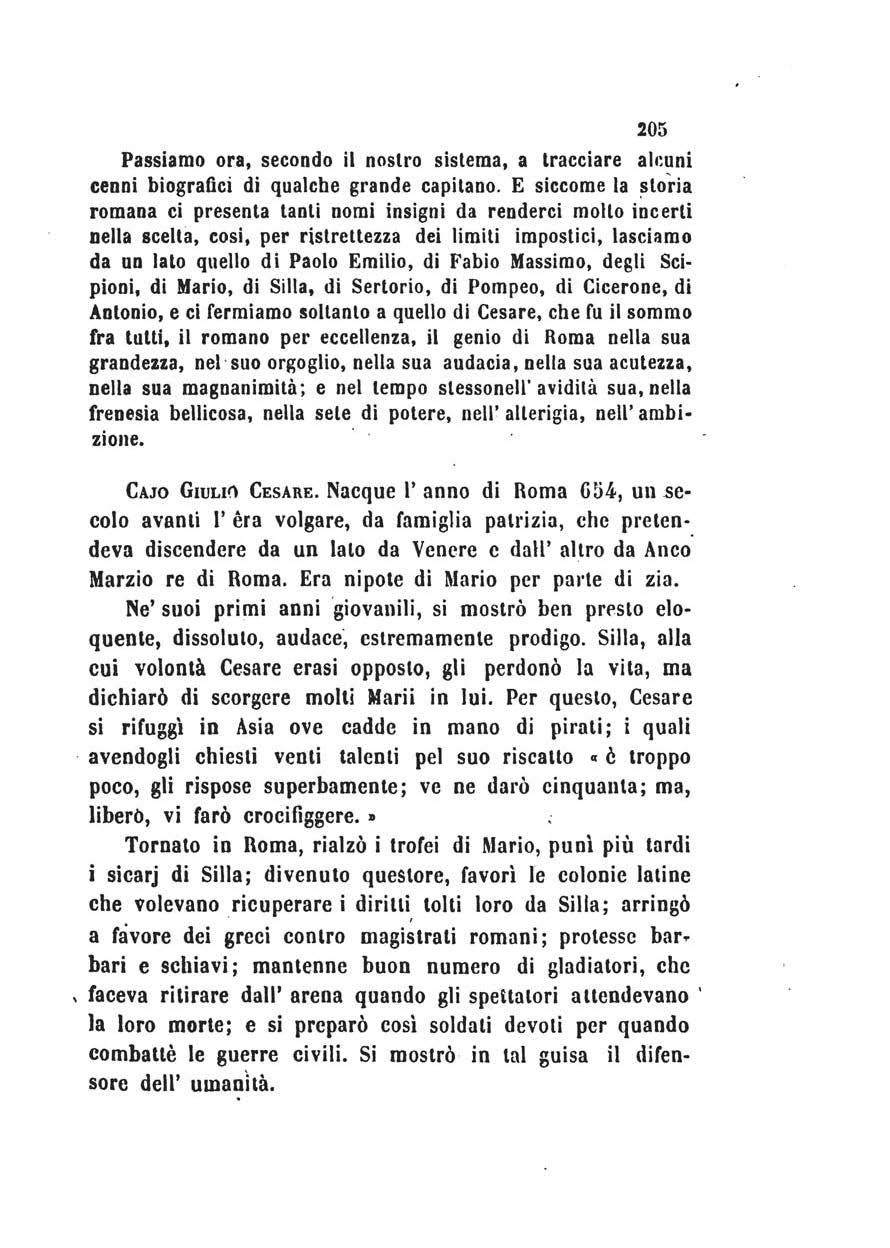
Ne' suoi primi anni 'giovanili, si mostrò ben prr.sto eloquente, dissoluto, estremamente prodigo. Silla, alla cui volontà Cesare crasi opposto, gli perdonò la vita, ma dichiarò di scorgere molli Marii in lui. Per questo, Cesare si rifuggì in Asia ove cadde in mano di pirati; i quali · avendogli chiesti venti talenti pel suo riscatto " è troppo poco, gli rispose superbamente; ve ne dat·ò cinquanta; ma, libero, vi farò crocifiggere. •
Tornato in Roma, rialzò i trofei di Mario, puoi più lardi i sicarj di Silla; divenuto questore, favorì le colonie latine che volevano ricuperare i diritti tolti loro da Silla; arringò ' ' a fàvore dei greci contro magistrati romani; protesse bari e schiavi; mantenne buon numero di gladiatori, che , faceva ritirare dall' arena quando gli spettatori attendevano · la loro morte ; e si preparò così soldati devoti per quando combattè le guerre civili. Si mostrò in tal guisa il difensore dell' uwaoÌtà.
20fì
Governò per alcun tempo la lusitania; e, fatto ritorno in 1\oma, si unì a Pompeo cd a Crasso, cd ottenne il consolato. Propose una legge agraria per dar pane ad una moltitudine sfaccendata c famelica, c pct· ripopolare luoghi deserti d' llalin.
Fallosi dare per cinque anni le Gallic c l' lllirio, vi combattè le guerre di cui parleremo. Durante le quali Roma fu in preda all' anarchia; c, finite, Cesare si trovò per gelosia a fronte di Pompeo, essendo già morlo Crasso che compieva il triumvirato. Pompeo era a capo della parte
· aristocratica, logorrt, i n vece h iato, c senza forza reale; Cesare aveva per lui un esercito obbediente, composto in gran parte di barbari, i quali ignoravano che cosa si fosse noma, la repubblica c le sue leggi. La lotla non poteva essere ugurtle. Cesare passa il Rubicone, c Pompeo fugge, prima a Brindisi, poscia in Epiro. Dopo avere superati c conciliati a sè i pompejaoi di Spagna, si rivolse a Grecia, ovc il rivale aveva raccolto tutte le forze d' Oriente; c venuto con lui a giornata n Farsaglia, lo ruppe e lo Pompeo cercò un asilo in Egitto, c vi trovò la morte.
Cesare ebbe guerra in Egiuo; poi ·passò in Asia, represse Farnacc t'e del Ponto, e fu allora cbe scrisse al senato Vani, Vidi, l'ici .
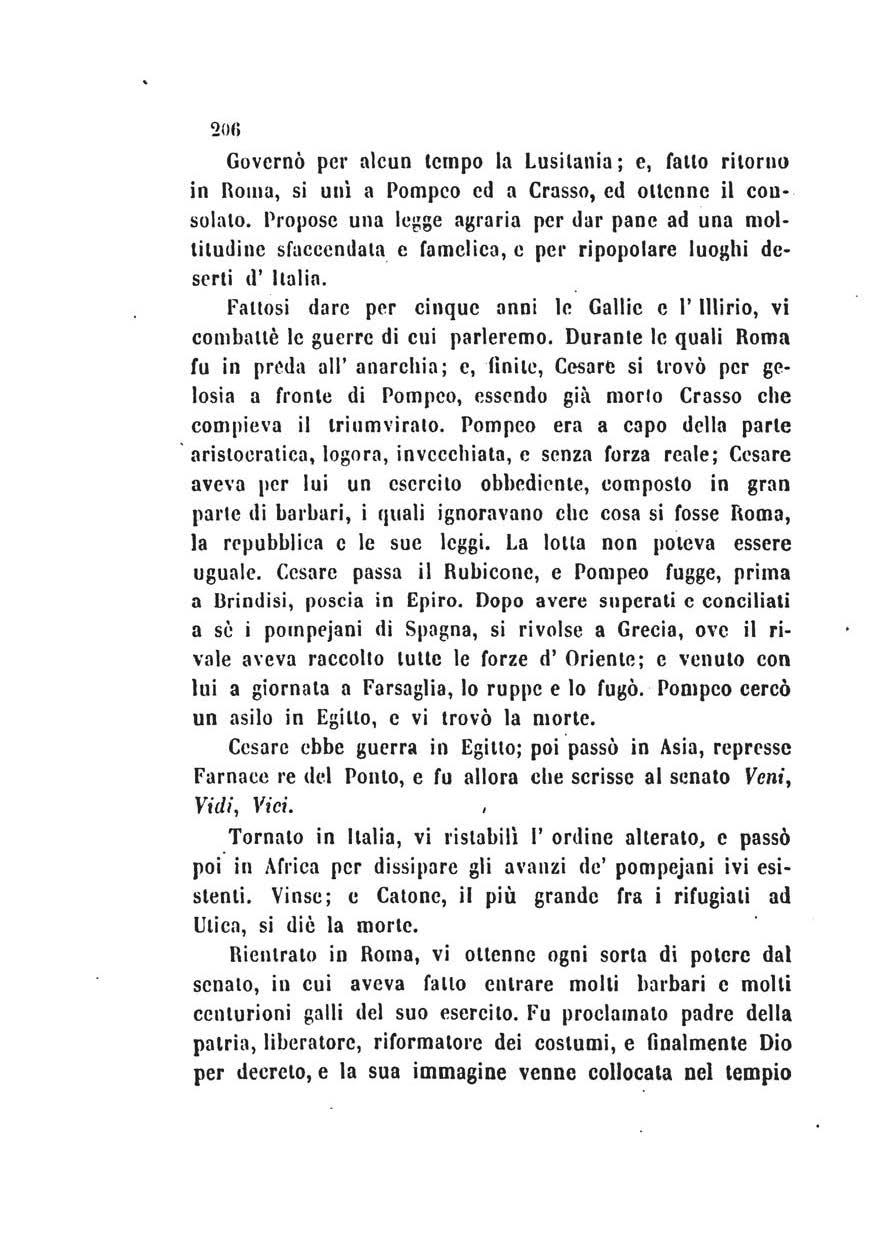
.Tornato in Italia, vi ristabilì l'ordine alterato, c passò poi in Mrica per dissipare gli avanzi dc' pompejani ivi esistenti. Vinse; c Catone, il più grande fra i rifugiati ad Uticn, si ùiè la morte.
flicntrato in Roma, vi ottenne ogni sorta di potere dal senato, in cui aveva fallo entrare molti barbari c molti centurioni galli del suo esercito. Fu proclamato padre della liberatore, riformato•·e dei costumi, e finalmente Dio per decreto, e la sua immagine venne collocata nel tempio
207 di Marte. QuaUro trionfi gli si dccl'ctarono: per le Galli c, per l' Egillo, pel Ponto, per l' Arl'ica .
.CombaLtuti in lspagna i due figli di Pompeo, che vi avevano raccoho un esercito, e vintili a Mumla, fece ritorno in patria, ove intendeva allora di fare nobile uso dd su!l potere dittatorio. Voleva unire tutte le leggi romane in un • codice, e imporle a tutte le nazioni; aprire a Roma un' immensa biblioteca, costruire nel campo di Martc un tempio colossale, riedificare Capua, l:orinto, e Cartagine, tagliare l'istmo di Corinto . Voleva domare i Parti, rinnovare la spedizione di Alessandro, torna1·e a Roma per la Scizia e la Germania.
Morte gli tolse il compimento dc' suoi \'asti disegni. Invidia, gt.llosia, timore di tirannide, suscitarono odj e congiura; e Cesare cadde vittima in senato dr.l pugnale dl Cassio, di Cimbro, di Bruto, c di .altri congiurali.
Fu ardito e prudente, \'aloro so cd accorto; peritissimo nell' arte di ordinare battaglie, pronto ai ripieghi, imperturbato sempre nelle sot·ti mutabili della guerra, nelle spedizioni rapido come lu folgore, lasciò ovunque vest igie profonde del suo passaggio. Le sue vittorie diedero a Roma lo scettro del mondo, e fecero penetrare un raggio di civiltà fra barbare nazioni.
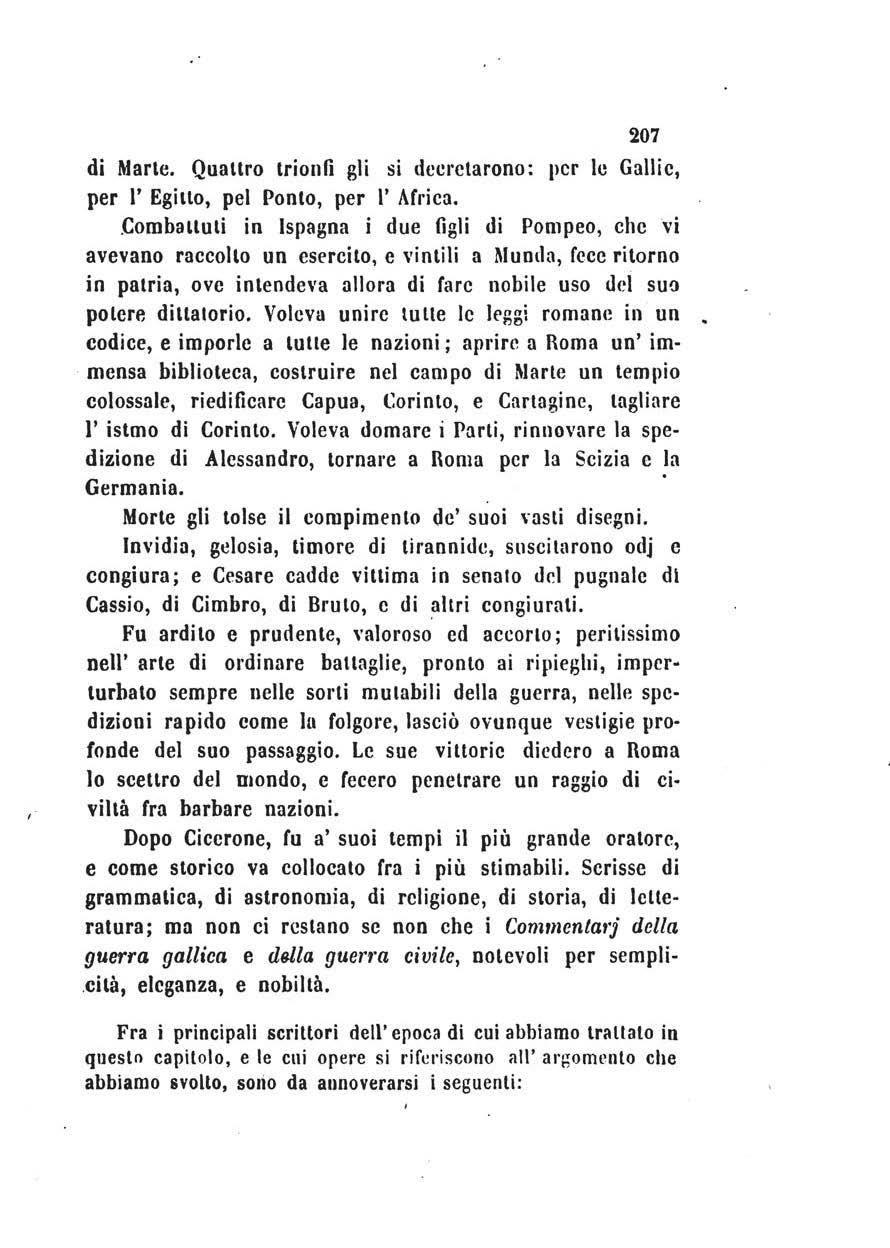
Dopo Cicerone, fu a' suoi tempi il più grande oratore, e come storico va collocato fra i più stimabili. Scrisse di grammatica, di astronomia, di religione, di storia, di letteratura; ma non ci restano se non che i Commentarj della guerra gallica e dslla guerra civile, notevoli per sempli.cità, eleganza, e nobiltà.
Fra i principali scrittori dell'epoca di cui abbiamo trattato io questo capitolo, e le cni opere si rifcl'iscono all' al'gomcnto che abbiamo svolto, sotio da annoverarsi i seguenti:
PoLtnto, Storia ge11erale . E autore degno di fede e di studio. Raccontò gli avvenimenti aopo avervi assistito, od averli veduti sul loro teatro. Ci 'diede una bella pillura delle guerre puniche, e ci mostrò il genio di Annibale qual era, non quale lo dipin· gevano i romani. Uomo di guerra e scrittore, passato parte della sua vita in Grecia , e parte in Roma, ovc fu condotto prigioniero dopo la battaglia di I>idna, potè lasciare un paugone giud izioso del sistema militare greco e romano, della falange e della legione. Fu discepolo di Filopemene ed amico degli Scipioni.
SALLUSTIO, La congiura di Catilina, e la Guerra ài Giugurta. Il primo è libro politico, il secondo militare. L'autore era stato in Africa, procnosole in Mauritania, e scrisse con conoscenza di lqoghl e di avvenimenti. Parlò io modo chiaro e preciso dell'ordine obbliquo di cui si fece l' applicazione nella ballaglia sul Mulolo, fra Giugurta e Metello. E scrittore deganle e conciso.
CKSARK, Commentarj. Trattano delle guerre galliche e delle civili. E una delle opere più importanti dell' antichità; ma per poteri a comprendere bene, è mestieri conoscere bene le istituzioo i militari e politiche dci romani.
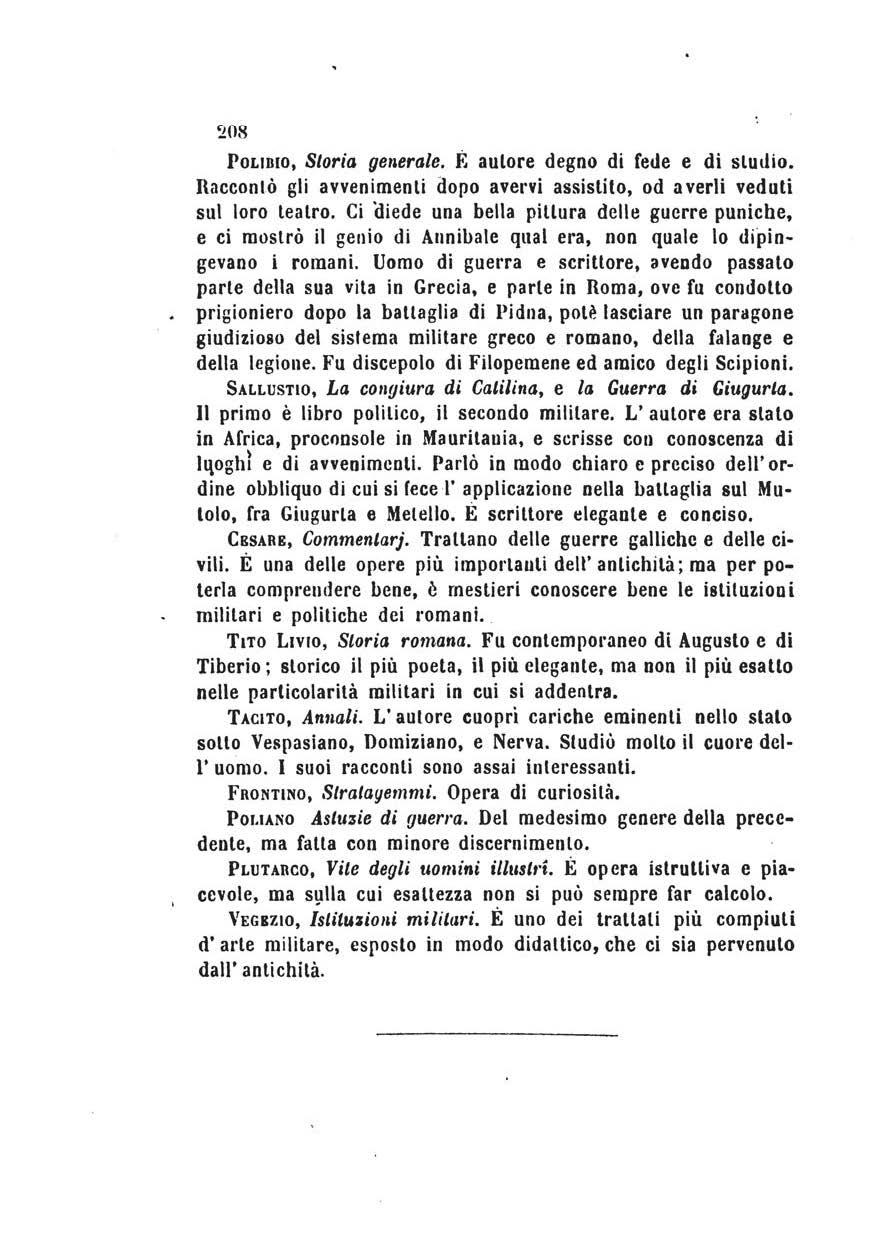
TITO Lmo, Storia romana. Fu contcmpot·aneo di Augusto e di Tiberio; storico il più poeta, il più elegante, ma non il più esatto nelle particolarità militari in cui si addentra.
TActTO, Annali. L'autore cuopri cariche eminenti nello slalo solto Vespasiano, Domiziano, e Nerva. Studiò mollo il cuore dell' uomo. l suoi racc onti sono assai interessanti.
FRONTINO, Stratagemmi. Opera di curiosità.
Por.rANO Astuzie di guerra. Del medesimo genere della precedente, ma falla con minore discernimento.
PLUTAnco, Vite degli uomini illustt'i. È opera istruttiva e piacevole, ma Sl}lla cui esaltezza non si può sempre far calcolo.
VEGBZto, Istitrnio11i E uno dei trattati più compiuti d ' at·te militare, esposto in modo didattico, che ci sia pervenuto dall'antichità.
l eartagioe•l e le guerre puolehe.
Cartagine era sorta rivale a contrastare a Roma l' cstendimento della pot('nza. Essa voleva tutto invadere per brama di ricchezze; Roma aveva lo stesso disegno per giungere unicamente al dominio. L' una assoggettava i popoli amne di obbligarli poscia a coltivare il loro territorio ed apportartene · i prodoui; l' altm soggiogava un paese per trarue soldati che l' ajutasscro a conquistare la contrada adjaccntc. Tutte due, imperturbabili nella loro politica, si servivano alternativamente dell' artificio e della violenza allo scopo di pervenire al eompin:Jento dci loro ,disegni. Ma la potenza commerciante, che voleva trarre grande vantaggio dalle conquiste sue, era obbligata a continuamente nella dipendenza; ment1·e la potenza militare, associando i vinti alle sue opere gloriose, faceva loro più facilmente obliare una sconfitta.
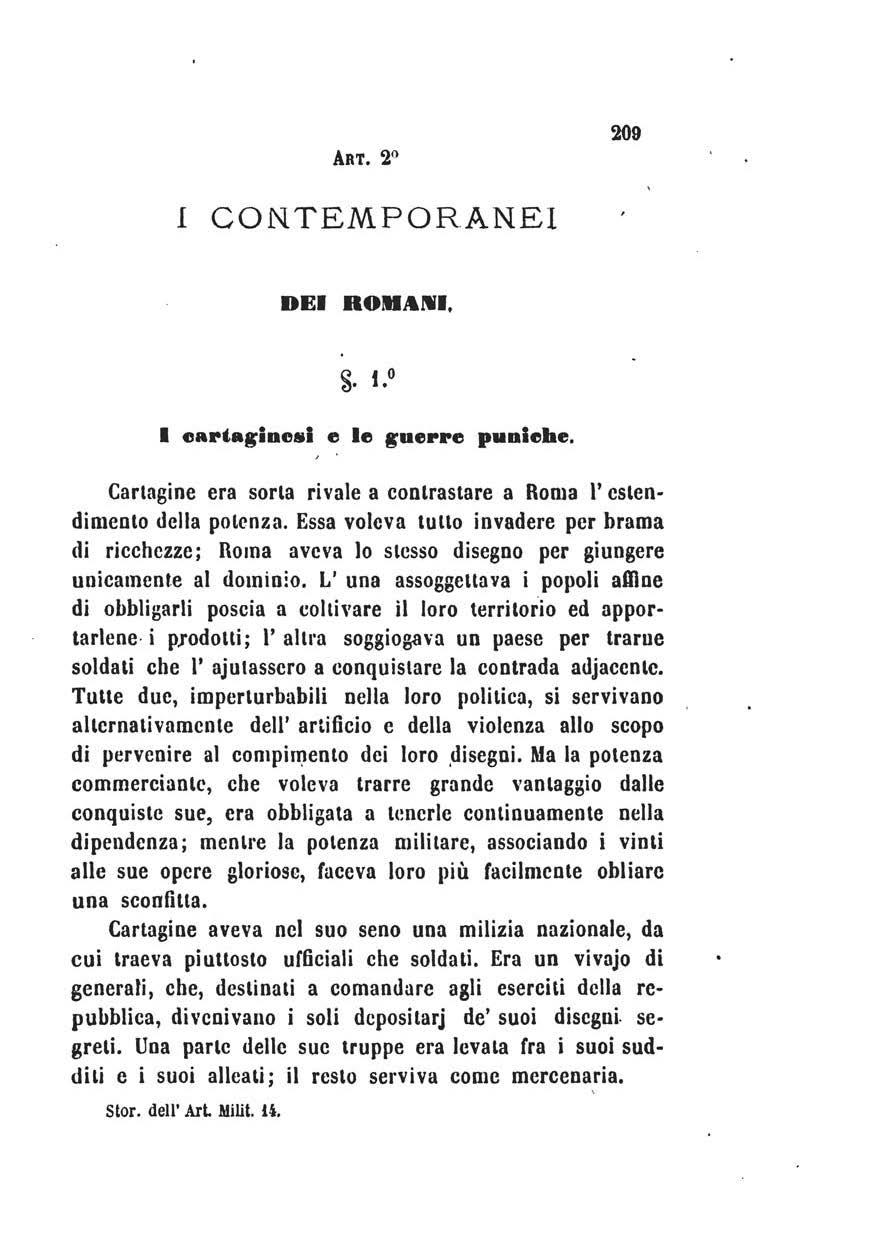
Cartagine aveva nel suo seno una milizia nazionale, da cui traeva piuttosto ufficiali che soldati. Era un vivajo di generali, che, destinati a comandare agli eserciti della repubblica, divenivano i soli depositarj de' suoi disegni. segreti. Una parte delle sue truppe era levata fra i suoi sudditi e i suoi alleati; il resto serviva come mercenaria. '
Stor. dell' ArL Milit. H.
Cartagine faceva combattere ciascun popolo nel modo che gli era più proprio, o cb' esso aveva maggiormente perfèzionato. La Numidia le somministra'<a uri' eccellente cavalleria; le isole Baleari i migliori f•·ombolieri del mondo; la una fanteria prode cd infaticabile; le Galli e, truppe da avamposti tanto audaci quanto intelligenti; Cartagine trovava allrcsì nella Grecia soldati scelti, ugualmente alle più abili manovre, sia nella guerra d! assedio, sia io quella di campagna. ·
Nulla si può dire di particolare sulla disciplina, sulle armi, sulla maniera di accampare, di marciare, di combattere, degli eserciti cartaginesi; imperocchè ciascuno de' popoli che li componevano, conservava lo spirito, gli usi, c i metodi militari che gli erano proprj. In quanto alla fanteria africana, composta dci cilladini mede sim i di Cattagioe, o di quelli riuniti da antichissimo tempo sotto il dominio di Ici, essa era ferma , coraggiosa, ben combatteva in falange, ed aveva le stesse armi e la stessa talLiea dei greci.
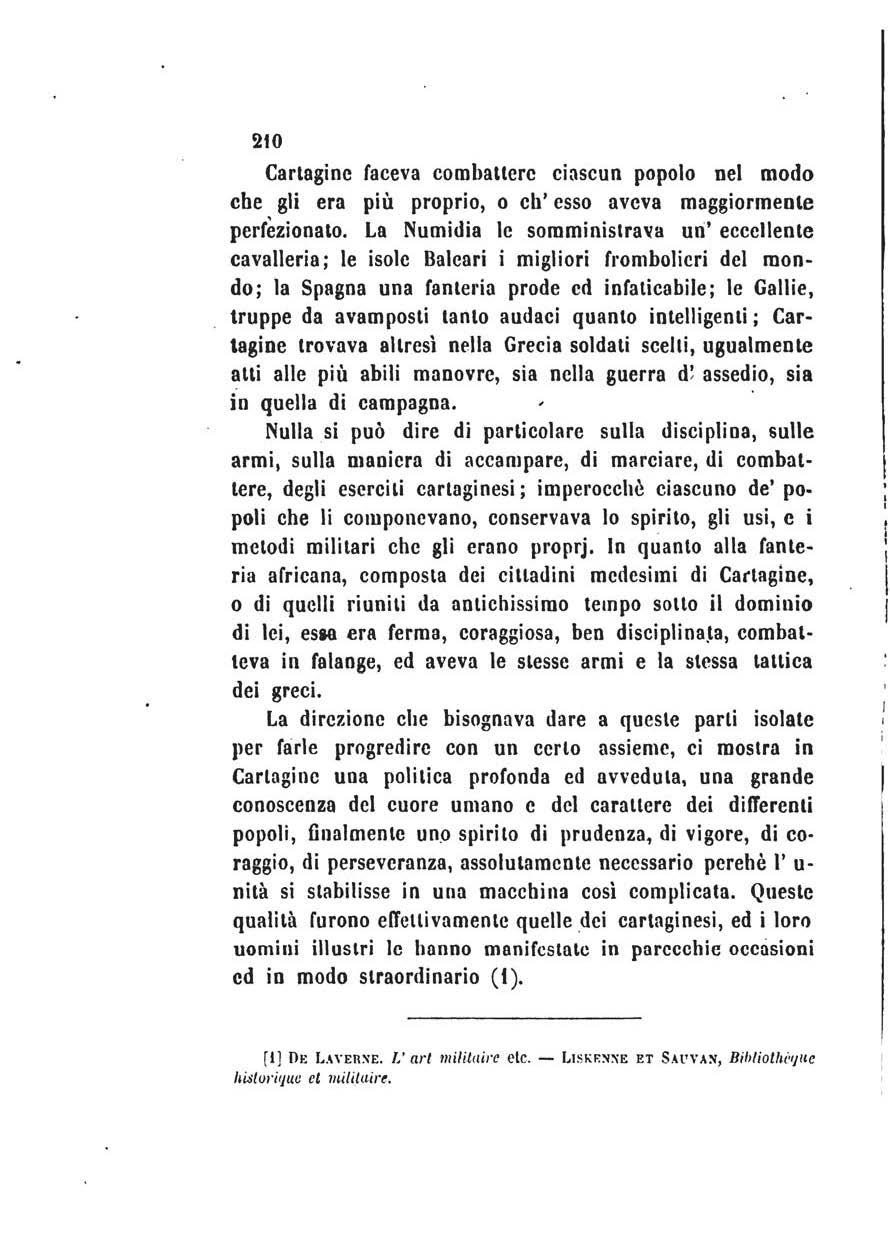
La direzione che bisognava dare a queste parti isolate Jler fàrle progredire con un certo assieme, ci mostra in Cartagine una politica profonda ed avveduta, una grande conoscenza del cuore umano c del carattere dei differenti popoli, finalmente uno spirito di prudenza, di vigore, di co· raggio, di perseveranza, assolutamente necessario perehè l' unità si s tabilis se in una macchina così complicata. Queste qualità furono effettivamente quelle dci cartaginesi, ed i loro uomini illustri le honno manifestate in parecchie occòsioni cd io modo straordinario ( t ).
[ I l Ot: L'a rt milituirc etc.-
Il pretesto della guerra fra cartaginesi c romani, noi l'abbiomo già indica\(\ nel sunto storico allorchll lo attribuimmo al soccorso chiesto dai mamerti ni ai secondi per essere protetti contro ai primi; la causa vera non si disse; era riposta io avidità di dominio, in gelosia da ambo le parti che degenerava in reciproca rivalità.
Le guerre dei cartaginesi coi romani danno prova della loro potenza c della loro perseveranza.
Nella prima di codeste guerre, dette puniclle, è notevole per tattica la battaglia di Tuoisi; ma il concetto non fu complcto; la in colonna delle tre linee di manipoli. r.on fu, come dicemmo, pienamente felice; i vuoti non bastavano al libero passaggio degli elefanti de' cartagioesi.
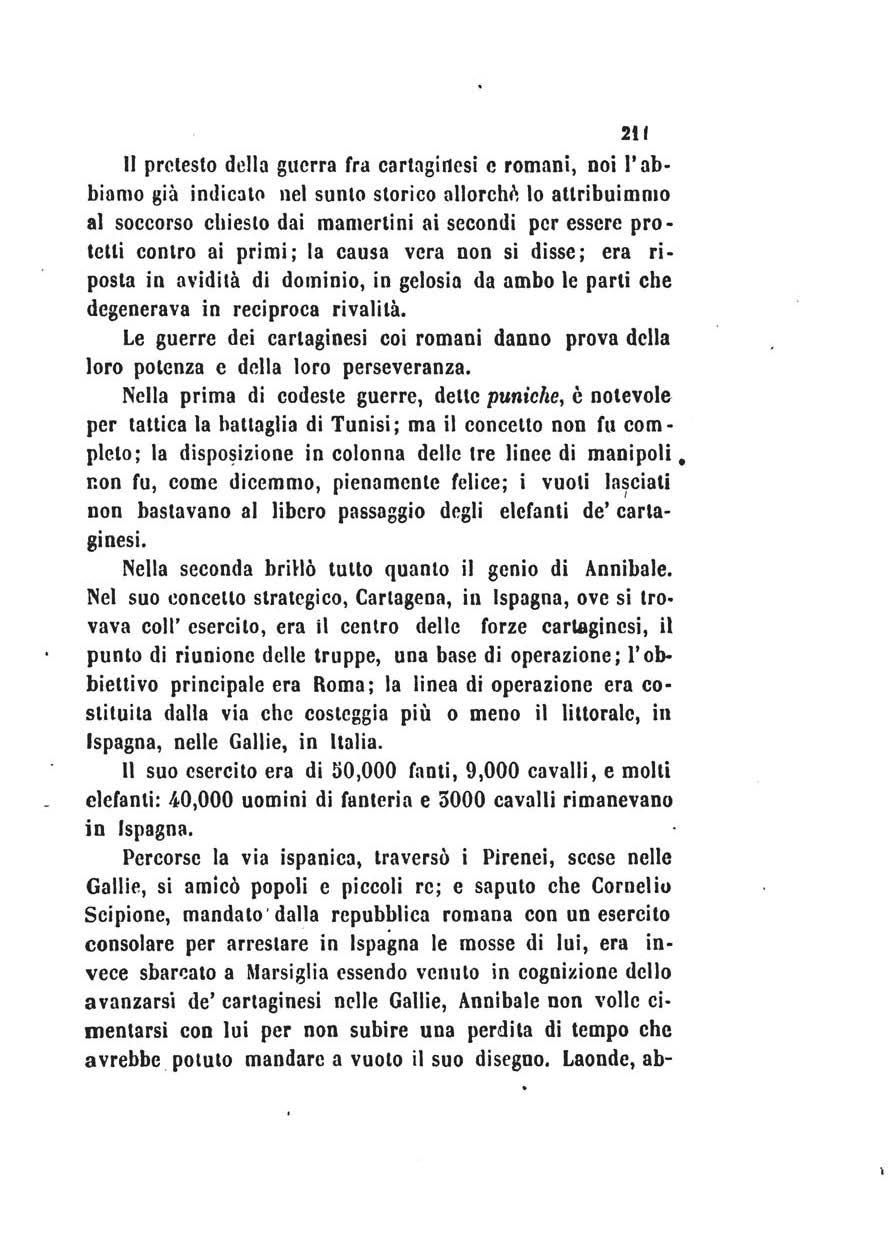
Nella seconda briHò tutto quanto il genio di Annibale. Nel suo concetto strategico, Cartageoa, in lspagna, ove si tro· vava coll' esercito, era il centro delle forze cartaginesi, il punto di riunione delle truppe, una base di operazione; l' obbiettivo principale era Roma; la linea di operazione era costituila dalla via che costeggia più o meno il littoralc, in lspagna, nelle Gallie, in Italia .
Il suo esercito era di 50,000 fanti, 9,000 cavalli, e molti elefanti: 40,000 uomini di fanteria e 5000 cavalli rimanevano io !spagna.
Percorse la via ispanica, traversò i Pirenei, scese nelle Gallie, si amicò popoli c piccoli re; e saputo che Cornelio Scipione, mandato · dalla repubblica romana con un esercito consolare per arrestare in lspagna le mosse di lui, era invece a Marsiglia essendo venuto in cognizione dello avanzarsi de' cartaginesi nelle Gallie, Annibale non ''olle cimentarsi con lui per non subire una perdita di tempo che avrebbe . potuto mandare a vuoto il suo disegno. Laoode, ab-
212 bandonata la prima linea di operazioni, allra ne scelse e fu l'alpina. La marcia nelle gole delle montagne fu ardull percbè fra nemici; e Annibale provvide alla sicurezza dell' e sercito colla buona disposizione delle armi e degl' impedimenti .
lo qual punto abbia eseguito il passaggio delle Alpi non è ben definito; molLi luoghi vengono designati pel vero. Qua· lunque fosse, egli è certo che il passo gli venne contrastato dagli Allobrogi, coi quali dovè combattere se volle continuare il cammino. Se è vero ch'egli sboccasse nelle pianure • subalpine per Augusta Ptetoria, conosciuta oggidì sotto il nome di Aosta , egli vi sarebbe gillnto nel piccolo S. Bernardo, seguendo in tal guisa la via che più in antico bauerono i galli per scendere in Italia, c che allora gli servivano io parte di guida e di ausilio.
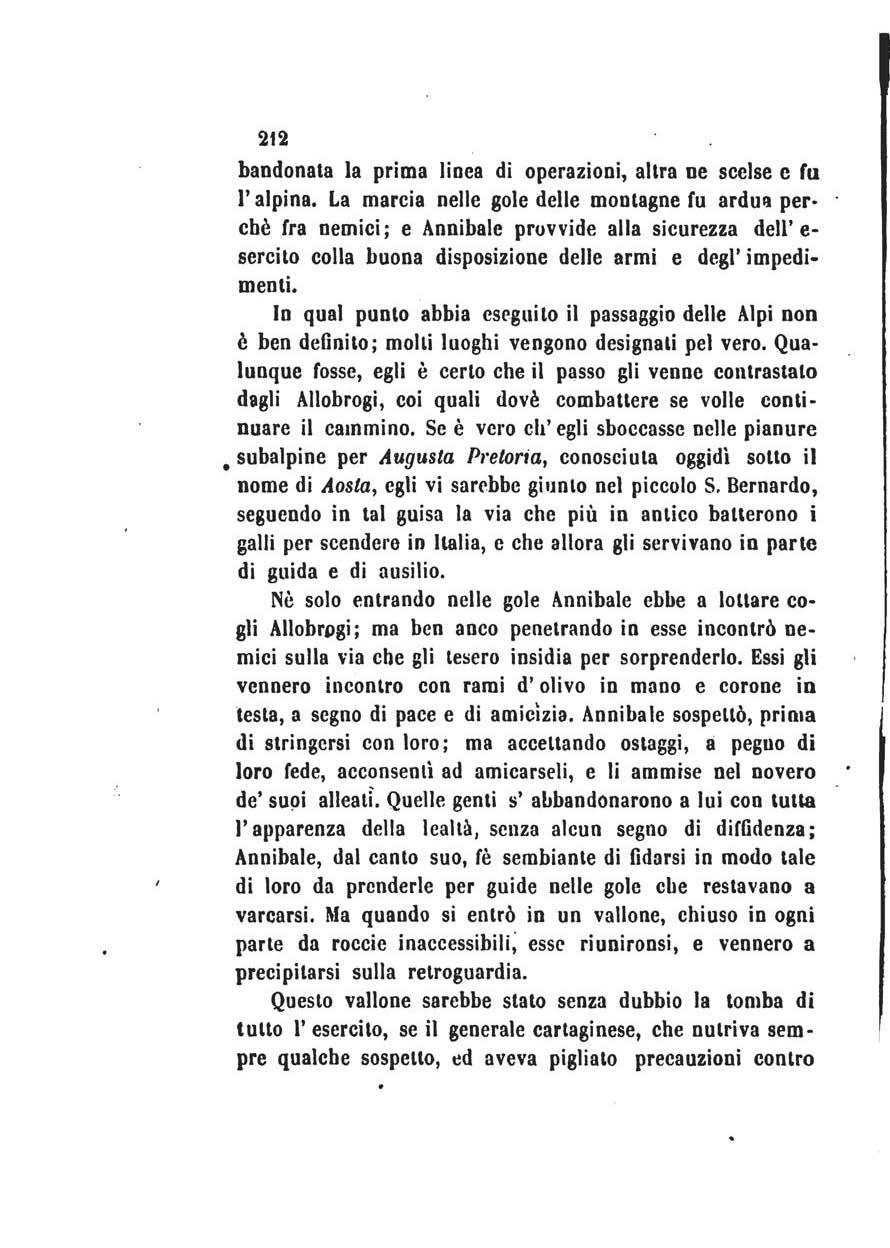
Nè solo entrando nelle gole Annibale ebbe a lottare cogli AllobrDgi; ma beo aoco penetrando in esse incontrò nemici sulla via che gli tesero insidia per sorprenderlo. Essi gli vennero incontro con rami d'olivo io mano e corone in lesta, a segno di pace e di amicizia. Anni ba le sospettò, prima di stringersi con loro; ma accettando ostaggi, a pegno di loro fed e, acconsentì ad amicarseli, e li ammise nel novero de' su!)i alleati. Quelle genti s' abbandonarono a lui con tuua l'apparenza della lealtà, senza alcun segno di diffidenza; Annibale, dal canto suo, fè sembiante di fidarsi in modo tale di loro da prcoderle per guide nelle gole cbe restavano a varcarsi. Ma quando si entrò io un vallone, chiuso in ogni parte da roccie inaccessibili ; esse riuniroosi, e vennero a precipitarsi sulla retroguardia.
Questo vallone sarebbe stato senza dubbio la tomba di tutto l'esercito, se il generale cartaginese, che nutriva sempre qualche sospetto, cd aveva pigliato precauzioni contro
il tradimento, non avesse messo alla testa i bagagli colla cavalleria, e nella retroguardia gli uomini armati pesante· mente. Questa fanteria sostenne lo sforzo de' nemici, e, senza di essa, la perdita sarebbe riuscita assai più grave. Malgrado però tale disposizione, perì grosso numerp d'uomini, di cae di bestie da soma; imperoccbè quelle genti avanzandosi per le alture, mentre i cartaginesi progredivano nella vallata, ora rotolavano 9ra geuavano pietre che spargevano fra le truppe il terrore ed il danno.
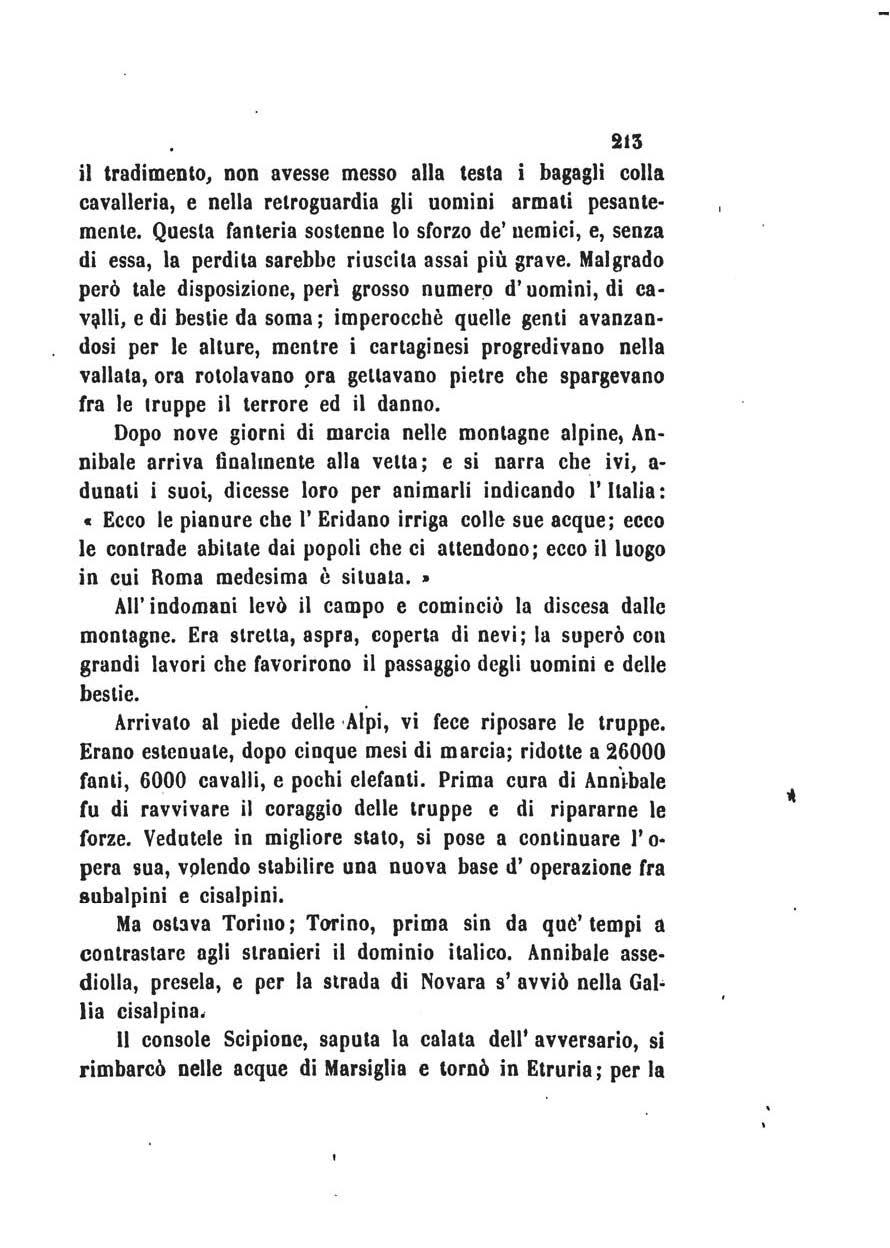
Dopo nove giorni di marcia nelle montagne alpine, Annibale arriva finalmente alla veua; e si narra che iv i, adunati i suoi, dicesse loro per animarli indicando l' Italia: • Ecco le pianure che l' Eridano irriga colle sue acque; ecco le contrade abitate dai popoli che ci attendono; ecco il luogo in cui Roma medesima è situata. •
All'indomani levò il campo e cominciò la discesa dalle montagne. Era stretta, aspra, eoperta di nevi; la superò con grandi lavori che favorirono il passaggio degli uomini e delle bestie.
Arrivato al piede delle ·Alpi, vi fece riposare le truppe. Erano estenuate, dopo cinque mesi di marcia; ridotte a 26000 fanti, 6000 cavalli, e pochi elefanti. Prima cura di fu di ravvivare il coraggio delle truppe e di ripararne le forze. Vedutele in migliore stato, si pose a continuare l'opera gua, vplendo stabilire una nuova base d' operazione fra subalpini e cisalpini.
Ma ostava Torino; Torino, prima sin da que' tempi a contrastare agli stranieri il dominio italico. Annibale assediolla, prcsela, e per la strada di Novara s' avviò nella Gal• lia cisalpina.
Il console Scipione, saputa la calata dell'avversario, si rimbarcò nelle acque di Marsiglia e tornò in Etruria; per la
..
2f..t la via di Pontremoli e Borgotaro si portò a Piacenza, colonia e di lì a Pavia c sulla sinistra del Ticino. Annibale si avanzò verso di lui costeggiando lo stesso fiume. S'incontrarono, e si diede il combattimento del Ticino.
Fu di cavalleria dalla parte de' cartaginesi; di cavalleria c vcliti da quella de' romani. La pa·icna su di una sola linea, i seconJi su due: vcliti nella prima linea romana a gruppi corrispondenti agl' intervalli posteriori. delle turme, c.wallieri nella seconda. l veliri furono resp inti , e si ritirarono in seconda linea: quindi fuvvi combattimento fra le due ca\'nllerie, deciso in favore dri cartaginesi da auaechi di rovescio dati dalle loro ali sui vcliti romani che posero tullo in disordine.
1..' esercito romano si ritirò sulla driua del Po c si accampò vicino. a Piacenza, alla destra della Trebbia,· io terreno vantaggioso alla fanteria, non tanto alle manovre d'ella cavalleria. lvi Seipionc ricevè i rinforzi che il console Sempronio suo collega gli conduceva da Rimini.
Annibale, ricc\'uto soccorsi d'uomini e di viveri dagli abitanti della riva sinistra del Po, accampò a cinque miglia dai romani, s' impadronì di Cas teggio che conteneva considerevoli magazzini, ne fece punto d'appoggio per le ulteriori operazioni, e offrì bauaglia sulla si oistra della Trebbia, rifiutata da Sci pione, accettata da Sempronio irriflessivo e presuntuoso.
l cartaginesi a\'evano 26,000 fanti compres i i galli reclutati ; tO,OOO cavnllieri fra numidi e galli. l romani avevano due eserciti' consolari.
La Trebbia scorreva tra i due eserciti. Annibale, che da qualche tempo nvcva riconosciuto il terreno, sapeva di ésserc separato dol nemico da un tratto piano e scoperto, nel qualt scorreva a fì:anco un ruscello le cui rive, abbastanza
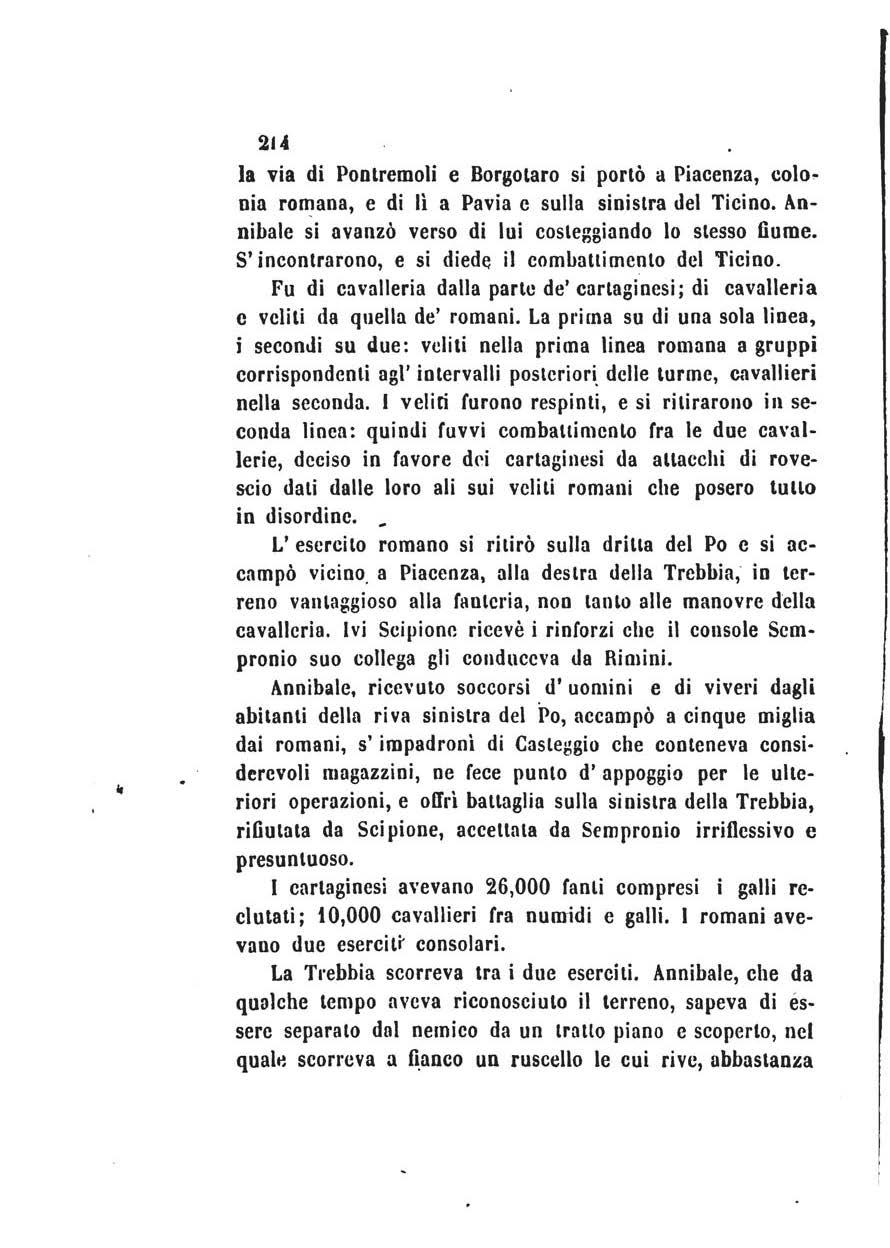
alle, erano coperte da folti cespugli. Parvegli che ruscello e cespugli fossero adatti ad un'imboscata, e vi fece uascon · dere Magone suo fratello con truppa scella di t 000 cavalli e 1000 fanti.
Ma tratlavaai di attirare Sempronio nel piano; e, affine di pervenirvi, Annibale diè ordine a suoi numi di di altraversare la Trebbia verso la punta del giorno, e di voheg.giare innanzi alte. lineè del console. Le truppe cartaginesi avevano mangiato di buon' ora, i cavalli erano governati, le armi si trovavano in ottimo stato .
Sempronio non aveva preso alcuna di queste precauzioni; contuLtociò diè ordine alla cavalleria di muoversi e di cominciare la zuffa; la fece seguire da .6000 veliti, cd egli medesimo, col. resto delle uscì dal campo.
Ma i oumidi avevano ordine di ripassare il fiume, e di fuggire io disordine dinnanzi alle truppe del console.
Era nel pieno l' inverno, e cadeva fittissima la neve. Nondimeno i romani partirono pieni d'ardore ed impazienza; ma quando passarono la Trebbia, goufia in quel giorno dai torrenti delle vicine montagne, l'acqua che giungeva fin sotto alle loro ascelle, il freddo, e la fame, li indebolirono d' assai.
Volendo nascondere le sue disposizioni, Annibale fece marciare le .sue truppe le,<;giere, e le seguì alla testa di tutto . l' esercito. Si schierò poscia su di una sola lineà. La sua fanteria, composta di galli, spagnuoli ed africani, occupò il centro. La cavalleria · fu collocata alle ali. Annibale estese l!l sua linea di battaglia col mezzo di truppe poste a dritta cd a manca della sua fanteria pesante, e coperte da' suoi elefanti.
L'ordinanza della fanteria romana era la solita; a scacchiere; la cavalleria alle ali.
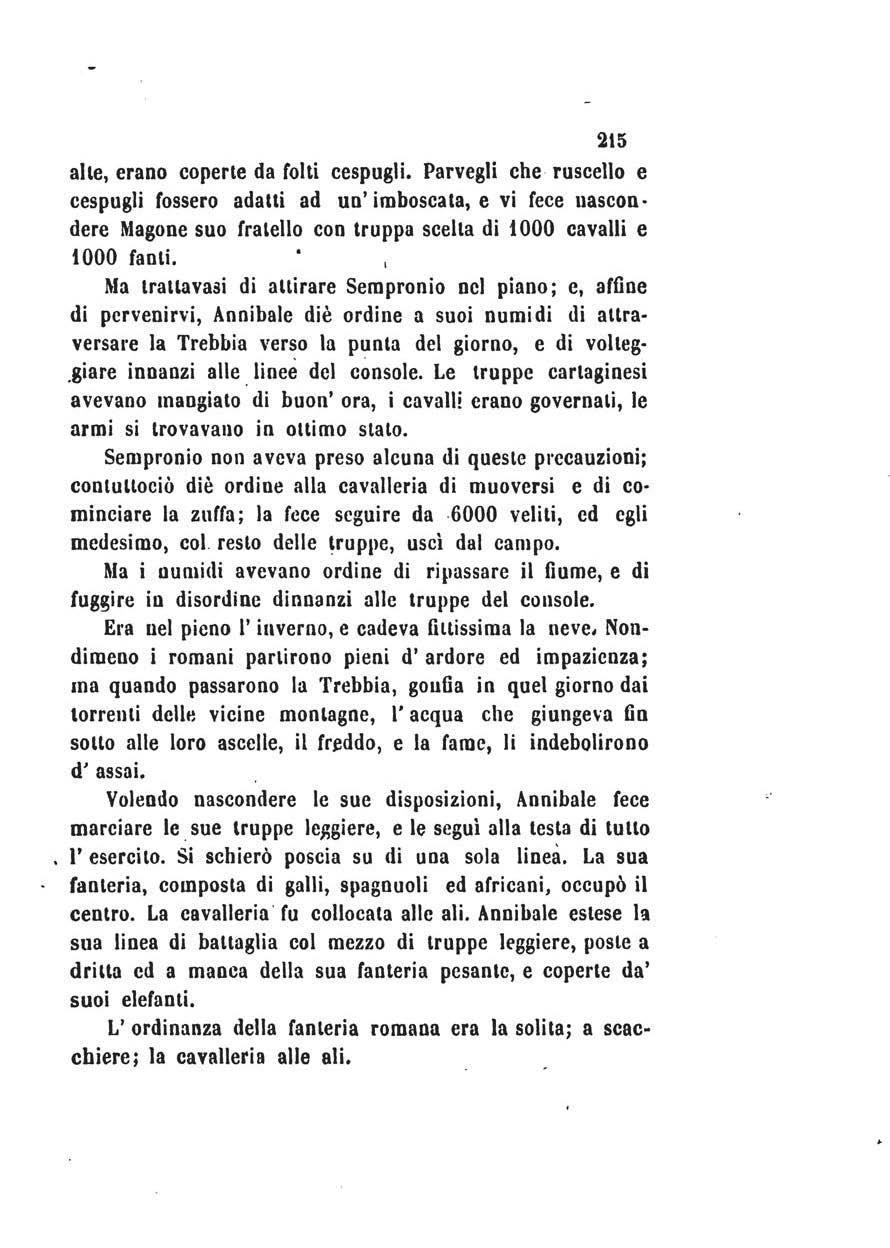
Dalla parte dei romani stavano soldati che sino dal mattino soffrivano freddo e fame, ed i cui dardi erano stati lanciati per la maggior parte nel combattimento contro i numidi. La cavalleria, tutto l'esercito, era u·gualmcnte nell'estrema difficoltà di agire. Nulla di tutto ciò dal lato dei cartaginesi: freschi, vigorosi, pieni di ardore, niuna cosa impediva loro di compiere il dovere.
La battaglia si combauè in ordine parallelo dalla parte de' romani, nel 4° ordine di Vegezio da quella de cartaginesi. Questi avnnzarono le due ali, ossia la cavalleria che sfondò la romana, e prese di rovescio il corpo d'armala col. concorso delle truppe d'imboscata che coadiuvarono a ·bauere a tergo. .
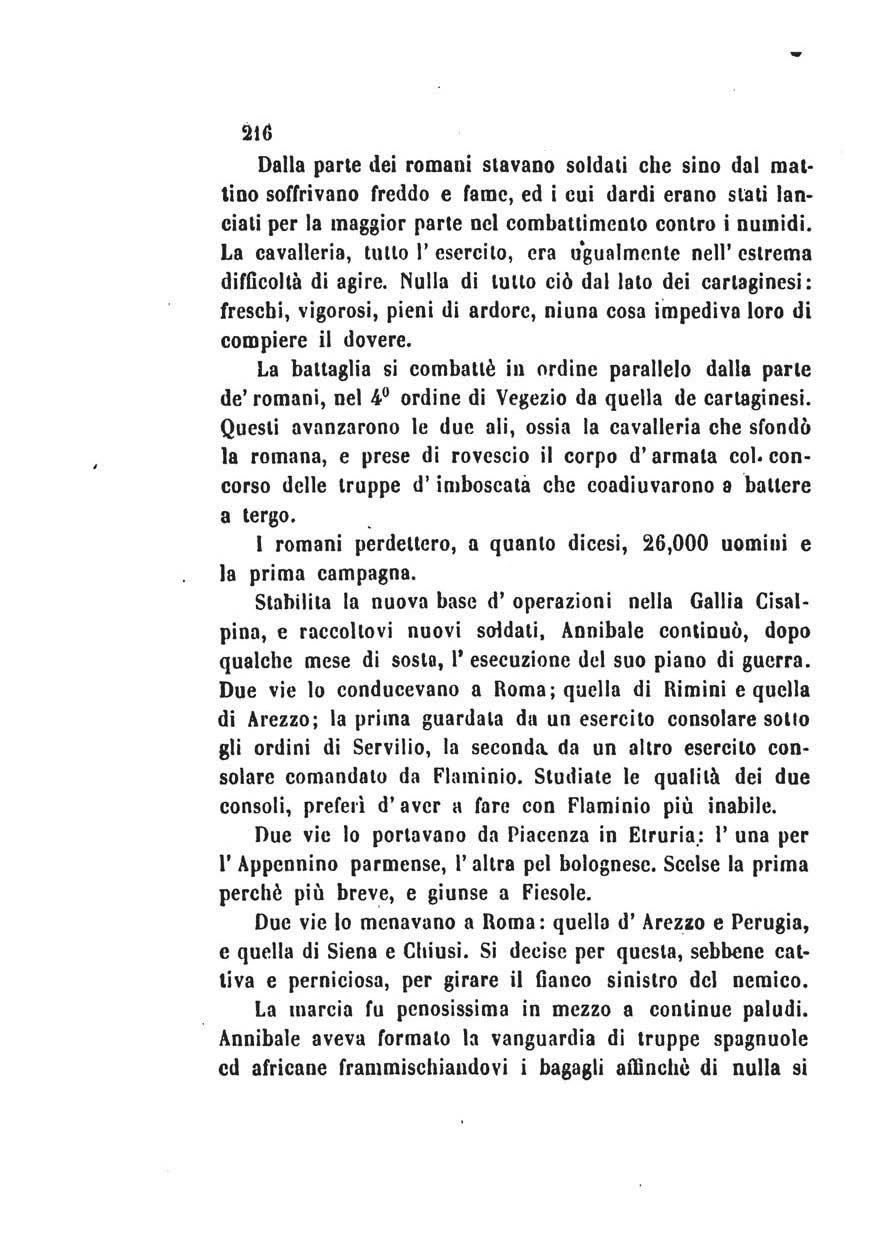
l romani perdettcro, n quanlo dicesi, 26,000 uomini e la prima campagna.
Stahilila In nuova base d'operazioni nella Gallia Cisalpina, e raccoltovi nuovi soidati, Annibale continuò, dopo qualche mese di sosta, l'esecuzione del suo piano di guerra . Due vie lo conducevano a Roma; quella di Rimini e quella di Arezzo; la prima guardata da un esercito consolare sotto gli ordini di Servilio, la seconda da un altro esercito consolare comandalo da Flaminio. Studiate le qualità dei due consoli , preferì d' aver M fare con Flaminio più inabile.
Due vie lo portavano da Piacenza in Etruria.: l' una per l' Appennino parmense, l'altra pcl bolognese. Scelse la prima perchè più breve, e giunse a Fiesole.
Due vie lo menavano a Roma: quella d' Arez.zo e Perugia, e quella di Siena e Chiusi . Si decise per questa, sebbene cattiva e perniciosa, per girare il fianco sinistro del nemico.
La marcia fu penosissima in mezzo a continue paludi. Annibale aveva rormato l:.t vanguardia di truppe spagnuole cd arricaoe frammischiaudovi i bagagli affinchè di nulla si
217 mancasse lungo il cammino. l galli ausiliarj sfilavano formando il corpo di battaglia; e Magone "enne posto in retroguardia colla cavalleria, con ordine di far marciare l' esercito e spingere innanzi i galli qualunque fosse la loro voglia, buona o mAia. <ili africani e gli spagouoli, vecchi soldati, abituati alle fatiche della guerra, passarono senza grave pena ; ma i galli ausiliarj, arruolati da poco tempo, e che trovavano la strada calpestata dalla vanguardla, sdrucciolavano ad ogni passo, c si affondavano nel fango. Ne morì up gran numero che non potè sopportare una marcia cosi penosa la quale durò quallro giorni c tre nolli. Annibale stesso vi pcrdè un occhio in conseguenza di un ollahnia 'ihe non ebbe tempo di curare.
Finalmente giunse in lu9go migliore; e per impedire che Servilio, già in cammino per congiungersi a Flaminio, arri vosse a tempo, provocò quest' ullimo, inoltrandosi nel · paese c devastandolo. Flaminio abbandonò la posizione e mosse a scguirlo.
• Annibale aveva scelto una posizione ollremodo vantaggiosa; in una strella costituita da alture a sinistra, dal lago Trasimeno a destra; e l' i nello console cascando nella rete, ebbe luogo la battaglia del Trasimeno. r romani furono avviluppati; combaucrono furiosamente per tre ore, ma invano; tentarono estendere la loro fronte a doppia coorte: e siccome il manovrare souo l' azione del nemico è sempre cosa pericolosa, cosi in quella circostanza riuscì fatale (V. Tav a. IX).
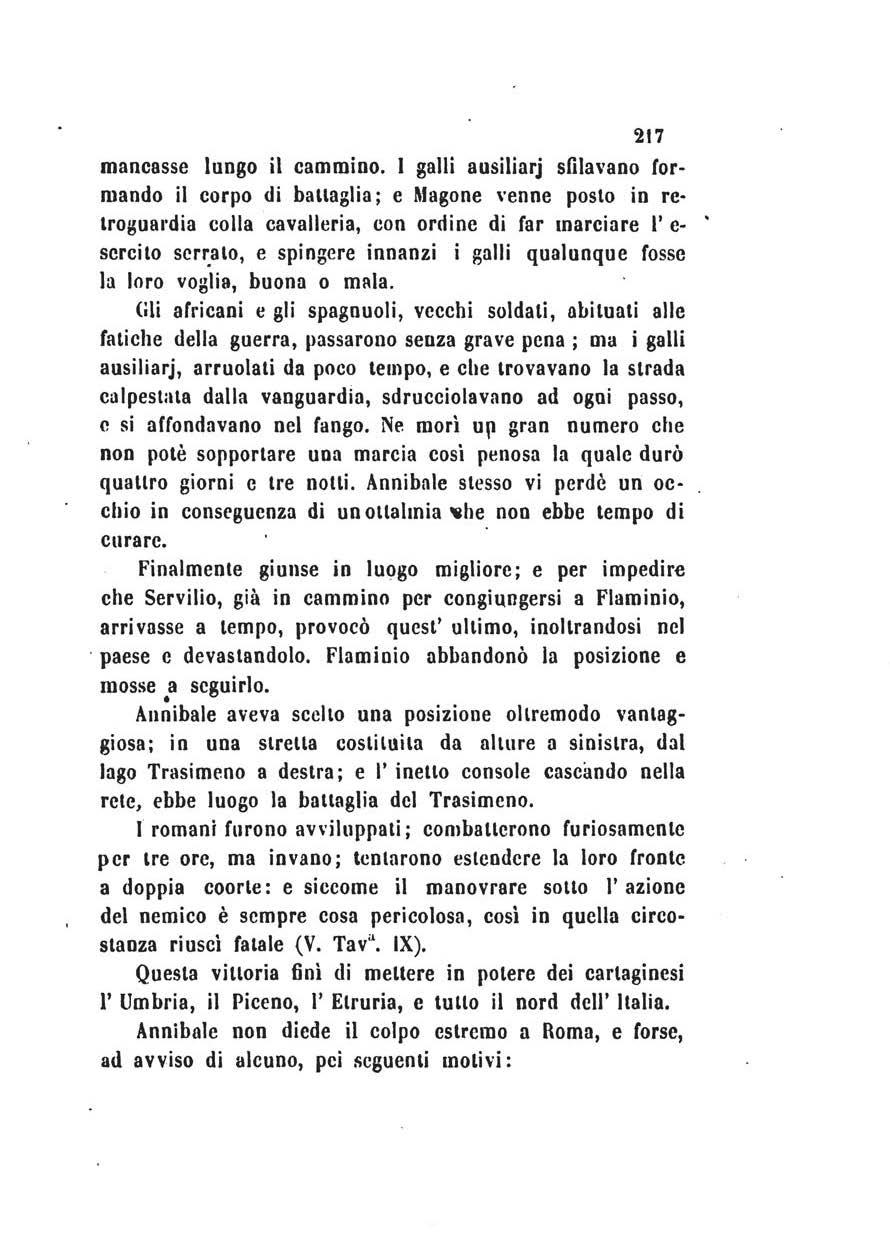
Questa viuoria fini di mettere in potere dei cartaginesi l' Umbria, il Piceno, l' Etruria, e tutto il nord dell' Italia.
Annibale non diede il colpo estremo a Roma, e forse, ad avviso di alcuno, pei :'ìcguenti motivi:
2t8
t 0 Per trovarsi separato dalla sua base d' operazioni della valle di Po in causa della catena appenninica.
2. 0 Perchè il suo esercito aveva sotTcrto assai nei passi dei monti, nelle maremmr, nelle bauaglie, e d' uopo di rinforzi prima di sobbarcarsi a un gran colpo.
5.0 Pcrchè l'esercito di Scrvilio, intero e compatto, lo avrebbe assalito' alle spalle qualora ci fosse andato sotto Roma, la quale inoltre sarebbesi difesa con pn altro esercito regolarmente o tumultuariamente riunito.
Roma scelse Fabio a. dittatore, il quale rimise gli eserciti, andò nella Puglia, adollò il sistema di osservare e ri. stringere i movimenti di Annibale, di togliere o almeno diminuire a lui i mezzi di sostenere più a lungo la guerra, c indcboli..to in quesh'\ guisa senza 01lli venire a gior:nata.
Cessato il potere di Fabio, i suoi successori ne conti· nuarono il sistema; ma la presa di Canne fatta da Annibale, ponentlo i cartaginesi in tale sicurezza da potere per molto tempo continuare la guerra, costrinse i romani alla decisione di venire a battaglia. Formarono due eserciti cooso•lari di otto legioni ciascun.o, che affidarono ai consoli Paolo Emilio e Terenzio Varronc. Il primo, esperto duce, vole\'a il nemico su terreno favorevole alla fanteria; il secondo, inetto, si la sciò trascinare a battaglia nel luogo che più conveniva all'avversario.
l romani avevano dunque due eserciti .consolari di doppia forza; 80, 000 fanti e 7,200 cavalli. l cartoginesi, 40,000 fanti e tO,OOO cavalli
Il terreno era piano, attravet·sato dall' Ofanto.
La disposizione de' romani era a scacchiere, con . intervalli più ristretti del prescritto. Cavalleria alle ali; 2,400 ca\·alli a destra appoggiati all' Ofanto; 4,800 a sinistra. Vcliti sulla front e; fanteria di linea dietro ad essi. Fronte al sud.
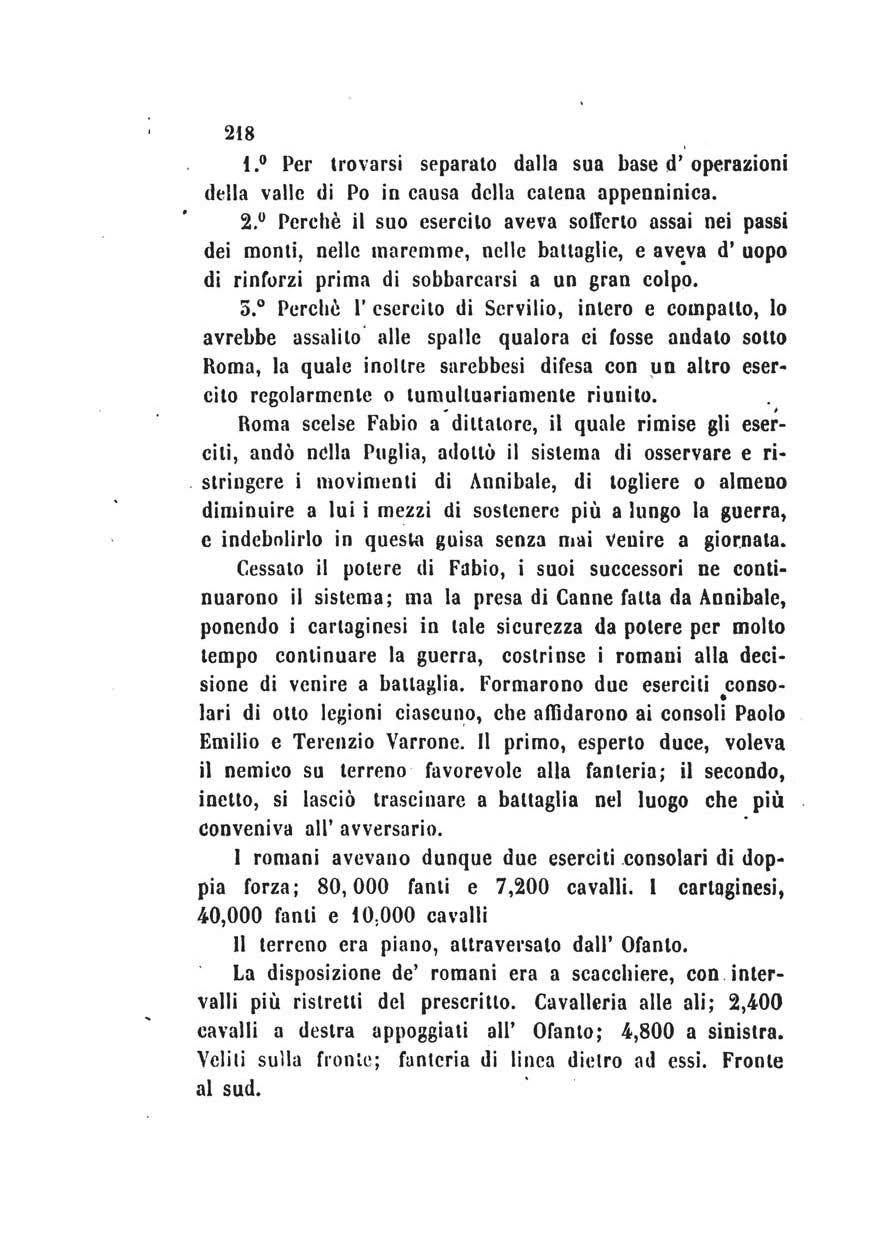
219 cartaginesi si posero su di una sola linea; galli c spagnuoli al centro formando una con\'essità; africani alle estremità di questi; cavalleria alle ali: frombolieri baleari dinanzi. Fronte al nord . .
V periodo: Zuffa delle truppe leggiere, che poi si ritirano scuoprendo le fronti. lo questo frauempo la cavalleria cartaginese dell' ala sinistra ro·vescia la romana che ha io faccia: i cavalli cri romani mettono piede a terra; è peggio; sono tagliati a pezzi; è ferito Paolo Emilio.
2. 0 l legionarj caricarono sulla convessità della linea nemica, la quale a po'co a ·poco si fece retta per riuscire infine concava. l romani s' impegnarono in questa concavità e serrarono le loro masse io 'modo da non poter più fare uso libero delle loro armi. l fanti africaoi eseguirono conversioni a destra e a sinistra, e atlaccarono i romani ai fianch i. lo questo mentre la cavalleria cartaginese di sinistra si portò ad unirs i a quella di destra; e la romana, che le sta\·a n fronte, si spaventò e si diede alla fuga.
5.0 La cavalleria cartaginese fece un attacco di rovescio sulle linee romane (V. Tav 3 X).
Strage ·numerosa dei romani: perdettero così la memoraoda battaglta di Canne.
Le cause del risultato furono:
1.0 Presunzione di Varrone;
2.° Cecità nel cadere nella rete ttsagli dal nemico ;
5.0 Lo appiedarsi de' cavalliea·i romani;
4. 0 Il restringimcnto della fronte legiooaria in modo da · lasciar facoltà ai nemici, inferiori immensamente di ·numero ma estesi di fronte, di accerchiarne i lati.
Dalla parte di Annibale vi fu· buona taltica nella scelta della posizione, nella distribuzione delle armi e dei corpi, nelle manovre preparate e poi ese8uite sul campo.
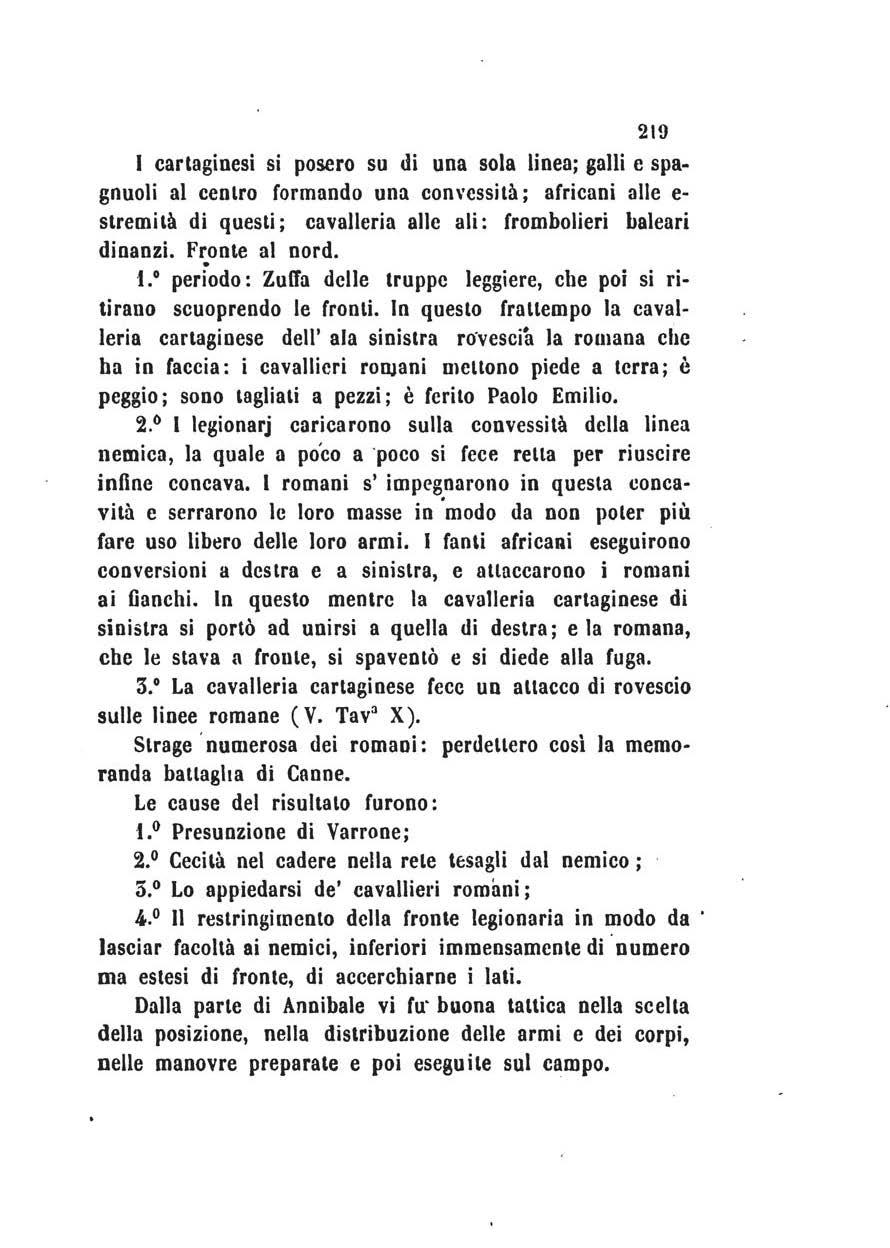
Ln prudenza distolse anche questa volla il generale cartaginese dal mare iare su Roma, occuparla, e por fine così alla guerra; ma sebbene molti storici gli rimproverino di non aver còlto quest' occasione per compiere .totalmente H suo disegno, pure si deve andare guardinghi dal giudi· care severamente la determinazione di un generale cbe risplende nella stòria come uno fra i primi che abbiano esistito.
Annibale stelle parecchi anni in Italia e procurò di formarsi nuovi alleati nella parte meridionale deJla penisola. Nelle diverse vicende delle sue guerre co' romani, risolse di chiamare a sè suo Asdrubale che con .varia fortuna combatteva· io e vi aveva ·perduto la battaglia di Tortosa contro gli Scipioni. Questa battaglia si diede dalla parte de' cartaginesi nello stesso ordine di quella di Canne, meno la della linea convessa ; dalla parte de' romani si presero le. precauzioni necessarie per tenere isolati i manipoli affinché non accadesse la formazione della massa grossa ed inerte che non potè agire nella battaglia d i Canne.
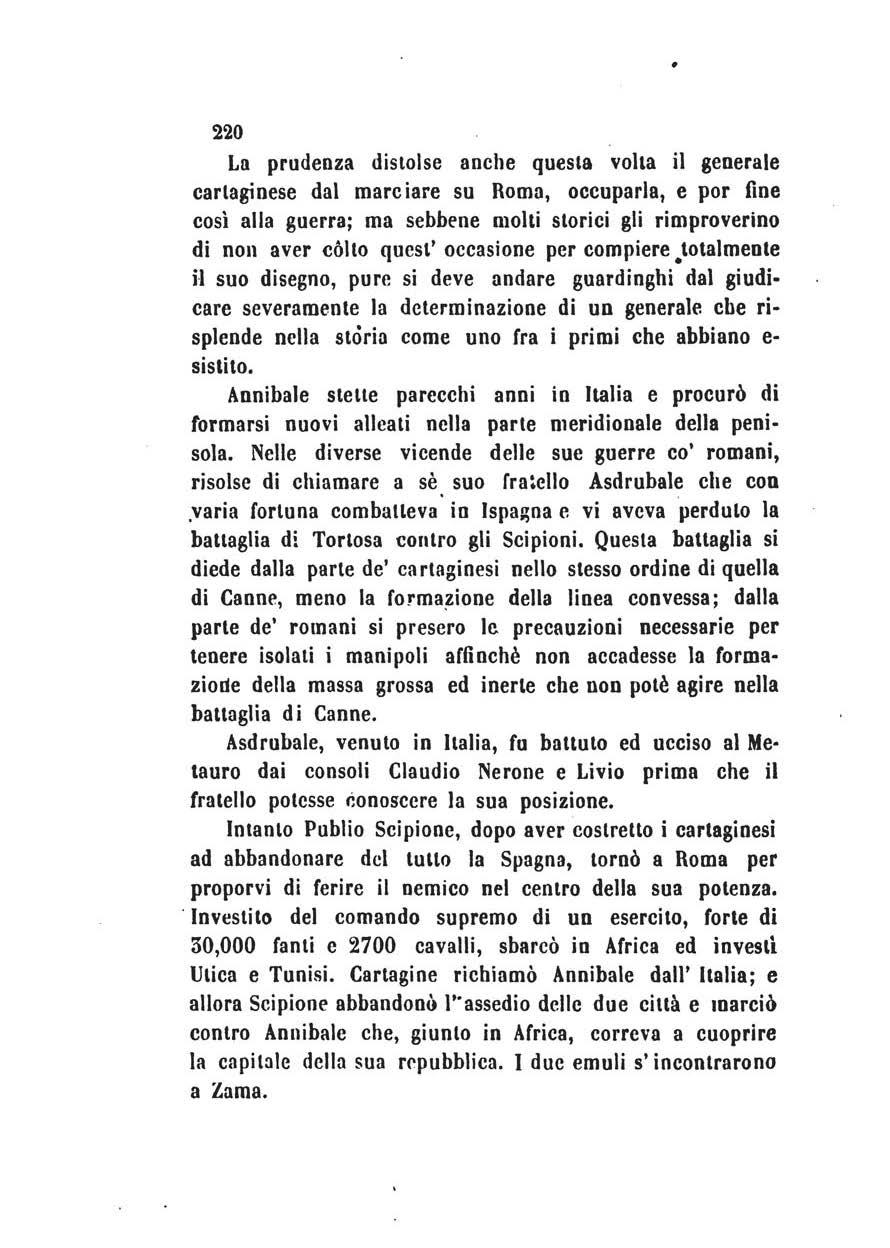
Asdrubale, venuto in llalia, fu battuto ed ucciso al Me· tauro dai consoli Claudio Nerone e Livio prima che il fratello potesse r.onoscere la sua posizione.
Intanto Publio Scipione , dopo aver costretto i cartaginesi ad abbandonare del tutto la Spagna, tornò a Roma per proporvi di ferire il nemico nel centro della sua potenza .
· Investito del comando supremo di un esercito, forte di 50,000 fanti c 2700 cavalli, sbarcò io Africa ed investi Utica e Tunisi. Cartagine richiamò Annibale dall' Italia; e allora Scipione abbandonù )''assedio delle due città e marciò contro Annibale che, giunto in Africa, correva a cuoprire la cnpilnle della sua repubblica. I due emuli s'incontrarono a Zama.
Le forze erano pressochè uguali; dai ai 50000 uomini . Ai romani ·s' era unito Massinissa co' suoi numidi, il quale dapprima era coi cartaginesi. l cartaginesi avevano por essi alJeati numidi sotto la condotta di Siface.
Annibale dispose la fanteria su tre lince; gli elefanti innanzi; la cn vallcria alle ali.
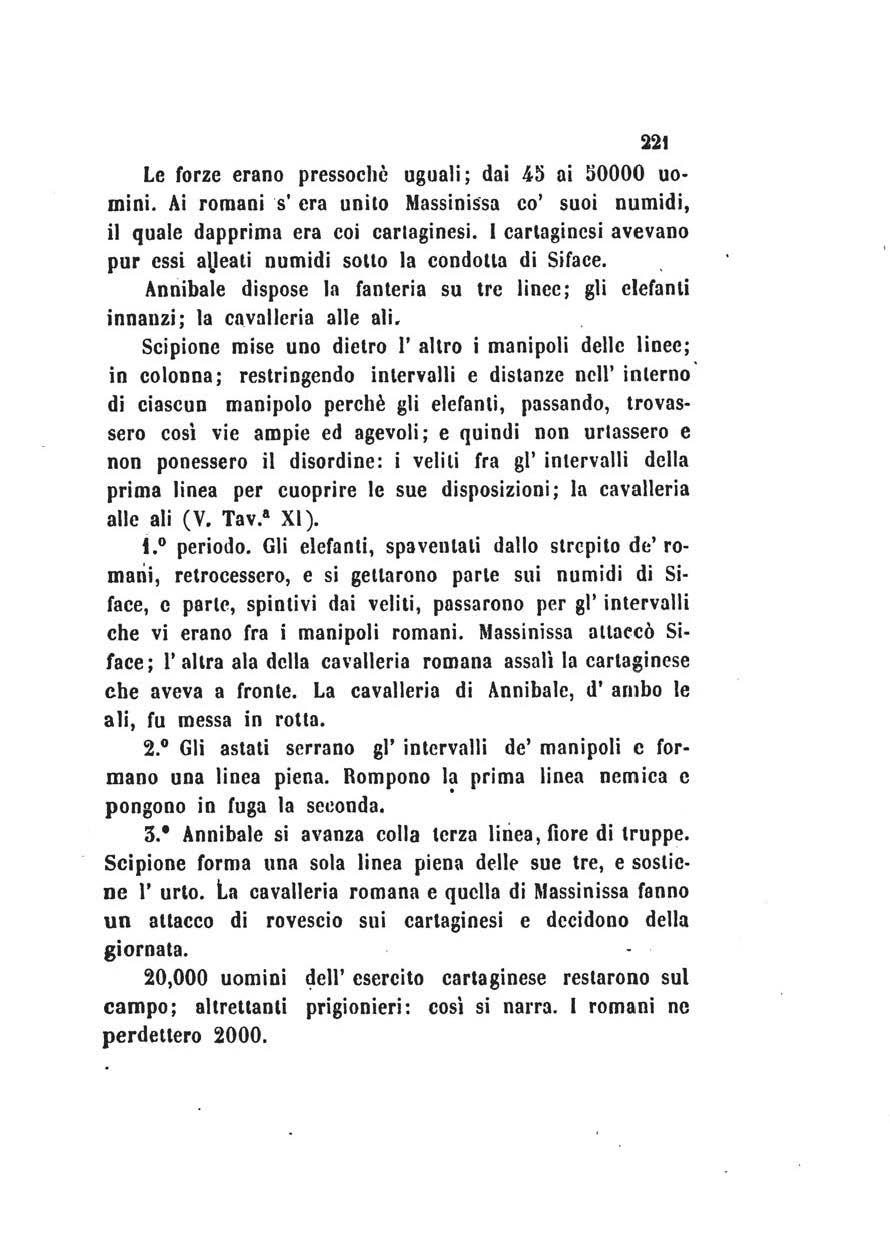
Scipionc mise uno dietro l' altro i manipoli delle linee; in colonna; restringendo intervalli e distanze nell' interno di ciascun manipolo perchè gli elefanti, passando, trovassero cosi vie ampie ed agevoli; e quindi non urlassero e non ponessero il disordine: i veliti fra gl' intervalli della prima linea per cuoprire le sue disposizioni; la cavalleria alle ali (V. Tav.1 Xl).
f.o periodo. Gli elefanti, spaventati dallo strepito dc' romani, retrocessero, e si gettarono parte sui numidi di Si· face , c parte, spintivi dai veliti, passarono per gl' intervalli che vi erano fra i manipoli romani. Massinissa attaecò Siface; l' altra ala della cavalleria romana assali la carta8incse ehe aveva a fronte. La cavalleria di Annibale, d' ambo le a li, fu messa in rotta.
2 . 0 Gli astati serrano gl' intervalli de' manipoli c formano una linea piena. Rompono prima linea nemica c pongono in foga la seconda.
a.• Annibale si avanza colla terza linea, fiore di truppe. Scipione forma una sola linea piena dellr sue tre, e sostiene l' urto. La cavalleria romana e quella di Massinissa fanno un attacco di rovescio sui cartaginesi e decidono della giornata.
20,000 uomini esercito cartaginese restarono sul campo; altrettanti prigionieri: così si narra. l romani ne perdeuero 2000.
Fu bella la disposizione di Sc1pionc, prima in colouna con distanze cd iotervaJli, poi io linea piena a forma falangi ta.
Fu bella la disposizione di Annihale su due Jinec e una riserva de' prodi, e la deJie diverse specie di soldati. La viltà di quelli della seconda linea sconcertò ·il suo piano.
La battaglia di Zama fini la seconda guerra punica, in , cui brillò il genio di Annibale.
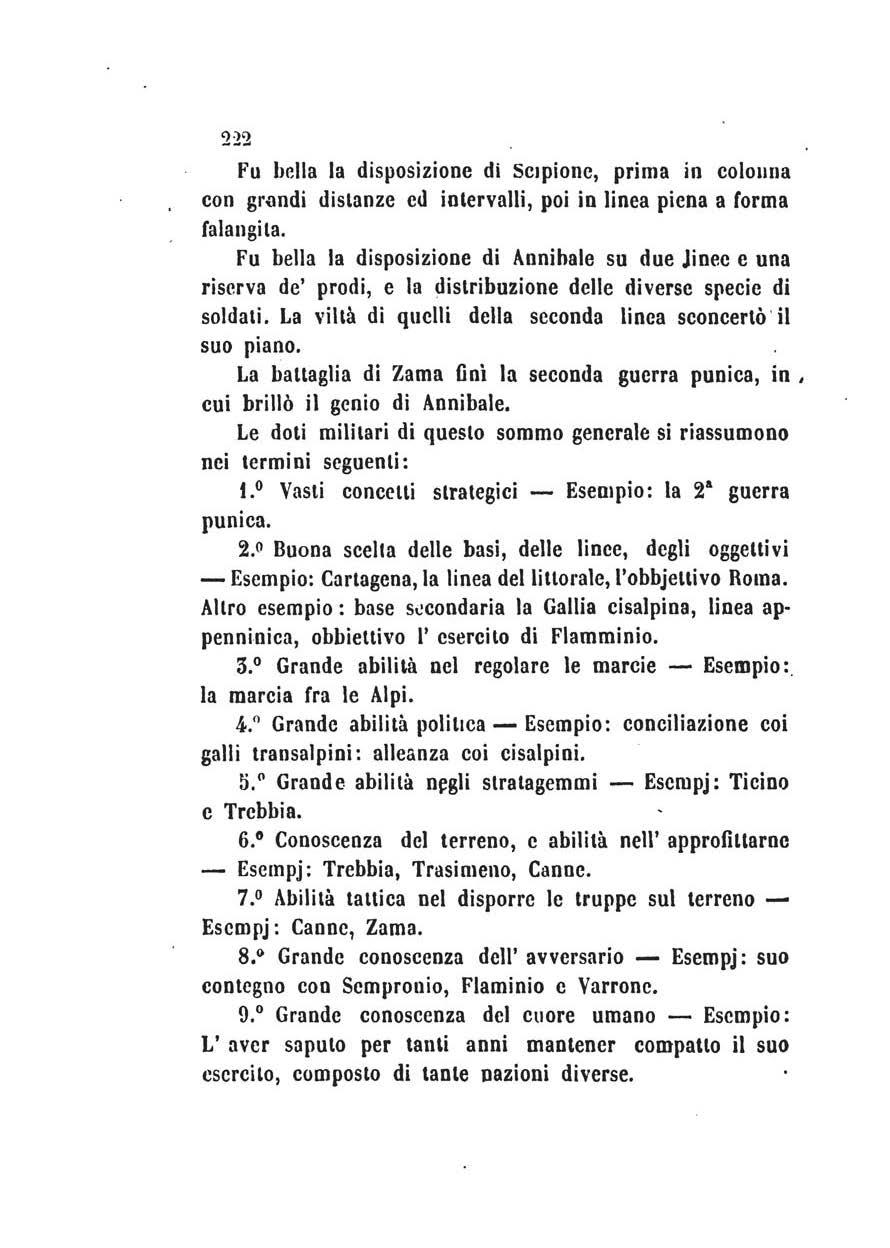
Le doti militari di questo sommo generale si riassumono nei termini seguenti:
f. 0 Vasti concetti strategici - Esempio : la 2• guerra punica.
2.o Buona scelta delle basi, delle lince, degli oggettivi -Esempio: Cartagena, la linea dellittorale, l'obbjellivo Roma. Altro esempio : base la Gallia cisalpina, linea appenni.nica, obbiettivo l' esercito di Flamminio.
5.0 Grande abili là nel regolare le marcie Esempio: . la marcia fra le Alpi.
4. 0 Grande abilità polittca Esempio: conciliazione coi galli transalpini: alleanza coi cisalpini.
5. 11 Grande abilità negli stratagemmi Escmpj: Ticino e Trebbia.
6.° Conoscenza del terreno, c abilità nell' approfiLtarnc - Escmpj: Trebbia, Trasimeno, Canne.
7 . 0 Abilità tattica nel disporre le truppe sul terrenoEscmpj: Canne, Zama.
8. 0 Grande conoscenza dell' avversario Esempj: suo contegno con Scmprouio, Flaminio c Varrone.
9 . 0 Grande conoscenza del cuore umano - Esempio: L' aver saputo per tanti anni mantener compatto il suo esercito, composto di tante nazioni diverse.
to.o flcrduranza - Esempio: sedici anni di contro gli stessi e per un medesimo fine.
Ollrc un mezzo secolo dopo la seconda guerra punicn, si accese la terza. Cartagine si era alquanto rimes s a, c Roma la volle distrutta. Scipione Emiliano compì la volonlà . della repubblica romana, e la distrusse . §. 2, 0
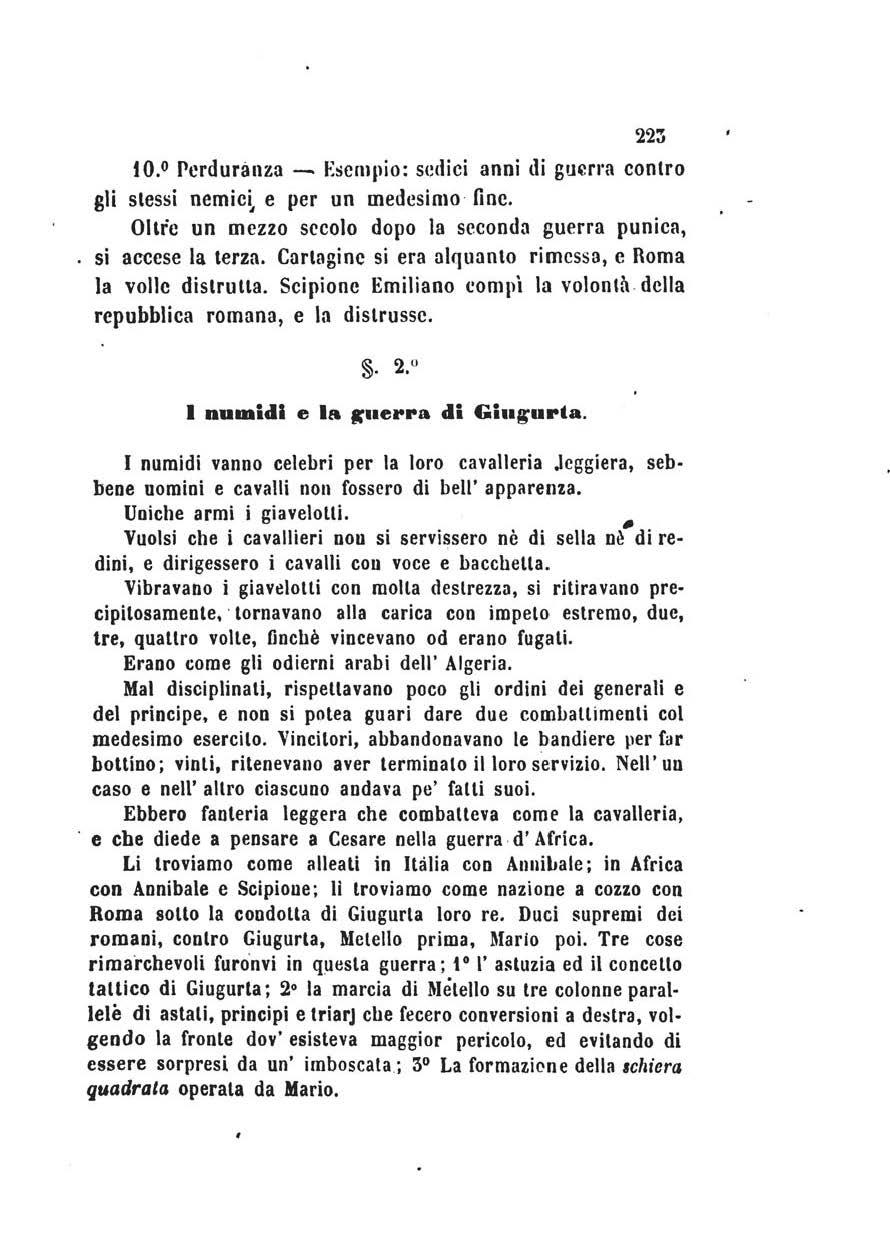
l numldl e la ttnel"l"a di Giugurta.
I numidi vanno celebri per la loro cavalleria Jcggiera, seb· bene uomini e cavalli non fossero di bell' apparenza.
Uniche armi i giavelolli.
Vuolsi che i cavallieri nou si servissero nè di sella nè di redini, e dirigessero i cavalli con voce e bacchetta .
Vibravano i giavelotti con molla destrezza, si ritiravano precipitosamente, · tornavano alla carica con impelO> estremo, due, tre, quattro volte, fìnchè vincevano od erano fugati .
Erano come gli odierni arabi dell' Algeria .
Mal disciplinati, rispettavano poco gli ordini dei generali e del principe, e non si potea guari dare due combattimenti col medesimo esercito. Vincitori, abbandonavano le bandiere per far bollino; vinti, ritenevano aver terminato il loro s'ervizio . Nell' uu caso e nell' altro ciascuno andava pe' falli suoi.
Ebbero fanteria leggera che combatteva come la cavalleria, · e che diede a pensare a Cesare nella guerra . d' Africa.
Li troviamo come alleali in ltàlia con Annii.Jale; in Africa con Annibale e Scipioue; lì troviamo come nazione a cozzo con Roma solto la coodolla di Giugurta loro re. Duci supremi dci romani, contro Giugurta, Mctello prima, 1\lario poi. Tre cose rimarchevoli furo'nvi in guerra; 1• l' astuzia ed il concetto tattico di Giugurta; 2• la marcia di Metello su tre colonne parai· lelè di astati, principi e triarJ che fecero conversioni a destra, volgendo la fronte dov' esisteva maggior pericolo, ed evitando di essere sorpresi da un' imboscata.; 3° La della 1cliiera quadrata operata da Mario.
22.t
Giugurta, impadronitosi con mezzi illeciti del regno dt Numidia, di cui non aveva ricevuto che il terzp in eredità, non potè ottenere la sanzione dc' romani a' suoi tradimenti e ai suoi raggiri, e dovè quindi sosten·ere una guerra con essi; dapprincipio riportò vittoria sorprendendo il campo ·nemico dopo aver corrotto i traci ed i liguri che ne rustodivano gli aditi. Ma i romani non accettarono una capitolnione fatta dal loro pretore Albino; e il console Metello, con rinforzo di truppe, andò in Numidia.
Arrivatovi, Giugurta fece éjccogliere con viso amico l'esercito romano dagli abitanti; ma Metello lliffidò delle appat'enze, e stelle io guardia nella persuasione che fosse tramata · perfidia . lnfaUi Giugurta tentava rallentare la vigilanza delle . legioni.
· lnf(lrmato che Metello s_i disponeva a passare il fiume Muthul, riuscì a fare parrecchie marcie a sua insaputa, ed a porsi io imboscata sul suo passaggio.
l romani dovevano vallicare un' alta montagna; poscia, per al fiume, trovavasi una pianura di sei leghe, fiancheggiata da un lato da colline coperte di mirti e di olivi.
Diviso il suo esercito in due part i, Giugurta approfittò della più considerevole fra le oolline che erano vicine alla grande montagna, si nascose il meglio che potè fra i boschetti e le vallate, e fece occupare dalle sue truppe una grande estensione di terreno. Al tempo stesso mandò un suo generale, Bomileare, col resto delle genti ad imboscarsi vicino al fiume.
Giugurta voleva aspettare che il nemico fosse disceso dall' alla montagna per occuparla poscia egli medesimo colle truppe tenute nascoste nel la collina; mentre il suo generale Domilcare avrebbe chiuso il passo innanzi al fiume.
I romani sarebbero stati assaliti in marcia; di fronte, di fianco, ed alle spalle.
Questo fu l' ardito e ben concetto disegno di Giugurta. ·
Ma fu sventato dalla ' preveggenza di Metello.
Il quale, sebbene ignorasse quanto accadeva, tuttavia dfffi· dava del nemico, e adottava disposizioni come un generale abile che sa prepararsi a tutti i casi.
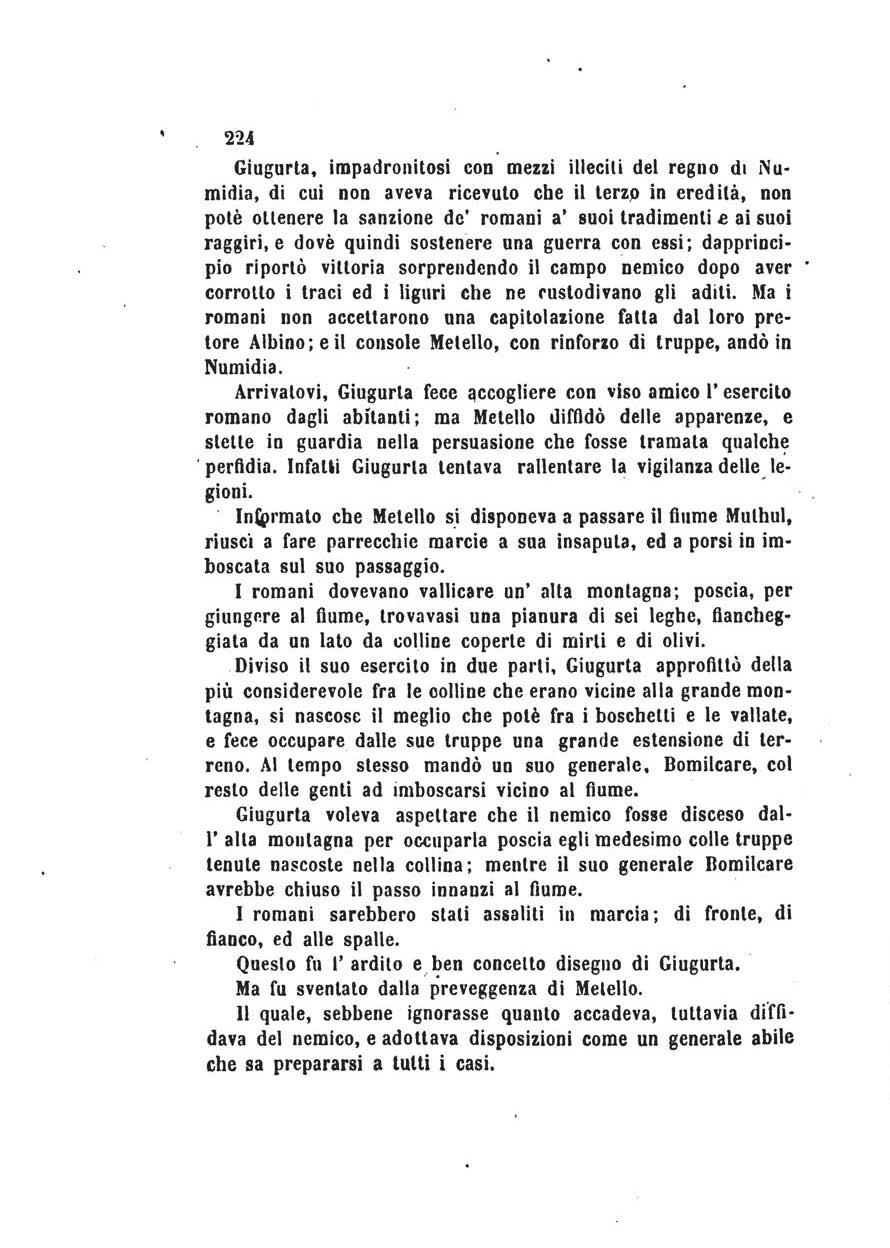
225
Il suo ordine <.li marcia fu quello che già descritto, secondo quanto ne dice Polibio, allorquando l' esercito formava tre colonne di manipoli (t). In tal guisa non potè essere sor· preso. Essendosi accorto dall' allo della montagna che truppe nemiche nascoste nelle colline gli tendevano insidia, non n'ebbe timore, fidò nelle sue disposizioni, scese al piano, mandò innanzi un corpo di cavalleria e parecchi manipoli c:oll' ordine d' impa· drooirsi delle rive del Oume, ed assalito furiosamente da Giu· gorla ne respln11e l' attacco, e riportò vittoria.
Dopo altri falli meno clamol'osi, Giugurta si rifugiò presso Bocco re di Mauritania, e lo decise a dargli soccorso di armati. Mario, succeùuto a Metello, invase più estesamente il paese nemico, prese città e fortezze, e nelle marcie segui il sistema di Mctello per potere volgere facilmente la fronte ovunque la circostanza lo avesse richiesto. Questa disposizione viene deuo· lata col nome di Schiera quadrata. ·
Combattè, vinse; c, abbandonato da Bocco, Giugurta cadde in suo potere e ne ornò il trionfo .
Cosi Onì la guerra di Numidia, 104 anni prima dell' èra volgare.
§. 3."
l galli e le guerre di Cesare.
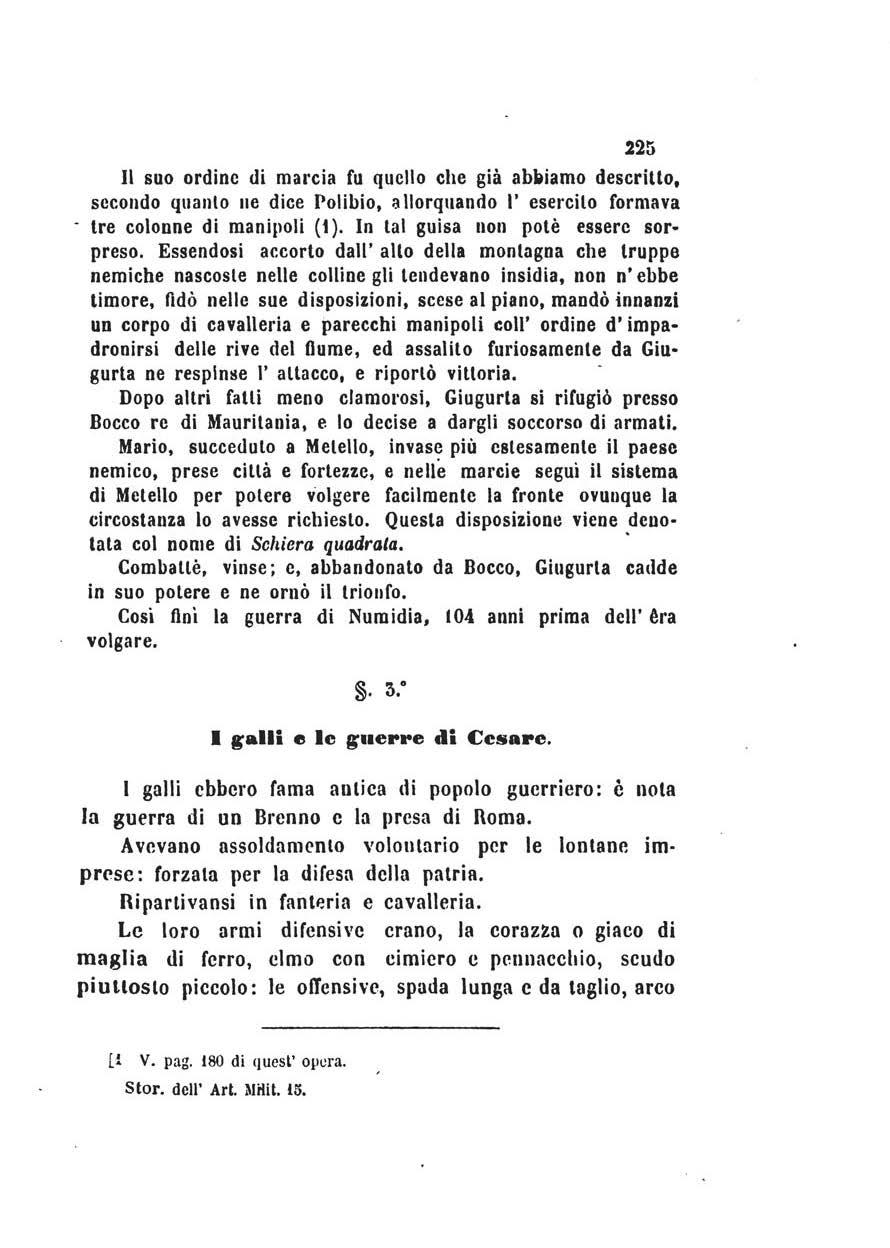
l gall i ebbero fama aulica di popolo guerriero: è nota Ja guerra di un Brcnno c In presa di Roma.
Avevano assoldamento volontario per le lontane imprC'sc: forzata per la difesa della patria. Ripartivansi in fantP.ria e cavalleria.
Le loro armi difensive erano, la corazza o giaco di maglia di ferro, elmo con cimiero c pcnnacchio, scudo piuttosto piccolo: Je offensive, spada lunga c da taglio, arco
L! V. pag. !80 di !J uesl' opera. Stor. dell' Art. Mìlil. t5.
226 e freccie.
L' ordinanza della fanteria era profonda; sino a 24 righe.
La cavalleria su cavalli e su cal'J'i. Alcuni popoli galli faceano seguire ogni cavaliere da due scudieri. l carri erano condotti con immensa destrezza; portavano soldati che n'ella corsa lanciavano dardi, nella fermata sallavauo n terra e combattevano a piedi.
l galli avevano cillà molto fortificate; costruivano i muri di cinta con un misto di pietre c di travi.
Non ponevano sempre gran cura negli accampamenti: qualche volla li circondavano di fosso e di palizzate; più tardi imitarono i romani.
CombaUe\'ano per solito su di una linea; cani al centro od ai fianchi; cavalleria alle ali. Talvolta si forma·vano in quadrato, o, a dir meglio, in massa.
La lattica consisteva nella sveltezza e nell' urto.
Il carallerc distintivo era la furia; gran fiducia in sè. Amava.no i duelli.
Sono celebri le guerre che ebbero a sostenere con Cesare.
Le Gallie erano divise in quattro parti; la bclgica, la celtica; l' aquitanica, c. la. narboncse o romana.
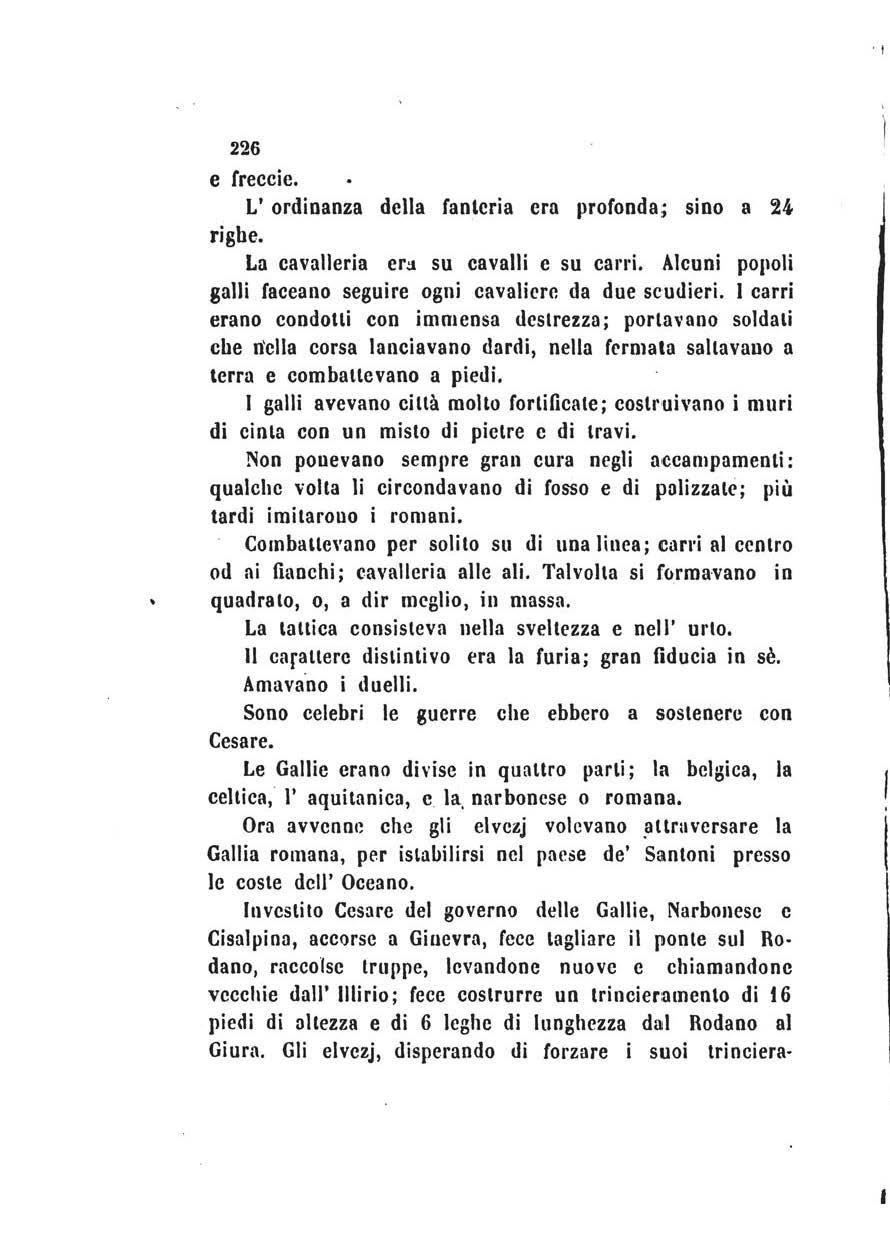
Ora avvenne che gli elvczj volevano la Gallia romana, per islahilirsi nel paese de' Santoni presso le coste dell' Oceano.
Investito Cesare del governo delle Gallie, Narbonese c Cisalpina, accorse a Giuevra, fece tagliare il ponte sul Ro· dano, racco 'lsc truppe, lcvandone nuove c chiamandone vecchie dall' Il lirio; fece costrurre un trincieramcnto di t 6 piedi di altezza e di 6 leghe di lunghezza dal Rodano al Giura. Gli elvczj, disperando di forzare i suoi trinciera·
227 menti per entrare nelle Gallic, traversarono invece. il Giura, c giunsero su lla Saona. Cesa re si portò a Chalons sulla Saona, soq1rcsc i popoli di ·Zurigo ch' erano accampati sulla . riva sinistra di questo fiume, li distrusse totalmente, inseguì il resto degli elv ezj per quindici giorni, con sei legioni e un corpo di cavalleria della città di Autun. Giunto ad una marcia da questa città, gli elvezj lo assalirono all' improvviso. Non ebbe se non che il tempo di disporre le sue quattro vecchie legioni in battaglia su tre linee, nel mezzo di una collina, e le due nuove, col bagaglio, su lla .cima. Dopo ostinato combattimento, gli clvczj furono battuti; essi levarono il campo nella notte stessa, c giunsero in quattro giorni presso Lnngrcs, inseguit i da Cesare, che loro accordò grazia, e li obbligò a tornare alla patria loro. Poi, volendo gli svcvi, condotti da Ariovisto, ·dividere la Gallia con Roma, cd avendo invasa la Franca Contea con 120,000 uomini, Cesare passò la Saona, Dcsanzonc, continuò la 'ma1·cia nella direzione del Reno. Il se uimo giorno, aycndo fallo un giro per ev itare le. montagne, i due eserciti si trovarono a' fronte. Gli alemanni erano lli alta statura, forti c prodi. Dopo parecchie manovre, i due eserciti vennero alle mani su. di un campo di lon tano sedici leghe dal Reno. Ariovisto fu battuto, il suo esercito inseguito sino a codesto fiume. Il disastro costernò i germani c salvò le Gallie. Così finì la prima campagna.
La disfalla degli c degli svcvi, c ·la presenza dell' esercito romano nella Gallia ccllica, fecero sì che i belgi temes sero per la loro indipendenza; per cui misero i n campagna un' esercito di 300,000 uomini. Cesure levò due nuove legioni, c giunse a Scns. Si accampò poscia sull' Aisnc, circondando il suo campo di opere for tificatoric. Arrivarono i belgi, passarono l' Aisne, assalirono le opere romane, ma
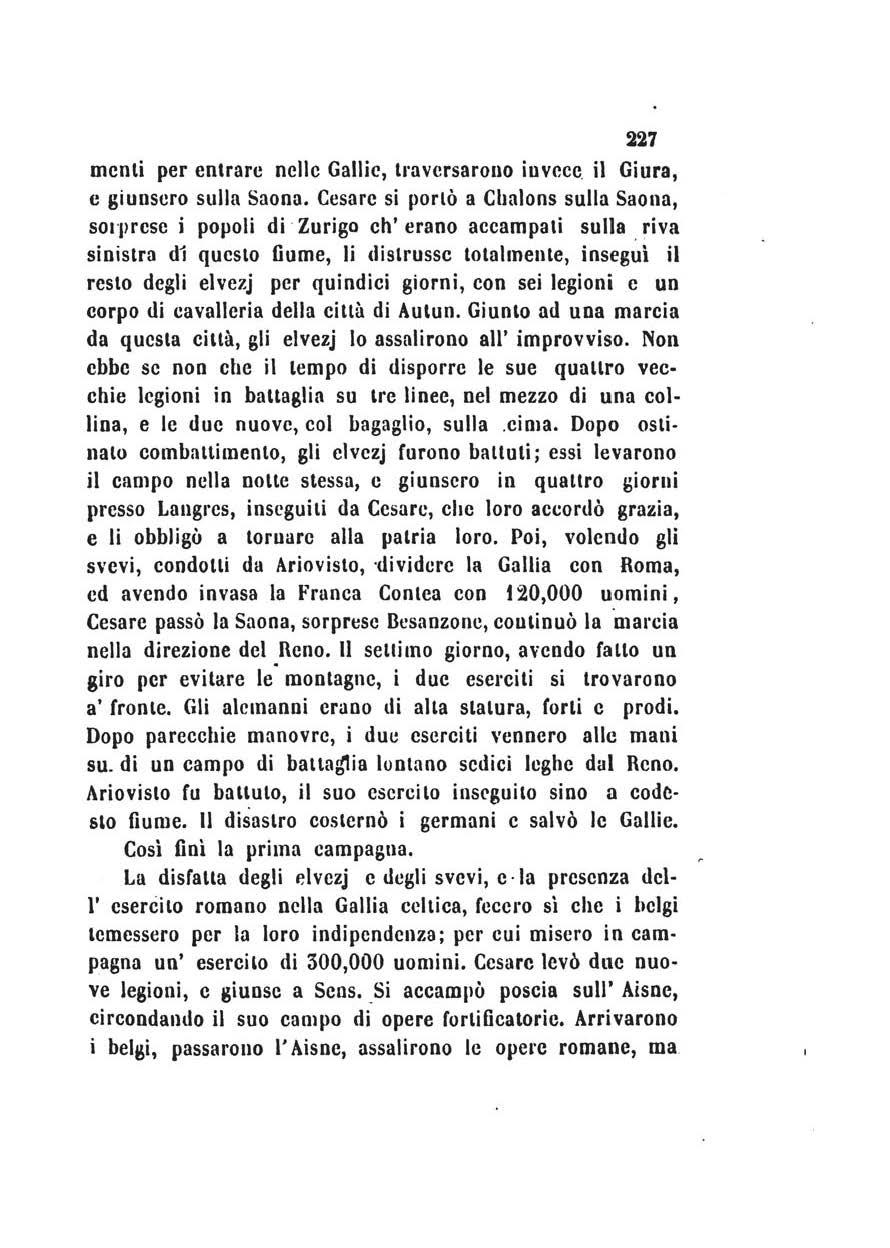
Cesare usci dal campo, li battè cO<Ila sua cavalleria e le sue truppe leggiere, e li cacciò sulla riva sinistra dell' Aisne. Minacciati da alcuni popoli cclli alleati dc' romani, i belgi si ritirarono nei loro paesi. .
Una parte di essi però si accampò a Maubeuge, sulla riva destra della Samb ra. Cesare marciò contro i nemici; dai qnali vennero sorprese le sue truppe mentre stavano fortificando il campo. Da principio la sorte si era spiegata favorevole ai belgi; ma poscia, arrivate nuove legioni, fu· rono cacciati con orrenda strage.
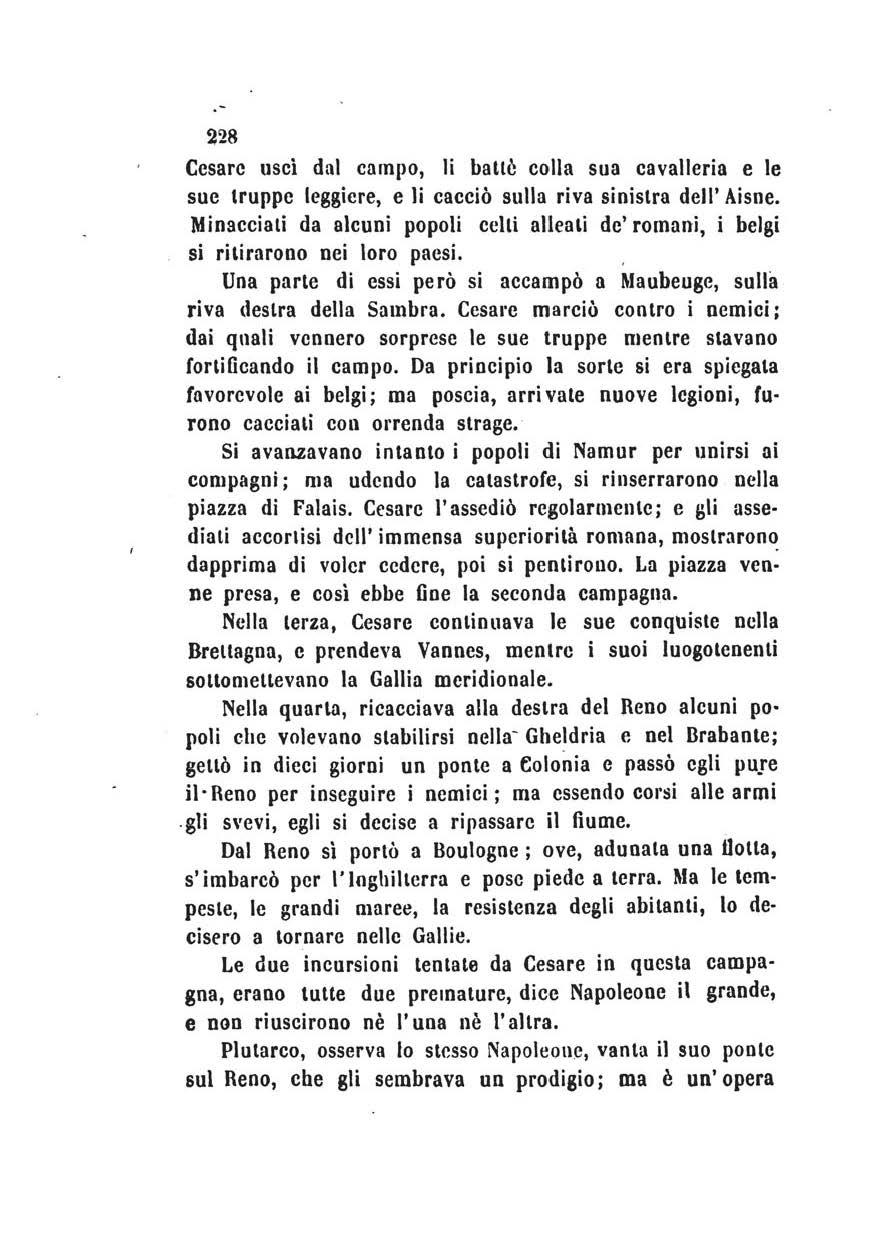
Si avanzavano intanto i popoli di Namur per unirsi ai compagni; ma udendo la catastrofe, si rinserrarono nella piazza di Falais. Cesare l'ass ediò regolarmente; e gli asse· diaLi accortisi dell'immensa superiorità romana, mostrarono dapprima di voler cedere, poi si pentirono. La piazza ne presa, e così ebbe fine la seconda campagna.
Nella terza, Cesare continuava le sue conquiste nella Breltagoa, c prende va Vanncs, menlrc i suoi luogotenenti sottometlevano la Gallia meridionale.
Nella quarta, ricacciava alla destra del Reno alcuni po· poti che volevano stabilirsi nella Gheldria e nel Brabante; gettò in dieci giorni un ponte a eolonia c passò egli pure il· Reno per inseguire i nemici; ma essendo c01·si alle armi .gli S\'evi, egli si decise a ripassare il fiume.
Dal Reno sì portò a Boulogne; ove, adunata una Uotta, s'imbarcò per l'Inghilterra e pose piede a terra . Ma le tem· peste, le grandi maree, la resistenza degli abitanti, lo de· cist>ro a tornare nelle Gallie.
Le due incursioni tentate da Cesare in questa campagna, erano tutte due premature, dic·e Napoleone il grande, e non riuscirono nè l'una nè l'altra . Plutarco, osserva lo stesso Napoleone, vanta il suo ponte sul Reno, che gli sembrava un prodigio; ma è un'opera
'229 che non ha nulla di straordinnrio, e che ,qualsiasi esercito moderno avrebbe potuto fa re con uguale facilità. Egli non volle passare sopra un ponte di battelli, pcrchè temeva la perfidia dei galli, e temeva purnnco che simile ponte si rompesse. Ne co:Hrui uno su palalhtc in dicci giorni e poteva farlo.
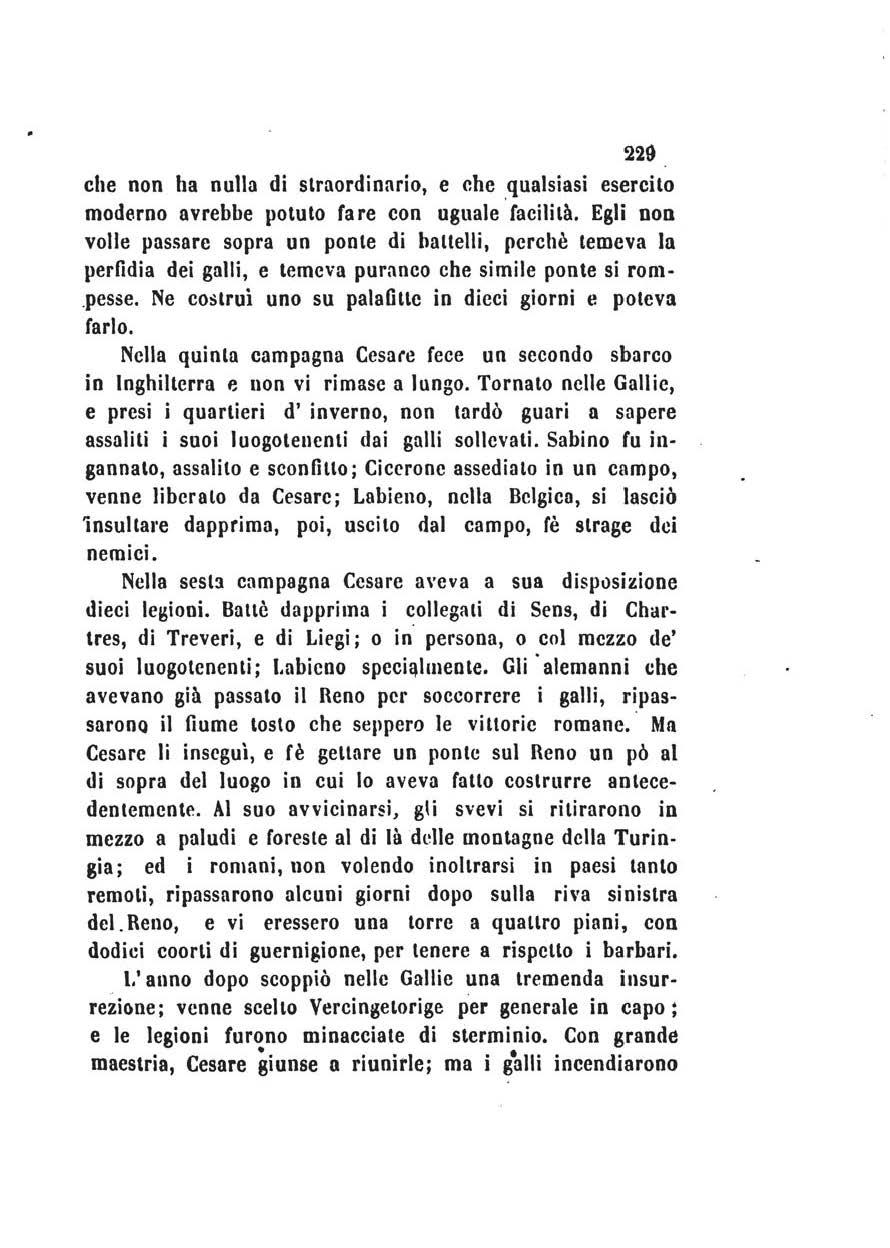
Nella quinta campagna Cesare fece un secondo sbarco io Inghilterra e non vi rimase a lungo. Tornato nelle Gallie, e presi i quartieri d' inverno, non tardò guarì a sapere assaliti i suoi luogotenenti dai galli sollevati. Sabino fu ingannato, assalito e sconfitto; Cicerone assediato in un campo, venne liberato da Cesare; Labieno , nella Bclgico, si lasciò 1nsultat·e dapprima, poi, uscito dal campo, fè strage dci nemici.
Nella sest3 campagna Cesare a\'eva a sua dispùsizione dieci legioni. Battè dapprima i collegati di Scns, di Chartres, di Treveri, e di Liegi; o in. persona, o col mezzo de' suoi luogotenenti; l.nbicno speciqlmeote. Gli ·alemanni che avevano già passato il Reno per soccorrere i galli, ripassarono il fiume tosto che seppero le villoric romane. · Ma Cesare li inseguì, e fè gettare un ponte sul Reno un pò al di sopra del luogo io cui lo aveva fatto costrnrre antecedentemente. Al suo avvicinarsi, gli svevi si ritirarono io mezzo a paludi e foreste al di là delle montagne della Turingia; ed i romani, non volendo inoltrarsi in paesi tanto remoti, ripassnrono alcuni giorni dopo sulla ri\'a sinistra del. Reno, e vi eressero una torre a quattro pinni, con dodici coorti di guernigione, per tenere a rispcUo i ba.rbari. l.' anno dopo scoppiò nelle Gallie una tremenda insurrezicme; venne scelto Vercingetorige per generale in capo ; e le legioni furono minacciate di sterminio. Con grande maestria, Cesare giunse a riuoirle; ma i galli incendiarono
230 le loro città per affamare il nemico; poi , scorati da una disfatta, si chiusero io Al esi a, che Cesare cinse di opere prodigiose. Fra molli fossi , in cui scorreva l'acqua di due fiumi che circuivano la fece sotterrare pel tronco :; file d'alberi, i cui radi coni, mozzi e aggozzati, diveni·vano impenetrabili. Seguivano 8 file di pozzi, irti di triboli ' nel fondo, coll'apertura coperta di cespugli, e intorno sparsi di cavalli di Frisia. Così potè con t O legioni resist ere al doppio attacco di ·vercingetorige cbe usciva dalla piazza, e dci 240,000 galli che assalivano i suoi trinceramenti dalla campagna. Questi ultimi furono alla fine dispersi e Vercingctorige si nrrese.
In qursta che fu la setlima, Cesnrc diede parecchie battaglie, e fece parecchi asscdii, due dci quali con esito favorevole . Fu la 1u·ima volla che ebbe a combaucre i galli riuniti. La loro risolutez za, l' ingegno del loi'O generale Vcrcingelorigc, la forza del loro esercito, lutto rende questa ·campagna gloriosa pei romani.
Le opere di Cesare erano considrrc,·oli; l'ese r cì lo ebbe quaranta giorni per costruirle, c le armi oiTensi\·e dei galli erano impotenti a distruggere simili ostacoli. ·
Nell' anno seg uente , Cesare percorse la Gallia per compirne la conquista, e la compì con un' ouava ed ultima campagna; d' allora in poi mostrò verso i galli estrema dolcezza.
l principj che guidavano Cesare, dice il grande, furono uguali a quelli di Alessandro c di Annibale; tenere le forze riun ite ; non essere vulnerabile in alèun punto; portarsi con rapidi tà sui punti più importanti; far calcolo sui mezzi morali, su lla riputazione delle sue armi, sul timore da lui inspirato, e sui mezzi politici per man. tenere nella fedc4tà i suoi alleati, c nell' •obbedienza i popoli vinti .
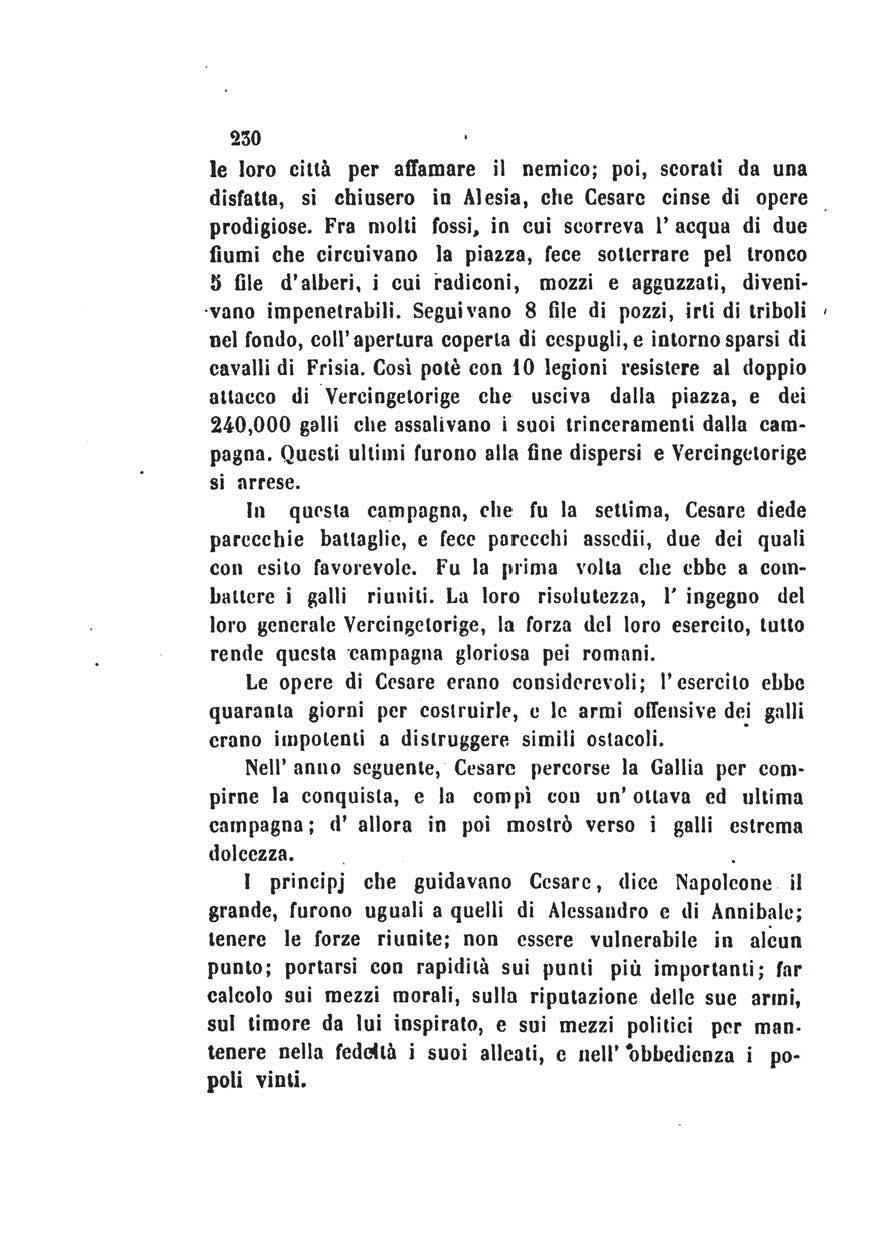
§. 4.0
Gli •PAI'Daoll.Gli antichissimi spagnuoli: e specialmente la parte celtica della nazione che abitava le montagne, portavano un sajo nero di rozza lana, e un drappo tessuto di peli che avviluppava le cosde e scendeva sino alle gambe . Più tardi li troviamo combattere solto Annibale contro i romani con tuniche bianche orlate di rosso porporino.
Le loro armi difensive erano: piccoli scudi a mezza luna; elmi con pennacchi rossi; corazza di ciiojo. Le offensive: lancia legKiera, da punta e da geltare; spada da punta e da laglio di finissima tempra; lungo pugnale. •
Quando si ordinarono ad eserciti, ebbero due armi: fanteria e cavalleria.
La fanteria era leggera e di linea. Della prima andavano cele· bri i frombolieri baleari; portavano pelli di montone, avevano piccolo scudo e giavelollo carbonizzalo in punta.
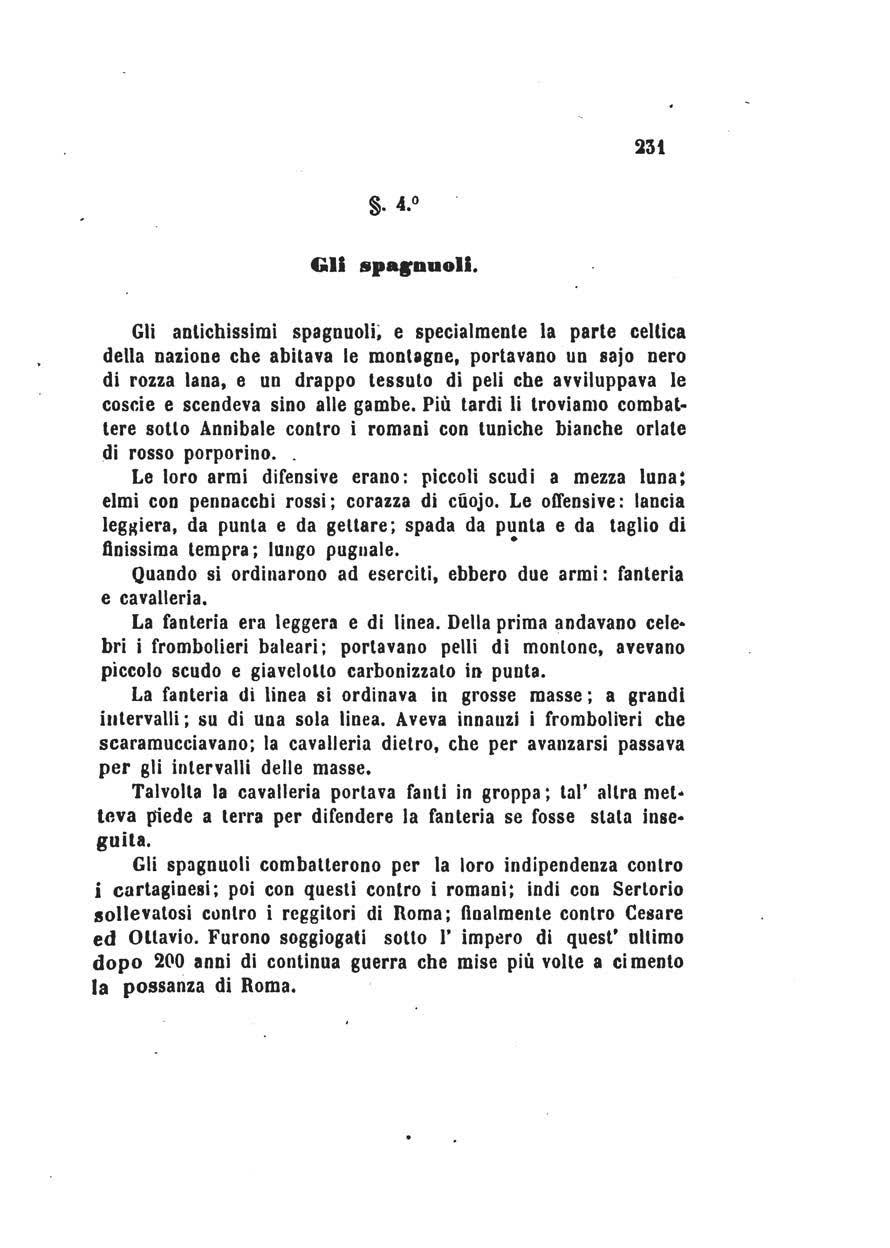
La fanteria di linea si ordinava in grosse masse; a grandi intervalli; su di una sola linea. Aveva innanzi i frombolitri che scaramucciavano; la cavalleria dietro, che per avanzarsi passava per gli intervalli delle masse.
Talvolta la cavalleria portava fanti in groppa; tal' altra mel· leva piede a terra per difendere la fanteria se fosse stata inse· guila.
Gli spagnuol i combatterono per la loro indipendenza contro i cartaginesi; poi con questi contro i romani; indi con Sertorio sollevatosi con t ro i rcggilori di Roma; finalmente contro Cesare ed Ottavio. Furono soggiogati solto l' impero di quest' ultimo dopo 2(10 anni di continua guerra che mise più volle a ci mento la possanza di Roma.
§. 5'1 .
l Parti, e le guerre dl Crasso e dl /lntoulo Erano ·esclusivamente cavallicri e di belli ssimo aspetto a cavallo.
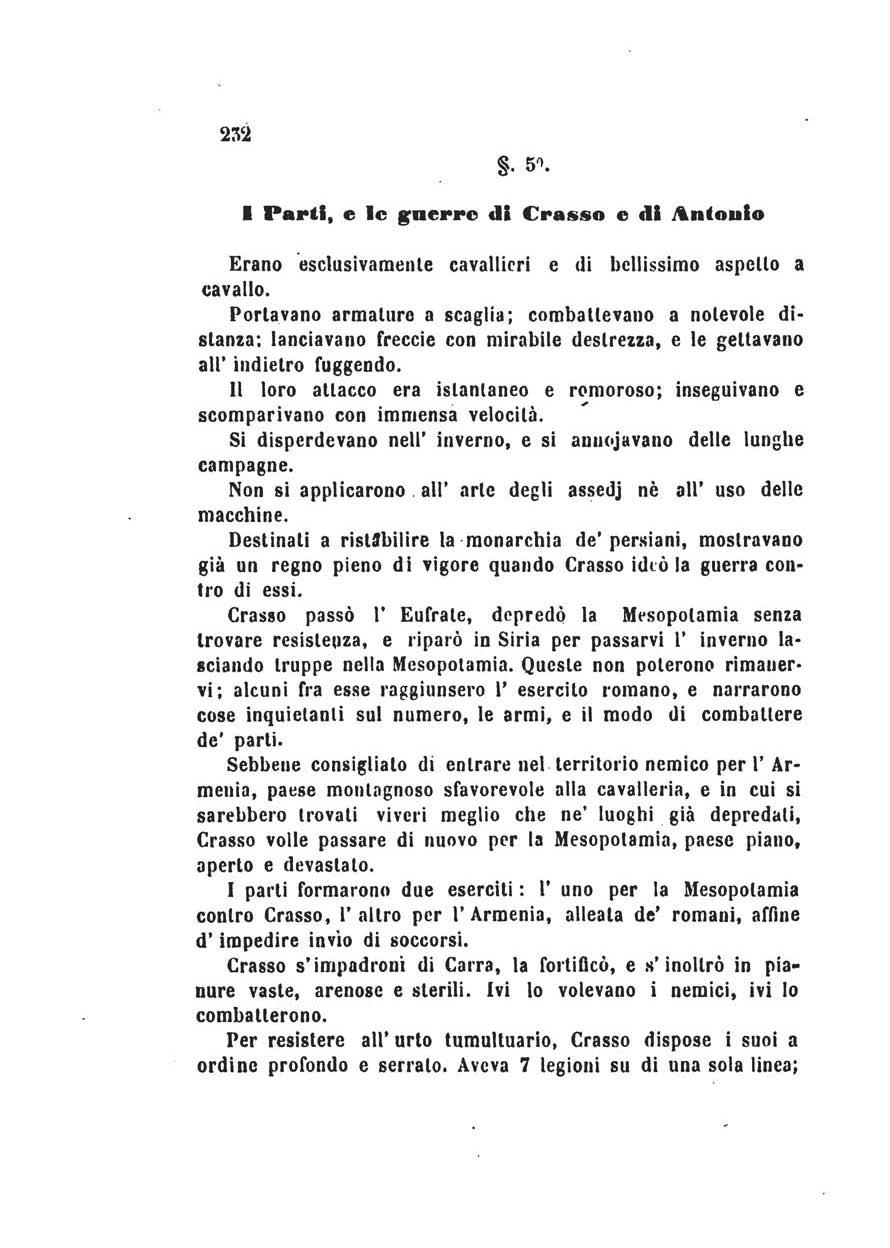
Porta.vano armature a scaglia; combattevano a notevole di stanza: lanciavano freccie con mirabile destreua, e le gettavano all' indietro fuggendo .
Il loro attacco era istantaneo e inseguivano e scomparivano con immensa velocità .
Si disperdevano nell' inverno, e si aDJwjavano delle lunghe campagne.
Non si applicarono . all' arte degli nè all' uso delle macchine.
Destinali a risUbilire la ·monarchia de' persiani, mostravano già un regno pieno d i vigore quando Crasso idrò la guerra contro di essi.
Crasso passò l' Eufrate, depredò la Ml' sopolamia senza trovare re sisteuza, e a·iparò io Siria per passarvi l ' inverno la· sciando truppe nella Mesopotamia . Queste non poterono rimauer· vi ; alcun i fra esse raggiunsero l' esercito romano, e narrarono cose inquietanti sul numero, le armi, e il modo di combattere de' parli .
Sebbene consiglialo di entrare nel . territol'io nemico per l' Armenia, paese montagnoso sfavorevole alla cavalleria, e in cui si sarebbero ta·ovali viveri meglio che ne ' luoghi già depredati, Crasso volle passare di nuovo per la Me sopotamia, paese piano, ape r to e devastalo.
l paa·ti formarono due eserciti : l ' uno per la afes opolamia contro Crasso , l' altro per l ' Armenia, alleata de' romani, affine d ' impedire invio di soccorsi.
Crasso s'impadronì di Carra, la fortifi cò, e 11' inollrò in pia· nure vaste, arenose e sterili . lvi lo volevano i nemici, ivi lo combatterono.
Per resistere all' urto tumulluario, Crasso dispose i suoi a ordine profondo e serrato. Aveva 7 legioni su di una sola linea;
Je divise in 3 grantli sezioni di !4 coorti ciascuna. Suddivise le sezioni io 2 P.arti uguali, e ordinò che una di queste parli si ponesse dietro all'altra, t', al caso, facesse fronte indietro mentre la prima sarebbe restata con fronte in lesta . La cavalleria, di 4000 cavalli, si pose fra gl'intervalli delle tre sezioni e sulle ali.
Quest'ordinanza era delta combattere in rotondo, e significa che una truppa si serra in massa e combatte da ogni parte. lnconlratisi gli eserciti ostili, i romani combatterono prima COlle truppe leggiere che non resislel'ono ai colpi nemici; le legioni sostennero l ' urto con ma un loro corpo di cavalli e fanti , distaccalo dal grosso dell'esercito, venne distrutto.
La notte pose tregua al combattimento, e i parli improvvisa· mente si allontanarono a considerevole distanza.
Crasso, approflllan do delle tenebt•e e dell' allontanamento del nemico, cominciò la ritirata su Carra; ma al mattino tornarono i parli e bersagliarono le legioni . Ciò si riprodusse ogni giorno, finchè i romani giunsero a Carra.
In uno di questi i romani pre.sero posizione difensiva su di un monticello di sabbia , e vi si disposero ad anfiteatro. Rimasero scoperti ai projetlili nemici, e furono bat· tu li (l).
Crasso fu poi ucciso a tradimento dai parli . Sbagliò inoltrandosi in terreno favorevo le alla cavalleria , arma esclusiva de ' suoi nemici ; operò bene adottando l'ordinanza accostantesi alla falangila per resistere all'urto tumultuario; non fu felice nella ' delle truppe intorno al monticello . lo seguito , Venlidio, incaricato da Antonio, baltè i parli in tre comballimenti e li cacciò dalla Palestina e dalla Siria. Poscia Antonio volle compiere l'impresa. Dopo alcuni van taggi riportati sui nemici . che non osavano più esporsi in battaglia ordinata contro le legioni, temè di mancare di viveri, e si decise alla ritirata . La eseguì su tre colonne, a 1chiera quadrata, in modo da polersi mettere sollecitamente in battaglia. ovunque fosse stato allaccato.
[t] V. pag. 190 di que sta Sto ria.
•
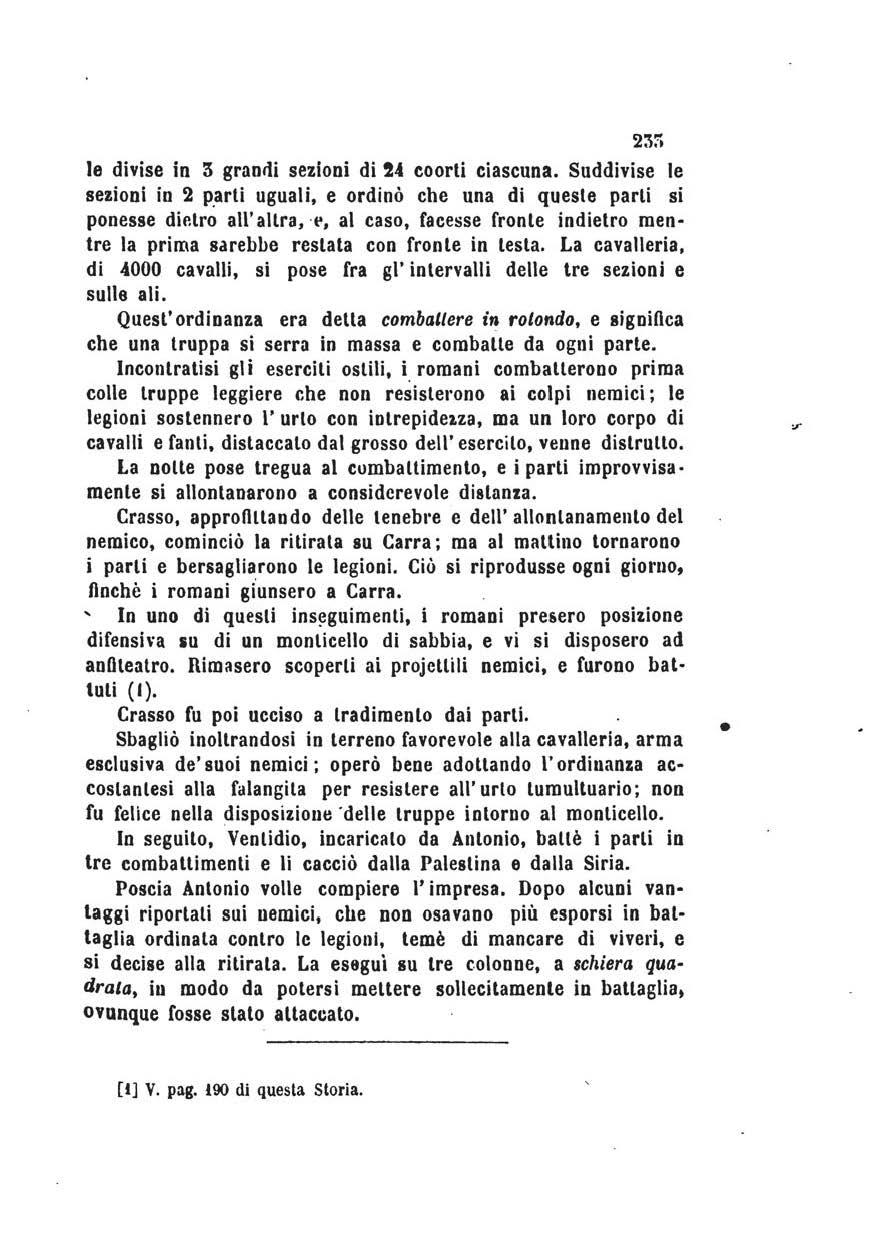
Vuolsi che Antonio sia stato il primo a formare la testuggine di tutta la sua fanteria in battaglia. Ciò accade nella circostaoaa da noi già descritta (l).
§. 6.0
Tutti coloro che fanciulli o vecchi ooo fossero, aveano l' ufficio di battersi.
I più prodi della tribù erano eletti capi nel momento di entrare in guerra.
Avevano fanteria e cavalleria.
Le armi difensive della fanteria erano: scudo di vamam ID· trecr.iati o di assi riunite, talvolta oblungo, tal' allra rotondo; rare volle corana ed elmo. Le offensive, la mezza picca leggera, e i giavelotti; non comuni a tutti la spada e la lancia . L' arma difensiva della cavalleria era lo scudo p1ù picc.olo di quello del fante . Le offensive, erano come quelle della fanteria.
Fanti e cavallieri armavansi a proprie spese.
Forza precipua era la fanteria; la cavalleria aveva cavalli mediocri, cavallieri poco esercitati.
La formazione abituale della fanteria era serrata e compatta. Suddividcvasi in cenlinaja e decine coi loro capi.
• Andavano al combattimento cantando, e facendo strepito percuotendo lo scudo.
Dando ballaglia, adottarono talvolta la formazione a cuneo.
Nel comballimento, il fante diveniva talvolta ·cavalliere bai· zando sul cavallo di un ucciso o ferito; tal' altra il cnalliere diventava fante saltando a terra, e lasciando più indietro la cavai· calura.
l capi guidavano piuttosto coll' esempio che con ordini, im· perocchè non avevano facoltà d' infliggere alcun castigo . Questo era un diritto che apparteneva ai sacerdoti.
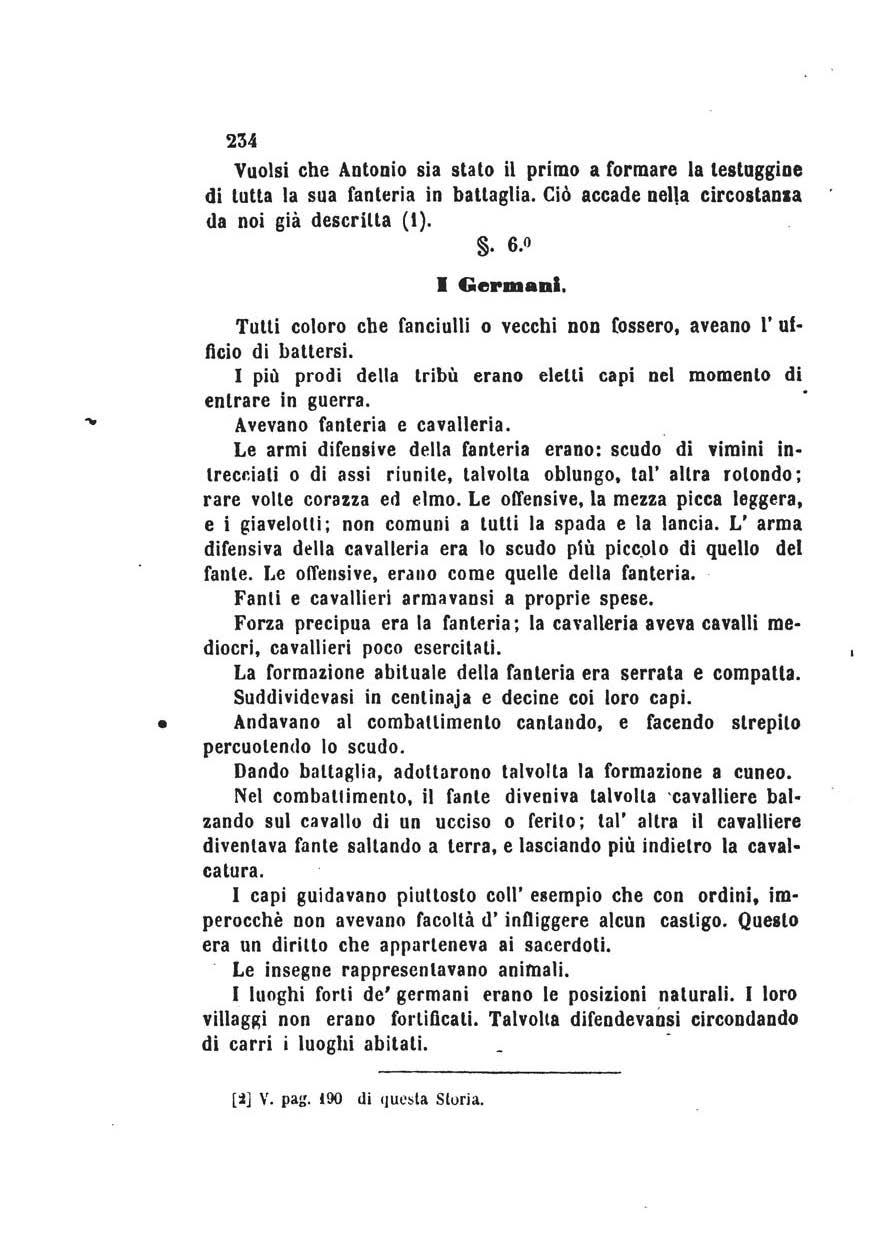
· Le insegne rappresentavano animali.
I luoghi forli de' germani erano le posizioni naturali. I loro villaggi non erano fortificali. Talvolta difeodevaosi circondando di carri i luoghi abitali. ·
[:1 ) V. pa:;. t90 di Storia.
Santo Storleo (1).
L' impero romano, invaso dai barbari, veniva squarcialo nelle sue membra, senza che il capo avesse vigor di mente da consigliare, e le braccia energia di forze da difendere . l goli, scesi dalla Scandinavia sin verso il Danubio, e1·ano divisi dal fiume Boristene in visigot i ed ostrogoti: goti dell' est, e goti dell' ovest: allorquando gli un ni, ve· nuti da stepJ'C asiatiche, passarono il Don, ed incomincia· rono ad invadere il t<>rritorio occupato dai goti. Lo spavento fu cosi grande, che i visigoti si gcllarono al sud del Danubio e fecero tremare Costantinopoli, mentre gli ostro· goti si dirigevano verso la Germania forzando le popola- e zioni a fuggire sul 8eno. Allora popolo spingendo popolo, nazione premendo nazione, tuui i barbari si cacciarono innanzi da tutte parti, ed invasero, e sconvolsero, c dominarono.
La Hrcttagna divenne preda degli angli e dci sassool. La Gallia dei franchi e dei borgognoni.
La Spagna dci visigoti.
[t] V. BALBO, Sommario della Storia d'Italia.
BRACON!'iii!R, Application de la Géo{Jraghie a l' hiltoire. MICIIA uv, Histoire des croisndes GIUI.BULLARI, Storia daJl' 800 aJ liOO•
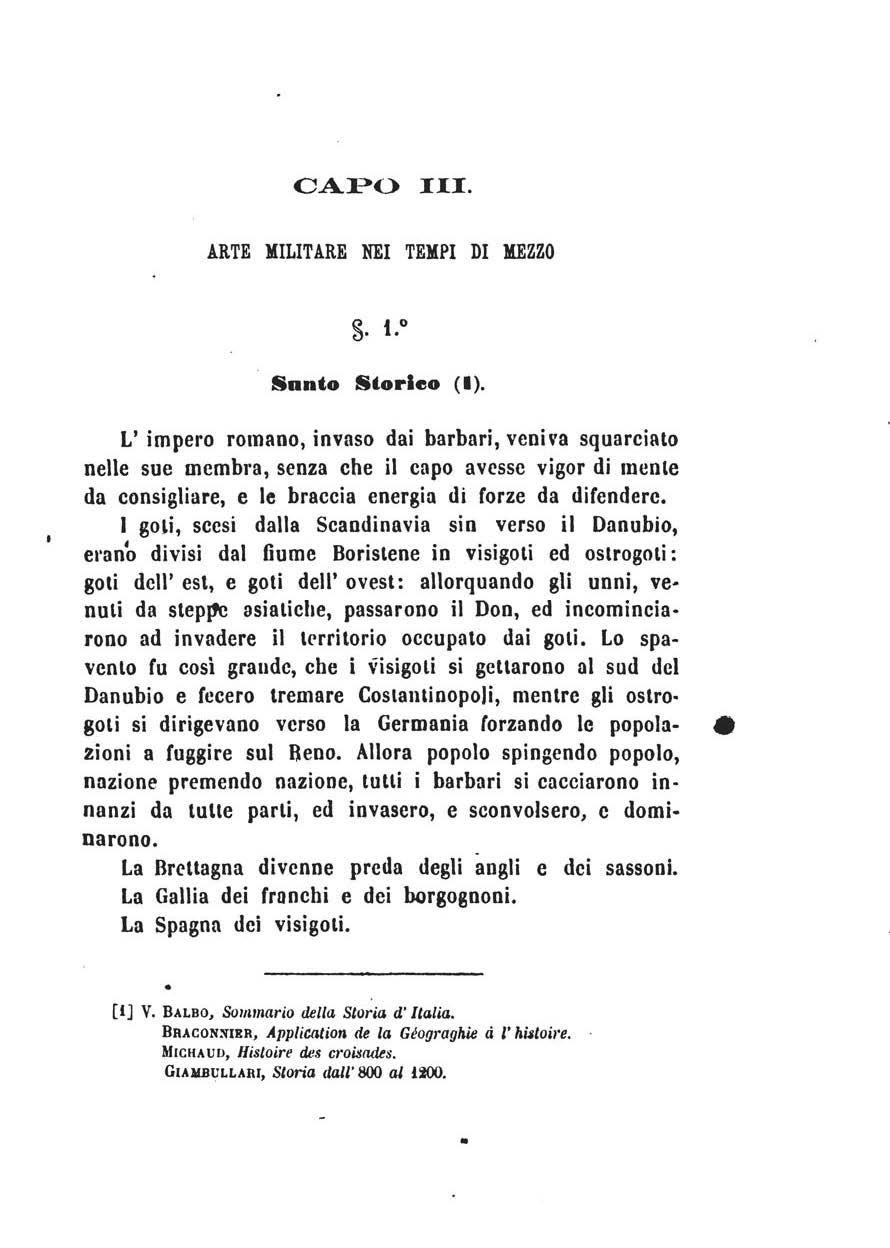
L' Italia ricevè essa pure la visita molesta di questi vi· sigoti. Alarico, loro re, venne, fu .cacciato, e tornò per saccheggiare l'antica capitale del mondo. Ma i suoi successori andarono allrove a conquistare.
Intanto veniva inalzato a re degli unni Attila flagello di Dio, il quale si vo lse prima all' impero orientale che si salvò con un anodo; poscia si precipitò sull' occi· dentale, s' ingrossò in Germania, piombò sulla Gallia. Ma riunitisi ivi, solto Ezio, i rnmani e parecchi barbari delle prime invasioni, gli opposero resistenza, vennero su lui a grande battaglia, lo vinsero a Chàlons, e lo rigettarono .sull' Italia.
Penetrò Attila nella nostra penisola, assediò e distrusse Aquileja, prese Concordia, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Milano, Pavia, portando ovunque grave eccidio. Giunto al Po, vi venne fermato da un' romana a cui era capo papa Leone; e fatto ritorno in Germania al suo ring, o cillà campale, vi morì poco appresso, e si sciolse il suo barbaro c momentaneo impero.
Se ne scat urì qunlche cosa di buono da tanto sovver· timento, si fu il sorgimento di Venezia, nobile ricello di coloro che scampavano dalle enormezze e dagli eccidj ope· rati dagli stranieri.
L' impero d' occidente durò ancora venti anni; finchè Odoacrc con genti raccogliticce, venuto per le Alpi Giulie, espugnò Roma; c deposto Romolo Augustolo, larva d' im· peratorc, assunse il titolo di re fissando la sua residenza in Ravenna e dominando su tutta l'Italia.
Mossa guerra in Pannon ia, . combatlè e vinse; ed il re di Pannonin, fuggito presso Teodorico, re dei goti orientali, cbiesP. soccorso e vendetta. Tcodorico, educato alla corte greca, cbbP. dall'imperatore d' la concessione d'Italia,
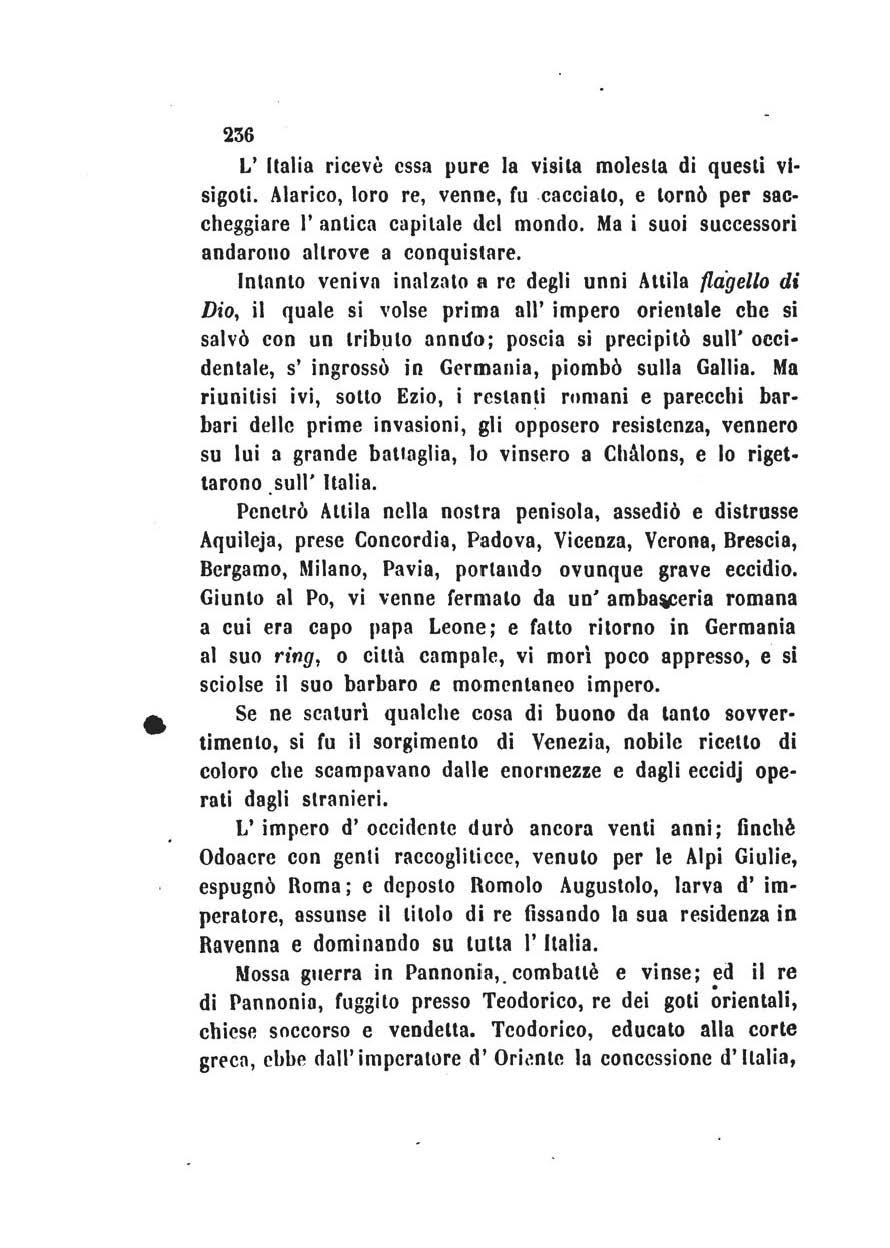
257 sulla quale, sebbene invasa, preténdeva conservare dominio. Teodorico s'incamminò con tulta sna gente dci goti, guerrieri, vecchi, fanciulli, donnu, armenti, carri e masserizie ·; guerreggiò per via e s' in grossò d' altre genti; passò le Alpi carniche, giunse all' lsonzo, dove l'aspettava Odoacre; e lì comblltterooo una prima \'Olta, poi una seconda solto Verona, poi. una terza all'Adda, rimanendo dapertulto sorc·ombente Odoacre che fu poscia ucciso alla barbara. Tu\La Italia fu di Teodorico.
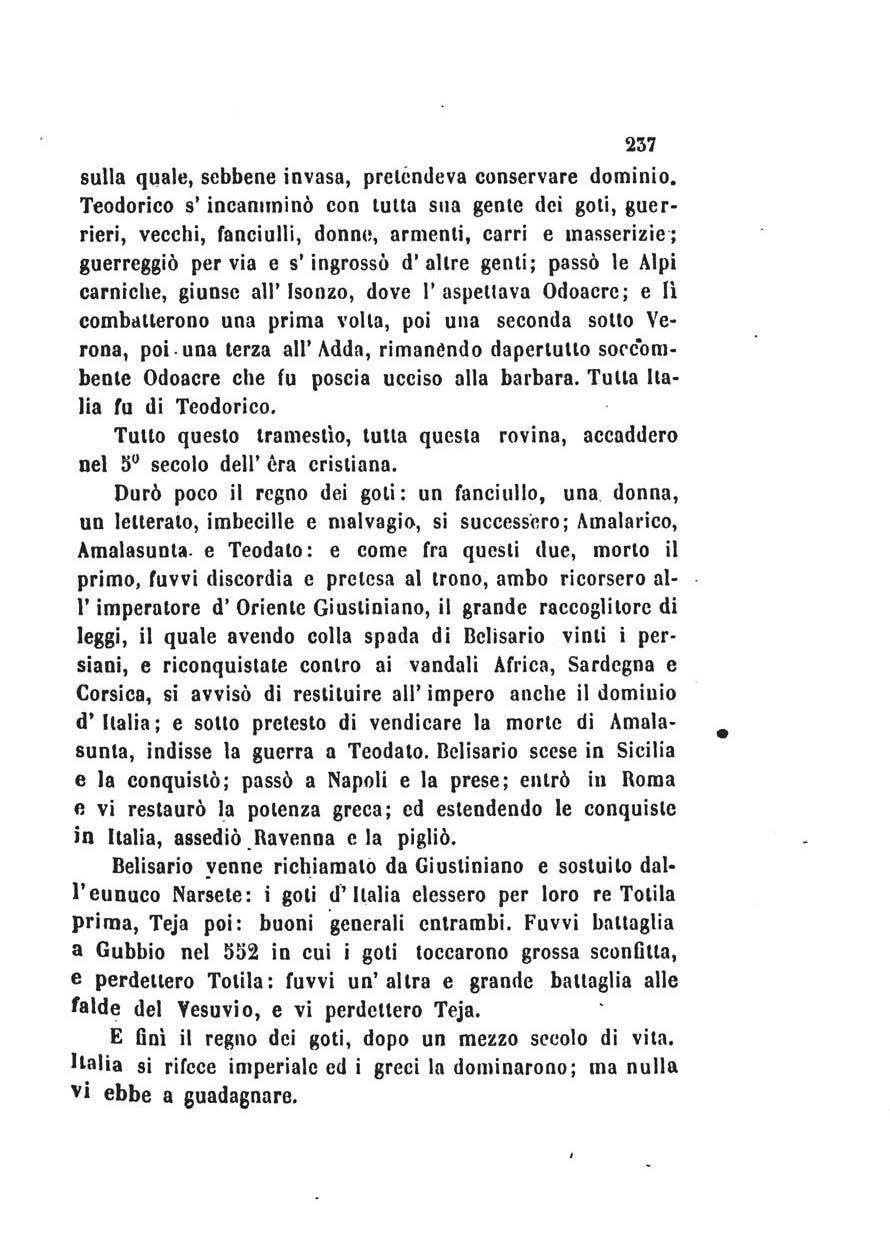
Tutto questo tramestio, tutta questa rovina, accaddero nel secolo dell' era cristiana.
Durò poco il regno dei goti: un fanciullo, una. donna, un letterato, imbecille e malvagio, si successero; Amalarico, Amalasunta. e Teodato: e come fra questi due, morto il primo, ruvvi discordia c pretesa al trono, ambo ricorsero all' imperatore d'Oriente Giustiniano, il grande raccoglitore di leggi, il quale avendo colla spada di Belisario vinti i pers iani, e riconquistate contro ai vandali Af1·ica, Sardegna e Corsica, si avvisò di restituire all' impero anche il dominio d' Italia; e sotto pretesto di vendicare la morte di Amalasuola, indisse la guerra n Teodato. Bclisario scese in Sicilia e la conquistò; passò a Napoli e la prese; entrò in Roma e vi restaurò la potenza greca; cd estendendo le conquiste in llalia, assediò . Ravenna e la pigliò.
Belisario yenne da Giustiniano e sostuito dal· l'eunuco Narsele: i goti d.' elessero per loro re Totila prima, Teja poi: buoni ·generali entrambi. Fuvvi battaglia a Gubbio nel 552 io cui i goti toccarono grossa sconfitta, e perdettero Totila: fuvvi un' allra e grande battaglia alle del Yesuvi o, e vi perdcttero Teja.
E finì il regno dci goti, dopo un mezzo secolo di vita. halia si rifece imperiale cd i greci In dominarono; ma nulla v i ebbe a guadagnare.
Un anno dopo, e precisamente nel :s:u., scese dall'Alpi un'orda di franchi e di alemanni sotto la condotta di Buecellino. Costoro corsero la penisola e la predarono per qualche tempo; ma venuti a giornata al Volturno, furono battuli a Casilino da Narsete e più non si parlò di loro.
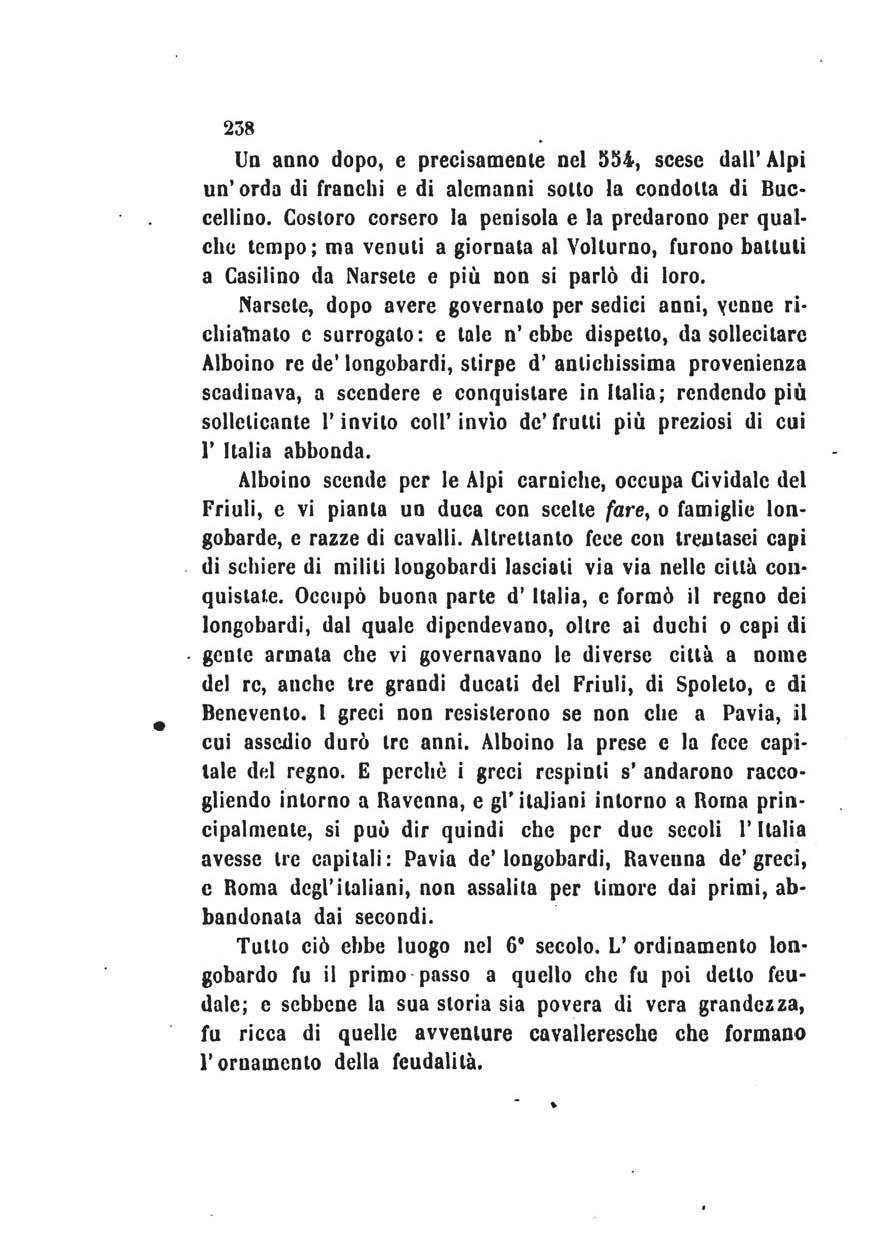
Narscte, dopo avere governato per sedici anni, venne riichialnato c surrogato: e tale n' ebbe dispetto, da sollecitare Alboino re de' longobardi, stirpe d' antichissima provenienza scadinava, a scendere e conquistare in Italia; rendendo più solleticante l' invito coll' invio dc' frulli più preziosi di cui l' Italia abbonda.
Alboino sccntle per le Alpi carniche, occupa Cividale del Friuli, c vi pianta uo duca con scelte fare, o famiglie longobarde, c razze di cavalli. Altrettanto fece con treutasei capi di schiere di militi longobardi lasciati via via nelle città con· quistate. Occupò buona parte d' llalia, c formò il regno dei longobardi, dal quale dipendevano, oltre ai duchi o capi di . gente armata che vi governavano le diverse cilLà a nome del re, anche tre grandi ducati del Friuli, di Spoleto, e di Benevento. l greci non resisterono se non che a Pavia, il cui assedio durò tre anni. Alboino la prese c la fece capitale dt:l rf.'gno. E perehè i greci respinti s' andarono raccogliendo i'n torno a Ravenna, e gl' ilaJiani intorno a Roma prin· cipalrnente, si può dir quindi che per due secoli l'Italia avesse tre capitali: Pavia dc' longobardi, Ravenna de' greci, c Roma degl'italiani, non assalita per timore dai primi, abbandonata dai secondi. ·
Tutto ciò chbe luogo nel 6' secolo. L' ordinamento Iom· go bardo fu il primo · passo a quello che fu poi detto fcu· dale; c sebbene la sua storia sia povera di vera grandcua, fu ricca di quelle avventure cavalleresche che formano l'ornamento della feudali là.
239
Il regno de' longobardi durò in Italia per due secoli: dal !)68 al 774.
l dissapori .fra i longebardi cd i greci cd il papa, indussero questo a fare per primo quella chitlmata dei franchi che fu sciaguratamente rinnovata poi da' s uoi successori.
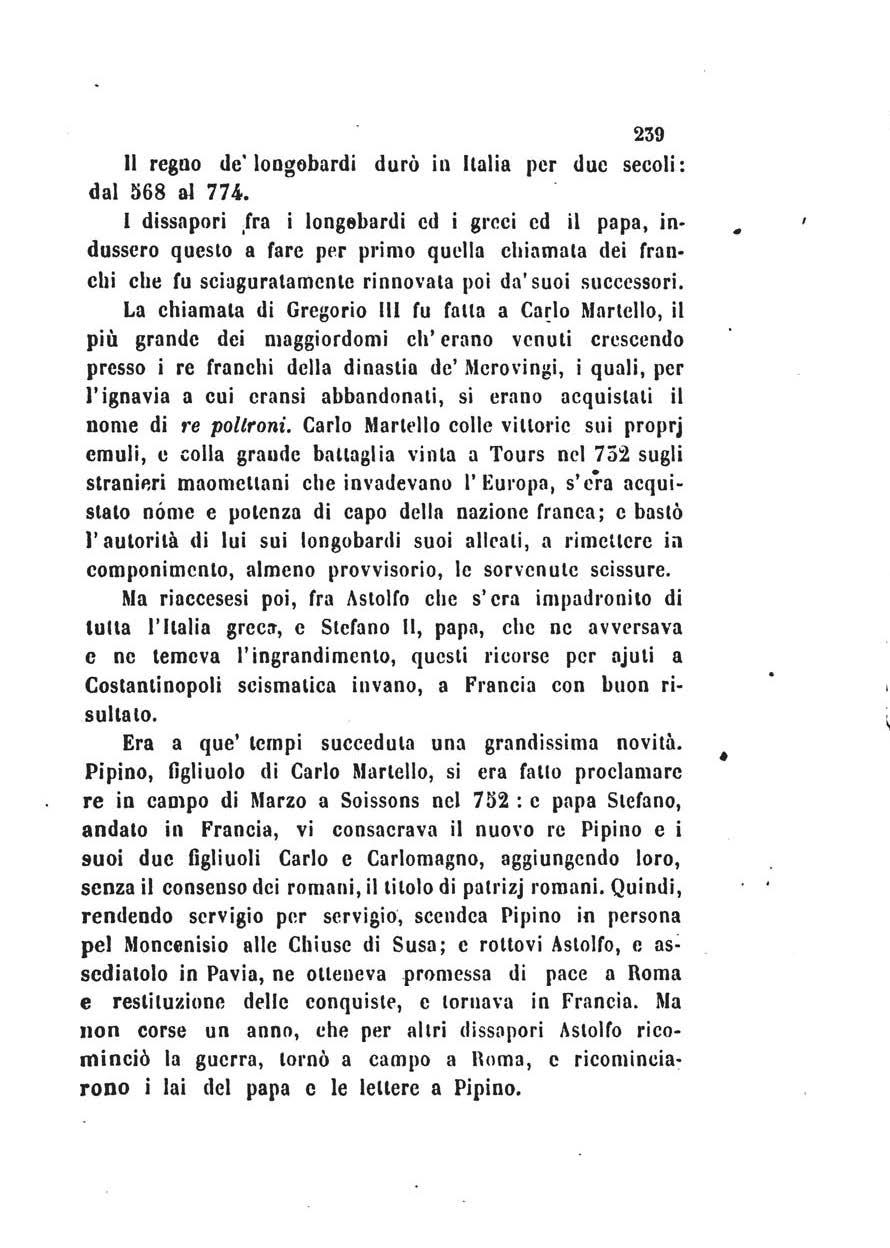
La chiamata di Gregorio Ili fu fatta a Martello, il più grande dei maggiordomi ch'erano venuti crescendo presso i re franchi della dinastia dc' Mcrovingi, i quali, per l'ignavia a cui cransi abbandonati, si erano acquistati il nome di re poltroni. Carlo Marlt•llo colle villot·ie sui proprj emuli, c colla grande battaglia vinta a Tours nel 752 sugli straoiP.ri maomcttani che invadevano l' Eut·opn, s'era acquistato nome e potenza di capo della nazione franca; c bastò )'autorità di lui sui longobardi suoi alleali, a rimettere iil componimento, almeno provvisorio, le sorvcnutc scissure.
Ma rinccesesi poi , fra Astolfo che s'era impad•·onilo di &una l'Italia grec3", c Stefano Il, papa, che ne a vversava c ne temeva l'ingrandimento, questi ricorse per ajuli a Costantinopoli scismatica invano, a Francia con buon risultato.
Era a que' tempi succcdutn una grandissima novità. Pipino, figliuolo di Carlo Martello, si era fallo proclamare re io campo di Marzo a Soissons nel 7!52 : c pnpa Stefano, andato in Francia, vi consacrava il nuo\'o re Pipino c i suoi due figliuoli Carlo e Carlomagno, aggiungendo loro, senza il consenso dci romani, il titolo di patrizj •·omani. Quindi, rendendo servigio per servigio· , sccndca Pipino in persona pel Moncenisio alle Chiuse di Susa; c rotto vi Astolfo, c scdiatolo in Pavia, ne olleneva .promessa di pace a Roma e restituzione delle conquiste, c tornava in Francia . Ma non corse un anno, che per allri dis snpori Astolro ricominciò la guerra, lo•·nò a campo a Boma, c ricomincia· rono i lai del papa c le lettere a Pipino.
2'10
Oh se la conquista longohardo fosse stata compiuta in ,tutta llalia, senza che l' invocato straniero venisse a sper· dcrla, forse non avremmo avut" il tristo spettacolo nella penisola di tanti secoli di guerre, di servitù e d' inelfabili dolori!
Pipino ricalcava la sua via, ribaucva i longobardi alle Chiuse, riasscdiava Astolfo in Pavia; e, ridouolo, prendeva il terzo del tesoro regio, gl'imponeva un tributo annuo, c fallesi restituire iu elTetto le conquiste, ne faceva egli poi donazione a S. Pietro, -alla chiesa romana ed ai papi, in perpetuo e per iscritto.
Nè còn ciò si mantenne la pace: i papi misero fuori altre pretese verso Desiderio succcduto ad Astolfo; c non ottenendo soddisfacimento pieno alle loro voglie, tornarono a tcmpestare di lettere il protettore Pipino, il quale od. inveccbiato od occupBlo in altro non tornò più.
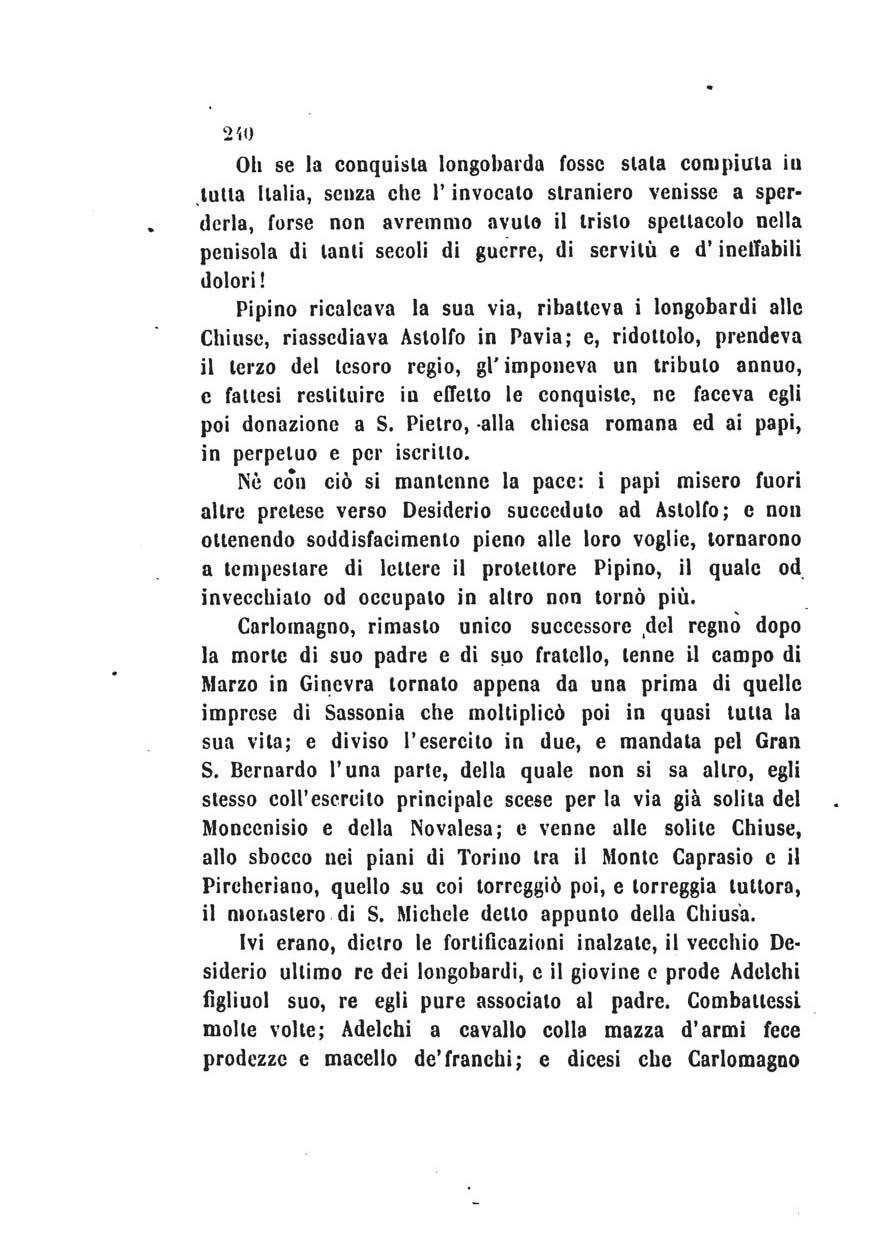
Carlomagno, rimasto unico successore ,del regnò dopo la morte di suo padre e di S!JO fratello, tenne il campo di l\larzo in Gil"!cvra tornato appena da una prima di quelle imprese di Sassonia che moltiplicò poi in quasi tutta la sua vita; e diviso l'eserc ito in due, e mandata pel Gran S. Bernardo l'una parte, della quale non si sa altro, egli stesso coll'esercito principale scese per la via già solita del e della Novalesa; e venne alle solite Chiuse, a11o sbocco nei piani di Torino tra il Monte Caprasio c il Pircheriano, quello .su coi torrcggiò poi, e torreggia tuttora, il mor1astero . di S. Michele dello appunto della Chiusa.
lvi erano, dietro le fortificazioni inalzate, il vecchio De· siderio ultimo re dei longobardi, c il giovine c prode Adelchi figliuol suo, re egli pure associato al padre. Combattessi molte volte; Adelchi a cavallo colla mazza d'armi fece prodczzc e macello de' franchi; e dicesi che Carlomagno
trattasse già di accorda od a neo d'indietreggiare. Quando, fosse per cl.' noo di un giull are, o di un diacono di Ra\·cnna maudatovi apposta, o per tradimento d'alcuni longobardi, o per perspicacia ed arte mili tare, Carlo metteva una schiera per le gole laterali e non guardate di Giaveno intorno al Pirchiriano, e così prendeva alle spalle i longobardi che se ne spaventarono e ruggirono sba ragliati. l due rc,'c i grandi del regno, si chiusero in Pavia e Verona; . e Carlomagno assediò la prima sulla metà del 775, e prese la seconda al ca"dere di quell' anno. Combattevasi tullavia alla campagna; c dicesi che si seminasse d' immenso numero di morti longobardi un campo che prese il nome di Mortara.
Dopo un anno d' assedio, Carlo prese Pa,·ia, c Desiderio re fu m;;mdato in Francia ove pare che si facesse monaco. Adelchi si rifuggì in Costantinopoli; c tornato da veoturiero in llnlia, fu famoso nelle fiabe del medio evo, c fallo illustre n' dì nostri da Alessandro Manzoni.
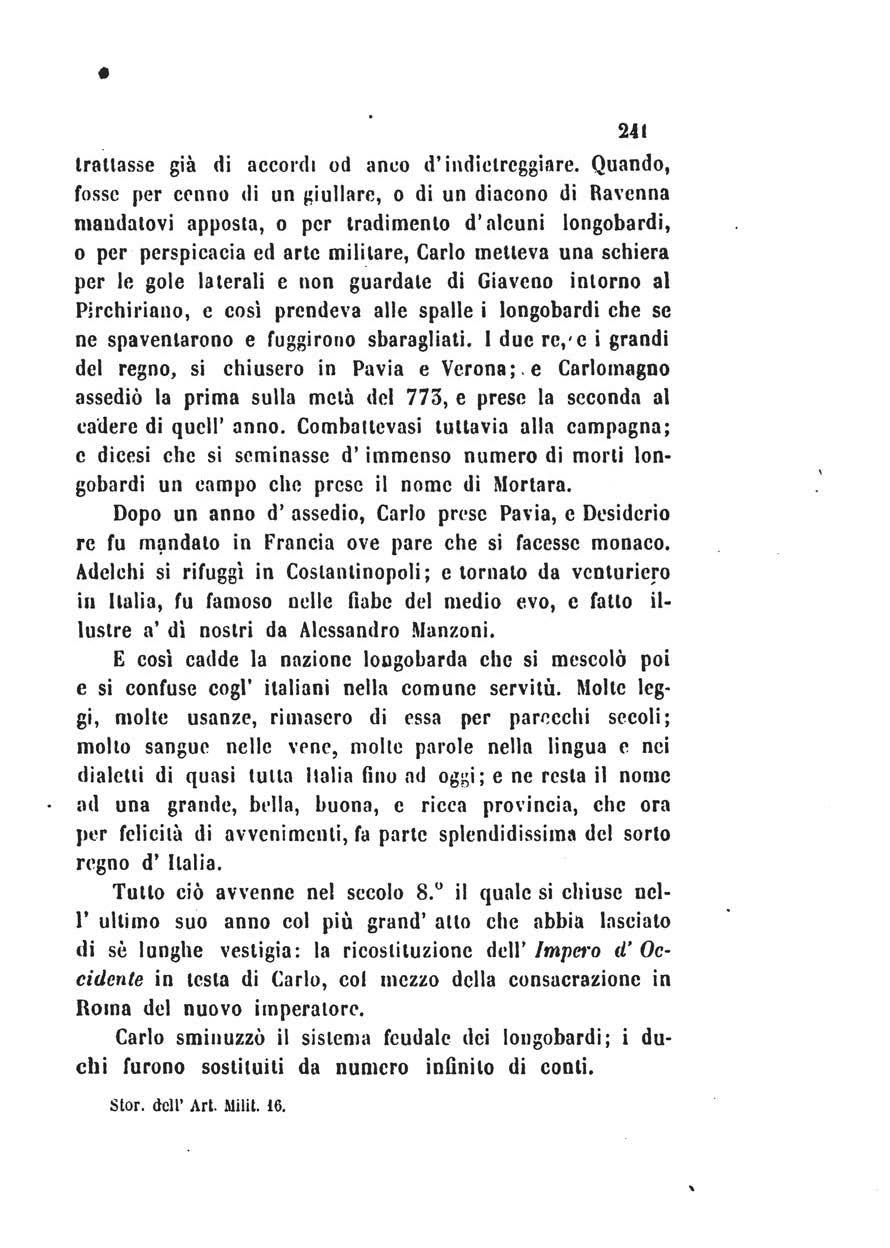
E così cadde la nozion e loogobarda che si mescolò poi e si confuse cogl' italiani nella comune servitù . Molte leg· gi, molle usanze, rimasero di essa per parr.cchi secoli; molto sangue nelle \'Pne, molte parole nello lingua c nei dialetti di quasi tu un Italia fino ad og 0i; e ne resta il nornc :ul una grande, bt'lla, buona, c ricca provincia, c he ora felicità di avvenimenti, fa parte sp lcndidi ssi ma del sorto regno d' llalia .
Tutlo ciò avvenne nel secolo 8. 0 il quale si chiuse nell' ultimo suo anno col più grand' atto che nbbia lasci ato di sè lunghe vestigia: la ricoslituzione dell' lmpet·o d' Occidente in testa di Carlo, col mezzo della consacrazione in Roma del nuovo imperatore.
Carlo smi nuzzò il sislcma feudale dci long obardi; i duchi furono sostituiti da numero infinito di conti.
Stor. dell' Art. Milil. 16.
L' impero ricostituito da Cado comprendeva la Gallia, l' llalia, e la Germania fino all' Oder c al Danubio; il corso delle vittorie dei barbari settentrionali venne arrestato; i popoli della Germania e della Scandinavia si fermarono e cominciarono a incivilirsi; c, sciolto dopo Carlo il nuovo impero romano, si di\·ise esso nei tre stati di Francia, d'Italia, e di Germania, rimanendo però inc()lumc il titolo d' impe•·atore che dalla corona franca era passato alla tedesca.
Coi Carolingi, principi gli uni miseramente pii, gli allri sfacciatamente scellerati, tuLLi mediocri, tutti contendenti pci numerosi ctJ instabili regni in cui si divi se c ridivise l' imperio, c ·quasi tuui per l 11 dignità d' imperatore che li dominava c li infcrmava , seguono i più poveri anni che si11no di falli veramente italiani. Il papa che incoronava gl' imperatori, i re d' Italia che entravano in quelle contese di famiglia, furono i soli che operassero; la nazione non fu, non fece nulla: in pnce ed in guerra serviva e soffriva.
Fuvvi un momento, sul finire del secolo 9.o in cui Carlo il Grosso, re ù' Italia, riunì di nuovo l' impero d' Occidente fondato da Carlomagno, c sarcbbesi detto che codesto impero fosse realmente ristaurato. !\la ciò non avvenne, o per l' incapacità del regnante, come •licono ta· luni, o piuttosto per la tendenza naturale cbc a\'e\'ano le diverse nazioni europee a ricostituire le loro nazionalità, or riunite ora divise, sempre offese tutti i Carolingi contro la nalUra delle schio tte c dci · limi ti.
Si separarono bentosto , c si ricostituirono Francia, Gcrmn· uia e Italia : la prima per sèmpre Ono a' dì nostri; le altre due a rimescolarsi e impedirsi e ouocersi a vicenda; fiochè, in questi ultimi anni, ambedue auesero al loro definitivo e compiuto ordinamento io nazione, ed i loro sforzi soste·
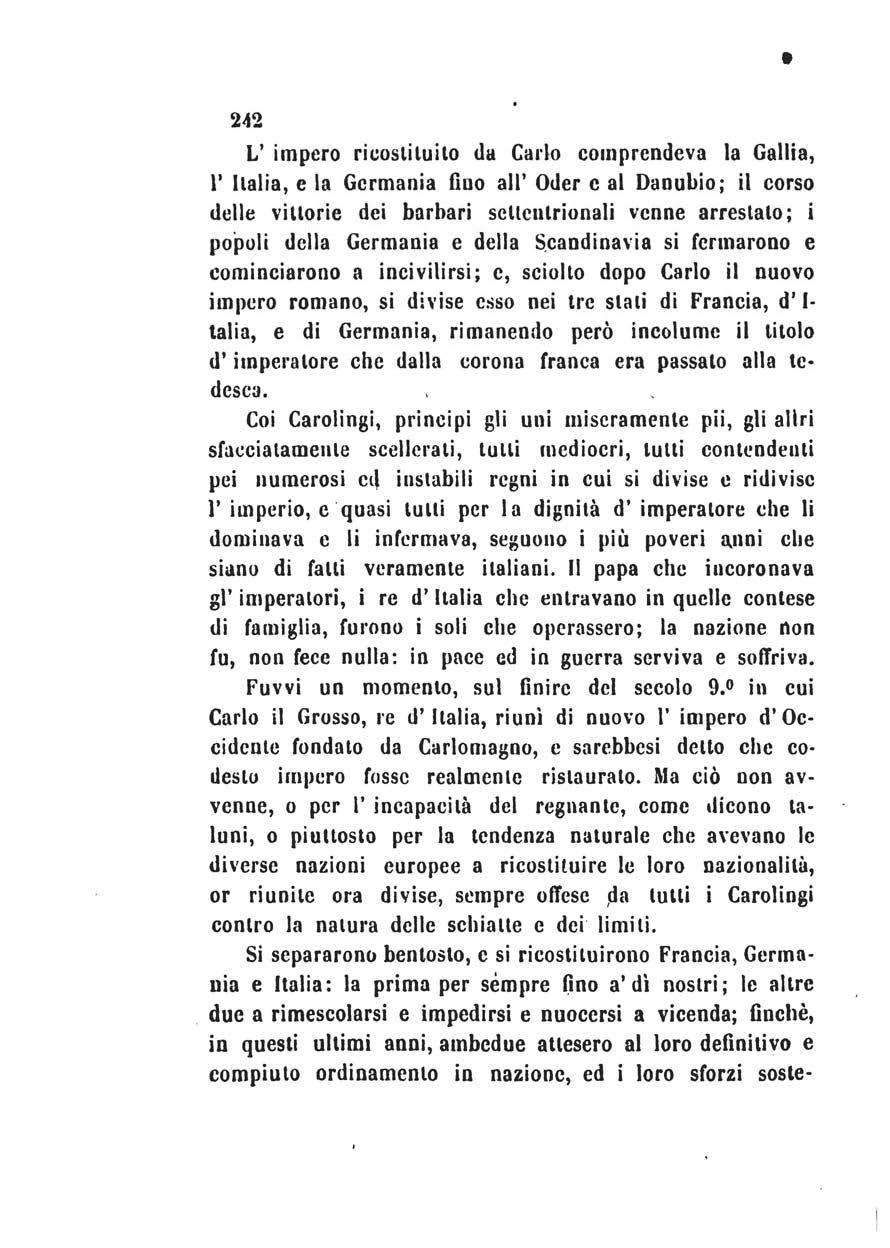
243 outi con molti sacriJicj, vengono coronati da felice risul· lamento.
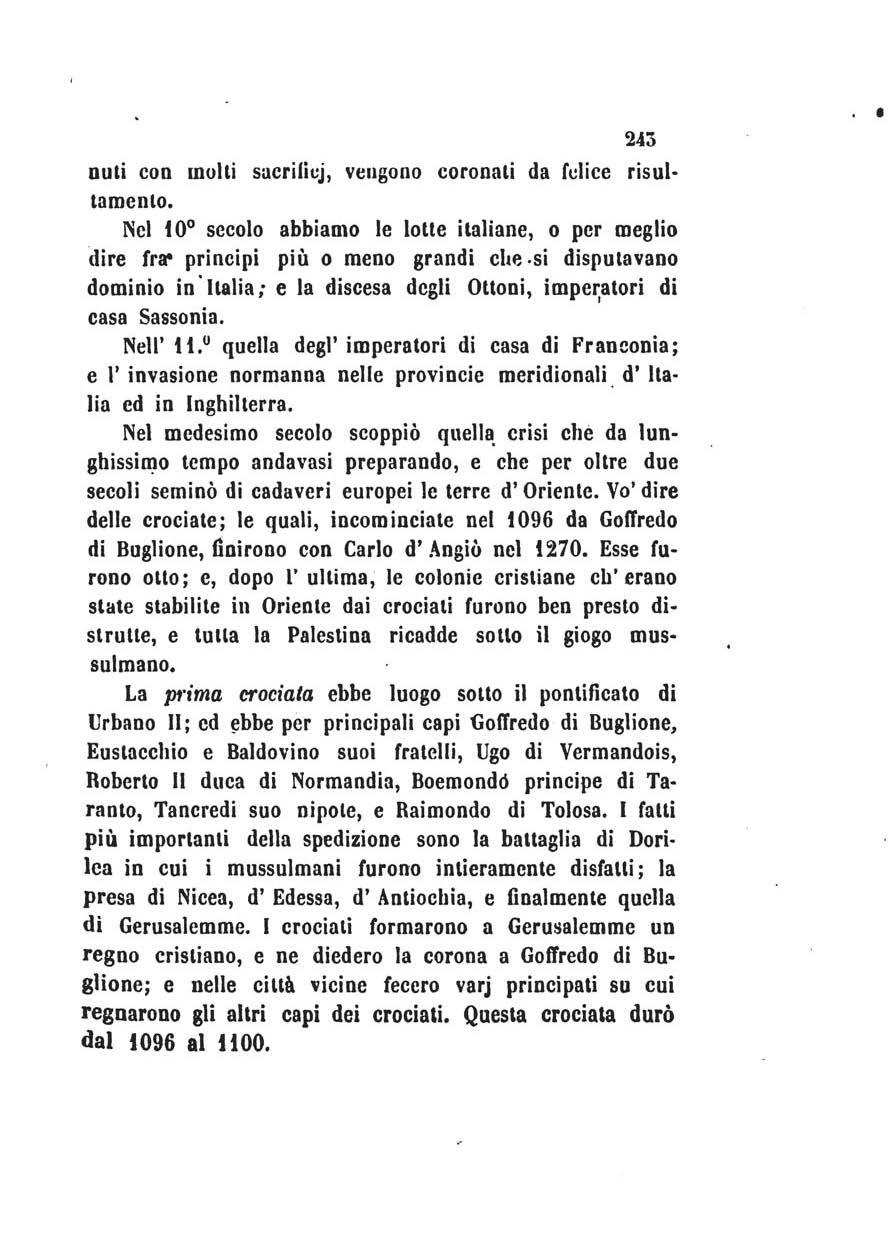
Nel t 0° secolo abbiamo le lotte italiane, o per meglio (lire fr:t principi più o meno grandi che .si disputavano dominio in 'llalia; e la discesa degli Ottoni, di casa Sassonia.
Nell' H . 0 quella degl'imperatori di casa di Franconia; e l' invasione normanna nelle provincie meridionali. d' Ila· Jia ed in Inghilterra.
Nel medesimo secolo scoppiò quella. crisi chè da luntempo andavasi preparando, e che per oltre due secoli seminò di cadaveri europei le terre d'Oriente. Vo' dire delle crociate; le quali, in com in eia te nel t 096 da Goffredo di Buglione, finirono con Carlo d' Angiò nel i 270. Esse furono ouo; c, dopo l' ultima, le colonie cristiane cb' erano state stabilite in Oriente dai crociati furono ben presto distrutte, e tulla la Palestina ricadde soUo il giogo mussulmano.
La pt'ima crociata ebbe luogo soLto il pontificato di Urbano Il; cd çbbe per principali capi 'Goffredo di Buglione, Eustacchio e Baldovino suoi fratelli, Ugo di Vermandois, Roberto Il duca di Normandia, Boemondo principe di Ta· ranto, Tancredi suo nipote, e Raimondo di Tolosa. l fatti più importanti della spedizione sono la bauaglia di Dorilca in cui i mussulmani furono intieramcnte disfalli; la presa di Nicea, d' Edessa, d' Antiochia, e finalmente quclJa dì Gerusalemme. l crociati formarono a Gerusalemme un regno cristiano, e ne diedero la corona a Goffredo di Buglione; e nelle ciuà vicine fecero varj principati su cui regnarono gli altri capi dei crociati. Questa crociata durò dal 1096 al 1100.
La seconda crociata fu intrapresa sotto iJ pontificato di Eugenio 111, ed ebbe per capi Luigi VII re di Francia c Corrado imperatore di Germania. Questi due principi sof· frirono molti rovesci. Essi sul punto di prendere Da- . masco , quando la discordia penetrò rra i signori dei loro eserciti, e li costrinse ad abbandonare l' impresa ed a ri\ornarc io Europa. Questa crociata durò dal t 147 al t t49.
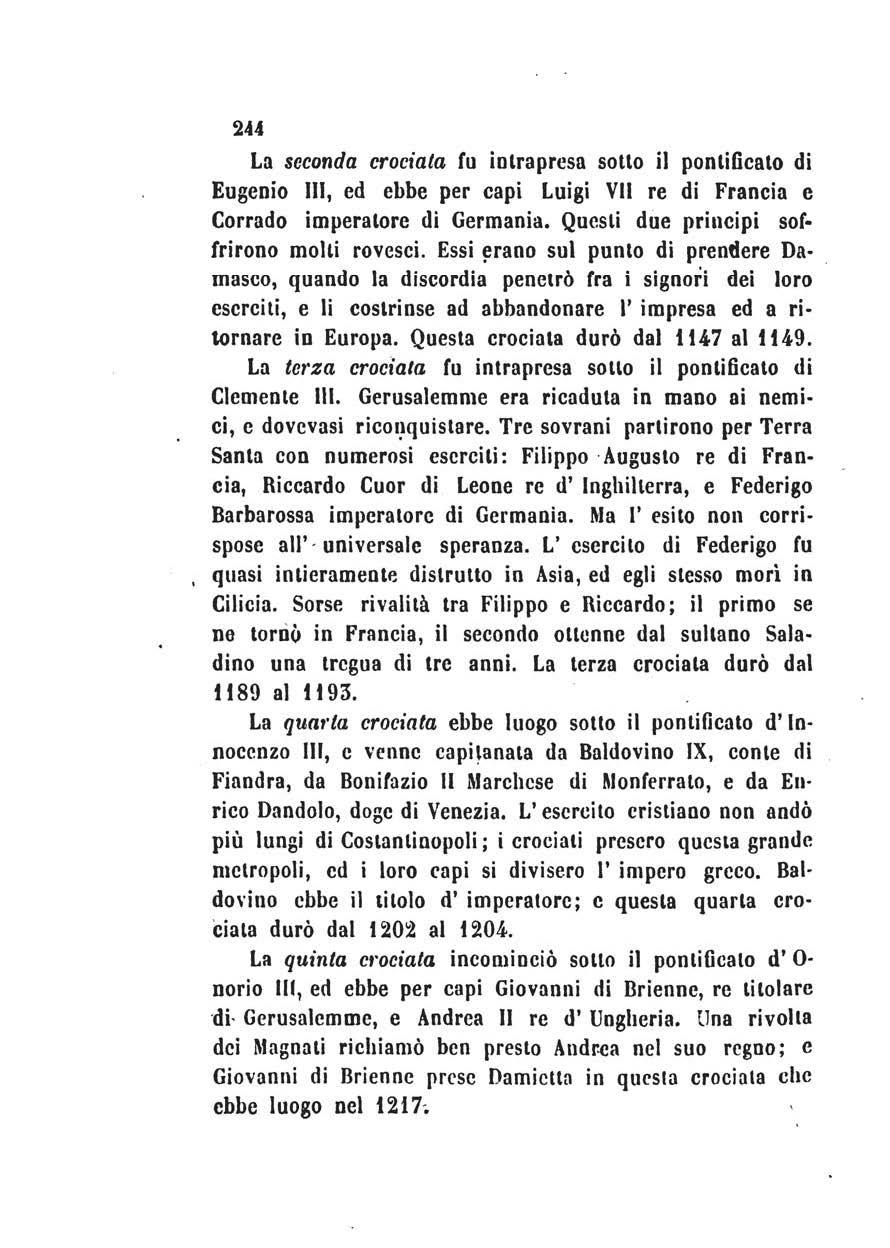
La terza crociata fu intrapresa sotto il pontificato di Clemente 111. Gerusalemme era ricaduta in mano ai nemi· ci, c dovevasi ricor}quistare. Tre sovrani partirono per Terra Santa con numerosi eserciti: Filippo ·Augusto re di Francia, Riccardo Cuor di Leone re d' Inghilterra, e Federigo Barbarossa imperatore di Germania. Ma l' esito non corrispose all' · universale speranza. L' esercito di Federigo fu . quasi intieramente distrutto in Asia, ed egli stesso mori in Ciii eia. Sorse rivalità tra Filippo e Riccardo; il primo se ne toròò in Francia, il secondo ottenne dal sultano Sala· dino una tregua di tre anni. La terza crociata durò dal tt 89 al t t 93.
La quat'ta crociata ebbe luogo sotto il pontificato d'In· noccnzo 111, c venne da Baldovino IX, conte di Fiandra, da Bonifazio Il Marchese di Monferrato, e da En· rico Dandolo, doge di Venezia . L'esercito cristiano non andò più lungi di Costantinopoli; i crociati presero questa grande metropoli, cd i loro eapi si divisero l' impero greco. Bai· do,·ino ebbe il litolo d' imperatore; c questa quarta ero· ciata durò dal t 202 al f 204.
La quinta crociata incominciò sotto il pontificato d' 0norio 111, ed ebbe per capi Giovanni di Driennc, re titolare ·di· Gerusalemme, e Andrea Il re d' Ungheria . Una rivolta dci Magnati richiamò ben presto Andr.ca nel suo rcgoo; c Giovanni di Briennc prese Damiclta in questa crociata che ebbe luogo nel
2.45
La sesta crociata fu compita sotto il pontificato di Gregorio IX dall' Imperatore Fedcrigo Il. Il sultano 'Meledino gli cedette Gerusalemme senza combauere, e tutto questo ebbe principio e fine dal t 228 al t 229.
La settima crociata fu intrapresa sotto il pontificato d' lnoocenzo IV, e capitanata da Luigi IX re di Francia. Essa fu diretta contro l'Egitto; il re di Francia prese Damietta, della anche Damiata, e vi diede la battaglia di Mansurah. Ma essendosi manifestata lo peste nel suo esercito, fu costretto di retrocedere innanzi al nemico, etl egli me· desimo cadde Comperò a caro prezzo la propria libertà; passò quattro nnni io Palestina e vi fortificò qualche città, poi rttornò io Francia dopo la morte della regina Bianca sua madre, ch' egli aveva lasciata durante la sua assenza. Questa crociata durò dal t 248 al t254.
L' ottava ed ultima crociata fu intrapresa sotto il pontificato di Clemente IV, e capitanata essa pure da Luigi IX re di Francia, accompagnato da Carlo d'Angiò suo fratello e dal principe Edoardo d'Inghilterra. Luigi si diresse verso Tunisi, sperando di convertirvi, come dice taluno, il si· gnore della cittù, Mohammed Mostanser. Ma ero appena giunto sotto le mura di Tunisi che vi morì di peste. Carlo d' Aogiò si mise allora alla testa delle truppe; riportò qual- · che vantaggio, e ritornò in Francia dopo aver costretto ' Mohammed a pagare le spese della guerra. Questa crociata llurò dal 1268 al t 270.
Dopo quest' ultima spedizione, le colonie cr istiane che erano state stabilite in Oriente dai crocitlli furono ben presto distrutte, e tutta la Palestina ricadde sotto il gi9go m ussulmano. ..
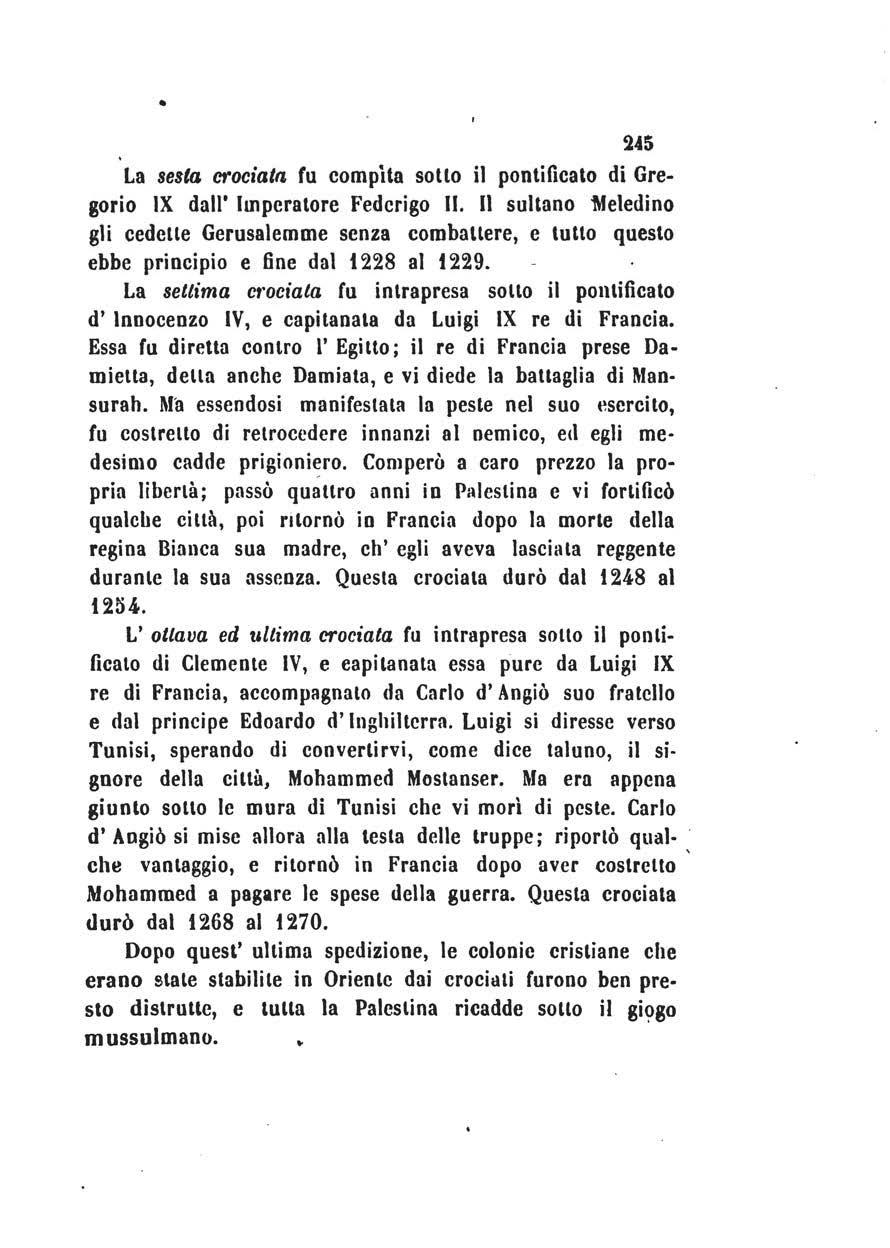
2-16
Fu pur dato il nome di Ct'ociate ad alcune spedizioni dirette ct>ntro gli eretici, e specialmente alla guerra contro gli Albigesi di Francia. ·
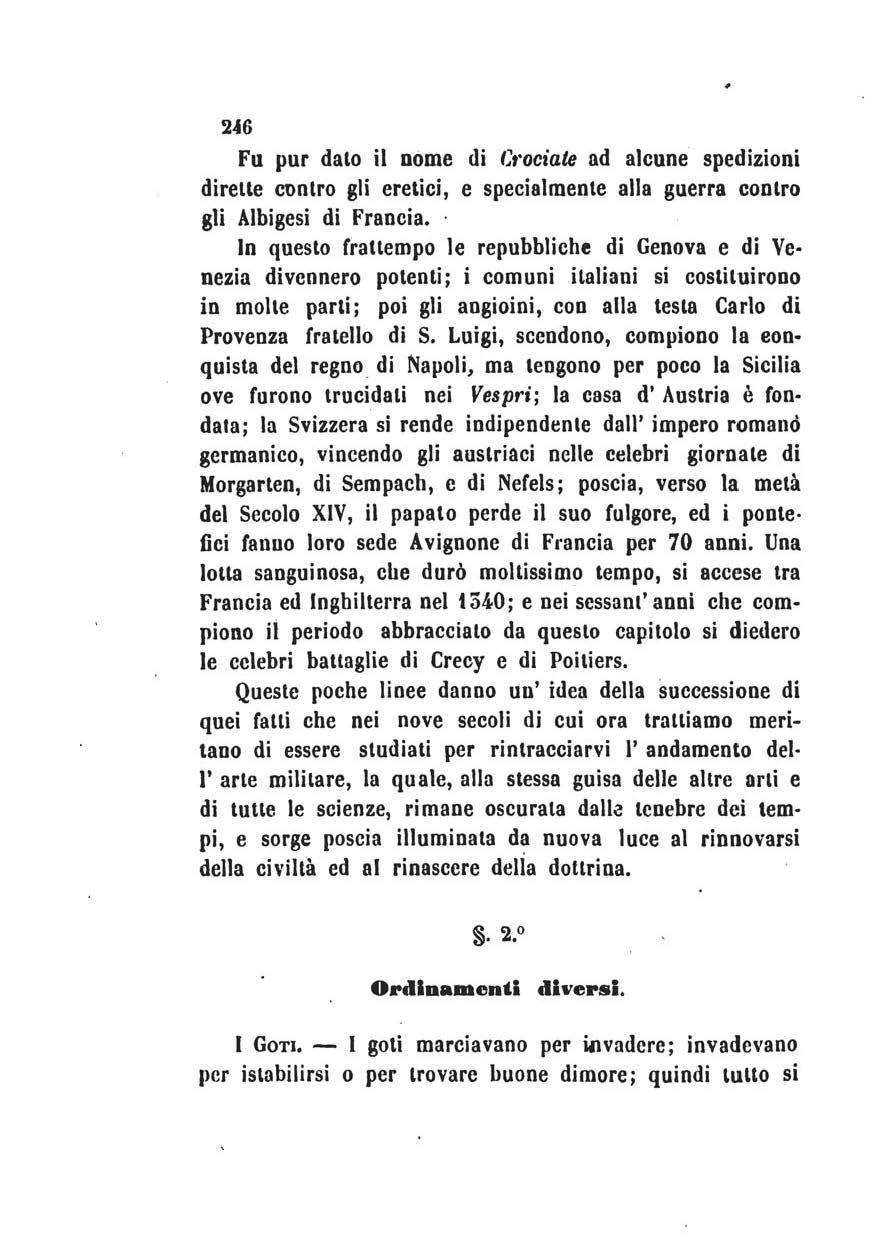
lo questo frattempo le repubbliche di Genova e di Ve· nezia divennero potenti; i comuni italiani si costituirono io molte parli; poi gli angioini, co o alla testa Carlo di Provenza fratello di S. Luigi, scendono, compiono la conquista del regno. di Napoli, ma tengono per poco la Sicilia ove furono trucidati nei Vespri; la casa d'Austria è fon· dala; la Svizzera si rende indipendente dall' impero romanò germanico, vincendo gli austriaci nelle celebri giornate di Morgarten, di Sempach, c di Nefels; poscia, verso la metà del Secolo XIV, il papato perde il suo fulgore, ed i ponte· fici fanno loro sede Avignone di Francia per 70 anni. Una lotta sanguinosa, che durò moltissimo tempo, si accese tra Francia ed Inghilterra nel t 540; e nei sessa n l'anni che compiono ii periodo abbracciato da questo capitolo si diedero
Je celebri battaglie di Crecy e di Poitiers. Queste poche linee danno un' idea della successione di quei falli che nei nove secoli di cui ora trattiamo meritano di essere studiati per rintracciarvi l' andamento del· l' arte militare, la quale, alla stessa guisa delle altre arti e di tutte le scienze, rimane oscurata tenebre dci tem· pi, e sorge poscia illuminata nuova luce al rinnovarsi della civiltà ed al rinascere della dottrina.
l GoTI. -l goti marciavano per Ìllvadcre; invadevano per istabilirsi o per trovare buone dimore; quindi tutto si
247 muoveva assieme, uomini, donne, fanciulli, masserizie. Ma, fermata stanza, si istituì governo più regolare; e, sotto i goti, una mi.lizia composta di proprietarj prese il luogo dello legione; lo stoto militare div e nne allora per questa sola ragione meno oneroso pcl pubblico erario . l goti erano tutti soltlnti; esiste un ordine di Teodorico con cui egli decreta la leva in massa.
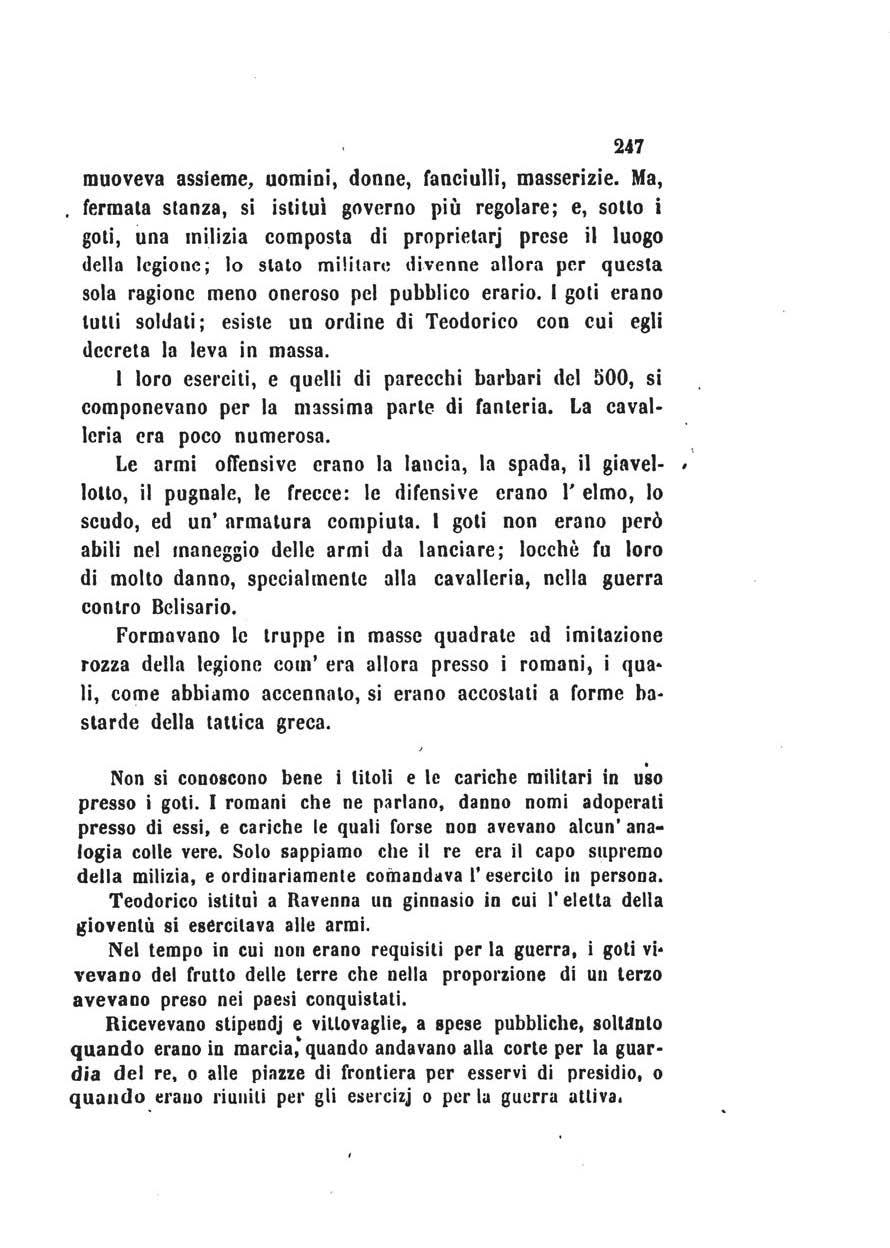
l loro eserciti, e quelli di parecchi barbari del 500, si componevano per la massima parte di fanteria. La cavalleria era poco numerosa.
Le armi offensive erano la lancia, la spada, il giave!- , louo, il pugnale, le frecce: le difensi\'e erano l' elmo, lo scudo, ed un' nrmatura compiuta. l goti non erano però abili nel maneggio delle armi da lanciare; locchè fu loro di molto danno, specialmente alla cavalleria, nella guerra contro Bclisario.
Formavano le truppe in masse quadrate ad imitazione rozza della legione com' era allora presso i romani, i qua· li, come abbiamo accennato, si erano accostati a forme ha· starde della tattica greca .
Non si conoscono bene l titoli e le cariche militari in uso presso i goti. I romani che ne parlano, danno nomi adoperati presso di essi, e cariche le quali forse non avevano alcun ' analogia colle vere. Solo sappiamo che il re era il capo supa·emo della milizia, e ordinariamente coinand11va l'esercito in persona.
Teodorico istituì a Ravenna un ginnasio in cui l'eletta della gioventù si esercitava alle armi.
Nel tempo in cui non erano requisiti per la guerra, i goti vi• vevaoo del frutto delle terre che nella propoi'Zione di un terzo avevano preso nei paesi conquistati.
Ricevevano stipeodj e viLLovaglie, a spese pubbliche, soltanto quando erano io marcia; quando andavano alla corte per la guardia del re, o alle di frontiera per esservi di presidio, o quando erauo riuniti pea· gli esercizj o per la guerra attiva.
I LoNGOBARDI. Prima di pal'larc dell' ordinam('nto militare dci longobardi, è mestieri dire alcune parole sul loro ordinamento politico e amministratho, pcrchè l' uno è iutrinsccnmcnte, inseparabilmente congiunto all' altro.
Ogni libero longobardo chiamavasi esercitale od ari. ma nn o.
All' età di f 2 anni ogni libero longobardo diventava capo di fam o famiglia, ·C partecipe, come arimanno, a tuui i diritti di cittadino.
Ogni decina, o per meglio dire dozzina di rare ( impc· rocchè le loro decine si componevano di t 2 uniti1 ) dicevasi decauìa cd era comandata do un clc_cano
Su dodici decane comandava uno sculdascio.
Su dodici sculdascic il duca.
Su tu lli . il re.
L' arimanno era capo c gimlicc nelle liti che fossero nate nella sun fara; poi il tribunale del decano; quindi, secondo la grav1•zza e la qualità dci cnsi, quello dello sruldascio, del ducn, del re. Questi giudicavano coll' avviso di t 2 sacramcutali, eletti dalla nazione ad ncccrtarc il ratto.
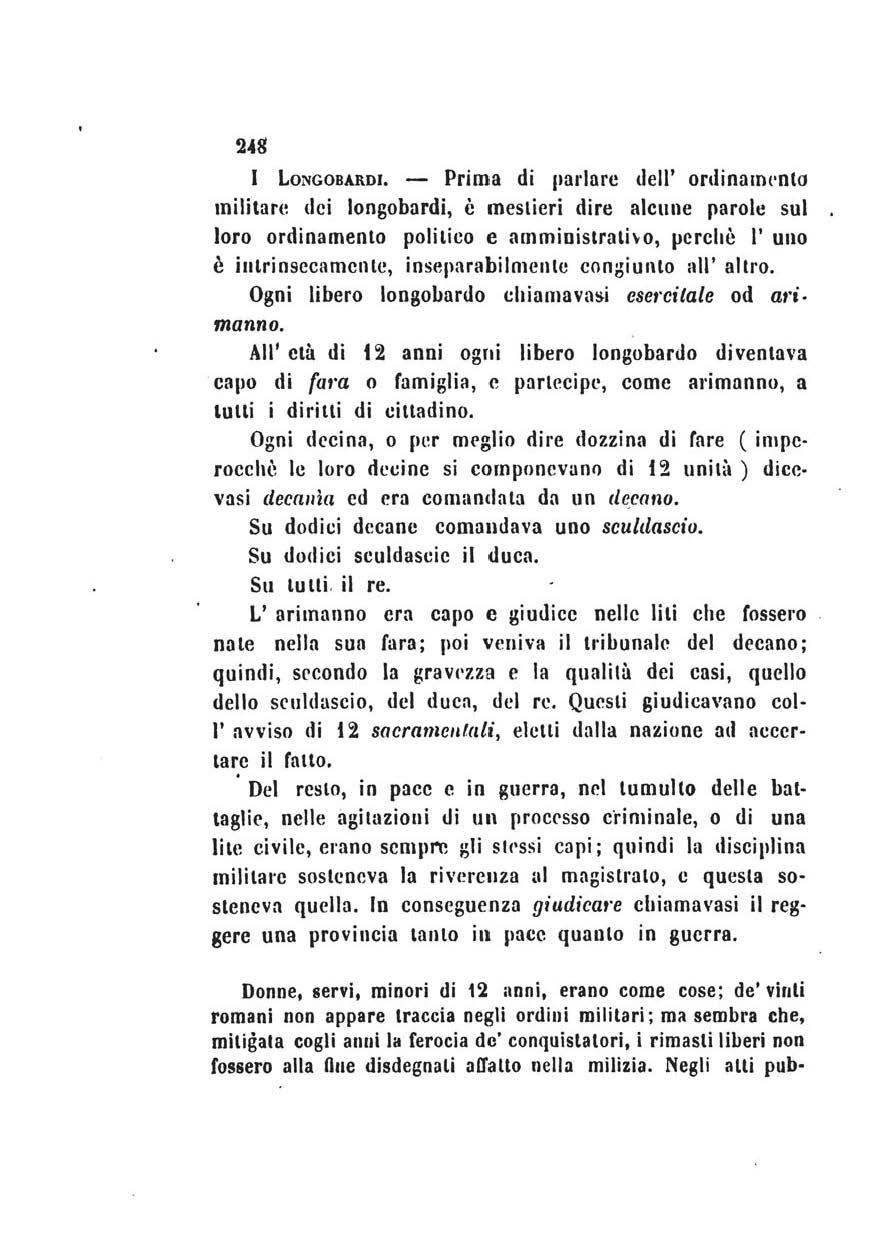
Del resto, in pace c in guerra, nel tumulto delle battaglie, nelle agitazioni di un proersso c·riminale, o di una lite civile, erano sempre gli SII'Ssi capi; quindi la tlisciplina milita1·c sosteneva la rivercuza tll magistrato, c questa sosteneva quella . In conseguenza giudicar·e chiamavasi il reggere una provincia tanto in pace quanto in guerra.
Donne, servi, minori di 12 anni, erano come cose; de' vinti romani non appare traccia negli ordini militari; ma sembra che, mitigata cogli anni la ferocia dc' conquistatori, i rimasti liberi non fossero alla Oue disdegnali affatto nella milizia. Negli alli pub·
24!) blici, libero arimantlo è il titolo d' ogni longobardo; libero sem· plicemente, quello d' ogni ingenuo romano ( l) .
Ciò esposto, diremo che la milizia costituiva un obbligo e un diritto precipuo di ogni libero cittadino; ed era proibito ad ogni schiavo il prend ervi parte prima di essere emancipato. l poveri, ossia coloro che mancando all'appello non avrebbero avuto di l che pagare la multa stabilita, re s tavano io paese .
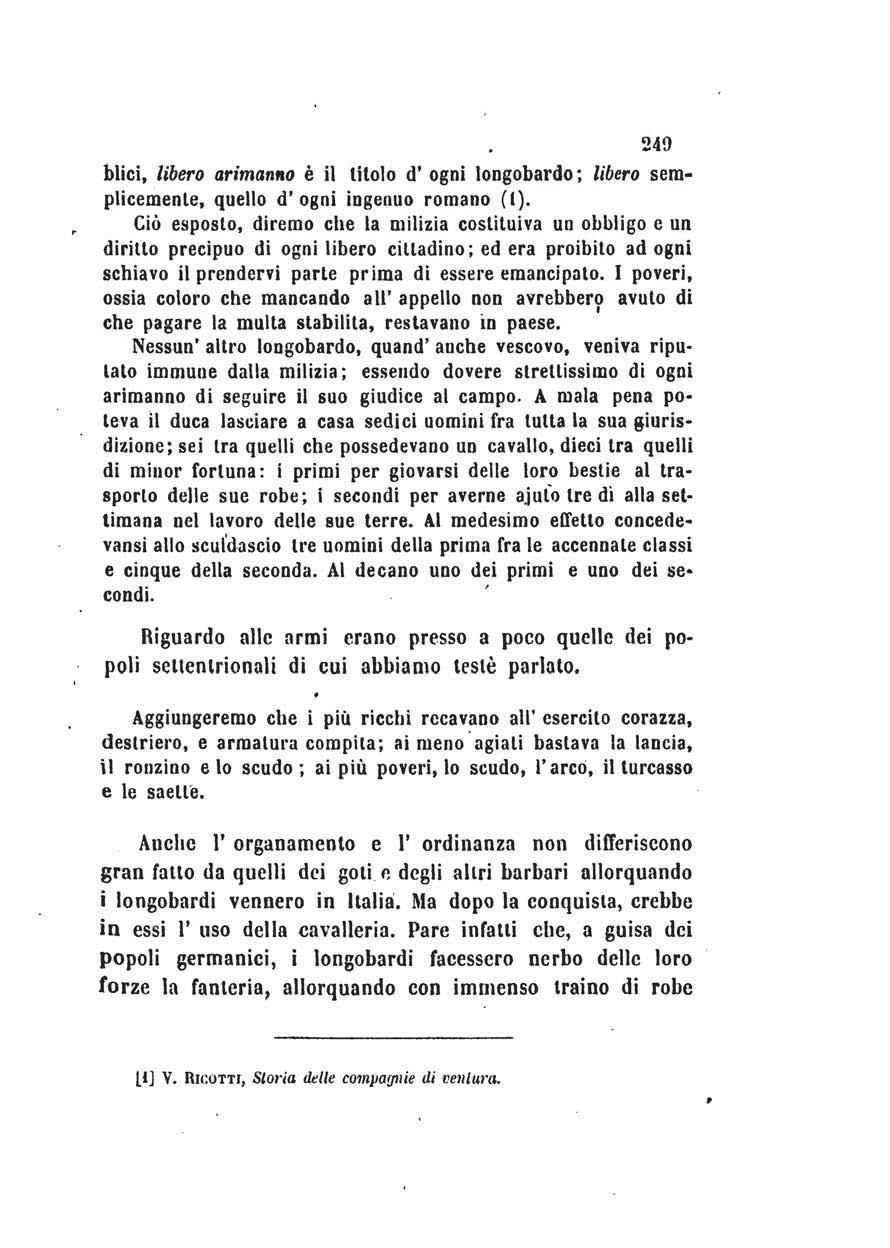
Nessun'altro loogobardo, quand ' anche vescovo, veniva riputato immune dalla milizia; essendo dovere strettissimo di ogni arimanno di seguire il suo giudice al campo. A mala pena po· leva il duca lasciare a casa sedici uomini fra tutta la sua giuris· dizione; se i tra quelli che possedevano un cavallo, dieci tra quelli di minor fortuna: i primi per giovarsi delle loro bestie al tra· sporto delle sue robe; i second i per averne ajulo tre di alla settimana nel lavoro delle sue terre. Al medesimo effetto concede· vansi allo !lcufdascio tt·e uomini della prima fra le accennate classi e cinque della seconda. Al decano uno dei primi e uno dei se· condi. '
Riguardo alle armi erano presso a poco quelle dei popoli se ll en trionali di cui abbiamo testè parlato.
Aggiungeremo che i più ricchi recavano all' esercito corazza, destriea·o, e armatut·a compita; ai meno ' agiati bastava la lancia, il ronzino e lo scudo ; ai più poveri, lo scudo, l'arco, il turcasso e le saelle.
Anche l' organamento e l' ordinanza non differiscono gran fatto da quelli dei goti r. degli allri barbari allorquando i longobardi vennero in Italia. Ma dopo la conquista, crebbe in essi l' uso della cavalleria. Pare infatti che, a guisa dci popoli germanici, i longobardi facessero nerbo delle loro forze la fanteria, allorquando con immenso traino di robe
LI } V. RICOT TI, Storia delle compay11ie di venltwa.250 e di persone andarono quà e là cercando ventura prima di piantar sede in Pannonia. dalla Paunonia arrecarono in Italia fiol'itc gt·cggie di cavalli: l' abbondanza degli ot· timi pascoli naturalmente le propagò; c moltissime oltre se ne fecero venire d' oltremonti. lo breve la necessità di coltivare con poche braccia gli enormi spazj di terreno diviso divulgò l ' uso dci cavalli, c bentosto quest' uso passò dall' agricoltura alla milizia. Ogni libero che possedesse un cavallo fu convocato a militare con esso; c questo riforma moltiplicò per dire l e forze dello stato, imperocc hè si poterono valicare grandi distanze in picciol tempo, e ad ogni pericolo era pronto un esercito. Laonde la milizia a piedi non fn più fornita se non che dai po\o·cri ·ed abbietti; e alcune spedizioni cominciaronsi a chiamare cavalcate, e cavalcare l' andare in gut>rra.
Fu questo il primo posso alle milizie feudali che descriveremo or' ora parlando dci franchi.
Pel mantenimento, i soldati esigevano viltovaglie dal paese in cui comballevano. Lo stipendio dei pùbblici ufficiali non era danaro, ma godimento di beni. Vi si aggiunsero i diritti delle multe ed il bottino; e tanto la carica che avevano, quanto l' usufrutlo proveniente da essa, chiamavansi onore. Questi onori però erano cosa diversa da bet1e{icio o feudo, con cui si confusero poscia nel tempo successivo dei Carolingi. ·
Durante una spedizione, e 12 s!orni prima ed altrettanti dopo di essa, P.rasi libero da ogni molestia per causa civile di debito o di malleveria: le liti che insorgevano nel campo si definivano dai capi: pena di 12 sold i a chi avesse disobbedito al duca, o non Cosse accorso, secondo l'ordine stabilito, all'esercito ed alle guardie; pena di morte ai sediziosi, sodducitori di schiera, abbaodonatori o traditori .del compagno nel combattimento.
l FnA:scnt. - l franchi antichi componevano i loro eserciti, n mo' dci popoli germanici, quasi esclusivamente di fan·
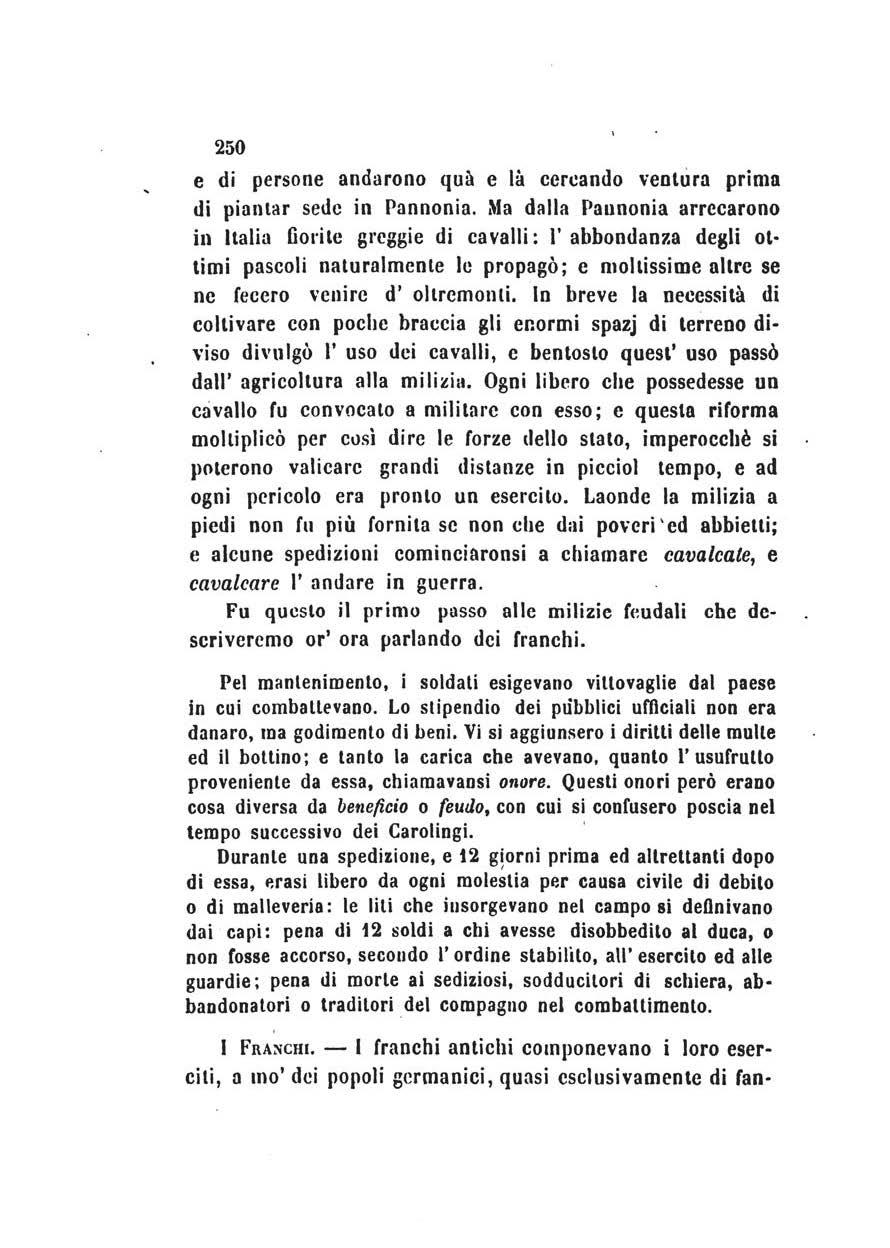
terin; la cavalleria forma n per lo più la scorta poco numerosa del capo. Col dei tempi, venendo sviluppo maggiore al sistema feudale, incominciò ad aumentare quest' arma sino a divenire principale negli eserciti.
Le armi offensive degli antichi franchi, erano: la spada, il ·giavellotto, e l'ascia, detta F,·ancesca. Avevano la fronda, ma non se ne servivano se non che negli assedj.
Non adoperavasi la spada se non che dopo aver rotto lo scudo del nemico col mezzo dell'ascia, la quale era a due tagli con un manico curto; e siccome era questa un'arma particolare e speciale dei franchi, così gli scrittori la designano col nome di Francesca.
Più tardi, e in diverse epoche, ebbero successivamente diverse armi : l' arco, la balestra, le freccie, il puguale, la lancia, la mazza, il maglio, la fionda.
Conviene notare che non tutte le armi erano adoperate iudif(ereotemente da ogni sorta· di persone, ed io ispecial modo da coloro cbe talv.olla vennero ammessi negli eserciti sebbene di condizione non del lutto libera; imperoccbè a questi era vietato di portare ordinariamente la spada o la lancia, ma potevano averne presso di sè allo scopo di difendere la terra del loro signore.
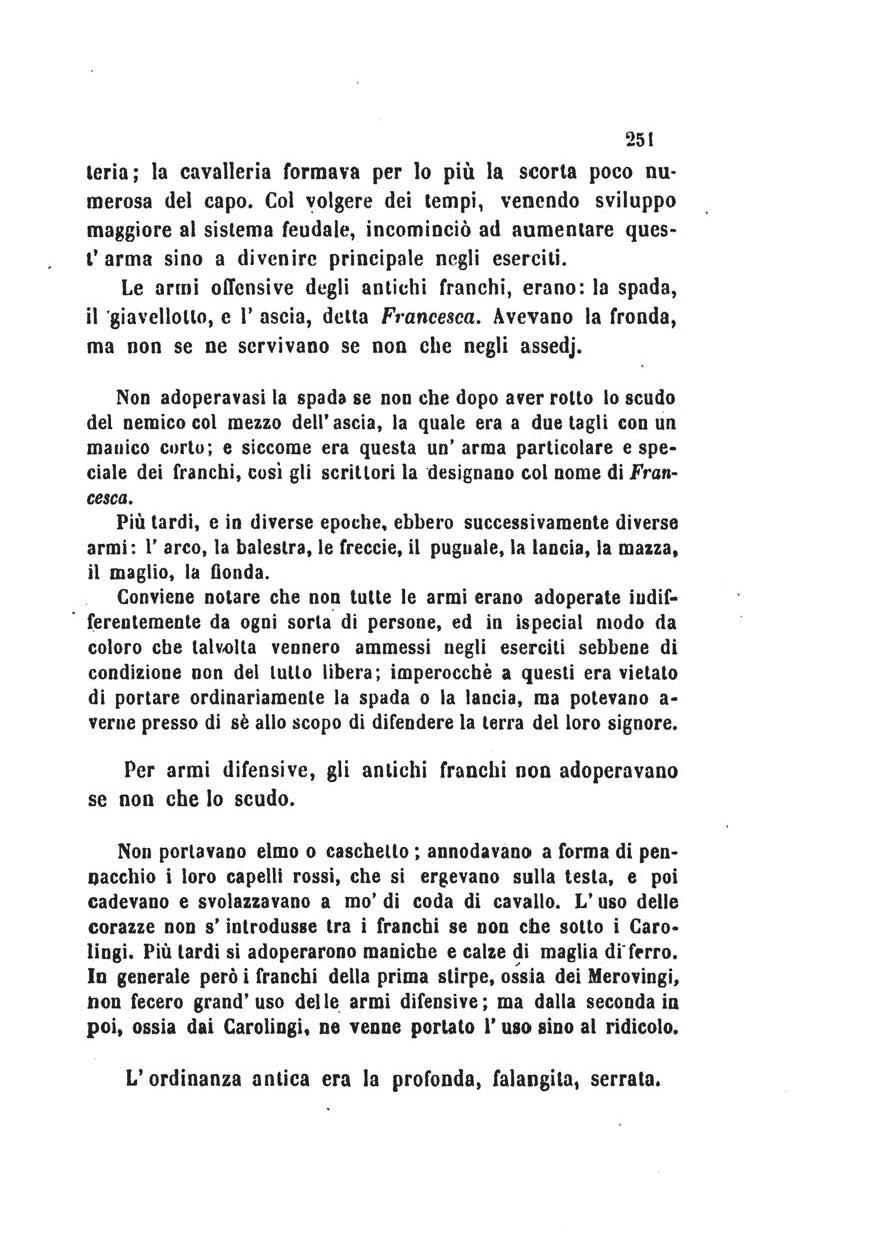
Per armi difensive, gli antichi franchi non adoperavano se non che lo scudo.
Non portavano elmo o caschetto; annodavano a forma di pennacchio i loro capelli rossi, che si ersevano sulla testa, e poi cadevano e svolazzavano a mo' di coda di cavallo. L'uso delle corazze non s' introdusse tra i franchi se non cbe sotto i Carolingi. Più tardi si adoperarono maniche e calze di maglia di' frrro. lo generale però i franchi della prima stirpe, ossia dei Merovingi, non fecero grand' uso delle. armi difensive; ma dalla seconda in poi, ossia dai Carolingi, ne venne portato l' uso sino al ridicolo.
L'ordinanza antica era la profonda, falangila, serrata.
Eranvi urtlciali primarj e suballerni; oltre i conti, o i loro castaldi, eranvi i millensrj, i ccntcnarj, i decani, i vessiliferi.
Nel 7. 0 secolo, i franchi erano ancora comandati alla guerra ·da que' medesimi ufficiali che li giudicavano in tempo di pace.
Havvi luogo a congetturare che Ono dallo stabilirsi della monarchia franca nelle Gallie fosservi esercizj per le milizie. Egli è certo però che si facevano riviste nei luoghi appellali Campi di marzo; c si esaminavano con cura le armi dei soldati per vedere in che condizione si tt·ovavano. Gregorio, vescovo di Tours, parlando di una rivista passata da Clodoveo dopo la battaglia di Soissoo, pone in bocca di quel re le parole seguenti dirette ad un milite: • Non havvi alcuno qui presente le cui armi sieno io disordine come le vostre; nè il vostro giavellotto, nè la vostra spada, uè la vostra ascia, sono in istato da potervi servire, •
Ebbero pure i franchi alcune regole di disciplina per ovviare a disordini che avessero potuto accadere. Chi era stato leso per danni cagionatigli dai militi nelle marcie, era obbligato a doman· dare giustizia e indennità. In tal guisa si otteneva rapporto e si veniva io cognizione di falti cl..te potevano rimanere sconosciuti. Il colpevole era condannato a pagare il triplo; e se colui che avesse causato il danno fosse stato un servo al seguito dell'esercito, gli si aggiungeva pena corporale.
C:hlunque si rosse ritirato dal campo senza il permesso del principe, veniva condannato a morte. Colui che nel comballimento fosse fuggito mal a proposito, o .si fosse rifiutato di marciare contro il nemico, veniva dichiarato infame, e perdeva la sua carica se era pubblico ufficiale.
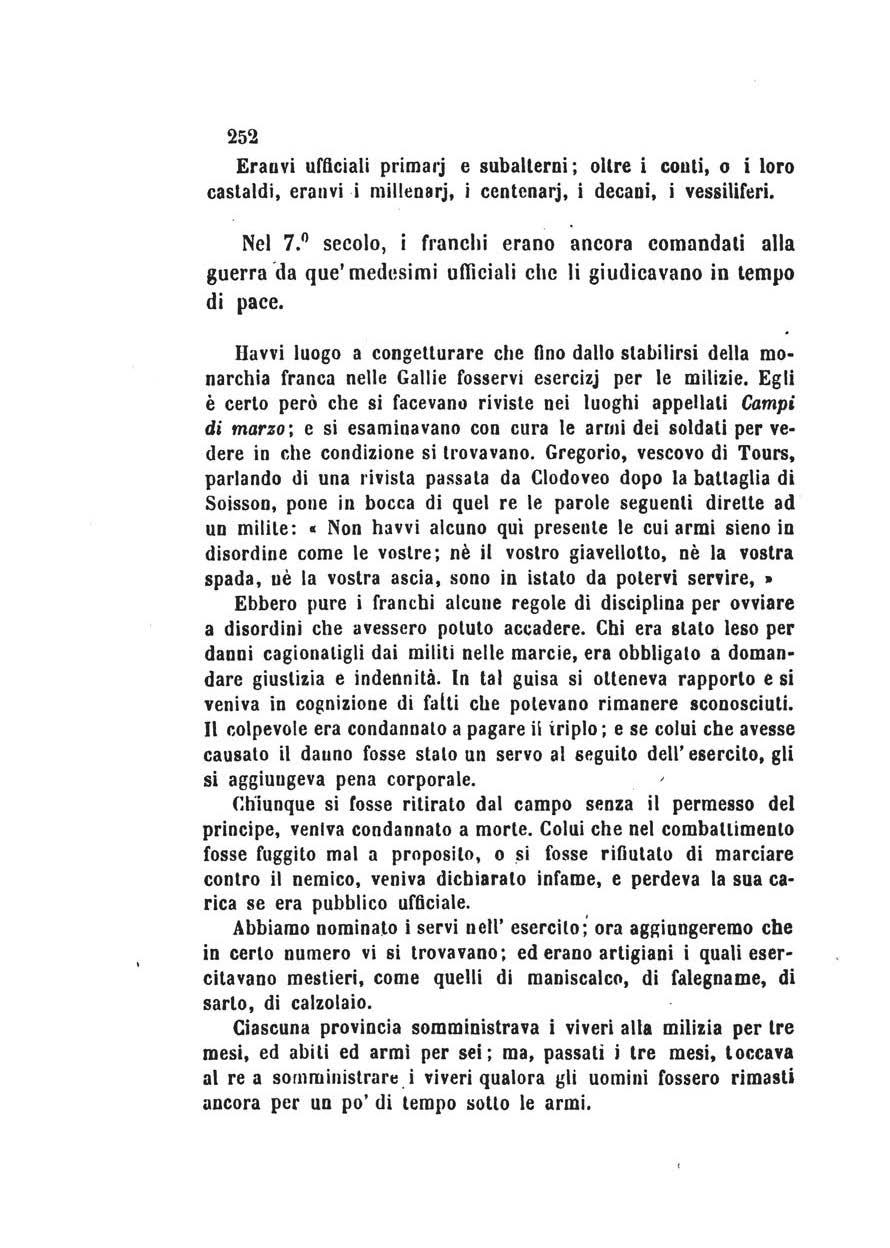
Abbiamo nominato i servi nell' esercito; ora aggiungeremo cbe in certo numero vi si trovavano; ed erano artigiani i quali esercitavano mestieri, come quelli di maniscalco, di falegname, di sarto, di calzolaio.
Ciascuna provincia somministrava i viveri alla milizia per tre mesi, ed abili ed armi per sei; ma, passati i tre mesi, toccava al re a i viveri qualora gli uomini fossero rimasti ancora per un po' di tempo le armi.
Nulla di soldo si dava in antico; le terre, divise tra i gentiluomini, i beneficj accordati di poi, imponevano obbligo di correre alle bandiere alla chiamata· del re, e sotto la condotta dei capi di cui abbiamo faLLo cenno. In antico, gli onori ed i benefìrj non erano dati e goduti che a vita, c tornavano al re dopo la morte del beneficiario, o quando costui abbando,nava il scrvizìo. Ma col tempo •·imasero proprietà di quest'ultimo, con alcuni obblighi verso il sovrano imperante, e feudi.
Col vo lgcre degli anni i franchi conquistatori si mescolarono agli antichi popoli abitatori delle Galli e, si confusero
· con loro, e gli ordini primitivi assunsero le forme seguenti. Ogni suddito doveva servire in guerra. Ve lo chiamava il . bando reitio od eribanno; ve lo conduceva, se vassallo, il proprio signore; se uomo della chiesa, l' anocato; se indipendente , il capo del distretto.
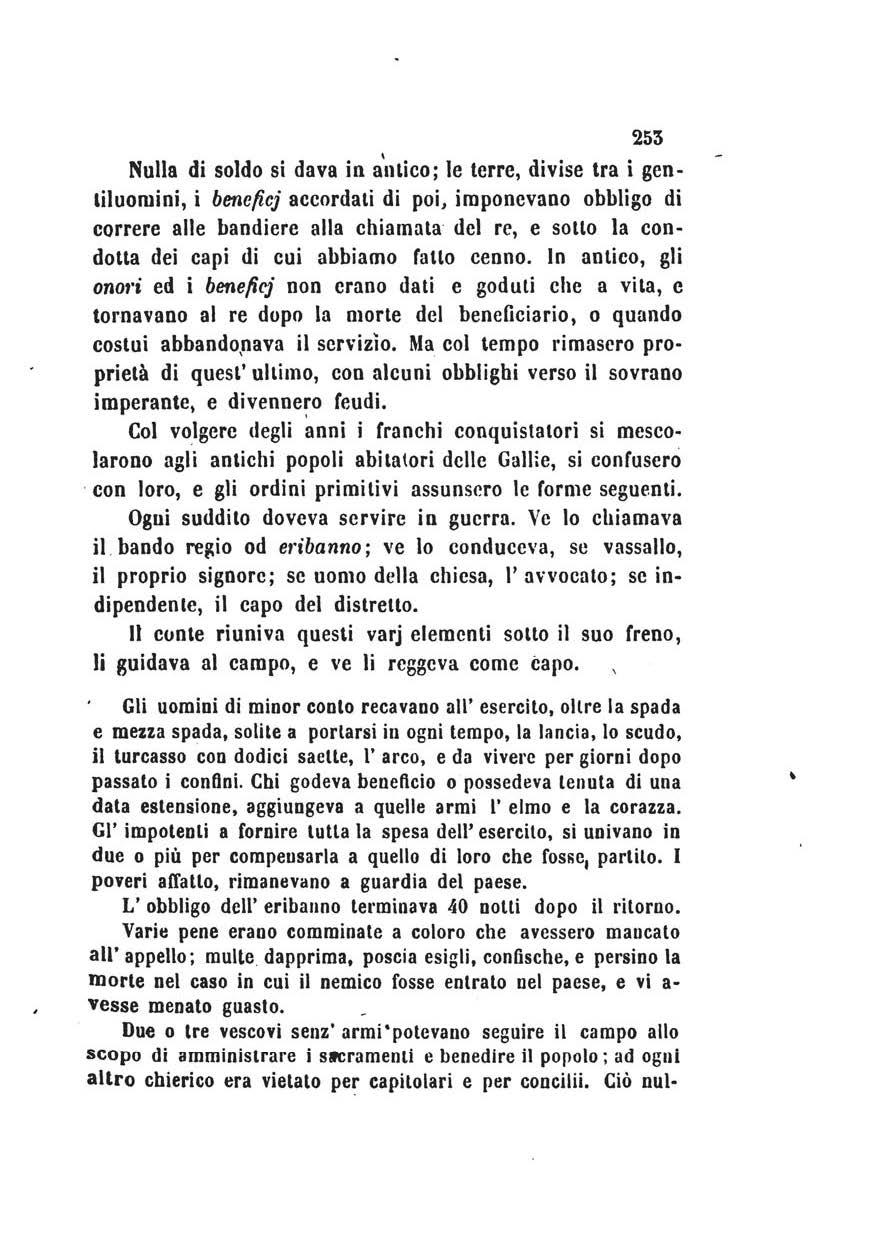
Il conte riuniva questi varj elementi sotto il suo freno, li guidava al campo, e ve li reggeva come capo.
Gli uomini di minor conto recavano all' esercito, ollre la spada e mezza spada, solite a portarsi in ogni tempo, la lancia, lo scudo, il turcasso con dodici saette, l' arco, e da vivea'e per giorni dopo passato i eonOni. Chi godeva beneficio o possedeva tenuta di una data estensione, aggiungeva a quelle armi l' elmo e la corazza. Gl' impotenti a fornire tutta la spesa dell'esercito, si univano io due o più per compensarla a quello di loro che partilo. l poveri atrauo, rimanevano a guardia del paese.
L' obbligo dell'eribanno tel'mioava 40 notti dopo il ritorno.
Varie pene erano comminate a coloro che aves sero mancato all'appello; multe. dapprima, poscia esigli, confische, e persino la morte nel caso in cui il nemico fosse entrato nel paese, e vi avesse menato guasto.
Due o tre vescovi senz' armi ' potcvano seguire il campo allo scopo di amministrare i stcramenli e benedire il popolo ; ad ogni altro chierico era vietato per capitolari e per coocilii. Ciò nul-
2:ii
Jameno, l'uso contrario prevaleva alla legge, e tanto maggiormente quanto più quest'uso veniva in certa guisa autorizzato dalla necessità. Già gran parte della potestà temporale era penenuta agli ecclesiastici, i quali non avrebbero potuto soslenerla e fruirne senza mezzi temporali. Vedeansi quindi vescovi ed abbati indossare elmo e èorazza , e colla lancia in pugno capitanare le genti delle terre e signorie ottenute in dono da devozione di privato o da munificenza di principe. Carlomagno stesso, sotto pretesto di combattere gl'infedeli, ruppe pel primo la propria legge; i re cbe gli succedettero, convertirono il permesso in comando. L'esercito era pure seguito da negozianti di armi e di vesti. Durante Il cammino, i coloni della corona fornivano le carra, certe ville regie il rimanente. Cavalli ed armi ricavavansi anche a titolo di annuo donativo ·dai monasteri e da altri luo gbi im· muoi. (t)
Sotto la prima dci re, ossia. de' Mcrovingi, il grosso ·degli eserc iti era composto, come dicemmo, di fanteria; ma sotto Pipino, e sotto Carlomagno, il numero dei gendarmi uguagliò quasi quello dei fanti; c quando i feudi divennero creditarj, gli eserciti francesi, per quanto fossero numerosi, erano pressochè tutti di cavalleria; i fan ti che vi si trovavano non éombattevano in corpo, e costituivano .quella fanteria che è conosciuta so tto il nome di Alcuni capitolari di Carlomagno, stabiliscono norme am· mioistrativc c disciplinarie. l
l SARACENI. Noi non teniamo speciale discorso di altri barbari io questo paragrafo degli Ordinamenti, pcrchè a dir vero non troviamo in essi a,lcune di quelle particolarità saglieoti che meritano di essere conosciute. ·
(t] V. RICOTTI, Storia delle Compagnie di ventura.
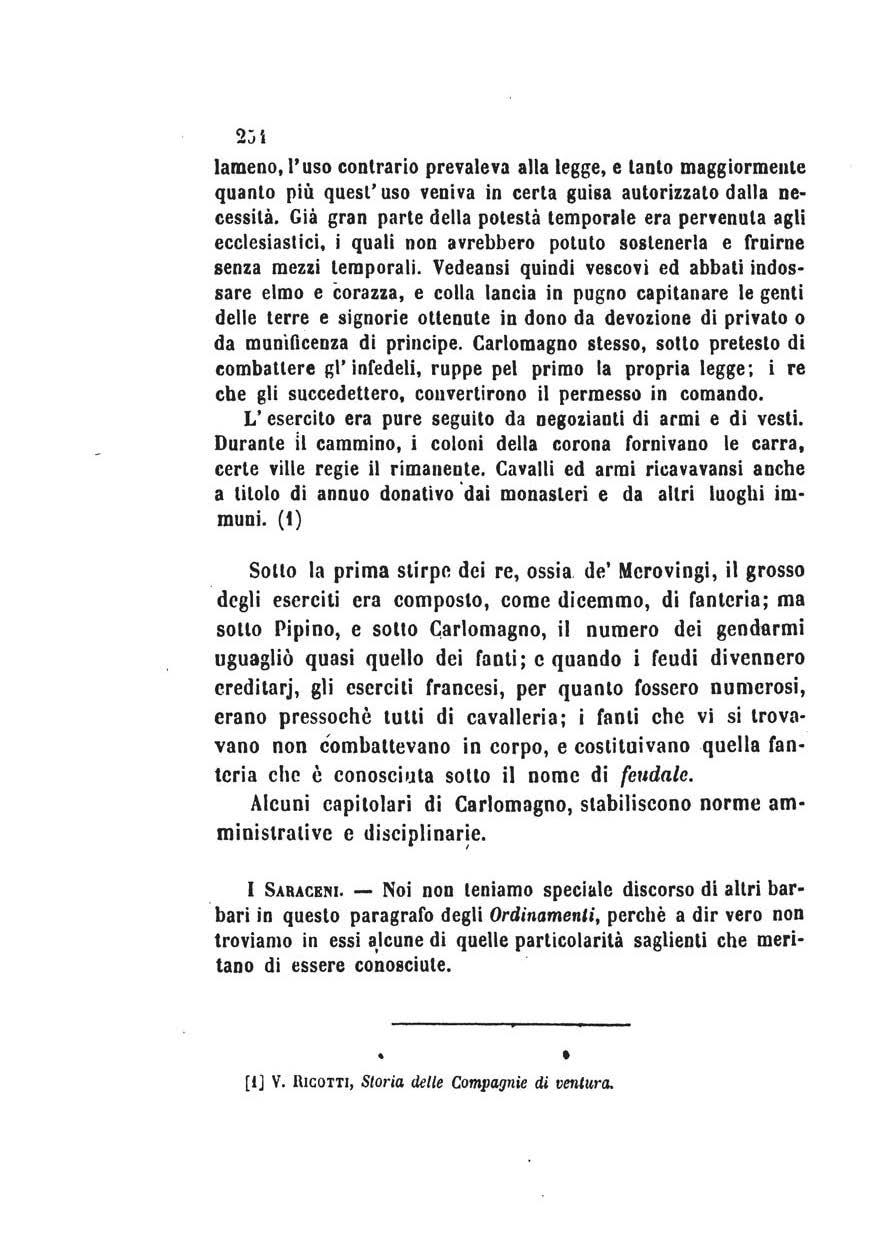
255
Tuttavia non ri6uteremo qualche parola a quanto concerne i saraceoi ed i normanni, per l'arditezza delle loro imprese, e per r estensione delle loro conquiste.
l primi seguaci di Maometto, ne portarono la mezza luna in Asia, io Africa ed io Europa.
Erano guidali dal fanati11mo che ne aumentava ad allo grado il valore ..
Le loro armi offensive erano la spada, la lancia corta e l ' arco. Le difensive consistevano in piastre con cui cuoprivano i budrieri ed i cavalli, in modo però da non danueggiarsi nell'agilità, Quelli che invasero il mezzoggiorno della Francia, adottarono per imitazione lo scudo, !a corazza, e la lancia lunga.
l loro eserciti componevansi di fanteria , e di molta cavalleria.
l loro ordini non erano serrati, le loro ljnec non restavano intere: si sparpagliavano.
La loro disciplina era mantenuta da un di generosità e di giustizia ai servigi prestati in guerra (t).
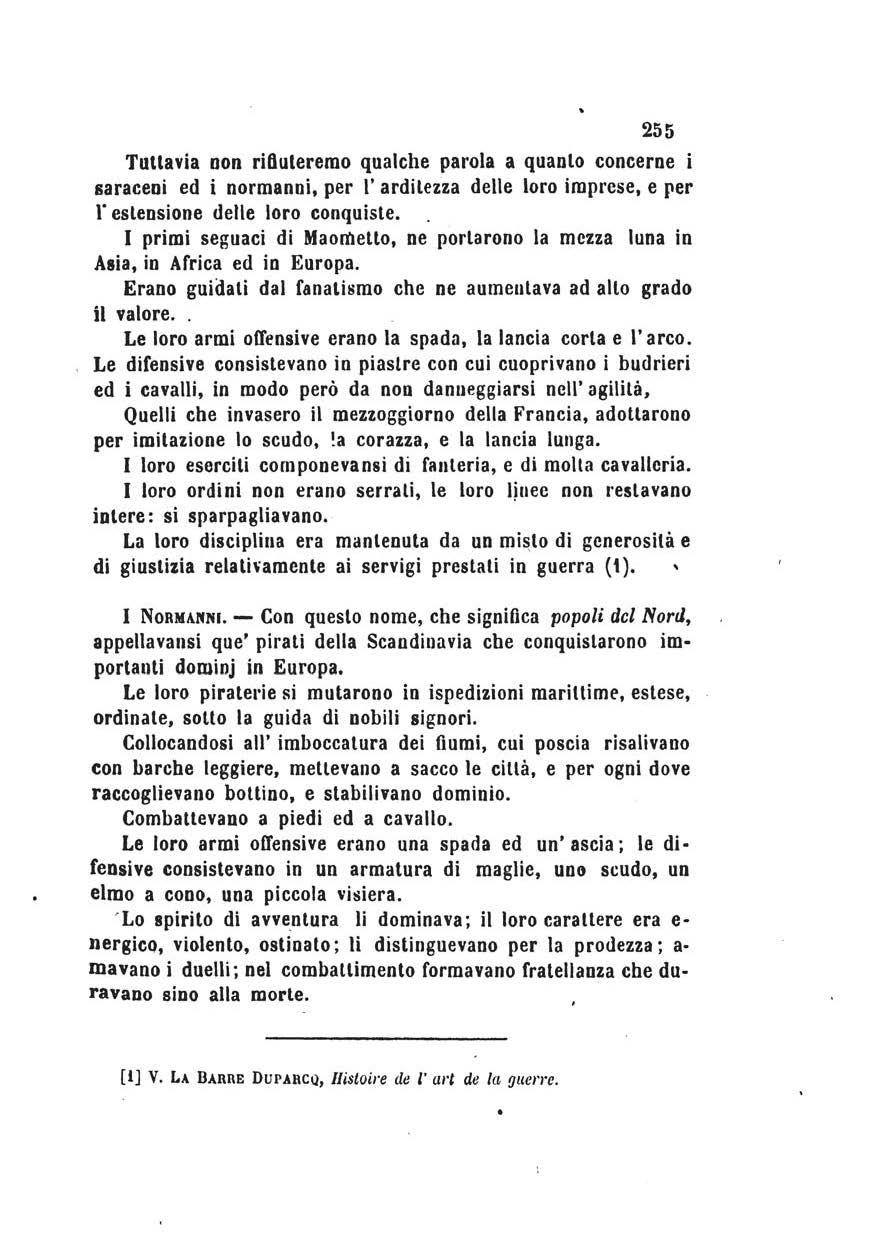
I NoRMA1'41'11. Con questo nome, che significa popoli del Nord, appellavansi que ' pirati della Scandinavia che conquistarono importanti domioj in Europa.
Le loro pirate1·ie si mutarono in ispedizioni marittime , estese, ordinate, sotto la guida di nobili signori .
Collocandosi all' imboccatura dei fiumi, cui poscia risalivano con barche leggiere, mettevano a sacco le cillà, e per ogni dove raccoglievano bottino, e stabilivano dominio . Combattevano a piedi ed a cavallo.
Le loro armi offensive erano una spada ed un'ascia; le difensive consistevano in un armatura di maglie, unG scudo, un elmo a cono, una piccola visiera.
'
Lo spirito di avventura li dominava; il loro carattere era energico, violento, ostinato; li distinguevano per la prodezza; a· ma vano i duelli; nel combattimento formavano fratellanza che du ravano sino alla morte.
(l) V. LA BARR E D UP AB Cil, /Ji stoir e de l' urt de la !JUI!ITC.
MJLlZlA FEUDALE. l primi barbari, ecceLlo gli uooi, uon ebbero cavalleria, o n'ebbero poca. Si sviluppò col sistema feudale.
Il pl'incipio antico dt:l reclutamento si snaturò, e divenne il seguente: Ogni suddito, ogni signore ·co' suoi dipendenti, doveva rispondere all'appello del re.
E rispondcvasi: prima colle torme di fanti, poi coi cavalli eri bardati.
Nacque la cavalleria del medio c\·o nell' interno delle dimore feudali, ed ebbe per proposito di dichiarare io primo luogo l' ammissione del giovine al gmdo di· guerriero, in secondo luogo il che lo univa al suo supel'iore feu· dale, a quegli che gli conferiva le armi della cavalleria. Il titolo di cavallicre, cspt·esso nell' età di mezzo colla parola Aliles, fu dato a ce1·ti signori che n poco a poco formarono un corpo distinto nello stato e negli eserciti.
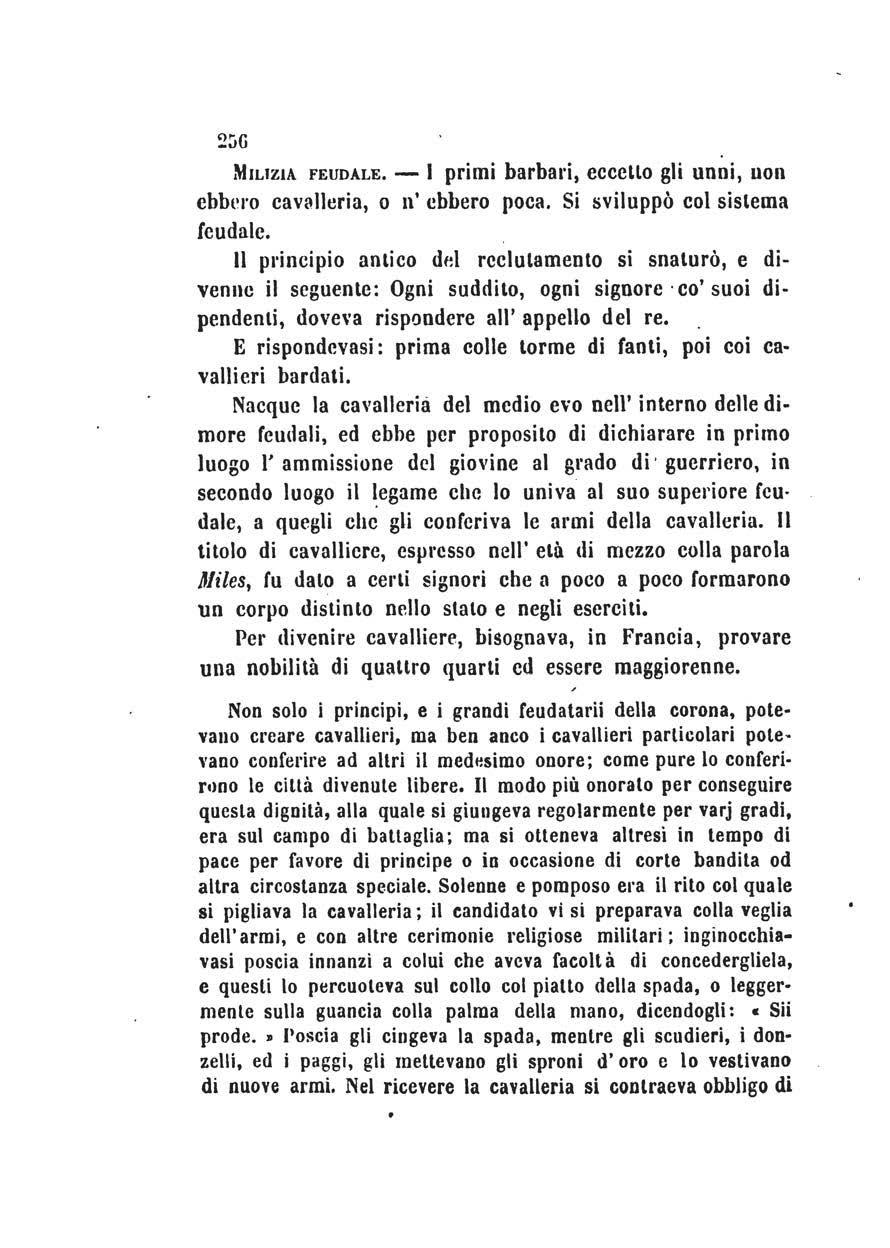
Per divenire cavalliere, bisognava, in Francia, provare una nobilità di quattro quarti cd essere maggiorenne.
Non solo i principi, e i grandi feudatarii della corona, potevano creare cavallieri, ma ben anco i cavallieri particolari potevano conferire ad altri il medesimo onore; come pure lo conferile cillà divenute libere. Il modo più onorato per conseguire questa dignità, alla quale si giungeva regolarmente per varj gradi, era sul campo di balla glia; ma si otteneva altresì in tempo di pace per favore di principe o io occasione di corte bandita od altra circostanza speciale. Solenne e pomposo era il rito col qua le si pigliava la cavalleria; il eandidato vi si preparava colla veglia dell'armi, e con altre cerimonie religiose militari ; inginocchiavasi poscia innanzi a colui che aveva facoll à di concedergliela, e questi lo percuoteva sul collo col piatto della spada, o leggermente sulla guancia colla palma della mano, dicendogli: • Sii prode. • l'oscia gli cingeva la spada, mentre gli scudieri, i donzelli, ed i paggi, gli mettevano gli sproni d'oro c lo vestivano di nuove armi. Nel ricevere la cavalleria si contraeva obbligo di
fedellà e devozione verso quegli cbe la conferiva; quest'obbligo era tacito od espresso con giuramento. Si olH>ligava inoltre il cavalliere a proteggere dame , donzelle, pupilli, orfani, e beni della chiesa, contro ogni ingiugta oppressione. Per la qual cosa l' istituzione della cavalleri·a contribui in certa guisa, ne' tempi di torbidi e di anarchia geuerale, a reprimere la violenza ed a mitigare i costumi; imperocchè, malgrado il ridicolo a cui tanti cavallieri sonosi esposti, il loro modo generoso di proteggere il debole per dove passavano, costituiva la sola polizia che allora si potesse esercitare delle campagne e sulle grandi strade.
Eranvi, in Francia, due specie di cavallieri: alti c bassi. Gli alti erano di due classi: appartenevano alla prima i ti· tolari, vale a dire duchi, conti, o baroni; quelli della seconda chiamavansi Banderesi. l bassi erano detti Baccclliet·i.
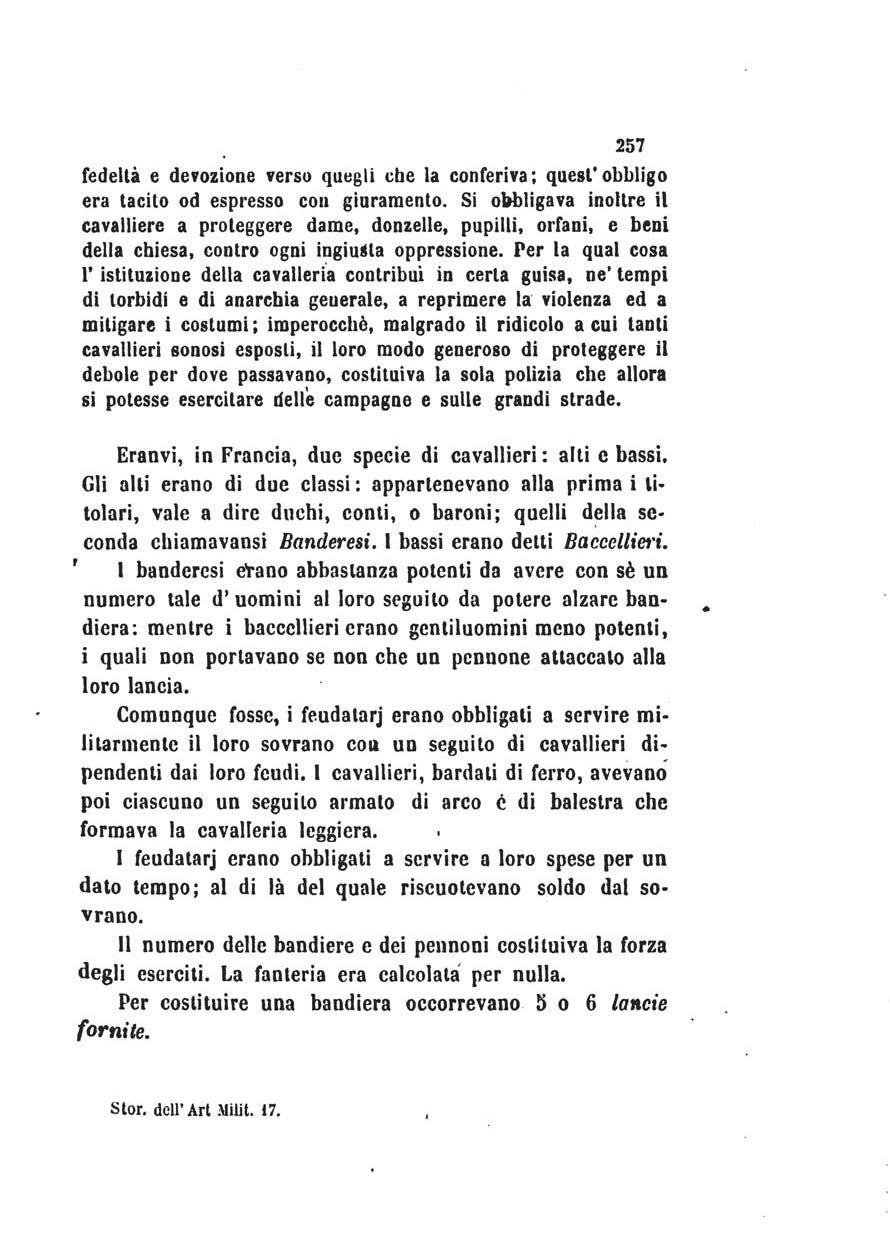
l banderesi etano abbastanza potenti da avere con sè un numero tale d'uomini al loro seguito da potere alzare bandiera : mentre i baccellieri erano gentiluomini meno potenti, i quali non portavano se non che un pennone attaccato alla loro lancia.
Comunque fosse, i feudatarj erano obbligati a servire militarmentc il loro sovrano co11 un seguito di cavallieri dipendenti dai loro feudi. l cavallicri, bardati di ferro, avevano poi ciascuno un seguito armalo di arco c di balestra che formava la cavalleria lcggiera.
l feudatarj erano obbligati a servire a loro spese per un dato tempo; al di là del quale riscuotevano soldo dal sovrano.
Il numero delle bandiere e dei pennoni costituiva la forza degli eserciti . La fanteria era calcolata per nulla.
Per costituire una bandiera occorrevano o 6 laJtcie fornite.
S lor. dell' Arl Milit. 17.
La lancia fornita componevasi dell' uomo d'armi coperto di ferro, di un costoliere, di un damigcllo o paggio, e di tre arcieri.
· Il costoliere era armalo di spada . lunga e sottile, a tre lati o col taglio da una banda sola e con forle . costola daW aILN ; marciava d' ordinario a piedi, e conduceva un cavallo che portava il bagaglio del cavalliere, od altro carico per uRo dell' esercito. Il damigello o paggio, presentava il suo cavallo di battaglia al cavalliere allorchè questi andava a comballere, ne portava lancia e scudo, ne custodiva i prigionieri. Gli arcieri erano giovani gentiluomini che s' iniziavano alla carriera militare ed aspiravano a divenire uomini d' armi. ·
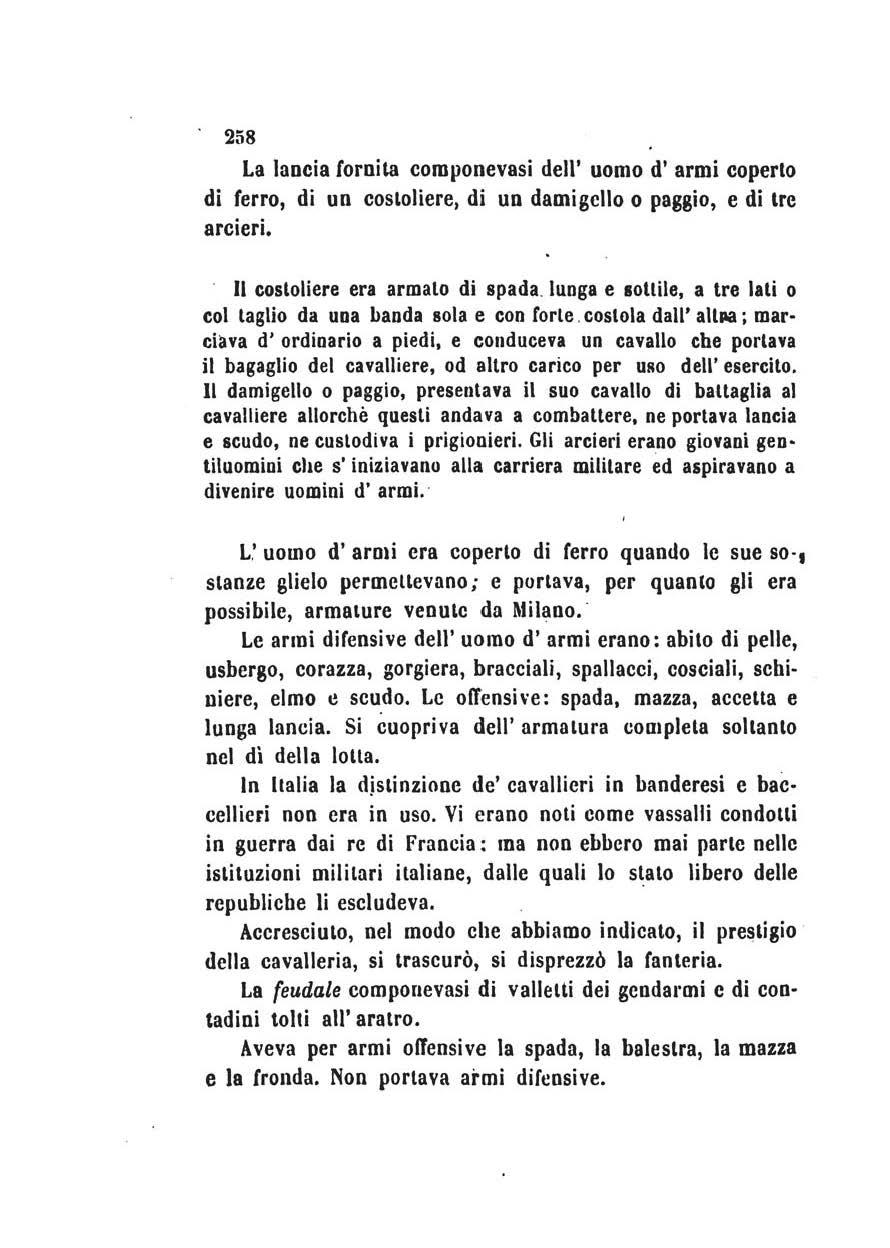
L.' uomo d' armi era coperto di ferro quando le sue so., stanze glielo permettevano; e portava, per quanto gli era possibile, armature venute da Milano. ·
Le armi difensive dell' uomo d' armi erano: abito di pelle, usbergo, corazza, gorgiera, bracciali, spallacci, cosciali, scbiniere, elmo scudo. Le offensi\-·e: spada, mazza, accetta e lunga lancia. Si cuopriva dell'armatura completa soltanto nel dì della lotta.
In Italia la djstinzione de' cavallicri in banderesi c baccellieri non era in uso. Vi erano noti come vassalli condotti in guerra dai re di ma non ebbero mai parte nelle istituzioni militari italiane, dalle quali lo stato libero delle rcpublicbe li escludeva.
Accresciuto, nel modo che abbiamo intlicato, il della cavalleria, si trascurò, si disprezzò la fanteria.
La feudale componevasi di valletti dei gendarmi c di contadini tolti all'aratro.
Aveva per armi offensive la spada, la balestra, la mazza e la fronda. Non portava armi difensive.
259
Serviva a i signo1·i caduti da cavallo cd a r imetterli in sella; a finire i cavalli cri nemici disarmati, a depre· dare nella villoria, a fuggire disordinatamente nella sconfina . Qualche volta scaramucciava nel principio dell'azione. Il conto in cui era tenuta, viene dimostrato dalla battaglia di Bouvines, nella quale il Conte di Boulogne fece formare dalla sua fanteria un quadrato vuoto entro cui andava a prendere fiato con seguito di cavalli eri. Non . si credeva che potesse prestare servigio più utile di _un semplice baluardo. Non. si può lasciare il discorso sulle milizie feuda li , senza dir par{)la de' tornei. Erano gli esercizj cbe si facevano dai cavallieri in tempo di pace affine di prepararsi per la guerra. Consistevano nel maneggio della lancia e della spada, nel servirsi bene dello scudo, nel tenersi fermi a nel sostenere gli assalli più violenti senza lasciarsi scavalcare. l cavallieri, . rinchiusi in un largo steccato, si a squadre., od a coppie, colle lancie in resta, e cercavano di rimanere padroni del campo gettando in terra l' avversario. l tornei sono d'origine francese; e furono in gran voga in Italia da<:chè Carlo, conte di Provenza, fece la conttuista del regno di Napoli. Firenze, Bologna, Ferrara, Verona, c altre città. principali, gareggiavano di magnificenza e di pompa in · queste feste militari.
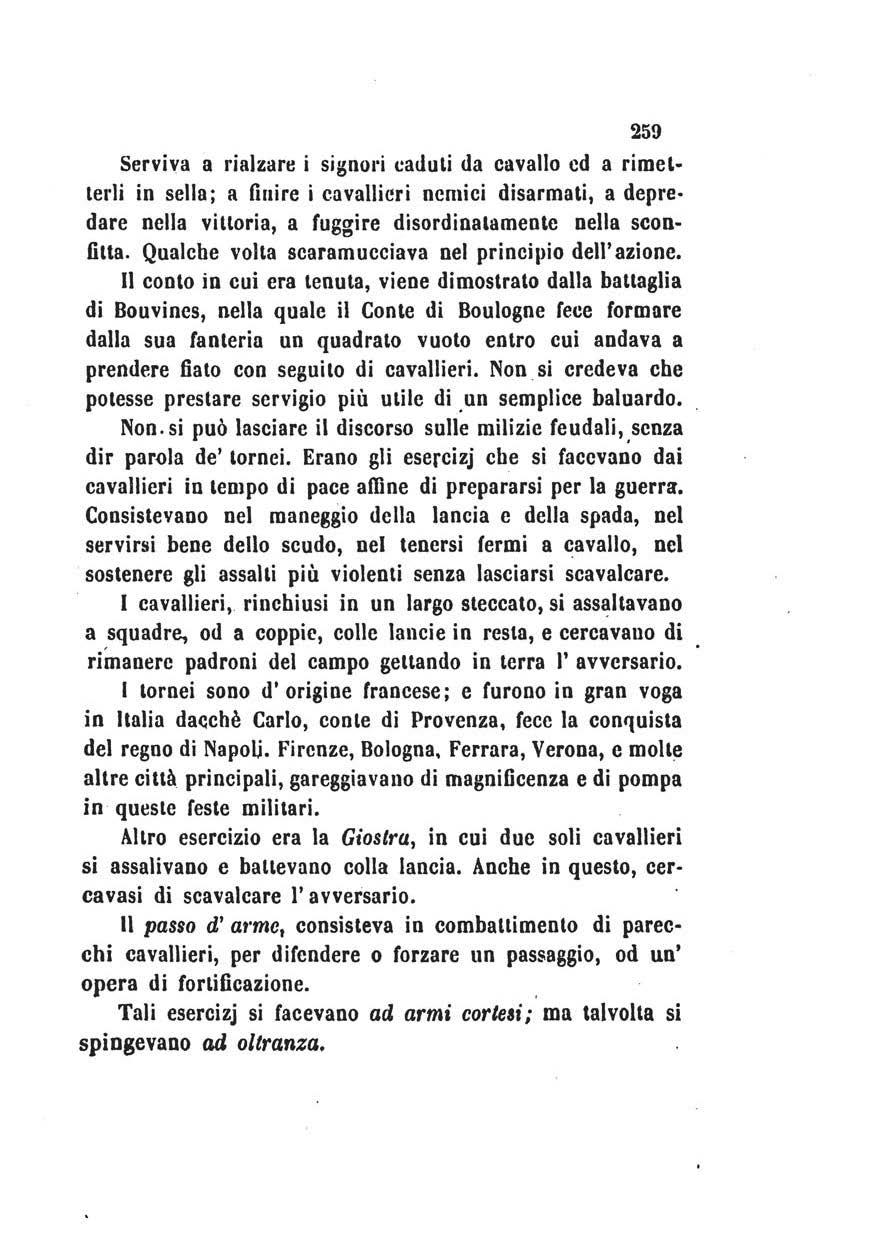
Altro esercizio era la Giostra, in cui due soli cavallieri si assalivano e battevano colla lancia. Anche in questo, cer· cavasi di scavalcare l'avversario.
Il passo d' at·mc, consisteva in combaltimento di parecchi cavallieri, per difendere o forzare un passaggio, od un' opera di fortificazione. .
Tali esercizj si facevano ad armi corteai; ma talvolta si spingevano aà oltranza.
Le armi cortesi erano spuntate ed ottuse . Spinti ad ol· tranza il torneo o la giostra, s'insanguinavano gli steccati colla morte di qualcuno.
MILIZIA coMUNALE Il contegno dc' signori feudali, mi· nacciava i principi sovrani e vessava i popoli. vrani c popoli si avvicinarono fra loro; e ciò fu una delle cause dell'istituzione di questa milizia che rendeva meno necèssario il servizio feudatarj . l sovrani concessero franchigie, i popoli assunserG obblighi; mediante le franchigie i popoli godettero diritti pelitici; mediante gli obblighi s'impegnarono a pagare un' imposta ed a levare una milizia pel servizio del monarca e del paese. L' dci comuni su più vasta c libera scala in Italia, portò effetti politici e sociali di maggior rilievo, c maggiore sviluppo si ebbe quella milizia che appunto si chiamò Comunale.
Era dcssa levata per ·autorità del comune.
Nella lotta tra fiorentini e sanesi, guelfi e ghibellini, vediamo che Firenze aveva ordinato che ogni suddito o citta.dino, fra i 15 e i 70 anni, fosse convocalo. Alcuni ufficiali designavano per ogni 1esto i pavesai, gli arcieri, ed i balestrieri. Due cittadini con un nolajo ed un maniscalco rivedevano e notavano le persone i · cavalli dei militi. Il contado e distretto somministrarono marra· iuoli e guastatori. Furono esenti tutti i mercanti della città e del . contado descritti nel libro dell' arte, accioccbè tenessero ben fornito il mercato del campo.
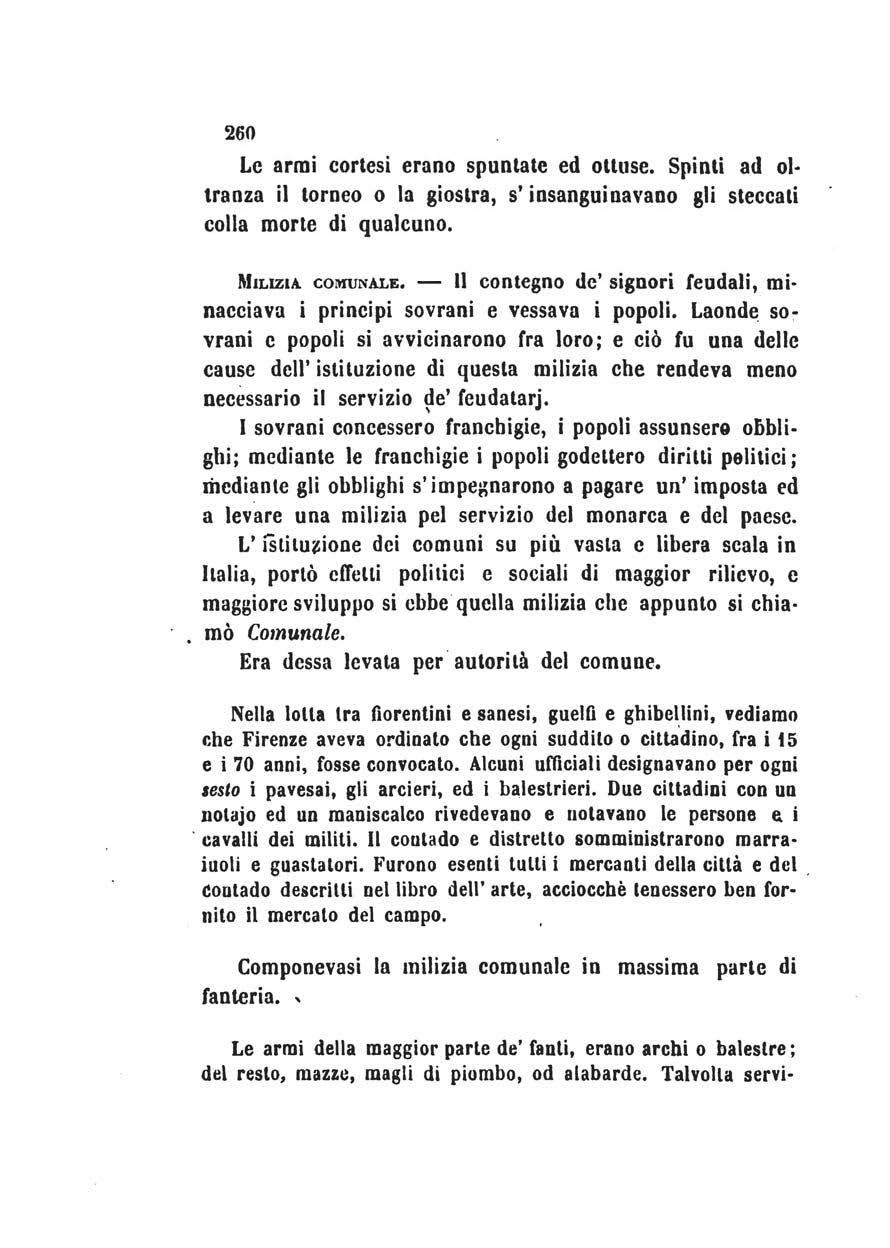
Componevasi la milizia comunale in massima parte di fanteria. ,
Le armi della maggior parte de' fanti, erano archi o balestre; del resto, mazze, magli di piombo, od alabarde. Talvolta servi·
26t vansl degli strumenti d' agricoltura. In alcune circostanze tro viamo il fante armato di panciera o corazzina con maniche di ferro, cappello d' acciajo o bacinetto con gorgiera, lancia e scudo.
Ciò non toglie che anche la cavalleria facesse parte delle milizie comunali.
Fren,ati i nobi!i più potenti, cd astretti i meno potenti a sperdere le radici di loro autorità feudale, dovettero questi ultimi pigliare stanza nelle città; c di cotesti vassalli inciuadinati si compose specialmente il nucleo della cavalleria dei comuni in Italia.
Nacque allora la cluplice distinzione tra milite e pedite. Alilite fu tanto il nobile quanto il guerriero a cavallo; pedite tanto il popolano quanto il soldato a ·piedi.
l comuni ponevano cura a mantenere in fiore la cavalleria con privilegi, vantaggi, stipendj, prcmj, encomj, e bollino.
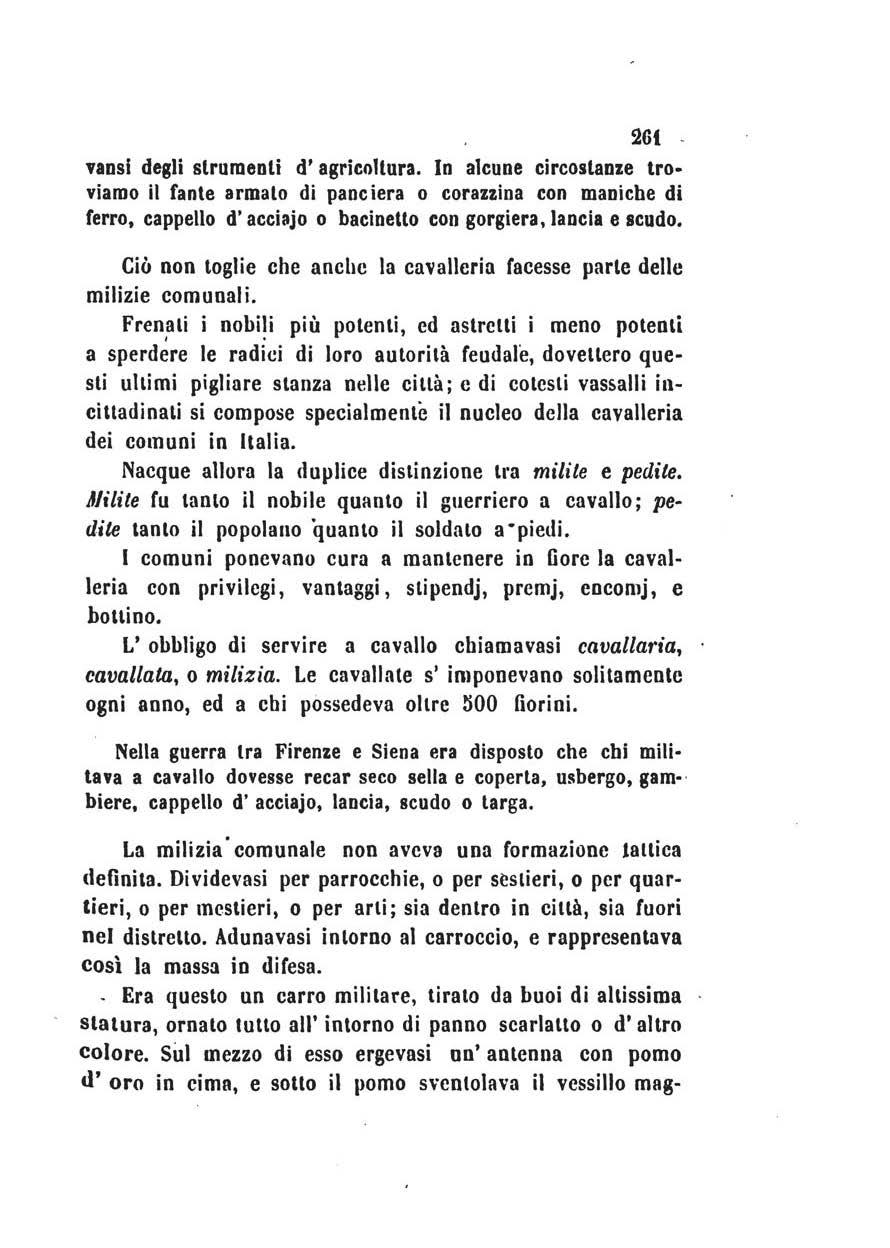
L' obbligo di servire a cavallo chiamavasi cavallaria, cavallata, o milizia. Le cavallnte s' imponevano solitamente ogni anno, ed a chi possedeva oltre !)00 fiorini.
Nella guerra tra Firenze e Siena era disposto che chi miti· tava a cavallo dovesse recar se co sella e coperta, U!lbergo, gam- · biere, cappello d' acciajo, lancia, scudo o targa .
La milizia· comunale non aveva una formazione tattica definita. Dividevasi per parrocchie, o per s(! slieri, o per quarlieri, o per mestieri, o per arti; sia dentro in città, sia fuori nel distretto. Adunavasi intorno al carroccio, e rappresentava così la massa io difesa.
. Era questo un carro militare , tirato da buoi di altissima statura, ornato tutto all' intorno di panno scarlatto o d'altro colore. Sul mezzo di esso ergevasi oo' antenna con pomo d' oro in cima, e sotto il pomo sventolava il vessillo mag-
giore del comune. Una campana attaccata all' antenna comunicava alla milizie l' ordine di andare avanti . o retrocedere. Sopra il carro si celebrava la messa e si amministravano sacramenti a feriti. '
Il carroccio era tenuto dagl' italiani come il palladio della loro e non eravi ignominia maggiore di quella del !asciarlo in preda ai nemici. ·
Io Francia, la milizia comunale marciava all' appello del re. In ILalia, era condona ·dapprima da un avvocato del vescovo, o da un capo municipale, o da un rappresentante del sovrano; poscia dai consoli e dagli anziani, allorquando al potere feudale andava sotteotrando un governo a popolo .
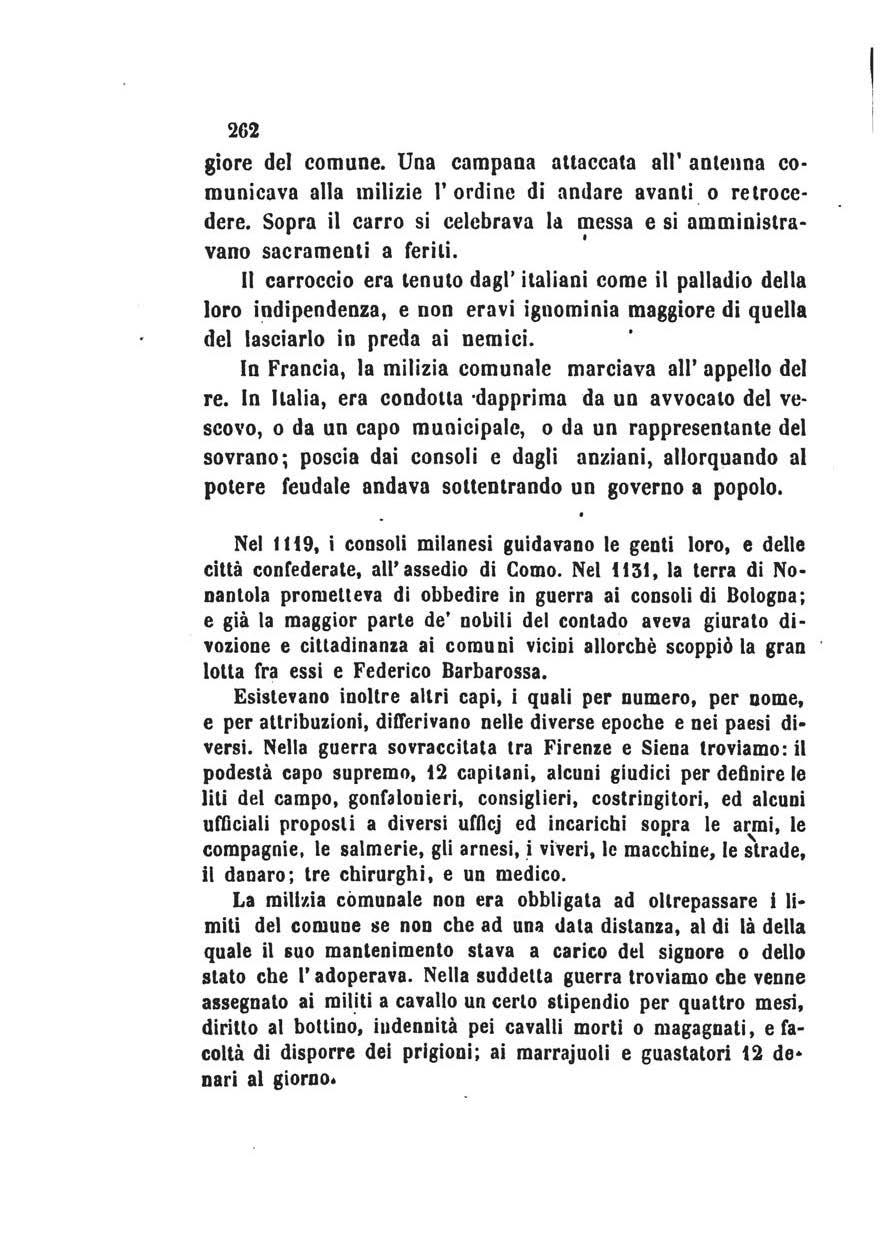
Nel llt9, i consoli milanesi guidavano le genti loro, e delle città conrederate, all'assedio di Como. Nel tt 31, la terra di Nonantola prometteva di obbedire in guerra ai consoli di Bologna; e già la maggior parte de' nobili del contado aveva giurato dilozione e cittadinanza ai comuni vicini allorchè scoppiò la gran lotta essi e Federico Barbarossa.
Esistevano inoltre altri capi, i quali per numero, per oome, e per attribuzioni, differivano nelle diverse epoche e nei paesi di· versi. Nella guerra sovraccitata tra Firenze e Siena troviamo: il podestà capo supremo, 12 capitani, alcuni giudici per definire le liti del campo , gonfalonieri, consiglieri, costringitori, ed alcuni ufficiali proposti a diversi urocj ed incarichi soP,ra le armi, le compagnie, le salmerie, gli arnesi, j viveri, le macchine, le il danaro; tre chirurghi, e un medico.
La milbia còmunale non era obbligata ad oltrepassare i li· miti del comune se non che ad una data distanza, al di là della quale il suo mantenimento stava a carico dtl signore o dello stato che l'adoperava. Nella suddetta guerra troviamo che venne assegnalo ai mil.iti a canllo un certo stipendio per quattro mesi, diritto al bollino, iudeonità pei cavalli morti o magagna ti, e facoltà di disporre del prigioni; ai marrajuoli e guastatori t2 de• oari al giorno.
Sebbene in parecchie circostanze troviamo disposizioni di ordine e disciplina nell'accolta di queste moltitudini, pure le loro marcie aveano piuttosto il carattere di processione anzicbè di mo· vimenli militari.
l re di Francia si servirono di siffalle milizie, ma non esonerarono i duchi ed i vassalli in genere di accorrere alla guerra all' appello dei re. Oltre agli uomini d'·armi, essi avevano il solito codazzo di fanteria feudale; e per tenere un po' in ordine questa turba confusa, Luigi IX diede loro un capo col nome di Gran mae1tro dei balutrieri.
In generale, le milizie comunali erano buone per la di· fesa del proprio paese; non valide nelle imprese lunghe o lo otane.
l VENTURtERt. Ed appunto per questa proprietà di essere • la comunale più idonea alla difesa che all' offesa, si creò un altro genere di milizia c fu quella dc' vcnturieri. Le loue intestine d' Italia produssero molti esuli che si trovavano in guerra per sè o per allri; i comuni ne appro6Uaa·ono dando loro per capi alcuni signoroui; e crescendo le bande, e unendolc a gente di niuno fede e di ni 'un partito , si le compagnie mercenarie che si vendevano al miglior compratore.
Anche le crociate, Imprese per la maggior parte· di ventura, contriburrono a sviluppare codeste bande in Europa. Tornati i guerrieri io casa loro, trovarono il paese sconvolto d,a gare .e da usurpazioni; e cercarono crearsi stato per sè, o trar profitto ponendosi al soldo allrui.
Nel secolo XIV, allorchè sorgeva In Italia l' uso di assoldar gente, lo stato eleggeva alcuni cittadini col titolo di amba1ciatori e consegnatori che la riunissero e rassegnassero . Prima di entrare al senigio, i venturieri giuravaòo di serbar fede al principe, di
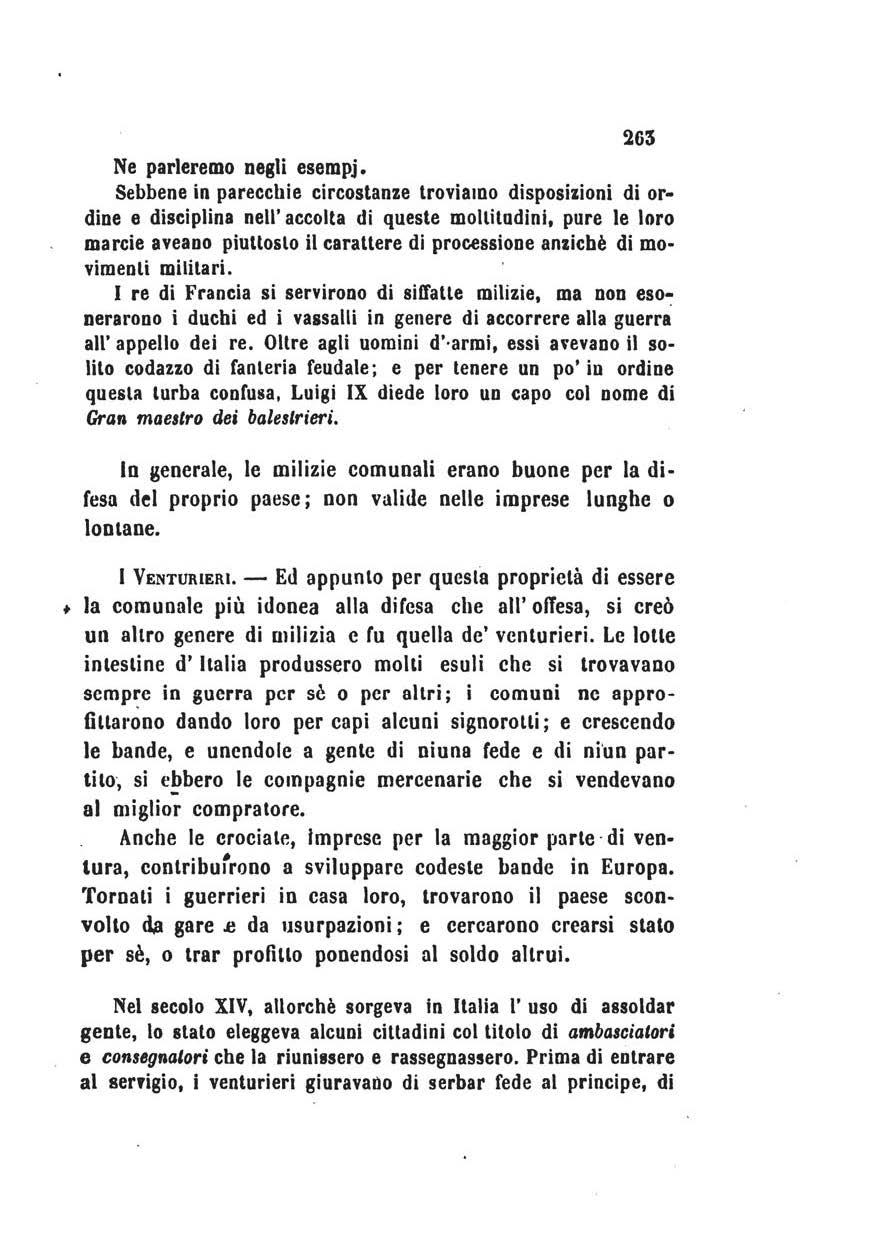
andare a combattere dovunque rosse loro comandato, di osservare ltl condizioni della condotta , di obbedire al Capitano generale, e di rivelare le congiure che pervenissero a loro notizia. Assoldavaosi in tre guise: io massa, a bandiere , od a drappelli. Più po· teote era il condottiero, più stretto il bisogno che se ne aveva, e migliori patti egli esigeva. Per solito, chiuso il contratto, rice· veva una somma a titolo di pre&tito, ne dava mallevadori, e si obbligava a scontarla sulte paghe mese per mese. Quindi passava colle sue genti la mostra armata al cospetto dei consegnatori che registravano e stimavano uomini , cavalli, armature, ed arnesi, ri· fiutando tutto ciò ebe non fosse ai patti.
L' ·armatura era varìa, aecoo,Jo i gradi e il genere della milizia.
Fra le più antiche di queste compagnie fuvvi quella desli Al· movari, nei primi auni del secolo XIV, composta io origine di Arragonesi che prima avevano combattuto in guerriglie io lspagoa contro i mori, poi erano venuti io Sicilia e nevano combattuto contro gli Angioini. Gli Almovari se ne andarono poscia d' Italia, guerreggiarono io Francia, in Grecia, e in altre contrade orientali, e poscia si stabilirono io Altme.
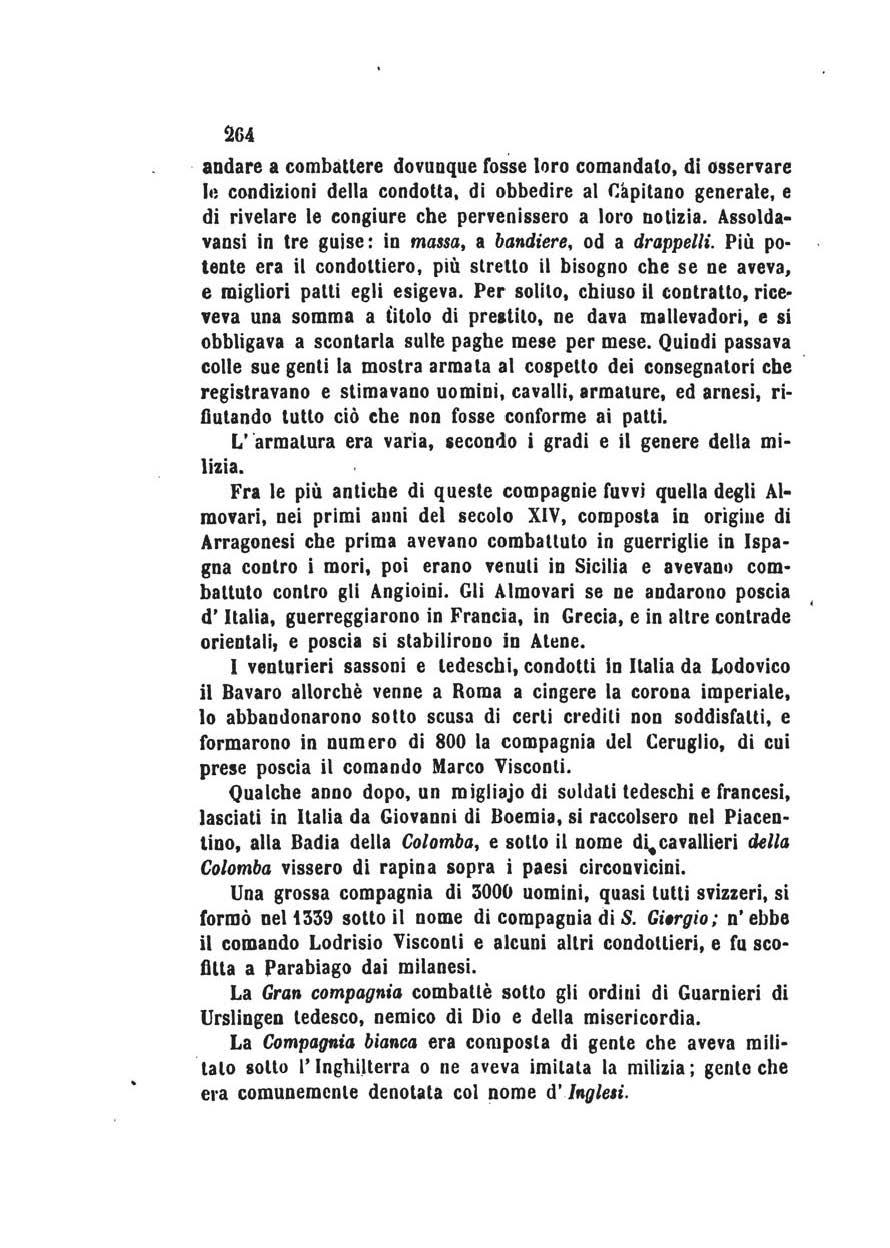
l veoturieri sassooi e tedeschi, condotti lo Italia da Lodovico il Bavaro allorchè venne a Roma a cingere la corona imperiale , lo abbandonarono sotto scusa di certi c1·editi non soddisfatti, e formarono in oum ero di 800 la compagnia ùel Ceruglio, di cui prese poscia il comando Marco Visconti.
Qualche anno dopo, un migliajo di soldati tedeschi e francesi , lasciati in Italia da Giovanni di Boemia, si raccolsero nel Piacentino, alla Badia della Colomba, e sotto il nome di._ cavallieri della Colomba vissero di rapina sopra i paesi circonvicini.
Una grossa compagnia di 300(1 uomini, quasi tutti svizzeri, si formò nel t339 sotto il nome di compagnia di S. Giergio; o' ebbe il comando Lodrisio Visconti e alcuni altri condottieri, e fu sco· filta a Parabiago dai milanesi.
La Gran compagnia combattè sotto gli ordini di Guarnieri di Ursliogeo tedesco, nemico di Dio e della misericordia.
La Compagnia bianca era composta di gente che aveva militato solto l' lnghi}tel'ra o ne aveva imitata la milizia; gente che el'a comunemente denotata col nome d' ]Jtgleli
Cio per quanto riguarda gl'italiani. Rispetto alla Francia, oltre alla fanteria feudale e comunale, si formarono bande di venlurieri verso. la fine del secolo Xli, composte di genti a piedi conosciute solto diversi e strani nomi: Ritarclalori, Jlalandrcni , Scorticatori, Ribalài, Tosatori, Mille Dia· 11oli ecc. Questi mercenarj, raccolli fra diverse nazioni, formavano truppe indisciplinate, vagabonde, e si occupavano a predare al· lorquando guerreggiavano. Essi ponevansi dalla parte dd sovrano che li pagava meglio . Luigi 'VII, re di Francia, n' ebbe fino a 20,000 al suo soldo. Il loro divenne intollerabile. Filippo Augusto inviò contro essi nel H83 un esercito che li scon· fisse in vicinanza di Dourges. Si rifecP.ro e continuarono a com_. battere ed a rubare fin sotto il regno di Carlo v. ·Finchè questo monarca, avendo pietà delle provincie francesi ch' essi devasta· vano, diè ordine a Du Guesclin di antlare a pigliar il comando delle loro grandi compagnie e di condurle fuori del regno; l'eroe bretone esegui nel 1366 questo còmpito difficile.
ARciERI INGLESI. - Erano consideraLi fra le migliori fanterie del secolo XIV.
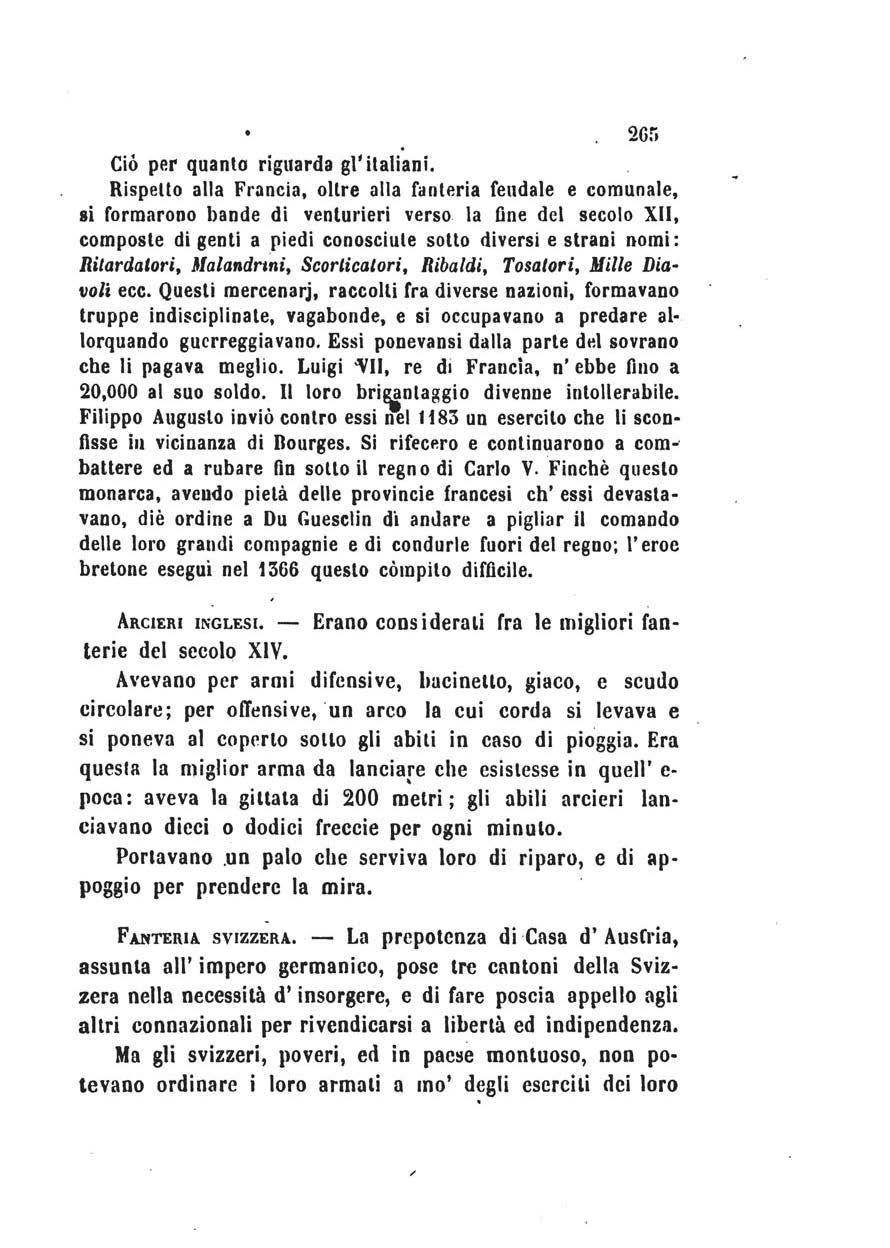
A\'evano per armi difensive, hacineuo, giaco, e scudo circolare; per oiTensi ve, ·un arco la cui corda si levava e si poneva al coperto souo gli abiti in caso di pioggia. Era quesla la miglior arma da lanciare che esistesse in quell' cpoca: aveva la giltala di 200 metri ; gli abili arcieri lanciavano dieci o dodici freccie per ogni minuto.
Portavano .un palo che serviva loro di riparo, e di ap· poggio per prendere la mira.
FANTERIA svizZERA. La prepotenza di ·Casa d' Ausrria, assuola all' impero germanico, pose tre cnntoni della Svizzera nella necessità d' insorgere, e di fare poscia appello l'gli altri connazionali per rivendicarsi a libertà ed indipendenza. Ma gli svizzeri, poveri, ed in paclle montuoso, non potevano ordinare i loro armali a mo' degli eserciti dci loro /
tiranni, ed al lusso della cavalleria imperiale non potevano opporre i forti gendarmi. Bisognava combattere a piedi: e per resistere all' urto nemico, era mestieri costituirsi in forte ordinanza, compatta , profonda, serrata, falangita , con lunghe picche alla foggia tle' greci antichi. La profothlità della for· mazione, e la robustt•zza e la lunghezza dell' arma, denotavano il carattere difensivo, lo scopo di resistenza dell' istituzione.
Sorsero allora i grossi ballaglioni, con picche di i 8 piedi di lunghezza, che ,per la moltiplicità delle punte venivano denotati col nome di istrice o t'iccio.
Per mantenere la eompauezza \'i era d' uopo d' insieme, per ottenere l'. insieme era indispensabile la disciplina. E gli s vizzeri avevano severa disciplina; fra le cui prescri&ioni debbonsi notare quelle che imponevano il silenzio più assoluto solto le armi, e vietavano ai soldati di lasciare il posto sotto pena di morte.
Il vero risorgimento dell' arte buona comincia dagli sviz· zeri.
ServiJio !anilario. La scarsezza dei dali su questo argomento, e il difetto di provvedimenti su tale ramo di amministrazione militare, non ci in grado di tenerne speciale discorso io ogni fase del medio evo su cui ci siamo fermati. Per questo ci limitiamo qui ad alcuni cenni generali.
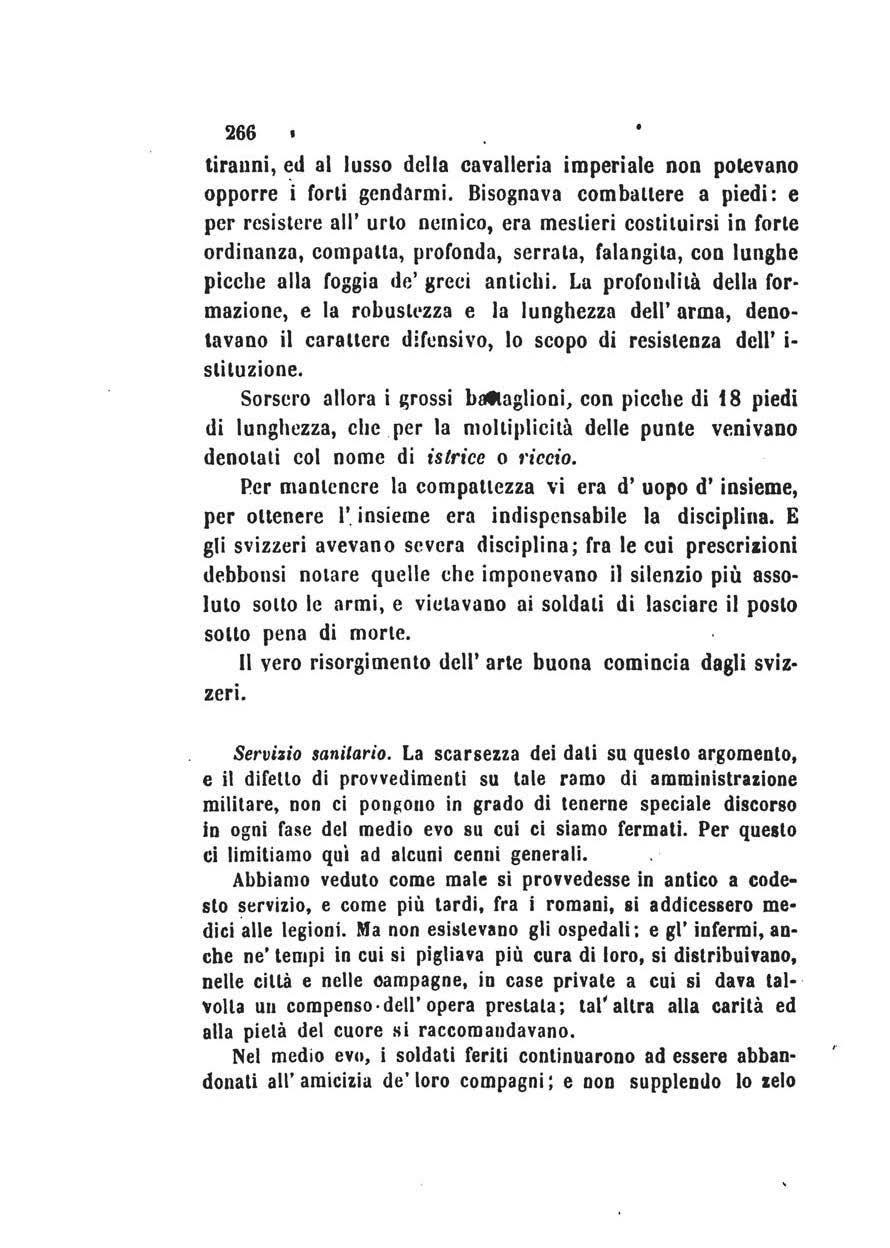
Abbiamo veduto come male si provvedesse in antico a codesto servizio, e come più tardi, fra i romani, si addicessero medici ·alle legioni. Ma non esistevano gli ospedali: e gl ' infermi, anche ne' tempi in cui si pigliava più cura di loro, si distribuivano, nelle cillà e nelle oampagne, io case private a cui si dava tal- · -.olla uu compenso· dell ' opera preslata; tal' altra alla carità ed alla pi età del cuore si raccomandavano.
Nel medio evu, i soldati feriti continuarono ad essere abban· donati all'amicizia de ' loro compagni; e non supplendo lo zelo
267 alle cognizioni, le ferile più leggiere si facevano mortali, le ma· 'lallie divennero contagiose, e mieterono eserciti e popolazioni. Se ne banno orribili esempj. ftfa sebbene si voglia che il pensiero d' istituire ospedali non siasi manifestato prima del secolo XVI, tuttavia è lecito il dubitare dell'esattezza di quest ' opinione, qualora si volga il pen· siero all' incursione dei crociati europei in Asia nei secoli Xl, XII e Xlii. I cavallieri Ospilalieri, che porst!ro soccorsi ai crociati, avevano da principio aperlo ospizj specialmente civili; ma questi stabilimenti furono trasformati, a\ tempo delle gu erre, in ospe· dali totalmente militari, od almeno partecipanti del regime militare; e nella riunione degli Ospitalieri della Palestina si trovano ·le traccie delle regole che banno poi servito di base all' ammi· slrazione degli ospedali militari . I convogli dei maiali e dei fe· riti duopo di essere protetti; e gli Ospitalieri, che dapprima non andnauo ad incontrare i pellegrini se non che per servire ati essi di guide, si armarono poscia per poter percorrere le strade, affine di difendere sè medesimi ed i feriti dagl' insulti del nemico.
Questo còmpilo, di dividere i pericoli e le glorie coi cavai· lieri combattenti, li rese degni di ricevere un organameolo cavalleresco.
Cacciali dall'Oriente dalle armi mussulmane, codesti Spedalieri portarono altrove le loro istituzioni; ma degenerarono; allo scopo dei fondatori dell'ordine, cb' era di soccorrere i ferili e gii ammalati, sostituirono quello d' essen i ammessi per godere splendidamente d ei vantaggi della riccheua e della nobiltà ; ed avendo cessato d i essere utili , cessò an cbe col vol g ere del tempo l' esistenza delta loro associazione.
1/acchine. Gli antichi barbari si servirono d·elle macchine dei viuLi . In seguito se ue costr.uirono alLre di proporzioni immense; ma più lente nel tiro, c di gittata più breve .
Troviamo nel medio evo le armi seguenti da lanciare projeuili : il trabocco, la manganella, il montone, il gatto, il grillo, la briccola .
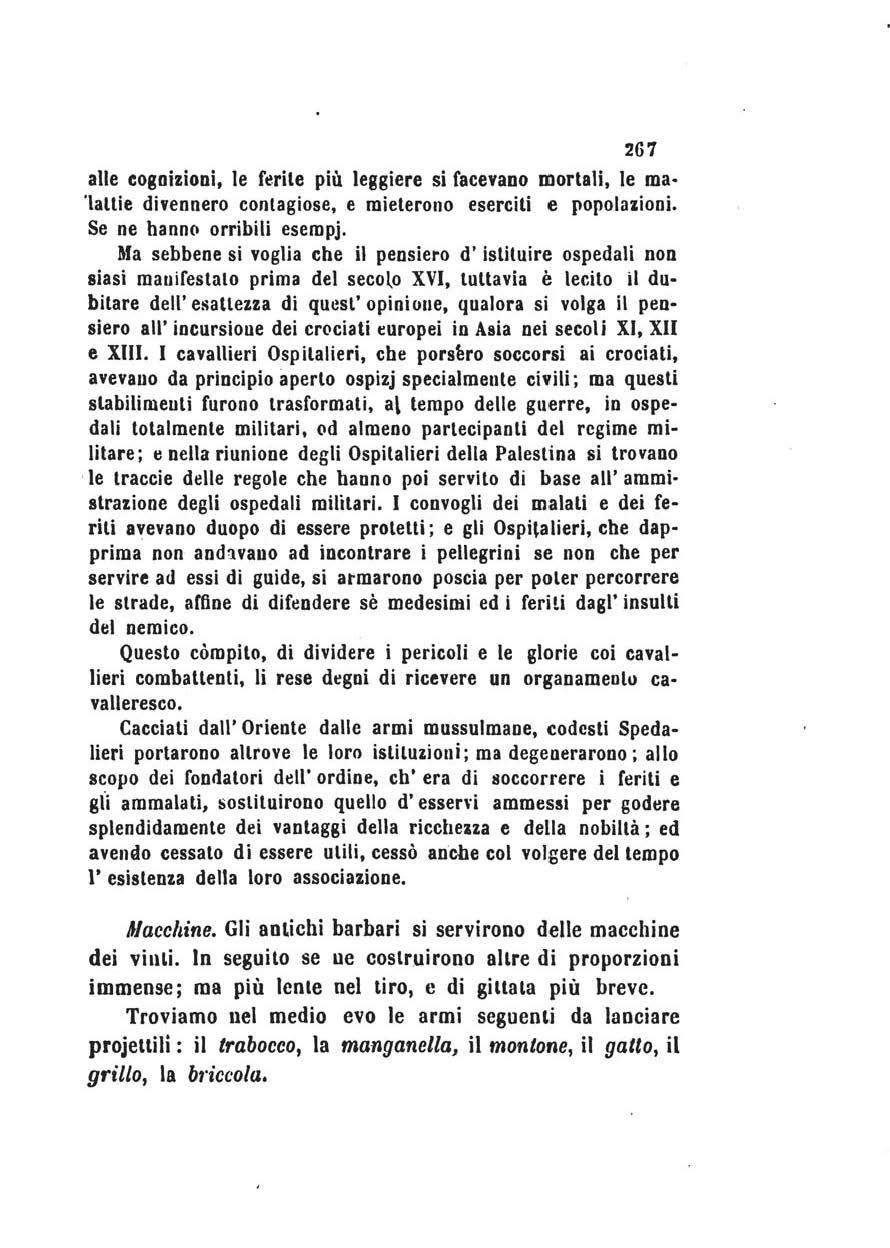
Il trab6cco, era macchina murale della milbia italiana, che faceva l' uffizio tlella balista dei romani, scagliando sassi di J•eso eno rme, e fuochi lavòrati nelle città assediate;
La manganella, che pur.e lanciava pietre; era forse l' onagro dei ' romani ;
Il moftt011e per bauere le muraglie: era lo stesso dell'ariete;
Il gallo, macchina d' un solo tetto e tavolato lntessuto di viachi, e coperto di pelli crude, dal quale pendevà una gran trava ferrata con cui si ballevano le mura nemiche, od un forte rampiconc di ferro col quale si ag_grapavaoo e traevano al basso i merli e le pietre smosse dall' urto del montone;
Il grillo. strumento di legname col quale gli assedianti s' accostavano al coperto aile mura della ciltà assediata per discaccia rne i difensori ed abbalterle;
La briccula. milita re adoperata dagl'Italiani prima dell' invenzione delle artiglierie, per iscagliare grosse pietre nelle città cbe asRedinamo: era la catapulta dei romani.
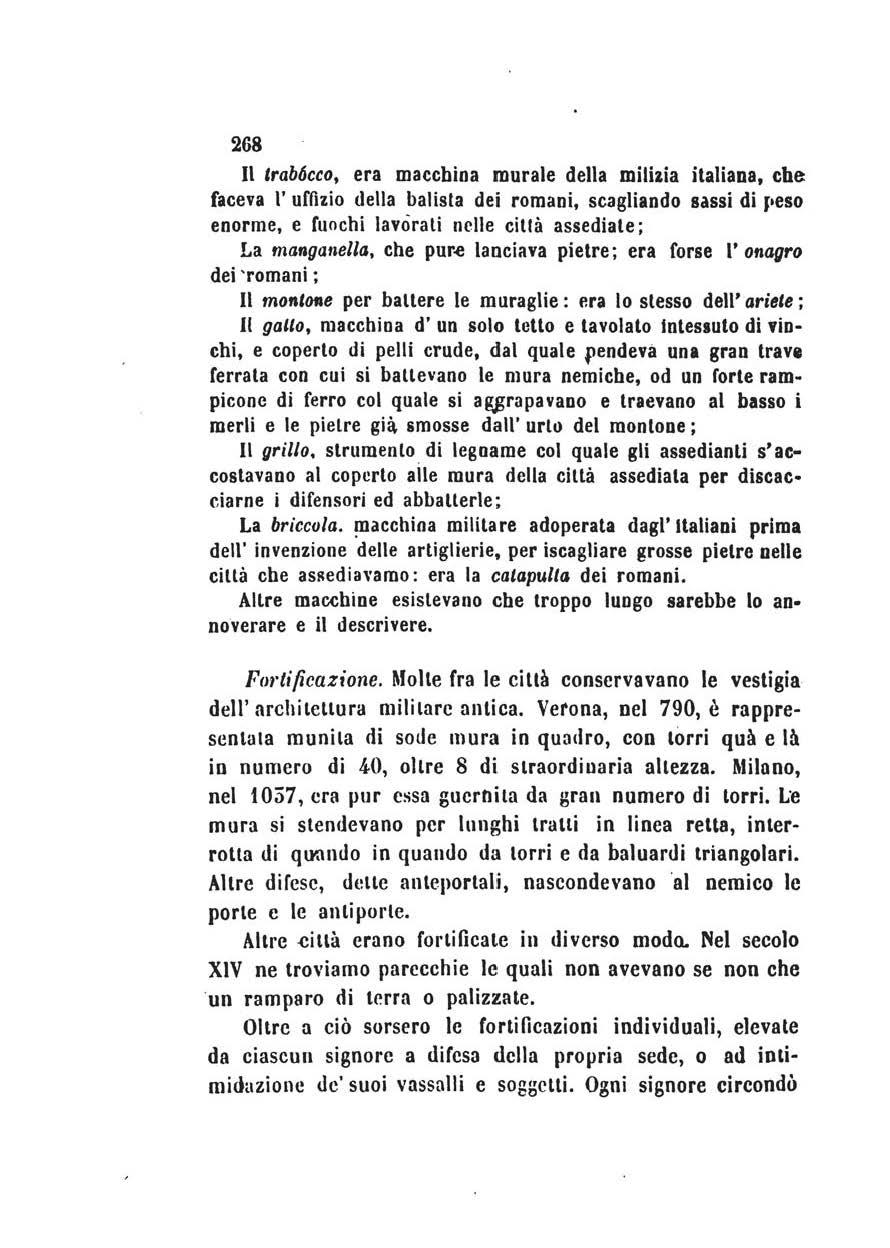
Altre macchine esistevano che troppo lungo sarebbe lo an· noverare e il descrivere.
Fo1'tificazione. Molte fra le città conservavano le vestigia dell' architeuura militare antica. Verona, nel 790, è rapprescntala munita di solle mura in qu:11lro, con torri quà e là io numero di 40, oltre 8 di straordinaria altezza. nel 1057, era pur essa guernita da gran numero di torri. L'e mura si stendevano per lunghi traui in linea retta, interrotta di qoondo in quando da torri e da baluardi triangolari. Altre difese, dette anteportali, nascondevano 'al nemico le porte c le an ti porte.
Altt·e erano fortilìcate in diverso modo. Nel secolo XIV ne troviamo parecchie le quali non avevano se non che ·un ramparo di terra o palizzate.
Oltre a ciò sorsero le fortificazioni individuali , elevate da ciascun signore a difesa della propria sede, o ad intimidazione dc' suoi vassalli c soggetti. Ogni signore circondò
269 )a sua residenza di un fo sso, di una , o più cinte di muraglie guemite di e con un mastio, di forma per lo più quadra, posto d'ordinario a difesa c rinforzo dell'entrata principale. Il mastio serviva ancora ad osser\·arc la campa- . gna circostante, e ad offrire un ullimo rifugio agli assediati. L' insieme di queste opere chiamavasi Castello.
Fra le fortificazioni del medio evo sono da notarsi . le Bastie o Bastite. piccole fortezze di forma quadrata , chiuse intorno da un fosso e da un terrapieno. Si guernivano talvolta di torri sugli angoli, c principalmente quando dovevano rimanere gran tempo in piedi. Le Bastie o Bastite vennero portate dai france si in Italia nel secolo Xlii, c adoperavansi per fortificare un luogo sul quale .non si potesse altrimenti piantare una fortezza. r egolare di mu•·o, o per combattere una ciuà, cingendola di tante Bastie quante bastas· sero per capire tolte le genti assedianti. Molte terre d' Italia ritengono ancora il nome di Bastia. §.
L' azloae. • l barbari non combattevano totalmente scnz' ordine; formavansi in masse quadrati!; .talvolta a triangolo, a cuneo, a di porco; tenevano ordinanza profonda; adoperavano la testuggine, formata da grandi scudi, per proteggere le prime righe. La loro cavalleria era poco numerosa, collocata per lo più alle ati :
Un esempio del modo con cui si diedero alcune battaglie nelle prime guerre fra i barbari e i romani del basso impero, l ' abbiamo io quella di Casilioo che descrive remo.
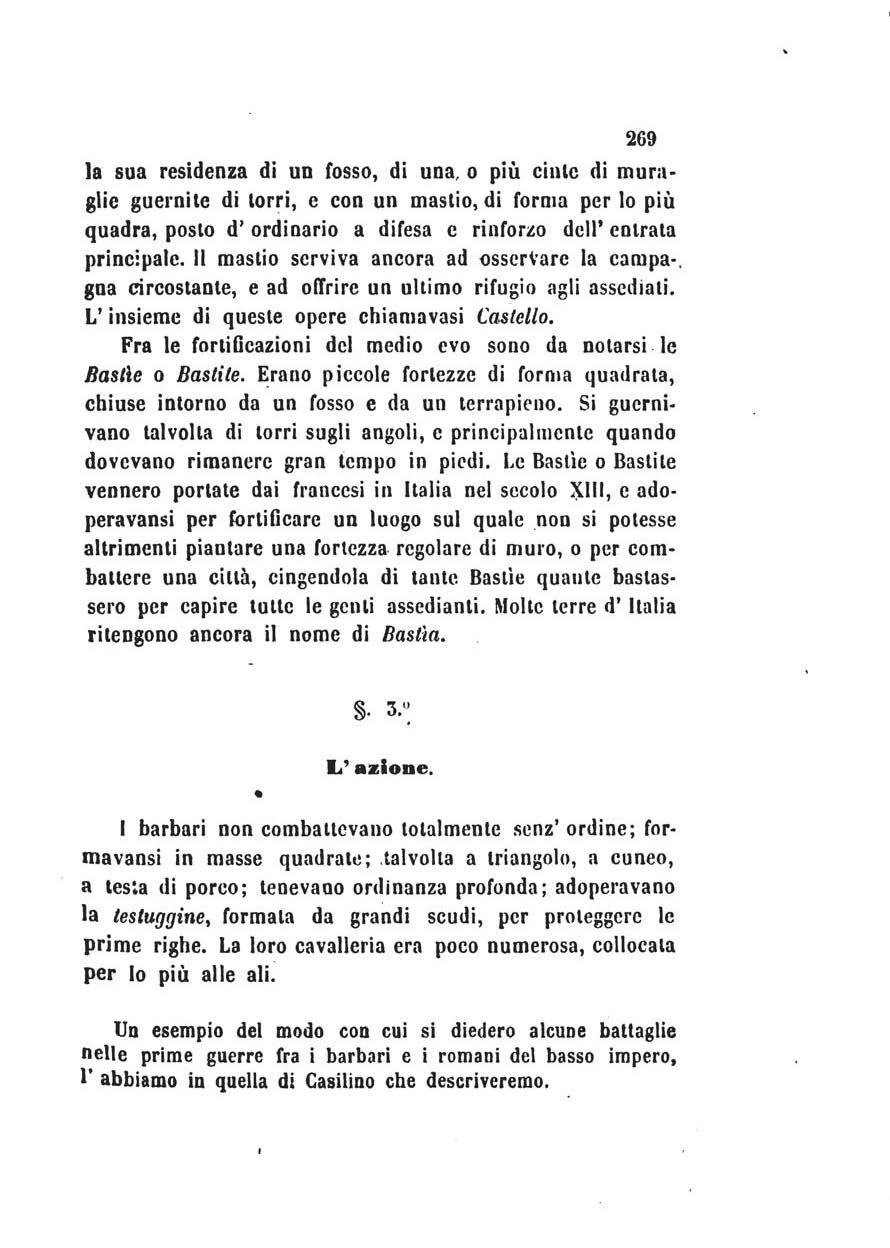
2i0
Se dall' insieme noi pasaiamo al modo individuale di comballere alloréhè i nemici si trovavano corpo a corpo, non è da passare sotto sil.enlio il metodo dei primi franchi.
Il fante gell!lva il giavellotto unciuato ( hang ) contro l' avversario; se pigliava alle carni produceva gravi ferile; se si attaccava allo scudo, allora il franco balzava con un piede sull' asta, e sforzando lo scudo ad abbassarsi, scuopriva .il nemico e cercava colpirlo colla francesca. Cosi combatterono i franchi sino alla lìne del 6n secolo.
Pare che per mollissimo tempo dopo Casilino si conservasse l'ordine profondo; lo troviamo alla battaglia di Tours, data nel 732 da Carlo Martello contro i saraceni. A•eodo egli a rendere vano il loro urlo tumultuario , dovè opporvi la solidità falangita, le grandi masse, colle quali vuolsi che rompessi! l'esercito ne· mico; per cui si trasmise coi secoli il dello • Dio fu pe' suoi grossi battaglioni. •
Dopo incominciò l'accrescimento, poi la prevalenza, indi il dominio della cavalleria.
In questo frattempo si segnò un' epoca nella storia che rimarrà per sempre memorabile. Il regno di Carlomagno. Considerandolo dal lato deU' nrlc militare, cd esclusi va mente nella parte che si riferisce all' azione, diremo riscontrarvisi una vasti tà di concetti a cui i difetti dci n1ezzi di que' tempi ponevano incagli e ritardi nell'esecuzione. Troviamo infatti che Carlomagno agì con parecchi eserciti assieme combinati, invase la Spagna contemporaneamente per la Navarra e per la Linguadoca e si riunì a Saragozza. Andò contro il re di Baviera per Augusta, per Farniga sul Danubio, per Bolzano nel Tirolo. Queste combinazioni, tenute secrele, agevolarono le sue vittorie. l difetti poi de' mezzi per ottenere il frullo de' suoi concepimenti, , si svelano nella lunghezza del tempo che si richiese per attuarli, come ad esempio le sue guerre coi sassoni che durarono .lrentatrè anni.
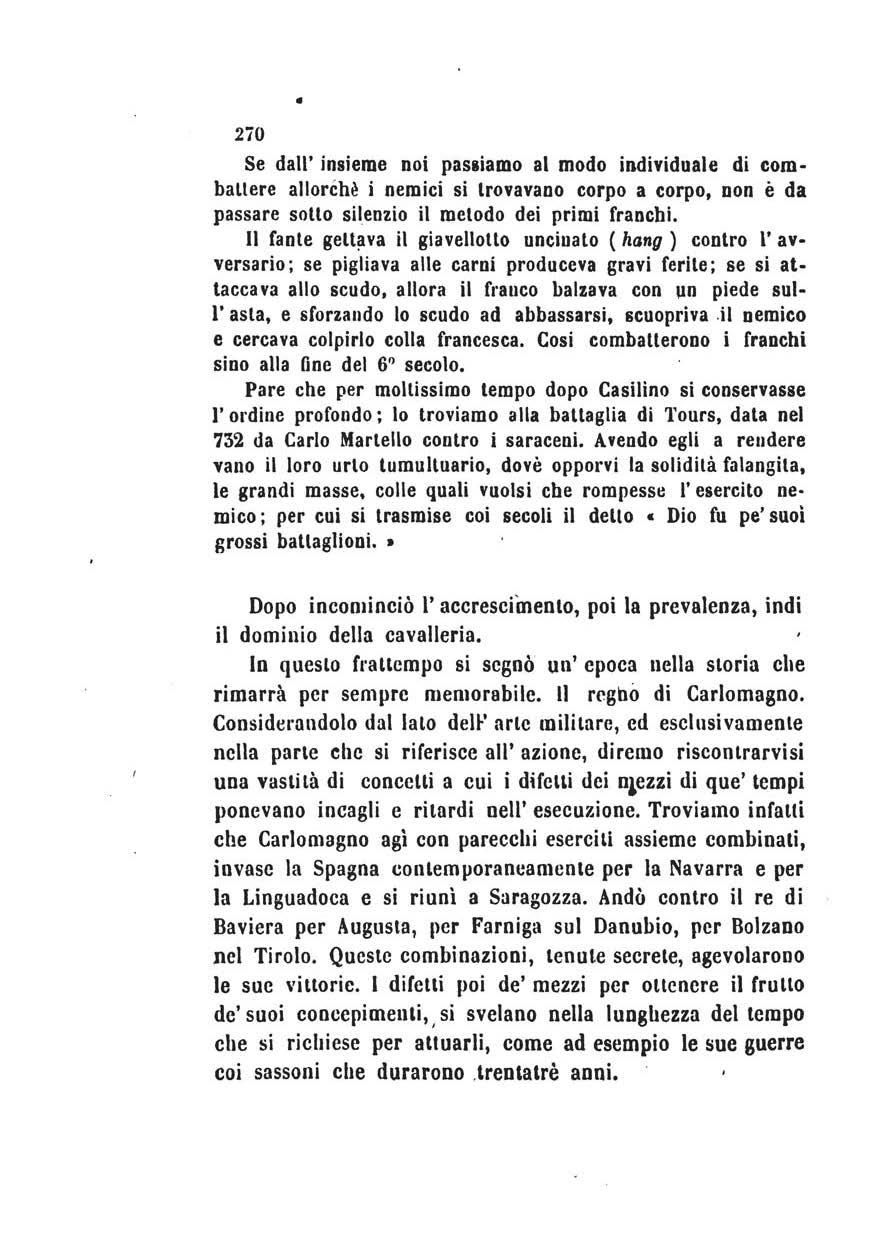
Il sistema, che già era cominciato a mutare sotto Carlomagno, finì col cambiarsi totalmente sotto ·i suoi sue· cessori.
All' insieme si sostituì l' individualismo, alla tattica la· prodezza. Non si combatteva con divisioni o suddivisioni di truppe formanti un tullo cospirante al medesimo fine; ciascuno agiva per sè , per farsi per farsi ammira· re, per acquistare fama di valore. Aumentando le suddivisioni politiche, si ebbero gruppi di signori indisciplinati c di paesani avviliti; invece di grandi guerre . fra nazioni armate, si videro lotte fra castello c cnstcllo, fra città e cillà, fra provincia e provincia, fra vas.sallo e sovrano, senza buone regole di comando e di obbedienza. Ovc non è oh· bedienza non è disciplina; ove non è disciplina non è insieme; ove non è insieme ooo è tatt ica. Quindi guP-rre e battaglie miserabili.
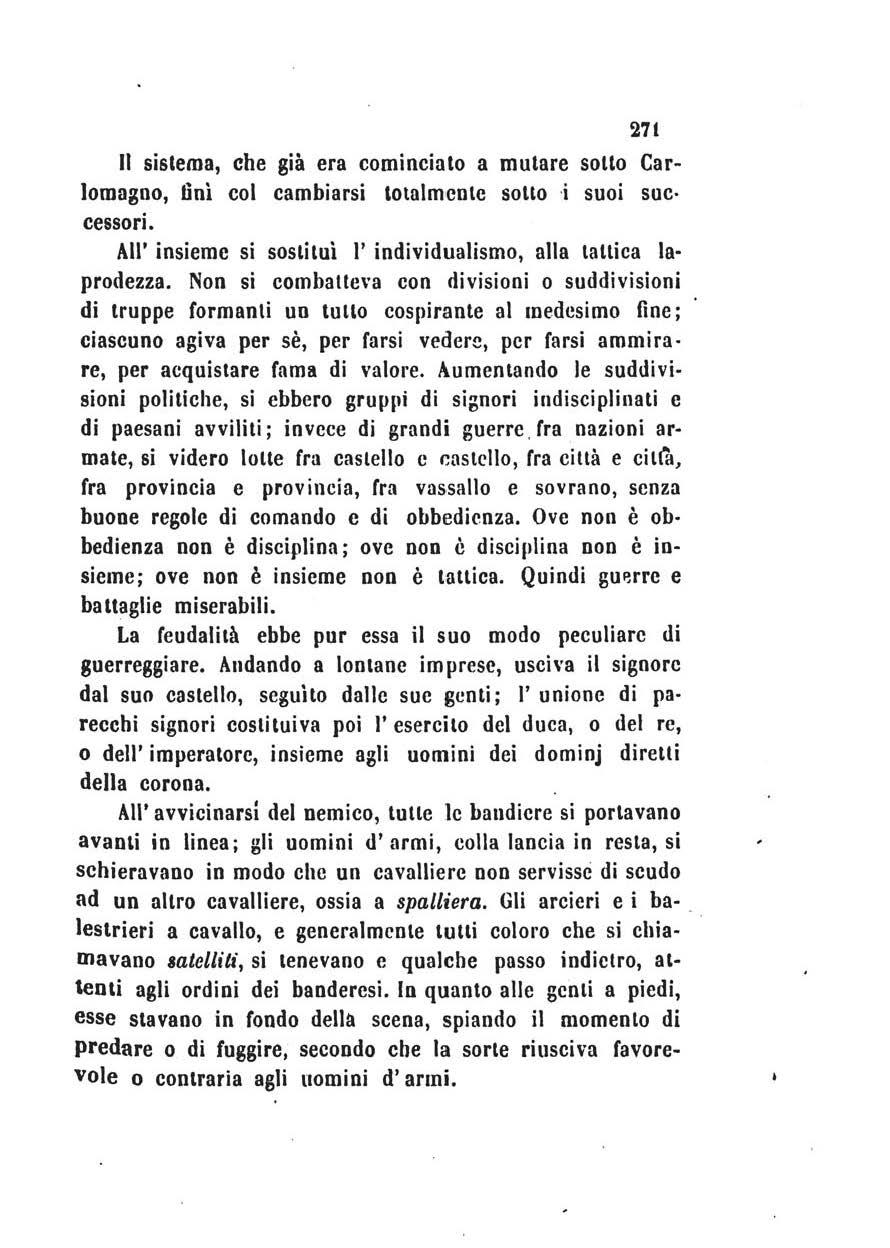
La feudalità ebbe pur essa il suo modo peculiare di guerreggiare. Andando a lontane im prese, usciva il signore dal suo castello, seguito dalle sue genti; l' unione di pa· recehi signori costituiva poi l'esercito del duca, o del re, o dell'imperatore, insieme agli uomini dei dominj diretti della corona.
All'avvicinarsi del nemico, tutte le bandiere si portavano avanti in linea; gli uomini d' armi, colla lancia in resta, si schieravano in modo che un cavallierc non servisse di scudo ad un altro cavalliere, ossia a spalliera. Gli arcieri e i ba- . lestrieri a cavallo, e generalmente tutti colo1·o che si chia· mavano •atelliti, si tenevano e qualche passo indietro, at\enti agli ordini dei banderesi. lo quanto alle genti a piedi, esse stavano in fondo dellà scena, spiando il momento di predare o di fuggire, secondo che la sorte riusciva favorevole o contraria agli uomini d'armi.
.
L'incontro avveniva sempre iu ordine parallelo, e ad 'un tempo su tutta la linea.
l saLelliti cominciavano a saramucciare fino al momento in cui l' una delle due. parti, accorgendosi del disordine o dell' esitazione nella gendarmeria opposta. si determinava a dare la carica. L'urto era seguito dalla mischia, loccltè significa che la forza del corpo e la sorte decidevano del successo.
Queste battaglie presentavano il quadro di un' infinità di duelli in cui ciascuno assaliva colui che aveva in faccia. l e tutti i capi, correvano gli stessi rischi dei semplici scudi cri; i capitani erano più occupati ad uccidere che a comandare. ·
La fanteria feudale poi non recava alcuna utilità sul campo; era d' imbarazzo piuttostochè di vantaggio.
Nel corso di queste cose ·avvennero le c•·ociate.
l primi motori delle crociate, vedendo l' immenso esten dersi delle conqui:ite de' mussulmani in Occidente, sentirono forse la necessità di una gran dr diversione; e, alla guisa di quauto fece Alessandro co' persiani, vollero forse assalire i nemici al loro centro per obbligarli a ripiegare le loro ali.
Ma anche ammettendo che sui prim.ordj siasi sentito questo gl'nn bisogno, a cui rispose un concetto non espresso ma generalmente concepito io gu is a, per cosi dire , latente, è certo che il modo di ripararvi non corrispose militarmente atla grandezza dell' idea; e sotto il rapporto dei progressi dell' arte le crociate non meritano una grande attenzione.
Il vantaggio che n' è venuto all' lirte si è quello di aver contribuito in certo modo al rialzamento della fanteria. La difficoltà di riparare in lontane regioni atle perdite di cavallicri bardati, rese più necessaria l' azione di quelle im-
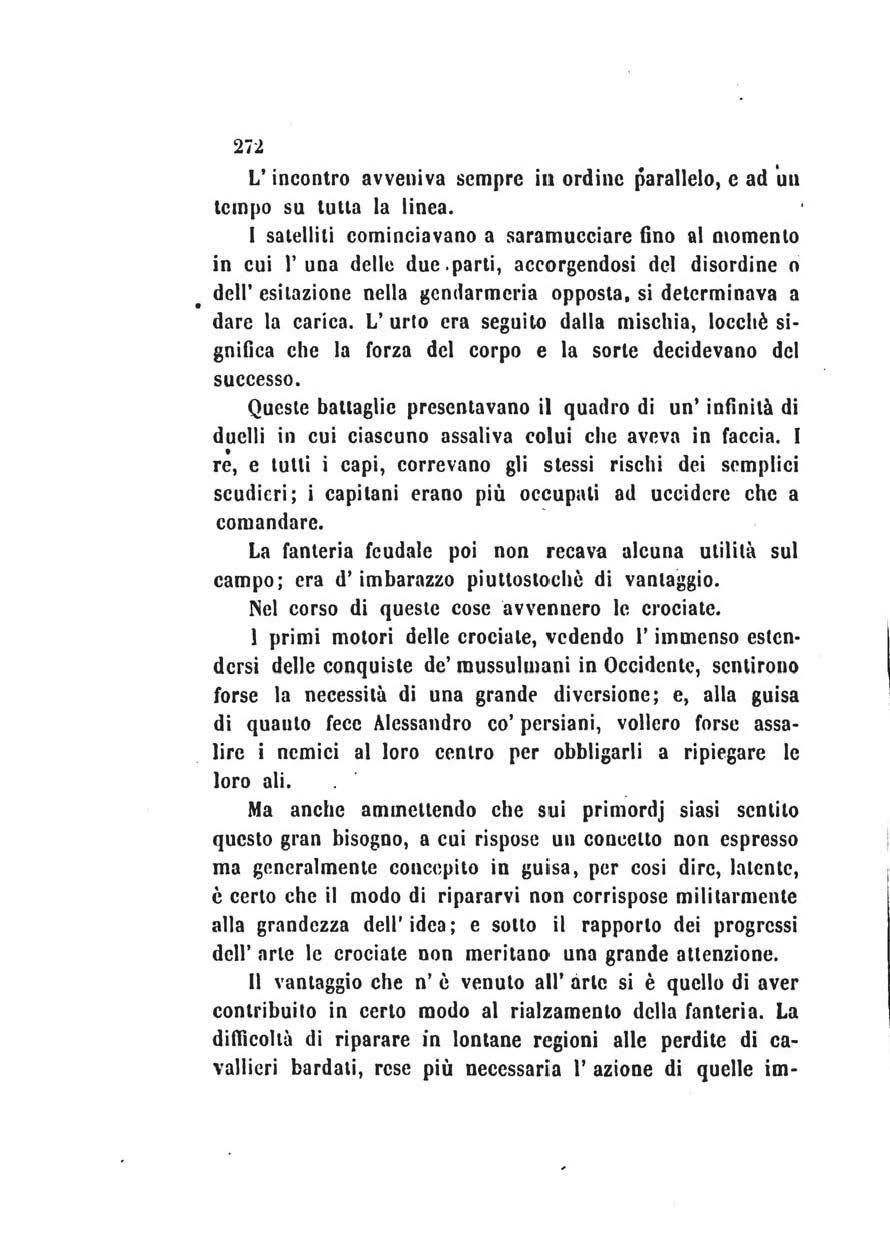
275 mense turbe d'uomini a piedi che recavansi in Oriente c che in Europa ernno disprezzati . Riconosciuto che costoro erano necessarj, si curarono di più, si ·armarono meglio, vennero un poco diciplioati; ed tanto lontani dalle loro terre, non potendo più fuggire e disperdersi alle' case loro come in Europa; ma dovendo in Oriente rimanere al campo ch' era la loro patria, da cui non potevano allontanarsi senza pericolo , dovettero restare più fermi al posto, c piegarsi alquanto agli ordini.
Le tradizioni poi portate dall' Oriente all' Occidente intorno ad una certa utilità dci fanti , deve aver contribuilo a rialzar questi c a diminuire l' importanza de' cavallieri.
E questo forse fu uno dc' primi passi al miglioramento dell' arte.
Se poi. andiamo ad indagare a qual punto trovavasi la grande tattica nelle guerre combattute in Terra Santa, dobbiamo dire che essa era bene in ÌJasso, e poco assoggettata ai calcoli del raziocinio. Fra gli eserciti in g•·an parte di· sordinati dei crociati mancava la disciplina; ove manca disciplina non vi può essere insieme; ove manca l' insieme non si possono attuare , come dicemmo, concetti tattici di rilievo.
Due esempj servono a corroborare il nostro avviso (t).
Nella 28 crociata -poco mancò che Luigi VII, detto il giovine, re di Francia, non perdesse la vita per un' imprudenza che svela la mancanza di tattica. Ciò avvenne nel momento in cui l' esercito cristiano, dopo aver passato il abbandonava Laodicca per entrare in Pamfilia.
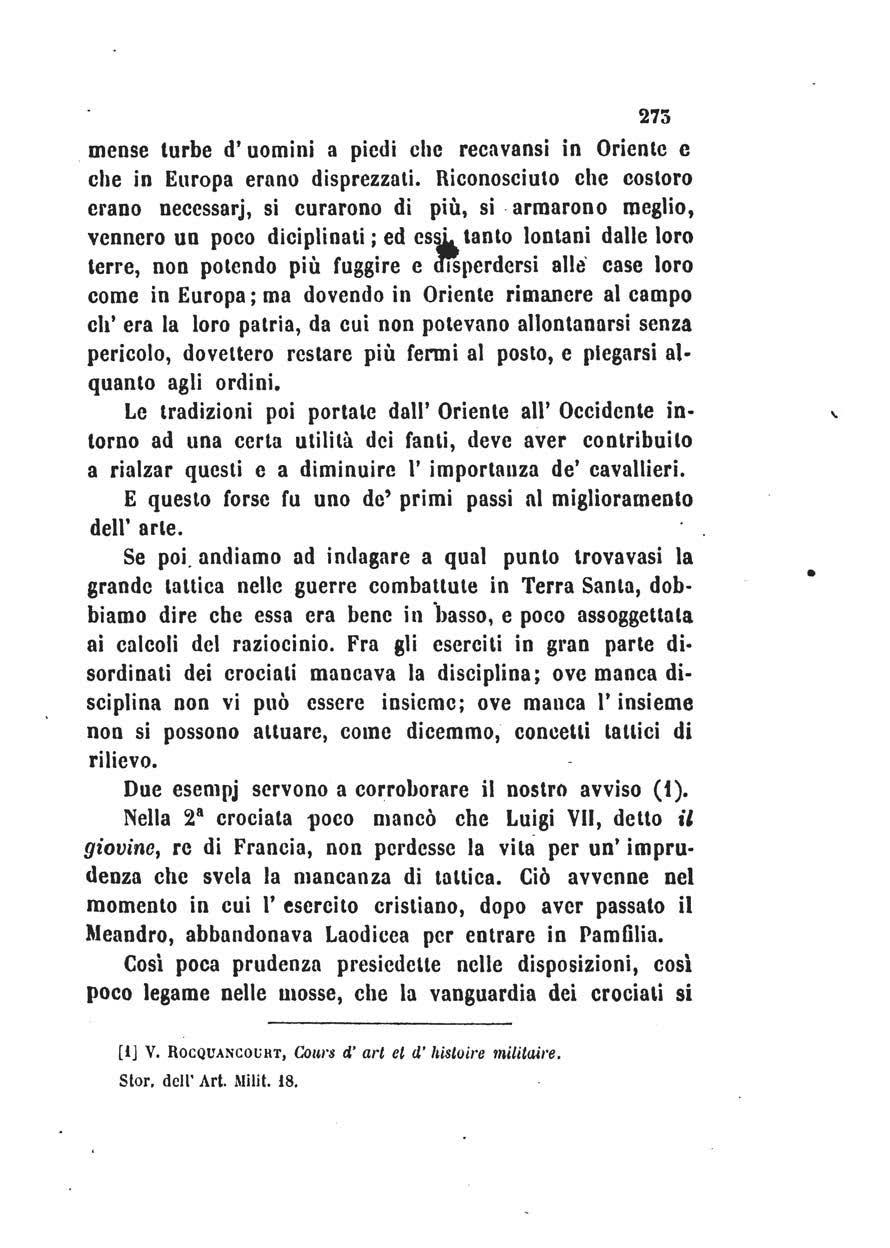
Cosi poca prudenza presiedette nelle disposizioni, così poco legame nelle mosse, che la vanguardia dei crociati si
[ t j V. R OCQ UANCOUIIT , Cow·s d ' art et d ' hist uit·e milit<Ure Stor . de ll' Art. Mìli t. !8.
274 trovò tanto lontana dal grosso dell ' esercito da esserne se· parata da una gola. Il nemico, il quale non aveva cessato di stare ai fianchi dei crociati nella loro marcia, questo momento per assalirli i.disperderli; sicchè re Luigi fu costreuo a rifuggirsi sulla punta di una roccia ove sostenne una specie di assedio.
Un altro esempio . Fra le crociate, quella che meglio venne concepita, e meno ·male diretta, perchè vi era unità di comando, fu quella di Luigi IX. Pure andò fallita per la cecità del Con te di Artois, frat ello del re, e per le pessime disposizioni date di poi . n conte, avendo veduto i saraceni sotto le mura di Mansurà, corse nd assalirli; senza contarnè il numero, senza guardare la posizione, senza calcolare se rimaneva collegato al grosso dell'esercito, si precipitò su di essi ; ed illuso da una loro finta riti restò tagliato fuori co; suoi seguaci.
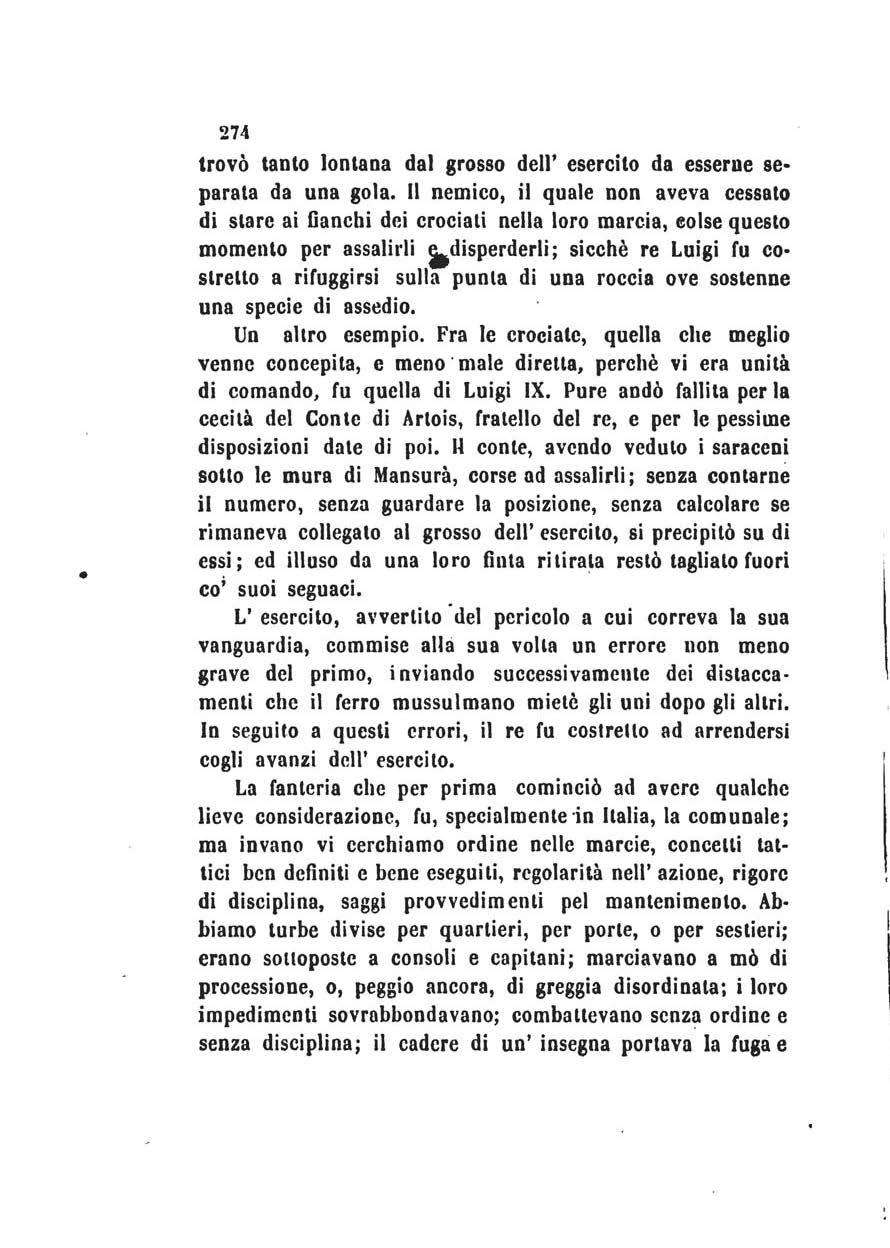
L' esercito, a\'vertito ·del pericolo a cui correva la sua vanguardia, commise alla sua volla un errore non meno grave del primo, inviando successivamente dci distaccamenti che il ferro mussulmano mietè gli uni dopo gli allri. In seguito a questi errori, il re fu costrecto ad arrendersi cogli avanzi dell' esercito.
La fanteria che per prima cominciò ad avere qualche lieve considerazione, fu, specialmente ·in Italia, la com un aie; ma invano vi cerchiamo ordine nelle marcie, concelti tattici ben definiti c bene eseguiti, regolarità nell'azione, rigore di disciplina, saggi provvedimenti pel mantenimento. Ab· biamo turbe divise per quartieri, per porte, o per sestieri; erano souoposte a consoli e capitani; marciavano a mò di processione, o, peggio ancora, di greggia disordinala; i loro impedimenti sovrabbondavano; combattevano ordine e senza disciplina; il cadere di un' insesna portava la fuga e
275
l' cecidio dell' esercito. Ne abbiaMto un esempio nella bat· taglia di Montcaperti combattuta nel secolo Xlii da Firenze guelfa contro la lega ghibellina sostenuta da Siena e protcUn dai tedeschi.
La milizia comunale formava poi, come dicemmo , intorno al carroccio la massa in difesa. L' introduzione del carroccio io guerra fu in quc ' teropi utilissima alla milizia italiana, pcrchè essendo essa composta di fanLi non b ene armati, e male . disciplinati, c dovendo combattere contro squadre di cavalli c cavallicri coperti d'armi e meglio di essa esercitati, aveva me s ti e ri di stringersi per resistere all' urto dci cavalli, di confidare nelle proprie forze, d' investire serrata in un sol punto, .c di muoversi tutti insiomc o ritirandosi lentamente.
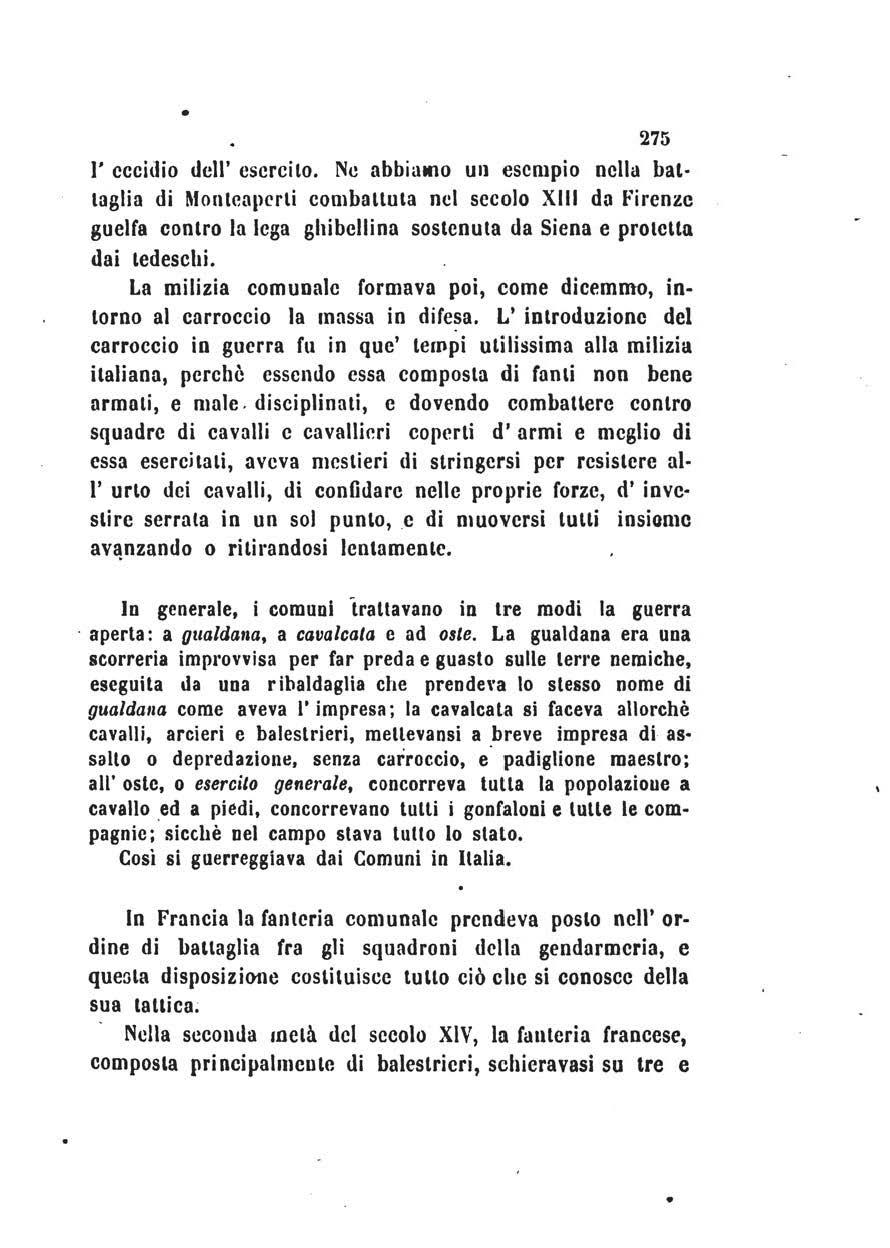
lo generale, i comuni -trattavano in tre modi la guerra · aperta: a oualdana, a cavalcata c ad oste. La gua ldana era una scorreria improvv isa per far preda e guasto sulle ter1·e nemiche, eseguita da una r ibaldaglia che prendeva lo stesso nome di gualdaua come aveva l' impresA; la cavalcata si faceva allorchè cavalli, arcieri e balestrieri, mellevansi a _breve impresa di as· salto o depredazione, senza carroccio, e padiglione maestro ; all' oste, o esercito generale , concorreva tutta la popolazioue a cavallo .ed a piedi, concorrevano lutti i gonfaloni e tulle le compagnie; sicchè oel campo stava lutto lo stato.
Cosi si guerreggiava dai Comuni in Italia.
In Francia la fanteria comunale prendeva posto nell' ordine di battaglia fra squadroni della gendarmeria , e que nla disposizione costituisce tutto ciò che si conosce della sua tauica .
Nella seconda metà del secolo XIV, la fanteria francese, composta pri ncipahncutc ùi balestrieri, schicravasi su tre e
276 quattro righe. Nell' onlinl di battaglia si poneva in prima )inca, dinanzi o sui lati della prima bauaglia, os!!ia linea . di gendarmi; formava la trsta negli attacchi. Ne è esempio la battaglia di Crecy .
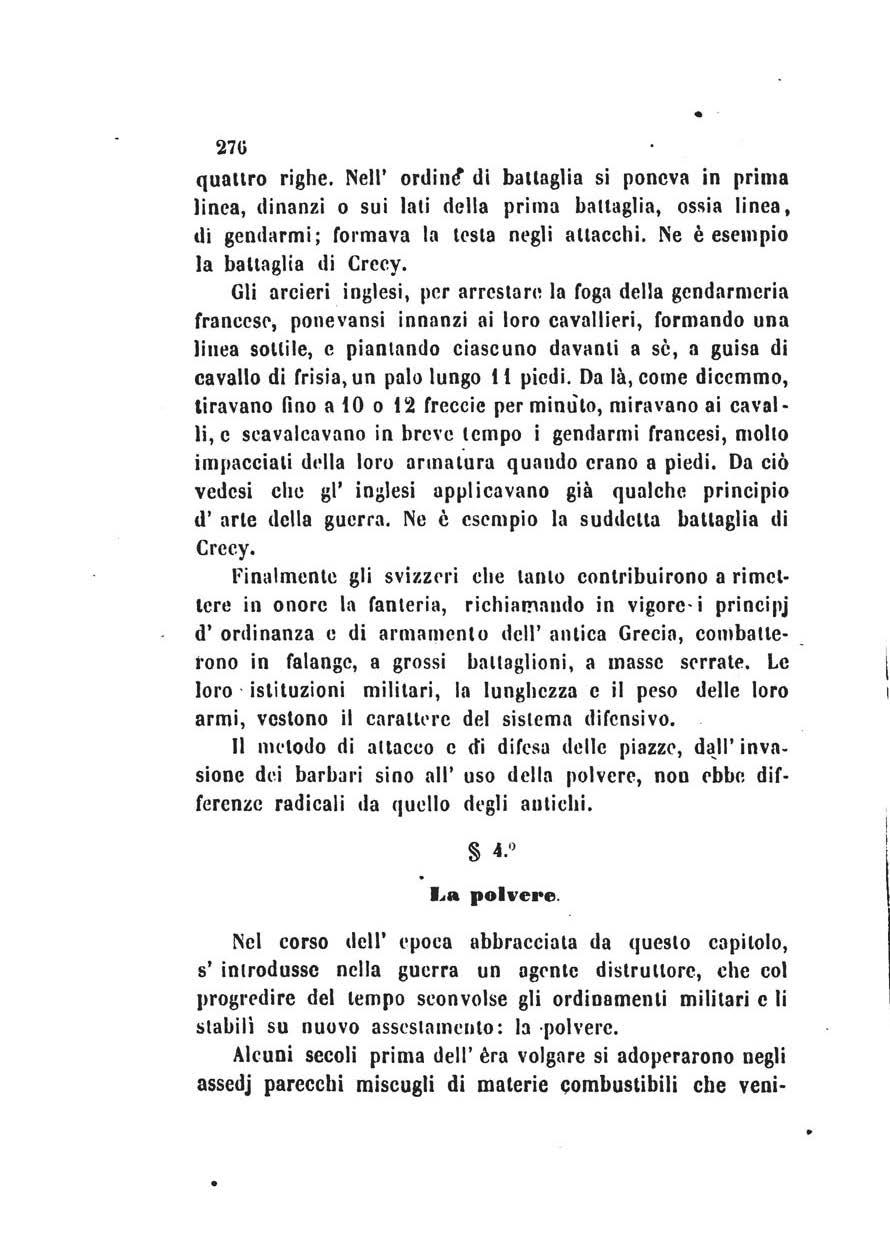
Gli arcieri inglesi, pe r arrestar«! la foga della gendarmeria franccsr, ponevansi innanzi ai loro cavnllieri, formando una linea sottile, c piantando ciascuno davanti a sè, a guisa di cavallo di frisia, un palo lungo t t piedi. Da là, come dicemmo, tiravano fino a t O o t 2 freccie per minùto, miravano ai cavai· li, c scavalcavano in breve tempo i gendarmi francesi, molto impacciaLi ddla loro armnlura quando erano a piedi. Da ciò vedcsi che gl' inglesi applicavano già qualche principio d' arte della guerra. Ne è esempio la suddcLta baUaglia di Crccy.
Finalmente gli svizzrri che turno contribuirono a rimct· tcre in onore la fanteria, richiamando in vigore · i principj d' onlinanza c di armamento dell' anLica Grecia, combatte· _ t·ono in falange, a grossi battaglioni, a masse srrrate. Le loro · istituzioni militari, la lunghezza c il peso delle loro armi, vestono il caralll'I'C del sistema dife nsivo.
Il nn·toùo di attacco c di dife sa delle piazze, dl!ll' in va. siooe dd barbat·i sino all' uso della polvere, noo <'bbr. dif· fcrenzc radicali tla quello dt•gli antichi. l.a polvere.
Nel corso dell' epoca abbracciata da questo s' introdusse nella guerra un og<'ntc distruttore, che col progredire del tempo sconvolse gli ordinamenti militari c li staiJilì su nuovo asscst:uncuto: 1::1 ·poh·erc.
Alcuni secoli prima dell' èra volgore si adoperarono negli assedj parecchi miscugli di materie çombustibili cbe veoi·
277 vano lanciati dagli assedianti o dagli assediati: oli i bollenti, pece fusa, misto di pece, di zolfo , di stoppa, di nrtmna, d' incenso , e di raschiature di legni gommosi, venivano gettati contro gli oggetti che si volevano Dugento anni prima di Cristo, i chincsi avevano parecchi composti incendiarj da essi nominati Fuoco del cielo, dell'J tel'ra, Fuoco ditJomnte, Canna da fuoco. !\la se conoscevano alcuni effeui della polvet·e, specialmente ·per le deflagrazioni, non ne perfezionarono però l' uso e non sep· pero valersene come forza projeuantc od oggetto di offeso.
Nel VII secolo, i greci del Basso impero adoperavano il Fuoco greco la cui invcnz!one è da essi aUribuita a Calli· nico architetto di Elipoli. Vuolsi però che fosse di dota immensamente più antica; che si conoscesse da popoli asiatici i quali ndopravano la nafta come principale ingre· dieote di esso; che fosse noto ai romani, i quali però non ne fecero uso se non che nella decadenza dell' impero, come si legge nelle Istituzioni militari di Vcgczio, il quale lo chiamò l)lio incendiario, c lo cred eva composto di bitume, zolfo c pece liquida; che quindi i greci lo avessero dai ro· mani dopo il trasporto della sede imperiaie a Costantinopoli, c che In denominazione di Fuoco greco sia erronea. Ad ogni m odo, il fuoco greco era una combinazione falla con tale artifizio, che, scorrendo liquida, si poteva con trombe e si fon i mandare all' insù e all' ingiù, c che in luogo di estinguersi nell' acqua vi acquistava maggior forza.
Nelle Memorie sulla China leggesi che nell' anno 969 di G. C., c 2. 0 del regno di Tn1-Tsou, venne presentata a questo principe una composizione che accencleua le freccie c le portava assai lungi. Ciò sembrerebbe indicare la del primo uso de'i razzi. Non pertanto, la conoscenza del
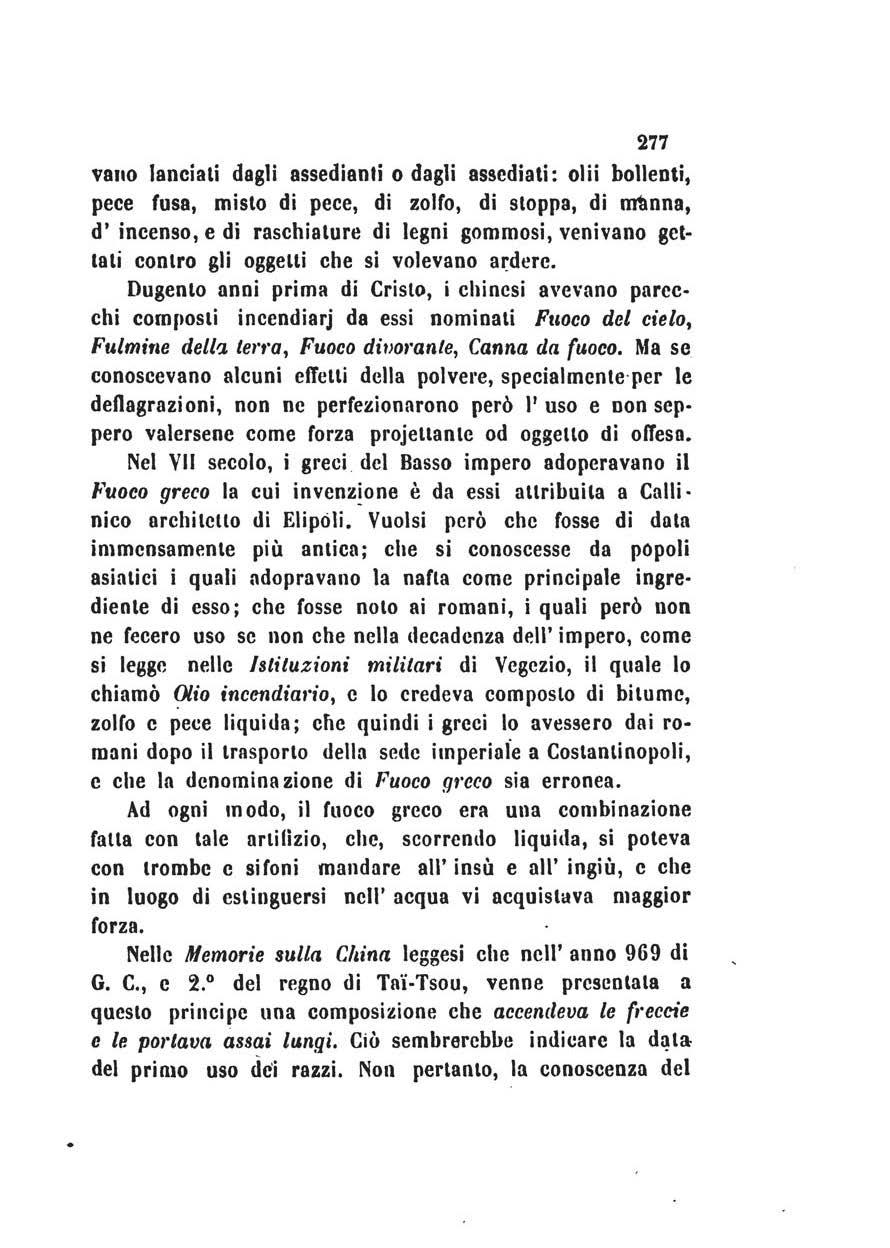
solnitro rimontava in China ad un' epoca anteriore; ma si scuopriva sollanto, nell' epoca citata, che riducendolo in polvere, per col carbone e collo zolfo, il miscuglio acquistava proprietà di combustione.
. Nella seconda metà del med esi mo secolo X, un autore arabo fa menzione di un libro sul fuoco, sulla nafta , e l' uso elle se ne fa in guerra; libro che non è giunto si no n noi.
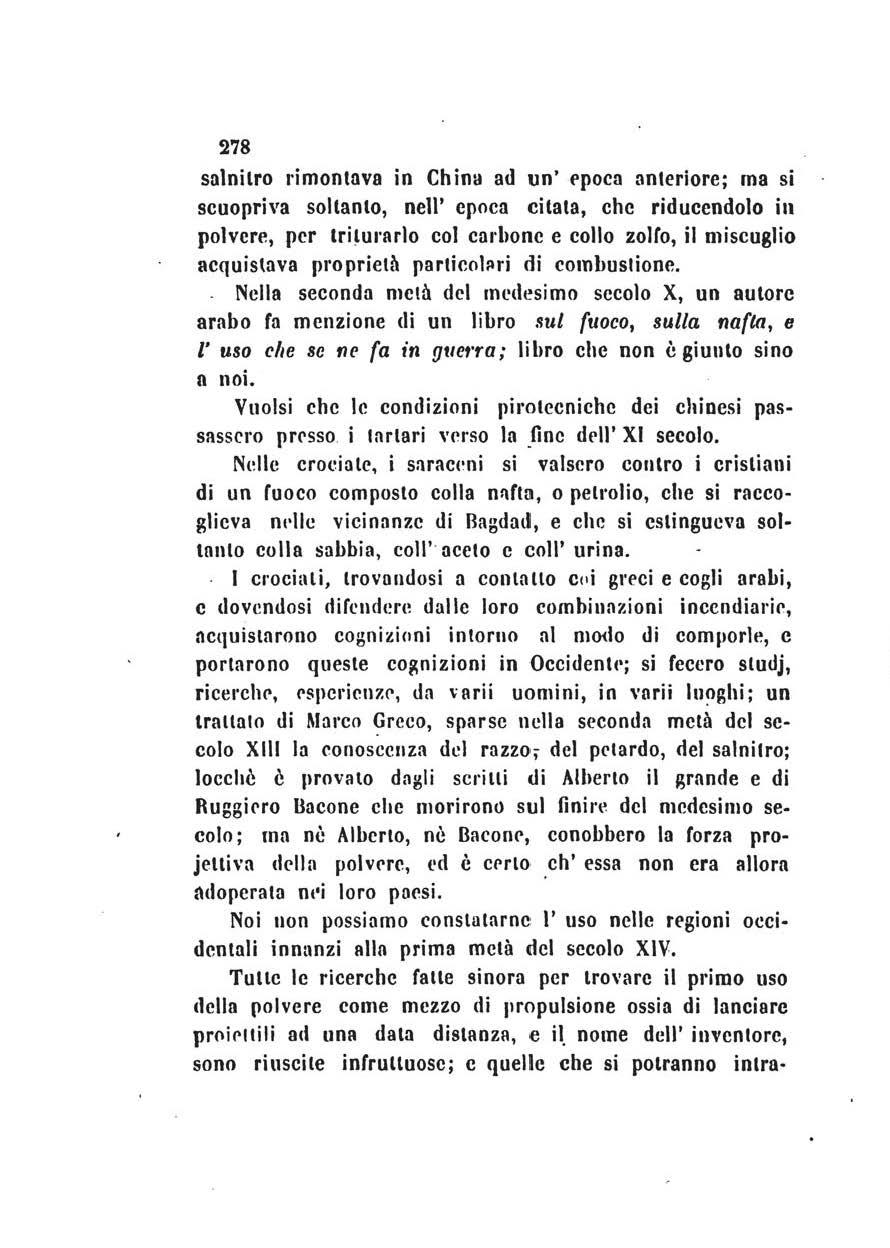
Vuolsi che le condizioni pit·otccnichc dci chiocsi passassero prrsso. i tartari ver so la fine drll' Xl secolo.
Nelle croeiatc, i saraceni si valsero contro i cristiani di un fuoco composto colla Mfta, o petrolio, che si raccoglieva nt•llc vicinanze di Ragd:ul, e che si estinguevo soltanto colla sabbia, colJ ' ·aceto c coll' urina.
. l crociali, trovandosi a contatto c toi g•·eci e cogli arabi, c dovt!ndosi difendt!re dalle loro combinazioni inccndia•·ir, acquistarono cognizioni intorno nl modo di comporle, c portarono queste in Occidentt•; si fecero studj, riccrchr, rspcl'icnzr, da vari i uomini, in \'Ori i un trallalo di Ma1·co spnrsc nella seconda metà del secolo Xlii la conoscenza del razzo; del petardo, del salnilro; locchè è provato dngli scritti ùi Alberto il grande e di Ruggirro Bacone che morirono sul fani1·e del medesimo secolo; mn nè Alberto, nè 0Rconr, conobbero la forza projellivn delln polvrrc, t•d è crrlo· ch' essa non era allora rtdopcrata nt•i loro pocsi.
Noi uon possiamo constatarne l ' uso nelle rt>gioni occidentali innanzi allo prima metà del secolo XIV..
Tutte le ricerche fatte sinora per trovare il primo uso della fiOivere come mezzo di propulsione ossia di lanciare proirltili ad una data distanza, e il. nome dell' inventore, sono riuscite infruttuose; c quelle che si potranno intra·
279 prendere non saranno probabilmente più felici . perchè si è giunti a questa scoJlerta in modo lento c graduale.
Tuttavia non dobbiamo taccere che in generale se ne dà merito a Bertoldo Schwartz, monaco agostiniano, nato a Gosslcr nel i 530 e vissuto a Fl'iburgo. Egli avrebbe scoperta le proprietà projettante della polvere preparando un miscuglio incendiario. Ma secondo l' opinione di taluno, egli non avrebbe fallo se non che ridurre a maggior finezza la polvere da guerra già conosci!Jla prima di lui. lnfoni, parecchi documenti allcsterebbero che le armi da fuoco fossero io uso sino dal secolo Xlii.
Nel 13 35 poi, sono menzionate da Giorgio Stella, autore di storie genovesi.
Un documento autentico fiorentino del f 325, parla di palle di ferro e di cannoni di mctalle.
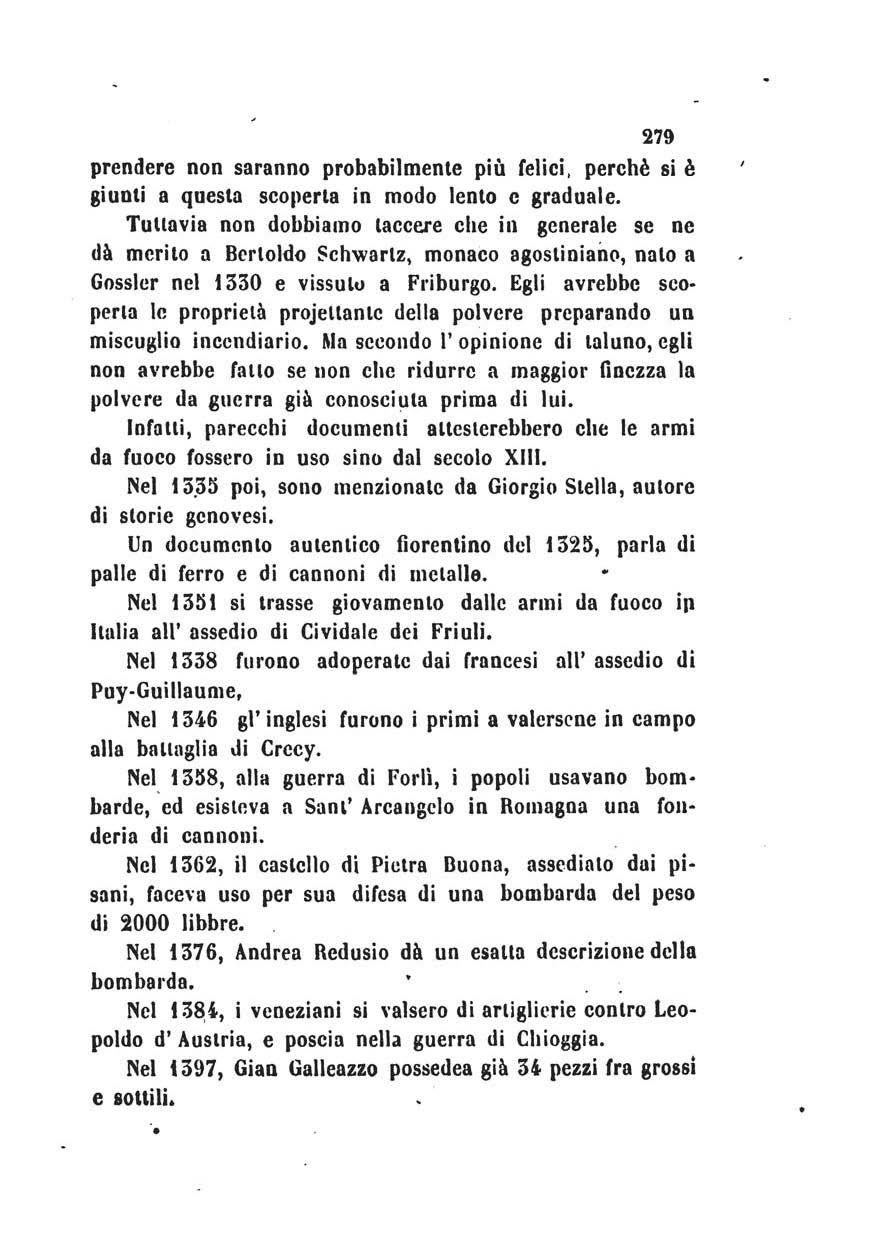
Nel t3:St si trasse giovamento dalle armi da fuoco ip Italia all' assedio di Cividale dci Friuli.
Nel t 338 furono adoperate dai francesi all ' assedio di Puy-Guillaume, Nel f 546 gl'inglesi furono i primi a valcrscne in campo alla bnllnglia Ji Crccy.
Nel _ f 3:S8, alla guerra di Forlì, i popoli usavano bombarde, ed esisteva n Sant' Arcangelo in Romagna una fon· deria di cannoni. .
Nel t 562, il castello di Pietra Buona, assediato dai pisani, faceva uso per sua difesa di una bombarda del peso di 2000 libbre.
Nel t 57 6, Andrea Rcdusio dà un esatta descrizione della bomba1·da.
Nel t i veneziani si \'alsero di artiglierie contro Leopoldo d'Austria, e poscia nella guerra di Chioggia.
Nel t 397 , Gian Galleazzo possedea già 54 pezzi Ira grossi e souili • ..
280
Le bocche da fuoco riccvellero adunque ben presto il nome di Bombarde: contro di •:sse n nuJia valsero le antiche macchine che all' azione del projeuile lanciato cona polvere andavano in · pezzi .
l cannoni adoperati nella prima metà del secolo XIV erano di piccolissi mo calibro; il projeltile pesava probabilmente meno di tre libbre; ma nella secondo metà di quel secolo aumentarono ossai per numero e per grossezia; alcuni ernno di ferro, altri d i uno lega di rame e stagno; i piccoli lancia v ano palle di piombo, i grossi gettavano polle di ferro o d i i> ietra.
Riguardo alle armi portatili, troviamo che iL marchese Rinaldo d' Este, signore di Ferraro, faceva preparare contro Argenta nel 1554 gt·ande quantitii di scMoppetti e di spin· garde.
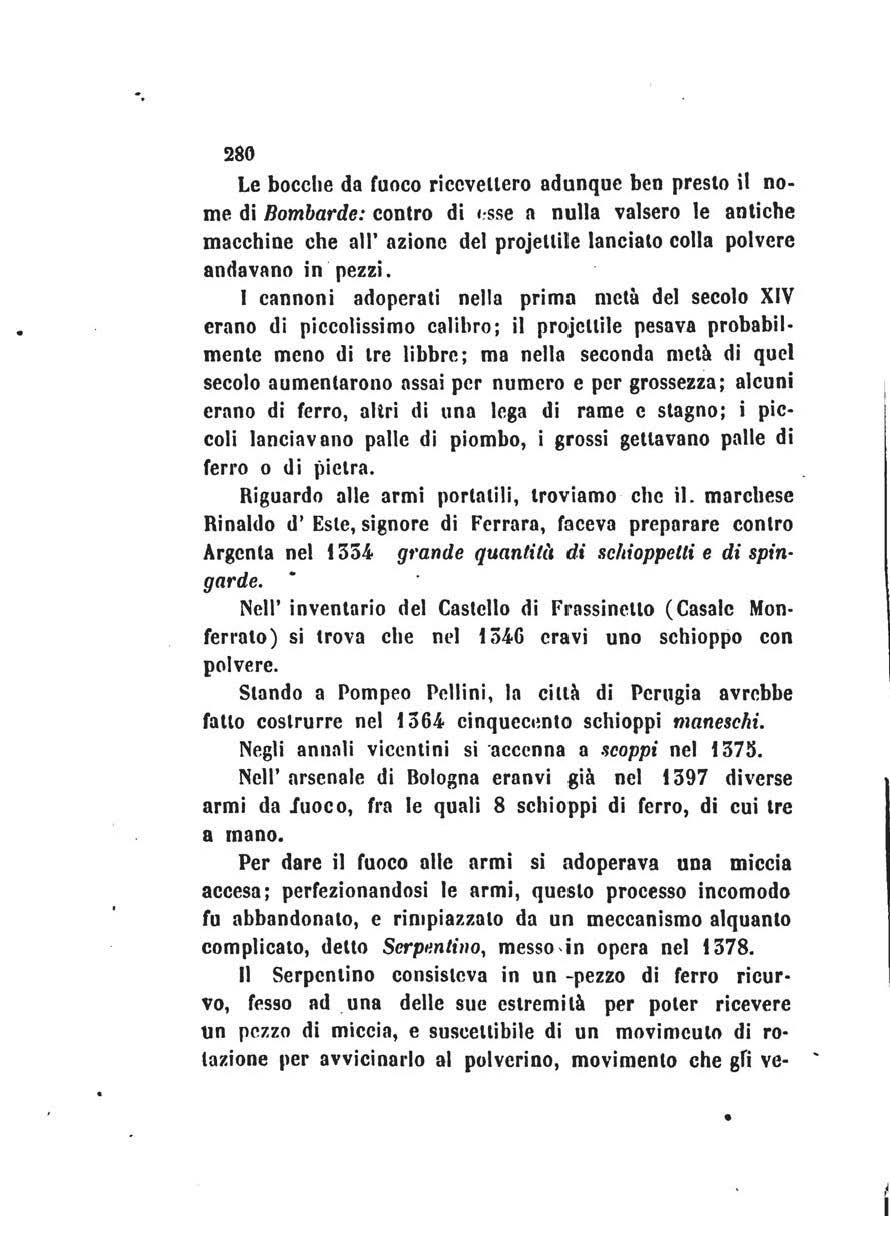
Nell' inventario del Castello di Frass i nello (Casale Monferrato) si trova che nel f 346 era vi uno schioppo con polvere.
Stando a Pompeo Pcllini, In città di Perugia avrebbe fatto costrurre nel f 564 cinquec.mto schioppi maneschi.
Negli an nn li viccntini si ·accenna a .<Jcoppi nel f Nell' nrsenale di Bologna eranvi .già nel 1597 diverse armi da Juoco, fra le quali 8 schio·ppi di ferro, di cui tre a mano.
Per dare il fuoco alle nrmi si adoperava una m1cc1a accesa; perfezionandosi le armi, questo processo incomodo fu abbandonato, e rimpiazzato da un meccanismo alquanto complicato, detto messo in opera nel 1578.
Il Serpcntino consisteva in un -pezzo di ferro ricur· vo, fesso ad . una delle sue estremità per poter ricevere un pezzo di miccia, e suscettibile di un movimculo di ro· tazione 11er avvicinarlo al polverioo, mov imento che gfi ve '
281 niva impresso col mezzo di una piccola leva, suJJa quale si agiva col dito. Per e'vitare gli accidenti durante la enrica, la miccia non si accendeva che dopo questa .operazione. Il sol· dato era adunque obbligato ad a\·ere sempre con sè del fuoco, cosa che poteva produrre inconvenienti, e rendeva impossibili le sorprese notturne. Nt•i giorni piovosi ed umidi non si potcvanò evitare i frequrnti scatti a vuoto che dava questo sistema. ·
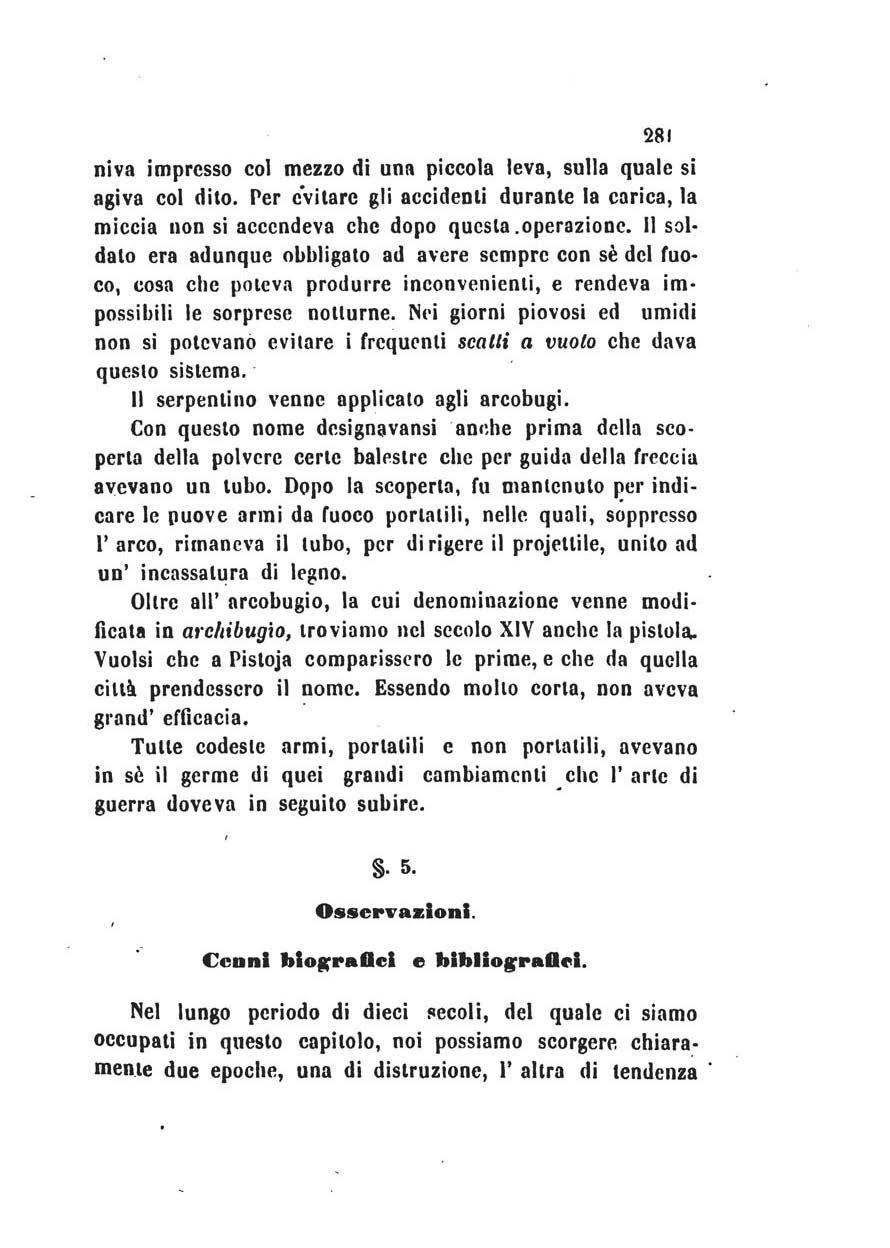
Il serpenti no venne applicato agli arcobugi. Con questo nome designavansi ·anr:he prima della scoperta della polvere certe che per guida della freccia un tubo. Dopo la scoperta, fu mantenuto indicare le puove armi da fuoco portatili, nelle quali, soppresso l' arco, rimaneva il tubo, per dirigere il projettile, unito ad un' di legno.
Oltre all' nrcobugio, la cui denominazione venne modificata in archibugio, troviamo nel secolo XIV anche la pistola..
Vuolsi che a Pistoja le prime, e che da quella città prendessero il nome. Essendo mollo corta, non aveva g..:md' efficacia. ·
Tulle codeste armi, portatili c non portatili, avevano in sè il germe di quei grandi cambiamenti . che l' arte di guerra doveva in seguito subire.
Nel lungo periodo di dieci del quale c1 s1amo occupati in questo capitolo, noi possiamo chiaramen.te due epoche, una di distruzione, l' altro di ·
al rinnovamento. Nella prima, collo scomparire della civ i hà e della sapienza antico, vediamo s.nàturarsi tulle quelle istituzioni mililat·i che avevano ricevuto per sanzione la gloria c le conquiste; nella seconda, colla scossa data al feudalismo, colla consacrazione dei diriUi dell' umanità, s' incominciò a rimettere in forza quegli clementi su cui naturalmente decsi calcolare per ·l a difesa dci diritti medesimi, ben longi però dall' avvicinarsi a quelle idee rette e a quel pcrrczionamento a eu i non si potè giungere se non che dopo altri secoli di lunghe . ed accanite lotte e di sanguinosi sconvolgimenti sociali.
Se noi investighiamo l' andamento dell' arte militare nelle diverse parti che la compongono, durante il corso io cui si compiè l' opern di distruzione e si diè mano a ristaurare gli ordini di società da cui ne uscì poi civiltà novella, ci vico fatto di dar luogo alle ·seguenti osservazioni.
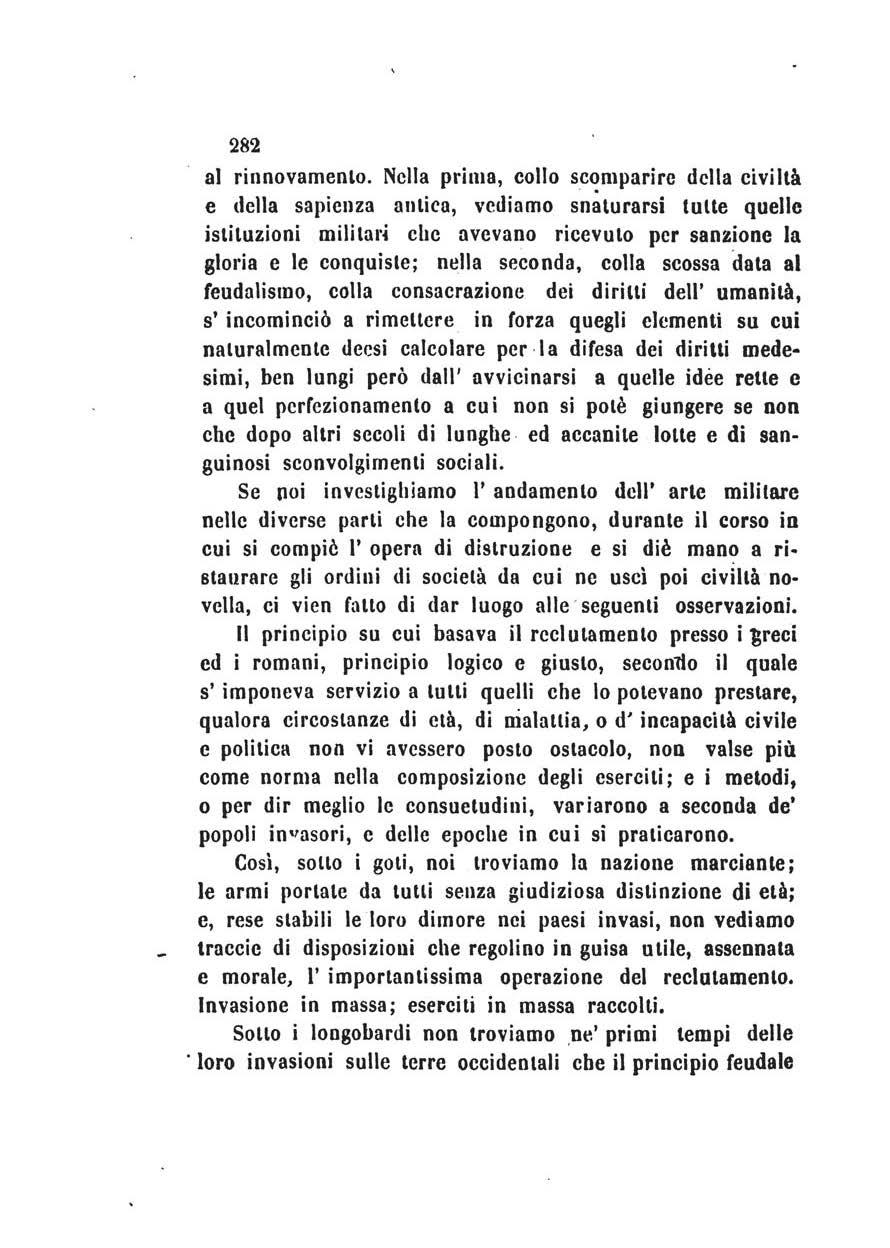
Il principio su cui basava il ree l uta mento presso i t;reci cd i romani, principio logico e giusto, seeonlio il quale s' imponeva servizio a tutti quelli che lo potevano prestare, qualora circostanze di età, di malattia, o d' incapacità civile e politica non vi avessero posto ostacolo, non valse più come norma nella composizione degli eserciti; e i metodi, o per dir meglio le consuetudini, variarono a seconda de' popoli invasori, c delle epoche in eu i si praticarono.
Così, solto i goti, noi tt·oviamo la nazione marciante; le armi Jlortate da tuui senza giudiziosa distinzione di età; e, rese stabili le loro dimore nei paesi invasi, non vediamo trnccic di disposizioni che regolino io guisa utile, assennata e morale, l' importantissima operazione del reclutamento. Invasione in massa; eserciti in massa raccolti.
Sotto i longobardi non troviamo primi tempi delle ·loro invasioni sulle terre occidentali che il principio feudale
285 reggesse il sistema di porre assieme gli eserciti; anch' essi, u mo' de' goti, erano tutti soldati; il servire in gucl'ra era comune a tulli, senza distinzione di tempo c disciplina; di eccezioni prr ssocc hè oiuua ; soltanto la divisione in gente libera c serva escludeva questa dnl servire o far parte in· trinsccn della milizia.
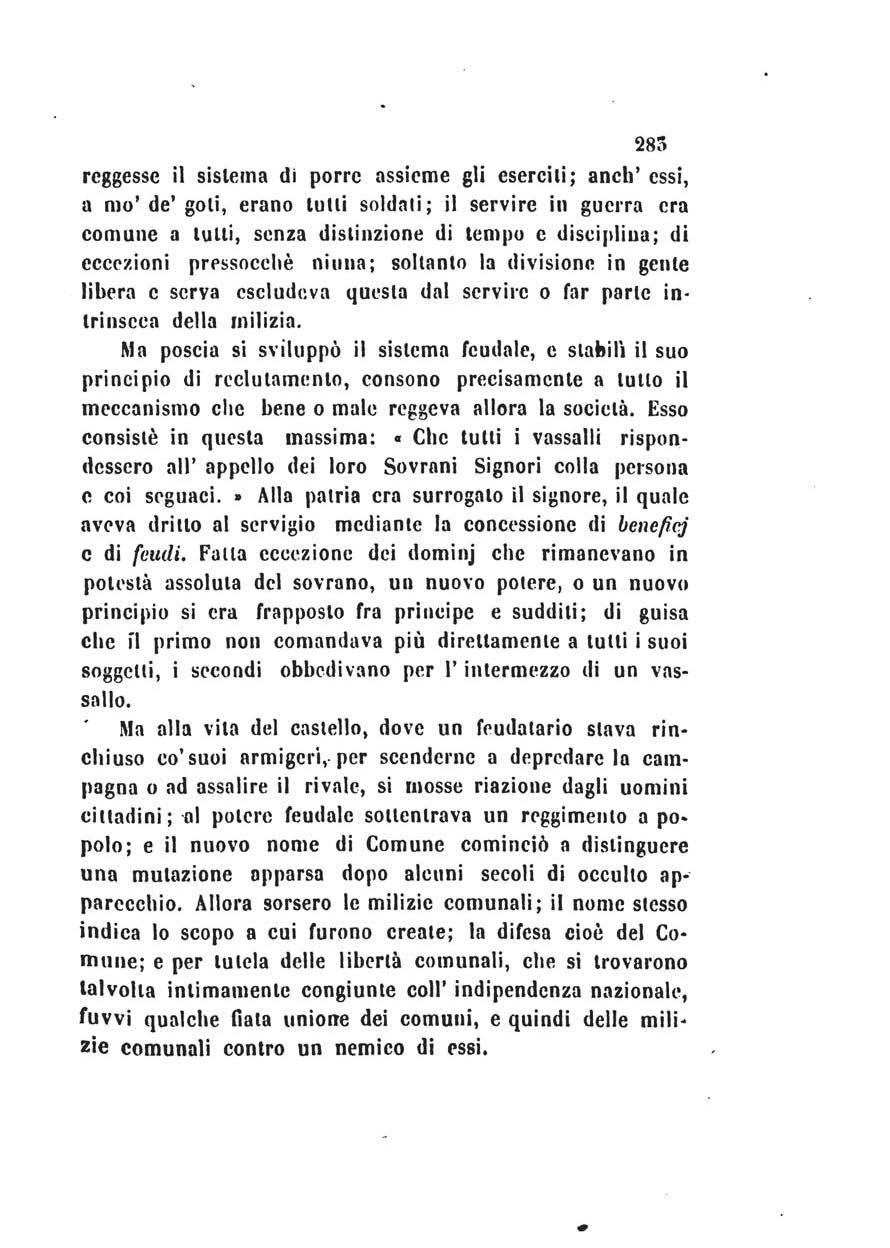
Ma poscia si sviluppò il sistema feudale, c stahilì il suo principio di reclutamento, consono precisamente a tullo il meccani sm o che bene o male reggeva allora la società. Esso consistè in que sta massima: • Che tutti i vassalli rispondessero all' appello dei loro Sovrani Signori colla persona c coi srguaci. • Alla patria era surrogato il signore, il quale nv<'va drillo al servigio mediante la conct.•ssionc di beneficj c di feudi. Falla dci dominj che rimanevano in potl•stà assoluta del sovrano, un nuo,·o potere, o un nuovo principio si era frapposto fra principe e sudditi; di guisa che il primo non comandava più direttamente a tutti i suoi soggetti, i secondi obbcdivano per l'intermezzo di un vassallo.
Ma alla vita del castello, dove un feudatario stava riochi uso co' suoi armigeri,. per seendemc a depredare lo ca m· pagna o ad assalire il rivale, si mosse riazione dagli uomini cittadini; ·ol potere fe udale sottcntrava un rrggimento a po· polo; e il nuovo nome di Comune cominciò a distinguere una mutazione opparsa dopo alcuni secoli di occulto ap• parecchio. Allora sorsero le milizie comunali; il nome stesso indica lo scopo a cui furono create; la difesa cioè del Co· rnnne; e per tutela delle libertà comunali, che si trovarono talvoha intimamente congiunte coll' indipendenza n3zionale, fuvvi qualche fiata unione dei comuni, e quindi delle mili· zie comunali contro un nemico di t>ssi.
2R4
Vidr.si allora, ma fu rnro, fu anzi unico, il CAso, in cui la lega dc' comuni italiani fu tanto forte da rrsistere ad un polcnrc nemico, nl Bnrbarosso, c lo sconfiggeva a Legnano.
Ma più di sovente le milizie comunali, d'Italia, ebbero lollc coi 1oro \' icini, o con signorotti che ne volevano di.rtruggerc le libertà. Laonde non dovcnllo sostenere guerre lunghe nè lontane, il reclutamento delle milizie si faceva intlistintamantc su tutti che au i fossero alle armi, posando sul principio: • Tulli in ma ssa a difesa delta patria, od n sostegno dc' suo i dirilli più o meno giusti. •
Le rrgole del reclutamento non ne scaturirono eonvenienti; il prrsonalc di guerra non andava soggetto a utile • scelta; gli uomini di età avnnzrita, fino a 70 onrii, ingombrnvnno le schir.r•', e non potevano servire che a dannoso occl'cscimrnto di numero; per In qual cosa siamo beo lungi dallo seorgrrc in quc' tempi l' applicazione delle massime fondnmr.nlnli pc•· un savio reclutamento di mi.lizie.
Ma proprio tlrlla milizia dri comuni era •li essere più idonea alla difrsa che all' ofTt•sa. E, per vero dire, quel· l' opcrajo o nc>gozinntc che srnza grave perdita di tempo saliva allrgramr.ntc sugli spnlti di una patria carissima, e con molto valore li difendevo dogli assalti degl' imperatori di Germania, a malincuore si svellcva da' suoi traffichi _ e . dalle sue industrie per guerreggiare in lontana spedizione. Si cercarono rimcdj collo stabilire un soldo per le milizie impiegate nelle lunghe fazioni; coll ' accordare privilegi a coloro che militavano; cui non prende re più tutto il po· polo , ma parte scelta pca· censo, pc•· età, e per qualità fì. sich<', a faa· pnrle dell' esercito. Ma tutto invano. La mi· tizia comunale era sr.aduta c più non si rilevava.
l.a quantità di esuli per le lollc intestine d' llalia, ed il ritoruo dc' crociati in Europa, influirono, come dicemmo,
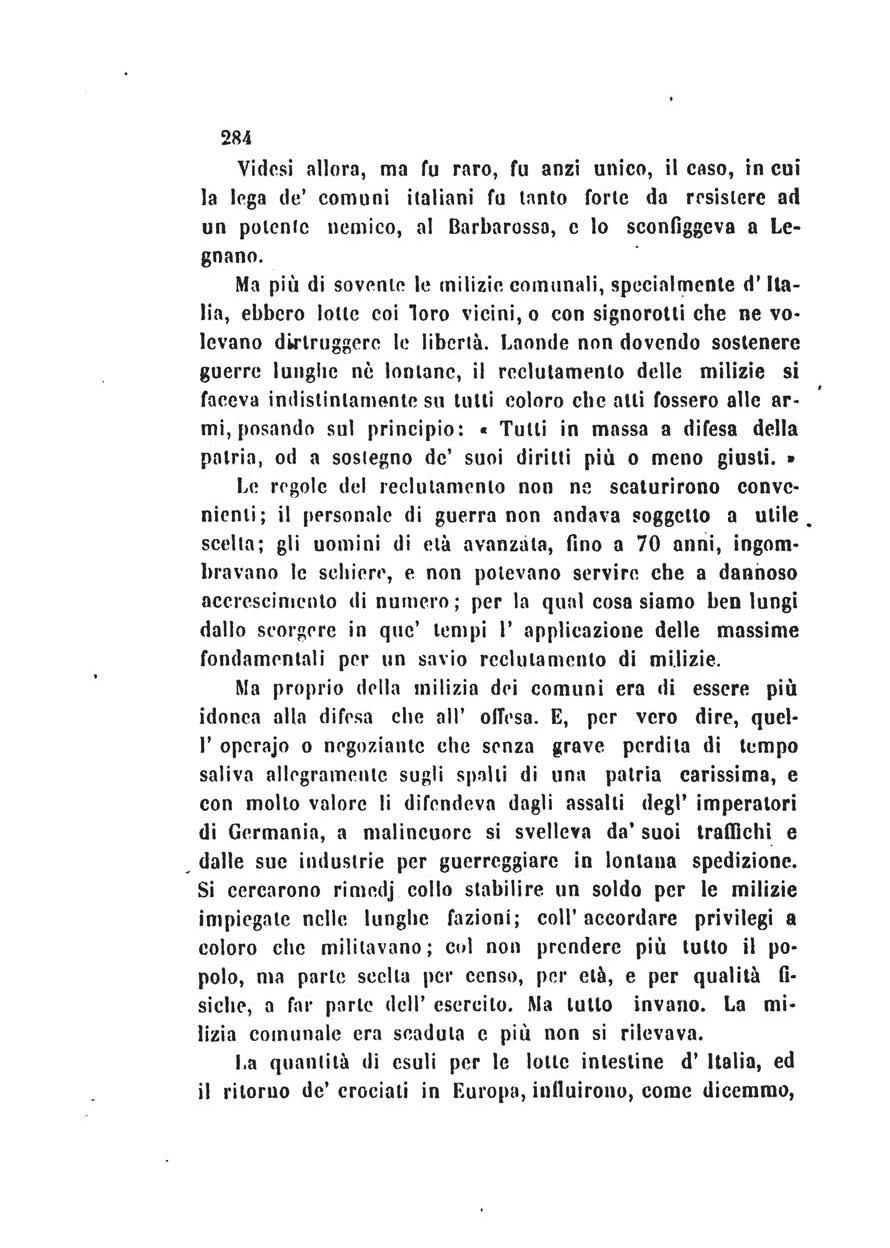
21-iiJ ·alla formazione di bande che servirono per mercede, c costituirono poscia le compagnie di ventura.
Allora il principio mutò, e si ridusse al seguente: " Il servizio delle armi è prestato al miglior compratore. • Lo stato militare divenne esci usivamcnte un mestiere.
Se portiamo le nostre considerazioni su nllrc parli del· l' ordinamento militare, c ci fermiamo alle unità tnuichr., noi vediamo che la formazione di esse, n cui tanta importanza annettevano gli ant ichi greci e romani, n cui t:mla e ragionevolmente se ne attribuisce nei tempi moderni, non era opera di cui nel medio evo si pigliasse cura alcuna.
Prescindendo dai hnrbari, i quali conset·vavano un' imitazione del sistema militare romano del basso impero, vediamo che nessun' idea di unità tauica regnava ne lla composizione degli eserciti feudali ; e le bandiere, c i corpi, formaronsi a seconda delle 'rorze di cui disponeva ch i li guidava al campo. D' altronde l' unità tattica ha per uno cJe' suoi scopi principali il combauimento d' insieme; loc· cbè non a v venendo negli scontri dc' cavalli eri che avevano inaugurato il combattimento individuale, ne ,·eniva di conseguenza che l' unità taUica non aveva ragione di esistere io quegli eserciti, e non esisteva.
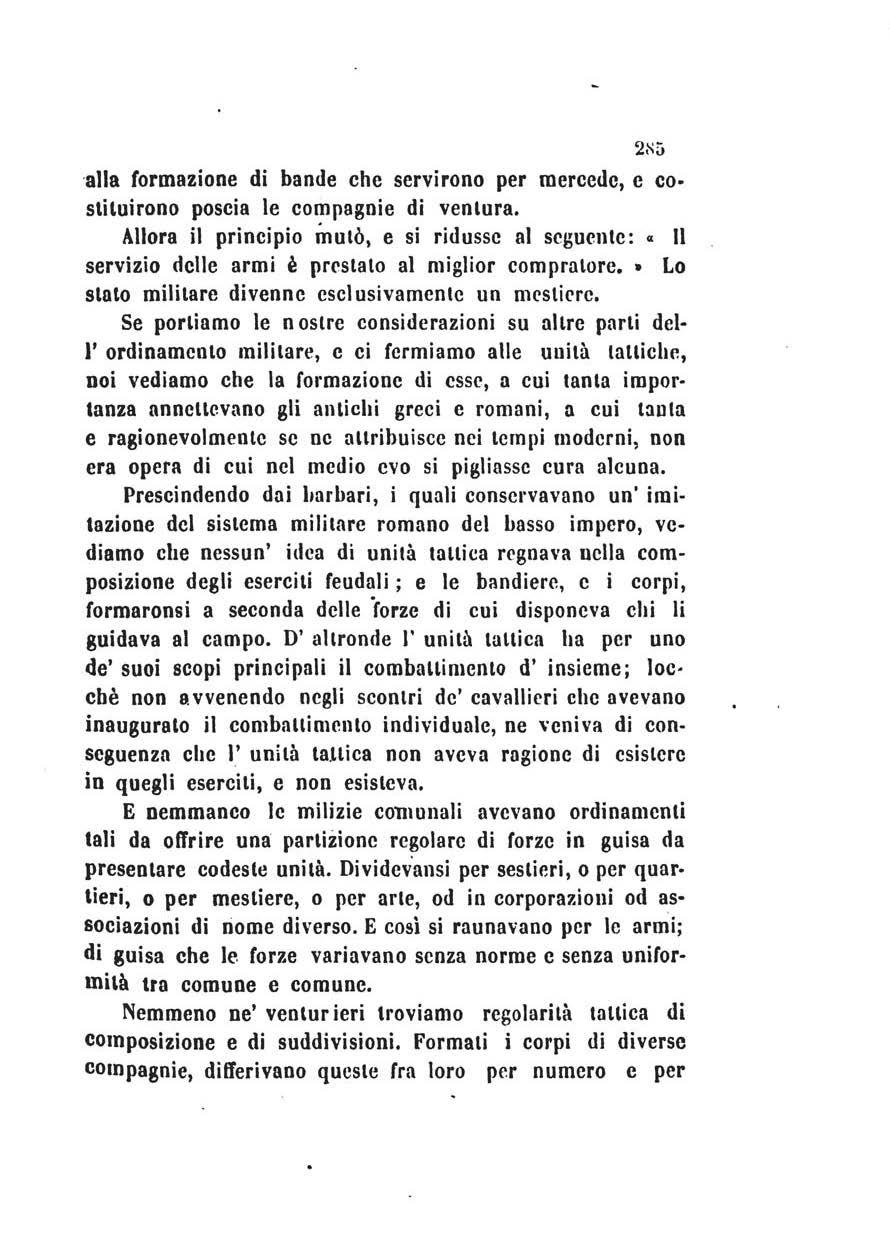
E oemmanco le milizie con10nali avevano ordinamenti tali da offrire una partiiionc regolare di forze in gu isa da presentare codeste unità. Dividcv'ansi per seslieri, o per quartieri, o per mestiere, o per arte, od in corporazioni od as· sociazioni di riome diverso. E così si raunavano per le armi; di guisa che le forze variavano senza norme c senza uniformilà tra comune e comune.
Nemmeno ne' veotur ieri troviamo regolarità tauica di composizione e di suddivisioni. Formati i corpi di diverse compagnie, differivano queste fra loro per numero c per
28G comando; ed erano beu lungi dal prcscntaJ'c quella omogenei Là fm esse che costi Luiscc un elemento necessario pc1· l' auuazionc di grandi movimenti c di vasti conct!Ui ta nici.
Il ri sorgimento della fanteria cominciò a far sentire il bisogno di codesta regolarità; ma dovè scorrcJ'C ben lungo tempo prima che le idee sane su tale argomento avcsséro impero .
Da tutto quanto abbiamo esposto in questo capitolo, si desume chiaramente che non mni il carauc r c delle milizie si svela più consentanea allo sp irito dci tempi; non mai si mostra con tanta evidenza quale espressione vi vissi ma dello stato della sQc ictà , le cci fasi, le cui vicissitudini, porta pro· fondamentc scoJpitc in sè.
L' arte· militare seguì la decadenza rapida ed universale di tutte le scienze e di tuue lè istituzioni che costituivano la civiltà del mondo nn ti co; c pel' conseguenza non potevano sorgere nè le grandi combinazioni di guerra, nè i g1·andi capitani, per mancanza di tutti i mezzi ausiliarj che sono condizioni indispcnsa bili del suo sviluppo c del suo perfezionamento. Una so la rra le arti ha raggiunto nel mcdio evo un grado di perfezione: l' architeuura. Ma anche dcssa veste il carallerc dei tempi. Ispirata dallo zelo ardente per la religione, fu vòlta ad edilìcarc templi e a decorarli con tutta la profusione attinta alla fervida immaginazione dci popoli.
l co nati pel risorgimento di nuova civiltà esercitarono qualche inllusso anche sull'arte militare e ne fanno prova i primi passi alla riabilitazione della fant eria; ma era ser 4 bato a secoli posteriori l'imprimere all' arte stessa quel carattrrc che lo svolgimento de' principj sociali e l' iotro· duziooe de' nuovi mezzi distruuori dovevano necessariamente apportarvi.
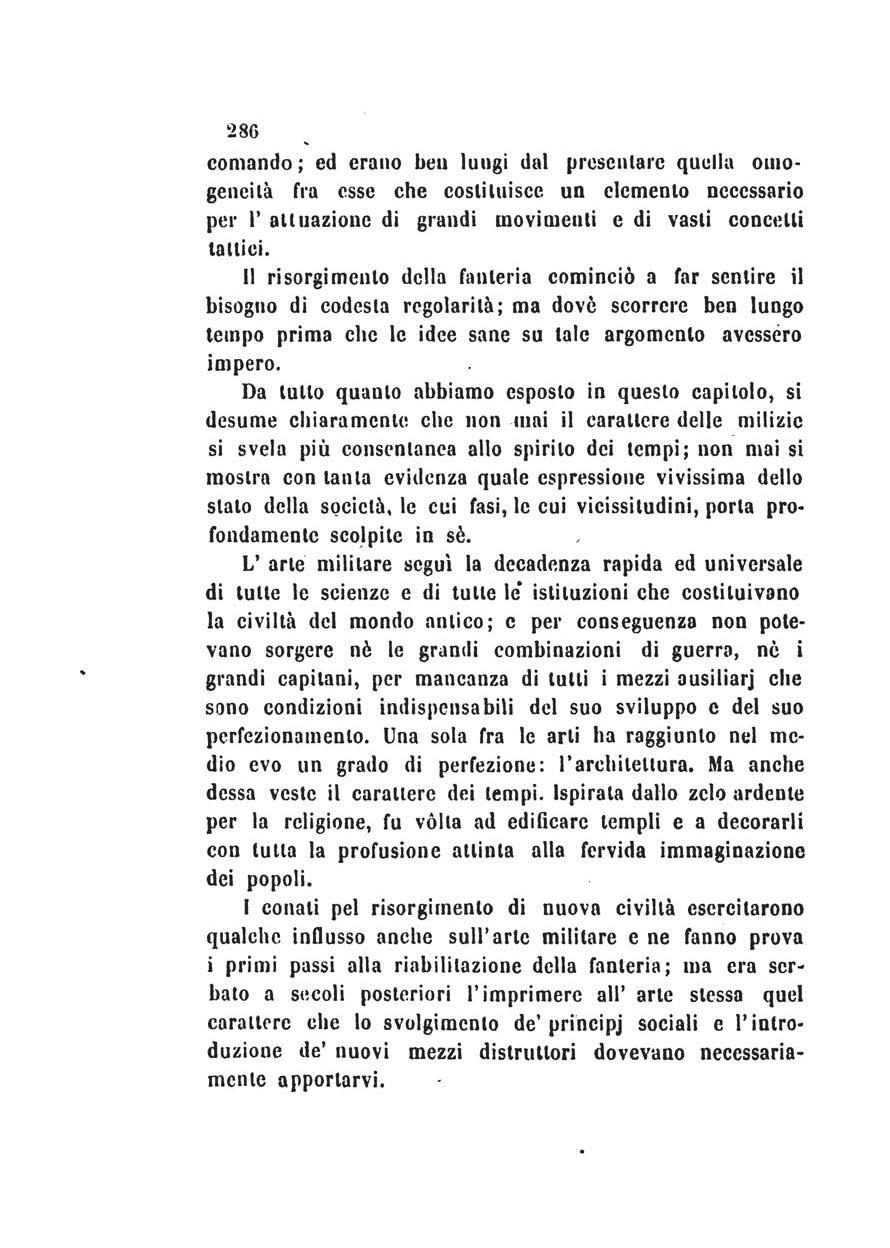
C)t,.l,, , Dicemmo che questa serie di secoli non fu illustrata ·da sommi capitani. Ed infatti, bramando noi di tracciare qualche cenno biografico pP.r seguire il metodo che ci siamo proposti nella compilazione di questa Storia, non· troviamo grande imbarazzo nella scelta; c non esitiamo a fermarci su Carlomagno come quel solo che riempì maggiormente il mondo di sua fama per la delle sue imprese.
CARLOMAGNO. - Nacque nel 742, e succedelle nel 748 a suo padre Pipioo il Breve stipite della seconda dinastia dci re di Francia. Pipino aveva diviso il regno fra suoi due figli Carlomanoo e Carlo; ma, morto il primogenito, Carlo assunse la sovranilà su tullo l'impero, · escludendone i uipoti che si rifugia rono presso Desidt:rio re de'longobardi.
Continuò vili oriosamente la guerra, dal padre, contro gli aquitani.
Poi si volse io Italia, battè Desiderio, e distrusse il regno de' longobardi .
Indi intraprese le lunghe guf'rre contro i sassoni. Causa ap parente e prossima di esse fu pretesto di religione: si volevano battezzare i sassoni, gentt lib era e fiera, affezionata alle vecchie sue credenze. Causa vera la invasione di essi sul territorio soggetto ai franchi. Da un lato si arsero chiese, dall'altro . si atterrarono idoli. In parte, e per poco , domati, i sasson·i furono battezzati a migliaja; ma . ad ogni allontanamento di Carlo, si sollevavano, e facevano guasto di altari , e strage dei conquistatori rimasti.
Io questo frattempo, le armi di Carlo toccarono, a qnanto narrasi, una grande sconfitta nelle gole de' Pirenei, a Routisvalle, combattendo contro i mori. Allora Vilikindo, uno de' capi sassoni più valorosi e creduli, insorge ' con gran seguito di gente non tollerante altra dominazione ed altro r•:. :o; chiese e monasteri vanno in fiamme; la Turingia e l'Assia sono devastate. Vitikindo splogesi fino al Reno, e illumina Colonia cogl' iocendj di Deutz sulla riva opposta, che manda a sterminio Ono allo sbocco della Mosella. Già la vecchia Franconia è invasa; già sta per essere disvelta dalla Germania ogni potenza dei !rauchi.
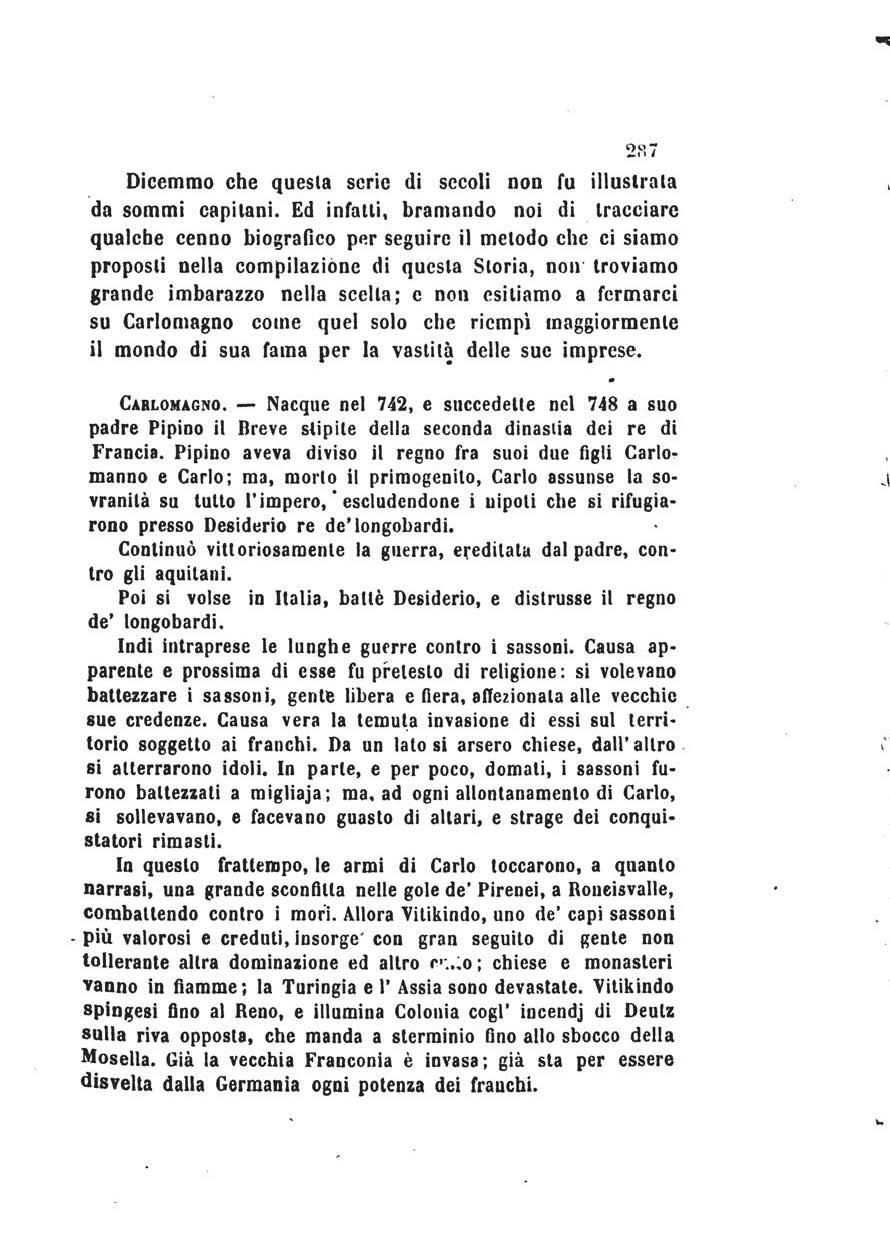
288
lla · i franchi orientali, obbede.1do agli ordini regj, arrestano qucl_la furia, respingono gl' invasori, menlJ·e Carlo, alla Lesta de' suoi paladini, entra in campagna. Vitikindo si ritira, si ricovera fra i danesi; il paese è conquistato; s' impogono battesimi e· giuramenti; si trasportano l 0,000 famiglie su terre deserte del Belgio e dell' Elve1ia. Non più assemblee politiche, non più giudici proprj; i sassooi ·rimasti dovettero obbedire a conti franchi; e per più anni la legge di guerra puniva capitalmente anche kl violazione de' precetti ecclesiastici.
Altre volle inao.rsero i sassoni. Vilikindo alla testa; vennero fiaccali e immersi nel sangue. Vilikindo, e Albione suo fratello, alicoltarono infine le parole di Carlo, e, passati in :fo'rancia, si sottomisero al ballesimo
Piegaronsi allora i sasso ni, ma risollevaronsi di poi; una vicen{)a d' in surre1ioni e di sconfitte prolungossi innanzi che Carlo riuscisse a uccidcndoli e tramulandoli; alla perfine si conchiuse pace deOniliu a Seltz, ed i sassoni adottarono il cristianesimo, giurarono fedeltà, e formarono coi franchi una gente sola.
Nulla può giustificare la diffusione col mezzo della spada di ciò che si · reputa principio di civiltà; e· rimarrà indelebilmcnte contaminala la memor ia di Carloma6IIO dalle stragi con eui intese di propagare appunto la civiltà e la religione. 1\la conviene riflettere che tutte l e guerre ·fra popoli parenti, e lo erano sassoni e franchi, sono micidialissime; e che, se per politica, Carlo trovava spediente qual si fosse via per reprimere la nuov a irruzione di barbari idolatri, non abusò alla fine della vittoria. Capi che la munificenza avrebbe operato più del terrore e l' adoperò; i capi, e Vitikindo stesso, guadagnati dalle amorevolezze e dalla generosità di lui, mantennero i giuramenti di fedeltà.
Codeste imprese furono tramezzate Ila molte altre, e da interni sconvolgimenli.
Carlo puoi i turingi di trama ordita; invase da tre parli la Daviera il cui re Tassilone, di lui nemico, fu costretto ad implo· rare mercede ed a sottometersi a vassallaggio ; poi a rinchiudersi in un chiostro; e la Bniera conquistata, divenne più importante in grazia della sua posizione, assicurando ii legame fra
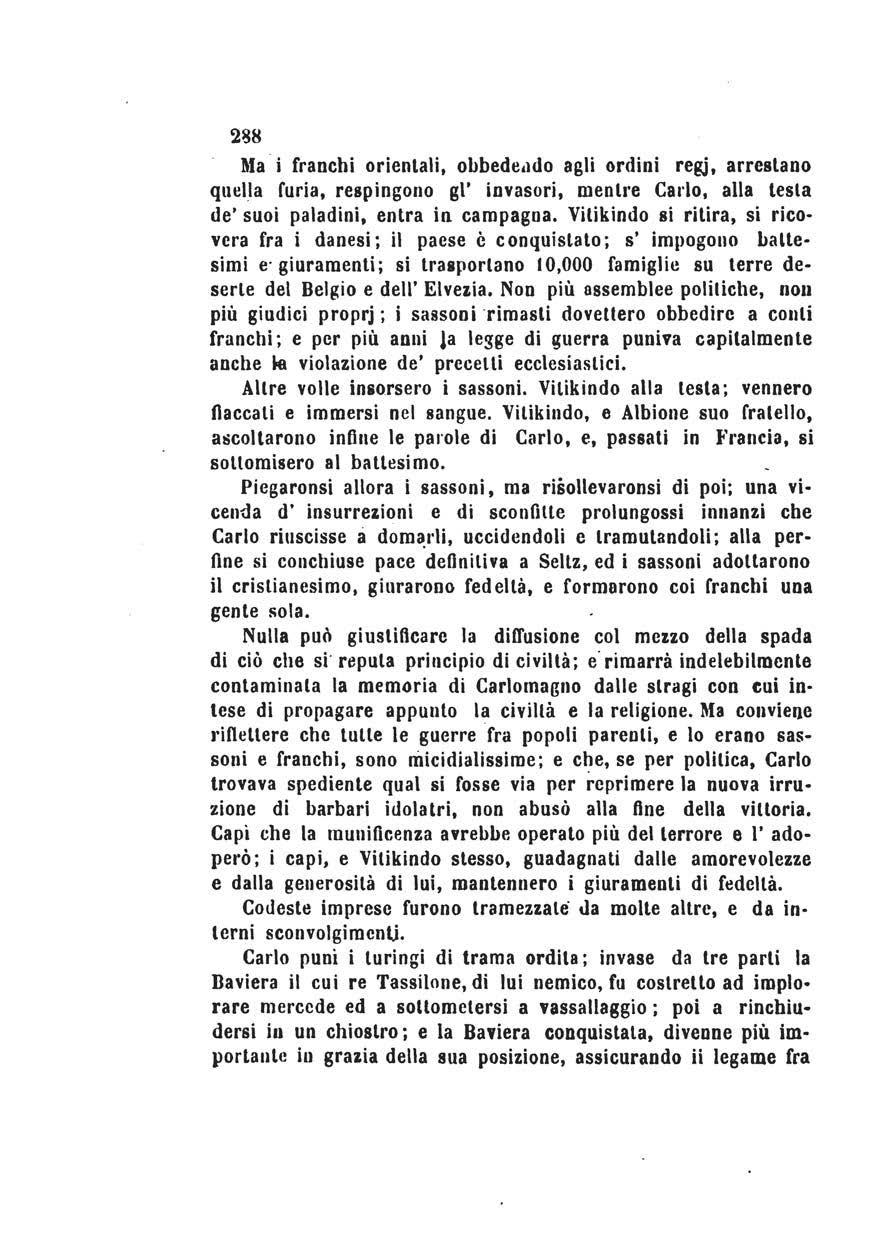
2R!) le provincie settentrionali e le meridionali dei franchi; c sta bi· !endo fra questi paesi germanici e l'Italia comanicazieni di grande conseguenza.
Poscia le armi di Carlo domarono gli Avari, indi gli slavi abitatori della Boemia; si trovarono, con varia sorte, a conOiUo coi danesi; furono Inviate contro i saraceni di Spagna, ma do· vellero retrocedere per fiaccare una solleva:zioue dei sassorii. Come dicemmo, furono sorprese a Roncisvalle ne' Pirenei, e vi subirono gravi perdite.
Esteso io tal guisa il potere de' franchi, ·Carlo venne inc:o· ronato dal papa a Roma quale imperatore romano, nel di di Na· · tale del 799.
Nell' 814 cessò di vivere.
Egli campeggiQ, come avviene degli uomini grandi, iu tutte le opere del suo secolo. Intese, fra la generale ignoranza, quanto l' educazione fosse efficace a proteggere i resti della civiltà ro· mana e i germi d' ltn\ nuova. Soldato e .conquistatore, amò la pace e il clero; barbaro, venerò la sapienza romana e ne raccolse le reliquie; erudito, non disprezzò le favelle illetterate del nord: fu tedesco d'origine, di lingua, d' abitudini, d' inclinazioni, di tutto fuorchè dell' ambizione di rinn<!Vare il nome romano (t).
Fra gli autori contemporanei di opere che si riferiscono all' arte od ai falli militari di quest' epoca si possono anno· verare:
LBON& lliPIUTORB, Istitu1ioni militari. È lavoro che contiene una serie di precetti importanti e degni di studio.
Vaturca GtovArcrct, /storie fioretlline, elle servono allo studio dell' arte della guerra io Italia ed ai falli accaduti nel secolo . XIV.
Qualora si desideri apprendere la storia del medio evo dagli autori e da documenti di que' tempi, havvi gran numero di semplici cronache, di raccolte di leggi o di capitolari, e di altri atti che possono servire di pascolo all' erudizione, e di lume a uoa via in que' secoli di tenebre.
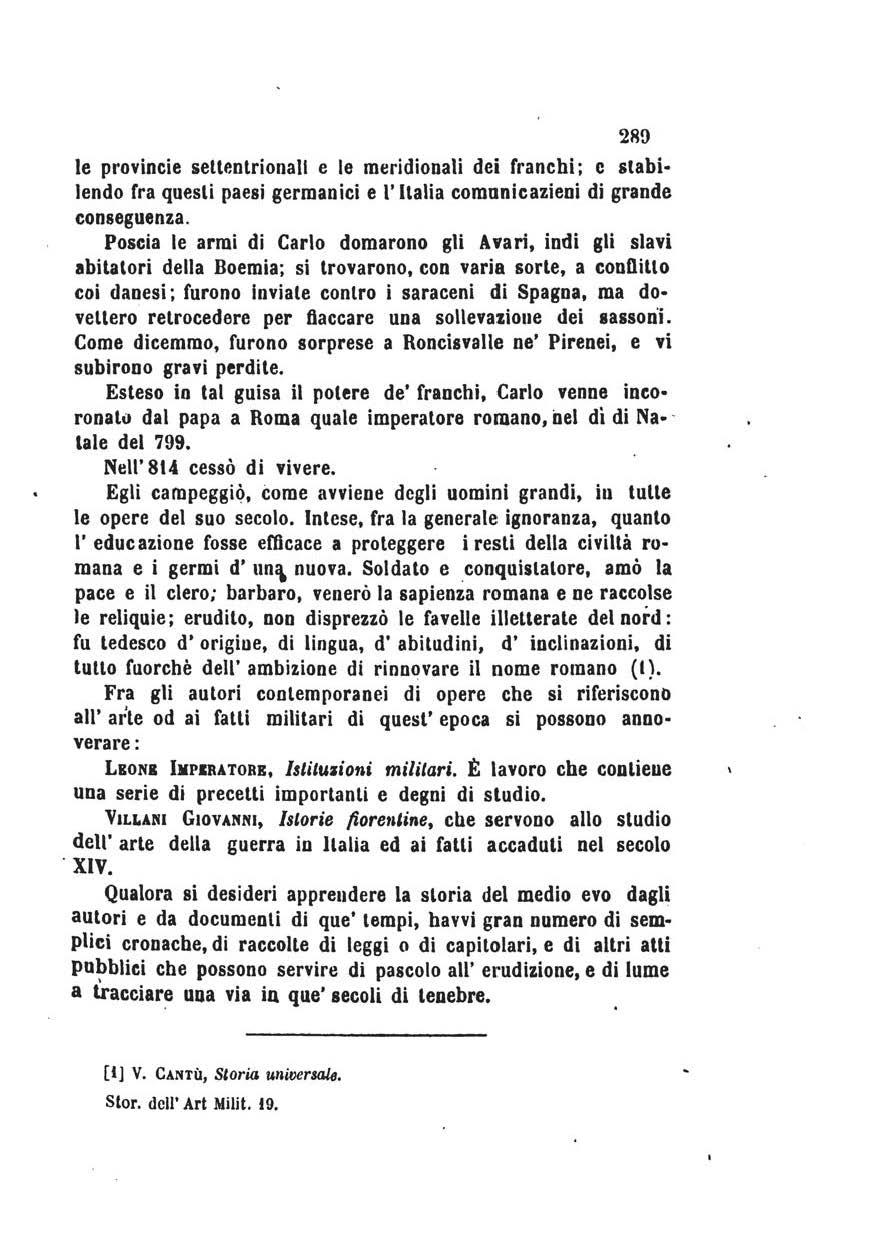
(l] V. CANTù, Storia Ulliver&al4.
Stor. dell'Art Milit. 19.
290
Le poesie dei trovatori servono pure a fornire un idea di quella cavalleria che al tempo stesso rappre11entava un principio sociale • militare.
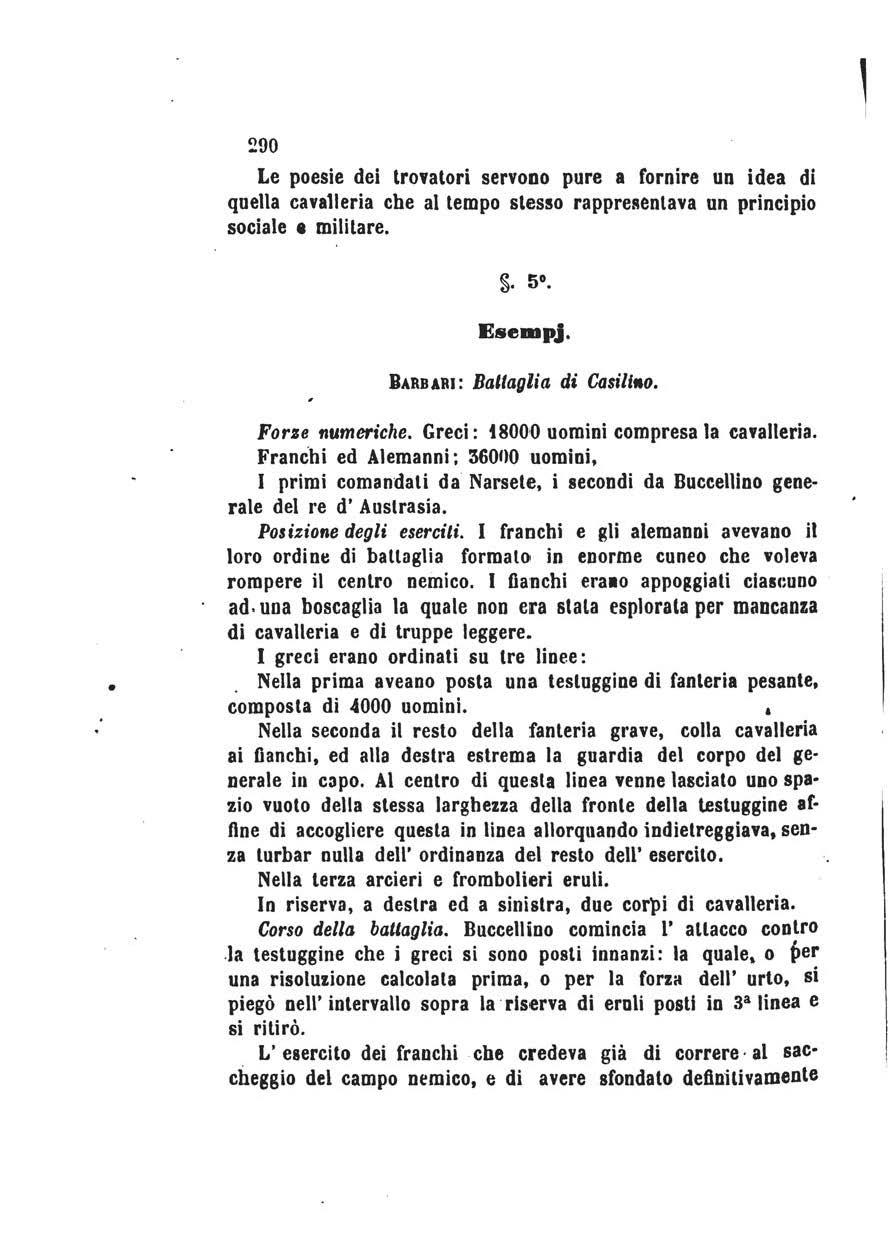
BARBARI: Baltaglia di Casilt•o.
Forse numeriche. Greci: 18000 uomini compresa la cavalleria . Franéhi ed Alemanni: 360fl0 uomini, l primi comandati da Narsete, i secondi da Buccellloo rate del re d' Austrasia.
Posizione degli eserciti. I franchi e gli alemanni avevano il loro ordine di battaglia formalo in enorme cuneo che voleva rompere il centro nemico. l fia ochi eraao clasc:uno ad . una boscaglia la quale non era stata esplorata per mancanza di cavalleria e di truppe leggere.
l greci erano ordinati su tre linee: . Nella prima aveano posta una testuggine di fanteria pesante, composta di 4000 uomini. ,
Nella seconda il resto della fanteria grave, colla cavalleria ai fianchi, ed alla destra estrema la guardia del corpo del ge· nerale in capo. Al centro di questa linea venne lasciato uno spa· zio vuoto della stessa larghezza della fronte della testuggine af· fine di accogliere questa in linea allorquando indietreggiava, sen· za turbar nulla dell' ordinanza del resto dell' esercito. Nella terza arcieri e frombolieri eruli.
In riserva, a destra ed a sinistra, due corpi di cavalleria. Corso della baUaglia. Buccellioo comincia l' altacco contro .)a testuggine che i greci si sono posti innanzi: la quale, o per una risoluzione calcolata prima, o per la forza dell' urto, si piegò nell' intervallo sopra la ·riserva di eroli posti io 3a linea e si ritirò.
L' esercito dei franchi che credeva già di correre· al sac· cheggio del campo nemico, e di avere sfondato definitivamente
291 l'esercito greco, ·si trovò chiuso in siffatla guisa che la testa della ·colonna fu arrestala dagli eruli, c i suoi duè Oancbi vennero attaccati dalle due parti della linea dei greci, da ciascun lato· dell' intervallo vuoto e dello spazio in cui era cominciata l' azione. Intanto la cavalleria de' greci, che aveva girate le boscaglie, piombò a tergo dell'esercito di Buccellino; e i franchi e gli alemanni, avviluppati da ogni lato per questa manovra, furono tagliati a peni (V. Tav.n Xli . ).
Rimltato. Distruzione dell' esercito de' barbari e presa del suo carppo pieno e ricco di bottino.
Osse,.vazioni. Questa bauaglia può dare un' idea delle azioni importanti che ebbero luogo per corso di secoli fra i barbari ed i romani decaduti; è una di quelle iu cui si è spiegato do una parte c dall' altra maggior arte, maggiore scienza militare, maggior valore. Vi si trova la tra.ccià di parecchie bauaglie celebri dell' antichità; c sembra un imilazionc di quella di Canne.
Nell' una e nell' al&ra, il centro è sfondato dall' esercito che crede gi& aver ottenuto ,vittoria; e questo esercito è avviluppato da quello che si crede sfondato c disfallo. l barbari perdenti a Casilino uon avevano perciaè si lrovava distaccata verso Po; i romani ne avevano a Canoe, ma ne fecero tale uso che sarebbe stato meglio per essi a non averne. Là e qui, l' esercito più forte io numero ri· mase violo.
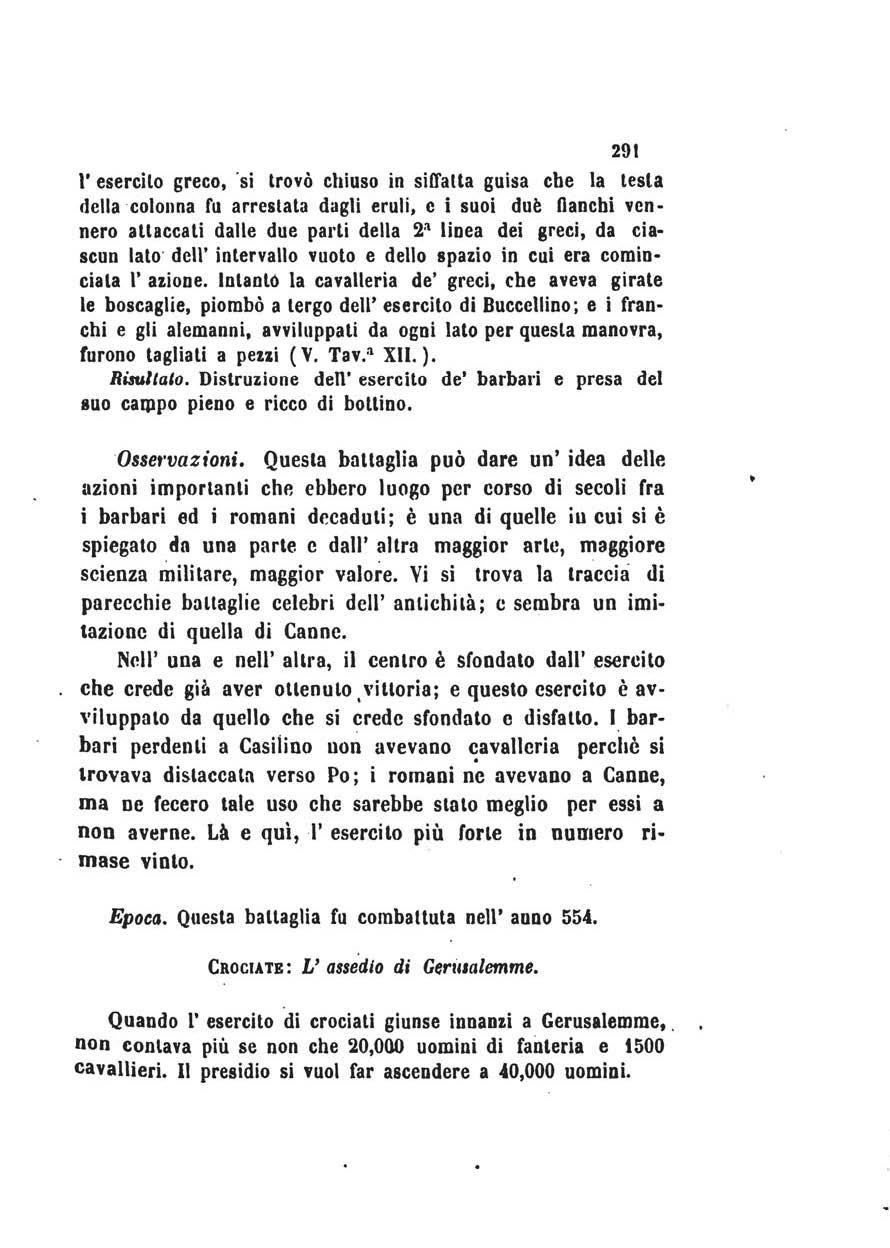
Epoca. Questa battaglia fu combattuta nell' anno 554.
CaocrATB: L' assedlo di Geri11alemme
Quando l' esercito di crociati giunse innanzi a Gerusalemme, . non conlava piu se non che 20,000 uomini di fanteria e t500 cavallieri. Il presidio si vuoi far ascendere a -40,000 uomini.
292
l crociali erano comandati da Goflredo di Buglione; i sara· ceni da Inikar Eddaulah. '
l crociati accamparono all' ovest e al flord della città; non s' in•estì nè all' est oè al sud per le difficoltà del terreno.
Sei giorni dopo, •i fu assalto generale respinto dai turchi. l principi cristiani pensano di far costruire macchine, ma non hanno legname a sufficienza.
Il ruscello di Kidron era secco; manca l' acqua per l' esercito; i cavalli dei crociati muojono G torme; i loro cadaveri corrompono l' aria e si sviluppa il contaggio.
Penuria di •i veri; calore straordinario ; ansietà nel campo crociato.
Di un' intera flotta genovese, mandata a soccorso de' crociati, un solo vascello entra uel porto di Laodicea.
Il timore del prossimo arrivo di uo esercito condotto dal sultano d' Egitto, fa decidere i cristiani ad uo assalto generale.
Ricevono l' assoluzione, marciano la uolle, assalgono all'alba, e dopo due giorni di combattimento en traoo io città. 70,000 persone, fra presidio e abitanti, nogono trucidati.
.
0&$ervazioni. t.° Cavalleria dell' esercito cristiano ridotta ai minimi termini : necessità di fare assegnamento sulla fanteria 2.• Trascuranza di lavori .d' assedio. 5.• Inopportunità dell' impresa in causa delle circostanze della stagione, ed effetti che ne 4.• Incuria nel provvedere ai bisogni dell' esercito crociato. 5. o Attacchi disordinati, e riusciti per disperazione c fanatismo. 6.° Crudeltà nella vit· toria. 7. 0 In complesso, assenza d'arte.
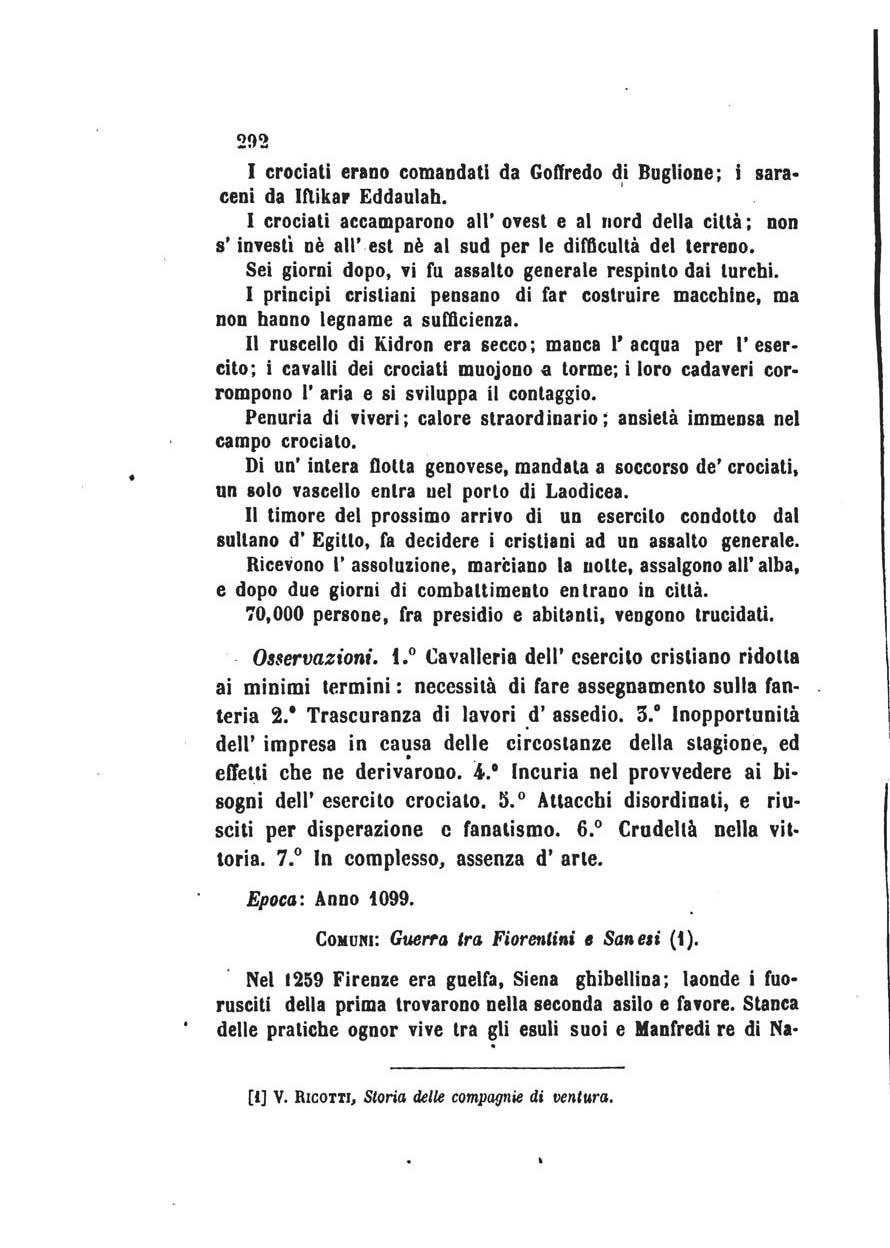
Epoca: Anno t099.
COIIUIU: Guert'a Ira Fiorentini 1 San e1i (t).
Nel 1259 Firenze era guelfa, Siena ghibellina; laonde i fuo· ruscili della prima trovarono nella seconda asilo e fnore. Stanca delle pratiche ognor vive tra gli esuli suoi e Manfredi re di Na·
[l) V. Rrcorrr, Storia delle compagnie di ventura.
293 poli, Firenze bandi la guerra contro Siena che li ricetta va; e tosto avendo piantato &!llla porta di Santa Maria la campana del carroccio, comandò di suooarla alla distesa notté e giorno, richiese d' ajuto le città amiche, e pose mano a fornire l' esercito.
Comiociossi dal consegnare il supremo indirizzo della guerra al podestà Jacopino Rangoni da Modena; si statui che la somma delle cose fosse rimessa in lui e in t2 capitani dell' esercito ch e erano cittadini eleltt nella proporzione di due per ogni sesto della città, la quale dividevasi io sei sesti; che io nome del podestà s• inviassero le lettere; si spedissero gli ordini, ai muovessero le schiere; che una parte dei 12 capitani lo seguisse io guerra, ed un' altra rimanesse io città; che il podestà fosse accompagnalo da alcuni cavallieri, giudici, e berrovieri, specie di sbirraglia; cavallieri e giudici per isbrigare le faccende e definire le liti del campo, berrovieri per egeguire i comandi.
Voscia dal suffragio unito dei capitani dell' esercito e degli anziani fnrono creali due capitani per ogni' sesto ed un goofalo· niere, due consiglieri e due costringitori, tanto sopra i milili, ch' erano i gÙerrieri a cavallo. quanto sopra i pnesai, 8li arcieri, ed i balestrieri di ogni sesto. L' ufficio dei costriogilori era quello di tenere be o disposte le schiere e slimolarle bffiochè facessero buona pro•a.
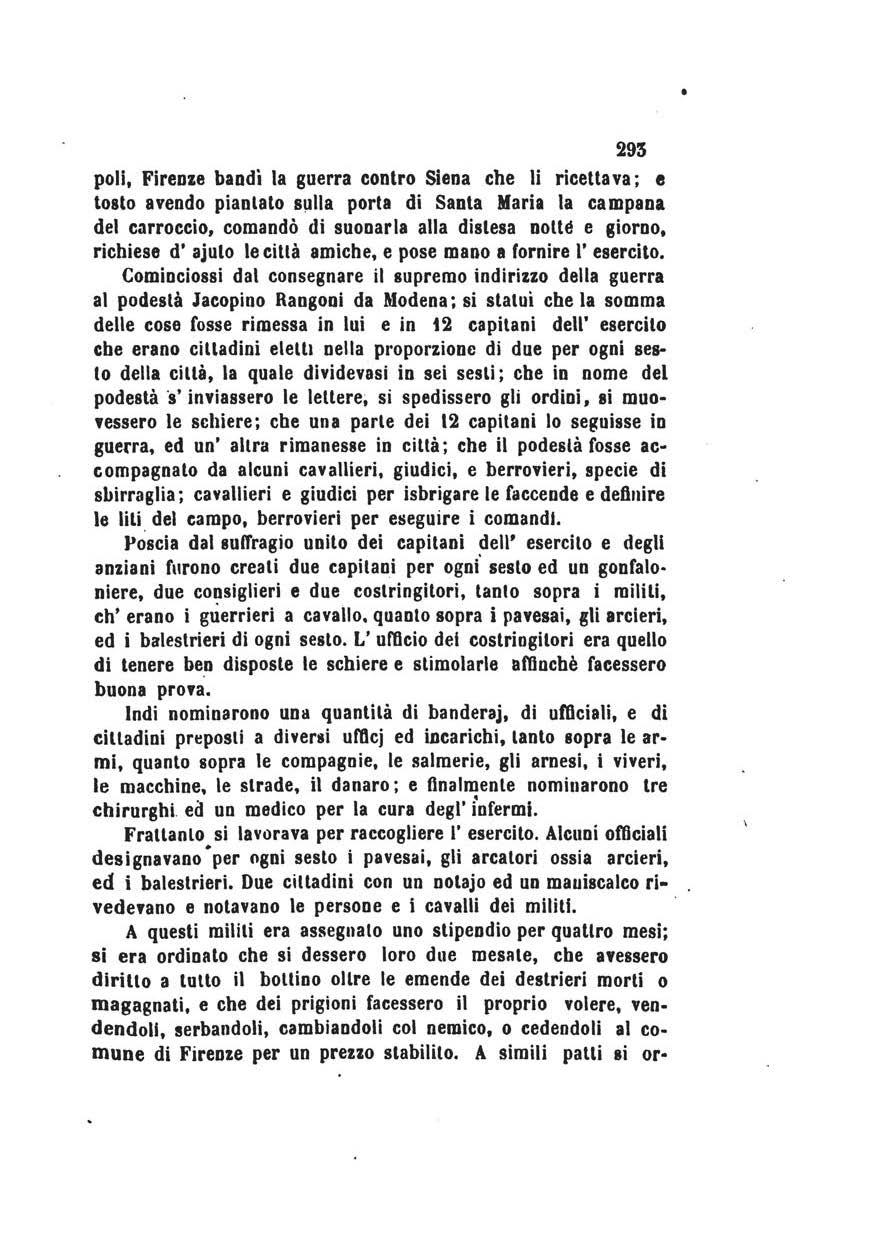
Indi nominarono UDII quantità di banderaj, di ufficiali, e di cittadini prt:posli a diversi ufficj ed incarichi, tanto sopra le ar· mi, quanto sopra le compagnie, le salmerie, gli arnesi, i viveri, le macchine, le strade, il danaro; e finalmente nominarono tre chirurghi ea un medico per la cura degl' infermi.
Frattanto si lavl)rava per raccogliere l' esercito. Alcuni officiali designavano·per ogni sesto i pavesai, gli arcatori ossia arcieri, ed i balestrieri. Due cittadini con un notajo ed un mauiscalco rivedeYano e notavano le persone e i cavalli dei militi.
A questi militi era assegnato uno stipendio per quattro mesi; si era ordinato che si dessero loro due mesate, che nessero diritto a tutto il bottino oltre le emende dei destrieri morti o magagnali, e che dei prigioni facessero il proprio volere, vendendoll, serbandoli, cambiandoli col nemico, o cedendoli al comune di Firenze per un prezzo stabilito. A simili patti ai or·
29-t dinò pure di :IS!loldare 400 berrovìeri o fanti di Modena e della Romagna, divisi per cinquantine, ciascuna sotto un conestabile e due capitani.
Dentro la cillà er1mo state imposte le cavallaie, ossia l' obbli gniooe di servire a cavallo, a seconda degli averi . Il d' uomo impotente per età o malallia, stimato e descritto esso fosse per pelo e per segno, consegnavasi al congiunto, od a quella altra persona, atta alle armi, che veniva da quello offerta io suo cambio.
Del resto qualunque suddito o cilladino fra i 15 e i 70 anni era stato convocalo. Tranne caso di pubblico servigio o speciale esenzione, sovrastava grave multa e pena ad- arbitrio del podestà a chiunque fosse mancato. Rispondeva del fuggiasco il comune che lo ricetta va o nou l' accusava; .la casa , ove fosse rio. venuto, doveva atterrarsi; c il nome suo a perpetua infamia pubblicarsi in tutti i pubblici consigli e nella messa solenne · della prima domenica d ' ogni mese.
Non lievi multe sotlrastavano alta·esì al notajo che avesse usato fl'ode nella descrizione dei soldati, al cittadino che avesse dalo uome · falso o risposto per altri, al milite che avesse no· duto, prestato o lrafugato, il delitriero della cavallata impostagli.
Chi militava a cavallo doveva recar seco sella e coperta, usbergo, gambiere, cappello d' acciajo . lancia, scudo o larga; il faule veniva armato di panciera o oorazz ina con maniche di ferro, cappello d' acciajo o con gorgiera, lancia , scudo o la· volaccio grande all' inglese. La manr.anta di ciascun pezzo im· portava una multa.
Ugualmente aneuiva per gli arcieri e balestrieri. Chi aven l ' imposta del balestro, partiva balestriere, ovvero' pagava , se cilladino, trenta soldi, se del contado 15. In ugual modo potevano riscattarsi dall' imposta dell'arco sborsando t5 soldi . Ma non per questo erano liberi; imperoccbè militavano poi tutti fra i pedoni, a meno che non li avesse salvati qualche motivo straordinario
Ne furono bensì dichiarali esentì lutti i mercanti della città e del contado descritti nel libro dell' arte, acciocchè tenessero ben fornilo il mercato del campo; ·ed a questo effetto i loro nomi vennero registrati per ogni sesto.

Il contado e di11tret1o somministrarono in buon numero mar· njuoli e guastatori colla paga di 12 denari al giorno; gli uomini che rimanevano ancora, tranne qualcuno a cavallo imposto ai bor· ghi principali, ebbero ordine chi di fermarvisi a guardia, chi di veuit·e sia a fat·e l' esercito od il mercato, sia a raccogliere e governare i palveai. Si diè ord10e uel tempo stesso a tutte le pievi di formarsi un padiglione e un vessillo, t:d eleggersi un capii :t no.
Erano esse 86, ·gia da due lustri ·ordinale a leghe o compa· goie io modo che l' una potesse soccorrere l' altra, e tutle in· sieme potessero soccorrere la cillà. Le compagnie poi dentro la città erano 20, uuite a sesti, coi proprj goufalouieri e caporali . Le insegne loro erano diverse: ciascu'na aveva la sua; la scala, il carro, il loro, ecc. Quella dej mercato era vergata; quella della sal meri a era bianca con entro un mulo nero: quella dei · guastatori bianca coi ribaldi io gualdana a giuocare; quel\a. dei ruarrajuoli e palajuoli portavano dipinte marre e pale; quelle de' pavesai e balestrieri il pavese e la balestra.
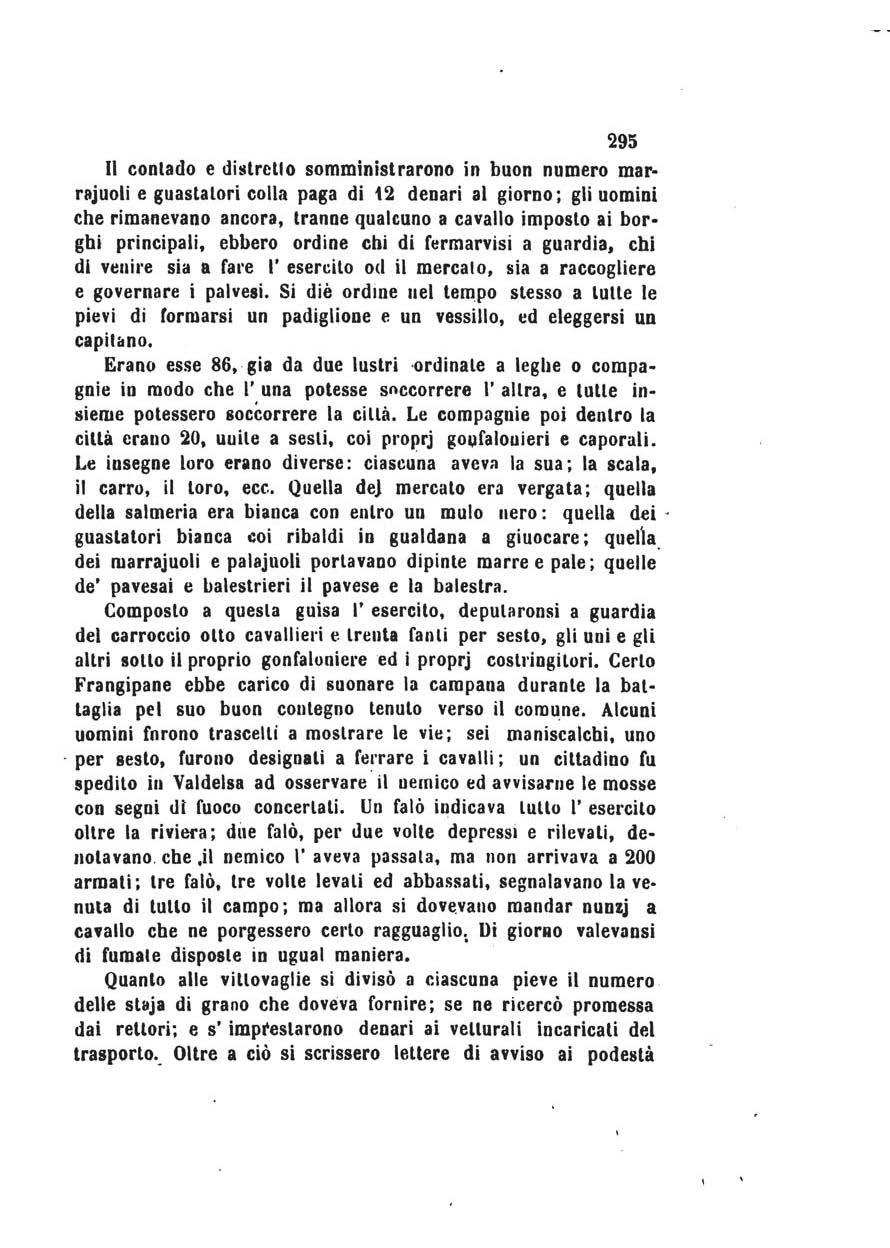
Composto a questa guisa l' esercito, depularonsi a guardia del carroccio otto cavallieri e trenta fanti per sesto, gli uni e gli altri aouo il proprio gonfalooiet·e ed i proprj costriogilori. Certo Frangipane ebbe carico di suonare la campana durante la bat· taglia pel suo buon contegno tenuto verso il comu.ne. Alcuni uomini furono trascelti a mo strare le vie; sei maniscalchi, uno · per sesto, furono designali a fe1·rare i cavalli; un cittadino fu spedito in Valdelsa ad osservare ·il nemico ed avvisarne le mosge con segni di fuoco concertati . Un falò indicava lullo l' esercito oltre la riviera; dite falò, per tlue volte depressi e rilevati, de· notavano . che ,il nemico l' aveva passata, ma non arrivava a 200 armati; tre falò, tre volte leva li ed abbassati, segnalavano la venuta di tollo il campo; ma allora s i dovevano mandar ounzj a cuallo che ne porgessero certo Di gioruo valevansi di fumale disposte io ugual maniera .
Quanto alle vittovaglie si divisò a ciascuna pieve il numero delle st11ja di grano che doveva fornire; se ne ricercò promessa dai rettori; e s' impl'estarono denari ai vellurali incaricali del trasporto._ Oltre a ciò si scrissero lettere di avviso ai podestà
296
delle terre per le quali era il cammino dell'esercito: c Sappiate, scriveva il podestà di Firenze a quei di Colle, Poggibonzl, e S. Donato in Poggio, sappiate che la mossa del glorioso nostro esercito si e occorre cbe ooo difettino i viveri per tanta moltitudine. Imperò, pel tenore delle presenti; vi mandia· mo che sollecilamenle e lodevolmente studiate a proeacclarvi il maggior numero di caldaje e farina e annona abbondante al pos· sibile, ed ogni specie di vittoYaglie per la difesa della . vostra terra e per l' oO'esa de' sanesi ed altri nemici del comune di Firenze. •
Compiti questi apparecchi, verso la fine dell'aprile 1260, i signori del contado e i cayalli eri cittadini trassero io gran pompa il carroccio fuori dell' Opera di S. Giovanni; e avendolo condotto nella piana di uuovo, quivi il posarono su certa pietra incavala a tal uopo. Ne assunsero allora la cura i super. stili, e i militi ed i fanti designati a guardarlo.
A questo spettacolo tolta Firenze era io moto, tutta la soldatesca in arme; e dovunque un brillar d' armature, un dimenar di pennacchi, un cozzar d'alte grida, un suonare di campane a gloria, uno strepitare ineO'abile di trombe e di timballi. Ginnta che ru la processione fuor delle al luogo del generale convegno, dove si erano piantate le bandiere e i gonfaloni, vi fermò i passi e lo strepito cessò. Restarono in Firenze tre insegne di balestrieri ed altrettante di arcieri e marrajuoli, le donne, i fanciulli , i vegliardi, tauti mugnaj quante macine sull'Arno, un certo Busso con tutta la sua famiglia acciocchè rimanesse a difesa della propria villa atta a rifugio ed a custodia, e un sarto per alcuni giorni flnchè avesse terminato le· coperte dei destrieri.
Al terzo alloggiamento, i gue1·rieri si posarono alla villa di Urmiano nel contado sanese, guidati continuamente nel camminu dai tocchi della marlinella, ossia campana di guerra dei ftoren· tini. Quivl pensarono di rinfrescare e compiere le leggi e gli or· dini militari già emanali due mesi prima.
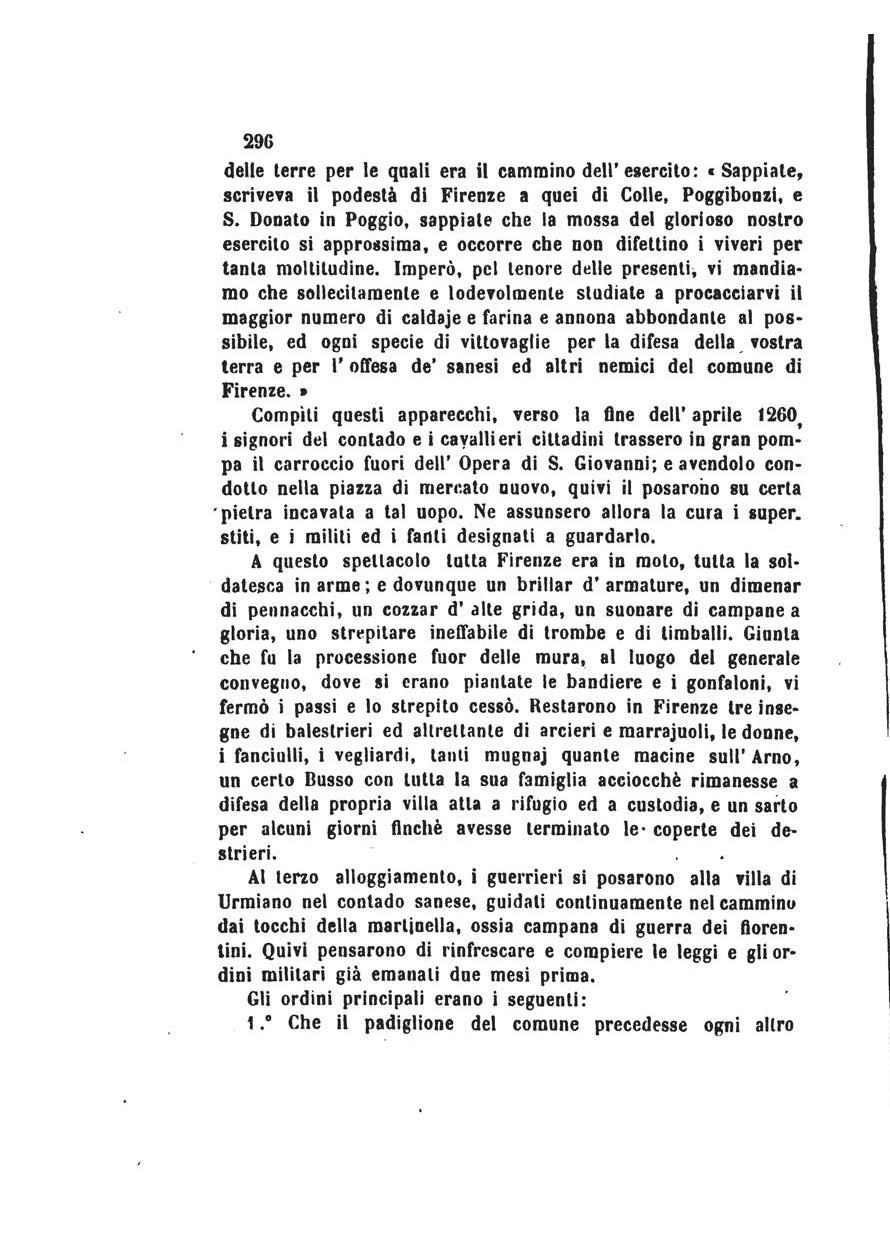
Gli ordini principali erano i seguenti:
1 .• Che il padiglione del comune precedesse ogni altro
297 nella m3rcia, e rrima d' ogni altr'o nnisse spiegato. Oltre ad una grne multa, sarebbesi abbrucciato al contranentore la sua tenda o trabacca.
2.° Che nion gonfaloniere entrasse nel campo prima della bandiera del suo ·sesto, nè veruna privata persona· prima del suo gonfalone.
:;,o Che le tende e trabacche di ogni sesto si disponessero bensì tutte in un corpo; ma con tale ordine che gli uomini e le bestie Ni trovassero agevol passo lramezzo.
.t .• Che dietro ai balestrieri mareiusero le some dei palvesi, por quelle delle balestre e dei torni, alftne il saellume e le tende -. del comune. Ad O@ni mutare di campo, i gonfalonieri de' palvesai camminassero in coda ai palvesi per vegliare che non andassero perduti; e cosi i go nfa Ioni eri dei balestrieri e degli arca tori od arcieri.
5.° Che· Il resto della salmeria pigliasse una strada diversa da quella dell' esercito: si però che per ogni bestia, nrebbe perduto ogni cosa e sarebbe stato punito ad arbitrio.
6.° Che chiunque, fosse milite, fosse fante, pavesaio, arciere, balestriere, guastatore, ma rraiuolo, picconajo o segatore, seguisse la sua l osego a e i suoi capi; nè se ne allontanasse senza licenza, nè prima che fossero posti gli alloggiamenti: gli arca tori ed i balestrieri procedessero sempre eone armi tese.
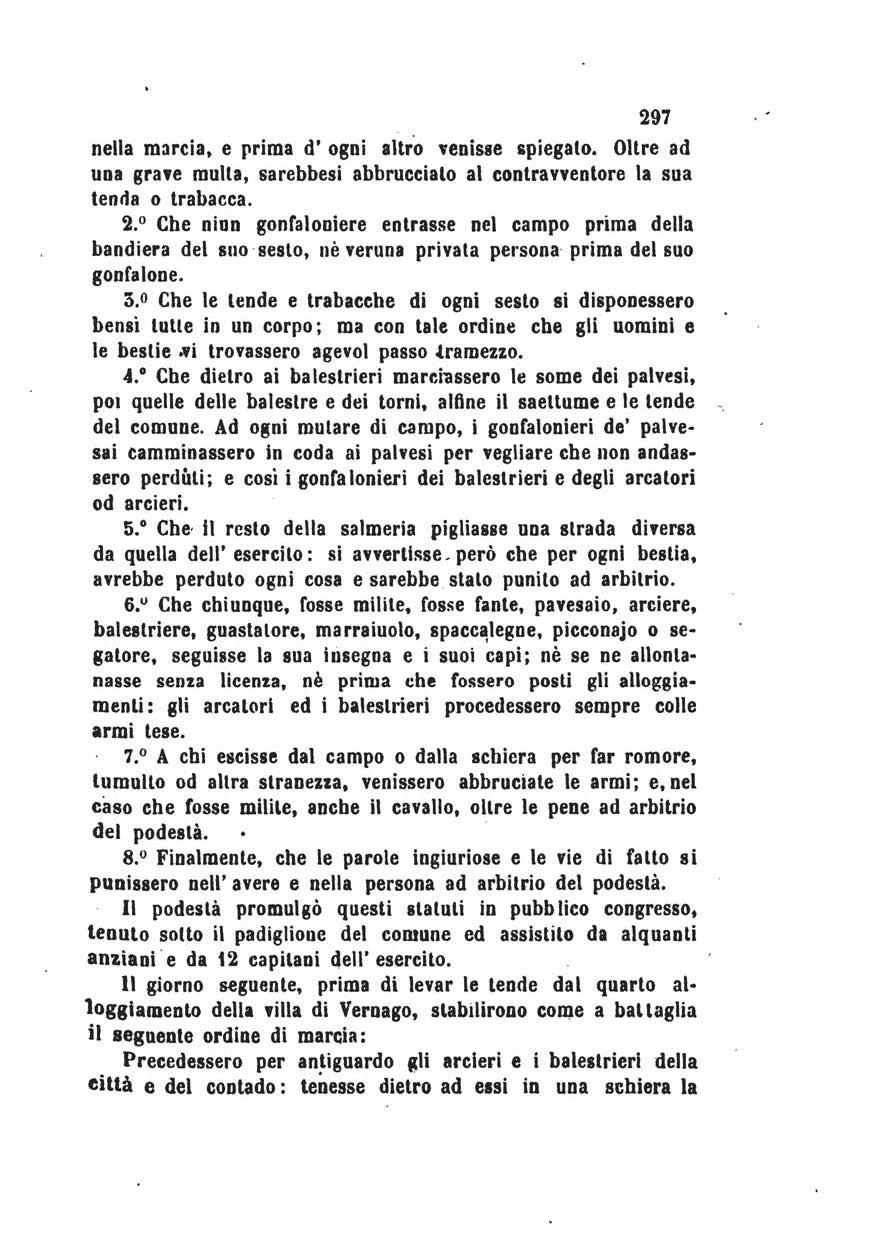
7. 0 A chi escisse dal campo o dalla schiera per far romore, tumulto od altra stranezza, venissero abbruciate le armi; e, nel caso che fosse milite, anche il cavallo, oltre le pene ad arbitrio del podestà.
8.° Finalmente, che le parole ingiuriose e le vie di fallo si punissero nell' avere e nella persona ad arbitrio del podestà. · Il podestà promulgò questi alatoli in pubblico congresso. tenuto sotto il padiglione del comune ed assistito da alquanti anziani ·e da t2 capitani dell' esercito.
Il giorno seguente, prima di levar le tende dal quarto alloggiamento della villa di Vernago, stabilirono coDJe a battaglia il segoente ordine di marcia:
Precedessero per antiguardo tli arcieri e i balestrieri della città e del contado : tenesse dietro ad essi in una schiera la
208 cavalleria di t1·e sesti della cillit. Venisse dopo il popolo de' medesimi sesti tutlo in un corpo, poi la cavalleria , poi il popolo de' sesti rimanenti. La cavalleria e prr ultimo i fanti dei confederali formassero il retroguardo.
Cosi ordinali s' inoltrarono ; e dopo. aver preso nel cammino i castelli di Vico, di Me zzaua e di Casciole, fermarono l'oste incontro a Presso all' autiporlo di Santa Petrooilla sorgeva un poggello. Quivi edificarono uua torre rivelata sopra i borghi e la città, e sulla torre collocarono la martinella che suonasse alla guardi a del campo. Disegno degli assalitori era di terminare la lite con oo gran fallo d' armi; disegno de' fuorusciti ghibellini, guidali da Farinata degli .Uberli, era di far cosa per cui il re &laofredi fosse obbligato a aoccorrerli mollo più. •
Aveva il re m andalo in loro ajuto uua mano di tedeschi, piccola bensì, ma che per di Farinata aveva portato seco la regale bandiera. Ora , una festa i fuorusciti empiono ben heoe di viuo que' beoni te_descbi, e quindi li inviano tumulloariameote contro i nemici. Ni un d' essi ne tornò più vivo; la loro bandiera, trascinata primameole per tull9 il campo, e poscia per le vie di Firenze, fu appiccala a rovescio alle pareti di San· la Reparata.
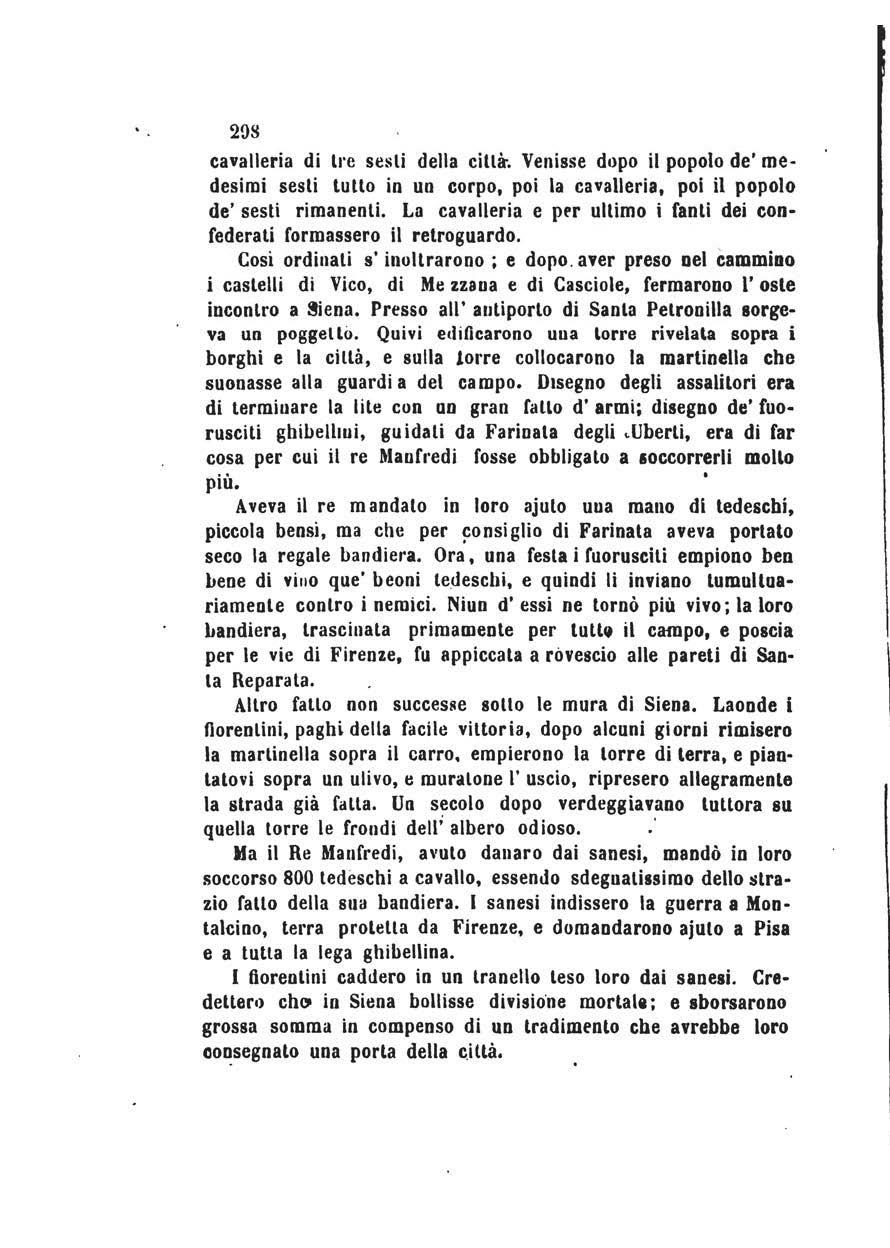
Altro fallo non succes11e sollo le mura di Siena. Laonde i fiorentini, paghi della facile vittoria, dopo alcuni gi oro i rimisero la martinella sopra il carro, empierono la torre di terra, e pian· latovi sopra un ulivo, e muralooe l'uscio, ripresero allegramente la strada già falla. Un secolo dopo verdeggiavano lullora su quella torre le frondi dell; albero odioso. ·
Ha il Re Manfredi , avuto danaro dai sanesi, mandò io loro soccorso 800 tedeschi a cavallo, essendo sdeguatissimo dello strazio ratto della Sllil bandiera. l sanesi indissero la guerra a Montalcino, terra protetta da Firenze, e domandarono ajuto a Pisa e a tutta la lega ghibellina.
l fiorentini caddero in un tranello leso loro dai sanesi. Credellert> choo in Siena bollisse divisio'ne mortale; e sborsarono grossa somma in compenso di un tradimento che avrebbe loro una porta della
299
Rifecero il campo; e col resto della lega gnelfa, si misero in via per soccorrere Montalcino con 30,000 pedoni e 3000 cavalli.
Giunti nel contado di Siena, e sempre nella vana lusinga di conseguire la città per tradimento, si posero nei colli di teaperti aspcllando d' ora in ora di v.eoire Introdotti. Ed ecco aprirsi di repente la porta promessa, che era quella di S. Vito. e fuori tutto il popolo di Siena gridando Battaglia! Baltaglia l, preceduto dai tedeséhi inanimiti dalla promessa di doppia paga. Crebbero la confusione tra' guelfi alcuni traditori, che al primo balenare delle schiere fuggirQno dalla parte de' sanesi. Ciò nullameno i più bravi ripigliarono cuore; siccfiè, riordinate con prestezza le genti, avrebbero ancora fatto buona resistenza, se nel punto in cui i fiorentini venivano investiti dai tedeschi, il malvaggio Bocca degli Abati, mozzando la mano di chi sventolava la bandi era del comune, non l' sospinta a terra. lo que' tempi, non v' essendo proporzione di gradi, nè disciplina, la sorte di una schiera pendeva dall'insegna. Al cader adunque . di quella, cadde ogni buon volere, oè fu più nel campo fiorentino cb e fuga ed ecc idio. Del popolo impotente a fuggire venne Jalto macello. Cl}i si . rinchiuse in Monteaperti restò preso e morto. Firenze, piena di lullo e di paura, fu abbandonata dai guelfi ai vincitori; e Farinata, autore della vitturia, dovè poco stante nel concilio di Empoli difendere a forza aperta cbe non la smantellassero e riducessero a borghi.
Cosi ebbe fine la spedizione contro Siena. Cosi si lrallavano le guerre tra i comuni oel secolo Xllll Veotinove aon_i dopo questa sconfitta, il divino poeta combalten fra le patrie ca vallate a Certomoodo contro gli aa·etioi; e quella era io Toscaya l' ultima battaglia, nella quaiP. le mHizie cittadine non fossero soverchiate dai mércenarj. Pochi anni ancora, e la maggior parte di que' comuni era sparita sotto la dominazione di un tiranno. Dalla caduta dei comuni d' Italia ba la storia delle compagnie di ventura.
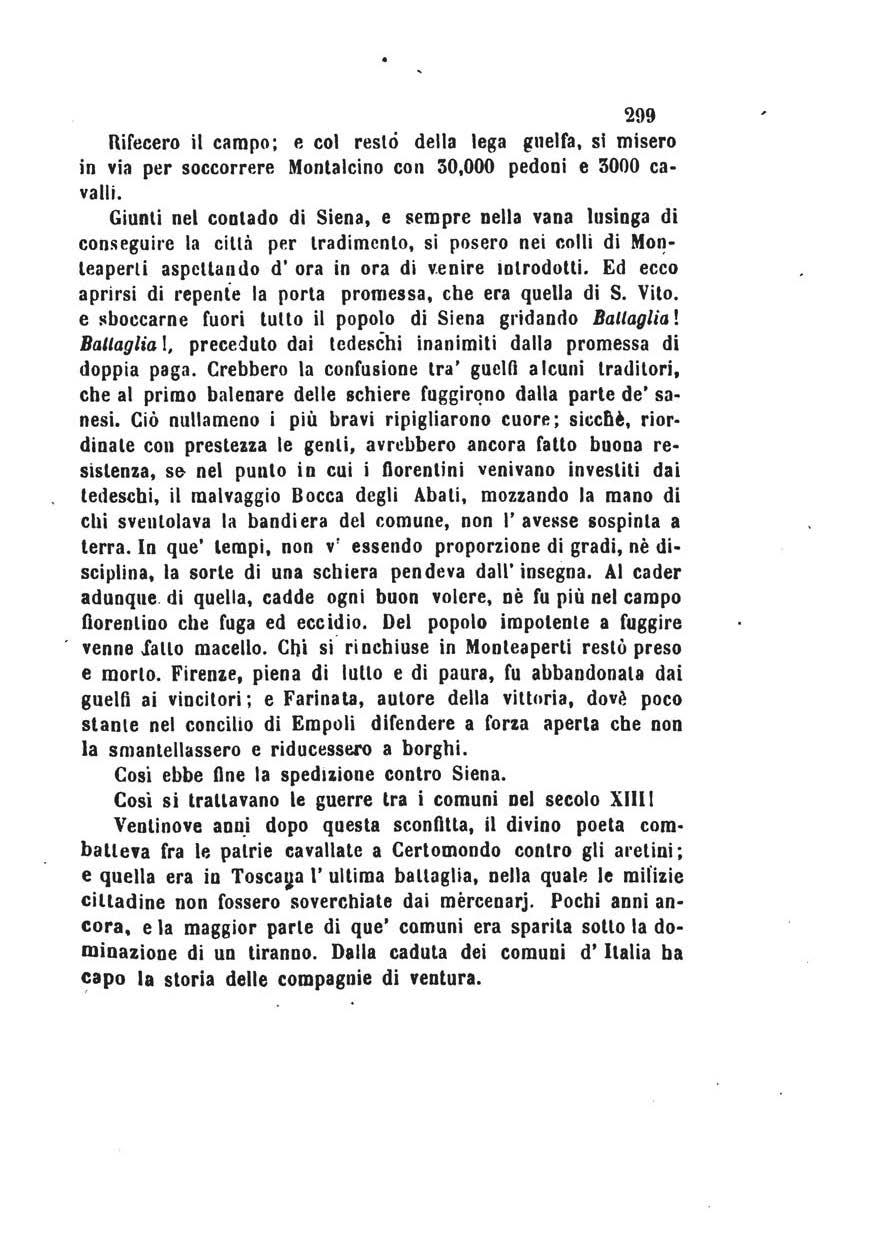
300
SEcoLo xtv: Battaglia di · Crecy.
Ferze numeriche. Inglesi: 50,000 uomini solto sli or· . dini di t:duardo 111.
Francesi: t 00,000 uomini sotto gli ordini di Filippo VI. Disposiziofle. Eduardo dispose le sue genti in tre battaglie: t.8 {ìendarmi a piedi ed arcieri sulla fronte;
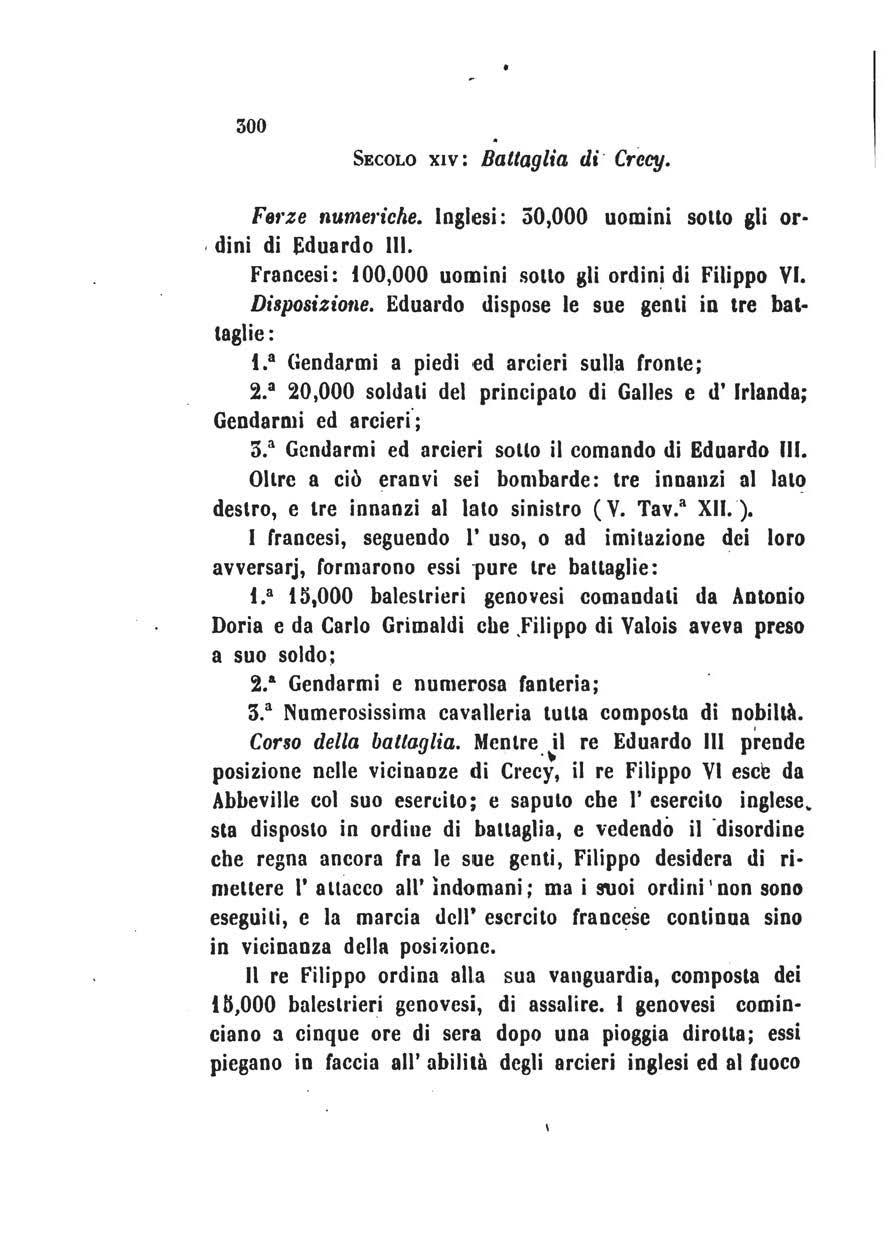
2. 3 20,000 soldati del principato di Galles e d' Irlanda; Gendarmi ed arcieri ';
5.3 Gendarmi ed arcieri sotto il comando di Eduardo 111. Oltre a ciò sei bombarde: tre innanzi al destro, e tre innanzi al lato sinistro (V. Tav.a Xli. ').
l francesi, seguendo l' uso, o ad imitazione dci loro avversarj, formarono t'ssi -pure tre battaglie: t .8 t 5,000 balestrieri genovesi comandati da Antonio Doria e da Carlo Grimaldi cbe ,Filippo di Valois aveva preso a suo soldo ;
2.a Gendarmi e numerosa fanteria; s.a Numerosissima cava11eria tutta compo&ta di nobiltà . Corso della battaglia. re Eduardo Ili prende posizione nelle vicinanze di Crecy, il re Filippo VI esce da Abbeville col suo esercito; e saputo che l'esercito inglese. sta disposto in ordine di battaglia, e vcdendò il ·disordine che regna ancora fra le sue genti, Filippo desidera di ri· mettere l' aLtacco all' Ìndomani; ma i S'UOi ordini ' non sono eseguiti, c la marcia clcll' esercito continua sino in vicinanza della posi1.iooc.
Il re Filippo ordina alla sua vanguardia, composta dei t 6,000 balestrieri genovesi, di assalire. l genovesi cominciano a cinque ore di sera dopo una pioggia dirolla; essi piegano io faccia all' abilità degli arcieri inglesi ed al fuoco
:;111 insolito delle bombarde nemiche. Le loro balestre non servivano più perchè le corde, essendo fisse, non si poterono togliere e riparare dalla pioggia come quelle dell' arco in· slese.
Filippo VI ordina che i genov('si siano sciabolali dalla cavalleria; e siccome non sembrava che i genovesi fossero disposti a subire tranquillamente le seiabolate dei francesi, ne risultò parapiglia e disordine.
Allora una parte della cavalleria francese, minacciata e bersagliata dai nemici, si getta la prima linea .nemica, si apre un passaggio fra gli arcieri inglesi, e si tro'a a fronte del resto de1le truppe della prima linea al cui soccorso si avanzavo la bollagli a; allorchè gli arcieri, serrandosi dietro ad essa, tagliano alla cavalleria nemica ogni comunicazione coll' esercito francese.
Filippo VI si avanza per liberare i suoi capitoni, ma ogni suo sforzo è reso vano dall' intrepidezza degli arcieri. i francesi continuano, senza piano e senza insieme, i loro attacchi, e subiscono i mmense perdi te dalla difesa regolata ed assennata degl'inglesi.

La battaglia fini al cominciare della notte; ed il re Eduardo, che non conosceva .ancora tutta la sua ,·ittoria, si congratulò colle sue truppe d' aver respinto l' attacco dei francesi senza il suo soccorso e senza il soccorso della 3' battaglia.
Al mattino una folta nebb ia cuopriva il campo. Il re Eduardo 111 inviò un corpo di 5000 uomini di cavalleria in ricognizione. Questo corpo non trova più i francesi che avevano battuto in ritirata nella notte, ma incontra la milizia comunale di Beauvaìs e di Amiens che, ignorando la sorte dell'esercito francese aveva marciato procelsionalmente tutta la notte per raggiungerlo. Sorpresa da questo
302 distaccamento di cavalleria inglese, ed incapace di resi:;Lenza , la milizia si pone in roua c viene tagliata a pezzi.
Un àllro corpo. della stessa milizia, condotto dan• arcivescovo di Rouen c dal Gran PriorP. di Francia, subisce ugual sorte; dimodochè la strage· del secondo giorno è an· cora maggiore di quella del primo. Risultato. La pet·dita dei francesi fu di 50,000 uomini fra cui rimasero uccisi t t principi e t,200 cavallieri; 80 bandiere caddero io potere del vincitore ·ct). Cause. Il disordine c l' indisciplina con cu i cominciò la battaglia; la ·circostanza per cui i genovesi non poterono far uso delle loro balestre; lo spavento incusso a questi dal cannone inglese: l'accrescimento della confusione prodono dal comando di sei.abolarli: c più di tuuo, la mancanza di piano, di buona ordinanza, d' insieme, e la superiorità delle disposizioni e dell' ordine degl'inglesi. Osservazicmi. In questa battaglia si videro agire diversi clementi di guerra, e questa diversità segnava . un' epoca di transizione; cavalleria feudale , arcieri inglesi, milizie comunali, mercenarj stranieri e armi da fuoco che per la prima volla comparvero sul campo di battaglia. Tulti questi elementi offrirono spiccatamente il loro càrallere: i cava1lieri bardati combattendo valorosamente, ma inetti a re-· sistere a buona fanteria, mostrarono il decadimento del medio evo; gli arcieri inglesi, agendo con ordine e con · precisione di tiro, esprimevano il risorgimento delle fanterie; la milizia comunale, giungendo tardi, marciando processionalmente, disperdendosi all' assalto di poco cavallieri, mostrò come non fosse strcua da buoni ordinamenti militari,
[l J V . KA US J.Rn Atlas des p/tls mèmoriW/es buttailles.
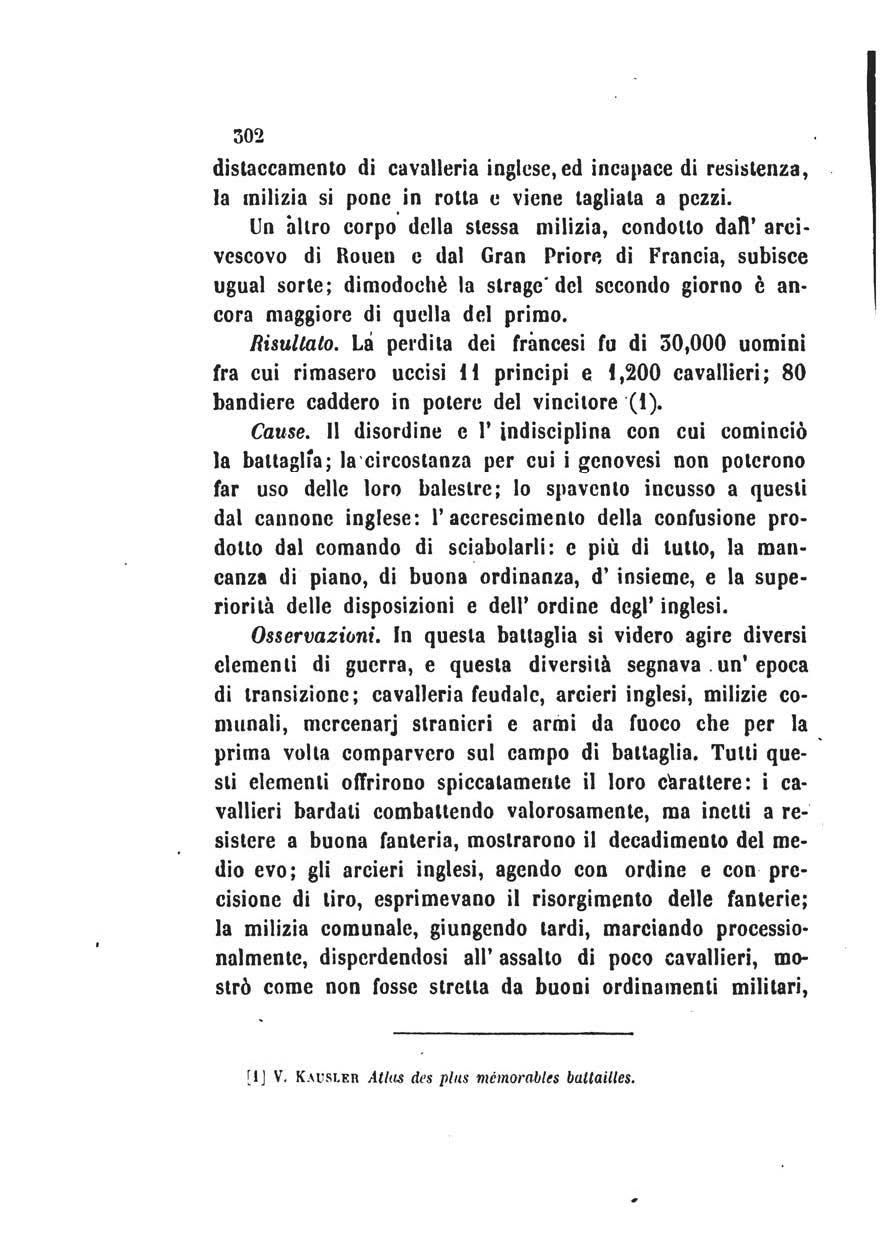
e fosse inetta ad aperta campagna; i mercenarj stranieri, rappresentando un elemento ctcregcnco, sono l' espressione di quel sistema di soldati comperati che combaltevano per chi li pagava; finalmente, le armi da fuoco svelarono per la prima volla sul campo . la loro presenza, e fecero predire i futuri mutamenti dell'arte militare.
Epoca: 26 Agosto t 346.
•
Gli austriaci sommavano a 8000 fanti e 4000 cavalli: gli svizzeri a t 500 uomini a piedi.
l primi, in quollro colonne colla cavalleria -alla testa, s'impegnano in una gola. Sono altaccati di fianco da un distaccamento svizzero che li con pietre c li schiac· eia con troachi d' alberi: la loro cavalleria si pone alquanto in disordine.
Il grosso degli svizzeri si forma · in colonna serrata, e finisce di porre in fuga la cavalleria che cal pesta la vropria fanteria. Poscia la colon n a svizzera insegue senza requie i nemici f\no a Egeri cagionando loro gravissime perdite. Gli austriaci lasciarono 1500 uomini sul campo, e gli svizzeri t 4.
Epoca: U Novembre t315.
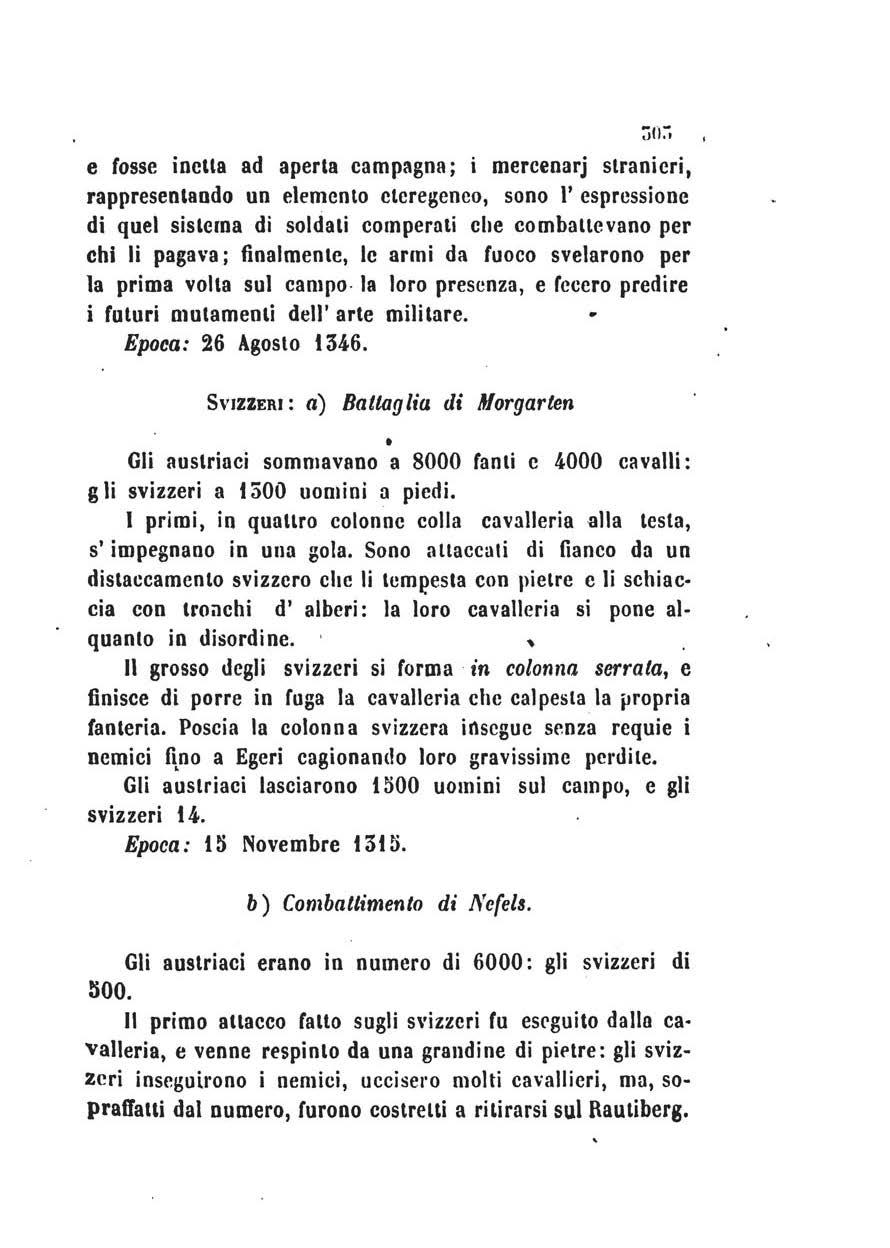
Gli austriaci erano in numero di 6000: gli svizzeri di 500.
Il primo attacco ratto sugli S\'izzcri fu es<'guito dalla ca· valleria, e venne respinto da una grandine di piE'tre: gli svizzeri inseguirono i nemici, uccise1·o molti cavallieri, ma, sopratJaui dal numero, furono costretti a ritirarsi sul Rautiberg.
i
Il combattimento s1 rmnova parecchie volle con vario esito; finchè gli svizzeri si slanciano dalle loro ahurc: in colonnl' serrata per precipilar.c sul nemico, mentre le montagne rimbombano del grido di guerra mandato dagli abitanti delle valli accorsi al tocco della campana a stormo.
Gli austriaci prendono la fuga; la cavalleria è rigeuata nella linth, la ·fanteria inseguita sino a Wesen ove il ponte si rompe sotto il suo peso.
Gli austriaci ebbero 2300 morti sul campo, a cui si aggiunsero gli annegati: gli svizzeri 5lS morti, e circa 200 •feriti.
Epoca: t Aprile t 538 .
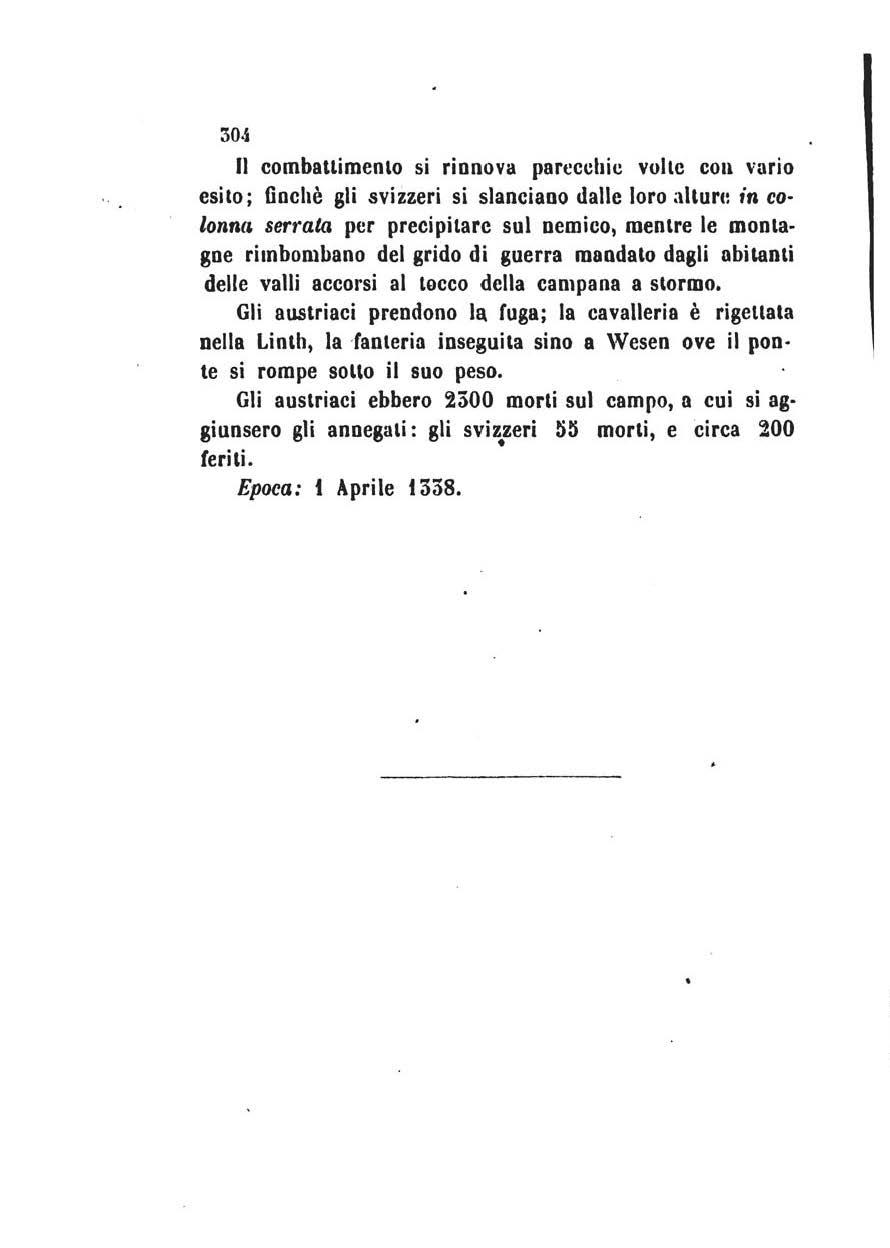
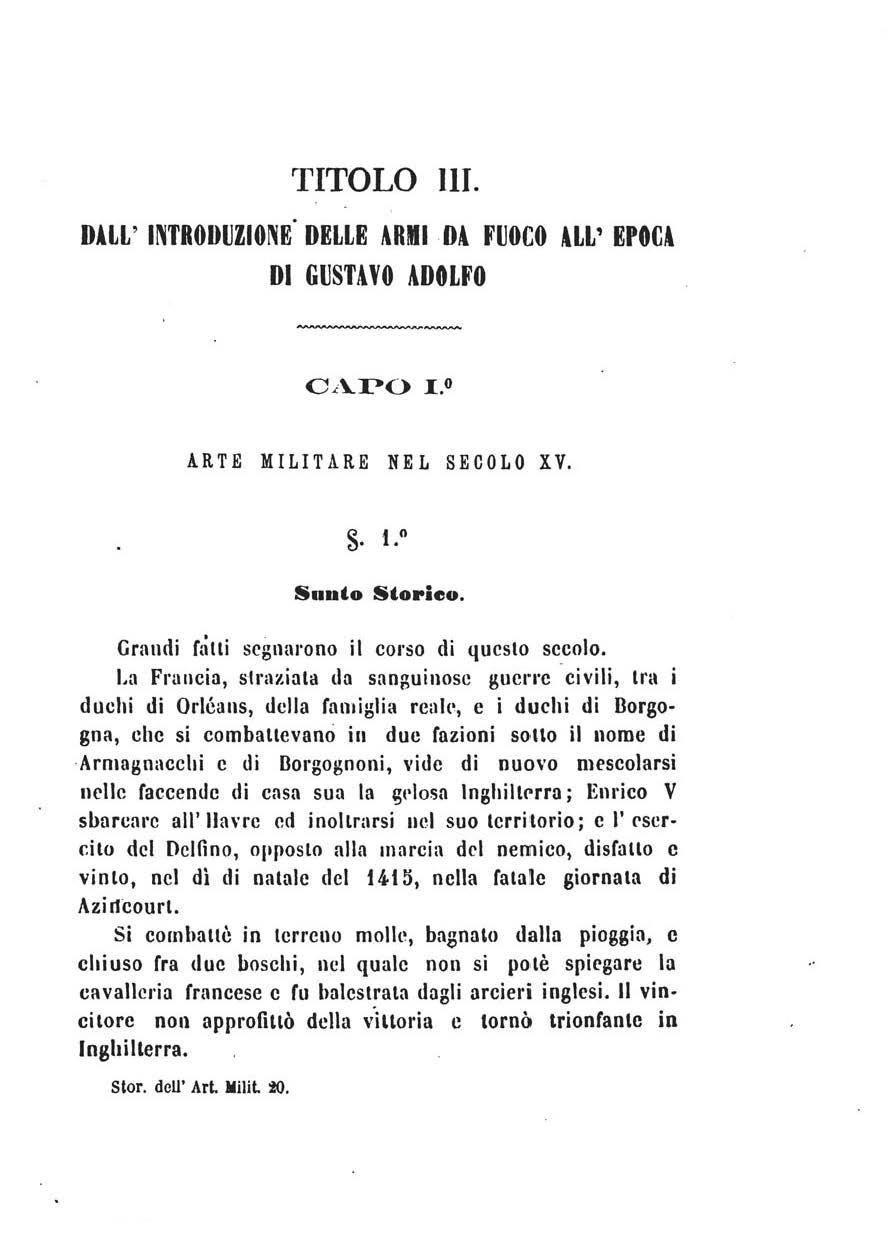
Grandi f:Ìtti scgawrono il corso di questo secolo .
La Francia, straziata da sanguinose guca·a·c ·civili, tra i duchi di Orléans, della famiglia rcah\ e i duch i di Borgogna, che si combattevano in due fazion i sono il nome di ·Armagnacchi c di Dorgognoni, vide di nuovo mescolarsi nelle faccende di sua la 'Jt•lo8n lnghilt<'rra; Enrico V sbarc:u·c all'Ila ne cd inoltrarsi nel suo tcrri ·torio; c l' rscrcito del Delfino, opposto alla marcia del nemico, disfallo c vinto, nel dì di natale del u.t 5, nella fatale giornata di Az i rtcourt.
Si combattè i n terreno molle, bagnato dalla pioggia, c chiuso fra due boschi, nel quale non s i potè spiegare la cavalleria francese c fu balestrata dagli arcieri inglesi. Il vincitore noll approfittò della vhtoria c tornò trionfante in Inghilterra.
Stor. dcU' Art. Milit. iO.
Ma continuandn ed imperversando vicmmaggiormcnte le camificinc, Enrico fu di nuovo chiamato e rivenne in Francia; c dopo alcuni pt·ogressi sulle tcrr"c m•miche, segnò un trattato col demente Carlo VI, . in virtù del quale sposava la figlia di qu•·sto re francese, e veniva dichiarato er<' dc del trono a detrimento del delfino Carlo.
Mori poco dopo a VinccntH•s, c gli leone ·subito dietro Carlo VI; in tale assunsl•ro il titolo di re di Francia Carlo delfino ed Enrico VI, fanciullo, sotto la del duca di Bcdforl.
Allot·a scoppiò la guerra; guerra d'indipendenza; guerra santa.
VII, ridouo a Bourgcs, a vendicare l' onore nazionale da lungo tempo calpestato, c le sue armi vinsE"ro le battaglie di Gr:wc llc c di Montargis. l suoi nemici asscdi:uono Orléans; c già h cillà slava per cndc>t'<', quando Giovanna d' Arco, llr\'Sc nlata si a re Carlo, si disse inviata da Dio per iscacciare gl' ·inglcsi da Orléans, e lui far con· sacrat·c a R<'ims. L' assedio ru levato l' 8 maggio t 429. Il coraggio, le vittorie, il martirio di Giovanna d' Arco, salvarono la Francia, diiT01Ìdcndo da per lutto l' orrore al nomc ingl<'sc; e la Francia riebbe la su11 indif'endenza colla cacciala completa tlei rwmici, c In sua grandl'zza m<'diantc un trattato concluso coi duchi di Borgogna i quali riconob· bcro In superiorità dc' suo i re.
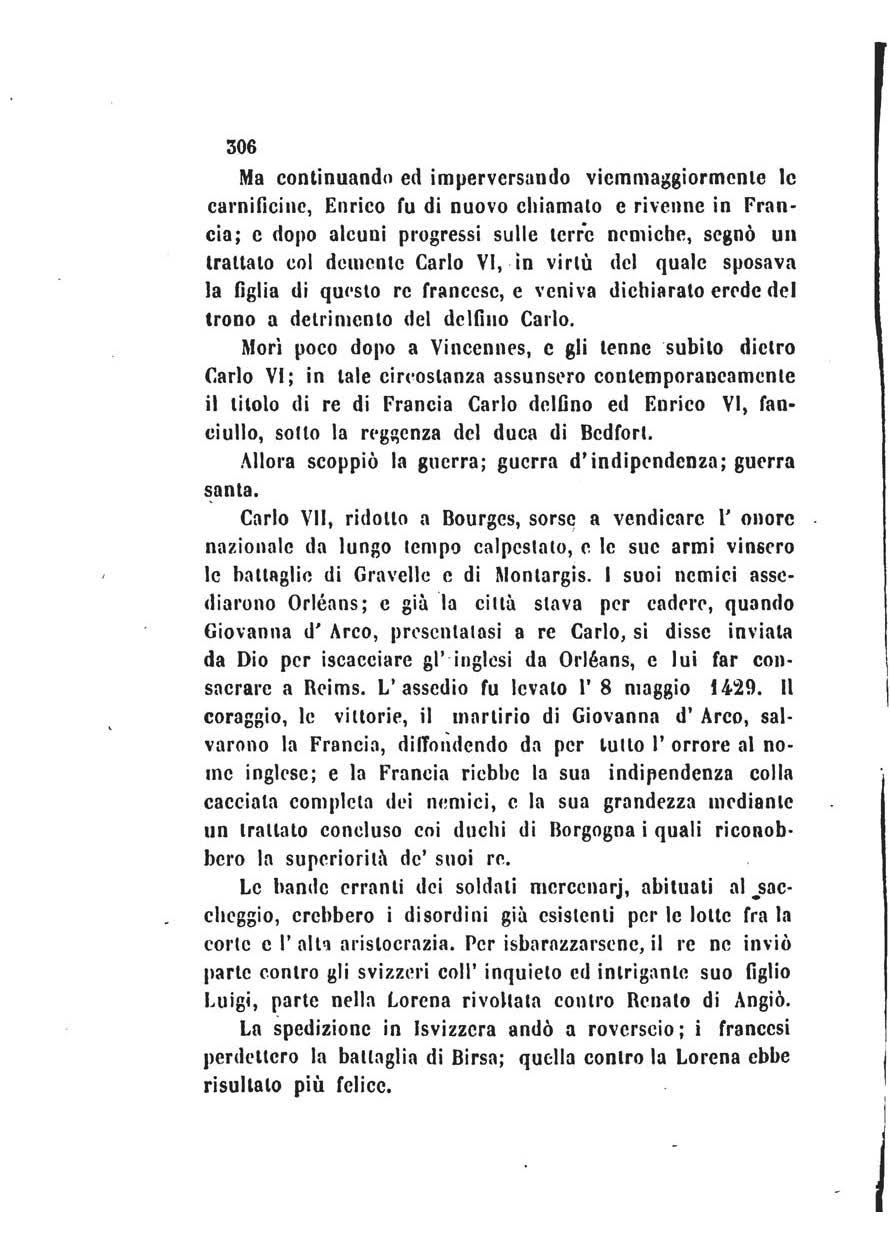
Le hanlle erranti dci soldati mcrccnarj, abituati nl .sac cheggio, crebbero i disordini già esistenti per le lotte fra la corte c l' nll'l aristocrazia. Per isbarnzzarscne, il re ne im·iò parte contro gli svizze ri coll' inquieto cd intrigante suo figlio tuigi, parte nella Lorcna rivoHatn contro Renato di ,\ ngiò.
Ln spedizione in lsvizzcra andò a ro vcrscio ; i francesi penlcllcro la ballaglin di Birsa; quella contro la Lorena ebbe risullato più felice.
Carlo VII si d_iede alla formazione di un esercito permanente, c si emancipò così dai signori feudali.
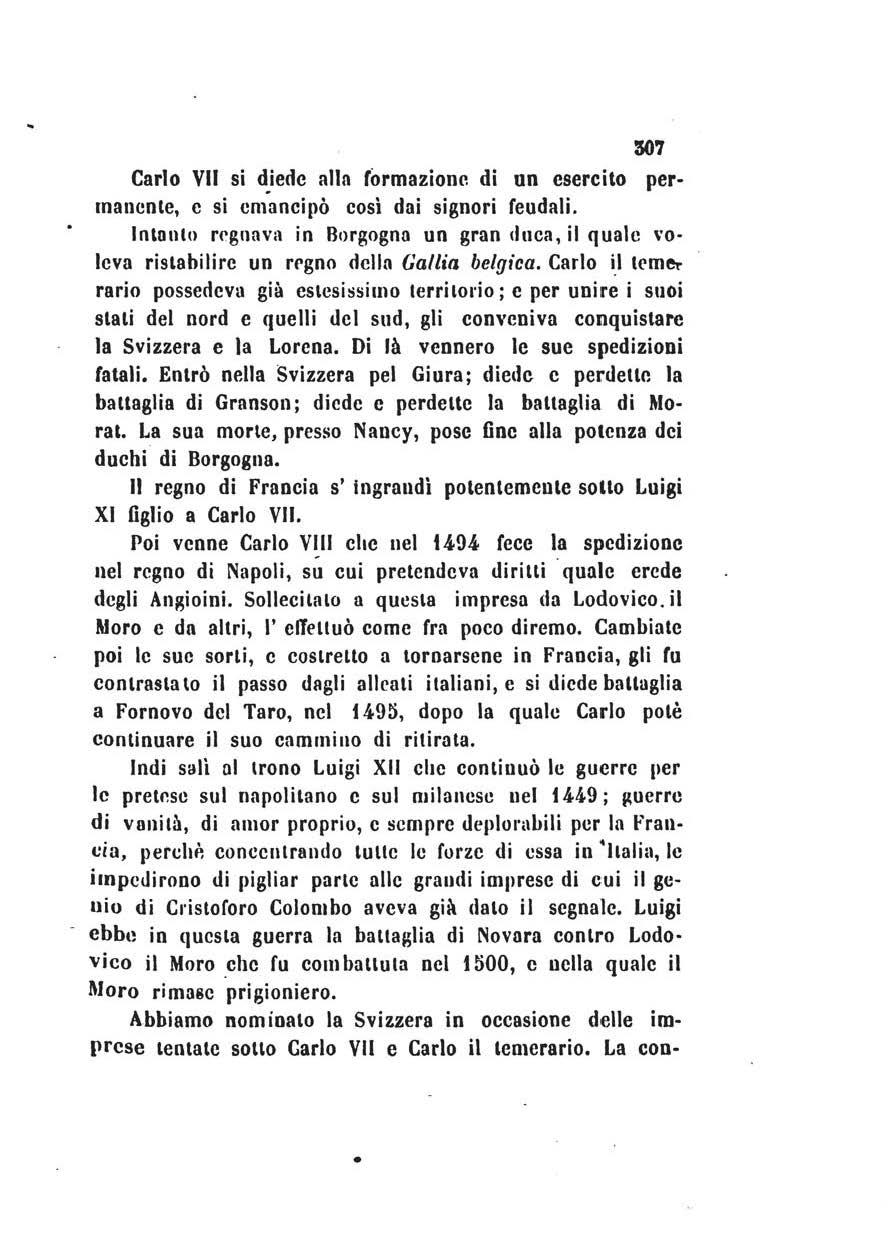
Intanto rPgiHIVèl in Borgogno un gran ciuca, il quale \'O· leva ristabilire un rrgno ciclln Gallia belgica. Carlo il tt'metrario possedeva già estesissimo territo•·io; e per unire i suoi stati del nord e quelli del sud, gli conveniva conquistare la Svizzera e la Lorena. Di là vennero le sue spedizioni fatali. Entrò nella Svizzera pel Giura; diede c perdettc la battaglia di Granson; diede c perdelte la battaglia di Mora&. La sua morte, presso Nancy , pose fine alla potenza dci duchi di Borgogna.
Il regno di Francia s' Ingrandì potentemente solto Luigi Xl figlio a Carlo VII.
Poi venne Carlo VI Il che nel t 494 fece la spedizione nel regno di Napoli, su cui pretendeva diritti ·quale crede degli Angioini. Sollecitato n que sta impresa da Lodovico. il Moro c dn altri , l' eiTeltuò come fra poco diremo. Cambiate poi le sue sorti, c costreuo a toroarscne in Francia, gli fu contrastato il passo dagli alleati italiani, c si diede battaglia a Fornovo del Taro, nel t 495, dopo la quale Carlo potè continuare il suo cammino di ritirata.
Indi salì ol trono Luigi Xli che continuò le guerre per le pretr.sc sul napolitano c sul milanese nel t 449; ((Uerrc di vanità, di amor proprio, c sempre deplombili per In Francia, perchP. concentrando tolle le forze di essa in •Jtaliu, le impedirono c.li pigliar parte alle grandi imprese di cui il genio di Cristoforo Colombo aveva già dato il segnale. Luigi in questa guerra la battaglia di Novara contro Lodo· vico il Moro che fu com battuta nel t 500, c nella quale il !\loro rimase ·prigioniero.
Abbiamo nominato la Svizzera in occasione delle imprese Lentate sotto Carlo VII e Carlo il temerario. La con-
308 federazione nascente, che già ·sugli austrinci aveva fatto sentire il peso della mano dci disprezzali montanari, si direse mirabilmente nella prima di codeste imprese; e la sua riputazione militare si accrebbe alla famosa battaglia di Birsa, in cui 1500 montanari uccisero all' esercito francese quasi t 0000 uomini. La Francili allora reputò meglio di renderseli amici.
Più tardi gli svizzeri, mostrandosi ognora più terribili, riportarono contro Carlo il temerario le sanguinose villorie di Granson c di Morat, al suono delle due trombe di gran· dczza mostruosa, che, dicesi, avevano ricevuto da Carlo· magno.
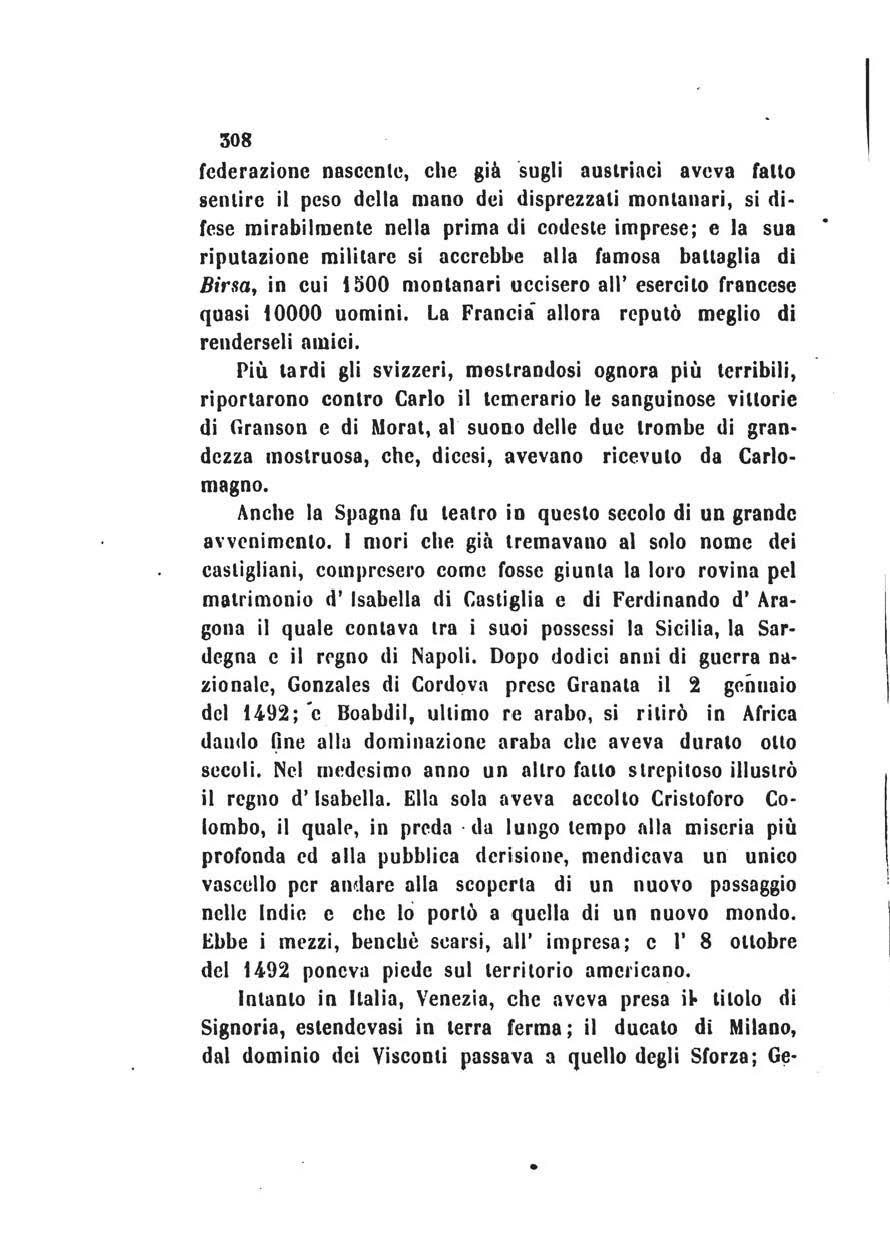
Anche la Spagna fu teatro io questo secolo di un grande a\'Vcnimcnto. l mori già tremavano al solo nome dei castigliani, comprcset·o come fosse giunta la lot·o rovina pel matrimonio d' Isabella di Castiglia e di Ferdinando d' Aragona il quale contava tra i suoi posses si la Sicilia, la Sardegna c il rrgno di Napoli. Dopo dodici anni di guerra nazionale, Gonzales di Cordqva prese Granala il gennaio del 1492; ·c Boabdil, ullimo r.e arabo, si ritirò in Africa dautlo alla dominazione araba che aveva durato otto secoli. Nel medesimo anno un allro fatto s trepiloso illustrò il regno d' Isabella. Ella sola aveva accollo Cristoforo Colombo, il qualr, in preda · t1a lungo tempo nlla miseria più profonda cd alla pubblica dcri1sione, mendicnva un unico vascello per andare alla scoperta di un nuovo passaggio nelle Indie c che lo portò a ·quella di un nuovo monllo. Ebbe i mezzi, bencl..tè scarsi, all' impresa; c l' 8 ottobre del 1492 poneva piede sul territorio americano.
Intanto in Italia, Venezia , che aveva presa titolo di Signoria, estendevasi in terra ferma; il ducato di Milano, dal dominio dci Visconti passava a quello degli Sforzo; G!!·
309 nova andava cadendo in preda alle ambizioni di Francia e di Milano; i duchi <li Modena divenivano nnchc duchi di Ferrara; i conti di Moricnna, divenuti duchi di Savoju,· ampliavano ed afTorzuvnno i loro stati di quà e di là dal· l' Alpi; la casa dei Medici, banchieri e mcrcatanti, fece di Firenze la sede della sua grand<'zzu; Roma, divisa dallo scisma d' occidente per cui i papi si trovavono ad Avignone, era dominata dalla famiglia Colon e nel regno di poli ·si succedevano gli Angioini e la casa di Aragona. Poi eravi un g•·osso numero di altri principoui che signoreggiavano quà e là su più ristrr.lli tlominj.
Continue guerre intestine stt·azinvano la penisolu, comballutc dni principi stranieri o dalle compagnie di ventura che venivano o•·a dagli uni orn dugli 11llri.
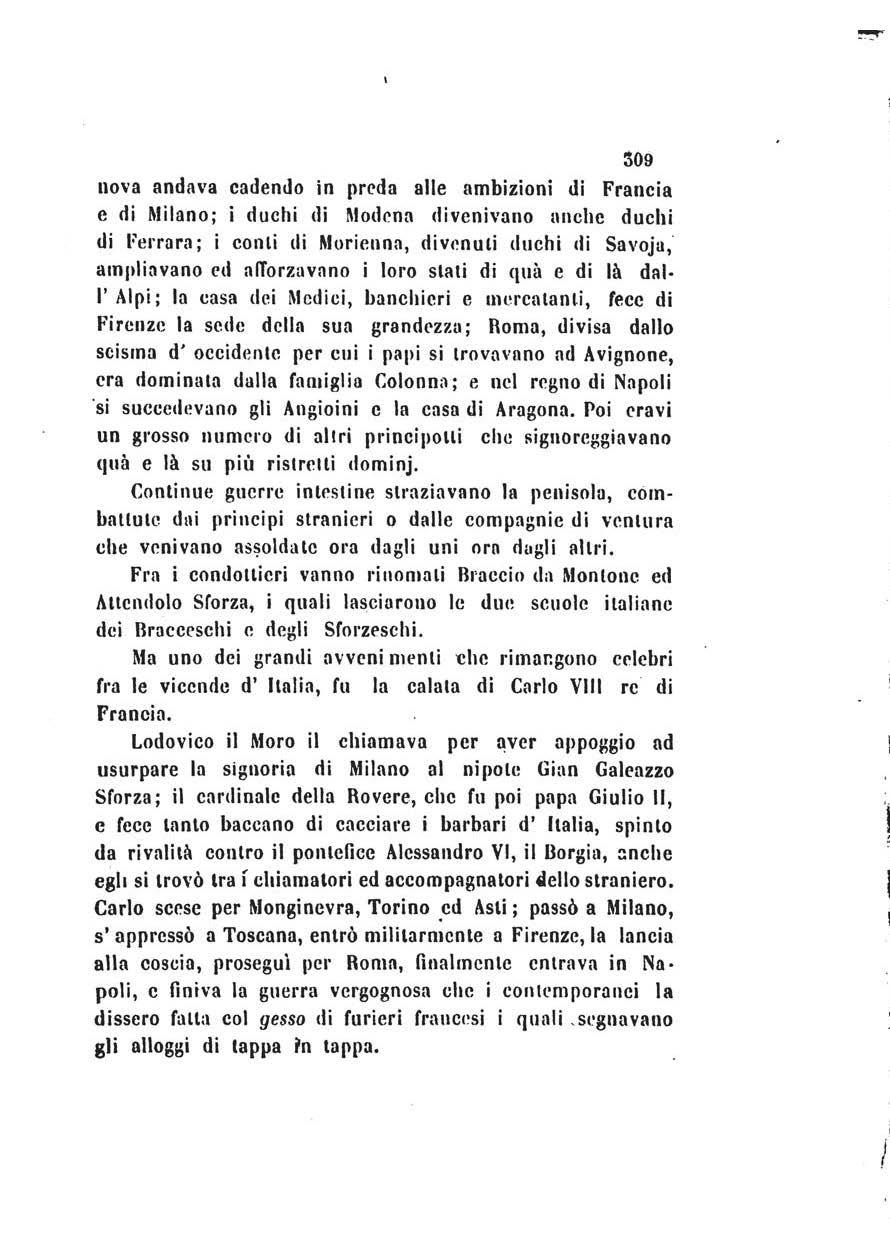
F1·n i condottieri vonno •·inomati Rt'aecio da Montone ed Attcndolo srorza, i quali lasciarono le due scuole italiane dci Bracceschi c degli Sforzeschi.
1\fa uno dci granùi avveni menti -che rimar.gono celebri fra le vicenclc d' llalia, fu la calata di Carlo VIli re · di Francia.
Lodovico il Moro il chiamava per appoggio ad usurpare la signoria di Milano al nipote Gian Galeazzo Sforza; il cardinale della Rovere, che fu poi papa Giulio Il, e fece tanto baccano di eaccint·e i barbari d' Italia, spinto da rivalità contro il pontefice Alessandro VI, il Dorgin, ::nelle egh si trovò tra f chiama tori ed accompagnatori 41ello straniero. Carlo scese per Monginevra, Torino .cd Asli; passò a Milano, s'appressò a Toscana, entrò militarmcnte o Firenze, la lancia alla coscio, proseguì per Roma, finalmente entrava in No. poli, c finiva la guerra vergognosa che i contemporanei la dissero fatta col gesso Ili furieri francesi i quali . segnavano gli alloggi di tappa in tappa.
Allora soJievavasi tutta Italia e mezza Europa: si lf'ga contro Carlo, il quale , minacciato, ripartiva da Napoli, passava per Roma, schiva,·a Firenze, passava per Pisa, e, varcato l'Appennino , trovavo a Fornovo, come dicemmo l'esercito degli alleati italiani, capitanato dal Marchese tli Mantova. lvi combattessi di 6 tli Luglio f 495, c disputasi anche oggi chi vincesse. Fauo è che i francesi avevano combattuto per passare, e passarono, c giunsero prima ad Asti, io Francia.
Riassumendo i falli principali che illustrarono questo secolo, diremo che furono:
1.0 L' invenzione della stampa .
2. 0 d' indipendenza della Francia contro l' Inghilterra.
5.• Scoperta -d' America.
4.0 Guerra d' indipendenza degli svizzeri contro francesi e i borgognoni.
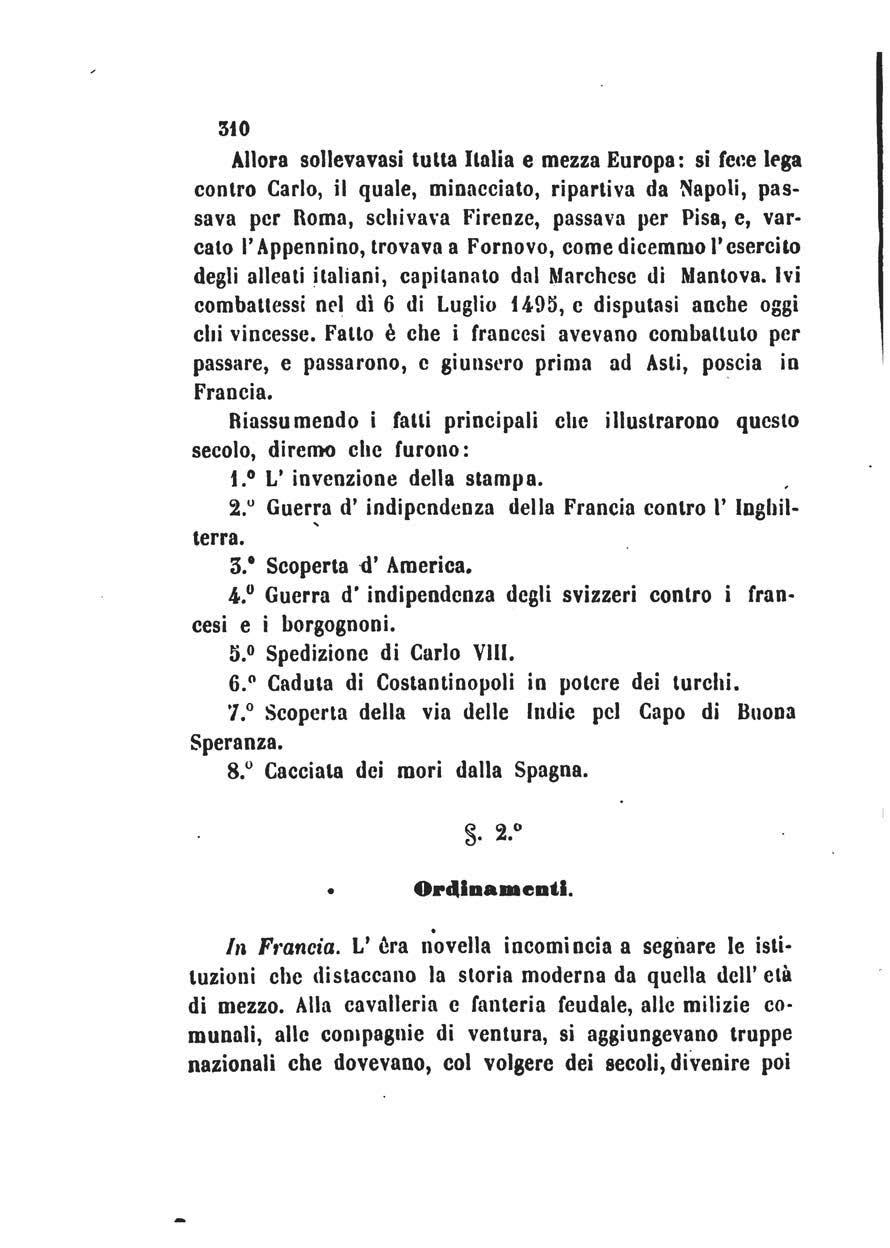
a.o Spedizione di Carlo VIli .
6.° Caduta di Costantinopoli in potere dei turchi . '/, 0 Scoperta della via delle Indie pcl Capo di Buona Speranza.
8.° Cacciata dei mori dalla Spagna.
/n Fmncia. L' era ,{ovella iocomi ocia a segnare le isti· tuzioni che distaccano la storia moderna da quella dell' etÌl di mezzo. Alla cavalleria c fanteria feudale, alle milizie comunali, alle compagnie di ventura, si aggiungevano truppe nazionali che dovevano, col volgere dei secoli , divenire poi
511 le esclusive degli eserciti. Al principio del reclutamento fondato sul concorso de' signori c de' loro dipendenti, sulla convocazione di cittadini alla rinfusa, sull' acquisto d' una masnada mediante danaro, s'in tr odusse di nuovo il prin· cipio non però ben compiuto, nè ben definito, nè bene ap. plicato, dell' obbligo dei cittadini di servire colle armi il proprio paese.
Carlo VII, dopo avere riconquistato il suo regno invaso dagl' inglesi, volle ratTerrnare la sua potenza so!ltcucndola trupJH! regolari e permanenti, che ponessero il suo eser•:tto n livello delle nuove istituzioni militan le qunli andavano sorgendo negli altri paesi, ed cmancipas!lcro lui dallo necessità di ricorrct·e csclush·amentc al servizio feudale spesso capriccioso e mal sicuro, al sc•·vill.io comuna le tli sovente indisciplinato ed imbelle, al venturiero sempre ladro per l' erario, sempre desolante pel popolo.
Per questo creò i Franchi arcieri per la fanteria, le Compagnie à' ordinanza per la cavalleria.
Ciascuna parrocchia doveva dare c mantenere un arciere, ch'era obbligato a rispondere alla chiamata del re.
Le armi difensive degli arcieri e1·ano giaco e celata; le offensive, arco e daga.
Costituivano quattro corpi di '"000 uomini; uno per ogni circolo mtlitare in cui fu diviso la Francia. Ogni corpo si suddivise in otto bande di uomini.
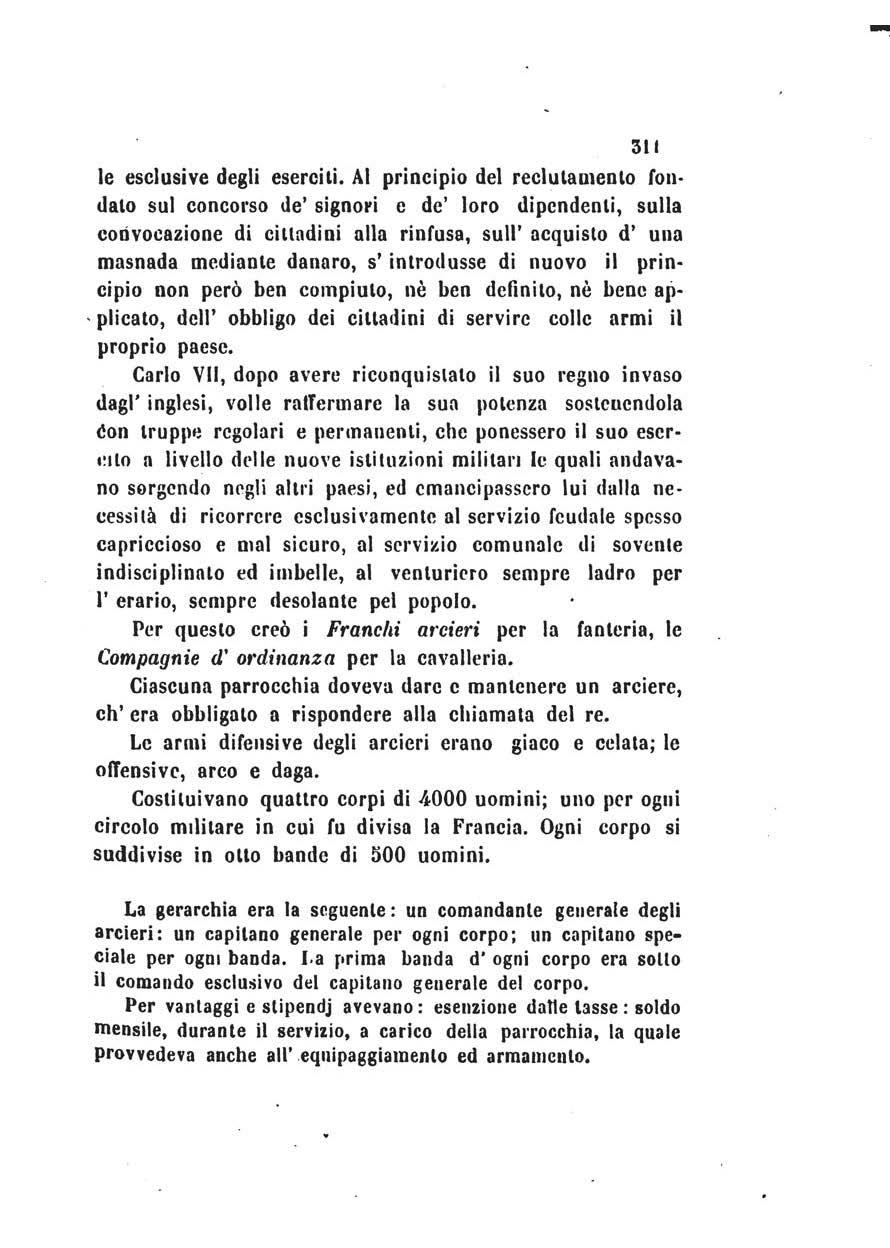
La gerarchia era la sr.guente: un comandante generale degli arcieri: un capila no generale pet· ogni corpo; un capitano speciale per ogot banda. J,a prima banda d' ogni corpo era solto il comando esclusivo dd capitano generale del corpo.
Per vantaggi e stipendj avevano: dane tasse: soldo mensile, durante il servizio, a carico della parrocchia, la quale provvedeva anche all' .equipaggiamento ed armamento.
Gli esercizj erano individuati; ogni festa s; istruivano gli arcieri nel tiro dell' arco.
Il franco arciere &l'Parte neva al re; poteva essere convocato ad ogni istontr., e per un tempo indeterminato. La nobihà non era più In rappresentante eselusi"Va dell' esercito, e non tardò guarì ad a regolamenti imperiosi .
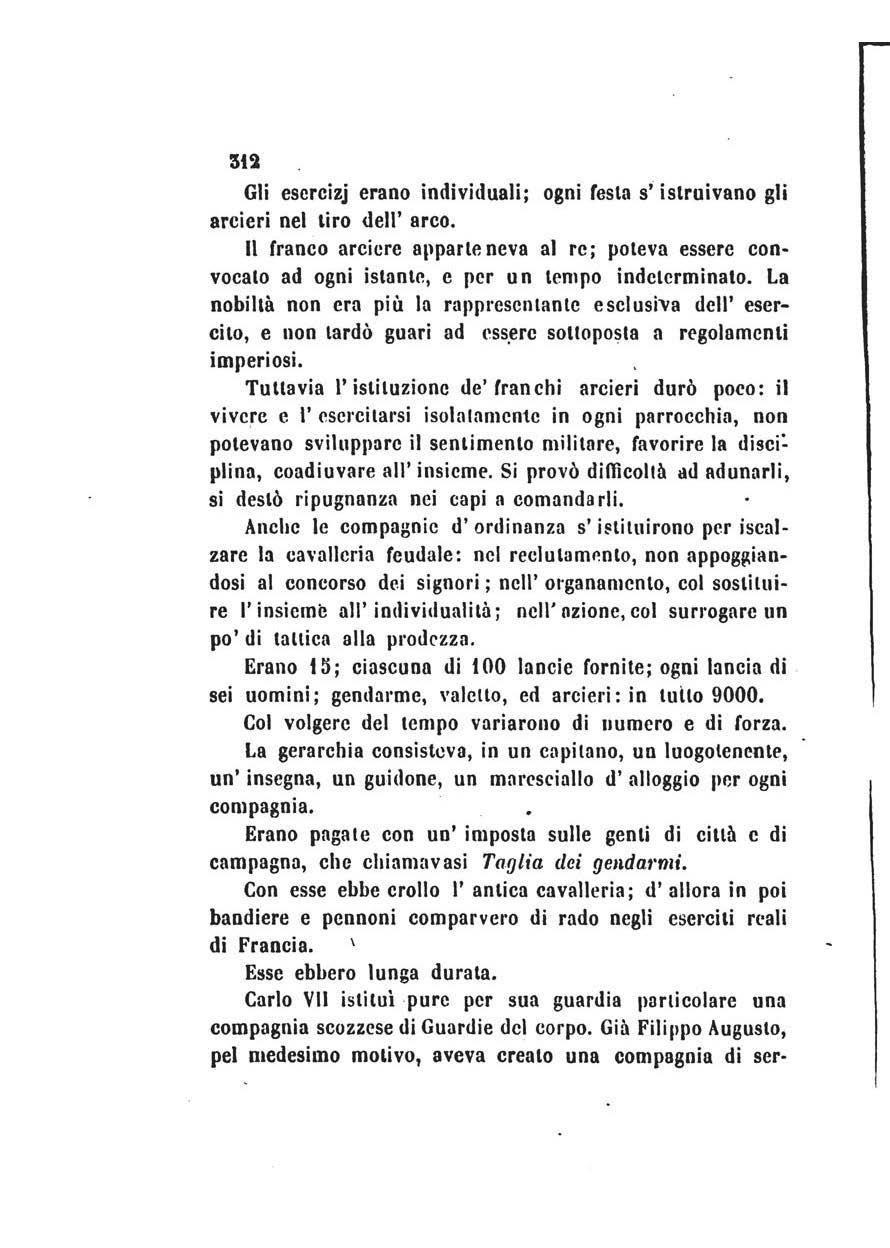
Tuttavia l'istituzione de' fra n chi arcieri durò poco: il vivere e l' cscJ·citarsi isolnlamente in ogni parrocchia , non potevano il sentimento militare, favorire la disci: plina, coadiuvare all'insieme . Si provò diffico l tà lld adunarli, si destò ripugnanza nei capi n comandarli.
Anche le compagnie d ' ordinanza s' per iscaJzare la ca, allcria feudale: nel reclutamP.nto, non dosi al concorso dci signori; nell' oq;anomento, col sostituire l'in sieme all' intlivillualità; nell'azione, col sunognre un po' di tattica alla prodezza .
Erano t 5; ciascuna di t 00 lancie fornite; ogni lanc ia di sei uomini; gentla1·me, \'aiello, ed arcieri: in tullo 9000 .
Col volgere del tempo variarono di numero e di forza.
La gerarchia consisteva, in un capitano, un luogotenente, un' ins egna, un guidone , un d' alloggio pr,r ogni compagnia .
Erano pagate con uo' imposta sulle genti di città e di campagna, che chiamavasi Taglia dci gendarmi.
Con esse ebbe crollo l' antica cavalleria; d' allora in poi bandiere e pennoni comparvero di rado negli eserciti reali di Francia.
Esse ebbero lunga durata .
Carlo VII istituì ·pure per sua guardia particolare una compagnia scozzese di Guardie del corpo. Già Filippo Augusto, pel medesimo motivo, aveva creato una compagnia di ser-
3t3 genti d' armi tutti gentiluomini. A quell' epoca si temevano gli nssassinj dei scttarj il cui capo era il Vecchio della mon· tagna.
Luigi Xl, ch'ebbe a comballerc contro gli svizzeri, s'in· namorò del valore di questi c della . solidità della loro or· dinanza: ne prese soldo; ne imitò la formazione con avventurieri francesi, c assoldò pur anco me1·ccnarj alemanni. Con queste truppe surrogò i franchi arcieri. 1\folti però pre· tendono che, alla sua mort<', ve ne fo ssero ancora in buon numero nell'esercito.
Luigi Xl prediligeva la fanteria; rappresentava il po· tcre regio il quale cct·cava domare i grandi vassalli, orgnnare potenti forze militari, c introdurre l'un ità nel governo c nell' amministl'aziooe.
Curò l'istruzione delle truppe; cd approfittando del tempo di pace, stob_ilì a Pont-de-l' Arche un campo d'istruzione. Obbligò pure i ·suoi geod armi a riviste frequenti, a una disciplina in certo modo severa, e li costrinse a diminuire il loro bagaglio.
Carlo VIII continuò a raccogliere le fanterie con elementi interni e con assoldamenti fra gli stranieri. La df!scrizione del suo esercito, che daremo negli esempj, porgerà un'idea del modo in cui era formato.
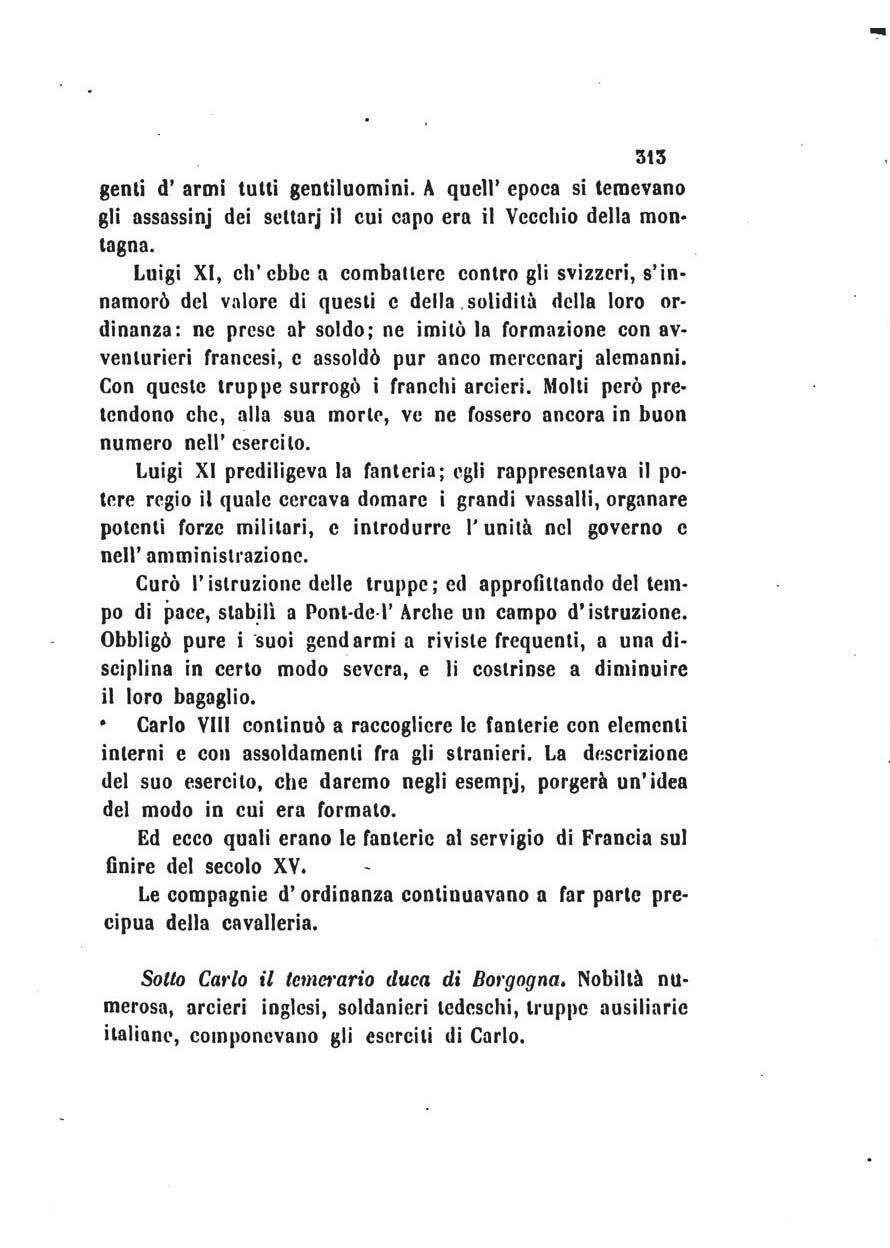
Ed ecco quali erano le fanterie al servigio di Francia sul finire del secolo XV.
Le compagnie d' ordinanza continuavano a far parte precipua della cavalleria.
Sotto Cat'lo il tcmct'ario duca di Borgogna. Nobiltà nu· merosa, arcieri inglesi, soldanieri tedeschi, truppe ausiliarie italionl', componevano gli eserciti di Carlo.
Vi prevaleva la cavalleria; Carlo disprezzava le genti a pi ed i. Qucs tr. erano in gran parte destinate a difcn1ferc carriaggi c l' artiglieria.
L' r.sr.rcito 11i f.arlo aveva molte :mni da fuoco.
Codesto re organizzò pel primo una sr,ecie di contabilità; il capitano dovca sempre portare un ruolino cou sè.
Adrlestrò alquanto la fanteria c la cavalleria a parecchi esercizj; e, fra gli altri, si assuefacevano i picchie ri , schierati in· nauzi agli arcieri a cavallo, a porsi in ginocchio e ad abbassare la picca per lasciar lib er o il tiro all' arciere, a formarsi in una l'pecie di quadrato o di massa rotonda per resistere all'assalto del nemico ;.si abituavano al'cieri a cavallo a discendere di sella e a tirar d'arco, ad attaccare et! imbrigliare i loro cavalli assieme , a marciare dietro <li paggi e agli uomini d'armi, e ad altre cose di simil genere.
Carlo il temerario rappresentava la fcn.dalità arrogante c snJwrba che credeva di poter fondare un impero scozn po· polo c senza punto centrale.
In Italia. Mancavano gli elementi per costituire una vera' milizia: ness un altro sc l'vigio si ·potea trarre. dalla cemunalc oltre a quello di una difesa momentanea c locale Per· ciò gli stati continuarono n valersi dci venturicri.
Le prime compngnic di ventura, come si scorge da quanto abbinmo esposto, erano composte di slraniet·i, sebbene parecchie fossero comandate da condoLLieri italiani. Ma sul fi. nit·c del scc.olo XIV, sorsero varie compagnie italiane, e principale fra esse fu CJUella di S. Giorgio formata da Alberico da Barbiano che sconlìsse i brettoni olia baltnglia di Marino. Al suo csr.mpio se or. crearono altre in tutto o in gran parlc ll' italiani; fra le poi meritano parli colare . menzione quelle di Dmccio c di Sforza.
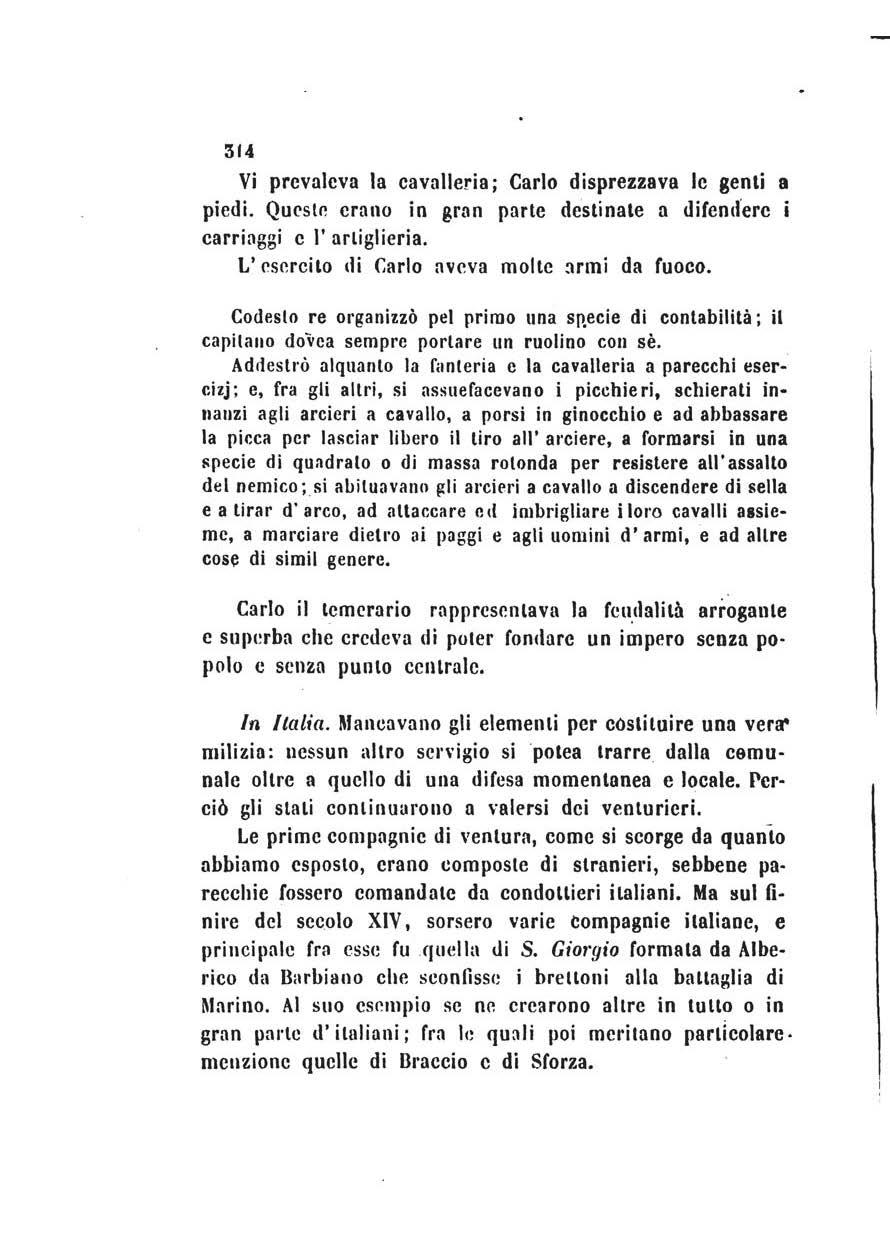
Allorquando la conclusione di una pace, od un ammu tinamento; suscitava fra le soldnteschc s traniere il proposito di riunirsi in compagnia, esse cleggevansi un capo, col quale diventavano comuni le imprese cd i guadagni . Le risoluzioni del capitauo d1pcudcvono da un con siglio nominato dalle schicrc; e siccome l'esistenza di codes te compagnie non era ass icurata dal possedimento tli alcune terre o provincia, così essa durava solo quanto glielo permette va la propl'ia fortuna o la dappocaggine altrui.
Non in sifTaua guisa passavano le cose nelle compagni e italiane. l con <lotticri le adunavano a poco a poco, cominciando da amici e congiunti; laonde il capo non era eletto dai soldati ma cm desso che li sceglieva c li riuni\'a: per con seguenza vi era un po' più di disciplina. Divenivano poi capi di compagnia i feudatarj di castelli e di teni.•te, o i gucr· rieri in grande fama di bravura. Nel primo caso la compagnia compoocvasi di vassalli, di dipendenti, e di uomini di masnada; nel secondo di antichi camerati c di seguaci divoti. Il capitano trattava a suo arbitrio coi principi , e pa· gava del proprio la compagnia; quindi cmno sue le imprese, suo1 1 guadagni. ( t ).
La fanteria componevasi di balestrieri, e di altri uomini scelti; e restava .esclusa la turbolenta moltitudine a piedi che si metteva alla coda delle comJiagnic straniere. La cavalleria coinponevasi di lancie.
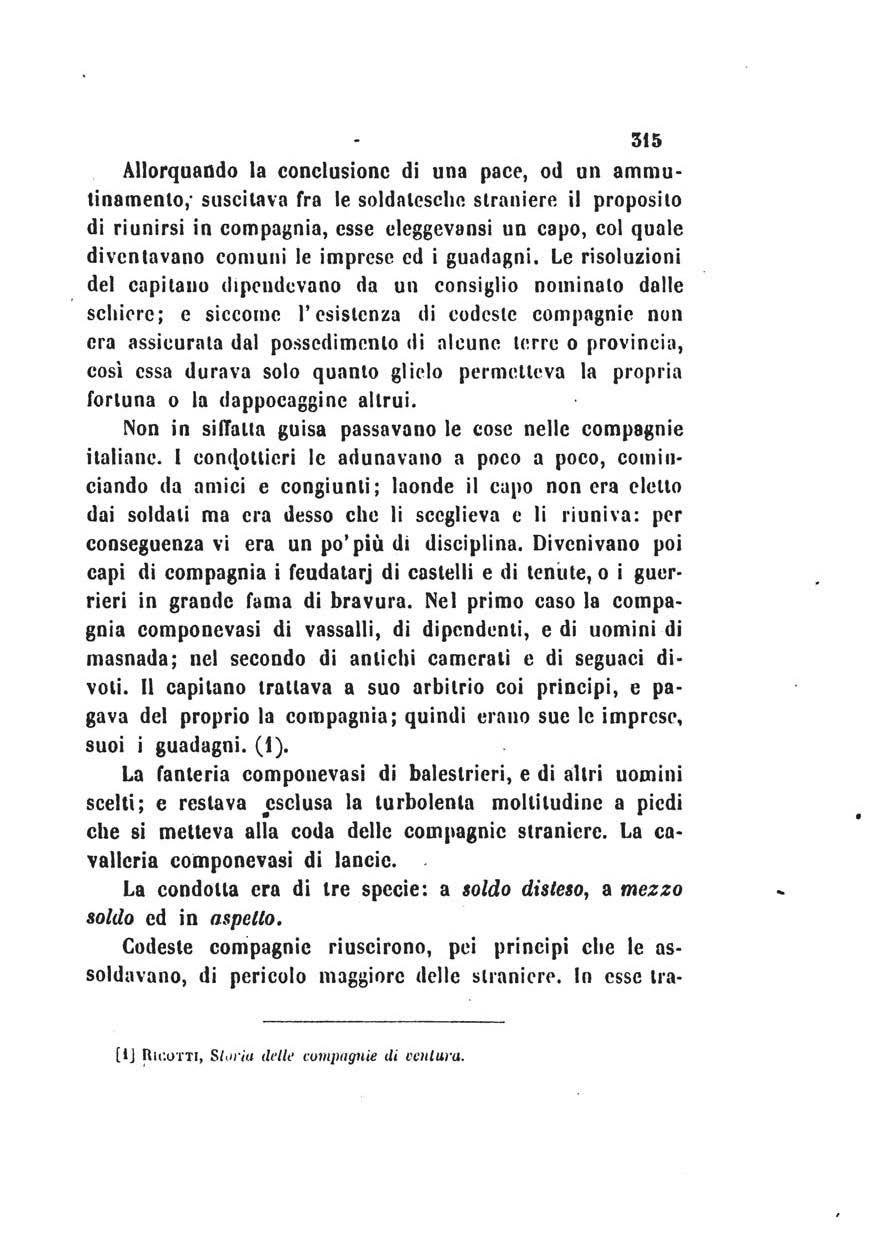
La condotta era di tre specie: a soldo disteso , a mezzo soldo ed io aspetto.
Codeste compagnie riuscirono, pci principi che le assoldavano, di pericolo maggiore delle slrnnicrl' . In esse tra·
S/,wiu
316 smettevasi il comando di padre in figlio i la supremazia assoluta permetteva al condoni ero di proseguire ·a suo agio l' intento che si proponeva; dapprima acquistava ricchezze. colla rapina i poscia colle ricchezze acquistava potenza: in ultimo elevava l'ambizione e cercava procurarsi un principato.
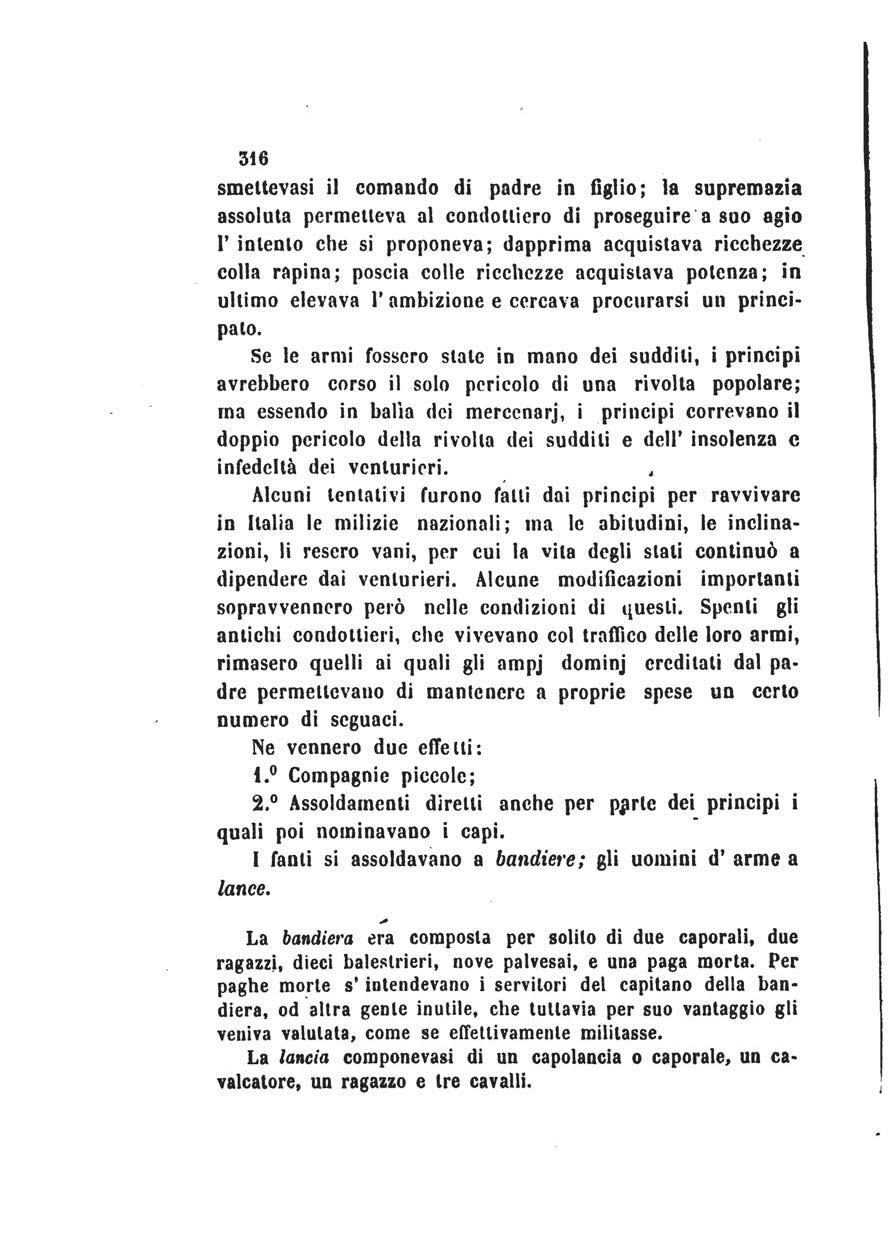
Se le armi fossero state in mano dei sudditi, i principi avrebbero corso il solo pericolo di una rivolta popolare; ma essendo in balia dci merccnarj, i principi correvano il doppio pericolo della rivolta dei sudditi e dell' insolenza c infedeltà dei venturirri.
Alcuni tentativi furono falli dai principi per ravvivare io Italia le milizie nazionali; ma le abitudini, le inclinazioni, li resero vani, per cui la vita degli stati continuò a dipendere dai vcnturieri. Alcune modificazioni importanti soprnvvennrro pea·ò nelle condizioni di 4uesti. Spenti gli antichi condouiel'i, che vivevano col trnffico delle loro armi, rimasero quelli ai quali gli ampj dominj ereditati dal pa· dre permettevano di manlencrc a proprie spese un certo numero di seguaci.
Ne vennero due effe Ili: t.° Compagnie piccole ;
Assoldamenti direlli anche per Plrlc dei principi quali poi nominavano i capi. • l fanti si assoldavano a bandiere; gli uomini d' arme a la nce.
La bandier·a era composta per solito di due caporali, due ragazzj, dieci nove palvesai, e una paga morta. Per paghe morte s' intendevano i servitori del capitano della ban· diera, od ·altra gente inutile, che tullavia per suo vantaggio gli veniva valutata, come se elfellivamente militasse.
La lar.cia componevasi di un capolancia o caporale, un cavalcatore, un ragazzo e tre cavalli.
Le armi difensive dei fan li erano, rotelle e poche altre; le oO't!osive, lancie lunghe e sottili, piccole partigiane, balestre. . Verso la fine del secolo XV li ' introdussero alcuni schioppelliel"i ; ma le loro armi erano di cattiva qualità, ed essi lenti ed inetti a maneggiarle.
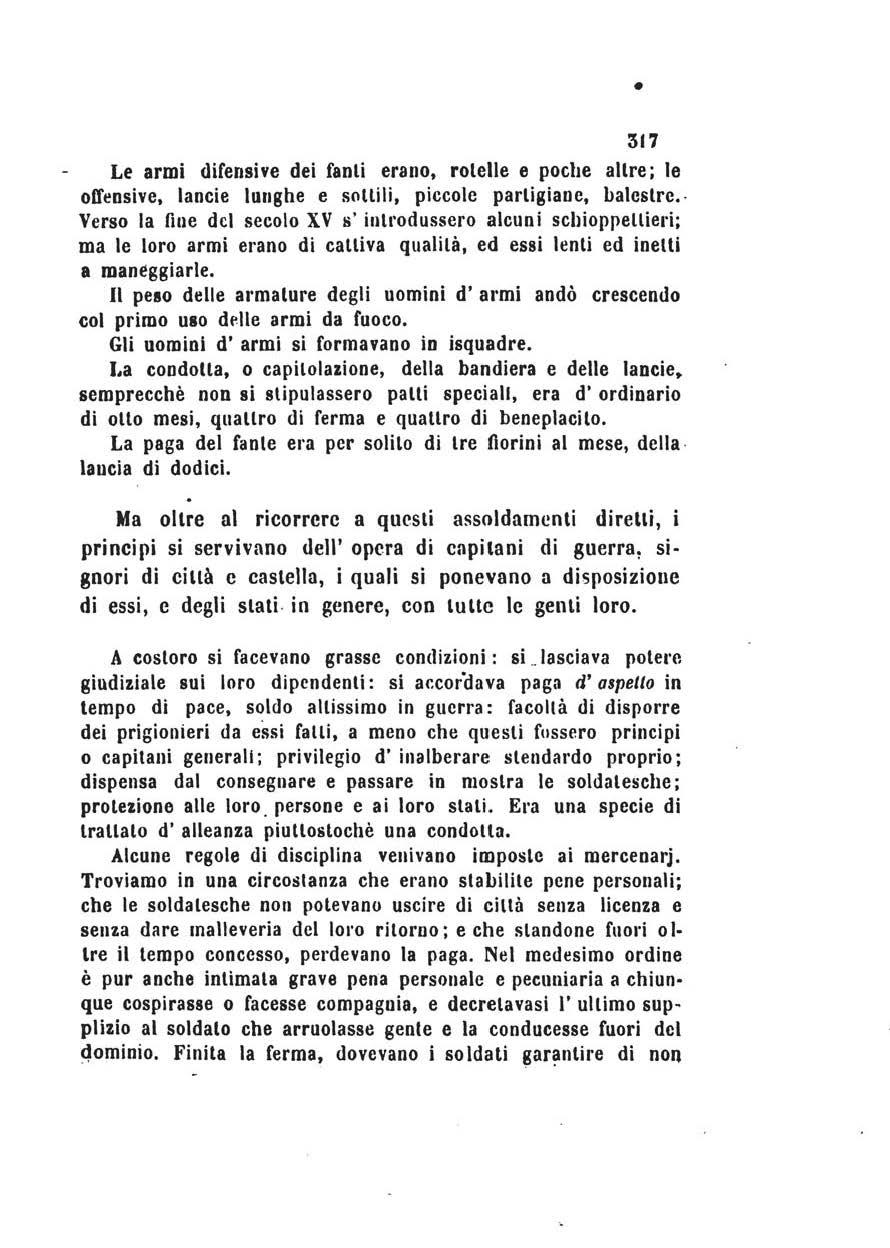
Il peso delle armature degli uomini d' armi andò crescendo col primo uso drlle armi da fuoco.
Gli uomini d' armi si formavano io isquadre.
J.a condotla, o capitolazione, della bandiera e delle lancie. semprecchè non si stipulassero palli speciali, era d' ordinario di otto mesi, qnallro di ferma e quattro di beneplacito.
La paga del fante era per soli lo di tre fiorini al mese, della lancia di dodici.
Ma oltre al ricorrere a questi assoldamenti direlti, i principi si servivano dell' opera di capitani di si· gnori di ciuà c castella, i quali si ponevano a disposizione di essi, c degli stati . in genere, con tutte le genti loro .
A costoro si facevano grasse cond izioni : si lasciava potero giudiziale sui loro dipendenti: si ar.coroava paga d' ospello in tempo di pace, soldo alti ssimo in guerra: facoltà di disporre dei prigionieri da essi falli, a meno che questi fussr.ro principi o capitani generali; privilegio d' inalberare st endardo proprio; dispensa dal consegnare e passare in mostra le soldatesche; protezione alle loro . persone e a i loro stati. E1·a una specie di trattato d' alleanza piutlostochè una condotta.
Alcune regole di disciplina venivano imposte ai mercenarj. Troviamo in una circostanza che erano stabilite pene personali; che le soldalesche non potevano uscire di città senza licenza e senza dare malleveria del lo•·o ritorno; e che standone fuori o J. tre il tempo concesso, perdevano la paga. Nel medesimo ordine è pur anche intimata grave pena personale e pecuniaria a chiun· que cospirasse o facesse compagnia, e decretavasi l'ultimo sop · plizio al soldalo che arruolasse gente e la conducesse fuori del Finila la ferma, dovevano i so ldati di non
318 uscire dalla citlli prima della grida solenne: fatta questa grida, soddisfacevasi col residuo d P-Ile paghe ai loro creditori; quindi i magistrati obbligavano le schiere a giurare di non portare le armi contro il principe, e le mandavano ton Dio. Nel ·caso che alcuno fosse partito prima della grida, doveva venir de"signato per traditore e bandito nella persona, e il suo mallevadore doveva essere condannato a pagare al fisco tutto il prezzo della sua condotta.
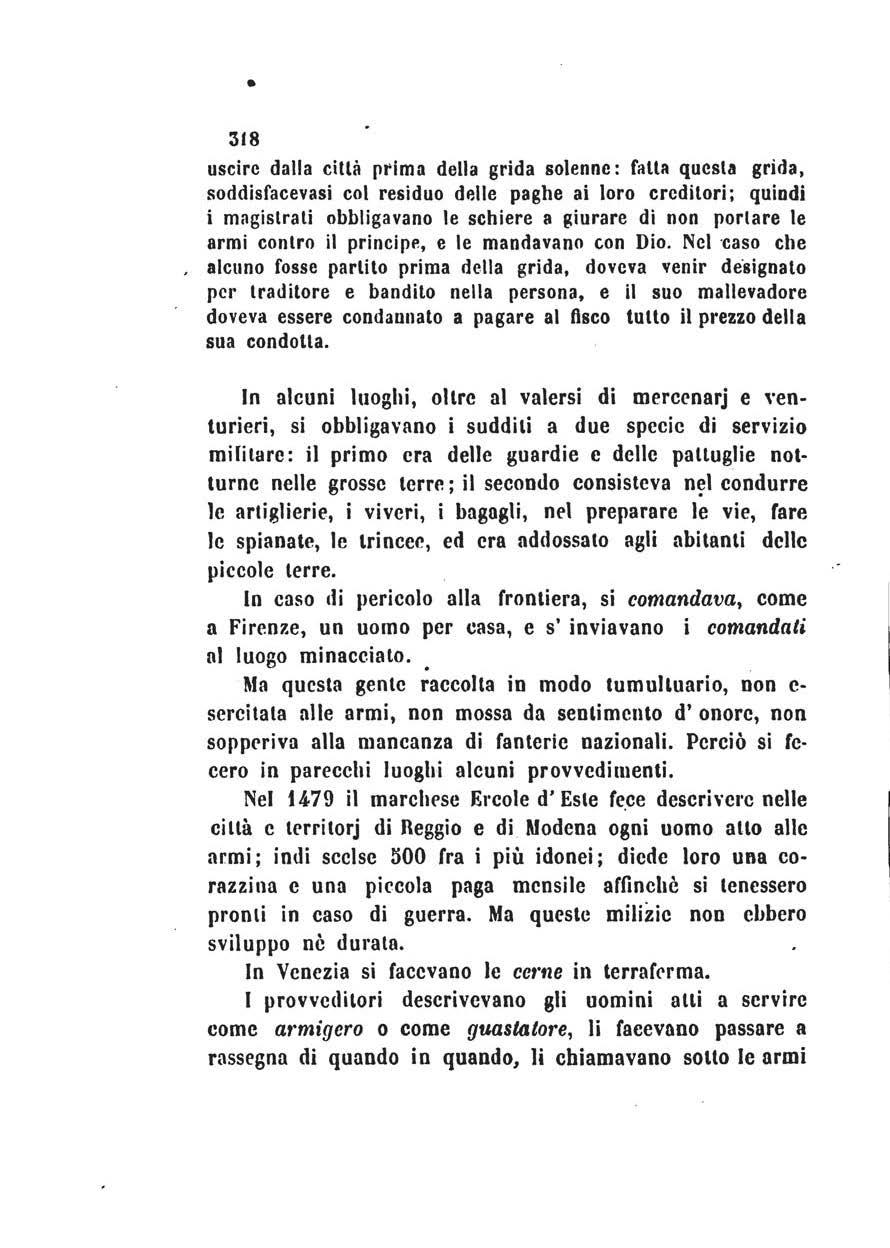
In alcuni luoghi, oltre al valersi di e , ·enturieri, si obbligavano i sudditi a due specie di servizio militare: il primo era delle guardie c delle pattuglie notturne nelle grosse terre; il secondo consisteva condurre l e artiglierie, i viveri, i bagagli, nel preparare le vie, rare le spianate, le trincee, ed era addossato agli abitanti delle piccole terre.
In caso di pericolo alla frontiera , si comandava, come o Firenze, un uomo per casa, e s' inv iavano i comandati nl luogo minacciato. • .
Ma questa gente raccolta io modo tumuJtuario, non esercitata nlle armi, non mosso da sentimento d' onore, non alla mancanza di fanterie nazionali. Perciò s i recero in parecchi luogh i alcuni provvedimenti.
Nel t479 il marcht>se Et·cole d' Este re.ce descri\·c•·c nelle città c territorj di Reggio e di Modena ogni uomo atto alle armi; indi scelse 500 fra i più idonei; diede loro una corazzina c una piccola paga mensile affincbè si tenessero pronti in caso di guerra. Ma queste milizie non ebbero sviluppo nè durata.
In Venezia si facevano Jc ce,.ne in terraf<'rma.
l provveditori descrivevano gli uomini alLi a servire come at·migero o come guastatore, Ji facevooo passare a rassegna di quando in quando, 1i chiamavano sotto le armi
319 in circostanza di guerra, e distribuivano i corichi di mantenimrnto sui comuni. Sui primordj si davano loro armi da lancinrc o da mano; i n srgui lo armi Ila fuoco il eu i maneggio era IOI'o insegnato lln abili tiratori che si facevano venire da lontano. Oltre alle vi r1·nno i pnrtiyin11i, o \'oloutarj, che facevano il servizio di fanterin Nondimeno, il modo parziale di rrclutamcnlo rese imperfetti questi ordini, c poco giovevoli siiTatte milizir.
La repubblica t1i Venrzia ricorse anr.hr all' ossoltlamcnto di una eavalh•ria straniera, allora in gll Strmliotti, o Cappelletti, o Albanesi Era una cavalleria lcggier:t sòrln per opporsi in pntria alle escursioni tlci turchi.
Avevano cavalli snelli c lrsti; soppravesti corte con lc(lgiPri imbottili; tal uno portava maniche e guanti di ferro; avevano un bastone, lungo dirci o dodici piedi, ferralo in cima, che serviva d'arme in asla c •la liro, ed era dello Zaf}aylia; portavano in capo un bacinetto tli ferro, al braccio un piccolo scudo, al fianco una larga spada, all'arcione una mazza d' armi.
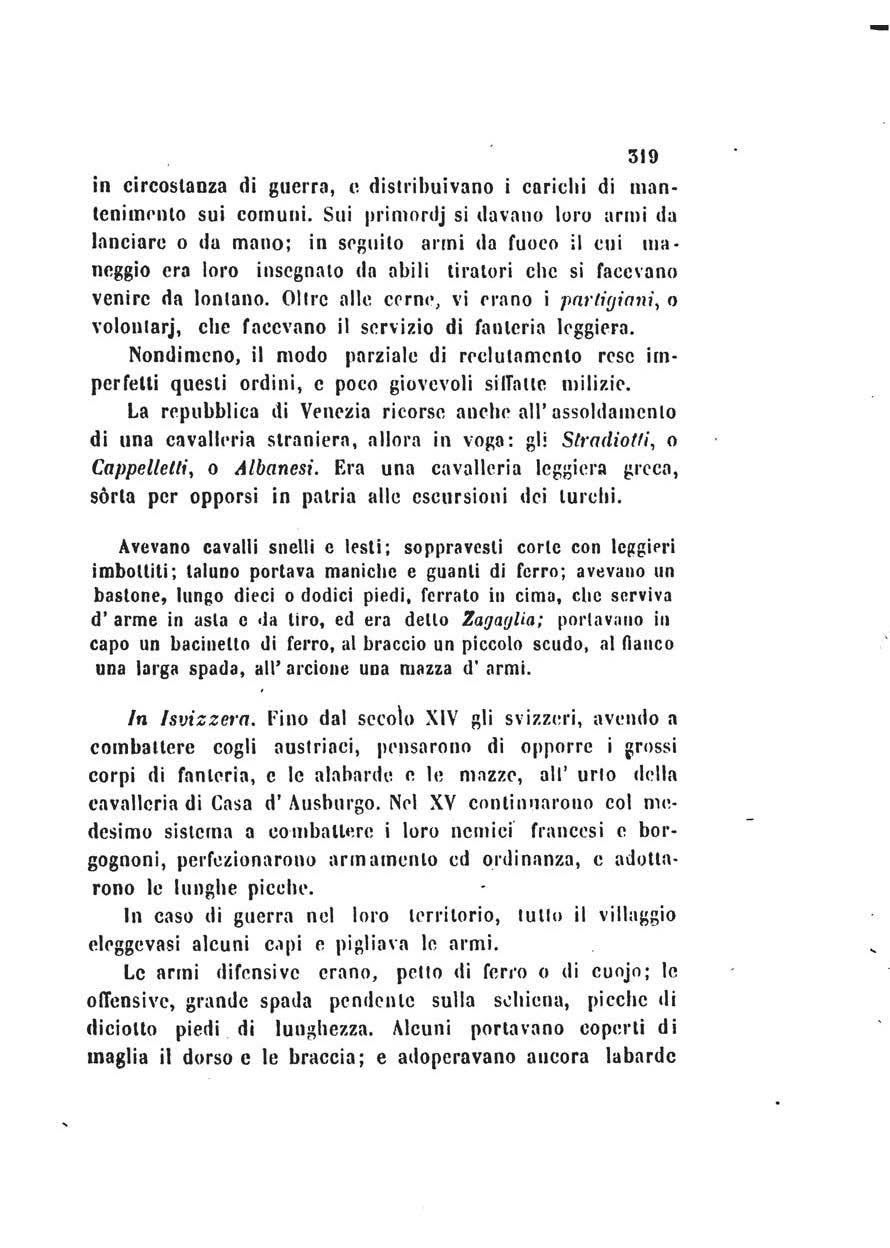
In /svizzera . Fino dal scco\u XIV gli svi?.ZI!I'i, avendo a COmbattere cogli :mstrioci, llt'llS:\rOIIO di Opporre i srossi corpi di fantcri'a, e le c le mnzzr, all' urto !Iella cavalleria di Cnsa d' Aushmgo. Nrl XV contin•J:tl'ono col medesimo sistema n co·mball•!rc i loro nemici' francesi c borgognoni, perfclionarono armamento cd ordinanza, c adottarono le lunghe picchl'.
In C<lSO di guerr<t nel loro territorio, tullo il villaggio eleggevasi alcuni c.1pi e pigli:n·n le armi.
Le armi difensive erano, petto di ferro o di cuojo; le offensive, g1·ande spada pendente sulla s\!hicna, picche 1li diciotto piedi di lunghezza. Alcuni porta vano copet·ti d i maglia il dorso c le braccia; e a1loperavano ancora labnrdc
lunghe tre braccia, col ferro in punta acuto, e più in giù rivolto a forma di scure.
Educavansi alle at·mi; istruivansi nel di esse; i le somministravano ai più poveri, c di quando io quando passavano in rassegna .ed esercitavano gli uomini di ciascun villaggio aLLi alla guerra.
lntrodollc le armi da fuoco, si diedero ad imparare il maneggio delle bombarde.
Le leggi principali di disciplina erano: obbedienza ai capi; silenzio nel combattimento; non abbandonare le file; non fare sedizioni·; non fuggire ; uccidere il compagno che volgesse il dorso al nemico : non gettare le armi; non isbandarsi per botlino sino a vittoria completa e ad ottenuto permesso; noo aa·dere gli ediOcj; non guastare molini e chiese; non otTendere donne e sacerdoti inermi; non dar quarlie1·e durante la mischia.
Pena la morte ai trasgressori.
Questi erano gli svizzeri combattenti in casa propria, per la loro libertà, per la loro indipendenza. Ordinamento saggio, scopò santo. In questa guisa essi rappresentavano l' elemento popolare, l' associazione, io opposizione all' elemento feudale, all' uoru!> d' armi.
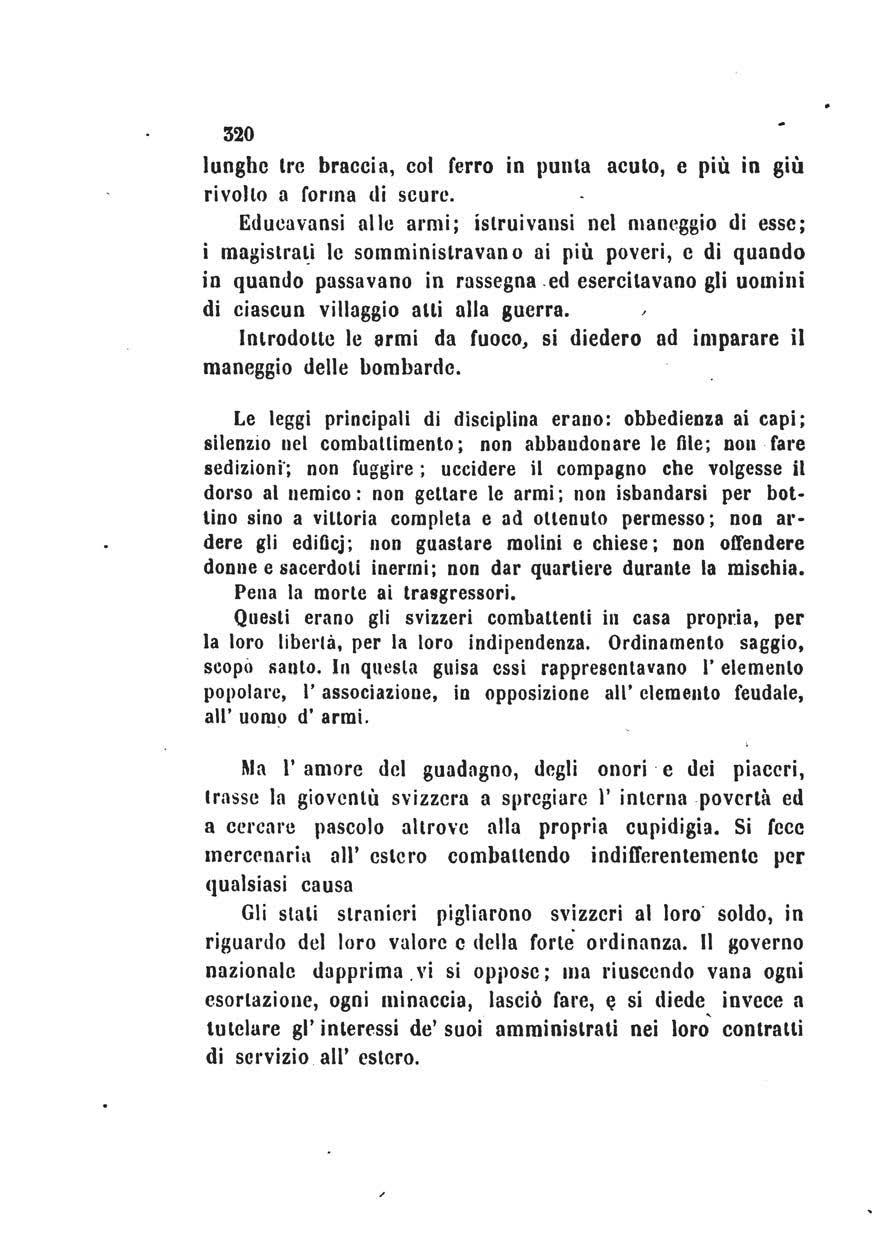
Ma l' amore del guadagno, degli onori · e dei piaceri, trasse la gioventù syizzera a spregiare l' interna .povertà ed a cercare pascolo allro\·c alla propria cupidigia. Si fece mcrcr.naria alJ' estero comballendo indifferentemente per (}Ualsiasi causa
Gli stati strnnicri pigliarono svizzeri al loro· soldo, in riguardo del loro valore c della fortè o1·dinnnza. Il governo nazionale dapprima . vi si oppose; ma riuscendo vana ogni esortazione, ogni minaccia, lasciò fare, si diede invece n tutelare gl'interessi de' suoi amministrati nei loro' contratti di servizio . all' estero.
I cantoni regolarono essi medesimi le condizioni d' assoldamento; e stabilite queste collo stato straniero richiedente, or· dinayano il reclutamento pel numero fissalo, e nominavano al· cuui a presiedere all' adunamento, all' armamento, alla partenza, ed a seguire le soldalesche fuori di paese, tanto per proteg· gerne gl'interessi, come per sorvegliarne la condotta. l capi erano solitamente nominali dai cantoni. l soldati giura.vano, prima di partire, di osservare le pàtrie leggi di guerra, e di servire onoratamente colui al cui soldo andavano a militare. •
Il cantone guarentiva ad ambo le parti l' adempimento dei patti, e permetteva d'inalberare il suo stendardo•
.
In Germania. Anche quivi si assoldavano mcrccnarj, specialmente nei circoli tedeschi prossimi al Reno. L' impe· ratorc Massimiliauo l s i pose a disciplinare le turbe inquiete c disordinate che aveano dato a pensare ai suoi anteccs· sori; diede loro una lancia e una daga, li istruì, e fe1 sorgere in questa guisa la fanteria detta dei Lanzicheneccld.
Avevano per armi difensive, corsaletto, barbuta o morione in capo; per offensive, lunga picca, spada o daga corta e larga.
L' ordinall:la era profonda c serrata.
Vendevano i servigj come gli svizzeri; quindi, per interesse di mestierE!, erano emuli di questi. per indole e per calcolo; belli di presrnza, pieni di vizj; feccia di canaglia che desolò l' Italia nostra, e ogui paese infr.stato dalla loro presenza.
Un ambasciatore veneto li descriveva come dis"bbedienti, arroganti, imllriacbi; che 11on temeva la morte, ma che 111111 aveva nulla rli iuvillo tlltimo; che portava seco molli impedimenti; cb' era della fante, e più ancora della sete; i cui ci:tpilani non volevano che si facesse la rassegna più di una volla; e volevano che si conlinuasse a sborsare sempre le medesime paghe sino alla fine della guerra, ancorcbè pochi ve ne restassero.
Stor. dell' ArL Milit. 21.
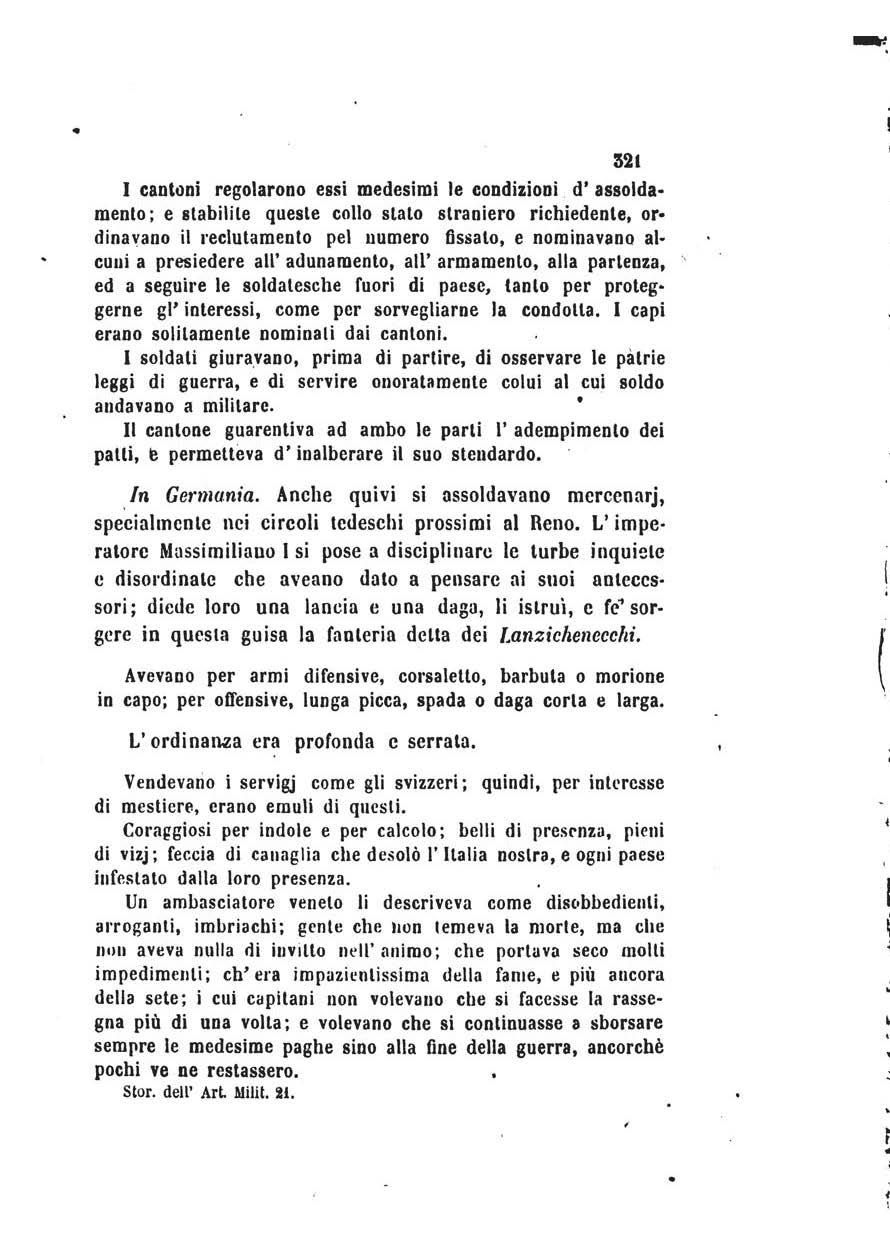
La cavalleria tedesca non era tenuta in gran conto, per la grave:tza dei cavalli, per la bassezza delle selle, . per la mancanza .di armatura alle coscie ed alle gambe. dei sol· dati.
Il soldo del fante tedesco t>ra di circa quattro fiorini al mese, quello del cavalliere di dieci o dodici.
/n ls]Jagna: Se la guerra facevasi in paese, allora i grandi vassalli erano a st>rvire il re colla persona propria e con sc•guaci. Lt• comunità somministravano in parte le fanterie; le quali però, stante la poca paga, si raccoglievano a gran fatica .
La paga data dal l'C pel tempo del servizio. Cessato il bisogno, cessava la spesa. Solo rin1aoeva in permanenza uno stuolo di fao ti e cavalli a guardia del sovrano; e duemila gentiluomini avevano provvig ione per esser pronti ' a marciare alla prima chiamata.
Se la guerra facevasi fuori di pat'Sl' , m•ssuno era obbligato a parte. L' àrruolamcnto era · volontario; a suono di tamburo. La paga poca sino alla frontiera; al di là, tanto si guadagnava quanto si vinceva .
l primi spagouoli che vennero in ltalin <'rano così mal messi che furono chiamati Bi sogni. In s<'guito miglior.arono di molto.
La fanteria era male armala; aste corte c soUili; piccoli scudi e partigiane larghe in punta. Consalvo di Cordova diè ai fanti armature di ferro, il brocchiero, la spada e il pu· gnale. Armati io silTatla guisa, si cacciarono fra le picche dei lanzi e degli svizzeri, e fra la cavalleria armata pesantemente, e si acquistarono alta rinomanza.
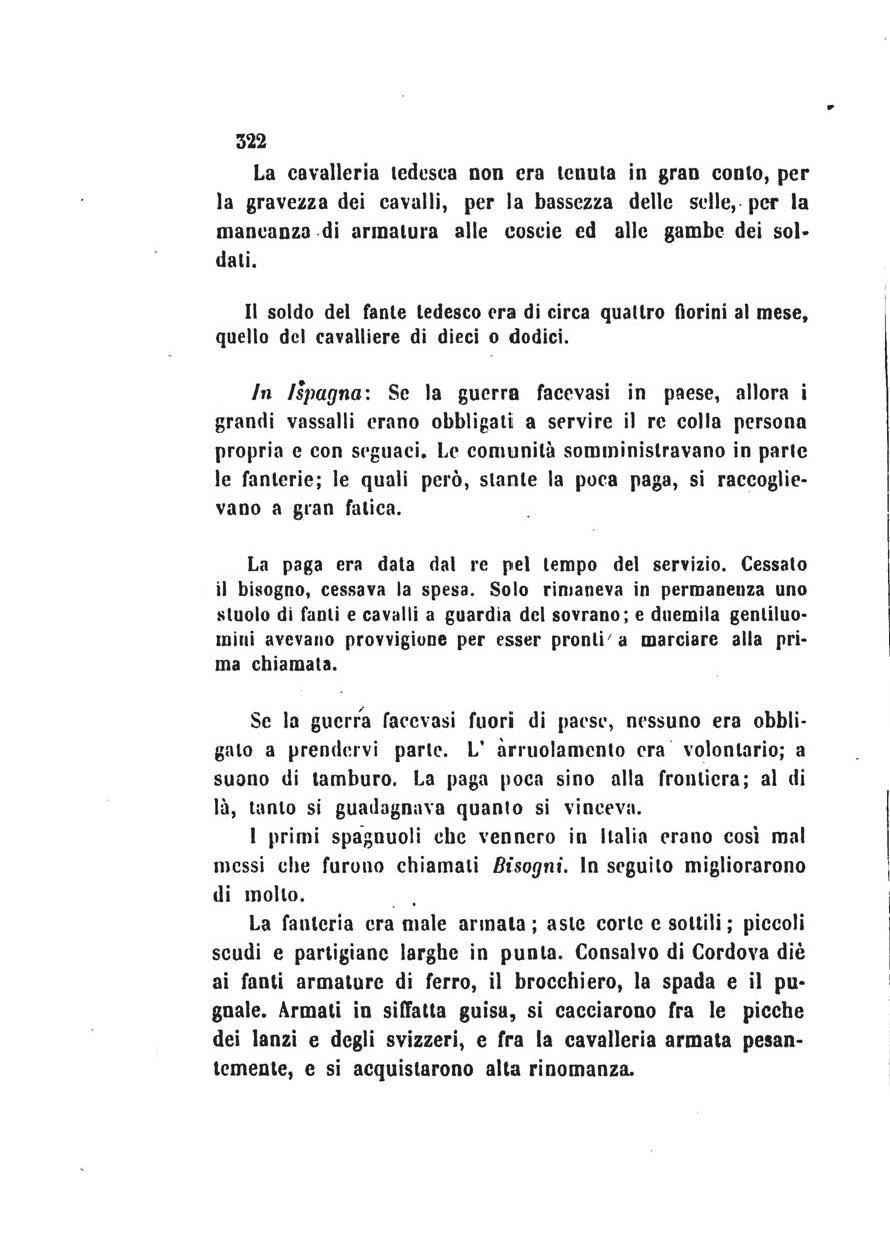
La cavalleria ern al di sotlo della francese c dell' ila· tiana. Era composta d' uomini d' armi c Giannetti. Costoro ·formavano una ca valteri a leggi era; ave a no spada corta, scudo cuneato di cuojo cotto, e lancie o giannetta sottilissime di frassino col ferro largo in punta.
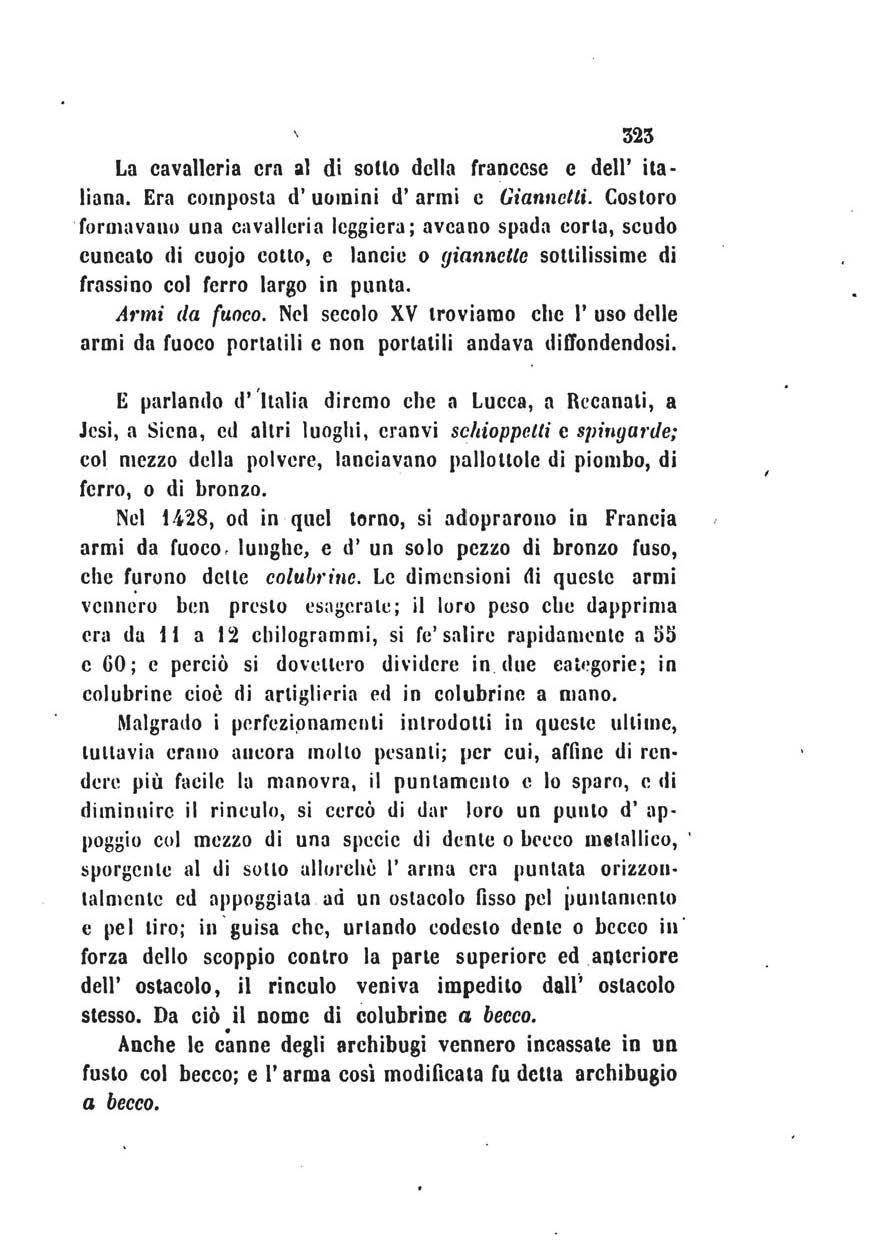
At'mi da fuoco. Nel secolo XV troviamo che l' uso delle armi da fuoco portatili c non portatili andava diffondendosi.
E parlantlo d' ' Italia diremo che a Lucca, a Recanati, a Jesi , a Siena, etl altri luoghi, cranvi scltioppctti c szJingarde; col mezzo della polvere, lanciavano pallottole di piombo, di ferro, o di bronzo.
Nel t4'28, od in quel torno, si adloprarono io Francia armi da fuoco . lunghe, e d' un solo pezzo di bronzo fuso, che furono delle colubrine. Le dimensioni eli queste armi vennero ben presto esagerale; il loro peso che dapprima era du i t a 12 chilogrnmmi, si fc' salire raJlidamcntc a 55 c GO; c perciò si dOH!lll!I"O di\·idcre in . due in colubrine cioè di artiglil'ria ed io colubrine a mano. Malgrado i pcrfczipnamcnli introdotti in queste ultime, tullaviA erAno ancora molto pt·santi; per cui, affine di rcn· dcre più fucile la manovra, il puntamculo c lo sparo, c eli diminuire il rinculo, si cercò di dat· loro un punto d' ap· poggio col mezzo di una specie di dente o brcco metallico, · sporgente nl di sott o ullurchè l'arma era puntata orizzontalmcnlc cd appoggiata aà un ostacolo fisso pcl jmntamcnto c pe l tiro i in ·guisa che, urlando codesto dro te o becco in · forza dello scoppio contro la parte superiore ed .aQtcriore dell' ostacolo, il rinculo veniva impedito dali; ostacolo stesso. Da ciò il nome di colubrine a becco.
Anche le degli archibugi vennero incassate in un fusto col becco; e l'arma così modificata fu detta archibugio a becco .
Si assevera che nel .i 429 s' introdusse a Norif(lbcrga ·il tiro a segno colle armi da fuoco portatili. Nel t 46 t s' introdusse il liro a segno cogli schioppctti &d Augusta; nel t475 a Basilea. ·
Nel t 476 esisteva nella rocca di Guastalla uno schio ppetto rigato ad elica; ed è questa la prima memoria di canne rigate e rigate a spira.
Nel 1487 sì tirava a segno cogli schioppeui e gli archibugi a Lu cca; nel 1490 nella repubblica veneta; nel 1498 con carabine rigate a Lipsia.
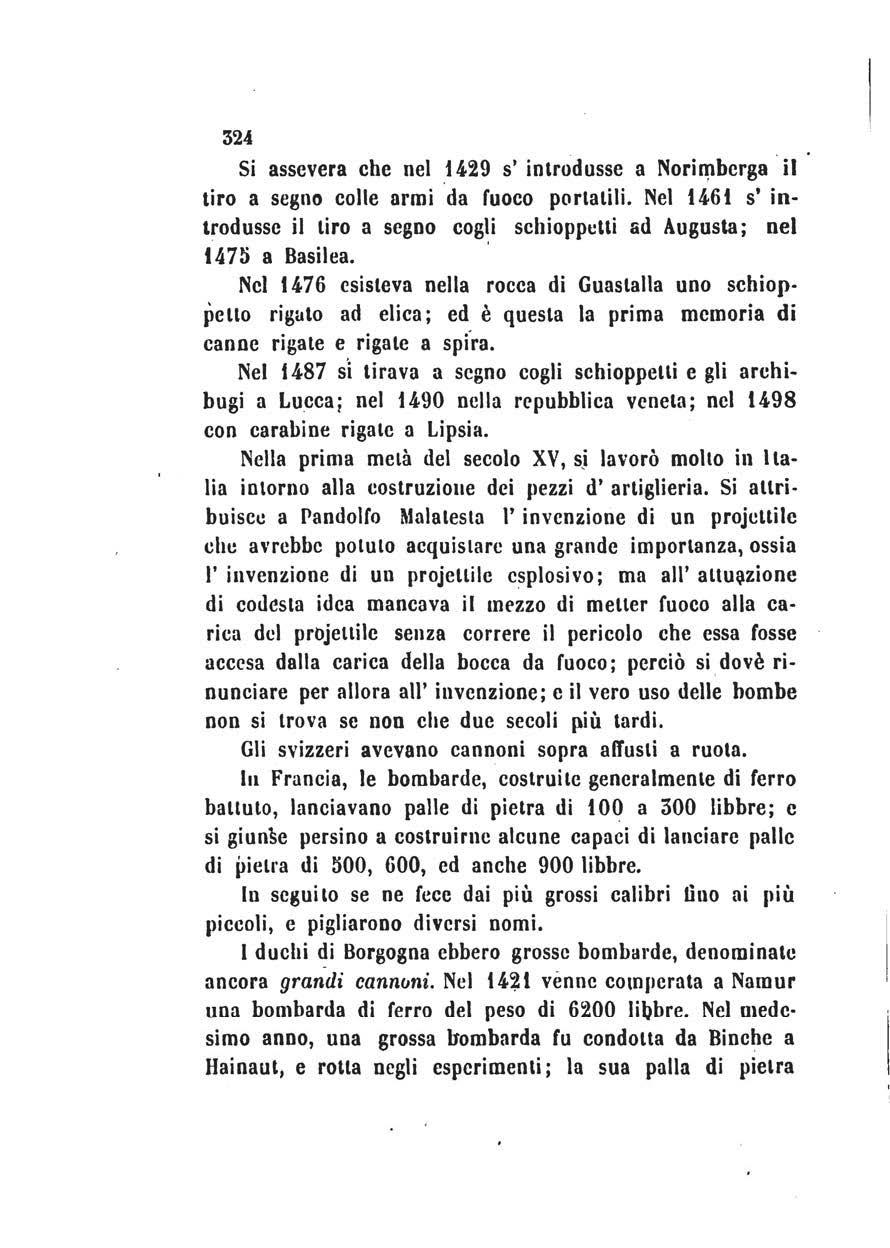
Nella prima metà del secolo XV, s,i la vo rò molto in llalia intorno alla costruzioue dci pezzi d' artiglieria. Si attribuisce a Pandolfo Malatesta l' invenzione di un projcLtilc che avrebbe potuto acquistare una grande importanza, ossia l' invenzione di un projellilc esplosi vo; ma all' di codesta idea mancava il mrzzo di metter fuoco alla carica del projellilc senza correre il pericolo che essa fosse accesa dalla carica della bocca da fuoco; perciò si dovè rinunciare per allora all' invenzione; c il vero uso delle bombe non si trova se non che due secoli più tardi.
Gli svizzeri avevano cannoni so pra affusti a ruota.
In Francia, le bombarde, costruite generalmente di ferro battuto, lanciavano palle di pietra di t a 300 libbre; c si giunse persino a costruirne alcune capaci di lanciare palle di pietra di 500, 600, ed anche 900 libbre.
In seguito se ne fece dai più grossi calibri fino ai più piccoli, c pigliarono diversi nomi.
l duchi di Borgogna ebbero grosse bombarde, denominate ancora gran-di canntJni. Nel t venne cotnJlcrata a Namur una bombarda di ferro del peso di 6200 libbre. Nel medesimo anno, una grossa IJombarda fu condotta da a Hainaut, e rotta negli esperimenti; la sua palla di pietra
pesava 400 libbre. Si fecero ancora bombarde e palle assai più pesanti.
Gl'inglesi facevano bombarde della longhtzza di oJLre tre metri e mezzo; erano formate ·di barre di ferro sovrap· poste come le doghe di una botte e saldate, poi consolidate col mezzo di cerchi combaciati.
Nella seconda metà del secolo XV, 8\' cvamo in Italia , secondo quanto ha scritto Francesco di Giorgio Mnrtiui, le seguenti specie di bocche da fuoco: l.n Bombarda, propriamente della, di rami', eli ferro, o di bronzo; lunga da 15 a 20 piedi ( da 4,m056 a 6, 01 760); e che tirava una pala di pietra di 500 libbre.
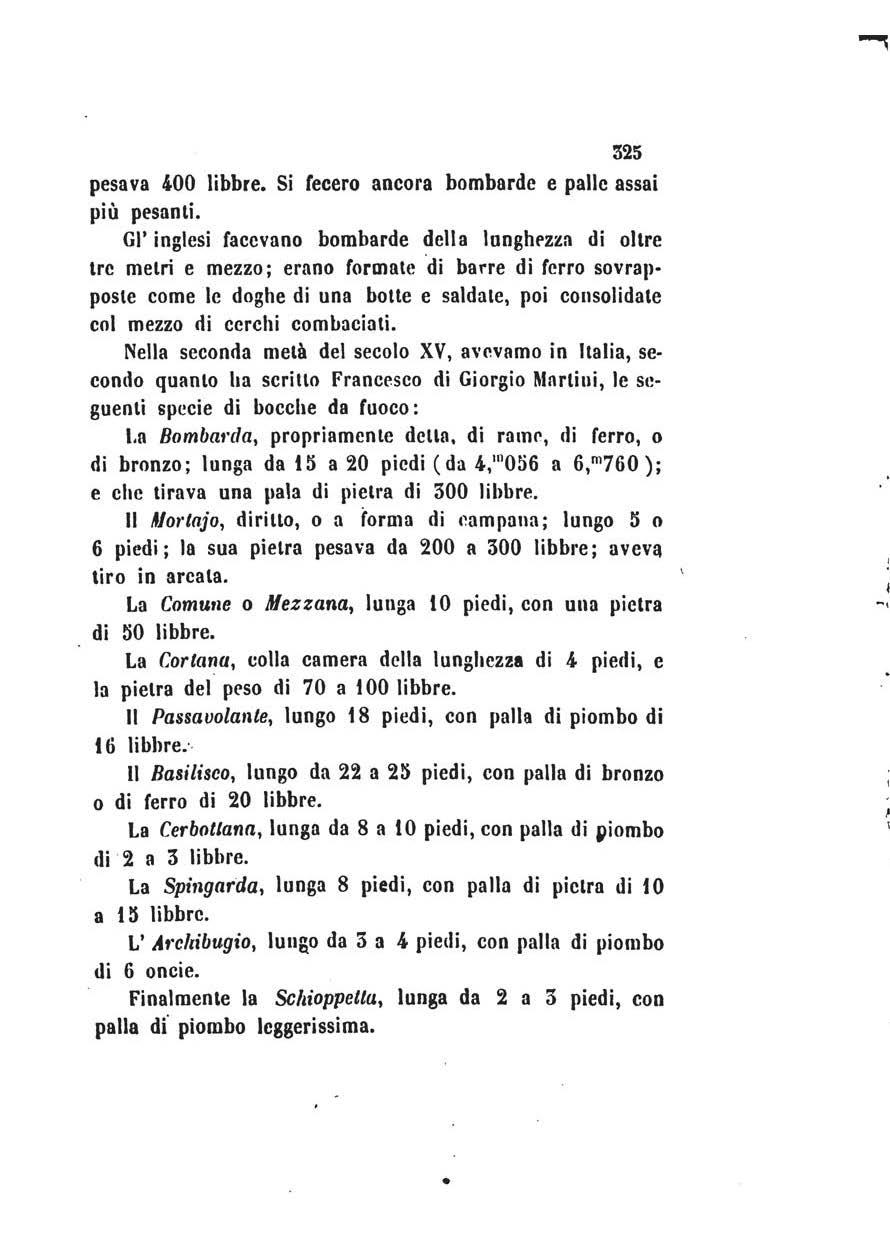
Il Alot·tajo, diriuo, o a forma di lun go o 6 piedi; la sua pietra pesava da 200 a 500 libbre; aveva tiro in arcata.
La Comune o Mezzana, lunga 10 piedi, con una pietra di 50 libbre.
La colla camera della lunghezza di 4 piedi, e 13 pietra del p<'so di 70 a t 00 libbre.
Il Passavolante, lungo t 8 piedi, con palla di piombo di 16 libbre:·
Il Basilisco, lungo da 22 a piedi, con palla di bronzo o di ferro di 20 libbre.
La Cerbottana, lunga da 8 a t O piedi, con palla di piombo di 2 a 3 libbre.
La Spingarda, lunga 8 piedi, con palla di pietra di IO a t !S libbre.
L' At·cltibugio, luuao da 5 a 4 piedi, con palla di piombo di 6 oncie.
Finalmente la ScMoppetta, lunga da 2 a 5 piedi, con palla df piombo leggerissima.
In Francia, sotto Luigi Xl, si fecero fonder e 12 cannoni da 45. Un pezzo del calibro tli !500 venne fuso a Tours, c scoppiò alla seconda prova .
Solto Carlo VIII, si fece uso per la prima volla di bocche da fuoco di bronzo, con palle di ferro e che si puntavano col mezzo dci loro orecchioni. L' artiglieria di questo re distinguevasi per numero e per legger ezza. Ne parlò Giovio descrivendo l' entrata a Roma dello stesso Carlo VIli.
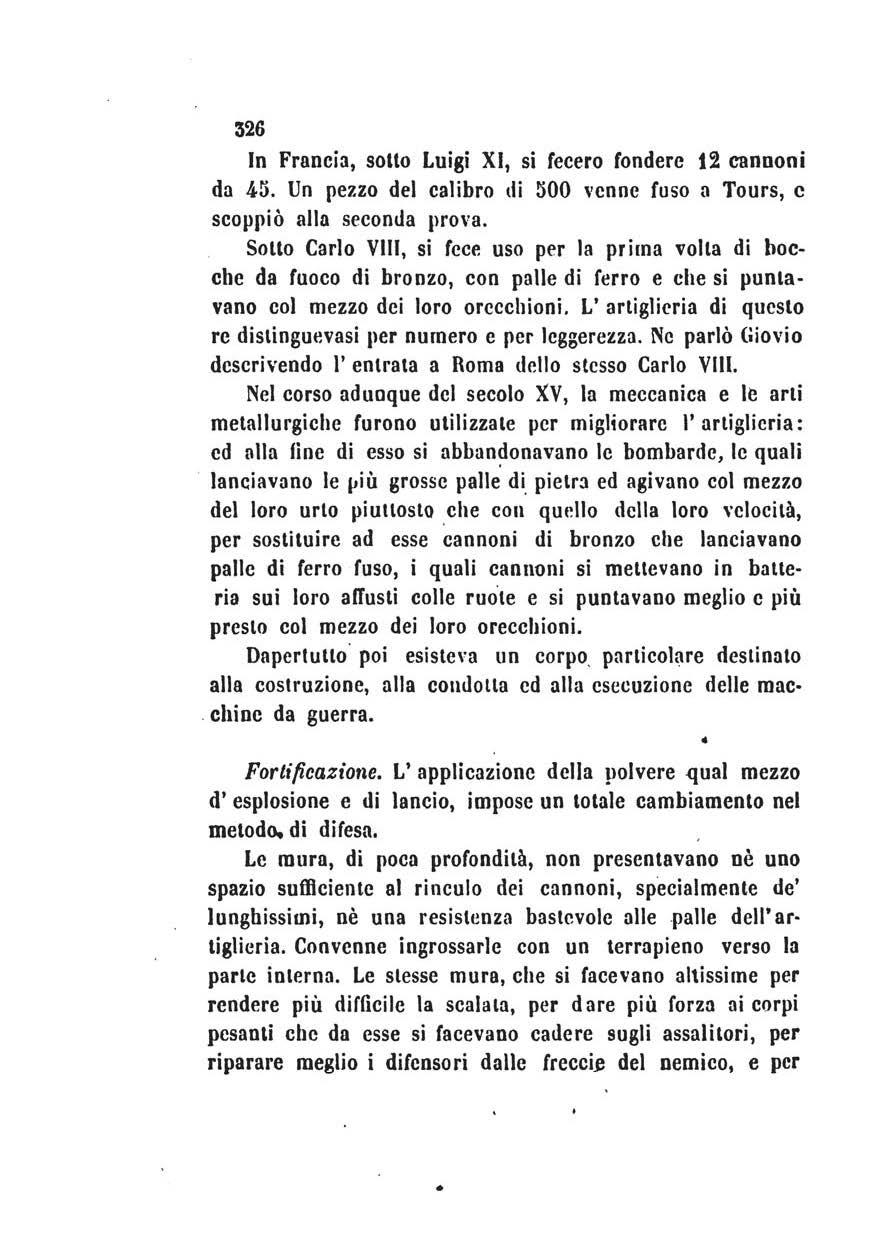
Nel corso adunque del secolo XV, la meccanica e le arti metallurgiche furono utilizzate per migHorarc l' artiglieria: cd nlln fine di esso si le bombarde, le quali lanciavano le jJÌÙ grosse palle di. pietra ed agivano col mezzo del loro urlo piuttosto .che con qur.llo della loro \'Clocità, per sostituire ad esse cannoni di bronzo che lanciavano palle di ferro fuso, i quali cannoni si mettevano in batteria sui loro affusti colle ruote e si puntavano meglio c più presto col mezzo dei loro orecchioni.
Dapertutlo · poi esisteva un corpo. destinato alla costruzione, alla condotta cd alla esecuzione delle mac. chine da guerra.
Fortificazione. L' applicazione della polvere .qual mezzo d' esplosione e di lancio, impose un totale cambiamento nel metodo. di difesa.
Le mura, di poca profondità, non presentavano nè uno spazio sufficiente al rinculo dei cannoni, specialmente de' lun gh issimi, nè una resistenza bastevole alle .palle dell' ar· tiglicria. Convenne ingrossarle con un terrapieno verso la parte interna. Le stesse mura, che si facevano altissime per rendere più difficile la scalata, per dare più forza ai corpi pesanti cbc dn esse si facevano cadere sugli assalitori, per riparare meglio i difensori dalle frecci.e del nemico, e per
327 avere un comando considerevolè sulla campagna, dovettero ab.bassnrsi affine di prP.sentare mino•· bersaglio al nemico, e si sguernirono di merli, di piombatoj, e di ogni altra opera in muraturu nella loro parte superiorr, allo scopo di evitare gli efTeui micidiali delle scheggie prodotte dal colpo delle palle.
Anche le torri si allargarono perchè l'artiglieria era in gran parte collocata su di esse, si abbassarono, e si avanzarono clal ricinto, collegandole a questo mediante una gola rellilinea e proteggendone la sporgenza con qualèhe opera. Queste torri ingrossate non ebbero sempre la forma circolare, ma talvolta si fecero esagonali, tal' altra pentagonali, e soventi coi fianchi rotondati, e terminati in punta per meglio protf'ggersi a vicenda.
Il tracciato s' andava quindi incamminando verso il bastionato moderno.
Il fosso si fece più profondo.
Le porte · della pinzza si protessero con mezza lune o con t•ivellini.
Le strade coperte vennero allargate ai rientranti per formarvi le piazze d' armi.
Queste innovazioni furono speciahnente ope1·a degl' ingegneri italiani.
Non si era fatto grandi progressi intorno al modo di accampare e di marciare. Gl' italiani però erano più abili dei francesi nell' arte dei campi; • essendo loro costume, dice uno scrittore francese, di farli sì grandi cbe lutti vi potessero essere in battaglia e in ordine. •
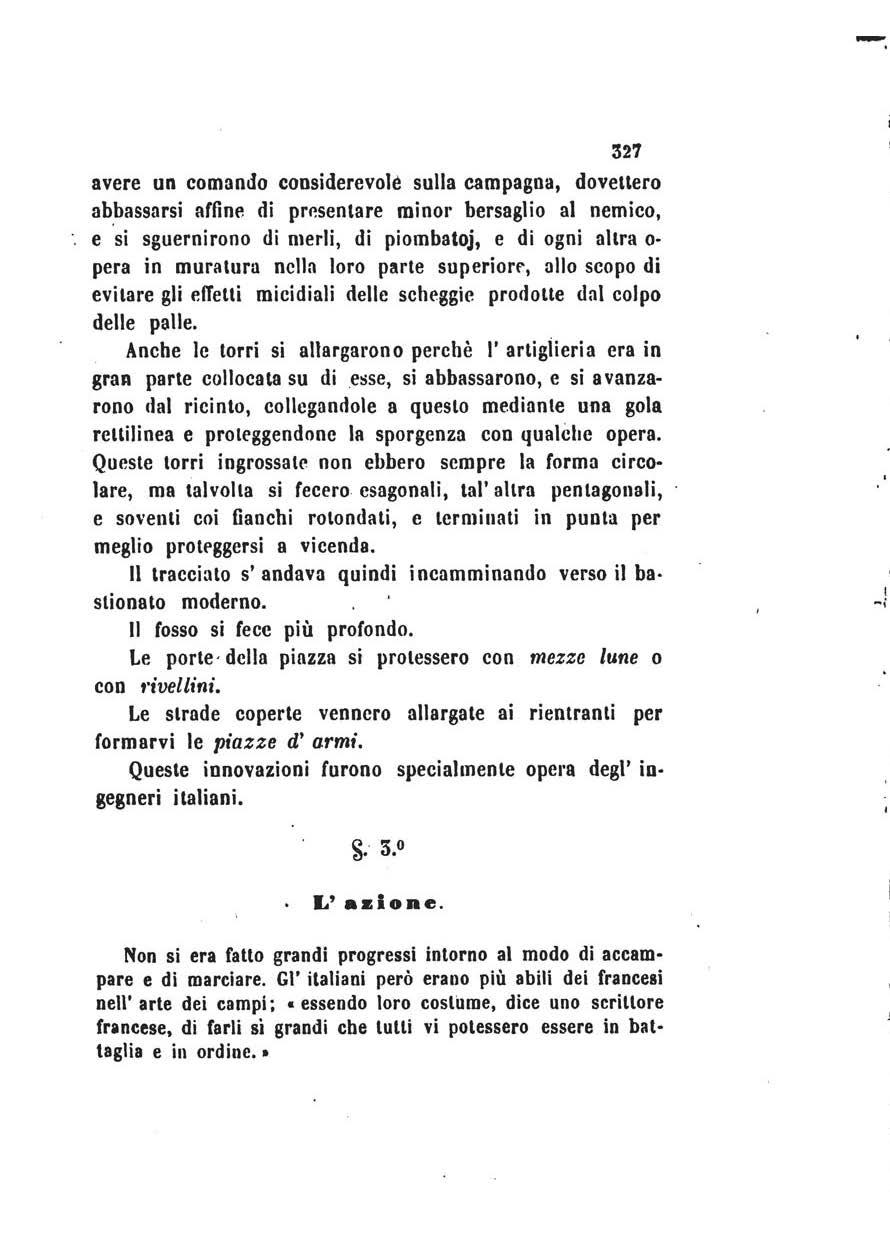
528
Riguardo alle marr.ie si persisteva generalmente a tenere gli eserciti divisi in tre corpi : vanguardia, corpo di battaglia, e retroguardia.
La fanteria , che andava sempre assumendo maggiore importanza, esercitò un grande influsso intorno al modo di comballere della cavalleria; la quale, dopo l' introduzione negli eserciti delle armi da . fuoco, invece di cercare scampo dai colpi dell' artiglieria nella prestezza, nella disciplina, nelle mosse opportune, nello oclattarsi al terreno, proseguiva a cercarlo nelle grosse armature le quiÌii anda. vano sempre crescendo di peso. Ciò nullameuo, la fanteria svizzera e gli arcieri inglesi costrinsero la cavalleria nemica, francese e borgognona, a scendere da cavallo e combattere a piedi. In questi casi i cavalli coi valletti restavano diP-tro alla retroguardia, e formavano una specie di protezione atta ad impedire un attacco di rovescio.
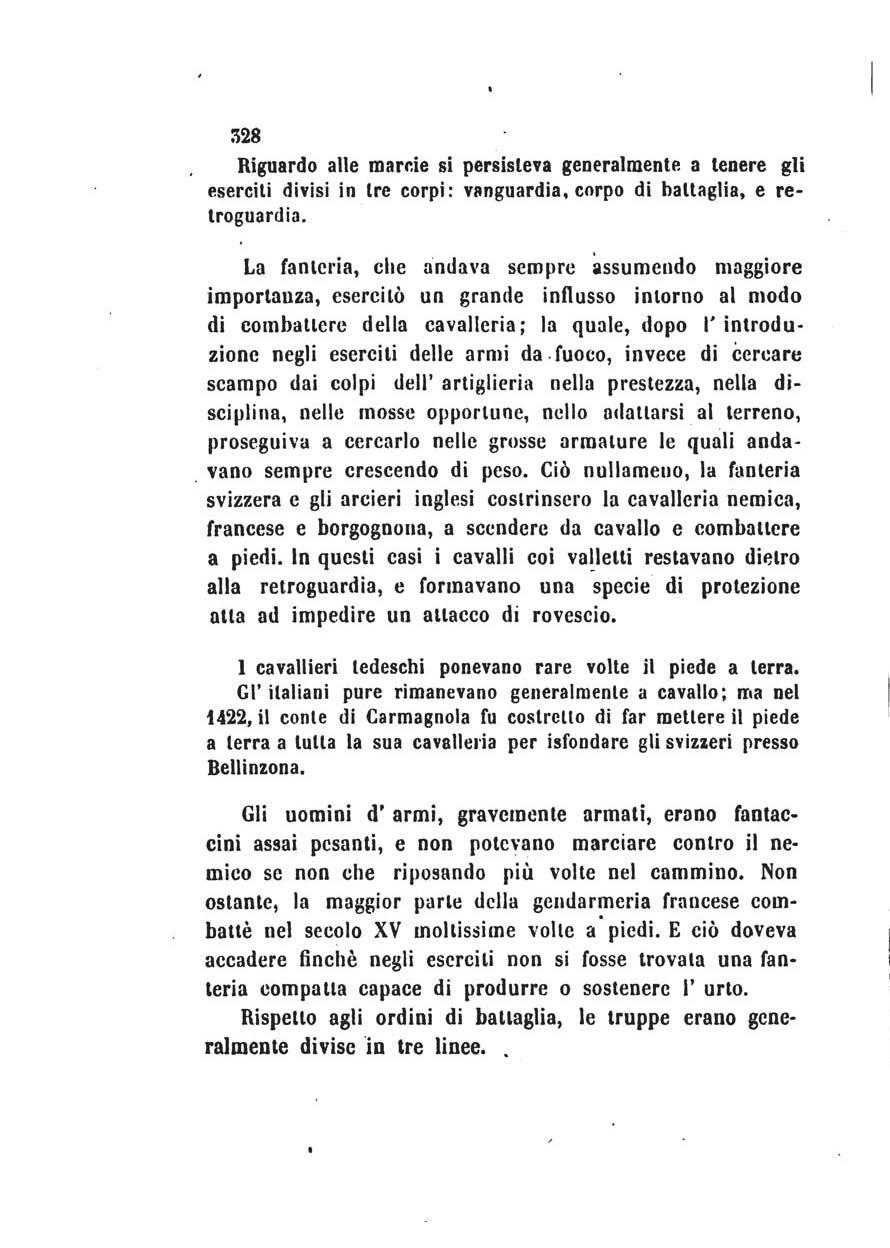
l cavallieri tedeschi ponevano rare volle il piede a terra. Gl'italiani pure rimanevano generalmente a cavallo; ma nel U22, il conte di Carmagnola fu costretto di far mettere il piede a terra a tutta la sua cavalleria per isfoodare gli svizzeri presso Bellinzona.
Gli uomini d' armi, gravemente armati, erano fantaccini assai pesanti, e non poteyano marciare contro il ne mico se non che riposando più volte nel cammino. Non ostante, la maggior parte della gendarmeria francese combattè nel XV moltissime volle a· piedi. E ciò doveva accadere finchè negli eserciti non si fosse trovata una fanteria compatta capace di produrre o sostenere l' urto.
Rispetto agli ordini di battaglia, le truppe erano generalmente divise 'in tre linee. .
Ma il duca di Borgogna, obbligato ati agire su di un terreno che presentava accif'lentalità, delibP.rò di porre le sue genti ì;u otto lince. La fanteria e la cilvalleria, disposte talora promiscuamente su medesime linee, s'impaccia vano a vicenda io luogo di ajularsi; le armi da fuoco non erano usate con molla efficacia; ed il cannone, immobile durante il comballimenlo, si ta·ovava alle volte io circostanza di non poter agire per essere coperto dai movimenti delle truppe.
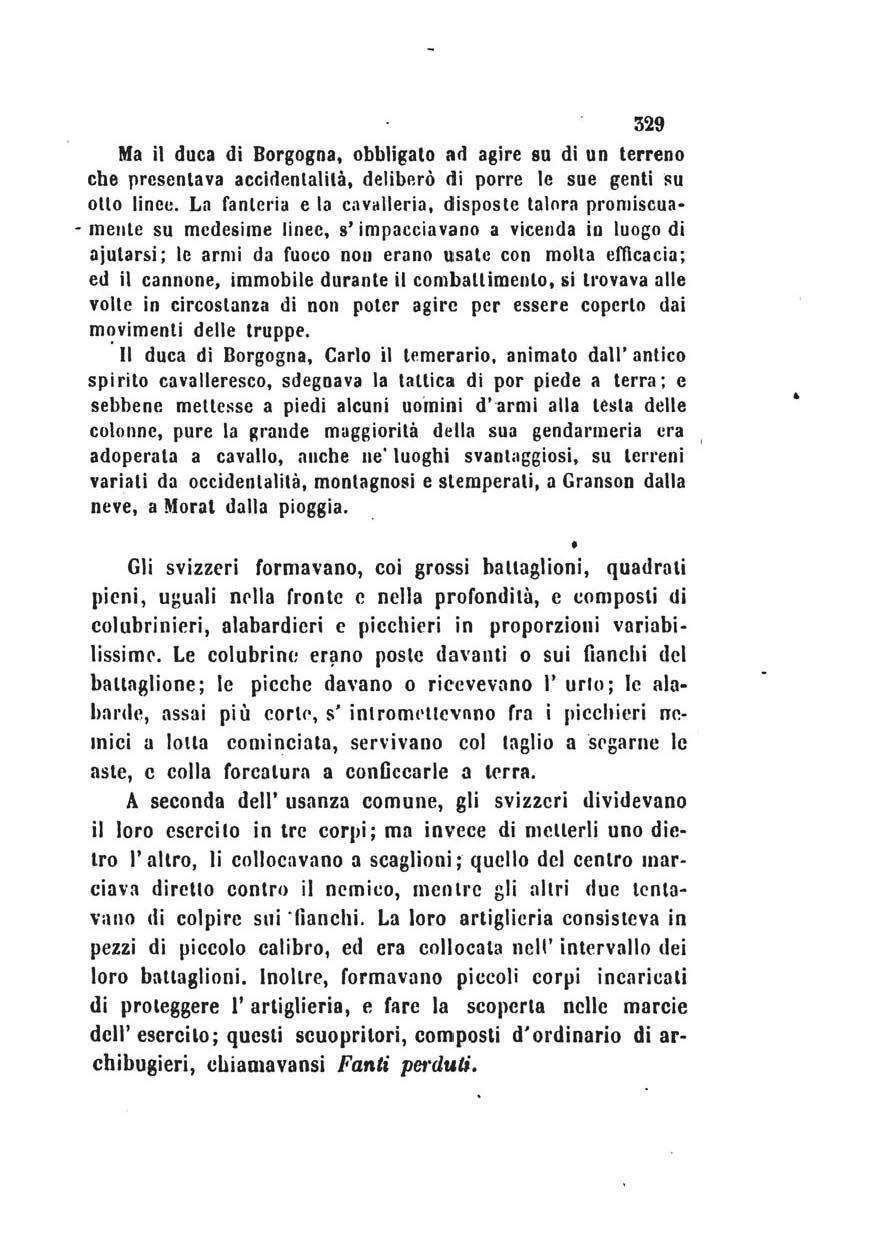
· Il duca di Borgogna, Carlo il temerario, animato dall' antico spirito cavalleresco, sdegnava la tattica di por piede a terra; e sebbene mettesse a piedi alcuni uo'mini d' armi alla testa delle colonne, pure la maggiorita della sua gendarmeria era , adoperala a cavallo, :mche ne' luoghi svantaggiosi, su teneni variati da occidenlalità, montagnosi e stemperati, a Granson dalla neve, a Morat dalla pioggia.
Gli svizzeri formavano, coi grossi battaglioni, quadrati pieni, uguali nrlla fronte c nella profondità, c composti di colubrinieri, alabardieri e picchieri in proporzioni variabilissimr. Le colubrine eqmo poste da\'anti o sui fianchi del battaglione; le picche daYano o ric-cvevnno l' urlo; le alabarde, assai più cort<•, s' i nt rom<'llcvnno fra i picchi cri nemici a lotta cominciata, servivano col taglio a ·srgarnc le aste, c colla forcatura a conficcarle a terra.
A seconda dell' usanza comune, gli svizzeri dividevano il loro esercito in tre corpi; ma invece di mcllerli uno dietro l'altro, li collocavano a scaglioni;· quello del centro marciava dirctlo contro il nemico, ment1·e gli altri due tentavano di colpire sui ·fianchi. La loro artiglieria consisteva in pezzi di piccolo calibro, ed era collocata nell' intervallo dei loro battaglioni. lnollre, formavano piccoli corpi incaricati di proteggere l' artiglieria, e fare la scoperta nelle marcie dell' esercito; questi scuopritori, composti d'ordinario di archibugieri, clliantavansi Fanti pet'duti.
330
Oltre a quella 'che abbiamo descritto, facevano gli svizzeri, al dire di Macchiavelli, molle forme di battaglia • io tra le quali una a modo di croce; perchè negli spazj che sono tra i vani di quella tengono securo dall'urlo dei nemici i lore scoppieltieri.
Essendosi l' uso delta picca e dell' ordine profondo vieppiù generalizzato sul finire secolo XV, la cavalleria potè cominciare a fare assegnamento sopra una fanteria solida, restare a cavallo, e non mctlerc piè a terra se ooq che rare volte.
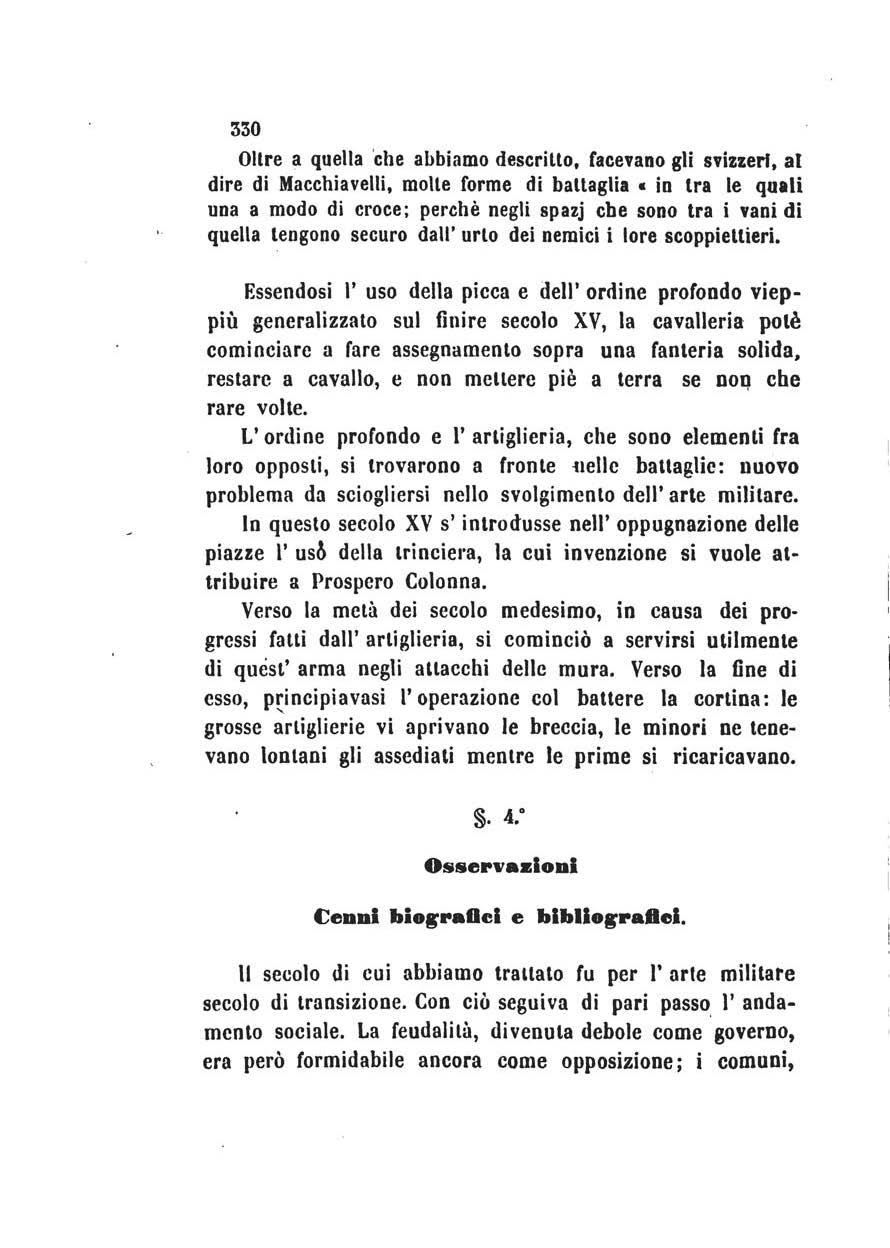
L'ordine profondo e l' artiglieria, che sono elementi rra loro opposti, si trovarono a fronte nelle battaglie: nuovo problema da sciogliersi nello svolgimento dell'arte militare.
lo questo secolo XV s' introdusse nell' oppugnazione delle piazze l' usb della trinciel'a, la cui invenzione si vuole attribuire a Prospero Colonna.
Verso la metà dei secolo medesimo, in causa dei pro· grcssi fatti dall' artiglieria, si cominciò a servirsi utilmente di quèst' arma negli attacchi delle mura. Verso la fine di esso, principiavasi l'operazione col battere la cortina: le 'grosse artiglierie vi aprivano le breccia, le minori ne tenevano lontani gli assediati mentre le prime si ricarieavano.
. .t:
Osserwazlonl11 secolo di cui abbiamo trauato fu per l' arie militare secolo di transizione. Con ciò seguiva di pari passo l' andamento sociale. La feudalità, divenuta debole come governo, era però formidabile ancora come opposizione; i comuni,
331 incapaci di forza preponderante, avevano mestieri della protezione di un potere centrale contro il potere feudale; il po · terc centrale, che prima aveva duopo di stringersi ai co· munì per la possanza feudale , sentiva m(•no bisogno . di protcggerli a seconda che codesta possanza decadeva, e consider:\V a i loro privilcgi come ostacoli al pieno ese rcizio della sua azione. Tutli i pot e ri avevano proprie;. ma difettando ciascuno di forze pr<•pouùeranti per prevalere, ne urti continui c continue· transazioni. Codesta combinazione di monarchia in progresso, di aristocrazia in lento e dei comu·ni che vanno con pari lentezza sviluppandosi, trova il suo riscontro negli eserciti contt!mporanei, i quali erano formati, di gendarmeria che rappresentava la feudalità battente; di truppe formate dai comuni, armnte con armi da tiro, d1e dovevano poi predominate nell' avvenire dell' arte, ma che allora non rappresentavano se non che un' arma ausiliaria; di mercenarj c di truppe nazion11li che rapil sostrgno del pote.re centrale. Così gli elementi che lottavano in società, ma cbe pure dovevano per allora esistere assieme, si trovavano pure ormati sul campo.
La transizione verificavasi pure nelle armi.
Le . armi da fuoco, moltiplicandosi, esercitavano grande influsso sui mutamenti che andavano preparandosi e svolgendosi; una_ palla tirata a grande distanza da un misera· bile fantaccino, forava le armature del più .'·igoroso gendarme; e questa insolenza dell' uomo a piedi, irritava la nobile altereiza del cavalliere antico .
Pure bisognava sopporLarc; ·bisognava resistere; e si re· sistè eopt aumento delle armature, che porta,·a in consc· guenza maggiore diminuzione di mobilità.
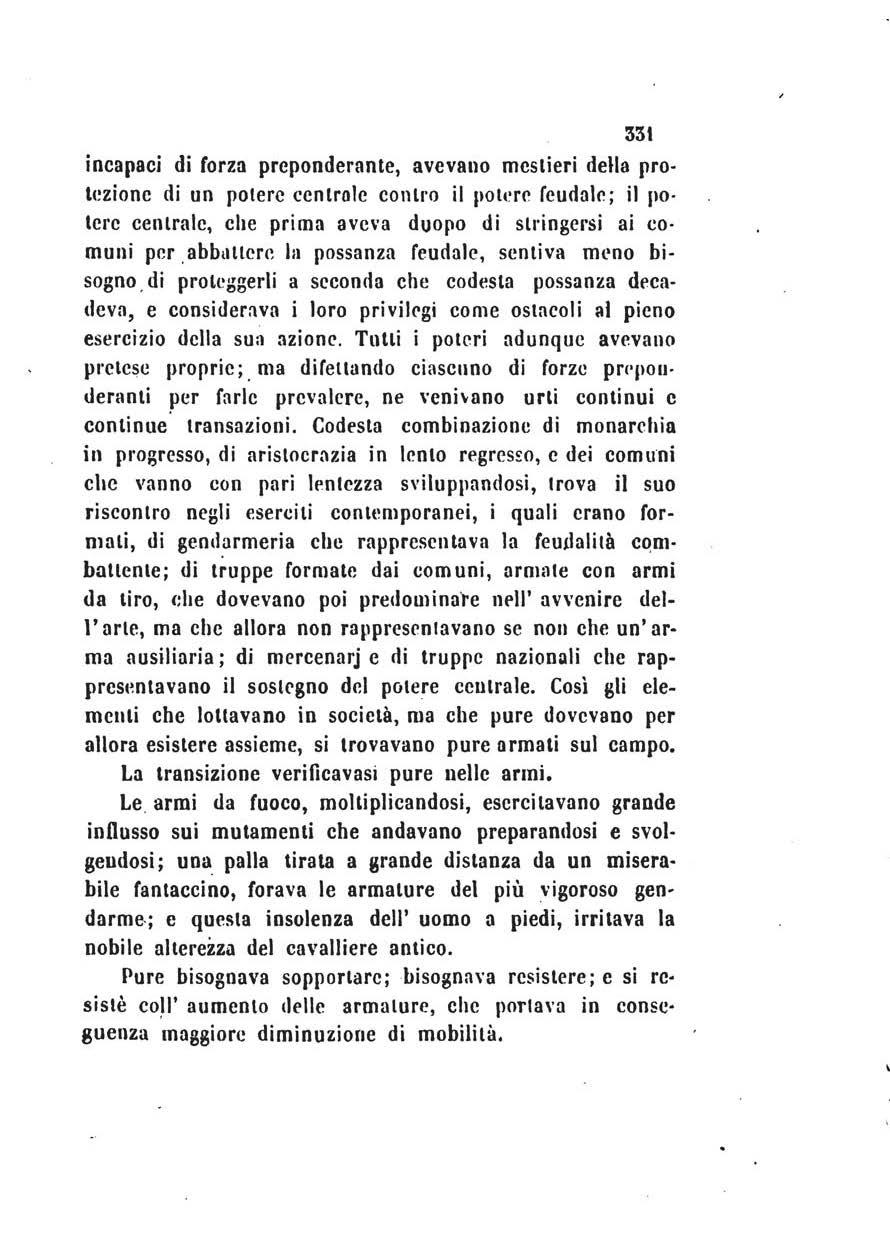
Ma a poco alla volla si dovè cedere innanzi a falli ineluUabili; il fantaccino disprezzato, si fe' rispeuare ; e, a poco a poco, rcllifìcati i sentimenti, si mutarono giudizj ed espress ioni; e si concesse importanza a coloro che dapprima si reputavano indegni di star a fronte del vero guerriero .
La fanteria fu più curata; ma era l ungi dal toccare un grado alto di perfezionamento. La proporzione delle armi da fuoco portatili colle picche era ancora in piccolissimo grado, da poter dar e alle prime q·uel posto che loro competeva. Servi vano pei s oldati leggi eri, e figuravano come archi e balestre.
Le non portatili però as s umevano il . domh1io sulle antiche, tanto nel campo quanto negli assalti c nelle difese delle fortezze.
La tendenza del secolo era doppia; aveva per oggetto di ri stabilire la civiltà degli antichi\ ed entrare in quella che corris.pondeva agli elementi delle società moderne (t); e mentre· ambo le due tendenze inducev,ano a combattere le istituzioni e le massime del medio evo, queste reagivano colla forza del loro dominio e della loro antichità. Codesta lotta si trova nella condizione dello scibile umano io quell' epoca. L' amore pei classici antichi faceva riunire gli studj delle loro opere a quelle dei moderni, per combattere poi i principj che il medio evo aveva fotto sorgere · e san. eire. Ma in generale più prevaleva l' erudizione che la pratica; la scienza era più considerata come una serie di verità la cui cognizione doveva soddisfare l' uma na, che come uu' utile apJllicaz ione ai bisogni generali della società; si verificava così la disposizione che pretlomioa na-
LI ] IJu:-; cn, DI'Ila scit•n ; a mi /it a 1·e ecc.
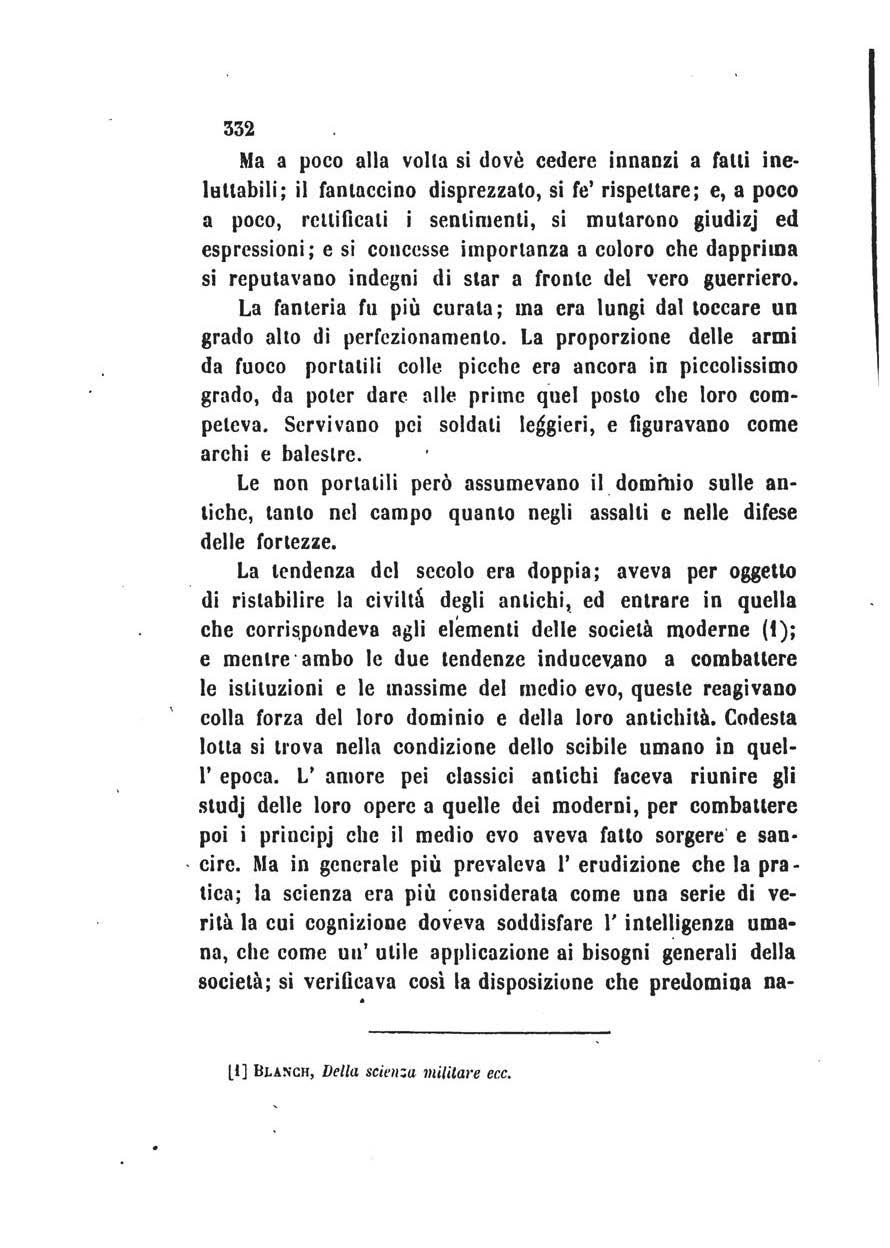
333 turalmente in tutte le epoche di creazione e di to ; · mentre vi sono sforzi che l' uomo fa per amore del bello e del vero più di quanto farebbe per amore dell' utile.
Da ciò si può dedurre, che la separazione degli eruditi · dagli uomini pratici, come delle scienze dalla loro utilità pratica, fece sì che l' arte militare non trovasse in queste i mezzi ed i metodi che alla condizione in cui essi si trovavano.
TuUavia qualche miglioramento si ottenne; alcune i m· prese, come quella di Carlo VIli nel regno di Napoli, dimostrano che i capitani di quel tempo avevano l' istinto delle grandi operazioni di guerra; mentre cercarono, colla politica, di assicurarsi nel progredimento dell' azione; e, colle marcie, di prevenire il nemico in un punto geografico importante, e· di giungere allo stesso scopo che a' nostri tempi i generali istruiti cercano di conseguire, e che ora Ja scienza, ridotta a regole chiare, indica c facilita (t). In Italia, l' indole nazionale, e lo stato di civiltà del paese, dimostrarono che la gran guerra avrebbe fallo progressi, ·sè il poco sangue sparso, e la veoalità delle bande, non avessero rese le ballaglie prive di grandi effetti politici; ma le scuole italiane di Sforza, di- Braccio, di Pieeioioo, di Del Vrrme, ·del 'carmagnola, ·del Gattamt!tata, i quali nei loro movimènti svelano ingegno, ci fanno riguardare queste guerre come campi d' istruzione. Da ciò ded uccsi che esi· stcvano disti nti capitani; ma che dess i non potevano clevars:i a grande riputazione pcrchè corrotti dal loro mcslic· re, dalle abitudini ne risultavano, e dalle truppe che comandavano. •
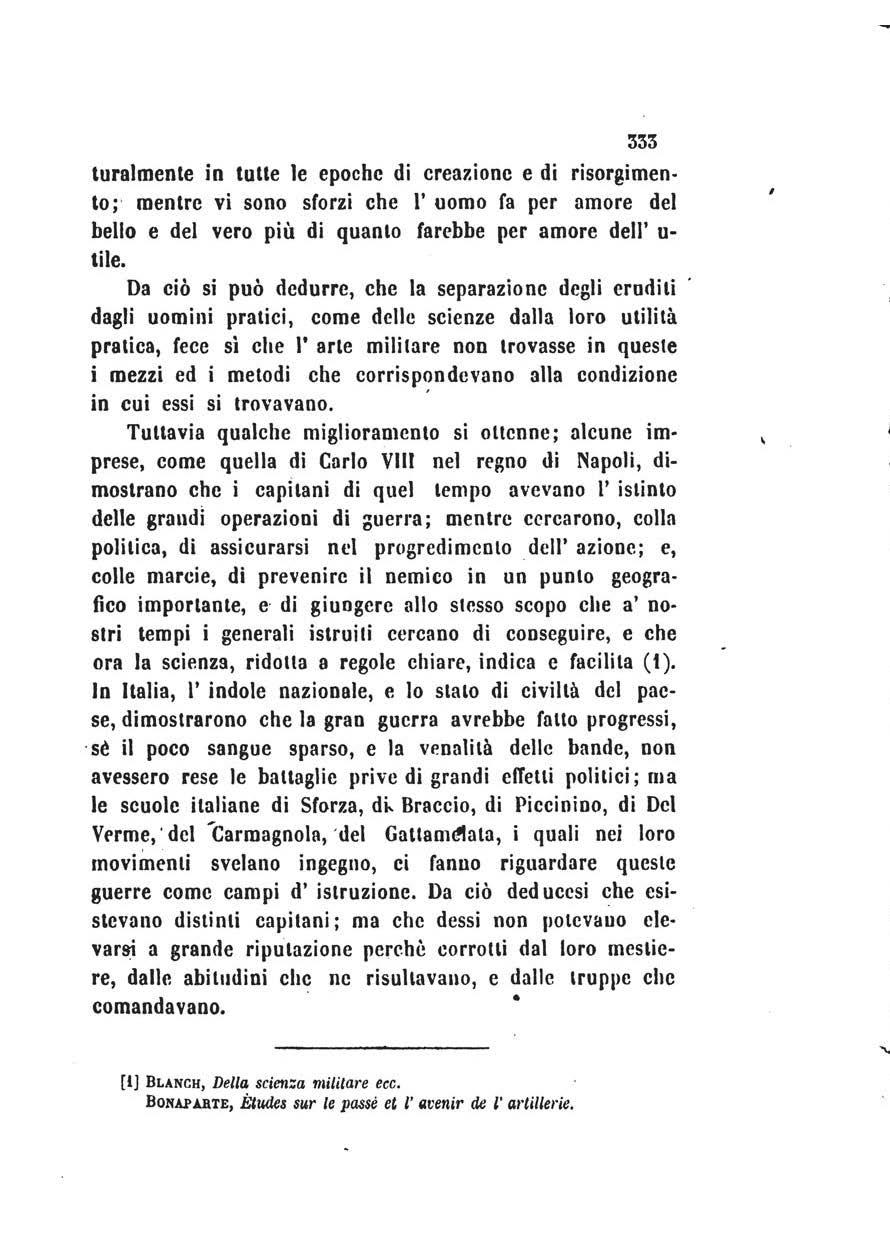
[l) BLANCH, Della scien:a militare ecc.
BONAP.UTE, È4ude& sur le passe e' l ' Qvenir de l' artille rie
E poichè menzionammo le scuole italinue dc' condottim·i, non sarà fuor di proposito lo esporre alcune considerazioni su due principali fra essi, Allcndolo Sforza c Braccio da Montone (t).
Le vicende dell' uno assomigliano in alcune parti a qur.llc dell' altro. Nacquero c morirono quasi a un tempo; ambo colla costanza, col valore, colla prudenza, salircno dagl' infimi ai più alti gradi della milizia; ambo amatissimi dai propri seguaci, ambo fortissimi enormemente di membra; più gagliardo lo Sforza a menare le mani, più alto Braccio alle sollecite fazioni; donde ai Piccinini cd agli 11ltri capitani della scuola braccirsca derivò quella furia nel fornire le imprcsr, che fu ·ad essi sovente cagione c compenso di gravi danni.
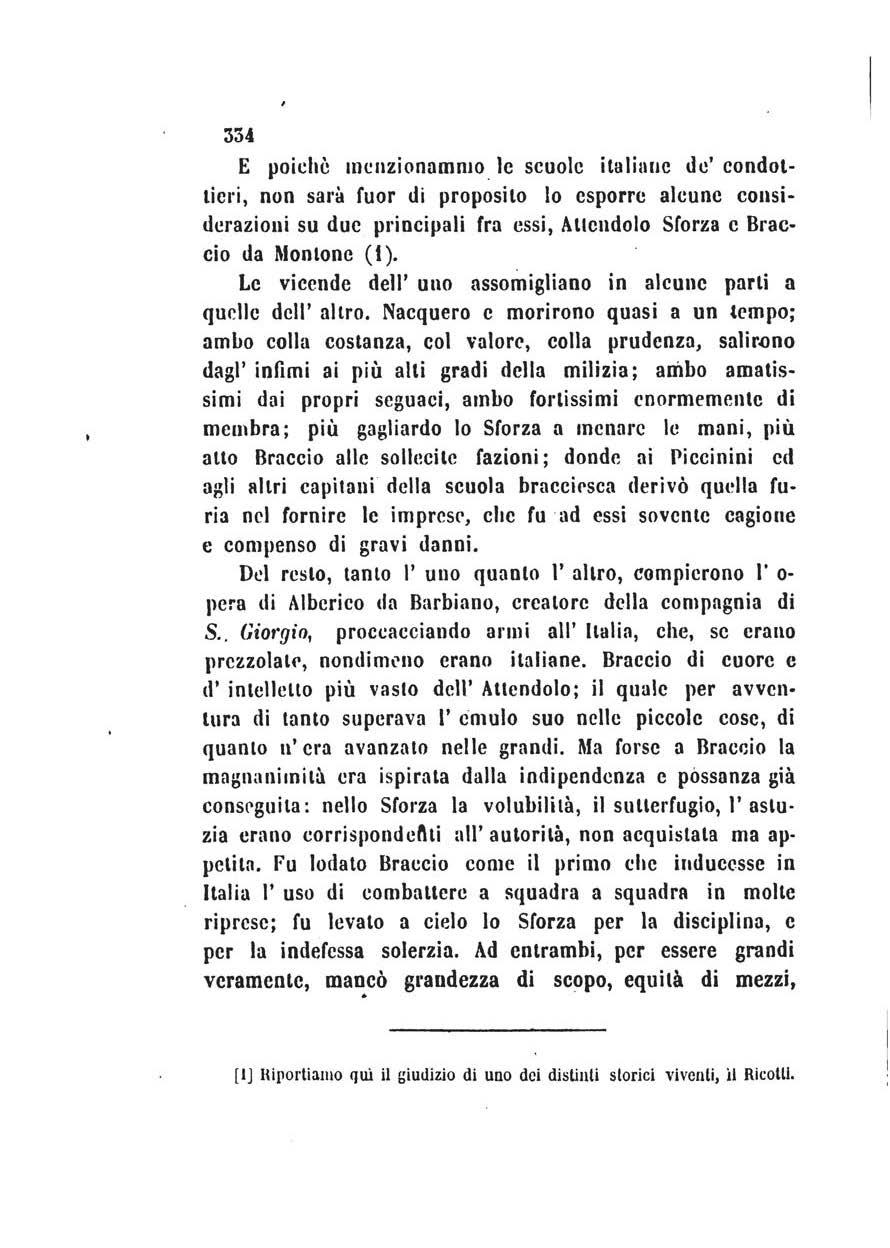
Dd resto, tanto l' uno quanto l' altro, compierono l' opera di Albcrico da Barbiano, creatore della compagnia di S.. Giorgio, proccacciando armi all' Italia, che, se erano prczzolat", erano italiane. Braccio di cuore c d' intcllcllo più vasto dell' Attcndolo; il quale per avvcn· tura di tanto superava l' emulo suo nelle piccole cose, di quanto n'era avanzato nelle grandi. Ma forse a Braccio la magnanimità era is pirata dalla indipendenza c pòssrmza già consrguita: nello Sforza la volubilità, il suuerfugio, l' astu· zia erano corrispondcati all'autorità, non acquistala ma ap· pctitn. fu lodato Braccio come il primo che iuduccsse in Italia l' uso di combattere a squadra a squadra in molle riprese; fu levato a cielo lo Sforza per la disciplina, c per la indefessa solerzia. Ad entrambi, per essere grandi veramente, grandezza di equità di mezzi,
( l ) Hip orti amo qui di uno dci distinti s torici viventi, il Ric olll.
555 altezza di concetti; senza de) che la gloria è strepito, la potenza c la dominazione tirannide. Dell' uno e dell' altro di essi l' Italia accrebbe, oltre il vero, l' onore; pur tanto povera da dover riporre tra i maggiori suoi capitani due condouieri di ventura!
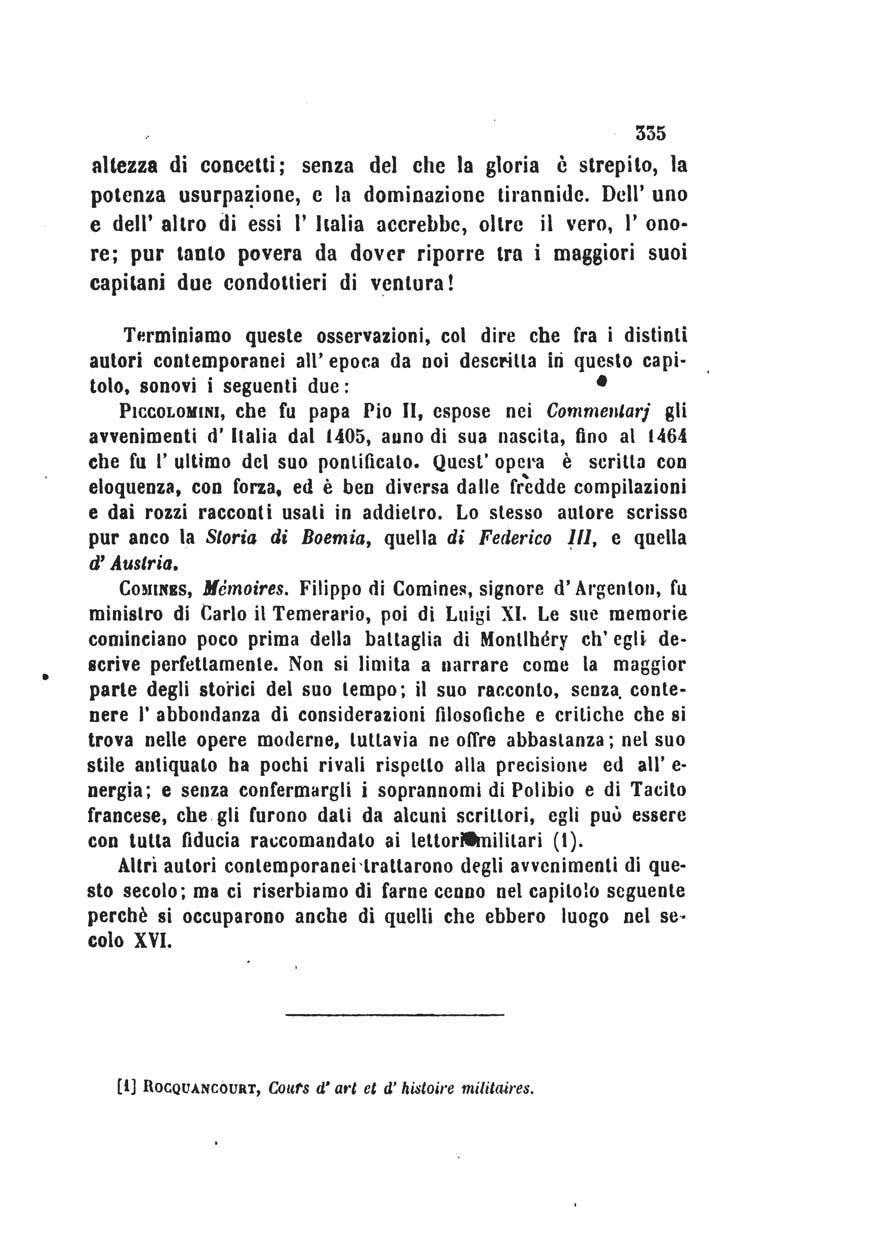
Tllrmlniamo queste osservazioni, col dire che fra i distinti autori contemporanei all' epor.a da noi descrilla iri questo capi· tolo, sonovi i seguenti due: • PiccoLOifiNI, che fu papa Pio II, espose nei Comme11larj gli avvenimenti d'Italia dal U05, auno di sua nascita, ftno al 1464 che fu l' ultimo del suo ponlifìcalo. Quest' opet•a è scrilla con eloquenza, con forza, ed è beo diversa dalle frèdde compilazioni e dai rozzi racconti usati in addietro. Lo stesso autore scrisse pur anco la Storia di Boemia, quella di Federico !11, e quella d'Austria.
Jlémoires Filippo di Comine!l, signore d' Argenlon, fu ministro di tarlo il Temerario, poi di Luigi Xl Le snc memorie cominciano poco prima della battaglia di Monllbéry ch' egH descrive perfdtamente. Non si lim ita a narrare come la maggior parte degli storici del suo tempo; il suo rar.conto, senza. contenere l' abbondanza di considernioni filosofiche e critiche che si trova nelle opere moderne, tuttavia ne offre abbastanza; nel suo stile antiquato ha pochi rivali rispclto alla ed all' e nergia; e senza confermargli i soprannomi di Polibio e di Tacito francese, che gli furono dali da alcuni scrillori, egli puù essere con tulla fiducia ai lettorJ-.nililari (l).
Altri autori conlemporanei'lrattarono degli avvenimenti di questo secolo; ma ci riserbiamo di farne cenno nel capitolo seguente perchè si occuparono anche di quelli che ebbero luogo nel se· colo XVI.
(t) RocQ UANcouu, Cours d' at·t et d' hi$tOil'e mililiUres.
g. 5."
Borgognoni: Variano le opinioni intorno al numero: cavalleria 115 cannoni: esercito UJisto.
Svizzeri: Oltre 20,000: 2!5 cannoni; esercito nazionale.
l primi comandati da Carlo il temerario; i secondi da Nicola di Scharnathal.
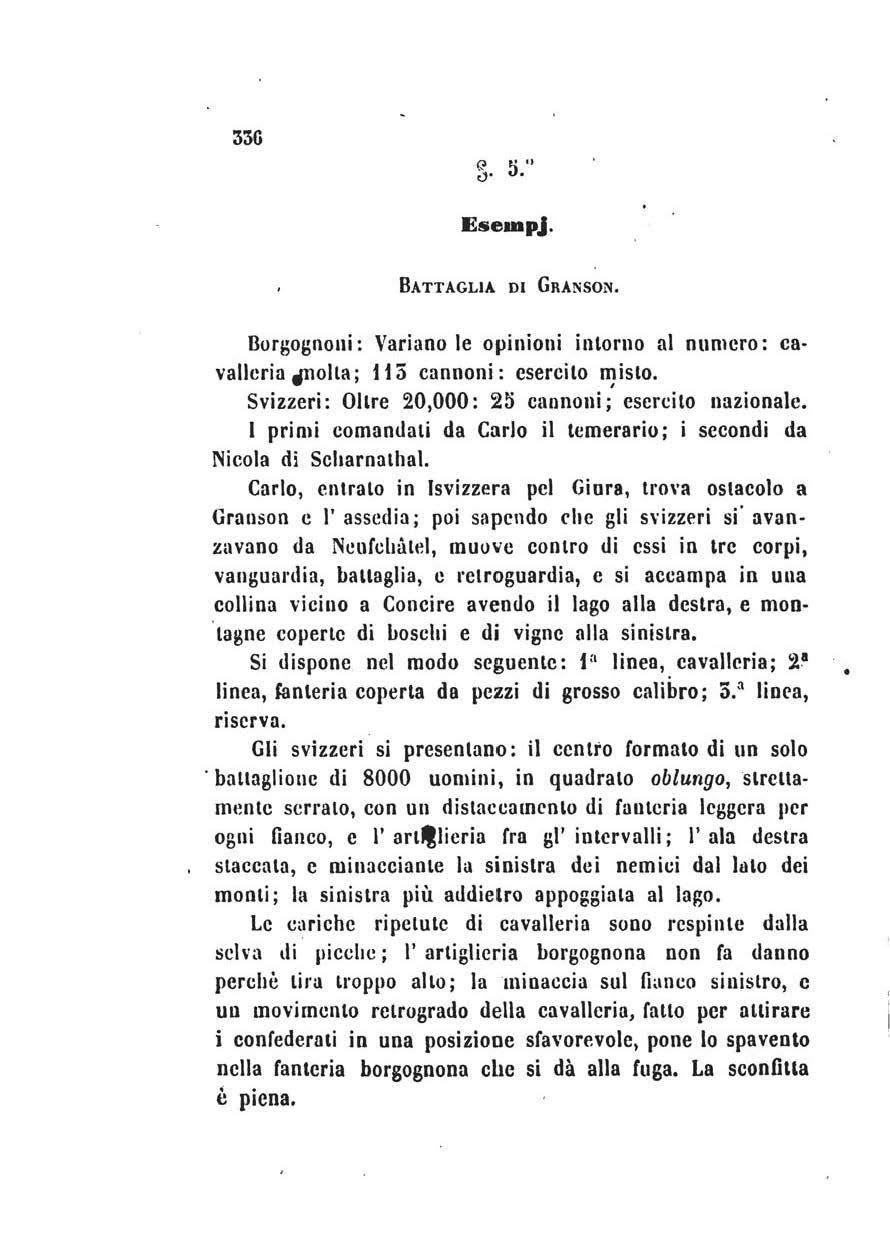
Carlo, entralo in lsvizzera pcl Giura, tro\'a ostacolo a Grauson c l' assedia; poi sapendo che gli svizzeri si' avanzavano da Ncufchàtel, muove contro di essi in Lrc corpi, vanguanlia, bauaglia, c retroguardia, c si accampa in una collina vicino a Concire avendo il lago alla destra, e montagne coperte di boschi e di vigne alla si ni stra.
Si dispone nel modo seguente: t:' linea, cavalleria; 2• linea, fanteria coperta da pezzi di grosso calibro; s.a linea, riserva.
Gli svizzeri si presentano: il centro formato di un solo ·battaglione di 8000 uomini, in quadrato oblungo, strcuamentc serrato, con un distaccamento di fanteria leggera per ogni fianco, c l' art,licria fra gl' intervalli; l' ala destra staccata, c minacciante la sinistra dci nemici dal loto dci morHi; la sinistra più addietro appoggiata al lago.
Le cariche ripetute di cavalleria sono respinte dalla selv<t tli picche; l' artiglieria borgognona non fa danno perchè Lira troppo alLo; la minaccia sul fianco sinistro, c un movimento retrogrado della cavalleria, fatto per auirare i confederati in una posizione sfavorevole, pone lo spavento nella fanteria borgognona cbe si dà alla fuga. La sconfina ; . e p1ena.
357
Risultato: Perdita del campo, di t 500 uomini e di tutta l' artiglieria pnr pnrtc de' borgognoni; abbandono dell' as· scdio di Granson.
Gli svizzeri ebbero 50 uomini uccisi; molto · più di feriti.
Cause: f. 0 Posizione S\'nntaggiosn pc' borgognoni, su lcrréno strcuo in cui l' esercito non poteva adoperare tutte le sue forze": 2. 0 Impotenza della cavalleria pesante contro . alla nuova ordinanza serrata svizzeri. 5.0 Uso inlclice dcii' artiglieri a.
Osservazioni. La rnnt<'ria acquistava vieppiù grande im· portauza: gli eserciti nazionali mostravano la loro supremazia: il medio evo era battuto sul campo.
Epoca: 5 Marzo 1476.
Paolo Giovio ci dà la seguente descrizione:
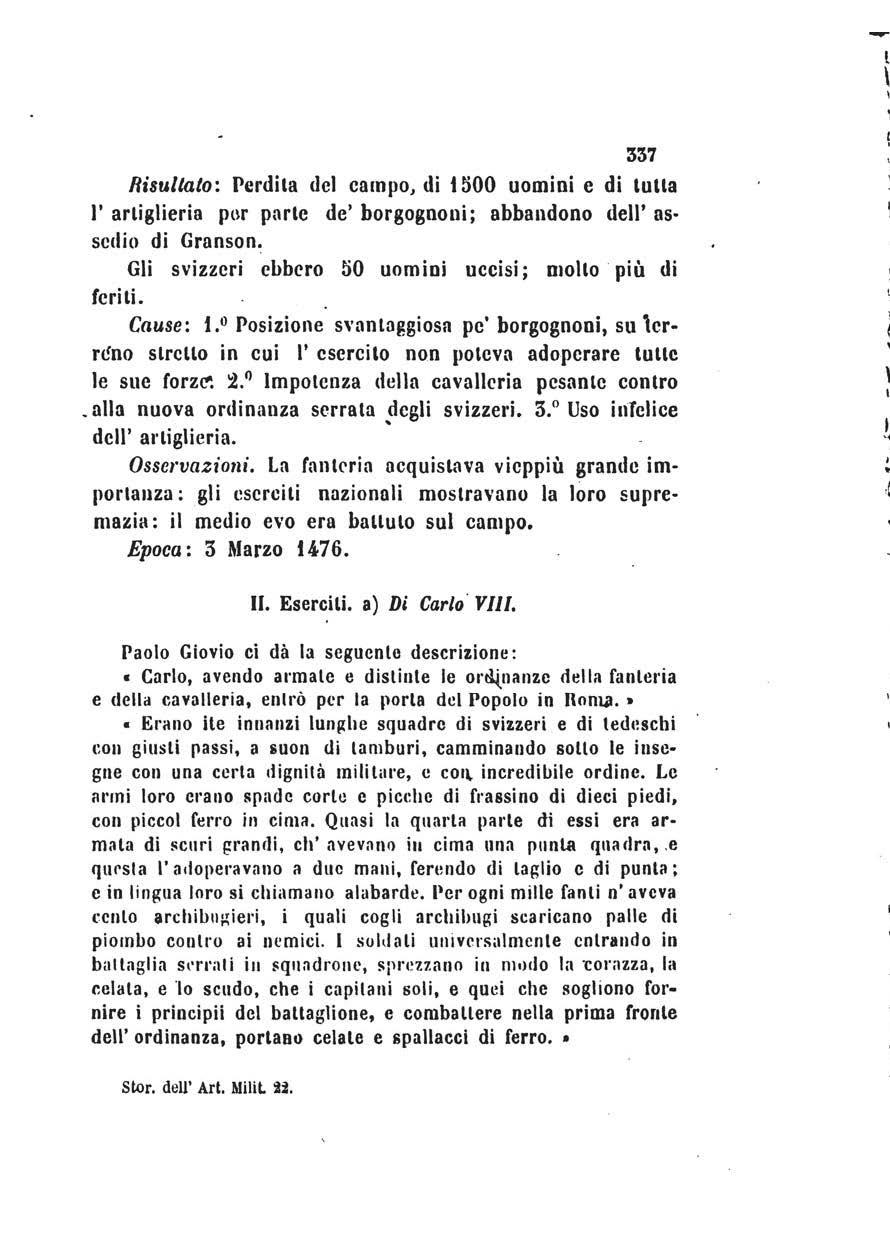
• Carlo, avendo armate e distinte le ord.{_nanzc rlella fantel'ia e della cavalleria, entrò per la porta del Popolo in • • Erano ile innanzi lunghe squadre di svizzeri e di tedt!schi t:on giusti passi, a suon di tamburi, camminando sotto le insegne con una certa dignità militar·e, c cOrl incredil.lile ordine. Le ar·rni loro c•·ano spade corte c picdre di frassino di dieci piedi, con ferro in cima. Quasi la quarta parte di essi era ar· mata di scuri granrli, ch'avevano iu cima nna punla quadrn, .e qursta l' a•lopet·avano a due mani, fert: ndo di taglio c di punta; c in lingua loro si chiamano alabarde. t•er ogni mille fanti n'aveva archillul.(ier·i, i quali cogli archihngi scaricano palle rli piombo contro ai nrmici. l soldati un iversal men te cntrllndo in ballaglia Sl'rr'ali in squadrone, spt'l!1.7.ano in m•Hio la tol'azza, la r.elata, e ·to scudo, che i capitani soli, e quei che sogliono fornire i principii del battaglione, e coroballere nella prima fronte dell'ordinanza, portano celale e &pallaccl di ferro. •
Stor. dell' Art. MìliL U.
..
3:5R
• Dietro a questi veniva no cinque m ila Guasconi quasi tutti balestrieri, i quali adoperavano balestre con l' arco di ferro mol· to eccellentemente in un punto di tempo caricando e saettando; la qual sorte d' uomini a paragone degli svizzeri pareva mollo brulla e male in arnese • .
.• Dopo la fanteria venne la cavalleria, scritla della nobiltà dì tutta la Francia. Venivano costoro con sajoni di tela indosso, e ben e ornati di pennacchi c di collane d'oro, con ordine lungo di compagnie e di bande. Gli uomini d'arme erano due mila e cinquecento; e cinquemila cavalli l eLfge ri. Usavano quegli, come ancora solevano fare i nostri, una lancia grossa e1t accannellala con punta soda, e la mazza di ferro. l cava Ili loro , gra ndi e fori i, c con le cbiome e le orerchic tagliat e, stimando i francesi che cosi stien meglio, parevano toolto t er a·ibili; ma per questo erano manco belli da vedere, pea·chè, com'e è costume de' nostri, essi mancavano la maggior pat·te di coper te falle di cuojo cotto. Cia· scun ·uomo d' 1.1rme :n· eva tre cavalli, un ragazzo che portava le armi, e due servilori, i quali si chiamavano bagaglioni e saccomanni. Il cavalleggiero, secondo l' usanza dei Brettoni, porta un grand'arco di legno e freccie grosse, e non adopra se non la col'azza e la celala. Alcuni di loro portano gia onettoni, coi quali essi sogliono piantar con la punta io terra i nemici abballuli dagli uomini d' arme io batta glia . 'fulli costoro avevano indosso lavorati all'ago e con ricami d'argento, ne' quali di bellissimo Javor o si v.edevano con Yere imagini espresse le propa·ie insegne de' capitani, perchè si conoscesse in ballaglla il valore e la viltà de' soldati •.
• Il re era tollo in meno da balestrieri a cavallo, fra' quali v' erano cento scozzesi, valorolii c fedeli. Ma innanzi a questi, dul'geoto uomini d' arme francesi, eltlti per no · bi\là e per valore , portando in spalla mazze di ferro, come scuri grandi, c benissimo a ordine stavano intorno al re quando egli andava l\ piedi; e quando ei cavalcava, a guisa d'uomini d'armi su' cavalli grandi, gli andavano innanzi, riccamente vestiti d'oro e di seta •
• Ma sopra lutto diedero gran maraviglia più che trentasei artiglierie su le carrette, le quali con incredibil prestezza erano
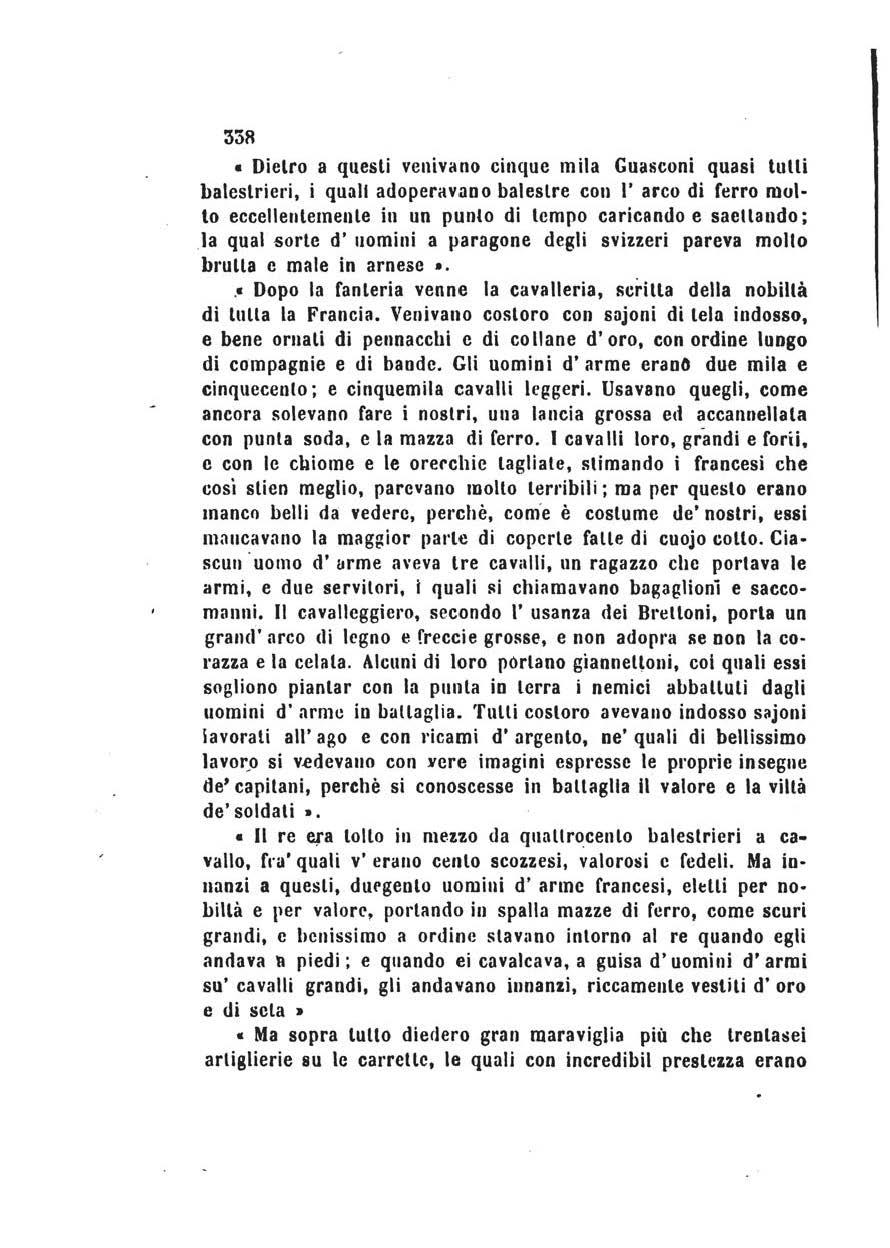
339 tirate da cavalli per luoghi piani c diseguali.' Le maggiori d' esse Ili lunghezza cl' otto piedi, c di pr.so di seimila libbre di bronzo si chiamavano cannoni; le quali lraevan·o una palla di ferro di grandezza quanto è il capo d' un uomo. Dopo i cannoni erano le colubrine, più ·lunghe la mctò, ma di piu stretta canna, e di minor palla . Seg uivano i falconelli di così ccrla proporzione mag· giot·i, c minori, che i mini111i pcui traevano palle grosse come un melo rancio. Tutti questi pezzi erano inserti in due grosse asse con le ftbbie tirate,·i sopt•a, e s' in guisa da poler dirizzare i colpi (1). l piccoli avevano solto due ruote, e i grossi quattro: delle quali quelle di dietro si poleuno levare e pot·re, per aiTrcttare o fermare il corso. E con tanta pa·cstezzn i lor maestri e carrcllicl'i le facevano correre, che i cavalli posti· vi solto, incitali dalle sfenc c dalle voci, ne' luoghi piani Jlareg· giavano il corso dc ' cavalli spediti •• c Entralo che fu il re, si consegnavano gli alloggiamenti per le case private •.
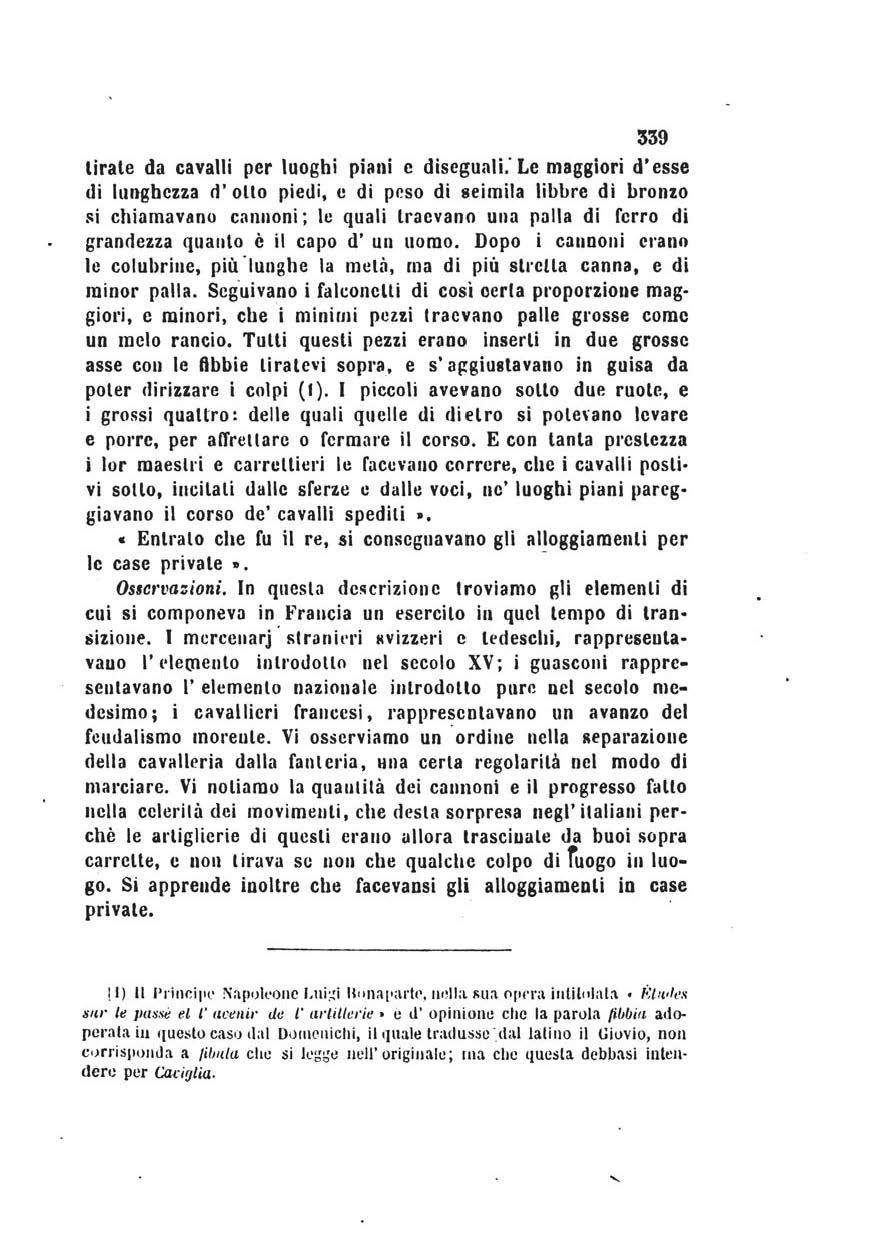
Osscl't'azioni. lo questa c l rovi amo gli elementi di cui si componeva in Francia un t'sercilo in quel tempo di tran· sizione. l mcrccuarj · stranit•ri MVizzeri c· tedeschi, rappresenta· vauo l' l' le{.llento introdollo nel secolo XV; i guasconi rappresentavano l' elemento nazionale introdotto pure oel secolo medesimo; i cavallieri francesi, rappresentavano un avanzo del fcudalismo morente. Vi osserviamo un ordine nella Repat·azioue della cavalleria dalla fanteria, lUla certa regolarità nel modo di marciare. Vi notiamo la quantità dci cannoni e il progresso fallo nella celeri! a dci movimeuti, che desta sorpre!la negl'italiani perchè le artiglierie di questi ea·auo allora lrasciuate da buoi sopra carrette, c non tirava se non che qualche colpo di Tuogo in luogo. Si apprende inoltre che facevansi gli alloggiameoli in case private.
! l ) Il l'rindp t• Nap•,lt-onc llunar•<ll' lt'. n•lli<L -"U:l ClfHTa ìutil,lala • Stll' le passi: et l' ua1ril· tlc l' nrlillct'it' • c Il' o pinione che la parola fiiJIJùt adoper ala iu •tucsto casOJ o l a l Oum cnichi, il quale tradusse ·dal Ialino il (jiuvio, non C•) rr is(llmlla a /illltla che si lt•g:;e nell'originale; 111a che questa debba si intender e per Qu:iylia.
a) Forze mercenarie al 1ervi1i o veneto.
Per dare uo' idea della condotta de' venluricri in Italia, trascriviamo per semplice esempio la nota dei condottieri che nel U27 gucrl'cggiavano al soldo di Venezia c de' suoi alleati; la qual nota è tolta dalle Vite dei Dogi di Vene1ia scritte dal Sanuto.
• Il conte Francesco Carmagnola capilan nostro generale lancc 230.
Il signor di Mantova, lance 4(10. Pietro Gianpaolo , 196. Taddeo Marchese, tOO. Frà nuffino da Mantova, 88. Falza e Antonello, 63. ninicri da Perugia, 60. Lodovico de' Micalolli, 70. Ballista Bevilacqua, 50. Giovanni di Mess. &larino, 50. Biaochino da Feltre, 50. Buso da Urbinn, 50. Scariollo da Faenza, 40. Lombardo da Pietramala , 50. Iacopo da Venezia, 10. Cristoforo da :Fuogo, 8. La nce spezzate, t 15. ln Casal maggiore, Bernardo Merosini, 60. Jacopo da Castello 26.- ln VeroAa, Antonello di Roberto, 50. Tesi a da Moia, 20. Jar.o po da Fiminalo, 15. Lance spezzat e, 12.- In Ulli11e, Giovanni Sanguinano, 65. - In Vene1ia, Ser Antonio degli Orclelaffi, 10. - In Ferrara, Volachino da Cologna, d5.- ln Rat,enlla, Il Conte Alendas, -15. Lance Conte Luigi del Verme, !ance condolle, 260. Orsini, 120. Messer Pietro Pelacani, 100. Giovanni da Pomaro, 58. Coututabili delle Faulerie. Il signor di Mantova, fanti 200. Il con t n Carmagnola, 21 O. Il Duso da Siena, 207. Il Cornacchia, l 01. Simone Parzcllo, t 00. Il Qu;ll'a nlollo; 150. Il Pcrugino, l 00. Masino Scaretto, 90. Anrlrrn dA Cesena, 85. Antoniolo da Parma, 75 . Cecco da Pisn, 75. Giuliano da Segna, 50. Sta11c1ino ·da 1\fnntolivclo, 150. VenlUI'II da Sirna, 50. Lombardo Lombardo, 50. Niccolò da Cavosclmo, 50. Romane llo da Siena, .40. Il Gras so d:t Venosa, 50. Domnnico da Venosa, 30. Cavriolo da Segna, SO. llologoìno da 50. Corrado da Dal'biauo, 35. Fagiulllo da Cr e mona, 50. Dolodl:ll a da Cas(•ntino, Petruccio da Napoli; 25. Duu· no da Marostica, 2!J. Antonello di Cristoforo, 50. Giovanni di \'illareale, 25. Giovanni Bondi da Siena, 25. Guglielmo di Radovecehio, 50, Pace da Cornello, 50. Giovanni da Bologna, 30. Bolognino Grasso, 50. Nereo da Ginevra, Pace da Verona, 57. Bartolomeo da Udine, 35. Balestrieri da Venezia, 100.- Fanti a Ravenna: Slefaoo
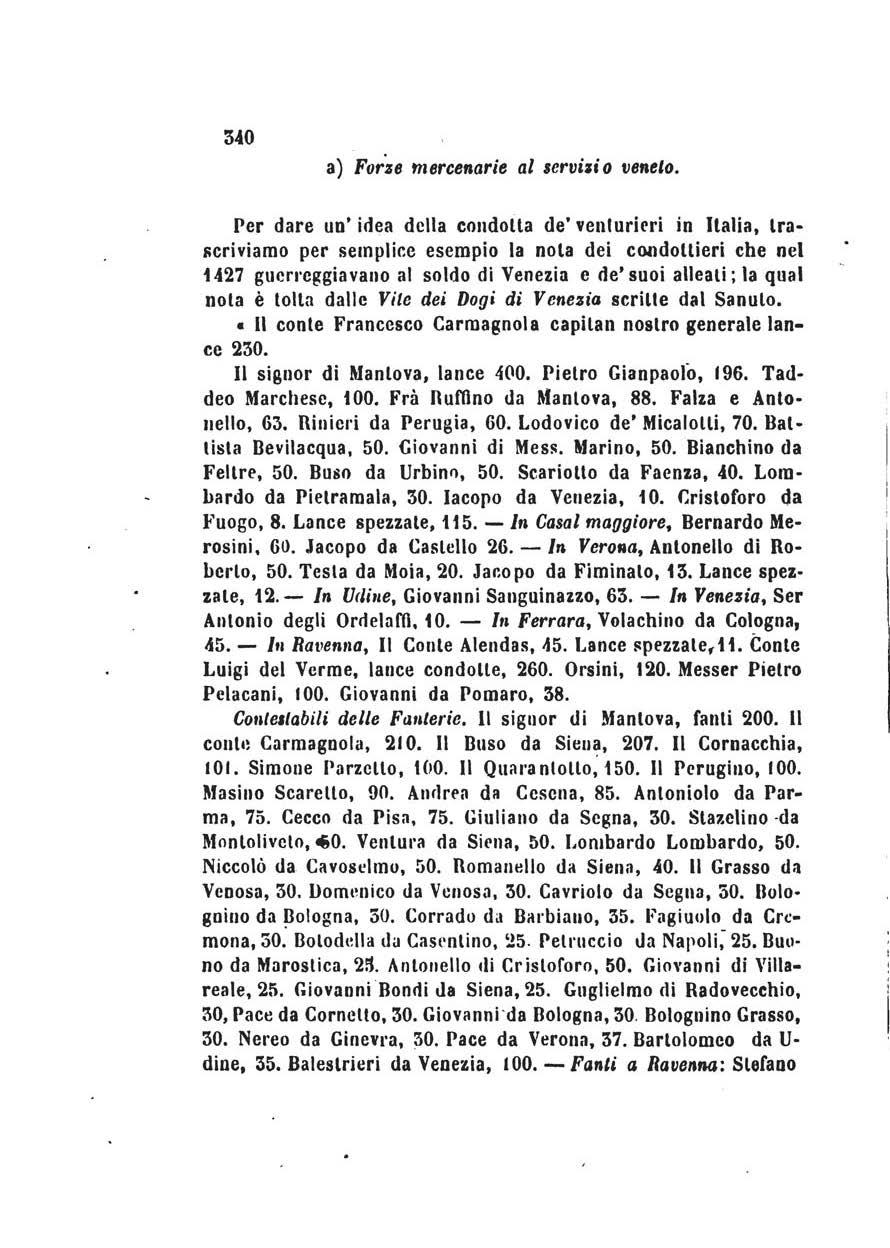
da Lugo, 30. Niccolò da Polenta, 30. Menaghlno da Barbiano, 30. Giovanni da Sant'Agata , 55. Maso da Radici, 35. Jacopo da Bo· logna, 30. Nicore, 90. Niccolò da Bologna, 50. Angiolino da Sala, 50. A Ferrara: Giovanni di Villata m, 100. Nani da Bologna, 30. Ira YicenJa: Scaramuccia da Savino, 85. -A Verona: Dar· lolomeo de' Puoli, 100. Indio da Parma, 75. Baraziano, 30. Mal· leo da Cotignola, 25. Bàrtolomeo da Bologna, 25. Pietro da Imola, 25. Girolamo da Pisa, 25. Lionardo Vel'lalo, 20. Ravagnano, 25. Sull'armala in Po: Stefano da Vicenza, 40. Benedetto da Pescia, 40. Sbardellato da Trivigi, 25. Antonio da Fazina, 25. Chiodino da lmol3, 30. Antonio dall'Erba, 30. - A Paclova: sono in tutti co' provveditori , tOO. A Casalmaggiors: Petruccio di Calariva, 50. Antonello da Siena, 60. Gaspare da Milano, 25. Ira Dre1cel/o: il Bozza da Siena, 60. li Cotica, 25 fanti, che mancano a fare la mostra, e sono scritti. Franco da Nola, 100. l'crugino, 100. Fran· eescbino da VenP.zia, 100. Martino d'Ascoli, 100. Luigi del Verme, 100. Francesco da Perugia, 20. Domenico da Roma, M. Nanni da Siena, 30. Rinaldo da Bologna, 30. Bartolomeo da Perugia, 25. Gianantouio da Siena, 30. Giovanni da Fermo, 30. Giovauui da Moliera, 25.
Condoltieri di Fil'etue . Il signor Ardicione da Carrara, !ance 400 . Tali ano Furlano, t 25. Bèrnardo da Provenza, 1t3. Il signor di Faenza, 200. Pietro da Novarino. 150. Calizio da ...... , 40. An· lonio da Fresco, 20. Lance spezzate, 50. Nicolò Forlebraccio, 73. Nicolò da Tolenlino, 400. Il marchese di Fer1·ara, 500. Arrigo della 'fasca, 120. Foruaino da Bilma, 75. Pietro da Tramai', 25. Giovanni Lout.ino da Sisco, 58. Antonio Alberigo, 25. Bracesciai 83 •.
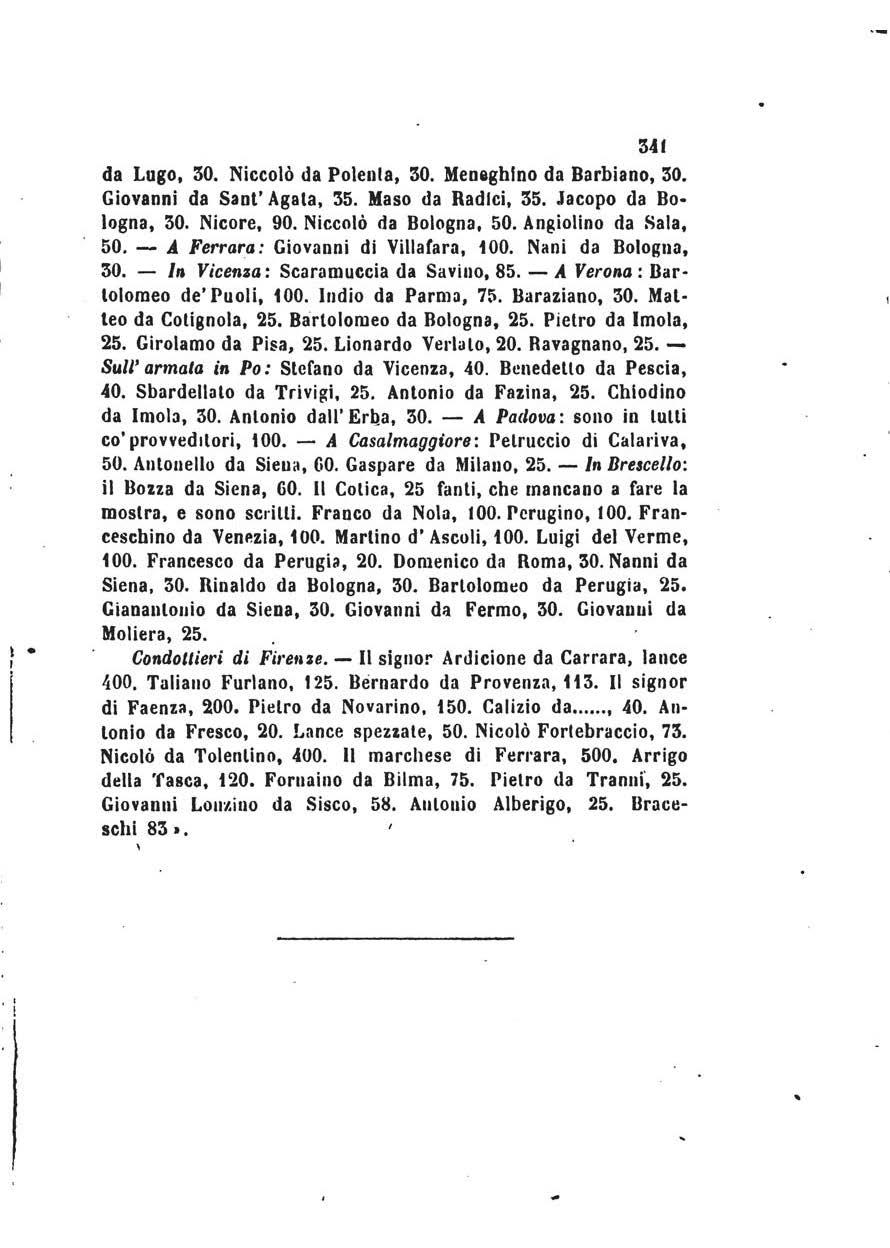
·CAPO IT.
ARTE MILITARE NEL SECOLO XVI. § . 1.0
Guerre lunghe c sanguinose straziar ono questo secolo XVI; d' ambizione, di religione, d' i ndipendenza.

Luigi Xli, il quale, succclluto in Francia a Carlo VIli, pretendeva al regno di Navoli pci litoli soliti degli Angioini, e al Milanese per eredità d'una Visconti avola sua, fece scendere in Italia uu di t O, 000 cavalli e t 3,000 fanti solto la condotta di Gian Jacopo Triulzio, e rovesciò la signoria di lodo\·ico il Moro senza colpo ferire; ma in bre,·c, ricacciatc le sue armi d.a prr sollevazione, più non gli rimase se non che Novara cd anche in procinto di cavitolarc col Moro, quando gli giunse un rinforzo di svizzeri. Svizzeri da una parte, svizzeri dall' altra, traquelli del Moro percllè meno pagati.
Pochi anni dopo, si strinse la famosa c ba·utta lega di Cambrai, colla quale Luigi Xli, Massimiliano d' Austria, Ft·rdinando il Cattolico, c papa Giulio 11, facc\'ano alleanza per comballeJ"e Venezia del cui ingrandimento si erano ingelositi. Luigi scese di Francia col Triu l zio c s' incontrò co' veneziani ad Agnadello il t 4 maggio f 509. Resistevano questi per qualche tempo contro la vanguardia francese; ma giunto il grosso dell' esercito nemico, e presi di fianco da Bajardu c da altri, dovettero cellere, c perdere colla giornata una gran parte dci domiuj da essi acquistati in tcr.raferm a.
3.43
oMo Venezia rialza il capo; toglie ai francesi gli alleati e ne forma una lr.ga con Giulio Il alla tes ta. In questo guerra brillò l' ingegno del giovane Gosto'ne di Foix; il quale, preso il comando de' francesi, si cacciò fra ' due eserciti nemici, spngnuolo e veneziano; •·espinse il primo da Bologna il 7 febb'rajo t 1St 2, ruppe il sccon do il t 9 dello stesso mese c riprese Brescia, poscio tornò sugli spngnuoli e sui popnlini e li sconfisse a Ravenna l' t t di Aprile. Morì in ' questo battaglia, lasciando celebrità acquistata in pochi mesi.
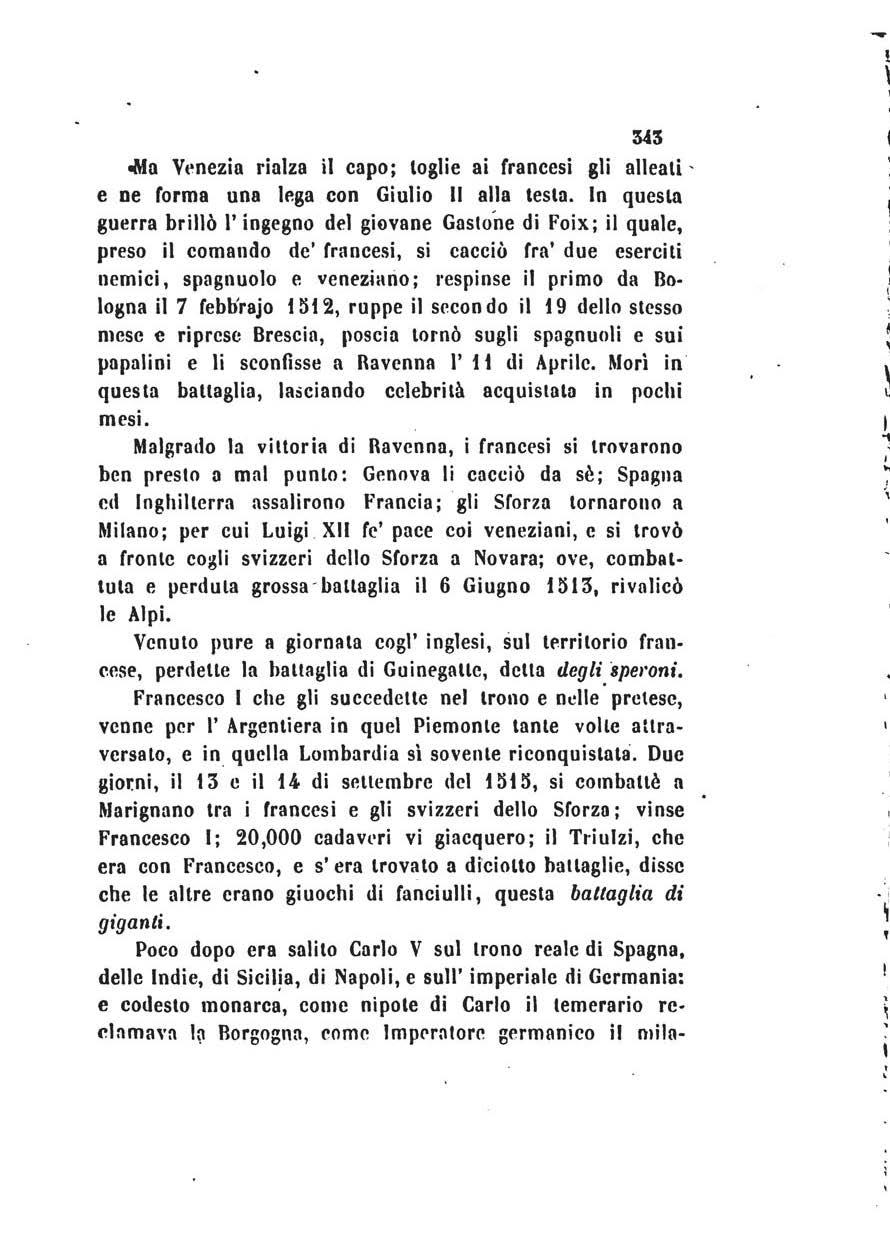
Malgrado la vittoria di Ravenna, i francesi si trovarono ben presto a mal punto: Genova li cacciò da sè; Spagna cd Inghilterra assalirono Francia; gli Sforzo tornarono a Milano; per cui Luigi . Xli fc' pace coi veneziani, c si trovò o fronte cogli svizzeri dello Sforza a Novara; ove, combattuta e perduta grossa battaglia il 6 Giugno HS15, rivolicò le Alpi.
Venuto pure A giornata cogl' in glesi, sul lr.rritorio francese, perd ette la battaglia di Guinegl\lte, detta degli 8petoni Francesco l che gli succedette nel trono e ndle ·pretese, venne per l' Argentiera in quel Piemonte tonte volte attraversato, e in. quella Lombardia sì sovente riconquistnta. Due gior.ni, il t 3 c il 14 di settembre del t 1St 1S, si combnllè a Marignano tra i francesi c gli svizzeri dello Sforzo: vinse Francesco l: 20 ,000 cadavt•ri vi giacquero: il Triulzi, che era con Francesco, e s'era trovato a dìcioUo battaglie, disse che le altre erano giuochi di fanciulli, questa battaglia di giganti.
Poco dopo era solito Carlo V sul trono reale di Spagna, delle Indie, di Sicilja, di Napoli, e sull' imperiale di Germania: e codesto monarca, come nipote di Carlo il temerario rc clnmaYn Borgognn , come lmprrnlor c germanico il miln-
344 nesf': Francesco l' rivendicava il regno di Napoli e la varra. Si venne a guerra. l francrsi, condoni dal maresciallo Lnuti'CC, furono sconfilli alla B!cocca il 29 Aprile t 522, e Carlo V conquistò il milanese.. Ridisceso Francesco l, assediò Pavia; assalito ne' suoi trincicramcnti, fulminò i nemici colla sua artiglieria; ma credendo di dover passare insrguimcnto, diè ordine a' suoi di carica•·e, c p oncndo l'esercito innanzi all'artiglieria, . costrinse questa .a cessare il fuoco. l nemici approfìllarono dell' e•·rore : e in quel dì 25 di febbraio del f 325, Francesco l perclè tutto fuor e/te l' onore. Rimasto prigioniero, in d i lasciato libero, si trovò di nuovo in guerra con Carlo, c ricercò persino ed ouenne l' ajoto dci turchi. Dopo lunghe louc r. vicende, fra cui la battaglia di Ceresole datasi il f 4 Aprile t 544, nella quale gl'imperiali toécarono grnvc rotto, si concluse tra Francesco e Carlo la pace di Crespi.
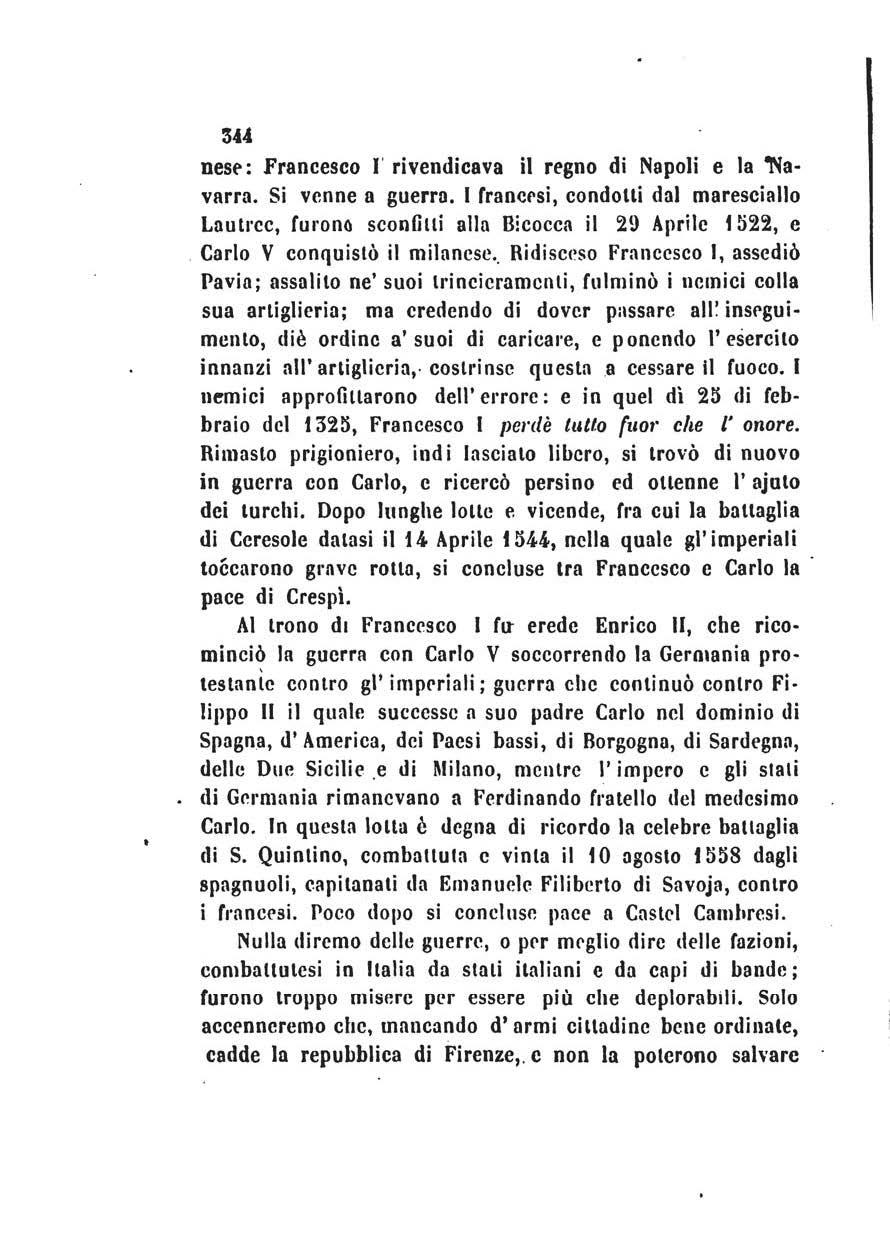
Al trono d1 Francesco l fil erede Enrico Il, che ricominciò la guerra con Carlo V soccorrendo la Germania protestante contro gl' imp<'riali; guerra che continuò contro Filippo Il il quale successe a suo padre Carlo nel dominio di Spagna, d'America, dci Paesi bassi, di Borgogno, di Sardegna , delle Due Sicilie .e di Milano, mentre l'impero c gli stati lli Germania rimanevano a Ferdinando fl'atello del medesimo Carlo. In questa lolta è degna di ricordo la celttbre battaglia di S. Qui n tino, combattuta c vinta il t O agosto t 558 dogli spagnuoli, capitanati da Emanuele Filiberto di Snvoja, contro i r.·nnC<'SÌ. Poco dopo si concluse pace a Castel Camhrcsi.
Nulla diremo delle guerre, o pC'r mf'glio dire delle fazioni, combattutesi in Italia da stati italiani e da capi di bande; furono troppo misere per essere più che deplorabili. Solo accenneremo che, mnncando d'armi cittadine bene ordinate, cadde la repubblica di Firenze, . c non la poterono sah·arc
345 nè gli scrilli del Muchiavelli nè il valore del Ferr1cci. Medici vi regnarono col titolo di duchi.
Cresciuta lentamente per via di eroici sforzi, la Casa di Savoja veniva all' orlo <kll' abisso fra il cozzo tempestoso della Francia e della Spagna.
In mezzo alle sciagure della sua famiglia, Emmanuele Filiberto militò negli eserciti imperiali di Carlo V, comba'uè in Piemonte, poscia prese parte alle guerre in Loreoa e nel Lucemburgo, indi, mandato nelle Fianda·c, diè poi la bauaglia di S. Quintino nella quale sconfisse le armi francesi, e in conseguenza prese la piazza del medesimo nome da lui assediata.
Allora Enrico Il di Francia senti il bisogno della pace, che fu conclusa, come dicemmo, nel t :S:S9 a Castel Cambresi, e per la quale Emmanuele Filiberto tornò al possesso dc' suoi stati e si diede a riordinarli.
Nel t :>62, scoppiò irf Francia la lotta civile tra ugonoui c papisti sotto il regno di Carlo IX. Ogni provincia, ogni fu teatro di guerra. l Montmorency, i Guisa, i Condè, i Coligny, combatterono fra loro aspramente. Fra le battaglie che si è celebre quella di Montcontour avvenuta nel t 569, in çui i protestanti comandati da Coligny vennero battuti. La strage degli ugonotti, consumatasi la notte di S. Bartolomeo del t :S72, fu il più orribile episodio di quella tolta orrenda.
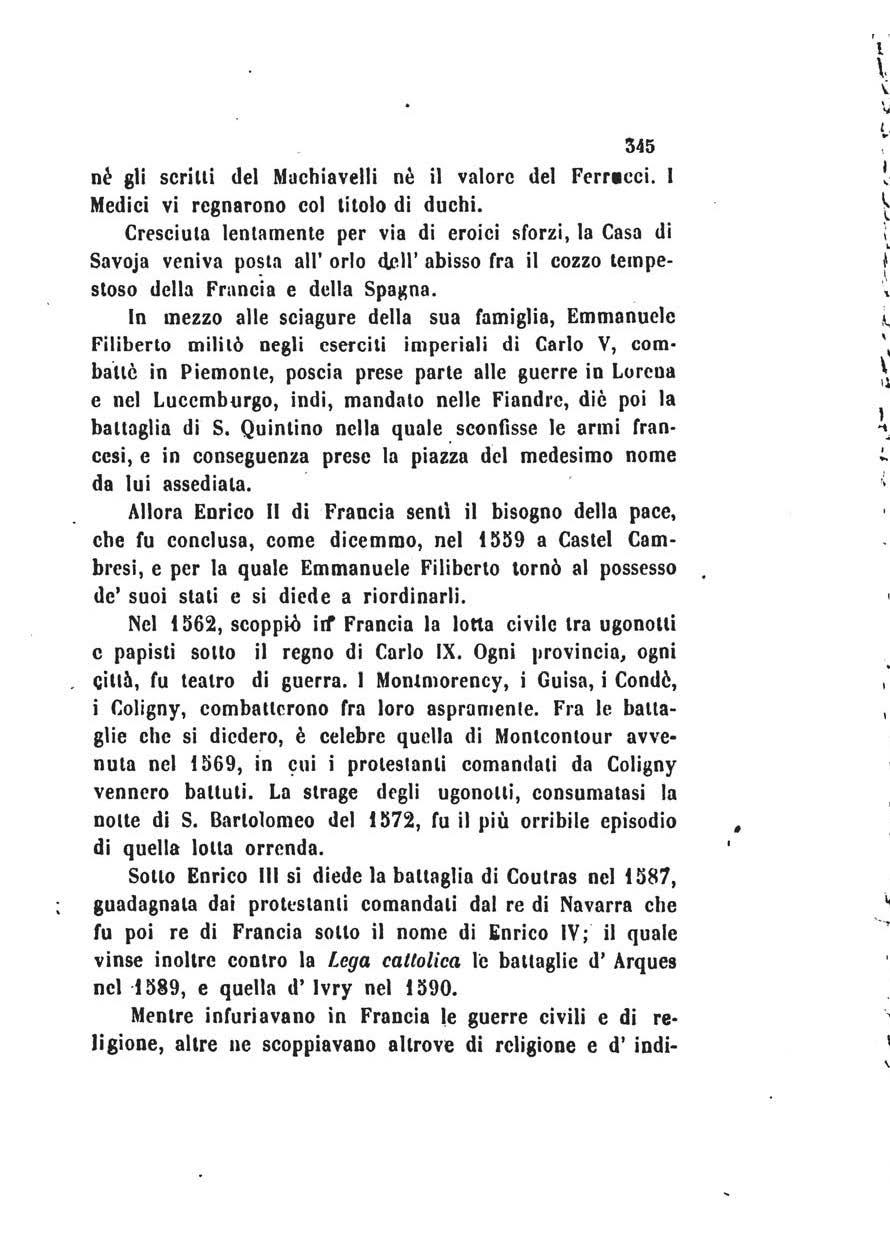
Souo Enrico 111 si diede la battaglia di Coutras nel t 587, guadagnata dai protestanti comandati dal re di Navarra che fu poi re di Francia sotto il nome di Enrico IV; · il quale vinse inoltre contro la lega cattolica le battaglie d' Arques nel ·t !589, e quella d' lvry nel 11S90.
Mentre infuriavano in Francia le guerre civili e di re· Jigione, altre ne scoppiavano altrove di religione e d' indi-
il
•
346 pendeaza. La tirannide e il fanatismo di Fil!ppo Il re di Spagna, aveva indotlo a sollevazione i nobili de' Paesi Bas· • si, che dagli spagnuoli venivano insolentemente denominati coll'epiteto di Mascalzoni. Il quca d'Alba, generale di Filippo, soffocò dapprima la rivolta col sangue; ma dovè retrocedere innanzi al coraggio dei Alascalzoni, di cui uno, Guglielmo d' Orange detto Il taciturno, la Confederazione delle sette provincie e ne fu nomalo StatoldeJ'. Una moltitudine di protest&nti francesi si rifugiò in questa repubblica; la qual e, coll' appoggio dell' Inghilterra, potè lottare con vantaggio contro gli eserc iti spagnuoli, comandati da Alessandro Farnese duca di Parma. A Gugliclme d' Orange successe suo figlio Maurizio di Na!'sau ; e la lotta continuò fra questi cd il Farnese, fondando ·le due scuole di guerra delle la Cattolica c la Protestante.
Filippo Il fu ancora in guerra coll'Ingh ilterra , contro la quale aveva spedito la sua nutnerosa flotta a cui egli pomposamente dava il nome di Invincibile armata, e che fu distrulla dai venti e dalla marina ·inglese.
In questo secolo XVI i turchi estesero le loro invasioni in Eui'Opa: So limano Il entrò nella politica europea e prese parre per la Francia contro l'impero germanico colla sua floua formidabile, comandata dal Barbarossa signore di Algeri, la q un le comhallè nell'arcipelago e nelle coste d' Italia. Sotto il suo successore Sclim Il, si diede la battaglia di Lcpanlo il 17 ouobrc f57t, in coi la Ooua cristiana ormala dal papa, da Casa Savoja, da Venezia, e da annientò la tu rca .• Ma le potenze cristiane non seppero prevalersi della vitt.oria, e i t•uch i continuarono. nelle loro conquiste.
Prima di chiudere questo sunto, giudichiamo opportuno di dire una parola sul modo con cui erano costituite alcùnc nazioni di Europa nella seconda metà del secolo XVI.
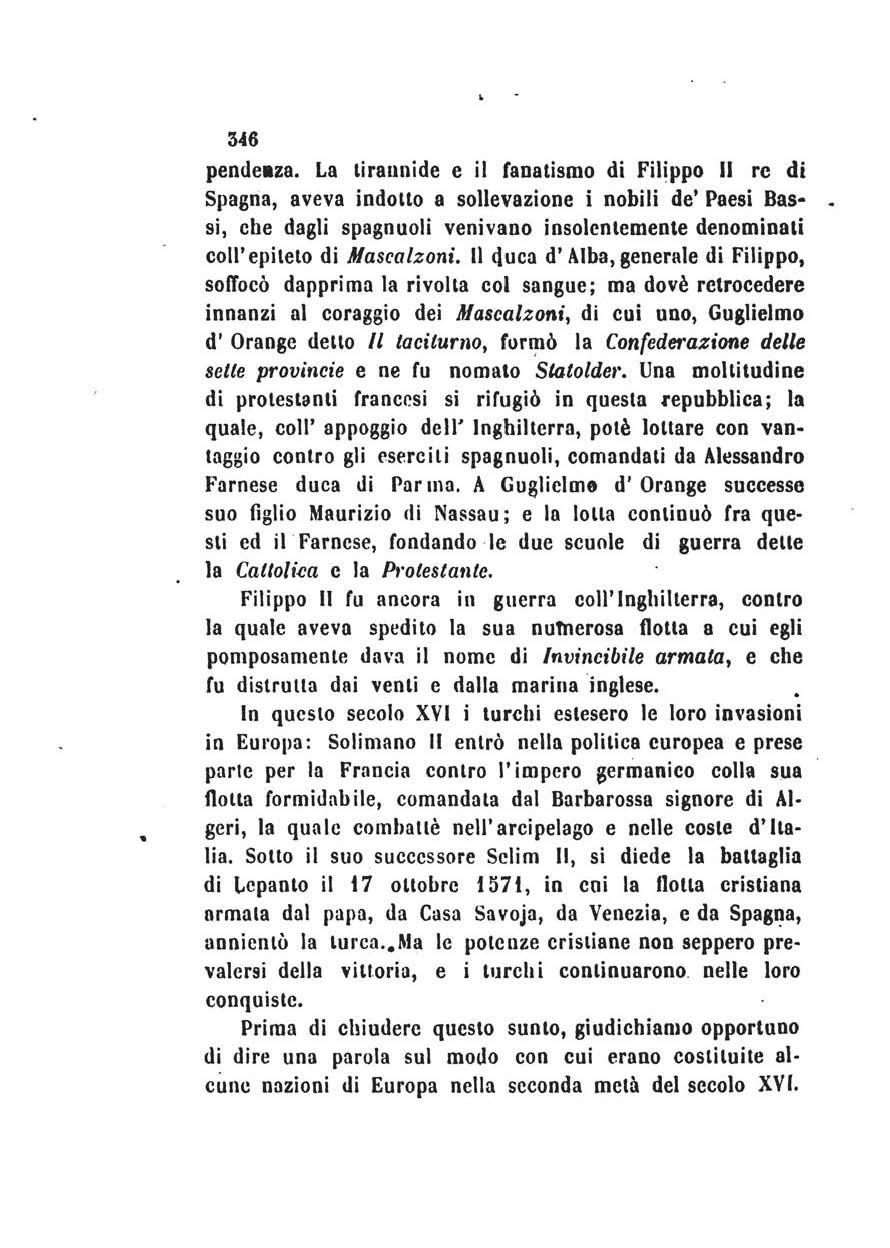
341
Già fino dal secolo antecedente alcuni popoli si congiungevano i n corpo. di nazione.
In Inghilterra, Arrigo VII, riuniva per maritaggio nel 1486 le due case di Lancastro e di York, rap'presentate dalle fazioni della Rosa rossa e della Rosa b'iatlca .
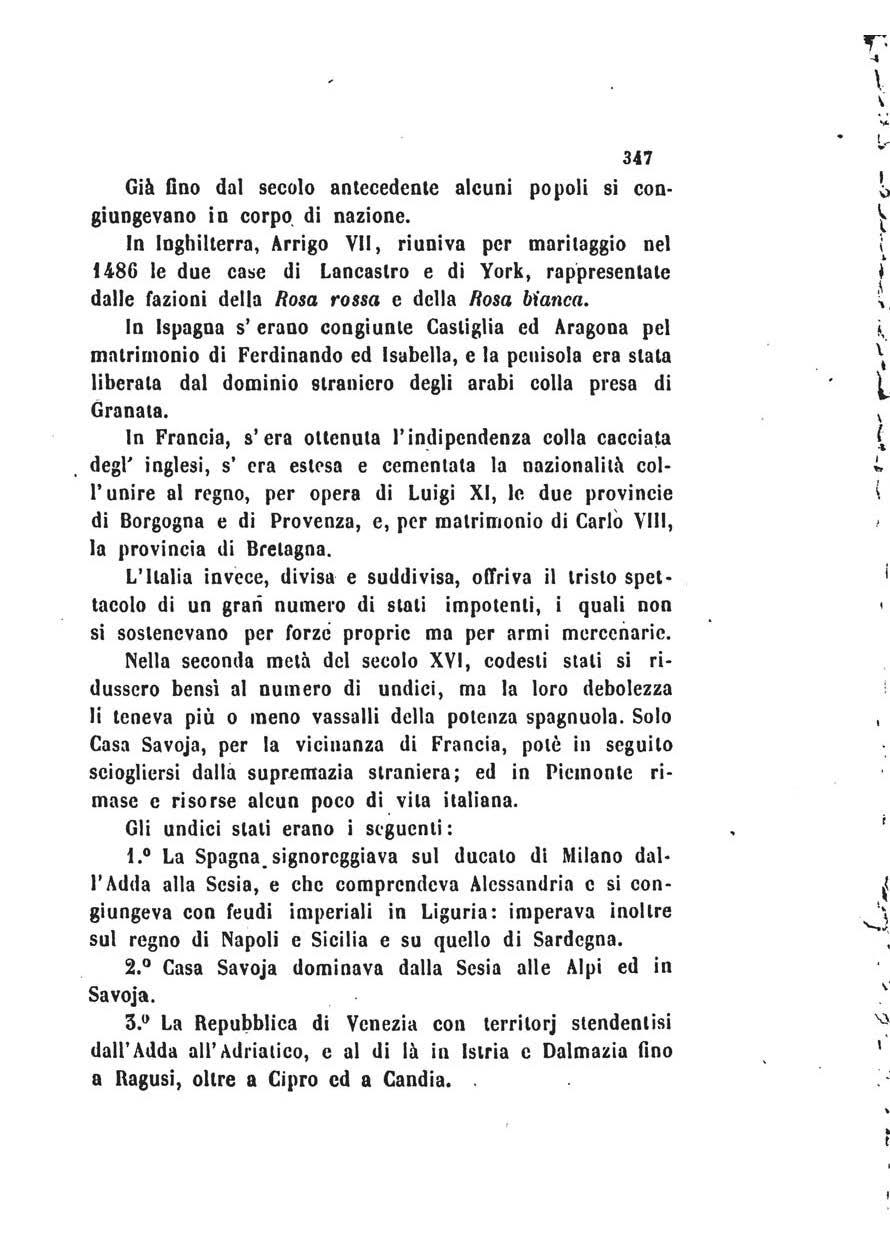
In lspagna s'erano congiunte Castiglia ed Aragona pcl mntrimonio di Ferdinando cd Isabella, e la penisola era stata liberata dal dominio straniero degli arabi colla presa di Granata.
In Francia, s'era ottenuta l' colla degl' inglesi, s' era estC'sa e cementata la nazionalità coll' unire al regno, per opera di Luigi Xl, le due provincie di Borgogna e di Provenza, e, per matrimonio di CariÒ VIli, la provincia di Bretagna.
L'Italia invece, divisa e suddivisa, offriva il tristo spettacolo di un gran nume1·o di stati impotenti, i quali non si sostenevano per forzé proprie ma per armi mercenarie.
Nella seconda metà del secolo XVI, codesti stati si ridussero bensì al numero di undici, ma la loro debolezza li teneva più o meno vassalli della potenza spagnuola. Solo Casa Savoja, per la vicinanza di Francia, potè in seguito sciogliersi dallà supr.emazia straniera; ed in Piemonte rimase c risorse alcun poco di . vita italiana .
Gli undici stati erano i stgucnti:
1.0 La Spagna. signorcggiava sul ducato dl Milano dall' Adda alla Sesia , e che comprendeva Alessandrin c si congiungeva con feudi imperiali in Liguria : imperava inollre sul regno di Napoli e Sicilia e su quello di Sardegna.
2.° Casa Savoja dominava dalla Sesia alle Alpi ed in Savoja.
3.0 La Repu\>blica di Venezia con territorj stendentisi dall'Adda all'Adriatico, c al di là in lstria c Dalmazia fino a Ragusi, oltre a Cipro cd a Candia. .
548
4. 0 La Republica di Genova colle due riviere, 'frastagliate da feudi imperiali, e colla Corsica.
5.' Il Monferrato c il Ducato d i Mantova sono i Gon· zaga. ·
6. 0 Il Parmigiano sotto i Farncsi.
1 .o Il Ducato di Modena c Ferrara sotto gli E..stensi: nel t 598 quello di Ferrara passò sono il dominio dei papi.
8.• La Toscana solto i Medici.
9. 0 Il Ducato di Urbino sotto della Rovere. t 0. 0 La RE-pubblica di Lucca. t t . 0 Lo Stato pontificio.
In Francia. Luigi Xli c.ontinuò a dare impulso allo sviluppo della fanteria : procurò di disciplinarla e darle consistenza e considerazione; Bajardo ed nlLri cavallierj accettarono il comando di bande a piedi; Mootluc lasciò la lancia per la picca.
La fanteria francese era allora generalmente composta di guasconi e di piccnrdi. l primi avevano balestre, portavano la celata c corsaletto di ferro. l secondi erano armati di picche. Francesco l pose anche maggior alacrita nell' ordi nameoto . della fanteria francese. Alla battaglia di Marignano mise piede a terra, e ponendosi alla testa della fanteria colla picca alla mano, si lanciò alla carica gridando • Chi mi vuoi ben mi segua ! • Accesi gli animi da queste parole, i fanti fraocesi fecero prodigj di valore e ruppero le falangi svizzere.
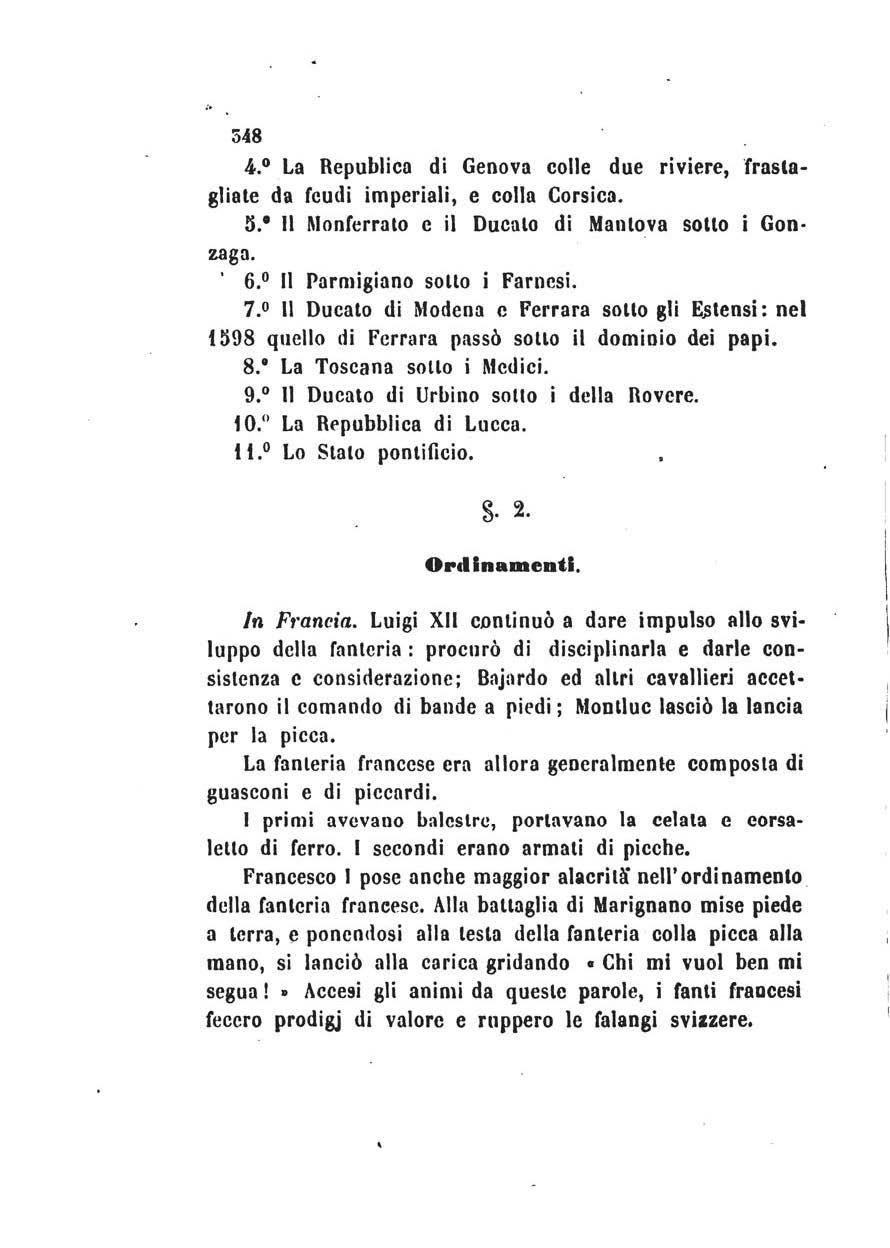
Sul principio del suo regno, la fanteria francese componevasi di compagnie d-' avventurieri, e di compagnie lcv ate per commissioni, io Linguadoca, in Guascogna.• c in Piccardia. Si chiamavano Vecchio bande, e le guerre continue le avevano rese permanenti.
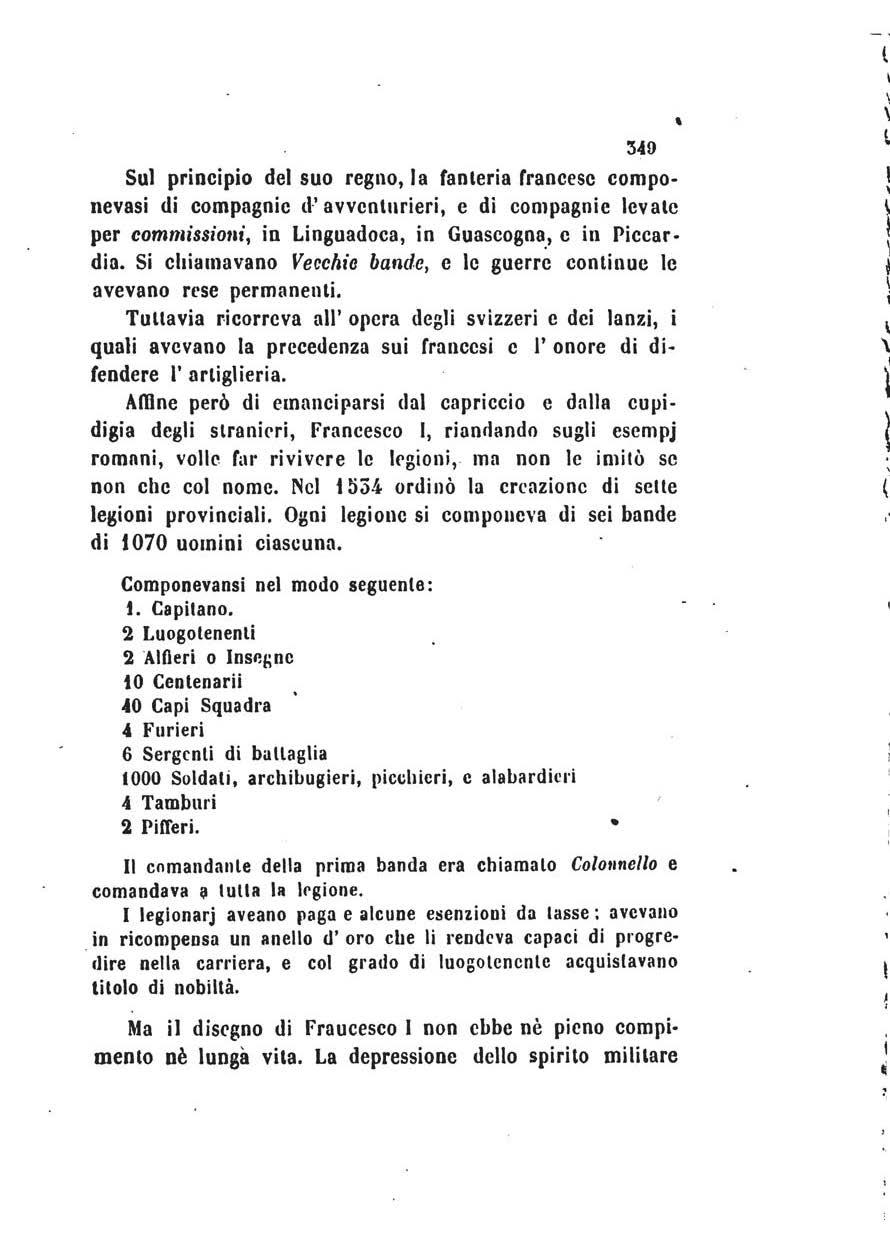
Tuttavia ricorreva all' opera degli svizzeri c dci !anzi, i quali avevano la precedenza sui francesi c l' onore di difendere l' artiglieria.
Affine però di emanciparsi dal capriccio e dnlla cupi· digia degli stranirri, Frnncesco l, rianrlando sugli escmpj romani, volle far rivivere le lrgioni, . ma non le imilò se non che col nome. Nel t !534 ordinò la creazione di selle legioni provinciali. Ogni legione si componeva di sci bande di f 070 uomini ciascuna.
Componevansi nel modo seguente: t. Capitano.
2 Luogotenenti
2 Alfieri O lnSP.ljnC iO Centenarii 40 Capi Squadra 4 Furieri
6 Sergenti di ballaglia tOOO Soldati, archibugieri, picchicri, c alai.Jardicri 4 Tamburi 2 Pifferi. •
Il comandante della prima banda era chiamalo Colounello e comandava 41 luliR la h•gione.
I legionarj aveano paga e alcune esentiooi da lasse: avevano . in ricompensa un anello d' oro che li rendeva capaci di progredire nella carriera, e col grado di luogolcncnlc acquistavano titolo di nobiltà.
Ma il disegno di Froucesco l non ebbe nè pieno compi· mento nè lungà vita. La depressione dello spirito militare
, 350 in Francia, uon lll'rmisc l'l1c si il numero sufficiente ti' uomini che rrano richiesti per le lrgionii il sisl('ma gt!· rarchico di tliLH' llllcnza dal comandante la prima banda c tuua · la legione, toglieva ai singoli cupitani la facilità di far brillare individualmente il proprio uomc i la disci· plina non pohwa esercitarsi in corpi, per quc'tcmpi special· mente, troppo grossi i per In qual cosa si ricorse di nuovo all ' antico sistema delle IJande isolate.
Le differenze principali tra le legioni e le bande sono le seguenti:
1. o Le legioni rapprest•ntavano un' imposta personale sulla nazione; le bande rappresentavano nn' imposta pecuniaria; impcrocchè in luogo di levare uomini come si faceva per riempiere le prime, si esigeva invece una taglia chiamala il soldo di cinquanta mila uomini a piedi, colla quale si pagavano gli assoldali nelle bande.
2. 0 Le legioni avrebbero dovuto t•ispoudere meglio ai principj della lattica e ai bisogni dell' amministrazione; le bande, essendo formale di corpi più piccoli e indipendenti, porgevano occasioni di distinguersi ad un maggior numero di capi, ed in tal guisa secondavano meglio l' llmbizione e la vanità.
Lt! bande erano C()tnpostc di avventurieri i (]Uali erano assoldati da colui che n'era investito del comando. Rcclu· tavnnsi nell' inlcrno cd all'estero. Vi accorrevano per lo più genlc e di mala vi la i ciò non toglie che nllc volte, e specialmente in quelle che comballcvano all' cslero, vi fossero uomini di genere migliore.
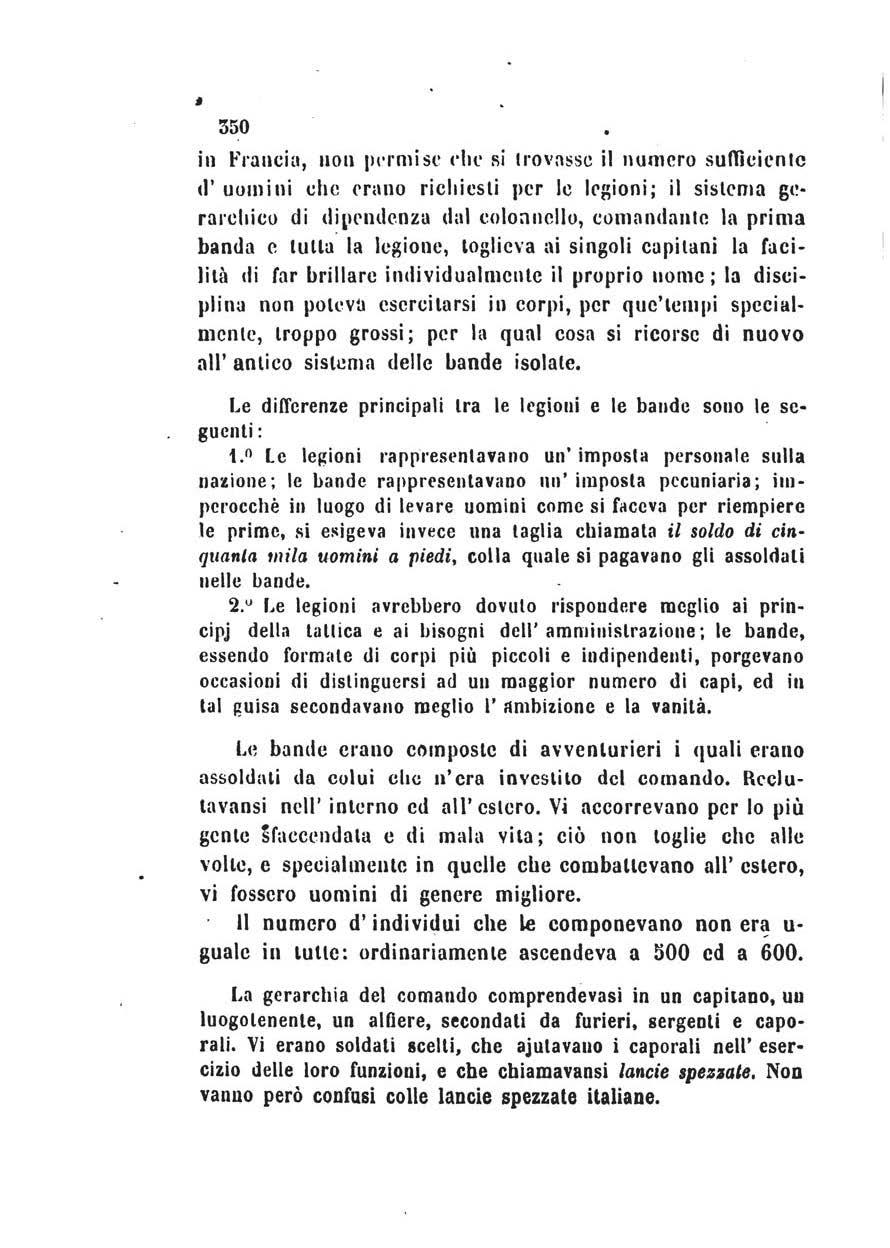
Il numero d' che Le componevano non erl! uguale in Lullc: ordinariamente ascendeva a 500 cd a 600.
La gerarchia del comando comprendevasi in un capitano, uu luogotenente, un alfiere, secondali da furieri, sergenti e caporali. Vi erano soldati scelti, che ajutavano i caporali nell' esercizio delle loro funzioni, e che cbiamavansi lancie spenate. Non vanno però confusi colle lancie spezzate italiane.
351
Le armi ofl'ensi ve erano: picca e spada per la fanteria peaante, archibugi e spada per la lr.ggiera. Le dift>nsive: elmi, bracciali, manopole e coscia li per la pritna; la seconda aveva ripugnanza per tullo quanto le arrecava peso e difficoltà di movimenti.
Le bande si fonnavano in quadrato pieno, ad imitazione svizzera c spagnuolu; picchicl'i al ccnu·o, archibugieri all' esterno.
Le bande francesi si dividevano in due grnndi categorie: l 0 bantle di Picrn on Le che combnttevan(l per In conquista tanto desiderata del milanese c del resto ù ' Italia.
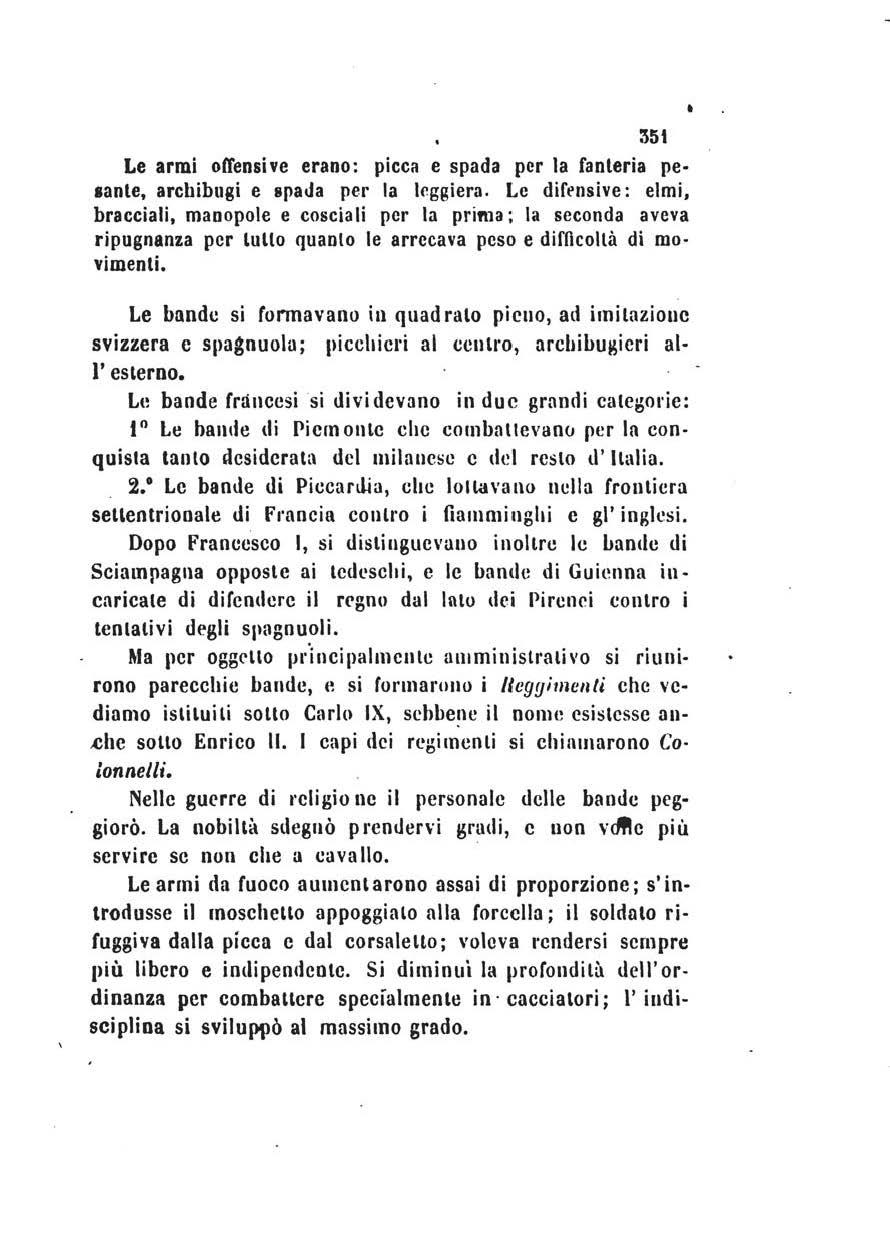
2.• Le bande di PiccarlUa, che lollavano nella frontiera seuentriooale di Francia contro i fìammiughi c gl'inglesi.
Dopo France'sco l, si disti ngucvano i noltre le IJandc di Sciampagna opposte ai tedeschi, e le bande di Guienna incaricale di difendere il rrgno dal lnLo dci Pirenei contro i tentativi degli spngouoli.
Ma per ogg<'LlO IJI:incipalmcnte a111minislralivo si riunirono parecchie bande, si fol'lnaruno i Ucgyimctlli che vediamo istituiti sotto Carlo IX, il nome esistesse an.chc souo Enrico Il. l capi 1lei rcgimcnli si chiamarono Colonnelli.
Nelle guerre di rcligio ne il personale delle bande pcg· giorò. La nobiltà sdegnò p a·eot.lervi gradi, c non v<Mc più servire se non che a cava Ilo.
Le armi da fuoco aumcnt aro no assai di proporzione; s'introdusse il moschetlo appoggiato alla forcella; il so ld ato rifuggiva dalla picca c dal corsalelto; voleva l'cndersi sempre più libero e indipendente. Si diminuì la profondità dell 'o rdinanza per combatlcre specialmente in · cacciatori; l' indi sciplina si sviluppò al massimo grado.
Siccome allora il moschcHo non era arma da urto, cd agiva sohanto col fuoco, ne veniva di consf'gucnza che l' ar· mamento restava privo di una qualità necessaria.
Il resto dell' armamento ed equipaggiamento era il séguP-nte: un ·morione, un corpetto di bufalo, un sacco ad anelli, un como da polvere.
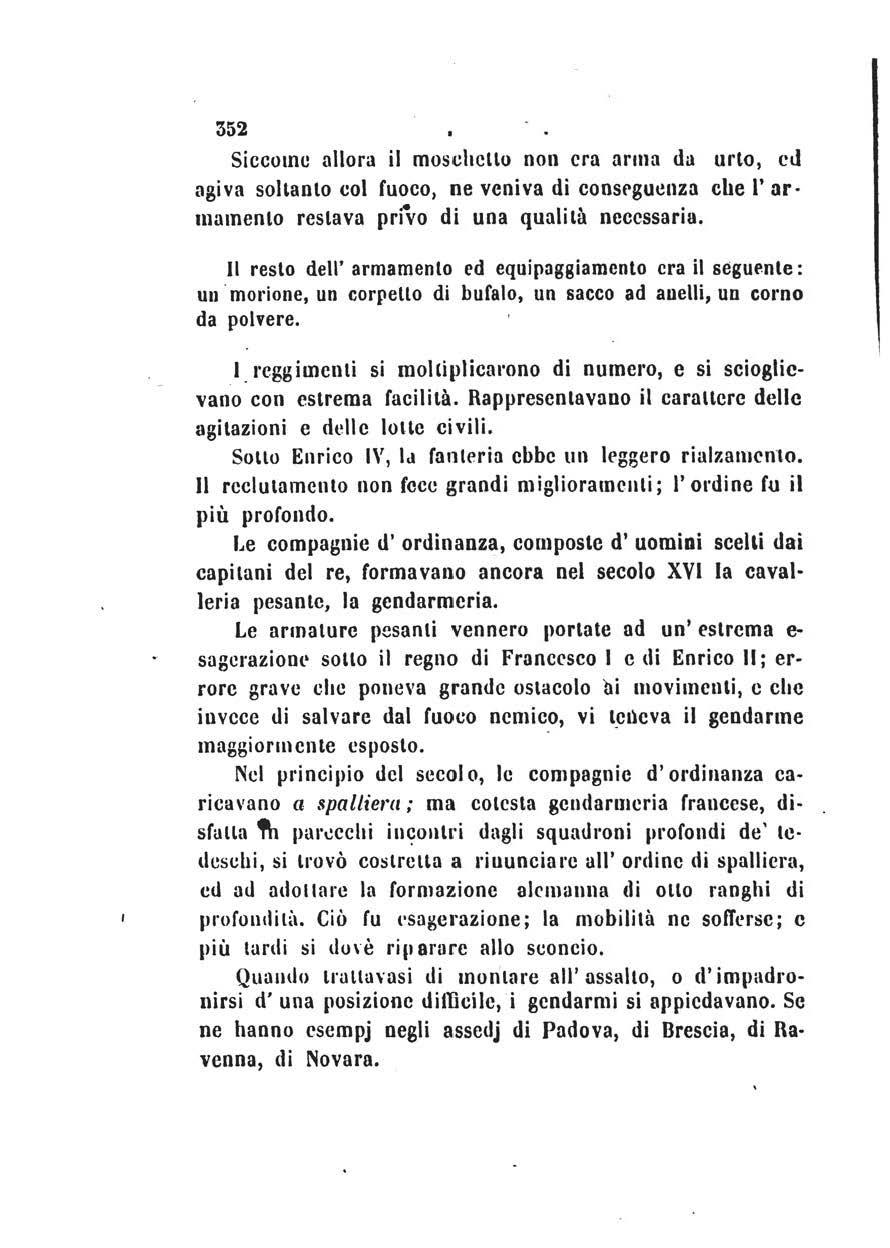
l . rcgg i menti si moltiplica•·ono di numero, e si scioglievano con estrema facilità. Rappresentavano il caraltere delle agitazioni e ddle lotte civili.
Sotto Enrico 1\', l.t fant eria ebbe un leggero riub:amenlo. Il reclutamento non fece grandi miglioramenti; l'ordine fu il più profondo .
Le compagnie d' ordinanza, composte d' uomini scelli dai capitani del re, formavallo ancora nel secolo XVI la caval· leria pesante, la gendarmeria.
Le armature pesanti vennero (lOrtate ad un' estrema esagcraziont• solto il regno di Francesco l c di Enrico Il; errore grave che poneva grande ostacolo bi movimenti, c che iuvcce di salvare dal fuoco nemico, vi il gendarme maggiormente esposto.
Nel principio del secolo, le compagnie d'ordina nza caricavano a spalliel'a; ma cotesta gendarmeria frances e, disfalla JHll'l!cchi dagli squadroni JH'ofondi de' le· deschi, s i ll·ovò costrclla a ri uuncia re all' ordine di spalliera, cd ad adottare la formazione alrmauna di ollo ranghi di profontliti\. Ciò fu t•sagerazione; la mobilità ne sofTl'rse; c più tardi si tlo\è riparare allo sconcio .
Quando lrallavasi di montare all'assalto, o d' impadronirsi d' una posizione ditlìcilc, i gendarmi si appiedavano. Se ne hanno rsempj negli a,ssedj di Padova, di Brescia, di Ravenna, di Novara.
3!'13
Nelle guerre d'Italia, Francesco l formò Ùn corpo di ca. vallcria leggicra sollo la condona dci principali signori italiani.
In quell'epoca si annoveravano nt>gli eserciti francesi qua t· tro specie di cavalleria, che si distinguevano per le arma· tu re e per l' altezza dci cavalli: t 0 l gendarmi • 2° 1 cavai· leggeri • 3° Gli sLradiotti · 4° Gli archibugieri, detti poscia At•gotdets.
Nel f t;43, c solto il regno di Enrico Il, Pietro Strozzi, non Brissac, creò i dragoni, i quali erano archibugieri il cui servizio richiedeva di combattere a piedi ed a cavallo .
La cavalleria, e specialmente la leggiera, continuò ad aumentare la sua profondità. · .
Nelle guerre di religione s' accrebbe il numero delle armi da fuoco anche nella cavalleria.
Un'altra variazione s'in tradusse allora; la carica al trollo, disciplinata; in luogo della carica a briglia sciolta, fino al· lora disordinata.
La diminuzione della · velocità, c l' aumento del peso nelle armature, a·endevnno In lancia inoffcnsiva pcl cavallicre. Si preferì la pistola; si soppresse la lancia. A questo cambia· mento influì anche la difficollà, che fu eonsrgucnza di ·quella guerra civile, di trovar cavalli atti al gendarme che' si sP.r· viva di lancia.
Oltre alla pistola, il gcndnrmc aveva la schioppclta. · Si fuorviò: la cavalleria non agiva più coll' urlo, ma col fuoco.
Ebbe JlUrc origine a que' tempi una cavalleria baslart1a di Corazzieri; e ve ni va considerata bastarda pere hè nel suo armamento non entrava a far parte la lancia del gendarme, e percbè montava cavalli meno imponenti di quelli degli uomini d' ormi.
S tor dell ' Art. MiliL i3.
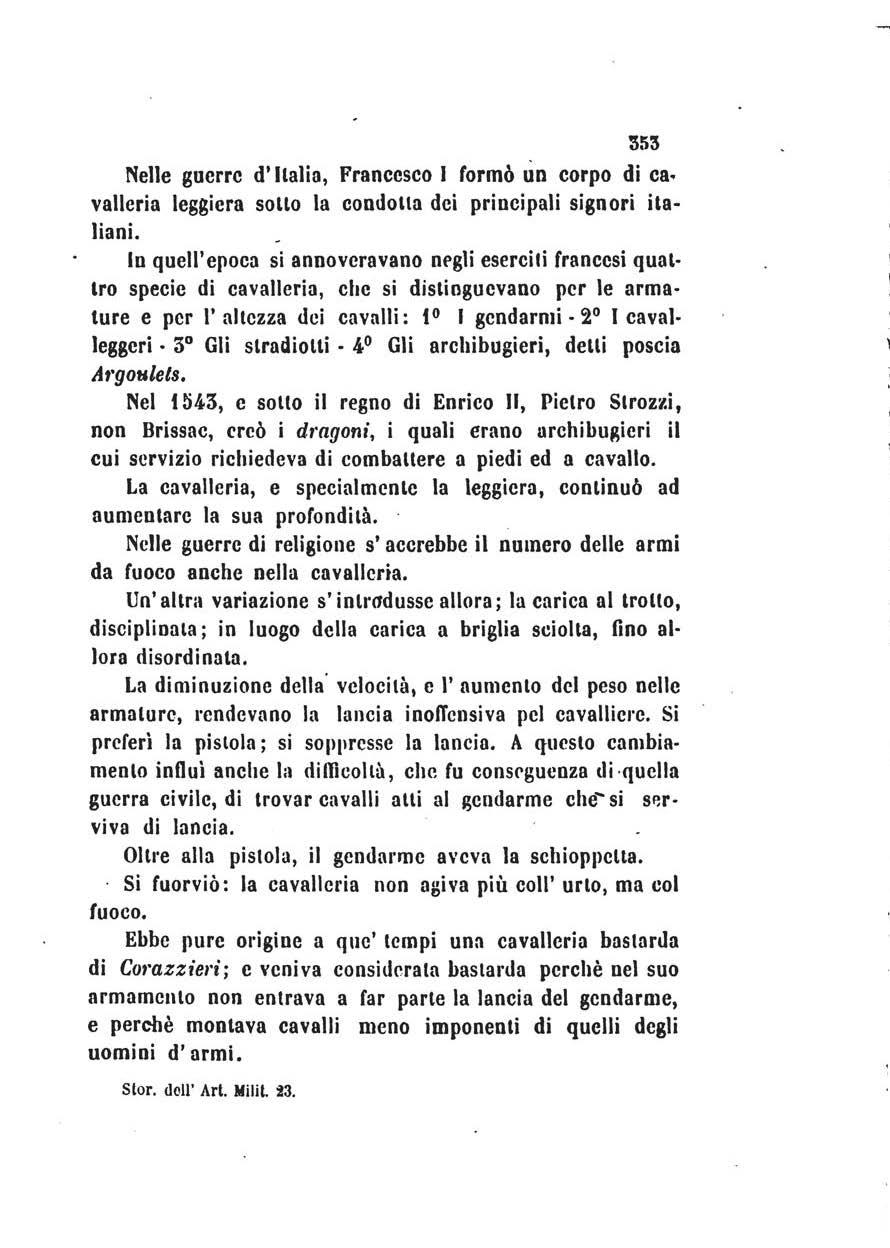
Enrico IV, la poca mobilità degli squadroni 11rofondi c ga·ossi di t 500 a 2000 cavalli, e d' altra parte la dcbolezz1.1 detic cariche a spalliera, adottò squadroni di 300 a 600 cavalli, disposti su cinque ranghi. Ma non fu · questa una formazione stabile e pea·mnnentc; fu d' occasione c nulla più.
Tutta questa serie di metodi successi.vi per la formazione degli eserciti, non aveva però fatto abolire il sistema di racil bando e il retrobando a cui il re P.oleva ricorrere, e non impediva che si assoldassero milizie all'estero e spet:ialmente in !svizzera cd in Germania.
Col bando si con\·ocavano i \'assalti; col retrobando lulli gli uomini abili a portare le armi.
Visto l'inconveniente dci bamli c rcta·obandi falli ana t'infusa al momento del bisogno, venne siabilito una rivista annua alla quale dovc\'ano com'parirc in persona tutti coloro che n'erano obbligati; e per meucrc un po' di regolarità, s'istituì un Capitano generale del bnndo e t'ctrobnndo.
Le truppe assoldate erano per la maggior parte licenziate alla pace; la sola truppa JH'rmanentc era la guardia del rE', forte di quallrocento uomini, alcune compagnie isolate di fanteria c di cavalleria, c alcuni deboli prcsidj di piazza.
Ai tempi di Francesco l, Pietro Navarra, soldato a Gen.ova, ufficiale nell'esercito spagnuolo, generale sotto Ximcncs, vin· citore degl' inglesi e degli algerini, cadde pl'igioniero dci francesi sotto Rologna; c ahbandonnto dalla Spagna che obbliava i suoi rnrriti, si diede con riconosccn1.a al servizio di Francia che lo aveva accolto, c'l istituì il corpo dci minatori. Gl'ingegneri francesi, diretti da lui, prepararono i successi del secolo segue n le.
L' artiglieria, ai tempi di Luigi Xli, differiva po·co da quella di Carlo VIli. I parchi erano numerosi come nel re-
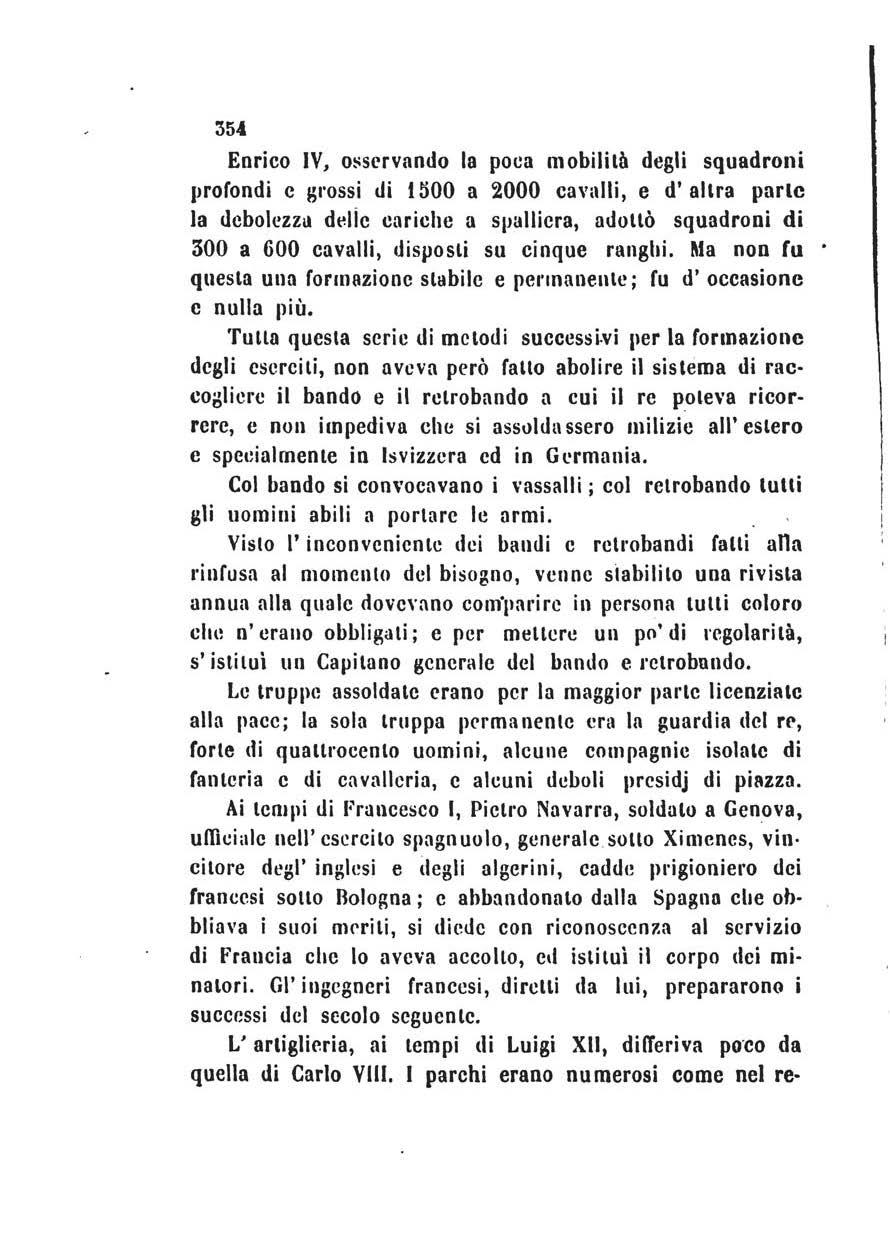
355 gno antecedente. La tra i pezzi e il personale dell'esercito era di tre o quattro ogni mille uomini. Sebbene nelle circostanze ordinarie l'artiglieria cominciasse ad incagliare un po' meno la marcia, pu1·e nelle circostanze critiche si faceva molto sentire la poca mobilità dci pezzi grossi. Tuttavia i piccoli calibri erano abbastanza mobili per poter prendere con qualche sollecitudine nel combauimcnto posizioni vantaggiose.
Solto Francesco l, l' artiglieria ebbe un grande aumento. Nella difesa delle piazze, i pezzi erano immensamente luoghi; negli· equipaggi da assedio c di erano abbastanza corti c ridotti a poco numero di calibri; locchè portò maggiore semplicità.
Enrico Il fece ridurre a sci il numero dei calibri, c adottò il pezzo da 35 ch' era il medio fra il troppo pesante c il troppo corto.

-Nelle guerre di religione l'artiglieria diminuì immensamente per le seguenti ragioni: i .G Per J' esaurimento dei mezzi pecuniarj: 2.0 Pcrchè si dovcue armare con essa una grande ttuaotità di luoghi: 3. 0 Per rendere più spediti i movimenti .delle truppe. Il maggior numero di pezzi stava in potere di coloro che possedevano ·la capitale. Enrico IV, finchè non ebbe Parigi, traeva i suoi cannoni c le sue ·munizi"oni dall' Inghilterra.
Riguardo all'istruzione militare in Francia, sappiamo che i giovani gentiluomini si educavano fra le truppe della casa del principe, o. nei corpi, specialmente di gendarmeria. Il capitano Lanouc, distinto guerriero c scr ittore, tracciò un disegno per l' istit9zione di scuole speciali per istruzione militare; ma l'attuazione delle sue idee era serbata ad un' epoca a lui posteriore.
356
Nt!Ha seconda metà del secolo XVI, tuui i ceLi dcHa so· ci età si dedicavano agli esercizj mili lari, essendo obbligati duHa guerra civile di somministrare soldati e di comballere. Persino i preti si uniformavano alle costumanze di guerra.
La disciplina mancava nel soldato francese e nei soldati stranieri. Ollre alla gelosia che regna va fra questi e quelli, per cui nc ve ni vano risse e lotte, allrc cause concorrevano a destare e mantenere J' indisciplina oellc_truppe; frn queste il passare_ improvvisamente dalla soggezione in cui era tenuto un paesano, alla libertà ed alla licenza della guerra; Ja scarscua di paga, che spingeva i soldati al fur to ·ed a tulti gli eccessi, e faceva sì che i capi dovessero toHcrare. Si tentarono però varj mezzi per rimcdiarvi, ma non si ot· tenne l'intento in modo soddisfacente.
Per l' amministrazione havvi da osservare che il servizio dei viveri differiva a seconda del modo con cui erano levate le truppe. Quelle del bando e del relrobando erano approvigionate col mezzo di requisizioni lasciate a disposizione degli ufllciali incaricati della leva e della condotta del bando.
Quelle degli assoldali nnivano nutrite dai loro capitani. Il governo pagava a ciascuno di questi somma convenuta pel reclutamento, una pea· le ,rimonle, un' altra pel soldo; e quest' ultima cJoveva bastare a tutte le somministrazioni necessarie per nulria·e e alloggiare i soldati. tanto in salute quanto io malattia. te armi erano eccettuate. Le cure del governo, dopo avere assicurato il soldo, si limitavano a far trovare provvigioni lungo le strade e nei campi, afll111chè gl' incaricali delle còmpere non difOcullà, pagan do, a far vivere l' esercito.
Immensi abusi nell 'a mministrazione Je lrup· pc; c queste si rivendicavano 11Ui poveri paesi da esse oc· cupati, e sui prezzi di riscatto che a loro si lasc iavano per diritto. ·
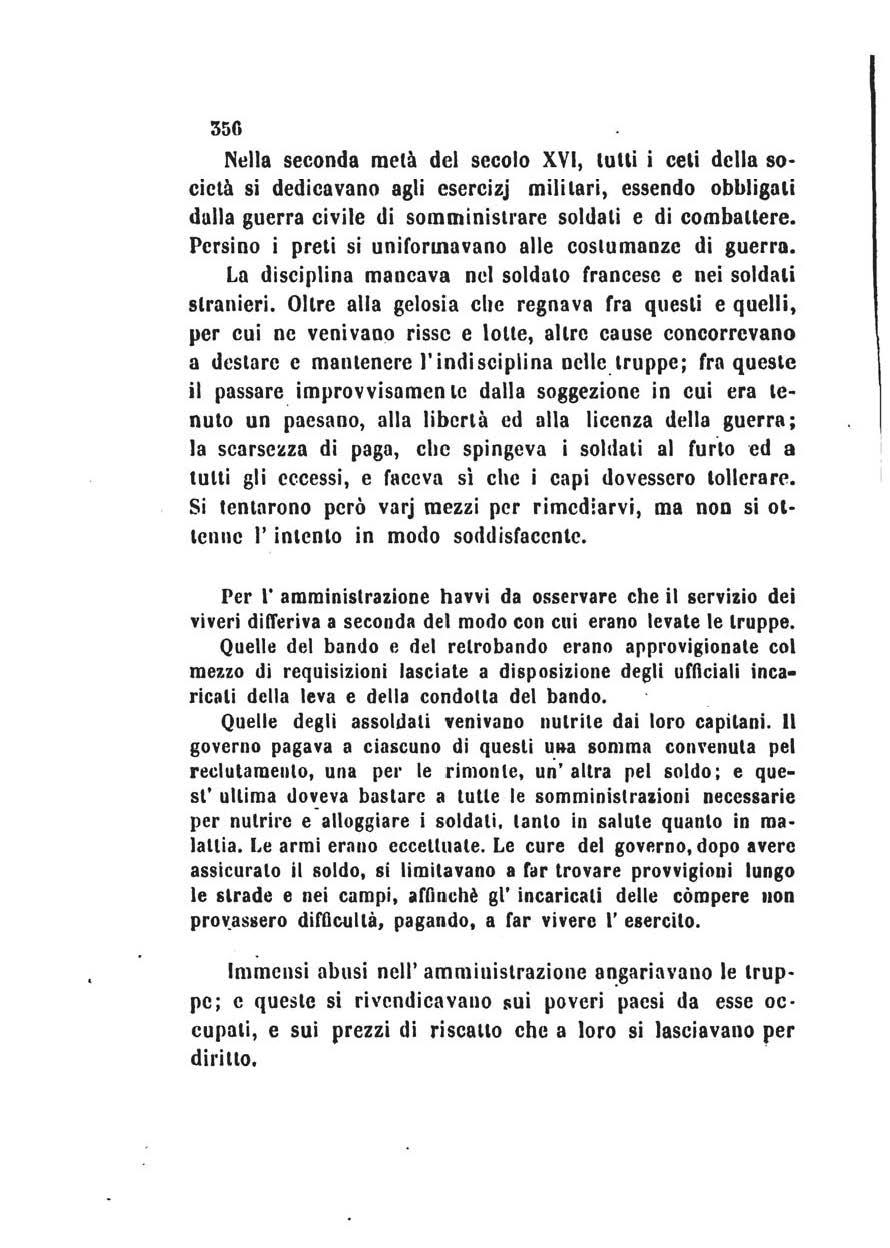
35'i Solto Enrico Il, veduti i mali provenienti da questa specie di mezzi amministrativi, il governo ricorse ad altri provvedimenti; s' incaricò di somministrare in natura i viveri delle truppe assoldate, supplire a quelli delle nazionali, e di regolare la distribuzione di tutti.
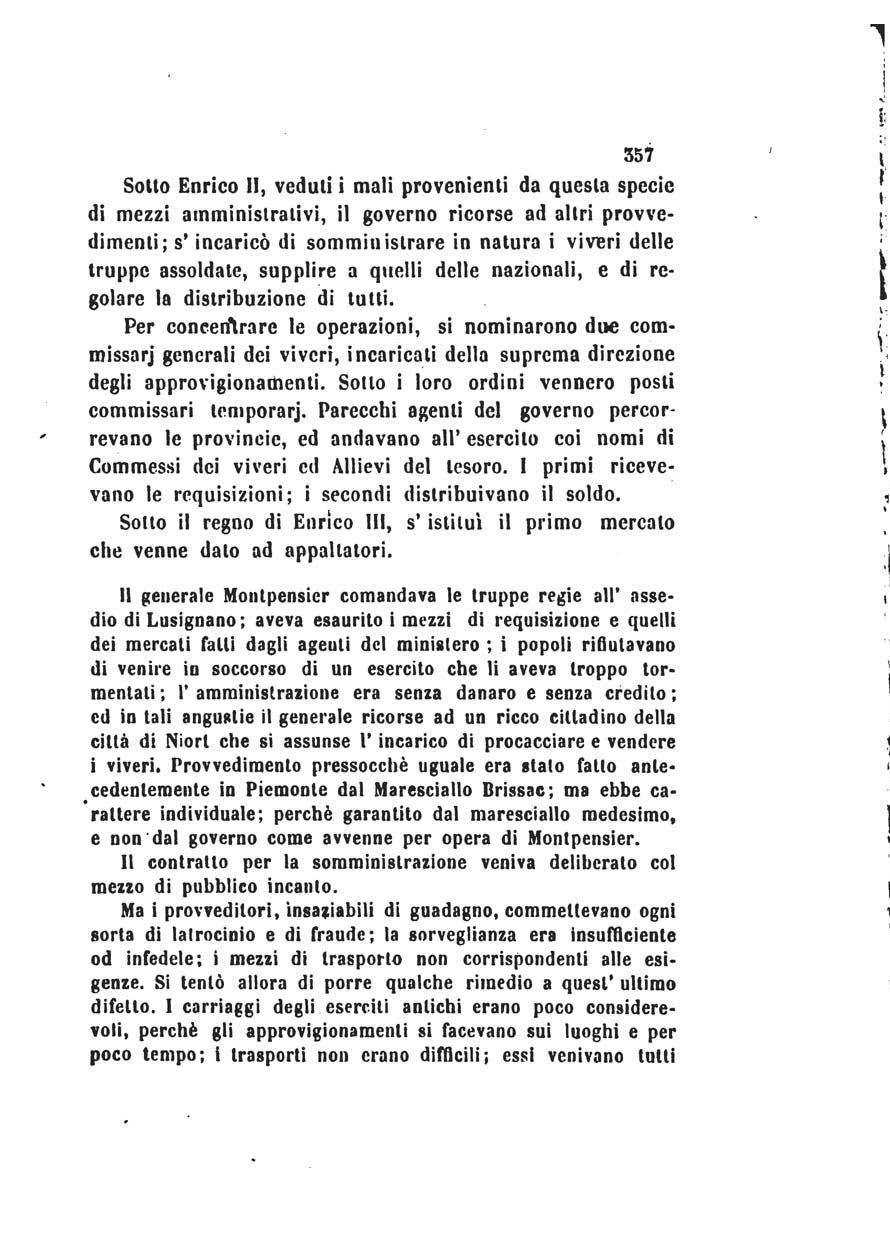
Per conr.erl\rarc le operazioni, si nominarono due com· missarj generali dei viveri, incarica ti dello suprema direzione degli approvigionamenti. Souo i loro ordini vennero pos ti commissari tcmporarj. Parecchi agent i del governo percorrevano le provincie, ed andavano all' esercito coi nomi di Commessi dei vh•eri cd Allievi del tesoro. l primi vano le requisizioni; i srcondi distribuivano il soldo.
Sotto il regno di Enrico 111, s' istituì il primo mercato che venne dato ad appaltatori .
Il generale Montpensicr comandava le truppe all' nssedio di Lusignano; aveva esaurito i mezzi di requisizione e quelli dei mercati falli dagli ageuti del ministero ; i popoli riftulavano di venire io soccorso di un esercito che li aveva troppo tormentati; l' amministrazione era senza danaro e senza credilo; cd io tali angu11lie il genel'ale ricorse ad un ricco cittadino della città di Niort che si assunse l' incarico di procacciare e vendere i viveri. Provvedimento pressocchè uguale era alalo fallo ante· cede ntemente io Piemonte dal Maresciallo Drissac; ma ebbe ca• rattere individuale; perchè garantito dal maresciallo medesimo, e non ·dal governo come avvenne per opera di Montpensier.
Il contratto per la somministrazione veniva deliberalo col meno di pubblico incanto.
Ma i proVYeditori, insa•iabili di guadagno, commettevano ogni sorta di latrocinio e di frau dc; la sorveglianza era Insufficiente od infedele; i mezzi di trasporto non corrispondenti alle esigenze. Si tentò allora di porre qualche rimedio a quest' ultimo difello. l carriaggi degli esfrdti aolicbi erano poco considereYoli, perchè gli si facevano sui luoghi e per poco tempo; l trasporti non erano difficili; essi venivano tutti
358 eseguiti col meno di requtstztone. Ogni luogo somministrava. !'lrnza retribttJionf', cavalli, vellure e carrettieri; ma l' amministrazione dei vhtri c quella fieli' nrligli tria, nssumend(l proporzioni ma ggiori , non si poterono abbandonare i movimenti dell' t!let·cil(l a mezzi non basl•·voli e•l in certi; lnondc convenne isli tu ire, pr. r conto dd gfJVCrno, Ull servizio permilnenle dei carriaggi ; tiJ lo 11i ft>cc solto Enrko H. • fu imperfetto; portò intralciament i, ritar•lò le marci e; e solo col volgere del tempo il !ìtrvizio dci vh•tri ottenne qualche pcrrezionamento.
Solto il regno di Enrico IV, c prccisnmrntc nel fti97, si istituì un servizio sauilnrio. Si divisero gli o s pedali in due calcgorie: la prima, tlt•gli ombnlanti, deui nppunlo Ambulanzr, seguiva il movimento degli eserciti; In seconda, clclln dci Setl entat'j, fu stabilita nt•llc piazze cd in paesi A· pct·ti. Sembra però che i primi siano stati alluati nel secolo XVI, c clte i secondi abbiamo avuto esistenza nel successivo; st•rvcnt.lo, in vece di essi, c fìnchè gli eserciti erano tli numero esiguo, gli ospedali civili ch'erano già in attività .
In lt1:Jhillerra . Un ordine del re chiamava le genti per ogni contado. Alla scella degli uomini concorrevano dai c castelli, c da lutti gli altri luoghi, quan-ti t!rano alli a portare le armi, dni 15 llino ai 40 anni , c comparivano alla rassegna in luogo ampio c spazioso. Portavano le armi che avevano, c le maneggiavano innanzi ai ma g istrati a ciò deputati. Poscia si elrggcvano i più gagliardi e robusti.
Di questi uomini gagliardi, pttrte si scrivevano a piedi e parte a cavallo.
La fanteria 11i faceva d' uomini più grandi, cd era divisa in quattro specie: La prima era de' Sagittorj , ossia degli Arcieri di CUi abbiamo parlato; Ja seconda di n011Clletle, che portavano arma d' corta e con ferro a Rimilitudine di una ronca; la terza d' Archibugieri, i quali valevano poco; la quarta di Picchieri.
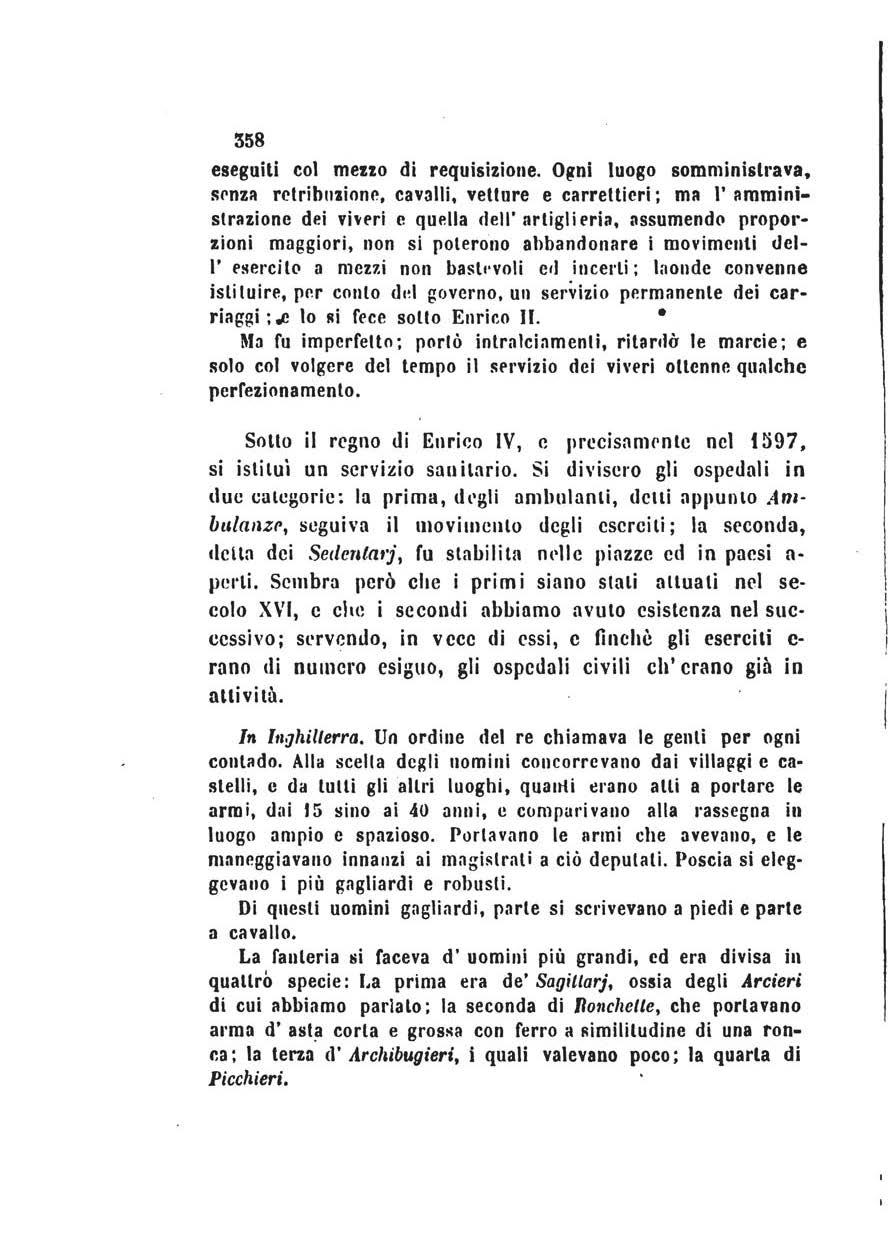
359
Coo queste quattro Kpecie di fanteria si sarebbe potuto ractogliere un e11ercito di 100,000 uomini; ma per nessunA o per rarissima occasione si soleva mellere insieme tutto quel numero.
La gerarchia militare era la seguente: il capitano generale, il maresciallo, che, in assenu, n e faceva le veci, il colonnello, il capitano, il lungolenente, il banderaro. il sergente.
La fanteria era divisa in compagnie di cento. Cogli uomini che non erano nè nè piccoli, ma destri però del corpo, si formava la cavalleria, la quale era di due specie; una di cavalli leggieri, e l 'altra d'uomini d'arme, i quali erano piuttosto di genti !uomini che d' altri, perchè quesli potevano sostenere le spese ed avere buon l cavalli. Dci si facevano due parti: una armala alla slradiolla, l' con giuppone di piastra o di maglia, mezza t es la, e lancia sottile e lunga; questa si serviva di ogni sorta di cavalli, perchè non urtava mai se non per fianco: coloro che la componevano chiamnvansi Lan· celle. .
La cavalleria era divisa in isquad re di cc n lo. D'ordinario, nelle spedizioni fuori dd regno, il reclutamento era volonlat'io.
Rispetto allo esercitarsi nelle armi, riprodurremo quanto nel i557 fu scritto in proposito dall'ambasciatore veneto Giovanni Micheli. (l):
• Il proprio e uso degl'inglesi è l'a rco e le frcccie, nelle quali è così grande il numero, prr il comune eserciaio che in esse si fa da tutte le sorle di persone 'senza distinzione di grado nè t:li età nè di profe ss ione, che ccr.cdono il vel'isimile. Il che nasce, oltre l' elezione, per l' obbligo che generalmente per allo di parlamento hann o tulti li r.api di casa, di tenernc p rovisto ciascuno della sua casa come arriva alli nove i: il tutto a fine non solo di rimover ogni altro esercizio, ma per accrescer questo con ogni diligenza, essendo in questo riposta, tutta la forza e tutta la speranza drgl' inglesi, altissimi, per dir vero, ad usarlo, sì che non cetleriano a qu:alsivoglia altri più
[l) degli amliu><:ialori rmeti al smalo: Firenze 18.'19.
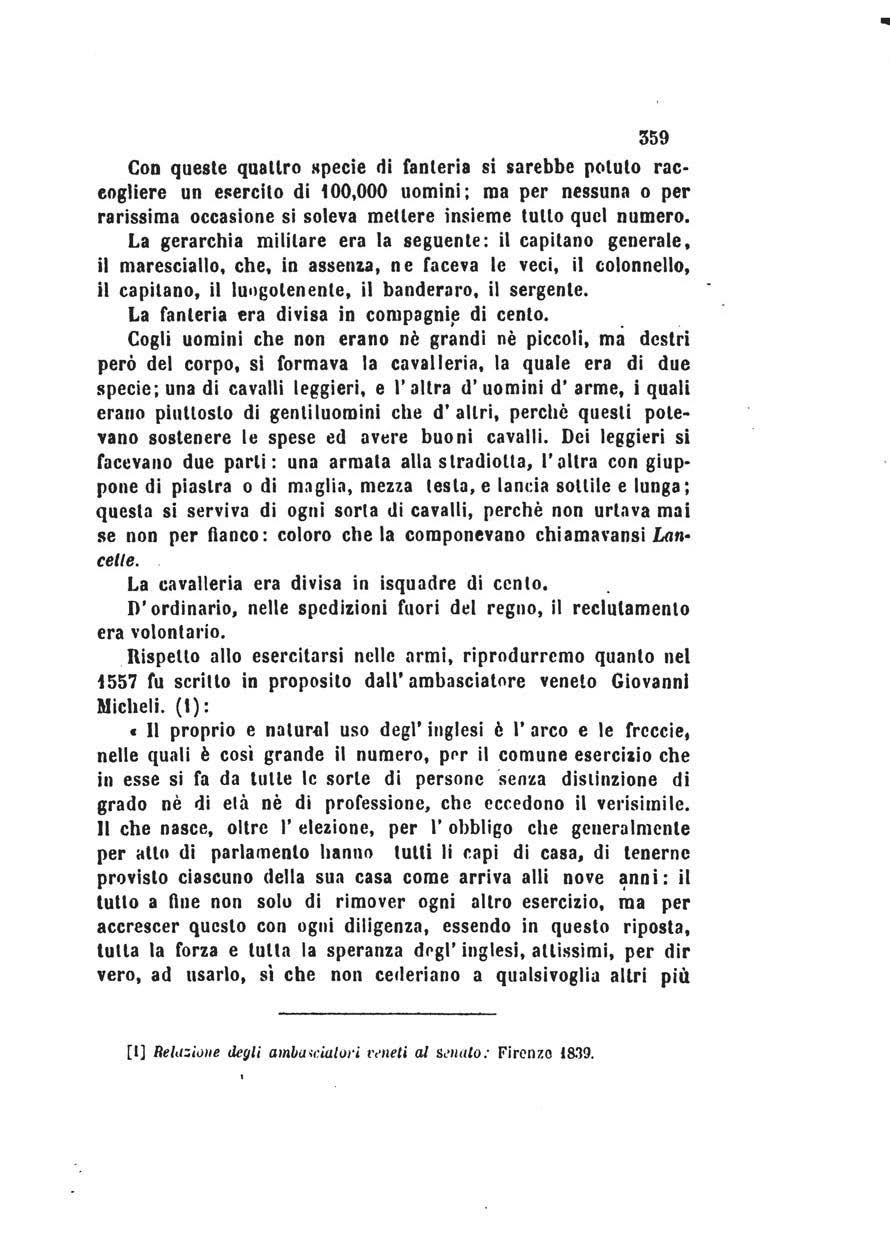
360 pratici e più esercitati di essi ; ed è tanta la alima ed opinione che ne hanno, che senza dubbio prepongono questa a tutte sorte d'armi ed agli archibugi, e più si confidano e tengono sicuri in quella, che in questi, con diverso parere però de' capitani e de' soldati d'altre nazioni. T irauo aneo l'arco con tanta forza e de· slrezza insieme, che alcuui hanno nome di pnssare li corsaletti cd armature intiere; e pochi de'loro sono, dei ·mediocremente esercitali, che per ogni tiro cbe lirano non si obblighiuo in una distanza, o tirino al di!ìteso, o come comunemente sogliono, per tirar più loulanQo, all' alla, di dar sempre un mezzo palmo presso il segno. • l giudizj, tanto capitali quanto civili, venivano giudicati nel campo in modo sommario. Ne era pi·csidcule il maresciallo del· l' esercito assistito da alcuni Questo foro si chiamava la corte di gucna. ·
/n Olanda. Sul cadere del secolo XVI, Maurizio di Nas· snu, salito alla somma delle cose, dic' opera ad ordinare l'esercito.
Ridusse i gt·ossi battaglioni quadrati c adottò pei piechieri un ordine soltilc. Questi battaglioni non oltrepassavano i 500 uomini, c si tlispone,·nno su !>O di ft·ontc c 10 di profondità.
Le compagnie erano di i 00 uomini.
La' gerarchia consisteva io un caJ•itano, un luogotenente, un' inscgnn, tre sergenti, tre caporali, sei ajutanti. dieci cnpi·Oia.
l bnttoglioni aum('nt:wnno In fronte raddoppinndo le fìle; c con certe manovre, le truppe comincinvono n sap<'r passar<', mediante S<'mplici convrrsioni, dall'ordine in balloglia oli' ordine in colonna, c ,·ir.cvcrsn.
Le armi difensive, come il corsalcllo, erano tenute .in gran conto: c Mauri7.io dava . pure molla importanza alle rotelle ossia scudi circolari.
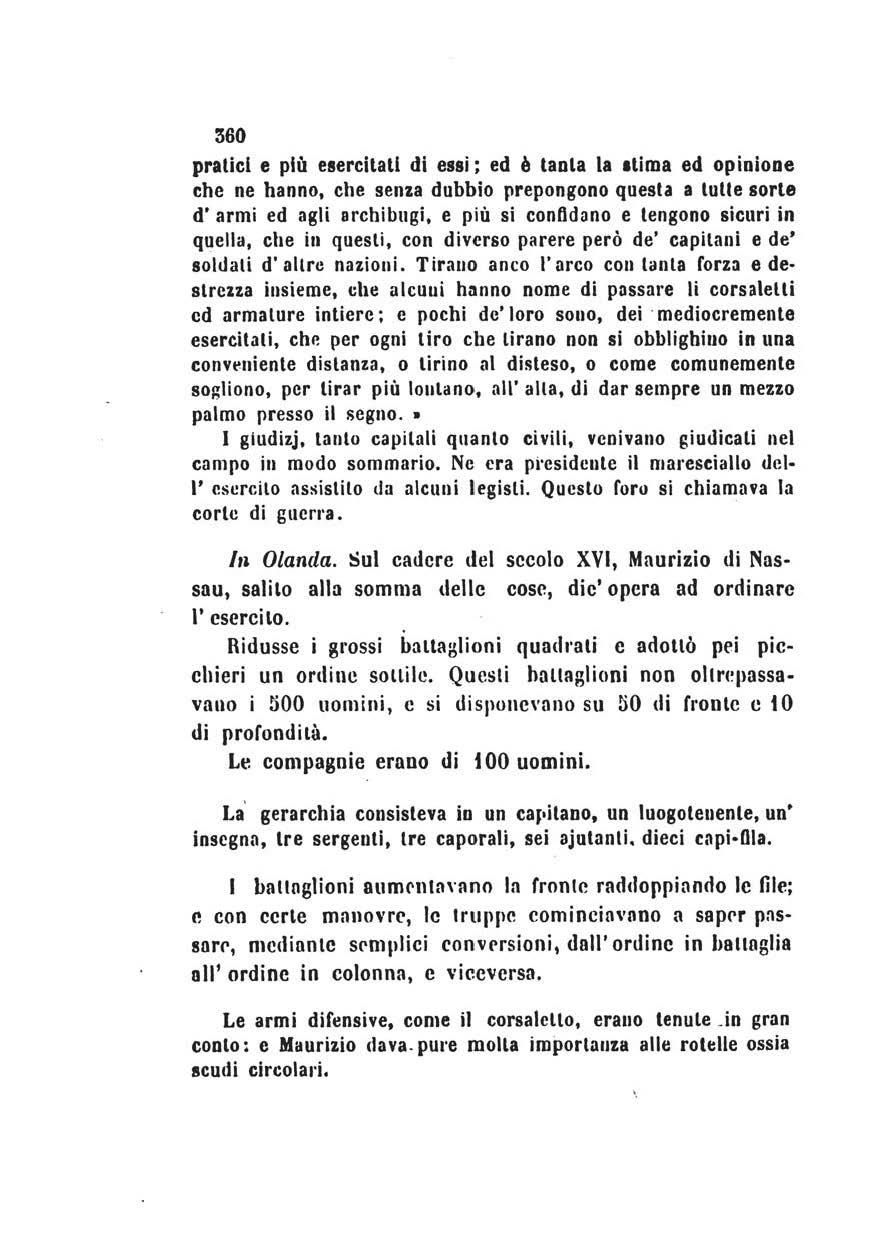
361
Gli uomini d' armi ed i carabini erano ordinati per reg· gimcnti. Ogni reggimento ero corÌiposlo di quattro cornette di 100 cavalli c in scunn, che si formavano iJl due squadroni su 10 di profondità.
In Olanda, come in Francia, i carabini mellcvnno sovcnli il pil.'dc n terra .
L' artiglieria si era formata sul modello spagnuolo.
Aveva alla ·testa un generale, un luogotenente generale, un ispt>tlore, due commissarii, uno de' qoali incaricalo del materiale dei pezzi, l' altro deHe munizioni e degli strumenti.
Eranvi 230 cannonieri ordinarj chiam11ti e circa 60 slraordinal'j. Prima di riceverli, si faceva loro subire un esame.
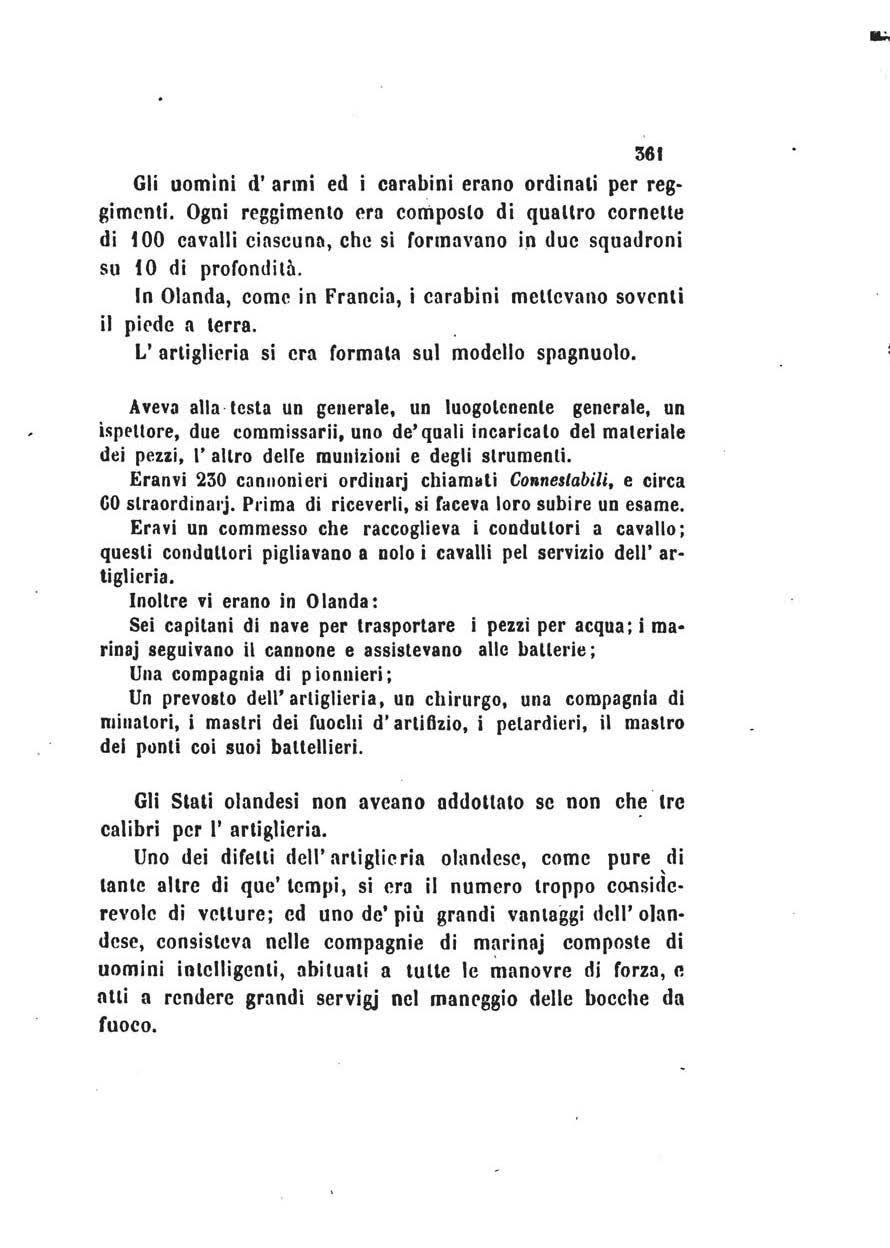
Era vi un commesso che raccoglieva i condullori a cavallo; questi conduttori pigliavano a nolo i cavalli pel servizio dell' ar· tiglicria.
Inoltre vi erano in O landa :
Sei capitani di nave per trasportare i pezzi per acqua; i ma· rinaj seguivano il cannone e assistevano alle batterie ;
Una compagnia di p ionnieri;
Un prevosto dell'artiglieria, un chirurgo, una compagnia di minatori, i mastri dei fuochi d'arti Ozio, i petardicri, il mastro del ponti coi suoi battellieri.
Gli Stati olandesi non aveano oddollnto se non che · tre calibri per l' artiglieria.
Uno dei difetti dell'artiglieria olande se, come pure di tante altre di que' tempi, si era il numero troppo COflsi(Ìc· re vole di vetture ; cd uno dc' più grandi vantaggi dell' olnn· dese, consisteva nelle compagnie di mnrinaj composte di uomini intelligenti, abituati n tulle le manovre di forza, e nlli n rendere gr:mdi servigj nel manl.'ggio delle bocche da fuoco.
3G2
Maurizio di introdusse una rPgolare disciplina uclle sue truppe; formò campi c vi es('rcitò accuratamente i sohlnti; opr.re esterne e strade coperte per difesa di città; diè prove di molta nbilità n<'ll' espugn.azione delle pinzzc, nel circondnrc il suo campo di trincrramenti; il campo suo divenne una scuola n cui nccorrevano iostesi, scozzesi, dnncsi, tedt!Schi protesta n ti, e francesi.
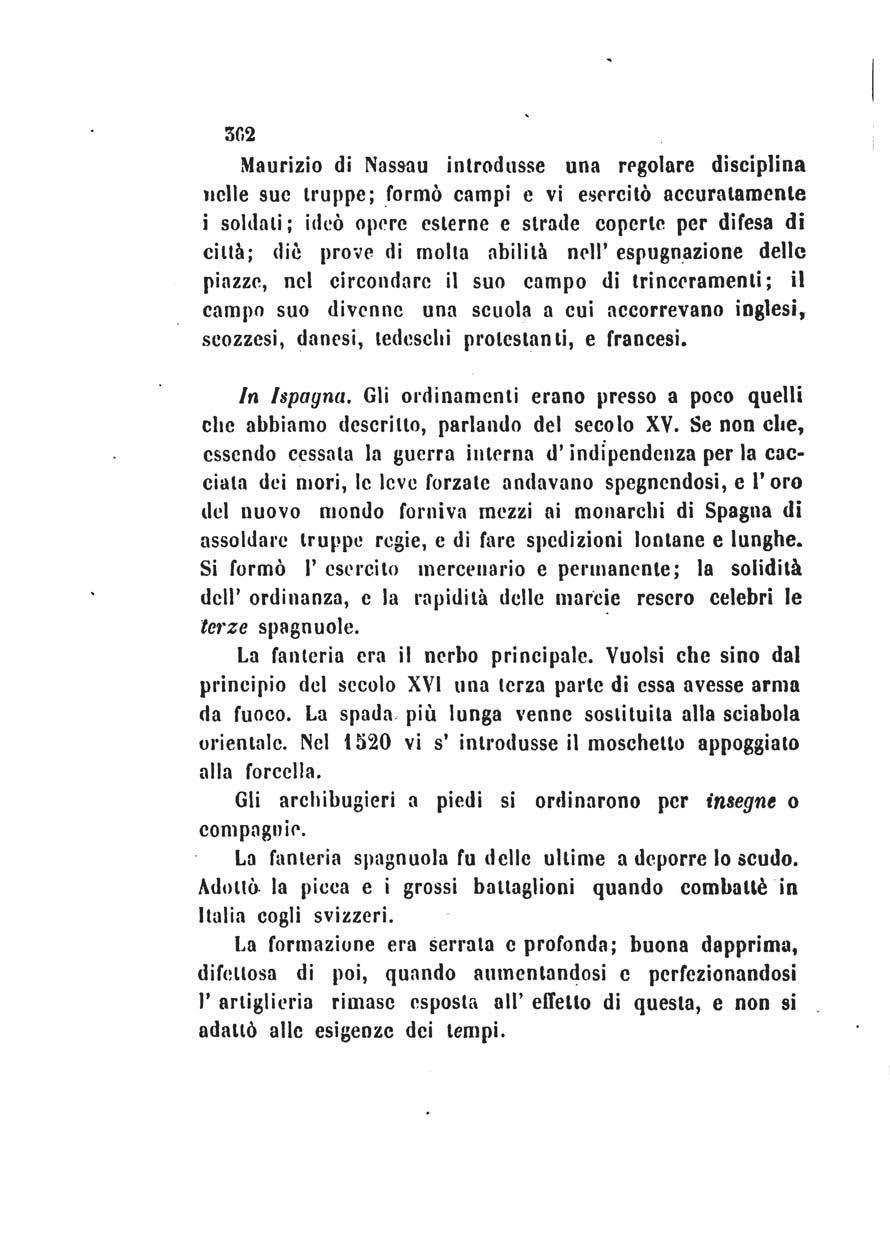
In /spagna. Gli ordinamenti erano presso a poco quelli che abbiamo descritto, parlando del secolo XV. Se non clte, essendo cessata la guerra interna d'indipendenza per la cacciata dci mori, le leve forzate andavano spegnendosi, e l'oro del nuovo mondo forniva mezzi ni monarchi di Spagna di assoldare truppe regie, c di fare spedizioni lontane e lunshe. Si formò P cst•rcito merct>nal'io e pel'lltanente; la solidità dell' ordinanza, c la rapidità delle marde resero celebri le lerze spagnuolc.
La fanteria era il ncrho principale. Vuolsi che sino dal pl'incipio del secolo XVI una terza parte di essa avesse arma eta fuoco. La spada , più lunga venne sostituita alla sciabola oa·ientnlc. Nel t 520 vi s' introdusse il moschetto appoggiato alla forcella.
Gli archibugieri a piedi si ordinarono per insegne o compngniC'.
La fanteria spagnuola fu delle ultime a deporre lo scudo. Adnttò. la picca e i grossi bauaglioni quando comballè in Italia cogli svizzeri.
La formazione era serrata c profonda; buona dapprima, dif(!ltosa di poi, quando aumentandosi c perfezionandosi l' artiglieria rimase esposta oli' effetto di questa, e non si adauò alle esigenze dci tempi.
Nella guerra dei Paesi bassi, i fanti l'pa{lnuoli non andavano all' assalto delle fortezze senza avere indosso una fascina fatta da esst io antecedenza.
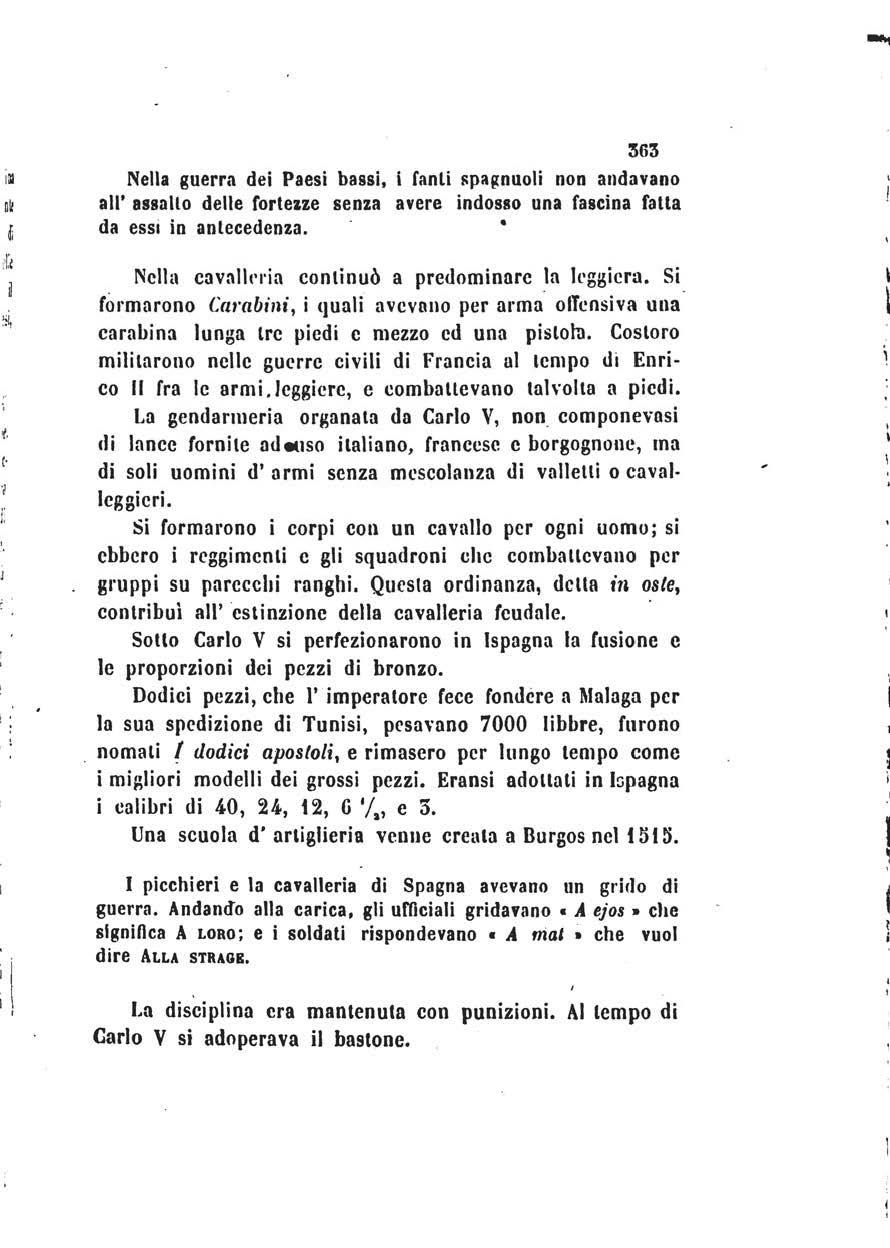
Nella cavallt•t·ia continuò a predominare ln leggicru. Si fÒrmarono Carabini, i quali avcvnno per arma oiTcnsiva una carnbina lunga tre piedi c mezzo cd una pistohl . Costoro militarono nelle guerre civili di Francia ol tempo di Enrico Il fra le armi.Jeggicrc, c combauevano talvolta a piedi. La gendarmeria organata da Carlo V, non _componevosi di !ance fornite adettso italiano, francese c borgognone· , ma di soli uomini d'armi senza mescolanza di valletti o cavalleggieri.
Si formarono i corpi con un cavallo per ogni uomo; si ebbero i reggimenti c gli squadroni che combattevano per SI'Uppi su parecchi rangh i. Questa ordinanza, delta in oste, contribuì all' estinzione della cavalleria feudale. ·
Sotto Carlo V si perfezionarono in !spagna la fusione e le proporzioni dci pezzi di bronzo.
Dodici pezzi, che l' imperatore fece fondere a Malaga per la sua spedizione di Tunisi, prsa\·ano 7000 libbre, fnrono . nomati ! dodici apostoli, e rimasero per lungo tempo come i migliori modelli dei grossi pezzi . Eransi adottali in lopagna calibri di 40, 24, 12, G '/,, e 5.
Una scuola d'artiglieria venne creata a Burgos nel f 5HL
I picchieri e la cavalleria di Spagna avevano un grirJo di guerra. Andando alla carica, gli ufficiali gridavano • A ejos • che significa A Loao; e i soldati rispondevano • A mal • che vuoi dire ALLA STRAGE.
l.n disciplina era mantenuta con punizioni. Al tempo di Carlo V si adoperava il bastone.
34\4
L'amministrazione presentava .moltissimi abusi; delle rubcrie degli ammin_istratori, i si rifacevano colle prede. Alessandro Farnese tentò introdurre un po' d'ordine, stabilendo che si desse ogni giorno n ciascun soldato nn pane di munizione al prezzo di mezzo scudo al mese, ed una vestitura compiuta ogni anno al prezzo di dodici scudi.
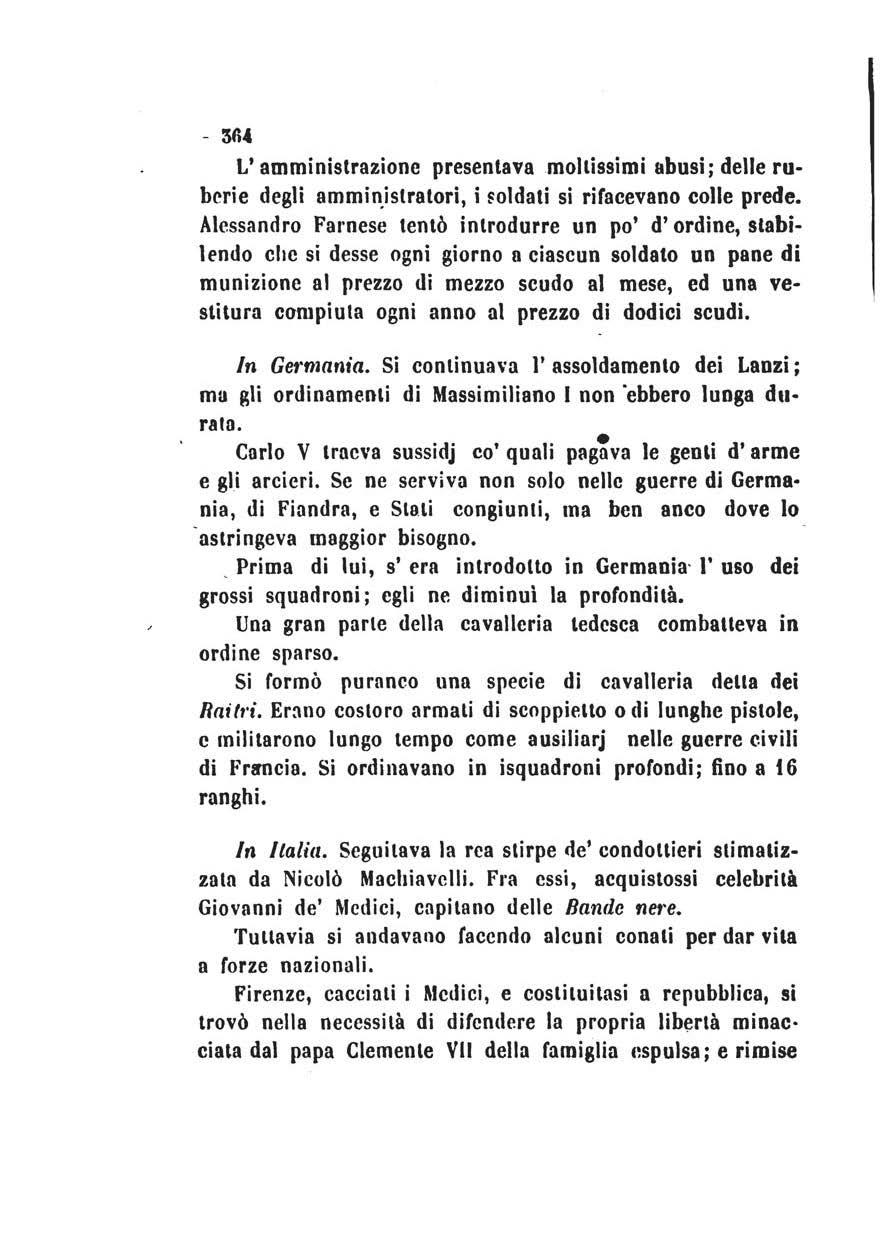
In Get'mania. Si continu:n·a l' assoldamento dei Lanzi; mu gli ordinamenti di Massimiliano l non ·ebbero lunga durato.
Corio V traeva sussidj co' quali le genti d'arme e gli arcieri. Se ne serviva non solo nelle guerre di Germa· nia, di Fiandra, e Sta.Li congiunti, ma ben anco dove lo astringeva maggior bisogno •
.
Prima di lui, s' era introdotto in Germania· l' uso dei grossi squadroni; egli ne diminuì la profondità.
Una gran parte della cavalleria tedesca combatteva in ordine sparso.
Si formò purnnco uno specie di cavalleria delta dei Raitt·i. Erano costoro armati di scoppietto o di lunghe pistole, c militarono lungo tempo come ausilinrj nelle guerre civili di Frmcia. Si ordinavano in isquadroni profondi; fino a f 6 ranghi.
In ltalill. Seguitava la rea stirpe de' condottieri stimatizzatn da Nicolò Machiavelli. Fra essi , acquistossi celebrità Giovanni de' Medici, capitano delle Banrlc nere.
Tuuavia si andavano facendo alcuni conati per dar vita a forze naz ionali.
Firenze, cacciati i Medici, e costituitasi n repubblica, si trovò nella necessità di difendere la propria libertà minac· ciata dal papa Clemente VII della famiglia f!spulsa; e rimise
365 io essere le ordinanze ossia le milizie del contadfl, creato dalla repuliblica, distruuc d ai 1\lcdict.
Si arruolarono tuui i sudditi fra i f 8 c i 56 :o nn i. Si divisero in 50 coa·pi o battaglie.
La milizia della città venne divisa in .quattro quartieri; ogni quartiere fu spartito io quattro gonfaloni; ogni gonfalone nominava i proprj ufficiali.
Tornati i Medici, si disarmarono gli abitanti della· città, si accrebbero le bande del contado; finchè sotto Cosimo, gran · duca, si ordinarono le milizie nazionali.
Una lista di tuui i muschi dai t 8 ai !H> anni \' Cniva compilata ogni anno dai comuni. Ugunl li sta era fatta dai ca· porali locali della milizia. l commi ssarj c i capitani confrontavano le liste, e ne riferivano al ruagistl'ato supremo. Un commissorio generale faceva la scelta dei giovani c li ascri· vcva alla milizia .
L' obbligo di servizio durava 50 anni.
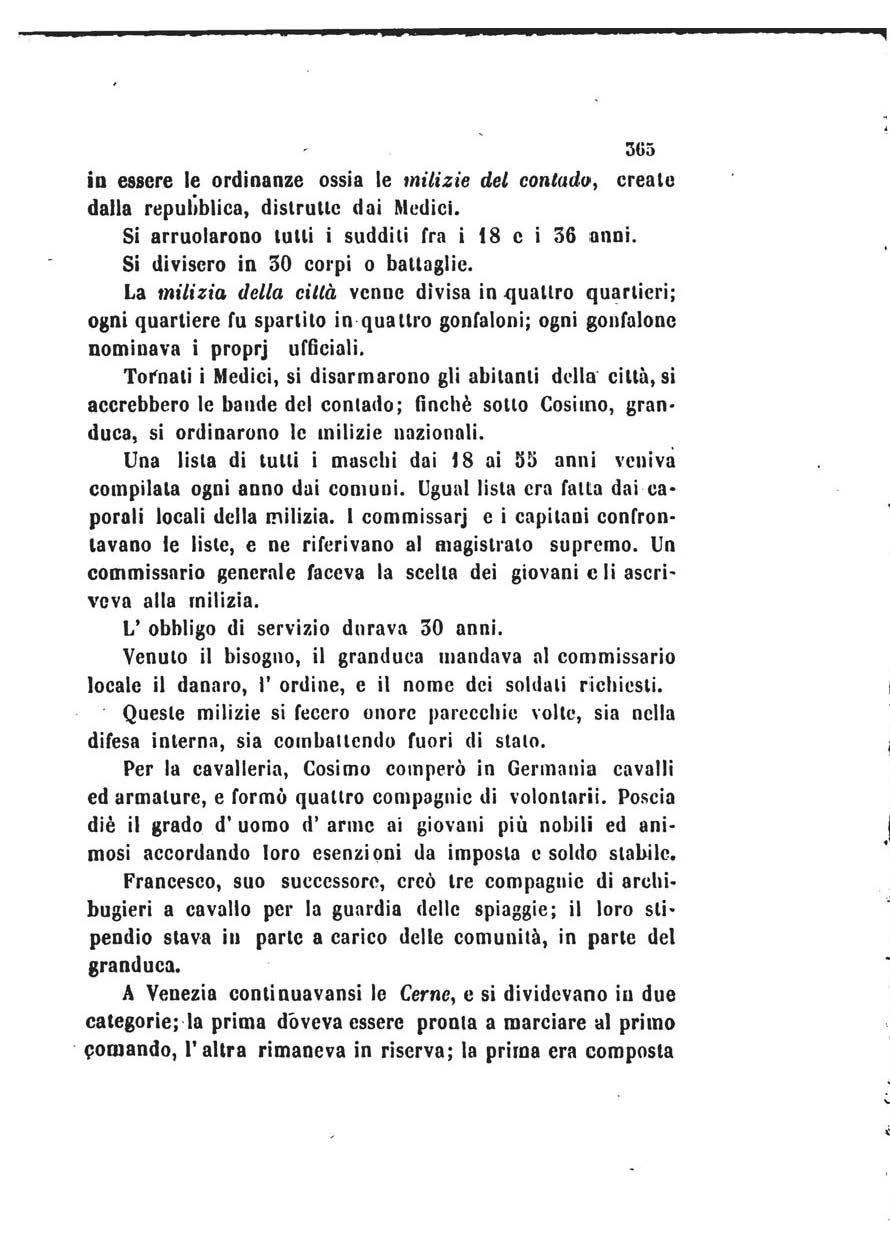
Venuto il bisogno, il granduca mandava al commissario locale il daoa1·o, l' ordine , e il nome dci soldati richiesti. · Queste milizie si fecero onore parecchie \'oltc, sia nella difesa interna , sia combattendo fuori di stato.
Per la cavalleria, Cosimo comperò in Germania cavalli ed armature, e formò quattro comp agnie di volontarii. Poscia diè il grado d' uomo d' arme ai giovani più nobil i ed ani· mosi accordando loro eseozi Qni ùa imposta c soldo stabile. Franct>sco, suo successore, creò tre compagnie di arch i bugieri a cavallo per la guardia delle spiaggi e ; il loro sti· pendio stav·a in parte a carico delle comunità, in parte del 8randuca.
A Venezia continuavansi le Cerne, c si dividevano in due cate8orie; ·la prima doveva essere pronta a marciare al primo · çomando, l'altra rimaneva in riserva ; la prima era eomposta
566 di 15,000 uomini, la seconda tli 40,000.
Ma la forza principale della Signoria riposava sulla. marina.
Genova, quietata alquanto souo il regime di Andn·a Doria, formò essa· pure diciasc\lc centurie ùi milizie.
Gli spagnuoli ebbero la velleità di formare un esercito io Lombardia; ma il sospet•o fece abbandonare i tentati vi. A Napoli incominciarono col creare il ballaglione delle mili· zie. Ogni terra doveva tiare cinque uomini per ogni cento fuochi ossia famiglie. Si formarono compagnie di l 00 uomini, con un capitano nominato dal viceri!, con allìcr<', scrg('tllc, c capisquadra nominali dal capitano : Il srrvizio era di otto anni. l capita ni do\'e\'ano adunare i loro uomini cd eser citarli dall' aprile al scuembre.
Si creò anche ca\'allea·ia napolitaua, che nel t !580 ascendeva a i 800 uomini JH'Csi sovra un dalo numero di fuochi.
Ma il vero nerbo delle forze era ri sposto sugli spagouoli c sui merccnarj forestieri.
Le antiche milizie di Casa Savoja s i tra eva no dai comuni, dai vassalli, e dai dominj direiAi della corona.
Ogni casa, fatte alcune eccezioni, dovcu somministrare un uomo.
In caso d' i n vas ione nemica, lutti erano obbligati a pi· gliarc le armi. Un araldo girava le vie gridando • Fuori Fuori, » c questo era l'avviso di adunata.
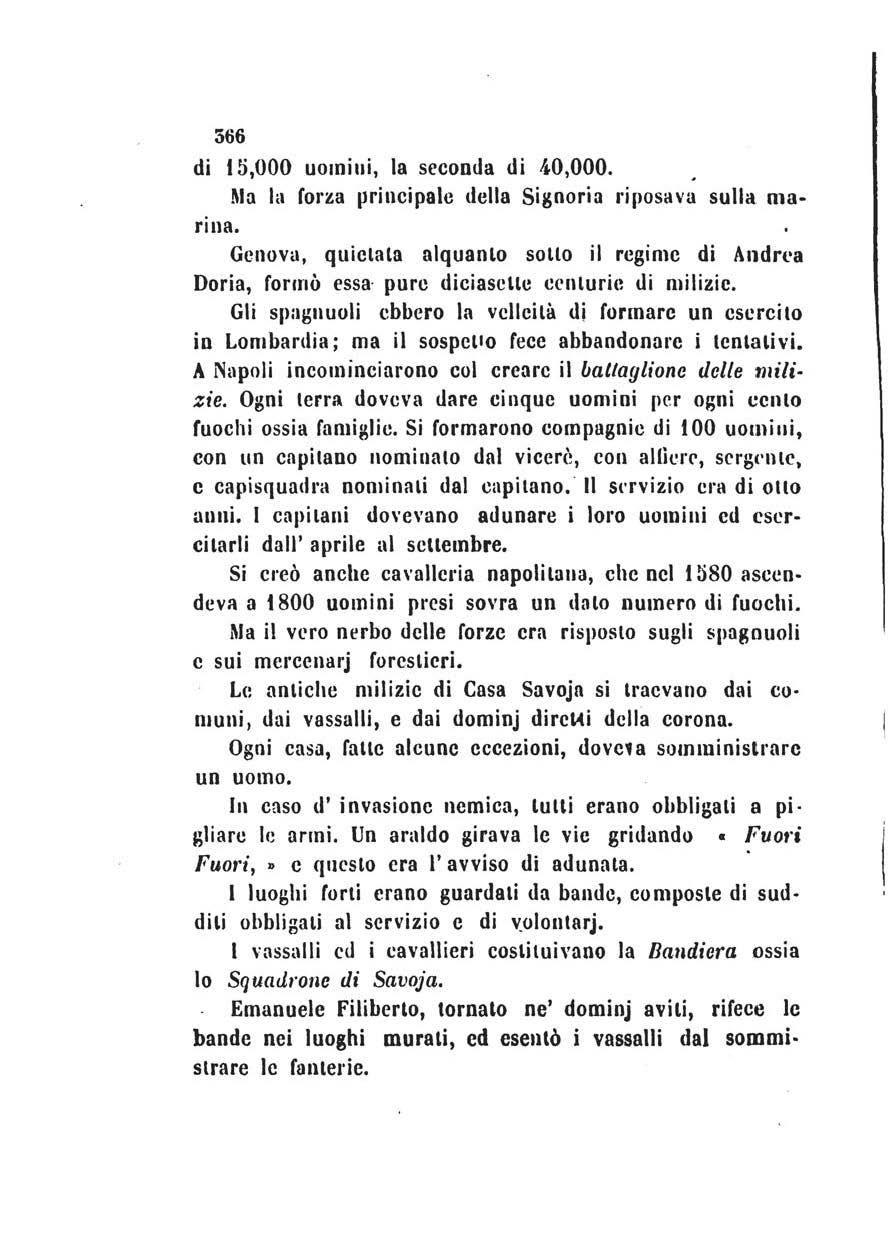
l luoghi forti erano guardati da bande, composte di sudditi obbligati al servizio c di l vassalli cd i cavallieri costi tuivano la Baudiora ossia lo Squadrone di Savoja.
Emanuele Filiberto, tornato ne' dominj avili, rifece le bande nei luoghi murali, ed esentò i vassalli dal sommistrare le fanterie.
Ordinò ai comuni di descrivere tuui i 'sudditi fra i t 8 e i !SO anni; si sceglievano i più idonei, c si costìtuiva la fanteria di 25,000 uomini; 1!5,000 somministrati dal Piemonte, 8,000 dalla Savoja. Si ammiserò volontarj c Ja cifra dei fanti ascese fino a 56,000.
Erano divisi per Colonnelli; ogni colonnello componevasi di sei compagnie, t1gni compagnia di qunllro centurie, ogni centuria di quattro squada·e.
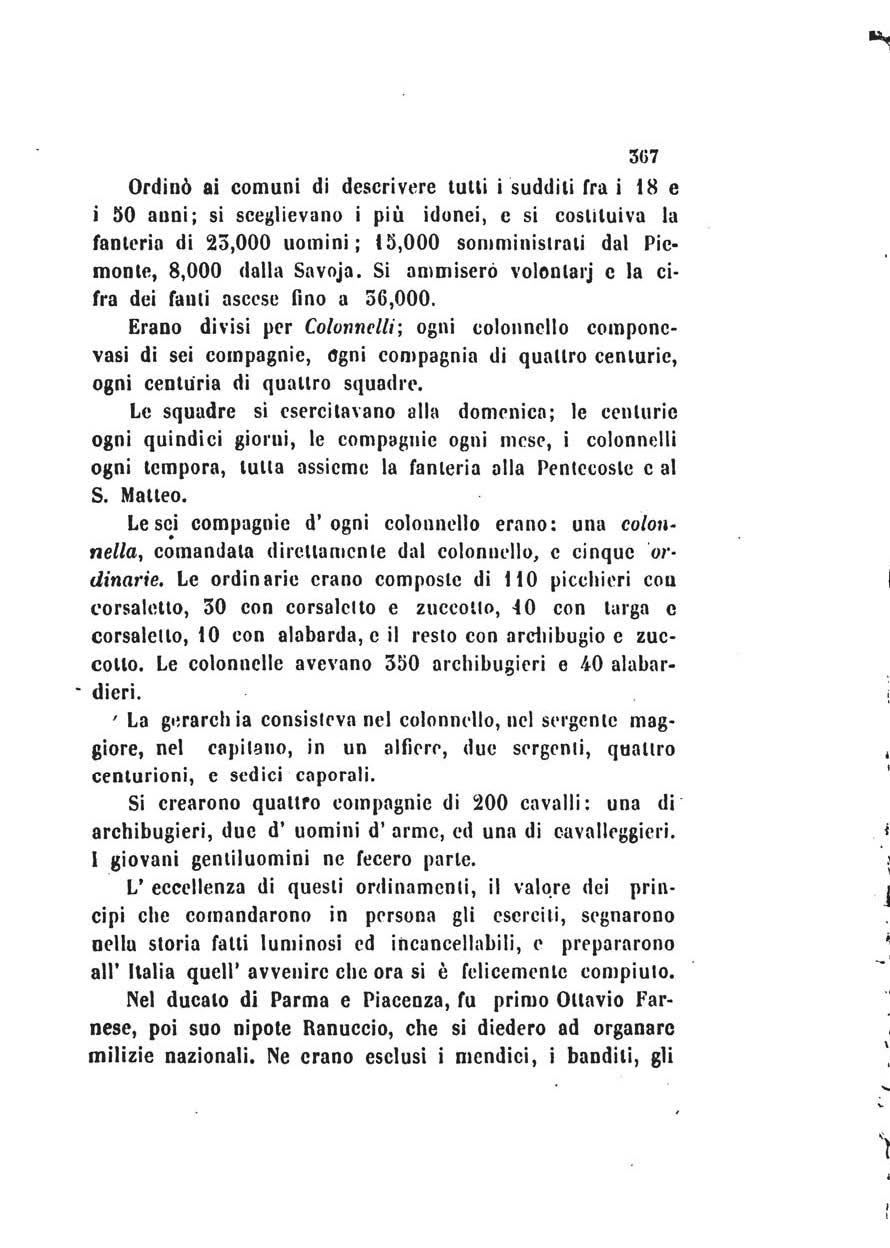
Le squadre si csercilR\·ano alla domrnicn; le centurie ogni quindici giorni, le compagnie ogni mcsr, i colonnelli ogni tcmpora, tulla assieme la fanteria olia Pentecoste c al S. Matteo .
Le sci compagnie d' ogni colonnello erano: una colounella, direttamente dal colonnl•llo, c cinque ·ordinarie. Le ordinarie erano composte di t t O picchi eri cou 50 con corsalclto e zuccouo, 4O con targa c corsaleno, t O con alabarda, c il resto con arclaiiJugio c zuccouo. Le colonnclle avevano 3!>0 archiiJugicri e 40 alaiJardicri.
' La g•:rarch ia consistrvn nel colonO(•Ilo, nel st•a·gcn te maggiore, nel capitano, in un alfìrrr, due srrgrnli, quauro centurioni, c sedici Cilporali .
Si crearono quattro compngnic di 200 cavalli: una di archibugieri, due d' uomini d' arme, cd unn di cavalleggieri. l giovani gentiluomini ne fecero parLc.
· L' eccellenza di questi ordinamenti, il dci principi che comandArono i n prrsona gli esc r ct t•, s<•gnarono oellu storia falli luminosi cd incancellabili, r prepararono all' 1\alia quell' avvenire che ora si è fclicemrnlc compiuto.
Nel ducato di Parma e Piacenza, fu primo Ollavio Farnese, poi suo nipote Raouccio, che si diedero ad organarc milizie nazionali. Ne erano esclusi i mendici, i banditi, gli
scandalosi, quelli di catth·a IHiscita, c chiunque si fosse trovato sottoposto a grave processo. Ne crono <'Senti i capi di famiglia numerosa c in tcllt;ra età. S' iscrivevano nei ruoli gli uomtni dai 20 a! 40 anni. Si calcolava a t 2000 uomini a piedi c a 1'200 a cnvnllo ·il numero dci tlescrilli nello stato; ma sollo le armi dovevano essere in cifra assai minore.
In Modena c Ferrara, Alfonso d' Este aveva · migliol'atc le milizie istituite tla suo padrr. Sotto di lui, si trovarono iscritti ai ruoli lìno a 27000 uomini, ma in realtà non ne avrebbe potuto mettere in armi più di tO,OOO a· piedi c tOOG a cavallo. Em però tutta gente bella, vnlorosn, c ot· timanH'nte di modo che quaaulo nel t 566 i 1nincipi d' Italia concorsero ad 11jutarc l' impcrntorc nella guerra ti' Ungheria, la milizia migliore parve quello d!-!1 ducn di Fcrrarn (t).
Ma dove il duca Alfonso merita menzione lutla speciale, si è prr quanto riguarda l' ortiglirria ceccssivamcnle mobile t•tl rflìcace da lui falla costruire. Giit, .sino dal t 509, a\'cva battuta In Dotta \' t!ncziana la quale avevo rimontato il Po per ossolirlo. Nd t atO, mise la sua artiglirrio al sel'vizio di Chournont. Nel 1!512 la prestò ancora all' esercito froncrse comnndato da Gnstone · d1 A questo 11roposito, l<'lcuronge asscvt•ra che il iluca di Ferrara era princi11C gentile, uomo di guerra, di buona mente, c ardito; che pigliava il suo. passatempo e si esercitava nel fondere arti· glicria, fortificare, cd ctlificaré; che non vi era fonditore fra' suoi che lo superasse. • Ilo vrduto, dic' egli, entro due luoghi ben trecento grossi pezzi nppartcnrnti a quel duca, c credo che tulti i princ1p1 d' llalia insieme non avevano tanta c così bella artiglieria quanta lui solo. Aveva tre sta-
[l j RICOTTI, Storia delle compa!JIIie di ve11tura.
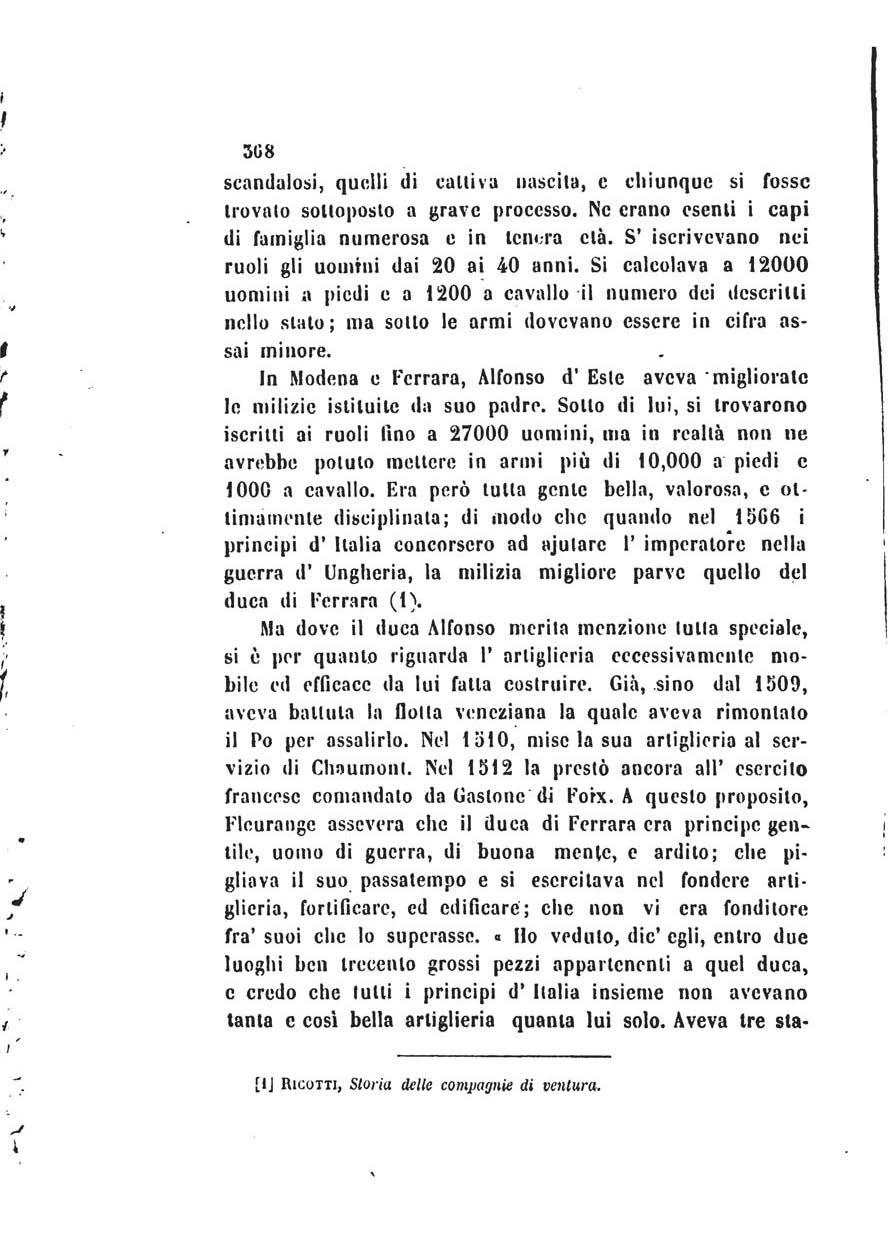
369 bili menti; ono scrv1va pf'r la fonderia, in un altro si (ace· vano le forme, e nel terzo gli affusti e le ruote (f).
Anche i papi istituirono le milizie, dapprima· in Roma, poscia nelle provincie.
Altrettanto fecero Siena c Lucca, allrellanto i Gonzaga a Mantova e nel Monferrato, i Della Rovere in Urbino. In generale però, ad eccezione del Piemonte in cui prin· cipi c popoli erano vincolati da un medesimo sentimento, era- ·· vi ·poco legnme fra governanti e governati, per cui le milizie nazionali non si svilupparono con ql!lella forza ch' era ne· cessaria a conservare l ' indipendenza•.
Ad ogni modo si ottennero due risullali: t.• D' incominciare a togliere alla milizia il tristo carat· tere antico delle condotte.
Di aver creato le base degli eserciti permanenti.
Esposti diversi ordinamenti parziali del !lecolo XVI, re· puliamo opportuno di dare un' idea del mod9 con cui for· mavasi ·un esercito mercenario, specialmente alla foggia spagouola, nella seconda metà del secolo medesimo.
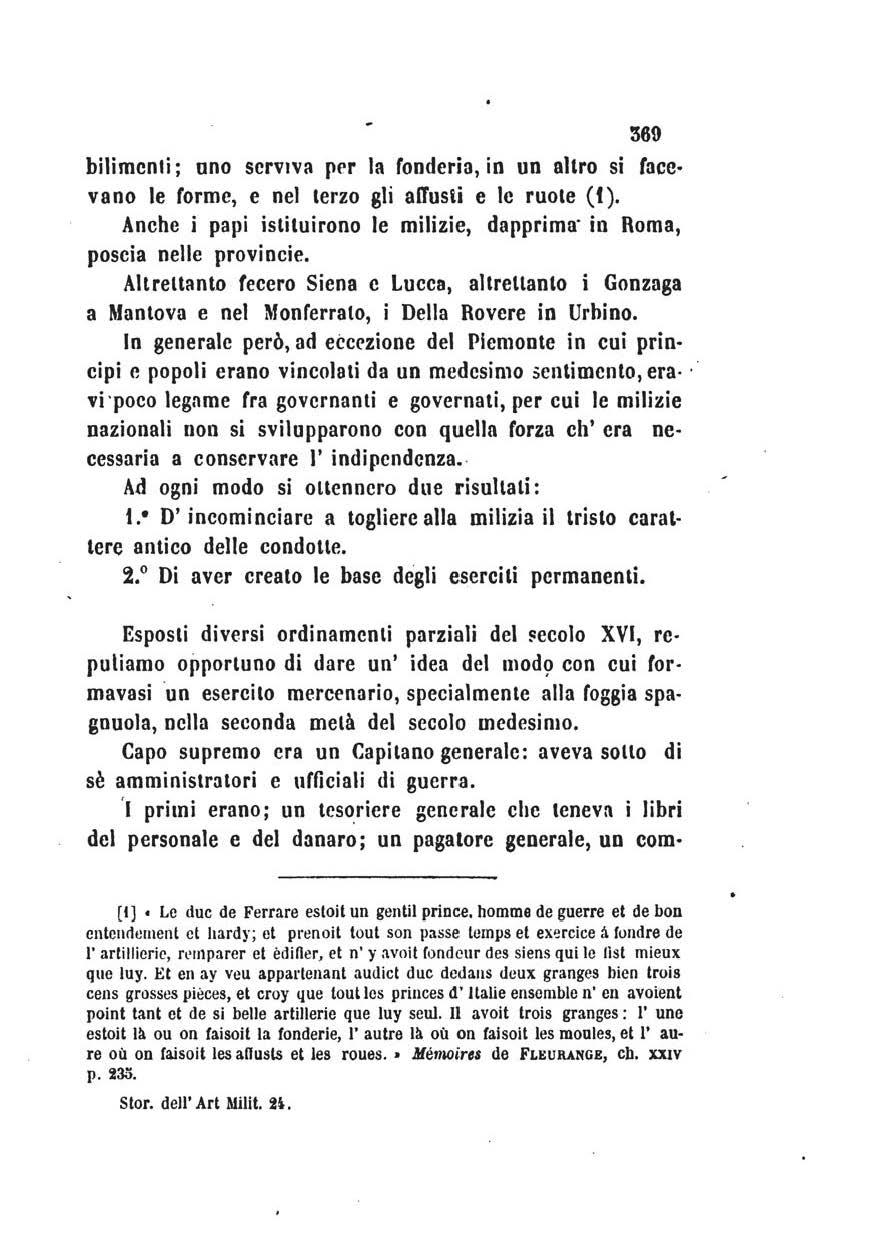
Capo supremo era un Capitano generale: aveva sotto di sè amministratori e urtìciali di guerra. 'l primi erano; un generale che teneva i libri del personale e del danaro; un pagatore generale, un com·
(t) • Le due de Ferrare estoit un gentil prioce. homme de guerre et de bon cntenclcmenl et hardy; et pnmoit tout son passe lt!mps el a fundre de l' artillicril:', n•rnparer et èdifier, et n' y rondcur des siens qui le lìst mieux que luy. Et en ay vcu appartcuant audict due dedans dtlux grangcs bicn trois cens grosscs pièees, et croy que tout Ics princes d· Jlalie enscmble n' eu avoient point tant et de si belle artillerie que luy seui. Il avoit trois granges: l' une estoit 111. ou on faisoit la fonderie, l' autre 111. où on fai soit les mooles, et l' aure où oo faisoit Ics all usts et les roues. • Mémoir.s de FLEUJUNGE, cb. XXIV p. i35.
Stor dell'Art Milit. U.
S70 missario pei vi veri, un rivcdilorc pei ruoli, per le spelle, e per le rasst'gnc.
l secondi erano; un mastro di campo generale, che aveva la suprema direzione. sia deJJ' amministrazione medesima dell' esercito, sia delle murcie, della giustizia, degli accampamenti; vegliava alla disciplina, all' armamento, agli eser· cizj; era coadiuvato da altri ufficiali, specialmente da un sergente maggiore generale. Eranvi inollre: un capitano gc· ncralc della cavalleria, ed un generale dell' artiglieria, ambo sorretti da subalte rni.
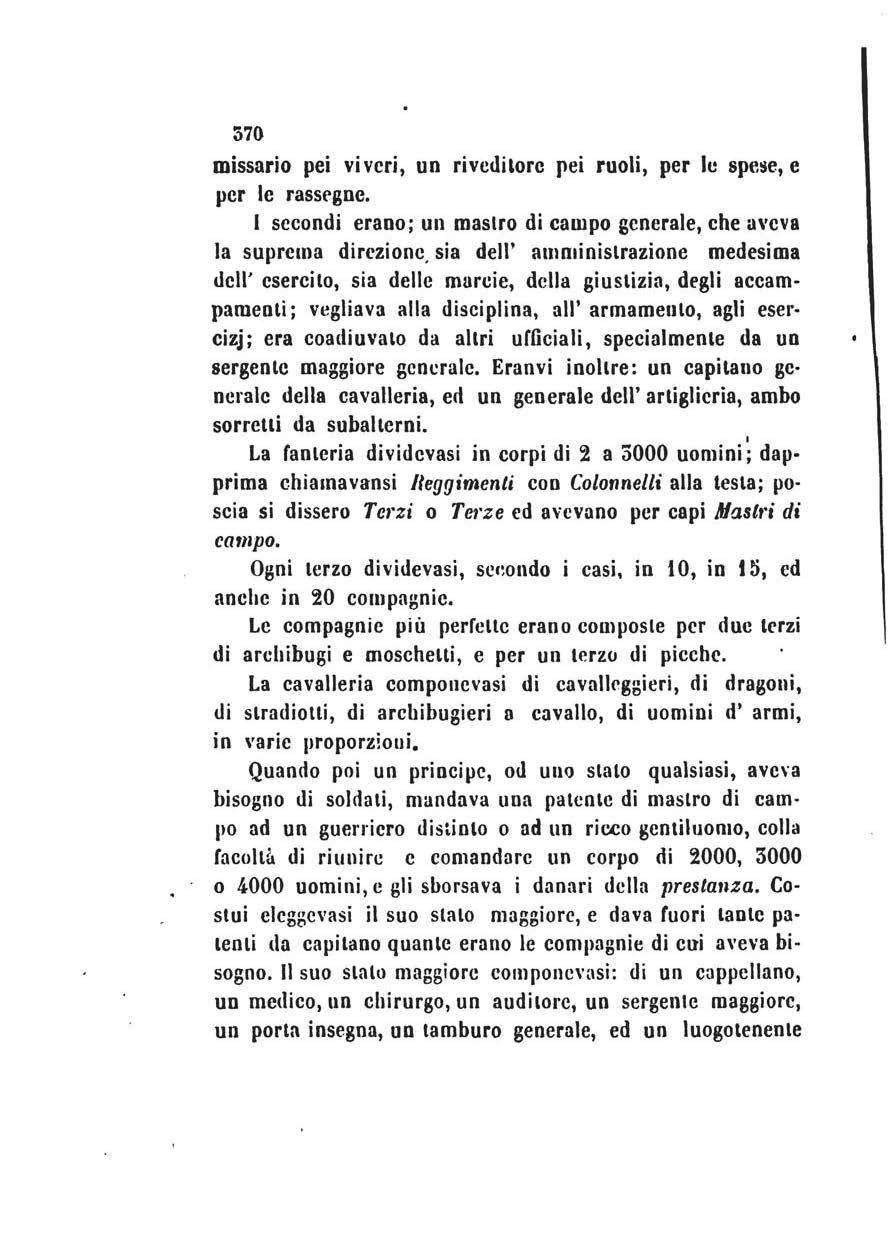
La fanteria dividevasi in corpi di 2 a 5000 uomini; dap· prima chiamavansi Reggimenti con Colonnelli alla lesta; po· scia si dissero Terzi o Terze ed avevano per capi Ma&tt'i di campo.
Ogni terzo dividevasi, scc:ondo i cas i, in 1O, in t 5, ed anche in 20 compagnie.
Le compagnie più perfcllc erano composte per due terzi di archibugi e moschetti, e per un terzo di picche.
La cavalleria componcvasi di cavalleggieri, di dragoni, di stradioui, di arcbibugie ri o cavallo, di uomini d' armi, in varie proporzioni.
Quando poi un principe, od uno stato qualsiasi, aveva bisogno di soldati, manda va una patente di mastro di cam· po ad un guerriero distinto o ad un ricco gentiluomo, colla facollil di riunire c comandare un corpo di 2000, 3000 o 4000 uomini, c gli sborsava i danari della prestanza. Costu i eleggevasi il suo stato maggiore, e da va fuori tante pa· tenti da capitano quante erano le COOlJlagnie di cui aveva bisogno. Il suo slalo maggiore eomponcvasi: di un cappellano, un medico, un chirurgo, un auditore, un sergen te maggiore, un porta insegna, uo tamburo generale, ed un luogotenente
che doveva la sua compagnia colonnella) e tenet·e d' tuuo il . Terzo.
l capitani nominavano i loro suballcrni.
Fatto ciò, i sergenti, i caporali, c le lancie spezzate, si sguinzagliavano per città c villaggi, eu tra\' ano in \averne c postriboli, piantavano banco in piazza, e colle lusinghe, col vino, e col ingaggiavano la canaglia. Tah·olta, per ordine del principe, si pigliavano persino i carcerati; lal' altra invece si voleva gente di buona vita.
Eseguito il reclutam.ento, si davano ai soldati vesti ed armi coi danari della pl'ima prestanza.
Un segno speciale, cucito sull' abito, faceva distinguere le soldatcsehe di un esercito da quelle di un ahro.
Il capitano riceveva dal principe un soldo fis so per eia· scun, uomo; ma non lo distribuiva tutto, nè in uguale misura. Tutti rubavano; egli, i sergenti, i tesorieri, i pa· gatori . Rubavano addosso al principe, od allo stato che assoldava, col farsi pagare per uomini che non esistevano; rubavano addosso ai sohlali, coll' appl'opriarsi indebitamente parte de'loro stipcndj; ruba vano addosso a.i paesi, coll'i m · porre alloggiamenti in quantità maggiore del reale, per poi ridurli mediante riscatto. l viveri dell'esercito si vendevano o si cambiavano di nascosto; le munizionì si sperperavano; i popoli erao·o oppressi dalle taglie; e ciò non ostante si deptorava il difetto d' uomini c di provvisioni. Dal canto loro i soldati si riraècvano sul luogo in cm st trovavano; e non di rado rispond evano alle frodi dei superiori con tumulti e sedizioni.
Per tenere a freno codeste turbe, i Ca()i cstrsissimo, c ne abusavano; impcroccltè sehbene le gravi mancanze dove ssero essere giudicate dal mastro di campo generale, coadjuvato dagli uditori, pure l'arbi trio dominava, e H capitano sentenziava spesse volte inappellabilmente.
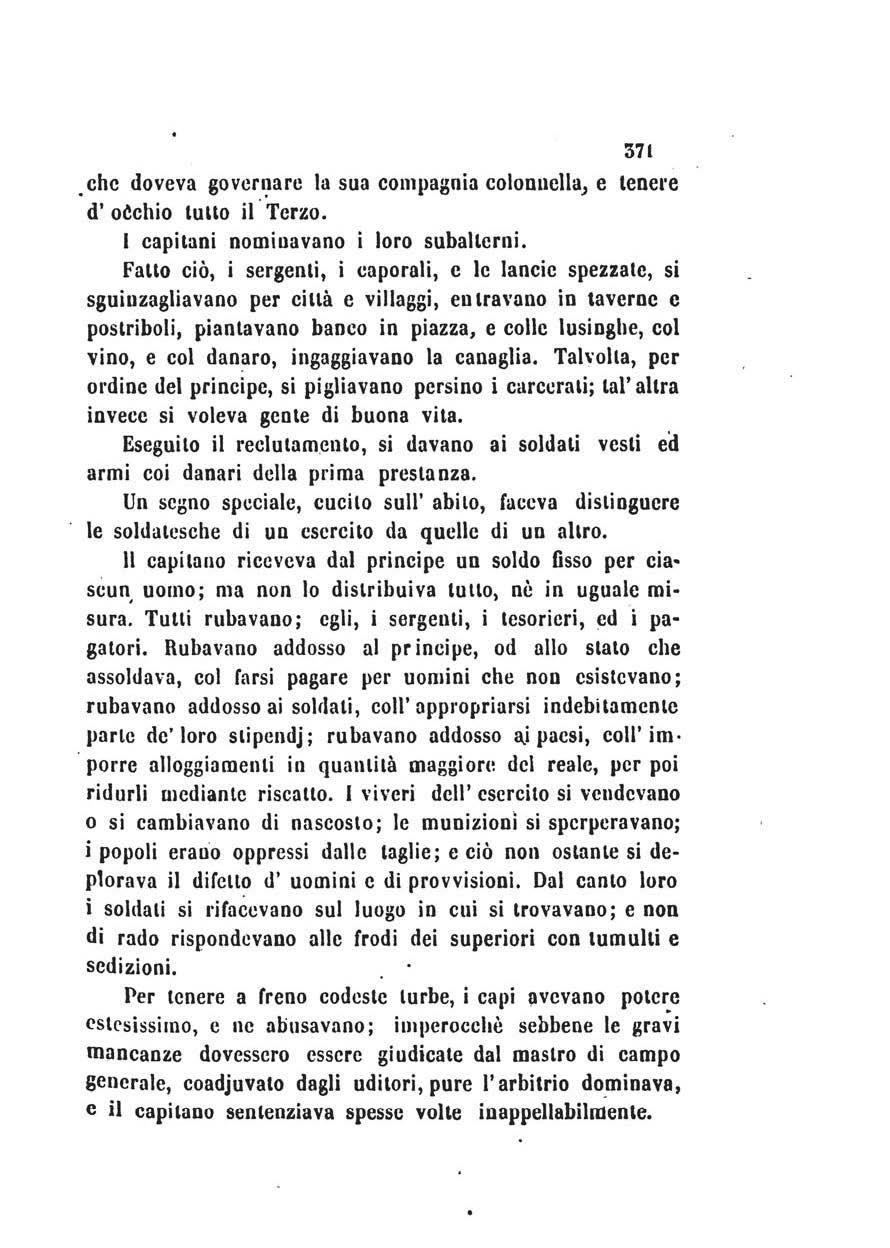
Ne accadeva che le punizioni non erano proporzio· nate alle ·colpe; la morte, Ja corda, i ferri, il carcere, le saccheltate, il taglio delle orecchie e del naso, le bastonate, erano. pene distribuite senza distinzione e senza equità .
Alcuni eercarono di porre un qualche assetto a tali confusioni; c fra questi dee notarsi Alessandro Farnese. Ecco il pere hè le truppe d i codesto generale poterono offrire una scuola d' insegnamento che ru degna rivale a quella degli olandesi.
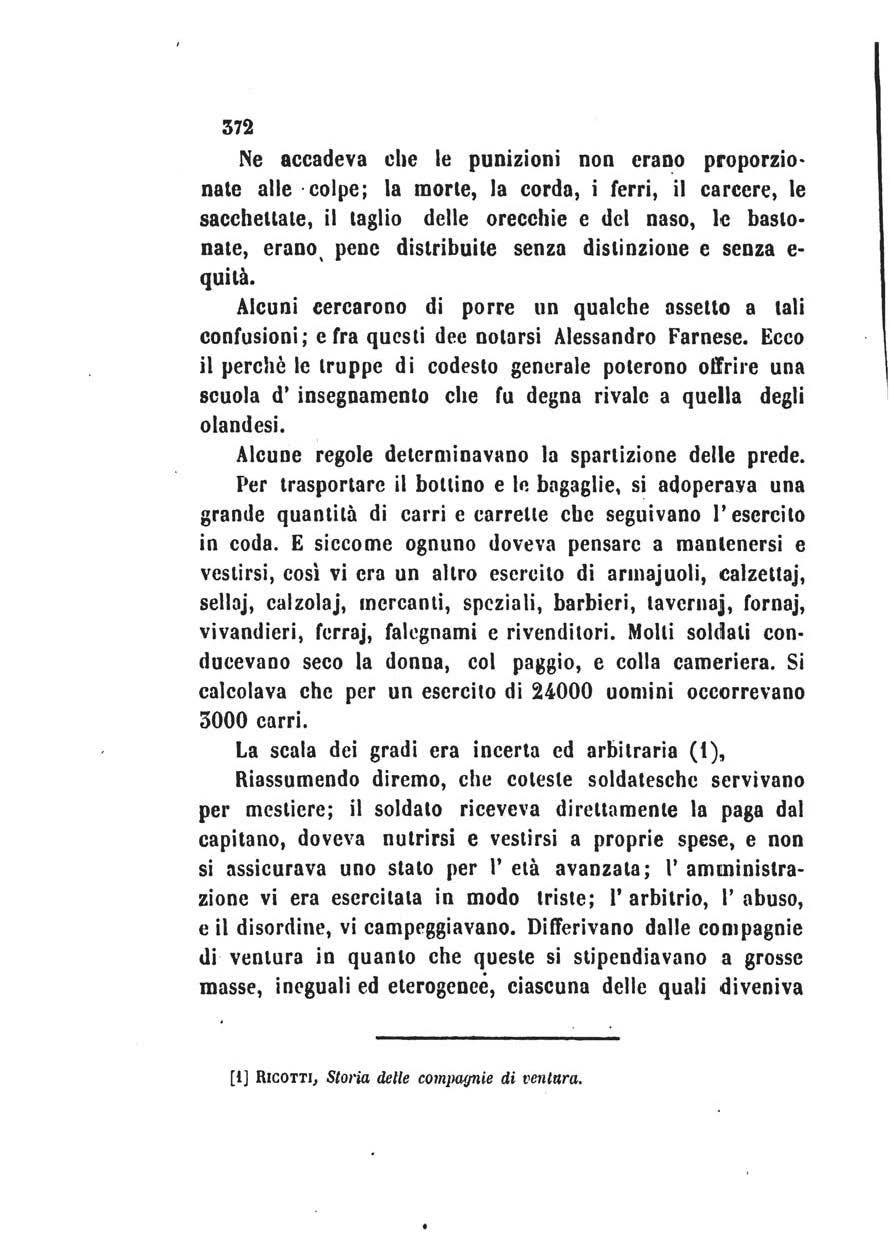
Alcune regole determioav11oo la spartizione delle prede.
Per trasportare il bottino e lP. bogaglie, s! adoperaya una grande quantità di carri e carrette cbc seguivano l'esercito in coda . E siccome ognuno doveva pensare a mantenersi e vestirsi, così vi era un altro esercito di armajuoli, calzettaj, sellnj, calzolaj, mercanti, spezia li, barbieri, ta veruaj , rornaj, vivandieri, rcrraj, falegnami e rivenditori. Molti soldati con· ducevaoo seco la donna, col paggio, e colla cameriera. Si calcolava che per un esercito di 24000 uomini occorrevano 5000 cnrri.
La senta dci gradi era incerta ed arbitraria (t), Riassumendo diremo, che coteste soldateschc servivano per mestiere; il soldato riceveva direttamente la paga dal capitano, doveva nutrirsi e vestirsi a proprie spese, e non si assicurava uno stato per l' età avanzala; l' amministrazione vi era esercitata in modo triste ; l' arbitr io, l' abuso, e il disordine, vi campeggiavano. Differivano dalle compagnie di venlura io quanto che queste si stipeod iavano a grosse masse, int'guali ed eterogenee, ciascuna delle quali diveniva
(t) RI COTTI> Storia delle comp(J(Jilie di ventura.
una parte importantissima dell' esercito, il quale perciò non aveva un' unità fissa di forza; il principe, o lo stato qualsiasi, trauava soltanto col condouiero, e non riconosceva alcun' altra autorità doiJo di lui; quindi il condott iero era il solo garante delle sue genti, e le raccoglieva, armava ed esercitava a suo talento. Invece, nelle di cui ora trattiamo, le compagnie erano piccole, prcssochè uguali di numero c . di forma, e costituivano l'unità di forza dell'esercito; il capo aon concludeva patti coi principi mali riceveva; i capitani avevano bensì le patenti dai capi, ma in nome del principe; i mastri .di campo e i capitani erano mallevadori pe' loro subordinati; le mosse delle diverse parti dell' esercito erano coordinate dalla suprema direzione del mastro di campo generale, o del sergente generale, nominato direttamente dal principe; gli auditori contrabbilanciavano, io certo qual modo, l' arbitrio dci capi; e mentre le grosse masse di venturieri formavano unità che staccandosi dal tutto poteano operare da sè e rendersi terribili agli stati, le compagnie di questi eserciti raccoglilicci potevano essere facilmente disperse e distrutte.
Gli eserciti ctie io questo secolo si armarono, e si posero in campo, oou asc endevano a cifre molto elevate,
Alla battaglia di Ravenna , gl' ispauo-italici ammontavano a circa 30,000 uomini tra fanti e cavalli; i francesi a t8,000 di fanteria e 10,000 di cavalleria. .
A Marignano, Francesco I disponeva di fanti, 2500 uomini d' armi, t500 cavalleggieri, pioooieri, e qualche corpo scelto.
A Ceresole, il duca d' Augbienna comandava a H,OOO fanti, e cavalli; mentre il suo avversario disponeva di 18,000 uomini a piedi, e UOO cavalli.
Nel 1554, il maresciallo di Brissac marciò verso Ivrea per assediarla con t7,000 ,fanti e I?CIOO cavalli; la so a fao'teria compre n· deva 7000 francesi, 4000 svizzeri, 5000 tedeschi, e 3000 italiani.
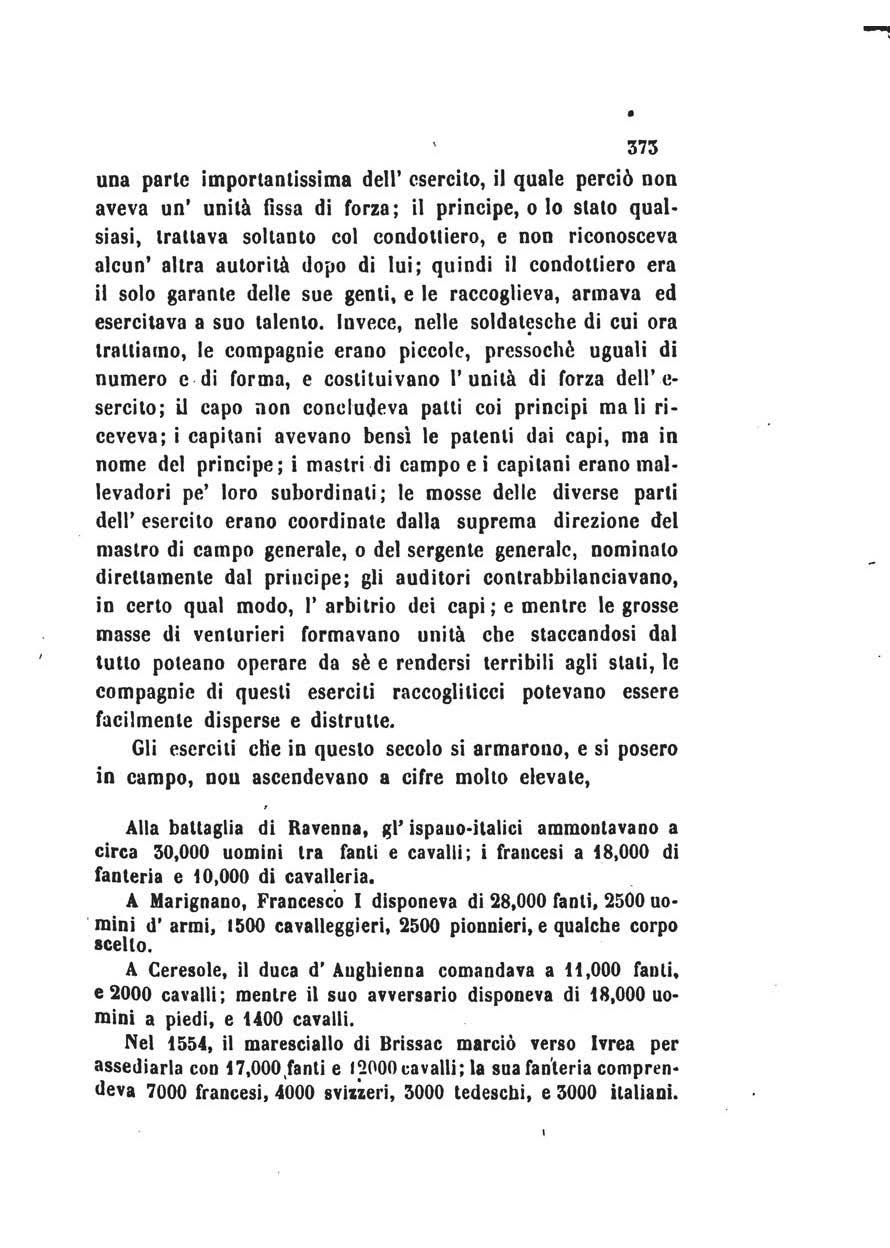
374
Esigue erano in Francia le forze belligeranti nelle guerre di religione; l' indole stessa della guerra che consisteva in iscaramncce, in r•·ese e riprese di posti, non ne esigeva di maggiori, e la disunione generale non perm!!lleva che si ottenessero (t) .
Alla battaglia di Montcontour, i caltolici avevano 16,000 fanti e 8000 cavalli; gli ugooolli 16,000 uomini a piedi e 7000 a cavallo.
Gli eserciti di·Manrizio di Nassau non erano più con!'iderevoli. A Neuporto disponeva di un esercito superiore di poco a quello dell ' arciduca Alberto, suo avversario, il quale comandava a t2,ÒOO fanti e i 200 cavalli.
Il duca d' Alba, portandosi da Milano in Fiandra coi terzi disponibili, non riunì se non che l 0,000 fanti c 1200 cavalli.
Quando invase il Portogallo trovavasi alla testa di 26,000 nomini .
ARMI DA ruoco. Dello sviluppo e dell' aumento di esse, e del problema che in conseguenza veniva posto nell' arte militare, già abbiamo con bastante t.lifTusione parlato negli ord i namcn ti di versi.
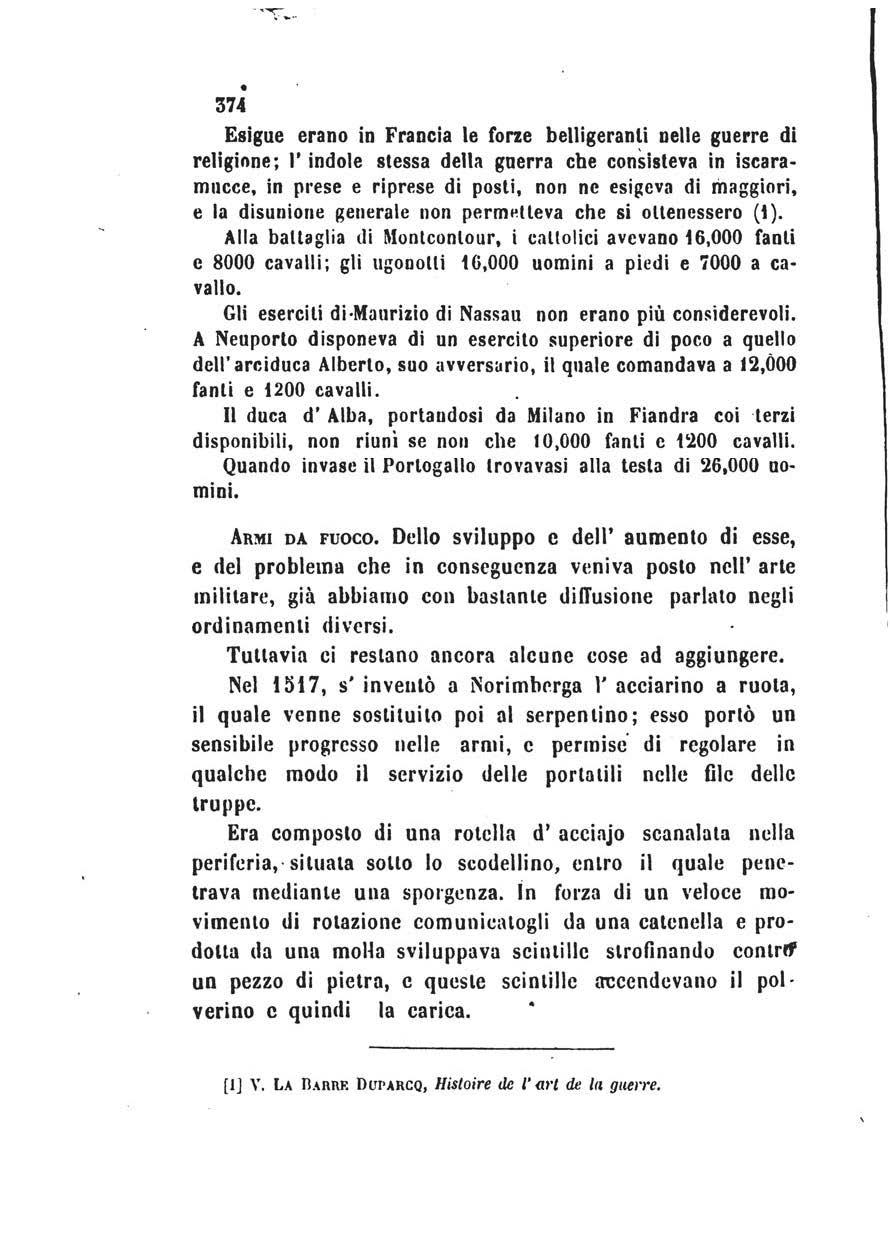
Tuttavia ci restano ancora alcune cose ad aggiungere. Nel t 517, s' inveutò a l' acciar ino a ruota, il quale venne sostituito poi al serpenti no; portò un sensibile progresso nelle armi, c permise di regolare in qualche modo il servizio delle portatili nelle file delle truppe.
Era composto di una rotella d' acciajo scanalata nella periferia, · situata solto lo scodellino, entro il quale penetrava mediante una sporgenza . in foa·za lli un veloce mo· vimento di rotazione comunicatogli da una catenella e pro· doua da una moHa sviluppava scintille strofinando contrfF un pezzo di pietra, c queste scintille :reccndcvano il poi· verino c quindi la carica.
( l) \'. LA n.\RRF. DUI'ARCQ, Histoire de l' m·t de 111 guerre.
375
VuoJsi che nel t t sia nsi adoperati per In prima volta i moschetti dagli spagnuoli sotto Carlo V alla battaglia di Pavia. Il nome di moschetto era da lungo tempo in uso; ma applicavasi ad n ltr' arma da getto, che lanciava freccic chiamate moscltettc. Il moschetto, come arma da fuoco, era un'a specie di archibugio, ma più grosso e più pesante, per cui maneggiavasi coll' appoggio di un' asta su cui veniva posnto, e che chiamavasi forchetta o forcella.
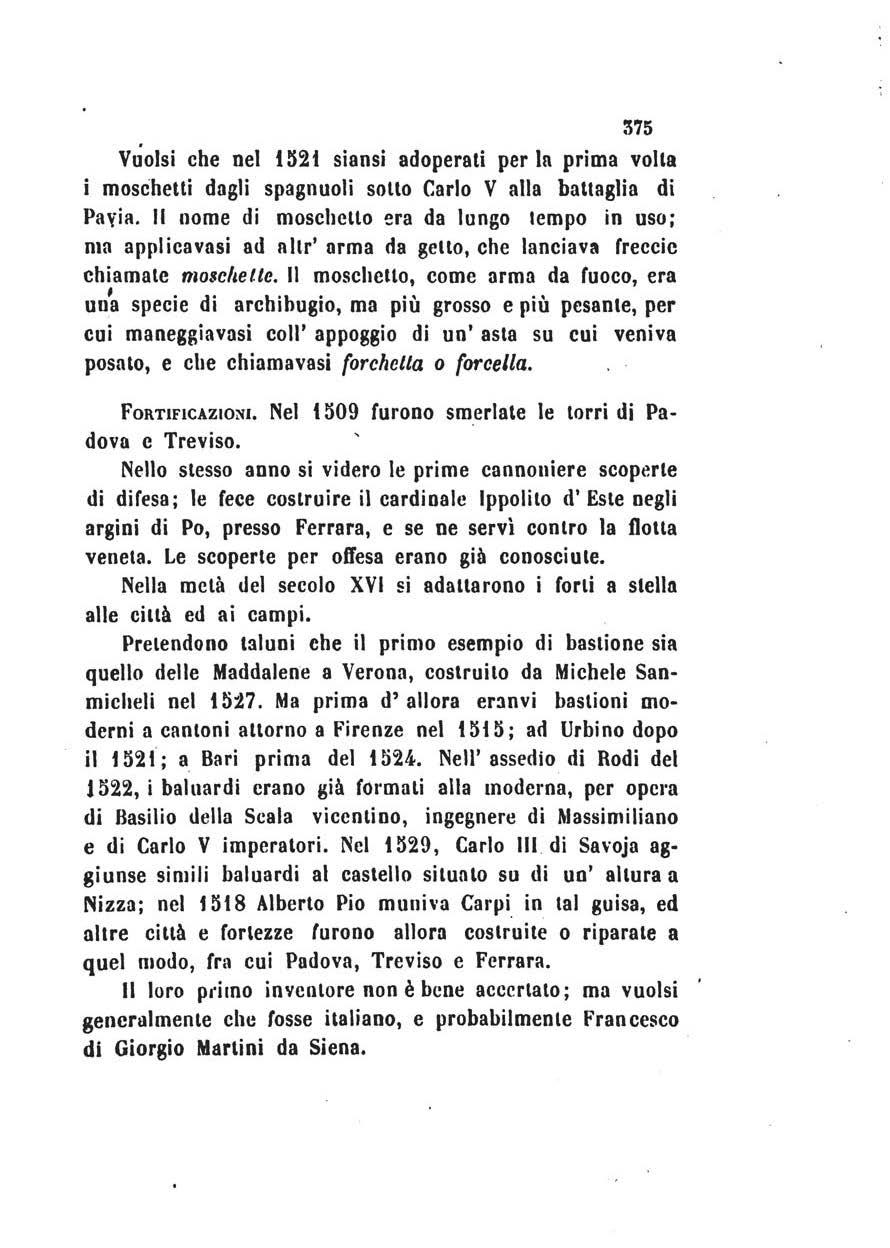
FoRTIFICAZIONI. Nel t 509 furono smerlate le torri di Padova c Treviso.
Nello stesso anno si videro le prime cannoniere scoperte di difesa; le fece costruire il cardinale lppolito d' Este negli argini di Po, presso Ferrara, e se ne servì contro Ja flotta veneta. Le scoperte per offesa erano già conosciute.
Nella metà tlel secolo XVI si adattarono i forti a stelltl alle città ed ai campi.
Pretendono taluni che il primo esempio di bastione sia quello delle Maddalene a Verona, costruito da Michele Sanmicheli nel t 5:27. Ma prima d' allora er:mvi bastioni moderni a cAntoni attorno a Firenze nel t 5H>; ad Urbino dopo il 152 f; a. Bari prima del t 524. Nell' assedio di Rodi del J 522, i baluardi erano già formaLi alla moderna, per opera di Basilio della Scala vicentino, ingegnere di Massimiliano e di Carlo V imperatori. Nel t529, Carlo 111 . di Savoja aggiunse simili baluardi al castello situnto su di un' altura a Nizza; nel f 518 Alberto Pio muniva Carpi in tal guisa, ed altre città e fortezze furono allora costruite o riparate a quel modo, fra cui Padova, Treviso e Ferrara.
Il loro pl'imo inventore non è bene acccrlato; ma vuolsi generalmente che fosse italiano, e probabilmente Francesco di Giorgio Martini da Siena.
l.e truppe, condotte in campo, venivano talvolta assicurate col mezzo. d' opere di fortificazione.
Il modo di eseguire le marcie non risulta chiaramente dagli storici di quel . tempo.
Troviamo però che io alcuni casi si fece coi carrr una specie di trinceramento mobile. Alessandro Farnese, recandosi io Francia durante la Lega, attraversò le pianure della Piccardia, marciando in colonna in mezzo a due file di carri che cuoprivano le sue truppe.
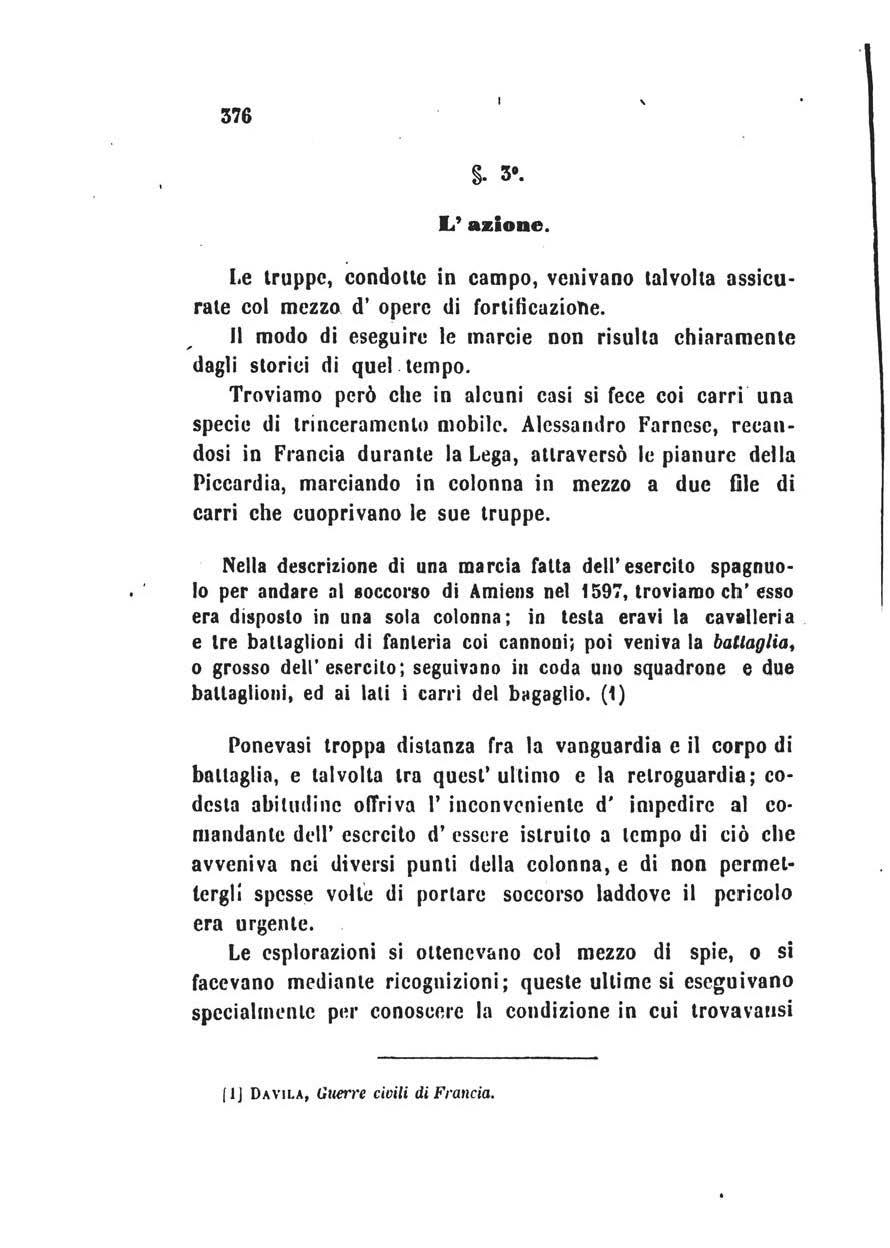
Nella descrizione di una marcia fatta dell'esercito spagnuolo per andare al soccot·so di Amiens nel t 597, troviamo ch' esso era disposto in una sola colonna; in testa era vi la cavalleria . e tre batlaglioni di fanteria coi cannoni; poi veniva la battaglia, o grosso dell'esercito; seguivano in coda uno squadrone e due battaglioni, ed ai lati i cari'i del (1)
Ponevasi troppa distanza fra la vaoguardia c il corpo di bollaglia , e talvolta tra quest' ul 'timo c la retroguardia; codesta abitudine offriva l' inconveniente d' impedire al co· mandante ddl' esercito d' essere istruito a tempo tli ciò che avveniva nei ùivca·si punti della colonna, e di non permettergli spesse volle di portare soccoa·so laddovc il pericolo era urgente.
Le esplorazioni si ottencv&no col mezzo di spie, o si facevano mediante ricognizioni; queste ultime si eseguivano spcciahncntc conoscere la condizione in cui trova\·ausi
( l j DAVILA, Guerre civili di Francia.
377
le strade e per riparare ai loro difetti; come pure si effettuavano prima delle battaglie per sapere le disposizioni del nemico. (t)
E giunte in faccia al nemico, come disponevansi ' le truppe in ordine di .
L' uso di distribuire l'esercito su tre linee, era un resto della tradizione romana; ma siccome ' nel secolo XVI le l truppe erano ancora ammassate in ordine profondo, e siccome .questa disposizione aveva lo svantaggio di porre in azione poca gente in un tempo stesso, cosi si derogò a siffaLta pratica t! si adottò talvolta l' ordine su di una sola linea.
Anche in questo ultimo caso però si conservarono le antiche espressioni per designare le tre divisioni dell' esr.rcito, ed allora la vanguardia divenne J' ala dritta, la ·bauagJia . il centro, e la retroguardia l' ala sinistra. Questa denominazione difettosa, che durò sino al secolo XVII, indusse in errore scrittori militari.
l francesi, sulla prima metà di questo secolo,_ incominciarono ad adottare l' ordine di battaglia ·df'gli svizzeri; ponendo cioé in iscaglioni, ed anche su di una medesima linea, le tre sezioni di vanguardia, corpo di battaglia e retroguardia . Alla battaglia di Cerignole, datasi nel 1525, essi erano in iscaglioni, c gl' italiani stavano disposti su di una linea sola.
Si formavano due specie di quadrati: d' uomini, e di terreno. l primi avevano ugual numero d' uomini da ogni luto; i secondi ave\'ano minor quantità d'uomini in profondità che sulla fronte; ma lasciandosi maggiore distanza fra le righe di quello che si lasciava tra· le file, i soldati occupavano sul terreno una superficie quadrata.
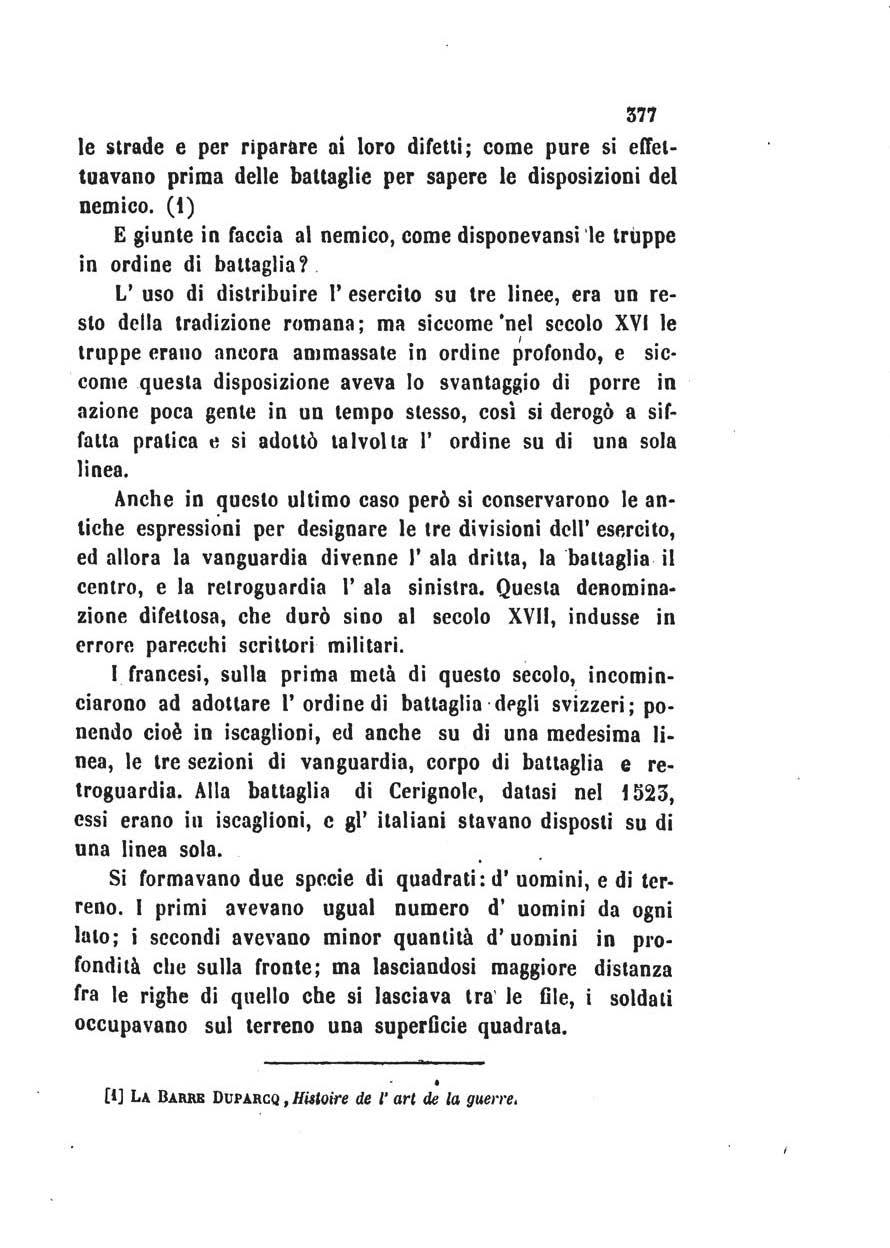
LA DAIU\B DUPARCQ, Hù&oire de l'art de la guerl'e
37R
L' artiglieria; a quell' epoca, imbarazzava il movimeato degli eserciti; di mano io mano che la lattica e la stra· tegia anda\'ano migliorando, si scorgevano vieppiù gl' inconvenienti di un'artiglieria la quale doveva sempre essere protella ne' suoi movimenti lenti cd incomodi. Daremo due · cscmpj: uno tattico e l' nhro strategico.
·L' artiglieria francese, collocata vantaggiosamente suJie rive del Garigliano, respinse tutti gli auacchi di fronte; ma avcn.do gli spagouoli gil'a ta la posizione, l' artiglieria · non potè rispondere colla sollecitudine de' movimenti, i francesi si ritirarono, c finirono con una rotta per la lentezza con cui marciava l'artiglieria medesima situata alla testa della colonna.
Gastone di roix, nelle grandi marc ie strategiche da lui esegu ite, dovè lasc iare indietro In grossa artiglieria; e nella sua marcia su Ravenna, restò quattro giorni fra Cotignola e Granarola per aspettare dodici cannoni e dodici pezzi più piecoli che gl' inviava il duca di Ferrara.
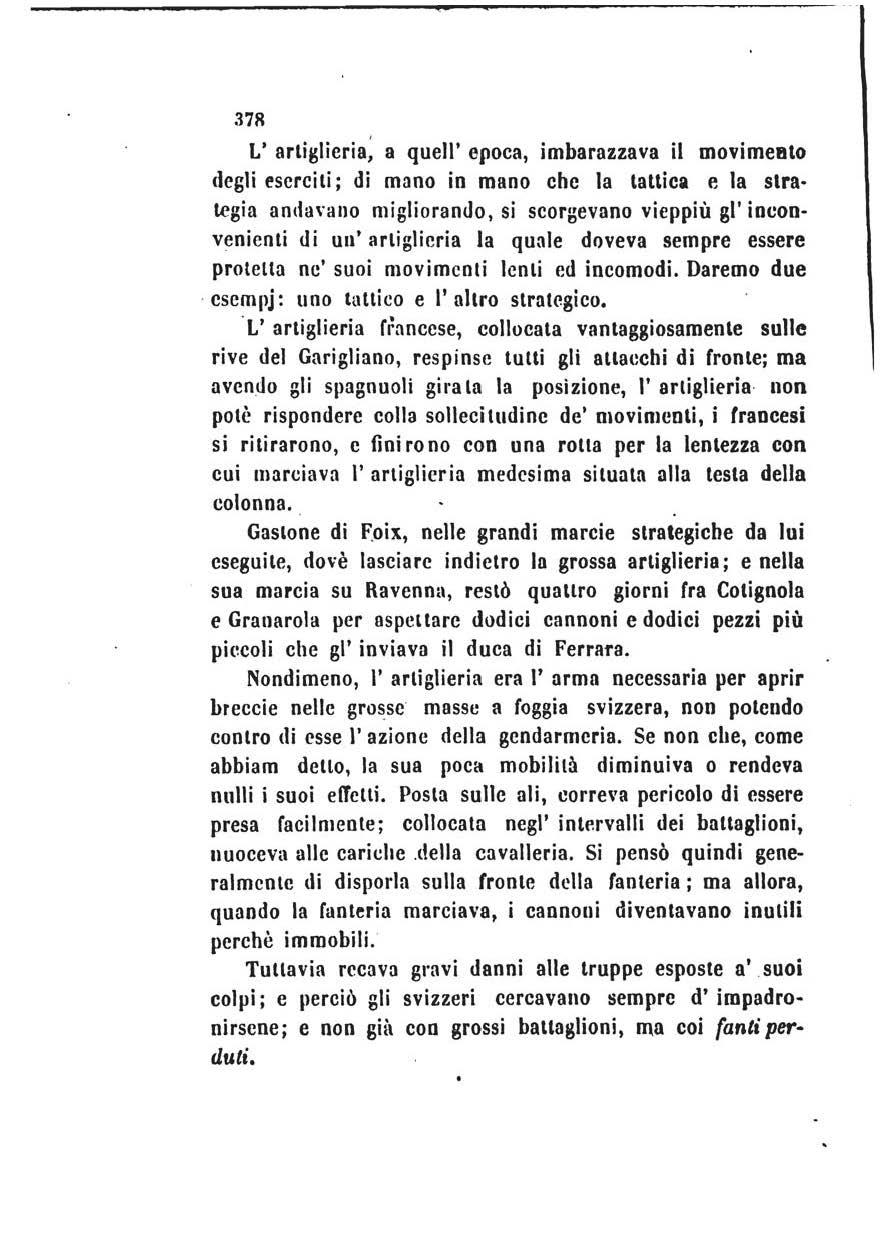
Nondimeno, l' artiglieria era l' arma necessaria per aprir breccie nelle mosse a foggia svizzera, non potendo contro di esse l'azione della gendarmeria . Se non che, come abbiam dello, la sua poca mobilità diminuiva o rendeva nulli i suoi effetti. Posta sulle ali, correva pericolo di essere presa facilmente; collocata negl' intervalli dei battaglioni, nuoceva alle cariche .della cavalleria . Si pensò quindi generalmente di disporla sulla fronte della fanteria ; ma allora, quando la fanteria marciava, i cannoni diventavano inutili pcrchè immobili.
Tuttavia rccav::1 gravi danni alle truppe esposte a' .suoi colpi; e perciò gli svizzeri cercavano sempre d' impadro· nirscne; e non gii\ con grossi battaglioni, ma coi fanti per· duti.
379
l battaglioni quadrati d' uomini non erano serrati 1!1 mnssa; ma in faccia nl nemico avevano l' intervallo di un pnsso tra le file, e circa lo stesso tra le righe. Questo spazio sPrviva n dar agli alabardieri, i quali, avendo un' arma più corta, andavano nella mischia a soccorrere i picchieri.
Nelle marcie, codesti quadrati si romprvano in parecchie sczi om, 10 guisa che queste sezioni non avessero più a fare se non che un Avanti in battaglia per formare il quadrato.
lncominciavasi ancora a frammischiare gli archibugieri colla cavali eri a. Ne sono csempj le battaglie di Pavia e di Ceresole.
Sembra che le truppe di Carlo V abbiano conservato l' antico ordine di battaglia; e che soltanto per eccezione la battaglia e l' avanguardia si avanzassero qualche volla su di una sola linea.
Nelle mnrcie in vicinanza del nemico,, si collocava la colonna d' artiglieria colle vetture al centro, la fanteria alla dritta, la cavalleria alla sinistra.
La buona riuscita suscita l'orgoglio, c l' orgoglio dà sempre un' idea delle proprie forze. Nel secolo XV, la cavallel'ia credeva 'potere far senza della fanteria: nel principio del XVI, gli s,·izzeri senza artiglieria e senza cavalleria credevano potere rovesciar tutto colla falange delle loro picche. Da altra parte la nobiltà francese, malgrado la grande importanza che dava all' artiglieria, rendeva soventi vohe inutile l' effetto del cannone per troppa temerità. Due grondi battaglie diedero a ciascuno de' due una severa lezione: Marignano agli svizzeri, Pavia ai francesi.
Nel tempo delle guerre di religione, il disordine che do· minava nella società si ripereosse ugualmente negli eserciti.
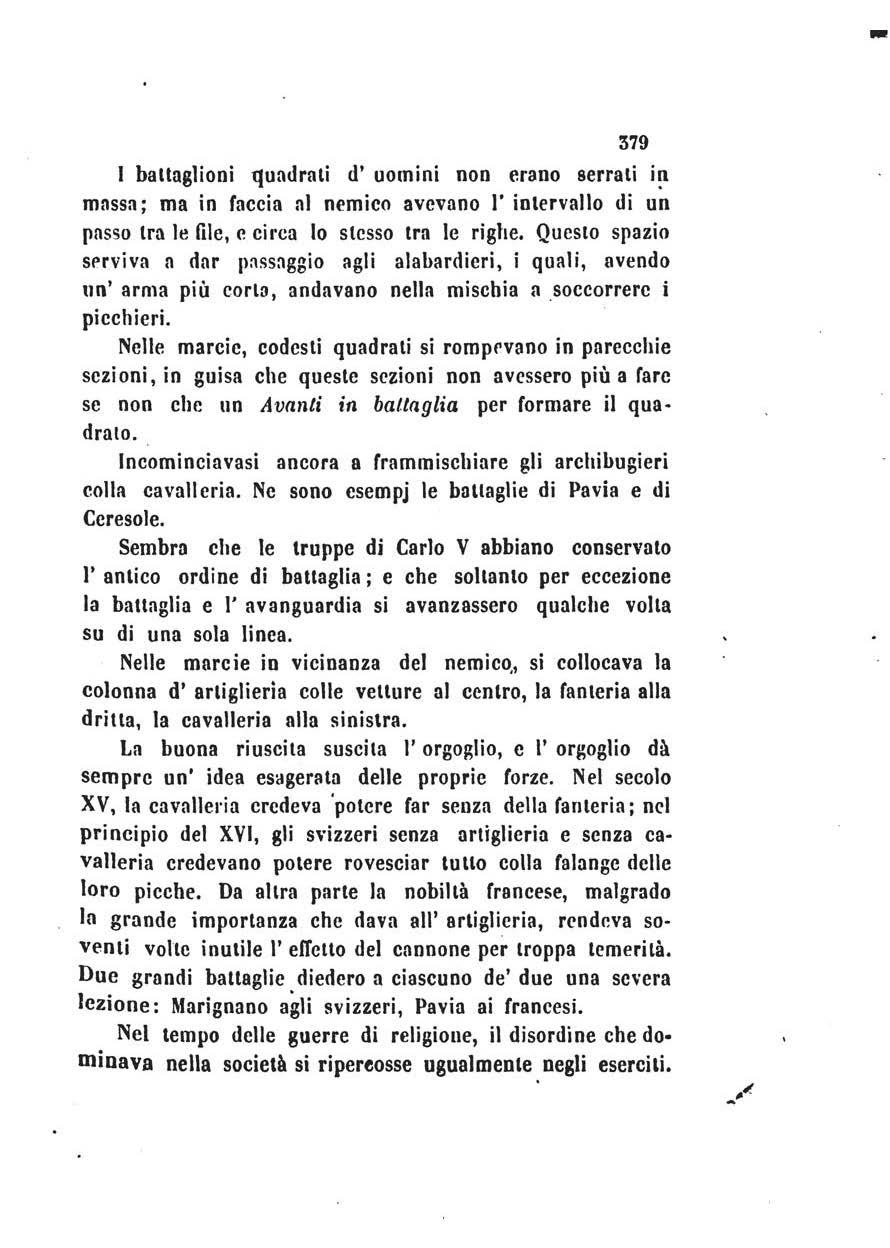
Nondimeno, mentre gli elemeoLi che cosLi tuiscono gli eserciti si dissolvevano, la tattica c la strategia si . sotto abili capitani. Più non si vedevano -grandi eserciti, ma si riscontravano in compenso più grandi capitani.
In queste guerre acquistarono celebrità i Raitri o Pistolieri, cavalleria tedesca che andò a servire in Francia; una piccola parte nell' esercito regio, la maggior parLe coi protestanti. .Formavansi .in grossi squadroni di t6, 20, e sino di 50 ranghi: si avvicinavano al nemico; il primo rango (acca fuoco quasi a bruciapelo, poi si ritirava in coda e i-icaricava le armi, lasciando scoperto il secondo rango che a sua volta racea altrettanto. E così via via. Talora i raitri pigliavano la spada alla mano c caricavano in massa; essi rovesciarono parecchie volte ·i gendarmi francesi che combattevano a spalliera. In scguiLo, i francesi adoltarono i grossi squadl'oni.
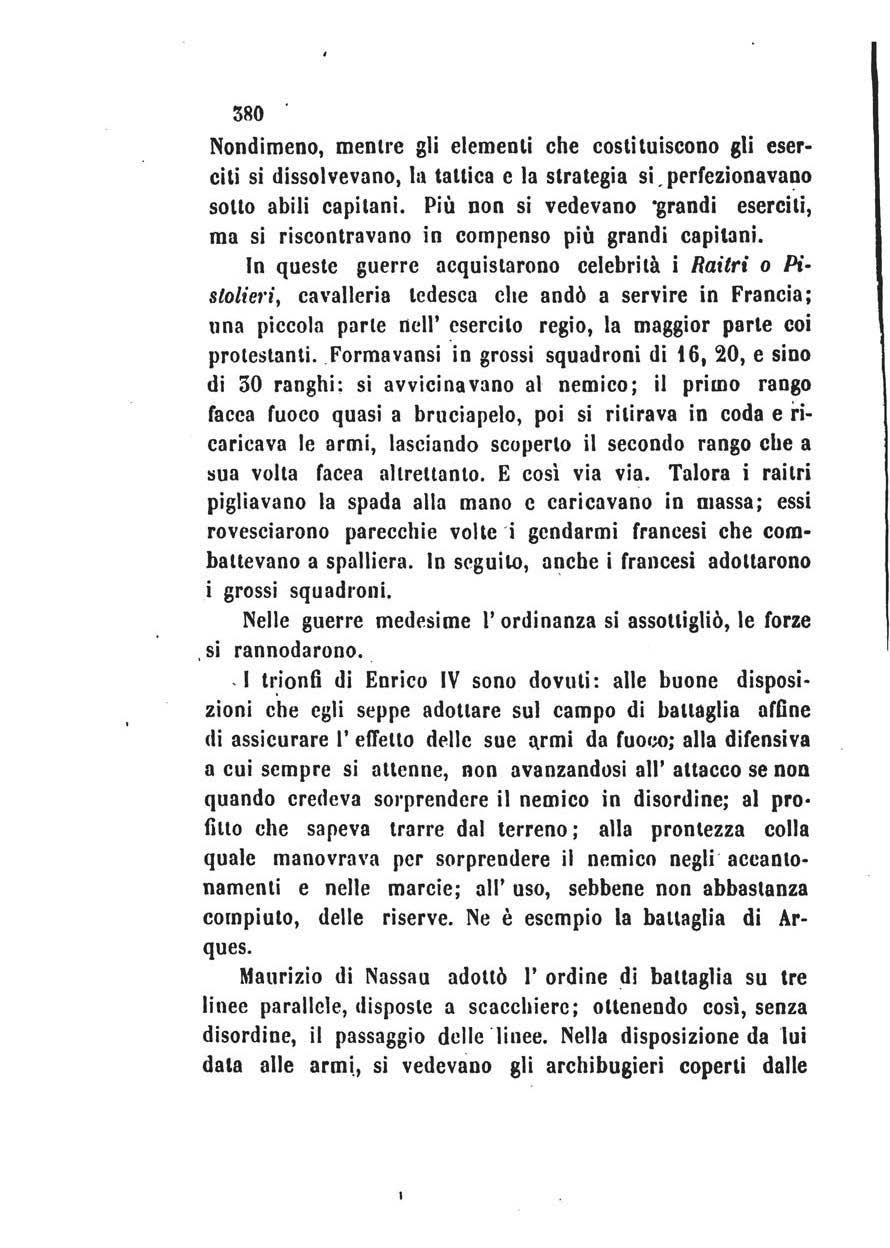
Nelle guerre medesime l'ordinanza si assottigliò, le forze . si rannodarono . .
.
l di Enrico IV sono dovuLi: alle buone disposizioni che egli seppe adottare sul campo di battaglia affine di assicurare l'effetto delle sue a.rmi da fuoc;o; alla difensiva a cui sempre si attenne, non avanzandosi all' attacco se non quando credeva sot·prendcre il nemico in disordine; al pro· fitto che sapeva trarre dal terreno; alla prontezza colla quale manovra\'a per sorprendere il nemico negli · accantonamenti e nelle marcie; all' uso, sebbene non abbastanza compiuto, delle riserve. Ne è esempio la bauaglia di Ar· ques.
Maurizio di Nassau adottò l' ordine di battaglia su tre linee parallele, disposte a scacchiere; ottenendo così, senza disordine, il passaggio delle ·linee. Nella disposizione da lui dala alle armi., si vedevàoo gli archibugieri coperti dalle
582
lavori d' assedio si i villani; ma non osando più costoro di esporsi al fuoco per lavorare alle tl'incec, se ne diede l'incarico ai soldati, ai quali si assegnò un tanto per ogl)i braccio di trincea. s. 4.0
Ed anche qursto secolo continua a un' rpoca di passaggio a quc' tempi che dipoi vengono a giusto lliillo designati per l'arte militare coi titoli di moderni. Se non che, cd è naturalissimo, di\•ersilìca dall' autccl'dcntc pci progrl'ssi che ciTcttivamcnlc ehbcro luogo, c che lo fecero vieppiù discostare dall' medio, i cui principj, le cui costumanze, le cui tendenze, anda,·ano ognor maggio1·mcntc perllcndosi.
Già Hdemmo come il sistema di conc<.•ntrazione andasse fra molte na1.ioni di ITondcndosi ; c questo si stema, in ma s· sima parte po1·tato dal potere regio, costituiva su più am· I>ie basi parecchi stati europei, c face\'a sentire il proprio influ sso sull'ordinamento degli èscrciti . toraui, il potere regio, o centrale qunlsiasi, rapprc s(·n· tante l'agglomerazione c l'unificazione, riusciva il conlrap)Josto della divi:>iooe e dell'individualità che formavano l'essenza del periodo feudale; quindi aveva d'uopo, per ·s<>ste· nersi, di forze che traessero un'origine diversa da quella la quale appunto dal sistema di divisione emanava. Soccorso in principio dai comuni, ofTorzato da bande mercenarie, pro1eUo dalle scoperte e dalla civiltà nascente, avevo bauuto prima di fianco poi a colpo diretto i mal sicuri vassam, c ridoue le forze loro a perdere quel prestigio che l' indole
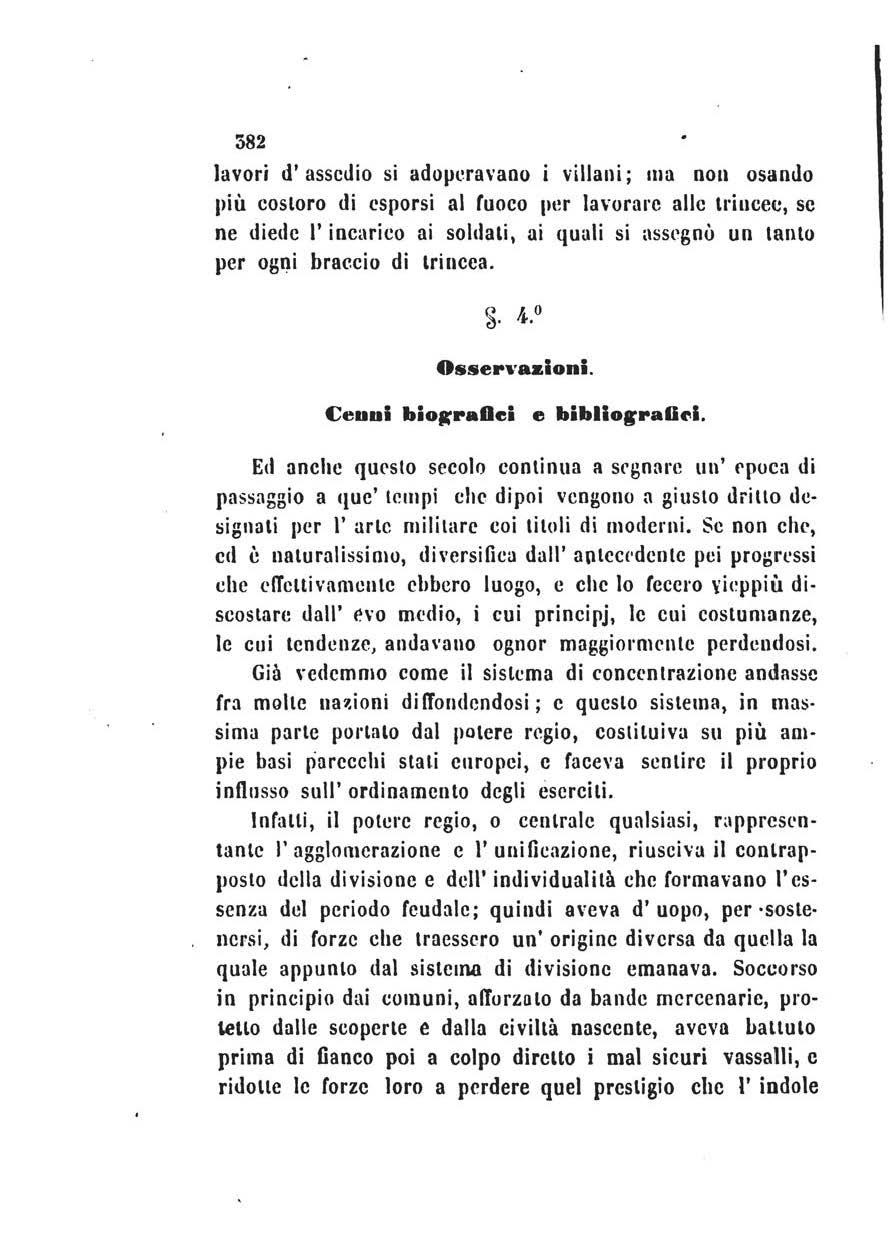
385 dei tempi aveva ad essi accordato. Abbattuti i grandi vassalli, rimanevano i piccoli facilmente dominati; ed ecco che perdendo l'importanza politica, perdevano valore le poche forze di cui potevano ancora disporre. Le nuove armi rendevano inutile, anzi impossibile, il loro modo di combaucre; <'d ecco che la loro pro1lezza non essendo più apprezzata come prima, ·non poteva nemmanco csSC!J'e più ricercata col bisogno di prima. Tollo questo emancipò il potere centrale dal· )'ausilio dei signori, c lo portò a ricercare altrove i mezzi per formare i suoi eserciti.
Altra circostanza certamente ,.i C(lncorse. El pote•·c centrale ricorse, come \'edemmo, anche ai comuui per traroe P.lementi di sostegno; ma, di mano in mano che l' ancr· sario principale e temuto, qual' era il fcudalismo, anda\'a cadendo, quel potere sentiva meno bisogno dei vecchi au· · siliarj, a cui doveva concedere diritti pc:r ottenere aj uto; diritti che menomando il libero c dispotico agire, riuscivano sempre più moJesti a chi li ave\'a concessi, c destavano nel-l: animo di chi li possedeva il desiderio non solo di manténerli ma di dilatarli e di moltiplicarli. Oltre n ciò, le milizie comunali avevano fatto i l tempo loro; a\·evnno ser\'ilo ad abbattere il potere feudale, ma non erano atte a lunghe e lontane guerre quali io qul'Sto secolo si combatterono . Nè gli uomini, nè le armi, nè gl'interessi famigliari di quelle milizie avrebbero permesso a Luigi XII, a Francesco l, a Carlo y, a Filippo Il, tli portare le armi loro su dh·ersi teatri di guerra; e perciò que' principi, c tolti i poteri centrali in genere, si volsero ad l)llra parLe per rintracciarvi clementi da còstituire i loro eserciLi; c come avevano fondato ampio stato o nazione omogenea, nello s tato e nella nazione cercavano foJ'Ze che non amavano più lrarrc nè dai sospetti od antipatici vassalli, nè dagl'imbelli od esigenti comuni.
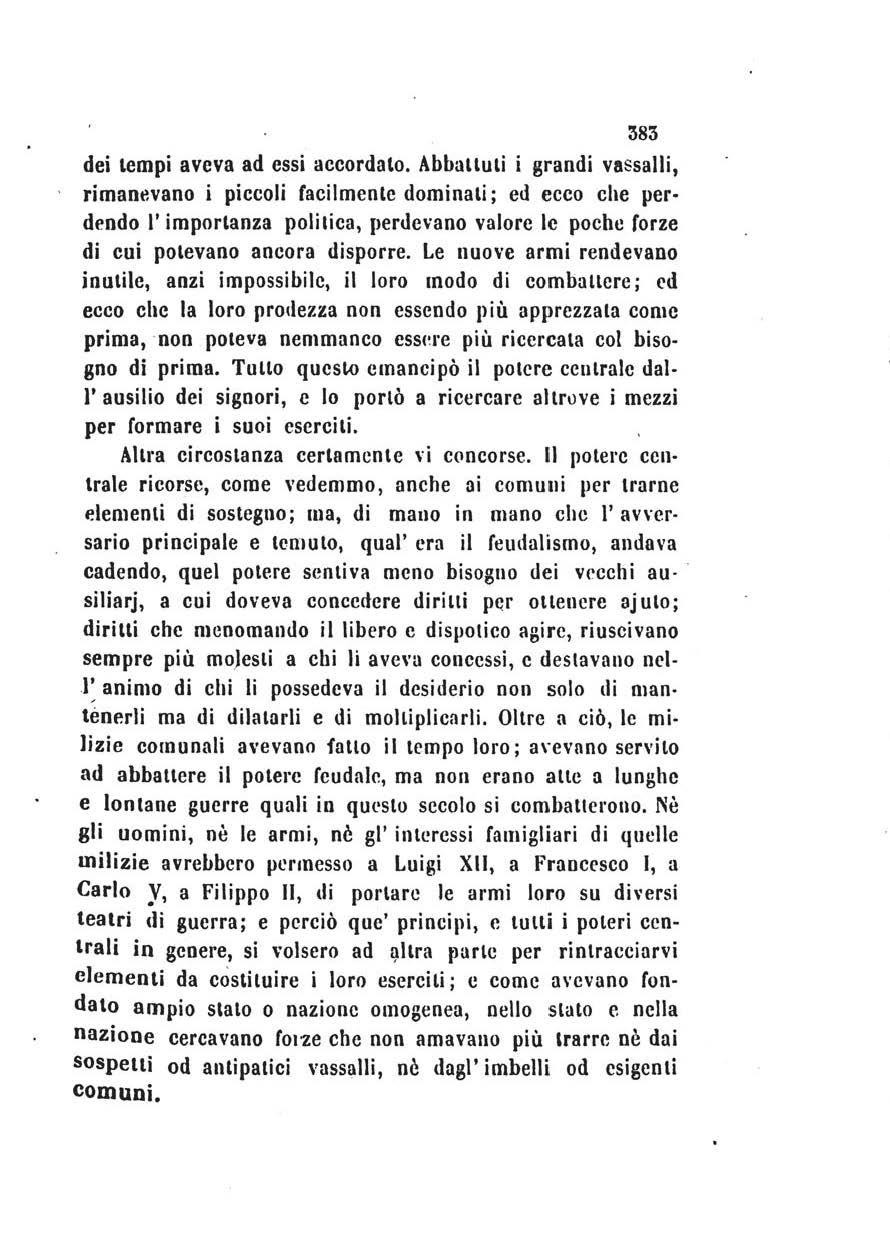
384
Per questo sorse1·o milizie nazionali e permanenti; per questo si adoltò un sistema di reclutamen to, il quale, tendendo n contcnc•·e l' al'istocrazia ed i comuni più che a giovarsene.', r.seludevano l' influsso e la gcrna·chia feudale o comu:1ale, dava alla fqrza pubblica una forma di ordini indipendenti dat suolo e dai luoghi, fondava insieme le forze del paese dapprima sparse e e le oppone\'a concentrate u ciascuna forza dissidente; c le guerre, portale più facilmente all' estero, recavano bensì con esse il carattere d'incursione e i danni delle devastazioni, ma poterono c dolVettero essere regolate da metodi più determinati, da istruzione più unisono, da previdenze più calcolate ed appropriate a ciascuna specie di spedizione ( 1).
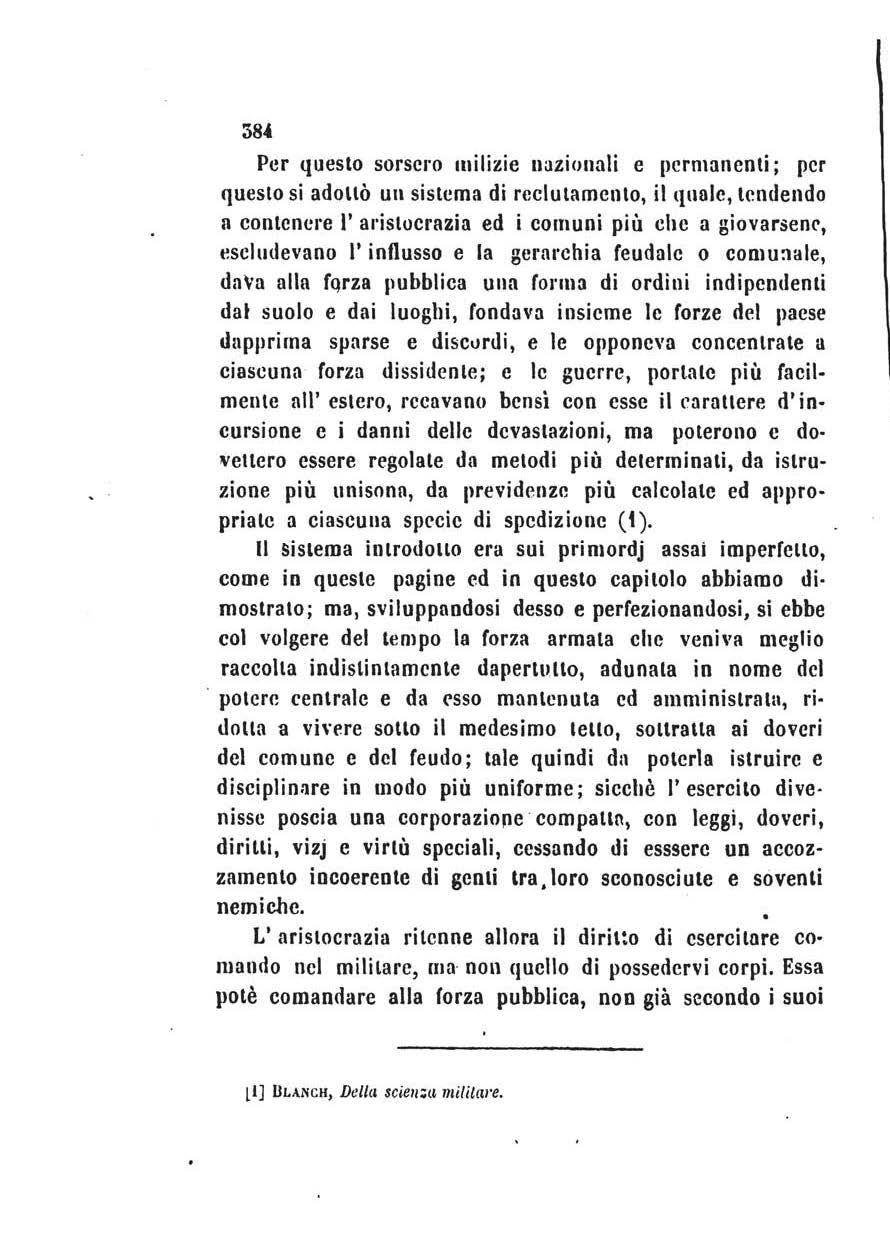
Il sistema introdotto era sui primordj assai imperfelto, come in queste pagine ed in questo capitolo abbiamo di· mostrato; ma, sviluppandosi desso e perfezionandosi, si ebbe col volgere del tempo la forza armata che veni\'a meglio raccolta indistintamente daperttllto, adunala in nome del · potere centrale e da esso mantenuta cd amministrata, ri· dollrt a viHre sotto il medesimo tetto, soLlratta ai doveri del comune e del feudo; tale quindi da potcrla istruire e disciplinare in modo più uniforme; sicchè l'esercito divenisse poscia una corporazione ·compallo, con leggi, doveri, diritti, vizj e virtù speciali , cessando di essserc un accoz · zamento incoerente di genti tra . loro sconosciu te e so venti nemiche.
L'aristocrazia ritenne allora il dirit:o di cscrcilllre comando nel militare, ma· non quello di possedcrvi corpi. Essa potè comandare alla forza pubblica, non già secondo i suoi [l ] DLAN CII, D el/11 sci ell;nmifilm·e.
385 interessi, non nel mollo e pci fini dell' ordine feudale, ma dirigendola con leggi non fatte nè consentite d,a essa; il po· tere centrale scelse tra i signori, ma questi al potere cen· arale non sovrastarono; furono essi preferibilmente, il più delle volte esclusivamente, reputati idonei al comando, ma comandarono per elezione, fecero la guerra per dovere e non per diritto. L' uso e l'abuso della guerra e degli armati passò io altra mano. Essi comandarono come ufficiali, e non come signori, a soldati non proprj. li passo e la novità fudi gran momento ·per la scienza della guerra e per l' ordine sor.iale; la forza della società a\·eva mutato di posto, di scopo e di mezzi. Servire la società, rappresentata da un potere ·centrale, era cosa ben diversa dall'esercitarvi il proprio comando; servire lungamente, uniti , sta · bilire nell' arte della guerra il proprio stato, ivi temere le pene e sperare i compensi, ravvisare nel monarca non l'emulo, non il primo fra i pari, come ai tempi feudali, ma il distributore quasi esclusivo della sventura ·o della fortuna, erano gralldi incitamenti a volere cd a potere promuovere i progressi della disciplina e della scienza militare . (t)
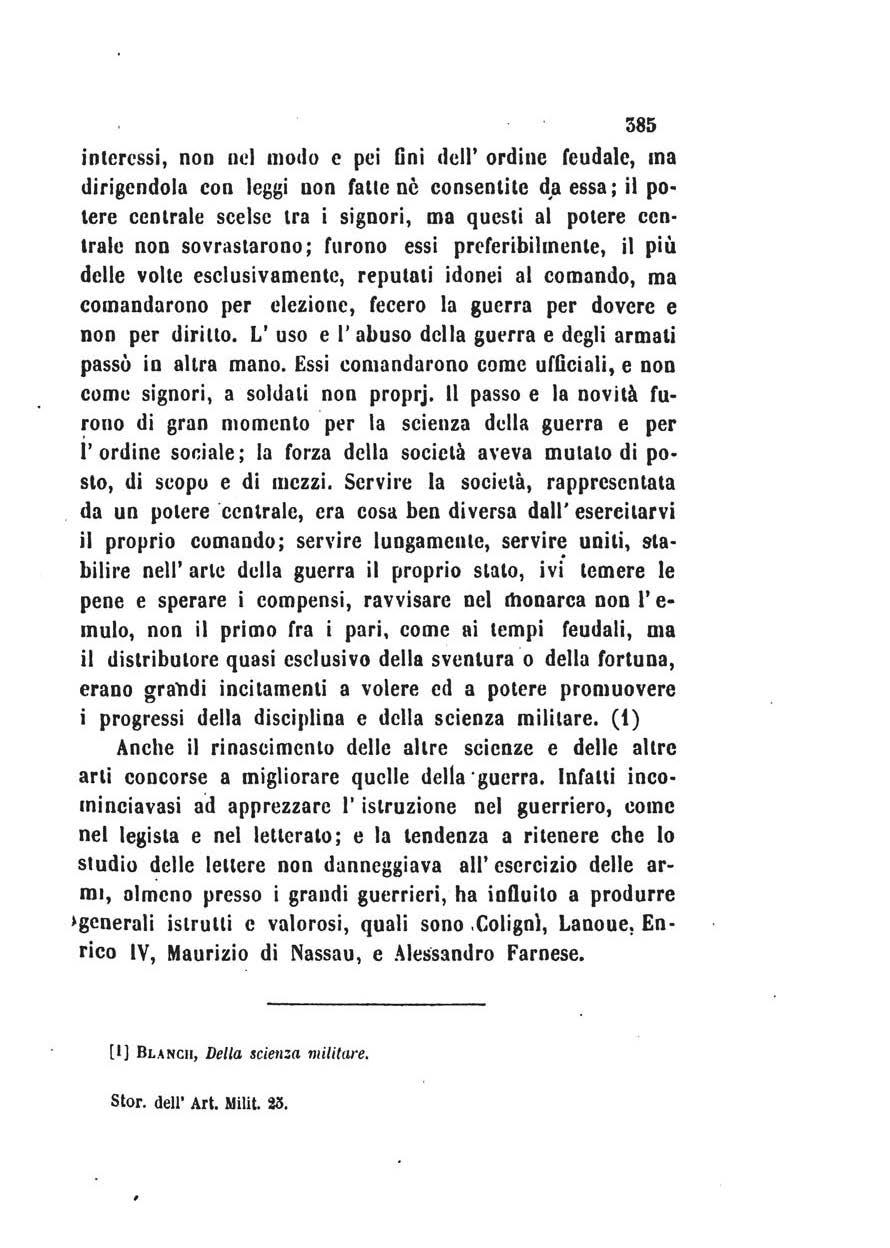
Anche il rinascimento delle altre scienze e delle altre arti concorse a migliorare quelle della ·guerra. Infatti incominciavasi ad apprezzare l' istruzione nel guerriero, come nel legista e nel letterato; e la tendenza a ritenere che lo studio delle tenere non danneggiava all'esercizio delle armi, ol meno presso i grandi guerrieri, ha influito a produrre )generali islrutti c va l orosi, quali sono .Coli gol, En· rico IV, Maurizio di Nassau, e Alessandro Farnese.
Stor. dell' Art. MiliL 2/S,
Non è ·a credersi però, oè a pretendersi, che i diversi l'ami della scienza milit&re avessero toccato un grado distinto di perfezione. Altri progressi dovevano fare le altre scienze per venire in socco•·so di essa; c tutto ciò per quel legame cbe stabilisce intimi rapporti fra tolte le parti dello scibile umano. Tuttavia la storia del secolo XVI ci addita buon numero di cap.itani che operavano con alta intelligenza, coll' istinto della strategia, c spesse volte coi metodi · di questa'. Le operazioni del Farnese per soccorrere Parigi e Rouen assediati da Enrico IV ed i movimenti da questo op· posti; la campagna del duca di Alba per impadronirsi dd Portogallo, e che finì colla battaglia t.li Alcantara, svela.no in que' capitani idee strategiche le quali sono bastevoli a lasciare. di essi -rinomanza distinta.
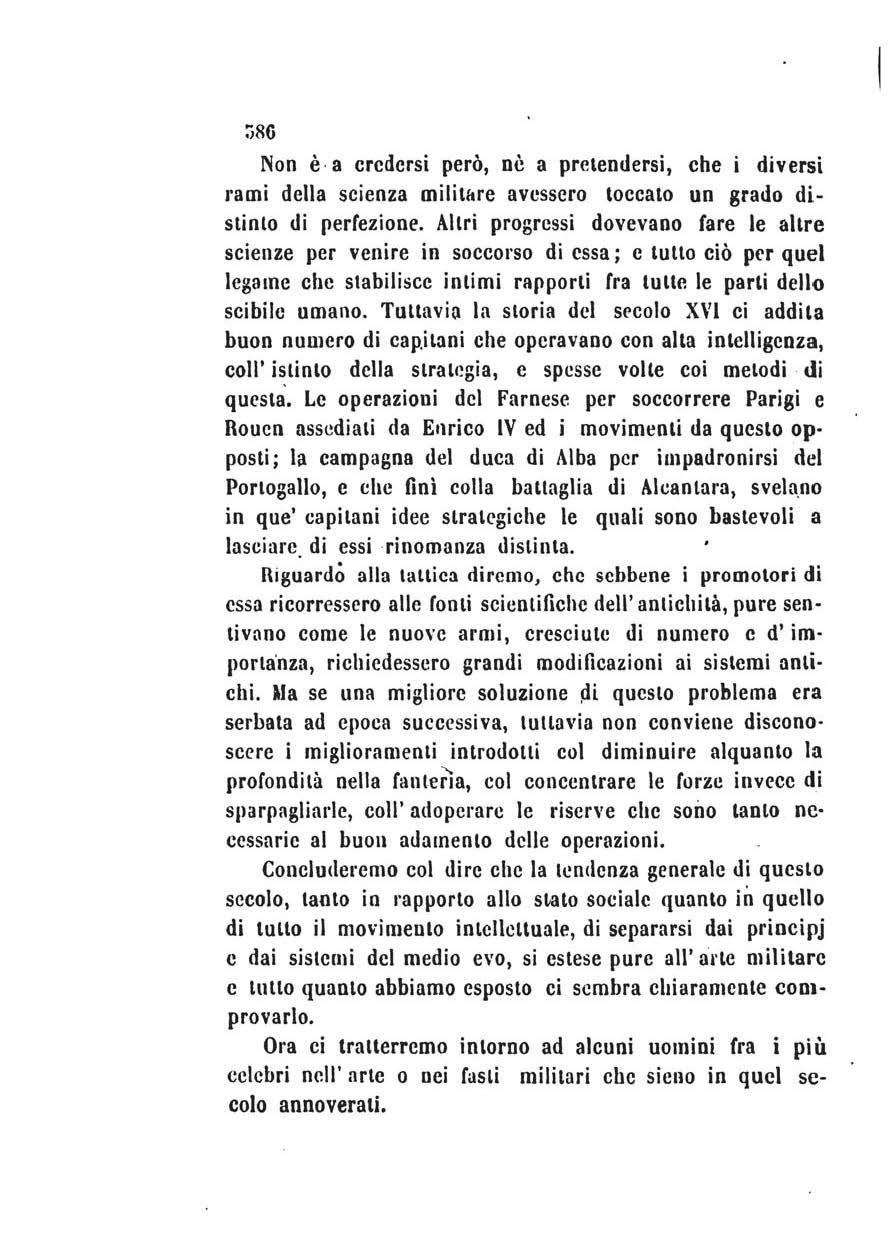
RiguardÒ alla tallica diremo, che sebbene i promotori di essa ricorressero alle fonti scientifiche dell'antichità, pure sentivano come le nuove armi, cresciute di numero c d' im· porta'nza, richiedessero grandi modificazioni ai sistemi anti· chi. Ala se una migliore soluzione questo problema era serbata ad epoca successiva, tullavia non conviene discono· scere i miglioramenti introdotti col diminuire alquanto la profondità nella fantefìa, col concentrare le forze invece di sparpaglial'le, coll'adoperare le riscrYe che SODO tanto DC· cessaric al buon adamento delle operazioni .
Concluderemo col dire che la tendenza generale di questo secolo, tanto in l'apporto allo sl6to sociale quanto in quello di tuuo il movimento inLcllcUuale, di separarsi dai priocipj C dai sistemi del medio evo, si estese pure all' Ul'te militare c tutto quanto abbiamo esposto ci sembra chiaramente comprovarlo.
Ora ci tratterremo intorno ad alcuni uomini fra i più celebri nell'arte o nei fasti militari che sicno in quel secolo annoverati.
MAcuaAVELLl . - Il posto speciale che occupa questo celeberrimo scrittore di cose ci consiglia a diste-samente di lui; c lo facciamo in questo capitolo che tratta del secolo XVI , · pere hè appunto in questo secolo egli scrisse sull' arte della guerra.
Nacq uc a Firenze il 3 di maggio del t469, da una· delle più cospicue famiglie di quella repubblica, la cui origine risaliva agli antichi march esi di Toscana. Ricc,vctlc educazione liberale, istruzione dotta c vasta . Della sua vita politica e letteraria c,i limi lcrcmo a dire che fu dalla repubblica fiorentina investito di eminenti cariche dello s tato, sia all' interno come all'estero, e che scrisse opere drammatiche, politiche, e storiche, le quali elevarono altissimo il nome di lui.
Ci fermeremo bensì sui lavori mi,1itari che lo posero fra gli scrittori più celebri in siiTatte materie, sebbene egli mi· litarc non foss(:.
Quando i principi e le repubbliche d' Italia . adottarono il tristo uso di noleggiar truppe, queste non rimanevano al servizio permanente dell' uno stato o dell' àhro, ma venivano considerate siccome una proprietà comune a tutti; le relazioni fra lo stato c i suoi difensori si riducevano ad un semplice traffico; l'avventuriere portava al mercato il ca· vallo, le armi, la forza propria e la propria esperienza; per lui era cosa indifferente che il conlrauo fosse concluso col re di Napoli o ·col duca di Milano, col papa o colla signoria di Firenze; egli si atteneva al salario, più elevdto ed al termine più lungo della condotta ; e, finita la campagna per cui s' era ingaggiato, non esisteva nè legge, nè riguardo , nè puntiglio, che gl ' impedisse di volgere sub i to Je armi contro gli antichi signori.
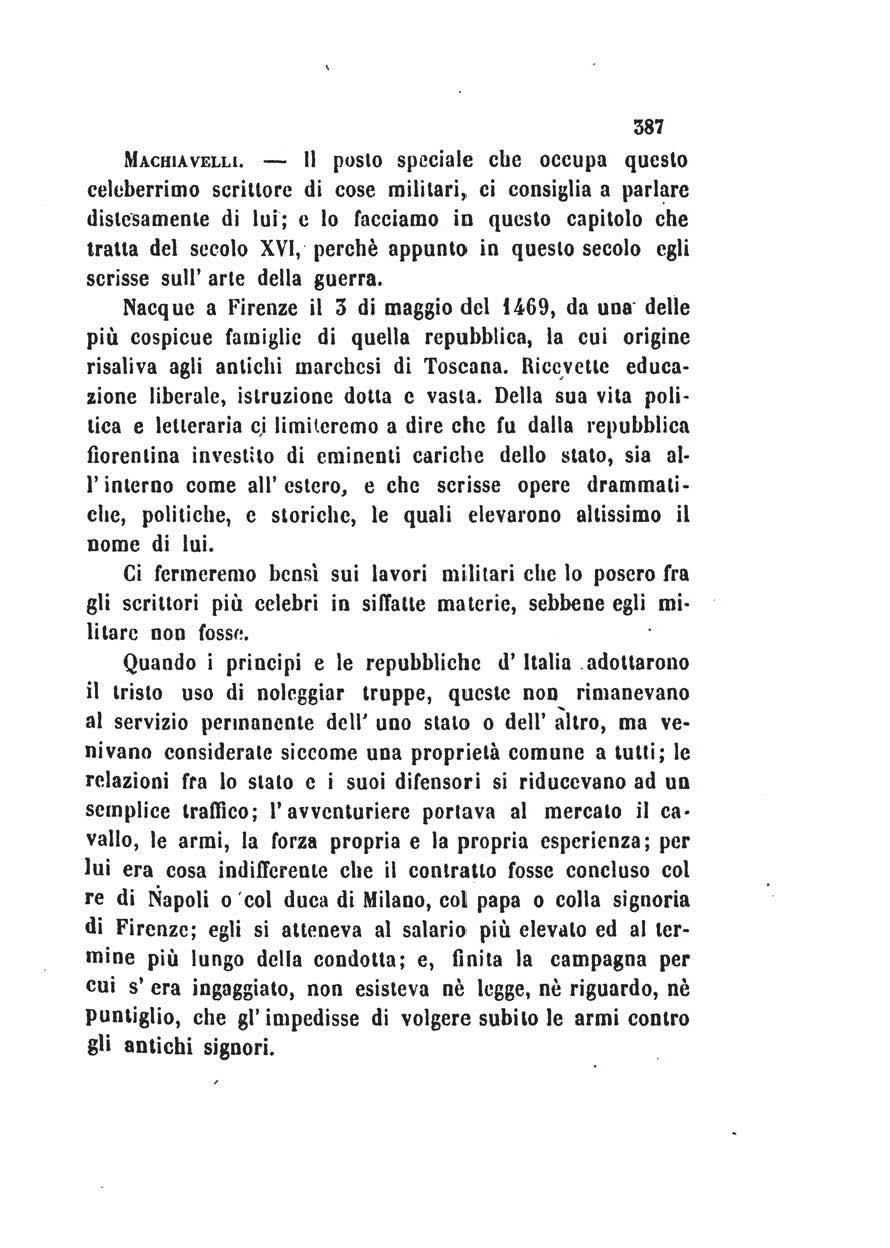
388
Niuno, meglio di quanto lo fece Alessandro Manzooi nella tragedia intitofata Il conte · di Carmagnola , dipinge al vivo il carattere di codesti mercenarj .
• Ahi ! Qual d' essi il sacril ego brando
. Trasse il primo i fratelli a ferire! Oh terror! Del conflitto esecrando La èagione esecranda qual' è !
• Non la sanno: a dar morte a morire, · Qui senz' ira ognun d' essi è venuto; É venduto ad un duce venduto, Con lui pugna e oon il percbè. •
Non è però a credersi che grandi stragi insaguinassero campi. .
Il soldato era totalmente disgiunto dal cittadino e dal suddito; ne ssun vincolo li univa; non patria, non atTetti, non aspirazioni comuni; c da questa separazione venne la conseguenza naturale. La!'ciata in mano d' uomini i quali non amavano coloro che difendevano, nè ottiavano quelli a cui opponevansi, uomini spesse volte vincolati da più forli legami all' esercito contro cui com battevano che allo stato il quale servivano, uomini che perdevano al terminare del conflitto, c guadagnavano al prolungat·si di esso, la guerra muta\'a d' indole totalmente. Ciascuno andava nel campo di battaglia penetrato dall' idea che pochi giorni appre sso polca prendere la paga dalla potenza contro cui era allora adoperato, e combauere a fianco de' nemici contro. coloro che in quel momento erano i camerati. Gl' interessi più forti i sentimenti più vivi, concordavano a mitigare le os.tilità di coloro ch'erano stati poco prima compagni d' armi, e che po teano presto diventarlo lji nuovo; perciò le operazioni di 'guerra riuscivano languide ed indecise; marcie e contrommarcie, spedizioni predatorie e blocchi, capitolazioni e zuffe
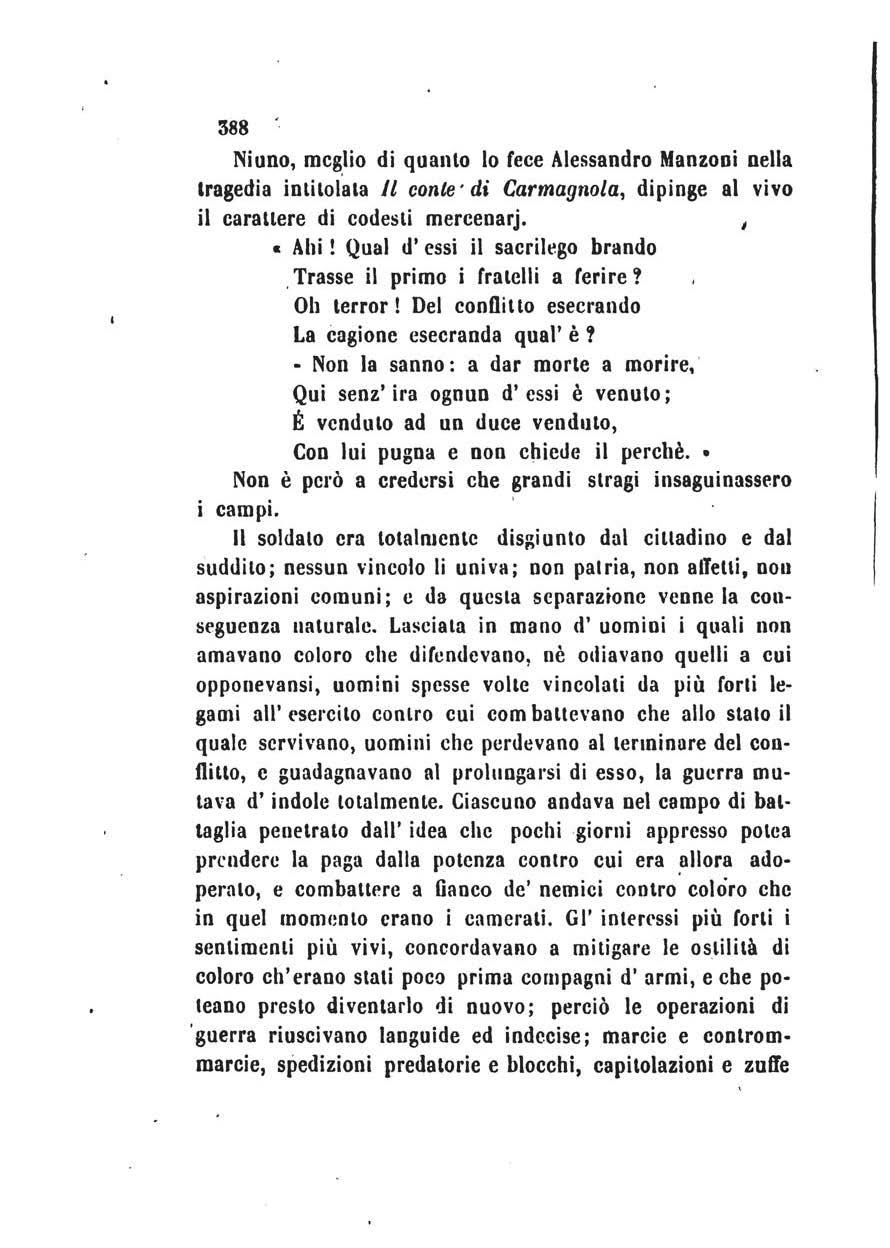
389 incruenti, riempirono la storia militare d'Italia pel corso di quasi -due secoli. Eserciti poderosi combattevano dall'alba al tramonto; una grande vittoria era riportata ; di prigionieri venivano presi; e, n malw pena , una vita ne andava perduta . Alla battaglia di Castracaro si com.bauè per una mezza giornata; si di.sputò la vittoril\ da una parte e dall' altr,a; e finalmente t('rminò l'azione senza che un solo uomo estinto. La battaglia di Anghiari, essa pure famosa, riuscì più micidiale: vi morì un cadendo da ca\·allo. Pare quindi che un a baUnglia campale fosse realmente mer.o pericolosa di un ordinnrio tumulto civile (t).
Le consejlut>nze furono fatali. La parte più ricca e più illuminata del mondo fu lasciata indifesa agli assalti d ' ogni barbaro invasore; alla brutalità. della Svizzera, ai capricci della Francia , alla feroce rapacità dell' Aragona .
In questa rea condizione di cose, Machiavclli rimpiangeva le del suo .paese, e chiaramente ne la causa ed il rimedio. Il sistema militare del popolo italiano si era quello che ne aveva <·stinto il valore e la disciplina, e lasciate le ricchezze facile preda ad ogni spogliatore strani ero. Machiavelli faceva un disegno, ugualmente onorevole al suo cuore ed al suo intelletto, per abolire l'uso delle truppe mercenarie, e per ordinare una milizia na· zionale.
Gli sforzi che fece per porre in ésecuzione questa grande idea, lo rendono meritevole della patria Beochè lo sua situazione e le sue abituclini fossero pacifiche, egli studiò con assiduità intensa la teoria della guerra, e SP. n e res e padrone in tuue le minute particolarità. Il governo
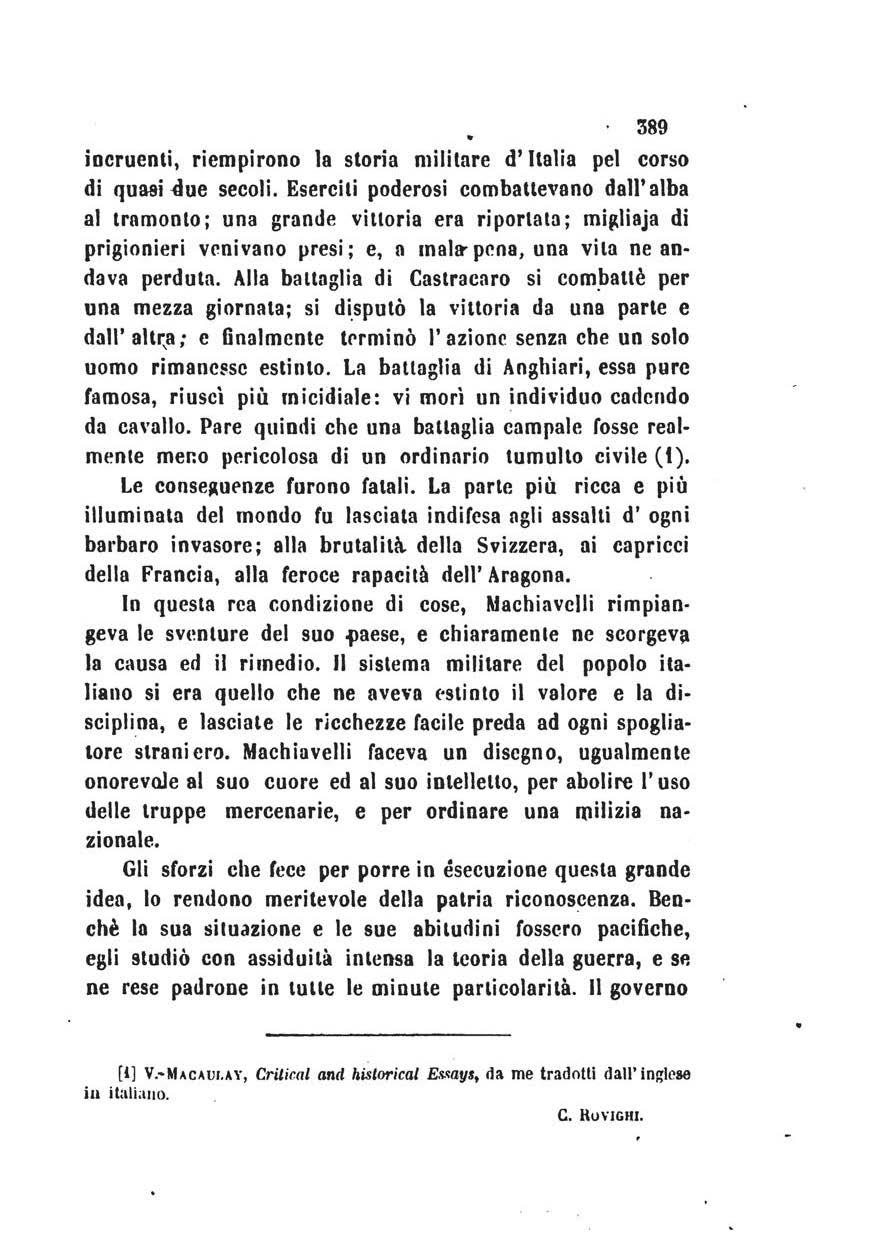
AUI.AY, Cr itica i antl hi$ torical da me trad otti dall'in glese iu ìtalia
C. Ro VJ GIIIfiorentino fu concorde ai suoi concetti; si nominò un consiglio di guerra, si decretarono leve, e l' infclticabile ministro correva da luogo n luogo per sopraioteudcre all' esecuzione del suo disegno; l tempi erano in certa guisa favorevoli nl\' espcrimf!nto. Il si stema di tatticll milit:lre aveva subito unn grande rivoluzione; la non era più considerata come la· forz(l di un esercito; e le ore che un cittadino poteva risparmiare dalle sue occupazioni ordinarie, se non erano pèr verun conto sufficienti a famigliarizzarlo cogli escrcizj d'un uomo d' armi poteano renderlo un utile fantaccino. Il timore di giogo straniero, di saccheggio, di stragf', e di conflagrazione, avrebbe potuto vincere la ripugnanza alla carriera militare; ripugnanza ordinariamente ge· nerata dall'industria e dall'ozio delle grandi cillà. E per un corso di tempo il disegno augurava bene; le nuove truppe si comportarono onorevolmente in campo; c Machiavèlli guarda\':\ con estasi paterna la riuscita del suo piano, c incominciava a sperare che le armi d' Italia potessero ancora una volta divenir formidabili a quelle del Tago e del Reno. Ma la marca dell'infortunio crebbe prima che fossero preparate le b;urierc eh•! vi dovevano re sistere. l mali d'Italia furono immensi. Firenze riebbe i Medici, tornati tini lungo esiglio al seguito d'invasori stranieri; le sue istituzioni militari c politiche furono distrutte; i principj di Machiavelli vennero abbandonati ; clt i suoi pubblici ricompensati colla povertà, collà prigione, e colla tortura.
Lo statista caduto rimase fermo nel suo disegno con indomato .ardore; e scrisse sette libri sull'arte della guerra, coll' intcndimt'nto di difenderlo da alcune obbiczioni popolari, c confutare alcuni errori prcdomin:mti intorno alla scienza militare. Quest'opera eccellente è in forma di dialogo. Le opinioni dello scrittore sono messe in bncca di
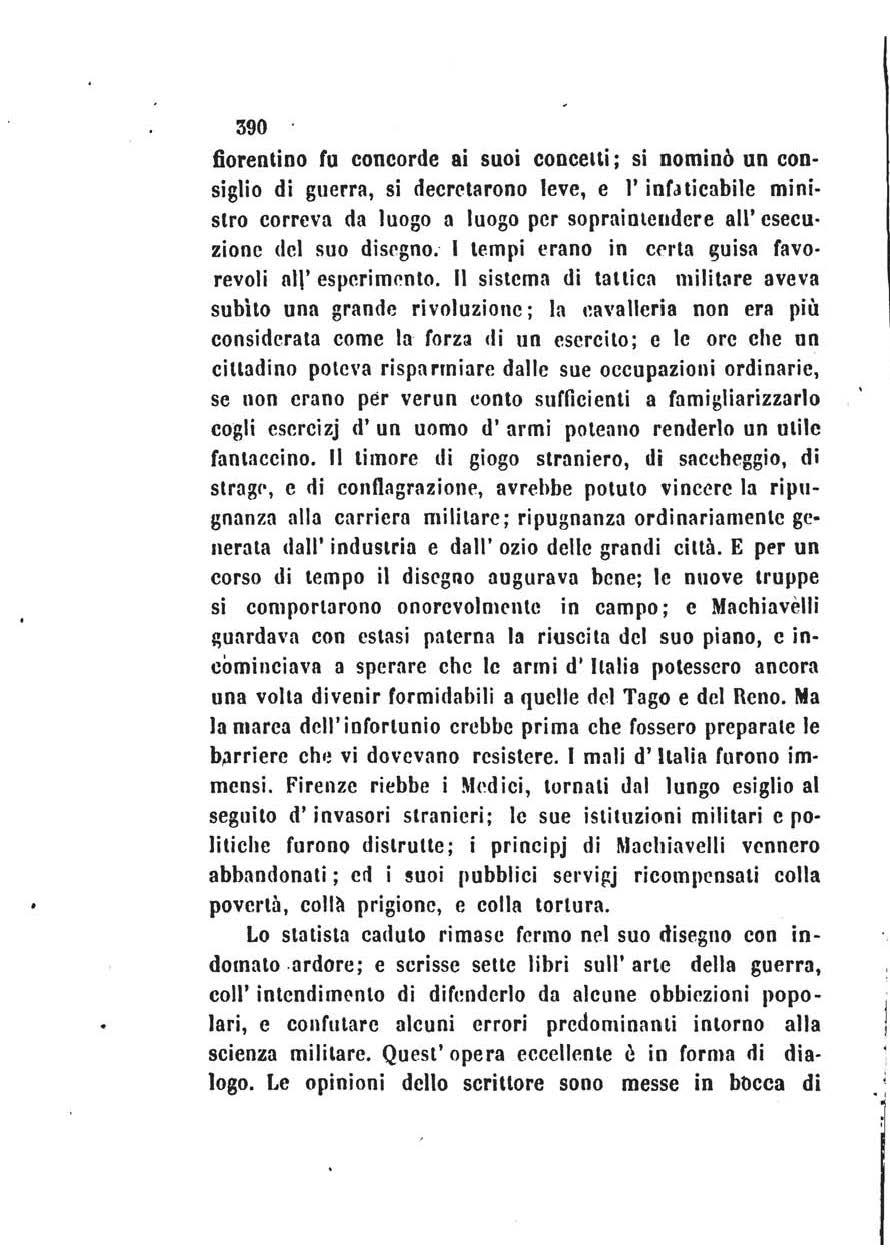
59 t
Fabrizio Colonna, nobile potente degli stati ecclesiastici, ed ufficiale di merito distinto al servizio del re di Spago3. Colonna visita Firenze venendo di Lombardia c andando ne' suoi dominj; ed è in vitato a trovarsi insieme nd nlcuni amici in casa di Cosimo R uccellai giovane g(!ntile e compilo la cui morte precoce è deplorala vivamente da Macbiavelli.
DOJlO un elegante banchetto , si ritirano nri reccessi più ombrosi d1!l giar1lino. Fabrizio è coiJlito dalla vista di alcune piante non comuni; c Cosimo dice che, sebbene rare nei tempi mollrrni, sono sovcnti menz.ionate dagli autori classici antichi; e che l'avo di lui, come molti altri italiani, si di praticare gli antichi metodi di coltivar giardini. Fabri1.io espresse il sno dispiacere che coloro i quali nei tempi recenti affettavano i costumi dt•gli antichi romani scegliessero per oggetto d' imitazione le occupazioni più futili. Ciò -eonduce ad una conversazione intorno · allo scadi· mento della disciplina militare ed ai mezzi migliori per ri· stabilirla; alla necessità di ricorrere perciò alle fonti antiche, come Machiavelli efTettivnmentc av('a fallo; vien difesa abilrucntc l ' istituzione della milizia fiÒrenlina, e si suggeriscono parecchi miglioramenti nei particolari.
In questo lavoro, ded icato a Lorenzo Strozzi, si esordisce osservando i rapporti che esistono tra la vita ci,·ilc e .la militare: si conruta l'opinione di chi no!' ammetlc che alcuna convenienza sia vi rra questa e qu<'lln; si .dimostra 1 che coloro i .quali vogliono incutere paura colla barba e colle bestemmie si St'parano dai cittadini c non sono veri soldati; mentre i migliori soldati della Grecia e di Roma furono altresì i migliori citLadini: si conclude esse rvi dunque stretto vincolo fra la vita civile e la militare impcrocchè l' una coll' altra vicendevolmente si sostengono.
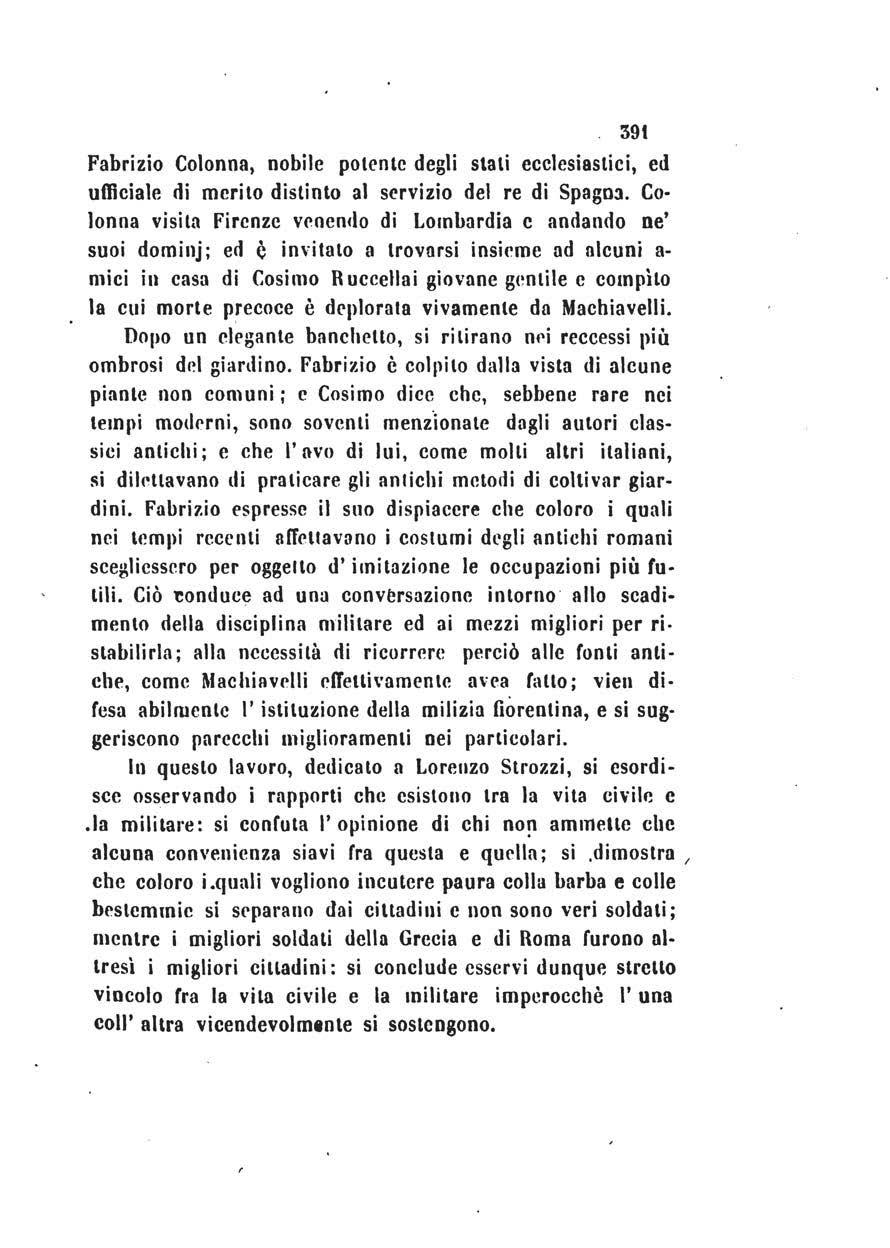
392
Ciò per l'esordio. In .quanto alla sostanza dei sette discorsi, daremo un breve sunto delle dottrine principali. Machiavelli sente la nr.ccssilà di impjlrare dai greci e dai romani l'importanza DHISS(!, A tempi gli svizzeri e gli spagnuoli crono considerati come i migliori soldati d' Europa. l battaglioni svizzeri compon<'vansi di piechieri, ed avc\'ano stretta so m igliaoza alla falange greca. Gli spagnuoli, a mo' dei soldati di Roma,· erano armati di spada e di scudo. te viuorie di Flaminio e di Emilio sui re ma· cedoni Filippo e Perseo, a Cinocefa!c e a Pidna, semb ravano provare In superiorità delle armi usate dalle legioni; e lo stesso esperimento crasi fatto allora, c col medesimo risultato, alla bauaglia di Ravenna . In quel cooOino memora· bile, l' iAfanteria d' Aragona, gli antichi compagni di Con· salvo, abbandonata da suoi all<'ati, si aprì una vja io mezzo al più fiuo delle picche imperiali, ed eseguì una ritirata regoh1rc al cospetto dci ·giandarmi di De Foix e della famosa artiglieria ·di Alfonso d' Este. Fabrizio, o per meglio dire Machiavelli, propone di combinare i due sistemi,· di armare le prime lince di picche allo scopo di respingere la cavalleria, c le pos teriori di spada come arma meglio adatta ad ORni altro effetto. L' autore esprime in tuua l' opera la più alla ammirazione della scienza militare degli antichi romani, ed. il maggiore per le massime che erano state in voga fra i generali italiani della generazione precedentP..
Egli preferisce la fanteria alla cavalleria, e la proclama nerbo degli eserciti e della nazione. Suggerisce l' uniformità del passo, l' uso dei tamburi, le bandiere, i pennacchi, i colori, e altri distintivi opportuni a conservare l' ordine; la necessità di esercitare le truppe; .e pone una gerarchia di grarli propon:ionata alla facoltà dell' uomo c cfcllc masse, e all' ordine profondo da lui proposto.
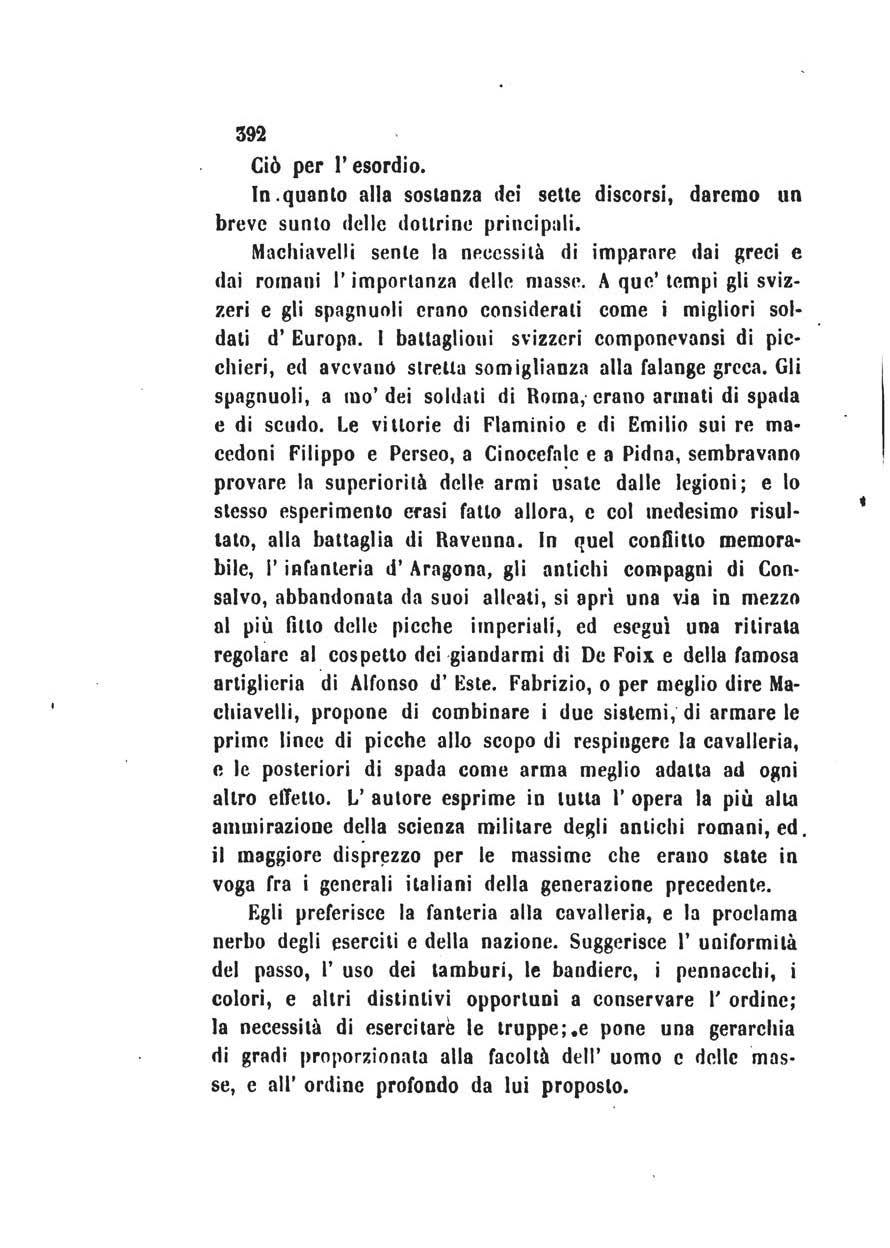
393
Le armi da fuoco avrebbero dovuto fare immediata· mente eslendf.re la fronte; ma vi si opponeva la consuetudine, c rr.stò ancora in uso l' ordine profondo l'er la fanteria. Questo fu sostenuto anche dn Machiavclli: il quale, benchè alcuni de' cambiamenti che doveaoo derivare dalle armi da fuoco , fu rauenuto dall' ammirazione dei romani, dalle usanze di quei tempi, e dall' esempio. degli svizzeri; sebbene la battaglia di Marignano avesse mostrato che l' ordine profondo non resiste aH' artiglieria. · Machiavelli stabilisce che gli eserciti siano da 24 a 30,000 uomini come quelli dei. romani.
È di parere che il cittadino debba essere esercitato di. continuo, ma che rion divenga soldato se non che all' istante del pericolo.
So.Homclle alln leva tutti gl'individui dai t7 ai 40 anni; in modo che ad un bisogno tutti possano prendel'e le armi, ma le armi non sieno professione speciale di alcuno . Quando la. forza è organizzata, si seguita a coscrivere, col progredire tempo, i giovani di t 7 anni. · Vuole corpi distinti per formare le scorte, i piccoli distaccamenti, le guardie d' onore, senza che per tali scrvigj s'abbiano a indebolire i ·battaglioni.
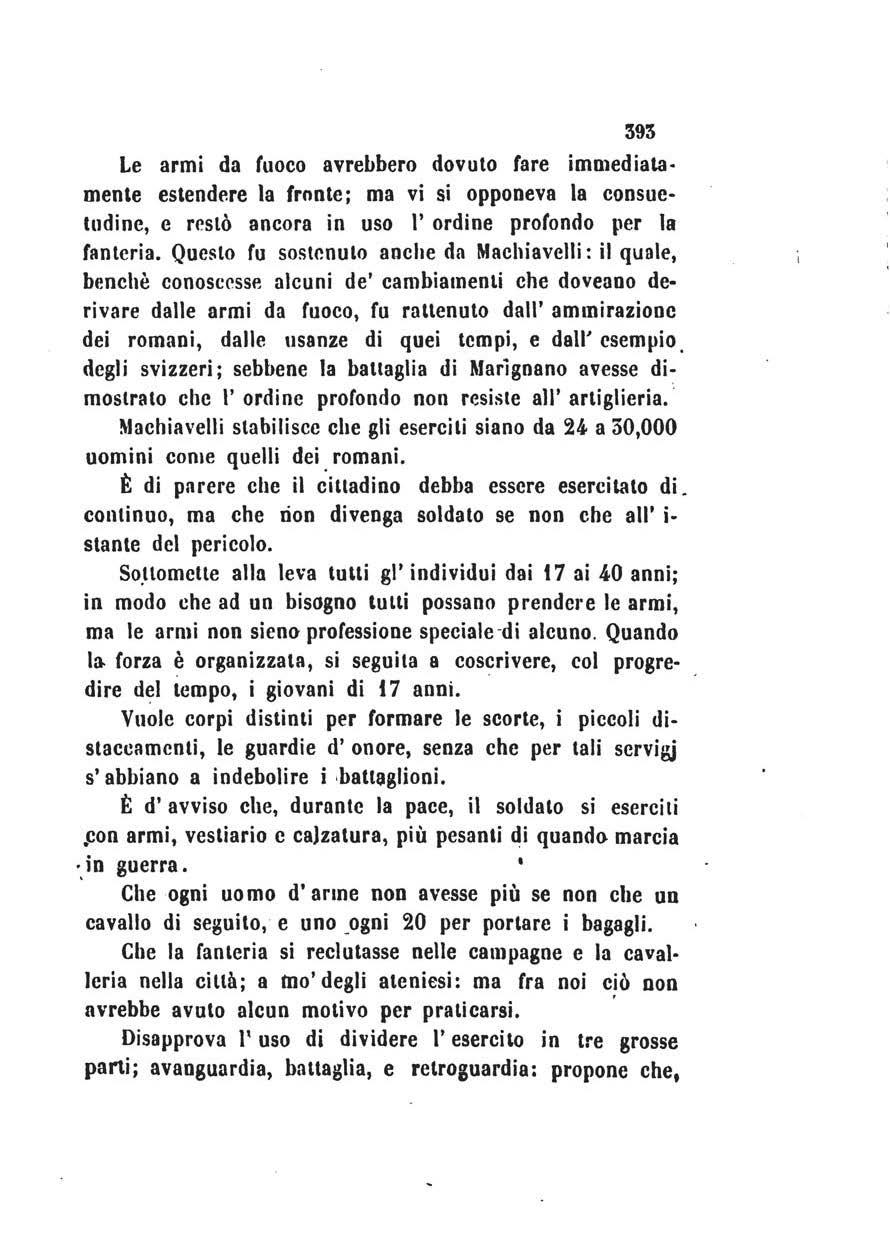
È d' avviso che, durante la pace, il soldato si eserciti .con armi, vestiario c calzatura, più pesanti di quandG marcia · . in guerra.
Che ogni uomo d'arme non avesse più se non che un cavallo di seguito , e uno ogni 20 per portare i bagagli.
Che la fanteria si reclutasse nelle campagne e la cavai· leria nella città; a mo' degli ateniesi: ma fra noi ciò non avrebbe avuto alcun motivo per praticarsi. ·
Disapprova l'uso di dividere l'esercito in tre grosse parti; avanguardia, battaglia, e retroguardia: propone che,
394 al modo dc' romani, qualche grullPO lli cavalleria preceda e segua; e preconosce col ragionamento il sistema delle colonne combinate che marciano parallelamentt-, corrispondendo fr a loro.
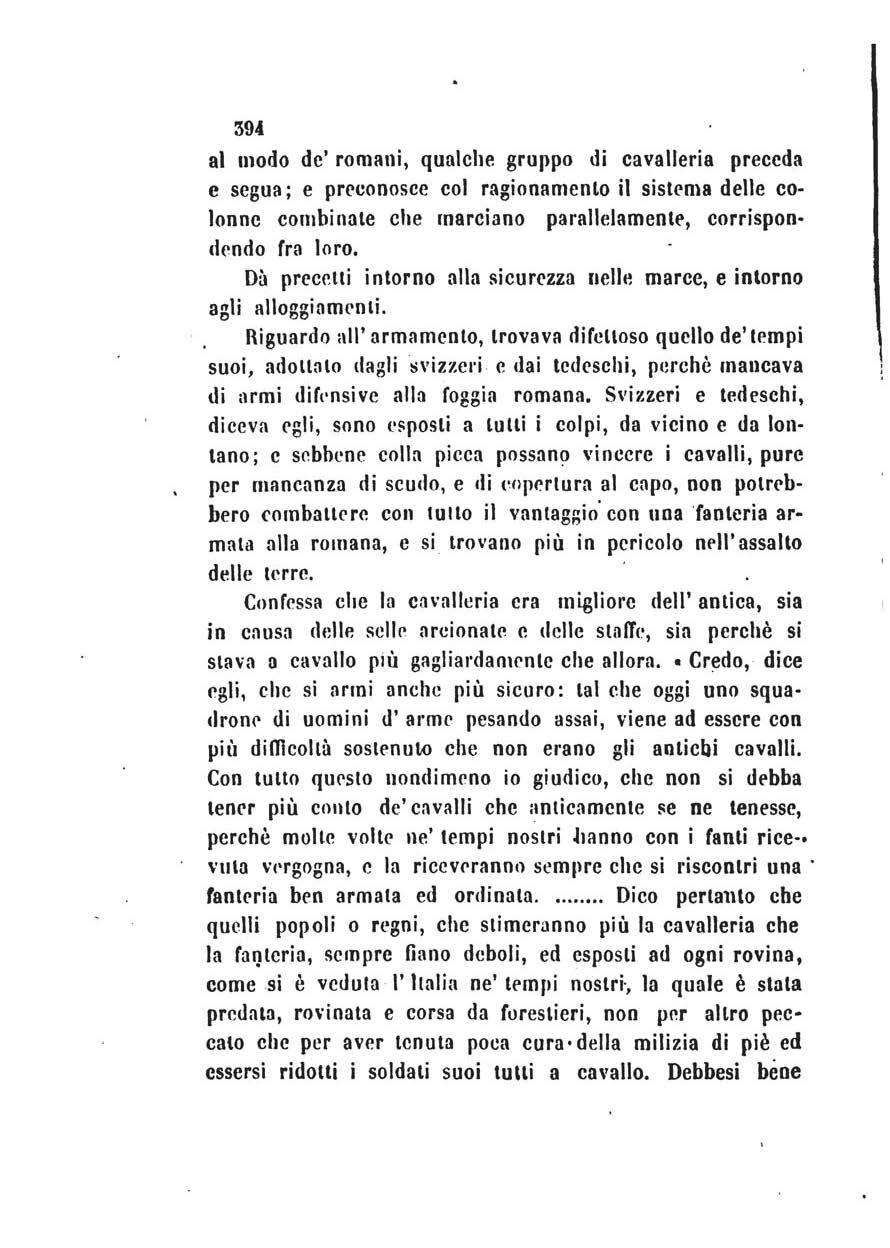
Dà precetti i ntorno alla sicurezza nelle marce, e intorno agli allogginmrnti.
Riguardo all'armamento, trovava difcHoso quello de' tempi suoi, adollnto dagli sv iz zel'i c dai ted<'schi, pcrchè mancava di Mmi difc•nsivc alla foggia romana . S\•izzeri e tedeschi, diceva egli, sono t'Sposti a tutti i colpi, da vicino e da lon· tano; c sebbene colla picca possano vincere i cavalli, pure per mancanza d i scudo, e eli enpr.rtura al capo, non potr<'b· bero comball<'rc con tullo il vantaggio· con una ·rantcria armattl alla romana, c si _ trovano più in pericolo orli' assalto delle terre.
Cnnfcssa che la cavalleria era migliore dell' antica, sia in causa delle se lle nrcionatc c delle stafT(\ sin perchè si s ta va o cavallo più gagliat·damentc che allora. • Credo, dice egli, che si armi anche più sicuro: tal che oggi uno squa· dron<' di uomini d'arme pesando assai, vien e ad essere con più difficoltà soste nu to che non erano gli anticbi cavalli. Con tutto qu<'slo nondimeno io giudico, che non si debba tenrr più cnnto de' cavalli che anticamente se ne tenesse, perchè molte volte ne' tempi nostri Jutnno con i fanti rice·· \'11\3 vc•rgogna, c la ricevrranno sempre che si riscontri una · tant<'ria ben armata ed ordinata. •....... Dico pertauto che quelli popoli o rt•gni, che s timeranno più la cavalleria che la faQlcria, sempre fiano deboli, ed esposti ad ogni rovina, come si è vcdura l' Italia ne' trmpi nostri·, la quale è stata prcdnta, rovinata e corsa da foreslieri, non altro peccato che per aver tenuta poca cura · della milizia di piè ed essersi ridotti i soldati suoi tutti a cavallo. Debbesi bene
395 . avere dc' cavalli, ma per sccondn e non per primo fondamento dell' esercito suo, perchè a fare scop<'rte, a corrf're c guastare il paese nemico, a tenere tribolato ed infestato l' es<'rcito di qu('llo r. in sulle armi sempre, e ad l<' sono necessari ed utilissimi: ma quanto alle giornate cd alle zuiTc campali, che sono l'' importanza della guerrn e il fine che si ordinano gli eserciti, sono più utili n st•guire il nemico, rotto che egli è, che a fare alcuna :lltra cosa che in , quelli si operi, e sono alla ,·irtù del peditnto assai inferiori ... . Ma veniamo all'altra domanda vostra, dove :voi desiderate intendere quale ordine o quale virtù nntu· fa che i fanti superano la cavalleria. E vi dico in prima, come i cavalli non possono andare, come i fanti, in ogni luogo. Sono più tardi ad ubbidire, quando occorre variar l'ordine, che i fanti; perehè s'egli è bisogno o andando nvanti tornare indietro, o tornando indietro andare avantl, o muoversi stando fermi, o andando fermarsi, srnza dubbio non lo possono così appunto fare i cnvalli come i f11nti. Non possono i cnvall'i, scndo da qualche impeto disordinati, ri· tornare negli ordini se non con diftìcollà, ancora che quf'llo impeto manchi; il che rarissimo fanno i fonti. Occorre, ·Oltre a qu(•sto, molte volte, che un uomo animoso sarò soprn un c'avallo vih•, e un vile sopra un animoso, tlonde conviene che queste disparità d'animo facdano disordine . Nè alcuno si meravigli che un nodo di fanti sostenga ogni impeto di cavalli, perchè il cavallo è animale sensato, c conosce i ricoli c mal volontieri vi entra. E se considerert'le quali rorze lo facciano andar ava n ti, c quali lo lengon-J indie.tro, ve· drele senza dubbio essere maggiori quelle lo ritengono che quelle che .lo spingono, perchè innanzi lo fa andar lo sprone, dall'altra banda lo ritiene o la spada o la picca. Tale che si è visto per le antiche e per le moderne espe·
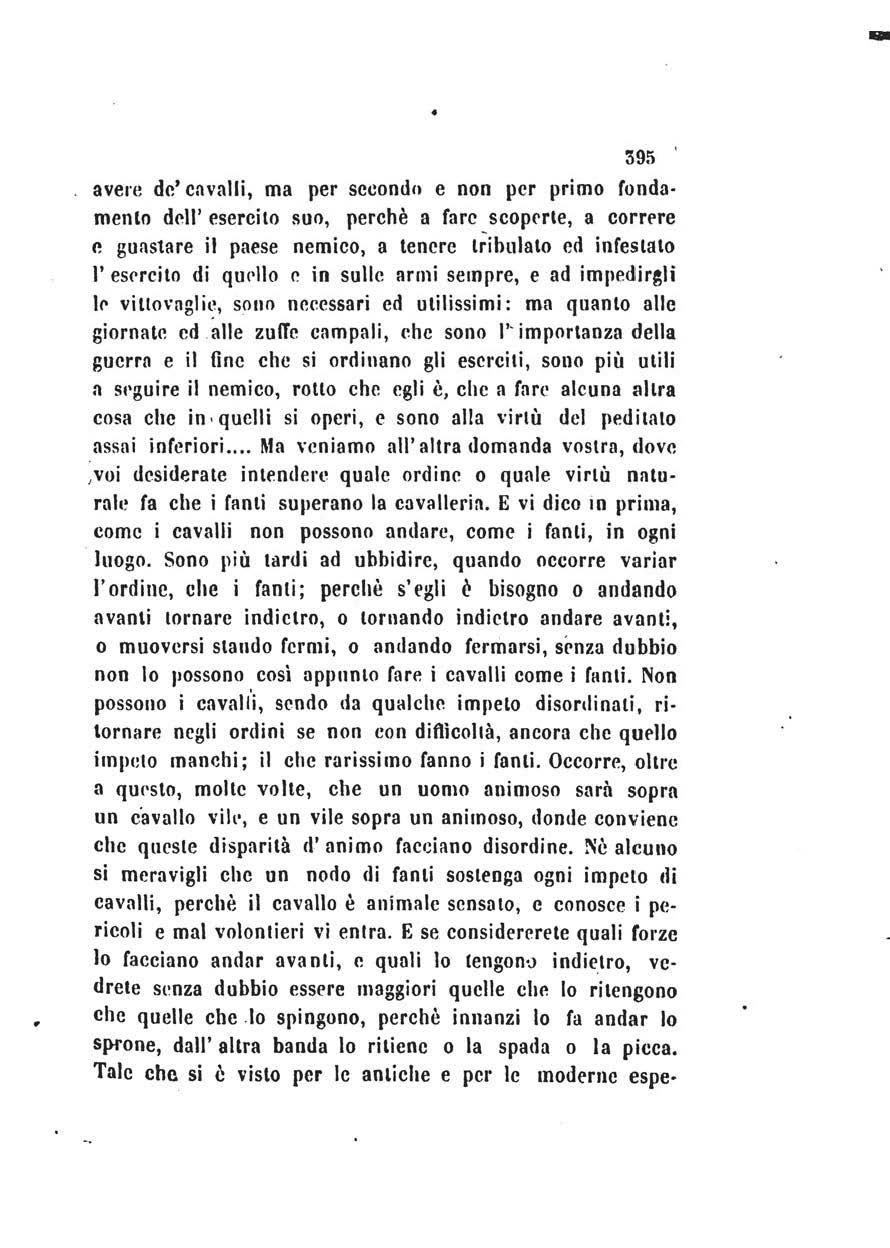
rienze, un nodo di fan ti esser sicurissimo, anzi insuperabile dai cavalli. E se voi arguiste da questo che la foga con la quale viene, lo fa più furioso ad urtare chi lt> volesse so· stencre, e meno stimare la picca che lo sprone, dico, che se il cavallo disposto comincio n vedere d' aver a percuotere nelle punte delle picche, o pfr sè stesso egli .raffrencrà il corso, di modo che, come egli sì sentirà a pugnere, si fer· merà allatto, o, giunto a quelle, si volgerà a destra o a sinistra . Di che se volete far esperi e nza, provate. a far correre un cavallo contro . ad un muro: radi ne troverete che, con vi vogliate foga, vi dicno dentro. Cesare, avendo in Francia a combattere con gli svizzeri, scese e fece scendere ciascuno n piè, c rimuovere dalla schiera i ' cavalli ; come cosa più alta a !uggi re che a combattere. Ma nono· ' stante questi naturali Impedimenti che hanno i cavalli, quel capitano che conduce i fanti debbP. elegger vie che abbiano per i cavalli più impedimenti si può, c rado occorrerà che l' nomo non possa assicurarsi per la qualità del paese. Perchè se si cammina per le colline, il sito ti libera da quelle foghe, di che. voi dubitate. Se si va per il piano, radi piani sono che per le colture o per li boschi non ti assicurino; perchè ogni macchia, ogni argine ancora debole toglie quella foga, ed ogni coltura, dove siano vigne ed altri arbori, im pedisce i cavalli. E se tu ne vieni a giornata, quello medesimo t' interviene che camminando, percbè ogni poco d'i m· pedimento che il cavallo abbia, perde la foga sua . Una cosa nondimeno non voglio scordare di dirvi, come i romani istimavano tanto i loro ordini, c confidavano nelle loro armi, che s'egli avessero avuto ad eleggere o un luogo si aspro per guardarsi dai cavalli , dove ei non avessero potuto spiegare gli orrlini loro, o uno dove avessero avuto a temer piti dc' cavalli, ma vi si fossero potuti distendere, sempre prendevano questo e lasciavano quello. •
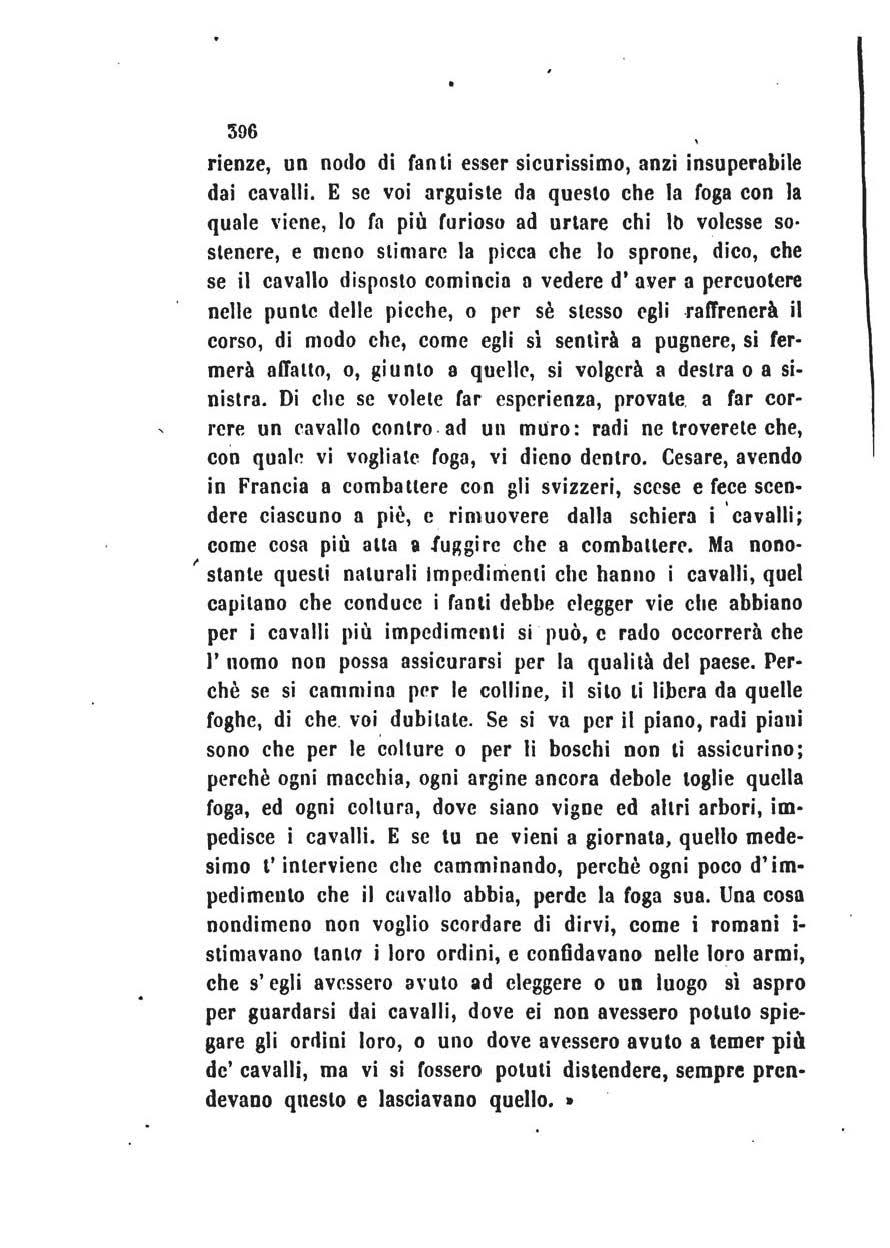
597
Parlando dell' artiglieria, dice: • Conviene adunque ai capitani, poi che non possono t1·ova.re un modo che li difenda, trovarne uno per il quale siano meno offesi: nè pos · sono trovare altro modo che preoccuparla subito . Il modo di prcoccuparla è andare a trovarla tosto e rado, non adagio cd in murcltio; perchè con la presenza non se le lascia raddoppiare il colpo, e per la radità può meno numero d' uomini offendere. • Erano questi i pl'incipj per la soluzione del problema intorno all' ordine da opporre all' artiglieria. Del resto non dà ancora all' artiglieria di èampagna quell' importanza che l' cspcl'ienza le ha poscia accordato.
La formo dell'esercito, proposta da Machiavclli, è la seguente.
Battaglioni di 6000 uomini divisi in tO battaglie, a guisa delle legioni che erano divise in t O co o•·ti. . Ògni battaglia dovca comporsi di 450 uomini; dc' quali 500 scudati e tOO picche ordinarie avrebbero formato la fanteria pesante; 50, armati di schioppctti, balt>stre, partigiane e rotelle, av1·ebbcro formalo la e dovuto chia· . marsi Veliti ordinarj.
Rimanevano inoltre t 500 uomini pe•· ogni Di eost?ro, t 000 sarebbero state picche straordinarie, c 500 veli ti straord inarj .
Proponeva pel comando c per la gerarchia: ·
In ogni battaglia un connestabile, 4 centurioni, e 40 capodieci: Nelle tOOO picche straordinarie, :5 conocstabili, IO centu·rioni e t 00 capodieci;
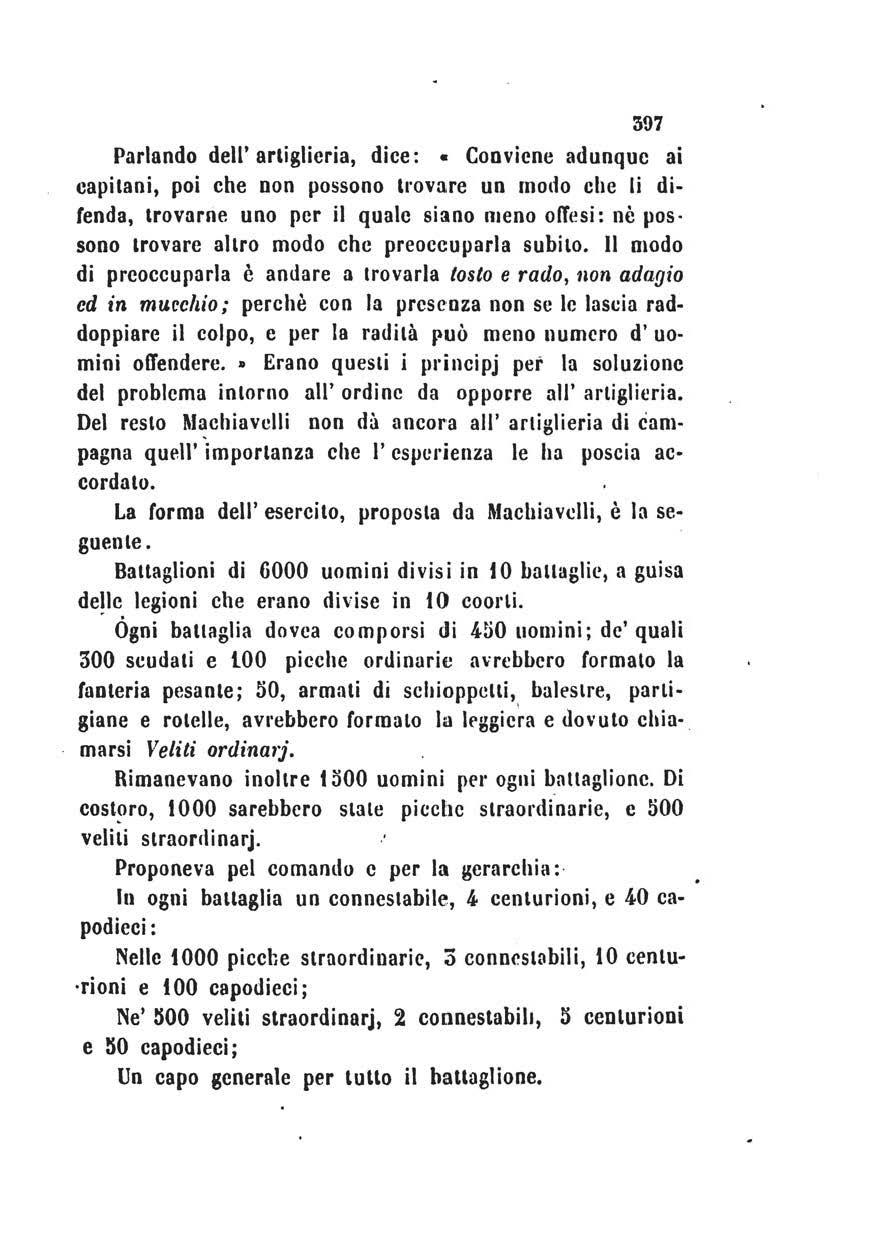
Ne' :SOO veliti straordinarj, 2 coonestabill, lS centurioni e :SO capodieei;
Un capo generale per tutto il battaglione.
398
Ogni prin cipe, ed ogni repubblica, avrebbe dovuto fare nel paese tanti battaglioni di quanti fosse capace, ed esercitarli bauaglia per battaglia.
Machiavelli ragiona pure intorno alle fortezze; pre\•cde gli <'ffeui della polvere nelle min e ; propone di fare le saracinesche a graticola, 'ad uso francese; di imitare pure i fran cesi nel metodo di aprire e chiudere i ponti lcvatoj; e dice che in una cillà forte non fa mestieri nè di ciuadclla, nè di ridotto , perchè la speranza riposta in qnr ste opere po· trcbhe snervare la guarnigione n ella dift>sa della piazza me· desirna. -

Finalmentc nella tattica, consiglia d ' aspcuarc il nemico piuttosto che assalirlo; e parla mollo del vantaggio di serbarsi una posizione d i ritirata.
Confida poscia che, cogli esempj degli antichi, si possano rinno\·are gli ordini della mi1izia, che dapertullo erano cattivi, in Italia pessimi.
Sebbene troppo scrvile nell' imitazione deg1i antichi, Machiavelli fu superiore agli altri dotti de' tempi suoi uel trattare l'importantissimo aa·gomento dell' arte della guerra. lo ogni modo è degno di allo encomio, avendo egli cercalo di rialzare la dignità della nazione colle nazionali allora avvilite: c tanto su qu este armi calcolava, da afl'ermarc.r.hc qualunque di· coloro i quali allora stati in Italia, • f:>sse entrato per primo nella via da lui proposta, sarebbe divenuto signore d'Italia innanzi di qualsiasi altro.
Nicolò Maehiavelli clliuse la sua vita nella natia città di Firenze il 22 di giugno del t 527; c nel sarcofago che in Santa Croce contiene le sue cent'!ri , leggonsi le alte e· meritate parole:
• Tanto nomini nullum pat· elogium. •
399
CARLO Qunno. Suo padre, Filippo d' Austria, era figlio dell' imperatore Massimiliano, e di Maria figlia di <:at·lo il temerario ed erede casa di Borgogna. Sua madt·e era Giovanna, unica Oglia di Ferdinando re d' Aragona t: d' Isabella di Castiglia. Carlo nacque a Gand nel 1500; e, morto suo padre. nel 1506, ereditò· l' Olanda e la Franca Contea. Fu educalo in Fiandra sotto la cura di Guglielmo di Croi, ed ebbe a precettore Adriano di Ulrecht che fu poi papa Addarao VI. Nel 1516, per la morte di Ferdinando d' Aragona, venne proclamato re insieme a sua madre. delta Giovanna la paua, perchè lo era; ed ereditò le corone di Aragona e di Castiglia, i vasti possedimenti d' America, i regni di Napoli e di Sicilia, e l' isola di Sardegna. · Andalo in lspagna con seguito di favorili fiamminghi, uon tardò guarì a trovarvi malcontento e resistenza; ' conseguenze dell'insolenza e della rapacità de' suoi seguaci; per la qual cosa si trovò costretto a giurare di mantenere i diritti e le libertà degli aragonesi prima che questi lo riconoscessero re.
Morto nel f5t9 l'imperatore l\lassimiliano avolo suo, fu elello imperatore d' Alcmagna, e a suo fratello Ferdinando venne affi· data l'amministrazione dei dominj di Casa d'Austria. Carlo andò io Germauia, e sul capo suo posò la corona imperiale ad Aquis· grana nel i520.
Intanto la Castiglia e molti allri paesi della Spagna; gl'insorti, sotto il nome di Comuneros, trionfavano; ma mostrandosi disposti a diminuire i privilegi della nobilità e del clero, perdellero l'appoggio di que' due ordini potenti. l comunero.,· vennero sconfitti; e Carlo, tornato io Jspagoa , vi riprese le redini del governo. Fu indulgente; accordò amnistia, eccet· luando i capi che. non perseguitò alacremente.
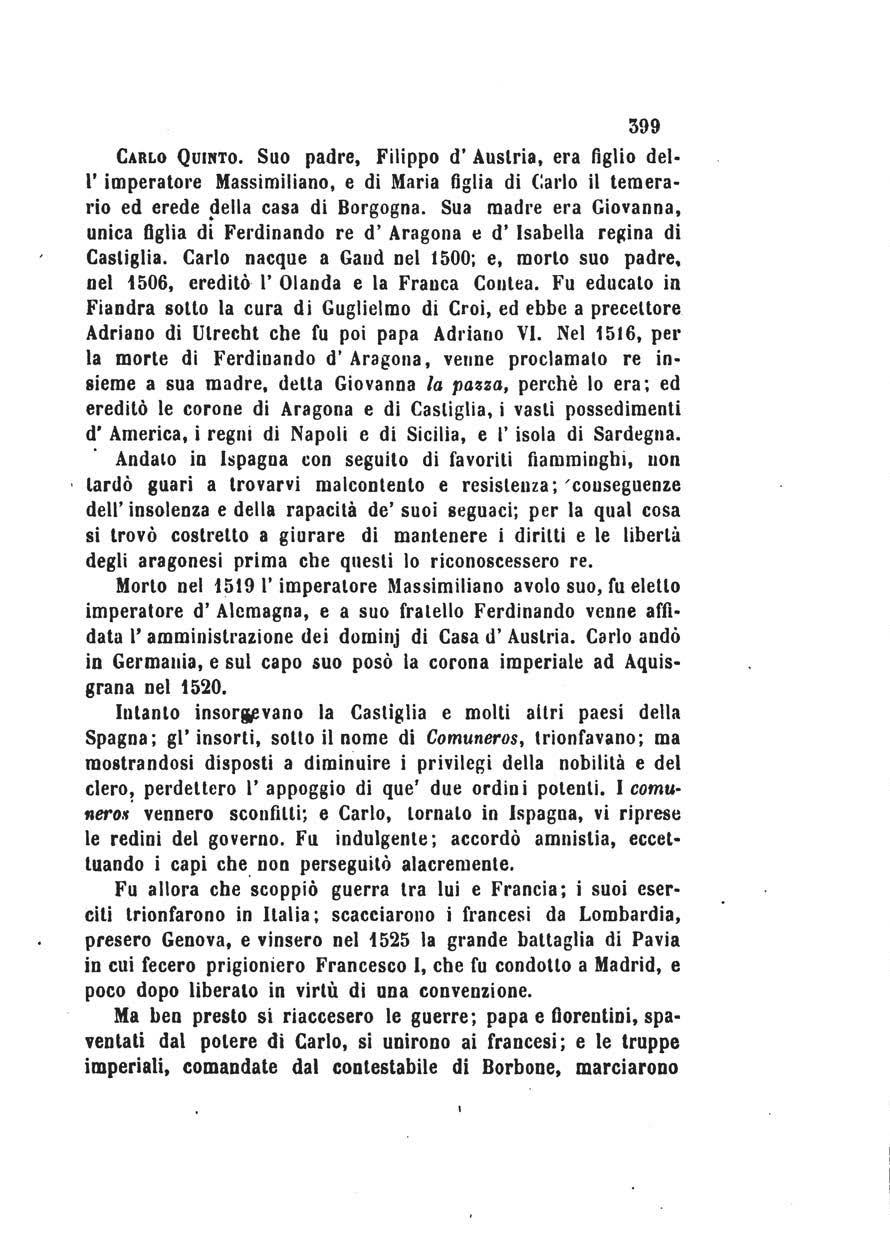
Fu allora che scoppiò guerra tra lui e Francia; i suoi eser citi trionfarono in Italia; scacciarono i francesi da Lombardia, presero Genova, e vinsero nel i525 la grande battaglia di Pavia in cui fecero prigioniero Francesco l, che fu condotto a Madrid, e poco dopo liberato in virtù di una convenzione.
Ma ben presto si riaccesero le guerre; papa e fiorentini, spaventati dal potere di Carlo, si unirono ai francesi; e le truppe imperiali, comandate dal contestabile di Borbone, marciarono
400 verso Roma, la presero, la posero J sacco, e vi tolsero prigioniero il rapa che s' acconciò a trattato di pace con dopo che altrettanto aveva fallo Francesco l rinunciando all11 sue pre t ese sull'Italia e sulle Fiandre. Allora le armi imperiali c poni iOcie si volsero contro Firenze, la quale, dopo eroica difesa, fu obb li gata ad arrendersi, ed a ricevere per principe Alessandro de' Medici.
In pace coll' Europa, Cal'lo se ne andò contro Tunisi per abbattervi Ariatleno Barbarossa, gran terrore dc' cristiani nel Me· diterraneo; lo abbattè, e risla bili sul trono Muley Hassan, spo· destalo dal Barbarossa, imponendogli vassallal!gio, e presidio spa(lnuolo a l.ll Goletta. .
To•·nalo in Europa, trovò re Francesco l preparato di per la guerra. l francesi entrarono in Piemonte; ma Carlo, rac· colte forze nell' Italia settentrionale, ne li scacc.iò, malmenando il paese peggio di quanto essi ;tvevano fatto. Invase la Provenza, assediò Marsiglia ma non la prese; e dopo avere devastato il paese e perduta la metà dell' esercito, si t•ilirò col rimanente in Italia, concludendo nel 1538 coll' avversario una tregua di tO anni. ·
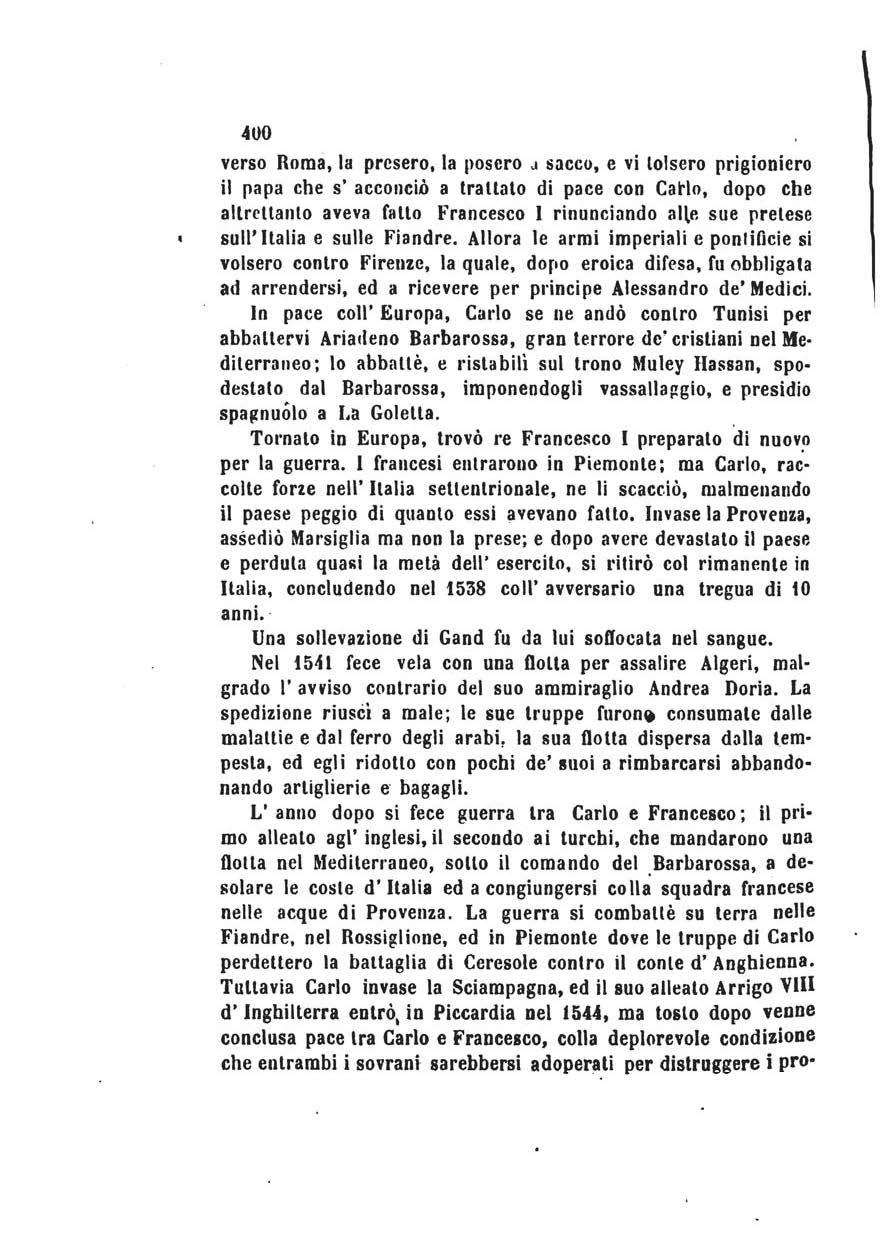
Una sollevazione di Gand fu da lui soOocata nel sangue.
Nel tMt fece vela con una Oolla per assalire Algeri, mal· grado l' avviso contrario del suo ammiraglio Andrea Doria. La spedizione riuscì a male; le sue truppe consumate dalle malattie e dal ferro degli arabi, la sua flotta dispersa dalla t.em· pesta, ed egli ridotto con pochi de' amo i a rimbarcarsi abbando· nando artiglierie e· bagagli.
L' anno dopo si fece guerra tra Carlo e Francesco; il pri· mo alleato agl' inglesi, il secondo ai turchi, che mandarono una Oolla nel Mediterraneo, sotto il comando del .Barbarossa, a de· Rolare le coste d'Italia ed a congiungersi co Ila squadra francese nelle acque di Provenza. La guerra si combattè su terra nelle Fiandre, nel Rossiglione, ed in Piemonte dove le trupp e di Carlo perdettero la battaglia di Ceresole contro il conte d' Aoghieona. Tullavia Carlo invase la Sciampagna, ed il suo allealo Arrigo VIli d' Inghilterra entrò, in Piccardia nel 1544, ma tosto dopo venne conclusa pace tra Carlo e Francesco, colla deplorevole condizione che entrambi i sovrani sarebbersi adoperati per distruggere i pro·
.tO t testanti nei loro dominj. Se ne fece strage in Francia; e, sorti in armi in Germania colla lega di Smalcalda, vennero battuti da Carlo.
Trovandosi ad Inspruck, l' imperatore corse pericolo di cader prigione nelle mani di Maurizio elettore di Sassooia; il quale, sebbene avesse avuto il sovrano dominio da Carlo a danno di suo suocero Federico colpevole di protestantismo, pure parteggiava occultamente pei dissidenti; e, levandosi poscia la masche· ra, si pose a capo di una confederazione di essi. Carlo fuggi precipitosamente; e con lui fuggirono spaventati i padri del con· cilio riuniti a Trento (1). •
Enrico II, succeduto a Francesco l, ripigliò le ostilità contro di lui ; per cui l' imperatpre fu costretto a sottoscrivere nel 1552 coi principi protestanti dell' Alemagna il trallato di Passa· via, mediante il quale si concedeva il libero esercizio del nuovo culto nei loro domioj. E mentre la lotta ferveva, anche co' tar· chi alleaii di Francia, udissi in un subito una grande determi· nazione di Cesare. Vinto dalle fatiche dell'animo e dalla debo· lezza del corpo, e desideroso di ritirarsi in solitudine per prepararsi alla fine che oggimai sentiva approssimarsi, rinunziava al figliuolo Filippo, il dì 25 ottobre del t 5t.5, la signoria dei fiamminghi, poi tre mesi dopo al medesimo flgliuqlo tutti gli altri suoi reami e stati patrimoniali, poi finalmente nell'agosto del 1556 la dignità imperiale al fratello Ferdinando. Mori nel t 558 da umile penitente di chiostro, essendosi ritira nel monastero di S. Giusto nell' Estremadura, in una valle romita alle falde della Sierra de Gredos.
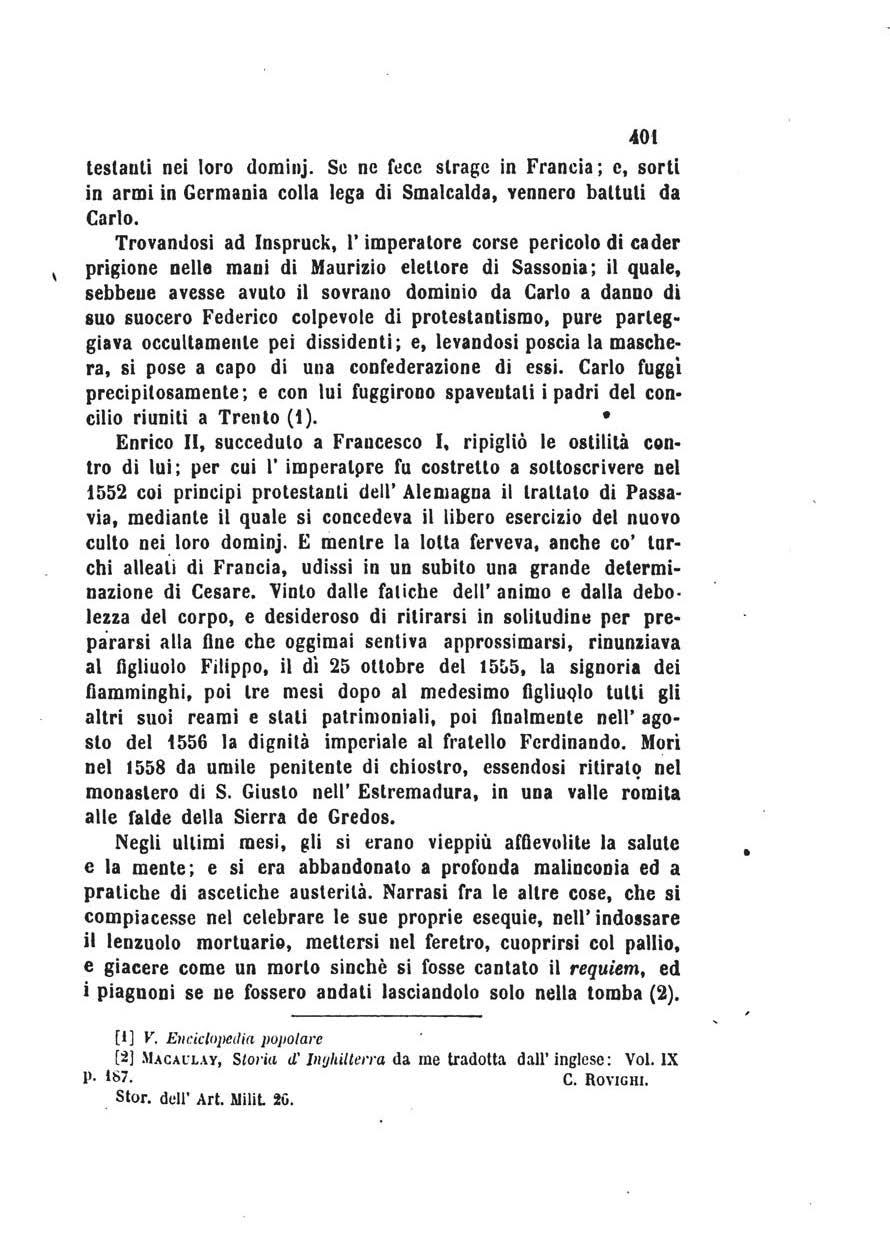
Negli ullimi mesi, gli si erano vieppiù affievolile la salute e la mente; e si era abbandonato a profonda malinconia ed a pratiche di ascetiche austerilà. Narrasi fra le altre cose, che si compiacesse nel celebrare le sue proprie esequie, nell'indossare il lenzuolo mortuario, mettersi nel feretro, cuoprirsi col pallio, e giacere come un morlo sinchè si fosse cantato il requiem, ed i piagnoni se ne fossero andati lasciandolo solo nella tomba (2).
JIOJIO/are
Invhilt erra da
Art. Milil
tradotta dall' ingl ese: Vol. IX
ROYIGlll.
-102
Di lui dice il Botta (i) che fu principe di non ordinaria grandezza d'animo, di molta ambizione, di mirabile acume d'in · geg no, di non poca pea·izia n ell' arte della guerra, ma di maggiore nei negoziati politici , sapendo in ciò mirabilmente vedere e prevedere, ed ancora cuoprire con esteriori appar enze, lontane dal vero, la profondità de' suoi pensieri. Perseverante nelle risoluzioni prese, abbracciava co' suoi pensic:ri smisurati la monarchia universale; e sarebbe anche stato pago del suo desiderio, se non avesse trovato nella Francia un insuperabile impedì· mento .
•
IL DUCA D' ALBA. Ferdinando Alvarez di Toledo, conosciuto sotto il nome di duca d' Alba, titolo di sua famiglia, nacque nel f 608 in Alv a, piccoli! terra della provincia di Salamanca, e venn e ammae s tralo da giovanissimo nell' arte militare e nelle scienze dell' uomo di stato . Ben pres to calcò i campi di guerra; dapprima in Italia contro Francia, poi in Africa contro il corsaro Ariadeno Barbarossa ridollo a Tunisi, indi all' assedio di Marsiglia non riuscito agli spa guuoli, poscia in Alg eri non presa da Carlo V, di poi contro i francesi sosltmendo egli la difesa di Perpignano, e obbligando il nemi co a desi s tere dagli sforzi d ' impadronirsi della ciltà.
S' acqnislò rinomanza; da Carlo V gli venne affidato l' irica rico di diri grre il giovine Filippo suo ftglio, nominato reggente di Spagna.
essen do scoppiata nel 1546 la guerra l l'a l ' impero e i principi protestanti di Germania, collegatisi a Smalcalda, Carlo lo chiamò a sè e vinse la battaglia di Muhlberg ove l' elrllore di Sassonia ed il lan gravio di Assia vennero fatti prigionieri, e condannati a morte da un cons iglio pr esieduto dal duca .
La sentenza nou fu eseguita per generosit à di Carlo, e a ma· · lincuore del duca cbe già spiegava la dissimulata sua indole orgogliosa , fanatica, crudele. .
Concluso in Germania il trattato di Passavia, l' imperalo!'& volse le armi contro Enrico Il di Fl'aucia, che s'era impadrouito di l\letz, di Toul, e di Verdun. Ebbe con sè il duca; si andò al-
[il DonA , Storia tl' Ital ia co111 ilw at a da fJ"cl/a d el G11 i cciardini.
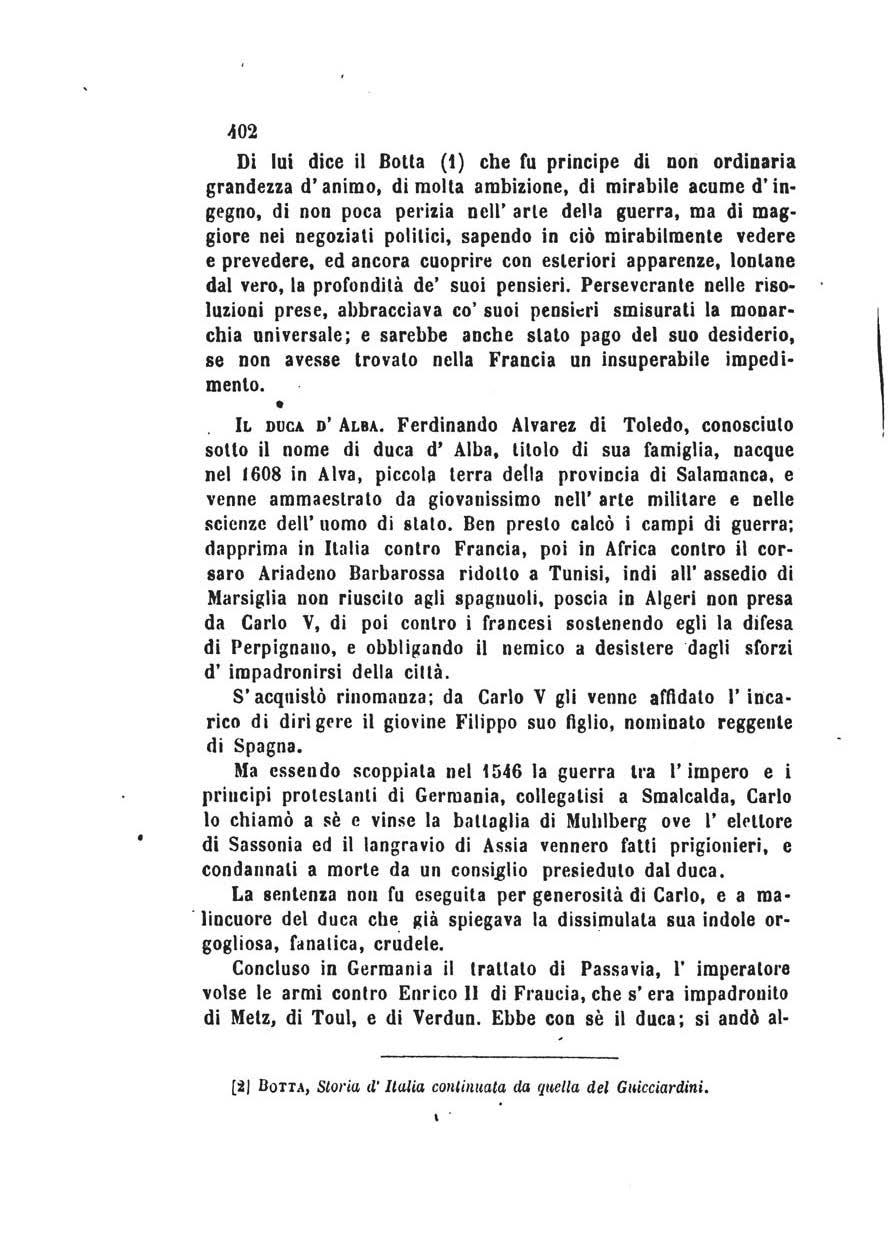
403 l'assedio di Metz; si dovè desistere dall'impresa pel valore del duca di Guisa. Carlo V abdicò.
Filippo, re, roosse guerra a Paolo VI, papa, che aven ioimi· cale Francia e Spagna per dare stato a un suo nipote Caraffa. Duce delle -armi spagnuole era il duca d' Alba, che invase il territorio pontificio, occupò Veroli, Terracina, Anagni , Ostia, e ac· cordò al papa una tregua di quaranta giorni la quale diè tempo al duca di Guisa di giungere con uo esercito francese a soccorso del pontefice. Ma il Guisa non istelle guari in llalia; chè, per la vittoria riportata da Emmanuele Filiberto a San Quiotirto, fu ri· chiamat o da re Ennco, e dovè partire. Allora, stretta da vicino Roma, il papa dovè cedere; e il duca d' Alba, dopo avergli re· stituilo il toltÒ, corse a Roma a chiedere perdono di avere por· lato le armi contro il santo Padre. Ipocrisia spregevoTe; degna dell' uomo e dei tempi. ·
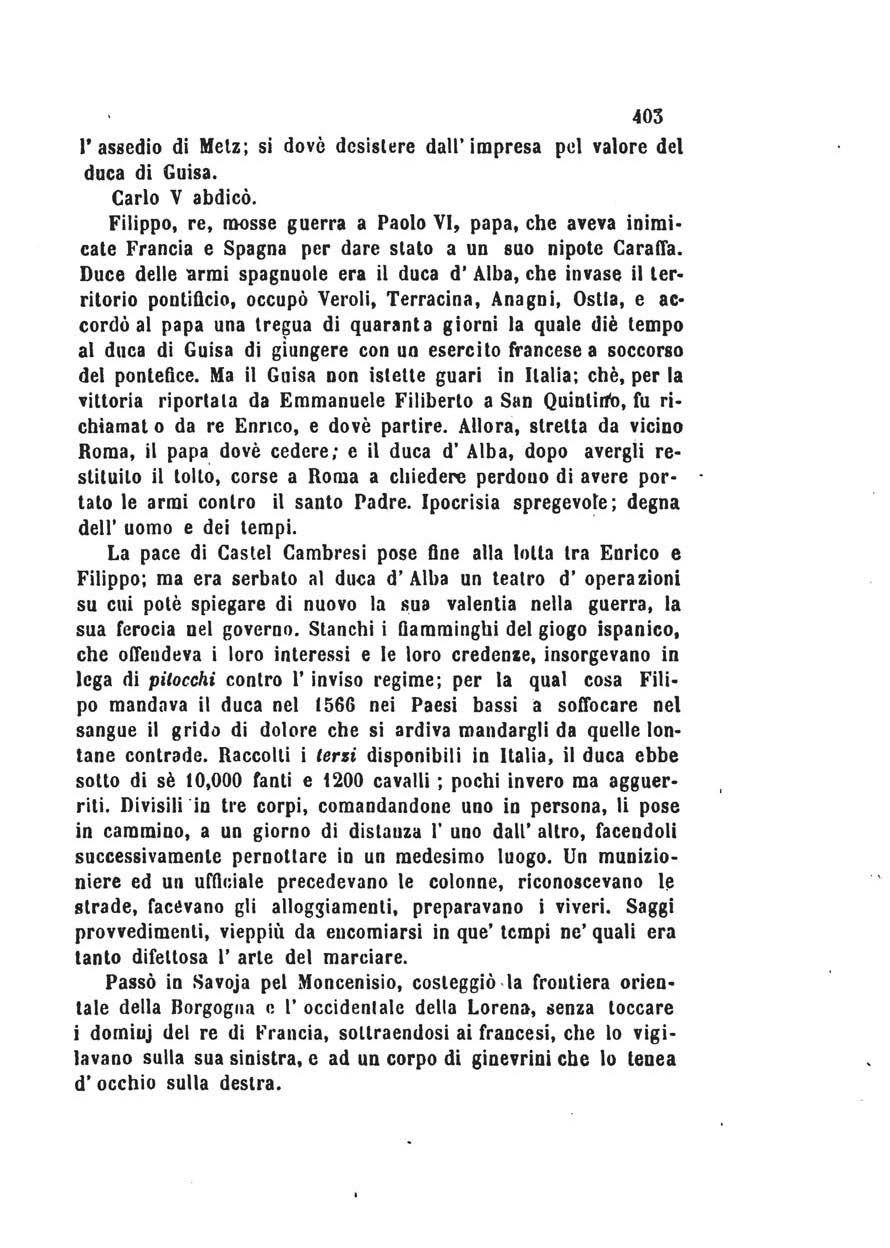
La pace di Castel Cambresi pose One alla lotta tra Enrico e Filippo; ma era serbato al duca d' Alba un teatro d' operazioni su cui potè spiegare di nuovo la valentia nella guerra, la sua ferocia nel governo. Stanchi i fiamminghi del giogo ispanico, che offendeva i loro interessi e le loro credenze, insorgevano in lega di pitocchi contro l' inviso regime; per la qual cosa Fili· po mandnva il duca nel 1566 nei Paesi bassi a soffocare nel sangue il grido di dolore che si ardiva mandargli da quelle lon· tane contrade. Raccolti i tersi disponibili io Italia, il duca ebbe sotto di sè tO,OOO ranti e 1200 cavalli; pochi invero ma agguerrili. Divisili ·io tt·e corpi, comandandone uno io persona, li pose in cammino, a un giorno di distanza l' uno dall' altro, facendoli successivamente perootlarc io un medesimo luogo. Un muoizioniere ed un uffit:iale precedevano le colonne, riconoscevano strade, facevano gli alloggiamenti, preparavano i viveri. Saggi provvedimenti, vieppitl da encomiarsi in que' tempi ne' quali era tanto difettosa l' arte del marciare.
Passò io Savoja pel Moncenisio, costeggiò -la rroutiera orientale della Borgogna c l' occidentale della Lorena, senza toccare i domiuj del re di Francia, sollraendosi ai francesi, che lo vigilavano sulla sua sinistra, e ad un corpo di ginevrini cbe lo tenea d' occhio sulla destra.
411 .-1 .
Giunto al destino, divise le truppe fra le città principali, istituì una corte di dodici, che la storia infamò col nome di tribunale di langue; il quale eseguì degnamente il còmpito suo facendo ardere, appendere, de ca pila re, squartare, a maggior gloria di Dio. l conti di Egmont e di Horn, attratti con inganno ad una conferenza, furono tra le vitti me; il di Orange si salvò colla fuga; il paese fu in prelia al saccheggio ed alla de· solazione, ·i mercanti fnggirono per la maggior parte io lngbil· terra, la popolazione spaventata si disperse; c i coraggiosi si raccolsero intorno a Guglielmo d' Orange che promise loro un vendicatore. Sconfitto il principe Luigi di Nassau a Gemingen, e temporeggiando col principe d' Orange, che, alla testa di 16000 fanti e 8000 cavalli aveva passato Reno a Mosa, il duca d'Alba riuscì, senza dare battaglia, a costringere quest' ultimo a ritirarsi in Germania, io forza del malcontento delle sue truppe mancanti di viveri e di danaro, c della difficullà di accenllcre la guerra civile per la cresciuta potenza degli spagnuoli.
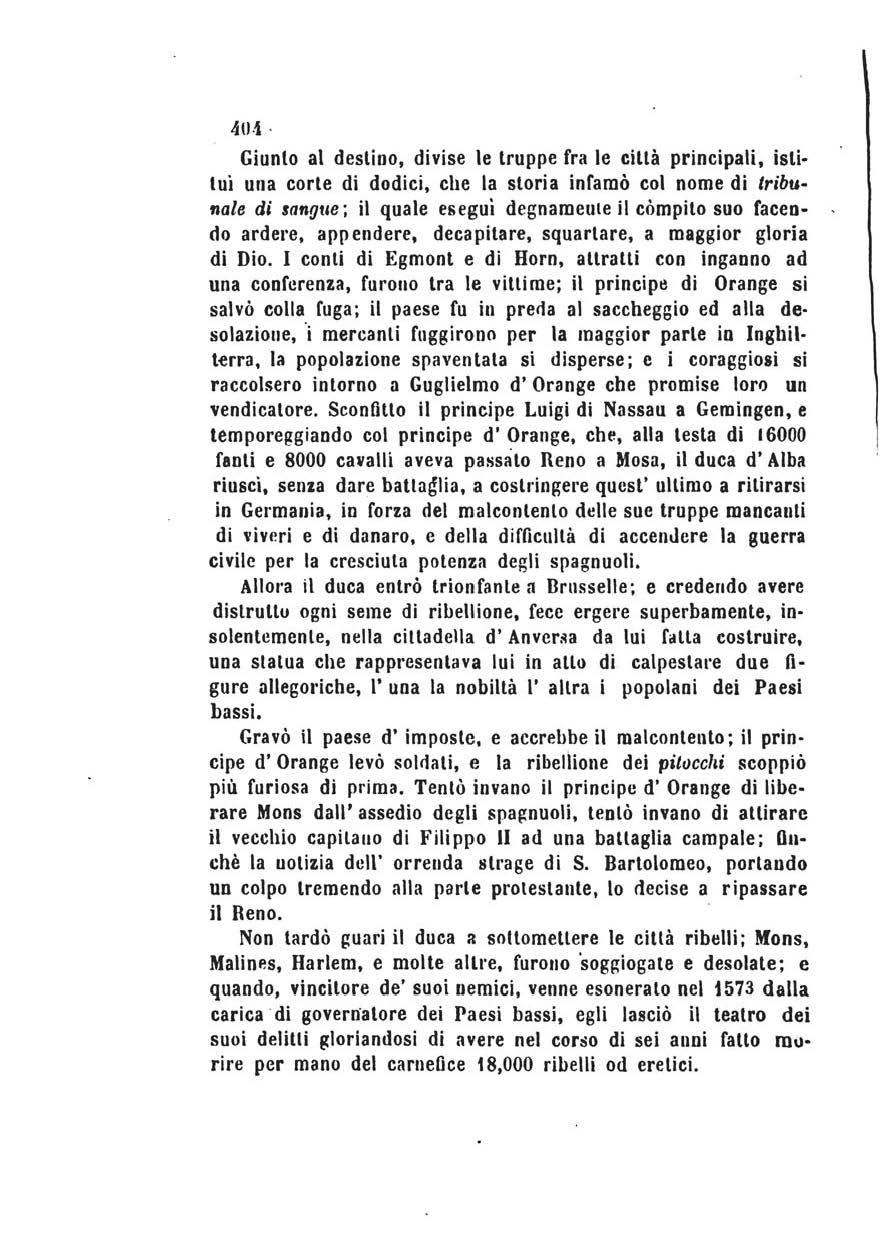
Allora il duca entrò triolllfante a llrnsselle; e credendo avere distrullo ogni seme di ribellione, fece erge1·e superbamente, insolentemente, nella cittadella d' da lui falla costruire, una statua che rappresentava lui in allo di calpestare due figure allego•·iche, l' una la nobiltà l' altra i popolani dei Paesi bassi.
Gravò il paese d' imposte, e accrebbe il malcontento; il prin· cipe d' Orange levò solliati, e la ribellione dei pilùcchi scoppiò più furiosa di prima. Tentò invano il principe d' Orange di liberare Mons dall'assedio degli teotò invano di attirare il vecchio capilauo di Filippo Il ad una battaglia campale; finchè la uotizia dell' orrenda sh·age di S. Bartolomeo, portando uo colpo tremendo alla parle protestante, lo rlecise a ripassare il Reno . ·
Non tardò guari il duca a sottomettere le città ribelli; Mons, MalinP.s, Harlem, e molte allre, furono 'soggiogate e desolate; e quando, vincitore de' suoi nemici, venne esoneralo nel i573 dalla carica ·di goveròalore dei Paesi bassi, egli lasciò il teatro dei suoi delitti gloriandosi di avere nel corso di sei anoi fatto morire per mano del carnefice 18,000 ribelli od eretici.
.t05
Tornato a Madrid, cadde in disgrazia per intrighi amorosi di un suo figlio che toccavano la susccttibi lità della corte, e venne rilegato per due anni nel suo castello di Uzeda. Ma volendo Filippo conquistare il Portogallo, lo chiamò di nuovo all' azione e lo mise a capo delle sue forze. Il duca d iede e vinse il 25 agosto del t 581) la battaglia di Alcantara; e due mesi dopo la sua partenza di Spagna, Lisbona e tutto il Portogallo furono sottomessi a Filippo.
Non sorvisse molto a questa vittoria; mori nel 1582 io età di 74 anni.
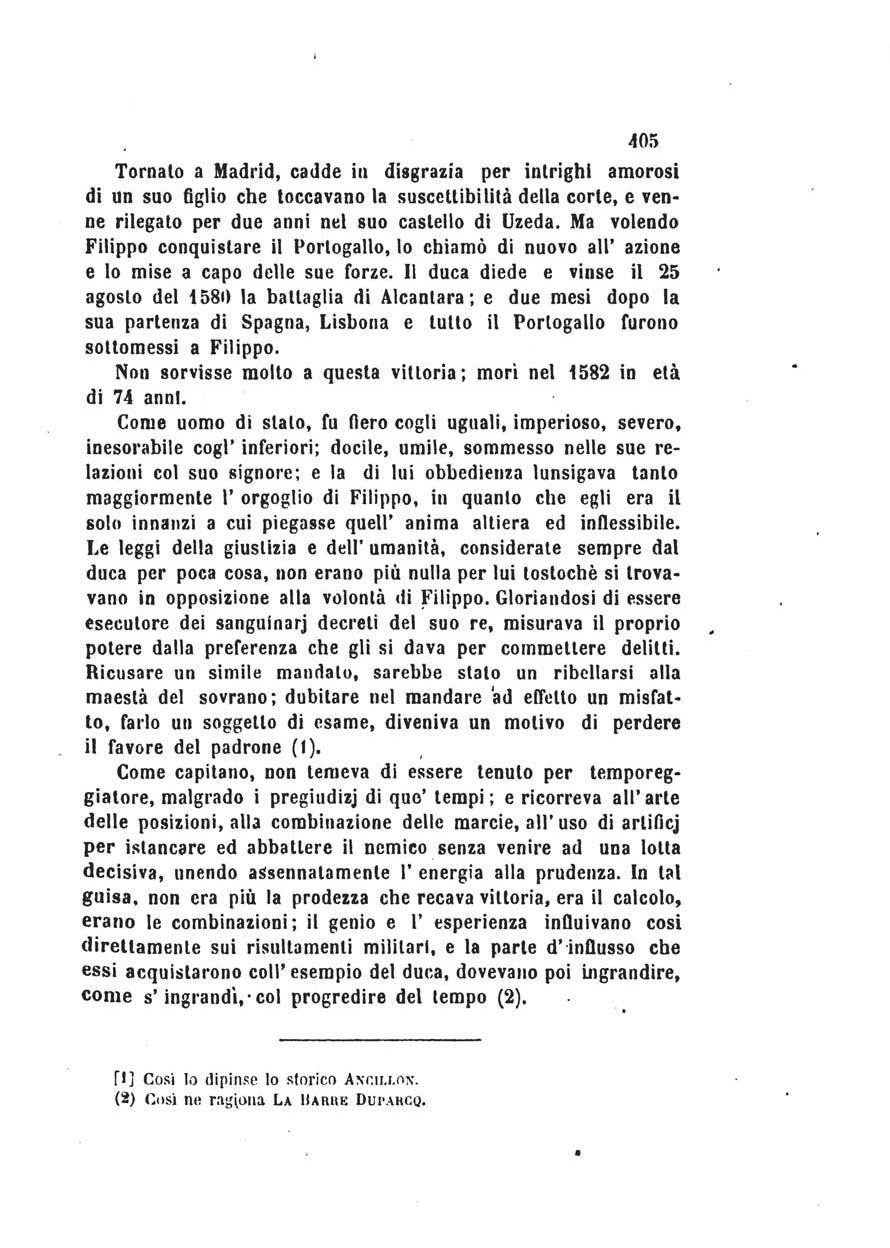
Come uomo di stato, fu fiero cogli uguali, imperioso, severo, ioesor·abile cogl' inferiori; docile, umile, sommesso nelle sue relazioni col suo signore; e la di lui obbedi enza lunsigava tanto maggiormente l' orgoglio di Filippo, in quanto che egli era il solu innanzi a cui piegasse quell' anima altiera ed inflessibile. Le leggi della giustizia e dell' umanità, considerate sempre dal duca per poca cosa, non erano più nulla per lui tostochè si trovavano in opposizione alla volontà di filippo. Gloriandosi di esecutore dei sangulnarj decr·eti del suo re, misurava il proprio potere dalla preferenza che gli si dava per commellere delitti. Ricusare un simile mandato, sarebbe stato un ribellarsi alla maestà del sovrano; dubitare nel mandare ad effetto un misfatto, fal'lo un soggetto di esame, diveniva un motivo di perdere il favore del padrone ( 1). .
Come capitano, non temeva di essere tenuto per temporeggiatore, malgt·ado i pregiudizj di quo' tempi; e ricorreva all'arte delle posizioni, alla combinazione delle marcie, all'uso di artiflcj per islancare ed abbattere il nemico senza venire ad una lotta decisiva, unendo assennatamente l' alla prudenza . In guisa, non era più la prodezza che recava vittoria, era il calcolo, erano le combinazioni; il genio e l' esperienza inOuivano cosi direttamente sui risulta menti militari, e la parte d' ·inOusso che essi acquistarono coll'esempio del dut\a, dovevano poi ingrandire, come s' ingrandì,· col progredire del tempo (2).
fl J Cosi lo tli pinse lo s to ri co Axr. u r.o x Cu s i 0 1\ ra ,; (Oil:l. LA llARIIE D UI'AII CQ
.406
Se il nome di lui trovò un posto distinto nella storia dell' arte militare, trovò poi una maledizione terribile . nella storia dell' umanità da lui cooculcata .
F1unr.nTo. Nacque in Ciamberì nel t528, ed ancor giovinetto fu per la gracile comvlcssionc destinato agli studj ecclesiastici. Ma questi non e rano per lui ; in\'o· gliatosi dell'arte militare, fece nel 1545 le sue prime prove nrgli imperiali di Carlo V; e l' imperatore, che lo conobbe capace di grandi cose, fu largo della sua confidenza. Emmanucle Filibe1·to sottentrò a Fabrizio Colonna nel comando delle truppe imperiali in Italia, combauè egregiamente nelle guerre del Piemonte, a S. Damiano, a Bra, a Saluzzo, c r:1ggiun sc s uhito dopo l' imperatore che sosteneva allre fatiche di guerra in e nel Luccmburgo . In questo frattempo gli moriva il padre, Carlo lll duca di Savoja, e le armi francesi vigliavuno di nuovo il soppraveoto io Piemonte.
Eletto nel t 556 da Filippo Il di Spagna a governatore generale dci Paesi bassi, l' anno appresso fu mandato nelle Fiandre, dove s' adope1·ò a raccogliere un' oste numerosa per assalire tla quel. Ialo la Francia; etl alla testa di quelle truppe, a cui si unirono bentosto altre \'cnule in soccorso dall' Inghilterra, andò a porre l' asse dio a S. Quintino. Una segnalata ''illori;l, procacciata da lui alle armi imperiali f t) 58, e la presa di quella piazza, misero al colmo la sua gloria miti tare • .
L'anno dopo si concluse la pace a Castello Cambresi, la quale portò per conseguenza la restituzione ad Emmnnucle J:o'iliber.to dei domioj a\'iti,·ad eccezione di Tòrino c di alcune altre città fino a nuova deliberazione, ed il suo matrimonio con• Margherita sorella al re di Entrato ne' suoi stati, l' accoglievano i popoli con grandissime dimostrazioni di allegrezza, sì pc•·chè amavano un
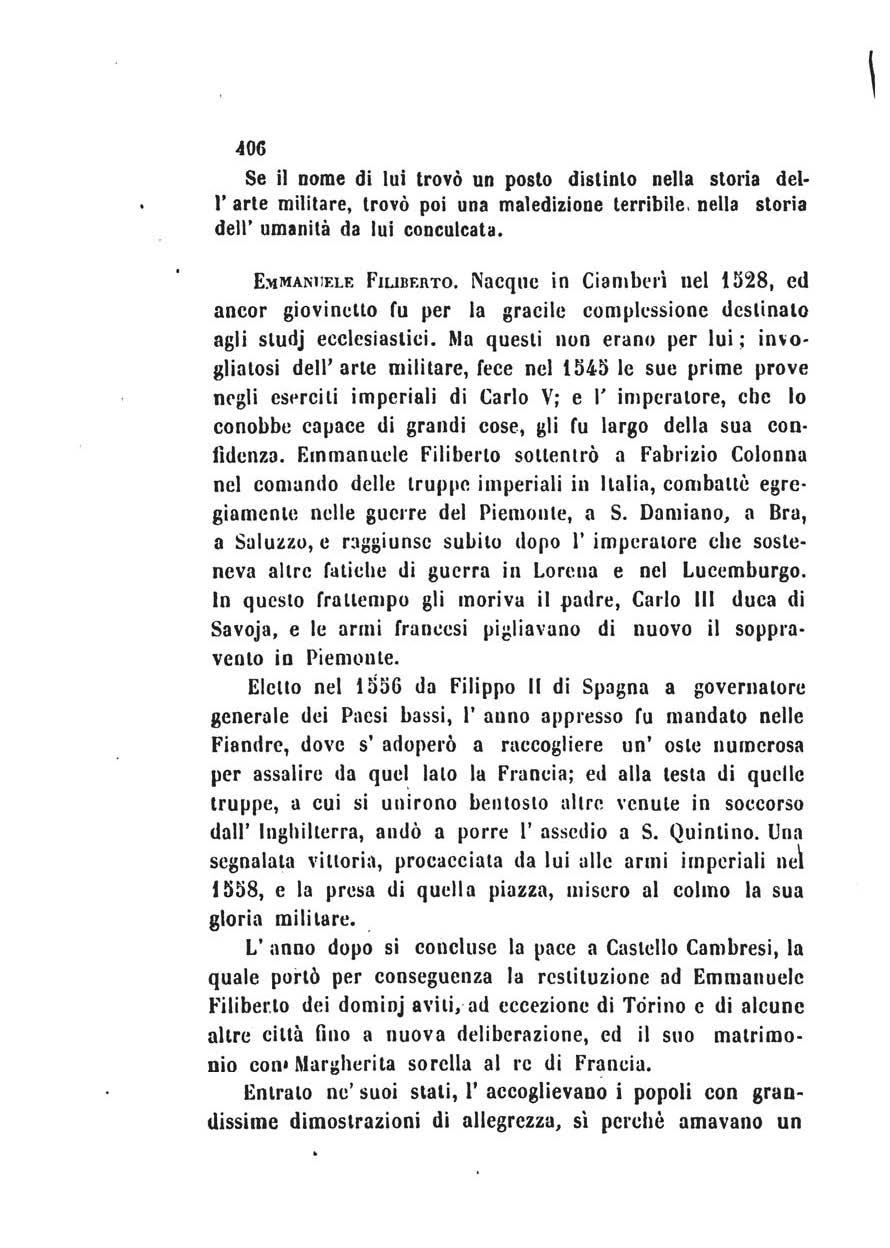
.ao1 principe proprio, e si per vedere ch' ei fosse tanto chiaro per segnalate vittorie.
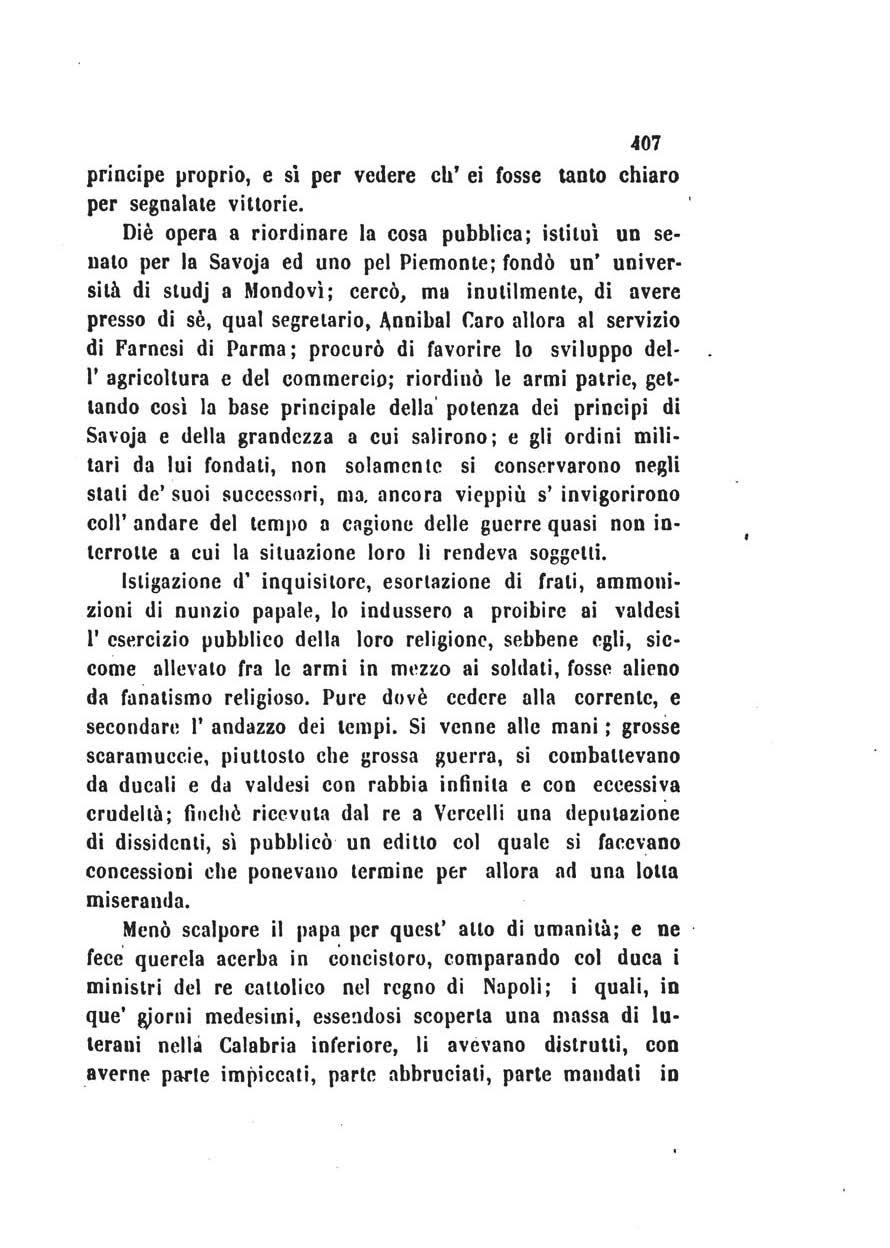
Di è opera a riordinare In cosa pubblica; istituì un senato per la Savoja ed uno pel Piemonte; fondò un' università di studj a Mondovì; cercò, ma inutilmente, di nvere presso di sè, qual segretario, ,\nnibal Caro allora al servizio di Farnesi di Parma; procurò di favorire lo sviluppo dell' agricoltura e del commercio; riordinò le armi patrie, gettando così In base principale della ' potenza dci principi di Savoja e della grandezza a cui salirono; e gli ordini militari da lui fondati, non sol amen te si conservarono negli stati de' suoi successnri, ma. ancora vieppiù s' invigorirono coll'andare del tempo n cngionc delle guerre quasi non interrotte a cui la situazione loro li rendeva soggetti.
Istigazione d' inquisitore, esortazione di frati, ammonizioni di nunzio papale, lo indussero a proibire ai valdesi l' esercizio pubblico della loro religione, sebbene egli, siccome allevato fra le armi in mt!ZZO ai soJilati, fosse alieno da fanatismo religioso. Pure dovè cedere alla corrente, e secondare l' andazzo dei tempi. Si venne alle mani ; grosse scaramuccie, piuttosto che grossa gue1·ra, si combattevano da ducali e da valdesi con rabbia infinita e con eccessiva crudeltà; finchè ricevuta dal re a Vercelli una deputazione di dissidenti, sì pubblicò un editto col quale si faccv.aoo concessioni che ponevano termine ptr allora ad una lotta miseranda.
Menò scalpore il papa per quest' allo di umanità; e ne fece querela acerba in c'oncistoro, comparando col duca i ministri del re cattolico nel regno di Napoli; i quali, io que' g,iorni medesimi, esse!ldosi scoperta una massa di lulerani nella Calabria inferiore, li ave\'ano distrutti, con averne parte impiccati, parte abbrueiati, parte mandati io
.t08 galera. Un gran parlare e sparlare di frati si faceva in Piemonte conlro Rmmanucle Filiberto P. poco mancò che non gli dessero dell'eretico pel' la testa (t).
Nel f 5.63 il duc:t Tol'ino dai fr nnc('si, vi trasportò la sua sede e la con una ciuadclla.
Nel 157 f le sue galere comb:ltlerono con onoce contro i turchi a Lcpanto. ,
Tre anni dopo, lr tc:rrc pirmont('si, ad eccezione del march('sato di Sa luzzo rimasto a Francia, vennero sgombrate dalle francesi c spagn uolc.
Nel f 566, Rmmanucle Filiberto mosse in njuto dell' imperatore Massimiliano minacciato dai turchi dalla parte d' Ungh('rin; ma 1 ' imtwrntore, ncc('ltnndo un sussidio di envalli, rimnnctavn il principe, sapendo come il Piemonte abbisognasse ddl' opera sua.
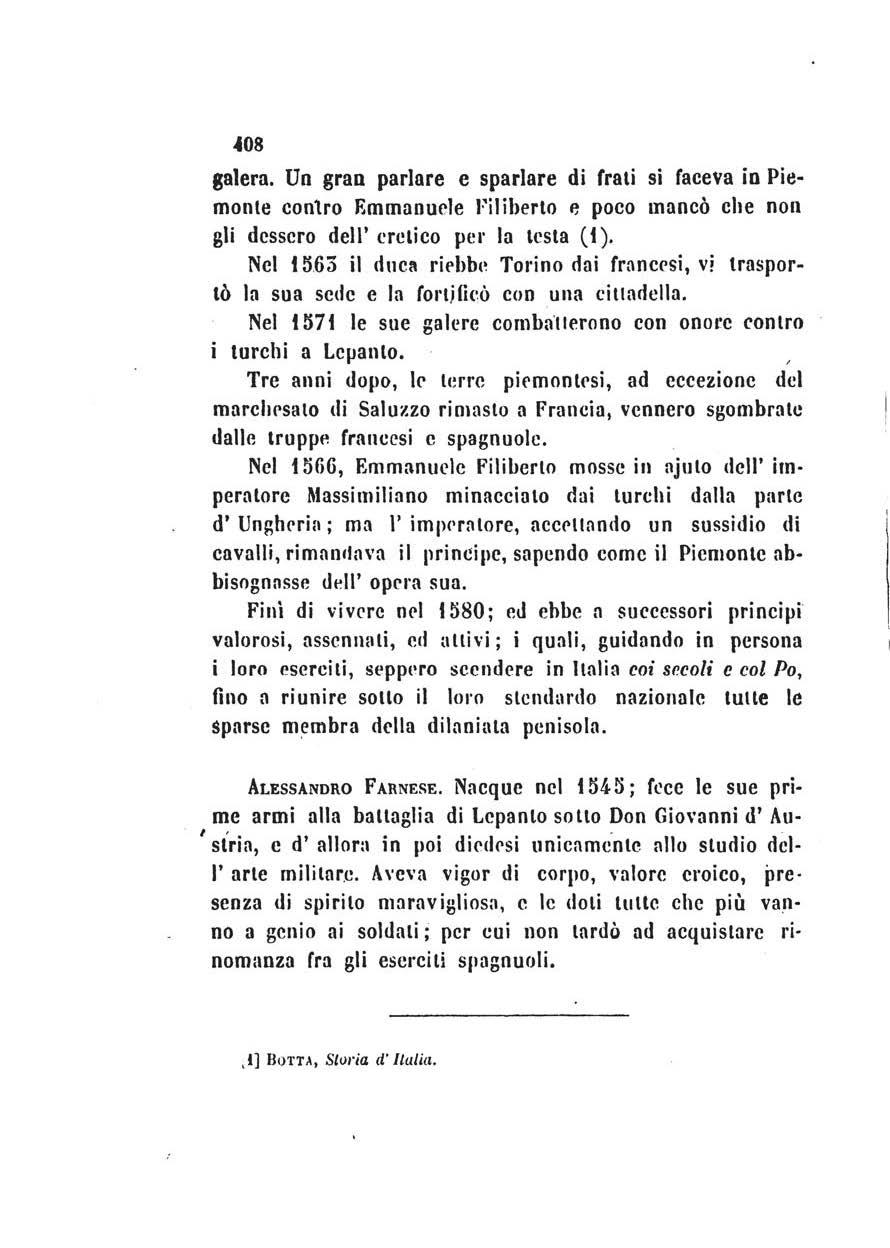
Finì di vivere n<'l t 580; ed chbc a successori principi' valorosi, assennati, c d attivi; i quali, guidando in persona i loro eserciti, seppe ro scendere in Italia coi secoli e col Po, fino a riunire sollo il lol'o stcndarclo nazionale tutte le sparse membra della dilaniata penisola.
ALESSANDRO fARNESE. Nacque nel f 54!); fl'ce le sue prime armi alla battaglia di Lcpanto so tto Don Giovanni d' Au' siria, c d' allora in poi di('d('si unicamc.ntc nllo studio dél1' arte militor.c. Aveva vigor di corpo, \'alorc eroico, pre· senza di spirito c le doti tutte che più van · no a genio ai soldati; per cui non tardò ad acquista re ri· nomaoza frn gli eserciti spagn uoli.
, 1] BoTTA, Slvl'ia d'llulia.
409
Nel l'IJ77 ricondusse in Fiandra un corpo di truppe di FiJippo morto ivi l'anno appresso Don Giovanni d' Au· stria, governatore dci Paesi bassi, Alessandro ne venne nominato successore dal re di Spagna, ristabilì col suo valore la riputnzione degli spagnuoli già molto scaduta per le vittorie degl' insorti, s' impadronì di Mnestricht e di alcune altre città, e valendosi delle di scordi c religiose, indusse molti cattolici a tornare all' obbedienza di re Filippo.
Deboli le Provincie unite per resistere da sè sole alla potenza spagnuola, chiamarono in ajuto il duca d' Angiò, fratello di Enrico Ili di Francia, il quale riportò alcuni vantaggi sul Farnese e l' obbligò a levare l' assedio a Cam· brai. Ma questi riprese ben presto il soprav\'ento, riebbe, dopo assedio, Dunkerque, Bruges, Yprcs, Gand, e Anversa, continuando po.i in Fiandra il corso de' suoi trionfi .
Entrato in Francia nel t 590, costrinse Enrico IV a le· \'are l' assedio di Parigi.
Tornato in Fiandra, si oppose ai progressi di Maurizio di Nassau, suo avversario in guerra, suo emulo in arte di guerra; per cui, come altra volta asserimmo, si formarono e andarono celebri le due scuole di Alessandro e di Mau 7 rizio.
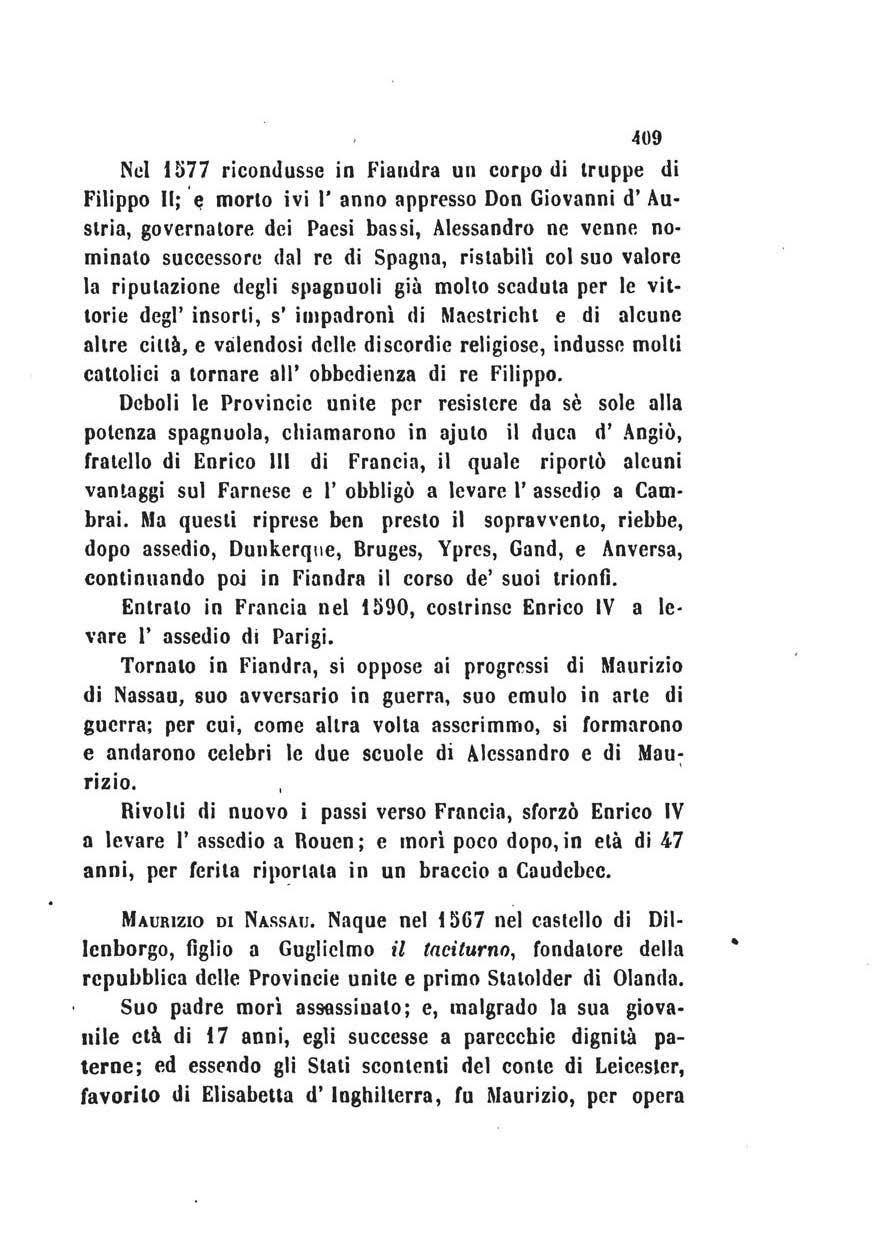
Rivolti di nuovo i passi verso Francia, sforzò Enrico IV n levare l' assedio a Rouen; e morì poco dopo, in età di 47 anni, per ferita riportata in un braccio o Caudcbcc.
MAuRIZIO o1 NAssAu. Naque nel f !>67 nel castello di Dillcnborgo, figlio a Guglielmo il taciturno, fondatore della repubblica delle Provincie unite e primo Statolder di Olanda.
Suo padre morì assessioato; e, malgrado la sua giovanile ctil di t 7 anni, egli successe a parecchie dignità paterne; ed essendo gli Stati scontenti del conte di Leicestcr, favorito di Elisabetta d' Inghilterra, fu Maurizio, per opera
.610 specialmente del gran pensionario Barneveldt, nominato 10 .luogo dell' capitano generale ed ammiraglio delle forz e olandesi. ·
Sebbene all' età di 20 anni, Maurizio diè tosto a divedere di quali talenti militari fosse dotato. Ristabilì la disciplina nell'esercito, ridu sse all' obbedienza parecchi ufficiali partigiani di Leiccstrr, c ri animò la fiducia dei soldati con alcuni vantaggi sin dal bel princiJlio oucnuti. Assaliti gli spa· gnoli, tol se loro alcune piazze importanti, fra coi quella di Breda, malgrado i rigori dell'inverno etJ anzi in gr.azia di codesti rigori. D' accordo con un bauellicre, fece nascondere nel fondo di un gran battello una sessan tina d'uomini, coperti da torba che doveva t!sserc introdotta in città. Gli spa· gnuoli, pel molto freddo, aspettavano con impazienza il bat· tello, cd ajutarono essi medesimi a tirarlo verso di una chiusa; ma essendo l' ora tarda , ed il battelliere solil3mente poco sorvegliato, venne di'posta a terra Ùnn parte del combustibile, c si rimise all' indomani lo scaricamento del resto. Sopraggiunta la notte, i soldati nascosti sbarcarono, si dhlisero in due assalirono i corpi di guardia, penetrarono nella cittadella e se ne impad ron irono, sccondati dall' arrivo dell' c:;ercito olandese a cui aprit·ono le porte. La ciuà s i so ttomise ; e Maurizio, a cui essa particolarmente apparteneva, ne il possesso.
Maurizio continuò prcssochè sempre felicemente le sue imprese, nelle quali io ispccial modo rifulse per la sua somma abilità nelle opere di fortificazione adattate alle circostanze; e la serie di prosperi eventi, avevano elevato di assai lo spiri to del suo esercito e In gloria del suo nome. Tra i falli più dl'gni di menzione, merita il primo posto la battaglia di Ncuporto, con•bauuta il 2 luglio del t 600. Quel giorno in particolare o fece nascere o confrrmò l'opi-
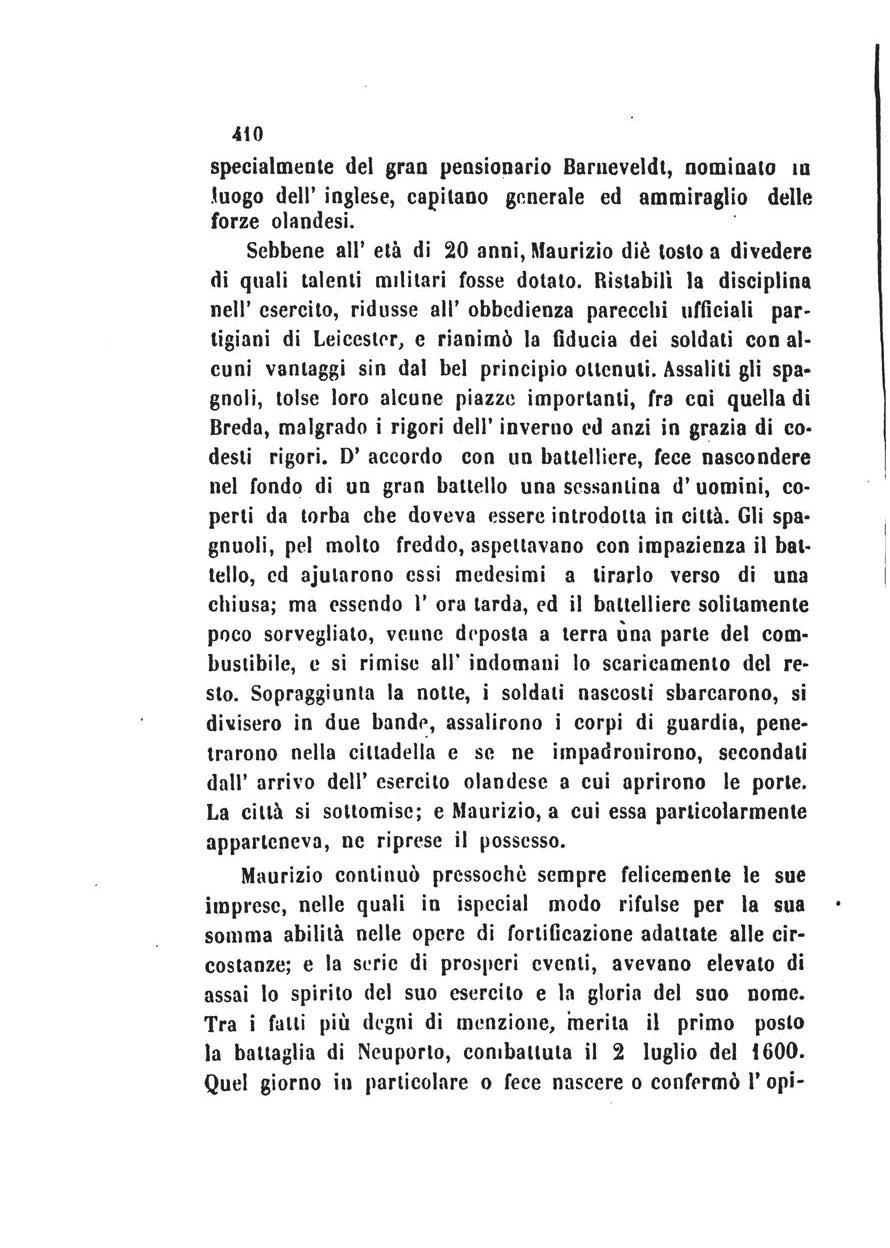
"l t nionc, che, s' egli valeva negli assedj, non valesse meno ancora nelle bauaglie. Cou qut>slo fallo memorando si chiu- . dono le geste operate da Maurizio nel secolo XVI; e qui dovremmo terminare il nostro discorso per non oltrepassare i limiti di tempo determinati dal titolo medesimo del presente capitolo. Ma per non lasciare incompiuto questo cenno biografico, diremo nlcune parole sino al terminare de Ila vita di così grande capitano, sebbene In fi_ne di lui non sia avvenuta se non che nel
Il celebre assedio di Ostenda, ratto dagli spag(luoli, c che da taluno viene definito come una me1·aviglia di quel secolo, durò tre anni, e fu uno scuola a cui andarono ad istruir,si gli urficiali di tuue le nazioni. In questo corso di tempo, Maurizio tentò più volle tli fnrc diversioni; ma sebbene fo sse ro ingegnosamente concepite e tatticamente ben . condotte, non ottennero però il risultamcnto supremo a cui si ·mirava, e la piazza si arrese nel t 604 ridoua ad un mucchio di ro,·ine.
Altri fatti, in cui rifulsc la perizia di Maurizio, si compirono nel c t606; finchè nell'aprile del 1607 si concluse una sospensione d' armi per dar luogo a trattative di pace. Vi si opponeva Maurizio, il quale, alla somma della cosa pubblica aspirando di andare, vedeva più difficile ottenere il suo intento in tempi pacifici c tranquilli che in tempi burrrascosi, in cui il suo influsso sarrbbesi aumentato. Ma non non prevalendo l' opinione sua, e \' i ncendo quella del gran pensionario ·Barncveldl che dichiarava non esservi più motivo di continuare la guerra dacchè la Spagna consentiva a riconoscere l' indipendenza delle Provincie unite, si conclusf! uel t609 una tregua di dodici anni. N' eb· be Maurizio profondo rammarico, e non potè al gran pcnsionario d' avergli :\ttrav<·rsato i suoi disegni nm-
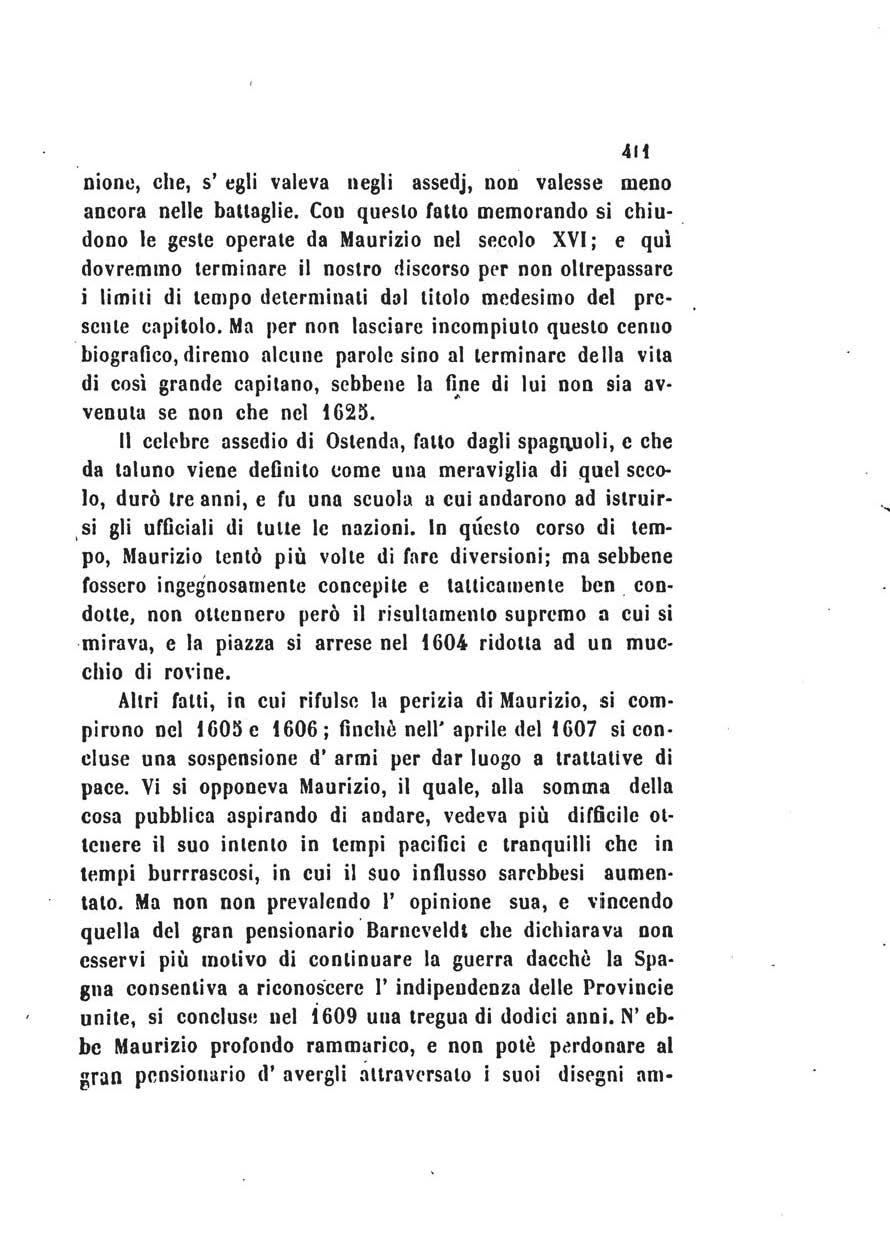
·.tl2 biziosi. Perciò gli giurò guerra; e trasse partito tfa disl!eosioni rèligiose pt>r riuscire atf abbattere i suoi avversarj politici. Favorì la setta dci calvinisti moderati detti Gdmaristi, e fece condannare da un sinodo come eretiche le opinioni dci calvinisti esaltati detti Afminiani. Poi, appoggiandosi su questa, ordinò. l'arresto de i capi degli arch'erano pure suo i nemici in politica, accusò di tradire la patria n favore di Spagna . Gli stati generali, che sostituì agli stati particolari delle provincie, come un passo verso l'unità c la monarchia, sentenziarono sugli accusati, e condannarono a morte il gran pensionario, alla prigione per·pctua il dottissimo Grozio. Il primo fu trauo al patibolo; il secondo fuggì poi di carcere c si salvò in terra d' esiglio.
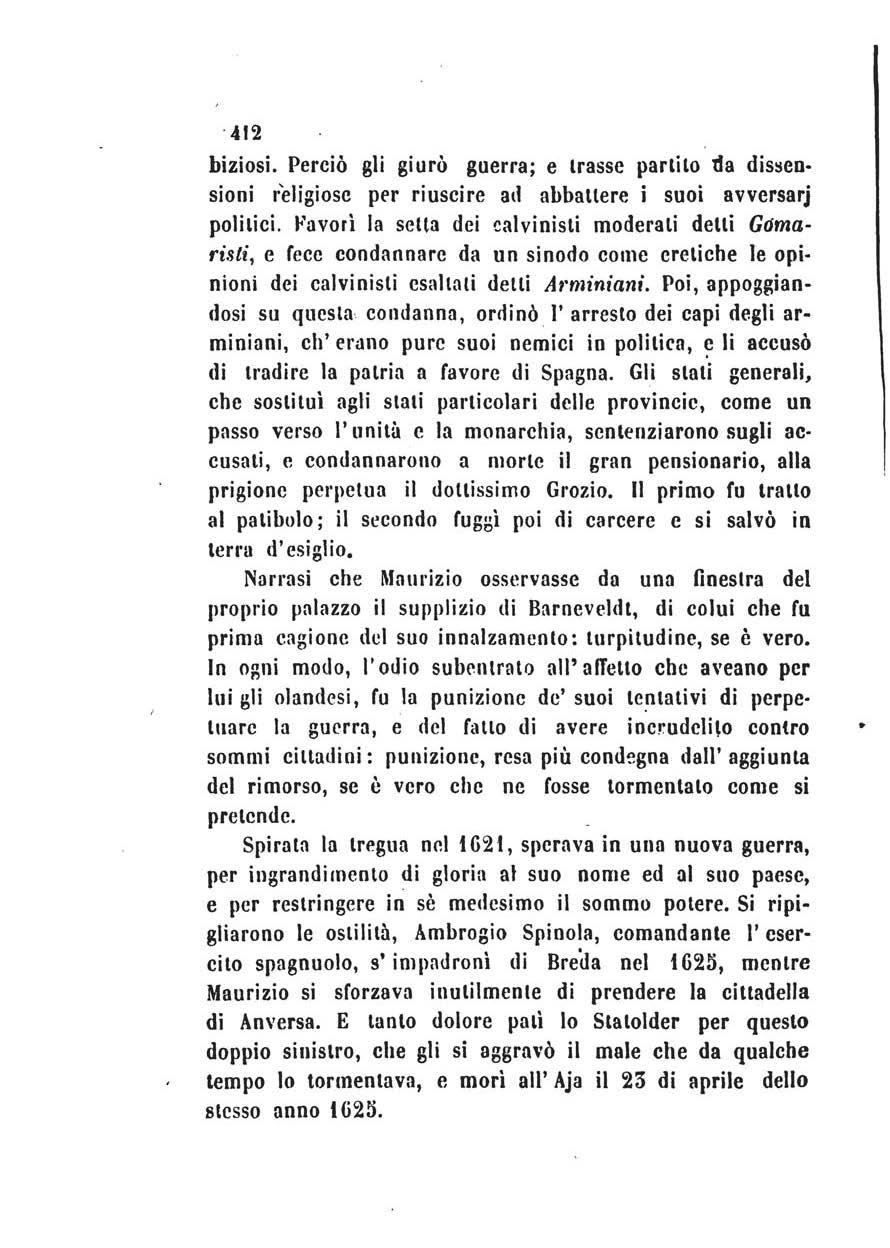
Narrasi che Maurizio osservasse do una finestra del proprio il supplizio di Barneveldt, di colui che fu prima cagione del suo innalzamcoto; turpitudine, se è vero. In ogni modo, l' odio subentrato all'affetto che aveano per lui gli oland esi, fu la punizione dc' suoi di perpetuare la guerra, e del fallo di avere iocrudclito contro somm i cittadini: punizione, resa più condegna dall'aggiunta del rimorso, se è vero che ne fosse tormentato come si pretende.
Spirata la tregua nel t G2 t, sperava in una nuova guerra, per ingrandimento gloria at suo nome ed al suo paese, e per restringere in sè metlcsimo il sommo potere. Si ripigliarono le ostilità, Ambrogio Spinola, comandante l' cser· cito spagnuolo, s' di Breda nel t 625, mentre Maurizio si sforzava inutilmente di prendere la cittadella di Anversa. E tanto dolore patì lo Statolder per questo doppio sinistro, che gli si aggravò il male che da qualche tempo lo tormentava, e morì all' Aja il 25 di aprile dello stesso anno t 625 .
Maurizio di Nassau si distinse precipuamente .per la sua abilità nel mantenere In discivlina fra le truppe, per la perspicacia nella scelta dell'ordine di battaglia c pc l suo genio come ingegnere.
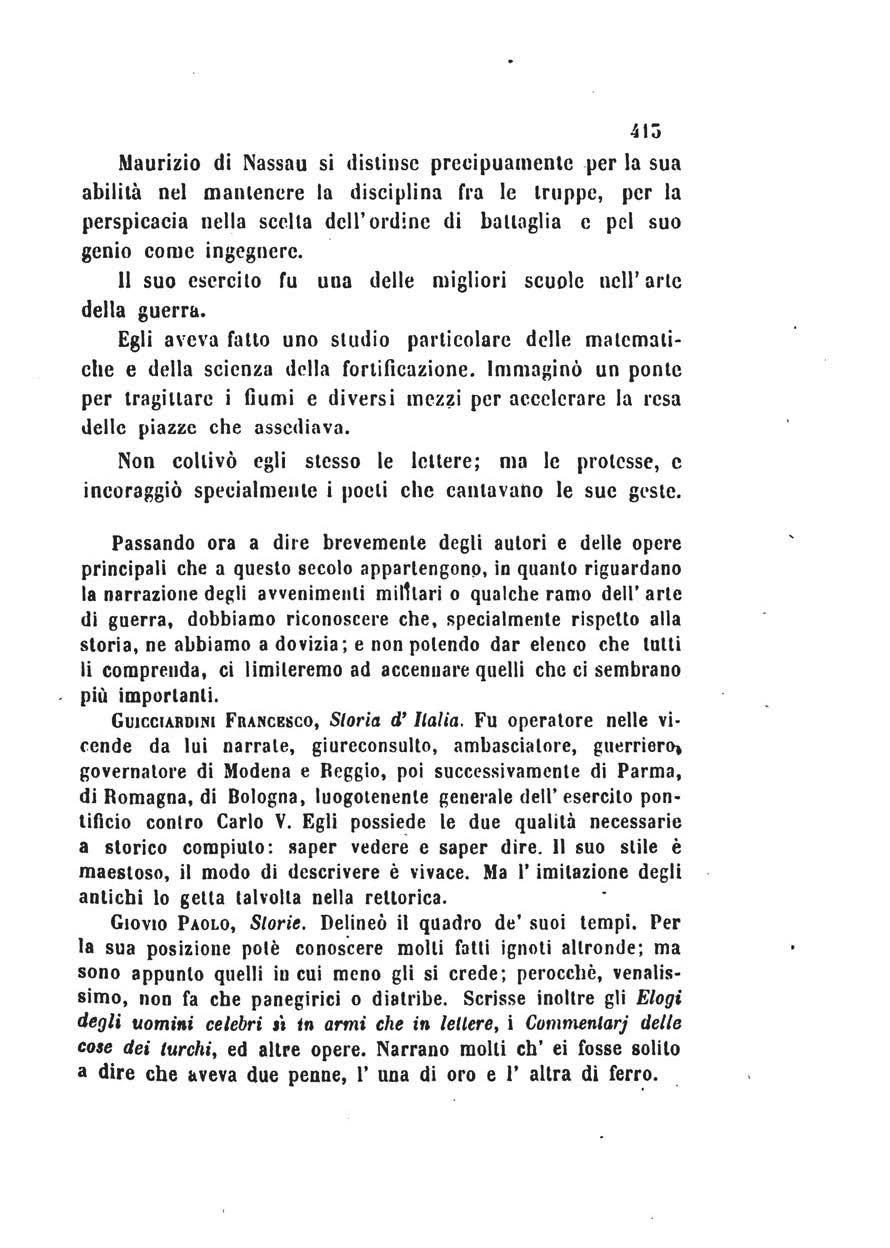
Il suo esercito ru una delle migliori sc uole nell 'a rte della guerr&.
Egli aveva fatto uno studio particolare delle matcm:lliche e della scienza della fortificazione. Immaginò un ponte per tragittarc i fiumi e diversi per accelerare la resa delle piazze che assediava
Non coltivò egli stesso le lcllere; ma le pt·otcsse, c incoraggiò specialmente i poeti che cantavano le sue gestc.
Passando ora a dire brevemente degli autori e delle opere principali che a questo secolo appartengo09, io quanto riguardano la narrazione degli avvenimenti mil1tari o qualche ramo dell 'ar te di guerra, dobbiamo ricono sce re che, specialmente rispetto alla storia, ne abbiamo a dovizia; e non potendo dar elenco che tulli li comprenda, ci limiteremo ad accenuat·e quelli che ci sembrano più importanti.
GuJcctARDINt FnANcKsco, Storia d' Italia. Fu operatore nelle vi· r.ende da lui narrate, giureconsulto, ambasciatore, gnt!rriero. governatot·e di Modena e Reggio, poi successivamente di Parma, di Romagna, di Bologna, luogotenente gene•·ale dell'esercito pon· tiflcio contro Carlo V. Egli possie de le due qualità necessarie a storico compiuto: 11aper vedere e saper dire. Il suo stile è maestoso, il modo di descrivere è vivace. !la l' imitazione degli anlichi lo getta talvolta nella rellorica.
G10v1o PAOLO, Storie. Delineò il quadro suoi tempi. Per la sua posizione potè conoscere molti f3lli ignoti altronde; ma sono appunto quelli iu cui meno gli si crede; perocchè, venalissimo, non fa che panegirici o diatribe. Scrisse inoltre gli Elogi degli uomirti celebri 1Ì tn armi che in lettere, i Ctmmunlarj delle co1e dei turclli , ed allre opere. Narrano molti cb' ei fosse solito a dire che ueva due penne, l' una di oro e l' allra di
414
MAcUJAVELLI NICOLÒ, /storie fior·eulme, L' ar•fe della auerra. Scrisse alt•·e npere; ma queste interessano meno il militare. Di lui abbiamo ragionato diffusamente.
BENTIVOGLIO Cardinale Gumo, La guPrra ài Fiaftdra. Nacque nel secolo XVI, narrò falli del secolo medesimo e pubblicò il suo lavoro nel susseguente. È opera interessante pel soggetto; ma non vi si trovano le notitie recondite che la posizioile del l'autore darebbe ad aspettare
DA\'ILA ENRICO, Guer·re civili di Francia. Combattè in queste guerre al soldo della corte. Conosce i luoghi ed i costumi, 'ed espone con cbiarctza. Si disse cbe conviene diffidare di lui quando loda la corte di Francia.
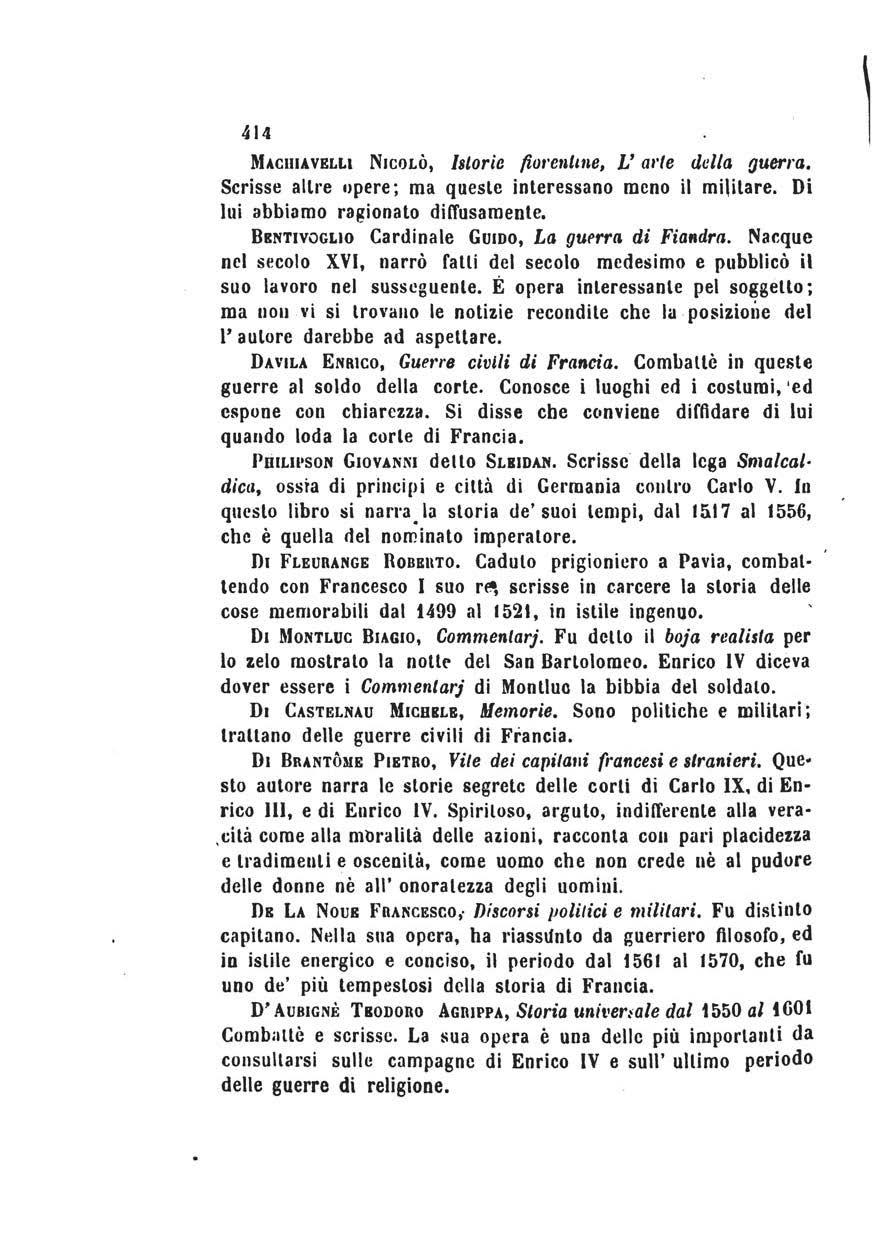
PmLII'SON GIOVANNI detto Scrisse· della lega Smalcal· àic11, ossia di principi c città di Germania contro Carlo V. lo questo libro si narra .la storia de' suoi tempi, dal Hil7 al 1556, che è quella ciel nominato imperatore.
D1 FLEURANGE RoBBI\TO . Caduto prigioniero a Pavia, combat· tendo con Francesco I suo scrisse in carcere la storia delle cose memorabili dal 1499 al 1521, in istile ingenuo.
D1 31oNTLUC BIAGIO, Commentarj. Fu dello il boja realista per lo te lo mostrato la nollt' del San Bartolomeo. Enrico l V diceva dover essere i Commentarj di Monlluc la bibbia del soldato.
D1 CASTBLNAU MICBILE, Memorie. Sono politiche e militari; trattano delle guerre civili di Francia.
D1 BRANTÒUE PIETRO, Vite dei capilaui francesi e stranieri. Que• sto autore narra le storie segrete delle corti di Carlo IX. di En· rico Ili, e di Enrico IV. Spiritoso, arguto, indifferente alla vera· .ci là come alla mbralità delle azioni, racconta con pari placidezza e tndimenLi e oscenità, come uomo che non crede uè al pudore delle donne nè all' onoralena degli uomini.
DB LA Nous FnANCBsco,- Disco rsi politici e militari. Fu dislinto capitano Nella sua opera, ha t•iassl1nto da guerriero filosofo, ed in islile energico e conciso, il periodo dal 1561 al 1570, che fu uno de' più tempestosi della storia di Francia.
D' AusJGNÈ Tsonono AGRIPPA, Storia dal 1550 al i GOl e scrisse. La !\Ua opera è una delle più importanti da con s ultarsi sulle campag ne di Enrico IV e sull' ullimo periodo delle guerre di religione.
SaPULVBDA GtovArcrcr. Era di Cordova; fu storiografo di Carlo V, ed educatore di Filippo 11. Scris'se la storia di que' due monarchi, con critica e verità per quanto può uno stipendiato.
AUre opere che verlono intorno ad argomenti militari nel secolo XVI, possediamo noi altri in llalia, e specialmente relative alle fortificazioni. Il Promis, commentando l'opera di Francesco di Giorgio Martini (l), pubblica una memor ia storica sulla vita e le opere degl' italiani scrittori di arliglieria, archilletura, e meccanica mililare, dal 1285 al 1560. E siccome trallasi di una serie non interrolla d' italiani nostri che in codesti temi militari apportarono il tesoro del loro ingegno e dei loro studj, così sarebbe colpa in noi se passassimo solto il silenzio costituisce uo lilolo speciale alla gloria nostra.
I limiti però a cui dobbiamo allenerei, ci vieta di registra·re tuili i loro no.mi, e molto meno di tessere biografie; ci limite· remo ad accennare alcuni di essi e le opere lasciate. Solo ci permetteremo d'includere nell' elenco anche quelli di taluni che vis· sero io secoli anteriori a quello che ora abbiamo descrillo, non avendone parlato nel capitolo nel quale sarebbero stati più COI.J· veoientemente per ragione di epoca collocati.
EGmto CoLONNA, scrisse, prima del t 285, un trallalo intito lato De principum, diviso io tre libt·i, e ciascun di essi io tre parti. Neli a terza parte del terzo libro tratta si io qual modo debbasi reggere la città od il regno ·in tempo di guerra; nei quindir.i primi capi parla della scelta, istruzione, e disciplina delle truppe: dal capo 16 al 22 di architettura milite re e bai i· stica; uel capo 23 ed ultimo, della guerra navale. Si trova in lui erudizione, non pl'atica, uè speculazioni.
MARINO SANUTO, scrisse un libro sopra la e conservazione ·di Terra santa, da lui presentato a papa Giovanni XXI nel 1321. Parla dell' esercito da sbarco, della flotta, della struttnra delle galee e delle navi da trasporto, della strullul'a d' ogni sorta di armi ed ingegni maneschi da offesa, da precelli circa gli accampamenti, e dimostrasi pratico nell'arte di fare fortezze, come comportava la scienza dell' età sua.
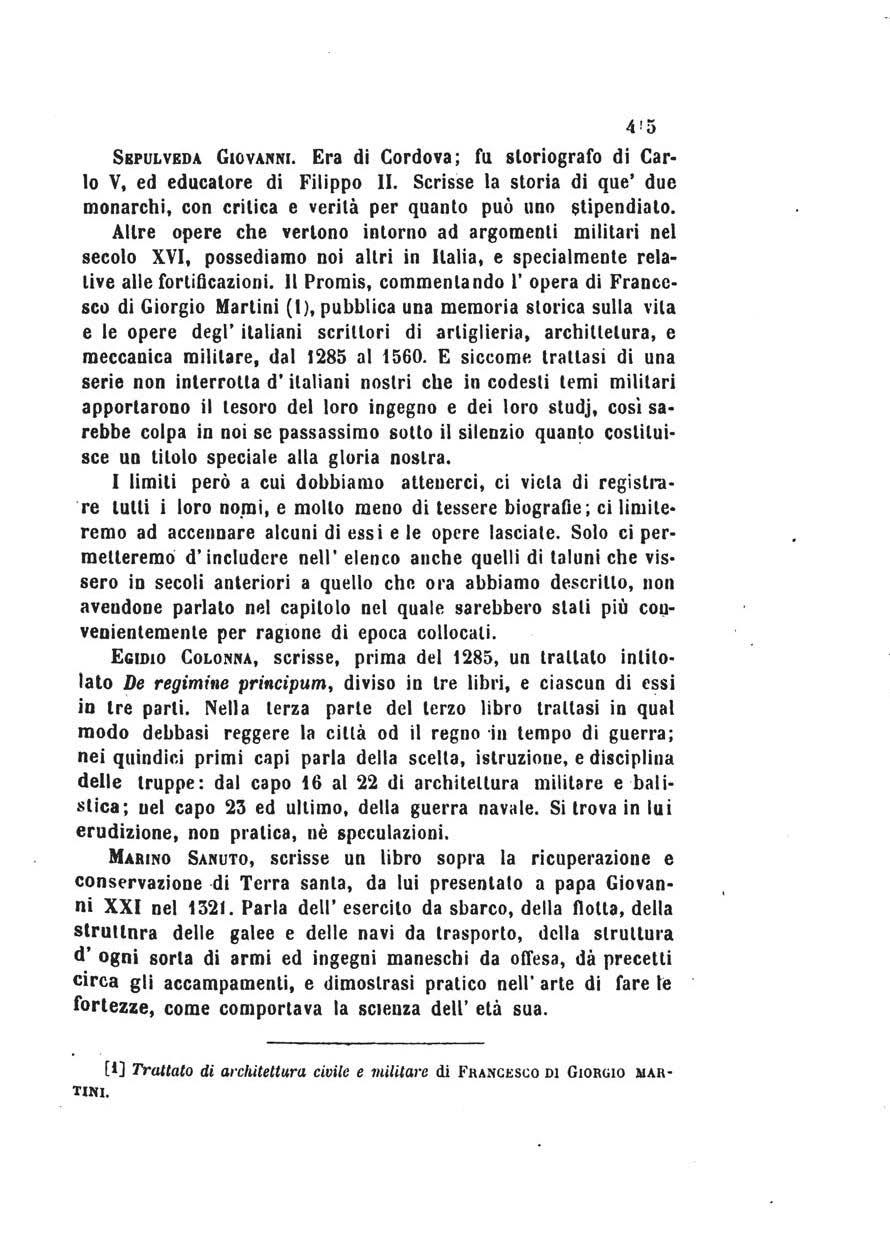
41(;
Gutoo DA VtGKVANo, com incia uu' O[Jll t'a sua coll' ésporrc come nel cnrreule auoo 13:55, essendo sta to ordinato un passaggio in Terra santa, egli vi concorr:! coi consigli. Il suo libro è diviso iu due parli, la prima delle quali contiene precetti medici, e la seconda si occupa dell' arte dell' ingegnere militare.
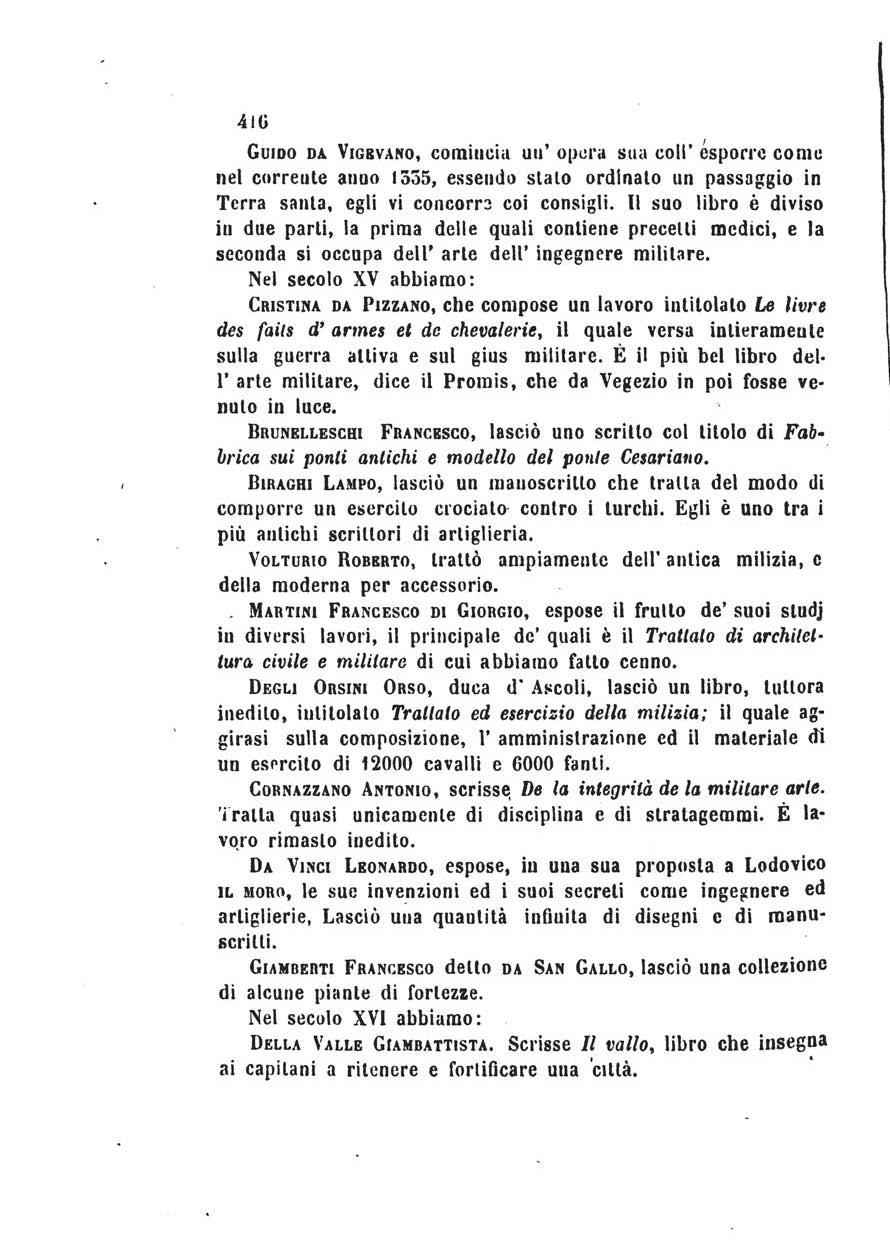
Nel secolo XV abbiamo:
CRISTINA DA PIZZANO, che compose un lavoro intitolato Le litwe àes (aits à' armes d dc chevalel'ie, il quale versa inlierameute sulla guena attiva e sul gi us militare. È il più bel libro del· l'arte militare, dice il Promis, che da Vegezio in poi fosse venuto io luce.
BRUNELLESCHI FnANC&sco, lasciò uno scritto col titolo di Fab· ùrica sui ponti antichi e modello del po11te Cesariatw.
BtRAGRI LAMPO, lasciò un mauoscrillo che tratta del modo di comporre un esercito crociato· contro i turchi. Egli è uno tra i più ;mlicbi scrittori di artiglieria.
VoLTURIO RoBBRTO, lJ'atlÒ ampiamente dell'antica milizia, c della moderna per accessorio.
. MARTIN! FRANCESCO Dl GIORGIO, espose il fruito de' SUOi sludj iu diversi lavori , il principale dc' quali è il Trattato ài architet· turll civile e militare di cui a bùiamo fallo cenno.
DEGLI OnsiNI ORso, duca d' lasciò un libro, tullora inedito, iutitolato Trattato ed esercizio della milizia; il quale ag· girasi sulla composizione, l' amministrazione ed il materiale d'i un esrrcito di 12000 cavalli e 6000 fanti.
CORNAZZANO ANTONIO, De la integrità de ltJ milittJre tJrle. Tratta quasi unicamente di disciplina e di stratagemmi. È laVQro rimasto inedito.
DA VINCI LBONARDO, espose, iu uua sua proposta a Lodovico IL MORO, le sue inv e nzioni ed i suoi secreli come iogetznere ed artiglierie, Lasciò uua quantità infinita di disegni c di manuscrilti.
GuMoEnTt FRANcEsco dello DA SAN GALLo, lasciò una collezione di alcune piante di fortezze.
Nel seco lo XVI abbiamo : DELLA VALLE GIAMBATTISTA. Scrisse Il vallo, libro che insegua ai capitani a ritenere e fortificare una 'c tltà . '
BrRJNGUGI VANNOcclo, scrisse nn tratlalo di DBLLA Rov111 FRANa&sco MARIA, duca d'urbino, lasciò i Di1corsi militari, che sono una raccolta di risposte da lui date a molle questioni mossegli in fallo di guerra.
TARTAGLIA NICOLÒ, lasciò la Nuova scienza che tratta di artiglieria, e l'opera intitolata Que&iti ed divn-11, io cui tratta e di artiglieria e di fortjOcàzione
B&LLUCCI GIAXBATTISTA, scrisse un Trall4lo di fortifica:&iOfle.
ALoDJSI GALAsso, da Carpi, lasciò un trattato che fu stampato col titolo; Delle fortifica;,ioni.
FusTI JAcoPo dello IL CASTRIOTTO, compose un trattato Della fortìfica;,ione delle cillà, ed uo sopra le forteue ad ora fatte nella Frarccia eà itt molti altri luoghi, nel quale si dimo1lra il modo da farne delle inespugnabili, ed ancora da ripa· r11re alle batterie. '
ZAI'fCRt GIAMBATTISTA, è rinomato pel s.uo trattato Del modo di fortificare le città.
CATANBO Prsrao, scrisse d'architettura: parecchi capitoli del suo lavoro trattano di fortificazione.
BARBAto DANI&LK. Egli pure si occupò dell' arte di fortificare.
LANTKRI JAcoPo, compose; t.• Due dialoghi del modo di dise· gnare le piante delle fortezze secondo Euclide, e del modo di com· porre i modelli e torre in disegno le pianto delle città: 2. 0 Due libri del modo di fare le (orlificaJiOfli di terra intorno alle città ed alle castella per fortificarle; e di fare così i (orli in campagna per gli alloggiamettli degli eserciti, come anco per andar sotto ad una terra e di fare i ripari nelle batterie. Rimaogo.oo inediti Quattro libri di Architellura, buona parte di ou' opea·a Sal modo di forli· /lcare di muro, ed un Di1corso del modo di (orli{icarB lo Ila/o di • terraferma della Serenissima reJtUbblica di YeneJia. .
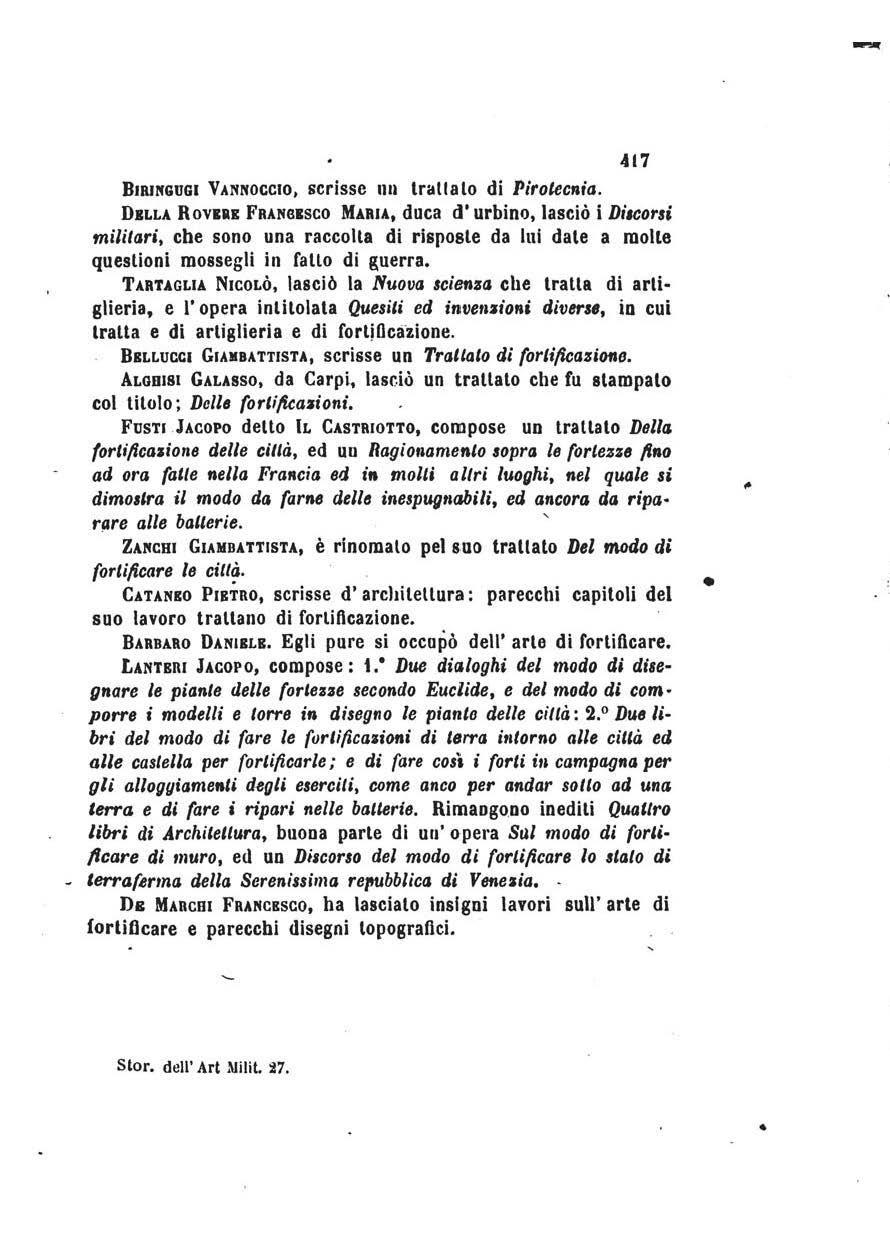
De MAnco! FRANcBsco, ha lasciato insignì lavori sull'arte di fortificare e pareccbi disegni topograflci.
Stor. dell'Art Milit. t.7
Battaglia di RavenM.
Esercito lspano-italico: circa 50,000 tra fanti e cavalli; 20 pezzi d' artiglieria: trenta carri armati d' archibugi e la nce.
Fratwcsc: 18,000 fanti tra lanzichenecchi, avventurieri, c piccardi; t 0,000 cavalli.
Il primo comandato dal capitano supremo D. Raimondo Cardona, vicerè di Napoli, che aveva seco Fabrizio Colonna c Pietro Navarra. Il secondo da Gastone di Foix, che aveva seco Bajardo, Allegri, e il duca di Ferrara. _
• l ft·anccsi stringevano d' assedio Ravenna, la quale è tra due fiumi; il Montone a sinistra, il Ronco a destra di chi guarda il mare. Tra questi due fiumi, e superiormente alla ciuà, s' era posto l' accampamento francese. Di lì si fulminarono le fortificazioni; poscia si tentò l' assalto, colle truppe partite in tre squadroni, l' uno di fanti tedeschi, l'altro d' italiani, il terzo di francesi. L' assalto andò fal · lito.
Ala intanto l' esercito ispano-italieo si era avvicinato a Ravenna per liberarla dall' assedio; aveva posto i suoi al· loggiamenti a tre miglia dalla città, sulla destra del Ronco; aveva circondato di un fosso tre lati dell' accampamento, essendo il quarto appoggiato al fiume; e di lì costringeva i francesi o a dar battaglia con isvantaggio, od a rititarsi dall' assedio con \' ergogoa; imperocchè la mancanza di vi· veri imponeva a Gastone di decidere senza esitanza.
Nella noue i francesi gcltarono un ponte sul Ronco, vi passarono sopra all'alba successiva, lasciando il retroguardo
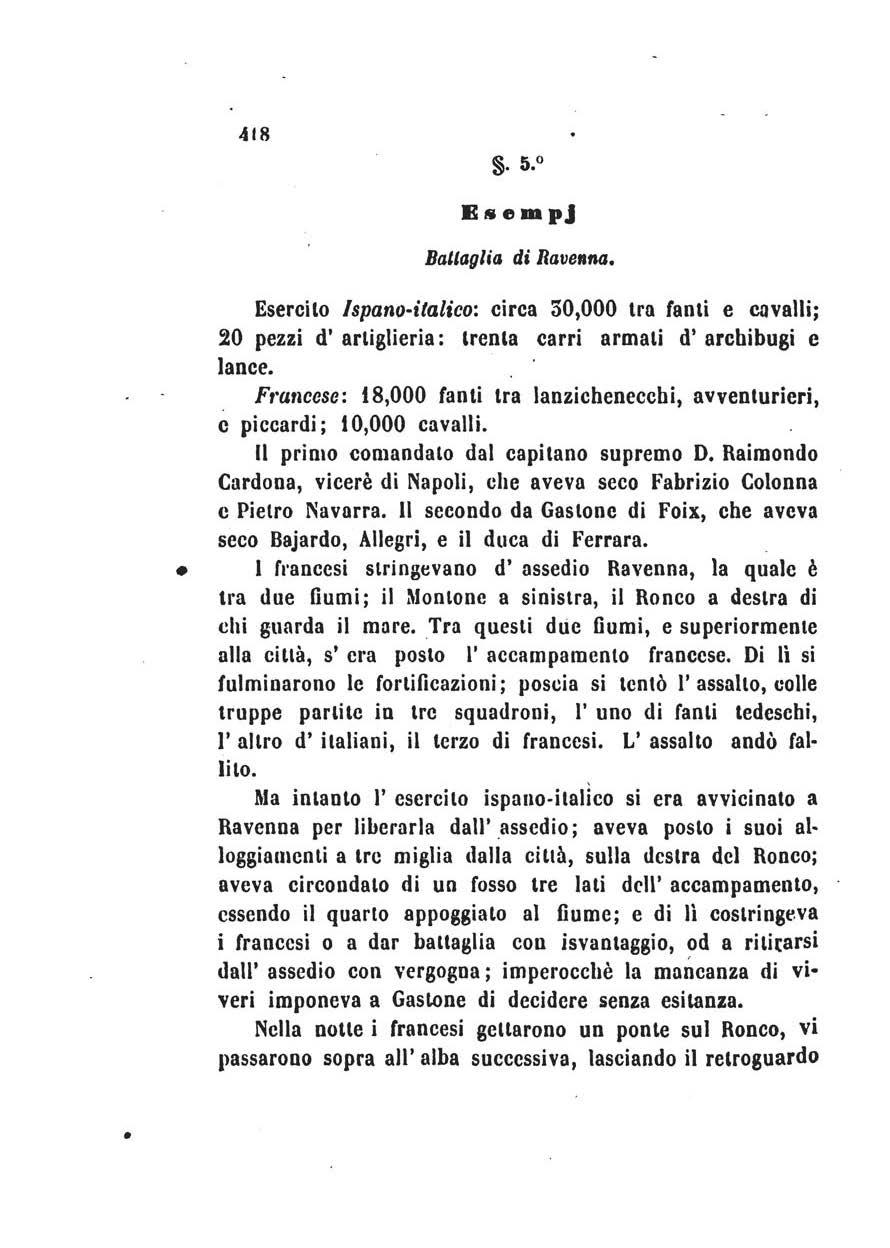
.&19 sulla rh·a sinislra per soccorrere l' t•scrcito o per opporsi ad una s4lrlita dalla cillà, c si prepararono col seguente ordine alla bauaglia. L' avanguardia con le artiglierie, gui data dal Duca di Ferrara, con 700 !ance e coi fanti tedeschi, fu collocata in sulla riva del fiume ch'era loro a mano destra, stando i fanti alla sinistra della cavalleria. Segui· tando da destra a sinistra, stavano a lato dell' artiglieria i fanti della baÙaglia, 8000, parte guasconi, parte piccardi, e dipoi l'ultimo squadrone di :5000 fanti italiani, e 5000 fra arcieri e cnvallrggif'ri. Dietro n qut'sti i qunH non formavnno una linea rl'lln, ma si pirgavnno o guisa di mezza lunn, erano collocale 600 lance della ballaglia. Gl' ispano-italiani sta,·auo negli alloggiamenti, in tre squadroni uno dietro l' altro; l'avanguardia, di 800 uomini d' armr, guidata da· Fabl'izio Cc tonna, fu collocala lungo la riva del fiume, ed aveva a destra uno squadrone di 6000 fanti; dietro :ld essa, pure lungo il fiume, era la battaglia di 600 lance condotta dal viccrè, e a slavalc uno squadrone di 4000 fanti; seguitava dietro alla ballaj;lia, JlUrc sulla riva del fiume, il rctroguardo di 400 uomini d'arme, con lo squadrone a lato di 4000 fanti e i ca,·am lcggieri dei quali era capitano gcncs·ate O' Avalos, marchese di Pescara. Le artiglierie erano poste alla testa delle genti d' nrmc; c Pietro Navarra, che con :wo fanti eleui non si ern obbligato a luogo alcuno, aveva in sul fosso alla .fronte della fanteria collocato trenta corrette, che avevano similitudioc di carl'i falcati degli nntichi, cariche Ili artiglierie minute, con uno spiedo lunghissimo OOJ)ra esse per sostenere più facilmente l' Ul'to dei francesi. Con quest'ordine stavano fermi dentro alla fortezza ·del fosso, aspcuando çhe l'esercito nemico venisse ad assaltarli.
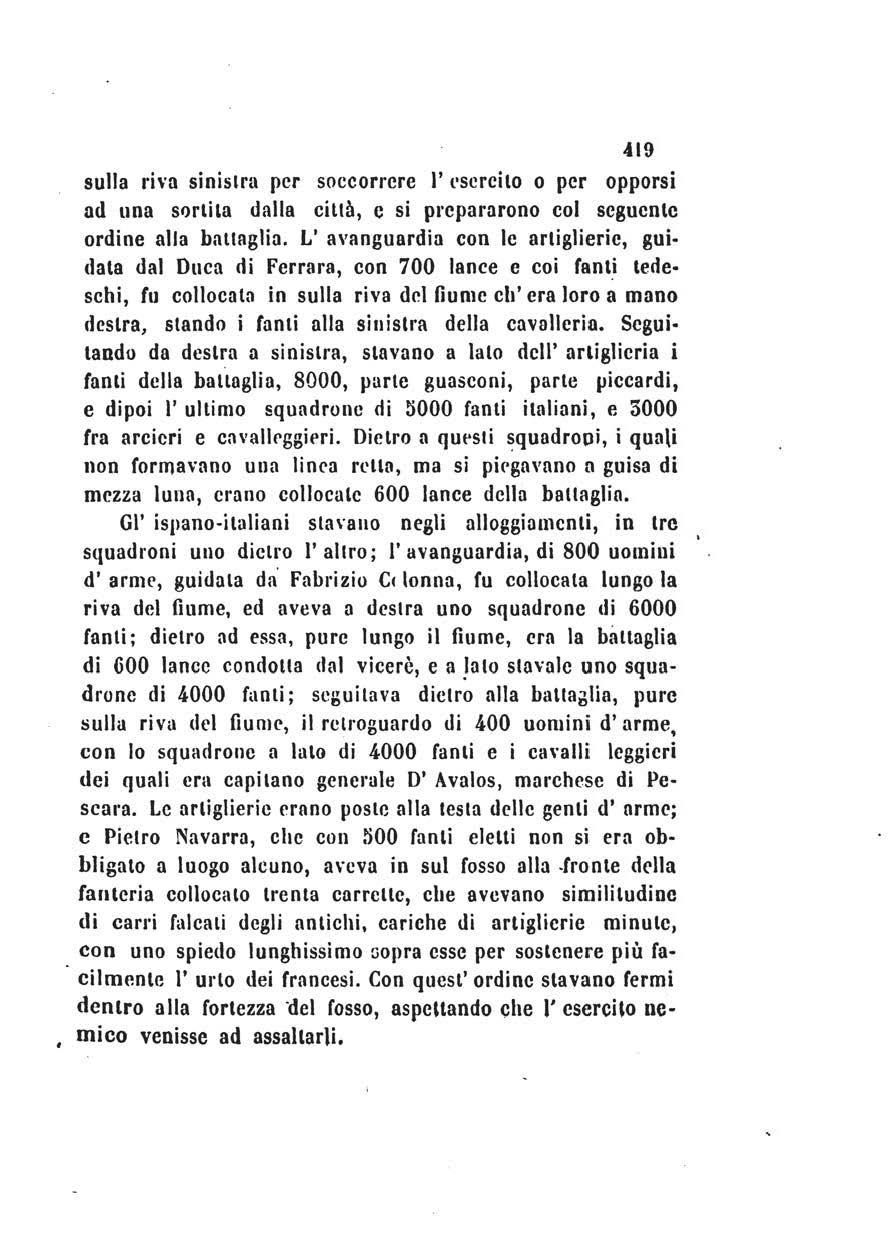
-120
l francesi si avanzarono sino a dugento braccia del fosso; ed ivi si fermarono per non dare il vantaggio ai nemici at· taccandoli in forti posizioni. Aspettavano che ne uscissero, cd a ciò li provocarono colle artiglierie. l colpi partivano ùa una parte e dall'altra, recando specialmente gr8\'e danno ai francesi ; quando il duca di FeTrara, tirata dall' ala destra c dietro aH' esercito una parte delle artiglierie, la condusse con grande rapidità alla punta sinistra ; la qual punta, per avere l' esercito la forma curvo, riusciva quasi alle spaJie dei nemici; donde cominciò a balle l'li per fianco ferocemente c. con grandissimo danno, massimamente della cavalleria; perchè i fanti spngnuoli, ritirati dal Navarra in luogo basso a canto all' argine del fiume , e gNtatisi per suo comando distesi in terra, non pote vano essere percossi.
Fabrizio, vede ndo la strage de' suoi, voleva che si uscisse a battaglia; vi ripugna.va il Navarra, che amava il danno de' compagni percbè maggior gloria ridondassc poi, vincendo, a sè cd ai suoi; ma non bastando più la pazienza o Fa · brizio, spinse fuori dal fosso le s ue genti, e Pietro Navarra fu costrello a dare il segno a' suoi fanti, i quali, rizzatisi con gran ferocia, si auoccarono con i funti tedeschi, che si erano .approssimati a loro.
Lo scontro fu sanguinoso .; ma la cavalleria della lega, essendo slata lacerata prima dalle artigli.eric, trovavasi con. quassata ; e dopo aver sostenuto per qualche tempo, più col valore dell'animo che con le forze l' impeto dei nemici , e dopo essere soppravvenulo loro addosso il rtltroguardo nemico, voltò le spalle, mentre il vicerè che comandava il secondo squadrone, non falla l' ultima esperienza clelia virtù dc' suoi, si era messo in fuga, ed era stato imitalo dal co· mandante del terzo squadrone. Fabrizio, che si era mosso per soccorrere la cavalleria, andò direttamente a ditre in
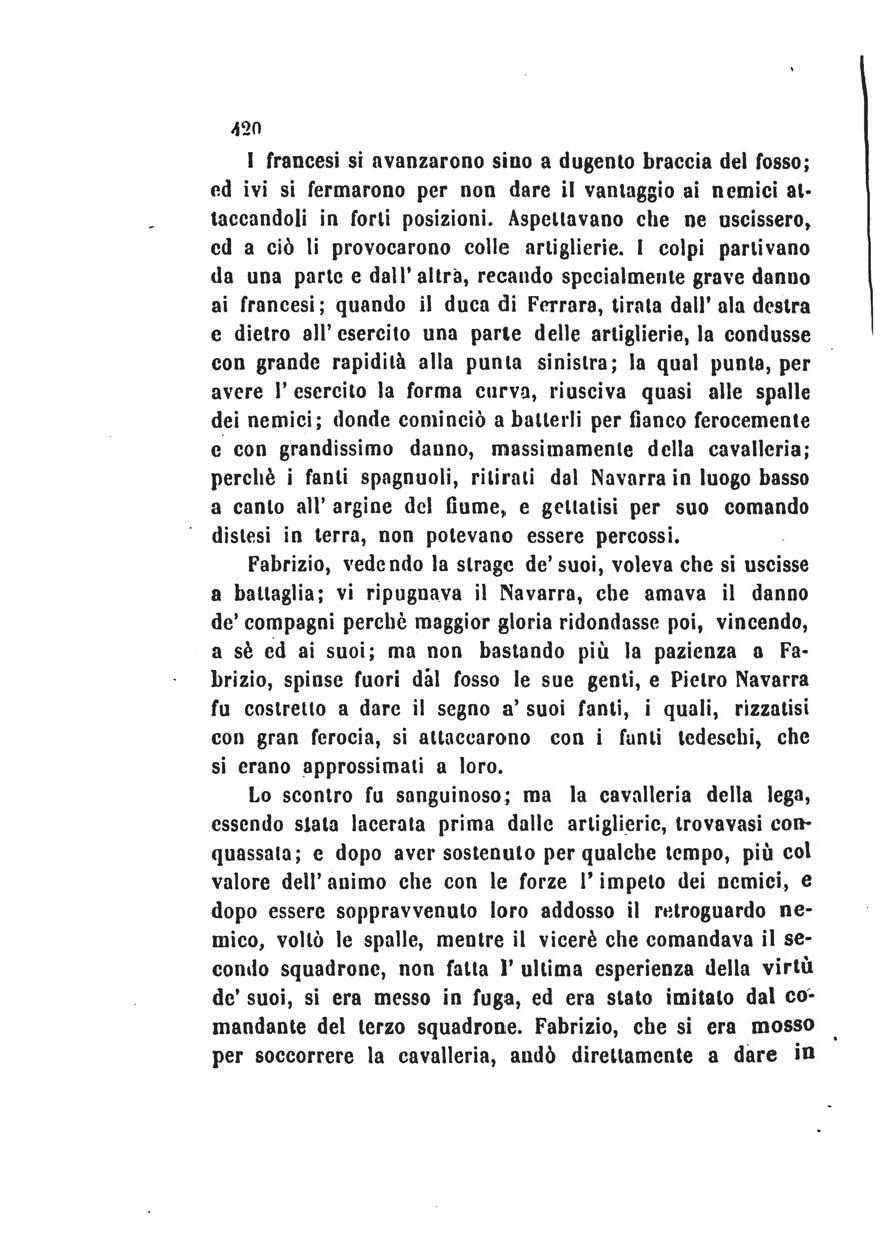
.t21 bocca dell' artiglieria del duca Alfonso; la quale gli sbaragliò lutti i soldati, cd esso dal duca fu fallo prigione.
Con tutto ciò la fanteria spagnuola combaLtevn con incredibile accanimento, mentre continuavano puranco a combattere i fonti itaJinni. Gli spagnuoli nel primo scontro coi tedeschi, erano stati a·lqunnti orlati dalle lunghe picche; ma accostatisi poi alla lunghezza delle spade, e coperti dagli scudi, cntrar.ono tra le ordinanze tedesche , c penetrarono sino n metà dello squadrone. Intanto i fanti italiani, non potendo t·esistcrc alla moltitudine dci nemici, piegavano; mn una parte dci fanti spagouoli, corsa nd ajuto loro, li fermò nella battaglia; mentre i · fanti tedeschi, oppressi dall' altra parte dagli a fatica potevano più resistere; ·quando essendosi voltato adosso agli SJlagnuoli Foix con grande moltitudine di cavalli, essi, piutlo!'to ritracndosi che scacciati dalla battaglia, senza scomporre gli ordini loro, entrati in sulla via è tra il fiume c l'argine. di passo c colla fronte stretta, ribouavano i ft·a.nccsi, c cominciavano a discostarsi. Ma non potendo comporlarc Foix che quella fanteria spagnuola ne andasse, quasi come vincitrice, salva nell ' ordinanza sua, andò furiosamente ad assalirla con una squadra di ca'·.alli; cd attorniato, c gillèlto da cavallo, vi pcrdè la vitn.
l fanti spagnuoli si ritirano allora senza molestia. Il rimanente dell'esercito era già dissipa tu e messo in fuga; presi i carriaggi, prese le bandiere e le artiglierie, presi Fabrizio Colonna, Pietro Navarra, il Marchese di Pescara, e molli ·altri signori e baroni spagnuoli e napoletani. (t).
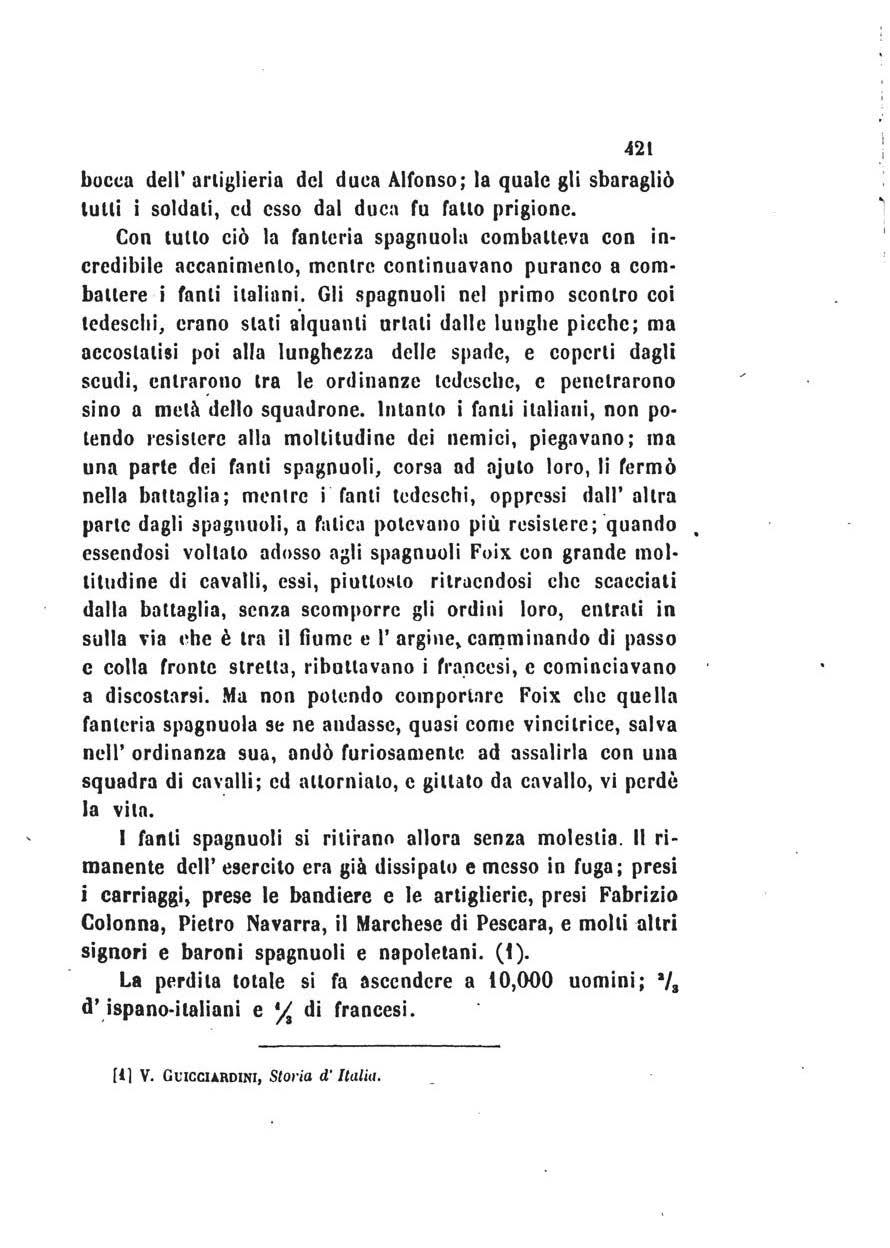
La pr.rdi ta totale si fa ascendere a t 0,000 uomini; •t. d' .ispano-italiani e Ya di francesi.
[t] V. Gt:ICCU.RDINT, Storia d' llaliu.
422
01servazioni. In questa battaglia si osservò la bravura e la prontezza della fanteria spngnuola nel cacciarsi io mezzzo alle file tedesche; l'utilità della loro arma difensiva, tanto predicata da Machiavelli; la compàltezza della loro ordinanza nella ritirata in mezzo ad 1111 esercito trionfante: ed bavvl specialmente ad osservare cotrie la banaglia di Ra· venna sia stata guadagnata dalle artiglierie, c come perciò si debba mettere a capo di tutti i falli d'arme che dall' ar· tigl ieri a vennero risoluti.
Epoca: t t Aprile t :St 2.
Battaglia di Pavia.
Francesi. Il numet·o non è ben e conosciuto, imperoccbè it' re, in causa delle frodi dei capitani, pagava per un numero d'uomini assai superiore del reale. Pare che le forze francesi, le quali presero parte alla battaglia , ascend.essero sollanto a t tOOO fanti c un miglinja di !ance, con altri 8000 uomiui negli alloggiamenti.
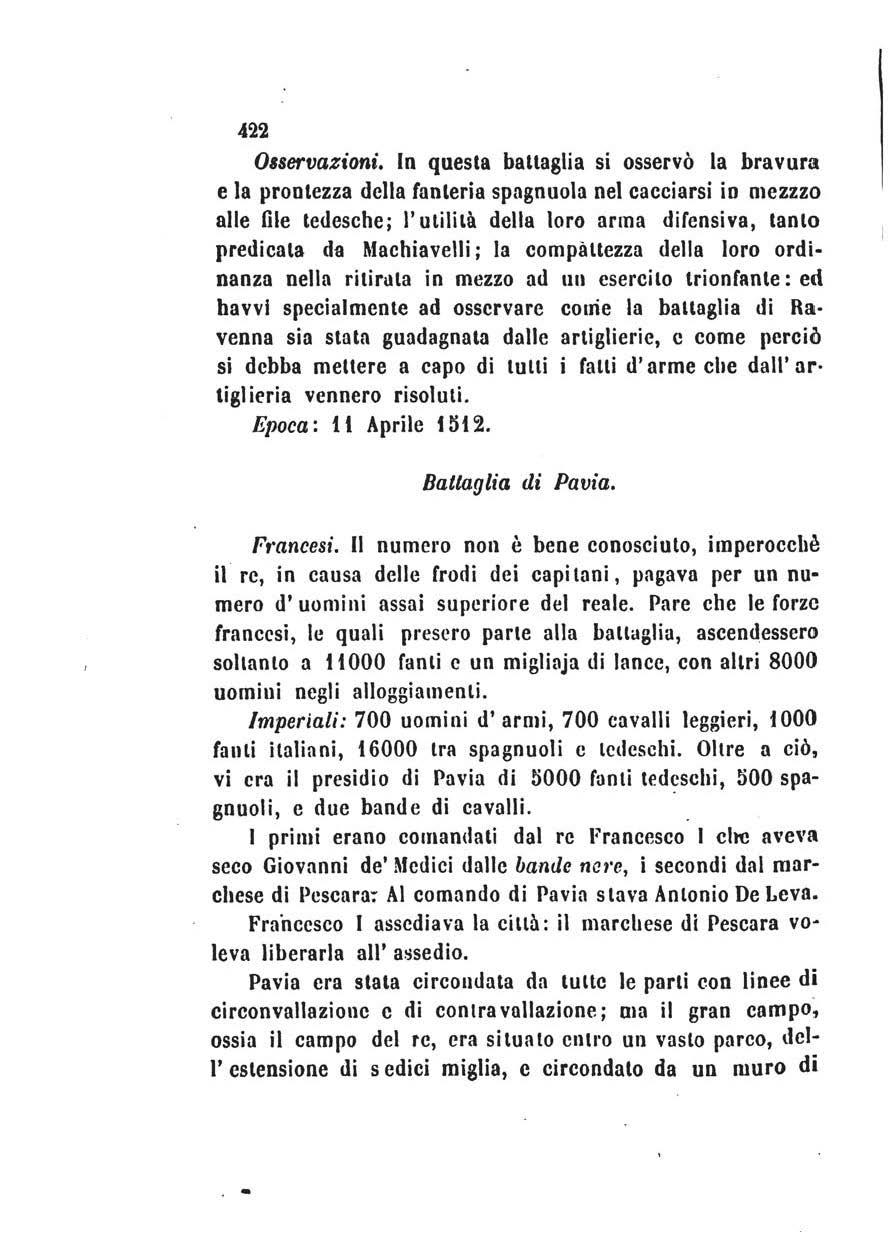
Imperiali: 700 uomini d'armi, 700 cavalli leggieri, fOOO fanti italiani, t6000 tra spagnuoli c tedeschi. Oltre a ciò, vi era il presidio di Pavia di fanti 500 spagnuoli, e due band e di cavalli. .
l primi erano comandati dal re Francesco l che neva seco Giovanni de' Medici dalle bande nere, i secondi dal marchese di Pescara: Al comando di Pavia stava Antonio De Leva.
Fra'nccsco l assediava la città: il marchese di Pescara vo· leva liberarla all' assedio.
Pavia era stata circondata da tutte le parti con linee di circonvallazione c di con Ira vallazione; ma il gran ossia il campo del re, era situato cntt·o un vasto parco, del· 1' estensione di sedici miglia, c circondalo da un muro di
.t25 cinta. Nel mezzo del parco sorgeva il castello detto di Mi· rubello, luogo di ritrovo pe' cacciatori, e destinato allora a magazzino di deposito.
Per assalire gli del re, o per forzare il re a battaglia, o per mettersi in comunicazione da quella parte colla città assediata, bisognava rompere il muro di cinto e penetrare nel parco. Mediante grosse travi, adoperate a mo' di arieli, si fecero di noCte tre aperture nel muro; cd all' alba l' esercito spagnuolo entrò nel parco.
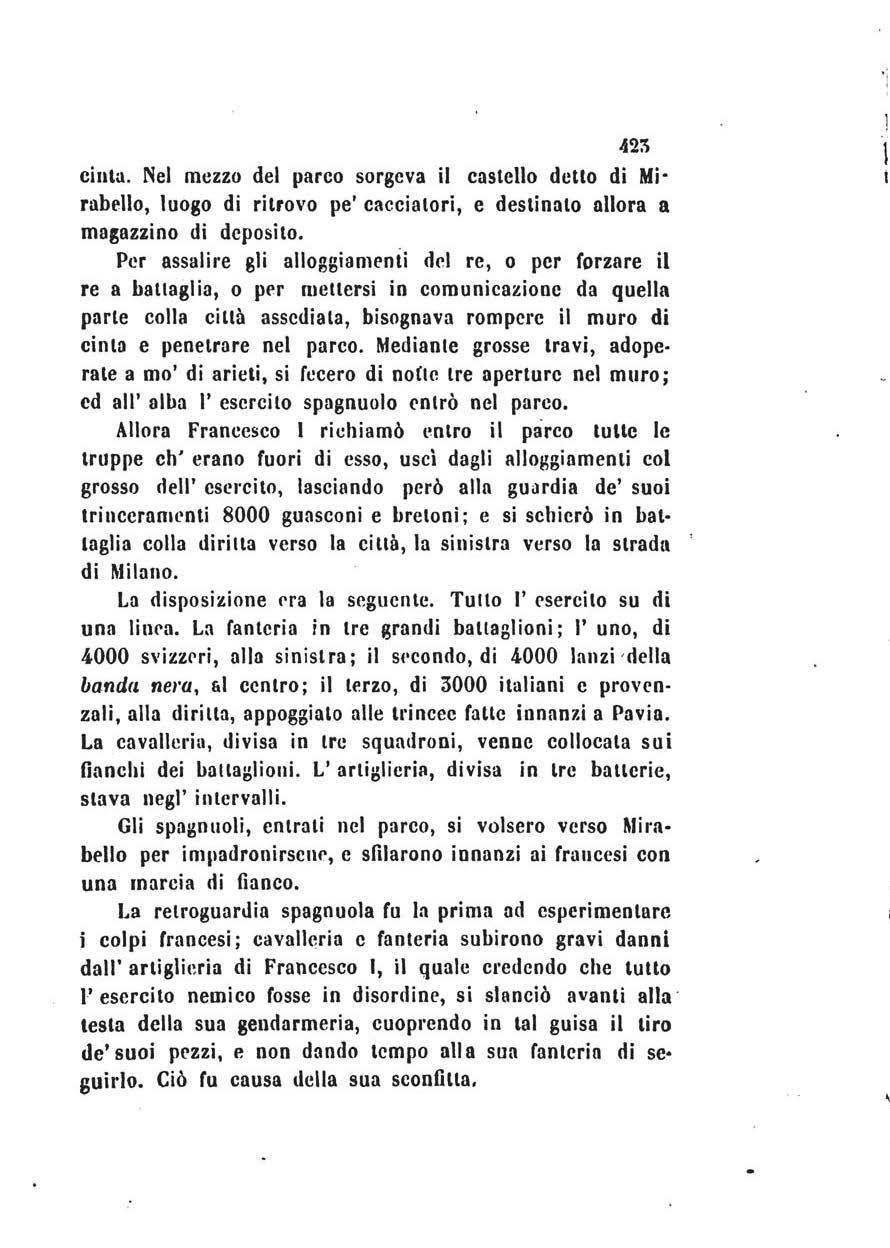
Allora francesco l richiamò llntro il pàrco tolle le truppe ch' erano fuori di esso, uscì dagli alloggiamenti col grosso dell' csc•·cito, lasciando però alln guardia de' suoi trinccramt'nti 8000 guasconi e bretoni; e si schierò in ba t· laglia colla dirilla verso la città, la sinistra verso la stradn di Milano.
La disposizione ('ra la seguente. Tutto l' esercito su di una linra. Ln fanteria in tre grandi battaglioni; l' uno, di 4000 svizzrri, alla sinistra; il st•condo, di 4000 lanzi ·della banda ne1·u, &l centro; il terzo, di 3000 italiani c provenzali, alla diritta, appoggialo alle ll'incec fauc innanzi a Pavia. La cavalleria, divisa in tre squadroni, venne collocata sui fianchi dei battaglioni. L' artiglicrin, divisa in lrc batterie, stava negl' intervalli.
Gli spagnuoli, entrati nel parco, si volsero verso Mirabello per impadronirscnr., c sfilarono innanzi ai francesi con una marcia di fianco.
La retroguardia spagnuola fu In prima ad esperimentare i colpi francesi; c fanteria subirono gravi danni dall' artiglieria di francesco l, il quale CJ'edcndo che tutto l'esercito nemico fosse in disordine, si slanciò avanti alla · testa della sua gendarmeria, cuopl'cndo in tal guisa il tiro de' suoi pezzi, e non d:tndo tempo ali a so n fanteria di se· guirlo. Ciò fu causa tlella sua sconfitta,
-424
truppe spagnuole, éhe già si erano impadronite di Mirabello, fecero un cambiamento di fronte, tornnrono indietro, e avanzarono· in ordine contro i francesi; i loro battaglioni serrati respinsero ogni attacco dei gendarmi ; i quali, da nllra parte, balestrati dagli arébibugieri e moschellieri spagnuoli, si sbandarono.
Éra il momento io cui sarebbe stata necessaria l'azione . vigorosa della fanteria; ma gli svizzeri, colti da terrore, gettano le picche e si danno alla fuga; invano una compagnia di gendarmi pone piede a terra; invano i !anzi seguiti tlagl' italiani e dai provenzali , combauono con immenso ardore contro la fanteria spagnuola e tedesca tripla di numero; circondati da ogni parte sono tagliati a pezzi; tuuo l' eser· cito è disperso; ed il re, dopo aver dalo prove di somma prodezza; cadde llrigioniero de' nemici, pe.t'duto tutto fuor elle l' onore.
La gun.rnigione, uscita da Pavia sotto gli ordini di An· tonio De Leva, aveva parte alla pugna.
Ouervazioni. La causa principale della sconfitta de' francesi fu l'impeto sconsiderato col quale il re si gettò innanzi . colla cavalleria, interdicendo l' azione all' artiglieria, e non va !endosi n te mpo . deli' opera dei fa n ti . Epoca: Febbrojo t
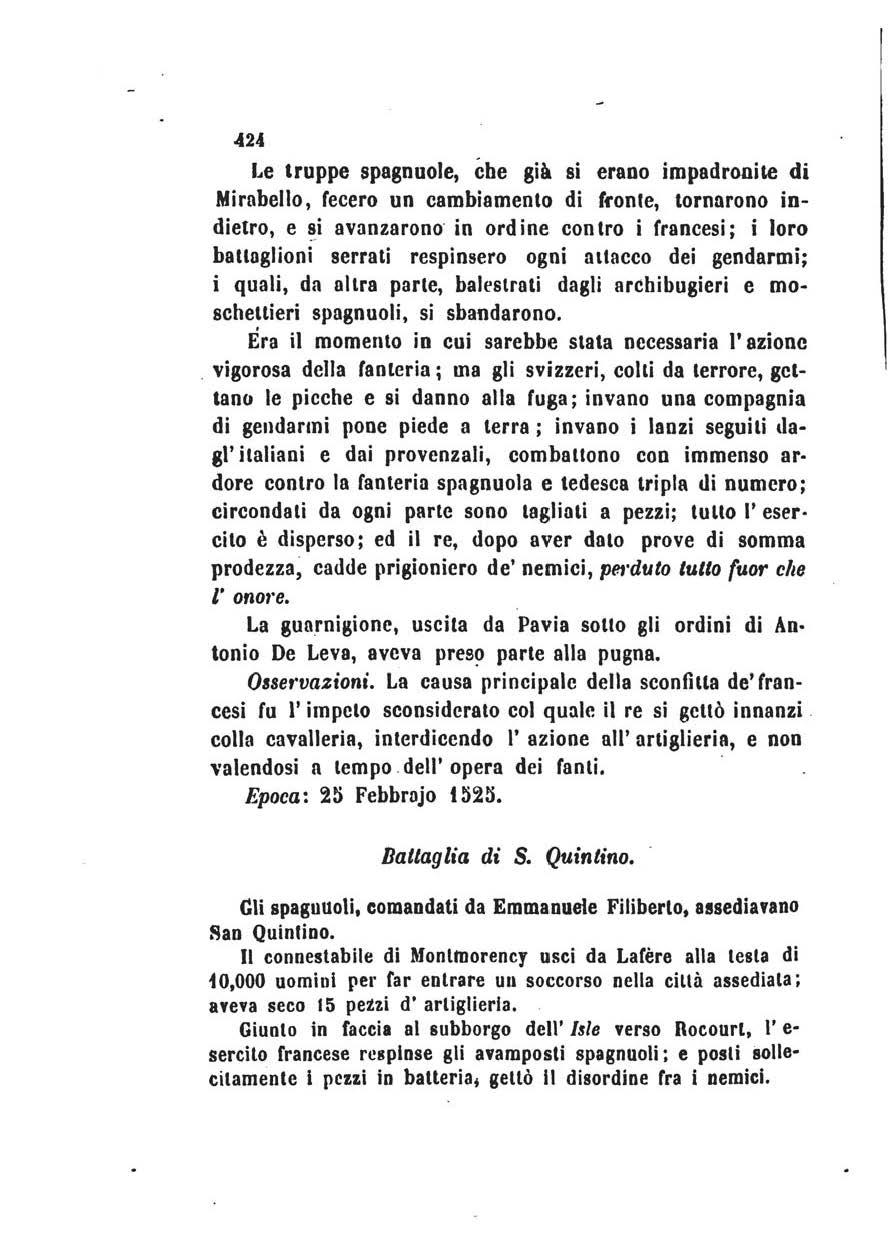
Gli spagnuoli, comandati da Emma.ouele Filiberto, assedianno San Quinlino.
Il eonnestabile di Monlfnoreney usci da LaCère alla testa di iO,OOO uomini per far entrare un soccorso nella cillà assediata; neva seco 15 petzi d' artiglieria. .
Giunto in faccia al subborgo dell' /sle verso Rocourl, l' e· sercito francese respinse gli avamposti spagnuoli; e posti sollecitamente l pezzi in batteria. gettò li disordine fra i nemici.
425
Tra l' esercito di soccorso e S. Quintioo eravl una palude : tra euo e 81i spagnqoli la Somma. Per far il soccorso, eransl .condotti su carrette parecchi battelli llestinali a trasportare i soldati nella piazza: ma queste carrette, invece di essere poste alla testa, furono messe in coda della colonna ; di modo che si aspettarono per due ore, e i battelli medesimi, carichi poi di soldati, non poterono approdare .
Gli spa«nuoli ebbero tempo di rinvf!nire dal primo sbalordìmeolo; ·fecero un giro intorno alla città, e sboccarono per una stretta che si tronva alla destra dei francesi, e che da questi non era st,ata occupata.
l francesi si r·tlirarono precipitosamente; e formarono una retroguardia di due com pago ie di gendarmi, spiegati sopra di un solo rèngo, per proteggere la ritirata.
Allora gli lanciarono contro di essi la cavalleria divisa in otto grossi squadroni'; 2000 cavalli caricarono il fianco sinistro dei francesi, 1000 raitri e tOOO uomini d'arme il ftanco diritto, 3000 cavalli il centro. Questi grossi squadroni respinsero agevolmente la cavalleria distesa in ordine sottile: la fanteria francese fece un po' di re11istenza, ma poscia venne rotta e tagliata a pezzi.
Tulla l' artiglieria francese rimase in potere del nemico. Le cause principali di questo risultato furono le seguenti : t . 0 Il non avere custodila la stretta per la quale gli spagm1olì potevano pallare; 2 .0 La ritirata precipitosa, non prolella da solide truppe, ma soltanto da 8endarmi io poco numero e disposti io ordine non consistente.
Epoca: i o Agosto
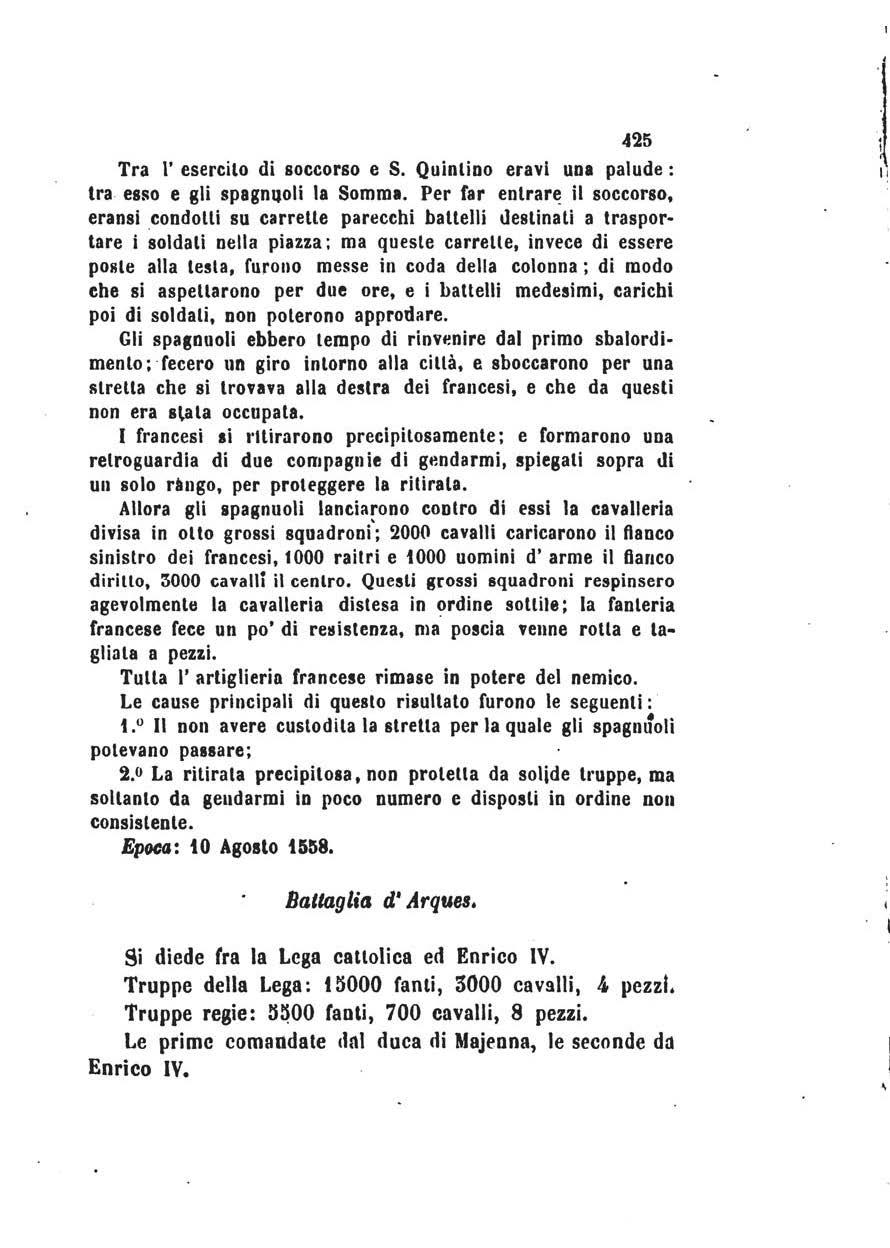
Si diede tra la Lega cattolica ed Enrico IV.
Truppe della Lega: t 5000 fanti, 3000 cavslli, 4 pezzi.
Truppe regie: fanti, 700 cavalli, 8 pezzi. Le prime comandate tini duca di Majeona, le seconde da Enrico IV.
.t2(1
Enrico, saputo lo avvicinarsi del nemico, esce da Dieppc dopo averne la difes3 , c va ad occupare. la posizione di Arqucs ali una lega e mezzo dal paese. Il terreno era prossimo allo sbocco delln Eaulnc e della Bethune nel torrente di t\rqucs; era fiancheggiato da unn foresta in una parte, da terreno paludoso nell'altra io riva dell' Eaulne; traeva protezione dal villaggio e dal castello di ArqueS' in cui trovavasi qualche pezzo d'artiglieria; e veniva pur anco rioforzala da due trinceramenti. Il primo si stendeva in linea retta da una coppella , che @li serviva di ridouo, fino al bo· sco; il secondo, tracciato sulla forma di fronte bastionato, appoggiavasi da una pa rr tc ad una folta siepe di 'Spini che costeggiava la via da Arqucs c Martin-Eglise, e dall'altra alla foresta.
La disposizione delle truppe regie. era.la seguente:
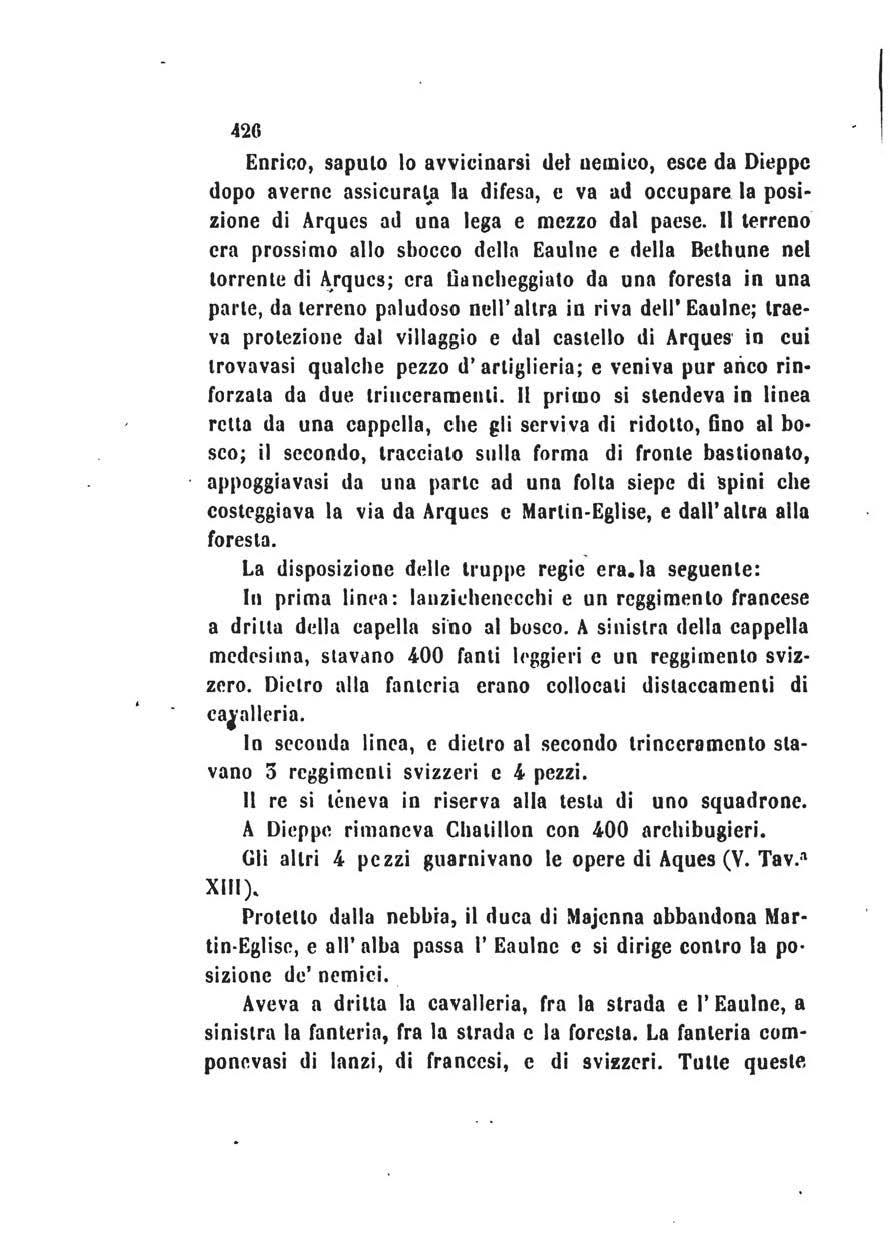
In prima lim·a: lanzichenccchi e un reggimento francese a dritta della espella srno al bosco. A sinistra della cappella mcdrsima, stavano 400 fanti ll•ggie1·i c un reggimento svizzero . Dietro alla fanteria erano collocati distaccamenti di cal·nllcrin.
lo seconda linea, c dietro al secondo trinceramento stavano 5 reggimenti svizze1·i c 4 pezzi.
Il re si téneva in riserva alla test11 di uno squadrone. A rimaneva Chatillon con 400 archibugieri.
Gli allri 4 pezzi guarnivano le opere di Aques (V. Tav.;\ Xlii) .
Protetto dalla nebbia, il duca di Majcnna abbandona Mar· tin·Eglisc, e all'alba passa l' Eaulnc c si dirige contro la po· sizionc dc' nemici . .
Aveva n drilla la cavalleria, fra la strada e l' Eaulne, a sinistra la fanteria, fra la strada c la foresta. La fanteria componcvasi di lanzi, di francesi, c di svizzeri. Tutte queste
• • .427 truvpc erano disposte su parecchie Dell' artigli eria, crnnvi soltanto 4 pezzi; gli altri furono lasciati di là dall' Enulne.
Avvicinatasi la cavalleria della LPga, il conte ·d, Auvergne l'assale co' suoi cavalleggieri e melle in disordine ma soppraggiuntivi altri , D' Auvcrgne dovè rit iritirarsi dietro alla fanteria della prima linea.
Intanto la fanteria della Lega si era approssimata alla prima linea delle truppe regie, le quali si preparavano a eombatlerla, allorquando videro parecchi distaccom<'nti di !anzi nemici che dal lato della foresta le minacciavano il fianco diritto; ma avendo questi lanzi gridato di voler passare a parte regia, furono ricevuti senza che prima si disarmassero. Appena entrati nel campo del re, i lanzi della lega abbasso•·ono le picche co"tro la fanteria r egia, hr quale assalita così di fronte c di fianco, abbandonò la linea trincerata sino alla cappello.
Lu fanlel'ia svizzera, alla sinistra dt•lla cappella medesima, si difende .,·igorosamcnte, cd obbliga col suo fuoco la eavaJeria nemica, che ha in faccia, a piegare o dt·itta, ovt•, l.Jo· vandosi impacciata in luoghi paludosi, è costretta a por piclle a lt•t·ra fra la ·mclmfl, e in tal guisa si trova nell' imposs ibilità tli pigliar paa·tc ulteriore all'azione.
Ma vedendo che la fanteria di dritta sì ritirava pel tra· tlimcnlo dei !anzi, gli svizzeri, minacciati al fianco dest1·o dalla .fanteria nemico che si a·vanzava, cominciarono a pensare alla ritirata; quando verso le undici la nebbia si dilegua, il campo si scuopre, i cannoni del re aprono il fuoco , e i soldati dello ·Lr.ga si arr es tano. Enrico IV coglie questo mom e nto per rnnnoda1·c le truppe della prima linea e ricondurle all'assalto.
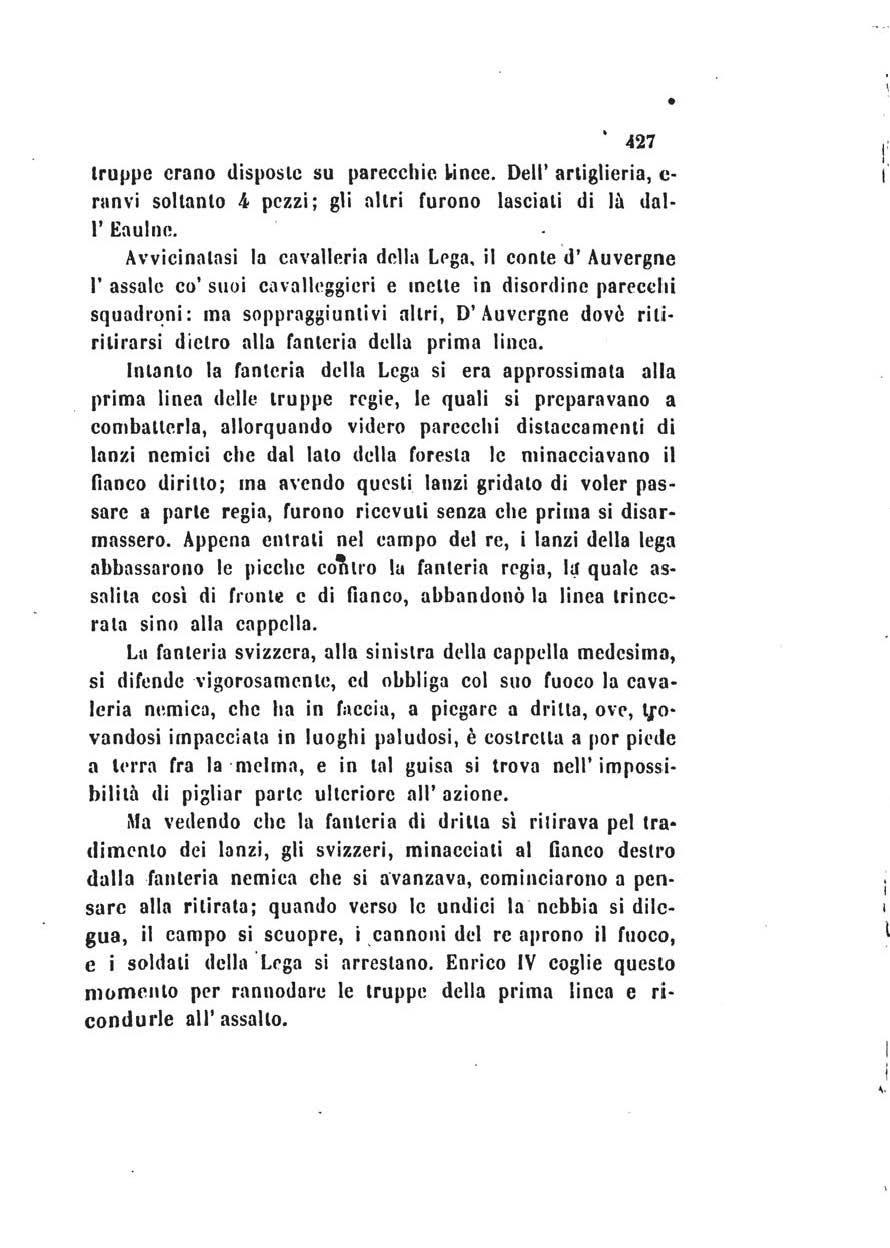
.428
NeUo stesso tempo, Chatillon, che nl rumor ·del cannone lasciava Dicppc, arriva co' suoi archibugieri, e, sostenuto da allrc truppe, riprende d'assalto la cappella di già perduta. Tuua lo prima linea è ripigli ata dalle truppe regie, e quelle della Legà ne respinte. ,
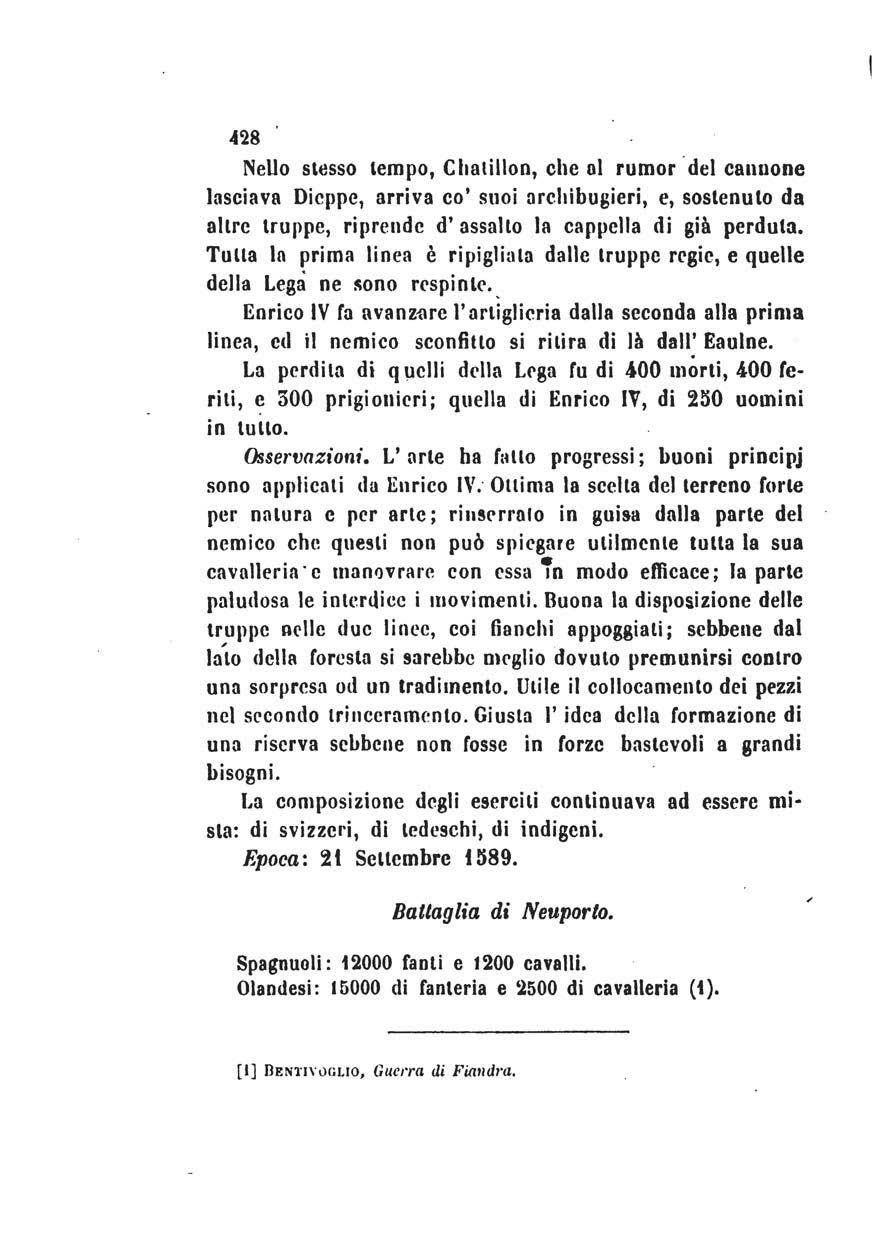
Enrico IV fa avanz-are l'artiglieria dalla seconda alla prima linea, cd il nemico sconfitto si ritira di là dall' Eaulne.
La perdita di q della Lrga fu di 400 morti, 400 feriti , 500 prigionieri; quella di Enrico IV, di 250 uomini in tutto.
Osservazioni. L' arte ha fallo progressi; buoni priocipj sono applicati da Enrico l\'; Ottima la scella del terreno forte per natura c per arte; rinserrolo in guisa dalla parte del nemico che questi non può sp iegar e utilmente tutta la sua cavalleria· c con essa lfn modo efficace; la parte paludosa le i movimenti. Buona la disposizione delle trupp e nelle due lince , coi fianchi appoggiati; sebbene dal la'to della for esta si sarebbe meglio dovuto premunirsi contro una sorpresa od un tradimento. Utile il collocamento dei pezzi nel secondo trinceramento. Giusta l'idea della formazione di una riserva sebbene non foss e in forze bastevoli a grandi bisogni.
l.a composizione degli eserci ti continuava ad essere mi· sta: di svizzeri, di tedeschi, di indigeni.
Epoca: 2t Seucmbre t:S89.
Spagnuoli: 12000 fanti e t200 cavalli.
Olandesi: t5000 eli fanteria e 2500 di cavalleria (1).
(1 ) DENl' l\'ùGLIO, Guerra di Filmdm.
.-
Comandante dei primi era l'arciduca Alberto d' Austria; dci secondi il principe Maurizio ùi Nassau. Maur izio, sapendo che l' esercito spagnuolo era in preda alla diserzione ed al disordine per ritardo d i pagamento di soldo, e che era di11perso ne' suoi accan tonamenti, deliberò di trasportare· la guerra in Fiandra, siccome la provincia che somministrava al nemico più grosse conll'ibuzioni; e credè di potersi impadronire di Neuporto prima che l' arciduca Alberto, a cui Filippo Il cedeva le sue provincie dei Paesi bassi ed altri domioj, pote11se soccorrere la eillà. Giuntovi solto le mura, vi si trinciern con tnlta cura, per chiudersi tra linee di circonvalla· zione. Ma l' al'ciduca riunisce .olla·e tO,OOO fanti e oltre 1500 cavalli, e corre sulle tl'acci e del principe Maurizio, risoluto di stringerlo al mare, o d' obbligarlo a raggiungere in disordine i suoi vascetH. Già aveva rovescinto là vanguardia olandese che gli voleva contrastare il passo di un ponte fra Ostenda e Ncuporto; e credendo sorprendere il neft'lico, si avan1.ava sulla riva del mare, facendo trainare sulla spiaggia otto pezzi d' artiglieria; allorquando il principe Maurizio, venuto in cognizione del suo avvicinarsi, volge la fronte indietro, si pone in battaglia innanzi al tùlmicello che forma il porto della città, ed appoggia la sinistra al mare . Il suo esercito è schierato su Lrè linee; sei pr,zz i .d ' artiglieria vengono mt>ssi io ballaglia sulla spiaggia, piantati su graticci affinchè non affondino nella sabbia; altri due pezzi sono collocati vantaggiosamente su di una duna; alcuni cannoni da campagna vengono nascosti dietro la cavalleria pt>r tirare all 'i m·· provviso; flualmeutc i vas ce lli olandesi flancheggiauo tnttn la linea di battaglia.
La cavalleria, cb e precede l'arciduca , comincia l' assalto; p;li olandesi la lasciano poi smascherano lutto ad un tratto la loro arlìglieria, la quale, facendo part'ccbie scariche micidiali, la a ritirarsi.
Intanto le truppe erano alle prese da ambo le parli so tutta la linea; si combatteva c:on accanimento. La marea che montava, e la balleria collocata sulla riva del mare, obblìgano l' arciduca a portare il suo attacco principale sulle dune, alla diritta di Mauma queali fa subito avanzare la seconda linea. Nondimeno
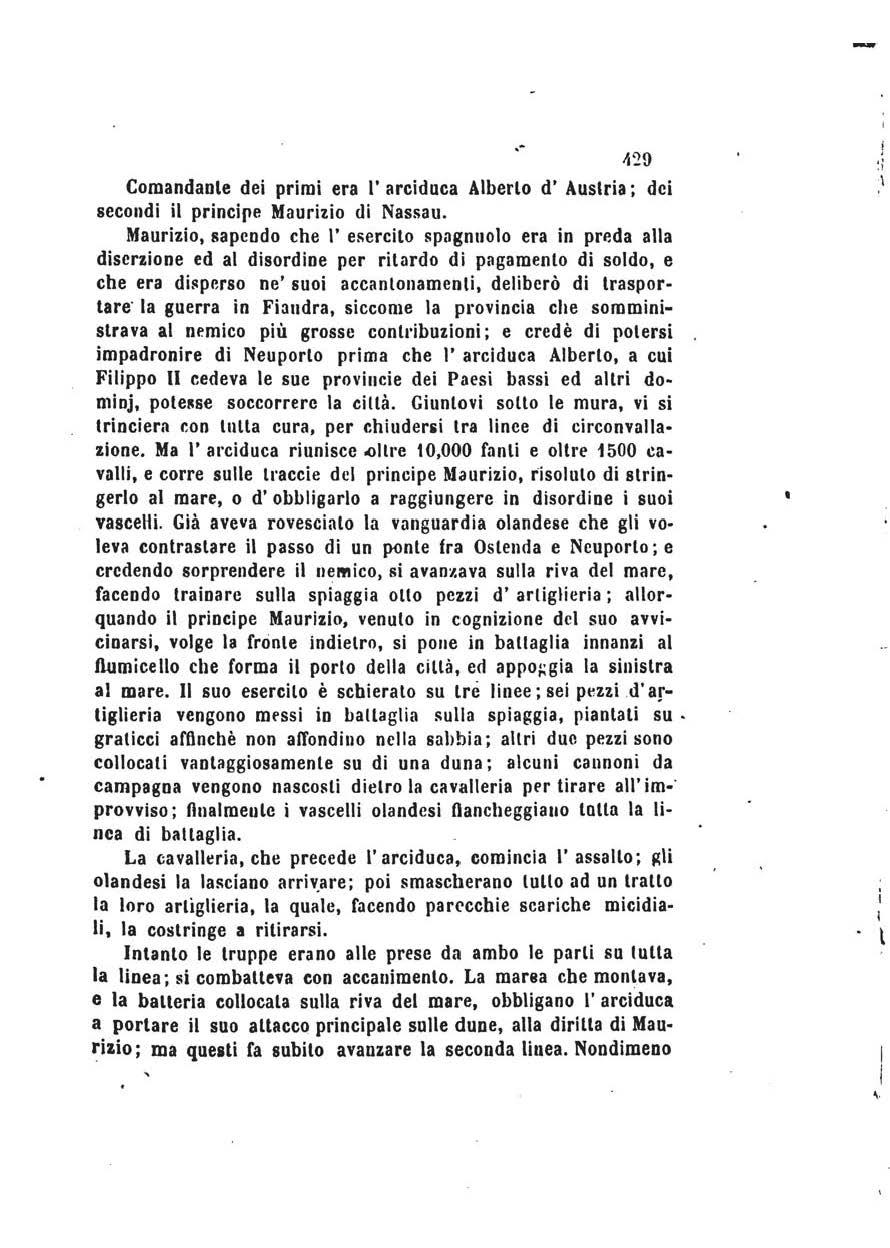
•
430
gli olandesi perdono terreno, e la vittoria è dubbiosa, allorch è la riserva, anivaodo, ripose il comballimenlo in migliori condi· zioni. • O vincere o gittarsi nel marl', • erano le pat'o le con cui 1\laurizio eccitava l' ardot·e delle truppe. Malgrado però le cariche fo t·tunate della cavalleria oland ese, l'ostinata fanteria Rpagnuola, rhe aveva consentilo a marciare dopo alcuni patli conclusi coll' at·ciduca, resi s teva ancora . Allora i cannoni della flotta la bat- · tono di rovescio, la fanno vacillare, ed un nuovo a11sallo generale ordinato da che è circ:ondato da gran numero di volontarj francesi, dec ide la \'itloria. Gli spagnuol i so Q. posti in rotla; ·l'arciduca fuFge a Brugcs lasciando sul campo .iOOO morti, 600 prigioni er i, 100 bandiere, 8 cannoni, ed i bagagli. Le truppe di Maurizio t•bbero 700 ferili, e 1500 morti.
Osscrvazio11i. La vittoria c dovuta all' ordine di battaglia addollato dal principe ordine che gli perm ise di ripat·are senza interruzioni a balloste parziali. J,a posizione vantaggiosa dell' artiglieria di terra e di mare, ccmtt·ibui all'esito della gior· nata. c gli spagnuoli medesimi riconobbero la superiorità delle disposilioui dell'eroe olandese: perchè l' ammiraglio Mendoza, fallo prigioniero io questa battaglia, non S•llo rimproverò alla sua cavalleria di non aver fallo il suo dovere, ma si dolse inol· tre pcrchè • le truppe erano andale lutle in grosso alla carica • • senza trnere sulla fine qualche retroguardia o riserva, afOne • di soccorrere di quà e di là gli squadroni ed i battaglioni, • quando erano costrelli a rinculare o a prendere la fuga; c in • questa guisa rnccoglierli per fare una nuova carica, come aveva • fallo il principe Maurizio, adoperando saggiamente- c rispar· • miando In sua fanteria e la sua ..:avalleria senza avventurare • tutte le sue forze ad un tempo. Egli lodò pure il principe • Maurizio per avere collocalo tanto In sua artiglieria, in modo da r eca re grave danno al nemico. • (l)
Epoca: 2 luglio 1600.
[ l ) 11 •1 :'\AI'AIITE, Slll' l' (II'(Ì/lt'rit!.
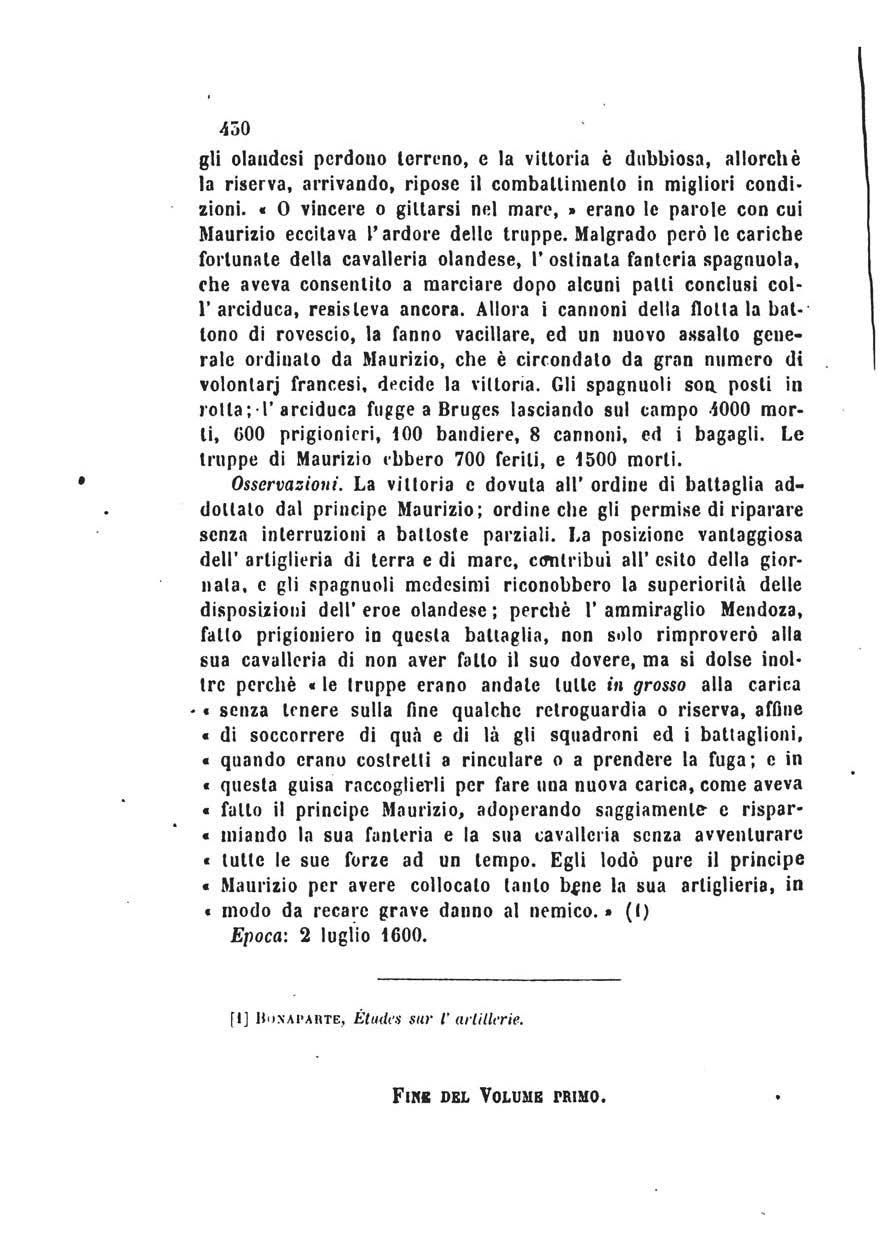
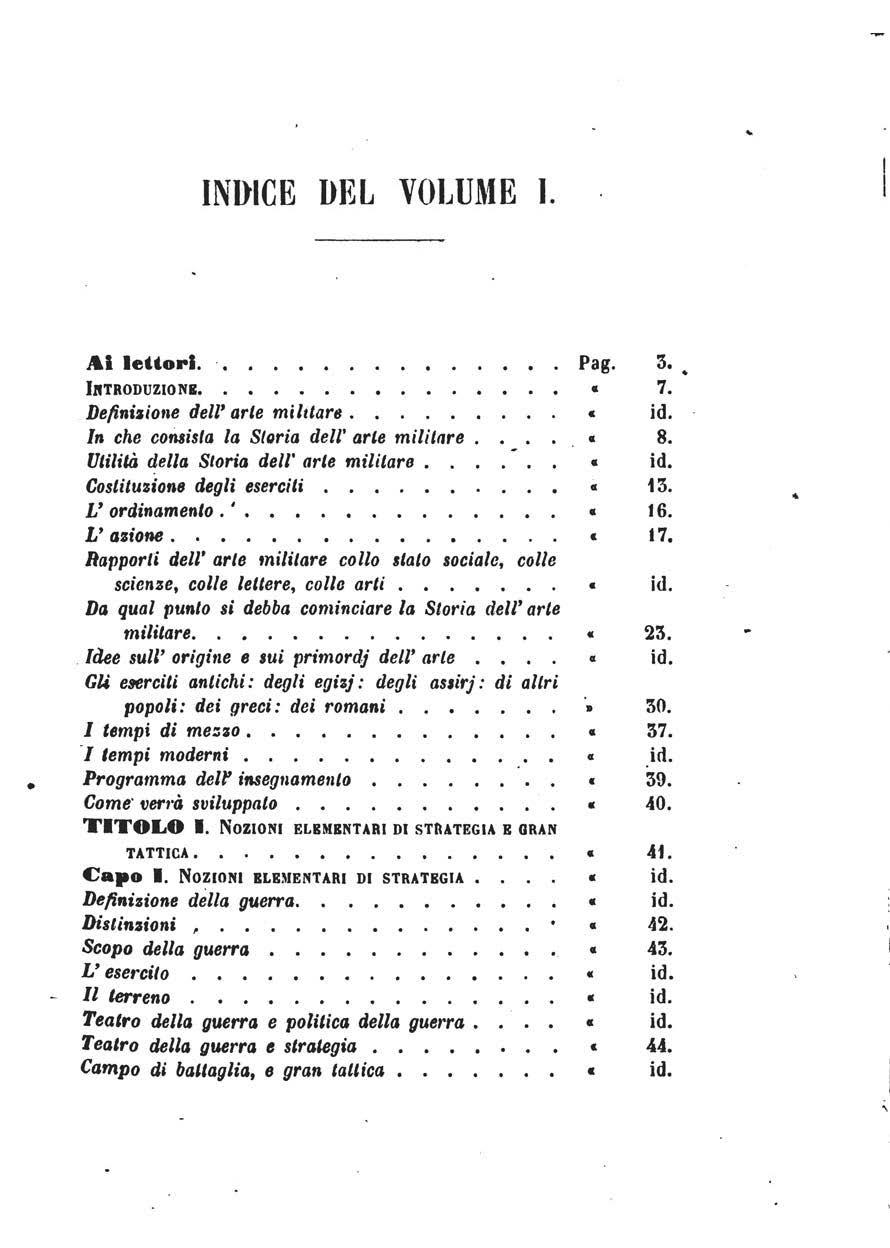
lettori. .
IJtTRODUZIO Nl.
DefìniJione dell'arte militare
In che comista la Storia dell' arte militare
Utilità della Storia dell' arte militare
Pag. 3.
7.
id.
8
id.
13. L' ordinamento .
Costituzione degli eserciti
f6 L' tnione.
Rapporti dell' arte militare collo llato 1ociale, colle scienze, colle lettere, collo arti
Da qual punto si debba cominciare la Storia dell'arte militare.
Idee sull' origine e • ui primordj dell' arte
Gu antichi: degli egizj: degli auirj: di altri popoli: dei greci: dei romani
l tempi di me.::Jo
J tempi moderni
Programma delt' imeguameuto Come· ver,·à sviluppato
TITOLO l. NoziONI ELBMBNTARI DI STRATEGIA K ORAN TATTICA.
Capo l. NoztOI'II DI STRATEG I A
Definizione della guerra.
DistinJioni ,
Scopo della guerra
L ' esercito
Il terreno
Teatro della guerra e politica della guerra
Teatro della guerra e strategia
Campo di ballaglia, e gran tallica
7. id
23
id. 30. 37. id. 39
o.
t. id
42.
id id•
id.
Base di operasio1•i
Punti strategici: obbjettivi Li11ce di operasioni
Linee di comun;casioni, fronte di operaziot1e, fronte •trategica, lirtee di difesa, punti di rifugio
La logistica
Della guerra offensivo, della guerr·a difensiva e della olfensivo-difen•iva
Còmpito del Generale in capo
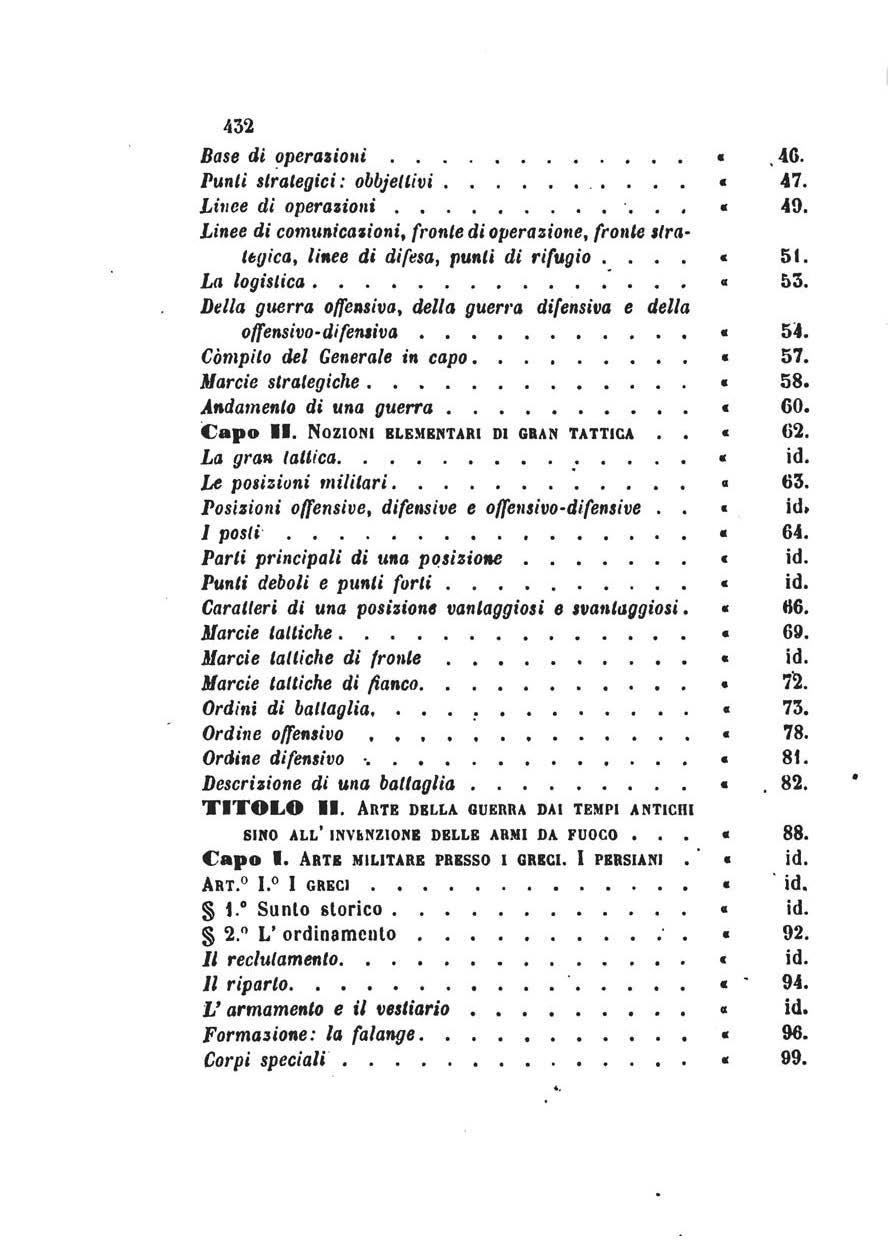
Marcie strategiche
Andamento di una guerra
(:;apo Il. NOZIONI BLEMBNTARI DI GIAN TATTICA
La graA tattica.
Le po1iziuni militari.
Posizio11i offensive, difensive e offeluivo-difensive l posti
Parti principali di una
Punti deboli e punti furti
Caratteri di una posizione vantaggiosi e •vantaggiosi
Marcie /altiche
Marcie tattiche di {ro11te Marcie tattiche di fianco. Ordini di batlaglia.
Ordit1e
Ordine difensivo
Descrizione di una battaglia
TITOLO Il. ARTI DILLA OUKRRA DAl TEMPI ANTICRI
SINO ALL' INVIINZIONB DILLI ARMI DA FUOCO
id.
Capo l. ARTI MILITARE PRESSO
ORICI. I PERS IANI ABT.
GRECI
Sun to storico
L' ordinamento
reclutamento.
riparto.
armamento e il vestiario FormaJione: la falange.
Corpi speciali'
id. id.
id.
id.
IstruJiorte ed escrciJj
Dirtiplina: e ricompenre.
Ammi•iltra,llio•e: soldo
Macthine.
FortificaJioae
§ . :S.• L' aziooe
Sludio delle porisioni. .Accampamenti
Ordini eli battaglia Jloclo eli combaUwe A.mdj.
§ . .t.0 Osservazioni
Carattere difensivo delltJ falange: e perchè
Come siasi rviluppata la sua formaJione
Utilita clelia falang e
Stl6ataggi.
TaUica e strategia. Stratagemmi.
RappDrlo della rciera::a ed arte militare clei greci colle altre 1cienJe e colle altre arti
Cenni biografici: SertO fume. Epaminonda
4/euandro
Cenni bibliografici
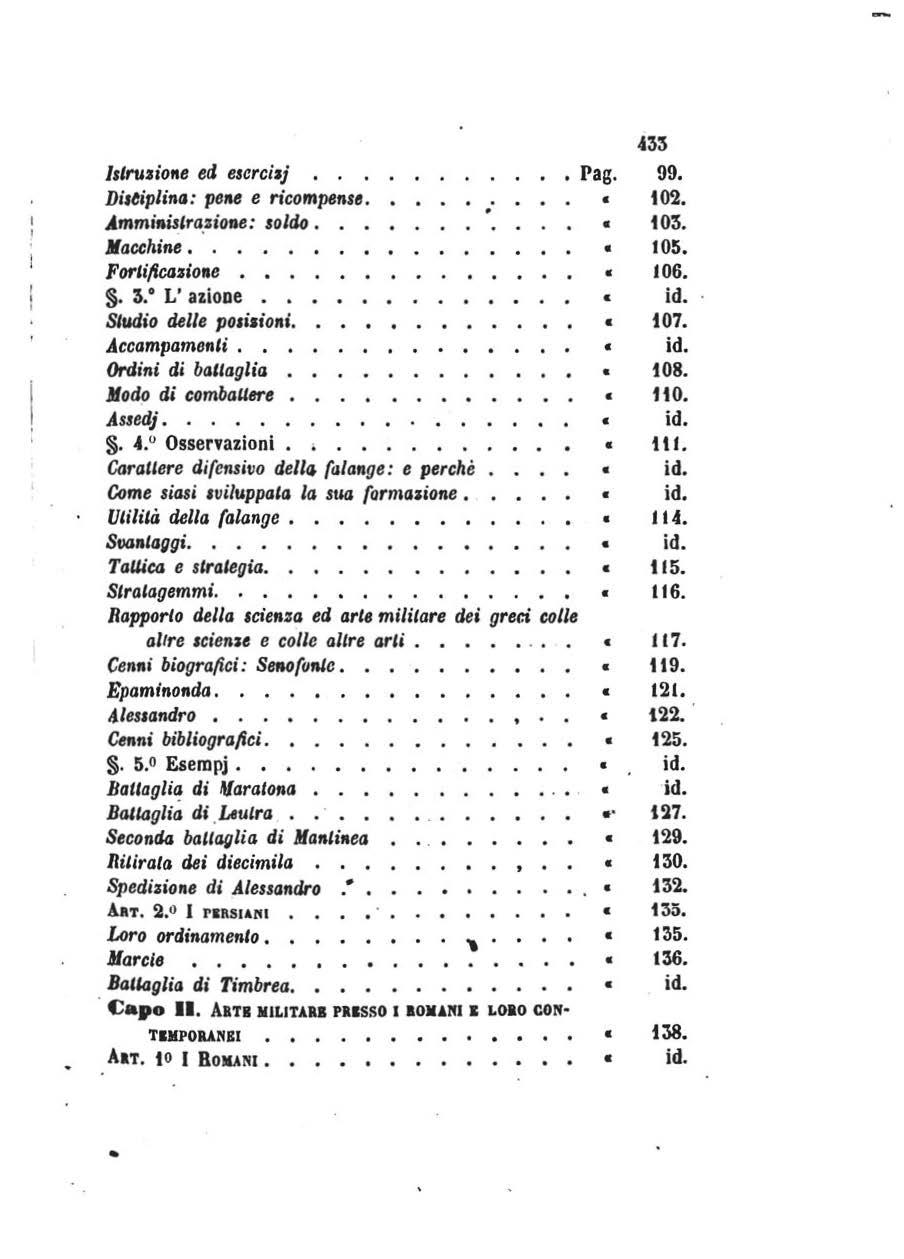
§. 5.o Esempj
di Varatona Battaglia di
Ltulra Seconda battaglia di Maratinea Rilirata dsi diecimila
SpediJione di Alessandro
AIIT 2.0 I PlllSIAl'll Loro ordinamento
Jlarcie
BaUaglia di Timbrea.
ABTI MlLITUI
TIJIPOI.ANBI
AlT. t O l BollA
Pag.
4:'i4
§. t o Sunto storico §. 20 L'ordinamento
Il reclutamettto
Il riparto
L'armamento e il L' .La legions
Gli eserciti coMolar.i
Mutamettli nella operati da Mario Mutamento introdotto àa Cesari
Mutamenti ai tempi di Adriano
Di Alessandro Severo
Di Yalentiniano Il ossia di Yegesio
Gerarchia militare
U(ficj e cariche
Insegne
Esercizj
Strumenti militari.
Amministrazione: soldo
Pag. t38. c r.t8.
id.
1.52.
t53.
t55.
t56.
t58
160.
id. c t6t.
t63.
t64.
c t67.
t68
id.
Discipliu: pene s ri<:ompense
c t 73.
t 70. Macchine.
id. §. 3° L'azione
t74
id. Piani di guerra
Modo di dichiarare la guerra
t 75. Accampamenti
t 76. Marcie.
t79. Modo di combattere
t80. Ordini di battaglia
t 83. Azione intorno alle {orteue c t85. Segnali di guerra
t 87. Pauaggio dei fiumi
id. §. 4.0 Osservazioni
id. Carattere della legione: e perchè
id. Modifico.•ioni ttegli ordini ài batt<Jglia
188. Cono della falange s della battaglia d4 PidM
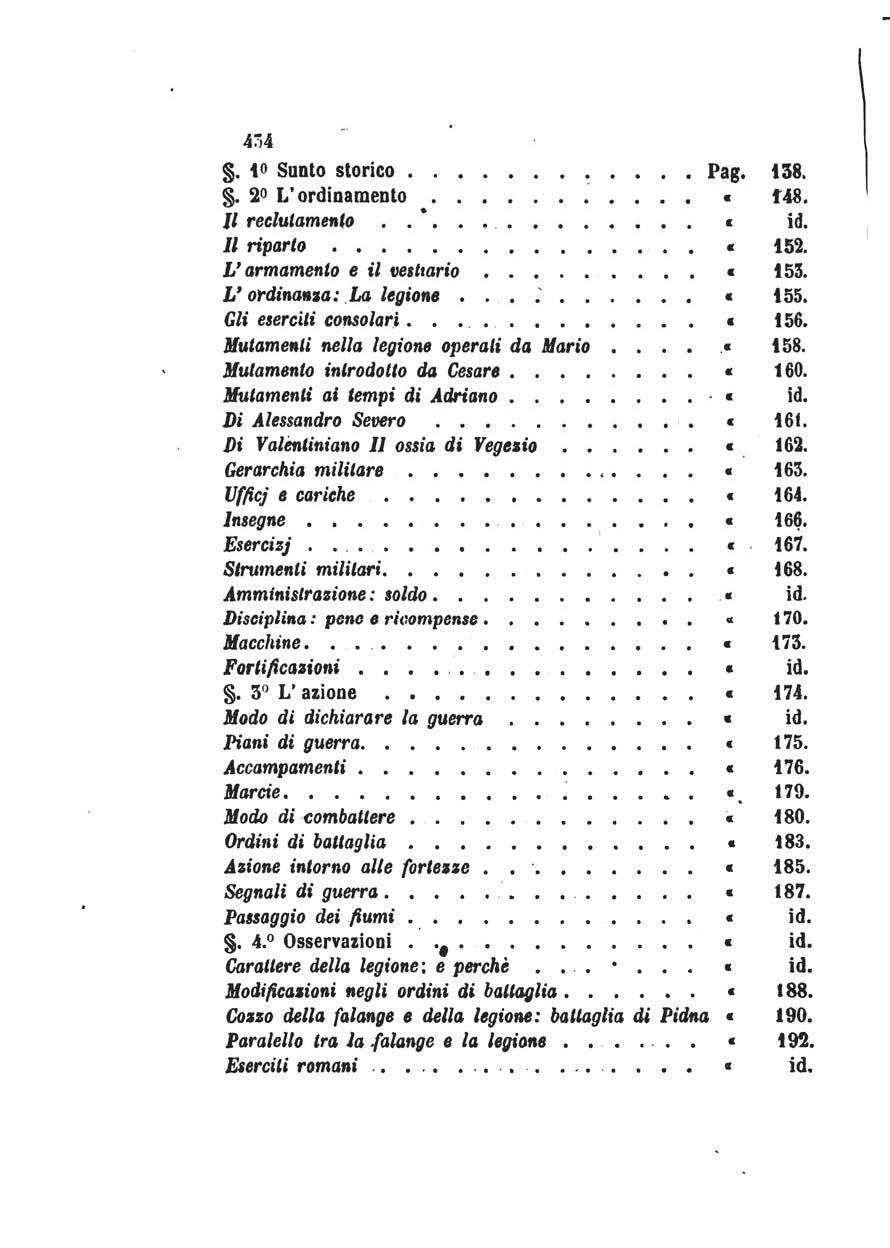
190. Paralel/o tra Ja {aùmge B lo. legiotts
Eserciti romani
id.
Decadimento dells miliaie romaM; motivi
Pag. .Rapportt della scieua ed arte militare prmo i romani colle altre 1cienae e le altre arli
Strategìa e tattica.
Osservazioni di NapoletJne sui campi romani
Stratagemmi
Superllizio11e
Cenni biografici.
Ce1are.
Cenni bibliografici.
ART. 2.0 l CONTEMPORA.NRI DRI ROMANI. ESRMI'I
§. a.o l cartaginesi e le guerre puoicbe
Eserciti cartaginesi
Motivi di guerra Ira Cartagine e Roma t, a Guerra punica.
2. 3 Guerra punica
di Annibale
Base d' operaaiotte, linee di operazio.11e, obbiettivo
Marcie
Combattimento del Ticino
llattaglta della Trtbbia
NuotJa base d' operaaione per Annibale Nuove linee di operazione Battaglia del TrtUimeno
Battaglia di Camte
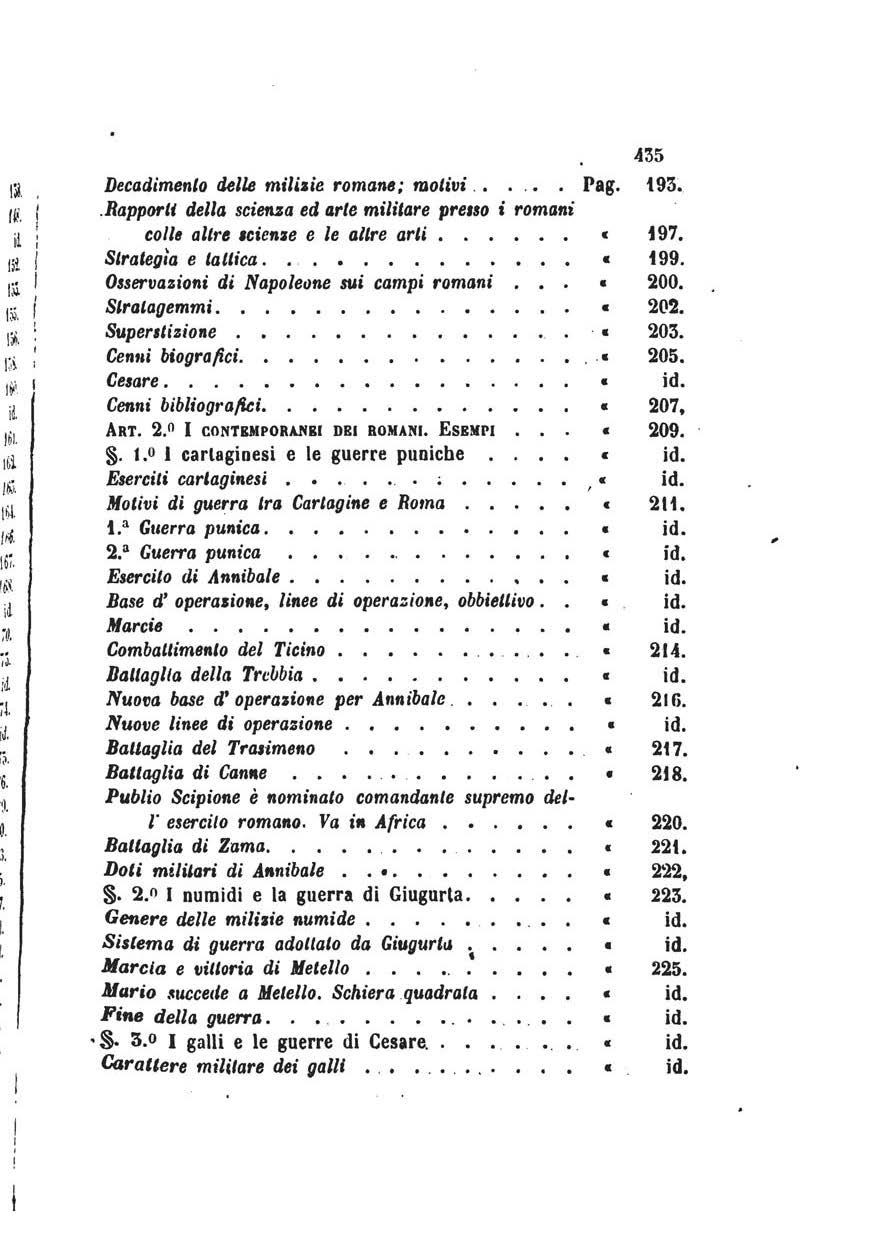
Publio Scipione è nominato comandante supremo dell' esercito romano. Va itt Africa Battaglia di Zama.
Doti mi/ilari di Attnibale
§. 2.fJ I numidi e la guerra di Giugurta. Genere delle miliaie numide
Si1lema di guerra adollato da GiugurtcJ
Marcia e di Jletello
Mario a Metello. Schiera .quadrata Fine della guerra
§. 3.o l galli e le guerre di Cesare.
Carattere militare dei galli
209. id. id. 211. id. id. id. id. id.
.436
·Loro milisie.
Loro guerre contro Cesare. Pottle sul Reno
()pere eseguite iflltrM aà .Aiesia.
4.0 Gli spagouoli
Loro milizie
Loro guerre
5.0 l p.1rti e le guerre di Crasso e di Antonio
Loro Milisie
Come Crasso abbitJ condotto la guerra
Come abbia guerreggiaiQ Anto11io
6. 0 I ge
Loro eaerciti
l.Moghi (orti
mani
1.0 Suolo storico
. 2.0 Ordinamenti diversi.
goti
Loro armametsto, cariche mili· lari
istruzione mi/ilare, uipendj
longobardi
Loro ordiaatmfllo sociale, po/Uico, amminislratiH, e militare
Reclutamento
Armamento
Ordinaua
Cavalli nella mili:sia Viveri, stipendio
Ricompense e punizioni.
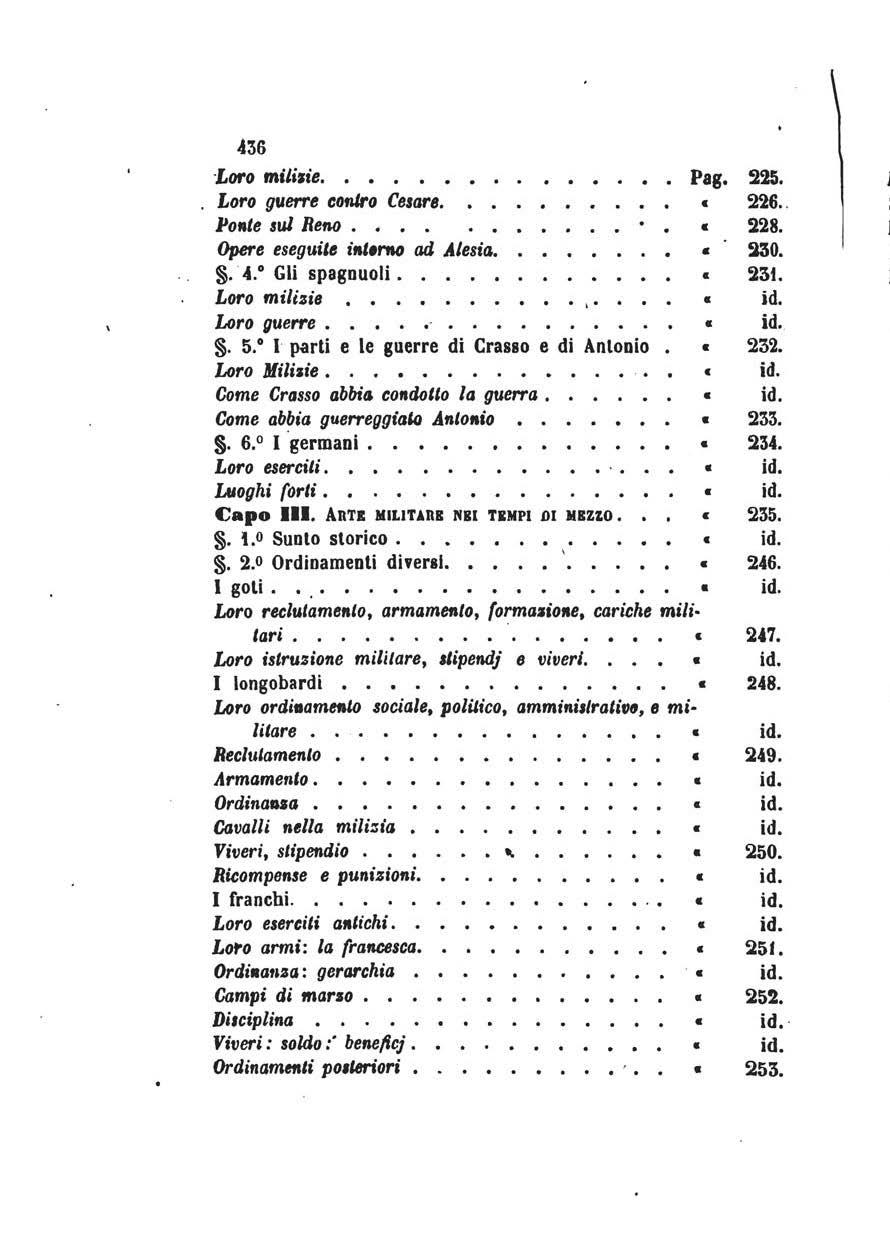
franchi.
Loro eserciti arctichi.
Loro armi: la franc8sca. Ordi•atJza: gerarchia
Campi di marso
Di1ciplina
Viveri: soldo:· beneficj
Ordinammti posl8fiori
235. id. 246. id. 267 id. 248. id. 249. id.
Reclutamento, armamenl6, punisi!Jne
Somministrasio•i .
ag. 253.
254.
id. lSI. Loro milisie, loro armi, loro duciplirta
I Saraceni .
255. l Normanni.
id.
id. il Milizie feudali
Loro impresB
:.J Origine della cavalleria
id. Riti per esrere creato ca valliere
id . l bandere1i : i Baccellieri
257. !oi. Gli uomini à' arme . .
258. Fanteria feudale . . .
id. i.J. Esercisj: tornei, gio1tre, passi à' arme.
259. id Milizia Comunale .
260. Sua origine . .
id. iL Milisia comunale in Italia
id. Reclutamen to . .
id. iL Armamento. . .
id. Cavalleria dei comu•i
26t. Il Carroccio
id. Capi militari . .
262. i' l Soldo: stato della dircipli•a
id . MiliJie comunali in Frattcia
263. id. I venlurieri.
id. Loro origine . . . .
id. id Reclutamento
id. id. Compagnie diverse ita Italia .
264. iJ. Compagnie diverse in Francia
265. Areieri inglesi
id. IJ. Loro armi .
id. id. Fanteria svizzera
id. id Sua origine
id. 2jl. l grotsi battaglioni
266. id. La diseiplina : risorgimento dell'arte militare
id. 1jt .Servi;io sanitario nd medio evo
id. id. Macchine . .
267. Fortifìcasiorte \ 268.
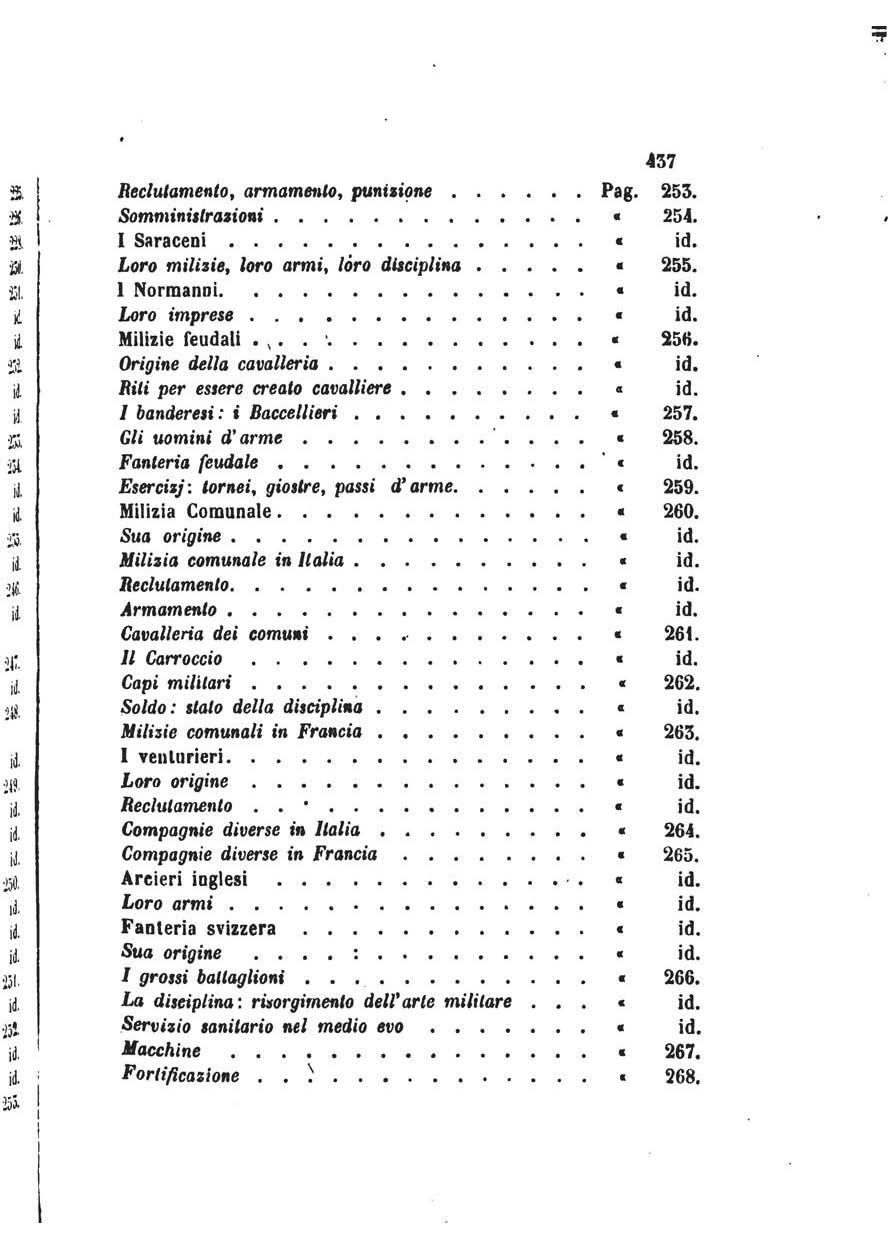
438
§. 3'' L'azione. •
Modo di combattere dei barbari .
Prevalensa della cavalleria Mutamento del sistema antico e sostituziofle del feudale Modo di combattere nel feudallsmo: la spalliera
Le crociate: lol'o in{lu.so 1ull' arte militare
Come debbasi considerare la milizia comunale in azione Modi di trallare la guerra dai comuni in Italia
Come adoperavasi la milizia comunale in Francia
Come combattevano gli arcieri inglesi
Come combattevano gli svi:ueri §. 4° La polvere .
Le prime armi da fuoco §. Osservazioni
Epoche di ctist•·uzione, e di tendenza al rinnovamento Principj ·,u cui 1i fondavano i reclutamenti dei bar· bari e collo svilupparsi del feudalismo
Principj del reclutamento comU11ale
Principi dtl reclutamento de' venklrieri
Le unità la tliche .
Rapporto della condisione dell' arte militare con quel· la delle 1cienre e delle iltituJioni sociali Ceftni biografici : Carlomaano
Cenni bibliografici . §. 60 Esempj
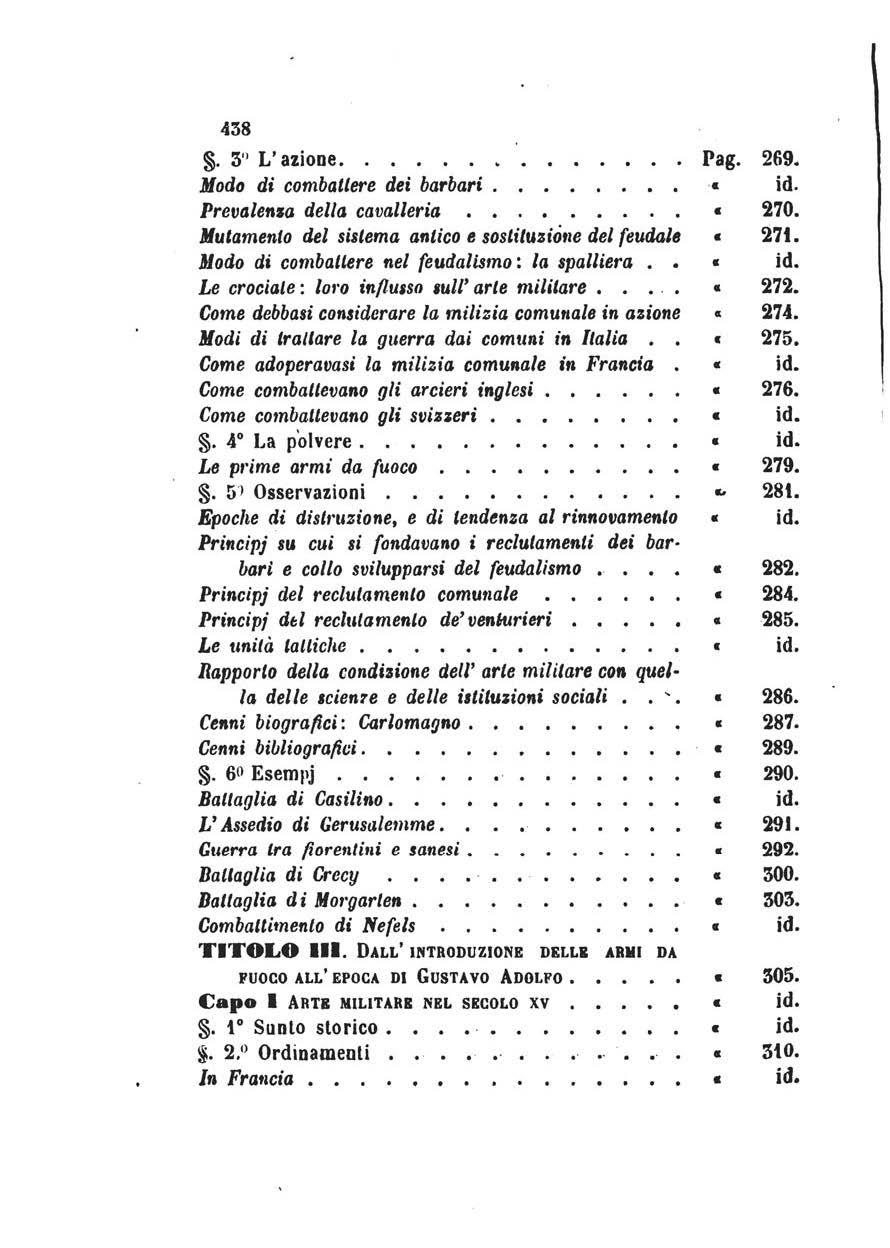
Battaglia di Casilino
L'Assedio di Gerusalemme.
Guerra tra fìorettlini e sanesi . Battaglia di Crecy Battaglia à i Morgarlen
Combattimento di Nefels
TITOLO 111. DALL' INTRODUZIONE DELLI ARIII DA FUOCO ALL'EPOCA DI GUSTAVO ADOLFO.
Capo l ARTI MILITARI NBL SECOLO
§. 1° Suolo sLorico
2.0 Ordinamenti
In Fraflcia
Pag. 269.
id.
270.
27t.
id.
272.
274.
275
id.
276.
id.
id.
279.
28t.
id.
282.
284.
285.
id.
286.
287.
289.
290.
id.
291.
292.
300.
303.
id.
305• id• id. 310• id.
Sotto Carlo il temerario
Ira Italia .
In l1vi:uera .
Ira Germaflia r.. flpagna
Anni da fuoco • Fortificaziorti . §. L' azione
MoM di e di marciare
/fl/lUSIO delle armi da fuoco 1ul modo di comballere
della cavalleria
Ordini di ballaulia
Modo di comballere degli svizzeri Uso della trincera
Attacchi delle mura .
§. 40 Osservazioni
Tran1izioni ..el secolo
Sulr influsso delle armi da fuoco · Rapporto dell'arte bellica colla conda:;ione degli studi scientifici e letlerarj
I capitani del secolo xv·
Attendo/o S{urza e Braccio da Montone Ce.•i bibliografici
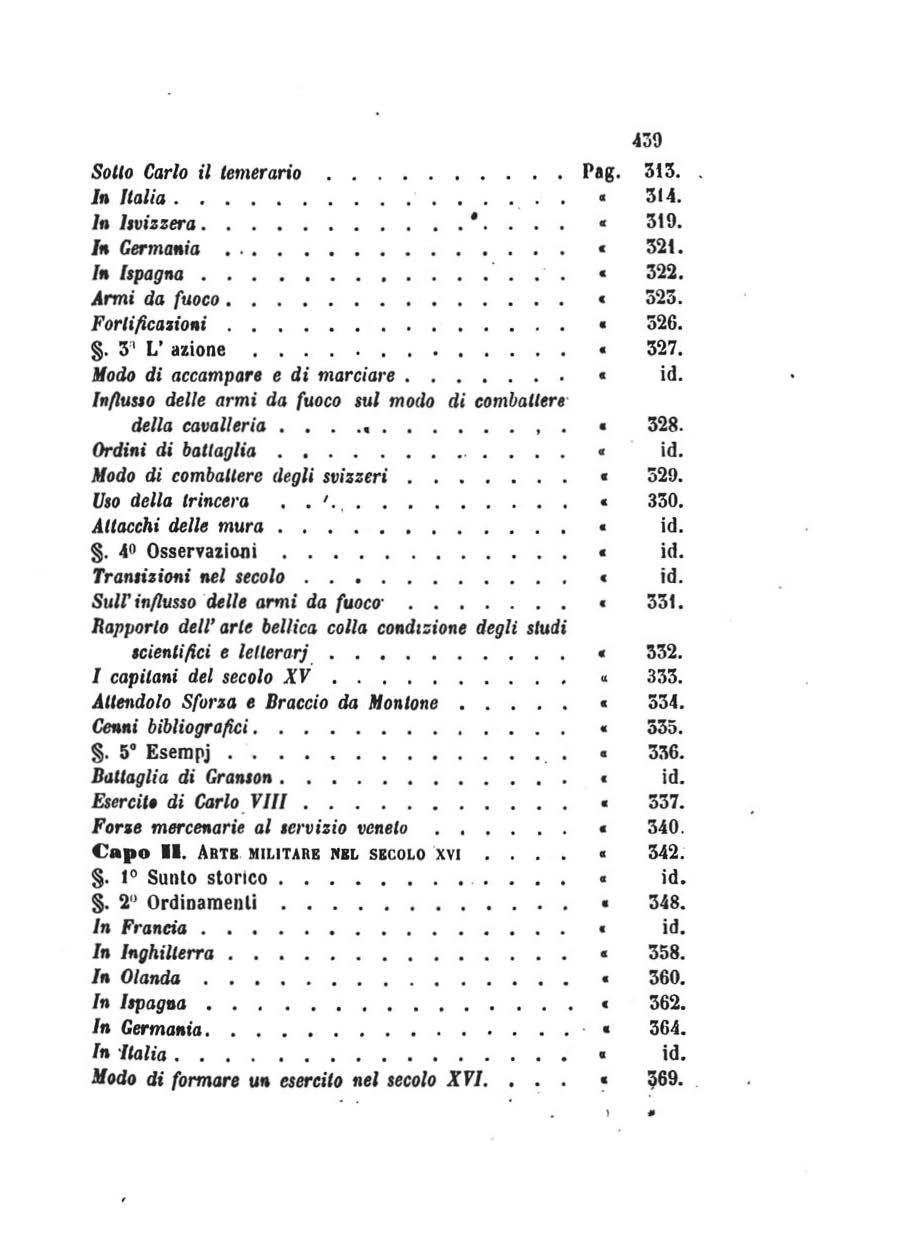
§. 5° Esempj .
Battaglia di Gran1ora . Esercii• di Carlo VIli For•e al 1ervizio veneto Capo Il. ABTB MILITARE l'IL SECOLO 'XVI §. t 0 Sunto storico . §. 211 Ordioameuli
/n Francia . Ira Inghilterra l" Olanda
/n
In Germa11ia . lfl 'Italia
Modo di formare "'" esercito nel secolo XVI.
313.
314.
3 w.
32t.
id.
328.
id.
529.
id
id.
id.
33t.
id.
id.
id.
id.
For11a degli
.Armi da fuoco .
Fortificazioni . §. 5.11 L'azione Campi
Marcie.
Ordini di ballaglia Guerre di religione
l/odo di combattere dei Raitri.
Arte di guerra di Enrico IV
Di Maurizio di Nassau
Di Alessandro Farnese
Del duca d' Alba
perfezionata delle. mine a polvere.
§. 4." Osservazioni
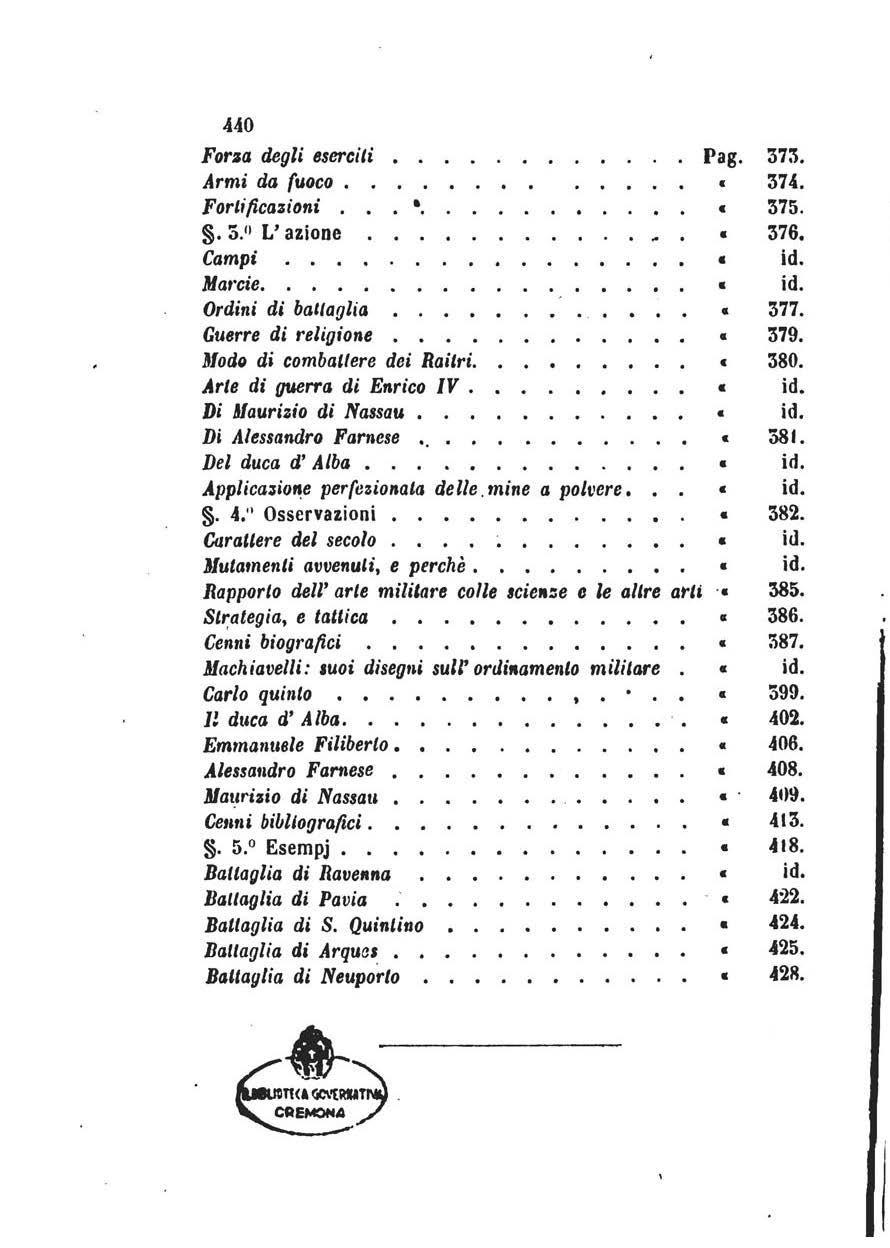
id
id. 377. 379. 380. id. id. 381. id
id. 382.
CaraUere del seco lo
Jlutamenti avvenuti, e ptrchè
Rapporto dell' arte colle 1cie11:e e le allre artt
Cenni biografici
icJ. id. 385. 386. 587. Str;ategia, e tattica
Machiavelli: •uoi disegni sulr ordiflamento militare
Carlo quinto
It duca à' .Alba.
Emmanuele Filiberto
Alessat1dro Farnese
di Nassau
Cem1i bibliografici
o E
a. sempJ
Battaglia di Rave11na Battaglia di Pavia Battaglia di S. Quintiuo Batlaglia di .Arqua•
BtJitaglia di Neuporto
id. 599. 402. 406. 408.
409.
413.
418.
id.
422.
42R.
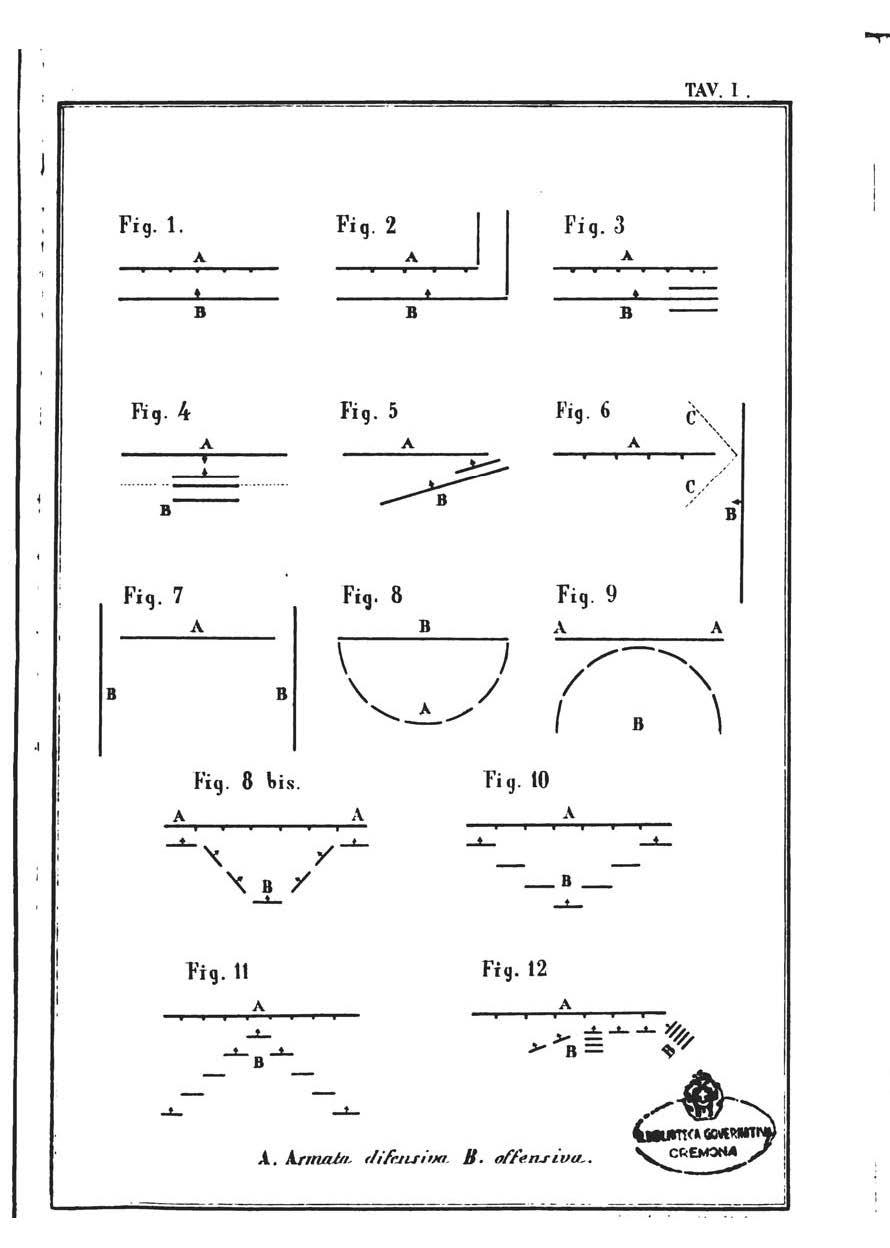
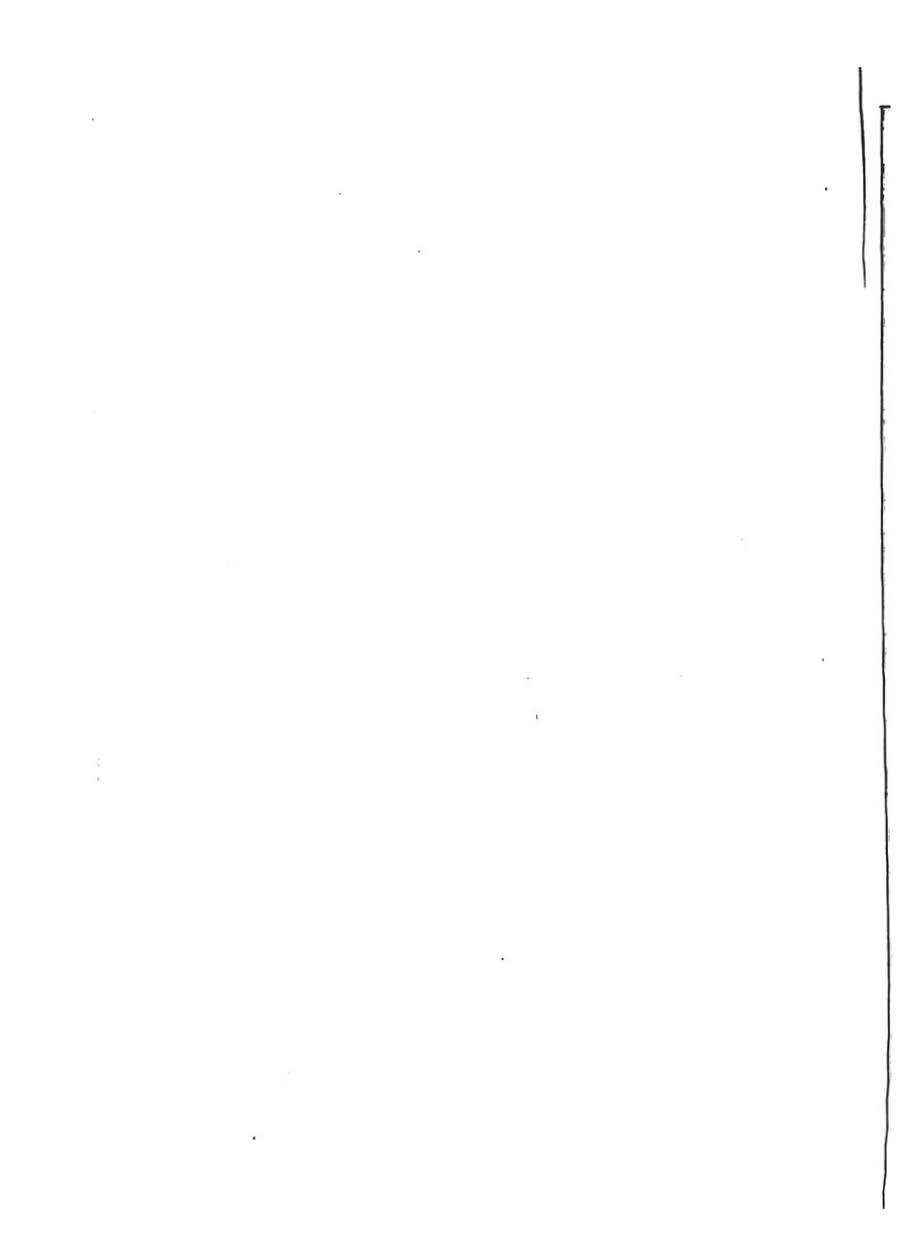
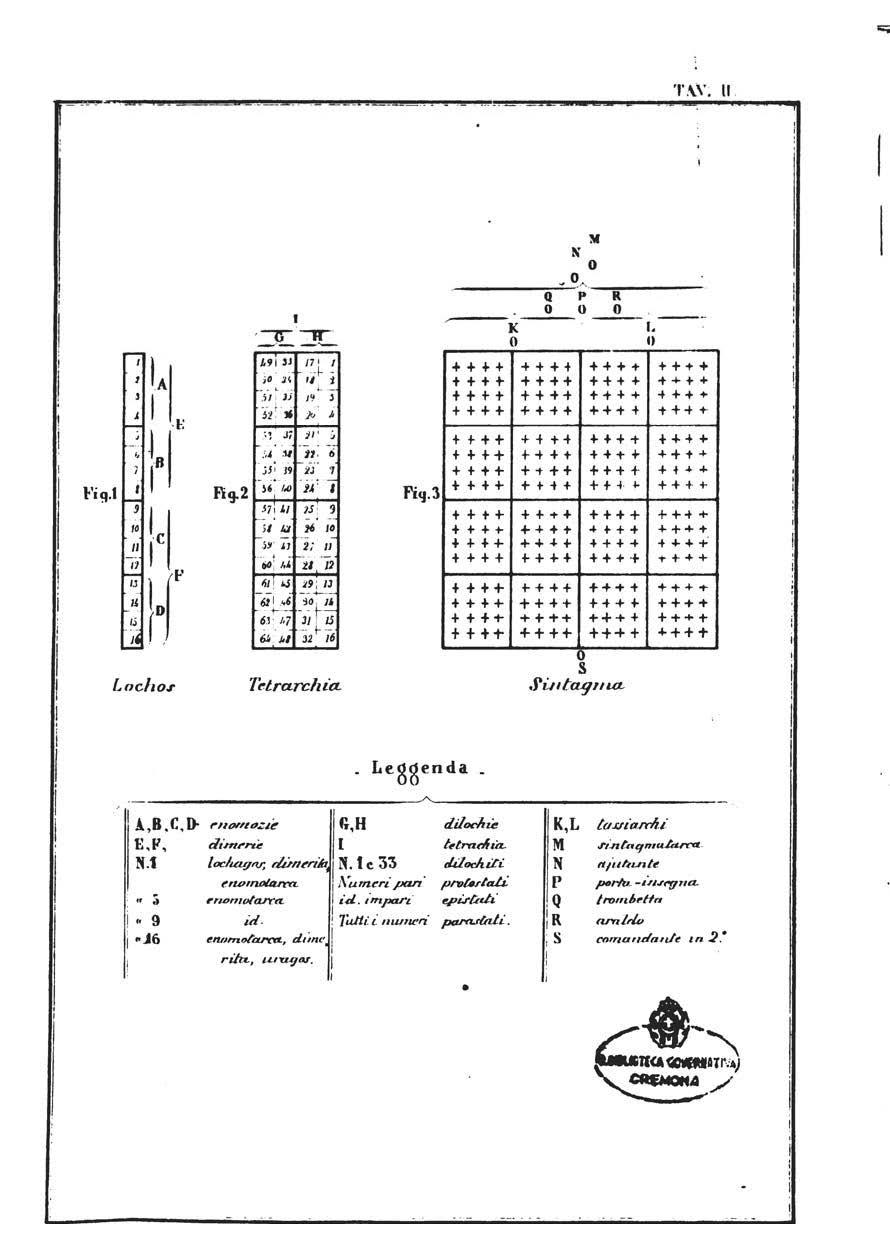
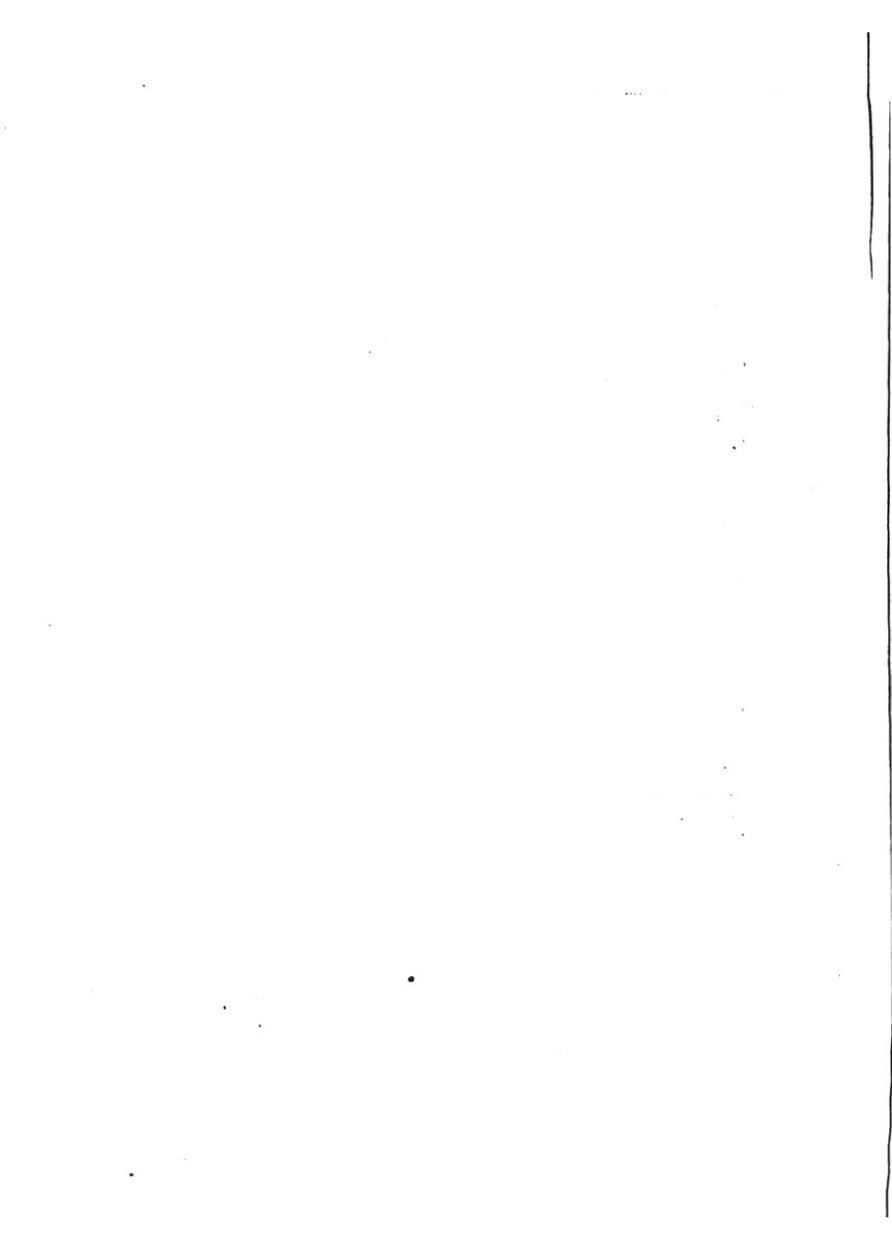
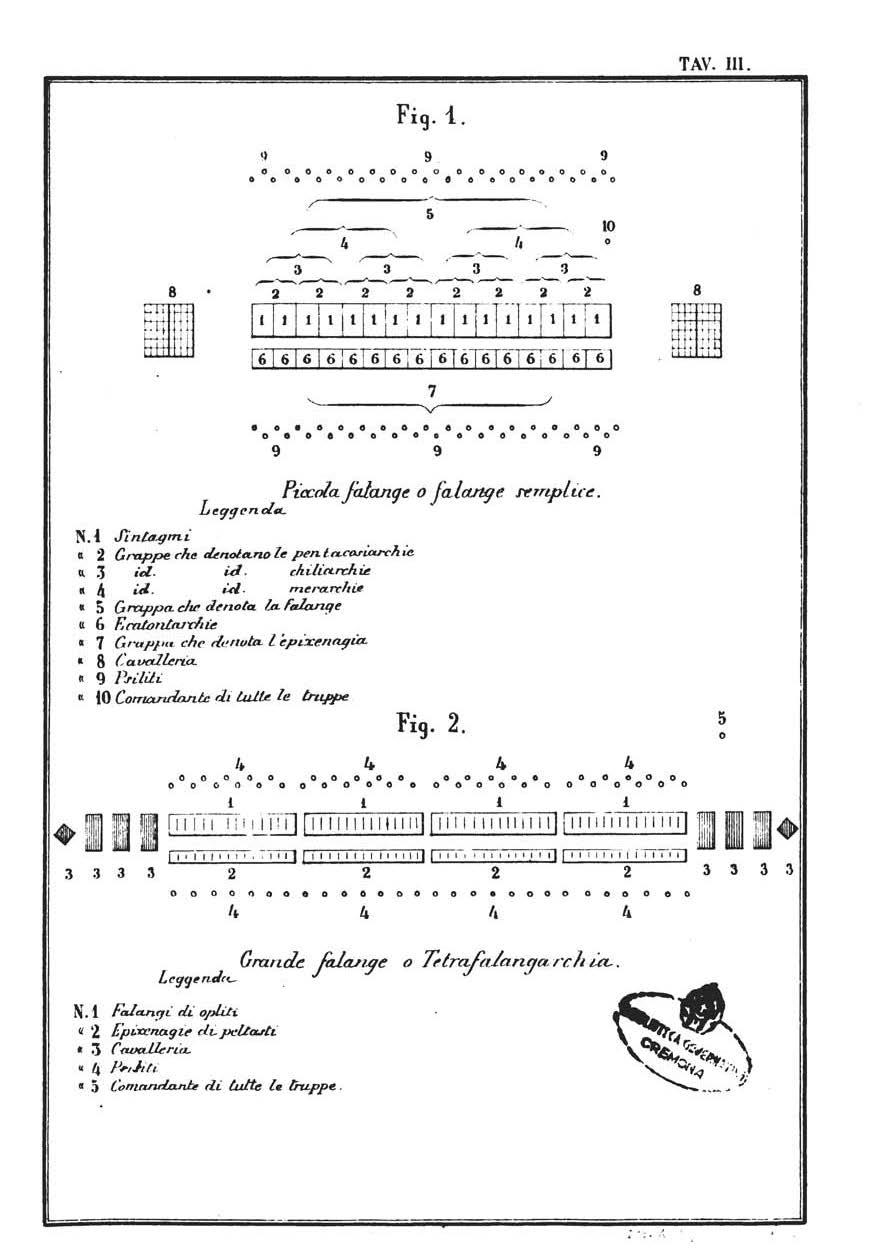
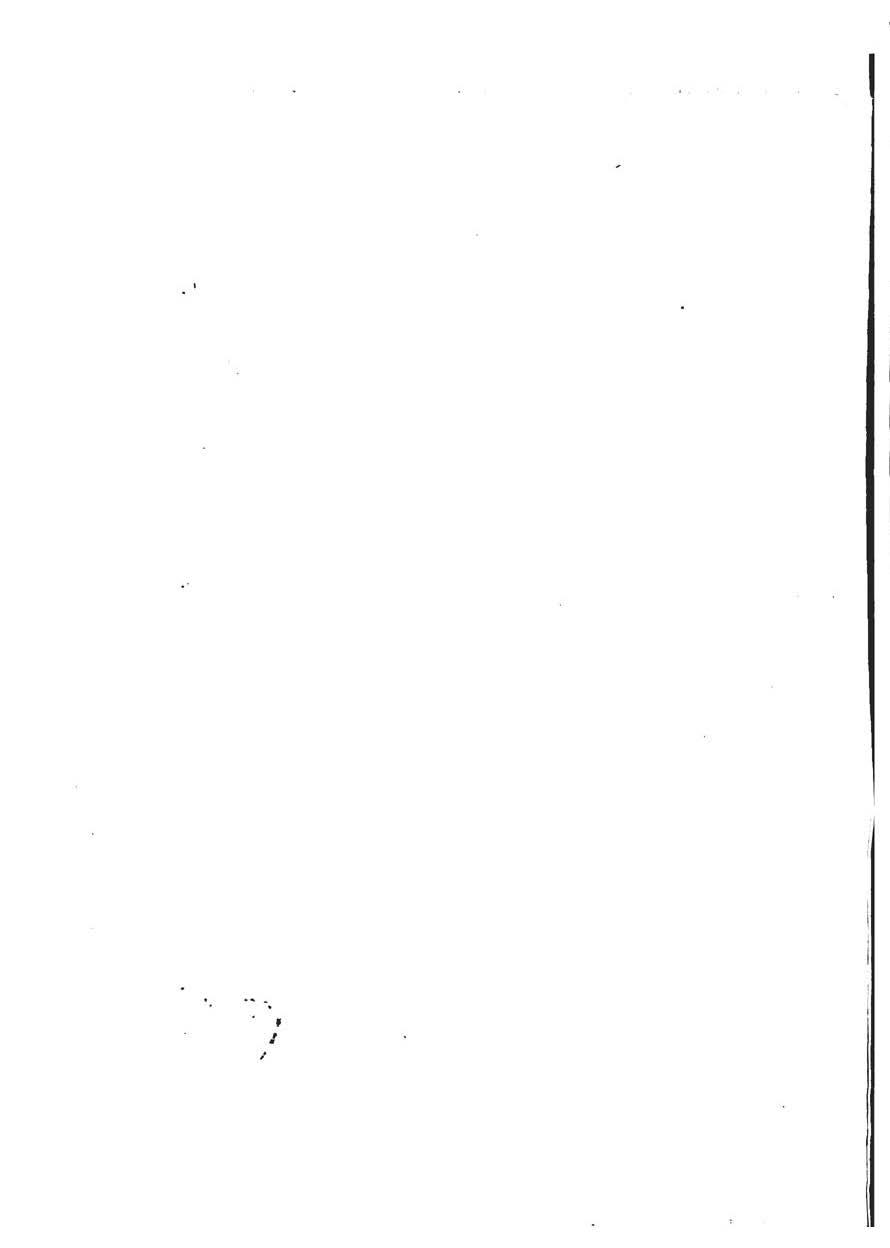
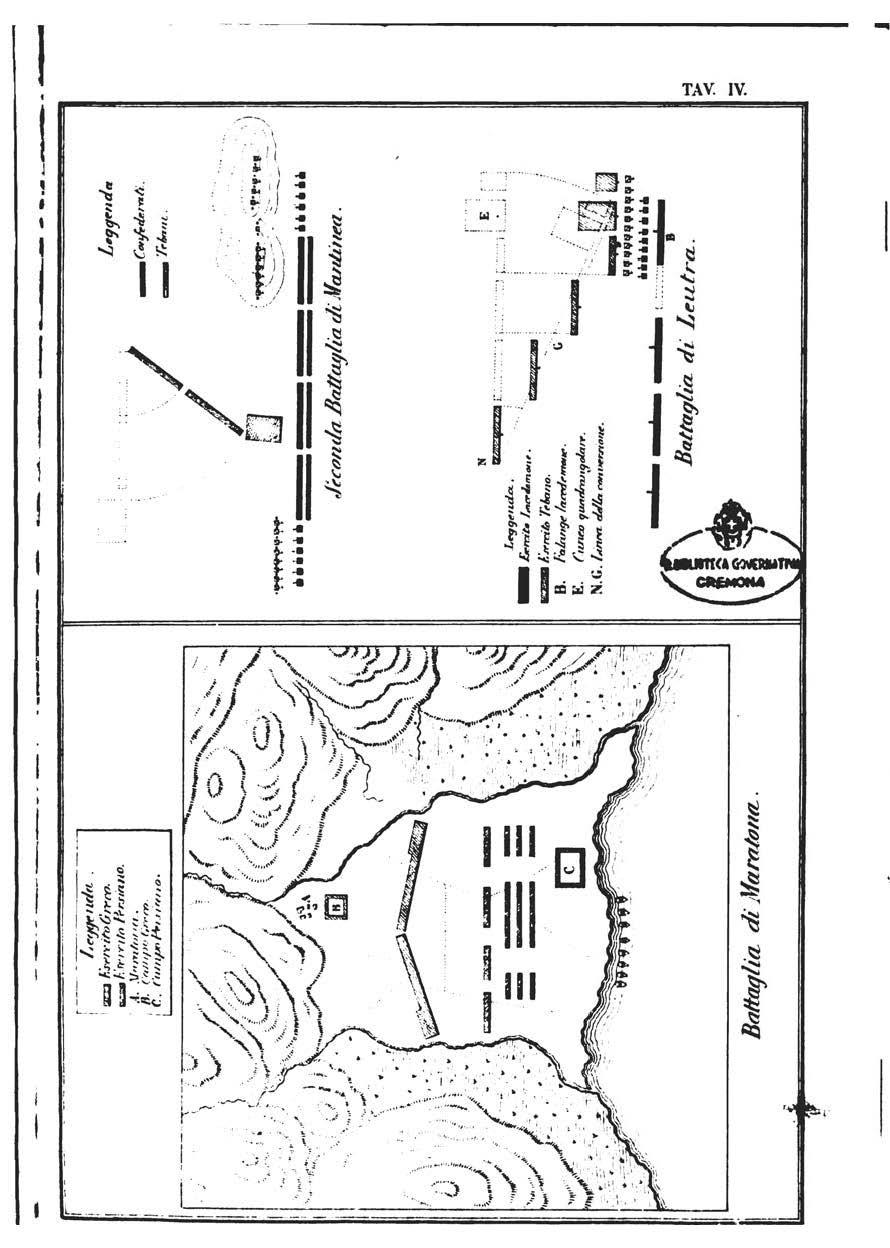
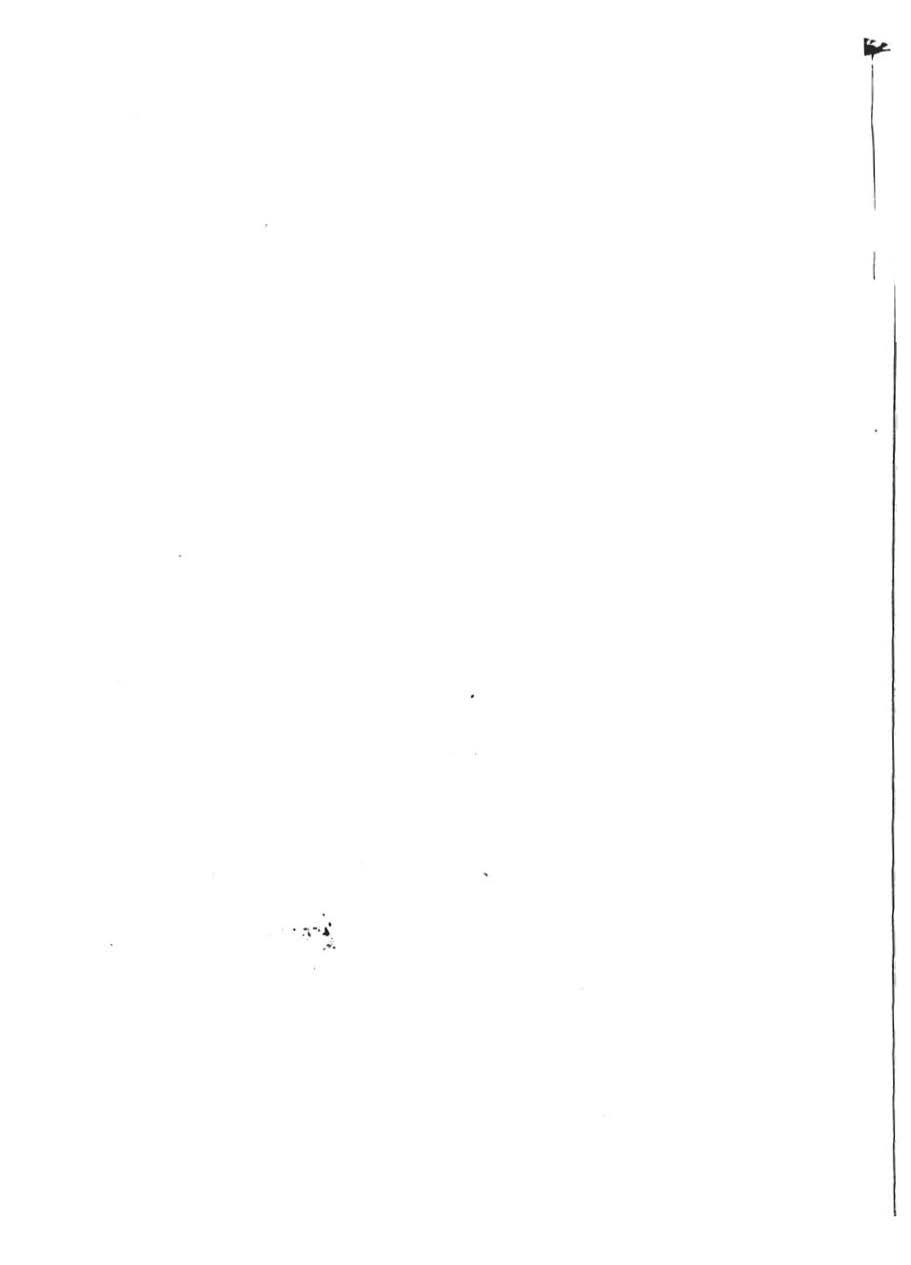
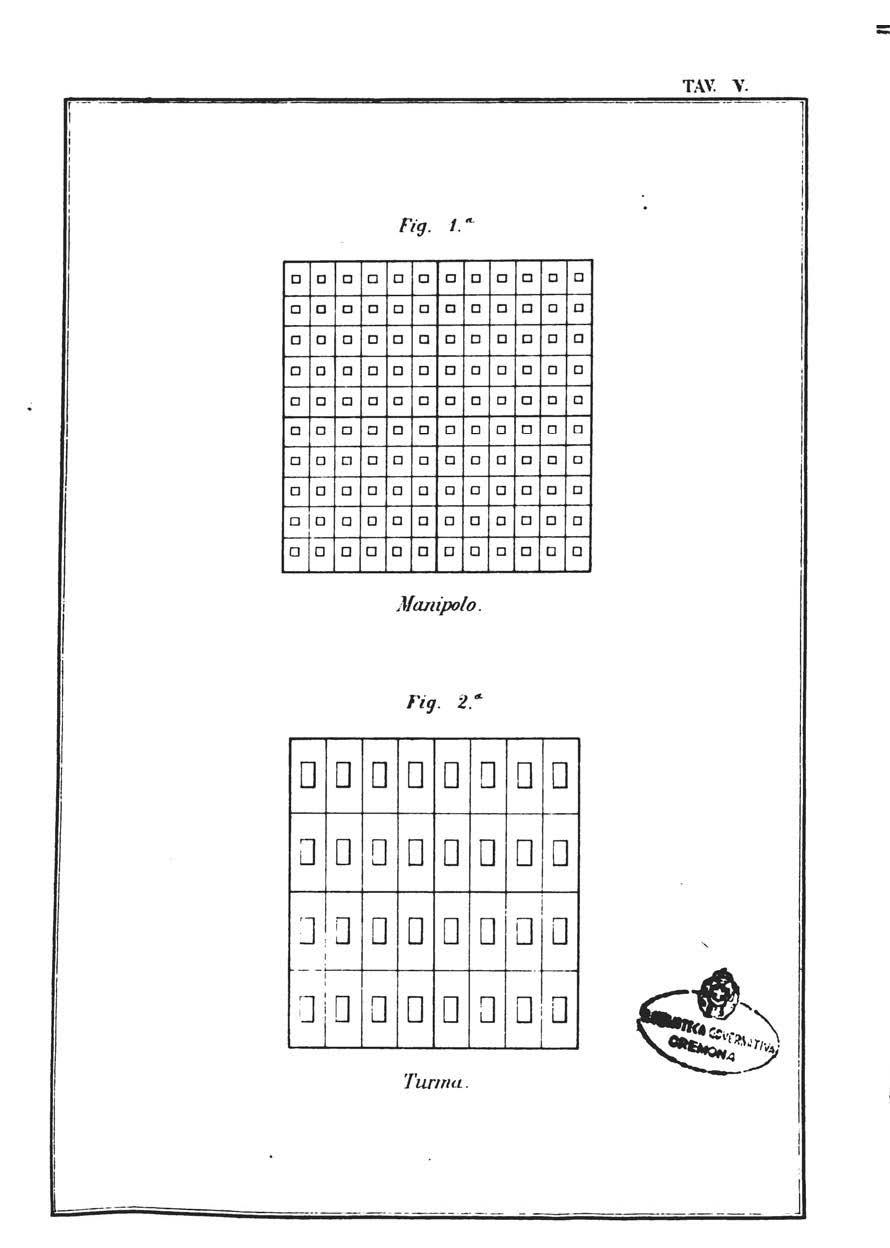
o o o D D D D o o o o o o o o o o o o o o o o o o D o o o o o o o D o o o o D o o o o o o o D o o o o o o o D D o o D o o o o o o o o o D o D o D o o o o o o o D o D o o o D D o o o o o D o o o D D o o o o o o o o o o o o o o o D o o D D D
;l!aJtipolo