

SARDONIA Trentesimo anno/Trentième année année Gennaio 2023 / Janvier 2023 https://www.vimeo.com/groups/sardonia https://www.facebook.com/sardoniaitalia Foto masuri La Grande Madre Su barralliccu Sa Pompia, dove e come si mangia Carbonia cinquemila e più anni Riapre il Padiglione a Sassari Carmen Salis al Premio Toffa Sardinia Insula Vini Ipazia martire Internati Militari Italiani Madame Dupont di Adriana Valenti Sabouret La vita agra di Garibaldi Et in Arcadia ego a Sa Manifattura Paola Sailis Premio Alziator Cinzia Ravaglia ed il Comic Burlesque La Triennale di Milano compie 100 anni Bob Dylan au MAXXI Cucina ebraica in Sardegna Le Raffinate, il meglio del mare Vivienne Westwood
Cagliari Je T’aime
Programma di creazione di Esposizioni e Manifestazioni Artistiche nella città di Cagliari a cura di




Marie-Amélie Anquetil Conservateur du Musée du Prieuré Directrice de la revue “Ici, Là bas et Ailleurs” Espace d’exposition Centre d’Art Ici, là bas et ailleurs 98 avenue de la République 93300 Aubervilliers marieamelieanquetil@ gmail.com https://vimeo.com/channels/ icilabasetailleurs
Vittorio E. Pisu Fondateur et Président des associations SARDONIA France SARDONIA Italia créée en 1993 domiciliée c/o UNISVERS Elena Cillocu via Ozieri 55 09127 Cagliari vittorio.e.pisu@email.it http://www.facebook.com/ sardonia italia https://vimeo.com/groups/ sardonia https://vimeo.com/channels/ cagliarijetaime
SARDONIA Pubblicazione dell’associazione omonima Direttore della Pubblicazione Vittorio E. Pisu Redattrice Luisanna Napoli Ange Gardien Prof.ssa Dolores Mancosu Maquette, Conception Graphique et Mise en Page L’Expérience du Futur une production UNISVERS Commission Paritaire ISSN en cours Diffusion digitale



Questo numero di Gennaio 2023 inaugura il trentesimo anno dell’esistenza dell’associazione omonima e fu preceduto da altre pubblicazioni, come Nosus & Co e Togus et Stravanaus prima di assumere il suo titolo attuale. Quest’anno appena trascorso ha visto l’associazione impegnatissima nell’organizzare sia i filmati di numerose manifestazioni culturali non solo locali, lasciando per altro alle istituzioni ufficiali e ben dotate di curare le riprese delle loro manifestazioni, preferendo dedicarsi a quelle più emergenti e sostenute da associazioni e personaggi che supportano direi eroicamente l’Arte e le sue espressioni, in un contesto se non proprio ostile al minimo chiaramente indifferente, senza dimenticare le numerose esposizioni sia della serie “Meglio una Donna” durante tredici mesi a partire dal marzo del 2021, ma anche a L’Arte é di Casa nell’Agenzia Onali e naturalmente all’Arrubiu Art Gallery Café dove ancora in questo momento la “Collettiva di Fotografia” che celebrerà l’8 gennaio il Catalogo finalmente stampato e che chiuderà le porte il 15 gennaio prossimo. Certo l’anniversario terntennale raggiunto sarà l’occasione, non solo di trasportare la Collettiva di Fotografia ad Iglesias, nei locali dell’Associazione Remo Branca, ma anche a Cagliari dove non disperiamo di completarla al fine di occupare degnamente la sala archi del Lazzaretto. Naturalmente altre iniziative sono in preparazione e speriamo di potervi dare al più presto le informazioni necessarie alla vostra partecipazione e tengo a ringraziare tutte le persone che hanno assicurato il successo delle mostre realizzate. L’associazione Terra Battuta non accoglierà più le nostre manifestazioni ma abbiamo già in serbo altri locali ed altre energie, senza dimenticare che la fine decretata della pandemia ci permetterà di ritrovare l’agognata Parigi dove contiamo di invitarvi a visitare non solo le opere degli artisti sardi in trasferta ma anche quelle dei parigini che potremo finalmente esporre. Non mi resta più che augurarvi un anno interessante (come dicono i cinesi) proponendovi inoltre di visitare il ristorante la Grotta Marcello, dove trentacinque linoleografie rappresentano altrettante vedute della città di Cagliari, ricordate, inventate o sognate dal sottoscritto, senza dimenticare di ringraziare Luisanna Napoli per la sua contribuzione letteraria con temi sempre interessanti e notre ange gardien al quale auguro una prontissima guarigione dei problemi che la inchiodano al letto in questo momento. Sperando vedervi come al solito numerosi ed entusiasti sia alle mostre ancora in corso che a quelle future non posso che consigliarvi di consultare i video delle manifestazioni di cui documentiamo i vernissages e le interviste degli artisti che , superando la proverbiale timidezza sarda, osano raccontarci la genesi e lo sviluppo delle loro attività che per altro presentano al pubblico ed alla critica.
Buon e felice duemila venti tre ! Vittorio E. Pisu

Uno dei concetti più affascinanti introdotti da Jung è quello di “archetipo”: costrutti universali inconsci, capaci di influenzare la vita psichica del singolo.
L’emergere delle costruzioni archetipiche avverrebbe nelle formazioni dell’inconscio, come ad esempio i sogni, attraverso temi tipici, oppure tramite i simboli.
Sul piano sociale, gli archetipi sarebbero rintracciabili nei grandi miti, nei racconti della religione e della letteratura.
Il loro influsso determinerebbe la comparsa di storie con contenuti e dinamiche simili, in popoli ed epoche diverse.
Uno degli archetipi considerati più rilevanti è quello della “Grande Madre”, teorizzato da Neumann: nella sua dimensione archetipica, alla maternità è assegnata una doppia anima; se da una parte vi è la “Grande Madre” come fonte di vita, della creazione e della generatività, dall’altra vi è la dimensione mortifera e distruttiva della maternità.
“Ogni donna è, come ogni grembo, il grembo primordiale della Grande Madre da cui tutto ha origine, il grembo dell’inconscio. La Grande Madre minaccia l’ego con il pericolo dell’autodistruzione, della perdita di sé, in altre parole della morte e della castrazione.” -Erich Neumann-
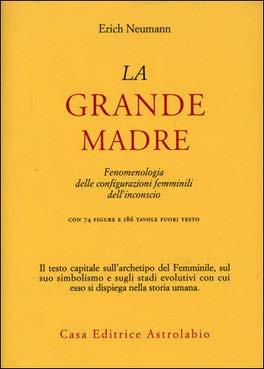
Se la prima concezione è universalmente nota, accettata e condivisa, la seconda pare invece rimossa, rifiutata, inquietante.
Questo secondo versante della femminilità, trova alcune declinazioni culturali affascinanti; pensiamo ad esempio alla figura sarda dell’Accabadora, la misteriosa figura femminile che, nel silenzio della notte, si dice si recasse dai moribondi, per porre fine alle loro sofferenze.
Oppure al ruolo della donna nella società dell’Italia medievale: Dante racconta di come fosse stato rimproverato da alcune donne, durante un momento di lutto e sconforto, perché visto piangere in pubblico.
Per la donna della società medievale, la gestione della nascita e della morte erano un territorio esclusivo, precluso a uomini, bambini e anziani.
Questa dimensione della maternità oggi appare rimossa, così come è rimossa dal discorso comune il suo oggetto, la morte.
Per approfondire: La Grande Madre Fenomenologia delle configurazioni femminili dell’inconscio Erich Neumann
Casa editrice Astrolabio Luisanna Napoli
Nella foto: “La Venere di Willendorf”, 30.00025.000 a.C.

3
Foto lanuovasardegna.it
a Sardegna ha conosciuto una significativa presenza ebraica soltanto fino al 1492, quando il volere dei re cattolici Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, attuato attraverso il celebre Decreto di Granada, ha cancellato per sempre ogni testimonianza materiale del giudaismo sardo.
A Cagliari, ad esempio, non solo il quartiere –la “giuderia”– è stato in buona parte distrutto, ma anche la sinagoga ed ogni altro simbolo materiale. Eppure, nonostante i secoli, la cultura ebraica è sopravvissuta in molte delle nostre tradizioni, nei rituali, in alcuni piatti tipici e perfino in alcuni giochi.
Tra questi ultimi, diffuso soltanto nell’area del Campidano, dove la presenza giudaica è stata più forte e maggiormente radicata, “su barralliccu”, una sorta di trottola che gli stessi bambini erano in grado di costruire autonomamente.
Bastavano un pezzo di legno da intagliare e un chiodo lungo e il gioco era fatto!

“Su barralliccu” è costituito da un piccolo cubo di legno e da un perno centrale sporgente da entrambi i lati.
Su ognuna delle quattro facce del cubo si incideva o dipingeva una lettera: la T, iniziale della parola “tottu”, cioè¨ tutto; la M, che indicava la parola “mitadi“, cioè¨ “metà “;
Foto artribune
la N che significava “nudda“, cioè “nulla”, la P che indicava la parola “poni“, cioè¨ “metti”.
La trottola serviva per contendersi un piccolo bottino di castagne, frutta secca, mandarini e qualche spicciolo.
Ogni giocatore, a turno, faceva roteare la trottola per mezzo del perno centrale e, quando questa si fermava, rivelava la lettera presente nella faccia visibile a tutti. Nel caso in cui fosse uscita la lettera “P” (“poni”), ad esempio, il giocatore che aveva azionato la trottola avrebbe dovuto mettere sul tavolo la sua parte di bottino, magari appena conquistata nella mano precedente.
La lettera “T”, invece, avrebbe regalato al giocatore l’intero bottino presente sul piatto.
A decidere, dunque, era la sorte e la durata del gioco era variabile in relazione al numero dei giocatori e alla ricchezza complessiva del piatto.
Pur non conoscendo le origini di questo gioco, si trova un interessante riscontro nella cultura ebraica, che utilizza il “sevivon” o “dreidel” con le stesse modalità.
Nel “dreidel” le 4 facce riportano le iniziali, in alfabeto ebraico, di “Nun”, “niente”, “Hei” o “halb” che vuol dire metà , “Gimel” che significa “tutto” e “Shin” che significa “metti”.
Su barrallicu: un gioco di antica memoria giudaica Un antico gioco con il quale i bambini e gli adolescenti erano soliti intrattenersi, soprattutto in occasione delle festività tradizionali, che conserva numerosi punti in comune con il “dreidel” usato nella tradizione ebraica.
E’ il gioco de “su barralliccu”, di antica memoria giudaica.
L
La parola Yiddish “dreidel” deriva “dreyen” che significa “far girare”, simile al tedesco “drehen”. Alcuni rabbini ritengono che le 4 lettere dell’alfabeto abbiano un significato simbolico collegato alla storia di Israele. In particolare sostengono che le quattro lettere si riferiscano alle quattro nazioni che avevano dominato Israele: Babilonia, Persia, Grecia e Roma. Ad ogni modo gli elementi comuni al dreidel e a su barralliccu raccontano ancora oggi la storia di una Sardegna giudaica le cui radici sembrano essere molto profonde, permettendo, così alla cultura ebraica di sopravvivere al triste epilogo del XV secolo e conservare la memoria storica di un popolo che ha apportato alla nostra cultura interessanti contaminazioni.
Me&Sardinia di Roberta Carboni
Via Bingia Bonaria 11 09134 Cagliari meandsardinia@gmail.com https://meandsardinia.it/ Tel.: +39 3485223897 P.IVA 03715780924
Riferimenti Bibliografici
C. Tasca, Ebrei e società in Sardegna nel XV secolo https://meandsardinia.it/su-barralliccu-un-gioco-di-antica-memoria-giudaica/
on è un limone, non è un pompelmo, non è un cedro.
È sa pompìa, un frutto che esiste solo in Sardegna, per la precisione nei comuni di Siniscola, Posada, Torpè e Orosei.
Una vera rarità, fino al 2015 non riconosciuto neanche dalla comunità scientifica, tanto da meritare il nome di “Citrus x monstruosa”, una sorta di limone mostruoso, buono come medicamento naturale, ma soprattutto per preparare gustosissimi dolci.
Lo sapevate? Sa pompìa è un agrume che esiste solo in Sardegna.
Bello di certo non è, fatto di una buccia rugosa e irregolare, ma c’è chi dice sia miracoloso.
Una giovane start up sarda, la Phareco, con la pompìa ha brevettato un olio essenziale in grado, secondo i suoi sviluppatori, di curare infezioni dell’apparato genitale femminile, dell’apparato digestivo e di quello respiratorio.
Ridotto a poche centinaia di piantagioni negli anni ’90 sa pompìa ha conosciuto una seconda vita quando si è deciso di impiantare nel territorio di Siniscola una piantagione estensiva di questo frutto per finalità sociali.
Da allora si è fatta molta strada e nel 2004 è nato proprio a Siniscola il presidio slow food della pompìa. (segue pagina 6)

5
N
(segue dalla pagina 5)
Fino ad allora sa pompia era nota con il nome di Citrus x monstruosa, “limone mostruoso”, per via del suo aspetto particolare.
Certo è che sa pompìa è molto buona, ma solo quando è cotta, cruda è immangiabile.
Prodotti conosciuti sono anche la marmellata di pompìa, il liquore di pompìa e s’aranzata thinoscolesa, un dolce tipico dei matrimoni, fatto di scorza candita e mandorle.

Le donne di Siniscola e dintorni custodiscono gelosamente la ricetta di questo dolce tipico, tanto che su Facebook è nato addirittura un gruppo denominato “Sa pompìa intrea”.
La sopravvivenza di questo frutto si deve al largo utilizzo che se ne fa nella zona di Siniscola e dintorni, soprattutto nei comuni di Torpé e Posada e, in misura minore, a Orosei. È infatti utilizzata come base per due dolci tipici della regione della Baronia: “sa pompia intrea” e” sa aranzada siniscolesa”, che differisce dalla versione nuorese proprio per l’utilizzo di questo particolare agrume al posto dell’arancia.
Per la loro realizzazione si utilizzano la scorza e la sottostante parte bianca del frutto.
Ma, attenzione, guai ad assaggiare la polpa: la sua elevata acidità, molto più alta di quella del li-
SA POMPIA E DOVE E COME SI MANGIA
mone, la rende praticamente immangiabile.
I dolci a base di sa pompia, un tempo, erano molto preziosi e rappresentavano un graditissimo regalo per padrini e testimoni di nozze. Questo perché la loro preparazione richiede molte ore di lavoro e l’impiego di ingredienti, come zucchero e miele, che in passato rappresentavano beni di lusso. Il frutto è utilizzato anche per la produzione di liquori, marmellate, gelati, sorbetti, granite e panne cotte, oltre che per accompagnare la carne, della quale esalta il sapore.
Nella nuova guida di Repubblica, Ricette di Casa della Sardegna, la signora Tonia Pau svela i suoi segreti per preparare Sa Pompia Intrea, così come la realizza nel suo agriturismo Punta Lizzu a Siniscola. Come preparare sa pompia intrea: Dopo avere grattato via la scorza del frutto, facendo attenzione a non danneggiare la parte bianca sottostante, si pratica un foro all’altezza del picciolo e si asporta la polpa.
Ciò che rimane è una sorta di palloncino vuoto che sarà prima lessato, per eliminare l’eccesso di acidità, e poi immerso in una teglia con il miele.
Si fa cuocere a fuoco lento, riempendo di miele l’interno del frutto fino a quando assumerà un aspetto ambrato.
Foto sardiniaslowholidays.com
Sa pompia intrea è così pronta per essere conservata, al riparo da fonti di luce e calore, in barattoli di vetro o terracotta ricoperta da gelatina di cottura o da miele. Ecco, inoltre, alcuni indirizzi di ristoranti in cui è possibile assaporare i piatti della tradizione sarda e dolci realizzati con questo agrume.
Aragosta, Siniscola
Ospitato all’interno dell’omonimo hotel, questo ristorante rappresenta un punto di riferimento per chi ricerca una buona cucina di mare, basata su prodotti freschissimi provenienti dalle acque locali.
Lo stile mediterraneo della struttura è reso ancora più affascinante dalla presenza di una piscina illuminata. Così, in estate, le tavole apparecchiate a bordo vasca diventano la location perfetta per cene romantiche. Tra le proposte, spiccano antipasti come il “croccante di cozze al carasau” e il “carpaccio di polpo con salsa citronette” e primi come i “tagliolini ai gamberi con pomodoro fresco e coulis di zucchine”, i “paccheri al tonno fresco con pomodorini, olive e salsa di ricotta” e il “risotto con scampi e zafferano”.
Alcuni dei secondi sono il “calamaro su crema di peperoni e tronchetti di zucchine” e il “turbante di branzino”.
Tra i dessert, non può mancare il “semifreddo di ricotta con sa pompia e mandorle”.
Il Moletto, Siniscola
Spiagge di dune bianchissime e acque cristalline rappresentano il biglietto da visita di Capo Comino, località della costa nord-orientale, in provincia di Siniscola. E rappresentano anche la cornice di questo locale affacciato sul mare, dove si gustano piatti che fondono tradizione e innovazione, realizzati con prodotti freschi e di qualità, con un occhio di riguardo per l’estetica.
Crudi del giorno e “carpaccio di tonno rosso con insalatina di finocchio e pecorino sardo” sono alcuni degli antipasti proposti; tra i primi, è protagonista la fregola, servita con verdure di stagione o mantecata al parmigiano con uovo pochet e spuma di patate; i secondi spaziano dalla spigola con patate al pollo scottato al bacon con riduzione al Cannonau.
Si conclude con i dessert della casa: seadas e dolce alla pompia.

Cucina tipica da Giovanna, Siniscola
Un locale storico de La Caletta, rinomata frazione di Siniscola, costituita da un grazioso borgo marino con un caratteristico porticciolo e da una lunga spiaggia.
Qui dal 1969 si gustano i piatti della tradizione isolana e in particolare le specialità a base di pasta fresca, vero cavallo di battaglia del ristorante, accompagnate da sughi caserecci.
(segue pagina 8)
7
(segue dalla pagina 7)
Alcuni esempi: i “ravioli ripieni di ricotta e spinaci con la bottarga” e i “maccarrones de busa” serviti con sugo di salsiccia fresca o con vongole e bottarga. Per secondo la grigliata mista di pesce e, su ordinazione, il maialetto arrosto. Tra le dolci proposte, non mancano seadas, papassini, amaretti e sa aranzada siniscolesa con sa pompia, tutti realizzati artigianalmente.
Sa Veletta, Siniscola La possibilità di gustare i piatti della tradizione sarda e un panorama mozzafiato sono due dei motivi per visitare questo ristorante affacciato sul mare e sulle spiagge de La Caletta e di Capo Comino. Sul menu, specialità tipiche del territorio come “sa suppa siniscolesa”, un ricco piatto a base di carne tipico delle cerimonie, e la scaloppina alla siniscolese.
Altre proposte sono gli “spaghetti con le arselle” e la “fregola sarda”, tra i primi, e la grigliata di pesce del golfo di Orosei e piatti a base di carni locali, tra i secondi.
Per concludere, i dolci della casa come “sa seata” (nome locale della seada) e la panna cotta realizzata con sa pompia.
Sos Arcos, Siniscola Situato al centro del paese questo ristorante colpisce l’attenzione per il murale esterno, che riproduce scene di vita sarda. La semplicità degli am-
Foto sardiniaslowholidays.com
bienti interni rispecchia quella della cucina, basata sulle pietanze della tradizione isolana e in particolare su quelle di mare.
Una visita a questo locale è l’occasione per assaggiare una specialità tipica del posto, sa suppa siniscolesa, oltre a piatti come gli spaghetti con arselle, ricci di mare e bottarga, il risotto con frutti di mare e le tagliatelle con pomodorini, gamberi, scampi e bottarga. Tra i secondi di mare, i più prelibati sono le aragoste e gli astici alla catalana, tra quelli di terra, spicca il filetto di manzo al Cannonau.
Passando ai dessert, il fiore all’occhiello è la “bavarese a sa pompia”.
Punta Lizzu, Siniscola L’azienda agrituristica in cucina utilizza solo prodotti lavorati o coltivati all’interno dei suoi terreni. Si preparano “Sos macarrones de punzu”, conosciuti come malloreddos, “Sos anzelotos de recotu” (ravioli di ricotta), ottenuti con una sfoglia sottile ripiena di bietole e ricotta, “Sos anzelotos de casu” (ravioli di formaggio), sono fatti a mano e ripieni di formaggio fresco.
La carne di maialetto da latte viene arrostita allo spiedo per circa 3, 4 ore e servita in Sos Ajones (contenitori concavi di sughero) o in Sos Tazeris (recipienti in

Foto cronachenuoresi.it legno di olivastro), su un letto di germogli di mirto o rosmarino, che ne esalta il profumo. Anche il Cannonau è di produzione propria. Grazia Cherchi, di Siniscola, ha imparato la ricetta dalla suocera, proprietaria di uno dei primi terreni in cui era stata impiantata sa pompìa.
Dopo avere raccolte i frutti a novembre prepara così sa pompìa intrea: Pulire la scorza del frutto con un pelapatate, fare due buchi nella parte superiore e nella parte inferiore per privarlo della polpa interna così da lasciare la sola parte pianca esterna.

La polpa si può riutilizzare per fare la marmellata. Ciò che rimane del frutto va immerso in acqua bollente per 6/7 minuti, per poi essere scolato e lasciato ad asciugare su un canovaccio fino al giorno dopo. Successivamente le pompìe vanno cotte in padella immerse nell’acqua con un chilo di zucchero e 600/700 grammi di miele (questo per 12/13 pompìe).
Cuocere a fuoco molto basso e girarle di tanto in tanto per circa 6 ore.
Una volta colorata a puntino sa pompìa è pronta per essere mangiata.
https://www.repubblica.it/sapori/guide/2019/10/04/ news/itinerari_gastronomici_sardegna_baronia_siniscola_agrume_sa_pompia
SARA COLLU ARCHITETTO E IL LADIRI
a oggi, dopo mesi di lavorazione, sono lieta di annunciare l’uscita del mio nuovo libro: Làdiri – Terra, acqua e paglia: il respiro della Terra Cruda in Sardegna. Disponibile, per chi volesse supportare il mio progetto, a questo link. https://www.amazon. it/L%C3%A0diri-Terra-paglia-respiro-Sardegna/dp/ La pubblicazione indipendente è curata da nootempo x books, factory sarda con cui collaboro e che da anni ormai diffonde arte e cultura residente.
Dopo l’esperienza fotografica di “Lost in Karalis” (sempre disponibile a questo link https://www.amazon. it/Lost-K%C3%A0ralis-Percorsi-Cagliari-sospesi/dp/B09SV5B3FQ), ho ripreso una delle mie ricerche più importanti, cominciata già ai tempi dell’Università e che rappresenta uno dei temi fondamentali su cui si basa buona parte del mio percorso formativo e professionale di Architetto: il rapporto tra uomo e territorio nella cultura campidanese sarda, che sento profondamente appartenermi anche da un punto di vista personale. Infatti, sono nata e cresciuta in un piccolo paese al confine tra il Sulcis e il Campidano Centrale, Vallermosa.
Le vicende e i luoghi in cui si sviluppa la vita di una persona, (segue pagina 10)
9
D
(segue dalla pagina 9) influenzano decisamente il suo modo di essere e il suo futuro e lo è stato anche per me.
Per questo voglio parlarvi di come nasce questo libro e di quali temi tratta.
Negli ultimi mesi ho visitato numerosi paesi della Terra Cruda in Sardegna, tra percorsi, centri storici, architetture, case vecchie e recuperate.
L’obiettivo è stato quello di approfondire, studiare e ricercare uno dei temi più importanti della nostra cultura isolana: il Làdiri (nome sardo che identifica i tipici mattoni di terra cruda).

Questo è un materiale incredibile! Naturale, nasce dalla terra e respira. Viene plasmato dalle sapienti mani artigiane dell’uomo, proviene da antiche tradizioni e ancora oggi si sposa con i temi dell’ecologia e della sostenibilità dell’abitare e del costruire i nostri territori. Costruire case in terra è ancora oggi possibile, nei nostri contesti!
Questo libro non sarà tuttavia un manuale (di cui abbiamo un’ampia e autorevole bibliografia), ma piuttosto uno studio che vi porterà a conoscere e capire come la cultura della Terra Cruda nasce, si evolve e arriva sino a noi.
Vi racconterò e vi farò conoscere i luoghi, le modalità e le tecniche costruttive che sono state alla base della cultura campidanese per secoli.
Foto saracollu
Il tutto arricchito e accompagnato anche da immagini di scorci, dettagli, textures e forme delle abitazioni in Làdiri, fondamentali per la comprensione dell’argomento.
L’intento è quello di trasportarvi all’interno di questa magica alchimia tra terra, acqua e paglia, sperando che possa essere utile a diffondere ulteriore conoscenza e consapevolezza sulla tematica e a produrre uno scambio culturale reciproco e dal basso.
Mi sono sentita, in questo senso, di raccontare anche una storia e un’esperienza che penso sia la storia di tanti di voi: crescere in un paese campidanese in cui le case prima si costruivano con materiali naturali e in forte equilibrio con l’ambiente.
Che la terra possa essere memoria, conoscenza, esperienza e ispirazione per le nostre scelte future!
Un grazie va a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo progetto e che sono stati disponibili durante la fase di ricerca e di incontro.
Ritenendo sempre molto importante partire dalla comunità del mio paese, vi anticipo che martedì 20 dicembre, a Vallermosa nella Biblioteca Comunale (ulteriori dettagli verranno dati nei prossimi giorni), si terrà un incontro per presentare il libro, a cui siete invitati a partecipare. (vedi la locandina qui) Inoltre, a partire dalle prossime settimane, verrà or-

ganizzato, in diverse tappe, un piccolo tour di presentazioni pubbliche nei paesi sardi, che rappresenta per me una delle attività fondamentali per poter incontrare le persone e potermi confrontare con loro. Seguendo la mia webzine potete restare aggiornati su questo e sui miei progetti futuri, che continuo a portare avanti nell’ottica della ricerca di nuovi linguaggi che mettono in relazione l’arte, l’architettura e la cultura.
Sara Collu Architetto, originario del sud Sardegna, consegue la laurea magistrale in Architettura nel 2015 presso la facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari con il progetto di tesi “Piazza nel Campo. Progetto di spazio pubblico per il margine nord di Vallermosa”.

La tesi indaga e propone sul tema del margine rurale/ urbano nei contesti minori della Sardegna. https://www.amazon.it/L%C3%A0diri-Terra-paglia-respiro-Sardegna/dp/ per Lost in Karalis Percorsi della città di Cagliari sospesi nel tempo https://www.amazon.it/Lost-K%C3%A0ralis-Percorsi-Cagliari-sospesi/dp/B09SV5B3FQ http://www.saracollu.com/ladiri-il-mio-nuovo-libro-dedicato-alla-terra-cruda-in-sardegna/
ur essendo la città di Carbonia una delle più giovani d’Italia il suo territorio (creata nel 1937), corrispondente a buona parte del dismesso bacino carbonifero del Sulcis, è ricco di numerose testimonianze preistoriche e storiche, relative alle civiltà e alle popolazioni presenti in questa zona della Sardegna. Nel territorio di Carbonia è attestata la presenza di una delle più antiche civiltà preistoriche della Sardegna, denominata di “Su Carroppu”, risalente al Neolitico Antico (5700 – 5000 a.C.), che prende nome dall’omonimo riparo sottoroccia, già frequentato nel Mesolitico, vicino all’antica borgata agro-pastorale di Sirri, a nord-est del centro urbano di Carbonia. Successivamente diverse civiltà preistoriche (partendo dal Neolitico Medio fino all’Età del ferro) si affermano in questo territorio, documentate dai reperti archeologici in numerose grotte e in siti del comune, tra i quali si ricordano le grotte “dell’Ospedale”, la “di Barbusi”, la grotta sepolcrale “Baieddus de Sa Sedderenciu” o eneolitica di “Su Cungiadeddu de Serafini” a Tanì, la “grotta di Serbariu”, quelle “di Polifemo”, “Sa Dom’e S’Orcu”, “Sa Turrita”, “della Campana”, “della Volpe” e “A.C.A.I. valle Rio Cannas”.
(segue pagina 12)
11
P
(segue dalla pagina 11)
Ulteriori testimonianze di questo popolamento del territorio carboniense a quell’epoca si ritrovano nelle tipiche necropoli prenuragiche a domus de janas di “Cannas di Sotto”, “Cùccuru Su Cardolinu de monte Crobu” e “Corona Maria” (a nord di Cortoghiana), “Is Arrùs de Riu Anguiddas” e “S’Ega de Is Elmas” a ovest di Cortoghiana; nei siti abitativi di Barbusi – rio Flumentepido, negli insediamenti del “poliambulantorio – valle rio Cannas” e nel riparo sottoroccia di “Coderra”.
Del periodo nuragico è attestata la presenza di questa civiltà in diversi siti, alcuni di notevole importanza come il complesso del nuraghe Sirai (fortezza e abitato), tra i quali si ricordano tra i più rilevanti il nuraghe “Mianu”, il “Mitzotus”, il “Paristeris”, il nuraghe “Piliu”, ed il “Su Conti” nell’omonimo medau. In totale si possono contare più di quindici nuraghi e oltre dieci domus de janas disseminate nel territorio comunale.

Della successiva civiltà fenicia e punica è documentata la presenza nell’importante insediamento di monte Sirai, già nuragico e poi romano, e in altri siti minori presenti nel territorio comunale.
La presenza della dominazione di Roma risulta documentata in numerosi siti archeologici minori del comune di Carbonia, e si riscontra nei reperti
CARBONIA CINQUE MILA E PIU ANNI
Foto wikipedia.org
ritrovati in tombe e in luoghi abitati, costituite da ville in campagna e da mansiones (stazioni di posta) lungo la strada romana che da “Carales” (Cagliari) si dirigeva verso “Sulki” (presso l’attuale Sant’Antioco), che attraversava il territorio carboniense.
Il periodo medioevale, quando la zona era compresa nella curatoria del Sulcis appartenente al giudicato di Cagliari, risulta documentato non solo da fonti storiche che citano località di questo territorio, ma soprattutto nelle vecchie chiese, presenti e relative alle antiche “biddas” (ville), oggi incluse nel comune di Carbonia, come l’antico monastero di Santa Maria di Flumentepido, la chiesetta di Santa Barbara di Piolanas, la chiesetta di Santa Lucia di Sirri, le rovine della chiesetta (di probabile origine bizantina) di San Michele, nell’omonimo colle in località “Is Arenas”, le rovine delle chiesette di Santa Maria di Barega, Santa Giuliana e di Santa Maria di Sirri, e, infine, le distrutte (e poi ricostruite in sito diverso) chiese parrocchiali di San Narciso di Serbariu e di Santa Maria delle Grazie di Barbusi.
A partire dalla seconda metà del XIV secolo, nel periodo di passaggio dal dominio dei della Gherardesca gherardiani a quello successivo aragonese, il territorio oggi del comune, come accadde nella maggior parte dei comuni della zona, venne abbandonato a causa
delle epidemie di peste e delle devastazioni portate dal lungo conflitto tra giudicato di Arborea e aragonesi. Nel Settecento, nel periodo di transizione fra il dominio spagnolo e quello piemontese-sabaudo, l’odierno territorio carboniense e in generale quello sulcitano (territori facenti parte del Marchesato di Palmas, feudo all’epoca di proprietà prima dei Brondo e poi dei valenzani Bou Crespi) registrò il ripopolamento, attraverso la nascita degli insediamenti rurali sparsi detti “furriadroxius” o “medaus”, da parte di famiglie iglesienti e pastori (in genere barbaricini) che, in transumanza in queste terre del Sulcis per diversi decenni, decisero di stabilirsi in questi luoghi quasi completamente disabitati da secoli, anche per via delle frequenti incursioni dei corsari barbareschi.
Proprio in questo territorio il generale e scienziato Alberto La Marmora fece la prima segnalazione ufficiale del carbone Sulcis, rinvenendo la sua presenza nel 1834 e nel 1846 in località “Cannamenda” (tra monte Lisau e “Medau Brau” in zona Terra Segada, già in comune di Gonnesa ora in quello di Carbonia), attraverso frammenti di carbone fossile, ma senza riuscire a localizzare gli affioramenti.
Ma è soprattutto grazie alla costituzione del comune di Serbariu, antico “boddeu” (borgata) staccatosi da Villamassargia nel 1853 e con la concessione di
permessi di ricerca mineraria (come quello di Caput Aquas) che si ebbe una certa vitalità e vivacità economica in questa zona, grazie ad una nuova legge mineraria del 1840, entrata in vigore in Sardegna nel 1848 e modificata nel 1859, che prevedeva la separazione della proprietà del suolo da quella del sottosuolo.
Ubaldo Millo fu lo scopritore del giacimento carbonifero di Bacu Abis nel 1851; il 29 maggio 1853 furono affidate le tre concessioni carbonifere di Bacu Abis, di Terra’e Colu e di Fontanamare alla Società “Tirsi-Po” di Millo e Montani.
Successivamente la concessione fu affidata all’ingegner Anselmo Roux, che nel 1873 costituì la Società Anonima Miniera di Bacu Abis.
I permessi di ricerca nel territorio del Sulcis-Iglesiente alla fine del 1861 erano alcune decine, ma salirono al centinaio nel 1870 e le concessioni raddoppiarono.
Il deputato algherese Angelo Roth nel 1915 favorì provvedimenti governativi a favore della Società Anonima di Bacu Abis, che gestiva le miniere carbonifere nel Sulcis. Seppur con andamento altalenante si ebbe un aumento delle ricerche minerarie e delle produzioni, specie carbonifere: in particolare per quel che riguarda il territorio dell’allora comune di Serbariu la scoperta (segue pagina 14)

13
(segue dalla pagina 13) del rilevante giacimento di Nuraxeddu - Serbariu diede un grande impulso ulteriore alle attività minerarie già in crescita, soprattutto negli anni del regime fascista durante il periodo dell’autarchia, tanto da rendersi necessario non solo lo sviluppo di numerosi e importanti impianti estrattivi e produttivi, ma anche la costruzione di una nuova città mineraria, come Carbonia, e di altri due nuovi centri abitati carboniferi minori, come Bacu Abis e Cortoghiana.

La scoperta di grandi giacimenti carboniferi nel sottosuolo sulcitano portò nei primi decenni del Novecento all’apertura di varie miniere e a numerosi lavori di sondaggio per valutare l’eventuale apertura di nuovi pozzi.
La Società anonima miniere di Bacu Abis fu dichiarata fallita il 12 aprile 1933 per difficoltà finanziarie.
Il 9 dicembre 1933 a Trieste, nella sede della Società Anonima Carbonifera Arsa, nacque la Società Mineraria Carbonifera Sarda SpA, (Carbosarda), per rilevare le miniere di carbone del Sulcis-Iglesiente.
Guido Segre, alto esponente della comunità ebraica triestina e già presidente dell’Arsa, fu il primo presidente della Carbosarda.
Il 9 giugno 1935 Benito Mussolini nella sua prima visita a Bacu Abis vi comunicò l’istituzione del
Foto wikipedia.org
bacino carbonifero del Sulcis, e il 28 luglio 1935 con R.D.L. n. 1406 si costituì l’A.Ca.I. (Azienda Carboni Italiani)[35], con presidente sempre Guido Segre, che gestì il bacino carbonifero del Sulcis con la Carbosarda e quello minerario dell’Istria sud-orientale con la Carbo-Arsa o Arsa.
Segre fu il vero artefice e dinamico presidente di tutte le società minerarie in attività sia nel bacino carbonifero sulcitano sia in quello istriano, costruendo due nuove città operaie di fondazione vicino alle miniere: Arsia e Carbonia.
Verso la fine del 1936 con il metodo dei sondaggi vi fu la scoperta del giacimento di carbone nella zona di Serbariu-Sirai, che si rivelò di un’enorme vastità, tanto che l’A.Ca.I. (Azienda Carboni Italiani), proprietaria dell’intero bacino carbonifero con la Carbosarda e in previsione di un’intensa attività estrattiva, propose al governo di costruire una città operaia vicino alle miniere e al porto di Sant’Antioco per il trasporto e l’imbarco del minerale. Il governo, condividendo la scelta dell’A.Ca.I., decise così di fondare una nuova città mineraria, da costruire al servizio della miniera e dei suoi lavoratori. Il nome scelto, Carbonia, denominazione futuristica che significa “terra o luogo del carbone” caratterizza que-
sta volontà.
Fu così che nel 1937, nei pressi della miniera di Serbariu, iniziarono i lavori per l’edificazione di Carbonia, fortemente voluta dal regime fascista. Precisamente il giorno della fondazione del centro comunale viene fatto risalire al 9 giugno di quell’anno, anniversario della prima visita del capo del governo fascista, Benito Mussolini, al centro carbonifero di Bacu Abis (destinato a divenire frazione mineraria di Carbonia, molto simile ad Arsia, in Istria), avvenuta due anni prima nella stessa data (le due città, oltre all’altro centro minerario istriano di Albona, sono oggi gemellate).
La rituale cerimonia della fondazione di Carbonia, con le tipiche celebrazioni del regime di quel periodo, si realizzò, in presenza delle diverse autorità civili, militari e religiose, con la posa della prima pietra e di un astuccio contenente una pergamena (con i nomi dei partecipanti al rito battesimale della nuova città) nel fosso delle fondamenta della torre Littoria, ora torre Civica, primo edificio costruito in città sul monte Fossone.
La costituzione del comune di Carbonia fu stabilita con Regio Decreto n. 2189 del 5 novembre 1937. Secondo l’articolo 1 del suddetto Decreto si prevede

l’istituzione del comune di Carbonia con capoluogo nel villaggio minerario in località monte Fossone, la cui circoscrizione comprende l’intero territorio del comune di Serbariu (che fu soppresso), nonché alcune parti dei territori dei comuni di Gonnesa e di Iglesias.
I lavori, costati circa 325 milioni di lire dell’epoca, vennero completati nel 1938, sebbene parecchi quartieri sarebbero stati costruiti negli anni successivi.
I lavori si basarono sui progetti realizzati dall’ingegner Cesare Valle e dall’architetto Ignazio Guidi.
«La città è sorta dal nulla, d’incanto.
Queste cose mi emozionano, mi rendono orgoglioso.
Sono le opere più belle. Pensa che da lì fuggivano tutti.
C’era una malaria tremenda, morivano come mosche.
Avevano terrore di vivere lì, invece ora ci corrono. Ho fatto dire a Starace quelle cose, perché dirle io era come chiamare gli applausi.
Ho avuto molto entusiasmo, erano pieni di gioia, deliranti.
Hanno apprezzato molto ciò che ho detto dei sardi. I bambini sono piccoli, patitini. Miglioreranno.» Reduce dal viaggio inaugurale a Carbonia, Benito Mussolini esterna a Clara Petacci le proprie sensazioni (segue pagina 16)
15
(segue dalla pagina 15) che la Petacci annota nel suo diario in data 19 dicembre 1938.
E in una telefonata serale sempre alla Petacci aggiunge: «Sono inquieto, perché sul giornale c’è scritto “l’autarchico carbone”, mentre io ho detto “l’autentico carbone”. È un significato completamente diverso. Ah! non ci sanno fare, sbagliano sempre tutto.» La data che è comunemente celebrata come l’anniversario della città è quella dell’inaugurazione, che avvenne nella giornata nazionale della fede per la patria fascista(commemorazione introdotta dal 1935 con le donazioni delle fedi delle spose italiane), il 18 dicembre 1938, alla presenza di Mussolini in persona il quale, nella sua seconda visita al bacino carbonifero del Sulcis, tenne un discorso inaugurale e propagandistico dalla torre Littoria in presenza di circa 35 000 persone radunate nella centrale piazza Roma, a conclusione dei lavori di edificazione del centro urbano della città, la seconda a carattere minerario realizzata dal regime dopo Arsia.

Seguì poco dopo un riconoscimento per Carbonia con l’attribuzione del titolo di Città (con Regio decreto legge del 9 febbraio 1939).
Un efficace spaccato di ció che fu la costruzione di Carbonia e delle realtà
Foto wikipedia.org
umane che vi contribuirono, affrontando non poche difficoltà, è riscontrabile nel romanzo Terra del carbone di Valerio Tonini, ingegnere che prese parte all’opera in prima persona con la ditta edile di cui era titolare. La città, negli anni dell’autarchia, fu meta di un vasto flusso migratorio da altre regioni dell’isola e anche da oltre Tirreno; si valuta che circa il 25% del primo nucleo di 12.000 abitanti provenisse da altre regioni italiane, in particolare dal Veneto, dalle Marche, dagli Abruzzi, dalla Basilicata e dalla Sicilia (di questo primo nucleo il 90% era costituito da uomini), infatti le miniere di carbone sulcitane lavoravano a pieno regime essendo una delle principali fonti di approvvigionamento di combustibile dell’Italia dell’epoca, fatto che aumentò notevolmente i livelli occupazionali nel Sulcis.
Nel 1940 venne approvato il “piano generale della zona carbonifera di Carbonia” il quale prevedeva un ulteriore sviluppo insediativo attorno a Carbonia, incentrato sia sui centri già esistenti di Portoscuso e Gonnesa (che avrebbero dovuto raggiungere rispettivamente i 20.000 e i 10.000 abitanti), sia su quelli di nuova fondazione come Bacu Abis e Cortoghiana (la cui popolazione prevista era di 10.000 e 5.000 abitanti rispettivamente) per realizzare il sogno di Mussolini di fare del Sulcis una sorta di “Ruhr italiana”.
Tuttavia, a causa della guerra, il piano venne accantonato e nel periodo compreso tra il 1940 e il 1943 tutte le miniere del bacino carbonifero del Sulcis furono militarizzate: furono raggiunti i massimi livelli di produzione di carbone con grandi sacrifici e numerosi incidenti sul lavoro, anche mortali.
La Carbosarda, forte della condizione di azienda militarizzata, attuò un regime di sfruttamento con provvedimenti arbitrari come l’aumento del costo dei viveri di prima necessità negli spacci aziendali e del costo dell’energia, fino all’aumento degli affitti per le case dei minatori e per gli alberghi operai, in contrasto con gli accordi contrattuali, tanto che vi fu quasi subito un’unanime reazione di contrapposizione da tutti i lavoratori del bacino carbonifero del Sulcis.
Così il 2 maggio 1942 nella città vi fu uno sciopero, non il primo in Sardegna e tra i primi in Italia durante il ventennio e la guerra, organizzato contro il caro vita da cellule clandestine del Partito Comunista e diretto da Tito Morosini, delegato confederale del sindacato corporativo fascista dei lavoratori, iniziato con l’astensione totale dal lavoro nei pozzi carboniferi di Sirai. Circa due settimane dopo, il 15 maggio 1942, venne inaugurata Cortoghiana (anche in questo caso alla presenza di Mussolini, che, alla sua terza visita nel Sulcis, fece un secondo discorso in piazza Roma a Carbonia),

tuttora una delle frazioni più popolate di Carbonia, da cui dista pochi chilometri.
Durante la Seconda guerra mondiale, nel 1943, Carbonia fu bombardata tre volte dagli aerei alleati, seppur subendo danni minori rispetto a quelli patiti da altri centri dell’isola.
Dopo la fine del conflitto e la caduta del fascismo si visse un nuovo periodo di espansione economica, essendo le miniere carbonifere sulcitane rimaste le sole a poter garantire adeguati livelli di produzione nel paese, dopo che l’Istria e i suoi giacimenti erano passati alla Jugoslavia.
Dal 5 ottobre 1948 al 16 dicembre dello stesso anno fu effettuato lo “sciopero bianco” di 72 giorni per contrastare le misure repressive e provocatorie della direzione della Carbosarda, in attuazione di una rigida politica di costi e ricavi nella gestione aziendale, posta in essere con licenziamenti e trasferimenti di personale (soprattutto quello più politicizzato e sindacalizzato), aumento indiscriminato dei fitti delle case e degli alberghi operai, dei viveri negli spacci aziendali, dei prezzi dell’energia e del carbone ceduto alle maestranze, riduzioni arbitrarie degli stipendi anche con applicazione delle multe ai dipendenti responsabili di presunti disservizi.
(segue pagina 18)
17
(segue dalla pagina 17)
Lo sciopero bianco si attuò con la “non collaborazione”; i minatori, presenti regolarmente al lavoro nei cantieri minerari, dopo le 8 ore di normale servizio giornaliero non effettuarono più prestazioni straordinarie a cottimo (retribuite secondo la quantità di carbone estratto), in base a precedenti accordi aziendali, tanto che la produttività della Carbosarda scese del 50%.

La direzione della Carbosarda reagì con misure drastiche e incontrollate ancora più pesanti di quelle sopra indicate, ricorrendo con intimidazioni alla Polizia e alla magistratura.
Esplose così, non solo a Carbonia e nel Sulcis, ma anche in tutta la Sardegna e nel resto della penisola, un vasto movimento popolare di solidarietà e sostegno alla lotta dei minatori carboniferi con i seguenti gesti significativi: parecchi lavoratori sottoscrissero a loro favore mezza giornata di paga, come i dipendenti comunali di Carbonia; i commercianti della città aprirono crediti alle famiglie dei minatori; la C.G.I.L. nazionale inviò più volte un contributo di un milione di lire; i minatori di tutta Italia proclamarono uno sciopero di 24 ore in segno di solidarietà. Un tentativo di mediazione fra la direzione mineraria e le rappresentanze sindacali, promosso dal Ministero del lavoro e
Foto wikipedia.org
della previdenza sociale il 19 novembre 1948, fallì per rigidità e intransigenze della Carbosarda. Dopo un lungo braccio di ferro nel quale la Direzione della Carbosarda minacciò di non corrispondere salari e gratifiche natalizie, e dopo che i minatori licenziati si barricarono nei pozzi minerari per non essere allontanati dal posto di lavoro con l’intervento della Polizia, la S.M.C.S., con la mediazione del presidente dell’A.Ca.I., ing. Mario Giacomo Levi (contrario alla posizione portata avanti dalla Carbosarda finora), sottoscrisse un accordo con le rappresentanze sindacali il 17 dicembre 1948, annullando tutti i provvedimenti restrittivi presi (licenziamenti, multe, aumenti dei prezzi nei viveri, nei fitti e nell’energia) e aumentando le retribuzioni, con vittoria quasi totale nella vertenza dei lavoratori carboniferi.
Per questo e altri episodi in cui l’intera popolazione cittadina difese in quegli anni le vertenze sindacali legate al lavoro nelle miniere, Carbonia fu soprannominata dalla stampa con l’appellativo di Stalingrado sarda.
Nel 1949 si toccò la punta massima di popolazione della storia cittadina, con oltre 48.000 residenti e 60.000 dimoranti.
A inizio anni cinquanta con la giunta municipale guidata dal sindaco Pietro Cocco fu avviato un primo
programma politico di riscatto dalla servitù aziendale dell’A.Ca.I., già tentato dalla precedente giunta diretta dal sindaco Renato Mistroni, che coinvolse tutta la cittadinanza appartenente sia alla maggioranza che alla minoranza politica.
Con l’adesione dell’Italia nel 1953 alla C.E.C.A (Comunità europea del carbone e dell’acciaio) si ebbero importanti conseguenze economiche e sociali per il bacino carbonifero del Sulcis e per le miniere a Carbonia.
Con la fine dell’embargo contro l’Italia, i carboni esteri, più economici e con minore presenza di zolfo, portarono alla crisi del settore estrattivo sulcitano, particolarmente grave in quanto all’epoca Carbonia e altri comuni della zona si basavano economicamente su questo tipo di attività.
Nell’autunno del 1962 vi fu il primo ritrovamento di un reperto nel sito archeologico di monte Sirai da parte di un ragazzo di Carbonia.

Tutto ciò desterà un interesse nazionale e internazionale sull’area, tanto che nell’agosto del 1963 vi fu la prima campagna di scavi sul sito archeologico, condotti dalla Sopraintendenza di Cagliari e dall’Istituto Studi del Vicino Oriente dell’Università La Sapienza di Roma.
Nonostante i numerosi scioperi alla fine si assistet-
te alla chiusura di molte miniere sulcitane, e tra queste anche quella di Serbariu, la cui attività estrattiva fu interrotta nel 1964.
Conseguenza di queste dismissioni fu una vasta emigrazione da Carbonia in poco tempo, la cui popolazione si assestò negli anni a seguire sui 30.000 abitanti.
Con l’apertura del vicino polo industriale di Portovesme, finanziato da aziende statali, i livelli occupazionali della zona si risollevarono, seppur in parte.
La popolazione della città aumentò leggermente tra gli anni settanta fino agli anni novanta.
Il successivo disimpegno dello Stato tramite le privatizzazioni di queste realtà produttive, dovuto all’eccessivo debito pubblico, mostrò ben presto la scarsa competitività delle medesime.
Ciò determinò una nuova pesante crisi della città e del suo tessuto produttivo, con una notevole diminuzione dei lavoratori nel polo di Portovesme.
Di conseguenza quest’ultimo fattore determinò un riaumento dell’emigrazione, che portò la popolazione a diminuire in meno di dieci anni di circa duemila unità.
Tutto ciò fu accompagnato da tragici fenomeni sociali che colpirono duramente soprattutto la popolazione giovanile.
Tra questi si può annoverare la diffusione tra la fine (segue pagina 20)
19
(segue dalla pagina 19)
degli anni ottanta e i primi anni novanta dell’eroina che da un lato determinò l’aumento di fenomeni legati alla cosiddetta criminalità predatoria e dall’altra a un notevole aumento della mortalità giovanile.
Per quanto i dati demografici del 2004 abbiano mostrato almeno una minima crescita della popolazione, si possono considerare come esemplificativi della condizione economica della città i tassi di disoccupazione giovanile maschile e femminile: il primo si attesta al 57%, mentre il secondo ben al 71%.
Tuttavia nel primo quinquennio degli anni 2000 vi è stata una notevole crescita del settore dei servizi, in particolar modo grazie alle nuove attività commerciali sorte in città.
Negli ultimi anni inoltre la città sta giocando la carta del turismo legato soprattutto all’archeologia industriale: a questo riguardo va segnalata la ristrutturazione della vecchia miniera di Serbariu, riconvertita a museo (ospita il Centro Italiano della Cultura del Carbone), e i lavori di ristrutturazione del centro storico (piazza Roma), ora più simile allo stile della fondazione.
Con l’attività di diversi comitati cittadini, ma grazie anche alla sensibilità e all’impegno di parlamentari e rappresentanti politici nelle istituzioni legislative e amministra-
tive, il 12 luglio 2001 viene istituita la Provincia di Carbonia-Iglesias, con l’approvazione della Legge Regionale numero 9 da parte del Consiglio della Regione Autonoma della Sardegna che crea quattro nuove province nell’isola, le quali divennero poi operative a seguito delle elezioni provinciali dell’8 e 9 maggio 2005.
Il 12 ottobre 2005, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 21 (Determinazione del Capoluogo. Atto Statutario.) a Carbonia, unitamente a Iglesias, è stata ufficialmente attribuita la qualifica di capoluogo della Provincia di Carbonia-Iglesias.
Tale situazione si manterrà sino al 2016, anno del passaggio del territorio del dismesso ente intermedio sulcitano alla Provincia del Sud Sardegna[53], di cui Carbonia diveniva il capoluogo, sebbene a titolo provvisorio, il 31 maggio di quell’anno.
Carbonia (Carbónia o Crabónia in sardo) conta oggi 26 217 abitanti.
Principale centro abitato del Sulcis, Carbonia è la nona città in Sardegna per numero di abitanti, nonché la più popolosa della provincia e in generale dell’intero sud-ovest sardo.
Terminata l’epopea mineraria, Carbonia è diventata centro di servizi per il territorio, basando la sua economia principalmente sul settore terziario e sull’indu-
 Foto wikipedia.org
Foto wikipedia.org
stria, grazie alla vicina area industriale di Portovesme, nel comune di Portoscuso.
La morfologia del territorio è in buona parte di bassa collina e pianura, con rilievi di altitudine modesta (tra i quasi 500 metri del colle più elevato del comune alla decina di metri del punto più basso del territorio comunale), che nonostante ciò vengono impropriamente denominati monti, tra cui monte Sirai (da cui si può ammirare un panorama sulla laguna di Sant’Antioco e sull’arcipelago del Sulcis (isole di Sant’Antioco e di San Pietro), monte Tàsua, monte Crobu, monte San Giovanni, monte Leone e monte Rosmarino. Il colle più elevato nel comune è il monte San Michele Arenas (in sardo Santu Miali), alto 492 m s.l.m.. Su questo colle, dove si può ammirare un vasto e notevole panorama di buona parte del territorio sulcitano costiero e montano, nei pressi dei ruderi della chiesetta di San Michele (ormai scomparsa e forse di origine bizantina), il ricercatore nonché generale Alberto La Marmora pose nel 1839 un punto geodetico centrale e principale per la Sardegna sud-occidentale con collegamenti maggiori (a nord con il monte Linas, a sud-est con Punta Sebera, a sud con capo Teulada, a sud-ovest con l’isola del Toro e ad ovest con Guardia dei Mori nell’isola di San Pietro) e altri collegamenti minori con altri punti del territorio.
Dal punto di vista idrografico il comune comprende basilarmente due bacini principali ed altri corsi minori, con l’abitato che è attraversato a sud dal rio Santu Milanu e ad est dal suo affluente rio Cannas (ovvero “rio delle canne”), due corsi d’acqua a carattere torrentizio come la prevalenza dei corsi d’acqua nel territorio carboniense, i cui alvei (canalizzati nel centro abitato) sono in secca per buona parte dell’anno e terminano nella laguna di Sant’Antioco.
Il rio Santu Milanu o Santu Millanu (che significa rio “San Gemiliano”, santo del I o II secolo d.C. originario di Cagliari) era denominato nelle carte catastali dell’Ottocento riu Bau Baccas (“guado delle vacche”).
Ad essi si aggiunge il rio Flumentepido (che significa fiume tiepido, dalla vicinanza del suo corso alle sorgenti ipotermali di Aquas Callentis, ovvero “acque calde” in sardo), che scorre poco più a nord all’esterno del centro urbano di Carbonia e che attraversa alcune delle frazioni del comune. Scorre per un breve tratto nel territorio comunale anche il rio Cixerri (idronimo che deriverebbe da “sicherru”, secco), uno dei principali corsi d’acqua della Sardegna meridionale avente foce nello stagno di Cagliari.
 Autori Diversi Wikipedia.org
Autori Diversi Wikipedia.org
21
Ma perché, a voi sembra forse un’operazione per valorizzare l’artigianato?
In realtà è una questione un po’ più complicata e articolata di così, e forse sarà opportuno cercare di fare un po’ di chiarezza in più.
Eugenio Tavolara, che nasce artigiano, oltre che un grande artista era un uomo altruista e illuminato, la sua grandezza prima che per i meriti artistici personali, va cercata nella sua valenza sociale e culturale, nell’accezione più nobile del termine.
Volle con tutte le sue forze quel Padiglione “Il Padiglione dell’Artigianato”, questo per tutti è sempre stato il suo nome.
Venne progettato dall’altro padre dell’artigianato e seconda colonna dell’I.S.O.L.A, Ubaldo Badas, altro grande dimenticato.
Lo volle per promuovere e valorizzare le imprese artigiane che aveva contribuito in maniera sostanziale a far nascere, levando la tessitura, e tutti gli altri mestieri, dai sottoscala dove erano relegati, per farli assurgere alla dignità di imprese artigiane.
Trasformando così l’oscuro lavoro sociale, spersonalizzato, non riconosciuto e non retribuito, in un lavoro remunerativo e di grande impatto, economico ed estetico, da immettere con grande dignità sul mercato.
Foto saracollu
RIAPRE IL PADIGLIONE A SASSARI

“Il Padiglione” sarebbe stato la loro vetrina, il loro salotto buono dove mostrare la bellezza delle nostre tradizioni e la forza dell’innovazione.
Per molte decadi, con le sue “Biennali dell’Artigianato”, è stato il punto di riferimento per tutti gli artigiani della Sardegna, guardati con ammirazione e invidia da tutta l’Italia.
Poi un giorno qualcuno ha deciso di buttare il bambino con l’acqua sporca e ci ha sfilato il “Nostro Padiglione”.
Gli hanno cambiato il nome, lo hanno dedicato a Tavolara, facendo finta di non sapere che in realtà stavano tradendo l’idea e la filosofia del progetto di Tavolara.
Sembra una di quelle situazioni che si vedono nei film sulle forze armate, quando si promuove qualcuno per estrometterlo da un ruolo.
Oggi, dopo vent’anni, il Padiglione riapre con ben altro progetto rispetto a quello per cui è nato, e per lavarsi la coscienza e rabbonire l’opinione pubblica, o meglio per nascondere le mire di personaggi in cerca di visibilità ad ogni costo, si invitano gli artigiani ad allestire quello che, per questo spazio, è poco più di un corner.
Non mi sembra una grande festa, dover andare a fare merenda in quella che era la tua casa ed ora è irrime-
diabilmente occupata.
Sarà che ho vissuto il Padiglione e una decina di Biennali prima, e la distruzione scientifica dell’artigianato poi, sulla mia pelle, per non capire di che razza di operazione stiamo parlando.
Il Padiglione era il tempio “dell’artigianato sardo”, e questo un’entità unitaria, ancorché composta da centinaia di imprese, che godeva di un’immagine forte, in Sardegna e fuori.
Un fiume di ricerca e di stimoli reciproci che favorivano la crescita di tutti e che andava in un’unica direzione, pur rispettando la ricerca articolata e la sensibilità dei singoli.
Oggi, paradossalmente, il livello qualitativo è cresciuto, ma ciascun artigiano è un mondo a sé e le occasioni di avere contatti e contaminazioni reciproche sono quasi inesistenti.
Non ci sono più luoghi e occasioni per mostrare i frutti del proprio lavoro e potersi confrontare con i colleghi.
Hanno distrutto l’artigianato svuotandolo dall’interno, gli hanno levato la sua anima.
Affinché fosse una scelta senza possibilità di ripensamenti, hanno dismesso il Padiglione di Sassari, la Sala Figari della Fiera di Cagliari, tutti i centri pilota sparsi per la Sardegna, i vari negozi ISOLA in Sardegna e fuori.

Come in un assedio in cui si tagliano i viveri e si blocca l’acqua.
È mancato solo il sale da spargere.
Poi hanno detto e ripetuto all’infinito che gli artigiani dovevano limitarsi ad eseguire, che progettare e inventare forme nuove non era affar loro.
Nelle poche manifestazioni fatte a nome e con i fondi del nostro comparto, gli artigiani hanno cominciato ad essere chiamati, non come protagonisti ma come comparse, ed altri si sono presi la scena, i meriti ed i soldi.
Proprio il contrario di ciò che la storia ci ha mostrato ed insegnato a cominciare dalle botteghe medioevali e quattrocentesche, fino ad arrivare ad “Arts and crafts”.
L’idea e il progetto nuovo che, confrontandosi con le tradizioni ed incrociando i saperi e la conoscenza dei materiali, genera un manufatto nuovo.
Non bastava tagliare i viveri alienando tutto il patrimonio di spazi e di manifestazioni, bisognava distruggerne le motivazioni, farne una maestranza da manodopera sempre disponibile, in cambio di un tozzo di pane da portare a tavola e al servizio di altri, senza più motivazioni proprie, ridotta a gioire per qualche chiamata da comparsa.
E al diavolo tutti gli altri e tutto il resto.
Giampaolo Mameli
23
uesta è la storia di Gianna, una donna alla quale il destino ha riservato un futuro difficile da gestire.
Carmen in questo romanzo ci regala una storia incredibilmente bella e dolorosa allo stesso tempo, racconta magistralmente la storia della sua famiglia. Una famiglia umile e dignitosa che è costretta a fare i conti con un nemico infimo.
Per combattere il nemico bisognerebbe conoscerlo, ma purtroppo i disturbi mentali non sono semplici da comprendere.
Lei era bipolare, dalla letteratura si sa che è un disturbo caratterizzato dall’alternanza di stati d’umore eccessivamente alto (mania) e patologicamente basso (depressione), ma Gianna non era solo bipolare: lei era grande nell’anima, oltre ogni più futile constatazione del suo essere, ed è questo che Carmen vuole trasmettere, a chi leggerà la sua storia.
Tutto il bene serbato in fondo al cuore da quella straordinaria donna che era, è, e sempre sarà Gianna.
Questo libro in ogni passo regala emozioni sorrisi amari e pugni nello stomaco, ma ancora di più regala amore.
Con quest’opera Carmen non ha solo mantenuto in vita il ricordo di Gianna ma ha regalato una sorella a tutti. Gianna è la sorella di ognuno di noi.
Manuela Aiello
GIANNA SALIS AL PREMIO TOFFA

Carmen Salis è una poetessa e scrittrice cagliaritana. Ha all’attivo dieci pubblicazioni. è direttrice editoriale della casa editrice “AmicoLibro”.
Con AmicoLibro ha pubblicato “Sa Levadora - la maestra di parto sarda” (2014) scritto con Ivan Murgana; “Gianna. Lei, era mia sorella” (2016); “La danza dei fiori secchi” (2018).
“Cose che ho scritto senza titolo” è il suo nuovo libro di poesie.
Ecco come si racconta sul suo sito : Nasco a Cagliari il 18 settembre del 1963. Sono una bambina riservata e silenziosa. Amo scrivere.
La prima storia lunga la scrivo in terza elementare. Poi mi fermo e riprendo a scrivere (solo poesie) a 12/13 anni.
Vorrei frequentare il liceo classico ma i miei mi impongono una scuola professionale. Allora ripiego su una scuola che mi ispira perché si studiano fotografia e grafica.
Mi diplomo quindi come fotolitografa e trovo lavoro presso una litotipografia dove resto per circa dodici anni a dirigere il reparto grafico e la camera oscura. Mentre studio mi preoccupo anche di lavorare e ho la fortuna di poterlo fare in radio.
Q
Foto unionesarda.it
Lavoro per circa un anno presso una radio libera occupandomi della messa in onda e di tutto il resto. Continuo a scrivere e incomincio a partecipare a qualche concorso letterario ma senza successo.
La mia curiosità mi porta sempre a imparare cose nuove e quindi frequento un corso per costumista. Decido anche di regalarmi una bella macchina fotografica e riprendo a scattare saltuariamente.
Mi sposo, lascio il lavoro perché decido di diventare mamma, ma nel frattempo insegno costumistica in due corsi regionali.
Riprendo a scrivere con più impegno. Vinco qualche concorso.
Divento mamma per la terza volta. Decido di riprendermi il sogno di diventare giornalista e mi impegno a collaborare assiduamente con un giornale locale.
Ho la fortuna di incontrare un editore che decide di pubblicare un mio primo lavoro ”Ex eros”, poi nasce il secondo ”Cose da condominio” poi il terzo ”Colloqui invisibili” e poi mi chiede di collaborare con lui. Nel frattempo divento giornalista pubblicista. Mi butto in un lavoro nuovo ma che mi piace da morire.
Leggere e poter parlare di libri mi affascina e mi completa.
Nasce il quarto libro, che è la mia prima raccolta di poesie accompagnate dalla fotografia “Ti regalo il mio cuore” e poi il quinto “Senso Essenze di donna”, poi il sesto “I racconti di Carmé”, dopo di che nasce la casa editrice “Amicolibro”.
Oggi scrivere, fotografare e cantare mi danno respiro; penso di non saper fare niente bene, perché spero di poter sempre imparare il meglio.
Sono curiosa, affamata di immagini e di pensieri. Con la poesia cerco di cantare i movimenti dell’anima.
Con le foto quelli del cuore.
Con i racconti gioco ed esprimo quello che vedo e che non mi piace.
Con i libri degli autori che ho la fortuna di accompagnare nel loro cammino mi nutro e respiro cose nuove. Non riesco a oziare.
Mi piacciono i gatti perché sono irraggiungibili. Amo tutta la musica al momento giusto. Detesto l’ipocrisia, la presunzione e la finta umiltà.
Vorrei essere eterna perché mi piace vivere.
Carmen Salis
FINALISTA AL PREMIO LETTERARIO

NADIA TOFFA E’ STATA CLASSIFICATA SECONDA CON “GIANNA LEI ERA MIA SORELLA”. www.carmensalis.it www.amicolibro.eu
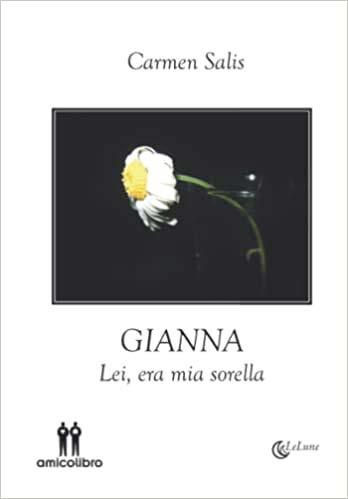
25
ino a qualche tempo fa si pensava che il vino e la coltivazione della vite, il suo addomesticamento coincidesse con l’arrivo in sardegna dei Fenici nel 900 a.C. circa e poi successivamente si diffuse in tutta l’isola con i Cartaginesi nel VI secolo a.C. e poi con Romani.

Oggi grazie a recenti scavi e analisi sempre più efficaci e precise possiamo dire che il vino e la vite sono presenti in Sardegna gia nel 1.500 a.C. nel periodo detto Bronzo Medio e poi nel Bronzo Recente.
In questi periodi ci sono rapporti e commerci con il bacino orientale del Mediterraneo, lo si vede dalle ceramiche molto piu raffinate e adatte a contenere liquidi di pregio, come vino e olio di oliva.
Ecco che nel sito del Nuraghe Antigori ritroviamo ceramiche micenee di importazione e quelle di imitazione locale, ma anche ceramica nuragica ( grigia), altro materiale è stato ritrovato al Nuraghe Arrubiu.
Nel Bronzo Finale, cioè nel periodo di maggior splendore della Civiltò Nuragica possiamo dire che la coltivazione della vite e il vino sono diffusi in tutta la Sardegna, i contenitori per il vino si evolvono in splendide brocche Askoidi tipiche sarde, ritrovate in tanti siti tra cui Nuraghe Lugherras, il Nuraghe Gen-
SARDINIA INSULA VINI
Foto gianmariofigonifrau
na Maria e il Nuraghe Santu Antine e Arrubiu di Orroli, a Santa Anastasia di Sardara e tanti altri. Brocche Askoidi sono state ritrovate in Sicilia, Tunisia, Spagna e tanti altri luoghi. Recentemente un ritrovamento straordinario, nel Nuraghe Adoni sono stati ritrovati acini carbonizzati, in uno strato datato con certezza al 1200 a.C. cioè Bronzo Finale. Siamo certi dal punto di vista scientifico che in Sardegna già dalla metà del II millennio a.C. era presente la vite e il vino. Non abbiamo invece prove per il periodo Preistorico, ma è abbastanza probabile visto i rapporti con altre popolazioni che gia conoscevano il vino e avevano addomesticato la vite.
Gian Mario Figoni Frau
Iritrovamenti archeologici di vinaccioli in Sardegna hanno confermato che alcuni dei vitigni sardi, ritenuti a torto portati da oltremare, sono invece autoctoni, derivati dalla vite selvatica locale. Ritrovamenti che possono riscrivere la storia del vino. La vite è stata addomesticata più di 7000 anni fa nel Vicino Oriente, e la Sardegna nuragica è stata uno dei centri più importanti di addomesticamento secondario di questa pianta.
F
Semi di vernaccia e malvasia risalenti a circa tremila anni fa ritrovati in un nuraghe nelle vicinanze di Cabras fanno ritenere che la coltura della vite nell’Isola fosse conosciuta sin dall’età del bronzo.
Antichi miti sardi raccontano che l’eroe culturale Aristeo, nato dalla Terra, girovagò per il Mediterraneo portando con sé tecniche ed arti per addomesticare le api, cagliare il latte, coltivare cereali, ulivo e vite; si fermò anche in Sardegna dove rivoluzionò la cultura degli uomini di allora, insegnando loro anche come fare il vino.
Il vino è stato, sin dalla Preistoria, un prodotto che ha suscitato nell’uomo ammirazione, rispetto, venerazione: si pensi alle divinità greco-romane connesse al vino, Dioniso e Bacco, e ai miti e riti che lo vedono protagonista; e naturalmente anche timore per gli effetti nocivi dell’abuso di alcool.
Per questo la vinificazione era, nell’antichità, sotto stretto controllo delle autorità politico-religiose e appannaggio solo di determinate classi sociali.
I ricercatori concordano nel situare il centro di domesticazione della vite e il suo utilizzo come bevanda alcolica in una zona compresa tra l’Iran e la Turchia, più di 7000 anni fa.

Già da tempo la Sardegna è stata però additata come uno dei centri secondari di domesticazione della vite
più importanti del Mediterraneo occidentale.
In effetti la viticoltura, la produzione di vino e di mosto d’uva cotto (sa sapa) detengono una lunga e importante tradizione sull’Isola, confermata da numerose fonti storiche di Età antica e moderna e dalle pratiche alimentari tradizionali osservate.
Le recenti scoperte sono avvenute nell’insediamento nuragico di Sa Osa, non lontano da Oristano e da Cabras, cittadina nei pressi della quale sono venuti alla luce i cosiddetti “giganti di Mont’e Prama”, statue alte oltre 2 metri che rappresentano pugilatori, guerrieri, arcieri, di 3000 anni fa.
A Sa Osa sono stati ritrovati numerosi vinaccioli in un pozzo che fungeva da contenitore di derrate alimentari, risalenti tra la fine della Media età del bronzo e l’inizio della Tarda età del bronzo; le analisi sul Dna sembrano confermare l’apparentamento di queste viti con due importanti vitigni locali, Vernaccia e Malvasia.
La Sardegna non è nuova a scoperte del genere. Alcuni anni fa nel complesso del nuraghe Arrubiu di Orroli si trovarono alcuni vinaccioli carbonizzati: le analisi molecolari convalidarono la somiglianza con due vitigni sardi, Bovale sardo e Muristellu.
Questi ed altri ritrovamenti (segue pagina 28)
27
(segue dalla pagina 27) hanno retrodatato e rivoluzionato la storia della vite in Sardegna, che tradizionalmente si voleva fosse iniziata grazie ai contatti con i Fenici, dal IX secolo a.C.
In buona sostanza, alcuni dei vitigni sardi che si riteneva fossero stati portati da oltremare da Fenici, Romani, Spagnoli eccetera nel corso dei secoli e delle dominazioni susseguitesi sull’Isola, si stanno invece rivelando autoctoni, addomesticati e selezionati a partire dalla vite selvatica locale. Certamente nei prossimi anni le ricerche archeologiche e archeobotaniche, supportate da quelle di botanica molecolare, daranno risposte alle tante questioni ancora sul tavolo.
Le fonti storiche hanno da sempre indicato l’Isola come un laboratorio vitivinicolo interessante e complesso, basti pensare alle parole dello studioso Andrea Bacci che nel 1586 nella De Naturali vinorum Historia appellò l’Isola “Sardinia insula vini”. Definizione lusinghiera, che si è rivelata anche profetica.

Alessandra Guigoni http://www.etnografia.it/
Scrittore, sceneggiatore e regista, Bepi Vigna (Nuoro, 1957) collabora da oltre trent’anni con Sergio Bonelli Editore.
È uno dei creatori di Nathan Never e tra gli altri ha scritto sceneggiature per Dylan Dog, Zagor e Martin Mystère. Nel 1993 ha fondato a Cagliari il Centro Internazionale del Fumetto, che dirige. Recentemente è stato nominato direttore artistico del Museo del Fumetto a Norbello (in provincia di Oristano), che si appresta a diventare polo del fumetto in Sardegna. Lo abbiamo intervistato. Già direttore del Centro Internazionale del Fumetto a Cagliari, hai appena ricevuto la nomina per dirigere il Museo del Fumetto a Norbello. Quali sono gli obiettivi che intendi raggiungere? Gli obiettivi sono gli stessi che guidano l’attività della nostra associazione, fin da quando nel 1993 è nata la scuola di fumetto (la prima in Sardegna) da cui deriva l’attuale Centro Internazionale del Fumetto: diffondere la cultura dell’immagine, studiare i media cinema e fumetto, valorizzare la grande tradizione che la Sardegna può vantare nel campo dell’illustrazione. La grafica applicata rappresenta una parte importante della cultura sarda e dovrebbe essere il nostro fiore all’occhiello, anche se spesso viene trascurata. C’è da dire, inoltre, che in un’epoca di culture con-

DI
SI CANDIDA A DIVENTARE UNO DEI PROTAGONISTI DELLA NONA ARTE IN SARDEGNA E NON SOLO. A RACCONTARLO È
IL MUSEO DEL FUMETTO E DEL DESIGN INTERATTIVO
NORBELLO
BEPI VIGNA, IL NUOVO DIRETTORE ARTISTICO DELLA SEDE IN PROVINCIA DI ORISTANO
Foto artribune.it
Foto artribune.it
vergenti e di interazione tra i vari linguaggi della comunicazione, occuparsi di fumetto e cinema vuol dire spaziare anche in altri campi della comunicazione. A Norbello sorgerà uno spazio dedicato anche alla realtà virtuale, dove saranno protagonisti i Peanuts. Per la gestione del museo ti affiderai a uno staff?

Curerò la direzione artistica potendo contare sull’aiuto e la competenza delle mie colleghe che mi affiancano da anni: Stefania Costa (che ha sempre curato i nostri allestimenti), Laura Congiu e Lorella Costa. Poi c’è l’amico Raffaele Piras, uno dei maggiori collezionisti sardi di fumetti, che vivendo a Norbello sarà presente spesso al museo per informare il pubblico e guidarlo alla visita delle mostre. Gli aspetti logistici e di gestione resteranno in capo al Comune e alla Pro Loco. Quali sono le tue aspettative?
Credo che investire nella cultura sia importante: un’iniziativa come questa può avere una ricaduta anche sul turismo. Occorre che l’amministrazione comunale ci creda fino in fondo. Se ciò accadrà, sono convinto che i risultati saranno sorprendenti. Ci parli della mostra inaugurale? Abbiamo pensato di mostrare al pubblico dei lavori originali di autori che hanno fatto la storia del fumetto. Le strisce e le tavole nascono per essere riprodotte,
ma all’origine sono pezzi unici, che ormai hanno catturato l’interesse dei collezionisti d’arte. Tavole dei grandi maestri vengono vendute nelle gallerie con quotazioni spaventose. Con questa mostra vogliamo provare a riflettere su come sia cambiata l’arte e l’idea dell’unicità dell’opera. Con quali criteri selezioni gli autori da esporre? Nel caso della mostra Originalia ci siamo basati sul materiale che sia noi del Centro del Fumetto sia Raffaele Piras avevamo a disposizione, scegliendo opere particolari, che coprissero un ampio arco nella storia del medium fumetto e potessero suscitare emozioni e ricordi in un pubblico di differenti età. Abbiamo una striscia di Paperino di Al Taliaferro, una tavola dell’Eternauta di Solano Lopez, alcune tavole di un giovane Milo Manara, altre della Marvel o di fumetti italiani degli Anni Cinquanta e Sessanta come Il grande Blek, Capitan Miki e Tex. Accanto a queste, però, abbiamo esposto anche dei “cels” (rodovetri) di alcuni famosi cartoni animati giapponesi, che magari il pubblico più giovane può riconoscere più facilmente. Quali vantaggi potrebbe trarne la Sardegna? Credo che in Sardegna sia necessario fare dell’attività culturale che permetta di dialogare con il mondo. (segue pagina 30)
29
dalla pagina 29)
Da questo punto di vista, organizzare degli eventi che riguardano il fumetto può essere molto utile, perché il linguaggio dei fumetti è universale, e i fumetti fanno parte della cultura di una vasta fetta di pubblico. Puoi anticiparci gli eventi in programma?
Non ci saranno solo mostre, ma anche incontri con autori e convegni dove cercheremo di approfondire aspetti legati al nuovo sistema dei media che si è venuto configurando in questi ultimi anni.
Il fumetto è un linguaggio ibrido che interagisce molto bene con altre forme di comunicazione e ne terremo conto. Come mostre, a febbraio ne proporremo una sui supereroi, che sarà anche l’occasione per ragionare su questi personaggi, ormai popolarissimi anche grazie al cinema, che costituiscono una grande mitologia moderna, e nei quali si riflettono molti aspetti della società contemporanea.
IPAZIA MARTIRE
Ci sono donne che, a quanto pare, rompono i coglioni anche da morte.

Sì, rompono proprio i coglioni: non si può usare altri termini, ché definirle “scomode” o “controcorrente” non rende appieno il profondo e radicato odio che riescono a suscitare attorno a sé.
Quelle donne lì, rompono proprio i coglioni. Anche se non fanno niente, per il solo fatto di esistere e di essere così come sono.
Che poi, così come sono, a non far niente oltre che esistere non sono capaci, e quindi rompono i coglioni ancor di più.
Ecco, Ipazia doveva essere proprio una di quelle. Una donna. Nel mondo antico, dove, per quanto la mentalità fosse un po’ più aperta di quanto sarà nel medioevo, non è che poi nascere donna fosse ‘sto ballo di carnevale. Greca, di origine.
E anche lì, bella roba. Perché i Greci erano tanto democratici in tutto, quando si parlava di uomini, ma le loro donne, al contrario dei Romani, le avevano sempre tenute, per quanto possibile, sepolte all’interno dei ginecei, a filare pepli per le Atene di turno.
Siccome donna e greca non le bastava, Ipazia divenne, in prima battuta, matematica. Cioè una donna che pretende di occuparsi di numeri e teoremi, campi che
(segue
Norbello, Museo
e del Design
San
Norbello Tel. +39 0785 519927 Cell. +39 347 3846907 midi.norbello@gmail.com culturaistruzione@comune.
www.facebook.com/midi
Roberta Vanali
dell’Immagine
Interattivo vico
Giovanni, s.n.c.09070
norbello.or.it
norbello
Foto agora
ancor oggi, quando nel nostro secolo illuminatissimo sono giudicati interessanti da qualche fanciulla, la fanciullina in oggetto viene guardata strana, perché si sa che le donne e i calcoli non quagliano, e l’unica possibile applicazione della matematica per una donna è contare gli spicci nel portafoglio per capire se può comprare subito o meno il favoloso maglioncino che ha visto in vetrina. Vabbe’, in lei lo si poteva scusare, forse, quell’interesse peregrino, perché il babbo Teone era matematico anche lui, ad Alessandria.
Si fosse limitata a fargli da segretaria, ricopiando qualche teorema qui e là, chiosando le sue chiose, la passioncella per la matematica gliela avrebbero perdonata.
Però Ipazia, che comincia come collaboratrice del padre, subito si dimostra qualcosa di più di una figlia devota che porta al babbo una tisana mentre quello si affanna sui libri e tiene in ordine i papiri degli appunti: il papà chiarisce, nell’incipit del suo commentario a Tolomeo, che il saggio è stato controllato punto per punto dalla figlia, la filosofa Ipazia. Il che lascia capire che, dei due, quella che aveva una conoscenza più approfondita della matematica pura e delle sue implicazioni teoretiche e filosofiche era Ipazia, e non il padre.

Insomma, era lei che veniva chiamata in aiuto da lui, per avere conforto e consulenza.
Difatti Ipazia studia geometria piana ed astronomia, probabilmente getta le basi per la costruzione di un più moderno astrolabio (che sarà realizzato dal suo allievo più caro, Sinesio di Cirene), e, in virtù del suo prestigio, diviene ben presto nome di punta e probabilmente anche vera e propria direttrice della scuola di Alessandria, istituzione erede, anche se appannata, del Museo fondato dai Tolomei come tempio di ogni sapere.
Oltre alla cattedra di matematica, insegna anche filosofia, seguendo la corrente neoplatonica fondata da Plotino: quella teoria che ipotizzava una Luce che si espanda piano piano, e, corrompendosi ed appesantendosi, si trasformi in materia: non è proprio la E=mc² di Einstenin, però qualche latente influsso su Einstein stesso da parte di queste teorie, molti secoli dopo, è stato ipotizzato.
Eh, già immaginarla così, unica donna in mezzo ad una consorteria di eruditi, che tiene lezioni di filosofia e matematica nella più prestigiosa scuola di alta formazione del mondo antico, altro che giramenti di coglioni doveva provocare in quei maschi che stentavano a far due più due.
Anche perché per le provocazioni, Ipazia doveva proprio (segue pagina 32)
31
(segue dalla pagina 31) avere un certo gusto. Intanto, non s’era mai sposata, quindi era donna, matematica, filosofa e per giunta tanto testarda da rifiutare pure quello che era il destino e l’unica funzione del suo sesso, la riproduzione. Poi di matematica e filosofia teneva pubbliche lezioni, cui si poteva accedere liberamente: quindi non solo donna che comandava a bacchetta un nugolo di studiosi, ma personaggio pubblico, che dibatteva a viso aperto, con gli studenti e con chi era interessato a seguirla. Senza paura, senza timore e senza quel pudor femminile che, secondo gli uomini stupidi, spinge le donne ad una naturale ritrosia, ad evitare il pubblico, il confronto anche violento per sostenere a brutto muso le proprie idee. Sì, una così pare nata apposta per far girare i santissimi e far saltare in un botto tutte le armonie platoniche delle sfere. Ma non pensiamola come una femminista invasata. Da quel poco che le fonti lasciano capire di lei, non è proprio questo il ritratto che se ne tira fuori. Per gestire per anni una struttura come l’antico Museo, e far filare d’accordo, se non d’amore, intellettuali di più discipline, bizzosi ed egocentrici come sempre i professori sanno essere, ci vuole capacità di coordinamento, mediazione, nonché pazienza ed auto-
Foto agora

revolezza. Una menade o una sventata non sarebbero durate due giorni.
Lei invece dura, e al lungo. Non solo: in una città come Alessandria d’Egitto, che è da sempre una miscela sul punto di esplodere per i continui conflitti fra i gruppi etnici e religiosi, diviene una figura di riferimento. È una pagana, Ipazia. In un periodo in cui non è più conveniente esserlo, non è conveniente per nulla. Dopo Costantino, i Cristiani, non più perseguitati, ci han messo poco ad impadronirsi di tutte le leve del potere, e passare in fretta da discriminati in discriminatori.
Ad Alessandria hanno combinato macelli: il vescovo Teofilo ha fatto di tutto per far chiudere i templi pagani, ne ha depredato gli arredi, non perde occasione per provocare i pagani, esponendo persino in pubblico le suppellettili trafugate dai loro santuari.
Ipazia si muove con una buona dose di sangue freddo in mezzo ad una situazione che può degenerare per ogni nonnulla: fa parte di quella corrente politica che si batte perché la cultura tradizionale greca, pagana, possa continuare ad essere conservata e salvaguardata.
Pagani e Cristiani possono secondo lei convivere, perché la religione a cui ciascuno aderisce è un fatto
personale, che non deve creare intoppi o problemi al vivere pubblico.
È una laica, insomma, vuole essere lasciata libera di credere e non credere in ciò che vuole, ed è disposta a concedere a tutti la stessa libertà.
Difatti fra i suoi allievi quello a lei più vicino è Sinesio, che sarà cristiano e diverrà persino vescovo, sempre mantenendo però il massimo rispetto e quasi una forma di devozione nei confronti della sua Maestra. Ma te lo vedi Cirillo, succeduto a Teofilo come vescovo di Alessandria, a sopportare una donna del genere come avversaria?
Una che non urla, non strepita, ma discute? Argomenta, la stronza, e non si riesce ad incastrarla, perché la ragione, ahimè, è roba sua.

Quanto la deve odiare, Cirillo. Ipazia è tutto ciò che lui detesta: una mente pensante, che non si fa intimorire; una studiosa, che pretende di indagare i misteri della Natura invece che crederli semplicemente imperscrutabili disegni divini; una donna, che non vuole starsene al posto assegnato, secondo visione di tutti i bigotti, alla donna nel creato: rifiuta assieme, insomma, Dio e di obbedire. Una bestemmia vivente.
Dalla sua Cirillo aveva Elia Pulcheria, che invece era una di quelle donne che parevano una stampa ed una
figura con i desideri dei cristiani: per non finire sposata a qualche barbaro aveva fatto voto di verginità, perché in quel caso la religione era un ottimo mezzo per evitare di essere allontanata dal potere; bigotta e intrigante, tanto s’era prodigata da riuscire a far convertire il fratello Teodosio al cristianesimo, e anche la di lui moglie; subito dopo lo aveva convinto a scacciare da tutti gli impieghi pubblici i pagani; lo spinse poi a bandire gli Ebrei da Costantinopoli e confiscar loro le sinagoghe. Due donne, l’una l’opposta dell’altra, si ritrovano a fronteggiarsi, infine: l’una con attorno i pagani, intimoriti, spaventati, ma non domi; l’altra Cirillo e i suoi cristiani oltranzisti, che possono contare una schiera di monaci fanatici.
Sono loro, i monaci, che risolvono alla fine il problema per le spicce.
Sono una muta di invasati, che vedono con sospetto tutte le arti e tutte le scienze, perché, come tutti i fanatici, le pensano emanazioni del maligno; figurarsi se poi queste vengono esercitate da una donna, e da una donna come Ipazia, sfrontata, ancora giovane, probabilmente piacente, e orgogliosa.
Una donna che pretende di usare la ragionevolezza per contestare i voleri di Dio e quelli della pia Pulcheria che da Dio è direttamente ispirata, per mezzo (segue pagina 34)
33
(segue dala pagina 33)
di Cirillo, vescovo, futuro santo e suo consigliere.
La aspettano una sera, i monaci, mentre torna a casa.
É notte. Le vie di Alessandria sono vicoli oscuri, pieni di ombre. Fermano la lettiga, la trascinano giù per i capelli, la sbattono sul selciato. E poi le si buttano addosso armati di pietre e di cocci di vaso acuminato. Non la uccidono, la macellano.
Usano gli ostraca, i cocci appuntiti, come dei macete: la fanno a pezzi, strappandole le carni dalle ossa mentre è ancora viva, scavandole gli occhi via dalle orbite, mentre, dicono i testimoni, ancora respira.
Poi, non contenti, prendono quello che resta del suo cadavere e lo portano in giro per la città, come un trofeo, per bruciarlo e disperderne le ceneri maledette.
È una furia belluina, senza freno: non le perdonano l’essere stata pagana e l’essere stata donna, il suo aver infranto tutte le abitudini e le convenzioni.

Vogliono punire quell’orgoglio che le ha fatto credere di potersi comportare non come una femmina ma come un essere umano pensante, in un’epoca in cui pensare autonomamente era pericoloso anche per un maschio.
È il branco che sbrana chi osa ribellarsi alla sua
legge, perché una donna così fa girare i coglioni, una donna così non ha il diritto di vivere. Muore male, Ipazia. Difficile immaginare morti più violente, senza dignità, morti peggiori.
L’inchiesta che viene aperta, è chiusa in fretta: Elia Pulcheria copre ciò che può, limitandosi a porre i monaci sotto il suo diretto controllo, un modo per dire grazie, ma adesso zitti, che sennò la faccia ce la perdo davvero; Cirillo nega di essere coinvolto, anche se l’ombra del dubbio gli rimane appiccicata per sempre; Sinesio è sconvolto, ma, lontano nella sua Cirene, nulla può se non piangere in silenzio.
Di Ipazia non si parlerà più per secoli.
Il suo nome è noto solo agli addetti ai lavori, filosofi, storici del mondo antico.
Il grande pubblico poco sa di lei ed ignora sia la sua esistenza che la sua morte.
Oddio, potrebbe saperne di più, se in Italia venisse finalmente distribuito un film dello spagnolo Alejandro Amenábar, che narra la sua vicenda.
Ma il film in Italia non trova un distributore, nonostante in Spagna sia già campione di incassi e altrove sia stato presentato in numerosi festival, sempre ottenendo buone accoglienze.
Foto the vision.com
Si dice e si sussurra che dietro alla mancata diffusione ci sia una certa insofferenza del Vaticano nel vedere spiattellata così la condotta di due santi, Cirillo e Elia Pulcheria, nonché dei monaci alessandrini assassini e linciatori: potrebbero sconvolgere il pubblico, questi ritratti poco edificanti di un vescovo e del suo entourage: siamo un paese dove i preti sullo schermo sono sempre o dei Don Camillo e o dei Don Matteo. E dove le donne come Ipazia faticano ad essere considerate eroine.
Sono donne che fanno girare i coglioni, ma tanto, e anche quando sono morte da secoli, sì.

Galatea Vaglio Agora (Ágora) è un film del 2009 diretto da Alejandro Amenábar, interpretato da Rachel Weisz. Il film narra in forma romanzata la vita della matematica, astronoma e filosofa greca-alessandrina Ipazia, durante l’epoca delle persecuzioni anti-pagane stabilite per legge dai Decreti teodosiani, fino alla sua morte che nel film avviene nel marzo del 415. Le riprese sono state fatte nei siti di Forte Ricasoli, Delimara, Medina, La Valletta e Marsa Scirocco sull’isola di Malta, sono cominciate il 15 marzo 2008 e sono durate quindici settimane.
https://youtu.be/fvAQouicCwU https://youtu.be/6tvIjZXGo7s
INTERNATI MILITARI ITALIANI
con degli amici mi hanno raccontato la storia di due Ogliastrini loro parenti e sapendo che le loro vicende in guerra mi appassionano mi hanno chiesto di trovargli delle informazioni.
Masala Giovanni nato nel 1913 a Urzulei in provincia di Nuoro.
Una volta che venne firmato l’armistizio fu come tutti i soldati italiani felicissimo di gettare le armi, invece per lui come tantissimi altri camerati iniziò un calvario...in quei giorni lui si trova a Spalato nel Fronte Croato ed i tedeschi di Hitler che il giorno prima erano loro alleati adesso diventano loro nemici ... più volte gli verrà chiesto di firmare per la nuova Repubblica Sociale Italiana detta “Repubblica di Salò”... ha cominciato a dire no, e poi ha ripetuto all’infinito il no....viene catturato il 09/09/1943 e deportato insieme a tanti altri italiani in un campo di concentramento. Il no di Giovanni era il no alla Repubblica Sociale. Dopo l’8 settembre, non voleva piu combattere e tanto meno insieme ad un’altra nazione che in quel momento non era più alleata, eravamo in guerra con la Germania. Lui insieme a tanti altri Sardi e Italiani furono classificati come IMI, Internati Militari Italiani (segue pagina 36)
35
hiaccherando
C
(segue dalla pagina 35) in modo da non essere riconosciuti come prigionieri di guerra (e di fatto privati di ogni tutela prevista dalla Convenzione di Ginevra). ... fu internato in diversi campi di concentramento e di lavoro tra la Germania e la Polonia ....venne liberato dagli alleati e rientro’ in Italia l’11/09/1945...due anni di inferno. Lui fu alla fine forte e allo stesso tempo fortunato, riuscì a tornare in Ogliastra dalla sua famiglia. Stessa vicenda vissuta dal suo caro amico Erittu Graziano di Baunei nato nel 1919, lui era un aviere dell’Aeronautica Militare ed in quei giorni si trovava a Mestre nel fronte Italiano e venne catturato dai tedeschi proprio l’8 settembre del 1943 nel primo giorno dell’armistizio dove si apprese attraverso i microfoni di Radio Algeri, dal generale Eisenhower che : “Il governo italiano si è arreso incondizionatamente a queste forze armate. Le ostilità tra le forze armate delle Nazioni Unite e quelle dell’Italia cessano all’istante.
Tutti gli italiani che ci aiuteranno a cacciare il tedesco aggressore dal suolo italiano avranno l’assistenza e l’appoggio delle nazioni alleate”. Era l’annuncio dell’armistizio, firmato cinque giorni prima a Cassibile....ma la guerra non era ancora finita per chi non si arrese o si alleava ai tedeschi...morte e dispe-
disegno di Paolo Orsini

Internati al campo di Wietzendorf 29 settembre 1944
paoloorsini
razione aspettava a questi ragazzi, Erittu Graziano fu internato nello STALAG XI A...e non possiamo minimamente immaginare cosa abbia vissuto, difficilmente chi rientro’ a casa aveva il coraggio di raccontare tutte le sofferenze.
Il Baunese Erittu rientro’ il 03/08/1945, anche per lui furono due anni atroci.
Per anni fino ai giorni nostri a questi I.M.I non venne riconosciuto nemmeno la sofferenza subita.
Da un po’ di tempo (2007 circa) lo Stato Italiano ha iniziato ha concedere un piccolo riconoscimento agli oltre settecentomila italiani militari e civili deportati ed internati in Germania.
Le ingiustizie e le sofferenze umane subite non possono essere risarcite se non in misura simbolica e un qualsiasi indennizzo arriva comunque troppo tardi per coloro i quali hanno perso la vita ma comunque è un riconoscimento che invito a tutti i familiari di richiedere anche per fare in modo che il loro sacrificio non venga dimenticato.
“È autorizzata la concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nel lager nazisti e destinati al lavoro coatto, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra
Foto
il 27 luglio 1929 dall’allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l’istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto”. In Ogliastra sono tanti ed invito i familiari a contattarmi per far conoscere la loro storia, molti studi si stanno facendo in Sardegna ed è giusto parlarne per fare in modo che i nostri cari non vengano dimenticati. ONORE agli Internati Militari Italiani.
Luisanna Napoli Le immagini che inserisco sono state prese dal sito https://www.lessicobiograficoimi.it/ .
L’ANRP - Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento, dalla Guerra di Liberazione e loro familiari ha sede centrale in Via Labicana n.15/A, 00184 Roma.
L’ANRP ha origine da quelle organizzazioni spontanee formatesi alla fine del Secondo conflitto mondiale dai Reduci dalla prigionia, dall’internamento (militari e civili) e dalla Guerra di Liberazione (con o senza le stellette).
L’ANRP, riconosciuta Ente Morale con DPR 30 maggio 1949 e successivamente Ente Nazionale con Finalità Assistenziali, DM 10 settembre 1962, senza scopo di lucro, tutela gli interessi morali e materiali dei suoi associati (negli anni successivi alla guerra oltre 600.000) e custodisce il patrimonio morale dei Reduci con l’impegno di trasmetterlo alle nuove generazioni.
DUPONT DI ADRIANA VALENTI SABOURET
MADAME
na poesia, un dipinto, un racconto, un film, un romanzo possono nascere da una scintilla improvvisa, dalla suggestione di un attimo, da un’idea di cui ci si innamora.
O dall’incontro con un personaggio carico di fascino e di mistero.
E allora scrivere diventa una spinta compulsiva, che si autoalimenta con il tenace studio di quest’uomo, per capirne la storia, per interpretarne i sentimenti; e il racconto di una vita diventa ricerca tenace, faticosa esplorazione di documenti, di archivi, di gazzette sepolte nelle polvere dei secoli.
É allora che la Grande storia cede il passo al racconto e l’esistenza di un uomo illumina e dá calore alle vicende asettiche descritte nei manuali universitari.
È l’arte che corregge, che sconfigge la storia e le sottrae l’anima, salvandola, dei suoi protagonisti.
Adriana Valenti Sabouret ha incontrato Giovanni Maria Angioy per caso, traducendo in francese il libro di un autore sardo, e ne é rimasta affascinata: Angioy, il protagonista del “decennio rivoluzionario sardo” che va dal 1789 al 1799 in una spirale di avvenimenti che gettano le basi per il superamento del regime feudale in Sardegna. (segue pagina 38)

37
U
(segue dalla paginan 37)
Su di lui hanno scritto Giuseppe Manno, Dionigi Scano, Carlino Sole senza chiarire gli aspetti problematici della sua personalità: punto di arrivo dell’Illuminismo, sardista ante-litteram o semplicemente un borghese affascinato dalla rivoluzione Giacobina?
L’autrice di “Madame Dupont” sfugge alla trappola di riscrivere per l’ennesima volta la storia politica di un nobile sardo che si ribella al potere sabaudo.
Potrebbe farlo, perche ha una padronanza perfetta della scrittura e della tecnica del racconto, e invece non ci delude: relega la storia in un angolo e si immerge nell’esistenza di uomo che vive di un sogno e ad esso sacrifica i suoi privilegi, le sue ricchezze, la sua famiglia; e descrive la Parigi del suo esilio con la precisione dello storico e con l’amore totale verso una Città unica al mondo.
La Ville Lumiere di Adriana é lo specchio fedele della Città di Madame Dupont.
La scrittrice studia con precisione chirurgica la vita di Angioy, sommo magistrato tormentato, che cerca lealmente di servire il suo Re come Alternos nel Capo di Sopra e poi capeggia la rivolta contro l’arroganza dei baroni; che é condannato a morte per tradimento e fugge a Parigi, terra di asilo, dove troverá altri patrioti sardi suoi amici
di sventura; che vive tra difficoltà economiche e incomprensioni; e che, da sconfitto nella vita, ritrova le sue ragioni di essere nell’incontro con una donna, che diventa intesa, complicità, solidarietà e, nella ricostruzione di Adriana, amore profondo.
Lentamente, ma ineluttabilmente, Angioy si riflette nella giovane donna che lo ospita a casa sua, facendosi carico delle spese non indifferenti per curarlo, e sfugge al personaggio della storia per diventare un uomo vero, fatto di passioni non solo politiche ma umane.
Angioy diventa finalmente Giovanni Maria, é innervato e prende corpo assorbendo l’amore di una donna; vive di emozioni e di sentimenti, cessa di essere oggetto di studi storici e delle polemiche conseguenti. E, come uno specchio che riflette l’eroina del suo libro, Adriana agisce sul rivoluzionario sardo: ci consegna un uomo nuovo, che lascia l’involucro della vita pubblica per ritrovare sé stesso e vivere i suoi sentimenti piu profondi nell’affetto per la sua donna.
Catherine e Giovanni Maria vivono anni intensi: lei che ama il patriota generoso e colto figlio del 1789, lui che respira l’intensa umanità di quella donna, protettiva e sicura.
Un rapporto che si rafforza nel tempo e diventa simbiosi tra anime alte, nobili.
 Ingresso a Sassari di Giovanni Maria Angioy di Giuseppe Sciuti
Ingresso a Sassari di Giovanni Maria Angioy di Giuseppe Sciuti
É cieco, e vede con gli occhi di Catherine; é disperato e riprende a vivere con la donna meravigliosa che gli dona se stessa.
É lontano dalla sua terra e ritrova in Catherine la sua Itaca. Lui sta morendo e lo sa.
E, alla fine dei suoi giorni, vuole che Catherine sappia tutto di lui, della sua azione politica, delle illusioni e delle cocenti delusioni, dei tradimenti e delle umiliazioni.
Il libro é proprio il lungo racconto dell’agonia fisica di quest’uomo sconfitto: uno Spartaco inchiodato alla vita che fugge, che però vuole ricordare i suoi anni e trova conforto in quella donna che lo ascolta nelle ultime sere alleviandone la paura di essere dimenticato. E qui, per un sortilegio che riesce solo ai bravi scrittori, avviene nel libro la svolta capace di cambiare tutto: Angioy é un nuovo Ettore che incontra Andromaca prima di andare incontro alla morte, come l’eroe troiano le consegna il futuro e la donna diventa la protagonista della storia.
Senza di lei tutto sarebbe dimenticato.
Madame Dupont é testimone della vita di un guerriero, di uno sconfitto, ma ne conosce il valore, la tenacia, la forza d’animo.

E diventa la testimone, la memoria della storia. Ascolta il suo uomo seduta a fianco del letto in cui
giace, lo cura nel corpo nell’anima, lo disseta e lo rianima, gli legge passi di libri che ama, lo consola con le considerazioni di Montaigne sulla vita e sulla morte, gli fa incontrare gli amici di esilio; e lo ama con la tenerezza e la sensualità di un’amante.
Una storia d’amore che travalica il racconto storico, che é però arricchito, reso seducente dalla presenza di questa donna affascinante, vera, umanissima, che non lascia un attimo l’uomo amato, che lo lava e lo profuma come una creatura divina, che trema per il suo polso flebile o il respiro interrotto.
Sa che lo perderà e resterá sola nella Parigi che appare come il centro del mondo e che nei colori cangianti della Senna e del suo cielo rispecchia la sua infelicità e la sua gioia.
Ha paura, Catherine, e prega Giovanni Maria di non andare via; lo invita con lo straziante “ne m’abbandonne pas, je t’en prie “, si strugge nei pianti solitari nella stanza vicina a quella dove un uomo si spegne.
Il ritmo lento del libro, ricco di analisi psicologiche dei personaggi, in realtà maschera la paura, che poi diventa nostra, di assistere troppo presto alla fine del patriota e quindi del suo amore per Catherine.
Giovanni Battista muore, e con lui si consuma (segue pagina 40)

39
Adriana Valenti Sabouret
(segue dalla pagina 39) la vita di Catherine, che non trova conforto neppure in terra sarda, dove si recherà per chiedere alle figlie di Angioy di onorare il testamento paterno.
Tornerà a Parigi con il ricordo del silenzio della campagna sarda e della violenza che aveva punito con il fuoco i villaggi schierati a fianco del sogno rivoluzionario del suo Giovanni Maria. É doloroso scoprire che il libro termina, come tutti i libri, ma resta il desiderio di chiedere ad Adriana di non lasciare morire il patriota della rivolta antifeudale e l’uomo che amò Catherine, di continuare le ricerche su di lui in terra francese, di trovare frammenti nascosti della sua vita da esule e di indicarci dove é sepolto, perché i sardi vi si possano inginocchiare e possano onorarne il ricordo.
Tonino Serra Contu
Madame Dupont di Adriana Valenti Sabouret ed. Arcadia 2021 http://www.arkadiaeditore.it/madame-dupont-su-sololibri/
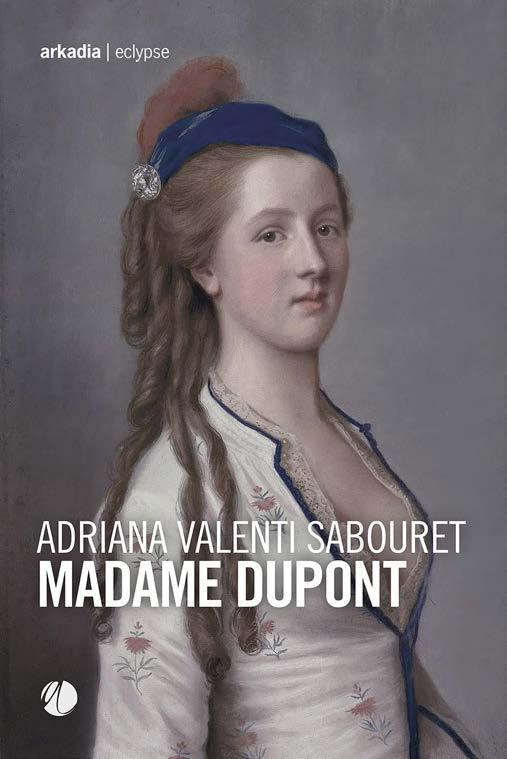
Sorprendente. È il primo aggettivo che viene in mente al termine della lettura di questo Garibaldi, ritratto dell’Eroe dei due mondi pubblicato per la prima volta, postumo, nel 1972, giusto un anno dopo la scomparsa del non ancora cinquantenne Luciano Bianciardi. Sorprendente perché da uno come lui, anarchico, ribaldo, irriducibilmente mai riconciliato con una qualche astratta normalità del Bello Scrivere, al culmine di una vita urlata, di un’esistenza “contro”, ci si aspetterebbe la desacralizzazione del sacro, la demitizzazione del mito, l’abbattimento della statua, il disegno dei baffi alla Gioconda.
In una parola: quel “parlar male di Garibaldi” che cent’anni di Italia postunitaria avevano eletto a tabù impronunciabile. E invece Bianciardi ama Garibaldi di un amore intenso e rispettoso, a volte carico di un trasporto da tifoso accanito; lo ama senza mezzi termini e senza compromessi, al punto da restituirne, in pagine puntualissime sotto il profilo dell’accertamento storico e sorrette da una lingua agile, vivace e modernissima, la stessa, perfetta icona che generazioni di studenti, prima di lui, avevano imparato a conoscere - con sempre maggior disinteressesui sacri testi. Garibaldi a cavallo, eroe senza macchia e senza paura, coraggioso, tenace, schivo e, verrebbe da
 Foto liberliber
Foto liberliber
dire, eterno.
Al punto che la solenne chiusa del libro - “Ancora oggi, per molta gente, il Garibaldi della leggenda torna più comodo del Garibaldi della realtà. Noi, modestamente, abbiamo cercato di farlo scendere dal piedistallo, di ritrovarlo uomo”, appare involontariamente distonica rispetto a quanto s’è appena letto: ma si può davvero chiedere a un eroe, per essere considerato tale, a un uomo per entrare nella leggenda, qualcosa di più e di diverso da quello che Bianciardi ci racconta del “suo” Garibaldi?
Per ritrovare il graffio del Bianciardi della Vita Agra o del Lavoro culturale, allora, bisogna addentrarsi in un percorso completamente diverso. Dare per postulato che l’alterità (per l’autore non certo un vezzo, quanto piuttosto una ragion d’essere) alberghi piuttosto in un “altrove” che si ripromette di fare giustizia di un’antiretorica che, a forza di aggredire il mito, s’è trasformata nella peggiore retorica.
(...) Si era nei primissimi anni Settanta, dopo tutto. Quanto a demitizzazione, il Sessantotto aveva da poco (almeno sotto questo profilo) cambiato il mondo.
Del Risorgimento non sopravviveva che una sbiadita collezione di sfocati busti di gesso (e andrà ancora peggio per i centocinquant’anni del 2011, affrontati quasi con un incomprensibile senso di colpa collettivo).
DI GARIBALDI
LA VITA AGRA
Si era già radicata, presso molti, l’idea che l’Unità non fosse poi stato un grande affare.
L’Italia guardava altrove. Il passato veniva revisionato, come accade periodicamente. I miti, se non proprio vilipesi, congelati. Il Risorgimento? Abbiamo dato, grazie.
Esattamente lo stesso moto di supponente sufficienza con il quale, più avanti, si liquiderà la Resistenza.
Bianciardi, invece, viene da un lungo “feeling” con il Risorgimento.
Garibaldi è la prosecuzione ideale di Da Quarto a Torino e Antistoria del Risorgimento: narrazioni a tratti didascaliche nelle quali la figura di Garibaldi è centrale.

E sempre luminosa. Credere in quella stagione eroica e nella sua persistenza nel tempo è l’atto di fede di un laico che, per quanto disincantato, ha individuato una bandiera nella quale riconoscersi e si ostina a sventolarla ad onta del generale scetticismo. È, ancora una volta, un gesto “contro”.
(...) Che cosa, però, piaceva tanto a Bianciardi, del Risorgimento?
D’impulso verrebbe da dire: lo slancio utopistico di cambiare le cose attraverso la rivoluzione, e quel gusto agrodolce, che da innamorato dei belli e perdenti il grossetano doveva adorare, che dà la consapevolezza del lavoro lasciato a metà: benedetta sia l’Unità, ma si doveva far meglio e di più. Noi siamo eredi di quella imperfezio-
41
ne, e non dobbiamo vergognarcene. Garibaldi è così la figura emblematica dell’intera, epica stagione. Quando descrive l’uomo di mare, nelle parole di Bianciardi senti la spuma del Tirreno; quando tratteggia con convinta passione i passaggi più audaci delle guerresche imprese, avverti l’entusiasmo del ragazzo agitato per il suo simile, la voglia di menare le mani perché senza una spallata, a volte, non si possono cambiare le cose. Viene da sé che l’affetto per Garibaldi non sarà mai disgiunto, in uno come Bianciardi, dalla diffidenza per Cavour. Spesso definito “il diabolico conte”.


L’uomo delle trame, degli accordi sottobanco, del raziocinio e dei piccoli passi. Quello che trasforma in potenza di rango mondiale uno staterello insignificante.
Alla fine - e questo nemmeno Bianciardi può negarlo - il “fine tessitore” sarà il vero artefice, il regista, il trionfatore, se è vero che il Piemonte si farà Italia, o, come dicono molti, l’Italia diventerà un’estensione del Piemonte.
Ma se è vero che senza Cavour avremmo avuto tanti coraggiosi e sfortunati fratelli Bandiera, che ne sarebbe stato del progetto del diabolico conte senza l’utopia di Mazzini e la forza dirompente di Garibaldi?
Be’, in quegli anni l’Italia calcolatrice, raziocinante, un po’ angusta ma aperta agli influssi dell’emergente borghesia europea, l’Ita-
Foto larepubblica.it
lia di Cavour, e quella passionale, ardimentosa, progressista, ma rissosa e lacerata da tensioni e rivalità, l’Italia della sinistra mazziniana, raggiunsero un miracoloso, irripetibile accordo.
Garibaldi incarnò la figura centrale di questo vasto movimento. L’Eroe.
Se lo si vuole degustare per intero, allora, questo piccolo, prezioso scritto, bisogna abbandonarsi al fascino della figura storica, così come ha presumibilmente fatto lo stanco e disilluso Bianciardi dell’ultimo periodo.
Rivivere un tempo che non tornerà mai più, appassionarsi a un eroe che, sì, avrà avuto, come chiunque, i suoi momenti d’ombra, ma che dobbiamo tenerci caro, come fece Bianciardi, e come si conviene a ogni eroe, per la maggior forza della luce che ha saputo spandere, con il suo esempio e le sue azioni.
Perché se i miti e gli eroi hanno un senso, ha scritto una volta Joseph Campbell, è quello di aiutarci a vivere meglio.
E il tempo nel quale l’esercizio preferito è quello di annientare i primi e disarcionare i secondi è un tempo grigio, triste. Banale e retorico.
Due aggettivi che Bianciardi odiava profondamente. Giancarlo de Cataldo www.repubblica.it/robinson/2020/09/22/news/la_vita_ agra
Garibaldi di Luciano Bianciardi.
Il testo che pubblichiamo è un estratto dalla postfazione di Giancarlo De Cataldo
Foto exibart.it
Arriva a conclusione il percorso di residenza “Et in Arcadia ego”, progetto promosso e urato dalla Quadriennale di Roma, che ha portato in Italia quattro artisti ucraini, Dariia Chechushkova, Danylo Galkin, Mykola Ridnyi, Sasha Roshen, accompagnati da altri due artisti-collaboratori, Anastasiia Dytso e Kyrylo Karalyus, per avviare un dialogo con la scena artistica italiana. Il primo capitolo del progetto si è svolto al Castello di Santa Severa, nel Lazio, con il coinvolgimento degli artisti italiani Edoardo Aruta e Caterina Morigi. Il 29 dicembre, invece, in occasione della fine della residenza svoltasi presso Sa Manifattura, a Cagliara, sono stati visitabili gli studi degli artisti ucraini, ai quali si sono aggiunti Iride Sechi e Giulia Casula, con l’allestimento di una mostra di restituzione. Per strutturare in maniera coerente il percorso e la sua narrazione, sono state coinvolte anche due curatrici ucraine, Valeriia Pliekhotko e Sofia Yukhymova.

«La Quadriennale è orgogliosa di aver realizzato questo progetto insieme a importanti partner quali Fondazione di Sardegna e Regione Lazio su mandato del MiC-Ministero della Cultura, in adempimento alla propria missione della promozione della giovane arte», ha affermato Umberto Croppi, Presidente della Quadriennale di Roma.
«Oltre a costituire un significativo messaggio di pace, lo scambio di conoscenza fra gli artisti ucraini e italiani rappresenta un contribuito alla consapevolezza dell’arte come fattore unificante». Il progetto di residenza rientra infatti nell’ambito di un ampio progetto elaborato su invito del MiC, per offrire sostegno agli artisti ucraini, realizzato anche con il supporto di Regione Lazio e Fondazione di Sardegna all’interno della piattaforma progettuale AR/S – Arte Condivisa in Sardegna, in collaborazione con Sardegna Teatro, Sardegna Ricerche e Fondazione Sardegna Film Commission.
«La Fondazione, all’interno della propria missione istituzionale, ha scelto di contribuire a questa importante iniziativa che, attraverso il linguaggio universale dell’arte, ha l’obiettivo di unire i popoli, di favorire la crescita delle libertà delle persone, rifiutando qualsiasi forma di violenza fisica e intellettuale», ha affermato il Presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu.
Fino al 6 gennaio 2023, dunque, sarà possibile visitare gli spazi di Sa Manifattura, allestiti con le opere di Dariia Chechushkova (Odessa, 1999 –vive e lavora a Odessa), artista concettuale che lavora principalmente con scultura, ricamo e pittura; (segue pagina 44)
43
La residenza per artisti ucraini di Quadriennale Roma chiude con una mostra a Cagliari negli spazi di Sa Manifattura, la mostra conclusiva del progetto “Et in Arcadia ego” residenza per artisti ucraini in dialogo con artisti italiani, a cura della Quadriennale di Roma. dal 29 dicembre 2022
(segue dalla pagina 43)
Danylo Galkin (Dnipro, 1985 – vive e lavora a Uzhhorod) in collaborazione con Kirilo Karalyus (Drohobyc), 1996 – vive Uzhorod) che lavora principalmente sui media dell’installazione e della scultura, con interessanti esiti anche nella grafica e nella pittura; Mykola Ridnyi (Kharkiv, 1985 – vive e lavora a Kiev), artista e curatore, particolarmente legato ai media del video e della scultura site specific; Sasha Roshen (Kharkiv, 1996 – vive e lavora a Kyiv), pittore e disegnatore and Anastasiia Dytso (Odessa 1998 – vive e lavora a Kiev) fotografa e artista concettuale.
Accanto alle loro opere, sarà presentato il lavoro di Giulia Casula (Cagliari, 1977), artista visiva e esperta in didattica dell’arte che vive e lavora in Sardegna, e di Ambra Iride Sechi (Las Plassas, 1992), fotografa e artista visiva la cui ricerca si concentra su temi come la memoria, l’identità e le relazioni sociali. Le opere degli artisti italiani sono state concepite e realizzate nel periodo di residenza e dialogo con gli artisti ucraini.
Studi Aperti
Dal 29 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023
Sa Manifattura Cagliari
Viale Regina Margherita
https://www.exibart.com/progetti-e-iniziative/la-residenza-per-artisti-ucraini-di-quadriennale-roma-chiude-con-una-mostra-a-cagliari/
PAOLA SAILIS PREMIO ALZIATOR
Paola Sailis nasce, cresce e vive a Guasila, paese della Trexenta, a 45 km da Cagliari.
Sin da piccola impara l’arte del cucito grazie a sua madre, ma non segue il suo talento perché ha altre ambizioni: creare una famiglia.
Giovanissima si sposa con Raimondo e si dedica interamente alla crescita dei suoi figli Andrea e Denise, il suo tesoro più prezioso.
Quando i figli sono ormai adulti e indipendenti, Paola entra a far parte del gruppo folk del paese dove ritrova i costumi e le tradizioni della sua Terra e decide di ricreare quei bellissimi scialli che tocca con mano e osserva minuziosamente durante le sfilate.

Fino ai primi del ‘900 lo scialle veniva indossato nel quotidiano dalle donne di tutta l’isola e il tessuto, così come i colori e il ricamo, raccontavano il luogo di provenienza di una persona, il ceto sociale e l’occasione in cui veniva sfoggiato.
Questi fazzoletti quadrangolari con frange venivano indossati ripiegati a triangolo e adagiati sopra cuffie o fazzoletti facendo scendere i lembi sul busto.
Vennero importati dai mercanti d’Oriente, ma anche dalla Francia (è il caso degli scialli galluresi) e presto le donne sarde iniziarono a produrne localmente, personalizzandoli con i simboli naturali del proprio territorio. Trascorso circa un secolo, attorno al 1920, in momento
Foto tottusinpari
storico in cui venivano utilizzati a diretto contatto con i capelli raccolti, l’uso dello scialle iniziò a decadere. Oggi, tranne le eccezioni (ad Oliena ed in altri Comuni del Nuorese, come in altre località dell’hinterland), le donne vedove indossano ancora lo scialle nero semplice, rigorosamente senza decori.Durante le celebrazioni locali invece, non necessariamente turistiche come le Cortes Apertas, sfoggiano scialli dalle nuances sgargianti e dai decori vivaci (proprio come si usava una volta). Se ne può ammirare la bellezza alle sfilate dei gruppi folk, in cui fanno capolino preziosi scialli in tibet di seta o lana con basi di ogni colore, damascati o ricchi di ricami floreali.
Alcuni sono riproduzioni di esemplari dell’Ottocento realizzate utilizzando i disegni ereditati da nonne e bisnonne; pochissimi, i più rari, presentano parti di pezzi antichi, perché un tempo era d’uso seppellire la donna con il suo scialle.
Grazie alla partecipazione al gruppo folk e alle sfilate, il cuore di Paola palpita e ritrova un amore dimenticato. Decide dapprima di ricamare lo scialle del suo costume riproducendo l’originale disegno di un tempo, ma, quello che sembrava destinato ad essere un unico lavoro, è diventato solo il primo di una lunga serie che oggi vanta oltre 100 scialli.
Alcuni di questi presentano riproduzioni antiche, da lei
scovate con tanto impegno e portate a nuovo per far sì che nulla della tradizione venga perduto; altri si prestano a nuove opere interamente create da lei.
Come per magia, Paola riscopre il suo amore per il ricamo interamente da autodidatta, mettendo in campo le tecniche del punto pieno (il più utilizzato negli scialli sardi) e degli altri punti, ognuno importante affinché il disegno diventi un’opera d’arte ispirata alla sua Terra.
La Sardegna non è solo mare, spiagge e sole, ma anche mille colori che la nostra artista riporta in vita nei suoi lavori, per i quali impiega anche due mesi per la realizzazione.
La traduzione viene riportata anche nella realizzazione delle frange, anch’esse eseguite totalmente a mano: circa 2500 fili intrecciati tra di loro con cura e maestria.
Da quel famoso incontro con la tradizione sono passati circa dieci anni.
Oggi gli scialli di Paola sono ammirati, richiesti e fotografati in Sardegna e a livello internazionale per l’eleganza e la bellezza, che si coniugano con la semplicità.

Ogni scialle è unico e prezioso tanto che a ognuno di essi viene dato un nome, unico e inimitabile.
“Il ricamo per me è una vera passione e l’ ago è il mio migliore amico, lavoro senza telaio né cerchio, posso intrecciare frange da 2.500 fili e riproduco scialli antichi aiutandomi con foto d’epoca.” (segue p 46)
45
(segue dalla pagina 45)
Con semplicità e maestria, Paola ottiene i suoi successi anche nelle passerelle dove il suo estro creativo sviluppa una nuova proposta.
“Quegli scialli erano troppo belli per essere indossati su un vestito qualsiasi….”
Ecco che da quella idea inizia il nuovo cammino da artista creando e ricamando abiti meravigliosi.
Questa scoperta la porterà a sfilare in giro per il mondo insieme a Capoterra 2000.
Viene dapprima invitata in Svizzera e poi in Russia e, successivamente, viene contatta da grandi stilisti per collaborare nella creazione di opere straordinarie, ma lei rifiuta.
“Il mio ricamo è arte, ma soprattutto è un hobby; la mia priorità è e rimarrà sempre la famiglia.”
E mentre racconta, Paola non smette di ricamare perché, come le piace ribadire, “Ogni traguardo si raggiunge senza fretta, ma senza sosta!”
Usando le preziose stoffe come tavolozze, ago e fili colorati, dà vita a delle vere e proprie creazioni artistiche che rappresentano un’operazione culturale messa a disposizione della comunità.
I suoi ricami sono unici e preziosi quanto l’artista che li crea; una donna, madre e moglie innamorata della sua famiglia e artista solo per hobby e per passione. Unica e preziosa come piace a noi, perché è proprio nell’unicità dell’essere umano che l’umanità trova la sua ricchezza.
Stefania Cuccu
CINZIA RAVAGLIA E IL COMIC BURLESQUE
Cinzia Ravaglia e la sua arte del Comic Burlesque, un modo per divertirsi con la femminilità e mettersi in gioco. Cinzia nelle sue coreografie divertenti sdramatizza il classico Burlesque, insegnante di fama internazionale di Comic Burlesque da lei inventato, nasce dalla necessità di fondere due realtà ben distinte: la comicità ed il New Burlesque. Il Comic Burlesque ha lo scopo di riprendere la parte burlesca del termine. Quindi l’autoironia e il ridicolo diventano parte preponderante di questa disciplina.
Rivista Donna l’ha incontrata per voi… Cinzia quale è il tuo percorso professionale?
Io nasco timida: fin dall’infanzia avevo paura di tutto figuriamoci nell’adolescenza un tripudio di emozioni che facevano cazzotti fra di loro.
L’unica cosa che poteva salvarmi era il teatro aiutandomi ad accettare i miei limiti, a lavorare profondamente sulle mie paure e a percepire la realtà come una possibilità di confronto con il mio mondo interiore e ciò che accadeva fuori da me.
La mia formazione nasce sui palcoscenici di cabaret dopo avere frequentato una scuola di teatro sia in Italia che in Svizzera e varie tournèe.
Una meravigliosa laurea in Comicoterapia, in psicologia, faticando tantissimo perché lavoravo e studiavo.
 Foto cinziaravaglia
Foto cinziaravaglia
Per non farmi mancare nulla ho anche studiato danza e da vent’anni insegno danza orientale perché i suoi movimenti e la sua ginnastica sono fondamentali per costruire un corpo consapevole, flessibile ed armonico: lavoro ad un progetto in Italia di formazione che si possa integrare con gli altri stili di danza.
Mi sono confrontata con tante esperienze di spettacolo e sono ritornata a calcare le scene con il Burlesque perché è un percorso molto interessante per qualsiasi persona che si voglia approcciare a questo mondo magico che gioca sull’ironia, sulla voglia di mettersi in gioco e credere nella propria capacità sensuale che è insita in tutte le donne.
Raccontaci cosa è il Comic Burlesque e come nasce?

La scelta del Burlesque nasce dalla mia volontà di fondere l’esperienza teatrale con quella sottile possibilità di mostrare un pizzico di esibizionismo e giocare con le proprie forme.

Non penso mai al Burlesque come ad uno spogliarello ma ad una storia che viene raccontata attraverso il proprio corpo.
Non prediligo la sensualità fine a se stessa ma gioco molto di più sul gesto comico: il fisico diventa la possibilità di giocare con i propri difetti e caratteristiche. Prima di tutto è necessario lavorare sull’autostima, non è facile porsi in modo sicuro sul palcoscenico se
non si hanno certe conoscenze teatrali bisogna essere pronti ad affrontare un pubblico che di solito è molto selettivo e molto tagliente per tutto quello che riguarda soprattutto il vestirsi in modo succinto e provocante.
La donna nel Burlesque è sempre stata “oggetto” del desiderio.
Quanto è difficile far ridere ?
Una bella donna è sempre a mio parere “un oggetto” del desiderio ma, ovvio, non è sufficiente, non basta essere belle per fare il Burlesque, l’impatto è importante ma ci deve essere molto di più, determinazione e fascino che non è di tutte.
Non tutte possono essere attrici, ci sono donne che non hanno nessuna necessità di esibirsi, altre si. Alcune possono risultare ridicole cercando di fare le belle.
C’è chi ha già una capacità innata nel fare Burlesque ma c’è anche chi può impararlo per migliorare la propria percezione: scoprire lati del proprio carattere che non si conosce e diventa magicamente un modo semplice per prendersi in giro, giocare con i propri lati oscuri e tante risate. L’approccio secondo il mio metodo di lavoro è quello dell’autoironia. Il Burlesque è un mondo magico in cui divertirsi e non annoiarsi mai.
E’ importante sviluppare il proprio lato comico nel Bullesque? (segue pagina 48)
47
47)
Le lezioni sono importantissime per cercare il proprio lato comico e sensuale.
La parte più difficile è fare ridere. Fare piangere è molto più semplice. La comicità è un lavoro di destrutturazione delle proprie sovrastrutture. Ricercare la parte più pura del proprio essere bambini.
La naturalità è il segreto e la chiave di svolta. Quando faccio i seminari non cerco di imporre altre strutture ma insegno a ridiventare delle bambine che sognano e che si meravigliano delle piccole cose.
Ritrovare la propria autenticità e femminilità insita in ogni donna.
I tuoi insegnamenti sono più burleschi che sensuali. Cosa è per te l’autoironia? Burlesque significa burla e quindi fare ridere. Non mi piace molto che si associ la parola Burlesque allo spogliarello.
Il New Burlesque forse e’ considerato uno spogliarello ironico.
Alla fine noto una gran confusione e tutti promuovono la propria convinzione.
Io penserei più ad una creatività insita in ognuno di noi che vuole esternarla attraverso questa espressione.
Quindi non c’è una migliore o peggiore artista ma ci sarà sicuramente una professionalità e sarà il pubblico a decretarla. Ognuno in base alle sue esperienze ed al suo vis-
cinziaravaglia
suto crea il proprio stile e la propria fantasia dando regole e limiti e valore.
Secondo il mio insegnamento più burlesco che sensuale ci si dirigerà verso quella meta di fare ridere con il proprio corpo, i propri limiti e le caratteristiche di ognuno di noi.
L’autoironia e’ fondamentale.
Non è importate essere quindi bellissime, ma bisogna essere convincenti credere in quello che si fa.
Di affascinante c’è tutto, ogni movimento deve essere ricercato deve avere un’intenzione perché così risulterà vero.
Dietro ci deve essere un lavoro da attore. Non è semplice, ma bisogna farlo per non risultare ridicoli. In due parole e’ affascinante perché si cerca di armonizzare un prodotto finale: studio della coreografia, la recitazione, la mimica, il trucco e l’abito . Il pubblico sarà così riconoscente ed attivo accogliendo calorosamente la performance.

La scelta del trucco, del costume e della musica come avviene?
Principalmente parte tutto dalla musica, ricerco vecchi video su youtube oppure ascolto musica un po’ datata per creare poi sulle note la coreografia. Il trucco viene di conseguenza sia alla musica che al vestiario. Mi piace molto giocare sul palco con atmosfere ed oggetti
(segue dalla pagina
Foto
che vanno ad integrare la coreografia, ogni esibizione si trasforma in una piccola storia che mette sempre in luce una parte comica, una difficoltà che si risolve.
Lo spettacolo è costruito con lo schema; preambolo svolgimento e risoluzione.
Quanta preparazione ci vuole per un’ esibizione?
Mi piace molto trasmettere le mie idee al gruppo. Il mio nome d’arte è Molly May questo nome mi è stato dato tantissimi anni fa da Giacobazzi e Pizzocchi mentre ci recavamo ad uno spettacolo in un locale nel ruolo di valletta ed avevo bisogno di un nome e tra una battuta e l’altra mi hanno coniato questo nome che mi è ritornato utile per le mie performance un nome a cui ero particolarmente affezionata.
Di conseguenza il mio gruppo si chiama le Mollette di Molly May e quando introduco anche qualche maschietto ovviamente Mollettone.
Per preparare le coreografie ho bisogno del gruppo, in base a questo intuisco le loro capacità creative del momento: in genere valuto la persona, cosa può dare sul palco e carpisco i suoi pregi e capacità ed anche le paure però sempre con ironia e divertimento. Il motto fondamentale è sempre: mai prendersi troppo sul serio. L’atto creativo è quello che mi procura più soddisfazione e quando quelli del mio gruppo ridono capisco che la gag funziona, lo scopo e’ stato raggiunto.
Poi perfezionista come sono vado spesso a modificare il lavoro che man mano cresce nelle nostre mani.
Ogni gesto e’ sempre calcolato, e’ specificatamente voluto montato con un senso e ricercato.
Si può improvvisare? Non credo molto nell’improvvisazione per quanto riguarda il mio modo di lavorare.
Mi piace come ho già riferito che tutto a priori sia in un certo senso studiato e perfezionato, e’ naturale che accadano imprevisti e bisogna essere in grado di improvvisare per rendere tutto credibile, anzi spesso accadono ed è il momento in cui ci si diverte di più sia per vedere la reazione del pubblico che la reazione difronte all’imprevisto. La ballerina di Burlesque deve essere pronta a qualsiasi inconveniente e con le sue qualità di attrice cerca di improvvisare e creare nell’intoppo nuove situazioni credibili nella sua performance ed in primis la sua comunicazione con il pubblico.
Se non è credibile non può arrivare nulla.
Tutto comincia da una burla cosa c’è di diverso nei tuoi show di New Burlesque?
Per quanto riguarda i luoghi comuni si pensa al Burlesque come ad uno spogliarello ed ho dovuto molte volte spiegare cosa è il Burlesque e discutere sulla sua reale credibilità. Io spiego sempre il termine Burlesque (segue pagina 50)

49
(segue dalla pagina 49)
cosa significa e che il tutto comincia da una burla. Penso comunque che con la velocità in cui si è sviluppata questa moda è possibile vedere un cambiamento di mentalità, soprattutto nelle donne che vedono in questa forma di spettacolo la possibilità di divertirsi e fare divertire, ne parlano ad amici, amiche e coinvolgono altre persone così, il passaparola fa notare che non c’è niente di così particolarmente trasgressivo in uno show di Burlesque. Cosa provi mentre ti esibisci?
Provenendo dallo spettacolo adoro stare sul palcoscenico e mi piace sentire l’energia che emana il pubblico. Cerco una connessione con esso, è una specie di magia che si realizza ogni attimo. Prima di entrare sul palco per me è un dramma ogni volta (le mie allieve si divertono a prendermi in giro), queste sono le frasi: “ma chi me lo ha fatto fare, ma perché non sono sposata con cinque figli, questa e’ l’ultima volta”. Il cuore mi batte fortissimo da scoppiare. Poi appena faccio un passo sul palcoscenico ecco che passa tutto ed entri, o la va o la spacca e ti senti in paradiso, perché devi dare sempre il massimo ed il pubblico va convinto coccolato ed amato. Io pretendo da me stessa e dai miei allievi il massimo. Quello che tengo conto sul palcoscenico e’ anche lo spazio, il rapporto con lo spazio. E’ un’equazione io
Foto cinziaravaglia
il pubblico e lo spazio che contiene me gli spettatori e i movimenti, la risoluzione? La magia che si crea. Come si può sviluppare l’autostima con il New Burlesque ?

L’autostima non nasce da un giorno all’altro ma può essere ricercata ed appresa con un training adeguato. Prima di tutto la donna si deve piacere ed essere consapevole sia dei complimenti che delle critiche e le critiche diventano un punto di forza per crescere ed essere sempre più pronti a fare i propri passi anche nel mondo del Burlesque per riscoprire la voglia di divertirsi con movimenti ricercati, mai volgari ma, simpatici e buffi per fare sorridere il pubblico, ed il pubblico deve pensare che sul palco c’è un’artista completa che conosce tempi comici e teatrali e non pensare ai numeri come semplici movimenti non studiati e poco convincenti. C’è sempre un lavoro dietro una consapevolezza che si costruisce con il tempo, l’esperienza e la costanza. Che aspetto evidenzi della tua personalità e della tua femminilità durante i tuoi spettacoli?
Quello che cerco di trasmette alle mie allieve è la sicurezza di stare di fronte ad un pubblico in modo competente e divertente.
Ovviamente se faccio una bella performance aumenta l’autostima aumenta la voglia di divertirsi e di cercare di piacere e avere conferme da chi ti sta guardando.
Foto cinziaravaglia
Non è semplice cercare di esternare sensualità se una donna non ha mai studiato il modo di cercarla dentro di se.
Io credo però che studiando le espressioni le intenzioni e concentrandosi sui feedbaak che si instaurano con il pubblico si può in un certo senso migliorare il proprio sentire ed il porsi in modo più completo e coraggioso. Però è importante anche sottolineare che ci sono delle donne che hanno già un forte sex appeal.
Lavorando con il sesso femminile mi rendo conto che ogni donna è un miracolo e mi diletto a vedere i cambiamenti da subito.
Già dalle prime lezioni le partecipanti perfezionano il loro atteggiamento la postura e come stare nello spazio. Sono delle attrici nate ed hanno tutte e dico tutte, le qualità per rafforzare le loro qualità e per divertirsi con i movimenti che mano a mano si creano durante la lezione.
L’importante per me è che le persone che hanno partecipato alle mie lezioni e agli spettacoli gioiscano e vadano a casa contente per quello che gli ho insegnato oltre che più sicure e felici.
Che consiglio daresti a una donna che vuole conoscere il mondo del Burlesque?
E’ una bellissima opportunità per conoscersi in modo divertente un’opportunità per mettersi in gioco ed esi-
birsi con personaggi divertenti creati sulla scena.
Si lavora con tecniche teatrali e comiche ed ovviamente non ci si deve prendere troppo sul serio.
E’ un corso che può migliorare la propria autostima e la propria postura, ecco la postura è fondamentale: la danza è utile per armonizzare il corpo. Di solito le ragazze che vengono ai corsi stanno sempre con la schiena arcuata oppure hanno il diaframma chiuso.Correggere la postura è un atto dovuto, la spina dorsale è quella che ci sorregge e deve essere sana e dritta, gli addominali devono essere tonici per potere sorreggere la schiena stessa. Una buona postura è un’ottimo inizio per il cambiamento, cominciare dal corpo e volersi più bene dà la possibilità anche di evolvere mentalmente.
Fare il Burlesque modifica il proprio modo di porsi e di essere felice se vogliamo metterla su un piano di percorso personale.

Ricordiamo sempre che il mondo delle arti fa bene alla salute migliora lo stato psicofisico e quindi anche l’intelligenza.
Ci sono prossimi eventi in programma per te?
Ho depositato il logo del Comic-Burlesque perché penso sia necessario ora progredire e proteggere il mio lavoro e chi vorrà fare un percorso riguardante il Burlesque e la recitazione può partecipare alla formazione professionale. (segue pagina 52)
51
L’Iter durerà un anno e prenderà in considerazione tanti elementi che serviranno per le esibizioni: esercizi di tonificazione, addominali, preparazione all’equilibrio, postura. studio delle camminate, camminare con i tacchi, camminate nel burlesque, studio del personaggio, gioco dei ruoli, studio del burlesque, studio del movimento burlesco, recitazione, mimica e pantomima, sequenze di passi nel burlesque, studio e coreografia con la sedia, studio degli oggetti nel burlesque.
Un percorso completo. Ho organizzato inoltre a Danza in Fiera 2015 il contest di Burlesque dove si sono esibite più di 80 performer provenienti da tutta Italia, una grande soddisfazione.
Ho anche da tre anni uno spettacolo teatrale “Tentazioni Burlesque” con una tournèe in Italia che ci ha dato tante soddisfazioni. E’ uno spettacolo completo, è la storia di un teatro che cerca di mettere in scena uno spettacolo di Burlesque e capita veramente di tutto.
Il mio sogno ora sarebbe quello di proporre questi corsi nelle formazioni alle aziende.
E’ un metodo ottimo per migliorare il proprio stato di vita e ricordiamoci sempre che… ridere fa buon sangue. www.cinziaravaglia.com/ http://www.rivistadonna.com/wp/2015/04/14/ cinzia-ravaglia-e-il-comic-burlesque/
Foto gianlucadiloia
Attingere dal passato per guardare al futuro”, “festa del pensiero”, “scuola”, “ricerca”, “sguardo intersezionale”, “inclusività”.
Sono alcune delle parole che ricorrono durante la presentazione della programmazione per il 2023 di Triennale Milano, un anno che coincide con l’importante ricorrenza del centenario dell’istituzione. La storia della Triennale, infatti, comincia a Monza nel 1923 con la manifestazione che si svolge ogni due anni nel Parco della Villa Reale: siamo nel periodo tra le due guerre, un momento in cui si guarda al mondo del design, dell’architettura, dell’industria e delle arti come un sodalizio necessario allo sviluppo sociale del Paese. Un legame che costituirà sempre di più la cifra caratteristica di Milano, dove l’istituzione (allora “Triennale Internazionale delle Arti Decorative e Industriali Moderne e dell’Architettura Moderna”) si stabilisce definitivamente a partire dal 1933 all’interno del Palazzo dell’Arte, edificio razionalista progettato da Giovanni Muzio.
A distanza di un secolo, ciò che si vuole conservare è quello spirito di comunione delle arti che si esprime oggi nel racconto della programmazione dei prossimi mesi, e in cui rientrano appuntamenti dedicati ad arti visive, design, architettura, fotografia, video, performance, teatro e incontri con autori.

Nomi storicizzati, grandi autori, nuove proposte, la narrazione della storia dell’istituzione, collaborazione con realtà italiane e internazionali, progetti trasversali che legano tra loro ambiti diversi.
Sono questi gli ingredienti che vedremo nella formula dell’offerta di Triennale del 2023, orchestrata da Umberto Angelini, Direttore Artistico di Triennale Milano Teatro, Nina Bassoli, Curatrice Architettura, rigenerazione urbana e città, Lorenza Bravetta, Curatrice Fotografia, cinema, nuovi media, Damiano Gullì, Curatore Arte contemporanea e Public Program, Marco Sammicheli, Direttore del Museo del Design Italiano, Luca Cipelletti, Direzione architettonica del Palazzo dell’Arte, coordinati dalla direzione di Carla Morogallo e dalla presidenza di Stefano Boeri.
Dalle mostre monografiche su Angelo Mangiarotti, su Lisa Ponti, su Anna Franceschini, su Sally Gabori sul rapporto tra Ettore Sottsass e la parola e su Gabriele Basilico a Milano, passando ai focus collettivi: i progetti Impact – Processing Landscape e Home Sweet home raccontano e ripensano lo spazio pubblico e privato attraverso architetti affermati e emergenti, mentre la mostra sulla pittura italiana contemporanea (a cura di Damiano Gullì, ottobre 2023 – gennaio 2024), riprende la tradizione della pittura murale delle Esposizioni Internazionali storiche e mette a confronto 100 pittori
La Triennale di Milano compie 100 anni e lancia il programma del prossimo anno. Ma si guarda già al 2026

Ettore Sottsass, Lisa Ponti, Anna Franceschini: sono solo alcuni degli autori che vedremo esposti in Triennale dei prossimi mesi, tra mostre di fotografia, arti, video, design e architettura, ecco annunciate le novità MUSEI di Giulia Ronchi
attivi dagli anni Novanta a oggi; Rovesciare i propri occhi / Renverser ses yeux esplora le sperimentazioni avvenute tra gli anni Sessanta e i primi anni Settanta con la fotografia e l’immagine in movimento; Photography Takeover è il concorso che selezionerà una realtà no profit per invitarla a esporre a Palazzo dell’Arte, invitandola a misurarsi con gli archivi di Triennale.
Anche il Museo del Design si ripensa, destinando uno spazio (nello specifico la porzione finale della Curva che ospita il museo) a mostre temporanee che celebrino il centenario, offrendo la “ricostruzione di alcuni interni la cui logica ha rappresentato un filone evolutivo fondamentale della disciplina attraverso esempi presenti in collezione o frutto di accordi strategici con enti e istituzioni”.
Concepiti come un discorso attorno alla storia e all’attività di Triennale sono, infine, i public program, che si articoleranno nel festival FOG di arti performative, nella Milano Arch Week e nei talk di Triennale Estate che animeranno il periodo estivo. Un luogo di ritrovo?
Uno spazio espositivo? La Triennale di Milano ha l’ambizione di diventare più di questo, e lo ha dichiarato in occasione della presentazione della programmazione del nuovo anno, lanciando le direttive del nuovo piano strategico 2022-2026, dal titolo (segue pagina 54)
53
(segue dalla pagina 53)
Design the Future: a scandirlo, quattro macro obiettivi collegati a 17 cantieri di progetto, i cui sviluppi saranno comunicati sul sito dedicato https://future.triennale.org/.
Si tratta di un impegno per un maggiore coinvolgimento del pubblico, del rafforzamento del brand-triennale, della valorizzazione del patrimonio attraverso l’implementazione del centro studi Triennale e della ricerca e dell’evoluzione del modello organizzativo, che punti in direzione di una sempre maggiore inclusività, ma anche verso il dialogo, la trasversalità tra le diverse discipline e la formazione di gruppi di lavoro autonomi e al tempo stesso interdipendenti. Il piano strategico incide anche con misure pratiche, come la Membercard, che verrà proposta al pubblico dai primi mesi del 2023 rappresentando una novità per l’istituzione e che va a sostituire la precedente formula offerta dagli Amici della Triennale, gruppo scioltosi negli scorsi mesi. “Ci identifichiamo come una “scuola” che affianca ai contenuti la prassi”ha spiegato la Direttrice Generale Carla Morogallo. “Il motivo per cui abbiamo deciso di presentare il piano strategico in questo momento, è stata la volontà di raccontarsi, rendere maggiormente chiara la nostra comunicazione e spiegare gli obiettivi attraverso i quali guardiamo al futuro”.
Foto trickdroid.org
BOB DYLAN AU MAXI
Può essere utile sapere, per i fan di Bob Dylan, il più famoso songwriter del ’900, e per coloro (pochi) che non hanno mai apprezzato il suo lavoro - e forse non conoscono nemmeno la sua opera pittorica - che la mostra “Bob Dylan. Retrospectrum”, in programma fino al 30 aprile al MAXXI di Roma, non espone le prove di un dilettante alle prime armi.
L’artista premio Nobel 2016 inizia infatti il suo percorso di visual artist già nei primi anni Sessanta e Settanta, con le copertine di album come Big Pink (1968) Self Portrait (1970) e Planet Waves (1974). In questo caso si tratta di opere influenzate da Chagall e dagli stilemi di altri pittori (europei) del Novecento.
In realtà, un primo contatto con l’arte era coinciso, nel 1966, con il leggendario, grave incidente motociclistico che aveva obbligato il musicista di Duluth all’isolamento, lontano da tutto e tutti. Poi, qualche hanno più tardi, nel 1974, il desiderio di imparare qualcosa di più del semplice disegno aveva portato l’autore di Hurricane nello studio newyorkese del pittore Norman Raeben, docente alla Ashcan School. Dylan racconta con entusiasmo questa esperienza, durata in tutto un paio di mesi: «Raeben sincronizzò fra loro la mia mente, la mia mano e i miei occhi. Ciò mi consentì di fare consciamente quello che incon-

sciamente già sentivo».
Dylan cominciò a parlare degli insegnamenti di Raeben durante le interviste del suo film Renaldo & Clara dichiarando che le tecniche apprese dal pittore yiddish nel suo studio all’11 piano di Carnegie Hall erano state molto utili anche nella realizzazione delle tracce di Blood on the Tracks (1975).
Da quel momento in poi, Dylan continuò a disegnare e a dipingere utilizzando varie tecniche senza mai esporre in pubblico i suoi lavori.
La prima occasione per farlo si presentò nel 2007 a Chemnitz, in Germania, con gli sketches di “The Drawn Blank Series”.
Tre anni più tardi fu la volta di “The Brazil Series” allo Statens Museum di Copenhagen e quindi, nel 2017, “The Asia Series” alla Gagosian Gallery di Manhattan, esposizione che ha scatenato svariate polemiche sulle quali torneremo più avanti.
“Bob Dylan: Retrospectrum” è stata inaugurata al Patricia & Phillip Frost Art Museum di Miami nel novembre del 2021 e ha chiuso i battenti nell’aprile di quest’anno.

Dopo un tour di successo a Shanghai, Pechino e Shenzhen, la mostra, la più completa esposizione di opere di Dylan mai realizzata, approda finalmente in Italia, con il plauso del cantautore:

«È molto gratificante sapere che le mie opere d’arte
sono esposte al MAXXI, a Roma» ha affermato, «un museo davvero speciale in una delle città più belle e stimolanti del mondo.
Questa mostra vuole offrire punti di vista diversi, che esaminano la condizione umana ed esplorano quei misteri della vita che continuano a lasciarci perplessi. È molto diversa dalla mia musica, naturalmente, ma ha lo stesso intento».
Il percorso espositivo comprende oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli, disegni a inchiostro e grafite, sculture in metallo, materiale video, che esplorano oltre 50 anni di attività creativa.
Otto le sezioni che ripercorrono il viaggio di Dylan nelle arti visive e, al contempo, ci fanno entrare in contatto con la sua creatività di musicista, poeta e artista.
Vediamole nei dettagli.
Early Works
Presenta una serie di disegni degli anni Settanta nei quali Dylan prende nota della realtà che lo circonda, di ogni immagine che ha a portata di mano, disegnando a piena pagina figure e oggetti.
Queste illustrazioni anticipano i lavori del 2018 quando, con “Mondo Scripto”, l’artista torna a far dialogare musica e arte visiva realizzando una serie nella quale i testi scritti a mano delle sue canzoni sono accompagnati da disegni originali che richiamano i titoli o i passaggi chiave dei brani composti.
The Beaten Path
È un ritratto del paesaggio americano,(segue pag. 56)
55
(segue dalla pagina 55)
un viaggio attraverso gli Stati Uniti per intravedere la bellezza in quei luoghi dimenticati che fanno da sfondo alla vita quotidiana. Ci sono scorci di motel e tavole calde sempre aperte, insegne al neon, luna park abbandonati e auto d’epoca, profili di imponenti palazzi illuminati dai lampioni. Spesso la strada scandisce la scena con lunghe highways che sembrano dispiegarsi all’infinito verso un orizzonte che appare sempre più lontano, come nel caso di Endless Highway.
Mondo Scripto Alcuni fra i testi più noti trascritti dall’artista e accompagnati dai suoi disegni.
Queste combinazioni di parole e immagini sottolineano il legame profondo e diretto tra la sua pittura e le sue composizioni. I disegni a matita esemplificano un dialogo tra immagine e testo, passato e presente, che ha cambiato il rapporto tra musica e parole. Fa parte di questa serie Subterranean Homesick Blues Series, che entrerà a fare parte della Collezione MAXXI.
Revisionist
Giornali che passione!
Dylan rielabora la grafica, le parole e i contenuti cromatici delle copertine di magazine famosi, da “Rolling Stone” a “Playboy”, per trasformarle in nuove immagini serigrafate di grandi dimensioni.
The Drawn Blank
Un diario illustrato nel quale ritroviamo ritratti, luoghi
Foto trickdroid.org
storici, panorami e angoli nascosti.
La serie nasce da una raccolta di schizzi a matita carboncino e penna realizzati tra il 1989 e il 1992 durante le tournée in America, Europa e Asia.
Negli anni, Dylan ha più volte modificato i disegni, aggiungendo dettagli, colore e nuovi particolari.
New Orleans
Documenta il legame tra Dylan e New Orleans, città natale del jazz, situata all’estremo sud della “Blues Highway”, la strada leggendaria del blues, che attraversa da nord a sud il centro degli Stati Uniti.

In ogni angolo di New Orleans, l’occhio dell’artista individua spunti per le sue opere.
I gesti e le abitudini dei suoi cittadini sono per Dylan una fonte di ispirazione.
Deep Focus
I dipinti, con particolari inquadrature e tagli dell’immagine, si ispirano allo spirito documentaristico della fotografia e ai luoghi iconici della storia del cinema. Il titolo stesso fa riferimento a una tecnica cinematografica - in cui l’immagine è il risultato della combinazione di primo piano, secondo piano e sfondo - molto apprezzata, fra gli altri, da registi quali Welles, Kubrick e Kurosawa.
Ironworks
Sculture in ferro e strutture funzionali composte da oggetti e attrezzi convertiti a nuovo uso che richiamano, insieme
al ricordo dell’infanzia di Dylan trascorsa nella zona mineraria del Nord del Minnesota, pure l’iconico passato industriale degli Stati Uniti.
Le controversie per “Asia Series”
Quando Gagosian annunciò nel 2017 la mostra dedicata al “taccuino di viaggio” di Dylan in Giappone, Cina, Vietnam e Corea, la galleria sottolineò che nella genesi delle opere esposte sarebbero state centrali «le rappresentazioni di prima mano di persone, scene di strada, architetture e paesaggi».

Una discussione sul sito “Expecting Rain” - dedicato ai fan del cantante - evidenziò invece le somiglianze tra diverse opere di “Asia Series” e alcuni scatti d’autore (di Henri Cartier-Bresson e Léon Busy).
L’autorevole “New York Times”, invece, riprese le esplicite dichiarazioni di Michael Gray: «La cosa più sorprendente è che Dylan non ha semplicemente usato una fotografia per ispirare un dipinto: ha preso lo scatto del fotografo, la composizione, e l’ha esattamente copiata» affermava l’autore di Bob Dylan Encyclopedia.
«Ha replicato tutto il più fedelmente possibile. Può essere un gioco (...), ma non è un approccio molto fantasioso alla pittura.
Forse non si tratta di plagio, ma di sicuro sta copiando parecchio».
Oggi questa affermazione si può tranquillamente estendere
anche alla serie “Deep Focus”, dichiaratamente ispirata al cinema e presente nell’esposizione capitolina.
Se ben poco c’è da osservare sulle capacità tecniche e sull’impatto cromatico delle opere di Dylan - competenze da estendere anche all’attività di scultore - non è di secondaria importanza il dibattito sui referenti alla base dei suoi dipinti.
A noi piace pensare a un grande artista che dipinge per passione, consapevole dei riferimenti artistici (da Edward Hopper ai Precisionisti) ai quali si ispira.
Come nel caso, più recente, dei fotogrammi (o foto di scena) di “Deep Focus”: «Tutte queste immagini provengono dai film» racconta Dylan.
«Evidenziano le diverse situazioni in cui si trovano le persone.
Che si tratti di James Cagney o di Margaret Rutherford, i sogni e gli schemi sono gli stessi: la vita che ti si presenta davanti in tutte le sue forme e i suoi aspetti».
E in questo senso, al di là di un’affermazione che appare come una vera e propria dichiarazione di poetica, la sottile linea di demarcazione che separa una semplice copia da una rielaborazione personale è labile come in un riff di poche battute o il verso di una canzone somigliante a una poesia poco nota dell’Ottocento.
Ma questa è tutta un’altra storia, in fondo “è la storia dell’arte…”Sonia S. Braga https://www.ad-italia.it/ article/bob-dylan-retrospectrum-maxxi-roma/
57
Sono tante le ricette sarde che hanno origini antichissime.
Alcune di queste, arrivano dalla cultura ebraica: dal pane purile che ancora viene prodotto in alcuni centri della Sardegna, per finire con la burrida, il tipico piatto cagliaritano.
“
La Sardegna porta con sé una memoria ancestrale di una cultura ebraica antica che ha lasciato nell’isola tracce indelebili ancora visibili in alcuni piatti tradizionali – spiega il presidente dell’associaizone Chenàbura Mario Carboni – noi siamo andati alla ricerca di queste tracce decifrando gli elementi di alcuni pietanze le cui origini e il cui significato sarebbero incomprensibili se non riferite alle cultura ebraica”.
Queste tracce sono state raccolte in una ricerca che é stata presentata a Cagliari mercoledì 28 dicembre nella sede dell’associazione al termine di un tour guidato nella giuderia cagliaritana, nel cuore di quel quartiere dove visse una laboriosa e stimata comunità di cui si persero le tracce.
A partire dal 1492 quando anche in Sardegna venne emanato l’editto di Granada con il quale i regnanti aragonesi cacciarono tutti gli ebrei dal regno. Molti ebrei si convertirono forzatamente al cristianesimo pur mantenendo nascostamente le loro abitudini alimentari che si tramandarono di genera-
Foto wikimapia
CUCINA EBRAICA IN SARDEGNA
zione in generazione, perdendo il ricordo dell’origine di quelle consuetudini.
L’associazione Chenàbura ha provato a ricostuire la storia di quella cultura culinaria in questa ricerca intitolata “La cucina sarda di origine ebraica” nell’intento di rivalutare e riscoprire una storia sepolta da troppi anni. Se al momento di lasciare la loro amatissima Spagna le donne sefardite trovarono la forza di cantare e di suonare il pandero, possiamo essere certi che portarono con sé anche l’arte della preparazione dei cibi, accuratamente avvolta nella memoria.
Tuttavia, poiché per secoli la loro sopravvivenza dipese dal non lasciare tracce, è difficile indagare anche l’ambito gastronomico, per quanto si tratti di un tema attraente dove volgere lo sguardo (e il gusto) quando ci si propone di sondare i percorsi della storia.

Uno di questi percorsi riguarda la Sardegna, situata al centro delle direttrici culturali del Mediterraneo, pertanto meta di passaggio o permanenza anche per chi viaggiava dalla penisola iberica verso l’Italia o l’Oriente. La presenza ebraica nell’isola risale a tempi assai remoti ma la documentazione nota inizia con l’epoca romana e si svolge ininterrottamente fino all’Editto del 1492, vigente anche in Sardegna in quanto territorio sottomesso al dominio aragonese.
Prima dell’Editto di Granada la Corona d’Aragona
mostrò un atteggiamento tollerante nei confronti degli ebrei dell’isola, la cui pratica del commercio e di attività indispensabili valse loro particolari privilegi, nonché il raggiungimento di un grado di integrazione con la popolazione locale, tale da far definire l’ebraismo sardo «una propaggine sefardita» .
I documenti tratteggiano una Sardegna frequentata principalmente da israeliti catalano-aragonesi, maiorchini e francesi, ma poiché dopo il 1492 le tracce della loro presenza sfumano, al momento dobbiamo supporre che gli elementi di origine ebraica presenti nella tradizione sarda siano stati introdotti principalmente prima di questa data, tramandati grazie allo spirito conservativo degli isolani e alla presenza di conversos.
E poiché la forza dei segni rimane operativa nel tempo perpetuata da memorie e consuetudini, ritroviamo raffigurazioni significative anche nelle arti sarde, ad esempio nelle caratteristiche pavoncelle. Queste sembrano condividere la stessa simbologia dei pavos reales della pileta trilingüe custodita al Museo Sefardí di Toledo, rappresentati l’uno di fronte all’altro intorno alla menorah, la quale in Sardegna è stata sostituita da vasi di fiori o da motivi lussureggianti.
Anche nel lessico, in particolare quello connesso alla scansione del tempo, la lingua sarda rivela etimologie evocative, spiegate da alcuni linguisti come appor-
to culturale degli ebrei dell’Africa settentrionale stabilitisi in Sardegna.
Tra queste, il mese di giugno – chiamato in sardo lámpadas – viene riferito da Max Leopold Wagner alla tradizione nordafricana di accendere fuochi durante le feste rurali del solstizio d’estate, mentre il mese di settembre viene detto cabidanni o capudanni perché coinciderebbe con l’inizio dell’anno ebraico, Rosh Hashanah, di cui rappresenterebbe una traduzione letterale. Mentre per quanto riguarda la cucina, il retaggio ebraico si fa risalire all’interpretazione del nome chenábura, con cui in lingua sarda viene denominato il venerdì, che secondo Giuliano Bonfante «è da riportarsi alla festa ebraica della vigilia del sàbato, la Parasceuē (…), chiamata infatti cēna pūra da Tertulliano», mentre il Wagner riferisce che gli ebrei adottarono il termine coena pura «per designare la vigilia della Pasqua, durante la quale ogni traccia di lievito doveva essere rimossa dalle case (…), e data la provata convivenza di cristiani ed ebrei nei primi tempi del Cristianesimo in Sardegna, fu adottato in seguito anche dai cristiani sardi» .
Tuttavia, in considerazione del fatto che il venerdì rappresenta un giorno di astinenza anche per i cristiani, propenderei per una decodifica meno risolutiva che renda conto invece di come l’isola abbia rappresentato (segue pagina 60)

59
Dalla burrida al pane purile, ecco le ricette sarde di origine ebraica
A partire dal 1492, molti ebrei si convertirono forzatamente al cristianesimo pur mantenendo nascostamente le loro abitudini alimentari
Framne dal film Shtisel
(segue dala pagina 59)
un raro esempio di convivenza propizia tra ebrei e cristiani.
Pertanto è plausibile ravvisare l’eredità di questa integrazione nella preparazione del pane àtzimu (azzimo) detto anche pane pùrile (senza lievito, veniva cotto nella cenere o sopra il carbone ), nel liquore di mirto, nell’antichissima arte del bisso, o nella predilezione per certi cibi, quali ad esempio la melanzana.

Quest’ultima vanta un considerevole numero di citazioni nel repertorio poetico-musicale sefardita, tra cui l’ironico ricettario in versi El guisado de las berenjenas, ed è curioso che anche nel repertorio della canzone popolare sassarese, alla melanzana sia stata dedicata una canzone salace che, seppur relativamente recente, rispecchia la considerazione per questo ortaggio.
Ciò nonostante, è nei cibi che scandiscono il calendario religioso ed agricolo – in particolare nei dolci preparati per celebrare le varie ricorrenze – che ritroviamo un simbolismo e una sacralità ancora così fortemente sentiti nell’isola da rievocare un passato recondito.
Solitamente riguardo a forme e sapori che sono presenti nella tradizione di civiltà lontane tra di loro è ragionevole ipotizzare una comune origine, quando non si voglia giustificare la questione attraverso gli universali umani.
E così la forma peculiare
della pàrdula è affine alla quesadilla dell’Ecuador o alla kalitsounia dell’isola di Creta, luoghi di approdo e rifugio dei sefarditi.
Al contrario, la versione salata delle pardulas con l’aggiunta di patate ed erbe, contiene gli stessi ingredienti delle gizadas de patata i kezo di Rodi, riportate da Stella Hanan Cohen, ricercatrice e discendente degli ebrei sefarditi dell’isola greca.
La pardula si compone di un ripieno di ricotta e formaggio ovini, adagiato su un cestino di pasta i cui bordi vengono pizzicati fino ad ottenere una stella a sei punte; tuttavia, secondo altre versioni, i biccos (pizzichi) devono essere cinque o sette, numeri altrettanto simbolici. La straordinaria varietà osservabile in tutte le tradizioni dell’isola, dalla musica all’artigianato, si riflette anche nelle diverse elaborazioni di uno stesso dolce a seconda del paese, giustificando la presenza di geosinonimi. Anche il Visitatore Reale Martin Carrillo, nel 1612, rende conto di questa varietà nel suo rapporto sulla Sardegna inviato al re Filippo III di Spagna, riferendo che i sardi «hazen frutas de pasta y mil, y pasta de Marçapanes, con muchas labores muy vistosas y curiosas, que no las hazen en Castilla».
Tra gli altri ingredienti troviamo: fior di farina di grano duro, uova, scorza di limone o arancia, zucchero e zafferano. E un pizzico di sale.
Foto mosaico-cem.it
La pardula condivide con altri dolci sardi questo importante dettaglio che la colloca in un contesto sacrale poiché il sale, emblema del patto con Dio ed indispensabile nelle oblazioni, ha un valore che si esprime anche nella quantità; dunque pochi granelli quale offerta al Signore, per un dolce che celebra una festività, vieppiù tanto speciale quando si tratta della Pasqua.
Dalla testimonianza di Grazia Deledda si evince infatti che la pardula o casadina nasce come dolce preparato alla vigilia della Pasqua e impiegato per suggellare occasioni solenni e rituali:
Ed in ogni casa si fanno “sas casadinas” (schiacciate di pasta), dentellate, con gli orli rivoltati e contenenti del formaggio fresco impastato con sale e zafferano (…). Ed al sacerdote che va a benedire le case si getta una moneta d’argento entro il secchiello dell’acqua santa, e un pane e “casadinas” nella bisaccia recata appositamente dal sagrestano».

La misura più comune delle pardulas è contenuta, ma anticamente (ed ancora oggi in taluni casi) veniva realizzata anche una versione grande «quanto un piatto» , che andava a costituire un pasto unico.
Nei percorsi immensi della tradizione orale, quando i contorni delle origini sfumano nel tempo, l’etimologia può essere di conforto.
Secondo alcuni il nome pardula deriva dal latino qua-
drula, in riferimento alla sua forma, tuttavia viene difficile individuarvi una forma quadrata, a meno che non si ipotizzi una versione antica di cui non è rimasta traccia, o ci si soffermi solo su una delle tante tipologie di lavorazione della base di pasta. Il suono ricorda piuttosto il termine sardo bàrdula (gleba) oppure bàrdule (uno dei sostantivi per denominare la pancia), entrambi significati afferenti a sagome arrotondate, quali quelle delle pardulas.
Questa particolare forma, unita alla presenza dello zafferano (spezia che «facilita il parto») evoca la simbologia della nascita e della vigilia, pertinente alla primavera anche in quanto periodo di nascita degli agnelli (da cui consegue maggiore disponibilità di ricotta e formaggio) nonché inerente all’uovo, emblema della ciclicità della vita.
L’etnomusicologa Susana Weick-Shahak che ha investigato il repertorio di canti sefarditi, informa che «Cuando ha nacido un niño varón, acompañando a “la parida” y a su criatura, se cantan diversos cantares (…), y muy especialmente en la última noche, llamada “noche de viola”» , ossia la notte di veglia dedicata al neonato.Percorrendo il filo dei suoni si arriva alla pasta violada (amalgama degli ingredienti che compongono il vassoio-base della pardula), (segue pagina 62)
61
(segue dalla pagina 61)
una locuzione in lingua sarda che restituisce il senso della sacralità dell’impasto di farina, acqua e sale ‘violato’ dall’aggiunta dello strutto.
Quest’ultimo ingrediente, evidentemente mai utilizzato dai sefarditi, potrebbe rappresentare una variazione alla ricetta originaria motivata dalla necessità di dissimularne l’origine ebraica (ciò spiegherebbe la percezione di profanazione dell’impasto suscitata dall’aggiunta del grasso di maiale), oppure delineare una rielaborazione indotta dalla maggiore reperibilità nell’isola di ingredienti derivati dal maiale, dal momento che le gastronomie tradizionali utilizzano sostanze disponibili in loco.

Il peculiare nome della pardula vanta una antica attestazione nel Canzoniere ispano-sardo, raccolta miscellanea di manoscritti del XVII secolo redatti in lingua castigliana e sarda, esempio del multiculturalismo vigente all’epoca in Sardegna.
A una dama melindrosa è il titolo della copla in spagnolo in versi ottonari, nella quale tra i vari cibi elencati compare il termine pardula, proprio nella prima strofa, curiosamente, dato che il dolce andrebbe a fine pasto e in questo caso è rappresentato da una melagrana:
No quiero, no quiero nada, sólo quiero mantequillas, párdulas, sí quesadillas, y por postre una granada, no quiero no quiero nada
Foto mosaico-cem.it
Come si può osservare il poema condivide con il repertorio sefardita l’impostazione umoristica di certi componimenti riferiti agli alimenti, nonché medesimi procedimenti enumerativi con ripetizioni e serie di versi parallelistici , tipici delle rethailas o di certe Canticas de boda.
Il discorso antifrastico peculiare della cultura sarda si esprime in questo caso nell’uso della negazione per formulare una preferenza, caratteristica che ritroviamo ad esempio nella cantica sefardita El novio no quiere dinero, o nell’ideale dialogo canzonatorio S’habés comida como es la razón.
Tuttavia in questo caso l’ingente quantità di cibo che la donna dovrebbe assumere, ricorda il suggestivo testo cumulativo intitolato Ke komiash, duenya, riportato da Liliana Treves Alcalay quale canto di Pèsach utilizzato per depistare la sorveglianza del Santo Uffizio.
Il novero degli alimenti che vengono citati meriterebbe una trattazione a parte, data la testimonianza storica e i riferimenti a un determinato contesto ed epoca. Compaiono infatti quesadillas, empanadas, confites y naranjada, che alla fine vengono idealmente disposti in una olla podrida, piatto tipico di Burgos e Castiglia, ereditato dal Medioevo.
Risulta significativa anche la presenza della melagrana (granada), di grande valenza simbolica per gli ebrei e
molto amata anche in Sardegna, come ci informa Andrea Manca dell’Arca.
L’agronomo del XVII secolo loda infatti le virtù e la base a forma di stella (a sei punte) del frutto «con geometrica e maravigliosa proporzione disposto», sottolineando come «dalle melogranate dolci nelli paesi abbondanti di questo frutto si spreme vino come dalle uve». L’uso di questa bevanda era in vigore anche presso i sefarditi.
Benché dopo circa 400 anni di presenza spagnola nell’isola risulti difficile distinguere quali apporti della cultura sefardita provengano da eredità diretta e quali da mediazioni successive o da usanze iberiche comuni, è pur sempre emozionante cercare nelle forme e nei sapori dei dolci sardi il profumo di Sefarad. Così uno sguardo attento può cogliere negli amarettos de mendula, composti di mandorle, zucchero e uova, una familiarità con gli almendrados del ricettario sefardita, mentre la delicatezza degli ashuplados kon almastica rivive nei marigosos sardi, anch’essi croccanti fuori e morbidi e gommosi all’interno.
O nei pittigados, la cui denominazione moderna ‘veronesi’ per coincidenza richiama i polverones nel nome, negli ingredienti (pasta di mandorle e acqua di fiori d’arancio) e soprattutto nella simbolica forma piramidale. Sembianza che ritroviamo anche nei pabassinos a s’an-
tiga, all’antica appunto, perché la forma odierna, più comune, ha perso l’altezza della piramide, conservandone solo la base.
Potremmo perderci poi nella grande varietà di forme delle origliettas (analoghe alle hojuelas) o trizzas, le quali come evidenzia quest’ultima denominazione, condividono tutte la forma intrecciata.
Oppure scorgere nelle tilicas (anch’esse confezionate con miele, frutta secca, scorza d’arancia e un pizzico di sale) il ricordo delle orejas de Hamán, e nei candelaus di pasta reale una rielaborazione sarda del pastel reale o masapan kon sharope di Rodi, a sua volta retaggio toledano.

I dolci, prediletti anche dai sefarditi, in Sardegna hanno radici latenti e talvolta inconsapevoli, ma dal simbolismo poderoso poiché nell’isola costituiscono una tradizione ininterrotta.
Possiamo beneficiarne oggi grazie alle donne sefardite e sarde che ne hanno trasmesso le ricette nel tempo e nello spazio, con una tenacia che illumina le parole del proverbio sardo: «sul boccone condiviso, ci si siede l’angelo» .
www.mosaico-cem.it/ cultura-e-societa/personaggi-e-storie/storia-e-cucina-reminiscenze-ebraiche-nei-dolci-di-sardegna/ www.cagliaripad. it/579484/dalla-burrida-al-pane-puerile-ecco-le-ricette-sarde-di-origine-ebraica/
63
Foto mosaico-cem.it
Gamberi, scampi, ostriche e tartare a domicilio?
Da ormai sei anni Le Raffinate seleziona, lavora e distribuisce ogni giorno pesce e prodotti freschi del mare in tutta la Sardegna, partendo dal suo stabilimento di Cagliari.
Siamo andati a farci raccontare come nascono i loro crudi di mare, i loro filetti e tutte le loro preparazioni.
I medici e i nutrizionisti raccomandano di consumare pasti a base di pesce almeno tre volte alla settimana.

Un consiglio utile per la nostra salute viste le eccellenti proprietà nutrizionali contenute nelle materie prime del mare. Purtroppo però comprare il pesce è un’esperienza un po’ lunga e complicata.
Bisogna andare al mercato, scegliere bene il box a cui rivolgersi (l’ideale sarebbe conoscere il pescivendolo) e sperare che il conto non sia troppo salato.
Spesso la busta può perdere del liquido nell’auto e poi bisogna tornare a casa, pulirlo e cucinarlo, facendo attenzione a non far trascorrere troppo tempo, visto che il pesce fresco dopo poche ore inizia a deteriorarsi. Insomma, ci vogliono ore
LE RAFFINATE IL MEGLIO DEL MARE
ed esperienza: chi lavora molto e ha una vita frenetica non ha sempre tutto questo tempo a disposizione e quindi per mangiare pesce si riduce spesso a comprare la prima cosa che trova nel banco freezer a prezzi veramente alti e con un contenuto, una volta aperta la bellissima confezione di cartone, veramente poco invitante.
Da ormai sei anni opera a Cagliari Le Raffinate, un’azienda che lavora e vende pesce fresco confezionato prodotto ogni giorno, seguendo standard molto elevati in termini di sicurezza alimentare e rispetto della catena del freddo.
Ci hanno aperto le porte del loro stabilimento per raccontarci come nascono i loro prodotti, venduti in quasi tutte le catene di supermercati della Sardegna, acquistabili in loco o ordinabili a domicilio.
A farci “da Cicerone” è Raffaella Nateri, una vita nel mondo della lavorazione e della distribuzione del pesce.
Raffaella ha deciso di dare vita alla sua azienda insieme al marito Giulio. Vestiti con camice, cuffia e copriscarpe, per preservare la salubrità dell’ambiente, entriamo nel cuore della produzione.
Il pescato arriva fresco ogni giorno a bordo di camion che viaggiano a una temperatura compresa fra i 2 e i 4 gradi. Una volta scaricato viene sistemato nelle celle
Foto leraffinate
frigo delle Raffinate, dove rimane a una temperatura controllata di 0°. “
La catena del freddo è fondamentale – spiega Raffaella -.
Basta poco tempo di esposizione a temperature non idonee per rovinare la materia prima”.

Il pesce viene pulito ed eviscerato dalle operatrici con dei macchinari specifici per poi essere lavorato e confezionato.
Orate e spigole pulite e pronte per essere cucinate vengono confezionate con una tecnologia particolare che toglie l’ossigeno e immette azoto e anidride carbonica, dei gas naturali già presenti nell’aria, che consentono di mantenere il prodotto fresco in frigorifero per almeno una settimana. Una comodità importante per chi non è sempre in grado di programmare pranzi e cene.
Un’altra modalità in cui viene confezionato il pesce de Le Raffinate è il formato “skin”, un sottovuoto rinforzato che invece elimina completamente l’aria ed è pensato per filetti di pesce bianco, tonno, pesce spada e salmone, e per preparazioni gastronomiche pronte per essere infornate o cucinate in padella: dal filetto di branzino con porcini e patate all’insalata di mare, passando per le mazzancolle sgusciate. Siamo rimasti colpiti dalla pulizia e dall’igiene di
questo stabilimento: la consueta e proverbiale “puzza di pesce” non esiste.
Merito delle temperature controllate (8-9° costanti tutto l’anno nelle sale di lavoro) e dell’attenzione e dalla delicatezza con cui vengono trattate le materie prime.
Alla fine del nostro tour ci facciamo preparare un plateau di crudi di mare da portare a casa: gamberi rossi, scampi, ostriche, tartare di tonno e salmone e una vinaigrette da abbinare.

Ovviamente abbiamo ripreso tutto con le nostre telecamere per mostrarvi ogni fase della lavorazione.
Il pesce si può ordinare tutti i giorni dal lunedì al sabato: ordini dalle 8 alle 18 per le consegne del giorno successivo, entro le 12 per la giornata in corso con consegne entro le 14.
Le Raffinat Via I. Newton, 24, 09131 Cagliari CA Tel.+39 070 456 0837 deliveroo.it https://www.vistanet. it/cagliari/2022/12/01/ gamberi-scampi-ostriche-e-tartare-a-domicilio-ecco-come-nascono-i-crudi-di-mare-de-le-raffinate/
65
vedi il video https://youtu.be/ ZAubkrjM_-Y
ivienne Westwood é morta oggi, serenamente e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nel sud di Londra»: inizia così il post affidato a Instagram che nessun vero amante della moda, ma neppure nessun curioso osservatore della società contemporanea, avrebbe mai voluto leggere, e che annuncia la scomparsa della geniale e amatissima stilista britannica.

E prosegue:
«Vivienne ha continuato a fare le cose che amava, fino all’ultimo momento, disegnando, lavorando alla sua arte, scrivendo il suo libro e cambiando il mondo in meglio.
Ha condotto una vita straordinaria.
La sua innovazione e il suo impatto negli ultimi 60 anni sono stati immensi e continueranno nel futuro.
Vivienne si considerava una taoista.
Ha scritto: “Il sistema spirituale del Tao.
Oggi non c’è mai stato più bisogno del Tao.
Il Tao ti dà la sensazione di appartenere al cosmo e dà uno scopo alla tua vita; ti dà un tale senso di identità e forza sapere che stai vivendo la vita che puoi vivere e quindi dovresti vivere: fai pieno uso del tuo carattere e pieno uso della tua vita sulla terra.
Il mondo ha bisogno di persone come Vivienne per cambiare in meglio».
E noi non potremmo essere più d’accordo.
Una vita intensa e ricchissima, quella della creativa
WESTWOOD
VIVIENNE
nata Tintwistle, l’8 aprile del 1941: ricca di intuizioni, di entusiasmo, di trovate, di provocazioni (anche), di invenzioni e di dispetti, ma soprattutto di passione, profusa in tutto quel che faceva, dalla moda al recente (ma già di lunga data, perché anche in questo è stata un’autentica visionaria) impegno per la sostenibilità e l’ecologia, intrapreso ben prima che diventasse una moda.
Dopo l’infanzia trascorsa in un piccolo villaggio del Derbyshire con il padre Gordon Swire e la madre Dora, si trasferisce con la famiglia a Londra, nel 1958, dove studia oreficeria e moda, anche se i suoi primi impieghi sono come insegnante di scuola.
Sposa nel 1962 Derek Westwood, ma è l’incontro con Malcom McLaren, che sarebbe poi diventato il manager dei leggendari Sex Pistols, a cambiarle la vita.
Nel 1971 i due aprono il loro primo, rivoluzionario negozio, Let it Rock, all’iconico 430 di King’s Road. Nel corso degli anni lo store cambia nome diverse volte (Too fast to live too young to die, Sex, Seditionaries e dunque World’s End) ma mai la sua missione di crogiolo di nuove tendenze, captate per le strade, tra le subculture giovanili nel loro nascere.
Westwood fa sua la tradizione, anche borghese, della società britannica, per stravolgerla dal suo interno, storpiandone i canoni fondanti e quasi irridendoli, ma sempre con ironia e con un affatto di fondo per il suo Paese e
V
Foto
michaelputland/getty
images
per le sue tradizioni.
Come, ad esempio, con il movimento punk e con lo stile che contribuì a creare, definire e in un certo senso a codificare, creando coi suoi abiti una vera e propria divisa, apparentemente aggressiva e provocatoria, fatta di spille da balia, borchie, chiodi in pelle, catene, jeans candeggiati e maglie strappate.
Ma la sua grandezza fu anche quella di irrompere nel sistema moda e nella sua industria, scardinandone dal di dentro le certezze a colpi di creatività, continuando con coerenza la sua personale ricerca artistica, con la collezione Pirate, una vera e propria pietra miliare della storia della moda del XX secolo, che segna l’irrompere del suo grande interesse e della sua sterminata conoscenza per la storia della moda e del costume in tutte le sue epoche, nelle sue collezioni.
Non a caso il corsetto, quello che arrivava dritto dritto dal XVII secolo, è stato per decenni, e continua ora a essere, uno dei suoi capi più riconoscibili, distintivi e diciamo pure iconici.
Negli anni ‘80 esplora i territori e le suggestioni dello stile tribale e post atomico, quindi è tra le prime a infrangere qualsiasi barriera tra il maschile e il femminile, a inventare il gender fluid prima ancora che l’espressione esistesse, mandando in passerella uomini in gonna, prendendo spunto dal kilt scozzese.
Indimenticabili anche i suoi accessori, dai gioielli con forme falliche agli stivali Pirate Boot, fino alle altissime zeppe che riuscirono nell’impresa di far cadere in passerella persino una modella pronta a tutto come Naomi Campbell.
Negli anni più recenti si è fatto sempre più profondo e totalizzante il suo impegno sociale e politico, portato avanti dalla stilista sostanzialmente dalle sue collezioni, diventate manifesti programmatici a favore dei diritti civili, ma anche di un’autentica consapevolezza ecologista: Propaganda, Active Resistance, Active Resistance to Propaganda sono alcune delle sue prese di posizioni più forti contro le amministrazioni Bush e Blair., in sostegno ad Assange, contro la guerra e ogni forma di sfruttamento.
Nel 1992 ha sposato uno dei suoi studenti di moda, Andreas Kronthaler, che da anni la affianca amorevolmente.
Oggi Kronthaler ha dichiarato: «Continuerò con Vivienne nel mio cuore. Abbiamo lavorato fino alla fine e lei mi ha dato un sacco di cose con cui andare avanti. Grazie Tesoro».
Si apprende ora che la stilista fosse malata da tempo, ma che non avesse voluto rendere pubblica la sua lotta. Pur avendola combattuta fino alla fine.
Con forza e coraggio, come ha fatto in tutto ciò che ha affrontato, nella vita.
Federico Rocca
www.vanityfair.it/article/ vivienne-westwood-morte-scomparsa-addio

67










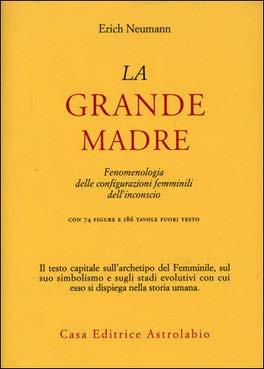



















 Foto wikipedia.org
Foto wikipedia.org
 Autori Diversi Wikipedia.org
Autori Diversi Wikipedia.org




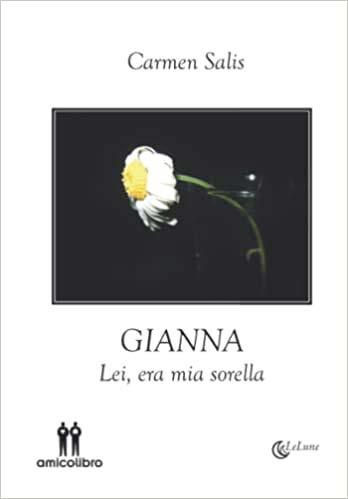













 Ingresso a Sassari di Giovanni Maria Angioy di Giuseppe Sciuti
Ingresso a Sassari di Giovanni Maria Angioy di Giuseppe Sciuti


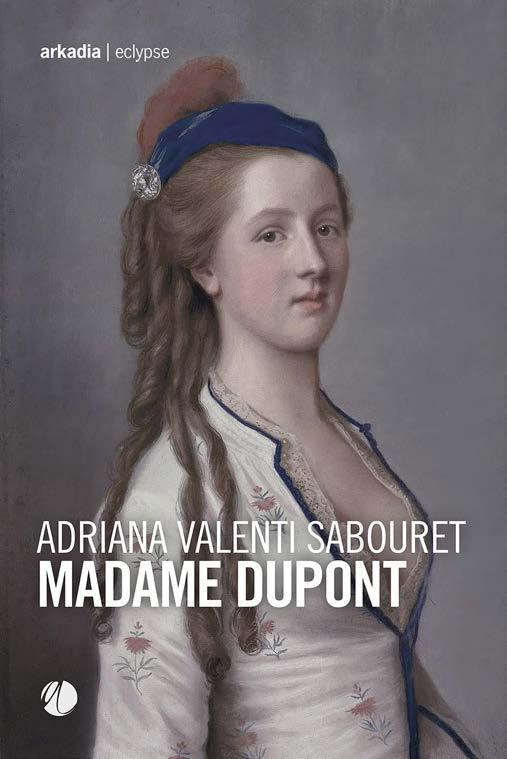
 Foto liberliber
Foto liberliber






 Foto cinziaravaglia
Foto cinziaravaglia























