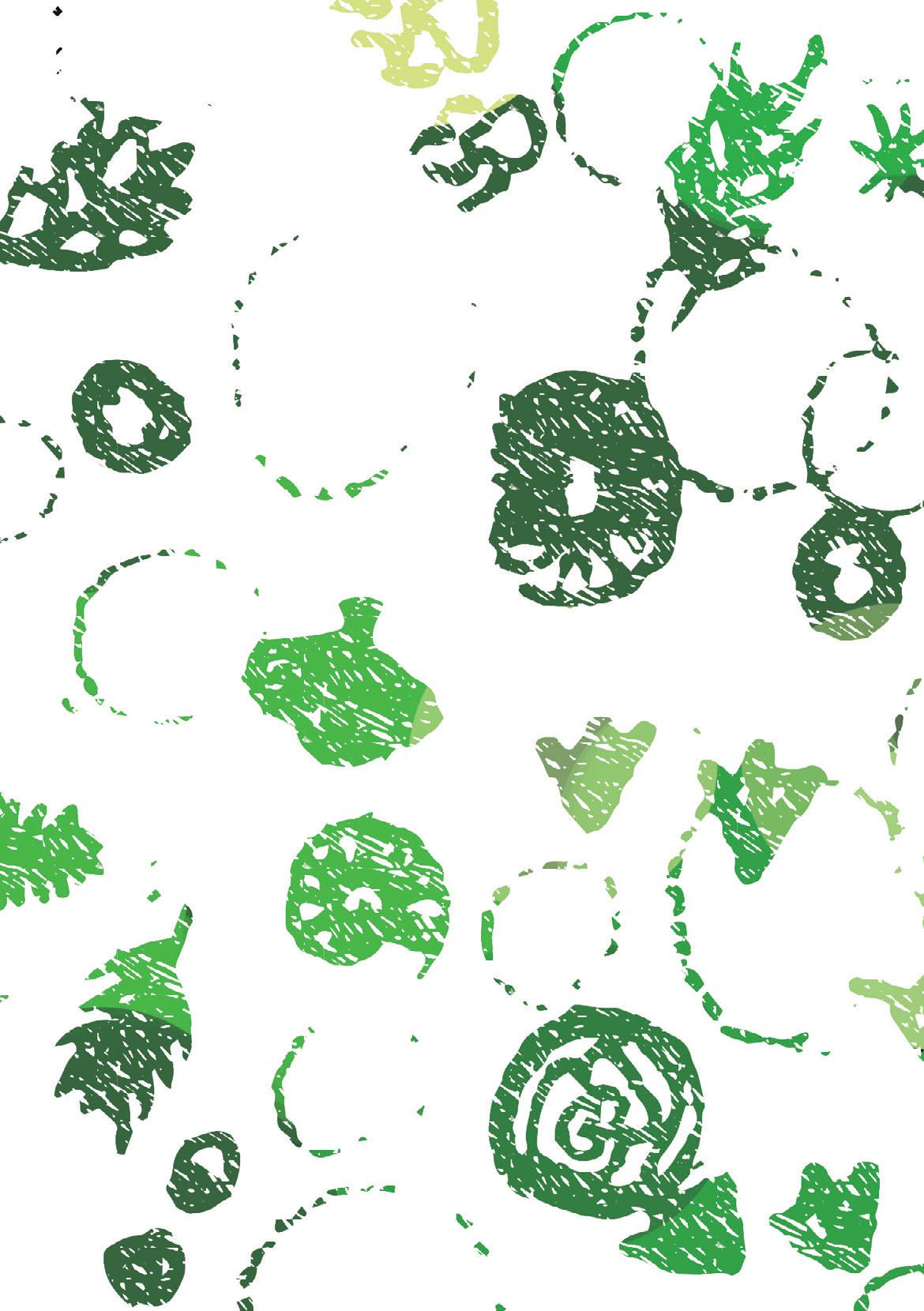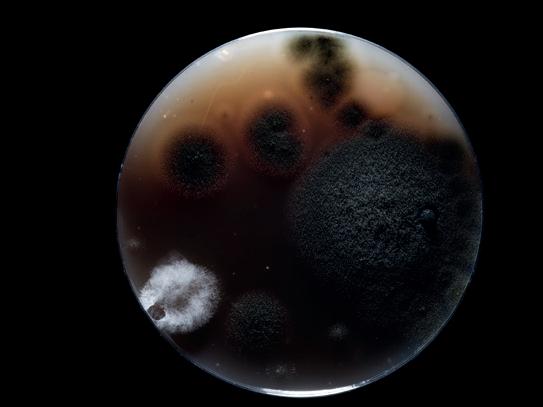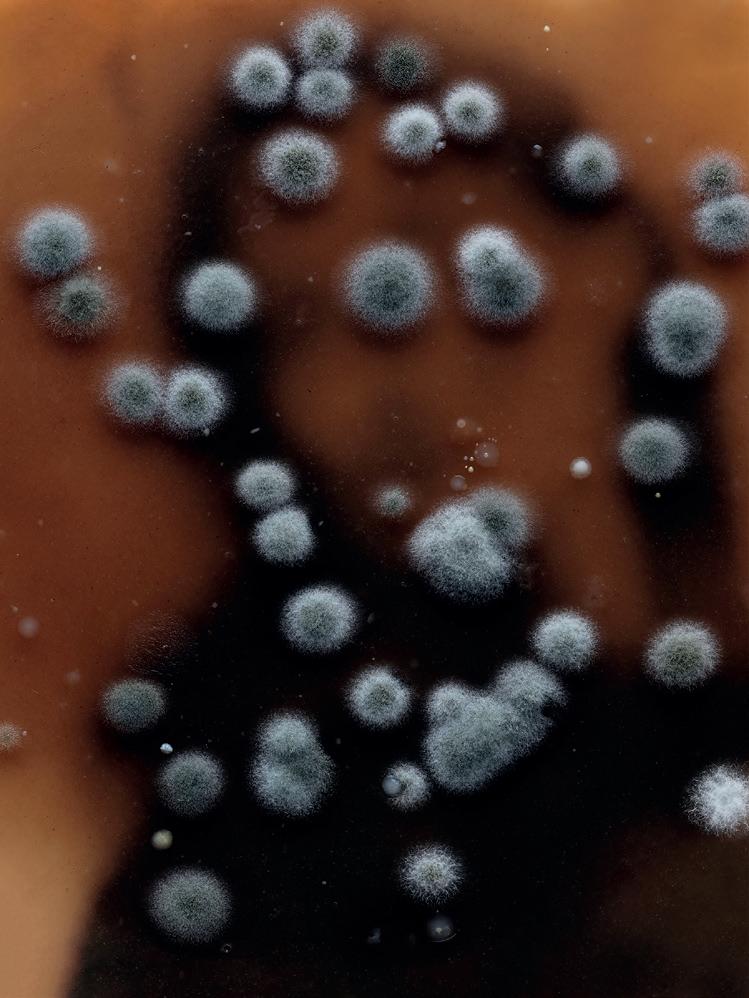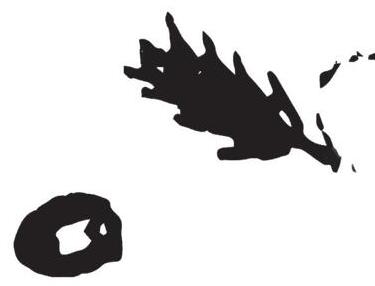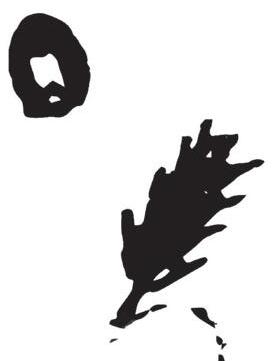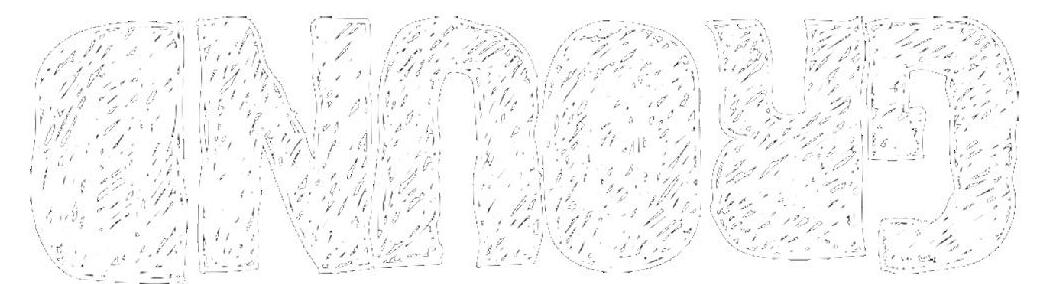 immaginare agire fare la rievoluzione
immaginare agire fare la rievoluzione
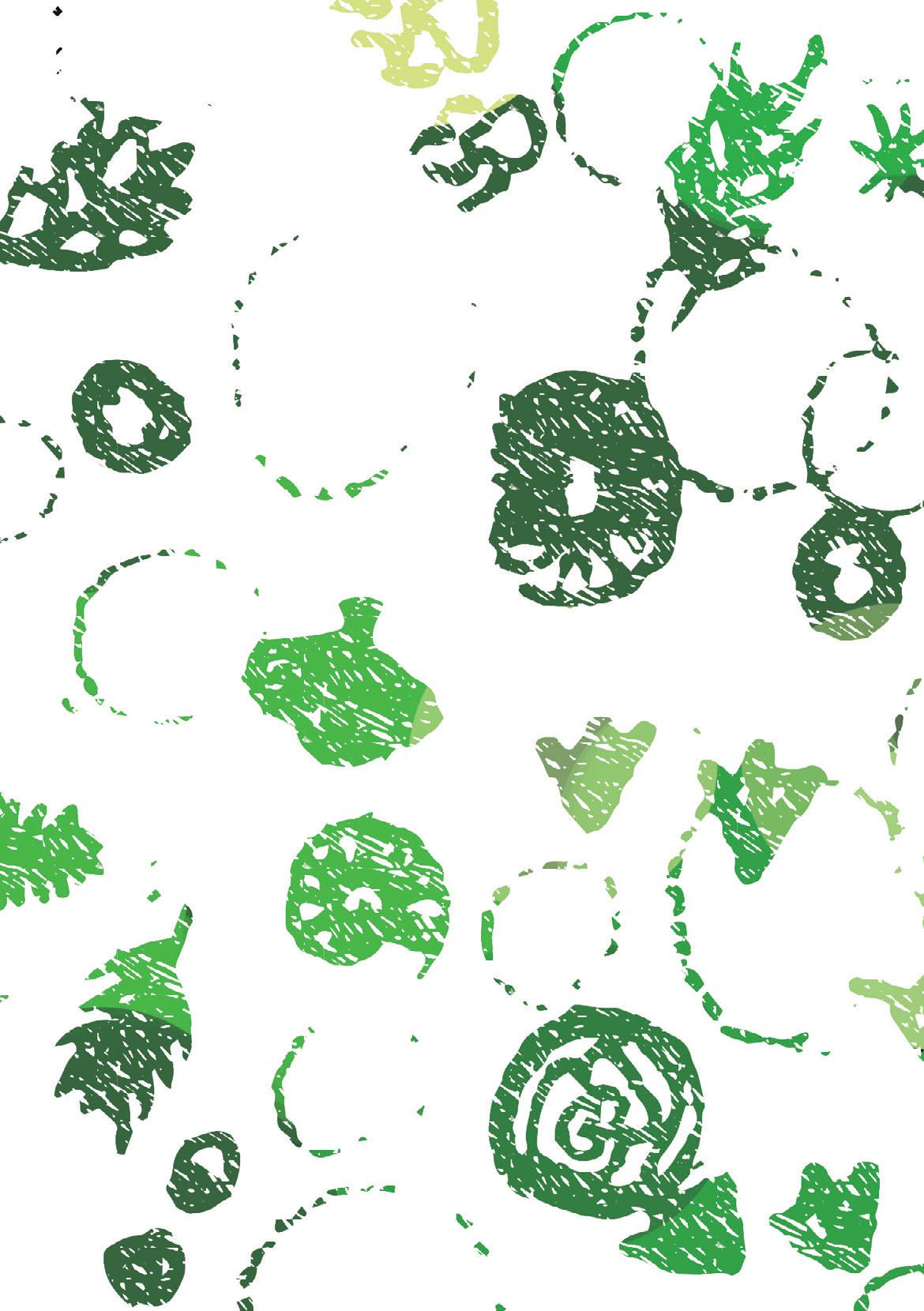
GROUND immaginare agire fare la rievoluzione a cura di Mattia
Bertin
Marco Lo Giudice
Tommaso Zorzi
GROUND
Immaginare agire fare la rievoluzione
a cura di
Mattia Bertin, Marco Lo Giudice, Tommaso Zorzi
ISBN: 979-12-5953-059-2 (cartaceo)
ISBN: 979-12-5953-086-8 (digitale)
Volume realizzato all’interno del progetto ClimHUB, sostenuto da Fondazione Cariverona con il bando Habitat 2022
testi: gli autori e le autrici dei saggi sono parte del comitato scientifico di GROUND Social Forum.
Adriano Altissimo, Stefano Bartolini, Miguel Benasayag, Mattia Bertin, Alan Chandler, Marta De Marchi, Gianfranco Franz, Alessia Franzese, Jacopo Galli, Elena Granata, Sara Lando, Marco Lo Giudice, Franca Olivetti Manoukian, Michela Pace, Andrea Pase, Gabriele Pasqui, Alice Pomiato, Anna Pozzi, Vittoria Prisciandaro, Katia Provantini, Simone Sfriso, Cristina Sudiro, Elena Svalduz, Maria Chiara Tosi, Luca Velo, Antoni Vives i Tomàs, Tommaso Zorzi
fotografie: Sara Lando
illustrazioni: Chiara Filippin
logo ground: Eleonora Munari
stampa: Digital Team, Fano
editore: Anteferma Edizioni
prima edizione: febbraio 2024
citazione: Mattia Bertin, Marco Lo Giudice, Tommaso Zorzi (2024). GROUND. Immaginare agire fare la rievoluzione. Conegliano: Anteferma
Copyright
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale
Questo libro è esito del GROUND Social Forum, organizzato da Rete Pictor e Università Iuav di Venezia, all’interno del progetto ClimHUB sostenuto da Fondazione Cariverona con il bando Habitat 2022.
Indice
1 Ground on / Ground in
17 Biodiversità fotografie di Sara Lando
2 Affondi dalla superficie
36 Questo palmo di terra Andrea Pase
39 Tornare a terra Adriano Altissimo
44 GROUND e l’ecologia della felicità Stefano Bartolini
48 Se tutto è urgenza ed emergenza Gianfranco Franz
54 Sulle collaborazioni artistiche Sara Lando
58 Non più minori Franca Olivetti Manoukian
63 GROUND e la politica Gabriele Pasqui
67 Abitare l’incertezza Javier Ruiz Sánchez
70 Cultural Heritage as a Common Ground: patrimonio culturale, sviluppo sostenibile e inclusione sociale Elena Svalduz
74 Quale GROUND? Maria Chiara Tosi
76 Recuperare la città nel XXI secolo Antoni Vives i Tomàs
79 La scienza tra terra e cielo Cristina Sudiro
82 Stranieri/estranei Anna Pozzi
85 L’immaginazione al potere Marco Lo Giudice
89 Un terreno comune in cui rammagliare i diritti ai corpi Alessia Franzese
93 Terreno, suolo, terra, Terra Marta De Marchi
98 Il passaggio da un mondo ego-centrico a un mondo eco-centrico Alice Pomiato
101 Appello all’immaginazione Michela Pace
105 Tra umanità e suolo Tommaso Zorzi
110 Muoversi in città. In bici o a piedi, per dove? Luca Velo
115 Il mondo può fare a meno dell’architettura? TAMassociati
119 Da grande salverò il mondo... Katia Provantini
122 Pressione. Filosofie non tristi del cambiamento Jacopo Galli
126 Siamo ancora liberi di solcare il mare Mattia Bertin
130 Viversi dentro il vivente Miguel Benasayag
140 I nuovi designer dei luoghi Elena Granata
143 Carbon and culture – nuove forme di produttività Alan Chandler
148 Piattaforme condivise e progetti comuni Vittoria Prisciandaro
3 Infiltrazioni
154 Saperi e Sapori di Stagione, Rassegna del gusto, Blank_, FeliceMente Fuori in Estate, Urban Jungle Angarangan, Dietro il paesaggio – stati generali della letteratura in Veneto, inTREEcciamo live, La timidezza delle chiome, Scrib*Scrib Fest!, STRA-bordi
4 Appendice
164 Notizie su autori e autrici
1

Ground on / Ground in
8
Introduzione
Ground [sth] on [sth], ispirarsi a; ground [sth] in [sth], fondare [qlcs] su; ground [sb] in [sth], insegnare a [qlcn] le basi di [qlcs].
GROUND è abitare la terra. È stare al livello del suolo, sulla strada, vivificare lo spazio aperto come piazza, superare i confini, i cancelli, le esclusioni. GROUND è brulicare di esistenze diverse che si mescolano, si contaminano, si organizzano. GROUND è moltitudini disorganizzate che operano individualmente e che si ricompongono in uno spazio comune, paritetico. GROUND è mettere le basi, generare un’idea, è ispirare. È un atto fondativo, centro di discussione, di proiezione, di orientamento. GROUND è una condizione comune che ci trattiene e ci spinge a immaginare, ad agire, a stare nel cambiamento. La necessità, sempre più urgente, di considerare la conversione ecologica, economica e sociale come parte di una nuova idea di terreno alimenta gli spunti di soggetti collettivi che operano per un cambiamento nel proprio territorio: comunità, cooperative, associazioni, ricercatrici e ricercatori che con il proprio operare provano a ridurre i divari e le esclusioni, attraverso e nello spazio pubblico, dal pianeta alla strada, per restituire usi e orientamenti inclusivi e sostenibili.
9 1 – Ground on / Ground in
Punto di partenza di queste riflessioni è il progetto ClimHUB, sostenuto da Fondazione Cariverona con il bando Habitat 2022, che s’inserisce in una cultura del progetto che considera unitariamente l’adattamento climatico e la valorizzazione sociale dei contesti urbani. In particolare il progetto opera sulle pertinenze di una villa palladiana sita a Bassano del Grappa (VI): Villa Angaran San Giuseppe, un complesso monumentale originario del XVI secolo, dove operano diverse realtà fortemente orientate al sociale che hanno fatto degli spazi della villa un bene comune, un luogo di incontro, accoglienza e benessere, un centro di promozione culturale. La strategia unifica tecniche di trasformazione territoriale a impatto misurabile, di formazione della collettività attraverso eventi culturali di massa, e di disseminazione di buone pratiche alla pubblica amministrazione.
La prima premessa è il superamento dell’approccio tecnicista e puntuale alla sostenibilità, nella consapevolezza che fragilità ambientali e sociali debbano essere considerate unitariamente nell’attuale processo definito “di transizione”. La seconda premessa è che la rievoluzione debba essere situata spazialmente, considerata in termini territoriali e quindi relazionali. Proprio sulla dimensione spaziale che intreccia questioni ambientali e sociali si basa la proposta per un nuovo welfare ecosistemico che, a partire dall’individuazione e dalla mappatura degli spazi di interesse pubblico, li consideri deposito potenziale per un progetto di adattamento territoriale. Attraverso l’esperienza di ClimHUB si intende proporre una prima ridefinizione di bene comune basata sulla potenzialità dello spazio aperto di interesse collettivo come luogo di resilienza integrata.
10
Sulla base di queste considerazioni, il GROUND Social Forum (14-23 settembre 2023) riflette sulla sostenibilità in maniera diversa rispetto al passato, superando le questioni puramente tecniche e inserendole invece in un più ampio progetto civile, che consideri fragilità ecologiche e sociali come necessariamente connesse. Il cambiamento, o meglio la rievoluzione, è dunque una premessa anomala, che non esaurisce la sua funzione all’inizio dell’osservazione, ma è situata nel presente, contemporaneamente punto di partenza e traiettoria sulla quale misurare le nostre riflessioni.
Nell’intenzione di recuperare la dimensione geografica del cambiamento, è necessario sviluppare un’officina di saperi e tecniche capace di innovare i processi di adattamento e trasformazione del territorio, un modello che riconosca nella complessa sfida della transizione questioni legate al welfare collettivo oltre che alla soluzione operativa, e che possa avvenire tramite opere piccole, buone pratiche e sistemi integrati di conoscenza. Questo stimola riflessioni che si muovono tra le scale, spingendoci a osservare la soglia domestica e contemporaneamente il quartiere, la città, la regione. L’osservazione spaziale, la realizzazione di strutture e infrastrutture, così come l’insieme di norme e regole a cui il progetto di territorio fa riferimento, sono necessariamente destinate al rapporto reciproco e alla variabilità: così come la premessa si rinnova, dovranno rinnovarsi l’osservazione e le risposte, senza perdere di vista la dimensione sociale della transizione e il suo rapporto con le strutture relazionali che proprio nello spazio trovano necessario supporto.
11 1 – Ground on / Ground in
Questo processo suggerisce una potenziale ridefinizione del concetto di bene comune in epoca di transizione ecologica: spazialmente situato, legato agli spazi aperti come deposito di naturalità e occasione di progetto per le comunità. È necessario oggi ridefinire in chiave contemporanea il patrimonio e il suo uso come bene comune, superando un approccio gestionale, verso un approccio più progettuale e inclusivo, operando sugli spazi aperti collettivi, sulla loro predisposizione a essere luoghi di incontro e conversione in depositi di naturalità e dispositivi di adattamento, aumentando, di fatto, la consapevolezza del ruolo che il suolo, (ground, appunto), è in grado di svolgere, nel rispetto delle sue fragilità e della necessità di limitarne il consumo attraverso azioni di cura.
12
GROUND Social Forum
La prima edizione di GROUND Social Forum è stata un’occasione per sperimentare una lettura plurale della relazione tra umanità e pianeta e per condividere una narrazione fertile su stili di vita sobri e rispettosi, in un approccio alla vita meno antropocentrico e più ecosistemico.
Aperto da un grande evento molto partecipato (come il concerto dei Marlene Kuntz, con oltre 800 partecipanti), il GROUND Social Forum ha accolto decine di persone differenti: classi degli istituti superiori bassanesi, professionisti e ricercatori, curiosi e abitanti del quartiere e della città. La modalità operativa è stata semplice: tutti i pezzi scritti dal comitato scientifico (presentati in questo libro) sono stati raggruppati in 10 tavole rotonde, i cui focus hanno esplorato temi come l’ambiente e il clima, l’accessibilità, la salute e il benessere, l’architettura e l’alimentazione. I partecipanti, mai più di 35 persone per gruppo, potevano iscriversi alle tavole rotonde, confrontandosi a partire dai contenuti proposti nei piccoli articoli. Si è trattato di un momento esperienziale poco didattico e molto riflessivo sul modo che abbiamo di stare al mondo, facendo interagire il bagaglio culturale sull’inclusione sociale del contesto di Villa Angaran San Giuseppe con la ricerca e l’approfondimento accademico della rete Iuav. In questo modo si è potuto attuare una divulgazione fertile, partendo da dati o da tematiche chiare per raccogliere in un ambito ristretto commenti e osservazioni, utili poi ad allargare (o ridefinire) le direzioni del Social Forum e dare stimoli e indicazioni per le scelte operative da attuare nelle proposte quotidiane di Villa Angaran, nei percorsi di ricerca di Iuav, nella vita di tutti coloro che hanno preso parte a GROUND.
13 1 – Ground on / Ground in
GROUND Social Forum è stato un momento di forte addensamento e confronto transdisciplinare, che per quanto florido e costruttivo resta un appuntamento di qualche giorno. Per questo motivo abbiamo voluto realizzare e raccontare (e continueremo a farlo) altri momenti occasionali di dibattito e crescita distribuiti nel corso dell’anno, che hanno lo scopo di disseminare e ampliare le tematiche di GROUND grazie a pubblici, ospiti, partecipanti sempre differenti. Abbiamo chiamato questi momenti infiltrazioni.
Questo libro prova a raccontare quanto vissuto prima e durante GROUND, con i testi proposti dal comitato scientifico e con alcune delle infiltrazioni realizzate nel corso dell’anno. L’obiettivo non è narrativo, rendicontativo o descrittivo; c’è invece l’intenzione di gettare, nel suolo enorme e incerto della letteratura scientifica divulgativa, tematiche e approcci che siamo convinti possano germinare in differenti ground, dentro e fuori la nostra penisola.
Il libro, come il Social Forum, è un dialogo in contrappunto tra i due mondi del sapere e del fare che, pur nell’interesse reciproco, spesso si contaminano poco. Il Social Forum nasceva sotto forma di due percorsi paralleli: uno sociale, l’altro territoriale. Durante il Forum abbiamo rivoluzionato tutto, abbattendo gli steccati e fondendo i percorsi paralleli, mescolando autori e pratiche. Questo libro vuole fare lo stesso: smettere di praticare la separazione moderna tra mondi e tornare nella complessità e nella conflittualità del mondo.
14
Questo libro non è un prodotto da vendere, semmai è un prodotto da conservare. La carta costa, quindi la versione cartacea ha un prezzo, ma serve solo a ripagare le stampe. La versione digitale è libera e vuole moltiplicarsi il più possibile. Inoltra questo libro a chi vuoi, la rievoluzione comincia dalla condivisione.

15 1 – Ground on / Ground in
Biodiversità
fotografie di Sara Lando





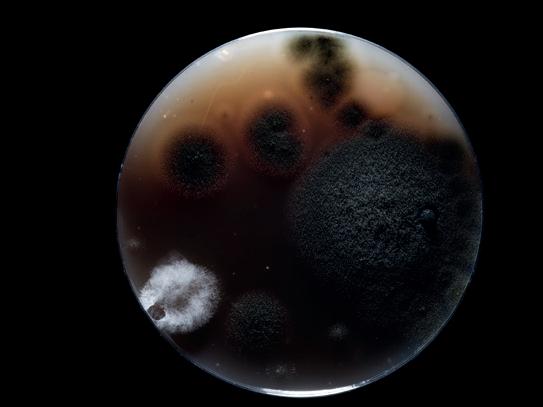




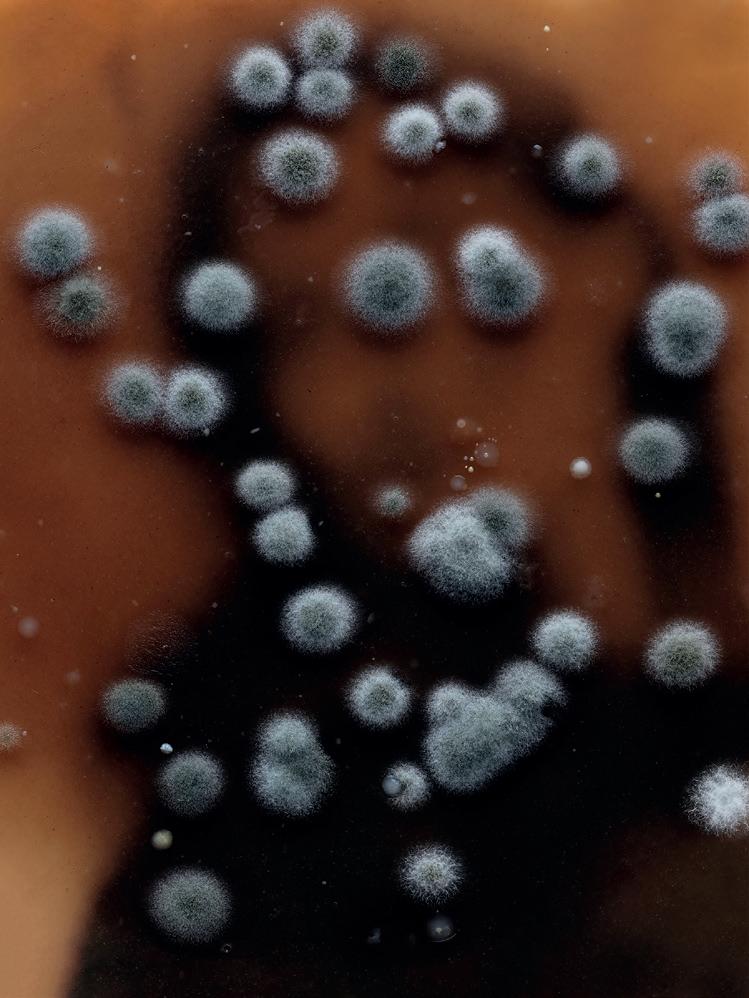




2

Affondi dalla superficie
34
28 autori e autrici si interrogano sul significato di ground: attraverso brevi saggi, possibili inneschi di discussione, viene esplorato il significato del nostro agire sulla e con la terra cercando di operare puntuali affondi a partire dalla superficie.
Quali sono le urgenze di frontiera per sviluppare un progetto di collettività che risponda a quanto auspicato da GROUND?
Quali sono i rischi da evitare per non fare di GROUND una chiacchierata elitaria tra pochi?
Quali sono gli auspici verso un’aggregazione tutta da costruire per un’Italia più GROUND?
35 2 – Affondi dalla superficie
Questo palmo di terra
Andrea Pase
Sul suolo, in superficie. È lì che abitiamo la terra: sulla sottile pelle che avvolge il pianeta.
Pelle morbida, che accoglie. Pelle viva, che traspira. Pelle rugosa, segnata dai conflitti, dalle amarezze. Pelle alle volte lacerata, e ricucita, con cicatrici evidenti. Pelle marcata da tatuaggi, da disegni di senso o da richiami identitari, spesso da dichiarazioni ostentate di differenza. Ground è questo spazio sottile che ci sorregge, ci nutre, ci collega. È anche la dantesca «aiuola che ci fa tanto feroci»1, se vista da molto lontano, dal cielo Empireo, il più astratto, l’unico immobile. Più sotto, anche il cielo è in sommovimento: l’atmosfera si scalda, colma di gas serra. E il suolo si inaridisce o improvvisamente si allaga. Gli estremi climatici si moltiplicano. La pelle trema, sferzata dal vento; si secca, prosciugata dal sole implacabile.
Poi vi è l’underground, il sottosuolo. Ciò che avviene nelle viscere del pianeta e che bussa con la violenza delle scosse sismiche o con le eruzioni vulcaniche. Ancora, il sottosuolo conserva ciò che noi gli affidiamo. Fin dall’«alba di tutto»2, la
36
terra accoglie le inumazioni. Avvolge gli antenati, preserva la loro memoria, nell’unica consolazione di chi (provvisoriamente) resta. Ma il sottosuolo è anche il luogo dove vengono nascosti i delitti contro la natura: le discariche abusive, i Pfas, i veleni della civiltà industriale.
C’è altro ancora, là sotto. Qualcosa di inquietante, ben descritto da Reza Negarestani nel suo Cyclonopedia3 . Per il filosofo iraniano, ciò che attiva i conflitti più devastanti (nel Medio Oriente e non solo), ciò che ammorba l’atmosfera e appesta il suolo proviene dalla profondità. Nell’epoca che altri autori hanno definito come Antropocene o Capitalocene, il pianeta da whole (un intero, una realtà compiuta e in qualche modo armonica, sensata) è diventato ( )hole, una realtà bucata, perforata, alla ricerca del «cadavere nero del sole». La pelle è trafitta. Il disseppellimento degli idrocarburi genera «correnti petropolitiche sotterranee» che sono l’autentico lubrificante politico-economico globale. Viviamo così immersi in «una follia assoluta, una piaga planetaria che sanguina in economie mobilitate dalle singolarità tecnologiche di civiltà avanzate»4. I territori da cui partono oleodotti e gasdotti, come gli spazi da essi attraversati, sono spesso segnati da guerre, bombardamenti, sabotaggi, inquinamento di suolo e di acque. Da ingiustizie, accaparramento delle risorse di tutti nelle mani di pochi, accumulazione di ricchezze illecite. Da corruzione.
Sempre sotto, stavolta nella profondità dell’inconscio di questa umanità disorientata e impaurita, si agitano fantasmi etnici, incubi identitari, angosce ancestrali che schiumano in superficie teorie del complotto e agitano la ricerca di nuovi capri espiatori, in vortici sempre affamati dei prossimi pogrom. Da sotto però risale anche energia vitale, pullula
2 – Affondi dalla superficie 37
l’acqua delle risorgive, emerge la forza del nostro pianeta, il suo calore interno. L’inconscio conserva i sogni dell’umanità, la sua stessa capacità di pensare alternative, modi diversi di generare il mondo. Di lì provengono poesia ed equilibrio, tenerezza e desiderio.
Ground è allora tutto questo: è la pelle, a contatto con l’atmosfera e con le fibre stesse di cui siamo fatti; è il passaggio tra l’interno e l’esterno. Saper leggere i segni sulla pelle della Terra è un’arte che richiede molte conoscenze (formali e informali) e tante pratiche (dall’alto e dal basso). E non basta conoscere, vi è poi la cura: la pelle del pianeta chiede di essere accarezzata, ha fame di creme nutritive, di profumi. Per troppo tempo è stata trascurata, abrasa, scarnificata, macerata, pensando che fosse solo superficie, puro spazio di proiezione della nostra volontà di possesso e di trasformazione. Ground è tutto quello che abbiamo, tutto ciò che siamo e potremo essere. Non vi è altro luogo, non vi è altro spazio. La pelle è preziosa, è protezione e possibilità di contatto, è la linea di ogni abbraccio, è la stessa possibilità di amare.
Forse in questi giorni possiamo provare a fare esercizio di lettura del futuro, così come esso appare nelle linee e nei monti del palmo di terra che viviamo. Quasi come chiromanti del tempo che viene.
1. Dante Alighieri, La Divina Commedia, Paradiso XXII, 151, 1472.
2. David Graeber e David Wengrow, L’alba di tutto. Una nuova storia dell’umanità. Milano: Mondadori, 2022.
3. Reza Negarestani, Cyclonopedia. Complicità con materiali anonimi. Roma: Luiss University Press, 2019.
4. Ivi, p. 67.
38
Tornare a terra
Adriano Altissimo Ground è un confine virtuale. Ground è immateriale, soil - suolo è materiale. Ground divide la biosfera in due parti:
ciò che sta sopra da ciò che sta sotto: aboveground –underground
Perché il suolo, il terreno, ha nomi diversi ed è un materiale, il risultato dell’evoluzione delle rocce originarie trasformato nel tempo, nei millenni, dagli eventi climatici, dalle piante e dagli animali. È una vera genesi, anzi una pedogenesi (da pedos = suolo); e il suolo contiene molta vita, ha una vita sua, indipendente da noi, genera la vita, da qui la terra come madre. Anche le piante sono composte da una parte che sta sopra il ground (aboveground) e una che sta sotto il ground, (underground) dentro al terreno, al suolo.
Ci interessa ciò che sta sotto il ground? Nel ground? Anche se non lo vediamo non è meno importante, anzi. Tenere i
2 – Affondi dalla superficie 39
.
piedi per terra, tenere il contatto con il ground, è essenziale per comprendere i fenomena, le cose che vediamo; come si sono generate, realmente. Quindi: quando abbiamo iniziato a perdere il contatto, il rapporto con il ground? A non avere più i piedi per terra? Quando ci siamo staccati dal suolo, dal terreno, dalla terra, ed essa da madre si è allontanata da noi. L’abbiamo allontanata, l’abbiamo persa, anzi abbiamo iniziato a considerarla sporca. Dobbiamo pulirci dalla terra, anziché conservare la terra.
Da qui, probabilmente, abbiamo iniziato a non capire più cosa sono le cose che ingeriamo, il cibo, da dove vengono. E abbiamo disconnesso il cibo dalla sua vera provenienza, dal ground: oggettivamente, culturalmente. Il cibo è diventato un oggetto dentro a un contenitore, una busta, un sacchetto, un oggetto. Vedere come si coltiva una pianta, si alleva un animale, è diventata attività quasi museale, come per un zoo di piante e animali. Staccarci concettualmente ed emotivamente dalla terra, dal ground, ha abbassato la soglia del rispetto e ha reso possibile farla diventare oggetto di consumo, maltrattarla, violentarla.
Cosa significa coltivare senza terra, senza il ground? Soilless? Perché diciamo polli allevati a terra? Si possono coltivare piante fuori suolo? E allevare polli senza terra? Una pianta fuori suolo (soilless), un pollo fuori terra cosa ci dicono? Diventano di fatto un’astrazione. Ciò da cui provengono non è più rilevante. Nel primo dopoguerra (anni Cinquanta) almeno la metà della popolazione italiana viveva e lavorava in campagna. Significa che, di fatto, quasi ogni persona aveva un rapporto più o meno diretto con la terra. La vedeva, la toccava, ci viveva. Oggi l’agricoltura e l’allevamento occupa-
40
no, nei Paesi sviluppati, il 2% della popolazione attiva, quindi meno dell’1% della popolazione complessiva. Significa che pochi toccano la terra, il ground. Pochi hanno con essa una relazione diretta.
Noi, di fatto, non occupiamo più il nostro tempo per procurarci il cibo, per far crescere le piante e gli animali che ci alimentano. Nella nostra breve storia di umani siamo passati da impiegare 6-7 ore al giorno per procurarci il cibo a pochi minuti al giorno, forse, ma di fatto per acquistarlo, non per generarlo. Come conseguenza non ci domandiamo più cosa c’è dietro al cibo che abbiamo sulla tavola, proprio perché non lo sappiamo, neppure lo immaginiamo, al massimo leggiamo l’etichetta, magari per vedere se ci sono tracce di qualcosa di pericoloso per noi stessi. Guardiamo le etichette, vogliamo il cibo tracciabile, un codice a barre, un QR code, ma di fatto non sperimentiamo cos’è il cibo. Addirittura non ci domandiamo come viene processato, lavorato, trasformato. Magari preferiamo la verdura, la frutta a chilometro zero e consumiamo alimenti che hanno subito un lunghissimo processo industriale, il quale ha del tutto disconnesso l’alimento dalla pianta o dall’animale da cui esso necessariamente proviene. Pretendiamo la sterilità del cibo nelle confezioni quando il microbioma è invece la chiave della nostra vita.
E così scivoliamo sempre più verso la produzione industriale del cibo, a partire dalla sintesi delle proteine per continuare a giustificare i nostri livelli insostenibili di impiego di proteine stesse. Senza domandarci da dove viene tutto ciò che serve per farle. Perché i pezzi per montarle servono! Senza mettere in discussione la radice dell’attuale modello alimentare che, peraltro, genera a cascata altri disagi sulla nostra salute. Per-
2 – Affondi dalla superficie 41
ché è noto che più il cibo è processato, più pesanti sono gli impatti per la nostra salute. E alla fine ci siamo convinti che l’abbondanza di cui godiamo, la facilità di accesso al cibo, sia equa e vada solo un po’ regolata.
Allora, se è così, non è più una questione di chilometro zero, di filiera corta, di ridurre semplicemente la distanza fisico-geografica tra produttore e consumatore (come faremo per il caffè, il tè, le banane, l’ananas e molti altri cibi che pensiamo siano prodotti nei dintorni), di energia per trasportare, di bilancio energetico complessivo, di minore impronta in termini di CO 2 emessa, di tipicità (cosa vorrà poi dire?), di zero pesticidi, zero residui, zero antibiotici. Il tutto ha radici profonde ma, tutto sommato, non troppo lontane. Un nuovo paradigma dell’alimentazione dovrà emergere. E non potrà essere un nostalgico e impossibile ritorno al passato (tra breve il 70% della popolazione mondiale vivrà in aggregati urbani, senza nessun rapporto con il ground dal quale il cibo proviene e senza nessuna possibilità di coltivare o allevare qualcosa direttamente). Umani e produzione di cibo sono attualmente disconnessi, ma profondamente legati.
Non è una questione di eventi, sagre, mercati e fiere, di mostrare e quindi vedere, per qualche istante della vita, le piante, gli animali (che carini) dei quali ci cibiamo, di visitare luoghi (magari come nella scena di un film) dove le piante crescono. Perché nel semplice atto del mostrare, vedere, non nasce nessuna empatia, non rinasce il rispetto per la terra; e non serve neppure proclamarlo per farlo riemergere. Le fratture culturali, la ricucitura dello strappo, del distacco dal ground, si risolvono ammettendo che esistono e affrontandone la complessità.
42
Come? Quali azioni, atti, quale lavoro di riflessione? A che livello? Un compito senz’altro complesso ma necessario per recuperare il contatto con il ground, per scendere di nuovo a terra e apprezzarne il valore come origine del nostro cibo.
Partiamo da lì, da quella che abbiamo attorno, a qualsiasi età. Proviamo di nuovo empatia, sentimenti, cogliamone il valore biologico, la vita che ne discende, l’unicità. Usiamo tutti gli strumenti che abbiamo, i sensi innanzitutto, annusiamola, facciamola fruttare, rispettandola. Sono certo che con GROUND Social Forum si possono immaginare molti percorsi per questo cammino di riavvicinamento, per tornare a terra.

2 – Affondi dalla superficie 43
GROUND e l’ecologia della felicità
Stefano Bartolini
Collettività, spazio aperto, condizione comune, soggetti collettivi, comunità. Sono alcune delle parole chiave usate da GROUND. Secondo GROUND la qualità della vita collettiva è la chiave per vivere meglio e in modo sostenibile.
Per questo GROUND mi interessa, perché condivido profondamente queste idee. Per molti anni ho svolto ricerche in economia della felicità, materia che insegno all’Università di Siena. Negli ultimi trent’anni la scoperta di varie misure affidabili della felicità ha dato vita a una enorme quantità di studi, il cui risultato è dirompente: quello che condividiamo è molto più importante per la felicità di quello che possediamo. Possedere di più è importante solo in condizioni di pri-
44
vazione materiale. Ma una volta assicurate condizioni di vita accettabili, che nei Paesi industriali sono a disposizione della gran parte della popolazione, non è quanto guadagniamo che fa la differenza per la felicità ma ciò che condividiamo. La qualità degli ambienti naturali e costruiti in cui viviamo e soprattutto le relazioni affettive e sociali hanno un’importanza dominante per la nostra felicità. Questa scoperta ha implicazioni enormi su come coniugare sostenibilità e felicità. Condividere rende felici e non inquina; possedere non rende felici e inquina. Infatti è l’enorme massa di beni che produciamo e consumiamo che sta lesionando la biosfera. Quindi, se vogliamo vivere in modo più felice e sostenibile, dobbiamo puntare a espandere ciò che condividiamo e non il possesso. Sono questi i temi che tratto nel mio libro Ecologia della felicità1 .
GROUND mi chiede come possiamo sviluppare un progetto di collettività. Gli studi sulla felicità hanno molte risposte a questa domanda. Sappiamo come fare per ampliare la condivisione: come organizzare le città in modo da ridurre la solitudine, compresa quella dei giovani e degli anziani; quali metodi di insegnamento usare nelle scuole per formare persone capaci di costruire buone relazioni e vite felici; quali modalità di organizzazione del lavoro nelle imprese favoriscano il benessere e le relazioni di chi ci lavora; quali leggi contrastino la manipolazione operata dal marketing, che ci convince che comprare è la soluzione di tutti i problemi. Sappiamo anche che se rafforziamo i legami sociali la spesa sanitaria diverrà più sostenibile, perché la sanità è il terminale del disagio, infatti la povertà di relazioni è una fabbrica di malattie fisiche e mentali. Sappiamo queste cose perché nel mondo pullulano esperimenti ed esperienze consolidate
2 – Affondi dalla superficie 45
su questi temi. E funzionano. In pratica dobbiamo fare il contrario di quanto stiamo facendo da molto tempo. Invece di cercare di migliorare la condivisione, la nostra società punta alla crescita economica, cioè all’espansione del possesso attraverso l’aumento del potere d’acquisto. Per questo le società industriali sono organizzate in base a priorità economiche. L’economia è stimolata con tutti i mezzi possibili, a cominciare dall’istruzione dei bambini, sempre più finalizzata al mercato del lavoro. L’intera organizzazione sociale si basa sulla stimolazione della competizione e del possesso, come se ciò che possediamo fosse tutto ciò che conta per vivere bene. Siccome non è vero, il risultato è una società che non è né felice né sostenibile. Negli ultimi decenni sono dilagate solitudine, perdita di senso di comunità, di solidarietà e di appartenenza, povertà di relazioni, percezione di impotenza personale e collettiva.
GROUND si colloca tra le esperienze che contrastano questa deriva, costruendo connessioni e bellezza condivisa. È questa deriva che ha reso il denaro sempre più importante per la felicità, perché possedere di più è l’unica difesa che abbiamo dal condividere di meno. Affidiamo ai beni materiali il compito di riempire il vuoto interiore causato da relazioni rarefatte e conflittuali, ci rifugiamo in vacanze in paradisi tropicali per sfuggire alle nostre città frenetiche e stressate, cerchiamo di lasciare ai nostri figli un bel gruzzolo per proteggerli dalle incertezze di un futuro degradato. La feroce caccia al denaro che tutto ciò ha generato è stata il motore della crescita economica degli ultimi decenni. La ricchezza privata è stata cioè alimentata dalla crescente povertà della vita condivisa. Questa crescita è definita “difensiva” proprio perché è generata da individui ansiosi che competono per
46
difendersi privatamente dal degrado comune. Un sistema in cui si produce e consuma sempre di più per sfuggire al declino collettivo ha prevedibilmente finito per destabilizzare anche gli ecosistemi, oltre alla nostra felicità. Negli ultimi trent’anni abbiamo emesso tanta CO 2 quanta nei due secoli precedenti e la felicità è declinata in porzioni enormi della popolazione mondiale. Insomma, è il degrado di ciò che condividiamo che alimenta l’ansia di possesso che ci sta spingendo ad assediare gli ecosistemi. Speriamo di cavarcela grazie ai soldi ma finiamo per distruggere i beni comuni, al cui degrado cerchiamo di sfuggire. La corsa a cercare soluzioni private a problemi collettivi è il problema e non la soluzione. Possiamo rompere questo circolo vizioso con le politiche per i beni comuni accennate prima. In questo modo possiamo ottenere sia sostenibilità sia vite migliori. Per farlo abbiamo bisogno di democrazie che prendano le decisioni giuste. Quelle attuali non sono in grado di farlo e vanno radicalmente riformate.
GROUND è stare sulla strada, è condivisione, umanizzazione della vita economica e sociale. È questa la via d’uscita da una crisi ambientale che è solo una faccia della medaglia di una crisi molto più ampia. Uscirne richiede infatti profondi cambiamenti politici, sociali, culturali ed economici. Essi sono possibili e necessari per smetterla di sfidare la natura, inclusa quella umana.
2 – Affondi dalla superficie 47
1. Stefano Bartolini, Ecologia della felicità. Perché vivere meglio aiuta il Pianeta. Milano: Mondadori, Aboca Museum, 2021.
Se tutto è urgenza ed emergenza
Gianfranco Franz
Folle di cittadini sempre più affannati da emergenze che si affastellano le une sulle altre e, insieme, gravano sugli affanni quotidiani.
Un’immagine che ci fa sovvenire il celebre quadro L’urlo di Edvard Munch. Il meteo che cambia a velocità incomprensibili, e che si manifesta in modalità sempre più violente, lasciandoci – sola – la speranza che la prossima volta non tocchi proprio a noi la grandinata che tutto sfascia, le auto, i pannelli fotovoltaici appena montati, il nostro piccolo orto e, adesso, anche le ossa di taluni malcapitati. Quindi corriamo ad assicurare auto e case contro il “clima impazzito”, quando i pazzi siamo noi, col sospetto che al momento del bisogno emergerà un problema, un cavillo, il fatidico errore umano che permetterà all’assicurante di non risarcire l’assicurato assicurandogli profitti e bonus, risorse per comprare, chissà, nuovi orologi da polso che fanno impallidire la saliera che Benvenuto Cellini cesellò per il Cardinale Ippolito d’Este e che questi non poté comprare perché troppo costosa.
48
I fiumi che si seccano quando dovrebbero essere colmi d’acqua ed esondano quando sarebbe periodo di magra. La terra che si spacca, come vedevamo accadere solo in Africa grazie ai telegiornali, compatendo quei poveri disgraziati. Non capiamo cosa stia accadendo perché fa comodo a tanti non capire e riprendere il cammino pur sapendo che la direzione è sbagliata.
I migranti che aumentano di mese in mese, di anno in anno, come un moto ondoso senza fine e sempre in crescita. Chi è sopraffatto dall’urgenza dell’aiuto e dell’accoglienza e chi, al contrario, dalla necessità di respingerli il più che si può finché si può, e tutti le con medesime ansie, opposte ma accomunate dalla consapevolezza che non si riuscirà né ad accogliere né a respingere tutti. Perché sono troppi.
I poveri che aumentano all’aumentare della ricchezza e del benessere, una contraddizione che ci lascia attoniti e, apparentemente, senza soluzioni. Taluni non vogliono guardare per non dover vedere perché sanno che i loro privilegi sono fondati su quelle povertà; altri sono mossi a compassione, elargiscono una moneta e al più sostengono entità intermedie perché si occupino dei disgraziati, augurandosi intimamente che non debba toccare a loro e ai loro familiari.
Gli anziani che sono sempre di più, con i loro bisogni, le loro lentezze incompatibili con i ritmi dei più giovani, la demenza o i tremori che arrivano a scombussolare la vita di chi dovrebbe occuparsene e non potendo affida i propri vecchi a donne venute da lontano, slave che diventano schiave nella speranza di dare un futuro ai propri figli nel frattempo affidati ad altre anziane. E tutti gli attori di questo dramma interpretano la propria parte con profondi sensi di colpa.
2 – Affondi dalla superficie 49
La guerra alle porte di casa che è arrivata all’improvviso sebbene sia stata coltivata per anni. Facciamo di tutto per non pensarci, come facciamo da decenni di fronte a tante altre guerre, piccole e grandi, lontane e vicine, con la differenza che sappiamo bene che quest’ultima porta con sé il pericolo dell’olocausto nucleare e ci costa una crescente massa di denaro che viene sottratta al nostro benessere. Che fare? Meglio non chiederselo e lenire le nostre angosce con le immagini dolorose, profuse a piene mani, dei disgraziati che sopravvivono o muoiono in condizioni subumane.
Le guerre alla fame, alla droga, alle mafie e al terrorismo sono tutte miseramente fallite dopo mezzo secolo di discorsi tanto più vuoti quanto più generosi e genuini. Di fame si continua a morire anche perché sempre più umani pesano su un pianeta sempre più esausto. Di cibo mal prodotto e ancor peggio processato si muore anche nei Paesi più ricchi, che continuano a sottrarre risorse alimentari ai più poveri come hanno sempre fatto da due secoli. Negli ultimi decenni una nuova forma di rapina viene perpetrata dal mondo ricco ai danni del mondo povero e che povero non sarebbe se fosse lasciato in pace: il cosiddetto land grabbing, l’acquisizione legale ma spesso forzata da violenza e corruzione, quindi l’agguantamento, di suoli agricoli ghermiti da società di capitali ai danni di Paesi in via di sottosviluppo e in perenne dipendenza.
Di droga si continua a morire, anzi, si muore di più perché il narcotraffico (paradossalmente insieme al turismo) è diventato la più florida industria globale, per numero di Paesi e di addetti coinvolti, per quantità di denaro movimentata e capacità di riciclaggio finanziario, in grado di produrre ulteriori profitti e ricchezze. Niente può fermare il crescente flusso
50
globale di sostanze stupefacenti anche perché un crescente numero di persone ne fa uso. Ci illudiamo che la morte di un Escobar, gli innumerevoli ergastoli comminati a El Chapo o gli arresti di interi clan calabresi siano colpi mortali assestati a questa industria perché rifiutiamo di accettare la realtà: a essere drogato è il sistema sociale, culturale e produttivo dominante.
Come se tutte queste angosce non fossero sufficientemente pesanti da affrontare, la cronaca quotidiana ci affligge di omicidi insensati e repentini, di stupri e violenze che, con crescente stupore, accadono due case più in là, nel condominio di fronte, due strade più avanti. Donne, anziani, bambini, madri e padri, amanti, accattoni, omosessuali, adolescenti, medici si uccidono, sono uccisi o sono abusati in un’infinita sciarada di solitudini piene di folla, per l’esclusiva gioia dell’unico incontrastato potere dell’epoca attuale, i media televisivi. Vicende di follia, lucida e ottusa al tempo stesso, che non meriterebbero altro che una lettura disattenta se non fosse che il loro ripetersi e il loro diffondersi richiederebbe l’accensione di un faro che ciascuno di noi preferisce non venga mai acceso perché dovremmo ripensare i modi di vita.
Se tutto è urgenza ed emergenza niente lo è più veramente e tutto s’intreccia, si fonde e si confonde in un caleidoscopio che non suscita meraviglia ma angoscia. I più si ritirano nelle solitudini domestiche e familiari, i meno si raccolgono entro cerchie sempre più ristrette in cui i timori, le critiche, le proposte sono da tutti condivise. Parrebbe che l’unica scelta sensata sia evadere, non preoccuparsi, lasciare che la corrente ci porti e ci trasporti facendo il più possibile attenzione agli inevitabili rischi e rovesci della vita, pregando
2 – Affondi dalla superficie 51
che non colpiscano proprio noi, qui e ora, perché, in fondo, domani è un altro giorno e ci fa bene pensarlo, ci rassicura vedere in dissolvenza il volto di Rossella e ci consola udire in sottofondo la voce di Ornella. È lecito farlo. È umano. Ma non ci permetterà di vivere meglio.
Non ci sono urgenze di frontiera. Ciascuna urgenza, ciascuna emergenza è una frontiera per ciascuno di noi. Solo un Ercole, un Sansone o una novella Maria potrebbero avere la forza, la saggezza e la grazia per sopportare e affrontare tutte le emergenze che ci fanno urgenza. Friedrich Nietzsche finì pazzo e Woody Allen, pur protetto dalla sua corazza d’ironia e sarcasmo, è finito a far filmetti patinati farciti di luoghi comuni e di stracche nostalgie.
Se l’evasione non ci piace e se comprendiamo il rischio insito nella clausura rassicurante di circoli ristretti e consenzienti, non resta altro da fare che continuare a parlare dopo aver tanto ascoltato, a dialogare, assumendoci tutte le nostre contraddizioni, correggendo senza ansie tutti gli errori quotidiani, evitando che i necessari compromessi di vita compromettano ogni giorno di più un’esistenza che vale la pena di essere pienamente vissuta in compagnia di altri. La comunità non è una soluzione ma è pur sempre la dimensione che – facendo attenzione che non diventi essa stessa un problema – è più prossima a noi, propria e appropriata al nostro io, alla famiglia, stretta o allargata che sia, alla cerchia degli amici. In definitiva, ancora oggi viene buono l’insegnamento – la cui origine non è certa, ma certamente appropriato a quel che penso dovrebbe essere la nostra attitudine oggi come domani – think globally, act locally. Come ancora più valida si conferma la dottrina del piccolo è bello, il monito che ci lasciò il grande economista Ernst Friedrich
52
Schumacher nel 19731. In un’epoca di gigantismo esagerato, di velocità forsennate, di perdita diffusa del senso del limite e di globalismo insensato, pensare il piccolo, agire il locale pensando sistemicamente al tutto è l’unica possibilità di resistenza e di sopravvivenza.

2 – Affondi dalla superficie 53
1. Friedrich Schumacher, Small is Beautiful. Oxford: Blond & Briggs, 1973.
Sulle collaborazioni artistiche
Sara Lando
Aver deciso di usare noi stessi come metro di paragone dell’intelligenza, della creatività, della capacità di creare legami significativi (in contrapposizione al resto degli esseri viventi che sono “meno di noi”) mi ha sempre fatto molta tenerezza, perché mi dà la stessa sensazione di quando ogni anno una persona terrestre vince miss Universo. Abbiamo creato definizioni che ci mettono in cima a tutto il resto, e a mano a mano che scopriamo (lentamente, perché non siamo brillantissimi) che il mondo è più complesso di come lo capiamo, cerchiamo di stringere la definizione in modo da mantenere
54
il vantaggio. Chissà cosa si prova a essere un uccello giardiniere, un ontano o una slime mold e a guardare gli esseri umani.
L’arte come viene percepita dalla maggioranza delle persone e delle istituzioni presuppone spesso una visione dell’artista che plasma il mondo con la propria volontà, creando dove non esisteva nulla, elevandosi al di sopra della quotidianità e trascendendola. La storia dell’arte come la studiamo in Italia è simile alla storia naturale nel suo costante tentativo di costruire tassonomie, ma come spesso accade il problema con questo tipo di approccio è che tutto quello che non corrisponde perfettamente alle regole viene frainteso o estromesso. Osservata attraverso i filtri dell’antropocentrismo e del colonialismo, la produzione di arte si è inevitabilmente legata a forme di ingiustizia e violenza.
L’idea dell’artista-genio che esiste separato da tutto funziona solo nella catalogazione pulita e semplificata dei libri di scuola o delle didascalie dei musei, ma basta davvero poco a rendersi conto di quanto sia insensata: persino l’artista più solitario lavora in spazi che non ha costruito, con materiali prodotti da altri, mangiando cibo che è stato coltivato da braccia che non sono le sue. La scelta dei materiali che usa è limitata a quelli che sono disponibili, dai budget a sua disposizione, dalle sue capacità di usarli. Allargando lo sguardo oltre il piano meramente umano, non possiamo non guardare le opere d’arte includendo il lavoro di batteri, muffe, microrganismi, agenti ambientali che nel corso del tempo modificano l’opera in modo anche radicale, aggiungendo o sottraendo elementi, a volte confondendo le generazioni successive1. Come specie ci siamo coevoluti con i trilioni di microbi che abitano i no-
2 – Affondi dalla superficie 55
stri corpi creando ecosistemi complessi: circa la metà della nostra biomassa non condivide il nostro DNA2. Pensiamo a noi stessi come individui, ma dal punto di vista di un Anaerobutyricum hallii siamo territorio. Cosa diventiamo, guardati da un bosco? La complessità di queste intersezioni solleva domande necessarie sulla nostra comprensione di cosa significhi essere un individuo, su dove tracciare il confine tra ciò che possiamo etichettare con sicurezza come “me” e ciò che costituisce “altro”. L’arte può essere un potente strumento per colmare questa lacuna, ma creare arte che includa l’alterità può portare a una nuova serie di domande. Il processo di cocreazione tra esseri umani e sistemi non umani ci porta a chiederci se la cocreazione si basi su una agency paritaria e prima ancora se accettiamo l’idea che qualcosa di diverso dagli umani abbia agency.
Le collaborazioni artistiche con un sistema vivente richiedono prima di tutto la lotta per mantenere vivo il sistema, per mantenere la flessibilità, per imparare l’umiltà e la pazienza necessarie per rispondere ai suoi bisogni e suggerimenti piuttosto che cercare semplicemente di forzare la nostra volontà sul processo, usando il sistema come mero strumento. I risultati sono spesso inaspettati.
L’arte pone domande su possibili modi di essere. La creazione artistica non è così diversa dal processo di inoculazione. Inoculare è introdurre qualcosa di nuovo, qualcosa di vitale, in un organismo o in un mezzo. Quando un’opera d’arte viene introdotta nel mondo, comincia ad assumere vita propria e dare inizio a una serie di reazioni a catena che non possiamo mai controllare o prevedere completamente. L’arte ha la capacità di iniziare una conversazione dove le parole non
56
arrivano, di espandere la conoscenza e spingere i limiti per aiutare a immaginare e costruire un futuro quando non solo non esiste ancora una mappa, ma nemmeno un territorio.
Cosa succede quando facciamo un passo indietro e mettiamo un attimo da parte il concetto di autore e cominciamo a vedere tutto come se fosse una collaborazione: con la comunità che ci sostiene, con i nostri riferimenti culturali, con l’ambiente, con lo spettatore, con il tempo? Come accompagniamo un’opera nel corso di tutta la sua vita, e come ci rendiamo responsabili di quello che le succede quando non sarà più viva? Come sleghiamo la produzione d’arte dalla produttività, includendo l’incomprensione, il fallimento, la distruzione come parte di un processo che non finisce nel momento in cui l’opera viene condivisa all’interno di strutture ufficiali?
E cosa possiamo fare per favorire una biodiversità artistica in grado di creare un ambiente fertile, vitale e in grado di autosostenersi?
1. Un esempio su tutti: le bianchissime statue greche che hanno ispirato il Neoclassicismo sono in realtà un’inesattezza, le statue originali erano dipinte con colori chiassosi. We know Greek statues weren’t white. Now you can see them in color, disponibile online su https:// www.npr.org/2022/07/12/1109995973/we-know-greek-statues-werent-white-now-you-cansee-them-in-color (consultato il 15 giugno 2023).
2. Sender, Ron, Shai Fuchs, e Ron Milo. Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. “PLoS Biology” 14, n. 8 (19 agosto 2016): e1002533, disponibile online su https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002533.
2 – Affondi dalla superficie 57
Non più minori
Franca Olivetti Manoukian
Nel GROUND Social Forum vorrei cercare di infiltrare qualche idea riguardante i rapporti che abbiamo con bambine e bambini, quelli che quando vengono presi in considerazione dalle istituzioni per comportamenti non conformi alle attese sociali diffuse, vengono chiamati minori.
Non solo minori di età ma minori comunque, collocati in posizioni di inferiorità, posti al centro, idealizzati e “mal trattati”. Nei confronti di questo gruppo sociale che è costituito dalle nuove generazioni che si affacciano a vivere in questo nostro mondo, mi sembra che siano sempre più evidenti e negate le disuguaglianze e le pesanti violazioni dei diritti inviolabili,
58
diritti umani fondamentali. Mi riferisco alle modalità con cui vengono – o piuttosto non vengono – allestiti contesti relazionali accoglienti e attenti, effettivamente impegnati a sostenere valorizzazioni di dotazioni diverse e diversi processi di crescita, attraverso esperienze in cui e con cui si apprende insieme a crescere e a convivere in una complessità sociale intrinsecamente disorientante e inquietante. Quando viene partorita una nuova creatura, è massima la mobilitazione di tutto ciò che può offrire e garantire l’assistenza sanitaria con le più recenti e aggiornate metodologie specialistiche, più tecnologicamente attrezzate. Le mamme – le donne – si ritrovano sole, con elevate attese che i neonati godano di tutto quello che è stato predisposto per loro e che diano ben meritate soddisfazioni, mangiando e dormendo, senza piangere quando è ora di riposare e stare tranquilli.
Il contesto familiare che nelle consuetudini vigenti (secondo le regioni) è tradizionalmente ben presente, accanto al nuovo nato e alla neomamma, è dislocato in abitazioni distanti, a volte sfaldato in articolazioni collegate per aspetti parziali. Da chi e come è costituito il “villaggio” che sostiene e tutela le condizioni che consentono a una bimba o a un bimbo di crescere (art. 31 della Costituzione)1? I servizi dedicati all’infanzia (nidi e materne) sono diventati un privilegio perché non esistono dappertutto e molti sono privati, fruibili solo con costi che solo alcuni sono in grado di sostenere. I consultori nel corso degli anni hanno subito una sorta di atrofizzazione delle loro funzioni, quasi ridotte a erogazioni di prestazioni ginecologiche ambulatoriali. Nel dettato normativo i nuovi nati sono considerati figli di una coppia – i genitori – a cui viene attribuito il dovere/diritto di «mantenere, istruire, educare i figli» (art. 30)2: è prevista anche la possibilità di
2 – Affondi dalla superficie 59
avvalersi di un congedo parentale (recentemente ridefinito) sia per il padre che per la madre e sono diffusi, nei territori, vari progetti rivolti a facilitare conciliazioni dei tempi famiglia-lavoro.
Tutto quello che è dichiarato, scritto in diversi provvedimenti legislativi, quanto e come trova traduzioni congruenti nella realtà? Non rischiano di moltiplicarsi disuguaglianze tra chi nasce in contesti familiari dotati di risorse conoscitive, affettive, economiche, che permettono di intraprendere e inventare opportunità e chi viene al mondo in ambienti relativamente isolati, ritirati entro modelli culturali autoreferenziali e dotazioni limitate, esposti a manipolazioni di ogni genere?
È comprensibile che mamme e papà vivano smarrimenti e ansie, pressati da un lato da motivazioni e spinte interiori a essere riconosciuti adeguati al ruolo e d’altro lato da pesanti incertezze rispetto a sconquassi incombenti negli equilibri di vita. Non è forse ora di riaprire interazioni fiduciose tra istituzioni e cittadini per allestire contesti di crescita “sufficientemente buoni”, in grado di ascoltare quello che bambine e bambini stanno vivendo e comunicando?
E qui è inevitabile chiamare in causa la scuola come istituzione, le scuole che in varie suddivisioni e in varie sedi costituiscono la quotidianità entro cui vivono gran parte del loro tempo le nuove generazioni. Da più parti vengono segnalati malesseri, difficoltà di frequenza, abbandoni e dati allarmanti sulla dispersione scolastica un po’ in tutti gli ordini di scolarità: parallelamente si moltiplicano giudizi purtroppo generici e sommari su allievi che non sono interessati a nessun argomento di studio, che sono monopolizzati dai social e dall’uso degli smartphone; in particolare in situazioni
60
singole vengono rimarcate incapacità e carenze dell’allievo, comportamenti impropri con valutazioni mal digerite dai genitori. Per tutelare i diritti di bambine e bambini, ragazze e ragazzi non andrebbero allestiti dei contesti che siano in grado di attivare e seguire dei processi di apprendimento che tutti possano sperimentare? Non andrebbero realizzati degli accompagnamenti a percorsi di socializzazione che permettano ai singoli di accostare accadimenti, incontrarsi e scontrarsi con persone e vicende, sperimentare paure e desideri, frustrazioni e soddisfazioni, collocarsi e ricollocarsi nelle relazioni con sé stessi e con gli altri? E in questa direzione non andrebbero forse interrogate delle scelte educative che si ricollegano a orientamenti di cui è assodata l’inconsistenza e che pur continuano a dominare decisioni decisive, comportamenti e atteggiamenti assunti come educativi?
Mi riferisco ad esempio a come vengono affrontati con bambini e ragazzi comportamenti violenti, aggressivi e distruttivi, a volte lesivi nei confronti di sé stessi e di altri: l’intervento a cui si ricorre, quello che più immediatamente viene pensato e agito è la punizione in cui è inscritta repressione, e repressione tanto più pesante quanto più pesante è il contenuto aggressivo del comportamento messo in atto.
Da quanto tempo abbiamo acquisito che la violenza se viene trattata con violenza scatena ulteriore violenza, instaurando aggressioni senza fine? Non riusciamo a contenere azioni e reazioni che nella loro distruttività comunicano stati d’animo ed emozioni importanti? Non è forse possibile fermarsi, riconoscere i nostri stessi sentimenti e cercare di mettersi in ascolto, cogliere qualche (minimo) segnale di discorso possibile? Per stabilire la pena va individuata la colpa: in
2 – Affondi dalla superficie 61
un gruppo che ha espresso comportamenti violenti o che è stato coinvolto in azioni violente che senso ha cercare a ogni costo di individuare un colpevole? Siamo sicuri che la pena, il castigo abbia effetti positivi per quella che chiamiamo educazione? Perché non riusciamo a rappresentarci che chi è piccolo, sotto tanti punti di vista, va rispettato comunque nelle sue inclinazioni e nelle sue scelte ed è in grado di pensare e sentire, capire e far capire, dialogare, costruire? E forse rispettarlo non corrisponde nel “micro” né a circondarlo di ogni possibile oggetto, di iscrizioni ad attività sportive, di frequentazioni parascolastiche e neppure – all’opposto –abbandonarlo a sé stesso, sostanzialmente disinteressandosi di cosa fa, che cosa sceglie, con chi passa il tempo. Non corrisponde neppure a livello più ampio a portarlo al centro dell’attenzione di qualche platea, facendolo diventare attore di sé stesso.
Si potrebbe cercare di istituire un incontro in cui alcune bambine e bambini parlano, si raccontano, raccontano direttamente o indirettamente attraverso un video, e genitori e insegnanti ascoltano, cercando di capire e di capirsi tra loro per provare a conoscere un po’ diversamente i piccoli che vedono tutti i giorni.
1. Costituzione Italiana (1947). Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
2. Costituzione Italiana (1947). Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
62
GROUND e la politica
Gabriele Pasqui
GROUND si propone di offrire una piattaforma radicata all’azione collettiva, costruendo un terreno comune per soggetti collettivi che operano per un cambiamento del proprio territorio.
Quali sono le condizioni di agibilità di un progetto di questa natura in tempi, per dirla con Colin Crouch, di postdemocrazia? Come evitare, per citare il manifesto di GROUND, che il percorso diventi un club, un luogo per chiacchiere tra pochi?
Abbiamo già avuto, in questi anni, innumerevoli tentativi di questo tipo, spesso abortiti perché troppo ideologici, troppo ambiziosi, troppo autoreferenziali. Onestamente, credo che gli ostacoli per un progetto come quello incarnato in GROUND siano moltissimi, anche a fronte della presenza di una pluralità di attori sociali fortemente ingaggiati sui temi, insieme globali e molto localizzati, che GROUND intende affrontare. Il primo
2 – Affondi dalla superficie 63
ostacolo da superare è quello della distanza dalla vita. Intendo dalla vita quotidiana delle donne e degli uomini che abitano, usano, molto spesso sfruttano e mercificano ambienti e territori. La prima necessità è assumere un atteggiamento, per usare la bellissima espressione di Albert Hirschman, di «reverence for life»: un atteggiamento che non presuppone di sapere come la vita accada, ma cerca di osservarla, anche nei suoi tratti e nelle sue dimensioni meno piacevoli. Reverence for life è l’esatto contrario dell’elitarismo delle minoranze colte e riflessive; è la necessità di misurarsi con la pluralità degli interessi e delle passioni per quello che sono e per come si manifestano. È il riconoscimento che chi soffre di più delle mostruose disuguaglianze sociali sembra poco propenso all’azione collettiva, quando non decisamente portatore di posizioni regressive. La «vendetta dei territori che non contano» in Europa e nel mondo, di cui ha parlato Andrés Rodríguez-Pose, dovrebbe averci insegnato qualcosa. Si tratta dunque di osservare e riconoscere processi, pratiche, culture e forme di vita dal proprio punto di vista, dalla propria prospettiva, affermando valori e generando, se necessario, conflitti culturali e politici. Tuttavia, bisogna farlo riconoscendo la varietà delle forme di vita, degli abiti e delle pratiche, la loro irriducibilità a nozioni predefinite di interesse comune.
La conseguenza di questo atteggiamento è una radicale politicizzazione delle questioni in gioco. In una fase nella quale i saperi esperti sono spinti verso una deriva neotecnocratica e cresce il conflitto tra una tecno-scienza sempre più autoreferenziale e insieme sempre più dipendente dalle traiettorie dell’economia globalizzata a trazione finanziaria e un sapere comune sempre più diffidente nei confronti delle
64
competenze, si tratta di comprendere la natura intrinsecamente politica dei saperi in gioco.
Per far questo, GROUND dovrebbe innanzitutto aver cura dei discorsi, dei propri e di quelli degli altri, esibendo la connessione tra produzione di conoscenza e intenzioni politiche e sospettando di qualunque neutralizzazione e naturalizzazione dei discorsi, compresi quelli ecologici. Ciò significa anche assumere la centralità del linguaggio comune, rispetto agli idiomi delle tecniche e alle verità presupposte delle scienze. Il terreno comune di GROUND non può essere che la conversazione sociale, inscritta radicalmente nel linguaggio ordinario.
Ripoliticizzare i saperi, prestare cura ai discorsi, praticare il linguaggio ordinario significa impegnarsi in un corpo a corpo con la questione democratica. Difficile dire quali siano oggi gli spazi di reinvenzione di pratiche di democrazia locali. Quel che è importante è che GROUND non pretenda di incarnare il punto di vista comune, quando esso non può che essere una parte, per quanto plurale. Questo è il senso più profondo di una democrazia pensata, per dirla con un liberale anomalo come Charles Lindblom, come un grande processo collettivo di messa alla prova, di probing, in cui i problemi pubblici vengono decostruiti e ricostruiti e la decisione pubblica assume la forma del mutuo aggiustamento partigiano.
Infine, proprio perché è un progetto di ricomposizione, GROUND deve accettare di abitare un campo strutturato. Il terreno non è solcato solo dalle linee dei poteri e dei saperi, ma anche dai pattern delle istituzioni, delle norme e delle pratiche di regolazione. Per agire nello spazio pubblico, come
2 – Affondi dalla superficie 65
intende fare GROUND, è indispensabile misurarsi con le istituzioni ma più ancora con i processi di istituzionalizzazione. L’incuria per le istituzioni, il discredito degli attori e il taglio delle risorse pubbliche, sono all’origine della drammatica povertà della sfera pubblica che abitiamo.
Non credo dunque che GROUND, come piattaforma fondativa di orientamento e di proiezione, possa evitare di misurarsi, nelle forme e nei modi più diversi, con la dimensione delle istituzioni. Non per aderirvi, ma per assumere la propria azione entro un campo strutturato, che definisce condizioni di possibilità e non solo limiti. Perché GROUND abbia un senso, devono dunque essere presenti condizioni di diversa natura; ma quand’anche esse fossero presenti, non c’è alcuna garanzia del successo di un’operazione così ambiziosa. D’altra parte, solo la messa alla prova sperimentale permette di esercitare effettivamente un’agency. Possibilmente senza velleitarismi, coscienti del limite e dei limiti, attenti a ripoliticizzare ma anche a deideologizzare i discorsi e le pratiche.
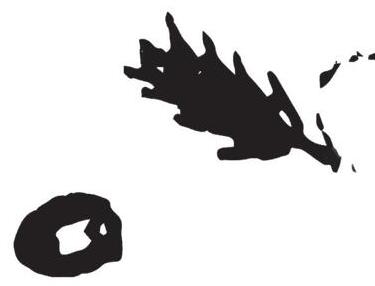
66
Abitare l’incertezza
Javier Ruiz Sánchez
A partire dalla fine del XX secolo breve, dall’apertura e dalla distruzione del muro di Berlino nel 1989, l’intero pianeta si è trovato di fronte alla domanda unanime: che ne sarà del domani?
In contrasto con il secolo passato, in cui l’idea di progresso generava un diffuso ottimismo e fiducia, gli ultimi tre decenni ci hanno messo di fronte a una serie di eventi più o meno inaspettati. Alcuni di questi – crisi, catastrofi, conflitti – comportano fluttuazioni e biforcazioni nella linea temporale prevista; altri, legati al cambiamento climatico, accelerano i processi derivanti da queste fluttuazioni. La combinazione è un’enorme gamma di futuri possibili, molto lontani dalla linea di equilibrio che ci permetterebbe di stabilire quadri di sicurezza.
Quasi tutti questi eventi hanno un’evidente implicazione spaziale, che riguarda le nostre città, i nostri territori e i nostri modi di vivere, siano essi catastrofi di qualsiasi tipo:
2 – Affondi dalla superficie 67
conflitti armati e attacchi terroristici, catastrofi naturali o causate da tecnologie fuori controllo, processi migratori incontrollati, pandemie; nella maggior parte dei casi si tratta di combinazioni spesso aggravate dagli effetti del cambiamento climatico. Possiamo quindi parlare di un’enorme gamma di futuri (urbani) possibili, che vanno dal riconoscibile (prevedibile) al mostruoso (estrema incertezza).
Non possiamo prevedere il futuro. In realtà, non siamo mai stati in grado di farlo, anche se in altri contesti l’umanità ha avuto un certo senso di equilibrio, che però è solo un’illusione. Tuttavia, oggi ci troviamo di fronte a un’incertezza a cui non siamo storicamente abituati. Abbiamo bisogno di un “cambio copernicano” del punto di vista, di accettare il nostro deficit di conoscenza, ma soprattutto di accettare che questo deficit di conoscenza è insito nella complessità stessa del sistema territoriale nel suo insieme: non è una questione di potenziamento delle tecnologie informatiche, non è una questione di dati ma della natura stessa della natura.
Non possiamo prevedere il futuro, ma possiamo pianificare e progettare (con dei limiti) le strutture con cui affrontare l’incertezza. E qui, di nuovo, si apre una gamma di possibilità. Avendo escluso l’utopia, la rifondazione, la tabula rasa del sistema (che, in ogni caso, non sarebbe auspicabile per la rigidità della risposta), le possibilità che si aprono vanno dal rafforzamento delle strutture, aumentando il livello di controllo sull’ambiente naturale incerto, alla complessità della struttura stessa, una struttura che consente risposte imperfette, ma comunque risposte all’incertezza. Si tratta di una scelta tra controllo e libertà. Il primo offrirebbe risposte precise a futuri che non possiamo formulare: possiamo davvero essere sicuri di ciò che accadrà e anticiparlo?
68
La seconda offrirebbe gradi di libertà per accedere a un numero indeterminato di risposte a problemi che non possiamo immaginare o prevedere. L’incertezza può indebolirci o renderci più forti, più resistenti. Ci indebolisce se abbracciamo la presunta angoscia dell’insicurezza e di conseguenza cerchiamo una falsa sicurezza in una moltiplicazione di restrizioni alla libertà di accedere a molteplici futuri possibili; restrizioni sotto forma di barriere e confini, regole, limitazioni alla mobilità e all’azione, e moltiplicazione di politiche e forze coercitive ereditate nelle loro idee e metodi dai sanguinari fascismi del secolo scorso. Oppure può renderci più forti se accettiamo l’inevitabilità dell’incertezza, del nostro ruolo su un pianeta che, per quanto modernizziamo le nostre tecnologie, è sempre più fuori dal nostro controllo. Ci dicono che viviamo nell’era dell’Antropocene, che l’umanità è la più grande forza trainante del cambiamento sul pianeta. Questo è vero, ma non implica che tale cambiamento possa essere controllato. La ricerca della sicurezza attraverso l’ipertrofia del controllo porta all’opposto, a una forte limitazione del controllo sul nostro futuro, a una ristrettezza mentale che, lungi dal rafforzarci, ci rende vulnerabili.
Pianificare e progettare con la natura, con la complessità della natura: abitare la complessità, la benedetta complessità del mondo inevitabilmente incerto in cui viviamo. E se l’incertezza fosse una benedizione? Certo, l’unica certezza che abbiamo è che il futuro è incerto.
Prima lo accettiamo, più abbiamo la possibilità di accedere a futuri più o meno desiderabili.
2 – Affondi dalla superficie 69
Cultural Heritage as a Common Ground: patrimonio culturale, sviluppo sostenibile e inclusione sociale
Elena Svalduz
In un momento storico di grandi cambiamenti e di nuove opportunità, come quello che stiamo vivendo, quale ruolo può assumere il patrimonio culturale?
Se è vero che i beni culturali possiedono un valore rigenerativo, è altrettanto vero che non è solo la rigenerazione a garantire e promuovere lo sviluppo inclusivo di comunità, ma che lo è soprattutto la conoscenza stessa del patrimonio con i suoi valori materiali e immateriali. Evocando le riflessioni di Stefano Rodotà in merito ai beni comuni e ai diritti umani1, possiamo forse affermare che la società della conoscenza, generata da un’enorme e veloce diffusione delle
70
informazioni, sia in grado di promuovere i diritti umani offrendo un accesso equo e inclusivo alla conoscenza stessa? Una maggiore inclusione può dar vita a contesti caratterizzati da una specifica attenzione per la sostenibilità sociale e ambientale?
In un suo contributo dedicato ai temi della cultura come componente vitale della creatività, della giustizia e dell’uguaglianza, ricordando come tra i compiti delle istituzioni vi sia quello di tramandare la memoria culturale esplorandone le potenzialità e tutelandone le funzioni presso le generazioni future, Salvatore Settis afferma che il patrimonio culturale rappresenta un punto d’osservazione privilegiato per comprendere «la sovrapposizione, la mescolanza, il contrasto nella convivenza», fino a diventare una «piattaforma» aperta al dialogo2
Queste riflessioni mi sembra possano riguardare una serie di esperienze e progetti di inclusione sociale relativi non solo a luoghi dell’alterità o del degrado (penso in particolare alle periferie), ma anche a manufatti storici recuperati e destinati ad accogliere persone con disabilità. All’interno di contesti che assicurano un forte legame tra obiettivi etici e culturali, è possibile collocare alcuni progetti virtuosi, perché legati alla storia dei luoghi e alla valorizzazione del patrimonio secondo la definizione data dall’articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio: «esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura». Esemplare sotto questo punto di
2 – Affondi dalla superficie 71
vista è il caso di Villa Angaran San Giuseppe dove, con il sostegno delle pubbliche istituzioni, una rete di persone nel corso degli ultimi anni ha realizzato, forse in maniera non del tutto consapevole, gli obiettivi del Manifesto della cultura accessibile a tutti3. In particolare quello di promuovere la ricerca «sui temi dell’accessibilità e dell’inclusione ai luoghi e agli eventi culturali al fine di ridurre i fattori di esclusione, di rischio, di nocività e di malessere ambientale, di disuguaglianza, di marginalizzazione dei diversi pubblici nell’accesso e nella partecipazione alla cultura».
Non c’è dubbio che il cammino di studio e di ricerca avviato a Bassano abbia potuto valorizzare al meglio il valore identitario di un particolare bene culturale come la villa, in quanto contesto di vita di una comunità, raccontando non solo quello che è stato ma anche quello che potrà essere. Prima cioè di attuare strategie di restauro e di rigenerazione, ci si è impegnati a conoscere la storia di un complesso di villa così fortemente integrato con il paesaggio: non solo, quindi, come oggetto da esibire o esclusivamente con prospettive di fruizione turistica, ma con ricadute educative e di formazione di nuove sensibilità, rivolte alle future generazioni, capaci di comprendere il valore del patrimonio culturale. Un approccio virtuoso, che ha prodotto e continua a produrre crescita culturale, oltre che sociale ed economica, diventando occasione di sviluppo sostenibile per l’intera comunità.
In linea, dunque, con le questioni discusse durante il GROUND Social Forum, si tratta di mantenere nel tempo la possibilità di fruire di risorse culturali secondo un’accezione ampia di sostenibilità (e di sviluppo sostenibile)4. Come ci ricorda Francesco Erbani, sono molte le storie di «un’Italia
72
che non ci sta», che «si dà da fare» sperimentando nuove forme comunitarie, nuovi sistemi cooperativi, nuove relazioni con il territorio... storie che si annodano intorno a un bene culturale in condizioni precarie, individuato da un gruppo di persone che decide di custodirlo, rimetterlo in sesto e farne il perno di una serie di iniziative5, come nella villa di Bassano.

1. Stefano Rodotà, Vivere la democrazia. Roma-Bari: Laterza, 2018.
2. Salvatore Settis, Architettura e democrazia. Paesaggio, città, diritti civili. Torino: Einaudi, 2017, p.105.
3. Per un manifesto dell’accesso alla cultura per tutti (castellodirivoli.org). Vedi anche Diritti umani e inclusione, a cura di Lura Nota, Marco Mascia, Telmo Pievani. Bologna: Il Mulino, 2019, in particolare cap. XI.
4. Marino Gatto, “Sostenibilità: una parola, molti concetti diversi”, La polifora, n. 36, 2023.
5. Francesco Erbani, L’Italia che non ci sta. Viaggio in un paese diverso. Torino: Einaudi, 2019.
2 – Affondi dalla superficie 73
Quale GROUND ?
Maria Chiara Tosi
Quale collettività?
Oggi mi sembra urgente comprendere e rappresentare i modi diversi di abitare la città e il territorio da parte di una collettività composta da una pluralità di soggetti e cose.
Se da un lato ciò richiede di saper fare i conti con sfondi concettuali e linguaggi diversi, dall’altro sollecita a essere consapevoli che emancipare il modo in cui guardiamo al mondo è questione ancor più tormentata poiché l’aver selezionato l’uomo come misura di tutte le cose, ha progressivamente ridotto l’ambiente naturale a oggetto puramente residuale, opposizionale, talvolta incapace di occupare il posto di soggetto. Principale conseguenza di questa consapevolezza è che per conoscere il territorio intercettando i fenomeni e le pratiche espresse dalla pluralità di attori umani e non umani da cui è abitato, e in modo disciplinarmente trasversale, è necessario modificare il punto di vista: decidere cioè quale
74
sia la nuova altezza e a partire da quale prospettiva vogliamo osservare il mondo che ci circonda. L’efficacia di questo diverso modo di guardare al mondo, inoltre, è correlata alla capacità di superare la nostra presbiopia o quella dei mediatori che solitamente abbiamo utilizzato e che si sono rivelati in costante ritardo ed eccessivamente lontani rispetto ai fenomeni e alle pratiche di vita. Una presbiopia che ci ha portato sovente a occuparci quasi esclusivamente di quanto abbiamo più vicino, di ciò che ci è prossimo, rispetto al quale possediamo i codici per interpretarlo.
Quale rappresentanza? Va sollecitata una nuova visione del mondo attraverso cui dare a tutti gli attori umani e non umani una rappresentanza e un diritto di partecipazione al dibattito politico. Solo così il dibattito oggi può definirsi collettivo. Esistono alcune sperimentazioni socio-tecniche da cui apprendere. Il parlamento delle cose, l’esperimento di rappresentazione delle cose da parte di altri soggetti sviluppato da Bruno Latour, ha consentito di misurarsi con una nuova agency del mondo capace di andare oltre una rappresentazione delle cose della natura accurata, precisa e competente e una loro rappresentanza da parte degli uomini affidabile e basata sulla fiducia e l’obbedienza, provando invece a confrontarsi con le interconnessioni che coinvolgono persone e cose, mescolandole.
Quale partecipazione? Sempre più spesso si promuovono living lab e policy lab come dispositivi di costruzione di comunità orientate a trattare e produrre innovazione rispetto a specifiche questioni. GROUND potrebbe promuovere un site-specific living lab che funga da esempio per trattare anche in altri contesti questioni che attengono gli usi collettivi della città e del territorio.
2 – Affondi dalla superficie 75
Recuperare la città nel XXI secolo
Antoni Vives i Tomàs
Oh, basta, siamo stati ingannati abbastanza dal vuoto fascino degli slogan d’altri tempi.
Siamo stufi della commercializzazione del Sessantotto. Forse nessuno come il cantautore argentino Kevin Johansen l’ha espresso così bene come nella canzone Mc Guevara’s O Che Donald’s: «Tutti si fanno crescere la barba e i capelli come se fossero lui, ma non sono come lui. Tutti dichiarano e parlano in suo nome come se fossero lui, ma non sono lui [...]». Il discorso di ciò che è politicamente corretto sulla città in Europa ha troppi luoghi comuni, troppi tormentoni, troppo caffè demiurgo e troppo poca pratica reale, troppo poca interazione con la realtà. E mentre parliamo e parliamo, le nostre città storiche si svuotano di gente e si riempiono di turisti, le nostre piazze e i nostri mercati si svuotano di attività e si riempiono di banalità terziarie.
Ciò che di veramente vivo e vario e denso e interessante nelle nostre città avviene, accade in realtà urbane di qualità apparentemente insignificanti, periferie squallide, pensate
76
come serbatoi di massa lavorativa o come serbatoi di ozi vuoti e sconsolati. Perché l’impronta della nostra società, quella che lasceranno come impronta le persone che hanno vissuto tra il XX e il XXI secolo, se non lo risolviamo presto, sarà un immenso campo di profughi urbani chiamato suburbia: case a schiera, isolati e blocchi di urbanites con un balcone e lo sguardo perso, strade espressamente svuotate di personalità a cui siamo sfuggiti, in fuga dall’apparente disastro dei nostri centri urbani. All’inizio non era così: la gente lasciava i quartieri medievali delle nostre città in cerca di aria e luce, in cerca di spazio. Poi è arrivata la necessità della casa e del giardino, il mito del piccolo proprietario che non ha bisogno di convivere, ma solo di vivere. I servizi?
Li porteranno a casa. Dopo l’automobile, il mito tecnologico portato all’estremo (come “cattivo” quanto il mito antitecnologico portato all’estremo).
E mentre la città è lasciata nelle nostre mani, morta per mano dei grandi centri commerciali di periferia, morta per mano dei grandi developer, morta per mano di amministrazioni povere incapaci di mettere sul tavolo soluzioni alla gentrificazione, si afferma un gruppo di politici di terz’ordine, per la maggior parte usciti da aule universitarie o funzionari pubblici poco esposti, loro stessi, ai problemi, ma soprattutto poco disposti a generare immagini, visioni ambiziose per un cambiamento che provochi davvero una nuova scena urbana del mondo.
Il tasto da premere? Poniti le domande giuste: come trasformare la periferia in un nuovo insieme di città policentriche con personalità? Come restituire ai nostri centri storici l’attività economica varia e mista? Come liberarsi del turismo nella giusta misura, cioè come metterlo in atto e farne un
2 – Affondi dalla superficie 77
motore di cambiamento, piuttosto che una lastra dalla quale non ci riprenderemo mai? Come densificare ciò che abbiamo già urbanizzato? Come determinare la nuova ratio aulica dei nostri spazi urbani? Come garantire che i servizi pubblici siano disponibili per tutti? Come rendere la città una piattaforma di possibilità personali e collettive piuttosto che uno spazio fisso e immobile? Come distruggere la disconnessione sociale, l’iperdipendenza dalle grandi infrastrutture, l’impronta urbana?
Ci sono così tante domande a cui è necessario rispondere con un approccio nuovo e semplice, che solo le persone che decidono di lasciare i bagagli ideologici e osano guardare il problema della città dritto in faccia, senza pregiudizi, solo queste persone saranno annoverate tra quelle che forniranno soluzioni al problema umano più importante del XXI secolo: come possiamo fare in modo che l’ecosistema urbano, l’unico veramente creato dagli esseri umani per vivere e svilupparsi collettivamente, sia di nuovo utile e non finisca per distruggerci tutti.
78
La scienza tra terra e cielo
Cristina Sudiro
Conoscere il mondo per poterlo cambiare, in meglio, con l’aiuto di tutti, nessuno escluso. È questa la grande aspettativa che ho su GROUND Social Forum. GROUND potrà essere il primo passo per portare un cambiamento nella nostra società. Sarà un crogiolo di idee, esperienze, opinioni e vissuti, senza discriminazione, con l’obiettivo di migliorare il mondo, sia il nostro personale che quello che ci circonda.
Come scienziata e ricercatrice penso che conoscere sia fondamentale. La mia esperienza, e la conoscenza a cui mi riferisco in particolare, si basa sulla scienza. O meglio, spero, sulla Scienza con la S maiuscola, quella basata sulla ricerca. La ricerca scientifica è necessaria per consentirci di conoscere e cercare di interpretare il mondo in cui viviamo. Un mondo in continuo movimento, in cui è facile confondere opinioni, pensieri soggettivi fondati su passati individuali e ambienti in cui si è cresciuti, ma che non necessariamente descrivono al meglio la realtà. La Scienza è basata su dati oggettivi ed evidenze. Il metodo scientifico si fonda infatti
2 – Affondi dalla superficie 79
su osservazioni e interpretazione di risultati, atti a provare o confutare un’ipotesi. Le ipotesi vanno testate, e scartate nel caso non siano corrette, e questo porta spesso ad altre ipotesi in un ciclo potenzialmente infinito. Un insieme di ipotesi/ postulati od osservazioni può formare una teoria che cerca di spiegare in maniera più dettagliata possibile un fenomeno. Questa spiegazione è la verità? La verità assoluta? Non esattamente. Le teorie sono sempre verità relative, e le ipotesi su cui si basano possono essere confutate in ogni momento dall’utilizzo di tecniche più avanzate, strumenti più accurati o nuove osservazioni. Ma ogni passo ci può avvicinare a una maggiore verità. Le teorie poi ci permettono non solo di vedere come sono le cose, sempre in un’ottica di verità relativa, ma anche di prevedere come saranno in futuro, e quindi provare, se possibile e auspicabile, a cambiarle. In meglio, ovviamente, per noi e per l’ambiente!
Ma la Scienza non è solo questo. La Scienza non è solo atta a descrivere il mondo naturale (o sociale) e a fornire strumenti per modificarlo, ma dà anche le fondamenta per un pensiero più critico e logico. Essa ci permette di filtrare le informazioni che ci vengono fornite, non solo sulla base delle conoscenze che abbiamo o che possiamo facilmente raggiungere tramite le moltissime fonti di informazione che abbiamo, ma anche con la consapevolezza che tante cose ancora non si conoscono. Ciò che rende la Scienza viva e in continua evoluzione è che non esistono verità assolute, ma che sicuramente ce ne sono alcune più probabili di altre.
Ciò non significa che creatività e libero pensiero non abbiano un ruolo preponderante nello sviluppo della conoscenza che abbiamo del mondo. Anzi! L’unione di diversi vissuti e
80
opinioni, un virtuoso, prolifico e salutare scambio di idee e visioni sono alla base del cambiamento e dell’avanzamento nella conoscenza e nel rispetto del mondo in cui viviamo. Penso che GROUND sia un luogo in cui la Scienza, che potrebbe sembrare elitaria e ristretta, ma deve essere visionaria e alla portata di tutti, debba essere messa al servizio della comunità, per interagire con chiunque voglia entrarvi in contatto, per essere fonte di ispirazione.
La Scienza infatti è semplicemente uno strumento che ci permette di stare con i piedi per terra, tenendo sempre e comunque gli occhi puntati al cielo e alle infinite possibilità che il mondo e la vita ci offrono.

2 – Affondi dalla superficie 81
Stranieri/estranei
Anna Pozzi
Alterità/estraneità.
L’essere spaesati, il non sentirsi a casa propria, l’essere stranieri a sé e agli altri possono essere condizioni esistenziali che ciascuno di noi prova in un tempo e in una dimensione spesso privi di riferimenti e di senso.
Ma sono innanzitutto la condizione di chi lascia – o è costretto a lasciare – la propria terra, la propria casa, la cultura, le tradizioni, le relazioni che hanno contribuito a costruire la sua identità e la sua comunità.
Vissuti di estraneazione sono l’esperienza più intima e, allo stesso tempo, più ampia e condivisa di tante persone in cammino alla ricerca di una vita migliore che non è concepibile
82
e realizzabile se non in una dimensione di incontro, ascolto, relazione. Il migrante, lo straniero, ci pongono da un lato di fronte alle dinamiche di un mondo globale e interconnesso, con tutte le sue contraddizioni, ingiustizie e disuguaglianze, dall’altro alle sfide dell’incontro con il diverso, con l’estraneo. La domanda: “Chi è l’altro?”, rinvia immediatamente a un’altra questione: “Chi sono io?”. E non è detto che sia più semplice rispondere a quest’ultima...
Limes/limen
Limite o soglia? Fine o inizio? Occorre superare l’idea di frontiera, che sia quella che divide i Paesi o metaforicamente le persone, per rileggere il limite, il confine, non come chiusura, ma come possibilità di apertura verso un oltre e verso un altro con uno sguardo rivolto su ogni orizzonte dell’umano. Limite non come fine di qualcosa, ma come inizio. In un’epoca come la nostra, segnata – specialmente in Occidente – dalla perdita di riferimenti e di qualunque forma di egemonia ideologica o religiosa (che non siano quelle del materialismo pratico o del conformismo emozionale), è importante puntare su alleanze trasversali in cui la qualità delle relazioni prevale sulle semplicistiche logiche dell’appartenenza. Questo può avvenire innanzitutto attraverso il gesto faticoso ma fecondo dell’accoglienza. Riconoscere l’altro, per riconoscere anche sé stessi, costruendo possibilità concrete e responsabili di creare reti o riannodare fili spezzati.
Ground/land
Solo se ciascuno accetta di costituirsi come interlocutore, il dialogo diventa possibile e le comunità crescono nella condivisione dinamica e generativa di valori, idee, progetti e desideri personali, collettivi e contaminati. Partendo dal
2 – Affondi dalla superficie 83
basso, dal ground appunto, per creare società più aperte e inclusive, in cui la comunicazione e la collaborazione sono sempre possibili nella misura in cui ciascuno interpreta e vive la pluralità delle idee e delle culture non come minaccia, ma come prospettiva arricchente. Per questo però serve una società di liberi, incentrata sulle dinamiche e sulle sfide della relazione, ovvero su percorsi individuali e collettivi capaci di incidere sull’abitare, l’innovare, il produrre, il prendersi cura, il creare e sul trovare un equilibrio tra alterità e identità. Per vivere da cittadini – e non da estranei – su questa terra. Rendendo di casa l’altro e l’altrove.

84
L’immaginazione al potere
Marco Lo Giudice
Immaginate di tornare a cinquantacinque anni fa, alle rivolte studentesche del Sessantotto. Immaginate di essere lì, studenti tra studenti.
Magari nemmeno tra i più convinti, ma con il cuore da quella parte. La percezione tangibile di un cambiamento in atto. Corpi, voci, tanti e tante, sulle strade, sulle piazze. Nelle aule delle università e poi delle scuole. Perché nelle scuole si giocava tutto quel che sarebbe stato il vostro domani: chi potevate essere, nonostante le provenienze, nonostante le classi sociali. Non volevate nuove promesse, volevate decidere le promesse e poi attuarle. Volevate potere – e cioè nient’altro che rendere possibile ciò che sembrava impossibile. Eravate tantissimi. L’energia era nell’aria, era fuoco, violenza, rabbia, gioia, amore, libertà.
Eravate il futuro. Il futuro era nel presente, il futuro era il presente, tutto era futuro: da immaginare, da costruire, per cui lottare. Ora immaginate di essere pochi, pochissimi.
2 – Affondi dalla superficie 85
Siete dentro scuole e università che contano sempre meno, che decidono poco o nulla del vostro domani. Avete la stessa energia – fuoco, violenza, rabbia, gioia, amore, libertà – ma non è nell’aria, è dentro di voi. Confusa, torbida, costretta in un solo corpo: può soltanto implodere o esplodere. Immaginate che il futuro non c’è, è una distopia a breve termine come si leggeva proprio cinquant’anni fa sui libri Urania. L’inabitabilità del pianeta è un’ipotesi che leggete nei quotidiani. Il futuro che vi raccontano è il prodotto di strati su strati su strati di scelte folli e di politiche egoiche. Vi resta il presente. Un presente eterno, maledetto. Siete una minoranza, intorno a voi le generazioni precedenti vi sovrastano in numero e possibilità. È un mondo di vecchi che depredano futuro e parlano al presente.
E in pochi che si fa? Si scende in piazza, nelle strade? Si occupano scuole che non hanno potere? In pochi chi ti ascolta? Potete fare cose inaudite, che nessuno si sognerebbe. Certo, potete toccare l’intoccabile, magari deturpando un’opera d’arte. O ancora potete rompere i coglioni, magari stendendovi su una tangenziale. Ma voi, come 55 anni fa, non siete tra i più convinti, ed è difficile esserci con così tanto coraggio. E allora non vi resta che scomparire, sottrarvi. Forse essendo in pochi l’assenza pesa di più, come quando si giocava con gli amici più cari e se qualcuno mancava ci si accorgeva immediatamente. Nello scomparire potete abbandonare anche la mente, che fa paura oggi come allora, come sempre. Potete usarla, la paura, usare i legami che avete e combinare le due cose per farvi sentire, per affermare che ci siete e che avreste qualcosa da dire. Con il risultato che vi diranno malati, che il vostro sottrarvi diventerà fobia, che dovrete essere curati prima che ascoltati. Siete pochi, sono tanti.
86
Quando si scrive, si legge o si dice che i giovani sono una minoranza significa – più o meno, con qualche licenza letteraria – questa roba qua. Siamo in un momento storico in cui di giovani si parla tanto e le parole ripresa e resilienza (sic) profumano di altrettanto denaro, anche per le politiche rivolte alle giovani generazioni. Sono politiche che parlano di giovani malati, dispersi, ritirati: la lettura dei bisogni coincide troppo spesso con la ricerca di nuove patologie e quindi di nuove cure. Cure per chi si chiude in camera, cure per chi se la prende con il proprio corpo, cure per chi abbandona la scuola, cure per chi non sa che fare di sé, cure per chi non sa chi è. Abbiamo affinato le nostre sapienze specialistiche, cerchiamo patologie, cerchiamo cure: è il nostro modo di leggere la realtà. Ha funzionato e funziona, anche con qualcuno di questi ragazzi. Ma.
Ma non si trova una visione d’insieme, non c’è uno sguardo generazionale. Manca in letteratura – è poca, troppo poca, perché dei giovani non si parla più seriamente se non tra addetti ai lavori! – e manca nel discorso pubblico. Il discorso pubblico sui giovani è diventato un altro dispositivo di potere: se son tutti malati, van tutti curati – poverini.
Quando andrebbero ascoltati, prima di tutto. Gli andrebbe lasciato spazio, forse allestito, forse anche no. Ci si dovrebbe mettere al servizio della loro idea di futuro. Discuterla insieme, certo, ma partire da lì. Dal loro immaginario. Ci si dovrebbe incuriosire – mica per forza appassionare – di ciò che li muove, che li accende, che li fa brillare. Dalla cura alla curiosità, ché l’etimo è lo stesso: si dovrebbe cercare dove sta la loro energia, dove si nasconde. Perché c’è, è potente,
2 – Affondi dalla superficie 87
ma spesso è celata dentro di loro e – diamine, ancora una volta – loro sono pochi!
Un passo indietro: dai luoghi e dalle smanie di potere, dalle poltrone, sì, dalle verità in tasca, dagli specialismi. Un passo avanti: dove stanno loro e dove loro stanno bene. In ascolto, con fiducia e speranza: non è granché ma è già tanta roba.
E forse ce la facciamo.
E forse si possono immaginare cose nuove, e tornare a potere.


88
Un terreno comune in cui rammagliare i diritti ai corpi Alessia Franzese
«Il Novecento è davvero finito» scriveva l’urbanista Cristina Bianchetti circa dieci anni fa; quando, in realtà, il Novecento non si era ancora concluso.
La pandemia che ci ha attraversato ne ha decretato davvero la fine.
In un podcast per Il Post pubblicato in quattro puntate nella primavera del 2021, Alessandro Baricco parla di «un’intelligenza non novecentesca», che egli riconosce come «un fare»: un’intelligenza istintiva – «animale» – e nomade, diffusa, collettiva e non individuale, capace di grande memoria e grande visione; un’intelligenza emotiva, leggera precaria sottile, e audace. Una forma di intelligenza che non deve essere inventata perché esiste già: «è un fare condiviso
2 – Affondi dalla superficie 89
da moltissima gente». Sembrerebbe allora che questa intelligenza non novecentesca – questo fare – si scontri con le inerzie dello spazio fisico, delle istituzioni disciplinari che lo hanno conformato, dei tempi lunghi necessari alla loro trasformazione, che si contrappongono all’immediatezza della rivoluzione digitale, portando le persone a vivere un’insanabile dicotomia tra la vita privata (proiettata al futuro) e quella pubblica e collettiva (ancorata al Novecento).
Per raccontare questo cambiamento – inteso come una razionalità che non segue le strutture logiche, stabili e specialistiche che ereditiamo dal secolo scorso – bisogna volgere lo sguardo a dei modelli alternativi e affermativi: ecologici, in quanto strutturati sulle relazioni orizzontali e non sulle gerarchie di potere; precari e instabili, in quanto non interessati a durare fissi nel tempo ma adattabili al continuo mutare delle condizioni. Questo cambiamento, che ha a che fare con un fare e che c’è già, si sviluppa in maniera tentacolare e incrementale, si riconosce nei movimenti che agiscono in spazi interstiziali ovunque nel mondo, su e per i beni comuni, quelli che si conformano attraverso pratiche collettive e collaborative minime, variabili e fragili e che, spesso, non hanno alcun interesse a diventare altro. Rivoluzioni gentili seppur sempre conflittuali e mai pacificate che si manifestano con il coinvolgimento in prima persona, forme molecolarizzate e disperse in ogni dove che generano una nuova antropologia fatta di impegno e rivendicazione di diritti.
Per poter leggere questo cambio di paradigma, che emerge come il bisogno di creare un pensiero nuovo che ci riposizioni nel mondo, è necessario avere nuovi occhi. E i diritti – come affermava Stefano Rodotà – sono uno strumento
90
potente per dire che un altro mondo è possibile: quello che, attraverso una rivoluzione etica, della dignità, pone al centro gli esseri viventi e non le cose, creando nuove relazioni non gerarchiche ma collaborative. Possesso e proprietà cedono il posto a uso e corpi. «Non è un altro modo di possedere, ma l’opposto della proprietà» quello a cui bisogna volgere il nuovo sguardo educato dai diritti, per poter riconoscere lo spazio di questo cambiamento. Questo spazio comune non è solo un supporto che accoglie pratiche di inclusione/esclusione: lo spazio-in-comune è soggetto agente, attivo, vivo. Spazi comuni, terre comuni, sono una scuola e una foresta, un teatro e un orto condiviso: sono luoghi in cui gli abitanti (non i cittadini, ma tutti gli esseri viventi) esercitano diritti fondamentali, praticano forme di emancipazione personale e collettiva. Nelle terre comuni la dimensione fisica, emotiva e situata del corpo (dei corpi) assume la concretezza di vivificare processi istituenti e mai istituiti, che non perdono così la loro vivacità, la multiformità e la mutevolezza della vita che li attraversa.
Spazializzare i diritti – di solidarietà, dignità e uguaglianza sostanziale, prima che di libertà – non è un esercizio facile o lineare. La loro sostanza (o sostanzialità) si manifesta attraverso la materialità dei bisogni di cui, però, si stenta a riconoscere una forma fisica. Tracciare diritti al suolo – disegnarli, mapparli – diventa, allora, una pratica necessaria, e una sfida, per rendere evidenti confini ed esclusioni, ingiustizie socio-spaziali e disuguaglianze di potere.
In questo passaggio epocale possono riemergere alcuni solidi baluardi novecenteschi per accompagnare la transizione verso un futuro che, nell’incertezza del presente, non possiamo più immaginare.
2 – Affondi dalla superficie 91
La Costituzione è uno di questi, in quanto si prefigura come un’opera aperta, una base fondamentale che si presta alle interpretazioni, storicizzate nel tempo che riesce ad attuarla. Si prefigura come un progetto per il futuro al cui centro ci sono i diritti degli esseri umani, finanche di tutti gli esseri viventi. Riscrivere le costituzioni occidentali, rifondare le proprie città, suggerisce ancora Baricco. Ma non sono gli spazi (le città) o gli strumenti-principi (le costituzioni) a perdere la loro validità; è l’intelligenza novecentesca stanziale, fissa, rigida a non lasciare spiragli di nuove interpretazioni. Non sono le inerzie opposte dallo spazio a impedire questo cambiamento, ma un approccio culturale scettico e pigro, che – prendendo in prestito le parole da un romanzo di Philibert Schogt – «impacchetta con la carta da regalo delle domande i propri pregiudizi».
Guardare a quei luoghi fragili in cui fioriscono o resistono idee e pratiche ibride e audaci, tra le macerie di un sistema moderno e capitalistico, che spreca e sfrutta risorse naturali e sociali, ci permette di esperire questa nuova forma di intelligenza, per poterla poi conoscere, riconoscere e applicare. La conoscenza di questo mondo avverrà attraverso l’ascolto e l’integrazione: sarà una forma di accoglienza, una conoscenza che recupera la vitalità e profondità della sapienza greca.
92
Terreno, suolo, terra, Terra
Marta De Marchi
Niente, nella vita dell’essere umano, è più radicato al suolo del cibo.
Il cibo viene dal suolo, e dall’acqua e dall’aria. Viene da luoghi vicini e molto lontani. Da tempi lontani e molto vicini. Il cibo è arte e artigianato. Il cibo è insieme diritto e piacere, e va rivendicato in entrambe le accezioni.
Il cibo è un sistema urbano e territoriale complesso, che intreccia luoghi, persone, attività, flussi, paesaggi, infrastrutture, culture, tradizioni, immagini e immaginari.
Il cibo, inteso come sistema, è costituito da un insieme di pratiche e processi, talvolta autonomi e individuali, talvolta collaborativi e interdipendenti. A complessità si aggiunge complessità.
Il cibo pone anche questioni urgenti: salute pubblica, equità sociale, transizione ecologica.
Il cibo è socialità, ecologia, spazio, economia, e può aiutarci ad affrontare i grandi cambiamenti in corso. Di più: ci obbliga a farlo. Ci spinge a non semplificare, a non banalizzare. Ci
2 – Affondi dalla superficie 93
spinge a essere attenti, vigili, curiosi. Ci consente di osservare pratiche di vita quotidiana e insieme fenomeni globali.
Se parliamo di transizione ecologica, possiamo (dobbiamo) parlare anche di transizione alimentare? Questa transizione alimentare è sempre positiva? Giusta? Democratica? La transizione alimentare è forse inevitabile?
Il sistema cibo cambia con l’ambiente e con il clima, con i paesaggi e con la tecnica. Si tratta di un adattamento forzato, perché dettato dalla sopravvivenza, soprattutto quella delle piccole economie. Ciò avviene da sempre, storicamente, e non solo oggi, perché si parla ovunque di transizione! I contadini adattano da sempre la loro opera al pianeta (al terreno, al suolo, alla terra, alla Terra).
La transizione alimentare è dunque determinata da fattori esterni (clima, mercato, consumo, ecc.). Ma può essere governata e orientata? Possiamo guidarla nella direzione migliore? Come farlo? Con quali risorse, con quali strumenti?
Ripartiamo dal concetto che il cibo è un diritto. Di più: il cibo è (dovrebbe essere) un bene comune.
La vastità della scala delle attuali filiere alimentari polverizza i diritti e polarizza la società. Ricchi e poveri. Affamati e insaziabili. La crisi del 2008 è stata una crisi alimentare, oltre che finanziaria; i principali prodotti cerealicoli, quelli che sostengono la popolazione mondiale, hanno subito innalzamenti incontrollati dei prezzi. La pandemia del 2020 ha isolato persone e comunità, ha rallentato il lavoro di molte imprese agricole, ha congelato le attività economiche legate
94
al cibo e alla convivialità. I fenomeni climatici estremi stanno distruggendo i raccolti, compromettendo le infrastrutture, danneggiando delicati sistemi ambientali ed ecologici. Alcune filiere, apparentemente locali, alimentano forme di lavoro neoschiaviste e favoriscono condizioni di vita ingiuste e intollerabili.
Ripartire dai diritti, degli umani e dei non umani, si fa sempre più urgente. Rivendicare, riappropriarsi, riconquistare è la strada per cambiare. Forme pionieristiche, eroiche, sperimentali, innovative di produrre e alimentarsi ci possono far riscoprire e riconoscere la vicinanza al terreno, al suolo, alla terra, alla Terra.
Coltivare il proprio orto, coltivarlo insieme ad altri. Camminare in campagna, raccogliere erbe selvatiche. Recuperare aree abbandonate, stringere alleanze. Chiedere agli anziani, raccontare ai bambini, comunicare a chi non conosce, invitare chi ha altre esperienze, storie, ricette e prodotti da condividere.
Non è una retorica della convivialità. È rivoluzione, è integrazione, è adattamento, è esplorazione, è sopravvivenza, è attivismo, è politica.
Ma attenzione! Non facciamoci sedurre troppo dal piccolo e unico, non guardiamo solo le esperienze virtuose. Teniamo in considerazione tutti i modelli alimentari, i più innovativi e quelli convenzionali, quelli di nicchia e quelli di massa, affinché gli uni possano beneficiare del confronto con gli altri, in una crescita reciproca che può guidare la transizione su più fronti.
2 – Affondi dalla superficie 95
La transizione alimentare è inevitabile. La transizione alimentare è auspicabile? Positiva? Vantaggiosa?
Sì, se è socio-ecologicamente giusta per tutte e tutti.
Sì, se è un programma eco-politico che include umani e non umani.
Sì, se è guidata per accomodare fattori esterni di cambiamento.
Sì, se è un veicolo di distribuzione di potere e di responsabilità.
Il cibo può essere fulcro e motore di rivendicazioni socio-ambientali e pratiche dal basso che affrontano la rigenerazione di territori e comunità.
Le pratiche sono portatrici di un sapere locale specifico, legato ai sistemi alimentari e ai territori, che aiuta a riadattare le politiche locali e potrebbe innescare una risposta politica.
La partecipazione può essere uno strumento per dare voce alle comunità e ricostruire il rapporto tra classe politica e società civile, mettendo in discussione gli ordini esistenti e interrompendo il discorso dominante.
Occuparsi di cibo non riguarda solo aspetti culturali e patrimoniali, ma permette di prendere coscienza delle disfunzioni legate al modo in cui produciamo e ci nutriamo e degli effetti che l’attuale sistema alimentare ha sulla società e sull’ambiente.
96
Tutte e tutti mangiamo, tutte e tutti siamo coinvolti. Tutte e tutti possiamo, e dobbiamo, essere attivisti e rivoluzionari, difensori e paladini. Noi che possiamo scegliere, per quelle e quelli che ora non possono.
Un boccone alla volta.

2 – Affondi dalla superficie 97
Il passaggio da un mondo
ego-centrico a un mondo
eco-centrico
Alice Pomiato
La crisi climatica che stiamo affrontando è la sfida più grande che siamo chiamati a combattere e alla quale non possiamo sottrarci.
In questo scenario ognunə ha un ruolo. In primis la politica, le istituzioni, le aziende, e poi anche i singoli. Siamo tuttə chiamatə a ripensare la nostra vita e ridurre i nostri impatti, riportandoli entro i limiti del pianeta, spostandoci verso dei modelli che restituiscono alla Terra più di quel che le tolgono. Nel mio ruolo di creatrice di contenuti per i social, di speaker e formatrice, cerco di decostruire quel che è complicato e renderlo facile, alla portata di tuttə.
Certamente, la crisi climatica è una crisi che interseca tutte le crisi (crisi finanziaria, crisi ambientale, crisi sociale, crisi sanitaria, crisi della salute mentale, crisi delle materie prime per citarne alcune) e ci ricorda che non siamo individui di-
98
sconnessi da tutto il resto, atomi solitari, ma condividiamo il pianeta con altre specie animali e vegetali. Eppure l’antropocentrismo ha quasi distrutto la capacità di autorinnovamento della terra.
Le domande che sorgono e che smuovono gli animi di milioni di giovani nei vari angoli della terra sono molteplici.
Possiamo illuderci che il sistema che ha causato questa crisi sarà lo stesso capace di porvi rimedio?
Come realizzare una transizione a un sistema produttivo che gradualmente escluda lo sfruttamento insostenibile di persone, terre e animali, e sia in grado di generare valore da altri tipi di redditi o sistemi rigenerativi?
Come questo può diventare sostenibile a livello ambientale, sociale, sanitario e di conseguenza economico e politico?
Con che strategie condurre il cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno per accogliere e ripensare nuovi modi di vivere con gli altri e con le altre specie animali e vegetali?
Come ricondurre le persone a riconoscersi in primis come cittadini e poi, eventualmente, come consumatori?
Come cambierà la governance? Si parla molto di governance bioregionale: territori gestiti dalle persone che ci abitano, li conoscono e se ne prendono cura.
Come potremo condurre le persone a rivivere le tradizioni di sempre in chiave sostenibile?
2 – Affondi dalla superficie 99
Considerando le sfide che ci attendono negli anni a venire, come preservare la biodiversità e le specie in via d’estinzione? E allo stesso tempo come porci di fronte alla naturale invasione delle specie aliene? Come trovare un bilanciamento in tanto squilibrio?
La ricerca e lo sviluppo di alternative sostenibili per l’innovazione; il supporto alle imprese rigenerative (cioè imprese che non cercano semplicemente di ridurre la propria impronta ecologica, ma che puntano ad ampliare la propria impronta socio-ecologica e a ripristinare la salute delle persone, dei luoghi, delle comunità e del pianeta); le attività di comunicazione, formazione, educazione e sensibilizzazione a tutti i livelli; lo sviluppo di mercati etici per prodotti e servizi; il sostegno alle economie locali e la collaborazione tra settori; le attività di monitoraggio e di valutazione per misurare l’impatto delle politiche e delle pratiche sostenibili adottate: quelle elencate sono solo alcune delle azioni che possono essere intraprese per sostenere politiche ambientali e climatiche, coscienti del fatto che ognuna di queste debba essere declinata puntualmente e che, ogni strumento include, al di là delle intenzioni, possibili contraddizioni, conflitti e incompatibilità.
Porci queste domande e interrogare alcuni degli strumenti che abbiamo a disposizione è un esercizio fondamentale per mettere in discussione alcune delle dinamiche attuali e progettarne di nuove, rispettose di tutti gli esseri animati e inanimati, per passare da un mondo ego-centrico a un mondo eco-centrico. Un modo più ground che inizi subito.
100
Appello all’immaginazione
Michela Pace
Utilizzando un’espressione coniata nel 1960 da un gruppo di artisti pop tedeschi e successivamente negli anni Ottanta, Mark Fisher parla di realismo capitalista, ampliandone il significato al di là dell’arte e del marketing.
Il realismo capitalista sarebbe la convinzione diffusa che il capitalismo sia l’unico modo possibile di far funzionare i sistemi politici ed economici. Negli ultimi quarant’anni, il realismo capitalista si è installato come la principale inclinazione alla gestione delle nostre società. Questo è ancora vero, nonostante la recente nascita di movimenti dalla spiccata sensibilità sociale e ambientalista e alla progressiva presa di coscienza dell’azione individuale legata alla transizione ecologica. Siamo portati ad accettare uno stato di cose spesso inumano e antiegualitario perché, secondo le narrazioni
2 – Affondi dalla superficie 101
dominanti, le alternative sarebbero peggiori e, sebbene non sia perfetto, questo è il migliore dei modi possibili. Questa sorta di realismo ha portato i soggetti a quella che si dice un’impotenza riflessiva: riconosciamo che il mondo è marcio, ma ci sentiamo indifesi e il più delle volte impotenti. Urge quindi un appello all’immaginazione ancor prima che all’azione.
Immaginare un’alternativa significa, anzitutto, riconoscere il valore del frammento, scartando le rappresentazioni monolitiche e le retoriche dominanti, spesso omogeneizzanti e allo stesso tempo parziali. L’illusione che si possano fornire risposte univoche per risolvere le questioni urbane, territoriali e sociali è solo e soprattutto una visione tecnocratica della realtà. I frammenti, d’altro canto, sono rappresentativi della natura eterogenea della società, ma riflettono anche l’impossibilità di descrivere i territori contemporanei come un unico elemento, comprensibile e determinato. Più ancora, riflettono l’illusoria ambizione moderna di una visione antropocentrica. Le città e i nostri territori rappresentano una grande varietà di soggetti animati e non animati, ciascuno con un proprio sistema di rappresentazione che ne descrive i bisogni, le ambizioni, i diritti e che interagisce sia con le narrazioni principali a larga scala che con i sistemi locali, con le ipotesi e le traiettorie imprevedibili del cambiamento. La domanda che dovremmo porci a questo punto è: è ancora possibile produrre un’immagine condivisa dei luoghi che abitiamo? O piuttosto, dobbiamo considerare la molteplicità delle immagini come il modo più realistico di rappresentarli?
Sicuramente, ogni territorio produce tentativi indipendenti di costruire nuove forze, e quindi nuove narrazioni. Gruppi di cittadini, associazioni formali e informali, soggetti indi-
102
pendenti e molti altri producono una serie di immagini che mirano a costruire l’identità del gruppo e, in alcuni casi, a illuminare nove possibilità future a un pubblico più ampio. Questo brulicare di iniziative non è necessariamente fondativo di qualcosa, non sempre esse hanno esiti pratici. Spesso hanno una natura occasionale, guidata da convenienze temporanee piuttosto che da una programmazione a lungo termine, altre volte sono più strutturate e mirano a essere riconosciute da autorità superiori. In ogni caso, rappresentano realtà prorompenti, frammenti che immettono e alimentano diverse idee di vivere, difendono alcuni interessi promuovendo attività e valori selezionati.
Il recupero dei frammenti suggerisce di considerare la narrazione come un processo malleabile e aperto a diversi input, anziché come un prodotto finito. Solo in questo modo i soggetti chiamati in causa potranno essere attori attivi e non semplice oggetto di descrizione. La complessità che intreccia le proiezioni, le esigenze e i desideri del mondo umano e non umano dovrebbe essere considerata una risorsa, e ancor più una strategia da rivendicare, uno strumento in grado di favorire la lettura e la comprensione dei luoghi.
Se liberati dalle distorsioni, gli immaginari hanno infatti un valore positivo e sono essenziali per alimentare la dimensione politica al di là delle questioni tecniche e negoziali. Gli immaginari positivi aiutano a informare un’idea di realtà che conta sulla conoscenza, sulla diversità e sulla specificità, in contrapposizione alla spettacolarizzazione delle procedure, alla rapidità del cambiamento e al primato della risposta scientifica alla complessità.
2 – Affondi dalla superficie 103
Per questo l’immaginazione è tanto potente. Perché è al contempo anticipatoria e progettuale. Cioè prefigura un possibile futuro e, nel farlo, abilita gli strumenti che lo rendono possibile. Essa oscilla tra la rappresentazione del desiderio e la proiezione del contenuto, e quando finalmente l’immagine diventa progetto (di città, di territorio, di comunità), siamo immancabilmente portati a percepire lo spazio costruito come una naturale conseguenza di ciò che già conosciamo. In questo senso l’immaginazione non produce semplici rappresentazioni ma è uno strumento culturale che genera possibilità, costruisce conoscenza.
Cosa può essere fatto, dunque, per sovvertire le narrazioni legate al realismo capitalista e trasformarle in spazi di autentica creazione? Anzitutto, per reclamare la nostra agency, dovremmo accettare che pensiamo, desideriamo e agiamo secondo uno schema strutturato. Anche se crediamo di esserne esterni, il nostro background culturale ne è influenzato e la spontaneità, così come la sovversione, sono nella maggior parte dei casi programmate all’interno dello stesso schema.
Sempre più, quindi, lo sforzo collettivo di rievoluzione, dovrebbe servirsi dell’immaginazione. Questo non significa la cieca opposizione alle narrative dominanti, ma piuttosto produrre immagini plurali capaci di coesistere con le prime, di produrre un fermento sotterraneo diffuso, molteplice, inafferrabile nella sua diversità e ricchezza. Una moltitudine di frammenti in grado di comporsi per costruire visioni alternative, consapevoli del ruolo strutturante dell’immaginario e della sua forza collettiva.
104
Tra umanità e suolo
Tommaso Zorzi
L’architettura è la forma di relazione più duratura che l’umanità ha stabilito con il
suolo.
Da 2,5 milioni di anni la specie Homo progetta e costruisce elementi tridimensionali che gli permettono di insediarsi in un ambiente con maggior sicurezza, comodità, piacere estetico e funzionale. In sempre più luoghi del pianeta la specie ha agglomerato masse di costruito che nel tempo sono mutate, alcune volte seppellite in strati di passato, altre volte trasformate e arrivate fino ai giorni nostri.
In questa sempre più precisa, veloce e gradualmente meno raffinata arte del costruire, nell’ultimo secolo abbiamo forse sopravvalutato la salvaguardia della vita umana. Nel rapporto con il suolo attraverso le nostre costruzioni, l’uomo conta troppo. Nella vitale e partecipata discussione relativa alla rievoluzione da compiere in contrasto alla crisi energetica, ambientale, sociale che abbiamo generato, va ripensata, quantomeno ridimensionata, l’importanza che la salvaguardia della vita umana riveste negli insegnamenti e nella disciplina costruttiva. Giustifichiamo progettazioni esagera-
2 – Affondi dalla superficie 105
tamente iperstatiche realizzate con materiali di provenienza industriale che ci sembrano affidabili grazie alle prestazioni che raggiungono nel breve periodo o in condizioni controllate di laboratorio, ma che richiedono enormi sforzi manutentivi o che risultano meno durevoli del previsto.
Su tutti, il calcestruzzo armato è esempio perfetto dell’agire novecentesco nel campo del costruire: per oltre un secolo abbiamo affidato la sicurezza strutturale della gran parte delle nostre opere civili a un materiale la cui fabbricazione è estremamente complicata ed energivora (sia per l’acciaio che per il cemento), la cui realizzazione richiede condizioni di temperatura e umidità molto limitate (regolate con additivi, che ne aumentano la complessità e la fragilità), la cui fase di indurimento e asciugatura è lenta e delicata, la cui durabilità, di conseguenza, è imprecisa e porta a collassi imprevisti, il cui rinforzamento e restauro è costoso e spesso viene affidato a materiali (resine o fibrorinforzati) su cui nuovamente non abbiamo sufficiente storia, tecnica, arte del costruire, conoscenza.
D’altro canto la questione stessa della durabilità merita un’attenzione particolare. Spesso infatti ci convinciamo che l’exegi monumentum aere perennius sia la via da seguire per ogni architettura, immaginando cioè che la costruzione debba arrivare ai nostri posteri e sottovalutando l’importanza e l’impatto della demolizione della stessa, tralasciando le operazioni necessarie alla scomparsa del nostro operato, non considerando gli effetti e il valore estetico, paesaggistico ed energetico del rudere che un giorno la nostra creazione diventerà. Se non consideriamo l’intera vita di un edificio, e quindi anche le operazioni e l’impatto della sua demoli-
106
zione, anche azioni animate da sincere intenzioni di riduzione dell’impatto ambientale possono diventare un disastro. Pensiamo a tal riguardo alla scellerata operazione pubblica del 110% che ha spinto nell’ultimo biennio molti italiani (o almeno quelli che sono riusciti a trovare imprese edili e banche disponibili a gestire le complicate operazioni fiscali e procedurali) a riempire le vecchie case degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta di polistirolo e cellulosa, schiume espanse e guaine incatramate. Perché la logica della riduzione dell’impatto energetico per termoregolare è di facile e immediata comprensione (cappotto termico che riduce la trasmittanza, pompe di calore che scaldano e raffrescano con dispendio di energia elettrica prodotta gratuitamente da impianti fotovoltaici e accumulata in potenti batterie al litio), mentre quella dello smaltimento, dell’impatto ecologico sul suolo e sull’ambiente circostante richiede più tempo e pazienza per essere colta, e soprattutto riguarderà qualcun altro e tra parecchi anni. (Salvo grandinate anomale che distruggono il fragile cappotto, come accaduto qualche settimana fa proprio a pochi chilometri da qui)!
Oggi architetti, progettisti, committenti e amministrazioni pubbliche, dovrebbero primariamente porsi l’obiettivo di distruggere. Di rimuovere. Di ridurre la materia inerte che le generazioni passate hanno costruito e che noi continuiamo ad accumulare. Chi riuscirà a rendere giustizia alla storia di questo tempo, che non si accontenta più di raccontare soltanto le vicende umane ma pretende un approccio meno antropocentrico, sarà chi avrà il coraggio e la capacità di demolire, di abbattere, di riportare terreno agli ecosistemi. Terreno che sia semplice suolo, utilizzabile da differenti organismi che lo abitano e lo rendono vivo. Una prima scommessa potrebbe
2 – Affondi dalla superficie 107
essere quella di costringere a ridurre cubatura o superficie utile ai progetti privi di impatto sociale, che cioè non contribuiscono a un miglioramento comunitario o ambientale, a partire proprio dalle singole abitazioni o dai condomini. Sostituire la logica del credito edilizio con il credito (o debito?) ecosistemico, volto a misurare il benessere di un’area sulla base del numero di specie (animali e vegetali) che trarranno beneficio e nutrimento dal nuovo intervento. O dalla qualità delle interazioni tra le varie specie che lì avverranno.
In un approccio necessariamente più articolato, gli elementi cardinali della progettazione di una costruzione ordinaria oltre alla durabilità, salvaguardia della vita umana, sicurezza, dovrebbero essere la rimovibilità futura dell’edificato, l’impatto dello smaltimento dei suoi materiali, il grado di invasività nell’ecosistema in cui è immerso. Tenendo in mente, in particolare, che chi ne farà primariamente le spese laddove si edificherà una nuova costruzione sarà il suolo, quel ground che andrà inevitabilmente impoverito dall’azione costruttiva, che ricco di vita diventerà superficie compattata e depauperata, da terra a roccia. Sostituiamo qualcosa di raro e prezioso con qualcosa di arido e abbondante.
Già, perché se guardassimo alla quantità di materia, più che terra il nostro pianeta dovrebbe chiamarsi roccia. La crosta terrestre è quasi interamente formata da silice e altri ossidi. Sotto il suolo e sotto i mari il nostro pianeta è un enorme agglomerato roccioso. Lo strato di suolo, quello che volgarmente chiamiamo terra, è davvero sottile. E quel che facciamo, per dare solidità al costruito, è sostituire il sottile suolo con quella roccia (in forma ghiaiosa, non a caso definita inerte) così abbondante che tiriamo fuori dalle profondità
108
dei monti per metterla in superficie, al di sotto delle nostre abitazioni, fabbriche, costruzioni. Il suolo si riduce, già confinato da sotto dalla roccia, viene compresso da sopra dal costruito. E quando è rimosso, spostato, laddove non diventa rifiuto speciale, perde la sua vitalità.
Pertanto, aspettando la legge giusta, l’auspicio di questo Social Forum è quello di attivare a ogni livello (committenti, amministrazioni, architetti, associazioni) progettazioni articolate basate su approcci sobri, lievi, che pensino a scomparire, che dialoghino con la terra, con il suolo, che riducano le superfici e i volumi, che rendano la relazione tra umanità e mondo non più un monologo, ma un dialogo multilingue di cui provare a farci interpreti.

2 – Affondi dalla superficie 109
Muoversi in città
In bici o a piedi, per dove?
Luca Velo
Muoversi e tempo.
Se paragonata alle realtà europee più avanzate, la situazione della mobilità attiva, intesa come combinazione di mobilità pedonale e ciclabile, nelle varie città italiane si presenta piuttosto disomogenea e diversificata (19° Rapporto sulla mobilità degli italiani – ISFORT 2022).
Esistono realtà locali che si confrontano costantemente con le migliori esperienze continentali e altre in cui i requisiti minimi di accessibilità ciclabile e pedonale (attraversamenti sicuri, segnaletiche, marciapiedi, percorsi ciclabili in sede propria, ecc.) risultano ancora molto faticosi da raggiungere.
Le ragioni sono difficili da rintracciare pienamente ma persistono almeno due motivi: da un lato una questione di natura culturale e, connessa, una questione politica. Se si pensa che Paesi come la Francia, la Danimarca, l’Olanda e la Germania ormai da qualche tempo hanno riorganizzato i propri ministeri per rispondere alle esigenze di una mobilità nuova, non solo più sostenibile ma anche più salutare per la popolazione, appare evidente quanto ancora il nostro Paese si stia solo recentemente avvicinando a qualche risultato in maniera del tutto disomogenea. La Francia per esempio nel maggio del 2023 ha approvato il Piano ciclistico e pedonale 2023-2027 (Plan vélo et marche) con tre obiettivi principali:
110
rendere la bicicletta accessibile a tutti, fin dalla prima infanzia e per tutta la vita; rendere la bicicletta e gli spostamenti a piedi un’alternativa attraente all’auto privata per gli spostamenti locali e in combinazione con il trasporto pubblico per gli spostamenti a lunga distanza; fare della bicicletta una leva economica, sostenendo gli operatori francesi del settore. Appare evidente che questo è l’esito di una politica ad ampio spettro che, attraverso un programma di investimenti mirato, tocca non solo i diversi settori (sociale, sanitario, economico, ecc.) ma soprattutto si misura sul lungo periodo. La questione della programmazione sul lungo periodo quindi diventa essenziale per orientare iniziative ma soprattutto per mettere in moto flussi di pensieri alternativi e innovativi in termini di mobilità.
Come ci stiamo muovendo?
In Italia tradizionalmente la storia della modernizzazione è coincisa con una storia di motorizzazione ma forse i tempi sono maturi per invertire la tendenza e muoversi verso principi di demotorizzazione1.
I motivi del ritardo italiano sono da ricercare in gran parte nella mancanza di un ruolo forte della politica nazionale che tradizionalmente ha trascurato le riforme forti sulla mobilità attiva, demandando alle amministrazioni locali e regionali la facoltà o meno di affrontare il tema tramite risorse di bilancio proprie.
È quindi concreta la difficoltà da parte delle amministrazioni pubbliche nell’intraprendere, entro politiche e competenze chiare, vere e proprie riforme di un quadro complessivo che risente di aspetti che riguardano la normativa, l’innovazione tecnologica, ma anche i cambiamenti sociali e culturali oltre
111
2 – Affondi dalla superficie
a una struttura territoriale policentrica con ampie porzioni di aree suburbane a bassa densità in contesti non sempre del tutto pianeggianti. Queste non possono essere unicamente le spiegazioni. Alcune città dell’Emilia Romagna e del Veneto, come Modena e Belluno, possono essere paragonate a realtà di città medie tedesche come Münster, mentre altri contesti, complici condizioni territoriali e politiche poco favorevoli, dimostrano quanto ancora vi sia da fare a partire già dalle dotazioni minime di sicurezza e dall’accessibilità scolastica. A fare la differenza sono spesso la qualità degli amministratori, la sensibilità culturale per questo genere di temi e una forma di cura del territorio che solo il ripensamento delle diverse forme di accessibilità può garantire.
Ne consegue che individuato l’obiettivo, cioè l’aumento del numero di utenti che possono agevolmente usare la bicicletta per recarsi a scuola o al lavoro o nel tempo libero, la scelta degli strumenti e delle strategie di azione diventano il terreno sul quale misurare le diverse esperienze entro una partita che possa coinvolgere tutti: amministratori, categorie, terzo settore e singoli cittadini; il caso del GRAB (Grande Raccordo Anulare delle Bici) a Roma, è emblematico di un di un progetto che viene dal basso, sviluppato da Velolove col contributo di una vasta rete di associazioni e istituzioni.
Valutare quanto è stato realmente condotto e monitorare i risultati ottenuti è però un esercizio complicato, soprattutto in assenza di parametri omogenei a cui fare riferimento. In questo consiste la difficoltà nell’operare nei contesti italiani laddove la specificità territoriale deve porsi al centro delle scelte progettuali, adeguando strategie e risorse in modo molto mirato. In questo senso, per l’Italia in generale, rien-
112
tra il concetto di città dei 15 minuti (il cui fautore chiave, il professore Carlos Moreno, parla della creazione di una ville de proximité in cui la vicinanza delle componenti base della nostra vita è considerata una virtù), spesso viene utilizzato più come slogan che come principio. Appare evidente infatti che in un contesto articolato e complesso, tale principio non sia applicabile per una lunga serie di limiti che non tengono in considerazione le dimensioni vere e proprie delle città, delle aree metropolitane e delle morfologie disperse degli insediamenti sul territorio italiano.
Una strada ancora molto lunga da percorrere Fino a non molto tempo fa, infatti, si riteneva che l’estensione delle piste ciclabili potesse rappresentare un indicatore importante di sviluppo della ciclabilità negli ambiti urbani. Andando a valutare la qualità delle opere, le connessioni, il comfort, la segnaletica, la presenza o meno di alberature, i possibili punti di sosta o di riparo, l’accessibilità ai vari servizi, in particolare in corrispondenza delle intersezioni, ci si è resi conto che parlare di estensione delle piste ciclabili è di fatto molto riduttivo e che le forme di accessibilità legate alla mobilità attiva, a ben guardare, all’interno dello spazio urbano sono assai più complesse. A questo si associa che anche in Italia, nonostante la complessità dei diversi siti, da qualche anno si siano intrapresi progetti che includano concetti come il traffic calming, favorendo la convivenza tra differenti fruitori della strada attraverso una riduzione generalizzata della velocità piuttosto che costruire piste ciclabili. Si tratta di ritornare a un’idea di spazio condiviso, sviluppata dall’ingegnere stradale Hans Monderman, che in molte città olandesi eliminò i semafori, le corsie, i cartelli stradali e altre indicazioni dagli incroci confidando nel fatto che le auto, le
2 – Affondi dalla superficie 113
biciclette e gli altri veicoli avrebbero fatto attenzione gli uni agli altri. Tali iniziative hanno avuto il merito di sradicare un’idea di strada come spazio esclusivamente dell’auto, ripristinando una visione e una fruizione diversa e decisamente assai più inclusiva della strada2.
All’oggi cercare di offrire una risposta alla domanda sui criteri di valutazione comparata della mobilità attiva impone in Italia alcuni parametri di equivalenza (PRIT – Piano Regolatore Integrato dei Trasporti 2025 dell’Emilia Romagna) che trascendono in senso stretto i criteri di specializzazione propri dell’ambito stradale. Si tratta di individuare parametri che coniughino l’estensione degli spazi riservati alla mobilità attiva, ciclabile e/o pedonale, con la presenza di forme di moderazione delle strade carrabili e di aree pedonali aperte alle biciclette. Qui risiede una sfida progettuale più complessa rispetto al trovare lo spazio specializzato per il pedone o il ciclista o chi pratica forme di micro mobilità. Ancora una volta nello spazio risiede una sfida culturale che coinvolge oltre alle pratiche anche un modo nuovo di condividere la strada, adeguando velocità e percorsi a chi si ha intorno. La città è comunque un luogo orientato al futuro: va riconosciuto che il tempo e l’ambiente stanno mutando rapidamente. Quanto agli obiettivi di neutralità carbonica che l’EU si è proposta per quanto ambiziosi e difficili da raggiungere, niente può battere la mobilità attiva, complici continui rincari dei carburanti e un cambio generazionale più aperto alle nuove tecnologie e all’innovazione.
114
1. Owen Hatherley, Clean Living Under Difficult Circumstances. London: Verso, 2021, pp. 221-226.
2. Louise-Ann Leyland, Ben Spencer, Nick Beale, Tim Jones; Carien M. Van Reekum, The effect of cycling on cognitive function and well-being in older adults, “PLoS ONE”, vol. 1, n. 2, 2019, e0211779.
Il mondo può fare a meno dell’architettura?
TAMassociati
«È un sapore che ha un solo fine: dare dignità, o meglio proteggere la dignità che ognuno di noi, anche nelle situazioni più frustranti, mantiene comunque.
Una dignità che in architettura si chiama decoro, un termine questo da tempo osteggiato e che oggi per fortuna si risente nelle conversazioni di coloro che danno speranza al nostro futuro» (Valerio Paolo Mosco).
Funzione dell’architettura è interpretare la realtà presente, dare risposta ai bisogni, prefigurare il futuro comune. Ma quali sono gli strumenti interpretativi a nostra disposizione negli attuali tempi di indeterminatezza e di vulnerabilità condivise? Perché è innegabile che questo è il momento dell’incertezza; momento in cui il nostro modello economico e culturale, di cui l’architettura è interprete, ha mostrato segni di profonda crisi. La globalizzazione, la messa in di-
2 – Affondi dalla superficie 115
scussione dell’antropocentrismo, delle verità scientifiche acquisite, della democrazia rappresentativa impongono una riflessione sui principi etici che stanno alla base della nostra convivenza. Questo impone una critica radicale anche del fare architettura verso le generazioni che verranno. Perché, oggi, è proprio il futuro, inteso come luogo del miglioramento, a essere messo in discussione. Ne deriva che il contesto sociale e ambientale che stiamo vivendo induce a una riflessione sul rapporto sussistente tra progetto e sostenibilità integrale, anche rispetto alle condizioni di contesto in cui ci troveremo a operare nel prossimo futuro.
Intendiamo con questo la necessità di mettere in risonanza il concetto di sostenibilità ambientale con quello di sostenibilità economica, attraverso la definizione di un approccio metodologico capace di generare un’estetica basata sulla sinergia di questi due fattori. Le risorse economiche messe a disposizione del progetto, spesso vissute come delle limitazioni, devono essere considerate come premesse fondamentali alla progettazione; è infatti importante iniziare a considerare i budget non più come ostacoli ma come occasioni verso nuove forme di creatività. Una sorta di ecologia dell’economia da affiancare a quella ambientale, in grado di generare un’architettura: sobria, essenziale, semplice, resiliente; che sappia coniugare bellezza ed efficienza, rispetto dell’ambiente e delle persone.
L’economia, seguendo l’etimologia greca che unisce le parole οἴκος (oikos), casa e νόμος (nomos), norma o legge, va intesa come buona gestione delle risorse per la propria casa, quindi una scienza tesa ad affermare i valori qualitativi di ciò che attiene al benessere e alla felicità della collettività; è una
116
visione che contrasta volutamente l’idea di economia come pratica che assume come valori i soli dati quantitativi, legati alla disponibilità, in più o in meno, di meri beni economici.
Nel prossimo futuro, infatti, ecologia, economia e giustizia sociale dovranno, per necessità, procedere in parallelo facendo convivere elevati standard ambientali e disponibilità di risorse economiche che dovranno essere rese più accessibili. Per esempio con uno sviluppo di strumenti innovativi di finanza etica e collaborativa che possano supportare nuove forme di progettualità, in particolare verso le fasce più deboli della popolazione.
Parallelamente sarà necessario identificare strategie mirate a eliminare gli sprechi attraverso processi di razionalizzazione e semplificazione; obiettivo raggiungibile anche attraverso processi di ascolto critico e partecipativo. Un lavoro complesso di analisi e ricerca che avrà come obiettivo limitare il superfluo materiale, energetico, estetico; senza per questo rinunciare alla qualità che il vivere contemporaneo richiede. Sarà un approccio pragmatico alla progettazione, capace di dare risposte concrete ed efficaci a questioni di tipo pratico.
Il rispetto rigoroso delle risorse disponibili, che sappiamo essere limitate sia in campo ambientale che economico, dovrà diventare, quindi, azione creativa imprescindibile. Dal punto di vista estetico questo significherà sviluppare un’attitudine alla sobrietà dell’azione progettuale. Semplificazione e razionalizzazione diventeranno quindi interazione creativa finalizzata alla ricerca di soluzioni orientate verso una nobile semplicità, una sobrietà concettuale e costruttiva che metta l’accento sui caratteri di solidità e durabilità.
2 – Affondi dalla superficie 117
In questo contesto, al fine di mettere in sinergia tutti gli attori coinvolti nei processi di produzione edilizia, sarà sempre più richiesto un approccio corale e sinergico che privilegi rapporti collaborativi, in una costante interazione tra gesto progettuale e suo riscontro economico e ambientale. Estetica ed economia si legheranno così indissolubilmente in progetti rispettosi, realizzati senza spreco di risorse materiali, immateriali ed economiche. In questo processo si misurano quindi le nuove qualità richieste al progetto: la flessibilità nel coinvolgere in modo proattivo una molteplicità di soggetti (non ultimi gli utenti e i committenti); la capacità di metabolizzare le risorse disponibili, per generare sostenibilità e processi rigenerativi; la possibilità di trasferire informazioni in forma di conoscenza replicabile; l’attenzione a generare processi in cui la crescita del capitale umano costituisca il valore aggiunto più importante. Il tutto nel quadro di quella ricerca espressiva che rimane comunque alla base del fare architettura.
Oltre quarant’anni fa Giancarlo De Carlo affermava: «Il mondo può fare a meno dell’architettura? Ne farà a meno se l’architettura continuerà a non essere utile a nessuno». Utilità, bisogni, decoro, bellezza, valore collettivo: nel porre al centro delle riflessioni questi termini si gioca oggi il senso del fare architettura.
118
Da grande salverò il mondo…
Katia Provantini
«Da grande farò il pompiere…» urla entusiasta Grisù, apparentemente ignaro delle aspettative paterne e, forse in parte, della realizzabilità dell’impresa.
Come per il draghetto, per molti bambini immaginarsi da grandi nei panni di un astronauta, di una principessa, di un pompiere o di una scienziata rappresenta il gioco delle possibilità pure: oggi ci si immagina di diventare maestre, domani Presidente della Repubblica, poi soldato, infermiere, giudice, fiorista in un susseguirsi di ipotesi, immedesimazioni, esplorazioni dei ruoli, compiti e stili dell’umana esistenza. Non ce ne siamo accorti subito ma, da diverso tempo, il gioco infantile per eccellenza è cambiato: da grande sarò/farò ha perduto l’entusiasmo, la leggerezza, la noncuranza delle
2 – Affondi dalla superficie 119
logiche di fattibilità, opportunità e coerenza; soprattutto ha perduto la gratuità e la libertà di immaginarsi camminare nel mondo ognuno a suo modo, come si può o come si vuole. Il gioco, se di gioco ancora si tratta, ha assunto i toni della responsabilità e dell’impegno; apparentemente verso sé stessi, in realtà verso i genitori e gli adulti che li hanno preceduti. In un istante, il gioco delle esplorazioni si è trasformato nel gioco del ripianare i debiti, sanare i torti, risolvere gli errori, riconoscere i privilegi (presunti) dell’opportunità ricevuta, ecc.
Accade così che ai bambini viene chiesto di essere originali, unici e grandiosi perché, gli si racconta, sono essi stessi originali, unici e grandiosi; ciò che non gli si racconta è di quei pesi insopportabili che le generazioni di adulti attuali si portano appresso. Pesi difficili da guardare, figurarsi da ammettere e farsene carico. Sono pesi che odorano di fallimento, di senso di colpa, di disperazione per quanto è stato rovinato, di paura di scoprirsi incapaci, pericolosi o, ancor peggio, impotenti. Ecco che il gioco da grande sarai magnifico e salverai il mondo concede un momento di tregua: forse grazie al nuovo figlio ci salveremo tutti, ci sveglieremo e tutto sarà risolto. E vissero tutti felici e contenti... disastro scampato! Colpe sanate!
Visto da questa prospettiva, il gioco degli adulti sembra assumere tutt’altro significato rispetto a quello originale di futuro immaginato e sognato dalle nuove esistenze; più simile al tirare avanti finché dura, sperando di passarla liscia. Sperando di non dover conoscere il momento in cui si dovrà ammettere che la partita è terminata e che, per molti aspetti, si tratta di una partita persa disastrosamente. L’aspetto disastroso va opportunamente considerato perché
120
credo sia ciò che ha generato l’individualismo esasperato del si salvi chi può. Ognuno a suo modo, rifugiandosi nell’eccellenza intravista nel più insignificante dettaglio della propria esistenza, tenta la via del recupero e della ripresa. Un figlio meravigliosamente dotato potrebbe costituire addirittura un salvacondotto: dovrà pur pesare nella valutazione complessiva, aver generato e cresciuto una tale risorsa per l’umanità!
Purtroppo ciò che si perde, nella corsa solitaria, è la visione di insieme: quella che ci farebbe percepire l’avvicinarsi del baratro e ci renderebbe consapevoli della necessità perentoria di fermarsi e cambiare rotta. Perché l’alternativa esiste. Concreta e perseguibile. Si tratta di ammettere che sono stati commessi degli errori. Che gli errori sono fatti per essere compresi. Che la comprensione degli errori non ci ripara da altri errori, si spera diversi e nuovi. Che la vita per essere sostenibile è fatta di ricerca, di pensieri, di sogni, di fatica, di risate, di lacrime, di cadute, di prospettive. Ed è fatta anche di altro e di altri. Tutto compreso. Senza sconti.
2 – Affondi dalla superficie 121
Pressione. Filosofie non tristi del cambiamento
Jacopo Galli
Una rapida scorsa ai giornali dell’estate 2023 restituisce anche al lettore più distratto una sequela pressoché continua di danni senza precedenti causati dal clima.
Dagli alberi caduti a Milano agli incendi devastanti alle Hawaii, dalle rotture di argini in Slovenia all’uragano che ha colpito la California. La società globale del rischio teorizzata da Ulrich Beck si dipana davanti ai nostri occhi giorno dopo giorno.
La necessità di sviluppare nuove forme di progettualità capaci di mitigare e adattarsi alle rapide evoluzioni delle condizioni climatiche è oramai ovvia; ma è altrettanto ovvio, se non più necessario, un cambio di sguardo, di approccio e di paradigma su tutto quello che riguarda la costruzione del futuro. Progettare al tempo della crisi climatica significa confrontarsi con cambiamenti disruptive, che minano le
122
fondamenta stesse del pensiero contemporaneo e alterano totalmente gli strumenti e le pratiche per la necessaria modifica continua degli spazi abitati.
Per sviluppare un nuovo sguardo è necessario innanzitutto accettare il cambiamento come unica forma possibile di dialogo e abbandonare ogni vano tentativo di riaffermazione dello status quo, o peggio ancora di ritorno a un’arcadia mai esistita, per abbracciare la necessità di soluzioni radicali. Le condizioni della contemporaneità inducono troppo spesso a una prospettiva di negatività, uno sguardo verso il collasso o la fine del mondo dove l’azione progettuale sembra impossibile e la paralisi in attesa del disastro appare come l’unica forma eticamente accettabile.
È però vero il contrario: la crisi climatica può e deve essere affrontata, ma potrà esserlo solo tramite un rinnovato sforzo progettuale che soppesi, selezioni e scelga idee che fino a oggi sono state considerate come scandalose e inapplicabili; forse persino impensabili. Il futuro della transizione sostenibile e della società posttransizione può essere indagato con uno spirito che tenga insieme senso di impellenza e positività, nella ferma convinzione che siano possibili filosofie non tristi del cambiamento, che vedano nuovi attori e nuove istituzioni come protagonisti nella costruzione di nuovi sguardi e modelli.
In questo senso la crisi pandemica dovuta al Covid-19 potrà forse in futuro essere considerata come il punto di svolta che ha consentito di abbandonare ogni forma di necessità nell’applicazione pedissequa del pensiero dominante e di continuo ritorno al there is no alternative, stridulo grido di battaglia
2 – Affondi dalla superficie 123
del pensiero neoliberista. Se milioni di persone, chiamate a un sacrificio individuale in nome del bene collettivo, sono riuscite a modificare in poche settimane i propri stili di vita diviene evidente come la modifica radicale di interi territori e dei loro caratteri sociali ed economici, le cui condizioni attuali non saranno in alcuna maniera mantenibili in futuro, sia non solo dibattibile ma pienamente attuabile.
Bisogna però guardarsi dal cieco affidamento alle forme istituzionali che hanno portato alla crisi, non si chiamano i piromani per spegnere un incendio, come dalla pigra applicazione di nuove tecnologie avanguardistiche, troppo spesso futilità caldeggiate da impresentabili guru, ma anche dal ritorno a un pensiero premoderno e indigeno, fonte sicura di ispirazione ma difficilmente applicabile alla magnitudo dei problemi odierni.
Occorre invece costruire faticosamente e senza scappatoie un nuovo sguardo che coniughi tecnologia e umanesimo, studio attento del passato e audace salto nel vuoto. Per costruire questo sguardo occorre mettere al centro del pensiero progettuale un concetto antico ma estremamente nuovo, quello di pressione, nella certezza che l’ambiente costruito a venire dovrà essere capace di prevedere, rispondere e confrontarsi in maniera continua con sollecitazioni multiple e impreviste.
Il progetto sotto pressione è quindi una nuova forma di delineamento del futuro in cui si riscopre la funzionalità strategica dei processi di costruzione del territorio e in cui si abbandona il senso di certezza del paradigma del moderno in favore dell’innesco di processi continuamente controllabili e verificabili ma la cui conclusione non è univoca. Solo tramite
124
un sistema progettuale aperto e capace di agire come sismografo del cambiamento continuo è possibile costruire scenari credibili, continuamente rinegoziabili e periodicamente adattabili; una sfida tanto affascinante quanto inderogabile.

2 – Affondi dalla superficie 125
Siamo ancora liberi di solcare il mare
Mattia Bertin
Nel manifesto di GROUND si parla di agire la conversione economica e sociale.
Per operare praticamente un cambio di rotta radicale, per scardinare la rotta moderna che ci sta portando alla catastrofe climatica e relazionale, è necessario interrogarsi su quali siano le rigidità che danno poco gioco al timone, che ci impediscono di pensare radicalmente il movimento da compiere.
La prima di queste rigidità è la concezione postmoderna di fine della storia e delle ideologie. A partire dagli anni Novanta, dopo la caduta del muro di Berlino, si è sviluppata una narrazione del politico come amalgama tecnico votato al buon governo. L’idea stessa di modelli diversi a questa interpretazione di democrazia occidentale è stata demolita attraverso la guerra (in Medio Oriente e Nord Africa), la persecuzione giornalistica, lo smantellamento dei corpi intermedi e delle grandi strutture collettive. Ideologico è divenuto un comodo insulto per chiunque cercasse un orizzonte ampio e complesso alle politiche e alle pratiche di lotta. Sono caduti
126
in questo schema anche molti intellettuali, pure di fede radicale, descrivendo la storia oggi come compiuta e poco incline a grandi sconvolgimenti, misurando però l’evolvere storico sui tempi della cronaca.
Nel giro di pochi anni, però, questo bluff è caduto, ed è facile oggi mettere in ordine molti eventi indubitabilmente di portata storica: l’avvento di presidenti paratotalitari in diversi Stati democratici (USA, Brasile, Ungheria, Polonia); la pandemia di Covid-19; la guerra tra Russia e Occidente in Ucraina; gli effetti sempre più devastanti del cambiamento climatico. Questa negazione di storia e ideologia a favore della cronaca e della tecnica è in realtà profondamente ideologica, e muove dall’intento di sottrarre l’orizzonte alla collettività, forzando ogni decisione, azione e rapporto in un estenuante qui e ora.
La seconda di queste rigidità ci riguarda più da vicino e ha a che fare con una concezione turistica e nostalgica delle città e del territorio: la conservazione del presente. Intendiamo collettivamente ciò che attualmente esiste, la sua forma, come patrimonio, o meglio come heritage (che al concetto di patrimonio unisce quello di radici culturali). La conservazione di questo patrimonio si fonda sull’idea di preservare il passato nel suo valore, nella sua bellezza, nel suo essere ispirazione per l’oggi e il domani. Spesso però in questo vi è un fraintendimento: lo stato delle cose che si intende conservare non è quello del passato, ma quello attuale. La stessa legislazione italiana che prevede un parere della Soprintendenza sull’alterazione di edifici con più di settant’anni non fonda il limite su caratteristiche del passato, ma solo sul fatto che ci sia oggi e da molto tempo, sul fatto che bene o male chi non è in pensione ha sempre visto quella cosa com’è oggi.
2 – Affondi dalla superficie 127
Questo atteggiamento, che ci porta a difendere le forme dell’attuale come assoluti solo perché chi oggi decide non sa com’era prima ha molto a che fare con quella ipotesi infondata di fine della storia descritta prima, ed è il viatico per la terza rigidità che impedisce una piena conversione.
La terza rigidità è la concezione fondativa della proprietà privata. Nonostante la proprietà privata sia in Italia secondaria rispetto agli interessi della collettività, spesso è il bene pubblico che deve cedere il passo all’interesse privato. Quanti sono le servitù di passaggio, i sentieri e le strade di campagna che sono state chiuse in questo decennio da parte dei proprietari dei terreni circostanti? Quante sono le abitazioni chiuse e inutilizzate in un tempo in cui è molto difficile e costoso trovare una casa dignitosa? Quanti i capannoni abbandonati o sottoutilizzati mentre si continua a consumare nuovo prezioso suolo per installare hub logistici? I nostri territori sono sventrati, trasformati in ricchezza economica e poi abbandonati quando divengono un costo per il privato, senza nessuna riflessione su quanto significhi privare (privato, sic) le comunità e l’ecosistema del suo bene per caricarli invece di danno e costo.
Una conversione ecologica e sociale, che si faccia carico dell’aumento delle disuguaglianze, dell’abbandono delle fragilità, del cambiamento climatico, del bene dell’ecosistema non solo in relazione allo sfruttamento da parte umana, non può permettersi di agire negli spazi troppo angusti lasciati da questi tre pilastri. Non è pensabile una conversione che accetti la fine della storia, il dominio tecnico sulla politica, la conservazione dell’attuale, il privato e il privare come fonte della relazione nelle comunità e sull’ambiente. La messa in
128
discussione di queste rigidità deve però operare a ogni scala, a partire dal sé, dal proprio vivere la relazione, la casa, il lavoro, il tempo. Se GROUND vuole radicare una conversione dobbiamo forse chiederci come eradicare questi tic, queste rigidità a cui diamo priorità nel nostro modo di operare.
GROUND Social Forum prende origine da un grande dolore: la repressione violenta della possibilità di cambiare il mondo. Un altro mondo è possibile si cantava, si gridava, si provava a fare nei social forum degli anni Novanta-Duemila. Quella possibilità negata, in Europa, ha un luogo, una data, un nome: Genova, Piazza Alimonda, 20 luglio 2001, Carlo Giuliani. Nelle repressioni del G8 di Genova è stata interrotta una strada che però ora è urgente riaprire. GROUND si occupi di questo, a partire da un auspicio: «Fratelli miei, non ci hanno vinti. Siamo ancora liberi di solcare il mare» (Luther Blisset, Q, Torino: Einaudi, 1999).
2 – Affondi dalla superficie 129
Viversi dentro il vivente
Miguel Benasayag intervista
Che cosa significa questa «uscita dall’antropocentrismo» di cui spesso parli nei tuoi testi e interventi?
In realtà, per cominciare, dobbiamo prendere atto del fatto che possa esistere una contraddizione tra l’idea di sostenibile (e di sviluppo sostenibile) e l’uscita dall’antropocentrismo, perché in realtà sostenibile riguarda l’idea di poter continuare, in parte, a comportarsi come prima ma cambiando le cose per permettere che il mondo non esploda e per evitare la catastrofe. Questa è un’ipotesi problematica per una serie di motivi. Innanzitutto perché in realtà la catastrofe e il caos non sono qualcosa che può arrivare se noi non facciamo così o cosà; noi siamo già in mezzo al caos! Quando pensiamo che il futuro sia minaccioso, non siamo più a questo punto, noi siamo già dentro a una realtà caotica, di distruzione, e ciò che può variare è soltanto il punto di vista da cui la guardiamo. La realtà attuale è così difficile per la convergenza, non fatale ma quasi determinante, che c’è tra due fattori. Il primo è la
130
perdita di centralità e potenza delle specie umana, il secondo è l’arrivo da quarant’anni circa di una potenza terribile, che è la potenza della tecnologia cibernetica. Essa ha un livello di autonomia e di autodeterminazione molto grande, ma dal mio punto di vista non è una tecnica padroneggiabile dall’essere umano, piuttosto è una strategia senza stratega. Questo non è un problema in sé, ma vanno distinti narrazione e processo: la narrazione della modernità ha messo l’uomo al comando del mondo, ma noi stessi possiamo vedere che il mondo, i mondi, sono processi molteplici e complessi di autoproduzione dentro ai quali la specie umana è un fattore tra gli altri. Questo per dire che non è stato mai l’uomo – l’uomo cartesiano, potremmo dire – la somma di tali fattori e il direttore di questo processo. Quello che realmente è accaduto, durante la modernità, è stato un incredibile e irrefrenabile sviluppo della tecnologia e al contempo della conoscenza dei processi meccanici e fisico-chimici, ed entrambe queste cose hanno sviluppato cambiamenti enormi, ben oltre il controllo dell’essere umano. Nei processi della modernità non esiste nessun antropocentrismo: i processi sono sfuggiti dalle mani dell’essere umano; certo, quest’ultimo è stato ed è effettivamente fondamentale nello sviluppo delle tecniche e delle conoscenze che abbiamo avuto fino a oggi, e che sono incredibili in rapporto a quelle che avevano in altre società o altre culture, ma non va dimenticato che l’antropocentrismo è una narrazione che copre quattro secoli di modernità. Uscire da esso significa cambiare punto di vista in rapporto ai processi materiali. Non basta dire: «l’uomo non è più al centro». L’epoca che stiamo vivendo è l’epoca in cui si rivelano forze e trasformazioni incredibili della natura, ed è l’epoca in cui la distruzione è maggiore della produzione. Se continuiamo ad avere il solito rapporto con il mondo, con la tecnologia e
131
2 – Affondi dalla superficie
con noi stessi, se tutto continua così, la distruzione diventa più grande della costruzione.
L’altro fatto che dobbiamo considerare è che ormai, da anni, stiamo vivendo un nuovo periodo di estinzione. L’estinzione dal punto di vista della biologia evolutiva ha due modalità: una è quando una specie scompare a causa della propria evoluzione, e ciò richiede un tempo lunghissimo; l’altra è dovuta a un agente esterno e non corrisponde all’evoluzione di una specie, ad esempio come accadde con i dinosauri e l’ipotesi del meteorite. La nostra estinzione è molto particolare e catastrofica perché è causata da meccanismi evolutivi, ma questi meccanismi hanno la rapidità di un elemento esterno che di colpo interviene. È per questo che, nella realtà, noi e tutti i viventi non abbiamo il tempo per stare al passo di questa evoluzione. In quarant’anni è sparito più o meno il 60% degli invertebrati: un processo di una rapidità enorme!
Noi occidentali (e occidentalizzati) dobbiamo imparare una cosa difficile, se non impossibile, da imparare: viversi, pensarsi e sperimentarsi come un’esistenza tra le tante nel mondo, e non come quella che può padroneggiare e orientare il risultato complessivo. E dobbiamo anche renderci conto che c’è un altro fattore oltre a noi, e prodotto storicamente da noi, che è la tecnologia. Non è così per altre culture nel mondo: per le Indie e per i popoli colonizzati in Africa non è mai stato l’essere umano o animale a poter orientare e dirigere il mondo. Quest’idea lì non è mai esistita, hanno sempre vissuto e si sono sempre sperimentati come un elemento tra i tanti. Abbiamo esperienza di molte culture premoderne e paramoderne in cui l’essere umano non è stato né un’unità né ha mai pensato di poter dominare la realtà molteplice; è per questo che un filosofo argentino dice che «l’uomo
132
moderno ha paura di Dio», dove con Dio intende non solo le divinità metafisiche in senso religioso, ma anche quelle forze della natura che non possono essere padroneggiate. Oggi siamo noi ad aver paura di Dio, divinità e forze della natura, e non sappiamo come fare pur avendo una forza tecnologica terribile.
Per tornare a quanto detto all’inizio, quando parliamo di sviluppo sostenibile usiamo un’espressione che ci intrappola perché spesso non comprendiamo la profondità della crisi attuale. Molte aziende o chiunque parli ogni giorno di sostenibile in realtà pensa a come continuare a fare più o meno le stesse cose di oggi ma con più attenzione. In questo senso la sobrietà può apparire come un invito simpatico, o eventualmente anche come un obbligo. Ma la sobrietà – che è invece, semplicemente, inevitabile – sarà per molto tempo causa di xenofobia e di enormi conflitti, e non sarà una sobrietà uguale tra i Paesi colonizzatori e quelli periferici colonizzati, non sarà uguale tra il migrante e il borghese. Questa sobrietà sarà così fino a che non saremo in grado di agire una sobrietà gioiosa, che appunto è la nostra sfida.
Sono tre le parti in gioco, al nostro interno: una prima parte ricerca uno sviluppo sostenibile, senza però assumersi la responsabilità di capire la profondità e la radicalità di questa crisi; una seconda parte appartiene all’ecologia radicale, che riconosce ci siano altri fattori e che l’uomo non è l’unica specie al mondo, che nutre una certa diffidenza nei confronti della tecnologia, ma che guarda ancora all’essere umano come al fattore principale e riconosce centralità all’idea di soggetto (e il conseguente bisogno ultimo di salvaguardia della specie umana). È la parte che ha saputo riconoscere
2 – Affondi dalla superficie 133
prima agli animali e poi agli esseri viventi in genere, come i fiumi, i laghi, le foreste, una legittimità giuridica. Una terza parte, invece, si può definire decoloniale, e non riconosce alcuna centralità al soggetto. Per la cultura decoloniale, ad esempio, dire «questa montagna è un soggetto di diritto» è contraddittorio, perché lei stessa non si autopercepisce come soggetto, ma si percepisce come una tra i tanti e con essi si collega. L’approccio decoloniale ci invita a riflettere e sperimentare dal punto di vista non dell’essere umano ma del vivente, a pensarsi e pensarci da viventi. Può essere difficile da capire o allo stesso tempo molto facile. Pensarsi, autopercepirsi soltanto come essere umano è una semplificazione che appartiene al nostro modo di essere: è come se un tifoso del Boca pensasse da tifoso del Boca, mangiasse da tifoso del Boca, amasse la moglie da tifoso del Boca. Questa è una monodimensionalizzazione che schiaccia le altre dimensioni.
Dovremmo cercare di viverci dentro il vivente e uscire da questa trappola unidimensionale: una cosa complicatissima eppure semplicissima.
Hai lavorato per tanto tempo su quelle che hai definito le «passioni tristi», e al tempo erano davvero le urgenze di frontiera per chi si occupava di fragilità sociale. Quali sono allora le urgenze di oggi? E come può contribuire in questo la «sobrietà gioiosa» che hai citato?
Esistono due modelli, diversi e opposti, che possono definire il ruolo contemporaneo dell’umanità. Il modello dominante – che dominerà per un lungo, lunghissimo tempo, e che vediamo resistere, evolvere e contribuire a costruire altri modelli simili – è quello dell’essere umano modulare, l’esse-
134
re umano profilo, avatar. In questo avatar, che noi creiamo e con il quale entra in rapporto la stessa società, ci identifichiamo sempre di più: per noi è sempre più complicato entrare in rapporto diretto con una qualche istituzione o anche semplicemente con le persone. Lasciando stare ad esempio il profilo Facebook o gli amici di Facebook, che per me chiamare amici è sempre un po’ doloroso, oggi è comunque diventato obbligatorio avere un’interfaccia per entrare in rapporto con ogni istituzione esistente. Ed è un dato di fatto che qualcuno possa sentirsi isolato se non ha accesso ai social e in genere e alla rete. Il modello dell’essere umano modulare è origine di quella che viene definita pedagogia delle competenze, che educa i bambini a essere utili, tagliando le competenze negative e insegnando le competenze positive Per apprendere quelle positive si devono dimenticare quelle che non servono più, e questa è l’assimilazione del cervello umano al computer. All’interno di questo sistema, si vede chiaramente qual è il ruolo che la tecnologia – seppur senza nessuna volontà – da sola sta costruendo per l’umanità: chiede a ciascuno di noi di diventare un operatore dell’informazione. Il progetto educativo attuale è quello di dover fare coppia per corrispondenza panoptica, e cioè la ricerca di ciò che corrisponde, delle buone competenze, di ciò che ci fa sentire simili, moduli che possono coincidere.
L’altro modello, diverso e opposto, appartiene all’organico e all’organicità – che non vuole dire biologico, attenzione: tutto quello che è biologico è organico ma l’organicità non è solamente biologica, può essere ad esempio l’organicità di una città, di un gruppo, della lingua e di tutto ciò che esiste in una complessità che non è utilitarista. Organico significa ciò che non è transitivo, ciò che non per forza serve, e che non
2 – Affondi dalla superficie 135
ha un proprio fine. Un filosofo diceva che l’essere umano non serve a niente, esso stesso è il proprio fine e la propria finalità, non è cioè transitivo. Questa profonda e radicale inutilità della vita serve a staccarci dall’imperativo di dover essere costantemente utili e produttivi, di dover sempre diventare qualcosa, di dover vivere la nostra vita con un progetto, che infine è sempre una sala d’attesa perché aspettiamo sempre di essere ciò che non saremo mai.
Una pratica decoloniale passa attraverso lo sviluppo di pratiche organiche, cioè di tutto ciò che rimanda il senso della vita prima di tutto alla vita stessa. Non dobbiamo più accettare il terrorismo sociale che dice: «devi valutare ogni giornata quello che hai fatto». Basta, finiamola: chissenefrega, quando ho vissuto. Dovremmo vederla proprio così: ho vissuto. L’approccio decoloniale è generale, collettivo, di tutti noi, ma è certamente vero e opportuno che ciascuno cerchi di capire, dentro la situazione individuale familiare, il proprio gruppo, la propria comunità, come sviluppare un modello organico in contrasto al modello modulare, che richiama performance, utilità e valutazione permanente.
Per ciò che riguarda la «sobrietà gioiosa», essa è inevitabilmente un appuntamento obbligato per l’umanità, e lo sarà in modo radicale e grave: in Spagna e anche qui in Francia, per fare un esempio, iniziamo a sentire notizie di piccole comunità con l’acqua razionata. Ci vorrà una specie di golpe, forse, e il giorno seguente ci sarà un proliferare di norme e disciplinari sulla sobrietà, perché sarà davvero impossibile fare diversamente. Questo è il grande segreto che hanno i potenti del mondo, che sanno che non ce ne sarà per tutti e che quindi cercano di difendere il proprio paese, la propria classe o il proprio gruppo che sia. La sobrietà sarà vissuta prima di tutto
136
come guerra, conflitto, egoismo, ci sarà molta violenza e una perdita progressiva e repentina dei legami sociali. Ci saranno – ci sono già – dei gruppi minoritari dal grande potere economico-militare e da ogni punto di vista. Per loro la sobrietà non ci sarà, anzi al contrario potranno godere di ciò di cui gli altri sono privati, e questo è un riflesso stupido e basso degli umani che si può osservare da tempo (l’immagine caricaturale dell’uomo felice che sta da solo a bordo di una piscina vuota con il suo drink: ho provato per la prima volta nella mia vita davvero questa esperienza, c’era una piscina in una casa in cui ero stato invitato ed era vuota, con questa sedia libera in cui mi sono seduto con un buon succo di arancia in mano. Mi sono detto: ora voglio provare la felicità, qui, adesso, dopo una vita molto dura. Be’, un fallimento assoluto! Mi sono innervosito, mi sono rotto le scatole e mi sono sentito anche un po’ stupido!).
Il nostro ruolo non è però di formare l’armata del bene contro l’armata del male, di polarizzare ulteriormente le nostre stanche società, ma di sviluppare pratiche ed esperienze che a poco a poco possano creare un immaginario alternativo di felicità e di desideri. Davanti a questo appuntamento inevitabile con la sobrietà possiamo dunque costruire una sobrietà gioiosa tramite l’assunzione di pratiche diverse di condivisione: chi sarà capace di produrre questo immaginario nuovo e alternativo di pratiche (e gli artisti e gli scrittori hanno un ruolo determinante!) potrà sperimentare un altro modo di abitare il pianeta, agendo attivamente con sobrietà e non patendo la sobrietà.
Ciò non significa che non ci saranno degli scontri, non potrà essere soltanto una resistenza sorridente e pacifica purtroppo.
137
2 – Affondi dalla superficie
Arriveranno dei momenti di confronto che dovremo per forza attraversare ma contrariamente all’ambizione del compromesso politico delle epoche precedenti, cioè della modernità, il confronto sarà semplicemente una conseguenza necessaria a un momento di sviluppo della nostra esperienza. E non è il confronto nella sua accezione moderna: «dobbiamo confrontarci col nemico, prendere il potere e poi cambiare le cose». È semmai il contrario, si tratta di sviluppare esperienze gioiose di condivisione ed eventualmente assumere, quando sarà necessario e in qualche momento lo sarà, il modello di chi ha saputo cambiare il mondo non puntando al potere ma accompagnandolo a seguire questi cambiamenti.
Veniamo alle pratiche di cura su identità malate di cui ti sei occupato e sulle quali ci stiamo ancora concentrando; pensiamo al tema delle psicosi e della malattia mentale, ad esempio. Proprio questo viversi dentro il vivente e pensarsi pluralità può essere una strada di cura. La frammentazione, se ricompresa in una pluralità, può essere davvero un nuovo modo di pensarsi.
Noi siamo molteplici eppure siamo costantemente schiacciati da un’identità; come tifoso del Boca, come uomo, come donna, anche come essere umano. Attenzione: la questione qui non è di unificare il nevrotico al malato e ancora meno rompere le scatole allo psicotico. La questione è quella di assumere questo insieme di cose come un fatto, e assumerlo come potenziale per agire, perché la modernità ha sempre cercato di schiacciare questo insieme di cose dentro un’unica identità, un unico io. Oggi si tratta di riconoscere che siamo un insieme di cose. La mia tradizione si definisce decoloniale ed è quella dell’antipsichiatria di David Cooper;
138
egli non ha mai detto che i pazzi sono soggetti rivoluzionari, ma semplicemente ha detto che la società deve tenere conto della molteplicità che la abita per fermarsi dall’aggredire lo schizofrenico, e che non si tratta di unificare chimicamente o disciplinarmente il malato, ma di assumere ciascuno di noi e le proprie molteplicità. Perché questo io è un’illusione, un’illusione che esiste e che ti facilita la vita, tutti si identificano con questo io. Ma è un’illusione. Le nostre verità sono da cercare nel molteplice.

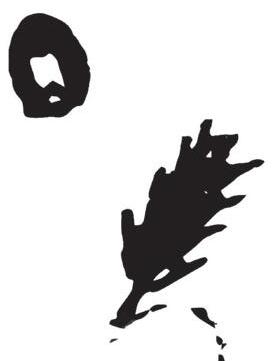

2 – Affondi dalla superficie 139
I nuovi designer dei luoghi
Elena Granata
Ormai da tempo
l’architettura ha perso il proprio ruolo di pungolo intelligente della società, la sua capacità di trasformazione reale dei luoghi e delle città, la sua capacità di generare visioni di lungo periodo.
Abbiamo bisogno di figure nuove, ibride, di plasmatori di spazi e inventori di nuovi luoghi di vita; li ho chiamati placemaker, sono gli inventori dei luoghi che abiteremo. Ne ho incontrati molti in questi anni di viaggi e di ricerche, figure ibride come il cittadino-viaggiatore, la sindaca-ambientalista, il politico-pedagogista, l’artista-imprenditrice, l’informatico-naturalista. Seguire le loro tracce, i modi di lavorare, le competenze inedite e la loro straordinaria creatività può essere decisivo per comprendere l’evoluzione delle professioni legate ai luoghi e ai territori ma anche per capire quali
140
nuove domande stiano emergendo dalle comunità e dalle città in profonda trasformazione.
Il placemaker non costruisce, ma connette, reinventa, rigenera. Non deve aggiungere, semmai deve togliere. Il suo compito è quello di ridare senso ai luoghi che lo hanno perso: dalle periferie cittadine alle aree dell’hinterland dove i campi sono stati abbandonati perché coltivarli non conviene più, fino ai borghi delle aree interne non più abitati. Il designer dei luoghi non è uno scienziato, ma è spinto dal desiderio di osservare la realtà per comprenderla. Non è neppure un artista in senso tradizionale, ma guarda il mondo con empatia. Non è un architetto, né un politico, né un imprenditore, ma ha la capacità di trasformare un’idea in un progetto, di pensare cose impossibili e, soprattutto, di farle accadere.
Reintegra la natura in contesti urbani, riforesta e ripristina ecosistemi, progetta soluzioni ispirate alla natura per contrastare i cambiamenti climatici, ricuce periferie sconnesse, reinventa borghi abbandonati, con un approccio che è anche imprenditoriale. Si cimenta con gli scarti delle città, con i muri ciechi e i capannoni inutilizzati, con gli spazi aperti e vuoti. Non agisce solo sugli spazi fisici ma anche sui comportamenti umani e sulla natura, sui sentimenti e gli stili di vita. In qualche modo è un designer dei comportamenti sociali e delle scelte che deve contribuire a orientare.
In una parola, si occupano di rigenerazione dei luoghi, nella sua accezione più ampia. Nel mio repertorio di nuovi placemaker troverete animatori di comunità, imprenditori civili, sindaci di piccole e medie città che hanno la passione per la rigenerazione dei luoghi. Attori che agiscono entro un processo sottrattivo e sostitutivo che però non ha nulla della rinuncia o della decrescita felice. Non ha nulla a che
2 – Affondi dalla superficie 141
fare con i sentimentalismi e con l’idealismo; opera nel più grande spazio economico su cui dovremmo investire.
Qualcuno la chiama transizione ecologica, il passaggio da un certo modello economico e di produzione/consumo di energia a un altro, da un modo di produrre di ricchezza che ha impatti pesantissimi sul pianeta a un riequilibro tra massa antropica e biomassa vivente, in un rapporto naturalmente a favore di quest’ultima.
Osservare come si muovono in grandi città o in piccoli centri queste nuove figure ibride ha corroborato la mia certezza che nei prossimi anni non vedremo all’opera architetti solitari ed eroici, né archistar, protagonisti egocentrici e solitari, preoccupati di lasciare la propria indiscutibile impronta estetica sulle città; nessuna figura tradizionale avrà più il monopolio delle trasformazioni urbane, il cambiamento sarà accompagnato da una nuova generazione di protagonisti, che si esprimerà in modo condiviso, corale, integrato. In un mondo già affollato di oggetti artificiali, questa generazione si cimenterà in processi concreti di dematerializzazione del mondo, facendo nascere nuove economie, nuove possibilità di abitare e nuove forme di socialità, lavorando su quello che già c’è, senza spreco di materia nuova, né di sterile creatività formale. Uno spazio di pensiero e di immaginazione che chiama in causa gli attori più diversi, dalle cooperative alle banche, dalle università ai mondi sociali, dai designer al mondo dell’impresa.
142
Carbon and culture – nuove forme di produttività
Alan Chandler
La mia carriera professionale di architetto specializzato in conservazione si riflette nell’insegnamento e nella ricerca, e in particolar modo nel lavoro condotto su alcuni monumenti importanti a livello nazionale e culturale
(come il Palacio Pereira a Santiago del Cile con Cecilia Puga e l’Altab Ali Park a Londra con il MUF), dove lo scopo era quello di garantire, assieme al progetto più strettamente architettonico, la partecipazione della comunità al processo trasformativo. Il punto di partenza intellettuale del mio lavoro è William Morris, che con la fondazione della Society for the Protection of Ancient Buildings nel 1877 ha voluto interpretare gli edifici storici non tanto come pezzi da museo, ma come contesti socialmente attivi e culturalmente significativi per la vita quotidiana della comunità. Morris
2 – Affondi dalla superficie 143
ha definito l’agenda per la filosofia della riparazione sancita dalla Carta di Venezia e dall’ICOMOS, ma ha anche definito l’agenda per la comprensione del patrimonio come pratica materiale viva e socialmente vitale, che sostiene l’identità culturale attraverso il lavoro qualificato. Questa pratica di produzione interna alla comunità utilizza conoscenze tradizionali e materiali locali e vernacolari, e ha anticipato di un secolo l’attuale emergenza climatica. L’aspetto politico di questa filosofia del patrimonio è di estremo interesse poiché pone l’etica al centro dello sviluppo, delle specifiche e dell’uso dei materiali.
In un periodo di emergenza climatica, in cui i modelli finanziari sono sotto stress e gli impatti dell’economia globale colpiscono le comunità e le identità locali, la nostra risposta deve essere sia tecnica che culturale, economica ed etica.
Nel ridefinire la produttività in modo da assicurare benefici comunitari e ambientali, è possibile cercare opportunità per attivare il valore dei territori che occupiamo in un modo che sia radicale, capace di invertire le pratiche di sfruttamento e insostenibilità che un’economia basata sui combustibili fossili ha prodotto e allo stesso tempo comprensivo dell’ecologia di questi territori dove, all’interno del temine ecologia, includiamo anche le persone.
Il patrimonio e l’innovazione sostenibile sono parte della stessa questione: si tratta di capire come interpretare criticamente i mezzi di produzione e trasformazione del territorio a vantaggio della comunità e dell’ambiente. Se il carbonio e la cultura dello sviluppo sono inestricabilmente legati alla storia coloniale, è necessario mettere in discussione i presupposti che li legano alla luce dell’emergenza climatica, intesa
144
come nuovo contesto per la ricerca e il cambiamento. La riflessione sugli edifici e sul loro ruolo sta infatti cambiando. La comprensione delle conseguenze legate all’uso e l’abuso dell’energia ci porta a vedere con maggior consapevolezza che i materiali con cui costruiamo contribuiscono in modo massiccio al carico di carbonio che rilasciamo nell’atmosfera e al dannoso cambiamento climatico che questa e altre attività creano.
Dobbiamo partire dalle materie prime che utilizziamo, dal modo in cui vengono acquistate a livello locale ed etico, dal modo in cui vengono trasportate, lavorate, utilizzate e riutilizzate, riutilizzate di nuovo e reimpiegate. Se utilizziamo materiali estratti da risorse naturali, ciò ha un costo, non solo in termini di emissioni di carbonio, ma anche per gli habitat da cui queste materie vengono estratte e per le comunità che il processo di estrazione coinvolge, spesso con scarse ricompense. Realizzare i materiali a livello locale significa applicare nuove conoscenze tecniche a pratiche spesso tradizionali. Le canne, ad esempio, sono state utilizzate in contesti dove erano presenti zone umide, come Norfolk nel Regno Unito per la costruzione di tetti e di additivi alla calce per la costruzione di muri. Queste piante a crescita rapida non solo trattengono il carbonio, ma forniscono habitat preziosi, puliscono l’acqua in cui crescono e forniscono un contesto paesaggistico che è patrimonio delle comunità locali. Grazie a una scienza dei materiali intelligente, il potenziale tecnico dell’agricoltura delle zone umide (chiamata paludicoltura) può consentire di ottenere prodotti che rivaleggiano, e quindi possono sostituire il cemento in molte applicazioni. La sfida critica all’utilizzo delle biocrete prodotte localmente non è tecnica, ma piuttosto legata alla percezione. Alle per-
145
2 – Affondi dalla superficie
sone provenienti da contesti socio-economici difficili viene venduta l’idea che modernizzarsi, utilizzando materiali eurocentrici come il cemento, sia una questione di dignità e che l’edilizia regionale, indigena o vernacolare, come l’utilizzo della terra, del bambù, delle canne, di prodotti riciclati o di scarto dell’agricoltura, non sia progressista. Questo è vero in Nepal come in Veneto o a Norfolk.
Cambiare la percezione dell’uso dei sottoprodotti agricoli è una questione di comunicazione quanto di scienza dei materiali. Comprendere i biomateriali come parte del patrimonio e del futuro di un territorio può aiutare le comunità a ripensare il ruolo delle risorse e a contribuire attivamente alla costruzione non solo di strutture ma anche di identità. Solo così avremo la possibilità di trasformare in maniera realmente collettiva i luoghi in cui viviamo.
Un esempio di materiale da costruzione a base vegetale che assorbe il carbonio, crea edifici sani ed economici e può sostenere eticamente le comunità che raccolgono e lavorano la materia prima è Sugarcrete®, sviluppato da Ayati, Chandler e Gutierrez presso l’Università di East London con il supporto del nostro partner industriale Tate & Lyle Sugars.
La canna da zucchero è la coltura più abbondante al mondo. Il sottoprodotto fibroso dopo l’estrazione della linfa è chiamato bagassa, e viene utilizzato come biocarburante o convertito in etanolo, un biosostituto della benzina. In entrambi i casi, il carbonio che la canna a crescita rapida ha assorbito dall’aria durante la crescita viene rilasciato di nuovo nell’atmosfera, senza creare nuovo carbonio ma senza ridurlo. L’uso delle fibre in combinazione con leganti minerali come la calce può, se progettato utilizzando additivi minerali appositi,
146
fornire un biocalcestruzzo che blocca il carbonio, portare alla realizzazione di costruzioni più economiche e, attraverso la condivisione dei processi produttivi e dei dati relativi a Sugarcrete®, generare opportunità economiche per i piccoli produttori a livello globale. In contesto europeo, la canna da zucchero a crescita rapida può essere sostituita con piante a fibra lunga a crescita altrettanto rapida, come la typha, che cresce su terreni non adatti all’agricoltura ma coltivati come parte della bonifica delle zone umide. Possiamo immaginare che il suo impiego possa contribuire a preservare il valore patrimoniale del paesaggio, a ripristinare l’habitat e la biodiversità locale e a catturare grandi quantità di carbonio, fornendo al contempo flussi di reddito per i produttori locali nell’ambito di un’economia che considera il patrimonio paesaggistico e sociale come parte del processo di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico.
Questo progetto è spinto da un’urgenza che va oltre la semplice contabilizzazione del carbonio. Con gli interessi politici acquisiti che minano gli impegni di net zero citando l’accessibilità economica e l’impatto sui più poveri della società come motivazione per il business as usual, le conseguenze politiche sono significative quanto quelle climatiche. Coinvolgendo le comunità in azioni di trasformazione territoriale, sensibilizzandole sulla comprensione del valore economico, culturale, sanitario ed etico legato a una transizione ecologica verso sempre minori emissioni di carbonio, si riconosce che non «basta un villaggio per crescere un bambino», ma ci vuole anche un paesaggio. Se consideriamo il carbonio e la cultura come indivisibili, abbiamo la possibilità di affrontare collettivamente l’emergenza climatica.
2 – Affondi dalla superficie 147
Piattaforme condivise e progetti comuni
Vittoria Prisciandaro
Tra le urgenze di frontiera per sviluppare un progetto di collettività che risponda a quanto auspicato da GROUND posso segnalare alcune questioni legate alla mia esperienza: il carcere e la giustizia riparativa, il tema delle donne rifugiate e della demenza senile.
Carcere e giustizia riparativa. È quanto mai necessario trovare forme alternative al carcere. «Sia chi lo fa per ragioni umanitarie, sia chi lo fa per motivi di sicurezza sa che il carcere è uno strumento superato. Dobbiamo impegnarci per forme ed esperienze nuove. Le statistiche ci dicono che il 75% di chi è stato in carcere ci ritorna, il 90% non trova un lavoro
148
regolare. Senza contare la vicenda umana – suicidi, condizioni disumane – studi sociologici indipendenti ci dicono che dopo un periodo in carcere si dimenticano le ragioni per cui si sta dentro e si ragiona semplicemente sulle condizioni in cui si vive, trasformando i carnefici in vittime, persone che una volta scontata la pena non provano una doverosa volontà di riconciliazione, di risarcimento ma rancore nei confronti delle istituzioni che hanno sottratto loro la libertà e li hanno costretti a vivere in condizioni non umane». Sono le parole di Giannicola Sinisi, magistrato. L’ho incontrato perché sostiene un progetto della diocesi di Andria, affidata a un prete diocesano.
Il progetto diocesano Senza sbarre, attua la misura alternativa al carcere di comunità (Legge n. 354 del 26 luglio 1975). L’originalità del progetto è che le persone affidate sono rieducate collettivamente, reinserite socialmente insieme e non separatamente. C’è semilibertà, affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare. Il progetto ha come fondamento la creazione di una rete di sostegno, di ascolto e di accoglienza residenziale e semiresidenziale nel territorio di Andria, per persone sottoposte a provvedimento privativo o limitativo della libertà personale. Il casale contadino riadattato anche come centro per supportare il progetto è diventato un tarallificio, un laboratorio tecnico-agricolo che avvicina detenuti ed ex detenuti al mondo del lavoro.
Donne rifugiate. Richiamo a questo proposito l’esperienza Astalli. La cosa che mi ha colpito delle storie e degli incontri fatti in questi anni è la necessità di pensare a percorsi personalizzati di accompagnamento per donne accomunate dalla violenza del viaggio, con background molto diversi e con
2 – Affondi dalla superficie 149
un vissuto da condividere anche per un arricchimento delle comunità accoglienti che deve trovare i canali opportuni per essere valorizzato. Donne e mamme, di fatto educatrici in primis dei cittadini del domani.
Demenza senile. L’invecchiamento della popolazione, l’allungamento della vita media, la gestione della demenza senile, sono questioni sempre più diffuse. Almeno al Centro-sud le strutture specializzate sono pochissime. Esistono progetti della comunità che valorizzano questa (possibile) fase della vita? Quale sostegno alle famiglie?
Per evitare che la condivisione di queste e altre riflessioni risulti una chiacchierata elitaria tra pochi è necessario condividere esperienze possibili nei vari settori, che partano dalla base, frutto di amministrazioni illuminate, di progetti privati virtuosi. È necessario portare alla luce quanto già esiste per far emergere nuove realtà positive. Questo ci aiuterà a costruire piattaforme condivise per portare avanti progetti e battaglie comuni.
150

3

Infiltrazioni
152
Le infiltrazioni rimandano al movimento indefinito delle radici, alla capillarità dell’acqua, all’esplorazione invisibile di larve, funghi e insetti nelle profondità del suolo. Hanno la caratteristica di essere organizzate di volta in volta con enti o associazioni differenti, di avere un tema specifico, di mantenere un contatto forte e chiaro con la terra e chi la abita. Le infiltrazioni sono convegni, eventi, festival, progetti con sede a Villa Angaran San Giuseppe e hanno lo scopo di disseminare e ampliare le tematiche proposte da GROUND durante tutto il corso dell’anno. I temi, i contatti e i contenuti emersi durante le infiltrazioni hanno contribuito alla definizione del Social Forum. Con il tempo, nuove infiltrazioni continueranno con lentezza e costanza a diffondere e divulgare la sobria rievoluzione di GROUND.
153 3 – Infiltrazioni
Saperi e Sapori di Stagione
Saperi e Sapori di Stagione è un mercato agricolo pensato all’interno di Oltrevia – Scuola di Politiche, il primo laboratorio di impronta ambientale e socio-culturale in Veneto per ragazzi e ragazze under 30. L’attività rappresenta un momento di confronto e osservazione del rapporto tra produzione agro-alimentare e territorio, nell’idea di stimolare, attraverso il confronto con produttori locali, l’impegno civico e la consapevolezza nei confronti delle economie locali. L’evento è stato realizzato in collaborazione con otto aziende del territorio (Agricola da Schio, Arcugnano; Agricoltura Nardon, Zanè; Conca d’Oro, Bassano del Grappa; Le Marmellate di Rosi, Crosara; Fattoria Piovega, Primolano; Silahan Farm, Valrovina; Azienda agricola Col di Stella, Marostica; La Pachamama fattoria sociale, Marostica), e ha approfondito le opportunità e le criticità proprie di un settore fatto di estremi, in cui alla grande produzione si preferiscono le microeconomie, la costruzione di reti territoriali a corto o medio raggio, la sensibilizzazione nei confronti della sobrietà ambientale prima che del prodotto.
[6 maggio 2023]
Rassegna del gusto
Nella più ampia cornice di educazione alimentare e consumo critico proposta da Villa Angaran, e all’interno di un progetto di approfondimento sulla qualità alimentare della trattoria Todomodo, la Rassegna del gusto è stata costruita assieme alla rete locale di Slow Food, come prima occasione di una collaborazione che si vuole rendere costante, sia attraverso
154
eventi specifici che attraverso un approfondimento culturale sull’alimentazione che passa dai piatti cucinati ogni giorno. Si è deciso di partire dagli alpeggi del Nord-est, che diventano protagonisti di un racconto in quattro puntate che esplora piccole produzioni di eccellenza: i formaggi, il sidro, gli impasti, gli amari e i fermentati. Lontano dalle intenzioni delle sempre più popolari degustazioni commerciali, la rassegna mette alla prova il senso del gusto con consapevolezza: il riconoscimento di profumi e sapori apre riflessioni che parlano anche delle sfide legate alla tipicità e alla varietà stagionale di prodotti che cambiano annualmente e in conseguenza delle condizioni atmosferiche in cui sono realizzati.
[11 maggio, 25 maggio, 8 giugno e 22 giugno 2023]
Blank_
Blank_ è tante cose: un gruppo di persone, un festival residenziale in tre giornate aperto alla comunità, ma forse, più di tutto, è un processo di costruzione di momenti formali e informali di confronto e circolazione di pensiero sulla condizione giovanile. Da qui il nome, che risponde alla necessità di lasciare degli spazi vuoti, di salvaguardare l’apertura, di farsi dare un nome, non esaustivo né definitivo, da quantә incroceranno questi percorsi e movimenti.
Blank_ nasce all’interno di InPratica, percorso formativo e educativo coordinato dal Progetto Giovani di Bassano del Grappa in collaborazione con gli otto istituti superiori del bassanese, che ha coinvolto da novembre 2022 un gruppo di studentә che si sono occupatә durante l’anno dell’ideazione e organizzazione del festival. L’iniziativa, attraverso una parte residenziale rivolta a un gruppo di 25 giovani del
3 – Infiltrazioni 155
territorio e un denso programma di eventi, laboratori e attività aperti a tutta la comunità, si propone di affrontare con approccio partecipativo e dialettico i temi della cittadinanza di seconda generazione, della scuola e dell’identità. Il festival ha coinvolto partner quali Non Dalla Guerra – associazione di educazione alla pace –, Dalla Parte Giusta della Storia –rete nazionale per la promozione di una nuova cittadinanza – e Croce Rossa. Nello specifico, si sono realizzati: un laboratorio sul riconoscimento del diritto alla cittadinanza per italianə di seconda e terza generazione, una cena cittadina autoprodotta e multietnica, una flaviada collettiva sul tema del viaggio e delle migrazioni, un silent lab per la realizzazione di una traccia sulla scuola del futuro, un laboratorio teatrale e un’attività di sensibilizzazione su sessualità e identità, momenti musicali di rap, trap e dj set.
A conclusione del festival il gruppo organizzatore ha manifestato l’interesse a riproporre l’esperienza, continuando ad attivare giovani under 20 in azioni capillari, orizzontali di impegno civile e sviluppo di cittadinanza.
[dal 2 al 4 giugno 2023]
FeliceMente Fuori in Estate
Il centro estivo FeliceMente Fuori in Estate è un momento della proposta educativa per l’infanzia di Villa Angaran San Giuseppe: promuove l’outdoor education, l’esperienza non strutturata all’aria aperta e diverse attività formative di agricoltura, floricoltura, cura e scoperta dei processi ecosistemici. Il centro estivo ha due gruppi: 3-6 anni e 6-11 anni e coinvolge più di trenta bambini e bambine che con cadenza settimanale partecipano alla proposta, nei mesi di giugno
156
e luglio. L’attività estiva è parte di un progetto più ampio, FeliceMente Fuori, che si sviluppa durante tutto l’anno attraverso laboratori domenicali e la gestione del “Giocapanno”: una struttura che è anche presidio permanente per l’infanzia capace di garantire un rapporto quotidiano con la natura. Il parco di Villa Angaran, in questo senso, è inteso non come un supporto a servizio di un’attività occasionale, ma come un bene comune sempre disponibile, dove bambini e bambine possono trovare stimoli e proposte da svolgere in autonomia all’aria aperta. Frequentare la natura in città, comprendere l’importanza della sua presenza e accessibilità, intenderla come luogo di formazione oltre che di svago è indispensabile per sensibilizzare i cittadini e le cittadine di domani al valore dei beni ecosistemici come risorsa indispensabile alla collettività.
[giugno e luglio di ogni anno]
Urban Jungle Angarangan
Giornata di inaugurazione e apertura alla città della nuova “piazza verde” sita nel parco nord di Villa Angaran San Giuseppe: un ettaro di terreno rigenerato grazie al progetto Urban Jungle Angarangan nel periodo 2021-2023. Il parco ha un’area di 11 mila metri quadri, è di forma trapezoidale e il perimetro è percorso da un anello pedonale di 400 m accessibile a carrozzine e a persone con limitata capacità motoria. Il parco è caratterizzato da un’area boschiva con circa 300 nuovi esemplari arborei, un brolo agricolo diviso da un viale di carpini di impianto monumentale, percorsi sensoriali e zona laboratoriale con erbe aromatiche, una pedana lignea circolare immersa tra gli alberi per incontri e convegni.
3 – Infiltrazioni 157
Nella giornata del 21 giugno 2023 diversi enti e associazioni hanno collaborato all’apertura del parco con un ricco programma di eventi e laboratori dal mattino alla sera. Il parco è stato simbolicamente offerto alla città con un momento di taglio del nastro, a cui Bassano ha partecipato in via istituzionale (sindaco, azienda sanitaria, parrocchia) e in forma di rappresentanza civile: oltre 100 bambini e bambine dei centri estivi, associazioni del territorio, vicinato. Il parco sarà gestito in condivisione con il quartiere Angarano in un’ottica di cura collettiva di un bene comune: il primo impegno concreto, semplice ma condiviso, è stata la presa in carico dell’amministrazione pubblica dei cestini dei rifiuti per i visitatori, che saranno posizionati all’esterno del parco (in area pubblica) e che saranno gestiti dal quartiere.
[21 giugno 2023]
Dietro il paesaggio – stati generali
della letteratura in Veneto
Dal 23 al 25 giugno in Villa Angaran San Giuseppe ha preso vita la prima edizione di Dietro il paesaggio – stati generali della letteratura in Veneto, evento organizzato dalla scuola di scrittura ri-creativa Alba Pratalia e Rete Pictor, in collaborazione con Libreria Palazzo Roberti, Biblioteca Civica di Bassano del Grappa, Grafiche Tassotti, con il patrocinio della Regione Veneto e dell’Assessorato alla Cultura della Città di Bassano e con il contributo di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank. Nei tre giorni di evento la direzione artistica, com-
158
posta da Paolo Malaguti, Alberto Trentin ed Enrico Zarpellon e coordinata da Tommaso Zorzi, ha proposto eventi, tavole rotonde, spettacoli e seminari che indagassero a che punto è e dove sta andando la letteratura in Veneto.
A partire dalla situazione e dalle suggestioni del suo paesaggio, sospeso tra grandi miti del passato recente e le sollecitazioni contraddittorie del presente. Il Veneto è una delle regioni in Italia e in Europa con la maggiore vivacità letteraria, sia sul fronte della lettura che sul fronte della scrittura, dell’editoria e della riflessione accademica. Gli stati generali della letteratura in Veneto hanno provato a coinvolgere tutti gli attori della filiera del libro e tutte le persone con la passione per la lettura. Gli stati generali non sono stati una vetrina né un’autocelebrazione identitaria e localistica, ma un’occasione di incontro, confronto critico e immaginazione condivisa, ponendosi un’importante domanda sul valore civico e sulla funzione che la letteratura riveste sullo sviluppo di un pensiero critico verso il paesaggio, il territorio e l’ambiente circostante. L’evento ha visto la collaborazione di 30 esperti (docenti, scrittori, editori, divulgatori) e di circa 1000 partecipanti, tra l’evento inaugurale con Andrea Pennacchi e i 15 appuntamenti di formazione, divulgazione, confronto sulle differenti tematiche dell’evento.
[dal 23 al 25 giugno 2023]
inTREEcciamo live
inTREEcciamo live è un ciclo di tre concerti all’interno del parco di Villa Angaran San Giuseppe. I concerti fanno parte della campagna di sensibilizzazione relativa al crowdfunding inTREEcciamo il cui scopo è quello di raccogliere fondi per il pagamento delle opere di riqualificazione sostenute in villa,
3 – Infiltrazioni 159
attraverso l’adozione di uno dei 300 esemplari arborei del nuovo parco Nord. Gli artisti che si sono esibiti, con un concerto di circa 90 minuti in orario aperitivo, hanno invitato il pubblico a aderire a inTREEcciamo e hanno barattato il loro compenso con l’adozione di un arbusto del parco.
[19 luglio, 26 luglio e 2 agosto 2023]
La timidezza delle chiome
Residenza artistica in villa del collettivo Genet (formato dalle tre fotografe Sara Lando, Sara Guarracino, Floriana Riccio) sul tema del bosco di comunità. Le tre artiste hanno convissuto e lavorato in villa, per costruire assieme un’esposizione artistica inaugurata nel corso di GROUND Social Forum, con vernissage sabato 16 settembre 2023. Il nome Genet è stato creato appositamente per l’occasione: in ecologia, il genet è un organismo che inizia la propria vita come zigote unicellulare e che dà poi origine a un organismo modulare che si accresce fino a formare una struttura ramificata, complessa e difficilmente prevedibile. Ogni modulo da solo non può condurre un’esistenza indipendente.
Il nome della residenza (timidezza delle chiome) è ispirato al fenomeno di crown shyness secondo cui le chiome di alcuni alberi si modellano in modo che non si tocchino tra di loro. La condivisione dello spazio è una conversazione costante in cui conflitto e cooperazione concorrono a fare di piante, animali, microrganismi e uomini un bosco. In questa residenza d’artista il collettivo Genet ha indagato nel contesto di parco Nord le interdipendenze e le relazioni che intercorrono tra tutte le entità che ruotano attorno a questo spazio nascente.
[dal 29 luglio al 2 agosto 2022]
160
Scrib *Scrib Fest!
Scrib *Scrib Fest! è l’unica infiltrazione che ha preso vita dopo il Social Forum, come segno che GROUND è un processo che è destinato a continuare fin da subito. Il festival è dedicato al mondo dell’illustrazione e del fumetto, dall’infanzia all’età adulta, con talk, workshop e una mostra collettiva di 28 illustratori e fumettisti, nel parco di Villa Angaran San Giuseppe. Il tema dell’illustrazione si inserisce nell’ampia discussione di GROUND, in quanto costituisce (negli ultimi dieci anni come mai prima) un potente strumento per affrontare tematiche complesse, sociali e civili. Tra il proliferare di social legati alle immagini e la crescita impressionante del mercato delle graphic novel, l’illustrazione è una forma di comunicazione, divulgazione, formazione sempre più efficace e riconosciuta e poter dedicare uno spazio in Villa Angaran a questo linguaggio, a metà tra l’arte e lo storytelling, ci aiuta a ragionare sulle forme di comunicazione e diffusione di temi vari, complicati, intrecciati e non immediati che GROUND sta cercando di far arrivare a più persone possibile.
[14 e 15 ottobre 2023]
Stra-bordi
Stra-bordi è un’attività di formazione gratuita per docenti, educatori, operatori dei servizi organizzata da Adelante e Università Iuav di Venezia, e vuole costruire azioni di riappropriazione spaziale per una città giusta, sana e sostenibile. Il corso è suddiviso in quattro moduli chiamati “interpretare”, “progettare”, “agire”, “raccontare”, intesi come momenti di scoperta ed elaborazione collettiva.
3 – Infiltrazioni 161
Nella parte didattica sono presentati e discussi temi di salubrità ambientale, resistenza al cambiamento climatico, diritto alla città e benessere nello spazio. Attraverso esempi lontani e vicini vengono discusse le buone pratiche, gli strumenti e i progetti che costruiscono una città resiliente e accessibile. I laboratori permettono ai partecipanti di costruire percorsi formativi di osservazione critica dell’ambiente che ci circonda, per capire cosa può essere ripensato in ottica sostenibile. In ambito scolastico, per esempio, si osservano le pertinenze scolastiche e periscolastiche con alunni e alunne di tutte le età scolari, per immaginare spazi meno motorizzati, che favoriscano il pedone e l’incontro. Situare i bisogni, le criticità e i desideri di ragazze e ragazzi permette di rileggere lo spazio della scuola non più come pertinenza tecnica ma come luogo in cui è possibile condividere molto più della semplice ricreazione. Azioni di urbanistica tattica sono parte del percorso di codesign che, a esperienza conclusa, viene raccontato all’amministrazione comunale con l’intento di portare alla politica le istanze delle giovani generazioni. Lo scopo è anche quello di aumentare la consapevolezza che agire per trasformare la città è possibile, e che riappropriarsi di piccole porzioni di città (a partire dalle infrastrutture collettive) significa creare un beneficio che va ben oltre l’oggetto scolastico.
[da maggio 2023 a maggio 2024]
162

notizie su autori e autrici
Altissimo Adriano
CEO e responsabile R&D, Landlab srl
Bartolini Stefano professore associato di economia politica, Università di Siena
Benasayag Miguel filosofo e psicanalista, Università nazionale di Avellaneda (Argentina)
Bertin Mattia
ricercatore in urbanistica, Università Iuav di Venezia
Chandler Alan
professore di architettura, University of East London, direttore dello studio Arts Lettres Techniques (UK)
De Marchi Marta
ricercatrice in urbanistica, Università Iuav di Venezia
Franz Gianfranco
professore ordinario di politiche per la sostenibilità e lo sviluppo locale, Università di Ferrara
Franzese Alessia
assegnista di ricerca in urbanistica, Università Iuav di Venezia
Galli Jacopo
ricercatore in composizione architettonica e urbana, Università Iuav di Venezia
Granata Elena
professoressa associata di urbanistica, Politecnico di Milano
Lando Sara fotografa freelance, Papermoustache
Lo Giudice Marco educatore, cooperativa Adelante
Olivetti Manoukian Franca sociologa, direttrice studio APS Milano
Pace Michela
ricercatrice in urbanistica, Università Iuav di Venezia
164
Pase Andrea professore ordinario di geografia storica, Università degli Studi di Padova
Pasqui Gabriele professore ordinario di politiche urbane, Politecnico di Milano
Pomiato Alice digital content creator, aliceful
Pozzi Anna giornalista e saggista, fondazione PIME ONLUS
Prisciandaro Vittoria giornalista e editrice, edizioni San Paolo
Provantini Katia psicologa, istituto Minotauro Milano
Ruiz Sánchez Javier professore ordinario di urbanistica, Universidad Politécnica de Madrid (Spagna)
Sfriso Simone architetto, cofondatore di studio TAMassociati
Svalduz Elena professoressa associata di storia dell’architettura, Università degli Studi di Padova
Sudiro Cristina direttrice scientifica e manager R&D, Landlab srl
Tosi Maria Chiara professoressa ordinaria in urbanistica, Università Iuav di Venezia
Velo Luca ricercatore in urbanistica, Università Iuav di Venezia
Vives Antoni i Tomàs scrittore, politico, consulente London School of Economics (UK), già vicesindaco di Barcellona (Spagna)
Zorzi Tommaso progettista Rete Pictor, dottorando in lettere, Universidad de Castilla-La Mancha (Spagna)
4 – Appendice 165
nota alle immagini di Chiara Filippin
Nel leggere i testi di questo libro, per illustrarli, ho sentito l’eco di un conflitto tra uomo e pianeta terra. Da una parte la natura, l’ambiente, con le sue infinite specie. Dall’altra l’Homo, un’unica specie, con il suo bisogno di fare. Ho scelto quindi di evidenziare questi opposti: l’impronta di tutto ciò che noi chiamiamo natura, nella sua infinita complessità, dipinta di verde, il colore che per eccellenza le abbiniamo; e la specie Homo, sola nel suo antropocentrismo. Per introdurre gli articolati discorsi della commissione scientifica, ho voluto togliere e semplificare: quindi ho preso una foglia di quercia e la mano umana, che si fronteggiano. La quercia, simbolo antico di regalità e misticismo, la pianta per eccellenza. E l’impronta dell’essere umano. Per concludere un augurio: foglia e mano si uniscono, nella speranza di una collaborazione.
febbraio 2023
stampato da Digital Team, Fano

GROUND è un’agitazione collettiva.
GROUND nasce dall’esigenza di una rievoluzione che superi i concetti della sostenibilità. GROUND sostiene la generazione di un nuovo abitare in equilibrio. GROUND è un libro-manifesto che raccoglie alcune delle penne più interessanti in Italia ed Europa, è stato scritto durante un Social Forum residenziale a Bassano del Grappa nel settembre 2023, mescolando professioni, saperi e culture. GROUND vuole contaminare: invialo, copialo, diffondilo.
9 791259 530592
Anteferma Edizioni € 18,00


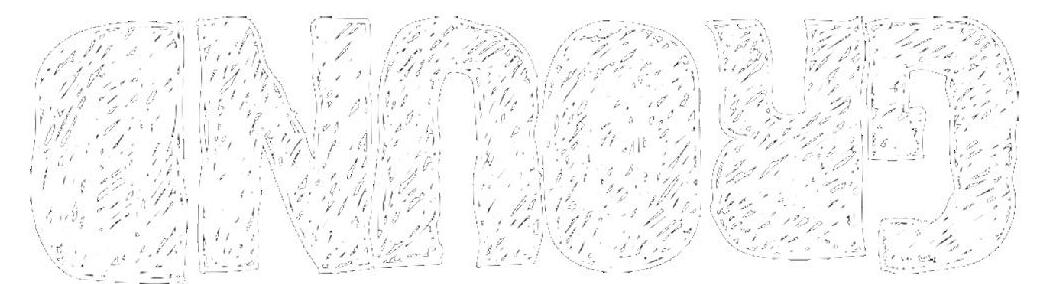 immaginare agire fare la rievoluzione
immaginare agire fare la rievoluzione