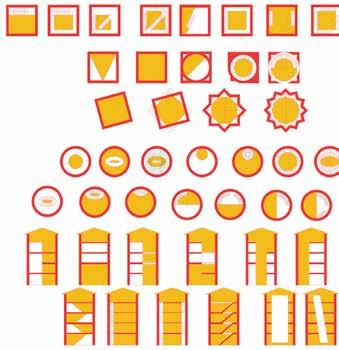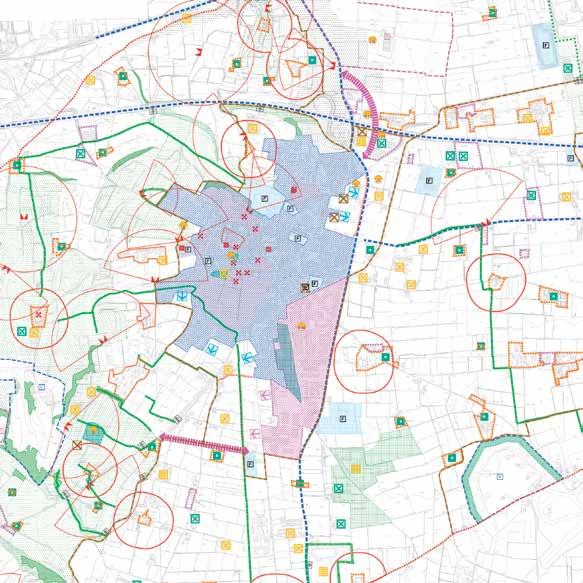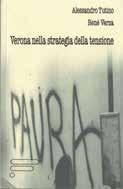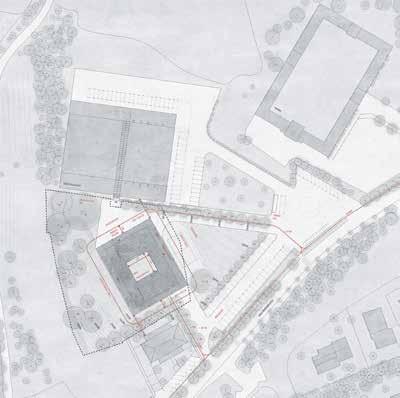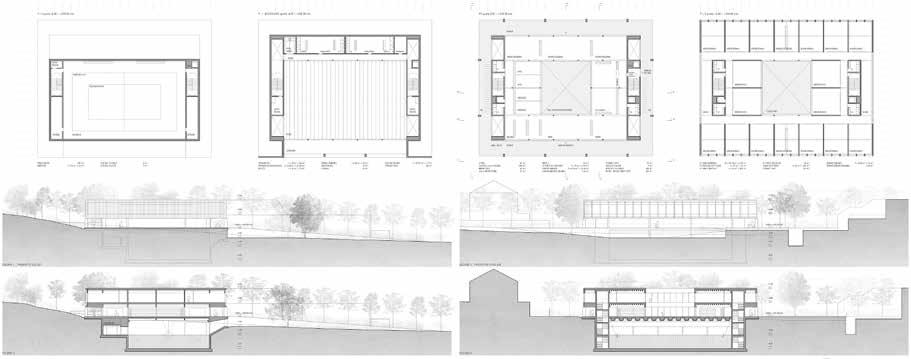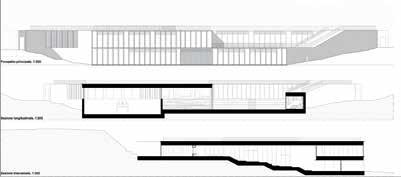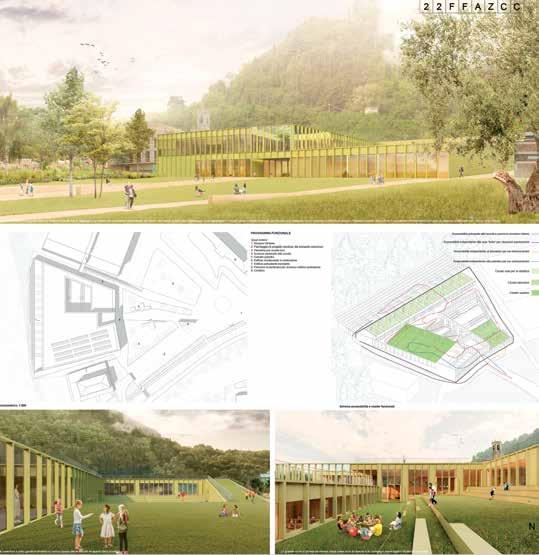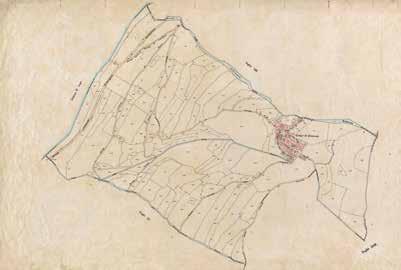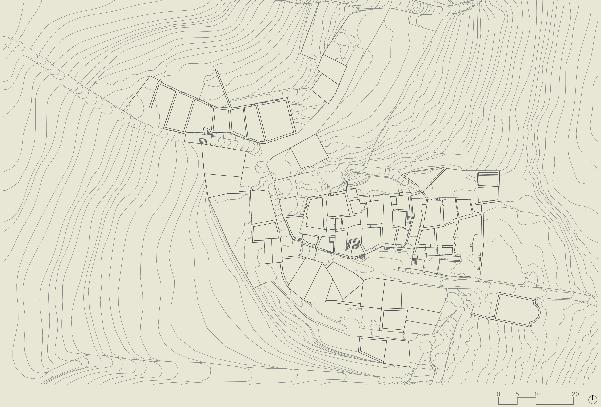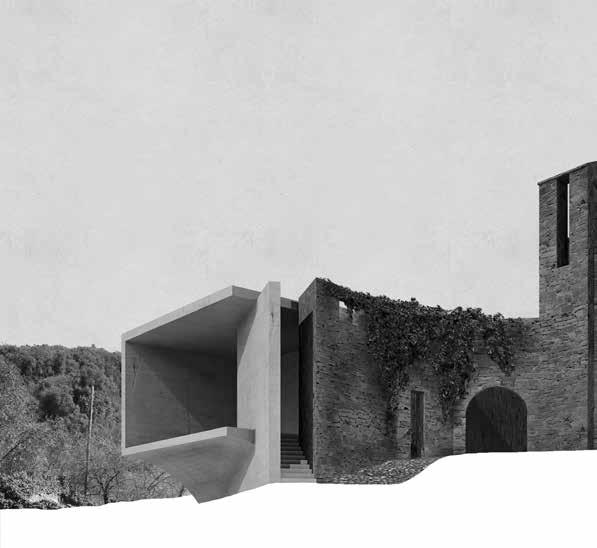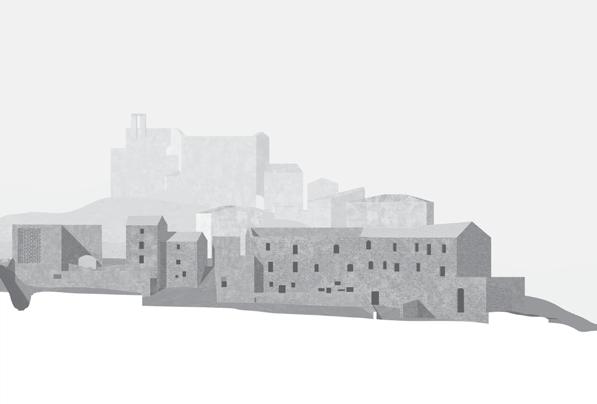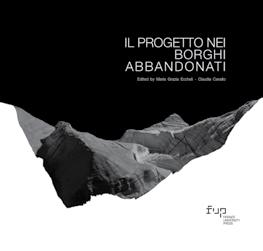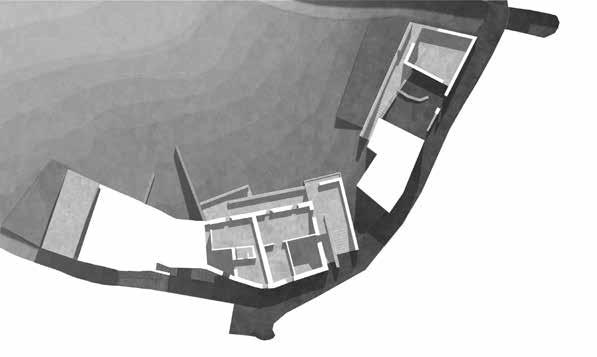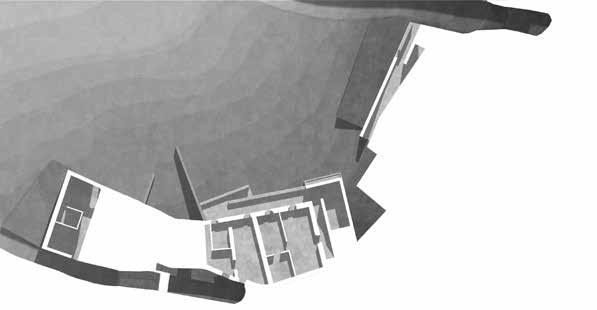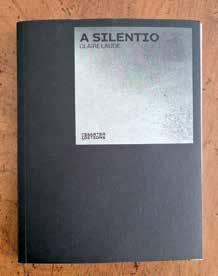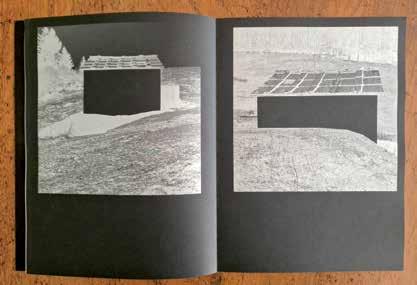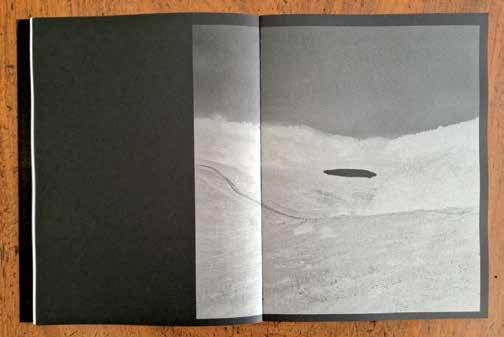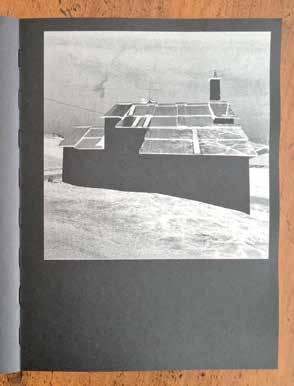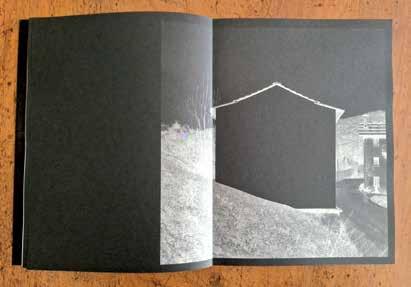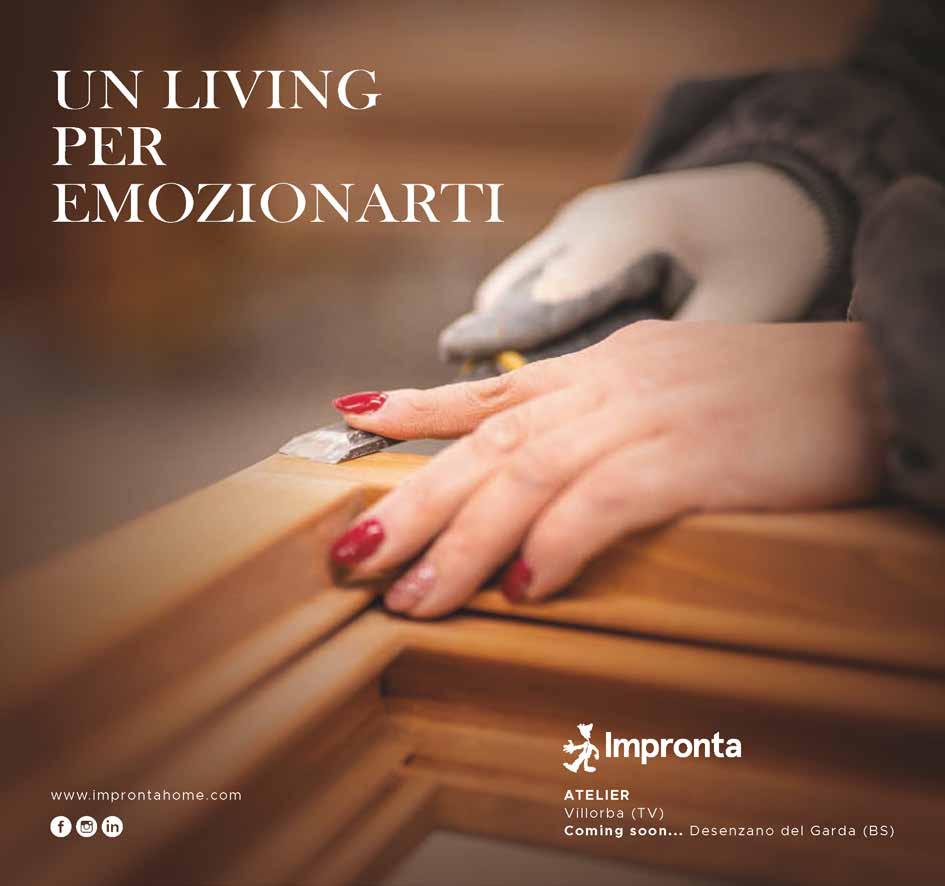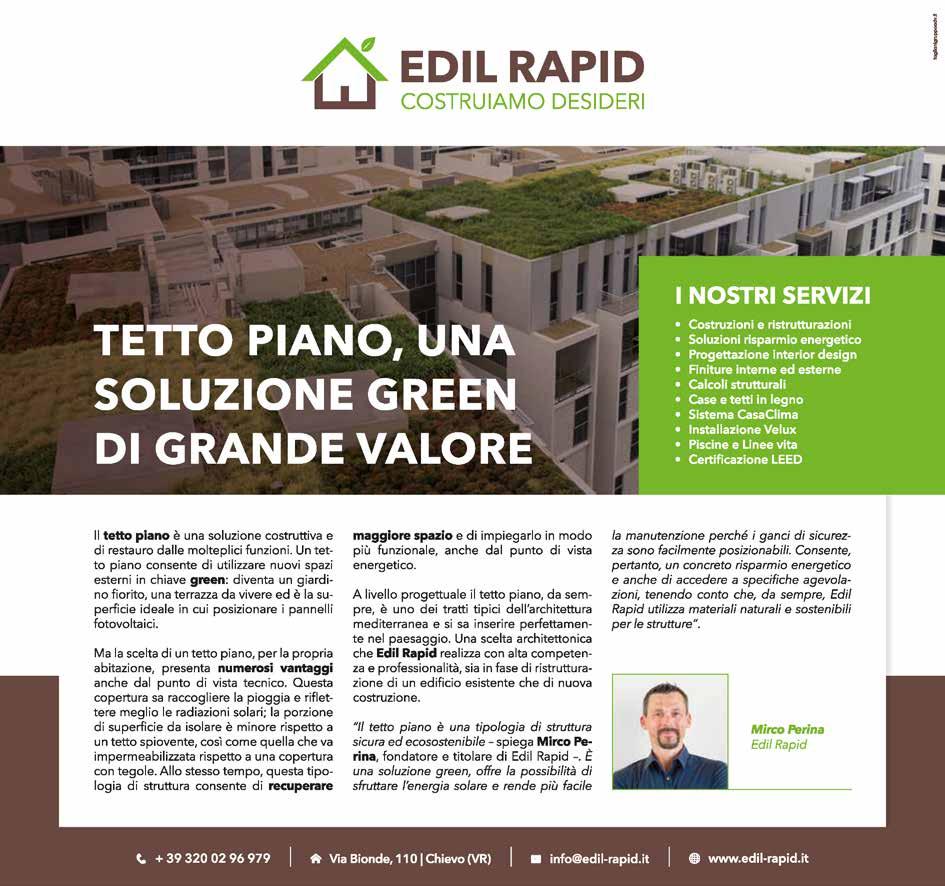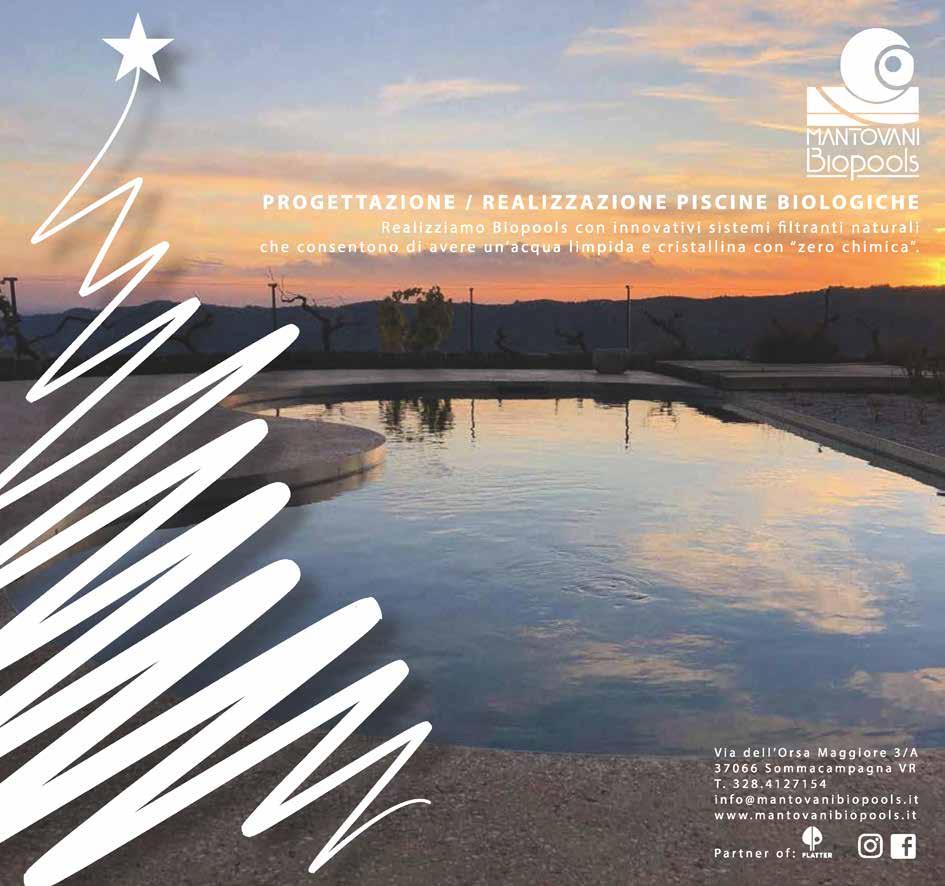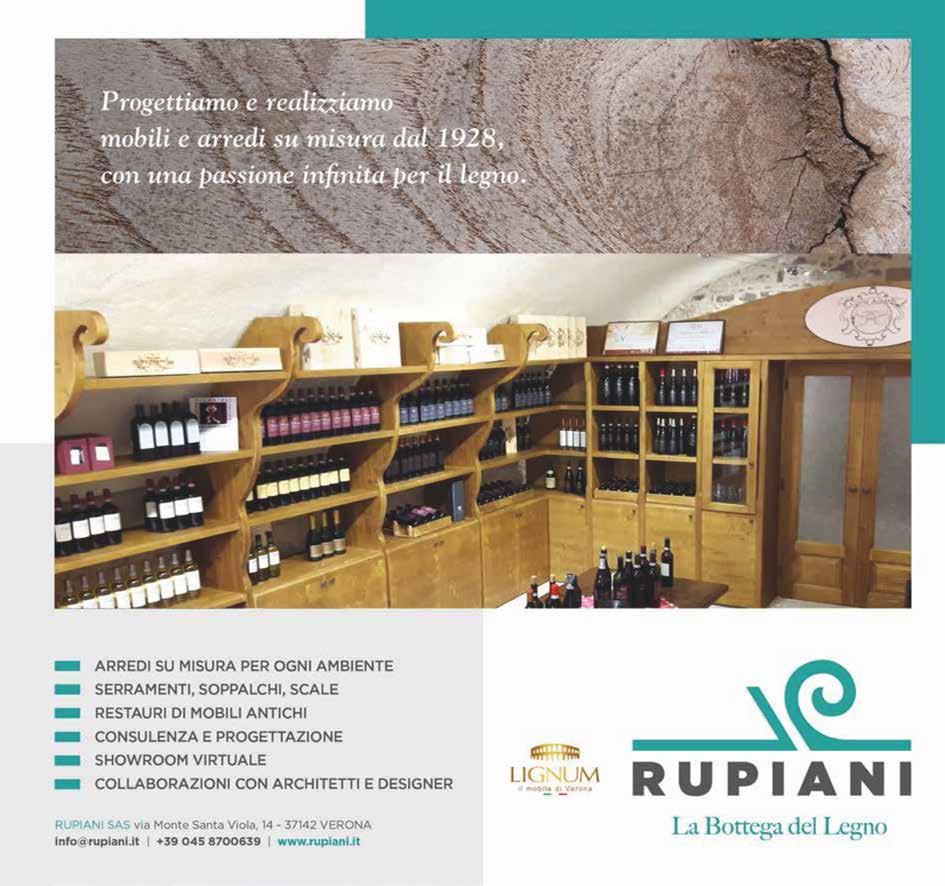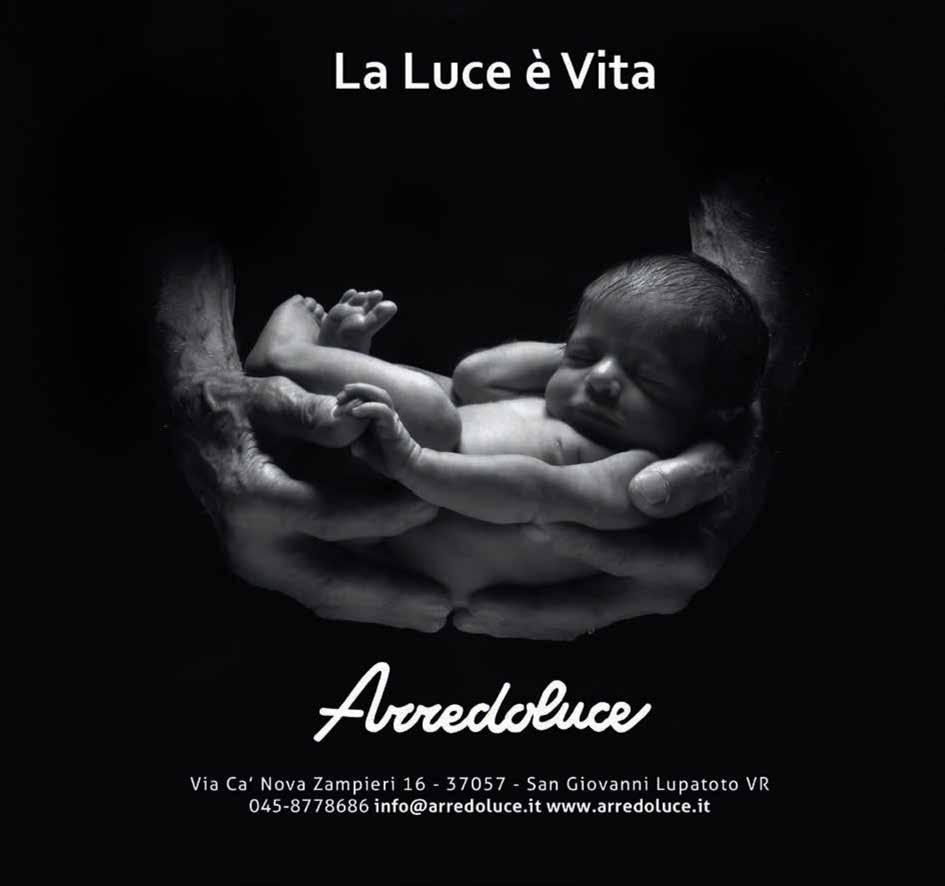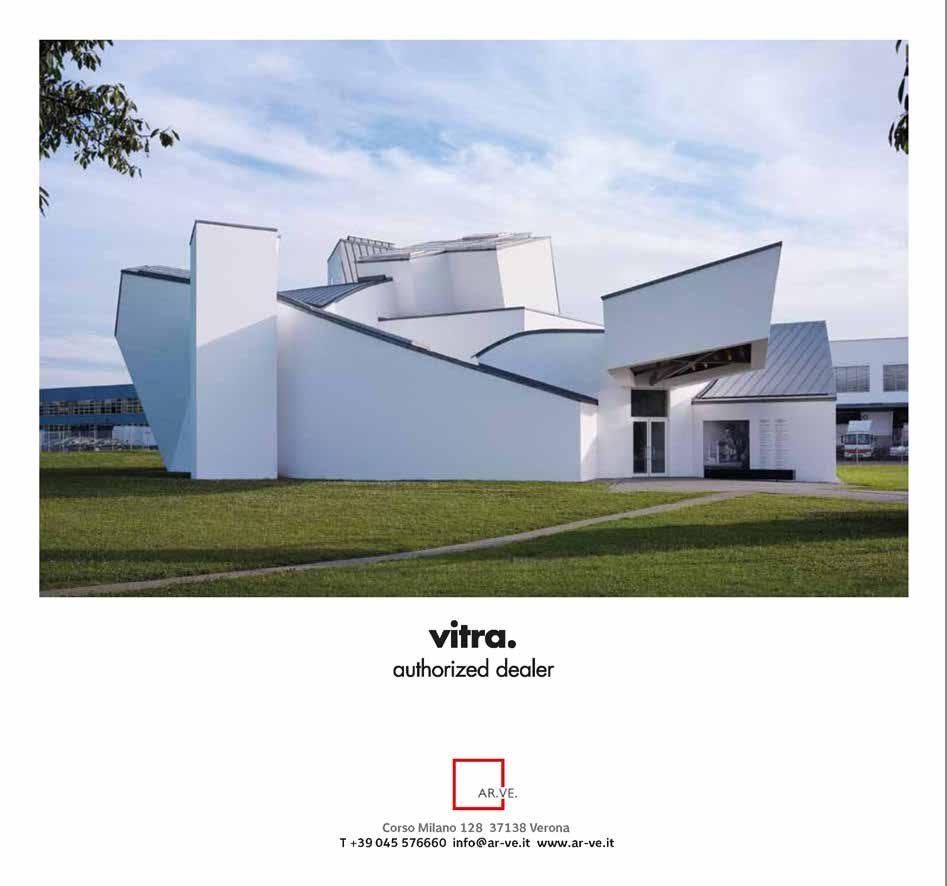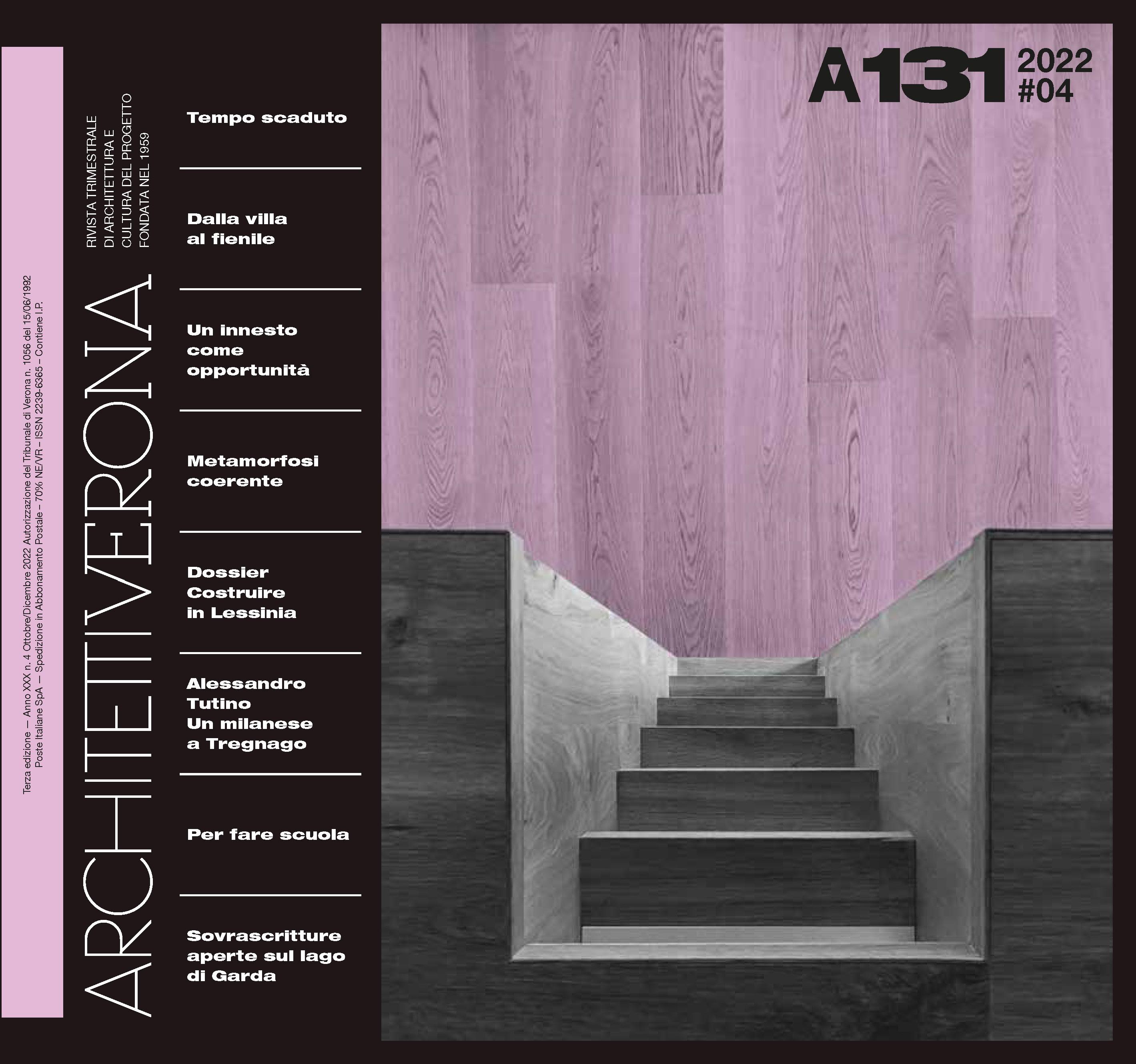
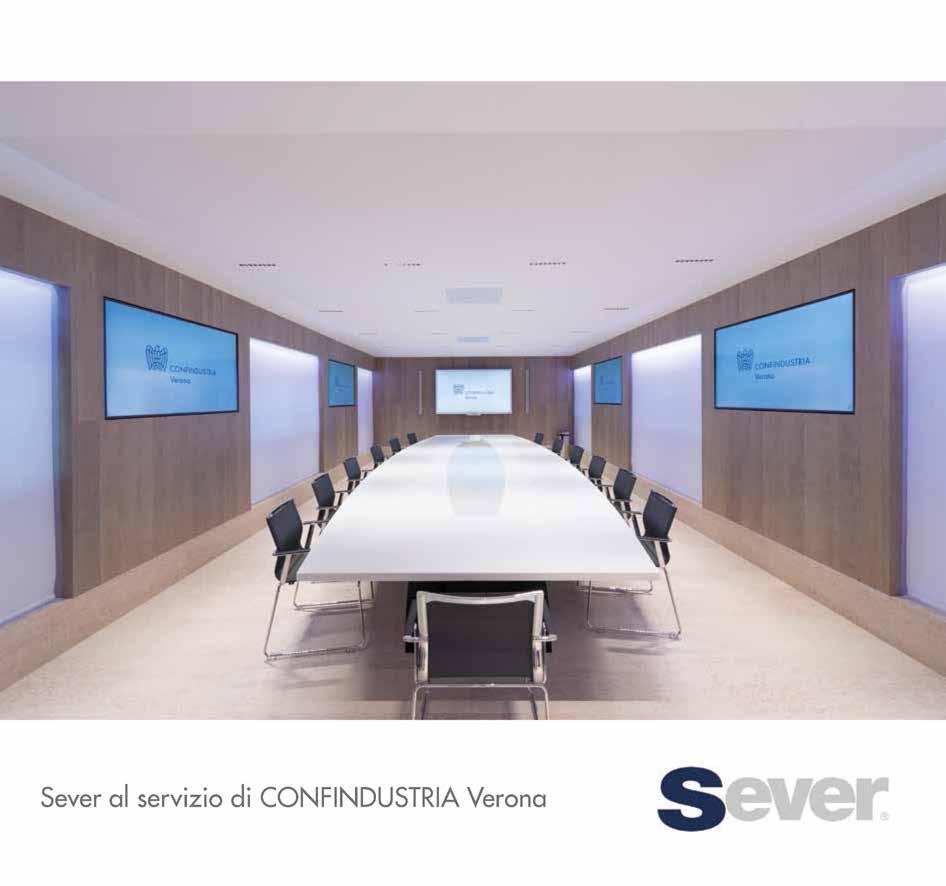
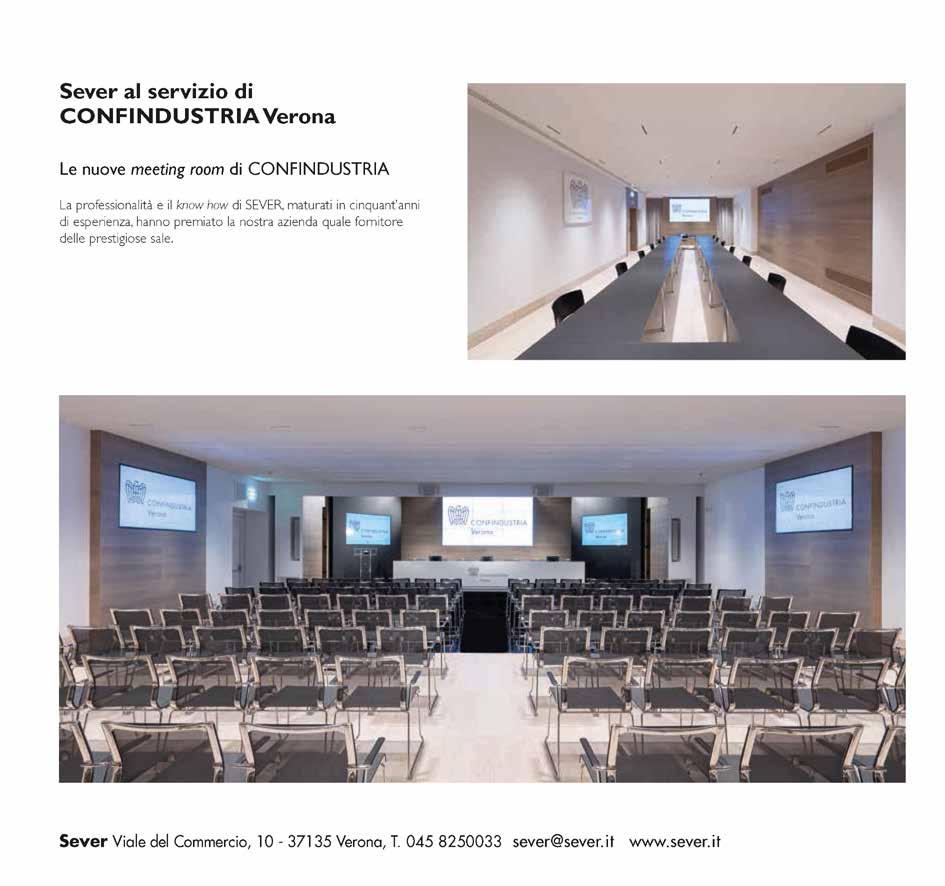






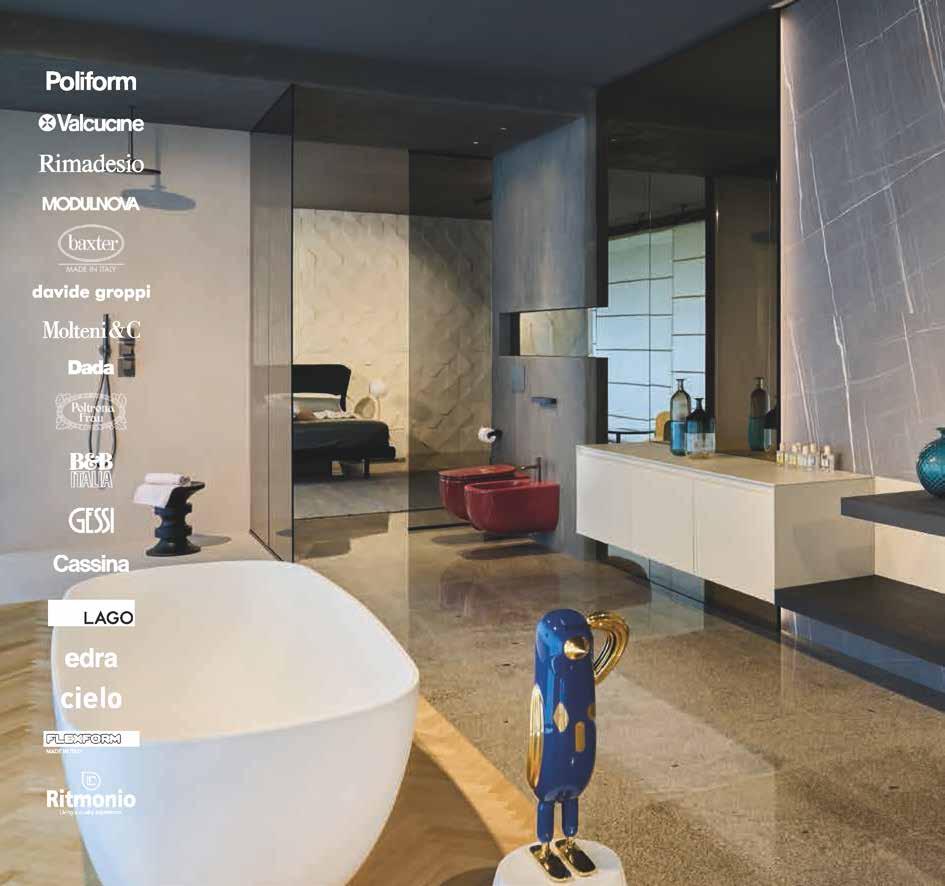

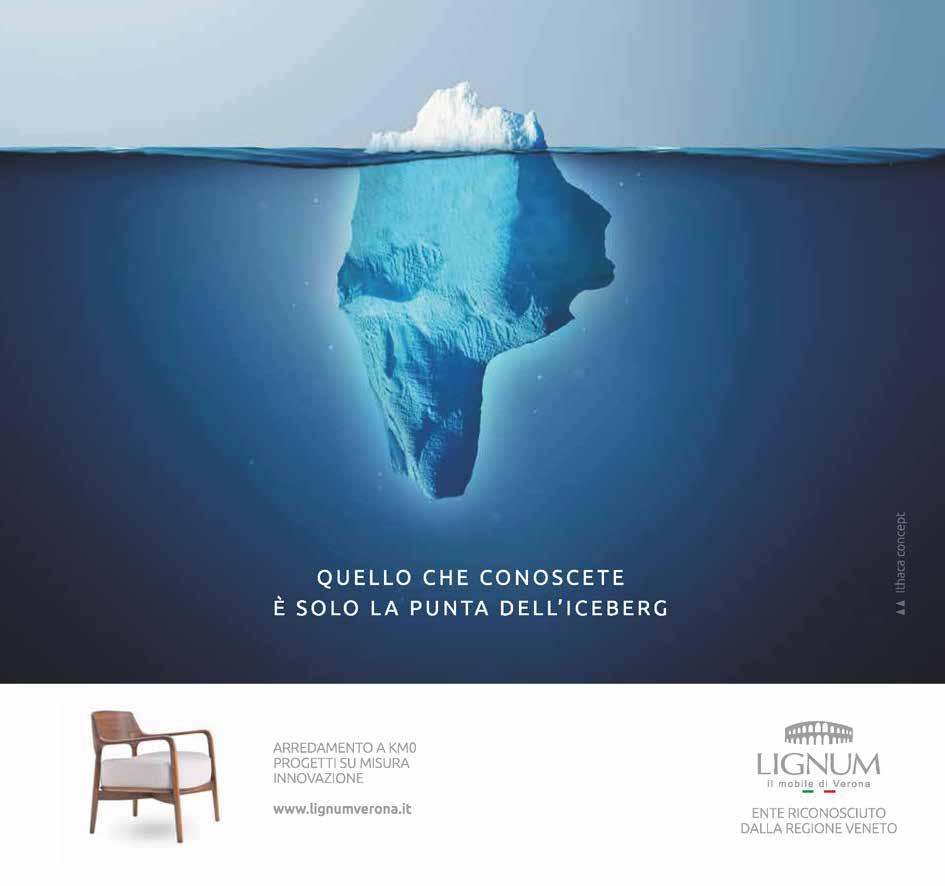








CONSIGLIO DELL’ORDINE
•
Presidente Matteo Faustini
•
VicePresidenti Paola Bonuzzi Cesare Benedetti
• Segretario Chiara Tenca
• Tesoriere Leonardo Modenese
• Consiglieri
Andrea Alban, Michele De Mori, Andrea Galliazzo, Roberta Organo, Fabio Pasqualini, Francesca Piantavigna, Leopoldo Tinazzi, Paola Tosi, Enrico Savoia, Alberto Vignolo
Rivista trimestrale di architettura e cultura del progetto fondata nel 1959 Terza edizione • anno XXX n. 4 • Ottobre/Dicembre 2022
rivista.architettiverona.it
DIRETTORE RESPONSABILE
Matteo Faustini
EDITORE
Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona Via Santa Teresa 2 — 37135 Verona T. 045 8034959 — F. 045 592319 architetti@verona.archiworld.it
https://architettiverona.it/rivista/
DIRETTORE Alberto Vignolo
REDAZIONE
Federica Guerra, Angela Lion, Luisella Zeri, Damiano Capuzzo, Filippo Romano, Leopoldo Tinazzi, Laura Bonadiman, Giorgia Negri, Marzia Guastella, Nicolò Olivieri, Giulia Biondani, Federico Morati, Ilaria Sartori rivista@architettiverona.it
DISTRIBUZIONE
La rivista è distribuita gratuitamente agli iscritti all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona e a quanti ne facciano richiesta all’indirizzo https://architettiverona.it/distribuzione/
CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER LA PUBBLICITÀ
Cierre Grafica Paolo Pavan: T. 348 530 2853 info@promoprintverona.it
STAMPA
Cierre Grafica www.cierrenet.it
L’etichetta FSC ® garantisce che il materiale utilizzato per questa pubblicazione proviene da fonti gestite in maniera responsabile e da altre fonti controllate.
ART DIRECTION, DESIGN & ILLUSTRATION
Happycentro www.happycentro.it
CONTRIBUTI A QUESTO NUMERO
Anna Braioni, Claudia Cavallo, Luciano Cenna, Federico Maria Cetrangolo, Bertilla Ferro, Alberto Ghezzi y Alvarez, Beatrice Graziani, Vincenzo Latina, Michela Morgante, Vincenzo Pavan, Guido Pigozzi, Paolo Righetti
CONTRIBUTI FOTOGRAFICI
Lorenzo Linthout, Marco Toté
SI RINGRAZIANO
Federico Padovani, Federica Provoli, Davide Turrini
Gli articoli e le note firmate esprimono l’opinione degli autori, e non impegnano l’editore e la redazione del periodico. La rivista è aperta a quanti, architetti e non, intendano offrire la loro collaborazione. La riproduzione di testi e immagini è consentita citando la fonte.
19
131









022 EDITORIALE Tempo scaduto di Alberto Vignolo 026 PROGETTO Dalla villa al fienile di Giorgia Negri 036 PROGETTO Un innesto come opportunità di Filippo Romano 044 PROGETTO Metamorfosi coerente di Damiano Capuzzo 050 PROGETTO Materia ritrovata di Angela Lion 054 INTERIORS Riflessi litici di Beatrice Graziani 057 INTERIORS In the closet di Leopoldo Tinazzi 060 INTERIORS A bella posta di Federico Morati 2022 #04
DOSSIER Costruire in Lessinia 064




DOSSIER Conservare l’architettura rurale e il paesaggio di Vincenzo Pavan 066
DOSSIER
Una Lessinia contemporanea: proposte nel cassetto di Alberto Vignolo
071
DOSSIER
Il quadro delle tutele tra paesaggio e beni monumentali di Federico Maria Cetrangolo 072
DOSSIER Amministrare l’architettura rurale di Federica Guerra 075
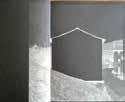


DOSSIER
Fragilità e interventi progettuali in Lessinia di Guido Pigozzi

077
DOSSIER Architettura e memoria storica dei luoghi di Paolo Righetti 081
DOSSIER Ri-costruzione della Torre Colombara di Gorgusello di Vincenzo Latina 86

ODEON Un milanese a Tregnago di Michela Morgante
090
ODEON Per Alessandro di Anna Braioni 092
ODEON
Una architetto come Presidente di Bertilla Ferro 093
ODEON Polpette e altro alla Rotonda frigorifera di Luciano Cenna 094 ODEON Fabbricare urbanità di Giulia Biondani

096
ODEON Per fare scuola di Alberto Vignolo 102

QUASI ARCHITETTI Sovrascritture aperte sul lago di Garda di Claudia Cavallo
106
QUASI ARCHITETTI Il progetto nei borghi abbandonati di Alberto Ghezzi y Alvarez 108
PORTFOLIO Claire Laude: un silenzio lessinico
21
062
131
Tempo scaduto
Potrebbe sembrare una fissazione, una mania o un cruccio, sì: da tempo questa rivista coltiva una sana curiosità intellettuale, e diremmo anche una passione, per Villa Girasole, la casa rotante di Marcellise. Non è cosa del resto che possa stupire: stiamo parlando di un unicum assoluto, un’architettura bizzarra e geniale, ieratica e dinamica al tempo stesso, misconosciuta e celeberrima, che arricchisce con la sua defilata eccentricità il novero delle meglio architetture del Novecento veronese.
Su queste basi, ci possiamo compiacere di essere riusciti a organizzare nell’ormai lontano 2008 una memorabile e affollata visita,
grazie alla cortesia del compianto Aurelio Galfetti (cfr. «AV» 82, pp. 100-105). La Villa appariva allora un tantino fanée ma sostanzialmente integra, completa di tutto punto dei suoi arredi fissi – si fa per dire – e mobili. E poi ancora, nel 2015 ci fu il nostro contributo all’esposizione sulla “poetica della macchina” di Villa Girasole, assieme agli amici ingegneri, con una approfondita campagna fotografica attraverso la quale, rivedendo oggi gli scatti, emergono già i segni di una accelerazione del degrado, tra le pareti degli spazi oramai svuotati (cfr. «AV» 101, pp. 66-69).
Nel tempo ci sono pervenute anche numerose richieste di informazioni circa l’eventualità di avere accesso alla Villa, come se gli architetti veronesi ne fossero i custodi putativi, grazie alla potenza della rete che ha fatto assommare i nostri articoli a quelli storici sul manufatto e alla bella pubblicazione del 2006 curata dallo storico statunitense dell’architettura Kenneth Frampton, allora docente presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio. Mentre infatti il mito di Villa Girasole continuava a circolare, l’opera in se, rimasta muta, silente e a questo punto statica nella bella valle di Marcellise punteggiata di ciliegi, era oggetto di un intricato destino.


La figlia del geniale creatore della villa, l’ingegner Angelo Invernizzi – nativo di Marcellise, che aveva fatto fortuna con la sua impresa di costruzioni attiva a Genova e che nel borgo natale volle realizzare il suo sogno di una casa rotante – per tramandare l’opera e garantirle un futuro aveva creato una Fondazione intitolata al padre e alla madre Lina, che era svizzera (ecco il motivo della fase elvetica della vicenda e del passaggio per Mendrisio). A un certo punto però, questa fondazione passa dall’Università svizzera alla Fondazione Cariverona: una sorta di ritorno a casa che doveva essere
foriero di azioni finalmente concrete verso un restauro della Villa e un ripensamento sul suo destino. In realtà, si apre in questo frangente una fase controversa, con l’alienazione dei terreni contermini alla villa e della corte quattrocentesca ricompresa nel perimetro del suo parco. Se ciò non bastasse, nei medesimi anni si inaspriscono i fenomeni di degrado anche strutturale, con un dissesto del terreno che ha portato alla formazione di numerose fessurazioni nella parte basamentale, quella su cui poggia la porzione rotante.
Di recente gli attuali vertici della Fondazione Il Girasole sono riusciti
22
Testo: Alberto Vignolo
01
Foto: Lorenzo Linthout
2022 #04
Su Villa Girasole, la più celebre architettura del Novecento veronese a livello internazionale, occorre uscire dal silenzio che la avvolge per “far girare” contributi e riflessioni sul suo destino
meritoriamente a ricomporre l’unità tra architettura e luogo, giungendo alla revoca della vendita della corte. Tutte queste vicende hanno di fatto rinviato ogni necessaria azione a favore del manufatto, investito tra l’altro dal fortunale dell’estate 2020 che ha causato non pochi danni. Saranno necessari analisi e studi approfonditi sullo stato attuale del bene prima di ogni ipotesi progettuale, questo è evidente: ma è altrettanto vero che il quasi assoluto silenzio attorno al futuro della Villa non giova. A romperlo ha provato l’amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo, entro il cui territorio siede Marcellise, ma una sorta di rivendicazione
« Stiamo parlando di un unicum assoluto, un’architettura bizzarra e geniale, ieratica e dinamica al tempo stesso, misconosciuta e celeberrima »


di appartenenza locale, quasi di quartiere, non sembra del tutto consona al suo valore universale. A lungo «AV» ha cercato di smuovere le acque, nel tentativo quanto meno di “far girare” idee e riflessioni sul Girasole e sul suo destino. Gli interrogativi infatti non mancano: che farne? E prima ancora, quale recupero per un’architettura così singolare? Una domanda su tutte: il movimento rotatorio oggi bloccato deve essere ripristinato, o va piuttosto considerato una “lacuna” all’interno di un processo di conservazione? Un ripristino “dove girava come girava” rischia di essere anacronistico: che
senso avrebbe infatti per i potenziali visitatori un andamento rotatorio lento e quasi impercettibile, di fronte all’ebbrezza di un qualsiasi ottovolante in un parco a tema? Senza mettere in campo opere di “restauro” devastanti e onerosissime – come quelle che hanno interessato la Stazione Frigorifera ai Magazzini Generali, per fare un esempio calzante – a raccontare la genialità della casa rotante si potranno utilizzare tutti i mezzi che la tecnologia mette a disposizione, dalle animazioni 3d alla realtà aumentata. E si potrà senz’altro fare un grande e accurato modello in scala adeguata, con il movimento rotatorio e i fondali con le simulazioni del giorno e della notte e dell’alternarsi delle stagioni, come fosse un orologio astrale. E a Natale ci si potranno pure mettere d’attorno le statuine del presepe coi pastorelli della Lessinia: aspettando che qualche Re Magio faccia sosta a onorare la gloriosa storia del Girasole. •
01-03. Alcuni frammenti visivi colti da Lorenzo Linthout nella campagna fotografica su Villa Girasole del 2015.
23
131
02 03
 Malga Podestaria. Cfr. pp. 66-71 (foto di Federico Padovani).
Malga Podestaria. Cfr. pp. 66-71 (foto di Federico Padovani).

Dalla villa al fienile
Un progetto di recupero condotto nel corso degli anni ha interessato le varie parti di una villa di campagna e dei suoi annessi rustici recuperati a uso abitativo e ricettivo

2022 #04 PROGETTO
01
Progetto: Rubinelli Studio
Testo: Giorgia Negri
San Pietro di Lavagno
A pochi chilometri da Verona, lontano dal traffico e dalla vita frenetica cittadina, la Val di Mezzane offre soluzioni abitative e ricettive immerse nelle colline, vere e proprie oasi di pace circondate da distese di vigneti e vegetazione rigogliosa. In tale contesto paesaggistico, poco distante dal centro di San Pietro di Lavagno, si insediava a partire dal 1600 una prestigiosa villa di campagna con annessi alcuni fabbricati di servizio a scopo agricolo, disposti a formare un cortile rettangolare chiuso su tre lati. La villa fronteggia a nord la strada principale, mentre a sud affaccia sulla grande aia, i vigneti di proprietà e il paesaggio collinare. L’accesso alla proprietà è regolato da due ingressi: l’originario ingresso principale sul lato ovest della villa, enfatizzato da una costruzione a torre che costituisce una sorta di “vestibolo” voltato, con un grande portale ad arco a tutto sesto affacciato verso il cortile; l’ingresso principale odierno, a circa 100 metri più a est dalla villa, un tempo considerato l’accesso diretto ai terreni di proprietà. I fabbricati di servizio, in parte a destinazione agricola e in parte residenziale, furono costruiti progressivamente a partire dalla prima metà del XIX secolo; questi si sviluppano lungo il lato ovest del cortile a partire da un corpo porticato a nord collegato al vestibolo di ingresso, e terminano con un edificio adibito a stalla e fienile sul lato corto a sud. Negli ultimi anni il complesso ha perso la sua vocazione agricola a favore di una destinazione d’uso prevalentemente residenziale e una piccola parte ad uso ricettivo. La transizione si compie gradualmente, con una prima fase che vede lo Studio Rubinelli impegnato nella ristrutturazione e la ridistribuzione del layout della villa padronale, ricavandone sette appartamenti; a distanza di circa vent’anni anni, durante i quali cresce e si consolida la stima della committenza nei confronti dei progettisti, inizia il recupero e la conversione in spazi abitativi dei fabbricati a destinazione agricola e la trasformazione del fienile in una country house ad uso ricettivo. L’idea della committenza era di ricavare quattro grandi appartamenti dai fabbricati collocati a nord e ovest del cortile, da destinare a locazioni di media-lunga durata, e recuperare il fienile per insediarvi una piccola locazione turistica (4 camere) per brevi periodi.
01. Veduta aerea del complesso comprendente la villa e gli annessi rustici.


02. Planimetria d’insieme.
03. Veduta dal cortile interno verso la villa e il fabbricato nord.
04. Il fronte del fabbricato ovest sul cortile interno.

131 27
03
02 04
05. Le ceramiche decorative colorate e il distintivo lampadario a stella caratterizzano servizi igienici degli appartamenti.
06. I colori chiari scelti per le finiture interne enfatizzano gli elementi strutturali conservati.
07. Il ferro è utilizzato sia per gli elementi strutturali e architettonici (scala, travi e serramenti) sia per l’arredo.




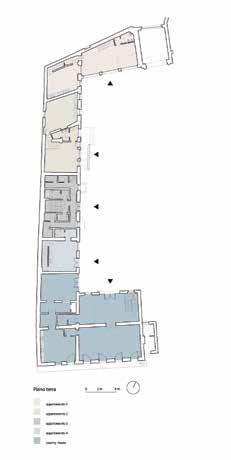
08. Layout distributivo degli appartamenti e della country house
L’approccio progettuale è prettamente conservativo e propedeutico a mantenere intatta la lettura tipologica dell’antico podere nella sua interezza. Le strutture verticali sono state interamente recuperate grazie a interventi di consolidamento puntuali, come l’inserimento di tiranti in acciaio nelle murature, così come la maggior parte delle coperture, costituite da grandi capriate in legno massiccio e manti in tavelle originali in cotto lasciate a vista; dove non c’erano le condizioni favorevoli al recupero degli elementi strutturali, come nel caso della maggior parte dei solai intermedi, le scelte progettuali sono rimaste coerenti alle tipologie costruttive e ai materiali originali. I nuovi solai e i soppalchi sono stati ricostruiti in travi di legno e assito mantenendoli a vista, mentre è stato possibile recuperare e consolidare un solo solaio nel fabbricato a nord,

2022 #04 PROGETTO 28
06 08 07 05
fienile
Dalla villa al
09
il quale rappresenta il soppalco della zona giorno di un alloggio.
Le forometrie esistenti dei prospetti e le relative cornici in pietra e mattoni non sono state modificate, fatta eccezione per il fienile, dove le finestre del prospetto sud sono state convertite in porte vetrate per favorire la vista sul paesaggio esterno e l’accesso al giardino con piscina. Tutte le aperture, esistenti e di progetto, sono classificate secondo una gerarchia dettata dai materiali utilizzati: il legno per le finestre con una funzione principalmente di servizio, il ferro per la realizzazione dei grandi serramenti ad arco al piano terra a chiusura dei portici e per i serramenti esposti a sud della country house che incorniciano il paesaggio.
Il ferro rappresenta un materiale chiave del progetto, utilizzato non solo per i serramenti considerati
09. La scala come elemento funzionale e di arredo, disegnata e realizzata artigianalmente.


10. Intervento di consolidamento strutturale della copertura realizzato mediante nuove capriate in ferro, tamponate con vetri per contribuire all’isolamento di vani differenti.
11. Uno dei bagni caratterizzato dalle ceramiche decorative colorate.

131 29
10 11
12. Piante piani terra e primo della country house
13. La struttura lignea originale della copertura del fienile è mantenuta a vista, così come i mattoni del pilastro centrale. 14. L’ingresso a doppia altezza
della country house con la pavimentazione in cotto e il grande lampadario a stella.
15. La scala in ferro su disegno.
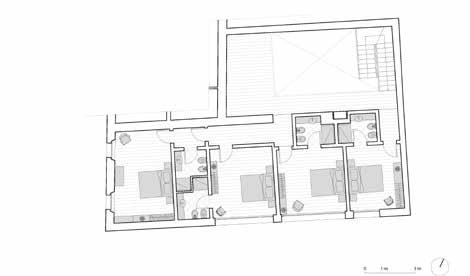
16. Spaccato assonometrico della country house



2022 #04 PROGETTO 30
13
14
12
Dalla villa al fienile
più “nobili”, ma anche plasmato in elementi strutturali, architettonici e di arredo che diventano protagonisti del recupero. Il ferro utilizzato per la scala e il parapetto del ballatoio affacciato sull’ingresso della country house rende immediatamente riconoscibile il nuovo da ciò che è esistente; lo stesso materiale e approccio viene adottato per gli alloggi, nei quali è possibile trovare scale con costruzione analoga alla precedente, ma anche elementi strutturali di consolidamento come capriate e travi in acciaio o, ancora, elementi funzionali e di arredo fissi come una libreria che, allo stesso tempo, assolve anche la funzione di parapetto. Nonostante la country house e gli appartamenti siano destinati alla locazione a terzi, la proprietà non ha rinunciato a soluzioni tecniche e impiantistiche all’avanguardia, finiture di qualità ed elementi d’ar-
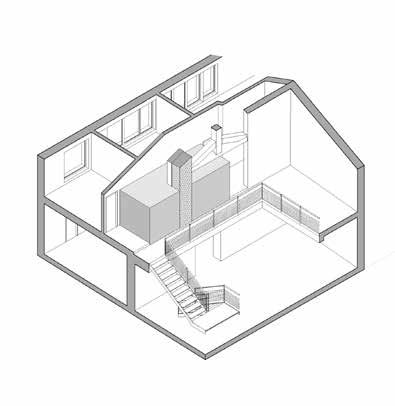
redo pregiati. Gli interni, in particolare, sono frutto di una sinergia nata tra i progettisti e la committenza, la quale tiene in modo particolare a curare personalmente l’arredo e la scelta di oggetti e tessuti decorativi.
Le scelte dei colori delle finiture interne sono dunque chiari, con il fine di creare degli spazi dallo sfondo “neutro” atti a ricevere qualsiasi tipologia di arredo e, allo stesso tempo, creano contrasto con gli elementi strutturali conservati e mantenuti a vista come i solai in cotto delle coperture e le capriate in legno. Tuttavia, vi sono alcune differenze nella scelta dei materiali utilizzati per la country house e agli appartamenti, nel primo caso più mirati a enfatizzare l’aspetto rustico del fabbricato. Per gli ambienti delle zone giorno ai piani terra degli appartamenti si è optato per una pavimentazione in pietra bianca
COMMITTENTE
Privato
PROGETTO ARCHITETTONICO Rubinelli studio ing. Gaetano Rubinelli arch. Leonardo Cabianca arch. Mattia De Marchi arch. Olimpia Rubinelli
COLLABORATORI arch. Maria Giulia da Sacco (paesaggista) dott. Nicola Padovani Asrar Nassar
IMPRESE E FORNITORI
Impresa Edile Zantedeschi Davide (opere edili), Secco sistemi (infissi metallici), Carpeneterie metalliche Tommasini (opere in ferro), Falegnameria Zanetti (cucine e arredi), Pauletti (rivestimenti e pavimento in legno), Fornace Polirone (pavimenti in cotto)

CRONOLOGIA
Progetto e realizzazione: settembre 2016-febbraio 2022
131 31
16 15
17.
18. Nelle camere gli arredi su disegno sono arricchiti da ulteriori mobili, oggetti
19.
e
17
con venature grigie, dall’aspetto elegante e delicato; il piano terra della country house viene invece trattato diversamente, utilizzando una pavimentazione più rustica in cotto che richiama quella esistente dell’aia.

Le zone notte delle residenze, collocate al piano superiore, sono finite con un caldo parquet in rovere, mentre le ceramiche dei servizi igienici, scelte personalmente dalla committenza con colori e decori sempre differenti, conferiscono personalità agli appartamenti; anche per le camere della country house viene scelto un parquet, mentre i colori e i decori delle ceramiche per i bagni sono decisamente più neutri e i rivestimenti ridotti allo stretto necessario (doccia, retro lavabo).



A completamento degli spazi ricopre un ruolo importante l’illuminazione, anche in questo caso occasione di confronto tra progettisti e committenza.
L’illuminazione di base degli ambienti, data principalmente dall’installazione di applique murali, viene arricchita da numerosi lampadari sospesi dalla forma a stella, di fattura artigianale; realizzati in metallo e vetro e con dimensioni differenti a seconda degli ambienti, rappresentano indubbiamente un elemento emblematico e distintivo del progetto.
All’esterno, i tre fabbricati sono distinti dalla scelta di finiture differenti: per il corpo a nord, nobilitato dai tre grandi archi delportico originale in conci di tufo bugnato, viene scelto un marmorino bianco; il lungo edificio a ovest, più semplice e privo di elementi decorativi, viene finito con un intonachino grigio, mentre la country house presenta un intonaco più grezzo costituito da inerti più grossolani, arricchito di ossidi sulla facciata rivolta a sud per conferirgli una colorazione simile a quella originale del fienile.
2022 #04 PROGETTO 32
Ceramiche e decori più sobri per i bagni della country house
tessuti scelti dalla committenza.
Le aperture originali del fienile diventano dei grandi serramenti che incorniciano il paesaggio.
19
18
« L’approccio progettuale è prettamente conservativo e propedeutico a mantenere intatta la lettura tipologica dell’antico podere nella sua interezza »
Dalla villa al fienile
RUBINELLI STUDIO
Rubinelli Studio è guidato dall’ingegnere Gaetano Rubinelli e dall’architetto Olimpia Rubinelli. Un sodalizio intergenerazionale, supportato e integrato dagli architetti Mattia de Marchi e Leonardo Cabianca, orientato principalmente al restauro e al recupero architettonico, sia in contesti storici di pregio che in ambito residenziale e rurale, con un’attenzione peculiare per il recupero di immobili dismessi e per la progettazione architettonica degli interni, capace di coniugare il ricorso a soluzioni innovative con l’utilizzo di materiali tradizionali e di recupero.


20
L’approccio conservativo si manifesta anche nel progetto degli spazi esterni, che comprende l’intervento di consolidamento statico dell’aia, l’ampliamento dell’aiuola centrale e la sistemazione delle pavimentazioni e dei cordoli del cortile, utilizzando materiali di recupero del sito. Lo spazio esterno pertinenziale alla country house è stato invece completamente riprogettato con la collaborazione dell’architetto paesaggista Maria Giulia Da Sacco, ed è costituito da un grande giardino terrazzato su due livelli, a distinguere due aree funzionali: una più ludica con la piscina, alla quota inferiore, e una più tranquilla e riservata a stretto contatto con la natura alla quota superiore. Particolare attenzione è stata riservata alla scelta delle essenze che arricchiscono il giardino e contribuiscono alla privacy degli ospiti. •
20. La sala per le colazioni degli ospiti al piano terra con vista sul giardino e sulla piscina.
21. Controcampo sulla vetrata di ingresso alla country house

131 33
21

2022 #04 PROGETTO 34 Dalla villa al fienile



131 35 22. Il fronte dell’ex fienile affacciato sul giardino con la piscina. 23. Un accostamento materico nel giardino. 24. Il fienile nello stato antecedente al recupero. 22 24 23
Un innesto come opportunità
Il recupero di un fabbricato in pietra posto ai margini del borgo di Avesa rappresenta per il progettista l’occasione di una rilettura contemporanea dell’edificio per un abitare più vicino alle esigenze del nostro tempo
Progetto: arch. Marco Buonadonna Testo: Filippo Romano Foto: Lorenzo Linthout

2022 #04 PROGETTO
01
Verona
Avesa è un piccolo borgo del comune di Verona, situata in linea d’aria a soli tre chilometri dal centro cittadino. Il suo nome deriva probabilmente da aves, o meglio falda acquifera, a testimonianza del legame che questo territorio ha instaurato con la sorgente carsica che alimenta il Lorí, un piccolo fiumicello di pochi chilometri che sfocia nel bacino dell’Adige: “Rì di Avesa”, talvolta accompagnato dall’articolo, “il Rì”, o nella forma più antica “lo Rì” (cfr. Corrà G., 2002).
La presenza dell’acqua nella vallata ha rappresentato una valenza fondamentale per l’antropizzazione e il successivo sviluppo socio-economico dell’area, diventando un’importante risorsa di approvvigionamento di acque potabili già nei primi insediamenti della città di Verona. Anche la tradizionale attività delle lavandare è strettamente legata all’ac-
getto dello studio OAMB di Marco
Buonadonna merita, per intelligenza e carattere, una considerazione nel panorama degli interventi finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio. Il lotto si trova fra il tessuto urbano veronese e il centro storico di Avesa, in prossimità del cimitero, in un’area dove gli edifici si diradano e lasciano spazio al paesaggio coltivato. Realizzato a completamento di un contesto edilizio più antico, l’edificio venne costruito in aderenza all’attiguo fabbricato sul lato nord: un corpo di fabbrica regolare sviluppato su due livelli, caratterizzato da paramenti murari in pietra tufacea provenienti dalle cave di Avesa e da strutture lignee che costituivano gli impalcati dei solai e la copertura. L’intervento ha preservato sia la sagoma sia le strutture dell’edificio, liberando completamente gli spazi
01. Veduta ravvicinata del nuovo volume annesso all’edificio storico: l’ombra degli alberi proiettata sul rivestimento in acciaio brunito.
02. Planimetria generale con evidenziato in grigio l’intervento.

03. Veduta del prospetto est: l’edificato originale in pietra e l’innesto.

«
Il piccolo volume annesso alla facciata sud ha offerto lo spunto per una nuova riflessione tipologica sul tema dell’addizione »
qua del Lorì: proprio sulle sue sponde, all’inizio dell’Ottocento, si recavano a lavare i panni per conto della borghesia cittadina, diventando nel tempo il primo servizio moderno nel territorio che, attraverso un’organizzazione per lo più familiare, si occupava di raccolta, pulizia e consegna della biancheria. All’interno di una corte rurale dove un tempo scorreva il Lorì, il recente recupero di una residenza privata porta alla luce la memoria storica di un manufatto edilizio dei primi del Novecento. Questo piccolo pro-
131 37
03
02
04. Disegni del prospetto est e della sezione trasversale.
05. Piante dei piani primo e terreno.
06. Il volume e le aperture verso lo spazio verde esterno.
07. Schizzo di studio del nuovo volume.
interni, prima definiti da una distribuzione tradizionale e privi di alcun valore storico-artistico. Trattandosi di una committenza privata, la richiesta riguardava la restituzione di un’abitazione, dotata di una zona giorno aperta al piano terra e una zona notte con due stanze da letto al piano primo, capace di interpretare lo spazio necessario per una famiglia contemporanea. Nella definizione del progetto prevalgono due caratteri apparentemente contrastanti: se da un lato l’approccio sembra mostrarsi a tratti conservativo, quasi a voler rievocare la storia e preservarne il ricordo portando a nudo le strutture dell’involucro edilizio, dall’altro il piccolo volume annesso alla facciata est ha offerto lo spunto per una nuova riflessione tipologica sul tema dell’addizione. Questa superfetazione, realizzata probabilmente negli anni Settanta come disbrigo domestico, diventa di fatto uno degli aspetti centrali del progetto, e rappresenta il tentativo di instaurare un nuovo dialogo tra addizione e preesistenza, attraverso un compromesso linguistico che possa evitare sia l’indifferenza sia il mimetismo.
Il nuovo volume, dichiarato come piccola architettura, re-identifica i caratteri e le forme precedenti: le lamiere di acciaio brunito rivestono interamente le superfici, conferendo a questo elemento un aspetto contemporaneo e stabilendo una nuova gerarchia di ruoli all’interno del progetto. Le facciate in pietra a vista, ripulite dagli intonaci, esaltano il contrasto fra il manufatto novecentesco e il nuovo corpo edilizio, il quale, staccandosi dalle facciate, diventa una figura indipendente all’interno del progetto. All’interno, questo spazio ospita la cucina dell’abitazione e assume le sembianze di una stanza totalmente bianca in stretto rapporto con lo spazio esterno, dove le grandi aperture offrono una vista a tutto tondo del giardino.
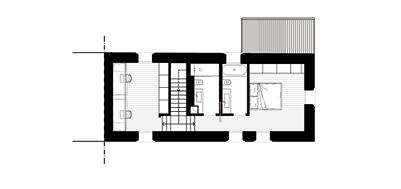


Occorre sottolineare come le trame ben disegnate della pavimentazione in pietra che costeggia l’abitazione offrano una nuova soglia di connessione fra gli ambienti interni e l’esterno dell’edificio, dove un ampio spazio a verde accoglie la ricca vegetazione ed un’area dedicata alla piscina. Oltre agli interventi di conservazione e ripristino di strutture e materiali,
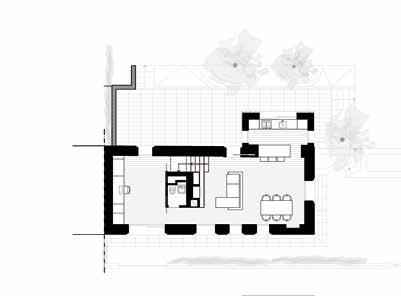
2022 #04 PROGETTO 38 05
04
Un innesto come opportunità
COMMITTENTE
Privato
PROGETTO ARCHITETTONICO E DIREZIONE LAVORI arch. Marco Buonadonna
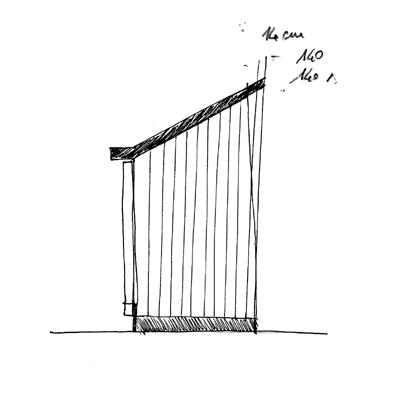
COLLABORATORI interior designer Paola Salatino
CONSULENTI ing. Enrico Magagna (progetto e D.L. strutture) ing. Riccardo Antoniazzi, Protecno (progetto termotecnico e impianti) geom. Claudio Cotugno (gestione processo edile)
IMPRESE E FORNITORI
MAC Costruzioni (impresa edile) Bertaiola Impianti (impianti idraulici) D.F. Legno De Vincenzi (serramenti) Arredo Design di Bagnoli (arredi e interior))

CRONOLOGIA
Progetto e Realizzazione: 2019-2020
131 39 06
07
gli spazi interni vengono riconfigurati attorno a un elemento centrale che guida il progetto dell’intero edificio: un nucleo posto in posizione baricentrica che diventa un apprezzabile dispositivo domestico e scandisce lo spazio libero del piano terra. Il grande camino di ispirazione wrightiana si stacca completamente dalle murature perimetrali originali, e accoglie alle sue spalle i servizi della zona
giorno e la scala di collegamento fra il piano di ingresso e quello superiore, separando l’ambiente del soggiorno da quello dello studio, ricavato nello spazio retrostante. Il linguaggio dell’architettura non mostra concessioni alla decorazione e offre un innesto scultoreo ben integrato, dove particolare attenzione è stata posta alla costruzione: le alzate sulle tonalità del grigio della scala a


2022 #04 PROGETTO 40 09
08. L’elemento centrale con il camino che scandisce lo spazio del piano terra.
09.
Particolare del camino.
08
Un innesto come opportunità
vista si fondono con l’oggetto architettonico e costituiscono un elemento continuo.


Le scelte architettoniche dell’autore vengono valorizzate da un elegante equilibrio nell’uso dei materiali: il legno presente nelle pavimentazioni e nei serramenti, così come le pareti intonacate dalle tinte chiare, donano all’abitazione un’atmosfera intima e calda.
Anche nella zona notte, che occupa il secondo piano, si riconosce l’essenzialità compositiva: il sistema distributivo, pensato come nucleo centrale dedicato ai servizi, lascia spazio a due camere ricavate sugli estremi opposti della pianta, dove l’altezza raggiunge la copertura, mettendo in risalto la suggestiva orditura in legno dei soffitti, prima nascosta dalla controsoffittatura piana in canniccio.
Un discorso a parte meritano gli arredi in legno su disegno, particolarmente funzionali al progetto: il mobile dello studio che occupa la parete cieca di confine, così come la particolare soluzione dei letti nella stanza per i bambini, sono oggetti che contribuiscono a definire le proporzioni dello spazio e, al contempo, lo arricchiscono.
Il risultato è una rilettura contemporanea dell’edificio: una sorta di operazione di ‘riordino e pulizia’ del costruito, riconfigurando lo spazio per un abitare più vicino alle esigenze del nostro tempo, pur mantenendo la sua conformazione originale. Un contributo efficace di riqualificazione che, attraverso pochi semplici gesti, è capace di ben interpretare le forme della contemporaneità all’interno di un ambiente semirurale qual è quello di Avesa. •
10. La luminosa cucina e le aperture sul giardino.
11 La cucina vista dal soggiorno.
MARCO BUONADONNA
Nato a Verona (1976), ha studiato architettura allo IUAV di Venezia, dove si è laureato nel 2003 dopo aver frequentato tra il 1999 e il 2000 la Faculdade Tecnica de Lisboa. Nel 2010 fonda lo studio OAMB - Officina di Architettura Marco Buonadonna. Nel 2016 partecipa al corso Quality Building-Costruire in qualità ottenendo il riconoscimento di Esperto CQ. Lo studio si avvale di collaboratori e professionisti dedicandosi alla progettazione, a collaborazioni, a laboratori ed esperienze interdisciplinari. Dal 2019, in collaborazione con lo studio PISAA con sede prima a Barcellona ed ora ad Atene, si occupa della progettazione di alcune residenze nelle isole Cicladi in Grecia.
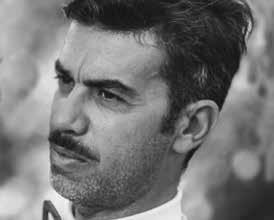
131 41
11 10
12. La stanza dei bambini al piano primo: la soluzione di arredo su misura per i letti e le scrivanie ricavate sullo spazio superiore.
13. Il mobile dello studio al piano terra che occupa la parete cieca sul lato nord.
14. Veduta della scala in legno che collega lo spazio per lo studio posto sopra ai letti.



2022 #04 PROGETTO 42
12 13 14 Un innesto come opportunità
16

15. La stanza da letto a tutta altezza, dove si scorge il soffitto ligneo, e il corridoio di distribuzione del piano primo.

16. Particolare della doccia illuminata dalla luce zenitale al piano primo.

131 43 15
Metamorfosi coerente
Progetto: Archingegno

Testo: Damiano Capuzzo
Foto: Diego Martini
La trasformazione di ex fienile all’interno di una corte di pregio propone la radicale reinterpretazione dei volumi interni quale strategia di riconnessione al contemporaneo 01
2022 #04 PROGETTO
Verona
Forse per statuto disciplinare o più semplicemente per questioni di rapporto con un costruito di più o meno radicata tradizione, il recupero architettonico lavora sul reale tendendo a escludere la straordinarietà, non nutrendo il bisogno del fenomeno mediatico come icona e tendendo quindi a proseguire un dialogo con la trama autoctona, pur nella ricerca di una metamorfosi necessaria agli utilizzi odierni.

È questo il tema che lo studio Archingegno ha affrontato nel ridisegno di una porzione di un piccolo complesso abitativo a corte di matrice storica, situato nelle prime frange di extraurbane della città a Verona, lungo il fiume Adige. Qui un ex fienile era stato oggetto negli anni Duemila di un intervento di recupero, rimasto incompleto, che lasciava inespresso il potenziale dell’edificio sospendendolo in uno stato di incompletezza, gravato dall’inserimento di solai in latero-cemento che alteravano la percezione delle volumetrie originarie, minimizzando la presenza di luce naturale in modo crescente verso un piano terra che si presentava cupo e angusto. La volontà e la capacità dei progettisti di rianno-
02
dare la trama con la preesistenza è ciò che ha permesso di guardare alle parti incompiute con occhio analitico, riscoprendo facilmente la presenza di ampie porzioni di murature in sasso che spessi strati di intonaco, necessari a colmare le imperfezioni di allineamento, avevano quasi interamente ricoperto. Nel rispetto del programma del committente, che intendeva trasformare i vecchi spazi in ambienti adatti a ospitare l’intero nucleo familiare, il progetto appare guidato da semplici ma chiari obbiettivi: ridare dignità alla struttura attraverso la riconoscibilità delle volumetrie originarie, ricercata in una combinazione di percorsi e volumi che animano lo
01. Gli ambienti del piano terra si offrono a generose visuali che amplificano la percezione degli spazi.
02. La nuova scala si arrampica attorno a un muro in sasso riportato alla luce dall’intervento di recupero.
03. L’ingresso all’abitazione anticipa l’equilibrio tra i materiali storici e quelli di nuova introduzione.

131 45
03
« Un modo pragmatico per dare risposta alle esigenze dell’abitare, attingendo alla tradizione o all’innovazione per renderle applicabili alle contingenze dell’attualità »
04-05. La cucina mantiene una stretta relazione con l’ambiente attiguo attraverso una vetrata con struttura in acciaio nero.


06. Il disegno di sezione rende evidente la giustapposizione di livelli sfalsati, che rendono mutevole la percezione degli spazi. 05

06 04
spazio interno, proponendo nuovi e inusuali punti di veduta e guidando la luce quanto più in profondità possibile, attraverso un gioco di riflessioni sulle superfici chiare delle finiture e degli arredi.
A permetterlo è la scelta di demolire ampie porzioni del solaio del primo impalcato e puntuali superfici del secondo, così da dividere gli spazi interni in due ambiti distinti ma tra loro collegati da veri e propri passaggi-ponte, sospesi a mezz’altezza e funzionalmente necessari a garantire la continuità dei percorsi. L’intera abitazione si sviluppa su tre livelli, con il piano terra dedicato agli ambienti di soggiorno e alla cucina, e i piani superiori con la zona notte e i relativi servizi.
La necessità di traghettare la poca luce naturale disponibile – in ingresso dai soli due fronti finestrati – massimizzandola lungo tutti gli ambienti interni, guida il disegno di un piano terra totalmente privo di partizioni, dove la cucina rimane a vista anche se separata a mezzo di un ampio serramento vetrato con struttura in acciaio nero.
Una scala dalle geometrie minimali e dal colore bianco, realizzata con parapetti pieni in metallo
2022 #04 PROGETTO 46
Metamorfosi coerente
07
verniciato, è l’unico elemento che si inserisce tra le distinte porzioni dell’interno, consentendone il collegamento; muovendosi nel vuoto che ricostruisce a tutta altezza il volume che caratterizzava l’antico fienile, descrive a chi la percorre la tridimensionalità del nuovo intervento, racchiuso in una scatola di più antica fattura. Il parapetto della scala, anch’esso bianco e realizzato in lamiera piena, è un elemento studiato per nascondere l’illuminazione della stessa, qui risolta da un profilo lineare nascosto nella piega che forma il corrimano e che in alcuni punti integra la presenza dei comandi luce con apprezzabile pulizia realizzativa. Nell’intento di valorizzare la doppia altezza che proprio dalla scala si rivela nella sua totalità, si è scelto di posizionare un lampadario decorativo a sospensione dal forte carattere iconico, unica eccezione a un progetto della luce che segue un carattere architetturale, in continuità con lo stile minimale degli interni e che qui demanda alla luce il compito di enfatizzare le superfici e la complessità delle tessiture murarie in sasso, pur rimanendo celata alla vista.
COMMITTENTE Privato
PROGETTO ARCHITETTONICO E DIREZIONE ARTISTICA studio Archingegno arch. Carlo Ferrari arch. Alberto Pontiroli
DIREZIONE LAVORI arch. Monica Michelazzi e geom. Marcello Ottolini
PROGETTO STRUTTURE ing. Umberto Guglielmini

IMPRESE E FORNITORI
Costruzioni Edili Marco Todeschini (opere edili), Bemax di Benedetti Massimo (impianti elettrici), Termosanitaria Trentin Marino (impianti meccanici), Arredoluce (illuminazione), Marmi Santa Caterina (opere in pietra)
CRONOLOGIA
Progetto e realizzazione: 2020-2021
07. Nella definizione dell’illuminazione interna il progetto accosta a sistemi integrati puntuali ma iconi apparecchi decorativi.
08. Veduta di una delle passerelle che attraversano il volume a doppia altezza collegando diversi ambienti al piano superiore.

131 47
08
è dunque attraverso questa tipologia di approccio che la ricerca degli architetti Pontiroli e Ferrari, fondatori di Archingegno, mette in evidenza uno dei caratteri peculiari del lavoro di recupero, ovvero la capacità di rivelare e valorizzare ciò che non è immediatamente visibile, mostrando le potenzialità di uno spazio che se opportunamente rimodulato e ripensato, può mostrare qualità e potenzialità inaspettate.
A mantenere saldo il legame con la preesistenza, pur nella necessaria revisione al fine di adattarlo alle esigenze dell’abitare contemporaneo, è anche il lavoro compiuto sui materiali sia esistenti che di nuova introduzione. La muratura centrale in sasso e mattoni è stata integralmente ripulita, puntualmente consolidata con elementi coerenti e lasciata a vista nella sua totalità di superficie, mentre le partizioni verticali di nuova realizzazione sono state trattate con intonaco di calce bianco, il cui effetto di finitura simile alla seta aumenta la vibrazione della luce definendo al contempo un corretto equilibrio con le più complesse porzioni a sasso. In materiale lapideo sono anche le pavimentazioni del
piano inferiore, per le quali i progettisti hanno scelto la Pietra d’Istria con finitura bocciardata e spazzolata a mano: lavorazione che le consente di assumere una fine eleganza materica mantenendo la colorazione chiara e omogenea, in equilibrio con le tonalità delle superfici verticali. È questo un intervento che nella totalità possiamo definire fluido, capace di riscoprire nella propria semplicità e in misurate eccezioni di utilizzo dello spazio, dove la funzione cede alla piacevolezza degli ambienti, un modo pragmatico per dare risposta alle esigenze dell’abitare, ricercando le tecniche più consone a mettere in equilibrio progetto e preesistenza, attingendo alla tradizione o all’innovazione per renderle applicabili alle contingenze dell’attualità. Necessaria metamorfosi del costruito verso un coerente strumento dell’abitare odierno. •



2022 #04 PROGETTO 48 Metamorfosi coerente
10
09 11
ARCHINGEGNO
Lo studio Archingegno dal 1998 ad oggi ha progettato e realizzato edifici pubblici, residenziali e terziari, con particolare esperienza nella progettazione di spazi per il lavoro. I soci fondatori Carlo Ferrari e Alberto Pontiroli considerano l’architettura come intreccio di elementi storici e contemporanei, con l’obiettivo di realizzare architetture di qualità, tecnologicamente avanzate, sostenibili ed efficienti. Tra i lavori dello studio, la Cantina Valetti a Bardolino («AV» 108, pp. 26-33) e la nuova chiesa della Beata Vergine Maria in Borgo Nuovo a Verona («AV» 118, pp. 22-29).

www.archingegno.info
09. Lungo le scale l’illuminazione lineare è celata nella piega della lamiera metallica che risolve il corrimano.
10. Il nastro continuo del parapetto metallico bianco della scala nello spazio a doppia altezza.
11. Il bagno padronale con una vasca free-standing e una partizione muraria rivestita in pietra che separa la zona wc.
12. Nella doppia altezza del soggiorno l’arretramento del piano superiore mette in evidenza il muro in sasso restaurato.

131 49 12
Materia ritrovata
Il recupero di una porzione di un villino liberty si caratterizza per la ricerca sugli interni nel dialogo tra spazialità ritrovate e contemporaneità dell’abitare

2022 #04 PROGETTO
01
Progetto: Studio Luca Toniolo
Testo: Angela Lion
Verona
Il tessuto edilizio di Verona si caratterizza per la presenza di numerosi esempi di ville liberty, sparpagliate con maggiore o minor concentrazione nei diversi quartieri limitrofi al centro storico: uno di questi è quello di Borgo Venezia.
Ai piedi delle Torricelle, nella zona che prende nome dalla chiesa di San Pio X, ne troviamo un esempio che, frazionato nel tempo in due diverse porzioni divise lungo la mezzeria, è stato oggetto di un intervento di restauro che ha riguardato una delle proprietà. Il progetto a firma dell’architetto Luca Toniolo, classe 1985, si caratterizza per il carattere di forte modernità conferito agli interni, pur preservandone i canoni stilistici tipici di quell’identità architettonica; negli esterni sono stati recuperati gli elementi caratterizzanti della tipologia architettonica.
rivestimenti, il camino e la scala principale di collegamento ai tre piani. Il camino nella zona giorno è stato restaurato, le cementine ritrovate sotto pavimenti ceramici sono state risanate e ricollocate, i nuovi solai sono stati eseguiti riproponendo le stesse travi a uso fiume che venivano utilizzate in quegli anni.



La pianta dalle forme regolari si caratterizza per aver conferito la massima ampiezza a spazi di per se contenuti. Ai vari piani corrispondono le diverse destinazioni d’uso, per lo più preservate nei tagli dimensionali con l’inserimento garbato di quelle parti accessorie spesso difficili da contestualizzare. Il tema della luce abbinata ai colori dei materiali e alla scelta delle finiture ha creato quel senso di raddoppiamento degli spazi, finalizzato a una massima fruizione degli ambienti.
01. Particolare con l’accostamento dei diversi materiali.
02. La villa liberty: l’ingresso e il fronte principale.
03. Il camino visto dalla scala principale.
04. Porta metallica di accesso alla camera padronale.
02
L’abitazione era stata rimaneggiata più volte nel corso degli anni, subendo divisioni e finiture che nascondevano internamente la bellezza delle componenti originali e la pulizia della pianta tipica delle villette dell’epoca. Il progettista ha scelto di riportare tutto all’origine attraverso lo svuotamento dell’intero edificio, con il solo mantenimento delle murature perimetrali insieme al solaio del piano primo. L’obiettivo progettuale è stato quello di preservare tutto ciò che aveva, e continua ad avere, un valore : i
131 51
03
04
« Il segno dell’intervento contemporaneo si riscontra soprattutto nella scelta dei materiali che, pur preservando l’esistente, lo arricchiscono di un valore ulteriore»
05. Scorcio del bagno all’interno di una stanza al piano primo.

06. Planimetria e piante di progetto.
07. Particolare del sottotetto che evidenzia la pluralità di materiali utilizzati.
Il segno dell’intervento contemporaneo si riscontra soprattutto nella scelta dei materiali che, pur preservando l’esistente, lo arricchiscono di un valore ulteriore. Materiali naturali come ad esempio le rasature a base di calce per le pareti, il metallo per i serramenti, la pietra e il legno: componenti che sono parte attiva del progetto e che, secondo Toniolo, devono “crescere e mutare negli anni assieme ai clienti che ci vivono”. In ciò emerge la ricerca di Luca Toniolo, sviluppatasi fin dal periodo della formazione quando, unendo le passioni per la grafica e l’architettura, ha maturato una serie di esperienze “itineranti”, come molti architetti della sua generazione. Il trasferimento in Olanda nel 2010 e la collaborazione con lo studio MaxWan di Rotterdam lo avvicinano alle ricerche più internazionali dell’architettura e
del design. Nel 2012 si trasferisce a Milano dove lavora come architetto e collabora come interior e product designer per negozi di abbigliamento e visual designer per eventi pubblicitari, sperimentandosi anche parallelamente per l’allestimento di eventi legati all’arte contemporanea. Oggi il suo studio con base a Marostica, nel vicentino, collabora con diverse realtà, e i suoi lavori vanno dall’ambito residenziale al retail – con alcune realizzazioni anche a Verona, come il ristorante Yard, cfr. «AV» 118, pp. 52-55 – assieme all’organizzazione e alla progettazione di spazi interni per hotel e resort.

La conoscenza del passato ormai dimenticato assieme alla consapevolezza di un vissuto contemporaneo conferiscono all’insieme di questo recupero un nuovo valore compositivo. •
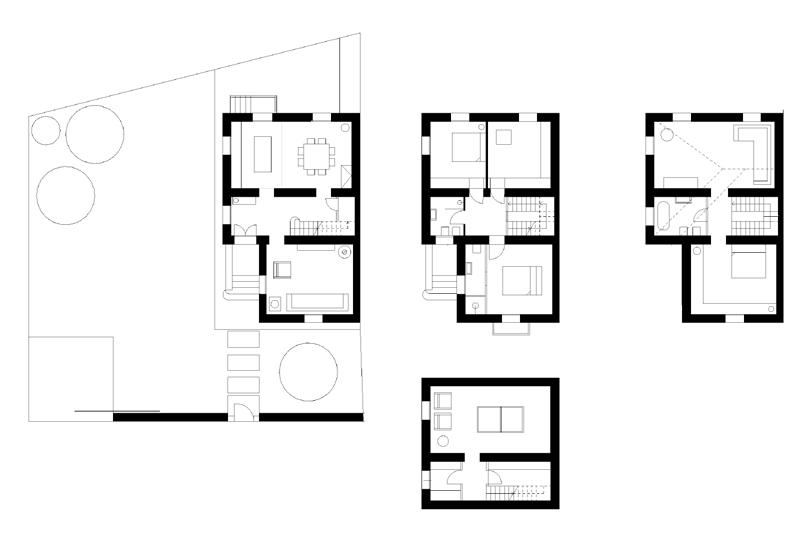
2022 #04 PROGETTO 52
05 07 06
Materia ritrovata
COMMITTENTE Privato


131 53
PROGETTO ARCHITETTONICO E DIREZIONE LAVORI Studio Luca Toniolo
PROGETTO INTERNI Studio Luca Toniolo
08 09
CRONOLOGIA Progetto e realizzazione: 2018-2019
08. La cucina con il recupero delle cementine. 09. Un dettaglio dell’orditura lignea della copertura e delle rasature a base di calce sulle murature.
Riflessi litici
Progetto: arch. Vittorio Longheu
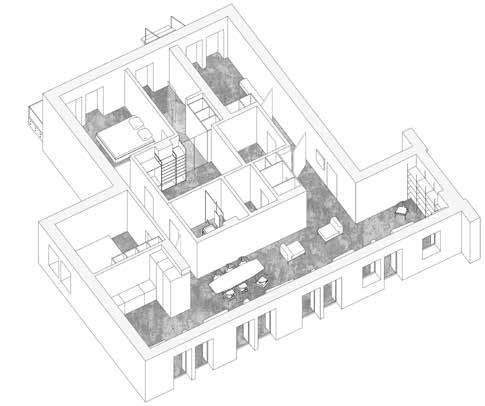
Testo: Beatrice Graziani

Foto: Federica Bottoli
Lungo il fiume Adige, a Verona, troviamo una realtà dove un sapiente studio degli spazi abitativi e rivestimenti lapidei di pregio esaltano e arricchiscono il tema della casa borghese, connotandone i caratteri sobri e di grande cura del progetto architettonico. Il progetto di un ampio appartamento per la famiglia di un collezionista, la cui sapiente progettazione pone attenzione alla matericità dell’opera architettonica e alla relazione che si crea con le tecniche costruttive, è firmato dall’architetto Vittorio Longheu. Laureato allo IUAV di Venezia nel 1988, nella sua carriera trentennale, Longheu ha saputo produrre architettura in cui il forte legame con la storia e il contesto della città e l’uomo è esperienza tangibile. La planimetria dell’appartamento è semplice ma efficace nella sua distribuzione. È definita da tre assialità principali: la prima, su cui è incardinata la zona giorno, incontra ortogonalmente le due ulteriori delle zone notte, distinte per i genitori e per i figli. Le parti più intime della casa sono organizzate in stretta relazione con il giardino posto sul retro dell’edificio, in un rapporto di continuità con la zona antistante affacciata sull’Adige.
I servizi trovano collocazione nel cuore di questo sistema distributivo, servendo le altre aree della casa. Sia il bagno padronale che i bagni minori
presentano materiale e lavorazioni lapidee di particolare pregio, con policromie suggestive che arricchiscono l’ambiente, sottolineando ancora una volta la cura del dettaglio nel progetto architettonico.
In questo contesto trovano spazio anche i lavabi e piatti doccia litici con griglie in legno di rovere disegnati dallo stesso Longheu per la collezione Piano di Posa, realizzata per Pibamarmi.
L’assialità e le relazioni tra gli spazi dell’appartamento sono favorite dalla presenza di grandi porte pivotanti. La loro collocazione permette un collegamento distributivo ma anche visivo tra la parte dell’abitazione rivolta verso il fiume e la parte che si affaccia sul giardino, sottolineando ancora una volta la stretta relazione con il contesto urbano nel quale l’abitazione si colloca. La policromia dei rivestimenti scandisce gli spazi dell’abitare, caratterizzandone i vari ambienti. La luce naturale gioca un ruolo fondamentale, mettendo in risalto le caratteristiche delle superfici, facendoci cogliere i riverberi ora della matericità grezza degli intonaci, ora della raffinatezza e della peculiarità delle superfici litiche. La forte presenza dei giochi di luci e ombre è permessa e scandita da un ritmo serrato e incalzante di aperture e chiusure dato dalle portefinestre – in particolare nell’ampio living – alcune

2022 #04 INTERIORS 54
Un ampio e luminoso appartamento affacciato sulle rive dell’Adige reinterpreta il tema della casa borghese arricchito dalla sontuosità dei rivestimenti
01 02
01. Veduta del corridoio verso la zona notte dall’ingresso: in evidenza l’assialità che distribuisce la zona notte e si innesta ortogonalmente nello spazio giorno.
02. Spaccato assonometrico dell’appartamento.


03. La lunga prospettiva della zona giorno, con il tavolo realizzato su disegno.

04. Dettagli del pavimento in Grigio dei Navigli.
05. Il gioco cromatico e materico delle superfici verticali.
131 55
03 COMMITTENTE Privato PROGETTO ARCHITETTONICO arch. Vittorio Longheu COLLABORATORI arch. Roberta Tognoli IMPRESE E FORNITORI Impresa Arturo Bottoli, Mantova (general contractor) Pibamarmi (opere in pietra) Merotto&Milani (arredi) CRONOLOGIA Progetto e realizzazione: 2018-2019 04 05
06. Veduta del livello giorno.
07. Il bagno padronale con il rivestimento e il lavabo in marmo Nero Port Laurent.
08-09. I bagni con i rivestimenti litici in Breccia Capraia e in Grigio dei Navigli. 07
delle quali sono anche dotate di specchi verticali inclinati per poter apprezzare il contesto cittadino dall’interno, suggerendo alla vista la monumentale presenza medievale di Castelvecchio. Percorrere e vivere gli spazi di questa casa di un collezionista significa compiere un viaggio tra proporzioni, presenze materiche e apporti luminosi sapientemente calibrati, in una alternanza di accostamenti e ritmi diversi ma armonici.
Spazi ampi e luminosi sono intercalati da spazi più intimi e raccolti, dove la sobria ma consistente presenza dei preziosi rivestimenti lapidei, a tratti drammaticamente enfatizzati dalla luce naturale, conferisce un arricchimento sensoriale.


Da questi aspetti emerge una capacità di reinterpretare il tema della casa borghese, in una lettura della contemporaneità che conosce il contesto esterno e lo porta all’interno, arricchito dalla sontuosità mai eccessivamente esibita dei rivestimenti lapidei. •


2022 #04 INTERIORS 56
Riflessi litici
09 06 08
In the closet
Progetto: CLAB architettura Testo: Leopoldo Tinazzi Foto: Marco Toté
All’interno della cinquecentesca villa Brenzoni-Guarienti di Punta San Vigilio a Garda, un dialogo fecondo tra il committente e gli architetti dello studio CLAB ha portato alla realizzazione di un piccolissimo progetto, l’inserimento di due nuovi bagni al piano terra. L’intervento è nato dall’esigenza di implementare i servizi dotazione di servizi della villa, utilizzata principalmente come dimora e sporadicamente concessa per l’organizzazione di qualche evento. Collocata nel punto più bello dell’intera sponda veronese, circondata dalle acque e dalla folta vegetazione del piccolo promontorio, la villa unitamente

La difficoltà nasce dal fatto che ogni possibile addizione o trasformazione apportata al manufatto edilizio esistente può mutarne l’assetto spaziale storico. D’altronde, sono molti gli esempi in cui edifici simili finiscono per essere alterati da superfetazioni incongrue, che magari soddisfano esigenze funzionali contingenti, ma che snaturano la percezione di uno spazio che è giusto preservare nella sua totalità. Da qui la necessità di operare con particolare sensibilità, in modo da rispettare quella che a tutti gli effetti è la magia intrinseca di un’architettura, ovvero la corrispondenza fra tutte le sue parti.
01. Particolare dell’accostamento tra il rivestimento ligneo dei bagni e il muro esistente.

02. Schema assonometrico di assemblaggio tra struttura a secco e rivestimento ligneo.
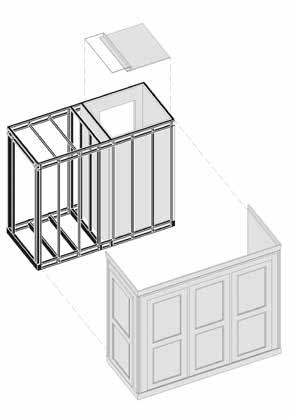
03. L’inserimento del volume all’interno della stanza. 01
al suo giardino è considerata uno dei migliori esempi di residenza nobiliare lacustre, ed è rimasta quasi intatta dall’epoca di costruzione (1540 circa) fino ad oggi. Come spesso accade in contesti simili, un tema semplice come la progettazione dei bagni si è trasformato in un’ardita sfida, tanto nell’ideazione quanto nella realizzazione.
131 57
Un piccolo innesto a servizio delle comodità contemporanee in un contesto storico è risolto con ironico illusionismo rispettoso dello spazio esistente
03 02
« Prendendo spunto dagli arredi storici esistenti, la struttura a secco è stata rivestita esternamente come fosse una grande credenza »
04. L’interno di un bagno con il rivestimento in multistrato di betulla.
05. Dettaglio del catino in rame utilizzato come lavabo.

06. Veduta dalla porta di un bagno.


07. Pianta dell’ambito d’intervento.
07
L’abilità in questo caso è stata proprio quella di aver saputo leggere il tema di progetto con estrema empatia nei confronti della villa, operando con delicatezza e trovando una chiave di lettura originale e inattaccabile, sia dal punto di vista lessicale che da quello funzionale.
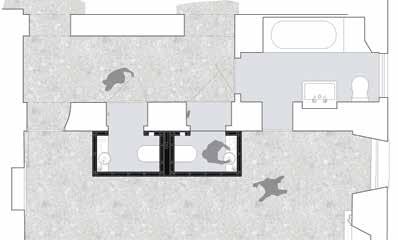
Per raccontare dunque il processo di ideazione, si deve considerare che a livello planimetrico il piano terra è composto da un lungo salone d’ingresso con due stanze poste simmetricamente su ciascuno dei lati e un loggiato di testa. Tra le due stanze di destra sono inseriti il corpo scale e, mediato da un ambiente di disimpegno, il bagno esistente. In questo ambito, per chiare esigenze distributive e impiantistiche, si è pensato di intervenire, progettando i nuovi servizi.
Il primo indizio per risolvere il tema si è presentato da solo: lungo il muro che delimita il disimpegno sul lato inferiore, due nicchie esistenti hanno dato l’occasione per pensare a una soluzione ad impatto quasi nullo. Infatti, abbattendo le due sottili tramezze incassate, si potevano aprire i due varchi necessari ai servizi da creare.

2022 #04 INTERIORS 58
In the closet
06
04 05
Dopo aver trovato un punto di contatto, questa prima breccia nel corpo edilizio della villa doveva svilupparsi in un oggetto costruito che instaurasse un rapporto di dialogo armonioso e duraturo.
Come risolvere quindi l’inserimento del nuovo volume nello spazio esistente? Il progetto si è avvalso di una tecnica da illusionisti. Prendendo infatti spunto dagli arredi storici esistenti, la struttura a secco è stata rivestita esternamente come fosse una grande credenza. Attraverso questo “trucco”, l’addizione dei bagni appare perfettamente integrata, in quanto viene letta come oggetto mobile e non interrompe né modifica la lettura dell’ambiente, derivante dall’assetto edilizio storico della villa.
L’ispirazione del rivestimento arriva dallo studio di quanto rinvenuto nel luogo, dove si trova come tema ricor-
rente la laccatura color verde e la suddivisione in quadranti regolari delle ante di porte e armadi.
Dal punto di vista interno i due bagni presentano caratteristiche speculari, con un vaso in ceramica bianca posto di fronte a un piano con un lavandino in rame e uno specchio. La finitura delle pareti interne è una boiserie in multistrato di betulla dalla verniciatura tendente a un marrone chiaro molto luminoso, in sintonia con il lato interno delle due porte recuperate dalle nicchie preesistenti.
L’obbiettivo dell’intervento era, ovviamente, quello di trovare una soluzione che limitasse l’impatto percettivo e fosse totalmente reversibile.
08. La grande “credenza” che dissimula l’ingombro dei nuovi bagni.
09. La facciata della villa sulla corte di accesso.

10. Gli accessi ai bagni visti dal disimpegno. 09 08 10
In questo senso, l’esito che qui presentiamo risponde perfettamente alle premesse, mostrando come la soluzione a un difficile inserimento fosse già sotto gli occhi di tutti. •
COMMITTENTE
Guariente Guarienti di Brenzone
PROGETTO ARCHITETTONICO

CLAB architettura arch. Nicola Bedin, arch. Andrea Castellani, arch. Matteo Fiorini, arch. Giulia Salandini

COLLABORATORI arch. Caterina Delaini, arch. Anna Valbusa
IMPRESE E FORNITORI
Ediltre S.n.c. (opere edili), Vassanelli Franco Imp. Term. (opere idrauliche), Falegnameria Zero6 (finiture)
CRONOLOGIA
Progetto e realizzazione: 2020-2021
131 59
01
01. Planimetria di progetto.
02. Veduta del tavolo in rame con le sedie in cuoio pieno fiore.
03. Il divano è protagonista dello spazio, delimitato da un morbido tappeto in seta di bambù e lana.
A bella posta
Progetto: arch. Paolo Richelli
Testo: Federico Morati
Foto: Michele Olivato
L’interno domestico progettato dall’architetto Paolo Richelli in collaborazione con Perbellini Arredamenti si trova all’interno dell’importante cornice dell’ex Palazzo delle Poste di Verona, oggi interamente riconvertito a residenze private. Come è noto, il palazzo è un progetto dell’architetto Ettore Fagiuoli realizzato in uno degli angoli più suggestivi del centro storico veronese, là dove sorgeva l’orto botanico voluto dalla famiglia Della Scala nel corso del Trecento. La mole severa del palazzo cela al suo interno spazi che si aprono sul contesto urbano attraverso grandi e caratteristiche finestre ad arco, come è


ben visibile negli spazi di soggiorno di questo alloggio. A questi si accede attraverso un corridoio che dall’ingresso – accanto del quale si apre il disimpegno verso la zona notte e i servizi – conduce verso la luce proveniente dai grandi finestroni. Un varco distinto da un sopraluce circolare segna il limite tra corridoio e soggiorno, che sono viceversa posti in continuità da un rivestimento con finitura Fenix color cacao Orinoco, opaca e dall’effetto vellutato.
Le grandi pannellature scure, in equilibrato contrasto con le tinte chiare delle pareti, sono ritmate in corrispondenza dell’ingresso da inserti verticali in ottone tra le ante a scomparsa, mentre nella zona giorno ricoprono la parete attrezzata della cucina, dove vengono ripresi alcuni elementi in ottone con finitura champagne. Nella parete attrezzata della cucina le pannellature lasciano spazio a una nicchia rivestita in quarzite Taj Mahal, in dialogo diretto con il vicino mobile a isola rivestito dello stesso materiale, che scende a cascata su un fianco fino a pavimento.
Infine, da notare è l’attenzione con cui la boiserie si relaziona all’altezza del varco tra corridoio e soggiorno, oltre che con la direzione suggerita dal parquet, dettando decise linee prospettiche.
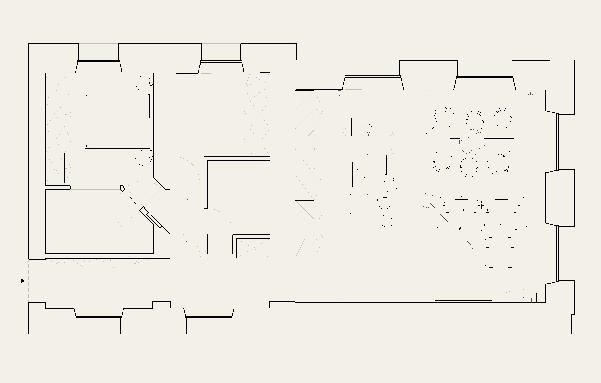
2022 #04 INTERIORS 60
L’allestimento di uno spazio abitativo all’interno di un contenitore storico declina una dimensione raffinata del progetto di interni
02
03
Il fondale ligneo delle pannellature agisce come una sorta di quinta scenica sulla quale si innestano gli altri elementi di arredo. Un lato del living è dominato dal divano in pelle Baxter, abbinato a una altissima piantana; l’altro lato invece è impreziosito dal particolarissimo tavolo da pranzo, costituito da un piano asimmetrico in rame anticato sorretto da due sostegni diversi tra loro, l’uno un cilindro con una finitura in terra cruda chiara, mentre l’altro è un parallelepipedo rivestito in onice posata in modo da formare un motivo a fiore con le sue venature.
A coronamento del progetto troviamo infine i corpi illuminanti – tutti pezzi di Davide Groppi – accuratamente distinti per tipologia: faretti incassati a soffitto in corridoio, faretti cilindrici a sospensione per la zona cucina, la piantana affiancata al divano, concludendo con la sfera in carta giapponese sospesa sopra il tavolo da pranzo. •



131 61 COMMITTENTE Privato PROGETTO ARCHITETTONICO arch. Paolo Richelli IMPRESE E FORNITORI SCC Costruzioni (general contractor) Perbellini Arredamenti (cucina e arredi su misura, complementi e illuminazione) CRONOLOGIA Progetto e realizzazione: 2020-2021 04. Il volume della boiserie nasconde l’accesso alla zona notte e articola la cucina. 05. Dettaglio del living. 06. Controcampo sul corridoio. 05 06 04
« Un varco distinto da un sopraluce circolare segna il limite tra corridoio e soggiorno »
Complesso della torre di Gorgusello, prospetto principale. Rilievo ante crollo di Paolo Righetti. Cfr. pp. 77-80.

Costruire in Lessinia
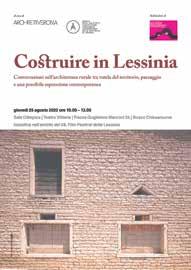
Costruire in Lessinia. Conversazioni sull’architettura rurale tra tutela del territorio, paesaggio e una possibile espressione contemporanea è il titolo dell’incontro promosso da «ArchitettiVerona» e dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Verona nell’ambito del 28. Film Festival della Lessinia, che si è tenuto a Bosco Chiesanuova il 25 agosto 2022.

Il grande patrimonio identitario dell’architettura di pietra della Lessinia, autentica e originale per caratteri insediativi, tipologici e costruttivi, mostra da tempo diverse criticità dal punto di vista della sua conservazione, del riuso e del rapporto con un contesto sottoposto a continue sollecitazioni. Di ciò hanno parlato rappresentanti delle istituzioni, studiosi e architetti in una serie di conversazioni che sono andate dalle forme dell’architettura rurale agli strumenti normativi di tutela, dalle pratiche operative ai progetti e alle ipotesi di un’espressione contemporanea del costruire anche per la Lessinia.
L’incontro è stato aperto dai saluti di
Matteo Faustini, presidente dell’Ordine Architetti PPC di Verona, e di Vincenzo Tinè, Soprintendente Archeologia Belle Arti Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza. Sono intervenuti: Vincenzo Pavan, studioso dei linguaggi dei materiali costruttivi e storico esegeta dell’architettura lessinica; Alberto Vignolo, direttore di «ArchitettiVerona»; Federico Maria Cetrangolo, funzionario architetto della Soprintendenza ABAP di Verona, . Guido Pigozzi, architetto e studioso attivo nel territorio della Lessinia; Federica Guerra, redattrice di «ArchitettiVerona»; Paolo Righetti, architetto e studioso dell’architettura popolare nell’area dei Cimbri; infine Vincenzo Latina, professore di Progettazione Architettonica e Urbana presso la “Struttura Didattica Speciale di Siracusa in Architettura e Patrimonio Culturale” dell’Università degli Studi di Catania. Presentiamo di seguito i contributi dell’incontro.
123 63 DOSSIER
Conservare l’architettura rurale e il paesaggio
 Testo: Vincenzo Pavan
Testo: Vincenzo Pavan
Una serie di crolli e nuove segnalazioni di grave degrado evidenziano una situazione di crisi, ormai cronica, dell’architettura rurale tradizionale della Lessinia.
I casi della Corte di Zivelongo, della Torre Colombara di Gorgusello e della Stalla del Modesto, per citare tre opere simbolo mutilate o interamente distrutte dall’incuria e dall’abbandono, impongono di interrogarci sulle cause del dissesto di molti edifici storici e contrade, e sulle possibili strategie per invertire una tendenza che si prospetta come inarrestabile.
Innanzitutto, al primo posto è ancora la sostanziale assenza di consapevolezza del contenuto e del valore culturale-economico di questo singolare patrimonio edilizio e del paesaggio antropico nel quale è inserito, nonostante le periodiche iniziative sul tema (mostre, interventi stampa, ricerche e tesi universitarie) incluso il conferimento del prestigioso International Award Architecture in Stone 2007, e l’apprezzamento di illustri architetti italiani ed esteri. Una carenza resa ancora più evidente da un eloquente aspetto di contrasto: mentre il patrimonio naturalistico dello stesso comprensorio territoriale gode di un generale riconoscimento, sostegno e difesa da parte dell’associazionismo ambientalista e della società civile locale e cittadina, l’architettura rurale continua a interessare solo un’area marginale, per lo più formata da rari cultori della materia. Si dovrebbe forse incominciare a considerare tale materia come una “seconda natura”, come Goethe
aveva definito nel suo Viaggio in Italia l’architettura per usi civili, che oggi chiamiamo utilitaristica, ossia le costruzioni rurali o funzionali non appartenenti a quelle colte degli stili. Intendendo con ciò degli artefatti, ovvero interventi dell’uomo “fatti ad arte” a integrazione della “prima natura” per dare forma alla propria vita.
E questo ci porta al secondo gradino, quello della comprensione, una operazione più complessa perché ci induce e costringe a capire il rapporto essenziale tra funzione e forma, evitandoci le fuorvianti scorciatoie del folclòrico e del pittoresco, che sembrano le uniche categorie, anch’esse stilistiche, adottate da chi costruisce oggi su queste montagne.
Nel caso della Lessinia il passaggio chiave è la pietra locale, un calcare lastriforme unico attraverso il quale hanno preso forma i linguaggi architettonici del territorio, le cui caratteristiche fisico-meccaniche hanno imposto le condizioni disciplinari del costruire nel corso dei secoli. In passato questa è sempre stata la regola, anche attraverso la riscoperta del materiale, ciò che ha permesso il suo adattamento a nuove necessità funzionali e quindi alla creazione di nuove forme. Riconoscere il ruolo fondante e autonomo della pietra nell’architettura e nel paesaggio lessinico è il primo passo verso una cultura conservativa consapevole del valore del patrimonio storico costruito che ci è stato lasciato in eredità e che abbiamo il dovere di conservare e tutelare.
Certo conservazione e tutela dell’architettura rurale e del paesaggio costituiscono compiti assai complessi nella situazione odierna nella quale questi beni rischiano di essere schiacciati tra l’incudine dell’abbandono, degrado, cancellazione, e il martello della crescente pressione della domanda edilizia per un turismo sempre più spinto, soprattutto a causa della crisi climatica, dai centri urbani di pianura verso la montagna.
Alcuni dei temi classici in materia richiederebbero la rimozione di fattori di impedimento peculiari del territorio lessinico mentre altri necessitano di aggiornamenti negli aspetti tecnici e burocratici.
64 2022 #04 DOSSIER
Dalla consapevolezza del valore culturale-economico del patrimonio edilizio della Lessinia e del paesaggio antropico nel quale è inserito alla sua comprensione
01
Tra questi, di particolare urgenza è ad esempio lo studio di norme che agevolino lo svincolamento delle proprietà edilizie da frazionamenti assurdi che ne ostacolano sia la vendita sia gli interventi manutentivi condannando molti edifici dismessi a lunghi periodi di abbandono e a una prospettiva di degrado quasi inevitabile.
Fondamentali per una concreta politica di conservazione del patrimonio storico edilizio sono alcune pratiche operative, ovvie ma di assai scarsa attuazione, sintetizzabili in tre punti: monitoraggio, manutenzione, messa in sicurezza. Il primo consiste in una seria e continuativa attività di controllo dello stato di salute degli edifici, specie dopo la loro dismissione, che come noto è legata anche alla sicurezza fisica delle persone. Tale attività per essere efficace necessiterebbe di essere svolta con frequenza, continuità e concertata tra proprietari privati e pubbliche istituzioni, ciò che permetterebbe di individuare precocemente problematiche strutturali che possono mettere in pericolo edifici e persone, e studiare interventi tempestivi che minimizzerebbero i costi di manutenzione ed eventuali futuri restauri. Fondamentale sotto questo aspetto il ruolo che può essere giocato dalle amministrazioni pubbliche: in primo luogo perché possono esercitare una azione di sensibilizzazione dei proprietari nella tutela dei loro beni e favorire iniziative di recupero, ma anche per appianare, attraverso un’opera di mediazione, le situazioni di conflittualità o disinteresse che possono portare all’abbandono e al degrado di edifici dismessi.
Il secondo gradino, la manutenzione, rappresenta un punto delicato e cruciale perché presuppone gradi diversi di intervento dai quali dipende il mantenimento in buono stato degli edifici, o la loro perdita. Soprattutto le costruzioni nelle quali, nonostante il livello di solidità e stabilità conferito dal materiale lapideo con cui sono edificate, si manifestano delle fragilità strutturali quando vengono meno le cure delle parti più vulnerabili, come i tetti parzialmente o interamente coperti da un pesante manto di lastre. In tal caso diventa fondamentale la tempestività negli interventi manutentivi per impedire
che eventuali danni strutturali diventino irreversibili.
Per quest’ultima eventualità, che colpisce edifici lasciati in stato di abbandono per lunghi periodi e nei quali si sia prodotto uno stato di degrado avanzato, sì impongono doverosi interventi di messa in sicurezza contro pericoli di crollo, sia per garantire la tutela delle persone, sia per salvare il bene culturale che rappresentano. Gli alti costi di recuperorestauro delle costruzioni in pietra lessiniche, ma anche solo della loro messa in sicurezza, ha spesso orientato i proprietari ad abbandonare gli immobili al loro destino, ossia al crollo, per una eventuale sostituzione con nuovi edifici. Tale scelta, che ha portato alla scomparsa di intere contrade o alla sostituzione di edifici storici con altri privi di valore architettonico, non è più in alcun modo giustificabile essendo oggi disponibili nuove tecniche avanzate e più economiche di protezione di strutture dissestate, come quelle ampiamente collaudate in aree colpite da sisma nel nostro paese negli anni recenti. La costruzione di una cultura conservativa del patrimonio edilizio storico richiede oggi un grande sforzo divulgativo che coinvolga popolazione stanziale e abitanti stagionali, amministratori e tecnici, progettisti, professionisti, imprenditori dell’edilizia e operatori del turismo, per mettere in atto queste e altre strategie di prevenzione e pratiche di conservazione in gran parte note e applicate in modo virtuoso in altri territori. •

01. Vaona, Sant’Anna d’Alfaedo, particolare di una concimaia della prima metà del Novecento (foto di Pietro Savorelli).
02. Stalla Campilonghi, Erbezzo, rivestimento dei primi decenni del ‘900 in lastre di Rosso Ammonitico (foto di Vincenzo Pavan).
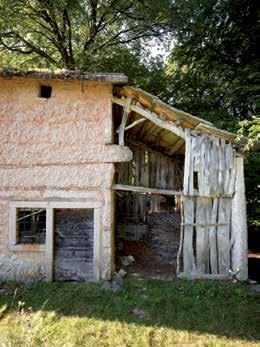
03. Stalla del Modesto, Roverè Veronese, particolare della connessione tra pietra e legno in una immagine prima del crollo del portico (foto di Pietro Savorelli). 03
02

65 131
Una Lessinia contemporanea: proposte nel cassetto
Le occasioni progettuali che nel corso degli anni hanno coinvolto alcuni protagonisti della scena internazionale dell’architettura
Le tre piccole storie che di seguito presentiamo sono un’espressione del grandissimo fascino che la Lessinia ha suscitato e suscita su tutti gli architetti, compresi alcuni di quei protagonisti della scena internazionale che si usano chiamare da tempo archistar e che hanno avuto occasione di provare a confrontarsi progettualmente con un’idea di Lessinia contemporanea, sia pure a livelli molto preliminari. Va detto fin da subito che si tratta di occasioni perdute e dunque è una storia di fallimenti, sui quali occorre quanto meno fare alcune riflessioni. L’origine comune di queste vicende si deve alla costante “seduzione” da parte di Vincenzo Pavan nei confronti di molti dei personaggi incontrati nel suo ruolo di curatore delle mostre culturali di Marmomac e del Premio Internazionale Architettura di Pietra1. Dal quartiere fieristico di Verona alla Lessinia il passo è breve, e da questa circostanza sono scaturite alcune visite con la guida d’eccezione di chi ha dedicato un’intera vita allo studio dell’architettura lessinica. Visite che in alcuni casi non sono state prive di conseguenze, almeno nei presupposti iniziali.

Il primo di questi personaggi è Antón García-Abril, che nel 2005 era stato premiato a Marmomac per il suo progetto di un centro studi musicali realizzato a Santiago de Compostela. L’occasione che si apre in questa circostanza riguarda una vasta area dismessa a Cerro Veronese, quella dell’ex caseifico sociale plav, che da alcuni anni era diventata di proprietà congiunta del comune di Cerro e della Comunità Montana della Lessinia. Le ipotesi che circolavano per quest’area posta
01
sul versante settentrionale del paese prevedevano sostanzialmente di demolire gli edifici del caseificio e di realizzare un nuovo insediamento residenziale e misto: ma grazie all’incrocio tra Guido Pigozzi, allora membro della Comunità montana, e Vincenzo Pavan, viene colta l’opportunità di coinvolgere l’astro nascente García-Abril per un ipotetico incarico di un progetto unitario. Nuovamente in Italia per una conferenza alla Facoltà di Architettura di Ferrara, García Abril viene accompagnato in visita alle cave di Prun – dove rimane molto colpito dal sistema moderno di escavazione delle lastre “a pacchetti”, sistema che avrebbe poi voluto utilizzare – e poi a Cerro assieme al sindaco di allora, in un sopralluogo all’ex plav. Quello di cui si può parlare non è altro

01-02. L’area dell’ex caseificio sociale plav a Cerro Veronese: veduta aerea e stato attuale di alcuni degli edifici.
03. A tavola con Antón García Abril: pensieri progettuali per l’area ex plav su una tovaglietta di carta.
04. García-Abril, di spalle, in visita alle cave di Prun.
2022 #04 DOSSIER 66
Testo: Alberto Vignolo
02
che una visione progettuale emersa durante il sopralluogo, attraverso le testimonianze di chi era presente e grazie ai fortuiti schizzi su delle tovagliette di carta con i quali a tavola, dopo la visita, le prime suggestioni hanno preso una forma embrionale2 La visione di García-Abril è parsa chiara fin da subito, a partire dall’idea di non demolire gli edifici esistenti ma di recuperarli destinandoli ad abitazioni e negozi, come era negli intenti iniziali, e in questo modo ottenere le risorse per costruire un Museo della Lessinia sotto forma di un edificio-monolite, molto sintomatico di un’architettura massiva e ieratica quale quella praticata dall’architetto spagnolo, e che avrebbe dovuto essere posto nella spianata oltre il caseificio verso la valle, in un’area di grande visibilità. Questo è quanto accaduto e rappresenta l’inizio ma anche la fine della vicenda: dopo quel sopralluogo promettente, non ha fatto seguito nulla di nulla. L’area dell’ex caseificio è ancora oggi in attesa di un suo destino.
Qualche anno più tardi, una nuova occasione lessinica si presenta per Alberto Campo Baeza, maestro dell’architettura litica e per questo una presenza costante a Marmomac. Siamo nel 2013 e da alcuni anni un padre francescano del convento di San Bernardino3 era solito trasferirsi d’estate in ritiro spirituale nei pressi della malga Gasperine di Dietro, sita in comune di Bosco Chiesanuova. Attorno a questo frate si era creato un seguito di fedeli, e le celebrazioni si tenevano in una radura attorno a un rudimentale recinto-altare allestito con il pietrame trovato in loco. Il frate trovava ospitalità nella malga, ma a un certo punto aveva manifestato il desiderio che si potesse realizzare proprio in quel luogo una piccola cappella con anche un spazio per dormire. Il racconto di questa opportunità suscita l’entusiasmo

di Campo Baeza, il quale si mette al lavoro su questo progetto e lo fa in maniera incessante: si tratta naturalmente di una auto committenza per sintonia con il tema e il luogo, nell’auspicio che l’opera potesse essere realizzata. Una produzione cospicua di schizzi, disegni tecnici e modelli dà conto delle varianti successive del progetto, che ruotano attorno a figure geometriche elementari da realizzare il lastre di pietra di Prun, con una copertura sospesa a filtrare la luce zenitale e delle grandi “ante” litiche per aprire lo spazio ai fedeli nel momento delle celebrazioni. Il rigore quasi ascetico e le forme rarefatte dell’architettura di Campo Baeza trovano in questa ricerca progettuale una particolare affinità in relazione alla sacralità dell’edificio e alle potenzialità della costruzione litica. A questo punto, però, arriva il mancato gradimento sul progetto da parte del proprietario dell’area su cui doveva sorgere, scelta naturalmente legittima che però ha affossato sul nascere l’iniziativa.

131 67
03 04
« Va detto fin da subito che si tratta di occasioni perdute e dunque è una storia di fallimenti, sui quali occorre quanto meno fare alcune riflessioni »
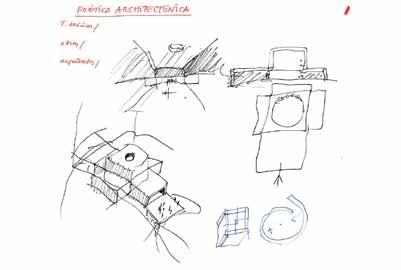
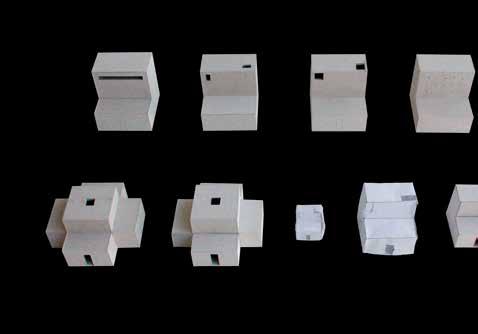

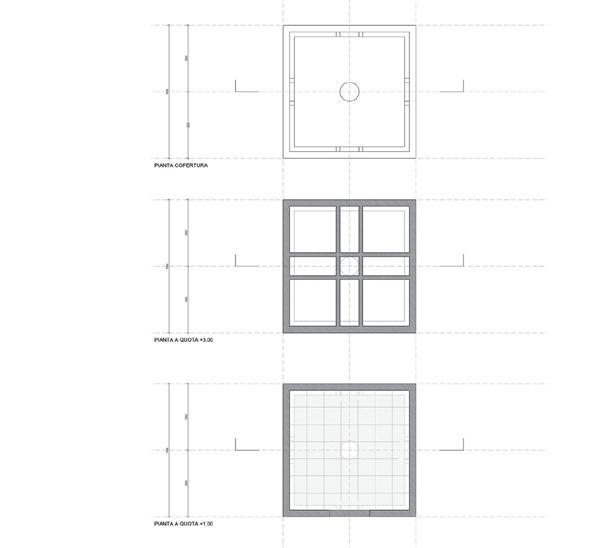
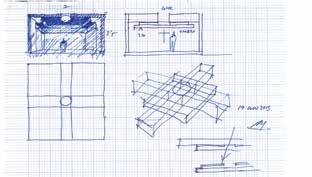
2022 #04 DOSSIER 68 06 08 05 07 09
La terza storia vede protagonista Kengo Kuma: l’architetto giapponese incontra per la prima volta la Lessinia in una visita guidata – Pavan in testa come sempre – che fa seguito a una sua conferenza tenuta al Museo di Castelvecchio nel 20144. L’escursione appassiona Kuma, tanto che l’anno successivo accetta di essere coinvolto nella proposta di un gruppo di architetti veronesi5 che proprio a partire dall’entusiasmo per l’architettura tradizionale della Lessinia dimostrato da personaggi , avanzano un nuovo tentativo progettuale. Kuma accetta l’invito e nel 2015 ritorna in Lessinia, tra un grande cantiere internazionale, una conferenza e l’altra, pur essendo chiaro che si trattava di una possibilità non certo lucrativa. La proposta era incentrata sulla possibilità di organizzare dei percorsi tematici tra natura e cultura, in cui agli aspetti naturalistici di rilievo si affiancassero a episodi antropico-culturali, quindi architettonici, di spessore. Il presupposto che all’interno del Parco Naturale della Lessinia non è possibile realizzare costruzioni ex novo ha



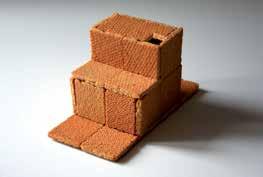
condotto a ipotizzare interventi architettonici “a zero volume”, come punti di sosta, luoghi-osservatorio a sottolineare punti particolari per orografia, panorama o importanza naturalistica. Su queste basi viene instradato il sopralluogo assieme a Kuma che, molto docile, curioso e appassionato, ha affrontato i due percorsi individuati come esempi di questa strategia, l’uno – il Sentiero dei Pellegrini – nella Lessinia occidentale in prossimità della sommità del Corno d’Aquilio, l’altro – il Nido delle Aquile –nell’orlo orientale dell’altopiano che strapiomba sulla valle di Revolto, nella parte terminale dell’alta valle d’Illasi. Il racconto della lettura dei luoghi da parte di Kuma e della raccolta dei “materiali” da utilizzare poi nel progetto sono poi confluiti in una proposta presentata all’Ente Comunità Montana della Lessinia, che ha anche sostenuto l’iniziativa. Alcuni primissimi schizzi, incentrati sull’utilizzo di lastre in sequenza a segnare i punti terminali di questi percorsi, sono rimasti invece nel cassetto in attesa di sviluppi: che però non sono mai arrivati.
05. Il luogo nei pressi della malga Gasperine di Dietro che ospitava le celebrazioni del frate francescano.
06-07. Schizzi progettuali di Alberto Campo Baeza, ipotesi settembre 2013 e soluzione finale, novembre 2013.
08. Modelli di studio di varianti progettuali, settembre-ottobre 2013.
09. Piante della soluzione finale, novembre 2013.
10. Modello con sequenza dell’apertura delle ante in pietra di Prun, ottobre 2013.
11. Render della cappella dall’interno, soluzione finale, novembre 2013.
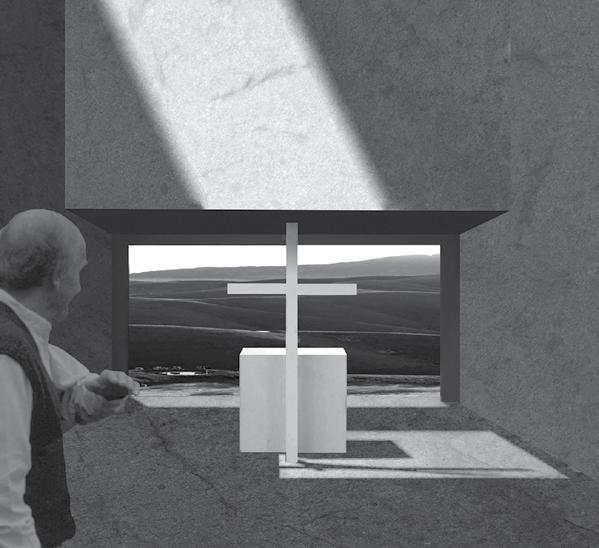

131 69
11 10
IL SOPRALLUOGO DI KENGO KUMA
Le immagini danno testimonianza del sopralluogo effettuato dall’architetto giapponese nel 2015 in due siti di interesse negli Alti Pascoli Lessini. Su questi luoghi, Kuma è stato invitato a pensare a un progetto – che non ha avuto seguito – che potesse contribuire alla valorizzazione del ricco patrimonio architettonico, storico e naturalistico del territorio.
12
LINK

https://architettiverona.it/video/ kengo-kuma-in-lessinia/
Anche questa occasione di dotare il territorio della Lessinia di architetture di qualità progettate da un grande maestro della scena internazionale contemporanea, che costituirebbero uno straordinario valore aggiunto culturale a questo prezioso territorio, è naufragata. Un ulteriore fallimento: ma speriamo che l’outing di questi progetti faccia scattare un senso di orgoglio e, magari, una qualche forma di riscatto. •


1 Il Premio si è tenuto con cadenza biennale dal 1987 al 2015.
2 Le tovagliette sono state custodite gelosamente da Guido Pigozzi, che si rigrazia per averle messe a disposizione.
3 Per approfondire si rimanda a Ugo Sauro, Emilio Romeri, un francescano doc in Lessinia, in «La Lessinia ieri oggi domani. Quaderno culturale», 44, 2021, pp. 221-228.
4 Cfr. Paola Altichieri Donella, K&K: Kengo a Castelvecchio, Kuma in Lessinia, in «AV» 98, pp. 52-55.

5 Il raggrupamento, formatosi per l’occasione, oltre a Vincenzo Pavan comprendeva Angelo Bertolazzi, Federica Guerra, Marco Marogna, Federico Padovani, Alberto Vignolo.
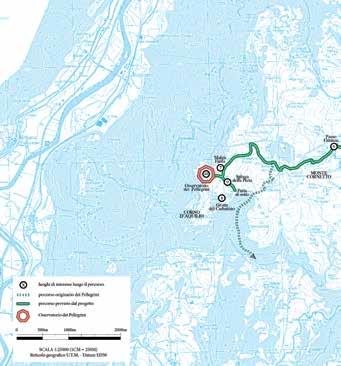
2022 #04 DOSSIER 70
VIDEO Federico Padovani
13
12. Un’immagine del sopralluogo effettuato da Kengo Kuma nel 2015 lungo percorsi individuati per la realizzazione di due osservatori tra natura e architettura (foto di Federico Padovani).
13-14. Mappe del Sentiero dei Pellegrini e del Sentiero dei Nidi delle Aquile (gruppo V. Pavan, A. Bertolazzi, F. Guerra, M. Marogna, F. Padovani, A. Vignolo).
Il quadro delle tutele tra paesaggio e
beni monumentali
Testo: Federico Maria Cetrangolo
Il governo del territorio è una disciplina che coinvolge molteplici aspetti e deve perseguire l’obiettivo di contemperare le diverse istanze mirate alla sua trasformazione. La Lessinia presenta indiscusse caratteristiche di grande valore ambientale, paesaggistico e culturale che necessitano di una maggiore attenzione. È pertanto auspicabile che incontri come quello che si è tenuto nell’ambito del Film Festival della Lessinia 2022 abbiano un seguito, soprattutto da parte degli organi professionali, che devono essere i principali promotori per tracciare la direzione da intraprendere verso una nuova architettura possibile. La Soprintendenza dispone delle modalità operative utili a orientare le trasformazioni del territorio. Lo strumento del vincolo, ovvero la formale dichiarazione di particolare interesse paesaggistico degli ambiti della Lessinia, non ancora sottoposti a tutela, è sicuramente auspicabile. Queste aree hanno sopportato per molti anni una pressione antropica che ora appare sempre più pressante.
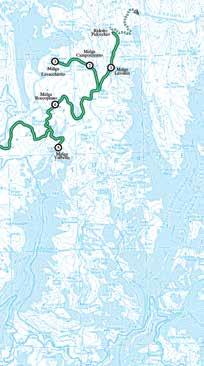
La rivalutazione e l’ampliamento degli ambiti da sottoporre a tutela paesaggistica sono un’azione necessaria che va condotta con modalità aggiornate. La definizione di regole certe e omogenee deve indirizzare i soggetti che partecipano a vario titolo al processo di trasformazione del territorio (committenti, progettisti ed enti di controllo) secondo principi di certezza e trasparenza, permettendo così di fornire una disciplina d’uso del territorio, che orienti la progettazione secondo parametri più definiti. Ciò favorisce contestualmente la riduzione delle astratte quanto inconciliabili aspettative rivolte a incongrue proposte di trasformazione del paesaggio, che frequentemente appesantiscono i procedimenti
di valutazione di compatibilità paesaggistica. La progettazione delle trasformazioni non può che essere preceduta da un’approfondita conoscenza del territorio e degli specifici caratteri che lo contraddistinguono. Tali caratteri devono essere riconosciuti e condivisi. Solo così se ne può garantire la conservazione, consentendo trasformazioni che si inseriscano in armonia con il contesto.
Un caso attualmente in corso di attuazione è quello che interessa la Valpolicella, dove la favorevole disponibilità manifestata dalle amministrazioni dei comuni di San Pietro in Cariano, Fumane, Marano di Valpolicella e Negrar di Valpolicella ha consentito alla Soprintendenza di riavviare, in modo condiviso, le procedure di revisione dell’attuale decreto di vincolo risalente al 1957, con l’obiettivo di integrarlo con un’analisi delle diverse componenti del paesaggio, attribuendo ad esse forme esplicite di tutela, recupero e valorizzazione.
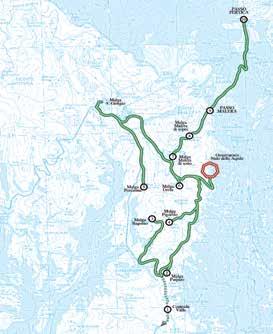
La definizione di procedure che riducano il margine di discrezionalità degli enti preposti (Comuni e Soprintendenza) porterà sicuramente a raggiungere il miglioramento della qualità paesaggistica, grazie soprattutto alla compartecipazione degli intenti. Non si può però dimenticare che la tutela del territorio è principalmente frutto del riconoscimento dei valori da parte di chi vi risiede e opera quotidianamente.
La sinergia tra gli enti è sicuramente una svolta importante per la tutela, in quanto segnala le crescenti aspettative, da parte dei cittadini, nei confronti della conservazione dei valori combinati di storia e natura del proprio territorio, riconoscendoli finalmente come concrete risorse da preservare e ricomporre nelle parti che, in passato, sono state spesso ignorate e talvolta danneggiate o cancellate. •
131 71
14
Amministrare l’architettura rurale
Gli strumenti e le politiche in atto per il governo del territorio della Lessinia a partire da una sua descrizione quantitativa
Testo: Federica Guerra
Chiamiamo Lessinia l’insieme di 17 comuni in parte completamente montani (13), in parte solo parzialmente (4). Su una superficie provinciale di 2.900 chilometri quadrati, la superficie di questi comuni, che costituiscono la parte veronese della regione lessinica – mentre una parte ricade in provincia di Trento e una parte in provincia di Vicenza – copre circa 490 kmq, pari al 15,7% della superficie totale.
Su una popolazione provinciale di 926.000 abitanti, il totale di quelli della Lessinia è di 63.500, pari al 7%. Si tratta quindi di un territorio poco denso, con aree densamente abitate e aree di una naturalità diffusa. Il patrimonio di edilizia rurale che insiste su tale territorio e che presenta caratteristiche di alto pregio, non è affatto omogeneo ma è un patchwork di situazioni differenti. Oltre ai nuclei urbani di diverse dimensioni e caratteristiche insediative, con nuclei abitati che vanno dai 3.500 abitanti di Bosco Chiesanuova ai 759 di Velo Veronese, parlando dei comuni prettamente montani, ma anche dai 16.000 di Negrar ai 3.000 di Marano di Valpolicella, considerando i territori di passaggio tra collina e montagna, si presentano situazioni insediative che quanto a dinamiche demografiche e prospettive di sviluppo sono assai eterogenee. Prime tra tutte le note contrade, che tuttavia ancora una volta hanno consistenze diverse: si va dalle contrade più sperdute composte da uno o più edifici in linea, spesso non più utilizzati né ai fini abitativi né di supporto all’economia rurale e quindi per lo più abbandonate, per passare alle contrade nate su un nucleo di edifici originari, spesso intorno a una chiesa o una cappella e poi sviluppatesi negli anni fino a diventare dei piccoli borghi – come per esempio la località
San Francesco di Roverè Veronese, nata come contrada Praisiolo intorno a un piccolo oratorio e poi sviluppatasi in un piccolo centro urbano – fino al caso di Azzarino (uno dei cosiddetti 13 comuni cimbri) composto da un susseguirsi di contrade autonome, ma che costituivano di fatto un’unità urbana. Quindi anche in questo caso, al termine contrada andrebbero attribuiti diversi significati in base alle loro caratteristiche insediative. A questo patrimonio si aggiungono gli edifici isolati delle malghe, delle casare, dei baiti e delle stalle d’alpeggio a formare un panorama assai composito. Governare un territorio così complesso significa, da un lato, parlare delle politiche che si devono attuare per il suo sviluppo e la sua contemporanea salvaguardia, dall’altra parlare degli strumenti necessari alla sua gestione. Di politiche e di strategie si occupano i piani a scala vasta come il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ma anche tutti i programmi messi in campo dalla Regione Veneto per l’utilizzo dei fondi regionali e dei fondi europei finalizzati all’intervento nelle aree alpine, primo fra tutti l’organismo dei GAL, i Gruppi di Azione Locale – nel nostro caso il GAL Baldo Lessinia – che propongono strategie di sviluppo locale e ne gestiscono il finanziamento tramite l’AVEPA –Agenzia Veneta per i Pagamenti. In questi anni il GAL Baldo Lessinia ha finanziato, tramite bandi aperti agli operatori locali e agli enti pubblici, numerosi progetti di riqualificazione e recupero del patrimonio architettonico, oltre che per lo sviluppo dell’economia rurale finalizzata alla lotta allo spopolamento e a progetti di sviluppo del turismo sostenibile. Questi strumenti mettono tutti al centro oggi la
01
01. Regione del Veneto, PTRC, stralcio tav. 07: la Lessinia non rientra nel Sistema delle politiche di coordinamento transregionale delle attività di pianificazione. Gli Alti pascoli vengono classificati come aree vocate all’agricoltura di Montagna, mentre solo Bosco Chiesanuova è classificata “città alpina”.
02. L’area lessinica nella Carta dei Vincoli del PTCP vigente (stralcio): vengono individuate puntualmente le numerosissime contrade per la cui tutela si rimanda alle Norme Tecniche attuative (art. 8-9-10).
03. Esempio di Scheda Norma della Contrada Gambari, secondo la rilevazione datata anno 2003.

2022 #04 DOSSIER 72
necessità di un’alleanza strategica tra amministratori e cittadini all’insegna della condivisione degli obbiettivi e del sistema di valori attribuiti, nello specifico per esempio, al patrimonio architettonico. Risulta interessante sottolineare, a questo proposito, i fattori che uno dei progetti europei a cui ha partecipato il GAL Baldo Lessinia (il progetto emblematic), aveva messo alla base del riconoscimento di unicità di un territorio: oltre ovviamente al riconoscimento istituzionale, al pregio paesaggistico, alla presenza di luoghi storici significativi, alla conservazione degli ecosistemi, c’era al primo posto l’orgoglio della popolazione locale, cioè il livello di identificazione delle persone con la propria montagna, la passione e l’amore per il luogo, l’orgoglio per la propria origine e le caratteristiche emblematiche. Da questo punto di vista l’associazionismo locale sta facendo molto nel campo della rivitalizzazione sociale del territorio, mentre per quanto riguarda il patrimonio
architettonico rurale risulta evidente la necessità di una regia istituzionale. Il primo livello di gestione del patrimonio è riconoscerne quindi il valore, per mettere in atto politiche culturali, economiche e di salvaguardia condivise con la cittadinanza attraverso il meccanismo della partecipazione.
I due principali strumenti di indirizzo delle politiche sono comunque il PTRC e il PTCP. Il PTRC vigente approvato nel 2020 dalla Regione Veneto (privo della sua valenza paesaggistica, per cui a tutt’oggi non esiste un piano paesaggistico regionale) dà indicazioni precise sulle dinamiche di sviluppo della regione, riconoscendo alcuni ambiti privilegiati dal punto di vista dello sviluppo economico-turistico, dal punto di vista della crescita sociale e culturale e dal
punto di vista degli obiettivi di progetto. Ci sembra di poter dire che in questo quadro la Lessinia sia stata considerata un’area marginale, perché se da un lato la Regione “riconosce la specificità dei sistemi insediativi montani e promuove la valorizzazione della montagna veneta, anche con progetti finalizzati allo sviluppo delle attività economiche al fine di assicurare la permanenza delle popolazioni”, dall’altro non riconosce la Lessinia tra le eccellenze turistiche: la Lessinia non rientra nel sistema delle politiche per la valorizzazione del territorio interregionale né interprovinciale, e non è classificata come un sistema territoriale da valorizzare (come invece vengono considerate, per esempio, la Riviera Berica o la riviera del Bacchiglione). L’accento viene comunque posto
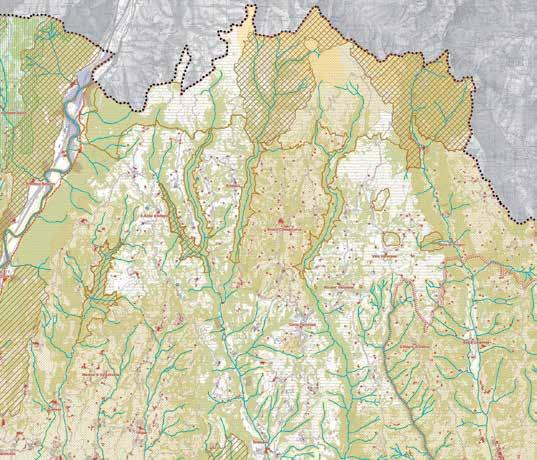

sul suo patrimonio di edilizia diffusa (“zona ad elevata presenza di rustici sparsi”) e all’art. 69 delle Norme tecniche operative “Sistemi culturali e territoriali” si afferma che “la Regione promuove la valorizzazione degli insediamenti rurali delle malghe”, ma senza farli di fatto rientrare nel quadro più generale di promozione e diffusione del portato culturale di questo patrimonio.
Meglio fa il PTCP, che nel Documento Preliminare individua la Lessinia come ambito dotato di particolari peculiarità per il quale si promuove il recupero delle strutture insediative delle malghe finalizzata al un turismo di prossimità, oltre che al recupero dell’agricoltura tradizionale di montagna e dei prodotti tipici. Già questo, se supportato da concrete politiche
131 73
02
«
Quasi tutti i piani rimandano a una Variante specifica relativa al recupero del patrimonio rurale »
di intervento, può diventare punto di partenza per la promozione del patrimonio architettonico. Ma gli interventi sull’edificato passano poi dalla valutazione del tipo di intervento ed ecco allora che scendiamo di scala e passiamo a parlare dalle politiche agli strumenti della gestione. A partire dagli anni Settanta la Regione del Veneto ha introdotto una serie di norme urbanistiche per la tutela dei beni culturali e ambientali e per l’edificazione nelle zone agricole (LR n. 58/1978, LR n. 40/1980, LR n. 24/1985, LR n. 61/1985). Con la riforma urbanistica regionale del 2004 (LR n. 11/2004), la Regione ha incaricato gli strumenti urbanistici comunali di censire e schedare gli edifici rurali esistenti, classificandoli in base a preordinate categorie di valore; di individuare, per ognuna di queste, le destinazioni d’uso ritenute compatibili e i tipi di interventi edilizi consentiti; di definire le modalità d’intervento (soluzioni progettuali, tecniche e materiali costruttivi) per il recupero del patrimonio edilizio esistente da salvaguardare. Anche in questo caso è evidente come la necessità di condivisione del valore del patrimonio sia indispensabile soprattutto dal momento in cui, decaduta l’obbligatorietà delle Commissioni edilizie e in presenza di un vincolo ambientale “a macchia di leopardo”, tutta la valutazione della qualità architettonica degli interventi poggia sulle spalle di
Uffici Tecnici spesso di piccolissime dimensioni, che a norma di legge valutano solo ed esclusivamente la rispondenza degli interventi allo strumento vigente. Diventa allora fondamentale la promozione della partecipazione, per esempio dei professionisti locali, ad azioni di divulgazione delle caratteristiche e dell’importanza del patrimonio architettonico rurale e soprattutto la formazione degli operatori pubblici. Parlando specificatamente di strumenti della gestione, possiamo rilevare come tutti i comuni della Lessinia siano dotati di Piani di Assetto del Territorio (a parte il comune di Erbezzo). Alcuni comuni hanno redatto Piani di Assetto integrati tra più comuni. Tutti i comuni che hanno adottato il PAT sono anche dotati di Piani degli Interventi, redatti nell’arco degli anni Duemila.


Nei diversi PI – comunque nelle Varianti Generali ai PRG – è sempre prevista una normativa di intervento specifica sul patrimonio di edilizia rurale. Questa normativa parte da una schedatura puntuale edificio per edificio, quasi sempre riportata dal precedente strumento urbanistico. Ma se la precedente ondata pianificatoria che ha interessato la Lessinia risale agli anni Novanta, è evidente come la valutazione che viene fatta in quelle schede risenta di sensibilità ormai superate, riferite a modelli anche architettonici sorpassati che non tengono conto delle nuove
tecnologie di recupero e di intervento sui manufatti storici. Oltre a ciò, l’identificazione fatta in quelle schedature è riferita a immobili che se non manutenuti negli anni potrebbero aver subito gravi danni e quindi essere in stato di conservazione assai diverso da quanto rilevato allora. La struttura di queste schedature è comunque la stessa di quella utilizzata per i centri storici: l’edificio viene valutato secondo una scala di valori storico ambientali che ha come conseguenza l’attribuzione di un Grado di Protezione, a cui corrisponde un Grado di Intervento, dal restauro filologico fino alla demolizione senza ricostruzione. In quasi tutti i piani è comunque previsto un “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” che stabilisce dimensioni delle forature, colori, aggetti, finiture sia per i fabbricati rurali che per le nuove edificazioni. È possibile leggere questo strumento di pianificazione come uno sforzo in atto teso alla riqualificazione del patrimonio. Poiché quasi tutti i piani rimandano a una Variante specifica relativa al recupero del patrimonio rurale potrebbe essere interessante – e a questo punto, assolutamente urgente – in occasione di questa nuova necessaria ricognizione degli edifici rurali, provare a pensare a un tipo diverso di catalogazione che non sia omogenea per tutti i nuclei rurali o per tutti gli edifici ma che tenga conto del caso specifico, dando magari indicazioni puntuali di progetto anche in funzione del ruolo dell’edificio all’interno del proprio contesto caratteristico. Queste indicazioni di progetto potrebbero anche fare riferimento a inserimenti contemporanei, quanto a volumetrie e finiture, una sorta di “piano per progetti” che riesca a coniugare la valorizzazione di questi edifici con la conservazione degli episodi di pregio ma anche con la rivitalizzazione e il loro adeguamento alle esigenze contemporanee dell’abitare. •

2022 #04 DOSSIER 74
03
Fragilità e interventi progettuali in Lessinia
Conoscenza del territorio, dei materiali e delle tecniche attraverso una costante ricerca progettuale sul campo
È parte del territorio della Lessinia l’importante patrimonio edilizio che si trova sparso per le contrade dell’altopiano. A pochi minuti da Verona si possono infatti raggiungere gli alti pascoli e le dolci verdi colline (oggi sempre più popolati da turisti del fine settimana) costellati di piccoli nuclei urbani, malghe e casolari.

Se si esplora bene il territorio si può facilmente riconoscere una chiara matrice costruttiva che nasce da un’antica cultura materiale. Di centrale importanza è infatti l’utilizzo della pietra locale, che viene estratta in varie cave sparse nei comuni della zona. Oltre al materiale, si possono riconoscere alcuni archetipi che, nonostante alcune leggere differenze – spesso riguardanti finiture o esposizione – ricorrono in quasi ogni contrada, o perlomeno in quelle ancora ben conservate, come ad esempio il baito, la chiesa, il fienile, la stalla.
La fragilità del territorio, per quanto riguarda il patrimonio edilizio, è minacciata prima di tutto da una scarsa conoscenza dei caratteri tipici del luogo e dei materiali autoctoni. Ciò porta a una compromissione della matrice costruttiva con interventi non rispettosi della cultura e tradizione locale. Anche l’abbandono di antichi edifici è un fatto non raro, e si rischia cosi di perdere alcune importanti testimonianze . Gli interventi e le trasformazioni che modificano gli edifici o i complessi di edifici datati non dovrebbero alterare la loro configurazione e di conseguenza la loro storia, ma si dovrebbe puntare ove possibile sul recupero e la conservazione. Recuperare e conservare tuttavia non significa necessariamente imbalsamare l’edificio, ma far dialogare la tradizione


e i materiali con nuove destinazioni d’uso e tecnologie. Il territorio è pieno di esempi sia di una che dell’altra specie. Il metodo migliore per capire e intervenire sui manufatti antichi è innanzitutto la presenza costante sul territorio, la conduzione di rilievi architettonici e la restituzione grafica. Partendo dall’analisi dei singoli elementi architettonici (ad esempio posizionamento delle pietre, tipo di copertura, materiali di finitura) si acquisiscono le basi per capire l’essenza compositiva dell’intero edificio e, a una scala più ampia, delle intere contrade. In alcuni casi i singoli elementi da soli riescono a rendere unico e straordinario l’intero edificio.
Per quanto riguarda i materiali, si può dividere l’area della Lessinia in due parti che differiscono per alcuni metodi costruttivi e utilizzo di materie prime. Infatti nella zona occidentale si trovano tessiture murarie regolari e un’ampio utilizzo di coperture in lastre di pietra, nonché l’utilizzo per altri svariati motivi delle lastre di pietra messe in piedi. Ciò è dovuto alla presenza in quella parte della Lessinia di molte cave della cosiddetta pietra di Prun.
Nel versante orientale, invece, la tessitura dei muri presenta l’utilizzo di pietre più irregolari, che spesso vengono intonacate completamente o a raso sasso.
01.
02.
03. Contrada Falz, Roveré Veronese.
131 75
02
Testo e Foto: Guido Pigozzi
Stalla in località Paradisetto, Roveré Veronese.
Contrada Sengio Rosso, Velo Veronese.
03 01
I tetti presentano lastre di pietra solo sulle creste dei muri perimetrali; le stalle presentano tetti a doppia pendenza con lastre sui muri laterali e sul fronte e il resto del manto è in coppi (o tegole) o lamiera (attualmente). Questi materiali hanno sostituito nel tempo la paglia, il cosiddetto canel, molto efficiente dal punto di vista sia dell’isolamento termico che dell’impermeabilizzazione, il cui uso è quasi del tutto sparito. Tracce si possono trovare ancora oggi sotto le lamiere o sotto i coppi di antichi fienili.
Gli intonaci tuttavia sono una delle problematiche più importanti relative al recupero dei manufatti. L’intonaco infatti rappresenta la pelle esterna dell’edificio che può mostrare o coprire la struttura e le tessiture che ci sono sotto.
Gli intonaci utilizzati negli edifici della Lessinia variano a seconda della posizione delle contrade. Infatti dipendono dal materiale che compone stradine piccole cave che ci sono nei dintorni degli edifici stessi. A seconda del sito si possono trovare varianti più giallastre, rosate o rossastre o grigie. Il miglior intervento possibile che si può fare in questi casi e quello di analizzare scientificamente composizione




2022 #04 DOSSIER 76
06
05 04
07
interventi
04. Malga Torla, Selva di Progno: particolare di intonaco a raso sasso.
05. Giassara Tommasi, Sant’Anna d’Alfaedo.
06. Tezza sulla Conca, Badia Calavena.
07. Contrada Bortoletti, Velo Veronese.
e granulometrie di brani di intonaco che si sono conservati nel tempo per poi riproporlo anche come stuccatura tra le pietre esistenti.
La percezione della pelle esterna delle costruzioni è il primo impatto che si ha quando si percorrono le strade del territorio. Fino agli anni Sessanta del Novecento per comporre gli intonaci si usavano le modalità sopra descritte. Il risultato era quindi una continuità cromatica dal paese centrale alle contrade agli edifici isolati. Con il tempo però è stato introdotto prima l’uso di intonaci preparati o graffiati bianchi a base cementizia per poi arrivare agli intonachini con stravaganti colorazioni accese quali gialli, rossi, rosa, azzurri, eccetera…
Se questi possono ancora risultare “accettabili” nell’ambito del nucleo centrale del paese, risultano essere del tutto fuori posto all’esterno, nelle zone di espansione.
Oltre agli intonaci a minare l’autenticità storica degli edifici è stata l’introduzione di altri materiali da costruzione ed elementi costruttivi, quali solai in laterocemento, coperture in coppi “nuovi”, infissi in alluminio.
•
Architettura e memoria storica dei luoghi



Il crollo del complesso della torre di Gorgusello e un’ipotesi di ricostruzione filologica delle strutture e della sua immagine all’interno del borgo
Testo: Paolo Righetti
La vicenda della Torre di Gorgusello è emblematica della sorte cui pare destinata l’architettura autoctona della Lessinia.
Da magnifica struttura dalle caratteristiche originali, espressione materica di cultura del costruire di un popolo antico con la pietra locale, ad ammasso di rovine nella indifferenza delle istituzioni locali quando non con loro improvvidi interventi di “messa in sicurezza”. Anche ad oggi quando sarebbero disponibili finanziamenti straordinari, come i fondi del PNRR, per il recupero dei patrimoni architettonici tradizionali.
Ma oltre al silenzioso e immobile terremoto che di tanto in tanto atterra le superstiti architetture abbandonate della Lessinia, l’altro sfregio cui è soggetta questa architettura è quella degli interventi di “ristrutturazione”: invece di specifici inserimenti di servizi moderni con la salvaguardia delle strutture antiche, si manomettono le antiche facciate, anche per rispettare incongrue normative sui rapporti di aeroilluminazione, si ampliano le finestrature, si perdono gli antichi contorni in pietra, gli originari intonaci terrosi vengono sostituiti da chiassosi strati cementizi a colori violenti, vengono aggiunti poggioli, i manti di copertura in sottili laste antiche sono sostituiti da solette in laterocemento magari sporgenti e coperte poi con laste a grosso spessore e taglio a macchina.
Il linguaggio arcaico e gentile dell’antica architettura viene massacrato.
Vanno perdute le tracce di un esempio originale di incontro tra cultura specifica di un popolo, quello dei “XIII comuni veronesi” – i cosiddetti “Cimbri” –
01
02
01-02.
131 77
progettuali dello Studio pigozzi
Recuperi e ristrutturazioni in Lessinia: esempi non esemplari.
03-04. Borgo di Gorgusello di Sotto, complesso della Torre. Piante piani terra, primo, e secondo. Piante piani terzo, quarto, struttura tetto torre e coperture. Rilievi di Paolo Righetti.
provenienti nel XIII secolo dalla Germania e di cui ancora si tramanda la parlata in antico tedesco e una particolare pietra, il “lastame” della Lessinia, pietra sedimentaria caratterizzata dalla sua configurazione stratigrafica e dalla possibilità di essere estratta in laste sottili e di grande formato.
Architettura e cultura che vivono per secoli qui, sulla montagna, di una straordinaria autonomia dai poteri centrali e dai loro condizionamenti: non esistono castelli in Lessinia, la struttura insediativa è quella delle contrade articolate nel territorio, per i “Cimbri” i boschi e i ruscelli erano popolati dagli spiriti della natura.
Questo incontro tra una specifica e autonoma cultura popolare da un lato e dall’altro un materiale da costruzione così caratterizzato, ha dato origine ad una cultura architettonica che nel pur vasto, ricco e onnipresente patrimonio delle antiche architetture popolari locali che troviamo praticamente in ogni luogo (anche se ormai in maniera sempre più compromessa), spicca per originalità e versatilità. Ma torniamo alla torre di Gorgusello: quello che era giunto fino a noi era in realtà un complesso di casetorri. Infatti attorno alla torre vera e propria si erano agglomerate, probabilmente in tempi successivi, delle altre strutture in parte direttamente connesse alla torre ed in parte autonome ma aventi con la torre strutture e probabilmente funzioni in comune. L’aspetto interessante e precipuo della torre di Gorgusello era proprio questo inglobamento di essa in un contesto funzionale ed anche architettonico di carattere agreste, probabilmente diverso dalla sua origine.
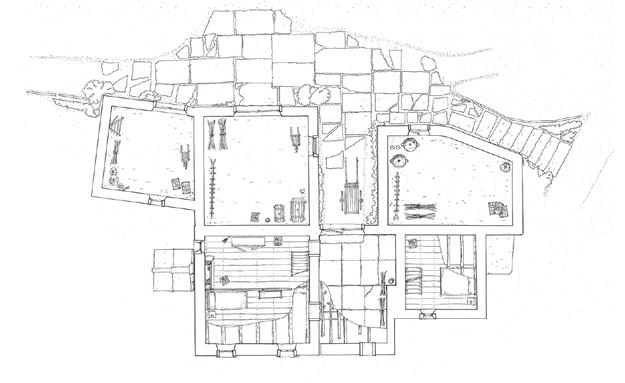

La torre infatti aveva probabilmente una funzione originaria di controllo della via che saliva dal fondovalle: in corrispondenza della torre l’antico tratturo curvava seccamente e dunque passava proprio ai piedi della torre stessa intersecandola direttamente. La struttura e il linguaggio architettonico della torre del resto denunciano una fattura che rimanda a un’edilizia “colta”, probabilmente risalente ai sec. XV-XVI: troviamo infatti una pianta pressoché quadrata con murature poderose, una possente struttura voltata al piano terra con voltine secondarie a “unghia” sulle

2022 #02 78 DOSSIER
03
aperture, la quasi monumentale scala in pietra di accesso al primo piano, le modanature alle finestre e l’alto coronamento in pietra prima del tetto. Di tutto questo rimane, sotto le macerie, probabilmente la base col vano voltato del piano terra. Come dicevo l’aspetto più interessante è questo inglobamento della torre nel complesso dell’architettura tradizionale locale che possiamo a buon conto chiamare architettura popolare essendo essa stessa espressione materica di una specifica cultura di popolo. La torre così era stata trasformata in una pacifica fattoria: lo scalone quasi monumentale ci faceva accedere ad una vasta cucina. Essa occupava l’intero corpo della torre, con pavimento in grandi laste e sulla parete ovest il sistema dell’acquaio in pietra ed un grande focolare dalla conformazione assai particolare. Sul fondo di esso infatti si apriva la bocca di un forno che sviluppava poi il suo corpo vero e proprio in autonoma piccola costruzione in pietra esterna al corpo della torre stessa, di cui costituiva singolare addizione. La combinazione forno esterno-focolare interno, che permetteva di far usufruire al primo la canna del camino del secondo, si ritrovava simile nella antica casa quattrocentesca di Camposilvano purtroppo demolita. Mentre il pavimento appoggiava sulla volta a botte, il soffitto rivelava l’orditura composita del solaio sovrastante: grossa trave squadrata correva longitudinale al centro e portava orditura secondaria in travetti squadrati poggianti sulle facciate sud e nord. Come il pianoterra si presentava cupo e maestoso, prezioso però nell’avere voltine secondarie incastonate nella principale, così la cucina rammentava una arcaica eleganza, un’antica possenza che emanava dalle sue ampie dimensioni, dalla quasi monumentalità del suo accesso, dal grande focolare, dal raffinato disegno del soffitto a orditura composita che con la grande trave caratterizzava di sé fortemente lo spazio. La torre continuava poi in altezza usando per il collegamento verticale l’edificio limitrofo: dalla cucina una seconda porta immetteva in vano ad est ove scaletta probabilmente in legno conduceva al piano superiore. Ivi due porte si aprivano nel muro della torre e davano accesso ad altrettanti vani in cui era
diviso questo piano della torre. Longitudinalmente e proprio sopra la grossa trave portante notata in cucina vi era parete divisoria sottile ma pesante, formata com’era da tre grandi laste poste in piedi e semplicemente accostate tra di loro. Questo esile massiccio diaframma precludeva comunicazioni interne, distingueva nettamente il vano in facciata sud da quello nella parte nord. E questi, entrambi di ridotte similari dimensioni, presentavano omogenei il fascino di semplici ma ricchi ambienti agresti: i bianchi intonaci irregolari delle pareti di pietra, il caldo legno del pavimento e del soffitto con strutture a vista, rimandavano a diffuse tracce di una cultura antica e a dimensione umana, quotidianamente esperita.
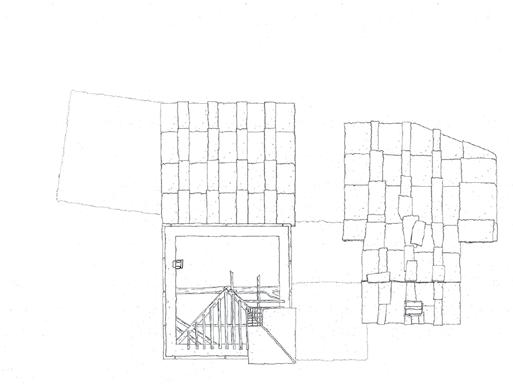
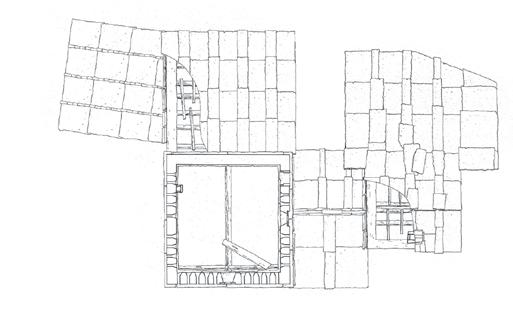
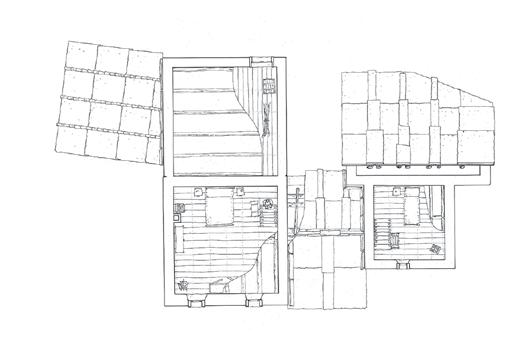
Singolare piramide trapezoidale emergeva dal pavimento di una delle due stanze e si innalzava per tutta la sua altezza: era la lunga cappa del focolare sottostante che lentamente si rastremava verso l’alto, per terminare più sopra con canna del camino a rilievo. Così riscaldava due piani e oltre. Accesso e comunicazione fino a qui dovevano avvenire da ambiti siti nell’edificio limitrofo: ma esso qui terminava in altezza e dunque al piano superiore della torre si accedeva dall’interno della stessa, con scaletta in legno posta nella stanza della parte nord. Si giungeva all’ultimo piano abitabile costituito da grande unitaria stanza, affascinante con le sue sole due piccole finestrine verso sud, verso la profonda vallata: sopra di essa altro solaio prima della copertura, per basso vano probabilmente collegato con scaletta di legno e chiusura orizzontale.
Trattavasi infatti della colombaia vera e propria contornata da murature traforate con le nicchie di accesso per i colombi.
Questo ultimo solaio piano aveva una grossa trave di orditura primaria poggiante sulle facciate sud e nord, posta dunque a 90 gradi rispetto a quella del primo piano, ottenendo così un funzionamento incrociato di legante strutturale delle murature.
Poi il tetto: un fiore di pietra e cotto poggiante sulle quattro facciate spesse ma traforate dai varchi della colombaia, quasi un arabesco di piccole fitte e più grandi aperture, irregolari e scavate nella viva pietra e dai monolitici contorni fortemente strambati, fori di
129 79
04
05. Il complesso della Torre di Gorgusello nel 1989 (foto di Paolo Righetti).
06. La torre prima dei crolli.
07. Borgo di Gorgusello di Sotto, complesso della Torre. Sezione longitudinale. Rilievo di Paolo Righetti.

luce che proiettavano raggi di un fantasioso gioco. Come dicevo all’inizio oggi per il recupero di architetture di questo tipo ci sono specifici ed eccezionali finanziamenti pubblici: finalmente a livello di istituzioni nazionali ed europee è maturata una consapevolezza sul valore di queste architetture e pertanto sta agli attori e alle istituzioni sul territorio operare.
Nel caso della torre abbiamo presumibilmente la sopravvivenza del piano terra voltato e delle murature a monte: la ricostruzione filologica delle parti mancanti è possibile partendo dall’esistente rilievo architettonico che ho personalmente eseguito prima della successione di crolli e demolizioni e che ho messo a disposizione gratuita del Comune.
Del resto conservare almeno l’immagine storica degli spazi del borgo così profondamente caratterizzato dalla presenza del complesso della Torre e delle sue aggregazioni edilizie contermini è un compito necessario se si vuol tramandare la specificità di un luogo.

Penso che riprendere in termini moderni tipologie edilizie caratteristiche, come anche la torre, materiali come la pietra locale, giocare con questi ed altri elementi per creare immagini nuove è senza dubbio la strada per connettere il nuovo alle tradizioni del luogo, ma non in sostituzione delle storiche presenze.
06
Recuperare le storiche presenze come peraltro è stato per il Teatro La Fenice di Venezia, per il campanile di San Marco, per Varsavia e per i centri storici della Germania postbellica, per le aree terremotate.
A Gorgusello opera una associazione di agricoltori biologici, che pubblica anche un giornale “Il Compascuoi” e che nel compendio della vita del borgo si è anche interessata alle sorti della torre. Oggi la situazione della torre è che essa è di proprietà demaniale, essendo stata oggetto di eredità giacente e di sentenza del Tribunale di Verona con l’attribuzione della proprietà allo Stato. Gli uffici del Demanio di Venezia, interpellati al proposito, si sono dichiarati ben disponibili ad una attribuzione del bene al Comune di Fumane, competente per territorio, a richiesta di questo. •

2022 #02 80 DOSSIER
07
05
Ri-costruzione della Torre Colombara di Gorgusello
Le visioni progettuali condotte da studenti siciliani nel borgo della Lessinia propongono alcune variazioni attente e misurate sul progetto di architettura contemporanea
 Testo: Vincenzo Latina
Testo: Vincenzo Latina
L’Architettura, la letteratura, la sceneggiatura, la cinematografia, l’arte sono tutte delle ri-costruzioni. L’architetto è il traduttore del testo architettonico, delle strutture preesistenti, nelle quali innesta nuovi interventi simili ad una somma di palinsesti, tra alterità e adattività.

L’Architettura allo stesso modo dell’Arte fa ampio uso delle ri-costruzioni. Ogni progetto, ogni idea nasce da un’immagine, da un’esperienza precedente e dalla trasfigurazione della stessa. Da una ricomposizione caratterizzata da alterità adattiva.
“La riscrittura del testo architettonico o letterario, che sia, comporta la traduzione dello stesso. Tramandare un edificio (ri-usarlo) richiede interpretazioni, traduzioni e ricostruzioni. Traduzione, Tradimento, Tradizione hanno un’unica radice latina che è Tràdere. Significa tramandare, trasmettere, consegnare. Ogni atto di ricostruzione è traduzione e trascrizione dal preesistente al nuovo, dall’antico al contemporaneo. Altre forme di Tradimento-Traduzione determinano la forma, la rigenerazione della città e il riuso dell’esistente. Gli architetti esprimono quello che della città comprendono tra ri-letture e ri-utilizzi. Operano allo stesso modo del traduttore del testo letterario. Non si può tradurre fedelmente una poesia russa o un romanzo americano, qualsiasi carme in qualsivoglia lingua. Il lavoro meticoloso, attento, dell’opera del traduttore, ovvero di colui che tradisce il testo, così da rinnovarlo, renderlo disponibile e comprensibile ai più […].
Le città sono una sequenza di “fratture” ed “assestamenti”, un continuo “bradisismo”, in cui alcune “vecchie” fabbriche degli edifici trovano rinascita attraverso la riattualizzazione e il riuso delle stesse. La strategia del riuso, sin dall’antichità alla contemporaneità, è una pratica che accomuna, anche nelle differenze, tanti straordinari edifici”1
Il programma di studio del Laboratorio di Composizione Architettonica 2 A-L, tra i vari esercizi e simulazioni, ha previsto anche la ricostruzione della Torre Colombara di Gorgusello.
Ringrazio molto Vincenzo Pavan, Anna Braioni e Alberto Vignolo, tutti architetti veronesi, che negli anni mi hanno fatto conoscere la Lessinia. Pavan, alcuni anni fa, mi ha chiesto di proporre un’idea una “visione” di ricostruzione della torre crollata, nell’accogliere la sua proposta, mi è sembrato più congeniale coinvolgere gli studenti del Laboratorio di Progetto II del quale sono responsabile. Il borgo di Gorgusello, nel comune di Fumane, area collinare veronese, si configura come uno dei più interessanti insediamenti della Lessinia.
129 81
01
02
03
01. Il borgo di Gorgusello di Sotto con evidenziata l’area del crollo della torre. Elaborazione su una foto di Ugo Sauro del 2013.
02-03. Cave di Pietra di Prun a Fumane e blocco in lavorazione (foto di Vincenzo Latina).
L’uso integrale della pietra locale, il calcare lastriforme denominato Pietra di Prun, connota in modo originale le costruzioni rurali del territorio montano. Le grandi lastre calcaree, con la loro trama geometrica, disegnano i confini della campagna e caratterizzano le strutture degli edifici. Gorgusello, tra i nuclei più antichi, negli ultimi anni ha visto il susseguirsi di una serie abbandoni e crolli parziali, culminati nel collasso pressoché totale della Torre Colombara.

L’immaginario comune auspica la ricostruzione della torre per anastilosi o filologicamente dov’era e com’era, diversamente ne è stata proposta una reinterpretazione.
Strumenti del progetto sono il tipo, gli allineamenti e le volumetrie originarie, i materiali del territorio, riletti con un linguaggio contemporaneo, che al contempo rievochino l’antica struttura e riattualizzino la cultura del progetto d’architettura. Sono stati studiati diversi approcci, scaturiti da progetti “referenti” e da riferimenti caratterizzanti
Le esperienze maturate con lo studio di architetture
« La riscrittura del testo, architettonico o letterario che sia, comporta la traduzione dello stesso. Tramandare un edificio (ri-usarlo) richiede interpretazioni, traduzioni e ricostruzioni »
disciplinarmente rilevanti trovano rispondenze e analogie nella simulazione progettuale; difatti è richiesta la scomposizione e l’analisi del caso studio la riprogettazione di una parte di esso o la ricomposizione ponderata, nel nuovo esercizio progettuale.
Uno dei temi del corso “le variazioni in architettura”, pone alcune riflessioni in relazione alla progettazione di una “Architettura Didattica” attenta e misurata, che intende tenere conto di molteplici fattori esistenti o predeterminati di ordine topologico, strutturale, distributivo e compositivo in genere. L’Architettura Didattica per l’apprendimento della composizione
04
Architettonica. Per alcuni fautori del “nuovo” ad oltranza e della estemporaneità tale metodo potrebbe sembrare eccessivamente “schematico” e riduttivo, al contrario, sono del parere che la stessa ripetizione e la sostituzione di modelli aiuti ad una espressività attenta, culturalmente legata alla disciplina del progetto.

Le esperienze compositive del II anno di corso non hanno la velleità del progetto d’architettura autonomo e compiuto, gli studenti sono ancora agli inizi del lungo viaggio nella composizione architettonica, per cui, su espressa indicazione del docente è stato proposto un “saggio” didattico, nel quale si evince l’apprendimento di alcuni concetti fondanti del progetto.
Tali assunti non sono dei vincoli rigidi o schematizzazioni sterili, anzi possono diventare un orientamento, un ausilio o meglio lo stimolo per una progettazione attenta, lontana da facili mode che propinano architetture estemporanee, autoreferenziali, cariche di connotati di eccezionalità estetica, spesso priva di fondamenti disciplinari.
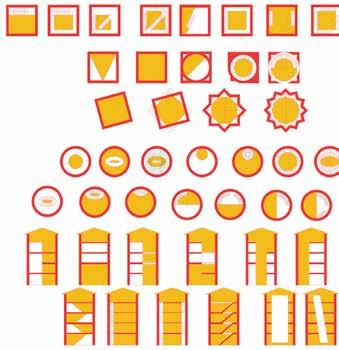
2022 #02 82 DOSSIER
Il corso di Composizione Architettonica estende il campo d’indagine e di applicazione dal dettaglio alla dimensione urbana, dalle discipline compositive, attente alla logica tettonica, distributiva, formale) con cui l’oggetto architettonico si relaziona, alle altre discipline. A tal riguardo è stato proposto un progetto nell’esistente in relazione ai caratteri peculiari di struttura, forma e materia. Si è proceduto con l’esplorazione dell’edificio esistente, attraverso disegni, i rilievi, le ricostruzioni, i collage, fotomontaggi e modelli tridimensionali, per proseguire con delle letture comparative.


Le operazioni progettuali hanno riguardato la lettura, la ricognizione, la comprensione e la trascrizione del caso studio assegnato tramite il suo ridisegno critico. A distanza di circa due anni dall’inizio della didattica a distanza, a causa del Covid, e delle esercitazioni singole da casa, sono state richieste elaborazioni progettuali in presenza, in gruppo (non più di tre studenti). Il lavoro comune è stato fondamentale per iniziare gli studenti al confronto delle idee, ha favorito pure la realizzazione di modelli di studio tridimensionali, digitali o modelli di cartoncino o materiali similari, delle dimensioni e delle scale appropriate; i modelli sono la simulazione o la traduzione di un’invenzione spaziale e non la rappresentazione miniaturizzata della realtà, di per sé irripetibile.
I modelli sono di aiuto a una migliore comprensione dell’architettura, inoltre contribuiscono all’educazione dell’osservatore. Il Laboratorio ha richiesto l’esecuzione di modelli interpretativi in cui si evidenzino le varie connessioni spaziali, distributive e tipologiche, in cui viene messa in rilievo la qualità materica e lo spazio tridimensionale. Tali relazioni non si basano su criteri d’indagine di tipo meccanicistico o procedurale, intesi come una prassi da seguire, per determinare un risultato già noto o presunto a priori, ma, una vera e propria verifica, un sistema di analisi “aperto” alle specificità del sito, dell’edificio, dell’autore e alla capacità percettiva dello studente.

Ringrazio particolarmente gli studenti del Laboratorio di Composizione Architettonica 2A, a.a. 2020-21, per la passione e il crescente impegno profuso. •

04. Schemi progettuali, piante e sezioni per la ricostruzione della Torre Colombara, materiali del Laboratorio.
05. Proposta di ricostruzione della torre. Studenti: Gioela Amato, Sofia Cunsolo, Giorgia Fiamingo, Stefania Guttà, Josephine Leotta.
06. Proposta di ricostruzione della torre. Studenti: Rocco Cambareri, Elia Fiamingo, Piermassimo Stimoli. Gaetano Distefano, Debora Dierna.
07. Seduta di esame, in primo piano alcuni modelli di studio realizzati dagli studenti del Laboratorio (foto di Vincenzo Latina). 06
129 83
07
05
Nuovo look per il manto stradale a Borgo Roma: lavori in corso (cfr. pp. 94-95).

2022 #04
86.
Un milanese a Tregnago

Il ricordo di Alessandro Tutino (1926-2022), architetto, professore di urbanistica e intellettuale, e il suo costante legame veronese grazie alla casa di famiglia di Tregnago dove ha trascorso gli ultimi anni
90.
Per Alessandro
La testimonianza di una militanza urbanistica a fianco di Alessandro Tutino nei suoi progetti veronesi
92.
Una architetto come Presidente
Alla fine degli anni Novanta al vertice dell’Ordine di Verona, Maria Giovanna Reni (1941-2022) nel ricordo di un’amica e collega
93.
Polpette e altro alla Rotonda frigorifera
In questo numero LC “mette il becco” sullo sviluppo della città in occasione della recentissima apertura della ex Stazione frigorifera specializzata ai Magazzini Generali come centro del food

94.
Fabbricare urbanità
La realizzazione di uno degli interventi di urbanistica tattica per Borgo Roma promossi da una rete di associazioni raccolte nel progetto La Fabbrica del Quartiere

96.
Per fare scuola
Gli esiti del concorso di progettazione bandito dall’amministrazione comunale di Cavaion Veronese per dotarsi di una nuova scuola secondaria di primo grado nel suo capoluogo
ODEON 85 131
Un milanese a Tregnago
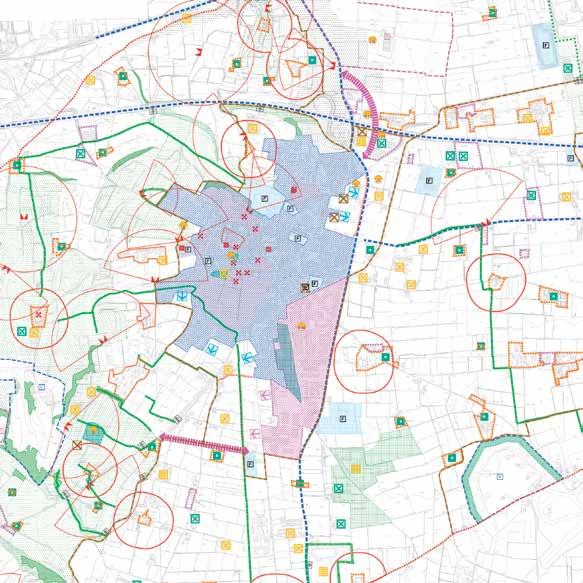
Il ricordo di Alessandro Tutino (1926-2022), architetto, professore di urbanistica e intellettuale, e il suo costante legame veronese grazie alla casa di famiglia di Tregnago dove ha trascorso gli ultimi anni
Testo: Michela Morgante
86 2022 #04
01
Le cronache nazionali ne hanno parlato davvero troppo poco, ma con la morte di Alessandro Tutino abbiamo perso l’ultimo decano vivente tra gli urbanisti italiani del dopoguerra. Era un intellettuale impegnato, un tecnico politicizzato nel senso elevato del termine. Classe 1926, milanese, tesserato del PCI della prima ora, aveva mantenuto costante il legame con Verona, grazie alle vacanze estive a Tregnago sin dall’infanzia. Qui si era ritirato a trascorrere la sua ultima stagione, una lunga vecchiaia operosa e ancora ricca di incontri ed esperienze. I contesti culturali e geografici incrociati da Tutino sono stati in realtà plurimi. Si era unito liceale alle brigate partigiane in Val d’Aosta e a fine conflitto si era iscritto al Politecnico milanese, entrando da praticante nello studio di Franco Albini. Aveva cominciato con il censimento delle macerie, in bicicletta, per le strade del centro meneghino, operazione preliminare al mitico “piano AR”. Gli studi in architettura li aveva completati nel 1953, ma allo IUAV, la facoltà dove insegnerà urbanistica per decenni (docente poi, fino alla pensione nel 1996, all’Università della Calabria).

All’interno del Collettivo di Architettura di Milano, studio professionale co-fondato a fine anni Quaranta e chiuso ufficialmente nel 1987, il lavoro era organizzato su base strettamente cooperativistica: redditi in condivisione, committenza esclusivamente pubblica, attitudine “di servizio” al territorio. Il Collettivo svolse una progettazione sociale a tutto campo, dall’edilizia pubblica ai complessi scolastici. Tutino, naturalmente, ne era il principale esperto per la pianificazione.
Il dibattito urbanistico era ancora un tema che appassionava giornali, sindacati e amministratori locali. La Legge Nazionale, quella del 1942, franava miseramente agli estremi, nella fase attuativa e a livello d’area vasta. I comuni delle cinture agricole gonfiate dall’immigrazione interna furono per il Collettivo il banco di prova per sperimentare su entrambi i fronti. Tutino firma gli studi per la “turbina” del PIM, al fianco di De Carlo, e il Piano Intercomunale di Bologna, accanto a Campos Venuti, più un’infinita serie di
02
piani regolatori nelle due regioni. Elabora a livello teorico, interviene, pubblica, contribuisce a codificare la nozione di “standard urbanistico” e di “oneri di urbanizzazione”1. Mentre la carriera dell’urbanista si svolgeva sulla scena nazionale, generazioni di studenti si formavano con lui. Tra questi alcuni veronesi, cui ha fatto da relatore di tesi a metà anni Ottanta. È il caso di Annalisa Valetti, a lungo tecnico comunale a Cavaion (una delle poche donne, ovviamente). All’epoca attivista nei movimenti di protesta contro la navigazione a motore sul Garda. Il tema – un diverso modello di sviluppo del turismo benacense, che rovesciasse lo schema privatistico dominante, facendo leva sul trasporto pubblico – era qualcosa di molto vicino alla sensibilità del professore. Per inciso, fa notare l’arch. Valetti, interpellata, dobbiamo a questa temperie culturale se la Legge regionale sulla navigazione ha imposto qualche forma di limitazione come le distanze dalle rive per il passaggio dei motoscafi.
Tra il 1977 e il 1983 Tutino è ai vertici dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, ma ci è arrivato da “personaggio scomodo” 2 . Difende posizioni ritenute dal suo stesso schieramento troppo moderate, in realtà modernamente e pragmaticamente orientate a quella che oggi chiamiamo concertazione. Il processo di piano –sostiene – deve far emergere il sottobosco
01. Piano di Assetto del Territorio di Sommacampagna, 2009: Carta della Trasformabilità, particolare
02. I fratelli Saverio (a sinistra) e Alessandro Tutino (a destra) in divisa da partigiani (fonte: https://www.facebook. com/saveriotutino/).
03. Villa Adelia a Tregnago.

ODEON 87 131
03
04. G. De Carlo, S. Tintori, A. Tutino, Schema a turbina del Piano Intercomunale Milanese, 1963 (fonte: Archivio cartografico Centro Studi PIM).
04
1 Tra i suoi numerosi scritti, vale la pena ricordare: G. De Carlo, A. Tutino, S. Tintori, La pianificazione nell’area Metropolitana Milanese, Ariminum, 1965; A. Tutino (a cura di), Metodi della pianificazione. Metodi della decisione, Edizioni del lavoro, 1985; A. Tutino (a cura di), L’efficacia del piano, Edizioni lavoro, 1986; A. Tutino (a cura di), Concordia Sagittaria: un esperimento di piano, F. Angeli, 1988; A. Tutino, V. Erba (a cura di), L’intervento urbanistico nella periferia metropolitana: analisi e proposte per il comune di Rozzano, F. Angeli, 1989.

2 Giampiero Lombardini, Valter Scelsi, Bruno Gabrielli, Città e Piani, Franco Angeli 2019, p. 200.
3 Cecchino Antonini, Un punto rosso nel bianco del Veneto. Quelli di Dp, «Popoff» 25 maggio 2017.
4 «La Piazza» n. 78, marzo 2005.
5 Geometria e natura, 2008, a cura di Stefano Carrullo, https://www. ancsa.org/pubblicazioni/
serie-storica-e-altrepubblicazioni/geometriae-natura/.
6 A. Tutino, Le piazze di Illasi, in «AV» 78, 2007, pp, 70-71.
7 Cit. in: Comune di Illasi, Storia di Illasi (a cura di Alessandro Anselmi), Progetto piccole città storiche, 2013.
8Ringrazio l’arch. Roberto Carollo, del Comune di Verona, per le preziose indicazioni sull’argomento.
9 In «AV» 79, 2007, AV reload: il punto sui grandi progetti (tramontati) per Verona Sud, pp. 57-8.
10 Vercelloni ebbe infatti il suo primo studio professionale, negli anni 1950-60, a Verona, e produsse negli stessi anni anche il PRG di Torri del Benaco. Cfr. F. Zanzottera, Archivio Virgilio Vercelloni (1930-1995), in «AAA Italia Bollettino» n. 9, pp. 46-7, 2010.
11 Alessandro Tutino, René Verza, Verona nella strategia della tensione, Caosfera, 2013.
ineliminabile degli accordi con i proprietari, in modo da monetizzare i vantaggi acquisiti nell’uso del territorio e restituirli alla collettività sotto forma di servizi.
All’epoca lo troviamo nuovamente coinvolto in vicende veronesi, in veste di garante più che di progettista. Alla fine degli anni Settanta l’urbanista è chiamato a redigere una perizia per difendere l’operato del giovane sindaco di San Zeno di Montagna, l’ing. Giuseppe Campagnari (a lungo poi Dirigente del settore Ecologia del Comune di Verona), fatto oggetto di una denuncia per interessi privati in atti d’ufficio. Una ritorsione politica della minoranza democristiana – riporta egli stesso – in seguito all’adozione di un PRG fortemente restrittivo in termini di cubature per le seconde case3
Nel 1992 Tutino si stabilisce a Tregnago, e una manciata di anni dopo trasferisce l’iscrizione professionale dall’albo milanese a quello di Verona. Ma continua a dedicarsi ai suoi incarichi di pianificazione in Calabria: l’impegno esclusivo in ambito nostrano slitta alla svolta del millennio, ancora sostenuto da ottima salute, amabilità di carattere, lucidità di pensiero. Tutino si inserisce facilmente anche nella dimensione micro-locale. Anima la vita culturale della Val d’Illasi, con un
occhio costante ai valori civici. Come quando su «Illasi allo specchio», periodico politico-culturale di cui è direttore, segnala con garbato dileggio l’obbligo imposto dal Comune di Colognola ai Colli di restaurare le scritte del Ventennio affioranti dalle facciate delle case private4
Nel 2006-7 coordina la revisione del Piano ambientale del Parco dell’Adige, conferendo all’esperienza quel valore aggiunto che Anna Braioni spiega molto efficacemente su queste stesse pagine. Il lavoro – rimasto purtroppo lettera morta – assume una risonanza nazionale presentato alla platea dell’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici (ANCSA)5.
Nello stesso 2006 Tutino è membro della giuria del concorso di idee per riqualificare le tre piazze di Illasi, accanto ad altri esperti di levatura non solo locale. Gli obiettivi del confronto sono da lui stesso chiaramente delineati su «ArchitettiVerona» 6: si trattava di intervenire su un sistema di luoghi centrali a bassa specializzazione funzionale, conferirgli identità e un adeguato disegno formale, soprattutto ai margini. Nel nucleo dell’Est veronese l’occhio dell’esperto coglieva un disordine stridente con un “impianto urbanistico [invece] di esemplare chiarezza”, degno di una “città di grande importanza e di lunga storia” 7. Egli stesso ne aveva ricostruito precisamente l’evoluzione con puntuale capacità di lettura storica. Unendo finezza di analisi a immaginazione ideativa, come i migliori esponenti di una generazione ancora indenne da sterili specialismi professionali. Forse in virtù di tale sincretismo, Tutino giudicava in complesso deludenti gli esiti di questa piccola grande occasione progettuale, e vi ritrovava i riflessi di una crisi più generale della cultura urbanistica italiana. Ancora nel 2006 interviene nel dibattito cittadino sulla cosiddetta “Variante Gabrielli” 8. I rapporti con il collega piemontese (scomparso nel 2015) erano di lunga data e risalivano all’impegno di entrambi nell’ANCSA, a inizio anni Settanta – al tentativo nazionale di utilizzare le politiche sociali per riqualificare i tessuti antichi. Le critiche al Cardo Massimo vengono proposte, come sua consuetudine, come spunto di riflessione il più possibile costruttivo. Tutino si pronuncia per conto del Comune di Sommacampagna (coinvolto
88 2022 #04
d’ufficio in quanto comune contermine), ai tavoli di consultazione previsti dalla VAS sulla Variante 282. E in sintesi sostiene la necessità di sopprimere il casello di Verona Sud, smistando il flusso di penetrazione dalla provincia al sistema delle tangenziali. L’urbanista nutriva infatti forti perplessità sulla capacità dei nuovi provvedimenti (rotatorie, mezzi pubblici in galleria ecc.) di alleggerire in modo sostanziale l’asse di viale del Lavoro, eliminandone l’effetto cesura a scala di quartiere. Senza contare il problema del “collo di bottiglia” costituito dai fornici del sovrappasso ferroviario di porta Nuova. Tutino ritornava sul tema anche l’anno seguente, interpellato da «AV»9, già in un mutato clima politico. Temendo l’archiviazione da parte di Tosi dell’intero dossier “Verona Sud”, da lui giudicato improcrastinabile, ribadiva il suo giudizio severo sul piano, con una sottolineatura sulla scala monumentale della
05
06
rambla, considerata estranea alla morfologia storica veronese.
Negli anni fra il 2007 e il 2013 Tutino è consulente del Comune di Sommacampagna, in squadra con i tecnici Paolo Sartori e Luca Lonardi. Nello stesso comune aveva presieduto, qualche anno prima, la Commissione edilizia: è dunque gradito all’amministrazione di centro-sinistra, ma grazie alla sua autorevolezza resiste al cambio di amministrazione del 2009. Per una serie di circostanze abbastanza casuali, l’insediamento cui Tutino metteva mano era cresciuto (vertiginosamente) all’ombra di un primo PRG firmato nel lontano 1964 dal cognato Virgilio Vercelloni10. L’urbanista si inserisce a distanza di svariati decenni a valle della prima fase di concertazione sul Documento preliminare, dando un apporto sostanziale alla stesura della Carta
« Tutino si inserisce facilmente anche nella dimensione micro-locale. Anima la vita culturale della Val d’Illasi con un occhio costante ai valori civici » 07
della Trasformabilità e a quella delle Invarianti. L’esperienza da lui maturata nel campo della dimensione metropolitana non poteva che coadiuvare le difficili scelte strutturali con cui si cercava faticosamente di correggere, trasformandole in opportunità, le ricadute date dalla vicinanza al capoluogo – in termini di effetti “dormitorio”, scarico dei flussi su gomma, compromissione del paesaggio collinare. La tormentata fase attuativa che seguì costituì un capitolo a lui fortunatamente precluso, anche per evidenti ragioni anagrafiche. Con un ponderoso volume sull’Est veronese riletto come epicentro della strategia della tensione, redatto nel 2013 con René Verza spulciando una mole impressionante di atti processuali11, si chiude il cerchio di un impegno pubblico improntato incessantemente ai valori della Resistenza abbracciati in gioventù. Rappresenta l’omaggio estremo dell’urbanista – amaro – alle sue terre d’elezione, Lombardia e Veneto, legate negli anni Settanta da inestricabili trame nere. Ricostruiamo dunque attraverso la testimonianza di Anna Braioni, al suo fianco nella professione nei decenni veronesi, il valore umano profondo insito nel suo attivismo: “prendersi cura” del territorio. •
05. Il contributo di Tutino sul concorso per la riqualificazione delle piazze di Illasi, «AV» 78, 2007, pagina di apertura.


06. Estratto dal contributo di Tutino sulla Variante Gabrielli, «AV» 79, 2007.
07. Copertina dei volumi L’efficacia del piano, 1986, e Verona nella strategia della tensione, 2013.
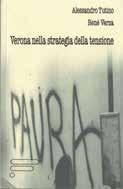

ODEON 89 131
Per Alessandro
La testimonianza di una militanza urbanistica a fianco di Alessandro Tutino nei suoi progetti veronesi
Testo: Anna Braioni
Non riesco a pensare ad Alessandro unicamente per la sua grande figura di architetto-urbanista, che ha sottolineato in tutta la sua vita professionale il diritto a una corretta gestione del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, il diritto cioè di vivere consapevolmente il bene comune. Lo ricordo come un “sapiente” che per habitat famigliare ha assorbito il pensiero della borghesia illuminata milanese, che guarda ed è guardato dalla cultura internazionale, che vive a pieno titolo le grandi azioni della storia italiana: la Società Umanitaria, organizzazione filantropica della fine dell’Ottocento tuttora vitale, la Resistenza, la Guerra partigiana, l’Internazionalismo – politico e sociale – del secolo scorso. Bisognerebbe andare tra i diari familiari depositati a Pieve di Santo Stefano nell’Archivio Storico istituito dal fratello maggiore Saverio, corrispondente per le più grandi testate giornalistiche da Cuba, dalla Cina di Mao Tse Tung, dai luoghi della Guerra Fredda, per capire qual era il clima culturale vivace e aperto al mondo di chi ha creduto e voluto vivere appieno quella stagione.
Lo ricordo durante i frequenti momenti conviviali (era un piacevolissimo obbligo festeggiare
il suo compleanno) presso la sua casa di Tregnago, nel giardino che dava sulla vallata1; spesso erano presenti alcuni suoi familiari, le sorelle Nannina e Isa – giornalista e scrittrice, che si compiaceva nell’estendere e rafforzare la memoria in tutti i campi del vivere, dalla moda alla casa nella società contadina 2 , assieme al suo compagno Franco Ottolenghi. Ricordo il piacere con cui descrivevano il locale dove si cenava, la boiserie di un
01
e Direttore artistico per diversi teatri musicali.
liberty elegante e pacato, disegnata, costruita e montata dagli studenti della Società Umanitaria 3 come regalo di matrimonio per la loro madre Fanny Castiglioni, così come il racconto di tutte le vicissitudini nel loro lavoro di recupero dopo l’occupazione tedesca che aveva visto la sala da pranzo trasformata in ambulatorio 4. Lo ricordo ancora alla fine degli anni Ottanta nel clima domenicale dei pomeriggi musicali presso la Chiesa della Disciplina di Tregnago, con importanti musicisti invitati dal figlio Marco, già famoso compositore a livello internazionale
Ma collaborare con Alessandro nel suo campo disciplinare, al di là della soggezione e dell’emozione che nei primi tempi mi prendevano, è stato il momento dello schiudersi mentale per quanto di ideologico mi impediva un approccio coerente alla professione: legata al territorio ma da vivere con gli “umani”. Solo in minima parte l’avevo recepito negli incontri dell’Istituto Nazionale di Urbanistica e a quelli, saltuari, dell’Unione Inquilini. Come si possono affrontare i grandi temi della pianificazione affinché restino connessi a chi vive il territorio? Quanto è importante e necessaria la critica se resta legata alla complessità?
La prima occasione di collaborazione è stata per il Porto turistico di Bardolino, dove era richiesto dall’Amministrazione comunale
01. I fratelli Alessandro, a sinistra, e Saverio Tutino, a destra, 2011 (foto da Flickr, Archivio diaristico Pieve di Santo Stefano).
02. Piano ambientale del Parco dell’Adige, revisione 2007, Tavola sinottica.

90 2022 #04
«
Il desiderio di imparare sempre dalle altre discipline per una verifica della propria davano il senso della sua apertura intellettuale »
lo Studio di Incidenza ambientale riguardante il progetto del suo ampliamento. L’interdisciplinarietà era d’obbligo, ma la pratica, tutt’ora largamente in uso, conduce ad apporti specifici a servizio di ciò che si intende dimostrare. L’iter, come invece il metodo scientifico richiede, di verifiche successive alla luce delle conoscenze che man mano si definiscono, apre, chiude, modifica prospettive indicate dall’ambiente umano nella propria storia e verso un futuro possibile che non è solo economico, né solamente estetico, ma compreso e vissuto passo a passo, azione dopo azione.
Quando poi gli chiesi di accompagnarmi nella revisione del Piano ambientale del Parco dell’Adige5, accettò l’incarico con grande piacere. L’esame del lavoro precedente a cui avevo partecipato con il coordinamento del prof. Sandro Ruffo, naturalista di fama internazionale, servì a lui per indirizzare le analisi su temi puntuali non particolarmente affrontati precedentemente, e cioè le basi socio-economiche per una gestione legata alle nuove misure europee per i territori a Parco e il lavoro divulgativo per una diffusa conoscenza dei temi. Ciò concludeva l’esame di tutti i fattori che incidono sulla realizzabilità di un piano urbanistico, a parte l’input politico-amministrativo affrontato molto spesso come unico tema che spesso svilisce tutto il sistema degli approcci, scientifici e non! Anche l’accompagnamento al PAT di Adria6 , seppur limitato al paesaggio, ha lasciato il segno su tutto il gruppo di progettazione riunito dall’Amministrazione comunale, perché il tema è stato

rivisitato nella sua complessità, non solo estetica così come da tanti relegato, ma umana, di memoria, di vita, di culture sedimentate, di diversità, di economie che si sono imposte nella storia.
La sua storia di urbanista possiamo definirla militante; parte dal suo vissuto famigliare, dalla sua storia intellettuale con un obiettivosogno: un territorio “giusto” per gli uomini e per l’ambiente attuale e futuro, un’abitazione per tutti, quartieri popolari attrattivi, centri storici che mantengono la memoria delle vite trascorse e non solo delle architetture. È il prosieguo della sua militanza nella Resistenza, del suo lavoro nel Collettivo di Architettura 3, la sua prima attività professionale a Milano. Credo pure di aver assorbito da Alessandro la sua intransigenza rispetto agli escamotage della pianificazione di quegli anni, chiarendomi i meccanismi nascosti che avrebbero inficiato i buoni “propositi” (un esempio l’uso della 167 nelle urbanizzazioni dagli anni Settanta in poi). In tal senso è stato un vero maestro. L’altro aspetto che, pur se compreso, non sono mai riuscita a ripetere, era la sua capacità di imporsi con un dialogo serrato, mai alzando i toni e soprattutto mai dichiarando la propria superiorità conoscitiva e speculativa, solo praticandola: l’atteggiamento maieutico che si evince anche leggendo i suoi testi, nell’esprimere i contenuti disciplinari gli ha permesso di affrontare temi complessi e coinvolgere altri, anche meno consapevoli, nelle possibili soluzioni.
È la conoscenza puntuale assieme a una visione futura del territorio
“umano” la conditio sine qua non per promuovere azioni virtuose e non produrre i disastri (e non solo quelli ambientali!) che ora si stanno verificando. L’errore può diventare la norma se non si riesce a mantenere uno sguardo dall’alto, ma conoscere bene il tutto dal basso, comprese le relazioni umane, è l’altra condizione imprescindibile.
Infatti per il Parco dell’Adige, così come nella prima fase di studio il sistema ambientale era stato sviscerato in tutti i suoi legami con l’uso del territorio, in questa seconda ogni porzione, ogni appezzamento veniva esaminato affinché l’ambiente potesse ritrovare un giusto equilibrio con le attività umane in tutte le sue sfaccettature, e quindi normato conoscendone gli obiettivi finali, specifici e complessivi. Ogni appezzamento aveva indicazioni progettuali, talvolta erano norme, altre di indirizzo per accompagnare
in senso maieutico, dialogico con il territorio, il progetto di trasformazione o di conservazione. Il desiderio di imparare sempre dalle altre discipline per una verifica della propria davano il senso della sua apertura intellettuale, pensiero attento che sapeva mettere assieme e al posto giusto nella scala dei valori i diversi input. Tutto ciò ha una profonda radice: essere stato un “resistente”, un pensante, un intellettuale organico nel periodo bellico, in quello postbellico, fin tanto che gli è stato permesso di vivere. •
ODEON 91 131
02
01. Un ritratto di Maria Giovanna Reni negli anni Novanta.

02. La Rotonda agli ex Magazzini Generali nello stato attuale.
Una architetto come Presidente
Alla fine degli anni Novanta al vertice dell’Ordine di Verona, Maria Giovanna Reni (1941-2022) nel ricordo di un’amica e collega
1 Villa Adelia, ai piedi della Pieve, poco prima dei campi sportivi, fu acquistata dal nonno materno Giovambattista Alessi dopo l’Unità d’Italia. Il nome veniva dalla prozia di Tutino, la madre dell’alpinista partigiano Ettore Castiglioni, fratello di Fanny, madre di Alessandro, Saverio e delle sorelle.
2 Isa Vercelloni Tutino è stata direttrice di «Casa Vogue» dal 1968 al 1992. Oltre alle numerose pubblicazioni, ha curato nel 1994 (con Ugo La Pietra e Giancorrado Ulrich) la riedizione di alcuni arredi disegnati da Guglielmo Ulrich, per “Abitare il tempo”. L’allestimento della mostra era firmato dal figlio Matteo Vercelloni, architetto, figlio di Virgilio Vercelloni (Milano, 1930-1995), urbanista e storico dell’architettura al Politecnico di Milano.
3 Il nonno Giovambattista Alessi prese parte alla spedizione dei Mille, fu parlamentare e presidente della Società Umanitaria, per dieci anni fino alla morte. L’Umanitaria da inizio Novecento promosse sperimentazioni di edilizia popolare. Dal 1919 avviò la prima Esposizione lombarda d’arte applicata, negli anni divenuta la Triennale.
4 Dal diario di Alessandro Tutino dal titolo Un sistema narrativo, scritto nel 2000-1, che raccoglie ricordi sin dal 1932. Cap. 18, “La manutenzione”. Cfr. Anna Iuso, Stile Tutino, in «Primapersona», 25, 2012.
5 La revisione del Piano ambientale del Parco dell’Adige, attuata nel 2006-7, faceva seguito al primo piano, voluto dalla giunta Sboarina nel 1989. Il Parco venne istituito nel 2005. Cfr. L. De Stefano, Parco dell’Adige. Per fare un parco ci vuole un albero, in «AV» 84, 2009, pp. 83-85.
6 Nel 2008 Tutino è cCapogruppo e riceve, con l’Autrice, l’incarico per la definizione dei criteri di salvaguardia delle aree agricole e del paesaggio agrario per il PAT di Adria.
Ho conosciuto Giovanna – Maria Giovanna
Reni – all’inizio degli anni Settanta, quando da giovane architetto (oggi si direbbe architetta) avevo iniziato a collaborare, tra altri lavori, con Otto Tognetti, che era solito avvalersi di neo laureati per realizzare ricerche, schedature e analisi urbane in vari comuni nei quali promuoveva la sua attività. Nello studio Tognetti in Palazzo Canossa, allora un crocevia per gli architetti veronesi, già lavorava in maniera più continuativa Giovanna, che non avevo avuto modo di incontrare prima in quanto il suo percorso formativo si era svolto a Città del Messico, dove era cresciuta con la sua famiglia e dove si era laureata.
In quegli anni di grandi opportunità, dopo non molto era giunto il momento di metterci in proprio, e decidemmo di aprire uno studio in condivisione, che mantenemmo dal 1972 fino alla fine degli anni Novanta. Si trattava in realtà di quello che oggi viene chiamato coworking, in quanto ognuna aveva i suoi lavori: rimaneva però una quotidianità di frequentazione e un’amicizia maturata da un’affinità e dal dialogo quotidiano, anche con animate discussioni politiche com’era nello spirito dei tempi. Anche il nostro studio, una volta
trasferito nel suggestivo spazio incastonato in Porta Leona, accoglierà nel tempo diversi altri colleghi.
Negli ultimi anni Giovanna si trasferì poi in un’altra coabitazione lavorativa assieme a Stefano Braggio, che era stato suo vice quando divenne presidente dell’Ordine, da febbraio 1997 a marzo 1999 (mentre a sua volta lei era stata vice di Gian Caleffi nel quadriennio precedente). Questo suo ruolo di primo piano è stato senz’altro significativo per aver infranto il “soffitto di cristallo” come prima – e finora unica – presidente donna dell’Ordine. Un ruolo di rappresentanza che le si addiceva, legata com’era anche per ragioni familiari a una dimensione politica della professione; erano del resto anni in cui essere schierati era naturale. Il suo impegno professionale era pertanto poco rivolto alla
progettazione architettonica e molto più dedito a studi e consulenze per amministrazioni pubbliche.
In tale ruolo ha anche fatto parte del gruppo dei progettisti del Quadrante Europa, una importante e lungimirante occasione per Verona.
Verso la fine degli anni Ottanta giunse una sorta di folgorazione creativa che l’ha portata a realizzare delle stampe su tessuti di seta con riproduzioni di mosaici da chiese palocristiane o romane, un’attività che per un certo periodo l’ha molto impegnata.
Al di là degli aspetti professionali e pubblici, rimane vivo il ricordo personale per la lunga consuetudine, unite dall’essere tra le poche donne architetto della nostra generazione.
•
92 2022 #04
Testo: Bertilla Ferro
01
Polpette e altro alla Rotonda frigorifera
In questo numero LC “mette il becco” sullo sviluppo della città in occasione della recentissima apertura della ex Stazione frigorifera specializzata ai Magazzini Generali come centro del food
alcune caserme; le vecchie Manifatture tabacchi, gli ex Magazzini generali e altri.
Non ho messo a caso il titolo di questo intervento che si annuncia polemico, ma non lo è: semmai ricorda i lamenti di chi non perde occasione per fare le pulci alle Amministrazioni pubbliche. Ben diverso avrei voluto titolare , per esempio: “Altro e polpette alla Rotonda frigorifera”, ma non posso: sono tempi in cui con una certa frequenza mi assale il dubbio di essere ancora in sintonia con le scelte e lo spirito della città, la nostra, che, pur credendosi e dicendosi avanzata culturalmente – o forse proprio per questo – trascura le occasioni favorevoli per dimostrarlo non cogliendo le opportunità che le si prospettano: ed è anche per questo motivo che posso apparire infastidito o polemico: ma sono solo dispiaciuto e scontento. Mi riferisco allo sviluppo culturale della città, ma non solo, che i tanti cambiamenti in atto – in economia, nei costumi, nelle tecnologie, nei modi di vivere e perfino nei valori – oggi propongono in modo apparentemente confuso. Da anni, infatti, alcune attività e funzioni, prima vitali, stanno perdendo significato: le manifatture escono dai capannoni liberando superfici edilizie; le strutture di commercio operano on line lasciando vuote botteghe e negozi; le attività direzionali abbandonano le prestigiose sedi aziendali ritirandosi con i loro pc nelle cucine e nei soggiorni dei loro impiegati, eccetera. Il fenomeno, tuttora in atto, non sappiamo quando e come si concluderà, ma da tempo stiamo registrando che la città sta espellendo alcune attività e che altre vengono meno, si trasformano o vengono assorbite, pur se crescono immensi centri logistici e commerciali ; di fatto si stanno liberando molti complessi edilizi : le sedi storiche di Pasqua e Tiberghien, le ex Carceri, l’ex Ospedale militare,
E proprio da questi ultimi due partirei, e mettendo il dito sulla piantina di Verona, segnalerei che le due principali occasioni del quartiere fieristico per attuare una politica di espansione o almeno di controllo delle aree a lei prossime, quella dei Tabacchi e quella dei Magazzini, le ha perse.
La prima è stata acquisita da una compagnia di Bolzano per trasformarla in un albergo e in superfici commerciali, la seconda, dopo decenni di proprietà pubblica, è ora di Fondazione Cariverona che ha trasformato in uffici gli edifici a magazzino e in un centro del food la gloriosa Rotonda frigorifera. Vanto ed emblema se non della città almeno della Verona industriale dell’anteguerra: e per di più vincolata. Sono del parere che non sia sempre perseguibile una politica di espansione fisica delle attività e che talvolta sia preferibile, proficuo e meno costoso, adottare criteri di “partecipazione” o di controllo –come già detto – intesi a potenziare i propri affari in modo lecito ma meno rischioso e più sottile e che pertanto, di volta in volta, si tratti di valutare come approfittare di una occasione per rafforzare la propria attività e immagine, come nei due casi che ho prima ricordato. L’interesse di Veronafiere al controllo dell’ ex Tabacchificio era garantito dalla reciproca collocazione sul territorio che
avrebbe visto l’area fieristica avvicinarsi di fatto alla stazione ferroviaria e alla città, ma anche assumere per dimensione e posizione, quel ruolo di centralità effettiva della Verona Sud, mettendosi in grado di trasformare di fatto l’intero settore urbano: dandogli, oltre alla testa, le gambe. Quanto ai Magazzini generali, la loro area poteva essere utile, più che alla Fiera, alla città per concentrarvi tutti o quasi gli uffici pubblici comunali e nella Rotonda un importante e stratosferico Centro culturale espositivo. E questa volta avremmo fatto Bingo: 1) realizzando di fatto il centro della Verona Sud; 2) conservando per intero la Rotonda, macchinari e tipologia funzionale inclusi; e 3) scusandomi per l’immodestia, raggiunto l’obiettivo di una mia proposta presentata a Veronafiere un paio di anni fa nell’ambito del suo futuro ruolo nel contesto urbano.
P.S. E adesso è più comprensibile il titolo: “Polpette (ovviamente ottime) e altro…”. •

ODEON 93 131
Testo: Luciano Cenna
02
Fabbricare urbanità
La realizzazione di uno degli interventi di urbanistica tattica per Borgo Roma promossi da una rete di associazioni raccolte nel progetto La Fabbrica del Quartiere


All’interno dell’ampio progetto de La fabbrica del quartiere, finanziato da Fondazione Cariverona e condotto da una pluralità di associazioni locali, è stato portato a termine a fine 2022 il primo di una serie di interventi di “urbanistica tattica” mirati alla valorizzazione del suolo comune all’interno del quartiere di Borgo Roma a Verona. Si tratta di una neonata prassi consistente nella rivalutazione degli spazi urbani tramite azioni partecipate che nascono “dal basso” a partire dalle necessità concrete dei cittadini. Il modello è quello delle oramai celebri piazze a pois milanesi – da piazza Dergano a piazza Angilberto II – diventate simbolo di questo nuovo approccio all’urbanistica. In sostanza, si promuovono tanti piccoli interventi di “agopuntura” a basso costo per rendere la carreggiata stradale il più democratica e accessibile possibile, una strada for all, stimolando quindi una riappropriazione dello spazio urbano in maniera differente.
A Borgo Roma si è creato un vero e proprio catalizzatore di energie collettive e sociali che ha trovato terreno fertile e possibilità di esprimersi grazie alla mediazione di una rete di professionisti, tra urbanisti e architetti, assieme agli uffici del Comune di Verona. Anche in questo caso la scelta è stata indirizzata verso interventi realizzati con mezzi leggeri e un ridotto processo burocratico ma di forte impatto visivo, con lo scopo di innescare, nel loro insieme e in tempi brevi, un miglioramento della viabilità urbana, anche con azioni volte al rallentamento del traffico automobilistico. Il nuovo look del manto stradale non deve essere concepito come una azione di tinteggiatura fine a se stessa, ma come occasione di tutela e di valorizzazione degli spazi.
Alla base della “tattica” c’è l’obiettivo di valorizzare lo spazio pubblico nei quartieri dando voce alle richieste effettive della cittadinanza a seguito di un attento processo di mappatura urbana. Con mappatura urbana si intende una campionatura e selezione mirata dei nodi più critici ove è necessario un’azione migliorativa, in maniera compartecipata sia dai cittadini che dai tecnici coinvolti.
All’interno di questo processo ermeneutico di criticità e potenzialità di ciascun nodo, sono state ascoltate, accolte e concretizzate le richieste poi tradotte in azioni progettuali.
L’intervento portato a termine in questa fase, eseguito da volontari, si è svolto in due fasi: la prima ha previsto la riorganizzazione di
94 2022 #04
02
Testo: Giulia Biondani
01
alcuni spazi stradali di via Redipuglia e viale dell’Industria con lo scopo di riattivare nuove aree e snodi per la socialità. Il manto stradale è stato dipinto con colori e forme che richiamano il fondale marino – in accordo con lo slogan Borgo Roma vista mare – e altri elementi che echeggiassero tematiche solari. Con l’occasione sono state realizzate alcune migliorie alla segnaletica orizzontale, tracciando due nuovi attraversamenti pedonali. La seconda fase è stata più dinamica e ha coinvolto realtà teatrali e band musicali, che hanno animato in una serata a metà ottobre l’intero percorso in una sorta di flash mob, richiamando l’attenzione della cittadinanza a dimostrazione del potenziale che possono avere gli spazi residuali.


In questo primo intervento si è costruita una linea di connessione tra i due parchi più significativi di Borgo Roma, quello di San Giacomo, relativamente più vecchio, e il più recente Parco di Santa Teresa, tramite un fil rouge – in questo caso verde – realizzato dagli stradini comunali. Si è concretizzata così l’idea proposta dai cittadini
stessi in sede di riunione, una linea di connessione costellata da scritte impresse sull’asfalto, fatta di moltissime frasi emblematiche della multietnicità di un quartiere in estremo fermento e cambiamento. È stata quindi promossa una pedonalizzazione temporanea per la sicurezza dei residenti a ridosso di alcuni incroci particolarmente pericolosi e rigenerato il tracciato pedonale e carrabile con un’azione di valorizzazione, a dimostrazione che il bello può essere intravisto anche negli spazi di risulta della carreggiata stradale. Vivere la strada come spazio pubblico vede la necessità di gestire e monitorare i flussi di accesso ai parchi, per consentire il gioco e l’attività fisica dei bambini anche in tratti del percorso dove mai si sarebbe potuto immaginare.
La Fabbrica del Quartiere, oltre a offrire uno spazio di espressione della cittadinanza, è stata promotrice di molte altre attività per favorire la socializzazione, come una rassegna di cinema all’aperto, un laboratorio completamente al femminile che ha previsto una campagna di sensibilizzazione con questionari mirati a incrementare la percezione della sicurezza del quartiere, laboratori di urban sketching Continue riunioni di aggiornamento e di work in progress per i prossimi interventi di urbanistica tattica animano costantemente la fervida fucina di idee di Bruto Poggiani 2, in una ricerca tesa al miglioramento di un tessuto non solo urbano ma anche sociale; due aspetti che non possono che procedere di pari passo. •
LA FABBRICA DEL QUARTIERE
Progetto promosso da COCAI aps, Comune di Verona, Energie Sociali Cooperativa Sociale ONLUS, COSP VERONA (Comitato Provinciale per l’orientamento scolastico e professionale di Verona), Cooperativa Sociale Reverse, Associazione Verona FabLab, Associazione Culturale Le Falie, Associazione AGILE

Con il sostegno di Fondazione Cariverona
www.lafabbricadelquartiere.it
01. La realizzazione di alcune scritte stencil come tappa del processo di riappropriazione della strada.
02. Veduta notturna dell’incrocio di via Bruto Poggiani.
03. Lavori in corso.
04. Volontari della Fabbrica del Quartiere.
ODEON 95 131
03
04
Per fare scuola
Gli esiti del concorso di progettazione bandito dall’amministrazione comunale di Cavaion Veronese per dotarsi di una nuova scuola secondaria di primo grado nel suo capoluogo
progetto 1° claSSificato capogruppo: arch g iorgio carlo SantagoStino

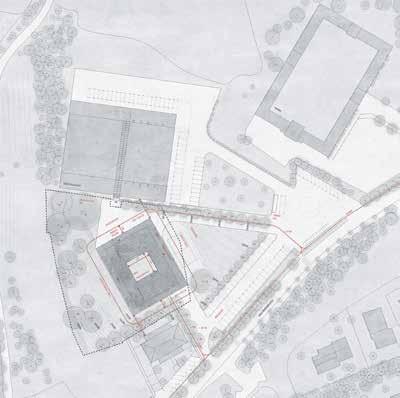
Si è conclusa con la graduatoria finale e l’identificazione di un bel progetto vincitore la procedura di concorso che il comune di Cavaion Veronese ha meritoriamente scelto per dotarsi di una nuova scuola secondaria di primo grado, ovvero di ciò che un tempo si chiamava semplicemente “scuola media”. Il tema è sicuramente azzeccato, perché di rinnovare lo stock obsoleto dell’edilizia scolastica italiana c’è un grandissimo bisogno, ed è per questo che tra le procedure concorsuali vanno per la maggiore per l’appunto le scuole di ogni ordine e grado: al punto tale da ingenerare la specializzazione per alcuni studi che assiduamente vi prendono parte. Per non parlare di iniziative monstre come quella del 2016, con 51 scuole messe a bando in tutta Italia – con risultati pare scarsi se non nulli – oppure quella per i 212 edifici scolastici innovativi e, rigorosamente sostenibili, del concorsone lanciato come una tavola da surf sull’onda del PNRR nel pieno dell’estate del 2022. Nel suo piccolo, Cavaion Veronese ha creduto nel concorso a prescindere da occasioni simili: anche se la presenza di un sindaco architetto non è certo da ritenersi estranea alla scelta. Perché, si ripete sempre fino allo sfinimento, il concorso è lo strumento principe per garantire la qualità architettonica, e quello in due
fasi è il principe dei concorsi. Com’è dunque andata a finire? Si dà il caso che chi scrive abbia fatto parte, su indicazione del nostro Ordine, della giuria del concorso, pertanto le note che seguono rappresentano l’occasione di una personalissima testimonianza “dal di dentro”. In ottima compagnia, le due sessioni di valutazione, quella di prima fase con tutti i progetti pervenuti e la selezione dei cinque per la seconda, si sono svolte con
01. Planimetria con inserimento nell’area.
02-03. Vedute esterne con il portico e il fronte verso il giardino e il parcheggio.
04-05. Vedute interne: spazi di relazione e palestra.
06. Piante ai diversi livelli e sezioni.
96 2022 #04
Testo: Alberto Vignolo
02
03 04
grande curiosità, attenzione e continue comparazioni tra scelte alternative comunque degne di interesse. Con l’occhio sempre rivolto al sito di progetto, rivisto in un sopralluogo in apertura dei lavori della giuria, e l’orecchio teso alle richieste del bando: anche quando sono parse stridenti o poco confacenti al combinato disposto tema-luogo, come si è reso poi evidente nel prendere visione delle proposte pervenute. Per non parlare del comune soprassalto, durante il sopralluogo, di fronte al cantiere di un edificio posto su uno dei lati dell’area di progetto, che nei documenti concorsuali risultava ancora una modesta casetta, diventata però un consistente volume edilizio fortemente condizionante gli affacci della scuola nei suoi confronti: e infatti non pochi dei partecipanti non se ne sono resi conto, fiduciosi di quanto proposto dalla “mappa delle mappe” – Google Street – recante ancora lo stato pre cantiere.
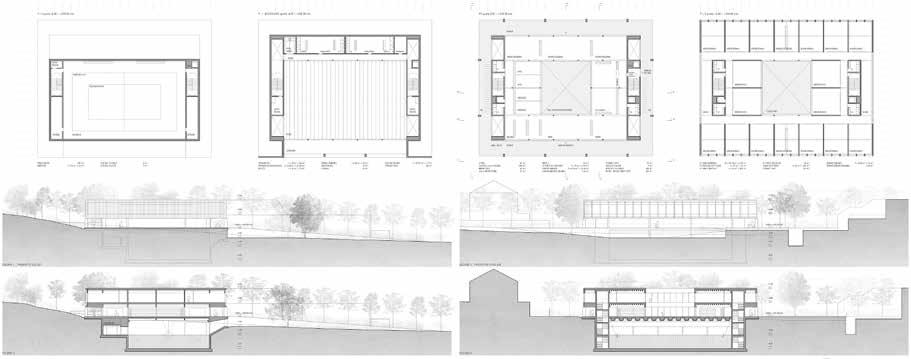
CAVAION VERONESE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Concorso di progettazione



1° CLASSIFICATO arch. Giorgio Carlo Santagostino (capogruppo) arch. Monica Sofia Alves Margarido arch. Stefano Farina ing. Alessandro Gasparini (Gap Progetti srl) dott. geol. Davide Gasperetti 06
05
ODEON 97 131
07. Tavola di progetto con pianta del piano terreno, schemi organizzativi e funzionali, render esterni e interni.



08. Veduta e sezione sulla corte.
Ma nonostante tutto, il concorso per una scuola in fondo piccola per un piccolo comune di seimila anime ha richiamato ben 59 partecipanti: il che significa, pensando a una media ottimistica di cinque persone coinvolte per ogni gruppo progettuale, almeno trecento persone che ci hanno creduto e provato. E questo nonostante l’abnorme richiesta di documentazione amministrativa e burocratica, ma anche il grado di approfondimento a ogni livello –morfologico, distributivo, strutturale, energetico normativo – previsto già in prima fase. A controprova di ciò,
i progetti presentati alla seconda fase si sono rivelati sostanzialmente identici, se non del tutto, a quelli della prima, solo spalmati sulle due tavole richieste invece che in una singola. Da cui la considerazione che, se la procedura del concorso in due fasi deve essere così organizzata – e lo è sicuramente – il risultato è solo una perdita di tempo secca dei tre-quattro mesi tra primo e secondo grado, altro che approfondimento!
Altro sarebbe se si potesse strutturare il primo livello in maniera molto più snella, incentrato sostanzialmente sull’idea generale e
98 2022 #04
07 08 progetto 2° claSSificato capogruppo: arch g
iulia Salandini
sull’impostazione di massima, per poi lasciare i necessari approfondimenti e adempimenti burocratici ai selezionati per il secondo grado. Davvero impossibile?
Non è l’unica contraddizione, del resto, con la quale ci si è imbattuti. Il bando prevedeva un importo massimo delle opere previste che in fase di valutazione è stato ritenuto unanimemente del tutto inadeguato. Ma naturalmente, tutti i progetti hanno dimostrato nei loro computi, come prescritto, la rispondenza con tale valore. Da cui il trionfo dell’ipocrisia: perché è comunque assodato che la disponibilità di un progetto è un prerequisito necessario per richiedere fondi tramite bandi, finanziamenti o simili, e dunque l’importo iniziale è giocoforza destinato a cambiare. Continua a sfuggire, nel mare degli adempimenti burocratici, il fine ultimo di un concorso, che dovrebbe essere quello di garantire il miglior progetto possibile, o forse meglio il miglior progettista con cui far crescere e maturare assieme
09
CAVAION VERONESE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Concorso di progettazione
2° CLASSIFICATO arch. Giulia Salandini (capogruppo), arch. Matteo Fiorini, arch. Nicola Bedin, arch. Andrea Castellani, arch. Anna Valbusa, arch. Pedro Ribeiro, arch. Ana Fereira, Sinergo (ing. Marco Brugnerotto, ing. Filippo Bittante, ing. Stefano Muffato, dott. geol. Daniele Lucchiari)
3° CLASSIFICATO arch. Federico Bertoli (capogruppo), arch. Davide Bigaran, arch. Mario Sassone, ing. Ivan Pavanello, arch. Paolo Pititu, arch. Marco Zocco, dott. Luca Arione, arch. Daniel Antonini
10
4° CLASSIFICATO (escluso dalla graduatoria per vizi amministrativi) arch. Dino De Zan (D-recta, capogruppo), arch. Massimo Galeotti, ing. Simone Carraro (Sogen), Dabster (ing. Marco Rossi, ing. Alessandro Gecchele, ing. Giorgio Grezzani), dr. Stefano Donadello (Dabster), dott. geol. Filippo Torresan, arch. Angelo Renna, arch. Gaetano Carambia
5° CLASSIFICATO arch. Federico Orsini (capogruppo), arch. Filippo Govoni, arch. Andreja Tagliatesta, ing. Enrico Pallara, ing. Gustavo Bernagozzi, dott. geol. Emma Biondani
progetto 3° claSSificato capogruppo: arch federico b ertoli 09-10. Vedute esterne con gli ingressi della scuola e della palestra. 11. Piante piano terra e primo.



99 131
ODEON
11
12. Tavola di progetto con planimetria generale, veduta esterna, schemi morfologici e modelli.

13. Spazio di relazione all’interno della scuola.

all’amministrazione una proposta che comunque rimane a un grado di definizione inferiore non solo a un progetto preliminare, ma anche a uno studio di fattibilità. Di fatto, anche ognuno dei fantastici cinque della seconda fase ha mostrato delle criticità per qualche aspetto che sarebbe stato comunque da mettere a punto in fase di confronto con i vari enti nelle eventuali fasi successive della progettazione. E dunque, tirando le somme tra i vari aspetti soggetti a valutazione secondo il bando, il risultato ha premiato il progetto che è sembrato
sostanzialmente più convincente e appropriato. La proposta, infatti, ha sorpreso per l’integrazione del volume della palestra nel corpo edilizio, con una soluzione seminterrata da mettere a punto ma funzionale a un’organizzazione degli spazi compatta, strutturalmente convincente, distributivamente corretta e capace di dare luogo a un’immagine architettonica estremamente sobria e razionale. Nel corso dei lavori della giuria, il progetto si era guadagnato il vezzeggiativo di “progetto svizzero” per la sua aria austera e rigorosa,
100 2022 #04
progetto 4° claSSificato capogruppo: arch d ino d e z an
12 13
forse un po’ mainstream ma anche per questo capace di suscitare l’auspicio di poter vedere realizzata anche in un piccolo paese un’architettura rappresentativa del proprio tempo. Anche gli altri quattro progetti giunti alla seconda fase avevano suscitato interesse e aspettative da parte della giuria, ma a conti fatti la valutazione di pro e contro, di pesi e contrappesi ha determinato gli esiti

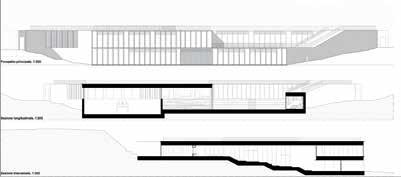
noti. A poco o nulla sono serviti i video richiesti come elaborato integrativo della seconda fase, una richiesta bizzarra perché poco utile a valutare le caratteristiche del progetto rispetto alla bravura – e al costo – dei renderisti di turno. Se ne poteva fare francamente a meno.
E ora? La storia dei concorsi è costellata di grandi speranze e di auspici delusi. Staremo a vedere. •
progetto 5° claSSificato capogruppo: arch federico o r Sini
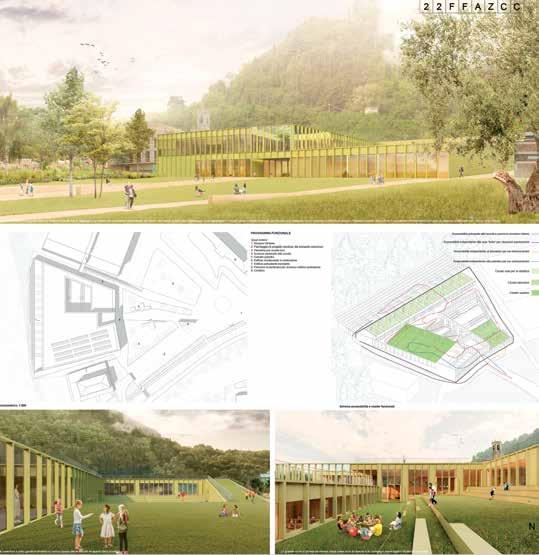
14. Tavola di progetto con vedute esterne, planimetria e schema assonometrico.
15-16. Pianta piano primo e profili.
ODEON 101 131
14 15 16
Sovrascritture aperte sul lago di Garda
I progetti per Campo di Brenzone elaborati sotto la guida di Maria Grazia Eccheli alla Scuola di Firenze e raccolti in un volume che dà conto di una ricerca sui borghi di pietra abbandonati

102 2022 #04 QUASI ARCHITETTI
01
Testo: Claudia Cavallo
Dove il Monte Baldo degrada in pieghe più dolci prima di immergersi nel Lago di Garda e il Mediterraneo irrompe con il suo clima mite, il borgo abbandonato di Campo di Brenzone appare come una concrezione del paesaggio di terrazzamenti ad ulivi del versante occidentale. Nel suo nome è raccolta la dialettica dicotomia che Campo intrattiene con il paese a valle, Brenzone, secondo la dimensione doppia che ha sempre connotato l’abitare sul lago, tra la riva e il vicinissimo monte.
Al rapido mutare delle rive del Benaco, trasfigurate nel corso del Novecento dal turismo ‘fast’, si contrappone poco più in alto, inerpicandosi su ripide mulattiere, una dimensione del costruito ancora estremamente prossima al suo ‘grado zero’.
Due torrenti stabiliscono come soglie metaforiche i margini estremi dell’insediamento: da un lato il ‘guado’ è un ponte che supera la forra incisa dall’acqua tra le pareti di pietra della “Valle della Madonna”, al capo opposto la fonte, bordata di pietre e raggiunta da una morbida gradonata, è quasi un piccolo teatro cui fa da sfondo la chiesa, quale ultimo avamposto ai piedi del bosco.
La strada che attraversa il borgo, prima di biforcarsi in una diramazione tra monte e lago, scandisce due parti di natura distinta: il ‘castello’ e l’anfiteatro naturale.
Un poggio che interrompe la pendenza è il luogo deputato per un’irregolare e imponente costruzione, cresciuta attorno a un mastio di cui si riconoscono le enormi murature in sasso e a sacco (oltre 1 metro di spessore). Castello, più per la collocazione emergente e il volume massivo che per il carattere dell’architettura. Il segreto dell’abitare in questo luogo
è scritto in sezione: gli ambienti voltati controterra ad altezze diverse disegnano un ancestrale raumplan , che ricompone idealmente l’andamento originario della collina tramutata in ‘castello’. Al di sopra di questo suolo cavo, l’azzurro del lago entra dentro le stanze, attraverso le finestre singolarmente grandi, i solai e le coperture crollate.
La strada che cinge l’antico nucleo insegue e quasi ricalca una delle sinuose isoipse, mentre le costruzioni disposte lungo il suo bordo compongono un anfiteatro frammentario, aperto verso le rocce vive del fronte bresciano e illuminato dalla luce calda del pomeriggio.
La forma dell’insediamento esprime la ratio fondativa medioevale, connotata dalla fortezza primigenia attorno alla quale si dispongono i tessuti abitativi, secondo progressive aggregazioni di un’elementare cellula base in muratura di pietra locale, con volte ai piani terra e solai lignei ai piani superiori. Tessuti che si articolano seguendo le forme suggerite dall’orografia del terreno e dai bisogni dell’e-
conomia familiare, mettendo in scena quella condizione di reciprocità tra centro abitato e paesaggio agrario caratteristica della vita di questi luoghi.
All’interno del Laboratorio di Progettazione della professoressa Maria Grazia Eccheli presso il Dipartimento di Architettura di Firenze, abbiamo proposto come tema di riflessione e progetto il recupero di Campo
01. Veduta di una delle stanze del cosiddetto ‘castello’ di Campo.


02. Campo di Brenzone. Catasto austriaco, 1848. ASVr (Archivio di Stato di Verona).
03-04. Sistemi voltati esterni e rovine attorno al nucleo più antico.
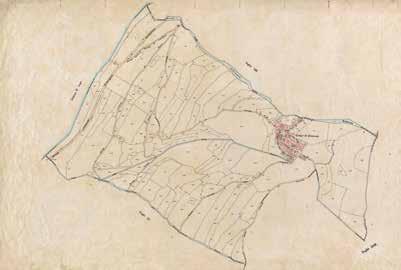
103 131
02 03 04
05. Campo di Brenzone, planimetria generale dello stato di fatto.
06. Camere sospese e nuovi affacci per l’antico accesso al castello. Pianta (dettaglio) e sezione prospettica. Studenti: T. Fressoia, A. Marini.
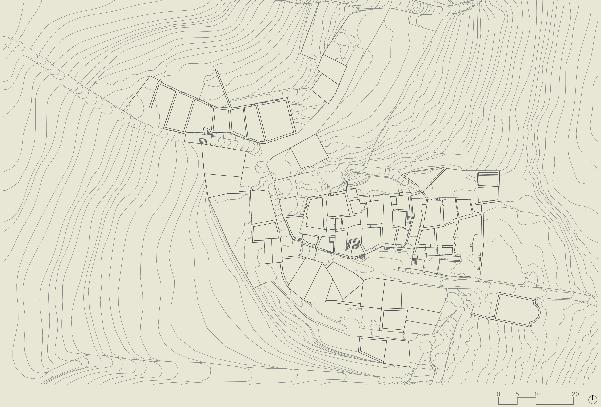
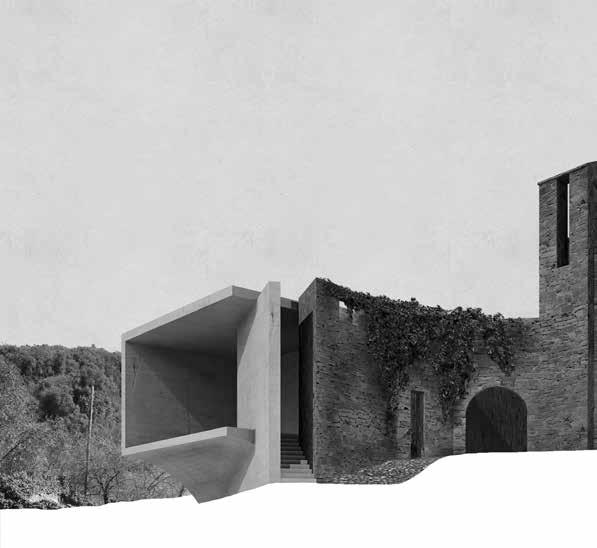
07. Nuovi personaggi attorno al castello. Studenti: A. Lico, S. Moscini.
di Brenzone, per un abitare temporaneo, o quantomeno stagionale, ma non per questo privo di memoria. Un grande ostello e minuti alloggi richiedono di immaginare nuove forme dell’abitare, diverse da quelle che hanno generato l’antico insediamento, allora profondamente interrelato a uno sfruttamento agricolo del territorio ai limiti della sussistenza. Un abitare da ripensare a fronte dell’abbandono di umili case cresciute l’una sull’altra, dove le murature irregolari, legate da veloci stesure di grezzi intonaci, sono ora scoperte e, crollate le coperture, esposte all’erosione. Gli spazi controterra raccolti o addirittura bassi, troppo bassi e troppo bui, perché misurati per tenere le bestie ai piani su strada (o sentiero) e i piani superiori pensati per gli uomini, più alti, ma ugualmente raccolti in sequenze di piccole stanze, sono
ora improvvisamente aperti in squarci franosi o sottili e poetiche fessure, che lasciano entrare nuove luci e permettono nuovi affacci.
Prima del progetto è l’interrogazione della ‘miniera’, il luogo, per disseppellire i segni e le icone che al luogo appartengono ed attendono di essere espressi, a partire dall’esperienza: camminare, misurare e disegnare tanto le forme dell’ambiente costruito, quanto la modellazione della terra coltivata che da esso si irradia. E ancora ascoltare e studiare, per entrare dentro una cultura che, anche se ‘minore’, è sempre ricchissima di soluzioni interessanti, a volte vere invenzioni spinte dalla necessità di fare e, nondimeno, dal desiderio del ‘ben fatto’, dignitoso, evocativo. Il laser scanner affina le possibilità di lettura e ci consegna un documento inestimabile che attesta lo stato di

104 2022 #04 QUASI ARCHITETTI
05 07 06
fatto e permette di considerare, nel progetto, quelle forme casuali generate dall’azione del tempo.
«Il fascino delle rovine è che un’opera dell’uomo viene sentita alla fine come un prodotto della natura». È proprio quell’eterna lotta «tra la volontà dello spirito e la necessità della natura», che nella rovina trova una pausa, o riconciliazione, a connotarne il senso estetico, secondo Georg Simmel, poiché «il palazzo, la villa e persino la casa colonica, anche quando si adeguano perfettamente alla disposizione del paesaggio, discendono sem-
pre da un diverso ordine di cose che solo a posteriori sembra combaciare con quello della natura». Ma oltre al carattere di riconciliazione fisica, «le rovine creano la forma presente di una vita passata […]»1
L’abbandono del borgo colloca la sua presenza in una condizione sospesa nel tempo e ricca di virtualità di completamento, in potenziale, alla quale non vogliamo rinunciare, poiché in essa radica il nostro attaccamento estetico alla rovina. E tuttavia, come ricostruire senza negare questo fascino?
08-09. Sezione trasversale e longitudinale del castello con interventi di progetto. Studenti: M. Ferraro, B. Fossatelli, L. Mucciolo.
10-11. Recupero degli edifici esistenti e nuovi inserimenti nell’anfiteatro naturale: planivolumetrico (studenti: L. Corbi, V. D’Andraia); vista prospettica (studente: Z. Ristovski).




105 131
09 08 11
10
a cura di Maria Grazia Eccheli, Claudia Cavallo
Firenze University Press, 2022 Scritti di Maria Grazia Eccheli, Gianandrea Gazzola, Alberto Pireddu, Claudia Cavallo, Caterina Lisini, Alberto Ghezzi y Alvarez, Ugo Rossi
Di fronte allo straniamento prodotto dall’incontro con le rovine, si aprono due strade possibili: una tenta di misurare e ricostruire l’architettura quantificandone lo spazio, provando a colmare i vuoti generati dagli elementi nel corso del tempo, come nell’impresa di leggere un antico manoscritto incompleto. La seconda sfrutta la tensione dell’inconoscibile, della contemplazione del frammento come ‘relitto’, monito dell’ascesa e caduta delle costruzioni che, inevitabilmente, ritornano ad essere parte della natura. Tale dicotomia è lampante negli schizzi che Le Corbusier realizza nei Carnets de Voyage d’Orient ; talvolta le rovine sono rappresentate in pianta, misurate e distanziate nel tentativo di ricostruire lo spazio per come era, e talvolta come oggetti plastici puri, emergenti dalla linea a matita del paesaggio. L’operazione filologica, legata all’approccio storiografico e archeologico, risponde alla necessità di conoscenza che il singolo proietta sulle rovine. Tuttavia, essa è solo una parte del racconto, come lo è la pura percezione del ‘sublime’. La comprensione della storia di un luogo,
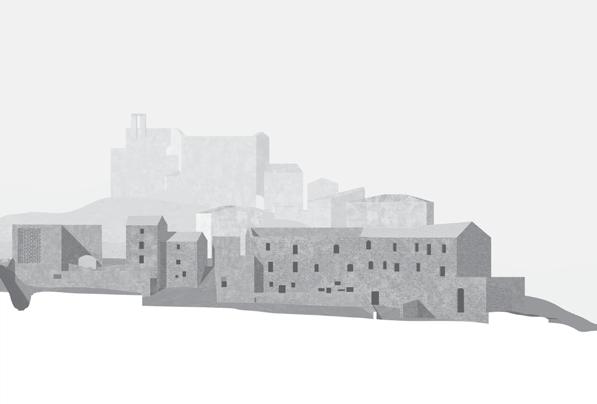
dei sistemi di vita passati che sfumano nel tempo lasciando lacerti sfuggiti «per miracolo all’annientamento» (G. Gazzola, Arte e Rovina, contributo al volume), è linfa vitale di una interpretazione poetica del carattere del luogo stesso. È proprio in questo terreno di confine tra esattezza filologica e percezione che si colloca il progetto nei luoghi abbandonati: l’importanza di interpretare le passate trasformazioni come bacini di possibilità differenti, rispondendo alla poetica del presente. La ricerca progettuale contenuta nel libro curato da Maria Grazia Eccheli e Claudia Cavallo, iniziata nel 2014, entra nel vivo della questione progettuale nei borghi abbandonati, visti come opportunità e alternative all’abitare nella densità delle aree metropolitane. Tale approccio non è indagato nell’ottica di un idilliaco e falsificato ritorno ad una civiltà contadina ormai scomparsa, sbandierata senza sosta dai laudatores temporis acti, bensì tende a una consapevolezza pienamente radicata nel presente. Il volume restituisce un quadro di esempi in cui il pensiero progettuale si è confrontato con la rovina e l’abbandono: nell’architettura di Giancarlo de Carlo a Colletta di Castelbianco, nei progetti di Buchner Bründler e le ricerche di Aldo Rossi in Canton Ticino e nell’arte di Gianandrea Gazzola. Il racconto trova poi compimento nelle esercitazioni progettuali svolte nel corso di quattro anni accademici (2016-2020), in cui gli studenti dei corsi di Progettazione IV della Scuola di Architettura di Firenze hanno trasformato i paesi fantasma Castiglioncello di Firenzuola (FI) e Campo di Brenzone (VR) attraverso case per artisti, teatri ed eremi d’arte, ascoltando la voce del luogo e ritrovando quei caratteri universali di un’architettura che sarà sempre contemporanea, pur destinata, anch’essa, a divenire rovina. (Alberto Ghezzi y Alvarez) •
12. Prospetto dell’anfiteatro naturale con i nuovi interventi di progetto sullo sfondo del castello. Studente: Z. Ristovski.
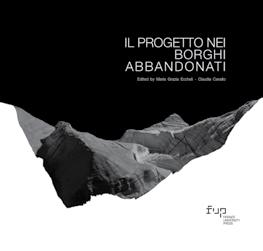
13. Maschere di pietra sospese sull’antica porta del castello. Pianta (dettaglio) e sezione. Studenti: A. Lico, S. Moscini.
12

La rovina suscita indubbiamente un senso di meraviglia che può rinnovarsi, anziché estinguersi, in un progetto che esalti la frattura generata dal tempo. Si tratta di dichiarare l’impossibilità di una ricostruzione dov’era com’era, dentro quella poetica già sperimentata da Maria Grazia Eccheli e Riccardo Campagnola e ben descritta nelle parole che Franco Purini ha dedicato ai loro progetti, dove il frammento «indica quello spazio discorsivo del comporre nel quale il parziale, l’interrotto, il residuale sono portatori del senso più completo della totalità»2 .
Nei progetti elaborati con gli studenti tra 2018 e 2020, il vuoto accompagna la percezione del costruito: vuoti inaspettati dentro densi svolgimenti di aggregati edilizi aprono nuovi sguardi su antichi manufatti, ora visibili da
106 2022 #04 QUASI ARCHITETTI
IL PROGETTO NEI BORGHI ABBANDONATI
13
inediti punti di vista. I nostri strumenti di progettisti sono il muro, la scala, il tetto e, nondimeno, il vuoto, la fessura, la pausa.
Si delinea una sovrascrittura aperta che espone, suggerisce ed evoca senza mai restituire l’immagine compiuta.
I luoghi collettivi sono allestiti con puntuali aggiunte all’interno delle grandi stanze ai piani superiori del castello, dove i solai crollati lasciano monumentali volumi, e i camini offrono il varco tra sale comunicanti. Le camere trovano luogo negli spazi voltati o nei piccoli piani sospesi in
sommità, dove l’altezza delle murature ne suggerisce la creazione. Non tutti gli ambienti vengono però nuovamente coperti e spesso una stanza diventa giardino segreto su cui si aprono nuove e generose finestre a illuminare stanze anguste.
Le scale di accesso al castello, che appaiono ricavate tra le murature di bordo di edifici originariamente distinti, restano aperte sul cielo, ma su di esse si affacciano le camere racchiuse da scultoree maschere di pietra. Nell’anfiteatro naturale si presentano alcuni nuovi personaggi carichi di memorie: un giardino di pietra a fianco del ponte invita ad attraversare spazi metafisici tesi tra murature incomplete e nuove mura coperte da sottili piani orizzontali.

Lo spazio degli alloggi è ricavato all’interno delle antiche cortine murarie, facendo di due case una sola,
14-15. Alloggi e spazi collettivi nell’anfiteatro naturale. Studente: Z. Ristovski.
16. Un giardino segreto tra nuove e antiche mura. Studenti: G. Giovi, S. Roseto. 15 16
14
iterando pieni e vuoti, mantenendo dialettiche distanze tra la controfacciata e l’involucro effettivo, dove si insinua il fascino discreto della rovina. Una nuova architettura si pone sulla strada e allunga la sua presenza verso il prato per costruire un collegamento diretto agli ambienti voltati controterra, enoteche o cucine condivise, che integrano gli ambienti minuti dell’abitare. La direzione del nuovo edificio approssima l’andamento del terreno, il fronte riprende il ritmo esistente nel borgo, l’interno declina antiche misure in nuovi spazi di relazione tra gli alloggi e gli annessi turistici. Questi ultimi si costrui-
scono in una dialettica serrata con l’orografia del terreno, da cui affiorano soltanto le murature in sasso longitudinali, come recinti tra terreni agricoli, che proteggono il patio scavato per catturare la luce. Nei completamenti e nelle nuove architetture di progetto si sperimenta la continua suscettibilità dei resti del passato ad usi e significati diversi, secondo il mutare delle circostanze, al fine di svelare il fluire di combinazioni e variazioni «soggette ad una logica interna che le organizza»3 e dispiegare poeticamente la morfologia genetica del luogo, in continuo equilibrio tra memoria e vita. •
1 G. Simmel, Le rovine, in Id., Saggi di cultura filosofica, traduzione di M. Monaldi, Guanda, 1993 (prima edizione 1985, ed. originale Philosophische Kultur, 1911), pp. 108-114.
2 F. Purini, Centri di resistenza poetica, in M. G. Eccheli, R. Campagnola, Architetture topografie leggendarie, Alinea, 2008, p. 10.
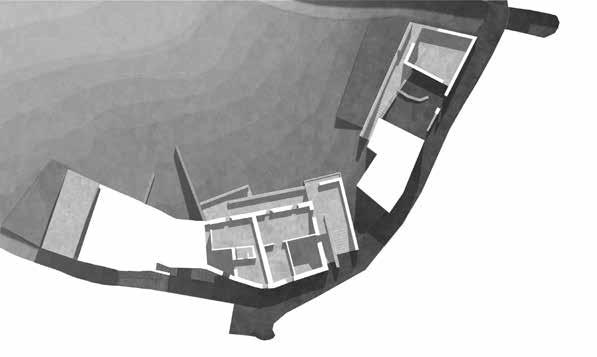
3 H. Focillon, Vita delle Forme, Alessandro Minuziano Editore, 1945, p. 67.
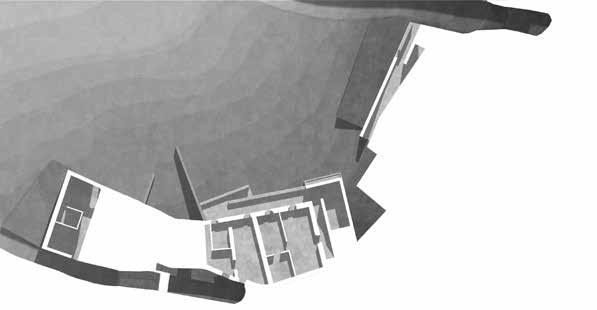
107 131
« L’abbandono del borgo colloca la sua presenza in una condizione sospesa nel tempo e ricca di virtualità di completamento »
PORTFOLIO CLAIRE LAUDE: UN SILENZIO LESSINICO
A silentio è il titolo di un volume che raccoglie la ricerca espressiva di Claire Laude, architetto e artista, nata in Francia e residente a Berlino. Due differenti luoghi, l’isola di Tinos in Grecia e la Lessinia, sono stati oggetto dell’indagine dell’artista. La tappa lessinica si è svolta grazie a una residenza d’artista: all’interno del progetto “SÅM – Esplorazione visiva della Lessinia”, curato da Ana Blagojevic, Chiara Bandino e Francesco Biasi in collaborazione con Film Festival della Lessinia e la Galleria Fonderia 20.9 di Verona. In questa occasione, attraverso la guida di Vincenzo Pavan, Laude è andata alla scoperta dell’architettura tradizionale della regione, interrogandosi sulla sua eredità e sulle nozioni di autenticità e identità.
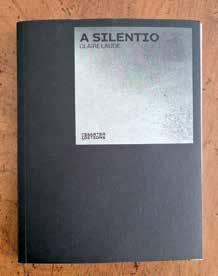

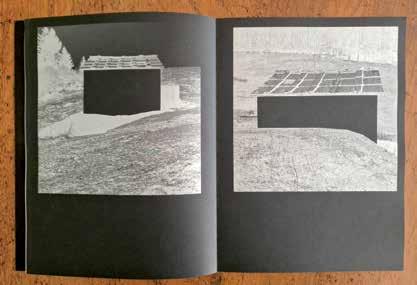
Il progetto è parte di una ricerca in corso sulle relazioni tra architettura e oblio. L’ambivalenza tra presenza e assenza di memoria, tra ciò che è immaginario e ciò che è vivo e la reinterpretazione di queste testimonianze in relazione a un luogo, sono il cuore del suo lavoro.
Presentato nell’ambito del FFDL 2021, il lavoro di Claire Laude è confluito nel libro pubblicato da ESSARTER Éditions (2021), dal quale sono tratte le immagini qui presentate. (A.V.)
108 2022 #04
Foto: Claire Laude
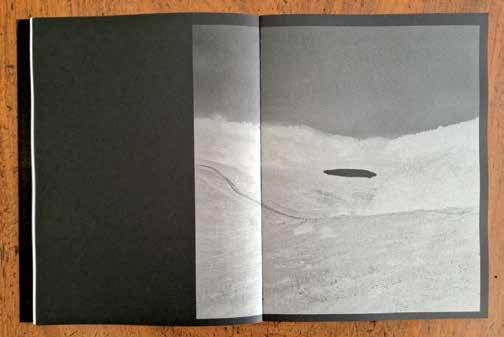

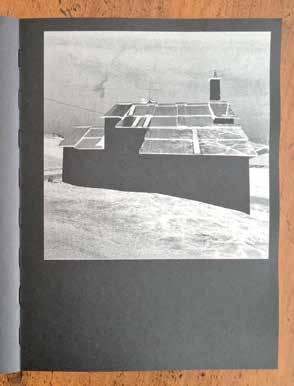
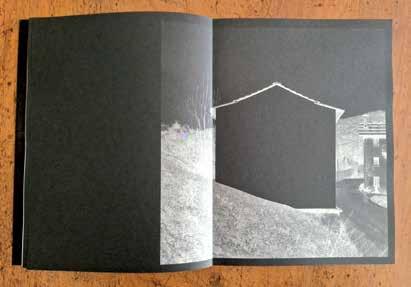
109 131
Forme di Oluce

Una riedizione per lo storico marchio di design nel campo dell’illuminazione fondato nel 1945




La lampada G.O. è la riedizione di un modello disegnato per Oluce da Giuseppe Ostuni negli anni ’60.
Una lampada che nella sua essenza progettuale è estremamente attuale, caratterizzata da uno stelo verticale da cui si snoda una tige orizzontale cui è montato il paralume. Il braccio, grazie al sistema di snodo, è quindi un elemento scorrevole e diventa riposizionabile e orientabile a seconda delle esigenze.

Una famiglia che mantiene intatti gli stilemi del progetto originale, come l’utilizzo del paralume cilindrico e il contrasto tra i materiali con cui sono realizzati i vari elementi. La riedizione è impreziosita da ricercati dettagli in oro satinato che emergono nel contrasto con il nichel nero – delle tige – e i colori della base e il paralume, quest’ultime disponibili in tre differenti varianti cromatiche: nero, rosso scarlet e anodic bronze.
L’uso del colore dona vigore e una nuova contemporaneità al progetto originale che prevedeva un’unica versione da tavolo, pensata sia per lo spazio domestico che per il mondo del contract. Questa riedizione invece amplia il progetto con una nuova versione da lettura, caratterizzata anch’essa dalla possibilità di riposizionare e orientare il fascio di luce.
Oggetto decorativo ma dal disegno pulito e lineare, G.O. colpisce per la sua attualità, confermando l’attitudine di Oluce di creare oggetti capaci di trascendere le mode e le epoche.
A Verona le collezioni Oluce sono disponibili presso Formediluce in corso Milano.

01-02. Lampada G.O., Oluce: declinazioni delle differenti finiture nelle versioni da tavolo (G.O.-252) e da lettura (G.O.-352).
03. Rosso scarlet per l’ambientazione delle due lampade.
04-05. Particolari del paralume cilindrico e dello snodo del braccio.
LA BACHECA DI AV 2022 #04 110 #publiredazionale Corso Milano, 140 - Verona - formediluceverona.it ILLUMINAZIONE E DESIGN FORME DI LUCE CORSO MILANO 140 37138 VERONA TEL +39 045 810 1138 WWW.FORMEDILUCEVERONA.IT INFO@FORMEDILUCEVERONA.IT
Corso Milano, 140 - Verona - formediluceverona.it ADREM studio VR ILLUMINAZIONE E DESIGN 03 01 02
04
05
Sezionali - Basculanti - Serramenti - Carpenteria
Stefano Berti quarta generazione dell’azienda Artgiana Berti snc realizza prodotti, non solo per il residenziale, basculanti, sezionali ( con un ns brevetto), serramenti in alluminio, ma anche, prodotti per l’industria di pregio come facciate continue uniche, personalizzate e arricchite da carpenteria su misura.
La conoscenza dei materiali sviluppata nel corso di quattro generazioni e la continua ricerca di nuovi materiali e soluzioni, permette a Stefano insieme ai suoi collaboratori e agli studi di progettazione di realizzare i desideri della committenza.






LA BACHECA DI AV 111 131 #publiredazionale BERTI SNC DI BERTI STEFANO VIA I MAGGIO 34 37012 BUSSOLENGO (VR) TEL +39 045 7150689 TEL +39 328 986 9051 WWW.BERTIVERONA.IT INFO@BERTIVERONA.IT
Dal 1890 solidità, utilità, bellezza
L’esperienza di MetalRiv a disposizione di progettisti e imprese
01-02. Due momenti della lavorazione in officina della scultura del Maestro Pino Castagna realizza per il Color Hotel di Bardolino.
03. La scultura finita nello stato attuale.

MetalRiv s.r.l. è un´azienda che opera con serietà e professionalità dal 1969 nel settore metalmeccanico, specializzandosi nella realizzazione di carpenterie metalliche medio pesanti e pesanti in acciaio.


Particolare attenzione è stata posta negli anni all’acciaio inox in tutte le sue finiture, forme e campi di utilizzo.

Con l’obiettivo di garantire uno standard di elevata efficienza e qualità per il cliente, l’azienda costantemente si aggiorna con le normative e le certificazioni di settore, facendo formazione interna e incrementando il personale.
La nostra professionalità si traduce in un rapporto costante con la clientela che supportiamo con personale qualificato sia in ambito di sviluppo dei disegni sia in ambito di produzione e realizzazione del progetto. In fase di design abbiamo sviluppato l’utilizzo di programmi di ultima generazione, passando dal tradizionale Autocad all’innovativo BIM (Business Information Modelling, con programmi come Tekla e Inventor).
Particolare attenzione dedichiamo all’aggiornamento e all’addestramento del nostro personale (in ambito sicurezza, saldatura, certificazioni) e alla ricerca delle migliori soluzioni in termini di qualità-prezzo. Una qualità, la nostra,
che si realizza ricorrendo alle migliori materie prime certificate, affiancandoci a partner di lunga data e a nuovi, per dare al cliente la possibilità di scegliere, con lavorazioni sempre coerenti con il periodo di avanzamento tecnologico. L’azienda vanta svariate realizzazioni e referenze nel campo industriale, con collaborazioni sempre maggiori nell’ambito delle costruzioni, sia private che pubbliche, con imprese di costruzione del nostro territorio affermate da anni. Partnership, costanza e impegno ci hanno consentito recentemente di raggiungere un importante traguardo: il passaggio da una classe di esecuzione EXC2 a EXC3, biglietto da visita per la realizzazione di lavorazioni di sempre maggior spessore. La versatilità della nostra azienda e dei nostri materiali ci consentono di collaborare anche con settori come il vitivinicolo, l’agricoltura, il tessile e l’alimentare. Non da ultimo il settore dell’ecologia, dove la nostra esperienza ci ha portato a sviluppare linee complete in acciaio inox dedicate allo smaltimento. Vantiamo anche collaborazioni nel mondo dell’arte, affiancando artisti e scultori di fama mondiale nella realizzazione dei loro progetti, garantendo la massima qualità tra l’artigianato e l’industriale.
Grazie alla nostra esperienza formata negli anni, offriamo oggi il nostro supporto e le nostre realizzazioni nel campo dell’architettura e del design, garantendo tutta la nostra disponibilità per la realizzazione del prodotto in linea con le richieste e le esigenze del cliente.
LA BACHECA DI AV 2022 #04 112 #publiredazionale METAL RIV SRL LOC. CAVATERRE ZAI, 4 37020 RIVALTA DI BRENTINO BELLUNO (VR) TEL +39 045 6284069 WWW.METALRIV.IT INFO@METALRIV.IT
I sarti del metallo
01
02 03
Casa Capra falegnameria dal 1950
Falegnami figli di falegnami: un nome una garanzia da sempre
Siamo una storica e significativa azienda ne mercato artigianale veronese di finestre, porte, strutture per la casa e l’arredo su misura d’interni.
La prima falegnameria nasceva al Chievo nel 1950 per iniziativa di Ettore Capra; 28 anni più tardi inizia il mestiere di falegname anche il figlio Giorgio, che in pochi anni prende in mano le redini della azienda e che nel 1994 apre, con la moglie Nicoletta, il negozio in via Croce Bianca 31. Qui nasce il marchio Casa Capra. Negli anni successivi l’azienda si allarga, nuovi dipendenti entrano nello staff e con loro i tre figli di Giorgio. Nel 2016 la richiesta sempre maggiore di clienti desiderosi di affidarci tutti i lavori di casa spinge l’azienda ad ampliare ulteriormente i propri servizi: Casa Capra diventa “ristrutturazioni chiavi in mano”.
La nostra azienda grazie alla competenza, professionalità, accuratezza del capostipite, del figlio e ora anche dei nipoti si è sempre più fatta strada nel panorama edilizio e nella positiva considerazione che tutti i nostri cari clienti ci hanno sempre dimostrato.

01-02. Il capostipite, Ettore Capra, e lo staff attuale.
03. Porta blindata motorizzata, classe 4, con pannello esterno in alluminio.
04. Ante battenti a tutto vetro per uno stile industrale minimalista.

05. Arredo su misura realizzato dalla nostra falegnameria. 01
Forniamo un’ampia gamma di opere personalizzate: finestre e serramenti, porte interne e blindate, oscuranti e zanzariere, divisori d’arredo e porte in vetro, inferriate e opere di falegnameria, tutte garantite da certificate aziende del panorama internazionale.

Casa Capra Falegnameria a Verona è presenza significativa nel mercato artigianale fin dal 1950, nata dall’esperienza, affidabilità, accuratezza e competenza di falegnami e figli di falegnami.
In armonia con le esigenze della vasta clientela e in collaborazione con architetti e studi tecnici, progettiamo e realizziamo strutture per ogni ambiente, avvalendoci del nostro personale qualificato, per poter garantire nel tempo ottime rifiniture sia per i prodotti di nostra realizzazione che di marchi prestigiosi.

Ci occupiamo con attenzione delle esigenze dei nostri clienti fin dalla fase di progettazione, successivamente nella fase di realizzazione e montaggio e infine con l’assistenza post-vendita.
Con orgoglio valutiamo il buon “passaparola” come uno dei motivi principali della positiva crescita in tutti questi anni.
Casa Capra rappresenta una delle aziende leader in Verona e provincia nella vendita di strutture per casa.

LA BACHECA DI AV 113 131 #publiredazionale CASA CAPRA STRUTTURE PER LA CASA VIA CROCE BIANCA 31A 37139 VERONA TEL +39 045 890 1997 WWW.CASACAPRA.IT CASACAPRA@TISCALI.IT
03
02
04 05
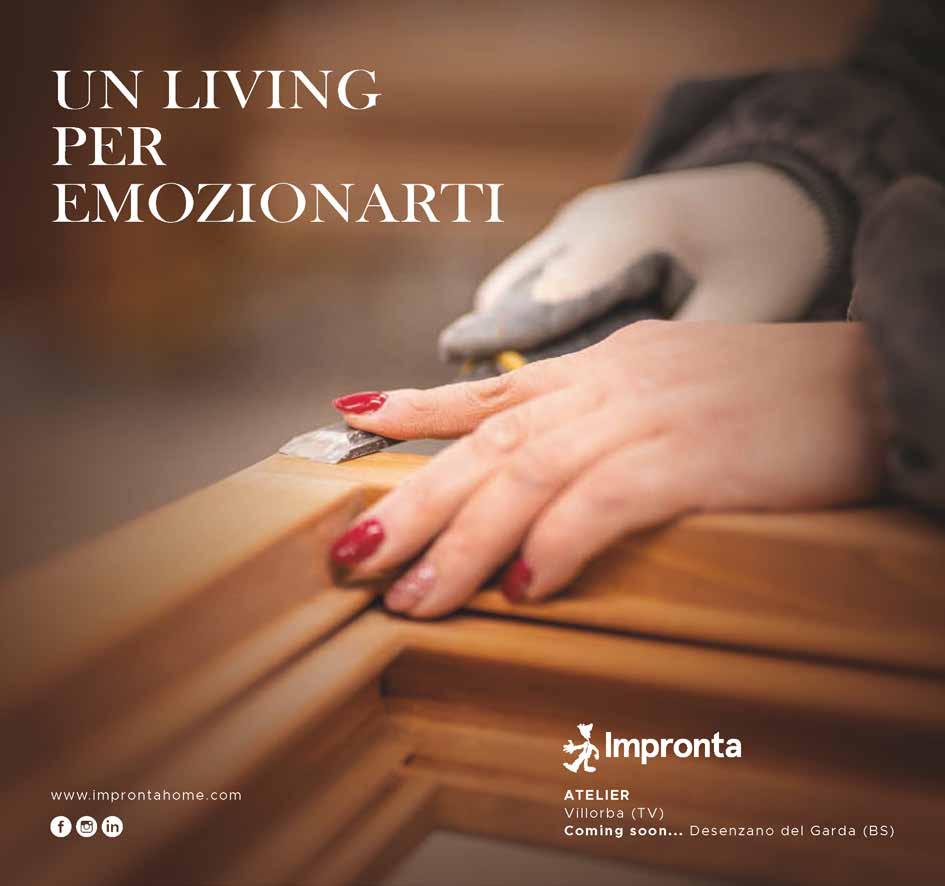


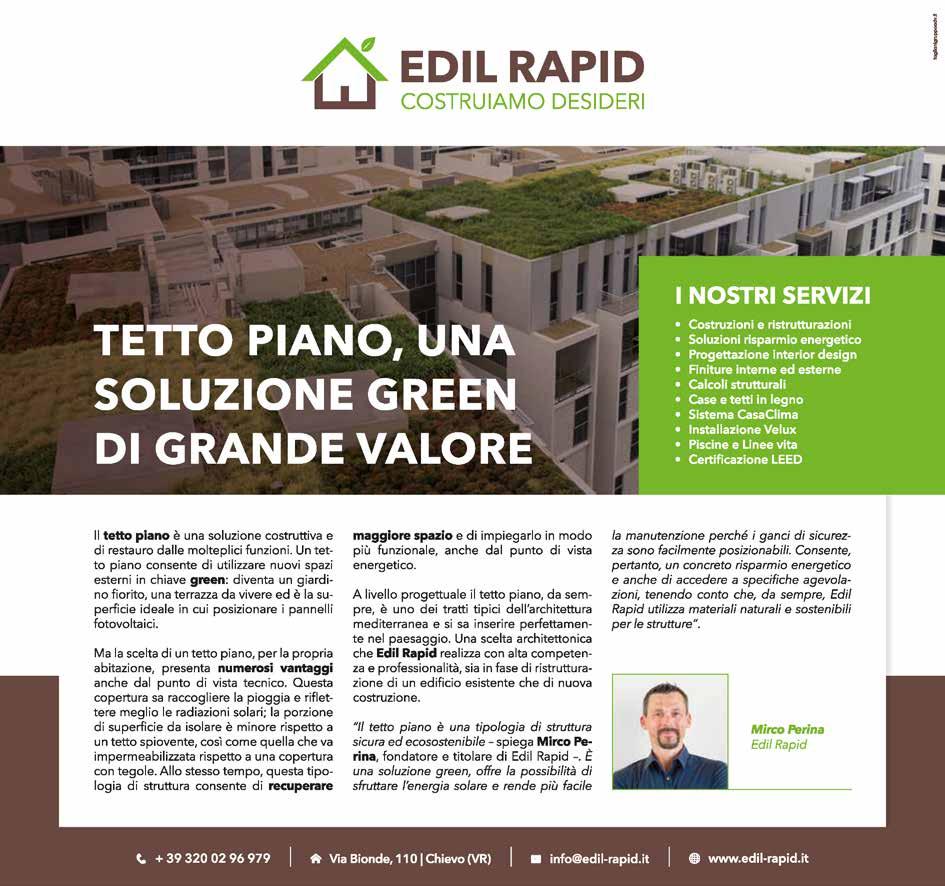
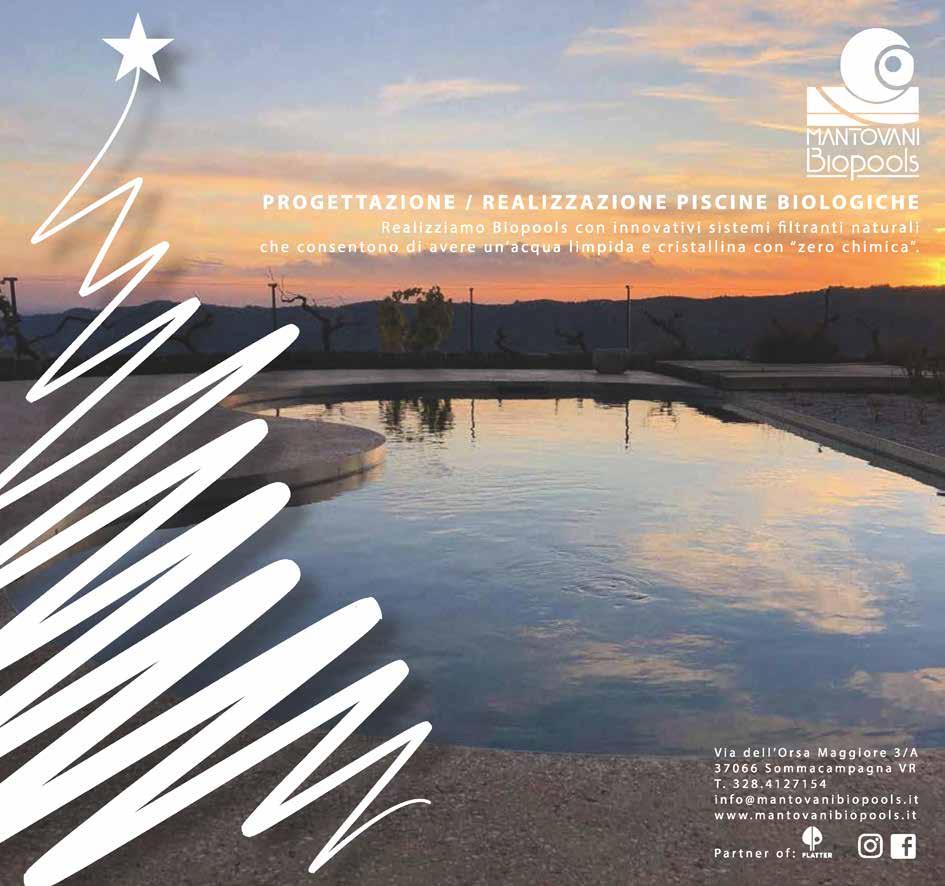
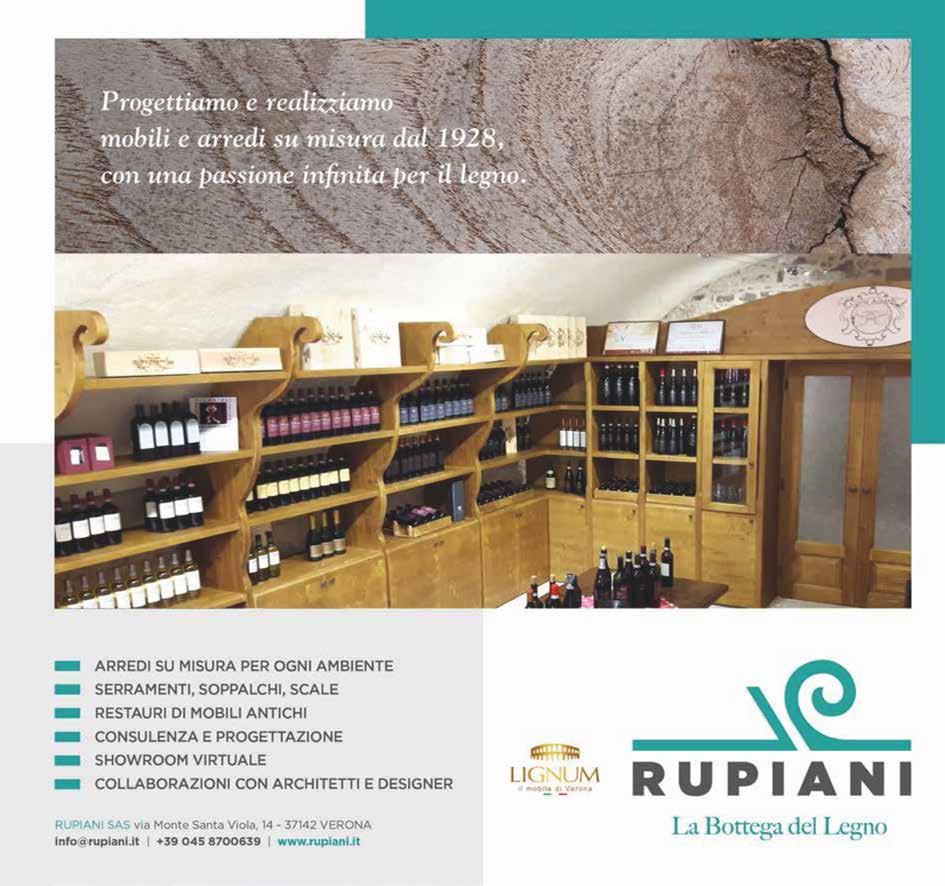
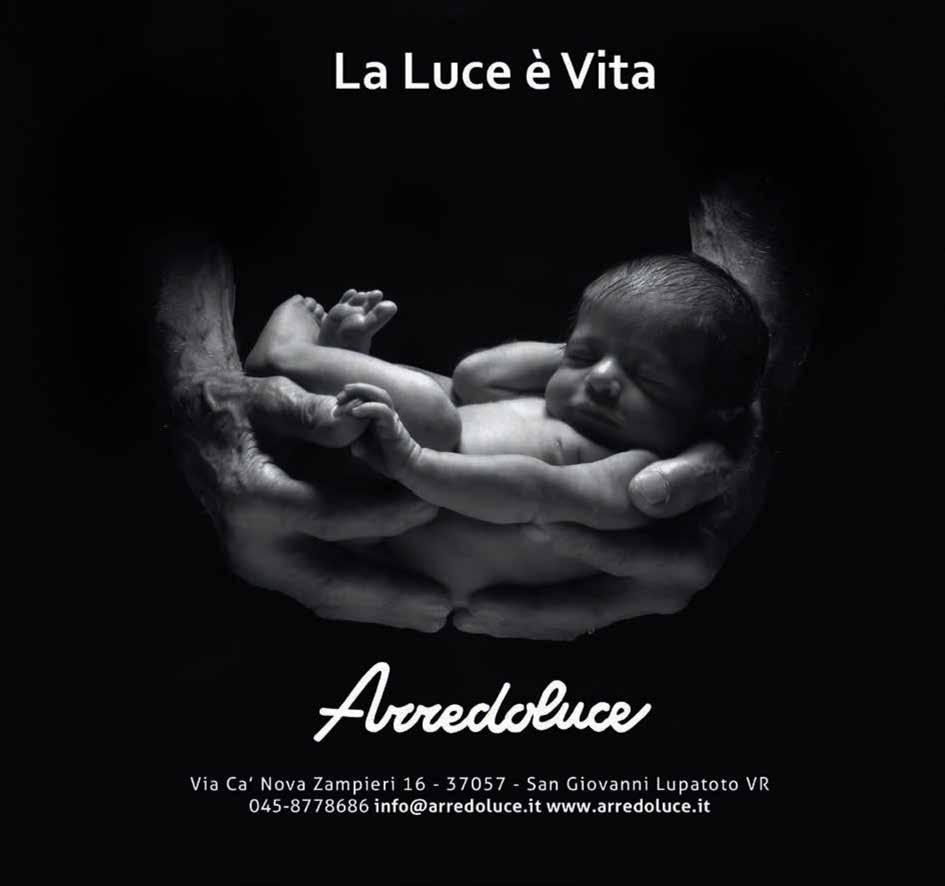

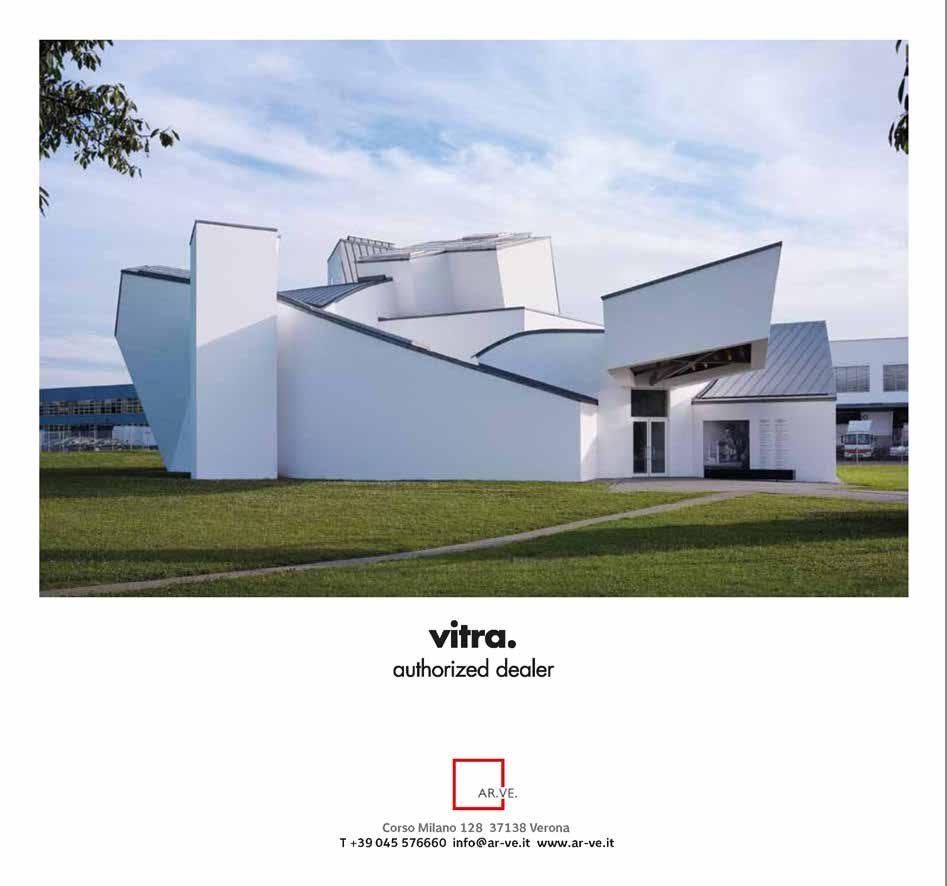
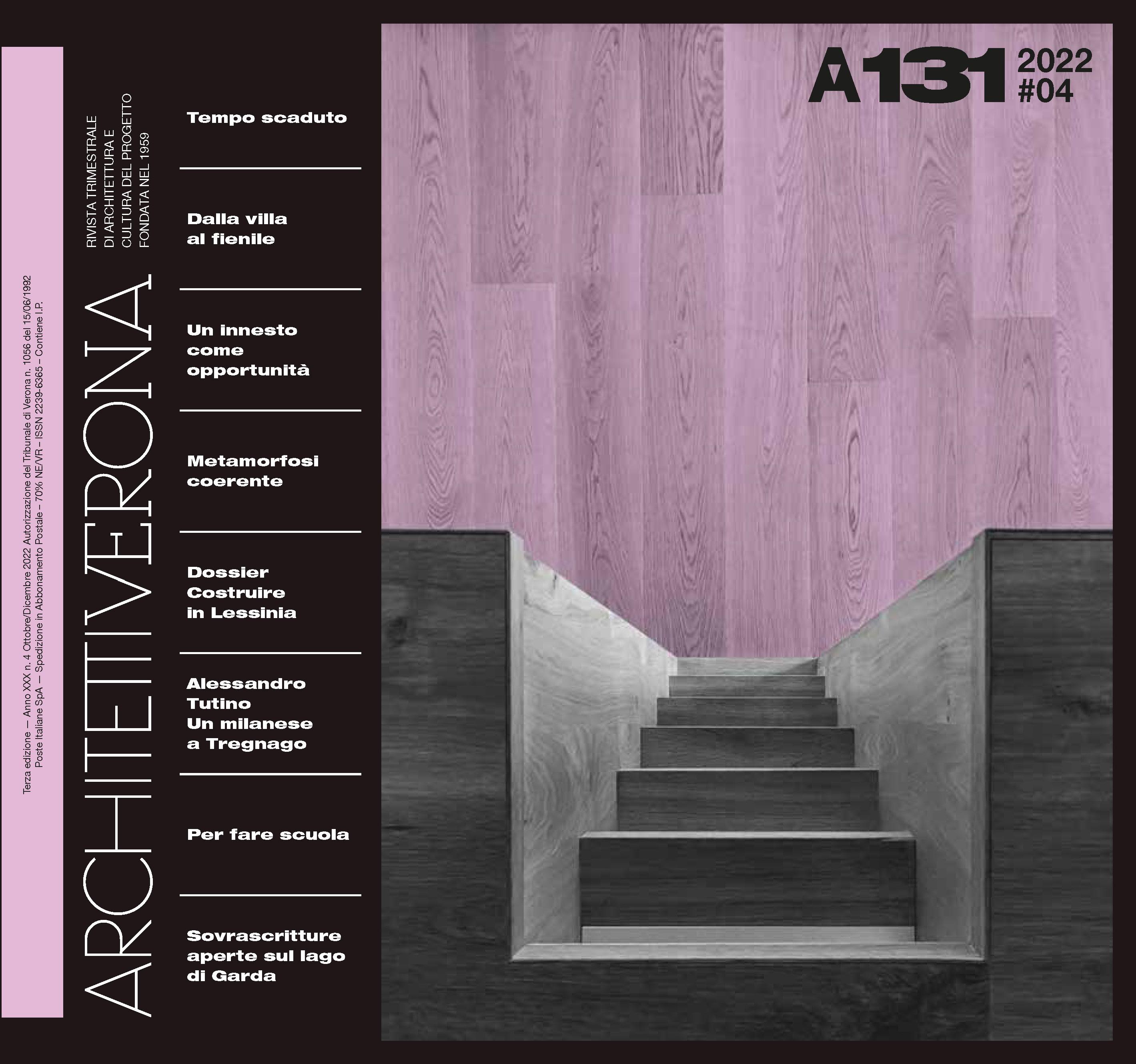
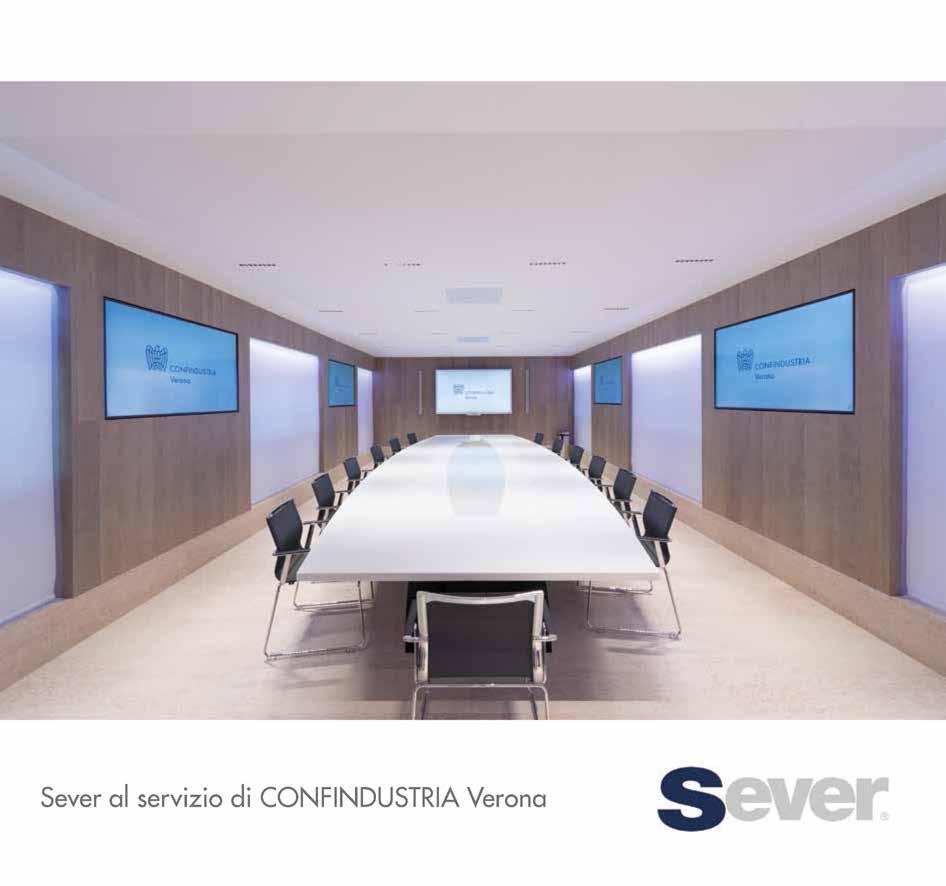
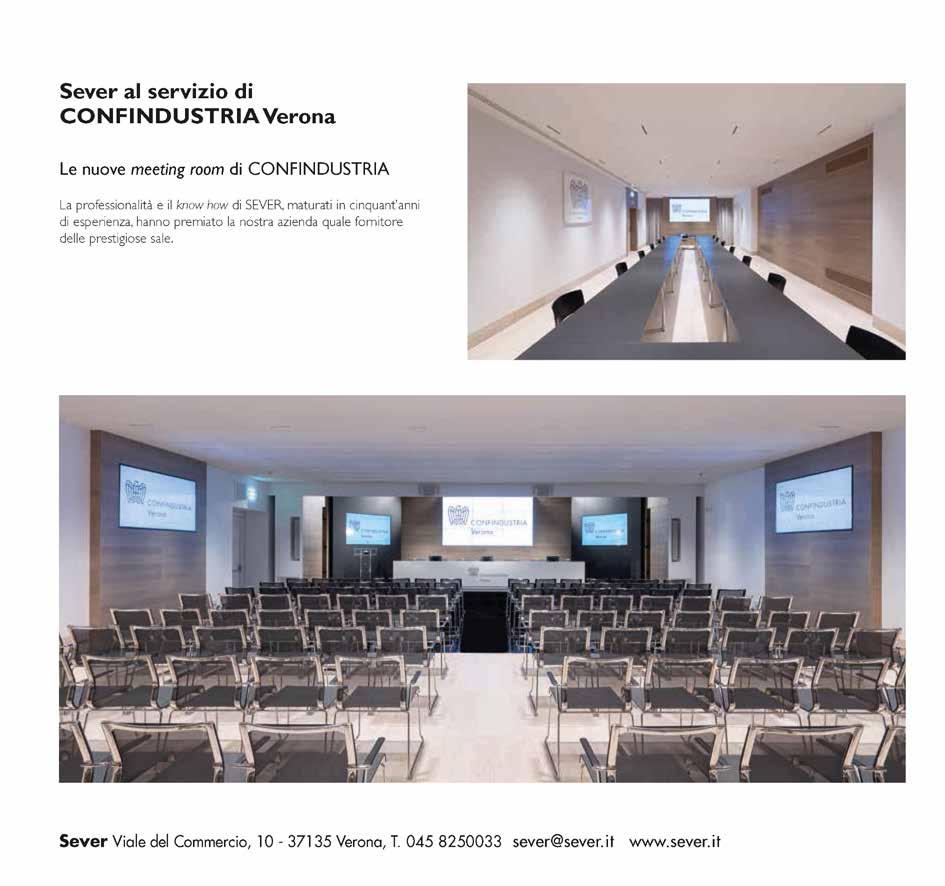






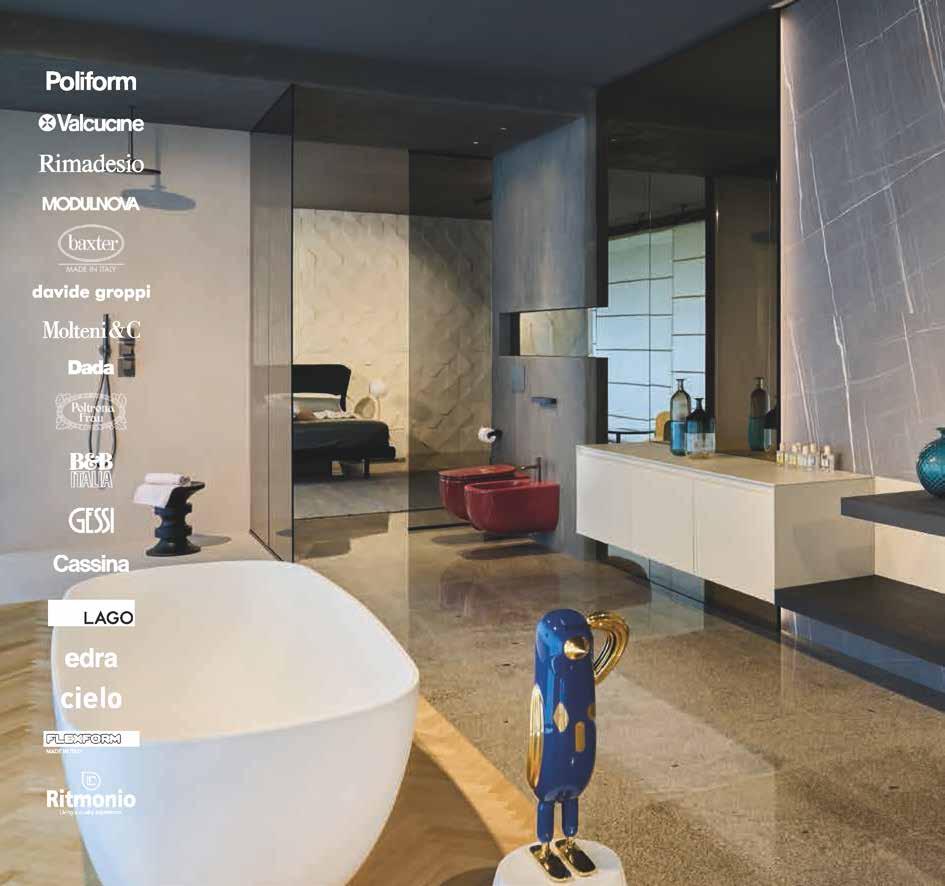

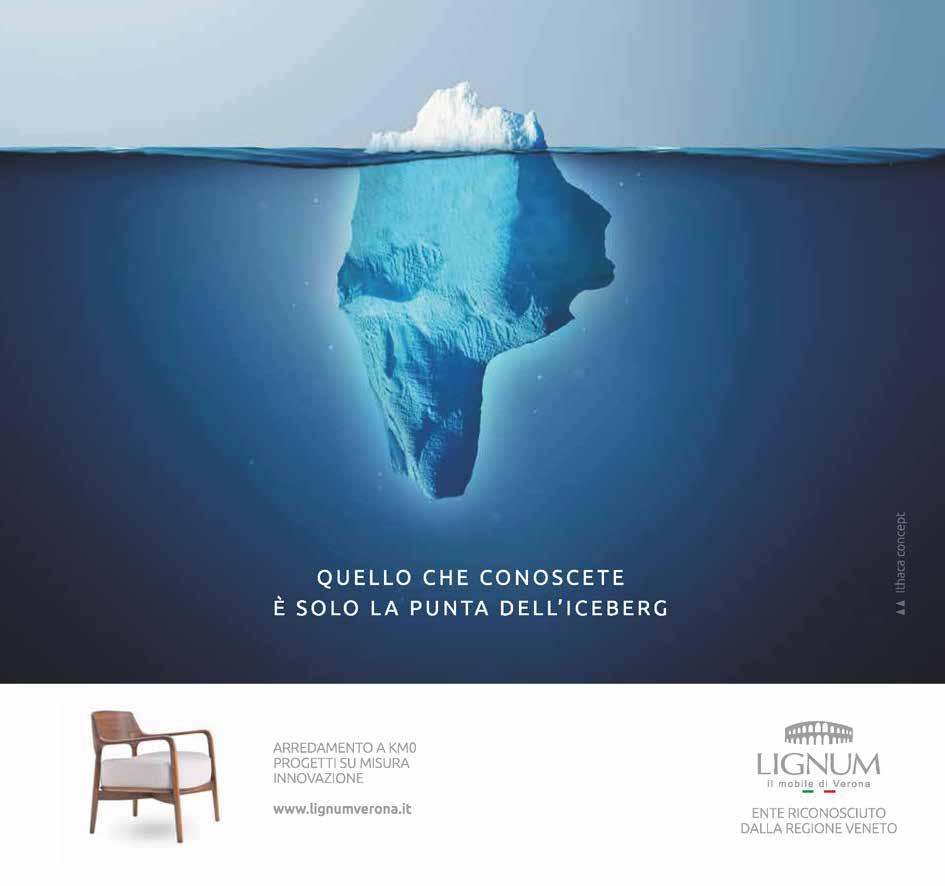





















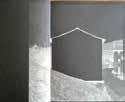











 Malga Podestaria. Cfr. pp. 66-71 (foto di Federico Padovani).
Malga Podestaria. Cfr. pp. 66-71 (foto di Federico Padovani).









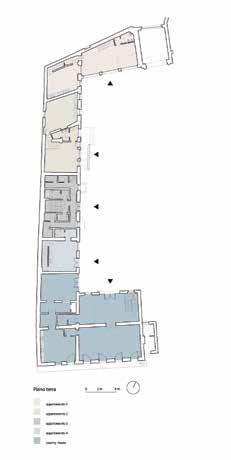




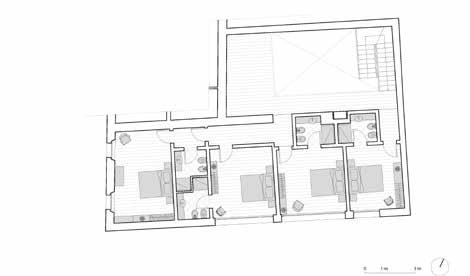



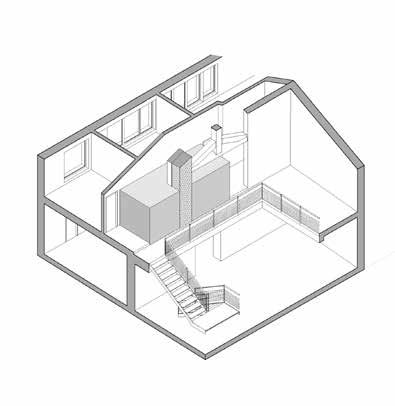















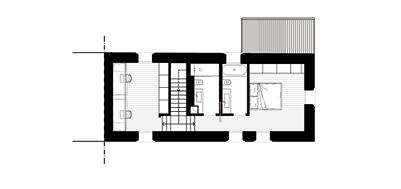


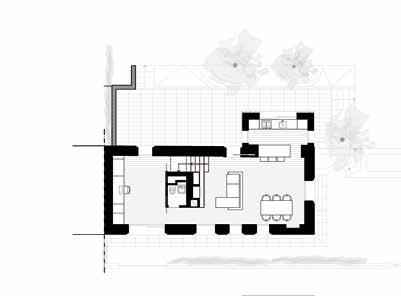
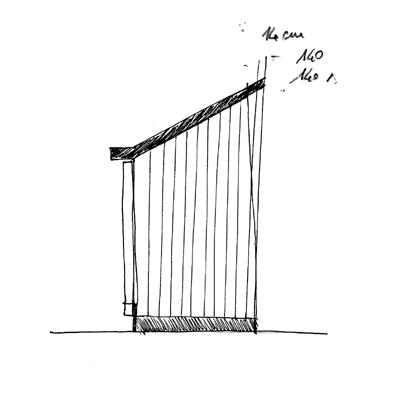





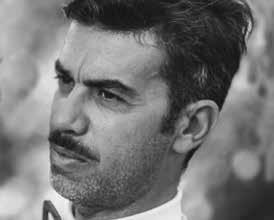

























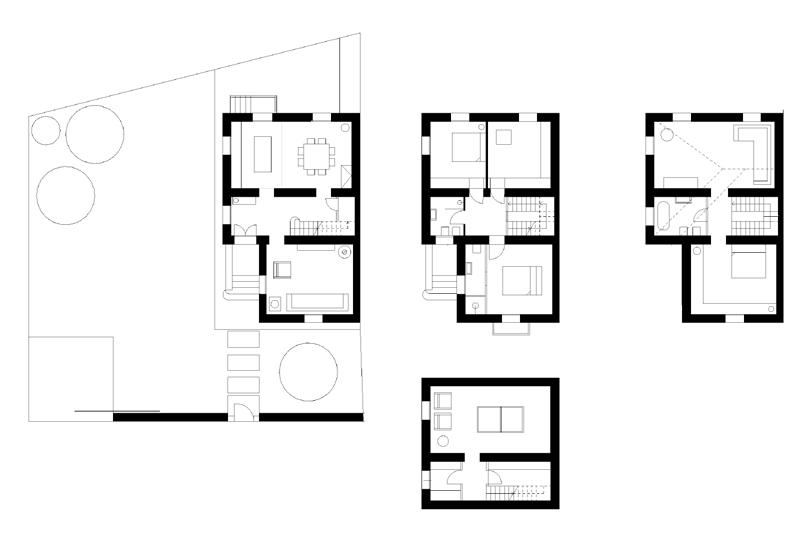


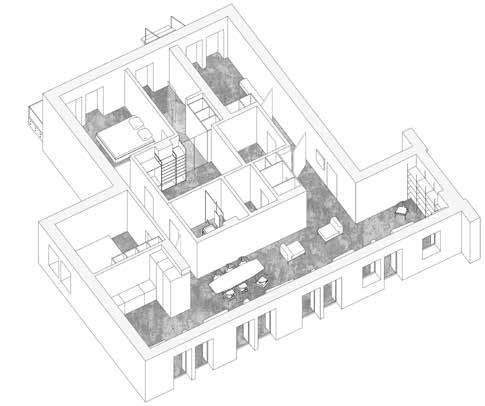











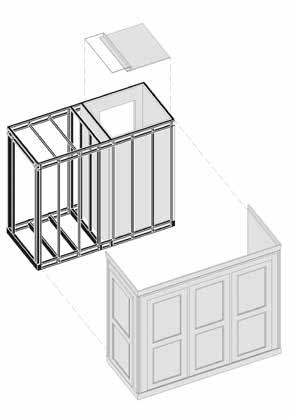



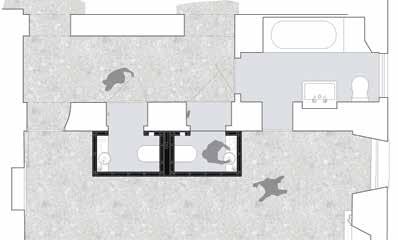






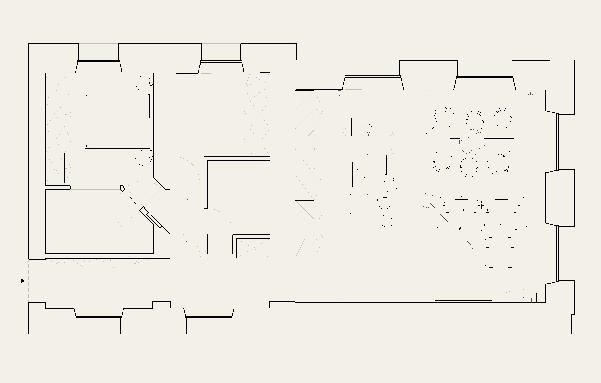




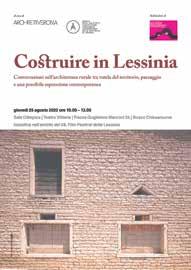

 Testo: Vincenzo Pavan
Testo: Vincenzo Pavan

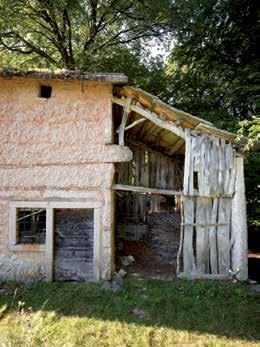





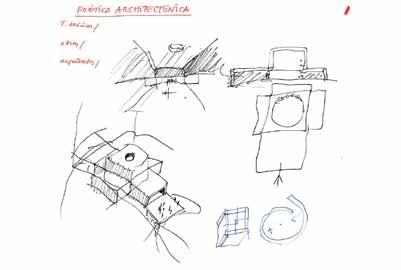
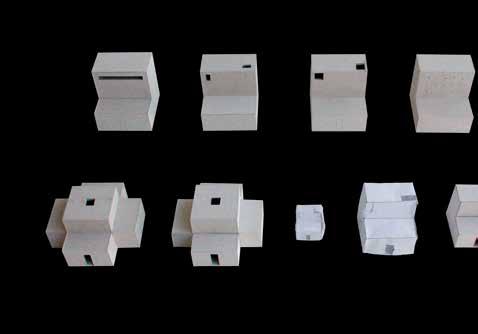

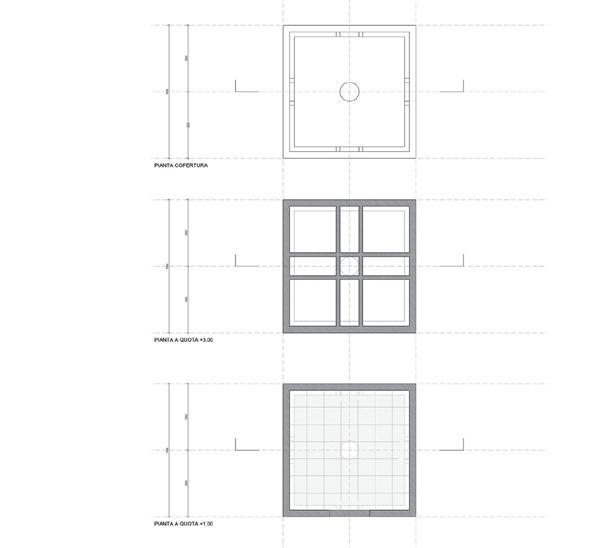
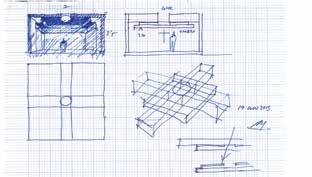



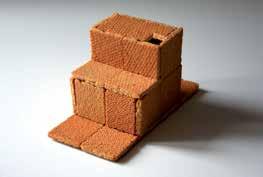
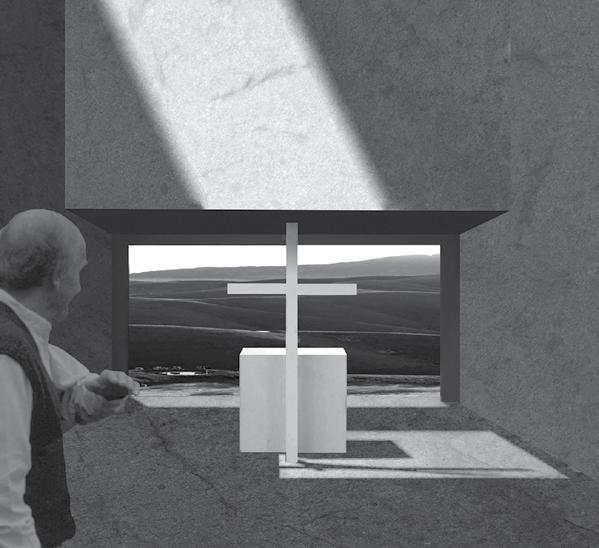





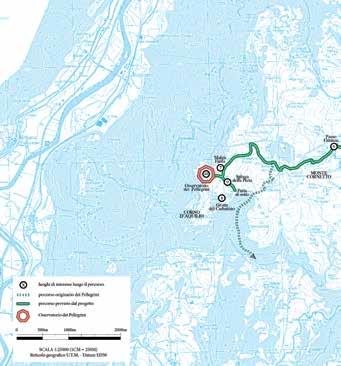
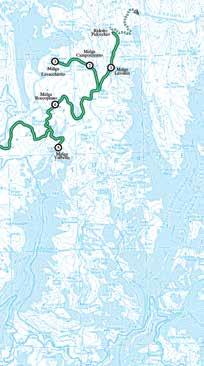
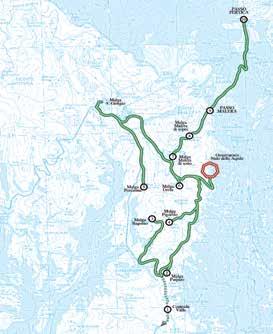

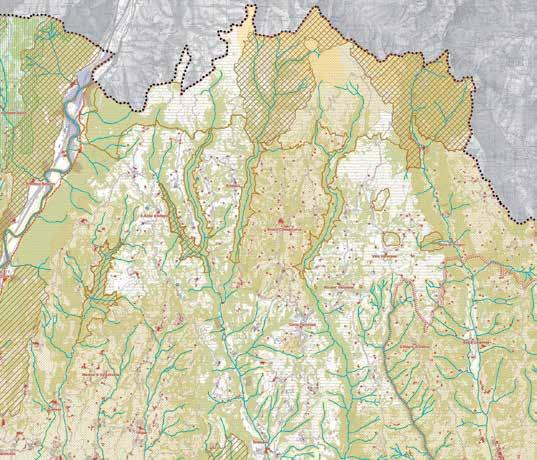














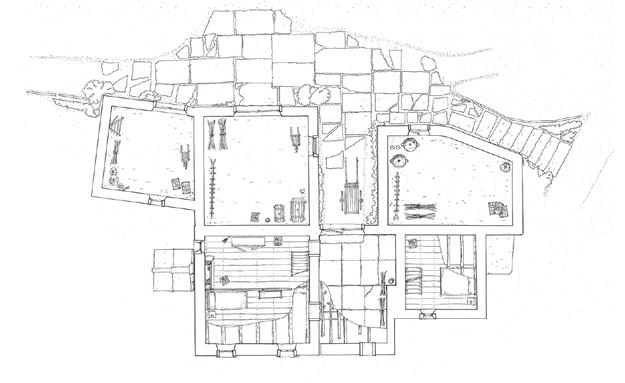


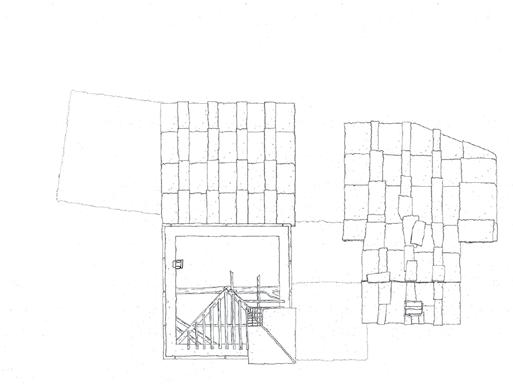
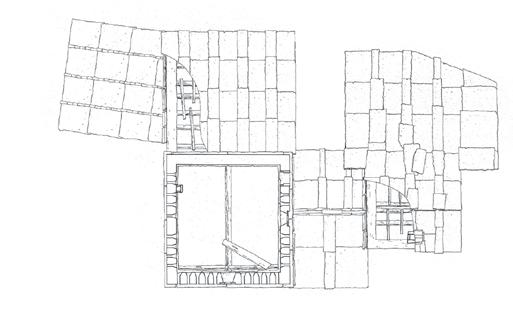
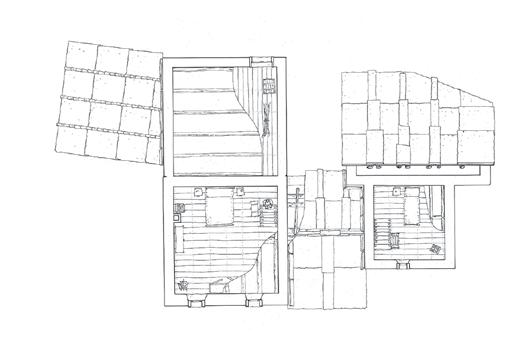



 Testo: Vincenzo Latina
Testo: Vincenzo Latina