Il 2023 sarà un anno di grandi migrazioni verso l’Europa. Siamo pronti ad affrontare l’emergenza?
ATTUALITÀ Pagina 25

Il 2023 sarà un anno di grandi migrazioni verso l’Europa. Siamo pronti ad affrontare l’emergenza?
ATTUALITÀ Pagina 25

È stata un’elezione dal sapore dei tempi passati, quella di mercoledì scorso a Berna – pur con le sue sorprese.
Con l’elezione incontestata dell’Udc Albert Rösti al primo turno, è sembrato di essere tornati ai decenni precedenti l’era Blocher, fatta invece di confronti aspri e sgambetti. Candidato di punta del proprio partito, già suo presidente, il bernese di Kandersteg e ammiratore di Adolf Ogi è una persona che cerca il consenso e sa creare alleanze con gli altri partiti di centro e centro-destra. L’Udc sta dunque perdendo la sua spinta radicale, o ha capito che per contare davvero nei governi deve trovare personalità aperte ai compromessi, mentre nei parlamenti può continuare a fare un’opposizione dura?
Con l’elezione di Elisabeth Baume-Schneider, una ex consigliera di Stato giurassiana perfettamente sconosciuta nel resto della Svizzera fino a qualche settimana fa, si conferma invece una certa tradizione che vede i parlamentari preferire una personalità femminile meno profilata e più… simpatica e materna. In altre e più dram-
matiche circostanze, nel 1993 i deputati preferirono Ruth Dreifuss alla sindacalista Christiane Brunner (in una prima votazione venne eletto il neocastellano socialista Francis Matthey, che poi non accettò la nomina). Mercoledì la giurassiana ha superato per pochi voti Eva Herzog, consigliera di Stato dal carattere forte, nonostante la basilese fosse molto più preparata sui dossier. Ma l’affermazione a sorpresa di Elisabeth Baume-Schneider è anche la conferma che l’elezione di un consigliere federale è anche influenzata da tatticismi politici: a volte si elegge qualcuno per sbarrare la strada a qualcun altro. Nel caso specifico il sospetto manifesto è che l’elezione della giurassiana servisse anche a impedire che il sindacalista ginevrino Pierre-Yves Maillard potesse un giorno ereditare la poltrona di Alain Berset. Con l’arrivo di Baume-Schneider c’è per la prima volta una maggioranza di membri latini in Consiglio federale (tre romandi e un ticinese), per cui alle dimissioni di Berset si dovrà puntare su candidati svizzero-tedeschi, con buona pace di Maillard.
Il risultato è un Consiglio federale che rispecchia l’anima rurale e periferica della Svizzera, mentre la ripartizione dei dipartimenti conferma la dominanza della maggioranza di centro-destra in governo.
Parmelin viene dal Vaud vinicolo, Baume-Schneider dalle terre agricole e periferiche del Giura, Cassis, Berset, Amherd da cantoni periferici, Keller-Sutter e Rösti da contesti rurali. I media svizzero tedeschi hanno infatti immediatamente rimarcato non solo l’inusitata maggioranza latina in governo (che rappresenta solo il 30 per cento della popolazione svizzera), ma anche l’assenza di esponenti delle regioni urbane. C’è chi, come il «Tages Anzeiger», nella foga ha chiesto che Alain Berset e Guy Parmelin si dimettano alla prossima rielezione del Consiglio federale (2023) per far spazio a rappresentanti urbani e per permettere di ristabilire gli equilibri linguistici all’interno del governo. Sullo stesso giornale, invece, il politologo Michael Hermann vede positivamente, per la coesione nazionale, una forte presenza di esponenti delle regioni peri-
feriche e rurali in governo: le tendenze economiche e sociali sono dettate dai centri urbani, i cantoni periferici e il mondo rurale hanno spesso la sensazione di essere scavalcati, quindi essere rappresentati in governo aiuta a sentirsi coinvolti nel dibattito politico.
Dicevamo della forza del centro-destra in governo: i dipartimenti sono stati assegnati secondo il volere dei ministri Plr e Udc (lasciando l’amaro in bocca al PS); la liberale Karin Keller-Sutter ottiene il Dipartimento delle finanze lasciato libero da Ueli Maurer, il democentrista Albert Rösti il Dipartimento dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Cassis resta al suo posto, nonostante fosse ambito da Alain Berset, Elisabeth Baume-Schneider va al Dipartimento di giustizia. I dipartimenti chiave sono in mano al centro-destra, che ora dovrà mostrare come pensa di affrontare le crisi attuali, a cominciare dalla politica energetica e più in generale da come definirà i rapporti con l’Europa e la neutralità in politica estera, senza dimenticare il futuro delle assicurazioni sociali.
Per la tutela dei camosci Migros Ticino sostiene un progetto per censire e tutelare la popolazione dei camosci del Monte Generoso
Pagina 7
Storia della cura dei denti Oggi abbiamo la prevenzione dentaria nelle scuole: ripercorriamo il lungo cammino dell’igiene orale
9
Anziani e traslochi Cambiare casa è faticoso per le persone anziane sole, ma esiste un servizio di aiuto di Pro Senectute
Pagina 11
Forse nella memoria di qualche giovane degli anni 50 del Novecento sarà rimasto impresso quell’autocarro rosso fiammante con il suo «razzo» cromato, capace di sparare immagini enormi sulle pareti delle montagne e persino sulle nuvole: pareva uscito da un libro di Giulio Verne.

Era lo Spitlight P.300.S, la meraviglia tecnologica dell’ingegner Gianni Andreoli, che si guadagnò l’attenzione internazionale illuminando la scenografica cornice dolomitica delle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo nel 1956.
Dopo le Olimpiadi il grande proiettore non ebbe successo e rimase per anni dimenticato in depositi a Lugano e a Lucerna
«Per tutta la durata delle Olimpiadi – si legge sulla rivista “Illustrazione ticinese” del 14 aprile 1956 – appena calata la sera, questa invenzione, destinata certamente a rivoluzionare il campo della propaganda e dell’informazione (poiché può funzionare indifferentemente su schermi naturali, nubi o montagne, o artificiali, cortine fumogene) ha proiettato sullo schermo naturale di 800’000 metri quadrati del massiccio del Pomagagnon i cinque cerchi olimpici, lo stemma del Comune di Cortina, la fiaccola olimpica, frasi di benvenuto inframmezzati da servizi informativi: l’ora esatta (a intervalli di un quarto d’ora dalle 18.00 alle 24), il notiziario sportivo, il bollettino meteorologico».
Esibito con successo nella vetrina olimpica, l’immenso potenziale dell’avanguardistico proiettore, somigliante a un razzo interplanetario, sembrava promettere un luminoso futuro in pieno boom economico. Era il 1956, e mentre la tecnologia televisiva muoveva i primi passi sul piccolo schermo, la sorgente luminosa del «cannone» di Andreoli oltrepassava la potenza di tutti i cinematografi di Milano riuniti.
Contro ogni aspettativa, invece, già al rientro in Ticino da Cortina, un pasticciaccio brutto di inaffidabili soci-investitori, società insolventi, cause e pignoramenti finì per spegnere ogni entusiasmo e lo Spitlight venne abbandonato (o nascosto) in un non meglio identificato deposito luganese per qualche anno. Fu così che la geniale invenzione dell’ingegner Andreoli, costata una cifra vicina ai 300mila franchi nel 1955, venne svenduta all’asta nel 1962 per 1000 franchi. L’autocarro-proiettore «Bedford-Spidlight» (come si legge sull’avviso dell’incanto fissato per il 9 febbraio 1962 presso la Cava Rossi di Ponte Cremenaga) tornò a casa, a Lucerna, dove aveva visto la luce sette anni prima, nella Carroz-
zeria Huber & Brühwiler, che si era facilmente aggiudicata l’asta.
Nel frattempo, nel suo studio d’ingegneria di Lucerna, l’inventore dello Spitlight aveva continuato a lavorare sulla luce, miniaturizzando il modello e producendo proiettori portatili dal design accattivante, che ottennero un notevole successo commerciale. Forse proprio sull’onda dei nuovi brevetti si tentò di recuperare e rilanciare sul mercato anche l’autocarro-cannone spara luce, probabilmente anche negli Stati Uniti, dove Andreoli si recò in viaggio d’affari tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. Ma la tecnologia correva veloce, così come il design e il mercato pubblicitario, cui il pesante Bedford con rimorchio mirava per il suo business. Ma con il pasticciaccio societario si era perso l’attimo.
Del resto Gianni Andreoli era un genio dell’ingegneria, non del commercio. Nato a Mendrisio nel 1919, il futuro inventore aveva mostrato fin da piccolo una spiccata propensione per il disegno di veicoli, fossero automobili, imbarcazioni o velivoli. Uscito dal Liceo di Lugano con l’ambito Premio
Maraini, si laureò al Politecnico di Zurigo con il prestigioso premio Barth. A soli 20 anni costruì il più piccolo aereo 6 cilindri al mondo, che fu esposto alla Landi, l’Esposizione nazionale del 1939. Appassionato di volo e promotore del Club di aeromodellismo di Mendrisio, fu pilota militare e lavorò al Centro federale di aeronautica di Emmen prima di specializzarsi nel settore dell’ottica e di aprire il suo studio di ingegneria a Lucerna, dove ideò, brevettò e costruì il suo gioiello spara-luce.
Il geniale inventore ticinese si spense prematuramente nel 1971 all’età di 52 anni, lasciando orfano il suo Spitlight P.300.S (inutilmente ribattezzato P.500.S), che venne dimenticato nei depositi della carrozzeria lucernese da dove era uscito negli ormai lontani anni Cinquanta.
Il letargo del vecchio camion, riportato all’attenzione mediatica da un articolo della «Luzerner Neueste Nachrichten», si interruppe una prima volta nel 1983, quando l’allora direttore del Technorama si accordò con la vedova di Andreoli per portarlo a Winterthur. L’ostacolo degli ingenti costi
di restauro fu brillantemente superato grazie all’opera di 22 ingegneri della locale sezione della Schweizerischer Technischer Verband (oggi Swiss Engineering STV), che rimisero a nuovo lo storico mezzo investendo 4000 ore di lavoro. Per un paio d’anni il Technorama utilizzò lo Spitlight per alcuni eventi interni ed esterni, ma anche i costi d’esercizio del vecchio proiettore si rivelarono ben presto insostenibili. Così il camion spara-luce venne dapprima parcheggiato in bella mostra all’ingresso del Museo e poi finì nuovamente in deposito.
Nel 2013, le linee vintage dell’impolverato oggetto di archeologia tecnologica attrassero l’attenzione di un appassionato, che si prese la briga di fondare l’Associazione Andreoli-Spitlight. Ma i costi di restauro vennero calcolati attorno ai 2 milioni e nessun investitore se la sentì di lanciarsi nel progetto. Nel 2019, quando il suo destino sembrava segnato, la fortuna ha, infine, voluto che la strada dello Spitlight incrociasse quella di ENTER, il Museo del computer e dell’elettronica d’intrattenimento, che aprirà i battenti a Derendingen (SO) nel 2023.
Trasferito da Winterthur a Soletta e affidato alle cure dei tecnici della Fondazione ENTER, camion e proiettore sono tornati come nuovi, anzi più che nuovi, perché alla sfavillante carrozzeria, che ha ripreso gli iconici colori degli anni 50 del Novecento, è stato dato un nuovo cuore tecnologico di proiezione. Ma non è tutto. Come ogni restauro che si rispetti, le fasi dell’«operazione filologica» sono state scrupolosamente documentate e costituiscono l’ultimo capitolo di un prezioso volume fotografico dal titolo Vision of a visionary, che ha ricostruito, salvandola definitivamente dall’oblio, la rocambolesca avventura dello Spitlight P.300.S e del suo geniale inventore.
Felix Wirth, Jan Liechti, Dominik Landwehr, Felix Kunz, Vision of a visionary, Stiftung ENTER, Solothurn, 2022. Il volume, in edizione bilingue tedesco/ inglese, può essere richiesto direttamente alla Fondazione ENTER (info@enter.ch). Info: www.enter.ch
«Vivere in Svizzera e poter cominciare qui ogni giornata è un dono. Quando saluto mio figlio davanti a scuola il mattino e io ho la mia giornata davanti mi dico: ecco, è un dono».
Jamileh Amini si racconta. È nata e cresciuta in Afghanistan, vive in Ticino dal 2011 con la sua giovane famiglia. «I miei genitori vivono in Iran, dove la situazione è molto difficile per il popolo iraniano e per le donne come vediamo in questi giorni. Le condizioni sono drammatiche anche per gli afghani in Iran che ultimamente vengono rimandati nel loro Paese in modo disumano».
Amini ha fondato un anno fa, nel dicembre del 2021, l’Associazione comunità afghana in Ticino (ACAT), che vuole essere «da una parte una risposta alla forte preoccupazione dei suoi membri per la situazione dei famigliari e degli amici rimasti in patria, dall’altra una struttura che possa promuovere attività di integrazione per i suoi membri e di conoscenza della cultura afghana nella società ospitante».
«Vogliamo aiutare chi è rimasto in Afghanistan, dove non c’è cibo, non c’è sicurezza e non c’è lavoro, ma anche far conoscere la bellezza del nostro Paese»
«Le storie dei miei compaesani si assomigliano. – continua Jamileh – L’obiettivo di chi lascia il Paese è partire senza una destinazione particolare, prima in Iran, poi in Turchia, dalla Turchia via mare fino in Grecia, poi i Paesi balcanici dove di solito si incontrano i passatori che portano in Italia. È un viaggio pieno di pericoli che nei casi peggiori dura più di tre anni, e tanti profughi giocano con le loro vite. Quando si lascia l’Afghanistan si pensa solo a salvarsi, a scappare».
«Sono una delle fondatrici e animatrici dell’associazione afghana. Sono molto contenta che ce l’abbiamo fatta, che siamo riusciti a mettere in piedi questa comunità. C’è la partecipazione volontaria della nostra gente quando organizziamo eventi. È importante che ognuno di noi faccia qualcosa per la comunità. È nato tutto durante l’estate dell’anno scorso, quando è crollato il governo e gli Stati Uniti hanno abbandonato il Paese tradendo il popolo afghano. Fra di noi c’era tanta rabbia e tanta tristezza pensando a chi è rimasto dove c’è fame e tanta violenza. Vogliamo aiutare chi è rimasto in Afghanistan ma anche far conoscere la ricchezza e la bellezza del nostro Paese. Grazie all’associazione siamo riusciti finora a sostenere circa 800 persone, racco-
azione
Settimanale edito da Migros Ticino Fondato nel 1938
Abbonamenti e cambio indirizzi tel +41 91 850 82 31 lu–ve 9.00–11.00 / 14.00–16.00 fax 091 850 83 75 registro.soci@migrosticino.ch
Costi di abbonamento annuo Svizzera Fr. 48.– / Estero a partire da Fr. 70.–
gliendo fondi e organizzando eventi. Abbiamo ricevuto anche tanti sostegni in Ticino, dove la nostra comunità, conta circa 6/700 persone».
La ACAT è intervenuta anche per promuovere una biblioteca. «Abbiamo aiutato a livello economico per sostenere la realizzazione di una biblioteca fornita di circa 2500 libri per ricordare l’attentato a Kabul del 30 settembre contro la scuola Kaaj. – ci dice Jamileh Amini – Leggere è importante, ti apre la mente, fa crescere, soprattutto in Afghanistan dove non c’è un diritto allo studio».
Jamileh Amini lavora come mediatrice interculturale e traduttrice: cosa significa integrazione? «Dalla mia esperienza posso dire che l’integrazione deve venire dalle due parti, da chi arriva e da chi accoglie. Da parte della nostra comunità c’è voglia di integrarsi, è gente giovane con tanta voglia di imparare e crescere ed essere utile alla società. Tanti della nostra comunità si sentono emarginati, hanno l’impressione di non contare molto. Bisogna che anche la popolazione ticinese sia disponibile e, per esempio, sostenga i progetti della nostra associazione. Bisogna avvicinarsi dalle due parti e cercare di apprezzare le culture di ognuno, anche se diverse, perché la diversità è una ricchezza. Per i nostri giovani conta molto il primo approccio, il confronto con la scuola, il rapporto con i docenti. La maggior parte di loro non sono istruiti, quindi il primo contatto è importante. Bisogna dare loro la speranza per il futuro e sostenerli, perché con il tempo potrebbe crescere la negatività e il pessimismo».

La situazione dei rifugiati in Svizzera è cambiata radicalmente con la guerra in Ucraina. Nel mese di settembre 2022, – precisa la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) –sono state registrate in Svizzera 2681 domande d’asilo, ossia 635 in più del mese precedente (+31%). Rispetto a settembre 2021, il numero di domande è aumentato di 1138 unità. I principali Paesi di provenienza sono stati l’Afghanistan e la Turchia. Sempre nel mese di settembre, lo statuto di protezione S è stato concesso a 2877 profughi provenienti dall’Ucraina.
Ma qual è la situazione dei profughi afghani oggi in Ticino? «Credo che la situazione di molti afghani residenti in Ticino sia leggermente migliorata nell’ultimo anno. – ci spiega Mario Amato, direttore di Soccorso operaio svizzero (SOS Ticino) – Mi riferisco soprattutto al loro statuto. Per diversi anni molti di loro si trovavano in una sorta di limbo. La loro domanda d’asilo era stata respinta da tempo ma, per motivi legati soprattutto alla mancanza di un documento
di viaggio, l’esecuzione dell’allontanamento verso il loro Paese d’origine non era stata realizzata. Vi erano quindi diversi cittadini afghani che non avevano più alcuno statuto legale di residenza. Quanto avvenuto nell’agosto del 2021 ha però permesso di rimettere in discussione una prassi e una giurisprudenza consolidate da tempo che distinguevano Province sicure e Province meno sicure, per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Afghanistan. La presa di potere da parte dei talebani ha permesso al Consultorio giuridico di SOS Ticino di avviare delle procedure di riesame, tendenti a dimostrare che nessuna provincia dell’Afghanistan è sicura. In questo modo diversi cittadini afghani hanno potuto quindi beneficiare dell’ammissione provvisoria (permesso F) e in molti casi questo ha consentito loro di poter avere un impiego. Resta chiaramente forte la preoccupazione per i famigliari rimasti in Afghanistan e rispetto ai quali si riesce a fare davvero ben poco».
La presidente della comunità afghana conferma l’incremento di rifugiati. «Stanno arrivando ancora mol-
●
Sede Via Pretorio 11 CH-6900 Lugano (TI)
Telefono tel + 41 91 922 77 40 fax + 41 91 923 18 89
Indirizzo postale Redazione Azione CP 1055 CH-6901 Lugano
ti profughi, soprattutto giovani. Tutto quello che sta accadendo in Afghanistan passa sotto silenzio. I giovani devono andarsene, devono salvarsi, lì non hanno futuro. Mi fa star male sentire cosa hanno vissuto questi ragazzi di 15 anni che hanno dovuto lasciare tutto, la famiglia, l’affetto genitoriale e la loro cultura. Hanno visto e vissuto già da piccoli tante cose brutte, forse troppe. Quando arrivano in Svizzera si sentono al sicuro ma hanno una forte preoccupazione per i loro famigliari rimasti a casa. La comunità internazionale dovrebbe intervenire in Afghanistan. Si tratta di salvare un Paese: se va avanti così, con l’inverno sarà un disastro. Siamo di fronte a una catastrofe umanitaria. Non ci sono aiuti concreti, non c’è cibo, non c’è sicurezza, non c’è lavoro».
Sono almeno 3,9 milioni i bambini afghani gravemente malnutriti e 19,7 milioni le persone, quasi la metà della popolazione afghana, che hanno sofferto di fame acuta dall’inizio dell’anno. I dati forniti dal Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (WFP) parlano di livelli di crisi e grave insicurezza alimentare in
Posta elettronica info@azione.ch societa@azione.ch tempolibero@azione.ch attualita@azione.ch cultura@azione.ch
Pubblicità Migros Ticino Reparto pubblicità CH-6592 S. Antonino tel +41 91 850 82 91 fax +41 91 850 84 00 pubblicita@migrosticino.ch
tutte le 34 province del Paese. L’organizzazione, in risposta a questa crisi umanitaria, ha fornito, dall’inizio dello scorso ottobre, cibo specifico per la prevenzione della malnutrizione a 7’400 donne e bambini. Allo stesso tempo, più di 98’000 donne e bambini sono stati curati per casi di malnutrizione acuta. Per svolgere questo lavoro il WFP sta attualmente supportando 2’205 centri sanitari.
Non è possibile immaginare una reazione della popolazione nei confronti dei talebani al potere? «Protestare in Afghanistan è difficile. I talebani reagiscono con bastonate e con i kalashnikov, sparano, non usano i lacrimogeni. D’altra parte passa tutto sotto silenzio, anche se le donne sono scese in piazza a rivendicare i loro diritti al grido di pane, lavoro e libertà. Però le donne sono isolate, non hanno mezzi, non possono comunicare, non sono istruite e sono confrontate con un regime violento che opprime il popolo. Sono più di 400 giorni che le scuole sono chiuse per le donne. È l’unico Paese al mondo in cui le ragazze non possono andare a scuola e non hanno diritti. È una vergogna per la comunità internazionale».
Dopo l’agosto dell’anno scorso c’è più facilità a far ottenere l’asilo ai profughi afghani? «Non direi. – afferma sconsolato Mario Amato – Oggi, rispetto al passato, è più probabile ottenere un’ammissione provvisoria, ovvero lo statuto che viene concesso quando l’allontanamento verso il Paese d’origine non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile. Ma il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo è limitato a coloro che riescono a comprovare o rendere verosimile l’esposizione a pregiudizi seri: per esempio funzionari del precedente governo, giornalisti, collaboratori di ONG straniere, ecc.».
Come vede il suo futuro la presidente della Comunità afghana? «In Ticino mi trovo bene, all’inizio non è stato facile: lontano dal tuo Paese e dai tuoi affetti più cari, a volte puoi anche sentirti persa. Ma ora posso guardare al futuro qui, anche se c’è sempre il sogno di poter tornare. Al Festival dei diritti umani, a Lugano, ho letto un mio testo sul futuro: la finestra futura è fatta di pace, inclusione e umanità. Guardo uno stormo di uccelli migratori volare su di noi e non posso non ripensare al viaggio che mi ha portato sino a qui, superando frontiere, vincendo paure. Penso all’umanità futura come quello stormo di uccelli che volano liberi, liberi di spostarsi senza preoccupazione di varcare frontiere, per dare risposta al loro bisogno di vivere in un posto migliore. Liberi di scegliere dove nidificare».
Editore e amministrazione
Cooperativa Migros Ticino CP, 6592 S. Antonino tel +41 91 850 81 11
Stampa Centro Stampa Ticino SA Via Industria – 6933 Muzzano
Tiratura 101’177 copie
Il pollame in generale è considerato cibo delicato, tenero, ben digeribile e, grazie alla sua versatilità, è ideale per tantissime preparazioni in ogni stagione. Anche in occasione delle festività di fine anno, sono molti coloro che scelgono specialità di polleria per portare in tavola sontuosi manicaretti. Oltre ai polli interi svizzeri Optigal, l’assortimento Migros spazia dai tacchini di diversi pesi e dimensioni al cappone e alla faraona , fino al rinomato pollo di Bresse francese e all’anatra. Un piatto particolarmente ricercato a Natale è il cappone. Questo gallo giovane castrato possiede carni morbidissime e bianche, molto tenere. Il modo più indicato per preparalo è lessato con l’aggiunta di erbe aromatiche e
verdure. Si può anche cuocerlo arrosto al forno, con un saporito ripieno. La cottura è simile a quella del pollo. Altro piatto tradizione delle feste natalizie è ovviamente il tacchino, che grazie alle sue dimensioni fa sempre bella figura in tavola. Alla Migros sono disponibili tacchini da 2 fino a 10 kg. La cottura richiede ca. 40 minuti per ogni 500 g di peso. I tacchini si cuociono solitamente al forno, con un gustoso ripieno che ammorbidisca e insaporisca bene la carne. La faraona ha carni scure particolarmente gustose. I tempi di cottura sono simili a quelli del pollo. È ottima ripiena oppure fasciata di pancetta trattenuta con uno spaghino. Il pollo di Bresse è una vera prelibatezza della cucina francese.
• Filetto di manzo Wellington (da riservare entro il 21.12.2022)
• Cappone
• Faraona ripiena (da riservare entro il 19.12.2022)
• Entrecôte di Wagyu
• Filetto di bisonte
• Entrecôte di renna
• Maialino da latte
• Pollo di Bresse

Possiede carni fondenti e saporite, grazie alla presenza di buon grasso tra le fibre. Affinché possa conservare le sue straordinarie qualità gustative e nutritive, si consiglia di cucinarlo nei propri succhi. Dopo averlo salato esternamente, mettete il pollo in una casseruola «cocotte» di ghisa. Salate, pepate e condite con un filo di olio di oliva. A metà cottura girate il pollo. Evitate di pungere il pollo e bagnatelo con i propri succhi ogni mezz’ora. Calcolate 45 minuti di cottura ogni kg di pollo, con una temperatura del forno a 200°C. Infine, vi ricordiamo che per richieste particolari, modalità di cottura e consigli personalizzati, i nostri specialisti dei banchi carne Migros sono a vostra completa disposizione.
Piatto principale per 8 persone
• 1 tacchino di ca. 5 kg, ordinabile in anticipo dal macellaio Migros
• 1 mazzetto d’erbe aromatiche miste, ad es. rosmarino, timo
• ca. 20 g di burro, ammorbidito
• sale
• 2 dl d’acqua
• 3 dl di sidro
• 2 cucchiai d’amido di mais
• pepe
Crostini di pane alle mele
• 2 mele acidule
• 250 g di pane semibianco, del giorno prima
• 3 00 g di sedano
• 2 cipolle rosse
• 1 mazzetto di salvia
1. Estrai il tacchino dal frigo un’ora prima della preparazione. Scalda il forno statico a 200 °C. Farcisci il tacchino all’interno con le erbe. Lega insieme le cosce sopra la cavità. Sfrega bene tutto il tacchino con burro e sale. Accomodalo in una brasiera e aggiungi l’acqua. Inforna al centro e fai rosolare il tacchino per ca. 30 minuti. Abbassa la temperatura a 180 °C e continua la cottura per ca. 2 ½ ore, spennellando la carne di tanto in tanto con il fondo che si forma nella brasiera. Quando la temperatura al cuore è di ca. 85 °C, il tacchino è cotto. Accomodalo su un piatto da portata con della carta alu e lascialo riposare per 20 minuti.
2. Filtra 3 dl di fondo di pollame formatosi nella brasiera e portalo a ebollizione in una padella con il sidro. Sciogli l’amido in poco fondo, poi incorpora al resto della salsa, mescolando bene, e porta nuovamente a ebollizione. Regola di sale e pepe.
3. Per i crostini di pane, dimezza le mele con la buccia, privale del torsolo e sminuzzale. Taglia a dadini il pane, il sedano e le cipolle. Mescola tutto con il resto del fondo (ca. 2 dl) nella brasiera. Aggiungi la salvia. Sala, pepa e cuoci al centro del forno per ca. 20 minuti, finché i cubetti di pane diventano croccanti. Trancia il tacchino e servilo con i crostini di pane alle mele e la salsa.
Attualità ◆ Presso i nostri quattro sushi corner si possono ordinare dei vassoi assortiti di sushi per gli aperitivi festivi

Shogatsu, Asakura, Kamakura e Takayama: così si chiamano gli speciali vassoi assortiti di sushi che potete richiedere rivolgendovi con almeno 24 ore di anticipo a uno dei quattro sushi corner situati all’interno dei supermercati Migros di S. Antonino, Locarno, Bellinzona e Serfontana. Non c’è niente di meglio di questi bocconcini di origine giapponese per gustarsi qualcosa che sia al contempo gustoso, sano e leggero. Tutti i nostri sushi vengono preparati al momento a mano, direttamente in
negozio, da parte di personale appositamente formato in cucina asiatica utilizzando solo ingredienti accuratamente scelti. Siccome il sushi è composto principalmente da pesce crudo fresco, per gli addetti è di fondamentale importanza prestare particolare attenzione all’igiene e il mantenimento della catena del freddo lungo tutta la fase di produzione.
La preparazione del sushi inizia già di buon mattino con la cottura del riso, il quale viene successivamente arricchito con gli altri ingredien-
ti tradizionali, tra cui per esempio salmone, tonno, gamberetti, cetrioli, avocado, ravanelli e altre verdure. Come alternativa sono disponibili anche sushi solo vegani o a base di carne di pollo. Si consiglia di gustare il sushi senza eccedere con la salsa di soia per non compromettere il sapore del pesce fresco. Per chi ama il piccante, si consiglia di accompagnare il sushi con della salsa verde wasabi. Infine, assaporando dello zenzero marinato tra un bocconcino a l’altro, aiuta a neutralizzare i diversi sapori.

Il noto pasticcere airolese Bruno Buletti produce il suo panettone nella regione del Gottardo utilizzando ingredienti 100% naturali e senza l’impiego di conservanti o emulsionanti. Il lievito madre viene prodotto e curato dalla pasticceria stessa, il burro d’alpe proviene da alcuni piccoli produttori locali e le uova sono da allevamento al suolo. La frutta delicatamente candita conferisce all’impasto una nota particolarmente fresca.

La produzione di un panettone artigianale di qualità necessita di una lunga lavorazione e un di un savoir-faire artigianale maturato in trent’anni di attività. La lavorazione dura non meno di 48 ore, tra preparazione dell’impasto iniziale, rinfreschi, lievitazione, cottura, raffreddamento e confezionamento.
La pasticceria Buletti è stata fondata ad Airolo nel 1992, quando Bruno Buletti dopo la formazione di panettiere-pasticcere -confettiere e alcuni anni di esperienza in patria e all’estero ritira, insieme al fratello Franco, un laboratorio già esistente nella località dell’Alta Leventina. Oggi i suoi prodotti sono riconosciuti e apprezzati non solo nel nostro Cantone, ma anche oltre Gottardo e in Italia. Oltre al panettone classico nei formati da 500 g e 1 kg, Buletti è presente sugli scaffali Migros anche con il pandoro e il panettone senza lattosio.
Pane della settimana ◆ Il Pane Passione Rustico IP-Suisse è un prodotto versatile da gustare ad ogni portata

Grazie all’impiego di ingredienti genuini personalmente selezionati da Bruno Buletti e a molta artigianalità, il panettone al burro d’alta montagna possiede un gusto e un aroma unici. Il lievito madre regala al prodotto una morbidezza e fragranza caratteristiche che si apprezza appieno conservandolo senza troppi sbalzi di temperatura e portandolo a temperatura ambiente un’oretta prima del consumo.
Che si tratti di preparare dei canapé per l’aperitivo, di accompagnare un antipasto a base di pesce o una croccante insalata, oppure ancora di abbinare al piatto forte o a un vassoio di formaggi misti qualcosa di particolarmente genuino… il pane passione rustico è in grado di «farsi valere» ad ogni occasione. Questa croccante e rustica specialità attorcigliata a mano viene prodotta secondo una ricetta esclusiva con farina di frumento scura, la quale viene ulteriormente arricchita con segale, spelta, semi di girasole, semi di lino e sesamo. La mollica morbida e alveolata spicca per i suoi aromi di grano. La sua tipica forma allungata è sinonimo di manualità: i panettieri del panificio Migros lavorano infatti a lungo l’impasto per ottenere un prodotto dall’aspetto rustico e sempre diverso.
Oltre ai prodotti Buletti, l’assortimento festivo regionale di Migros Ticino annovera ancora alcune chicche di produzione locale: il gonfiotto ai marroni Cuoco, i panettoni gianduia e tradizionale Dolcemonaco, il panettone della fondazione La Fonte e la triestina al cioccolato Poncini. Inoltre, non vanno dimenticati i sempre apprezzati panettoni e pandori dall’ottimo rapporto qualità-prezzo a marchio Jowa, specialità prodotte in toto nel panificio di S. Antonino per tutti i negozi Migros della Svizzera.
disponibili alla Migros, quest’anno spicca quello norvegese intero con coltello accluso, da affettare sul momento. Questo delicato filetto viene affumicato a freddo con metodi tradizionali e conquista ogni palato con il suo sapore delicato e caratteristico.


Sono passati quasi vent’anni da quando i camosci del Monte Generoso si ritrovarono di colpo sotto i riflettori mediatici perché al centro di un acceso dibattito sull’opportunità o meno di aprirne la caccia. Con il tempo l’attenzione mediatica però è scemata, e oggi, se si escludono i dati risultanti da qualche saltuario censimento da parte dell’Ufficio cantonale ivi preposto, poco si sa sullo stato di salute, sulle abitudini e sulla genetica di questi ungulati.
Il numero dei camosci alpini (Rupicapra rupicapra) negli ultimi quindici anni si è ridotto in modo notevole, arrivando, in alcune regioni, addirittura a dimezzarsi. La popolazione degli ungulati presente sul Monte Generoso è considerata molto particolare, poiché oltre a essere l’ultima di questa specie al sud delle Alpi, è una popolazione chiusa, dunque senza alcuna possibilità di potere contare su nuovi individui esterni. Si tratta di una popolazione non cacciata, isolata in seguito alla frammentazione e alla perdita di habitat e insediata in una zona non protetta e dal forte valore turistico; il rischio legato alla situazione attuale è dato dalla possibile importante consanguineità, che può condurre a una decrescita degli individui e infine, in ultima battuta, alla loro estinzione.

Come sottolinea Norman Polli (nella foto con la presidente della
Commissione culturale del Consiglio di cooperativa Gaby Malacrida), presidente del Comitato distrettuale dei cacciatori del Mendrisiotto, che ha dato vita al progetto «La conservazione della popolazione dei camosci alpini del Generoso», se si desidera conservare questa popolazione, la cui sopravvivenza è fondamentale per il mantenimento della biodiversità e dunque della fauna di montagna, è necessario conoscerne dapprima a fondo lo stato di salute attraverso uno studio dettagliato della situazione attuale. Il progetto lanciato dal Comitato distrettuale dei cacciatori del Mendrisiotto tra i suoi obiettivi principa-
li ha individuato il censimento della popolazione, la sua caratterizzazione genetica, oltre alla comprensione del suo stato generale di salute e delle sue dinamiche. Lo studio dei dati raccolti permetterà, in un secondo momento, di sviluppare delle soluzioni ad hoc per la conservazione di questa specifica popolazione che potranno poi eventualmente essere applicate anche ad altre popolazioni della medesima specie isolate, o parzialmente isolate, sulle Alpi. L’importante e ambizioso progetto (su cui torneremo nel corso dell’anno prossimo) ha preso il via questo mese e si protrarrà fino al dicembre del 2024.
Integrazione ◆ L’Associazione




«Migliorare la convivenza», è questo il motto del programma di sostegno «ici.gemeinsam.hier», promosso da Migros Impegno. Un progetto ad ampio respiro atto a favorire e rafforzare l’integrazione degli stranieri nel nostro territorio. 233 sono i progetti che hanno partecipato al programma, 92 quelli che potranno godere di un sostegno con un importo compreso tra i 5’000 CHF e i 50’000 CHF. Per partecipare era fondamentale rispondere ad almeno uno dei seguenti criteri: incontro interculturale e comunicazione nella vita di tutti i giorni, plurilinguismo nei bambini prima dell’inizio della scuola dell’infanzia e creazione di prospettive professionali per gli adulti.

Tra i progetti premiati vi è anche quello dell’Associazione bellinzonese

Eccoci, il cui mandato è la creazione di un luogo di incontro che permetta di rispondere alle esigenze dei richiedenti asilo. A Eccoci ci si riunisce una volta alla settimana per seguire i corsi di lingua italiana, ma non solo. Come spiega la coordinatrice Lucia Peduzzi, Eccoci sostiene anche le persone nelle candidature di lavoro, si impegna anche nell’ambito dell’integrazione scolastica, della gestione delle situazioni di vita quotidiana e, non da ultimo, organizza uscite di gruppo.
Per maggiori informazioni ici-gemeinsam-hier.ch e, su Facebook, Eccoci Bellinzona
Ricevi 3 mesi gratuiti e partecipa al concorso per vincere uno dei 3 abbonamenti annuali!

















Igiene orale ◆ Dall’Antichità ai giorni nostri, l’evolversi di un’arte medica tra vermi e oro, ciarlatani e scienza. Oggi la prevenzione dentaria nelle scuole è il fiore all’occhiello del nostro Cantone, ma non è sempre stato così
Sara Rossi GuidicelliSe avete paura di andare dal dentista, o comunque siete un po’ riottosi, un rimedio c’è: pensare a cosa è stata in passato la cura dei denti; vi basterà visitare un museo della profilassi dentale (ce ne sono a Torino, Bologna, Londra, Linz, Baltimora…) o anche solo fare un giro sul web alla ricerca di mummie con i denti d’oro o antichi strumenti da «medico della bocca».
La storia dell’odontoiatria si estende molto nel passato e rivela che la cura dei denti è una delle arti più antiche che l’uomo conosca. Ci sono prove che già nel neolitico si è cercato di curarli e nelle terre del Pakistan di 7000 anni or sono i contadini avevano denti cariati «riempiti» con materiali diversi.
La ricostruzione delle origini dell’odontoiatria mostra che i metodi di cura dell’epoca erano apparentemente molto efficaci. La prima otturazione dentale, a base di cera d’api, è stata scoperta in Slovenia e risale a circa 6500 anni or sono: un canino fratturato è stato così rifatto. Sin dai tempi dei Sumeri si credeva che un verme fosse responsabile della carie nei denti e questa credenza perdurò fino ai tempi moderni. Esiste un libro, del VII secolo a.C., ritrovato nella biblioteca assira del Re Assurbanipal, che si intitola Quando un uomo ha mal di denti Il testo dice che quel verme è con ogni probabilità un demone o uno spirito maligno e quindi che va curato con scongiuri e rituali magico-religiosi.
Per moltissimi secoli, in tutto il mondo cristiano, l’unico rimedio (perlomeno per i poveri) è stato quello di pregare Santa Apollonia, martire vissuta ad Alessandria d’Egitto nel III secolo a.C. e alla quale sono dedicate numerose cappelle anche in Ticino. Ancora oggi è la santa protettrice dei dentisti, dato che il suo martirio consistette nell’estrazione di tutti i denti prima di essere gettata nella pira.
La tecnologia dentale fu inventata probabilmente dagli Etruschi e dai Fenici, che la tramandarono agli arabi che estesero le loro conoscenze agli antichi Romani e Greci, raggiungendo il mondo occidentale. Aristotele inventò uno strumento particolare (una specie di pinza) per l’estrazione dei denti dolorosi e si cominciò a sostituirli con finti denti di oro o avorio. I dentisti nell’antica Roma erano spesso schiavi greci, che potevano ottenere la libertà se riuscivano ad alleviare il dolore dei
loro pazienti. Nel Medioevo, invece, la professione di dentista era esercitata dai barbieri, ricordate come si presenta il Barbiere di Siviglia? «Io son barbiere, parrucchiere, chirurgo, botanico, spezial, veterinario, il faccendier di casa…». In realtà, prima era stato affare dei monaci e dei sacerdoti, ma in piena epoca di crociate si era deciso che gli uomini di Dio non si sarebbero più occupati di queste cose; Papa Alessandro III disse: «Gli interventi sanguinosi sono incompatibili con il sacerdozio: Ecclesia abhorret a sanguine (la Chiesa si ritrae di fronte al sangue)». Uccidere sì, curare no.
Dall’Ottocento, poi, le corporazioni di barbieri e chirurghi in Europa si separarono, e fu così che i barbieri poterono finalmente occuparsi solo di barba e capelli, mentre la professione di chirurgo si andava specializzando nel resto del corpo umano. Se prima le cure dentarie e la chirurgia in generale erano considerate «medicina di serie B», le cose con il tempo sono cambiate, avvicinando piano piano la professione del chirurgo e del dentista agli studi di medicina. L’anestesia, per fortuna, era nata nel 1776, con la somministrazione di gas esilarante, passata poi all’etere e al cloroformio.


Solo nel 1843, la teoria del verme viene trasformata dall’anatomista Michael Pius Erdl in una teoria parassitaria; segue poi l’idea che si tratti di infiammazione, fino al 1890 quando si
comincia a parlare di batteri. È allora che si inizia a pensare che «un dente pulito non marcisce mai». Successivamente, si sviluppa l’ipotesi della placca, che stimola i germi e i lattobacilli. La strada per la profilassi dentale come rimedio primo è spianata, anche se ci vorranno ancora molti anni prima che davvero si diffonda la cultura della cura preventiva dei denti.
L’igiene orale era nata però molto tempo prima: già nell’Antichità si usano bastoncini fibrosi che fungevano da spazzolino da denti e il sorriso smagliante era già segno di bellezza. A coniare il nome di dentifricio era stato Plinio il Vecchio. Ingredienti per fabbricarlo: osso, corno o conchiglia di mollusco polverizzato, polvere di pomice, bicarbonato di sodio mescolato con mirra (se si pensa che come collutorio veniva usata l’urina, un osso di mollusco non dovrebbe fare tanto ribrezzo). Altre tecniche per prevenire la carie erano, presso i popoli cinesi ed egizi, masticare corteccia di albero, piume di uccello, lische di pesce o aculei di porcospino.
Il primo spazzolino rinvenuto risale alla Cina del 1500, ed era composto da setole di maiale. In Europa lo spazzolino si è diffuso solo alla fine del Settecento, ancora tutto fabbricato con materiali animali. La pratica di spazzolarsi i denti tuttavia è diventata di uso comune a partire dalla Seconda guerra mondiale, quando l’e-
sercito americano richiedeva ai soldati pratiche igieniche ferree, tra cui il lavarsi i denti quotidianamente; nel 1938 seguì lo sviluppo del primo spazzolino in nylon.
Sembra che il primo programma di profilassi infantile sia stato lanciato nel 1851 in Belgio. Da noi in Ticino ha iniziato a svilupparsi dagli anni Quaranta del Novecento e nel 1985 si è tenuto il primo corso di assistente di profilassi dentaria comunale. Oggi lavorano 57 operatrici dentarie scolastiche che fanno visita due volte all’anno a tutti gli allievi delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari. Forse ve le ricorderete: si occupano di sensibilizzare i bambini alla pulizia dei denti, insegnano come usare lo spazzolino e spiegano l’importanza di prevenire la carie invece che curarla. Rispetto ai ricordi di chi andava a scuola negli anni Cinquanta o Sessanta, la pedagogia usata ha fatto passi da gigante: ora queste visite sono un gioco, piuttosto che un momento di terrore.
Le statistiche dimostrano come le carie nei ragazzi ticinesi siano drasticamente diminuite, soprattutto nel periodo tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta. È avvenuto un salto di qualità immenso nella cura dei denti da parte dei ragazzi: la cultura della prevenzione ha funzionato. E ora che siamo alla terza generazione – mi spiega Alessandro Perucchi, responsabile cantonale delle operatrici dentarie sco-
lastiche e membro della commissione di vigilanza del Servizio Dentario Scolastico – si possono veramente raccogliere i frutti. Purtroppo i problemi si vedono ancora, soprattutto quando i genitori non sono stati sottoposti anche loro a questo programma di istruzione. La cultura della profilassi è qualcosa che ci si passa di generazione in generazione.
Quello che invece ancora molti non sanno è che lo zucchero può nascondersi in prodotti «insospettabili», come il ketchup o le bevande gassate. La combinazione di acido e zucchero è deleterio, mi spiega il medico dentista SSO Perucchi. Per questo il servizio dentario scolastico non si limita alla profilassi indirizzata ai bambini, ma in collaborazione con il Cantone, ha creato delle linee guida per la merenda nelle scuole, gli spuntini e le direttive per i pranzi al sacco, dove si consigliano alimenti sani, acqua da bere e frutta al posto dei dolci.
Altro pilastro del servizio è che a ogni sede scolastica delle elementari e delle medie è assegnato un medico dentario: ogni bambino ha diritto di andare a fare una visita gratuita di controllo ogni anno. Il medico dentista verifica se ci sono problemi di carie, di igiene orale od ortodontici e propone eventuali misure profilattiche e terapeutiche, oppure ancora consiglia una visita specialistica. Tutto ciò fino a un massimo di 700 franchi all’anno per bambino, normalmente rimborsati alla famiglia, anche se alcuni Comuni chiedono una partecipazione ai genitori. Tuttavia in media vengono usati circa 150 franchi per bambino. È anche preposta una Commissione Cantonale di controllo affinché non ci siano abusi da parte dei medici dentisti.
I dentisti oggi consigliano ai genitori di lavare loro stessi i denti ai propri figli una volta al giorno almeno fino alla terza elementare, e proseguire anche dopo diminuendo la frequenza a una volta su sette, per un paio di anni ancora. È importante responsabilizzarli ma anche mostrargli che è un’attività di famiglia, che riguarda tutti e che ci si può anche divertire per l’appunto lavandosi per esempio i denti a vicenda.
Non ci resta dunque che ammirare questa parte dell’evoluzione umana e iniziare a toglierci l’atavica paura del dentista.












Pro Senectute ◆ Il Servizio aiuto trasloco con i suoi cinque incaricati regionali fornisce assistenza alle persone anziane sole per organizzare e gestire al meglio il trasferimento in una nuova residenza
 Barbara Manzoni
Barbara Manzoni
Ogni cassetto nasconde un ricordo, ogni ripiano custodisce oggetti riposti con cura, ogni oggetto ha una storia. Se vi è capitato di aiutare un nonno, un genitore o un parente anziano durante un trasloco vi siete sicuramente trovati ad aprire quei cassetti e a svuotare quei ripiani che rispecchiano una generazione per la quale l’usa e getta non era neanche lontanamente concepibile. Così il lavoro di inscatolamento diventa laborioso, in equilibrio tra i tempi dettati dai termini di disdetta del contratto locativo e quelli dell’emotività di chi lascia ambienti famigliari.
«Il primo contatto è delicato, si entra nelle case e nell’intimità della persona anziana e lo si deve fare con il dovuto tatto»
Il trasloco per una persona anziana non è mai indolore, lo sanno i parenti e lo sanno anche gli operatori di Pro Senectute Ticino e Moesano che si occupano di aiutare chi di parenti su cui contare non ne ha. Il Servizio aiuto trasloco della fondazione è attivo dal 2018, ha avuto una battuta d’arresto durante la pandemia, ma ora ha ripreso la sua normale attività e gestisce una quindicina di traslochi all’anno, come ci conferma Paola Lanfranchini, referente amministrativa del Servizio aiuto trasloco di Pro Senectute Ticino e Moesano. Le richieste di aiuto arrivano sul suo tavolo da tutto il Cantone e sono valutate singolarmente, «non sempre possiamo assumere l’incarico – spiega Paola Lanfranchini – a volte le tempistiche non sono adeguate oppure la richiesta si sovrappone ad altri incarichi, per coordinare al meglio un trasloco abbiamo infatti bisogno di circa un mese. Altre volte, dopo una prima presa di contatto con la persona in-
Che meraviglia questo albo. Ti conduce, attraverso una storia semplice e potente, a un finale di meraviglia, nel senso platonico di sguardo inedito sul mondo, quello sguardo che ti spinge a porti profonde domande di senso. È un silent book, ma in questo silenzio quante cose accadono, raccontate dalle immagini di Chiara Ficarelli, sulla base di un’idea e una sceneggiatura di Lenina Barducci. C’è un gorilla, e c’è un bambino. Campo e controcampo. Chi è l’altro? Ciascuno dei due, a seconda del punto di vista. Perché questa è una storia (anche) di punti di vista. C’è un bambino, c’è un gorilla, e c’è una gabbia. Uno dentro, l’altro fuori. Questa è una storia (anche) di dentro e di fuori. Di recinti e di libertà. Di qui e di altrove. Di soglie tra il qui e l’altrove, quelle soglie che i bambini sanno attraversare così bene. E di soglie tra io e l’altro, quelle soglie che all’inizio tengono a distanza, e poi, se nasce una relazione, possono stemperarsi e farci avvicinare. Il bambino, sulla pagina di sinistra, guarda il gorilla, al di là delle sbar-
teressata al nostro servizio quest’ultima rinuncia». Va detto subito che il servizio non è gratuito, ma è anche vero che Pro Senectute attraverso il suo servizio sociale offre alle persone con difficoltà economiche la possibilità di ottenere un aiuto finanziario individuale.
Ma chi sono le persone che chiedono un aiuto per traslocare? «Principalmente sono persone sole – continua Paola Lanfranchini – della terza o quarta età che devono lasciare il proprio domicilio perché ricevono una disdetta o perché l’abitazione non è più adeguata alle loro esigenze attuali o perché vogliono rientrare nel loro Cantone o Paese d’origine, c’è chi cambia casa per trasferirsi in un appartamento più piccolo e funzionale, c’è chi sceglie di trasferirsi in un appartamento protetto, più raramente, ma ci è capitato, sono “accumulatori” che decidono di voler cambiare il loro modo di vivere e in questo caso lo sgombero è davvero impegnativo, ma una volta presa la decisione e portato a termine il trasloco, per questi utenti inizia veramente una nuova vita. Ogni situazione comunque è diversa, ogni trasloco è un caso a sé e la persona va aiutata non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche da quello emotivo».
Ed è qui che entrano in gioco gli incaricati regionali. Pro Senectute Ticino e Moesano ne ha cinque, ognuno responsabile per una zona: Mendrisiotto, Luganese, Locarnese, Bellinzonese, Biasca e Valli. Sono loro a essere il vero punto di riferimento per l’utente. Manuela Peverelli è l’incaricata per il Locarnese e mi spiega che per lei il primo importantissimo passo appena ricevuto il mandato è quello di conoscere la persona interessata: «Il primo contatto è sempre delicato, in fondo si entra nelle case e nell’intimità della persona anziana e lo si deve fare con il dovuto tatto, per questo motivo se la persona è già un utente
di Pro Senectute organizzo la prima visita in modo da essere accompagnata dal collega del servizio sociale che la segue normalmente. È molto importante che l’anziano si senta a proprio agio, nonostante lo stress che un trasloco può causare. Inoltre il rispetto della privacy è un aspetto assolutamente prioritario. Per la parte pratica mi accerto che disdetta e nuovo contratto siano a posto, chiedo se la persona vuole trasportare tutto nella nuova casa o desidera eliminare qualcosa, mi occupo di valutare il tempo e il materiale necessario per inscatolare, contatto le ditte di trasloco e richiedo dei preventivi, organizzo il personale che aiuterà a inscatolare e a volte anche a svuotare le scatole nella nuova casa. Insomma coordino tutto affinché il trasloco si svolga nel migliore dei modi. Poi si deve ancora provvedere alla pulizia dell’appartamento da riconsegnare, anche in questo caso chiedo dei preventivi a ditte di pulizia. Spesso l’utente preferisce an-
●
re. Il gorilla, sulla pagina di destra, guarda a sua volta e al contempo il bambino, al di là delle sbarre. Nasce una relazione, prima cauta, poi fiduciosa, fatta di sguardi e di movimenti. Un dialogo di sguardi e movimenti, in questo libro che non poteva che essere un silent, perché i gorilla non parlano un linguaggio di parole, e questo gorilla, così efficacemente creato in immagini da Chiara Ficarelli (che riesce a mantenere un suo eccellente tratto personale, senza appiattirsi sul modello del celebre illustratore di gorilla Anthony Browne) non è umanizzato. È un animale, in tutta la sua dignità, fiera e giocosa. Anche il bambino è un animale, uma-

no però. L’altro è una storia di soglie, e la soglia non è solo la gabbia, ma anche ciò che mi separa dall’Altro, dal diverso: questa soglia è perfettamente rappresentata, nel libro, dalla piega centrale della rilegatura tra la pagina di sinistra e quella di destra, che qui acquista proprio una funzione narrativa, di confine. Un confine che, nella meravigliosa sorpresa finale, un personaggio riuscirà a superare, passando letteralmente dall’altra parte, dalla parte dell’altro, sull’altra pagina, dando la mano all’altro, verso l’Altrove.

Onirico, gentile, elegante, tra i 10 migliori albi illustrati del 2022 nella classifica «New York Times» e «New York Public Library». Il titolo Spuntino di mezzanotte forse rimpicciolisce il fascino sontuoso di questa storia, che non è il racconto di uno che apre il frigo in cucina di notte (per dire), ma un’intensa storia di condivisione e di cura. Night Lunch, questo è il titolo originale, fa riferimento a quei carri, trainati da un cavallo, che
il più bel ricordo legato ai tanti traslochi? «Direi il primo in assoluto che ho organizzato – ci confida – non posso ovviamente entrare nel dettaglio della situazione personale dell’utente che era piuttosto complicata, ma dopo un po’ di tempo mi è capitato di incontrarlo nuovamente per caso e nei suoi occhi ho colto una gratitudine che mi è rimasta nel cuore».
Shutterstock
che essere accompagnato al momento della riconsegna delle chiavi della vecchia casa e, a volte, mi è capitato di riconsegnarle io stessa».
Nonostante un’organizzazione ormai collaudata nel tempo, non mancano le difficoltà: «c’è chi ha paura del cambiamento – racconta Manuela Peverelli – o ha difficoltà ad accettare la nuova situazione, chi esprime un sentimento di incertezza e di instabilità. È normale e comprensibile: lasciano appartamenti dove hanno vissuto molti anni, la loro quotidianità viene un po’ stravolta. L’unico modo che abbiamo per aiutarli è mettersi in ascolto e dimostrarsi disponibili». Non ha dubbi poi, Manuela Peverelli, quando le chiediamo cosa le piace del suo lavoro: «spesso si crea davvero un bel rapporto con l’anziano, il mio lavoro mi arricchisce e mi fa diventare una persona migliore anche se a volte mi arrabbio davvero molto di fronte alla poca sensibilità che amministratori o proprietari dimostrano». E
Una gratitudine che esprime anche Lario Bognuda, 83enne di Lodrino, che qualche anno fa si è avvalso del Servizio aiuto trasloco. «Abitavo al quarto piano in una palazzina senza ascensore – ci racconta – a 80 anni e con qualche problema di salute mi sono reso conto che era troppo faticoso soprattutto quando dovevo portare la spesa o qualsiasi cosa di pesante. Ho avuto la fortuna di trovare un appartamento di proprietà del patriziato di Lodrino, vicino a dove abitavo, sempre a un piano alto ma con l’ascensore. Ho deciso subito che era l’occasione giusta, ma restava l’incognita del trasloco e di quei quattro piani di scale! Per fortuna gli assistenti sociali mi hanno aiutato, mi hanno suggerito di contattare Pro Senectute e alla fine io sono rimasto letteralmente a guardare. Si sono occupati di tutto, in modo efficiente, discreto e rispettoso, e poi hanno anche disposto il mio nuovo appartamento molto bene, anche meglio di come l’avrei fatto io. Vivo da solo e davvero non ce l’avrei mai fatta senza un aiuto così professionale». Oggi il signor Bognuda si dice molto felice della scelta, il nuovo appartamento lo definisce «un luogo bellissimo». A riprova che anche i cambiamenti che sembrano quasi insormontabili dopo averli affrontati presentano dei lati positivi e a volte, come per Lario Bognuda, anche belle camere con vista.
Informazioni www.prosenectute.org; aiuto.trasloco@prosenectute.org
di notte, a fine Ottocento, giravano per le città americane vendendo cibo a tutta un’umanità notturna composta ad esempio da reporter, poliziotti, gente dello spettacolo, operai, infermieri. Ristoranti notturni su ruote, cibo caldo per viandanti infreddoliti. Antesignani, molto più poetici, dei nostri fast food o take away. In rete si trovano diverse fotografie, o manifesti pubblicitari, di questi Night Lunch Wagons, e molti recavano l’insegna «The owl», il gufo. Evidentemente in riferimento al fatto che il gufo è un animale notturno. In Spuntino di mezzanotte è proprio un gufo il cuoco di questo carro ristorante, che arriva, con le sue lucine, trainato da
un cavallo bianco, nella città buia e silenziosa. «Clippete cloppete, zoccoli e ruote/La luna illumina le strade vuote…».
Il testo poetico, splendidamente tradotto da Chiara Carminati, è dell’autore canadese Eric Fan, del duo The Fan Brothers (celebri per Il giardiniere notturno o La meraviglia caduta dal cielo). Qui però Eric non è in coppia col fratello, perché le immagini sono di Dena Seiferling, al suo esordio in Italia. E sono immagini spettacolari, notturne ovviamente, ma calde, riscaldate dai toni seppia, dall’espressività dei personaggi e da un alone di magia. Il gufo dunque cucina per la volpe, per il tasso, per le falene, per gli opossum, a ognuno un manicaretto, ma c’è chi non può permettersi un pasto, e costui è un topo che fa il netturbino nell’oscurità delle strade. Un topino tremante e affamato, che il gufo scorge, alle prime luci dell’alba, mentre sta per chiudere il suo carro ristoro. Non a caso gli autori hanno scelto un topino, creatura infima e preda dei gufi nella realtà. Ma qui siamo in un mondo magico e onirico, un mondo dove può accadere che un gufo cuoco inviti un topino alla sua mensa, e lo ristori davvero.







Incontri (8) ◆ Nato e cresciuto in Ticino, Thomas Meylan, a 45 anni ha deciso di emigrare… in Svizzera, nella Riviera vodese dove, risistemando la casa dei nonni, sta impostando la sua nuova vita
Matilde CasasopraCi sono momenti in cui, pur parlandogli, si ha come l’impressione che lui sia altrove e invece… è lì. Ti ascolta così attentamente da sembrare assente e invece… è presente al punto che, quando ti risponde, sa andare subito al cuore del problema, della domanda, della questione. Thomas Meylan è uno che sa passare inosservato, ma è un grande osservatore. Ergoterapista di professione, qualche anno fa ha ridotto sensibilmente l’uso dell’automobile per la bicicletta e durante la pandemia, con un gruppo di amici, ha dato vita, a Pregassona, a un orto coltivato sulla base dei principi fondanti la permacultura. Un’esperienza che Thomas, con Lara – la sua compagna – intende proseguire nel canton Vaud, dove già lavora da questa primavera e dove da questo mese di dicembre andrà ad abitare.
Perché lasciare il Ticino per il canton Vaud?
Il motivo principale è che a Montreux c’è la casa dei miei nonni. I figli – rispettivamente genitori – avevano ormai la loro casa e, questa dei nonni, era, diciamo così, superata dagli standard abitativi attuali. Bref: nessuno ci sarebbe andato ad abitare. La decisione: venderla. Così, dopo un accordo con la famiglia, la mia compagna (che è architetta) e io abbiamo deciso di andarci a vivere. Una decisione che risale all’estate del 2020. Entrambi, allora, lavoravamo in Ticino. La sera del venerdì partivamo per Losanna e nel tempo libero eseguivamo quei lavori necessari a rendere la casa… abitabile.
Insomma, una scelta fondata su una casa… No. Diciamo che la casa è stato lo spunto, il pretesto, per rivedere la vita che stavamo conducendo. Una vita sempre più imprigionata in un circolo di abitudini che avrebbero, prima o poi, potuto trasformarsi in routine. Insomma, abbiamo deciso di cambiare per evitare una «morte lenta». Lara, abituata a vivere fuori dal Ticino, e che come me aveva bisogno di ampliare i suoi orizzonti, si è trasferita prima. Da gennaio 2021 è assistente al Politecnico federale di Losanna e segue una formazione di nutrizione olistica a Ginevra. Mi sto progressivamente trasferendo anch’io per continuare lì il mio lavoro di ergoterapista.
Lei, infatti, è ergoterapista. Com’è arrivato a scegliere questa professione?
Diciamo che non è stata la mia prima idea… Chissà… Forse perché ho un approccio lento a quelle che si definiscono le «scelte di vita».
Approccio lento. Esemplificando? Mi viene in mente mia madre che mi racconta di quando ero piccino e di come, mentre mi spingeva in passeggino, mi allungassi per regalare qualsiasi cosa avessi a portata di mano ai passanti, per strada così come al parco. Normalmente le persone, quando definiscono il periodo dell’adolescenza – che è il periodo della presa di coscienza di sé, della ribellione alle regole e alla routine – indicano il periodo tra i 12-13 anni e i 18. Ebbene, la mia adolescenza è iniziata tra i 16 e i 17 anni. Ero al liceo e, grazie a docenti particolarmente sensibili, mi sono reso conto del fatto che
vivevo ai margini della realtà. Questi docenti mi hanno insegnato a leggere i giornali, a individuare i messaggi subliminali e le letture di parte che, a dipendenza della testata, potevano essere fornite di un medesimo evento. Così… mi sono svegliato dal mio mondo perfetto, ordinato ed empatico. Mi sono svegliato e ho capito che il mondo non era quel luogo meraviglioso che, grazie ai miei genitori, avevo imparato a pensare che fosse.
Ho cominciato a frequentare il Centro Sociale Organizzato Autogestito e antiteticamente lavoravo al supermercato e per agenzie di collocamento mentre finivo il liceo. Volevo vivere a modo mio. Poi ho trovato lavoro a Zermatt come cameriere e mi è venuta l’idea di dedicarmi alla ristorazione. No. Non ho aperto un bar, ma ho incominciato a lavorarci, a Lugano. Ed è così che ho scoperto che, ad appassionarmi, erano soprat-
tutto le persone in quanto tali. La ristorazione offre molte possibilità in quest’ambito, ma più passava il tempo, più mi rendevo conto che non mi bastava questo rapporto del tipo «toccata e fuga». Mi sono guardato allo specchio e ho capito che dovevo decidermi a fare qualcosa per dare uno sbocco al mio interesse naturale per la relazione d’aiuto. Ho letto, mi sono informato e poi ho scelto: l’ergoterapia racchiude in sé tutti gli aspetti che cercavo. Sono tornato a scuola e, nel 2014, ho conseguito il Bachelor of Science SUPSI in Ergotherapie con un lavoro di tesi in ambito ergonomico.
Tutto bello, ma… proprio perché è lei stesso a porre l’accento sull’interazione personale le chiedo: com’è riuscito a lasciare le persone con le quali era entrato in relazione come ergoterapista?
Vede – e preciso che la definizione non è mia ma dell’Associazione
Thomas, ha a disposizione 666 battute per illustrare tre momenti topici della sua vita:
1. La prima bocciatura al Liceo. Ebbi l’opportunità di confrontarmi con la sensazione di fallimento. Penso sia così che entrai nell’adolescenza e iniziai a scontrarmi con il mio mondo.
2. La prima lezione di yoga. Avevo 25 anni. Ebbi la possibilità di iniziare un percorso di ricerca interiore che continua ancora oggi. Per questo sono molto grato a mia madre, Raffaella, che era la maestra che guidò la lezione.
3. In un mio momento di profonda crisi, un mio carissimo ami-
svizzera degli ergoterapisti – l’ergoterapia è una professione incentrata sullo sviluppo e il mantenimento della capacità di agire delle persone contribuendo al miglioramento della loro salute e qualità di vita. Le persone – anziani, bambini, adulti – che ho incontrato, i miei «clienti», hanno intrattenuto con me un rapporto personale e professionale. Ho offerto loro le mie competenze per far sì che potessero performare meglio le attività nel loro mondo. Io, come ergoterapista, sono una presenza occasionale determinata dai casi della vita. Arrivo con un mandato medico. Do una mano per tornare a una vita nella norma. Poi esco di scena. Se non lo facessi vorrebbe dire che non sono riuscito a svolgere al meglio il mio lavoro. Certo, ci sono rapporti che resistono anche oltre la cura, ma a quel punto si parla di amicizie e, come accade anche nella vita extra-lavorativa, le amicizie sono rare.
Scusi, ma ha un segreto per essere così «immerso nel» e così «distaccato dal» mondo?
Più che un segreto è una pratica di vita che ho scoperto grazie a mia madre che è insegnante di yoga. Già a 16 anni mi sono avvicinato alle discipline yogiche tramite un piccolo manuale scritto da Babacar Khane, maestro che ha sviluppato una pratica fondendo nei-chia, lo stile interno del kung-fu, con lo yoga egiziano. A 25 anni mia madre mi ha introdotto al Raja Yoga. Ne sono rimasto affascinato e ho così seguito il ciclo formativo di quattro anni per insegnanti Viniyoga con Claude Marechal che sviluppa e tramanda gli insegnamenti di Krishnamacharya e di suo figlio Desikachar. È così che da anni, ormai, oltre ad essere ergoterapista sono occasionalmente anche insegnante di yoga. Uno yoga lontano dalle posizioni acrobatiche. Nel mio corso la pratica si fonda soprattutto sulle asana di base e il pranayama.
Nella sua scheda come sogni nel cassetto ha indicato la cupola geodetica e la condivisione dei principi della permacultura. Pensa di realizzarli?
Diciamo che provo a realizzarli. E… vede… siamo tornati da dove siamo partiti. La casa dei nonni. Come tutte le case contadine anche quella dei miei nonni ha l’orto che, con Lara, stiamo già coltivando secondo i principi della permacultura. Entrambi siamo convinti che Bill Mollison, fondatore della permacultura, aveva ragione quando affermava che «il più grande cambiamento che dobbiamo fare è dal consumo alla produzione, anche se su piccola scala, nei nostri giardini. Se solo il 10% di noi lo fa, ce n’è abbastanza per tutti». Noi ci stiamo provando. Per la cupola geodetica… sì, forse ci vorrà un po’ più di tempo, ma mai dire mai.
Nato
Hobby: esperienze musicali, contatto con la natura

Rimpianto: attaccamento a un passato mai esistito? No grazie
Sogno nel cassetto: costruire una grande cupola geodetica in natura in cui insegnare yoga e organizzare attività associative e di condivisione di nozioni utili alla permacultura
Amo: il percorso condiviso con Lara, persona meravigliosa; gli insegnamenti di Patanjali; la Terra; l’Essere umano; insomma un sacco di cose…
co, Alex, educatore e counselor, attraverso una serie di domande mi permise di capire la differenza tra amare e essere innamorati. Questa differenziazione mi permette oggi di riconoscere meglio, quando riesco a farlo, tanti condizionamenti e attaccamenti che prima non avrei saputo osservare.
Non sopporto: anche in questo caso un sacco di cose. Veramente tante. Però credo che quando mi ricentro praticando meditazione o yoga, nessuna di queste resti insopportabile, le stesse diventano anzi una chiave di discernimento. Se proprio devo sceglierne una, la presenza di calabroni.
La mia foto preferita: il tramonto sul Lemano dai monti sopra Montreux, spazi aperti, colori sgargianti, un riquadro di tutti gli elementi della natura nella sua bellezza
Motori ◆ La nuova Fiat 500e Abarth sarà lanciata in edizione limitata: 1949 saranno gli esemplari pensati per ricordare l’anno di nascita del marchio storico
Mario Alberto CucchiL’arrivo sul mercato della nuova Fiat 500e Abarth rappresenta una scommessa elettrizzante. Sono pronti gli appassionati di auto sportive a convertirsi ai veicoli a zero emissioni? La strada è tracciata già da tempo da costruttori come Porsche che ha già venduto l’elettrica Taycan in decine di migliaia di unità. Anche Ferrari e Lamborghini sono pronti alla conversione totale. Ma qui si parla di un altro tipo di utente finale.

Chi ha comprato sino a oggi la 500 Abarth equipaggiata con il motore a benzina da una parte ha senz’altro un potenziale di spesa differente, dall’altra non vuole passare inosservato e gli piace che il sound del motore arrivi prima ancora che si possa vedere l’auto. Proprio così. E infatti le 500 Abarth puntano da tempo su terminali di scarico caratterizzati da un cupo rombo. I clienti a volte investono soldi proprio per avere scarichi ancora più spinti e riconoscibili come gli Akrapovič. Insomma all’apparenza si tratta di una clientela a cui piacciono le auto sportive, rumorose e con prestazioni entusiasmanti.
La nuova 500e Abarth elettrica risponde a queste caratteristiche? In parte. Indubbiamente è caratterizzata da forme grintose e sportive, ma non è rumorosa per nulla. Anzi, si viaggia nel silenzio più assoluto con buona pa-

ce delle zone 30 km/h. Non è vero! Il sound è simile alle versioni a benzina anche se si tratta di una registrazione della 695 a benzina riprodotta all’esterno da alcuni altoparlanti. E le prestazioni? Insomma. Se sono anche migliori sull’accelerazione va detto che la velocità massima è autolimitata a 155 km/h. Ben oltre i limiti autostradali ma molto meno degli oltre 200 km/h delle versioni alimentate a benzina.
Come detto compensa almeno in parte lo scatto. Bastano sette secondi per raggiungere i cento all’ora. Impiega un secondo in meno da 20 a 40 km/h rispetto a una Abarth a benzina. Un secondo più veloce anche nell’accelerazione da 40 a 60 km/h e un secon-
do più veloce pure da 60 a 100 km/h. Persino le batterie sono veloci: si ricaricano alle colonnine rapide sino all’80% in soli 35 minuti.
L’autonomia dichiarata è di 250 chilometri. Insomma una «Scorpionissima» con la spina, la cui plancia in Alcantara si abbina agli inserti del volante sportivo a tre razze con lo scorpione al centro e ai sedili sportivi. Non mancano le minigonne laterali e i pedali sportivi in alluminio in cui ovviamente manca quello della frizione. Suona bene invece l’impianto audio premium studiato con JBL. Ma alla fine abbiamo a che fare con una vettura elettrica che sarà usata molto in città, ed ecco che allora diventa importate
l’avanzato sistema di sensori a 360 gradi drone view e la telecamera posteriore ad alta definizione che mostra le immagini su un display da 10,25”.
Anche il quadro strumenti è digitale ma più piccolo: sette pollici. Sotto il cofano si trova invece un motore elettrico a magneti permanenti che è in grado di erogare una potenza massima di 155 cavalli e una coppia massima di 235 newton metro. Tre le modalità di guida gestite dall’elettronica: Turismo, Scorpion Street e Scorpio Truck. Nella prima, l’accelerazione è più dolce e la potenza è inferiore (limitata a 136 cv). Tutti i cavalli vengono invece erogati nelle altre due modalità in cui tutto diventa più orientato alla sportività.
Grazie alla carta di credito Cumulus, senza tassa annuale.












Per vincere la scommessa,










































ingegneri
carta dell’esclusività: verrà prodotta inizialmente in soli 1949 esemplari che ricordano l’anno di nascita dello storico marchio. Disponibile solo in due colorazioni: verde acido e blu elettrico. Insomma una limited edition per lanciare la nuova 500e Abarth. Potrebbe essere proprio questo a trasformare un lancio in un successo in grado di portare le 500 elettriche a essere vendute tutte prima ancora di arrivare nelle concessionarie a inizio 2023.
Il prezzo? Un poco sopra i 40mila franchi svizzeri. Ne siamo convinti, un altro passo importante verso le emissioni zero è stato fatto.
Lo abbiamo visto bene anche quest’anno. Di fronte ai problemi di una civiltà sempre più in crisi ci si affretta a cercare soluzioni praticabili.

La gestione di queste urgenze mostra i limiti di una razionalità dal respiro corto, che si agita per proporre soluzioni pragmatiche, spesso parziali e ancor più spesso tra loro conflittuali. Sotto lo stress di un «che fare» sempre più impellente, spesso si naviga a vista. Certo, «che fare» è la domanda, ma questa domanda dovrebbe essere il punto di arrivo di altre domande che la renderebbero meglio pensabile in un mondo in cui tutto si tiene; domande che rimangono invece in ombra, sullo sfondo.
Ad esempio: perché siamo arrivati a questa situazione di crisi ambientale ed energetica? Perché tanto disorientamento nell’affrontare l’emergenza sanitaria? E perché ancora tante ingiustizie sociali, tante offese ai diritti umani, a tradire gli ideali della modernità? Domande come queste ci
portano a scavalcare il ragionare appiattito sui singoli problemi contingenti e ci invitano a interrogarci sul senso del nostro agire, ci invitano a chiederci in che direzione vogliamo andare per abitare meglio il mondo. Le conoscenze offerte nell’immenso mercato delle informazioni, nella loro polifonia disorientante, si rincorrono in tempo reale e parlano immediatamente al bisogno di un agire concreto. Per comprendere davvero abbiamo bisogno di scavalcare l’immediatezza dei dati raccontati in tempo reale; abbiamo bisogno di un’espansione del pensiero, di un’apertura della ragione al di là del mantra pragmatico che imprigiona l’esercizio della razionalità. È necessario andare oltre, e questo significa riconoscere e accogliere anche il valore cognitivo del sentire che è stato espunto e rimosso, come ben sappiamo, proprio da una ragione sempre più tecnologica. Eppure, quando ci interroghiamo sul
senso della realtà, dalle parole stesse emerge come proprio la capacità di sentire stia al cuore del bisogno di comprendere. Questo sentire ha a che fare con un’altra postura nel nostro modo di incontrare la realtà. Ha a che fare con uno sguardo altro nei confronti di ciò che si offre a noi, accogliente verso ciò che si rivela spontaneamente, al di fuori delle gabbie in cui lo rendiamo oggetto della nostra conoscenza razionale. Una realtà fatta di cose, non di oggetti da tenere a distanza. Perché le cose ci toccano e possono trasformarci, come ci ricorda uno dei messaggi più luminosi del filosofo Bruno Latour: una verità che purtroppo spesso trascuriamo. Guardare le cose che si rivelano a noi nel loro darsi spontaneo significa aprirsi a uno sguardo poetico sulla vita, un’occasione per esprimere in modo più fecondo la nostra umanità. Da poco abbiamo detto addio a Christian Bobin, scrittore poeticamente ispirato: «La poesia – diceva
Elon Musk annuncia al mondo che entro sei mesi sarà realtà l’impianto di un chip Neuralink nel cervello umano, quindi sarà più vicina la possibilità di interazione tra mente umana e mente digitale. Mentre l’utente medio di tecnologia sta ancora tentando a fatica di digerire e integrare, ad esempio, il concetto di Cloud e le sue applicazioni concrete nella vita quotidiana, Musk precorre senza alcuna remora i tempi, verso una integrazione del digitale nel biologico. La realtà è che sta proprio a noi, utenti passivi e oggettivamente obsoleti, di iniziare ad accelerare il passo, volenti o nolenti, prima di perdere il filo di quanto sta accadendo.
In una direzione informativa e di divulgazione si è mosso qualche settimana fa il TX Group Sa, una società «di intrattenimento, informazio-
ne, orientamento e assistenza» di cui fanno parte il gruppo editoriale Tamedia e «20minuti». Occorre osservare bene la dinamica aziendale: quello che per anni abbiamo considerato come colosso economico-editoriale, il Gruppo Tamedia, oggi è diventato soltanto il tassello di un’operazione di ampia portata, che mette in primo piano i suoi asset tecnologici, e soltanto in secondo piano quelli informativi. Il TX Group, quindi, ha promosso una «Conference» che si è tenuta sia in presenza sia sul web, dal titolo: Intelligenza artificiale e apprendimento delle macchine: il loro impatto sui media, sulla pubblicità, sull’intrattenimento, sui mercati digitali e le industrie fintech La giornata voleva proporre spunti di riflessione sul tema dell’intelligenza artificiale in vari settori economici e culturali. L’approccio era
«Il cellulare non prende», ripetono uno dopo l’altro le due 14enni, la 16enne e il 16enne, il 17enne, il 20enne e perfino i due 8enni. Sono le Parole dei figli, i nostri, arrivate in mezzo al mare della Grecia quando quest’estate con una coppia di amici abbiamo deciso di condividere le vacanze da famiglie allargate: tre, più due, più tre la somma aritmetica dei giovani dell’equipaggio. Quel che è successo dopo, in quella lunga e calda settimana di fine agosto, ve lo racconto oggi perché vorrei che ognuno magari ne traesse un po’ di ispirazione in vista delle vacanze di Natale. Ovviamente non per andare in mezzo al mare, ma per riprodurre una breve disconnessione dei cellulari in accordo con i propri figli anche solo per qualche ora, in una baita in montagna, ma anche a casa propria vicino all’albero di Natale illuminato
Otto in tutto, abbiamo detto, i giovani dell’equipaggio accompagnati da noi quattro adulti che siamo la mamma di Clotilde ed Enea, ma anche moglie del papà di Kim, Uma e Tao, il papà di Martina, Tommaso e Andrea, e la sua compagna. Chi ci ha visto partire non è riuscito ad astenersi da commenti del tipo: «Mi raccomando, almeno tre conte al giorno, che altrimenti qualche pupetto me lo lasciate in mezzo al mare!» oppure «Ma chi ve lo fa fare!». I problemi con cui ci potevamo imbattere sono stati sviscerati più volte durante le cene dedicate ai preparativi andate avanti fino a notte fonda: la convivenza da famiglie allargate in un ambiente ridotto per una settimana, i conti da fare con il portafoglio (nessuno di noi – è bene chiarirlo subito – naviga nell’oro, anche se ci consideriamo fortunati), i pranzi e le cene da prepa-
molto «americano», spettacolarizzato, quasi si trattasse di un evento che doveva servire a convincere degli investitori. E probabilmente lo era: il bersaglio eravamo noi partecipanti, attivi nel mondo dei media, dello studio e del commercio. A dispetto delle aspettative di chi scrive, la giornata non ha proposto contributi «tecnici» ma piuttosto genericamente informativi. È stato interessante notare come dai vari contributi dei relatori trasparisse una chiara volontà di vincere i dubbi attorno all’ntelligenza artificiale (IA). I vari professionisti del settore esprimevano un atteggiamento più da predicatori/ venditori che da tecnici. Non hanno spiegato come funziona, insomma, ma solo cosa può fare e perché vale la pena di usarla. E le osservazioni riguardo ai dubbi etici mossi contro l’IA sono state del tipo già sentito ri-
– entra nel mondo come in una casa amica, rivela le cose, le porta a rivelarsi, non le forza». Ci tiene lontani dal desiderio di possesso, di uso e di dominio del mondo. Lo sguardo poetico è contemplazione che provoca commozione verso ciò che riusciamo a vedere senza renderlo subito oggetto delle nostre spiegazioni razionali. «Il mondo è pieno di visioni che attendono degli occhi. Le presenze ci sono ma ciò che manca sono i nostri occhi».

Credo davvero che questa possibilità di abitare poeticamente il mondo sia una grande risorsa in grado di alimentare la conoscenza con una luce diversa, di renderla più autentica. Una porta di accesso a una più profonda comprensione di noi stessi e della realtà cui apparteniamo: un’esperienza in grado di trasformarci. Anche la filosofa spagnola Maria Zambrano parlava di sapienza dell’anima, di una forma di conoscenza più autentica, antecedente al sapere
razionale. Anche per lei, il sentimento poetico è quell’infinita disponibilità al mondo che offre al pensiero la capacità di sentire un’intimità originaria con le cose; un’intimità che riempie il logos di grazia e verità. Insomma, il bisogno di dare un senso al nostro agire ci invita ad avvicinarci alla realtà anche con uno sguardo poetico. Uno sguardo in cui dare voce al non saputo, al non detto, e a ciò che forse non sarà mai del tutto dicibile.
Uno sguardo che è accoglienza, attenzione alla bellezza, a volte fin troppo nascosta, tradita e maltrattata, ma che sempre ci chiama a riconoscerla e ad abitarla, prendendo un po’ le distanze dal bisogno di assoggettarla e di dominarla. Lasciarsi interpellare dalla bellezza è un progetto etico. Ce lo ricorda la saggezza antica: in greco, bellezza e chiamata hanno la stessa radice etimologica, mentre nei valori della polis il bello è sempre intrecciato al bene.
rare accontentando un po’ tutti i gusti, i due più piccoli costretti a dormire nella dinette per ottimizzare spazi e costi. La verità è che nessuno di noi adulti ha invece pensato a che cosa volesse dire per dei nativi digitali stare per sette giorni senza connessione: per chi è costretto per lavoro a stare sempre attaccato al cellulare, potersene liberare per qualche giorno è solo una benedizione! Non così per i giovani membri dell’equipaggio. Niente TikToK, stop ai vocali WhatsApp inviati a qualunque ora del giorno e della notte, e neanche il videogioco Brawl Stars che di solito tiene inchiodati per ore gli 8enni. In breve tempo «il cellulare non prende» diventa la frase ripetuta in modo quasi isterico e in coro dalla mandria di ragazzini che si accorgono di essere alle prese con il telefono senza campo. Ma solo all’inizio. Giorno dopo
spetto ai produttori di OGM: «Stiamo attenti, se non lo facciamo noi ci sarà comunque qualcun altro che lo farà, e noi rischiamo di rimanere indietro». Le critiche, insomma, sembravano già previste sin dall’inizio. Il susseguirsi degli interventi dal tono positivo ed entusiasta era in effetti messo in discussione dai commenti istantanei presenti nella «chat» offerta ai partecipanti online. Con gentilezza e affabilità vi si invitava a rivolgere domande «a distanza» ai relatori, ma, di fatto, molte delle domande e dei commenti erano chiaramente ostili. Era palpabile la sfiducia nei parametri di decisione dell’IA e della sua capacità di seguire dei percorsi etici, spiegabili, responsabili. «Come potremo sapere se l’IA saprà capire “il significato” delle sue scelte?» osservava qualcuno con acume filosofico. E proprio
dalle reazioni presenti nella chat ci è stato offerto un elemento interessante di riflessione. Uno degli interlocutori ha chiesto, senza avere risposta, se le raccomandazioni emesse dalla commissione europea sugli «Orientamenti etici per un’IA affidabile» sono prese in considerazione dai professionisti del settore. Nonostante la (prevedibile?) mancata risposta degli animatori della chat, a noi non resta che prendere nota del suggerimento. Il documento si trova qui: https://ec.europa.eu/futurium/ en/ai-alliance-consultation.1.html.
Non sarà molto, ma può essere un punto di riferimento autorevole, utile alle autorità che dovranno concentrarsi su questo settore, in cui si sta correndo molto velocemente e in cui non si sa bene se gli operatori siano interessati a comprendere le implicazioni connesse all’uso dell’IA.

giorno la disperazione si trasforma in opportunità. Ecco cosa succede. L’assenza della Rete riporta in vita le lunghe partite a Monopoli tra largo Augusto e vicolo Stretto: inizialmente sono i due piccoli a costringere con la loro insistenza i grandi a giocare; al terzo giorno c’è da non credere alle proprie orecchie quando sentiamo il 20enne e il 16enne chiamare a raccolta i due di 8 anni: «Venite a giocare?». Ci sono poi le gare di tuffi a testa con giuria che dà i voti e le baie esplorate con il materassino. Le nottate sono scandite da full d’assi e fiches colorate in sfide a poker che ancora un attimo e ci viene il dubbio di stare crescendo dei giocatori d’azzardo. La domanda insistente «Quando scendiamo a terra?» viene sostituita dalla richiesta «Possiamo mangiare in barca anche stasera?». Sembrano perfino azzerarsi le differenze d’età: quel
che conta è divertirsi insieme! Niente più occhi abbassati sui cellulari, la musica non è più quella ascoltata da ciascuno con le proprie cuffiette, ma quella della playlist della vacanza in cui ognuno ha scelto 5 canzoni. Felicità di Albano e Romina Power insieme a Molotov del rapper Lazza, Su di noi di Pupo insieme a Ballas RMX di Diss Gacha
Non tutto è sempre perfetto, la vita è più complessa di un racconto: per alcuni è la vacanza più bella di sempre, per altri una semplice esperienza. Non è mancato qualche screzio, ma che importa. In sette giorni senza cellulare la generazione nativa social prima si è sentita come il naufrago Robinson Crusoe, poi sembra essersi ritrovata in una magia. In cui la gioia diventa anche il pane fresco al mattino trovato dal panettiere dell’isola. Buon Natale!
IMPORTANTE:

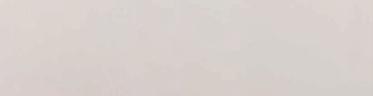



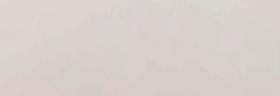







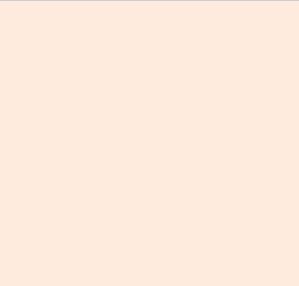

La bella olandese sconosciuta
Il paesaggio di Leiden è dominato dall’acqua e da innumerevoli ponti e canali che la rendono pittoresca
Pagina 19
Il cuore vichingo di Mainland
Un viaggio tra monoliti, menhir e saghe scozzesi sull’isola-madre dell’arcipelago delle Orkney
Pagina 21
Con nocciole e cannella Ricoperti parzialmente da glassa di cioccolato, sono tra i biscotti più classici e amati di sempre
Pagina 22
Un po’ come Clark Kent, che dopo aver smesso gli abiti civili si trasformava in Superman, anche Alessandro Veletta quando indossa la sua… divisa da battaglia (spesse volte un semplice costume da bagno) si trasforma in un’entità tutta diversa: il Cavaliere Delpho.
«Il Cavaliere Delpho è colui che tutto può, anzi è colui che non lascia nulla di intentato, fino alla fine (Usque ad finem), come recita il suo motto», tiene a precisare il 43enne di Tenero. Che, di imprese, ne ha già collezionate diverse. «Il mantra del Cavaliere Delpho è quello di provarci sempre e comunque: se hai un sogno, uscire dalla comfort zone e provare a realizzarlo è un tuo diritto, ma anche un dovere. Qui e ora, non domani o dopodomani. Vivere con i rimpianti non è vivere…».
Così, quasi a ridosso dei quarant’anni, eccolo salire la scalinata mozzafiato del Ritom, per la Stairways to Heaven, la gara di Vertical più ripida d’Europa. «Un’impresa nell’impresa visto che la mia stazza non era certo l’ideale per simili gare: ma ci sono riuscito». E non una volta. Perché, poi, quei 4261 gradini con dislivello 790 m (in soli 1,9 km di arrampicata da brivido) li ha scalati altre due, tre e quattro volte. «La scorsa edizione, la mia quinta, ho pure stabilito il primato personale: un’ora 4’ e 36”».
Il Cavaliere Delpho, però non è solo questo. È un vulcano di idee. E un vulcano, vero e proprio, l’ha visto da vicino a ottobre dell’anno scorso, l’Etna, quando ha indossato la sua divisa da battaglia prediletta (il costume da bagno) per tentare un’altra impresa: attraversare lo Stretto di Messina. E non nuotando a stile libero, cosa peraltro già realizzata da diversi altri prima di lui. No, Alessandro ha scelto di provarci nuotando a delfino. Ma prima di scoprire com’è andata l’ultima sfida saliamo uno a uno i… gradini della scala, stavolta metaforica, che l’hanno portato nel Mediterraneo.
«Fin da piccolo, adoravo stare nell’acqua. Poi, appunto, sono iniziate le sfide personali. Per dimostrare, a me stesso prima di tutto, di essere in grado di alzare di volta in volta l’asticella. Ho imparato tutto praticamente da autodidatta. Così, un’abbondante dozzina d’anni fa mi sono appassionato alle lunghe distanze: la 14 km del lago d’Orta, il gran fondo del Naviglio (che dapprima era una 18 km, poi diventata 21 e infine 24 km). Ho fatto anche il gran fondo sul Po, da Cremona a Castel Maggiore. Col favore delle correnti, di per sé è stata come una nuotata di soli 22-23 km, ma sulla
carta restano pur sempre 52 km: una bella soddisfazione!».
L’elenco delle sue imprese degne di nota non si esaurisce certo qui. Tra quelle che non si possono non citare c’è la sfida delle 24 ore consecutive di nuoto, fatta a scopo benefico per la raccolta fondi Ogni centesimo conta Storia del 2018: 47 i km nuotati nella vasca da 25 m del Lido di Locarno.
Dopo aver macinato chilometri e chilometri a stile libero, il Cavaliere Delpho si converte al delfino, indubbiamente lo stile più faticoso del nuoto. «Quando partecipavo alle ga-
re di gran fondo, le ultime bracciate ero solito farle a delfino. Mi piaceva… Così, un po’ per scherzo e un po’ per sfida, ho iniziato ad allenarmi in questo stile. Sotto l’occhio attento di Igor Nastic, il preparatore, ho coperto il mio primo chilometro, aggiungendone di volta in volta uno in più. Finché mi sono trovato a percorrere le grandi distanze anche in questa disciplina, cominciando col giro dell’isola di Gallinara: sono stato il primo a completare i 6 km a delfino».
Tutto fatto però, prima che con la forza delle braccia, con la testa: «È
Collezionare con leggerezza
Dalla raccolta di tazze a quella delle calamite da frigo, così Carola ha tenuto traccia dei suoi viaggi
Pagina 23
uno stile che sollecita parecchio la cuffia rotatoria delle spalle. A lungo andare rischia di creare problemi. Per questo, specie sulle lunghe distanze, occorre una specifica preparazione fisica. Cosa che ho fatto seguendo una dieta ketogenica, facendo CrossFit e andando regolarmente in palestra». Non sono mancate, ovviamente, le attenzioni degli specialisti del delfino, a cominciare da Noè Ponti, che si sono fatti opinioni ben precise in merito alle sue performance: «Mi è ovviamente già capitato di scambiare qualche parola con Noè. Tanto lui quanto gli altri mi dicono che sono pazzo a fare distanze simili; loro non le farebbero mai…».
Il campo-base per la conquista dello Stretto di Messina, Alessandro Veletta l’ha piazzato a Salò, sul Lago di Garda, «dove, in previsione della traversata dello Stretto, mi sono scaldato nuotando per 5 km in due ore e spiccioli».
Le prove generali le ha poi fatte alla traversata del Ceresio, da Caprino a Lugano. Andata e ritorno però: «Sono arrivato a Caprino un paio di minuti prima che prendesse il via la gara vera e propria, così il ritorno l’ho fatto in compagnia degli altri, sempre a delfino, lasciandomene alle spalle una buona quarantina prima di toccare riva!».
E
conti. Complice il dispendio di forze per la partenza a pieno regime, infatti, mi sono fatto trasportare troppo al largo dalla corrente, addirittura in prossimità della rotta delle navi che attraversano lo Stretto. A quel punto ero già in acqua da oltre due ore e avevo nuotato oltre 7 chilometri: aggiungerne altri due per completare l’attraversata era comunque troppo; lì le correnti non perdonano! È comunque stata una bellissima esperienza e, moralmente e virtualmente, la ritengo riuscita».

E ora? «Il mio sogno è quello di rievocare la storica fuga da Alcatraz: partire dal carcere al largo di San Francisco e raggiungere la baia, come avevano fatto un paio di intrepidi per evadere. Ma io, ovviamente, nuotando a delfino. Per realizzarlo, però, non bastano le mie forze: servirebbero gli sponsor. Più realisticamente, in progetto c’è una 22 km organizzata dalla Salvataggio Paradiso: mi piacerebbe parteciparvi, nuotando stavolta a stile libero, con l’intento di contribuire a modo mio alla raccolta di fondi per la neo costituita associazione benefica Il diritto di splendere ».


Reportage ◆ Una città troppo poco conosciuta, con un magnifico centro storico e un paesaggio davvero ammirevole; da non perdere lungo i canali il rigoglioso orto botanico e i due storici mulini superstiti
Tommaso Stiano, testo e fotografie

Posta a metà strada tra le più blasonate ed esuberanti Amsterdam e Rotterdam, la tranquilla città di Leiden, 124mila abitanti, è a soli venti minuti di treno dall’aeroporto di Schipol. Leiden è sorta sulle sponde di due grossi rami del Reno (Oude e Nieuwe Rijn) che si uniscono proprio nel centro storico dove troviamo le vestigia del Burcht, la fortezza risalente all’XI secolo. Simbolo sulla sua bandiera bianca e rossa sono due chiavi incrociate che ricordano la chiesa di San Pietro, un edificio tardogotico del XII secolo, oggi sconsacrato e trasformato in spazio multiuso.
Va da sé che l’acqua domina il paesaggio con i suoi innumerevoli canali e ponti che danno quel tocco pittoresco ammirato da tutti i visitatori. Particolarmente bello, il centro storico – il secondo più grande dopo Amsterdam – è contornato da un fossato di sei chilometri costruito a suo tempo come elemento strategico nella protezione della città assieme ai bastioni di cinta sui quali spiccavano i mulini a vento a fungere da sentinella. I punti d’interesse sono tutti dentro le mura e raggiungibili facilmente attraverso itinerari a piedi, o con una bici noleggiata se il tempo è propizio, partendo dalla avveniristica stazione centrale. E, se tenete ai vostri piedi, attenzione a non invadere le piste ciclabili onnipresenti e frequentatissime perché nei Paesi Bassi la due ruote è regina incontrastata.

Iniziamo dai due mulini. A Leiden ce n’erano parecchi di quelli a vento ed erano sparsi nelle campagne oltre le mura. Nel 1573 furono distrutti dagli abitanti della città per non lasciarli cadere in mano agli Spagnoli, otto furono poi ricostruiti in legno sui bastioni come risulta da una piantina del 1600. Con l’avvento del vapore e dell’elettricità, i mulini cessarono la loro utilità, per questo oggi nel profilo di Leiden ne spiccano solo due: il nuovo mulino a pilastro De Put (Il Pozzo) e il vecchio mulino a torre De Valk (Il Falco).
A cinque minuti dalla stazione, visitiamo dapprima il mulino-museo De Valk che nella forma attuale fu edificato nel 1743 in sostituzione di quello in legno del 1611. Nel XVIII secolo il De Valk aveva due proprietari con i relativi alloggi nel mulino. Malgrado l’elettrificazione di alcune
parti, la morte dell’ultimo mugnaio segnò il destino del De Valk che cessò l’attività nel 1965 e, acquisito dal comune, divenne sede museale unica dell’arte molitoria.
Disposto su otto piani, raggiunge i 29 metri di altezza e i 27 d’apertura delle pale. Al piano terreno si visita l’appartamento dell’ultimo mugnaio con i locali rimasti intatti; il primo piano, un tempo magazzino, è diventato una sala proiezioni per ripercorrere la storia degli impianti molitori
di Leiden; nei due livelli superiori si trova il museo con diversi oggetti legati alla secolare industria di macinazione. A 14 metri di altezza c’è il reparto confezione dei sacchi di farina e la terrazza dalla quale si gode il panorama sulla città; il quinto piano, quello più affascinante, ospita tre coppie di macine con i meccanismi di legno.
Il mulino De Put si trova a dieci minuti di marcia dalla stazione e assieme al ponte Rembrandt compone
Tipiche costruzioni nel centro cittadino di Leiden; sotto, la Moorsport, accesso occidentale al centro storico di Leiden.

diventa una grande fiera affollata di bancarelle e giostre con tanto di parata delle autorità a piedi, a cavallo e in carrozza davanti allo Stadhuis, il palazzo municipale. Attualmente l’Università di Leiden è uno dei più rinomati centri internazionali di ricerca con sette facoltà e ben 28mila studenti nelle diverse sedi sparse in città e a L’Aja. Visitiamo l’antica sede che si trova nel perimetro delle mura fortificate, a circa venti minuti dallo scalo ferroviario. Qui, molto bello e ampio è l’orto botanico il cui nucleo è nato per scopi scientifici nel 1587 e oggi, completato da una serra per le piante esotiche, è un’attrazione ben frequentata.
la cartolina dell’accesso cittadino di ponente. Si tratta di un impianto a pilastro, così chiamato perché qui gira tutto il corpo del mulino in cerca di buon vento e non solo il cappuccio come nel De Valk. Non è sempre aperto, noi lo visitiamo in piena attività, affascinati dai molteplici ingranaggi di legno lubrificati con il lardo che girano sotto i nostri occhi per sfornare farina buona. Dell’impianto originale risalente all’inizio del XVII secolo non restavano che le fondamenta sulle quali un gruppo di volontari negli anni Ottanta ha promosso la costruzione ex novo del De Put Abbandonati i mulini, ci dirigiamo verso l’Università di Leiden, tangibile segno di gratitudine verso la popolazione che aveva resistito a lungo all’assedio spagnolo nel XVI secolo, che il principe Guglielmo I d’Orange – capo dell’insurrezione e padre dei Paesi Bassi – regalò alla cittadina. Fondata ufficialmente nel 1575, è l’ateneo più antico d’Olanda e ancora oggi ogni anno funge da valido collaboratore nell’organizzazione della festa del 3 ottobre, giorno esatto in cui nel 1574 Leiden scacciò definitivamente gli invasori.

Per il Leiden Ontzet (la liberazione di Leida) tutto si ferma, gli studenti hanno vacanza e il centro storico
Non mancano poi musei e porte. Come ogni città che si rispetti, anche Leiden offre al visitatore degli spazi interni dedicati alla cultura; ebbene, a distanza ravvicinata, ci sono ben tredici musei tra grandi e piccoli. Un repertorio dell’arte olandese dal Cinquecento ai giorni nostri si trova al Museum De Lakenhal che venne fondato nel 1874 vicino al mulino De Valk; ha riaperto i battenti nel 2019 dopo un restauro del vecchio edificio e la costruzione di una nuova ala durati tre anni. Molto belli i trittici in entrata; oltre alla quadreria, il museo espone suppellettili, oggetti vari, sale tipiche delle dimore borghesi e macchinari legati all’industria tessile.
Affacciato sullo stesso canale dell’università visitiamo il Museo nazionale delle antichità, Rijksmuseum van Oudheden, spazioso e ben fornito di testimonianze a partire dagli Egizi, Greci e Romani fino alla nascita dei Paesi Bassi; di particolare pregio, visitiamo la collezione dei reperti egizi collocata tra le dieci più importanti al mondo.
Circolando a piedi o in bicicletta non passano inosservati i due accessi antichi al centro città, unici rimasti di otto che erano nel Medioevo: la Morspoort, ossia la Porta occidentale del 1669 e la Zijlpoort, la Porta orientale su cui campeggia lo stemma della città. Finisce qui il nostro giro di due giorni nella cittadina di Leiden, una Cenerentola a torto snobbata dalla moltitudine dei turisti.


Su www.azione.ch trovate una più ampia galleria fotografica.



























Reportage ◆ La più alta concentrazione di monumenti neolitici del Regno Unito è in Scozia, più precisamente sulle Isole Orkney (Orcadi)

 Enrico Martino, testo e foto
Enrico Martino, testo e foto
Nuvole color catrame si dissolvono in luci degne di William Turner, maestro indiscusso di atmosfere tempestose, ma la giovane coppia che scende dalla macchina è troppo impegnata in una diretta Facebook per accorgersene, mentre i due figli si rincorrono tra le Standing Stones di Stormness, i grandi monoliti di pietra che si alzano in riva a un loch sfiorato da un vento gelido. Insensibili a tablet e bambini, pecore e gabbiani si contendono l’erba in un paesaggio minimalista capace di mandare in scena le quattro stagioni in dieci minuti.
Le due star indiscusse sono Midhowe Broch, un forte intatto dell’Età del Ferro, e Midhowe Cairn la «Nave della Morte»
Su una collina lontana il grande cerchio di menhir del Ring of Brogdar incorona il cuore di Mainland, l’isola-madre dell’arcipelago delle Orkney. Un pugno di scogli e di terre separati dalla costa scozzese da sei miglia marine che le acque turbolente del Pentland Firth trasformano in un confine liquido tra due mondi. A sud c’è la Scozia gaelica dei tartan e dei clan ma qui i drakkar, le lunghe navi dei vichinghi, se ne sono andati solo nel 1469 lasciando un’eredità di toponimi norvegesi che punteggiano ogni roccia, ogni insenatura, e anche una saga, l’Orkneyinga popolata da personaggi sopra le righe come Thorfinn Torf-Einarsson conosciuto come Thorfinn Skull-splitter, il «fracassacrani» che ha persino battezzato una birra locale.

Sul molo dell’arcigno villaggio di pescatori di Stromness, dove l’unica strada ventosa è la spina dorsale di vicoli e case grigie raggrumate sul porto, un enorme vichingo dipinto sulla fiancata di un ferry indica l’orizzonte, perché questa non è la fine di un mondo, è la porta di entrata di un altro. Una terra di confine scandita dagli stacks, giganteschi monoliti che emergono dal mare, quello che resta di scogliere scolpite tempesta dopo tempesta da onde che hanno preso la rincorsa sull’altra sponda dell’Atlantico.
Quando il piccolo bimotore che collega Mainland al resto del mondo scivola tra nuvole che per pochi istanti rivelano tasselli di prati e un mare grigio ferro, ci si chiede perché gli uomini abbiano sentito l’irrefrenabile esigenza di spingersi quassù lasciando la più alta concentrazione di mo-
numenti neolitici del Regno Unito. Il segreto è una terra particolarmente fertile, «Siamo la più importante area di mungitura a nord di Sterling» dicono con orgoglio i farmers locali.
Le popolazioni neolitiche arrivarono sulle isole circa seimila anni or sono attraversando su fragili imbarcazioni il Pentland Firth e lasciarono tracce di una cultura sofisticata, capace secondo le più recenti scoperte archeologiche di influenzare persino siti come Stonehenge. Un Patrimonio UNESCO di complessi siti archeologici perfettamente integrati in un paesaggio teatrale, spiazzanti per chi è abituato alla classicità mediterranea o alla grandeur dell’Egitto dei Faraoni.
«Una simile ricchezza di materiali preistorici non esiste in tutta l’Europa settentrionale e nasce dalla mancanza di alberi che ha costretto gli abitanti a utilizzare solo la pietra» spiega l’archeologa Julie Gibson. «Questa architettura tridimensionale continua a raccontarci molti dettagli, come l’alto tasso di violenza che traspare dalle analisi delle ossa ritrovate nella Tomba delle Aquile», scoperta da un farmer abituato, come dicono degli Orkadians in Scozia, «a usare raramente una parola quando basta non dirne neanche una».
«Un giorno mio padre trovò alcuni utensili cerimoniali. All’inizio non capiva di cosa si trattasse, poi alla luce di una sigaretta scoprì una trentina di scheletri, ma mi ha raccontato di non essere stato particolarmente excited» ride Kathleen, figlia di Ronald Simison che in una sera d’estate del 1958 trovò tra le scogliere di South Ronaldsay questa tomba intatta che conteneva trecentoquaranta defunti, e le ossa di aquile di mare che le hanno dato il nome. Adesso le figlie mandano avanti il piccolo museo mentre lui guarda perplesso da una bacheca l’onorificenza ricevuta dalla regina Elisabetta.
Per arrivare nel cuore dell’«Egitto del Nord», l’isoletta di Rousay, bastano venti minuti di un piccolo traghetto da Mainland, «abbiamo la più alta concentrazione archeologica del Regno Unito, anche se forse dirlo è un po’ presuntuoso» concede Patrick Maguire, un irlandese trapiantato qui che mi aspetta al molo per accompagnarmi lungo il miglio del Westness Heritage Walk. Le due star indiscusse sono Midhowe Broch, un forte intatto dell’Età del Ferro aggrappato a una scogliera che sembra scivolare nel mare, e Midhowe Cairn la «Nave della Morte», un impressionante cimitero
collettivo neolitico che dall’alto sembra la carena di una nave di pietra.
L’«Egitto del Nord» si contende il ruolo di protagonista archeologico delle Orkney con la «Pompei del Nord» accucciata nell’erba di una grande duna che domina la falce di sabbia della Bay of Skaill. In uno dei punti più inospitali del pianeta Skara Brae, il villaggio neolitico più intatto dell’Europa settentrionale, precede di duemila anni le piramidi egiziane, ma fu scoperto solo nel 1850, quando una violenta tempesta spazzò via le dune svelando un mondo rigorosamente di pietra, letti e arredi inclusi, così irresistibili da avere ispirato il cartoon dei Flintstone e un videogioco.
Contemporaneo di Skara Brae è un imponente tumulo ricoperto d’erba, Maes Howe dal celtico Maes Hwyr «il campo della sera dopo il tramonto», il più raffinato monumento funebre neolitico europeo costruito intorno al 2750 a.C. Persino il nome è

perfetto per evocare il mistero nascosto alla fine di un angusto corridoio lungo dieci metri che il sole attraversa a ogni solstizio d’inverno per illuminare la camera centrale.
«Forse è un messaggio simbolico» ragiona Julie Gibson, «il sole illumina la casa dove sono rinchiusi i fantasmi degli antenati, oppure è un momento in cui le loro anime rivivono».
Ogni interpretazione è aperta perché all’interno non è stato trovato nulla, a parte la sterminata quantità di rune lasciata da graffitari vichinghi del dodicesimo secolo in cerca di tesori nascosti. Un’archeologia in progress di cui fa parte il Ness of Brogdar, un sito in corso di scavo che sta rivelando un sofisticato complesso cerimoniale neolitico.
Da queste parti la storia, di tracce, ne ha lasciate tante, dalla cattedrale di San Magnus a Kirkwall, il più raffinato edificio medioevale della Scozia settentrionale, alla molto più re-
cente e popolarissima Italian Chapel costruita dai prigionieri di guerra che lavoravano alle Churchill Barriers, le dighe che proteggevano la base di Scapa Flow dagli U-boot tedeschi. Un passato testimoniato dai relitti di tre corazzate e quattro incrociatori tedeschi autoaffondatisi alla fine della Prima guerra mondiale che fanno la gioia dei divers e contribuiscono alla pubblicità di una birra locale che «va giù più in fretta della flotta del Kaiser».
È difficile non cadere vittima dell’ispida bellezza di queste isole che ti mangiano l’anima, lo supplica persino un eroe dell’Orkneyinga, «Dopo avere girato il mondo con le mie lunghe navi… quello che sogno è tornare nelle mie fredde e grigie acque del mare delle Orcadi».
Su www.azione.ch, si trova una più ampia galleria fotografica.
●
Pasticceria dolce
Ingredienti per circa 50 pezzi
250 g di burro morbido
150 g di zucchero greggio semolato 1 presa di sale
1 uovo
150 g di nocciole
1 cc di cannella
350 g di farina farina per spianare la pasta
1 bustina di glassa per dolci chiara o scura per decorare
1. Mescolate bene il burro con lo zucchero e il sale. Incorporate l’uovo. Tritate le nocciole mediamente fini. Aggiungete la cannella, la farina e le nocciole. Formate l’impasto, avvolgetelo nella pellicola trasparente e mettetelo in frigo per circa 1 ora.
2. Spianate l’impasto su poca farina in una sfoglia di circa 4 mm. Con uno stampino ritagliate dei triangoli con i lati di circa 5 cm. Accomodateli su teglie foderate di carta da forno. Mettete in frigo per circa 30 minuti.
3. Scaldate il forno statico a 180 °C. Cuocete una teglia di biscotti dopo l’altra al centro del forno per circa 8 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare su una griglia.
4. Fate fondere la glassa al cioccolato seguendo le istruzioni sulla confezione, poi trasferitela in un recipiente profondo. Immergete i triangoli nel cioccolato fino a metà. Lasciate sgocciolare e consolidare il cioccolato su una griglia.


I triangoli si possono decorare anche con glassa di cioccolato bianco.


I biscotti possono essere immersi anche direttamente nella confezione. Bisogna semplicemente aprire di più la confezione.
Preparazione: circa 30 minuti; refrigerazione: circa 1 ora; cottura per teglia: circa 8 minuti.




Per persona: circa 2 g di proteine, 7 g di grassi, 10 g di carboidrati, 110 kcal/450 kJ.
I membri del club Migusto ricevono gratuitamente la nuova rivista di cucina della Migros pubblicata dieci volte l’anno. migusto.migros.ch





Rappresentano i luoghi visitati viaggiando: sono calamite, quindi sono tutte attaccate sull’unica superficie possibile: «Una calamita va vista, mica può essere riposta in un cassetto, e l’unico posto dove sta attaccata è la porta del frigorifero». A parlare è Carola che spiega quello che lei definisce rigorosamente un gioco piuttosto che una vera e propria mania di collezionismo, iniziato insieme alla figlia «quando ho comprato il frigo americano: grande, con dispensatore di ghiaccio. Quello di prima aveva la porticina coperta con il legno della cucina americana, come era d’uso, e non si potevano attaccare le calamite».
Barcellona, Parigi, Lisbona, Bruxelles, New York, e ancora la Grecia con Corfù, Creta, l’Italia per ora rappresentata da Gallipoli, il Portogallo: ve ne sono parecchie che però Carola non ritiene siano sufficienti per considerarle una vera collezione: «Per chiamarla davvero così penso si debbano ricercare dei pezzi in modo più assiduo. Per noi è un semplice gioco, niente di più». Le facciamo notare che, ad esempio, nella moda si dice: «Quando si sviluppa una collezione standard (in termini di dimensioni), solitamente si parla di almeno dodici capi o look. Tuttavia, ci possono essere collezioni più piccole o più grandi, a seconda di fattori come la stagiona-
lità, i tempi di consegna, il budget e via dicendo».
Come altri collezionisti che abbiamo avuto modo di conoscere, l’idea di essere definita tale proprio non le sorride, quasi temesse di entrare in una zona di compulsione. Condividiamo il punto di vista dello psicologo e psicoterapeuta Amleto Petrarca, sulla differenza fra collezionista e collezionista patologico: «Collezionare significa conservare oggetti che per noi hanno un valore, un significato e che portano a dare un piacere estetico e sensoriale». Si tratta perciò di un «buon passatempo che soddisfa pienamente coloro che vi sono dediti e migliora il loro benessere psicofisico». A volte però, afferma lo specialista, «collezionare rischia di diventare una patologia, un’ossessione che diventa difficile da estirpare quando si superano determinati limiti, si investono risorse economiche importanti, e l’hobby diventa sempre più costoso, spesso a discapito delle esigenze primarie».
Ribadiamo che queste calamite attaccate al frigo ci sembrano una vera collezione, seppur in fase iniziale dati i pochi pezzi. Dal canto suo, la nostra interlocutrice è ancora poco convinta e riflette ad alta voce: «Fossero solo due pezzi sarebbero un po’ pochini per essere chiamati collezione.
Anche se ne abbiamo qualcuna in più, le nostre calamite sono comunque un numero ancora poco apprezzabile per meritare davvero questa etichetta». Ma poi ci riflette: «Però è da un po’ di tempo che abbiamo inaugurato questa consuetudine di comprarne una che rappresenti ogni luogo che visitiamo: devo ammettere che quando abbiamo l’occasione di andare in giro ci pensiamo sempre e non dimentichiamo mai di entrare in uno di quei negozi di souvenir che ne vendono a iosa. Così coltiviamo quest’abitudine che forse sì, può essere il segno che sta davvero diventando una collezione. Ad esempio, mia figlia è andata a Bruxelles e mi ha portato una calamita, così, come un piccolo pensierino, tutto qui».
Scopriamo che tutto nasce proprio da quando la figlia era piccolina e ogni volta che vedeva dei negozi di souvenir chiedeva di comprare qualcosa: «Ai tempi, compravamo una tazza, ma a un certo punto abbiamo dovuto smettere perché mica si può riempire la casa di tazze! Ora a casa ne abbiamo a sufficienza, una diversa dall’altra e ciascuna acquistata in un posto che abbiamo visitato». Così, oggi sono passate alle calamite, ma non è finita: «Non ci stancheremo certo di viaggiare, ma quando saremo stufe di comprare calamite, magari ci

inventeremo qualcos’altro, chissà…». Intanto, racconta che non ve n’è una a cui è più affezionata di un’altra: «Anche perché ribadisco che non mi sento una vera collezionista così come questa non è una vera collezione: abbiamo smesso di riempire la casa di tazze, abbiamo continuato a comprare souvenir virando sulle calamite, ma si tratta di un gioco estemporaneo: in fondo, non vado a cercarle ma ne compro solo se vado in un posto dove non sono mai stata, oppure in un luogo particolare, o ancora se vado a fare qualcosa di significativo».
Non è certa che il primo pezzo sia quello di New York, ma il più bello è senza ombra di dubbio un gatto che viene dalla Grecia e quello a cui è più affezionata non lo sa definire, perché «non si ritiene una collezionista». Lo ribadisce all’inverosimile e non possiamo che prenderne atto, chiedendo
infine a chi lascerebbe un giorno questa sua «non collezione»: «E chi può dirlo? Ora posso solo fare una battuta: bisognerà capire se il giorno in cui mia figlia uscirà di casa porterà via con sé la sua parte di calamite o me la lascerà qui. Se deciderà di arredare il frigo della sua nuova casa con quelle che ha acquistato lei, la mia collezione potrebbe dimezzarsi».
Quindi, ora Carola ha una collezione di calamite rappresentanti luoghi visitati nel tempo, ma che «non è una collezione». È fatta di pochi pezzi che vanno a sostituire le tante tazze che li hanno preceduti, e un giorno si potrebbe addirittura dimezzare. «Giochiamo così finché ne avremo voglia; il giorno in cui ci stuferemo, basta!». Quest’ultimo pensiero ci ricorda che non bisogna mai prendersi troppo sul serio. Neppure collezionando.

Forse non tutti sanno qual è il nome scientifico della pigna e l’alloggio dove è situato il pinolo. Scoprilo risolvendo il cruciverba e leggendo nelle caselle evidenziate. (Frase: 8, 8)





















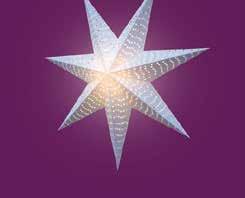

Al fronte o in fuga Mancano uomini in Russia e il mercato del lavoro sperimenta una forte carenza di manodopera
Pagina 27
Tra violenza e soprusi Un saggio di Caroline Elkins, che insegna ad Harvard, ripercorre la storia dell’impero britannico
Pagina 31
Un pianeta troppo affollato? L’umanità conta ormai otto miliardi di persone distribuite in modo irregolare sulla Terra
Pagina 33
 Lucio Caracciolo
Lucio Caracciolo
Il 2023 sarà probabilmente un anno di grandi migrazioni verso l’Europa. Concorrono verso questo scenario fattori diversi. Primo: la guerra in Ucraina continuerà ancora a lungo e provocherà nuovi flussi di persone in fuga verso la Polonia e di lì verso i Paesi dell’Europa centrale e occidentale. Intendiamo molti milioni di ucraini che non potendo abitare il loro Paese distrutto dai russi cercheranno sistemazione altrove. Sotto questo profilo alcuni Paesi europei hanno una capacità di accoglienza superiore per prossimità, vedi Polonia, o per quantità di popolazione ucraina da tempo residente, vedi Italia.
Secondo: le crisi e le guerre africane sono in via di intensificazione. La mobilità interna ed esterna al continente africano aumenta di anno in anno. In particolare va osservato il fronte dell’Africa settentrionale dalla costa mediterranea alle profondità saheliane. Il primo e più evidente punto di fragilità sta nella disintegrazione dello Stato libico. Al suo posto, milizie in permanente competizione armata,
turchi ormai incardinati a Tripoli e dintorni, russi (della Wagner) in Cirenaica. Non è concepibile restaurare una qualche forma di Stato libico unitario. L’Italia e altri Paesi europei hanno cercato di surrogare la mancanza di un potere centrale negoziando a suon di dollari (o euro) con i capi delle milizie e delle tribù locali. Ma i boss locali si affittano, non si vendono. Incassato, pongasi, un milione da Roma, si offrono a Parigi per due, e viceversa.
La mobilità interna ed esterna al continente africano aumenta di anno in anno, in particolare va osservato il fronte dell’Africa settentrionale
Peraltro nelle Libie si osserva solo la schiuma di questo tragico fenomeno. Le radici dei flussi sono molto più profonde e originano nel Sahel e anche nell’Asia centro-meridionale. Un’area di particolare fragilità geopolitica è il Corno d’Africa, anche se in
queste settimane qualche spiraglio di pacificazione in Etiopia si comincia a intravedere. Ma qui non sono tanto le guerre quanto le devastazioni ambientali e le crisi alimentari a determinare la fuga dai territori ancestrali.
Il caso più eclatante sotto il profilo ambientale è sul fronte occidentale dell’Africa, in particolare attorno a quello che una volta era il Lago Ciad. Un lago talmente profondo e vasto da parere un mare alle avanguardie dell’esercito romano che vi si spinsero più di duemila anni fa. Oggi è una pozzanghera. O poco più. Nulla da pescare, pochissimo per coltivare. Questo significa una crisi alimentare, ambientale e socioeconomica. Di cui profittano gruppi jihadisti, innalzanti la bandiera nera del profeta, che spadroneggiano in pseudo-Stati o Stati molto fragili come il Burkina Faso o lo stesso colosso nigeriano.
Che l’origine sia il Corno d’Africa o il Golfo di Guinea, le correnti migratorie che puntano verso il Mediterraneo tendono a convergere verso il Niger, lungo carovaniere e piste plu-
uno e madre due Che cosa scrivere nei documenti quando i bambini si trovano con due mamme o due papà?
Pagina 35
risecolari, punteggiate da pozzi e rare oasi. Il Niger, a suo tempo epicentro dell’impero francese d’Africa, ne è tutt’ora sua parte informale, oltre che un’area geopolitica di rilievo globale.
Che l’origine sia il Corno d’Africa o il Golfo di Guinea, le correnti migratorie che puntano al Mediterraneo tendono a convergere verso il Niger
Non fosse che per le sue enormi riserve di uranio che oltre ad alimentare le centrali nucleari francesi rappresentano il 60% di quel micidiale minerale bianco argento disponibile nel pianeta. Nel cuore del Niger, la città di Agadez è il crocevia delle rotte provenienti dall’Africa orientale, occidentale e meridionale. Di qui i passatori favoriscono a caro prezzo la traversata del deserto dei migranti diretti verso le coste libiche. E dalla «quarta sponda» comincia l’avventura verso l’Europa, di cui l’Italia è pontile affacciato sul Mediter-
raneo, quasi a toccare le coste africane.
Siamo pronti ad affrontare questa emergenza senza isterismi e senza negligenze? Probabilmente no. L’impatto dei migranti su un continente che sta subendo le conseguenze non solo economiche ma soprattutto psicologiche e culturali della guerra in Ucraina sarà molto più incisivo di quanto accadde negli anni passati. Soprattutto conseguenza generale del conflitto ucraino è la tendenza a perdere di vista gli interessi comuni e a mettere l’accento sui propri. Anche contro gli interessi e le intenzioni dei vicini. Sotto questo profilo l’Italia è uno Stato decisivo, perché dal punto di vista dei Paesi situati oltre le Alpi deve assorbire la maggior parte dei migranti. Ciò che non avviene, come sanno bene ad esempio gli svizzeri, che non brillano per controllo delle proprie frontiere con l’Italia, né tantomeno con la Germania. Si parla spesso di una politica migratoria europea. Ma senza coinvolgere Berna e i Cantoni di frontiera questa chiacchiera, già abbastanza vuota, è insensata.








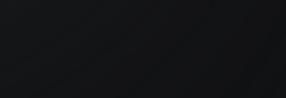













 Anna Zafesova
Anna Zafesova
Sono usciti semplicemente sfondando il cancello, a passo di marcia, già vestiti in mimetica e anfibi: il video dei mobilitati che hanno abbandonato il poligono di addestramento di Kazan ha fatto il giro della Rete russa, diventando lo spot di quelle microrivolte che sono in corso in tutto il Paese. In numerose caserme – da Belgorod al confine ucraino, a Ulan-Ude nella Siberia profonda – sono decine le proteste dei «mobiki», gli uomini russi mobilitati sul fronte per ordine di Vladimir Putin. A Rostov una delle reclute è fuggita dalla caserma minacciando di sparare ai suoi inseguitori. A Serpukhov, vicino a Mosca, i coscritti si sono ribellati dopo aver scoperto che la dispensa della caserma era piena di provviste mentre loro ricevevano un solo pasto al giorno.

I mobilitati dalla Yakutia hanno diffuso un video in cui si vedeva che dormivano sul pavimento di una caserma non riscaldata, nel Tatarstan è scoppiata una protesta delle mogli dei neo soldati, che venivano armati con Kalashnikov arrugginiti e vestiti con uniformi logore e totalmente inadatte all’inverno. In Chuvashia le autorità sono state costrette a rilasciare i riservisti dalle caserme per non rischiare una rivolta armata. A Elan, in un centro di addestramento, si sono verificate diverse morti di neomobilitati, e le famiglie sostengono che sui loro corpi erano visibili segni di percosse, nonostante le cause di morte ufficiali parlano di malattie improvvise o di intossicazione alcolica. Ma la protesta più spettacolare è stata appunto quella di Kazan, dove i mobilitati, infuriati dal rifiuto del comando di concedere loro una libera uscita per salutare le famiglie prima di partire per il fronte, hanno semplicemente sfondato i cancelli della caserma per uscire e non tornare più.


L’incubo del Cremlino ora è proprio questo: lo scontento non più di dissidenti isolati, ma di gruppi di militari armati. I «mobiki» sono in maggioranza sostenitori del regime putiniano, o comunque lontani

da movimenti di protesta. Gli altri, i seguaci dell’opposizione, hanno in buona parte lasciato la Russia già all’inizio dell’invasione dell’Ucraina, oppure alla fine di settembre, quando Putin ha proclamato la chiamata alle armi. Secondo i dati dei Paesi che hanno accolto questo grande esodo – Georgia, Kazakistan, Armenia, Turchia, Finlandia – si parla di almeno un milione di cittadini russi che hanno preferito scappare piuttosto che correre il rischio di finire in trincea nel Donbass. Non è casuale che il presidente russo e i suoi collaboratori abbiano a più riprese sottolineato che la mobilitazione sarebbe stata soltanto «parziale» e che non ci sarebbe stata una seconda ondata di coscrizione dopo il reclutamento di 300 mila riservisti. L’obiettivo è far tornare chi è partito (o si è imboscato in patria, magari in campagna) e tranquillizzare chi si stava preparando alla fuga. Indiscrezioni raccolte dal giorna-


le d’opposizione in esilio «Meduza» parlano di un’imminente nuova chiamata alle armi, anche perché il tasso di mortalità tra i «mobiki», scaraventati al fronte spesso dopo pochi giorni di addestramento, è elevatissimo, e stime del ministero della Difesa parlerebbero di 100 mila reclute uccise o gravemente ferite entro la primavera.
Lo scorso luglio solo il 32 per cento dei russi era favorevole a passare a un negoziato di pace, ora chiesto dal 55 per cento degli interrogati


Una prospettiva che spiega bene il motivo per il quale i numeri dei sondaggi si sono ribaltati in tre mesi: a luglio solo il 32% dei russi era favorevole a passare a un negoziato di pace, ora richiesto dal 55% degli interrogati, mentre i sostenitori della prosecuzio-
ne della guerra sono crollati dal 57% al 25%. I dati sarebbero stati raccolti, sempre secondo «Meduza», da un sondaggio riservato del Cremlino, e quindi si può ipotizzare che la situazione reale sia ancora più sfavorevole a Putin. La mobilitazione ha rotto quel patto che aveva stretto con il suo elettorato, al quale aveva promesso benessere, sicurezza paternalista e orgoglio nazionale. Il benessere è ormai un lontano ricordo e la prospettiva di dover combattere per l’orgoglio nazionale rischiando in prima persona ha reso la guerra in Ucraina la prima a non aver fatto crescere i consensi del leader russo.





Una delusione che non significa necessariamente il rifiuto delle ragioni della guerra: molti «mobiki» contestano più le modalità in cui si trovano costretti a combattere che i motivi dell’invasione dell’Ucraina. Il sociologo Grigory Yudin non vede per ora il potenziale di una rivolta, la società




















russa è «apatica», ma non esclude che la situazione economica e sociale potrebbe invece spingere i russi ad agire. Anche perché la mobilitazione ha dato un colpo durissimo a un’economia già in difficoltà. Tra i maschi che sono emigrati (spesso insieme alle famiglie) e quelli finiti in trincea, il mercato del lavoro russo sta sperimentando una carenza di manodopera senza precedenti negli ultimi trent’anni, come segnalato dall’Istituto di politica economica. Interi settori, come quello minerario o agricolo, sono rimasti senza braccia, dopo le retate dei militari a caccia di coscritti nelle fabbriche e nei villaggi. Alcune compagnie aeree stanno cancellando voli per mancanza di piloti, e le palestre hanno registrato un crollo del 30% della clientela, anche perché mancano gli allenatori.
Il sociologo Grigory Yudin non vede per ora il potenziale di una vera rivolta, la società russa è «apatica», ma non esclude un futuro diverso



Ma il danno più grave si registra nei settori che impiegano manodopera qualificata: a fuggire dalla Russia sono stati ovviamente i più benestanti e istruiti, i più globalizzati e moderni, come gli informatici. Il settore tecnologico è talmente alle corde che il Governo russo sta discutendo un’esenzione dei suoi dipendenti dalla mobilitazione. Difficile però che possa far tornare la fiducia: i 300 mila neomobilitati raccontano alle famiglie e ai social storie di abuso e abbandono da parte dei comandanti, di fame e freddo, di indennizzi non pagati e di bugie dei superiori. Ed è sintomatico che Vladimir Putin abbia scelto di incontrare come «madri dei soldati» soltanto funzionarie e attiviste del suo partito, invece di rischiare un faccia a faccia con le donne che da mesi non riescono ad avere notizie dei loro figli uccisi o catturati in Ucraina.














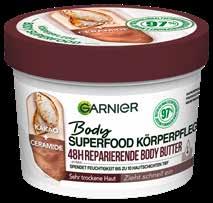



Trattamenti per il corpo tanto naturali quanto efficaci. Scopri la cura per il corpo di nuova generazione! Certificati di ORIGINE NATURALE al 96%, CON FORMULA VEGANA*. IDRATAZIONE
FINO A 48 ORE**. La nuova gamma di prodotti combina la forza dei superfood e l’efficacia dei principi attivi naturali per nutrire e rigenerare a fondo la pelle.

Trattamento lenitivo per pelli da normali a secche L’estratto di aloe vera è noto e apprezzato da tempo per le sue proprietà idratanti, lenitive, protettive e rinfrescanti. Il magnesio PCA ha proprietà calmanti e, in più, aiuta a remineralizzare la pelle, la rivitalizza e ne rafforza la barriera protettiva.
Trattamento idratante per pelli disidratate
L’estratto di anguria alla base del prodotto viene ottenuto attraverso un processo di frantumazio-
ne più rispettoso dell’ambiente e mescolato a glicerina. Grazie alla sua peculiare capacità di legare l’acqua in percentuale pari a 1000 volte il proprio peso, l’acido ialuronico idrata a fondo la pelle, rassodandola e restituendole elasticità e luminosità.
Trattamento nutriente per pelli da secche a molto secche

L’olio di avocado aiuta a mantenere la cute elastica e idratata. Il principio attivo omega 6 è noto per la sua capacità di rafforzare la barriera protettiva della pelle.
Trattamento riparatore per pelli molto secche
Il burro di cacao va a reintegrare gli acidi grassi, preziosi componenti naturali della barriera cutanea che provvedono a mantenere la pelle liscia, compatta ed elastica. Anche le ceramidi sono lipidi presenti per natura nella pelle e, in qualità di additivo naturale, esercitano un effetto rigenerante sulla cute.





In Svizzera, una buona parte della popolazione soffre di disturbi del sonno. Sono molti i medicinali che promettono una soluzione, ma è importante scegliere quello giusto. Per contrastare il problema sul lungo periodo, infatti, le persone affette da disturbi del sonno devono affidarsi a un farmaco adatto e ben tollerato. A tale scopo, sono disponibili in commercio farmaci a base di sostanze vegetali come Baldriparan – Per la notte. E questo è solo uno dei motivi per cui già diverse persone in farmacia chiedono di Baldriparan, disponibile senza ricetta.

Da lungo tempo, ai farmaci fitoterapeutici a base di valeriana è stato
attribuito un effetto positivo contro i disturbi del sonno. In simili medicinali è la quantità di questo principio attivo a fare la differenza. Baldriparan contiene un pregiato estratto di radice di valeriana, il cui supporto in caso di disturbi del sonno è stato comprovato. Questo estratto favorisce inoltre il sonno.








Un riposo rigenerante è alla base di buone capacità fisiche e mentali. Chi dorme bene, il giorno dopo si sente più in forma e riposato. Per raggiungere questa condizione è necessario che la fase di sonno profondo sia lunga a sufficienza. La par


ticolarità di Baldriparan consiste nel mantenere il ciclo naturale del sonno e nel preservare la fase di sonno profondo. In questo modo, questo farmaco a base di sostanze vegetali permette di iniziare la giornata ben riposati. Un altro consiglio: la calma e il rilassamento aiutano il tuo corpo a prepararsi al sonno.

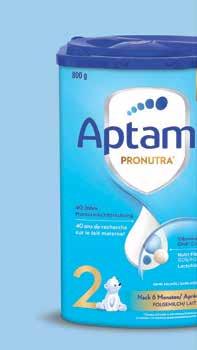


il Commonwealth, contrastandone le spinte centrifughe





 Pietro Veronese
Pietro Veronese
La morte della regina Elisabetta, lo scorso settembre, è stata commentata con accenti molto diversi nella madrepatria e nelle ex colonie di quello che fu, fino alla metà del secolo scorso, il più grande impero che il mondo abbia mai conosciuto. Unanime il cordoglio per la persona della sovrana scomparsa; ma mentre nel Regno Unito la straordinaria partecipazione popolare al lutto è stata considerata un chiaro segno della vitalità della monarchia, molto diversi sono stati gli accenti nei Paesi dove, malgrado la distanza geografica e culturale, l’inglese resta la principale lingua parlata, e anche in quelli per i quali chi siede sul trono di Londra è ancora formalmente il capo dello Stato. A cominciare dall’Australia – dove i governanti hanno fatto velate allusioni alla possibilità che le cose possano cambiare in un futuro non troppo lontano – i legami con la Corona britannica si avviano verso una fase di ripensamento dall’esito incerto. Molti commentatori hanno segnalato che tra i compiti prioritari del nuovo re Carlo III ci sarà quello di mantenere in vita il Commonwealth, l’organizzazione che riunisce 56 Stati appartenuti in passato (con quattro eccezioni) all’Impero, contrastandone le spinte centrifughe.
Difficili da leggere sono le descrizioni delle torture inflitte ai ribelli che osavano sollevarsi contro l’Union Jack e i suoi agenti coloniali

Gli ultimi viaggi ufficiali di membri della famiglia reale in Paesi del Commonwealth non sono filati molto lisci. In particolare quello di William – all’epoca duca di Cambridge, oggi principe di Galles, cioè primo erede al trono – e di sua moglie Kate nei Caraibi, la scorsa primavera. La visita è stata segnata da proteste e manifestazioni. In Giamaica, in particolare, cento accademici, politici e persone




di cultura hanno colto l’opportunità per chiedere ai reali scuse e riparazioni per il passato coloniale e schiavistico. Voci analoghe si levano adesso in Kenya e altrove. La fine dell’Impero britannico viene fatta coincidere formalmente con la consegna di Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese, nel 1997. Ma è come se la straordinaria longevità di Elisabetta II e la conseguente eccezionale durata del suo regno avessero ritardato di quasi un quarto di secolo il tempo dei bilanci. Che adesso sembra arrivato.
Come un sasso in questo enorme stagno del lascito coloniale britannico, così esteso nel tempo e nello spazio, viene a piombare un libro uscito quest’anno, con perfetto tempismo, negli Stati Uniti. Il volume, di quasi 900 pagine, s’intitola Legacy of Violence. A History of the British Empire (Retaggio di violenza. Una storia dell’Impero britannico). La sua autrice, la storica Caroline Elkins, insegnante a Harvard, è una studiosa molto stimata da quando, nel 2005, uscì il suo Britain’s Gulag, una ricostruzione altrettanto ponderosa della repressione della rivolta dei Mau Mau, che negli anni Cinquanta del secolo scorso segnò l’inizio della fine del dominio britannico in Kenya. Proprio da quelle ricerche Caroline Elkins ha proseguito il suo lavoro, arrivando diciassette anni dopo a un’opera di molto maggiori respiro e ambizione, uno sguardo complessivo sull’operato imperiale della Gran Bretagna.
La conclusione di questa colossale impresa storiografica è enunciata senza ambiguità nel titolo: quel che resta dell’impero è una lunga scia di sopraffazione e di violenza, una signoria imposta a intere nazioni senz’altro argomento che la forza delle armi, la repressione poliziesca, carcere e sevizie contro chiunque tentasse di opporsi al dominio del più forte. Brutalità, dalla Palestina al Kenya, dalla Malesia a Cipro. Particolarmente difficili da leggere, in proposito, sono le ricorrenti descrizioni delle torture inflitte ai ribelli che osavano

sollevarsi contro l’Union Jack e i suoi agenti coloniali, descrizioni talvolta basate sulle testimonianze degli aguzzini. Si va dalle umiliazioni alle sevizie, alla morte provocata nelle maniere più orrende. In altre pagine si raccontano le operazioni militari contro la popolazione civile. «Procedevamo sistematicamente, di villaggio in villaggio, distruggendo le case, riempiendo i pozzi, abbattendo le torri, tagliando gli alberi, bruciando i raccolti, sfondando i serbatoi […] In capo a quindici giorni la valle era un deserto e l’onore era appagato». Così Winston Churchill descriveva la campagna nel Punjab indiano, nel 1897.
Un’opera della portata di Legacy of Violence non si esaurisce in questa dimensione, anche se essa è certamente dominante. Elkins è ugualmente attenta alle decisioni politiche prese
da un’assai lunga serie di governi britannici, e alle implicazioni economiche e geopolitiche dell’impresa imperiale. Ma l’impressione prepotente che si prova sfogliando le centinaia di pagine del libro è quella di un rovesciamento probabilmente irreversibile della narrativa. Nessuno ha mai preteso che la scelta imperiale coloniale fosse libera da una dimensione repressiva, o non poggiasse sull’insostenibile squilibrio dei rapporti di forza militari. Questo tuttavia si ammantava dell’ideologia della missione civilizzatrice, dell’emancipazione dei popoli soggetti, della benevola elargizione di sapere, educazione, sviluppo, ricchezza. Legacy of Violence ribalta il racconto. L’impero coloniale, ci dice, è stato in primo luogo sopruso, oppressione, sfruttamento, prepotenza armata.
Anche questa non è una novità.
Nella recensione scritta per il settimanale «The Nation», l’africanista Howard W. French ricostruisce le battaglie della storiografia angloamericana sul colonialismo, i lunghi decenni di negazionismo, le prime revisioni critiche degli anni Sessanta, le successive rivalutazioni del passato imperiale, fino alla nuova generazione di storici che a quel passato non fanno sconti. Il contributo di Caroline Elkins, con autorevolezza, fa ora pendere la bilancia nettamente da questa parte. Il suo libro del 2005 è servito da base all’azione legale intentata con successo contro il Governo britannico dai sopravvissuti dei campi d’internamento in cui furono rinchiusi i ribelli Mau Mau. Questa nuova opera spingerà forse i governanti del Commonwealth a spezzare l’ultimo legame con l’eredità dell’impero.
























 Alfredo Venturi
Alfredo Venturi
Non c’è dubbio, questo pianeta comincia ad andarci stretto. Poiché le terre emerse misurano 149 milioni di chilometri quadrati, il 29 per cento della superficie del globo, il fatto che l’umanità conti ormai otto miliardi di persone significa che abbiamo mediamente a disposizione un chilometro quadrato per ogni 54 abitanti. Una densità che sembrerebbe accettabile, se non fosse per due dettagli: da un lato buona parte della Terra aritmeticamente disponibile è più o meno se non del tutto inospitale (deserti, montagne, foreste pluviali). Inoltre la popolazione è distribuita in modo tutt’altro che regolare: si va da aree completamente spopolate a certe massicce concentrazioni urbane, ad esempio le formicolanti megalopoli asiatiche. Come tutte le medie, anche quella dei 54 abitanti per chilometro quadrato è un dato matematicamente ineccepibile ma praticamente ingannevole. Per esempio il Bangladesh, il più popoloso fra i grandi Paesi del mondo, deve fare i conti con una densità ventidue volte più alta: oltre milleduecento abitanti per chilometro quadrato.
La Terra abitabile non solo è relativamente poca, ma è anche impoverita dall’uso dissennato che ne facciamo riducendone le capacità vitali






La verità è che la Terra abitabile, «l’aiuola che ci fa tanto feroci», non soltanto è relativamente poca, ma è anche impoverita dall’uso dissennato che ne facciamo riducendone le capacità vitali. Fra l’altro il boom demografico ha conosciuto negli ultimi decenni un’impetuosa accelerazione. Per aggiungere al dato complessivo l’ultimo miliardo di esseri umani sono bastati undici anni: infatti nel 2011 eravamo «solo» sette miliardi. Ma fino a quando il dato continuerà ad aumentare? Qualche tempo fa si temeva che questa tendenza fosse destinata a sopraffare prima o poi ogni possibilità di sostentamento. Secondo le valutazioni più recenti l’aumento è invece destinato a culminare in un picco, oltre il quale comincerà una fase calante. Gli esperti delle Nazioni Unite ritengono che negli anni Ottanta di questo secolo sarà superata la soglia dei dieci miliardi e che a questo punto l’umanità smetterà di crescere e anzi avvierà una lenta parabola discendente.
In confronto al vertiginoso aumento registrato nel ventesimo secolo e nei primi decenni del ventunesimo, i due miliardi supplementari dei prossimi sessant’anni corrispondono dunque a un drastico ridimensionamento del fenomeno. Nel 2020 per la prima volta da decenni l’aumento annuale della popolazione mondiale si è mantenuto al di sotto dell’un per cento. Siamo comunque di fronte a valori ben superiori a quelli dei secoli passati. Infatti eravamo non più di un centinaio di milioni ai tempi dell’impero romano, mentre a metà del Trecento gli europei decimati dalla peste nera si ridussero in una manciata di anni da 450 a 350 milioni. Quattro secoli più tardi, con la rivoluzione industriale, le migliori condizioni di vita provocarono un deciso aumento della vita media e un parallelo aumento della natalità. In
soli due secoli la popolazione mondiale raddoppiò, ma si dovette aspettare metà Ottocento perché superasse la fatidica soglia del miliardo di esseri umani.

Poi la crescita si fece vertiginosa: oltre un miliardo e mezzo nel 1900, due miliardi nel 1940, sei nel 2000, fino ad arrivare agli otto miliardi di oggi. Nel secolo scorso l’impetuosa accelerazione portò alcuni Paesi a tentare con misure d’intervento sociale e con il ricorso alla contraccezione l’abbassamento del tasso di natalità. Ma poiché nel frattempo il fenomeno aveva conosciuto una netta divaricazione, da una parte la bomba demografica in quello che allora si chiamava Terzo mondo, dall’altra la denatalità nell’Occidente industrializzato, in alcuni Paesi europei si cercò e si cerca, al contrario, di incoraggiare le nascite con politiche di tutela sociale e di sostegno economico. Nonostante questi interventi alle lunghe, prevedono le stime delle Nazioni Unite, la tendenza globale sarà invertita.
Vivono in «Cindia» attualmente poco più di 2,8 miliardi di persone quasi equamente divise fra i due Paesi, con una leggera prevalenza della Repubblica Popolare
Di particolare interesse l’andamento demografico nei due Paesi, Cina e India, che da soli ospitano un terzo degli abitanti della Terra. Vivono in «Cindia» attualmente poco più di 2,8 miliardi di persone quasi equamente divise fra i due Paesi, con una leggera prevalenza della Repubblica Popolare Cinese, che resta sovrappopolata nonostante i lunghi anni della cosiddetta politica del figlio unico. Ma, secondo le proiezioni, entro la fine dell’anno prossimo la Cina cederà all’India il primato di Paese più popoloso del mondo, mentre a metà di questo secolo gli indiani saranno 1,7 miliardi e i cinesi si ridurranno a 1,3. Nonostante il ridimensionamento della popolazione nella Repubblica Popolare, i due Paesi asiatici con-

tinueranno dunque a contenere un terzo dell’umanità.
La forte densità demografica e i problemi che pone, a cominciare dal
secondo le quali certi «poteri forti» intenderebbero ridurre drasticamente gli abitanti della Terra. Puntando sul controllo delle nascite? Ma no, avvalendosi di tecniche che vanno dalla creazione di pandemie, come quella recente del coronavirus, fino alla diffusione su larga scala di sostanze tossiche e farmaci letali. A parte queste divagazioni, la conseguenza più ovvia della sovrappopolazione, o per meglio dire della sua distribuzione squilibrata fra le varie parti del mondo, è sotto gli occhi di tutti. Si tratta del fenomeno migratorio, della propensione di milioni di esseri umani oppressi da nere prospettive di vita a trasferirsi verso aree che a torto o a ragione considerano più tranquille e vivibili.







Proprio su questo aspetto la comunità internazionale è chiamata una buona volta a orientare le sue scelte, liberandosi dai vincoli imposti da quel reticolato di frontiere chiuse che la rendono prigioniera di vecchi schemi isolazionisti e nazionalistici. Si tratta di ripristinare l’equilibrio, così spesso alterato, fra pressione demografica e disponibilità alimentari. Ma andrebbe soddisfatta in primo luogo una condizione necessaria anche se non sufficiente: quella pace universale che si sogna da secoli e che ancora oggi è confinata oltre l’orizzonte spaziale e temporale.


















Italia ◆ Una questione burocratica legata alla definizione di due genitori gay nei documenti d’identità diventa battaglia politica
Alfio CarusoC’è una bambina romana, nata con la fecondazione artificiale, che ha due mamme, quella legale e quella adottiva, tuttavia sul suo documento d’identità l’anagrafe pretendeva di scrivere che avesse una madre e un padre. E in un eccesso di generosità lasciava alle signore la scelta su chi delle due dovesse cambiare genere, almeno sulla carta. Un’enormità perfino per un Paese abituato agli eccessi e alle stramberie di una burocrazia sempre cieca e spesso dannosa. A quel punto, con il sostegno della Rete Lenford –avvocati, professionisti, studiosi della questione LGBTI – è partito il ricorso al tribunale civile. Il giudice Francesco Crisafulli ha accolto l’istanza delle due mamme. Un’ordinanza di venti pagine per dettagliare la sua decisione, con un fondamento: il provvedimento voleva restituire «un senso alle parole». Quindi «la dicitura che dovrà comparire sulla carta di identità della bambina dovrà essere neutra: genitore, anziché padre e madre». Il giudice ha spiegato fino in fondo la sua decisione: «Un documento indicante una delle due donne come “padre” contiene una rappresentazione alterata e perciò falsa della realtà», di conseguenza – a suo dire – i funzionari dell’anagrafe erano stati costretti ad un falso in atto pubblico mettendo sulla carta d’identità la dicitura «padre». Nel passaporto appena rilasciato la bimba ha ufficialmente due madri e nessun padre.
Nel 2019 Matteo Salvini aveva imposto alle coppie omosessuali di identificarsi come «padre» e «madre», alla faccia del buonsenso e dei diritti
Benché la sentenza valga soltanto per il caso esaminato, le conseguenze pubbliche sono state inevitabili e in Italia hanno già creato un nuovo casus belli tra i difensori delle tradizioni, arroccati intorno al segretario della Lega e ministro Matteo Salvini, e quanti non vogliono chiudere gli occhi dinanzi all’evoluzione della società. Il Governo Meloni ha promesso massima attenzione, però pare soprattutto preoccupato dai problemi tecnici, cioè dalla modifica del sistema anagrafico vigente con il rischio di mandare in tilt l’intera macchina d’identificazione personale. Ma non è una pura questione burocratica, viceversa riguarda direttamente le famiglie omogenitoriali, quelle che vengono chiamate famiglie arcobaleno. Il problema insorge quando i bambini si trovano con due mamme o due papà: che cosa scrivere nei documenti?
Secondo inveterato costume, Matteo Salvini si è affidato alla mozione degli affetti, con lacrimuccia incorporata, che a lui solitamente si ritorce contro: «Illegali o discriminanti le parole mamma e papà? Le
parole più belle del mondo, ma secondo il Tribunale civile di Roma sarebbe una violazione delle norme comunitarie e internazionali. Non ho parole, ma davvero». Al contrario, ne ha a bizzeffe per difendere il decreto emesso il 31 gennaio 2019 da ministro dell’Interno, quando aveva imposto alle coppie omosessuali di identificarsi come «padre» e «madre», alla faccia del buonsenso e dei diritti elementari. Un decreto volu-

to, nonostante i pareri opposti del garante della privacy e dei Comuni. E che all’epoca era stato votato anche dal M5S alleato nel Governo presieduto dal miracolato Conte. Adesso Alessia Crocini, presidente delle famiglie arcobaleno chiede la cancellazione di quel decreto: «I bambini con due mamme o con due papà hanno il diritto di veder riconosciuta la loro storia e la loro famiglia». In senso opposto si è subito mossa l’associazio-

E nel nostro Paese come funziona?
«Azione» lo ha chiesto all’Ufficio dello stato civile del Cantone che ha precisato: «Nel caso di coppie eterosessuali i documenti relativi all’atto di nascita (sia nazionale sia internazionale) prevedono che i genitori vengano indicati come “madre” e “padre”». Mentre nel caso di coppie omosessuali la situazione cambia. «A fine maggio 2022 la Svizzera ha ratificato la Convenzione internazionale di stato civile n° 34 relativa al rilascio di estratti e di certificati plurilingue,
che è entrata in vigore il 1° luglio di quest'anno (per informazioni si legga www.ciec1.org/convention-34-presentation-fr)». La convenzione precedente – spiega il documento online citato – non era più adeguata ai c ambiamenti intervenuti nel diritto di famiglia dopo la firma della stessa nel 1976, ad esempio l'introduzione di matrimoni e unioni registrate tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di Paesi. «In base ai modelli previsti dalla Convenzione n° 34 – afferma l'Ufficio dello stato
Shutterstock

ne Pro Vita&Famiglia: raccolte oltre 47mila firme per non toccare la dizione «madre» e «padre».

D’altronde è dieci anni che la contrapposizione va avanti. Nel 2013 Camilla Seibezzi, cinquantaduenne funzionaria del comune di Venezia, una figlia avuta con un’altra donna, propose la dicitura «genitore 1 – genitore 2» per la modulistica scolastica del municipio veneziano, di cui era consigliera delegata a diritti civili e
politiche anti-discriminazione. La richiesta puntava a modificare i moduli per l’iscrizione agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, che riportano la dicitura «padre» e «madre». Ma la dicitura primo genitore e secondo genitore (cioè il primo che firma e il secondo che firma), ha dato adito al malinteso di «genitore 1» e «genitore 2», ricomparso pure nell’ultimo caso, malgrado nessuna delle parti in causa vi abbia accennato. In realtà anche Seibezzi, come ha spesso chiarito, aveva usato il termine «genitore», così inviso ai partiti di destra, per venire incontro ai bambini privi di un padre o di una madre. E l’aveva fatto copiando dal libretto delle giustificazioni delle scuole superiori dove sta scritto «firma del genitore o chi ne fa le veci».
«Genitori» è da preferire a «madre» e «padre», anche per eliminare la discriminazione nei confronti di chi ha soltanto uno dei due
civile ticinese – è possibile rilasciare degli atti di stato civile con l’indicazione di due madri o di due padri. Inoltre l’Ufficio federale dello stato civile ha messo a disposizione un modello di certificato di famiglia nel quale i coniugi vengono indicati come “sposi” e non più “moglie” e “marito” e vi è la possibilità di indicare due madri o due padri». Un passo avanti dunque. Per quello che riguarda i documenti di altro tipo, per esempio quelli scolastici, valgono la sensibilità e la volontà dell’autorità che li emette. /RED
A rinfocolare la polemica l’introduzione nel 2015 della carta d’identità elettronica voluta dal Governo Renzi. Per i minori la richiesta poteva esser presentata dai «genitori o tutori». Nella sezione «genitori» si leggeva «cognome e nome dei genitori o di chi ne fa le veci», con la traduzione inglese «parents – tutor’s name». Ma nel gennaio 2019 si scatenò Salvini, fresco ministro dell’Interno. Per decreto la frase «o dai genitori o tutori in caso di minore» fu sostituita da «o dal padre o dalla madre, disgiuntamente, o dai tutori, in caso di minore». Dunque «genitori» venne rimpiazzato da «madre e padre»; le parole «cognome e nome dei genitori» da «cognome e nome del padre e della madre». Non si salvò nemmeno la traduzione inglese: al posto di «parents», «father and mother». Infine la variazione, che tanti problemi ha causato ai bimbi con un padre o con una madre: nella sezione dedicata alla presentazione della richiesta della carta d’identità elettronica, il decreto Salvini non dava scampo: «La richiesta valida per l’espatrio per il minore è presentata dal padre e dalla madre congiuntamente, o dai tutori». E chi aveva un solo genitore rimaneva a casa.
In disaccordo anche l’Europa, alle cui normative si rifà il prefetto Lamorgese quando subentra a Salvini da ministro dell’Interno: «genitori» è da preferire a «madre» e «padre», anche per eliminare la discriminazione nei confronti di chi ha soltanto uno dei due. All’epoca, però, è proprio Meloni a guidare il coro di quanti lamentano la reintroduzione di «genitore 1» e «genitore 2», nella pratica mai esistiti. Dopo la sentenza del giudice Crisafulli la partita è ricominciata sulla pelle dei bambini.
Con i due nuovi menù Anna’s Best puoi portare in tavola un piatto gustoso a tempo di record e con minimo impegno. Ma cosa si abbina meglio ai classici e come si può disporre il piatto in modo ottimale? Lasciati ispirare!

servilo così Prepara lo Stroganoff secondo le istruzioni riportate sulla confezione. Affetta un cetriolino sottaceto. Servire lo stroganoff con panna acida e sottaceti e cospargere di erba cipollina.



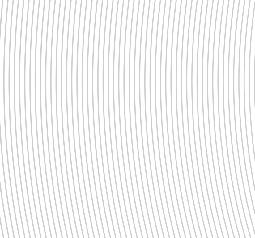
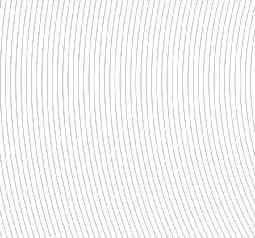



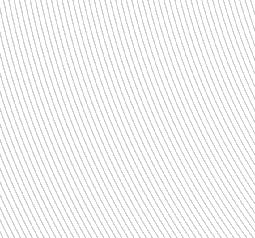
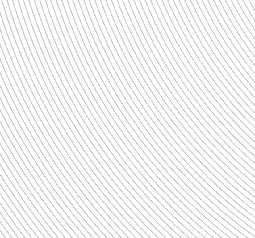
















La carriera eclettica di Marina Viotti
Premio svizzero di musica 2022, la mezzosoprano figlia d’arte si racconta a partire dai suoi esordi nei Night-wish, una band metal
Pagina 41
«Mio amatissimo fratello…»
Per Casagrande sono uscite le intense lettere che il pediatra ebreo Willy Schwarz scrisse al fratello Franco tra il 1943 e il 1945
Pagina 43
Un album di cover per il Boss Solo i più forti sopravvivono è il titolo del disco di Bruce Springsteen, un divertissement in attesa del nuovo tour
Pagina 46
Mostra ◆ Le opere esposte al MASI ci raccontano di come, con pochi tratti, l’artista creasse personaggi, espressioni e atteggiamenti
Alessia BrugheraForse non tutti sanno che della smisurata produzione di Paul Klee, composta da circa novemila opere, una buona metà è costituita da disegni. Utilizzando una definizione tanto semplice quanto efficace, il maestro svizzero descriveva il disegno come «l’arte di condurre una linea a fare una passeggiata», rivelando quanto per lui fosse importante l’uso di un tratto spontaneo e disinvolto per dare vita al suo universo dalla creatività unica. Non a caso il tipo di segno che più lo affascinava era quello delle pitture rupestri dell’arte preistorica, così immediato e primitivo, e quello dei disegni infantili, scarabocchi dalla grande purezza formale.
E difatti, secondo le parole che lo stesso Klee scriveva all’inizio del suo Pedagogical Sketchbook (uno dei libri più studiati al celeberrimo Bauhaus, dove l’artista ha insegnato per una decina di anni), era necessario saper generare «una linea attiva, che cammina, muovendosi libera, senza un obiettivo». Una linea versatile in grado di pulsare di vitalità e di cogliere ciò che non è visibile, vero fine ultimo dell’arte.
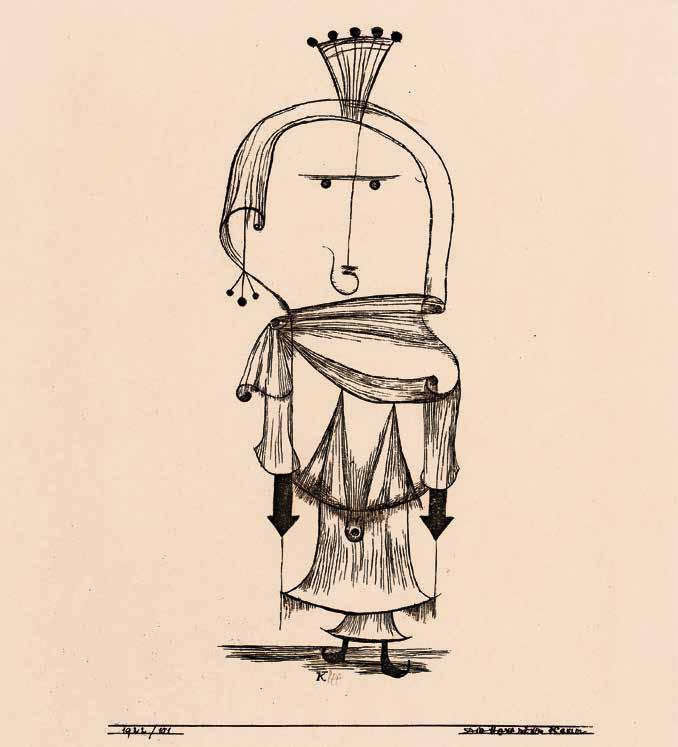
Nei disegni di Klee, da lui mai concepiti come meri schizzi o bozzetti preparatori per un dipinto, bensì come opere autoreferenziali, dotate di un proprio valore estetico, i tratti, ora fluidi ora spezzati, ora sottili ora spessi, si evolvono in cifre, lettere e simboli che raccontano storie in bilico tra ironia e inquietudine. Questi lavori sono composizioni leggere ed essenziali in cui il procedere cadenzato della linea definisce figure umane, animali, piante, creature immaginarie e architetture precarie che ci catapultano in una dimensione fisica e spirituale insieme. Attraverso un segno agile e sciolto Klee profila un personaggio, crea un’atmosfera, isola uno stato d’animo con quella sua sfuggente precisione capace di penetrare la realtà e di restituirla rarefatta.
Una valida occasione per comprendere meglio il ruolo fondamentale che disegno e linea hanno avuto nel percorso artistico di Klee è la mostra allestita negli spazi del Museo d’arte della Svizzera Italiana a Lugano, dove è esposto un corposo nucleo di opere realizzato dal maestro svizzero tra il 1914 e il 1940, anno della sua morte. Si tratta di settanta lavori, tra disegni a matita e a penna, pastelli, acquerelli, acqueforti e litografie, appartenenti alla collezione Sylvie e Jorge Helft, una raccolta che i due grandi estimatori di Klee hanno incominciato a mettere insieme più di cinquant’anni fa e che per la prima volta viene proposta nel suo insieme in un contesto museale. Leggendo le biografie dei coniugi Helft non si fatica a immaginare come sia nata la loro comune passione per Klee: Jorge, nato a Parigi in un’illustre famiglia di antiquari, lascia il proprio lavo-
ro per dedicarsi a tempo pieno all’arte, al teatro e alla musica. Sylvie è un’abile pianista, soprano e direttrice d’orchestra. La loro storia e i loro interessi trovano una profonda corrispondenza con quelli di Klee, figlio di un professore di musica e di una cantante e a sua volta eccellente violinista, capace di trasferire nelle sue opere d’arte i princìpi che governano i componimenti sonori in un perfetto accordo di tinte e forme. Nel modo di strutturare le scene, nel ritmo delle linee e nella disposizione dei colori Klee ha sempre fatto trasparire il musicista che si nascondeva dietro l’artista. Anche per questo è riuscito ad attraversare le correnti avanguardistiche del Novecento senza lasciarsi inquadrare in schemi predefiniti: membro fondatore del Der Blaue Reiter insieme a Kandinskij, in contatto con il Dadaismo e con il Surrealismo, insegnante di pittura al Bauhaus, non ha mai smesso di essere un solitario che con il suo stile lirico e primigenio ha lasciato una traccia indelebile nell’arte contemporanea.
La rassegna luganese, il cui allestimento è stato concepito in un ambiente raccolto per permettere al visitatore di entrare in intimo dialogo con le opere, esplora secondo un percorso tematico i soggetti più amati da Klee nonché le fasi più significative del suo cammino creativo.
Nei lavori dedicati alla natura si manifesta appieno il modus operandi dell’artista, il suo disegnare senza avere in mente a priori la scena da raffigurare lasciando che essa scaturisca in maniera spontanea attraverso un segno libero. D’altra parte Klee non è mai stato interessato alla riproduzione oggettiva della realtà. Per lui l’artista era una sorta di filosofo capace di osservare l’intero cosmo non per rappresentarlo così come è ma per visualizzarlo in forme e simboli, svelandone gli aspetti più reconditi. Il tratto spigliato di Klee delinea in queste opere infiorescenze delicate, sagome di città che emergono da massicci rocciosi, microrganismi marini che diventano fiori. «L’artista è esso stesso natura», sosteneva Klee, e partendo da questo concetto si interrogava sul processo artistico in un parallelismo tra creazione umana e naturale, entrambe guidate da un impulso vitale che porta a una nuova nascita.
Del periodo tra le due guerre e degli anni trascorsi al Bauhaus, di particolare interesse è L’altra stanza dei fantasmi (nuova versione), datata 1925, un’opera dalle suggestioni metafisiche che nella collezione Helft occupa un posto di riguardo poiché è il primo lavoro di Klee acquistato da Jorge, vendutogli nel 1970 dal mercante d’arte Heinz Berggruen, all’epoca il più grande esperto del pittore svizzero.
Come con pochi tratti Klee riuscisse a suggerire personaggi, espressioni e atteggiamenti è ben visibile nei disegni
che hanno per soggetto la figura umana e il mondo animale. Qui l’artista si diverte a comporre scene grottesche in cui le gerarchie e i rapporti tra uomo e bestia vengono ricalibrati in maniera sarcastica. La medesima attitudine all’ironia si ritrova anche nei titoli che Klee dà alle proprie opere, spesso inventati insieme alla moglie Lily e al figlio Felix con l’obiettivo di trovare soluzioni audaci e a doppio senso, generate da associazioni enigmatiche e da modi di dire dialettali. Oltre alla musica, Klee amava molto la letteratura e il teatro. Assisteva a rappresentazioni di tutti i generi, da quelle culturalmente «alte» a quelle più popolari (il circo o gli spettacoli di marionette, ad esempio), trovandovi figure e situazioni da riprodurre nei suoi lavori con una linea scattante e sintetica, come ben dimostra la sezione dedicata alle arti performative.
Il suo tratto, poi, si fa ancor più rapido ed essenziale nei disegni collocati a fine percorso che testimoniano l’ultimo periodo dell’artista, quello segnato da una malattia al tempo sconosciuta, la sclerodermia progressiva. Pur provato nel fisico e nella mente, Klee, che nel frattempo aveva lasciato la Germania per fare ritorno in Svizzera da esiliato, anche in questo momento buio della sua esistenza continuava a lavorare con tenacia (tra il 1937 e il 1939 realizza quasi duemila opere!), riversando nelle sue creazioni le inquietudini che lo tormentavano. In Metamorfosi interrotta raffigura sé stesso con un volto dai contorni marcati, simbolo della sua paura, e con un corpo frammentato, manifestazione della sua condizione di estremo dolore.
Piccola chicca presentata a chiusura della rassegna è una preziosa selezione di pubblicazioni d’epoca che gli Helft,
appassionati bibliofili oltre che amanti dell’arte, hanno raccolto con dedizione. A spiccare è un raro esemplare completo del portfolio Meistermappe des Staatlichen Bauhauses, datato 1923, che contiene, tra le altre, una vivace litografia di Kandinskij e una composizione minimalista di Moholy-Nagy, a documentare quel fervido clima culturale e artistico che si respirava al Bauhaus, di cui Klee, con la sua inesauribile vena immaginifica, era stato uno dei principali animatori.
Paul Klee La collezione Sylvie e Jorge Helft. Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano.
Fino all’8 gennaio 2023.
Orari: ma, me e ve 11.00 – 18.00; gio 11.00 – 20.00; sa, do e festivi 10.00 – 18.00. www.masilugano.ch













Incontro ◆ Alla scoperta di Marina Viotti che quest’anno ha ricevuto il Premio svizzero della musica
Davide FersiniCharme, eleganza e misura. Sono le doti che colpiscono immediatamente chiunque abbia modo di trovarsi a quattr’occhi con Marina Viotti. Poi, durante la conversazione, emergono la consapevolezza, la lungimiranza e l’esperienza di una giovane professionista che ha già vissuto due vite o forse anche tre. Il cognome è di quelli illustri, ma il nome – almeno in ambito classico – è iniziato a circolare solo pochi anni fa. In breve, però, al mezzosoprano ginevrino sono state spalancate le porte dei più prestigiosi palcoscenici.

Quando si è accorta che la sua non era una famiglia normale?
Molto tardi. Noi vivevamo veramente in un mondo parallelo e per un po’ di tempo non mi sono resa conto che la quotidianità degli altri era diversissima dalla nostra. Un padre direttore d’orchestra, una madre violinista, due fratelli cornisti e un altro anche lui direttore; la musica «classica» era il nostro lessico famigliare. Ma c’era anche moltissimo amore e tanta libertà: nessuno è stato obbligato a studiare uno specifico strumento e tanto meno la musica. Ovviamente, però, vivere in quel mondo ci ha influenzati: i teatri, le sale da concerto, i grandi cantanti con i loro magnifici costumi e il trucco esagerato. Come poteva una bambina resistere a quel richiamo? Così, a otto anni ho dichiarato ai miei genitori che avrei fatto la cantante e loro prudentemente mi hanno iscritta a flauto. «Per cantare è presto, – mi dissero – ma puoi iniziare a farti il fiato!» Poi, però, quando è arrivata l’età giusta, mio padre è scomparso e io mi sono allontanata sempre più dalla musica classica. Mi sono laureata in lettere e filosofia e parallelamente ho iniziato a cantare in una band metal, i Night-whish. Un’esperienza epica! Voce lirica, amplificatori, distorsori e un pubblico che in alcune serate raggiungeva i cinquemila spettatori. Purtroppo ben presto mi sono accorta che il metal non avrebbe pagato i miei conti e così mi sono iscritta a un master in management culturale. È stato il destino a riportarmi in teatro: per il tirocinio mi hanno affidato la cura del marketing di un festival di musica classica e finalmente sono tornata nel mio mondo.
Un lieto fine, insomma. Piuttosto un nuovo inizio; e non dei più semplici. È inutile negarlo, il mio cognome ha aperto molte porte, ma soprattutto perché nei teatri c’era la grande curiosità di sentire come cantava la figlia di Marcello Viotti. Gli inviti alle audizioni arrivavano a mazzi. E l’aspettativa era molto alta! Dal punto di vista psicologico è stata durissima. Dovevo essere all’altezza del mio cognome e nel contempo combattere la «sindrome dell’impostore» – in un angolo della mia psiche c’era la convinzione che mi scegliessero solo per chi ero e non per come cantavo. In più, prima di ascoltarmi, tutti volevano esprimermi cordoglio e raccontarmi qualcosa su mio padre, rischiando così di produrre effetti disastrosi sulla mia performance. Alla lunga però sono riuscita a corazzarmi e durante questi primi anni di carriera ho imparato qualcosa che allora non sapevo: nessuno può resistere a lungo nel teatro d’opera senza avere delle qualità reali.
A questo punto inizia una nuova vita come mezzo-soprano. Si identifica con la sua vocalità?
Totalmente! Non ne vorrei una diversa. C’è in me una componente molto androgina che si diverte un mondo a interpretare i ruoli en-travesti con tutte le possibili declinazioni del maschile come Cherubino, Octavian, Sesto. Recentemente ho cantato Stefano nel Roméo et Juliette di Gounod e ho dovuto imparare a combattere con una spada; un’esperienza entusiasmante! Poi c’è la componente più femminile del mezzosoprano, tutta giocata nel segno della sensualità con i ruoli da femme fatale come Maddalena o Carmen. Insomma, è un tipo di vocalità molto versatile che permette di impersonare ruoli lontanissimi fra loro e questo è un dono impagabile per un’attrice!
È interessante che lei parli di sé come attrice. Per quanto riguarda la recitazione, il mondo dell’opera è cambiato moltissimo negli ultimi anni. È finita, forse, l’era del belcanto?
Dobbiamo essere onesti. A parità di talento e qualità musicali, oggi si sceglie l’interprete che più soddisfa le richieste della regia. La voce non basta più. Qui entra in gioco

una componente fisica – oltre che estetica. – che ci impone di essere in forma e agili, per poter assecondare al meglio ogni necessità di palcoscenico. A questo, poi, si deve aggiungere un altro aspetto che in passato contava in maniera marginale: non solo bisogna saper cantare e recitare in maniera superba, ma è necessario avere sotto controllo la propria immagine pubblica. A volte ho l’impressione che questo impegno costituisca il 50% della nostra attività di artisti. Nessuno ti insegna come si fa, ma ormai è parte integrante della professione e tutti si aspettano che tu sappia farlo.
Questo ci porta al Premio svizzero di musica 2022. Per iniziare una domanda secca: se lo aspettava? No, per nulla! Non sapevo nemmeno di essere nella lista dei finalisti. L’ho scoperto solo a cose fatte: ero in macchina e stavo guidando quando ho ricevuto una telefonata da un numero sconosciuto. Normalmente non avrei risposto, ma si trattava di un prefisso svizzero e ho pensa-
to che potesse essere un parente, un teatro o qualche ufficio pubblico. E in effetti era l’Ufficio federale della cultura che mi cercava per darmi la bella notizia.
«Versatilità tecnica e interpretativa fuori dal comune, che la fa sentire a proprio agio in repertori di stili ed epoche anche molto distanti». Sono le motivazioni date dalla giuria del premio, cosa ne pensa? Mi commuove, perché questo non è un premio per la mia voce; è un premio per i miei progetti, per la mia personalità, per la mia visione del canto e per il messaggio che cerco di far passare nei concerti. Sin da quando ho iniziato la carriera di mezzosoprano, ho sentito la necessità di aprirmi ad altri mondi, di costruire ponti tra i generi musicali e tra i diversi tipi di pubblico. Le motivazioni di questo riconoscimento, quindi, mi emozionano particolarmente: sono la prova che la missione che mi sono data e gli sforzi che ho fatto per realizzarla sono stati percepiti e apprezzati. Gradualmente anche le istitu-
zioni musicali si stanno accorgendo che il pubblico spinge per un rinnovamento delle formule rituali e questo non può che farmi piacere!
Un rinnovamento nei contenuti, dunque, non è più sufficiente?
In effetti quello è solo il punto di partenza. Prima della lirica, ho cantato il metal, il jazz, la chanson e ho sempre avuto una fortissima curiosità verso le comunità musicali distanti dai miei gusti. Col tempo mi sono accorta che l’opera e la musica classica soffrono – in quelle comunità –di un’immagine un po’ stantia, come se si trattasse di generi che possono essere apprezzati solo da un’élite, sia per i prezzi sia per i contenuti. Ovviamente sono consapevole che si tratta di stereotipi, ma per modificarli e allargare il pubblico bisogna provare nuove forme, nuove vie della performance. Così ho iniziato a lavorare sull’unico tipo di spettacolo in cui l’interprete possa avere il controllo totale: il recital di canto e pianoforte. Si tratta di un intrattenimento da salotto che ha conquistato i teatri nel corso del Novecento, ma lentamente è diventato sempre meno popolare anche fra i melomani più accaniti. Perché? Perché nel nostro presente nessuno può sopportare una star della voce che entra in palcoscenico, canta lieder di Schubert per un’ora e mezza e poi se ne va senza dire nemmeno una parola; non solo è noiosissimo, è anche aberrante.
È necessario coinvolgere gli spettatori – come si fa durante i concerti metal o jazz – e per farlo il cantante deve essere pronto a raccontare una storia, a creare percorsi alternativi attraverso i generi, a stimolare risposte; in poche parole, a dialogare con le persone. Le prime volte, io stessa mi sono chiesta se stessi facendo la cosa giusta e se il pubblico avrebbe capito le ragioni di un accostamento fra melodie classiche e canzoni della world-music. Per fortuna in Svizzera c’è molta apertura verso l’ibridazione e tutti i miei esperimenti sono stati accolti con grandissimo calore. Questo mi ha permesso di continuare a esplorare nuovi repertori e arricchire la mia personalità, la mia voce e i miei concerti. D’altronde non avrei potuto fare altro. Questa è la mia cifra: una insaziabile curiosità musicale.
Proteggiamo le meraviglie della natura.





























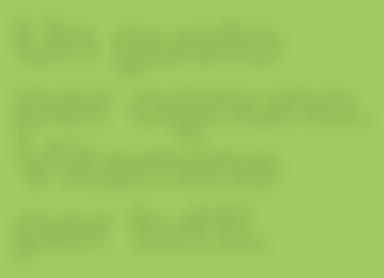



Il racconto e lo studio delle terribili esperienze della Seconda guerra mondiale sono giunti oramai da qualche anno a un punto di svolta: il progressivo venire meno dei testimoni diretti, dopo un primo momento in cui avevano prevalso rimozione e silenzio (emblematica la fatica di Primo Levi, cui Einaudi rifiutò inizialmente la pubblicazione di Se questo è un uomo), impone oggi un radicale ripensamento di strategia nella narrazione delle pagine più cupe del Novecento. Il capitolo incarnatosi in figure forti e carismatiche come quelle di Elie Wiesel, Simon Wiesenthal, Sami Modiano o Liliana Segre è destinato infatti a chiudersi per sempre e molto presto, ma non può chiudersi per questo – assieme alla voce fisica dei testimoni – la nostra consapevolezza di quelle esperienze. Troppo attuali rimangono purtroppo i temi della discriminazione e del genocidio.
In quest’ottica diventano tanto più preziosi i documenti che continuano a emergere da archivi pubblici e privati, magari non innovativi dal punto di vista della lettura generale dei fenomeni, ma ricchi di dettagli e sfumature che suggeriscono comunque interpretazioni nuove. Quello della ricerca storica è infatti, inutile illudersi, un cantiere mai finito, anche alle nostre latitudini. Si prendano ad esempio i diari della piccola Bruna Cases, pubblicati a inizio anno da
Abendstern. O il carteggio dei coniugi Sommaruga, oggi all’Archivio federale di Berna. I documenti inediti di Federica Spitzer conservati all’Archivio storico della Città di Lugano. O ancora il bel libro di Sandro Gerbi, stampato in queste settimane da Casagrande di Bellinzona, con le lettere scritte durante la guerra dal pediatra milanese Willy Schwarz (1906-89) al fratello Franco (1908-82), esule negli Stati Uniti.

La famiglia Schwarz è interessante per più ragioni: per l’origine ebraica, per la rete di contatti estesa su scala europea, per la parentela con Eugenio Colorni (cognato di Willy, che ne aveva sposato la sorella Silvia), per l’interesse coltivato da molti suoi membri per le ricerche antroposofiche di Rudolf Steiner e per la relazione dinamica, mai chiusa, con l’identità cattolica, alla quale Willy e la madre Caroline Rothschild finirono poi per aderire. Se è vero che l’identità dovrebbe essere sempre declinata al plurale, la famiglia Schwarz è l’emblematica rappresentazione di questa regola non scritta.
Entro i molti materiali conservati dagli eredi, il curatore ha operato una selezione drastica ma non per questo meno significativa: soltanto quattro lunghissime lettere di Willy a Franco, scritte in momenti cruciali della guerra (attorno all’8 settembre 1943 e al 25 aprile 1945, ad esempio), da Mi-
lano, Lugano e Ginevra, indirizzate alla volta dell’America. Le difficoltà di comunicazione dell’epoca e l’affastellarsi continuo degli eventi fanno di queste lettere – e il mittente ne era ben consapevole – un prodotto ibrido, a metà strada tra il diario e la cronaca. Sono testi scritti contemporaneamente per sé, per il destinatario e per i posteri, testi dettati soprattutto dalla volontà di fissare su carta i fatti e i pensieri di un momento eccezionale. Vi trovano spazio i grandi eventi che tutti conosciamo, ma anche i destini dei singoli membri della famiglia, dal drammatico suicidio dell’anziano padre Gustavo Schwarz (che tentò invano di varcare il confine svizzero) all’accoglienza di Willy nel seminario arcivescovile di Venegono, dove tra le altre cose poté coltivare, nella vasta biblioteca dell’istituto, un insolito interesse per la patristica e le testimonianze scritte dei primi secoli del cristianesimo.
Il fenomeno è noto, anche se non ancora raccontato forse in tutta la sua portata storica: mentre alcuni italiani, funzionari o privati cittadini, stanavano ebrei e li denunciavano alle autorità tedesche, altri li nascondevano presso di loro non senza rischi per la loro stessa incolumità. «Silvia e io» scrive Willy al fratello nell’ottobre del 1943 «abbiamo pensato a trovare un rifugio per le nostre bambine, in un istituto religioso, mentre io, per

me stesso, avevo pensato subito a un altro istituto, dove mi recai […] senza nessuna raccomandazione, ma solo esponendo la situazione mia e della mia famiglia; e dopo alcuni giorni […] con grandissima mia gioia ne riportai una risposta affermativa». Persona colta e di vaste esperienze, sia umane che professionali, Willy Schwarz affida a queste lettere-diario lucide riflessioni sull’Italia che attende disperata di conoscere il proprio destino dopo l’armistizio, al quale non aveva fatto seguito una riconquista alleata sufficientemente rapi-
da. Sono i mesi di Salò, dell’illusione della Svizzera, dei bombardamenti di Milano: mesi convulsi che il giovane pediatra non riesce però a leggere in termini del tutto pessimistici, con il cuore sempre aperto a una speranza suggeritagli anche dalla sua personalità vivace, volonterosa eppure pacata. Meritevole delle nostre attenzioni.
Willy Schwarz, «Mio amatissimo fratello». Fuga da Milano (194345). A cura di Sandro Gerbi, Edizioni Casagrande, 2022


























 Giorgia Del Don
Giorgia Del Don
◆ Il collettivo racconta la sua visione










«Il Ticino è molto più grande da quando esiste Ticino is Burning », ci dice Simon Waldvogel, uno dei cinque artisti che compongono il giovane e dinamico collettivo ticinese recentemente insignito di uno dei prestigiosi Premi svizzeri delle arti sceniche 2022. Un’affermazione in linea con un movimento nato dal desiderio di riflettere sul modo in cui il Ticino considera la produzione scenica locale, così come dal bisogno di sviluppare una rete di contatti che vadano ben al di là dei confini territoriali, il tutto espresso in maniera tanto precisa quanto provocatoria da artisti coscienti degli stereotipi che soffocano il cantone più latino della Svizzera. Invece di camuffare le proprie debolezze o di minimizzare le difficoltà legate al vivere e creare in un cantone periferico, il collettivo TIB ha deciso di parlarne apertamente cercando di attirare l’attenzione su un territorio troppo spesso dimenticato dal resto della Svizzera. Quella del Ticino si rivela allora una ristrettezza non tanto reale quanto immaginaria, un’autoesclusione nutrita dall’immagine limitante che il resto del territorio elvetico gli rinvia e che plasma silenziosamente le mentalità di chi lo abita. Pensarsi differentemente, osare aprirsi ad altre realtà, andare fieri delle proprie differenze cercando di creare nuove forme di coesistenza fra gli artisti e le istituzioni locali ma anche nazionali, rende allora senza dubbio il Ticino più grande.







TIB è composto da quattro artisti che abbiamo avuto il piacere di incontrare al loro rientro in Ticino (nella foto) dopo un’importante tappa a Ginevra dove a fine ottobre hanno ricevuto il Premio svizzero delle arti sceniche. Sono Elena Boillat, Camilla Parini, Francesca Sproccati e Simon Waldvogel, partiti da Milano per diventare ballerini, performer e attori in scuole prestigiose: la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi (Elena e Camilla), il Centro Internazionale Movimento e Danza di Franca Ferrari (Francesca), la Scuola Teatro Arsenale e l’Accademia dei filodrammatici di Milano (Simon) prima di ritrasferirsi a Sud delle Alpi. Discutendo con loro delle motivazioni che li hanno spinti a costruirsi un percorso artistico in Ticino, la questione della responsabilità individuale torna come un leitmotiv: «da una parte in Ticino c’è poco, allo stesso tempo esiste però la possibilità di attivare delle sinergie, di provare a cambiare le cose. È un’attitudine che fa anche parte del mio lavoro come artista, l’attivare, il generare situazioni mi smuove artisticamente. Finché rimango in Ticino ritengo sia mia responsabilità quella di provare a starci in maniera at-
tiva e propositiva», spiega molto bene Francesca. Un punto di vista condiviso da Camilla che aggiunge: «Sono tornata in Ticino pensando che fosse temporaneo, ma c’è un momento in cui ho capito che dovevo cambiare il mio setting mentale. Mi sono detta che non serviva a niente rimanere in Ticino senza rimanerci veramente, così facendo non avrei costruito niente. Starci senza abitarci veramente era faticoso. È stato allora che le cose hanno cominciato a muoversi e che il terreno sul quale lavoravo è diventato più fertile».
TIB nasce da un senso di isolamento rispetto al resto della Svizzera ma anche dal sentimento di frustrazione per un territorio poco interessato a ciò che lo circonda. «C’era il bisogno reale e condiviso di fare in modo che determinati meccanismi cambiassero», spiega Camilla. «Il punto di partenza è il nostro senso comune di isolamento e le domande che ne conseguono. Ci siamo chiesti come mai ci sentivamo così e una delle risposte è stata che non conoscevamo quello che stava al di fuori, il resto della Svizzera. Da lì è nato il bisogno di incontrare altre realtà, di studiare dei modelli da esportare all’interno del nostro territorio, di renderci visibili per il resto delle Svizzera», precisa Simon. Rivendicare la propria esistenza partecipando a colloqui quali per esempio l’m2act tenutosi a Zurigo nel 2021, lasciarsi guidare da una sana curiosità e da questioni intimamente legate alla loro condizione di artisti della scena ticinese è stato il primo, importante passo in avanti fatto dal dinamico collettivo.
Elena, Camilla, Francesca e Simon si sono ben presto accorti del potere che la loro voce, da sola, possedeva. Il successo di TIB, formato da soli artisti, è infatti stato abbastanza istantaneo risuonando con forza oltre Gottardo e intrigando istituzioni come Pro Helvetia o il Percento culturale Migros. Riflettere sulle arti sceniche da insider permette a TIB di andare al cuore della questione, di privilegiare il processo, promuovere la discussione, e l’incontro andando oltre la sterile ed esclusiva focalizzazione sugli obiettivi. Il lavoro messo in atto per cercare di istaurare un rapporto più orizzontale con le istituzioni locali è sicuramente faticoso e il successo non garantito, ma ciò che importa e che rende il suolo ticinese fertile è la grinta con la quale si tenta di cambiare le cose. Senza voler deresponsabilizzare l’artista, tutt’altro, TIB ammette che probabilmente si dovrebbe agire su più fronti, quello individuale e quello istituzionale che a volte ignora i bisogni reali degli artisti.






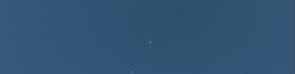


 Fabrizio Coli
Fabrizio Coli
◆

«Volevo fare un album dove semplicemente avrei cantato e celebrato il grande repertorio americano degli anni Sessanta e Settanta». Parole del Boss, per spiegare il senso di Only The Strong Survive, il suo nuovo lavoro arrivato a due anni dal personalissimo Letter to You. È un album di cover questo, il secondo in carriera dopo We Shall Overcome del 2006. Se allora al centro c’era il folk di Pete Seeger, questa volta l’amore di Springsteen si riversa su qualcos’altro, il soul e il rhythm and blues della Motown e della Stax, il Philly Sound di Gumble e Huff, mettendo insieme una collezione che intreccia molti brani da scoprire o riscoprire con qualche «quasi classico» più noto.
Il trasporto di Springsteen è autentico e l’incantesimo del soul e del rhythm and blues riesce a stregare anche stavolta
Questo disco lo si può leggere in più modi. Da una parte c’è l’onesta passione per brani che riportano Springsteen alla sua giovinezza. Lo raccontava lui stesso nelle interviste che sono seguite alla pubblicazione, ricordando le sottoculture giovanili del suo New Jersey negli anni Sessanta, gruppi diversi e separati che però trovavano un terreno comune
proprio nell’R&B quando si trattava di scendere sulla pista da ballo. «C’erano un elemento pop nella Motown, un elemento soul e un elemento rock che trascinavano tutti quanti»: parola di Boss.
D’altra parte però questo lavoro suona anche inevitabilmente come un divertissement di una rockstar planetaria che ha fatto di tutto e di più e come meglio non si poteva, e forse ha sentito la voglia, per un attimo almeno, di mettersi alla prova su territori affini e attigui ma diversi da quelli che percorre di solito. Un disco, per chiarire, che ti può venire in mente di fare in età matura, complici anche quei due anni in cui tutto il mondo si è fermato a causa della pandemia.







Ha anche senso quindi che in questa avventura estemporanea non ci sia la fedele E-Street Band, responsabile del sound muscolare che ha fatto del Boss il Boss. A suonare praticamente tutto qui è il produttore Ron Aniello (con l’aggiunta, quella sì, dei fiati degli E-Street Horns). Non ci si è inventati nulla: i quindici brani che compongono l’album – al di là del suono aggiornato al 2022 – sono riproposti in maniera corretta ma convenzionale, niente stravolgimenti, niente rivisitazioni originali. Su questo solco Springsteen si diverte, come dichiarato, a mettere al centro la sua voce di 73enne: una voce calda e rugginosa, una voce che non è nera
ma sicuramente è scura, una voce che non manca di indulgere in momenti di accentuato lirismo.
Se si può avere l’impressione, come ha scritto il critico John Murphy sul magazine online musicOMH, di sentire un «Bruce Springsteen Karaoke», piano piano però questa collezione di brani fa la sua magia e ti entra sotto pelle. D’altra parte – e queste sono parole di uno degli intervistatori di Springsteen, Chris Jordan di Ashbury Park Press – in

quelle canzoni ci sono «elementi di verità, c’è l’amore, la passione, la saggezza della mamma e un messaggio che in generale è quello che se non sei sincero con chi ami e chi ti ama sei condannato».
Le atmosfere ripercorse sono quelle di personaggi come Jerry Butler, la cui Only The Strong Survive ha finito per dare il titolo all’album e di altri artisti e autori come Levi Stubbs, David e Jimmy Ruffin, Dobie Gray, Diana Ross, i Four Tops ma anche
Frankie Valli. L’unico della «vecchia guardia» a partecipare direttamente è Sam Moore, che dà una mano a Springsteen in Soul Days e I Forgot to Be Your Lover. Tra ballad per cuori spezzati come What Becomes of The Brokenhearted fino a qualche raro momento che potrebbe funzionare anche nel repertorio da stadio dello Springsteen più classico come So I Love You (Indeed I Do) di Frank Wilson, fra canzoni più conosciute come quella Nightshift che i Commodores dedicarono ai giganti del soul Marvin Gaye e Jackie Wilson (forse l’unico pezzo fuori dallo spettro temporale dichiarato perché è di metà anni Ottanta) fino a canzoni che lo stesso Springsteen non aveva preso in considerazione prima di lanciarsi in questa avventura come Hey, Western Union Man (ancora Butler), questo disco scivola via liscio e piacevole.
Tirando le somme: se ne sentiva davvero l’urgenza? A dirla proprio tutta no. Ma dal momento che c’è, perché non goderselo? Il trasporto del Boss è autentico e l’incantesimo del soul e del rhythm and blues riesce a stregare anche stavolta. Alla fine è un momento di caldo relax in attesa di rivedere finalmente Springsteen in versione Springsteen nel tour che partirà a febbraio e che il 13 giugno toccherà anche il Letzigrund di Zurigo. Stavolta, ben inteso, con la E-Street Band.


















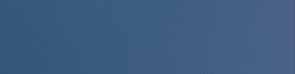
Così si avvereranno tutti i desideri di Natale: con la carta regalo Migros offri un dono ricco di possibilità. Disponibili ora in tutte le filiali e su mondocarteregalo-m.ch



Nella sala d’attesa del medico di famiglia i discorsi vertono sulla nostalgia per un passato che non è mai esistito. La nostra città non è più quella di una volta, quando, se chiudevi la porta di casa prima di allontanarti, i vicini si offendevano. Quando, se perdevi il portafoglio chi lo ritrovava e te lo riportava ci metteva dentro qualche banconota in più per consolarti dello spavento. Adesso non si è più sicuri di niente. Non mi credete? Date uno sguardo alle pagine della cronaca: «Tira fuori la mano dal finestrino per segnalare la svolta e gli sfilano dal polso il Rolex». «Gli portano via scarpe e vestiti mentre è chiuso in cabina per misurarsi un paio di pantaloni». «Mentre è seduto davanti alla TV gli svaligiano la casa. Se ne accorge sono quando pretendono di portargli via il televisore ancora acceso». C’è da avere paura persino a viaggiare sul tram. Ascolto e taccio. Non voglio alimen-
tare paure immotivate, non racconto la mia avventura lunedì mattina, sul tram numero 15 pieno di studenti diretti al palazzo dell’università. Giunto alla mia fermata, per scendere devo scostare con forza un braccio che mi sbarra la strada. Guardo a chi appartiene e incrocio lo sguardo pietroso e la mascella serrata di un giovane uomo, i capelli neri e ricci.
Lampo di memoria: ultimi giorni d’agosto del 1988, su un vecchio tram di Lisbona, i sedili su due file contrapposte lungo i bordi. Si sale e si scende dal centro della vettura, per andarsi a sedere si passa da un varco. Viaggio seduto controllando il percorso su una piantina della città.
Quando arriva per me il momento di scendere, mi alzo e mi trovo il varco sbarrato da un braccio; anche qui si tratta di un giovane uomo che lancia uno sguardo di sfida. L’ho forse senza volerlo offeso? Oppure si tratta di
Vivere nelle fiabe, è questo che contraddistingue la specie umana. Se non c’è fiaba è un guaio. Supponiamo che uno abbia un incontro amoroso, l’incontro si svolge, c’è un certo piacere carnale, l’incontro potrebbe occupare anche un mese, un anno, poi la vita va oltre.
Passano gli anni e una sera di malinconia uno pensa al tempo che fu. Pensa a quell’incontro amoroso, e a come l’abbia sprecato: ah! Potesse tornare indietro! Quanto la saprebbe amare! Cioè quanto sarebbe adesso consapevole di vivere un’epoca meravigliosa, mentre allora tutto era passato via nella smemoratezza. Cos’era mancato? La fiaba. Cioè solo a distanza di tempo si è raggrumata attorno a quei fatti amorosi la fiaba; a distanza di tempo si selezionano i momenti più intensi, si stringe tutto in una specie di film appassionato che allora non si era stati capaci di

raccontarsi; un po’ perché si era nel mezzo della vicenda e non si vedeva l’intero; un po’ perché nella vita le cose sono diluite e miste. Allora cosa si dovrebbe fare? Beh forse si dovrebbe vivere l’incontro e allo stesso tempo raccontarselo, come si fosse protagonisti di una fiaba in corso, con le sue magie, le meraviglie, e anche ad esempio un titolo, perché nessuna fiaba è uguale a un’altra. A mano a mano che succedono i fatti reali uno dovrebbe anche raccontarseli con lo stupore che gli stiano accadendo. Poi questa fiaba va aggiornata ogni giorno, a seconda della piega che prendono i fatti, che un po’ si possono guidare. Quindi è più facile guidare la fiaba parallelamente, vivere e raccontarsi con meraviglia cos’è quel che vive. Ho fatto l’esempio di un incontro amoroso, ma è lo stesso per ogni cosa che accade, cose belle e cose do-
una provocazione per farmi cadere in una trappola approfittando del fatto che, come prova la piantina, non sono pratico del posto? Con timore e con sforzo spingo in là il braccio e riesco a scendere a terra. Il giovane prepotente prosegue la sua corsa sul tram e io mi sento sollevato come se fossi sfuggito a un oscuro pericolo. M’incammino e il sollievo dura fintantoché non cerco di mettere mano al portafoglio scoprendo che mi è stato rubato; dentro c’erano i soldi e tutti i documenti, meno per fortuna il passaporto. Così ora, sul tram numero 15 della mia città, venendomi a trovare in un’analoga situazione, la mano corre rapida alla tasca del portafoglio: c’è ancora! Non solo, ma questa volta il giovane che mi sbarrava l’uscita scende con me; mi vergogno di aver sospettato di lui che ha certamente notato il mio affannoso palparmi le tasche. Mi profondo in scuse, gli dico
che se avessi capito che anche lui sarebbe sceso alla mia fermata non l’avrei spintonato per farmi largo. Il giovane non parla, si limita a sorridere e si allontana. Io m’incammino nella direzione opposta.
Compiuti una decina di passi, il giovane mi raggiunge con il respiro affannato dalla corsa. Mi consegna un mazzo di chiavi, sostenendo che l’ho perso scendendo dal tram. Accenna a un mezzo sorriso e non riesce a frenare uno sguardo di trionfo. Fugge via senza darmi il tempo di ringraziarlo, di offrirgli un caffè. Sono stordito dal pensiero di cosa avrebbe significato in termini di fatica e di spesa rifare tutte le serrature aperte da quelle chiavi se le avessi perdute. A mente fredda ci ripenso: mi sembra impossibile che quel mazzo che tengo sempre dentro un sacchetto di stoffa in una tasca profonda sia potuto cadere da solo per terra senza che io me ne accorgessi.
Tre sono le ipotesi. La prima: le chiavi mi sono effettivamente cadute per terra e il giovane mi ha rincorso per riportamele. Ma allora perché è scappato subito via? Seconda ipotesi: mi ha preso la busta dalla tasca e poi, vedendo che conteneva solo delle chiavi me le ha riportate, colpito dal fatto che mi ero scusato con lui una volta scesi alla fermata. Terza ipotesi: quando ha notato che mi tastavo la tasca dov’era il portafoglio, mi ha sottratto le chiavi con l’intenzione di riportarmele per dimostrami che, nonostante tutte le mie precauzioni, lui era in grado di sottrarmi qualcosa dove e quando voleva. Delle tre ipotesi preferisco quest’ultima perché in questo caso io e lui siamo alla pari; non c’è subalternità né da una parte né dall’altra, non c’è ossequio servile né un mal riposto senso di superiorità, non c’è paura dell’altro, ma una volta tanto c’è sfida, gioco, gesto gratuito.
lorose, perché anche un lutto può evaporare, oppure stare dentro a un racconto con una sua trama e un suo godimento narrativo, fatto anche di lacrime e di disperazione. Spesso il racconto sorge tempo dopo, e uno ripensa alle parole che avrebbe voluto dire, perché quando poteva dire e fare, non sapeva in che vicenda era dentro, in che fiaba, e allora tutto è spezzettato, ma anche il dolore può essere meraviglioso, passa al galoppo, non si fa in tempo a goderselo, resta il rimpianto tardivo, non tanto delle cose accadute, ma del fatto che non le abbiamo sapute vedere quando erano lì presenti e vive. Il vantaggio di un bel romanzo sulla vita è che il romanzo lo si può rileggere, un film lo si può rivedere, sono vita già in forma di fiaba, cioè confezionata perché ci si possa fermare ad assaporarla.
La letteratura è una macchina che ci

Si chiamava A Duan, ed è quasi tutto ciò che sappiamo di lui. Veniva dalla Cina, e intorno al 1750 si trovava in Italia. Avrebbe potuto essere il capostipite o il progenitore della comunità cinese, che oggi è una delle più numerose e in alcune città, come Milano e Firenze, ha già una storia secolare: i discendenti dei primi immigrati hanno iniziato a raccontarla in italiano. Anche A Duan è rimasto in Italia per sempre. Ma non sappiamo se l’abbia scelto.
La sua vicenda individuale è appena un frammento, un bagliore in una storia che lo esclude o lo ignora. Secondo una versione, A Duan aveva soggiornato a Venezia. Ed è possibile, perché la capitale della Repubblica Serenissima, benché avviata al tramonto (avrebbe cessato di esistere nel 1799), era ancora al centro di traffici e commerci con l’Oriente: vi transitavano e a volte vi si stabilivano genti
di ogni razza, lingua e paese (turchi, persiani, mori, indiani). Il fascino che esercitavano questi «orientali» è testimoniato dalla coeva pittura di Tiepolo, popolata di seduttrici esotiche ed enigmatici profeti in turbante.
Secondo un’altra versione, A Duan si trovava invece a Roma, che aveva raggiunto in occasione del Giubileo del 1750. E anche questo è possibile, perché l’anno santo attirava nella città eterna pellegrini di ogni provenienza. In proporzione al numero di abitanti del pianeta, in quantità paragonabili agli attuali flussi turistici di massa. I più poveri o devoti arrivavano a piedi, gli altri in carrozza. Il viaggio poteva durare mesi. Ma tutti visitavano le sette basiliche, e ricevevano l’indulgenza. A patto che fossero cristiani cattolici. A Duan però poteva essersi convertito. I missionari non avevano rinunciato a conquistare le anime e cercavano di diffondere la paro-
la di Dio in ogni angolo della terra. In ogni caso, A Duan non era solo. Viaggiava con la sua giovane sposa, cinese anche lei. Ignoriamo il suo nome. I due, benestanti, erano accompagnati da una domestica. Li hanno trovati in un borgo della Valnerina, Ferentillo.
Apparteneva allo Stato Pontificio, ma non era lungo la via Francigena né lungo la strada percorsa usualmente da chi volesse dirigersi a nord (o nella direzione opposta, verso Roma). La strada seguiva il corso dell’impetuoso fiume Nera, fra costoni sempre più ripidi e infine le montagne. Lungo la valle – verde di foreste e prati – si potevano trovare monasteri, villaggi, locande, e stalle per cambiare i cavalli. Ma poco altro. È una strada che si percorre piuttosto fuggendo. Stavano fuggendo, infatti, A Duan e la sua sposa. Il colera (altri dicono la peste nera) dilagava nello Stato Pon-
dà in prestito le fiabe che non abbiamo saputo vedere quando c’eravamo dentro, una macchina della restituzione di pezzi di vita, persino nel caso non ci siano mai stati nella nostra vita effettiva, in tal caso sono aggiunte, e uno può aggiungere tanto, come se la vita avesse spaziato oltre la cosiddetta realtà, perché in fondo siamo fatti di fiabe, che inventiamo noi o che ci vengono prestate.
Anche un politico in fondo è un narratore di fiabe; e come ci sono quelli bravi a raccontare barzellette, analogamente ci sono i bravi raccontatori di realtà, cioè i politici che ci raccontano la fiaba collettiva che stiamo vivendo; ogni politico ha la sua, ma la struttura in genere è la stessa: stiamo correndo un grave pericolo, ci salveremo percorrendo una strada che porterà al lieto finale.
La storia stessa è una grande fiaba che come tutte le fiabe muta e si ag-
giusta a seconda di chi la racconta. Per questo il passato cambia continuamente. Storici, politici, preti, psicologi eccetera hanno questo compito di tenerci dentro a tante fiabe, aiutati dai giornali e dalla TV. Uno poi sceglie la fiaba, a seconda del suo carattere e dell’età, e crede di vivere nella consapevolezza, ma sono tutte balle, è inevitabile, di cui noi esseri umani abbiamo bisogno per il fatto che parliamo e pensiamo con un linguaggio che fluisce, a differenza degli animali, insetti, rettili, pesci, mammiferi e su su fino alle scimmie e agli scimpanzé nostri cugini primi, che non vivono dentro le fiabe, a quanto ne sappiamo.

Perché dico fiaba? Beh, perché c’è del magico, esseri e cose inesistenti, e poi sembra che tutte le fiabe siano riconducibili a un’unica fiaba con delle varianti. Forse è così; le varianti contano poco.
tificio. L’insalubrità di Roma (flagellata dalle febbri malariche) era nota, ma le misure di quarantena in caso di epidemie di morbi infettivi assai rigorose. Nel corso dei secoli i papi avevano istituito appositi ministeri della salute e durante le epidemie conclamate chiudevano i confini, sguinzagliando su strade e ponti squadre di bargelli. Non filtravano nemmeno le merci. Forse A Duan e la sua sposa temevano – soffermandosi ancora a Roma – di restare rinchiusi. Forse temevano soltanto di contrarre il morbo. Era più probabile ammalarsi in una città popolosa, dove le condizioni igieniche erano carenti perfino nei rioni centrali, che in una valle fra le montagne.
Fuggirono dunque verso l’interno. Ma si erano già contagiati. Quando arrivarono a Ferentillo stavano così male che dovettero fermarsi. Morirono entrambi, dopo pochi giorni di de-
lirio. Gli abitanti del posto li seppellirono nella cripta della loro chiesa di Santo Stefano – benché dei due stranieri conoscessero a stento il nome. Sarebbero rimasti sepolti nell’oblio se il microclima, la chimica e i sali della terra non avessero deciso che quegli ospiti di passaggio dovevano restare per sempre. Dopo l’editto di Napoleone che vietava le sepolture all’interno delle mura cittadine, vennero costruiti nuovi cimiteri e le spoglie traslate. I morti della cripta però erano intatti. Mummificati. Avevano ancora pelle, unghie, capelli, denti, labbra… Della sposa di A Duan si è conservato addirittura il ricco vestito. Di entrambi, il volto. I loro lineamenti orientali ci interrogano ancora col loro mistero, a rivelarci la mobilità inattesa di genti che – per fede, per amore, per affari o per curiosità – giravano il mondo come fosse un’unica casa.


















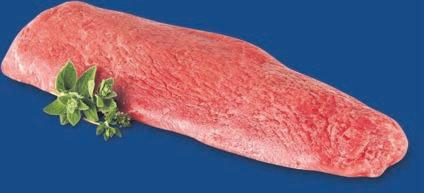




































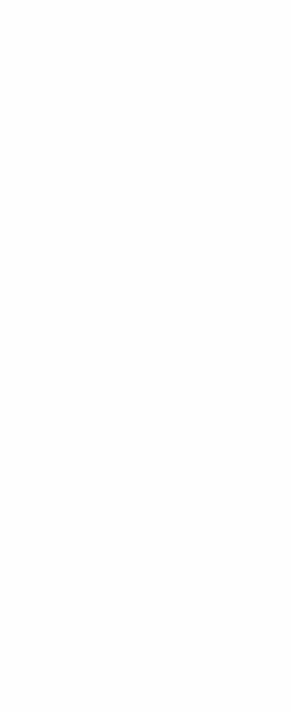



















































































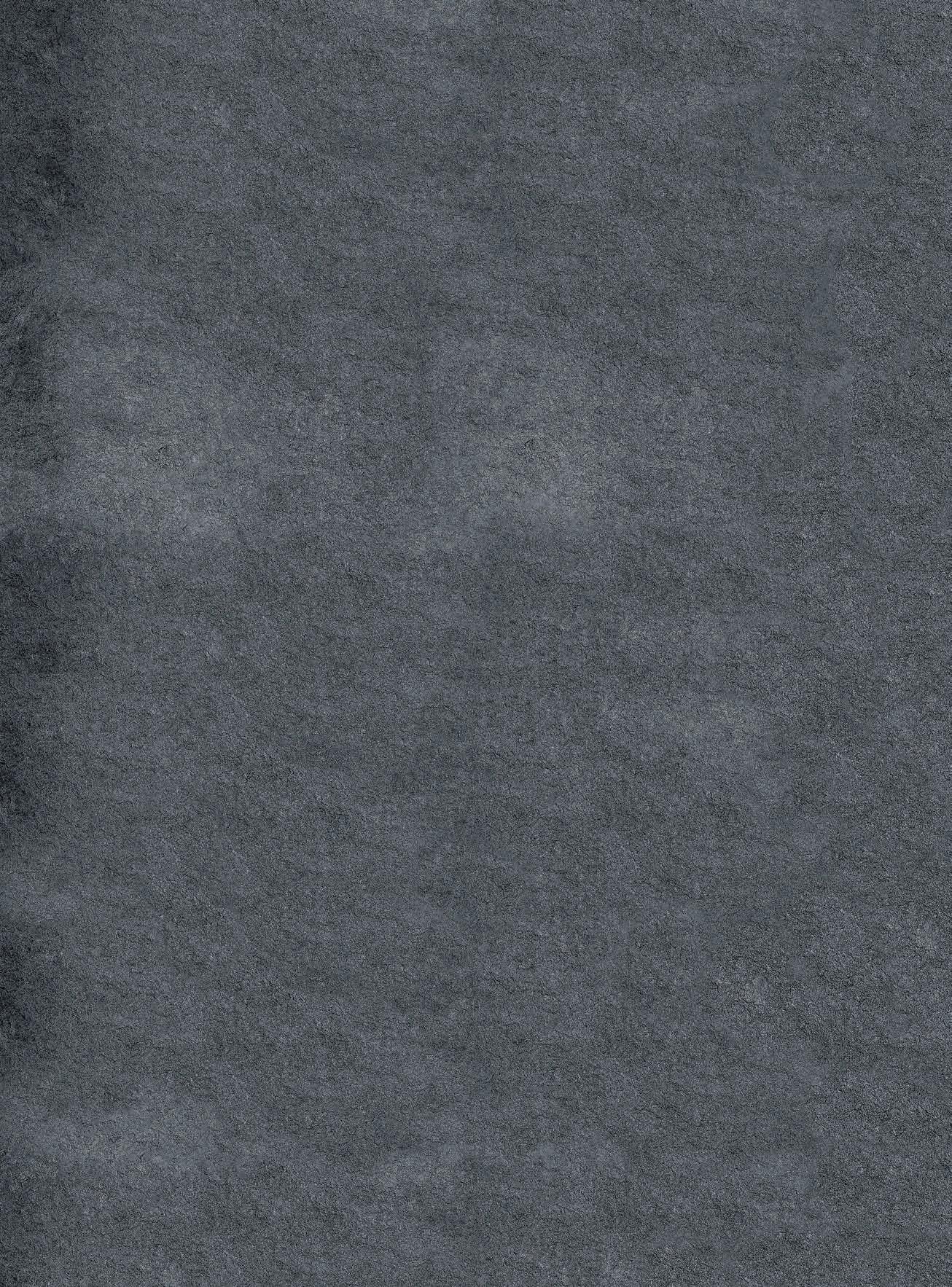

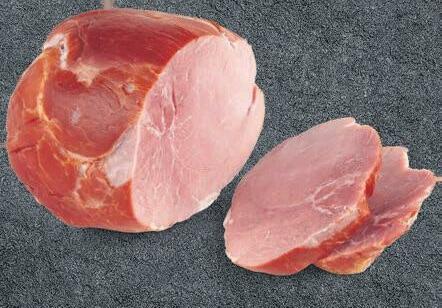











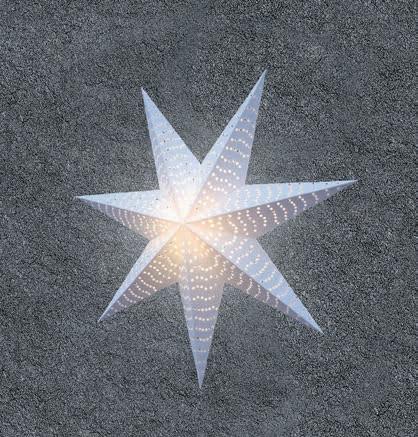






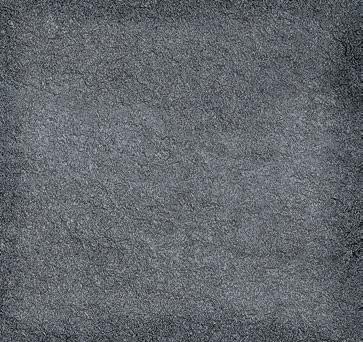





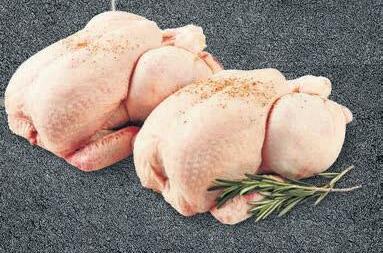

























































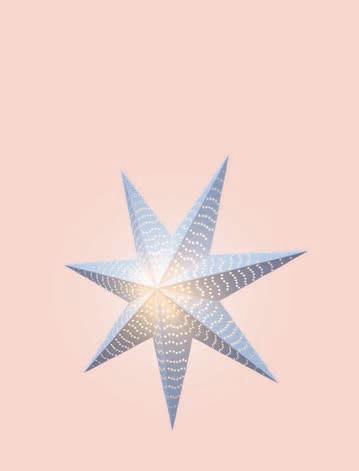





Tutti i panettoni e i pandoro San Antonio per es. Il Pandoro, 800 g, 9.– invece di 11.85, prodotti confezionati



Tutte le palline di cioccolato Freylini Frey per es. classic, 480 g, 7.80 invece di 9.80
Tutte le truffes Frey (confezioni multiple escluse), per es. assortite, 256 g, 10.– invece di 12.50































































Sollievo immediato per la pelle secca
Creme per le mani Neutrogena non profumate, profumate o ad assorbimento rapido, per es. non profumata, 50 ml, 6.95 invece di 9.30









Tutte le creme per le mani (conf. multiple, conf. da viaggio e prodotti M-Classic esclusi), per es. crema per le mani Express I am, 100 ml, 2.40 invece di 3.20





Quando fa freddo le ghiandole sebacee producono meno grassi. Inoltre l'aria riscaldata disidrata la pelle. In inverno lava quindi le mani solo con acqua tiepida e usa un sapone a pH neutro. In seguito applica una crema per le mani leggera di giorno e una crema ricca prima di andare a letto.
Assorbenti o salvaslip Molfina per es. salvaslip Bodyform Air, FSC®, 2 x 46 pezzi, 2.80 invece di 3.30





Creme per le mani I am, Atrix, Garnier, Nivea o Le Petite Marseillais per es. balsamo per mani e unghie I am, 2 x 100 ml, 4.80 invece di 6.40





Offerte valide solo dal 13.12 al 19.12.2022, fino a esaurimento dello stock.






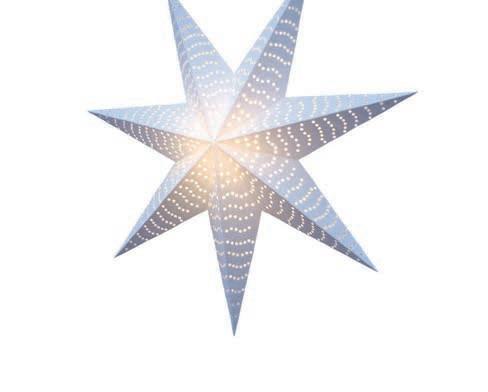









Salviettine detergenti umide Soft Deluxe, camomilla o aha! Sensitive, per es. Deluxe, 3 x 50 pezzi, 4.55 invece di 5.70











Tutto l'assortimento di biancheria intima da donna e da uomo Sloggi per es. slip da donna Tai, bianco, tg. 38, il pezzo, 10.70 invece di 17.90









































Solo da questo giovedì
Pentole delle serie Deluxe, Titan, Gastro e Prima della marca Cucina & Tavola per es. padella Titan a bordo basso, Ø 24 cm, il pezzo, 29.95 invece di 49.95, offerta valida dal 15.12 al 18.12.2022



Tutte le arance sfuse per es. arance bionde bio, Spagna/Italia, al kg, 2.15 invece di 3.10, offerta valida dal 15.12 al 18.12.2022













Da tutte le offerte sono esclusi gli articoli M-Budget e quelli già ridotti. Fino a esaurimento dello stock

