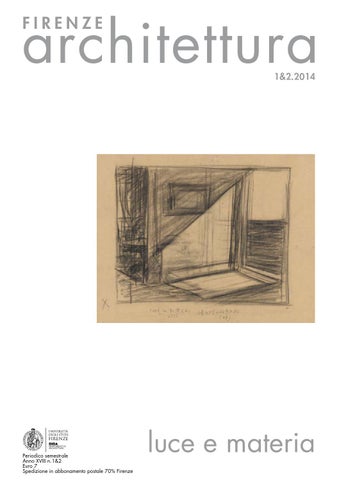luce e materia
architettura firenze
firenze architettura
1&2.2014
1&2.2014
ISSN 1826-0772
DIDA
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Periodico semestrale Anno XVIII n.1&2 Euro 7 Spedizione in abbonamento postale 70% Firenze
luce e materia
In copertina: Edward Hopper, Tow studies for Rooms by the Sea (recto), 1951 Carboncino su carta Katharine Ordway Fund 2008.144.1 Photo Credit: Yale University Art Gallery
DIDA
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Dipartimento di Architettura - DIDA - Direttore Saverio Mecca via della Mattonaia, 14 - 50121 Firenze - tel. 055/2755419 fax. 055/2755355
architettura firenze
Periodico semestrale* Anno XVIII n. 1&2 - 2014 Autorizzazione del Tribunale di Firenze n. 4725 del 25.09.1997 ISSN 1826-0772 - ISSN 2035-4444 on line
Direttore - Maria Grazia Eccheli Direttore responsabile - Saverio Mecca Comitato scientifico - Alberto Campo Baeza, Maria Teresa Bartoli, Fabio Capanni, Giancarlo Cataldi, Francesco Cellini, Adolfo Natalini, Ulisse Tramonti, Chris Younes, Paolo Zermani Redazione - Fabrizio Arrigoni, Valerio Barberis, Riccardo Butini, Francesco Collotti, Fabio Fabbrizzi, Francesca Mugnai, Alberto Pireddu, Michelangelo Pivetta, Andrea Volpe, Claudio Zanirato Grafica e Dtp - Massimo Battista Segretaria di redazione e amministrazione - Grazia Poli e-mail: firenzearchitettura@gmail.com Proprietà Università degli Studi di Firenze Gli scritti sono sottoposti alla valutazione del Comitato Scientifico e a lettori esterni con il criterio del Blind-Review L’Editore è a disposizione di tutti gli eventuali proprietari di diritti sulle immagini riprodotte nel caso non si fosse riusciti a recuperarli per chiedere debita autorizzazione The Publisher is available to all owners of any images reproduced rights in case had not been able to recover it to ask for proper authorization chiuso in redazione novembre 2014 - stampa Bandecchi & Vivaldi s.r.l., Pontedera (PI) *consultabile su Internet http://www.dida.unifi.it/vp-146-firenze-architettura.html
architettura firenze
1&2.2014
editoriale
Light is much more Alberto Campo Baeza
percorsi
James Turrell This must be the place: il Roden Crater Agostino De Rosa
12
La costruzione di nuove chiese e il tema della luce naturale Massimiliano Bernardini
20
Mangiarotti Morassutti Favini Il restauro della Chiesa di Baranzate Giulio Barazzetta
24
Studio TAMassociati Le stanze del silenzio Raul Pantaleo
34
João Luís Carrilho da Graça Una palpitante bellezza Fabiola Gorgeri
42
Yung Ho Chang Atelier FCJZ - Vertical Glass House Vetri Fabrizio Arrigoni
54
Kengo Kuma: Risarcire i luoghi attraverso vedute e trasparenze Andrea Volpe
62
Miti di luce effimera Alberto Pireddu
72
L’Arte dell’Architettura - La Scuola di Luciano Semerani Antonio Monestiroli
82
Laura Andreini - Archea Luce, Materia, Architettura Laura Andreini
90
MDU Architetti Luce e materia Marcello Marchesini
98
luce e materia
ricerche
atlante dida
eredità del passato
eventi
letture a cura di: english text
2
Maria Grazia Eccheli Riccardo Campagnola Riverbero tra i canneti
106
Lo spazio gonfiante del Mercato dei Fiori di Pescia una interpretazione Fabio Fabbrizzi
110
Danteum la luce si fa corpo Francesco Collotti
118
Dichtung und Wahrheit. Scarpa a Castelvecchio: l’invenzione della luce Riccardo Campagnola
128
Angiolo Mazzoni in Toscana Mostra itinerante Giulio Basili Galleria dell’architettura italiana Monestiroli Architetti Associati. Aule Salvatore Zocco Forlì, Musei San Domenico Liberty - Uno stile per l’Italia moderna Fabio Fabbrizzi Venezia 2014 Due passi e un salto alla Biennale Architettura Michelangelo Pivetta Roma, Accademia Nazionale di San Luca Eur sconosciuta Andrea Volpe Giuseppina Farina, Martina Landsberger, Fabrizio Arrigoni, Ulisse Tramonti, Riccardo Renzi, Ugo Rossi, Mirko Russo, Ezio Godoli, Silvia Mantovani
140 146 150 154 158 162 166
LIGHT IS MUCH MORE Alberto Campo Baeza
LIGHT IS MUCH MORE Quando un architetto scopre che la luce è il tema centrale dell’Architettura, allora inizia a essere un vero architetto. Ogni giorno che passa, sono sempre più convinto di ciò che ho scritto e pubblicato ormai più di quindici anni fa. Materiale lussuoso La luce è il materiale più bello e lussuoso che gli architetti possano usare. L’unico problema è che è gratuito, che è a disposizione di tutti e, pertanto, non lo si valorizza sufficientemente. Gli architetti antichi usavano marmi e bronzi, mentre gli architetti più moderni utilizzano acciaio, plastiche speciali e vetri. Tutti con l’intento di costruire architetture capaci di permanere nella memoria degli uomini, di durare nel tempo. E solo gli architetti più grandi, i maestri, hanno compreso che la luce, proprio la luce, è il principale materiale con cui l’architettura è capace di sconfiggere il tempo. Lo capirono tanto Adriano quando costruì il Pantheon quanto Antemio di Tralles o Isidoro di Mileto quando innalzarono Santa Sofia, o Mies Van der Rohe quando realizzò la Casa Farnsworth. Emozione E per rivelare la luce, darle solidità, è necessaria l’ombra. L’adeguata combinazione di luce e ombra è solita risvegliare nell’architettura la capacità di commuoverci profondamente, fino alle lacrime, e convocare la bellezza e il silenzio. Quando durante questi ultimi anni molti dei miei studenti hanno visitato il Pantheon di Roma, puntualmente mi hanno scritto una cartolina dicendomi: “ho pianto”. Quelli che non “hanno pianto” non mi hanno scritto. Così ne discutiamo in aula e loro mantengono la promessa.
2
Quando gli impiegati della Caja de Granada entrarono a lavorare per la prima volta nel mio edificio a Granada, alcuni si commossero profondamente e piansero. Non smetto di andare a visitarli ogni volta che vi torno. E quando la Regina di Spagna entrò nell’edificio per consegnare alcuni premi, ebbe la generosità di elogiarne la bellezza della luce. E la stampa raccolse puntualmente gli elogi. Lei capì perfettamente che la luce è il tema centrale di qualsiasi Architettura. Come il sale Spesso ho comparato, nelle mie lezioni, la luce col sale. Quando la luce si dosa con precisione, come il sale, lo stufato dell’architettura raggiunge il suo punto giusto. Più luce di quella necessaria disfa, dissolve l’architettura. E meno la lascia insipida, muta. Esattamente come la mancanza di sale nella cucina lascia gli alimenti insipidi, l’eccesso li rovina. In generale quasi tutti gli architetti eccedono nell’uso del sale, della luce. Qualità della luce E se la quantità di luce utilizzata è importante, non lo è di meno la qualità. Così ha sempre insegnato la Storia. Quando l’Architettura grazie all’acciaio che permette di aprire grandi vuoti e al vetro che consente di chiuderli cambia il concetto di luce solida con quello di trasparenza, si produce una profonda rivoluzione. Nel Pantheon di Roma, la sapienza dell’architetto porta a incorniciare la massima quantità di luce con la massima quantità di ombra. E, così, l’oculo luminoso è circondato dall’ombra più profonda che rende, se mai fosse possibile, ancora più luminosa quella luce divina venuta dall’alto.
Alberto Campo Baeza Appunti
3
A Santa Sofia, Istanbul, i brillanti architetti aprono una corona di alte finestre attraverso le quali non solo penetra la luce diretta, ma anche quella indiretta, riflessa dai profondi stipiti bianchi in un modo tale che pare un miracolo veder incrociarsi i raggi di luce nell’aria. Nella Casa Farnsworth, l’architetto con la stessa sapienza dei suoi predecessori, però già esperto dell’acciaio e del vetro, decide di proporci la trasparenza assoluta. E lì la luce sospesa nell’aria ci evoca “il soffio dell’aria soave” con cui il profeta evoca la presenza della divinità. Per cosa Si potrebbero scrivere migliaia di libri sulla luce. Suggerisco quelli di Henry Plummer e le opere di Le Corbusier. In queste brevi note introduttive non voglio fare altro che rivendicare, ancora una volta, il valore massimo della luce come materiale primo e principale con cui lavoriamo noi architetti. E che ci è concesso gratuitamente ogni giorno. Col fine di permanere nella memoria e nel cuore della gente. Per renderli felici con l’Architettura. Le mie opere alla luce della luce Cercherò di far luce sulla comprensione della LUCE nelle mie opere. La Casa Gaspar a Cadice, “Hortus Conclusus”, è una casa piena di OMBRA, dove i quattro grandi vuoti degli spigoli fanno sì che passi la luce silenziosa in una chiara operazione di TRASPARENZA per ottenere la continuità dello spazio contenuto nei patii. La Casa Turegano a Madrid, “Bianca e Cubica Capanna”, è una scatola attraverso la quale entra abbondantemente il SOLE del sud. La luce speciale dell’OVEST, che al tramonto catturiamo attraverso una
4
grande vetrata aperta in alto a ovest, è una lezione che ho appreso nelle case di Pompei, che utilizzano lo stesso meccanismo. La Casa Asencio a Cadice utilizza, con maggiori dimensioni, gli efficaci meccanismi della Casa Turegano ma l’orientamento è differente, la grande vetrata si apre qui nel tetto come un grande lucernario attraverso il quale entra una cascata di LUCE. La Casa De Blas a Madrid, “Belvedere”, sviluppa una operazione di TRASPARENZA a favore dello spettacolare PAESAGGIO che ci si offre dinanzi. Così si SOTTOLINEA il paesaggio valorizzandolo. In basso, all’interno del podio pieno d’ombra, si apre una finestra quadrata che INCORNICIA lo stesso paesaggio allontanandolo. Il Centro BIT a Mallorca, “Giardino Segreto”, è un giardino quasi biblico di 24 poderosi aranci racchiusi in una scatola di travertino aperta verso il cielo. Per dotarla di OMBRA per lavorare, la si copre con un tetto leggero in una operazione di massima TRASPARENZA. La CAJA de GRANADA a Granada, “Impluvium di LUCE”, è, tra le altre cose, una scatola cubica di vetro e alabastro al centro di una più ampia scatola di cemento armato, con 9 potenti lucernari di dimensioni tali e in posizione tale che il SOLE tutti i giorni li attraversa facendo sì che alla LUCE si accompagnino la BELLEZZA e il SILENZIO.
5
LUCE La Luce è una componente essenziale, imprescindibile per la costruzione dell’Architettura. La Luce è MATERIA e MATERIALE. Come la pietra. Quantificabile e qualificabile. Controllabile e misurabile. Senza Luce NON c’è Architettura. Avremmo solo costruzioni morte. La Luce è l’unica capace di mettere in tensione lo spazio per l’uomo. Di porre in relazione l’uomo con lo spazio creato per lui. Gli conferisce tensione, lo rende visibile. La Luce che da ragione del TEMPO, la LUCE COSTRUISCE il TEMPO. Di come la luce vince la gravità La Luce, materiale perennemente in movimento, è precisamente l’unica capace di far sì che gli spazi plasmati da forme costruite con materiali pesanti, galleggino, levitino. Fa volare, sparire la Gravità, la vince. L’insopportabile pesantezza della materia, inevitabile e imprescindibile, può essere vinta solo dalla Luce. L’imponente massa del Pantheon, la cui forma sferica ideale palesa la potenza schiacciante di quello spazio, grazie alla magia del sole che attraversa l’oculo magnifico, si innalza in un movimento ineffabile, come se si trattasse di una levitazione. La Luce vincendo la Gravità convoca la Bellezza sublime. Ed è curioso, o non tanto curioso, che le invenzioni tecnologiche che hanno reso possibile la rivoluzione in Architettura siano direttamente relazionate con la Luce e la Gravità: il vetro piano di grandi dimensioni e l’acciaio, solo o come armatura del calcestruzzo. Il vetro piano rende possibile la rivoluzione copernicana della Luce verticale che incide il piano orizzontale sulla testa
6
dell’uomo. Rende possibile la trasparenza del piano orizzontale superiore. L’acciaio, solo o nel calcestruzzo armato, rende possibile l’ulteriore rivoluzione copernicana di poter separare il tamponamento dalla struttura portante. La pelle dalle ossa. Quelle ossa, quei pilastri, attraverso i quali ora scorrerà l’ineludibile Gravità fino a incontrarsi con la terra. Il passaggio chiarificatore del tempo Il Tempo, costruito per mezzo della Luce, fa scomparire lentamente e pazientemente gli elementi superficiali con cui tante volte si adorna l’Architettura frivola, vanitosa. Il Tempo, come il medico che cercasse di restituirla alla vita, la spoglia fino a lasciarla nella sua essenzialità. L’Architettura resta allora con i sui attibuti essenziali. Dimensione, proporzione, e scala danno vita al materiale che porta al suo interno la tensione invisibile della Gravità. E tutto ciò è toccato dalla Luce che, costruttrice del Tempo, produce la tensione visibile che lascia muto l’uomo. Ciò, paradigmaticamente, appare a volte nella rovina che, spogliata di ogni ornamento superfluo, si innalza radiosa di fronte a noi con lo splendore della nuda Bellezza. Quando Heidegger, con parole precise, parla del “solido germogliare del tempio che rende visibile lo spazio invisibile dell’aria”, fa sorgere dinanzi a noi la “rovina” del Partenone in tutto il suo splendore come Architettura Essenziale, che sembra ascoltare le sue parole: “il tempio, nel suo sussistere, fa sì che le cose siano presenti e che gli uomini prendano coscienza della loro presenza”.
7
L’aria si rasserena e si veste di bellezza e luce sconosciuta
to, ben sviluppato e ben costruito perché vi possa suonar bene l’Architettura.
In questo testo si cerca di stabilire un parallelismo tra lo strumento musicale e lo spazio architettonico. Lo strumento musicale tramite l’aria produce il regalo della Musica. Lo spazio architettonico, mediante la luce, quel qualcosa di ineffabile che è l’Architettura.
IDEA. CONCEzione Lo strumento musicale e lo spazio architettonico devono essere ben concepiti. È imprescindibile avere un’idea chiara di ciò che si vuol fare. E, dopo, sapere come farlo, controllare con precisione le forme, le dimensioni e le proporzioni che portano a conseguire il risultato cercato. Se uno vuole ottenere il timbro di un violino, dovrà concepirlo nelle forme e nelle dimensioni del violino. Un violino non è uguale a un violone. Oggi ascoltavo in radio un programma su un Museo che espone strumenti musicali. E mi sembrava “contro natura” che gli strumenti musicali, la cui ragion d’essere è la musica, fossero esposti come se si trattasse di cadaveri, morti. Gli strumenti musicali servono per suonare, per fare musica, quando l’aria passa attraverso essi e si produce il miracolo. Se un architetto vuole ottenere uno spazio messo in tensione dalla luce - può esistere uno spazio senza luce? - dovrà concepirlo con forme e proporzioni precise perché l’edificio si risvegli ogni mattina e, al ritmo della luce che scandisce il tempo, viva durante il giorno, durante il TEMPO. L’idea di un progetto deve contenere dal suo concepimento questa ineludibile relazione con la luce. Non mi stancherò mai di insistere sul fatto che l’IDEA chiara di un progetto è la base imprescindibile perché appaia l’Architettura. E la LUCE deve essere parte centrale di quella IDEA. È in questa prima fase che si decidono le PIANTE dell’opera di Architettura. È la fase in cui si deve sapere che cosa è e come si costruisce uno spazio architettonico.
“L’aria si rasserena e veste di bellezza e LUCE sconosciuta, Salinas, quando suona la MUSICA formidabile, governata dalla vostra mano sapiente”. Inizia così l’Ode III a Francisco Salinas dove Fray Luis de León parla della LUCE e della MUSICA con sì splendide parole. Il fatto è che uno spazio architettonico è simile a uno strumento musicale. E tanto negli strumenti a fiato come in quelli a corda, il segreto è nell’ARIA. L’aria passa attraverso lo strumento a fiato e vibra nello strumento a corda. E tanto l’aria soffiata in un flauto quanto quella fatta vibrare dalle corde tese di un violoncello, producono quella sublime cosa che è la musica. Senza ARIA non sarebbe possibile la MUSICA. Similmente, la LUCE, la luce naturale, la luce del sole, attraversando uno spazio sapientemente messo in tensione dall’architetto, per mezzo di precise bucature, produce quell’ineffabile emozione che solo l’Architettura è capace di risvegliare. Senza LUCE non sarebbe possibile l’ARCHITETTURA. LUCE che tempera l’aria contenuta nello spazio architettonico. E se affinché in uno strumento musicale suoni la musica, è necessario che esso sia ben concepito, ben costruito e ben accordato, così è altrettanto necessario che lo spazio architettonico sia ben idea-
8
9
Sviluppo. accordo E se dopo la sua perfetta costruzione, lo strumento musicale richiede di essere accordato, altrettanto accade con lo spazio architettonico. E questo affinamento architettonico non è la pur plausibile attenzione che alcuni architetti dedicano al dettaglio. Il perfezionamento, in questo caso, appartiene alla precisione nella relazione dello spazio con la LUCE. María Zambrano diceva della Poesia che era “la parola accordata con il numero”. E, analogamente, Osip Mandelstam annotava che “in Poesia tutto è misura”. Ecco, questa precisione che è la condizione sine qua non nella Poesia, lo è anche nella Musica e nell’Architettura. La precisione è imprescindibile in ogni creazione artistica. La massa confonde la creazione artistica, l’arte, con il gesto, l’arroganza, o la forma capricciosa. Esattamente al contrario, la creazione artistica richiede una enorme precisione e perfezionamento, e esige sapienza e tempo da parte dell’artista che crea l’opera d’Arte. Perché uno strumento musicale arrivi a suonare con quella musica formidabile descritta da Fray Luis de León, dopo essere stato ben costruito, ha bisogno di essere ben accordato. Negli strumenti a corda, le corde devono essere tese con assoluta precisione perché vibrino nel modo migliore. E negli strumenti a fiato, i diametri dei tubi e dei fori che si praticano in essi devono essere realizzati con estrema accuratezza. Affinché l’Architettura suoni con musica divina quando è attraversata dalla LUCE, è necessario che sia ben affinata. È necessario che la posizione, la forma e la dimensione delle aperture con le quali si relaziona con l’esterno, con la LUCE, siano perfettamente definite dall’architetto. Le porte, le finestre, i lucernari possono, devono intendersi come
10
perforazioni nello spazio architettonico, che lo pongono in relazione con la luce, con le viste e con l’aria. Tutto ciò deve essere definito con precisione in questa seconda fase che è il PROGETTO ESECUTIVO. Il PROGETTO ESECUTIVO non è un mero sviluppo meccanico delle prime idee. È un autentico accordo dello strumento. COSTRUZIONE Una volta costruito e accordato lo strumento musicale, è necessario saperlo suonare molto bene. Un buon interprete musicale dinanzi a un valido strumento musicale ben accordato saprà ottenere le note precise capaci di commuoverci nel profondo. Saprà far vibrare l’aria in maniera tale che muova il nostro cuore. In Architettura, dopo l’IDEA concepita, come una costruzione mentale, e dopo il suo sviluppo dettagliato in quello che gli architetti chiamano PROGETTO ESECUTIVO, l’interpretazione del pezzo è precisamente la sua COSTRUZIONE MATERIALE, la sua messa in piedi. Questa costruzione materiale è una vera e propria interpretazione di quella prima idea. Costruzione materiale che non è nemmeno essa una meccanica esecuzione di quel progetto esecutivo. Un’attenta direzione dei lavori permette all’architetto di perfezionare ulteriormente, se possibile, l’organismo architettonico. Ho citato spesso Saramago per dire, con le sue parole, che noi architetti abbiamo come dei piccoli cervelli nella punta delle dita, e ciò fa sì che si possa dire che pensiamo con le mani. E leggevo da poco che un gran compositore sivigliano del XVII secolo, Francisco Guerrero, per elogiare Pedraza, il meraviglioso organista della Cattedrale di Siviglia diceva: “in ognuna di quelle dita vedo un angelo”. Ecco: un
architetto è qualcuno che costruisce idee e pensa e suona con le mani. Nel caso della Musica è semplice distinguere tra costruzione, accordo e suono dello strumento. Nel caso dell’Architettura, è la costruzione fisica, materiale, ciò che noi consideriamo come interpretazione di quella prima idea. E poi la LUCE, come l’aria nella Musica, attraverserà lo spazio creato dall’architetto perché possa suonare. E, come se si trattasse di un miracolo, quando la LUCE arriva, si produce quel poter come toccare il tempo, qualcosa che, pur sembrando impossibile, è alla nostra portata e ci si chiude il cuore in un pugno. Sospendere il tempo dicono i poeti. Che la LUCE costruisce il tempo non è una frase corretta per un testo pedagogico. Quel miracolo speciale è una realtà tangibile alla nostra portata. FINALE In definitiva, se imposto questa comparazione tra strumenti musicali e spazi architettonici, è per insistere ancora una volta su come le opere di Architettura che ci interessano, non siano frutto del capriccio né della moda né dell’arbitrarietà né di formalismi capaci di stupire gli ignoranti. Al contrario, l’Architettura reclama chiarezza nelle idee generose, precisione nello sviluppo e adeguatezza nella costruzione. E sempre il saper intendere la LUCE come materiale principale. È ben nota la classificazione che Paul Valéry, nel suo Eupalinos, fa delle opere di Architettura: edifici muti, edifici che parlano e edifici che cantano. Perché “cantino”, gli edifici devono essere ben concepiti, ben ‘accordati’ e ben costruiti. E così l’Architettura canterà con la musica più elevata e sarà capace di illuminare e rendere felici gli uomini. Traduzione di Alberto Pireddu
11
James Turrell
This must be the place: il Roden Crater Agostino De Rosa
Il Roden Crater project, situato in un remoto angolo nel Painted Desert (Arizona) è un land-formed work al quale l’artista statunitense James Turrell (Los Angeles, 1943) lavora da più di trent’anni. L’intento del progettista è quello di trasformare un cono di ceneri estinto, generato da secoli di attività geologica, in un’opera d’arte a scala paesaggistica capace di intessere, per mezzo della luce, declinata in tutte le sue possibili manifestazioni fisiche e metafisiche, un fitto dialogo con l’ambiente naturale che la circonda, sia a quota terrestre che celeste. Per la progettazione vera e propria, Turrell si è avvalso della collaborazione di architetti ed ingegneri, che hanno garantito il rispetto di elevati standard esecutivi e normativi, mentre, per quanto riguarda l’orientazione cardinale e siderale dei singoli spazi, dell’aiuto di astronomi. Pur essendo monumentale nelle dimensioni e inedito nella concezione, il Roden Crater project non nasce per commemorare eventi o ricorrenze storiche, ma vuole essere una sorta di tempio in cui si celebra la percezione umana nella unicità della sua esperienza: l’individuo che godrà del privilegio di entrare nel corpo sotterraneo del cratere, avrà modo di ridefinire non solo il proprio modo di percepire i fenomeni naturali, ma anche di commisurasi con la scala degli eventi celesti, in una perfetta e risonante corrispondenza tra micro- e macro-cosmo. Il Roden Crater project è dunque la sintesi di anni di intenso lavoro per James Turrell, anzi di un’intera vita: qui infatti lo scopo manifesto dell’artista è quello di usufruire delle ricerche e delle idee che hanno ispirato le sue installazioni precedenti, proiettandole a scala paesaggistica in modo da poter godere delle qualità psico-percettive associabili alla luce naturale, diurna e notturna, e al
12
moto apparente o reale dei corpi celesti. La luce, vero cardine dell’intero progetto, penetrerà all’interno della superficie del cratere attraverso aperture e gallerie, opportunamente orientate e quasi invisibili dall’esterno: i vani sotterranei funzioneranno come mantici luminosi e camere oscure, gli specchi d’acqua ipetrali agiranno come lenti che magnificheranno gli effetti di riflessione della luce desertica, ed i lunghi tunnel come condotti ottici che decanteranno le immagini del Sole e della Luna, in particolari giorni dell’anno. La forma degli ambienti, che configurano l’intero progetto, non è determinata da principi estetici, bensì dalla loro funzione principale: quella di accogliere, dirigere e conservare la luce. Lo scopo dell’opera, secondo l’autore, è quello di incorporare una precisa sequenza di fenomeni atmosferici e celesti al suo interno e offrirli al sistema percettivo del visitatore: “Il mio desiderio è quello di predisporre un evento al quale condurre l’osservatore e lasciare che sia lui a vederlo. Sto facendo questo al Roden Crater. Non si tratta tanto di appropriarsi della natura, quanto di porre l’osservatore in contatto con essa”.1 L’organizzazione spaziale e cardinale dei singoli ambienti, ma anche la struttura panoramica o ipogea dei percorsi che li collegheranno, agiranno in maniera interattiva: il paesaggio desertico sempre mutevole, grazie alle continue variazioni meteorologiche, offrirà infinite suggestioni percettive che inevitabilmente influenzeranno la fruizione degli spazi interni, predisponendo all’epifania di un silenzioso e remoto fenomeno celeste in un ambiente immerso nell’oscurità, o alla visione di fugaci luci occidue che modificano le dimensioni apparenti di una stanza. Ma, naturalmente, il processo è re-
1
1 Roden Crater, Arizona Veduta delle coperture dell’Alpha Space (East Portal) e dell’Eye of the Crater 2 Planimetria del Roden Crater project Legenda: 1-South Lodge, 2-South Space, 3-East Space, 4-Fumarole Space, 5-Sun and Moon Space, 6-Alpha Tunnel, 7-East Portal, 8-Eye of the Crater, 9-West Portal, 10-Beta Tunnel, 11-North Moon Space, 12-Amphitheater, 13-North Space, 14-Sunrise tearoom, 15-West space Pagine successive: 3 Veduta interna dell’Eye of the Crater 4 Il rim del Roden Crater 5-6 La rampa di accesso al cratere 7 L’Alpha Space (East Portal) visto dall’ultimo tratto dell’Alpha Tunnel 8-9 Percorrendo, in salita, l’Alpha tunnel Foto Agostino De Rosa
2
13
15
5
versibile, dall’interno all’esterno quando, abbandonando la materna ricettività delle camere interrate, si approderà in luoghi all’aperto dove lo sguardo sembrerà non raggiungere mai i suoi limiti massimi, e l’udito, dopo le fantasmagorie degli echi sotterranei e delle whispering galleries, si re-immergerà nel silenzio ‘frastornante’ del Painted Desert. La dimensione sensoriale acustica non è secondaria all’interno dell’opera: sotto la regia attenta di Hiroshi Morimoto (Berkeley, California) il Cratere risuonerà non solo in consonanza con gli spazi terrestri che lo circondano, ma soprattutto con quelli celesti che abitiamo inconsapevolmente. In particolare, nell’ambiente in costruzione chiamato Fumarole space, un oculo sommitale consentirà di inquadrare la regione celeste sovrastante, compresa in un angolo di 22°33’4”, a chi siederà nello sky bath: si tratta di una vasca in una lega bronzeo con un percentuale minima di silicone, ancorata al pavimento e caratterizzata da una superficie interna a doppia
16
curvatura. La sezione longitudinale mostra infatti un profilo semi-parabolico, il cui fuoco si collocherà esattamente in corrispondenza dell’estremo occidentale del diametro dell’oculo superiore. La relazione tra la superficie paraboloidica del catino bronzeo e questo punto della struttura non è casuale, ma prevista attentamente da James Turrell, in modo che il sistema creato da questi elementi si configuri come un semi-telescopio Cassegrain: qui però, quelle raccolte dallo strumento non saranno tanto le informazioni fotoniche provenienti dagli oggetti celesti, bensì le relative onde radio. La musica delle sfere sarà finalmente udibile dal visitatore quando questi si immergerà, fino alle orecchie, nell’acqua riscaldata contenuta nella vasca: il liquido, infatti, fungerà da cassa di risonanza per le informazioni acustiche captate da un apparecchio ricevente a cristalli di quarzo, collocato proprio nel punto focale di cui si diceva. Nelle intenzioni di Turrell, i corpi celesti i cui segnali radio risuoneranno all’interno dello sky bath sa-
ranno, nell’ordine: il Sole; il pianeta Giove; la radiazione cosmica di fondo (abbreviata in CBR, da Cosmic Background Radiation); la via Lattea; il residuo della supernova nota come Nebulosa del Granchio (M1), posta nella costellazione del Toro; e infine β Cassiopeiae. Naturalmente, i segnali emessi da questi oggetti celesti arriveranno sulla Terra in forma molto indebolita e confusa: per ovviare a questi problemi, James Turrell ha previsto che attorno al cratere saranno collocate quattro antenne riceventi, alla cui sommità verranno disposti poli opportunamente orientati per captare le informazioni radio solo da uno degli elementi siderali selezionati. A tradurre i dati in segnali sonori sarà, come si diceva, un semplice crystal set (o crystal radio receiver), funzionante senza l’ausilio di pile, e in grado di ricevere trasmissioni in onde medie e corte da migliaia di chilometri di distanza. L’acqua del catino svolgerà il ruolo solitamente affidato, in questo tipo di apparecchi riceventi, alle cuffie ad alta impedenza. Il coinvolgimento corporeo
del fruitore che, in pieno deserto, dovrà immergersi nella vasca, implicherà una sua partecipazione emotiva totalizzante: il tepore dell’acqua indurrà uno stato di rilassatezza muscolare, predisponendolo all’epifania dei suoni celesti che potrà avvenire, indifferentemente, di giorno o di notte. Inoltre, Il Fumarole space, in qualità di radio-telescopio, potrà catturare e riprodurre anche i segnali sonori provenienti dall’ambiente ecologico circostante, come ad esempio, quelli generati dalle Grand Falls collocate a circa quattro miglia di distanza, verso est, lungo il percorso del Little Colorado River. Proprio dalla constatazione dei lunghi tempi previsti per il completamento del Roden Crater project è nata l’idea, maturata nel 2002 presso l’Università Iuav di Venezia e da me coordinata scientificamente, di realizzare un modello digitale interattivo dell’intero complesso, grazie al quale fosse possibile descrivere e documentare criticamente - sia dal punto di vista figurativo che tecnico-scientifico - il
ruolo che la luce, l’ombra e la lettura dei fenomeni celesti svolgono e svolgeranno nella definizione degli spazi architettonici progettati da James Turrell.2 I risultati di questa ricerca, condotti attraverso uno stretto contatto tra l’équipe veneziana e l’artista californiano, hanno costituito il nucleo di una serie di mostre (Aula Gino Valle dell’Università IUAV di Venezia, ottobre 2007; Galleria e collezione Panza di Biumo, Varese, giugno-agosto 2008; Palazzo Riso, Museo d’Arte Contemporanea della Sicilia, Palermo luglio 2009; Museo Solomon R. Guggenheim, New York 2013) e del relativo catalogo, in cui sono state (e saranno in futuro) esposte, oltre alle ricostruzioni digitali di ciascuna singola installazione, soprattutto gli inediti metodi combinatori dei così tanti saperi coinvolti nell’opera di Turrell, definendo i ruoli che il progetto e la sua rappresentazione geometrica giocano all’interno di ambienti che si situano al confine tra architettura tout-court, progettazione paesistico-ambientale e archeo-astro-
nomia. Le ambienze sonore delle mostre sono state curate da un team di musicisti, provenienti dall’area dell’improvvisazione jazz e da quella della musica contemporanea ed elettro-acustica (Maria Pia De Vito, Maurizio Giri, Michele Rabbia, Anja Lechner e Eivind Aarset), che hanno scritto e improvvisato la colonna sonora di un video digitale, prodotto da Imago rerum-Iuav, suggestivo dei futuri scenari - terrestri e celesti - visibili nel sito. Come è facile desumere, la ricerca artistica di James Turrell nel Roden Crater project coinvolge molteplici discipline e interessi, ma ognuna di esse ruota intorno ad un centro immobile, costante e onnipresente: la percezione, soprattutto quella visiva, nel suo modo di strutturarsi e de-strutturarsi attraverso l’impiego controllato della luce, artificiale e naturale. Come ha osservato Theodore Wolff l’opera di James Turrell ammette diversi livelli esegetici: “…come motivata sul piano estetico; come una dimostrazione accuratamente calcolata di certe leggi applicabili
17
7
alla percezione e alla cognizione umana; come un processo demistificatorio teso a incrementare la consapevolezza del funzionamento della relazione tra l’uomo e il suo ambiente; come uno strumento per investigare stati mentali sottilmente trascendentali o metafisici”.3 Nonostante Turrell non attribuisca, almeno in apparenza, alcun significato mistico-religioso alle sue creazioni artistiche, in esse è potentemente attivo l’archetipo della luce, riconducibile alle sue radici quacchere, e alle correlate pratiche del silenzio e dell’accoglienza della radiazione luminosa. I suoi spazi fin dagli esordi, si servono di un vocabolario ‘limitato’ di elementi che si combinano a seconda delle esigenze del luogo o della funzione, nel rispetto di un rigorosa sobrietà di soluzioni formali e scelte materiche. La grammatica formale di James Turrell è come fondata su una serie ristretta di segni la cui elasticità e la cui bellezza, isolate o derivate dalla reciproca combinazione, ne fanno una serie di ‘concetti assoluti’, prossimi alle scelte
18
linguistiche di un importante architetto contemporaneo, Tadao Ando, con il quale, fra l’altro, l’artista ha frequentemente collaborato. Due elementi avvicinano decisamente il modo di Ando e di Turrell di impiegare la luce nelle loro realizzazioni: anzitutto l’idea che la luce possa sinesteticamente trasformarsi in materia quasi tangibile, odorabile, udibile. Scrive Ando: “La luce dona un’esistenza agli oggetti in quanto tali e relaziona lo spazio alla forma. Isolato in uno spazio architettonico, un raggio di luce indugia sulla superficie degli oggetti e evoca le ombre sul fondo. Quando l’intensità della luce varia seguendo i cambiamenti temporali e stagionali, anche l’apparenza degli oggetti muta. Ma la luce non diventa oggetto, né prende forma finché gli oggetti materiali non l’hanno accettata ed isolata”.4 Per Turrell: “...lavorando con la luce, ciò che è veramente importante... è creare una esperienza di pensiero senza parole, rendere la qualità e la sensazione della luce stessa in qualche modo realmente vicina al tatto. Spesso
la gente si sporge e cerca di toccarla”.5 Il secondo aspetto che lega i due personaggi è l’interesse per il dissolvimento dei limiti spaziali: da un lato, James Turrell ha sperimentato la possibilità di colmare un ambiente o con una foschia luminosa e colorata tale da essere difficilmente discriminabile il confine di un ambiente, o con un’ombra tale che i contorni energetici dell’opera siano indistinguibili “dalla luce idioretinale prodotta nella rètina da una casuale scarica nervosa”;6 dall’altro, Tadao Ando sfrutta l’ombra per definire, all’interno dei suoi edifici, delle terre ignote i cui confini fisici, puramente accademici, sono scalzati dalla mobilità di fendenti luminosi che rivelano la natura più riposta e rituale di uno spazio. Strumento teso ad ampliare i confini della percezione, ad implementare la conoscenza del mondo fenomenico, per James Turrell la luce non è veicolo di informazioni, poiché essa stessa, e di per se stessa, è informazione: “le mie opere non sono uno sguardo su qualcosa, bensì
uno sguardo dentro qualcosa; non il posizionamento di una massa, ma l’intervenire nello spazio; non oggetti in una stanza, bensì la stanza. Il formato non è costituito da cose all’interno di un ambiente, ma è l’ambiente stesso”.7 Turrell crea, con le sue installazioni luminose, volumi di luce e ombra che vengono percepiti come essenze fluttuanti, e l’osservatore è disorientato tra la consapevolezza della loro immaterialità e l’illusione che comunque esse costituiscano un’entità percepibile, talvolta più degli oggetti materiali. “Più che essere incentrate sulla percezione (il che potrebbe ritenersi valido per l’arte minimalista o, complessivamente, per tutta l’arte), le immagini luminose di Turrell sono composte dalla percezione. I suoi ‘oggetti’ sono luce e spazio, e sono così fondamentalmente integrati con la percezione che sarebbe senza senso separare queste opere dalla psicologia e dai processi psicologici che esse disgelano”.8 Sorge allora la domanda se sia lecito, nel caso di simili opere, l’uso dei tradizionali
metodi della rappresentazione geometrica e della teoria delle ombre (anche attraverso i più sofisticati softwares di rendering digitale) per ricostruire i confini cangianti delle loro apparenze. La risposta dovrebbe essere negativa; le opere di James Turrell indicano l’inadeguatezza dell’idea di una propagazione rettilinea della luce -e dunque dell’ombra-, e alludono invece al modello quantistico, oggi prevalente, che tuttavia non ha trovato ancora una coerente traduzione in termini info-grafici; ma soprattutto quelle opere suscitano in noi uno stimolo all’osservazione dei fenomeni umbratili del tutto analogo a quello provocato dai fenomeni luminosi, suggerendoci così di ridefinire in qualche modo le leggi della visione, e più in generale della percezione sensoria. Forse il nostro occhio interiore, capace di leggere le stratificazioni secolari - fisiche e metafisiche - di un segno naturalmente iconografico come l’ombra, è stato abbagliato dal concetto manicheo di una rappresentazione che, illuminando
ogni angolo del suo edificio teorico, ha risposto a necessità meramente razionali, a finalità tettoniche o meccaniche. Così facendo probabilmente abbiamo smarrito uno dei valori aggiunti del disegno che con la precisa descrizione delle ombre, in un soprassalto di hubris (tracotanza), tenta di fissare sulla carta o nella schermata di un monitor il moto eternamente cangiante del Sole.
1 J. Brown, Occluded front. James Turrell, Los Angeles 1985, p. 22. 2 Il gruppo di lavoro, coordinato dallo scrivente, è composto dagli arch. Francesco Bergamo, Giuseppe D’Acunto, Isabella Friso, Gabriella Liva, Cosimo Monteleone, Mark Sonego, Marta Torres. Le elaborazioni digitali del Roden Crater Project sono state eseguite presso il Dipartimento Culture del Progetto (dCP) dell’Università Iuav di Venezia, tra gli anni 2002-2007 3 T. Wolff, Introduction, in J. Brown, a cura di, “Occluded Front, James Turrell”, cit., citato in C. Adcock, James Turrell: The Art of Light and Space, Berkeley 1990. 4 T. Ando, Buildings, Writings, Projects, New York 1984, p. 84. 5 C. Adcock, James Turrell. The art of light and space, cit., p. 2. 6 Ibidem. 7 C. Adcock, op. cit., p. 36. 8 Ivi, p. 38.
19
La costruzione di nuove chiese e il tema della luce naturale Massimiliano Bernardini
L’esperienza della luce è, nella vita di ogni essere umano, un’esperienza originaria, fondamentale. Non a caso si usa l’espressione “venire alla luce” o “vedere la luce” per significare il momento stesso della nascita di una persona, il momento in cui ognuno di noi accede ad una percezione diretta, dei colori, degli oggetti, delle persone. Tuttavia, non è facile per noi uomini contemporanei avere un’esperienza efficace della luce: le esigenze tecnico-produttive del nostro tempo ci costringono a vivere in ambienti costantemente illuminati e non ci consentono di seguire il naturale ciclo della luce, che dall’alba conduce al tramonto e alla notte. Le nostre città e le nostre case non sono mai immerse nell’oscurità: l’esperienza di un’oscurità totale ci farebbe immediatamente percepire il nostro limite e la nostra fragilità. Privati dei riferimenti visivi, ci sentiremmo insicuri, esposti al pericolo, immersi in una realtà sconosciuta e indefinita, indecifrabile. Noi apparteniamo però ad un tempo tecnologico, che cerca pervicacemente e disperatamente di metterci al riparo da tutto ciò che potrebbe costringerci ad esperire il nostro limite e la nostra finitezza. Per riappropriarci di un’efficace esperienza della luce ed avere una percezione della sua capacità di strappare le cose alle tenebre, sarebbe necessario esperire il limite di una cecità temporanea: dovremmo lasciarci condurre da altri in un luogo sconosciuto, chiuso e totalmente buio e lì sostare ad occhi aperti per un tempo indefinito (che sia però sufficientemente lungo da farci avvertire il disagio di non poter vedere). Se qualcuno d’improvviso accendesse una fiamma, vedremmo le cose emergere dall’oscurità, le vedremmo ad un tratto acquistare forma e colore;
20
vedremmo i volti dei presenti emergere da un caos indefinito, per affacciarsi all’esistenza, e ci sentiremmo rincuorati e rasserenati da questo improvviso e imprevedibile chiarore. Ma pur con la difficoltà di essere “uomini tecnologici”, non ci è impossibile comprendere la ragione per cui l’uomo abbia da sempre considerato la luce come la manifestazione più immediata della forza vitale. Gli storici della religione ci spiegano che, intorno al 9500 a.C., l’uomo ha creato i primi simboli della divinità: le statue della dea madre e del toro. Queste rappresentazioni sono all’origine della religione neolitica, che si svilupperà poi nel IV millennio, a seguito dell’invenzione della scrittura cuneiforme, e si riferiscono al mistero della vita, sotto il duplice aspetto di potenza fecondatrice e di fecondità accogliente. La luce e il suo calore, necessari alla vita e al suo sviluppo, così come l’acqua, si sono imposti quasi come un sinonimo della vita stessa. Questo nesso tra “luce” e “vita”, insieme al carattere misterioso e affascinante, chiarisce la ragione per cui la prima sia stata addirittura identificata con il divino, fino a fare della luce stessa una divinità. Nell’Egitto del IV millennio, i contatti con la civiltà sumerica produrranno un grande mutamento. “Gli uomini si stupiscono osservando la natura: cielo luminoso, sorgere quotidiano del sole, piena regolare del fiume, inondazione della valle, vegetazione lussureggiante” (J. Ries). Nascerà da qui la dottrina di Atum-Re, il Dio solare di Eliopoli. Accanto a questo, potremmo anche ricordare come le popolazioni indoeuropee utilizzassero la parola deiwo per indicare la divinità, la cui radice “dei” ha il significato di “brillare”, “emettere una luce”; o ancora
come nelle Upanishad, i testi che stanno alla base di quel complesso fenomeno religioso che identifichiamo con il termine induismo, brahman e atman sono identificati con la luce.1 Se passiamo alla Sacra Scrittura, ci basterà una semplice osservazione per capire che il tema della “luce” attraversa tutta la rivelazione biblica. Il racconto del primo capitolo della Genesi si apre con la creazione della luce. È questo il primo atto creatore di Dio che viene narrato: “Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte” (Gn 1, 3-4). Al termine della rivelazione biblica, nel libro dell’Apocalisse, leggiamo che la luce di Dio cancellerà ogni traccia di tenebra: “Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli” (Ap 22, 5). Possiamo già cogliere un elemento che è al tempo stesso di continuità e di rottura tra il mondo biblico e quello pagano: anche nella Bibbia la luce è innanzitutto un elemento fisico legato alla vita, la base e la condizione della vita sulla terra; ma, a differenza del mondo pagano, essa è presentata come una creatura, un indizio del divino, anziché una divinità essa stessa. Un elemento che non può sfuggirci nei testi veterotestamentari è la contrapposizione tra luce e tenebre. Gli autori dell’Antico Testamento esprimono angoscia per l’assenza della luce, condizione che significa il dominio del caos e del peccato. Non a caso, per il popolo di Israele, infedele e indurito dal peccato, il giorno del Signore si presenterà come giorno di tenebra: si veda a tal proposito la visione apocalittica di Isaia 5, 30: “...ecco,
1
saranno tenebra, angoscia e la luce sarà oscurata dalla caligine”; o le parole del profeta Amos: “Che sarà per voi il giorno del Signore? Sarà tenebra e non luce”. [...] Come quando uno “entra in casa, appoggia la mano sul muro e un serpente lo morde” (cfr. Am 5, 18.20). Al contrario, la presenza della luce esprime sicurezza: durante la marcia attraverso il deserto per sfuggire alla dominazione egiziana, Dio guida il popolo eletto “di notte con una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero andare” (Es 13, 21). La luce del mattino segna l’avvio delle attività umane (si veda Gn 22, 3; 1Sam 29, 10-11) e svela al contempo i drammi che si sono consumati nell’oscurità (si veda 2Re 19, 35; Gdc 19, 26-27). La luce è anche un segno di bontà e di benedizione: i malvagi infatti “si ribellano alla luce [...] e non ne frequentano i sentieri” (Gb 24, 13); un governatore che governa con giustizia il suo popolo è paragonato alla “luce del mattino, al sorgere del sole, in un mattino senza nubi” (2 Sam 23, 4). La luce accompagna poi, nell’antico testamento, le manifestazioni della presenza di Dio. Non si tratta propriamente di una luce fisica, ma di una nube luminosa che invade e ricopre il luogo in cui Dio sceglie di manifestare la propria presenza. Così, alla consacrazione del tempio del re Salomone, la gloria del Signore lo riempirà come una nube, tanto da impedire ai sacerdoti di esercitare il loro servizio cultuale (2 Cr 5, 13-14). Ancora una nube simile si stabilirà sul monte Sinai, quando Mosè vi salirà per ricevere le tavole della legge (Es 24, 15-18) e la pelle di Mosè apparirà “raggiante, per aver parlato con lui” (Es 34, 29). Se ci accostiamo al Nuovo Testamento, ritroviamo questo complesso e articolato quadro di significati associati alla luce,
che si concentra sulla figura di Gesù e, di conseguenza, riverbera sulla comunità dei credenti. Nel vangelo di Luca i pastori, che ricevono l’annuncio della nascita del Salvatore, vengono avvolti di luce dalla gloria del Signore (Lc 2, 9); ancora nel vangelo di Luca, vediamo il vecchio Simeone prendere tra le braccia il piccolo Gesù e benedire Dio, esclamando: “[...] i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele” (Lc 2, 30-32). L’autore del Vangelo di Matteo applica la profezia di Isaia a Gesù: “[...] il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce; su quelli che abitavano in terra e ombra di morte una luce si è levata” (Mt 4, 16; cfr. Is 9, 1). Nel Vangelo di Giovanni, il più tardivo dei quattro, questo elemento della luce sarà elaborato in termini teologici raffinati e complessi. Nel prologo, con riferimento al Figlio, si dice “In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta”. Il Battista è indicato come colui che doveva rendere testimonianza alla luce (cfr. Gv 1, 4-5. 7). Ancora al v. 10 del prologo si dice di Gesù: “veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo”. A margine dell’incontro tra Gesù e Nicodemo, l’autore del quarto Vangelo spiega: “il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere” (Gv 3, 19 - 20). Nel capitolo ottavo, l’evangelista fa dire Gesù stesso di sé “Io sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8, 12).
La luce che è Cristo, illumina quanti credono in lui tanto da consegnare loro la responsabilità di risplendere davanti agli uomini, “perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro” (Cfr. Mt 5, 16). L’apostolo Paolo esprime questa dimensione scrivendo alla comunità di Tessalonica: “voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno”; e anche l’autore della lettera agli Efesini lo riprende: “Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Camminate perciò come i figli della luce” (Ef 5, 8). Molto interessante, sempre nell’epistolario paolino, è il legame espresso, nella seconda lettera ai Corinzi, tra la creazione e la redenzione: “E Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo” (2Cor 4, 6). Paolo esprime così la consapevolezza della continuità tra la dimensione della creazione e quella della redenzione e lo fa proprio servendosi del tema della luce. Anche la chiesa antica vide nel tema della luce un immagine di straordinaria potenza e, con la libertà che viene da una fede incrollabile nella reale resurrezione di Cristo, utilizzò quanto elaborato dal pensiero pagano intorno al rapporto tra sole e luna, per esprimere il rapporto tra “Dio e uomo”, nella sua accezione tipicamente cristiana, ossia nel mistero “Cristo e Chiesa”. La timida ed iniziale riflessione teologica della Chiesa primitiva, vide nelle immagini del sole e della luna, elaborate dal pensiero ellenistico, “un positivo sviluppo dei passi scritturistici, per sé solo indicativi, ed una più comprensibile spiegazione dei misteri”.2 I padri svilupperanno questo mistero del rapporto tra Cristo e la Chiesa, avvalendosi delle immagini elaborate dal pensiero pagano sul rapporto tra sole e
21
luna, secondo tre prospettive: la Chiesa morente, partoriente e raggiante. Morente, perché la Chiesa è la vera Selene rivestita della luce del divino Logos, che “in un incessante ripetersi dell’atto di rinunzia proprio dell’amore coniugale essa va incontro al nascondimento, all’invecchiamento, alla soppressione della sua visibilità terrena, per attuare, proprio in questo amoroso annientamento, la più intima unione con lo sposo”.3 Partoriente perché “fecondata dalla virtù generativa di Dio, è madre, genitrice di vita. Come Selene in virtù dell’annientamento subito nell’incontro con Elio diviene madre degli esseri viventi sulla terra [...] così la Chiesa, morendo in Cristo, proprio nel quotidiano annientamento della sua visibilità terrena, nel mistico occultamento della sua unione con Cristo, riceve la forza per generare la vita spirituale, diviene la sorgente della spiritualmente pregnante acqua battesimale, donatrice della rugiada della grazia, che essa spande nel silenzio notturno della vita terrena”.4 Raggiante perché “la Chiesa cammina verso quel giorno in cui ogni morire e pellegrinare cessa, [...]. Come Selene con passione repressa e un sempre rinnovato slancio gira intorno ad Elio e il suo morire si tramuta immancabilmente nella pienezza dello splendore del plenilunio, così la Chiesa è modello e anticipazione della futura resurrezione della carne, e sarà una volta la trasfigurata unità del glorioso genere umano risuscitato, lo splendore della spirituale luce del plenilunio nel cielo”.5 Anche il magistero recente riprenderà quest’idea della luce di Cristo che rifulge sul volto della Chiesa. Nel 1958 Giovanni Battista Montini, allora Arcivescovo di Milano, nella festa di sant’Ambrogio, citando il santo vescovo di Milano, dirà “la Chiesa perfino alla luna è paragonata, nelle cui fasi di diminuzione e di crescita si riflette la vicenda alterna della Chiesa che decade e che rimonta, e che mai viene meno,
22
perché fulget Ecclesia non suo sed Christi lumine, splende non di luce propria, ma di quella di Cristo”.6 Il Concilio Ecumenico Vaticano II, riprenderà questa idea nell’incipit della Costituzione dogmatica su la Chiesa: “Essendo Cristo la luce delle genti, questo sacro concilio, radunato nello Spirito Santo, desidera fortemente illuminare ogni uomo con la sua luce, che risplende sul volto della Chiesa, annunciando il Vangelo ad ogni creatura”.7 Infine una mistica del ’900, Adrienne von Speyr, medico svizzero, nata nel 1902 e che si convertirà al cattolicesimo nel 1940, dopo l’incontro con il teologo Hans Urs von Balthasar, userà il tema della luce per descrivere la grazia della fede: “Avviene a questa fede che, se è vivente, somiglia a una fiamma di continuo alimentata, da cui escono sempre nuovi variopinti effetti di luce, scintille e lampi, che illuminano diversamente le cose, gettano ombre vive e fanno emergere dalla semioscurità vividi contorni. L’immagine di Dio e del mondo che una fede vivente rappresenta è un’immagine altamente mossa, impossibile a fermare, a esaurire. Essa si spinge avanti, vuol essere vista, rivela sempre nuovi tesori. Si fa catturare in molti aspetti, ma mai esaurire, perché altre facce aspettano ancora”.8 Proprio questa ultima citazione ci introduce al tema della luce nella costruzione di una nuova chiesa e ci restituisce un’idea della ricchezza che essa potrebbe rappresentare nella progettazione di uno spazio destinato al culto e alla preghiera della comunità cristiana. È del tutto evidente che gli aspetti tecnico-funzionali e che la stessa funzionalità liturgica hanno un’importanza decisiva, ma è altrettanto vero che lo studio della luce non può limitarsi a questo. Pensare il modo in cui la luce filtra all’interno dello spazio, definendone i contorni e scolpendone i volumi, significa anche disegnare un luogo che, pur inserito nella trama urbana della città, in mezzo
alle case e ai luoghi di quotidiana attività degli uomini, lascia intuire una dimensione ulteriore; un luogo di gratuità, che non obbedisce alle leggi della produzione e del profitto, ma che invita a sostare e aiuta ad entrare in contatto con la propria coscienza, con la propria interiorità. È lì che l’annuncio del Vangelo può incontrare il bisogno di ogni uomo e di ogni donna di incontrare Dio. Anche sotto il profilo più propriamente liturgico, pensare l’interazione tra lo spazio e la luce, e le modalità con cui quest’ultima lo penetra, può aiutare la comunità che celebra a cogliere la ricchezza, la forza e la vivacità della propria fede. Può sottolinearne il carattere di anticipazione della festa escatologica; la dimensione dell’imprevedibile irrompere nella storia della grazia dell’Incarnazione e della Redenzione; il senso di un popolo che è in cammino verso il definitivo e festoso incontro con il suo Signore. È chiaro che le implicazioni e le possibilità potrebbero essere quasi infinite, ma è certo che questo tema deve tornare centrale nella progettazione di spazi destinati al culto, anche in considerazione del fatto che la forza evocativa e simbolica della luce appare assai congeniale alla sensibilità estetica contemporanea.
1
si veda J. Ries - C.M. Ternes [ed.], Simbolismo ed esperienza della luce nelle grandi religioni. «Atti del colloquio internazionale tenuto in Lussemburgo nel 1996», Milano 1997, pp. 12-13. 2 Hugo Rahner, L’ecclesiologia dei Padri, Edizioni Paoline, Roma 1971, p. 149. 3 Ibidem, p. 150. 4 cfr. Hugo Rahner, L’ecclesiologia dei Padri, Edizioni Paoline, Roma 1971, p. 151. 5 cfr. Hugo Rahner, L’ecclesiologia dei Padri, Edizioni Paoline, Roma 1971, p. 151. 6 G. B. Montini, Discorsi e scritti milanesi, vol. II: 1954-1963, pp. 2462-2463. 7 cfr. Lumen Gentium, 1. 8 A. von Speyr, La luce e le immagini, Jaca Book, Milano 1995, pp. 30-31. Massimiliano Bernardini è membro del Comitato per l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana
1-2 Fernando Menis Chiesa del Santissimo Redentore a Tenerife foto gentile concessione Š Menis Arquitectos
23
Mangiarotti Morassutti Favini
Il restauro della Chiesa di Baranzate Giulio Barazzetta
Interno giorno Due immagini: l’inizio dei lavori, giugno 2013, e la fine del montaggio del rivestimento, aprile 2014, mostrano lo stato del cantiere in corso alla parrocchia di Nostra Signora della Misericordia di Baranzate. Si preannuncia qui la conclusione del lungo lavoro di progettazione per il restauro e l’adeguamento di questo edificio esemplare dell’architettura italiana contemporanea. Opera di A. Mangiarotti, B. Morassutti, A. Favini, progettata e costruita tra il 1956 e 1958, per il programma del cardinal Montini per le nuove chiese della periferia metropolitana milanese, l’edificio venne inaugurato al culto l’8 novembre 1958.1 Caratteri/Architettura/Costruzione La chiesa, un volume prismatico rivestito in vetro alto 9 metri a pianta rettangolare di 14 metri per 28 coperto in cemento armato, ha la dimensione di una cappella o un oratorio piuttosto che di una parrocchiale, ed è appoggiata a due metri dal piano di campagna su un rilievo raccordato con il suolo da un pendio erboso. La chiesa è racchiusa da un più ampio recinto che ne delimita lo spazio sacro, anch’esso a pianta rettangolare di 30 per 60 metri, costruito da un curvo muro a scarpa di calcestruzzo e ciottoli a vista. Il recinto porta all’interno le formelle della Via Crucis scolpite da Gino Cosentino che circondano il volume bianco dell’aula liturgica. Varcandone l’unica soglia di fronte alla chiesa ci si trova di fronte due scalinate affiancate, a sinistra una che sale verso l’aula risplendente di vetro bianco, a destra un’altra in discesa verso un ingresso in ombra, a fianco della vasca d’acqua prospiciente il fonte battesimale.
24
Entrando in chiesa dal basso, come si dovrebbe, dalla penombra degli ambienti seminterrati inferiori si sale attraverso lo scalone interno alla sovrastante luce diafana dell’aula vetrata. All’interno quattro colonne portano la copertura ricca di rilievo e penombra. Due travi principali, gettate in opera reggono, incastrate, sei travi longitudinali, la cui ossatura è formata da trenta conci prefabbricati montati e post-tesi. Lo spazio è infine coperto da pannelli prefabbricati appoggiati fra le travi. La struttura della copertura così articolata diviene ordine architettonico che decora le più corte facciate di accesso e retro, mostrando la sezione a ‘X’ delle travi, separata da un ampia pausa trasparente dal rivestimento bianco. La carpenteria metallica leggera del rivestimento complanare alla copertura reggeva pannelli composti da due lastre di vetro rigato resi isolanti da un foglio di polistirolo interposto. L’isolante garantiva il carattere dell’involucro rendendo all’esterno abbagliante il volume bianco della chiesa, mentre all’interno si diffonde la luce solare filtrata dalla materia biancastra. La sera l’aula si trasforma così in una lanterna diafana che irradia debolmente lo spazio circostante del recinto sacro. Uno spazio semplicemente straordinario di cui lo stesso Montini ebbe a dire all’inaugurazione: “... scorgo un profondo simbolismo che richiama l’essenza della casa del Signore, questa chiesa di vetro infatti ha un suo linguaggio che può essere ricavato dall’Apocalisse dove è detto: vidi la città santa che discendeva dal cielo, le sue pareti erano cristalli...” In questa costruzione la tettonica dell’abrì souverain’ si compone con la leggerezza del tamponamento che consiste nella
1
Restauro della Chiesa di Baranzate (MI) Progetto di restauro: Bruno Morassutti Angelo Mangiarotti Aldo Favini Giulio Barazzetta (capogruppo) Dip ABC Politecnico di Milano con SBG architetti 2006-2012 cantiere in corso: 2013-2014 Tecnologie: Anna Mangiarotti, Ingrid Paoletti Strutture: Aldo Favini, Tito Negri Impianti: Giancarlo Chiesa, Mario Maistrello Opere Civili: Seregni Costruzioni srl Milano Facciate: Progetto Arte Poli srl Verona Direzione lavori: Sergio Gianoli, SBG architetti Assistenza al progetto e alla direzione lavori: Giorgio Corbetta e Giovanni Maggi Curia Arcivescovile di Milano Ufficio Amministrativo Sezione Tecnica Committente: Parrocchia Nostra Signora della Misericordia, Baranzate (Mi)
1 Interno 1958 foto Giorgio Casali Fondo Morassutti, Archivio Progetti, IUAV (VE) Pagine successive: 2 Cantiere 1957 struttura vista frontale foto Giorgio Casali Fondo Favini, Archivi Storici, Politecnico (MI) 3 Cantiere 1957 struttura vista laterale con muro/basamento foto Giorgio Casali Fondo Favini, Archivi Storici, Politecnico (MI) 4 Progetto 1956 Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti pianta (disegno originale a penna) Fondo Morassutti, Archivio Progetti, IUAV (VE)
25
27
5
materializzazione della luce. Un tetto animato dal chiaroscuro, sorretto da quattro colonne e racchiuso da un sipario che conforma l’interno in un luogo immateriale di raccoglimento, transfigurando sorprendentemente lo spazio protetto dal rigore assoluto della struttura. Nella ‘chiesa di vetro’ di Baranzate la tecnica della costruzione viene assunta come fondamento dell’architettura, la struttura e la limitazione dello spazio si congiungono nella loro armonica differenza, ingegneria e disegno si intrecciano nell’opera.
5 Dettaglio rivestimento esterno 1958 foto Giorgio Casali Fondo Morassutti, Archivio Progetti, IUAV (VE) 6 Esterno vista frontale 1958 foto Giorgio Casali Fondo Morassutti, Archivio Progetti, IUAV (VE)
28
Stato di fatto/Vincolo/Progetto Lo stato della chiesa fino al 2012, prima del cantiere in corso, era il risultato del degrado dei materiali nel tempo e dei cambiamenti imposti dalle circostanze e dall’uso. Ciò nonostante la parrocchiale di Baranzate è rimasta comunque contrassegnata dal percorso di accesso all’aula dal basamento sottostante, dal
contrasto tra l’involucro luminoso opalescente con la penombra di calcestruzzo del seminterrato e infine dal volume della chiesa composto con il recinto che lo contiene. La campagna a nord di Milano degli anni cinquanta è ora la conurbazione metropolitana milanese, ma proprio il recinto ha conservato il carattere di questo luogo al mutare del circostanze. Restauro/Conservazione/Adeguamento Il progetto di restauro della chiesa di Nostra Signora della Misericordia ha l’obbiettivo di ripristinare il complesso architettonico di Baranzate adeguandolo alle esigenze e allo standard di comfort richiesti, avendo come riferimento l’edificio inaugurato l’8 novembre 1958. Questo progetto riflette una condizione particolare del ‘restauro’ che consiste nella riscrittura di una stessa opera da parte degli medesimi autori.2 Se questa condizione propone comunque la definizione delle
stesso termine, la lettura di ciò che è avvenuto materialmente all’edificio nel corso del tempo, e la sua iconografia in questo caso straordinariamente documentata da Giorgio Casali con gli stessi progettisti, ne costituscono il ‘filo’ imprescindibile. A presiedere questo dialogo si è individuato come luogo rigoroso delle nuove installazioni e dei nuovi elementi costruttivi, il diaframma delle murature e della facciata, gli strati interposti fra le pavimentazioni e la struttura preesistente o il terreno. Nello spazio ricavato nel limite fra interno ed esterno, negli strati della materia dunque, si evidenzia lo scarto fra vecchio e nuovo. Una interpretazione del termine ‘restauro’ che sta tutto nella differenza “fra” i materiali e “dentro” la costruzione. Facciata/Rivestimento Per il rivestimento da sostituire ciò ha significato un attento campionamento per l’individuazione del grado di imitazio-
ne, alla ricerca dell’aspetto necessario ad evocare il gioco della luce riflessa e rifratta dalla facciata originale Gioco da bilanciare attentamente fra la effettiva possibilità materiale dell’opalescente predisposto dalle stratigrafie e caratteristiche dei vetri e l’assenza della materia plastica isolante da attraversare. Il pannello di tamponamento originario di progetto ed esecuzione sperimentale del 1958, documentato nelle riprese dell’edificio finito e dai resti materiali, era il risultato dell’assemblaggio di elementi semplici nella giustapposizione di due lastre di vetro industriale colato “rigato” con sezione a prismi, inframmezzate da un pannello di polistirene espanso a bassa densità di colore bianco per uno spessore totale di 4,5 cm. Quello che è stato progettato, varie volte campionato successivamente, alla fine prodotto e posato in opera è un pannello composito basato sulla tecnologia dei filtri
basso-emissivi, della giustapposizione di camere e dalla sommatoria degli strati e trattamenti superficiali dei vetri, a cui è affidata la qualità di isolamento termico e di protezione dall’irraggiamento. Ai trattamenti delle superfici mediante rigatura acidatura, colorazione e superificie corrugata interna è affidata invece una possibile riproduzione dell’aspetto dell’edificio originale o perlomeno della sua idea, sostituendo per così dire alla verità materiale dell’originale distrutto la copia verosimile della sua immagine e della sua qualità opalescente. 1 Questo testo rimanda ai testi pubblicati su Casabella 721/2004 e in Il vetro nell’architettura del XX secolo: conservazione e restauro/ Glass in the 20th Century Architecture: Preservation and Restoration a cura di / edited by Franz Graf e Francesca Albani, e alle bibliografie lì contenute. 2 Una circostanza che si è realizzata poche volte coincidendo con la manifestazione di una necessità civile, come è stato per la ricostruzione del Padiglione d’Arte Contemporanea ricostruito da Ignazio Gardella con il figlio Jacopo a Milano nel 1996.
29
7
30
7 Interno particolare ambone 1958 foto Giorgio Casali Fondo Morassutti, Archivio Progetti, IUAV (VE) 8 Interno vista verso altare, 1958 foto Mangiarotti e/o Morassutti photoshop Barazzetta, sbg architetti 9 - 10 Progetto 1956 Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti sezione longitudinale e sezione trasversale (disegni originali a penna) Fondo Morassutti, Archivio Progetti, IUAV (VE)
10
Pagine successive: 11 - 12 Progetto 2008-2011 particolari parete: rilievo 2008 ed esecutivo 2013 in costruzione sbg architetti 13 - 14 Cantiere in corso 2014 interno altare e interno facciata Sud-Est montaggio del nuovo rivestimento foto Sergio Gianoli sbg architetti
31
COMUNE DI BARANZATE PROVINCIA DI MILANO PARROCCHIA DI NOSTRA SIGNORA DELLA MISERICORDIA
PROGETTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO STATO DI FATTO
08R REV. 04
12-mag-08
DETTAGLI SCALA 1:20 1:5 1:1
arch. Giulio Barazzetta capogruppo ing. Agostino Besana coordinamento architettura arch. Bruno Morassutti arch. Angelo Mangiarotti tecnologie arch. Anna Mangiarotti arch. Ingrid Paoletti strutture ing. Tito Negri ing. Aldo Favini impianti ing. Giancarlo Chiesa ing. Mario Maistrello
sbgarchitetti
11
COMUNE DI BARANZATE PROVINCIA DI MILANO PARROCCHIA DI NOSTRA SIGNORA DELLA MISERICORDIA
PROGETTO DI RESTAURO E ADEGUAMENTO ESECUTIVO
43 REV. 02
FEB 2013
PARTICOLARI FACCIATA 2 SCALA 1:1
arch. Giulio Barazzetta capogruppo ing. Agostino Besana coordinamento architettura arch. Bruno Morassutti arch. Angelo Mangiarotti tecnologie arch. Anna Mangiarotti arch. Ingrid Paoletti strutture ing. Tito Negri ing. Aldo Favini impianti ing. Giancarlo Chiesa ing. Mario Maistrello
sbgarchitetti
32
12
Studio TAMassociati
Le stanze del silenzio Raul Pantaleo
Il padiglione di meditazione è parte integrante del Centro di Cardiochirurgia “Salam” recentemente realizzato in Sudan per conto dell’organizzazione umanitaria Emergency ong. Il complesso è il solo a fornire assistenza gratuita ai pazienti in un’area di dieci milioni di chilometri quadrati e trecento milioni di abitanti. Il Sudan è un paese che nel corso degli ultimi vent’anni è stato flagellato da numerose guerre inter-etniche ma soprattutto inter-religiose. Etnicamente gli Arabi costituiscono il 39% della popolazione gli Africani il 61%; dal punto di vista religioso il 70% dei Sudanesi risultano essere di fede musulmana, mentre il restante 30% è costituito da cristiani e altre fedi religiose (Dati tratti dal rapporto di “Human Rights Watch”: Q&A: Crisis in Darfur del 05/05/2004). Quando ci siamo trovati a dover pensare ad un luogo che ospitasse la preghiera, com’è consuetudine avvenga in qualunque luogo di cura, ci siamo dovuti confrontare con questo difficile dilemma: pensare uno spazio che potesse ospitare la complessità spirituale che alberga in questo paese. La scelta è stata quella di non privilegiare alcuna forma di culto ma di creare uno spazio capace di ospitare la preghiera e meditazione di tutte le fedi. L’esterno è dominato dalla grande vasca d’acqua, carica di significati simbolici in questa zona subsahariana. L’acqua è prelevata dal vicino fiume Nilo e poi reimpiegata per l’irrigazione delle aree verdi dell’ospedale. La vasca crea un distacco spirituale tra macrocosmo esterno dell’ospedale/mondo e microcosmo, ventrale, dell’edificio formato da due cubi bianchi sfalsati
34
e comunicanti con copertura semitrasparente realizzata con le anime di foglie di palme. Gli interni dei due cubi sono caratterizzati dalla presenza di due alberi che rendono questi spazi contemporaneamente sacri ma anche profani per la presenza di un elemento naturale all’interno di uno spazio artificiale. Abbiamo dovuto, ovviamente, confrontarci con la religione musulmana che è la fede professata dalla maggioranza dei Sudanesi e con le regole imposte da questo culto (le abluzioni, la separazione uomini donne) ma abbiamo calato queste regole in un contesto straniante che non le rendesse dominanti. La cosa è stata possibile occultando tutti i simboli e gli elementi religiosi che potessero essere ricondotti ad un’unica religione. Ad esempio lo spazio per le abluzioni non è altro che uno spruzzo d’acqua più alto che, prima dell’ingresso, permette il lavaggio ma che non ha alcuna connotazione religiosa e che viene percepito come un elemento della vasca d’acqua.
1
Padiglione di meditazione e preghiera Presso il centro di Cardiochirurgia “Salam” Khartoum Repubblica Federale del Sudan Committente: Emergency ong Progetto 2007 Realizzazione 2007 Progetto: Studio TAMassociati Gruppo di progettazione: Raul Pantaleo, Massimo Lepore, Simone Sfriso Program coordinator: Pietro Parrino Direzione lavori: Roberto Crestan Foto: Raul Pantaleo © AKAA/Cemal Emden
A-A’
2
B-B’
scale 1:100
35
Pagine precedenti: 1 Padiglione e vasca d’acqua foto Raul Pantaleo 2 Pianta, prospetto, sezioni
6
3 Padiglione, ingresso foto Raul Pantaleo Pagine successive: 4 Meditation pavilion foto © AKAA/Cemal Emden 5 Particolare della copertura foto Raul Pantaleo 6 Dettagli costruttivi 7 Meditation pavilion, interno foto © AKAA/Cemal Emden
36
6 Particolare del controsoffitto e del capitello destro dell’arco dell’abside 7 Interno della navata centrale verso l’abside 8 Esecutivi del controsoffitto: sezione, pianta, travi curve e tirante
7
8
5
1. Brick wall (of local production) 2. Metal plate 3. Metallic tubular (100*40 mm) 4. Metallic tubulars (ÎŚ 30 mm) 5. Metal plate (40 mm)
Detail 1
6
6. Metallic tubulars (30 mm) 7. Palm leaf stalks 8. Metallic reinforcing rod (ÎŚ 6 mm)
1:10
Detail 2
39
João Luís Carrilho da Graça
Una palpitante bellezza Fabiola Gorgeri
Il vuoto e la luce sono sinonimi di misura e relazioni. Il vuoto è un atto plastico con cui esprimere una misura fatta di distanze e di assenze: la dimensione relativa che accumula e densifica i valori emozionali e trasforma il vuoto in spazio. Il vuoto è la condizione di esistenza della luce stessa, che ospita in quanto materiale inevitabile, dando ad essa la forma e la consistenza di un desiderio: l’immanenza dell’assente che si fa potenziale presenza. Tutti i materiali in natura sono fatti di luce che è stata spenta, e questa massa sbriciolata chiamata materiale, proietta ombra e l’ombra appartiene alla luce. Allora la luce è davvero la sorgente di tutto l’essere.1 In questa mancanza, che è anche distanza tra le cose, la luce orienta, emoziona, abbacina, si confonde nello sguardo: è al tempo stesso un’esperienza simbolica e una parte reale del mondo; un dardo di fotoni rifratti dall’atmosfera terrestre che diviene nesso ontologico e metafisico di conoscenza. La vista presuppone oltre agli occhi e alla cosa, la luce. Gli occhi non vedono la luce ma l’oggetto nella luce. La luce vuota lo spazio. Questo spazio vuoto presuppone il movimento del desiderio. Il vuoto prodotto dalla luce resta uno spessore indeterminato, ma anche la condizione di confronto con l’altro.2 Il vuoto intriso di luce è anche la distanza colmata dall’intreccio fenomenologico della percezione:3 lo iato necessario tra le cose appartenenti distintamente ad una stessa totalità affinché l’atto percettivo si renda possibile. In ciò, si costruisce il paesaggio, come tonalità di uno specifico territorio: l’atmosfera4 che unifica la molteplicità delle cose presenti, oggetti e distanze, in modo sinestetico. Nell’ampliamento del Palácio de Belém,
42
per la realizzazione del Centro di documentazione e informazione, il vuoto è un elemento sintattico della narrazione espressiva nella presenza ripetuta dei giardini, e una modalità, nella sospensione da terra e nello sbalzo. Le opere di Carrilho da Graça dosano, senza sfocature, netti spazi d’ombra nella chiarezza della luce piena e diretta, generati perlopiù da volumi sospesi e da una sapiente integrazione orografica nei luoghi. A Belém, un piano erboso è il nuovo livello di riferimento da cui il progetto origina e l’articolazione del complesso si sviluppa, creando un sistema semi ipogeo di locali funzionali disposti ad L, secondo una distribuzione di autonomi spazi collettivi e privati, collegati al palazzo presidenziale. I chiostri conventuali e i giardini all’italiana, che il luogo conserva come lacerti memoriali, ritornano in una palingenesi di luce e ombra, presenza e assenza. Rimandi fisici quanto ideali, concreti e astratti, nella matericità del manto erboso e nella purezza del bianco, i piani di cui quest’architettura è costituita entrano in una sorta di risonanza armonica con il contesto, determinando paesaggio. I piani modellano e definiscono il vuoto. Il vuoto è lo spazio della luce. La luce richiama il desiderio di annullare la gravità, esalta la leggerezza del muro abitato, sospeso in equilibrio su di uno zoccolo d’ombra: un vuoto che taglia orizzontalmente, alla base, il muro-schermo, misura degli spazi aperti circostanti. La superficie esterna, astratta come un quadro di Malevic, ˇ accoglie soltanto il tenue grafismo, punteggiato e mutevole, dell’ombra degli alberi che la circondano. Il volume bianco condensa in sé la luce calda lisbonese: quasi indifferente al
Centro di Documentazione e Archivio Palácio de Belém Presidenza della Repubblica Lisbona, Portogallo 1997-2002 Primo premio di concorso, 1997 Progetto: João Luís Carrilho da Graça Team: Anne Demoustier, Giulia de Appolonia, João Maria Trindade, Mónica Margarido, João Manuel Alves, Susana Rato Architettura del paesaggio: João Gomes da Silva Ingegneria strutturale: Pedro Morujão Foto: © Maria Timóteo Fabiola Gorgeri
Chiesa di Sant’Antonio e Centro sociale San Bartolomeo Portalegre, Portogallo 1993 - 2008 Progetto: João Luís Carrilho da Graça Team: Inês Lobo, João Maria Trindade, Flávio Barbini, Maria João Barbini, Luís Barros, Filipe Homem, Paula Miranda, Susana Rato, Pedro Ricciardi, João Manuel Alves, Inês Cortesão, Joanna Malitzki. Ingegneria strutturale: Pedro Morujão Foto: Fabiola Gorgeri
43
2
3
44
variare delle ore del giorno, è un contrappunto e un complemento della massa d’ombra del bosco secolare a margine. Lo zoccolo è al tempo stesso asola di luce, continua e dinamica, per lo spazio interno in cui fluisce, con la propria mutevolezza, vibrante e riflessa da un piano d’acqua. Una luce palpitante che sfuma la soglia delle forme, riempie il vuoto come un liquido amniotico. Una luminosità corpuscolare e irradiante che smorza i confini creando un’adeguazione reciproca e osmotica dell’esteriorità all’interiorità, in cui la luce misura un tempo dilatato quanto lo spazio: i limiti spazio-temporali divengono soglie trasparenti e filtranti, modulatori di luce, su cui le immagini riflesse si sovrappongono in dissolvenza, come negli anfratti della memoria. Un’architettura generata in sezione, che predilige i vuoti come spazi di vita ed elegge l’uomo come primo principio di misura. La luce diurna, morbida e palpabile, penetra all’interno dall’alto, si mescola con quella diagonale proveniente da un piccolo impluvio luminoso e a quella
orizzontale del confine vetrato, alternativamente opalino, scivola fluida sulle superfici lucide dei pavimenti e con la consistenza di un pastello sulle pareti verde pallido, intride le masse smaterializzandone i margini formali. Lo spazio ctonio, profondamente protettivo, diviene nucleo rivelatore quando la luce naturale si affievolisce. Come in un’immagine al negativo, i luoghi d’ombra, che esplicano la chiarezza compositiva di piani e orizzonti estesi, spesso sottolineati dalla rugosa opacità di materiali scuri, divengono, la sera, eloquenti sorgenti luminose della natura frammentaria del complesso. Questo palpitare della luce come battito del tempo ciclico rivela al contempo l’essenza stratigrafica dell’insieme. I segni geometrici tracciati dal progetto, rendono analitica una stratificazione temporale di accadimenti architettonici, dove il bianco muro abitato, agisce come un frammento di una totalità astratta molto più ampia, cui rimanda con allusiva incompiutezza. Se da un lato, essendo schermo,
Pagine precedenti: Centro di documentazione e archivio, Palácio de Belém 1 Parete sospesa Foto © Maria Timóteo Courtesy by Carrilho da Graça Arquitectos 2 Sezione longitudinale Courtesy by Carrilho da Graça Arquitectos 3 Pianta Preesistenza e addizione Courtesy by Carrilho da Graça Arquitectos 4 Vista dal giardino pensile Foto Fabiola Gorgeri
45
5 6
nega il proprio ruolo tettonico dall’altro, così sospeso, allude ad una potenziale costruzione in divenire o di cui esso costituisce una possibile, residua, permanenza. La sospensione fisica del piano-parete che crea un basamento dato in assenza, in cui e da cui la luce fluisce, suggerisce un’atmosfera rarefatta e una sospensione nella comprensione logico-deduttiva. Questo pertugio di ambiguità nell’oggettività del segno astratto consente al segno stesso di evocare e significare altri paesaggi; sia nel porsi come neutro piano visivo, oltre il quale espandere l’immaginazione, sia nel rimando mnemonico tanto alle rive del Tejo e alla specificità antropogeografica del luogo, quanto al più ampio paesaggio alentejano punteggiato di bianche oggettualità architettoniche.
46
L’edificio agisce come un frammento rammemorante appartenente più alla natura che all’artificio. L’astratta essenzialità che caratterizza l’intervento d’integrazione all’esistente, contribuisce alla serenità di un luogo racchiuso e pacificato che ritrova nell’intensa plasticità di un gesto segnico, insieme frammento, misura e paesaggio, in parte anche privo di prove e verifiche causali, una sintetica regola di lettura dell’intero complesso. A Belém, la luce è la voce narrante di una palpitante bellezza5 rivelatrice del trascorrere chiarificatore del tempo e di un’idealizzata astrazione poetica in grado di essere segno ordinatore. Linea dopo linea, attorno ad un incubo di desiderio, un movimento di oscurità,
e il bagliore oscuro della … vita sembra raggiungere un’unità dove tutto è confermato: il tempo e le cose.6 La luce può agire come medium ostensivo di compresenze. Nel Museo do Oriente a Lisbona, l’illuminazione, quasi barocca, scolpisce immagini narrative della storia coloniale portoghese ripercorsa attraverso oggetti e reperti d’arte e di cultura materiale. Lo sfondo dell’architettura è indefinito nella quasi assenza di luce diffusa mentre la presenza oggettuale delle collezioni diviene sorgente essa stessa di luce riflessa. La luce artificiale restituisce unità di percorso all’eterogeneità espositiva, disvela gli oggetti nell’oscurità, conferendo loro simultaneamente singolarità e comunanza tematica.
La stessa arte del mostrare, nella luminosa chiarezza naturale, rintraccia l’ordine implicito nella struttura territoriale da cui le opere originano e a cui appartengono come figure e sfondo. Nella periferia di Portalegre, il complesso parrocchiale dos Assentos narra la propria presenza nella luce abbagliante dell’alto Alentejo, con la precisa armonia di un teatro delle ombre, tra ciò che con la forma dichiara e il virtuosismo tettonico di cui consiste. I muri, continui e muti, che delimitano e ridefiniscono un intero isolato, intensificano la percezione del dislivello orografico presente e conferiscono omogeneità al nucleo sociale e religioso che si assimila alle abitazioni limitrofe per cromia, ma ne differisce per le maggiori dimensioni.
La luce smaterializza le pareti già bianche, le trasforma in piani ottici che accolgono e proiettano ombre; penetra tra i piani che delineano gli spazi, nelle fessure lasciate dalle loro mancate intersezioni: enfatizza il dinamismo della scatola neoplastica, accentuandone la spazialità aperta. L’ingresso al complesso è un’interruzione di continuità: un’anomalia d’ombra generata, nel limite volumetrico, da un piano sollevato che invita ad entrare: una soglia dove si può sostare, attendere, ripararsi dal sole; una pausa e un passaggio da un’urbanità eterogenea e dispersa ad un’altra che si fa intensa e concentrata. La chiesa è arretrata e lo spazio antistante svolge il ruolo di sagrato nella funzione che le è propria e nel rimando che la memoria collettiva ritrova nel segno tipologi-
5 Piani d’ombra e di luce Foto © Maria Timóteo Courtesy by Carrilho da Graça Arquitectos 6 Asola di luce Foto Fabiola Gorgeri
47
7
co; ma è anche chiostro con le funzioni plurime e sociali che vi prospettano; e domestico patio mediterraneo, cisterna di luce, dove i volumi divengono meridiane del quotidiano. In questo vuoto, la luce disegna un movimento di piani d’ombra geometrici che riflette le dualità di vuoto e pieno, transito e stasi, massa e leggerezza; esplicita il tema del vuoto leggermente contenuto - presente in altre opere come la Scuola di Musica e il Padiglione della Conoscenza a Lisbona - sfidando la gravità delle masse sospese e contrapponendo il dinamismo di percorsi spiraliformi alla staticità di uno spazio confinato. La trasparenza dei limiti consente l’assialità e la continuità visiva degli spazi sequenziali che dall’esterno conducono ad una profondità eloquente: rivela la stanza smisurata della natura, miesiana, ricondotta nel finito di uno spazio indiviso.
48
La consequenzialità asseconda una gradazione mistica con tre diverse modulazioni della luce, dove l’aula religiosa occupa il centro di due vuoti interclusi: lo spazio della comunità sociale e lo spazio della contemplazione. Vi si accede, in modo asimmetrico, da un varco in ombra nel basamento inclinato e trasparente: un’assenza di opacità che sospende la parete muraria su di un sottile affioramento di natura, di ghiaia e di manto erboso. La relazione tra questi spazi in continuum è anche un calibrato rapporto tra limiti, dove la luce si assenta o riflette, unisce e divide al contempo, disegna pareti immateriali. All’interno la forza decorativa è concessa soltanto alla natura: le pareti completamente bianche, il pavimento in resina nera, le superfici vetrate nella parte bas-
sa ad unire socialità e sacralità, creano un’atmosfera sospesa, definita dalla presenza materica e generativa della massa rocciosa. La luce è diffusa e costante, nell’essere necessità e verità tematizza e differenzia lo spazio dell’aula centrale, centripeto e comunitario, dalla verticalità delle navate laterali. Sulla parete quarzifera, esterna quanto interna, che è anche sfondo presbiteriale, la luce è variabile. L’acqua è un dispositivo che completa il vuoto. La luce riflessa su di essa duplica le presenze, acuisce le ombre, annulla la fissità delle cose: restituisce l’immagine di un movimento, continuo e reiterato, quasi sonoro, denunciando una presenza superiore. Lo spazio è cornice neutrale,7 luogo di unione in cui l’uomo non soltanto occupa la relazione tra cose ed entità, ma è la relazione stessa. La forte astrazione dei volumi consente
8
una definita relazione dialogica di natura e artificio che costruisce un nuovo paesaggio. Nella fase analitica del processo progettuale il frammento è un dispositivo conoscitivo che rende possibile un’astrazione selettiva; nella fase espressiva l’estrema sintesi concentra nel frammento, che l’opera stessa costituisce, il senso dell’intero. Frammento d’artificio e frammento di natura determinano l’opera nella sua unità. La luce unifica i due frammenti nella loro distanza. È questo stare nel luogo e oltre il luogo che connota le opere di Carrilho da Graça e che consente loro la modificazione creativa8 di un territorio. 1
Louis I. Kahn, Light, (1973), in John Labell, Between silence and light. Spirit in architecture of Louis I. Kahn, Shambhala, Boston 1979, p. 22. 2 Emmanuel Levinas. Totalità e infinito. Saggi sull’esteriorità, Jaca Book, Milano 1987, p.195.
3 Cfr. Maurice Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, 1969. 4 Cfr. Gernot Böhme, Atmosphäre. Essays zur neuen Asthetik, Suhrkamp, Frankfurt, 1995. 5 Uma espécie de palpitante e ambígua beleza ... uma luz especial que vinha de dentro como a luz do deserto. (Una sorta di palpitante e ambigua bellezza ... una luce speciale che veniva da dentro come una luce del deserto). Da Herberto Helder, Lugar Lugares in H. Helder, Os passos em volta, Assírio & Alvim, Lisboa 2009, pp. 49-55. 6 H. Helder, Poeta oscuro in Ibidem, p. 165. 7 Christian Norberg-Schulz, Un colloquio con Mies, in Vittorio Pizzigoni (a cura di), “Ludwig Mies van der Rohe, Gli scritti e le parole”, Einaudi, Torino 2010, p.171. Cfr. Christian Norberg-Schulz, Rencontre avec Mies van der Rohe, in “L’Architecture d’aujourd’hui”, LXXIX (settembre 1958), n.29, pp. 40-41. 8 Cfr. Vittorio Gregotti, Infinito, in V. Gregotti, “Il sublime al tempo del contemporaneo”, Einaudi, Torino 2013, Ebook pp. 1362-1466.
7 Interno. Luce sulle superfici Foto © Maria Timóteo Courtesy by Carrilho da Graça Arquitectos 8 Interno Foto © Maria Timóteo Courtesy by Carrilho da Graça Arquitectos
49
9
50
11
Pagine precedenti: Chiesa di Sant’Antonio e Centro sociale San Bartolomeo 9 Sagrato Foto Fabiola Gorgeri 10 Luce e ombra nel vuoto Ingresso al complesso Foto Fabiola Gorgeri 11 Natura e artificio Foto Fabiola Gorgeri 12 Cappella battesimale nella navata laterale Foto Fabiola Gorgeri 13 Aula centrale Foto Fabiola Gorgeri
53
Yung Ho Chang Atelier FCJZ Vertical Glass House
Vetri Fabrizio Arrigoni
Man weiß noch nicht, wie ein Saal wirkt, der nur vom lichtdurchlassenden Fußboden aus beleuchtet wird. Man könnte da auf dem Lichte gehen. Derartiges und vieles Andre müßte ausprobiert werden.1 Paul Scheerbart, Glasarchitektur
La Vertical Glass House è un prototipo di alloggio urbano disegnato nel 1991 da Yung Ho Chang in occasione dell’annuale Shinkenchiku Residential Design Competition organizzato dal Japan Architect Magazine. Il progetto fu insignito della Honorable Mention ma solo ventidue anni dopo, nel 2013, quell’iniziale ipotiposi, debitamente riconsiderata dall’Atelier FCJZ, ha trovato la via della costruzione, divenendo uno dei padiglioni permanenti della West Bund Biennial of Architecture and Contemporary Art di Shanghai.2 L’impronta planimetrica del padiglione è basata su un quadrato di lato 6.60 m. con una area utile a piano minore di 40 m.;2 la sezione verticale è ripartita secondo tre livelli ai quali si aggiunge il basamento interrato alla quota di -2.10 m. Spiccato alla quota + 70 cm. dal ciglio del selciato, il ritmo dei quattro moduli è di 3.20 m. con il vano ultimo a doppia altezza. Le cortine murarie in cemento armato sono state gettate con casseri le cui paratie hanno consentito di ottenere, pur nella medesima consistenza materica, una dicotomia perfetta nell’aspetto delle superfici: frante, scabre e irregolari all’esterno quanto continue e prive di accidenti all’interno. A contrasto di tale gravitas i solai sono realizzati con lastre composite di vetro temperato dello spessore di 7 cm., comprese quelle disposte in copertura; queste sottili lame quando intercettano le pareti a settentrione e meridione ne fessurano il
54
manto determinando finestrature a nastro fortemente ribassate - 20x290 cm. - per poi proseguire in leggero aggetto oltre il limite della facciate stessa. Nella direzione opposta la compattezza della muraglia è del tutto salvaguardata con il ritmo della compartizione percepibile all’istante tramite le sincopi e le sfasature presenti nella trama delle casseformi lignee.3 Il vuoto dell’edificio è organizzato e sostenuto attraverso un pilastro quadrato d’acciaio brunito posto nel punto di centro; da esso una croce di travi sempre in acciaio compartiscono la geometria di base in quattro quartieri, uno dei quali occupato dalla scala circolare. Una ridotta famiglia di oggetti - i sanitari, gli arredi del living e della cucina - allestiscono un calibratissimo paesaggio oltre che fissare laconicamente la distribuzione funzionale della casa: «all the furniture were designed specifically for the rooms inside the Vertical Glass House to be true to the original design concept and keep a coherence appearance with its structures and stairs. Air conditioning was added to the house».4 Il telaio descritto oltrepassa la sua ragione tecnica divenendo l’agente capace di offrire ancoraggio, struttura e spinta verticale all’insieme; una conferma esplicita di tale ruolo ordinatore è il suo insistere nella zona apicale della fabbrica allorquando, smarrita ogni urgenza statica, diviene manifesta la sua azione segnica - Wink - e concettuale. «È curioso come l’albero abbia dominato la realtà occidentale e tutto il pensiero occidentale, dalla botanica alla biologia, l’anatomia, ma anche la gnoseologia, la teologia, l’ontologia, tutta la filosofia […]: il fondamento-radice, Grund, roots e fundations». Questa nota espunta da Mille plateaux5 introduce un tema che risulta essere di grande intesse nella de-
Vertical Glass House Xuhui District Longteng Road Shanghai, China 1991-2013 Client: West Bund Office: Atelier FCJZ Principal Architect: Yung Ho Chang Project Architect: Lu Bai Project Team: Li Xiang Ting, Cai Feng Building Area: 170 m2 Type: Housing/Exhibition Photographs: courtesy Atelier FCJZ
2
cifrazione dell’opera; se punctum crucis di quest’ultima può essere individuato nel rapporto, perentorio quanto incisivo, che essa allestisce tra suo abito corporeo e luce naturale, tuttavia tale luogo sorgivo del disegno occorre perimetrarlo nei confini più vasti di un dialogo - e di un confronto - tra motivi occidentali e orientali.6 Una propensione allo scambio e all’incrocio dei temi e delle attitudini testimoniata, in prima istanza, dalla biografia stessa dell’autore - e ciò senza volere costringere in una corrispondenza univoca la vita e l’opera. Yung Ho Chang, nato a Pechino nel 1956, conclusi i suoi studi (Master’s Degree of Architecture presso l’Università della California a Berkeley) ha insegnato per oltre una decade negli Stati Uniti prima di tornare in patria e aprire con Lu Lijia, nel 1993, l’Atelier FCJZ (Fei Chang Jian Zhu),7 primo studio indipendente del paese; tra il 2005 e il 2010 è stato a capo del Department of Architecture al MIT di Cambridge e parallela all’attività di docenza, costante è stato l’impegno di conferenziere, analogo di un antico “con-
56
sigliere itinerante” You shi: Yale, Princeton, Cornell, SCI-Arc, Penn, Berkeley, Berlage Institute di Rotterdam, Chinese University di Hong Kong, Hong Kong University e Tunghai University, Taiwan. È in tale métissage di contesti, esperienze e contributi critici che l’atelier ha tratteggiato gradualmente la propria fisionomia e le proprie tipologie di intervento: «in the past fifteen years, we have developed a body of work that ranges from interior design, building design, urban design, master planning, to art installation. In the process, our trajectory does go beyond a basic agenda from time to time, and ventures into the realms of culture, ecology, economy, and social/urban issues. This exhibition tries to map the development of FCJZ comprehensively and also includes a retrospective glimpse into some of the more hermetic design research I did prior to returning to China in order to establish the evolution of certain recurring ideas in our work».8 La VGH è caso studio esemplare nel suo porsi come campione di ricerca e sperimentazione e dunque
exemplum del tutto separato sia dalla produzione edilizia corrente - incardinata al dato quantitativo, alla rendita finanziaria e alla velocità di esecuzione - sia dalle strategie riferibili agli uffici-vettori della globalizzazione socio-economica - con la loro subalternità congenita alla novitas e lo spasmo compulsivo nell’imporre il segno ab-solutus e dissonante, cifra dell’Iconic Building: «I believe architecture is something more down to earth, and ultimately relates to how people live. Although I’ve done my share in some way, I don’t think architects can just fly around and build structures anywhere, but rather they need to anchor themselves in one place. For example, you say Italian architects can still be the Marco Polos of today, and come to Beijing and stay for a year… and then there are actually Italian architects here, working and so on… but I’m suspicious of global practice. They may produce a very glorious kind of architecture, but it’s not architecture that would belong somewhere. That being said, I think jet setters is very much a
3
result of evolution. When I was younger, I remember I was so envious seeing the stars of my days talking about doing little sketches on their flights between locations, and that was the time for the architect to be creative. Now I would say what a lousy idea. You should really sit in your studio and work with materials and with your team».9 Wen-hua è termine cinese che vale l’endiadi “cultura-trasformazione” e che può essere accostato-dipanato alla fatica della traduzione vale a dire alla «trasposizione di una lingua nell’altra mediante una continuità di trasformazioni. Spazi continui di trasformazione, non astratte religioni di eguaglianza e di somiglianza, misura la traduzione».10 Un campo semantico che possiamo associare a VGH e al suo aver origine in una segnatura storica del Moderno stesso; sono gli stessi autori a sottolineare questa provenienza, questa linea genealogica, ma al contempo tale debito è come riscattato dalle alterazioni e dagli scuotimenti, dalle metamorfosi e dai sommovimenti, cui viene con risolutezza
sottoposta: «[the house] discusses the notion of transparency in verticality while serving as a critic of Modernist transparency in horizontality or a glass house that always opens to landscape and provides no privacy. While turning the classic glass house 90 degrees, Vertical Glass House is on one hand spiritual: With enclosed walls and transparent floors as well as roof, the house opens to the sky and the earth, positions the inhabitant right in the middle, and creates a place for meditation».11 Cancella le tracce!, Verwisch die Spuren!, è l’imperativo brechtiano adottato da Walter Benjamin.12 La Glaskultur novecentesca è tecnica congenita al Neue Zeit, al tempo della barbarie e della miseria di esperienza («Nein, soviel ist klar: die Erfahrung ist im Kurse gefallen...») ed è primariamente un processo di smantellamento e riduzione dell’intérieur borghese, con la sua ovattata intimità (Gemütlichkeit), i suoi infiniti gusci protettivi (Gehäuse), le sue stanze ingombre di cose d’affezione e consuetudini, orme dei giorni terreni. Il vetro è virtù rivoluzionaria par excellence,
dissipa il “segreto” e indebolisce il possesso sino alla sua lenta estinzione e dove sorgono ostruzioni e opacità sostituisce passaggi, comunicazioni. Il vetro non ha aura, è algido, puro, privo di significazione, su di esso le vicende, gli accadimenti, scivolano, senza disseminare lasciti: «Glas ist nicht umsonst ein so hartes und glattes Material, an dem sich nichts festsetzt. Auch ein kaltes und nüchternes. Die Dinge aus Glas haben keine “Aura”. Das Glas ist überhaupt der Feind des Geheimnises. Es ist auch der Feind des Besitzes. Der große Dichter Andre Gide hat einmal gesagt: Jedes Ding, das ich besitzen will, wird mir undurchsichtig.» Sappiamo del sincero, quanto duraturo interesse del filosofo berlinese per Paul Scheerbart; e tuttavia le posizioni tra i due non coincidono. Se condiviso è il ripudio dell’universo guglielmino e dell’umanesimo filisteo delle sue classi dominanti, la Glasarchitektur del Phantast produce e conserva tuttavia un rigenerato senso del rifugio, del raccoglimento - Gespensterhafte Beleuchtung -, un rinnovato equilibrio tra anima e suo
57
4
luogo;13 la questione in gioco non è la liquidazione dell’interno per tramite di una profana e totale visibilità - Sichtbarkeit - quanto abbattere gli impedimenti che ostacolano o limitano lo spandersi della luce-colore «che tutto vuole abbracciare e ch’è viva nel cristallo». Il vetro - «organo dello spirito fantastico» - è l’agente alchemico di una trasfigurazione, di un trapasso, attraverso il quale si compirà «l’interiorizzazione dell’esterno» oltre ogni principio di trasparenza.14 La casa di vetro è locus amoenus: una lanterna magica, una lucciola, un piccolo cosmo policromo fatto di iridescenze, di baluginii, di accensioni, secluso da ciò che l’attornia: «quando mi trovo nella mia sala di vetro, non voglio sentire né vedere niente del mondo esterno. Se ho nostalgia del cielo, delle nuvole, del bosco, posso benissimo uscire all’aperto…».15 VGH partecipa di questa vicenda, apportando un’inedita Raumproblematik rammemorante l’anti-funzionalismo fiabesco scheerbartiano, il simbolismo emancipativo della Glasutopie di Bruno Taut, l’elementarismo immanente di Adolf Benhe.16 Le murature cieche impediscono ogni estroflessione ed ex-pressione lasciando che l’introspezione sia sporadicamente violata da vedute fortuite: salvaguardia di un Leibraum riservato e spoglio come il calcestruzzo levigato che l’avvolge sottraendolo al resto, allo spazio equi-valente della Großstadt.17 Entrato al primo livello da un portone di ferro, l’ospite è immerso
58
5
in un “pozzo celeste”, un cavo attraversato da relazioni fluttuanti tutte sul solo asse verticale. Una polarità che si dispiega nella giunzione-transizione tra terra e cielo, tra basso e alto, tra scuro e luminoso, tra chiuso e aperto, tra fisso e mobile, tra costante e cangiante: le tante specie dell’originario nesso tra fenomeno costruito - lineamenti e materie - e spazio uranico - aria e luce (di sole di luna di stella). 1 «Attualmente non si sa ancora che effetto possa fare una sala illuminata soltanto da un pavimento che lascia filtrare la luce. In questo modo si potrebbe camminare sulla luce. Cose di questo genere e molte altre ancora andrebbero sperimentate.» Paul Scheerbart, Glasarchitektur, 1914 (trad. it. di M. Fabbri e G. Schiavoni, Architettura di vetro, Adelphi, Milano 1982, p. 101.) 2 Cfr.: http://www.westbundbiennial.com/ L’edificio è attualmente impiegato come residenza temporanea per artisti e architetti ospiti dell’istituzione. 3 Da sottolineare come tale discontinuità nel trattamento delle forature sia confermata nell’assetto costruttivo della fabbrica dove le pareti intonse risultano di maggiore spessore rispetto alle due traforate. L’attenzione al dato artigianale e al costrutto fisico ereditato dalla tradizione - un insieme denso di conoscenze, tecniche edificatorie e materie - è fatto che accomuna una generazione di nuovi progettisti cinesi: una sorta di recupero del binomio Formlehre e Werklehre che corroborava il Bauen bauhausiano. Su questi temi vedi i risultati delle due esposizioni: Positions. Portrait of a New Generation of Chinese Architects, a cura di F. Edelmann e F. Ged, Actar-D, Barcelona New York 2008; From Research to Design. Selected Architects from Tongji University of Shanghai, a cura di Xiangning Li, Triennale di Milano, 2012; cfr: http://www.domusweb.it/content/domusweb/it/notizie/2012/09/11/ dalla-ricerca-al-progetto.html 4 Yung Ho Chang / FCJZ, Vertical Glass House Description. 5 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Éditions du Seuil, Paris 1980, (trad. it. di G. Passerone, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, 27, Castelvecchi, Roma 2003). 6 Sulla legittimità di riconoscere una molteplicità irriducibile nel cuore della Kultur vale per queste pagine la premessa: «[…] la cultura non può esistere unicamente al singolare e la pluralità, lungi dal costituirne
Pagine precedenti: 1 Interno 2 Prospetto sud, sezioni A e C, piante basamento, piano primo, piano secondo 3 Vista della casa da nord 4 Interno notte 5 Dettaglio della facciata 6 Interno living Pagine successive: 7 Interno bagno 8 Interno ultimo livello
6
59
semplicemente una variazione, gli è consustanziale. Infatti, se da un lato vediamo le culture prendere in prestito l’una dall’altra, assimilare, fondersi in insieme più ampi, annullare le proprie specificità e infine uniformarsi, allo stesso tempo osserviamo anche la dinamica inversa, quella di una continua ri-specificazione e ri-individuazione. Esse continuano a subire un effetto di globalizzazione e, contestualmente, a ricostituirsi nella loro dimensione locale: la cultura è, infatti, sempre legata al contesto di appartenenza, a un “ambiente” diceva Nietzsche: rappresenta di fatto una questione eco-logica». François Jullien, De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Fayard, Paris 2008 (trad. it. di B. Piccioli Fioroni e A. De Michele, L’universale e il comune. Il dialogo tra culture, Laterza, Roma Bari 2010; p. 154). 7 Una sigla traducibile come architettura singolare, rara, non usuale. 8 Yung Ho Chang, Develop: The Architecture of Yung Ho Chang/Atelier FCJZ, SA+P, MIT School of Architecture+Planning, February 15/April 13 2007. 9 Interview with Yung Ho Chang of Atelier FCJZ in “Design Boom”, 25 settembre 2012. Una stanzialità che si specchia nella sede che accoglie l’atelier di Chang a Pechino, cfr.: Atelier Feichang Jianzhu, http://www.chinese-architects.com/en/feichang/ source:index_a_z/category:1/index:10/count:75 10 «Die Übersetzung ist die Überführung der einen Sprache in die andere durch ein Kontinuum von Verwandlungen. Kontinua der Verwandlung, nicht abstrakte Gleichheits- und Ähnlichkeitsbezirke durchmisst die Übersetzung.» Walter Benjamin, Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, 1916 (trad. it. di R. Solmi, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo in Id., Angelus Novus, Einaudi, Torino 1962; p. 64). 11 Yung Ho Chang / FCJZ, Vertical… op. cit. 12 Walter Benjamin, Erfahrung und Armut, 1933 (trad. it. di M. Palma, Esperienza e povertà, in Id., Scritti politici, Editori Internazionali Riuniti, Roma 2011, pp. 253-260). 13 Su questi temi cfr. Massimo Cacciari, La catena di vetro in Id., Dallo Steinhof. Prospettive viennesi di primo Novecento, Adelphi, Milano 1980, pp.125-129. 14 Fabrizio Desideri, Introduzione in Paul Scheerbart, Lesabéndio, Edizioni Studio Tesi, Pordenone 1982, p. XII. 15 Paul Scheerbart, Glasarchitektur, op. cit., p. 54. Una interpretazione che distingue il sentire dello scrittore gedanese dalla Klarheit del moderno in Rosemarie Haag Bletter, The interpretation of the Glass Dream - Expressionist Architecture and the History of the Crystal Metaphor, in “Journal of the Society Of Architectural Historians”, vol. 40, 1981, pp. 20-43. 16 Adolf Behne, Glasarchitektur Manifest, in “Frühlicht”, Heft 1, 1920. 17 «Vertical transparency visually connects all the utilities, ductworks, furniture pieces on different levels, as well as the staircase, into a system of domesticity and provides another reading of the modern theory of “Architecture as living machine”.» Yung Ho Chang / FCJZ, Vertical… op. cit. La puro-visibilità di impianti, reti, tubi di scarico, più che retorica o esplorazione del meccanico-tecnologico sembra essere un ribadito Zeichen der Transparenz.
60
7
Kengo Kuma: Risarcire i luoghi attraverso vedute e trasparenze Andrea Volpe
«Non bisogna studiare ciò che gli antichi maestri facevano, ma quello che cercavano»
È con questa citazione tratta dall’Oku no Hosomichi,1 la celebre cronaca di viaggio scritta nel XVII secolo dal poeta Basho, ¯ che Bruno Taut2 riassume la problematica relativa all’ethos dell’architettura giapponese moderna.3 Giudicata vittima di un fatale fraintendimento. Da un lato condizionata dalla pesante monumentalità degli edifici governativi e istituzionali costruiti in epoca Meiji, Taisho¯ e Showa ¯ (frutto dell’ibridazione fra stilemi eclettici di importazione europea con i caratteri dell’architettura tradizionale). Dall’altro talmente irretita dalla nuova architettura proveniente dall’occidente da accettarla acriticamente attraverso edifici indifferenti ai caratteri dei luoghi, al clima ed alle tradizioni locali, che mimavano senza troppi scrupoli i bianchi e squadrati volumi del Moderno Internazionale. Per Taut, in definitiva, la nuova architettura nipponica rischiava di ridursi ad una mera operazione di adesione stilistica. Timore confermato poi nel lungo resoconto sullo stato scritto per l’Architecture d’Ajour d’hui nel Novembre 1934 e pubblicato l’anno seguente.4 È dunque imprescindibile per Taut parlare dei tratti costitutivi della tradizione prima di affrontare un rigoroso discorso critico sulla produzione contemporanea locale. D’altronde fin dal giorno del suo cinquantatreesimo compleanno, il 4 maggio 1933, il secondo dal suo arrivo in Giappone, egli fu testimone -grazie ai buoni uffici di Isaburo Ueno- di un’esperienza straordinaria, sconvolgente, indimenticabile. Una serie di frasi spezzate, trascritte velocemente nel suo diario, testimoniano con efficacia l’emozione provata durante la nota, oramai mitologica, visita alla Villa
62
Imperiale di Katsura. Nell’architettura di una residenza principesca del XVII secolo in puro stile sukiya Taut trova dunque non solo il paradigma per misurare la bontà della produzione architettonica contemporanea giapponese ma un termine di paragone di valore universale, al pari della seconda meraviglia architettonica da lui visitata pochi mesi più tardi in Ottobre. Il santuario shintoista di Ise, con i suoi templi lignei ciclicamente ricostruiti, costituisce difatti l’altro polo significante nella nuova geografia concettuale che l’architetto tedesco metterà a punto durante la sua permanenza in Giappone. Inevitabile dunque, dovendo parlare di Kengo Kuma, del particolare uso che egli fa della luce e dell’ombra nella sua architettura, richiamare alla mente un’altra scoperta -o meglio- un nostos. Un aneddoto che segna in qualche modo l’inizio della maturazione stilistica dell’architetto giapponese dopo i contraddittori esordi a Tokyo con opere connotate da un pesante (e forse già allora tardivo) uso di un codice, il postmodern, purtuttavia declinato in modo da rispecchiare la frammentazione ed il caos polisemico della capitale giapponese.5 “Il [...] momento di svolta per me avvenne pochi mesi dopo quando mi fu proposto di disegnare una guesthouse ad Atami, in un lotto prospiciente l’oceano. Mentre stavo camminando attorno all’area fui avvicinato da un abitante del quartiere che mi raccontò che un famoso architetto era l’autore della sua casa. Mi invitò a visitarla nel caso fossi stato interessato. La sua casa dall’esterno sembrava del tutto ordinaria ma quando entrai dentro fui meravigliato dalla misteriosa atmosfera che vi regnava. Si trattava di Villa Hyuga -conosciuta anche come la
1
1 Noh stage in the forest, Toyoma (1996) Particolare dell’ingresso ovest © Mitsumasa Fujitsuka 2 Noh stage in the forest, Toyoma (1996) Veduta dell’area per gli spettatori dal palcoscenico © Mitsumasa Fujitsuka Pagine successive: 3 Ando Hiroshige Museum, Bato (2000) Veduta del museo dalla corte © Mitsumasa Fujitsuka 4 Ando Hiroshige Museum, Bato (2000) L’area d’ingresso vista dalle sale espositive © Mitsumasa Fujitsuka 5 Takayanagi Community Center, Takayanagi (2000) Il centro comunitario e la risaia © Mitsumasa Fujitsuka 6 Takayanagi Community Center, Takayanagi (2000) Lo shoji visto dall’interno © Mitsumasa Fujitsuka
2
63
3
casa-fantasma- progettata dall’architetto tedesco Bruno Taut”.6 Figlio di un appassionato d’arte, collezionista di molti degli oggetti disegnati da Taut in Giappone (tazze in ceramica, scatole in lacca e di altri complementi di arredo) Kengo Kuma può essere forse considerato, nonostante l’ovvia distanza temporale, uno dei migliori allievi giapponesi del maestro tedesco. La sua personale evoluzione poetica è del resto sintomatica di quella generazione di architetti nipponici nata nella seconda metà degli anni ’50 che, dopo aver completato la propria formazione con esperienze all’estero -come lo stesso Kuma- o dopo aver lavorato per un periodo negli studi dei loro maestri, si è potuta inserire sul mercato solamente negli ultimi anni della bubble economy. Kuma incontra l’opera di Taut in una fase particolare della sua carriera. Agli inizi degli anni ’90 l’economia nipponica è crollata; e con essa le ragioni stesse del caos incredibilmente eccitante di Tokyo/ Edo. Le occasioni professionali si trovano ora nelle province, generalmente me-
64
diante piccoli progetti attraverso i quali rimodulare il proprio approccio teorico anche in virtù del confronto diretto con gli artigiani del luogo. Kuma, già allievo di Hiroshi Hara al campus di Roppongi della Tokyo University, non è infatti indifferente alla materialità dell’architettura. Ha partecipato da studente ai viaggi di studio in Africa organizzati dal suo professore. E con lui ha scoperto l’architettura vernacolare locale. Hara più interessato alle architetture dei deserti, con forme e piante forti costruite in terra cruda, Kuma forse già attratto dai leggeri intrecci di paglia, di rami o di fibre vegetali che connotano le capanne delle popolazioni centrafricane. Tangenze e differenze che comunque risulteranno fondamentali nella sua formazione. Il primo incarico offerto dopo l’esplosione della bolla economica è dunque un osservatorio, situato in un’isola del mare interno del Giappone, nei pressi della città di Imabari. “Il mio ultimo scopo è quello di cancellare l’architettura perché credo che un
5
edificio debba essere una cosa sola con il luogo che lo ospita. Questo è ciò che ho sempre pensato e che continuerò a pensare. Come fare allora per dissolvere l’architettura?”7 L’osservatorio sul monte Kiro è un progetto invisibile. Scavato nella cima della montagna, è puro spazio senza alcuna facciata. Architettura sepolta, dissolta, fantasmatica come l’annesso progettato da Taut visitato pochi mesi dopo ad Atami. Non a caso è una casa-osservatorio quella che permetterà a Kuma di riconsiderare il suo punto di vista sull’architettura tradizionale. E di ripensare le sue architetture non più come figure frammentate nel caos urbano/dal caos urbano. Né solamente come ecologici spazi negativi affondati nella terra. Dunque è l’incontro con quella casa, così presente nella sua assenza, che plasmerà il progetto Water/Glass, completato nel 1995. Costruita sulla balza di terreno immediatamente superiore a Villa Hyuga, la guesthouse è descritta da Kuma come un omaggio al suo maestro ritrovato. “La casa in Atami mi impressionò così tanto che cominciai a ‘divorare’ tutta l’intera serie dei suoi libri. Anche se visse in Giappone solo tre anni la sua conoscenza della cultura giapponese era sorprendentemente profonda ed io ho imparato molto sul mio paese attraverso i suoi scritti
66
[…]. Dopo aver letto i suoi libri ho deciso di concepire la guesthouse come un omaggio a Taut. Il primo passo è stato quello di costruire una veranda fatta d’acqua. Taut ha espresso una profonda ammirazione per gli engawa di Villa Katsura. Egli riteneva preziosi questi spazi di transizione fra esterno ed interno, in quanto elementi che collegavano il giardino all’edificio. Sono gli esili territori dove il luogo si fonde con lo spazio abitato dall’uomo”.8 Ambiente iconico della guesthouse è una stanza con pareti in vetro, con arredi anch’essi trasparenti, che poggia su un ‘isola’ ellittica posta al centro di una liquida piattaforma. La stanza sfuma i propri confini nel panorama della baia. Il tutto è coperto da un leggero tetto, fatto di vetro e lamelle in acciaio, che filtra la luce e disegna le ombre. L’architettura non è più frammentata, né nascosta nel terreno. Adesso fluttua, leggera, immateriale ma inevitabilmente glaciale. Forse il mistero di Villa Hyuga può aver avuto un ruolo nel successivo progetto per il Noh stage in the forest (1996). Un progetto che segna il riavvicinamento di Kuma alla tradizione, ai suoi materiali, colori e caratteri. Grazie a questa occasione aulica, il legno, la pietra, le stuoie, il bambù, la paglia, la carta tradizionale washi torneranno a comparire sempre sempre più frequentemente nei suoi pro-
6
67
8
getti. Non c’è più bisogno di un’utopia della dissoluzione che frammenti la figura architettonica nel caos urbano perché d’ora in poi saranno i materiali ad essere tesi, lavorati, traforati, inseriti -per usare la terminologia di Kuma- in un processo di “particlization”.9 Sul palcoscenico di 5,4 per 5,4 metri chiamato butai, lo spazio vuoto dove divino ed umano si incontrano, tutto in nuce è già presente: i campi di battaglia e le sale dei palazzi imperiali, le case degli eroi, le vedute poetiche sul paesaggio... e Katsura ed Ise. Un astratto spazio denso, posto sotto l’ombra del grande tetto che proiettandosi verso il giardino, in virtù dell’assenza di qualsiasi parete o schermatura, scioglie ambiguamente l’opposizione dialettica (tutta occidentale) fra l’esterno e l’interno. “Bizzarro mondo d’ombra è quello del Noh. Mondo di bellezza e di intrinseca oscurità. Per noi appartiene all’universo delle illusioni teatrali; ma, ai nostri avi, forse non appariva molto distante dalla vita ordinaria. […] Piacciono, a noi Orientali, i sortilegi che traggono il loro potere solo dai
giochi d’ombra. «Raccogliete sterpi e legateli. Una capanna. Scioglieteli. Lo sterpaio di prima.» Queste parole esprimono bene il nostro modo di pensare: non nella cosa in sé ma nei gradi d’ombra, e nei prodotti del chiaroscuro, risiede la beltà”.10 Concisione espressiva quella del Noh che indurrà progressivamente Kuma ad esaltare singoli elementi della tradizione, come il sudare (le tende avvolgibili in bambù) gli shoji (i pannelli scorrevoli in carta di riso e legno) o il koshi-do ¯ (la schermatura costituita da una serie di travetti di legno) per farne ogni volta tema portante ed esclusivo del progetto. In particolare l’ultimo diverrà l’elemento più citato, la vera e propria cifra stilistica della produzione di questa fase. È con l’Ando Hiroshige Museum completato a Bato nel 2000 (e con lo Stone Museum di Nasu dello stesso anno) che l’opera dell’architetto giapponese assurgerà al successo internazionale. A Bato i temi della cultura costruttiva giapponese sono piegati all’esplorazione dei principi di leggerezza e di sfumatura dello spazio. La vibrazione della luce, l’alternarsi fra pieni e
vuoti raggiunge qui il parossismo, funzionale alla diluizione dell’edificio nel luogo, in accordo con quello che forse è il principale aspetto concettuale dello spazio giapponese: lo shizen. La coesistenza armonica con la natura. Il museo include una strada pedonale pubblica diventando così una porta, aperta sulla retrostante montagna e dunque il vero ingresso al tempio posto sulla sommità di questa. La pelle del museo diviene per metonimia il bosco stesso che ha fornito il materiale per la sua costruzione. La natura filtra la luce, la natura è traguardata dall’interno, nella luce. Poco prima dell’iconico edificio di Bato, Kuma mette in opera due prove generali. Due opere forse meno famose ma parimenti importanti perché appartenenti a questo momento di conquista di una poetica tesa alla verifica continua dei modi della tradizione. Nel centro comunitario di Takayanagi (2000) nei pressi di Niigata, i materiali consueti sono posti a contatto con i nuovi. Così la carta washi convive con lo styrofoam dell’isolamento, mentre la tecnica
69
tradizionale del tetto vegetale tipico delle minka, le case di campagna del nevoso Nord, è posta a contatto con le strutture pretensionate e con l’asfalto. Ma è soprattutto l’opalescenza degli scorrevoli in carta di riso e la nettezza dei ritmici tagli a costruire il mistero. Nel Nasu History Museum di Ashino, una delle tappe dell’Oku no Hosomichi, è invece inserita della paglia all’interno dei pannelli scorrevoli racchiusi fra le lastre di lamiera stirata. La luce è filtrata dall’unione di elementi opposti, resi complementari nel nome della leggerezza. Un gioco dialettico, quello fra tradizione e rinnovamento, analogo a quello dell’ultimo Basho. ¯ 11 Dove la struttura fatta di rivelazioni propria dell’haiku vive nella reiterazione di concetti non contraddittori bensì necessari l’uno all’altro. “L’haiku è la concentrazione millimetrica nelle parole dello sguardo e di ciò che questo vede. L’haiku è il risultato di una sintesi, nello spazio e nel tempo, dell’occhio del poeta e dell’oggetto della sua visione. […] Prima del momento dello sguardo e dopo non c’è nulla. Le parole dell’haiku appaiono fra un silenzio ed un altro, fra uno spazio e l’altro, fra un intervallo e l’altro. L’haiku sembra la traduzione di un incontro in un istante del viaggio, fra lo sguardo-pensiero del poeta e la natura”.12 È dunque una sequenza di istanti assoluti quella che ci pare di scorgere in queste prime opere di Kengo Kuma. 1 Basho¯ Matsuo, L’angusto sentiero del Nord, Vallardi, 2009. Apice della sua produzione l’Oku no Hosomichi descrive in una prosa molto stilizzata inframezzata da brevi haiku il viaggio di cinque mesi che il poeta (in compagnia di un allievo) compie a piedi nel 1689 verso le remote province settentrionali dell’Impero. Considerato uno dei testi più importanti della letteratura classica giapponese, l’Oku no Hosomichi fu molto amato da Marguerite Yourcenar, tanto che negli ultimi anni della sua vita ne ripercorrerà le tracce seguendo l’itinerario di Basho. ¯ E come il poeta raggiungendo Matsushima (una delle tre vedute celebri del Giappone) per vedere il chiaro di luna riflesso nelle acque dell’arcipelago. Cfr. M. Yourcenar, Basho¯ on the road, in Il giro della prigione, Bompiani, Milano, 1999. 2 Invitato da Isaburo Ueno, portavoce dell’associazione giapponese per l’architettura internazionale, Bruno Taut (oramai in esilio dalla Germania nazista) sbarcò in Giappone il 3 Maggio 1933 pensando di rimanere solamente 3 mesi impegnato in conferenze, lezioni e visite per poi proseguire verso gli Stati Uniti. Rimase invece ben tre anni e mezzo, scrivendo quattro saggi sull’arte e l’architettura nipponica oltre a un ricchissimo diario di viaggio. Nel paese del Sol Levante riuscì a costruire un solo edificio mentre progettò e realizzò oltre 300 oggetti fra arredi e complementi di arredo. Il suo contributo alla conoscenza di Villa Katsura, intesa come manifesto ed esempio massimo della modernità dell’architettura tradizionale giapponese è stato fondamentale per più generazioni di architetti, soprattutto locali. 3 Più precisamente nel saggio Getemono oder Haikara ripubblicato in Manfred Speider, Japanische Architektur. Geschichte und Gegenwart, Stuggart, 1983, pp. 72-74. 4 Architecture nouvelle in Japon, in l’Architecture d’Ajour d’hui, n.4, 30 agosto 1935, pp. 46-83. Secondo lo Speider, nonostante gli esempi pubblicati, l’articolo in buona sostanza afferma che non esiste al momento
70
in Giappone un’architettura moderna. Su 220 fotografie inviate alla rivista francese ben 40 sono relative ad architetture tradizionali. 5 Cfr. http://kkaa.co.jp/works/architecture/m2/ “Quando progettai l’edificio M2 (1989-91) a Tokyo agli inizi della mia carriera, ero convinto che se avessi creato un’architettura della frammentazione l’edificio stesso si sarebbe dissolto e fuso nel caos che lo circondava. Tokyo è spesso definita come «città del caos», dove il vecchio e il nuovo, la piccola e la grande scala, l’artificiale e il naturale sono mescolati insieme senza alcun ordine apparente. È possibile riscontrare questo fenomeno -che al tempo stesso è orribile ed attraente- in molte città asiatiche. Era particolarmente predominante nei tardi anni ’80, quando Tokyo era piena di energia e l’economia era florida.”, Kengo Kuma, Introduction, in Botond Bognar, Kengo Kuma, selected works, Princenton Architectural Press, New York, 2005, p. 14. 6 Kengo Kuma, cit. Villa Hyuga rimane infatti l’unica architettura completata da Taut in Giappone. Si tratta di un annesso alla casa di Rihei Hyuga, facoltoso uomo di affari. La casa, posta su un pendio prospiciente l’oceano nella famosa località termale di Atami, era praticamente già completata. Per ottenere una porzione di suolo pianeggiante su cui organizzare il giardino panoramico i precedenti progettisti realizzarono una piattaforma in cemento armato sostenuta da una importante sostruzione. Taut lavorò all’interno di questa struttura ipogea (da qui il soprannome di Casafantasma, poiché invisibile dall’esterno in quanto posta sotto al giardino panoramico) successivamente collegata alla quota della casa principale da una rampa di scale. I tre ambienti così ricavati si configurano dunque come una sorta di padiglione per gli ospiti, organizzato in tre ambienti principali, ognuno aperto sulla vista della baia di Sagami. Taut concepì le tre sale come una sorta di sintesi fra architettura occidentale e nipponica. Non cercando una media ma esaltando al contrario in un’unica composizione i singoli elementi ed i differenti stilemi e caratteri. Il tentativo evidente era quello di declinare in un unico progetto di interni la lezione di Katsura dove “ogni elemento -la casa, l’acqua, l’imbarcadero, l’albero, la pietra, vive di una vita propria. Cerca soltanto buoni rapporti...qualcosa di simile ad una buona compagnia.”. Le tre sale, rispettivamente la Beethoven room (con pavimento in legno in cui ospitare serate danzanti o partite di ping pong che presenta un inedito uso del bambù impiegato nelle schermature, nei corrimano e negli arredi), la Mozart room (una sala di altezza maggiore, sempre in stile occidentale ovvero con pavimento in legno, concepita come un osservatorio sull’oceano contendendo al suo interno una gradonata con alzate in cromia alternata e pareti rivestite di seta rossa) ed infine la Bach room (l’ultimo ambiente in stile giapponese con pavimento in tatami ed un’ulteriore gradonata lignea in cui è ricavata la nicchia del tokonoma, un ambiente privato e gli arredi), sono collegate da una serie di porte scorrevoli che filtrano lo spazio e la luce richiamando così le prospettive e le profondità degli ambienti shoin attribuiti a Kobori Enshu. 7 Kuma, cit. 8 Kuma, ibidem 9 Kengo Kuma, Relativity of materials, The Japan Architect, n.38, 2000, p.86. 10 Junichiro Tanizaki, Libro d’ombra, Bompiani, Milano, 1982 [1935], pp. 57 e 64. 11 “La grande novità apportata dall’opera di Bash¯o è consistita, come detto in apertura, nell’aver dato dignità ad un elemento della poesia a catena, l’hokku (oggi definito haiku). Elevandolo a elemento poetico autonomo; e nell’aver trasfuso in esso il frutto di una serrata ricerca letteraria e linguistica condotta con gli strumenti colti propri della cultura classica cinese e della filosofia zen. Una ricerca culminata, nel momento della maturità artistica di Basho, ¯ in una poesia caratterizzata solo dagli elementi essenziali dell’estetica della povertà e della semplicità, e dalla riscoperta della bellezza della quotidianità. In questa forma poetica, caratterizzata da un linguaggio chiaro e conciso, essenziale e, nella sua liricità, quasi rarefatto, Bash¯o inserì infatti elementi del vivere quotidiano, spesso banali o umili, attraverso cui si colgono però i segni delle emozioni del poeta, immerso nella natura e in colloquio con gli antichi, in una mescolanza di bellezze universali e di oggetti comuni, di banale e caduco e di sublime e di eterno, che è forse per il lettore di oggi la massima espressione dell’opera del poeta.” Muramatsu Mariko, Dall’haikai all’haiku: la poesia di Basho¯ in Matsuo Basho, ¯ Poesie. Haiku e scritti poetici a cura di Muramatsu M., La Vita Felice edizioni, Milano, 2010 [1996], pp. 14-15. 12 Fabián Soberón, El viaje y el poema, in Espéculo. Revista de estudios literarios, n.31, 2005, Universidad Complutense de Madrid, p. 42
9
Pagine precedenti: 7 Takayanagi Community Center, Takayanagi (2000) Giochi di luce sulla veranda esterna © Mitsumasa Fujitsuka 8 Takayanagi Community Center, Takayanagi (2000) Veduta notturna dell’area d’ingresso del padiglione © Mitsumasa Fujitsuka 9 Nasu History Museum, Nasu (2000) Veduta dell’attacco del museo con la porta esistente © Shokokusha Pub. Co. Ltd. Photo by T. Hata 10 - 11 Nasu History Museum, Nasu (2000) Veduta delle trasparenze interne attraverso i pannelli scorrevoli © Mitsumasa Fujitsuka
11
71
Miti di luce effimera Alberto Pireddu
È come indelebile, nella memoria di chi approfondisce la storia recente dell’architettura spagnola, l’immagine di alcuni dei padiglioni che durante il XX secolo hanno rappresentato il paese in occasione delle principali esposizioni universali e internazionali, con le loro forme sospese nel solo apparentemente irriducibile contrasto tra produzione e rappresentazione, regionalismo e internazionalismo, permanenza e transitorietà. A Parigi, nel 1937, le aeree trasparenze del Padiglione della Repubblica Spagnola all’Esposizione Internazionale Arti e Tecniche nella vita moderna, frutto della difficile e complessa collaborazione tra Luis Lacasa e José Luis Sert. Un edificio di tre piani, organizzato intorno a un grande patio-auditorio centrale, appena coperto da un velarium, nel quale i riflessi e le ombre mutevoli della Fuente de Mercurio di Alexander Calder dialogavano con il tenue chiaroscuro del montage à sec della struttura di elementi prefabbricati e con le apocalittiche visioni della Guernica di Picasso, straordinario contributo dell’artista alla causa della República Española. Nel 1958, il Padiglione Spagnolo all’Esposizione Universale di Bruxelles, opera di Ramón Vásquez Molezún e José Antonio Corrales, un arcipelago di moduli esagonali, metafisici ombrelli di differente altezza che componevano uno spazio di luce, intelligente e chiaro, versatile e austero, brillante come idea prima che come oggetto. Esso sorgeva su un terreno in forte pendenza, in prossimità di un gruppo di alberi, e del bosco intendeva mantenere il carattere diafano e trasparente, nella leggerezza dei sostegni in acciaio galvanizzato, nella copertura in pannelli di fibra di legno e cemento, nello smaterializzarsi dei con-
72
fini in un sapiente alternarsi di cristalli e superfici in laterizio. Pochi anni dopo, nel 1964, il Padiglione di Javier Carvajal Ferrer all’Eposizione Universale di New York, con lo straordinario contrasto tra la severità dell’esterno - un gioco di volumi prismatici di muri bianchi e rugosi nella parte inferiore, grigi e ordinati in blocchi regolari in quella superiore - e la ricchezza spaziale dell’interno. Come un palazzo arabo che custodisce i propri tesori dietro spesse pareti e labirintici percorsi. Il centro della composizione era, ancora una volta, il patio, cuore della vibrazione luminosa accessibile per mezzo di una promenade popolata di opere d’arte e volutamente lasciata in penombra. Intono a esso si disponevano gli spazi espositivi, pensati nei toni del legno e dell’argilla, con le vetrine illuminate da lampade di alluminio che confondevano le proprie geometrie con quelle del soffitto e accoglievano la grande varietà degli oggetti esposti in un continuo tentativo di integrazione tra arti plastiche e architettura.1 All’alba del nuovo secolo, sono i padiglioni di Francisco Mangado e EMBT a rappresentare la “modernità” spagnola in occasione dell’Esposizione Internazionale di Saragozza del 2008 e dell’Esposizione Universale di Shanghai del 2010. Lungo le rive dell’Ebro, Mangado affida al rifrangersi della calda luce d’Aragona sui materiali più poveri (la terracotta, il sughero, il legno e l’acciaio galvanizzato) e ai riflessi dell’acqua, da cui nascono gli esili sostegni della copertura, il compito di misurare quel paso del tiempo che solo può decretare l’autentica capacità di rappresentazione dell’architettura, la sua densità in termini di idee e contenuti e la sua reale continuità, oltre il “momentaneo spettacolo”. Sul lotto trapezoidale, destinato al padi-
glione della Spagna, nasce un “bosco” di colonne dal diametro mutevole che intende contrapporre una forma singolare e poetica - di tessenowiana memoria - alla debole caratterizzazione del luogo: una grande, deserta, ansa del fiume a nord della città storica. Come radure protette dalla luce diretta del sole, in un progressivo addensarsi di ombre, gli spazi espositivi veri e propri sono contenuti in due grandi navi di cristallo, in parte opalino, internamente libere da ingombri strutturali e accessibili per mezzo di calibrati percorsi adagiati sull’acqua. Al loro interno, il ritmo delle grandi travi lignee dei solai si sostituisce a quello delle colonne, disposte in un gioco apparentemente sospeso tra ordine e caso. La vibrazione cromatica si intensifica grazie al sapiente uso dei materiali: l’acciaio galvanizzato dei supporti, il legno annerito dei pavimenti, il sughero dell’intradosso della grande copertura; ovunque, si moltiplicano le viste attraverso le vetrate, oltre le infinite scanalature di terracotta e, a sud, in direzione dell’Ebro e della città antica. A Shanghai, la luce raccolta intorno a un patio, mediterranea e serena, dei padiglioni di Parigi e New York si tramuta, infine, in una cascata luminosa che agli esili ombrelli di Bruxelles e ai fittili pilares di Saragozza sostituisce le trame di un intricato, quasi surreale, cesto di vimini. Sulla sua superficie si narra dell’incontro tra Occidente e Oriente, Spagna e Cina, del sole e della luna, della Natura, degli alberi, del cielo, ma anche dell’eterno dualismo tra positivo e negativo, luce e tenebre, suono e silenzio, vita e morte, caldo e freddo, anima e corpo, maschile e femminile... Come se il lavoro sulla materia, la sua dissoluzione e la conseguente ri-composizione, nel costituire una nuova autenticità rea-
1
1 Ramón Vásquez Molezún e José Antonio Corrales, Padiglione Spagnolo all’Esposizione Universale di Bruxelles, copertura del teatro, zona sud, 1958 2 Ramón Vásquez Molezún e José Antonio Corrales, Padiglione Spagnolo all’Esposizione Universale di Bruxelles, vista notturna esterna, 1958
2
Pagine successive: 3 Ramón Vásquez Molezún e José Antonio Corrales, Padiglione Spagnolo all’Esposizione Universale di Bruxelles, zona nord, 1958 4 Ramón Vásquez Molezún e José Antonio Corrales, Padiglione Spagnolo all’Esposizione Universale di Bruxelles, interno, 1958
73
3
le, cercassero di esprimere un “qualcosa” che sta oltre il colore, la forma, lo spazio e il tempo: una sostanza inalterabile - simile alla luce stessa - che possiede una realtà su un lato e un’altra su quello opposto. Se, però, “la rivelazione dello spazio è l’analogia della rivelazione della luce, del colore, della materia”,2 ecco che gli interni possiedono una intensità non dissimile rispetto a quella dell’involucro esterno. Una grande piazza introduce le sale espositive, in cui le forme curve del padiglione accompagnano il visitatore in una virtuale esperienza della città e della cultura spagnole: dalle origini perdute nella notte dei tempi di Atapuerca e Altamira fino ai nostri giorni e a quelli ancora a venire di
74
Miguelin, il gigante bambino metafora di un immaginato futuro. Nel vestibolo d’ingresso una scala sospesa distribuisce il blocco del ristorante e dei servizi: gli uffici, l’auditorium, la sala stampa, le sale per le riunioni e gli spazi per il personale. La struttura di tubolari d’acciaio, posta a sostegno dei pannelli ondulati di vimini, esibisce il proprio carattere tettonico, innalzandosi da terra e legandosi all’immaterialità del cielo per catturarne la mutevole luce, come una pergola di bambù giapponese o la cupola di un bagno turco perforata da un vortice di stelle luminose.3 È palese il riferimento ad alcune tecniche artigianali comuni alla Spagna e alla Cina nella realizzazione di manufatti intreccia-
ti. Ma non è, forse, l’arte tessile una delle lontane origini dell’architettura? Almeno secondo il semperiano Mysterium der Transfiguration.4 La ricerca sull’involucro e la sua struttura è, certamente, uno dei trait d’union più forti con i padiglioni precedenti e la loro indiscussa “modernità”: con la lezione di Tessenow e Poelzig, che Lacasa portò in Spagna da Dresda e materializzò a Parigi nelle forme di un padiglione che adattava le proprie misure alle dimensioni standard dei materiali disponibili e con la sperimentazione, al limite delle possibilità tecniche della Spagna sul finire degli anni Cinquanta, condotta a Bruxelles da Ramón Vásquez Molezún e José Antonio Corrales.
4
Picasso non dialoga più con Calder delle atrocità della guerra tra Guernica e Almadén e sono lontani i tempi in cui la Spagna rivendicava la propria autarchia di fronte ai più avanzati paesi d’Europa. A Shanghai, come già a Saragozza, va in scena una più matura consapevolezza della propria identità in un mondo ormai globalizzato. Una vecchia fotografia stereoscopica ritrae il Padiglione della Germania di Mies van der Rohe all’Esposizione Universale di Barcellona del 1929. Nella quotidianità di un piovoso pomeriggio d’autunno, l’edificio si dissolve in infiniti riflessi: quelli degli alberi e delle torri del padiglione attiguo, sulla parete rivestita di
marmo, e quelli delle nubi e delle persone che lo popolano, sulle superfici d’acqua volute da Mies e moltiplicate dalla pioggia. Il fotografo coglie i personaggi nell’istante in cui questi si accingono a lasciare il padiglione suggerendo, almeno apparentemente, che esso abbia già vissuto “il suo luogo e la sua ora”. In realtà lo scatto fissa per sempre uno dei rari momenti in cui l’architettura, innalzandosi sul principio di una rituale intangibilità, raggiunge la sua massima bellezza e la sua assoluta perfezione.5 Negli ultimi due secoli le luci effimere di numerose esposizioni si sono spente. Da Parigi a Shanghai la Spagna ha dimostrato di aver compreso la fondamentale
lezione miesiana: che all’architettura non è dato di svanire con esse. 1
Per un approfondimento sul Padiglione di Javier Carvajal Ferrer all’Eposizione Universale di New York, cfr. Juan Miguel Otxotorena, Utopía o nostalgia, tradición o traición. Sobre Javier Carvajal y el Pabellón español de la Feria Mundial de 1964 en Nueva York, in 1964/65 New York World’s Fair. The Spanish Pavillion, Pamplona, T6) Ediciones 2014. 2 Kazimir Severinovich Malevich, La Lumière et la couleur: textes de 1918 à 1926, Lausanne, L’Age d’homme 1981. 3 Cfr. Bernard Rudofsky, Vernacular virtuosity, in Id., Architecture without architects, New York, The Museum of Modern Art, 1964. 4 Cfr. Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder praktische Aesthetik …, Vol. 1: Die Textile Kunst …, Frankfurt am Main, Verlag für Kunst und Wissenschaft, 1860; vol. 2, Keramik, Tektonik, Stereotomie, Metallotechnik, München, Friedrich Bruckmanns‘Verlag, 18631. 5 Cfr. Juan José Lahuerta, Mies popular, in Id., Humaredas. Arquitectura, ornamentación, medios impresos, Madrid, Lampreave 2010, pp. 287-339.
75
76
5 6
5 Javier Carvajal Ferrer, Padiglione Spagnolo alla Eposizione Universale di New York, esterno, 1964. Archivo General de la Universidad de Navarra Fondo Javier Carvajal Ferrer Proyecto 443 6 Javier Carvajal Ferrer, Padiglione Spagnolo alla Eposizione Universale di New York, Secci贸n comercial, Mobiliario y decoraci贸n, Alfombras y textiles, 1964. Archivo General de la Universidad de Navarra Fondo Javier Carvajal Ferrer Proyecto 443
77
7
8
Pagine precedenti: 7 Francisco Mangado, Padiglione Spagnolo alla Esposizione Internazionale di Saragozza, 2008, foto © Pedro Pegenaute 8-9 Enric Miralles Benedetta Tagliabue - EMBT, Padiglione Spagnolo alla Esposizione Internazionale di Shanghai, 2010, foto © Iñigo Bujedo Aguirre
8
80
L’Arte dell’Architettura La Scuola di Luciano Semerani Antonio Monestiroli
Ho letto più volte il libro di Luciano Semerani, Attrazione e contrasto fra le forme, ogni volta con un piacere più intenso non soltanto perché capivo sempre di più ma anche perché riuscivo a riconoscere una rete di riferimenti molto larga, a volte anche contraddittoria, all’interno della quale Semerani colloca il suo discorso. Dopo la prima lettura fatta tutta di fila, resta un piacere senza una chiara motivazione, un piacere per una scrittura di grande chiarezza e precisione pur dovendo parlare di un problema complesso e poco frequentato di questi tempi. Un piacere dovuto anche alla particolare inclinazione di Semerani per il carattere dei personaggi di cui parla, il loro modo di affrontare le questioni dell’architettura attraverso la forma e tutto ciò che riguarda la sua creazione. Semerani vuole bene ai suoi autori, in modo diverso uno dall’altro ma sempre con una grande, motivata simpatia. Motivata da una personale amicizia, a volte da una antica collaborazione, da un’adesione profonda, che lui chiama empatia, verso il mondo di forme creato da ognuno di loro. Ecco, la prima affermazione può essere questa: Semerani scrive solo delle cose che ama, non ha interesse per la critica, per la polemica, per la negazione del lavoro di chicchessia. Anche quando incontra un mondo di forme verso il quale non prova grande trasporto, si legge sempre la volontà di renderle in qualche modo attraenti. Naturalmente questo atteggiamento, fortemente positivo, è all’interno di un campo che esclude proprietà come la razionalità, l’ordine, la semplicità e la classicità delle forme. Queste proprietà appartengono ad un
82
1
mondo che Semerani considera sterile, un mondo di forme accademiche, prive della capacità di procreare, se non copie di se stesso. Semerani sta dall’altra parte dello steccato, sta dalla parte di chi fonda nell’universo delle sensazioni il proprio fare artistico. “L’architettura non è una scienza” dice, sapendo di contraddire, con questa affermazione, una storia lunga millenni. (Basta ricordare la definizione di Leonardo che dice: l’arte è una scienza, che adopera le mani.) Per questo il libro è interessante, provocatorio e, ripetendo una sua parola, attraente: perché questa affermazione obbliga chi la fa ad avere argomenti per sostenerla. Semerani è un maestro in questo senso e lo sappiamo, uno degli ultimi maestri della sua generazione, forse uno degli ultimi in assoluto. Lo avevo capito leggendo un suo libro precedente in cui parla di altri maestri da un punto di osservazione che appartiene proprio al mondo delle sensazioni. Il libro è L’altro moderno edito da Allemandi nel 2000 e bruciato in un magazzino più di dieci anni fa. Ma proprio come l’araba Fenice il libro oggi rinasce in una nuova edizione in cui il concetto di architettura come forma artistica e non come scienza è più forte che mai. Per questo è un libro importante, perché afferma o forse bisogna dire rivendica, tutta la precarietà, l’incertezza, la casualità, ma anche la volontà, la determinazione, il desiderio che sta sotto ogni forma d’arte compiuta, in tutto il tempo della sua esistenza, dalla preistoria ad oggi. È impossibile non entusiasmarsi a questo discorso. Anche da parte mia. Per
cui ho riletto il libro per verificarne la resistenza ad una disposizione d’animo, la mia, secondo Semerani avversa al suo punto di vista. Il libro è fatto di due parti, una prima parte, Incontri, è una sfilata di personaggi, sono scritti d’occasione, lieta ma anche triste, e la seconda, Lezioni, sono saggi sulla questione che riguarda tutti noi, la più difficile delle questioni da affrontare, quella della genesi delle forme. In realtà la distanza fra la prima e la seconda parte è più ridotta di quel che sembra perché Semerani, nella seconda parte, parla ancora di personaggi e questo perché non può fare a meno di legare le forme alla persona che le produce, alla sua vita in un contesto ben definito, con una sua geografia, una sua storia, una sua cultura, ecc. Questa prevalenza della vita nel discorso sulla genesi delle forme rende il testo di Semerani molto denso, impregnato di umanità, un testo in cui è difficile distinguere l’opera dal suo autore, le forme dalle mani che le hanno prodotte. Escludendo, sempre escludendo, questioni di teoria generale. Escludendo ogni forma di deduzione possibile. A questo proposito sono andato a riprendere un brano di Paul Valéry che vi leggo perché sembra scritto da Semerani. “Il lavoro dell’artista, dice Valéry, anche nella parte tutta mentale di questo lavoro, non può ridursi a delle operazioni di pensiero deduttivo. Da una parte, la materia, i mezzi, il momento stesso e una schiera di accidenti introducono nella fabbricazione dell’opera una quantità di condizioni che non solo immettono l’imprevisto e l’indeterminato nel dramma della creazione, ma concorrono persino a renderlo razionalmente inconcepibile,
perché lo trascinano nell’ambito delle cose, “dove si fa cosa” e da pensabile diventa sensibile. D’altra parte, lo si voglia o meno, l’artista non può assolutamente staccarsi dal sentimento dell’arbitrario. Egli procede dall’arbitrario verso una certa necessità, e da un certo disordine verso un certo ordine; e non può fare a meno della sensazione costante di questo arbitrario e di questo disordine, che si oppongono a ciò che gli nasce tra le mani e che gli sembra necessario e ordinato. È questo contrasto che gli fa sentire che sta creando, poiché non può dedurre ciò che gli viene da ciò che già ha. Per questo la sua necessità è completamente diversa da quella del logico. Essa sta tutta nell’istante di questo contrasto e riceve la sua forza dalle proprietà di questo istante di risoluzione, che si tratterà di ritrovare in seguito, o di trasporre o di prolungare secundum artem.” Paul Valéry: Discorso sull’estetica. In: La caccia magica. Guida editori, Napoli 1985, p.188. Il mondo dell’arte è il mondo dell’induzione in cui la realtà fa resistenza ad una perenne volontà di fecondazione. Fecondare la realtà vuol dire darle un senso. Dare un senso a qualcosa che altrimenti non avrebbe senso. Semerani per spiegare questo passaggio fa riferimento alle parole del Vangelo secondo Giovanni, “in principio era il verbo”, per dire che l’origine di tutte le cose sta nella loro denominazione. Anche la Genesi, nella Bibbia, inizia con queste parole: “In principio Dio creò il cielo e la terra… Prima del principio la Terra era una cosa deserta e vacua e tenebre erano sopra la faccia dell’abisso”. Si tratta di quella “invenzione dell’esistente estratta dal vuoto o dal nulla”. In altre parole questo è il compito dell’arte:
2
83
3
dare un senso a ciò che altrimenti sarebbe privo di senso. La spinta alla creazione di forme è dunque il desiderio di senso. Per affrontare il suo discorso Semerani fa riferimento ad altre discipline come la filosofia, la psichiatria, ma soprattutto le altre arti come la musica o la pittura, costruendo un castello che sostituisce quello della razionalità del mondo come sistema in cui muoversi per la sua costruzione. La costruzione del mondo non obbedisce a delle regole precostituite ma obbedisce ad un atto di volontà liberamente determinato. Almeno così è nel mondo dell’arte. La parola più volte ripetuta nel testo di Semerani è la parola desiderio. Dobbiamo riflettere su questa parola e porci la domanda di come, in ognuno di noi, si presenta il desiderio. Questo è il punto sul quale Semerani poggia il suo discorso sull’architettura come arte. La radicalizzazione del suo discorso sull’architettura, (dopo L’altro Moderno in cui Semerani inventa la funzionalità splendente per dire che la funzione va considerata nella sua più alta accezione di finalità), si traduce nella negazione della funzione. La ricerca sulla forma non è indotta dalla funzione ma dal desiderio di un mondo migliore, di una più autentica umanità. L’immagine che lega l’uomo delle caverne con il bisonte disegnato migliaia di anni fa, è il risultato del desiderio di esprimere la consapevolezza, la coscienza di un rapporto con la natura e con il mondo. Saltando migliaia di anni la stessa consapevolezza spinge Francis Bacon a dipingere i suoi ritratti che non ritraggono solo le forme del volto, ma tutto quello che si nasconde nei corpi dei suoi modelli. È ancora il desiderio di conoscenza che
84
porta Bacon a deformare i suoi modelli. E questa è la scuola di Picasso. In questo modo Semerani dice la sua anche sulla storia, o meglio fa dire la loro ai suoi autori che per lo più la negano come continuità e progresso e la assumono come “un groviglio di esperienze”, come dice Lina Bo Bardi, che si ripresentano a una distanza di tempo infinita. Quindi non è la funzione che mette in opera la genesi delle forme, ma il desiderio di conoscenza. A me sembra che questa affermazione sia un punto di partenza solido e aperto a diverse interpretazioni. Nel libro di Semerani si parla di molti suoi amici e di personaggi che ha incontrato e che lo hanno colpito. Fra i suoi amici io penso che Carlo Aymonino, Guido Canella, Aldo Rossi, siano quelli con i quali ha più condiviso il mondo delle forme. Forse dopo Miela Reina per la quale ha parole di grande affetto e ammirazione. Proprio parlando di lei, all’inizio del libro, Semerani mostra il suo modo di parlare dell’arte: la metafora del lago usata per presentarci Miela Reina è un saggio di bravura letteraria che si protrae per molte pagine successive. Ma degli amici, i saggi a mio parere più belli sono quelli su Aldo Rossi e Guido Canella. Rossi e Canella sono presentati come due artisti sovversivi, due artisti capaci di sovvertire l’ordine delle cose. L’incontro con Rossi è al Teatro del Mondo a Venezia dove Rossi scopre difetti di costruzione anche grossi: la zattera inclinata, la struttura messa al posto sbagliato, eccetera. Difetti che Aldo Rossi è capace di rovesciare come testimonianza dell’effimero e quindi come pregi dell’opera. Il
significato del Teatro del Mondo per Aldo Rossi sta altrove, non certo nella perfezione dell’esecuzione, ma nel suo essere simbolo dell’intera città di Venezia. Se proviamo a pensare cosa avremmo fatto noi al suo posto, se Portoghesi avesse dato l’incarico a noi e non a lui, capiremmo perché Semerani, parlando di Rossi, parla di genialità. Perché Rossi, con un unico piccolo edificio galleggiante, in qualche maniera, è capace di riassumere tutta Venezia. Rossi conosce a fondo Venezia, l’ha studiata in lungo e in largo anche con l’aiuto di Saverio Muratori. Gli studi su Venezia, sistematici e in fondo di matrice positivista, vengono sovvertiti dal Teatro del mondo. Ho già detto altrove a questo proposito del rapporto di Rossi con Herman Melville, della differenza fra le tante balene inseguite e uccise durante la caccia, sistematicamente descritte e classificate in uno straordinario catalogo di cetologia e la balena bianca, sempre inseguita e mai uccisa, sempre presente davanti agli occhi del Capitano Achab come delirante necessità di farla cosa sua. Come la caccia alla balena di Melville anche l’architettura per Aldo Rossi è un’idea fissa, anche l’architettura procede attraverso il sovvertimento di un mondo conosciuto razionalmente. Un atteggiamento simile è quello di Guido Canella, amico di Aldo Rossi e di Luciano Semerani. Per parlare di Canella, Semerani sceglie due progetti che anch’io ho sempre considerato straordinari. Il progetto per Padiglione Italia fatto per una Biennale di Venezia (1988) e un altro, del ponte dell’Accademia, per un’altra Biennale (1985). Io ho partecipato a questo concorso, conosco bene
4
5
85
6
il problema posto e sono in grado di capire bene il volo acrobatico fatto da Canella nel suo progetto. Pensate a quante soluzioni tecniche si presta un tema come quello del ponte, quante soluzioni che rispondono nel modo più efficiente al problema dell’attraversamento del canale. Canella risponde con una costruzione acrobatica che porta in alto chi vuole vedere tutta Venezia. Anche in questo caso come per il Teatro del Mondo di Rossi, il tema è la città di Venezia, nella sua totalità e nel suo significato carico di meraviglia. Un progetto inaspettato, fuori dal comune, impossibile da far capire alla giuria, destinato alla storia del pensiero sull’architettura. Lo stesso vale per il Padiglione Italia sempre a Venezia nell’88. Dice Semerani: “Sulla pelle squamosa di un gigantesco animale marino un percorso di stazioni trasformava il palazzo per esposizioni in un camminamento. Sull’orizzonte più alto ricordi di gru dissolvevano la dimensione museale arciconsunta della Biennale in una operatività operaia desunta dalle vicine aree cantieristiche”. Semerani conclude il suo bellissimo scritto su Canella dicendo: “Se un giorno qualcuno vorrà riscrivere la vera storia dell’arte del XX secolo, Guido avrà un posto tra i suoi contemporanei che hanno creduto che le costruzioni e le città avessero un’anima”. Questa è vera amicizia. Dopo gli amici, i maestri: i maestri di Semerani a Venezia e a Milano: Samonà, Gardella, Rogers. Un triangolo formidabile fra tre maestri di cui avremmo ancora un grande bisogno. Jean Cocteau dice che “il poeta si ricorda dell’avvenire”. Pensate a questa affermazione, che tira una fune tra la storia e l’avvenire delle città.
86
È quello che fa Samonà con il suo libro L’urbanistica e l’avvenire delle città europee in cui, dice Semerani, le città vengono studiate nelle loro differenze, specificità, forme, architetture di cui sono fatte. L’unità architettura urbanistica di cui parla Samonà, porta fuori l’urbanistica dal suo apparato burocratico e fa si che noi riusciamo a riconoscere di ogni città il corpo, con una sua fisiologia e morfologia che le distingue una per una. Da qui gli studi di analisi urbana avviati a Venezia prima e a Milano dopo che saranno alimento per tutti quegli architetti che nel progetto cercano quel supporto rigido di cui parla Aldo Rossi, su cui innestare la loro immaginazione. Gardella è un ingegnere. Semerani insiste su questo fatto come se volesse sottolineare una attitudine di Gardella alla razionalità del procedimento, come se gli ingegneri avessero questa attitudine e, parlando della casa alle Zattere, orienta tutto il suo discorso sulla decorazione come unico fattore di quella casa che la lega alla città di Venezia. Come se tutta la casa fosse contenuta nel fronte sul canale della Giudecca, quel vuoto urbano per usare le parole di Samonà, su cui affacciano anche le opere di Palladio. È come se di quel fronte interessasse solo la decorazione o l’ornamento, parole usate in questo caso come sinonimi da Semerani. “L’ornamento, la materia, il colore, il rivestimento e la facciata non sono più solo costruzione ma sono la scoperta della maschera e non può non essere detto che Venezia, nella immensa ricchezza della sua scenografia urbana e nelle sue fabbriche, è soprattutto la capitale del Teatro”. Ma cosa dire di questo ingegnere-architetto lombardo che per respirare l’aria di
Venezia come dice lui stesso in questo caso, forse l’unico della sua carriera, rinuncia a mostrare il corpo dell’edificio e lo riduce al suo scena fronte? Forse senza neanche avere la consapevolezza della mutilazione compiuta e della maschera di cui parla Semerani. Credo che la tanto citata casa alle Zattere di Gardella non fosse all’altezza della battaglia con Reyner Banham, battaglia che invece ha vinto la Torre Velasca dei BBPR, quella torre, costruita a Milano, che lo stesso Gardella avrebbe voluto “opera sua”. Parlando del suo terzo ma forse primo maestro e cioè di Ernesto Nathan Rogers, Semerani parla appunto della Torre Velasca. Nel libro, lo ripeto, si parla sempre delle persone attraverso le opere, come si parla delle opere attraverso le persone. È come se per Semerani vi fosse una specie di passaggio osmotico del carattere delle persone nelle opere e viceversa. Nell’antichità si credeva che negli edifici entrasse lo spirito degli Dei, Semerani dice che negli edifici della modernità si nasconde il carattere di chi li ha concepiti, in ogni caso le sue intenzioni. Ho detto altrove che Semerani è il migliore allievo di Rogers per la sua apertura mentale e attitudine al pensiero filosofico. Semerani parla di Rogers, legandolo ai filosofi milanesi, Enzo Paci prima degli altri, che gli trasmettono quella generale capacità della filosofia (e dell’architettura) di dare “un senso a ciò che altrimenti sarebbe privo di senso”. Di ciò abbiamo già parlato ma va detto che la Torre Velasca svolge proprio questo ruolo rivelatore nel momento in cui la torre si racconta raccontando la sua potenza. “Una potenza muscolare e fisica,
7
Pagine precedenti: 1 Luciano Semerani, schizzo “Ospedale Universitario Regionale di Cattinara”, Trieste, 1978 (china su carta 8,5 x 13,5 cm) 2 Carlo Aymonino, “Colosso”, Roma, 1982-84 3 Ernesto N. Rogers, “Acquarello” 4 Aldo Rossi, “Il Teatro del Mondo”, 1980 5 Guido Canella, “Ponte dell’Accademia”, Biennale Venezia, 1985 6 Luciano Semerani a La Habana, Archivio Enrico Bordogna, 1995 7 Luciano Semerani, schizzo Mostra “Lina Bo Bardi architetto” Biennale Venezia, 2004 (china su carta 14,5 x 20,5 cm) 8 Lina Bo Bardi, “MASP” San Paolo del Brasile, 1957-1968 Pagine successive: 9 Manifesto “Berlino - più bella che mai” “Programma nazionale per la ricostruzione della capitale” 10 John Hejduk, “Abitazioni a Kreutzberg”, Berlino 1988 Immagini dal libro Luciano Semerani, Incontri e Lezioni. Attrazione e contrasto tra le forme, Clean, Napoli, 2013
8
87
9
con un tono grave di pesantezza propria della torre e non dei grattacieli che cercano invece lucentezza e levità”. Una descrizione questa di Semerani tutta rivolta all’espressione che però mette in evidenza un meccanismo che è proprio del lavoro degli architetti milanesi, “quello della ricerca intenzionale, attraverso l’immagine, dell’interpretazione autentica del “tema”.” Semerani nel libro parla più volte di Rogers e ne mette in evidenza la grande fragilità non solo fisica: “Ernesto era autorevolmente timido e allegramente infelice” dice Semerani che come sempre con poche parole centra l’essenza delle persone e delle cose. Ma come conciliare l’infelicità, fragilità dell’autore con la potenza della torre? I casi sono due: o Rogers non è stato il primo architetto della torre, cosa che io non credo, oppure è proprio questa infelicità che lo ha accompagnato nel tempo e gli ha fatto crescere la forza da trasferire alla sua Torre. Il rapporto osmotico fra l’artista e ciò che produce è particolarmente sottolineato nell’opera di due architetti molto amati da Semerani: Lina Bo Bardi e John Hejduk. Di Lina Bo Bardi dice: “è una donna sensibile e insofferente. Sensibile nei confronti di un mondo magico che si esprime con forme abnormi di vitalità nella cultura degli schiavi africani. Insofferente verso i luoghi comuni di una civiltà europea da esportazione e di colonizzazione. La proclamazione del diritto al brutto che Lina Bo Bardi sviluppa con i suoi pamphlet e con le sue esposizioni d’arte popolare si invera nei disegni di architettura e nelle opere costruite. È l’unica rivoluzione praticabile da un architetto in prima persona.
88
Il mondo di Lina, continua Semerani, ha il suo motore nel desiderio. È difficile non pensare al desiderio come a un fiume, che percorre tutta la creatività furiosa di Lina Bo Bardi”. Questo rapporto fra le opere e chi le produce è particolarmente forte per John Hejduk. “Lui era molto alto e grosso” dice Semerani. “Per queste sue misure era stato scartato dal servizio militare”… questo sembra l’attacco di un racconto di Carver. Poi continua: “Nella casa di Hejduk, che era molto piccola, e più adatta alle forme della moglie Gloria, vi erano due stampe: una della Battaglia di San Romano, dipinta da Paolo Uccello alla metà del ’400, dove dice Semerani “la stratificazione dei piani e la rotazione dei corpi è ad un tempo artificio compositivo e metafora del passaggio dalla vita alla morte”. L’altra stampa è un ingranaggio di Fernand Léger, metafora del mondo delle macchine. Tutto questo appartiene alla persona di Hejduk, uno dei dieci architetti del secolo scorso di cui vale la pena di parlare. Il corpo è importante per Hejduk, non solo il suo corpo e il corpo dei cavalieri di Paolo Uccello, ma il corpo degli edifici. “Hejduk fa uso della fisiognomica” dice Semerani, e continua “l’espressione architettonica si appoggia alle figure del corpo umano per far risuonare le corde dell’anima avendo come tòpos il corpo” dice Semerani citando Bataille e continua: “Hejduk ha concesso agli edifici, se non un’anima, una dimensione psichica. Essi sono nevrastenici come i loro abitanti, impotenti, libidinosi, cattivi o anche generosi”. In questo modo Hejduk mette in scena una moltitudine di caratteri che, come
dice Semerani, ricorda le invenzioni architettoniche di Ledoux. Così siamo arrivati alle conclusioni, all’ottava lezione intitolata “La composizione e la cultura del XX secolo”. In questa lezione, che conclude il libro, dopo aver citato John Cage e la nozione di “composizione aleatoria”, un’ idea della composizione che lascia spazio al caso, che nega l’importanza di ogni intenzionalità nel fare artistico, Semerani rivendica la necessità di definire nuove regole in cui si dia spazio all’evocazione dell’irrazionale. Come è avvenuto nelle avanguardie del XX secolo, dice Semerani: “si è formata una miscela esplosiva di dati razionali e di depositi irrazionali, di circostanze individuali e di “imprinting” regionali”. Per concludere voglio leggere il passo di Semerani che considero l’ipotesi fondativa del nostro mestiere. Questo dopo che Semerani ha dissodato il terreno della partecipazione degli uomini e delle donne, anima e corpo, ai loro progetti, lasciando circolare in piena libertà tutti i desideri che il pensiero logico deduttivo ha sempre soffocato. “La composizione, dice Semerani, risponde alla necessità di ridurre o estrarre dai dati immediati dell’esperienza, l’essenza, ovvero la struttura e le forme dell’esperienza” e evocando il pensiero di Husserl continua: “quel razionalismo ampliato che pone l’irrazionale e l’empirico come dati da porre a fronte, sullo stesso piano e in un’unica verità, con le forme della ragione”. Dichiaro di essere totalmente d’accordo.
Intervento fatto nel maggio 2014 al Dottorato in Composizione architettonica, IUAV, Venezia sul libro di Luciano Semerani, Incontri e Lezioni. Attrazione e contrasto fra le forme, Clean, Napoli, 2013.
10
89
Laura Andreini - Archea
Luce, Materia, Architettura Laura Andreini
Per comprendere che luce, materia e architettura, siano termini assolutamente inscindibili, non serve far ricorso alla conosciutissima definizione lecorbuseriana di architettura quale esito del gioco sapiente dei volumi sotto la luce, basta riflettere sulla circostanza che in assenza di luce, cioè nel buio assoluto, non può esserci alcuna consapevole percezione dello spazio, né le minime condizioni per abitarlo e, per quanto sublime possa sembrarci l’esistenza di ciò che non vediamo, anche l’immaginazione si nutre di immagini e quindi di luce. Potremmo obiettare che la materia, i materiali e con questi l’architettura, sia indipendente da tale condizione esprimendo intrinsecamente una propria consistenza, una propria grana e quindi una propria tattilità, tuttavia se per l’oggetto domestico di piccole dimensioni possiamo riuscire a comprenderne forma e caratteristiche attraverso un contatto ravvicinato con il corpo, per l’architettura questa opportunità ci è negata nella generalità delle circostanze. Se ciò è vero occorre indagare in che modo non l’architettura, quale esito finale di un processo creativo, ma il progetto possa, o meglio, debba utilizzare la luce quale elemento costituivo di ogni composizione. Occorre cioè discutere ed analizzare la luce non come condizione accidentale ed ineluttabile dell’architettura, viceversa interpretarla quale strumento intenzionale di costruzione e definizione tanto dello spazio architettonico quanto delle sue caratteristiche plastiche e formali. Ancora una volta più delle parole può l’esperienza e, per tutte, quella semplice e mistica della visita al Pantheon dove la luce conquista una fisicità ed una consistenza materica più potente dello stesso involucro architettonico, disegnando sulle pareti non solo
90
la proiezione dilatata dell’apertura apicale ma la rappresentazione inequivocabile della presenza divina e, con questa, l’idea e l’immagine del tempio. La vibrazione che ne deriva nel fruitore è del tutto esaustiva e pervasiva occupando l’immaginario di chi guarda oltre qualsiasi confine immaginifico, disvela le regole dell’esistenza, le leggi della fisica quali la gravità e il rapporto tra il sistema solare e i suoi pianeti, l’alternanza giorno notte e quindi la rotazione terrestre, il mutare delle stagioni, il rapporto tra natura e artificio, il valore dell’effimero e del reale, in definitiva il ciclo della vita ed il senso ultimo del nostro abitare sulla terra. Attratti da un simile spettacolo, stupefacente quanto comune, abbiamo sempre cercato nel nostro lavoro quotidiano sul progetto di considerare la luce, sia essa naturale e quindi legata al ciclo diurno, sia essa artificiale, e quindi protagonista delle ore notturne, come una delle componenti principali dell’arte del costruire, il materiale più prezioso, lo strumento più efficace di ogni narrazione e di ogni percorso artistico. E nell’ambito delle arti che da sempre si mescolano e influenzano l’architettura quale tautologia della creazione, abbiamo sempre guardato con attenzione a quelle espressioni figurative che - non si tratta di un gioco di parole - hanno rinunciato alla figura in favore della luce e dello spazio, dai tagli e buchi di Lucio Fontana alle superfici vibratili di Castellani, dalle estroflessioni di Bonalumi agli inviluppi di Scheggi fino ai vuoti seriali di Dadamaino, tanto per restare in un territorio creativo tutto italiano e sufficientemente recente, mentre dovremmo e potremmo tornare senza remore alle origini e quindi a Brunelleschi e Michelangelo che della luce e del rigore geometrico, così come della naturalità hanno tratto il senso del loro messaggio universale.
1
Cantina Antinori/Antinori Winery Bargino, San Casciano Val di Pesa, Italia 2004-2012 Progetto Architettonico/Architectral Design: Archea Associati Laura Andreini Marco Casamonti Silvia Fabi Giovanni Polazzi Direzione lavori/Bulding site supervisor: Paolo Giustiniani Progetto strutturale/Structural design: AEI Progetti Progetto impianti/Design of plants: M&E Management & Engineering Committente/Client: Marchesi Antinori srl Foto: Pietro Savorelli
2
91
Pagine precedenti: 1 La scala dei visitatori vista dalla quota di sbarco al livello dell’arrivo uve e del ristorante 2 Schizzo iniziale del progetto 3 La grande volta della barricaia rivestita in elementi in cotto vista dalla balconata 4 Vista complessiva della barricaia con le barriques in rovere posizionate in filari doppi 5 Vista dal basso del lucernario in corrispondenza dello spazio di ingresso 6 Sezione trasversale della cantina in corrispondenza delle volte che racchiudono le due barricaie, la tinaia e la bottaia Pagine successive: 7 Vista della scala elicoidale in acciaio corten che conduce dalla hall di ingresso visitatori, alla terrazza panoramica fino alle vigne, superando un dislivello di 16,80 ml 8 Planimetria generale della cantina 9 La hall d’ingresso caratterizzata dalla presenza dei pilastri a “V� che interrompono le grandi luci della soletta di copertura in cemento armato 10 Sezione trasversale della cantina in corrispondenza di uno dei due piazzali di carico e scarico
5
C
ARCHEA ASSOCIATI CANTINA ANTINORI ANTINORI WINERY
sezione CC / seccion CC 0
10
20 m
C
Parcheggio uliveta
Affinamento in bottiglia Tramoggia
Tinaia
Ristorante
Barricaia
Uffici amministrativi Museo
Uffici amministrativi Parcheggio bottaia
Strada di accesso
Vigneti
Strada statale Cassia
Terrazza panoramica
6
95
4
0
10
30
8
50 m
ARCHEA ASSOCIATI
96
CANTINA ANTINORI ANTINORI WINERY
planimetria generale / general plan
9
B
ARCHEA ASSOCIATI CANTINA ANTINORI ANTINORI WINERY
sezione BB / seccion BB 0
10
20 m
B
Vano tecnico / Technical room
Tinaia / Vat cellar
Piazzale barriques / Barrique square
Hall visitatori / Visitors’ lobby
Galleria di ingresso / Entrance tunnel
Ristorante / Restaurant
10
97
mdu architetti
Luce e materia Marcello Marchesini
Sulla luce Nel maggio del 1994, sul numero 760 di Domus, il direttore Vittorio Magnago Lampugnani pubblica un breve saggio scritto da Alberto Campo Baeza dal titolo ARCHITETTURA SINE LUCE NULLA ARCHITETTURA EST che indaga sul tema “Intorno alla luce”. Ciò che il famoso architetto spagnolo sostiene, è che l’architettura non esisterebbe senza luce. Tesi che in effetti è difficilmente confutabile se si pensa che è possibile vedere tutto quello che vediamo, solo grazie alla luce; in effetti al buio non è possibile vedere niente. Campo Baeza però si spinge oltre e spiega che la luce deve essere considerata a tutti gli effetti un materiale da costruzione. Un materiale che l’architetto deve imparare ad usare e gestire per migliorare e perfezionare la sua architettura: “quando, infine, un architetto scopre che la luce è il cardine dell’architettura, solo allora comincia a capire qualcosa, a essere un vero architetto”. Potremmo quindi dedurre, dalle parole di Baeza, che il segreto dell’architettura risiede nella profonda comprensione della luce come materiale, come materia, un materiale moderno, come materia che condiziona tutta la storia dell’architettura: “nessuna architettura è possibile senza luce”. Una posizione netta e molto interessante facilmente condivisibile che però non tiene conto del fattore esperenziale, quello cioè legato alla capacità di percepire, annusare e non necessariamente vedere una determinata cosa. Fattore questo che trasporta l’individuo in una dimensione onirica dove il fantastico prende il sopravvento. Per esprimere meglio questo tipo di relazione con l’esistente, fortunatamente ci viene in aiuto Sanguineti, ricordandoci che “c’è qualcosa di più importante della logica: l’immaginazione”.
98
Il rovescio della medaglia è infatti rappresentato dal pensiero espresso dall’artista americano James Turrell che concentra la sua ricerca sulla percezione della luce e dello spazio. Anche per Turrel la luce è materia, ma non serve solo per costruire lo spazio architettonico; la luce è soprattutto materia di indagine esistenziale: “voglio creare spazi che si possano sperimentare con gli occhi aperti. Solo quando la luce viene ridotta considerevolmente possiamo avvertire la sensazione che gli occhi si muovano fuori dallo spazio. Il mio lavoro vuole ridurre l’intensità della luce al punto da avvertirne la presenza”. In questo modo la luce passa da essere oggetto di esperienza tattile e visiva, all’essere “esperienza di pensiero”. La ricerca esasperata del grado zero riguardo l’uso della luce, sposta l’indagine su un piano di astrazione totale dove la luce da elemento materiale passa ad essere elemento immateriale; a questo punto diventa molto più importante il vuoto per comprendere l’essenza delle cose e dell’architettura. Concettualmente è la stessa operazione compiuta dal compositore John Cage con la sua opera dal titolo 4’33” dove antepone il silenzio alla musica. In questo caso il silenzio diventa l’occasione giusta per poter ascoltare quei rumori che altrimenti con la musica non potrebbero essere sentiti. Si lavora pertanto per sottrazione, per paradossi: senza luce posso vedere e sentire cose che vengono elaborate attraverso la forza del pensiero, con la fantasia, con la mia sensibilità percettiva. Sulla materia Se per materia intendiamo semplicemente i materiali da costruzione con i quali sono fatti gli edifici, allora siamo fuori strada. In architettura il rapporto tra materia e ma-
1
Nuovo Teatro Comunale Lea Padovani Montalto di Castro, Roma Concorso Internazionale - Primo premio Committente: Comune Montalto di Castro area totale 10888 m2 superfice totale edificio 1220 m2 teatro per 400 posti arena esterna per 500 posti progetto 2004 - 2005 realizzazione 2005 - 2011 Progetto: mdu architetti Consulenti: ingegneri strutturisti - ACS Ingegneri ingegnere meccanico - Federico Boragine computi - A. Silvestri ingenere acustico - Gianluca Zoppi scene teatrali - Roberto Cosi Foto: Pietro Savorelli
2
99
3
teriale è fondamentale perché legato alla consapevolezza, all’intenzionalità, all’azione dell’uomo, alla sua naturale predisposizione ad agire. I materiali che costituiscono gli edifici che gli architetti progettano sono il frutto di una trasformazione ordinata della materia. Questo passaggio non è né semplice, né scontato anzi è carico di una serie di significati profondi che hanno determinato tutta la storia dell’architettura antica, moderna e contemporanea. San Tommaso ha scritto che, se è vero che
100
una nave è fatta di legno, non è detto che il legno generi in sé la nave. Occorre allora un salto creativo che sappia misurare la distanza tra materia, materiale e intenzione. Carlo Marx, nel celebre apologo su l’ape e l’architetto, ricorda che la sapienza dell’ape, che sa costruire celle in cera con una geometria perfetta, non è confrontabile con quella dell’architetto. Nella mente dell’ape non c’è un progetto ma solo un istinto biologico; in quella dell’architetto invece c’è l’idea di ciò che egli vuole re-
alizzare. I materiali determinano la qualità e la durata nel tempo di ogni architettura realizzata. Non solo, consentono di rendere un edificio più o meno confortevole e accogliente, di qualificare il rapporto con il contesto in cui si inserisce. Se per materia intendiamo il peso con il quale ogni architettura si deve misurare, allora introduciamo un concetto fondamentale: quello della forza di gravità. Richard Buckminster Fuller amava instillare il dubbio e far riflettere committenti e
6
102
7
103
8
Pagine precedenti: 1 Dettaglio ingresso principale con scorcio del foyer e sala principale 2 Il teatro visto dal paese 3 Interno della sala con il rivestimento in legno 4 Dettaglio della parete in cemento armato a faccia vista 5 Ingresso principale con la grande copertura 6 Pianta e sezione longitudinale 7 Dettaglio materiali 8 Particolare della tenda che divide il foyer dalla sala 9 Dettaglio del rivestimento in legno 10 Particolare accesso al bar
104
colleghi, ponendo a bruciapelo la solita, irriverente domanda: “ma quanto pesa il suo edificio?”. Domanda che l’architetto americano non ha esitato a rivolgere al suo amico Norman Foster e che i registi Norberto López Amado e Carlos Carcas hanno recuperato, facendola diventare il titolo del film che racconta la storia del Barone inglese e la sua architettura. Il peso in architettura è un fatto oggettivo, una certezza con la quale il progetto ha instaurato un dialogo perpetuo. Nonostante questa evidente condizione, la storia dimostra che l’architettura è contro la gravità. In antichità ciò si manifestava attraverso l’alternanza dei pieni e dei vuoti, in epoca moderna con l’uso di materiali leggeri e trasparenti. Appese, sospese o smate-
9
rializzate, le architetture cercano sempre di limitare la loro dipendenza ontologica dalla forza di gravità. Sulla luce che incontra la materia Quando un raggio luminoso incontra la materia, il raggio si scompone in tre parti: luce riflessa, luce assorbita e luce trasmessa. In fisica classica, con il termine materia, si indica generalmente qualsiasi cosa che abbia una massa e che occupi spazio; ma questo vale solo per l’infinitamente grande. Quando il campo di ricerca diventa l’infinitamente piccolo, entrano in gioco le leggi della meccanica quantistica e la materia si presta ad interpretazioni diverse. Succede allora che lo spazio occupato da un oggetto è prevalentemente vuoto, che
energia e materia sono equivalenti e che insieme compongono ogni cosa esistente. A confermarlo è l’ equazione della relatività ristretta del 1905 di Albert Einstein: E=mc². In architettura sembra che l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande trovino un punto di contatto che la fisica non riesce a confermare. Prendiamo un qualsiasi edificio. Questo, come tutti gli altri, non può sottrarsi alla forza di gravità, al peso, al fatto di essere denso. In realtà non è così, perché tutti gli edifici, pur essendo infinitamente grandi, sono costituiti per lo più da vuoti e non da pieni. Il senso dello spazio nell’opera di Eduardo Chillida è collegato principalmente al concetto di vuoto. Lo spazio, entità concava, cava, viene ritagliato nella materia. Ritagliare lo spazio
dentro la montagna di Tindaya significa creare un luogo che da pieno diventa vuoto. È il concetto di “spazio carico”, di “vuoto pieno di tensioni e vibrazioni” che sta al centro della ricerca spaziale di Chillida: un vuoto da abitare, da riempire. La costruzione non è più nel mettere una pietra sull’altra per gravità, nell’interporre oggetti dentro lo spazio; la costruzione è costruire lo spazio, costruire la forma immateriale dello spazio dove la luce non serve per rivelare ed esaltare plasticamente le forme dell’architettura, ma per dare corpo al vuoto, per riempire lo spazio ottenuto per sottrazione di materia. La luce allora è un pieno e la materia un vuoto. Il Nuovo Teatro Comunale Lea Padovani è materia scavata dalla luce.
105
Maria Grazia Eccheli Riccardo Campagnola
Riverbero tra i canneti
Bao Gang Wu Liu è un piccolo lotto in Shanghai: succube e immerso in una caotica area industriale in velocissima trasformazione; sbarrato da un enorme fascio di binari, quasi introvabile nel labirinto di corsi d’acque, affluenti dell’immenso estuario dello Yangtse River. Recuperare e trasformare spazi esistenti, mediante demolizioni quasi obbligate; costruire piccole architetture, le sole necessarie alla sua nuova destinazione di Wine World. Piccoli innesti l’idea sottesa al nostro lavoro. Alle demolizioni è, infatti, affidato il compito di dare forma, sia ai vuoti esistenti che quelli ottenuti dalle demolizioni di capannoni obsoleti, in un geometrale disponibile ad accogliere quel bosco di bambù che, si dice, essere in Cina simbolo di lunga vita: certo per una eleganza unita ad una sua virtuosa disponibilità alla costruzione. Nell’area pensata come sineddoche del mondo del vino, il visitatore sarà accolto in edifici immersi nel verde e nell’acqua: temi che il progetto assume per la loro capacità di avvicinare oriente ed occidente. Le terre coltivate a vigneto hanno da sempre caratterizzato il paesaggio di appartenenza, in cui l’esaltazione di una geometria essenziale si trasforma nella morfologia di terreni collinari, costruendo l’aspettativa dell’architettura quale sigillo finale. Elemento principe di tutta la composizione è la strada coperta -Wine Gallery- che, con andamento est/ovest, unisce trasversalmente entrambi i confini dell’area. L’ombra che in oriente sembra avere una sorta di equivalenza con la luce, è la ragione della schermatura della strada/galleria mediante un brise-soleil
106
costituito da una struttura in legno di bambù che trasmette e infonde allo specchio d’acqua da cui sorge una sorta di teorema di luce. La strada/galleria, abitata da parallelepipedi in vetro accidiato, è segnata dalle grandi aperture che ne segnano il carattere di distribuzione, compresa la scala che porta alla cantina sotterranea. A sua conclusione lo spazio “wine bar” si specchia in una grande vasca d’acqua, in cui il ritmo degli esili legni moltiplicano le loro ombre e il riverbero dell’acqua moltiplica i disegni della luce. A filo d’acqua un bianco cubo accoglie e protegge un piccolo ristorante. La strada/galleria distribuisce, a sud, la Main Hall: un edificio esistente la cui destinazione ad uffici viene in parte confermata, ad eccezione del piano terra, destinato a spazio commerciale, e dell’attico disponibile a sala conferenze. Il progetto prevede di avvolgere l’edificio in una maglia di acciaio corten, intagliata da grandi scritte pubblicitarie. La nuova “maschera”, superando in altezza tutti gli edifici dell’intera area, può essere vista dalla concitate strade liminari al lotto, dalla ferrovia e di notte divenire un luminoso faro. A nord della Wine/Gallery, lo spazio per eventi viene ricavato nel grande hangar in cemento, uno spazio tripartito da una ordinata selva di pilastri che la luce, filtrando dall’alto, trasforma in una affascinante rovina del moderno. L’atmosfera délabré, sarà abitata, in un voluto contrasto, dai nuovi bianchi prismi a contenere la molteplicità delle destinazioni. In fregio alla strada Jiangyang South Road, l’accesso a un parcheggio underground, anch’esso coperto dal canneto.
Progetto di riconversione di un’area industriale in Wine/World Shanghai 2013 Progetto: Maria Grazia Eccheli Riccardo Campagnola Alessandro Cossu Collaboratori: Marco Nicoletti Serena Romiti
1_WINE/GALLERY 2_MAIN HALL 3_RESTAURANT ON THE WATER 4_HANGAR 4a_GREENHOUSE 5_WAREHOUSE Pa_UNDERGROUND PARKING P_WAREHOUSE PARKING
107
4
5
108
Il riverbero sull’acqua e l’interno della Wine/Galery
109
Lo spazio gonfiante del Mercato dei Fiori di Pescia una interpretazione Fabio Fabbrizzi
Dalla metà degli anni ’30, la cultura architettonica italiana si dibatteva tra l’adesione a quella cifra classicista già ampiamente postulata durante il Fascismo e le inaspettate visioni che l’estetica funzionalista lasciava intravedere come ricco potenziale di innovazione. Nell’immediato dopoguerra, il bilico di questa incertezza si spostò decisamente verso la ricerca di una realtà sentita come unica e possibile via da percorrere in grado di emanciparsi in maniera netta dal recente passato e contemporaneamente dare una possibilità di futuro. A Firenze, questa revisione ha radici più lontane e parte fondamentalmente da Michelucci e dalla distanza che prende nei confronti dall’appena costruita Stazione di Santa Maria Novella. Una revisione, la sua, capace di individuare proprio in questa realtà, il sovrapporsi di tutte le infinite e mutevoli variabili che concorrono a formare ogni ragionamento che legittima la forma, non più sentita in soli termini di stile, ritmo, proporzione e struttura, ma disposta a scoprirsi sempre più vicina agli innumerevoli bisogni dell’uomo. Posizioni queste, che avranno il merito di condizionare profondamente le generazioni dei suoi collaboratori, quali Leonardo Ricci, Leonardo Savioli e in particolare Giuseppe Giorgio Gori. Ma a ben vedere, si tratta di una visione di realtà pensata come fatto complesso e dotata all’apparenza di una incoerenza dalla quale però, i giovani collaboratori di Michelucci, riescono a cogliere tutta la carica germinativa che essa contiene, ovvero, un nuovo orientamento possibile nella multiforme condizione del progetto, rivolto alla ricerca di una verità, che non è solo bellezza ma soprattutto necessità. Una risposta, questa, che non conterrà gli assoluti di una posizione certa, ovvero non si baserà sulle assertività del funzionalismo né sulla ricerca di regole e standard come
110
il Moderno internazionale stava facendo, quanto piuttosto sulle tracce evolute e interpretate di un possibile nuovo Umanesimo, capace ora come in passato, di riportare l’uomo al centro di ogni ragionamento. Il nuovo Umanesimo di questa giovane generazione fiorentina, nasce dunque già maturo; nasce dal revisionismo critico alle istanze del Moderno, sentite come troppo astratte e inapplicabili in un contesto come quello toscano, poco disposto a svendere i propri caratteri in nome di un’imperante omologazione che nell’adeguarsi a logiche e modelli, pare non tenere conto alcuno di una possibile visione emotiva del progetto. Trasferito Michelucci nel 1947 ad Ingegneria a Bologna, la Facoltà fiorentina rimane in mano ai suoi assistenti e nel forte clima di collaborazione caratterizzato dall’urgenza della ripresa culturale ed economica, il gruppo formato da Gori, Ricci e Savioli, pur con la saltuaria presenza di altre figure professionali, inizia ad elaborare una grande quantità di progetti. Tra questi, spiccano le innovative visioni di una nuova “Firenze sul Fiume”, lasciando il segno di una non scontata reciprocità tra la città e l’acqua in occasione del concorso svoltosi nel ’46 per la ricostruzione delle aree distrutte dai tedeschi attorno a Ponte Vecchio, così come sono da ricordare le innovative proposte elaborate per i concorsi delle ricostruzioni dei vari ponti fiorentini, tutte improntate ad un felice connubio tra la dimensione quotidiana della città e la rappresentatività di un linguaggio che cerca di rendere più umana la propria classicità. Tra questi figurano il progetto del ’45 denominato “L’uomo sul ponte” per il nuovo Ponte alla Vittoria, così come le quattro versioni del progetto del ’49 denominato “Ponte di città” per il nuovo Ponte alla Carraia, o ancora, del ’45 il progetto denominato “Le
1 Il Mercato dei Fiori subito dopo la realizzazione Foto Barsotti Pagine successive: 2-3 Il Mercato dei Fiori subito dopo la realizzazione Foto Barsotti 4 Pianta di progetto 5 - 6 - 7- 8 Prospettive del progetto di concorso contraddistinto dal motto “Quadrifoglio” Archivio di Scienze Tecnologiche, Università degli Studi di Firenze
111
casette” per il nuovo Ponte alle Grazie, come anche la soluzione a tre archi per il nuovo Ponte S. Niccolò. Questa gamma di progetti, anche se permette di leggervi una comune impostazione basata sul “segno” e che costituirà poi un ideale di riferimento che caratterizzerà le poetiche -per dirla con Zevi- dei “due Leonardi fiorentini”, contiene anche in maniera inequivocabile, la costante prevalenza dell’attenzione al metodo impiegato piuttosto che al risultato conseguito. Ricci e Savioli, avranno modo di evolvere questa attenzione verso sfere maggiormente personali, legate al versante dell’espressione, mentre Gori, al contrario, parrà rinunciare molte volte a se stesso, in nome di una via progettuale meno squillante, capace però di dare voce alle infinite diversità delle relazioni che formano il carattere e l’identità di un luogo e di un tema. Come nella migliore accezione di variabilità, non c’è quindi nella poetica di Gori, l’idea precostituita della forma, quindi di una qualunque risposta architettonica e urbanistica intesa nel proprio valore assoluto, ma solo l’incertezza di un percorso che in ogni caso va verificato. Un percorso che è esso stesso risultato e non semplice mezzo per garantire un fine. Poco prima di dare esito consolidato a queste personali posizioni, il gruppo formato da Giuseppe Giorgio Gori, Emilio Brizzi, Enzo Gori, Leonardo Ricci e Leonardo Savioli elabora però un progetto che è un capolavoro nel tenere insieme nello stesso spessore compositivo il segno, l’espressione e il percorso compiuto, ovvero: il Mercato dei Fiori di Pescia, un’opera capace di sovrapporre memoria e innovazione in un percorso che affida principalmente alla dimensione costruttiva il proprio potere al contempo tematico ed evocativo. Nell’autunno del 1949, il Comune di Pescia bandisce un concorso nazionale per la realizzazione di una piazza coperta da destinarsi a mercato orto-floro-frutticolo e da collocarsi in un’area compresa tra la stazione e il centro della città, sulla via Amendola nel nuovo quartiere di S. Michele. La necessità di questa struttura nasce in conseguenza della generalizzata riconversione produttiva dell’area pesciatina che fin dagli anni ’30 si andava evolvendo in un’agricoltura specialistica legata alle produzioni di fiori e in particolare di garofani. Nella stesura del bando viene già richiesta esplicitamente una copertura in cemento armato, dotata ai lati della piazza di uffici, magazzini e servizi, per cui i pochi margini di manovra della commissione valutatrice possono orientarsi a stretta maggioranza sul progetto del gruppo individuato dal motto “Quadrifoglio” perché oltre che dotato di quella bellezza che solo la semplicità pos-
112
siede, appare anche come il più economico da realizzare. Fin da subito, apparve come l’aerea e sottilissima volta in cemento armato immaginata dal gruppo, si librasse in aria gonfiandosi di un proprio moto ascensionale interno, sollevandosi come un telo teso dagli ancoraggi a terra. Rispetto al progetto di concorso, il progetto esecutivo redatto a cavallo tra il ’49 e il ’50, modifica leggermente la quota della chiave della volta e prevede la possibilità di chiusura delle volte laterali su suggerimento della giuria. Nel 1951 l’edificio viene inaugurato e consegnato alla città anche se le rifiniture saranno completate l’anno successivo, ma ciò non impedisce di cogliere la grande forza di questa semplice “tenda” capace di realizzare una copertura di un’area di 72x24 m attraverso la volta di una catenaria ottenuta con travetti di laterizio armato che vanno a scaricare su 6 setti -anch’essi in cemento armato- per ogni lato del rettangolo di base e posti a circa 14 m di distanza l’uno dall’altro. L’incedere parallelo dei setti, ognuno dei quali conformato come una sorta di sperone triangolare definito dalla risultante delle spinte della volta, si modifica solo sugli angoli, disponendoli a 45° in modo da farli funzionare come controventature. La sottilissima volta intonacata di bianco che in chiave misura appena 15 cm, viene sfrangiata alla base lungo i suoi lati da altri archi tesi tra sperone e sperone, dando così all’insieme quel caratteristico aspetto volante che tanto colpì all’epoca della sua realizzazione e che continua tutt’oggi a colpire per l’estrema leggerezza visiva. Negli spazi individuati dal ritmo dagli speroni, viene collocata una serie di bassi volumi quadrangolari coperti da una soletta piana in cemento armato che funziona da irrobustimento dei setti. Questi volumi che ospitano gli uffici, i magazzini e i servizi, sono rivestiti esternamente di bozze di pietra calcarea della Cava Maona situata presso Montecatini e vengono caratterizzati nella propria immagine severa e murata, dal solo tratto filante di alte asole orizzontali che ne illuminano gli interni impedendone la vista dall’esterno. Un’architettura, questa del Mercato dei Fiori, le cui dimensioni costruttiva e figurativa, costituiscono un bilico perfetto nell’esprimere una forma chiara, certa e reale, ma contemporaneamente anche nell’esprimere il paradigma di una dimensione ulteriore, a tratti analoga, in grado di alludere a quella misura serena e a quel carattere arioso che sono propri di una generica memoria architettonica toscana, ottenuta attraverso il ritmo delle parti, attraverso il sapiente rapportarsi di ombra e di luce, nonché l’alternarsi di pieno e di vuoto. Ad essa pare sommarsi, però, forse
2
113
anche in maniera più evidente della prima, una memoria meno paradigmatica e più specifica legata alla peculiarità dei sistemi urbani e architettonici presenti a Pescia, primo fra tutti, quello della cosiddetta “Piazza”. Nella particolare conformazione di questa città caratterizzata dal segno assertivo di una lunga striscia libera dall’edificato -l’attuale Piazza Mazzini ma appunto solo la “Piazza” per ogni suo abitante- emerge con forza la piccola massa compatta dell’Oratorio dei Santi Pietro e Paolo che costituisce insieme al Palazzo dei Vicari, una delle due teste di questo singolare sistema urbano. Solitamente, si arriva in questo spazio provenendo da sud, cioè dal basso, ovvero dal piede della Piazza, per questo, l’Oratorio viene anche individuato come la Chiesa della Madonna di Piè di Piazza. Costruita attorno alla metà del XV Secolo da Andrea di Lazzaro Cavalcanti detto il Buggiano, allievo e figlio adottivo di Filippo Brunelleschi, essa rappresenta uno dei primi esempi di architettura rinascimentale costruita fuori da Firenze. La definizione dei suoi tre fronti, si imposta sul medesimo schema di una grande arcata che interrompe un’alta trabeazione sostenuta da colonne. Questo disegno, realizzato in pietra serena, si ritaglia contro lo sfondo bianco dell’intonaco e nel proprio nitore, rappresenta una delle figure maggiormente ricorrenti dell’architettura antica, più volte illustrata dal Serlio, alcuni decenni dopo questa realizzazione, nei Libri del suo “Trattato di Architettura”. Mentre la Chiesa della Madonna di Piè di Piazza fa da sfondo ad un sistema ad asse longitudinale, il Mercato dei Fiori viene pensato come la parte centrale di un sistema anch’esso longitudinale, ma che spazia sul paesaggio verso opposti punti focali secondo la direzione Est/Ovest, collegandosi in una sorta di doppio cannocchiale sia con il fiume che con la collina. Ovviamente oggi, con le costruzioni a più piani cresciute disordinatamente intorno all’edificio, questa percezione risulta altamente compromessa, depotenziando visibilmente il vigore del segno ottenuto dall’interpretazione stilizzata della serliana che i due fronti corti del mercato offrivano nei confronti dell’intorno. Naturalmente, non esiste nessun dato che ci confermi in maniera certa questa che potremo chiamare come una possibile interpretazione di un’interpretazione, ma mi piace pensare che il disegno della catenaria con i due elementi laterali di sostegno, sia davvero una stilizzazione attuata attraverso la capacità di rendere dinamica la staticità dell’arco tramite l’atto del gonfiarsi, colto solo un attimo prima della posizione del perfetto semicerchio. Quel semicerchio che, forse, potrebbe essere stato preso a
114
memoria delle serliane presenti nella Chiesa di Piè di Piazza. Così come lo stesso atto dell’imprimere movimento ad un elemento architettonico consolidato, fatto non estraneo alla cultura architettonica fiorentina, riporta immediatamente all’esperienza della Cupola di Santa Maria del Fiore e a quel voler dargli una doppia pelle “perché torni più magnifica e gonfiante”1 secondo le parole dello stesso Brunelleschi. Quindi, un enunciare la certezza di una regola ma subito superarla con la forza del progetto. Quella stessa Cupola che Michelucci in “Brunelleschi mago”, definì capace di contenere uno spazio accogliente, ovvero in grado di usare le relazioni della città per fare nuove relazioni, diventando essa stessa città. La stessa idea dello spazio accogliente, tanto rincorsa anche negli anni del dopoguerra dalla variabilità della cultura architettonica fiorentina, trova profonda verità in questa realizzazione che spontaneamente, nei giorni e nelle ore non occupate dal mercato, diviene un vero pezzo di città, attraversato da infiniti flussi vitali e abitato da un vero battito urbano. Notevolissima è stata la fortuna critica di questa architettura, subito salita all’attenzione internazionale anche grazie al premio vinto alcuni anni dopo la sua realizzazione, alla Biennale di San Paolo del Brasile per la sezione dedicata alle opere pubbliche. Un premio che nelle intenzioni degli organizzatori doveva essere una sorta di premio Nobel per l’architettura ma che non andò però mai oltre la prima edizione. Una giuria di caratura internazionale formata fra gli altri da Le Corbusier, Gropius e Aalto, riconobbe all’unisono la bontà di questa realizzazione ed Ernesto N. Rogers che in giuria rappresentava l’Italia, ebbe a dire tempo dopo sulle pagine di “Casabella Continuità” che “Al di là di ogni giudizio comparativo, riguardando oggi questo lavoro, sono lieto del plauso che ha ricevuto in così alta sede perché ravviso in esso qualità intrinseche tuttavia emergenti: la chiara impostazione di problemi pratici si risolve nella limpida eco dello spazio imponente, senza prosopopea come vuole il tema dei fiori che richiedono protezione affettuosa nella dosata economia dell’aria e della luce. Tradizione toscana: un insieme che ci fa pensare al succedersi prospettico brunelleschiano degli archi e delle volte, staticamente logici e coerenti, eppure materialmente lievi”.2 L’autore desidera ringraziare la Dott.ssa Gianna Frosali, Biblioteca di Scienze Tecnologiche dell’Università degli Studi di Fienze. 1 Cfr. Archivio di Stato di Firenze, Filippo Brunelleschi, “Delibera costruttiva del 30 luglio 1420” 2 Cfr. E. N. Rogers, Il mercato dei fiori a Pescia”, in Casabella Continuità n°209/1956, pp. 28-33.
3
4
115
5
6
116
7
8
117
Danteum la luce si fa corpo Francesco Collotti
In una scena graffiante di Uccellacci e uccellini, Pierpaolo Pasolini inventa il Convegno dei Dentisti Dantisti presi a modello di un’Italia stantia, inadatta alle contraddizioni del contemporaneo.1 È la parabola ultima che denuncia la mistificazione della Divina Commedia. Nella costruzione della nazione, Dante è stato usato in chiave patriottico risorgimentale e spesso stravolto, chiamato a legittimare la costruzione di una mitologia italica da epitaffio e lapide, popolata di poeti navigatori ed eroi. L’uso e l’abuso del sommo Poeta ha l’apoteosi politica in epoca fascista, quando la tensione dell’intero sacro poema, non senza schermaglie tra versanti contrapposti di sostenitori, diviene tutta tesa verso quell’aquila che simbolizza la monarchia (cioè l’impero?) e il veltro salvatore e guida, profetizzato da Virgilio nel primo canto dell’Inferno come punto di arrivo del percorso di ascesi. Entità che, secondo una lettura profetico-politica, avrebbe impersonato la figura del Duce.2 Spogliata la Commedia di tutto questo apparato ideologico, di volta in volta piegato alle circostanze, resta la straordinaria costruzione di Dante Alighieri che è un mondo analogo di alto profilo simbolico, i cui molteplici significati evocano un percorso iniziatico che parla a chi sa di dover cercare. Ed è per questa via che sembra intonso e grande il lavoro del Poeta. Beatrice forse è sofia/sapienza e non donna mortale? L’intera opera della Commedia ancora un formidabile teatro delle analogie attraverso cui leggere il mondo? Ciò che sappiamo è che la dialettica tra luce e ombra sta dentro il viaggio che per gradi si dipana nelle cantiche. È lotta e tensione, non acquietata descrizione. Se-
118
quenza di passaggi di stato comprensibili solo per via esoterica, alchemica forse? Riesce il Danteum a tener dentro nella sua pura forma tutto questo? L’incarico parte dall’ideatore Rino Valdameri, Presidente della Reale Accademia di Brera (all’epoca amico e illuminato committente di Lingeri per vari progetti, tra cui le case dell’Isola Comacina e la sequenza di progetti per l’Acccademia con Terragni), ed è ben presto scontro tra la sua figura intraprendente e impegnata sul fronte dell’architettura moderna e dell’arte e l’entourage frenante del ministro Bottai. L’idea è distante da un palazzo come da un museo, prendendo piuttosto a prestito la figura del tempio (la biblioteca, con tutte le edizioni dell’Opera e il fondo illustrato, sarà posta a cripta e sarà l’unica parte aperta verso l’esterno). Secondo una ricostruzione documentata e attendibile,3 Lingeri contatterebbe Terragni (en passant fratello del podestà di Como), mentre la compagine dei sostenitori politici comprende un conte milanese finanziatore per buona parte dell’iniziativa, i ministri dell’Educazione, della Cultura e delle Finanze, nonché Ugo Ojetti, Giovanni Gentile, Massimo Bontempelli e Vittorio Cini. Nomi dunque di primo piano per la valutazione dell’iniziativa, e tuttavia su versanti anche distanti, che porteranno comunque all’implosione del progetto. Dopo i due grandi concorsi romani per il Palazzo del Littorio (1934 prima in via dell’Impero e quindi sull’Aventino 1937) e per il Palazzo dei ricevimenti e dei congressi all’E42 (1937-1939), fatti con Terragni, Lingeri giunge a Roma per il tempio laico composto intorno ai tre grandi ambienti evocati dal Poeta.4 La costruzione perfetta della Divina
1
Tutte le immagini sono riprodotte per gentile concessione dell’Archivio Pietro Lingeri Via Sacchi, 12 Milano 1 Vista dalla torre 2 Vista prospettica
2
119
3
Commedia prende corpo nel Danteum adagiandosi con qualche viscosità sul fianco di quel gesto innaturale che fu la Via dell’Impero in Roma. Allineandosi alle rovine preesistenti più che alla nuova traccia della Via, il Danteum sceglie un tempo più lento rispetto all’ultimo squarcio del regime. La sequenza di proporzioni auree sta dentro le radici romane della basilica di Massenzio, ma per sensato approfondimento, sembra affondare le sue radici in una classicità forse più greca che romana,5 o, meglio, mediterranea ancor prima che augustea? È del resto il lavoro per il Danteum tutt’uno con la ricerca (anche di fronda) di Bardi e Bontempelli prima in “Quadrante” e poi in “Valori primordiali”. È un viaggio di lungo corso per Lingeri e Terragni. È una luce inesorabile la cui corsa arriva a Como da Barcellona, Algeri, Atene per fermarsi nella prospettiva lunga delle montagne bianche di neve che serrano il lago a nord. Ecco il corsivo n.40 su Quadrante: “... sapranno i popoli del Mediterraneo portare,
120
nell’immediato avvenire (…) un ulteriore contributo allo sviluppo dell’architettura europea? Una revisione di alcuni elementi nordici del razionalismo è per noi necessaria. Il clima modifica le funzioni e le forme della parete esterna (Noi sentiamo che gli emozionanti rapporti di pieno e di vuoto di certe case rustiche del mezzogiorno sono esatti; i popoli del litorale mediterraneo – forse anche per la loro povertà – ebbero sempre il senso della precisione essenziale).6 Il paesaggio posato che si traguarda da Villa Leoni a Ossuccio, terrazza di vigna e ulivo che si fa pergola monumentale radicata nella pietra di questa riva del lago ai piedi della Madonna del Soccorso (Lingeri, 1938-1944) o lo sguardo ambizioso dalle travature sommitali della Casa del Fascio di Terragni,7 dicono di un’atmosfera mitica, trascendente il costume, le mode intellettuali: un assieme di forze primigenie, operanti nella realtà e nello spirito.8 La luce che han negli occhi i Maestri comaschi evoca scenari mediterranei primordiali, più profondi che non la sola traduzione ro-
mana “nella massa” del muro che i coevi architetti perseguono.9 Il Danteum, un gesto in pietra ferro e vetro, quasi una costruzione a secco alla maniera di un padiglione temporaneo che tende a una profonda ammirazione per l’astrazione classica, implicitamente avverso al classicismo di maniera che spesso, a Roma e nelle provincie più zelanti, precipitava nella parodia del barocchetto? Volume assoluto il Danteum, appena chiaroscurato dai bassorilievi che ne rinforzano il muro. La luce, più che i numeri, consentono di tradurre la Commedia in forma costruita.10 Ascesi per via di gradi successivi dall’opaco delle colonne di travertino nella Selva alte otto metri per un metro di diametro (e soffitto in lame di vetro interposte ai giganteschi dadi posti a capitello dei fusti), passando per la spirale descritta dalle sette diverse colonne dell’Inferno, sino al solare Paradiso scandito dalle 33 colonne alte 7 metri per 80 centimetri di diametro da erigersi in mattoni di vetro molato. La luce è nel Danteum materiale da co-
4
struzione, come l’ombra del resto, che ne è inseparabile daimon.11 La grande pianta, il Raumplan, le sezioni che ci accompagnano nel viaggio, il gioco a scacchi nello spazio, sono tutti dispositivi di una sequenza narrativa per gradi e stazioni. Come l’opera di Dante è una straordinaria analogia che vive nel teatro della memoria di luce e ombra, così l’organizzazione spaziale analoga fa dunque prender spessore e spazi al viaggio iniziatico verso la luce. Per passaggi di stato mediante luoghi sensibili che tali passaggi segnano, sfalsamenti di piani, gradini, proporzioni degli spazi cui si viene introdotti. Con i poveri strumenti dell’architettura, senza effetti speciali. Come dovrebbe sempre essere. La pianta inestricabile dalla sua sezione è qui messa in opera di una singolare coincidenza programmatica. Nella pianta si compiono le scelte e si distribuiscono i pesi della forma costruita, ma è nella sezione che colgo come la luce e l’ombra si costituiscano in materiali da costruzione.
Ed è pianta commisurata allo spazio in cui vengo accolto. Proporzione in sezione che mi dice di un luogo ove posso consistere, e allora il respiro è più ampio, ovvero mi dice di un corridoio dove incedere, luogo di andare e non di stare. Il testo del Poeta prende corpo, seleziona gerarchie e dispone gli spazi secondo un ordine definito. Pochi numeri in proporzione. Rapporti, questi sì, e tanti, che si fan geometria. Gli spazi tutti in progressione, non solo all’interno di ciascun ambiente, ma nelle relazioni tra ambienti fra loro. La pianta è qui generatrice e impronta di volumi coerenti. La geometria non è il fine, ma un mezzo per il controllo delle idee finalizzato al raggiungimento dell’unità compiuta. Freddi sono quei disegni che riducono i corpi a trame o superficiali orditi grafici. Le case che ne derivano, figlie di quell’ombra negata, il più delle volte esprimono mancanza. La calda vita, al contrario, vien invece fuori nella sequenza di spazi che sanno anche di ombra: la luce mi attira e mi prende per mano in un criptoportico a villa Adriana12
3 Inquadramento generale 4 Planimetria Pagine successive: 5-6-7 Prospetti 8 - 9 - 10 Sezioni 11 - 12 - 13 Piante
121
5
8
11
122
7
10
13
123
14
15
14 Paradiso 15 Purgatorio 16 Inferno 17 Impero Pagine successive: 18 - 19 - 20 - 21 Viste prospettiche
124
16
17
125
18
20
come in un interno di casa dis-velato per gradi, mi fa cogliere uno spessore murario dietro a un tratto scuro (Le Corbusier parla della pianta e dice della luce). La luce e la sua ombra mi danno lo spessore e il tempo di un muro visto a Costantinopoli scavato dal passare delle esperienze, la luce mi tira dentro nel racconto, ma se fossi solo abbagliato non coglierei la piega che mi fa entrare. E per entrare tocca mettersi in ascolto, altrimenti non si passa. Così gli attori estremi di fronte ai quali Virgilio conduce Dante, e che presenta di volta in volta virtuosi o fallaci in ragione della loro condotta terrena, sono immaginati a corrispondente distanza dall’an-
126
gelo caduto posto al centro del mondo analogo capovolto. Del resto pare che gli antichi alchimisti dicessero: Sol et ejus umbra perficiunt Opera. 1
Uccellacci e uccellini Regia: Pier Paolo Pasolini; soggetto e sceneggiatore: Pier Paolo Pasolini; aiuto regia: Sergio Citti; fotografia: Tonino Delli Colli, Mario Bernardo, musica: Ennio Morricone; montaggio: Nino Baragli. Tra gl interpreti: Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi, Gabriele Baldini (il dantista/dentista), Riccardo Redi. Produzione Arco Film (Roma). Italia, 1966; durata: 86’. 2 J.T. Schnapp, Un tempio moderno, in AA.VV. Giuseppe Terragni, catalogo della mostra presso la Triennale di Milano, Milano 1996. 3 Elena Lingeri (vedi infra) in C. Baglione, E. Susani, Pietro Lingeri 1894 1968, Milano 2004. 4 La questione dell’attribuzione del Danteum resta controversa e non risolta. Nel catalogo della prima mostra commemorativa di Terragni tenuta presso
il Salone del Broletto (Como 27 luglio – 10 agosto 1949) pubblicato presso la Tipografia Noseda nel luglio del 1949, in vita e presenti quasi tutti i protagonisti di quella straordinaria stagione, il Danteum non risulta né nell’elenco delle opere del solo Terragni, né nell’elenco delle opere in collaborazione. Il lavoro comune dei due architetti su quel progetto viene tuttavia citato da Alberto Sartoris nell’introduzione titolata “Presenza di Giuseppe Terragni”. Finchè Lingeri fu in vita (primavera 1968) la questione dell’attribuzione non fu ulteriormente discussa, mentre la nota pubblicazione curata da Bruno Zevi su Terragni nell’autunno del 1968, singolarmente e improvvisamente, inserisce senza dubbio il Danteum nell’opera di Terragni. All’estensore di queste note non resta che osservare che le tavole originali che qui mostriamo erano nelle valigie appositamente predisposte che il solo Lingeri portò al cospetto di Mussolini il 10.11.1938 e che recano ciascuna in basso a destra la dicitura inequivocabile Arch. Prof. Pietro Lingeri. Inoltre, nella cartella depositata presso l’Archivio di Stato relativa alla corrispondenza personale di Mussolini risulta citato il solo Lingeri. Le stesse valigie furono poi, al ritorno da Roma, ritrasportate da Lingeri a Tremezzo presso la
19
21
villa di famiglia e lì scamparono al bombardamento dell’agosto 1943 che distrusse lo studio milanese di corso Vittorio Emanuele e la più parte dei disegni ivi contenuti. Firenze Architettura ha potuto visionare queste valigie e il loro contenuto, nonché copia della corrispondenza citata, presso lo studio Lingeri in via Sacchi 12 a Milano grazie alla disponibilità della nipote Elena Lingeri, curatrice dell’archivio. 5 C. Baglione, E. Susani, cit. Milano 2004. 6 “Quadrante: La rivista mensile di arte, lettere e vita”, Direttori M. Bontempelli e 1933. “Pini, vino, oleandri” è il racconto di Bardi di ritorno dalla Grecia con l’ansia di chi sa di “riattingere alla sorgente”. 7 Definitivo e profondo su Terragni si veda da ultimo: A. Pireddu, In abstracto: sull’architettura di Giuseppe Terragni, Firenze 2013. 8 Presagi in “Valori primordiali” n.1 febbraio, Roma Milano 1938. 9 È difficile ritornare sul Danteum aggiungendo qualcosa di nuovo dopo la pubblicazione della monografia del 2004, che ha il merito di ricostruire la vicenda a risarcimento di tante inesattezze che nel tempo la storiografia aveva accumulato. In particolare il contributo nel volume da parte di Elena Lingeri (Attraverso il Danteum: un percorso)
restituisce alla vicenda i suoi contorni documentali, riordinando i materiali e la ricerca che la stessa aveva già presentato in Weltpremiere con Gigi Spinelli e Tommaso Lingeri nel corso di Architekturtheorie tenuto dal sottoscritto presso ETH/Politecnico Federale di Zurigo il 22 novembre 1995. Non ritorniamo sulla vicenda, rimandando alla bibliografia nota su Lingeri e Terragni. 10 Cit. in AA.VV. Giuseppe Terragni, catalogo della mostra presso la Triennale di Milano, Milano 1996. 11 Secondo Platone, non è dato corpo che non porti con sé la sua ombra (mito di Er, libro X della Repubblica). Daimon, entità intermedia tra divino e umano, compagno unico e tipico nostro affidatoci, prima della nascita. Ci piace pensare che questa parte inseparabile sia è l’ombra. Tolta l’ombra non siam più. Il daimon/ombra che non si separa dalla luce, ricorda il contenuto della nostra immagine, gli elementi del disegno prescelto (per alcuni sarebbe il portatore del nostro destino? Forse è solo l’inconscio?). 12 Le Corbusier, Verso un’architettura, Milano 1966.
127
Dichtung und Wahrheit. Scarpa a Castelvecchio: l’invenzione della luce Riccardo Campagnola
“Quando si parla dell’opera [di Carlo Scarpa] - ammoniva Bruno Zevi nel 19781 molti amano adagiarsi in un’atmosfera drogata, arcana e criptica, cui fa riscontro una fraseologia letteraria in bilico tra l’incanto e il melodramma. Chi ha frequentato Carlo assiduamente, nella sua fatica quotidiana, sa benissimo che, di fronte a queste magiche rievocazioni, si metterebbe a ridere” [forse meglio: “si sarebbe messo a ridere”. Una correzione quasi obbligata per uno scritto che, pur intriso di commozione per la morte dell’Autore, non sembra tuttavia rinunciare a certe rivendicazioni su astratte e, a suo giudizio, disattese sue proprie teoresi “alle quali mai Scarpa avrebbe risposto”, testimonia lo stesso Zevi nella seconda parte del suo scritto]. Scarpa, infatti, così avaro nelle sue comunicazioni e/o lezioni, improntate ad una recita poeticamente retorica - la seduzione, quale più profonda alternativa al convincere, come concesso ad ogni vero maestro,2 - vien rivelandosi, invece, sia nelle sue “sofferte” lezioni che nelle rare interviste, ben conscio del livello europeo - della sua cultura: francese, forse, nell’evocazione di un mondo teorico/poetico? O forse viennese, per esplicita ammissione dei propri archetipi formali? O orientale infine, data la metamorfosi di ogni riferimento nell’unità della sua opera appartenente - per manifesta fede - ad una sorta di ideal-typus costantinopolitano? In realtà, tali sintagmi sembrano ripercorrere, in une raccourcie storica e stilistica ad un tempo, la doppia anima (occidentale/orientale) della città per eccellenza: Venezia. In definitiva: una solida struttura teorica ben lontana da quel paradigma d’ingenua artisticità nascente in cui si suole rinchiude-
128
re l’autore. Una coscienza ostinatamente tenuta segreta, così da venir solitamente disattesa ad ogni esplicita richiesta: l’ho sentito criticare il Pantheon, il modello di tutte le architetture, per il suo monolitico quanto elementare (seppur leggendario) sistema proporzionale. Ma, appunto, evidentemente sapendo di barare: impossibile non conoscesse - lui, poi - le infinite trasgressioni con cui l’edificio romano mediava la sua cosmica essenza nella narrativa costruzione dell’edificio… . Già è stato detto: “Ogni artista tende a segretare, più che a rivelare, i propri convincimenti e il proprio mestiere”… . I Nella conferenza tenuta da Scarpa a Madrid - “Mille cipressi”3 - sia pur sotto forma di distratta constatazione, nasce un vero principio teorico: “io non ho fatto molti lavori ex novo. Ho messo a posto [l’assonanza con la nota declinazione dialettale veneta si rivela, come sempre, sostitutiva di un italiano non altrettanto espressivo] musei e allestito mostre, operando sempre in un contesto. Quando il contesto è obbligato, forse [impagabile l’avverbio], un lavoro diventa più facile”: un understatement che vale un trattato… E, subito dopo, pragmaticamente: “Se vi sono delle parti originali [nell’edificio da restaurare/modificare], vanno conservate: qualunque altro intervento deve essere disegnato e pensato in maniera nuova. Non si può affermare: “io faccio il moderno - metto acciaio e cristalli -“: può andare meglio il legno, oppure potrebbe essere più adatta una cosa modesta…”. Inequivocabili, per quanto improbabili, echi Tessenowiani? Di seguito, sono dedotte conseguenze di non poco momento con una singolare
contro-intervista: “[Lei] ricorda come nella Querini Stampalia ho risolto il restauro della scala di accesso ai piani superiori?” - la domanda rivolta nel maggio 1978 da Scarpa all’agguerrito intervistatore spagnolo Martin Dominguez ha un’unica risposta obbligata - “Lei ha collocato delle lastre di marmo sopra i gradini danneggiati dal tempo”. La risposta di Scarpa costituisce il primo paradigma (Dichtung?) del rapporto tra tempo e progetto: “Precisamente - risponde Scarpa -. In questo modo si può rinnovare una scala senza distruggerla, preservandone l’identità e la storia, aumentando la tensione tra il nuovo e il vecchio: [e l’idea viene subito ampliata a principio compositivo] mi preoccupava molto articolare le connessioni dei giunti per spiegare la logica visiva dell’unione tra le diverse parti”. Ancora il Tessenow de “il dividere e il collegare”? Ma l’endiadi richiede, come decisivo, un secondo paradigma (Wahrheit): “a Castelvecchio gli antichi costruttori si erano posti il problema dell’identità formale di una serie di abitazioni e della loro connessione. Le stanze erano disposte in fila, fra due muri distanti e distinti; erano le due facciate del Castello. Il muro più antico e massiccio, quasi senza aperture, dava verso il fiume, all’esterno. L’altro, più recente, era più sottile e aperto sul giardino. Vede come nel tempo l’edificio conserva la sua identità? È un principio fondamentale…”. Che importa che Scarpa qui mis-interpreti storia e filologia dell’edificio? Una nativa vis ermeneutica disseziona e critica l’esistente, forse già autorizzata, in un’inestricabile dialettica, dall’intenzionalità in divenire del progetto stesso. Eppure, in altro luogo,4 e quasi riassumen-
do, Scarpa conclude con un inappellabile: “A Castelvecchio, tutto era falso…”. È questo il momento in cui “poesia e verità”, divenendo ragione l’una dell’altra, inaugurano nel processo del progetto di Scarpa quella scepsi analitica che, a poco a poco, ricostruirà la complessa natura del castello originario, soprattutto nell’interrelazione del suo significato rispetto alla città. Si tratta di un passaggio imprescindibile dello Scarpa progettista ma a cui è stato dato quasi sempre un valore meramente statistico: in realtà esso attraversa l’opera del maestro con il valore di uno spartiacque tra metodi diversi di progettare. Metodi che richiederebbero uno studio sulla struttura del processo progettuale di Scarpa. Un indizio è nella doppia cézanniana qualità sorprendentemente rinvenuta nelle “pratiche grafiche” di Carlo Scarpa da Hubert Damisch,5 a partire da un esame della relazione dei disegni con la specificità dell’oggetto di progetto. In una stringente analisi dei disegni, inesorabilmente “esecutivi”, di Scarpa - (visti con l’occhio strutturalistico dell’analista sommo del dizionario di E. Viollet-le-Duc)6 - l’autore rileva una loro duplice intenzionalità basata appunto sulla qualità degli oggetti: “trattandosi di un modello quale quello di Castelvecchio, si può comprendere come l’architetto non si sia preoccupato in alcun momento di visualizzare (nei disegni) “un dispositivo per far vedere”, e ciò a cominciare dai diversi tagli operati nella massa archeologica dell’edificio”; notando subito dopo che “la medesima cosa non accade allorché il progetto (di Scarpa) nasce su una tabula rasa, nel senso letterale dell’espressione…”. II Il castello: storia e inventio del problema. Assicurano gli storici che già l’“augurale” conoscenza romana del luogo avrebbe intravisto - nel punto di minima distanza tra la giacitura del decumano (nel suo proseguimento oltre la porta Borsàri) e la falcata e dolcissima riva curva del fiume - un luogo adeguato a un (non ben specificato) apparecchio di difesa. Tuttavia, perché nel luogo sorgesse l’attuale Castello Scaligero - iniziato da Cangrande II nel 1354, venticinque anni dopo la morte di quel Cangrande I la cui equestre effige sarebbe stata elevata da Scarpa a icona dell’intero museo - era necessaria la presenza di una dramatis persona ulteriore. Proprio quel muro comunale - la cui ragion d’essere nel luogo era l’inglobamento del romano Arco dei Gavi (l’ante-porta dell’urbana Porta Borsàri) come prima
130
porta di ingresso alla città - divenne, con geniale intuizione scaligera, il catalizzatore dell’esistenza del nuovo castello: era il muro comunale a dirimere il vero senso del nuovo edificio, vale a dire a rendere visibile la sua ambigua natura tesa tra due mondi inconciliabili: reggia e piazza d’armi, città e campagna. Si deve appunto al lavoro di Scarpa il disseppellimento (l’“inventio”, si sarebbe detto un tempo) del vero senso dell’immagine e della sua ratio. Ad esempio, la costituzione di una genealogia tipologica che rimanda, quale astratto archetipo, al Castello di Villafranca: ipotizzando, in tal modo, quel rapporto trasformazionale che avrà un ruolo nella teoresi nell’elaborazione italiana dei fondamenti della composizione… . Il muro comunale diviene discrimine tra un interno e un esterno della città e, contemporaneamente, anche del castello. Così che: - all’interno del muro comunale la piazza d’armi scaligera - ripetendo il gesto con cui la città romana aveva demandato alla sola presenza del fiume la propria difesa, rinunciando alle mura per l’intero perimetro bagnato dal suo corso - avrebbe fatto a meno di qualsiasi fortificazione lungo il fiume, lasciando sorprendentemente “aperto” e vuoto il quarto lato del proprio recinto fortificato in corrispondenza della riva del fiume; - all’esterno del muro comunale, mastio e reggia (la “parte residenziale” del castello), sarebbero state unite alla riva sinistra del fiume da un mirabile ponte fortificato, ma con l’esclusione della città, quasi ad additare alla Signoria stessa il suo referente ideale, ghibellino/imperiale che fosse. Il legame tra le due parti dell’edificio, se non dell’idea stessa del castello, è racchiuso in quella Porta del Morbio aperta nel Muro Comunale che - rinvenuta, con logica da sillogismo aristotelico dall’infinito disegnare di Scarpa - sarebbe divenuta, nel progetto, un discrimine non meramente politico/territoriale, ma gnoseologico. III Proprio quel quarto lato del recinto, originariamente aperto sul fiume, divenne l’elemento dialettico del rapporto castello e città: l’intervento “napoleonico”, con la costruzione di due lati contigui dei quattro del recinto fortificato, aveva dato inizio alla “falsa storia” dell’edificio. Si veda quel “falso” muro medioevale innalzato sull’ansa del fiume (che, di lì a poco, sarebbe divenuto anche confine di stato), a comporre la “falsa immagine” di un castello turrito… .
Pagine precedenti: 1 La luce del sud proietta sulla pavimentazione la sovrapposizione delle “false” finestre sulle geometrie dei serramenti di Scarpa 2 La luce autunnale diversa tra cielo e la sua antimateria nella luce del sacello foto Michelangelo Pivetta
La sua facciata sulla piazza d’armi, invece, snellita nello spessore, sarebbe divenuta - con il suo volto originale sfigurato - il paziente supporto dell’ultimo (dei tanti) idòla ottocenteschi: vale a dire il succube lapidarium dei lacerti restituiti da una delle tipiche “macchine urbanistiche” ottocentesche (costruzione degli argini nei centri storici, distruzione delle mura, il superamento di ogni limite nelle espansioni…). Nuovi e geometrici allineamenti, secanti le “naturali” e/o storiche anse dei fiumi urbani secondo “scientifiche” intenzioni, depositeranno i “frutti” di loro astratte geometrie “urbane” quali inerti reperti di una storia inesorabilmente conchiusa. A Verona, è proprio la facciata francese a divenire la tavola anatomica di ricomposizione dei resti, secondo una sorprendente allotropica intenzionalità semantica. Su di essa, stilemi gotici e rinascimentali si comporranno secondo inesorabili quanto estranee simmetrie, a trasformare una “facciata” che, da militare, avrebbe dovuto assumere un’astratta immagine “civile”. IV A - A catalizzare l’intelligibilità della caserma francese e il suo ruolo dialettico nella processualità del progetto museale di Scarpa, sarà la luce (in sue varie declinazioni: da quelle naturalmente varianti ma immodificabili legate alla giacitura astronomica dell’edificio, a quelle dipendenti dai rapporti di illuminazione dettati (o forse costretti?) dall’ultima trasformazione del monumento). In una nobile quanto sommessa lezione di (s)composizione architettonica, cesure e improvvisi vuoti vengono aperti dal progetto proprio nei punti di contatto tra il “falso” edificio napoleonico e gli antichi interpreti del luogo: sono tali criteri di certezza (pur labili ed ancor in attesa dell’unica legittima approvazione, quella proveniente dal progetto stesso) ad insinuare dubbi proprio sulla “verità” di quel fronte edilizio (facciata) sulla corte d’armi: sul suo significato, sul suo senso, sulla sua adeguatezza… B - È proprio l’attenta ricerca della luce: del suo legame con la giacitura astronomica dell’edificio e, quindi, della sua variabilità stagionale;7 del tono con cui si adagia sulle sculture rivelandone i più segreti valori (basterebbe la foto in cui Scarpa indugia, si direbbe, ad interrogare la statua di Santa Cecilia): quasi una vera e propria invenzione della luce cui Scarpa affida il compito di annullare il valore semantico di impropri corpi edilizi e di disgiungere analiticamente unità tra loro incongruenti:
132
3
3 Luce diretta, a misurare la profonditĂ dello spazio, e la riflessa a evidenziare minimi bassorilievi foto Carmelo Provenzani
133
vale a dire estranee alla storia e all’idea strutturale dell’antico edificio. 1. Le conseguenze. Nelle motivazioni per la demolizione della “scala napoleonica” che collegava la piazza d’armi alla “reggia”, fermentavano diverse intenzionalità: - la restituzione del nesso originale storico/architettonico tra le due parti del castello - la medioevale Porta del Morbio - che avrebbe restituito la logicità, se non la storicità, dei nessi sintattici ancor vivi nel teorematico castello; - da cui, per pura consequenzialità progettuale, la possibile ”apertura/distruzione” dell’ultima campata dell’edificio napoleonico (un muro “rifatto”: ennesimo emblema di quel tutto falso ipotizzato, quale controparte immaginativa, da Scarpa). Si sarebbe messa a nudo, in tal modo, l’originaria forza strutturante del muro comunale (di cui si è parlato), su cui si sarebbero create le condizioni del dialettico crogiolo immaginativo del futuro “locus solus” del Cangrande: un luogo, talmente affine alla cosmologia progettuale di uno Scarpa, da essere stato previsto (divinato?) in diversi disegni precedenti e in luoghi diversi del castello… La creazione di un mito? 2. Un’anti-simmetrica voragine (intellettuale prima ancora che reale) venne aperta da Scarpa nel muro “finto medioevale” sull’ansa del fiume, a risarcire il senso architettonico-edilizio della torre di nord-est e delle sue idiomatiche aperture; e - per pura sapienza compositiva - a ritrovare al contempo la luce del nord per la nuova biblioteca angolare (un’artificiale motivazione di un’ironica causalità dialettica). È sorprendente come, dalla raison d’être di tali operazioni di distruzione, venga lentamente a coagularsi negli schizzi del maestro la forma del succedaneo e decisivo mezzo compositivo: una sorta di “non finito” di secondo grado nel senso che, a sua volta, trasforma materiali puramente astratti (pietra, ferro e legno) in araldici emblemi, evocativi di un senso ulteriore, da non determinarsi ma da lasciare aperto ad una sorta di aspettativa (inconscia ma prevista): si veda la forma assunta dal legno nella parete e nel tetto del locus solus del Cangrande, la forma del tetto in rame, il tetto ridotto alla sola trave di colmo ecc. Di qui ne deriva un’atemporale profondità storica (sia concesso l’ossimoro, per il suo senso diegetico) tesa alla conquista di una legittimazione dallo stesso problema che il progetto si propone di risolvere. C - La critica formale messa in atto da Scarpa dissolve e costringe alla loro primitiva (e, finalmente, libera) natura di
134
4
4 L’uso drammatico della luce affidato al variare della luce nell’anno: una liturgia perenne foto Carmelo Provenzani
135
frammenti, gli elementi architettonici obbligati, dal “restauro” dell’Avena del 1926, all’impropria e impossibile funzione di ricomporre l’infranto. Si veda l’improbabile ma obbligata simmetria generale in cui resti gotici, al solito vivi per improvvise e asimmetriche motivazioni narrative, sono obbligati a comporre immagini improprie (un disinvolto uso di elementi di spoglio quale materia meramente disponibile alla creazione di una parodistica e atopica “reggia”, proprio accanto al suo originale appena oltre il muro comunale). Il progetto di Scarpa mira a una vera e propria “de-gestaltizzazione” (sia ammessa la parola a seguire l’intenzionalità degli avàri, sia pur concettualmente decisivi, “studi” sull’esistente) delle varie aperture: finestre, bifore, logge… di una storia raggelata. 1. Tale storia evidenzia soprattutto due strumenti compositivi.
136
Strutturale il primo: la distruzione del valore astrattamente sintattico (secondo una simmetria totale) della falsa compiutezza della facciata così da minarne l’interna gerarchia con la decostruzione delle sue due estremità (sulla corte e sul fiume) nel loro aderire a corpi loro preesistenti. Si tratta di un problema da sempre presente nell’anamnesi di Scarpa: un’intenzione che, risalendo addirittura alla mostra su Altichiero, testimonia l’individuazione istintiva del problema. L’artificiale simmetria della facciata (nel senso che essa non corrispondeva ad alcun interno…) si regge(va) sulla distribuzione dei quattro archiacuti: due all’estremità destra (per chi guarda la facciata) e - occorre dirlo? - due alla sinistra. La sistematica destrutturazione (si legga in senso metaforico) di Scarpa ricava sensi e significati ulteriori ed imprevisti esattamente dal loro esserci (nel senso
5 Il compito strutturale del muro comunale nella storia del castello viene evidenziata dalla negazione del tetto: il tetto si ritrae da ogni compito ad additare significati e sensi ulteriori... 6 Nel vuoto della storia, s’insedia Cangrande: elevato, su un’arca invisibile, ha il compito di unire le due parti e i due piani del Castello, quale sorridente gnomone eponimo della città foto Carmelo Provenzani
che l’esistente viene piegato a sensi altri). Così: se il primo dei due archi di destra verrà diviso a metà dal salomonico muro discriminante l’ingresso dall’uscita del museo; il secondo fermenterà la più poetica delle invenzioni scarpiane: quel “sacello” che, quasi sotterraneo portato alla luce, se n’esce con violenza dal filo di facciata alla ricerca della luce e di un senso altro (arcosolio, forse?) per l’archiacuto. Di contro, dei due archi a sinistra, se il primo scomparirà in nome di più alta etica (ad accogliere l’aereo locus del Cangrande e, ad un tempo, la ritrovata Porta del Morbio nelle mura medioevali a ristabilire equilibri e definitive stabilità semantiche); il secondo verrà coniugato al ritrovato vallo originario ai piedi delle mura medioevali… . 2. La luce, in un corpo fortificato è, per definizione, la negazione dell’una nell’altro. Quale la soluzione di Scarpa? Ai tentativi iniziali di trovare una soluzione per l’illuminazione del museo, ancora succubi della falsa forma della facciata,8 seguirà una sorta di superamento per una soluzione più generale e ben più difficile: in una ostinata e immaginativa obbedienza alle (segrete) richieste dell’edificio e delle destinazioni museali, ogni apertura riceverà una declinazione che ne restituirà la particolarità, in contrappunto con l’immodificabile partitura della facciata. Nel proseguire il suo teorema, il progetto dei serramenti pare ovvio richiedesse forme evocativamente “altre” rispetto alla struttura architettonica degli apparati architettonici esterni posti in essere da una volontà museale senza alcuna prevista distanza critica dall’esistente. Non senza problemi, Scarpa dispone sul filo interno del muro (staccati pertanto dall’immediata cogenza della forma esterna della finestra) i nuovi serramenti, sfuggendo al gioco dei modelli architettonici “ricomposti” (da una storia perenta) per ritrovare una libertà interpretativa altrimenti impossibile… Le nuove forme dialetticamente contrapposte alla geometria degli elementi in pietra, recedono nell’ombra dettata dallo spessore del muro, con un gesto che sembra non immemore dello svuotamento kahnniano del limite esterno degli edifici da ogni sorta di determinazione stilistica in nome di una ritrovata (e salvata) natura di rovina per il nuovo/vecchio edificio… D - Da qui, ne discende la dissoluzione della sbrigativa simmetria delle aperture della (“completamente falsa”) facciata mediante un inesauribile processo ermeneutico che, “pro veritate”, possa evocare: - una vera e propria drammatizzazio-
138
ne della luce (si veda il lungo studio sull’esatta disposizione della “Crocifissione della Tomba”); - e possa prevedere l’introduzione, nella profonda penombra della loggia centrale, di un corpo oscuro (un brise-soleil?) all’altezza d’imposta degli archi archiacuti così che ne possa sorgere anche un’illuminazione riflessa dal pavimento (per il sarcofago di S. Sergio ad esempio). - e, già accennata, la possibilità di corpi estranei che trasformino le aperture ad arco verso il cortile, in rovine disponibili fino alla propria negazione: dai più funzionali, fino alla più poetica delle transustanziazioni (il sacello).
1
Questa, come tutte le citazioni successive, sono riprese dalla quarta edizione (2013) di F. dal Co e G. Mazzariol, Carlo Scarpa 1906-1978, Milano 1984. Il libro è costituito, notoriamente, da meditazioni / “interpretazioni” di vari architetti e storici in cui è ancora viva l’emozione di vari architetti a fronte dell’improvvisa morte di Scarpa. Di fatto, un’istantanea della cultura architettonica italiana e non solo, sorpresa nei suoi esiti e nelle sue intenzioni… 2 La tesi appartiene, inequivocabilmente, a Luciano Semerani, così da dispensare la ricerca di un “luogo preciso” per la citazione. 3 Madrid, estate 1978, in op. cit. pag. 287. La piantumazione de I Mille cipressi era la prima operazione “progettuale” prevista da Scarpa nel luogo della Tomba Monumentale Brion a San Vito d’Altivole. Reso assoluto, il titolo sembra demandare ad una poesia perenne, forse francese ancora: cfr. J. Giono, L’homme qui plantait des arbres, 1953. 4 Ancora in “Mille cipressi”, Ivi, pag. 287. 5 Hubert Damisch, Il disegno di Carlo Scarpa, ivi, pag. 208-2013 6 Cfr. H. D., Introduction à l’«Architecture raisonné», extraits du «Dictionnaire de l’architecture française», Paris 1964. 7 Già il Palladio, nel suo rilievo del teatro romano, annotava al centro dello zoccolo della seconda delle “passeggiate” (così ai chiamano i portici (forse) che misuravano, in larghezza e, per sovrapposizione, anche in altezza, l’intera collina che sovrasta la città e ai cui piedi si adagia il teatro): “volto ad ostro a gradi 15”. A tale orientamento a mezzogiorno (“ad ostro”) obbediva l’intera struttura teatrale: la stessa dei decumani della città ad esso perpendicolare… Non è chi non conosca, tra veronesi, come il sole, in certi periodi dell’anno, inveri all’occaso la stessa giacitura dei decumani, rivelando un’esperienza unica: le strade del centro antico perdono ogni ombra, cosicché, in tutta luce, si rinnova l’antico teorema che univa teatro e città… 8 Cfr. Richard Murphy, Carlo Scarpa & Castelvecchio, Venezia 1991, le pagine 26-29, sono dedicate ai primi studi e alla formulazione del problema.
7 Una delle due incisioni, nel corpo “falso” del lato del castello sul fiume (storicamente mai esistito prima di Napoleone), interpreta la veridicità della soluzione: la torre ritrova la sua forma originaria... foto Michelangelo Pivetta
1
eventi
Angiolo Mazzoni in Toscana Mostra itinerante I toscani, i nati in Toscana e quelli le cui radici sono nella bella terra regina dell’intelligenza e dei geni della patria non possono comprendere per alcuna ragione il modo di dire le cose dei quiriti. Roma stroncò la civiltà etrusca con le armi ma non riuscì a strapparne le radici dal suolo. E dalle radici spuntarono poi i cipressi e il giglio di Firenze.1
La mostra itinerante Angiolo Mazzoni in Toscana rappresenta un significativo tributo all’opera dell’architetto e ingegnere del Ministero delle Comunicazioni e consente di ripercorrere, attraverso un numero copioso di opere, realizzate durante gli anni Venti e Trenta del secolo passato, un emblematico viaggio attraverso il paesaggio toscano, misurando la traduzione architettonica di questi edifici in rapporto all’icastica tradizione dei luoghi in cui si inseriscono. Il legame tra Mazzoni e la Toscana non è solo un fatto di origini - i genitori erano senesi, lo zio Lorenzo Doveri fu professore presso l’Accademia delle Belle Arti di Siena e tra le sue opere ricordiamo il primo nucleo del cimitero monumentale della città - ma la Toscana è, oltretutto, la regione nella quale costruisce il maggior numero di edifici, che rappresentano un complesso significativo per orientarsi all’interno di una ricerca architettonica a volte contraddittoria, sempre in bilico tra adesioni palesi al “moderno” e a soluzioni “tradizionaliste”, dovute al tumulto delle interminabili pratiche burocratiche e alla subordinazione alle mutevoli volontà politiche. Ed è proprio in quegli edifici toscani in cui dimostra una predilezione per alcune figure e forme che esaltano la complessità tecnica della costruzione e che diventano veri e propri temi architettonici declinati in numerose varianti, che vengono fuori quei caratteri di assoluta modernità: nei
140
monumentali propilei d’ingresso della colonia marina al Calambrone, studiati alla stregua di un palinsesto figurativo capace di trasformare in gioco luminoso il simbolo del regime fascista; i cilindri dei serbatoi idrici con le scale avvolgenti; o ancora il sistema metallico, di chiaro stampo costruttivista, costituito dalla scala, i camini e la passerella, utilizzato nella centrale termica di Santa Maria Novella a Firenze in una più complessa volontà di abbracciare l’estetica meccanicista. Tutti elementi esaltati da Marinetti nei suoi articoli e che, insieme ad una attenzione particolare alla “policromia”, assumono una funzione importante per un accredito futurista, pur lasciando tuttavia lo spazio, ad una più felice identificazione con la figurazione metafisica dechirichiana. Certo è che il contributo di Mazzoni risulta fondamentale alla definizione di una architettura di Stato che ambisce a tenere insieme i temi dell’adesione alla memoria e ai significati dei luoghi, in un processo di trasformazione e evoluzione dei tipi architettonici ottocenteschi, propri di edifici di notevole complessità tecnica e infrastrutturale come le stazioni ferroviarie. L’architetto recupera l’unità dell’organismo edilizio superando la dicotomia tra l’immagine urbana del fabbricato viaggiatori e il retrostante apparato tecnologico e funzionale rappresentato dalla galleria dei treni, sostituito con le moderne pensiline in cemento armato, materiale che diviene funzionale ai forti aggetti. È il caso della stazione di Siena, dove il piano geometrico senza soluzione di continuità tra i binari e l’ingresso è allo stesso tempo caratterizzazione formale e soluzione funzionale, ascrivibile direttamente ad una intuizione di Boccioni nel suo Manifesto dell’Architettura Futurista del 1913.2
2
141
Si configura così una strategia compositiva a carattere inclusivo dovuta ad una sensibilità straordinaria nel leggere i luoghi - rara avis tra i funzionari di Stato - caratterizzata da una concezione più aperta e distesa, com’è evidente nella stazione di Montecatini, e da un disegno planimetrico franto arricchito da un linguaggio complesso, formato dalla giustapposizione di corpi di fabbrica geometricamente regolari, configurati come elementi verticali e orizzontamenti di grande luce, che mediano tra la scala del paesaggio e quella della città. Mazzoni per primo fissa le proporzioni e la misura degli atrii delle sue stazioni in rapporto alla scala umana, ed alcuni elementi architettonici che egli utilizza, come ad esempio i portici e le corti, si
142
pongono in continuità con la tradizione configurandosi come soglie attraverso le quali si palesa il mutamento di scala fra interno ed esterno. In alcuni casi il progetto prende avvio dall’interno, evidenziando la peculiarità dello spazio mazzoniano che sembra essere quella di aderire, ancora una volta, alle teorie boccioniane: “il nuovo esterno che risulterà dal trionfo dell’interno creerà ineluttabilmente la nuova linea architettonica”.3 Non ultima, va ricordata la straordinaria qualità del dettaglio costruttivo, frutto di una abilità di tipo artigianale fortemente legata alla tradizione costruttiva italiana, e della sperimentazione di infinite soluzioni materiche che permettono di armonizzare le opere con l’ambiente nel quale si inse-
riscono; mentre l’uso di materiali preziosi arricchisce gli interni, studiati e disegnati in sintonia, come osservato da Giovanni Klaus Koenig, con una sensibilità degna precorritrice del design italiano. Giulio Basili
1
Lettera di Mazzoni ad Alfredo Forti del 21 giugno 1973, ASF, Fondo Forti-Mazzoni, Busta 4 inserto 33. “Le navi le automobili le stazioni ferroviarie tanto più hanno acquistato di espressione estetica quanto più hanno subordinato la loro costruzione architettonica alla necessità dei bisogni cui erano destinate. Alle grandi tettoie ferroviarie che erano lontanamente legate al grandioso della navata della cattedrale subentrano le pensiline sufficienti e necessarie al treno in arrivo e in partenza”. 3 Umberto Boccioni, Manifesto Futurista dell’Architettura. 2
4
5
143
6
Pagine precedenti: 1 Palazzo delle Poste, Grosseto, 1930/32, scala interna, Archivio privato 2 Stazione, Siena, 1933/35, particolare delle pensiline, MART, Maz S.L. 77/03 foto D. Anderson Roma 3 Centrale Termica e Cabina Apparati, Firenze SMN, 1925/32, esterno dai binari, MART, Maz B13 F 20 4 Stazione, Montecatini Terme, 1933/37, esterno verso la cittĂ , MART, Maz B07 F2 04 5 Stazione, Montecatini Terme, 1933/37, sezione, MART, Maz A16 F1 021 6 Colonia marina per i figli dei postelegrafonici e dei ferrovieri, Tirrenia, 1925/32, ingresso, MART, B3 F3 14 7 Colonia marina per i figli dei postelegrafonici e dei ferrovieri, Tirrenia, 1925/32, serbatoi idrici, MART, B3 F8 4
145
Galleria dell’architettura italiana Monestiroli Architetti Associati. Aule
1
146
Così, come ha sottolineato Antonio Monestiroli nella conferenza di presentazione, “Aule” non è solo il titolo della mostra dedicata ad alcuni suoi progetti ma uno dei temi su cui lo studio Monestiroli Architetti Associati fonda il suo lavoro di ricerca. Accurati rapporti geometrici, rigorose simmetrie, equilibri dettati dal sapiente utilizzo di luci, ombre e trasparenze caratterizzano questi progetti. Il continuo confronto con il tema -sempre attualedella rilettura dei tipi architettonici consolidati nella struttura delle nostre città non ha alcun intento classificatorio ma diventa strumento necessario a stabilire il rapporto fra architettura e società. La grande aula, unica, indivisa è il luogo della comunità. È il risultato di una naturale, logica e meticolosa composizione degli strumenti del fare architettura. Ogni elemento, il muro, la soglia, la copertura indipendente dal recinto, è pensato, disegnato ed infine realizzato per sublimare questo tema. Un continuo lavoro finalizzato a ritrovare ogni volta l’ecclesia e l’agorà. I progetti in mostra si distinguono per la diversa declinazione che viene attribuita all’abitare assieme lo spazio architettonico. Questo è chiaro per esempio nei progetti delle aule sacre. Nel rapporto tra la chiesa e lo spazio dell’assemblea e di conseguenza nel rapporto tra lo spazio liturgico ed il fedele. Il progetto per una chiesa al Gallaratese evidenzia, nello sviluppo longitudinale dell’impianto, spazio indiviso tra interno ed esterno, il rapporto tra l’assemblea e lo spazio dedicato ai celebranti, mediato frontalmente dall’ingresso all’aula. Nel progetto per la chiesa di Bergamo i
quattro bracci enfatizzati da muri perimetrali svettanti rispetto alla loro copertura, confluiscono nella centralità dello spazio presbiteriale. Il tema della centralità dello spazio liturgico è ancora più evidente nella chiesa di San Carlo Borromeo a Roma. All’esterno un muro ci accompagna fino allo spazio dell’assemblea racchiusa, definita, protetta dal recinto. Un altro separa lo spazio interno della chiesa dall’esterno. Un’altro ancora delimita gli spazi della canonica e della catechesi. La torre campanaria, faro per il fedele, si innesta come un elemento di mediazione tra lo spazio esterno e l’interno. La luce di questo grande canon à lumière benedice lo spazio del presbiterio intorno al quale si raccolgono i fedeli. Gli spazi destinati alle aule civili confermano l’aspirazione a cui tendono le architetture di Monestiroli, ovvero “chiarezza costruttiva portata alla sua espressione esatta”.1 Nella loggia di Fidenza come nel progetto per la biblioteca di Pescara passando attraverso il progetto di Limbiate è sempre rintracciabile “una soluzione diversa, più avanzata, di un tema di architettura”.2 Le grandi lastre di cielo coprono il recinto che abbraccia l’aula, lo spazio della comunità. “Nel tema di architettura è racchiuso tutto un patrimonio di conoscenze e aspirazioni di una collettività […] Ogni tema viene posto dalla collettività cui appartiene storicamente e torna, dopo essere stato nuovamente svolto, alla collettività stessa”.3 Salvatore Zocco 1 W. Blaser, Mies van der Rohe. Lehre und Schule, Birkhäuser, Basel 1977, p 15. 2 A. Monestiroli, L’architettura della realtà, Torino 1979, p. 20, 22. 3 Ibidem
2
1 Inaugurazione della mostra 2 Progetto per una sala civica a Torricella Peligna, Chieti 1985 Pagine successive: 3 Progetto per il Palazzetto dello sport di Limbiate, 1998 4 Progetto per il Planetario e il Museo della Scienza a Cosenza, 2001 foto di Lisa Carotti
147
3
148
4
149
Forlì, Musei San Domenico Liberty Uno stile per l’Italia moderna
1
150
La breve utopia di un’arte nuova Nel complesso passaggio di fine Ottocento, gli ideali positivisti e borghesi di un’Italia che prevedeva un proprio sviluppo non più agricolo ma industriale, sono alla ricerca di uno stile che possa esprimere al meglio questa nuova identità, aggiornandosi alle consonanze della contemporanea stagione artistica europea, contrassegnata da una comune impostazione che viene variabilmente indicata sotto le differenti dizioni di Art Nouveau, Jugendstil, Modern style, Stile Floreale e Modernismo. Nella generale intenzione di realizzare lo scambio di un’idea per l’arte e un’arte per l’idea, la cui essenza ultima sia il mutamento profondo della società, la forza della linea pare assumere la tensione di questa innovazione, divincolandosi dalle zavorre di un recente passato capace solamente di guardare senza interpretazione, alle scorze dei linguaggi storici. Si scardina, quindi, la stessa grammatica della forma, non più legata fondamentalmente a processi sintattici e tettonici, quanto rivolta ad una composizione improntata alla sinuosità della linea che diviene melodiosa, ma anche elastica, nervosa, capricciosa e in alcuni casi finanche sferzante. Tra tutte le accezioni possibili per indicare il movimento, l’Italia sceglie quella di Liberty, derivata oltre che dal nome dello store londinese nel quale si vendono oggetti artistico-industriali dal gusto moderno, anche a causa dell’immediatezza con la quale questo termine traduce la forte volontà di scrollarsi l’affrancamento al passato, alla tradizione e all’Accademia. Un momento di diffusione di questa arte fu sicuramente l’Esposizione Universale svoltasi a Parigi nel 1900, anche se in Ita-
lia, lo stile raggiunse la sua apoteosi durante l’Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa Moderna di Torino del 1902. Il rinnovamento è repentino e globale. La nuova arte diviene immediatamente arte universale che liberata da ogni vincolo diviene movimento estetico che coinvolge le arti maggiori e quelle minori, l’architettura, l’arredo, la moda e la grafica pubblicitaria. In ogni campo, i temi e le figure che sottendono i processi formali, vanno a guardare la natura, intesa quale serbatoio primigenio di riferimenti. Della natura interessano fondamentalmente i principi che la regolano, desunti attraverso un metodo di osservazione analitica e sperimentale dedotto dagli studi recenti della botanica e della zoologia, arrivando così a ricercare un vocabolario di nuovi elementi che deriva dal mondo vegetale e animale e cercando di trasporre nell’arte la rappresentazione stilizzata dei diversi processi vitali. Per questo la linea fluida viene preferita a quella retta, esprimendo al meglio la fugacità della vitalità e la sua transitoria configurazione. L’avvinghiarsi di un fusto, la casualità di un tralcio, lo sfumarsi di una voluta di fumo, lo sfilacciarsi di una nuvola, la languidezza di un dorso, la sorpresa di un guizzo. Una linea serpentiforme che a sua volta evocando la danza, il ritmo, la musica, si sofferma sul particolare, che viene degerarchizzato rispetto all’impianto totale, ribaltando i ruoli e i rapporti tra le parti. In pittura, questa celebrazione del particolare quale controcanto alla fluidità del generale, pare assumere una precisa dimensione di reazione a quell’allontanamento che tutta la recente prospettiva impressionista ha generato come sensazione nella percezione dell’opera. Le
2
3
151
nuove forme del Liberty, agiscono sulla complessa rappresentazione del reale, lo fluidificano e lo trasfigurano, fino a renderlo prossimo al mondo del sogno e del simbolo, mentre in scultura il corpo, tra vigore e languidezza, diviene l’allegoria di un nuovo annuncio dove il risveglio delle umane caratteristiche di genere, paiono essere il tratto più assertivo e dominante dell’intera modernità. Detto questo, appare dunque oggi quasi necessario, che dopo Wildt e il Novecento, si concludesse con il Liberty (1 Febbraio - 15 Giugno 2014), il trittico di mostre che il San Domenico di Forlì ha voluto dedicare alla modernità. Una mostra sapientemente orchestrata, ricchissima di opere di eccezionale caratura e altrettanto generosa di contributi capaci di offrire il meglio sull’argomento fino ad ora mostrato in Italia. Antonio Paolucci inquadra la generalità dell’evento, Fernando Mazzocca indaga il segmento artistico compreso tra i Preraffaelliti e i Futuristi nel quale il Liberty si pone come nuovo stile per l’Italia mo-
152
derna. Virginia Bertone e Monica Vinardi affrontano il rinnovamento estetico della forma nella Torino del 1902, mentre Maria Flora Giubilei analizza le mostre di Venezia e di Milano del 1903 e del 1907 quali vie italiane alla realizzazione di un nuovo stile. Alessandra Tidda affronta il tema dell’armonia e della bellezza quali utopia europea per una nuova arte e Matteo Fochessati e Gianni Franzone analizzano il tema delle arti applicate attraverso la linea e l’ornamento. Anna Villari affronta il tema della pubblicità e della cartellonistica italiana tra stile floreale e propaganda di guerra, così come Claudia Casali si concentra su Domenico Baccarini e il suo Cenacolo Romagnolo, Antonella Imolesi Pozzi con l’inconscio rivelato attraverso gli autoritratti di Domenico Baccarini, Emanuela Bagattoni affronta il tema dell’Aemilia Ars a Bologna tra tradizione e innovazione e Marco A. Bazzocchi, quello della Ninfa Liberty, così come Gianfranco Brunelli il tema delle figure della letteratura e quelle dell’arte. Un discorso a parte meritano le questioni di architettura, curate da Ulisse Tramonti
che ci conduce lungo un itinerario attraverso “lo stile futuro dell’architettura italiana” condotto in piena “libertà di fantasia con regola di ragione”, sottolineando che l’affermazione di uno stile prende vigore quando si manifesta nell’architettura. Tramonti ci ricorda che la previsione della necessità di uno stile futuro per l’architettura italiana era stata dettata fin dal 1880 da Camillo Boito, quando cioè tutti gli eclettismi erano ormai giunti ad un punto di non ritorno. L’Italia in quegli anni guardava all’Inghilterra, al movimento delle Arts and Crafts, all’area francobelga dove la cultura dell’avanguardia si stava consolidando in un ambiente maggiormente spregiudicato, ma soprattutto alla viennese Wagnerschule capace di tenere insieme nel medesimo spessore operativo, la radice della tradizione e il movimento dell’innovazione. Nei progetti che l’allestimento della sezione dedicata all’architettura ci mostra, si nota come il nuovo stile sia capace di apportare fondamentali innovazioni alla cultura compositiva quali l’individuazio-
ne di una progettazione globale basata sulla solida alleanza tra l’arte e l’industria, così come il principio dell’inscindibilità tra struttura e decorazione. A questi, si somma il principio di un inedito rapporto di continuità tra interno ed esterno e una nuova continuità spaziale tra le parti risolta attraverso la completezza espressiva delle murature, delle decorazioni, degli arredi e delle suppellettili. Per la reale difficoltà di fornire strumenti di adeguato controllo alla scala urbana, il Liberty rimane legato allo spazio domestico e a quelle tipologie architettoniche legate allo svago, alla ricreazione e al tempo libero. Località termali, centri di vacanza, località turistiche costiere, rappresentano dunque, i territori privilegiati di applicazione di questo nuovo e affascinante stile che rimane tuttavia estraneo ai centri nevralgici del potere economico e religioso. Attraverso i lavori di Ernesto Basile, Raimondo D’Aronco, Giuseppe Summaruga, Giulio Ulisse Arata, Paolito ed Ezio Somazzi, Giuseppe Palanti, Pietro Fenoglio, Antonio Sant’Elia, Giulio Casanova
e Alberto Pasquinelli, si narrano le alterne vicende di questa breve ma intensa stagione architettonica e artistica italiana. Già dal 1910 un generale “ritorno all’ordine” inizia a ritagliarsi contro le provocazioni del Liberty, ritenuto ormai anche dalla stessa classe borghese che l’aveva fortemente voluto e sostenuto, privo di fondamento e vicino al cattivo gusto di un semplice divertissement. La pietra tombale del movimento spetta comunque a Marcello Piacentini, già da tempo avviato verso una personale e moderna interpretazione di un ennesimo ordine rinascimentale, sentito come motivo principale di razionalità e verità. Di ritorno dall’Esposizione di Lipsia del 1913, non esitò a definire conclusa la stagione del Liberty, scrivendo che “l’arido e tormentoso periodo dello stile moderno, la banalità plebea dell’arte nuova è cessata: le cartellette piatte e i nastrini convulsi, i testoni muliebri e i rami fioriti, le parallele a chitarra e i punti e i cerchi, hanno fatto ormai il loro tempo”. Fabio Fabbrizzi
Pagine precedenti: 1 Ulisse Tramonti durante l’inaugurazione della Mostra 2-3 Allestimento sale espositive 4-5-6 Allestimento sale espositive foto Giorgio Sabatini
153
1
Venezia 2014. Due passi e un salto alla Biennale Architettura Incipit Il viaggio dalla stazione di Santa Lucia lungo il Canal Grande, rimane sempre come una delle parti migliori di ogni Biennale possibile. Forse solo la teoria di architetture della Strada Novissima ha potuto, nella storia della Biennale, affiancarsi, senza scomparire del tutto, al palinsesto architettonico del Canale più bello del mondo. La scelta di utilizzare un giorno feriale si dimostra azzeccata, non tanto nel tentativo di evitare moltitudini di rumorosi architetti allineati nel loro immancabile radical-chic total black outfit, di cui ormai se ne fa volentieri a meno, ma piuttosto per farsi un’idea del popolo che frequenta cinque giorni su sette la Biennale. Straordinario e rincuorante l’afflusso di comitive studentesche anche di giovanissima età, condotte da vivaci docenti affascinate da altrettanto vivaci guide. Al contrario, tra chiacchiericci in tedesco, francese, olandese e ovvio inglese, risulta drammatica la totale assenza di italici colleghi. Probabilmente distratti dall’ecatombe economica e dalla tragica afasia realizzativa, preferiscono rimanere al chiuso dei loro studi, lottando tra pratiche e normative, invece di godersi una giornata di sole lagunare tra spazi sempre dignitosamente ordinati e padiglioni che rappresentato un decalogo architettonico degli ultimi 100 anni. Se nemmeno la garanzia di ottenere qualche ormai imprescindibile credito formativo e di bere un buon spritz al Bacaro Risorto può smuovere l’interesse degli architetti italiani non solo è un pessimo segnale, ma deve far pensare che forse di Architettura in Italia si parla troppo poco, o davvero, come molti sostengono, se ne parla troppo e male.
154
Due Passi Impossibile non confessare come il modello a scala reale (in legno però...) della Dom-ino, susciti affezione quanto sgomento per l’inattesa consistenza materica e per lo straniante effetto di scala nel suo inserto come nuovo padiglione del parco. L’atteggiamento utilizzato nel settore curato direttamente da Koolhaas, Elements of Architecture, in tutta onestà, sembra quello dell’accatastamento più che del sagace collage. Anzi, a mente fredda, viene da paragonarlo più ad uno straziante decollage di Rotella che ad un sofisticato Matisse. Dopo qualche minuto camminando tra oggetti appesi, pedane-trappola, video, stanze asfittiche, frammenti a scala reale, posti lì nel tentativo di riassumere la storia dell’architettura attraverso alcuni elementi in 500 metri quadri, non si vede l’ora di uscire finalmente a riveder le stelle. L’impressione straniante che rimane, oltre a quella tipica dopo la visita ad un polveroso robivecchi di provincia, è che il genio olandese non abbia voluto disattendere troppo se stesso. Che lo abbia fatto per ordinato rigore (credibile?) o per distratto interesse nella vicenda a questo punto poco importa. Un salto Tra tanta tracotanza nel segno del “doverci essere ad ogni costo” e frammentaria, spesso equivoca, manifestazione di intellettualismo (penso ai gratuiti caratteri boccacceschi, a trattarli bene, di alcune istallazioni di Monditalia) e la volontà di manifestare ponderatamente una sorta di superiorità (geografico-culturale?) nel Padiglione Italia, non si può che ammettere come il vero salto di qualità l’abbia fatto il lavoro fatto dai curatori del Padiglione Tedesco.
2
155
L’inattesa sfida della star olandese è stata raccolta scaltramente dai due tedeschi che nella sovrapposizione tra il Padiglione “classico” (1909) e il Kanzelerbungalow di Sep Ruf (1964) hanno iconicamente riassunto il profondo rapporto dell’architettura tedesca contemporanea con i propri consci e subconsci, confessabili ed inconfessabili, veri fundamentals. Niente di scritto ne proiettato, nessun schiamazzo e nessuna fuorviante trasgressione, ma solo la realizzazione, dal vero, di una operazione di innesto architettonico, tra due entità icastiche. Nelle tracce che emergono da questa operazione di sovrapposizione fisica tra le due storie della Germania del ’900 sembra racchiuso il segreto dell’attuale e
156
innegabile supremazia del mondo tedesco sul continente. Anche alla Biennale, come in Europa, un vaso d’acciaio tra una ventina di coccio. Piacevolmente bello il ritorno acustico del cinguettio di uccelli a rasserenare la mente e contestualizzare l’idea stessa di un’architettura tedesca radicata nel piano naturale. Ciò che rimane - La facciata stile “Festa di Santa Rosalia” con cui si apre Monditalia, più per l’ironico posizionamento intellettuale che per il disegno complessivo che come unico vero risultato ottiene quello di sottolineare la magnifica possanza dell’antico contenitore ipostilo veneziano.
- I teatrini stile “Globe” che scandiscono il lungo cammino delle Corderie come semplice ma sofisticato modo di dar luogo, nell’evento architettonico, ad un’interessante commistione con altre arti come il teatro e la danza. - La stampa di 25 metri quadri della sublime scalinata di Villa Malaparte, con quell’inedito senso prospettico che ne esalta il valore iconografico. - Il pannello d’oro su cui appaiono incastonate (un po’ in economia a dire il vero) le opere fotografiche di Charlie Koolhaas. Artista e fotografa ormai di fama internazionale a cui il padre (poi parlano di nepotismo italiano…) ha voluto riservare un piccolo ma importante ruolo: quello, dopo tele cadenti, posters,
4
memorie radicali e maccheroni-punk, dell’attribuzione di “fundamental” nella cultura architettonica dell’intera umanità all’immensa opera michelangiolesca della Laurenziana. - Il modello della torre di Ignazio Gardella per Piazza Duomo a Milano del 1934 nel Padiglione Italia a cura di Cino Zucchi, Appeso ad altezza inarrivabile come un antico araldico trofeo di famiglia trasmette l’impressione, anche fisica, del suo totale distacco dall’universo delle tribolate pochezze contemporanee esposte a pochi metri di distanza. - Come sempre alla fine, sopra ogni cosa e nonostante tutto, l’incredibile Squero delle Gagiandre del Sansovino... Michelangelo Pivetta
Pagine precedenti: 1 MONDITALIA 2 Elements of Architecture - maniglie 3 Biblioteca laurenziana - Charlie Koolhaas 4 Padiglione Italia - Torre Gardella foto Michelangelo Pivetta
157
Roma, Accademia Nazionale di San Luca Eur sconosciuta Ne Il disagio della società occidentale Sigmund Freud per meglio dimostrare nell’esistenza della vita psichica dell’uomo una dimensione di compresenza delle esperienze dimenticate con le circostanze dell’attualità ricorre all’immagine di una Roma popolata dai fantasmi di architetture remote che persistono nei diversi siti occupati oggi da altri monumenti. Descrivendo in definitiva una dimensione del tempo orizzontale, stratificata, slegata dalla successione cronologica: “ciò significherebbe quindi che sul Palatino i palazzi dei Cesari e il Septizonium di Settimio Severo si ergerebbero ancora nella loro antica imponenza, che Castel Sant’Angelo porterebbe ancora sulla sua sommità le belle statue di cui fu adorno fino all’assedio dei Goti, e così via [...]. Dove ora sorge il Colosseo potremmo al pari ammirare la scomparsa Domus Aurea di Nerone; sulla piazza del Pantheon troveremmo non solo il Pantheon odierno, quale ci fu lasciato da Adriano, ma sul medesimo suolo anche l’edificio originario di Marco Agrippa; sì lo stesso terreno risulterebbe occupato dalla chiesa di Santa Maria sopra Minerva e dall’antico tempio su cui fu costruita. E a evocare l’una o l’altra veduta basterebbe forse soltanto un cambiamento della direzione dello sguardo […].” La mostra Eur sconosciuta, il “piccolo codice” di Giuseppe Pagano per la città corporativa e altre visioni urbane, curata da Marco Mulazzani e Paolo Zermani svoltasi presso l’Accademia di San Luca, segue la pubblicazione sul numero 842 di Casabella dell’inedito e prezioso documento redatto, fra il Gennaio 1938 e l’Aprile 1939, dal Pogatschnig. Già coautore assieme a Marcello Piacentini, Luigi Piccinato, Ettore Rossi e Luigi Vietti del primo piano regolatore per l’Esposizione
158
Universale di Roma del 1942, pubblicato con enfatico ottimismo nel numero 114 del 1937 di Casabella-Costruzioni. Il ritrovamento del manoscritto illustrato da acquerelli, planimetrie e della relazione di progetto, avvenuto nei sotterranei della sede della rivista per merito di Federico Bucci e Silvia Sala, restituisce dunque un prezioso contributo per la comprensione delle vicende dell’E 42. Su un bianco tavolo, disposti come in un cinematografico piano sequenza, si susseguono i fotogrammi di un’occasione perduta. Un altro fantasma; o meglio un’altra serie di fantasmi. Come non pensare infatti a tutti quei progetti che Pagano aveva intenzione di affidare agli architetti indicati per le varie zone in cui era divisa la “mostra delle industrie”: Albini, Bottoni, Belgioioso, Baldessari, Banfi, Cattaneo, Cosenza, Diotallevi, Figini, Gardella, Lingeri, Marescotti, Mollino, Nizzoli, Peressutti, Pollini, Terragni ed altri ancora. Tutti spettri, da aggiungere a quelli elencati da Freud. Abitanti di una Roma (im)possibile e di un EUR forse troppo milanese perché figlio degli indimenticabili allestimenti per le Triennali e per le Fiere. Perciò eretico, in quanto portatore di un’altra idea di architettura. La mostra ci riconsegna l’editoriale definitivo di Pagano. Il più critico ed estremo verso la deriva monumentale intrapresa dall’“artificiale Vitruvio” Marcello Piacentini. Estremo e coraggioso come quel grande portale della luce, “incastellatura libera con effetti luminosi”, che interrompendo l’asse visuale del viale posto fra il Teatro Imperiale di Moretti e la Mostra della Romanità di Aschieri sembra quasi anticipare l’Anitona gigante di Fellini. Incursione quasi Pop nell’immutabile Italietta che alla fine vince sempre. Andrea Volpe
ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA “CASABELLA” MOSTRA
eur sconosciuta Il “piccolo codice” di Giuseppe Pagano per la città corporativa e altre visioni urbane
Accademia Nazionale di San Luca Roma, piazza dell’Accademia di San Luca 77 presentazione e inaugurazione
mercoledì 29 ottobre 2014 | ore 18 apertura al pubblico
30 ottobre – 15 novembre 2014 dal lunedì al sabato | ore 9-19 infor mazioni 06.6798850 www.accademiasanluca.eu
159
160
2
Pagine precedenti: 1 La locandina della mostra 2 L’allestimento contrappone il grande tavolo che ospita il progetto di Giuseppe Pagano per la “Mostra delle Industrie” agli studi progettuali di Luigi Moretti, Gaetano Minnucci e Marcello Piacentini. Sullo sfondo la pianta dell’Esposizione Internazionale E 42. I materiali cortesemente messi a disposizione da Casabella, Milano, Massimo & Sonia Cirulli Archive, New York e Eur SpA, Roma foto Chiara De Felice
161
letture
Dario Costi La lezione del progetto. Scritti intorno a Ernesto Nathan Rogers MUP, Parma, 2012 ISBN 978-88-7847-417-8 Tenere nelle mani e leggere questa raccolta di scritti fa cogliere gli obiettivi della collana di cui fa parte: Manuali di architettura. Occasione flessibile per la sistematizzazione d’esperienze e scambio fra ricerca e didattica, la collana vuole far convergere il “macrocosmo” delle riflessioni teoriche della ricerca ed i “microcosmi” di progetti didattici, saggi, antologie e tesi. Questa dichiarazione di intenti è avvalorata dai contenuti dei prossimi volumi di cui saranno autori Francesco Venezia ed anche Emanuele Palazzotto, Lucio Serpagli, Matteo Agnoletto. Nello scenario contrassegnato dall’integrazione fra teoria e pratica, il volume di Dario Costi è esplicativo e programmatico a cominciare dal titolo. Nella raccolta di scritti intorno a Ernesto Nathan Rogers, la cui struttura è positivamente influenzata dalle radici milanesi della formazione dell’autore, sono messe a confronto differenti ricerche storico critiche e riflessioni sul concetto di metodo, sulla sua continuità e modernità, e considerazioni connesse all’attività progettuale e didattica svolta a Parma. Anche la complessa eredità che la lezione del progetto è destinata a raccogliere, così come è nell’assunto dialettico rogersiano, fra conoscenza ed esperienza, oggettivo e soggettivo, trasmissibile e nascosto, è descritta, brevemente per caratteristiche della pubblicazione, dalla consapevole pratica dell’autore come architetto e come docente universitario. Il filo conduttore si intesse a partire dai maestri Gropius e Van de Velde procede con gli enunciati di Rogers e con la conoscenza del pensiero di Rossi, Cannella, Gregotti, fino alla definizione della sonda del progetto concepita da Pasquale Culotta e filtrata dalle esperienze dell’autore con la Scuola Palermitana. Nell’insieme questi scritti su Rogers definiscono una struttura articolata: precisate le parole chiave, “segnaposto del pensiero”, come se fossero neuroni, componenti essenziali di una struttura celebrale in continua evoluzione che è il metodo, le riflessioni e le interpretazioni dell’autore creano continue giunzioni sinaptiche, impulsi di interazione e connessione fra i vari piani, lasciando alla capacità critica del lettore la possibilità di nuovi confronti e approfondimenti. Un originale strumento a supporto del lavoro di docenti e studenti. Giuseppina Farina
162
Daniele Pisani Paulo Mendes da Rocha tutte le opere Electa, Milano, 2013 ISBN 978883708736 Materia e luce in Paulo Mendes da Rocha Ho incontrato un anno fa Paulo Mendes da Rocha a San Paolo, nel suo studio: una grande stanza luminosa all’interno di un bel edificio, un po’ delabré, di Rino Levi. Di quel luogo ricordo un lungo tavolo posto parallelamente alla facciata principale composta di una serie di finestre “a nastro” in ferro, apribili tramite un insolito congegno. Mendes da Rocha, al tavolo, illustrava, a me e al mio compagno di viaggio, il suo progetto in via di completamento per il Museu dos Coches di Lisbona. Una serie di fotografie di cantiere, alcuni disegni, e un piccolo modello erano gli strumenti attraverso cui renderci partecipi del carattere e dell’idea di progetto. Ricordo l’attenzione riservata al tema della costruzione, alla scelta della “materia” e allo studio della luce, intesi quali elementi necessari per l’attribuzione di carattere al progetto. Materia e luce sono due degli elementi fondamentali con cui fare i conti quando si affronti il lavoro del maestro brasiliano. Il cemento armato – come la maggior parte degli architetti brasiliani della cosiddetta scuola Paulista – è il materiale che egli pare prediligere. Una materia idonea a formare il volume massivo dell’edificio, e in grado di accogliere tagli, aperture, varchi attraverso cui far penetrare la luce, elemento da cui spesso, in Brasile, risulta necessario difendersi. Il nuovo volume di Daniele Pisani dedicato a Mendes da Rocha attraverso l’attenta riproduzione di disegni - ad oggi spesso inediti in Italia - dei progetti di una vita, e la documentazione fotografica degli stessi, ci introduce nel mondo del maestro brasiliano, un mondo di cui l’architetto ha il dovere di offrire una interpretazione. Ciò che il volume mette in evidenza è come in Mendes da Rocha, l’idea e la sua possibilità realizzativa, si muovano sempre di pari passo. È la tecnica a rendere possibile la costruzione dell’idea, a essa la materia si sottopone assumendo, ogni volta, una forma nuova. Basta osservare con attenzione uno qualunque dei molti schizzi pubblicati per rendersi conto di tutto ciò e per capire come, fin dall’inizio del progetto, il tema della luce – sempre rappresentato attraverso la sfera del sole e la direzione dei suoi raggi – entri, quale elemento determinante, nella costruzione del progetto. Martina Landsberger
Claire Beck Adolf Loos. Un ritratto privato Castelvecchi, Roma, 2014 ISBN 978-88-6826 Qualche lettore ricorderà come si concludeva il libro di Benedetto Gravagnuolo dedicato al Baumeister di Brno: una pagina, priva di commento, con l’immagine di un cubo di granito patinato con su inciso Adolf Loos. Si trattava della tomba disegnata da lui medesimo: un modo di terminare la ricerca secondo una laconicità eloquente. Fu per raccogliere le risorse economiche necessarie all’edificazione di questo sobrio sepolcro che Klara Franziska (Claire) Beck, terza e ultima moglie del Nostro, pubblicò nel 1936 Adolf Loos privat, un memoir redatto con l’esplicita volontà di restituire la personalità e «la vitalità del vivere accanto a Loos». Il diario - edito per la prima volta nel nostro paese con la traduzione di Ilenia Gradante – narra episodi risalenti ai tre anni della loro unione, consumata tra l’estate del 1929 e la primavera del 1932. Claire, fotografa e scrittrice, apparteneva ad una di quelle famiglie borghesi – Hirsch, Kraus, Turnowsky - che in Boemia furono clienti e sostenitrici del maestro – a Plzenˇ, città natale della giovane, oltre la cosiddetta Brummel Haus sono tredici gli intérieurs portati a compimento tra la fine degli anni venti e i primi anni trenta. Il volume è la silloge di 70 brevissimi capitoli, ciascuno dei quali con un proprio titolo e ordinati cronologicamente: dal primo incontro all’ultimo sguardo nella clinica di Rosenhügel a Vienna, alla vigilia della morte dell’architetto. Istantanee, rapidi schizzi capaci, nel loro sommarsi, di fissare un abito mentale, una passione, una sensibilità morale, una radicata convinzione, una debolezza. E qui il miracolo discreto: sideralmente lontana da ogni tecnicismo o scienza disciplinare, l’affabulazione, directement nonchalant, si dipana aderendo alla piega specifica dell’esistenza, rivelandone i ritmi e le inclinazioni profonde – l’amico Peter Altenberg avrebbe chiosato che è proprio della letteratura l’afferrare tale irriducibilità della vita, il suo esser così, né più né meno. All’inizio della seconda guerra mondiale Lerle Loos (sempre volle mantenere il nome da coniugata) decise, assieme alla madre Olga Feigl Beck, di fare ritorno a Praga. Ebrea, fu preda della polizia nazifascita ed internata nel ghetto di Terezín per poi essere tradotta in Lettonia, nel campo di concentramento di Riga dove morì nel 1942. Aveva trentasette anni. Fabrizio Arrigoni
Riccardo Renzi Abitare Sociale. La cultura del progetto in Italia dal Dopoguerra ad oggi. Verifiche progettuali per un nuovo insediamento sociale nel comune di Calenzano. Edifir Edizioni, Firenze, 2013 ISBN978-88-7970-596-7
Esther Diana Santa Maria Nuova Ospedale dei fiorentini. Architettura ed assistenza nella Firenze tra Settecento e Novecento. Polistampa, Firenze, 2012 ISBN 9788859610489
La pubblicazione, nata come sintesi documentaria dei risultati di una convenzione di ricerca sull’abitare sociale, svolta dal 2011 al 2013 tra il Dipartimento di Architettura ed il Comune di Calenzano (FI), è suddivisa in due parti, la prima delle quali ospita un’indagine relativa alla cultura architettonica dell’abitare sociale in Italia dal secondo dopoguerra alla contemporaneità, mentre la seconda presenta dieci esercitazioni progettuali maturate nel corso del Laboratorio di Architettura Specialistica, da me tenuto nell’A.A. 2010/11 e coordinate da Riccardo Renzi, oltre ad un approfondimento sviluppato nel corso di una Tesi di Laurea magistrale. Renzi nella sua ricerca compie una rigorosa lettura dell’edilizia economica e popolare sugli esempi italiani più significativi, rivolta ad affrontare la scansione cronologica ed al contempo una distinzione tipologica dei progetti dei principali maestri dell’architettura italiana della ricostruzione postbellica, da Mario Ridolfi a Ludovico Quaroni, da Mario Fiorentino a Adalberto Libera, da Luigi Cosenza a Carlo Aymonino, da Giovanni Michelucci a Leonardo Savioli e Leonardo Ricci, da Vittorio Gregotti a Guido Canella, passando attraverso le esperienze dell’UNRRA-Casa, del fenomeno INA casa e della gestione GESCAL, per approdare infine alle singole maturazioni locali, spostandosi sul territorio per esempi magistrali che hanno arricchito la cultura del progetto in Italia. La seconda tematica investe la questione del lessico compositivo dei progetti presentati nel primo capitolo, individuando un insieme di percorsi che ne accomunano gli sviluppi e le matrici. Il terzo tema indaga invece l’originale questione legata al mondo degli interni. La seconda parte del volume racconta l’esperienza tra il Dipartimento di Architettura ed il Comune di Calenzano, che ha avuto come scopo la riprogettazione di un’area in forte rinnovamento, quale quella denominata “Il Pino”, ad uso di quartiere popolare. Le condizioni imposte dalla nuova centralità favoriscono la nascita di un diverso assetto che coinvolge l’abitare sociale come elemento di continuo dialogo tra gli elementi caratteristici dell’area, e spinge la funzione di edilizia sovvenzionata a partecipare in propria quota al miglioramento del sistema di relazioni tra cittadinanza e luoghi. La necessità di legare le ipotesi ad un luogo concreto come quello di Calenzano e quella di considerare le ricadute didattiche degli assunti teorici, hanno condotto ad affrontare il tema specifico non solo in un’ottica per così dire estetica, quanto nella luce di un impegno etico, cui rivolgere gli stessi allievi. Ulisse Tramonti
Il poderoso lavoro sviluppato dall’autrice nel corso di anni di studio, relativo alla storia degli ospedali fiorentini, iniziato con la Tesi di laurea sull’architettura assistenziale del XVII secolo, pone come obiettivo una restituzione integrale degli eventi, non solamente legati al campo architettonico, che ruotano attorno al ruolo urbano e sociale dell’Ospedale di Santa Maria Nuova. Il volume nasce grazie all’occasione offerta dalla riorganizzazione funzionale e architettonica del complesso suddetto, messa in atto a partire dal 2000, e si pone all’interno di un percorso di studi e di ricerca promossi dal fiorentino Centro di Documentazione per la Storia dell’Assistenza e della Sanità. L’autrice affronta, attraverso una suddivisione in cinque parti del libro, tematiche diverse tra loro che esplorano i ruoli dell’ospedale nei suoi sistemi relazionali con la città e con la medicina, raccontando sistematicamente i pesi e le misure capaci di modificare le strutture costruite e di accoglierne i progressi tecnologici a queste connesse. La chiave di lettura offre un vasto repertorio iconografico e documentale, perlopiù proveniente da un fondo detto “nuovo versamento” depositato recentemente presso l’Archivio di Stato di Firenze, utile a comprendere le vicende urbane di trasformazione del grande complesso ospedaliero, che da trecentesco esempio tipologico di impianto distributivo a croce capace di influenzare altri esempi italiani ed europei, si confronta con la città tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo. Il volume non si limita all’analisi delle sole vicende architettoniche di Santa Maria Nuova nella sua declinazione locale, ma esamina puntualmente lo sviluppo delle tipologie assistenziali in Italia, muovendosi attraverso un’attenta analisi dell’evoluzione delle procedure legate al sistema sanitario come determinante di cambiamenti distributivi e tipologici. In tale ottica le dinamiche in profonda mutazione della professione medica, ampiamente trattate in più parti del libro, offrono una fertile occasione di riflessione e di rilettura delle conseguenti ricadute sociali ed organizzative legate indissolubilmente al fenomeno architettonico. Al tema dell’ospedale di Santa Maria Nuova si sovrappone poi un racconto dettagliato relativo all’intera architettura sanitaria fiorentina, di cui l’ospedale pediatrico Mayer ed il nuovo quartiere sanitario di Careggi, nati per rispondere ad esigenze che il trecentesco complesso assistenziale, non era più in grado di soddisfare per una città in grande crescita. In chiusura un’ampia sezione di tavole fuori testo, a colori, raccontano i momenti principali di trasformazione dell’edilizia sanitaria fiorentina. Riccardo Renzi
163
Michelangelo Sabatino Orgoglio della modestia. Architettura moderna italiana e tradizione vernacolare Franco Angeli, Milano 2013 ISBN: 9788820444730 Michelangelo Sabatino non poteva trovare titolo più simbolico e significativo per fornire una chiave di lettura e condensare il contenuto del suo libro - Orgoglio della modestia - pubblicato in inglese nel 2010 per la University of Toronto Press e ora disponibile nella versione italiana per la Franco Angeli, nella collana diretta da Marco Biraghi. Il titolo principale è tratto dallo scritto di Lionello Venturi del 1933, “Per la nuova architettura”, in cui lo storico dell’arte individua un “fondamento comune negli architetti moderni: il disgusto di ogni esteriore inutile ricchezza; l’orgoglio della modestia”. Tante volte Giuseppe Pagano ha utilizzato questo fondamento comune per esprimere come l’architettura moderna e italiana non sia data esclusivamente dalle opere eccezionali ma dalle moltissime architetture, cosiddette minori, sottoposte alle limitazioni della modestia. Estraneo alla ricerca dell’arte di eccezione, Pagano estrapola una rassegna sulla casa rurale ed è attratto da oggetti anonimi come la sedia e l’aratro. La leva del nuovo atteggiamento moderno è una leva morale, un atto di liberazione, quasi selvaggio, contro ogni abitudine esteticamente falsa. È soprattutto da questo punto di vista che il libro di Sabatino indaga e racconta l’architettura italiana dal 1911 agli anni Settanta, fornendo le tappe della ricerca dell’identità culturale che va ben oltre il concetto di tradizione. Sabatino rileva che l’architettura moderna in Italia si è nutrita costantemente della presenza delle proprie radici popolari e arcaiche, della propria tradizione paesana e rurale e per questo, nella sua lunga storia, non sono poche le incursioni nell’etnografia, nella letteratura, nel cinema. Sovvertendo l’interpretazione e l’ottica con cui si affrontano gli studi sull’architettura moderna, che pongono l’esperienza italiana come storia periferica e marginale, l’originale impostazione di Sabatino dà risalto alla cultura ‘paesana’, solitamente considerata una parentesi rispetto alle architetture monumentali, leggendola, invece, come punto fondamentale per interpretare e capire un’esperienza singolare come quella dell’architettura del ventesimo secolo in Italia, che stabilisce un indiscusso primato: la tradizione nella modernità. Ugo Rossi
164
Renato Capozzi L’Idea di riparo Clean, Napoli, 2012 ISBN 978-88-8497-228-6 Occasione di ricerca e sperimentazione didattica, come l’autore stesso afferma, L’idea di riparo è anzitutto un momento di riflessione sui temi e le ricerche condotte qualche anno addietro con Salvatore Bisogni, Maestro di Renato Capozzi, al quale il libro è dedicato. Il volume si apre con la presentazione di Valeria Pezza che rileva i molteplici spunti offerti, seguita da una breve nota a cura dell’autore che racconta le ragioni del libro e introduce ai contenuti articolati in due distinte Parti. Nella Parte I “Architettura, forme elementari, spazio, costruzione” viene descritto con grande rigore il tema del riparo, il valore che questo ha in quanto archetipo che «contiene, a un livello ancora più astratto di quanto avviene nel tipo, l’idea primigenia del ricovero, del coprire, del definire un luogo per lo stare». Nel seguito, i capitoli tendono a costruire una riflessione strettamente legata alla disciplina compositiva: da “Gli elementi primi dell’Architettura”, passando per le considerazioni sulle forme elementari, sul tipo, sulla costruzione, sul luogo urbano e sulla natura, per concludersi con una riflessione sul futuro del tema trattato. Anche la postfazione, di Federica Visconti, pone l’accento sull’attualità della riflessione proposta dall’autore facendo riferimento a tre grandi architetture di altrettanti Maestri: la Festhalle di Tessenow a Rugen, il Crematorio a Enskede di Asplund e la Neue Nationalgalerie di Mies van der Rohe a Berlino. Segue la riproposizione di alcuni manoscritti di Salvatore Bisogni, “Lezioni sul riparo” e la riproduzione di alcuni appunti già trascritti corredati da schizzi di grande espressività e chiarezza. La Parte I si conclude con uno scritto di Raffaela Napolitano, “L’architettura della “struttura” nel Politecnico di Luigi Cosenza”, lasciando il passo alla Parte II, “Seminario sul tema del riparo” che si compone delle lezioni di Raimondo Consolante, Camillo Orfeo, Luigi Coccia, Massimo Fraldi e Andrea Maglio, seguite da alcune delle Tavole elaborate nel Laboratorio di Composizione del I anno e aventi ad oggetto ricomposizioni analoghe del Foro di Pompei e della Agorà di Assos dove i ripari progettati dagli studenti sono chiamati a costruire nuovi luoghi pubblici della città. In un ideale percorso generazionale, dalla lezione del Maestro ai lavori degli studenti, il libro propone una interessante riflessione sulla composizione, trattando in maniera chiara i temi proposti e guardando alla lezione di chi è venuto prima «alla ricerca di qualche frammento su cui poter ri-costruire il nuovo, il moderno». Mirko Russo
Nicola Squicciarino La Great Exhibition del 1851. Una svolta epocale nella comunicazione Armando editore, Roma, 2014 ISBN 978-88-6677-374-0 La concezione della Great Exhibition di Londra, come fantasmagoria delle merci prodotte dall’industria volta ad attestare il livello di sviluppo raggiunto dal genere umano, non è certo più quella delle più recenti esposizioni universali a tema. Quell’evento è stato però l’inizio di tanti fenomeni di lunga durata, come la internazionalizzazione della produzione e del commercio, la creazione di nuovi e efficaci strumenti di comunicazione e di promozione delle merci, la ricerca dell’innovazione tecnologica, la comprensione dell’importanza del fattore formale ai fini della commerciabilità del prodotto e del carattere feticistico delle merci, il turismo di massa, che in parte condizionano ancor oggi la nostra realtà e i nostri modi di vita. In una esauriente sintesi delle molteplici implicazioni dell’esposizione, l’autore esamina il Crystal Palace di Joseph Paxton, avvalendosi di fonti bibliografiche d’epoca non solo inglesi, e fornisce una interpretazione della sua modernità più comprensiva della consueta lettura teleologica che insiste sul suo valore di battistrada della costruzione mediante il montaggio di componenti standardizzate realizzate prodotte industrialmente, economicamente vantaggiosa per la possibilità di recupero e di riutilizzo dei materiali. Indipendentemente dalla sua ricostruzione a Sydenham Hill(1852), il Crystal Palace esprime una concezione della modernità come “le transitoire, le fugitif, le contingent”, secondo la definizione formulata nel 1863 da Baudelaire e condivisa in testi successivi da Nietzsche e Simmel. Celebra “la bellezza del non-durevole” e “la seduzione del nuovo ed il suo inevitabile ‘essere per la morte’”, afferma Squicciarino, “vale a dire la dinamica propria della moda, definita dai concetti vita-morte, creazione-distruzione, che sono poi i caratteri fondamentali dell’epoca moderna: una sempre più celere produzione industriale di massa ed una conseguente crescente usura comunicativa dei beni prodotti”. Questa nozione di breve durata trovava emblematica espressione in quella sensazione di incorporeità che colpiva il visitatore di questo “Vacuum ricoperto di vetro” (Semper), dove il grande afflusso di luce erodeva la corporeità delle strutture metalliche e abbagliando l’occhio gli impediva di percepirne le dimensioni. In sinergia con la luce i colori primari scelti da Owen Jones concorrevano alla smaterializzazione delle strutture, con effetti che hanno indotto un acuto Lothar Bucher a scrivere di un edificio non decorato, ma costruito dai colori e un giornalista dell’Illustrated London News ad accostare la visione complessiva degli interni alla “foschia indistinta” dei paesaggi di Turner, tema che sarà poi ripreso da Siegfried Giedion. Ezio Godoli
donnArchitettura a cura di Maria Grazia Eccheli e Mina Tamborrino FrancoAngeli, Milano, 2014 ISBN 978-88-917-0708-6 Esiste un modo femminile di fare architettura? Un qualche approccio estetico, ad esempio, che caratterizzi gli spazi creati da un architetto-donna, e li renda per questo riconoscibili e diversi dai luoghi e dalle forme progettate da un architetto-uomo? E tra le donne architetto c’è qualcosa che accomuna la “tenace, irriducibile” Gae Aulenti, indipendente sperimentatrice di spazi innovativi di fama internazionale, alla devota Lilly Reich, raffinata progettista di interni e di mobili di arredo, perennemente all’ombra del compagno di vita e di lavoro Mies van der Rohe, misconosciuta e “mortificata dalla Storia”? Difficile rispondere: quello che emerge dalla pubblicazione dall’evocativo titolo “DonnArchitettura” è certamente una sconfinata varietà di mondi e di linguaggi architettonici appartenenti all’universo femminile. “Un libro di donne progettato da donne”, che non cavalca però una facile retorica da quote rosa, ma che ha il merito di andare a illuminare una zona d’ombra della storia di questa disciplina, rendendo giustizia a tutte quelle “pioniere dell’architettura”, che con fatica hanno tracciato per noi la strada: razionalizzando gli spazi e gli oggetti del lavoro domestico, come Margarete Schütte-Lihotzky; o conquistandosi rispetto e una posizione di rilievo all’interno di un mondo professionale fortemente maschilista, come Marianne Brandt; o ancora ricoprendo, in modo critico ed indipendente, prestigiosi incarichi accademici, come Jaqueline Tyrwhitt. Le curatrici, Maria Grazia Eccheli e Mina Tamborrino, hanno immaginato tre ambienti per animare questo spazio al femminile. L’ingresso è costituito dai RITRATTI, dove giovani ricercatrici hanno ripercorso il passato prossimo delle loro antenate, per fare finalmente emergere tutto l’universo di esperienze e competenze troppo a lungo nascoste o trascurate. Seguono le STANZE, spazio più intimo e raccolto, galleria di ritratti realizzati da Franca Pisani, artista fiorentina che ha contribuito a dare un volto alla storia individuale di ciascuna protagonista, attraverso l’utilizzo, forse non del tutto casuale, di pergamena e di ossidi di (madre) terra. In uscita troviamo i PAESAGGI, dove la narrazione architettonica continua, ma si apre alla città-territorio, andando a indagare rapporti e relazioni tra spazi aperti e spazi costruiti. In sottofondo, come esile ma potente filigrana capace di unificare il multiforme approccio delle donne all’architettura, Monica Centanni sembra intercettare una attitudine comune, che ha provato a definire, chiedendo aiuto al mondo classico, come la “sapienza di tessere la tela con abilità e pazienza”, dote divina attribuita dagli antichi ad Atena “la dea della trama e del progetto”. Oggi potremmo forse indicarla, con un linguaggio più moderno, come un’etica della cura: una modalità tutta femminile di approccio al mondo, che nasce dall’esperienza e dalla continua pratica, sviluppata nei secoli dal-
le donne, di cura del particolare, di attenzione all’altro. Se le generalizzazioni hanno un senso, questo potrebbe essere allora, in risposta alla domanda inziale, il tratto distintivo che caratterizza il fare architettura al femminile: la competenza innata nel tenere conto delle relazioni, la capacità di prendersi cura anche quando si progetta. O come scrive Ida Origgi il “saper guardare prima ancora che provare ad affermare qualcosa”. Silvia Mantovani
165
Light is much more Alberto Campo Baeza
cerrarlos cambia el concepto de dominio de la luz sólida por el de transparencia, se produce una profunda revolución.
(page 2)
En el Panteón de Roma, la sabiduría del arquitecto le lleva a enmarcar la máxima cantidad luz con la máxima cantidad de sombra. Y así el óculo luminoso se cerca con la más profunda sombra que hace más luminosa aun si cabe aquella luz divina venida de lo alto. En Santa Sofía de Estambul, los brillantes arquitectos abren una corona de altas ventanas por donde no sólo entra la luz directa, arrojada, sino también la indirecta, reflejada en sus profundas jambas blancas de una manera tal que parece un milagro el ver cruzarse los rayos de luz en el aire. En la Farnsworth House, el arquitecto con la misma sabiduría que sus antecesores, pero que ya sabe del acero y del vidrio, decide proponernos la transparencia absoluta. Y allí la luz suspendida en el aire nos evoca “el soplo del aire suave” con el que el profeta describe la presencia de la divinidad. PARA QUÉ Se podrían escribir miles de libros sobre la luz. Yo les recomiendo los de Henry Plummer, y las obras de Le Corbusier. En estas breves palabras de introducción yo no quiero más que, una vez más, reivindicar este valor máximo de la luz como material primero y principal con el que trabajamos los arquitectos. Y que se nos concede gratuitamente cada día. Para permanecer en la memoria y en el corazón de la gente. Para hacerles felices con la Arquitectura. MIS OBRAS A LA LUZ DE LA LUZ Trataré de arrojar algo de luz sobre el entendimiento de la LUZ en mis obras. Light is much more Cuando un arquitecto descubre que la luz es el tema central de la Arquitectura, es cuando empieza a ser un verdadero arquitecto. Cada día que pasa estoy más convencido de esto que escribí y publiqué hace ya más de quince años. MATERIAL LUJOSO La luz es el material más hermoso, el más rico y el más lujoso utilizado por los arquitectos. El único problema es que es gratis, que está al alcance de todos y que entonces no lo valoramos suficientemente. Los arquitectos antiguos usaban los mármoles y los bronces, y los arquitectos más modernos usan el acero y los plásticos especiales y los vidrios. Todos intentando hacer arquitecturas capaces de permanecer en la memoria de los hombres, de permanecer en el tiempo. Y sólo los arquitectos que han merecido la pena, los maestros, han entendido que la luz, precisamente la luz, es el principal material con el que la arquitectura es capaz de vencer al tiempo. Así lo entendieron tanto Adriano cuando construyera el Panteón como Antemio de Tralles o Isidoro de Mileto cuando levantaron Santa Sofía, o Mies Van der Rohe cuando puso en pié la Farnsworth House. EMOCION Y para hacer presente la luz, para hacerla sólida, es necesaria la sombra. La adecuada combinación de luz y sombra suele despertar en la arquitectura la capacidad de conmovernos en lo más profundo, suele arrancarnos las lágrimas y convocar a la belleza, y convocar al silencio. Cuando a lo largo de estos últimos años muchos de mis alumnos han visitado el Panteón de Roma, puntualmente me han escrito una postal diciéndome: “he llorado”. Los que no “han llorado” no me han escrito. Así lo hablamos en clase y ellos cumplen el pacto. Cuando los empleados de la Caja de Granada entraron a trabajar por primera vez en mi edificio en Granada, algunos se conmovieron profundamente y se les saltaron las lágrimas. No dejo de ir a verles cada vez que vuelvo allí. Y cuando la Reina de España entró en el edificio con motivo de la entrega de unos premios, tuvo la generosidad de deshacerse en elogios sobre la hermosura de la luz que allí había. Y la prensa lo recogió puntualmente. Entendió perfectamente que la luz es el tema central de cualquier Arquitectura. COMO LA SAL Muchas veces he comparado en mis clases la luz con la sal. Cuando la luz se dosifica con precisión, como la sal, el guiso de la arquitectura alcanza su mejor punto. Más luz de la cuenta deshace, disuelve la tensión de la arquitectura. Y menos la deja sosa, muda. Al igual que la falta de sal en la cocina deja a los alimentos insípidos, el exceso de sal los arruina. En general casi todos los los arquitectos se pasan de rosca en el uso de la sal, de la luz. CUALIDAD DE LA LUZ Y si la cantidad de luz empleada es importante, no lo es menos la calidad. Así nos lo ha enseñado siempre la Historia. Cuando la Arquitectura por mor del acero que permite abrir grandes huecos y por el vidrio que permite
166
La Gaspar House en Cádiz, “ Hortus Conclusus”,es una casa llena de SOMBRA donde los cuatro grandes huecos de las esquinas hacen que pase la luz silenciosa en una clara operación de TRANSPARENCIA para lograr la continuidad del espacio contenido por los patios. La Turegano House en Madrid, “ Blanca y Cúbica Cabaña”, es una caja por la que entra el SOL del sur a raudales. La luz especial del OESTE que al atardecer atrapamos a través de un gran ventanal abierto a oeste en lo más alto, es una lección aprendida las casas de Pompeya que utilizan el mismo mecanismo. La Asencio House en Cádiz, emplea con mayores dimensiones los eficaces mecanismos de la Turegano House pero como la orientación es diferente, el gran ventanal se abre aquí en el techo como un gran lucernario por donde entra la LUZ a raudales. La De Blas House en Madrid, “Belvedere”, desarrolla una operación de TRANSPARENCIA a favor del espectacular PAISAJE que se nos ofrece delante. Así se SUBRAYA el paisaje poniéndolo en valor. Abajo, en el interior del podio lleno de sombra, se abre un ventanal cuadrado que ENMARCA el mismo paisaje alejándolo. El Centro BIT en Mallorca, “Secret Garden”, es un jardín quasi bíblico de 24 poderosos naranjos encerrados en una caja de mármol travertino abierta al cielo. Para proveerla de SOMBRA para trabajar, se cubre con un techo ligero en una operación de la máxima TRANSPARENCIA. La CAJA de GRANADA en Granada, “Impluvium de LUZ”, es, además de muchas otras cosas, una caja interior cúbica de vidrio y alabastro en el centro de una caja mayor abarcante de hormigón armado, con 9 potentes lucernarios de tales dimensiones y en tal posición que el SOL todos los días lo recorre de tal manera que con a la LUZ le acompañan la BELLEZA y el SILENCIO. LUZ La Luz es componente esencial, impresindible para la construcción de la Arquitectura. La Luz es MATERIA y MATERIAL. Como la piedra. Cuantificable y cualificable. Controlable y capaz de ser medida. Sin Luz NO hay Arquitectura. Sólo tendríamos construcciones muertas. La Luz es la única capaz de tensar el espacio para el hombre. De poner en relación al hombre con ese espacio creado para él. Lo tensa, lo hace visible. La Luz que da razón del TIEMPO, la LUZ CONSTRUYE el TIEMPO. DE CÓMO LA LUZ VENCE A LA GRAVEDAD La Luz, material pero siempre siempre en movimiento, es precisamente la única capaz de hacer que los espacios conformados por las formas construídas con material grávido floten, leviten. Hace volar, desaparecer la Gravedad. La vence. La insoportable pesantez de la materia inevitable e imprescindible sólo puede ser vencida por la Luz. La imponente masa del Panteón, cuya forma esférica ideal hace patente la potencia aplastante de ese espacio, al conjuro del sol que atraviesa el óculo
magnífico, se levanta en inefable movimiento como si de una levitación se tratara. La Luz venciendo a la Gravedad convoca a la Belleza sublime. Y es curioso, o no tan curioso, que los dos inventos tecnológicos que han hecho posible la revolución en la Arquitectura estén en relación directa con la Luz y la Gravedad: el vidrio plano en grandes dimensiones y el acero sólo o armando al hormigón. El vidrio plano hace posible ese giro copernicano de la Luz vertical incidiendo en el plano horizontal sobre la cabeza del hombre. Hace posible la transparencia del plano horizontal superior. El acero, solo o en el hormigón armado, hace posible ese otro giro copernicano de poder separar el cerramiento de la estructura sustentante. La piel de los huesos. Esos huesos, esos pilares, por donde ahora correrá esa Gravedad ineludible a encontrarse con la tierra. EL PASO CLARIFICADOR DEL TIEMPO El Tiempo, construído por la Luz, hace desaparecer lenta y pacientemente los elementos superficiales con que tantas veces se adorna la coqueta Arquitectura. El Tiempo, como médico que buscara devolverla a la vida, la desnuda hasta dejarla en lo más esencial. Queda entonces la Arquitectura con sólo sus atributos esenciales. Dimensión, proporción y escala dan vida al material que lleva en su interior la tensión invisible de la Gravedad. Y todo ello tocado por la Luz que, constructora del Tiempo, produce la tensión visible que hace enmudecer al hombre. Lo que de manera paradigmática aparece a veces en la ruina que, despojada de todo ornamento superfluo, se alza radiante ante nosotros con el esplendor de la Belleza desnuda. Cuando Heidegger, con términos precisos, habla del “sólido brotar del templo que hace visible el espacio invisible del aire”, hace surgir ante nosotros la “ruina” del Partenón en todo su esplendor como Arquitectura Esencial, que parece escuchar sus palabras: “el templo, en su subsistir, hace que las cosas estén presentes y que los hombres tomen conciencia de su presencia”. EL AIRE SE SERENA Y VISTE DE HERMOSURA Y LUZ NO USADA Se intenta en este texto establecer un paralelismo entre el instrumento musical y el espacio arquitectónico. El instrumento musical mediante el aire produce el regalo de la Música. El espacio arquitectónico mediante la luz produce ese algo inefable que es la Arquitectura. “El aire se serena y viste de hermosura y LUZ no usada, Salinas, cuando suena la MÚSICA estremada, por vuestra sabia mano gobernada”. Así comienza la Oda III a Francisco Salinas donde Fray Luis de León habla de la LUZ y de la MÚSICA, con tan hermosas palabras. Y es que un espacio arquitectónico es semejante a un instrumento musical. Y tanto en los instrumentos de viento como en los de cuerda, el secreto está en el AIRE. El aire pasa a traves del instrumento de viento y se pone en vibración en el instrumento de cuerda. Y tanto el aire insuflado en una flauta como el puesto en vibración por las cuerdas tensadas en un cello, producen ese algo tan sublime que es la MÚSICA. Sin AIRE no sería posible la MÚSICA. Pues de semejante manera, la LUZ, la luz natural, la luz del sol, al atravesar un espacio bien tensado por el arquitecto, a través de perforaciones precisas, produce esa inefable emoción que sólo la Arquitectura es capaz de despertar. Sin LUZ no sería posible la ARQUITECTURA. LUZ que tempera el aire contenido en el espacio arquitectónico. Y así como para que en un instrumento musical suene la música, es necesario que esté bien concebido, bien construído y bien afinado, así también es necesario que el espacio arquitectónico esté bien ideado y bien desarrollado y bien construído, para que allí suene bien la Arquitectura.
Si un arquitecto quiere conseguir un espacio tensado por la luz, ¿puede existir un espacio sin luz ?, deberá concebirlo con forma y proporciones precisas para que el edificio despierte cada mañana y, al compás de la luz que marca el tiempo, viva a lo largo del día, a lo largo del TIEMPO. La idea de un proyecto debe contener desde su concepción esa relación ineludible con la luz. No me cansaré de insistir en que la IDEA clara de un proyecto es la base imprescindible para que allí aparezca la Arquitectura. Y la LUZ debe formar parte central de esa IDEA. Es en esta primera fase cuando se deciden lasTRAZAS de la obra de Arquitectura. Es la fase de saber qué y cómo se construye ese espacio arquitectónico. DESARROLLO. AFINADO. Y si tras su construcción más perfecta, el instrumento musical necesita ser afinado, igual sucede con el espacio arquitectónico. Y no es este afinado arquitectónico el plausible cuidado que algunos arquitectos hacen del detalle. El afinado en este caso pertenece a la precisión en la relación de ese espacio con la LUZ. María Zambrano decía de la Poesía que era “la palabra acordada con el número”. Y en este mismo sentido, apuntaba Osip Mandelstam que “ en Poesía todo es medida”. Pues esa precisión que es condición sine qua non en la Poesía, lo es también en la Música y en la Arquitectura. La precisión es imprescindible en toda creación artística. Confunde el vulgo la creación artística, lo artístico, con el gesto, el desplante, o la forma caprichosa. Muy al contrario, la creación artística requiere de una enorme precisión y afinado, que exige sabiduría y tiempo por parte del artista que crea la obra de Arte. Para que el instrumento musical llegue a sonar con aquella música estremada descrita por Fray Luis de León, tras estar bien construído, necesita estar bien afinado. En los instrumentos de cuerda, las cuerdas deben estar tensadas con absoluta precisión para que vibren de la mejor manera. Y en los instrumentos de viento, los diámetros de los tubos y los de los boquetes que en ellos se hacen, deben estar hechos con perfecta exactitud. Para que la Arquitectura suene con música divina cuando es atravesada por la LUZ, necesita estar bien afinada. Necesita que la situación, la forma y la dimensión de las perforaciones con que se relaciona con el exterior, con la LUZ, esten perfectamente definidos por el arquitecto. Las puertas, ventanas y lucernarios pueden, deben entenderse como perforaciones en el espacio arquitectónico, que lo ponen en relación con la luz, y con las vistas y con el aire. Pues todo ello debe definirse con precisión en este segundo estadio que es el PROYECTO DE EJECUCIÓN. No es el PROYECTO DE EJECUCIÓN un mero desarrollo mecánico de las primeras ideas. Es un verdadero afinado del instrumento. CONSTRUCCIÓN. Una vez construído y afinado el instrumento musical, es necesario tocarlo muy bien para que muy bien suene. Un buen intérprete musical ante un buen instrumento bien afinado sabrá arrancar las notas precisas capaces de conmovernos en lo más hondo. Sabrá hacer vibrar el aire de tal manera que mueva nuestro corazón. Pues en Arquitectura, tras la IDEA concebida, como una construcción mental, y tras su desarrollo detallado en lo que los arquitectos llamamos PROYECTO DE EJECUCIÓN, la interpretación de la pieza es precisamente su CONSTRUCCIÓN MATERIAL, su puesta en pié. Es esta construcción material una verdadera interpretación de aquella idea primera. Construcción material que tampoco es una puesta en pié mecánica de aquel proyecto de ejecución. El atento seguimiento de las obras hace que el arquitecto siga afinando todavía más si cabe el organismo arquitectónico.
IDEA. CONCEPCIÓN. El instrumento musical y el espacio arquitectónico, deben estar bien concebidos. Es imprescindible tener una idea clara de lo que se quiere hacer. Y luego, saber cómo hacerlo, controlar con precisión las formas y las dimensiones y las proporciones que lleven a conseguir el resultado buscado.
He citado muchas veces a Saramago para, con sus palabras, decir que los arquitectos tenemos como pequeños cerebros en la punta de los dedos, que hace que se pueda decir que pensamos con las manos. Y leía hace poco que un gran compositor sevillano del XVII, Francisco Guerrero, para alabar a Pedraza, el maravilloso organista de la Catedral de Sevilla decía : “en cada uno de cuyos dedos veo un ángel“. Pues eso. Un arquitecto es alguien que construye ideas y piensa y sueña con las manos.
Si uno quiere conseguir timbre de violín, deberá concebirlo con forma y dimensiones y proporciones de violín. No es igual un violín que un violón.
En el caso de la Música es fácil hacer la distinción entre construcción, afinado y el tocado del instrumento,
Hoy escuchaba en la radio un programa sobre un Museo que expone instrumentos musicales. Y me parecía “contra natura” el que los instrumentos musicales, cuya razón de ser es la música, estuvieran expuestos como si de cadáveres se tratara, muertos. Y es que los instrumentos musicales son para sonar, para hacer música, cuando el aire pasa por ellos y se produce el milagro.
En el caso de la Arquitectura, es la construcción física, material, lo que consideramos como interpretación de aquella primera idea. Y luego la LUZ, como el aire en la Música, atravesará el espacio creado por el arquitecto para que suene. Y, como si de un milagro se tratara, cuando la LUZ llega, se produce ese poder como tocar el tiempo, algo que pareciendo inasible, está a nuestro alcance y nos pone el corazón en
167
un puño. Suspender el tiempo, dicen los poetas. Que la LUZ construye el tiempo no es una frase acertada para un texto pedagógico. Ese milagro espacial es una realidad tangible a nuestro alcance.
João Luís Carrilho da Graça
A palpitating beauty by Fabiola Gorgeri (page 42)
FINALE En definitiva, si planteo esta comparación entre instrumentos musicales y espacios arquitectónicos, es para insistir una vez más en cómo las obras de Arquitectura que nos interesan, no son fruto del capricho ni de la moda ni de la arbitrariedad ni de los formalismos capaces de asombrar a los ignorantes. Muy al contrario, la Arquitectura reclama claridad en las ideas generadoras, precisión en el desarrollo y adecuación en la construcción. Y siempre el entendimiento de la LUZ como material principal. Es bien conocida la clasificación que Paul Valery en su Eupalinos, hace de las obras de Arquitectura: edificios mudos, edificios que hablan y edificios que cantan. Pues para que “canten”, los edificios deben estar bien concebidos, bien afinados y bien construídos. Y así la Arquitectura cantará con la más alta música y será capaz de alumbrar y hacer felices a los hombres.
Studio Tamassociati
Prayer and Meditation Pavilion in the “Salam” Centre for Cardiac Surgery, Emergency ngo Khartoum, Popular Republic of Sudan by Raul Pantaleo (page 34)
The prayer and meditation pavilion is an integral part of the recently realized Cardiac surgery centre in Sudan, built by the Italian humanitarian organization, Emergency NGO. The complex, planned and designed by Tamassociati architecture studio, is the only one of its kind to provide free health-care to patients in an extensive area within a ten million square km. radius and counting three hundred million inhabitants. The Popular Republic of Sudan is a country that, over the past twenty years, has been scourged from numerous Inter-ethnic as well as Interreligious wars. The Arab Ethnic group constitutes 39% of the population and 61% of Africans; and in terms of religion, 70% of people in Sudan are Muslim, while the remaining 30% are Christian or belonging to other religious faiths (“Human Rights Watch”: Q&A: Crisis in Darfur 05/05/2004). We needed to think of a place that could accommodate prayer, as customary in any place of health-care, so we had to deal with the difficult dilemma of thinking of a space that could host the spiritual complexity of this country. Our choice was not to privilege any specific religion, but to create a space that could accommodate the prayer and meditation of all faiths. The outside hosts a large water pool, as a strongly symbolic image in this sub-Saharan zone. The pool creates a spiritual separation between the external macrocosm of the hospital/world and the ventral microcosm of the building formed by two unaligned white cubes, which are connected by a semi-transparent cover of palm leaf stalks. The inner parts of the two cubes contain two trees, which render these profane spaces sacred with their presence, as natural elements inside artificial spaces. We obviously had to seriously consider the Muslim faith, which is the religion of the majority of the Sudanese, along with the religion’s rules (ablutions, separation of men and women), but we decreased the contextual impact of those rules in order not to make them appear dominant. This was made possible by concealing all symbols and elements that are specific to only one religion. For example, the ablution area is nothing more than a higher water spray that, before entrance, allows for washing without connoting a strong religious symbol, and it is simply perceived as an element of the water pool.
168
The void and the light are synonyms of some measure and relation. The vacuum is a sculptural expression to achieve a measure made of distances and absences: the relative size able to accumulate and densify the emotional values and transform the vacuum in space. The void is the condition of existence of the light itself, housing it as a inevitable material, giving it the shape and consistence of a desire: the immanence of the absence that becoming potential presence. All materials in nature are made of light was turned off, and this mass crumbled, called material casts a shadow, and the shadow belongs to light. Thus the light is really the source of all being.1 In this lack which is also the distance between things, the light directs, moves, dazzles, confuses the glance: it is both a symbolic experience either an real part of the world; a dart of photons refracted by the atmosphere which becomes metaphysical and ontological nexus of knowledge. The sight presupposes the existence of the eyes, the thing, and also the light. The eyes do not see the light, but the object in the light. The light empty space. This empty space presupposes the movement of desire. The vacuum produced by the light remains a thickness indeterminate, but also the comparison condition with the other.2 The vacuum drenched in light is also the distance that is bridged by the intertwining of the phenomenological perception:3 the necessary hiatus between things individually belonging to a same totality so that the perceptual act is made possible. In this, the landscape is constructed such as a shade of a specific territory: as the atmosphere4 that unifies the multiplicity of the present things, objects and distances, so synaesthetic. In the extension of Palácio de Belém, in order to achieve the Centre for Documentation and Information, the vacuum is a syntactic element of the narrative expression by the repeated presence of the gardens, and a mode, by suspending from the ground and the overhang. The works of Carrilho da Graça dosing, blur-free, clear-cut areas of shadow in the clarity of full and direct light, generated mostly by suspended volumes and a careful integration orographic places. In Belém, a grass platform is the new reference level from which the project originates and the articulation of the complex is spread, creating a semi-underground system, connected the presidential palace, according to a distribution of functional and autonomous spaces, collectives and private, willing in L shaped. The place retains monastic cloisters and italian style gardens as fragments of memory, which return by a palingenesis of light and shadow, presence and absence. The geometric planes that constitute this architecture are references both physical and ideal, concrete and abstract, with the materiality of the turf and the purity of white, which enter into a kind of harmonic resonance with the context, so determining landscape. The planes shape and define the void. The void is the space of the light. The light evokes the desire to cancel the gravity, enphasizes the lightness of the “inhabited wall”, hanging in the balance on a basement of shadow: a vacuum that cuts horizontally at the base, the wall-screen, which is measure the surrounding open spaces. The external surface, as an abstract paint of Malevich, accept upon itself only the soft graphism, dotted and changing, from the shadow of the trees that surround it.
The white volume sums up in itself the warm light of Lisbon, almost indifferent to vary the hours of day: it is a counterpoint and a complement of the dense shadow of the ancient woodland in the margin. The basement is at the same time a slot of light, continuous and dynamic, for the interior space into which it flows, with its mutability, vibrant and reflected by a water surface. A palpitant light that fades the threshold of the forms, fills the void as amniotic fluid. A brightness, corpuscular and radiating, dampens the boundaries creating mutual and osmotic adequation of exteriority and interiority, where the light is measures a dilated time such as space: the limits of space and time become transparent thresholds, light modulators, on which the reflected images are superimposed with fading, as in the crevices of memory. This is an architecture generated in section, which elects the voids as spaces of life and the human as the first principle of measure. Inside the daylight, soft and touchable, penetrates from above, blends with the diagonal light from a small bright well and with the horizontal light from partly opal borders, glides on smooth shiny surfaces of the floor and with the consistency of a crayon on the pale green walls, permeates the masses and dematerializes the margins of the shape. This inner chthonic space becomes the detector core when the natural light fades. As an image at the negative, the places of shadow, which declare the clarity of the composition made of planes and extended visual horizons, often highlighted by the wrinkled opacity of dark materials, become, in the evening, source of light, declaring the fragmented aspect of the complex. At the same time, the palpitate of the light as a beating of cyclical time, reveals the stratigraphic essence of the whole. The project marks certain geometric lines, which make analytical the temporal stratification of architectural events. So, the white wall acts as a fragment of a much larger abstract totality, to which it refers with its allusive incompleteness. If from one side, being a screen, denies its role tectonic, so suspended, it alludes to a potential construction or of the which it constitutes a possible residual permanence. The suspension of the plane-wall, in which and from which the light flows, suggests a rarefied atmosphere and a suspension in the logical-deductive understanding. This ambiguous opening in the objectivity of abstract sign enables the sign itself to evoke and mean other landscapes. The neutral visual plane to make possible the imagination and a mnemonic reference to the banks of the Tejo, the specificity geographic of place and also the landscape of Alentejo, dotted with white architectures. The building acts as a remembering fragment, that belonging more to nature than artifice. The abstract simplicity that characterizes this integration to the existing architectures contributes to the serenity of a peaceful place, which finds in the intense plasticity of the architectural sign, that is together fragment, measure and landscape, partly devoid of causal reasons, a concise rule of reading for the entire complex. In Belém, the light is the narrative voice of a palpitant beauty5 revealing the clarifier passage of time and of an idealized poetic abstraction that become sign of order. Line after line, around a nightmare of desire, a movement of obscurity, and the obscure glow... life seems to reach a unity where everything is confirmed: the time and things.6 The light can act as a ostensive medium of multiple presences. In the Museo do Oriente in Lisbon, the lighting, almost baroque, sculpts narrative images of the history of portuguese colonial, told through objects and artifacts of art and material culture. The background of architecture is undefined in the almost absence of scattered light, while the presence of the objects of the collections becomes themselves a source of reflected light. Artificial light returns an unit of path to the heterogeneity exhibition, reveals the objects in the darkness giving them simultaneously singularity and thematic commonality. The same art of showing, in the bright clarity natural, discovers and shows the order implicit in the territorial structure from which the works originate and to which they belong as figures and background. On the periphery of Portalegre, the parish complex of dos Assentos tells its presence in the dazzling light of the High Alentejo, with the precise harmony of a shadow theater, between what the shape represents and its tectonic virtuosity. The walls, continuous and silent, that redefine a whole urban block, follow the orographic and give homogeneity to the social and religious centre, similar to the near buildings but different for a greater extent. The light dematerialized the already white walls, turns them into optical planes that receive and cast shadows; penetrates between the planes that delineate the spaces, in the cracks left by their missing intersections: emphasizes the dynamism of the neoplastic box, accentuating the open spatiality. The entrance to the complex is an interruption of continuity: an anomaly of shadow generated in the limit of the volume, by a raised floor that invites you to enter: a threshold for stopping, waiting, sheltering from the sun; a break and a transition from an heterogeneous and dispersed urbanity to another that is more intense and concentrated.
The church is set back and the space in front of it plays the role of the churchyard in the function that is proper and in the reference that the collective memory found in the typological sign; but it is also the cloister with multiple functions and social facing in it; and domestic mediterranean patio, light tank, where the volumes become sundials of everyday life. The entrance to the complex is an interruption of continuity: an anomaly of shadow generated in the limit of the volume, by a raised floor that invites you to enter: a threshold for stopping, waiting, sheltering from the sun; a break and a transition from an heterogeneous and dispersed urbanity to another that is more intense and concentrated. The church is set back and the space in front of it plays the role of the churchyard in the function that is proper and in the reference that the collective memory found in the typological sign; but it is also a cloister with multiple and social functions that face on it; and domestic mediterranean patio, cistern of light, where the volumes become sundials of everyday life. In this vacuum, the light draws a movement of geometric planes of shadow that reflects the duality of emptiness and fullness, transit and stasis, mass and lightness; It expresses the theme of the content slightly empty - present in other works such as the School of Music and the Pavilion of Knowledge in Lisbon - defying the gravity of the suspended masses and contrasting the dynamics of spiral paths to the static nature of a confined space. The transparency of limits allows the alignment and visual continuity of sequential spaces that from outside lead to a eloquent depthy. It reveals the nature of the immeasurable room, of Mies, brought into one undivided space. This consequentiality of spaces favors a mystic gradation, with three different modulations of light, where the religious courtroom occupies the center of two hollow landlocked: the space of the social community and the space of the contemplation. The access is in asymmetrical position, through the transparent, reflective and tilted, plane, even here, of the absent base. This is emphasized by the black color and a thin outcrop of nature, gravel and grass, which anticipates and limited the spaces. The relationship between these spaces in continuum is also a calibrated relationship between limits, where light is absent or reflected, unites and divides at the same time, draws immaterial walls. The tripartite spatiality corresponds to a syntax of construction, revealed in section, of a frame system placed directly on a rock outcropping quartz- This is both tectonic expression and symbolic: it refers to the territorial structure of reference like procedural support for the project, starting premise, but it is also evocative fragment. Inside the decorative power is granted only to nature: the white walls, the floor in black resin, glass surfaces in the lower part to unite sociality and sacredness, create a suspended atmosphere, defined by the material and generative presence of the rock mass. The light is diffused and constant; it is necessity and truth, so thematizes and differentiates the central, centripetal and community, space from the verticality of the side aisles. On the rock, which is also presbytery background, the light is variable, reflects in the water mirror and reproduce a repeated and continuous movement, denouncing another presence. The strong abstraction of volumes establishes with the fragment of nature, a clear dialogic relationship between nature and artifice, which is a new landscape. The space is neutral frame,7 place of union, in which the human is the relationship itself between the things and the entity. In the analytical phase of the design process, the fragment is a cognitive device that makes it possible selective abstraction; in the expressive phase, the extreme synthesis focuses in the fragment that constitutes the work itself, the sense of the whole. Fragment of artifice and fragment of nature determine the unity of work. The light unifies the two fragments in their distance. It is this being in the place and beyond the place that characterizes the works of Carrilho da Graça, allowing them the creative modification8 of a territory.
1
Louis I. Kahn, Light, (1973), in John Labell, Between silence and light. Spirit in architecture of Louis I. Kahn, Shambhala, Boston 1979, p. 22. 2 Emmanuel Levinas. Totalità e infinito. Saggi sull’esteriorità, Jaca Book, Milano 1987, p. 195. 3 See Maurice Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, Bompiani, 1969. 4 See Gernot Böhme, Atmosphäre. Essays zur neuen Asthetik,Suhrkamp, Frankfurt, 1995. 5 Herberto Helder, Lugar Lugares in H. Helder, Os passos em volta, Assírio & Alvim, Lisboa 2009, p. 49. 6 H. Helder, Poeta oscuro in Ibidem , p. 165. 7 Christian Norberg-Schulz, Un colloquio con Mies in Vittorio Pizzigoni (edited by), Ludwig Mies van der Rohe, Gli scritti e le parole, Einaudi, Torino 2010, p. 171. See also Christian NorbergSchulz, Rencontre avec Mies van der Rohe, in L’Architecture d’aujourd’hui, LXXIX (settembre 1958), n. 29, pp. 40-41. 8 See Vittorio Gregotti, Infinito in V. Gregotti, Il sublime al tempo del contemporaneo, Einaudi, Torino 2013, Ebook , pp. 1362-1466.
169
YungHoChangAtelierFCJZ-VerticalGlassHouse Glass by Fabrizio Arrigoni (page 54)
“Man weiß noch nicht, wie ein Saal wirkt, der nur vom lichtdurchlassenden Fußboden aus beleuchtet wird. Man könnte da auf dem Lichte gehen. Derartiges und vieles Andre müßte ausprobiert werden.”1 Paul Scheerbart, Glasarchitektur The Vertical Glass House is a prototype of an urban dwelling designed by Yung Ho Chang for the annual Shinkenchiku Residential Design Competition organized by Japan Architect Magazine. The project was awarded an Honorable Mention, but only twenty-two years later, in 2013, was the initial hypothesis, duly reworked by Atelier FCJZ, actually built, becoming one of the permanent pavilions of the West Bund Biennial of Architecture and Contemporary Art in Shanghai.2 The pavilion’s footprint is based on a square, each side measuring 6.60 meters, with a usable space of 40 square meters per floor. The vertical section is divided into three levels, to which should be added a fourth level, a basement 2.10 meters underground. Set back 70 cm from the edge of the pavement, the four modules are each 3.20 meters high, with the top floor having a double-volume ceiling. The reinforced-concrete curtain walls were poured using formwork whose shuttering enabled the achievement of a perfect dichotomy in the surfaces, even though both sides are of the same material: scabrous and irregular on the exterior while perfectly smooth on the interior. Contrasting with this gravitas, the floor slabs and roof are all made of sheets of composite tempered glass 7 cm thick. On the north and south sides, these glass slabs cut through the concrete walls to form narrow ribbon-like windows - 20 x 290 cm - cantilevered to project slightly from the facades. On the other sides, the wall’s compactness is fully preserved in the rhythm of the divisions, immediately perceptible in the breaks and mismatches in the pattern left by the wooden formwork.3 The interior space is organized and supported by a square burnished steel post placed in the center; from it an intersection of steel beams divides the space geometrically into four quarters, one of which is occupied by the spiral staircase. A limited family of objects - the plumbing fixtures, living room furniture and kitchen fittings - furnish a carefully calibrated interior landscape as well as laconically determining the functional distribution of the house: “All the furniture were designed specifically for the rooms inside the Vertical Glass House to be true to the original design concept and keep a coherence appearance with its structures and stairs. Air conditioning was added to the house.”4 The framework just described goes beyond its technical raison d’être to become the agent capable of offering anchoring, structure, and vertical thrust to the whole; explicit confirmation of this organizing role is its persistence at the top of the building where, its static purpose already fulfilled, its action as a sign - Wink - and conceptual role become manifest. “It is curious to see how the tree has dominated the reality of the West and all of Western thought, from botany to biology, anatomy, but also gnosiology, theology, ontology, all of philosophy…: the taproot, Grund, roots and foundations.” This note excerpted from Mille plateaux5 introduces a topic that is of great interest for deciphering the work; if its punctum crucis can be identified as the relationship, as peremptory as it is incisive, which this sets up between the corporal shell and the natural light, nonetheless this wellspring of the design has to be traced out within the vaster confines of a dialogue - and a comparison - between Western and Eastern motifs.6 It is a propensity towards exchange and intersection of themes and aptitudes evidenced, in the first place, by its designer’s own life history - and this without attempting to force life and work into a direct, univocal corre-
170
spondence. Yung Ho Chang, born in Beijing in 1956, after finishing his studies (a master’s degree in architecture from the University of California at Berkeley) taught in the United States for more than a decade before returning to China and opening, with Lu Lijia in 1993, the Atelier FCJZ (Fei Chang Jian Zhu),7 the country’s first independent architectural firm. From 2005 to 2010 he headed the Department of Architecture at MIT in Cambridge, and parallel with his teaching activities, he was a frequent lecturer, analogous to an ancient You shi itinerant counselor, at Yale, Princeton, Cornell, SCI.Arc, Penn, Berkeley, the Berlage Institute in Rotterdam, the Chinese University of Hong Kong, Hong Kong University, and Tunghai University in Taiwan. It is in this métissage of contexts, experiences, and critical contributions that the firm has gradually delineated its own physiognomy and types of work: “In the past fifteen years, we have developed a body of work that ranged from interior design, building design, urban design, and master planning to art installation. In the process, our trajectory does go beyond a basic agenda from time to time, and ventures into the realms of culture, ecology, economy, and social/urban issues. This exhibition tries to map the development of FCJZ comprehensively and also includes a retrospective glimpse into some of the more hermetic design research I did prior to returning to China in order to establish the evolution of certain recurring ideas in our work.”8 The Vertical Glass House is an exemplary case study in the way it presents itself as a specimen of research and experimentation and thus an exemplum far removed from current building production - centered around quantity, financial return and speed of completion - and from the strategies emanating from the offices that are vectors of social and economic globalization, with their congenital submissiveness to novitas and compulsion to impose an ab-solutus, dissonant mark on the landscape typical of the “iconic building”: “I believe architecture is something more down to earth, and ultimately relates to how people live. Although I’ve done my share in some way, I don’t think architects can just fly around and build structures anywhere, but rather they need to anchor themselves in one place. For example, you say Italian architects can still be the Marco Polos of today, and come to Beijing and stay for a year… and then there are actually Italian architects here, working and so on… but I’m suspicious of global practice. They may produce a very glorious kind of architecture, but it’s not architecture that would belong somewhere. That being said, I think jet setters is very much a result of evolution. When I was younger, I remember I was so envious seeing the stars of my days talking about doing little sketches on their flights between locations, and that was the time for the architect to be creative. Now I would say what a lousy idea. You should really sit in your studio and work with materials and with your team.”9 Wen-hu is the Chinese term which expresses the pair “culturetransformation” and can be associated/developed with the effort of translation, that is to say of the “transposition of one language into another by means of a continuity of transformations. Continuous spaces of transformation, not abstract religions of equality and resemblance, are the measure of translation.”10 This is a semantic field which we can associate with the Vertical Glass House and the fact of its originating in a historic signature of Modernism itself; the designers themselves stress this place of origin, this genealogy, but at the same time the debt is redeemed, as it were, by the alterations and displacements, the metamorphoses and upheavals, to which it is deliberately subjected: “[the house] discusses the notion of transparency in verticality while serving as a critic of Modernist transparency in horizontality or a glass house that always opens to landscape and provides no privacy. While turning the classic glass house 90 degrees, Vertical Glass House is on one hand spiritual: With enclosed walls and transparent floors as well as roof, the house opens to the sky and the earth, positions the inhabitant right in the middle, and creates a place for meditation.”11 Erase the traces!, Verwisch die Spuren! is Brecht’s imperative adopted by Walter Benjamin.12 Twentieth-century Glaskultur is a technique congenital to the Neue Zeit, the time of barbarism and poverty of experience (“Nein, soviel ist klar: die Erfahrung ist im Kurse gefallen...”) and is primarily a process of dismantling and reducing the bourgeois intérieur, with its cozy intimacy (Gemütlichkeit), its countless protective shells (Gehäuse), its rooms crammed with things reflecting affections and habits, footprints of days on earth. Glass is a revolutionary virtue par excellence; it dissipates the “secret” and weakens possession until it slowly fades into oblivion, and where obstructions and opacity arise it replaces them with passages and communication. “Glass has no aura; it is cold, pure, devoid of meaning. Over it slide events and happenings without leaving a trace: “Glas ist nicht umsonst ein so hartes und glattes Material, an dem sich nichts festsetzt. Auch ein kaltes und nüchternes. Die Dinge aus Glas haben keine ‘Aura’. Das Glas ist überhaupt der Feind des Geheimnises. Es ist auch der Feind des Besitzes. Der große Dichter Andre Gide hat einmal gesagt: Jedes Ding, das ich besitzen will, wird mir undurchsichtig.” We know about Benjamin’s sincere and enduring interest in Paul Scheerbart; and yet their positions do not coincide. While they may share their repudiation of the Wilhelminian universe and Philistine humanism of the dominant classes, the Glasarchitektur of the Phantast nonetheless produces and preserves a regenerated sense of refuge, of drawing inwards - Gespensterhafte Beleuchtung - and a renewed balance between the soul and its place.13 The issue at stake is not liquidation of the interior by means of a profane, total visibility - Sichtbarkeit - but of knocking down the barriers that
block or limit the expansion of light-color “which wants to embrace everything and lives in the sheet of glass.” Glass - “organ of the fantastic spirit” - is the alchemical agent of a transfiguration, a passage, by means of which the “interiorization of the exterior” will be accomplished, beyond any principle of transparency.14 The glass house is a locus amoenus, a magic lantern, a firefly, a small multicolored cosmos made up of iridescence, glimmers, flashes, secluded from what is around it: “When I am in my glass room, I do not want to hear or see anything of the outside world. If I miss the sky, the clouds, the woods, I can easily go outside…”15 The Vertical Glass House participates in this experience, contributing an unprecedented Raumproblematik reminiscent of Scheebart’s fairy-tale anti-functionalism, the liberating symbolism of Bruno Taut, the immanent elementarism of Adolf Benhe.16 The blind walls prevent any extroversion or pressure outwards, letting introspection be sporadically violated by fortuitous views: safeguarding a Leibraum as reserved and spare as the polished concrete that envelopes it, subtracting it from everything else, the equi-valent space of the Großstadt.17 Entering the first level through an iron door, the guest is immersed in a “heavenly well,” a pit traversed by relations all fluctuating solely on the vertical axis. It is a polarity that operates in the junction-transition between earth and sky, low and high, dark and light, closed and open, fixed and mobile, constant and changing: the many species of the original nexus between the built phenomenon - lines and materials - and celestial space - air and light (of the sun, the moon, the stars). Translation by Susan Scott
ity of the plumbing and electrical systems, drains, etc., more than being rhetoric or an exploration of the mechanical-technological aspect, seems to be a reiterated Zeichen der Transparenz.
Kengo Kuma: Recovering places through transparency and frames by Andrea Volpe (page 62)
1
“At the moment, we do not yet know what effect a room illuminated only by a floor that lets the light through will have. With this, one could walk on the light. Things like this and many others too should be experimented.” Paul Scheerbart, Glasarchitektur, 1914 (translated here from the Italian edition by M. Fabbri and G. Schiavoni, Architettura di vetro, Milan, Adelphi, 1982, p. 101.) 2 See http://www.westbundbiennaial.com. The building is currently used as a temporary residence for artists and architects who are guests of the institution. 3 It should be emphasized that this difference in treatment of the openings is echoed in the building’s structure, where the walls left solid are thicker than those pierced by windows. The attention to the actual making and the physical construction inherited from the tradition - a dense sum of knowledge, building techniques, and material skills - is an aspect shared by a new generation of Chinese architects, a sort of recovery of the paired terms Formlehre and Werklehre that underpinned the Bauhaus Bauen. In this regard, see the results of two exhibitions: Positions. Portrait of a New Generation of Chinese Architects, curated by F. Edelmann and F. Ged, Barcelona - New York, Actar-D, 2008; From Research to Design. Selected Architects from Tongji University of Shanghai, curated by Xiangning Li, Triennale di Milano, 2012; see also http://www.domusweb. it/content/domusweb/it/notizie/2012/09/11/dalla-ricerca-al-progetto.html. 4 Yung Ho Chang / FCJZ, Vertical Glass House Description. 5 Gilles Deleuze and Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie, Paris, Éditions du Seuil, 1980, (here translated from the Italian edition by G. Passerone, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, 27, Rome, Castelvecchi, 2003). 6 On the legitimacy of recognizing an irreducible multiplicity at the heart of the Kultur, the following premise is valid here: “Culture cannot exist solely in the singular, and plurality, far from being merely a variant of it, is consubstantial with it. For if on one hand we see cultures borrowing from each other, assimilating, melding into something larger, canceling out their specific traits and becoming uniform, at the same time we observe also the inverse dynamic, that of a continuous re-specification and re-individualization. They continue to undergo an effect of globalization, and at the same time to reshape themselves into their local dimension; because culture is always tied to its native context, to an “environment,” as Nietzsche would say: it is by its very nature an ecological matter.” François Jullien, De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures, Paris, Fayard, 2008 (here translated from the Italian edition by B. Piccioli Fioroni and A. De Michele, L’universale e il comune. Il dialogo tra culture, Rome-Bari, Laterza, 2010; p. 154). 7 The initials can be translated as meaning a unique, rare, unusual architecture. 8 Yung Ho Chang, Develop: The Architecture of Yung Ho Chang/Atelier FCJZ, SA+P, MIT School of Architecture+Planning, February 15-April 13 2007. 9 “Interview with Yung Ho Chang of Atelier FCJZ” in Design Boom, 25 September 2012. This stability is reflected in the quarters of Chang’s firm in Beijing, in Atelier Feichang Jianzhu, http:// www.chinese-architects.com/en/feichang/source:index_a_z/category:1/index:10/count:75. 10 “Die Übersetzung ist die Überführung der einen Sprache in die andere durch ein Kontinuum von Verwandlungen. Kontinua der Verwandlung, nicht abstrakte Gleichheits- und Ähnlichkeitsbezirke durchmisst die Übersetzung.” Walter Benjamin, Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, 1916 (translated into Italian by R. Solmi, “Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo,” in Angelus Novus, Turin, Einaudi, 1962, p. 64). 11 Yung Ho Chang / FCJZ, Vertical… op. cit. 12 Walter Benjamin, Erfahrung und Armut, 1933 (Italian translation by M. Palma, “Esperienza e povertà,” in Scritti politici, Rome, Editori Internazionali Riuniti, 2011, pp. 253-260). 13 On these questions see Massimo Cacciari, “La catena di vetro,” in Dallo Steinhof. Prospettive viennesi di primo Novecento, Milan, Adelphi, 1980, pp. 125-129. 14 Fabrizio Desideri, introduction to Paul Scheerbart, Lesabéndio, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1982, p. XII. 15 Paul Scheerbart, Glasarchitektur, op. cit., p. 54. An interpretation that distinguishes the feeling of the Polish writer from the Klarheit of the modern in Rosemarie Haag Bletter, “The Interpretation of the Glass Dream - Expressionist Architecture and the History of the Crystal Metaphor,” in Journal of the Society of Architectural Historians, vol. 40, 1981, pp. 20-43. 16 Adolf Behne, “Glasarchitektur Manifest,” in Frühlicht, Heft 1, 1920. 17 “Vertical transparency visually connects all the utilities, ductworks, furniture pieces on different levels, as well as the staircase, into a system of domesticity and provides another reading of the modern theory of ‘Architecture as living machine,’” Yung Ho Chang / FCJZ, Vertical… op. cit. The pure-visibil-
«Do not study what the ancient masters did, but what they sought». With this quote taken from Basho’s celebrated 17th century travelogue Oku no hosomichi,1 Bruno Taut2 summed up his ideas on Japanese modern architecture. According to the German master, Japan was unable to develop its own personality in architecture for two main reasons: on one hand, there was the persistent legacy of the monumental style typical of he Meiji, Taisho¯ and Showa ¯ eras; a redundant canon heavily influenced by western classicism and still used for all the new civic buildings of the Empire; on the other hand, there was the attitude of a fresh generation of enthusiast young Japanese architects who designed the expected white modernist buildings, totally indifferent both to the character of a site or to Japanese traditional building techniques and local climate conditions. Their naiveté led them to copy uncritically the latest architectural trends imported from Europe. Bruno Taut’s ability to understand that Japanese architects were conceiving their ethos only as a matter of style had been already exposed in his long reportage published in 1935 by “L’architecture d’Ajourd’hui”.3 In that piece, Taut’s critical strategy was crystal clear. He simply could not talk about any new architecture built in the Land of the Rising Sun without setting the consitutent parts of Japanes architecture in a precise relationship with the extraordinary modern values of its traditional practices, represented by the luminous example he saw just the day after his arrival in Japan4 on his 53th birthday; an unforgettable experience made possible through Isaburo Ueno’s precious diplomatic work. A series of broken phrases, quickly copied down by Taut in his diary, bear witness to the amazement he experienced during his notorious visit to Katsura Imperial Villa. In the pure sukiya style of the 17th century palace, built in the western suburbs of Kyoto, Bruno Taut found not only a paradigmatic term of comparison he would always place in juxtaposition to modernist Japanese architecture, but a universal masterpiece of architecture itself, just like the other wonders he would visit a few months later in Mie prefecture: the wooden shrines of the Shinto sanctuary of Ise, which is rebuilt every 20 years as a part of the Shinto belief of the death and renewal of nature and the impermanence of all the things and as a way to pass building techniques from one generation to the next. With his discovery of Katsura and Ise, Bruno Taut’s new conceptual geography would be developed definitively around these two landmarks. Almost sixty years later the same path leading to Katsura would be followed by Kengo Kuma. Kuma’s body of architectural work is famously distinguished by the rhythmic use of natural light and shadows. This attitude mutuated from the traditional themes of Japanese architecture and was literally rediscovered by Kuma after his early period “architecture of fragmentation” whose most iconic project, the M9 building built in Tokyo in 1991 and heavily influenced by a late postmodernist canon, is conceived as an inevitable reaction to the chaotic urban environment of the Japanese megalopolis.5 “The next important turning point for me came a few months later, when I was asked to design a guesthouse on a lot in Atami, which faced the Pacific Ocean. While I was walking around the premises, a neighbor approached me and told me that a famous architect designed his house. He invited me to drop by if I was interested. His home looked like an ordinary house from the outside, but when I set foot inside, I was truly amazed by the mysterious atmosphere that pervaded it: it was the Hyuga residence -also known as the Phantom House- designed by the German architect Bruno Taut.”6 As the son of an art connoisseur and collector of the numerous objects designed by Taut in Japan, Kuma paradoxically could be considered one of the last heirs of the German master. After all, Kuma’s personal design evolution
171
represents well the story of that generation of Japanese architects born in the second half of the fifties who, after having completed their studies abroad (like Kuma himself) or having practiced in the offices of their masters, started their professional careers in the late years of the so-called “bubble economy” era. Kengo Kuma’s rendez-vous with Bruno Taut’s work happened in this very delicate moment of Japan’s recent history. After the golden economic boom of the eighties, during the first years of the following decade, the Japanese economy was in collapse due to the bankruptcy of businesses and the failure of financial institutions. Consequently the incredible, exciting, apparently never-ending growth of Tokyo/Edo dramatically slowed down. Professional commissions for architects became rare, downsized and mostly coming from the provinces. Nevertheless, through these small projects Kuma dared to redefine his personal approach towards architectural design through the application of traditional Japanese building techniques, a heritage kept alive by those artisans and craftsmen he met in the various building sites. As a disciple of Hiroshi Hara at the Roppongi campus during his student’s yea at Tokyo University, Kuma as trained to study and to appreciate the materiality of architecture since his field trips to Africa organized by his tutor. There they both studied local vernacular architecture. Hara was more interested in the architectures of the desert, built with adobe mud bricks and with strong plans and forms. Kuma perhaps was already interested in the lightness of the woven natural fibers screens of the typical huts built in Central African countries. Such similarities and differences with Hara’s interests would become important in Kuma’s academic training and in his subsequent professional career. The first important professional commission offered to Kengo Kuma after the bursting of the economic bubble was an observatory, placed on the top of Mount Kiro near Imabari City. “My ultimate aim is to “erase” architecture because I believe that a building should become one with its surroundings. This is how I have always felt; this is how I will continue to feel. How, then, can architecture be made disappear?”7 The Mount Kiro observatory is an invisible project. Dug into the top of the mountain, it is conceived as a pure space without any facade. A sunken architecture designed to act like an experience or a phenomenon rather than as an object. It is almost an impressive anticipation of that other invisible annex designed by Taut and later re-discovered in Atami by Kuma: Villa Hyuga after all is just another observatory, one that would allow the Japanese architect to seriously reconsider his point of view on traditional architecture. The legacy of the German master would be received in its entirety: no more would fragmented postmodernist architectural figures mirroring the urban chaos of Tokyo or ecological negative spaces sunk deep in the ground shape Kuma’s work from now on. The 1995 Water/Glass guesthouse project, built in a lot placed just above the Phantom House, explored the possibilities of a dialectic approach with vernacular architecture, becoming at the same both Kuma’s manifesto of his new architecture design poetics and his personal tribute to Bruno Taut’s unforgettable lesson. “Taut fled Germany in 1933 and moved to Japan. Although his life in Japan -German’s ally during the war- was by no means a happy one, he completed two houses there. One was the house in Atami, which impressed me so much that I began to devour a whole series of books by the architect. Even though he stayed in Japan for only three years, his understanding of Japanese culture was surprisingly deep, and I learned a good deal about my country from his books. […] As I read his books decided to make the Atami guesthouse an homage to Taut. My first step was to create a water deck. Taut had expressed admiration for the Katsura Villa ‘s dec made of bamboo. In his view, a deck is a medium that links the garden to the building; it is the place where the environment unites with the human elements.”8 The most iconic space of the guesthouse is the oval-shaped room surrounded by glass walls, almost an “island” floating on the cantilevered water deck. It is an environment which blurs the distinctions between inside and outside, erasing its borders with the landscape of the Atami bay: a view framed by the light glass and stainless-steel louvered roof which filters the light, casting neat shadows. Kuma’s architecture now gently fluctuates, immaterial, lightweight but inevitably frozen in its cold materiality. Maybe the mysterious warmth of Villa Hyuga’s bamboos, lacquers, and high-quality wood work cold have played a role in the subsequent project by Kengo Kuma: No¯ stage in the forest (1996). As part of this noble commission, the Japanese architect started to explore his own Japanese identity through a more frequent use of natural materials like stone, wood, tatami mats, straw, bamboos and, last but not least, washi, the japanese handmade paper. Having dismissed utopia to make architecture disappear in the environment through its literal fragmentation, Kuma proposed simple architectural forms, whose enclosure walls, facades, borders will be progressively pierced, stretched, chiseled in an increasing process of so called “particle-ization”.9 In Toyoma, Miyagi prefecture, the empty No¯ stage definesa tense space where human and the divine elements blur into one another. Everything is simultaneously visible and invisible on the butai’s wooden floor: the battlefields and the houses of the heroes; the elegant halls of the Imperial palace and the poetic views of the landscape....and Katsura... and Ise. Placed under the heavy shadow of the roof, mysteriously projecting its limits toward the forest, Kuma’s conceptual sacred space contains the infinite possibilities of the ritual No¯ performances. Western thought’s typical dialectical opposition between what is standing outside and what is contained inside does not make any sense here since it will be inevitably diluted within No¯ ’s dark holistic whole.
172
“The darkness in which the No¯ is shrouded and the beauty that emerges from it make a distinct world of shadows which today can be seen only on the stage; but in the past it could not have been far removed from daily life. […] We Orientals, as I have suggested before, create a kind of beauty of the shadows we have made in out-of.the-way places. There is an old song that says «the brushwood we gather -stack it together, it makes a hut; pull it apart, a field once more». Such is our way of thinking -we find beauty not in the thing itself but in the patterns of shadow, the light and the darkness, that one thing against the other creates.”10 The stylistic concision of No¯ culture would inspire Kuma to exalt and to update every single traditional element: like the sudare (bamboo blinds), the shoji (door, window or room divider consisting of translucent paper over a frame and lattice made of wood) or the ko¯ shi-do (wood lattice formed by closely placed bars used as screen for windows and doors). In the following works these vernacular elements would all be turned by Kuma into the main project theme - especially the latter, which would become a sort of constant trademark for the Japanese architect. With the Ando Hiroshige Museum, completed in 2000, in Bato, Tochigi Prefecture (and with the Stone Museum in Nasu, Tochigi Prefecture, completed in the same year) the work of the Japanese architect will reach the status of international recognition. In Bato the paroxysmal use of the traditional Japanese wood-lattice pattern is extended to form the skin, the roof, and the interior partitions of the building, which is conceived now as an ambiguous filtering space evoking at last -thanks to its alternated rhythm of light and shadows- one of the most importan cornerstone of Japanese architecture philosophy: the shizen or the way to create an harmonic coexistence with nature. The Hiroshige Ando Museum plays an important role in its environment. Placed on the pedestrian public road connecting the parking lot to the mountain and to the temple built on its top, the Museum may be also read as a sort of Torii: a gate open toward the near wilderness while its wooden, patterned skin becomes a clear metonymy for the trees used to build it. Undoubtedly Kuma created an osmotic architecture in Bato, a museum/ membrane continuously interacting with nature, light, and darkness. Beside the iconic Ando Hiroshige Museum, Kengo Kuma completed other two works, verifying once again his new poetics based on interpretation of the Japanese architecture vernacular themes. The first is the Takayanagi Community Center, Niigata Prefecture (2000) where the architect presents traditional materials placed besides new ones: Kadodewashi paper, insulating styrofoam, the thatched roof (typical of the local northern country houses called Minka), asphalt and the diagonal post-tensioned synthetic tendons. The result is a small, extraordinary, buildingdesigned to serve various purposes for the rural community. One of its most impressive features is the meeting room with its open loft space, which reveals the wooden structural frame of the roof and its large floor, both covered with the softly textured white paper. Last but not least are the shoji screens, separating the interior from the exterior and becoming iconic with their cut open slits. The juxtaposition between their translucent surfaces and the neat, stark views of the rice field creates a seductive and mysterious rhythm whose structure is conceptually similar to the one which characterizes the Haiku poetic form. The Nasu History Museum (2000) is the second of the two works. It is located in Ashino, Tochigi Prefecture, one of the stages described in Basho¯’s Oku no Hosomichi haiku diary. Here Kuma conceives another space, conceptually similar to the Hiroshige Ando Museum. A simple long glass building ties together the historic elements of the site: a restored gate, an old storehouse, a stone column from an earlier elementary school. On the inside a filtering process is obtained with sliding panels made of straw and aluminum mesh, two opposite materials joined by Kuma in a poetic gesture, a dialectical game set between innovation and tradition similar to the one that marked Basho¯’s late work.11 In his last haiku poem, the wandering Zen monk conceived of a juxtaposition of apparently contradictory images to get a much stronger poetic effect. “Haiku is the millimetric concentration obtained with words of a gaze and of its visible object. Haiku is the result of a cutting process, a synthesis in space and in time of the Poet’s look, mirrored in the object of his own interest. [...] Before and after that moment nothing exists. The haiku words appear in between two silent moments, in between one space and another, in between one entr’acte and another. Haiku is the result of a rendez-vous happening in one precise moment during the journey of life. An encounter which tie eternally the mindful gaze of the Poet and the natural environment which surrounds him.”12 In this author’s humble opinion these early works of Kengo Kuma look exactly like Haiku written in the Japanese landscape; just like Basho¯, Kuma conceives their syllabic meter through sequences of sublime illuminations. 1 Basho¯ Matsuo, L’angusto sentiero del Nord, Vallardi, 2009. In his masterpiece, Basho¯ describes with a very stylized prose interspersed with haiku the five-month-long journey he completed on foot in 1689 along the paths leading to the far northern provinces of the Empire. The narrow road to the Deep North is considered one of the major works in the whole of Japanese literature. This haiku diary was highly revered by Marguerite Yourncenar. In the last years of her life the Belgian writer followed the same itinerary visiting Matsushima (one of the famous ‘Three Views of Japan’ or ‘Nihon Sankei’) just to see the same moon light Basho¯’s saw reflected in the archipelago waters. Cfr. M. Yourcenar “Basho¯ on the road” in “Il giro della prigione”, Bompiani, Milano, 1999.
2 “Getemono oder Haikara” published in Manfred Speider, Japanische Architektur. Geschichte und Gegenwart, Stuggart, 1983, p.p. 72-74. 3 “Architecture nouvelle in Japon” in l’Architecture d’Ajour d’hui, n.4, 30 August 1935, p.p. 46-83. According to M. Speider, despite the modernist buildings published in the reportage, Taut claimed that in Japan there was no Modern Architecture at all. Among the 220 photographs sent to the Editorial Board of the French magazine, 40 illustrated traditional and historical architectures. 4 Isaburo Ueno, spokesman and founding member of the International Architecture Association of Japan, invited Taut to Japan for a series of lectures and visits to new and historic buildings. The German master planned a three-month stay in the Land of the Rising Sun. However, once he was banned from the Third Reich, he ended up living in Japan for three-and-a-half years, writing four essays about Japanese art and architecture and an important carnet de voyage. Taut built only one building in Japan. At the same time, though, he designed and produced almost 300 objects and pieces of furniture. Taut’s contribution of critical praise of Villa Katsura as the brightest example of the proto-modernism latent in Japanese tradition is undoubtedly well known. His books, articles and essays have informed generations of Japanese architects. 5 Cfr. http://kkaa.co.jp/works/architecture/m2/ “When I designed the M2 Building (1989-91) in Tokyo at the beginning of my career, I believed that if I created an architecture of fragmentation, the building would dissolve and blend into the chaos that surrounded it. Tokyo is often called a «city of chaos», where the old and the new, the small and the large, the artificial and the natural are mixed together without any discernible order. You will encounter this phenomenon -which is both a weakness and an attraction- in many Asian cities. It was particularly predominant in the late 1980’s, when Tokyo was full of energy and business was booming”, Kengo Kuma “Introduction” in Botond Bognar, Kengo Kuma, selected works, Princenton Architectural Press, New York, 2005, p. 14. 6 Kengo Kuma,“Introduction”. Villa Hyuga is the sole building designed entirely by Taut in Japan. It is an annex to an existing house built for Rihei Hyuga, a wealthy businessman. The existing house, placed on a lot facing the Pacific Ocean and Sagami Bay, was already completed. Its panoramic garden is organized on a foundational structure made of reinforced concrete built over the sloped ground. Taut worked inside this structure designing an underground series of spaces. The name Phantom House derives from this invisibility. The hidden annex is connected to the existing house through an underground staircase. The three halls designed by Taut are conceived as a sort of pavilion for guests and each of them is dedicated to a European composer. The first environment (the Beethoven room) has a wooden floor and a remarkable set of bamboo railings and detailing. Dancing parties or ping-pong matches used to be held there. The second one (the Mozart room) is still conceived in a Western style, with red silk facing the walls and an observatory deck -shaped as a tribune- overlooking the ocean. The last environment (the Bach room) is a traditional Japanese-style room with sliding shoji doors, tatami floor and a tokonoma. Villa Hyuga represents Taut’s attempt to blend European and Japanese architecture in a unique series of spaces, trying not to reduce the two different traditions in one hybrid-like composition, but on the contrary enhancing their differences into one new, strong concept. The deep sequence of spaces is somehow in debt to the abstract perspectives seen by Taut in Kobori Enshu’ shoin pavillons in Katsura. 7 Kengo Kuma, “Introduction”, p. 14 8 Kengo Kuma, “Introduction”, p. 15 9 Kengo Kuma, “Relativity of materials”, The Japan Architect, n.38, 2000, p.86. 10 Junichiro Tanizaki, “Libro d’ombra” [In praise of shadow], Bompiani, Milano, 1982 [1935], pp. 57 e 64. 11 See Muramatsu Mariko, “Dall’haikai all’haiku: la poesia di Basho¯” in Matsuo Basho¯, “Poesie. Haiku e scritti poetici” curated by Muramatsu M., La Vita Felice edizioni, Milan, 2010 [1996], pp. 14-15. 12 Fabián Soberón, “El viaje y el poema” in Espéculo. Revista de estudios literarios, n.31, 2005, Universidad Complutense de Madrid, p. 42
Myths of ephemeral light by Alberto Pireddu (page 72)
In the memory of those who delve into the recent history of Spanish architecture, the image of some of the pavilions which during the twenti-
eth century represented the country at major universal and international exhibitions is as though indelible, with their suspended shapes in the only apparently irreducible contrast between production and representation, regionalism and internationalism, permanence and transience. In Paris, in 1937, the airy transparency of the Pavilion of the Spanish Republic at the International Exposition dedicated to Art and Technology in Modern Life, the result of a complex and difficult collaboration between José Luis Sert and Luis Lacasa. A three storey building organized around a large central patio-auditorium, barely covered by a velarium, in which the changing reflections and shadows of Alexander Calder’s Fuente de Mercurio converse with the soft chiaroscuro montage à séc of the structure composed by prefabricated elements and the apocalyptic visions of Picasso’s Guernica, the artist’s outstanding contribution to the cause of the República Española. In 1958, the Spanish Pavilion at the Brussels World’s Fair, designed by Ramón Vásquez Molezún and José Antonio Corrales, an archipelago of hexagonal modules, metaphysical umbrellas of different heights that made up a space of light, smart and clear, versatile and austere, brilliant as an idea more than as an object. It was built on a steep slope near a grove of trees, intending to preserve the diaphanous and transparent character of the forest in the lightness of supports made of galvanized steel, the roof made of wood fibre and concrete panels, in the dematerialization of boundaries in a clever alternation of glass and brick surfaces. A few years later, in 1964, the Pavilion of Javier Carvajal Ferrer at the New York World Fair, with the extraordinary contrast between the severity of the exterior – a game of prismatic volumes of rough, white walls at the bottom and grey, regularly sorted blocks in the upper part – and the richness of the interior space. Like an Arabic palace guarding its treasures behind thick walls and labyrinthine paths. The centre of the composition was, once again, the patio, a heart of luminous vibrations accessible through a promenade populated by art works and intentionally left in the shade. Around it the exhibition space was arranged, designed in shades of wood and clay, with the windows illuminated by aluminium lamps whose shapes blended with those of the ceiling and welcomed the wide variety of the exhibits in an ongoing bid for integration between art and architecture.1 At the dawn of the new century, the halls of Francisco Mangado and EMBT represent Spanish “modernity” for the Zaragoza International Exhibition in 2008 and the Expo 2010 Shanghai China. Along the banks of the Ebro, Mangado entrusts to the refraction of warm, Aragonese light on the poorest materials (terracotta, cork, wood and galvanized steel) and the reflections of the water, from which the slender supports of the covering rise, the task of measuring that paso del tiempo which alone may determine the authentic representational capabilities of architecture, its density in terms of ideas and content, and its real continuity, beyond “momentary entertainment”. On the trapezoidal surface, intended for the Spanish Pavilion, appears a “forest” of columns with varying diameters intended to contrast a singular and poetic shape – of tessenowian memory – with the weak characterisation of the site: a large, deserted river bend to the north of the historic city. Like glades protected from direct sunlight in a gradual thickening of shadows, the real exhibition spaces are contained in two large vessels of glass, partially frosted, internally free from structural obstructions and accessible by means of calibrated paths lying on water. On the inside, the rhythm of the large wooden beams of the ceilings overrides the rhythm of the columns, arranged in a suspended game between order and chance. The chromatic vibration is intensified with the clever use of materials: galvanized steel supports, blackwood floors, cork which covers the interior of the great roofing; views multiply everywhere through the stained glass windows, beyond the endless grooves of clay and, to the south, towards the Ebro and the ancient city. In Shanghai, the light gathered around a patio, Mediterranean and serene, of Paris and New York pavilions becomes a luminous waterfall that the thin umbrellas of Brussels and clay pilares of Zaragoza transform into the threads of an intricate, almost surreal, wicker basket. Its surface tells stories of meetings: between West and East, Spain and China, Sun and Moon, Nature, trees, the sky, but also the eternal dualism between positive and negative, light and darkness, sound and silence, life and death, heat and cold, soul and body, male and female... As if the work on the matter, its dissolution and subsequent re-composition to form a new genuine and current reality, were trying to express “something” that is beyond colour, shape, space and time: an unalterable substance - similar to light itself - which possesses a reality on one side and another on the opposite side. If, however, “the revelation of space is an analogy for the revelation of light, colour and material”,2 interiors have an intensity not dissimilar to that of external spaces. A large square presents the exhibition rooms, where the curved shapes of the pavilion accompany the visitor on a virtual experience of Spanish cities and culture: from the origins of Atapuerca and Altamira, lost in the mists of time, to the present days and those yet to come of Miguelín, the baby-giant, metaphor of an imagined future. In the entrance hall a suspended staircase leads to the restaurants and services block: offices, the auditorium, the press room, meeting rooms and staff spaces. The structure of tubular steel columns, supporting the undulating wicker
173
panels, displays its tectonic character, rising from the ground and binding itself to the immateriality of the sky to capture the changing light, like a pergola of Japanese bamboo or the dome of a Turkish bathhouse punctured by a swirl of bright stars.3 There is a clear reference to some traditional techniques common both to Spain and China in the production of manufactured intertwined items. But isn’t textile art one of the distant origins of architecture? At least according to the Semperian Mysterium der Transfiguration.4 The research on the package and its structure is, of course, one of the strongest trait d’union with the previous pavilions and their undisputed “modernity”: from the lesson of Tessenow and Poelzig – which Lacasa brought to Spain from Dresden and which took the form in Paris of a pavilion that fit its measurements to the standard sizes of available materials and experimentation – to the limit of Spanish technical abilities in the late fifties, brought to Brussels by Ramón Vásquez Molezún and José Antonio Corrales. Picasso and Calder no longer speak of the atrocities of the war between Guernica and Almaden, and the days when Spain sought isolation from more advanced European countries are gone. In Shanghai, as in Zaragoza, there is evidence a deeper awareness of the country’s own identity in a globalised world. An old stereoscopic photograph shows the German Pavilion by Mies van der Rohe at the 1929 Barcelona Universal Exposition. In the mundaneness of a rainy autumn afternoon, the building dissolves into infinite reflections: in the marble-covered walls, those of the trees and pavilion towers; in the surface of water, placed by Mies and swelled by the rain, those of the clouds and the people that populate the building. The photographer captures the characters at the moment when they are about to leave the pavilion, suggesting, apparently, that its “time and its place” have already passed. In reality the shot forever captures one of the rare moments in which architecture, building on the principle of the ritual of inviolability, attains its highest beauty and its absolute perfection.5 In the past two centuries the ephemeral lights of many exhibitions have been extinguished. From Paris to Shanghai Spain shows that she has fully understood the fundamental Miesian lesson: that architecture is not ready to disappear with them. Translated by Arba Baxhaku 1
See: Juan Miguel Otxotorena, Utopía o nostalgia, tradición o traición. Sobre Javier Carvajal y el Pabellón español de la Feria Mundial de 1964 en Nueva York, in 1964/65 New York World’s Fair. The Spanish Pavillion, Pamplona, T6) Ediciones 2014. 2 Kazimir Severinovich Malevich, La Lumière et la couleur: textes de 1918 à 1926, Lausanne, L’Age d’homme 1981. 3 See: Bernard Rudofsky, Vernacular virtuosity, in Id., Architecture without architects, New York, The Museum of Modern Art, 1964. 4 See: Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder praktische Aesthetik …, Vol. 1: Die Textile Kunst …, Frankfurt am Main, Verlag für Kunst und Wissenschaft, 1860; vol. 2, Keramik, Tektonik, Stereotomie, Metallotechnik, München, Friedrich Bruckmanns‘Verlag, 18631. 5 See: Juan José Lahuerta, Mies popular, in Id., Humaredas. Arquitectura, ornamentación, medios impresos, Madrid, Lampreave 2010, pp. 287-339.
light; it is sufficient to reflect on the fact that in the absence of light - or in other words in total darkness - there cannot be any conscious perception of space, nor the minimal conditions for living in it. And regardless of how sublime the existence of something we cannot see may appear to us, also our imagination depends on images and thus on light. We might object that matter, materials and thus architecture is independent from this condition, as they intrinsically express an individual consistency, texture and thus tactile quality; but while we may manage to understand the form and characteristic of a domestic object by bodily contact, this is impossible in most cases when it comes to architecture. If this is so, then it is necessary to study the way architecture - not as the final result of a creative process but as its design - can, or rather must, use light as a constitutive element of every composition. It is, in other words, necessary to discuss and analyse light, not as accidental and ineluctable condition of architecture, but on the contrary interpret it as a means for an intentional construction and definition of both the architectural space and its plastic and formal characteristics. As is often the case, words cannot compare to experience, and least of all to the simple and mystical one of visiting the Pantheon, where the light conquers a physical substance and a material consistency which is more powerful than the self-same architectural shell, designing on the wall not just the dilated projection of the skylight on top of the building but the unmistakeable representation of the divine presence and, with it, the idea and image of the temple. The pulsation inspired in the observer is wholly exhaustive and pervasive; it occupies the imagery of the onlooker beyond any imaginary limit, unveiling the rules of existence, the laws of physics as gravity and the relationship between the solar system and its planets, the alternation of day and night and thus of the rotation of the earth, the changing of the seasons, the relationship between natural and artificial, the value of ephemeral and real things; in the final analysis, the cycle of life and the ultimate meaning of our life on earth. Fascinated with such a sight, which is as amazing as it is common, we have always sought in our everyday work as architects to consider light - whether natural and thus dependent on the time of day or artificial and thus protagonist of the nocturnal hours - as one of the principal components of the art of building, the most precious material, the most efficient instrument of every narration and every creative process. And within the context of the arts - which have always been related and influential to architecture as tautology of creation, we have always looked attentively to those figurative expression which and it is not a matter of play with words - have renounced figurative expression in favour of light and space, from Lucio Fontana’s cuts and holes to Castellani’s vibrant surfaces, from Bonalumi’s concavities and convexities to Scheggi’s envelopes, to Dadamaino’s serial voids, to remain in a completely Italian and sufficiently recent creative territory, while we would have to, and could, return without hesitation to the origins, and thus to Brunelleschi and Michelangelo, who have derived the sense of their universal message from light and geometric rigour, as well as naturalness.
Maria Grazia Eccheli Riccardo Campagnola The glare of the reeds (page 106)
Laura Andreini - Archea
Light, Matter, Architecture by Laura Andreini (page 90)
To understand that light, matter and architecture are absolutely inseparable it is not necessary to resort to Le Corbusier’s famous definition of architecture as the result of the skilful play of volumes brought together in
174
Bao Gang Wu Liu is a small site in Shanghai: it is placed long a chaotic industrial area in fast transformation, closed by a huge beam of binary, almost impossible to find in the maze of rivers and waters, tributaries of the immense estuary of the Yangtse River. the purpose of the project is Retrieve and transform existing spaces, with almost forced demolitions, build small architectures, only necessary to its new destination of Wine World. The idea behind our work are small grafts.
The demolitions mold the existing that become available to accommodate the bamboo forest, the China symbol of long life: symbol of elegance and strong attitude to construction. The area is designed as a metaphor of the world of wine. the visitor is welcomed in buildings surrounded by greenery and by water: elements that the project takes for their ability to approach East and West. The vineyards have always characterized the landscape; they build a geometry that transforms the morphology of hilly, they mold nature into architecture. The order element of the whole composition is a covered road with course east / west -Wine Gallery-, that it pass across the limits of all area. The shadow is the reason of the shielding of the gallery, realized by a brise-soleil wooden frame of bamboo, that born and reverberates itself from the water, because the shadow in the East seems to have an equivalence with light. The road / tunnel, inhabited by parallelepipeds glass, is marked by large openings that show the distribution, including the staircase leading to the underground cellar. At the end of the tunnel is located the “wine bar” which is reflected in a large tub of water, in which the infinite sequence of wood elements multiplies the shadows; the water glare multiplies the designs of light. To the side of the tub of water is located a small restaurant the south side of the road / tunnel distributes the Main Hall: an existing building in which are located the offices, commercial space, and a conference room. The project of this building is to cover the build with corten steel, in which are engraved large advertising signs. The new “mask”, surpassing in height all the buildings of the whole area can be seen from the hectic streets, from the railway and at night can become a bright beacon. North of Wine / Gallery, is located the space for events, that is recovered from the large hangar existing concrete, a tripartite space ordered by a forest of pillars, it becomes a fascinating ruins of the modern. Long the Jiangyang South Road is placed access to underground parking covered by reeds. Translation by Alessandro Cossu
Danteum – Light takes form by Francesco Collotti (page 118)
In the construction of the nation, Dante was used in an often distorted patriotic revival key, called on to legitimize the construction of a mythical Italy from epitaph to headstone, populated by heroes, navigators, poets. The use and abuse of the great poet had its political apotheosis during the fascist era, when the tension of the entire epic poem, not without clashes between opposing sides, became drawn towards that eagle which symbolized the monarchy (or the empire?) and its saviour and guide, prophesized by Virgilio the first canto of Hell as a starting point for the ascent. An entity which, according to a prophetic-political reading, was supposedly personified by Benito Mussolini. Stripping the Divine Comedy of all this ideological apparatus, time and again a victim of circumstance, we are left with the extraordinary construction of Dante Alighieri which is a highly symbolic analogous world, whose numerous meanings recall a journey of initiation addressed to those who know they ought to search. It is in this sense that the Poet’s work seems untouched and great. Is Beatrice maybe not a mortal being/woman but sophia/wisdom? The whole Comedy still an awesome theatre of analogies through which to read the world? What we certainly know is that the dialectics between light and darkness lies within the journey gradually unravelling through the canticas. It is struggle and tension, not a quiet description. Sequence of phases of transition maybe only comprehensible through esoteric and alchemic approaches? Does Lingeri’sand Terragni’s Danteum manage to hold all this within its pure form? The assignment comes from the project creator Rino Valdameri, President of the Royal Academy of Brera (at the time Lingeri’s friend and enlightened commissioner for many projects, amongst which the Isola Comacina houses and the sequence of projects together with Giuseppe Terragni for the Brera Academy of Milan). Soon there was a dis-
pute between the enterprising Valdameri, actively involved in modern architecture and art, and minister Bottai’s restraining entourage. The idea does not consider the palace or the museum but rather borrows the figure of the temple (the library, with all the editions of the Opera and the illustrations, will be put in a crypt and be the only part open to the outside). According to an accurate and reliable reconstruction (Schnapp 1996), Lingeri contacted Terragni while the whole of the political supporters included a Milanese count, mainly sponsoring the initiative, the Ministry of Education, Culture and Finance, as well as Ugo Ojetti, Giovanni Gentile, Massimo Bontempelli e Vittorio Cini. First rate names for the initiative evaluation, but still of distant views, who would bring to the project to implosion. After the two great roman competitions for Palazzo del Littorio (first in 1934 in Via dell’Impero and then, in 1937, on the Aventino) and for Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi at E42 (1937-1939), Lingeri e Terragni arrive in Rome for the laic temple created around the great three landscapes recalled by The Poet. The perfect construction of the Divine Comedy takes shape in the Danteum leaning, with a certain viscosity, against the unnatural gesture represented by the Via dell’Impero in Rome. Aligning itself to the prior ruins rather than the new trace of the Road, the Danteum chooses a slower time compared to the latest violent demolitions of the regime. The sequence of golden proportions lies within the roman roots of Massenzio’s Basilica but, due to a sensible in depth-analysis on Lingeri’s part, it seems to slide more into a Greek, rather than Roman, classicism. Lingeri’s work for the Danteum is, furthermore, intrinsically linked with Bardi’s and Bontempelli’s research (even of internal opposition) first in “Quadrante” and after in “Valori primordiali”. It is a long journey for Lingeri and Terragni. It is a dazzling light whose motion arrives in Como from Barcelona, Alger, Athens to stop in the long prospective of the snow covered mountains that enclose the Northern area of the lake. Here it is, the cursive script nr. 40 in Quadrante: “...will the Mediterranean people be able to bring, in the near future (…), a further contribution to the development of European architecture? We consider strictly necessary a revision of certain Nordic elements of Rationalism. The climate modifies the functions and shapes of external walls (We feel that the emotional relationships between full and empty of some rustic houses in the South are right; people living along the Mediterranean coast – probably because of their poverty as well – always had a sense of essential precision – Quadrante 1933)”. The calm landscape that can be admired between Villa Leoni and Ossuccio, a terrace of vines and olive trees, a monumental arbour rooted in the stone of this lake shore at the foot of Madonna del Soccorso (Lingeri, 1938-1944), or the ambitious view of the ceiling beams of the Casa del Fascio di Terragni, remind us of a mythic atmosphere, transcendent customs, intellectual fashions: a whole of primordial forces, operating in reality and in the spirit. The light in the eyes of the Masters of Como recalls primitive Mediterranean scenarios, deeper than the mere roman translation “in the mass” of the wall, that the contemporary architects pursue. The Danteum, a gesture in stone, iron and glass, almost a dry stone construction in the style of a temporary pavilion, a deep admiration for classical abstraction, implicitly against classical approach which often, in Rome and in the most eager provinces, fell in the parody of Baroque? The Danteum is absolute volume, with just an hint of chiaroscuro due to the low-reliefs that reinforce the wall. Light, more than numbers, allow the translation of the Divine Comedy into a built shape. Risen through consecutive degrees from the opaque colour of travertine columns in the Dark Woods, eight meters high and one meter in diameter (and ceiling made of glass blades alternated with giant cubes placed as capitals of the columns), going through the spiral described by the seven different columns of Hell, to the solar Paradise articulated in 33 columns, seven meters high and eighty centimeters in diameter, erected in grinded glass bricks. In the Danteum light is a building material, as well as the shade which is its inseparable daimon. The big plant/map, the Raumplan, the section which accompanies us on the journey, the chess board effect in the space, are all devices of a narrative sequence which evolves for degrees and stations. The same way Dante’s work is an extraordinary analogy which lives in the theatre of light and shade memory, also the space organization gives depth and space to the initiation journey towards the light. State transitions through sensitive places that mark these passages, staggered floors, steps, the proportion of the spaces you are introduced to. With the poor architectural instruments, without special effects. As it always should be. The impenetrable map of its section is here implemented with a unique programmatic coincidence. On the map choices are made and the weights of the built shape are distributed. It is in the section, though, that I can understand how light and shadow become building material. Section proportion that proposes a place where I can live, so breathing becomes deeper, a hallway to walk down, a place to pass through not to stay. The Poet’s text takes shape, selects hierarchies and places, spaces following a precise order. All spaces are in progression, not only inside each ambient, but in the relationship of the ambients between each other. The map is here creator and sign of coherent volumes. Geometry is not the aim but the means of controlling ideas in order to reach accomplished unity.
175
Università degli Studi di Firenze - DiDA Dipartimento di Architettura Direttore - Saverio Mecca - Professori ordinari - Maria Teresa Bartoli, Amedeo Belluzzi, Stefano Bertocci, Roberto Bologna, Cosimo Carlo Buccolieri, Fabio Capanni, Mario De Stefano, Romano Del Nord, Maria Grazia Eccheli, Ezio Godoli, Antonio Lauria, Vincenzo Alessandro Legnante, Saverio Mecca, Giancarlo Paba, Raffaele Paloscia, Fabrizio Rossi Prodi, Massimo Ruffilli, Marco Sala, Maria Chiara Torricelli, Francesca Tosi, Ulisse Tramonti, Paolo Zermani, Maria Concetta Zoppi - Professori associati - Alberto Baratelli, Gianluca Belli, Mario Carlo Alberto Bevilacqua, Alberto Bove, Susanna Caccia Gherardini, Giuseppe Alberto Centauro, Elisabetta Cianfanelli, Francesco Collotti, Angelo D’Ambrisi, Giuseppe De Luca, Maria De Santis, Maurizio De Vita, Maria Antonietta Esposito, Enrico Falqui, Luca Giorgi, Pietro Basilio Giorgieri, Paolo Giovannini, Biagio Guccione, Flaviano Maria Giuseppe Lorusso, Giuseppe Lotti, Alberto Manfredini, Carlo Natali, Raffaele Nudo, Riccardo Pacciani, Michele Paradiso, Giacomo Pirazzoli, Daniela Poli, Massimo Preite, Giuseppe Ridolfi, Alessandro Rinaldi, Giacomo Tempesta, Carlo Terpolilli, Ugo Tonietti, Silvio Van Riel, Corinna Vasic Vatovec, Alberto Ziparo - Ricercatori - Elisabetta Agostini, Francesco Alberti, Gianpiero Alfarano, Mauro Alpini, Laura Andreini, Giovanni Anzani, Fabrizio Franco Vittorio Arrigoni, Barbara Aterini, Dimitra Babalis, Pasquale Bellia, Elisabetta Benelli, Marta Berni, Carlo Biagini, Riccardo Butini, Ferruccio Canali, Antonio Capestro, Stefano Carrer, Carmela Crescenzi, Alessandra Cucurnia, Alberto Di Cintio, Fabio Fabbrizzi, David Fanfani, Fauzia Farneti, Paola Gallo, Giulio Giovannoni, Laura Giraldi, Fabio Lucchesi, Cecilia Maria Roberta Luschi, Pietro Matracchi, Alessandro Merlo, Francesca Mugnai, Gabriele Paolinelli, Camilla Perrone, Michelangelo Pivetta, Paola Puma, Andrea Ricci, Rossella Rossi, Tommaso Rotunno, Luisa Rovero, Roberto Sabelli, Claudio Saragosa, Marcello Scalzo, Marco Tanganelli, Lorenzo Vallerini, Giorgio Verdiani, Stefania Viti, Andrea Innocenzo Volpe, Leonardo Zaffi, Claudio Zanirato, Iacopo Zetti - Ricercatori a tempo determinato - Michele Coppola, Valeria Lingua, Patrizia Mello, Francesca Privitera - Responsabile amministrativo - Stefano Franci - Personale tecnico/amministrativo - Cinzia Baldi, Rossana Baldini, Lorenzo Bambi, Francesca Barontini, Massimo Battista, Marzia Benelli, Franca Giulia Branca, Tullio Calosci, Carlo Camarlinghi, Laura Cammilli, Daniela Ceccherelli, Gianna Celestini, Daniela Chesi, Giuseppe Ciappi, Donatella Cingottini, Elena Cintolesi, Stefano Cocci, Laura Cosci, Luigia Covotta, Annamaria Di Marco, Cabiria Fossati, Stefania Francini, Lucia Galantini, Gioi Gonnella, Marzia Messini, Rossana Naldini, Neda Para, Nicola Percacciante, Grazia Poli, Maria Cristina Righini, Donka Tatangelo
In copertina: Edward Hopper, Tow studies for Rooms by the Sea (recto), 1951 Carboncino su carta Katharine Ordway Fund 2008.144.1 Photo Credit: Yale University Art Gallery
DIDA
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Dipartimento di Architettura - DIDA - Direttore Saverio Mecca via della Mattonaia, 14 - 50121 Firenze - tel. 055/2755419 fax. 055/2755355
architettura firenze
Periodico semestrale* Anno XVIII n. 1&2 - 2014 Autorizzazione del Tribunale di Firenze n. 4725 del 25.09.1997 ISSN 1826-0772 - ISSN 2035-4444 on line
Direttore - Maria Grazia Eccheli Direttore responsabile - Saverio Mecca Comitato scientifico - Alberto Campo Baeza, Maria Teresa Bartoli, Fabio Capanni, Giancarlo Cataldi, Francesco Cellini, Adolfo Natalini, Ulisse Tramonti, Chris Younes, Paolo Zermani Redazione - Fabrizio Arrigoni, Valerio Barberis, Riccardo Butini, Francesco Collotti, Fabio Fabbrizzi, Francesca Mugnai, Alberto Pireddu, Michelangelo Pivetta, Andrea Volpe, Claudio Zanirato Grafica e Dtp - Massimo Battista Segretaria di redazione e amministrazione - Grazia Poli e-mail: firenzearchitettura@gmail.com Proprietà Università degli Studi di Firenze Gli scritti sono sottoposti alla valutazione del Comitato Scientifico e a lettori esterni con il criterio del Blind-Review L’Editore è a disposizione di tutti gli eventuali proprietari di diritti sulle immagini riprodotte nel caso non si fosse riusciti a recuperarli per chiedere debita autorizzazione The Publisher is available to all owners of any images reproduced rights in case had not been able to recover it to ask for proper authorization chiuso in redazione novembre 2014 - stampa Bandecchi & Vivaldi s.r.l., Pontedera (PI) *consultabile su Internet http://www.dida.unifi.it/vp-146-firenze-architettura.html
luce e materia
architettura firenze
firenze architettura
1&2.2014
1&2.2014
ISSN 1826-0772
DIDA
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
Periodico semestrale Anno XVIII n.1&2 Euro 7 Spedizione in abbonamento postale 70% Firenze
luce e materia