Educazione civica
equilibri
#PROGETTOPARITÀ
Lezioni su Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale
Un calendario per l’educazione civica
Pier Giorgio Viberti Giorgio OlmotiIl nostro tempo dalle storie alla Storia
Educazione civica
Coordinamento redazionale: Marco Mauri Redazione e coordinamento: Matteo Gorla, Roberto Rustico, Daniela Previtali
Art direction: Enrica Bologni
Impaginazione: Andrea Guarneri multimedia Ricerca iconografica: Daniela Previtali Immagine di copertina: Shutterstock
Contenuti digitali
Progettazione: Giovanna Moraglia
Realizzazione: ITG Torino, bSmart Labs
La gamification Mission 2030 è stata realizzata da Eicon
Si ringraziano le professoresse Gladis Omaira Capponi, Rossella Kohler e Rosanna Imbrogno per il prezioso contributo alla progettazione e realizzazione del volume.
Referenze iconografiche

Alamy, Shutterstock. Tutte le altre immagini provengono dall’Archivio Principato. Per le riproduzioni di testi e immagini appartenenti a terzi, inserite in quest’opera, l’editore è a disposizione degli aventi diritto non potuti reperire, nonché per eventuali non volute omissioni e/o errori di attribuzione nei riferimenti.
ISBN 978-88-416-5159-9
Il nostro tempo Volume 1 con Atlante storico 1 + La storia antica + Educazione civica + Studiafacile
ISBN 978-88-6706-536-3
Il nostro tempo Volume 1 con Atlante storico 1 + La storia antica + Educazione civica + Studiafacile
eBook+
ISBN 978-88-416-5170-4
Educazione civica
ISBN 978-88-6706-541-7
Educazione civica eBook+
Prima edizione: gennaio 2023
Printed in Italy
© 2023 - Proprietà letteraria riservata.
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Le riproduzioni per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi (Centro licenze e autorizzazioni per le riproduzioni editoriali), corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org
L’editore fornisce – per il tramite dei testi scolastici da esso pubblicati e attraverso i relativi supporti o nel sito www.principato.it e www.gruppoeli.it –materiali e link a siti di terze parti esclusivamente per fini didattici o perché indicati e consigliati da altri siti istituzionali. Pertanto l’editore non è responsabile, neppure indirettamente, del contenuto e delle immagini riprodotte su tali siti in data successiva a quella della pubblicazione, dopo aver controllato la correttezza degli indirizzi web ai quali si rimanda.
Casa Editrice G. Principato sito web: http://www.principato.it www.gruppoeli.it
Via G.B. Fauché 10 - 20154 Milano e-mail: info@principato.it
La casa editrice attua procedure idonee ad assicurare la qualità nel processo di progettazione, realizzazione e distribuzione dei prodotti editoriali.
La realizzazione di un libro scolastico è infatti un’attività complessa che comporta controlli di varia natura. È pertanto possibile che, dopo la pubblicazione, siano riscontrabili errori e imprecisioni. La casa editrice ringrazia fin da ora chi vorrà segnalarli a:
Servizio clienti Principato
e-mail: info@principato.it
Stampa: Tecnostampa – Pigini Group Printing Division – Loreto – Trevi 22.85.206.0PIl tuo libro di Educazione civica
Il libro che ti accingi a leggere vuole suggerirti spunti di riflessione su aspetti fondamentali che interessano la vita di ogni cittadino e cittadina e si propone di fornirti suggerimenti grazie ai quali potrai migliorare la tua educazione (“civica”, appunto).
Lezioni di Educazione civica
La prima parte sviluppa il discorso intorno ai tre nuclei concettuali individuati dalle linee guida del Ministero:
Della Costituzione, il documento fondamentale su cui si basano le leggi vigenti nello Stato italiano, si prendono in esame i suoi principi fondamentali, i diritti e doveri dei cittadini e delle cittadine, l’ordinamento dello Stato; seguono una lezione dedicata allo sviluppo sostenibile (con gli obiettivi dell’Agenda 2030) e una alla cittadinanza digitale.

Un calendario per l’Educazione civica
Nella seconda parte i tre temi che caratterizzano lo studio di questa materia sono presentati secondo il calendario delle Giornate ad essi dedicate. Giornate nazionali e mondiali che trattano e affrontano alcuni fra i temi più importanti della vita dell’umanità nel suo insieme (la difesa dell’ambiente, la pace, i diritti umani, lo sviluppo, la convivenza civile ecc.).

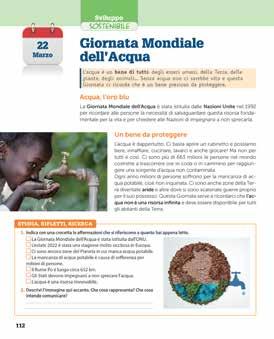
Vi troverai approfondimenti storici, notizie di attualità, personaggi e altri materiali curiosi e interessanti. Potrai così scoprire la bellezza di una materia che merita davvero tutta la tua attenzione.
Ad ogni argomento è stato associato un colore (blu per la Costituzione, verde per lo sviluppo sostenibile, giallo per la cittadinanza digitale), che identifica ogni data così da mettere subito in evidenza l’area di interesse.
Nel corso delle lezioni, lo spazio STUDIA, RIFLETTI, RICERCA invita a metterti in gioco attraverso riflessioni e attività legate alla ricerca e all’approfondimento.
È il gioco online per scoprire i 17 obiettivi e i traguardi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Inquadra la pagina e inizia a giocare!

 3. La cittadinanza digitale
1. La Costituzione
2. Lo sviluppo sostenibile
3. La cittadinanza digitale
1. La Costituzione
2. Lo sviluppo sostenibile
1
Lezioni di Educazione civica

Lezione Vivere in società
Nessun uomo è un’isola
Il desiderio di vivere insieme per proteggersi, condividere e aiutarsi è presente fin dalle origini delle comunità umane.
Nessun uomo è un’isola scriveva più di quattro secoli or sono il poeta inglese John Donne. Il significato di questa affermazione è chiaro: nessun uomo può vivere “isolato”, cioè solo. Il desiderio di vivere in gruppo per proteggersi, condividere rapporti affettivi, aiutarsi è sempre stato presente, fin dalle origini delle comunità umane. Non a caso gli studiosi definiscono l’uomo un «animale sociale». Dunque un insieme di persone si può considerare un gruppo quando:
• condivide uno spazio e un tempo;
• ha degli obiettivi, delle idee, un linguaggio comuni;
• ogni persona si sente legata alle altre.
Vivere in un gruppo non è sempre facile: per questo è necessario stabilire delle regole condivise che permettano di sentirsi accolti/e, rispettati/e e liberi/e di potersi esprimere. Le leggi sono le regole che permettono al cittadino di convivere in maniera pacifica. Naturalmente ci vuole qualcuno che le stabilisca e le faccia rispettare: questo «qualcuno» è lo stato, che si compone di tre parti:
• il territorio;
• il popolo;
• la sovranità (ossia il potere di imporre le leggi).
Lo studio dell'educazione civica
"La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese."
Dunque, l'insegnamento dell'Educazione civica, così come oggi viene proposto dalle linee guida fornite dal Ministero dell'Istruzione, si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali:
Ovvero temi che riguardano il diritto (nazionale e internazionale), la legalità e la solidarietà.
Uno stato si dice democratico quando riconosce i diritti a tutti i cittadini, i quali partecipano con il voto e con altre forme di espressione, alle scelte che interessano la società intera. Uno stato democratico si regge generalmente su una Costituzione, cioè su un documento che stabilisce l’insieme delle norme a cui tutte le altre leggi devono uniformarsi. Essa definisce gli organi fondamentali dello Stato e ne indica i poteri, inoltre garantisce i diritti fondamentali dei cittadini.
Temi legati all'educazione ambientale e alla conoscenza e tutela del patrimonio storico-artistico e paesaggistico.
Un buon cittadino non può accontentarsi di vivere secondo le norme date dalle leggi, poiché vive al centro di un mondo complesso, in continua evoluzione. Tutta l’umanità si muove seguendo un progresso scientifico e tecnologico che deve essere controllato dalle autorità competenti per evitare che produca disastri ambientali e sociali anche molto gravi. Non basta però delegare ad altri il compito di sorvegliarlo: ognuno di noi deve essere consapevole dei pericoli che si corrono e deve adottare comportamenti che non aggravino i problemi già esistenti.
Le istituzioni politiche ed economiche, così come i singoli cittadini, devono avere come obiettivo il raggiungimento di un progresso sostenibile, capace di coniugare sviluppo e ambiente.
La capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
L’avvento della comunicazione digitale ha cambiato le nostre vite, permettendoci di svolgere operazioni un tempo impossibili e velocizzandone altre. Una scheda di plastica ci permette di pagare la spesa o di ritirare denaro da un bancomat; una tastiera del cellulare o del computer ci permette di scrivere lettere che arrivano a destinazione in tempo reale, di leggere un quotidiano, di inviare fotografie, di prenotare un ristorante e così via. Durante la recente pandemia di COVID-19 molti hanno potuto svolgere il proprio il lavoro da casa grazie allo smart working Attenzione, però: il mondo digitale non è esente da pericoli Nel mondo di internet è facile imbattersi in truffe, in tentativi di attrarre giovani ingenui per fini sessuali, in fake news, (notizie false).
STUDIA, RIFLETTI, RICERCA
1. Organizzate un debate sul tema: In ogni gruppo è necessario stabilire delle regole. Formate due gruppi. Il primo è d’accordo con questa affermazione, il secondo ritiene che si possa vivere insieme anche senza regole. Elencate i pro e i contro motivando i vostri pareri. Insieme all’insegnante trovate un’opinione condivisa.
Il Capo dello Stato, Enrico De Nicola, firma la Costituzione italiana a palazzo Giustiniani, il 27 dicembre 1947. Al suo fianco, da sinistra a destra, Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio, Francesco Cosentino, funzionario, Giuseppe Grassi, guardasigilli, e Umberto Terracini, presidente della Costituente.

Lo Stato italiano e la Costituzione
1° gennaio 1948: una giornata fondamentale per l'Italia
Il 1° gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione, documento fondamentale della nuova Italia repubblicana.
Al termine della Seconda guerra mondiale, gli Stati che erano stati coinvolti nel conflitto decisero di rifondarsi, riscrivendo le proprie leggi. In Italia, il 2 giugno 1946, i cittadini furono chiamati a votare per scegliere fra la conservazione della monarchia e l’istituzione della repubblica: vinse la repubblica, che da allora costituisce il nostro sistema istituzionale.
Il nuovo Stato aveva bisogno anche di nuove leggi. A questo scopo fu istituita un’Assemblea Costituzionale, formata da settantacinque persone elette dal popolo, alle quali fu assegnato il compito di scrivere una Costituzione. Entrata in vigore il 1° gennaio 1948, essa costituisce il documento fondamentale a cui tutte le leggi italiane fanno riferimento e indica i valori che sono alla loro base; inoltre stabilisce l’organizzazione dello Stato e le regole che noi cittadini e cittadine dobbiamo seguire. È composta da 139 articoli suddivisi in tre parti, ognuna delle quali sviluppa temi specifici.
Le caratteristiche della Costituzione italiana
La Costituzione italiana presenta alcune caratteristiche particolari:
• è rigida, poiché gli articoli costituzionali si possono modificare solo attraverso una procedura lunga e complessa, detta revisione costituzionale;
• è scritta, come quasi tutte le Costituzioni in vigore nei Paesi democratici, eccetto la Gran Bretagna;
• è popolare, in quanto fu scritta dall’Assemblea Costituente eletta a suffragio universale, cioè con la partecipazione di tutti i cittadini aventi i requisiti di età richiesti;
LE PAROLE DELLO STATO
Liberale: il liberalismo è una filosofia politica e morale basata sul riconoscimento dei diritti inalienabili dell'uomo (insopprimibili).
• è democratica, perché attribuisce la sovranità al popolo, che la esercita eleggendo i propri rappresentanti in Parlamento;
• è dettagliata, perché non contiene soltanto norme di carattere generale, ma presenta indicazioni che riguardano molti settori della vita civile.
• è frutto dell’incontro e della sintesi di idee e culture diverse, come erano quelle dei partiti antifascisti: in particolare, la nostra Costituzione è una sintesi delle culture liberale , cattolica e socialista.
La struttura della Costituzione
La Costituzione italiana si compone di 139 articoli, cinque dei quali sono stati successivamente abrogati, cioè annullati. Ogni articolo è formato da una o più parti, ciascuna delle quali è detta comma. I vari commi sono separati gli uni dagli altri da un punto fermo e cominciano sempre a inizio riga.
Art. 3
Comma 1 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Comma 2 È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
I 139 articoli sono suddivisi in tre Sezioni, la seconda e la terza delle quali comprendono un certo numero di Titoli:
Principi fondamentali dello Stato
Articoli 1-12
Sono i valori e gli ideali su cui si fonda lo Stato italiano
PARTE PRIMA. Diritti e Doveri dei Cittadini
Articoli 13-54
Specifica i diritti e i doveri dei cittadini
Titolo I – Rapporti civili
Titolo II – Rapporti etico sociali
Titolo III – Rapporti economici
Titolo IV – Rapporti politici
PARTE SECONDA. Ordinamento della Repubblica
Articoli 55-139
Indica come deve essere organizzato ogni aspetto dello Stato
Titolo I – Parlamento
Titolo II – Presidente della Repubblica
Titolo III – Governo
Titolo IV – Magistratura
Titolo V – Regioni, Province e Comuni
Titolo VI – Garanzie costituzionali
STUDIA, RIFLETTI, RICERCA
1. Indica con una crocetta se le affermazioni sono vere (V) o false (F).
a. Nel 1948 la repubblica sostituì la monarchia.

b. L’Assemblea Costituzionale stese la Costituzione.
c. La Costituzione è il documento fondamentale dello Stato.
d. Il 1° gennaio 1948 fu annullata la Costituzione Italiana.
e. Ancora oggi la Costituzione è il documento di riferimento per il nostro Paese.
➔ Vai a pag. 10
➔ Vai a pag. 12
➔ Vai a pag. 14
Lezione La Costituzione Principi fondamentali dello Stato
Articoli 1-12
I principi fondamentali indicano i valori e gli ideali su cui si basa lo Stato italiano.
La Costituzione si apre con i dodici Principi Fondamentali. In questi Principi si indicano i valori della Costituzione a cui dobbiamo riferirci per vivere in una comunità, e che lo Stato Italiano difende e in base ai quali legifera. Leggiamoli.
Art. 1 - L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua , di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5 - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento
Art. 6 - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche
1. Principio democratico 6. Principio pluralista 2. Principio di personalista e di solidarietà 3. Principio di uguaglianza 4. Principio lavoristaArt. 7 - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale
Art. 8 - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Art. 10 - L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11 - L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo
Art. 12 - La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Titolo I
I rapporti civili
La Costituzione PARTE PRIMA Diritti e doveri dei cittadini
Articoli 13-54
La prima parte del testo costituzionale indica i diritti e i doveri dei cittadini.
La prima parte della Costituzione garantisce le libertà essenziali del cittadino come individuo. Inoltre tutela i diritti della famiglia e affronta i grandi temi della salute, dell’istruzione, del lavoro, dell’iniziativa economica pubblica e privata, della partecipazione del cittadino alla vita politica. L’affermazione dei diritti è sempre accompagnata dal richiamo ai doveri: a ogni diritto corrisponde infatti il dovere di riconoscere agli altri un uguale diritto. Il cittadino ha poi dei doveri verso lo Stato (cioè verso tutta la comunità): per esempio, quello di pagare le imposte in misura adeguata alla sua ricchezza. Leggiamo e commentiamo insieme un articolo per ciascuno dei quattro Titoli.
Art. 19 - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché, non si tratti di riti contrari al buon costume.

L'art. 19 della Costituzione afferma il principio della libertà di scelta religiosa, un principio che è stato negato tante volte in passato e lo è ancora oggi in alcuni Paesi del mondo. L’articolo consente inoltre ai fedeli di frequentare i luoghi di culto della propria religione, quale che sia, e di propagandarla tanto in privato quanto in pubblico. L’unico divieto che si pone riguarda i culti che offendono il buon costume.
Titolo II
I rapporti etico-sociali
Art. 29 - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
L’art. 29 stabilisce quale nucleo della società la famiglia fondata sul matrimonio, civile o religioso. All’interno del matrimonio la legge attribuisce all’uomo e alla donna uguali diritti e doveri. Gli stessi diritti sono riconosciuti anche alle coppie unite civilmente mentre non lo sono nel caso di coppie che sono conviventi.
Art. 36 - l lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé, e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Il principio enunciato in questo articolo garantisce al lavoratore le condizioni che gli permettono di vivere in maniera libera e dignitosa. Purtroppo la piena realizzazione di questo articolo è assai difficile, soprattutto in alcuni settori lavorativi e per certe categorie di lavoratori, in particolare giovani e immigrati, costretti a volte a sopportare per salari insufficienti carichi di lavoro eccessivi.
Art. 48 - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
L’art. 48 fa proprio il principio del suffragio universale, per cui ogni cittadino maggiorenne ha il diritto di voto, salvo le rare eccezioni stabilite dalla legge: ricordiamo l’infermità di mente, la condanna definitiva per alcuni tipi di reati, una condanna, definitiva o temporanea, che comporti l’impossibilità di ricoprire i pubblici uffici. Il voto ha lo stesso valore per qualsiasi elettore e deve essere espresso liberamente, senza che il votante subisca pressioni di alcun genere. Votare è un diritto, ma è anche un dovere per un buon cittadino, anche se non sono previste sanzioni per chi non si reca alle urne. A partire dal 2003 è concessa la possibilità di votare anche ai cittadini italiani residenti all’estero.
STUDIA, RIFLETTI, RICERCA
1. Leggi con attenzione l’art. 54 della Costituzione e rispondi alle domande:
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
• Qual è il significato della parola “Repubblica”? Spiegalo con le tue parole:
• Adesso rifletti: essere fedeli alla Repubblica e osservarne le leggi porta risultati positivi: solo a te stesso/a a tutta la società
Spiega il perché della tua risposta.
2 Un calendario per l’Educazione civica

21

Settembre Giornata Internazionale della Pace



Tutte le organizzazioni internazionali concordano: la pace è indispensabile per costruire non solo delle società giuste, ma anche per facilitare lo sviluppo economico e ridurre le disuguaglianze.



Una Storia senza pace



Nella Storia, l’umanità non ha probabilmente mai conosciuto un periodo in cui ogni parte del pianeta sia stata contemporaneamente in pace. Anche in questo momento, nel mondo ci sono oltre sessanta situazioni di forte tensione o di vera e propria guerra tra Paesi. L’invasione russa dell’Ucraina del febbraio 2022 è solo l’ultimo di un lungo elenco di conflitti: dall’Afghanistan, alla Libia, al Myanmar, alla Palestina, alla Nigeria, sono molti i Paesi del mondo che vivono la guerra come una tragica normalità che può durare anche decenni. I motivi che scatenano le guerre sono diversi e numerosi. Alcuni conflitti sono causato da lotte per il possesso di risorse strategiche (petrolio, gas, acqua o terre fertili) come accade in molte delle guerre scoppiate nel continente africano; altri sono generati da scelte operate dalle potenze globali sullo scacchiere geopolitico, come avvenuto in Vietnam, Corea e Afghanistan; altri ancora sono causati per ottenere il controllo dei commerci di sostanze illegali, come la guerra dei Narcos in Messico. A volte il conflitto si svolge all’interno di uno stesso Paese: in questo caso si parla di guerra civile. Così è stato negli anni Novanta del secolo scorso nella ex Yugoslavia, nel cuore dell’Europa.



I danni della guerra
La guerra causa direttamente la perdita di molte vite umane. Vengono abbandonate le attività agricole e quindi manca cibo per la popolazione. L’industria non produce più: spesso le fabbriche sono tra i primi obiettivi dei bombardamenti. Quando la guerra finisce, nei campi restano le mine antiuomo, pericolose bombe messe nel terreno, che lo rendono inutilizzabile per le coltivazioni. Ragazzi e ragazze non possono frequentare la scuola, e quindi preparare il proprio futuro.
Grandi parti delle città vengono distrutte e, finita la guerra, molti edifici e infrastrutture (come le strade e le ferrovie) devono essere ricostruiti.
Migliaia, a volte milioni, di profughi sono costretti a emigrare, diventando così rifugiati in un altro Paese.
I movimenti pacifisti
In molte parti del mondo sono nati movimenti pacifisti che rifiutano la guerra come soluzione dei problemi. Assisi, in Umbria, la città di San Francesco, è considerata la capitale mondiale della pace; ogni due anni, da più di 40 anni, lungo il tratto di 24 km che separa Assisi da Perugia si svolge una Marcia per la Pace, che vuole testimoniare l’opposizione a tutte le guerre. Negli anni, all’idea iniziale di “pace” come contrario di “guerra” si sono aggiunti altri, obiettivi: la solidarietà fra i popoli, i diritti umani, la libertà, la giustizia, l’uguaglianza.
Gandhi il personaggio
Nel secolo scorso la personalità che ha rappresentato un simbolo di pace per tutto il mondo è stato il politico, filosofo e avvocato indiano Gandhi (1869-1948). Dal suo popolo era conosciuto come Mahatma, che vuol dire “Grande Anima” o anche “Santo”. Nel 1930, per sfidare l’Inghilterra che allora dominava l’India, Gandhi organizzò una “marcia del sale”: insieme a migliaia di persone raggiunse delle saline sull’Oceano Indiano e prese un pugno di sale. Con il suo gesto, Gandhi voleva dire che il sale apparteneva agli Indiani e non doveva essere controllato e tassato dagli Inglesi. Questo gesto sancì la nascita del movimento della non-violenza, che portò alla liberazione del suo Paese senza ricorrere alla guerra.

STUDIA, RIFLETTI, RICERCA

1. Indica quali conseguenze negative ha la guerra.
a. sull’agricoltura:
b. sull’industria:
c. sul futuro dei giovani:
d. sulle città:

2. Il testo che hai appena letto indica alcune delle numerose cause che scatenano le guerre. Cerca informazioni in rete per individuarne altre: elencale e corredale di una breve spiegazione
a.
b.
c.
d.
3. Leggi questa famosa frase pronunciata da Gandhi: Dicono che sono un eroe. Ma io sono debole, timido, quasi insignificante. Eppure ho fatto quello che ho fatto: immaginate allora che cosa potete fare tutti voi, insieme. Qual è secondo te il significato di queste parole?
Il rifiuto della guerra
Anche la nostra Costituzione ribadisce con forza il rifiuto della guerra.
Art. 11 - L’Italia ripudia la guerra come strumento degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La pace è un bene importantissimo, perciò l’Italia rifiuta le guerre di aggressione, cioè i conflitti armati con cui si vuole togliere l’indipendenza a un altro Stato, annettere una parte del suo territorio oppure ottenere dei vantaggi economici.
Combattere la povertà per favorire la pace
Per favorire la pace, però, bisogna innanzitutto che in ogni Paese la popolazione migliori le proprie condizioni di vita, che tutti e tutte abbiano il necessario per vivere, curarsi, studiare e lavorare, che diminuiscano le disuguaglianze di reddito.
Tutte le situazioni di estrema povertà e disagio, infatti, creano tensioni che possono trasformarsi in situazioni di guerra.
STUDIA, RIFLETTI, RICERCA


4. Rifletti in classe coi compagni e cercate una definizione comune delle seguenti parole, che avete letto nell’Art.11 della Costituzione.
a. Ripudia:
b. Risoluzione delle controversie internazionali:


c. Limitazioni di sovranità:
d. Organizzazioni internazionali:
5. Conosci il nome della principale organizzazione internazionale che promuove la pace tra le Nazioni?
6 Gandhi diceva che “la povertà è la peggiore forma di violenza”. Che cosa ne pensi? Scrivilo qui sotto e poi confrontati con la classe.
L’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030
L’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 mira alla pace in tutti i Paesi del mondo
Raggiungere gli scopi dell’Obiettivo 16 non è facile, perché significa non solo lottare contro ogni tipo di guerra, ma anche combattere la violenza in tutte le sue forme: la criminalità organizzata, lo sfruttamento di donne e bambini, la corruzione, il tra co di armi.
Alcuni traguardi dell’Obiettivo 16:
• ridurre tutte le forme di violenza;


• mettere fine allo sfruttamento dei più deboli;

• garantire a tutti la possibilità di accedere alla giustizia;
• ridurre il tra co di armi e combattere tutte le forme di criminalità;
• far partecipare anche i Paesi meno avanzati a tutte le decisioni che riguardano il Pianeta;
• proteggere le libertà fondamentali, come il diritto all’informazione;
• promuovere leggi contro il razzismo e le discriminazioni.

STUDIA, RIFLETTI, RICERCA
7. Il mantenimento della pace non è solo una questione da persone adulte.
a. Ti capita di litigare con un tuo compagno o una tua compagna?
b. Come ti comporti?
Cerco di capire le sue ragioni e provo subito a fare pace.
So di avere ragione, quindi non cedo.
Anche se ho torto, aspetto che siano gli altri a voler fare la pace.
Se litigo con qualcuno non do più nessuna possibilità di essere ancora amici/amiche.
Altro
c. È importante, secondo te, “allenarsi” a comportamenti pacifici fin da piccoli?
Sì. No. Perché
Settembre

Giornata Mondiale del Turismo 27
Il turismo è una bellissima attività. Permette di conoscere il proprio Paese e il mondo al di fuori dell’ambiente in cui viviamo. Viaggiare come turisti ci permette di incontrare una natura diversa, popoli con stili di vita differenti dai nostri e la sorpresa di colori, profumi e sapori che forse nemmeno immaginavamo.

Turismo per crescere
Il turismo è un’occasione di crescita per tutti. Viaggiando si imparano la Geografia, la Storia, la Storia dell’Arte, le Scienze completando con l’esperienza ciò che si studia sui libri. Se si viaggia all’estero si ascoltano nuove lingue, se si viaggia in Italia è bello scoprire i dialetti e gli accenti diversi della lingua italiana. Quando non si può viaggiare, si possono fare dei tour virtuali; i siti di molti musei, ad esempio, o rono la possibilità di esplorarli in questo modo scoprendo così il loro patrimonio.
In giro per il Pianeta
Per tutti questi motivi e anche perché è un’importante attività economica, dal 1980 si celebra il 27 settembre la Giornata Mondiale del Turismo. Ogni anno i festeggiamenti principali si svolgono in un Paese diverso, proprio perché si vuole far capire che ogni luogo merita di essere conosciuto e visitato. Ci sono mete che richiamano i turisti per le bellezze naturali: paesaggi costieri con rocce e spiagge, valli di montagna, fiumi e laghi, boschi, zone collinari. Altre mete sono di tipo culturale: le città con i loro centri storici, gli edifici, i musei ricchi di opere d’arte; ci sono poi i siti archeologici, i castelli e altre testimonianze della storia degli esseri umani.
STUDIA, RIFLETTI, RICERCA









1. Se dovessi organizzare una gita o un viaggio, ti attirerebbe di più una meta con: bellezze naturali. ricchezza culturale.
Motiva la tua scelta

2. Indica con una crocetta i motivi per cui il turismo rappresenta un’occasione di crescita: Mi permette di approfondire le mie conoscenze.
L’aria pura delle località che visito mi fa diventare più alto/a. Posso gustare cibi diversi da quelli a cui sono abituato/a. Non conosco nessuno, tanto mi bastano i miei amici. Imparo qualche parola in un’altra lingua o dialetto. Altro

Il Touring Club Italiano

Il Touring Club Italiano (TCI) è stato fondato nel 1894 con lo scopo di promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto turistico alla portata di tutti.
La bicicletta oggi è anche un mezzo ecologico e sostenibile perché non inquina: l’unica energia che consuma è quella delle nostre gambe!


il personaggio
Tra i numerosi testimonial di TCI, figura anche Paola Gianotti (1982). Per quale motivo la più importante associazione che si occupa di turismo in Italia ha scelto proprio lei? Perché Paola conta, tra le sue imprese, il giro del mondo in bicicletta, dove ha percorso 30 000 chilometri; la partecipazione come unica rappresentante del genere femminile alla Transiberiana in bicicletta; la “pedalata” da Milano a Oslo a sostegno di Bike the Nobel, una raccolta fondi per acquistare 48 biciclette da regalare ad altrettante donne del Karamoja, in Uganda.


Per Paola Giannotti, pedalare è il più bel modo di viaggiare perché:
• si fa molto esercizio;
• fa bene alla salute;
• non inquina l’aria;

• è silenzioso
• poco costoso;
• lascia tempo per pensare;
• la bicicletta si ripara facilmente;
• permette di conoscere da vicino i Paesi e le loro abitanti.
STUDIA, RIFLETTI, RICERCA
3. Organizzate un questionario sull’uso della bicicletta da sottoporre a tutti gli studenti e a tutte le studentesse della vostra scuola. Ricordate che le domande dovranno essere pertinenti al tema, svilupparsi “a imbuto” con domande prima generali e via via più specifiche, alternare quesiti a risposta chiusa e altri che prevedano una risposta libera. Sottoponete il questionario e, una volta raccolti i dati, elaborateli e organizzate una presentazione che illustri quanto emerso.
Il turismo sostenibile



Come altre attività umane, il turismo trasforma un territorio e ne utilizza le risorse. Ad esempio si costruiscono alberghi e case di vacanza, piste da sci, spiagge attrezzate e porti turistici. In alcuni periodi dell’anno la concentrazione di turisti è altissima e possono esserci problemi nel rifornimento d’acqua e nella gestione dei rifiuti.

Il turismo sostenibile si preoccupa di conservare il patrimonio naturale: utilizza il più possibile edifici e vie di comunicazione già esistenti, riducendo così al minimo il “consumo” di territorio. Presta attenzione al risparmio energetico, all’uso di mezzi di trasporto poco inquinanti e alla protezione di piante e animali.
Vacanze verdi
Ci sono alcune forme di turismo più sostenibili di altre. Ad esempio l’agriturismo, cioè il soggiorno in fattoria, avvicina i turisti alla natura e li coinvolge nelle attività agricole e nello stile di vita della famiglia di contadini. L’ecoturismo è praticato nei parchi e in altre aree protette: si svolgono attività sportive, come le escursioni a piedi lungo i sentieri o in canoa in torrenti e fiumi, oppure il birdwatching, cioè l’osservazione degli uccelli. Questo tipo di turismo si adatta ai ritmi dell’ambiente naturale, senza disturbare la crescita delle piante e la vita della fauna selvatica.
La Bandiera arancione
Dal 1998 Touring Club Italiano seleziona e certifica con la Bandiera arancione i piccoli borghi eccellenti dell’entroterra italiano. Si tratta di uno strumento di valorizzazione del territorio, della sua cultura e della sua storia che promuove uno sviluppo turistico sostenibile. La Bandiera arancione è un marchio di qualità turistico-ambientale, ed è stata pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita. Viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma che sanno o rire al turista un’accoglienza di qualità.

La Rete Web ci può aiutare moltissimo nel programmare i nostri viaggi e le nostre vacanze. Possiamo utilizzare:
• Google Maps per individuare sulla mappa i luoghi da visitare;
• Google Earth per visualizzarli;
• i blog di viaggi per saperne di più basandoci sulle esperienze di chi ha già visitato quegli stessi luoghi;
• siti aggregatori per trovare alberghi, campeggi, b&b, case in a tto ecc.;



• i siti dei musei, dei parchi e di altre attrattive per approfondire la loro conoscenza e avere precise indicazioni.
STUDIA, RIFLETTI, RICERCA
4. Esistono nella Regione in cui vivi Comuni che hanno ottenuto la Bandiera arancione? Cerca informazioni in rete.
a. Quali sono?
b. Tra quelli che hai elencato, scegline uno a tuo piacere e presentalo con un file PowerPoint.
Il codice per i viaggiatori e le viaggiatrici
Oltre a proteggere l’ambiente, i turisti attenti alla sostenibilità si considerano ospiti: rispettano perciò anche la cultura e le tradizioni delle persone che li accolgono. Ecco i punti di un codice etico, cioè di comportamento corretto, per i viaggiatori e le viaggiatrici.

Codice etico per viaggiatori e viaggiatrici
• Viaggia con desiderio di incontrare la gente del luogo.
• Evita comportamenti o ensivi.
• Chiedi il permesso di fotografare le persone.
• Abituati ad ascoltare e a osservare.
• Rispetta i modi di pensare di erenti.
• Scopri la ricchezza di un altro modo di vivere.
• Alla sera rifletti sulle esperienze fatte durante la giornata.
STUDIA, RIFLETTI, RICERCA
5. Consultati con i compagni e le compagne e insieme scrivete alcuni suggerimenti per essere turisti sostenibili che adottano le buone pratiche di casa anche in vacanza.
Primo Lunedì di Ottobre
Giornata Mondiale dell’Habitat

Di solito quando si parla di habitat il nostro pensiero corre agli ambienti naturali in cui vivono gli animali: l’habitat dello scoiattolo è il bosco, l’habitat della trota è il fiume, quello della rana lo stagno ... E qual è il tuo? È la tua casa!
A ciascuno il suo habitat
Il termine “habitat”, che deriva dal latino e significa “egli/ella abita”, indica il luogo con caratteristiche fisiche e ambientali che permettono a una determinata specie di vivere, svilupparsi, riprodursi, avere una buona qualità della vita. L’habitat è formato da tutti gli elementi di cui l’essere vivente, umano o animale, ha bisogno: il cibo, l’acqua, il riparo, lo spazio per allevare i piccoli Parlando, raramente usiamo la parola “habitat” in riferimento alle comunità umane, preferiamo usare “abitazione” oppure “casa” per indicare il luogo in cui ci sentiamo al sicuro, dove troviamo i nostri a etti e abbiamo il nostro posto per riposarci, giocare, apprendere, divertirci e vivere in salute.
Diritto all'habitat
Per ricordare il diritto di ogni persona a un’abitazione sicura, nel 1986 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) ha istituito la Giornata Mondiale dell’Habitat che si celebra il primo lunedì di ottobre. Anche nei Paesi considerati più ricchi ci sono infatti persone che vivono in ripari di fortuna o in strada per motivi diversi: povertà, guerre, disastri naturali come terremoti o inondazioni.
STUDIA, RIFLETTI, RICERCA







1. Qual è il significato della parola “habitat”?





2. Quali sono gli elementi che un essere vivente deve trovare all’interno del proprio habitat?
3. Quali altri elementi aggiungeresti all’habitat in cui vivi?
Musei etnografici
I musei etnografici testimoniano lo stretto legame tra l’uomo e il suo habitat. Essi hanno il compito di raccogliere, conservare e valorizzare le testimonianze antropologiche (cioè dell’uomo) di un determinato territorio.
Il museo etnografico è perciò uno specchio in cui una comunità può riconoscersi scoprendo la propria origine, e dunque la propria identità. In un museo etnografico si troveranno dunque tracce materiali e immateriali che raccontano la vita dell’uomo.
A sinistra: Le modalità costruttive, gli utensili e gli attrezzi da lavoro, i mezzi di trasporto, gli abiti o gli strumenti musicali tipici sono esempi di tracce materiali
A destra: Documentazione relativa a espressioni orali (canti, racconti, arti dello spettacolo), pratiche sociali, riti, danze, feste e tradizioni, sono esempi di tracce immateriali
STUDIA, RIFLETTI, RICERCA
4. Scopri se nella Regione in cui vivi esistono musei etnografici, che tipo di testimonianze conservano, a quale cultura sono legati (contadina? Marinara? Di pianura? ). Organizza poi una presentazione utile a preparare una visita d’istruzione.
Reinhold Messner il personaggio

Reinhold Messner (1944) è noto in tutto il mondo grazie alle sue tante scalate e traversate. Dal 1969, Messner ha compiuto oltre 100 viaggi in deserti e montagne
Il suo intento non è però battere più record possibili, quanto fare esperienza della natura con il minimo equipaggiamento possibile e vivere in ambienti naturali dalle condizioni estreme potendo contare solo sulle proprie forze. Tra le Dolomiti, sua terra natale, Messner ha fondato il Messner Mountain Museum articolato in ben sei sedi museali dedicate all’habitat montagna. In particolare, MMM Ripa (dove, in lingua tibetana “ri” sta per “montagna” e “pa” per “uomo”) di Brunico (Bz), raccoglie testimonianze della vita dei popoli di montagna che hanno saputo sviluppare una cultura basata sulla responsabilità personale, sulla rinuncia al consumo, sul mutuo aiuto.



STUDIA, RIFLETTI, RICERCA


5. “La vita e la storia delle montagne si riassumono nella vita e nella storia degli uomini che le abitano”. Commenta con i tuoi compagni e le tue compagne le parole di Reinhold Messner.

Case del mondo
Utilizzando e adattando i materiali trovati nell’ambiente in cui si è insediato, l’essere umano in molti casi ha già realizzato case sostenibili e resilienti. Sostenibili perché realizzate con materiali naturali e riciclabili e a risparmio energetico, ad esempio sfruttando il calore del sole con i pannelli solari. Resilienti perché resistenti in caso di catastrofi naturali, come i terremoti, ma anche confortevoli e accessibili, ad esempio priva di barriere architettoniche.
TEPEE

Abitazione caratteristica degli Indiani nomadi delle praterie nordamericane, costituita da una tenda di forma conica, alta fino a 6 metri, formata da un’intelaiatura di pali di legno legati tra loro alla sommità e ricoperta di pelli di bisonte, corteccia o stuoie spesso decorate. Il teepee era resistente, impermeabile e facilmente trasportabile.
YURTA
Abitazione circolare, tipica delle popolazioni nomadi della Mongolia, realizzata con bastoni di legno incurvati e incrociati, ricoperti con pelli e feltro (sto a realizzata con peli di pecora, capra, cammello, yak). È una struttura facilmente montabile e smontabile che, grazie alla sua copertura, gode di un’ottimo isolamento termico.

SONRON




Abitazione tondeggiante del Burkina Faso, in Africa, con mura di fango prive di finestre e decorate con disegni geometrici, animali, oggetti della vita quotidiana (serpenti, avvoltoi, tamburi). Realizzati dalle donne del posto con argilla rossa e coloranti naturali, ottenuti dal fango o dalle piante, hanno la funzione di allontanare gli spiriti maligni.

IGLOO
Piccola abitazione tipica degli Inuit, popolazione originaria dell’estremo nord del Canada. Ha forma semisferica, costruita con blocchi di neve pressata. Due persone al suo interno e la presenza di un fuoco permettono di raggiungere e mantenere i 17°C mentre la temperatura esterna resta costantemente tra i -40°C e -50°C. Il fuoco acceso scioglie un sottile strato di neve delle pareti interne che si trasforma in ghiaccio appena il fuoco si spegne, isolando così l’interno dal vento.

OCA
Abitazione tipica del Brasile. “Oca” proviene dalla lingua tupi e indica una casa indigena. Si tratta di una capanna di diverse forme e grandezze, priva di finestre, con il tetto di foglie di palma e struttura in legno o bambù rivestita di paglia intrecciata.


Abitazione tipica dell’Islanda. La torba, su cui cresce l’erba, ricopre i tetti offrendo maggior isolamento termico all’abitazione. Si tratta di un esempio di architettura candidata a patrimonio UNESCO come espressione dei valori culturali della società, in grado di adattarsi ai cambiamenti sociali e tecnologici che hanno avuto luogo attraverso i secoli

L’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030
L’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 intende rendere inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili gli insediamenti umani.
Alcuni traguardi dell’Obiettivo 11:
• garantire case sicure, comode e ben attrezzate per tutti;





• riqualificare, cioè migliorare, i quartieri più poveri;
• ridurre l’impatto ambientale delle città, in particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti;
• implementare i legami economici, sociali e ambientali tra zone urbane, periferiche e rurali;
• aumentare il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche verso l'inclusione, l'e cienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri;
• supportare i Paesi meno sviluppati nella costruzione di edifici sostenibili e resilienti. STUDIA,
RIFLETTI, RICERCA
6. Non solo i grandi progetti architettonici sono pensati per limitare il loro impatto ambientale, ma è possibile trovare soluzioni anche per le abitazioni comuni. Hai mai sentito parlare della “casa passiva”? Cerca informazioni in rete per spiegare il significato di questa espressione e per descrivere le caratteristiche di questo edificio.

