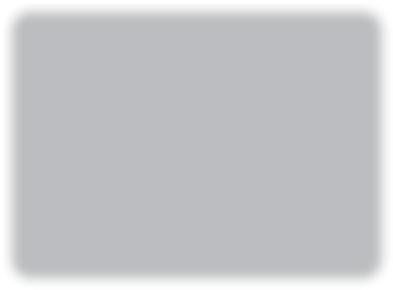Il nostro tempo dalle storie alla Storia

Il Medioevo 1
equilibri
#PROGETTOPARITÀ
Il piacere di apprendere
Guida al metodo di studio: percorso facilitato per ogni lezione
“Raccontare la storia”: la storia vista da vicino
Studiafacile: schede per il ripasso e la preparazione all’esame
Gruppo Editoriale ELi
Pier Giorgio Viberti Giorgio Olmoti

Stampa: Tecnostampa – Pigini Group Printing Division – Loreto – Trevi 22.85.186.0P
Con attività di LETTURA delle CARTE 1 INDICE • L’Europa feudale 2 La diffusione del feudalesimo 2 L’Europa a metà dell’XI secolo 3 • L’Europa dei mercanti 4 Vie e aree commerciali in Europa nel XIII secolo 4 Le rotte commerciali delle repubbliche marinare 5 • L’Europa delle città 6 Le città europee nel Basso Medioevo 6 L’Italia alla fine del XII secolo 7 • La Chiesa dei santi e dei crociati 8 L’itinerario della prima crociata 8 Gli itinerari della seconda e della terza crociata 8 La diffusione degli ordini mendicanti 9 • La crisi del Trecento 10 La diffusione della peste in Europa 10 RIvolte urbane e contadine nel XIV secolo 11 • L’Impero ottomano 12 II primo nucleo dell’Impero ottomano 12 L’impero ottomano nel Trecento 12 L’impero ottomano alla fine del Quattrocento 13 • L’Italia: dai comuni alle signorie 14 L’Italia all’inizio del Trecento 14 L’Italia a metà del Quattrocento 15 • Lo scisma d’Occidente 16 L’Europa cristiana si divide 16 ©Principato
ATLANTE STORICO
L’Europa feudale


Il feudalesimo: dove e quando Unità 6
Il sistema feudale comincia ad affermarsi nel IX secolo nei domini di Carlo Magno. Esso è tuttavia un fenomeno di lunghissimo periodo. Ciò significa due cose:
1. il feudalesimo si diffonde a poco a poco in diverse regioni d’Europa;


2. il sistema feudale dura molto a lungo e può esistere insieme con altre forme di potere (per esempio il potere dei re, degli imperatori, della Chiesa, delle città).


















Agli inizi del IX secolo
Alla prima metà dell’XI secolo
Alla fine dell’XI secolo

Alla prima metà del XIII secolo

2 Atene Roma Genova Pisa Napoli Amalfi Siracusa Alessandria Barcellona Valencia Granada Lisbona Porto Toledo Parigi Aquisgrana Amburgo Lubecca Danzica Stoccolma Riga Copenaghen Brema Amsterdam Londra Dublino Bordeaux Orléans Narbona Marsiglia Lione Ratisbona Belgrado Ragusa Durazzo Ravenna Trento Venezia Costantinopoli Egitto Reno Rodano Danubio Danubio Novgorod Mar Mediterraneo Oceano Atlantico Mare del Nord Mar Nero Mar Baltico CARTA 1 LA DIFFUSIONE DEL FEUDALESIMO
©Principato
L’Europa
alla metà dell’XI secolo Unità 6, unità 8 (lezioni 1, 2, 3)


Questa è una carta politica: mostra gli imperi, i regni e i principati europei alla fine dell’XI secolo. Come hai studiato nell’unità 6, i signori feudali esercitano una serie di poteri nei loro feudi: amministrano la giustizia, riscuotono le tasse, costruiscono i castelli, arruolano i soldati. Però riconoscono l’autorità di un re o di un imperatore, al quale giurano fedeltà. Il potere dei feudatari, quindi, coesiste (= esiste insieme) con quello dei regni e degli imperi.
Confini del Sacro romano impero Spedizioni scandinave
Mondo musulmano alla fine del X secolo
Regni cristiani della Penisola Iberica
LEGGI LE CARTE
Metti a confronto le carte 1 e 2 e indica le risposte o i completamenti esatti.
a. I primi territori in cui si a erma il feudalesimo
sono: Regno di Francia e Regno di Germania. Italia e Francia. Nord Europa.
b. Il feudalesimo si a erma anche nel mondo musulmano? SÌ NO
c. In quale epoca il feudalesimo si di onde nell’Impero bizantino?
Nell’XI secolo. Nel XIII secolo. Mai.
d. In Italia il feudalesimo si a erma: prima in Italia meridionale e nelle isole. prima in Italia settentrionale e centrale.
3 Atlante storico 1
CARTA 2 L’EUROPA A METÀ DELL’XI SECOLO
Mar Nero Mar Mediterraneo Oceano Atlantico Contea di Castiglia Contea di Barcellona Regno di León Regno di Navarra Califfato di Cordoba Regno di Germania Regno d’Italia Ducato di Polonia Borgogna Regno d’Ungheria Impero bulgaro Principato di Kiev Irlanda Boemia Scozia Inghilterra Islanda Croazia Bosnia Normandia Siria Impero bizantino FATIMIDI SLOVACCHI Regno di Francia Regno di Danimarca Roma Palermo Atene Il Cairo Gerusalemme Damasco Antiochia Venezia Costantinopoli Parigi Londra Amburgo Fær-Øer Shetland Kiev Cracovia Novgorod CARMATI PECENEGHI Fleury Cluny CARELI LAPPONI NORVEGESI SVEDESI FINNI Carinzia Sicilia
©Principato
L’Europa dei mercanti


Le vie del commercio Unità 7 (lezioni 4, 6)

Come hai studiato nell’Unità 7, nei secoli del Basso Medioevo l’Europa importa grandi quantità di seta e di spezie dall’Oriente. Ci sono però anche altri prodotti molto ricercati: il legname, indispensabile per costruire case e imbarcazioni; la cera, che serve per fabbricare le candele; le pellicce, utilizzate sia per ripararsi dal freddo sia come ornamento degli abiti dei nobili; l’ambra, con cui si preparano profumi; infine i falchi, che sono addestrati per la caccia.

Principali rotte marittime




Principali vie terrestri
Principali vie fluviali
Città dell’Hansa
Grandi fiere

Città commerciali (sedi di banca)
Principali aree commerciali




Italia del Nord
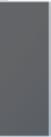

Fiandre

Champagne
Loira

Garonna

CARTA 3 VIE E AREE COMMERCIALI IN EUROPA NEL XIII SECOLO Mare del Nord Mar Baltico
Mar Mediterraneo
Roma
Pisa
Venezia
Bruges
Torun Marienburg
Kiev
Southampton Rodano
Elba Oder Danubio
or o utensili, sale schiavi,legname,
cera,pellicce,miele,
preziose pellicce, avorio, falchi, pesce
oro,tessuti
Oceano Atlantico
Mar Nero Lisbona
Firenze
Genova Milano Francoforte La Rochelle
Parigi Lagny Provins Bar-sur-Aube Troyes Londra
Amburgo Brema Stettino Danzica
Riga
Caffa Costantinopoli Antiochia Acri Alessandria Novgorod Lubecca Ypres Arras Gand
Reno
Tago Dnepr schiavi,
ferro,pellicce
cavalli,oro,schiavi pietspezie,seta, re
legname,ferro,pellicce
utensili,sale oro, ambragrigia schiavi
©Principato
Le repubbliche marinare Unità 7 (lezione 7)
Nei secoli dopo il Mille, alcune città italiane sviluppano enormemente i loro commerci. Sono le Repubbliche marinare: Amalfi, Pisa, Genova e Venezia. La potenza di Amalfi tramonta presto, mentre le altre città marinare italiane moltiplicano e allungano le loro rotte commerciali.
Domini di Venezia
all’inizio del Duecento
Vie commerciali di Venezia
Domini di Genova
all’inizio del Duecento
Vie commerciali di Genova
Domini di Pisa
all’inizio del Duecento
Vie commerciali di Pisa
LEGGI LE CARTE
Leggi i nomi di tutte le merci indicate nella carta 3 ed esegui le attività.
a. Le merci indicate nella cartina compiono lunghissimi viaggi per arrivare sui mercati in cui saranno vendute. Tutte queste merci hanno una caratteristica comune: quale?
Provengono tutte dall’Oriente, cioè dall’Asia.
Sono tutte merci che servono per costruire edi ci o per confezionare vestiti.
Sono tutte merci non deperibili, cioè che non rischiano di andare a male o perdere valore rapidamente.
b. La maggior parte delle merci importate in Europa:

è costituita da prodotti di lusso, destinati ai nobili e ai ricchi.
è costituita da prodotti di uso quotidiano, destinati a tutti.
5 Atlante storico 1 CARTA 4 LE ROTTE COMMERCIALI DELLE REPUBBLICHE MARINARE Mare del Nord Mar Baltico Oceano Atlantico Mar Mediterraneo Mar Nero Tunisi Pisa Amalfi Genova Augusta Ulma Valencia Baleari Corsica Sardegna Barcellona Marsiglia Venezia Bruges Caffa Tana Costantinopoli Amastri Amiso Beirut Sidone Tiro Gerusalemme Antiochia Trebisonda Alessandria Fiandre
Dalmazia
©Principato
Il nostro tempo dalle storie alla Storia
Gruppo Editoriale ELi Il piacere di apprendere 1
Medioevo
Pier Giorgio Viberti Giorgio Olmoti
Il
Il tuo nuovo corso di storia
Il nostro tempo è il tuo nuovo corso di storia in tre volumi:
Il Medioevo, L’età moderna, Dal Novecento ad oggi
Ogni volume è affiancato da un Atlante storico. Completa il corso lo Studiafacile, con sintesi semplificate e attività Verso l’esame di Stato.

Le unità
Il profilo storico è suddiviso in unità. Ogni unità si apre con quattro rubriche di inquadramento:
• Il personaggio: una figura simbolo del periodo trattato;
• Il tempo: gli eventi principali sulla linea del tempo;
• Lo spazio: una carta storica che fissa gli eventi nello spazio;
• La fonte: una voce importante dell’epoca.
Le lezioni
Le unità sono divise in lezioni proposte sempre su doppia pagina a fronte:
• ogni paragrafo è introdotto da una sintesi dei contenuti essenziali;
• ogni lezione si chiude con Studia con metodo, esercizi che ti aiutano a studiare in modo semplice e autonomo.
Il racconto storico
In questo tuo nuovo libro la storia è narrata in modo coinvolgente nella scheda
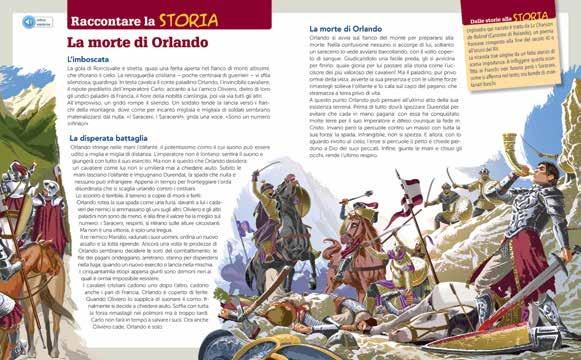
Raccontare la storia, dove viene proposto e illustrato un episodio storico memorabile, alla luce degli sviluppi storici più generali (“Dalle storie alla Storia”).

II
©Principato
Gli approfondimenti e l’educazione civica


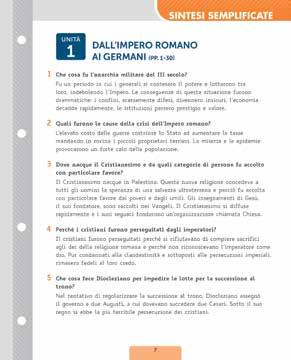
Nel corso dei volumi troverai frequenti spunti di riflessione legati ai temi dell’educazione civica e numerose schede su diversi aspetti della vita, della cultura e della società del passato:


• La donna nella storia
• Storia e arte
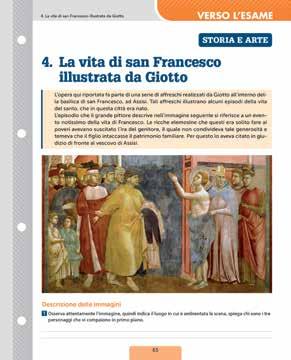
• Vita quotidiana
• Scienza e tecnica
Gli esercizi
Il nostro tempo prevede materiali per lo studio in tre diversi momenti:
• esercizi per verificare se hai capito nelle singole lezioni;
• mappe e sintesi per il ripasso;

• attività per lo sviluppo delle competenze storiche a fine unità.
Lo “Studiafacile”
Il volume contiene:
• sintesi per il ripasso di tutto il corso in forma di domanda-risposta, in carattere ad alta leggibilità;
• temi e attività per la preparazione al colloquio d’esame
III
©Principato
Contenuti digitali integrativi
Nelle pagine sono inserite le seguenti icone, che indicano la presenza e il tipo di contenuti digitali disponibili sul libro.
Video
Videolezioni introduttive ai grandi argomenti
Audio

Lettura espressiva delle rubriche Raccontare la storia
Alta accessibilità


La funzione Alta Accessibilità degli soddisfa pienamente le esigenze della didattica inclusiva. Le funzionalità di base del servizio di ALTA ACCESSIBILITÀ:
• carattere specifico per dislessia

• leggibilità ad alto contrasto
• sintesi vocale dei contenuti testuali, un vero e proprio audiolibro
• pagine “liquide” con possibilità di ingrandimento



Realtà Aumentata

L’applicazione librARsi permette di accedere ai contenuti multimediali direttamente da smartphone e tablet in modo semplice e rapido:
• scarica l’App gratuita
• inquadra la pagina del libro in cui sono presenti le icone dei contenuti digitali



• accedi ai contenuti multimediali

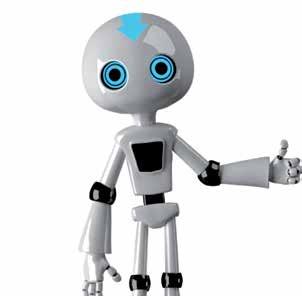
Esercizi
Test di diversa tipologia e correzione immediata anche con Google moduli
Download

PowerPoint modificabili con la sintesi delle unità

È il gioco online per scoprire i 17 obiettivi e i traguardi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Inquadra la pagina e inizia a giocare!
I contenuti digitali sono fruibili sul sito www.principato.it, sull’ e con l’App librARsi
IV
©Principato




























V INDICE Unità 1 DALL’IMPERO ROMANO AI GERMANI 1 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 2 Lezione 1 L’anarchia militare del III secolo 4 Lezione 2 La rivoluzione del Cristianesimo 6 Lezione 3 Gli estremi tentativi di arrestare la crisi 8 Raccontare la storia “Con questo segno vincerai ” 10 Lezione 4 La fine dell’Impero d’Occidente 12 Lezione 5 La fine di un’epoca 14 Lezione 6 I Germani 16 Lezione 7 La società 18 Vita quotidiana Romani e Germani: due diversi tipi di alimentazione 19 Lezione 8 I regni romano-germanici 20 Lezione 9 I regni degli Ostrogoti e dei Franchi 22 Sintesi attiva 24 Mappa concettuale 26 Costruisci le competenze 27 Spunti di riflessione e approfondimento 30 Unità 2 BIZANTINI E LONGOBARDI 31 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 32 Lezione 1 L’Oriente bizantino e Giustiniano 34 Lezione 2 Giustiniano riconquista l’Occidente 36 Lezione 3 Il riordino dei codici e il cesaropapismo 38 Raccontare la storia “ Nika! Nika! ” 40 Lezione 4 L’Italia nuovamente invasa 42 Lezione 5 I Longobardi in Italia 44 Lezione 6 Il Regno longobardo 46 Lezione 7 Decadenza e fine del Regno longobardo 48 Sintesi attiva 50 Mappa concettuale 52 Costruisci le competenze 53 Spunti di riflessione e approfondimento 55 Educazione civica - Calcio giovanile il figlio viene ammonito e il padre picchia l’arbitro e uno spettatore 56 Unità 3 LA NASCITA DELL’ISLÀM 57 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 58 Lezione 1 La Penisola arabica, una terra dai due volti 60 Lezione 2 Maometto, il messaggero di Allah 62 Raccontare la storia La rivelazione di Allah 64 Lezione 3 La sottomissione ad Allah 66 LA donna nella storia La donna musulmana 68 Lezione 4 Il trionfo di Maometto 70 Lezione 5 I califfi elettivi 72 Lezione 6 Alla conquista di un Impero 74 Lezione 7 Il primo mercato “globale” 76 INDICE Lettura espressiva Lettura espressiva Lettura espressiva Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Verifica interattiva Verifica interattiva ©Principato








































VI Lezione 8 Una splendida civiltà 78 scienza E tecnica Storia dello zero 78 STORIA E ARTE La Moschea della roccia 80 Sintesi attiva 82 Mappa concettuale 84 Costruisci le competenze 85 Spunti di riflessione e approfondimento 88 Unità 4 LA CHIESA E CARLO MAGNO 89 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 90 Lezione 1 L’Europa, un continente cristiano 92 Lezione 2 Lontani dal mondo, più vicini a Dio 94 Vita quotidiana La giornata del monaco benedettino 97 STORIA E ARTE Il monastero benedettino 98 Lezione 3 Carlo Magno, re dei Franchi 100 Raccontare la storia La morte di Orlando 102 Lezione 4 L’esercito di Carlo 104 Lezione 5 Un grande Impero nel cuore dell’Europa 106 Lezione 6 Cultura e religione 108 Sintesi attiva 110 Mappa concettuale 112 Costruisci le competenze 113 Spunti di riflessione e approfondimento 116 Unità 5 L’IMPERO DIVISO E I NUOVI INVASORI 117 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 118 Lezione 1 L’Europa dopo Carlo Magno 120 Lezione 2 L’Impero sotto attacco 122 Lezione 3 I Vichinghi, terrore d’Europa 124 STORIA E ARTE L'Arazzo di Bayeux 126 Lezione 4 I Vichinghi: grandi esploratori e colonizzatori 128 scienza E tecnica Il drakkar 129 Raccontare la storia La scoperta di Vinland 130 Lezione 5 Altri temibili incursori: Saraceni e Ungari 132 Sintesi attiva 134 Mappa concettuale 136 Costruisci le competenze 137 Spunti di riflessione e approfondimento 140 Unità 6 IL SISTEMA FEUDALE 141 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 142 Lezione 1 La società dei tre ordini 144 Lezione 2 Il feudalesimo 146 Lezione 3 Un sistema fragile 148 Lezione 4 Il castello, centro del potere feudale 150 STORIA E ARTE Il castello 152 Lezione 5 La cavalleria 154 Vita quotidiana L'istituzione della cavalleria 156 Raccontare la storia La vestizione del cavaliere 158 Lettura espressiva Lettura espressiva Lettura espressiva Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Verifica interattiva Verifica interattiva Verifica interattiva Videolezione
©Principato
Carlo Magno




































VII INDICE Lezione 6 L’economia curtense 160 Lezione 7 Non solo agricoltura: altre risorse per la sopravvivenza 162 LA donna nella storia La donna nel Medioevo 164 Sintesi attiva 166 Mappa concettuale 168 Costruisci le competenze 169 Spunti di riflessione e approfondimento 171 Educazione civica - La libertà è come l’aria 172 Unità 7 IL RISVEGLIO DELL’OCCIDENTE DOPO IL MILLE 173 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 174 Lezione 1 I progressi dell’agricoltura dopo l’anno Mille 176 Lezione 2 L’alba di un nuovo mondo 180 Vita quotidiana Vivere in una città medievale 182 Lezione 3 La rinascita dell’artigianato e la rivoluzione commerciale 184 Lezione 4 Mercanti e mercati 186 Lezione 5 Monete, banche, lettere di cambio 188 Lezione 6 Nuove rotte commerciali 190 scienza E tecnica Le invenzioni che cambiarono il modo di navigare 191 Lezione 7 Le Repubbliche marinare 192 Raccontare la storia La battaglia della Meloria 194 Sintesi attiva 196 Mappa concettuale 198 Costruisci le competenze 199 Spunti di riflessione e approfondimento 202 Unità 8 CHIESA, IMPERO E STATI NAZIONALI 203 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 204 Lezione 1 La monarchia francese 206 Lezione 2 Inghilterra e Germania 208 Lezione 3 L’Europa cristiana 210 STORIA E ARTE L’architettura medievale dal romanico al gotico 212 Vita quotidiana Una religiosità tra paura e speranza 214 Lezione 4 La decadenza morale della Chiesa 216 Lezione 5 Lo scontro Chiesa e Impero 218 Raccontare la storia Enrico IV a Canossa 220 Sintesi attiva 222 Mappa concettuale 224 Costruisci le competenze 225 Spunti di riflessione e approfondimento 228 Unità 9 I COMUNI CONTRO L’IMPERO 229 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 230 Lezione 1 La nascita di una nuova società 232 Lezione 2 L’organizzazione economica del comune 234 Lezione 3 Come funzionava il comune 236 Lezione 4 L’importante ruolo di artigiani e commercianti 238 Lezione 5 I protagonisti della vita culturale: docenti e studenti 240 Videolezione Il risveglio dell'Occidente dopo il Mille Lettura espressiva Lettura espressiva Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Verifica interattiva Verifica interattiva Verifica interattiva ©Principato








































VIII Vita quotidiana I poveri e i malati: prescelti del Signore o parassiti oziosi? 242 Lezione 6 Impero, Papato e comuni: le lotte infinite 244 Lezione 7 Innocenzo III e Federico II, protagonisti del loro tempo 246 Raccontare la storia Leonardo Fibonacci e le cifre indo-arabiche 248 Lezione 8 Si riaccende la lotta fra l’imperatore e i comuni 250 Sintesi attiva 252 Mappa concettuale 254 Costruisci le competenze 255 Spunti di riflessione e approfondimento 258 Unità 10 VIAGGIARE E COMBATTERE PER LA FEDE 259 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 260 Lezione 1 I viaggi dei pellegrini 262 Lezione 2 I Turchi Selgiuchidi in Medio Oriente 266 Lezione 3 Liberare il Santo Sepolcro 268 Lezione 4 Le crociate 270 Raccontare la storia La crociata dei bambini 272 Sintesi attiva 274 Mappa concettuale 275 Costruisci le competenze 276 Spunti di riflessione e approfondimento 279 Educazione civica - Qual è la “vera” religione? 280 Unità 11 LE ERESIE E GLI ORDINI MENDICANTI 281 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 282 Lezione 1 Vivere secondo il Vangelo 284 Lezione 2 La Chiesa contro gli eretici 288 Lezione 3 Gli ordini mendicanti: i francescani 290 Raccontare la storia San Francesco rinuncia ai propri beni 292 Lezione 4 Gli ordini mendicanti: i domenicani 294 LA donna nella storia La monaca nel Medioevo 296 Sintesi attiva 298 Mappa concettuale 300 Costruisci le competenze 301 Spunti di riflessione e approfondimento 304 Unità 12 LA CRISI DEL TRECENTO 305 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 306 Lezione 1 La piaga della carestia 308 Lezione 2 Le rivolte popolari 310 Lezione 3 La morte arriva da Oriente 312 scienza E tecnica La medicina nel Medioevo 314 Lezione 4 La Guerra dei Cent’anni e lo scisma d’Occidente 316 Raccontare la storia La morte di Giovanna d’Arco 320 Lettura espressiva Lettura espressiva Lettura espressiva Lettura espressiva Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Verifica interattiva Verifica interattiva Verifica interattiva ©Principato




















































IX INDICE Sintesi attiva 322 Mappa concettuale 324 Costruisci le competenze 325 Spunti di riflessione e approfondimento 328 Unità 13 IL FAVOLOSO ORIENTE 329 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 330 Lezione 1 Gengis Khan, il più grande conquistatore di sempre 332 Lezione 2 L’Impero mongolo 334 Lezione 3 Venezia, un ponte verso l’Asia 336 Raccontare la storia Marco Polo alla corte del Gran Khan 338 scienza E tecnica La Cina, un Paese di inventori 340 Sintesi attiva 342 Mappa concettuale 343 Costruisci le competenze 344 Spunti di riflessione e approfondimento 346 Unità 14 L’EUROPA ALLA FINE DEL MEDIOEVO 347 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 348 Lezione 1 L’avanzata dei Turchi e la caduta dell’Impero bizantino 350 Raccontare la storia La caduta di Costantinopoli 352 Lezione 2 La Spagna riunificata 354 Lezione 3 Persecuzioni e cacciata degli Ebrei 356 Lezione 4 L’Europa settentrionale 358 Sintesi attiva 360 Mappa concettuale 361 Costruisci le competenze 362 Spunti di riflessione e approfondimento 364 Unità 15 L’ITALIA DEL RINASCIMENTO 365 IL PERSONAGGIO · IL TEMPO · LO SPAZIO · LA FONTE 366 Lezione 1 Dai comuni alle signorie, dalle signorie ai principati 368 Lezione 2 Gli Stati regionali nell’Italia del nord 370 Lezione 3 Gli Stati regionali nell’Italia del centro-sud 372 Lezione 4 L’uomo nuovo al centro del mondo 374 Lezione 5 Umanesimo e Rinascimento 376 LA donna nella storia La donna del Rinascimento 378 Lezione 6 Il genio di Leonardo da Vinci 380 Raccontare la storia La Battaglia di Anghiari 382 Lezione 7 I grandi artisti del Rinascimento italiano 384 STORIA E ARTE Il Rinascimento rinnova la pittura 386 Lezione 8 La stampa, un’invenzione rivoluzionaria 388 scienza E tecnica La stampa con i caratteri mobili 388 Sintesi attiva 390 Mappa concettuale 392 Costruisci le competenze 393 Spunti di riflessione e approfondimento 395 Videolezione Il favoloso oriente Videolezione L'Italia del Rinascimento Lettura espressiva Lettura espressiva Lettura espressiva Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Sintesi inclusiva in PowerPoint Verifica interattiva Verifica interattiva Verifica interattiva Verifica interattiva ©Principato
Lo studio della storia Che cosa è la storia
Conoscere il passato per capire il presente
La storia è la disciplina che ricostruisce il nostro passato restituendoci la memoria degli eventi, dei personaggi, delle idee maturate e delle forme artistiche realizzate. Essa studia inoltre la vita materiale dei nostri antenati vicini e lontani, descrivendoci il loro modo di vivere e vestire, mangiare, spostarsi, lavorare, costruire...

È nella storia che noi ricerchiamo le nostre radici, ossia quegli eventi che hanno contribuito alla formazione culturale, religiosa, politica del nostro popolo ed è sempre la storia a spiegarci perché altri popoli hanno usanze, credenze, forme organizzative diverse dalle nostre.
Lo storico: detective attraverso il tempo
La storia è ricerca, descrizione e interpretazione Lo specialista che vi si dedica è lo storico, il cui lavoro si svolge attraverso due fasi: egli effettua la ricerca dei materiali che possono fornire una testimonianza diretta delle epoche passate e in seguito interpreta quanto raccolto inserendolo in un quadro il più possibile ampio e coerente. La sua ricerca potrà concentrarsi su singoli eventi, personaggi o fenomeni specifici (un’epidemia, un cambiamento climatico ecc.).
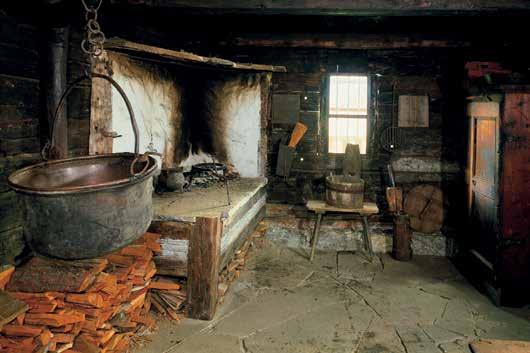
La ricostruzione storica

La storia si basa sullo studio delle fonti, cioè su quei documenti e materiali che permettono di comprendere gli eventi accaduti in epoche precedenti alla nostra. Le fonti per la ricerca storica sono diverse:
• materiali: resti umani, animali e vegetali, oggetti fabbricati dall’uomo;
• orali: racconti tramandati a voce, parole dei testimoni;
• scritte: testi incisi su legno o su pietra, scritti a mano o stampati;
• iconografiche: disegni, dipinti, sculture, fotografie;
• miste: composte di immagini e parole, come nel cinema e nella televisione.
Lezione X 1
Ricostruzione dell’interno di un maso di montagna, Museo provinciale degli usi e dei costumi, Teodone (Bz).
Un’archeologa impegnata in uno scavo.
©Principato
La caduta del muro di Berlino, 1989.
Il calcolo del tempo

Le date di riferimento



Per la ricerca storica è fondamentale collocare eventi, personaggi e fonti. Nel mondo occidentale il tempo è calcolato a partire dall’anno della presunta nascita di Gesù Cristo: gli anni che la precedono sono accompagnati dalla scritta a.C. (avanti Cristo), quelli che la seguono dalla scritta d.C. (dopo Cristo). Se le sigle non sono presenti, la data è successiva alla nascita di Cristo. I musulmani, invece, avviano il computo del tempo dal 622 d.C., anno in cui Maometto si trasferì dalla Mecca alla città di Medina
Gli anni sono espressi con i numeri cardinali (490 a.C., 1492 d.C.).





Gli anni (e i secoli) indicati con la dicitura a.C. seguono un ordine decrescente perché si va verso l’anno 0.
Gli anni (e i secoli) indicati con la dicitura d.C. seguono un ordine crescente perché si va dall’anno 0 in poi.
con i numeri ordinali scritti in cifre romane seguite dalla dicitura a.C. o d.C. (Il I sec. d.C. copre gli anni 1-100, il II sec. gli anni 101-200 ecc.)
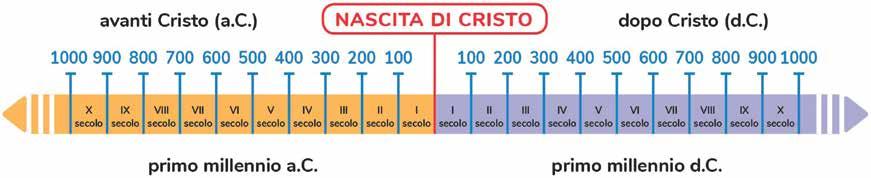

Collocare gli eventi nella storia



Gli storici suddividono il nostro passato in due grandi ere:
con la cifra araba preceduta dall’apostrofo solo per il periodo compreso fra gli anni 1200 d.C. e 2000 d.C. (il '200, il '300)

• la preistoria, che va dalla comparsa dell’uomo fino all’invenzione della scrittura
• la storia, che dall’invenzione della scrittura giunge fino a noi ed è divisa in:
– Età antica dal 3200 a.C. alla caduta dell’Impero romano, nel 476 d.C.
– Età medievale dal 476 alla scoperta dell’America, nel 1492
– Età moderna dal 1492 alla Rivoluzione francese, nel 1789
– Età contemporanea dal 1789 a oggi
Uno strumento utile per sintetizzare i tempi della storia è la linea del tempo, che permette di evidenziare i rapporti temporali tra gli eventi.

Lezione XI 2
I secoli sono espressi 900 a.C. (circa) Civiltà etrusca Guerre puniche 264-146 a.C. Inizio della repubblica 509 a.C. 98-117 d.C. Traiano imperatore 44 a.C. Morte di Giulio Cesare 31 a.C. Augusto imperatore 235 d.C. Inizio
Fondazione di Roma 753 a.C. 0 Indicare date e secoli ©Principato
della anarchia militare
Le vie commerciali nei secoli XII-XIII
Gli strumenti per lo studio
leggere il titolo della carta, dove si indica il fenomeno rappresentato
Novgorod Stoccolma
Mare del Nord
Visby
Stettino Straslund Lubecca Amburgo Bruges Brema
Tallin
Riga
Le carte storiche
Southampton GRANO

Parigi
Londra Danzica Thörn Cracovia
Francofor te Magdeburgo Colonia
Troyes
Provins Bar-sur-Aube
La Rochelle Venezia
Milano Genova Montpellier Barcellona
Firenze Pisa
Roma
Bari Amalfi
Palermo
Bugia Tunisi
Odessa
Ca a
Mar Nero
Principali centri economici italiani
Principali itinerari delle città marinare italiane
Principali città della Hansa
Principali itinerari commerciali anseatici
Fiere della Champagne
Principali centri dell’industria tessile
I cavalieri franchi
Costantinopoli
Focea
Candia Famagosta Antiochia
Mar Mediterraneo
Trebisonda S. Giovanni d’Acri Alessandria
studiare la legenda, cioè le indicazioni che traducono i segni convenzionali riportati sulla carta (colori diversi, frecce, simboli ecc.)
Questa miniatura, eseguita nel monastero di San Gallo (in Svizzera) nell’XI secolo, mostra un gruppo di cavalieri franchi. L’immagine è una fonte preziosa per conoscere l’equipaggiamento dei cavalieri franchi, anche se è successiva all’epoca di Carlo Magno.
L’elmo A in metallo proteggeva la testa, compresa la nuca. Era molto costoso, perciò solo i cavalieri potevano permetterselo.
Lo scudo B era in legno con strisce di metallo. Aveva forma triangolare. Ogni cavaliere era armato di spada C , lunga circa 1 metro.
La lancia D era lunga e pesante. Impugnata dal cavaliere lanciato al galoppo aveva una terribile forza d’urto: era usata infatti per colpire i cavalieri avversari e disarcionarli, cioè gettarli giù da cavallo.

I cavalieri più ricchi indossavano la brunìa E , un pesante giaccone di cuoio ricoperto di lamelle metalliche. I combattenti dotati di brunìa formavano il nucleo più forte della cavalleria di Carlo Magno, la sua arma vincente.
La sta a F permetteva di mantenere l’equilibrio e di manovrare il cavallo più facilmente nella confusione della battaglia.
LA FONTE
La società medievale
Il vescovo Adalberone di Laon (947 circa-1030) riassume la struttura della società medioevale, dandone una giustificazione religiosa e pratica allo stesso tempo.



La Chiesa con tutti i suoi fedeli forma un solo corpo, ma la società è divisa in tre ordini. Infatti la legge degli uomini distingue altre due condizioni: il nobile e il servo non sono sotto una stessa legge. I nobili sono guerrieri, protettori della Chiesa, difendono con le loro armi tutto il popolo, grandi e piccoli, e ugualmente proteggono se stessi. L’altra classe è quella dei servi: questa razza di infelici non possiede nulla senza dolore.
Ricchezze e vesti sono fornite a tutti dal lavoro dei servi e nessun uomo libero potrebbe vivere bene senza i servi. Dunque la città di Dio, che si crede essere una sola, è in effetti triplice: alcuni pregano, altri combattono e altri lavorano. Questi tre ordini vivono insieme e non possono essere separati; il servizio di uno solo permette l’attività degli altri due e ognuno di volta in volta offre il sostegno a tutti. Adalberone di Laon, Poema dedicato al re Roberto
Le carte storiche rappresentano gli eventi che si sono svolti in una determinata area (ad esempio invasioni, migrazioni, battaglie ecc.) e/o le condizioni territoriali, politiche, militari, economiche, demografiche di una determinata zona in un determinato periodo.
Per imparare a comprendere questo tipo di carte è necessario leggere il titolo e la legenda.
Leggere e interpretare le immagini
L’osservazione e l’interpretazione delle fonti visive (dipinti, sculture, affreschi, disegni, fotografie) può fornire dettagli rivelatori di aspetti interessanti della vita nel periodo storico studiato.
Spesso il manuale accompagna le immagini con testi che aiutano a dare un’interpretazione complessiva della scena rappresentata e insegnano a osservare con attenzione tutti i dettagli.
Leggere e interpretare i documenti scritti
Un altro tipo di fonte che incontrerai con frequenza nelle pagine del manuale è costituito dai documenti scritti, ossia lettere, leggi, trattati, iscrizioni, cronache, diari, giornali, ecc. Per facilitare la comprensione, il manuale introduce l’estratto e, al termine della lettura, propone una guida per l’analisi del testo.
LEGGI L’IMMAGINE D E B C F A Lezione XII 3
Le tre classi della società medievale: chierico, cavaliere, contadino; miniatura del tardo XIII secolo.
SETA LINO SPEZIE VETRO ARMI SALE TESSUTI LEGNAME LEGNAME PELLICCE GRANO GRANO GRANO
©Principato
DALL’IMPERO ROMANO AI GERMANI

 I soldati romani sottomettono i Daci. Bassorilievo dall’Arco di Costantino, Roma (II secolo d.C.).
I soldati romani sottomettono i Daci. Bassorilievo dall’Arco di Costantino, Roma (II secolo d.C.).
©Principato
UNITÀ 1
Costantino il grande
Dopo la crisi del III secolo, caratterizzata da interminabili guerre civili, l’imperatore Diocleziano tenta di salvare l’Impero romano con una riforma che, in realtà, si rivela fallimentare. Alla sua morte, infatti, nuovi pretendenti al trono si affrontano dando vita a scontri sanguinosi. Da queste lotte emerge la figura di Costantino, un personaggio di grande personalità, destinato a lasciare un’impronta duratura nella storia. Uomo energico, intelligente, a volte anche crudele (fa uccidere il figlio e la moglie), egli sa sconfiggere gli avversari e ristabilire il potere centrale su tutto l’Impero. La sua opera è determinante in ogni settore. La fine delle guerre civili gli permette di rafforzare la difesa delle frontiere e di frenare le incursioni dei popoli germanici. A oriente, dove sorge l’antica Bisanzio, fonda una nuova città che in suo onore prende il nome di Costantinopoli. Questa città, cinta di mura imprendibili, diventa in breve tempo una metropoli fra le più grandi e prospere del mondo allora conosciuto. Assicurata la pace politica e militare, Costantino vuole garantirsi anche quella religiosa, perciò concede la libertà di culto ai cristiani, ponendo fine alle persecuzioni nei loro confronti. L’unità del mondo cristiano, però, è messa in pericolo dai violenti contrasti sorti circa l’interpretazione della natura di Cristo. L’imperatore, allora, convoca a Nicea, nel 325, un grande concilio, chiamato a pronunciarsi in maniera definitiva su questo tema. Le decisioni prese in quell’occasione pongono le fondamenta della dottrina della Chiesa nei secoli successivi.









IL TEMPO
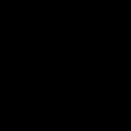

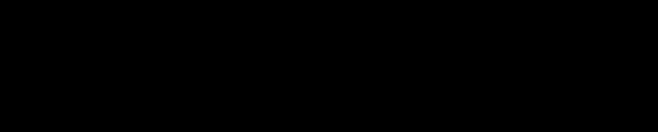




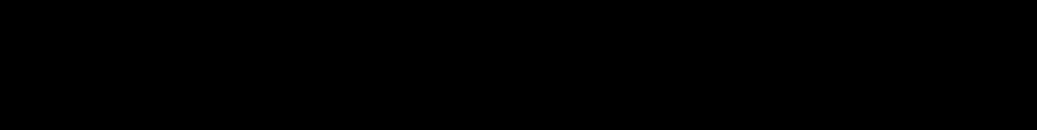










2
Statua in bronzo dell’imperatore Costantino il Grande, eseguita dallo scultore scozzese Philip Jackson (1998).
IL PERSONAGGIO
Anarchia
Regno
Regno di Diocleziano Battaglia di Adrianopoli I Visigoti saccheggiano Roma 235-284 378 410 284-305 306-337 Discesa di Attila in Italia 452 Teodorico re d’Italia 494 Odoacre depone l’ultimo imperatore 476 Battaglia di Teutoburgo 9 ©Principato
militare
di Costantino
LO SPAZIO

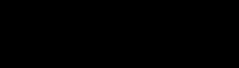


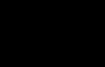

Massima espansione dell’Impero romano (117) Province conquistate da Traiano

LA FONTE
Come vivevano i Germani
Il brano che segue è tratto dal De bello gallico (Sulla guerra contro i Galli) di Giulio Cesare, che non fu soltanto un grande generale e uomo politico, ma anche un eccellente scrittore. Venuto a contatto con i Germani durante la campagna di Gallia, rimase fortemente impressionato da questo popolo ancora primitivo e selvaggio, ma forte, fiero e coraggioso.


Tutta l’esistenza dei Germani è concentrata sulla caccia e sugli impegni dell’attività militare; fin da piccoli si sottopongono alla fatica e alla vita dura. Non si dedicano all’agricoltura, e la maggior parte della loro alimentazione consiste in latte, formaggio, carne. E nessuno ha una quantità stabilita di campagna o terreni propri; ma i magistrati e i capi assegnano per i singoli anni alle famiglie quanto terreno serve loro, e l’anno dopo li costringono a passare altrove. Per spie-
Guerriero gallo fatto prigioniero dai Romani con le mani legate e la corda al collo (II secolo a.C.).
gare questa pratica, usano molti argomenti. In primo luogo vogliono evitare che gli uomini, condizionati da una prolungata attività, finiscano per dedicarsi troppo all’agricoltura a scapito dell’impegno nel fare la guerra. Inoltre vogliono evitare che i membri più potenti caccino dai possedimenti quelli più umili, o che si dedichi troppa cura nella costruzione delle abitazioni per evitare il freddo e il caldo. Temono anche che nasca un eccessivo attaccamento al denaro, cosa da cui nascono fazioni e discordie. I Germani tentano, in questo modo, di far sì che gli animi rimangano sereni, vedendo che tutti i membri della tribù dispongono di mezzi uguali.
possedimenti

Giulio Cesare, De bello gallico.

Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 3
OCEANO ATLANTICO Mar Mediterraneo MAURETANIA TINGITANA BETICA LUSITANIA TARRAGONESE CIRENAICA SIRIA GIUDEA EGIT TO ARABIA PETREA AQUITANIA LUGDUNENSE BRITANNIA BELGICA REZIA NORICO DALMAZIA DACIA TRACIA Ancona Roma Car tagine Alessandria BITINIA GALIZIA CAPPADOCIA CILICIA ARMENIA PONTO ASSIRIA MESOPOTAMIA Mar Caspio Mar Nero ASIA ACAIA EPIRO MACEDONIA LICIA PANNONIA SUPERIORE MESIA SUPERIORE MESIA INFERIORE PANNONIA INFERIORE Corsica Sardegna Regno dei Par ti Sicilia Cipro Creta ITALIA GERMANIA SUPERIORE GERMANIA INFERIORE NARBONENSE MAURETANIA CESARIENSE AFRICA PROCONSOLARE
©Principato
L’Impero romano sotto Traiano nel momento della sua massima espansione
Ritratto di Aureliano; scultura in bronzo dorato (268 -269 d.C).
L’anarchia militare del III secolo
L’Impero all’asta
Nel III secolo d.C. l’Impero romano attraversa un periodo di grave crisi. I generali si contendono il potere e lottano tra loro, indebolendo lo Stato.


Alla morte dell’imperatore Caracalla (217), ucciso dai suoi stessi pretoriani, seguì un periodo di disordini che divennero particolarmente gravi negli anni della cosiddetta anarchia militare (235-284). Durante questa fase gli imperatori venivano spesso eletti dalle loro legioni, oppure la carica imperiale era messa in vendita dai pretoriani. A volte due o anche più imperatori si trovarono a regnare contemporaneamente. Questa situazione diede origine a scontri sanguinosi fra i pretendenti, ma i vincitori non avevano nemmeno il tempo di gioire del loro successo che già erano costretti ad affrontare nuovi avversari. Il senato perse ogni autorità e le leggi non contavano più nulla, poiché ormai solo il denaro e le armi avevano un valore reale. Le conseguenze di questa situazione furono drammatiche:

• i confini, scarsamente difesi, divennero insicuri;
• l’economia decadde rapidamente;

• le istituzioni persero prestigio e valore;
• la popolazione diminuì in misura sensibile La crisi dell’Impero toccò il punto di massima gravità quando si formarono due Stati indipendenti dal potere centrale: a occidente un generale romano impose il suo controllo sulla Gallia, la Gran Bretagna e la Spagna; a oriente sorse un regno che si estendeva sulla Siria e sull’Egitto. Solo grazie all’energia dell’imperatore Aureliano, che regnò dal 270 al 275, fu possibile riportare questi territori sotto il controllo di Roma. Ma, a dimostrazione dell’instabilità politica del tempo, lo stesso Aureliano cadde vittima di un attentato.
Bassorilievo raffigurante Giove e il Sole.
LE PAROLE DELLA STORIA
Pretoriani: soldati che costituivano la guardia del corpo dell’imperatore.
Anarchia: stato di disordine che si ha quando le leggi sono assenti o inosservate.
Latifondisti: proprietari dei latifondi, ossia di tenute agricole di grandissima estensione.
1
Lezione 4 ©Principato
Troppi soldati, troppe tasse, pochi contadini
L’elevato costo delle guerre costringe lo Stato ad aumentare le tasse, mandando in rovina i piccoli proprietari terrieri. La miseria e le epidemie provocano un forte calo della popolazione.
La mancanza di una guida sicura non fu l’unico elemento di crisi. Altrettanto gravi furono le difficoltà che si andarono evidenziando nel sistema economico
L’Impero romano si estendeva dall’Europa all’Africa e all’Asia e governare e difendere un territorio così vasto costava moltissimo denaro. La fine delle conquiste militari privò lo Stato dei bottini di guerra e impedì di avere nuovi schiavi (che, in genere, erano prigionieri di guerra).
Poiché lo Stato aveva bisogno di soldi per pagare i generali, i soldati e tutti gli uomini che amministravano le province, le tasse aumentarono in misura eccessiva. Così molti piccoli proprietari terrieri andarono in rovina. Dovettero vendere il loro campo e andare a lavorare, quasi come schiavi, per i pochi grandi proprietari terrieri latifondisti. Altri, per evitare questa fine, preferirono lasciare le campagne e trasferirsi in città, con la conseguenza che molti campi rimasero incolti e la produzione agricola diminuì.
Poiché i prodotti agricoli erano più difficili da trovare, il loro prezzo aumentò e gran parte della popolazione cadde in miseria. Questo provocò un calo delle nascite, poiché le famiglie non avevano più i mezzi per sfamare i loro figli. La mancanza di cibo e la diffusione di malattie aggravarono ulteriormente la situazione, tanto che il numero delle nascite a un certo punto non riuscì più a compensare il numero dei morti.
Nell’immagine in alto, mosaico romano raffigurante la raccolta delle olive (III secolo d.C.).
In basso, mosaico romano raffigurante i lavori agricoli (aratura e semina) che si svolgono nei campi in autunno (III secolo d.C.).


STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
a. In quali modi venivano eletti gli imperatori durante il periodo dell’anarchia?
b. Quali furono le conseguenze di questo sistema?
c. Che effetto ebbe sui piccoli proprietari l’aumento delle tasse?
Individua i rapporti tra cause ed effetti
2. Completa le affermazioni che seguono, riferite alle cause della decadenza economica dell’Impero.
a. Reggere un territorio vastissimo costava molto denaro. Lo Stato perciò
b. Molti piccoli proprietari terrieri andarono in rovina e dovettero
c. Per evitare di essere ridotti a una condizione simile a quella degli schiavi essi preferirono
d. Di conseguenza la produzione agricola
e. E il costo della vita
Rifletti sul lessico
3. Scrivi il termine corrispondente alle seguenti definizioni.
a. Situazione in cui le leggi non esistono o non sono rispettate:
b. Soldati che costituivano la guardia del corpo dell’imperatore:
c. Proprietari di tenute agricole di grandissima estensione:
d. Persona priva di libertà e diritti:
e. Tributo che il cittadino deve pagare allo Stato in proporzione alla propria ricchezza:
Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 5 ©Principato
Vangeli: i quattro libri che raccontano la vita e la predicazione di Gesù di Nazareth.
La rivoluzione del Cristianesimo
Il Cristianesimo, una religione di salvezza
In Palestina nasce una nuova religione, il Cristianesimo, che predica la speranza e promette la salvezza dopo la morte. Essa è accolta con particolare favore dai poveri e dagli umili.
Mentre l’Impero precipitava in una crisi sempre più grave, per i sudditi romani, sconvolti dalle guerre, stremati dalle tasse, colpiti dalle epidemie, si accendeva una speranza. A portarla era una nuova religione, il Cristianesimo, nata in oriente, e precisamente in Palestina. Essa diffondeva il messaggio di Gesù Cristo, rivolto a tutta l’umanità, non solo ai potenti. Gesù, uomo e figlio di Dio al tempo stesso, non si presentava come una delle superbe divinità dell’Olimpo, ma agiva come un semplice predicatore, sempre a contatto con la gente comune. Ai suoi seguaci non prometteva ricchezze e potere, ma la felicità in un mondo ultraterreno. Questa religione stabiliva l’uguaglianza di ogni essere umano davanti a Dio. Essa, infatti, accoglieva tutti, anche gli schiavi, e quindi restituiva senso e dignità alla vita di ogni uomo, qualunque fosse la sua condizione sociale.




Ad attrarre consensi al Cristianesimo era anche il fatto che esso predicava in primo luogo l’amore e la pace, valori tanto necessari in quella turbolenta fase storica.

La “lieta novella”

Incisione in avorio che rappresenta gli apostoli Pietro e Paolo (V secolo).
Gli insegnamenti di Gesù sono raccolti nei Vangeli. Il Cristianesimo si diffonde rapidamente e i suoi seguaci fondano un’organizzazione chiamata Chiesa.
Prima di morire, Gesù aveva affidato ai suoi discepoli il compito di predicare in tutto il mondo la “lieta novella”, cioè la “lieta notizia” della salvezza che attende i buoni e i giusti. I suoi insegnamenti, riportati nei quattro Vangeli scritti, secondo la tradizione, dagli apostoli Marco, Matteo, Luca e Giovanni, ebbero larga diffusione in tutto l’Impero. Nello svolgere questo compito si distinsero particolarmente l’apostolo Pietro e Paolo di Tarso, divenuto fervente seguace del Cristianesimo dopo esserne stato un persecutore. La comunità cristiana diede vita a un’organizzazione che prese il nome di Chiesa, parola derivata dal greco, che significa “assemblea”. Il primo capo della Chiesa, cioè il primo papa, fu Pietro
LE PAROLE DELLA STORIA 2 Lezione 6 ©Principato
Le persecuzioni contro i cristiani
Il cristiani, condannati alla clandestinità e sottoposti alle persecuzioni imperiali, rimangono fermi nella loro fede.
A indebolire l’impero furono anche le tensioni suscitate dalle divisioni religiose che nacquero in seguito al diffondersi del Cristianesimo. In realtà fra la popolazione coesistevano da sempre numerose credenze religiose: oltre a quella pagana, vari altri culti erano stati importati dall’oriente. Gli imperatori non li avevano mai ostacolati, cosicché ogni suddito era libero di seguire quello che preferiva. Diverso fu l’atteggiamento tenuto verso i cristiani, cui si rimproverava il rifiuto di compiere i sacrifici agli dei della religione romana, obbligatori per legge. La loro concezione monoteistica, inoltre, era guardata con sospetto in un mondo in cui tutte le religioni avevano più divinità. Presto si diffusero dicerie secondo cui i cristiani si macchiavano di orrendi delitti e, a partire dall’imperatore Nerone (64 d.C.), essi furono periodicamente sottoposti a persecuzioni spietate.

Il sacrificio dei martiri
I cristiani sono costretti a praticare i loro culti in condizioni di segretezza e subiscono feroci persecuzioni, ma resistono. I martiri preferiscono morire piuttosto che rinnegare la loro fede.
Nonostante la politica repressiva il Cristianesimo continuò a diffondersi sempre più, anche se i suoi seguaci furono costretti a professare il loro credo in clandestinità, cioè in condizioni di segretezza. Numerosi furono i seguaci di questa religione che rifiutarono di rinnegare la loro fede e affrontarono la morte. Essi furono chiamati martiri, cioè “testimoni”, in quanto con il loro sacrificio avevano testimoniato la verità della fede in cui credevano. Per loro il martirio non rappresentava la morte, ma una rinascita in Cristo. Tra i personaggi più illustri che subirono questa sorte vi furono san Pietro e san Paolo
STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.

a. A chi era rivolto il messaggio di Gesù Cristo?
b. Che cosa prometteva Gesù ai suoi seguaci?
c. Da chi furono scritti i Vangeli?
d. Che cosa rimproveravano ai cristiani gli imperatori romani?
e. Chi erano i martiri?
Verifica la comprensione
Monoteistica: religione caratterizzata dalla fede in un solo Dio.
2. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false
a. Il messaggio di Gesù era rivolto a tutti gli uomini.
b. Gesù prometteva ai suoi seguaci la felicità su questa terra.
c. Nei Vangeli è detto che tutti gli uomini raggiungeranno la salvezza.
d. Il primo capo della Chiesa fu Pietro.
e. Il messaggio cristiano porta speranza in un momento storico di grande instabilità.
f. Le persecuzioni costrinsero tutti i cristiani a fingere di abbandonare la loro religione.
Martirio di cristiani dati in pasto alle belve del circo; avorio del VI secolo.
LE PAROLE DELLA STORIA
V
F
V
F
V F
V F
V F
V F Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 7 ©Principato
Le date della storia
325 d.C.
Gli estremi tentativi di arrestare la crisi
Le riforme di Diocleziano
Nel tentativo di regolarizzare la successione al trono, Diocleziano assegna il governo a due Augusti, a cui dovranno succedere due Cesari. Sotto il suo regno si compie la più terribile persecuzione dei cristiani.
A restituire allo Stato l’antica efficienza provarono due imperatori dotati di grande personalità: Diocleziano (243-313) e Costantino (280-337). Diocleziano attuò una riforma destinata, nelle sue intenzioni, a impedire il ripetersi delle lotte fra i pretendenti al trono. Egli suddivise l’Impero in due parti, governate da altrettanti Augusti, ciascuno dei quali poi avrebbe affidato a un Cesare una parte del suo territorio. Al momento della successione il Cesare sarebbe divenuto Augusto e avrebbe scelto a sua volta un nuovo Cesare. In tal modo si sarebbe impedito l’inserimento di eventuali usurpatori. Lo Stato divenne così una tetrarchia .
La riforma non diede però risultati positivi perché i successori di Diocleziano tentarono di appropriarsi di tutto il potere. Si verificò allora una serie di conflitti che videro fronteggiarsi, a un certo punto, ben sei Augusti!

LE PAROLE DELLA STORIA
Tetrarchia: potere esercitato contemporaneamente da quattro persone.
Ariani: seguaci di Ario (256-336), pensatore cristiano secondo il quale in Gesù era presente la sola natura umana.
Dogma: verità rivelata da Dio o affermata dalla Chiesa, che non può essere posta in discussione.
Eretico: così erano definiti quei cristiani che seguivano una dottrina ritenuta errata dalla Chiesa.
Diocleziano realizzò importanti riforme anche in campo militare ed economico. Il numero dei soldati fu incrementato e le legioni furono stanziate in parte lungo i confini, pronte ad effettuare rapidi interventi, e in parte scaglionate nel cuore delle province interne. Per fermare il continuo aumento dei prezzi dei generi di consumo, emanò un editto che fissava per legge il prezzo di ogni bene. Con Diocleziano si ebbe l’ultima e più sanguinosa persecuzione dei cristiani, che anche questa volta seppero superare la terribile prova.
Massimiano Territori assegnati agli Augusti (286) Diocleziano
Costanzo Cloro Province assegnate ai Cesari (286) Galerio Con ni della diocesi Capitali dell’Impero
OCEANO ATLANTICO Mar Mediterraneo BRITANNIA Londra Lutetia Cordova Cadice Car tagena Tarragona Marsiglia Milano Roma Bisanzio Trapezunte Nicomedia Tessalonica Atene Cirene Car tagine Efeso Antiochia Damasco Alessandria Leptis Magna Gerusalemme Sirmio GALLIA ITALIA REGIONE DI VIENNE SPAGNA MESIA REGIONE DEL PONTO ASIA PANNONIA TRACIA ORIENTE AFRICA Treviri Mar Nero Germani Marcomanni Quadi Ostrogoti Visigoti
Il Concilio di Nicea condanna la dottrina di Ario.
8
©Principato
L’Impero romano al tempo di Diocleziano
Lezione
3
Costantino, l’ultimo grande imperatore
Costantino accentra il potere, sposta la capitale a Costantinopoli e concede libertà di culto ai cristiani.
Le lotte fra i pretendenti al trono imperiale si conclusero con il trionfo di Costantino, che diede vita a un progetto politico opposto a quello di Diocleziano. Egli, infatti, abolì le cariche di Augusto e di Cesare, e accentrò tutto il potere nelle proprie mani. Inoltre spostò la capitale a Bisanzio, un’antica città greca situata sul Bosforo ( cartina a p. 8), situata in una posizione strategicamente favorevole dal punto di vista militare e commerciale. La città, a cui fu dato il nome di Costantinopoli (Città di Costantino), fu rifondata e cinta di mura possenti. Da allora essa divenne uno dei centri urbani più popolosi e fiorenti del mondo antico. Anche in campo religioso la politica di Costantino fu opposta a quella di Diocleziano: mentre quest’ultimo aveva tentato di annientare il Cristianesimo, Costantino decise di concedere libertà di culto ai seguaci di questa religione con un editto nel 313. Egli comprese che il paganesimo non riusciva più a soddisfare le esigenze spirituali degli uomini del suo tempo. I cristiani, invece, potevano costituire la base su cui rifondare un Impero profondamente in crisi.
Il Concilio di Nicea
Il Concilio di Nicea afferma che Gesù ha natura sia divina sia umana.

Purtroppo, i cristiani diedero vita ad accese controversie sui principi fondamentali della loro fede, in particolare sulla figura di Gesù Cristo. Ario, un sacerdote nato ad Alessandria nel 256, sosteneva che Gesù aveva solo la natura umana e non quella divina (che apparteneva unicamente al Padre). Altri, invece, gli riconoscevano sia la natura umana sia quella divina. Per porre fine ai contrasti, Costantino convocò un Concilio a Nicea (325): in quella sede egli volle che fosse presa una posizione definitiva. Gli ariani furono sconfitti: Gesù andava considerato uomo e Dio, e chi non avesse accettato questo dogma sarebbe stato considerato eretico.
STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
Concilio di Nicea (325) indetto e presieduto dall’imperatore Costantino, durante il quale avvenne la condanna per eresia di Ario (XII secolo).
a. In che modo Diocleziano pensò di riformare il meccanismo della successione al trono?
b. In quali modi Diocleziano e Costantino affrontarono il diffondersi del Cristianesimo?
c. In che cosa differivano le posizioni degli ariani rispetto a quelle espresse nel Concilio di Nicea?
Leggi le carte
2. Guarda attentamente la carta riportata a pagina 8, quindi rispondi alle domande.
a. In quante parti fu suddiviso l’Impero?
b. Rispetto a Roma, le città di Treviri, Milano, Sirmio e Nicomedia erano più vicine o più lontane dai confini?
Verifica la comprensione
3. Completa il testo inserendo i nomi opportuni. Nel Concilio di Nicea, convocato dall’imperatore , venne stabilito che è al tempo stesso e dio. Chi non accettava questo veniva considerato .
Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 9 ©Principato
“ Con questo segno vincerai ”





La lotta per il trono
Corre l’anno 312 d.C., e le truppe di Costantino sono in marcia verso Roma. Ad attenderle vi sono altre truppe, quelle di Massenzio, il generale che si è autoproclamato imperatore. Fra i due condottieri è in atto una guerra all’ultimo sangue, ma la posta in gioco è tale da giustificare qualsiasi spietatezza, qualsiasi eccesso: al vincitore toccherà metà dell’Impero, quella occidentale. Poco tempo è trascorso da quando l’imperatore Diocleziano ha lasciato il trono e si è ritirato nel superbo palazzo di Spalato, sulle coste della Dalmazia. Ma già i successori hanno cominciato a combattere ben altre battaglie. I pretendenti sono diventati quattro, poi cinque, tutti in lotta tra loro: come sempre, la successione è stata affidata alle armi.
La croce nel cielo
In questa generale confusione, Costantino, il più energico e abile dei pretendenti, prende l’iniziativa. Disceso dalla Gallia, cavalca alla testa della sua armata ed è a poche ore di cammino da Roma, dove lo aspetta il rivale Massenzio. A un tratto, nella limpida giornata di ottobre, un lampo accecante attraversa il cielo e il sole si accende di una luce più viva. Gli sguardi si volgono in alto e un mormorio corre sulle bocche dei legionari. Una croce luminosa è comparsa sulla volta celeste e sotto di essa è ben visibile una scritta di fuoco: In hoc signo vinces, “Con questo segno vincerai”. Pochi istanti e la visione si dissolve, ma Costantino sa che non si è trattato di un miraggio. Che cosa significa quella croce? E in che modo trasformare il segno in una vittoria? La marcia prosegue finché in lontananza non si scorge il ponte Milvio, sospeso sulle scure acque del Tevere, e al di là, sull’altra riva, i tetti di Roma. Ma è sera e presto scenderanno le tenebre. Tutto è rimandato a domani, domani tutto si deciderà: morte ai vinti, gloria e ricchezza ai vincitori.

Il sogno rivelatore
Costantino non trova pace nel suo letto da campo. Sa di giocarsi la carriera e molto probabilmente la vita nello scontro che lo attende, ma a inquietarlo sono ancora quella scritta e quel segno. Se, come è certo, i suoi occhi e quelli dei suoi uomini non sono stati vittima di un’allucinazione, chi ha mandato il messaggio? Che cosa voleva fargli capire? Nonostante gli sforzi, il sonno non giunge e i pensieri si inseguono sempre più inquieti. Poi, nel doloroso dormiveglia, una voce sconosciuta si materializza nella sua mente: «Costantino, quello che hai visto è il segno della croce, di quella croce che io ho portato per salvare gli uomini. Ordina che sia posta sulle tue insegne e la vittoria non ti sfuggirà». A pronunciare queste parole è la bocca di un uomo ancor giovane, dai dolci lineamenti, con una lunga chioma che gli cade sulle spalle. Un attimo, poi nella tenda ritornano il buio e il silenzio, ma il generale ha riconosciuto la figura di Cristo e ha compreso il messaggio. Domani sugli scudi e sui vessilli del suo esercito campeggerà la croce cristiana e per Massenzio non ci sarà scampo.

Lettura espressiva Raccontare la STORIA
©Principato
Non si sa se l’episodio narrato sia da considerarsi leggendario o realmente accaduto. Di certo l’armata di Costantino recava sugli scudi e sulle insegne un segno simile a una croce, la cui interpretazione, tuttavia, non vede concordi gli studiosi. Alcuni la ritengono effettivamente un simbolo cristiano, altri un emblema del dio solare Mitra, il cui culto era particolarmente diffuso tra gli eserciti. La battaglia comunque si concluse con la piena vittoria di Costantino e con la morte di Massenzio, annegato nelle acque del Tevere.













©Principato
Dalle storie alla STORIA
Staffe: anelli che pendono ai lati della sella, nei quali il cavaliere infila i piedi per salire a cavallo e per rendere più stabile la sua posizione durante la cavalcata.
La fine dell’Impero d’Occidente
La difficile difesa dei confini

Le guerre civili impegnano gran parte dell’esercito romano e indeboliscono la difesa dei confini, minacciati dai Parti e dai Germani.
Ai problemi interni, così gravi e urgenti, si aggiungeva quello della difesa delle frontiere. Fino a quando il potere fu saldamente nelle mani degli imperatori e l’economia rimase solida, l’Impero seppe difendere i propri confini dagli attacchi dei Parti a oriente e dei Germani a occidente. Con questi ultimi, anzi, furono stabiliti rapporti commerciali e spesso i loro guerrieri furono arruolati nelle legioni romane dove erano apprezzati per la forza e il coraggio. La situazione cambiò completamente in seguito alla crisi del III secolo, quando gli eserciti romani, più che nella protezione dai nemici esterni, furono impiegati nelle guerre civili. Venne allora a mancare una guida forte, in grado di coordinare e dirigere le operazioni militari su tutto il territorio dell’Impero. Questo stato di cose ebbe gravi conseguenze: le scorrerie dei Parti a oriente e delle tribù germaniche a occidente si fecero sempre più frequenti e incontenibili. Tale era la gravità del pericolo che l’imperatore Aureliano, fra il 270 e il 273, temendo per la sicurezza della stessa Roma, ordinò la costruzione di un’imponente cinta muraria attorno alla città
Gli Unni, i terribili cavalieri delle steppe
Dalle steppe dell’Asia centrale arrivano in Europa gli Unni, feroci e temibilissimi guerrieri.
Ad accelerare la fine dell’Impero fu una serie di migrazioni che ebbe inizio nelle lontane pianure dell’Europa orientale. L’evento che segnò l’inizio del fenomeno fu la comparsa degli Unni, un popolo nomade fino ad allora sconosciuto, proveniente dalle steppe dell’Asia centrale. Non conoscevano la scrittura, perciò ben poco si sa della loro storia precedente. Abilissimi arcieri e cavalieri (furono loro a portare in Europa le staffe), gli Unni erano guerrieri formidabili Poiché l’allevamento e il saccheggio erano le uniche attività che praticavano, erano sempre alla ricerca di nuovi pascoli per il loro bestiame e di villaggi da depredare. Le loro abitazioni consistevano in tende a forma di cerchio, che venivano sistemate su ruote e potevano essere trainate da buoi. La loro alimentazione era costituita di latte di asina e di carne di cavallo o di pecora.

Lezione 12 4
La Porta Asinaria nelle Mura Aureliane a Roma (270-273 d.C.).
©Principato
LE PAROLE DELLA STORIA
LA FONTE
Gli Unni
Nel passo che segue lo storico Ammiano Marcellino (330 – 400 ca.) descrive i caratteri fisici e le usanze di un popolo da poco entrato nell’orizzonte dell’Impero romano: gli Unni. Provenienti dalle pianure euroasiatiche, essi presentano ai suoi occhi caratteristiche tali da renderli più simili a demoni sprigionati dall’inferno che a esseri umani.

Gli Unni hanno l’abitudine di incidere profondamente con un coltello le gote ai bambini appena nati, affinché la barba, quando spunta al momento debito, sia debole a causa delle rughe delle cicatrici. Perciò anche da adulti sono senza barba, e non possiedono alcuna bellezza. Hanno membra robuste e salde, grosso collo e sono stranamente brutti e curvi, tanto che si potrebbero ritenere animali bipedi o simili a quei tronchi grossolanamente scolpiti che si trovano sui parapetti dei ponti. Per quanto abbiano la figura umana, sebbene deforme, sono così rozzi nel tenore di vita da non aver bisogno né di fuoco né di cibi conditi, ma si nutrono di radici di erbe selvatiche e di carne semicruda di qualsiasi animale, che riscaldano per un po’ di tempo fra le loro cosce e il dorso dei cavalli. Non sono mai protetti da alcun edificio e neppure una casupola con il tetto di paglia si può trovare presso di loro, ma vagano attraverso montagne e selve, abituati sin dalla nascita a sopportare geli, fame e sete. Quando sono lontani dalle loro sedi, non entrano nelle case a meno che non siano costretti da estrema necessità, né ritengono di essere al sicuro trovandosi sotto un tetto. Adoperano vesti di
lino oppure fatte di pelli di topi selvatici, né dispongono di una veste per casa e di un’altra per fuori.
Ma una volta che abbiano fermato al collo una tunica di colore appassito, non la depongono né la mutano finché, logorata dal lungo uso, non sia ridotta a brandelli.
Ignorano profondamente, come animali privi di ragione, il bene ed il male, sono ambigui ed oscuri quando parlano, né mai sono legati dal rispetto per una religione o superstizione, ma hanno un’immensa avidità d’oro. A tal punto sono mutevoli di temperamento e facili all’ira che spesso in un sol giorno, senza alcuna provocazione, più volte tradiscono gli amici e nello stesso modo, senza bisogno che alcuno li calmi, si rappacificano.
STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1 . Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
a. Che cosa fece l’imperatore Aureliano per provvedere alla sicurezza di Roma?
b. Come erano fatte le abitazioni degli Unni?
Verifica la comprensione
2. Indica le risposte corrette alle seguenti domande.
a. Da dove provenivano gli Unni?
Scandinavia
Asia centrale
Asia minore Germania
Leggi e interpreta il documento
b. Quale attrezzo essi portarono in Europa per la prima volta?
la staffa l’arco
la spada ricurva l’aratro
3. Sottolinea una volta i passi del documento in cui l’autore descrive l’aspetto fisico degli Unni e due volte quelli in cui descrive il loro carattere.
Ammiano Marcellino, Storie, XXXI-XXXI.
Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 13
©Principato
Un barbaro brandisce la spada contro un soldato romano; bassorilievo della colonna di Traiano a Roma (113 d.C.).
476 d.C.
Viene deposto l’ultimo imperatore romano e inizia una nuova fase storica: il Medioevo.
La fine di un’epoca
Le frontiere vengono abbattute
I Visigoti distruggono l’esercito romano nella battaglia di Adrianopoli e circa trent’anni dopo saccheggiano Roma.
Da secoli l’Europa centrale e orientale era abitata da popolazioni di stirpe germanica. I rapporti di queste popolazioni con i Romani avevano visto alternarsi scontri militari e momenti di pace, tuttavia esse non costituivano un pericolo mortale per l’Impero. La situazione cambiò rapidamente quando da oriente penetrarono nelle pianure russe gli Unni. Gli Ostrogoti e i Visigoti, le tribù germaniche stanziate in questa area, tentarono invano di opporsi alla loro avanzata: gli Ostrogoti furono sottomessi, i Visigoti spinti verso occidente. Questi spostamenti misero a loro volta in movimento altre tribù. In breve tempo una massa di Germani fece ingresso nei territori dell’Impero, nel tentativo di sfuggire alla minaccia unna. Le legioni si trovarono così ad affrontare un compito difensivo superiore alle loro forze e furono sconfitte. Ad Adrianopoli
(378) l’esercito romano fu letteralmente distrutto dai Visigoti e lo stesso imperatore Valente, che lo guidava, trovò la morte.
Nel 410 si verificò un evento che riempì di stupore e di terrore i contemporanei: i Visigoti, guidati del re Alarico, penetrarono in Italia e saccheggiarono Roma, ormai priva di difesa militare. La corte imperiale, rifugiatasi a Ravenna, assistette impotente alla caduta della gloriosa e millenaria città.

La caduta dell’Impero d’Occidente
Gli Unni invadono l’Italia, ma il loro capo, Attila, si ritira dopo aver incontrato papa Leone I. Nel 476 viene deposto Romolo Augustolo, l’ultimo imperatore romano.
Intanto gli Unni, sotto la guida di Attila, estesero il loro controllo su un territorio immenso, che andava dalla catena dei monti Urali fino al Reno e al Danubio. Agli ordini del re si muoveva un esercito sterminato, nel quale militavano, oltre agli Unni, i guerrieri delle popolazioni germaniche sottomesse. Con questo esercito, Attila si diresse verso occidente, invadendo la Gallia (451) e mettendola a ferro e a fuoco ma, ai Campi Catalaunici, nella Gallia settentrionale, fu respinto dai Romani, guidati dal generale Ezio, e dai Visigoti che in quell’occasione si erano uniti a loro. L’anno seguente Attila discese in Italia, dove le truppe romane rimasero chiuse nelle loro fortezze perché da sole non erano in grado di contrastarlo. Tuttavia, per ragioni che non sono chiare, dopo aver
Thomas Cole, La distruzione dell’Impero romano (1836).
Le date della storia Lezione 14 5 ©Principato
incontrato papa Leone I nei pressi di Mantova, decise di ritirarsi. Morì poco dopo (453) e il suo potere, fragile perché formato da genti di stirpe diversa, si sgretolò rapidamente. Il destino di Roma, però, era segnato: mentre la parte orientale respinse tutti gli attacchi e sopravvisse ancora per un millennio, l’Occidente era perduto per sempre. L’atto che segnò la sua fine fu la deposizione dell’ultimo imperatore, Romolo Augustolo, per opera di Odoacre, capo della tribù germanica degli Eruli (476). Ormai, dall’Italia alla Spagna, dalla Gallia all’Africa settentrionale il potere era passato nelle mani di nuovi padroni: i Germani.
Con il Medioevo comincia una nuova era storica
Con la caduta dell’Impero romano d’Occidente inizia una nuova era storica, il Medioevo, destinata a durare per circa un millennio.
L’anno della deposizione di Romolo Augustolo segna l’inizio di una nuova era chiamata Medioevo. Il termine, che significa letteralmente “età di mezzo”, indica un periodo posto fra la storia antica e quella moderna. La parola fu usata per la prima volta dagli intellettuali italiani del XV secolo. A loro avviso, dopo la grande civiltà classica greco-romana e la nuova civiltà rinascimentale che stava iniziando, vi era stata un’età di decadenza: il Medioevo, appunto Questo periodo ebbe la durata di circa un millennio, in quanto lo si fa terminare con il 1492, data della scoperta dell’America. Per secoli il Medioevo fu ritenuto un’era di barbarie, incapace di sviluppare una civiltà paragonabile a quella antica, ma oggi gli studiosi hanno in gran parte rivisto questo giudizio. Certo, le tribù germaniche che abbatterono l’Impero romano avevano una cultura per molti aspetti primitiva, ma con il loro arrivo l’Occidente iniziò un nuovo percorso storico definendo una civiltà che nulla aveva da invidiare a quella classica.
STUDIA CON METODO
Fissa
i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
a. Che cosa fece Attila dopo aver incontrato papa Leone I?
b. Quale atto segnò la definitiva caduta dell’Impero romano d’Occidente?

c. Chi usò per primo la parola “Medioevo” e con quale significato?
Verifica la comprensione
2. Scrivi i nomi dei personaggi o dei popoli protagonisti degli eventi sotto indicati.
a. Inflissero una disastrosa sconfitta all’esercito romano nella battaglia di Adrianopoli.
b. Era alla guida dei Visigoti che nel 410 saccheggiarono Roma.
c. Incontrò Attila nei pressi di Mantova poco prima che questi si ritirasse dall’Italia.
d. Ultimo imperatore romano, deposto nel 476.
Rifletti sul lessico
3. Scrivi il termine corrispondente ai seguenti periodi di tempo.
• cinque anni
• dieci anni
• cento anni
• mille anni
Moneta in oro con l’effigie di Romolo Augustolo (475-476 d.C.).
Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 15 ©Principato
LE PAROLE DELLA STORIA
Barbari: in greco antico la parola barbaro significava “balbuziente” ed era riferita agli stranieri che parlavano lingue incomprensibili, tali da apparire quasi un balbettio alle orecchie dei Greci.
I Germani

La battaglia di Teutoburgo cambiò il corso della storia?
La sconfitta di Teutoburgo impedisce ai Romani di sottomettere e integrare le popolazioni germaniche.
Nei primi giorni di settembre dell’anno 9 d.C. tre legioni romane agli ordini del generale Quintilio Varo furono distrutte dai Germani, nella selva di Teutoburgo. Il loro compito era quello di sorvegliare la vasta regione che si estende fra i fiumi Reno ed Elba, in gran parte già sottomessa al dominio di Roma. L’attacco, inatteso, pose fine per sempre alla penetrazione romana in Germania. L’imperatore Augusto, infatti, rinunciò a proseguire la conquista di questi territori e spostò i confini dell’Impero lungo il Reno, che da allora avrebbe diviso il mondo romano da quello germanico.
La battaglia di Teutoburgo riveste un’enorme importanza storica poiché ebbe come conseguenza la rinuncia dei Romani al controllo della Germania. Senza quella sconfitta bruciante probabilmente le tribù germaniche si sarebbero sottomesse all’Impero (in parte già lo erano) e si sarebbero integrate nel suo tessuto, come era accaduto ai Galli e a numerose altre popolazioni.
Le popolazioni germaniche erano stanziate da secoli nell’Europa centrale e orientale e comprendevano numerose tribù che avevano in comune la lingua, la religione, la struttura sociale e il modo di vivere.
I Germani erano davvero barbari?
Gli stanziamenti delle popolazioni germaniche
nel IV-V secolo
I Germani sanno realizzare oggetti in metallo, ma non conoscono la scrittura.
Impero romano d’Occidente Impero romano d’Oriente
Chi erano i Germani e come vivevano?
I Romani, dicendo «barbari», si riferivano soprattutto a loro. L’opinione che ne avevano i Romani, cioè che fossero genti primitive, violente e selvagge, è però inesatta. In realtà, per vari aspetti, i Germani erano tutt’altro che arretrati. Sapevano realizzare oggetti pregiati, gioielli, armi e materiali d’uso comune (vasellame, stoviglie) di alta qualità.
Si vestivano con tuniche o con calzoni, e con grossolani mantelli di stoffa o di pelle, appuntati con una fibbia o con una spilla
Amavano molto ornarsi, e presso alcune tribù era in uso il tatuaggio. Non conoscevano però la scrittura e vivevano seguendo le tradizioni, poiché non avevano leggi scritte.
OCEANO ATLANTICO Mar Mediterraneo SPAGNA GALLIA EGIT TO INGHILTERRA Ravenna Roma Costantinopoli Nicea Car tagine ASIA MINORE Mar Caspio Mar Baltico Mar Nero AFRICA Ostrogoti Unni Visigoti Vandali Burgundi Franchi Angli Sassoni
16
©Principato
Lezione
6
Pastori e agricoltori
L’attività più importante dei Germani è la pastorizia, ma praticano anche l’agricoltura. Non conoscono la moneta.
I Germani, in origine, erano nomadi e vivevano essenzialmente di pastorizia, oltre che di bottini di guerra. Sappiamo comunque che quando restavano stabili su un territorio praticavano anche l’agricoltura. Coltivavano il terreno, ricavandone soprattutto cereali e ortaggi; conoscevano l’uso dell’aratro. Allevavano pecore, capre, mucche. Non esisteva presso di loro la proprietà privata. La terra era considerata un bene di tutti e di anno in anno veniva ridistribuita in piccole parti a tutti gli uomini liberi, perché la facessero coltivare dai semiliberi.
I Germani praticavano il baratto, ossia scambiavano oggetti con altri oggetti di pari valore. Solo nel III secolo, dopo essere entrati in contatto con l’Impero romano, nel mondo germanico entrò in uso la moneta, e così pure la scrittura. Grazie ai rapporti con i Romani, impararono il latino, da cui ricavarono una loro scrittura rudimentale, chiamata runica

A questa scrittura i Germani attribuivano un valore magico e la ritenevano fonte di potere. Secondo la leggenda, la sua scoperta sarebbe stata opera di Odino, la massima divinità della loro religione.
Runica: i 24 segni utilizzati da questa scrittura erano chiamati rune. L’alfabeto runico, diff uso nell’antico mondo germanico, cadde in disuso nel Medioevo, sostituito dall’alfabeto latino.
STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.

a. A che cosa è dovuta l’importanza storica della battaglia di Teutoburgo?
b. Come vestivano i Germani?
c. Quali erano, in origine, le loro attività?
Verifica la comprensione
2. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. I Germani non conoscevano l’aratro. V F
b. La terra apparteneva a poche famiglie nobili. V F
c. Prima del III secolo i Germani non utilizzavano la moneta, ma ricorrevano al baratto. V F
d. Dopo essere venuti in contatto con i Romani elaborarono una loro forma di scrittura. V F
Individua i rapporti di causa ed effetto
3. Secondo molti studiosi, la battaglia di Teutoburgo (causa) ebbe conseguenze tali da cambiare il corso della storia europea (effetti). Indica di quali conseguenze si tratta.
a. Permise la creazione di un vastissimo Impero germanico.
b. Causò la distruzione dell’Impero romano.
c. Causò la caduta dell’imperatore Augusto.
d. Impedì a Roma di sottomettere e di integrare nel suo Impero le popolazioni germaniche.
Due artigiani forgiano una spada (1200 circa).
LE PAROLE DELLA STORIA
Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 17 ©Principato
7 La società
Le suddivisioni sociali
La società germanica è divisa in tre classi, ma solo le prime due sono formate da uomini liberi. Le donne sono rispettate.
La società germanica era divisa in tribù e organizzata in grandi famiglie o clan. Il potere spettava a un re o a un consiglio di capi, scelti dall’assemblea dei guerrieri. I Germani si dividevano in tre classi:
• gli arimanni, uomini liberi dalla nascita, formavano la massa di guerrieri;
• gli aldi, uomini semiliberi, svolgevano i lavori manuali più qualificati;
• gli schiavi sopportavano i lavori più pesanti.
L’occupazione principale degli uomini liberi era la guerra: quella germanica era una società guerriera dove i re, i capi e i nobili erano circondati da una schiera di soldati fedelissimi. Le donne erano rispettate e il matrimonio era considerato un vincolo importante. Tuttavia la donna adultera poteva essere punita dal marito, anche con la morte. E se non era uccisa, era scacciata di casa ed esposta al disprezzo di tutto il villaggio
Una religione semplice
La religione dei Germani è legata alle forze della natura.
I Germani non avevano sacerdoti e la loro religione era assai semplice, legata alle manifestazioni della natura. Il re degli dei era Wotan o Odino, generalmente raffigurato con mantello e cappuccio, su un cavallo a otto zampe. Al suo fianco stavano i figli Thor, dio del tuono e delle tempeste, e Baldur, o Balder, dio del Sole. Freya era la dea dell’amore e della fertilità, cioè della capacità riproduttiva, ma anche della guerra. Loki, perfido e ingannatore, dedito al male ma capace, seppur raramente, di compiere buone azioni. La religione germanica aveva un carattere cupo e violento poiché i suoi protagonisti erano spesso impegnati gli uni contro gli altri nell’eterno conflitto fra il bene e il male. Tale conflitto si concludeva con una drammatica battaglia fra gli dei e i giganti, nel corso della quale morivano lo stesso Odino e il figlio Thor. Allora la Terra, privata della luce del Sole e delle stelle, sprofondava negli abissi marini.


STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
a. Qual era la condizione della donna germanica?
b. A che cosa era legata la religione germanica?
Verifica la comprensione
2. Indica quali compiti svolgevano i seguenti gruppi sociali:
• nobili:
• uomini liberi:
• uomini semiliberi:
3. Scrivi il nome delle divinità germaniche che corrispondono alle seguenti definizioni.
• re degli dei:
• dio del Sole:
• dio del tuono e delle tempeste:
• dio dedito al male:
18
Lezione
Statuetta femminile germanica in bronzo (800-400 a.C.).
©Principato
Romani e Germani: due diversi tipi di alimentazione
Le diversità climatiche

L’incontro fra le popolazioni germaniche e quelle mediterranee, inserite da secoli nelle strutture dell’Impero romano, fu anche un incontro di abitudini alimentari diverse. La diversità derivava innanzitutto dalle condizioni climatiche e ambientali in cui questi popoli vivevano: il mite clima mediterraneo, ad esempio, favoriva la coltura della vite e dell’olivo, mentre le rigide temperature continentali non consentivano la produzione di queste piante. Ne derivò un diverso modo di cuocere i cibi: fritti nell’olio quelli romani, saltati nel burro o nel grasso animale quelli germanici. Anche le bevande erano diverse, poiché se lungo le sponde del Mediterraneo si beveva vino, nelle regioni dell’Europa centro-settentrionale, prima del contatto con i Romani, prevalevano il latte di giumenta, una sorta di birra chiamata cervogia e il sidro, una bevanda ricavata dalla fermentazione della frutta.
Prodotti della terra e carne
A segnare un solco profondo fra i due tipi di alimentazione era però il differente peso dato ai prodotti della terra da una parte e alla carne dall’altra. La civiltà greco-romana basava la sua dieta sul grano, sull’orzo, sugli ortaggi e sulla frutta coltivata; i Germani mangiavano prevalentemente carne, anche se non disdegnavano verdure e frutti selvatici. Ciò non significa naturalmente che i Romani non mangiassero carne, ma questo alimento aveva sulle loro tavole un’importanza minore in quanto il vero fulcro della loro alimentazione erano il pane, le polente, le minestre. Non si trattava soltanto di una scelta gastronomica, ma anche di un indicatore di civiltà poiché questi prodotti erano il frutto dell’agricoltura, cioè del lavoro dell’uomo che modifica l’ambiente e piega la natura ai suoi bisogni. Per le popolazioni germaniche, invece, era la carne a detenere una posizione di assoluto rilievo: questo cibo era segno di potenza e di virilità poiché la forza e il coraggio dell’animale si trasmetteva a chi lo mangiava. Per questo le carni preferite erano quelle degli animali che vivevano liberi nei boschi, in particolare del cinghiale, ma era praticato anche l’allevamento del maiale allo stato brado.

Coppa in cui venne ritrovato il famoso tesoro vichingo della valle di York: è un contenitore d’argento con striature d’oro realizzato in Francia o in Germania attorno al X secolo e decorato con tralci, foglie e sei scene di caccia con leoni, cervi e un cavallo.




 Nell’immagine in alto, natura morta con pesci e anatre; particolare di un mosaico del I secolo d.C. proveniente da Pompei.
Nell’immagine in alto, natura morta con pesci e anatre; particolare di un mosaico del I secolo d.C. proveniente da Pompei.
Vita QUOTIDIANA Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 19 ©Principato
I regni romano-germanici
La nascita dei regni romano-germanici
LE PAROLE DELLA STORIA
Limes: così era chiamata la serie di fortificazioni che correvano lungo i confini dell’Impero per difenderlo dagli attacchi esterni.
Vandali: il termine “vandalo”, che originariamente designava ciascun membro di questo popolo, con il tempo venne attribuito a chi per istinto o per ignoranza distrugge e deturpa beni pubblici e privati.
Nell’immagine in alto a destra, spilla in argento dorato (400-450 d.C.).
In basso a sinistra, figura umana su ruota.
In basso a destra, immagine di un dio della mitologia nordica in equilibrio su un cavallo; moneta in oro (400-600 d.C.).






Alcune popolazioni germaniche si stabiliscono all’interno dell’Impero d’Occidente e vi fondano dei regni.
Superato di slancio il limes, la varie tribù germaniche proseguirono la loro marcia all’interno dell’Impero d’Occidente, occupandone tutte le province. Inizialmente si limitarono a saccheggiare le città e i villaggi, ma poi si fermarono nei territori conquistati e vi si stabilirono in maniera definitiva. Qui diedero vita a quei regni che gli storici definiscono romano-germanici o romano-barbarici, in quanto al loro interno convivevano due stirpi diverse: quella germanica e quella latina. Non si trattava ancora di Stati veri e propri, poiché:
• mancavano di funzionari in grado di tenere la contabilità e di riscuotere le tasse;
• non avevano leggi scritte;
• non possedevano strutture capaci di costruire opere pubbliche (strade, ponti, acquedotti ecc.)


Tuttavia alcune loro caratteristiche erano già di tipo statale; essi infatti:
• occupavano un territorio dai confini abbastanza definiti;
• obbedivano a capi in grado di esercitare efficacemente il potere politico e militare.
Una difficile convivenza
La convivenza fra la popolazione romana e quella germanica è resa assai difficile dalle differenze culturali e religiose e dalla diversa posizione sociale.
La popolazione dell’ex Impero romano e i Germani che convivevano all’interno di questi regni rimasero inizialmente separati da sensibili differenze di lingua, di cultura e di religione, e distinta rimase anche la loro posizione economica e sociale. Mentre ai Germani erano riservati la proprietà delle terre e l’uso delle armi, la popolazione latina era impiegata come manodopera servile nel lavoro dei campi Tuttavia forme di integrazione, non sempre coronate da successo, furono cercate in varie parti del territorio. A favorire, seppur lentamente, tale integrazione furono le relazioni già avviate prima delle invasioni, quando i Romani avevano utilizzato i barbari come mercenari oppure avevano stipulato alleanze con loro. Un altro fattore che favorì la convivenza dei due popoli fu la religione. La maggior parte delle popolazioni germaniche, infatti, si era ormai convertita al Cristianesimo
Lezione 20 8 ©Principato
I principali regni romano-germanici
I principali regni romano-germanici sono quelli degli Ostrogoti, dei Visigoti, dei Burgundi, dei Franchi e dei Vandali.
Tra gli invasori, i gruppi più forti e numerosi assorbirono quelli minori e occuparono porzioni di territorio più ampie. Nel panorama che si delineò in seguito alla caduta dell’Impero d’Occidente emersero:

• il regno dei Burgundi tra la Svizzera e la valle del Rodano;
• il regno dei Franchi nella Gallia;
• il regno degli Ostrogoti in Italia;
• il regno dei Visigoti nella Penisola iberica;
• il regno dei Vandali sulle coste dell’Africa settentrionale, in corrispondenza con gli attuali stati di Marocco, Algeria e Tunisia.
I Vandali, per iniziativa del re Genserico, si dotarono di una temibile flotta e spadroneggiarono per qualche tempo sul Mediterraneo occidentale compiendovi frequenti scorrerie. Nel 455 sbarcarono nel Lazio e sottoposero Roma a un terribile saccheggio, guadagnandosi la triste fama che ancora circonda il loro nome.
Altri gruppi di Germani (Sassoni, Svevi, Alemanni, Gepidi) rimasero fuori da quelli che erano stati i confini dell’Impero; i Longobardi vi entrarono più tardi.
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
a. Perché i regni romano-germanici non possono ancora essere definiti Stati nel vero senso del termine?
b. Quale posizione occupavano nella società, rispettivamente, i Germani e la popolazione latina?
c. Quali furono i principali regni romanogermanici?
Verifica la comprensione
2. Sottolinea, fra i nomi delle popolazioni germaniche qui riportati, quelli dei popoli che non diedero vita ai regni romano-germanici.
Gepidi • Burgundi • Marcomanni • Turingi • Visigoti
• Ostrogoti • Eruli • Franchi • Sassoni • Vandali
Rifletti sul lessico
3. Collega ciascun verbo al suo significato.
1. proclamare A. farla da padroni
2. deporre B. depredare e distruggere
3. saccheggiare C. privare di un’autorità, di una carica
4. spadroneggiare D. dichiarare, nominare

Regno Anglo-Sassoni
Regno dei Franchi
Regno dei Burgundi
Regno degli Ostrogoti
Regno dei Vandali
Regno dei Visigoti
Regno dei Suebi
REGNODEGLIOSTROGOTI

Coppia di spille visigote a forma di aquila, oro intarsiato con bronzo e pietre preziose (VI secolo d.C.).


OCEANO ATLANTICO Mar Mediterraneo CELTI GALLES REGNO DEGLI ANGLOSASSONI REGNODEIFRANCHI REGNO DEI SUEBI FRISONI TURINGI SLAVI UNNI (HUNNI, HUNA, HSIUNG-NU) GEPIDI ALEMANNI LONGOBARDI
REGNO DEI BURGUNDI Ravenna Marsiglia Toledo Siviglia Milano Reims Parigi Besançon Roma Costantinopoli Supposto campo trincerato di Attila Nicea Tessalonica Atene Alessandria Car tagine Mar Nero
I R E G N I BRETTONI
REGNODEIVISIGOTI REGNODEIVANDAL
STUDIA CON METODO
Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 21 ©Principato
I regni romano-barbarici
Lezione

9
I regni degli Ostrogoti e dei Franchi
Latini: con questo termine non si intende più il popolo dei Latini stabilitosi in Italia fra il III e il II millennio a.C., cui appartenevano i Romani, ma la popolazione dell’ex Impero romano, la quale nei secoli aveva acquisito lingua, cultura e costumi comuni. Latini sono considerati quindi, in questo senso, i sudditi dei conquistatori germanici.
Teodorico, re degli Ostrogoti, conquista l’Italia e fonda un regno che non dipende più dall’Impero romano d’Oriente.
Tra i regni romano-barbarici si affermò inizialmente quello fondato in Italia da Teodorico, re degli Ostrogoti (= Goti orientali). Egli era un uomo colto ed era stato educato alla corte di Costantinopoli.








Fu lo stesso Zenone, imperatore d’Oriente, a invitarlo in Italia a combattere contro il germanico Odoacre, che si era proclamato governatore del Paese dopo avere deposto l’ultimo imperatore romano. Teodorico usò tutti i mezzi per ottenere il suo scopo: non solo le armi ma anche l’inganno e l’assassinio. Dopo avere convinto Odoacre a fare la pace, lo invitò insieme al figlio a un banchetto di festeggiamento e li uccise entrambi
Il Regno ostrogoto costituì uno Stato indipendente, non più legato all’Impero romano d’Oriente.
Teodorico avvia un processo di integrazione fra Ostrogoti e Romani
Teodorico raccoglie le leggi latine in un editto che porta il suo nome. Gli Ostrogoti, però, sono liberi di seguire le loro consuetudini in fatto di diritto.
Il dominio degli Ostrogoti in Italia portò a un periodo di pace e stabilità
L’agricoltura e il commercio cominciarono a migliorare e la vita tornò alla normalità. Teodorico, incoronato re nel 494, spostò la capitale a Ravenna
Il nuovo sovrano riconobbe la grandezza della civiltà romana e si servì di amministratori latini per rimettere in vigore le antiche leggi, raccolte nel cosiddetto «editto di Teodorico». Egli, tuttavia, comprendendo l’impossibilità di assoggettare conquistatori e conquistati a una stessa legge, stabilì che gli Ostrogoti seguissero le loro consuetudini orali, mentre i Latini furono vincolati al nuovo editto. Inoltre, poiché era convinto che la fusione fra i due popoli non dovesse essere affrettata, vietò i matrimoni misti fra uomini e donne appartenenti alle due stirpi.
©Principato
LE PAROLE DELLA STORIA 22
Teodorico, un re germanico per l’Italia
Scultura ispirata alla leggenda di Teodorico: l’imperatore insegue un cervo che in realtà è il demonio e lo conduce nel cratere dell’Etna (XII secolo).
Il tentativo di integrazione fallisce
L’imperatore d’Oriente perseguita gli ariani e Teodorico reagisce perseguitando i cattolici. Fallisce così il tentativo di integrazione fra Ostrogoti e Latini compiuto da Teodorico.
Teodorico si dimostrò prudente anche in campo religioso. Per questo evitò di interferire nei contrasti che opponevano la popolazione italica, seguace del cattolicesimo, a quella germanica, che aderiva all’arianesimo. Negli ultimi anni, però, la situazione cambiò. Quando l’imperatore d’Oriente scatenò una persecuzione contro gli ariani, Teodorico reagì perseguitando a sua volta i cattolici. Egli temeva inoltre che i funzionari latini della sua corte e papa Giovanni I stessero tramando con l’imperatore d’Oriente per sottrargli il regno, perciò ruppe i rapporti con loro. Il filosofo Boezio, il più influente e prestigioso fra i suoi collaboratori, venne condannato a morte, e lo stesso papa fu imprigionato. In questo modo il processo di integrazione fra Ostrogoti e Romani fu condannato al fallimento.
I Franchi
I Franchi, sotto il regno di Clodoveo, si convertono al cattolicesimo e fondano uno Stato potente che comprende tutta la Gallia. Questo territorio prende da loro il nome di Francia.
Fra tutti i popoli germanici, furono i Franchi a integrarsi con più successo con la popolazione latina. Fondamentale fu la loro conversione al Cristianesimo secondo il credo cattolico (nell’anno 496), perché favorì l’incontro tra i Franchi e le popolazioni locali che vivevano nella Gallia romana. Sotto la guida di Clodoveo, il primo importante sovrano della dinastia merovingia, essi estesero i confini del loro regno sconfiggendo i Visigoti e respingendoli oltre i Pirenei. Anche i Burgundi, stanziati nelle vallate alpine tra la Gallia e l’attuale Svizzera, dovettero sottomettersi al loro dominio. Il regno dei Franchi giunse così a comprendere tutto il territorio di quella regione che da loro prese il nome di Francia, e divenne il più forte e duraturo fra i regni romano-germanici. La città di Parigi divenne la capitale del regno
STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
a. In quale modo Teodorico riuscì ad avere la meglio su Odoacre?
b. Quali conseguenze ebbe sull’Italia il dominio ostrogoto?
c. Per quale motivo l’atteggiamento di Teodorico verso i latini cambiò?
d. Quale elemento favorì l’integrazione dei Franchi con le popolazioni sottomesse?
Verifica la comprensione
Mausoleo di Teodorico a Ravenna, la più celebre costruzione funeraria

Merovingia: dinastia fondata dal semileggendario re Meroveo.
2. Scrivi il nome dei personaggi cui si riferiscono le seguenti descrizioni.
a. Fondatore del regno ostrogoto in Italia:

b. Filosofo condannato a morte da Teodorico per sospetto tradimento:
c. Governatore germanico tradito e assassinato da Teodorico:
d. Mitico fondatore della dinastia merovingia:
e. Fondatore del regno dei Franchi:
Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 23
LE PAROLE DELLA STORIA
ostrogota (520 d.C.).
©Principato
Fissare




le conoscenze e sviluppare le competenze di base



Completa i testi inserendo le parole opportune, che sceglierai fra quelle proposte.
La crisi delll’Impero d’Occidente
tetrarchia • cristiani • Diocleziano • demografico • Cesari • Costantino • natura • crisi • persecuzione • Costantinopoli • Nicea
A partire dal III secolo d.C. l’Impero romano cade in una profonda. Le guerre civili, le tasse eccessive, le carestie e le epidemie determinano un crollo . suddivide l’Impero in quattro parti affidate a due Augusti e a due e realizza un sistema che prende il nome di . Sotto questo imperatore avviene l’ultima e più feroce dei cristiani.

A riprendere tutto il potere nelle proprie mani e a ristabilire l’unità dell’Impero è , che porta la capitale a Bisanzio. Questa città prende poi il nome di . Costantino concede libertà di culto anche ai . Per porre fine alle controversie religiose convoca il Concilio di , in cui viene definitivamente riconosciuta la umana e divina di Gesù Cristo.
I Germani
barbari • arimanni • leggi • tribù • guerra • nomadi • aldi
I Germani sono popoli che abitano le regioni dell’est e del nord dell’Europa. Sono , non hanno scritte e adorano divinità diverse da quelle dei Romani. I Romani li chiamano « » e li considerano inferiori a loro, perché hanno una civiltà diversa. La loro società è costituita dagli uomini liberi ( ), semiliberi ( ) e schiavi. Gli arimanni si dedicato alla e alla caccia, gli altri ai lavori dei campi e all’artigianato. Le principali germaniche sono gli Ostrogoti, i Visigoti, i Franchi e i Vandali.
ATTIVA Sintesi inclusiva in PowerPoint 24
Sintesi
©Principato
La caduta dell’Impero romano
Medioevo • Attila • Romolo Augustolo • Leone I • Odoacre • Roma
Gli Unni, una popolazione asiatica da poco entrata in Europa, spingono verso le frontiere dell’Impero romano le tribù germaniche.
La difesa dei confini dell’Impero si fa sempre più difficile. Nel 410 i Visigoti devastano . Pochi anni più tardi (453) gli Unni guidati dal re arrivano quasi fino a Roma. In seguito a un incontro con papa , Attila decide di lasciare l’Italia. Muore l’anno dopo e il dominio degli Unni si disgrega rapidamente. Ormai la parte occidentale dell’Impero romano è perduta: i Germani la invadono e gli imperatori non sono più in grado di controllarla. Infine, nel 476, un generale germanico di nome toglie il trono all’imperatore (476).
È la fine dell’Impero romano d’Occidente. Da questa data finisce l’età antica e comincia il .
I regni romano-germanici
cattolicesimo • Boezio • Ravenna • Italia • Teodorico • Clodoveo
I popoli germanici danno vita ai cosiddetti regni romano-germanici. I principali sono quelli dei Visigoti, dei Franchi e dei Vandali. In si forma il Regno degli Ostrogoti. Il re fissa la capitale del suo regno a e cerca di far vivere pacificamente insieme Romani e Germani. Il suo tentativo inizialmente ha successo, ma poi i rapporti diventano difficili e il re perseguita alcuni intellettuali latini, fra cui il filosofo , che viene condannato a morte.
Fra tutti i regni romano-germanici, emerge quello dei Franchi, che con il re conquistano la Gallia sconfiggendo i Burgundi e i Visigoti. I Franchi, a differenza degli altri popoli germanici, si convertono al .
Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 25
©Principato
Mappa concettuale
Crisi dell’Impero cause
Economiche
- aumento delle tasse
- piccoli proprietari in rovina
- diminuzione della produzione agricola
Demografiche
- carestie
- epidemie
- crollo demografico
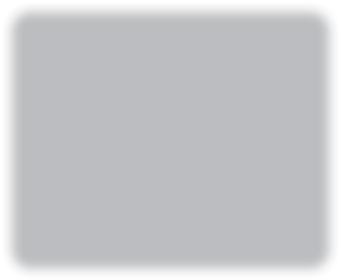




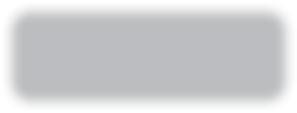




Politico - militari
- guerre civili

- anarchia
- indebolimento militare



Religiose
- divisione tra pagani e cristiani
- contrasto tra cattolici e ariani
conseguenze


invasioni dei Germani incapacità di difendere le frontiere
nascita dei regni romano-germanici

26
©Principato
Particolare di una scena di battaglia del popolo dei Pitti, presso Aberlemno in Scozia; stele in pietra del VIII-IX secolo d.C.
Costruisci le coMPETENZE

Leggi e interpreta le carte
1. Osserva la carta riportata a pagina 8, quindi scrivi i nomi delle città che, sotto Diocleziano, divennero le capitali delle quattro parti in cui fu diviso l’Impero.
2. Osserva la cartina di pagina 21, quindi collega con una freccia ogni popolo germanico alla regione europea in cui si stabilì.
Colloca nel tempo gli eventi della storia
3. Riscrivi in ordine cronologico gli eventi qui riportati in maniera casuale.
Odoacre depone Romolo Augustolo • Battaglia dei Campi Catalaunici • I Visigoti saccheggiano Roma
• Costantino convoca il Concilio di Nicea • Attila incontra papa Leone I • Teodorico fonda il regno ostrogoto in Italia • Battaglia di Adrianopoli
Conosci le parole della storia
4. Scrivi il nome delle divinità germaniche a cui si riferiscono le seguenti definizioni.

a. Il re degli dei:
b. Il dio delle tempeste:
c. Il dio del sole:
d. Dio perfido e ingannatore:
Stabilisci legami di causa ed effetto
5. Collega le cause elencate nella colonna di sinistra agli effetti indicati nella colonna di destra.
1. Continue lotte civili fra i pretendenti al trono

2. Necessità di pagare un esercito numeroso
3. Abbandono delle campagne
4. Diminuzione della produzione agricola
5. Guerre, carestie e epidemie
A. Calo della produzione agricola
B. Crollo demografico

C. Carestia
D. Indebolimento della difesa dei confini
E. Aumento delle tasse
Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 27 Verifica interattiva
1. Spagna
2. Gallia
3. Italia 4. Africa
A. Vandali B. Visigoti C. Ostrogoti D. Franchi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
©Principato
Comprendi aspetti e strutture dei processi storici
6. Per ciascuna delle seguenti affermazioni, indica se è vera (V) o falsa (F).






a. Nel III secolo d.C. una serie di epidemie e carestie fece diminuire la popolazione dell’Impero romano.
b. I fiumi Po e Tevere segnavano i confini dell’Impero romano.
c. L’ultimo imperatore romano, Romolo Augustolo, era di origini germaniche per parte di padre.
d. Nel V secolo gli Unni saccheggiarono Costantinopoli.
e. Come tutti i popoli germanici, nemmeno i Franchi si integrarono con successo con la popolazione latina
f. Genserico era re dei Vandali.
g. I Visigoti possedevano una forte flotta.
7. Completa il testo inserendo le parole opportune, che sceglierai fra quelle proposte. cattolici • Ostrogoti • misti • Latini • Ravenna • ariani • Boezio • papa
Teodorico si sforzò di favorire l’integrazione fra gli e i Latini. Sotto il suo regno l’Italia conobbe un periodo di pace e stabilità. Il nuovo sovrano portò la capitale a e si circondò di consiglieri latini. Emanò il cosiddetto “editto di Teodorico” a cui, però, erano vincolati solo i .
Convinto che il processo di integrazione dovesse procedere gradualmente, vietò i matrimoni
Quando l’imperatore d’Oriente cominciò a perseguitare gli , Teodorico cambiò la propria politica e perseguitò a sua volta i . Temendo che Giovanni I e i funzionari cattolici tramassero contro di lui, ruppe i rapporti con loro e condannò a morte il filosofo .
Leggi
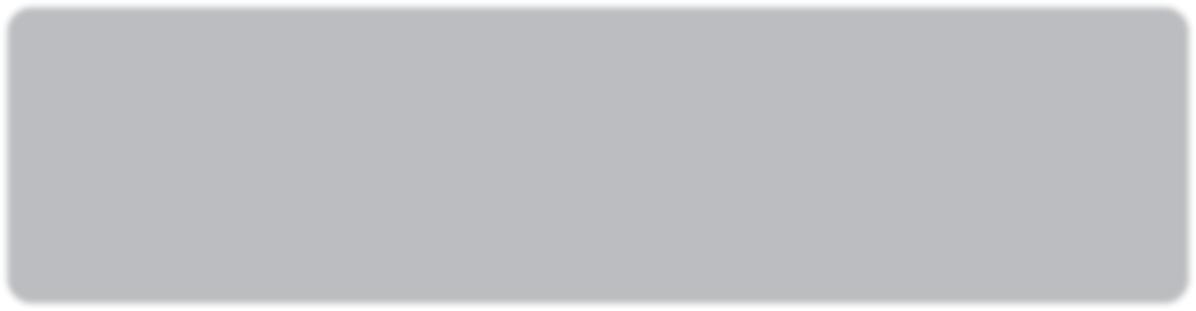

e interpreta il documento
8. Il documento esprime le considerazioni di sant’Agostino, uno dei più importanti pensatori cristiani, a proposito del saccheggio di Roma (410) per opera dei Visigoti. Leggi il testo, quindi rispondi alle domande.
«E tutto ciò che nella recente sconfitta di Roma è stato commesso di rovina, uccisione, saccheggio, incendio e desolazione è avvenuto secondo l’usanza della guerra. Ma si è verificato anche un fatto secondo una nuova usanza. Per un insolito aspetto degli eventi la rozzezza dei barbari è apparsa tanto mite che alcune spaziose basiliche sono state scelte per essere riempite di cittadini da risparmiare. In esse nessuno doveva essere ucciso, da esse nessuno portato fuori, in esse molti erano condotti da nemici pietosi perché conservassero la libertà, da esse nessuno neanche dai crudeli nemici doveva esser condotto fuori per esser fatto prigioniero. E chiunque non vede che il fatto è dovuto al nome di Cristo e alla civiltà cristiana è cieco, chiunque lo vede e non lo riconosce è ingrato e chiunque si oppone a chi lo riconosce è malato di mente.»
Agostino, De Civitate Dei, I,7.
a. In che modo l’autore giustifica la devastazione compiuta a Roma dai Visigoti?
b. In che modo, però, il loro comportamento si è rivelato insolito?
c. Come hanno trattato gli abitanti della città?
d. A chi o a che cosa si deve la salvezza degli abitanti?
28 Verifica interattiva
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
©Principato
Costruisci le coMPETENZE





Conosci e usa le parole della storia
9. Completa i testi aiutandoti con l’illustrazione.








Sistema politico in cui il potere è esercitato da un re.
Sistema politico in cui il potere è esercitato da quattro re.
Religione basata su un solo dio.
Religione basata su più divinità.


Unità 1 Dall’Impero romano ai Germani 29 Verifica interattiva
©Principato
di riflessione e approfondimento SPUNTI
Sintetizza i concetti e i contenuti

1. In base a quanto hai letto nelle pagine precedenti (documenti di p. 3 e 13; scheda di Vita quotidiana, p. 19), poni a confronto le abitudini delle popolazioni germaniche e quelle degli Unni. In particolare ti soffermerai sul loro legame con il territorio (sedentari, nomadi), sulle loro abitazioni, sulle loro attività economiche (agricoltura, pastorizia, caccia), sulla loro alimentazione, sul loro atteggiamento di fronte alla guerra, sulla presenza o assenza di valori morali.
Lavora in classe
2. In classe, ripassate le lezioni 1 e 3 di questa unità. In seguito, dividetevi in tre gruppi. Il primo indicherà le ragioni che provocarono la grave crisi dell’Impero romano nel III secolo; il secondo e il terzo spiegheranno le riforme tentate rispettivamente da Diocleziano e da Costantino per dare una soluzione alla crisi.
Intervista il personaggio storico
3. Nell’anno 452, Attila, il re degli Unni, discese in Italia per vendicarsi della sconfitta subita l’anno precedente a opera delle legioni romane guidate dal generale Ezio. Dopo aver messo a ferro e a fuoco l’Italia settentrionale, incontrò, nei pressi di Mantova, papa Leone I. Subito dopo il breve colloquio, rinunciando a invadere il resto della Penisola, ritornò nella sua terra. Eppure Roma appariva indifesa e le sue ricchezze potevano sicuramente fare gola al capo barbaro. Perché Attila prese quella decisione che nessuno è mai riuscito a spiegare in maniera del tutto convincente?
Realizza, insieme una compagna o a un compagno, un’intervista immaginaria. Uno/a di voi domanderà ad Attila, oltre a qualche notizia sulla sua vita, il motivo di quella decisione. L’altro/a immedesimandosi nel personaggio intervistato, risponderà. Per svolgere meglio l’esercizio, potete cercare sul web notizie relative ad Attila e all’episodio a cui si fa riferimento.
VERSO L’ESAME DI STATO (Tipologia A. Testo narrativo)
4. Immaginando di essere un cittadino romano o una cittadina romana testimone del momento in cui i Visigoti di Alarico conquistarono e saccheggiarono Roma, scrivi un testo in cui racconterai ciò che hai visto. Il lavoro dovrà essere frutto di fantasia, ma per renderlo più credibile sul piano storico potrai seguire con attenzione il documentario di Rai Storia che ricostruisce il saccheggio di Roma (410) per opera di Alarico, collegandoti al sito: http://www.capitolivm.it/impero/il-sacco-di-roma-del-410-d-c.
30
©Principato
EDUCAZIONE CIVICA
Due episodi della vita del patriarca Abramo: ospitalità ai tre angeli e sacrificio di Isacco. Mosaico della Basilica di San Vitale a Ravenna (537-545 d.C.).

UNITÀ 2

BIZANTINI E LONGOBARDI ©Principato
Nell’immagine a sinistra, l’imperatore Giustiniano. A destra, l’imperatrice Teodora.
Giustiniano e Teodora
La coppia imperiale che per alcuni decenni governa l’Impero romano d’Oriente ha in comune la modesta provenienza sociale. Figlio di pastori Giustiniano, figlia di un guardiano degli orsi presso l’ippodromo la moglie Teodora. Giustiniano sale al potere grazie all’appoggio dello zio Giustino, che aveva fatto carriera nell’esercito ed era diventato imperatore. Teodora diventa imperatrice grazie alla bellezza e all’intelligenza che hanno stregato Giustiniano.


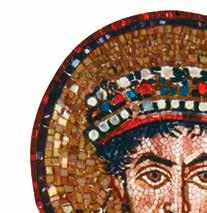
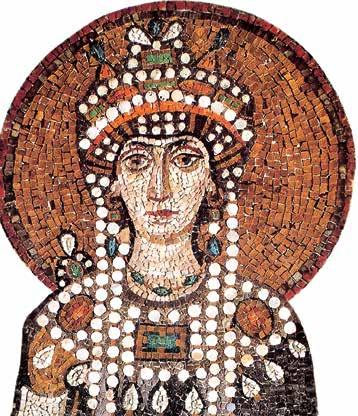
I due, pur diversi per carattere, sono rispettosi l’uno dell’altra, e l’imperatore tiene quasi sempre nella dovuta considerazione i saggi consigli della moglie.


Decisivo è l’atteggiamento di Teodora quando, in seguito allo scoppio di una rivolta popolare a Costantinopoli, sa convincere il marito ad affrontare energicamente la situazione. L’imperatrice non riesce però a dissuadere Giustiniano dal progetto di riconquista dell’Occidente. Quel progetto che, pur riuscito, porta all’Impero più danni che vantaggi.




Spetta poi a Giustiniano il merito di aver affidato ai suoi esperti il compito di realizzare l’opera che gli avrebbe dato il giusto riconoscimento degli storici: il Corpus Iuris Civilis (il Codice del diritto civile). Questa profonda riforma del diritto romano sfiderà i secoli e rimarrà fino al Settecento come il punto di riferimento dei governatori e dei giuristi del mondo occidentale.


32
527 Inizia
572 Morte di Alboino 643 Editto
728 Donazione
603 Agilulfo fa battezzare il glio con rito cattolico 568
Pipino
755-756 535-553
©Principato
Mosaico della chiesa di San Vitale a Ravenna (metà VI secolo d.C.).
il regno di Giustiniano
di Rotari
di Sutri
I Longobardi scendono in Italia
il Breve scon gge Astolfo
Guerra gotico-bizantina I PERSONAGGI IL TEMPO
LO SPAZIO
LA FONTE
Il codice del diritto civile

L’opera più meritoria di Giustiniano, imperatore bizantino, fu certamente la riforma dei codici romani, in vigore ormai da secoli. Il lavoro, di eccezionale impegno e difficoltà, portò alla realizzazione di una raccolta di leggi che restituì efficienza e giustizia al diritto.
In nome del Signore e Dio nostro Gesù Cristo.
L’Imperatore Giustiniano all’Eccellentissimo Senato, al Popolo e a tutte le città dell’Impero.
Secondo la nostra abitudine, invocato l’aiuto divino, affidammo all’illustre Triboniano e ad altri illustri esperti di diritto il difficile incarico di raccogliere e ordinare le leggi e le sentenze della saggia antichità, già quasi confuse e disperse. Ma dal detto Triboniano ci venne riferito che gli antichi avevano scritto quasi duemila volumi e più di tre milioni di righe. Era dunque necessario leggerle ed esami-
L’Impero bizantino al tempo di Giustiniano


narle completamente per poter scegliere tutto ciò che vi era di meglio. […] La divina bontà ci ha concesso di restituire nuova bellezza alle antiche leggi, ormai decisamente invecchiate, e di elaborare un’ordinata raccolta: impresa che nessuno prima di noi osò mai sperare, né pensò che fosse in alcun modo realizzabile dall’ingegno umano. Si trattava, infatti, di armonizzare tutto il diritto romano dalle origini di Roma fino ai giorni nostri, quindi per un periodo di circa 1400 anni.

Unità 2 Bizantini e Longobardi 33 OCEANO ATLANTICO Mar
Ravenna Milano Marsiglia Cordova Roma
Mediterraneo
Benevento Car tagine Tripoli Alessandria
VANDALI ARABI AVARI GEPIDI PANNONIA ITALIA SVEZIA LONGOBARDI BURGUNDI FRANCHI SVEVI VISIGOTI SLAVI ALANI Mar Caspio Mar Nero
Trebisonda Antiochia Gerusalemme Costantinopoli Nicea Tessalonica Adrianopoli
Presentazione del Corpus Iuris Civilis
Giustiniano trionfante preceduto dalla vittoria alata; moneta aurea (VI secolo d.C.).
Estensione territoriale nel 527 Territori conquistati da Giustiniano Spostamenti dei Longobardi
©Principato
LE PAROLE DELLA STORIA
Spezie: sostanze vegetali che si usano per insaporire i cibi (pepe, cannella, noce moscata, chiodi di garofano ecc.).
L’Oriente bizantino e Giustiniano
L’Impero romano d’Oriente sopravvive alle invasioni

L’Impero d’Oriente, grazie alla sua forza militare e alla sua prospera economia, resiste alle invasioni e sopravvive per altri mille anni.

La caduta della parte occidentale dell’Impero romano non trascinò con sé anche la parte orientale. L’Oriente, infatti, era più ricco e più potente sul piano militare ed esercitava un controllo completo sui mari. Inoltre la sua capitale Costantinopoli (l’attuale Istanbul) era resa imprendibile da una cinta muraria imponente, che gli permise di resistere agli attacchi dei nemici esterni. Grazie a questi punti di forza sopravvisse ancora per circa mille anni.
La situazione economica rimase prospera, legata a un’agricoltura fiorente e a un artigianato di alto livello, ma furono soprattutto i commerci ad arricchire lo Stato. Cuore pulsante della rete commerciale era Costantinopoli, che sorgeva in un’invidiabile posizione strategica, all’incrocio fra Mediterraneo e Mar Nero, fra Europa e Asia. Qui si vendevano e si acquistavano merci di ogni tipo: dall’Egitto giungeva il grano, dall’Europa orientale si importavano schiavi, pelli e ambra (una resina fossile usata per fabbricare gioielli), dall’Arabia profumi, dall’India avorio, spezie e pietre preziose, dalla Cina la seta. La città, che arrivò ad avere circa mezzo milione di abitanti, era dotata di un porto ben attrezzato, frequentato da navi e persone provenienti dai luoghi più lontani. Altri centri urbani fiorirono nelle varie parti dell’Impero, come Alessandria in Egitto, Efeso e Antiochia in Asia minore, Cartagine in Africa, Ravenna in Italia.
Lezione 34 1 ©Principato
Veduta dei resti delle mura antiche di Costantinopoli (324 d.C.).
L’Impero romano d’Oriente diventa “bizantino”
L’Impero d’Oriente si distacca sempre più dal modello romano e assume caratteristiche proprie.

Il progressivo distacco da Roma e dall’Occidente finì per modificare la cultura dell’Impero, che assunse un carattere greco e orientale. La lingua greca, che già in precedenza era la più diffusa, sostituì completamente quella latina e il cerimoniale di corte si ispirò alle monarchie asiatiche
L’Impero d’Oriente perse l’attributo di “romano” e assunse quello di “ bizantino”, dal nome dell’antica colonia greca Bisanzio, su cui sorgeva Costantinopoli. D’ora in poi, perciò, non parleremo più di Impero romano d’Oriente, ma di Impero bizantino
Giustiniano e il sogno della riunificazione dell’Impero
Giustiniano, imperatore d’Oriente, rafforza lo Stato e coltiva il progetto di una riunificazione dell’Impero romano. L’impresa riesce parzialmente, ma è destinata a fallire in poco tempo.
Salito al trono nel 527, alla morte dello zio, l’imperatore Giustino, Giustiniano regnò per poco meno di quarant’anni. Durante questo periodo svolse un’intensa attività politica, militare e religiosa, e promosse una fondamentale riforma del diritto romano. Uomo instancabile inseguì e in parte realizzò un progetto ambizioso: la riunificazione dell’Impero romano. A questa impresa dedicò la maggior parte delle energie personali e delle risorse dello Stato.
Il successo, però, fu di breve durata e gli eventi che seguirono la morte dell’imperatore dimostrarono come quel progetto non tenesse conto della realtà storica venutasi a creare in seguito alla nascita dei regni romanogermanici. L’opera di Giustiniano fu comunque fondamentale perché contribuì a rafforzare le basi di quell’Impero bizantino che avrebbe svolto per ancora un millennio un ruolo di protagonista nella storia del mondo mediterraneo.
STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.

a. Com’era la situazione economica dell’Impero d’Oriente?
b. In quale modo il distacco da Roma influì sulla cultura e sulla lingua dell’Impero bizantino?
c. Quale fu il grande progetto coltivato da Giustiniano?
Verifica la comprensione
Cerimoniale: le regole che devono essere seguite durante una cerimonia.
2. Rispondi alle seguenti domande.
a. Perché l’Impero romano d’Oriente sopravvisse alla caduta dell’Impero d’Occidente?
b. Perché l’Impero d’Oriente venne poi chiamato “bizantino”?
Rilievo in avorio con l’imperatore Giustiniano a cavallo (prima metà del VI secolo).
LE PAROLE DELLA STORIA
Unità 2 Bizantini e Longobardi 35 ©Principato
Giustiniano riconquista
l’Occidente

La guerra in Italia
Giustiniano intende ricostruire l’Impero romano. I suoi eserciti riconquistano l’Africa, la Spagna e l’Italia.

Per riconquistare i territori occidentali occupati dai Germani e realizzare il progetto di riunificazione dell’Impero romano, Giustiniano aveva al suo servizio due strumenti: un esercito efficiente e due generali molto abili, Belisario e Narsete. L’offensiva portò alla riconquista dell’Africa settentrionale, dove fu sconfitto il regno dei Vandali, e di una parte della Spagna, sottratta ai Visigoti. Ma l’obiettivo più ambizioso era costituito dall’Italia, che Giustiniano intendeva strappare agli Ostrogoti. Il conflitto, chiamato guerra goticobizantina, durò dal 535 al 553. La Penisola fu devastata e le città saccheggiate. Alla fine il generale Narsete riuscì a piegare la resistenza degli Ostrogoti e ad abbatterne il regno.
Una vittoria pagata a carissimo prezzo
La guerra gotico-bizantina provoca carestie ed epidemie.
Il prezzo pagato fu però altissimo: epidemie e carestie seguirono la marcia degli eserciti, migliaia di persone soffrirono la fame e morirono di stenti. La popolazione si ridusse di numero, le città si svuotarono, i campi rimasero incolti; molte delle grandi strade costruite dai Romani furono abbandonate
In queste drammatiche circostanze, nessun aiuto fu dato alla popolazione dal nuovo governo. Al contrario, l’imperatore, nel tentativo di recuperare il denaro speso per finanziare la guerra, impose agli abitanti dell’Italia tasse pesantissime che peggiorarono ancor più la loro condizione economica.

A Ravenna, Giustiniano ordinò la costruzione della Chiesa di San Vitale, un edificio più grande e fastoso di tutte le chiese di Roma.
 Abside della Basilica di San Vitale a Ravenna, decorata con mosaici (VI secolo d.C.).
Statua dell’imperatore Giustiniano, Skopje (Macedonia).
Abside della Basilica di San Vitale a Ravenna, decorata con mosaici (VI secolo d.C.).
Statua dell’imperatore Giustiniano, Skopje (Macedonia).
Lezione 36 2 ©Principato
La riconquista dell’Occidente fu un errore?

La riconquista dell’Occidente ha altissimi costi militari ed economici e provoca più danni che vantaggi poiché indebolisce la difesa delle frontiere.
La riconquista dell’Occidente sembrò realizzare il grande progetto di Giustiniano, ma si trattava di un’apparenza ingannevole. Le conquiste, infatti, si rivelarono precarie e i costi necessari per realizzarle furono ben più alti dei guadagni che ne derivarono.
Lo sforzo finanziario e militare sostenuto per combattere Vandali, Visigoti e soprattutto Ostrogoti ebbe conseguenze catastrofiche poiché indebolì l’esercito e impoverì le casse dello Stato. Di questo approfittarono i Persiani, che compirono incursioni nelle province orientali, rimaste pressoché indifese. Per ottenere che si ritirassero, l’Impero fu costretto a comprare la pace versando molto denaro. La stessa Italia, ridotta a un deserto quasi spopolato, fu presto invasa da un’altra tribù germanica, quella dei Longobardi
Un sogno irrealizzabile
Il progetto di Giustiniano non può essere realizzato perché non tiene conto dei mutamenti verificatisi in Occidente in seguito alle invasioni germaniche.
Il tentativo dell’imperatore era irrealizzabile poiché i tempi erano completamente cambiati rispetto al passato. Nuove popolazioni si erano insediate in Italia, in Gallia, in Spagna portando con sé le proprie usanze e nulla avrebbe potuto ricreare la situazione precedente. Un Occidente imbarbarito e impoverito, quasi privo di città, di scuole, di leggi e di comunicazioni era ormai un mondo diverso, che ben poco aveva a che fare con la splendida storia passata.
STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
città,








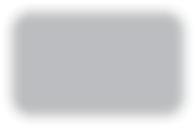
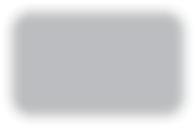




1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
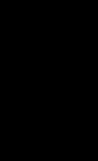
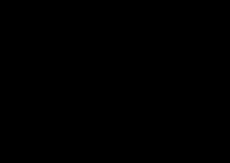
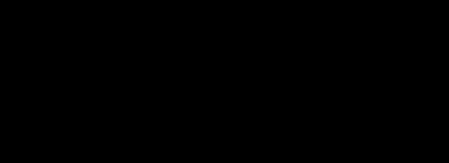
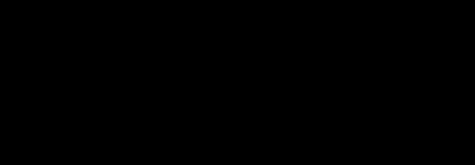
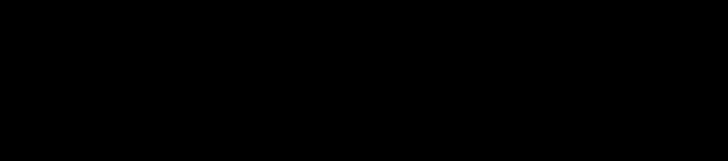
a. Quali territori furono riconquistati dagli eserciti di Giustiniano?





b. In quali condizioni fu ridotta la popolazione dell’Italia a causa della guerra gotico-bizantina?
Individua i rapporti tra cause ed effetti
2. Scrivi quali sono gli effetti delle guerre condotte da Giustiniano.
Le guerre condotte da Giustiniano per riconquistare l’Occidente effetti sulla popolazione dell’Italia sulla stabilità delle province orientali
Aquila in lotta con un serpente; mosaico del VI secolo d.C. proveniente dal Gran Palazzo di Istanbul.
Unità 2 Bizantini e Longobardi 37 ©Principato
Lezione
3
Mosaico dell’imperatore Giustiniano che tiene in mano il modello della Basilica di Santa Sofia di Costantinopoli (X secolo).





Il riordino dei codici e il cesaropapismo
Il Codice di diritto civile


Giustiniano raccoglie e riordina le leggi antiche e realizza un nuovo codice che sarà studiato e utilizzato per secoli.
L’opera più importante e duratura di Giustiniano fu il Corpus Iuris Civilis (Il Codice di diritto civile), una profonda riforma dei codici che l’imperatore affidò a un gruppo di esperti coordinati da Triboniano, un celebre studioso di diritto.
Tra le varie leggi emanate nel corso dei secoli, molte si ripetevano o si contraddicevano, rendendo assai difficile stabilire il torto e la ragione di chi doveva essere giudicato
Da tale confusione di solito traevano vantaggio i ricchi, che erano in grado di assumere gli avvocati più abili a ricercare le norme favorevoli alla loro causa.
Il nuovo codice raccoglieva e sistemava con ordine tutte le leggi scritte dai Romani nel corso della loro lunga storia, eliminando quelle ormai inutili, ripetute o contraddittorie. Esso ebbe due effetti positivi: da un lato rese più facile il lavoro dei giudici, ai quali fornì un orientamento sicuro, dall’altro permise la conservazione di un patrimonio giuridico che rischiava di andare perduto.
Il Corpus Iuris Civilis fu studiato e utilizzato per tutto il Medioevo e anche in seguito. Perse progressivamente di importanza nel XIX secolo, con l’affermarsi dei nuovi codici elaborati sulla scia del codice di Napoleone del 1804.
Giustiniano signore della Chiesa e dell’Impero
Giustiniano dà vita al cesaropapismo, un sistema che concentra nelle mani dell’imperatore sia il potere politico sia quello religioso.
La religione fu decisiva nel determinare il successo dell’opera di Giustiniano. Egli riunì nella sua persona il potere politico e quello religioso, con un sistema detto cesaropapismo
Ciò significa che guidava non solo lo stato e l’esercito, ma anche l’organizzazione della Chiesa e il culto.
Cesaropapismo: sistema in cui il potere politico e quello religioso sono concentrati nelle mani di una stessa persona. Il termine è composto dalle parole cesare e papa.
Egli si riteneva l’erede degli apostoli di Gesù e, come tale, attribuiva a se stesso il compito di guidare la Chiesa. Era perciò il capo religioso dei suoi sudditi, esattamente come lo erano stati gli antichi imperatori romani.
Al suo fianco operava il patriarca di Costantinopoli, che era il più importante tra i vescovi di tutto l’Impero bizantino.
In virtù dei poteri che le erano riconosciuti, la figura dell’imperatore era considerata sacra e i sudditi davanti a lui dovevano prosternarsi, cioè piegarsi in un inchino profondo, fino a sfiorare il suolo con la fronte
38
LE PAROLE DELLA STORIA ©Principato
Costantinopoli, la «Nuova Roma»
Al tempo di Giustiniano, Costantinopoli diventa una città splendida, tanto da poter essere paragonata alla Roma imperiale.
Durante il regno di Giustiniano, Costantinopoli divenne un’autentica meraviglia. La sua estensione, le mura possenti, le costruzioni religiose e civili non avevano paragone con il resto del mondo. Era allo stesso tempo la residenza dell’imperatore e la capitale dell’Impero d’Oriente. Come Roma, era circondata da sette colli e questo aspetto le dava un rilievo speciale. Il capolavoro architettonico dell’età di Giustiniano fu la Chiesa di Santa Sofia, meta di pellegrini che giungevano da tutta l’area del Mediterraneo. Custodiva un tesoro incomparabile: arredi e vesti indossate dai sacerdoti durante le cerimonie religiose; croci e icone (immagini di santi dipinte su tavolette in legno); reliquie (ciò che resta del corpo di un santo dopo la sua morte).
Una metropoli internazionale
Costantinopoli diventa una metropoli internazionale, frequentata da gente di ogni provenienza, ma una parte della popolazione vive in povertà.
Costantinopoli era una metropoli internazionale. Greci, Latini, Germani, Siriani, Africani formavano un mondo colorato e vivace di cui facevano parte funzionari pubblici, militari, mercanti, marinai, avventurieri, artisti di strada, prostitute e altri personaggi ancora.
La città, però, aveva i suoi lati negativi Molti poveri mendicanti si accalcavano nelle sue strade, vestiti di cenci. La popolazione di oltre mezzo milione di abitanti viveva in quartieri sovraffollati. Nel 539 Giustiniano cercò di risolvere questi problemi con una legge: «Chi è nato a Costantinopoli ed è sano di corpo ma senza mezzi di sostentamento sia impiegato in lavori pubblici. Se si rifiuta, sia espulso dalla città. Gli invalidi e i vecchi siano lasciati in pace e mantenuti dagli abitanti di buona volontà. Tutti gli altri ritornino ai luoghi di provenienza».
STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
a. Perché Giustiniano sentì il bisogno di operare una riforma dei codici?
b. Quali poteri deteneva Giustiniano?
c. Quale atto dovevano compiere i sudditi davanti all’imperatore?
d. Quale era il capolavoro architettonico di Costantinopoli al tempo di Giustiniano?
e. Quali aspetti negativi presentava la città?
Verifica la comprensione
2. Completa il testo inserendo le parole opportune. religioso • inchino • Corpus Iuris Civilis • cesaropapismo • leggi • Triboniano Giustiniano affidò al giurista il compito di riordinare gli antichi codici romani, eliminando le che si ripetevano o si contraddicevano. L’opera che fu realizzata prese il nome di , ossia Codice del diritto civile. Giustiniano riunì nella sua persona il potere politico e quello , con un sistema detto
. Davanti a lui i sudditi dovevano prosternarsi in un profondo .
Unità 2 Bizantini e Longobardi 39 ©Principato
“Nika! Nika!”



Le gare ippiche a Bisanzio fra tifo, religione e politica


Corre l’anno 532. Costantinopoli è in fiamme. Una folla inferocita si è riversata sulle strade distruggendo e bruciando case, monumenti, perfino le chiese. Nulla e nessuno è al sicuro. Nemmeno l’imperatore Giustiniano, che se ne sta rinchiuso nel palazzo reale protetto da poche centinaia di soldati.
Ma che cosa è accaduto per provocare uno sconquasso simile? Può sembrare assurdo, ma tutto è partito dalle corse delle quadrighe, cioè da quello che è lo spettacolo di gran lunga più amato in questa città. L’Ippodromo, contenente 100 mila posti, è quasi sempre gremito e i campioni sono seguiti da tifosi appassionati e rumoreggianti, pronti a esaltarsi per le vittorie, a disperarsi per le sconfitte, a indignarsi per i presunti torti subiti. Gli aurighi sono divisi in più squadre, ma a contendersi la vittoria sono sempre le solite due: i Verdi e gli Azzurri.

quasi sempre gremito e i campioni sono seguiti da tifosi appassionati e rumoreggianti, sempre le solite due: i Verdi e gli Azzurri.


Per questo Giustiniano ha tentato di reprimere con la forza le manifestazioni più estreme dei due gruppi, ma non ha previsto che cosa sarebbe successo. La reazione è stata immediata e violenta: Verdi e Azzurri si sono coalizzati e sono insorti al grido di: «Nika! Nika!» («Vinci! Vinci»). In poche ore Costantinopoli è in fiamme. Anzi le fiamme si estendono allo stesso palazzo imperiale e alla Basilica di Santa Sofia, il gioiello della città. Viene addirittura nominato un antiimperatore di nome Ipazio.
estendono la vergognosa?






























Giustiniano è incerto se restare o fuggire
Giustiniano, impaurito, non sa che fare. La fuga gli farebbe perdere il trono, ma gli salverebbe la vita. I suoi consiglieri, riunitisi per esaminare la situazione, spingono per indurlo a lasciare la città. Il suo sguardo, incerto, si rivolge allora all’imperatrice Teodora. Essa giunge davanti all’imperatore, quindi parla con voce calma e senza incertezze: «Se anche non rimanesse altra via di salvezza che la fuga, non vorrei fuggire. Non siamo forse tutti destinati a morire fin dalla nostra nascita? Coloro che hanno portato una corona non devono sopravvivere alla sua perdita. Io prego Dio che non mi si veda neppure un solo giorno senza la mia veste imperiale. Tu, imperatore, se vuoi fuggire, hai tesori; per te la nave è pronta e il mare è libero; ma non temi che l’amore per la vita ti esponga a un esilio miserabile e a una morte vergognosa? Quanto a me, io resto!». Giustiniano, scosso dal rimprovero della moglie, rimane al suo posto. I consiglieri tacciono. La decisione è presa.
decisione








STORIA
re
©Principato
Lettura espressiva
La rivolta è domata

I disordini proseguono per tre giorni. Le poche guardie imperiali riescono a malapena a difendere il palazzo, ma certo non possono reprimere la rivolta. Ed ecco che, proprio quando Giustiniano si sta pentendo di aver dato ascolto alla moglie, arriva la salvezza. Il generale Belisario, di ritorno dal fronte orientale con il suo esercito, ha le forze sufficienti per schiacciare i ribelli. E lo fa nel modo più crudele: sbarra le porte dell’ippodromo dove essi si sono riuniti e scatena una carneficina colossale. L’ordine ritorna a Costantinopoli, ma al prezzo di 30 mila vittime.

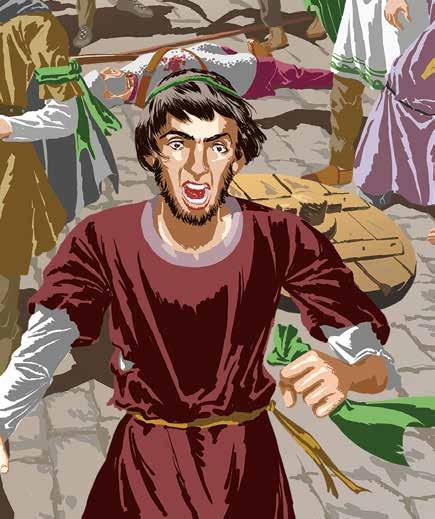

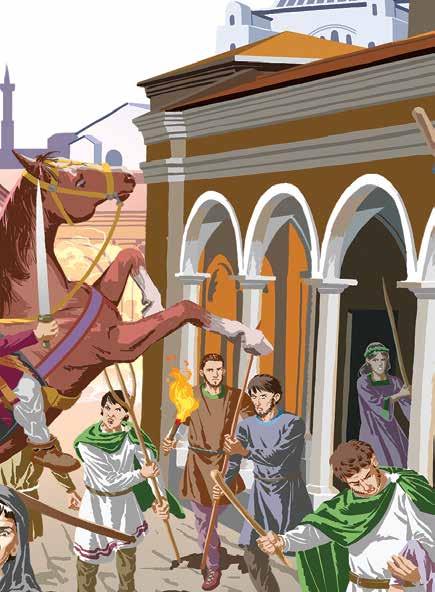
L’evento qui descritto segnò una tappa importantissima nelle vite dei protagonisti. Giustiniano non solo salvò la vita e l’onore, ma riuscì a mantenere il trono. Teodora dimostrò a tutti di aver meritato il titolo di imperatrice non solo per il suo fascino ma anche per l’intelligenza e il coraggio di cui disponeva. Il generale Belisario si guadagnò con la sua energica azione il diritto a comandare le spedizioni che presto sarebbero state inviate contro i Vandali e gli Ostrogoti.




STORIA
Dalle storie alla
©Principato
Duchi: la parola duca (dal latino dux = comandante) indicava il capo che guidava un gruppo di famiglie imparentate tra loro e che aveva ai suoi ordini i guerrieri che ne facevano parte. Ducato era detto il territorio amministrato dal duca.
L’Italia nuovamente invasa

I Longobardi scendono in Italia
Un nuovo popolo germanico, i Longobardi, scende in Italia guidato dal re Alboino e ne conquista gran parte. Pavia viene scelta come capitale del Regno.
La guerra goticobizantina era da poco terminata, quando un altro popolo germanico, quello dei Longobardi, invase l’Italia. I nuovi arrivati provenivano da terre lontane, addirittura dalla Svezia. Essi si erano spostati lentamente nel cuore dell’Europa centrale, stabilendosi per qualche tempo in Pannonia, territorio corrispondente all’incirca all’attuale Ungheria. Qui si scontrarono con altre popolazioni germaniche, soprattutto con i Gepidi, che sconfissero duramente, uccidendone il re Cunimondo. Infine, spinti dal loro istinto nomade e dalla pressione degli Avari, tribù centrale, si mossero verso l’Italia

Una facile conquista
I Longobardi invadono l’Italia senza incontrare una forte resistenza. La parte settentrionale della Penisola viene presto conquistata; tra le maggiori città, solo Ravenna rimane in possesso dei Bizantini.
Sotto la guida del re Alboino, i Longobardi discesero nel Friuli e penetrarono nella Pianura Padana (568). Non erano molto numerosi, forse 150 mila in tutto. L’Italia, dopo la guerra goticobizantina, si trovava però in una situazione di grande debolezza.
L’esercito imperiale evitò di affrontarli in campo aperto, ma si limitò a difendere alcuni centri urbani e fortezze. Una dopo l’altra, però, le maggiori città del nord Italia – Aquileia, Brescia, Vicenza, Verona – caddero nelle mani dei conquistatori. Resistette solo Ravenna, centro amministrativo e militare dei possedimenti bizantini, potentemente difesa da un buon numero di armati e dalle paludi che la circondavano. Dopo un lungo assedio cadde anche Pavia, che Alboino volle fare capitale del Regno d’Italia, del quale si proclamò sovrano.
Guerrieri longobardi (985-987 d.C.).
4
Lezione 42 4 ©Principato
LE PAROLE DELLA STORIA
L’Italia divisa fra Bizantini e Longobardi
I possedimenti bizantini sono ridotti alle aree costiere, alle isole e ad alcune zone dell’Italia centrale; la parte restante cade sotto il controllo longobardo.
Dopo la morte di Alboino, furono eletti altri sovrani, ma il loro potere fu limitato dalle ambizioni contrapposte dei duchi. Alcuni di questi, infatti, aspiravano direttamente alla successione, mentre altri appoggiavano i pretendenti con cui erano alleati.
Nel decennio 574584 si ebbe una serie ininterrotta di guerre civili e di congiure che resero praticamente ingovernabile il Paese. Solo più tardi la monarchia assunse un carattere ereditario e poté consolidarsi. Questi eventi non arrestarono l’avanzata dei Longobardi, che tuttavia non riuscirono a impadronirsi di tutta la Penisola. Poiché essi non disponevano di una flotta, i Bizantini, mantennero il possesso delle zone costiere e delle isole, che potevano essere rifornite dal mare. Inoltre rimase sotto il controllo di Bisanzio una fascia di territorio posto fra Ravenna e Roma, comprendente la Romagna, l’Umbria e il Lazio Alcuni gruppi di Longobardi raggiunsero l’Italia meridionale, dove fondarono i ducati di Spoleto e di Benevento, rimasti pressoché indipendenti dal potere centrale del sovrano.
L’amministrazione delle città più importanti era affidata a un governatore locale, il duca, dal quale dipendevano i gastaldi, vicegovernatori con sede nei centri minori.
STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
a. Da dove provenivano i Longobardi?
b. Quali territori rimasero ai Bizantini?
Verifica la comprensione
2. Rispondi alle seguenti domande.
a. Perché i Bizantini riuscirono a mantenere il possesso delle zone costiere?
b. Quali ducati longobardi sorsero nell’Italia meridionale?
.
Cagliari Palermo Salerno Napoli Benevento Roma Sutri Narni Spoleto Ancona DUCATO DI SPOLETO DUCATO DI BENEVENTO Perugia Firenze Lucca Ravenna Bologna Parma Genova Asti Pavia Ivrea Milano Brescia Verona Trento Treviso Cividale Aquileia Taranto Brindisi Reggio Siracusa Mar Tirreno Mar Ionio Mar Adriatico Corsica Sardegna Sicilia
Territori longobardi Territori bizantini
Unità 2 Bizantini e Longobardi 43 ©Principato
I territori longobardi e bizantini del VI secolo
Lezione

I Longobardi in Italia
Un popolo primitivo e violento
I Longobardi, che avevano avuto ben pochi rapporti con la civiltà romana, si dimostrano più selvaggi e violenti degli altri popoli germanici.
LE PAROLE DELLA STORIA
La dominazione longobarda si rivelò ben più dura di quella imposta in Italia dagli Ostrogoti. I nuovi conquistatori, infatti, si dedicarono in un primo momento soprattutto alle razzie e al saccheggio, e in seguito trattarono la popolazione sottomessa come una massa di schiavi. La ferocia di questo atteggiamento si spiega con il fatto che i Longobardi avevano avuto in precedenza ben pochi rapporti con il mondo romano. Vissuti a lungo lontani dalla civiltà, avevano mantenuto i loro costumi rozzi e primitivi
Alcuni guerrieri di questa tribù, assoldati come mercenari dai Bizantini durante le guerre contro gli Ostrogoti, si dimostrarono talmente feroci che furono ben presto congedati. Lo storico bizantino Procopio riferisce che essi «appiccavano il fuoco a qualsiasi tipo di edificio e assalivano le donne rifugiatesi nei santuari».
La società longobarda
La società longobarda è organizzata per la guerra. In essa gli unici uomini liberi sono gli arimanni, guerrieri e cacciatori.
Il nome “Longobardi” ha due spiegazioni probabili: può derivare da Langbart, «lunga barba», o da Langbarte, «lunga lancia». Entrambe le spiegazioni potrebbero essere vere, perché dalle fonti risulta che i Longobardi portavano delle lunghe barbe e combattevano imbracciando lunghe lance.


La loro società era organizzata in funzione della guerra, che combattevano con crudeltà estrema. Il gruppo più importante era composto dagli arimanni, uomini liberi addestrati alle armi. Gli arimanni formavano gruppi di famiglie, chiamati fare o sippe. Le fare si riunivano per eleggere il re, che era il loro condottiero in battaglia. Nella gerarchia sociale venivano poi gli aldi, uomini semiliberi addetti ai lavori dei campi, all’allevamento e all’artigianato, e gli schiavi
Nessun diritto per la donna
La donna longobarda vive in uno stato di completa sottomissione all’uomo. Prima è il padre a esercitare su di lei il mundio, ossia un’autorità assoluta; poi, con il matrimonio, tale diritto passa allo sposo.
Totalmente sottomessa era la posizione della donna, cui venivano negati il possesso di beni e qualsiasi altro diritto. Il padre esercitava su di lei il mundio (dal tedesco Mund = protezione), ossia un potere assoluto. Tale potere gli conferiva il diritto di amministrare i beni della figlia e perfino di venderla o addirittura di ucciderla. Quando la donna lasciava la famiglia paterna per unirsi allo
 longobardo di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli (metà del VIII secolo).
Mercenari: soldati che combattono per denaro.
longobardo di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli (metà del VIII secolo).
Mercenari: soldati che combattono per denaro.
44
©Principato
5
sposo, quest’ultimo pagava al padre di lei una somma prestabilita e otteneva il diritto di sostituirglisi nell’esercizio del mundio. Di fatto, il matrimonio significava, per la sposa, il passaggio da un padrone all’altro. In cambio di questa totale sottomissione il detentore del mundio, padre o marito che fosse, aveva soltanto il dovere di garantire alla donna una sussistenza decorosa. Nel caso in cui la sottoponesse a maltrattamenti ingiustificati, perdeva il possesso del mundio, che però passava a un altro uomo. In nessun caso, dunque, la donna poteva liberarsi di questo pesante vincolo.
Che cosa resta dei Longobardi
Nonostante il carattere primitivo, i Longobardi lasciano pregevoli opere di artigianato e di architettura.
I Longobardi non conoscevano la scrittura, quindi poco sappiamo della loro lingua, anche se ne derivano certamente alcuni nomi propri di persona (Anselmo, Federico, Guido, Umberto), di località (oltre al nome Lombardia, nomi di città terminanti con il suffisso -engo) e di oggetti della vita quotidiana ( palla, panca).
Nonostante uno stile di vita decisamente primitivo, questo popolo seppe eccellere in alcuni settori dell’artigianato, in particolare in quello legato alla lavorazione dei metalli. Dato il loro carattere guerriero, i Longobardi si distinsero soprattutto nella produzione di armi (spade, sciabole, lance, scudi), ma furono anche capaci di realizzare squisiti lavori di oreficeria
Dopo la loro conversione al Cattolicesimo ( p. 47), e grazie all’influenza della cultura romana, crearono opere d’arte di notevole qualità. In particolare costruirono chiese, arricchite talvolta con pregevoli decorazioni.


STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
a. Da che cosa deriva il nome “Longobardi”?
b. Da quali gruppi era composta la società longobarda?
c. In quale settore dell’artigianato essi eccellevano?
Verifica la comprensione
2. Scrivi i nomi corrispondenti alle definizioni.
a. Gruppi di famiglie della società longobarda:
b. Uomini addestrati alle armi:
c. Uomini addetti ai lavori dei campi, all’allevamento e all’artigianato:
d. Potere esercitato dal capofamiglia sulle donne del proprio nucleo familiare:
Interno del tempietto longobardo con stucchi decorativi e affreschi di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli (metà del VIII secolo).
Borchie di scudo longobardo (VII secolo).
Unità 2 Bizantini e Longobardi 45 ©Principato
Il Regno longobardo

I Longobardi si danno una legge scritta: l’editto di Rotari
Rotari emana un editto che costituisce la prima legge scritta dei Longobardi; con questo editto viene proibita la faida, sostituita con una multa in denaro.
Nel 643 re Rotari emanò un editto che da lui prese nome e che fu la prima legge scritta dei Longobardi.
L’editto introdusse un importante cambiamento delle regole antiche. In particolare, proibì la faida. La faida era la vendetta privata, ossia il diritto di ognuno di restituire il torto subìto colpendo il responsabile o la sua famiglia con un’offesa di pari gravità. In pratica: se un uomo libero veniva ferito, i suoi familiari avevano diritto di ferire a loro volta il colpevole. Rotari sostituì la faida con un risarcimento in denaro, chiamato guidrigildo
Con queste leggi Rotari voleva evitare la spirale d’odio provocata dalle faide, le quali davano avvio a una catena di vendette che continuava di padre in figlio. L’indennizzo in denaro era proporzionale alla gravità dell’offesa subita e anche alla condizione sociale dell’individuo.
Non tutti sono uguali davanti alla legge
L’editto di Rotari non pone tutti gli abitanti del Regno nelle stesse condizioni: servi e donne ricevono un trattamento decisamente più severo.
I servi erano puniti in maniera molto più dura rispetto agli arimanni. Ad esempio, se un servo uccideva il padrone era condannato a morte, ma se l’omicida era un uomo libero doveva pagare una multa.
O, ancora, se una donna uccideva il marito era condannata a morte mediante lapidazione, se il marito uccideva la moglie era condannato al pagamento di una somma in denaro. Il pagamento, comunque, doveva chiudere per sempre l’inimicizia tra le due famiglie e dare soddisfazione a entrambe. L’editto, nonostante i dubbi di Rotari a questo proposito, confermava una misura tipica della mentalità longobarda, cioè l’ordalia, o Giudizio di Dio. Essa prevedeva che in certi casi l’imputato dimostrasse la propria innocenza sottoponendosi a prove terribili, ad esempio camminando a piedi nudi sui carboni ardenti o tenendo in mano un ferro rovente. Si riteneva che se fosse stato innocente, Dio gli avrebbe permesso di superare la prova. Il mancato superamento di questa determinava una sentenza di colpevolezza.
Lezione 46 6 ©Principato
Miniatura raffigurante il re Rotari e la sua corte (metà dell’XI secolo).
La conversione al Cattolicesimo
Grazie all’opera della regina Teodolinda, i Longobardi si convertono al Cattolicesimo.
Al momento del loro ingresso in Italia, i Longobardi avevano ormai abbracciato il Cristianesimo, che professavano però nella forma ariana ( p. 9), considerata eretica dalla Chiesa di Roma. Ciò contribuì a inasprire i rapporti fra il Papato e gli invasori, anche perché questi erano attratti dalle ricchezze che la Chiesa aveva raccolto nel tempo, grazie alle numerose donazioni ricevute dai fedeli. I rapporti fra le due parti rimasero tesi fino a quando re Agilulfo, consigliato dalla moglie Teodolinda, fece battezzare il proprio figlio secondo la fede cattolica (603). L’esempio del sovrano spinse il suo popolo a fare altrettanto. La conversione al Cattolicesimo favorì in modo decisivo il processo di integrazione fra Longobardi e Italici. Teodolinda si rivelò una figura di primo piano anche dopo la morte del marito, intrattenendo rapporti amichevoli con Gregorio Magno e con la Chiesa.
La Donazione di Sutri
Re Liutprando dona al papa un territorio che costituisce il primo nucleo dello Stato della Chiesa.
Più tardi un altro sovrano, Liutprando, compì un nuovo passo nella direzione di una più stabile convivenza fra il Regno longobardo e la Chiesa. Nel 728 egli donò al pontefice Gregorio II alcuni territori attorno alla città di Roma, tra cui un castello situato nella località di Sutri, da cui la donazione stessa prese il nome. I terreni e gli edifici donati da Liutprando costituirono il primo nucleo di quello che sarebbe diventato, in seguito, il ben più ampio e potente Stato della Chiesa. Su questo Stato il papa eserciterà, come capo politico, il potere temporale fino al 1870.
STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
a. Che cos’era la faida?
b. Quale religione professavano i Longobardi al loro arrivo in Italia?
Verifica la comprensione
2. Completa il testo inserendo le parole opportune.
guidrigildo
ordalia
faida
Croce di Agilulfo in oro con decorazioni in pietre preziose, conservata nel Duomo di Monza (inizio del VII secolo).

Potere temporale: il potere politico; il potere temporale si contrappone al potere spirituale, che riguarda il governo delle anime.
c. Che cosa favorì i rapporti fra il Regno longobardo e il Papato?
d. Che cosa fece Liutprando per migliorare i rapporti con la Chiesa?
delitto
legge

donne
I Longobardi non avevano una scritta. Fu Rotari a dare al suo popolo un editto che sostituiva la , ossia la vendetta privata, con il , una risarcimento in denaro proporzionato alla colpa commessa. L’entità della pena dipendeva, oltre che dalla gravità del , anche dalla condizione sociale del colpevole. La legge era inoltre più dura nei confronti delle . L’editto di Rotari confermava inoltre l’ , che consisteva nel sottoporre l’imputato a terribili prove.
•
•
•
•
•
LE PAROLE DELLA STORIA
Unità 2 Bizantini e Longobardi 47 ©Principato
774 d.C.
La sconfitta di Desiderio per opera di Carlo Magno segnò la fine del Regno longobardo.
Decadenza e fine del Regno longobardo

Un Regno diviso e fragile
L’autonomia dei duchi indebolisce il potere del re. Il conflitto con la Chiesa provoca una guerra con i Franchi, giunti in aiuto del papa.
Nonostante i tentativi fatti da alcuni sovrani di notevole capacità, il Regno longobardo non riuscì mai a consolidarsi in maniera efficace e definitiva. Il comportamento indipendente dei duchi, infatti, sottraeva al re una buona parte del territorio e delle risorse economiche e militari.
Non solo: spesso gli stessi duchi organizzavano complotti per portare sul trono degli usurpatori
Un altro elemento di debolezza era costituito dai difficili rapporti con la Chiesa, mai definitivamente pacificati, neppure dopo la donazione di Sutri. I sovrani longobardi, infatti, non rinunciarono mai del tutto alla possibilità di estendere i loro possedimenti invadendo i territori della Chiesa. Quest’ultima, pertanto, non avendo un esercito con cui contrastare tali pressioni, fu costretta a cercare aiuto presso altre potenze
Nulla poteva fare a questo proposito l’Impero bizantino, impegnato a difendere le sue frontiere orientali e settentrionali. I papi chiesero allora la protezione dei Franchi, che avevano creato al di là delle Alpi un Regno vasto e potente. Quando il re longobardo Astolfo minacciò di attaccare Roma, papa Stefano II invocò dunque l’intervento dei Franchi. Sotto la guida di Pipino il Breve, questi discesero per due volte in Italia sconfiggendo Astolfo, che dovette chiedere la pace e ritirarsi.





La fine del Regno longobardo
Prosegue lo scontro con la Chiesa. Un nuovo intervento dei Franchi segna la fine del Regno longobardo.
La politica di Astolfo fu presto ripresa dal suo successore Desiderio. Questi inizialmente cercò di allearsi con i Franchi, dando la propria figlia Ermengarda in moglie al loro re Carlo Poco dopo, però, Carlo si separò da Ermengarda e si risposò con un’altra donna, rompendo, di fatto, l’alleanza. Desiderio reagì riprendendo gli attacchi contro i territori controllati dalla Chiesa finché papa Adriano I, nel 751, chiese nuovamente l’aiuto dei Franchi. Carlo discese in Italia e, nel 774 , inflisse ai Longobardi una sconfitta decisiva. Desiderio cadde prigioniero e così il dominio longobardo sull’Italia settentrionale ebbe fine Nell’Italia centrale e meridionale, invece, i ducati longobardi sopravvissero per altri due secoli.
Lezione 48 7 ©Principato
Pipino il Breve (714-768).
Le date della storia
Non solo barbari
I Longobardi favoriscono gradualmente la nascita di una nuova società che si realizza pienamente nel corso del Medioevo.
I Longobardi sono stati considerati a lungo dagli storici come un popolo selvaggio, colpevole di aver ritardato la ripresa della società italica dopo la caduta dell’Impero romano.

Oggi gli studiosi hanno modificato in parte quella visione.
Se da un lato gli invasori compirono effettivamente grandi devastazioni al momento del loro arrivo in Italia, in seguito svolsero una funzione positiva.
La conversione al Cattolicesimo favorì una graduale integrazione con la popolazione italica, e un effetto analogo ebbero le leggi scritte emanate da Rotari
I Longobardi diedero inizio al processo di fusione fra la cultura germanica e quella latina, ponendo le premesse per la formazione della società medievale che avrebbe dominato l’Europa per diversi secoli. Essi stabilirono nuovi insediamenti, come dimostrano numerosi nomi di paesi e città, e crearono una rete di grandi possedimenti terrieri che davano lavoro a uomini liberi e a servi.
L’altare di Ratchis
Nel Battistero di Cividale del Friuli è conservato l’Altare di Ratchis, così chiamato dal nome del duca longobardo, divenuto poi re, che ne ordinò la realizzazione.
L’altare è costituito da un unico blocco di pietra a forma di parallelepipedo. Su di esso sono scolpite quattro scene di carattere religioso, riferite a episodi del Vangelo.
Nella figura riportata sotto è descritto l’episodio dell’adorazione dei Magi.
STUDIA CON METODO
Fissa i concetti sul testo
1. Sottolinea sulle pagine le risposte alle domande.
a. In che modo il comportamento dei duchi indeboliva il potere del re?
b. In che modo i papi cercarono di difendersi dalla minaccia dei re longobardi?
c. Quale evento pose fine all’alleanza tra Carlo e Desiderio?
d. Quali fattori favorirono l’integrazione fra Longobardi e Latini?
Verifica la comprensione
2. Indica il nome dei re longobardi protagonisti degli eventi sotto descritti.


• Fu sconfitto dai Franchi chiamati in Italia da papa Stefano II:
• Fu definitivamente sconfitto dai Franchi guidati da Carlo Magno:
3. Quali sono i personaggi raffigurati nell’immagine riportata in questa pagina?
Altare di Ratchis, rilievo in pietra raffigurante l’adorazione dei Magi, Cividale del Friuli (VIII secolo).
LEGGI L’IMMAGINE Unità 2 Bizantini e Longobardi 49 ©Principato
Fissare le conoscenze e sviluppare le competenze di base




Completa i testi inserendo le parole opportune, che sceglierai fra quelle proposte.


L’Impero d’Oriente sopravvive


romano • millennio • bizantino • Costantinopoli
L’Impero romano d’Oriente più ricco e meglio organizzato, resiste alle invasioni e sopravvive ancora per circa un dopo la caduta dell’Impero d’Occidente. La lingua, la cultura e la stessa figura dell’imperatore si allontanano sempre più dal modello . L’Impero romano d’Oriente viene chiamato , dal nome dell’antica città greca su cui era sorta .
L’imperatore Giustiniano
Giustiniano • Vandali • Codice • cesaropapismo • Persiani
• Ostrogoti • Visigoti • epidemie
Nell’anno 527 sale sul trono l’imperatore che ha un progetto ambizioso: ricostruire il grande Impero romano. Giustiniano sconfigge i e i e riprende parte della Spagna e l’Africa settentrionale. Poi entra in guerra con gli e conquista l’Italia.
In Italia la guerra gotico-bizantina provoca miseria, carestie ed che decimano la popolazione. La realizzazione del progetto di Giustiniano ha costi altissimi perché impoverisce le casse dello Stato e indebolisce le frontiere, soprattutto quelle orientali, minacciate dai . La riunificazione, del resto, era ormai impossibile poiché in Occidente si erano stabiliti nuovi popoli e si erano formati nuovi regni. Il merito più grande di questo imperatore è la realizzazione del del diritto civile, che rinnova e semplifica le antiche leggi. Giustiniano instaura inoltre un sistema detto , per cui l’imperatore detiene non solo il potere politico ma anche quello religioso.
Sintesi inclusiva in PowerPoint
Sintesi ATTIVA
50 ©Principato
I Longobardi invadono l’Italia
Alboino • ducati • guidrigildo • arimanni • fare • mundio
Nel VI secolo i Longobardi, sotto la guida del re , invadono l’Italia. Il territorio conquistato è diviso in . La società longobarda è divisa in gruppi familiari che si chiamano , composte da uomini liberi detti . Della società fanno parte anche i semiliberi e gli schiavi. La condizione delle donne è regolata dal , un’antica usanza che le sottomette totalmente all’autorità del padre o del marito.
I Longobardi non hanno leggi scritte e praticano la faida. Ciò significa che, se qualcuno è ferito o ucciso, i suoi familiari possono vendicarlo.
Nel 643 il re Rotari emana la prima legge scritta dei Longobardi, conosciuta come editto di Rotari. L’editto vieta la faida e la sostituisce con il , cioè con un risarcimento in denaro.
I difficili rapporti con la Chiesa e la fine del Regno
Carlo • Gregorio Magno • Liutprando • Franchi • Teodolinda • Sutri
La regina favorisce la conversione del suo popolo alla religione cattolica e migliora i rapporti con papa .
Successivamente re dona al papa il castello di , nel Lazio, primo nucleo territoriale di quello che diventerà nei secoli successivi lo Stato della Chiesa.
Nell’VIII secolo i rapporti fra i Longobardi e il Papato peggiorano rapidamente perché re Astolfo minaccia di invadere i territori della Chiesa. Papa Stefano II chiede l’aiuto dei , che, guidati da Pipino il Breve, scendono in Italia e vincono in battaglia i Longobardi. Re Desiderio, successore di Astolfo, riprende gli attacchi ai territori della Chiesa. Papa Adriano I chiede l’aiuto del re franco , che sconfigge definitivamente i Longobardi e mette fine al loro regno (774).
Unità 2 Bizantini e Longobardi 51 ©Principato
Bizantini e Longobardi
Bizantini Longobardi
Politica - Economia
- l’Impero romano d’Oriente sopravvive

- Costantinopoli capitale, è difesa da mura
- economia e commercio sono prosperi
Giustiniano
- 527 sale al trono




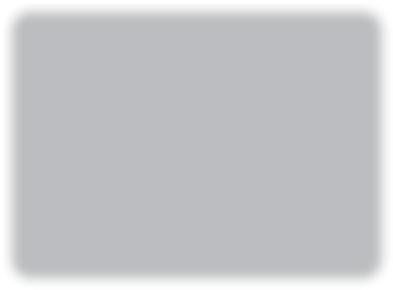

- sposa Teodora
- progetta di riconquistare l’Occidente (guerra gotica-bizantina)
- emana il Corpus Iuris Civilis
- cesaropapismo
Società
- divisa in fare (famiglie)



- formate da arimanni (uomini liberi)
- aldi
- schiavi Sovrani
- Alboino : fondatore del Regno



- Rotari: editto


- Liutprando : donazione di Sutri
- Desiderio : sconfitto da Carlo Magno. Con lui termina il Regno Religione
- ariani
- si convertono al Cattolicesimo (Teodolinda)
52
©Principato
Corona votiva di Teodolinda, conservata nel Duomo di Monza (inizio del VII secolo).
COMPETENZE
Mappa concettuale
Leggi e interpreta le carte
1. Sotto il dominio bizantino e longobardo tre furono le città più importanti d’Italia: una perché capitale del Regno longobardo, un’altra perché sede del governatore bizantino, la terza perché sede del Papato. Scrivi negli spazi bianchi il nome delle città e la funzione da loro svolta.
nome:
funzione:
nome:
funzione:
nome:




funzione:
Colloca nel tempo gli eventi della storia
2. Scrivi accanto a ciascun evento l’anno in cui avvenne. Sceglierai le date fra quelle elencate. 527 • 535-553 • 568 • 643 • 728 • 774
a. I Longobardi scendono in Italia
b. Fine del Regno longobardo
c. Inizia il Regno di Giustiniano
d. Editto di Rotari
e. Guerra gotico-bizantina
f. Donazione di Sutri
Comprendi aspetti e strutture dei processi storici
3. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
a. Costantinopoli fu saccheggiata dagli Unni.
b. Giustiniano era nipote dell’imperatore Giustino.
c. L’imperatrice Teodora proveniva da una nobile famiglia.
d. Lo sforzo compiuto da Giustiniano per riconquistare l’Occidente indebolì l’Impero a Oriente.
e. L’editto di Rotari stabiliva che nessun delitto fosse punito con la pena di morte.
f. La regina longobarda Teodolinda era di religione ariana.
g. Il re longobardo Astolfo sconfisse due volte Pipino il Breve.
h. Carlo, re dei Franchi, sconfisse i Longobardi e pose fine al loro Regno.
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
V F
Unità 2 Bizantini e Longobardi 53 Costruisci
Verifica interattiva ©Principato
le coMPETENZE
4. Completa il testo con le parole opportune che sceglierai tra quelle proposte.

Pavia • Spoleto • Alboino • Svezia • isole • Benevento • costiere
I Longobardi provenivano dalla . Dopo aver attraversato l’Europa centrale, entrarono in Italia sotto la guida di re . I Bizantini non li affrontarono in campo aperto e preferirono ritirarsi nelle città. Molte di queste, però, furono conquistate e divenne la capitale del nuovo Regno. I Longobardi non riuscirono a impadronirsi di tutta l’Italia e i Bizantini continuarono a controllare le zone e le , che potevano essere rifornite via mare.
Nell’Italia meridionale nacquero due potenti ducati longobardi: quello di e quello di .
5. In ciascuno dei seguenti elenchi di parole ce n’è una che non corrisponde alla definizione: trovala e cancellala con un tratto di penna.
a. Territori riconquistati dall’imperatore Giustiniano: Spagna – Gallia – Africa del nord – Italia
b. Sono sovrani longobardi: Alboino – Alarico – Rotari – Liutprando
c. La società longobarda è governata da: re – duchi – gastaldi – senatori
d. Fatti che avvennero nel Medioevo: guerra-gotico bizantina – guerra fra Longobardi e Franchi – donazione di Sutri –Concilio di Nicea
Individua i rapporti tra cause ed effetti

6. Completa le seguenti affermazioni.




a. L’Impero bizantino era ricco e potente perciò riuscì a sopravvivere .
b. L’Impero bizantino, poiché era stremato dalla guerra gotico-bizantina, non riuscì a difendere efficacemente l’Italia .
c. Le antiche leggi romane spesso si ripetevano o si contraddicevano, perciò Giustiniano volle attuare una riforma
d. Il papa temeva che i Longobardi invadessero le sue terre, pertanto chiamò in suo aiuto .
Comprendi e interpreta il documento

7. Il breve brano che segue è tratto dall’editto di Rotari. Leggilo, poi rispondi alle domande.

Se qualcuno avrà ucciso il suo padrone, sia egli stesso ucciso. Se qualcuno vorrà difendere l’omicida paghi novanta soldi, metà al re e metà ai parenti del morto. Se qualcuno avrà ferito nel capo un altro, in modo da rompere solo il cuoio capelluto, paghi un indennizzo di sei soldi. Se avrà fatto due ferite, paghi dodici soldi. Se saranno tre, paghi diciotto soldi. Se saranno di più, non si conteranno e si pagherà l’indennizzo solo per queste tre.
Editto di Rotari.
a. La pena di morte in caso di omicidio è riservata a una sola categoria di persone. Quale?
b. Come è punito il ferimento di una persona?
c. In che cosa consiste la differenza tra la faida e il guidrigildo?
54 Verifica interattiva
©Principato
Costruisci le COMPETENZE
Sintetizza i concetti e i contenuti
1. Inserisci nella tabella le informazioni richieste.
Capitale
Numero di abitanti della capitale
Città principali

Lingua prevalente
Impero bizantino
Situazione dell’Italia dopo l’invasione longobarda
Capitale del Regno longobardo
Altre città conquistate dai Longobardi
Città bizantina che resistette ai Longobardi
Ducati longobardi autonomi nell’Italia meridionale
Lavora con i compagni
2. Svolgerai questo esercizio insieme a quattro tra le tue compagne e i tuoi compagni. Ognuno di voi presenterà uno dei personaggi sotto elencati. Di questo personaggio ricorderà molto brevemente gli eventi di cui fu protagonista.
• Alboino:
• Teodolinda:
• Rotari:
• Liutprando:
• Desiderio:
VERSO L’ESAME DI STATO (Tipologia C. Comprensione e sintesi di un testo)
3. Rileggi il testo di pp. 40-41 (Nika! Nika!), quindi, seguendo il metodo giornalistico delle cinque W, rispondi alle domande.
• Who? [«Chi?»]
• What? [«Che cosa?»]
• When? [«Quando?»]
• Where? [«Dove?»]
• Why? [«Perché?»]
Unità 2 Bizantini e Longobardi 55 ©Principato
EDUCAZIONE CIVICA di riflessione e approfondimento SPUNTI
Educazione CIVICA
Calcio giovanile, il figlio viene ammonito e il padre picchia l’arbitro e uno spettatore

Ha picchiato l’arbitro e uno spettatore dopo la partita di calcio fra under 14 in cui al figlio era stato dato un cartellino giallo. I carabinieri hanno arrestato il genitore. È successo a Firenze sabato pomeriggio sul campo sportivo di Peretola dove si era appena giocato l’incontro del campionato Giovanissimi provinciali tra Firenze Ovest e Albereta San Salvi, due gloriose società dilettantistiche del capoluogo toscano. L’uomo, 34 anni, fiorentino, gravato da numerosi precedenti per il parapiglia che ha scatenato è accusato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, percosse, lesioni personali.
All’arbitro ha sferrato un pugno al volto, allo spettatore arrivato a difendere lo stesso direttore di gara ha dato spinte e colpi a un ginocchio.
Nella partita il direttore di gara aveva ammonito il figlio del 34enne il quale dagli spalti ha iniziato ad urlare ed offendere, suscitando la reazione di altri spettatori uno dei quali, solo perché aveva cercato di tranquillizzarlo, era stato minacciato. Per tali intemperanze l’arbitro ha sospeso temporaneamente la partita che, ristabilita la calma, è proseguita regolarmente. Ma alla fine quando l’arbitro lasciava l’impianto, è stato aggredito così come lo spettatore che ne ha preso le difese.
Rispondi alle domande
Anche i carabinieri, intervenuti per contenere l’aggressività del 34enne, sono stati spinti, minacciati e offesi dal padre del baby calciatore. Un militare ha ricevuto un calcio a un ginocchio riportando lesioni. […] L’arbitro e lo spettatore hanno presentato querela contro di lui. Il militare e lo spettatore feriti hanno riportato lesioni giudicate guaribili, rispettivamente, in quattro e sette giorni. L’arbitro si è riservato di fornire referto medico dell’ospedale.
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2022/05/08
1. Ti è mai capitato di assistere a intemperanze da parte del pubblico di un evento sportivo?
2. Si è trattato di intemperanze verbali o addirittura di violenze fisiche?
3. Ti è mai capitato di insultare gli atleti, l’arbitro o i tifosi delle squadre avversarie?
Discuti in classe
Apri una discussione in classe con i tuoi compagni e le tue compagne su questo tema: qual è, a tuo parere, il limite che un tifoso non dovrebbe mai superare?
Rifletti con l’insegnante anche su come si può fare per gestire i propri sentimenti e le proprie emozioni in momenti di forte coinvolgimento, quando si rischia di perdere il controllo.
56
©Principato










































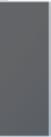





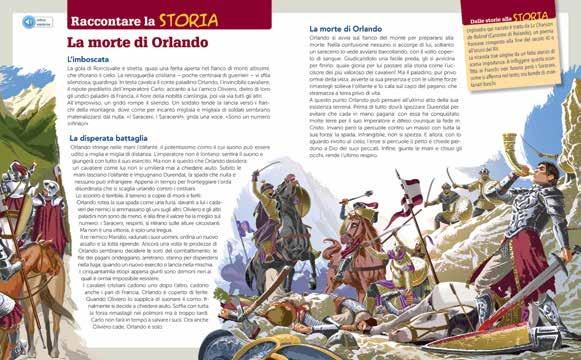



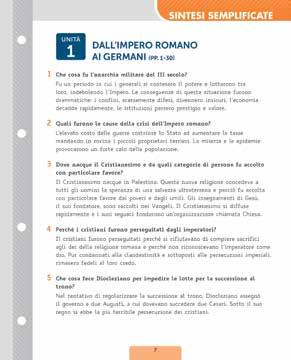


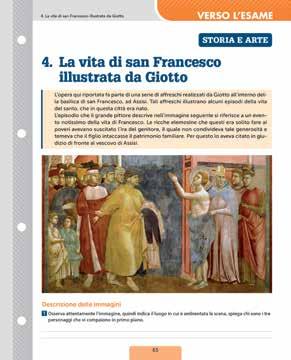







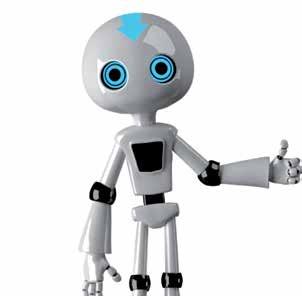







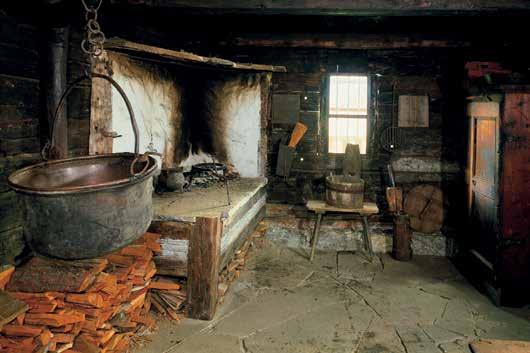

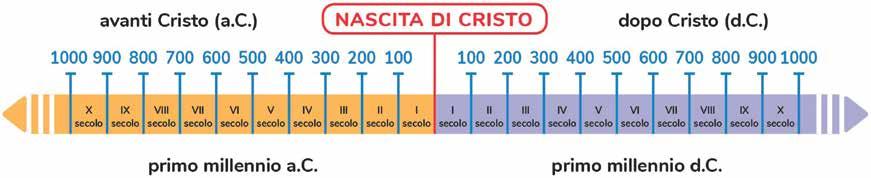





 I soldati romani sottomettono i Daci. Bassorilievo dall’Arco di Costantino, Roma (II secolo d.C.).
I soldati romani sottomettono i Daci. Bassorilievo dall’Arco di Costantino, Roma (II secolo d.C.).









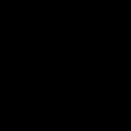

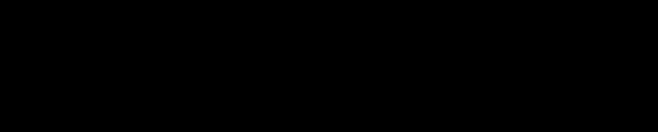



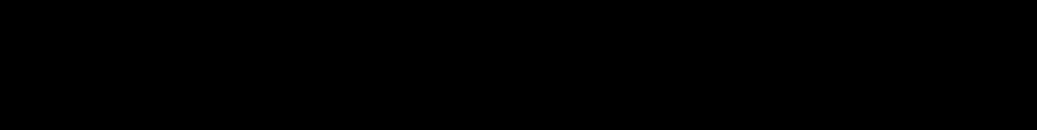








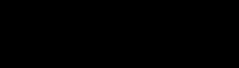


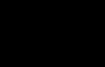















































 Nell’immagine in alto, natura morta con pesci e anatre; particolare di un mosaico del I secolo d.C. proveniente da Pompei.
Nell’immagine in alto, natura morta con pesci e anatre; particolare di un mosaico del I secolo d.C. proveniente da Pompei.






















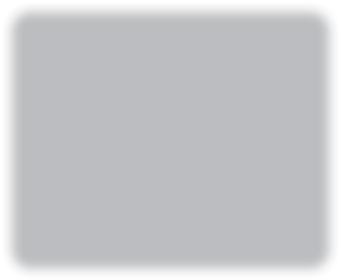




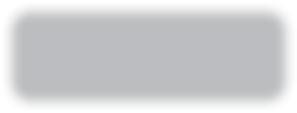









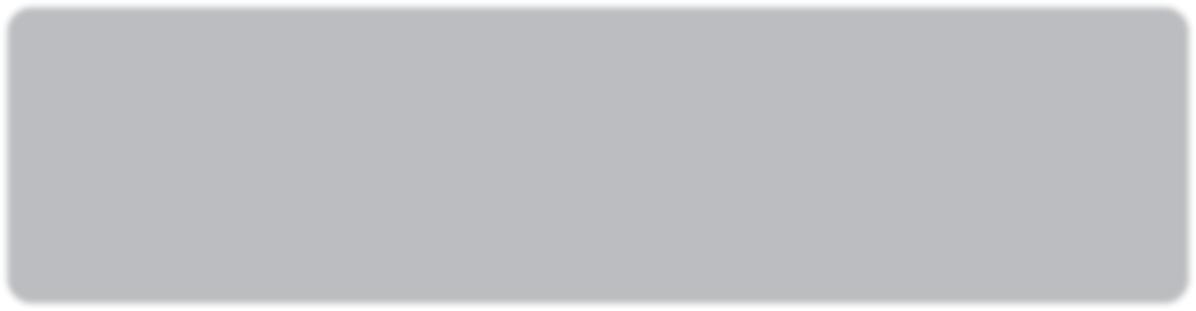













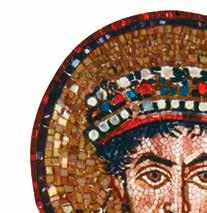
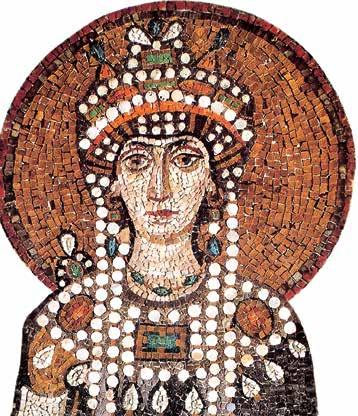














 Abside della Basilica di San Vitale a Ravenna, decorata con mosaici (VI secolo d.C.).
Statua dell’imperatore Giustiniano, Skopje (Macedonia).
Abside della Basilica di San Vitale a Ravenna, decorata con mosaici (VI secolo d.C.).
Statua dell’imperatore Giustiniano, Skopje (Macedonia).






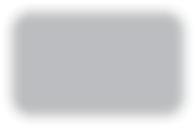



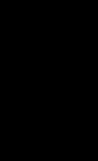
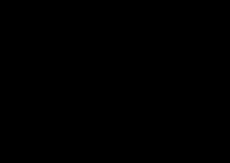
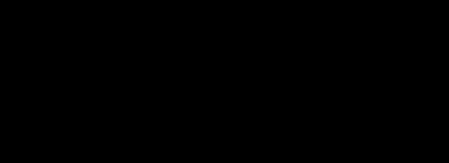
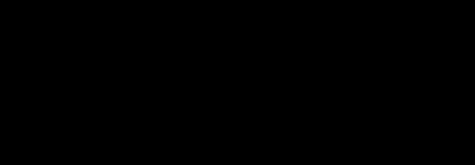
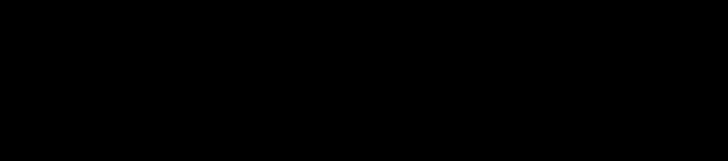




























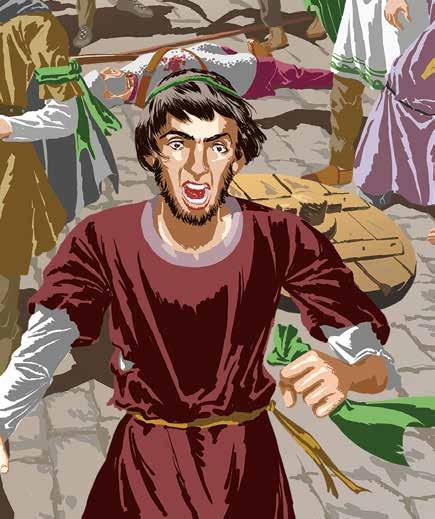

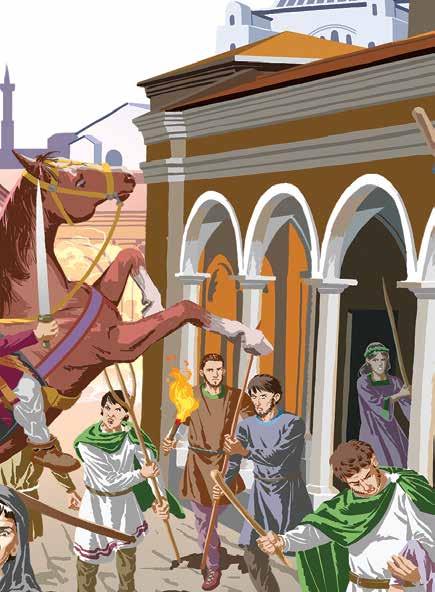







 longobardo di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli (metà del VIII secolo).
Mercenari: soldati che combattono per denaro.
longobardo di Santa Maria in Valle a Cividale del Friuli (metà del VIII secolo).
Mercenari: soldati che combattono per denaro.