Nuove sfide per la distribuzione horeca e il fuori casa

Una più alta qualità della vita per una società più sostenibile
RAPPORTO 2023

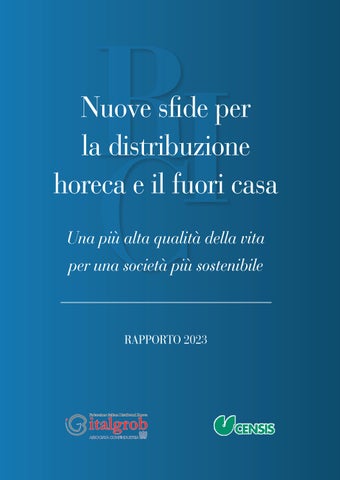

Una più alta qualità della vita per una società più sostenibile
RAPPORTO 2023


Una più alta qualità della vita per una società più sostenibile
RAPPORTO 2023
07 | INTRODUZIONE
11 | CAPITOLO 1
Il fuori casa per una società più sostenibile
1.1. L’originale contributo
1.2. La convivialità rilanciata e il valore vero della Movida
1.3 Il ruolo strategico della Distribuzione Horeca nel nuovo contesto
1.4. I risultati in pillole
19 | CAPITOLO 2
Punti d’attacco
2.1. L’abitudine che torna
2.2. La Distribuzione Horeca decisiva
2.2.1. Forme di supporto

2.2.2. L’upgrading della cultura di filiera
2.3. Nuove sfide in avanti: la sostenibilità
2.3.1. Qualità della vita e valore della relazionalità
2.3.2. La sostenibilità per il fuori casa
2.3.3. Approfondimenti necessari
2.3.4 I rischi della sostenibilità penitente
2.4. Pratiche verdi
2.4.1. Stato di avanzamento
2.4.2. Esempi concreti
2.4.3. Stimolo per un fuori casa più sostenibile
2.4.4 Verso una più alta sostenibilità sociale
33 | CAPITOLO 3
Cibo e convivialità, un nesso molto italiano
3.1. La quotidianità cambiata
3.2. Un valore attualissimo
3.3. Il punto di vista degli italiani
37 | CAPITOLO 4
Convivialità extradomestica
4.1. La nuova attrattività del fuori casa
4.2. I comportamenti
4.2.1. Attuali
4.2.2. Desiderati
4.2.3. Il senso dei dati
4.3. Il buon giudizio
4.3.1. Qualità della vita migliore
4.3.2. Chiusure uguale decadenza
46 | CAPITOLO 5
Oltre retoriche fuorvianti
5.1. Equivoci da superare subito
5.2. Le opinioni
5.2.1. I dati
5.2.2. Il significato sociale
5.2.3. La professionalità che garantisce
51 | CAPITOLO 6
Gestire il cambiamento
6.1 Colmare il gap tra valore sociale e social reputation della Movida
6.2 No Movida, no sicurezza
6.3 Le ragioni sociali attuali
6.3.1 Temporaneo ed essenziale: una quota di benessere soggettivo irrinunciabile
6.3.2 Piattaforma per modalità
diverse di vivere la vita: la voglia di lentezza
6.3.3 Consumi simbolici da tutelare
6.3.4 Dalla parte dei giovani
60 | CAPITOLO 7
Perché fuori casa e Distribuzione
Horeca sono essenziali
7.1 Un percorso interpretativo
7.2 Il paradigma della Movida
7.3 L’ampliamento possibile del bacino del fuori casa

Cueva de las manos, se dovessimo trovare un’immagine per descrivere il secondo Rapporto Censis-Italgrob questa caverna, con le sue pitture rupestri, sarebbe sicuramente una delle candidature più promettenti. Quell’insieme di mani rosse con cui un essere umano ai primordi ha deciso di istanziare se stesso, pervaso dall’illuminazione di un cogito ancestrale, è una descrizione icastica della Distribuzione Horeca così come emerge da questo Rapporto. Se, infatti, la differenza tra l’essere e l’esistere è rappresentata proprio dall’istanziarsi, da quel marcare la differenza tra il dire ci sono e agisco, inteso non come una spinta acefala al fare insostenibile ma come il divenire attanziale del sé nel mondo, allora, dopo l’epifania dell’esserci del Distributore, oggi il Censis ne racconta l’esistenza. Ma lo fa delicatamente, per connotazione, così da contestualizzarne la presenza nell’affresco di una società disperatamente in cerca d’autore.
In questo dipanarsi narrativo, quasi sulle arie smetaniane della Moldava, i punti d’appoggio sono due: la sostenibilità sociale e il rito. La prima si articola su quattro distinti principi:
• La sostenibilità interna, intesa come la capacità della Distribuzione Horeca di dimostrare che una logistica socialmente inclusiva è possibile mantenendo le regole dell’economia di mercato; per il Distributore lo stare insieme non è solo l’enunciazione di un modello di business, ma rappresenta un modo di intendere l’esistenza;
• La sostenibilità esterna, perché la vita è riscoperta del piacere del corpo, di quella fisicità dionisiaca a cui Nietzsche ha dedicato vita e destino; quell’essere umano, troppo umano, per cui se proprio dev’essere sanbenito che almeno sia oltraggioso, come si addice ai periodi di crisi. La sostenibilità penitente è insostenibile;
• Sostenibilità istituzionale, perché la Distribuzione Horeca deve essere parte attiva nei processi normativi che interessano la comunità di riferimento, rappresentandone, nei fatti, la materia prima di costruzione; non c’è vita al di
fuori delle mura dell’Horeca;

• Sostenibilità culturale, perché il sapere imprenditoriale del Distributore permette di armonizzare le diverse velocità con cui si muove il corpo sociale non solo attraverso le competenze tecniche specifiche, ma anche con il suo ruolo di mediatore culturale occulto a cui spetta il compito di diversificare i contesti relazionali.
Si tratta, in ultima analisi, di descrivere il modello di business distributivo come un architrave che poggia su tre colonne: la mimesi, quale momento di infeudazione dell’impresa nel territorio, la genesi, come tratto di orientamento creativo delle dinamiche sociali e la plasticità, intesa come un adattarsi dinamico ai cambiamenti senza venir meno alla propria natura essenziale.
Il secondo punto d’appoggio è il rito. Questo Rapporto, infatti, ha il pregio di distinguere con molta finezza, rispettivamente, le strutture sociale e culturale, definite come il modo di intendere la vita con il suo bisogno, tutto mediterraneo, di stare insieme, il rito, inteso come la modalità con cui si concretizza il bisogno, e l’esperienza, connotata dal sé mnemonico che, prevalendo su quello esperienziale, trasforma la gestualità allargata del rito in simbolo attraverso un percorso di unificazione. Su questo aspetto è importante fare chiarezza, perché il rischio di toccare da vicino la nozione di confusione è molto alto, in particolare con riferimento al rito.
Nel Rapporto la Movida, emendata dalla forzata torsione etica e ricondotta nell’alveo sociale che le è proprio, è presa come ipostasi del consumo fuori casa inteso come rito. Il rito non comunica nulla e, di per sé, non è neanche una relazione sociale. Rimanda, piuttosto, ad un’esperienza che istituisce, grazie a una prossemica gestuale e simbolica specifiche, le basi per interconnettere gli esseri umani tra loro e con una serie di simboli. Il rito, quindi, è una sorta di meta-contesto che indirizza i percorsi di comunicazione, mentre le azioni che lo concretizzano, che pure non sono traducibili direttamente in simboli, terminata la gestualità costitutiva permettono a esperienza e simbolo di unirsi indissolubilmente. Detto altrimenti, l’atto di andare al bar è un rito e, come tale, è distinto dal bisogno sottostante e dall’esperienza che ne deriva.
La portata concettuale di questa visione è formidabile perché permette di concludere che se è vero che l’HoReCa non morirà mai, altrettanto non si può dire del bar o del ristorante o di qualunque altro rito; nuove forme di somministrazione si stanno affacciando sul mercato, nuovi riti stanno innestandosi in un corpo sociale sfibrato
ma ancora vitale e la Distribuzione Horeca è chiamata alla mimesi, alla genesi e alla plasticità. Al Distributore, pronao del tempio sociale, è affidata la custodia del senso di appartenenza di ciascuno di noi in quanto animali sociali.
Buon lavoro, Distributore, sprona la tua cavalcatura attraverso spazi ignoti e strappa meraviglie dalle mani del tempo.
Antonio Portaccio Presidente Italgrob
Il presente Rapporto riconduce il valore del fuori casa nel nuovo contesto sociale ed economico segnato dalla successione delle emergenze e dal primato della sostenibilità intesa in senso ampio.
Ogni attività economica e sociale deve rispondere ad appropriati criteri per ridurre l’impronta ecologica e contribuire alla lotta al riscaldamento globale, essere economicamente inclusiva con prezzi accessibili per un gran numero di persone e rispettare taluni criteri di socialità, dai diritti di lavoratori e fornitori alla diversity, al benessere delle comunità locali.
Esito di tali trasformazioni non può che essere una qualità più alta della vita delle persone, altrimenti sarà molto difficile conquistarne l’adesione attiva a un processo collettivo che richiede il coinvolgimento dal basso di milioni di individui.
Infatti, se la transizione alla sostenibilità non genera anche più alto benessere soggettivo e migliore qualità della vita, e anzi provoca temporanee o permanenti contrazioni di entrambi, è facile prevedere reazioni contrarie da parte dei cittadini con una non compliance alle modifiche richieste agli stili di vita.
Da qui l’assoluta e urgente priorità di promuovere subito, nella materialità del quotidiano delle vite delle persone, il nesso concreto fra transizione sostenibile e più alta qualità della vita. Ecco perché la molteplicità di adattamenti nelle pratiche di vita imposti dalla sostenibilità non possono non essere affiancati da aspetti del quotidiano che, a lungo andare, incidono positivamente sul benessere soggettivo e la qualità della vita.
In tale contesto gli attori principali del fuori casa, dalla Distribuzione Horeca agli esercizi pubblici, possono dare un contributo essenziale all’arricchimento qualitativo della sostenibilità e a una transizione smooth a essa, poiché la loro attività rende possibile, facilita e promuove la relazionalità sociale diffusa, dimensione
costitutiva della buona qualità della vita, ancor più apprezzata dagli italiani in questo periodo così tumultuoso.

Pertanto, riguardo al rapporto tra sostenibilità e filiera del fuori casa, si può dire che quest’ultima è molto impegnata ad adempiere ai precetti del green e della sostenibilità in generale, anche perché sollecitata dall’elevata attenzione dei clienti in tale ambito.
Però il dato essenziale aggiuntivo è che tale rapporto non si esaurisce solo ed esclusivamente nel rispetto puntuale degli adempimenti previsti, ma coinvolge una dimensione aggiuntiva, originale, un di più che il fuori casa è in grado di mettere in campo a beneficio della società italiana: il contributo che, tramite la generazione di relazionalità sociale, può dare qui e ora al benessere soggettivo e alla qualità della vita e, quindi, a un’idea di società sostenibile in linea con le aspettative delle persone e, anche, in grado di promuovere un’elevata social acceptance della transizione ad essa.
Questa la novità vera del presente Rapporto: esso focalizza un ulteriore specifico contributo della filiera del fuori casa ad una società sostenibile, poiché con la sua attività genera e promuove quella relazionalità sociale che migliora la qualità della vita, facilitando anche la conquista del consenso alla trasformazione per la sostenibilità.
In estrema sintesi si può dire che: gli attori del fuori casa stanno operando con impegno per adattarsi ai precetti della sostenibilità intesa in senso ampio; al contempo, la società sostenibile ha bisogno di un fuori casa in grado di dispiegare per intero i benefici della sua azione che intensifica la buona relazionalità e migliora la qualità della vita delle persone, contribuendo così a promuovere il consenso sociale a una visione qualitativamente più ampia e attrattiva di società sostenibile.
Nella società italiana sotto sforzo per le tante sfide emergenziali e per la necessità di cambiare modalità produttive, modelli di consumo e stili di vita per adattarsi ai nuovi precetti della sostenibilità, il significato sociale della convivialità si amplia poiché, oltre ad essere un costitutivo dello stile di vita italiano, essa deve contribuire a migliorare la qualità della vita di persone che, altrimenti, avranno ben poca voglia di seguire i nuovi precetti della sostenibilità.
In pratica, una società più sostenibile non può essere solo più green, economicamente inclusiva e rispettosa di diritti sociali, ma deve anche contemplare una qualità della vita più alta per la maggioranza delle persone: ecco la visione più ampia della sostenibilità che, presumibilmente è in grado di coinvolgere maggiormente gli italiani.
Componente importante per generare una migliore qualità della vita è senz’altro una relazionalità appagante, serena, apprezzabile. La filiera del fuori casa con i suoi molteplici protagonisti è l’attore economico e sociale che, più degli altri, è in grado di promuovere una relazionalità diffusa che risponda a quel desiderio di socialità che, come si è visto nell’astinenza pandemica, è molto forte.
Lo è ancor di più in tempi in cui le difficoltà si moltiplicano con una successione di eventi globali che planano nel quotidiano modificando radicalmente le condizioni di contesto, affaticando fino a sfiancare individui e collettività.
Ebbene, è proprio di fronte a tale situazione che va valutata con grande attenzione la portata sociale, oltre che economica, della filiera del fuori casa quel di più che offre in termini di convivialità che è parte dello stile di vita italiano e dimensione ancor più apprezzata in questa fase storica di grandi difficoltà.
Per tale ragione, occorre emancipare il tema della convivialità dalla diatriba tra Movida e MalaMovida, valorizzando il fuori casa come portatore di una relazionalità essenziale per la buona qualità della vita che va sempre più proposta come componente costitutiva della società sostenibile verso la quale ci si è collettivamente incamminati. Mettere la filiera del fuori casa nelle condizioni di operare bene è, oggi, una priorità tanto quanto verificare la sua compliance rispetto ai precetti della sostenibilità.
D’altro canto, la Movida è vista dagli italiani come una delle forme di convivialità diffusa, una piattaforma sociale in cui le persone si incontrano, stanno insieme a tavola tra cibo e bevande, con effetti positivi sul benessere soggettivo.
La buona valutazione della Movida si fonda sulla fiducia che gli italiani hanno negli attori del fuori casa, nella convinzione che imprenditori capaci e competenti sono in grado di garantire una convivialità apprezzabile e serena nei luoghi della Movida.
L’apprezzamento degli italiani nei confronti della relazionalità che si svolge nel fuori casa e il suo positivo impatto sulla qualità della vita emerge anche dalla voglia di uscire con maggior frequenza la sera, beneficiando con più intensità delle opportunità relazionali legate ai tanti e diversi luoghi del fuori casa.
Non c’è dubbio, quindi, che per la maggioranza degli italiani i protagonisti del fuori casa oggi vanno supportati e messi nelle condizioni di dispiegare gli effetti positivi della propria azione.
Da ora in avanti parlare di sostenibilità non deve richiamare alle persone solo ed esclusivamente una serie di adempimenti che sono chiamati ad applicare, ma l’idea di una società in cui, oltre a miglior tutela dell’ambiente e diffusa inclusività economica e sociale, ci sia più alta qualità della vita per tutti, anche grazie ad una socialità diffusa, gratificante, condivisa.

nuovo contesto
In una filiera chiamata alla sfida della sostenibilità in un momento per essa molto difficile a causa di eventi globali, è importante rilevare il valore sicuro del fulcro della filiera, vale a dire la Distribuzione Horeca. Ecco in estrema sintesi le ragioni della sua rilevanza strategica:
• se il fuori casa all’allentarsi dell’emergenza sanitaria è potuto ripartire, modulando l’offerta sulle nuove esigenze dei cittadini, è perché la Distribuzione Horeca, connettendo industrie produttrici ed imprese del fuori casa, ha continuato a garantire l’approvvigionamento puntuale di cibi e bevande a costi sostenibili per imprese spesso in notevoli difficoltà. Infatti, dopo i duri colpi del periodo emergenziale, le imprese del fuori casa, in gran parte piccole, sono alle prese con il rialzo dei costi dell’energia e, più in generale, l’inflazione e con la conseguente minaccia di finire fuori mercato;
• di fronte al rischio di una diffusa insostenibilità economica e finanziaria delle imprese del fuori casa, è stata vitale l’azione della Distribuzione Horeca che ha agito come banca di fatto. Infatti, con modalità flessibili in relazione alla mutevolezza dei contesti, essa ha garantito e garantisce respiro nei pagamenti delle forniture, erogando credito sostanziale;
• ecco perché la Distribuzione Horeca è il soggetto senza il quale il mondo del fuori casa andrebbe incontro ad una ristrutturazione feroce che ne muterebbe i connotati, con una pericolosa morìa di piccole imprese che sono fonte di reddito per una moltitudine di famiglie di titolari e dipendenti, e committenza di tante altre dell’industria del food & be-
verage. In questo senso, la Distribuzione Horeca va considerata come il fulcro della filiera senza il quale è alto il rischio che essa subisca uno sfoltimento estremo con rilevanti costi economici e sociali;
• la Distribuzione Horeca esercita poi nei confronti degli altri attori della filiera e, in particolare, a beneficio della moltitudine di operatori sui territori, una funzione pedagogica di upgrading delle culture imprenditoriali e di gestione. Di fatto, le imprese della Distribuzione Horeca sono per quelle del fuori casa interlocutori con più alte competenze e maggior spessore imprenditoriale, in grado di dare supporto e consulenza per decisioni che, nel concreto, molto incidono sugli esiti dell’attività aziendale;
• quello della Distribuzione Horeca è un supporto culturale a vari livelli, che trasferisce alle imprese del fuori casa approcci più evoluti che hanno già dato ottimi risultati, ad esempio, nella promozione di prodotti locali, spesso scoperti e inseriti nelle offerte dei punti vendita del fuori casa proprio su sollecitazione degli operatori della Distribuzione Horeca. Sono sempre più rilevanti gli stimoli per i piccoli imprenditori del fuori casa ad adottare, ad esempio, soluzioni più in linea con le nuove sensibilità e i nuovi valori dei consumatori, e con i precetti delle diverse dimensioni della sostenibilità;
• il supporto culturale della Distribuzione Horeca potrà essere decisivo nel tempo anche per un upgrading sistemico di cultura e gestione della Movida; può contribuire, infatti, a costruire modalità più efficaci di promozione e gestione della relazionalità nel fuori casa sia da parte dei singoli titolari e gestori degli esercizi pubblici sia da parte delle istituzioni con cui aprire un dialogo attivo mirato a condividere soluzioni sistemiche. La Distribuzione Horeca oggi è l’attore più avanzato della filiera, in grado di far evolvere le culture imprenditoriali dell’ampio e variegato mondo del fuori casa, con benefici rilevanti per le economie locali e le comunità.
Convivialità, abitudine italianissima. Il 92,9% degli italiani dichiara che lo stare insieme per bere e mangiare è uno degli aspetti fondamentali dello stile di vita
italiano. È un’opinione trasversale ai gruppi sociali ed ai territori, con percentuali maggiori tra i redditi medi (96,5%), i laureati (94,8%), gli anziani (94,6%), gli adulti (93,9%) ed i residenti nel Nord-Ovest (94,6%). In generale, i dati confermano che per la grande maggioranza dei cittadini la convivialità a tavola è una tradizione italiana, sia quotidiana sia come perno di eventi e ricorrenze. La ritrovata rilevanza del fuori casa richiama la nostalgia per essa emersa nel periodo dei divieti, la voglia di tornare a frequentarne i luoghi nel post emergenza ed un aspetto più strutturale e di lungo periodo, vale a dire la convivialità a tavola come componente della cultura sociale degli italiani.

Uscire la sera fa vivere meglio. Il 47,3% degli italiani quando esce la sera si reca in locali pubblici, di solito nei luoghi della Movida: l’8,8% (oltre il 23% tra i giovani) lo fa quasi sempre, il 10% almeno una volta ogni quattro giorni e il 28,5% sempre. In pratica, nelle uscite serali quote elevate di italiani dei diversi gruppi sociodemografici si recano nei luoghi del fuori casa e, in particolare, in quelli condensati nei territori della Movida. È un’abitudine di massa, socialmente e territorialmente trasversale, componente stabile dello stile di vita di milioni di italiani. Al 40,3% degli italiani piacerebbe uscire di più la sera, perché ritiene che avrebbe un effetto positivo sulla propria qualità della vita. È questo uno spazio di ulteriore ampliamento del fuori casa che nasce dalla convinzione diffusa che coltivare almeno una parte delle proprie relazioni fuori dalla propria abitazione contribuisca a far vivere meglio. Tale domanda potenziale è una conferma che il fuori casa in questo periodo è percepito come essenziale dagli italiani e non come voluttuario e superfluo, ed indica una straordinaria opportunità per la filiera di ampliare il proprio bacino di riferimento.
I luoghi del fuori casa migliorano gli spazi pubblici. Il 70,5% degli italiani ritiene molto o abbastanza importante che nelle città italiane ci siano luoghi con una certa concentrazione di locali dove mangiare, bere, divertirsi, stare insieme. Ne sono più convinti i residenti nei Comuni maggiori (82,2%), i residenti nel NordEst (76,2%) e i redditi medi (73,8%). In particolare, per il 25,6% la concentrazione di locali dove mangiare, bere e divertirsi è molto importante per la buona qualità della vita di tutti e per il 44,9% è abbastanza importante poiché potenzia l’attrattività turistica del territorio. È evidente il positivo giudizio degli italiani sui luoghi del fuori casa, visto il nesso con la qualità della vita e con l’attrattività tu-
ristica. La presenza di contesti organizzati adeguatamente che consentono alle persone di incontrarsi, mangiare e bere insieme sono percepiti come una opportunità dalla maggioranza degli italiani. Solo il 5,6% associa l’ingovernabilità dello spazio pubblico alla concentrazione di locali del fuori casa. Tale dato è una smentita secca alla demonizzazione periodica a cui viene sottoposta la Movida.
Il fuori casa che rigenera e tutela le comunità. Per il 78,5% degli italiani la chiusura di locali non fa che attivare processi di degrado facilitandone la presa di possesso da parte della microcriminalità. È un’idea diffusa, trasversale a territori e gruppi sociali e rinvia alla convinzione che i luoghi del fuori casa, moltiplicando i flussi permanenti e di attraversamento degli spazi pubblici, generano effetti positivi su sicurezza e qualità dei contesti. A ulteriore conferma di questa positiva valutazione sociale ed economica del fuori casa, il 65,7% degli italiani è convinto che la presenza di un denso tessuto di attività in un territorio sia uno straordinario e potente antidoto contro criminalità e degrado. Il fuori casa, in pratica, per gli italiani è un fattore della prevenzione sociale, non una fonte di illegalità e violenza.
La Movida, piattaforma di relazionalità sociale diffusa. Alla richiesta di indicare cosa pensano quando sentono la parola Movida, il 50,8% degli italiani ha risposto in modo positivo, vale a dire a luoghi della città dove è possibile passeggiare, mangiare, bere, stare insieme, posti dove trascorrere tempo con gli amici. Tale positiva visione della Movida come piattaforma relazionale è condivisa trasversalmente ai gruppi sociali, sia pure con qualche differenza. La condividono il 59,9% dei giovani, il 55,5% degli adulti ed il 35,6% degli anziani, il 61,8% dei laureati, il 55,6% dei diplomati ed il 43% dei più bassi titoli di studio e 57,4% degli alti redditi ed il 42,2% dei redditi bassi. Come rilevato, nel complesso la social reputation della Movida presso gli italiani è positiva, in contrasto netto con le letture demonizzanti.
Imprenditori del fuori casa, garanti della buona convivialità. L’83,4% degli italiani è convinta che gestori di locali con appropriata professionalità siano la garanzia di una Movida senza eccessi e in sicurezza. È un’opinione che prevale in modo trasversale a gruppi sociali e territori che conferma indirettamente la buona social reputation degli operatori del settore e la fiducia che gli attribui-
scono gli italiani. La Movida, per gli italiani se gestita da imprenditori professionali del fuori casa è utile e necessaria, un fenomeno positivo perché piattaforma di relazionalità di cui le persone hanno in questa fase un gran bisogno e che migliora la qualità della vita.
La sostenibilità già in atto. Le imprese del fuori casa sono da tempo impegnate a praticare forme di sostenibilità, visto che ben il 91,1% delle persone apprezza molto i locali che comunicano in modo trasparente le proprie pratiche ecologiche quali, ad esempio, la riduzione degli sprechi, la raccolta differenziata per i rifiuti, il ricorso a prodotti bio o a chilometro zero. È una pressione rilevante che la domanda esercita sull’offerta stimolandola ad adattarsi. Anche sugli sprechi il fuori casa si va adeguando, visto che ormai oltre il 57% dei giovani è pronto a portarsi via dal ristorante gli alimenti avanzati dai pasti.

Qual è il rapporto degli italiani con il fuori casa in una società segnata da un triennio di emergenze, con poca voglia di fare sacrifici e vite pervase da incertezza estrema? Letture semplificatorie ritengono che l’eccezionale, tanto più se prolungato come in questo triennio, spinga le persone a tagliare tutto ciò che eccede il basic, limitandosi al solo necessario a vivere. Eppure, è proprio nelle difficoltà che le persone vanno alla ricerca di qualcosa di più dell’ordinario, di occasioni per star bene, che consentano loro di uscire dal peso della quotidianità e dalle urgenze che ne condizionano gran parte delle giornate.
È questo un primo importante risultato del presente Rapporto Italgrob-Censis: la nostalgia che tanti italiani avevano espresso durante il periodo pandemico per l’impossibilità di ricorrere al fuori casa nelle modalità solite si è poi materializzata in un ritorno al fuori casa, magari con intensità e modalità nuove e originali, che comunque consentono di affermare che fa parte in modo strutturale e ineliminabile dello stile di vita italiano.
Il presente Rapporto può registrare la falsificazione anche di una seconda ipotesi a lungo veicolata nel periodo emergenziale: che la domesticità avrebbe invaso tutto lo spazio di vita delle persone riportando in casa, in maniera monopolistica, una molteplicità di attività che tradizionalmente venivano svolte nei luoghi del fuori casa.
Anche questa seconda ipotesi è stata smentita dalle concrete pratiche degli italiani che sono tornati nei luoghi del fuori casa. In quello del tempo libero, nella relazionalità di vario tipo, amicale e business, il fuori casa ha così riconquistato un ruolo significativo che è espresso da dati di spesa e, più ancora, da quelli relativi ai concreti comportamenti sociali degli italiani.
Per questo, il Secondo Rapporto può partire da un punto più avanzato rispetto a quello a cui era arrivato il Primo Rapporto, poiché la dinamica concreta dei comportamenti sociali ha confermato il valore sociale del fuori casa e, anche, quello dei suoi principali attori.
Questa realtà di fatto rilancia anche il ruolo della Distribuzione Horeca, attore a lungo misconosciuto della filiera del fuori casa e invece protagonista a tutto tondo a cui si deve la sostenibilità dell’attuale configurazione del fuori casa, capillare e diffusa, su tutto il territorio.
2.2.1. Forme di supporto

È utile riprendere alcuni dei temi più rilevanti emersi nel Primo Rapporto, a partire dall’importanza strategica della Distribuzione Horeca.
Infatti, se il fuori casa all’allentarsi dell’emergenza sanitaria è potuto ripartire, peraltro modulando l’offerta sulle nuove esigenze dei cittadini, è anche perché la Distribuzione Horeca, come settore di connessione tra industrie produttrici ed imprese del fuori casa, ha continuato ad operare assumendosi i rischi di approvvigionamenti puntuali di cibi e bevande a costi sostenibili per soggetti dalla solvibilità claudicante.
In questa fase, poi, le piccole imprese che compongono il settore, dopo aver subìto l’urto dello straordinario periodo del Covid-19 con restrizioni, chiusure, difficoltà di esercizio della propria attività, hanno dovuto registrare sui propri conti economici l’impatto tremendo dei rialzi dei costi dell’energia e, più in generale, della pressione inflazionistica sulle forniture e sui costi di funzionamento. La fragilità economica e finanziaria strutturale di una parte consistente delle attività del settore, unita agli effetti prolungati in termini debitori del periodo della pandemia, quando in tanti hanno avuto fatturati azzerati, le ha portate in prossimità del punto di fuga dal mercato e, ancora una volta, è stata vitale l’azione della Distribuzione Horeca che ha agito come banca di fatto.
Un settore strutturalmente fragile ha potuto resistere e rilanciarsi perché si è trovato con le spalle coperte dal supporto di un altro settore, la Distribuzione Horeca che a sua volta in modo permanente, con modalità flessibili in relazione alla mutevolezza dei contesti, ha garantito respiro nei pagamenti elargendo così credito sostanziale, oltre agli approvvigionamenti che hanno consentito alle imprese di continuare a fare fatturato.
Come più volte evidenziato, non ci sarebbe il fuori casa come quello in essere, e quindi anche il valore economico e sociale che esso crea, se non ci fosse tra l’industria e il pulviscolo differenziato di esercizi del fuori casa un settore che ha intenzionalmente assunto l’onere economico ed operativo di una molteplicità di funzioni di raccordo e supporto.
Per questo la Distribuzione Horeca è molto di più che un anello di connessione in una filiera complessa: è il soggetto senza il quale il mondo del fuori casa andrebbe incontro ad una ristrutturazione feroce che ne muterebbe i connotati, con una pericolosa morìa di piccole imprese che sono non solo la fonte di reddito per una moltitudine di famiglie di titolari e dipendenti, ma anche committenza per tante imprese dell’industria del food & beverage.
Oltre alla molteplicità di funzioni di supporto economico e finanziario che la Distribuzione Horeca esercita nei confronti degli altri attori della filiera e, in particolare, a beneficio della moltitudine di operatori sui territori, va richiamata una funzione ulteriore che si potrebbe definire di pedagogica promozione dell’upgrading della cultura della filiera.
È una funzione aggiuntiva, troppo spesso in ombra rispetto ad altre più operative e urgenti, che però ha una rilevanza fondamentale poiché consente alle piccole imprese del settore, spesso familiari, di avere interlocutori con più alte competenze e maggior spessore imprenditoriale, e quindi di beneficiare di supporto e consulenza per decisioni che, poi nel concreto incidono molto sugli esiti dell’attività aziendale.
Questa dimensione di supporto culturale ai vari livelli che viene svolta a beneficio degli imprenditori del settore non può più non includere anche la promozione di un approccio più evoluto a cultura e gestione della Movida, e più in generale alla promozione della relazionalità fuori casa.
Infatti, il fuori casa è l’infrastruttura sociale della relazionalità e la Movida ne rappresenta una modalità di fruizione sui territori. Pertanto, è evidente come sia uno degli ambiti in cui è più urgente il supporto di operatori come quelli della Distribuzione Horeca che possono aiutare a fare le scelte giuste.
In fondo, si tratta di valorizzare un canale di comunicazione e scambio già operativo e che, ad esempio, ha già dato buoni risultati in materia di promozione di prodotti locali, che spesso sono stati scoperti e inseriti nelle loro offerte dagli
operatori dei punti vendita del fuori casa proprio su sollecitazione della Distribuzione Horeca.
Inoltre, come sarà approfondito più avanti, la funzione di promozione dell’upgrading della cultura della filiera è rilevante anche per la transizione sostenibile del settore.
Infatti, gli operatori della Distribuzione Horeca possono stimolare e supportare i tanti piccoli imprenditori del fuori casa ad adottare soluzioni più in linea con le nuove sensibilità e i nuovi valori dei consumatori, generando anche positivi effetti sui conti economici delle imprese coinvolte.

2.3. Nuove sfide in avanti: la sostenibilità
2.3.1. Qualità della vita e valore della relazionalità
Nel periodo segnato dal susseguirsi di emergenze, la sostenibilità si è affermata come componente costitutiva della cultura sociale collettiva e, anche, come criterio ordinatorio primario di attività economiche e sociali.
Troppo spesso, però, prevale una visione ristretta e semplificatoria, schiacciata sulla dimensione della tutela ambientale e della lotta al riscaldamento globale.
Certo che è una dimensione decisiva, perno di tanta nuova programmazione Ue che poi ricade nei processi operativi nazionali, che orienta e condiziona l’attività delle aziende e gli stessi comportamenti dei cittadini; e tuttavia da sola non riuscirà a modificare l’economia e la società.
Intanto il boom dei costi dell’energia, amplificato dall’aggressione russa all’Ucraina, ha imposto di considerare al fianco della dimensione ambientale quella economica, di sostenibilità dei budget delle famiglie, delle imprese e degli Stati. Inoltre, è diventato evidente che non si possono abbandonare in toto le forme di energia più tradizionali in assenza di soluzioni in grado di garantire flussi adeguati di energie alternative a costi accessibili per una società abituata al benessere diffuso.
Prende quota anche la dimensione sociale, quella dell’inclusione che richiede sempre maggiore puntualità ed efficacia poiché, ad esempio, deve consentire la partecipazione piena alla vita economica e sociale delle tante componenti della popolazione. È l’obiettivo della diversity a cui se ne aggiungono altri ancora, dal rispetto dei diritti dei tanti stakeholder della vita economica e d’impresa al coinvolgimento nei processi decisionali d’impresa come della società.
Ambiente, economia e società si sono quindi imposti come le tre dimensioni
che devono convivere per la trasformazione sostenibile della società. Tuttavia, a questo stadio è fondamentale ampliare il significato di sostenibilità con una dimensione poco richiamata e che invece risulta decisiva: la qualità della vita. Infatti, dal contesto ambientale a quello economico e sociale l’esito complessivo non potrà che essere una migliore qualità della vita dei cittadini. Pertanto, quando si parla di transizione verso una società più sostenibile non si può non considerare oltre alla tutela ambientale, che implica beni e servizi accessibili così da generare anche inclusione sociale, anche una più alta e diffusa qualità della vita che risponda alle aspettative dei cittadini, a cominciare da una relazionalità gratificante, che soddisfa e risponde alla domanda di socialità.
È importante valorizzare il richiamo alla qualità della vita come componente costitutiva della società sostenibile, il cui raggiungimento deve guidare ed essere visibile anche nella fase di transizione. Altrimenti sarà molto difficile ottenere una elevata social acceptance all’idea stessa di società sostenibile e più ancora alla transizione verso tale modello.
Da qui l’importanza di un focus sui tanti e diversi aspetti che contribuiscono a determinare una buona qualità della vita e, considerando la filiera del fuori casa, l’attenzione non può non soffermarsi sul valore della relazionalità e delle modalità con cui le persone riescono a costruire e gestire relazioni con gli altri.
In estrema sintesi: la sostenibilità è un concetto più ampio delle dimensioni ambientale, economica e sociale perché ingloba anche il diritto trasversale, di tutti, ad una qualità migliore della propria vita.
In tale contesto, come rilevato, assume un valore particolare la relazionalità, di cui gli italiani sono stati a lungo privati a causa dell’emergenza sanitaria, e che invece è un elemento costitutivo del benessere soggettivo. Per questo è fondamentale fissare l’idea che una società più sostenibile non potrà che portare anche verso una moltiplicazione delle opportunità relazionali, perché è uno dei percorsi obbligati per migliorare la qualità della vita delle persone.
In questo quadro, parlare di sostenibilità in relazione agli attori della filiera del fuori casa impone di considerare non solo gli adempimenti a cui essi sono chiamati relativamente ai processi e prodotti della loro attività, ma anche allo specifico valore aggiunto che il settore offre, in termini di piattaforme relazionali, a beneficio della qualità della vita. Un aspetto che sempre più andrà considerato componente costitutivo di una società in transizione verso la sostenibilità.
È utile approfondire ulteriormente il complesso nesso tra fuori casa e sostenibilità, poiché quest’ultima ha molteplici significati concreti per la filiera ed i suoi protagonisti.
In primo luogo, c’è la preferenza dei consumatori per prodotti la cui produzione e distribuzione sia in linea con i precetti della sostenibilità. Le persone, infatti, vogliono acquistare prodotti a minore impronta ecologica, che non lasciano una scia di inquinamento perché, ad esempio, non sono oggetto di spostamenti troppo lunghi.
Man mano che nella società si radicheranno i valori della sostenibilità, dall’attenzione alla tutela ambientale e alla lotta al riscaldamento globale con un conseguente adattamento dei criteri di acquisto, anche gli operatori del fuori casa dovranno adattarsi.
Di certo avranno un vantaggio competitivo quelli che riusciranno a rispondere meglio al nuovo sistema di valori e relativi criteri di acquisto dei consumatori.
Quest’ultimi sceglieranno maggiormente gli esercizi pubblici che garantiranno la disponibilità di prodotti in linea con i valori della sostenibilità.

Analogo il processo evolutivo relativo alla scelta dei locali, perché di certo avranno un vantaggio competitivo quelli che rispetteranno in modo trasparente e verificabile i precetti della sostenibilità. In questo caso conta anche la sostenibilità sociale, cioè il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei fornitori. In tal senso, le storie relative allo sfruttamento estremo o alle retribuzioni distanti dai valori medi che emergono sui social, generano un effetto negativo sulla social reputation delle aziende coinvolte, che è già oggi consistente.
C’è poi la necessità che i prodotti e le imprese sostenibili garantiscano anche la sostenibilità economica, con prezzi accessibili per i clienti e, al contempo tali da garantire la tenuta dei conti economici delle aziende e dei relativi livelli occupazionali.
Va poi richiamata una dimensione ulteriore della sostenibilità specificamente legata al fuori casa che rinvia all’impatto che la sua azione ha sulla qualità della vita delle persone e le comunità. È un aspetto che sarà sempre più decisivo della sostenibilità, che costituisce un di più del fuori casa nel rapporto con essa.
Il fuori casa, infatti, offre luoghi organizzati, gratificanti, accessibili per fruire di una relazionalità che soddisfa e rende migliori i contesti in cui è presente, migliorando la qualità della vita delle persone.
Custodi e promotori di una relazionalità positiva: è questo il ruolo della filiera del fuori casa, quel che la rende uno dei motori di una sostenibilità compiuta perché oltre alla tutela dell’ambiente, a prezzi che facilitano l’accessibilità, genera il valore immateriale della relazionalità che fa decollare la qualità della vita delle persone.
Il di più che il fuori casa garantisce è particolarmente importante in questa fase in cui la società è impegnata nella transizione alla sostenibilità perché, a fronte di una molteplicità di aspetti del nostro tempo che attaccano la qualità della vita, essa, alimentando la piattaforma relazionale nella società, opera per preservare e migliorare la qualità della vita.
È importante anche perché in questa fase la società è alle prese con emergenze difficili ed è costretta anche a ripensare i propri stili di vita, spesso in modo restrittivo, per rispettare i nuovi criteri di tutela ambientale o di sostenibilità economica.
Pertanto, si può dire che la transizione alla sostenibilità dal punto di vista delle persone ha una desiderabilità che molto dipende dagli effetti concreti che esercita sulle vite, e se il tutto si dovesse risolvere in una moltiplicazione di adempimenti quotidiani con una riduzione di fatto della qualità della vita e del benessere soggettivo, allora diventerebbe alto il rischio di una reazione avversa.
È evidente che una traslazione semplificata dei temi della sostenibilità alla filiera del fuori casa rischia di sottovalutare il suo contributo complessivo alla società sostenibile ed anche alla transizione ad essa. Se, infatti, ci si limita a considerare solo l’adattamento ai precetti green delle attività di produzione dei servizi del fuori casa ed il rispetto dei precetti della sostenibilità economica e sociale, si finisce per perdere di vista il suo contributo complessivo.
Come rilevato, il fuori casa crea relazionalità, ne consente la fruizione di massa, organizzata, gradevole e così facendo migliora la qualità della vita delle comunità in cui eroga i suoi servizi e dei cittadini che ne fruiscono.
È come se aggiungesse qualcosa all’idea di sostenibilità, portandola oltre la visione che la intende solo come una sorta di pratica concreta di imprese e cittadini che hanno obiettivi, scelte e comportamenti coerenti, misurabili e verificabili.
La sostenibilità in senso ampio, invece, non è e non deve essere una sommatoria di precetti tecnici da rispettare o il portato di grandi programmi sovranazionali che ricadono nel quotidiano, ma un processo sociale che coinvolge, mobilita e struttura stili di vita, culture sociali, modi di lavorare, produrre, distribuire e consumare.
Ecco perché è importante la soggettività delle persone che concretamente devono adottare certi comportamenti e, di conseguenza, le modalità con cui nel quotidiano percepiscono e praticano la sostenibilità.
Ed è molto difficile rendere socialmente coinvolgente una prospettiva che non espliciti, anche nella fase della transizione, la sua capacità di innalzare la qualità della vita delle persone.

Guai a sottovalutare lo stato d’animo degli italiani in questa fase storica, molto provati da almeno un triennio di sacrifici, stress, difficoltà inedite, disillusioni rispetto all’idea del new normal come riproduzione della normalità pre Covid. Non sorprende che vada emergendo anche una soggettività recalcitrante, refrattaria a mobilitarsi salvo poi ritrovarsi ad affrontare ulteriori costrizioni e sacrifici.
C’è nella società una stanchezza per la persistenza di eventi avversi che portano sempre nuove rilevanti sfide nel quotidiano. L’80,3% degli italiani dichiara di sentire il peso degli ultimi anni difficili, duri, fatti di sacrifici e impegni di fronte ad eventi inattesi. In pratica, gli italiani in questa fase sono convinti che di sacrifici ne hanno fatti e ne dovranno fare ancora tanti, e, pertanto, valutano come puro autolesionismo aggiungerne altri, non importa se in nome di una società che nel tempo dovrebbe essere migliore perché tutela l’ambiente.
È la ragione per cui occorre una visione alta e ampia della sostenibilità, ben oltre i suoi limiti solo ambientali o tecnico-astratti, per entrare nella molteplicità di aspetti senza i quali difficilmente potrebbe imporsi. Non ci può essere sostenibilità ambientale senza inclusione economica, ma non ci può essere sostenibilità senza l’indicazione che produrrà anche una migliore qualità della vita.
Perché ciò sia possibile, una società sostenibile deve disporre di un tessuto relazionale significativo, in grado di generare ricadute positive sulla qualità della vita ed il benessere delle persone e delle comunità.
È qui che si innesta l’apporto specifico della filiera del fuori casa che, se da un lato adotta criteri di sostenibilità dalla produzione, dai servizi ai prodotti, dall’altro però, tramite la buona relazionalità, contribuisce ad innalzare la qualità della
vita individuale e collettiva.
In definitiva, il fuori casa rende più sostenibile la società non solo perché pratica il green economicamente sostenibile e inclusivo, ma perché la sua attività è di per sè stessa promozione di una dimensione costitutiva della società sostenibile, la buona qualità della vita, ed è anche origine di una più facile transizione ad essa.
2.3.4
È utile comprendere al meglio l’importanza del miglioramento della qualità della vita, anche grazie ad una relazionalità appagante, come motore di conquista di consenso per la transizione sostenibile.
Si è già evidenziato come attualmente vada emergendo socialmente una stanchezza per i tanti eventi avversi e per i sacrifici dell’ultimo triennio, e va anche emergendo una certa insofferenza per quella sobrietà di fatto a cui alludono retoriche green che demonizzano i consumi e colpevolizzano i non conformi. Tanti sono, infatti, gli italiani che ritengono che la propria vita sia ormai troppo piena di ingiunzioni invasive che vorrebbero colpevolizzare le persone. A questo proposito, ad esempio, al 79% degli italiani dichiara che capita di sentirsi colpevole quando non adotta comportamenti ecosostenibili, cioè se ritiene di sprecare cibo, di non praticare la differenziata per i rifiuti, di acquistare o gettare prodotti in plastica. Non solo: il 79,2% degli italiani teme il razionamento dell’acqua e sente la pressione di diktat relativi ad utilizzi non conformi a criteri di sobrietà di essa. Le persone si sentono giudicate per docce prolungate, per aver lavato l’auto o, anche, per avere innaffiato il giardino. Così, la sostenibilità a livello sociale viene troppo spesso associata di fatto a forme di colpevolizzazione nel quotidiano che pesano sui singoli e vorrebbero indurli ad adottare comportamenti che, di fatto, sono percepiti come rinunce, privazioni, sacrifici. È evidente che una tale visione della transizione sostenibile è ad alto rischio di subire un rigetto da parte degli italiani.
Ecco perché è fondamentale sia allentare la pressione delle visioni più estreme della sostenibilità sia innestare dentro alla trasformazione sostenibile della società anche aspetti più positivi, virtuosi, di miglioramento della qualità della vita. In fondo, vale la pena impegnarsi nel quotidiano per una società sostenibile non solo come risposta all’emergenza ambientale, ma anche perché include valori di prossimità, di socialità, di maggiore e migliore relazionalità tra le persone e,
quindi, di migliore qualità della vita.
Senza questa dimensione, per la quale sono decisivi anche i promotori di relazionalità, è alto il rischio che la sostenibilità sia percepita dalla maggioranza dei cittadini come grezza, troppo pressante e, di conseguenza, come un obiettivo per il quale non vale la pena coinvolgersi e che, anzi, genera ripulsa.

2.4.1.
Considerando le tre componenti classiche della sostenibilità, emerge che la filiera del fuori casa è avanzata nella sua ridefinizione.
Infatti, sul piano ambientale oltre agli adeguamenti dei diversi aspetti di esercizio delle attività, a volte imposti dalla legge a volte esito di scelte anticipatorie degli operatori del settore, c’è attenzione agli effetti delle attività sul contesto anche, ad esempio, attraverso la valorizzazione di prodotti locali, scelta che ha effetti molto positivi sia sulla riduzione dell’impronta ecologica sia sulle opportunità di sviluppo locale.
Poi c’è la dimensione sociale relativa ai diritti degli occupati in ogni fase del processo lavorativo e a quella dei fornitori.
Per la Distribuzione Horeca va richiamata anche la già citata dimensione economica e sociale implicita nell’esercizio della funzione di approvvigionamento, decisiva per un settore così diffuso sul territorio in cui una molteplicità di attività micro hanno difficoltà a garantirsi equilibri di budget nel tempo.
Contribuendo alla sostenibilità economica degli esercizi pubblici, la Distribuzione Horeca assolve a funzioni sociali decisive, come garantire i redditi di una molteplicità di famiglie coinvolte dalle attività delle imprese del settore, una committenza rilevante per gli operatori industriali, la tenuta sociale di intere comunità a rischio depauperamento e svuotamento economico e relazionale qualora il tessuto di imprese del fuori casa cessasse la propria attività.
Più in generale, è forte l’impegno del fuori casa sul green, anche perché sta crescendo nel quotidiano il peso dei criteri di sostenibilità nelle scelte di acquisto dei consumatori. È, infatti, alta la quota di italiani che dichiara di preferire prodotti sostenibili o che sono proposti da aziende sostenibili. La pressione della domanda inevitabilmente obbliga gli attori dell’offerta a ripensarsi, adottando riferimenti green.
Per fissare con maggior concretezza lo stato di avanzamento della filiera del fuori casa rispetto alla sua ridefinizione in linea con i precetti della sostenibilità, è utile partire dall’evoluzione del rapporto degli italiani con il cibo. Infatti, nell’immaginario collettivo il rapporto con il cibo ha una sua centralità perché incorpora il piacere di stare insieme, è funzionale alla buona salute e al benessere e, mediante la scelta degli alimenti e la corrispondente dieta, le persone tendono a proiettare un’immagine di sé stessi e, addirittura, ritengono di dare così un proprio contributo a cambiare in meglio il mondo.
Nel tempo, come più volte rilevato, è cresciuta l’attenzione degli italiani alla sostenibilità ambientale, alla lotta al riscaldamento globale, e la spesa e i consumi alimentari sono stati da tanti italiani rimodulati anche in funzione di tali nuovi valori. È un mutamento copernicano del rapporto con il cibo, che porta a dare valore a quel che si presenta come sostenibile perché è stato prodotto riducendo l’impronta ecologica. Queste nuove sensibilità alimentari non restano in casa quando le persone si recano nei luoghi del fuori casa. Pertanto, anche questa dimensione è sempre più investita dai nuovi criteri green.
Infatti, ben il 91,1% delle persone apprezza molto i locali che comunicano in modo trasparente le pratiche ecologiche quali, ad esempio, la riduzione degli sprechi, la differenziata per i rifiuti, il ricorso a prodotti bio o a chilometro zero (fig. 1)

È un’opinione condivisa da quote plebiscitarie trasversalmente ai gruppi sociali ed ai territori.
Si tratta di un’onda già alta di nuova valutazione di locali e prodotti nel fuori casa destinata a restare e con cui gli operatori, già da tempo, fanno i conti adottando opportune politiche di riadattamento delle proprie attività e offerte. Farsi riconoscere come green, non a parole ma con fatti verificabili, è oggi una sfida importante per gli operatori del fuori casa e della Distribuzione Horeca, poiché il racconto della sostenibilità di un’azienda del fuori casa tende a valorizzarsi se include anche il richiamo a filiere sostenibili.
È una stagione nuova appena agli inizi, che è destinata ad essere via via sempre più connotata da questa dimensione della sostenibilità ambientale come criterio valutativo concreto dei consumatori che, appunto, preferiscono quel che si fa riconoscere come green rispetto ad eventuali alternative.
Altro esempio, semplice ma emblematico, è relativo alle pratiche anti-spreco, che sono particolarmente apprezzate dagli italiani. Così, se fino a qualche anno fa la richiesta, soprattutto ristoranti, di avere un contenitore per raccogliere e portare via dal locale i resti dei pasti consumati sarebbe parsa fuori luogo, oggi addirittura il 58% dei giovani è pronto a farlo. L’esito è la messa a disposizione in tanti locali di soluzioni per l’impacchettamento e il trasporto dei prodotti non consumati.
Lo stimolo dei consumatori nei confronti dei protagonisti del fuori casa nell’intraprendere il sentiero della più alta sostenibilità è molto forte perché, come in altri ambiti del consumo alimentare, si materializza in richieste precise a cui le imprese non possono che adattarsi.
Il fuori casa non si è certo sottratto a tale nuova sfida, al contempo però è un percorso lungo in cui sarà senz’altro di notevole utilità la funzione di upgrading della cultura di filiera che, come rilevato in precedenza, la Distribuzione Horeca in molti casi ha assunto e che, presumibilmente, dovrà esplicarsi anche nelle scelte relative alla ridefinizione sostenibile della filiera.
A questo proposito, è utile considerare alcune delle richieste più diffuse tra i consumatori che impattano anche sulla composizione della domanda rivolta al fuori casa. In primo luogo, come rilevato in precedenza, c’è la richiesta di poter verificare le pratiche ecologiche, da economia circolare che un’impresa dichiara

di utilizzare. La trasparenza è un valore molto apprezzato, tanto più in tempi di fake news e, anche, di storytelling fondato su forme diversificate di green washing.
Questo è un punto essenziale su cui gli operatori del settore, come di altri ambiti della filiera del cibo, devono concentrare la propria attenzione: guai a promuovere rappresentazioni non veritiere del proprio operato sulla sostenibilità, perché ogni fake rischia di avere effetti di ritorno dirompenti.
Altra richiesta molto diffusa e che fa molto apprezzare i luoghi del fuori casa è la provenienza verificabile di un prodotto da un determinato territorio, che nella percezione collettiva dei consumatori è garanzia di qualità e sicurezza del prodotto alimentare.
Made in Italy, chilometro zero e provenienza certificata o comunque verificabile da un territorio ad alta social reputation sono altrettanti fattori virtuosi che valorizzano la percezione del fuori casa agli occhi degli italiani. Una cultura adeguata della filiera non può che trasformare in altrettante pratiche operative tali richieste, rendendo verificabili le soluzioni che sono messe in campo.
È indubbio che la Distribuzione Horeca può giocare un ruolo importante nell’upgrading della cultura della sostenibilità della filiera del fuori casa. La moltitudine di operatori del settore, infatti, è troppo spesso pressata dai vincoli del conto economico o dall’operatività minuta del quotidiano e non è nelle condizioni di promuovere mutamenti di fondo, investimenti culturali relativamente alla propria offerta. È così fondamentale un ruolo di orientamento, consulenza, proposta di processi e prodotti da parte delle Distribuzione Horeca.
L’accelerazione della transizione sostenibile del settore dipende probabilmente in misura significativa anche dall’esercizio compiuto della funzione di stimolo della Distribuzione Horeca nei confronti delle imprese clienti, portandole a prendere nella dovuta considerazione gli orientamenti green, salutari e di attenzione alla sostenibilità ampiamente intesa degli italiani.
Negli stimoli della Distribuzione Horeca agli attori del fuori casa va dato uno spazio rilevante anche al rapporto con il lavoro, vista la propensione a garantire quello regolare, preferibilmente a tempo indeterminato nel rispetto delle normative e in generale dei diritti.
È cosa non scontata nel nostro tempo e soprattutto ha un valore più alto in una
filiera in cui ci sono stati casi di infiltrazione di imprese, che hanno ricorso a modalità irregolari di utilizzo del lavoro.
La buona imprenditorialità che gestisce la gran parte del fuori casa è stata quindi costretta a fronteggiare la competizione sleale di imprese che utilizzano lavoro nero o irregolare.

Invece la sostenibilità, intesa in senso ampio, richiede il rispetto dei diritti del lavoro, e sotto questo profilo la Distribuzione Horeca è sicuramente una best practice e pertanto può esercitare un effetto positivo sul resto della filiera, tramite la potenza imitativa del buon esempio e anche ricorrendo a forme di moral suasion. In questo senso, la Distribuzione Horeca diventa l’alleata migliore dell’imprenditorialità, che vuol operare all’interno delle regole di mercato, fatte di competizione ma senza colpi bassi o slealtà legate a forme di irregolarità.
con la sollecitazione le varie dimensioni della sostenibilità, la Distribuzione Horeca contribuisca alla modernizzazione della filiera, portandola sulla frontiera più avanzata dei valori sociali degli italiani.
Se è vero che cresce l’attenzione dei consumatori anche alla sostenibilità sociale, allora è evidente che l’adeguamento delle modalità di rapporto con il lavoro costituisce non solo un adeguamento valoriale, ma anche un investimento economico che può portare a buoni risultati sul piano del fatturato e del conto economico delle imprese.
È un’ulteriore indicazione di come, promuovendo con l’esempio e
Nell’ultimo triennio gli italiani hanno fatto propria la convinzione che tutto può accadere, anche gli eventi più estremi che a lungo hanno considerato solo oggetto di romanzi di fantascienza. Negli ultimi tre anni, invece, abbiamo avuto una pandemia, il lockdown, la crisi energetica e il ritorno della guerra di trincea, oltre che il rischio del ricorso all’atomica.
Pertanto, nel sentiment della maggioranza degli italiani c’è ormai l’idea che occorra convivere con il rischio che eventi globali modifichino d’improvviso e in modo radicale il contesto quotidiano in cui si svolge la vita.
Poiché si moltiplicano tali rischi, il quotidiano delle persone si va strutturando, facendo i conti con questa ansia da catastrofe dietro l’angolo, che è molto più che uno stato mentale, poiché è il riflesso della materialità della vita individuale e collettiva. Sono infatti ormai tanti e diversificati i rischi globali sui quali non si ha controllo e che si ritiene possano stravolgere le vite.
Così, ad esempio, è cresciuta l’eco-ansia con il 68,3% degli italiani che dichiara di avere paura che il pianeta e la vita umana finiscano in catastrofe a causa del riscaldamento globale, dell’inquinamento o di altri eventi atmosferici avversi. Inevitabilmente quella italiana è oggi una società insicura, con il 66,5% delle persone (+10 punti percentuali rispetto al 2019) che, pensando al futuro proprio, si sente insicuro.
Il fenomeno chiave è l’assottigliamento del diaframma tra grande storia e microstorie di vita: qui nasce la percezione di rischi di tipo nuovo incontrollabili e, per questo, ancor più potenti e insinuanti. Quel che qui interessa sottolineare è che, ora che la storia ha ricominciato a correre, il quotidiano non è più segnato da una sorta di quieto andare, ed è reso ancor più ansiogeno dal racconto in presa diretta che ne viene fatta dalla comunicazione incessante e ininterrotta, dove a chiunque è concesso di partecipare
alla produzione di informazioni e, più ancora, alla moltiplicazione di tensioni generate da notizie vere o false.
Il mood generale, quindi, è segnato da paura, ansia, incertezza e anche, per l’82,4% degli italiani da un senso di disorientamento, visto che stentano a capire quello degli eventi che hanno luogo.
È questo il quotidiano in cui si svolgono le attività di vita delle persone e in cui, pertanto, è indispensabile valutare il senso, il peso e il valore che le persone attribuiscono a ciascuna delle proprie attività.
3.2. Un valore attualissimo

Se il periodo pandemico, marcato da divieti e restrizioni, ha quasi costretto gli italiani ad apprezzare ancor di più, per astinenza, il valore del fuori casa e della molteplicità di esperienze di relazionalità nei suoi luoghi, il nuovo contesto di rischi globali incombenti, a sua volta, valorizza ulteriormente, seppure in modo diverso, il fuori casa.
Pertanto, gli italiani sono stati portati a guardare il rapporto con il fuori casa e, in generale, con la dimensione della convivialità, meglio se intorno ad una tavola condividendo cibo e bevande, con nostalgia e poi con una grande voglia di recuperare il tempo perduto. Ciò rinvia ad un aspetto fondativo dello stile di vita degli italiani.
“Mangiare insieme è il fondamento dell’identità culturale e della continuità delle comunità in tutto il bacino del Mediterraneo. È un momento di scambio sociale e di comunicazione, affermazione e rinnovamento dell’identità di famiglia, gruppo o comunità. La dieta mediterranea mette in risalto i valori dell’ospitalità, della vicinanza, del dialogo interculturale e della creatività e un modo di vivere guidato dal rispetto per la diversità”.
Sono le parole dell’Unesco che spiegano la scelta di iscrivere la dieta mediterranea nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, rimarcando l’importanza attribuita dalle persone allo stare insieme, alla condivisione di cibi e bevande, al tempo da trascorrere in un clima di serenità all’insegna del benessere psicofisico.
Sono concetti che ben si applicano alla buona dieta italiana, rendendo evidente l’esistenza di una radice culturale profonda e antica, che lega lo stile di vita degli italiani al rapporto con il cibo ed alla relazionalità che intorno ad esso si crea.
Si può dire che, al di là delle specificità del nostro tempo, la convivialità intorno
alla condivisione di pasti e bevande è componente caratterizzante dell’identità culturale degli italiani.
Nel mondo segnato dalla globalizzazione degli stili di vita con relativa omogeneizzazione di aspetti costitutivi del quotidiano le specificità nazionali, come ad esempio la convivialità a tavola degli italiani, nella migliore delle ipotesi venivano lette come persistenze folkloristiche, magari da utilizzare per attrarre flussi turistici.
Invece, come rilevato, il nesso tra socialità ed enogastronomia, così ben espresso dalle parole dell’Unesco per la dieta mediterranea, è molto di più che folklore funzionale al buon marketing turistico: è un componente costitutivo dello stile di vita italiano, molto apprezzato anche all’estero.
Le emergenze di questi anni, sia nella fase dei restringimenti e divieti sia in quella più recente delle rinnovate difficoltà economiche, non hanno fatto altro che rendere ancor più evidente il valore soggettivo che le persone gli attribuiscono e l’importanza che riveste per il benessere individuale e collettivo. Ad una buona relazionalità nel fuori casa sono legate dimensioni fondamentali della nostra società e, pertanto, sminuire o svilire queste dimensioni afferenti all’attività del fuori casa o ridurre quest’ultimo ad un settore che risponde a fabbisogni voluttuari, significa non cogliere aspetti sostanziali del punto di vista degli italiani su società e vita attuale.
Il 92,9% degli italiani dichiara che lo stare insieme per bere e mangiare è uno degli aspetti fondamentali dello stile di vita italiano, ed è un’opinione condivisa trasversalmente ai gruppi sociali e ai territori (tab. 1). Lo pensa infatti:
• il 92,6% degli uomini ed il 93,6% delle donne;
• il 91,8% delle persone con al più la licenza media, il 93,4% dei diplomati ed il 94,8% laureati;
• l’87,9% dei 18-34enni, il 93,9% dei 35-64enni ed il 94,6% degli anziani;
• il 94,6% dei residenti nel Nord-Ovest, il 93,3% del Nord-Est, il 93% del Centro ed il 91,3% del Sud-Isole.
Sono dati che confermano che, malgrado i rivolgimenti degli ultimi anni, la convivialità resta una componente consolidata della cultura sociale collettiva italiana e parte integrante dell’identità nazionale.
Sono risultati inequivocabili, che non lasciano dubbi sul fatto che per la grande maggioranza dei cittadini la convivialità a tavola sia molto più che una semplice funzionalità quotidiana.

Riunirsi per trascorrere tempo insieme condividendo pasti e bevande è anche il fulcro di una molteplicità di eventi e ricorrenze familiari e della comunità.

È praticamente impossibile fare riferimento ad una celebrazione o ricorrenza, anche a livello locale, senza associarla a cibi e bevande spesso tipici del territorio. Ci sono poi un’infinità di sagre e festival in cui il cibo e le bevande sono ancor di più moltiplicatori di socialità.
Al fianco di fattori di contesto più congiunturali legati agli eventi straordinari di questi anni che hanno generato nostalgia e voglia di tornare al fuori casa, ci sono aspetti più strutturali di lungo periodo, culturali poiché legati da lungo tempo allo stile di vita italiano.
Sono considerazioni che amplificano il ruolo della filiera del fuori casa, perché è anche dalla sua azione che dipende il buon esito della convivialità intorno al cibo, dimensione molto italiana largamente riconosciuta e apprezzata a livello globale.
4.1.
Molto si è insistito nel periodo emergenziale e anche per una parte del dopo emergenza sullo spostamento definitivo del baricentro delle vite individuali e collettive verso la domesticità. In troppi hanno ritenuto imminente una sorta di cambio di civiltà, con una concentrazione di attività all’interno degli ambienti domestici e, più ancora, la fine del fuori casa. In realtà, negli ultimi tempi è andato sempre più emergendo che nel concreto delle vite delle persone è in atto una soggettiva ricerca di equilibri migliori per modelli ibridi tra casa e fuori casa. Lavoro, studio, tempo libero e poi, anche, relazioni amicali e molto altro ancora, tutto viene rivisto alla luce del ritorno delle opportunità della compresenza fisica.
È indubbio che il digitale ha reso altamente spendibile il remote e, tuttavia, resta che la relazionalità diretta, quella che nasce dalla compresenza fisica e, poi, anche dalla frequentazione di luoghi diversi rispetto a quelli soliti, dall’abitazione al luogo di studio e lavoro, resta un obiettivo e un valore riconosciuto dalle persone. Non solo non c’è la fine del fuori casa e della voglia di convivialità nei luoghi diversi dalle abitazioni, ma esse trovano uno specifico e più alto valore dentro i nuovi equilibri ibridi.
Infatti, quanto più le persone lavorano o studiano o trascorrono parte del tempo libero in casa, tanto più sono motivate dalla voglia poi di incontrare amici in contesti diversi, piacevoli, originali, in cui divertirsi, staccare rispetto alle routine ed ai luoghi più frequentati del quotidiano.
Al di là degli aspetti economici, sul piano delle scelte soggettive è evidente che la voglia di fuori casa resta molto alta sia per la convivialità del tempo libero sia per quella business, anche come effetto del fatto che per altre attività si tende a stare di più in casa.
4.2.1. Attuali

Quanto è diffuso il fuori casa tra gli italiani, in che misura escono la sera per recarsi nei luoghi del fuori casa? È il quesito diretto a cui rispondono i dati dell’indagine del Censis.
Il 47,3% degli italiani quando esce la sera si reca in locali pubblici, preferibilmente nei luoghi della Movida: l’8,8% lo fa quasi sempre, il 10% almeno una volta ogni quattro e il 28,5% lo fa sempre. Un’abitudine largamente diffusa tra gli italiani, con differenze di un certo interesse (fig. 2).

Infatti, quando escono la sera si recano con maggior frequenza presso i luoghi della Movida ovviamente i giovani (83,5%) e gli adulti (52,4%), i laureati (58,8%) ed i diplomati (54,5%) e poi i maschi (56,4%). Non distanti sono le quote di frequentatori delle quattro macroaree geografiche. Sono dati che pur mostrando che alcuni gruppi sociali hanno una più alta propensione ad associare le uscite serali ai locali del fuori casa in particolare nei luoghi della Movida, confermano anche che è un’abitudine diffusa trasversalmente.
Hanno una coincidenza più alta tra uscite serali e frequentazione dei luoghi del-
la Movida, ovviamente i giovani tra i quali il 22,9% quasi sempre fa tale scelta, e i residenti dei Comuni più grandi (17,7%).
In ogni caso, quel che è importante sottolineare è che nei luoghi della Movida non si recano solo i giovani o gli stakanovisti della vita notturna, ma persone con caratteristiche sociodemografiche ed economiche molto diverse tra loro.
È interessante enucleare anche la domanda potenziale di fuori casa, vale a dire le persone che rispetto ai loro standard attuali avrebbero voglia di uscire e vivere di più la sera o notte, presumibilmente recandosi anche nei luoghi del fuori casa.
È il 40,3% degli italiani a dichiarare che gli piacerebbe uscire di più la sera perché sarebbe importante per le relazioni e la qualità della vita (tab. 2). Ecco richiamati:
• il nesso stretto tra la possibilità di beneficiare dei servizi di luoghi organizzati per una relazionalità sicura, piacevole intorno a cibo e bevande e la qualità della vita delle persone;
• la voglia di farlo di più, perché è un’abitudine valutata molto positivamente.
A desiderare di uscire di più la sera, nella convinzione che migliorerebbe la qualità della loro vita sono:
• il 55,9% dei giovani, il 45,6% degli adulti ed il 19,3% degli anziani;
• il 54% dei residenti al Nord-Ovest, il 53,3% al Nord-Est, il 47% al Centro ed il 49,4% al Sud-Isole;
• il 34,1% delle persone con al massimo la licenza media, il 44,7% dei diplomati ed il 47,7% dei laureati. Esiste visibilmente uno spazio potenziale di ampliamento ulteriore del fuori casa, con una intenzionalità di uscire con maggiore frequenza dichiarata da quote significative di cittadini, trasversalmente ai gruppi sociali e territori e che quindi coinvolge sia chi già esce con una certa intensità che le persone che attualmente sono più portate a restare in casa.
I4.2.3. Il senso dei dati

I dati confermano sia quanto va emergendo dalla dinamica della spesa per gli italiani per il fuori casa che ha rapidamente recuperato il tremendo tonfo pandemico, sia quanto è osservabile direttamente nei luoghi del fuori casa con un ritorno importante delle presenze.
Come rilevato, sono di particolare interesse i dati sul desiderio di uscire di più la sera, perché delineano una domanda potenziale che potrebbe dispiegarsi, qualora trovasse appropriate condizioni economiche e, presumibilmente, anche un’offerta più modulata sulle proprie esigenze.

Persiste una domanda attuale molto forte di fuori casa, che consentirebbe di

allargare ulteriormente il mercato, malgrado la dinamica inflazionista e le problematiche socioeconomiche che vanno emergendo.
I dati sul punto di vista degli italiani, quindi, confermano quanto rilevato in precedenza: il fuori casa è qui per restare, vale a dire che è una delle modalità predilette dagli italiani per praticare nel quotidiano la convivialità e la relazionalità che, a loro volta, sono componenti costitutive del loro stile di vita. Gli italiani escono con una certa frequenza la sera e la notte, vorrebbero farlo di più e sono convinti che gioverebbe alla qualità della loro vita: ecco il senso ultimo dei risultati emersi che sono molto positivi per le prospettive del settore e che, indubbiamente, richiedono opportuni investimenti da parte degli operatori.
Infatti, come rilevato, i dati mostrano che potenzialmente il mercato del fuori casa è espandibile ulteriormente perché esiste una richiesta potenziale che, al momento, resta allo stato dell’intenzionalità, ma che potrebbe tramutarsi in domanda pagante, presumibilmente anche per effetto di una maggiore attrattività dell’offerta.
Questo è un punto rilevante, poiché mostra non solo che il rapporto con il fuori casa è di massa, strutturale e di lungo periodo resistente alle tante e diverse prove di questi anni, ma è ulteriormente ampliabile, proprio perché risponde ad esigenze profonde e al contempo attualissime degli italiani.
È la smentita all’idea che le emergenze portano le persone a restringere il circuito di vita all’essenziale e, comunque, segnala che il rapporto con il fuori casa, l’accesso ai suoi servizi per una parte fondamentale degli italiani rientra nell’alveo delle cose essenziali su cui spendere.
Gli italiani escono molto la sera ed hanno una propensione diffusa a farlo di più: sono dati di per sé sufficienti, soprattutto se affiancati a quelli relativi alla dinamica della spesa del fuori casa, che consentono di dire che è alto il grado di fiducia e il riconoscimento degli italiani nei confronti degli attori del fuori casa.
È un settore riconosciuto socialmente come importante perché risponde a bisogni concreti e perché accresce il desiderio di utilizzarlo di più.
Ulteriore conferma del positivo giudizio degli italiani sul fuori casa e sul suo
impatto sulle vite individuali e collettive consiste nel fatto che il 70,5% ritiene molto o abbastanza importante che nelle città italiane ci siano luoghi in cui c’è una certa concentrazione di locali dove mangiare, bere, divertirsi, stare insieme. Convinzione che raccoglie il consenso di maggioranze trasversali alle caratteristiche sociodemografiche, economiche e di residenza delle persone, con quote un po’ più alte nei Comuni più grandi (82,2%) e nel Nord-Est (76,2%).

È in ogni caso evidente la visione positiva che gli italiani hanno della filiera del fuori casa e in particolare (tab. 3):

• il 25,6% ritiene che la concentrazione di locali dove mangiare, bere e divertirsi sia molto importante per la buona qualità della vita di tutti;
• il 44,9% ne riconosce l’importanza, anche se focalizza l’attenzione sul positivo impatto che esercita nell’attrarre turisti.
Spicca il giudizio largamente positivo sulla concentrazione di luoghi del fuori casa in taluni territori dei Comuni. È evidente che, al di là della pubblicistica prevalente, nella percezione degli italiani è assolutamente positivo il giudizio per contesti organizzati che creano modalità appropriate per le persone di incontrarsi, mangiare e bere insieme.
Alla luce di queste opinioni così radicate, è evidente che la condensazione dei locali nei territori non può e non deve essere considerata a priori un fatto negativo, laddove è in grado di generare il beneficio delle opportunità relazionali tra persone minimizzando il costo di eventi avversi.
È importante anche il nesso tra aree specifiche del fuori casa e attrattività turistica, poiché rende evidente come nella cultura sociale collettiva non si possono richiamare turisti prescindendo da un’offerta di esercizi pubblici all’altezza delle aspettative degli stranieri verso la convivialità all’italiana. La quota che associa automaticamente l’ingovernabilità dello spazio pubblico all’insieme di locali del fuori casa è assolutamente minoritaria: il 5,6%, quota che resta ridotta trasversalmente ai gruppi sociali ed ai territori.
In pochi credono che i luoghi del fuori casa siano all’origine di fenomeni incontrollabili o ingovernabili, vince invece una visione positiva poiché una concentrazione appropriata di locali contribuisce a migliorare i contesti per i residenti e per i turisti.
Sul nesso tra concentrazione di locali in un determinato territorio e governo dello spazio pubblico o, eventualmente, tutela dell’ordine pubblico, è utile un ulteriore approfondimento, poiché è noto come periodicamente, con eccesso di semplificazione, si tenda ad associare taluni fenomeni di degrado o criminali alla presenza di un numero eccessivo di locali pubblici.
È una forzatura mediatica che non trova conferma nel punto di vista degli italiani che, anzi, sono in maggioranza convinti che il problema vero non sia l’eccesso di locali in un territorio, piuttosto l’eventuale svuotamento del territorio da essi. Si può dire che così come l’apertura e lo svolgimento delle attività dei locali contribuisce a generare prosperità economica e qualità sociale della vita, la chiusura o l’assenza di essi trasformano i contesti in terreno fertile per criminalità e degrado sociale ed economico, poiché sono territori desertificati e svuotati di relazionalità.
Il nesso tra chiusura di locali, quali bar, ristoranti, enoteche e simili, e degrado dei territori è condiviso dal 78,5% degli italiani (fig. 3): ne sono particolarmente convinti i residenti al Centro (85,1%) e gli adulti (80%). In ogni caso, emerge dai dati che è una convinzione trasversalmente condivisa da gruppi sociali e territori.
D’altro canto, gli italiani sono anche convinti che lo sviluppo di un denso tessuto di attività in un territorio sia nei fatti uno degli antidoti migliori alla criminalità ed al degrado: lo pensa il 67,4 %, anche in questo caso con maggioranze trasversali a gruppi sociali e aree geografiche di residenza (fig. 4).



Non solo la rete degli esercizi pubblici non è un fatto negativo, ma nella visione degli italiani è addirittura un pilastro potenziale di politiche di prevenzione sociale.
Queste ultime dovrebbero incorporare l’attenzione alla promozione dei luoghi della relazionalità sul territorio visto che notoriamente i territori svuotati da esercizi pubblici sfuggono alla convivenza civile e, anche, alla legge dello Stato e, di conseguenza, sono occupati stabilmente dalla microcriminalità e da molteplici forme di degrado.
Guai a sottovalutare, infatti, quanto è importante che i territori siano quotidianamente attraversati da persone per le più diverse ragioni e che il territorio stesso sia presidiato da operatori economici che hanno tutto l’interesse a contribuire a rendere gli spazi pubblici puliti, accessibili, gradevoli. Il paradosso in cui troppo spesso si cade è di trasformare i motori della buona qualità localistica della vita, come i luoghi del fuori casa, nella causa del degrado, con una logica autolesionista visto che è interesse collettivo promuovere l’attività di imprenditori consapevoli, motivati, competenti nella gestione di flussi di persone che scelgono di incontrarsi fuori casa.
È fondamentale rilanciare il legame virtuoso tra sicurezza del territorio e vita quotidiana, nella consapevolezza che l’assenza di attività commerciali, a cominciare dai luoghi del fuori casa, facilita l’infiltrazione criminale e la deriva di degrado dei luoghi pubblici.

La Movida, termine importato dalla Spagna e in particolare dalla Madrid degli anni Ottanta, indica l’affollamento festoso di persone in contesti urbani connotati da una presenza intensa di luoghi del fuori casa. Sono strade e piazze limitrofe in cui bar, caffè, ristoranti, trattorie, osterie, wine bar, enoteche ecc. si susseguono attirando persone in cerca di convivialità intorno a cibo e bevande. La Movida, quindi, all’origine richiamava una fenomenologia sociale positiva, fatta di divertimento, incontri, scambi, cibo e bevande consumate insieme in contesti gradevoli, in cui le persone avevano anche l’opportunità di ampliare le proprie relazioni.
Una straordinaria piattaforma che valorizzava anche economicamente i territori generando al contempo positivi effetti sulla qualità della vita delle persone. Poi, progressivamente, il termine Movida ha cominciato ad essere associato anche al suo opposto, vale a dire a fenomeni di degrado, ubriachezza, molestie, violenza e, con notevoli semplificazioni nei media, tali fenomeni sono stati attribuiti proprio all’eccesso di locali del fuori casa in determinati territori.
Circa un decennio fa, poi, fu coniato dal Censis il termine MalaMovida per distinguere nettamente tra:
• l’attività virtuosa di operatori del fuori casa che offrono un servizio altamente apprezzato dalle persone in cerca di convivialità intorno a cibo e bevande;
• la patologia di fenomeni di ubriachezza, degrado e di vera e propria violenza che nulla hanno a che fare con l’attività del fuori casa e, semmai, rinviano alle attività di pseudo-imprenditori predatori, protagonisti di concorrenze sleali e distanti dagli standard di serietà e professionalità di chi gestisce i locali del fuori casa.
Il dibattito tra Movida e MalaMovida, però, rischia di moltiplicare gli equivoci
ed i fraintendimenti, cosa che rende indispensabile emancipare da esso le tematiche relative al fuori casa, a cominciare dal suo contributo alla qualità della vita degli italiani come componente essenziale di una società più sostenibile. È urgente riportare la riflessione sul fuori casa e le sue risorse nell’alveo più naturale, quello costitutivo dell’Italian way of life
Il fuori casa italiano non è un portato recente della Movida, piuttosto quest’ultima è una delle modalità in cui si può estrinsecare il modello italiano di convivialità fuori casa.
Certo che la Movida è un fenomeno positivo, virtuoso, che promuove valorizzazione economica e anche rigenerazione urbana e tuttavia il persistere di fraintendimenti e semplificazioni impone di ripartire dal valore della convivialità, a cui è ascrivibile anche l’attività del fuori casa, un settore economico che favorisce la fruizione di spazi organizzati e apprezzabili che consentono agli italiani di incontrarsi, avere scambi, stare insieme in serenità.
La Movida va recuperata al suo significato originario e ricondotta alla sua sostanza reale: componente della più generale convivialità promossa dal fuori casa. Così sarà finalmente possibile tenerla distinta e distante, anche nel dibattito pubblico, dalle degenerazioni patologiche con cui troppo spesso viene confusa.
5.2.1. I dati
Quale opinione hanno gli italiani della Movida? È stato chiesto alle persone di indicare a cosa pensano quando sentono la parola Movida: il 50,8% ha dichiarato di pensare ad una cosa positiva, in particolare a luoghi della città dove si può passeggiare, mangiare, bere, stare insieme con amici, posti dove trascorrere tempo con gli amici (fig. 5). Condividono tale positiva visione della Movida:
• il 57,4% degli uomini ed il 44,7% delle donne;
• il 59,9% dei giovani, il 55,5% degli adulti ed il 35,6% degli anziani;
• il 43% dei possessori di al massimo la licenza media, il 55,6% dei diplomati ed il 61,8% dei laureati;
• il 57,4% degli alti redditi ed il 43,2% dei redditi bassi. Sono dati che confermano come nei vari gruppi sociali sia prevalente, o comunque alta, la quota che al termine Movida reagisce positivamente, perché la
mente va ad eventi di vita apprezzabili come passeggiare, bere, stare insieme con amici e trascorrere il tempo con gli altri. In fondo, anche tra gli anziani, i più negativi, oltre un terzo fa propria una visione positiva. In contrasto con la retorica prevalente nei circuiti mediatici, la Movida è per gli italiani sinonimo di buona relazionalità, di opportunità di beneficiare di tempo libero in modo gradevole.

I risultati consentono di dire che è di certo una forzatura rispetto alla cultura sociale collettiva l’associazione della Movida quasi esclusivamente a fenomeni di condotta comportamentale sregolata, con eccessi, tensioni e violenze che la renderebbero, in buona sostanza, un fenomeno da cui è opportuno tenersi alla larga.
È invece importante sottolineare come sia la bad narrative mediatica a dipingere pervicacemente la Movida come un fenomeno patologico fatto da eccessi di ogni tipo come luoghi sovraffollati, giovani ubriachi, molestie di ogni genere. La verità è che la Movida oggi è una sorta di paradigma del divario che esiste tra

il racconto reiterato che viene rilanciato nei circuiti mediatici e la materialità del quotidiano delle persone che, non a caso, alla parola Movida associano eventi soggettivi e collettivi positivi.
Nella visione dei cittadini la Movida è associata soprattutto a luoghi delle città in cui è possibile sviluppare relazioni sociali e professionali e dove, dal rapporto con il food & beverage alla conformazione degli ambienti, tutto è funzionale a sviluppare una positiva relazionalità tra le persone, a consentire di vivere in piena sicurezza e tranquillità le occasioni di convivialità.
Sono opinioni su cui convergono anche persone che non hanno frequentazione intensa della Movida, ma comunque ne hanno una rappresentazione lontana da quella demonizzante proposta dai media.
È evidente che ormai esiste una sorta di cortocircuito tra la Movida e i fenomeni degenerati, con un’attribuzione quasi automatica dei secondi alla prima, senza che la distinzione tra Movida e MalaMovida riesca più a tenere separate le cose.
Nella positiva percezione della Movida gioca molto la fiducia degli italiani nel fuori casa come settore e che si estende agli attori principali, vale a dire i gestori dei locali sulla cui professionalità e competenza gli italiani contano.
Infatti, l’83,4% degli italiani dichiara che con gestori di locali con appropriata professionalità è possibile organizzare senza eccessi e in sicurezza anche la Movida. Tale opinione prevale in modo trasversale a gruppi sociali e territori (fig. 6)
La presenza di locali pubblici è una garanzia di tutela dei territori e delle comunità dal degrado e promuove la buona qualità localistica della vita, anche grazie a imprese con gestori professionali, competenti, capaci.
È evidente che non sono attività che si possono improvvisare, perché richiedono una capacità imprenditoriale relativa agli aspetti economico-finanziari e relativa anche, molto all’organizzazione dei fattori produttivi, non ultima la gestione della clientela con opportuni meccanismi di selezione che operano come prevenzione di fatto dei comportamenti patologici.
Uno dei fattori che fanno degenerare la Movida è la presenza di operatori improvvisati, poco coinvolti dal senso profondo che invece è proprio del settore e che pertanto non hanno la professionalità e la social responsability che, invece, gli italiani riconoscono agli imprenditori del fuori casa.
È evidente che la maggioranza degli italiani non accetta di ridurre la questione dei luoghi della Movida o comunque degli spazi con addensamento di locali a tema di ordine pubblico.

Piuttosto ritengono che occorra valorizzare una imprenditoria professionale facendo di essa l’alleato migliore perché il settore del fuori casa possa operare massimizzando i benefici che crea per la collettività e minimizzando i rischi di degenerazioni, come quelle che poi conducono a soluzioni custodialiste sui territori.

Occorre uscire presto dall’autolesionistica visione demonizzante della Movida e dalle conseguenti penalizzazioni degli operatori del settore e di quelli dei settori limitrofi. Come? In primo luogo, attivando un approccio sistemico nell’affrontare le criticità, coinvolgendo i diversi attori istituzionali, politici ed economici della filiera e dei settori interessati condividendo scelte e interventi e facendo convergere le forze verso obiettivi unitari.
Troppo spesso la filiera del fuori casa viene lasciata sola ad affrontare situazioni che invece rinviano anche alle responsabilità di altri soggetti relativamente ad un’adeguata organizzazione e gestione dei territori, non tanto sotto il profilo dell’ordine pubblico, quanto su quello della creazione di dimensioni infrastrutturali materiali e immateriali di prevenzione delle cause di fondo dei fenomeni degradati e patologici della MalaMovida.
Le derive patologiche urbane uniscono luoghi e città diverse, come dimostra ad esempio il degrado patologico e ormai strutturale dei dintorni delle stazioni ferroviarie di città piccole e grandi. Sebbene le stazioni eroghino un servizio ineliminabile sono comunque costrette a convivere con gli effetti di un degrado sociale che condensandosi intorno ad esse finisce per minacciare la sicurezza collettiva e personale.
Naturalmente, partecipare ad un dialogo sociale e istituzionale richiede tempo, energie, risorse e competenze, che troppo spesso vanno molto oltre le forze dei singoli operatori del fuori casa, particolarmente stressati in questo periodo dal moltiplicarsi delle sfide alla loro stessa sopravvivenza sul mercato.
Per questo motivo è importante il ruolo dei player maggiori che, nel caso del fuori casa, chiama in causa anche la Distribuzione Horeca che sarebbe in grado di portare un contributo, come già evidenziato, sia di upgrading delle culture
imprenditoriali di gestione dei servizi erogati, sia di proposta nel rapporto con le istituzioni.
Il polverizzato mondo degli esercizi pubblici non può essere lasciato solo di fronte alla tartassante pressione e colpevolizzazione mediatica successiva ad episodi di cronaca o di fronte alla richiesta di fare supplenza nei controlli, tenendo a freno malintenzionati e molesti.
È importante che i protagonisti della filiera, a cominciare dalla Distribuzione Horeca che è così vitale per l’attuale configurazione e tenuta della filiera stessa, entrino in gioco nei luoghi istituzionali da cui dipende l’evoluzione delle modalità di gestione dei luoghi della Movida.
Si tratta di un salto di qualità, in primo luogo istituzionale, di riconoscimento degli stakeholder e, tra questi, attori come la Distribuzione Horeca, che per collocazione, capacità, esperienza e tipo di rapporto consolidato con la molteplicità delle piccole imprese del fuori casa, possono apportare risorse ed energie importanti contribuendo ad organizzare una Movida finalmente riconosciuta per quel che è: una risorsa per l’economia e per la società.

Il punto di vista degli italiani sulla Movida è di grande maturità e consapevolezza perché, non solo l’apprezzano e reagiscono positivamente quando viene richiamata, ma ne enucleano le funzioni sociali in atto e quelle potenziali. Colpisce, ad esempio, come nelle opinioni degli italiani sia esplicito il nesso tra Movida e sicurezza nei territori, in modo diametralmente opposto a quello che viene rilanciato con automatismi perversi nel circuito della comunicazione. Infatti, come si è visto, per la maggioranza degli italiani la presenza di tanti locali pubblici e il connesso pacifico afflusso di tante persone senza episodi molesti o di violenza, sono un valore perché rendono i luoghi vissuti, gradevoli e soprattutto sicuri.
A preoccupare gli italiani sono invece i luoghi svuotati di vita, quelli che, anche a causa della chiusura degli esercizi pubblici, sono a rischio di essere abbandonati a sé stessi e di cadere nel degrado fisico e relazionale diventando preda facile di occupazione da parte della criminalità.
In questo senso, quindi, la condensazione appropriata di locali valorizza i contesti territoriali, li rende più attrattivi e migliora anche la vita dei residenti, addirittura al di là della loro frequentazione.
Si tratta di un punto distintivo aggiuntivo rispetto ad ogni retorica anti-Movida: la presenza di luoghi della Movida, laddove ben gestiti, può migliorare sensibilmente la vita dei residenti. Non è quindi vero che c’è un conflitto inevitabile e quasi sempre insanabile tra chi abita il territorio e chi ci lavora con la propria attività e i relativi clienti. È proprio sul tema controverso e molto delicato del rapporto tra residenti e esercizi del fuori casa che un approccio sistemico e condiviso può dare risultati importanti. È infatti l’ambito in cui esso può creare le condizioni per un’inedita alleanza proprio tra residenti e operatori del fuori casa, poiché in punto di principio le attività del settore se opportunamente organizzate hanno un effetto di valorizzazione degli spazi pubblici, in termini di qualità della vita, sicurezza e, anche, valore economico degli immobili.
Ogni fenomeno sociale di massa non può trovare spiegazione solo nel suo valore economico e nella maggiore o minore efficienza tecnica della sua organizzazione.
Invece, la Movida troppe volte viene relegata ad un fatto quasi tecnico, di condensazione di locali e persone che genererebbe problematiche più o meno gravi da risolvere o addirittura rimuovere con logiche custodialiste.
In realtà essa, come modalità di manifestazione della convivialità tipica dello stile di vita italiano, è in questa fase molto di più, in quanto esercita funzioni sociali significative che non si possono sottovalutare quando si fa il bilancio di costi e benefici sociali del fenomeno per deliberare scelte e interventi.
La società italiana, infatti, vive una fase molto particolare, segnata da una certa ansia per il rischio di un balzo indietro, dovuto alle difficoltà economiche, alle avversità atmosferiche estreme o alle guerre globali.
Come rilevato, ci si sta abituando all’idea che può accadere di tutto, come dimostrato dal lockdown, dal ritorno dell’inflazione, scomparsa da quasi un quarantennio o dall’inatteso rischio atomico.
Diventa cultura sociale diffusa l’idea che eventi globali e geograficamente lontani possano cambiare improvvisamente e radicalmente il proprio contesto vitale e la propria quotidianità. A fronte di questo mainstream psicologico della
società scattano i meccanismi di adattamento che, notoriamente, nella società italiana sono particolarmente efficaci.
Un contraccolpo negativo, che accresce la voglia di proteggersi, di avere una qualche forma di sicurezza, e, al contempo, spinge a ritagliarsi momenti di benessere, cercare e valorizzare ciò che può far bene sia pure in modo temporaneo e reversibile, di solito piccole cose il cui valore diventa esponenzialmente più alto.
Sono proprio i luoghi del fuori casa quelli in cui si può beneficiare delle esperienze del quotidiano che vengono lette e vissute in modo diverso, su tutte la relazionalità, specie nel post pandemia.
È un valore sociale diretto, evidente, che coinvolge e richiama la funzione dei luoghi della Movida, percepiti come la condensazione delle opportunità di relazioni, il loro essere vibranti, pieni di persone e di locali in cui avere accesso a cibi e bevande che magari non si hanno nella routine quotidiana; un aspetto che li rende essenziali per contribuire a soddisfare quella voglia di micro-benessere di cui gli italiani, che hanno alle spalle un triennio traumatico e davanti ad essi aspettative non certo esaltanti, dichiarano di avere assoluto bisogno.

Di fronte agli sforzi prolungati dei cittadini, da quelli estremi del periodo di emergenza sanitaria a quelli comunque intensi per fronteggiare le attuali difficoltà economiche, a cominciare dalla forza erosiva dell’inflazione, non si può affrontare ogni aspetto di vita collettiva con logica custodialista e annessa moltiplicazione di divieti e restrizioni.
Se le emergenze si susseguono, diventa addirittura vitale per la società italiana trovare modalità per vivere adeguate, e pertanto occorre favorire, incentivare quelle attività che alleviano il peso della pressione, che generano momenti di vita bella, sia pure reversibili.
La Movida va letta anche in questa chiave perché consente di rilevare le ragioni sociali attuali della sua importanza, che rinvia al valore conclamato, e largamente analizzato nel presente Rapporto, della convivialità.
Avere un vibe che opera da antidoto alla malinconia sociale imperante dovrebbe spingere a considerarlo una risorsa, creando le condizioni della sua valorizzazione: è il modo in cui andrebbe trattata la Movida in questa particolarissima fase storica.
È importante ampliare il senso del ruolo sociale della Movida, intesa come modalità di concreta manifestazione della convivialità degli italiani, perché essa in questa fase allevia non solo la pressione dei giorni difficili e non ha solo la forma vibrante e chiassosa che quasi spontaneamente richiama, legata all’affollamento di locali, persone ed alla moltiplicazione delle opportunità relazionali.
Questa è soltanto una delle sue forme, probabilmente la più raccontata e anche la più controversa perché è in essa che si innestano le criticità sintetizzate nel termine di MalaMovida.
Ma i luoghi gradevoli, attraenti, di concentrazione di esercizi pubblici per bere e mangiare insieme sono spesso risposta ad esigenze diverse, in linea con l’articolazione delle tipologie di consumatori che, come rilevato nelle uscite serali, si recano con frequenza più o meno alta presso i luoghi della Movida. Un esempio emblematico, poco attenzionato, ma molto rilevante anche dal punto di vista dell’evoluzione delle strategie di offerta degli operatori rinvia all’accelerazione delle vite che l’irruzione definitiva del digitale nel quotidiano ha portato alle estreme conseguenze.
Oltre alla più volte citata pressione di eventi epocali inediti, c’è una dimensione più strutturale che si è andata consolidando nelle vite degli italiani: l’accelerazione dei tempi di realizzazione delle attività, l’accorciamento dei tempi delle decisioni di ogni tipo e anche della fruizione di rapporti, prodotti e servizi, con relativo intasamento dei tempi di vita.
Esito di ciò è l’innalzamento della produttività sociale di ogni minuto della giornata, con un’accelerazione estrema e una conseguente spinta a fare ancor più attività rallentando ulteriormente il quotidiano.
È un meccanismo sociale formidabile con cui le persone devono fare i conti e una delle reazioni maggiori, già citata come evidente nella psicologica collettiva, consiste nella ritrazione nel proprio guscio, in una diffusa ritrosia a praticare quelle attività che sono socialmente indicate come importanti per migliorarsi.
Tuttavia, tale reazione non è sufficiente per dare risposta alla pressione sociale che spinge alla rapidità dei rapporti e delle decisioni ed alla prevalenza sistematica del fare sul pensare.
Rispetto a questa dinamica molto complessa, sfuggente, probabilmente ancora allo stadio iniziale, è però già oggi rilevante il ruolo essenziale che hanno i mo-
menti di lentezza, quelli in cui le persone possono lasciarsi andare, occuparsi di sé stessi e degli altri, rilassarsi nel senso più profondo del termine che non significa necessariamente oziare, piuttosto dedicare a quel che si vuol fare per piacere, con l’effetto netto di rallentare almeno temporaneamente, in specifici momenti, la frenesia accelerazionista delle vite.
Si formano così originali stili di vita ibridi in cui le persone restano dentro le dinamiche accelerate del mondo digitale e, tuttavia, se ne difendono anche grazie al ricorso a spazi di quotidianità soggettivamente modellati in relazione alla domanda di lentezza che, come rilevato, sta crescendo. Dentro i momenti slow c’è indubbiamente voglia di introspezione, di ozio nel senso alto del termine, cioè come tempo per pensare alle cose che interessano e piacciono senza necessariamente farsi condizionare dalla performance, ma c’è anche bisogno di relazionalità fisica, diretta, non condizionata dal ritmo concitato che di solito connota le vite. Una relazionalità che può richiamarsi ai meccanismi più rallentati, quasi analogici, tipicamente umani, e che in questo contesto genera benessere psicofisico.
I luoghi del fuori casa sono anche risposta a questa domanda sociale profonda e crescente, che poco si vede e poco si racconta, anche perché diventa evidente socialmente solo quando emergono, magari per fatti di cronaca, le conseguenze nella psicologia individuale e collettiva della frenesia accelerazionista, con ad esempio il diffuso burn out che colpisce ormai numeri elevati di persone in ambiti molto diversi o anche a causa della ormai conclamata moltiplicazione del disagio psicologico.
Sul piano dell’offerta del fuori casa, quindi, è importante riflettere sull’articolazione della domanda che ad essa si rivolge e sulle sue esigenze specifiche, perché la componente slow sta sicuramente crescendo ed è presumibilmente più alta tra le persone con almeno trent’anni e in generale tra gli adulti. Una domanda esigente, di solito con discreta capacità economica, per la quale è importante trovare nei luoghi del fuori casa e della Movida contesti che offrono l’esperienza del rallentamento, con mix materiale e immateriale che consente di fruire di momenti di lentezza che ammortizzano, sia pure parzialmente, quella pressione sociale che impone sempre più velocità in ogni microattività e decisione del quotidiano.

L’ecatombe post emergenza sanitaria del fuori casa, annunciata da molti in nome di una società relegata in casa per sempre, non è avvenuta. Dati di spesa e di frequenza, infatti, segnalano quella voglia di tornare nel fuori casa che è stata più volte evidenziata nel Primo e nel Secondo Rapporto Italgrob-Censis. Tuttavia, anche la filiera del fuori casa non potrà non misurarsi con le trasformazioni socioeconomiche in atto, marcate da un’evidente erosione del ceto medio, cioè di quella parte significativa della società italiana nel cui stile di vita è radicata anche la frequenza dei luoghi del fuori casa. Anzi, tra gli aspetti più citati dai settori del ceto medio che più sperimentano il declassamento c’è proprio la paura di dover rinunciare oppure l’esperienza di avere dovuto rinunciare in tutto o in parte alle uscite, una o più volte a settimana, con relativa passeggiata, magari un cinema e poi cena o drink nei luoghi del fuori casa.
Il mutamento reale e/o percepito del rapporto con il fuori casa, in particolare con quello che tradizionalmente si trova nei luoghi più vibranti dei territori, incarna simbolicamente l’avvenuto o il temuto cambio di status, cioè la presa d’atto della discesa in basso nella scala sociale e nella condizione economica. Ci si accorge di essere passati da uno stato di relativa agiatezza ad uno di sostanziale sopravvivenza quando si diventa consapevoli che la vita si è ristretta alle attività essenziali, tra lavoro e famiglia, e poco o niente resta oltre tali ambiti, con in particolare la contrazione o scomparsa dei loisirs che rinviano al fuori casa. È evidente quindi che, al di là delle motivazioni, scelte e interventi che colpiscono il fuori casa limitandone l’attività e incrementando i costi di produzione e gestione hanno impatto sociale negativo, perché rendono di più difficile accesso servizi e consumi che hanno un alto valore simbolico, oltre quello materiale positivo sul benessere.
E anche le derive custodialiste e proibizioniste nei confronti della Movida partecipano di questo approccio disattento al valore socialmente simbolico che l’accesso al fuori casa ha per quote molto ampie di cittadini.
Rendere più difficilmente accessibile il fuori casa e spegnere i luoghi della Movida rischiano di essere quasi operazioni di accompagnamento del lento svuotamento delle opportunità di consumo e quindi del benessere degli italiani, a cominciare da quello dell’ampio ceto medio alle prese con una ristrutturazione radicale della propria condizione.
Da tempo l’Italia sembra concorrere per il titolo di Paese ostile per i giovani, e non solo per le note dinamiche demografiche di riduzione dei nuovi nati e delle classi di età più basse e rigonfiamento del numero degli anziani, ma anche per scelte politiche generali e specifiche in cui è visibile una disattenzione, se non addirittura una penalizzazione, dei giovani.
La Movida, come rilevato, coinvolge persone di ogni età, ma ha anche un suo specifico valore per i giovani, tanto più per le generazioni attuali che cumulano disagi socioeconomici, mobilità sociale difficile e gli effetti della prolungata amputazione relazionale e di qualità della vita indotte dall’emergenza sanitaria.
Guai a sottovalutare le conseguenze psicologiche che tali eventi hanno avuto sui giovani e l’imprinting generazionale che di certo eserciterà i suoi effetti anche nel futuro.

Si pensi ad esempio che al 60,7% dei giovani è capitato nel periodo emergenziale di sentirsi spesso solo/a, dato nettamente più alto di quello degli adulti (44,3%) e degli anziani (24,1%). Nell’attuale contesto è pari al 31,8% la quota di giovani che dichiara di essere di fatto solo/a, di contro al 19,2% degli adulti ed al 16,7% degli anziani.
Sono i numeri di una vera emergenza relazionale di cui poco o per niente si parla e che certo non può essere affrontata amplificando e prolungando nel tempo misure custodialiste, che, in ultima analisi, spengono i luoghi pubblici e blindano le persone in casa, a cominciare dai giovani.
La carenza relazionale ha certamente contribuito alla ormai certificata diffusione di disagio psichico, forme di depressione più o meno conclamate o comunque a quel malessere psicologico e del tono dell’umore causato anche dalla chiusura dei luoghi in cui viene giocata una parte importante della relazionalità dei giovani, che è per sua natura molto aperta a nuovi incontri ed ha assoluto bisogno di contesti come quelli che rientrano nella definizione di Movida. Spesso nella insistenza con cui la Movida viene trasformata in puro problema di ordine pubblico emerge una sorta di accanimento verso il loisir dei giovani, verso le modalità e i luoghi in cui si relazionano, con toni non distanti da quelli comprensibilmente duri del periodo più acuto dell’emergenza, quando si trattava di evitare assembramenti per impedire il diffondersi del contagio.
Attualmente la situazione sanitaria non ha nulla a che vedere con quella dei periodi peggiori della pandemia, ed è essenziale riportare l’attenzione sulla spe-
cifica e legittima domanda di relazionalità dei giovani che trova nei luoghi della Movida una risposta adeguata e importante, che non può essere demonizzata, penalizzata o comunque sovraccaricata da una sorta di condanna implicita e pregiudiziale.
Contesti vibranti ad alta intensità relazionale sono una necessità per società evolute, ancor più per i giovani che sono in una fase in cui è decisivo avere luoghi strutturalmente organizzati per favorire l’incontro, la conoscenza, la convivialità e lo scambio.
Senza luoghi deputati e organizzati per favorire gli incontri si pratica un’amputazione di fatto della relazionalità dei giovani, con costi sociali certi come si è visto nel prolungato periodo restrittivo. La relazionalità è un valore per le persone e per la società e le piattaforme che la promuovono vanno considerate come generatrici di valore sociale, non come fonte di costi.
Questa riflessione è ancor più potente laddove si rileva che l’Italia è sempre più segnata socialmente da persone che vivono sole, che non hanno convivenze stabili e che quindi hanno un bisogno strutturale di ricercare fuori dalle mura domestiche le opportunità relazionali.
Una società di persone sole non può non poter contare su piattaforme relazionali diffuse, solide, gradevoli e di facile accesso, altrimenti è alto il rischio di moltiplicare i costi sociali della deprivazione relazionale.
Parlare della Movida vuol dire far entrare in gioco anche queste dimensioni di psicologia e di comportamenti sociali legati sia alla stretta attualità post Covid, sia a dinamiche di più lungo periodo come quelle sociodemografiche di riduzione di numero e peso dei giovani e di moltiplicazione delle persone che vivono sole.

Primo e Secondo Rapporto Italgrob-Censis hanno delineato un vero e proprio percorso interpretativo che ha consentito di incastonare il valore economico e sociale della filiera e, in specifico quello della Distribuzione Horeca, all’interno della evoluzione socioeconomica del nostro Paese. Non un racconto parziale, di sola filiera, ma una interpretazione delle ragioni che rendono il fuori casa un attore essenziale di economia e società italiana, perché funzionale alla possibilità per le persone di praticare lo stile di vita tipicamente italiano.
Nello specifico, il Primo Rapporto ha focalizzato le componenti del valore sociale della Distribuzione Horeca all’interno del più ampio valore sociale di tutto il comparto, mettendo in luce una verità poco conosciuta: se il fuori casa ha la configurazione capillare che lo rende una sorta di infrastruttura socioeconomica essenziale per territori e comunità delle diverse aree, lo si deve ad una molteplicità di esiti dell’azione della Distribuzione Horeca.
Le imprese del fuori casa, infatti, riescono a restare sopra la soglia della sostenibilità economica anche perché sono affiancate da quelle della Distribuzione Horeca che, in diverso modo consentono di avere un conto economico accettabile.
Non solo: la Distribuzione Horeca gioca un ruolo di stimolo alla modernizzazione o almeno allo sforzo di adattamento delle imprese del fuori casa all’evoluzione di valori e materiale dei consumatori.
Il Secondo Rapporto ha modulato il valore sociale del fuori casa e, al suo interno il ruolo della Distribuzione Horeca, rispetto al criterio ordinatore che in questo triennio drammatico si è andato affermando: la sostenibilità.
Ma il Rapporto non si limita a raccontare la compliance, alta, del settore ai precetti della lotta al riscaldamento globale, a quelli del rispetto dei diritti degli stakeholder e, anche, a quelli relativi alla promozione di una maggiore inclusività sociale, ma evidenzia il valore aggiunto che proviene dal fuori casa: il contributo all’upgrading della qualità della vita delle persone, grazie alla moltiplicazione delle opportunità relazionali, in un tempo davvero difficile per la nostra società in cui il valore delle relazioni è notevolmente amplificato. Gli esiti di questa indicazione originale, nuova, sono almeno duplici:
• in primo luogo, ci sono quelli relativi al concetto socialmente diffuso di sostenibilità che molto concretamente deve estendersi ad una ulteriore dimensione oltre le tre consolidate, ed è quella della qualità della vita e al suo interno della relazionalità. Senza questa dimensione è difficile si formi un consenso sociale maggioritario e prolungato per le dimensioni più tradizionali della sostenibilità, perché quantità e qualità delle relazioni incidono sulla qualità della vita e quindi anche sulla propensione delle persone a impegnarsi per opzioni sostenibili. È pertanto una dimensione importante, anche se troppo spesso sottovalutata nel discorso pubblico;
• se la convivialità è così rilevante anche per promuovere la sostenibilità, allora la filiera del fuori casa e anche la Movida come modalità di manifestazione concreta della convivialità e piattaforma di relazioni, non possono essere affrontati solo sotto il profilo economico o, addirittura in alcuni casi dell’ordine pubblico. Sono componenti essenziali sia delle economie locali sia della vita sociale, e ogni ostracismo o approccio unilateralmente orientato alla penalizzazione non ha motivo di essere.
A ciò si aggiunga il di più di valore dell’azione del fuori casa che nasce dall’importanza sociale e soggettiva che le persone, in particolare i giovani, attribuiscono alle relazioni dopo l’esperienza traumatica e ad alto tasso di solitudine del periodo emergenziale.
Il Secondo Rapporto in pratica potenzia le conclusioni del Primo Rapporto riguardo al fatto che mettere la filiera del fuori casa, i suoi tanti e diversi protagonisti nelle condizioni migliori di operare non è un’esigenza corporativa riservata a chi nella filiera opera, ma ha elevati ed evidenti benefici sociali, ben oltre la soddisfazione dei soli clienti e il successo economico degli operatori.
È importante rilanciare, come viene fatto nel Secondo Rapporto, il valore sociale della Movida, come una delle modalità con cui si estrinseca la voglia di relazionalità degli italiani, quella convivialità costitutiva del nostro stile di vita e che è attualmente ancor più apprezzata dopo l’esperienza restrittiva del periodo pandemico.
Ed è importante sottolineare come, malgrado anni di intossicazione informativa intorno alla confusione tra Movida e fenomeni di degrado e disagio sociale, gli italiani continuano ad averne una visione positiva, a percepire la rete di strutture del fuori casa come una risorsa e la loro assenza come una minaccia.
Non solo: è radicata la convinzione che valorizzando opportunamente la presenza di esercizi pubblici ed il vibe dei luoghi della Movida sia possibile praticare politiche di prevenzione dal degrado e di promozione della sicurezza per le persone, a cominciare dai residenti.
È la cultura sociale collettiva degli italiani che mostra una maturità ben più alta di quella che emerge dalle letture semplificatorie che poi finiscono per considerare la presenza di reti di locali e l’afflusso di clienti come un fattore strutturalmente portato alla confusione sociale.
Invece per gli italiani i luoghi della Movida sono attrattori di turisti, occasione per momenti di benessere soggettivo, antidoto al degrado ed alla criminalità e quindi anche funzionali al benessere dei residenti.
Se così è nella percezione soggettiva, allora il fuori casa e i luoghi e gli attori della Movida vanno messi nelle condizioni di operare secondo i canoni della professionalità e della capacità imprenditoriale che nel tempo la grande maggioranza ha mostrato di avere.
Fare questo richiede un salto di qualità di governance del fenomeno in cui è importante entrino i players che hanno la robustezza e le competenze.
Su questo piano la Distribuzione Horeca può svolgere una funzione importante, anche perché assume già ora in molti altri ambiti un ruolo di stimolo alla crescita degli attori del fuori casa ed è in grado di dialogare con gli altri stakeholder, a cominciare dalle istituzioni locali e nazionali.

Nell’evoluzione necessaria della Movida è importante considerare l’opportunità rappresentata dalla voglia degli italiani di frequentare di più i luoghi del fuori
casa e, nello specifico, proprio i luoghi notoriamente connotati come legati alla Movida. Come emerso dall’indagine, gli italiani vorrebbero uscire di più la sera, frequentare di più il fuori casa perché sono convinti che inciderebbe positivamente sul proprio benessere.
È una sorta di risultato contro-intuitivo visto che dall’inizio della pandemia al ritorno dell’inflazione in tanti hanno insistito sul carattere inessenziale, voluttuario delle spese per il fuori casa e, di conseguenza, sulla ridotta importanza della filiera di offerta, da mettere in secondo piano anche nella distribuzione delle risorse pubbliche.
Il Secondo Rapporto Italgrob-Censis mostra come proprio in questa fase, per le tante ragioni più volte ripetute nel presente testo, gli italiani amerebbero poter uscire di più.
È evidente che si tratta di una straordinaria opportunità per gli operatori del settore e, al contempo, è anche un’indicazione di priorità che proviene dai cittadini che dovrebbe impegnare gli attori politici e istituzionali a non penalizzare l’attività del settore, a valutare con cautela interventi che generano rialzi dei costi o anche costi aggiuntivi se non altro di natura burocratico-amministrativo. La voglia di usufruire di più dei servizi del fuori casa da parte degli italiani è un altro punto forte del Secondo Rapporto, perché rende ancor più profondo e denso il valore sociale riconosciuto della filiera e della Movida e dei suoi attori; inoltre, segnala che se gli operatori dell’offerta sapranno modulare i servizi erogati, magari anche con uno sforzo ulteriore di upgrading rispetto alle nuove aspettative sulla sostenibilità dei consumatori, ci saranno spazi nuovi di mercato da conquistare con annessi risultati importanti anche per i conti economici delle imprese.
Anche questa è una traiettoria possibile per la filiera del fuori casa che richiama l’importanza strategica del ruolo di stimolo alla crescita culturale e imprenditoriale esercitata dalla Distribuzione Horeca.
Conquistare nuovi segmenti di clientela, magari in settori demografici e sociali oggi meno coinvolti, è una sfida possibile vista l’intenzionalità dichiarata dagli italiani evidenziata nel presente Rapporto. Tuttavia, anch’essa richiede un salto di qualità culturale della filiera, in linea con quello richiesto per contribuire ad una più alta sostenibilità della società italiana e per stare al passo con i nuovi valori degli italiani.
Di certo, per ora, c’è che il fuori casa e la Movida sono da intendersi come ri-
sorse e non come costo e che la Distribuzione Horeca può svolgere anche nella nuova fase una funzione di traino alla modernizzazione della filiera ed alla sua collocazione sulla frontiera più avanzata dell’innovazione sociale italiana.


Una più alta qualità della vita per una società più sostenibile
RAPPORTO 2023
Lo studio è stato realizzato nell’ambito di una collaborazione tra Italgrob e Censis. Si ringraziano:
• il gruppo di lavoro Italgrob, composto dal Direttore Generale Dino Di Marino e dal Consigliere Febo Leondini,
• il gruppo di lavoro del Censis, coordinato da Francesco Maietta e composto da Aglaia Gallo, Vittoria Coletta e Gabriella Addonisio per le attività di ricerca.
