DENTRO























4 EDITORIALE
NOVITÀ PRODOTTI
TECH
EVENTI
A URBANPROMO
PRESENTATO L’ATLANTE DELLA MOBILITÀ DOLCE
cura di Urbanpromo
MERCATO | ESCLUSIVA CERVED
“VENTI FAVOREVOLI...”
cura della redazione
TRANSIZIONE ENERGETICA
FOTOVOLTAICO E SOLARE
TERMICO: SPUNTI
RIFLESSIONE
Simone Monotti e Vincenzo Argenti
INTERVISTA
IDROGENO: IL COMBUSTIBILE DEL FUTURO DIVENTERÀ REALTÀ?
Silvia Martellosio
ANNIVERSARI
DA 50 ANNI UN CLIMA DI VALORE di Silvia Martellosio
SPECIALE INNOVAZIONI
MATERIALI INTELLIGENTI PER L’EDILIZIA DEL FUTURO di Patrizia Ricci DENTRO L’OBIETTIVO
QUANDO LO SHOPPING DIVENTA SOSTENIBILE
cura di Fondazione Promozione Acciaio


NON SOLO SCUOLA... di Polistudio A.E.S.
SUPERBONUS 110%
“RACCONIGI 25”: A TORINO
Organo ufficiale di:
RINASCE UNA COMUNITÀ,
UN QUARTIERE
Giorgio
IL COORDINAMENTO DELLA
DEI CANTIERI
RISTRUTTURAZIONE
BENI MONUMENTALI
Luca Vienni
CONSULENZA FISCALE
IL BOLLO
REDDITO
cura di Assocaaf
IMPIANTI ELEVATORI SENZA
CONFORMITÀ: SERVE
SOLUZIONE
Iginio
“THE BIG FIVE CONSTRUCT
2022”, L’IMPORTANZA

MADE IN ITALY
Comitato consultivo
Carla Tomasi (Finco)
Angelo Artale (Finco)
Giorgio Albonetti (Quine)
Marco Zani (Quine)
Comitato scientifico
Dario Amici (Assoroccia)
Antonio Arienti (Aif)
Alfio Bonaventura (Aifil)
Cesare Boffa (Fire)
Sandro Bani (Anfus)
Sergio Fabio Brivio (Finco)
Fabio Brondolin (Assofrigoristi)
Francesco Burrelli (Anaci)
Paolo Cannavò (Fecc)
Davide Castagnoli (Anacs)
Innocenzo Cipolletta (Aifi)
Italo Cipolloni (Anisig)
Pier Luigi D’Ambrosio (Aiz)
Daniela Dal Col (Anna)
Caterina Epis (Fondazione
Promozione Acciaio)
Emilio Fadda (Ansag)
Guido Faré (Unicmi)
Nicola Antonio Fornarelli (Acmi)
Roberto Frassine (Assocompositi)
Fabio Gasparini (Assites)
Gabriella Gherardi (Aises)
Hans Paul Griesser (Ancca)
Iginio Lentini (Union)
Giuseppe Lupi (Aipaa)
Antonio Maisto (Assoverde)
Luca Marzola (Zenital)
Laura Michelini (Anfit)
Aurelio Misiti (Cnim)
Fabio Montagnoli (Pile)
Francesco Morabito (Assografene)
Daria Pasini (Archeoimprese)
Paolo Pastorello (Restauratori Senza Frontiere)
Marco Patruno (Fisa)
Massimo Poggio (Fias)
Giuseppe Riello (Afidamp)
Walter Righini (Fiper)
Kristian Schneider (Ari)
Angelo Sticchi Damiani (Aci)
Daniele Succio (Anipa)
Paolo Taglioli (Assoidroelettrica)
Eleonora Testani (Ancsa) Bruno Ulivi (Ait)
Redazione Giorgio Albonetti | Direttore Responsabile Silvia Martellosio | Coordinamento Editoriale s.martellosio@lswr.it - Cell. 349.1801063
Collaboratori Vincenzo Argenti, Assocaaf, Fondazione Promozione Acciaio, Iginio S. Lentini, Simone Monotti, Polistudio A.E.S., Patrizia Ricci, Giorgio Sandrone, Urbanpromo, Luca Vienni
Pubblicità Elena Genitoni | Ufficio traffico e.genitoni@lswr.it
Servizio abbonamenti abbonamenti.quine@lswr.it - Tel. 02.864105 Abbonamento annuale (6 fascicoli): 40 € Costo copia singola: 2,30 € (presso l’Editore)
Produzione Antonio Iovene | Procurement Specialist a.iovene@lswr.it - Cell. 349.1811231 Grafica e Impaginazione: Life sh.p.k. Stampa: Aziende Grafiche Printing Srl Peschiera Borromeo (MI)
Editore Quine Srl Sede legale Via Spadolini, 7 - 20141 Milano www.quine.it - info@quine.it tel. 02 864105

Quine è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione n° 12191 del 29/10/2005. Registrazione del Tribunale di Milano n° 79 del 3/3/1986. Tutti i diritti di riproduzi one degli articoli pubblicati sono riservati. Manoscritti, disegni e fotografie non si restituiscono.

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 di seguito GDPR, i dati di tutti i lettori saranno trattati sia manualmente, sia con strumenti informatici e saranno utilizzati per l’invio di questa e di altre pub blicazioni e di materiale informativo e promozionale. Le modalità di trattamento saranno conformi a quanto previsto dagli art. 5-6-7 del GDPR.
I dati potranno essere comunicati a soggetti con i quali Quine Srl intrattiene rap porti contrattuali necessari per l’invio delle copie della rivista. Il titolare del tratta mento dei dati è Quine Srl Via G. Spadolini 7 - 20141 Milano, al quale il lettore si potrà rivolgere per chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e ogni altra operazione di cui agli articoli 15-21 del GDPR.
Testata associata

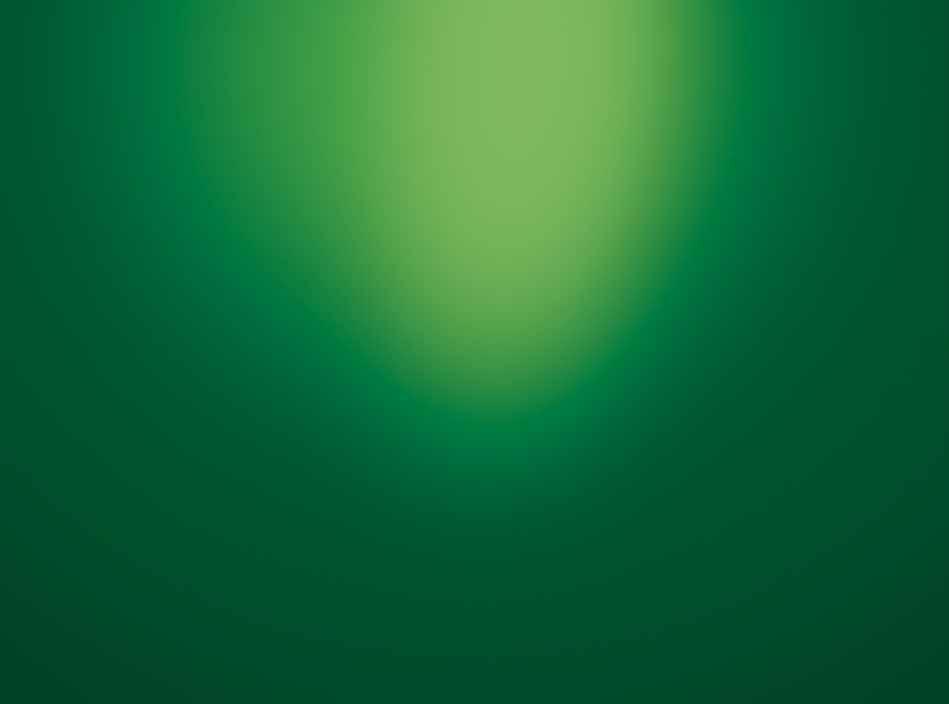
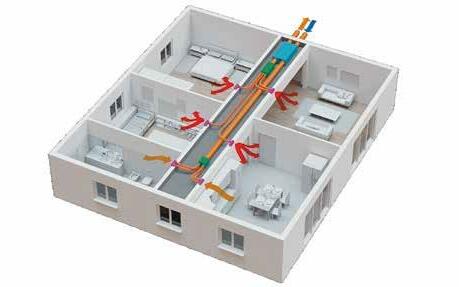

La scarsa incisività dei contenuti presenti nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza (5 agosto 2022, n. 118, pubblicata nella G.U. del 12 agosto 2022, n. 188 – Molto bene comunque che almeno vi sia) induce una riflessione su quali siano effettivamente “i poteri forti” in Italia. Una locuzione che spesso si usa (o abusa) quando non si sa bene cosa dire o di cosa si parli.
In Italia i cosiddetti “poteri forti” (non pubblici) da un punto di vista economico, di fatto, non esistono quasi più; molta della forza che avevano si è trasferita all’estero con l’acquisizione delle nostre principali imprese. Solo per fare qualche esempio: Fiat divenuta Chrysler, ora Stellantis, con sede in Olanda e quotata alla borsa di Parigi, la cui maggior influenza è oggi nel nostro Paese la proprietà di “la Repubblica” e “La Stampa”; Luxottica adesso Essilor, con maggioranza francese e quotata a Parigi. E si potrebbe continuare.
Dal punto di vista aziendale, società realmente forti – con capitalizzazione di borsa, numero di dipendenti e capacità di influenza su imprese, fornitori e stakeholders – sono Eni (Snam\Terna), Enel, Leonardo e, tra le non quotate, Ferrovie dello Stato (che include Anas), Poste e GSE; Rai a parte. Peraltro queste aziende costituiscono ormai da tempo i principali singoli contribuenti di Confindustria in base a una situazione anomala in cui la maggior organizzazione italiana di imprese private ha come soci più importanti le imprese pubbliche o a controllo pubblico attraverso Cassa Depositi e Prestiti (mai che il MEF, azionista di ultima istanza, si sia pronunciato in merito al fatto che fiumi di denaro pubblico vengono convogliati da oltre 20 anni in ogni singola territoriale di Confindustria, associazione che, per giunta, inibisce ai soci l’adesione ad altre organizzazioni in contrasto
con quanto previsto dalla Costituzione e dalla Legge 180\2011 in tema di libertà di impresa e sindacale).
Ma allora chi sono i “poteri forti”?
Sarò molto semplice, ai limiti del semplicismo. I poteri forti sono quelli che condizionano la vita di ogni giorno dei cittadini di qualunque condizione; quindi, non è (solo e soprattutto) Mediobanca, né sono gli eredi di Cuccia; non è la Fiat, o come si chiama adesso.
Sono i tassisti che non si trovano mai e che da quarant’anni riescono a mantenere il privilegio di una licenza che si trasmettono, coronando il sogno di qualunque essere umano di avere una barriera all’ingresso al proprio lavoro e che – ove messa in dubbio – bloccano le città (è come se un padre, che spende più dell’equivalente di una licenza per portare il figlio alla laurea, bloccasse la città perché questo poi non trova lavoro). Ricordiamo che in Italia sono riusciti ad azzerare Uber, unico Paese “sviluppato” in cui ciò è avvenuto.
Sono i mezzi di trasporto pubblico locale che funzionano secondo logiche, almeno nelle grandi città, tutte da verificare e con puntualità (si fa per dire) spesso casuale. Sono gli stabilimenti balneari che, di fatto, impediscono l’accesso a spiagge gestite pagando canoni mediamente risibili; sono gli operatori ecologici che, specie da Roma in giù, non svolgono adeguatamente il lavoro per i quali sono pagati e le cui aziende sono tutte municipalizzate e ipersindacalizzate e neanche per sbaglio sono soggette a gara per l’affidamento (e le cui tariffe sono sempre assolutamente svincolate dalla prestazione). E così via…
Potere forte è la burocrazia (vicinissima ad auto togliersi il limite massimo di 240.000 euro annui di stipendio) che
ultimamente si è digitalizzata: digitalizzazione fatta per favorire chi sta dall’altra parte dello sportello e non l’utente che, anzi, ha visto la sua situazione peggiorare. Non parliamo, poi, di anziani “informaticamente analfabeti” che per usufruire di tali servizi hanno bisogno di assistenza. Questi sono i poteri forti che, tra l’altro, non sono soggetti ad alcun controllo e sono spesso governati non da Presidenti, Amministratori Delegati o Direttori Generali, ma dai Sindacati, i cui interessi dovrebbero essere contemperati con quelli del “sindacato dei cittadini” cioè, nelle città, il Sindaco che li rappresenta. Ma basta vedere la vicenda dei taxi per capire che così non è. Qualcuno dirà: “Ma ci sono le lobby tra i poteri forti”. Premesso che, anche qui, va fatta chiarezza. Non esiste una lobby tanto forte da poter firmare una legge se non c’è un parlamentare, senatore, deputato o un membro dell’Esecutivo che lo faccia; certo ci sono le lobby (i cosiddetti portatori di interessi). Infatti sono viste con attenzione e andrebbero regolamentate, cosa che non si riesce a fare da cinquant’anni per colpa, usiamo questa parola, dei politici che non vogliono consentire l’inibizione del loro passaggio alla sfera lobbistica una volta finito il mandato. Le cose a volte sono più semplici di quanto non si creda. I poteri forti sono certamente anche la Magistratura, cui abbiamo dedicato un editoriale ad hoc. E, nella vita di tutti giorni, anche banche e assicurazioni, il cui controllo istituzionale – assolutamente insufficiente – è rispettivamente in capo a Banca d’Italia e Ivass (Istituto di controllo sulle assicurazioni). La stessa architettura di questo controllo ne denuncia l’inadeguatezza: l’Ente di controllo Banca d’Italia ha come principali azionisti due dei maggiori Istituti italiani (Intesa Sanpaolo e Unicredit) che dovrebbero essere oggetto del controllo. Non solo, ma da Banca d’Italia proviene anche il Presidente del citato Ivass. ll risultato è che continuiamo a vedere cambiamenti complicati e unilaterali delle condizioni, richiesta di doppie e triple firme, comunque vessatorie, contratti di una tale complicazione che sono fatti apposta per scoraggiarne la lettura, la permanenza di voci inaccettabili, come – solo per fare esempi in ambito bancario – la cosiddetta commissione di massimo scoperto, che ora alcuni Istituti denominano in modo differente, il tema dell’anatocismo etc. E mi astengo, in questa sede, dall’affrontare il tema della cessione dei crediti in ambito Superbonus. Chi di noi non si è imbattuto in simili circostanze. Vediamo poi delle penalità e delle indicazioni correttive assolutamente risibili e fatte quando non se ne può fare proprio a meno. Siamo un Paese dove c’è assolutamente bisogno di più concorrenza reale.

La linea di cassonetti per interni a vista dalle prestazioni termoacustiche certificate. Disponibile in versione verniciabile o rifinita da abbinare a serramenti in legno, PVC e alluminio.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) lancia la pompa di calore EHS Mono HT Quiet. È una soluzione di climatizzazione resistente nel tempo, che combina funzionalità avanzate e nuove tecnologie per raggiungere una temperatura dell’acqua calda fino a 70 °C e livelli di rumorosità di appena 35 dB(A). Ideale per il segmento delle ristrutturazioni residenziali anche sui territori con condizioni climatiche estreme, in quanto è in grado di garantire il 100% delle prestazioni di riscaldamento anche con temperature fino a -25 °C e +43 °C. Inoltre, l’installazione e la manutenzione dell’unità si eseguono facilmente. Nonostante le dimensioni compatte, adatte anche a essere posizionato sotto l’altezza di una finestra, EHS Mono HT Quiet presenta uno scambiatore di calore con un’area più grande (dell’8,8% circa rispetto ai modelli tradizionali), in grado di trasferire il calore in modo più veloce ed efficiente. Dotata di un nuovo compressore scroll , che comprime i gas refrigeranti a pressioni molto più elevate, e di una tecnologia “Flash Injection” che, a sua volta, aumenta la portata del gas refrigerante, questa pompa di calore ad alta temperatura garantisce un funzionamento costante anche a temperature molto basse, fino a -30 °C. L’unità esterna è protetta anche da un rivestimento anticorrosione “Durafin Ultra” , applicato sullo scambiatore di calore e sul telaio per garantire la massima durata nel tempo in condizioni climatiche più rigide. Inoltre, questa pompa di calore vanta valori di SCOP pari a un’efficienza energetica A+++. L’unità può essere anche controllata da remoto con SmartThings: uno dei vantaggi è la possibilità di monitorare all’istante il consumo energetico quotidiano, settimanale e mensile. L’unità esterna è dotata di un sistema di isolamento acustico a doppio strato, con design brevettato “Groove Grid Felt”, in grado di assorbire efficacemente ogni tipo di rumore prodotto dalle parti soggette a compressione e minimizzare le vibrazioni. L’utilizzo di ammortizzatori a molla (anziché in gomma) nel montaggio del compressore riduce la trasmissione delle vibrazioni del 90%. Il compressore sfrutta un albero motore rinforzato che diminuisce il rombo a bassa frequenza, mentre l’unità esterna si avvale di un ventilatore Multi-Serration che limita in modo significativo il rumore prodotto.
EHS Mono HT Quiet è il primo modello della line-up premium di pompe di calore ad alta temperatura, a marchio Samsung. È disponibile in tutta Europa in 3 taglie (8, 12 e 14 KW) e con alimentazione monofase e trifase. Tutte le tre versioni saranno dotate dello stesso telaio. La disponibilità di questo nuovo modello potrà variare a seconda del mercato. La pompa di calore è molto versatile e si adatta facilmente a ogni sistema, in primis , con ClimateHub , un sistema integrato per la gestione del riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. www.samsung.it






Ariston compie un ulteriore passo concreto nei confronti della sostenibilità presentando la nuova gamma di caldaie a condensazione One+ NET, compatibili con le miscele di idrogeno al 20% grazie alle innovazioni tecnologiche apportate alla gamma. Prodotti di punta della nuova gamma sono le caldaie Alteas One+ NET e Genus One+ NET, la cui classe energetica arriva fino alla A+, dotate di funzioni in grado di gestire il riscaldamento di casa in modo intelligente ed efficace, in base allo stile di vita e alle esigenze di ciascuno. La gamma presenta una rivisitazione d’avanguardia anche dal punto di vista tecnico. Infatti, lo scambiatore in acciaio inox XtratechTM, cuore delle caldaie One+ NET, è un componente unico nel suo genere che garantisce performance nel tempo e affidabilità; quindi, un minor rischio di intasamento ed elevate prestazioni anche nelle situazioni più critiche. Inoltre, grazie al nuovo Ignition System+, sono state ridotte le emissioni di NOx del 30% rispetto alla precedente gamma One. È diminuito notevolmente anche il livello di rumorosità rendendo le caldaie della gamma One+ NET tra le più silenziose della propria categoria.

Il nuovo termostato smart
Come se non bastasse, le caldaie sono dotate del termostato Sensys
HD. Il termostato presenta un design completamente rinnovato, con schermo TFT a colori ad alta risoluzione e un’interfaccia utente più moderna e intuitiva. Infine, grazie all’intelligenza artificiale le nuove caldaie presentano anche la nuova funzione di manutenzione predittiva. Analizzando più nel dettaglio i modelli, Alteas One+ NET è senza dubbio il prodotto che più rappresenta le innovazioni di gamma. Presenta anche un nuovo circolatore con maggiore prevalenza e maggiore efficienza, riducendo così i consumi e la rumorosità. Il modello si distingue anche per un design moderno ed elegante: il pannello in vetro temperato e antigraffio lo rende infatti un oggetto d’arredo esteticamente esclusivo. Genus One+ NET, invece, è la sintesi moderna tra performance , facilità d’uso e tecnologia connessa. È dotata anch’essa del termostato di serie –Sensys HD – e WiFi integrato in caldaia, in grado di rilevare la temperatura esterna direttamente da internet senza sonda esterna. Infine, Clas One WiFi è la combinazione ideale di comfort e risparmio, con WiFi integrato

direttamente in caldaia e rapporto di modulazione aumentato fino a 1:8. È anche disponibile nella versione 30L con componenti maggiorati di serie, ed è particolarmente indicata per le sostituzioni in presenza di impianti di vecchia generazione. La nuova gamma di caldaie a condensazione One+ NET è nativamente connessa anche con l’app Ariston NET. Ciò consente di gestire i prodotti in tempo reale e a distanza, di accenderli e spegnerli, di impostare i programmi, modificare la temperatura e cambiare le modalità di funzionamento, anche tramite i principali assistenti vocali, come Hey Google e Alexa, per garantire costante efficienza e comfort. Inoltre, grazie all’innovativo sistema di controllo da remoto, l’app può avvisare anche in caso di imprevisti di malfunzionamento dell’impianto, previa sottoscrizione di un contratto di manutenzione, che garantisce anche 10 anni di assistenza garantita su parti di ricambio originali, manodopera, chiamata e intervento.
www.ariston.com
Diloc presenta “Green Line”: la linea di barriere d’aria per ambienti commerciali e grandi superfici in grado di offrire un comfort impeccabile e ottimizzare l’isolamento, eliminando le dispersioni termiche. Applicando le barriere sopra a porte e ingressi, il muro d’aria creato dal sistema di ventole protegge l’ambiente da flussi termici in entrata e in uscita, mantenendo il locale correttamente climatizzato ed evitando gli sprechi. Completo di tecnologia Eco e funzionalità smart , il sistema di ventilazione permette di lasciare aperte le porte di negozi, uffici, grandi magazzini e ingressi merci, e isola gli ambienti da sbalzi termici e infiltrazioni di smog, fumi o insetti. Gli sprechi energetici sono eliminati e le emissioni nell’ambiente sensibilmente ridotte, mantenendo sempre il massimo livello di comfort. Il sistema di ventilazione di Green Line combina l’azione di ventole multiple per offrire l’isolamento termico più adatto a ogni esigenza applicativa. La speciale ventola Centrifuga canalizza un flusso d’aria più intenso ed è progettata per installazioni a 300 cm d’altezza. La ventola tangenziale, discreta e silenziosa, permette un’installazione a partire da 250 cm. Grazie al flusso d’aria angolato a 105 gradi, le barriere d’aria possono inoltre essere utilizzate a moduli per aumentare la superficie coperta. La linea è disponibile in quattro modelli, con tagli di portata d’aria variabili da 1400 m2/h a 3600 m2/h e assorbimento energetico compreso tra 160W e 350W. www.naicon.com

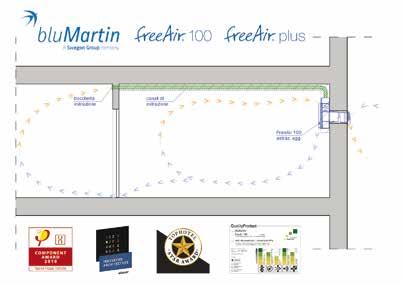
L’impianto intelligente che unisce i vantaggi del centralizzato con quelli del decentralizzato si presta anche per le ristrutturazioni
Installando l’impianto di ventilazione freeAir100 in posizione semiincassata nella muratura perimetrale si minimizzano le opere murarie. Grazie al kit di estrazione per stanze aggiuntive è possibile estrarre l’aria dai locali come bagno, lavanderia o guardaroba. In questo modo è possibile servire più ambienti minimizzando i tubi e recu perando il calore dalle stanze più calde e umide. La mandata resta a bordo macchina, mentre l’aria pulita si distribuisce negli ambienti vicini grazie alla differenza di pressione creata dalle estrazioni canaliz zate. Non ci sono tubi di mandata e le relative criticità per la pulizia e la sanificazione nel tempo. Oltre alle estrazioni aggiuntive, la macchina modula in automatico o al bisogno l’estrazione a bordo in modo da gestire eventuali odori del locale soggiorno/cucina. Se la cucina fosse in locale separato, si può estrarre con una tubazione aggiuntiva. Le unità interne freeAirPlus, dotate di sensori VOC, modulano l’aria nelle camere da letto, quando è necessario, senza la necessità di canali di mandata. L’impianto è ideale per abitazioni fino a 80 mq circa. L’installazione prevede di eseguire un foro di circa 27x27 cm; la con trocassa viene fissata al muro, sporgendo all’interno di circa 20 cm, ed è poi rivestita in cartongesso. In tal modo si agevola la posa dei canali di estrazione collegati al plenum superiore. freeAir100 modula la portata in base al fabbisogno reale tramite otto sensori, compreso quello della CO2. Il recupero di calore è fino al 94%, certificato Passive House e con Sigillo Qualità CasaClima. Filtri ePM10

di serie (opzionali ePM1) e bypass automatico per il free-coo ling. È possibile collegare il tutto al software freeAir Connect anche via WiFi, in cloud e con e-mail alert gratuito. Il sistema ha vinto diversi premi, tra cui: il Passive House Component Award, l’Iconic Design Award e il TopStar Hotel Award.
Wavin Italia presenta il nuovo sistema DRY per la realizzazione di impianti di riscaldamento radiante a secco. Pur mantenendo inalterate le peculiarità della precedente release , il sistema è in grado di assicurare un elevato livello di resistenza allo schiacciamento grazie al solo pannello, rendendo superflua la presenza della lamiera di copertura in acciaio zincato in precedenza necessaria per la ripartizione dei carichi. Pensato per applicazioni civili che non prevedono l’utilizzo di un massetto cementizio a copertura dell’impianto, complici l’assenza di un elevato spessore per la posa dell’impianto e il peso sopportabile ridotto, DRY si conferma una soluzione che garantisce il massimo comfort, velocità di posa ed efficienza sia in nuovi edifici che in caso di ristrutturazione. Il sistema a secco è composto da un pannello in polistirene espanso sinterizzato di soli 26 mm di spessore, che assicura livelli di resistenza meccanica e termica ottimali, rivestito da una lamina di alluminio con cinque scanalature a interasse di 15 cm predisposte per l’inserimento di un tubo di 16 mm di diametro. Una delle

sezioni di testa del pannello è invece stampata in modo da permettere la realizzazione di curve e di due tratti rettilinei di attraversamento. Per l’accoppiamento dei pannelli è sufficiente avvicinare i bordi ed eventualmente usare del nastro adesivo alluminato, mentre il fissaggio al pavimento richiede l’utilizzo di un’apposita colla da cappotto. Il rivestimento può essere realizzato con piastrelle direttamente incollate sul pannello, previa posa di opportuni primer di protezione, oppure in parquet flottante o incollato. www.wavin.com

Sherpa Aquadue di Olimpia Splendid è la serie di pompe di calore split polivalenti per il residenziale, che si distingue per la classe energetica superiore (fino alla A+++ in riscaldamento – clima medio) e il doppio circuito frigorifero brevettato, che migliora il comfort e incrementa l’efficienza. Sherpa Aquadue consente, infatti, di raffrescare in estate, riscaldare in inverno e produrre ACS in contemporanea: una caratteristica che – oltre a evitare interruzioni nell’erogazione del comfort indoor – rende possibile recuperare energia durante il raffrescamento estivo, aumentando l’efficienza del sistema. Sherpa
Aquadue può inoltre portare l’ACS a 75 °C in modo autonomo, senza l’ausilio di resistenze elettriche o generatori supplementari (come caldaie o solare termico). La possibilità di stoccaggio di ACS ad alta temperatura, a sua volta, consente di evitare il periodico ricorso ai cicli antilegionella (con i relativi picchi nell’assorbimento di energia elettrica) e di ridurre fino al 30% il volume del bollitore a pari quantità di ACS erogabile, ottenendo così un minore ingombro complessivo. Da sottolineare come le potenzialità di questa tecnologia si moltiplichino in presenza di un impianto fotovoltaico: tutte le pompe di calore Sherpa Aquadue sono infatti dotate di un contatto che consente di aumentare l’autoconsumo dell’energia prodotta dal fotovoltaico, immagazzinando l’energia sovraprodotta e riducendo la quantità di energia elettrica da acquistare dalla rete, anche quando l’irraggiamento solare è assente. Le pompe di calore split polivalenti di Olimpia Splendid sono disponibili nella versione a torre, con bollitore da 150 litri integrato, e nella versione pensile: unità quest’ultima che, grazie all’utilizzo di uno speciale kit, può essere installata con estrema flessibilità, a incasso o semi-incasso, all’interno così come all’esterno dell’edificio.
Panasonic Heating & Ventilation Air Conditioning presenta air-e, il primo generatore indipendente di particelle nanoe™X a soffitto. Il nuovo generatore è ideale per una vasta gamma di applicazioni in cui la qualità dell’aria indoor è un elemento fondamentale. Air-e è una soluzione a basso consumo energetico (4.0 W) e un singolo dispositivo può coprire una superficie di circa 20 m2. In caso di superfici maggiori, è possibile installare più di un’unità per una copertura completa degli spazi. Air-e è una soluzione a soffitto dal design discreto, che non richiede l’installazione aggiuntiva di tubazioni, ed è l’ideale per lavori di ammodernamento di ambienti con impianti di climatizzazione privi di tecnologia nanoe™X. Il suo peso di soli 1,1 kg lo rende estremamente semplice da installare, mentre il livello di pressione sonora di 25,5 db (A) ne garantisce un funzionamento discreto. Il generatore rilascia fino a 4,8 trilioni di radicali ossidrilici (noti anche come radicali OH) al secondo. I radicali ossidrilici, abbondantemente presenti in natura, possono contribuire a inibire 5 tipi di inquinanti, tra cui alcuni virus, batteri e muffe, nonché a neutralizzare i cattivi odori, come ad esempio il fumo di sigaretta. Gli studi condotti negli ultimi anni da Panasonic hanno inoltre dimostrato che il generatore di nanoe™X è in grado di inibire anche il SARSCoV-2 e il virus dell’influenza A sottotipo H1N1 fino al 99,9%. www.aircon.panasonic.eu

In occasione di Interclima e Chillventa, Clivet ha presentato in anteprima la nuova gamma VRF CVT8, disponibile dal 2023. Tra le caratteristiche della nuova gamma, in particolare, troviamo:
• ampio campo di funzionamento: da -15 °C a +55 °C in raffrescamento, fondamentale nei locali tecnici con apparecchiature elettriche, e da -30 °C a +30 °C in riscaldamento;
• design compatto e lunghezze frigorifere ancor più incrementate per adattarsi alle diverse esigenze impiantistiche;
• silenziosità;
• controllo intelligente tramite app;
• installazione flessibile ed efficiente grazie a procedure automatizzate.
Le unità esterne assicurano un elevato risparmio e un’alta affidabilità; è infatti possibile controllare accuratamente le variabili ambientali per ottenere le massime prestazioni e un consumo minimo (3W) in stand by L’installazione è flessibile e semplificata così come la manutenzione. L’impiego della tecnologia Mild Air migliora il benessere e la purezza dell’aria, mentre il nuovo EasyCom – bus avanzato di comunicazione e controllo a due cavi autoalimentato e indipendente delle unità interne, basato su una tecnologia sviluppata internamente con una tipologia d’installazione libera – assicura una comunicazione rapida e resistente a eventuali disturbi elettromagnetici. La capacità del singolo sistema VRF si estende fino a 90 kW per singolo modulo e 270 kW in combinazione; il funzionamento è controllato approfonditamente tramite 19 sensori distribuiti su tutto il circuito frigorifero e il box dove sono alloggiate le schede elettroniche è completamente isolato dalla polvere ed eventuali schizzi d’acqua. Completano la gamma di unità esterne le unità Mini VRF con gas R32 da 8-18 kW e gas R410 da 8 fino a 67 kW, combinabili fino a 3 moduli (200 kW) e con espulsione aria canalizzabile (80Pa), anche queste con ampio range di funzionamento da -15 °C a +55 °C in freddo e da -30 °C e +30 °C in caldo. La gamma di unità interne composta da 13 serie con potenze da 1,5 a 56 kW, compatibili sia con refrigerante R32 che con R410, assicura un ottimo controllo, un accurato filtraggio e la massima purificazione dell’aria con un indice di capacità fino al 200%.


Nell’ottobre 2021 sono stati completati i lavori di riqualificazione dell’ex Liceo Celio, a Rovigo, per ospitare l’Urban Digital Center. La storicità dell’edificio ha reso necessaria una scelta di interventi accurati a livello progettuale e installativo degli impianti di riscaldamento e raffre scamento. Il progetto prevedeva ambienti molto più grandi degli ambienti scolastici esistenti e strutturalmente si è dovuto procedere con l’abbattimento di mura interne e la realizza zione di una copertura eterogenea e sicura. In questo scenario, gli spazi a disposizione per eventuali centrali termiche non erano presenti. Pertanto, è stato fondamentale studiare una soluzione con impianti compatti e flessibili che non andassero ad appesantire la struttura e a diminuire gli spazi, calcolati al millimetro sulla base delle esigenze universitarie.
L’impianto di riscaldamento a radiatori esi stente è stato sostituito con la soluzione ad aria a fluido variabile VRF ECOi EX di Panasonic a due tubi, in abbinamento a una ventilazione meccanica controllata (VMC). I sistemi VRF sono maggiormente adattabili a edifici di diverse tipologie gra zie alla minima dimensione delle tubazioni di refrigerante; inoltre, in fase di progetta zione, non si deve tener conto di ulteriori ingombri dedicati ad accumuli d’acqua, pompe e trattamenti acqua. Oltre che più compatti, i sistemi VRF sono anche più semplici da gestire dato che, una volta avviati, funzionano senza dover control lare sistematicamente la qualità dell’acqua, la circolazione e la pulizia delle tubazioni. Un altro punto a favore è la possibilità di ragionare in termini di efficienza energetica e comfort umano grazie alla possibilità di regolare automaticamente la temperatura di evaporazione (VET) o condensazione (VCT) e di impostare la temperatura di uscita dell’aria tra i 7 °C e i 22 °C.

Per garantire il massimo in termini di comfort termico-acustico e qualità dell’aria è stata richiesta una soluzione con:
• terminali d’impianto dimensionati alla minima velocità, posizionati al cen tro delle stanze per escludere qualsiasi situazione di correnti d’aria;
• terminali con tecnologia per la purifica zione dell’aria integrata senza appesan tire ulteriormente la struttura con ulteriori device finalizzati alla IAQ.
Vincente è stata la scelta nel garantire aria primaria tramite la VMC e preservare la qualità della stessa mediante un impianto con tecnologia di purificazione integrata.
Ogni zona (aule, uffici, sale studio e common room) è controllata in temperatura, velocità e qualità dell’aria grazie ai comandi CONEX di Panasonic in modo autonomo con esclu siva mandata e ripresa dell’aria all’interno di ogni stanza. Con il fine di garantire una migliore qualità dell’aria sono state instal late, al centro della stanza, unità interne a cassetta 90x90 Panasonic con tecnologia nanoe™ X integrata mark 2. Tale soluzione consente di rilasciare 9.600 miliardi di radi cali ossidrilici al secondo che, a loro volta, inibiscono 5 tipi di inquinanti, allergeni, pollini, cattivi odori e alcuni virus e batteri. L’innovativa tecnologia garantisce gli stessi benefici all’interno degli edifici, rendendoli più confortevoli. Le unità interne installate, inoltre, hanno la funzione di pulizia interna e permettono il controllo dell’umidità, l’impo stazione individuale dell’orientamento delle quattro alette e hanno una ridotta rumoro sità della ventola in modalità lenta.


Sempre nell’ottica di voler preservare la qualità dell’aria, tutte le unità UTA sono state posi zionate nel sottotetto (quindi protette da intemperie) e la loro presa d’aria esterna è a quota oltre 9 metri dal piano stradale. Ogni stanza è dotata di diffusori ad alta induzione a effetto elicoidale per massimizzare la diluizione dell’aria pulita dentro la stanza. Le aule sono utiliz zate con profili fortemente variabili e le UTA sono state suddivise proprio in funzione di tali profili: così i consumi energetici sono funzionali all’effettivo utilizzo degli ambienti.
Energeticamente parlando, ogni zona ha il controllo dei principali parametri di comfort e, al tempo stesso, è presente una supervisione da pannello centralizzatore touch screen Pana sonic (CZ-256ESMC3) dal quale è possibile impostare diversi profili di utilizzo. Il comando regola il funzionamento dell’impianto di climatizzazione, comprensivo della ventilazione mec canica, mettendo a disposizione funzioni di monitoraggio on-demand, calcolo carico (interno/ totale), indicazione dell’impostazione del livello limite massimo in accordo al prezzo dell’e nergia, alla domanda di elettricità e al carico per il condizionamento. Oltre al comfort, è stato infine richiesto dalla committenza di preservare il buon funzionamento di apparecchiature molto particolari. Il raffrescamento della sala server è stato garantito da un impianto TKEA Panasonic con due unità ridondanti tra loro. In caso di avaria il sistema sarà capace, in modo istantaneo e automatico, di garantire le condizioni climatiche ottimali affinché l’apparecchia tura
possa essere nelle sue migliori condizioni per operare.


per la Transizione Energetica INES.2S – centro francese supportato dalla Commissione francese per le energie alternative e l’energia atomica (CEA) – ha recentemente presentato VIPV (Vehicle Integrated PhotoVoltaics) , soluzione per integrare l’energia solare nei trasporti privati. Il kit, per ora ancora in fase di prototipo, è piuttosto semplice, non invasivo e di facile utilizzo. Consiste in un pannello fotovoltaico con una potenza di 145 Wp; il modulo vanta una faccia posteriore magnetica e un design meccanico che gli consentono di adattarsi a qualsiasi carrozzeria metallica. L’elettronica è costituita da un regolatore di carica MPPT, associato a una batteria oltre che da un microinverter.

Il kit è estremamente versatile e facilmente montabile e smontabile; può essere utilizzato su qualsiasi veicolo dotato di carrozzeria metallica, ma ha la pecca di non riuscire ad alimentare direttamente la batteria principale, dettaglio su cui il team di ricerca si sta concentrando al fine di trovare un modo per permettere al panello di caricare direttamente l’accumulatore mantenendo le perdite al minimo.
Il prototipo è stato testato con successo su una Renault Zoe, dimostrando la possibilità di guadagnare fino 4 km al giorno, potendo sfruttare l’energia solare di una giornata estiva con una potenza di 145Wp, e un consumo stimato di 150Wh/km. Indubbiamente i dati raccolti, per quanto incoraggianti, sono piuttosto limitati ed è necessaria una serie di feedback di mesi su veicoli diversi per quantificare con precisione il contributo effettivo in chilometri solari che il kit è in grado di fornire. Secondo il team una stima piuttosto veritiera si attesterebbe a circa 800 km di autonomia aggiuntiva all’anno, sempre considerando l’adozione di un kit solare con una potenza di 145 Wp utilizzato sul modello di riferimento. Per ora l’Istituto francese punta ad accendere la curiosità dei possessori di un veicolo elettrico attorno alla propria invenzione, in modo da poterla testare e renderla un prodotto finito e commercializzabile.






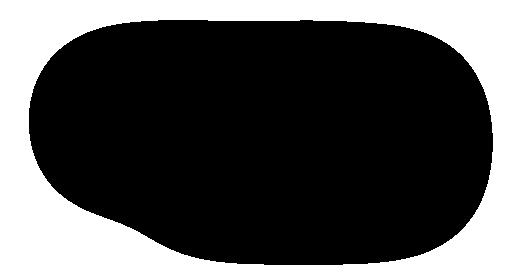
DEMO (Demonstration Fusion Power Reactor) entrerà in funzione intorno alla metà del secolo e permetterà di produrre fino a 500MW
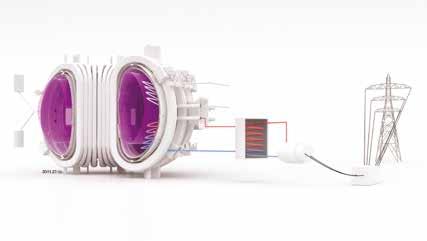
la progettazione ingegneristica della prima centrale dimostrativa a fusione, denominata DEMO (Demonstration Fusion Power Reactor), che si pone l’obiettivo di produrre, intorno alla metà del secolo e in modo sicuro e sostenibile, 300-500 MW di energia elettrica, in grado di soddisfare i consumi annuali di circa 1,5 milioni di famiglie. Lo ha annunciato a Bruxelles il Consorzio EUROfusion – di cui fanno parte 21 organizzazioni italiane coordinate da ENEA, tra cui Istituto per la scienza e tecnologia dei plasmi del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istp) e Consorzio RFX – in occasione della conferenza di lancio di Horizon EUROfusion , il nuovo programma europeo di ricerca sulla fusione cofinanziato dalla Commissione europea tramite Euratom. Il reattore dimostrativo DEMO sarà il successore dell’impianto sperimentale ITER, attualmente in costruzione nel sud della Francia, a Cadarache. “Si tratta di un passo importante che traghetterà la ricerca sulla fusione da un ambito puramente sperimentale alla produzione vera e propria di energia elettrica. Per farlo DEMO dovrà adottare le più avanzate tecnologie per ‘controllare’ il plasma e generare elettricità in modo sicuro e continuo operando con un ciclo del combustibile chiuso”, sottolinea Alessandro Dodaro, direttore del Dipartimento ENEA di Fusione e tecnologie per la sicurezza nucleare. “A questo scopo, stiamo realizzando, con i nostri partner , il super laboratorio Divertor Tokamak Test (DTT) presso il Centro Ricerche di Frascati. Qui testeremo nuove e diverse configurazioni e materiali per il divertore, il dispositivo che avrà il compito di smaltire il calore residuo all’interno dei reattori a fusione con flussi di potenza superiori a 10 milioni di Watt per metro quadrato, confrontabili a quelli della superficie del Sole”, aggiunge Dodaro. “Questo passo conferma la roadmap europea che si pone come scopo la produzione di energia elettrica da reazioni di fusione – spiega Daniela Farina, direttrice dell’Istituto per la scienza e tecnologia dei plasmi del Cnr. Per conseguire questo obiettivo con successo è importante che la ricerca della comunità scientifica prosegua attivamente sui temi scientifici e tecnologici tuttora aperti in un’ottica
più ampia possibile, sui quali il Cnr sta lavorando in sinergia con gli altri enti e istituzioni italiani e nel quadro di una straordinaria collaborazione mondiale. È uno sforzo globale che non può attuarsi senza un sostegno convinto nel lungo termine”.
“La decisione di sviluppare il progetto di DEMO, un reattore a fusione dimostrativo in Europa, è il naturale sviluppo del costante impegno europeo, da sempre all’avanguardia a livello globale, nella promozione della ricerca di risorse energetiche a basso impatto ambientale di cui la fusione dell’idrogeno rappresenta uno degli ingredienti del paniere di fonti rinnovabili ed eco-sostenibili – sottolinea Piergiorgio Sonato, presidente del Consorzio RFX, i cui soci sono Cnr, ENEA, INFN, Università degli Studi di Padova e Acciaierie Venete. Il Consorzio RFX ospita a Padova, presso l’Area di Ricerca del Cnr, oltre all’esperimento RFX-mod che è una delle infrastrutture di ricerca ad alta priorità come definito nel PNIR 2021-27 (Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca Italiane), il laboratorio di sviluppo degli iniettori di particelle neutre per ITER, NBTF-Neutral Beam Test Facility ; rappresenta l’elemento indispensabile per accendere e controllare la reazione di fusione dell’idrogeno nel reattore ITER in fase di installazione a Cadarache, in Francia, e a cui contribuiscono Cina, Corea del Sud, India, Giappone, Russia, Stati Uniti d’America e Unione europea”, aggiunge Sonato. L’annuncio di DEMO arriva dopo il risultato record ottenuto da EUROfusion presso l’impianto europeo JET (Joint European Torus) a Culham (Regno Unito), che ha prodotto 59 megajoule di energia totale da fusione utilizzando lo stesso mix di combustibili di deuterio-trizio (plasma) che sarà impiegato in ITER, in DEMO e nelle future centrali elettriche a fusione. Il record è stato possibile creando e sostenendo plasmi stabili in grado di generare elevati valori di potenza di fusione, circa 11 MW, per 5 secondi, a fronte di circa 33 MW di potenza di riscaldamento immessa dall’esterno.
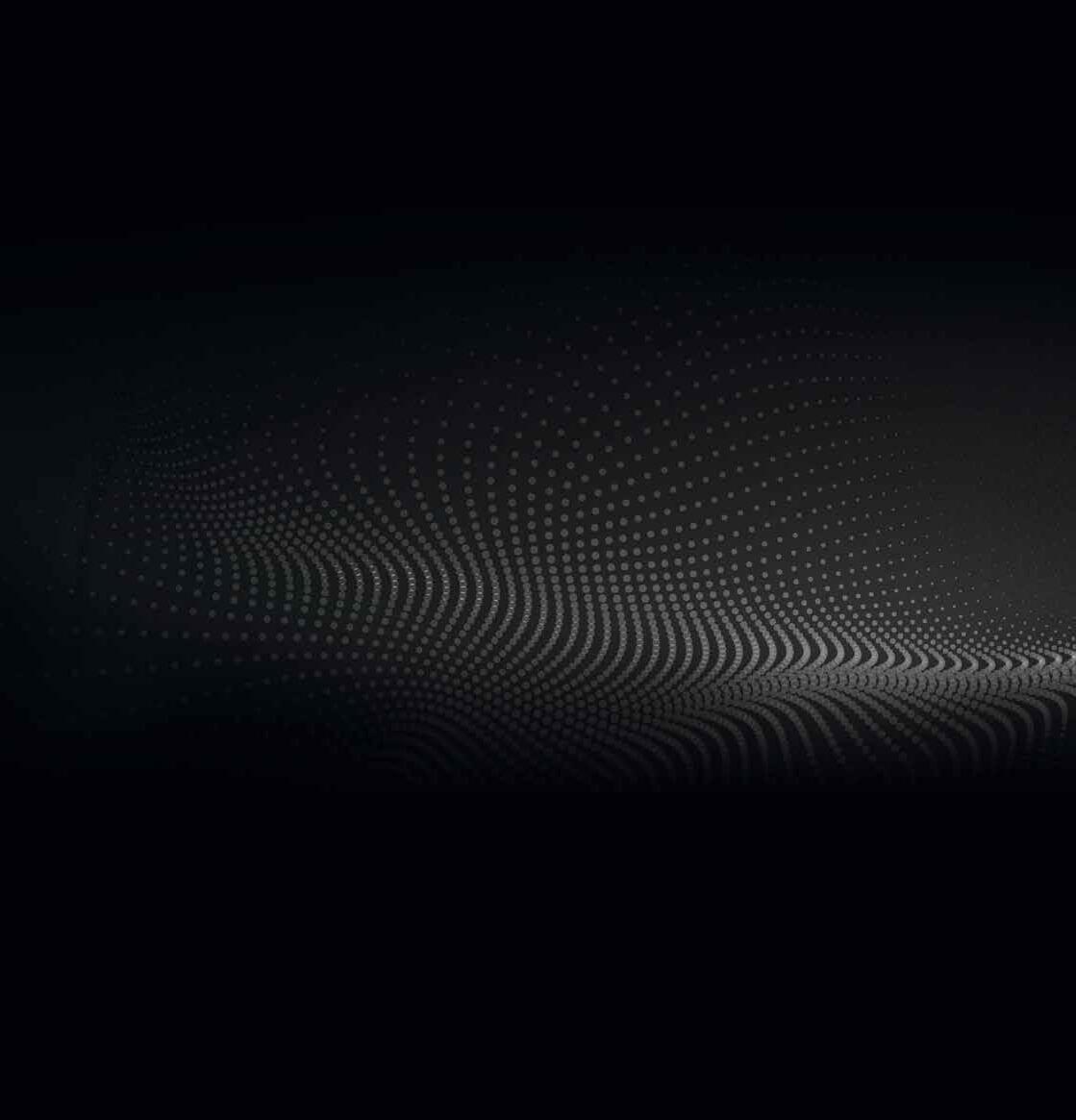
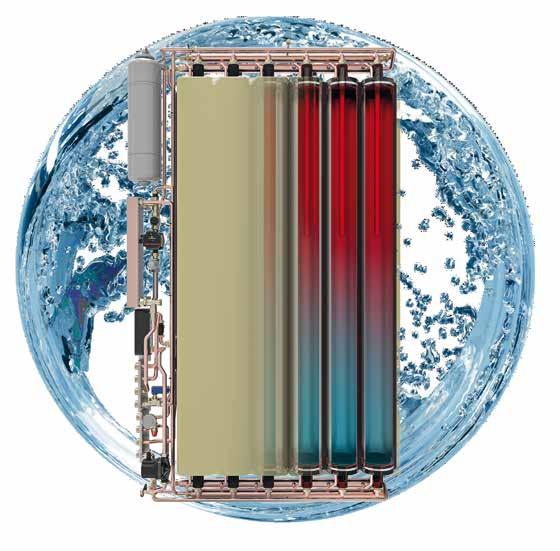

Uno studio del Cnr ha indagato la variazione del valore immobiliare degli edifici residenziali di Firenze in funzione delle anomalie termiche superficiali estive
Ilrisultato di questa ricerca del Cnr è stato pubblicato a metà luglio, ma riteniamo sia da considerare ancora valido anche per gli anni a venire. Nonostante la sempre maggiore attenzione indirizzata all’impatto di alcuni eventi estremi legati ai cambiamenti climatici (tra cui tempeste, innalzamento del livello del mare, inondazioni, incendi) sul patrimonio immobiliare, ancora scarsa è quella dedicata all’effetto delle elevate temperature. Le anomalie termiche superficiali urbane, esaltate dal fenomeno delle isole di calore, possono infatti associarsi a un significativo aumento dei costi per il raffreddamento degli ambienti interni, del consumo di acqua e a un generale disagio che incide sensibilmente sulla qualità della vita. Questo aspetto è rilevante soprattutto in Europa, una delle regioni più attraenti al mondo per gli investimenti immobiliari, e ancor più in Italia, dove oltre il 70% della popolazione è proprietaria di abitazioni. Nello studio, pubblicato sulla rivista Sustainability , coordinato dai ricercatori dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe) con il contributo di Ispra, è stata indagata la variazione del valore immobiliare degli edifici residenziali in una città storica italiana (Firenze) in funzione delle anomalie termiche superficiali estive.
Dalle analisi è emerso che la temperatura superficiale è sempre più determinante per la valutazione del valore di un immobile residenziale man mano che ci si allontana dal centro storico. “Gli effetti sono infatti
Abbiamo utilizzato dati satellitari NASA per la stima della temperatura superficiale, quelli sul valore degli immobili dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate e quelli sulle caratteristiche urbane (consumo di suolo, copertura arborea ed erbacea e corpi d’acqua) forniti da Ispra. Per valutare il diverso valore immobiliare si è tenuto conto anche delle caratteristiche urbane circostanti gli edifici. Le analisi sono state condotte in varie zone della città (centrale, semicentrale e periferica) e su edifici con diversi pattern termici (hot-spot, cool-spot e zone neutre)
MARCO MORABITO, ricercatore Cnr-Ibe
evidenti nella fascia semicentrale e soprattutto periferica, dove l’aumento del valore di mercato dell’immobile è associato linearmente a una diminuzione della temperatura – commenta Marco Morabito, ricercatore Cnr-Ibe. La temperatura superficiale, invece, non è determinante per il valore immobiliare nella fascia centrale, dove altri elementi come la vicinanza a luoghi storici, paesaggistici e architettonici influisce in modo determinante. Anche se il 37% degli immobili residenziali centrali ricade in hot-spot termici, quasi il 10% di questi appartiene alla classe con il valore di mercato più alto”.
L’identificazione degli edifici in zone di hot-spot e la conoscenza delle caratteristiche urbane che li circondano sono informazioni utili per pianificare interventi mirati a renderli sostenibili e più efficienti dal punto di vista energetico. “In questo modo potranno essere evitati futuri deprezzamenti del valore immobiliare dovuti agli effetti del caldo. Per quanto ancora l’attrattività e il fascino di un edificio residenziale nel centro storico prevarranno sui costi di gestione sempre più elevati necessari per garantire una buona qualità della vita, viste le temperature sempre più elevate per periodi prolungati dell’anno?”, conclude il ricercatore Cnr-Ibe.
Lampade a LED che, oltre a illuminare, sono in grado di sanificare da batteri e virus – tra cui il virus SARS-CoV-2 – scuole, uffici e luoghi pubblici, ma anche superfici, aria e acqua, in modo sicuro, rapido, sostenibile ed economico. È questa una delle ultime novità realizzate da ENEA. In particolare, le due tecnologie applicate si chiamano SAVE e UV-CiSANA e si basano su sistemi LED e di tipo UV-C.


SAVE è una lampada da soffitto pronta per l’industrializzazione, dotata di un sistema smart che abbina algoritmi e tecnologie radar per la gestione sicura del personale. Di facile installazione e già dotata di certificazione virucida, oltre a sanificare consente di programmare il funzionamento e segnala l’eventuale ingresso indesiderato di persone o animali durante le operazioni. In soli 45 minuti è in grado di sanificare da virus e batteri, incluso il SARSCoV-2, un ambiente di circa 20 mq, in assenza di persone o animali. “Con un livello di maturità tecnologica 6, il cosiddetto Technology Readiness Level o TRL, il nostro prototipo SAVE è stato dimostrato in ambiente rilevante ed è pronto per l’industrializzazione –sottolinea Mariano Tarantino, responsabile della divisione ENEA di Sicurezza e sostenibilità nucleare del Centro Ricerche di Bologna.
Per il futuro prevediamo di implementarne le funzionalità con sistemi di assistenza per ipovedenti e di estenderne l’applicazione, per esempio, sui mezzi pubblici o in agricoltura, per la sanificazione da patogeni, come contributo al controllo della pandemia mondiale”. Il progetto SAVE è stato finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e, in parte, da risorse ENEA.
LED a ultra-violetti per la sanificazione battericida e virucida
Per quanto riguarda UV-CiSANA, si tratta di lampade innovative a LED UV-C per sanificare superfici, aria e acqua, in grado di eliminare oltre il 99,9% di batteri e virus, incluso il SARS-CoV-2, anche in pochi secondi di irraggiamento. Le lampade a LED UV-C sono compatte, facilmente trasportabili, sostenibili e con dimensioni e tempi di accensione e spegnimento ridotti rispetto alle lampade a mercurio comunemente utilizzate. La tecnologia è efficace anche per la sterilizzazione in tempo reale di acqua con flusso tipico di un comune rubinetto, così come per la sanificazione dell’aria in locali chiusi (uffici, aule scolastiche, negozi, etc.). “La capacità sterilizzante dei LED UV-C, che emettono radiazione ultravioletta della banda C, è nota da tempo: la sua efficacia si basa sul fatto di essere assorbita efficacemente dal DNA/ RNA dei patogeni (virus, batteri, funghi), rompendone i legami e causandone quindi l’eliminazione o l’inattivazione – spiega Sarah Bollanti del laboratorio ENEA di Applicazioni dei plasmi ed esperimenti interdisciplinari. La tecnologia a LED UV-C è promettente e la nostra esperienza in ottica, in particolare in sorgenti di luce ultravioletta, ci permette di progettare e realizzare dispositivi ad hoc per le diverse necessità. Siamo disponibili a nuove collaborazioni anche per valutare applicazioni in cui compattezza, trasportabilità e rapidità di utilizzo siano prioritarie, come ad esempio su treni, aerei e altri mezzi di trasporto”.
Queste speciali lampade sono state sviluppate dai Centri Ricerche ENEA di Brasimone (Bologna) e Frascati (Roma)Il progetto è promosso da Rete Ferroviaria Italiana e dalle 29 associazioni che costituiscono Amodo, l’Alleanza per la mobilità dolce
a cura di URBANPROMO
L’
Atlante della mobilità dolce è stato presentato nell’ambito di Urbanpromo (11-14 ottobre), manifestazione organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit a Torino presso Cascina Fossata. Il progetto dell’Atlante è promosso da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e dalle 29 associazioni che costituiscono Amodo, l’Alleanza per la mobilità dolce. Si parte dai big data e dalla geografia collaborativa per mettere in relazione
stazioni ferroviarie, ciclovie, cammini, sentieri e greenways con il patrimonio storico, artistico e naturalistico presente su tutto il territorio nazionale: è il primo compendio che opera questa rilevazione in modo integrato. Il protocollo, avviato nel marzo dello scorso anno, è di durata triennale e – oltre a offrire uno strumento di divulgazione – vorrebbe orientare e aiutare le scelte delle istituzioni e degli enti locali per lo sviluppo della mobilità dolce nei propri territori.
Si è esaurita la prima fase in cui sono state raccolte e sistematizzate le informazioni. Ora fino a marzo 2024, momento di conclusione del protocollo Amodo-Rfi, il lavoro proseguirà con l’aggiornamento e l’implementazione delle banche dati, lo sviluppo ulteriore dell’analisi e il confronto con gli enti interessati – ovvero Regioni, Province e città di dimensioni maggiori – per promuovere la traduzione delle informazioni in politiche. Emerge che abbiamo a disposizione un potenziale importante di accessibilità dolce, ma in generale manca l’ultimo miglio. Perciò vogliamo scegliere tra le oltre 3.000 stazioni ferroviarie quelle che diventeranno hub della mobilità dolce per pianificare e realizzare – con il Ministero delle Infrastrutture, Rfi e gli enti locali interessati – i collegamenti con gli elementi della rete che sono ad esse prossimi, come i sentieri, i cammini, le piste ciclabili
GIULIO SENES, componente del Comitato di Gestione ristretto di Amodo
Nella prima fase del lavoro è stata conclusa la mappatura integrata di oltre 3.000 stazioni ferroviarie attive (di cui circa 2.000 di RFI), delle 28 linee ferroviarie turistiche attive o in progetto (per circa 1.600 km), dei circa 900 borghi delle reti appartenenti ad Amodo (Bandiere Arancioni, Borghi Autentici d’Italia, Cittaslow, Comuni Virtuosi, Borghi più Belli d’Italia), dei circa 12.000 km di sentieri nazionali e internazionali (Sentiero Italia del CAI e i sentieri internazionali di FIE), degli 83 cammini (per un totale di circa 24.000 km), delle 1.656 aree protette per un totale di circa 100.000 km2 (24 Parchi Nazionali, 147 Riserve Naturali Nazionali, 134 Parchi Naturali Regionali e Riserve Naturali Regionali, 68 SIC e 610 ZPS, 171 Altre Aree Naturali Protette, 112 Oasi WWF, 3 Parchi Naturali Sommersi e 27 Aree marine protette, 66 Parchi Minerari ReMI), dei 55 siti Unesco (per circa 5.700 km2), dei circa 18.000 km di greenways e ciclovie, esistenti e in progetto (37 greenways, 3 itinerari Eurovelo, 10 Ciclovie Turistiche Nazionali, 20 itinerari Bicitalia). Sono state, inoltre, individuate e mappate le 50 linee ferroviarie in esercizio di straordinaria bellezza che attraversano le aree interne e i territori italiani, che sono state denominate da Rfi e Amodo come “Linee del paesaggio” da proporre per il turismo slow www.urbanpromo.it

“
“

La progettazione ha un ruolo centrale nella transizione energetica. Una progettazione “all-round” che guarda alla produzione ed all’utilizzo dell’energia, al mondo termico ed elettrico, alla climatizzazione ed alla mobilità.
ll Concorso di Idee Viessmann 2022 è il contest che premia i progetti che hanno una visione di sistema atta a massimizzare l’efficienza globale nel contesto in cui si opera.

Partecipare è semplice! Fino al 30 novembre candida i progetti che meglio rappresentano le tue proposte di progettazione efficiente. Viessmann ti premia!
Scopri come partecipare e i premi in palio!
energetica
Secondo i dati Cerved, nel 2021 il settore della refrigerazione, ventilazione e condizionamento è cresciuto nettamente. Ma ora sconta l’impatto dell’aumento dei costi di materie prime, componentistica ed energia

a cura della REDAZIONE
Il peggio è (forse) alle spalle. Dopo il calo del 2020, il set tore della refrigerazione, ventilazione e condizionamento è in netta ripresa e chiude il 2021 con numeri che fanno ben sperare. Dalla fotografia scattata da Cerved nell’ultimo report (maggio 2022) emerge un trend positivo, con una domanda in decisa crescita per tutte le categorie di prodotto del com parto, grazie soprattutto alla ripresa del sistema economico dopo la pandemia Covid-19. Restano, a ogni modo, alcune incognite per il 2022 e gli anni a venire, a causa dei conflitti
internazionali in corso, che stanno comportando una difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime e componentistica e un generale aumento dei costi. Considerando l’intero settore, la produzione interna di impianti di refrigerazione, ventilazione e condizionamento nel 2021 si attesta a 4.103 milioni di euro, in aumento dell’11,3%. Un incremento trainato sia dall’aumento delle vendite sul mercato interno, in crescita del 16,4%, per un totale di 1.865 milioni di euro, sia dall’incremento delle esportazioni, che registrano un
Questo studio è realizzato da Cerved Market Intelligence, la divisione Cerved che ti consente di conoscere il mercato in cui operi e far crescere il tuo business. Vuoi approfondire le evoluzioni del tuo settore di riferimento? Scrivici a info.marketingsolutions@cerved.com
Fonte: elaborazione Cerved su fonti qualificate
aumento dell’8,0% e si attestano a 2.460 milioni di euro. Sebbene l’export continui a rappresentare il 60% della produzione nazio nale, anche le importazioni, pur rimanendo marginali, alimen tando solo l’11,9% del mercato interno, mostrano un aumento positivo (+15%).
La produzione nazionale di impianti di refrigerazione e venti lazione è tra le più importanti al mondo e nel 2021 si attesta a 2.338 milioni di euro, segnando una crescita dell’11,5% rispetto all’anno precedente.
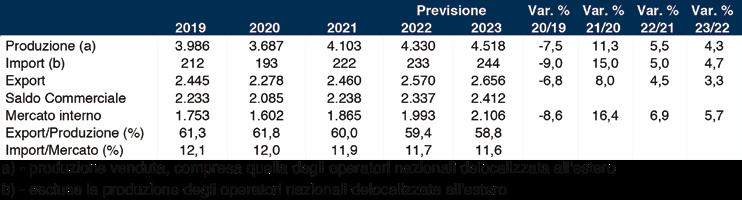
I produttori italiani detengono un ruolo di primo piano nel con testo settoriale su scala mondiale e vantano una considerevole specializzazione tecnologica.
I principali operatori nazionali presentano un’elevata propen sione alle esportazioni, che assorbono quasi il 60% della pro duzione italiana in valore, per una dimensione di 1.400 milioni di euro, in aumento del 10,8%. Il mercato interno vale 1.030 milioni di euro e mostra un incremento del 12,3%, con le importazioni che soddisfano circa il 9% della domanda nazio nale, attestandosi sui 92 milioni di euro. La maggior parte degli operatori è specializzata nel settore o presenta una diversifi cazione relativa alla componentistica (scambiatori di calore) o alla vendita di arredi e attrezzature per punti vendita della ristorazione.
Entrando nel dettaglio della produzione italiana di impianti di refrigerazione e ventilazione, questi i risultati delle 4 aree d’affari: ■ refrigerazione commerciale (banchi, mobili e celle frigo rifere). Il segmento rappresenta il 43,2% del totale, con un
valore di 1.010 milioni di euro, in aumento del 16,9%; i dati evidenziano come nel 2021 vi sia stato un incremento di espositori e banchi frigo per supermercati e dei prodotti per l’industria e la logistica alimentare. Resta debole, invece, la domanda del mercato ristorazione e alberghiero, dove l’inci denza delle esportazioni è elevata per la presenza di grandi operatori specializzati, che vantano una ampia e consolidata presenza internazionale;
■ refrigerazione industriale (condensatori, gruppi frigoriferi, raffreddatori di liquido, aeroevaporatori, dry cooler, refrigera tori a bordo macchina). L’area, che rappresenta il 36,1% del totale, con un giro d’affari di 840 milioni di euro (in crescita dell’8,4%), nel 2021 è influenzata dal rilancio della domanda europea dopo l’intensa flessione del 2020, dalla tendenza più favorevole per le macchine che utilizzano gas refrigeranti naturali (anidride carbonica, ammoniaca) e che dispongono di un maggior contenuto tecnologico (in termini di sistemi elettronici di gestione e controllo);
■ ventilazione. L’area rappresenta il 13,8% rispetto al totale, con un valore di 325 milioni di euro, in aumento del 7,3%, che comprende anche una parte di componentistica (soprattutto ventole). La produzione nel 2021 cresce grazie allo sviluppo della domanda del comparto agroalimentare (allevamenti, serre, industrie alimentari) e alla leggera ripresa di quella industriale e del terziario. Per alcune linee di prodotto a bassa complessità, la produzione italiana resta penalizzata dalla cre scente concorrenza dei produttori internazionali, soprattutto nell’ambito delle esportazioni;
■ scambiatori di calore a fascio tubiero. Il segmento copre il rimanente 6,9% del totale, con una dimensione di 163 milioni di euro, in aumento del 5,2%, destinati in gran parte all’export. Dopo alcuni anni di continua contrazione, l’area torna a registrare un incremento della produzione italiana, in relazione alla ripartenza degli investimenti in grandi impianti nel comparto petrolchimico ed energia.
TABELLA 1. Il settore degli apparecchi per la refrigerazione, la ventilazione e il condizionamento. Dati in milioni di euro, variazioni percentualiLa produzione italiana di impianti per il condizionamento cen tralizzato registra nel 2021 una crescita dell’11,0%, arrivando a quota 1.765 milioni di euro. La forza del settore risiede sicura mente nel numero elevato di produttori con competenze tecno logiche consolidate e in grado di presidiare la domanda nazio nale e internazionale. L’andamento positivo della produzione nazionale è favorito sia dalla crescita del mercato interno, che ha una dimensione di 835 milioni di euro e segna un incremento del 21,9%, che dalla ripresa delle esportazioni, che aumentano del 4,4% e si attestano su un valore di 1.060 milioni di euro. L’ac celerazione del mercato influisce anche sul livello delle importa zioni, aumentate del 18,2%, fino a raggiungere un valore di 130 milioni di euro. L’export ha un’importanza rilevante per il settore e copre circa il 60% della produzione nazionale, coinvolgendo tutte le aree di prodotto. Per alcuni segmenti, tra i quali i gruppi refrigeratori nelle fasce di potenza superiori a 50 kW o le unità terminali, l’incidenza dell’export sulla produzione nazionale è particolarmente alta.
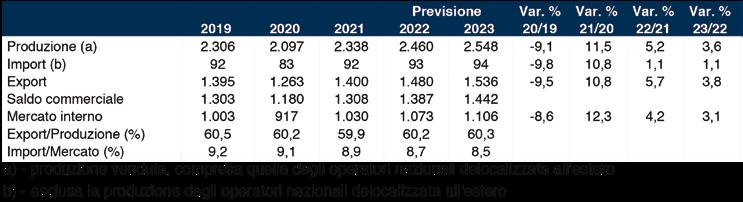
La produzione nazionale di impianti centralizzati di condiziona mento riguarda cinque aree d’affari, con caratteristiche, ambiti di destinazione, canali distributivi e andamenti differenti: ■ gruppi refrigeratori (chiller). Costituiscono l’area setto riale più rilevante e rappresentano il 63,2% della produzione nazionale in valore, in crescita del 12,1% a 1.115 milioni di euro (pari a 71.000 macchine, in aumento del 12,7%). L’attività dei produttori mostra tassi di crescita maggiori per i sistemi a condensazione ad aria, in particolare per le macchine di potenza minore che hanno beneficiato della tendenza del
mercato residenziale a spostarsi verso sistemi a pompa di calore, anche per effetto del Superbonus 110%. Per i sistemi a condensazione ad acqua, caratterizzati da potenze e dimen sioni decisamente maggiori, per i quali i produttori italiani vantano una forte specializzazione e sono leader a livello internazionale, la produzione registra invece un rallenta mento, penalizzata anche dalla contenuta ripresa dell’export; ■ unità interne (ventilconvettori, fan coil). Il segmento rappre senta il 13,3% della produzione nazionale in valore, in crescita del 11,9% a 235 milioni di euro (pari a 850.000 macchine, in aumento del 13,3%). I produttori nazionali sono leader a livello europeo e mondiale e destinano all’export il 50% circa della propria produzione. La forte accelerazione di questi pro dotti è strettamente legata alla forte diffusione delle pompe di calore di piccola taglia, in particolare sul mercato residenziale. I maggiori aumenti della produzione hanno riguardato i ven tilconvettori standard con mantello e i sistemi hi-wall; hanno mostrato una crescita significativa anche le unità interne di taglia maggiore per i sistemi canalizzati;
 TABELLA 2. Il settore degli apparecchi per la refrigerazione e la ventilazione. Dati in milioni di euro, variazioni percentuali
Fonte: elaborazione Cerved su fonti qualificate
TABELLA 2. Il settore degli apparecchi per la refrigerazione e la ventilazione. Dati in milioni di euro, variazioni percentuali
Fonte: elaborazione Cerved su fonti qualificate
Fonte: elaborazione Cerved su fonti qualificate
■ centrali trattamento aria. Costituiscono il 9,6% della produ zione nazionale in valore, con un incremento del 9,7% a 170 milioni di euro. In conseguenza della pandemia Covid-19 si è diffusa una maggiore consapevolezza relativamente all’im portanza della qualità dell’aria, motivo per cui i produttori settoriali stanno sviluppando sistemi dotati di nuovi metodi di filtrazione che includono tecnologie di sanificazione (tra le quali lampade UV, filtri elettronici, non thermal plasma);
■ condizionatori di precisione per centri di elaborazione dati (CED). Rappresentano il 6,8% della produzione nazio nale in valore, in crescita del 9,1% a 120 milioni di euro. I produttori italiani distribuiscono i propri prodotti princi palmente all’estero, sia per l’appartenenza a grandi gruppi multinazionali sia a causa della dimensione contenuta del mercato nazionale. La produzione nazionale beneficia del forte sviluppo di centri di calcolo e data center indotto dalla ampia adozione dello smart working, la cui diffusione è solo parzialmente calata con il superamento della fase pandemica più critica;
■ altri sistemi (packaged, rooftop, aerotermi). Il segmento copre il 7,1% della produzione nazionale in valore, con un incremento del 4,2% a 125 milioni di euro. I produttori italiani sono leader a livello nazionale e mostrano un’ele vata propensione all’export per alcune tipologie di prodotto (principalmente i condizionatori packaged). Questi segmenti di prodotto non hanno ancora recuperato i livelli produttivi pre-Covid a causa di una ripresa della domanda inferiore rispetto ad altre categorie di prodotto.

Secondo i dati Cerved, nel primo semestre del 2022 il settore si sta dimostrando dinamico e in crescita, grazie alla ripresa degli investimenti del comparto commerciale, agli effetti degli incentivi pubblici di sostegno alla domanda e al portafoglio di ordini inevasi nel 2021 di cui tanti operatori stanno bene ficiando. Il settore è anche favorito dal superamento della
fase pandemica per i mercati della ristorazione e dell’alber ghiero, la ripresa degli investimenti nell’industria petrolchimica e gli effetti sull’industria italiana delle azioni messe in campo dal Governo per stimolare gli investimenti pubblici e delle imprese (PNRR).
Qualche incertezza sembra invece esserci per la seconda parte dell’anno, nella quale il settore potrebbe risentire dell’incerta evoluzione di alcuni fattori esterni, che potrebbero limitare lo sviluppo della domanda e dei livelli di produttività e margina lità delle imprese. Fra questi, vanno considerati in particolare l’incremento, a partire dall’ultimo trimestre 2021, dei costi di acquisto e la scarsa disponibilità di materie prime (acciaio, allu minio, rame) e della componentistica meccanica ed elettronica e la crescita dei costi di trasporto e logistica e dell’energia, che nel breve periodo determinano una notevole criticità per gli operatori in termini di riduzione dei livelli di marginalità del business. A livello internazionale potrebbero influire la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, le sanzioni economiche verso Russia e Iran, così come la critica situazione sociale e politica in Nord Africa e Sud America. Per quanto riguarda invece le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina, il settore finora non ne ha risentito molto, dal momento in cui per i produttori nazionali le esportazioni verso Russia, Bielorus sia e Ucraina rappresentano una quota decisamente contenuta dell’export totale. Vanno però considerati gli effetti indiretti sulle imprese italiane del conflitto e delle sanzioni economi che adottate dall’Unione Europea, poiché hanno determinato una accelerazione dell’aumento dei costi delle materie prime e soprattutto dell’energia elettrica, in relazione all’importanza della Russia nella fornitura di gas naturale all’Italia e ad altri Paesi europei. L’aumento dei prezzi di vendita potrebbe infine influenzare negativamente la dinamica, già penalizzata dalla crescente instabilità economica e politica, soprattutto a livello europeo, della domanda industriale e commerciale.
TABELLA 3. Il settore degli apparecchi per il condizionamento centralizzato. Dati in milioni di euro, variazioni percentuali


Un complesso quadro normativo, dal punto di vista pratico, che pone spesso dei vincoli per la tutela paesaggistica
La tutela ambientale è senza dubbio uno dei temi cruciali in cui l’ingegneria può e deve dare il suo fattivo contributo da protagonista. In questi mesi contrassegnati dal conflitto bellico russo-ucraino e dalla conseguente crisi dei prezzi e
della fornitura di gas naturale, il tema della diversificazione delle fonti energetiche appare ancor più decisivo, soprattutto in chiave di ecosostenibilità. In questo quadro di riferimento il fotovol taico non è certo una novità. Ormai da anni è tra i protagonisti
del settore, anche a scapito di alternative più problematiche o comunque meno in voga come l’eolico, il geotermico e il moto-marino. Dopo il vero e proprio boom dei primi tre lustri degli anni 2000, dovuto anche agli incentivi economici e il busi ness derivante, il fotovoltaico è diventato una presenza costante in caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, ma anche nel caso di interventi di puro efficientamento energetico. La spinta derivante dal Superbonus non ha fatto altro che confermare e rafforzare questa positiva e auspicabile tendenza a favore della tutela ambientale e del risparmio.
Come sempre accade in ogni ambito, però, ci sono criticità e aspetti secondari che meritano riflessione e approfondimenti per ottimizzare il processo e minimizzare i problemi. Uno degli aspetti più spinosi, oltre allo smaltimento e alla manutenzione, appare essere quello della tutela paesaggistica. Tra pannelli integrati, non integrati e parzialmente integrati il quadro è ben chiaro e, soprattutto nel caso di installazione su coperture, è ben noto come impattare al minino sull’aspetto paesaggistico. Cercando di fare chiarezza, ricordiamo che l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e-quater) dispone che i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, rientrino in attività di edilizia libera, fatte salve le pre scrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme anti sismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeolo gico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (l’articolo interessato è il 136).
Nel dettaglio, dovendo installare pannelli fotovoltaici, devono essere seguite le indicazioni del D.L. n. 28 del 03/03/2011, attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e in parti colare l’art. 7-bis (Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili).
Il comma 5 di tale articolo recita che: “Ferme restando le dispo sizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’instal lazione di impianti solari fotovoltaici e termici con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’ar

ticolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici su strut ture e manufatti diversi dagli edifici non ricadenti fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati”. Da ciò emerge che, nelle zone vincolate paesaggisticamente, l’installazione dei pannelli è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi (autorizzazioni).
Passando in rassegna il D.L. n. 42 del 22 gennaio 2004, troviamo l’articolo 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) che recita: “1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geo logica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposi zioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetco e tradizionale; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze”. Ogni regione o territorio può ovviamente inserire determinate zone nell’elenco di quelle da tutelare. Nella regione Umbria, per esempio, in base a quanto previsto all’articolo suddetto, con la DGR 1089 del 08/10/2018, pubblicata in GU, serie generale 285 del 07/12/2018, si dichiarano varie zone di notevole interesse pubblico più specificamente i soggetti in ambito dei punti c) e d). Analogo iter è seguito in altri territori. A ciò si sommano il
D.L. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il D.P.R. 31 del 2017 (Regolamento recante individua zione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) che va a specificare quali sono gli interventi esclusi e quelli non esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. A fronte di questo complesso quadro normativo, dal punto di vista pratico, ci si trova spesso di fronte a vincoli che recitano: “I pannelli fotovoltaici e solari dovranno essere integrati nel manti copertura, del tipo non riflettente e di colorazione simile al materiale di copertura o, comunque, di una gamma cromatica tenue, nella scala delle terre locali, compatibile con i colori del contesto”.
Sulla base di tutto ciò appaiono spontanee e inevitabili alcune riflessioni operative.
Premesso che pannelli fotovoltaici e solari hanno l’obiettivo di captare le radiazioni elettromagnetiche provenienti dal sole e non di rifletterle o disperderle verso l’esterno.
Premesso che, mentre per i pannelli fotovoltaici esistono in diverse colorazioni, i pannelli solari termici sono solo di una colorazione standard.
La frase “o comunque” della prescrizione fa capire che il colore del pannello, non è vincolato al colore del manto di copertura, bensì dalla scala delle terre locali, quindi sembrerebbe che la discriminante sia il colore delle terre locali, purché però compa tibile con i colori del contesto.
A fronte di tutto ciò ci si chiede se il colore dei pannelli debba essere compatibile con i colori del contesto oppure compatibile
con la gamma cromatica delle terre locali. Nelle zone del conte sto periferico umbro è predominante per esempio il colore del verde dei prati o dei terreni coltivati, oppure il verde bottiglia scuro dell’olivo o di altre essenze arboree.
Da un’attenta lettura si evince quindi che sono i colori del con testo che vanno a definire la colorazione del pannello predo minante. A creare necessità di riflessione ci sono anche motiva zioni puramente tecnologiche. Un pannello solare fotovoltaico colorato costa circa quattro volte quello standard, ha una resa inferiore di circa il 25%-30%, ha tempi di attesa per la fornitura dopo l’ordine di circa 8 mesi e per ottenere la stessa potenza installata ha bisogno di una superficie maggiore del 20% (mac chia paesaggistica più grande). Passando ai solari termici, come detto, il problema è ancor più grave, perché non esistono in commercio pannelli di colorazione diversa dal nero opaco clas sico. Pertanto la scelta del colore risulta obbligata.
Se si è costretti quindi a installare pannelli solari termici scuri, è evidente che anche i fotovoltaici dovranno avere la stessa colo razione, per evitare contrasti cromatici perlomeno discutibili, ma ciò potrebbe far incorrere nel mancato rispetto delle prescrizioni cromatiche sopra citate.
Appare evidente come il tema meriti necessità di uniformazione centrale non essendo facilmente gestibile una eccesiva varietà di interpretazioni da territorio a territorio, soprattutto quando le località sono vicine, paesaggisticamente analoghe, ma afferenti a province o regioni diverse (zone di confine).

i protagonisti del settore si incontrano per discutere dei temi cruciali e delle principali sfide che attendono il mondo dell’edilizia. Un appuntamento fondamentale per professionisti, aziende e stakeholder, per confrontarsi sul futuro di un mercato in continua evoluzione, con la partecipazione dei massimi esperti in ambito accademico, istituzionale, associativo e del mondo imprenditoriale. Il convegno prevede l’erogazione di CFP per ingegneri e architetti




platinum sponsor con il patrocinio di







Mentre persistono ostacoli burocratici ed economici, sono sempre di più gli Stati che promuovono la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno “pulito” come fonte di energia. Una scelta che si presenta come la più “coerente” per centrare gli obiettivi della transizione energetica, ma anche ardua. Le sfide tecnologiche, economiche e sociali, infatti, non mancano, e anche l’Italia dovrà affrontarle se vuole viaggiare stabilmente a emissioni zero. Abbiamo parlato di tutto questo con Raffaele Candela, Baxi Product Manager - Hydrogen Country Coordinator

C&C: Nelle strategie di transizione energetica di molti Paesi e anche della Commissione UE, l’idrogeno si sta sempre più affermando come elemento-chiave. In questo contesto, quali sono le potenzialità, ma anche le eventuali criticità, del suo utilizzo?
R.C.: Da anni tutto il mondo occidentale sta spingendo verso la decarbonizzazione. Già a dicembre 2015, con l’accordo di Parigi sul clima, 183 Stati membri della convenzione quadro delle Nazioni Unite firmarono un accordo per ridurre le emis sioni di gas serra a partire dal 2020. Seguì un’accelerazione verso tutte le fonti di energia alternativa, tra cui quella solare, eolica e idroelettrica. Sulla stessa scia, Baxi – su incarico del gruppo di appartenenza BDR Thermea – nel 2016 ha iniziato a concentrarsi sull’idrogeno. Una scelta precisa, impegnativa sia dal punto di vista della ricerca che da quello finanzia rio, ma assolutamente premiante: l’idrogeno, infatti, è un gas simile agli altri, ma che – se prodotto con elettrolisi alimen tata da fonti rinnovabili (solare o eolico) – offre il grande vantaggio di non rilasciare emissioni di CO e CO2. Il prodotto della combustione è essenzialmente vapore acqueo. Si trova ovunque; è un gas non tossico, invisibile, inodore, più leg gero dell’aria e con un altissimo potere calorifico. Apparen temente un quadro perfetto, insomma, se non si considerasse il complesso studio legato al suo utilizzo per gestire l’alta volatilità, lo stoccaggio, la solidità dei materiali che vi entrano in contatto. Baxi ha dunque impiegato ingenti risorse per riuscire a proporre al mercato una caldaia a condensazione funzionante al 100% a idrogeno, ma con le stesse potenzialità e prestazioni di una caldaia tradizionale. Il tutto senza avere praticamente alcun parametro di riferimento tecnico e nor mativo legato all’utilizzo dell’idrogeno. A livello normativo, oggi qualche passo è stato fatto per i prodotti funzionanti con una miscela di gas contenente fino al 20% di idrogeno, ma manca l’aggiornamento del quadro normativo relativamente a trasporto, distribuzione e installazione degli apparecchi per uso residenziale funzionanti al 100% a idrogeno.
Quando l’idrogeno potrebbe fare il proprio ingresso in maniera consistente nel comparto del riscaldamento? Sarà possibile “adattare” le attuali caldaie a questa tecnologia o dovrà per forza avvenire una sostituzione?
Nel 2022 Baxi ha messo in funzione la prima linea produttiva in Europa della caldaia funzionante al 100% idrogeno green L’obiettivo è arrivare a installarla nelle case degli italiani dal 2025. Non sarà idealmente possibile adattare le caldaie esi stenti per farle funzionare a idrogeno, fatta eccezione per le nostre attuali gamme Luna Style e Luna Classic, progettate per funzionare al 20% di idrogeno. In futuro sarà reso disponibile un kit di trasformazione che le renderà operanti al 100% idro
 RAFFAELE CANDELA, Baxi Product Manager – Hydrogen Country Coordinator
RAFFAELE CANDELA, Baxi Product Manager – Hydrogen Country Coordinator
 IDROGENO PURO. Prima linea Europea per la produzione di caldaie funzionanti a idrogeno puro
IDROGENO PURO. Prima linea Europea per la produzione di caldaie funzionanti a idrogeno puro
geno. In Europa ci sono 110 milioni di caldaie a condensazione installate: la transizione verso l’idrogeno richiederà del tempo, ma l’auspicio è che venga supportata da importanti incentivi per invitare alla sostituzione della caldaia.
L’ostacolo più grande al momento è convincere gli enti erogatori a sostenere la distribuzione dell’idrogeno e a investire su di essa. Comun que, il passaggio dal metano all’idrogeno verde è questione di tempo, come prima è stato per il passaggio dal gas di città al gas naturale.
A livello di componentistica, che complessità pone la caldaia all’idrogeno?
L’80% della componentistica nelle caldaie a idrogeno è uguale a quella presente nelle più avanzate caldaie a metano. Il bruciatore e la sensoristica sono le parti più evidenti soggette a cambiamento e, per questo, oggetto di pro lungate e approfondite ricerche che hanno portato, già a partire dal 2016, alla selezione di specifici fornitori che potessero contribuire con proprie competenze alla progettazione e ottimizzazione delle parti utili per il passaggio. Un altro aspetto delicato è relativo al collaudo, che implica un’attenzione maggiore rispetto a quello di una caldaia con tecnologia a gas tradizionale.
Quanto si risparmia (costi e consumi) con una caldaia a idrogeno?
La caldaia a idrogeno nasce come un prodotto ad alta efficienza, dunque simile in tal senso alle più evolute caldaie a gas. L’obiettivo minimo è quello di assicurare lo stesso livello di effi cienza. Si tratta però – va sottolineato – di un prodotto a emissioni zero: sostituendo il metano con l’idrogeno verde, a parità di prestazioni, le emissioni di CO2 verranno azzerate. È un vantaggio innegabile. La caldaia a idrogeno è un prodotto senza precedenti, frutto di inve stimenti, ingegno, competenza e perseveranza: una caldaia che utilizza idrogeno puro, verde, che può essere prodotto da energia eolica e solare. È stata progettata per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, e la sua installazione e messa in servizio sono del tutto simili a quella dei prodotti attuali a gas naturale, con l’enorme vantaggio di abbattere ulteriormente anche le emissioni di NOX

L’Italia è pronta ad accogliere questa novità a livello di infrastrutture?
In Italia gli operatori che si occupano di trasporto e stoccaggio del gas naturale hanno iniziato nel 2019 a fare i primi test con basse percentuali di idrogeno per poi portarle al 10%. Il processo di sperimentazione sta continuando affinché, oltre a sviluppare tutta la filiera italiana, ci possa essere un passaggio di crescenti quantitativi di idrogeno miscelato con gas naturale nell’attuale infrastruttura. In linea di massima, si può dire che l’in frastruttura di distribuzione esistente, che ad oggi trasporta il gas naturale, può essere impiegata per trasportare idrogeno. Ovviamente in seguito a opportune verifiche effettuate dalle società competenti. Tra queste c’è RINA, società italiana leader nella certificazione a livello internazionale, che si sta occupando di verificare la compatibilità tra linee gas esistenti e trasporto di idrogeno. Attualmente la rete di distribuzione, come ripe tuto più volte dai maggiori trasportatori e distributori, è pronta per una
LIVE TEST MONITORING di tutti i progetti dimostrativi attualmente installatiLa gamma di caldaie a condensazione Luna Style vanta elevati livelli di efficienza (classe A+ pari al 98%, equipaggiata con Baxi Mago e sonda esterna) ed è stata progettata per funzionare con una miscela composta fino al 20% da idrogeno. Il nuovo display ampio, retroilluminato e a colori è dotato di icone per gestire facilmente i valori di funzionamento di tutte le zone dell’abitazione da un unico pannello di controllo. Il sistema è semplice e intuitivo grazie alla manopola di selezione e ai soli tre tasti di comando. Altrettanto semplice è la regolazione dell’ACS. Attraverso il dispositivo Power set, una volta regolati i parametri dal pannello di controllo, la portata termica della caldaia si autoregola a seconda del fabbisogno energetico.
La pompa elettronica a modulazione totale con motore a magneti permanenti riduce i consumi elettrici, migliorando prestazioni e durabilità. Risparmio a cui contribuisce anche l’ampio campo di modulazione (fino a 1:10) che, riducendo il numero di accensioni/spegnimenti, migliora efficienza, silenziosità e durata della caldaia.
La funzione elettronica di deareazione impianto, inoltre, semplifica la rimozione dell’aria in fase di prima accensione. Il sistema GAC (Gas Adaptive Control) garantisce il controllo automatico della combustione misurando continuamente il segnale di fiamma e adeguando la portata di gas per mantenere costante la qualità della combustione. Ciò riduce i tempi di installazione, eventuali regolazioni manuali e anche l’impatto ambientale grazie al controllo delle emissioni di CO/CO2
Tra gli altri plus di Luna Style spiccano la silenziosità, il manometro digitale, affidabilità e durabilità. Per il risanamento di canne fumarie preesistenti, inoltre, l’azienda ha sviluppato un sistema che consente un facile intubamento grazie a un tubo di scarico rigido e flessibile di Ø 50 mm adatto a tutti i modelli Luna Style; è possibile anche l’allacciamento a canne fumarie collettive in pressione.
Le caldaie Luna Style 24/35 Mago sono dotate di serie del Baxi Mago, il cronotermostato modulante con WiFi integrato che permette di gestire completamente il comfort domestico da remoto da un’app dedicata. Per gli altri modelli della gamma, è disponibile come accessorio e consente comunque di accedere all’Ecobonus 65%. Tutta la gamma gode della detrazione Bonus Casa.

miscela al 10% tra gas naturale e idrogeno. Tuttavia, si stanno compiendo passi da gigante in materia e auspichiamo che ci possano essere quanto prima dei risultati molto incoraggianti con una percentuale sempre maggiore di idrogeno fino a raggiungere il 100%.
Infine, c’è l’aspetto sicurezza. Pressioni 700 volte superiori a quella dell’atmosfera richiedono contenitori dalle pareti spesse e rivestimenti speciali per assicurare che l’idrogeno, che ha
dimensioni molto piccole, non le attraversi e si disperda. Come viene affrontato questo aspetto?
La caldaia progettata da Baxi prevede l’utilizzo di gas idro geno alla pressione nominale di 20 mbar. Questo per favo rire, in futuro, la distribuzione di questo gas in una rete domestica a bassa pressione, esattamente come accade oggi per il gas metano. L’idrogeno è un gas paragonabile a tutti gli altri, ma con il grande vantaggio di non rilasciare emissioni di CO e CO2: il prodotto della combustione è essenzialmente vapore acqueo.
Era il lontano 1972 quando Bruno Menini diede inizio alla storia di Sime. Una storia ricca non solo di successi, ma anche di sfide e ostacoli. Oggi Sime è tra i primi costruttori ad avere gran parte dei prodotti già certificati per il funzionamento a miscele di idrogeno. Abbiamo chiesto a Maria Cristina Menini, figlia del fondatore e per dieci anni a fianco del padre, di raccontarci la loro storia

C&C: Il 2022 rappresenta per Sime un importante traguardo: 50 anni di attività e una storia ricca di primati tecnologici e di successi, ma sicuramente anche di sfide e ostacoli…Nel 1997 “Repubblica”
– in occasione dei 25 anni dell’azienda – la apostrofò “La figlia di ferro”. Si rivede ancora in quelle parole? Come è cambiata l’azienda in questi 50 anni?
M.C.M.: 50 anni sono stati un lungo percorso. Ricordo ancora quando nel 1993, da giovane donna, assunsi la guida dell’azienda dopo la scom parsa di mio padre per continuare a portare avanti il suo sogno imprenditoriale e farlo diventare mio. Ero giovane e avevo mia figlia di un mese fra le braccia, non proprio l’emblema di una “donna di ferro”. Ma la mia tenacia e determinazione mi fanno pensare che forse posso riconoscermi in questa definizione. Ricordo, infatti, di non avere mai avuto dubbi nell’intraprendere questo cam mino e mai ho pensato di mollare. Era necessario trasformare Sime in un’azienda manageriale, rin novare e adeguare la governance ai tempi che ci aspettavano, sempre sul solco della qualità, dell’in novazione e dell’etica; pilastri – mi ha insegnato mio padre – che ci hanno permesso di tenere testa ai colossi del nostro settore.
Sime è tra le prime aziende ad avere gran parte dei prodotti già certificati per il funzionamento a miscele di idrogeno. Quali sono le prospettive in tal senso e i progetti in fase di sviluppo?
Non è semplice prevedere quali saranno le pro spettive e le tendenze per il mondo della clima tizzazione invernale. Pensare che l’idrogeno sia il futuro del settore è ancora tutto da scoprire, ma sicuramente è una via concreta da esplorare ed è per questo che nel nostro R&D stiamo sviluppando apparecchi che siano auto adattativi rispetto al tipo di gas distribuito, ma anche pronti a utilizzare altri vettori energetici in modo flessibile e efficiente. Il nostro futuro è rivolto anche alla realizzazione di caldaie in grado di utilizzare idrogeno puro in piena sicurezza e comfort per l’utente finale. Nel breve termine, tuttavia, crediamo sia altrettanto importante porre il focus sulla ibridazione delle fonti energetiche: apparecchi intelligenti capaci di scegliere quale fonte energetica usare in base alle disponibilità e ai costi del momento. È nostra intenzione anche supportare con la nostra espe
Gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla passione e all’impegno dei nostri collaboratori e di tutti coloro che hanno condiviso con noi il percorso che ci porta a celebrare il cinquantesimo anniversario. Questo traguardo è sicuramente motivo per rinnovare il nostro impegno a sviluppare sistemi per riscaldamento efficienti ed ecologici e per continuare a trasmettere il clima di valore che contraddistingue la famiglia Sime MARIA CRISTINA MENINI alla guida dell’azienda di famiglia

rienza gli organismi chiamati a stendere le nuove norme di riferimento per il settore: Sime è infatti membro del gruppo CEN/TC/109 per la normazione delle caldaie in ambito europeo.
Nel periodo di stop forzato causato dalla pandemia e in quello post-Covid, quali sono state le strategie e le politiche messe in atto dall’azienda sia internamente che nei riguardi dell’utente finale? Durante la pandemia tutti abbiamo cambiato le nostre abitudini lavorative. Nei periodi di stop forzato il nostro obiettivo è stato quello di non perdere il con tatto con i clienti e i partner; pertanto, ci siamo subito attivati per creare canali alternativi di comunicazione: abbiamo fornito formazione e informazione con webinar e seminari online, strumenti che sono ora diventati di uso corrente. Nel momento in cui il nostro settore ha potuto godere di nuovi strumenti legati all’efficientamento energetico (Ecobonus e Bonus Casa) abbiamo deciso anche di affiancare gli installatori per supportarli nell’offrire lo sconto in fattura e la cessione del credito ai propri clienti finali. A tal fine abbiamo creato una nostra piattaforma e un servizio di consulenza a loro dedicati.
Da inizio anno la reperibilità delle materie prime e il loro costo stanno creando problemi a diverse aziende. A questo è andato ad aggiungersi il “caro bollette” (energia e gas). Come state fronteggiando questa situazione, certamente difficoltosa per molti?
“
“
Murelle Revolution è un sistema ibrido compatto, interamente contenuto in un involucro murale del tutto simile a quello delle tradizionali caldaie, e non necessita di unità esterna per funzionare. Infatti, la pompa di calore aerotermica e la caldaia a condensazione sono entrambe alloggiate nell’involucro avente dimensioni 60x90x39 cm. Per installare il prodotto occorre semplicemente collegarsi agli attacchi acqua e gas lasciati liberi dalla caldaia che si sostituisce. Installare l’ibrido compatto Murelle Revolution è quindi molto semplice e rapido quasi come l’installazione di una caldaia a condensazione murale. L’unica differenza consta nella necessità di realizzare due fori da 16 cm, per collegare il condotto di aspirazione e di espulsione aria con cui verrà fatta lavorare la pompa di calore. La pompa di calore è in serie alla caldaia a condensazione e, nel caso si debba raggiungere temperature di mandata elevate, questo consente un preriscaldo ad alta efficienza. Un circolatore a giri variabili garantisce la minima temperatura di ritorno possibile, necessaria al funzionamento efficiente della pompa di calore. Oltre all’estrema compattezza Murelle Revolution ha una particolarità unica: è dotata di un secondo evaporatore posto nello scarico fumi della caldaia che consente, durante il funzionamento contemporaneo dei due generatori, di recuperare quasi tutto il calore altrimenti disperso al camino, portando il COP a 3,5 con aria esterna a -7 °C e la temperatura dei fumi espulsi sotto i 10 °C. Le caratteristiche tecniche consentono di risparmiare dal 35% al 45% sui costi di
Come tutti gli operatori economici – soprattutto come azienda manifatturiera dotata anche di uno stabilimento energivoro come la fonderia – abbiamo sofferto dei pesanti rincari del costo dell’e nergia. Per mitigare gli effetti miriamo a concludere contratti di fornitura a lungo termine che ci assicurino una parziale stabi lità dei costi. Abbiamo colto l’occasione di difficoltà per analiz zare o ottimizzare i processi produttivi e la supply chain, oltre,
BOX 2
gestione del sistema di climatizzazione invernale e spesso il prodotto è in grado di innalzare da solo l’indice di prestazione energetica dell’edificio (APE) di due classi permettendo perciò di usufruire dell’Ecobonus 110%.

ovviamente, ad aver adottato comportamenti virtuosi di saving energetico. Sul fronte materie prime e componenti critici da un lato ci siamo attivati già nel 2021 per diversificare le fonti di acquisto e dall’altro abbiamo coltivato negli anni rapporti con i nostri fornitori che ci hanno consentito di non interrompere la produzione, specialmente nell’ambito dei segmenti di prodotto “caldi” come quello degli ibridi.
Durante il mese di settembre Sime ha organizzato una crociera nel Mediterraneo occidentale insieme alla forza vendita e ai clienti italiani ed esteri per celebrare il traguardo dei 50 anni di attività. L’evento ha visto la partecipazione dell’Ing. Paolo Nespoli, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea che – raccontando le incredibili vicende personali che l’hanno portato sullo spazio – è stato fonte di riflessione e ispirazione per gli ospiti. La crociera è stata anche occasione per rinsaldare i legami di tutta la squadra e condividere il percorso e gli obiettivi di Sime per i prossimi anni, per affrontare il futuro ancora più forti e uniti.
La sostenibilità ambientale è un tema caro a Sime da molti anni. Già nel 1996, quando nessuno parlava ancora di transizione energetica, lanciammo il Combustion Quality Project che pre vedeva l’abbattimento degli agenti inquinanti. Nacque Mistral, la prima caldaia ecologica che conquistò riconoscimenti fuori confine. Nel 2008, in collaborazione con l’Università di Padova, siamo stati pionieri nello studiare l’integrazione di diverse fonti energetiche e abbiamo messo a punto un sistema che adotta algoritmi di funzionamento delle varie fonti per ottimizzare l’ef ficienza minimizzando le emissioni nocive. Dal 2009 gli stabili menti produttivi di Sime hanno adottato un Sistema di Gestione Ambientale dell’Organizzazione certificato, conforme alla norma ISO 14001.
















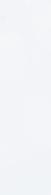
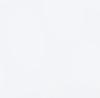

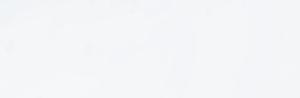








































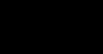












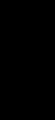
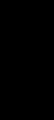





































































Materiali a cambiamento di fase (PCM) e nanomateriali: dalla ricerca un’importante classe di nuovi materiali che contribuiscono allo stoccaggio dell’energia termica, all’uso efficiente dell’energia solare e alla riduzione delle emissioni atmosferiche

Il tema delle emissioni gassose dovute ai combustibili fossili e delle relative ripercussioni sull’ambiente è oggi partico larmente sentito, tanto che negli ultimi anni l’UE e i singoli Governi Europei sono più volte intervenuti, definendo un complesso quadro normativo per la loro regolamentazione e il loro controllo. I nanomateriali e le nanotecnologie possono rappresentare un valido aiuto per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e la riduzione della CO2 Se introdotte correttamente nel solare termico, nel fotovoltaico e nel settore dei materiali da costruzione – come nel caso degli isolanti e dei metodi per il trattamento delle superfici – queste tecnologie innovative possono migliorare le presta zioni dei pannelli, sia in termini di generazione di energia che di perdite, e l’efficienza energetica degli edifici, contribuendo al loro ripristino termico. In questo contesto, lo stoccaggio energetico assume un ruolo fondamentale per il completo sfruttamento della tecnologia, a causa della variabilità della radiazione solare. Per questo motivo, già da diversi anni, ci si sta concentrando sullo sviluppo di materiali a cambiamento di fase per l’edilizia (PCM) in grado di accumulare il calore latente.
La riduzione dei consumi energetici degli edifici è stretta mente connessa con la limitazione delle conseguenze negative
sull’ambiente. L’attenzione al tema dell’efficienza energetica è cresciuta sempre di più negli anni, sia nella realizzazione degli edifici di nuova generazione che nelle ristrutturazioni di quelli esistenti. Nel mercato dell’edilizia residenziale è cresciuta anche l’attenzione alle esigenze di miglioramento del comfort abitativo, sia dal punto di vista acustico, termo-igrometrico che della qualità dell’aria (IEQ - Indoor Environmental Quality). In particolare, la progettazione dell’involucro ha assunto un ruolo importante per la riduzione delle dispersioni termiche. Il concetto stesso di involucro è passato negli anni da sem plice elemento protettivo a elemento in grado di rispondere alle funzioni di regolazione climatica degli ambienti interni. A questa evoluzione ha contribuito anche la progettazione di edifici a elevata efficienza energetica con un fabbisogno energetico davvero minimo (NZEB – Nearly Zero Energy Buil ding), diventata obbligo di legge, in Italia, per tutti i nuovi edifici da gennaio 2021. Il raggiungimento di questi obiettivi è reso possibile anche grazie a tecniche di immagazzinamento dell’energia termica della radiazione solare.
Come spesso accade per le fonti rinnovabili, l’energia solare – pur avendo un enorme potenziale nel soddisfacimento della domanda energetica degli edifici in inverno – è intermittente e variabile nell’arco della giornata, con un picco di radia zione che si verifica intorno a mezzogiorno. Per dare una continuità alla fonte, uno dei principali problemi da risolvere è quello dell’accumulo e dell’immagazzinamento dell’energia

termica. In tal senso, l’energia solare può essere raccolta e conservata durante il giorno per poi essere rilasciata all’aria interna quando la temperatura della stanza scende durante la notte. Come per il caldo in estate, anche il freddo può essere immagazzinato dall’aria ambiente per convezione naturale (o forzata) durante la notte e quindi utilizzato nelle ore più calde della giornata. I meccanismi di accumulo di energia ter mica, quindi, permettono di ridurre gli sbalzi di temperatura dell’aria interna e migliorano il livello di comfort termico e il benessere delle persone. Tali sistemi, definiti con l’acronimo TES – Thermal Energy Storage, garantiscono la “conserva zione” di un certo quantitativo di energia in modo da poterlo utilizzare in periodi successivi alla fase di accumulo. Queste tecnologie possono contribuire direttamente, sfruttando l’e nergia termica fornita dalla radiazione solare e indirettamente, migliorando le condizioni di utilizzo degli impianti di riscal damento e raffrescamento dell’abitazione. Consentendo per definizione il trasferimento di calore al mezzo di accumulo durante il periodo di carica e il successivo rilascio della medesima quantità di energia in un secondo momento sfruttando il cambiamento di fase di un materiale, i sistemi TES garantiscono l’efficienza sia nelle aree caratterizzate da tem perature molto rigide che in quelle soggette a climi più caldi. Strutturalmente, nel caso per esempio dell’involucro edilizio, si basano sulla sua capacità di opporsi al passaggio di flusso di calore grazie all’assorbimento di un’aliquota più o meno elevata, che non viene rilasciata immediatamente, ma dopo un determinato periodo di tempo, contribuendo al conteni mento delle oscillazioni termiche. Una soluzione efficiente in ottica di risparmio energetico e comfort degli edifici è rappre sentata proprio dai cosiddetti materiali a cambiamento di fase PCM (Phase Changing Materials) che contribuiscono ad aumentare l’inerzia termica dell’edificio, in particolare dell’in volucro, e consentono una riduzione dei consumi energetici degli edifici mediante il loro sfruttamento nei sistemi TES a calore latente (LHTES), per i quali si rimanda all’appro fondimento sull’accumulo di energia (BOX 1).
I PCM, materiali a cambiamento di fase, sono composti accu mulatori che assorbono i flussi di energia entrante durante la transizione di fase, conservando un’elevata quantità di energia termica a temperatura costante che rilasciano durante la fase di ritorno alle condizioni originali, a seguito di un abbassamento della temperatura esterna. Il PCM più comune è l’acqua che tuttavia, avendo una temperatura di congela mento a 0 °C, risulta inservibile nella maggior parte delle applicazioni. Solitamente, questi materiali si trovano allo stato
solido a temperatura ambiente; con l’aumento della tempe ratura sopra una certa soglia, fondono, accumulando calore che restituiscono durante il cambiamento di fase liquido-so lido. Di norma queste sostanze presentano un elevato calore latente di fusione. Perché possano essere utilizzati al meglio nei sistemi di accumulo di calore, i PCM devono possedere determinate caratteristiche termodinamiche, cinetiche, chimiche, tecniche ed economiche. Ovvero devono avere un punto di fusione nell’intorno delle temperature di lavoro utilizzate; un elevato calore di fusione per avere scambi di energia il più possibile isotermi; elevata densità specifica di energia, in modo tale da minimizzare il volume occupato; un elevato calore specifico, così che sia possibile sfruttare anche la parte di calore sensibile; elevata conducibilità termica, che comporta la necessità di minori ΔT per caricare e scaricare l’accumulo. Inoltre, devono poter fondere completamente, così che le fasi di liquido e solido siano omogenee. Ciò evita differenti densità tra solido e liquido che portano al fenomeno della segregazione, quindi ad un cambiamento della compo sizione chimica del materiale (fusione congruente). Devono essere caratterizzati da un ridotto volume di cambiamento di fase durante la transizione, per la possibilità di utilizzare semplici contenitori; da stabilità chimica per evitare perdita di prestazioni; nessuna decomposizione, per aumentarne la vita operativa; comportamento non corrosivo, non tossico, non infiammabile e non esplosivo. Semplicità, applicabilità, effica cia, compattezza, compatibilità con i materiali utilizzati per il loro contenimento e affidabilità, sono requisiti importanti per questi materiali. Infine, in relazione all’aspetto economico, dovrebbero essere disponibili in commercio a basso costo ed essere facili da reperire.
Al fine di individuare nuovi potenziali PCM, nel corso degli ultimi quarant’anni, sono stati studiati molti materiali. Princi palmente i PCM si suddividono in tre macro gruppi – orga nici, inorganici ed eutettici – che a loro volta sono suddivisi in sottocategorie:
■ gli organici, in composti di paraffine e non;
■ gli inorganici, in sali idrati e metallici;
■ gli eutettici, in organici-organici, inorganici-organici e inorganici-inorganici.
I materiali a cambiamento di fase organici, di cui fanno parte le paraffine e gli acidi grassi, sono i più utilizzati. Seguono i materiali inorganici di ultima generazione, come i sali idrati, e i materiali eutettici, oggi considerati più performanti e sicuri. Ciascun gruppo presenta dei vantaggi e degli svantaggi. Vediamo le principali caratteristiche di ogni tipologia.
BOX
Le politiche di salvaguardia del pianeta, incentrate sulla riduzione dell’uso delle fonti fossili e quindi delle associate emissioni inquinanti, a netto vantaggio di quelle rinnovabili, la recente e incontrollata variazione dei prezzi, accelerata soprattutto in questi ultimi mesi, stanno spingendo sempre di più verso una diversificazione delle fonti primarie impiegate nella produzione dell’energia. Negli ultimi anni, inoltre, l’incentivazione delle fonti rinnovabili, ha portato a una sempre maggiore diffusione del fotovoltaico, e ad un mutamento della tipologia di generazione di energia nella rete elettrica, con profonde modifiche strutturali della stessa e l’introduzione di sistemi di controllo dei flussi di energia e di potenza legate al fatto che essa debba essere in grado di garantire in ogni momento una fornitura di potenza e energia all’utenza nonostante la natura discontinua e non programmabile della fonte rinnovabile. Come già affermato, tale fornitura può essere gestita con l’impiego di un sistema d’accumulo o di Energy Storage (ES). In generale, i sistemi d’accumulo vengono classificati in base alla forma d’energia utilizzata per l’immagazzinamento e si distinguono in accumulo meccanico, chimico, biologico, magnetico e termico. Nel caso in questione, quello di nostro interesse e sul quale soffermeremo l’attenzione, è proprio quello termico, che viene realizzato mediante una variazione di energia interna del materiale dovuta a uno scambio di calore sensibile, latente o termochimico.
I sistemi TES sono caratterizzati da diversi parametri, quali la densità di accumulo, ossia la quantità di energia immagazzinata nell’unità di volume (misurata in kWh/m3) che varia in base alla tipologia di accumulo e al materiale utilizzato; la capacità di accumulo, quindi la massima energia immagazzinabile; l’efficienza del sistema, data dal rapporto tra l’energia estratta durante la scarica e l’energia immagazzinata durante la carica; la conservazione nel tempo delle caratteristiche dell’accumulo e la temperatura
Sono composti organici che derivano dalla raffinazione del petrolio e quindi sono un sottoprodotto del processo produttivo dei carburanti e lubrificanti e hanno un range di temperature di transizione compreso tra -8 °C e 40 °C. Possiedono un valore di densità di stoccaggio compreso tra 130 e 210 kJ/kg. Tra i vantaggi ricordiamo: buona capacità di accu mulo termico; capacità di solidificare senza ulteriore sottoraffreddamento (fenomeno che si verifica quando il PCM inizia a solidificare a temperature più basse rispetto alla sua temperatura di fusione/solidificazione); assenza di segregazione di fase durante la fusione; ampio range di temperatura con punto di fusione che varia con il numero di atomi di carbonio nella catena (si tratta di miscele di catene di n-alcani del tipo CH3-CH2-CH3); sono sicure e affidabili; non sono corrosive; chimicamente inerti e stabili a temperature inferiori a 500 °C anche dopo numerosi cicli; sono caratteriz zate da bassa tensione di vapore e minimi cambiamenti di volume durante la fusione, circa del 10%; hanno un elevato calore di fusione, 35-40 kcal/ kg; presentano fusione uniforme e buone proprietà di nucleazione. Tra gli svantaggi, vanno considerati un ciclo di condensazione-fusione lungo, l’incompatibilità con contenitori di plastica, una moderata infiammabilità, la bassa conducibilità termica, circa 0,2 W/m/K, e il costo variabile, con l’andamento del prezzo del petrolio.
Per lo più, i PCM non-paraffine sono costituiti dagli acidi, nocivi e costosi, e dagli oli vegetali. Sono caratterizzati da un elevato calore di fusione, una bassa conducibilità termica, infiammabilità e instabilità ad alte temperature. In base al tipo di acido (laurico, palmitico e stearico), gli acidi grassi hanno un valore di calore latente di fusione nell’intervallo 170 e 210 kJ/kg. Gli oli vegetali sono derivanti da fonti naturali (ad esempio l’olio di palma, di colza, di soia e di cocco) o provenienti da grassi animali. Hanno un range di temperature di lavoro compreso tra -40 °C e 150 °C. Sono biodegradabili e non tossici, manifestano una variazione di volume minima, sono stabili, possono durare nel tempo, hanno un elevato calore latente, resistono al fuoco e sono più economici rispetto ai PCM derivati dal petrolio.
I sali idrati
Sono leghe di sale inorganico e acqua, composti che formano una struttura solida cristallina con una formula generale del tipo
AB
nH
O
Dal cambiamento di fase derivano composti di sale idrato e acqua che hanno un punto di fusione compreso tra i 15 °C e 80 °C. Sono gli unici materiali inorganici usati con discreto successo come PCM perché hanno un costo inferiore rispetto alla paraffina; un elevato calore latente per unità di volume; un’elevata conducibilità termica (circa il doppio della paraffina); non sono molto corrosivi; sono compatibili con la plastica, atossici e non
infiammabili. Tra gli svantaggi occorre considerare una fusione incoerente, quindi il problema della segregazione, il sottoraffreddamento a cui sono soggetti, una variazione di volume in fusione che può essere maggiore del 10% e il fatto che si deteriorano se esposti all’aria. I nuovi involucri in alluminio e polimero li rendono adattabili a molteplici installazioni e abbinabili a diversi sistemi di posa.

Hanno un’elevata conducibilità termica, un elevato calore di fusione per unità di volume e una bassa tensione di vapore ma, tra gli svantaggi, ele vato peso e basso calore specifico.
I PCM eutettici, caratterizzati dalla combinazione di due o più PCM, misce lati al fine di ridurne la temperatura di fusione, fondono e solidificano senza il fenomeno della segregazione, ma non sono molto utilizzati perché le leghe eutettiche disponibili in commercio hanno normalmente una purezza elevata e di conseguenza sono abbastanza costose. Tuttavia i materiali eutettici possiedono diverse caratteristiche interessanti: sono stabili, la loro conduzione del calore è due volte superiore rispetto ai PCM tradizionali, mentre la loro capacità di accumulo del calore è tre volte maggiore. Per ridurre al minimo i costi, nell’ambito del progetto europeo THERMO STALL (Horizon 2020), i ricercatori si sono concentrati su leghe a bassa purezza composte da metalli a basso punto di fusione. Hanno sperimentato un’ampia gamma di metalli con punti di fusione che variavano tra 70 e 230 °C al fine di identificare le miscele con le proprietà termofisiche più idonee. Queste nuove formulazioni PCM sono mirate per l’uso nei sistemi per l’accumulo stagionale dell’energia termica in abitazioni e piccoli edifici commerciali. In generale, le leghe eutettiche possono ridurre notevolmente la complessità di progettazione e i costi di fabbricazione dei sistemi di accumulo dell’energia termica.
alla quale si trova il materiale utilizzato per lo stoccaggio. Un fattore determinante quindi è la durata, ovvero il tempo durante il quale l’energia può essere conservata con perdite energetiche accettabili. Le tipologie di TES si differenziano anche in base all’intervallo di temperature di lavoro e sono suddivisi in:
■ HTTES (High Temperature Thermal Energy Storage). È un accumulo ad alta temperatura che comprende tutti gli impianti che operano con temperature di lavoro maggiori di 300 °C;
■ LTTES (Low Temperature Thermal Energy Storage), corrisponde all’accumulo a bassa temperatura. È costituito da tutti quei sistemi che operano tra 10 °C e 150 °C (tipicamente utilizzati per il riscaldamento e il raffrescamento di edifici, i sistemi di trattamento aria, le serre, i forni solari e i serbatoi d’acqua);
■ MTTES (Medium Temperature Thermal Energy Storage), i cui processi hanno un intervallo di temperatura tra i 150 °C e i 300 °C che corrispondono ad un accumulo intermedio tra quello di bassa e alta temperatura (impiegato negli impianti solari a concentrazione e il solar cooling, cioè la produzione di freddo con macchine frigorifere ad assorbimento);
■ CTES (Cold Thermal Energy Storage), in cui l’accumulo termico del freddo è caratterizzato da temperature inferiori ai 20 °C, ossia minori di quella ambiente.
In base al metodo di accumulo di calore, i TES sono anche classificati in:
1. sistemi accumulo di calore sensibile (SHTES), che immagazzinano energia termica mediante riscaldamento o raffreddamento di un mezzo di accumulo liquido o solido, come ad esempio l’acqua, il cemento e alcune pietre;
2. sistemi di accumulo di calore latente (LHTES), che si basano sul calore assorbito o rilasciato quando un materiale effettua una trasformazione di fase da solido a liquido oppure da liquido a gas;
3. sistemi di accumulo termochimico (TCES), derivanti dalle reazioni chimiche.
Un accumulo sensibile è costituito da materiali che nei processi di carica e scarica termica non cambiano di fase. Le problematiche di questa tipologia di accumulo sono legate alla bassa densità energetica consentita (energia accumulabile per unità di volume) e alla temperatura variabile nel corso della carica e della scarica dell’accumulo. L’accumulo latente è legato alla variazione di entalpia associata allo scambio termico nel passaggio di fase liquido-solido o viceversa di una specifica massa di sostanza. Negli anni più recenti, la ricerca ha individuato diverse sostanze in grado di realizzare accumuli per applicazioni che vanno dalla climatizzazione degli edifici a quelle di potenza. La diffusività termica, indice della rapidità nel seguire le variazioni di temperatura a fronte di una somministrazione di energia termica, deve costituire un requisito fondamentale delle sostanze da utilizzare come accumulo termico. Tale fattore è determinato dal rapporto tra la conducibilità termica [W/ mK] della sostanza e la capacità di accumulare energia termica. Tuttavia, in presenza di un gradiente di temperatura, perché il flusso di calore possa attraversare tutti gli strati di materiale e non limitarsi soltanto ai primi, non è sufficiente che esso sia molto conduttivo, ma è necessario che sia anche poco massivo e con basso calore specifico.
I PCM sono materiali in grado di accumulare il calore latente. I TES latenti sono caratterizzati da un’elevata densità di energia accumulata, maggiore rispetto a quelli sensibili, che consente ai PCM di lavorare con differenze di temperatura molto piccole. Nei sistemi SHTES il calore viene immagazzinato in un materiale durante le fluttuazioni di temperatura; in quelli LHTES, l’accumulo avviene in condizioni quasi isotermiche durante i passaggi di stato. I sistemi LHTES, con ridotta differenza di temperatura tra l’accumulo ed i cicli di recupero, sfruttano i materiali PCM, assorbendo energia mentre si verifica la transizione di fase e rilasciandola durante la fase di ritorno alle condizioni originali. Nell’accumulo latente a temperatura costante, le trasformazioni più adatte sono liquido-solido e solido-solido; mentre le trasformazioni solido-gas presentano lo svantaggio di necessitare di grandi volumi per il passaggio di stato. (fonte: ENEA)
Abbiamo visto che l’energia termica può essere conservata sotto forma di calore sensibile o latente. Dato però che per la prima forma occorre una massa di materiale pesante, l’accumulo di calore latente viene preferito per l’elevata densità energetica manifestata in un piccolo intervallo di tempe rature e per la natura isotermica del processo di immagazzinamento deter minato dal cambiamento di stato del materiale. Tutti i materiali possiedono la capacità di accumulare calore, ma questa aumenta con l’aumentare della densità e del calore specifico. Diversamente dai materiali più comune mente utilizzati in edilizia – calcestruzzo, mattone pieno, pietra, etc. – che forniscono all’edificio una massa termica artificiale basata sulla capacità di accumulo inerziale, i PCM sfruttano il calore latente. Solitamente, vengono impiegati come materiale isolante, spesso a supporto di isolanti tradizionali, integrati in diversi materiali sotto forma di microcapsule.
Per essere impiegati al meglio in questo settore, i materiali PCM devono avere una temperatura di fusione intorno ai 25 °C, un basso costo, un elevato calore di transizione e disponibilità nel mercato e non devono essere tossici e corrosivi. In base alle caratteristiche precedentemente descritte, quelli che meglio si adattano ad applicazioni di risparmio energetico sono gli organici. In particolare, le paraffine, le prime ad essere testate in edilizia, presentano una transizione di fase solido-liquido con immagazzinamento di notevoli quantità di energia nell’intervallo tra 15 e 40 °C, e sembrano essere le più promettenti, anche perché è possi bile modulare sia la temperatura che il calore di fusione, modificando la lunghezza media della catena idrocarburica. Le cere paraffiniche che si trovano in commercio sono chimicamente stabili e hanno buona affidabilità termica. Tuttavia la loro durata in genere non
MICELIO. Può essere una valida alternativa alle schiume plastiche per costituire la struttura ermetica di edifici e abitazioni, con il vantaggio che si decomporrà naturalmente una volta terminato il suo ciclo di vita

supera i 10 anni e sono tendenzialmente infiammabili. Abbiamo già sottolineato come, oggi, l’involucro esterno dell’edificio venga considerato sempre più spesso un elemento in grado di interagire con continuità con l’ambiente e permettere un mag gior comfort e bassi consumi. Utilizzando un nucleo interno di materiale PCM, è possibile affiancare un’inerzia artificiale all’isolamento fornito dall’involucro esterno. Durante il giorno i materiali PCM utilizzati all’interno della muratura, accumu lando calore mediante un processo endotermico, subiscono un passaggio dalla fase solida a quella liquida ed evitano il surriscaldamento dell’ambiente. Di notte, con il calo delle tem perature si solidificano rilasciando il calore precedentemente accumulato (funzionamento estivo). Al contrario, in inverno, il calore accumulato durante le ore più calde viene rilasciato durante la notte. I PCM possono quindi essere inseriti nei muri perimetrali, o in altri componenti degli edifici, per garantire un rilascio progressivo di calore quando la temperatura, interna o esterna, scende o sale sotto o sopra il punto di fusione del materiale. Quelli più utilizzati presentano cambiamenti di fase fra 22 e 25 °C, che corrisponde all’intervallo di riscaldamento e raffrescamento passivo degli edifici.
Le applicazioni che prevedono l’inserimento di PCM nei manufatti per l’edilizia vanno dai muri di Trombe, ai laminati per rivestimento, dai muri leggeri per strutture prefabbricate alle persiane e imposte, i mattoni, i sistemi di riscaldamento a pavimento, pannelli a soffitto, e altre ancora. Sul mercato i PCM sono disponibili come elementi opachi, ovvero lastre di gesso contenenti PCM in microcapsule, per il rivestimento di interni e pareti divisorie; intonaco caricato con una piccola quantità di microcapsule contenenti PCM, per i rivestimenti interni; pannelli macro-incapsulati flessibili con PCM mine rale inorganico. Oppure come elementi trasparenti, cioè sotto forma di pannelli trasparenti in lastre di polimetilmetacrilato (PMMA) contenenti microcapsule di PCM ed elementi traspa renti in vetro a più strati con intercapedini contenenti gas nobili con materiali a cambiamento di fase [1].
I vantaggi sono molteplici. In primo luogo, l’elevata inerzia termica che conferiscono ai componenti edili in cui sono inte grati; poi il peso ridotto e la riciclabilità della materia prima, specialmente per paraffina e sali idrati; la possibilità di sce gliere la temperatura di fusione per garantire il benessere termico degli ambienti interni in funzione della zona climatica o ambiente specifico a cui sono destinati; l’indipendenza dallo spessore, al contrario dei materiali tradizionali; nell’intervallo prossimo alla temperatura di fusione, la capacità di accumulo molto elevata (circa 80-100 volte quella dei rispettivi sistemi tradizionali) a parità di peso.
Sfruttando la transizione di fase, i PCM possono essere con siderati “accumulatori di calore intelligenti” che, riducendo i
picchi giornalieri di energia e favorendo un risparmio in ter mini di energia e di climatizzazione dell’ambiente, assicurano una diminuzione delle emissioni di CO2 degli edifici in cui sono inseriti. Alcuni studi sperimentali hanno dimostrato una riduzione del consumo energetico e delle emissioni di ani dride carbonica di circa il 20% in contesti climatici caldi, come nel Centro-Sud italiano. L’abbinamento di questi materiali con un ulteriore strato di isolamento termico potrebbe portare tale riduzione al 70%. Il ridotto spessore di questi materiali garan tisce anche notevoli recuperi volumetrici in edilizia. I limiti sono invece legati ad una maggiore complessità nella fase di progettazione e realizzazione; alla necessità di un packaging in grado di contenere questi materiali per un lungo periodo; alla difficoltà nella scelta della temperatura di fusione più adatta per consentire il cambiamento di fase e ad un costo ancora abbastanza elevato. Occorre considerare anche il pos sibile surriscaldamento nel periodo estivo, quando le tempera ture sono molto alte per periodi prolungati e c’è il rischio che la temperatura notturna non scenda sotto quella del materiale, impedendone la solidificazione. In questo caso, l’adozione di sistemi attivi o passivi per il raffrescamento notturno o di scambiatori di calore per il recupero termico può risolvere il problema del surriscaldamento estivo. A causa dell’elevata infiammabilità dei PCM costituiti da paraffina, appartenenti ai gruppi B1 e B2 – rispettivamente “difficilmente” e “normal mente” infiammabili in base alla UNI EN 13501-1:2005 che regolamenta la classificazione dei materiali e degli elementi da costruzione in funzione della loro reazione al fuoco – il loro utilizzo è consentito in una quantità pari al 20%, esclusi gli edifici pubblici. Laddove siano necessarie quantità maggiori di materiale PCM, è preferibile impiegare i sali idrati.
Il maggiore vantaggio nell’uso dei PCM viene conseguito negli edifici cosiddetti “a bassa inerzia termica”, tendenzialmente associati all’edilizia leggera tipica di una modalità di costru zione più veloce e flessibile. Tuttavia, un analogo apporto positivo viene conferito da questi materiali anche all’edilizia pesante, andando ad alleggerire l’impegno inerziale dei com ponenti massivi.
Per la progettazione di un sistema di accumulo di calore latente si devono considerare tre fattori di scelta:
1. materiale a cambiamento di fase più adatto alle tempera ture di lavoro;
2. contenitore che racchiuda il PCM;
3. superficie di scambio termico per il trasferimento del calore dall’ambiente al PCM e viceversa.
È necessario considerare le caratteristiche della zona climatica nella quale si opera e il periodo dell’anno nel quale si vuole sfruttare il PCM. La temperatura di fusione del PCM non deve essere troppo bassa, altrimenti non si raggiungerebbero le condizioni di comfort durante la notte, e nemmeno troppo alta poiché non riuscirebbe ad accumulare sufficiente energia durante il giorno, non permettendo il passaggio di stato. Per evitare il surriscaldamento interno in primavera e avere una situazione di comfort, la temperatura ideale è di circa 26 °C, che però scende a 23 °C con una sollecitazione esterna infe riore. Il contenitore funge da barriera con l’esterno e prote zione dalle interazioni dannose, ma deve anche offrire un’a deguata superficie di scambio e garantire stabilità strutturale, maneggiabilità, resistenza alla corrosione, stabilità termica, resistenza meccanica e flessibilità. A seconda del metodo uti lizzato per l’immagazzinamento dei PCM, si distinguono fon damentalmente due tecniche:
1. macro-incapsulamento, in cui una determinata quan tità di materiale PCM viene incapsulata all’interno di un contenitore singolo (tubi, sfere, pannelli e altri recipienti) che viene successivamente incorporato negli elementi da costruzione. È diffusa nel settore residenziale, perché
consente di utilizzare l’aria come mezzo per lo scambio termico;
2. micro-incapsulamento, in cui ogni particella solida o liquida di PCM viene trattenuta in contenitori sferici com posti da un film polimerico ad elevato peso molecolare.
L’integrazione dei PCM nell’involucro edilizio può avvenire in tre modi diversi:
■ incorporazione del PCM nei sistemi costruttivi: con siste nella miscelazione del materiale PCM, in polvere o liquido, con materiali edili, come gesso o cemento. Bisogna prestare attenzione alla compatibilità dei due materiali;
■ immersione del PCM fuso dentro a un materiale da costruzione poroso (blocchi di cemento o gesso, mediante assorbimento capillare): con questo metodo si possono convertire pannelli di rivestimento ordinari in pannelli di rivestimento con PCM, ma occorre tenere pre sente che dopo un lungo periodo si possono verificare delle perdite;
 THE CUBE, CAMPUS DELLA TECHNICAL UNIVERSITY DI DRESDA. L’edificio è stato realizzato con l’utilizzo del cemento rinforzato con fibre di carbonio, materiale di considerevoli caratteristiche prestazionali in termini di leggerezza, flessibilità e resistenza alle cattive condizioni atmosferiche
THE CUBE, CAMPUS DELLA TECHNICAL UNIVERSITY DI DRESDA. L’edificio è stato realizzato con l’utilizzo del cemento rinforzato con fibre di carbonio, materiale di considerevoli caratteristiche prestazionali in termini di leggerezza, flessibilità e resistenza alle cattive condizioni atmosferiche
La dimensione del mercato dei materiali a cambiamento di fase a base di paraffina micro-incapsulata ha superato i 200 milioni di dollari nel 2021, con una stima di crescita annua del 9% dal 2022 al 2028 trainata dall’espansione del settore edile, unitamente a una crescente domanda nel settore degli imballaggi. In termini di volume, la dimensione del settore potrebbe superare le 173,2 kilo tonnellate entro il 2028. I materiali a cambiamento di fase micro-incapsulati sono i più utilizzati nel settore edile, compresi i sistemi di recupero del calore di scarto, il raffrescamento degli ambienti e il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua solare. I PCM di paraffina microincapsulata sono materiali sensibili all’ambiente, che rispondono a uno stimolo esterno ambientale (trigger) mediante un cambiamento fisico del materiale. Questa nuova tecnologia trova applicazioni crescenti anche nei settori automobilistico e aerospaziale, tessile, del confezionamento e imballaggio, dell’elettronica e delle industrie chimiche e farmaceutiche. Le ricerche condotte per testare l’efficienza dei PCM a base di paraffina micro-incapsulata negli edifici hanno mostrato risultati positivi in termini di risparmio energetico nella maggior parte degli esperimenti. Attualmente, i produttori
stanno sperimentando i PCM anche nel settore tessile, per i cosiddetti tessuti intelligenti, nell’imballaggio a temperatura controllata per l’industria farmaceutica e nel confezionamento per prodotti alimentari surgelati. Tuttavia, il mercato globale sarà trainato principalmente dall’escalation sia nel settore edile che in quello dell’imballaggio, soprattutto a causa della crescita esponenziale dell’industria dell’e-commerce. Le applicazioni HVAC in Europa influenzeranno positivamente la domanda di materiali PCM per tutto il periodo di previsione. Il mercato dei materiali a cambiamento di fase in paraffina micro-incapsulata per l’edilizia genererà oltre 110 milioni di dollari entro il 2028. In questo settore, i PCM sono micro-incapsulati e incorporati in materiali a struttura porosa per aumentare la massa termica dell’edificio. L’integrazione di materiali a cambiamento di fase in paraffina micro-incapsulata nei sistemi di riscaldamento e ventilazione influisce notevolmente sulla temperatura ambiente. Nuove e diverse applicazioni dei PCM, ancora più promettenti, sono attualmente in corso di sperimentazione per l’utilizzo negli edifici al fine di ridurre l’impronta di carbonio e quindi risparmiare energia. (fonte: www.gminsights.com)
■ incapsulamento dei PCM: si utilizza una capsula che garantisce flessibilità, resistenza alla corrosione, stabilità nel tempo e protegge il PCM da interazioni dannose con l’am biente, fornendo sufficiente superficie per il trasferimento del calore. Le forme di incapsulamento possibili sono due, macro e micro-incapsulamento. Grazie a questo metodo è possibile superare i problemi di infiammabilità, ma l’in cremento di conducibilità rimane a valori bassi. I PCM possono essere integrati in molti materiali, tra cui legno, cartongesso, intonaco, plexiglas e vetro, e in soluzioni impian tistiche di riscaldamento o raffrescamento, nei collettori solari o negli scambiatori di calore.
In termini di inerzia termica in rapporto ai carichi termici interni all’edificio, il maggiore vantaggio offerto in edilizia dai PCM, rispetto ai materiali tradizionali, è l’indipendenza dallo spessore che consente una conservazione e un rilascio termico ottimali anche con una massa minima. Relativamente al contenimento dei carichi termici esterni, radiazione solare e temperatura dell’aria, occorre porre particolare attenzione alla stratigrafia della muratura. In funzione della posizione del PCM nella stratigrafia della muratura – all’interno, al centro
o all’esterno, rispetto all’ambiente esterno – cambia il rendi mento del sistema. I possibili modelli di parete sono tre:
■ Modello 1: Intonaco interno – isolante termico – strato di PCM – intonaco esterno. Di giorno, lo strato di PCM assorbe il flusso termico dovuto alla radiazione solare e alla differenza di temperatura dell’aria. Di notte, viene rilasciata all’ambiente esterno la maggior parte dell’energia termica accumulata dal materiale;
■ Modello 2: Intonaco interno – isolante termico – inter capedine ventilata – strato di PCM – intonaco esterno. Di giorno, lo strato di PCM assorbe il flusso termico dovuto alla radiazione solare. Di notte, il calore va, in parte, verso la parete esterna e, in parte, viene rimosso dall’aria che passa attraverso l’intercapedine;
■ Modello 3: Intonaco interno – isolante termico – strato di PCM – intercapedine ventilata – intonaco esterno. Di giorno, lo strato di PCM assorbe il flusso termico dovuto alla radiazione solare e alla differenza di temperatura dell’a ria. Di notte, la maggior parte dell’energia termica accu mulata dal materiale fluisce verso la parete esterna e viene rimossa per ventilazione naturale attraverso l’intercapedine.
In pratica, se il PCM viene posizionato nell’intonaco interno, accumula calore quando la temperatura dell’aria della stanza
è maggiore di quella di fusione del materiale scelto, mentre lo rilascia per solidifica zione quando la temperatura scende al di sotto di quella di fusione. Se invece il PCM viene inserito all’interno del muro, vicino allo strato esterno, assorbe calore di giorno, raffrescando l’ambiente interno e lo rilascia di notte, in entrambe le direzioni, ovvero sia verso l’interno che l’esterno. Da ultimo, se il PCM viene posizionato tra l’interca pedine d’aria e l’intonaco esterno, accumula calore durante il giorno e lo rilascia di notte per solidificazione. La ventilazione nell’intercapedine contribuisce ad evacuare parte del calore.

Le numerose ricerche effettuate negli ultimi anni nel campo dei materiali PCM per l’edilizia, sia a livello internazionale che nazionale, hanno portato allo sviluppo di nuovi prodotti e sistemi innovativi per la loro integrazione, attualmente disponibili in commercio. Fermi restando i requisiti ai quali tali materiali devono sottostare per l’impiego – temperatura di fusione simile a quella per il comfort termico, entalpia, inerzia termica, stabilità nel tempo, temperatura di congelamento, aspetti ecologici, prezzo tossicità e reperibilità – la ricerca ha dimostrato che, ad esempio, per non com prometterne le proprietà, è preferibile inserire i PCM di paraffina nella miscela costi tuente i materiali da costruzione, in microcapsule di polimetilmetacrilato, solitamente di diametro 2-20 μm, ovvero in involucri di plastica per evitare la possibile fuoriuscita dall’intonaco che li contiene, durante il cambiamento di fase della liquefazione. Queste capsule, disponibili come polvere secca da miscelare con altre sostanze o materiali,
possono essere inserite in pan nelli di cartongesso o in legno, isolanti termici, intonaci o sistemi di facciata vetrati o in plexiglas. Si tratta di pannelli molto leggeri, di pochi mm di spessore, installa bili su pareti divisorie per interni, soffitti o dei muri esterni (dall’in terno) e montati dietro i pannelli di rivestimento a secco ordinari. Sono disponibili anche sistemi di facciate vetrate realizzate con materiali PCM. In questo caso si tratta di facciate pluristrato, com poste da un insieme di vetri di sicurezza e intercapedini varie rea lizzate da pannelli frangisole, gas nobile e pannelli a cambiamento di fase, che realizzano sistemi tecnologici innovativi, capaci di garantire un’illuminazione natu rale diffusa, con elevata inerzia termica e una bassa trasmittanza termica che possono essere instal lati al posto di un normale infisso, mantenendo uno spessore estre mamente ridotto. Il loro costo è ancora molto oneroso. Per ovviare al problema della quantità limite utilizzabile della paraffina, pari al 20% per normativa, si utilizzano come elemento base i sali idrati che sono meno infiammabili. La possibilità di introdurre una quan tità maggiore di materiale porta a un aumento dell’inerzia termica pur rimanendo nei limiti di infiam mabilità consentiti.
Con la sigla ss-PCM, si intendono i materiali a cambiamento di fase stabilizzati in forma che possono immagazzinare fino a cinque volte più energia termica rispetto ai compositi PCM tradizio nali. Gli ss-PCM vengono utilizzati per mantenere la forma solida,
BIO MATTONI DI PAGLIA E LANA, ideali per l’isolamento termoacustico e l’assorbimento di sostanze inquinanti presenti nell’aria, perfino i funghianche quando si verifica il cambia mento di fase da solido a liquido e per evitare le interazioni tra PCM e materiali o ambiente circostanti, anche a temperature elevate. Gra zie agli ss-PCM è possibile il con tatto diretto tra PCM e Heat Tran sfer Fluid (HTF) agendo sul tasso di scambio termico e aumentan dolo rispetto alle tradizionali tec niche di macro-incapsulamento. In questi materiali la forza capillare e la tensione superficiale, fornite dal materiale dello scheletro, riescono a limitare il flusso dei sali fusi e ne prevengono la fuoriuscita. Tra i materiali di stabilizzazione della forma, caratterizzati da aree super ficiali elevate, volume dei pori elevato e buona stabilità termica e chimica a temperature elevate, la diatomite è sicuramente la più utilizzata. Possiede infatti diverse proprietà che la rendono idonea, tra cui massa leggera, elevata area superficiale specifica, elevata poro sità (80–90%), eccellente capacità di assorbimento e buona stabilità termica e chimica a temperature elevate. Inoltre, è abbondante e ha un prezzo relativamente basso. In una recente ricerca dell’Uni versità Martin Luther di Halle-Wit tenberg (MLU) e dell’Università di Lipsia, in Germania, pubblicata nel Journal of Energy Storage [2], il team di ricercatori ha sviluppato un innovativo materiale ss-PCM che aumenterebbe significativa mente l’accumulo di calore, sin tetizzato attraverso un processo molto più efficiente ed ecologico. Il materiale di accumulo di calore in questione è racchiuso in una struttura di silicato solido e non può fuoriuscire a causa delle ele vate forze capillari. Le sostanze utilizzate per la sua produzione sono principalmente acidi grassi
NANOSFERE DI PCM. Possono essere aggregate nei pannelli in cartongesso o in legno, nella pasta degli intonaci, nei sistemi di facciata trasparenti, nonché in vari isolanti termici
innocui come quelli che si trovano comunemente nei saponi e nelle creme. Gli addi tivi, che conferiscono al materiale forza e maggiore conducibilità termica, sono invece ottenuti dalla lolla di riso. Secondo gli studiosi, l’innovativo materiale potrebbe essere integrato nelle pareti degli edifici fungendo da massa termica, sostituendo i classici mattoni o il cemento con una maggiore resa. Il problema della stabilizzazione di forma dei PCM è stato affrontato in molti modi ed esistono già in commercio diversi tipi di PCM incapsulati, principalmente per il settore edile. Una soluzione innovativa [3] proposta dal Consorzio INSTM, costituito da 50 Università italiane, consiste nell’abbinamento delle proprietà di un PCM a quelle di un materiale stabilizzante elastico, flessibile, impermeabile, fonoassorbente come la gomma. L’idea è quella di sfruttare la matrice elastomerica come stabilizzatrice della forma: il PCM viene disperso nell’elastomero e, in seguito alla vulcanizzazione, vi rimane confinato. Abbinando gomma e PCM, quindi, si potrà creare in definitiva una nuova tipologia di PCM stabilizzato. L’obiettivo è che, oltre a mantenere la forma al di sopra della temperatura di fusione del PCM, il nuovo materiale composito elastome rico risulti stabile, dal punto di vista chimico-fisico, anche dopo molti cicli termici. In particolare il calore latente di fusione dovrà ridursi il meno possibile, per prolungare l’efficienza del materiale nel prodotto finale. Inoltre dovrà essere possibile realizzarlo con le tecniche e le attrezzature tipiche della produzione della gomma. Un composto con tali caratteristiche potrà trovare impiego in applicazioni molto diverse, a seconda della temperatura di transizione di fase del PCM ( fonte INSTM ):
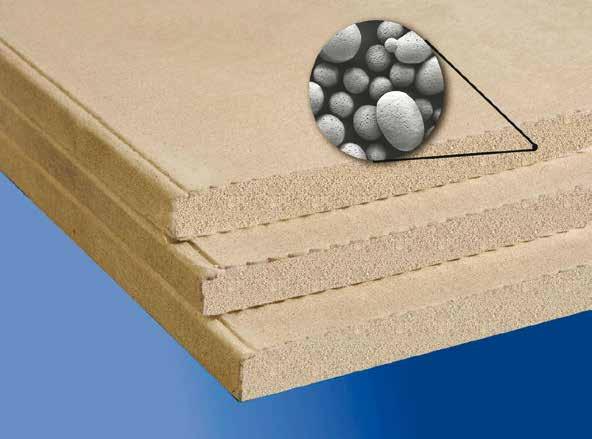
■ sotto 0 °C: potrà essere usato nel mantenimento della catena del freddo (risparmio di energia e migliore stabilità in temperatura di celle frigorifere, vani termostatati, etc.);
■ tra 20 e 25 °C: potrà trovare applicazione come isolante attivo negli edifici (diminuzione dello sbalzo termico giorno/notte);
■ vicino alla temperatura del corpo umano: potrà essere appli cato su tessuto, per migliorare il comfort termico dell’ab bigliamento tecnico per alpinismo, mute subacquee, etc.;
■ sopra i 40 °C: potrà costituire un accumulatore termico per immagazzinare il calore prodotto da altri processi (Thermal Energy Storage).
Nel campo dei PCM, lo step di ricerca più avanzato riguarda sempre più spesso i nanomateriali e le nanotecnologie. In questo ambito, l’attenzione si focalizza sull’inserimento di nanoparticelle finalizzato all’incremento della capacità e delle prestazioni dei PCM anche del 20-60% per quanto riguarda il calore specifico e di circa il 15% del calore latente, con il chiaro obiettivo di utilizzare sempre meno materia prima e ottenere la massima efficienza, nell’intento di limitare l’uso delle fonti fossili e le emissioni climalte ranti [4]. Quindi nanotecnologie e nanomateriali sono in prima linea sia nelle rinnovabili che nell’edilizia per conseguire un aumento di calore specifico e di conducibilità elettrica dei materiali per una maggiore efficienza . Tra i materiali oggetto di studio in edilizia, ci sono anche i polimeri che vengono impiegati per realizzare
gli involucri e i gusci protettivi dei PCM utilizzati ad esempio nei cementi per sfruttare l’accumulo termico, onde evitare la dispersione dei materiali a cambiamento di fase quando fon dono. Sempre nel caso dei cementi, i PCM possono anche essere inseriti in particolari argille e materiali naturali per incrementare l’accumulo di calore e la resistenza del com posto. In generale, gli studi e le ricerche prodotte nel campo dei PCM hanno mostrano che tali materiali hanno buoni valori di capacità termica, ma soffrono di una bassa condut tività termica (diffusività) in fase solida, che è insufficiente per lo sviluppo di TES efficienti.
Per questo, negli ultimi anni, le ricerche si sono concentrate nello sviluppo di nuovi mezzi di accumulo, da impiegare come sistemi alternativi di accumulo termico, costituiti da una miscela di PCM e nanoparticelle. In particolare, sono stati realizzati e caratterizzati nuovi materiali a cambiamento di fase nano caricati (nano-PCM) attraverso la selezione e caratterizzazione dei PCM di base e delle nanoparticelle da aggiungere agli stessi. Inoltre, sono stati studiati e svi luppati dei metodi di miscelamento PCM-nanoparticelle in grado di assicurare una buona miscelazione e distribuzione dei singoli componenti. Per esempio, una ricerca condotta dall’Università di Perugia [4] e relativa alla selezione e carat terizzazione di una miscela di materiali a cambiamento di fase e nanoparticelle per lo sviluppo di un sistema di accu mulo termico nell’intervallo di temperature 200-250 °C, ha identificato come adeguato un mezzo costituito da una miscela binaria di sali (NaNO3 -KNO3) cui si è aggiunta una piccola quantità (1%wt) di nanoparticelle di SiO2 e Al2O3 ( fonte ENEA ).
1. Utilizzo dei materiali a cambiamento di fase in edilizia – P. Corongiu, M. Papagni, M. Surra – AiCARR Journal 55.
2. Influence of surfactants and organic polymers on monolithic shape-stabilized phase change materials synthesized via sol-gel route – Felix Marske, Joe Dasler, Caroline Haupt, Kirsten Bacia, Thomas Hahn, Dirk Enke - Journal of Energy Storage Volume 49, May 2022.
3. Compositi elastomerici a transizione di fase per l’accumulo ed il rilascio di energia termica – Consorzio INSTM (online).
4. Studio, produzione e caratterizzazione di un nanoPCM, sia in forma massiva che micro incapsulata, con temperatura di fusione prossima a 220 °C – Manila Chieruzzi, José Maria Kenny (Università degli Studi di Perugia) - Report RdS/PAR2013/227.
5. I materiali a cambiamento di fase – Luca Ferrari, RCI 2016 [Online].
6. Problemi e potenzialità degli accumuli termici a cambiamento di fase: Progetto di un impianto di prova – Francesco Grigolato, Tesi [Online].
7. Accumulo termico in edifici residenziali con materiali a cambiamento di fase – Roberta Zuanetto, tesi [Online].
8. Test sperimentali di nuovi materiali a cambiamento di fase in grado di assicurare performance più elevate in termini velocità di risposta del PCM alla variazione di temperatura del fluido primario – F. D’Annibale, G. Zummo, C. Menale, F. Sfrattoni – ENEA Report RdS/PAR2013/156 [Online].
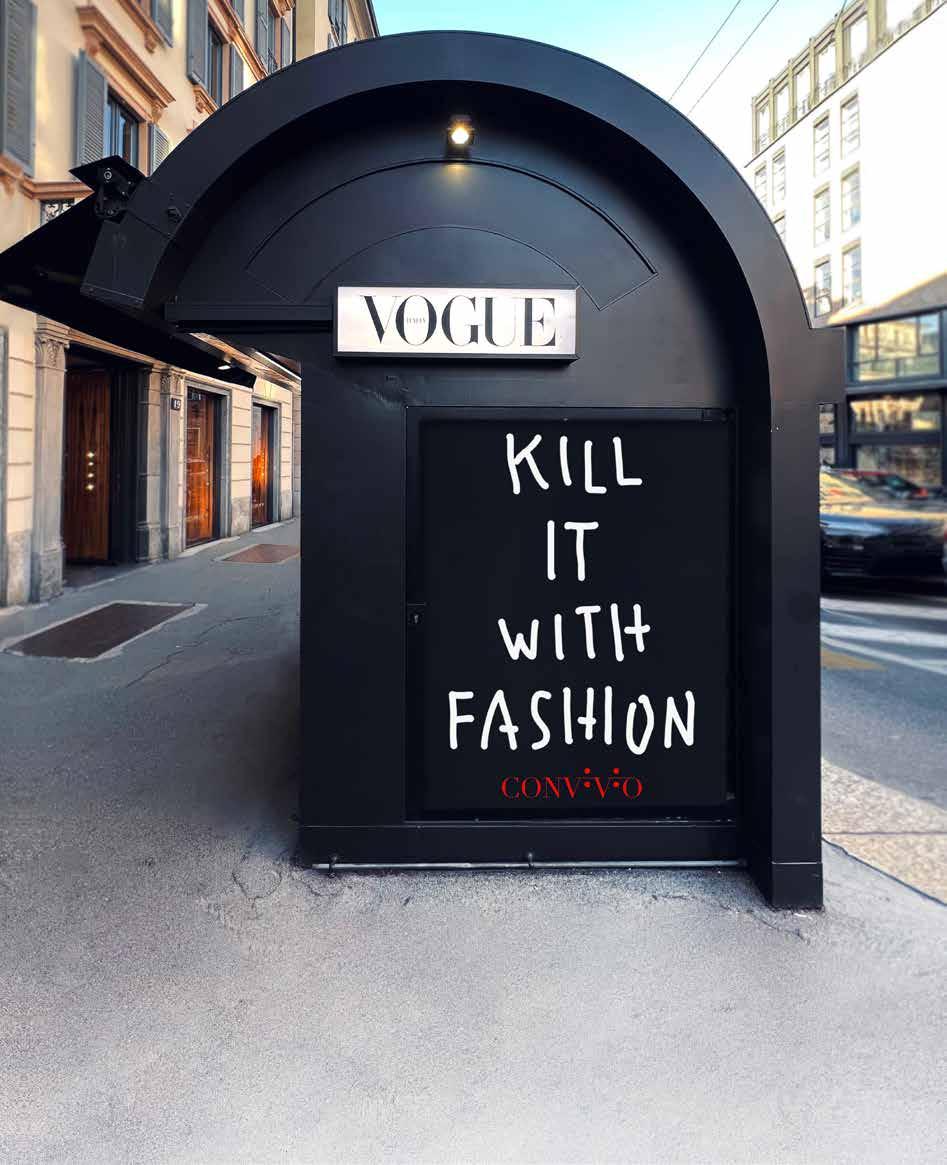
Un edificio per acquisti verdi, che mette in pratica i principi dell’architettura ecologica. È il Green Pea di Torino, il primo green retail park al mondo

Nell’ex zona industriale Carpano, in zona sud di Torino, si staglia il volume semitrasparente del Green Pea , complesso polifunzionale e commer ciale di 15.000 mq di superficie complessiva, che ospita 57 spazi di vendita, un’area wellness e una dedicata alla ristorazione. Il “verde” svolge un ruolo fondamentale per l’area, pesantemente industrializzata nel Novecento, andando a ridefinire il panorama urbano con un’immagine
sfaccettata e organica, permeata da luce e vegetazione. Il volume si sviluppa su cinque piani fuori terra per 25 metri di altezza, in continuità con il filo edilizio esistente e prolungando la facciata dello store Eataly. L’orientamento nord-sud e la forma svasata dell’ultimo piano, oltre che per garantire la migliore distribuzione dell’irraggiamento solare, sono concepiti per adattarsi alle condizioni clima tiche e ambientali.
Le strutture portanti dei piani fuori terra sono state realizzate in carpenteria metallica. La richiesta architettonica di ridurre a pochi appoggi puntuali le strutture orizzontali – per consen tire maggior libertà nella concezione e gestione degli spazi – ha generato il principale obiettivo seguito in fase di pro gettazione strutturale: realizzare una struttura leggera, ma al tempo stesso ad alta resistenza.
La struttura portante del Green Pea è in acciaio e intera mente montata a secco tramite unioni bullonate, in modo da essere facilmente smontabile e rimovibile per essere ria dattata alle esigenze di un eventuale cambio di destinazione d’uso o terminato il ciclo di vita. L’impiego di strutture in carpenteria metallica asseconda la volontà architettonica di ridurre a pochi appoggi puntuali gli elementi orizzontali, per consentire una maggiore libertà di configurazione degli spazi. Travi in profili HEA 1000 ordite in entrambe le direzioni e con luce massima di 16,6 metri costituiscono la maglia principale,


che si innesta su colonne tubolari circolari di Ø 406,4 x 10 mm, per le colonne meno solle citate, e di Ø 521 x 40 mm. Travi secondarie in IPE 400 disposte in direzione nord-sud e di luce massima pari a 8 m completano le strutture orizzontali. I solai sono in lamiera grecata di tipo Hi-bond e getto di completamento sp. 12 cm. In copertura, data la presenza di ampie superfici trattate a verde e conseguente maggior carico di piano, sono poste travi composte saldate aventi altezza pari a 990 mm, spessore d’anima di 25 mm e ali di 40 mm. Gli elementi in acciaio sono in qualità S355JR. Le travi HEA 1000 sono state forate, dove necessario, per consentire il passag gio degli impianti tecnici.
Le facciate, dalla particolare forma sfaccettata, sono formate da montanti e traversi riportati su apposita struttura realizzata in carpenteria metal


lica che a sua volta grava sulle travi perimetrali dell’edificio. La pelle esterna è costituita da brise soleil in listelli di legno che si innestano su profili a T ottenuti da ½ IPE 600 in acciaio zincato a caldo. In corrispondenza della copertura vetrata della hall, le facciate sono sostenute da montanti esterni in IPE 600 e interni in IPE 270 in acciaio zincato, collegati tra loro da doppi piatti calastrellati, insieme che è assimilabile a quello di una trave Vierendeel.

Green Pea è stato progettato come un elemento innovativo e resiliente, sostenibile in ogni suo dettaglio, in modo da permettere all’edificio di respirare e far respirare, in armonia con l’essere umano e con gli elementi naturali. L’utilizzo di materiali green svolge un ruolo fondamentale per il progetto e la vegetazione, più di 2.000 alberi, piante e arbusti, è uti lizzata in larga parte, non in maniera mimetica ma visibile e fruibile. Piante ad alto fusto trovano spazio in vasche inserite in un sistema di terrazzamenti che rendono di fatto l’edificio un organismo naturale che vibra a seconda della luce e della crescita della vegetazione. In copertura è stata prevista una piscina panoramica in cemento armato con parte terminale in vetro. La piscina si appoggia da un lato sulle travi metalliche del piano copertura stesso, men tre sul lato esterno che si affaccia sulla facciata ovest è retta da

due puntoni in acciaio zincato che trasferiscono il carico alle travi metalliche del piano sottostante. Il grande tetto-giardino in sommità dell’edificio diviene la “quinta facciata” di Green Pea, fiore all’occhiello della bioedilizia.
L’edificio dimostra l’efficacia della produzione di energia attraverso l’impiego di fonti rinnovabili che garantiscono alta efficienza e riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Queste soluzioni sono rese accoglienti e parlanti dall’intero edificio. Dal punto di vista energetico l’edificio utilizza diverse fonti rinnovabili: pozzi geotermici, pannelli fotovoltaici, pan nelli solari, smart flowers, fino a pavimenti piezoelettrici che consentono il recupero dell’energia cinetica generata dal pas saggio degli utenti.
Green Pea è un edificio NZEB Nearly Zero Energy Building

in classe A3, con le seguenti caratteristiche:
■ energia termica prodotta da impianto geotermico: 1.848.697,13 kWh;
■ acqua calda sanitaria: fabbisogno di energia termica 187.484,77 kWh, di cui 87,81% = 164.630,38 kWh da fonti rinnovabili.
■ fabbisogno di energia termica 1.900.967,095 kWh, di cui 88,59% = 1.684.066,75 kWh da fonti rinnovabili;
■ energia elettrica prodotta da fotovoltaico: 140.530,59 kWh.
■ fabbisogno di energia elettrica 156.232,20 kWh, di cui 89,94% = 140.530,59 kWh da fonti rinnovabili.
DIREZIONE OPERATIVA CANTIERE: Carlo Piglione
PROGETTO ARCHITETTONICO E DIREZIONE
LAVORI: ACC Naturale Architettura Cristiana Catino e Negozio Blu Architetti (Gustavo Ambrosini, Paola Gatti, Carlo Grometto)
COLLABORATORI: Maurizio Bussone, Marco Lagamba, Milena Maccaferri, Rocco Scuzzarella, Francesco Piscazzi
PROGETTO STRUTTURALE E GEOTECNICO: Ceas srl
LANDSCAPE E VERDE: ACC Naturale Architettura, Negozio Blu Architetti con Studio Associato Vigetti e Merlo – agronomi

PROGETTO ENERGETICO E IMPIANTISTICO: Studio Sapi
IMPRESA: Impresa Novara srl
CARPENTERIA METALLICA: CML
IMMAGINI: Fabio Oggero (finito), ACC Naturale Architettura e Negozio Blu Architetti (cantiere)
Un manuale operativo che delinea dettagliatamente le procedure per i Professio nisti Tecnici per l’applicazione del Superbonus 110%, aggiornato con le novità introdotte dalla legge 29 luglio 2021, n.108 di conversione del DL Semplificazione e il nuovo Decreto Prezzi: un’occasione di crescita per il Paese e, soprattutto, per i Professionisti Tecnici e le imprese edili.
Il testo è un vero e proprio supporto, concepito per una gestione in project management del Superbonus, fornendo gli strumenti per efficientare i processi, rendere più snelle le procedure che portano dalla ideazione e alla effettiva realizzazione degli interventi.
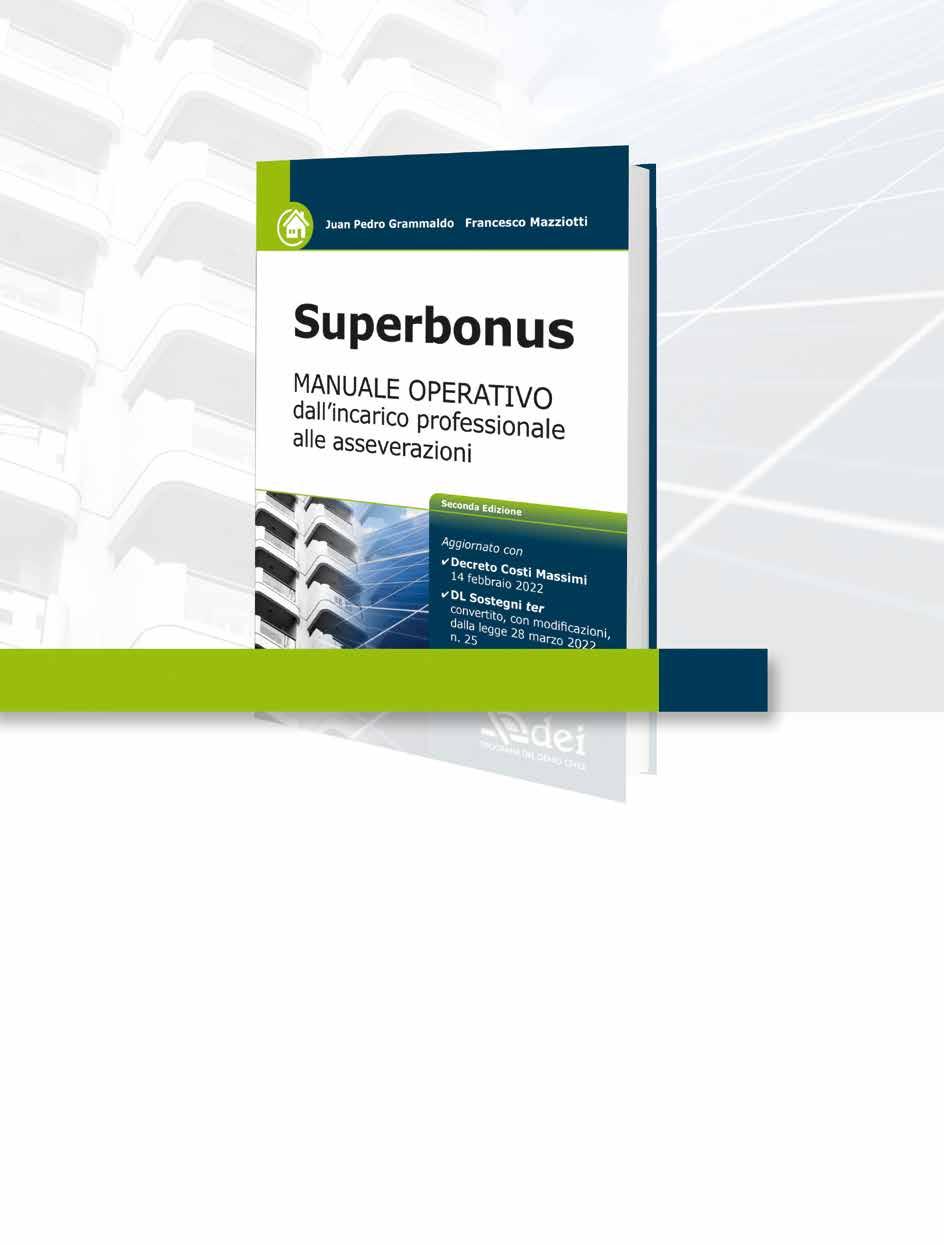
Per ogni protagonista del Codice Superbonus, indicazioni chiare e circostanziate delle attività che devono essere esperite per la realizzazione di interventi che pos sano usufruire delle agevolazioni.

www.build.itnuova edizione
La scuola Catullo è un progetto realizzato con sistemi costruttivi e impianti a basso impatto ambientale. Un edificio scolastico NZEB che utilizzerà principalmente energia rinnovabile

C on l’inizio dell’anno scolastico, la scuola primaria Catullo di Riccione ha riaperto i battenti. Si è trattato di un appalto di partenariato pubblico-privato che ha previsto la progettazione, l’esecuzione, la gestione e la manutenzione dell’opera da parte delle imprese per i successivi 20 anni.
Il team di Polistudio ha curato la progettazione architetto nica, studiando l’organizzazione spazio-funzionale, il rap porto tra gli spazi esterni e il contesto urbano. Si è trattata di una vera e propria progettazione integrata, che ha coinvolto le diverse realtà presenti. La progettazione multidisciplinare e la modellazione in BIM hanno permesso di ottenere un prodotto progettuale particolarmente evoluto, garantendo elevati standard di controllo sin dalle prime fasi di sviluppo
Polistudio A.E.S S.r.l. | Ing. Stefano La Motta
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Polistudio A.E.S S.r.l. | Arch. Gianluca Corvina, Arch. Andrea Banci
Studio Landi - Uff. Tec. Subissati
PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA
Serpilli S.r.l. | Ing. Gianluca Serpilli
Studio ad’Arte Archeol | Chiara Cesaretti
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Massimo Gradoni
GEOLOGIA E MISURE SISMICHE
Geol. Marco Brunelli
AGRONOMIA
Dott. Samuele Mencaroni
RUP
Ing. Michele Bonito
COSTITUENDA ATI
Subissati S.r.l., Ubi Leasing, CAT Impianti S.r.l.
dell’edificio. Nel progetto sono state impiegate energie e risorse naturali, seguendo criteri di massima sostenibilità (A4 NZEB). Un’opera portata avanti anche da Serpilli Srl (impianti, acustica, antincendio), S.T.A. Landi (strutture) e dalle imprese Subissati e CAT Impianti.
La scuola è sorta in seguito alla demolizione di un edificio preesistente, avvenuta nella primavera del 2021. L’edificio, sviluppato secondo i principi della rigenerazione urbana sostenibile, è stato realizzato completamente in legno con spazi flessibili e modulari. La struttura in legno lamellare con sistema costruttivo con tecnologie a secco, non solo

ha permesso una rapida realizza zione della scuola (in poco più di un anno), ma anche maggiore salubrità degli ambienti, impor tanti prestazioni di isolamento termo/acustico e alte prestazioni di risparmio energetico.



L’approccio alla didattica scelto dall’amministrazione comunale e dalla dirigenza scolastica ha reso necessarie alcune scelte proget tuali: spazialità versatili e flessibili, spazi polifunzionali e multicentrici in alternativa a quelli tradizionali unidirezionali, da sempre pen sati per ospitare prevalentemente lezioni frontali. Ogni ambiente è diventato luogo dove si può apprendere: corridoi per lavori in piccoli gruppi, atri per la condivi sione di esperienze, cortile per la realizzazione di attività creative. La superficie della scuola è di 1.077 mq ed è in grado di ospitare 125 studenti.
Sono presenti tre blocchi edilizi distinti, legati tra loro e allo spa zio esterno in maniera organica. L’entrata principale dell’edificio è situata nel blocco dei servizi generali, disposto su due piani.
Dall’ingresso principale si accede alla sala polifunzionale, un ambiente su due livelli affiancato da una gradinata che, grazie a una parete mobile, può formare uno spa zio unico con la mensa. Gli altri locali al piano terreno sono collegati dal corridoio che mette in comunicazione la sala polifunzionale con le aule, la palestra e con due ingressi di servizio.
 ©Subissati S.r.l.
©Subissati S.r.l.
©Subissati S.r.l.
©Subissati S.r.l.
©Subissati S.r.l.
©Subissati S.r.l.
©Subissati S.r.l.
©Subissati S.r.l.
Il progetto è un mix di forme orga niche e volumi puri. Si identificano chiaramente il grande volume di ingresso fronte strada, la palestra e il blocco aule.
Nella scuola sono previste cinque aule con conformazione architet tonica a forma di fiore e pareti mobili. Ogni padiglione costitui sce una classe ed è modulabile e accorpabile con l’utilizzo di pareti scorrevoli. Le ampie finestre e l’o rientamento dell’edificio, lo ren dono particolarmente luminoso. Il primo piano è dedicato ai docenti e a un’aula/laboratorio, anche questa modulabile nello spazio e nella funzione. Esternamente a ciascuna aula sono previste delle zone pavimentate con doghe di legno, uno spazio didattico esterno coperto da una tensostrut tura pensata per ospitare lezioni all’aperto. Inoltre, è presente una serra per i lavori di laboratorio e un campo da gioco multifunzio nale per attività sportive e ludiche.





La palestra, grazie ai suoi servizi e a un’entrata dedicata, potrà fun zionare autonomamente rispetto all’orario scolastico. È collocata nella parte opposta delle aule per una superficie di circa 400 mq e si apre direttamente sul giardino, creando un collegamento con le aree gioco esterne. La palestra sarà messa a disposizione per le sezioni ATR (Ginnastica Acrobatica) e per la sezione Ginnastica Artistica.
La luce naturale è protagonista indiscussa del progetto, irradiando gli ambienti durante tutta la gior
nata. La disposizione delle aperture dell’intero organismo architettonico è stata infatti studiata in relazione all’orientamento solare, oltre che alla funzionalità, ed è modulata da sistemi di schermature che ne regolano l’ingresso e ne filtreranno i raggi. Il sistema di illuminazione artificiale lavorerà in sinergia con l’apporto della luce naturale, con l’utilizzo di tecnologie che renderanno possibile mantenere costante, durante l’intero arco della giornata, la luminosità interna agli ambienti.
©Subissati S.r.l. ©Subissati S.r.l. ©Subissati S.r.l. ©Subissati S.r.l.
Il Prontuario costituisce uno strumento di lavoro per tutti gli operatori del can tiere, siano essi Professionisti Tecnici, imprese o funzionari tecnici che operano nella Pubblica Amministrazione: un testo che unisce la cultura giuridica ad una conoscenza di natura tecnica e si rivela di fondamentale ausilio poiché fornisce competenze di carattere legale, tecnico e amministrativo che consentono di in terpretare le disposizioni normative con l’ottica del tecnico di cantiere. Modelli, diagrammi di flusso schemi ed analisi dettagliata delle principali problematiche che si presentano durante la fase esecutiva dei Lavori Pubblici offrono una rispo sta operativa a dubbi e domande, le più frequenti nella pratica professionale del cantiere. Allegati al volume modelli editabili per redigere: attestazioni e relazioni riservate del Direttore Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento, verbali di consegna, sospensione e ripresa lavori, di concordamento nuovi prezzi, dispo sizioni e ordini di servizio per Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza.

www.build.it

Intendendo sperimentare l’applicazione del Superbonus su cantieri che superino il mero aspetto della riqualificazione edilizia del singolo fabbri cato, divenendo volano per una più profonda trasformazione in grado di coinvolgere l’ambiente urbano circostante, il gruppo di lavoro per il pro getto “RACCONIGI 25” (società SECAP, studi SMAPROGETTI, T61 Asso ciati, Chiabrera, società Tekinda, vedasi dettagli nel box, ndr.) ha inteso rispondere all’avviso pubblico promosso dall’Agenzia Territoriale per la Casa - ATC il 16 luglio 2021 sul complesso di corso Racconigi a Torino. Si sono colte le opportunità di raggiungere gli obiettivi prefissati, dimostrando le potenzialità del Superbonus in relazione alla riqualificazione del patri monio edilizio e agli aspetti di carattere sociale.

È nata così nel gruppo di lavoro l’idea di valorizzare l’immagine di uno dei sei quartieri popolari costruiti nei primi del Novecento e ampliati in anni successivi, costituito da 8 palazzine per complessivi 345 appartamenti, dove il profondo risanamento strutturale e impiantistico degli appartamenti si coniuga con il mantenimento dell’immagine esteriore dei fabbricati carat terizzata da fregi in facciata di gusto Liberty e dal ripristino della qualità degli spazi condominiali a giardino e a parcheggio. Nel febbraio del 2022 l’assemblea condominiale valuta i progetti perve nuti e sceglie il progetto presentato dalla società SECAP, riconoscendo il maggior valore della proposta progettuale. L’opportunità di inserirsi in un contesto urbano, con un intervento che utilizza il Sismabonus e l’Ecobo nus e che interessa 6 delle 8 palazzine esistenti, ha orientato il gruppo di lavoro nel proporre un progetto che possa risultare esso stesso volano per una qualificazione sociale, stimolando nei residenti del quartiere un
rinnovato sentimento di appartenenza. A tal pro posito è stata svolta una operazione di naming dell’intervento che ha portato alla creazione di un logo al fine di rafforzare la riconoscibilità del rinnovato quartiere.
Sotto il profilo tecnico il progetto predisposto per RACCONIGI 25:
■ riqualifica integralmente le strutture orizzon tali e verticali comprese scale e ascensori;
■ riconduce le falde del tetto alle forme del progetto originario alleggerendole di peso in favore della sicurezza sismica;

■ rinnova integralmente gli impianti comuni e dei singoli alloggi;
■ sostituisce tutti i serramenti esterni;
■ prevede l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento ad acqua calda centralizzata con distribuzione a pavimento tramite sistema ibrido di pompa di calore.
È un cantiere “sfida” per la complessità che esso rappresenta in rapporto al termine perentorio per la fine lavori imposto dalla legge. A un anno esatto dalla pubblicazione dell’avviso di ATC è stato avviato il cantiere anche grazie a un’azione di accompagnamento dedicata a ogni singola famiglia ancora residente nei fabbricati in degrado. Questa attività, svolta da SECAP, quale accompagnamento all’individuazione delle residenze temporanee più idonee alle singole esigenze specifiche espresse da ogni nucleo famigliare, costituisce parte integrante del progetto, dando la giusta attenzione agli aspetti umani degli abitanti interessati da un trasloco temporaneo in attesa di poter rientrare nei pro pri appartamenti completamente riqualificati. Gli interventi di consolidamento strutturale saranno quindi svolti su immobili liberi da persone e cose.
Dal punto di vista strutturale il complesso è stato realizzato secondo le tec niche costruttive dell’epoca, ossia maschi in muratura portante con mattoni pieni, solai voltati a padiglione, scale con gradini in lastre di pietra murate e copertura lignea a padiglione.
Nel corso degli anni sono state apportate alcune modifiche di natura strut turale, quale l’inserimento del vano ascensore per ciascuna scala, il rifaci mento della copertura con una falda in latero cemento, la posa di nuovi pavimenti sugli esistenti, aumentando notevolmente i carichi permanenti sulla struttura. Inoltre, il fabbricato con affaccio su corso Racconigi è stato soprelevato di 2 piani, con muratura a cassavuota in mattoni forati a soste gno di solai in latero cemento gettati in opera.
La vetustà dell’immobile, oltre ad alcune scelte progettuali effettuate nel passato, ha restituito dei fabbricati con elevate criticità strutturali oltre a evidenti segni di degrado, che implicano obbligatoriamente un intervento di rinforzo strutturale diffuso su tutte le palazzine.
L’obiettivo principale è quello di ridurre al minimo i carichi verticali per manenti, oltre a perseguire un comportamento scatolare per garantire una migliore risposta in caso di evento sismico. Nello specifico, si prevede il rinforzo strutturale di tutte le volte e il rinforzo delle putrelle a supporto degli impalcati, il rifacimento del vano ascensore con nuova struttura por tante opportunamente connessa ai solai, il rifacimento delle coperture e l’inserimento di un cordolo sommitale in muratura armata per ridurre al minimo le spinte fuori dal piano dei maschi. Si prevede altresì la realizza
zione di catene trasversali alla manica principale dell’edificio e l’inserimento di fasce marca-piano al fine di omogeneizzare il comportamento del fabbricato, oltre alla messa in sicurezza di tutte le scale.

In corrispondenza dei due livelli sopraelevati si prevedono delle opere integrative, quali la rea lizzazione di pilastri in cemento armato all’in terno della cassa vuota, per trasferire la portata verticale ai nuovi elementi anziché alla muratura in mattoni forati, oltre al rinforzo a pressofles sione dei maschi murari dei primi due livelli.
Dal punto di vista edilizio, il consolidamento delle volte comporta la demolizione e il rifaci mento di tutte le partizioni interne degli alloggi.
La ricostruzione delle suddette murature con sente non solo il risanamento, ma anche il miglioramento dal punto di vista acustico delle pareti di divisione fra diverse unità immobiliari; parallelamente, è previsto il rifacimento di tutti i sottofondi, di tutti i pavimenti interni degli alloggi e dei rivestimenti esterni dei terrazzi verso cortile. Gli interventi prevedono anche la sostituzione di tutti i portoncini di ingresso agli alloggi con nuovi blindati e dotati di isolamento termico e la sostituzione di tutte le porte interne. Saranno inoltre interamente ricostruiti tutti i bagni con le relative dotazioni e tutte le cucine
ANALISI DEI MASCHI MURARI DI UNA PALAZZINAcomprendendo il rifacimento delle colonne di scarico e delle colonne di estrazione dei fumi di cottura. La sostituzione dei serramenti terrà conto delle caratteristiche di valenza stori co-architettonica degli immobili garantendo anche i requisiti termici e acustici. Per quanto riguarda la parte impiantistica e di contenimento energetico, l’intervento sarà volto all’efficien tamento energetico dell’impianto di climatizzazione e produ zione di acqua calda sanitaria (ACS), nonché all’incremento delle prestazioni energetiche dell’involucro dei fabbricati. Ciò si tradurrà in un miglioramento di diverse classi energetiche per ciascun edificio e in una riduzione dei consumi di energia primaria. Attualmente ciascuna unità immobiliare del com plesso è servita da una caldaia autonoma per la produzione di ACS e riscaldamento ambiente. Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra elencati, si è optato per la creazione di un impianto centralizzato in ciascuna palazzina per il riscalda mento ambiente e la produzione di acqua calda sanitaria. Tali impianti saranno di tipo ibrido, ossia costituiti da generatori a condensazione di ultima generazione, alimentati a gas, e da pompe di calore mono-blocco aria-acqua ad alimenta zione elettrica, queste ultime installate in corrispondenza dei giardini condominiali. Gli impianti, inoltre, saranno dotati di centraline di controllo in grado di selezionarne la modalità di funzionamento, passando da sola pompa di calore a ibrido e,
infine, a sola caldaia e ottimizzando, in tal modo, l’efficienza di generazione del sistema.
Per sfruttare al meglio gli impianti ibridi, verranno installati negli appartamenti dei sistemi di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento, in sostituzione dei radiatori preesistenti.
Il riscaldamento radiante permette di contenere le tempera ture dell’acqua che circola nell’impianto, massimizzando in tal modo sia l’efficienza delle caldaie a condensazione che quella delle pompe di calore. Infine, per ridurre le dispersioni termiche dei fabbricati, è stato previsto di coibentare il sotto tetto e sostituire i serramenti delle abitazioni, garantendo in tal modo un miglioramento del comfort termico e acustico all’interno delle unità
Il cantiere, organizzato per fasi di intervento, tiene conto della necessità di ottimizzazione delle attività in relazione all’im patto sul quartiere: vengono utilizzati gli ingressi carrai posti sulle vie laterali per l’approvvigionamento dei materiali ed è stata posizionata un’unica gru in grado di servire tutte le palazzine oggetto di intervento.
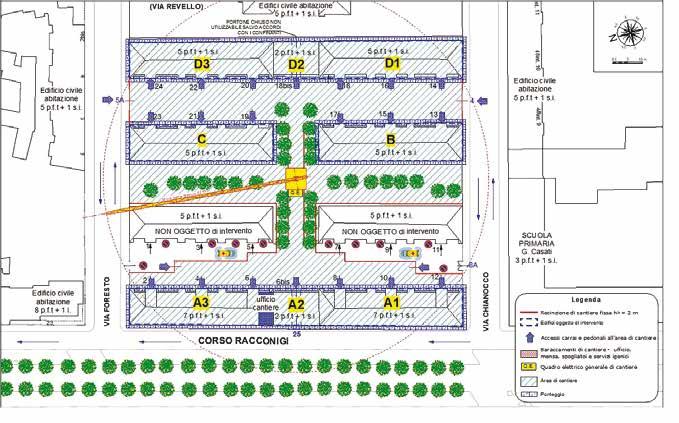
presente articolo
stato pubblicato anche sul n° 7/2022
Giornale dell’Ingegnere”
Più di 15.000 prezzi del mercato nazionale dei cantieri di nuova costruzione, suddivisi in costi di manodopera, noli-costi orari, materiali, opere compiute e sicurezza. L’edizione contiene l’aggiornamento dei prezzi della parte materiali e delle tabelle della manodopera di tutte le categorie.

In questa edizione sono state riportate le novità per quanto concerne le materie prime, acciaio per cemento armato e per strutture, quali travi e profili, e calcestruzzi precon fezionati.
Ampie voci dalla descrizione dettagliata sono state inserite per i nuovi sistemi di effi cientamento energetico e per i serramenti in legno e PVC.
 Rilevazione prezzi FEBBRAIO 2022
NUOVA EDIZIONE 1° SEMESTRE 2022
Rilevazione prezzi FEBBRAIO 2022
NUOVA EDIZIONE 1° SEMESTRE 2022
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 494/1996, anche le Soprintendenze per i Beni Architettonici e Monumentali, che gestivano i lavori di restauro di edifici monumentali, si trovarono nella necessità di individuare dei coordinatori esterni, dato che tra il personale in forza alle Soprintendenze, così come avvenne in quegli anni per qua lunque altro Ente pubblico, non vi erano tecnici formati a tal punto da svolgere in prima persona il ruolo di coordinatore. Essendo tra i primi tecnici ad aver conseguito l’abilitazione per
lo svolgimento del ruolo di coordinatore, fui incaricato dalla Soprintendenza di Firenze di occuparmi di cantieri di restauro in edifici storici di notevole importanza, tra cui il cantiere per il restauro della torre campanaria del Duomo di Pistoia, che è la mia città. Era il 1998, per tanti versi eravamo agli albori dell’appli cazione di norme che all’epoca rappresentavano una novità; da allora sono passati quasi 25 anni: è stato recepito il Testo Unico 81/2008, il cui titolo IV ha sostanzialmente ripreso i contenuti del D.Lgs. n. 494/96, e sono state introdotte molte indicazioni

specifiche, per guidare l’attività dei coordinatori nei vari ambiti operativi in cui questi operano. In questo articolo tracceremo le caratteristiche principali dell’attività di coordinamento in cantieri per il restauro dei beni storici monumentali. Lo faremo sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, iniziata come detto alla fine degli anni ’90, fino all’ultimo incarico svolto dal nostro studio riguardante il coordinamento per la sicurezza e la progettazione strutturale del restauro e risanamento conservativo della chiesa della Santissima Annunziata di Pistoia.
Nell’attività di coordinamento per i cantieri di restauro di edifici monumentali rivestono particolare importanza gli aspetti rela zionali e la concorrenza delle differenti competenze dei tecnici coinvolti. Per la redazione del PSC il coordinatore ha necessità di confrontarsi con l’architetto progettista, con i tecnici della Soprintendenza e con il progettista strutturale. In particolare, per approcciare compiutamente il coordinamento di questa tipo logia di cantieri è necessario analizzare approfonditamente la relazione storica e la relazione tecnica indicante le metodologie e tecniche di restauro. In questa tipologia di cantieri, la conser vazione e la tutela del bene sul quale si interviene rappresenta infatti un obiettivo primario, secondo solo alla tutela della salute e sicurezza degli operatori, che resta lo scopo principale di tutto il sistema organizzativo-gestionale della sicurezza in cantiere.


Si tratta di cantieri particolari perché i beni di cui ci occupiamo hanno generalmente necessità di interventi di restauro, talvolta di risanamento conservativo, più raramente di manutenzione straordinaria; interventi da condurre nel rispetto delle caratte ristiche storico-architettoniche dei beni sui quali si interviene. Discende da questo un profilo etico per il coordinatore per la sicurezza: si interviene su beni che le generazioni precedenti hanno passato alla nostra, e che noi lasceremo alle generazioni che seguiranno. All’atto pratico questo profilo etico si declina in attività progettuali specifiche, due esempi per tutti: il fascicolo per l’uso e la manutenzione dell’opera deve essere redatto con riferimento a una prospettiva temporale adeguata e per le attività di revisione/manutenzione procrastinate nel tempo necessario per introdurre apprestamenti o dotazioni, che siano anzitutto rispettosi del bene monumentale; i dispositivi anti-caduta, qua lora siano da installare, devono essere progettati in modo da non alterare la percezione dell’involucro dell’edificio.
La consapevolezza che questa tipologia di cantieri abbia in sé notevoli fattori di rischio è evidente. Tutti abbiamo davanti
agli occhi il devastante incendio che ha colpito la cattedrale di Notre Dame di Parigi, durante i lavori di ristrutturazione e di restauro. Nonostante que sto, in un’ideale scala di rischio basso/medio/alto, possiamo classificare questa tipologia di cantieri, come vedremo, tra quelli a “rischio basso”. In questo senso i fattori che influenzano in maniera decisiva la gestione della sicurezza nei cantieri di restauro di beni monumentali sono tre:
Questo tipo di cantieri, per propria natura, ha tempistiche “lente”, ossia adeguate e congruenti con le attività di verifica in situ, delle parti strutturali, artistiche e architettoniche devono essere restaurate. Il cantiere di restauro della Santissima Annunziata, un complesso monumentale che si sviluppa su un’area edificata di circa 3.000 mq, con “tempio” ad aula unica di dimensioni 11,20x44,70, caratterizzata dalla presenza di 12 capriate, è durato 24 mesi. Per quanto riguarda il restauro della copertura, la parte più danneggiata, è evi dente che fintanto che non si sono potuti portare alla luce gli appoggi delle capriate, non si è potuto stabilire con certezza quali fossero gli interventi di consolidamento e restauro necessari, che sono stati quindi progettati nello specifico, discussi con la Soprintendenza e realizzati. Il cantiere di restauro è dunque per sua natura un cantiere in “divenir facendo”, il cui cronopro gramma operativo è influenzato da tempistiche in certo qual modo dilatate, fattore che contribuisce a mantenere le condizioni di sicurezza del cantiere.

Le opere di restauro di beni monumentali possono essere condotte solo ed esclusivamente da imprese che sono in possesso di qualificazioni specifiche (SOA cat. OG2 classifica VI restauro e manutenzione di beni sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali; cat. OS2-A classifica V superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico oltre alla cat. OG1) e da un’alta specializzazione, anche per la necessaria pre
senza di maestranze iscritte all’elenco dei restau ratori specializzati. Avere in cantiere maestranze esperte, in possesso di professionalità specifiche, contribuisce al rispetto delle condizioni e delle misure di sicurezza.
Per le ragioni esposte le maestranze impiegate nei cantieri di restauro sono generalmente ridotte; dunque, conseguentemente si riducono i rischi per la salute e sicurezza degli addetti. A titolo di esempio il cantiere per il restauro della Santis sima Annunziata è stato condotto con la presenza mediamente di 5 addetti: un capocantiere specia lizzato in restauro, due operai specializzati, due restauratori specializzati in restauro ligneo e di superfici decorate. Non ci sono state condizioni di interferenze se non nella fase, pur estremamente complessa, di montaggio dei ponteggi interni ed esterni, affidata a un’impresa specializzata.

Nel restauro della chiesa della Santissima Annun ziata, un appalto privato, abbiamo avuto la pos sibilità di partecipare al processo di formulazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori – cui sono state poi invitate sette imprese – e ai lavori della commissione giudicatrice delle proposte pervenute. È stato così possibile richiedere, quali requisiti premianti, l’indicazione della qualifica zione del responsabile tecnico per la sicurezza (art. 97 D.Lgs. 81/2008) e del direttore tecnico di cantiere. L’impresa aggiudicataria aveva indi cato, per le rispettive figure, un ingegnere e un architetto, entrambi iscritti all’elenco dei restaura tori specializzati; tecnici che hanno ampiamente contribuito all’attuazione delle misure di sicurezza previste dal PSC. È chiaro che quando il coordi natore viene coinvolto sin dalle fasi preliminari, la progettazione della sicurezza del cantiere si sviluppa in modo adeguato. È auspicabile che le pubbliche amministrazioni si adoperino per adot tare questa prassi, che peraltro è perfettamente rispondente all’art. 90 del Testo Unico.
Il presente articolo è stato pubblicato anche sul n° 5/2022 de “Il Giornale dell’Ingegnere”Nel volume vengono affrontati tutti i diversi aspetti degli interventi in facciata, con indicazioni molto dettagliate dall’analisi dei degradi alla proget tazione dei lavori, dalle check list per il posatore fino all’esecuzione delle opere – con tutte le illustrazioni per la cantierizzazione, comprese diverse illustrazioni che chiariscono le modalità operative delle attività da eseguire.
Un Manuale dedicato a Progettisti, Tecnici e Imprese che operano nell’ambito del recupero e restauro di facciate degradate, nella riqualificazione energetica degli edifici civili e negli interventi di adeguamento e miglioramento sismico.

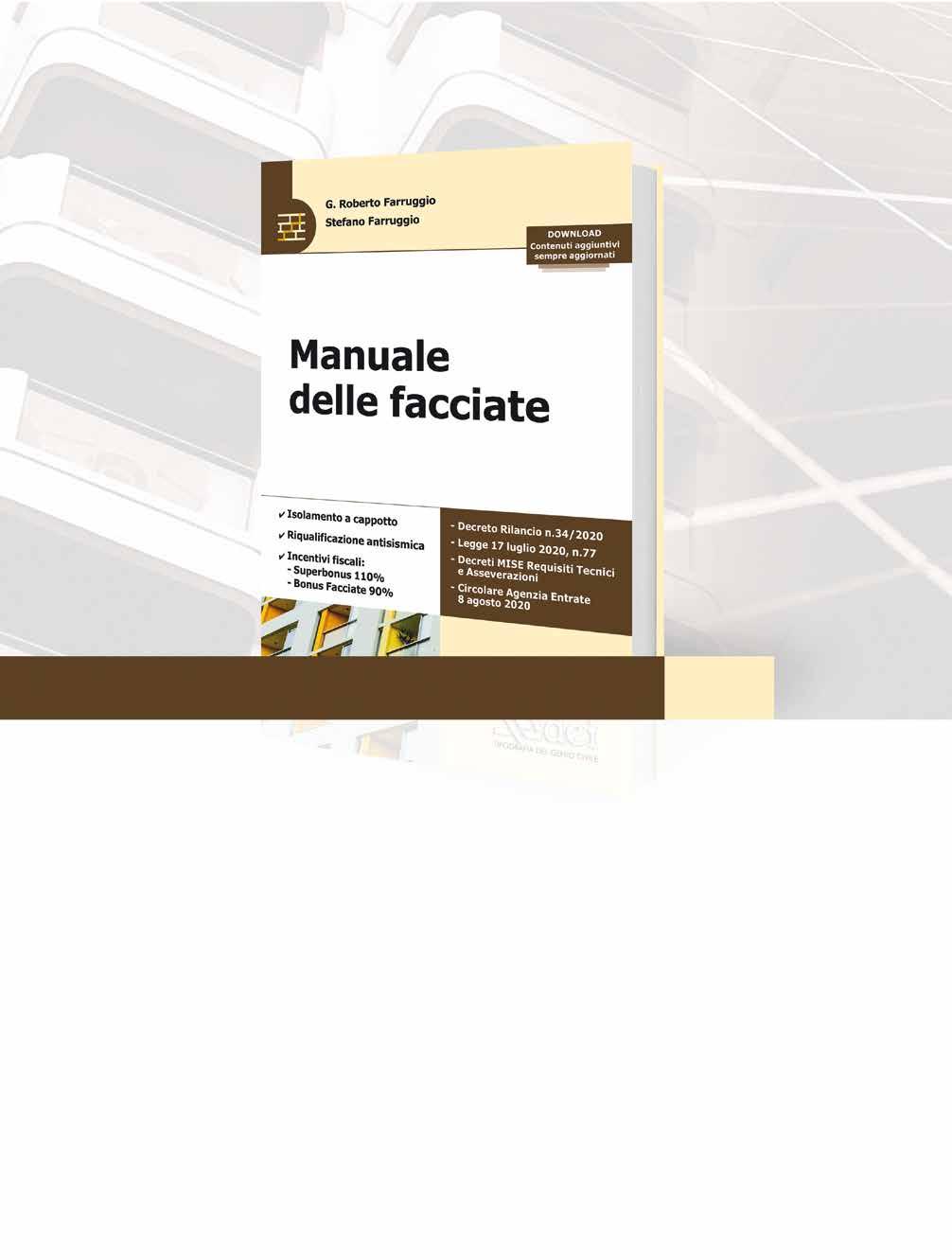
Tra gli atti, i documenti e i registri soggetti al tributo sono incluse anche le fatture se la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a Iva

L’Agenzia delle Entrate – con la risposta n.428 del 12 agosto del 2022 – fornisce un chiarimento sull’imposta di bollo per le fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario. Il chiarimento riguarda l’assoggettabilità o meno a tassazione, nell’ambito del suddetto regime, dell’imposta di bollo addebi tata in fattura ai propri clienti. La questione sottoposta all’esame riguarda l’inclusione tra i ricavi o compensi dell’importo dell’im posta di bollo addebitato in fattura dal soggetto che la emette e la sua conseguente imponibilità fiscale, ai fini della determina zione del reddito nell’ambito del regime forfettario. Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate specifica che, con riguardo all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’impo sta di bollo, l’art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce la solida rietà nel debito relativo da parte dell’emittente la fattura e del
committente. Tuttavia, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della for mazione, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta a IVA.
Fermo restando che l’obbligo di corrispondere la predetta impo sta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo può chiedere al cliente il rimborso dell’imposta. In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista/prestatore d’opera il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 e concorre al cal colo per la determinazione forfettaria del reddito.
Tale chiarimento ha una serie di conseguenze:

1. il committente/sostituto d’imposta, che ha considerato nella predisposizione della C.U. del professionista in regime for fettario l’imposta di bollo pagata al fornitore tra le “somme che non costituiscono reddito” di cui al codice 22, dovrebbe emettere una nuova C.U. 2022 per l’anno 2021 in cui andrà a inserire l’importo nei compensi (codice 24);
2. la rettifica del reddito con la maggiorazione dell’imposta di bollo può avere come conseguenza la fuoriuscita dal regime agevolato per superamento dei 65.000 euro, attuale limite massimo di ricavi e compensi fissato per la permanenza/ accesso nel regime;
3. dal momento che la risposta è del 12 agosto 2022, soprat tutto per i forfettari che emettono un numero rilevante di documenti, si dovrebbero modificare le dichiarazioni dei red diti predisposte, sia per l’anno 2021 sia quelle per gli anni d’imposta precedenti, con indicazione di maggior reddito. Si verrebbero così a determinare maggiori imposte dovute e non versate (il cui importo dipende dal numero di bolli addebitati al cliente), ma soprattutto, potrebbe verificarsi la fuoriuscita dal regime forfettario, per superamento dei 65.000 euro, in anni precedenti al 2021;
4. se l’importo della marca da bollo deve essere considerato compenso, lo stesso sarà assoggettato non solo a imposta sostitutiva regime forfettario (5% o 15%), ma sarà assoggettato
(sempre al netto della deduzione) anche al pagamento dei contributi INPS (quadro RR sezione I o II della dichiarazione) o al contributo soggettivo previsto dalle casse private;
5. le casse private (es. cassa forense), inoltre, calcolano il con tributo integrativo sui componenti positivi di cui al rigo LM 22-colonna 3 del modello redditi PF; pertanto, il contributo integrativo verrà calcolato anche sull’importo di euro 2,00 dell’imposta di bollo.

La soluzione migliore, al momento, sembra essere quella di non addebitare più l’imposta di bollo al cliente. Si ricorda che, nel caso in cui le fatture venissero emesse in formato elettronico (diventato obbligatorio per molti forfetari dal 1° luglio 2022), il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, deve essere effettuato:

■ entro il 31/05 per le fatture emesse nel primo trimestre;
■ entro il 30/09 per le fatture emesse nel secondo trimestre;

■ entro il 30/11 per le fatture emesse nel terzo trimestre;
■ entro il 28/02 dell’anno successivo, per le fatture emesse nel quarto trimestre.
La scadenza del primo trimestre è prorogabile al 30 settembre, qualora l’ammontare dovuto sia inferiore a 250 euro, e al 30 novembre, se l’importo totale del primo e del secondo trimestre non supera i 250 euro.
 di Iginio S. Lentini | Presidente UN.I.O.N.
di Iginio S. Lentini | Presidente UN.I.O.N.
Con una nota inviata al MiSE a novembre 2021, UN.I.O.N. (Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati) ha espo sto alcune criticità riguardanti l’applicazione dell’art. 12, comma 2 bis, del D.P.R. 162/1999. In particolare, ha posto l’attenzione sulle problematiche che sussistono nell’eventualità di mancato possesso da parte del titolare di impianti elevatori della dichiarazione di conformità; questione che ha portato allo stallo delle procedure amministrative VAI. Per impedire tale blocco, i Comuni hanno adottato una prassi che ritiene sufficiente l’effettuazione di VAI, pur senza il corredo della dichiarazione di conformità.
Pertanto, UN.I.O.N. – fintanto che non intervengano novità nor mative o esplicite direttive ministeriali – ha suggerito ai propri associati di adeguarsi a tale procedura.
Il MiSE, attraverso la Divisione VI – Normativa Tecnica, Sicurezza e Conformità dei prodotti (DGMCCNT), ha dato subito riscontro alla nota in questione ribadendo come non fosse consentito derogare alla disposizione di legge che richiedeva, oltre all’ef fettuazione di verifica straordinaria anche, appunto, la dichiara zione di conformità.
Riguardo alla tematica esposta, poi, appare pertinente la parte della “Guida Blu” all’attuazione della normativa UE sui prodotti
(la nuova versione è stata pubblicata il 29 giugno 2022) in cui viene disposto: “Se un prodotto modificato è considerato un prodotto nuovo, esso deve essere conforme alle disposizioni della normativa applicabile nel momento in cui viene messo a disposizione o in servizio [...], occorrendo valutare nuovamente la conformità del prodotto modificato ai requisiti essenziali appli cabili e la persona che apporta la modifica sostanziale è tenuta a soddisfare gli stessi requisiti del fabbricante originario, ad esempio in termini di documentazione tecnica, redazione di una dichiarazione UE di conformità e apposizione della marcatura CE sul prodotto [...]. La persona fisica o giuridica che apporta o fa apportare modifiche al prodotto è responsabile della confor mità del prodotto modificato e deve redigere una dichiarazione di conformità, anche se utilizza prove e documentazione tecnica già esistenti”.
Al di là dell’ambito specifico relativo alle modifiche di prodotto, si ritiene che il dato di maggiore rilevanza sia il riferimento a una nuova dichiarazione di conformità, rilasciabile anche sulla scorta di documenti e prove già disponibili.
Infatti, ciò consentirebbe, laddove applicato mediante gli oppor tuni emendamenti alla problematica VAI sopra richiamata, di tro vare una soluzione che sarebbe perfettamente idonea a fornire agli utenti il massimo livello di sicurezza, che l’attuale procedura è volta a garantirgli.
Considerando il notevole numero di impianti in esercizio sprov visti della matricola, essendo vincolante allegare alla complessiva documentazione la dichiarazione di conformità che neppure esi steva all’epoca degli impianti installati ante direttiva ascensori, pertanto, costituendo un problema insolubile per la regolarizza zione di un consistente numero di ascensori, la norma introdotta nel nuovo documento della Commissione Europea consente di avviare un processo di best practice per dotare oltre 100.000 impianti elevatori della loro identificazione.
L’Associazione si augura che l’esposizione di queste problema tiche possa costituire uno spunto per la definizione di un tema la cui soluzione è oggettivamente attesa dal mercato, risolvendo anche un problema per l’operatività degli Organismi Notificati.

La manifestazione si svolgerà dal 9 all’11 novembre presso il Sarit Expo Centre di Nairobi
Da tempo Finco è impegnata a promuo vere, con il supporto ICE, la partecipa zione delle imprese italiane sui mercati esteri; non solo in quelli più prossimi, ma anche in quelli più distanti. Uno dei Paesi oggetto di attenzione è il Kenya – segnalato dalla Federazione sia nell’ambito della campa gna promozionale del nostro Paese sia nella Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione –nel quale, dal 9 all’11 novembre 2022, si svol gerà la manifestazione “The Big Five Con struct Kenya 2022”
Lanciata nel 2017, “The Big 5 Construct Kenya” rappresenta la principale manifestazione fieri stica in Kenya dedicata al settore delle costru zioni ed è riconosciuta dal Ministero dei Tra sporti, delle Infrastrutture e dell’Abitazione di quel Paese come evento internazionale. Il Kenya rappresenta una delle economie a più rapido sviluppo in Africa, grazie alla buona sta bilità del contesto macroeconomico, alla cre scita del settore turistico e allo sviluppo infra strutturale a livello nazionale e locale.
Secondo le ultime ricerche della Banca Mon diale, il settore delle costruzioni crescerà dell’8,7% quest’anno e farà registrare una cre scita media del 6,2% annuale fino al 2026. Il Paese ospita al momento oltre il 25% dei grandi progetti infrastrutturali dell’Africa orientale.
Si va dal Tatu City Project da 2,1 miliardi di dol lari – circa 5.000 acri nella periferia della capi tale – al progetto Lamu Port, da circa 1 miliardo di dollari, e non ultimo una delle iniziative più importanti del continente: la costruzione della città tecnologica di Konza Techno City, con un investimento di circa 6 miliardi di dollari.
Abrasivi Adria Srl, Bampi Spa, Centrufficio Loreto Spa, Chimiver Panseri Spa, Colorificio Atria, Condor Group Spa, Di.Bi. Porte Blindate Srl, Emmedue Spa, Foppoli Bramin Srl, G.D.A. Marmi e Graniti, Gedy Spa, Geoplast Srl, Gielle di Galantucci Luigi, Global Solution Srl, Gruppo Stamplast Spa, Hidronix Srl, Icobit Srl, Icsa Serrature Srl, Iris Coatings Srl, Italiana Ferramenta Srl, Lamitex Spa, Loggia Industria Vernici Srl, Luxury Windows Italia, Mappy Italia Spa, Metalco Srl, Metco Srl, Miro Europe Srl, Molaro Aldo Serramenti Srl, New Polaris Lux Srl, Oikos Spa, Orefice Srl, Orieflon Srl, Plastek Srl, Prandelli Spa, Serramenti f.Lli Teofilo

ACEPER – Torino
Associazione Consumatori e Produttori Energie Rinnovabili
Presidente: Veronica Pitea
Vice Presidente: Simone Ruffinatto
ACMI – Roma
Associazione Chiusure e Meccanismi Italia
Presidente: Nicola Fornarelli
Vice Presidente: Antonio Gramuglia
Presidente Onorario: Vanni Tinti
AFIDAMP – Milano
Associazione fabbricanti e fornitori italiani attrezzature macchine prodotti e servizi per la pulizia professionale
Presidente: Giuseppe Riello
Vice Presidente: Gianfranco Bonotto
Direttore: Stefania Verrienti
AIFIL – Roma
Associazione Italiana Fabbricanti
Insegne luminose
Presidente: Alfio Bonaventura
Vice Presidente: Marisa Graziati e Cinzia Dall’Anese Segretario Nazionale: Claudio Rossi
AIPAA – Bergamo
Associazione Italiana per l’Anticaduta e l’Antinfortunistica
Presidente: Giuseppe Lupi Direttore: Tommaso Spagnolo

AISES – Roma
Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza
Presidente: Gabriella Gherardi Vice Presidenti: Toni Principi e Eros Pessina
ANACI – Roma
Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari
Presidente: Francesco Burrelli Segretario: Andrea Finizio


ANACS – Milano

Associazione Nazionale Aziende di Cartellonistica Stradale Presidente: Franco Meroni Vice Presidente: Adriano Castagnoli
ANCCA – Castelrotto (BZ) Associazione Nazionale Contabilizzazione Calore e Acqua Presidente: Hans Paul Griesser Vice Presidente: Luca Magni Responsabile Rapporti Istituzionali: Dr.ssa Angela Marchese

ANCSA – Roma
Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli Presidente: Eleonora Testani Vice Presidente: Enzo Ciabatta Direttore: Alessia Lentini
ANFIT – Ferrara
Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy Presidente: Marco Rossi Vice Presidente: Giovanni Dalfino
ANFUS – Brescia
Associazione Nazionale Fumisti e Spazzacamini Presidente: Sandro Bani Vice Presidente: Pietro Bonello
ANNA – Bolzano

Associazione Nazionale Noleggio Autogru e Trasporti Eccezionali
Presidente: Daniela Dal Col


Vice Presidente: Simone Gramigni
Past-Vice Presidente: Angelo Gino
ANIPA - FIAS – Piacenza

Associazione Nazionale Imprese Pozzi per Acqua

Presidente: Gino Longo
ANSAG – Roma

Associazione nazionale sagomatori Presidente: Emilio Fadda
Vice Presidenti: Paolo Venturelli, Ezio Michielin, Dario Carniello
ARCHEOIMPRESE – Bologna
Associazione Italiana Imprese di Archeologia
Presidente: Cristina Anghinetti
Vicepresidenti: Claudio Calastri e Matteo Tadolti Tesoriere: Francesca Guandalini
ARI – Roma
Associazione Restauratori d’Italia

Presidente: Kristian Schneider Vice Presidente: Irene Zuliani Segretario: Paola Conti
ASSITES – Roma
Associazione Italiana Tende, Schermature solari e Chiusure Tecniche Oscuranti Presidente: Fabio Gasparini Vice Presidenti: Loris Di Francesco, Nereo Sella
ASSOBON – Roma
Associazione Nazionale Imprese Bonifica Mine ed Ordigni Residui Bellici Presidente: Generale Potito Genova Segretario: Valerio Bellei Consiglieri: Stefano Gensini, Paolo Orabona e Werter Cacciatori
ASSOCOMPOSITI – Milano
Associazione dei materiali compositi e affini Presidente: Roberto Frassine Direttore: Simona Tiburtini
ASSOFRIGORISTI – Padova Associazione Italiana Frigoristi Presidente: Fabio Brondolin Direttore Operativo: Marco Oldrati
ASSOIDROELETTRICA – Bologna Associazione dei Produttori Idroelettrici Presidente: Barbara Franchi Direttore Generale: Paolo Taglioli


ASSOROCCIA – Trento Associazione Nazionale costruttori opere di difesa dalla caduta di massi e valanghe Presidente: Dario Amici
Vice Presidente: Diego Dalla Rosa
Direttore Generale: Bruno Zanini


ASSOVERDE – Roma Associazione Italiana Costruttori del Verde Presidente: Rosi Sgaravatti
Vice Presidente: Michele Bindi Segretario Generale: Stefania Pisanti
CNIM – Roma
Comitato Nazionale Italiano Manutenzione Presidente: Aurelio Salvatore Misiti
FIAS – Roma
Federazione Italiana delle Associazioni Specialistiche del Sottosuolo Presidente: Massimo Poggio Vice Presidenti: Mauro Buzio, Stefano Chiarugi
AIF – FIAS – Roma

Associazione Imprese Fondazioniconsolidamenti - indagini nel sottosuolo Presidente: Gabriele Graziani
ANIG HP – FIAS – Roma


Associazione Nazionale Impianti Geotermia –Heat Pump Presidente: Moreno Fattor

















ANISIG – FIAS – Roma
Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche
Presidente: Italo Cipolloni
ASSOCIAZIONE MASTER - Roma
Presidente: Stefano Bufarini
Presidente Emerito: Vincenzo D’Aria
Direttore: Domenico Squillacioti
Vice Direttori: Santo Mineo - Sandro Pariset
CONSORZIO PER L’ITALA – Palermo
Presidente: Salvatore Nasci
Vice Presidente: Rosalba Calandra
Direttore: Nino Galante
FIPER – Roma
Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili
Presidente: Walter Righini
Vice Presidente: Hanspeter Fuchs, Federica Galleano
Direttore: Vanessa Gallo
FIRE – Roma
Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia
Presidente: Cesare Boffa
Vice Presidente: Giuseppe Tomassetti
Direttore: Dario Di Santo
FISA – Roma
Fire Security Association
Presidente: Marco Patruno
FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO

Ente per lo sviluppo delle costruzioni in acciaio – Milano
Presidente: Caterina Epis


Direttore Generale: Simona Maura Martelli
PILE – Varese
Produttori Installatori Lattoneria Edile
Presidente: Fabio Montagnoli
Tesoriere: Palmiro Bartoli
UNICEDIL – Roma
Presidente: Francesco Siervo Vice Presidente: Alessandro Guaglione
UNICMI – Milano

Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti
Presidente: Guido Faré
Vice Presidente delegato rapporti Finco: Mauro Furlan Direttore Generale: Pietro Gimelli
UNION – Roma
Unione Italiana Organismi Notificati Presidente: Iginio S. Lentini
ZENITAL – Monza

Associazione Italiana sistemi di illuminazione e ventilazione naturali, sistemi per il controllo di fumo e calore Presidente: Luca Marzola Vice Presidente: Raffaele Scognamiglio Direttore: Giuseppe Giuffrida
ACI – Roma
Presidente: Angelo Sticchi Damiani
ALFA ACCIAI SPA – Brescia
Legale Rappresentante: Amato Stabiumi
ANAS SPA - Azienda Naz. Autonoma delle Strade
– Roma
Presidente: Claudio Andrea Gemme


Amministratore Delegato: Aldo Isi
ATAC SPA - Roma
Amministratore Unico: Giovanni Mottura
CASEITALY SRL – Roma
Presidente: Laura Michelini
CSI SPA – Milano
Presidente: Antonella Scaglia
Vice Presidente: Alessandro Ciusani
Amministratore Delegato: Vincenzo Ruocco
ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT – Milano
Presidente: Rita Marino
Amministratore Delegato: Stefano Goberti
GRAVILI SRL – Lecce
Amministratore Delegato: Antonio Gravili

HARLEY DIKKINSON CONSULTING SRL – Milano
Presidente: Alessandro Ponti
INTERBAU SRL – Milano
Presidente: Giuseppe Cersosimo
ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA – Genova
Presidente: Sergio Scanavino
Segretario Generale: Luca Timossi
LAPI SPA - Laboratorio Prevenzione Incendi – Prato
Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante: David Borsini




M3S SPA – Roma
Legale Rappresentante: Anna Maria Mangialomini

PASINI METALS PRODUCTIONS – Brescia
Presidente: Icaro Pasini
Vice Presidente: Piergiacomo Pasini
PERAZZI ENGINEERING & C. SRL – Piacenza Amministratore Delegato: Italo Perazzi
PRAGMATICA AMBIENTALE SRL – Ravenna
Presidente: Nedo Biancani
Amministratore Delegato: Alberto Guidotti
Direttore: Laura Mazzavillani
PSC INSURANCE BROKERS SRL – Roma Legale Rappresentante: Romeo Piluso Direttore: Giuseppe Oliviero











RESIT SRL – Roma
Presidente: Ugo Vittorio Rocca
Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento “Leonardo” – Città Sant’Angelo (PE)
Presidente: Mauro Pallini
SINERGICA SRL – Taranto
Presidente: Ludovico Motolese
TRANSFORMTESSILE – Napoli
Amministratore Delegato: Aniello Ciabatti
ZANZAR S.p.A. – Grottaglie (TA)
Presidente: Angelo L’Angellotti
Amministratore Delegato: Sergio Fabio Brivio e Nicola Lippolis CFO Direttore Generale: Sergio Fabio Brivio
ABBONATI! INVIA SUBITO QUESTO TAGLIANDO ALL’INDIRIZZO MAIL ABBONAMENTI@QUINE.IT




