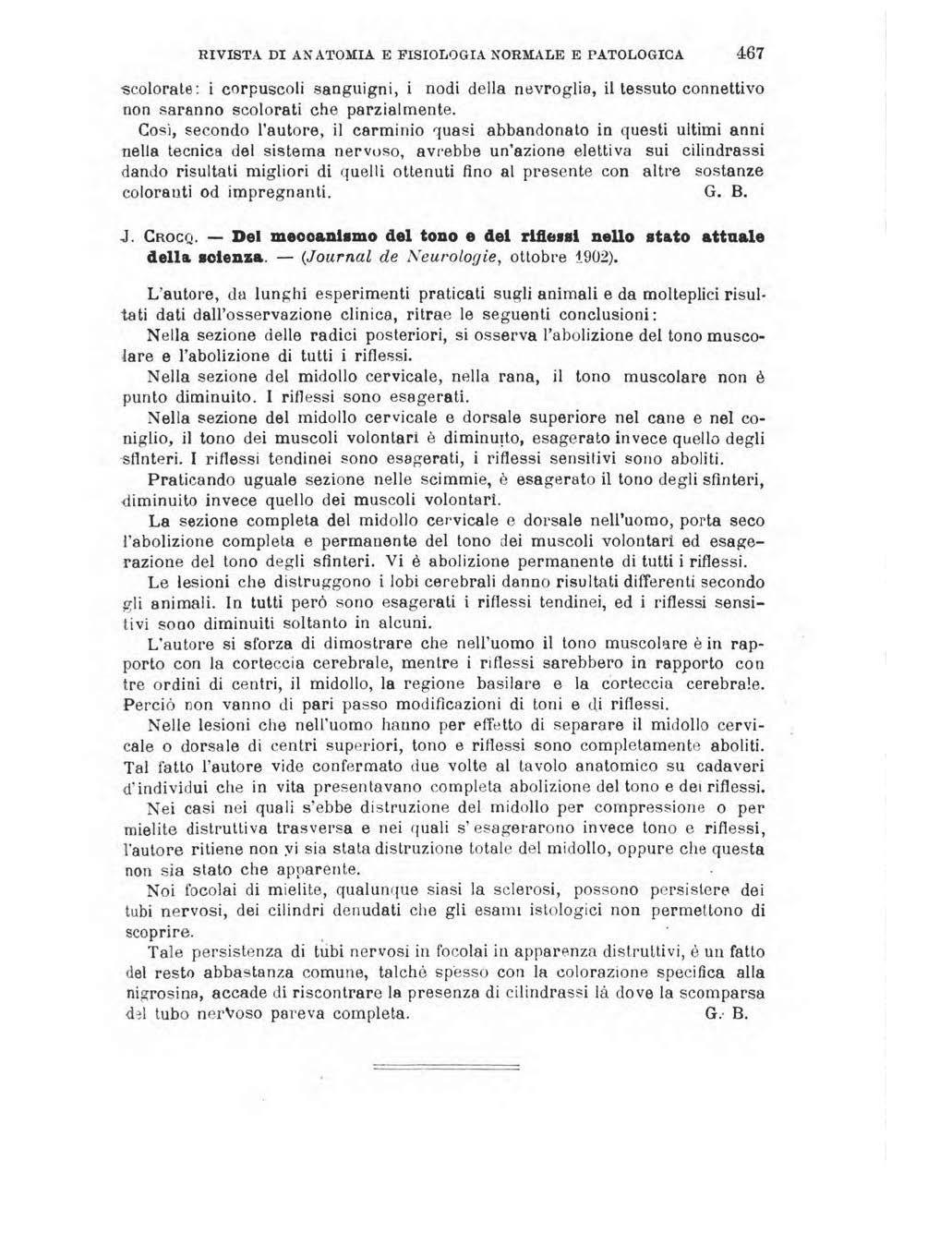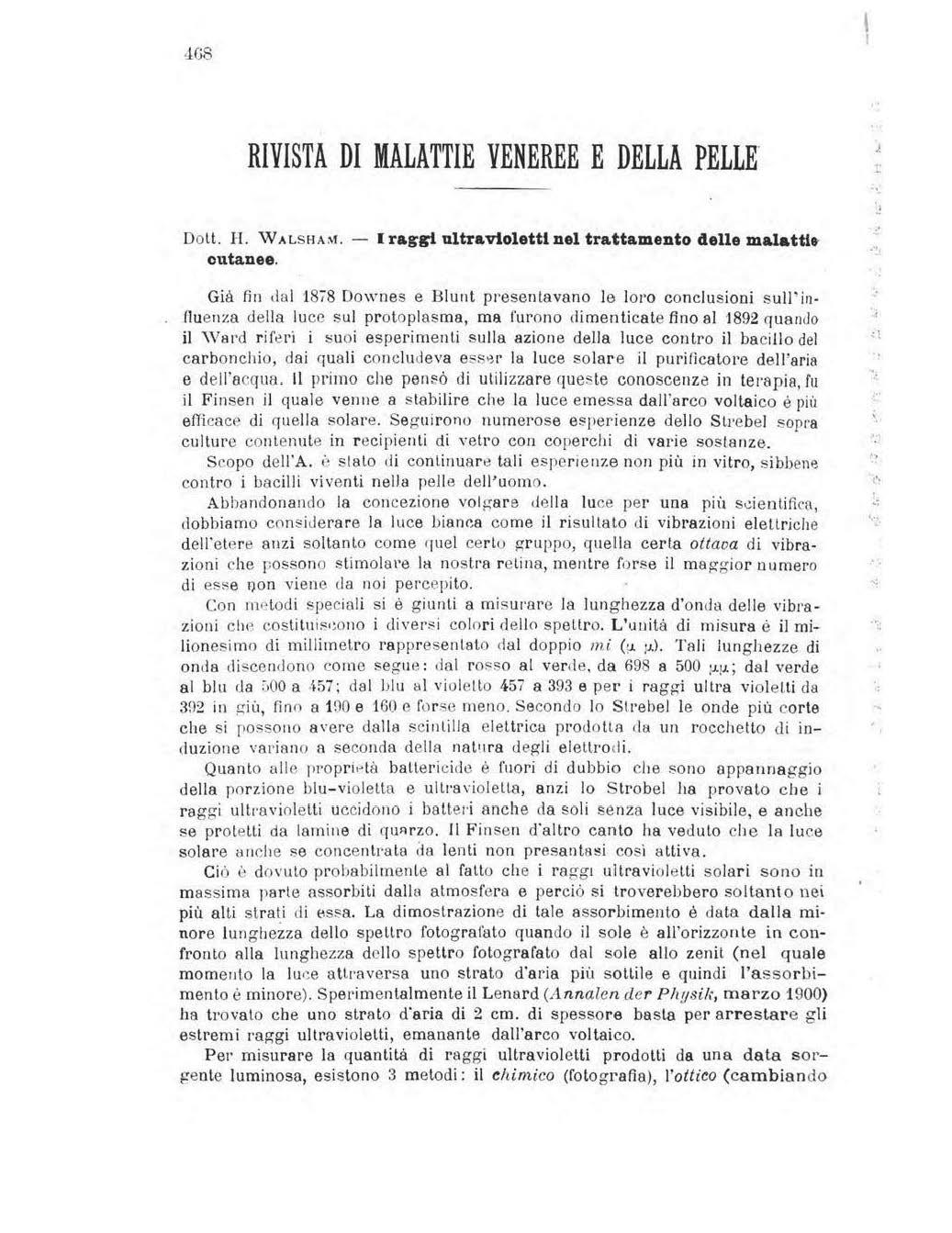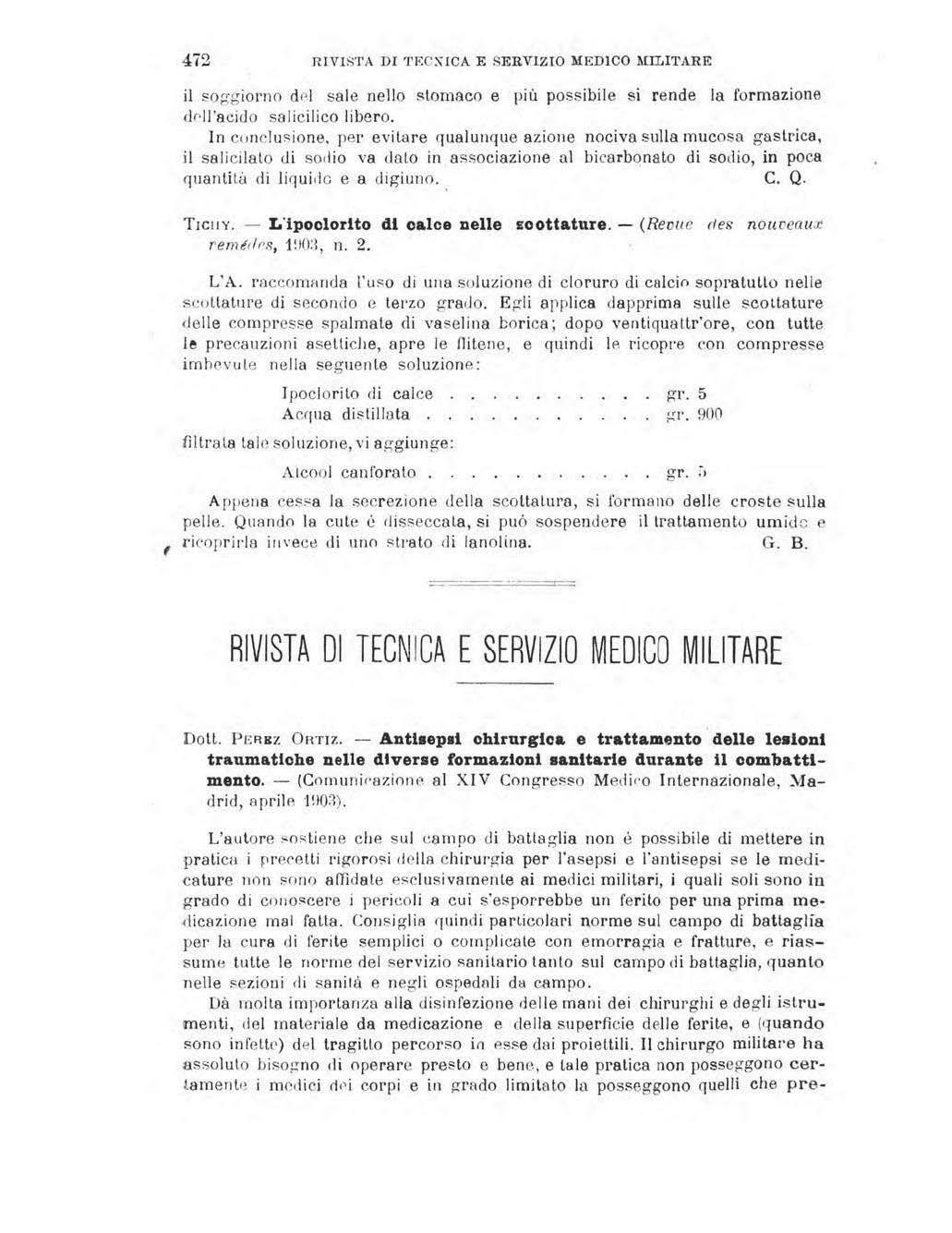Il p ri mo eifl<auantennlo oli olel nostro gro rnale • • • • • • •

••: •ea11:
Altellelll - Ricer ehe lnlorno al rApp o rto fra vlsu< e lucP (i nOuPnza della fall r.a)
l'ertgo - li.azi l mprovvi <ati JU'r lo sgo mbero tlei fe rili tlal di b:ll t.aglifl
lli
lllvlstAI
.IYI8TA •• c;UORJIIAI.I lE D F.8TIEal.
l l r J[
P UBBLICATO 1lAidt' ISPETTORATO DI SANITÀ ANNO LI FASC.'
190 3 '31 GENNAIO l ;( SOMMARIO
b
I
vosta
. . . . . . • .
Rivi s ta do nevmpatolugia
chirurgica • • •
ista do oto-rino-larlngo latria • •
ista do oeullstoea • • Rlvosta tl i tecniCA e servizio medico militar•.
l<ta d'igiene. • • • • • Misce1la11ea • • • • • • • • ••• Y. l ' Jndict utU' inln'no dtlla coptrllna. O ' REZIONE ED AMMINIS TRAZTONE ROMA • l'a!JLuu del della Gaerra, YJa XX Settembre - HOMA. ( 28 l
3
U • 40 Pog 5t 115 • et 84 611 78 • 19...
RoY
Riv
Rlv
Pag.
Pog.
INDICE
DELL.à. RIYISTA DI ylORXAJ,l ITAIJIA.NI ED ESTERI
Rl\'ISTA
Wetreff, I JChowak. - Rice rca nell'orina
Proach er. - R1 cerca rlella biliru bina nell' orina mediante la diazc reaz1one d1 lthrlich
Geo,.. lloe LookwNd - La gastrite cronica non alcoolica
Mara - Il riOMso del ngo • • •
RIVISTA 01 NEVROPA TOI.OGIA .
••'• e Petlat. - Un raro caso di amnMia Iste rica, con pe rdita della p r imlti,•a pensonalitll. Pag 55
I\IVISTA CHtnURGICA.
CrOmer - Uiagnosi del carcinoma ciel grosso intestino
Trev... - L•intervento chirurgico nell"appendlclte . . . . .
Lem ke . - L'lnter•ento chlrurglro nella tubercolosi polmon.1re
RIVISTA 01

Barth - Lo condi&loni dell"organo dell"udito e delle vie aeree superiori In 17G recl ute
RIVISTA Ul OCUI.ISliC.:A.
S.ell - Sulla cecita ttansltoria prodo tta prolungata tlegli occhi all"ulone del ragg i solari • • •
Lor e Clall-rta.- L'ettrolisi pericorneale e sopracorneale nel trattamento del pan no tta· comatoso e delle cheratiti • • • • •
Olue••· - Processo di cao tarlwulone del globo oculart', destinato a sostituire ne1 fanelulll la enucleulooe dello stesso •
II IIIIIMOW - Trattamento tlelle cheratiti suppu rate medlanJe la luce solere
Suaaparel. - Trattamenlo dello pterigio col massaqlo . . . . . . . . .
RIVI STA 01 TECNICA E SERVIZIO MEDICO MILITARE
Hara. - Il sanitario inglese nella gu.ma conlro l Boeri
D'IGII.l:NE
lome - Vacclnazlono e riYaccloazione
5t •83
Pag 52
ISC&l.LANEA Pag 59 eo • 61 Pa g. 81 Pag 6\ 65 •66 • 116 • 67 Pog. 118 Pog. 18 Pag 79 l l o i ., •
GIORNALE MEDICO

DEL ESERCITO P UB BLICATO
LI
ROM A TIPOGRAFI A ENRICO VOG HERA 1903
DALL' I SPETl'ORATO DI SANl'fÀ MILI'fARE ANNO
- 190:}

l l
IL PRIM:O CINQUANTENNIO DI VITA DEL NOSTRO GIORNALE
oggi il nos tro Giornale in nuova e più forbita veste, co me si addice a chi fPstegg ia una data sole nn e, sentiamo il dovere di rico rd are brevemente ai n ostri l ett ori le origin i e i progress i di questa. pubblicazione, val qnanto dire le origini e i progressi del nostro corp o, rie ,-oca.ndo nei vecchi gra te e glori ose m e morie, e additando ai giovani non inutili ese mpii.

Co l R egio D t> creto de l30 otto bre 1850, s i inizi ò una nuova. er a pel Corpo sanitario dell'eserci t o sardo. Si può dire anzi che dati da. allora soltanto la costituzion e di un Corpo san itario mili tare. Prima di allora il Sl'rvizio sanitario dell'es ercito e ra distinto in due rami: medico e chi rur gico Vi erano m edici e vi erano chirurghi; non vi erano medici·chirurghi. Ver o è che fino dal 18 ! 3 un s ovrano provvedimento aveva. ordinato che dal
1• gennaio 1846 n ess un chirurgo magg iore in 2• potesse essere am messo agli esa mi per la promozione a c hirurgo maggio r e. se non tosse munito dell a doppia laurea. Ma se la maggior parte deg li uffiziali di sanità venne cosi ad avere nominalrnente la duplice qualità di medico e di ch irurgo, n essuno poi l'aveva P. ffe ttivamente. po ichè l 'organamento de l servizio, i quadri ste:;si d e l co r p•l continuavano a portare la separazione. Il serv izi-Q dei corgi era tutto fatr.o d a i chirurghi. Agli ospedali erano add etti medici e chi rurg hi pei ri s p ettivi servizii.
Quanto ques ta d1" cinzione pregiudicevole al servizio e al decoro de l Corp o sani ·ario, d i quan to ostacolo f osse al pArfezionamento sciemtifi.co di questo non occorre accennare. Essa mantene\'a poi un perenne antagonismo tra i due rami del personale. affettando i m edici verso i chirurghi una. certa avanzo dell'epoca, del resto già. anche allora molto lontana, in cui i chirurghi d ei co rpi erano sce lti e stipendiati direttamente dai colonnelli, e in cui chirurgo e flebotomo erano spesso sinonimi .
A questo stato di cose venne, come abbiano accennato, a. porre rimedio il nuovo r egolamento del 1850, i cui primi due articoli portano
...
appunto la escl usione dal Corpo sanitario dei muniti di una·sola e l 'abolizione della in personale medico e personale chirurgico. Cogli articoli successivi si stabiliscono la gerarchia, le competenze, i diritti del nu ovo corpo, che risultava composto di:
3 medici divisio uali di l,. classe (a L. 3200), pareggiati a maggio ri;
6 id. id. di 2" id. (a L. 2800), id. id.
16 med ici di reggimento di l" classe (a L. 2400), paregg. a capitani;
16 id. id. di id. (a L. 2200), id. id.
16 id. id. di 3• i d. (a L. 2000), id. id.
56 medici di battaglione di l " id. ( a L. 1600), paregg. a tenenti;
56 id. id. di 2" id. (a L. 1300 ' • id. id.
Nè la proporzione numerica dei gradi, nè gli stipendi rappr esentavano invero una molto brillante posizione. Era però per quei tempi un grande progresso. Notiamo anche che il Consiglio superiore di sanità non era considerato come faciente parte de l Corpo, essendo in del Governo di eleggere i suoi membri dovunque credesse.
Ben dodici articoli, dei trentotto che compongono l'in tero regolamento, s i occupano della istruzione degli ufficiali medici, prescr ivendo corsi di esercitazioni pratic he e lezioni teoriche, e soprattutto la istituzione di riunioni scientifiche da tenersi periodicamente presso gli ospedali d ivisionar ii, e la compilazione di memorie cliniche.
Questo nuovo ordinamento. che incontrò subito il favore, anzi rentusiastica appr ovazione del Corpo sanitario, si dovè all'uomo insigne, la oui nobile effigie appare riprodotta nel frontispizio del nostro Giornale .
Alessandro Riberi, nacque in Stroppo nella provincia di Cuneo il 2 aprile 1796 ( l). Laureato non ancor vtmtenne, nel l 8l5, in medici na. e chi rurgia, conquistò rapidamente un'alta considera zione. Al grande ingegno, alla vasta cultura, all'acume clinico, all'abilità chirurgica, co n · giungeva. egli belle qualità oratorie, cosicchè dive nn e ben pre,to uno de i più acclamati professori dell'Ateneo torinese e salì in ancor verde età. a. g rande fama in Italia ed all'estero. Ma renumerare i suoi m er iti scientifici ci porterebbe troppo in lungo, volendo noi qu i parlar solo delle sue benemerenze verso il Corpo sanitario in genere e verso questo Giornal e in particolare. Il Riberi era fino dal 1825 chirur go mag-
(Il Nell'articolo biografico insrrito neWEnciclopedia medica ilaliana d ol Vallardi. comJlil ato clnl dottor A. L ONGIli. In data della nascita e il apro le 179\. Però vi è ciNto che mori d a 65 anni. Cùlla. data riferita dal LonRhi con corda anche 'IUella risultanle dali" Archivio d e l Scnntn. Secon<lo un'n l tra lliogralla, rlol •lottor PKRON>:, in.1erita nel Giornale di medici>la malllt&re. anno 186\t. pag. G, il Riheri snrobbe uoto il !6 aprile t794. In altr& biografia inserita popolare ltalia11a • invece nato il 17 aprile 1791. Noi ei siamo atltnuti alla data risultante dalla matricola del Cor pù sanitar io esisten te nell"Archivio dell' Ispettorato, e compi lata durante la vita dal Ribori

4 IL PRIMO OINQU A::\TE:.NI O DI VITA
giore delle guardie del Corpo di Sua Maestà, la qual carica t enne fino al 18!3, anno in cui fu chiamato a succedere al dott. Gillio ( 1), defunto nel dice mbre dell'anno precedente, nella oarica di Preside nte del Consiglio di sanità militare. Data fino da allora ropera di risanamento e di ri costituzioue del Corpo sani ta rio. a cui dedicò cosi gran parte d ella sua at t ività, e che gli era grande mente facilitata dalla immensa autorità che circondava il suo n o me, come chirurgo, come profe3So re, come uomo pubbli co (2) La sinte3i, p er cosi d ire, ufficiale di questo suo lungo lavoro fu il nuovo ordinamento del 1850 di cui più sopra abbiamo parlato.
Col largo censo guadagn11 tog li dall'esercizio profess ionale egli beneficò in vita più gli al tri che s e stesso; e si e resse morendo un m onumento di gra-titudine più dure,·ole del bronzo.
Dato, col nuo vo ordinamento, un felice ris veglio alla cultura d el corpo sanitario, pensando che lo stimolo dell'emulazione è più sentito quando l'agognato guiderdone non consista soltanto in una co· rona d'alloro, erogò ogni anno, del proprio, la somma di 1000 lire per conferire un premio ai medici militari autori di memorie scientifiche. Il primo concorso fu bandito nel 1856, e da allora in poi, il conferimento di quel premio continua regolarmente a dare un non piccolo incentivo all'attività. scientifica del nostro corpo.
Allo Spedale di S. Giovanni in Torino egli rilas ciava annua!mente il suo intero stipendio perohè fosse impiegato nella istituzi one e nel mantenimento di un museo d'anatomia patologica nello stesso Ospedale.
Ma delle beneficenze da lui fatte in vita troppo lungo sarebbe il discor rere, e difficile il ricer carne la indicazione documentata, poichè, oome bellamente fu scritto in una delle Epigrafi d6ttate pel suo funerale da Luigi Cibrario, la sua pietà non era ostentata ma s incera; la sua beneficenza occulta ma opet·osa; non potè più celm·la marendo.

Veuuto infatti a morte il 18 novembre 1861, furono fatti pubblici i suoi ultimi voleri, coi quali una cospicua parte del suo patrimonio fu destinata ad opere di beneficenza ed a incoraggiamento agli studii. A noi basti accennare che in favore del cor po sanitario militare, provvide alla continuazione in perpetuo del Premio Riberi, già istituito in vita; e in favore della scienza. medica in genere provvide alla. istitu-
111 Era nato nel 1761. Fu ìl primo prPsirl•nte rlcl surcr iore rli sn nlla mPillco rull••gta lo fino !!al 1796. P ru anche de lla racolta merltca d e ll' un•ver>i ta Ne l 1814 ru nominato m llro tlelll eilla Iella di Torin o. Ispettore )(r ncrale d egli o<pMali milllari nel tSt S e mo Il eo nettn6 furono le earlch• publllirhe rb lui coperte. fra le quali tli•·itlevn In StHt • trnor· thmna atllvila Pu, tra altro pr•slrlrnte rlel •:on siglio snperior•• tlell' Istr uzion e p uhhiiCA ;
11•1 R•·zno th l 1 49. Protom•docn Ile Ila Rea t l'a miglia, e med ico per,on:ale del Ile , ns.ihte Ca rlo AllJ erto and•e n l'lle 5ue ultime ore in Oporto.
DEL 'NOSTRO GIOR!\ALE
zione del vistoso premio di L. 20000 da conferirsi dall'Accademia di medicina di Torino. Quest' ultimo premio però doveva, giusta il suo testamento, e:1ser conferito soltanto 7 volte dopo la sua morte , di tre in tre anni; di modo, che dopo anno, esauri t osi il capitale, il premio sarebbe venuto a cessare. Il degno erede del nome e d e lle sostanze di lui, l'avv. Antonio Rib er i, perfezionando per sua generosa iniziat i Ya. ropera generosa dello zio, provvide del suo al completamento del capitale, in modo che il premio, da conferirsi ogni 5 anni, è di,·euuto perpetuo.
Ma, d opo questa necessar ia digrelisione sul pril}lo instauratore del corpo sanitario, torniamo alla storia del nostro giornale.
Il risveglio scientifico po r tato nel corpo dal nuovo ordinamento de l 1850, la libertà di stampa recentemente largita dal r egime costituzionale, l'obbligo infina delle riunioni scientifiche da tenersi presso gli Speùali, fec ero nascere conte mpora neamente in diversi medici militari l'idea di fondare un Giorn ale « che (lo diciamo coll e parole stesse del Programma inserito nel P numero dell'anno I') mettesse in mu t ua r'elazione gli sparsi figli della famiglia medico militare e loro ren dess e profittevoli i frutt i delle conferenze scientifiche tenute negli Sped ali militari pubblicandone i process i v erbali, le storie le tte delle mal a ttie, e tutti i lavori scient ifici in det t e conferenze comunicati, non t r alasciando in pari tempo di trattenersi sugli inter es si g enerali del corpo sanitar io e sulle r iforme p ossono chiamarsi utili al buon andamento de l sanitario dell'armata » .
« Quantunque questo bisogno di pubblicità. d e i lavori degli uffi c iali d el co rpo fosse generalmente sentito, debbesi però agli uffiziali sanitari del Presidio ed Ospedale divisionale di Sciamberì (l) l'iniziativa della
(l ) Qne!' la pro pos ta fu fatta alla Conferen:ta scientifica del m febb rai o 1851 dal m edico rtl r eggim• nto dott. &ro nc d o Oeau fort, co me a pag. 33 t• de l gio mnle Fu ' ' " e Il med ico divisional e Comi$setti. presidente •l c ll'atlunanza, s e ne reco il pro tJUil'n.1· tore pra1•o Il Consiglio s ur•e r• o re.

Il Comls<elll e ra nato il Il tnarzo l a&:;. Fu il te rzo pros lde nte d el s upe ri oN>, ed 1l pri mo rh o ar r ivasse a capo de l Cor po Su r. itar•o percorrendo una regolare cnrriPra Entrò nl servizi o tuil i! a re com• t.htruri(O ma jfgiore d t t • clas se nel 183:! Fu medico in cnpo tl e l Corpo ai s pediz ion e In Ortc ute nr l e lo in cari co c bhe p er lo campagne d el 11159 e 1800. S u cce:sse al niherl nr l l 86! nrlt n carica rll presl•lc nt ù de l Consiglio. che tenne Ono al t8i3, in cui fu coll ocato n Mod Il '!4 te mhrc 188:1 Oen c ht) s u ccedesse a un u omo di tantn rinomanza. •rnnlc il Riheri, egli vtt co n tato t r a i h cne me rltl Ile i corpo >nnltarlo lt:tllano t 'e poca in cui eg li t r·nno la i>ri• Siti Pnzn ru una dell o p ltt
.1111lclll e Jl ien n rti imp rtantl , quali la rus ion e nel Corpo samtnrlo it uliano d ei tloll bo r bonico, c ciel co rpi vo lontari ; Il tra s loco d otrufll cto da To rino a FlrPttZf, cltc fu s in cr on o a ll o scoppio d r lla I!Uerra d r l1866 tasc10 molti lodati sctltli srlc nt lll r i, tra 1 t(lt:tli cl l'lat·c r tco rcl a re l e Ann ot az i oni •ull' ollilu.diue cùgli Italian i al Jt nJizio mililn re . Ftrc nzc l &i i . Il Ra rohu Camillo ll og ì•• r d e D•aufor L nato Il '!3 dicem br e ! SII a tto •w c•lo di !tlodcnn. La ur ea to a Pisa n e l 183i ser vi nel 18!8 Il Govern o p rov viso ri o d t Mod ena eo m o me< l1 co ci i r es:gi mt•u to ne lla m ode nese: poi ne ll' anno stesso p :13sò co me Chirurgo nell ' Eser ci to p icmou te;e.
G IL PRIMO CINQUANTENNIO
DI 'VITA
Mori 3 Torino •l !2 Rl>ril o 1858.
proposta al Consiglio super iore onde ottenere un giornale che potesse stimarsi l'organo del corpo sanitario di tutta l'Armata ».
Il Riberi non solo accolse la proposta, che corrispondeva ad un concetto già. da l n i careggiato, non solo se ne fece caldo sostenitore presso i! Ministero dolla Guerr a per ottenerne la sanzione, che ebbe luogo per dispaccio dell'li Luglio 1851, ma d e tte al nuovo Gio r nale il suo validissimo appoggio, con tribuendovi coi suoi scritti, e a gg iunse poi a tutti questi benefizii un g e neroso contributo pecu niario. Ecco perche il froutispizio del .nostro Giornale si adorna della sua effigie, come di quella del suo beùemerito fondatore (1).
Il p r imo numero del Giornale uscì il 28 luglio 1851. E qui dobbiamo subito giustificar e un'apparente con tradizione; poichè partendo da quella data il Giornale avrebbe ora compiuto 51 anni e mezzo, e l'anno 1903 anzichè il 51o sarebbe il 53" della sua vita. La differenza dipende da una interruzione di un anno avvenuta n e l periodo d ella gue r r a di Crimea. Così la numerazione d ell e annate fu la seguente: Anno l" dal 28 luglio 1851 al 26 luglio 1852; anno II" dal 2 agosto 1852 al 25 luglio 1853; anno nr· dal l" agost.o 1853 al 31 luglio 1854; anno IV" dal 7 agosto 185-1 al 3 1 di cembre 1856, con inte rruzione dal 27 giugno 1855 al 9 no ve mbre 1856. Dall'anno v• (1857) in p oi la numerazione degli anni, corrisponde esattamente cogli anni $Olari.
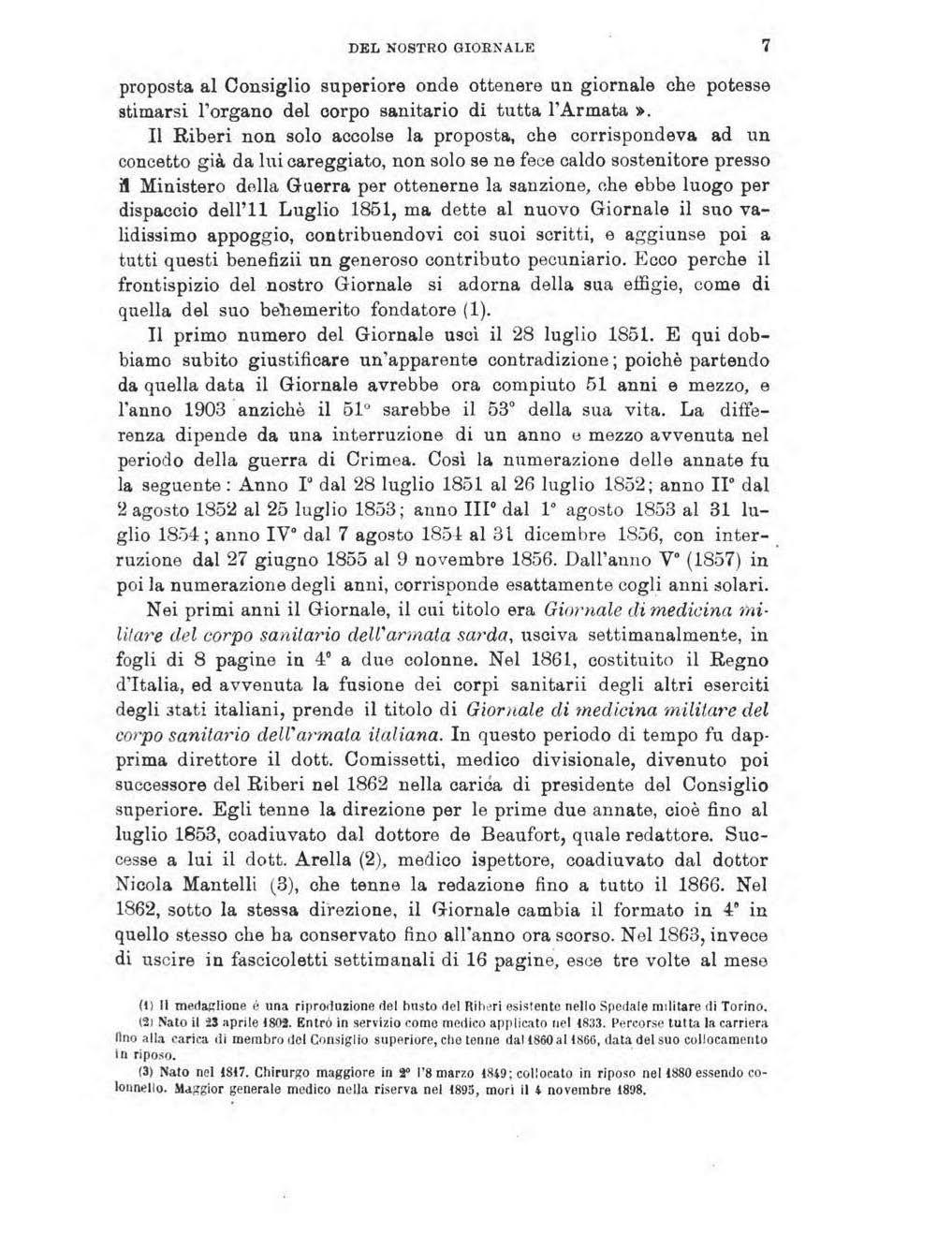
Nei primi anni il Giornale, il cui titolo era Giornale di medicina mi· litm·e d el corpo sanitario dell'armata sarda, usciva settimanalmente, in fogli di 8 pagine in 4" a due colonne. Nel 1861, costituito il Regno d'Italia, ed avvenuta la fusione dei corpi sanita.rii degli altri eserciti degli Jtati italiani, prende il titolo di Gi ornale di medicina militare del corpo sanitario dell'armala italiana. I n questo periodo di tempo fu dapprima direttore il dott. Comissetti, medico divisionale, divenuto poi successore del Riberi nel 1862 nella cariéa di presidente del Consiglio su pe riore. Egli tenne la direzione per le prime due an nate, cioè fino al luglio 1853, coadiuvato dal dottore de Beaufort, qnale redattore. Successe a lui il dott. Arella (2), medico ispettore, coad iuvato dal dottor Nicola Mantelli ( 3), che tenne la redazione fino a tutto il 1866. Nel 18 62, sotto la stessa dire zione, il Giornale cambia il formato in 4• in quello stesso che ba conservato fino alranno ora scorso. N e l1863, invece di us cire in fascicoletti settimanali di 16 pagine, esce tre volte al mese
( t ) Il c una ri produ zi one riai hn sto rlcl esiste nte nello Spcdalo mditare eli Torin o . Nato il :!.3 nprile ISOS. Entr6 ìn romo medico appl ica to ur i 1833 tutta la carriera llno alla ca ri ca di membro !lol s up eri ore, eho tenne dal1860aiiS66, data. del s uo collocamento In (3) Nato nel t817. Chirurgo maggiore in 1'8 marzo collocato in nel ISSO esse nd o colonnello. M.lggior generalo m edico n e lla rise rva nel 1895, mori il 4 novembre 1898.
DEL NOSTRO GIOR!\ALE 7
in fascico li d i 32 pagine. In questo s t esso anno si aggiunge alla direzion e, come compila to re, il compianto Baroffio (l ), allora m edico divisionale, che tanta p arte della sua. attività dedicò in seguito al gio r nale.
L'annata 1866 fo r m a un vol um etto che raggiung e appena la metà. dei precedenti. Il giornale sospende le sue pubblicazioni riu r ante la camp agn a. In questo stesso anno avvie ne il t r as loco de l Consiglio s up eri ore di Sani tà da T or ino a Firenze; e conseguemente le pu bblicazioni, interrotte n el maggio a. T ori n o, si riprendono nel settembre successivo a Fuenze. Nel 1867 l a direzione è assunta dal dott. Nicolis, med ico i spettore (2), co n tinuando a d esser e r edattore il BaroO:ìo . N e l 1869 cessa la direzione d el Nicol is e resta. il solo r edatto re B aroffìo. Nel 18 70, troviamo d irettore il medi co i s pettore Cera le (3) ; continua come r edattore il Baroffìo. Il giornale si pu bblica sempre n ominai· ·mente in 36 numeri annui; ma in sostanza esce mensilmen te a numeri tripli. Al Cer ale succede nel 1873 per pochi m esi il medico ispettore Orselli (4). Nel 18 74 troviamo dire t t or e il colonnello medico ispettore Manay ra (5); co ntinua come red atto r e il tenente colonnello B arof.fio. Co l 18 75 il g iornal e segue il comitato di sanità milita r e a Roma. e mercè l'ap· ,pogg io finanziario dato dal Ministero d ella Guerra (era allora ministro il generale Ri cotti) radd oppia. quasi il suo volume e di venta, anche nominalmente, m ensile.

La direzio n e si compone del colonnello ispettore Manay ra e d el capitano medico .Federico Tosi (6) come reda ttore. (Il Barof.fio era rimasto
( l ) N&IO Il 3 o tt obre t 81 'i. F ece i suoi st udi• in P.tvia, e i primi passi proresslnnali a M1lano. Appartenevi! a. q uella ralangc di giovani medici che. raue l e campagne dol 1848 e 18,9, dl 311rgnando nman ere souo Il giogo aUJir la co, presero scn izio neii'Esen:ilo sa n:lo, q ua li il Corteso, Il Giud ici, il Bcsoui. fu m aggio r generale medico nel t 88i; Ispe t tore ca po nel 189J. Mon Il 13 gmgn o t 893. Uomo diinstanca· h ile nllhit:l, 14nto nel cam po •c•entinco che nel campo t ecni co enmmin istrallvo, IBsclò vasta. e lmpenlur3 traccia d1 e pei m oll i scritti scienli nc i e pe r le rirorme ed l miglioramenti da l u i s tudi ati nel ser· vizio m edico mll•1.3re.
(SI Nato il robhraiu t 816. Allievo chirurgo ne l 1837. Ispettore membro del Consiglio s u periore ne l t 863 Fu collocato in ne l ! 869.
(31 Nnl o Il 5 lu glio 18 13. Chirurgo maggiore Il 9 ago;to 1836, mo miJro d el Con!lgllo s uperior e ncl 1869. t:ollocalo i n rip oso nel 1876. un {! ran num er o dllllslinzionl m criln te s ui cnmpi d i bott.al!l •a. full primo co mp ilator e rlello regola ri s l.3 ti stiet•e san ifarie de ll'EserCito dopo i primi saggi Ile i JlaronJo
(4) Na t o In Tosca na ne l 18il; prPse parte, p rima co me se mph ce voionl.3rio e !lupo ch irurgo n e l battaglione vo lonta ri o nore11lln o. alla campa,.:na. (lei t S\8. 1\lma<to poi t o>o.1no, parto nlln ca Ul pagna del t 8l 9 come merl ico di hr igata a<ld ello n! co mand o rt oll e trnp110 di d o tto tru p pe ru promosso mcdJ co Is pe ttore Co ll oca t o in ne l 1878, mo r i
(51 i'\ alo Il 7 Ollob ro 1817 n Sospello e ntral o in sP-rvi?.io rome chi rn r)(o mng!(lorc in!' n•• II SI\1. Stli al cll ge n era li' e di Pres itlente del co mitat o nel t SSQ, al colloca mtnto iu ri poso rlcl Mo ri Il 4 gen na io 1887, pochi giorni do po il s uo In posizio ne a usi liaria. Fuuo• n o 111 mnlta dott r ina o•l e rullzione. Tra i s u o i nnmerosi sc r •lti é notovole un lrntl:l l o s ulla m cnin;pte cc reh ro SJli n.,le ep idemica.
(GJ Nato a 11i Carrara il ! 837. a :;(gi unto nel corpo sani t ario nc ii'Es••rcill• re· la re sartlo noi 1859. Pu per molli anni prima cl el Comitato •li s:u11 t n. e 1111i di rvttor•• t iPI\.• scuola <Il l'it•ll'una e nell'altra si acquistò lo rt(•l rorpo s ·•n•tano. dopo a1er Il :;rado di m a;:gior generale IOOtll':\ 1h acuta m SllCHt il 19 OIIObrc 1896.
8 IL l'RIMO DJ VITA
a Firenze come direttore di quello Spedal e). N el 1877 al Tosi succede il capitano medico Ettore Ricciardi, ora generale medico in posizione ausiliaria; nel 1879 la redazione passò al capitano medico Carlo Fretti, ora colonnello medico in posizione ausiliaria. N el 1880 la direzione passa al colonnello med ico i spettore Elia (o ra maggiore general e in riposo 1, essendo stato il Manayra promosso maggiore generale e presidente del Co· mitato, in sostituzione del Cortese, collocato in riposo. Nel 1882, assume la direzione il colonneìlo medico ispettore Baroffio, che la fino alla sua promozione ari ispettore capo nel1892. Colla direzione del Baroffio fm·ono redatto ri del giornale il capitano medico Fretti fino a tutto il 1882, il capitano medico Sforza, ora. tenente colonnello, fino al sett em bre 1890, epoca in cui gli successe chi scrive questi appunti.
Nel1885 il giornale cambiò il suo vecchio titolo in quello di Giornale meclico del R. 0 Esercito e della R.• Ma1·i,1a . A dar ragione di questo cambiamento, occorre tornare qualche passo indietro. Il corpo sanitario della Marina. formava in amico nn solo corpo con quello dell'Esercito, ed era. pur esso alla dipendenza del Consiglio superiore di S anità ; perciò il Giornale eli medicina militare, nei primi anni, era veramente l'organo scientdìco dell'uno e dell'altro ramo di servizio. Ma dopo la separazione delle due carriere, dopo la costituzione presso il Ministero della Marina. di un ufficio direttivo e consultivo che adempieva completamente le funzioni del Consiglio superiore di Sanità, il Giornale di medicina mililu.re perdt, a. poco a poco la qualità di organo scientifico comuue ai due corpi.
Essendo frattanto il corpo sanitario della marina cresciuto in numero ed ancora. più in meritata considerazione, fu giustamente sentita la convenienza di dar nuovamente a questo corpo un mezzo di render pubblica la sua notevole attività scientifica.; e perciò, il giornale, ridivantato l 'organo dei due corpi, ampliò ancora il suo volume, di due fogli per fascicolo, facendo posto, con parità di diritto, ai lavori dei nostri egregi colleghi della marina, i quali erano pure rappresentati n ella compilazione del giornale da un collaboratore speciale (l). Questa comunanza durò fino al 1895; anno in cui, aumentando felicemente, in misura non piccola., la produzione scientifica dei due corpi, si riconobbe . che, non bastando più il vecchio giornale a contenerla, e ra necessario che il corpo sanitario della marina avesse un suo organo scientifico particolare.
E i l giornale nostro, ascrive a suo grande onore lo avere accolto nel suo se no i primi germi vitali di una pubblicazione che ha preso di già
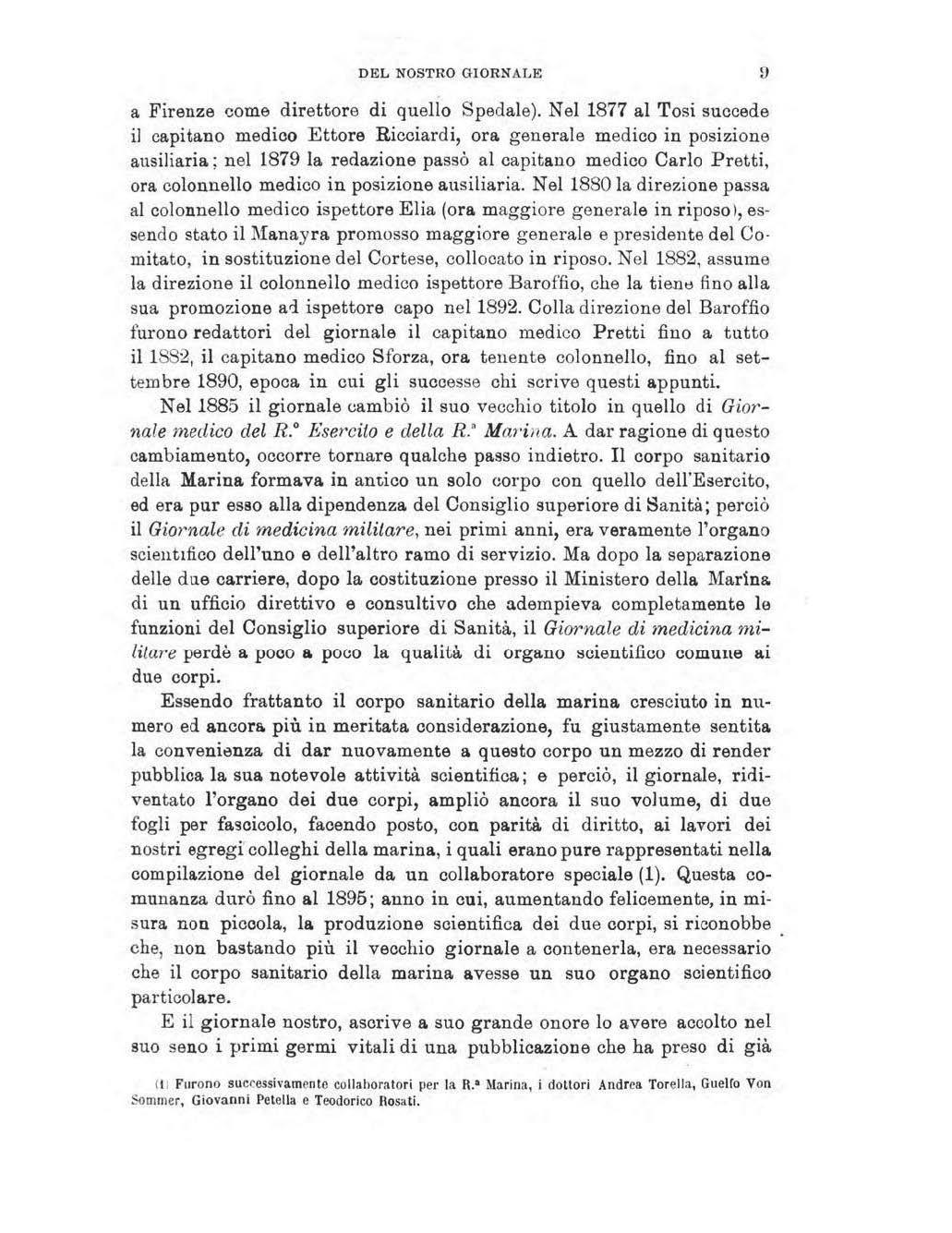
DEL NOSTRO GIORNALE
(1 , furo no sucressi,•amento collahoratori per la n.• Marina, i dottori Andrea. Torel la, Guelfo Von &lmrner, Giovanni Petolla e Teodorico l\osati.
un posto così brillante nella stampa medica, gli Annali eli m edi ci nrt navale.
Dopo il Baroffi o tennero successivamente la direzione il colon ne llo medico Regis (1), poi maggior g e nerale ed i s pettore capo, fi no al 18 96; il maggior generale medico Tosi per pochi mesi di detto anno, il colo n· nell o medico Ricc iar di fino al settembre 1897; il col onn ell o medico Panara fino all' ottobre 18 98; il colo nnello medi co Gi ,·ogre a tt uale is pettore capo di sanità., fino al febbraio 1899; poi di nu o vo, fino a l luglio 18 99, il colonnello medico a cui successe l' ctttuale direttore , maggior generale medico comm. Landolfi..

Abbiamo ritenuto non inutile, sebbene forse alquan to arida., qu est a enumerazione delle tappe seguite nel suo cammino dal giornal o. E ssa ci ha ri evocato l e memorie antiche del nostro corpo, dai primi t em pi, in oui, privo di t r adizioni scientifiche, liberato appena allora. dall'in ceppa· mento conseguente dagli antichi ordinamenti, dovette i l suo rapido sviluppo ad un elevato sontimento di cameratismo professional e, fino ai nostri t empi, in cui, conquistato felicemente un posto dignitoso fra. i corpi sanita ri di tutte le nazioni, può guardare con orgoglio il suo passa t o e con altrettanta. fiducia. il suo avvenire.
Sia. sempre il nostro giornale, come nei dieoi lustri ora t ermi n a t i, lo specchio fedele dei prog r essi della famig lia medico-militare i e pos8a. fra cinquaut' anni ce lebrare il suo centenario co ll'evocazione di memorie se mpre più gloriose.
I l ) i'ia to il 14 t83G Entrato in SPrm<in n t l ! R:;s. l>rettore capo d i S.1nila mtl• tar.• ti rt 1899 Uo mo d i rara cultura. ma <l' allreuant'> rara non ch e JtOdll' l racete guo va lo re sric nt tlico Di me nte ! e rena e pruden te. <Il animo avre h lw po tut o rrn tlc r o a ncora g randi ser V>t' i al corp< • quand'> la m orle lo cols e ti fe hltra to 11!99.
10 IL l'UlMO CI:-IQUANTE...,.NIO DI
VITA DEL NOSTUO
. ..
RI CERCI-I E
I NTO RN O A L R A PPORTO F R A V I SUS E L UCE (INFLUENZA DELLA FATICA)
Un problema d i Ottica fisiologica è quello che si riferis ce alla sensibilità. d ell'occhio, il c u i stimolo normale è la luce. La sensibilità dell'occhio è rappresentata dall'impressione più o meno viva, prodotta sul medesimo d alla luce e particolarmente dalle varie spe cie di luce
S'ignora, è vero, in qual modo la. ìuce ecciti la retina e quali rapporti passino t r a i mutamén ti della r etina e l'eccitazione di essa; ma non s'ignor a che, ad eccitare la retina, basta nua luce di durata straordinariamente breve e d' i ntensità. straordinariamente picco la.. Si sa, infat ti, che ad impressionare l a retina umana è sufficiente la durata della scintilla elettrica, che è di 0,000,000,668 di minuto secondo, e l' intensità luminosa di 0,000, 000,029 di candela normal e.
A questo propo.sito, ·mi piace di ricordare le ultime interessantissime r icer che d i La. ngley, professore all'Osser vatorio Smithsoniano n egli Stati Uniti d'Amer ica

Il L angley, con l e sue esperienze, ha. dimostrato che, data la stessa. in t ensità, la impressione p iù· forte sulla. retina. è prodotta dal colore $pettrale verde; in altri termini il verde è la. radia.zione fisiologicamente più econo mica.
L'esperienze del Langley sono interessantissime, perchè hanno accertato la prodigiosa. sensibilità dell'occhio i n date condizioni. Anch'egli si propose di risolvar e i l problema della sensibilità. della r e tina, e si domandò quanta energia luminosa occorra per produrre la. più debole impressione che l'occhio possa. percepire. I n seguito a. calcoli e ad esperienze, il Langley concluse: « Se si suppone che in una turbina. alta.
MEMOR I E OR I GINAL I
Labo ratorio dt Fisiologia della R. Università di Torino diretto dal pro r. A . MOSSO
----
Dott. Alb e r&o &Uobelli. m edi co - Assistente onorario
non più di un metro, C!ld& una mass a d'acqua d i uu litr9 soltanto e che, per mezzo della dinamo o della co rrente elettrica, l'energia così sviluppata venga. trasformata interamente, senz'alcuna perdita, in luce verde, la quantità. di luce così ottenuta basterebbe a. man tene r e per tre milioni di anni il più debole chiarore, che l 'occhio possa. perce pire».
Lord parlando del telefono ebbe ad osservare che se esso è un'invenzione veramente meravigliosa, più meraviglioso an co ra. è l 'orecchio, il q u ale resta impre3Sionato da piccolissima dose di en erg ia. Che dire p oi dell'occhio, l11. cui sensibilità specifica è immensamente superiore a qu ella dell'orecchio?
La. sua sensibilità. s i ri vela. sopratutto nel campo dell'astronomia. Gl'immensi progressi, fatti nello studio del mondo stellare, n on si devono soltanto nl perfezionamento degl' istrumenti; una parte del suc· cesso spetta, senza dubbio, all'organo della vista
Lo st udio d e lle stelle nuove fu res o possibile dal t eloscopio, dal fotom e tro, e più s pecialmente dallo spettrosco pio e dalla fotog ra fia, com· binata parte col telosco pio parte collo spettroscopio. Ma se la lastra fotografì Ga resta impressionata nei casi, in cui il corpo celeste splenda di luce tu rchina, violetta e ultravioletta. (alla quale il nostro occhio è poco o punto sensibile), essa per altro non riproduce in tutti i casi quei minu t i particolari , che, neila luna e nei grandi pianeti, si possono rilevare con l'occhio.

Un a ltro problema di ottica fisiologica molto discusso è quello che si riferis ce al rapporto tra angolo visuale e luce.
N on pochi hanno a studia.rlo, e tra i tanti cito d egli italiani il Rey mond, l' Albertotti e più recentemente il Colombo, aiuto alla clinica oculistica d ella R. Università di Bologna.
I m etodi di misura, adoperati per stabilire quali rapporti esi stan o tra l'angolo visuale e l a. luce, sono parecohi ; ma. tutti hann o per base o la luminosità assoluta dell'oggetto, o l a. luminos ità fra l'oggetto e il fondo, ossia il contrasto .
Per variare il contrasto poi si può ricorrere a dùe mezzi, o dimi· nuendo la. luminosità. dell'oggetto se nza modificare quella. del fondo, o diminuendo la luminosità. del fondo s enza modificare q uella dell'ogg etto. M:a ciò non basta. Come giustamente fanno osser v are i cul tori di ottica fi s iologica , in tutte le esperienze che hann o per iscopo di risolver e il problema d ei rapporti che esiston o fra l ' angolo vis uale e la luce, il primo ter mine, ossia il pun t o di partenza. sta. nel valore della lu ce minima st,(ficienle che permetta la. distinzione di du e punti separati da. un d etermina to angolo visuale (Ag V).
12 Rl Cij.RCJIF.
PPORTO
1:\TO RX O AL RA
('
l l
Ora è facile il comprendere che la determinazione del Visus, così fa t ta, ha pure lo scopo di misurare il se nso della luce (Licht sinn), di cui si ammettono il limite di eccitazione (Reizsch w elle) e il limite di differenziazione ( Unterschiedssch w elle ).
Qui è opoortuno di rivolgersi la domanda: Che intendesi per senso della lu ce ?
Per l'Aubert il senso della luce consiste nella facoltà della re t ina di distinguere la luce e la diffe renza di luce.
Secondo l'Ole Bull il senso della luce non è che la semplice facoltà di distinguere le difièrenze di luce.
Treitel chiama senso della luce la fa coltà. che permette all'occhio di distinguere un oggetto dalle parti circostanti.
Per il Bjerrum il limite di eccitazione può equipararsi al lim ite di
E cosi il "\Volffberg dice che, volendo dete rmin are il senso della luce, oc-::orre stabilire tanto il minimo stimolo lumino3o quanto la minima diflerenza fra gli stimoli.
Dal canto suo il Philipsen ritiene che il senso d ella luce è nè più nè meno che il limite d'eccitazione.
Finalmente il Parinaud ammette che il senso della luce consista n el minimo della differenza apprezzabile fra due luci e nel minimo visibile di ciascuna delle due luci.
Si capisce, pertanto come gli st.ndiosi di ottica fisiologica abbiano attivamente continuate le ricerche e gli esperimenti, intes i a chiarire il problema che si riferisce alla quantità di luce necessaria per l'occhio sano, ond ' esso possa distinguere due punti separati da un in te rvallo conosciuto. Tali ricerche ed esperimenti sono per la fisiologia assai interessanti; perohà si tratta di misurare quella che Cbarpentier chiama sensibilità visuale, ossia la sensibilità. luminosa in funzione del senso della forma.
Il prof'. Mosso, volendo ch'io m'occupassi dello studio dei rapporti fra v isus e luce, non solo mise a mia disposizione la tavole fotopto· metriche del Colombo; ma fece appositamente costruire dal bravo meccanico del laboratorio sig. Corino un banco ottico, secondo il modello e le misure date dallo stesso Colombo.
Al prof. Mosso che mi assegnò il tema, e mi forni i mezzi neoes· sari .per eseguire l'esperienze, al . mi fu. di constgli e di aiuto d 0 e professo 1 sens1 della m1a v1va grat1tudme.

' ev d' d
Le ricerche d aticate, banno avuto per 1scopo 1 ve ere prtma . , a me pr . d' . . d " . . d' l rapporti esi,te t' ii ·sus e luce m con tzton• or mar1e, e pm 1 stu· di n 1 ra vz d 11 fì are in reJa.· d · l'influenza e a at10a.
' -tone a ess1,
l!'RA V'ISUS E Lt;OE 13
RICERCHE ll'iTORNO AL RAPPOUTO
Per poter comparare i risultati occorreva naturalmente un'indagine sistematica, la quale avesse come base di misura l'acuità. visiva centrale di un gruppo d'individui oon occhi perfettamente normali. Cosi facendo, le cause d'errore venivano ad essere eliminate o almeno rid otte ad un grado minimo.
Tarole. - Le tavole di cui mi avvalsi n ell'esperienze erano quelle medesime, che il prof. Albertotti della R." Università di Modena presentò, a nome del dott. Colombo, in una delle sedute del Congresso in.ternazionale dei fisiologi, tenutosi a Torino dal17 al21 settembre 1901.
Chi voglia conoscere i minuti dettagl i e i dati tecnici d e lle suddette tavole, non ha che a leggere le due monografia dello stesso a u to re, l" una dal titolo: Mistwe SJJeJ·ii,tentali dell'eme1·alopia e dello1·pore ?'Clinico (Pa,·ia, 1901), e l'altra: Note alla seconda edi;;ione delle lut'ole foloptometriche (Bologna 1902). - Io mi limito so ltanto ad enunciare i principi, su cui è fondata la loro costruzione.
j.jsse appartengono al tipo di quelle ideate clall'Albertotti nol 1878, e pubblicate nel 1895:

«
t• Una superficie bianca., di cui un.a parte sia occupata co n d e l nero uniformemente distribuito su di esse mediante un tracciato di righe nere parallele, viene a cost.itu ire un fondo uniforme a. ti uta. grigia più o meno oscura a seconda d ella quantità di nero impi egato,·i, allorquaudo è vista ad una tale distanza per cui riesca imposs ibile a.ll'occh io. che l'osserva, riso l vere il tracciato ».
« 2• La quantità di luce incidente che viene r eflessa (di tl'usa ) da una tavola così costru tto. è espressa e misurata dal rapporto col quale trovaus• su di essa distribuiti il bianco ed il nero :..
« 3° Il rapporto tra il bianco e il nero in una tavola così costrutta. (cioè ottenuta mediante un tracciato di righ e nere parallele di la r ghezza e lunghezza costanti per tutta l'estensione della tavola e separ ate da intervalli bianchi di larghezza costant.e per tutta l'estensione della tavola e di lunghezza eguale a quella delle linee nere) è uguale al rapporto fra la larghezza della linea bianca e quella della linea n era. Infatt i noi possiamo considerare eguali segmenti di una linea bianca di una l inea nera come rettangoli di eguale altezza; ed è un noto teorema. di geometria. quello che dimostra che le aree di r ettangoli di eguale altezza. stanno fra loro come le basi ».
Le t11.vole de l Colombo sono in numero di dieci, e tutte portano im· pressi i segni del Landolt. La l' (a fondo bianco) ha il valore fotometrico ed è contraddistinta dal segno L (hu:e) == l. L e altre nove hanno fondi graduati, secondo le serie delle frazioni decimali dell'unità da'/ ,. ad '/,•.
14
Ma per fare l'esperienze, oltre alle speciali tavole, accorrevano:
a} un ambiente perfettamente oscura bile;
b) un banco fotom et rico graduato;
c
) due sorgenti di luce della gtessa natura.
Nulla di quanto mi era necessario, a me mancava.
Ambiente. - L 'esperi enze furono eseguite in una delle sale de l laboratori o, e precisamente in quella destinata alle ri cerche di ottica fisiologica.
La sala dalle pareti tinte a nero, si può re ndere completamente oscura, in modo che non passi raggio di luce, m e rcò la perfetta chiu· sura dell e due porte e delle due.fìne3tre.
B anco (otometJ·ù.:o.- Fu. come dissi già, appositame nte costruito.
Esso risulta di due parti principali, cioè di un apparecch io per centrare l'occh io iu esame, e di nn tavolo mu11ito di un quadretto portaottati p i e di lampade elettriche spostabi li .
Ad una dell'estremità della sala è piazzato un sedile p el soggetto in esame. D l).vanti al s edile su un tavollno trova.u:;i un sostegno, come <tuel\o annes:>o all'oftalrnometro d ello J a va l, e per la centratura de ll 'occ hio. L'occhio si centra, dopo che il s ogg(j tto ab bia p og· giato il mento e la fronte sul menzionato sostegno, col gnar.lare le mire o traguardi costituiti da due punti luminoSI, dati da. due pi <.:CO· lissime lampct.dine elettriche. La luce d' ogni lampiLdiua d e ve perClo trave rsa re un forarne di 2 millimetri di dia met10 di un c ilindrico metallico lungo 10 centimetri, posto su uno dei r agg i d e lla ,·isnal e.
All'estremità opposta della sala è piazzato uu tav olo r ett,angolare, graduato, lungo 2 metri, disposto nel senso d e lla. hnea. assiale biente. Il lato d el tavolo, attiguo alla della sala, ha un quadretto porta.·ottotipi di 32 centio1e tr i per ogni lato cou uua scanalatura, la quale permE.'Itte l'introduzione delle tavole montate su cartoni. Il qu adretto è imperniato QSa.ttamente al suo centro di figura. in modo da poter ruotare liberamente, conservando sempre la sua posizione in un piano normale a quella. del banco.
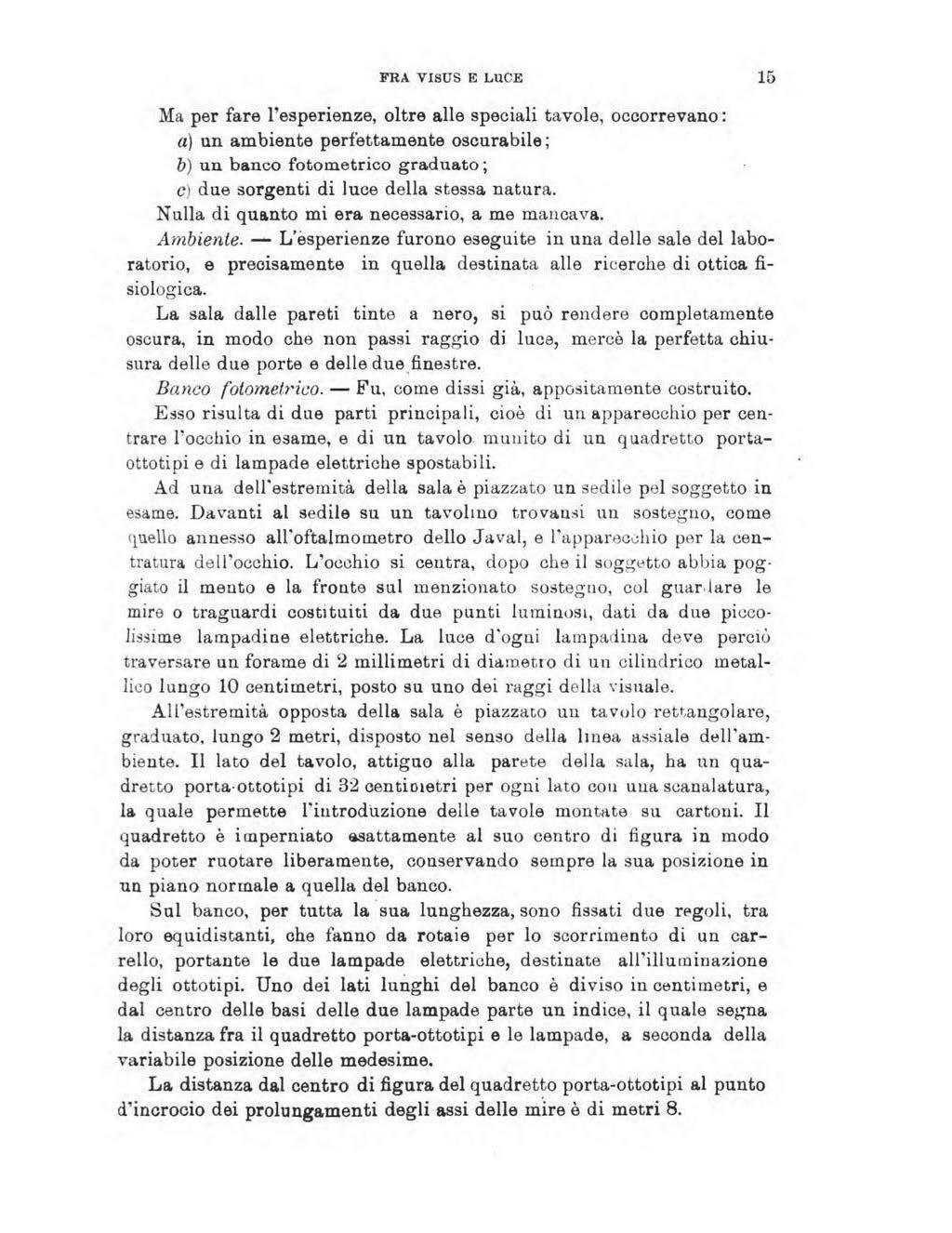
Sul banco, per tutta la ·sua. lunghezza, sono fìssllti due regoli, tra l oro equidistanti, che fanno da rotaie per lo scorrime nto di un carrello, portante le due lampade elettriche, destinate all'illuminazione degli ottotipi. Uno dei lati lunghi del banco è di viso in e dal centro delle basi delle due lampade parèe un indice, il quale segna. la distanza fra il quadretto porta-ottotipi e le lampade, a seconda della variabile posizione delle medesime.
La. distanza dal centro di figura del quadretto porta-ottotipi a.l punto d'incrocio dei prolungamenti degli assi delle mlre è di metri 8.
FRA VISUS E LUCE
15
L'altezza del centro di figura del quadretto porta-ottotipi sul piano del pavimento è di metri 1,32.
Sorgt>nti di lace. - P er l'illuminazione delle tavole si adoperò, come poc'.tnzi accennai, l 'incandescenz a elettrica, cioè due lampade d i inten;;itti dett>rmiuata.
Ognuna delle du e sorgenti luminose è data. da una lampada. elettrica. di forma st'erica, a. vetro smerigliato, chiusa in un para.·luce cilindrico di latta annerita. Questo ha un'apertura. circolare corrispondente alla parte, dove sorge il quadretto porta-ottotipi. La. lampada. essendo spostabile anche in se nso verticale, può col suo centro essere messa. alla stessa. altezza del centro di figura del quadretto porta-ottotipi.
In ricerche di qu esto genere è di massima importanza. il sistema d'illuminazione .
Si sa che l'inten sità e la qualità d ella. luce diurna variano continua· mento, a seconda delle ore del giorno, dell'altezza del sole, dello stato dell'atmosfera, ccc. Ora., per esperimenti, come quelli da me eseguiti, si dovrel.Jbe dispo r re di una sorgente luminosa. normale che in ogni ora del giorno si mantenesse di un' intensità costantemente eguale. Ma allo stato attuale della scieuza per a.pprossimà.rsi alle condizioni di una sorgente luminosa normale, è da preferirai la luce artificiale alla luce naturale, come precisamente consigliano di fare o hanno fatto .Mayer, Javal, Klei n, Cohn, Uhthoff, Albertotti, Nicati, Colo mbo.
Quest'ultimo autore giustamente osserva (e del medesimo parer e è il capitano medico prof. E. Trombetta, insegnante alla. scuola d'applicazione di sanità mili tare di Fir enze) che nei oasi, in cui la. determinazione del Visus può ass umere l'importanza di un giudizio medic o-legale (esame di reclute, d i ferrovieri, ecc.), essa dovrebbe essere fatta a luce artificiale, della. quale si conosca l'intensità.
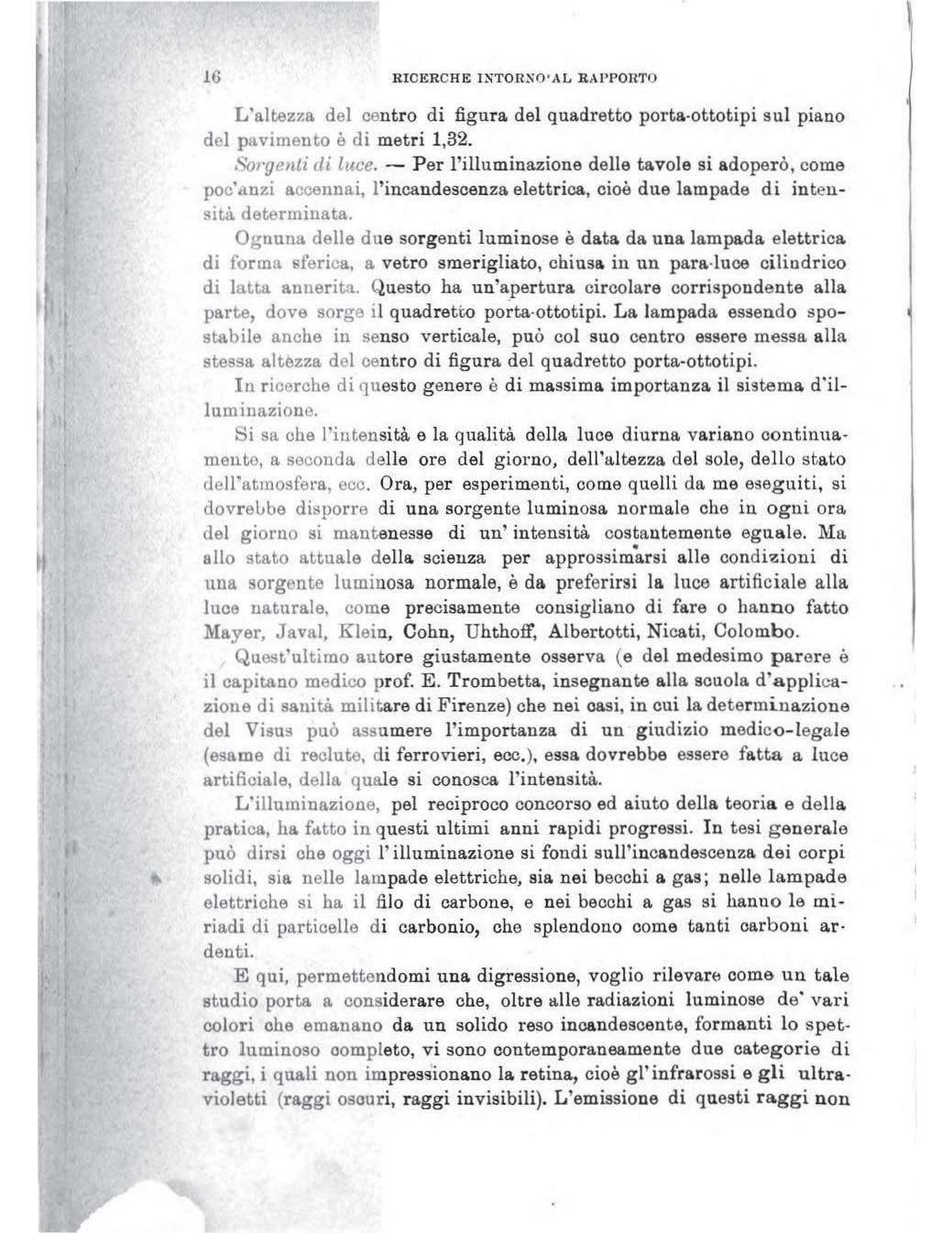
L'illuminazione, pel reciproco concorso ed aiuto della teoria e della pratica, ha. in questi ultimi anni rapidi progressi. In tesi generale può dirdi che oggi 1' illuminazione si fondi sull'incandescenza. dei corpi solidi, si a. nelle lam pade elettriche, sia. nei becchi a gas; nelle lampade elettr iche si ha il fi lo di carbone, e nei becchi a gas si hanno le miriadi di particelle d i carbonio, che splendono come tanti carboni ar· denti.
E qui, permettondomi una. digressione, voglio rilevare come un tale stu dio por ta a considerare che, oltre alle radiazioni luminose de' vari col ori ohe emanano da un s olido reso incandescente, formanti lo spettro luminoso oompleto, vi sono contemporaneamente due categorie di raggi, i quali non i mpressionano la retina, cioè gl'infrarossi e gli ultra· v i oletti (raggi osou ri, raggi invisibili). L'emissione di questi raggi non
16 RICERCHE INTO.R:\O'
AL RAPPORTO
solo è inutile, ma. è altresì. dannosa; perchè, anche facendo astrazione dall'energia che vien consumata per produrli, essi presentano lo svantaggio di rialzare ]a temperatura delÌ'ambieute.
Dal punto di vista dell' illuminazione è di grande importanza il determinare sperimentalmente per un foco laio di luce la proporzione relativa dei raggi luminosi e dei raggi oscuri. Grazie ag li strumenti termometrici assai perfezionati, con qu esto studio sperimentale s i sono ottenut i interessant i r isultati. Cosi pel carbone s i è trova t o che quau t o più alta è la temperatura, cui ard e, tanto maggiore è la proporzio ne dei raggi luminosi in confronto di quelli osc uri; e quind i quanto p i ù ele vata è la tempe ra.tLua, alla. quale una l a mpada bruci_a, tan t o più f orte è il s uo rendimento luminoso.
D'altra parte questi espe rime nti hanno pure indicat o q uali pro· grassi res tino ancora da realizzars i. Bast i il ri corda re c be in u na lampada ad inca nd escenza ord ina ria, i r aggi st<tn n o tr a il 3 e il 5 p. 100, e che n e lle lam p a d e a d arco la proporzione v a. d a l 1 3 <• l 15 p. 100. S icch è l'emissione d e i raggi in v isibili rappr esen t a u na perdita dell' 85 al 97 p. 100.
Ora, r ito rnando al cas o n ostro, tra la luce na t ur al e, che varia. co ntinua mente p er i n te nsi t à e quali tà, e la luce ar t i fic iale, ch e varia men o, non cade dubbi o sulla s celta . Ma p u r da nd o la prefe re n za a s or genti di luce ar t ificial e (gas di carb on e , gas a ce til ene, incand esce nza ele t tri ca, ecc. ), nell'is t ituire ricerch e im pro ntate a car a t t ere di mass ima esattezza, come so no a p pun to le ricer che sui r a pporti fra ango lo visuale e luce, è assolutame nte indispensabile misurare l'in tensita luminos a. delle sorgenti, che si adope rano.
A qu es to riguardo, devo dire che la fisica dis p one di numerosi a p· parecc hi misnratori, fondati si principi differenti; ma essa non dispon e a ncora di un a pparecchio tipo che di a risulta t i rapidi p e r q uanto s icuri.
L e misure fotometriche, come osserva il R oiti, pres entano s e mpre d elle gravi incertezze; perchè le varie luci h a nno tinta diversa, perchè l'occhio non discerne le piccole di fferenze d'inte nsità, e perchè è fic ile procurarsi un'un ità eli l uce che si mantenga costa nte, e s ia egualm ente i-iproducibile.

N e ll'espe rie nze da me compiute, ad es empio di quant o praticò il C o lombo, feci uso di lampadine elet trich e ad incandescenza.
La corrente è fornita al laboratorio di fisiologia dalla S ocietà Alta I talia. Essa è continua, ba un voltaggio nominale di 240, ed è munita di apparecchi misuratori.
Potei convincermi, in seguito alle numerose determinazioni fatte in quattro mesi in differenti ore del giorno, che l'intensità luminosa
- Gwrnale m eclico.
FRA VISUS t;: LCCE 17
delle l ampadine pe l rischiaramento delle tavole fotop to m et riohe non andava soggetta a forti oscillazioni. E ciò significava per le mie ricerchE'! un indiscutibile vantaggio; perohè è un fatto assodato che Ja costanza nella composizione cromatica. della luce delle lampade ad incandescenza è intima mente l egata all'invariabilità della corrente. In al t ri termini, col varia r e dell' energia della co rrente possono variare le proprietà. della luce.
Per evitare anche le piccole oscillazioni sar ebbe stato opportuno intercalare alla corrente una survoltri ce Thompson. Ad ogni modo, dur ante l'esperienze, se la. cor rente presentava fo rti oscillazioni, io me n'avvedeva, tenendo d'occhio l'indice di un sensibilissimo Milli-A mpenn eter di Harlmann e Braun, che avevo intercalato alle lampadine.
Per misurare l'intensità. luminosa dalle lampade, feci sempre uso del fotometro del Weber, ed in ogni esperie nza tenni per norma imprescindibile, oltre alla. misura eseguita. immediatamente prima e dopo, la comparazione dei poteri illuminanti delle due lampadine.
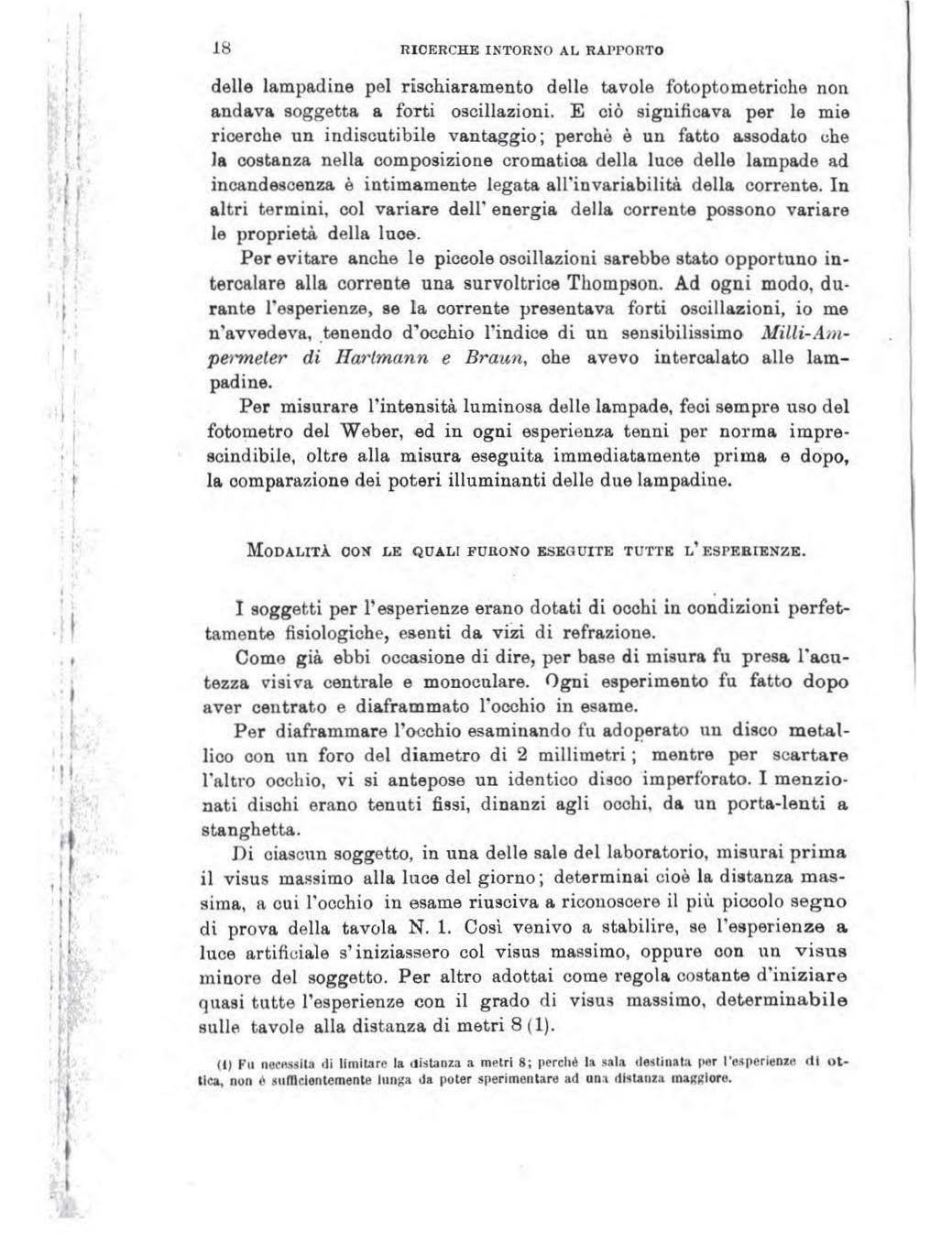
I soggetti per l'esperienze erano dotati di occhi in condizioni perfettamente fisiologich e, esenti da vizi di refrazione.
Como già. ebbi occasione di dire, pe r base di misura fu presa. l'acutezza visi va centrale e monoculare. Ogni esperimento fu fa tto dopo aver centrato e diafr ammato l'occhio in esam e.
P e r diafram ma r e l'occhio esaminando fu adoP.erato un disc o metallico co n un foro del d iametro di 2 millimetri ; mentre per scartare r altro occhio , vi si antepose un identico disco imperfo rato. I menzionati dischi er ano tenut i fissi, di nanzi agli occhi, da un porta- l enti a stan ghetta.
Di c iascun soggetto, in una delle sale del laboratorio, misurai prima il visus massimo alla luce del giorno; dete rminai cioè la dis tanza massima., a cui l'occhio in esame rius ci va. a. riconoscere il più piccol o s egno di prova. d ella. tavola N. l. Così venivo a stabilire, se l 'esperienze a. luce artifi ciale s' iniziassero col visus massimo, opp ur e con un visus minore d e l soggetto. Per altro adottai come regola costante d'iniz i are quasi tutte l'esperienze con il grado d i visns mass imo , determinabile suliE'I tavole alla dista nza di metri 8 ( l ).
(IJ d i ll mlt.'He la a m etri 8; perché lll sala destinata 11er l'esperien ze r ll o tUca, non o s uffi cientemente lunga da poter ad una rnal!glore.
l l 'l. ' l ! 8 RIOER CllE INTORNO AL RAPPORT O
MODALITÀ OOM LE QUAL[ FURONO ESEGUITE T U'rT E L' ESPERrENZE.
Nel cominciare ogni esperienza avvicinavo le lampadine al cartello, che rapprese ntava la I tavola, con moto lento ed uniforme. Appena l'occhio aveva raggiunto sulla I tavola il suo massimo visus, misurato a.d 8 metri, io presentava successivamente le altre nove tavole della sene, determinando p er ciascuna di esse il grado del visus.
Noa occorre dire che nel presentare le tavole facevo ruotare in vario senso il quadretto porta ottotipi, onde i segni di prova potessero assumere diverse posizioni, e che ri chiedevo dal soggetto la designazione esallissima· della sede e specialmente della direzione dell'apertura di quel segno di prova, che egli riusciva a distinguere.
Fra. l'una e l'altra tavola. allorchè notavo diminuzione n el visus, interponevo un intervallo di tempo costante; e questo periodo intervallare fra l'una tavola e l'altra fu precisamente d i tre minuti primi. Non s'i mpiegò un intervallo maggiore, come quello di dieci minuti adottato dal Reymond e di sette minuti adottato dal Colombo, per il grande inconveniente che ogni soggetto in esame si stancava.
Di guisa che l'esperienze si componevano di due distinte parti; la prima consisteva nel porre l'occhio esaminando in condizione di luce mini m& sufficiente (L m S) pel suo angolo visuale (A g V) minimo; la seconda con8isteva n el rilevare come lo stesso occhio si comportasse di fronte alla luce decrescente (o al decrescente contrasto) .
Per stabilire quindi la L m S, occorreva avvicinare le lampadine, sostenute dal descritto carrello, al piano degli ottotipi; e in tal modo si aumentava gr&datamente il risohiarMnento dei medesimi, fìnohè l 'occhio in esame raggiungeva il massimo visus misurato in antecedenza co n eccesso di luce, ossia alla luce del giorno.
Iu ogni esperimento a me interessava (poichè costituiva il dato fondelle ri cerche) di sapere il potere rischiarante dei luminari e la loro distanza dal piano del ca rtello al p rimo termine dell'indagine. Ciò costituiva, come ho detto, il dato fondamentale per la ragione che le caratteristiche del torpore retini co sono espresse da un valore di L mS - a parità. di condizioni sperimentali e di AgV iniziale- più elevato dalla media normale, e da un aumento angolare prematuro, rispetto ai normali, di fronte alla luce e a l decrescente contrasto.
Per. ottenere che l'intensità luminosa. della corrente fosse maggiormente costante, cercai di praticare l'esperienze in ore, in cui non funziona.ssero in laboratorio motori elettrici. Nondimeno per ri cavare una medi a. che potesse rap.presenta.re l'andamento normale del fenomeno, anche di sperimentare in ore differenti.
Finalment.e per vedere se la fati ca esercitasse o no un'influen:.r;a modificatrice sul rapporto fra visus e luce mi regolai così:

J.'RA VISOS E LOOE 19
D ei sette sogg etti, due ( rimas ti sempre a mia dispos izione) venivano a ffati cati, salendo e discende n do parecchie volte per le scale del labo· ra.to r io, le quali dalle cantine vanno al soffitt o, (95 g radi n i, alti iu media cm. 15) con u n peso nello zaino di kg. 28; g li altri cinque venivano affaticati, facendo istr uzioni militari per un dete rminato tempo o marcia di una determi n ata lunghezza, sempre con ar m i e bagagli o.
Perchè l'espe rienz e, fatte dopo la fatica fossero confrontab i li co n q u elle- fatte all o stato di riposo, esse eran o iniziate, per ogni soggetto, sempre co n lo stesso vis us. Così solamen te mi era p ossibile di constatare, se la fatica esercitasse un'i nflue nza modificatrice su l rappor t o f ra visus e luce. Ma oltre a.d. essere iniziate co n lo stesso vis us, tali espe· r ienze furono com piute quasi s empr e nelle medesime ore; e ciò allo di poter istituire un più esatto confro nto.
Ogni soggetto, immediatamente prima di esse re sottoposto a lresperienza, era tenuto per venti minuti al buio p er adattarlo. Quindi p er og ni es perien z a si troverann o du e ind i cazioni, qu el la di occhio malo, e.l·al tra. di occhio adattato.
Riass um e ndo di co che tut te resperienze, i cui risul tat i sono espressi n e lle apposite tab elle, furono eseguite a luce ar tificiale (incand Pscenza elettri ca) sempre con le stesse norme:
a) L'occhio in esame era adattato, ·ce n trato e diaframmato;
b) L'occhio in esame era distante dalla tavola f oto p to metrica m. S .
Le misure delle sorgenti lumin ose (esp r esse in di Hefner-Altenek ) sono state rica Ya t e dalla m edia a ri t m etica di almeno qn&.ttro determinazioni.
SoooETTI P Bn ( l ).
t • Boldrin Antonio, soldato ne l 23• fanteria, classe di leva 18 79;
V::=: : ad ambo gli occhi.
2" Cravero Anto nio, soldato nel !)• fìlln te ria, cl asse di leva 1879;
V - ad ambo gli occh i.
3' Alban o Pi etr o, caporale nel r b ersaglieri, classe di leva 1880;
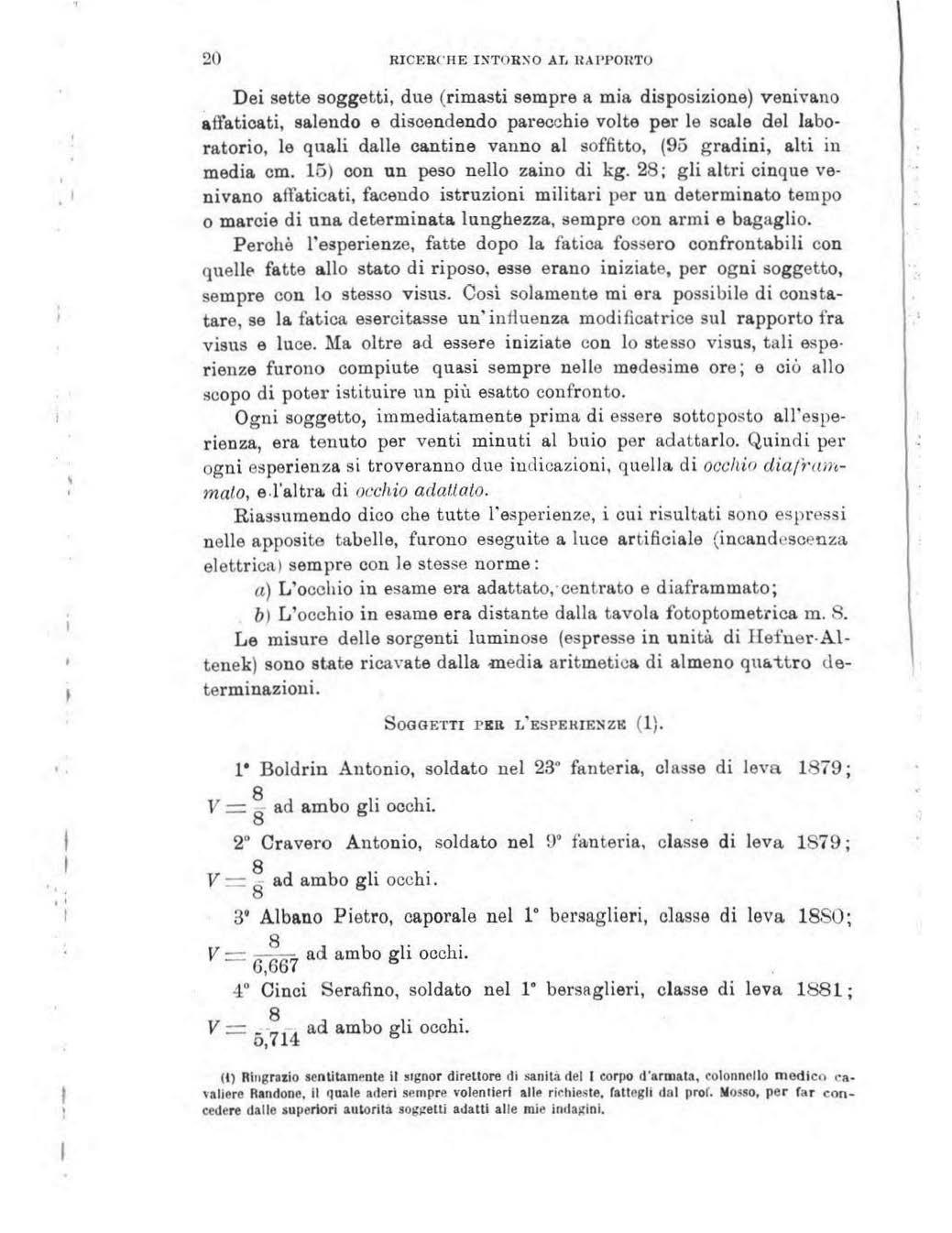
V == a d ambo gli occhi .
4• Cinci Ser afino, sol dato ne l r bersaglieri, cl asse di leva l l:;S t ;
V == ad ambo gli occhi.
(l) Rl ug ruio scnlitamPnte Il srgoo r direuore di sani ta d el l corpo d'armata, colon nrllo medi co .,a. 'nliere Randone. Il quale aderi sempre vol enlierl alle rirhieste. fattegli dal pror. Mo•so per rar concede re dalle 'uperiori a ulorila sogj!etti a..tatti all e mie inda){ini.
' . •, '' l 20 RI CE RC HE IXTOR:\ 0 AI, HAI'POH'l'O
o• Corti Attilio, soldato nel l" b ersaglieri, classe di. leva 1881 ; 1· = ad ambo gli occhi.
6" Montermini Giuseppe, soldato nel l" bersaglieri, classe di leva 8 1881; v = 6,667'
7'' Pera.gine Pietro, soldato nel l • bersaglieri, classe di leva 1881; r = ad ambo gli occhi.
Nelle tabelle, che seguono, sono raccolte l"es perienze compiute sui va r i soggetti.
Quell'esperienze risultate identiche per l'angolo visivo iniziale e terminale e per la serie dei rapporti angolari in te rcorre nti sono tra loro riunì te.
Le colonne, in cui c iascuna tabella è divisa rappresentano rispettivamente :
Co lonna A - Giorno e ora dell'esperienza oppure dell' espe · rienze a.llorchè queste per l'identità dell' Ag V iniziale e terminale e dei rapporti angolari intercorrenti il primo e l 'ultimo termine si sono potute riunire.
Colonn a B. - Angolo visuale ( .1g V ) a l primo termine della o de l l" espe rienze.
Colonn a C. - Angolo visuale al primo termine assunto come unità.
Colonne D, E, F, G, H, l , L, 111, N. - Rapporti successivamente assunti da ll'angolo visuale con l'angolo visuale del primo te rmine, posto eguale ad uno durante il corso d ella o dell'esperienze. Queste colonne corrispondono ordinatamente alle nove tavole, con l e quali furono compiute l'esperienze ( 1).
( I l In luogo tlei cal•:oli del Vis us si sono mess i i calcoli basati sui valori • eali del( li a n(o!oli visuali.
È facile rico!truìre l'!'lperienze, il m e todo or t.llnario; basta ai va lori dei rapporti quelli rtel •·lsll!l in frazioni d ecimali.
l visll!l Iniziali <Ielle espe rienze wno trii:
l . s "'' R v- s __ = 'i ; = 6,667 ; - 5,714

In rrazio n1 deci mali si hanno
l' = l ; l' = t.l ; l'= 1.4.
Prendentlo. ad esernrio, on'esporienza co n 1 isu; iniziale. C!(Uale arl l, nella quale al 4° te rmine SI trovi un rappCJrto di = 1.56, pe r sapere qual e l'isus vi corrisponda in dc.:imah. si sta· bi lisce la proporzione
11 x : VI =l : 1,56
l Vx = 1,56 = O,M
Co.!i. per portar e nn altro esempio, si prenda un'esperie nza eoo iniziale = 1,4, nella all 'SO termine , 31 troVi un rapporto = '!.19, il ••is us in rt eci rnali sara dato Ja
FRA VISUS E LU CE 21
E SPERIENZE.
quale
Colon na O. - Angolo visuale all' ultimo termine della o de ll'aspe · rienze.
Co lo11 n rt P. - Valore medio ( l ) del risc hiarai:ne nto delle tavole du r ante il co'rso delresperienze, espresso in unità di Hefue r-Aiten ek . Allorq uando parecchie esperienze sono raggruppate, il valor e di q u es ta colonna rappresen t a la media aritmetica d e i v a lori d el rischia ramen t o d i c iascuna dell'es perienze ste3se.
Colonna Q. - Riguarda esclus ivamen te gruppi di es p erie nze Compare in essa la di fferenza fra il valo re massi mo e il v a lore minimo del ri schiara.mento, che entrano n ella somma dei d etti valori, d a lla qual e fu dedottA la media aritme tica, che fig ura n e lla colonna P.

Colonna R. - I ndi cazioni di cond izioni specia li, in cui furono compiute alcune esperienze.
L'ultima delle tabelle. la quale è stata desunta dalle preced enti, s i riferisce all'esperienze di confronto per vedere l'influenza modifi ca t rice della fati ca. sul ra pporto fra visus e luce.
Nella. tabe lla, in cui sono riportate l ' esperienze di confronto, la. colonna Q indica la differen za di risohiara.me nto d elle tav o le prima e dopo la fatica. .
(t ) 1 Yal o rl d el riscluara mento fur ono determina t i pe r cìascu no de i SPg ni o u o me lr ici con tenuti neiiP ta Yo le usa te n elle n cerehe, secondo la no ta formu la n - l co•. i d •
Il c.1 leolo <Il q u es ti ,·alo ri \'e nne per cia <cu no de i d ue lum ma rl 11 per ri a.;eunn rt elle Jl(hid onl da e:;,;l occu pat i, n s petlo a lle tavole a l ioiz1a le d'ogn i slug la e.•pe roe nza. lA! ta vole furono aempro nc ll 'o3cc uzoo ue di calco h , m (Jos11lu nr m•rm ule, coo., rullfl due lm···· o rlno nlah llrn llauto l'aptrtura tlc l fra l segn i o lt o me Lr ici, r.onten ulo m eu e. pa ra lle lamente.
Pel rno •IO, con cui furono de r ova ti l valori c he co mpa iono nrlla colon na P. con O n. s oldato B·•ldrl n (3 1 - o re 15.30). Per qu e, L'espe r u·u m Il va lore Ile i JUltll re rischiara nte de liA •lue so rs:enLI di Luc'!, es presso in un ita di Hefn r r ora l.a d o;Lantn d ci lun u na ri dal plano, ove erano IH LaYtJ ie (misumla sulle normali co nrlotto tla ciascuna luminosa su qu es ti) plano ) e ra di m 0 78
l rtl pro ••a riconosciuto sulle diiTr rentl tavolo de li Ase n o de ll'occhio esaminalo nel co rso di IJU Cll t'espr rlenza furono o rdlna!nmento quoll e ch e corrl s pomJono al seguenti
La somma olel due coemclenll d i ri;chiaram e nto (clou de i l'a lorl d i r-o;; 1 d cte rmona to p er cla<eun
. .' ,, l i l ' 22 TNTORN O A r. RA l'l'O RTO
r - .s - 8 IO
811.1 t , 8 r s = tul!5 , ,_ 8 ' - 50
V=-
Nel corso delle mie esperien ze ho osserva to quanto era stato notato dal Colombo nelle sue numerose ricerche in questo campo, cioè:
l o Il valore di luce minima sufficiente non è una costan te per i differ enti occhi, e n eppure per uno stesso occhio in istato
2° Rip etendo le misure sopra uno stesso occhio è facile trare una certa costanza nei valori dei rapporti angolari, che corrispondono alle diminuzioni d e l contrasto; ma nessuna legge di gener!ile applicazione regola la successione degli angoli dall ' iniziale minimo al terminale massimo dell'esperienza. .
Per parte mia. debbo rilevare pure che le differ enze f ra i valori d i L mS per uno stesso Ag V raggiungono, alcune volte, per l"occlrio di uno stesso sog getto a.ftitt icato gradi notevoli e superiori a. fJUelli che si osservano in condizioni fis iologiche (1).
ln base all'ultima tabella., ricavata dalle- al tre - di confì·o1l lO - mi è l ecito di affermare che
A parità di angolo visuale e di adattamento retinico preliminare e di diafra.mmatura, gli occhi dei soggetti affaticati ric hiesero in generale valori di Luce superi ori (e in qua l che caso no te volmente superiori ) a quelli ri chiesti dagli stessi occhi, allorquando i sogg etti n on erano stati affaticati innanzi di sottoporli all'esperienze.
I ri&ultati sperimentali permetterebbero di hsserire che gli occhi di soggetti affaticati dimostrano una delle carat teristiche del to rpore retinico, ritenendo questo, p er d efinizione del Reymond : c uno stato par-

luminare In quella posizione dei luminan rispl'tto all e tavole) é rappresentata tlalla seguentu ;Il valori, c he c orrispondono no differenti ottometricl:
La so mma di questi valori é espressa da
K la modla aritmetiCA da
l\ volore 111 t,80t rnppreseotn dun11Ue la m edia !Ielle so mme dei eoenleientl di ri• chiara mcn to (va· lou dt i per tullll di prova c he hann o ser vito a quPst'e;periensa. Questo valor e mollipliento
Ptr '·H la rormola Ilei ri.11chia ram e nto ptil sop ra r ico r daL•J darà il mellio rtel rlsehlarame t.u degh ouotipl o•Mi n e li"•'-'!Per it> n 7.n con O D del solda t o Boldrln di sop ra menlionat.a.
So noti poo che per cla<eun liCjlno di prova l valori rt el eo•fficien te Ili ri,;chlaramen to v•nnero llelmnon•to pet poot.o d'mcroeio tltlle lliago nali d el quadrato che rti JlJlrPst•n ta la degli a nelli.
Ch C4•fronta - E4perìenle t e 3 gwgno con q u t ile del 7 e 18 gi ugno del soldato Cravero.
FRA VISOS E LU CI': 23
CoNCL USIONI.
U36 V9t i,St3 !.774 t.i37 i ,863 16 814 :i,Bre
tioolare d e lla. retina. per cui E'SS&. a vrebbe bisog no di essere impressionata da una luce più in ten sa che allo stato fisiologico, perchè il sensorio p ossa. raccogliere un ' impressione distin ta 1),
Ma, si ccome è noto per gli stessi st udi del Rey mond, un altro fatto concorre a caratterizzare il to rpore della r etina, ed è l'aumento angolare prematuro, richiesto dall 'occhio a reti n a tor p ida in confronto di un occhio in condizioni no rmali risp etto alle prime d iminuzio ni della Luce iniziale ( LmS per Ag V iniziale dell'esperimento).

Ebbi ocas ione di constatar e qu esto fatto una sola. vo l t a in tutta. la serie delle espe ri enze, da m e compiute, e precisamente nell'es p erienz a del 5 luglio su OD del soldato Cor t i dopo una marcia.
Merita di ricordare, a questo proposi to, come tutte q uan te le mie esperienze siano state invariabilmente preced ute da un p eriodo di adattamento alrosou ri tà di venti minuti. Sarebbe f orse p ossibile la dimostrazione intera d ei fenomeni che carat terizza no lo sta to torpido della retina, qualora si r itentassero l'espe rienze senza farl e precedere dall'adattamento degli occhi
Il fatto che posso affermare in base ai risultati sperim entali, c10e la necessità eli una maggio;·e luce, l 'occhio del soggetto affaticalo ,·aggiunga quell'angolo t•isi·vo, i l q·uale dete1-mina in n ormali il su o pote1·e di m 'è sem brato tuttavia degno di un certo interesse tanto dal lato scientifico q ua nto dal lato pratic o ; e però ho voluto r e nderlo noto co n questa pubblicazione.
Torino, ottobre 1902.
24 RICERCHI':
INTOR:-<0 AL RAPPORTO l''RA VISUS E LUCE

DELLE
Giorno e or a d e ll' es pericnM
., c :! .-;; > ""< A l B
., . 6 o u s c ;; ., >·= "'" <
Rnp JIOrli s ucr.essivamenlc assunli dall'Ali\"

' § o
t.!! _-.: ;= ,. ;; &.. ..:..c:. 1;-
Condizi oni specia li n·•lie •1uali rurono compiute alèun e es perienze p l o 'l> _ l E "F! - G IH ·r-1-·1 L l M l N l _.!.._ c o R
ri<petto a q uello del l ' t ermin e eguale al l 'uni t a
So'dato B oLDHI N - Es ptrlt t!Ze eseg"ite cotl l'o cchio deot ro , adatta t o e dfajram mato.
Sl.V - b. 9,1 5. SI. Y - b. 15,30. I l . I l 1 , . » l' l )) i1.25 l) l D ., 1.25 1.39 11 56 2.08 16 25 1.89 \ 1.56 l) 1."18 .6.25 6',14' ',99 1 1.101 • ()' ,14",99 11.881 , 2 v l - h. 8,30 . 3. VI - b. 8,30. 2 . Yl - h. 9,80 . 5 '\' l - 11.15,90. 2 YJ - b. 15,30 S. YI - b. 15,90. 2. YI - h. 18,30 . 5. Y I - b. 9,30 6 VI - b. l O lì. YJ 7 VI h 16,30 . l' l ' l ' l' l ' l ' 1. Yl l - b. lO .. l l' - h. 16,30 . \ · l l )) l ,, >l l )) " l )) » 1.25 1.25 1.25 1 1 39 199 1 ., l 1.56 l l."i'8 ;117 : 4' ,10'' l :39 l.5G 1 56 i.J n . 4 ',10" )) 4.11 4',1 0' ' n » 11.25 1 l) 11.311 l b 13. 125 9',7",5 l 25 )) 1 39 o) 1.56 4.1'7 4',10'' )) l )) l 1.25 l )) l l 39 1.5\i l " 4. 17 4',10" 1.25 1 J.:!!l 1 L5G 1.78 lu25 6',14",9V Ha rauo 60 1·o ite le scalo. col peso di 9 .iS 5 .1 5 kg. i 8 sulle srallc. 9.19 10.01 )) 8.971 8 .79 '7.84 Ba !nlt.o 40 I'Oite l e eo l peso dl 1-g. '!8 s ulle Slmllo. 8 .i:3 l Ila ratto 65 • o lte lo sca1e, col peso di kg. 28 sulle spalle. 1.051 l lh fallo 45 l'oll e le s cale. oltre quello d e l ma limo, rol prn;o di kg 28 s u lle L-::1 C) ('l l'l l:d ('l :.; t.>J .... z "'! o ;o z o > t" Il> "' " o
S o l da t o B o i, DI.liN - E sp erie·u e cug u ile co11 l'occ lliu Htt i &lro, adattato e diaf ra mm ato .
28. \' - h. H,SS . l l '
3 1. v - b 9,45 .

-
.
. V I - h .l
. l
G. Y I - b . 9 . . l l '
VI - b. 9 . . l l ' '7. VI - b . 9 . . l l '
. VI - h .
l l '
18. ' l - l• I li 8 . V II-
9 . l' l l ' l » l l o 11.25 1.:t:, 1 :J!II· .. · ··1. 11 )} , 1 3\l , • 156 12 08 !4 11 .J', l v" 4', 10" 1 1.:115 l 5.88 1 • 1 11a 1:u1 u • ollc ,,, sc•llc , col peso d i sull" s ;•.llle. l)
Il
6.
2.
3
7
15,30.
l'i.
Hl 8 Vll
h. I O 18. Y l
h I O : : l
.·l l ' l ! )) • l • ' l 2 5 .. l o l 25 1 .25 , • l 39 1.39 , 156 2.08 14. 17 4', 10'' 1.39 » l l.'i8 , 6.25 6',14'',119 l 56 1 l.'J8 2.08 ;6 .25 6',14" ,99 :·::1: l l l 9 8 4 " l )) • i l 25 1.39 1.56 • 1 1.78 14 17 l 4',10" 7 G8 2.85 ' l l t . l >) l • l l 39 1 l l l l l l l Ha fatto 60 volle l e scale, col peso d i kg ! 8 sul le ,;pallé .:"'!l" 1 4.1 ' :4',10" 1.401" '' , )} 11.5 ò l4li i 4',1 0" , 8.6l >) l " l> 1 1.25 1.25 • ·1 1.3<) 1.39 ,. . • l 25 » • • 1.2 5 ' l >) 1 1.25 ,, l • 1 1.2 5 " 1.39 11.56 l l .:i9 " l 39 " • 1 .2 5 ' " 1.39 1.25 )) l 1.3!) 1.5li l 'i8 6.25 6' 14" 99 9.56 • J ra tto 40 volte le o llrr 'f UPiie • 1 del •na ll iuo , w l di 28 s u ll e 1.39 l U)(j 1'3.12:> l 5 () l • 4.17 l l.:HI(U?5 l. ùG Il.18 . Il5 6 14.1 , ). :,1\ 14 1'i (l.\)4 1 )) l ·1',1 0" l (\ 9 4 • G ' ,H '' ,!)9 10 .i31 » 3'. 7",5 6' ,14'',99 9 (l:J spa ll e. fl:o fatl o 65 , oftc :e scah•, col peso di
>Palle Ha ratt o 45 '' olte lP s ca le, col peso d i sull o Sll:ol k r l ',l {)'' l 7.!'3 4 ', l ll" )0 119 l 1.\12 ,, lRa fa t tn i5 Vlll l• ' le sca l<', col peso di kg . sull e >l'a ll e. ":: ::0 .. cn c ID l'l o l"l l\:) ...
3 1. v
4
16 l ' l' 2. VI - b. 9,30 . l ' 2. ' ' l - h. l S. \' ! - b \l,SO. 5 V I - h IO,SO 5. \'l - !1. 16,30 .
\' l - h. 15,30 . l'
VI -h. 16,:JO . l l'
6,30
l'
5.
VI - b .
-
-
'
' " " "
Soltlat o CnA vKno. - eugu i t c cotl l'occltiiJ destro, adattat o e d i aframma lo.

- - ---- - -· --.. l .:l 00 2 ;..
Cuwh7.10III
E - :> c
o
. - --·-;:l
Ra ppor h ....... , .amt nlf' ;a... 1h.ll \ \ ;! \ o
speriah
ora 3 fl'lll'ltfl o 'IIICIIO -:- •tuall flmmo 1h•ll' e<pr r io•ltZl r. "' "' •lei 1° trr111lnr all'uuit;• akune e,pr rh•nze > >:;:: >-= >:?:: <"' < <-
--l l . \ l Il c Il E p G H l l l• N o Q l n
o ['l ::;) G 28. y - h. 10, 'l l' l 2;) •• 1.39 1 " I l 3.1251 S' l » " . 13 25 l) l l l ..... Sl. V - h. 10t3;,' l' l " . 1) 1.2;) " 1.39 1 UG 125 3',1 ', 5 13 38 • -l 3 1. v - h. 15,50 . l l' l l jJ.2;, •• I l l.flli 1208 4. 17 4',10'' 114 25 Ila ratto JO I OIIù h• :1 l'Olio col o " " • IO pesu eli j8 Sl•a lltl. z o 2. Yl - h 9 " l l' l t) l) ' 1 2;, ,, ., " l.:'!!l 1.1 8 3 12<J 3't7''t5 11·1 Il!"• Q !>c2. "l - h. Il ;o l l ' l 1.2(> l,:1!) ,, l.::il'o ('125 :l't'";"t5 16 91 f>.l i3 :;. .. Il .. .. "Cl 2. \'l- 11.15 l è l l l l l 2;) 1.39 • l • l, "6 3 125 3' 7' 5 ;o 2. VI - b. 18 Il >) " 2o.Gi • ....: ' l l t t 6 3. VI - h. 9 l ' l • " l 25 .. 1 39 • 1.5G l 'ì8 4.11 4'tl0" 29 8 1 l) Ila r.1 11o 30 ' 'oltc tr I'Oitc col l.:l!l • l 56 14 li 4', 10'' \li sulle Sf'atlc. 3. Yl - 1• 1;:; .. , 1 1 • • " l • • » Ila ratto 21 le ,c3le, rol 1•eso di l l l ' kg. il! >U II P opa tle. 5. VI - h. !l l l l . . ..... il. VI - h. IO .. 5. VI - b. 15 . . l' l " il )) 1.2;j >) 1.3!1 1 1.:16 13.125 3't7' ,5 19Auj 9.Sti s. n - h. o,so . ) / l l 2:•. li. \'l - h. l G .. l l' l l ,, 1.2:. " !.3!1 1 :,r, " " ,·l. l'i 4',1 0' , _ ___ ---n- h 11.:10 n , l
Soldato CR AVtmo - esegu i te co11 l' occhio si 11 i8lro, adn ttato e diaf ra mma/o. 28. v - h . 15, 30. l '

Ila ratto 30 volte In scale ; 5 vo llo col peso d i s ulle spal le . » l Ha fn ll o 30 l'o lte te >cal•·; 10lte col l"'so d• kg. s ull e ;pa ll e. l .. l l la ratt o 30 I' Oile le s<al e, o lire que lle del mau mo, cui peso di kg s ull e
"
l
Il a f•llo altre 35 vol t o• le scal e, col peso l di 28 sulle s pa llu. u.<'5'
Il a rauo !:. l Oli o• le scale, co l veso di il! su lle spalle. :? 1 37 :.!O.u5
Il:• fat t e Si! l'ol t•• le scal••, co l di sulle
17. V I - Il l i>,:JO. 18 VI - h. 9,30 SO VI -b !l l' /' l ' l l , 1 l )) l l 25 l) 1.:2:/ l) ' 1.25 u » 1.3 9 1.:.!9 l ;j\) l " ;3. ! :?5 " ' Uit> 171 :3 125 3',7",5 •1', 10" S',7•,:; J 7 :Il 20 sa 26.6 2 l) l lln fa llo Vlll l e l e scale, col peso 111 '!8 s u lle spa lle.
h. 10,10
l' Sl. V - h
16,30
l ' 2 vl -h l o . . l' 2. VI - h. 16 l ' 2. Vl - h.l9 l ' !l. v l - b . l o l l ' 3 V I - h 16 l l ' 5. VI - h. 16 u. VI 6. VI '7. VI 7 . VI l ' - h. 8,30. l _ b . 15 . ·Il' - b. 8,:30 . l \ l t - h. 1 5 l 1'7. \'l - h 16 30 . VI - b. 10 l ' 18 . VI - h.l 0.30. l' l » l ,, 1.25 )) )} JJ 1 .n \) l) l 4 l • l l 1.2 5 1.25 1 1.25 1 1.25 1.:?5 1.25 l) l) l 1.:25 1.25 ' ! 1.2;} 1.25 )) )) l 39 » Il Ul9 1 .2:1 » 1.25 l 3!J ,, » 1.3!) 1 1.56 l l.'i8 13 125 " 11.56, 1.78 13 125 1.:.!9 l 56 1.7 8 r l.1 7 l 3\J 1. 56 1.78 ,:3.1 25 1.3() " 1.39 o l.vG r l.J2,> l 56 2.08 4. 11 1.39 1 • l 1.56 1·1.1 1 1.3() 1. 3H l '' Il l 1.56 l 56 ' :11.2;) l.5 ii 14. 17 D 14 .17 l.:l\1 l.:l\1 " ' 1 3. 12r>/ ,, l ;}li ·l l'i l 3',7' ,5 3','111,5 4', 1u' 3, - 1r,l ,OJ :3',7'1,5 3','7'',5 4',10" 4',10'' 3', 'iu15 ·1',10" 4 ',10'1 :r,1",:J 1', 10" 1 3.38
:?1.9
Ht 5 IS.:m
31. v -
.
.
.
1 l) 1 12 43 l . 2 5.27 17.7 1 1·. 23 SI
4 .32.1i l 32.'; 1)
1.5:? l 3 .5i
l>j ::0 :>< !il c: (J) t'l (') 1:'1 1.-:> 9
---o ... ; 3 -= -"' succes.<irameute dai i'Ag\" .,.., Gondizi •· ni
o Gioruo e ora E
rispelto a que llo "' "' ndl c c1 uali compi uto d oli' o-pencuza c::::: N c -;:; d el 10 te rmìn r eg nale a ll'unità "'" e al cunu C'perienze > :.,..; ..=.-= :.. -te <:< 5 :,; Q .. < -l l l l l l l o- 1- .\ l B c o E F G l H l L 111 N o l' R
Caporale A lOANO. - Bsperie nze escgu1te co 11 l'occhio destr o, ad •ttato e d i ajramm'lto.
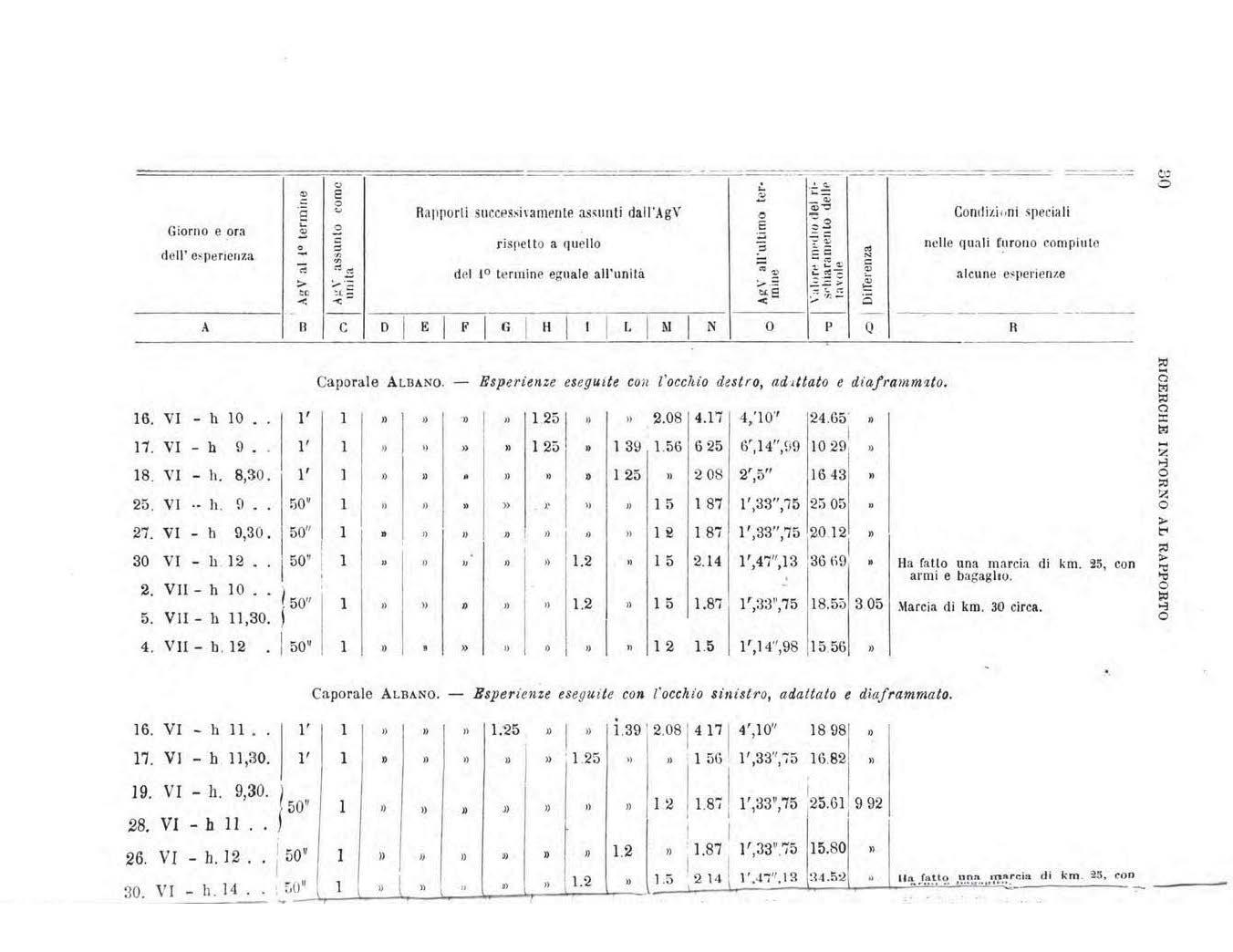
i!
:
l l 2.08 4.li 4,'10'' 16. VI -h 10 l 1 " l • • ,, 1 25 •• >) 24 G5 • 10 29 1 11 . VI-h 9 l' 1 ,, " )) • l 25 • 1 sv 1.56 6 25 " 18. VI - h . 8,30. l' 1 • • . • .. b l 25 )) 208 2',5" 16 43 • 9 GO' l l 87 1',33",15 25 05 25 VI ·· h l .. •• • )) ,. " .. 1 5 . 27. VI - h 9,30 . 50" 1 • " )) • .. • l) 1 e 1 Si l',33",75 20 12 • 2.1 4 1',47'',13 136 ti9 1 • 30 VI - h 12 50' l u " " • )\ 1.2 " l 5 Ha ratto una marc ia rli km. 25, co n 1.8'1 11',33",;, 18.5>1 '" armi e bag aglto. 2. v Il -h l o l 50" l • " o ,, ., 1.2 " l 5 .\larcia di km . 30 circa. 5. VII- h 11,30. j 4 . V II- h . 12 l 5o' l • » , o • n 1 2 1.5 1',14",98 15 56 Caporale ALBANO. - Esperienze esegu i te con l'occhio sinistro, adattato e diaframma/o. 16. VI - h l l . .I l' 1'7. VI - b 11,30. l' 19. VI -h 9,30. / 50" 28. VI - h 11 .. 26. VI - h. 12 . 50V 30. v l - h. 14 . ;,()' l >) l » l l) l )) l " l) " 1.'25 " )) Il l l) l) J) Il )) •> l » l " n • l )) 1.39 2.08 14 11 4',10" 18 98 o " ' 1 .25 .. .. l ;>6 1',33'',"75 1G.82 .. l 2 ! 1 87 1 1' 83' '75 1 25 61 . 9 92 l) ,, )) l \ ' l l l » o 1.2 )) 1.8'7 1',33' .75 15.80 » l .. 1.2 • 1.3 2 14 1 1 ',.!":'1.19 . 11 f!..fnU9,. ,':l.fta.. da di km l:S, I"OD o :0 ò t<l :0 o x t<lz ..., o ;ò o > 1:" :o > ..., ..., o :0 ..., o
CJNCJ. - 81perienu esegw ite con {'occhio destro , adattato e tiiofr ammato.

:l \ ' IJ - h l o . . ( 511' l . l l l "l lls. 10 1.,11 ,rl •l 'a rnH, l Il l .. l .. l ., l ' :l ' . l:> 1.87 l ',:lS",;:; 2299 •.t..-11•• :t a li• • :1 . \ Il - h \ l l l 1:: Olll l lllO l , Marr1;:t. di km SO drr&
lG \ ' l - h. 14,30. l' l • l D l • l " • l " l . 1.:16 4 17 4', 10' 13.34 1 • 17 V I - h 9,30 l' l l R l) l • l • o » o 1 1.56 1 1',3 1•.75 13 2G I » 18. VI - b 8 .. l ' l • .. • • o • >l 1.2:> 2 .08 2 ',5'' 11.51 l • • 1.40 1.75 , 2.19 1 1',33' ,'15 11035 25. \'i - h 9,30. i''' t l o 1.1 1 l • » . . 'l 21. V I - h 11,30 . u'','> l o • 1.1 'l • • • 1.94 1 2.19 1 1',33",15 i12.GO j !lO. VI - h. l l,30. n•,so l Il " 1.17 • Il • 1 1,40 o 12 ,19 1 1',33",75 121.08 1 . f3tlO marrla 111 '!5, con armi e 2. v Il - h. 10,30 4! .. l . Q • • u 1.1'1 • ! 40 2.19 1',33' ,15 1623 1 .. SI:< t•• all't<lllt7.o In pi a7za oJ'armi, dalltJ 5 allo• 9. l IO- 4 . VII- lt 11,30. l Il ,, l) 1.:71 o •l 1 1'1 n 1 1.9 1 1',33",75 SlR " • >) l.'lO 1.75 219 1',33' ,75 13211 <l 5, \'IJ - b. 10,30. a•,s.. l Jl Marcln rll 30 cirrn. (il Il l) Il r. rn l'l Soldato - l!.•perit lltt euguite COli l'occhio si11i1t
adattat o e d iaframmafo. t" c: o ["' 16. VI - h 15,30 . l' 1 )) " l) Il l » i l.:)!) l ;;6 Il 4.1 1 1 4',1ù'' ' 536 1 • l 17. VI - b 12 . l' l • • " » l • l) l . 1.25 2.5 1 2',30. 10. 191 n . l 9. \'l - h l o . t!",l.; l • • 11'7 • • 1.40 ·• 1 9 1 2.19 1',33•,j5 9 44 . ' l · 1 1.17 , .. 26. VI - h. 11 30. i!'' ,h l • " . \') - h. 11,30 . l l) l u l • • o l 1 1 li l. i> :. 19 l ,33 1 r5 1 14 6i> » 30 \'1 - h 14,30. n',•oJ l • i IJ l Il \1 • • t l.40 » 12 .19 ! 1',33',7:> 3349 ' Il a l.> tl n mHd a di t ;; ron l arnu e l. VII - h 10,30. ll'',Soi l ,, l Jl • • • • 1.17 . 2 19 l ',33'',75 28.1)0 • Sll\IO illl'l•t r uttvn8 in tl'Rrmi, l l •l"lle S all t 9. 3. Yll -h 11,: o. l • D l • o • l.li ,, l 94 1',23",34 1:?.43 • t': anol,l!o all'rolru710 ite 5. \ ' IJ - h 14 .. l ·"l l 1.1'1 ' 1.40 1.75 2 19 1 1' ,33' ,";5 20.22 • di Lm 30 cirra. (.1: . l) l) " l ..... .....
ro,
. - ·--· ' --------- ------- w c ' 4)
O) E " o ... Rapporti ass unti •l:tii"Ag\· o """ Condizi nni specia li 'Co Giorno e ora l g ·E oo c ri spetto a •1 urllo nelle (Juali furo no compiute ii: "' dell'esperienza - e;:; N c "' del t • term ine eg uale nlcune tspericnze > >·;: E.::> "' eo ..,- ttC "'" "' l::: < <" <- Q -- --- - f":\ l n c Il l E F G Il l L N o p Q l R
Soldato C ORTI. - E3p er ienzc eug 11ite co n l'occhio destro, adattat o e di(ljl·amtila to .
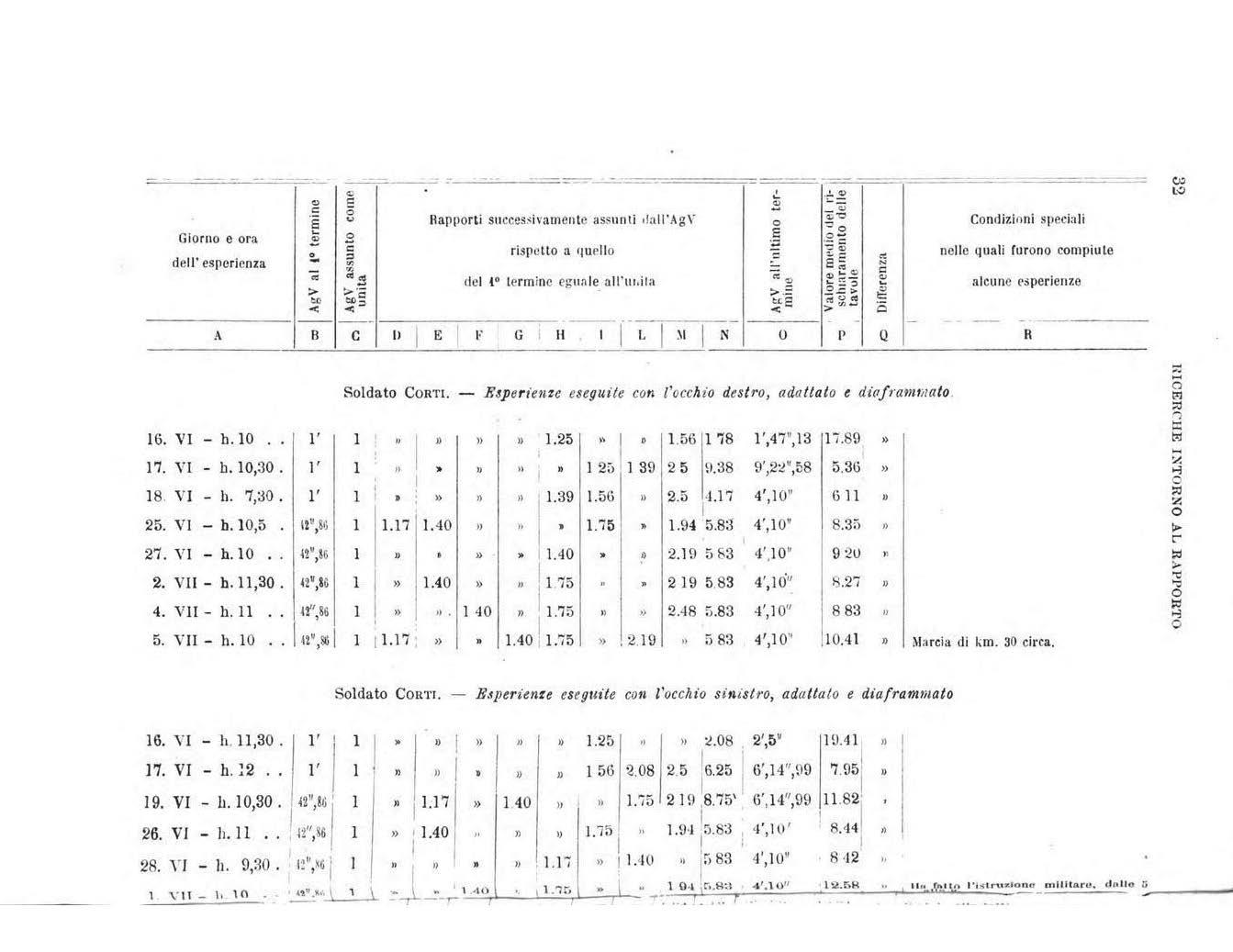
l-:>
...
-
"
C'l t'l ;:j r') 16. VI - h. 10 .. l ' l " l » n » 1.25 " l • 1.56 l '18 1',47' ,13 17.89 " t>J .... 17. VI - h. 10,30. l ' !1.38 9',2:!',il8 5. 36 Y. l " » • >l " l 25 l 39 25 )) .., o 18 . VI - h. 7,:30 . l' l • » » )) 1.39 1. 56 l) 2 .5 417 4',1 0" Gll • ;:j l . z lu1 o 25. VI - b. 10,5 ll' ,&ol l J..I O )) " l • 1.15 • 1.94 5.83 4',10' 8 .35 » t.>r 27. VI - h . 10 n' ,&6 l » • » » l 1.40 . o 2. 19 5 &3 4',10' 9 :!U n i:d Il,.._ ). 2. Vll - b. 11,30. n•,s& l l 1.40 2 19 5 8 3 4', HÌ'' "d " » » l li) . . » "' o 4 Vll- h. 11 u",ss l » l 40 1.75 2 .48 5.8 3 4' ,1 0'' 8 83 » i:d . . .. . " l) " .., o 5. VII - h . 10 . . l 11.17 ' l) . 1.40 1.75 l) . 2 .10 ,, 5 83 4',10" 10.41 » dì 30 cir ca Soldato COilTI. Esperienze eug11ite co n l'occhio sini st ro, ada ttato e dìaframmato 16. YI - h. 11,30. l ' l l l » ! l " » 1.2:> .. " :!.08 2',f>' l !J.41 l) l 17. VI - h . 12 .. l ' l t " " l » » l 56 2.08 2 5 :6.25 6',14'', \19 '7.!l5l l 19. VI - Il. 10,30. 12",M l 11.17 » l 40 )/ " l.'i5 2 l !l 8.75' G',14'',99 11.82 26. Vl - h. Il .. H'', S6 i <l', l ll ' l 8.44 1 l l , 1.40 " n )/ l. i5 • . 1.94 ,5.83 ,, l l l 28. Yl - h . 9,:l0 . 1'' 1''<r 1 l Il •• • Il . 1.1 i )) l 1.40 ,, IG83 4',10" 8 •12 ,, . ' ' l l l Y ll - \, 10 + .. . \4ò .. _ 1 0 4 1 lr._S!.J 4 '.1011 \>t.6R .. ll u ,'):lt n J•l.çtn.1dono nlllttaru. d n llo li--..,.-. . .. . . .. t
Soldnto MOISTERMllSI. - Espe r ienze eugu i t e con l'occllio #nillro , ad4tta to e diaframma/o.

:$. \ li - h ll,vll .l.:, 5. \'Il - h. l:J a•,,, ' 1 n/ .. l . • • l .l • l v l .. '. 1 l •IO l. i:> • l :!.IU l • 1:>.83 <! ' ,Hl ·- "l Il :1:, l. ::.O l.llU .l&lo4 ._u k1n. 34' d rca Soldo.t o i\loNTKR:-tJNI - Biptrien •e eseguile colf l'occhio deJtro, adottato e diaframma/o w "" W. VI - b. l' l l o )) . • 11.25 » l » 1 1.39 13.125 S1,7 u,5 114.15 a· ... 17. Yl - h. 1l l' 1 .. • • » » 1.25 J) 1.39 12.5 2',30'' 32.07 ::. .. 18. YI - h. 7 .. l' 121.81) :! l • • • • • l 25 Il 2 08 2',5' 2>. VI - h 10,30 'l l ' i l 27. VI - h. 10,30. l 30. VI - h. 12,30 l:l<'' l • » » o " \) 1.2 » 11.05 2 5 2',5' 22.03 12.3R Ha fl1t10 una marcia di km. ;!5, con armi e baf('•GI•u· 4. 'Il- h . 12,30. 5. y Il - b. 11 .. . l l Marcia di 30 km. ci rca.
16. VI - b. 12 . ·1 l' l l " " 1 25 ' • )) l) 1.39 12.05 1 2'.30' 12G.441 : l 11. n - h. 13,30 . l' l 1.25 Il l 56 208 2',5" 15 17 » J) l) . l) l 19. n - h. 11 .. ' l 30 VI - b. 13,3(1 ./ l Ha ratto una marcia di km. !5, co n arm• u oaga ,; llo . . 50' l " " .. )) )) 1.2 , l L'i 25 2',5'' 33 42 8 6·1 l. VII- b.ll,SO. l È stato In piazza d'armi, l Llalle 5 9. 5. ' ' Il - h. 14,30. , Marcia di km. 30 circa. 25 VI - b. 10,30 . !iO' l Il » )) • )) l 2 Ui • 25 2',5' 14.78 )l 28. Yl - h. 10,30. 50' l l) li . • 1.2 • » l 5 12 .5 2',5" 14 52 2. Vll - h. 11 .. lu:s l l lÈ stato alla t t ltica. 50' l l » n » " 1.2 • . 2.5 2',5' 2S.SS Ul8 4. VII - h. 10,30 . l , ::l ).. <! u; <": tJl t'l t' <": /") l'l Cl> w
Uto rnn c on 11··11' -A lG . \'1 -h . 15 l
--., c :; E u Ra ppo rll assu nti •lall 'Ag V o -=o Co nrhti oni :: ;:! :. " ri.;petlo a quello :; .. nelle quali rurono compiuto 7 N .. ,.,_ dt• l t• all ' unità .. ., f .::: : e al cuno c;perlenzc > :,] > .: @ e• ::> !:;,(= Q < -c: ..,- -- - -- - -- --n c: u l E l F l (l Il l l l f. l M l :-; o p Q n
Soldato PBR AOI:SE. - Espe rienze t sepll ile co n l'occhio destro, adattato t diaframma/o
Soldato P rmAO I:>E. - Bs perienze eseguit e C<l ll l 'occh io &iJ1istro, ada/lato e
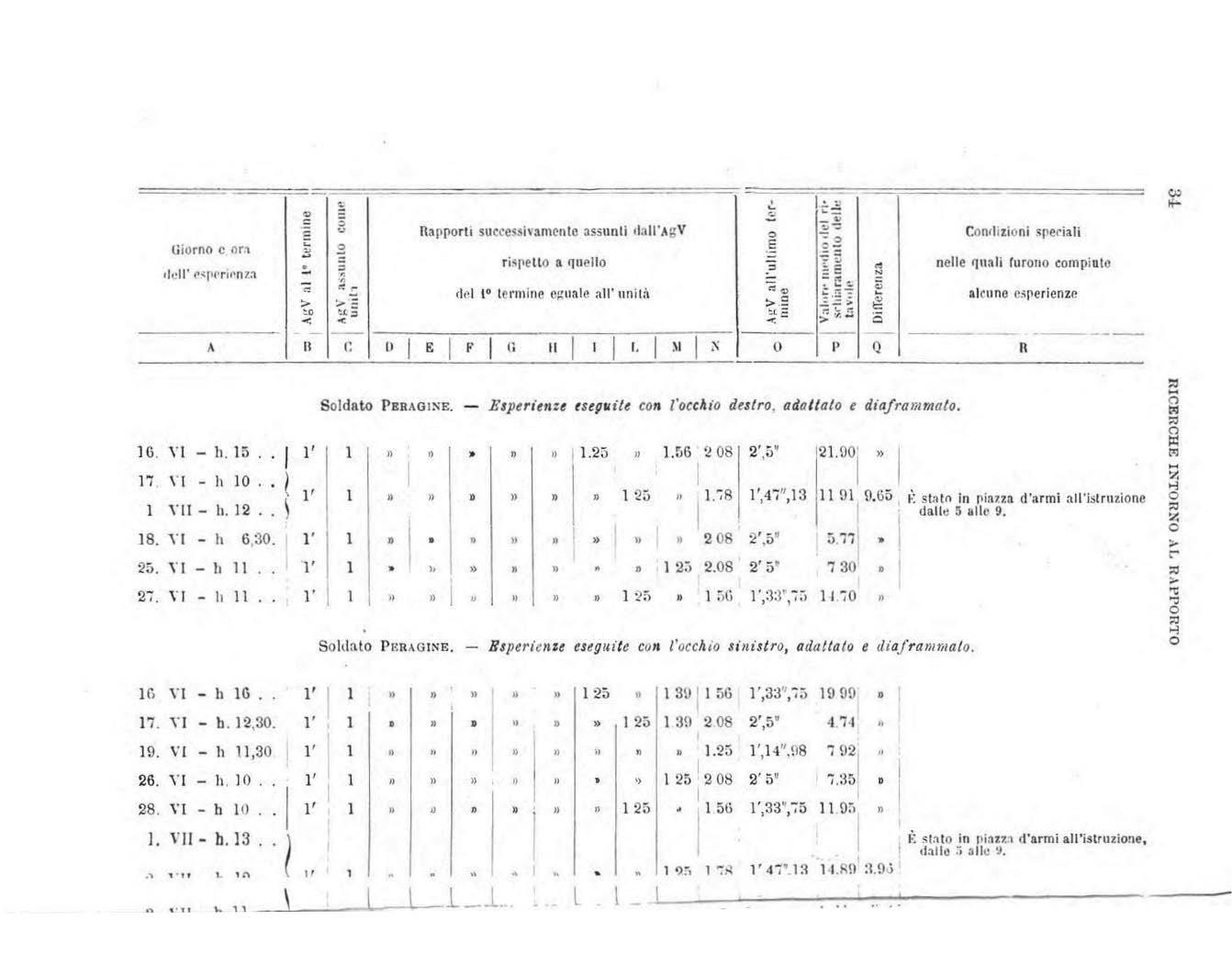
18.
25.
2i.
17
19.
26.
IO
l 28.
l. \'Il- b. 13 t l "' .. " \
li \ ' l -h lO { Yll - h. 12
Yl - h G 30.
\'l - h li
\'l - h Il l G Yl - h lG ..
. \'l - b . l 2,30.
VI -h \1,30
Yl - h ,
.
\'l - h 111
l l n • • • l) 1.25 '' UG 208 2' - · , ù 2 l. !l0' )) l l' l • l) • )) D ,, 1 2;) Il 1.':8 l ', 4ì",13 11 !li 9 65 st.oto In pin7za d'armi all'istruzione dali.: 5 alle 9. l l l 2 ' ,5' l ' l • • " • )) )) • 2 08 ;) ii • l l' l . )o » • » . D l 2:} 2.08 2' 5" 7 30 • l l' l ,, l) l l) Il D l :!1\ • l l ·,:3:3' 11 iO l) •
l ' l ,, • . Il " Il l :25 • l 3!1 l 56 19 09 • l ' l • » • ., D » l 25 l 3!1 2 08 2',5· 4 i l 1' 1 O) " )) O) n \J n • 1.:?:3 1',1-1",!18 i 112 l , 1 l) )) O) O) )) . o) l 25 2 08 2' 5' 7 .:l5 D l l l l' l " • • l ll o 1 25 . 1 1 5u 1',33'',-:5 11 sta t o in t•oat7.1 d'armi all'istruzione , l l ;; a ll e ) l 1 . . .. . l ". l 1' 4i 13 ll.f\ !1 :1.!1J l l l_l... . L l l C>J :::1 o tlll ;::l Q l'l .... >-i o :::1 o ;;. r :::l ).. "C ..., o ;::l >-i o

!'4,,Jtfato IJor.on
d( rouJ'ro HIO
C'O li l'orchio d e liro , nda/I<J I O e tllo.(J'a ntmn lv 2 . \ ' l - h . f!,SO l' 1 l " l • •1.2r1 • 1.39 l.t>U l 7 8 4 17 4',10' l !1.48/ :l2:l 3 · " 1 -h f',30 l' l 1 " " l 25 ·• 1 39 ' l 5G l i8 4 lì 4',10' 12 701 Ila loll n GO ' 'ollu le sr olr, col reso di •• , , l l " so ' l l kg. c -l "• l l • l • 1 25 • • 1.39 • 15() 4 .17 -1' . 10" 913, a n - h so l ' l \ l . , ' ' 0 .97 "• l , » 125 l 39 • ,. l 56 • 4 J, 4 ,IO 10.10 Ha ratt o 40 voiiP lo 'rol e . quelle . l l d el lllalltiiO, tOI Ili kg, !'1. G. 'l -h 10 . l' 1 • • 1.25 ., 1 39 ! • 1 56 • 4.11 4',10' 7 J..l2 'i 'l - h I O . 1' l • • 1.25 • l !l\l 1.56 1.78 1)2;, 6' 14'.09 9 .261 Ilo fa lln r.s voltt• rol oli l kg ti '1- h \6 20. l' l ·• " 1.:.!::>. 1:!0 • I ::>G • 4. li 4',1 0'' ' l.Oì ; Yl - h 1 t; 30 l ' l • " 1.2u 1.3!1 l ;}(j J •• 1.'78 G.:l5 G', H " 8.9 1l Ilo fnt to 1:; 1 olto lo lP. quf'lle ' 1 l dvi ro l ['r>o dì kg . ., 1'7 \l- h 15 l' l " • \2:> ·· 1 J f191 " 1'78 ·1.\i 4' . 10' li4B(· ::5 • 6 RR :.\'1 - h Il 1 l ' _) " l •> 1 \.\!;} • • l 3!1 • l 5G ·Ili 4', 10'' 13 36 < ,-: Sol c! ato - J?sperlt1lze d1 con(• OII (O eugr11'le ccm l'ucchiu sin istro, tJdalla to e dfa(ramm?f o. 00 . 2. VI - lo. 9,30 Il'I l " . " 1 1.30 Il ;)(j • 1 1.78 4 .17 , 4', 10" l \!. IO/ l g s. "l -h . !:1, 30. l' l ,, " 1.25 " l.SO • 1.56 1.78 4 .1ì 4 ', 1o· 9 l o\ ,, Ila lntlo GO l'O l te le scalo, rol peso rli l l 2 Yl - h lu,30. l ' l • • " 1.2:> ·• 1 311 ,, 1.5G 4. l 'i 4',10" 8601 O !JG 3. Yl - b . lli,30 l ' l Il " 1.25 • l 3!l " 1.56 178 6.25 1)',14",99 9.561 1 l ""(alto IO le ollrr 1 elci onattono, col <h (·, ' ' l - b 9 l ' l • • l :t5 ,, l :39 " l 56 " 4 .11 4' ,1 0' . . . 3.711 7 Yl - h. 9 . 1' l ,, • 1.23 ·• 1.39 1.5G • l.i8 1>.25 G'.14",9i1 10 73 1 Ila fallo (i:; ,·olte lo sca le, col peso do .. G. VI _ b 1:1,30 . l ' l ,, ' • 1.25 • 1.39 • 1.5G 1.78 4.)') 7.35/ 2.29 ,.. . 7. VI - h. 1530. l ' l • 1.25 • l • 1.39 l 5G 1.'78 G.2:> G'.l4'' ,99 9.64\ 111 45 1ul te lo sca le, col prso oli ' l kg. 11. \'[ - h. 16 l ' l • • • 1.25 " 1.39 Il 1.56 4.li 4'.1 0'' 8.7911.30 18 . Yl - b. 16 l' , l •• » 1.25 • l » 1.39 l.:>G • 4.17 1 4'.1 0' 10.09l
rN _
t!lf'IUtle
- -o !.:: "' E s c <> .., u Rappo rti s u ceessh·amente assunti dali'A g\" o .,., Con<ltztonl speciali i: "'o Giorno o ora 3 o ,§ c -::.:: rispetto a quello i::2 nelle !Inali fur ono co mlllu lc tl cll' esperten7.a :. e; .. ::i3 del t• termino eguale all'unito al cun e e•perienze .. >
Soldato CRA VKRO. - Etper(enre di con(rOilto eseguite con l 'occhio destro, adatlalo t dia{.-ammato.
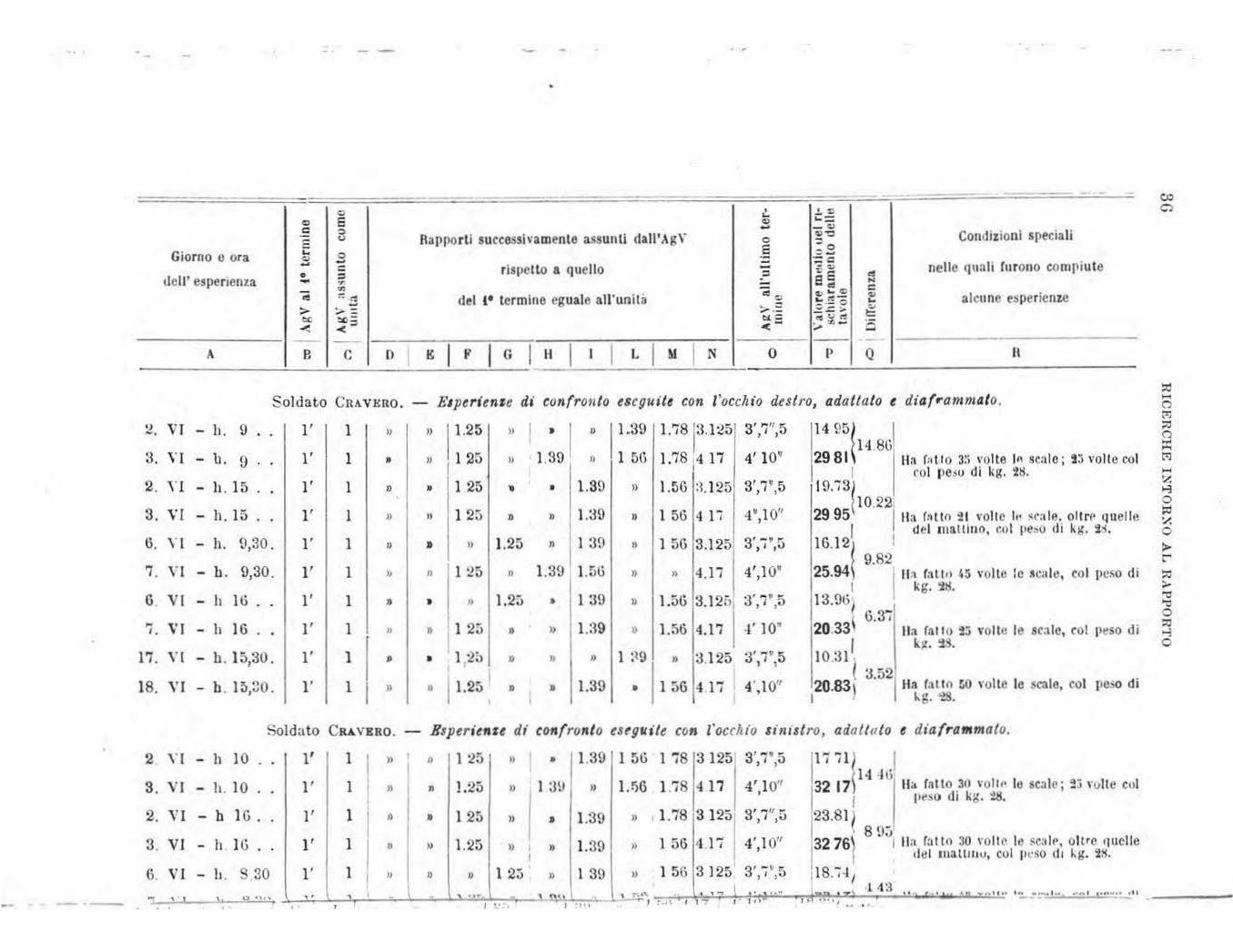
l
l Il l l l L l
:,....: .:::.=> i: "' :; tt= -<: < - o --A B c o K l F
G
M N o p Q Il-
2. V J - b. {) l' l " )) 11.25 ) ) l l " 1.39 1.78 ,3.125 3',7",5 l4 8li 3. \"1 - b. o l' l • )) 125 )) l . SD » l 5(i 1.78 l4 17 4' lO' 29 8 1 Ila f:d to 3:'• volte In scalo ; col l ro l [lc.;o di kg. 2. Yl - h . 15 l' l l 25 LSD U G :1. 125 3',7',5 19.i3! l) .. )) 10 22 3. \"l - h. 15 l ' l » )) l 2::> • • 1.:!9 • l 56 411 4 ' ,10" 29 95 j Ila fotto l'OliO h• 'rale. oltrr quelle 1 del ma ttino, rol pe u dt \11. 6. \"l - h. 9,30. l ' 1 " • )) 1.25 n l 3!1 & l 56 3.125 3',i' ,:i l 4.11 1 4',10' 9.82 7. \ ' l - h. 9,30. l ' l " " l :?5 Il 1 .39 1 J.:j(j • n 25.94 Ila ralln 45 vo lle :c col di 1 kg. 6 VI - h Ili. l ' l • • ,, 1.2:i • l 3D » 1.56 s.12r. :r,1 ',5 13.9ti l 6.311 'i. VI - h 16 . l ' l " • l 2:i • » l l.:l9 u 1.56 4.11 .f 10· 20.331 Ila rar to vo lle lil scale, col o.! i ' l 1:1. 17 \"l - h 15,30. l' l • • l l . l :l 9 » a 125 3',1 ,5 10 31 ( 1.39 • 1 1 :>6 3 52 1 l l l l d " 18. YI -h . l:>,:JO. l ' l " • 1 1.25 • • 417 4' ,10'' 20.83) Ila rat to W , .o tr c e, co • l '1!8.
C RA VRRO. - Bsper ierut df co11{ro 11to urglliit con l'occh i o 8imsl ro, adatt uto t diafratrtma to. 2 Yl - h 10 3. VI - h 10 2. VI - h 16 . 3 . V I - h l G . G VI -h S 30 ---- ... l' l l )) 3 l 25 " l l' l n • !.25 )) l' l n l • l 25 l) l l' 1 l • l • 1.25 )) l ' l l " • l) l 2:> , . ' ' ... • 1 1.39 l 56 l i8 3 125 3',1.,:i lli il/ l }.!)(i l 78 4 11 l 4',10'' 14 -l ti l 3\1 1 » /32 17\ ratto 311 •·olro• le scale ;:!; •·vile c ui l 1'<'>0 dt kg. ti!. • 1 1.39 • 1.78 3 125 3',i",5 l"·"l 4 .1i 4 ',10'' · an;-. 1.3{) • l 56 32 76l 1 Ila fallo 30 • oll r le scaiP, o ltre •1uc11e malltuv, col I' <'SO d1 l 3!) )) 1 56 3 125 3',i',5 lS i-1 1 ' .. l l 43 ' ,. , - r :.n 1 , , ! ••"•,, , , •• ll•• , _ _. u o ::d ..... (') tr. ;:tl g C'l ..... ,., o ::: o 1>t"' \:::1 :... o -. o
Soldato
'7. \'1 - h l
17 . \l - h 11} . l' l
18 \'1 - b. 10,30. l ' l l
Caporale ALBA:>O
21 . VI - h . 9,30. 50' l "
30. V I - b 12 . 50' l
Blptriense di confroll to etegl4i(e con l'occliio jufro, adattato e diafratnma t o.
Soldato CJNCJ . - B1perie11U di ueg11ite con l'occhio dut r o, adattato e diaf r amma/o

Soldato CORTI. - Bst>trienre di confronto ueg 11ite con l'occh io du l1·o1 adattato e di(fframmflto.
Soldato MoNTBRMII\1 Bsper itn:t di confronto eugu1te con dt3lro, adattato e di afra mma to.
tl,
, l·l
\l - Il
f> l '
..
l
..
•
• » !
1 :1:'1 t.:ll! ! >l .. l .:l5 l.S!'! )l 1.25 " 1.:!9 1 r.t; • 1 4.1"1 J 4',10' .. l1. sr, 3.125 1 S'17' 15 " 156 ,4.17 ·1',1 0'' 26 74 \ , _ ll n lnllo 1r1 .1·ullt• l•· "';tlt•. olt ro• tjlll'lh' l · 1 1 tlcl mnl\1110 1 rol tll · 118.2;)1 l 20.05 1 1·80111a In Ilo 50 l'olic lo scale, col pe,o di l iii.
4 . Vll- h. 12 . 150' l
5 \'Il - h. ll,SO. 50'' l
• ù l n l • • • 1.2 !.Sì 1',33' ,75 20.1 2( 16.!>7 D • l u )l 1.2 " 1.5 2.14 1',41'',13 3.669 .: l l • " " . D 1.2 l 5 1 1',14',!!8 1.55G! ,, 11.2 l 1.41 • • " )l 1.5 l 87 , 1',33'' ,75 1.70 3 l M:uria.
27. Yl - b. 11 ,30 l"'·'" l . • l li l 17 )) l • l l l.94 , 2.19 1',33',75 112.601 30 . VI - h ll ,SO. 1.1'7 » l 8.4R1 l » • » • 1.40 • 2.19 ! ..... ., r00, . ...,_ 4 . \'Il- h. 1; . 30 . ' 1!11,:16 1 l l l D )) )) l • )) )) 11.1i » ; 1.94 1',23"134 8 .18 5 VII - h 10,30. l l )) l 1.17 . .. - !5.03 ) ) • » l) l 1.40 1.75 2.19 l ,33 , •5 .13.21 l Marci.1.
4. VI! - b.ll. · IW,IG' l l )) l 1 1.40 1 • 1.75 5 VII- h 10 l 1.11 • » 1.40 1.15 • l " 12.48,5.83 , 4',10" • 2.1!) • 5.8:l t 4',10'' ' 8.83! 1.58l l 0.4 1 Marcia.
27. VI - h. 10,30. 50' l )) • . • " 1.2 • 1.5 2.5 2',5" I ·I.OIJ l l 20.34 30. VI - h. 12,30. 50' l » Jt " • 1.2 • 1.5 2.5 2','!>'' 34.381 Yarc1a. l 1.5 12.:> l 4. VII - h. 12,30. 50' l : l " i l) » • 1.2 • 2 ',5'1 11.6(1 5 VII - b.ll .. 50'' l >l l • " Il 1.2 Il L ::i 2.5 2'1!>'' 130.19 "l ;r.. :: fJl c: fJl t'l r Cl C'l t'l c..: ""
INDICE B IBLIOG RAFICO
t - l'hysi cl/og ische l"nltrs ucltungt >l im Gt bit lt d t r Opt ik 1863.
2 Aousu H. - Pl1!1d o l ou1e der ,\"et zhtr ul llre<lau. !Sii.
3 II KLIIII OLTZ.- Optiqut l'h!JIÌOlO{Ii q u t lrad1111e pa r JA\"AI e l 1\1.1! 1" l l!G7
4 C RKYII ONIJ - /l>ltrprt ln : wn e d.li"Em t r t.Jtap •a. t Ks t r a11o dal Gwnt •• le d f lla Il A cctr d t lll ill d i tlt do r iiHI da T o rmo, 187 1)
5. C RK \'IIONil - hm ota ; wn t sod "'''/ ore d el/11 r t l•nO. ( K>lra 11o l Gior1111 l t dd/11 n A aud t muo di .lledlfillll 1/t Tora11 0, 187t)
6. 1\Ltmc N. Tu - D t l'inJlurnce d t l'ècla imge $ 1tr l"acuitt v i slt• 1/r Pa n •. ,: lo t.•ur, 1873.
7. A. R u tTI - Tr a lta lo di fisica. Fìrenze, Su rccs sora l.o Mon nwr,
s. GRA KP R und -llloudbucl• der g esammlen Augw lo t itlòulli C Lr•tlll l!(. Vcrlag \ Oli \\" all wl rn Kugd rnann, 1Bi7.
9 MA VKKL. - lptl r PCIIItinn de l 'aw i t é viw r lle Sll iiS l e oapporl d e l' ti}Jiiloul t pr (l(eui n nll ellc chu lfS so ld<ll$ 11 / es nw1·ins (lf•·chit•ts ae 4/eatcill t " '' v" l t T 3 1, ann o U! 79 Jl Mt
10. E. - llrcherch es rela tivu u l' é lude cle l'act<ìlli ui , uellc• I AII•Iul l'l ct ' Otulisi " JII t, T. I.X xx111, rag. 5:i, t 880).
Il GIRA!IIl T HUL VN f'. - /.u Vll ion el I C& fluomalit s. Paris, 6l ISSI).
t t O Our.L. - Sltadl'll iiber U cltlsnlll u 11a Forben<iom , ( t;m e(t's Archi v, Brl. X \' Il. A hllr S. 155. li.
13. MK\'f! R O. - l'ebt:r •lit f 'arbe .Jes el<'l.:h·,.chen t.iclllu. l.'t'llil'lllll. v. l)ll'fm·o l t tlrn :li, V) .
U. 0JRH" UII l.- f'ntersut/IIUil)ell iibe 1· dPit ltnd cletl /1!1111/lilllll IJei VC I I Chltd<llfn Augeu· krcmkhr ìltll. ( t;ru e( t 'l Ar chiv, Il ei. XXX, Al o . 'l. 188\).
15. 1\o NI GA.- Zur l\t nllllrà$s dicr o motischer A rclrlt•, 11. XXX, Ah ':!,
IO Il 1\0 I.BR. - Nachlrag zur dtr l'igmenl(•trhtt<. ((;me(t'$ Arth l c , Il l. XXX. AIJ &, I SJ U.
17 S KGUIIL - l.'tbf•r 11ormnl• S • hs ch a r{t u1ld die /Je:ieh lt tl(}t >l tl. t r $ Pir sclt• tr{( :;w· fl e{'ra c11 011 ( {;ntr(c ' ,< Archiv, 8. X XX. Ah. !!,
Hl. 11. Al•IIK KT - Dit 1/elligl.:elt de. Schu·r11 z u11d W eiss. ( PJlua er'• Arc lli v (. d Il· J•hysiol o!J, XXXI. p a g flJ)
19. WOLVVIIBAII L. - Utller dit P ni { u ng des Lichlsinru . Eillt l u •lie (l; mt(c's Ar ch1 r, D. X X X l, AhL l • t SliS)
!O. c. l) o Ro ts - Sfheiuh eit owd 1.:1, i >Uter Seluui tl kt l f(;rn t (< 'l A o·rlli v. X X\ Il. A h. 3, 91. IIBRIIASN Bum'. - Fa cu llt vi s ut ll t par Ilo e ia irte du jour ph olomelo uJut ,, oet r lt· AllrotHmtlt•
d'Ophlo lm nlogie llt t cl t l b• ··g. 9, t O
'H. Tn f't bt r d al W eu n d f r Lichllwllllti rtmn . .tr·clliv. XXXIII. AIo th. l. ! Sii ).
u. SciiiiiOT RIWPI tK.- ;lfCIIIWIIt d 'oc u lislica e d' o f l cJl f11(1 JCtl}Jl U Traohl1.10 111l ll3 1iJ rt 3 d e i ol u tt o ri C A:- T U e CoKS. Mila n o , \'all artlì.
24 - St llpr obt n Tu [rln :;ur Prii(uti {J d es Mu nrhrn.
- La et c o uleurs. l'aras l.>hrairm 1 Il Bar ll ll'r o· t' l F rl < , ISSS.
!!fi. OR KT f.ANOOLT. - Traiti co mpiei d"oplltahn o tog i e. l'ari• , e t llaht,l, ll nr:a lre••'clitc urs ,
!117• \I ULLKII, ( .\'811 l"nl er su.cllu lt{ltll ( lfr cl l. r i tllll. Il , l 'h!JiÌ OI , s. !l i )
i 8. MASCAIIT. - 7'rnicé d'OJ>Iiqt<t. l'Jri;;. Gaulh11•r, Vall:trs •• l Fil ' l b91, T 1° e 3°
99. "llKR l. M. - m-. Cll emuchCII des Lichles ll all ·. A. s. \\'dh c m i<MII/),
.'lO. - De l' acu.illi vi.w elle. Pari;, li h,airie l. R. llaalli u rc e t
31. W NacATI. - Br.hrlles visuellu elleurs upplicutinlls. CAnna/es tl ' Ocllll.<l iltu e, T. CXI , pasr H5, 18 91)
3! W. 1\0•TER - U111e rmclwngm zur vo1n ( f;r tu(e's Ar clliv,lld XLI, All.4. SJ. l{ aii P.S V. - Ile ber die { ow cllollellen l' "rsciliedenheile •L d e.< !Yet:lw u/ t:wl rii iii S rmc l dtt· Nacllbn•·tlle• l e (t,'•·ae(e'' A rcltiv, 1111. Xl..ll. Ab l. 3 , S. 95. t 33. 189G)
SNKt.LKN. - ,\'.olt $ 0 11 visiu11 and r etina/ p ercr J)liOIL. B ow maow L cclure thr Opi h . So c. 101Jillll lle w itw, p. ua, 1896)
35. KRa KNK S JIAN S.- t:ener 1/tmtrlllupie. Wies h aden Verlna; ' " n l. F Rc ra an nnn,
3G. P.;R tNA UD. - l.a \'l$illn. Eltaa e pii!Jsi o l o{lique Parli , Octa\'r Onin, •·olotc ur. 189G.
37. II KCll ll: - Bi nfgs Bemtrl>ungen :ur ;lle$•u•tll der Seltsclw r[e. ( A•·cltio (. A u (lt lllle jj /.: •wd ,, s. :!8 1, 18n).
38 TscuERNING - Oplique phyliologique Paris , G. Garre el C Naud. 1898.
39. I ,AI'IOOLT E - Nouvtaux o hjel-typ ts pour la délerminllh nll d e l'11c uìté vl$u t lle P.trh , Octa\'e Uoin, t899.

RIC' EROHE D/TORSO AL R APPORTO
40. Ds·Wscuo ol Bchelle mett·ique pour m e.lUrttl' l"acu i l é visuelle, le r eti$ cromatiqtLe et te wu luminetw;. Troisiéme crli tion , Pari <, lloin, 1899.
H. LANOOLT E.- Atlllale& cl 'oc ulirlf•t rte Al(Osto 19110, pa:;: 159. Discussione sos tenuta in occasione ''"' tre.Jiccoi mo Congresso tl i MCIIiclna in Pari:;:i.
Eo. Psor:s11s - C:<IJtr f'11cU!r t n toelche dru Jirl: elllten von Sehprotm • ee in{lusstn. (Ardtiv ( Augenlteili;., Brt XLIII, II P( t. i, 1901, S. 144).
-13. C. KsrM •>x o. - S"t valore d•gli op olipi '''' alfabeto degli oculisti. t enuta al Polirli· n;ru genera le eli Torino Milano, Vatlarrti.
u. C. KRfliOND. - Stato torpido e stati emera/npici della t•elinll. Stnrli clinici sui rapporti clelia acui"' vi;iva col ( A>muli di olta lm otogi fl, IV, pa:,!. Il'!).
4:; Cou.•.- Ei11ige ! 'oruersuche ill1e r dii• AIJIII"'!I'Oktil der .S ela.<eluir{e vo11 <ler lleilifii>Pi l, Jlritr:i:;:o zur Augenheilk . Pcslc hr. zur l'eler <les iOj li el>urt<ta:;:cs ll ernn Ge li. llut. Prof. F•i r>le r S. 195. Z>llll. Are/a. {. XXX I).
16. L. W OLPPnKnG.- d ie Pl'ii.{amg d es Lichtsinu:J, ecc. (\'. n . t9 di questo
4i. G. ALDKRTOTTI. - Sul rapporto fra V. P,l 1.. Studio cii m"<>irna e><'gnito laboratorio ottaldi ·ror ino. ( A•mall di ollalmntogifl, :m nn ;•, rase t •)
18. G ALBKnTOTTI. - Eoperienze di ottica fi<i ()log i ca intOI'IIO alle Vfl.r ia ; i onl d ell' aii!JOlo •;isuule rilpOfldenti allfl Luce (A n nuli di ot111lmo l og ia, XXIV).
19 AL8ERTOT T I. - 1\'ole t·igttardanli l't/Tetto di otl olip• costu111i e variabili m (OIIdo va•·inbile e cosla11le. Estra tto del Vol X, Scrfl} Il, delle Memll rio !Iella R Accadem ia •h Sc•cnzc, Lt•Ltere ctl Arti. Mo11ena •
r.ll. - Sur la mesure de l'acuiti vimtlte. ( AIItlales T. CXI).
51. D•r.s•R H - lfeber die /Jeeiufl•us rmg des Licllt;itut es dure/l :)trycll.llin ( Are/a (. f.l'ptriln. P al/1. u Pharmakol XXXIII, S. i 5 tl.
:a A. F1c• - lle/Jer SltibchensehscMir{c u. Zap(ellseh.lcluir{e (Grat(e's Arclli u. (. Ophll>. , XLV, !, s. 33ti).
53. GUILLERV - Z1tr Pl•ysto loqie d es J\'el::.llaulctlllrunu. ( Artlaiv. (. I)!S. l'hy.•iot, 66)
5.1. GUILLEKV. - /JPgri/T und lle.<stuty der centralen Stlasclwr{e ut<( pltysiologischu· (;ruudlaoe. (. , XXXV, S 35).
5j GOLn•No 111110 •:<n Sc ttAf' En. - Obserua liou s on l/le slrncl!l1't o( l/te Cetl lral (ovw o( the httllllllt eye (lllltmal .1/onotsschr. (. Allfl '. u. I'I•!ISi o l. tlellll. t , S. t).
56. - f'ebtr augtbliche d er Zap(e11 :>elizellet•. ( Arch. (. d. Qt i Jlll ysiol., LX, S. 519).
:ii. Huwu &L<IIKill. - lleber dm Eiu{luss der l'upillen•vei le au( clie Sel•sclllir(e bei verschied ellòl' /11· l tnlltal di't' IJtleuchlung (Grfle(es Arch. (. Ophl, X LV, '!. S. 35i).
58. 1\o NIG A - Die AIJhriugiyl;eil cter SchAchar(e von der JJeleuchllmg's illlensittil. (Sit::.unysber. d. 1Jerli11 Alcad , XXVI, S. ,
59. li ER<SG E. - de" E.u(luu cler lulea auf. specl r a l e (P{luger·s Archiv. (. d gu. l'l•ysintogi e, 1111. S.
60 .\IAssoN.- Btude& de l 'ilotométrie Eleclraque. ( Annales d e Cllimie et Phy&icJt<e, T. XIV. Troisiè me Paris, 4l!45)

61. Ono SCHIRliEII. - lfeber die GiWìqkeit del 1Verbesche 11 Ge&etz e• (ii r den Liclil$ilm. Arclliv (. Ophl, 8<1. XXX. VI, Ab. 41
6t. UuTUOFP W. - l'ebl'r dar Ablui'ngigkeils verh<illniss der Sthscllnr{e v on de•· Beleuchlun!]sinten · silti't. (Grae(t's Arch•v. Bd. XXX II, Ab. t . S. t7 t ,
63. L. - lleoer die Fund i on&prii(unqen de& Auges. (ArchiD {. Augenhei/1;., XXVI).
\\'iJLnrNG. - lfeber den kleinsten (;esichtswillk«l (Zeilscllri(l {. Binlogie, XXIX, N. F. Xl).
<lJ. o: lloccr. - Esperienze i.Uorno all'in{luwzu della fatica aulla visiùne. (l;iortwle dell'A ccademicr di dlediciua di Tor ino, 1891).
65. E. TooliDP.TTA.- L 'Influenza della luce nella determinazione dell'acult z::a vi> i va. ( 6'ior·naleme· aico dd R. e&ercilo, dic e mbre 1900).
61. G. CoLOIIno - Misure apel'imenlali dell'emer alopia e dellorpo1·e rttinico. Pavln, 190t
ò8 G. - 1\'ole alla stcoud<l edi:i OIIt d elle !avole {oloptomelt·ich e. t90J.
69. Knz - lfeber dar Mintmum det· Be/euchtunq bein1 At·beilen. ( 0 11ais mensch en osweschtllii dlja
nati}, Wratsch, X VI li ).
;o GUYE. - /Ji bllulh éq ue (illiver$e/le, 1!101.
FRA VISUS E L UvE 3\J
•t•
L\rPRO v'TrsATI PER L O
SGOMBERO DEI FERITI DAL CAl\IPO DI BATTAGLIA
Per Il doti. 't'itCorio P e r -o, CapitJ UO
Ognuno può facilmente immaginare di importanza sia il rapido sgombero dei f eriti dal campo di battagl ia, e quante difficoltà si inc ontrino p e r ciò far e in causa de l numflro grande d i feriti s i posso no aver e in seg uito a ciascun co mbattimento, per la deficienza del personale, e per la mancanza di adatti mezzi di traspo r to.

L e autorità militari, le società di soccorso, i club sportivi, in ogni tempo si sono occupati p er trovar mezzi di pronto, facil e e comodo traspor to delle persone colpite da qualche malan no ; e distinti scienziati, per lo più medici , si studiar ono d i fabbricar e sedie e let.tig he, sostegni , barelle, ecc. ecc. che oltre a mostrare l'i ngegno d egli inventori, han no prova to il loro s pirito di filantropia e l 'import.anza della causa p er la quale si adoper avano.
Ma io credo che la m aggior parte, nell'accingersi al lavoro, abbia dimenticato che un mezzo di trasporto, per essere r ealmente utile, d eve con mol ta facilità. e prestezza pote r trovar si sul luogo dove sta la persona da. t r asporta r si, de ve essere di facile applicazione anche da persone di m ediocre intelligenza e facilmente improvvisabile con le ri sor se che si possono t rovare nell' aperta campagna o tu tto al più in un casolare o d in un piccolo villaggio.
U na comitiva di alpinisti che si accinga ad una escursione, una compagnia di cacciatori che si a vventuri nella campagna, un distaccame nto di alpini, c he si accinga ad un pa ssaggio difficile, no n si porteranno certo nè l a sedia-l ettiga mod e llo Guida, nè la gerla-barella d el capitauo m edico Aba t e od il sostegno del Froelich per il trasporto dei feriti, giacch è di troppo è il bagaglio degli escursionisti, senza che debba essere aggravato con a l tri impedimenti, molto più se di n atura che alJa maggior parte sembri essere di cattivo augur io. Eppure a nessun altro meglio che a costoro può capitare all'improvviso qualche grave acc iden te, per cui sia indispen sabile un pronto trasporto, tal vo lta anche
40
in posizione orizzontale. In questo caso un apparecchio che si potesse improvvisare con gli !!tessi indumenti peri!Onali del ferito e dei propri co mpag ni, coi bastoni delle picche o con i rami degli alberi, Cf)n gli a lr;enstock, con le corde, ecc., eco., certo corrisponderebbe meglio di qua lsiasi più elegante, comodo, solido, ingegnoso e consegu.entemente anche cost.oso apparecchio, che prima di giungere in sito, ri c hi ederebbe tempo assai, ed allontanerebbe dall'ammalato le persone che dovrebbero invece servire a soccorr erlo ed a confortarlo.
Ora, se questi mezzi improvvisati appaiono utili nei casi isolati che possono avvenire per un accidente di caccia, per una escursione alpina, molto più devono essere n ecessari sul campo di battaglia, dove i fe riti in poco tempo si troveranno in gran numero, dove il materiale di tra.sporoo, per i rapi d i spostam enti d e lle truppe che combattono, difficilmente potrà giungere in tempo, o se vi giungerà, non sarà in quantità sufficiente al bisogno1 oppure, per la data antica di sua costruzione, non reggerà allungo uso, massime se adoperato da persone un po' grossolane.
Chi di noi fu in Africa, ri corda le cattive prove fatte dalle nostr e barelle, e come invece servissero egreg iamente i mezzi di trasporto i[)jprovvisati specialmfmte dai nostri alpini, che con rami -verdi d'albero, vimini, fuscelli, frasche e cappotti, cos truì vano barelle a quattro, sei, fino a dodici portatori 1 sulle quali i nostri poveri feriti compierono con poco disagio centinaia di chilometri di strada.
Sulla l inea di fuoco, più che in qualsiasi altro luogo, sareb be necessario che i nostri portaferiti sapessero oon le ris orse local i improvvis are mezzi di trasporto, valendosi ad esempio di un bastone, delle cinghie dei pantaloni, dei cappotti o delle coperte da campo per co· st ruire una sp ecie di barella. a sospensione, oome quella che si può vede re nella qui umta fig. l • .
A questo proposito io credo non sarebbe fuor di luogo che i portafe riti reggimentali, i quali in tempo di guerra non portano fucile, fossero invece provvisti ciascuno di un bastone lungo metri 1,85 del diametro rl.i 3 centimetri, di lurice o di castagno, munito al bisogno ad una del le estremità di un p•1ntale di ferro piuttosto robu sto. Questo bastone oltre che di appoggio al portaferito, servirebbe molto bellE\ ad improvla barella da me ideata, senza bisogno di andare a cercare i rami d'albero che non sempre si trovano vioini, nè della voluta qualità Questo genere di alpenstock è adoperato sulle montagne di Lombardia dai portatori di carbone i quali lo ritengono cos't utile che non se ne staccano mai.
Questa barella è di facilissima e rapida costruzione, perchè basta prendere otto cinture da pantaloni e dopo averle riunite a due per due,
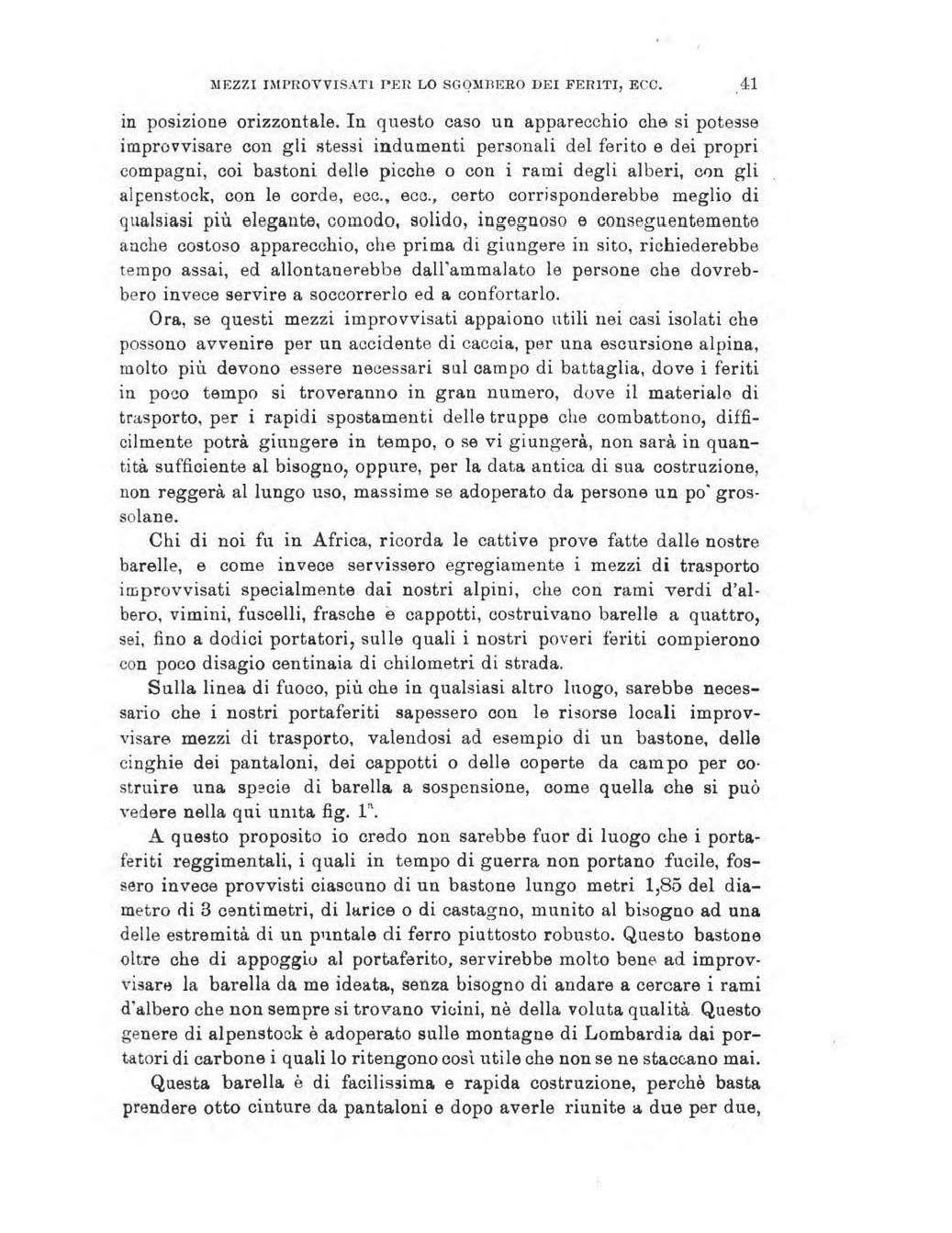
MEZZI IMPROVVISATI !"EH LO SGqlmERO DEI
41
FEniTI, ECC.

li E Z i'. I PE R LO S :J O MDE IW
, !
Fig 1•
formare q uattro anelli più o meno grandi a seconda del volume dell' individuo da traspor t arsi. Detti anelli si infilano sul bastone, a circa 25 cm . l'uno dall' altro, e d opo esse rsi assic urati che tutt i abbia no la stessa lar· g hezza, vi si adatta no nella concavità t re o quatt ro cappotti o coperte da. campo disposti longi t udi n almente in modo da fo rmare un soffice giaciglio.

Vole ndo sopra di questo caricare il ferito s i p ossono posare a terra i cappotti e sciogliere gli anelli d elle c ingh ie , che r estano parallelamente
distese s ol terreno. Accomodato il ferito sui cappotti, si torn.ano ad a ffibbiare le cinghie sul b astone che le deve reggere, e fatto questo, due portaferiti sollevano con precauzione legge rmente da terrllo il ca rico per conoscere la r esistenza del bastone e delle cinghie, come pure per misurare la lunghezza d egli anelli e giudicare s e il peso sia uniformemen te distribuito (fig . 28 ).
Quand o tutto è in ordine, i portaferiti al t ro non devono fare che inginocchiarsi l ' uno dalla parte de lla testa del ferito, e l'altro dalla parte dei piedi, caricandosi ciascuno l'estremità. del bastone sulla spalla destra ed afferrando il ferito stesso l'nno al di sotto delle ascelle, l ' altro al di sotto dei popliti o dei polpacci e sollevandosi contemporaneamente
DEl FERITI DAL
4:>
CAM PO DI BATTAGLIA
Fig. 3".
agli ordini di uno dei due portaferiti o di un graduato che eventualmente fosse presente.
Ad e vitare che il bastone dovesse sfuggire dalle spalle dei portatori. sarà necessario fissarlo co n un'altra. cintura che dalla spalla. andrà ad affi bbiani al di sotto dell'ascella opposta (fi g. 3")
In tal modo il peso del ferito viene a gravitare, oltre che braccia d e i portafe riti, anche sulle loro spalle e quindi molto maggiore sarà la distanza alla quale i porta.feriti stessi potranno trasportare il loro carico, senza eccessivamente affaticarsi. Il ferito potrà essere tre.sporta t<> in posizione orizzontale ed anche in p osizione leggermente rip iegata. sul bacino quando ciò fosse necessar io per ferita dell'addome: sarà questione d i regolare diversamente la lun ghezza degli anelli. Si potrà pure portare con le g ambe perfettamente distese e munite di adatti ap· parecc hi in caso di frattura, purchè l'estre mità del bastone dalla parte del portaferito che sta ai piedi, sorpassi di circa un metro la s palla del portatore così che sul tratto sporgente, si possano aggiungere altre cinghie di sostegno della. gamba frattu rata.
È inutile dire, perchè troppo eviden te, che in mancanza di cinghie potranno servire dei pezzi di corda, delle strisci e robuste di teli da tenda., delle corde r esistenti di paglia intrecciata, tutti quei mezzi insomma che si possono aver sotto mano e che non ri chiedono ordigni speciali di costruzione, n è una mente superiore per l'adattamento.

Un altro mezzo molto semplice per il trasporto dei feriti dal campo di battaglia potrebbe esse re fatto ancora con le cinture dei pantaloni foggiate a piccoli anelli tenuti rispettivamente ciascuno da due portaferiti, cosi che quattro portaferiti posti di fronte l'uno all'altro pot reb bero reggere contemporaneamente quattr o di que3ti cerchi. Se i medesimi poi si riuniscono secondo l'asse longitudinale dell'apparecchio per mezzo di altre due cinture, in modo che i cerchi stessi non abbiano ad allontanarsi di soverchio e sovra il tutto si mettono cappotti o coperte, si vetTà. a. costruire un soffice giaciglio sul quale un ferito potrà adagiar si comodamente in posizione orizzontale, sorretto al bisogno dalla parte della testa da un quinto portaferito.
Sono questi s'intende, e come ho già ripetuto, me zzi improvvisati di trasporto, che non possono gareggiare con gli innumerevoli tipi di como:ie barelle attualmente in uso presso i vari eserciti e le diverse società di soccorso, ma che hanno sop ra. il vantaggio del poco o nessun costo e della. pronta. attuazione, là dove il bisogno li richiede.
Altri due apparecchi che sto per descrivere dovrebbero servire per il trasporto dei fe ri ti specialmente in montagna. L 'idea. di questi congegni n on è mia, ma. del do ttor Oscar Bernard. I o ho cercato di modi-
MEZZI IMPROVVIS ATI PEJl LO S GO MDERO
fica.rli e d i meglio adattarli allo scopo, che però confesso fin d ' ora non è ancora completame nte raggiunto. Ad altri forse sarà. dato di t rovare qualche nuova. modificazione che renda gli ap pa recchi stessi di una utilità indiscutibile.

U primo di questi, c he io vorrei chiamare sgab ello a sospensione, e
costituito da. un'assicella. reniforme con i diametri maggiori di 62 X 23 centimetri , rafforzato da tre assicelle verticali e cinto in cor ri spondenza della. sua. concavità, là dove adattasi al d or so, da un'a l tra assicella ricurva., che d_eve rendere più dolce la. pressione d ell'apparecchio sul dorso del portatore. Quattro fori praticati nell'assicella stessa, due nella parte mediana verso il ma rgine anteriore alla distanza di 16 centimetri
DEI "!."ERITJ D A L Dl BA'l'1'AGI.IA
F ig. '" ·
e due verso il margine posteriore alla distanza runo dall'altro di 30 ce n· timetri, ser vono per il passaggio d'3lle cinghie di sostegno; ma questi due pos ter iori meglio andrebbero sostituiti da d :te r obusti uncini tenuti in p osto da l amiera di ferro o p por tunamE:nte avvitata, che darebbe solidità alrapparecchio.

L o sgdbe llo. mediante opportune cinghie, cl1e pot r ebbe ro esse r e di quelle d a tappezzier e, d ov rebbe e;;ser sospeso al dors o d e l p o r t a ferito a. non più di -10 centi metri d all e spaile, vale a di re in co rri sponde nza della regione lombare all'altezza delle cre;;te iliache. Perciò l e cing h ie do· vrebbero ave re delle opportu n e fibbie p er poter allungar e od acco rciare i sostegni ad attandoli alle diverse altezze dei portaLo ri. B n ece;;sario cht' una c inghia trasversale impedi;;3a alle due laterali di scivohlr dalle spall e (fig. 4a).
Come è fac ile immaginare, il ferito o l" ammalato seduto su questo sgabello vie n e senza fatica caricato s ull e spall e del por ta.to re da d ne porlaft'llriti che lo sollevano uno per parte in sieme coll"apparecchio, mentre un t erzo portaferiti affibbia l e cinghie e regola iil carico sn l p ort atore.
Qua nto tutto è in posto, il ferito n o n fa al tro che a bbracc ia r e il collo di chi lo regge tenendo le sue gambe penzolo ni lungo le coscie del po r tato r e. Questi, avendo libere le mani , può benissimo app oggiarsi ad un bas to ne come quello che io prop or rei r egola.rmentare pe r tutti i portafe riti in guerra., e n or:. si se nte eccessi vame nte aggravato del p eso che sopporta, aven dolo uniformemente distribuito sull e spalle, sul dorso, sui l ombi, in modo che le risultanti ten do no t utte verso il s uo centro di g ravità. Questo fatto aumenta. di molto la. resistenza del portatore. co me ce lo rlicono coloro che si occuparono circa alla raz i onale distri· buzione de ll'equipaggiamento sul corpo del soldato (fig. 5' )
Ma. si dirà tosto che questo non è un a pparecchio improvvisato, ed io soggiungo subito che qual che di sim ile si può benissimo imp rovvi,:;ar e con una co rd a ad ansa, nelle cui estremità si a fatto passare nn bastone, che viene poi ricope rto da qualche cosa. di sof· da. una coper t a, pe r e;;e mpio, o da. nn cap potto. Questo può b eni!lsimo r togge r e un fe ri t o senza produrgl i dolore e senza d annegg ia r e i lom bi d el portatore. E se mancass e anche il bastone, la s e mpli ce conJa. e d il ca ppotto potrebbero bas t are, riun en do la prima ad q.nello ed a.rl attando la in modo che passasse trasvers alme nte su ll e spalla e sull11. r egione lombare de! portatore, dove ap p unto servirebbe di sostegn o all e natiche d e l ferito posto a cavalcioni di ch i lo regge. Se si considera. che in gran part e le nos tre gue rre dovranno svolge rsi in sit.i a l pe5tri, dove non è da p en sare ai traspor ti. in barella,
l ,, AU:7.7.l DIPROVVISA'l't PIW T, O S(l0)11lF:RO

DF. l Ff: RHI DAL D I DATTA CH. rA
perchè in certi punti a mala pena può passare un uomo soLo, credo che questo mezzo di trasporto non sia da disprezzarsi, mo lto più che per il suo piccolo volume e tenue peso, potrà permet t ere di porta r e ove è chiesto lo sgombero, una grande quantità di apparecchi costruiti lì per li d a l più modesto falegname c he s,i può tro vare presso qualsias i villagg io, o presso un r eggimento.
In ta.l modo si potranno anche dalle vette più pe r icolose togli ere i f eriti, che ab ba nd onati senza i voluti soccorsi , sarebbero certo condannati a morire, più che per la g ravità delle loro l esioni, per il rigore d e lla temperatura abituale sulle alte montagne specialmente di nottò.
L ' altro apparecchio che si vede diseg nato nella fig. 6" è quello che io vorrei chiamare sga.bello·sostegno, e che ho costruito sempre s.egnenclo il criterio di distribuire uniformemente il peso sulle spalle, sul dorso e sulla regione lombo- sacrale dE'l portatore.
Ho pure cercato d'imit!lr l'esempio dei portatori di montagna, i quali si caricano per solito gli enormi fastelli di legna e di fi eno o le balle di carbone sopra la testa, la nu ca e le spalle, mantenend oli in equilibrio con adatti sostegni, mentre con le mani l ibere si appoggiano ai loro bastoni ferrati .

Questo s istema. di carico inoltre, gravitando verticalmente sulla colonna. vertebrale, permette al portatore una maggiore res istenza e più stabile equilibrio.
Col mio apparecchio ho pur voluto cercare di ridurre a l minimo poss ibile il diametro antero-posteriore costituito dalla. massa che formano portato e po r tatore; cosicchè riusc isse facile il passaggi o anche nelle brusche voltate sn stretti sentieri, in riva a. precipizi. E finalmente ho voluto utilizzare per il trasporto dei feriti mezzi che prima p otessero servire a. trasportare sulla linea di fuoco l e munizio ni , o nei punti avanzati ed altri oggetti. Ed infatti sul piano di questo sgabello si può caricare unu larga. ces t a. ripiena di tutto ciò che può occo rrere all e truppe combattenti.
Ma con tutt.a. la mia buona volontà, l'apparecchio non corrisponde ancora. allo scopo per cui fu costruito, a meno che il portatore sia di una robustezza eccezionale ed il carico non su peri ore ai 60 od al massimo 70 chilogrammi. Inoltre , per l'altezza in cui si trova l'individuo trasportato. questo è preso da. paura e Ja sua inquietudine trasm essa al portatore in forma di scossa, finisce per fa rgli p erdere l'equilibrio. Ad ogni modo cre do utile d escri"erlo ugualmente, nella speranza che qualcun o sappia modificarlo in m odo util e ed anche pel fatto che si pu ò caricare più in basso ed improvvisare con molta facilità. B asta che ,; i
·18 UIPli OV'I' l SA'l' [ PER r.o SGUMDEltO

DEI FERITI DAL OA:MPO DI BATTAGLIA 49 • &C.iontOie
r iuniscano due rami bifidi meri iante tre bastoncini trasversali e si mettano n el nno della biforcazione fasci di paglia, cappotti o coperte, e si sospenda il t ut t o con due corde a spallaccio sul dorso di u n portaferito, in modo che il sedile corrisponda a lla regione sacrolombare del portatore.
Il mio sgabello adunque è formato da. una specie di rattangolo in l egno leggermente conca,·o in avanti, che per mezzo di due assicelle ricurve si adatta sul do r so d el portatore pre me nrlo sulle s capole e sulla regione sacro-lombare. Questo rettangolo sostiene un sedile che 1\ pial·imeuto si può abbassare e solle,·are e vi è mantenuto fisso nelle due anzidette posizioni mecliaute o p po r tune ,·iti.
La parte del rettango lo che sopravanza le spalle del portator e serve d'appoggio al ferito, i l quale vi potrebbe esser e anche a ssicur ato med iante cinghie passate nelle mag liette che trovausi ai lati delle branche montauti di detto r ettangolo (fig. 6•).
Il ferito seduto su l pia n o o rizzon ta le o su l piano l egge r mente in· clinato, ciò che si può ottener facilmente mettendo un pr>zze tLo d i l.•gno n e lla parte inferiore dell a do,·e scorrono i r ego li di del sed i le, me t te le gambe da\·anti alle spalle d e l portatore e si attacca con le mani alle due e>ltremità superiori d e l rettangolo l fig. 7• ).
Il portafE> rito curvo legge r mente in a vanti s•1l suo alpenstock , che tiene nella mano d estra, con la mano sinistra. fissa l'apparecchio contro la propria regione lombo-sa.crale e ce rca di procedere senza. imprimere al carico grandi scosse.

Questo sgabe llo una volta chiuso, pre 3eulando una fignra quasi piana, può tro,·ar posto dappertutto e, per il suo peso relntivamente piccolo, può essere caricato in diversi esemplari anche sopra una sola bestia. du. soma., e rie:'! Je poi di nessuna fi1ti ua se portato da. un indi· viduo (fig. 8').
Con opportune corde potrebbe essere so<>pe-;o ai lati di nu o di una bardella, puruhè. dal l'altra parte Yi fosse i l oecessMio co n · trappPso, ad esempio un altro apparecchio consimile, e che le estre· mitl\ infer iori degli npparecchi stessi veui:-;:;ero tenute leggermente l ontane d11. l corpo del quadrupede, mediante ba:;;toni passati sotto il Yentre d ol medesimo, come u sano i mulatLieri in T oscana per le ball e di car bcne cho trasportano dalr A ppennino.
Esilendo così. caricato lo sgabello, il ferito appoggerebbe l a schiena contro la spalliera, alla quale pot.rebbe e,;sere as;;icurato mediante cinghie, e lascere bbe penzoloni le gambe dal bordo d el sedile.
Ilo YOluto trattare questo argomento sebbene molto modesto, p erchè
)lEZZI UIPIWYVI:>A1'1 PER LU SGOMnJ.:RO
ritengo che il còmpito de l medico mili t are sul campo di battaglia sia principalmente qu e llo d ello sgombero dei feriti. D opo di averli ristora.ti in fretta e n el mi g lior modo possibile e d i ave re applicato per ogni ferita una medicatura occlus i va col materiale antisettico dei pacchetti da medicazione, delle tasche e d egli zaini di sanità, o di aver applicato apparecchi contentivi ai fratturati, valendosi in mancanza d'altro di m ezz i improvvisat i, i p!tzien ti devo no con g rande sollecitudine essere trasportati al posto d i med icazion e, d ove il perllonale rimasto provvederà alle operazioni di ne cess ità, a ph1 adatti apparecchi od a medicazioni più complicate.
Un'allacciatura di grossi vasi, una tracheoto mia d'urg e n:r,a, s i potranno fare anche sul terreno dove a vvenne il comba ttime nto, sempre che s ia modificato l'armamentario d egli zaini d i sanità; ma anche in casi che s'impongono bisognflrà frenare più che sia p ossibile la m ania di operare, p ensand o che un laccio applicato opportunamente od un tamponamerito con garv.a all' i odoformio posso no arrestare qualunque grave emorragia almeno fino a l'interven to operativo p ossa avvenire con magg ior calma, in luogo più opportuno e con mezzi p iù a d atti. Portar via il ferito ripeto, portarlo v ia presto e bene dovrà esse re l a principale preoccupazione del m edico militare sulla linea di f uoco, ed a ciò rius ci rà quando n on si ostini, per paura di rendere settiche le ferite, a voler da solo medicare, riservando a i caporali aiutanti ed ai portaferiti il sem p lice incarico del trasporto.
I o cred o giustissima l'opinione del F avre, che, se in caso d' urgenza un a. mano profana spolvererà una fer i ta d' iodoformio, occludendo la poi co n un po' di garza. e di cotone a l sub li mato, ne verrà minor danno al colpito che non abbandonando lo a se stesso, a contatto di tutti gli agenti infettanti che lo circondano, non esclus i i fazzoletti e le pezzuole s udicia d e i quali istintivamente il feri to cercherà coprire la propria lesione .
Ed anche in guerra io credo che il personale ans ilia.rio potrà presta re o t timi servigi, quando in tempo di pace sia· convenientemente istruito, istruzione che m entr e lo deve m ettere in g rado di compren· dere r importanza di una m edicazione, lo dev e pure rendere capace di improvvisare un apparecchio, od un mezzo quals ias i di trasp orto de l ferito .
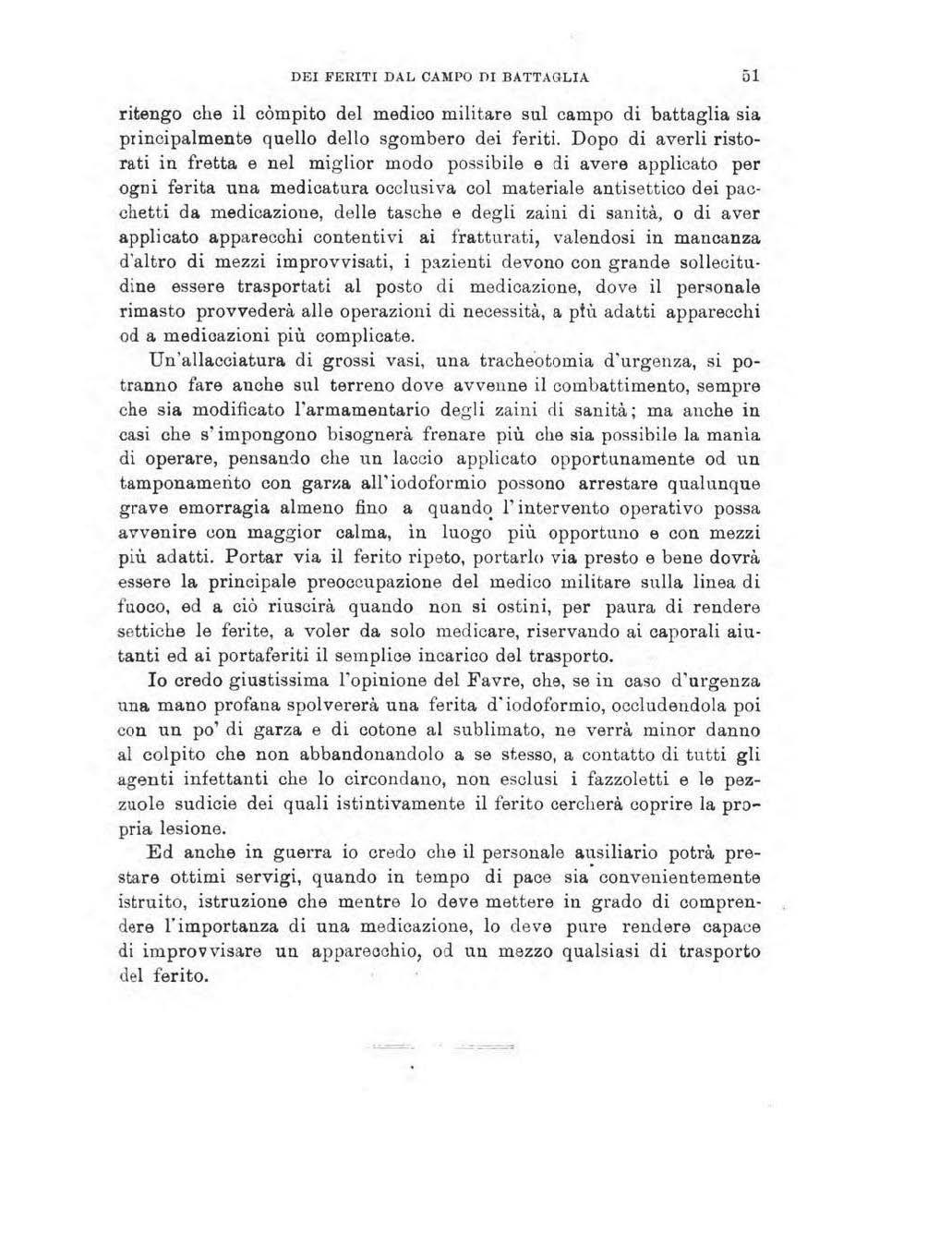
DEI FERITI DAL CAMPO ni BATTAG LIA 51
RI VISTA DI GIOR NALI IT ALI AN I ED ESTERI
R I V I S T A ME DICA
WETROFF, BYCIIOWSK - Bloeroa deU'albumiD& nell'odn&. - (BollettinoChimico-Farmn.c eutico, n. 6, 1902)
S(}DO due metodi fa cili, che vanno tenuti pras enli nell e ricP r che cliniche.
W e tro ff consi g lia di riscaldare in un tubo da 5- 10 centime tr i cubi· d'orina fino all'ebullizione , che una v o lt a otte nuta, si allontana la provetta dall a fiamma e v i :oi alcune g o cce di (lO pet· ce nto). Do p o qualche secondo, in pres enza dell'albumina si fo rma un prec ipitato fi occosn, che si raccog lie alla superfici e e sulle pareti del tubo e che per la sua forma grumos a può faci lmente s epararsi me diante filt r azione. Ess o presenta un as pello diverso da quello che si osserva quando la precipitaz ione dell'albumina viene falla con l'acido azotico, e pe r ciò è riconoscibile s e nza dirtìcoltà
La quantita dell'albumina separata può valutarsi approssimativamente perconfr onto, o d anche venire d eterminata g r avimetricamente.
L ' orina in e s ame dev'e sser e recentemente emessa, altrimenti l'ammoniaca.. formatasi per la fermentazione, decompone la formalina.
Bychowsk in un bicchie re od in altro recipiente incoloro contenente a cqua bollente ra agitare u na goccia d'orina. Se questa possiede anche tracce di al· bumina, nell'acqua si produce u n intorbidamento opalescente a s sai facilmente· percettibile e che r ammenta la nube d e l fumo d e l sigaro.
Questa reazion e , che non é altro c l1e un cambiamento d el saggio all'eb olli:done, è mollo più sensibile di quest'ultimo, perchè basata su l contras to di colore tra l'acqua incolore e l' albumina coagulata 0palescente Nell'es e g uire il è buona pratica di tener il recipiente s opra un fondo. nero. Se l'intorbidamento provie ne dai fosfati, s i può rilevarlo con facilità mediante l'addizio ne dell'acido acetico. ct1
Pnosc HER. - Btoeroa d ella btllrublna n e ll'orlDa medl&Dte la diazoreazlon• di Ehrlloh . -(Bollettino Chimico - Farmaceutico, n. 3, 1902).
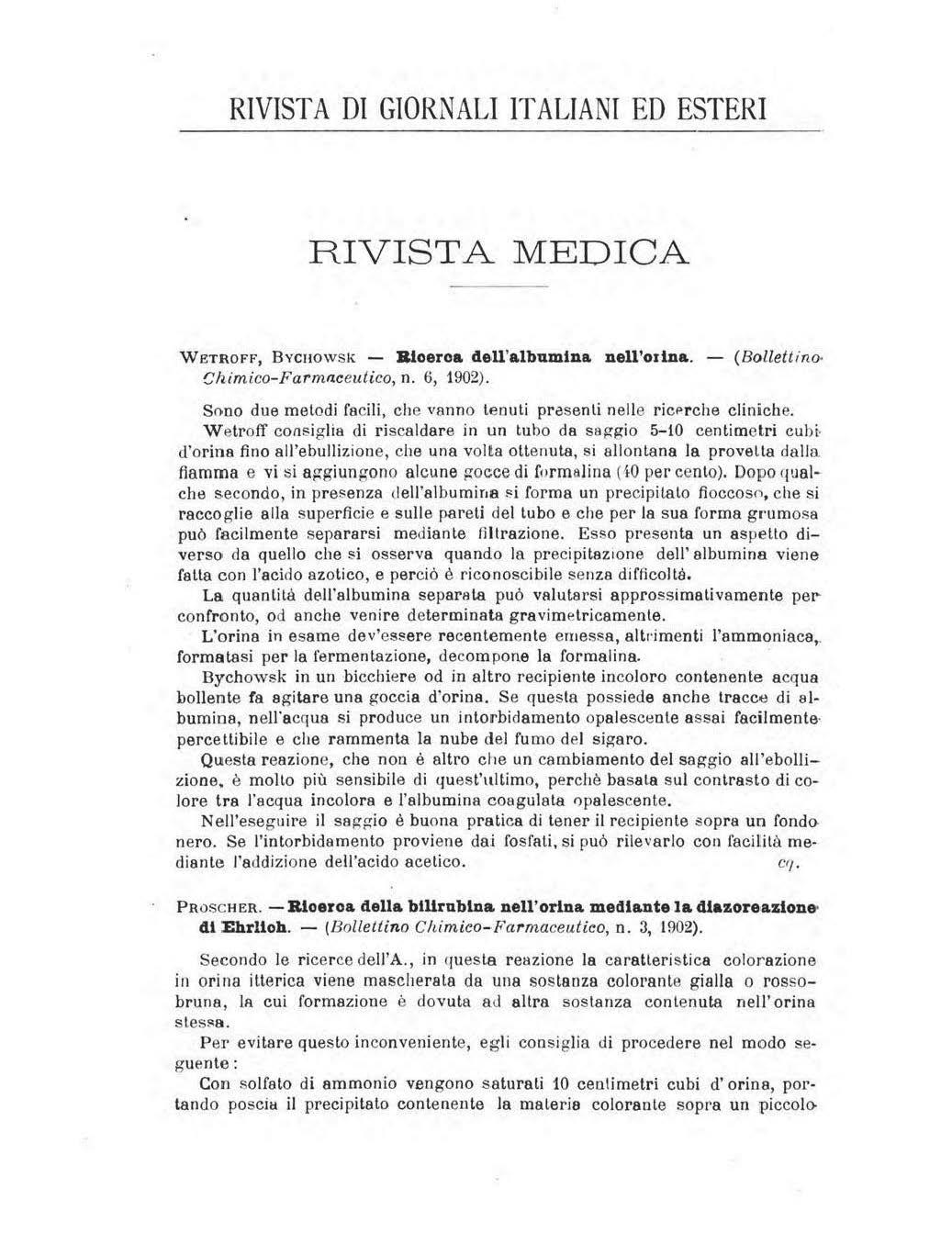
Secondo le ric e rce dell'A., in rruesta reazione la caratteri s tica colorazione in o r ina ilterica viene mascherata da una sos tanza coloi'anle gialla o ross obruna, IR cui formazion e è dovuta ad altra sos tanza conte nuta nel!' orina s tes l"a.
P er evitare ques to in conveniente , e g li con s ig lia di procedere nel mo do seg ue nte:
Con s olfato di ammonio vengono saturati 10 centimetri cubi d'o ri na, portando pos ciH il precipitato contenente la materia colorante sopra un piccolo.
filtro ed estraendola ancor umida con alcoo l a !)0 per cento. Si acidifica rortemente l'tlstrallo alcoolico e lo si tratla con la d iazosoluzione.
In pres enza delh1 bilirubina si allora la colorazi one azzurra, la quale con l'ag!(iunta dr un alcali passa al ver de attraverso il r ol'SO.
Questa reazione può pur·e essere ut ilizzata alla r icerca della bilirubina nel siero del s angue, ge si ha cura di pr·ecipitar·e l'alb umina del sie ro c oo al cool, di aciditi care il filtr ato, lrallandolo poscia con la diazosoluzione. cq.
GEO RGE RoE Loctnvooo. - La ga•trlte oronloa non alooolloa . (Medical Record, maggio 190 ).

Sono i risultati di un accurato studio, che l'A. ha intrapreso da lungo tempo, di qu e s ta forma mo r bosa, e r irerenlisi a 4() casi da lui incontrati nella sua pratrca privata in persone di diverse etli, di ::<e<>so diverso e di S\'ariala condi· zione sociale l n tutti la diagnos i è s tata veri licata da analis i d e l contenuto gas tri co, ripetuta più volte; in tutti stato esattamente e me nte og ni renome no mot•boso, e da l compl esso de lle sue re g istrazioni l'A. ha co ncluso che la s inlo matol ogia realm ente offe rta dalla gas tri te non al coolica è mo llo d ifferentt:: da quella che si suoi leggere ne i libri di testo. Ed é appunto per dr mostrare la Lra il c orso clinico di questa ma lattia e que llo che si apprende nella letle r a tur·a medica ch'egl i s i é deciso a pnbblicare le s u e osservazion i. '
Dall'esame dei varii si utomi da lui osse rvllli e r e le l'A . di pole 1· alla divisione di Lutti i casi in tr e gruppi , a seconda della qualila e fJUanlila di s ecrezione gastrica:
a) gast rite con iperacidila;
b) gastr ite con acidità normale;
c) gast rite con acidità diminuila.
Ogni gruppo av r ebbe poi una div isione naturale io due sotlogruppi secondo -c he esista, o meno, atonia dello stomaco.
Esaminali poi lutti i cAsi partita mente scende allt:l seguenti conclusioni:
1' Nei casi incomplicati di gastrite cronica non alcoolica, quando il potere muscola r e de llo stomaco sia-;i mantenuto nor·male o quasi, il solo sintomo degno di menzione é ia pirosi; il che egli ha ri sco ntrato verificarsi in· più cbe la metà dei casi osservati.
2' Le gast riti con iperacidita possl)no avere un de corso ra ssomigl iante a qu e llo delle gas tron ev r·osi, inquantoèhè i sin tomi sono intermiltenli e vengono fa cilmente influenzati da conrlizioni nervose. R itiene pe r ò che una nevrosi gastrica di lunga durata sia estremamente rara e che la maggior parte delle af· fezion i gastriche attrib uile a nevros i a ltr o non sieoo che lo di u na lesione or ganica in coincidenza dr accessr nevrolici.
3' Nelle gastriti, contrariame nte alle idee finora prevalse, sarebber o da IPnersi in considerazione i seguenti ' fatti: a) l'appetito è gene ra lmente buono. Le p0che eccezioni appartengono a gli stati nevras t e nici ed al l'avanzata atonia, nella quale non s ono ben tollerate grandi qu a ntita di cibo . I n nessun caso pe r ò la gastrite è, di per !';è stessa, causa di a n o ressia; b) i dolol'i s i originano in due mo di: 1° oe r la ipei'acidil.à, e questi non differiscono in a lcun m odo dai -dolori che si manifestano nell' iperacidita nervosa; 2° per il sovercllio svidi gas, e questo gene re di dol or i è per·fellarnente identico a quello
RIVISTA MEDICA 53
che si ha ne ll'!lto nia s enza gas trite ; c) no n v i ha n Ausea in r·e lazione coi pasti. Color o c he soffro no di g astr·itc con atonia, 0 con posson o lagnarsi di nau sea , ma rru es ta no n su l l o r o appetito. E ssa si ve l'ifìc a or·dinariam ente CJUand o il paziente è sta n co o rrrrtato ; d ) nelle g as triti no n 111cool i c he manc a il v o mito; e) a meno che nott e!'.ista d iArr ea lA n utriz ion e g enera le del paziente e buona e n o n esi s te ane mia, fall1:1 eccezio ne pe r l e strlli c on atonia, n lle quali però deYe p i ullO!'l O co nsi derarsi come cau sa, c h e c o m e efre tto del la f!"al'trite;
4' Se il poter·e mu sco l ar e dello s tomaro é po v e ro si OS!'i•' r·va d i !ZA!' , e ci ò Rccnrle più facilm ente nei cR si ed é probal"i l m en t e dovuto ad &l'ia in goia la;
5• La gas tr·i te pu ò dnr lu ogo a grave ed o stinata dia r r·ea , co n stw cessi, a emac iazio n c, il c he p w\ ori g i na r e pPri ro l osi err o l'i d1a g nos t ici, fa c ili ad e,·itars i quando si facciano ri petuti ed accur·llli esami d el coutenulo
6° L '1lleri z 1a co n lutto il dei s uo i sinto n1i é raram ente oo ,·u ln ari un d i;.o r din e fu •lzi o nale p r·i111ari o J el ma g-e ne t' ll l m e nte a l o x Pmra intestina le, in dipende nzA a q:uo lche d i sor d111e del la l' h i mica gA>i lri ca, ch e l as ci a passar·e nef!l i iutestini un chimo im pe r·fetta mP. nte p r epa1·a to
7• Anetnia e cos t rpa zion e sono spe sso i sol i si nto mi di u na :zastril e e la loro per s ist enza serrz1:1 cau!"a appar.-nle d ev e sempre consi dt> rars i com e u n. avvertim ento, pel m edico, aù anali zza ee il contenuto de llo !'\ l om aco
M A vs - Il rl8e11o del vago . - (B oston m ed a!Ul. Surgi cal J o urnal. 16 ;raio 1002).
Wall es fln d al 1870 aveva n otato ch e la c0 mpr•ession e del va g-o nella r·edel coll o r>rov ocavfl unR cfin t<H'me n tim•• ril o, r a ramente d 1 dnlore al c apo, un senso di lt111 g uo r e e d i d elif1uio L:he po t eva conv e rt ir·s i in uua sincope ,;e la c om pr e!"i:' Ìo ne co ntinuava
M Rys u sufrui di q ue.;to f eno m eno per la d i ag-no si J i tub er co l o si pol m onare E gli lr'o v ò ell e quando l'afl'ezi u ne è un ilater·al e la co mprel'sione del va go da l IHLo corT ispo nde nte p uò pro voc ar·e fèn om en i r i lh•ss i: c o m e sen so di cos ll'izione e tosl'e dolore all' o cc 1pite , v o mito, m entt•e fJUes t i l'alli n o n s i osservano c o lla c o mpressi on e del va g:o !'8110
Oi più ten tò una cura dei sintomi l'ill eso: i del l a tu beJ'col o::;i c o l le iniezi o ni nel la pr.) fo rrdita d el coll o di una soluzione di nitr ato rl 'ar·g eoto all' l-2 per c ento pr e,•i a una init>z 1on e d i cocaina. E g li alferma di avet• ottenuto migl i o ram enti in. tutti i sinto mi funz io n ali e speci alm enlH nella t osse e nel vomit o

RIVI STA liEDICA
c. J.
G. O.
RIVISTA DI NEVROPATOLOGIA

Doll. A. MELE, capitano m r dico , ouo1·ario a ll n Clinica P sichiatrica di Napoli. e E PATINr, sollolenente rned ko di compl emento, alunno n el l\lani co mio pro vrnciu te di Na poli.- Un raro caso dl amnesia hterloa.. oon perdita. della prlmlUv• personalltà.- ( DH g l i .r1nnali di S eo r olo!tia . fa se. I. V , 1111110 X X}.
È un caso r he si n10lto dAlla comune l<irrtonralologra p er i falli somaticr, quflnto f•er i faLli P"ichic i. Cr d iHrno utile pe r ciò di darne uu laqzo sunto.
Un mAes tro elemeutare di 10 anni, eon l'!lllll c lrc prect>denle e r ed itario n on mol to impor tant e, d ' iutelli !.(enza poco rt i cand t CI'e e m i8a ntro pico, eccessivamente alli!C('alo All' con vi "e"a i n corr una Slia fante sca, da cui cu rr l ratto di r ec·en lc la si filide, da urra doppia irite e da un attacco c erebrale, r e!-idullto in !'r rdparesi. Da <(lll!l c h e t empo p-li er a so rt o il sospello ch e si di ru harp-li un piccol o #;trm.zolo, fr utt0 dei suoi risparmi, co mplke la sua amante; e be n fJUP>'ti i"o"!"'lli cominciarono ad essere rafforz11ti da Prr o ri sen so riuli s••tlo fo r me d'illus i oni vulitive e visive che gli fa r evano sentir•e pur·ole mi11a cc i ose e venere dovunrfli P d i brutti cetlì. Finalmente un giorno il dE'l i rio !<i l'A p iu vi vo, l'i11 1'ermo v edo assalita l o s u.a da la ct l'i, e la fante sca c he ti ene l o r o mano , e allo r·a •·gli, g r·idando ag l i a ssAi"Sini, ucci de ques ta con un r·asoi o.
Portato in carcere i n e stre ma af!i lozi o nl' , fu al ienato, e tra s rer ito a un m 1wicomio c1·iminale, ove fu d ichinrato e d o nde a qntlllO di Napoli.
I l primo e:!ame Eo mati ro , ft1tto nell'agosto 1901, fece ril evare i seg uenti fal l i notev o li: c mian es te sia tattil e l'l dolol'il i('a sinii"t r·a; ageu!'lrn ed ipoacusia emianop>'ia tempo ral e destra; paresi faccral e si nis tra e de ll'a rto srrperiore; b1·adif'asia, aboliz ;o ne della srritlura spo ntanea e solto dettatura, possi!Jilità di copiare malamente i segni grafici. no n più inter pre ta ti com e srmbol i foneti c i, e quindi completa
L'esame psidlico mise in ev id enza no n solamente un ind eb0limento del po· tere pe r cellivo, ma spec ialmente una va!'lta la c una mnemonica , si estendeva a lulta la sua vita passata fin o alla dimora nel manicomio criminale. E gl i non ri cor ·dava di essere sta to maestro, aveva dimentica lo le per,.one e 1 luoflbi pr1ma a lui familiari, aveva perduti molti concetti a><L1·atti, corrre quello della scuola Tutte le !"ue cognizioni al·quis ite erano slal e travolte o PI mare rlell'oblio , non esclusa la letlu1·a e l a sc J·ittura. Il suo potrrmonio mentAle in questo perio do e ra cosUluito solamente dall a poche fatte dall'epoca in cui era uscito da quel secondo stato in cui pi ombò il del delitto.
L'infermo restò in questo stato sino al dicernb1·e succe!';si v o, 11uando si n o tò l a !.'Comparsa ci ell'em ianopsra, il rest r ingimento delta zona anes tetica, ecl il ritorno p11 r ziale d ella facolta di leggere. An c he la lac una mnemonica si and ò restrsngeudo n ei mesi successivi, l'ideazione si fece prù ri cca, e ritornò la co -
55
scienza di'Ila sua primitiva personalità . Co!"i mano mano t utt i i fatti morbosi psicltici andarono e, cosa notevoli!"sima. il rio.-dina r si della p!<i che procedeva pa r allel!tmente colla dei 8intomi sO n1atici, co:Hcehé nell'a pril e 1902 l' infer·mo era r-itornato menta l mente quale Pra prima, ed er·a sparita l'anes t esia cu tan ea e dPi !'en;:i !<peci l ici; inc.llre egii A seri veva come prima. testo !"Ono r iportati i sal!g• d i scnttura per copia. solto delIalo P spontanea che segnano i varii passa).?gi sino alla complo•a r iacqui><izione dell'uso dPi segni gt·afìci.
Un p1·imo fallo degno di nola in qut>stn caso é la sumiA"Iionza del primo per iodo della p.:;icosi colla parulisi pr ogrP!'si ,•a, diagnol'i falla app unto nAI manicomio cri m iualo Stabil ita la diagnosi di i s ter•sm o, e v1!'to co111e Lutti i falli sieno i n dipendenza di quest o, per il parallelis u •o Psallo dte e!>iste nel decor so dei !'intomi so mati ci tip ici di nevro;:t e gli altl'i c he non sono in e ssa frPI'!U"nti, ven111mo ad esa mi11are parl•tamente u lti mi che si trovauo tanto nel campo somolico, llU81llO rwllo psiclnco.
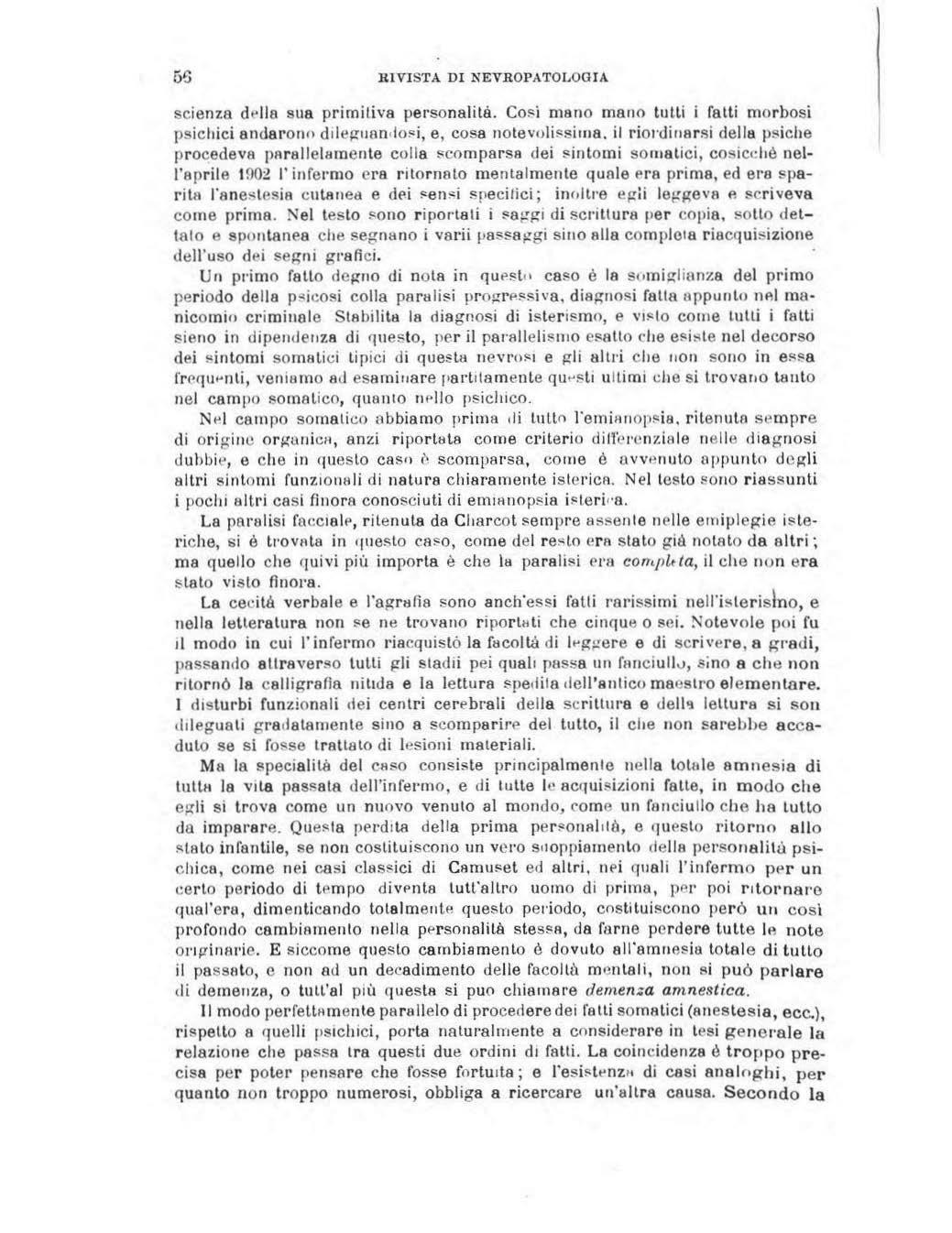
NPl campo sornatico abbiamo p rim a di lu tto l'emilln Op!<ia ri tenuto se m p r e di o ri gini} o rg un i cH, anzi ri porta ta com e c riteri o diiH.•r·cn zie l e n el l e d•a gnosi òuhbit>, e ell e in questo casr, •' scompa r·sa, come é nvwnuto appunto altri sintom i f unz •onttli d i natura ch i81'arnenl e istc•·icA. Nel testo sono ria ssunti i poclu altri casi finora conosciuti eli i !<Leri•·a.
La paralisi faccraiP, r iten uta da Cll a r cot l'ernpr·e assente u t>lle ric he, si é tr·ov11ta in qne!'>Lo CAl"O, come del lo (' l'A stato già notato da altri; ma quello che q uivi più imporla è che la l't'a con.pltla, il che nun era s tato visto finOr'a.
L a cecità verb ale e sono anch'es si falli rat·issirn i nell'ister islno, e nella lette rat ura non !'e ne trovano r ipor luti che cinque o !><'i. Notevole poi fu Il modo in c u i l' infet'mo r'ia cquistò la di l ..g!!ere e di scrh·er e, a gradi, passando attraverso luLti pei qual• passa un fm•ciullv, si no a che non r 1torn ò la ca lligrafia niltda e la lettu ra spedita dell'a ntico ma(•stro el e mentare. I d tsturbi funzi o nali clei cen tri cerPbrali della sc rillur·a e dell'l lettura si so n dileguali gra.latamenle sino a scomparirP del Lullo, il che n on sarebbe acc aduto se si fo!'-se Lr allato di l esi oni materiali.
M a la speciali lil del CA!'-O consiste principalmente nella toltlle amnesia di lUtlfl la v1ta pas!'ala dell'infer·mo, e di tutte Il• aet(Ui !'itioni f alle, in modo che egli si trova come un n uovo venuto al m ondo, ro m e un fan ci ullo c he h a lutto da impar·are. Que!'ta ppt·drt.a della prima pe r;;:onAhlà, e 11 ut>slo t•itorno allo !'>la to infan tile, se non costituiscono un vér·o s•roppi amen to della per·sonalitil psichica, com o casi clas,:ici di Camuse t ed altri, nE'i qual• l ' infermo pH un certo period o di t t>mpo divPnta lutt'allr·o uomo di prim a, pPr· poi rllOI'nat·o qual'era, dimenticando totalmente questo periodo, però uu così profondo cambiAmento nella pt-r sonalilà ste ssA , da farne p er dere tutte lP. nole o r·rp-innrie. E siccome questo cambiamento é dovuto a ll'am u esi a t o tal e di tullo il passa t o, c non liÙ un decadim en to delle facoltà m entali, n on si p uò par l are di de m euzo, o tu LL'a l p1 ù questA si puo chiamare deme n::a amnestica
Il m odo per·feltttm ente parallelo di proceder e dei fall i somatici (an es tesia, ecc.), rispetto a quell i ps tclllci, porta nalur·aln•ente a considerar e in gene r·al e l a r elazione che passo Ira questi due ordini dr fatti. La coincidenza ò troppo p r ecisa per poter pensar e che fosse fortUita; e di casi per quan to non troppo numerosi, obbliga a ri cerca r e un'altra causa. Secondo la
RlVISTA Dl NEVROPATOLOO fA
ipotesi de l Janel la manifes ta zione di ratti so rnatici isterici non sa r ebbe p r o-do tta se non da una limitazione della coscienza , ch e !'ar·ebbe quasi tagliata fuori dalla comunicaz1one con certe vie dPIIa sens1bilità. D'altra par te di S lr lirnpell, che consiste nel far cade r e in so nno uno che a bbia ane!'le!'ia rren e ra le, quando p-li s i chiudono gli occhi e gli orecch1, dimosll·a come le funzioni ps1ch ic h o vengono a man ca re quando tutti gli stimoli e!'terni sono sopp1·essi. dunque vemre alla conclusione che le allt>raz1oni somatiche e p!>ichiche sian o indissolubilmente tru di lor·o e ri spPllo Al meccani!>mo genetico. Il pun to di partenza non si ha né dall'una n è dall'a lLra srem, poiché ent ra mLe queste !'i possono fondere in un cancello unico, e dire che i falli psichici sono un r iflesso dei fRtli so matici, e que«ti s<mo il r iver·be1·o, quasi lo pr·oiezione di quelli.
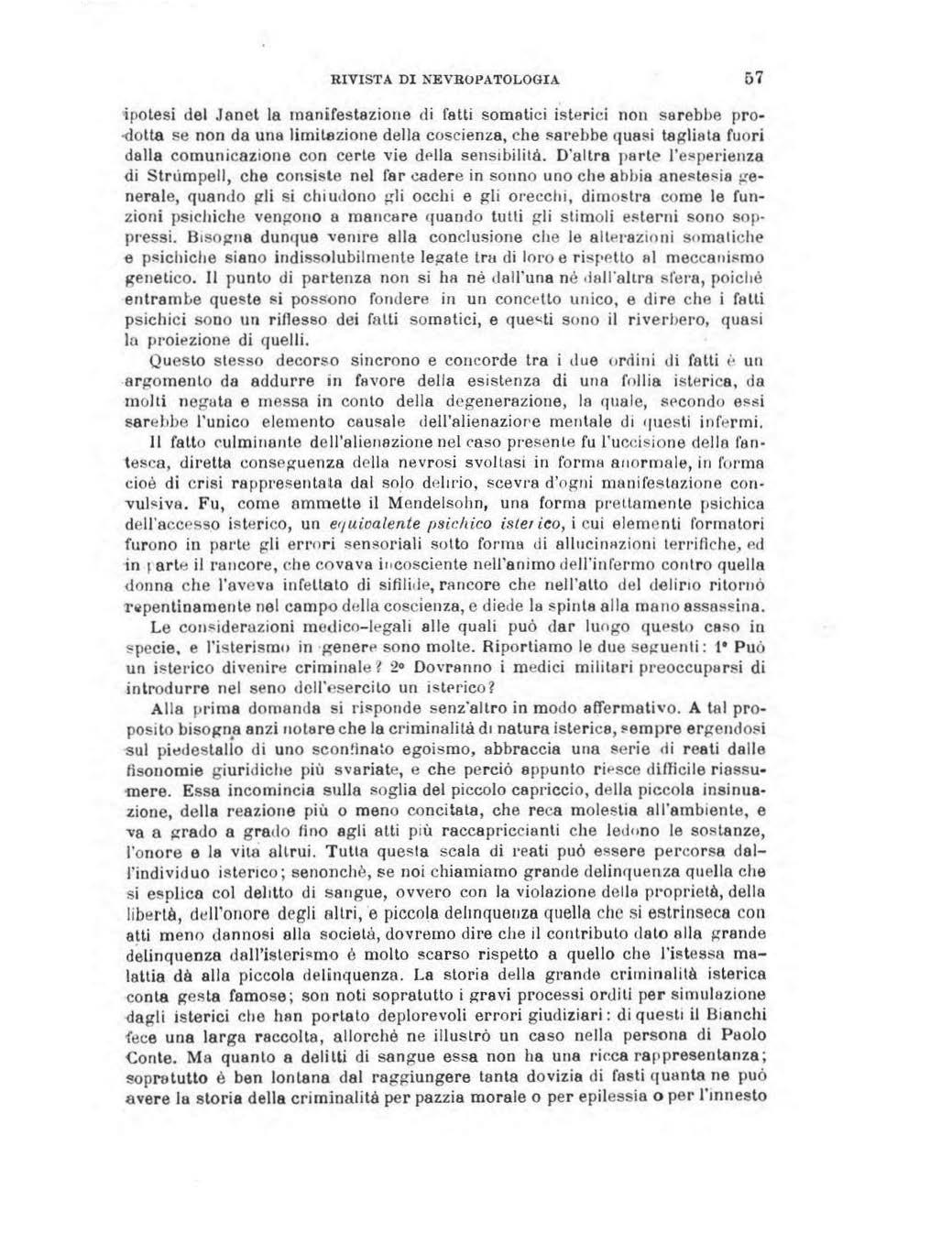
Questo s tesso decorso sincrono e concorde tra i due ordini di falli i· un argomento da addurre in fAvore della e sis tenza di una follia isterica, da m olti n ego ta e m essa in con to d e lla degenerazione, la (]Uale, st>condo e!>si s arebbe l'unico elemento causale dell'alienazioPe m en tale d1 ttu csti infer mi.
Il fatto ru lmi nan le d e ll'alienazione nel <.'oso p 1·e1<ente fu de ll o fon· tesca, d ir·e tta const>g-uenza della nevrosi svo l tas1 i n fo rma ano r male, in forma cioè di c r isi ra pp1·e.c;ent ata dal so lo sce vra d'ogni m ani festazione con· vul " iva. Fu, co m e am m ette il Mcndelsohn, una forma p1·ettamen te psichica de ll'accesso is te ri co, un equivalent e psicltico iste1 ico, i cu i eleme nti form Atori fur o no in parte g li er r·ori sot to fol'ma di a llu cinHzioni terr·inche, t>d in 1a rll:l il t'ancore, c he covava i 11cosciente ne ll'an1rno detr in fer·mo cont r o quella uonn a che l'ave va infe ttato di sifilide, r Anco r e che nell'alto del delir1o rilor·nò
Tepen tioam enle nel ca m po della coscienza, e diede la !> pinla alla m ano a ssA!'Isina.
L e con"ideruzioni m edico- legali alle quali può d ar lungo qut>sto caso io specie. e l'ic;te r ismu in geoe r t> sono molte. Ri po rt iamo le d ue seg u enti: 1• Può un isterico divenire c rim inale? 2° Dov r anno i m edici militari pr·eoccuparsi di inlrod urre nel seno ùcii'Pse r cilo un islf'rico?
A lla p r·ima domand a s i l'i.c;ponde senz'altro in m odo affe r ma tivo. A tal proposi to bisol{n,a anzi notare c he la criminalità dr natura ister ica, l:'e m p r e -sul pi tldestallo di un o scon!inato egoismo, abbraccia una serie rli reali dalle fisooo m ie gi uri d iche più sva ria te, e c h e pe rciò appunto r i..sce difficile r iassumere. Essa inco mincia sulla soglia del piccolo capricci o, d e lla piccola insinuazione, della r·eazione più o meno conci ta la , che r eca m olestia all'ambiente, e va a j:rra do a g ra do fino egli atti p1ù raccapriccianti c he ledo no le sostanze, l'onore e la v ita alt r ui. Tulla questa scala d i r·eati può e.c;se r e p e r·corsa dall'individ uo isterrco; s e nonchè, se noi c hiamiamo g ra nde del inquenza quella che s i col delitto d i san gue, ovvero con la violazione della pr·op l'ietà, della li be rtà, de ll'o no r e degl i alt r i, e piccola dehnquerrza quella che s i est r inseca co n atti m eno dannos i alla socie tà, dovremo di re che il contributo dalo al la g rand e de linqu e nza da ll'istcri flmo 6 molto scarso ri spetto a quello che l'is tessa m alattia dà alla piccola de linq uenza La stori e de lla g r·ande cr·irn inalità is te ri ca co nta g es ta famo s e ; son noti sop ratutl o i gravi pl'Ocessi orditi pe r sim ul azione dagli is terici che hAn p o rta to deplorevoli e rrori giud iziari: di ques t1 il B1anchi fece una larga raccolta, allorché ne illustrò un caso n e lla per sona di Paolo Con te. Ma quanto a d elitti di sang ue essa non h a una ricca r a pp r esentanza ; sopra tutto è ben lontana dal raggiungere ta nta dovizia di fast i qut1n ta ne può avere la sto r ia della criminalità pe r pazzia morale o p er epilessia o per l'rnnesto
RIVISTA DI NEVROl'A TOLOGIA &7
di entramb e sullo individuo. An zi a tal pt·opo!'lito pot emmo dire che, m er1lre il folle m oral e A sempt'fl in imminenza di e l'epiletti co genui no n e ha una probabilità più o meno l!l'and t• , l'1st f' t'i co iuvere ne ha la pnss1htlil8. Il delitt o di nell'ister ismo è puramentfl eventuale. Rit ornando or't\ alla questione di medi cina l e!la le m ll i l Rre, sarebbe una e;:agt>l'azi one rl voler veder e in og ni i sLN·ico un r r tm i nale latentP, e rl vol ergli per c 1ò tiare l'ol'tr Acil'mo Ma.11nche senza p r eoccupa r ci ch e il deiiR dll'Ciplina m•litare po.-::!'la al l'1 tnp r ov,·i so fa r e e!' ploder e la delrufJUen7.a tn un io;tl•r·ico, l'empre 11 f8lto che 6!'!'8 può :>em p r e cltiam11rc in r!"Ct>na la pi ccol a olelin(Juanza. Per S<>!lgetti normali l'am bi.·nt a mililart', tt('punto pet·ché e!'arc1ta contnll!Amenle i polPri di iuibi71one, a!..'i!'.I'P da mezzo t-duc ato re; ma pt>r i :-:ter 1ci, tlotati di una e m iJtivilù palltlogira. c ut \'ila p;:ichica
ì· il di tal e em oth ·ità, e la cui caral let';!'ti ca ,·on!<i,.te proprtn nel ùifelto e n ell'e!'aur·ibl ltl!ì d i q u ei poteri, l'alllbieule militar·"' n on fa che pt•nvocllrP le r Pa1.in ni del l"nrallet•e i :;Le t·i co, quAndo p ure non t'tt•!"Cfl a l r a«pnJ'tare In dolio !'<LH IO di IAtenzfl in quello del l e !"ue ciO!'!"iche Ora n n i c1 d orna ntliHmo : (Jnn l vnnla!!gio pot1 à rlet•tval·ue Alla di!'ci('lina ed nl più t' e!.rolare f'unzinnnn •enlo dt-lln cnll t}t llvi lit milllal'e ;:o tto lo armi ::>i 111 tli indiviJui 1 C•·l'lo il mq;!'lior pl'nv vedimenlo, in fo rmHtO da un1:1 plll'le Ad UJI umAnitarto e dnll'allra Alla m: g lior tu tela degli Ol'dllltHn e nti ru il ital'i, >-&r't!hb e IJUello di eliminarli senzn ri se rva dal se rl O dell'csPr ci l o. i\-11:1 in pratica llll tal p r ovvedimento 110 11 e di fn c i le e!'PCUZi o nC, percftt'• 1101l f:Pmp t·e noi s: i nmo rn di fa1' co n ce rlt-zza la dtag-nosi dell'is:Lr r·i f: m o . Tu tte le volte qu tnrli c h r , nell'eMtninare i nuoYi chiamali soLto le 81'tni, ur i stortci cnncl am tt t i, sarebhe l'a dle adoLlare il rinwdi o d Pila lo1·o p ro nta eli minazio n e dalla n11hzia Quando invece incontrassimo dei con ('Oche ed iudcci::-o note, che racel"sero piu sospeUa r e che l a !>.u tldetta nevro!'<i, allora rl m iglior c r ed tamo, !'a rebhe 'lll<'llo d'mvi a r l i ai cor pi cou dell e spPetali inotirazinni e con l'av\'f>rtimentn, che O;.!ll i 101'0 man il'el'LAztone in conLJ'HSlo con la di!<cipli na ,·cnis-.e g ru dicalA a! lumi-' d r criteri medi d , affinché non a ppE' na !"i riusci s!'e pe r 8 \'Vt>lllu r·a a formulnr,, con fJIIPil a
;:i anche per· loro il r adicale pro v\'Pdirnento dello zione dal r l•;:tante !'el'\'r zio mi lita r e.
Il della nevrosi il"Lerica vi e nE> ad E'S'-'er e a n co ra pi u Ila 'l n lo CllS:O per i l'11tli rar1s !'i rni o arld i l'ilt ura nuo vr in e !'o!>O O!>Sei'VO ti. Ed è leri t o domnnclare dove si arre!' la 1 Cert o no n vi é al c una t eorica per che vi s ia un limite Alle sue lras fo rm aztoni. E il far pompa g iot·n o di unR nuovA v E-s te é una g-uida di p tu pet· indu r ci aù una tale previ · !>ione. S ia c he l'istf' J'i s mo s'inte rpt·e ti co me una n e vro s-i ce r ebro -co rlt Cillt\ ai sen s i dello IAn et, sia che lo si ritenga una nevros i dell'asl'e cer ,.bJ•o- spinale in t o to, come v o rl' rbbe il Gt·asset, nel p r imo pe1· le inoumet•evoli t• dazi o ni tra i cenlt- i c e r·eb1·ali e i vari sistP.mi ed app11rat• nel secondo ca;.o per la par·tecipazion e alla nev rosi di qualunque zona del sis t ema n ervoso in ùireLLa comuni cazione coi sud detti s i s t emi ed apparati, si può avanzar l ' ipotesj, che no n vi s ia alterazi one funzionale dell'org anismo ch e non possa e;:sere presen t ata dall 'i steria e che r1uesla possa ri sietlere, SQ vrana eJ a scosa manipolatric<', dtelro qualunfJue scenario dell'umana patologia.

58 RIVISTA DI
RIVISTA OliiRU R GIO A
F . CR UMER. - Dlag a.oaldel oarolnoma del gro11o lnt eatl no . - (.\1 ti nt:hner \Voehensclt r t.fl, 18 giug-uo 190:2).
Gli attacchi di colirhe intesti nali, che avven)!ono ad intervnlli più o meno sono i primi sintom i di qut>!<l& condizione m orb i)SA e quando !Juesti attacchi si notano in pe,.!'nne npparenlemP.nte l'alle, specia lrncnle rh•l abbiano pnsseto la mezza etll, posson o .;esl81'e rptlllche so::;pello e con«iulia r e. ad un accurato esame per IR pre!'enza di un caJ·cinomll d t> l gro!'<l'O intestino. Certamente n o n tutli i ca!'i rli questa mAlAttia !"ono AccompRf!IIAlt da coiJ ciJr, né può dirsi ch' <"S"e non sieno qua lche voltn prndotte da Altre cause, pal'lico l nJ·menle dall'abuso del taba cco, ma in rn ndo non sa1'Ù mai cht rimprov erllt•si il fare SW'CiAie a llenzio ne a quell'evenienza .
La rigidità c i t> l l'intesLino alla pa!pazione è uno dei s tntnmi più COJ'IIlli'I'J·

;:liri dell'ostruzi on e intt>s t cnale e quando i ri petuti esami ri tene a·e cltc• l'ostruzione sia di caa·a tler e cronico, é uno dei sinlom1 p1ù vnlutnltili prr· «lAbilia•e IR diagnosi di un carcinoma prr·os«o inLP"<tinn. LH l ocalizzA7.i•Hro della l'ig"ICfilU non deve neres;;ariam en te conispo odere AllA l nrA IJ7.Z&7.ione ch>ll\· O"<tr uziom c quindi il si ntomo non è vnlevole pe r ..'elo>rmina•·e l'e>-n lln 1'-Jlunzion del l•tmot·e.
l <'Osi detti r·umori slenotici es!"i pu1·e d i \'Oiorc• e convenir·e c he mol li autori non clitnno ad es i la dovuta im portAnza Que<>lr rum ori dl'vo no t>S"ere acC"u ratamenle clilferenziali da Qliei suoni gor,:roglinnti ch e si st>nlono fa·equenlo>mente in vari e condizillni intes tinali. l':l<si dt>bbo no r·a s!"ostrel.tam e nte al a·umore prodotto dall'acqua fatta cndt>r e da uno certa allezza in un r ec1piente '(Ualsias i e debbono sentirsi dJstiolamente a 1Ju8l('he piede di distanza.
Il t e n el'mo per!tislente i• mollo nel carcinoma dell'intes tino ed 11 s uo )l r ado d i per!'i slenza e di in tensila pu0 fornire moltA luce !\UIIa Jocalrzzatione del tum r>r<-: P cù in basso é collocalo il tumore , p1ù grande la persis te nza e l'intens1lt\ rli questo sintomo.
L e emorragie curallel'isl:che d1 questa malattia sono costituite da piccol e quantiU\ di saugue frt:>seo o appena coagulato e s i ripeto no a inte rvalli frefJu c nti, per un periodo di temp o assai considere vol e. Ques to fenomeno acq UJs la m o lta importanza 'JUando u o attento esame r ettal e collo spPc ul o abbia ratto escluder·e la presenzA d1 emorroidi o di qualsia si stato infiammato rio del re t t o
I n tali condiz1oni anche la presen za di pus nelle scA r iche é sigoniflcativa.
Il pus in modo dPve se mpre essere so ttoposto all'esame microscopico, onde se vi l'i e no dei fragm enti di t essuti carcinomalosr.
Da al c uni au to ri è staLa dala m o lta importanza a nche alla pr esenza de lle feci cosi dette sleno t i ch e, la cui forma ù dipendente dalle condizioni del retto e dello s llnctere anale.
rn solo n e i casi, in c ui il carcinoma è situato abbastanza ·bal'so p e r pr odur-re un'irritazione di qu fl ste parti , possono aversi le feci sLenotiche in questa ma lattia, e 'luind i il lo1·o valore, come segno diagnostico, é limitato soltanto a quella classe di casi la c ui diaguosi é spesso poss ibile col solo e s am e dil·etlo e. f.

F. T REvEs. - L ' Intervento ohlrargloo nell'appencllolte. c a l Journ.al, 1902).
(B,·i l ish Medi·
Il mag g ior numero Jei cas i di ap p e nrli cile . s econd o l'opinio ne de ll ' A., guarire bbe !'porrtaneame nte , e, se m·ll e s lali;:li ch e s i includes se r o tutte le gradazio ni di qu es ta ma lattia, la mortalila gen e ra le non s up e rerebbe il 5 p. 100 operazioni intraprese durante un attacco Ac uto non sono esenli da un ·considerevole pericolo per la Yila del pazi r nle, pericolo che arriva a cambiar si .jo tris te cel'te zza di e s ito le tAl e nel 20 p. 100 circ a d i tutti i c a si, ed io laluni os peJali co n pro porzioni an c he mag p:iori. Né bis ogna dimenti care ch e spesso avvengono r ecicli\'e dopo operazioui compiute nel p "'riod o llcuto.
La J'im ozion e d e ll 'append ice d urant e il pe r ioclo qui e sceHle può e sser fa tta con un ri sc hi o minimo; ma con quale prolilto ?
L'A. rit1 e ne che le nos tre s ulla patolog ia de lla malattia io discor·so e la sua g e n e l'ale morlalita n o n la pratica, oramai tropp o -co mune, di aprire l' addome in ù g ni di appen d i-cite , app ena ne sia stabilita la diagn osi.
L'operazio ne immediata è rich ies ta, e al più pres to posl:ibile , io tutti i cas i ult!'a-acuti. Tra ques ti si tr ovano e se mpi c o n d ecorso d ispe r ato, che presentano fin dall ' inizio tutti i sintomi di una inten s a infezion e , co n evid e nte e p r ofond o avvelenamento di tutlo l'OJ'ganis mo. La morte può avvenire, in tali casi, fra 36 e 48 o re. Appartengono a <.JUes ta cate gor'ia le avpendiciti, i cui sintomi -so no altrettanto a cuti e non di s simili da quelli d e lla perforazione dell'ulcera di sto maco.
L 'oper·azione imm ediata è pu r e r ich iesta quando vi sia r a g ionevole sospetto che pu s s a e s s er·si determinata la sup pu r azione.
I n lutti g li llllri cas i, la l'(ues tione d ell'o perazione dovr ebbe mette r s i in campo solo qualche giorno dor>o l'attacco e, !ascia r la insolula fino al quinto giorno e an che piu tardi, imperocchè la mag g ior parte dei casi di appeudicite può gua rire spo nlaneamente e senza formazion e di ac ce sso. l casi ullr·a- aculi so pramenzio nati s ono g e ne ralmente rari ed anche quelli con esito in s uppurazi o oe sono r elativame nte n on mollo c omuni.
Talune volte , s pecialm e nte negli adulli, l'attacco di appendicite sembra determinato da un di so rcline didelico, c o me in quegli individui che non han n o denti, in coloro c he ù ivoeano s enza ma l' tica r e, in quelli c he e ccedono n el mangia r e o eire mangrano costanteme nt e ci bi ind iges ti e finalmente nelle persone c he LJ·ascuraoo i loro intestini. Se qu e sti errori ven g ono co rre tti, essi possono non avere una r•ipetizione dell'allacc o.
La rimozione d<lll'app e ndice può venir consigliAta oell'appendidte cronica, in quei cas i in cui non vi sono attualmente atta cchi, ma ne i quali vi è abi· lua!e malessere nella fossa iliaca destra, con esace rbazioni di questo malessere in determinale circostanze. Ma noo si dim e ntichi che tale rimozione ciell'appendice n o n é u na panacea. e. f.
(ì0 RIVISTA
GHIR!JRGICA
LEMKE.- L 'Intervento ohlrarsloo nella taberooloa! polmooare. - (Ameriean Ga.z _oj surgery , luglio 1902).
La speranza di otten ere buoni re s ultali nelld cura d e l te rribile ha naturalmente tentato anche i chi ru r g hi, i quali hanno escogitato varii metodi pe r conseg uire lo scopo. Un recente processo s tud iato dall'A. c ons is te nello iniettare dentro alla cavità de lla ple ura de ll' azoto od a n c he s em plicemenlede ll'ar·ia, per o ttenere una co mpre ssio n e e·d una conseg u e nte isc h e mia d ell'org ano ammalato. Quando la malattia é e stesa ad ambe d ue i polmo ni il trattame nto d ovre b be applicars i s uc cess ivamente, non s imultan ea mente, e la raf!i o neè a s sai ovvia. La compres sione ottenuta, o ltr e a portare l' isc h e mia de l polmone ed il re s trin g im ento di o g ni s ua c avità fi s io lo gico e pato lo gico, pr·odurrebbe dr c onseguenza anche una diminuzi o ne d ella attività funzi o nale ; e lutto ciò avrebbe, o almeno dovre bbe ave re , una influenza benefica s ul processo ch e si vu ole combattere.
Il L e mk e ha pubblica to r ecente mente i d Plle s ue esperienze , c he a prima vi s ta s embrerebber o m o lto in coraggitmti , m a s tesso po ne s ull'avvis o che, p e r· non procurArsi trop po amare di s illus ioni , non biso gna fare tr oppo affidamento s u CjUes ti primi tentativi fo r tunati, im per'occltè s ia lecito dubilar·e c h e s oltanto una mecca ni ca sul polm one possa avere un'azione veramente speciftca !' ul proc esso tub e rc ola re.
La te cnica per l'introduzion e de ll 'azoto o dell 'a ria ne lla ple ur a no n ha bis o g no di essere spiegata, ma l'A. n o n s i s ta nca di raccoma ndar·e la s tl3rilizza zio ne tanto degli str umenti come del gas .
S e mbrerebbe cbe in taluni casi siasi verifi cato abb ass am e nto della temperatura tino alla n orm ale, diminuzio n e d e ll'es pe ttorazion e in poc hi g io rni ed aumento ne l peso del corpo. L1:1 ra g ione di qu es ti res ultati s a r·ebbe da ri cerc a rsi quasi intieramente nella diminuila e s ten s ione dell'are a malata, e nell'inazion e , cui v iene obbligato il po lmone. E a q ue s to sec ondo fattore l' A. a sse g na una grande importanza, r icordando come s ia pre r.elto anti cl) in medicina il mettere prima di lutto io ripos o l'orga no m a lato, io q ual s ias i forma infiammatoria e , nel ca!:'o s peciale, valga c o m e e s empio il trattamento che s i pratica in molti cas i di tubercolosi de ll e articolazioni.
L'A. fa inolt.re una spP.cie di classificazione dei punti ch'e g li co ns ide ra come indicazioni in ques ta spe cie di cura.

In alcuni casi caratte rizzati dall ' acuzie dei s into mi l' effe tto dello compressio n e del polmone è stato molto marcatame nte be n efico, come pure in altri m e no gravi, ma con fr·equ e nti emor r·ag ie. Ne g li uni e ne g li altri cr ed e pos s a allribuirsi l'effe tto fa\·orevole d el procedimento alla d iminuila circolazio ne del sa n F! ue e della linfa ed all'a bbas sata at tivi la fi s io log ica de l po lmone.
I n altri ca s i, in cui esis tono cavità di r ecente for·mazio ne , l'itie n e possa rajl'ionevolmente sparars i che la c omp!'ession e del polmone sia di c ons ider·e vo le a iuto al pro ce sso d i c icatrizzazione, d d u cendo l'area s uppurativa, che è se mpre una g rave minaccia pe r la v ila del pazie nte ed un serio ritardo nei suo i pr·ol(r e s si ve rso la guarigi o n e .
É possibile che le iniezioni g a s sos e intrap leural i po ssano av e re una q ualc he ulilitil. nel trattamento di pe rsistenti e profus e emo rra g ie po lmo na ri da tube rco losi o da c ause e parrebbe che in tali condizioni pote s s er·o e ssere un potente aus ilio delle altre ri s orse, ma questo metodo non va us ato se nza graude
RIVI S1'A ClillW RGlCA 61
ci r coc:pczione. Vi ha un Ct' rl o pl"l"Ìcolo che l a del polmone possa ce u" are lu di->semmezio ne della malallia , p o i cl•è é evi len t e c he quantlo una cevilù tuhe1·rolnre vit>nc compre:-se, m e ntre uuo pa r te del suo r ontenulo e del m Ateri a le pulo_!!eno dt>i va >< i tende ad e><l:'cre !:<pinto ru01·i, 6. anche pm>!:'ibde che nun ce1ta '(Uunll lil runa !'l a in questi VèiSt ,-enga ri caccia ta più profondamente net Le":-.uti , «ill pe r elli• llo delh; !:<les:<a compr···><sione, s1a, e JHÙ tm<'Ora , p<•r la suzinuo che :::i oper·a ne i v asi s t es><i, I"JUaudo Il pol m o ne 1>i ri t>><pande per il del gas che era sta to lutro m c-.so nt•lla pleura. T ale conrliz1011e non 1>1 verificher·a nella ma !!ginennza dei Ctt!'l, ma bi sog-na consi J er urlll com() poc:s1blle. sp...cialmente nelle ca vita d1 fr·e!'ca le cui p111" eli non coflhmo In protezione, che può esser dala dalla barnet·a fib1·osa tli u na cavità d i dttlll JIIÙ Oll lii'O.
E i n sn mmo ancu1·a troppo presto pe1· a ssefrnare un val o r e a que!';to n1rtoJo, chC' d'd lll' a parte n0 n può u epp ut"e PS!'CI'e al •hand oua to, oll"r endo esso urr vn!:'LO campo per ed ui Leri Ot"l. I l s uo s u ccesso ù ipon dt> ril certamente da un"accura l a sel ezi one do i ca :-. i, 11011 di 111 en ti ca ndo che no n si po t ranno mai avm·e huoni r e,.ultall dal lratlmm•nlo c hii'UI"Ilico S<' nza la coopt'I'UZIOne di tulli i m e1.zi l e r apeutici dte abb 101 11 0 u no>< ll"a di spO''I Zion e pet· la sal ute l!en c r alo del pllzi enle. c .(.
RIVIS TA DI OTO-RINO-LARINGOIATR IA
U.\IITJI. - Le oondlzlonl dell'organo dell· udlto e delle v l e aeree superiori ln 27 6 reclute. - (lJt!tlls tnil . itr.;tl . Zt:tiS., 1!}1):!, fus..:. 9 e I O) .

ò che All"ll rriv o dt•lle r eclu te YCil /!8 pr11lir·ato l"c,.:nme dt-ll'udrlo ed il r eperto di dei vi!-l l alr LJ·a>:cr rllo !'<li r ••!:!il'llri. Que;;Li e,..HI"ni hanno d nlo morlo all' A. di l'if<l i"II"C ci1ca In frequen za ed lmJ•Orlanza dl•lle l e,.io ni Auri cola ri, ua ,..al i , fnrin;..re•· " boccnli n elle r eclute.
L 'e..,nme doll"orl•c:·hin fu pt•alil'alo in un CMI'ioloin lun g-o 3 l m Plri, Allo;, lli>' LI'I , il cl•e spi •'!!a con1e l 'A. ammetta :11i mrLri c01110 d1:>tanz<t uditiva nOI'II10ie IWI' In voce afono. Dr que"ti 275 ud i vano l a vo c;e lll"o na hilatcJ'A im e lllC:
a :JG m r tri 1!H = p. IJJù
Il .%- :30 711 =
a 29-20
S.H »
T o tal e 9:!,7 p l OU
V cnl! r cclul<' (7,2 p JOO) pre"enla vano alle1·azinr11 patnl0giche cloll' oret'chio m edio di ca r'allt> t't' cronico: pe r l"nra z ioni della nw mlo1·a na 7 volte (2,l p. 1 00) con duninuziono ti"ud i t o po1' l a vot.:e afona fino a 3 m el l'l ; t:ala rri cronici dcii" o r ecchio m edio, r·et razi oni, t>d opacitA della m em b1·aua: 13 uomi ni ( i- ,8 p 1 01)).
Due uomini presen tavano sor·JilA d i g rad o c lt:vato d a vegetazio ni ode noidi
RIVI S TA DI OTO-.RINO-LARI:\GOIATRIA
··osi voluminose da ri empire il ri nofa t·inge ed at'l'i\'are s ino n l e da ren der e impossibile la r·espir·azion e nasale; fu t'OliO oper ati di aJenoidectomia con ottimo r isultato awst1co
B Art h esaminò an(' he il l'ino far i n ge. di>'l in g uenJo l e tonsil l e in quatt ro o r dini; 1• la t o ns illa s 1 pre>-enta va solo co n piccole jl.'t'<lllu l u zi o ui ( lù t :.:: :16,ì p. 1001; 2° la t onsil la aveva la s ua fo r n 1a carttllt• ri stica nui no n 8 r l'iva va al n1arginr superio 1·e del le coanl' (!JO = 3 2. l p. 100); 3• rag giungeva il mal'gi ue superi o re delle co ane (62 = 2:!,5 P· 100); 4° cOpl'iva una pal'le maggtore o tn i uore dt:lle coan e (22 = 8 p. 100) Se si r.ome patologic11e solo quelle dell' ultima ca t egoria , si vede com•• le per ce n tual i s i avvic in111o a quelle date da Sexe ( 12 p 100 ), Clavué (1.0 p 10()), Q,. l i uo ( Il p 101!1.
La grande proporzione di to nsille faringee tr10l1o grosso n ellt3 l'eclule r tb adisce l'opinio ne già esp t·essa dul r efe r enLe cl te l' irwolu z ione d i l111foide avviene nwl to pi u tat·di di quello elle gerrer·a lm rn l e s'um metla da t l'i-

l dist ut•bi elle pro \'Ocano que!<le vegeta zi o ni adeuo idi !<O no noli. Il Barili tnt gli a lf.-tli da ipertrofìa de llu ton sil l a di L usd tka dt'l la :l" cntego ria tr o v i> alter azioni pa t olo gich e dell'ol"ecchi(J nel 20.9 %, in quelli della 4a cntegOI'ia 27;!. -;. I nte res s ante è un caso d i euu r·esi notturna, guarila coll'adenoidectomin iu 1111 ro os.;hdti er e che n e so ffr·h·a fin dall' 1n fanzia An che l o psichico é at·r e:::talo in ques li adeno i d ei: dtt info r·mazi0ni ri chieste ai co m a wlanli di ce>nrpagnia è r i s ulloto che il 71,1 p 100 di r erlule dichia ra le dclìcit:nti i nl!:'llellualmente p r esentava ostac oli alla I'C>' fdrazi o ne
E ' con osciula Jai rin o l o_gi la freq r1 enza dell e a l lf' t·azioni pnl1•logiche n e l na!'O SPnza eire in so r;rtrn o distu1·bi gravi. l'\ el uO p 100 l ' A Lro ,·ò dev i azioni o spi ne del sello, nel 36 p 100 tum efazioni dei turbin ati. L'oslawlo nlla r e!'<pirnziOil e n a,;ale ('liÒ essere compatiiJil e con un uLi le !'<e l·vizio , 111a imped i ;:oce g li ese r·c izi d i nuoto, pe r·ché nes,;.un o può nuo tare od impa 1·ar·e a nuota r e :-;e llt)ll r <'spit·a pel naso e!<:;endoch é pe r la boccu aperto entra non solo ar1a m» aucl1e a cqua
N ella bocca >' i risco n t ra l'Ono : carie d•• u laria piu o m eno eslt'l"fl nel\'80·!!0 p. l f' O, ipe rtrof i a deli<> to n s ille boc<'a li u ell' Il ,a p IUO. ugulu hitìda nel 3, i p. 100, u gula strHO I'd i na r iamenlB so ttil e 111 1:1 cas i. P e r r·ig-utn·do a l"(ue«t'ulumo Ba1·llt pot e l"ile\'are che 7 !' u D di que;;ll 1111li vi lui n v eva uo m urcatu er cd ilà tu be r colar e .
L'esame lariu goscop i cu ri <:o nobbe pa r ecch1e \'o l'it:llù nMmali di epiglollid..,, .g-111 tlide, aritcnoidi, caltl t' r o de lla mu cnl"A uel :l u p. 100 ed un c n;o th l; adtid•:t•tniu in indivi d uo afl'd t o da vegt; tazi o ni udeno11.l i d i m ed ia g ran dezza e da deviazio ue del !<ello G. O.
RIVI STA DI G3
RIVISTA DI OCULlSTICA

SruEON SNEJ,L. - SlJlla oeoltà tran•ltoria prodotta dall"e•poalzlone prolungata degll ooohl all'astone diretta del raggl•olarl. - (B r itish M edical J ourn al, 18 jan. 1902).
L'A. rifer isce la sto r ia clinica di un individ uo di 40 anni, il quale a veva. o sse rvato attentamen te un'e cclissi di sole pet• ci rca 2 ore, guardan do a ripr ese attraver·so un ve tro r osso ed un vetro azzurro, ed anch e pe r f]Ua lc h e s e condo con l'occ hio nud o. Circa due o1·e ciopo t e r minato ques ta osservazione, n ell'a l- · tende re al s uo lavo r o, s i accorse di un ce rto in lor bidarn en to della vista in amlJo gl i occhi: la sera poi, ne l legge r e il g io rnale, n otò due mac chie scu r e a fo r ma rotondeggiante, a couto r·ni in tl istioti, della g ran dez za a ppr ossimativa di d ue mon e te da due soldi. Il g io rn o dopo, essendo!'li fatto visital'e dall'A., ques ti tro vò in ambo gli occhi A V = 1/, nell o sg uardo diretto, mentr e nello sguardo obliquo un ' AV = ' fs. All"esame oLtalmoscopico s i r invenne in ambo i lati un lieve inlorbidamento intomo alla papilla c on modico in go r godelle vene coroicleah. No n v'era alb razi o ne d i s0rta n e lla re gione ma c ula r e. Il paziente p e rò accusava u n notevole annebbiamento della vista in co r rispondenza dell'area ù i fi ssazion e; infatti , gua r dando una per·sona situata di fr·o ntee fi ssa nd one p. es . il petto, n on Ji s tin g ueva n e ttamente altro che la e le gambe .
I n seguito all ' uso di occhiali protettivi colorali, ed alla s omminis lr11zione di j orl ur <; potassico internam ente, i sintomi subbiettivi andarono g ra datamen tescemand o , e l'of'l'u sca mento andò sempre atten u andos i, finché, dopo. circa 14 g io rni dall'acc idente , sco mpa r ve del tutto, ed il vis us torn ò al n ormale.
Da quanto r ife ri sce l'A. , si può arg u ire s i sia tra ttato d i uno seotom a centrale positioo r elat i oo, il quale caso c i s embra abbastanza inte ressante s ia pe r · l'etiologi a , s ia r e r la bilatera lità della lesione, ed infin e perché il pazien te, persona mo lto inte llige nte ed e ccellente osse rvato re de i propri sintomi sub-biettivi, poté fornire a l r ig ua r do le più esatte ind icazioni.
È anche deg n o di no ta il fallo, che l'esame otl Almosco pico fu pressochè n egativo, m e n t r e in alt r i casi riportat i da altri autor i si osse r varono quas i costantemente Rlterazioni della zon a mac ulare cle lia r e tina
I n un alt r o caso s t udiato precedentemente dallo Snell si tr attava di un giovane, il quale, gua rdand o a tt r av e r l:' o un polen te cannocc hiale d i giorno n el. p u ntare t.t·o ppo in alto lo strumento, era s tat o colpi lo dai r a ggi solari direttam en te nell'occhio des tro, in SPguito Ji c he g li rima se uno scotoma ce n tr a le positivo del la grandezza di una t es ta di spil lo , ch e, ma lg r a do tutt e le cu r e pra ticate, rimase pe r man e ntem e nte, a ssoci and osi a ten o me ni di m e ta · morfopsia: il visus r·imase del r esto integ ro.
I n ge ne ral e la pt·ognosi di qu es ti scolomi é benigna, e sse ndo essi in gen eral e mo lto limitati ; e ta lora, dopo 110 per·iodo più o m eno lun go, s co mpaiono completamente , come appunto nel 2° caso dello Snell, di cui è parola in qu es to la vo ro.
64
DaJ p u nto di vista pratico poi questo djmos lra l'in s ufficienza d e i vetri color ati a proteggere utilmente l'occ hio dall"azione de i luminosi tro ppo intensi.
L'A. n o n accenna affatto a lla palogenesi di questa affezione, la quale è del r esto abbastanza faci le a spiegars i con la te o ria deli'Angelucci de ll'adattamento alle varie g r ada zioni luminose m ercè de lla del p igmento re tinico: in questi casi si avrebb e un fenomeno di abbag liamen to inten s o de lla retina n e lla r e gion e macu là r e in seg uito allo stim olo troppo vivo sui co ni e ba<:lonci ni non protetti abbastanza in tem po dalla d iscc!'a dei gt•a nuli pigmenta li Questa teo r ia é o rmai confo rtata da un grandissimo num e r o di esper ienze non c h é dal la clinica, ed è quindi quella p i ù gene r almente adollala da g li oflalmologi. s. R.
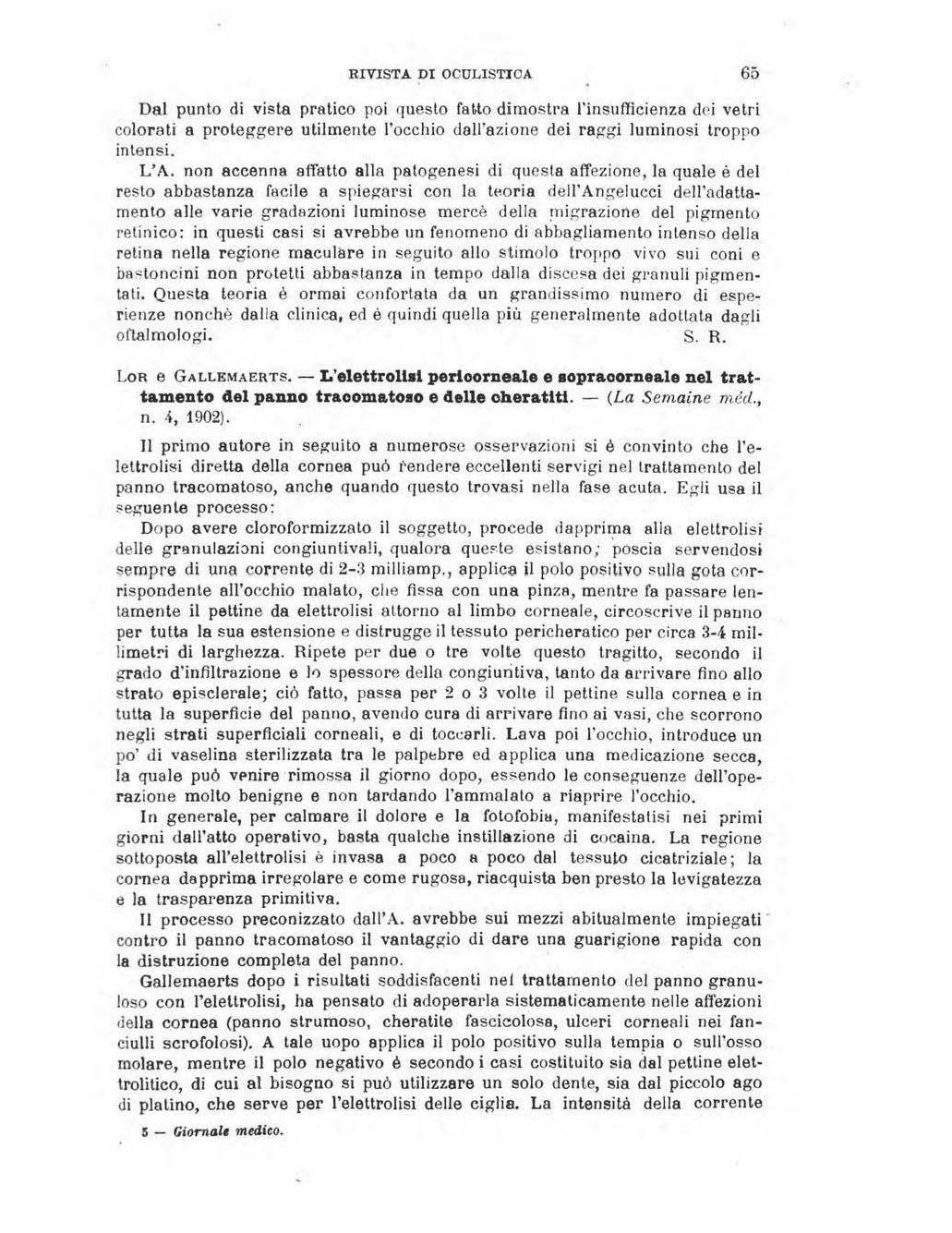
LoR e GALLEMAERTS - L 'elettrolt•t penoomeale e aopraoomeale nel trattamento del panno traoomato•o e delle c heratiti . - (La Semain e mdd. , n. 1 902).
Il primo auto r e in seguito a numerose osser·vazioni si é convinto che l'elettro lisi diretta della co r nea può rendere eccellenti ser\'i g i n e l trattamento del pa nn o tracomatoso, anche quando questo travas i n e lla fase acuta. Egli us a il seguente processo:
Dopo avere cloroformizzato il soggetto, p r ocede dapp t•ima alla elettrolisi de lle g r!lnulazioni co ng iuntiva!i, qualora qu e!':le 'poscia serv e ndosi se mpre di una corren te di 2- 1 milliamp. , il polo pm;;itivo go ta C0 rrispondente all'occhio malato, ch e fissa con una pinza , men tre fa passare lentamente il pettine da e lettrol isi aLtomo al limbo cornea le , circoscrive il panno pe r tutta la s ua este nsione e distrugge il tess uto pericher atico per c irca 3-4 mi!· li mel!'i di larghezza. Ripete pe t· d ue o tre volle questo tragitto , secondo il grado d ' in fil trazione e l0 spessore della congi u n tiva, tanto da ar·r·ivare fin o allo stra to epis clerale; ciò fatto, passa per 2 o 3 volte il pettine sulla co r nea e in tutta la supe r fi cie del panno, avendo cura di arrivare fin o a i va s i, che sco rrono negli s trati super ficiali corneali, e di toco.:arli. Lava poi !"occ hio, intt·oduce un po' di vaseli n a ster ilizzata tra le palptbre e d applica una med icazione secca, la quale può vPni r e rimossa il gio r no dopo, essendo le co ns eg uenz e dell'operaz ione molto benigne e n on tardando l'amma lalo a riaprire l'occhio .
I n generale, per calmare il dolore e la fotofobi1:1 1 manifes talis i nei primi g iorni dall'atto operativo, basla qualche instillazione d i cocaina. La regi one so ttoposta all'elettrolisi è invasa a poco R poco dal cicatriziale; la corn ea dappMm a irreg-ola r e e come ru gosa, riacquista ben presto la lovigatezza e la tras pare n za primitiva.
Il processo preconizzato dall'A. av r ebbe s u i mezzi abitualmente impieg ati · con tro il panno tracomatoso il vantaggio di dare una gua ri g ione r apida con la distr uz ione completa del panno.
Gallemaerts dopo i r is ultati soddisfacenti nel trattamento del panno gra n uloso con l'elellroli si, h a pensato di adoper arla s istema ticamen te nelle affezioni della co r nea (pa n no slr umoso, che r a tite fascicolosa, ulc P. r i cor neali nei fanci ulli scr·ofolosi). A tale uopo applica il polo p ositivo sulla te mpia o sull'osso molare, m entre il polo n egat ivo é secondo i ca s i costituilo sia dal petti n e elettrolitico, di cui al bisogno si pu ò utilizza re un solo dente, sia dal piccolo ago di platino, che serve per l'elettrolisi d elle c iglia. La intensitA della col'l'ente
RIVISTA DI OCULISTJOA 65
5 - Gi orntJI • mtdico
n on deve mai sorpassare i 2 milliamp ; si u sa la se m plice cocain izzazione, se l a e le ttrolisi viene adoperata c o nlt·o le ulcc razi oni corn ea li o contro la cheratite fascicolosa; t> preferibile rico rre t·e alle narcosi f!ene ral e ne i casi di lesio ni più estese e poi t)el panno totale, occo r rend o allora una p eritomia ele llrohlica.
L ' A ha adope r ato q uesto trattamento in una tr entina di casi di lesioni co rn eali , ottenendo sempre b'uo ni rt s ullat i. La fotofobia se ne trover ebbe io special m odo fa vo t•evolmente inlluenzata; fanciulli che per setti m ane banno tenuto g li occhi chiusi, dopo il tt·altamento io disco t·so li hanno riaper ti qualche volla il successivo all'in terv ento . C'J .
DJ ANoux . -Processo di caut e rizzazione del globo ooulare, destinato a soltltulre nel fa nololllla enucleazione dello stesso. · - (La S emai n e m ddica/e , n. 1, 1002).

È un pro cesso r ico rdato tla Vall io n e ll'ullima seduta dell 'Accademia d i m edic:i na a Pari g i nel decorso anno, ch e do vre bbe sostit uit·e la enuc leazione de l g lobo oc ulare n ei fanci ulli , enucleazio ne ca u s a di defo rmi tà, la CJ Uale si esage ra c o l p r og r ed iee degl i anni .
Desso va pl'efe ri to in tutti i casi, men o rru e lli d i tumori ma lig ni dell'occhio e di iridoc icliti infetli ve traumatich e. Consi::;te nel pratica r e s ulla cornea con la pun ta del termocauterio, po rtata al r o!\sO oscu r o, u na cauterizzazione a forma di stella , !:'enza a prire la camera anteriore Ci ò fallo, va tracc iato verso il centr o de lla co t·nea stessa un cerch io di 2 millime tri di rai!'gio, e pescia svuo· ta to il d isco cosi circosaitlo' e perfo rato al centt•o, po rta ndo bruscam e nte al ro sso vivo la p unta d elte rmoc anle rio , in m odo che s coli l'umor a cq ueo .
L a ferita r esidua si spolverizza con bismuto, e l'occh io vien e t en uto chiuso pe r 3 gio rni med iante fa sciat ura co m pr essiva Al termin e di qnes to tempo si lava la superficie suppurante co n acqua bollita, mentre s'instilla tra l.e palpeb r e qualche goccia d i colliri o a lla eucaina ed all'esel'ina , continuandone l'uso Jìn o alla completa cicatl'izzazione.
Quando la c icat ri ce è fa lla solida e quando è scomparso qualsiasi fatto ir· ril11tiv o, si co mpleta il ri s ultato ope r a torio con qualche sed uta d i massaggio, procedendo poi al tatua ggio della co r nea. c q.
NJ ES NAMO W. - Trattameat o delle oheratltl suppurate m e diante l& luce solare. - (La. Semain.e médtcale, n. 1, 1902) .
Aven do l'A. is titui to una se r ie di espe ri enze s u gl i animali pe r s tudi a re g li effetti d ei r a ggi sola ri su ll'occhio , ha osservato che q uesti concenl!·ati per mezzo di una lente di + 8 D. e di 10 centimetri di d iametro n o n solo non esercitano alcuna azione nociva sull'occhio ma ancora addimos trano un'influenza favo t·evole sulle cheratiti suppurate, artificialmente provoca t e, purchè però s i procuri d i esclude re l'i r radiazi o ne dei r a gg i caloriferi, fac e n d o passare la luce s olare attraverso un o s trato di a cqua colora ta con bleu di metilene.
Sicuro di ques ti dati sperimentali, cercò egli allora di utilizza r e la s tessa l uce solare n el la c ura delle cheratiti suppu r ate svoltesi natura lmente nell'uomo.
Ebbene in tutti i casi, da lui s otto posti a ques ta s pecie di fototer apia, ebbe a
GG tUVIST.A. DI OCULISTIOA
notare che il processo suppurativo d ella co rn ea cessò dop o qua lche sed uta quotidia n a di 2 a 6 minuti , avviand osi alla cicalrizzazione; e ciò s ia che s i· fos!;e tratlato di cheratite traumalic.a o pos t- ope r ator ia, s ia di fl eg masia t racomatosa, fliLtenulare ecc.
Questo trattamento nelle sue m an i non died e luogo ad a lc uno inco nveniente. T uttav ia non si potrebbe rieo 1·re re ad esso con tutta sicu1 ezza, se non nei cal'li, in cui la r e tina è per cosi di1-e protetta dall'azione della luce o da una infiltrazio n e del la cornea, o dall'accumulo di pus n e lla ca mera anteriore ed anche da q uals ias i a ltra lesione analoga eq
S ASSAP.\ REL. - Trattamen to dello pteriglo ool m u sag gio. m èd icale, n. 1, 1902) (La Semain e
L 'A., m edico rr.ilitare ru sso, s i se rv e di una pomata a l 11ubl imato ed alla cocaina, che e gli per lo addietro av eva pr ccon izr.ato coo t1'0 le cherati ti e le congtuutivi ti cro niche e la cui fo rmo la é la seg uente :

Soluzio ne di sublima to al 5 p 100 c en tigrammi 6
Cloridrato di cocai na . . . id. 12
Vaselina bian ca . g r am mi 12
S'introduce una piccola quanlita di qu es ta pomata n el culdisacco congiunth·aJe e se n e lascia qu a lche poco s ulle pal peb r e, e poi si p1·atica il massoggio del g lobo oculare, facendo col pollice dei movimenti in se nso pe r pendicolare e pa rallelo a lle palpebre e c ircolarmen te; durante il massaggio s i ha c ura di ese rcitare una com p r essione pi ù ene1·gica a livello dello ispessimento de lla congiuntiva. L e sed ute debbono e sse r fatte ogni g iorno e della du r a ta di ci r ca 2 minuti.
Secondo riferisce l'A ., fin dalle prime sedute s i os>'e rva un mi g lioramento sensi bile ne lle condizion i dello pLerigio; la me mbrana s i asso tti gli a e s i fa meno vascolare. Ne l caso da lui riferito, dopo un mes e ed av e ndo pra ti cato il massa ggio pe r sole 19 sed ute, lo pterigio e1·a quasi completamente sco mparso, r e s id uan dos i so!Lanto una li e ve pigrnen ta-.:i on e n el Lsss ulo congiuntivale e due vasi s an guigni. Questo ri sultato e r a Len to _piu notevole in quanto c he il traUamento non era stato seguito in modo regolare, essendosi il soggetto se mpre esposto a l vento ed a lla p o lvere.
L'A perciò c red e di poter affe rmar e ch e prendendo pe r l'occhio tullt- le necessar ie preca uzioni contro le irritazioni ester ne e p1·aticando il massaggio gior nalmente, si po trà ottenore la scomparsa dello pte ri gio in più breve tempo ( l) cq.
(I J 11 trattamento prcconizzato dall' A. potra riuscire e fficace nello pteri gio tenu e o membraooso, ehe si presenta so ttile e povero di vasi; ma ne lle varietà 1lello pterlglo vascolo&o, carno10 o erano, costllulto d i denso tessu to conne ttivale c r icco di vasi, l'unico trattamento efficace é l'esportazione col processo Pagenstec ker.
RIV I STA DI OCULI:STI C A 6 7
RIVISTA{)l TECNICA ESERVI ZIO MED ICO MILITARE
H ERZ. - n • ervtslo aaDltarlo ne ll'ese rcito lngleae n e lla gue rra contro l
Boe ri . - Wienna, Safa r , 190:!.
Di (Juesta m o nog rafia d el val rn le collega dell'ese r cito austro-ung arico, moggior e medi co ùolt. Herz, gaa n olo p er pa recchi pregicvoli lttvori sul se rvizio soni ta rio in guer·r·a, da r emo urùrmpia e de llagl iaLa r·ivis la.
T eat ro d ella gue rra sotto i l punto el i oista igienico. - Il clima tro picale del Sud -Aft'ica è r·e lativamenle f r esco e sano ed adatto anche pe a· Eur·opei. Mancano p rim a ve ra ed autunno, il passagg io dall'estate all 'i n ve rn o avvi e ne ò i un lt·atto In es tate, l'epoca d e lle pio,:zgie, la temp eralu r·a uel g io r no i 40° C , m a nella nolle a vveugono dei le mp o aali che r·inft•escano l'ar ia. La s laf<ion e mi g lior·e e l'inve rr)o, - dall'ap r i le a lla fine di s ette mbreil cielo ò c hiaro di gio ru o e di notte, l'aria asciutta, fre sca: al calar e s ole bisogna vestirsi di panni pesan ti.
N e i d is tret ti più alli le nolli son mollo fredde e le oscillazio ni di te mper·olu r a in un possono an dare da 4 a 40', onde faci li i cata r ri intestinali e n ecessari e le fa scia addominal i di lana, come 11 mantello impermeabile per la n o tte.
L'acqua buona n e.l Sud-Afric a é rara, rllrissi m a q uetla di so r ge nt e. L ' acqua di fiume é spo r ca nel periodo delle pioggia, man c a nel peri odo a sciutto, per c ui viene conl'lervala in ci!'<tern e. L'eser c ito in g lel'e trovò pP r que!lto ri gua r do mille di ffi colla. L 'ebolli zione non fu possibile pe r man canza di com buslibil <' Il filt r o Berkefte ld, assegnalo all e truppe in di u n o og ni cento u omini, presentò i incon ven ie nti: a) .._, troppo fr agile; b) è di troppo po co r e ddi to special m ente ver acq ue mollo inquinate. Negli o spedali furono provati co n vanta f,rt!io allri sistemi di filtri.
Le malattie do minan ti nel paese sono:
1° il tifo ad do m inal e , c h e colpisce i imm ig rali nei primi 2-3 anni del loro m entre pare acquis tino in seguito una ce r ta immuniz zazione od a cclimatazione . Infierisce specia lmente n elle cillà prossime al le min ie re come a Kimb e rl ey o J oannesb urg, Pie le rmaritzburg e L adysmyl h. Rico rre più specia lmente n e i m esi di febb aaio , ma rzo ed &pt•ile;
2• ltt. di 'isente r ia, m ollo diffusa alla cos ta, ma c he no n manca nelle localité più E'levate;
3" la malaria ende mica alla costa, e mali g n a più specialm ente nel di s tr e tto del Lim po po e uei mes i d i mar zo, aprile e ma ggio;

4' i parassiti intes tinali, le oftal mia (lracoma), le p o lmoniti e d i r eumatismi.
del sanitario in u uerr.t. - Ad o gni ballttg lione, re ggime nto di cava lle ria, d i visione d'arti glieria e compagnia del ge nio, so n o asse g na ti un m e dico e d un infermiere O gn i battag lio ne ha ollo bartjlle portale da i po rtaferiti re ggimentali (str etc hen bea r er). Il m edico e l'infermiere a ccompagnano il co rp o di truppa al combatLimenlo e durante il co mbatti m ento
prestano il primo soccorso. Le perdi t e totali de l • R oyal m eùical Cot• ps » fu di 400 uo mini, tra i quali 9 me dic i morti e 17 feriti. U na gran parte di fer iti fu colpita altre v olte, e talora n e llo stesso momento in c ui veniva me dicata da l m edic o . Altre volle riusciva di ka s port.are i feriti in un p iccolo avvallamento de l le•·reno (donga): altre volte ancora i med ici appres tavano il primo soccor s o, ma non potevano sgombrarli ve r so l'in d ietr·o, p e r c hé i portatori s astati qua s i c e rtamente co lpili du rante il tra s porto.
Molte volte i ferili furon o medicati dai compag ni col pacchetto di m e dicazio ne.
Dal campo di battaglia i feriti so no traspo rtati ul la collect i ng station , ove s i trova la compa g nia dei portaferiti (bearer co mpa n!J). Questa è co mposta di 3 ufficiali m edici, 58 uomini di trup pa di sanita e 38 uomini del treno, ed ha iO carri per fe riti, 2 carri di requisizione, 2 carri viveri e d un carro per acqua. Durante l'azione la porlaferiti forni sce:
a) 2 sezioni a 4 pattuglie incaricate di sgo mbrare il campo di battaglia in unione ai porlaferili reg!Z ime ntali;
b) il di medi cazione (collecting station), il più vicino p ossibile al campo di battagLia.
Ad ogn i bri gata di fanteria battaglioni), e ad ogni brigata di cavalleria è assegnata una co mpagnia portafe rili.
Secondo le di s posizioni r·egolamentari i carri per feriti sono divisi in due sezioni: 1° quelli di prima linea pe r il trasporto dei feriti dal posto di medicazio ne alla s ezione di sanita (dressing station) ; 2° quelli di s econda linea per il trasporto dalle sezioni di sanità a gli da campo. I car ri per feriti s ono di due tipi : marca III per due feriti io posizione orizzontale e quattro sed uti, mar ca V per 12 seduti o due jn posizione orizzontale e quattro seduti;
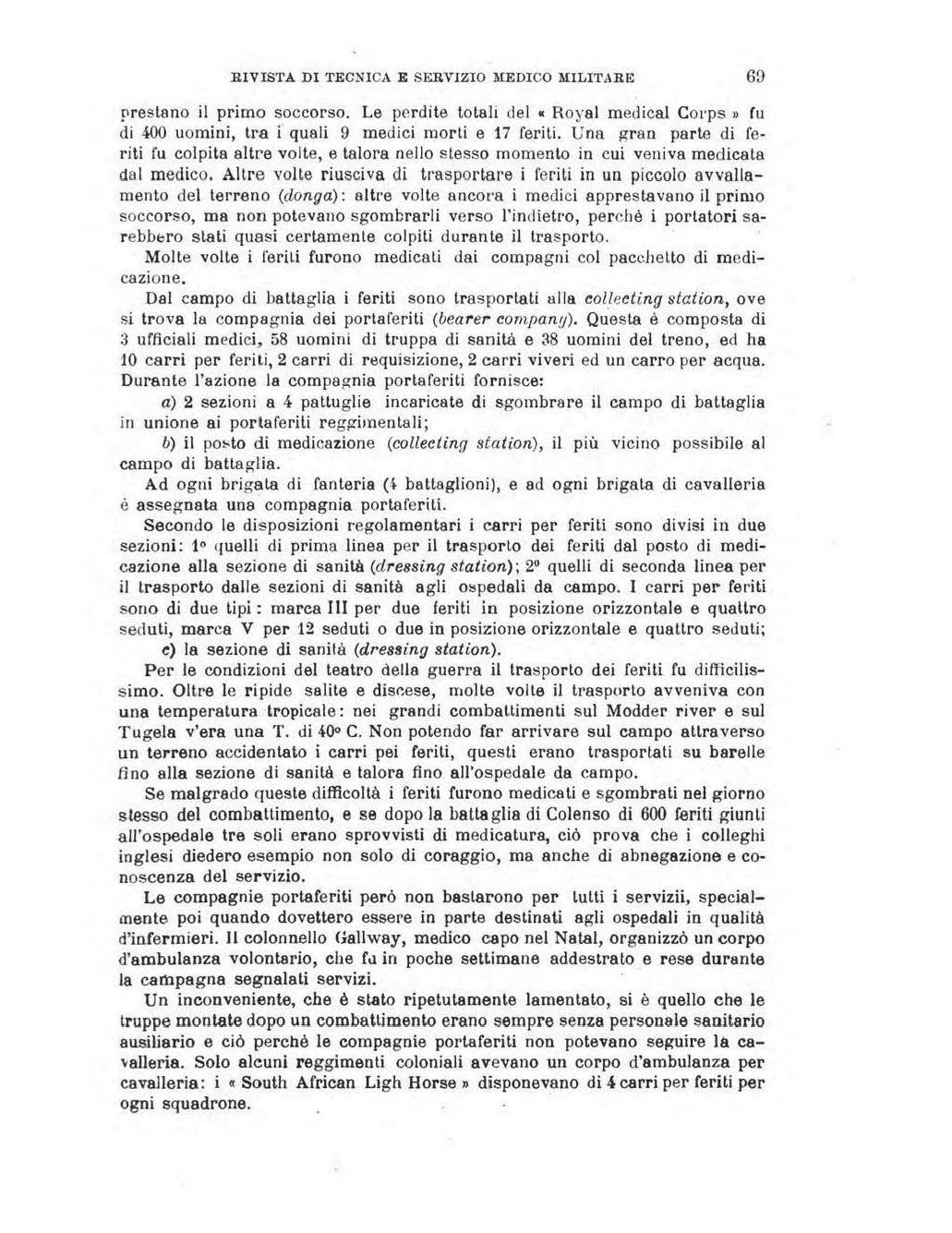
e) la sezione di sanità (dressing station).
P e r le condizioni del teatro della guerra il trasporto dei feriti fu difficiliss imo. Oltre le ripid e salile e molle volte il trasp<lrlo a vveniva con una temperatura tropicale: nei grandi combattimenti sul Modde r river e sul Tugela v'era una T. di 400 C. Non potendo far arrivare sul campo attrav e rso un terreno a ccidentato i carri pei feriti , questi erano trasportati su barelle fino alla sezione di sanita e talora fino all'ospedale da campo.
Se malgrado queste difficoltà i feriti furono medicati e sgombrati nel giorno stesso del combattimento, e se dopo la battaglia di Colenso di 600 feriti giunti all'ospedale tre soli erano sprovvisti di medicatura, ciò prova che i colleghi inglesi diedero esempio non solo di coraggio, ma anche di abnegazione e conoscenza del servizio.
Le compagnie portaferiti però non bastarono per lutti i servizii, specialmente poi quando dovettero essere in parte destinati agli ospedali in qualità d'inferm ieri. Il colonnello Hallway, medico capo nel Nata!, organizzò un corpo d'ambulanza volontario, che fù in poche settimane addestrato e r ese durante la campagna segnalati servizi.
Un inconveniente, che é stato ripetutamente lamentato, si è quello che le truppe montate dopo un combattimento erano s empre senza personele saoitario ausiliario e ciò p e rché le compagnie portaferiti non potevano seguire la ca"alleria. Solo alcuni regg imenti coloniali avevano un corpo d'ambulanza per cavalleria : i « South African Ligh Horse " disponevano di 4 car r i pe r feriti per ogni squadrone.
ll.lVIS'rA. DI TEC NI CA li: S ERVIZIO MEDICO MILIT,\li.E 6D
N el COI'JlO volontario della Colonia del Capo la compagnia pOI'l.aferil i l'Mpedtll t' da c-ampo ftll'ono ri uniti i n un solo co manr!o perchc fin dal principio d.,lla f(Uer r n lamentAto che la portofe1·iti lavol'a va snlo dul'ante u n comballimento, m e ntre il pe r sonale dell'Os!Jcdale era obe r ato dal !!t>r•v izio arwhe negli 111trr\'alli.
Uspc la le da (Fie/d - Ad og ni corpo d'ar•mata acoscgnali 12 O!<pedali eia cnmpo, cioè uno ad otzni brigata o colonna in.Jrpend •,nte : gli Altri sono sotto la dipendenza d el comando del co r po d'a1·mata o di L'o!<pedale tl B campo nel suo funz io name nto tr r ne piir della !lezio ne di sAnita, puichè trutla i fe rili e m a lati solo pe r t -2 ;.:rorni ed in ntal·c-ia immedio tat nenle le IJ·uppe alla testa del treno. I l per·sorwle é tO!>titui to da 4 m f"d tci, t contobile, 11 o mini d i sanità e 20 del t r eno: il material e l· t r aspo r tato s u 6 carr·i d1 r·t>qui!lizione, 2 ca rr r viv e r i e 2 ca r ri per a cqua: hu inoltr e 25 te nd o pe r mal u li e 14 t e ndP. pe r il pe r so nale e !<Cr vi7.i d t'll'o!<pedal e. Ogni o spedale ha l'occo t'J'errte p e r· 100 letti ed è divis i bile i n quoll r o sPzio n i: ma rr e l Sud A fr·1 c n par·ecdli os ped ttl i do velie r o r iceve r ne tìno a 300.

Du l'on l o il g l i ospeda li dn ca m po rm•ono slobi li li per In più diet r o la pnl>i zi() rw de ll 'a r tig lier ia; cosi d ietro Mon te A lice nel la lmt ta f.(l ia Ji S pio nk op , o Nav a li Ili ll nel la battag-lia d i Colenso.
Molto pt•a lico e semplice s i dimos t rò il pr ocedim ento 111 M ac Cox·mo c n e ll'impian to d e ll'ospedale. Dopo scelto il po!'.lo e r izza to lt' trnde, lo l'JlA zio d<'stinato era cinto da una ze r iba o do un filo di fe r r·n a punte la· s<"iandovi un solo a ece!<!>O. All'entr·ata il d rr e ttor·e dell'ospedale ciH• , ·isilava r nuovi Hrrivali e li de"tinava a •i un letto di un a di'terminata tenda: nem m eno i e della Be a r rr Company potevauo Yar·ca r e la po r tA d'entrata dcll'ospPdale.
L'utLivJlil di qu e!<li osped11l i fu en o r me. Crto i sef!uen t i fatti. Alla batta!:lia di Belmont lulli i fe rrti (258) el'ano ad un'ora dopo r·ico,·ernti in una casa, a lle 5 pom. del 1:rio r no dopo erano i le,zgieri !:'U Or·a11ge ri vcr, i j..:rav• su un ospedale ve r s o cithi del Capo. La baltnglia di M oclde r r i ve r dr E'de 480 fé rrti: alle i e mezzo pom. del gio1·no dopo l utti 1 fe r 1L i e rano in via per la ciltil del Caoo. Alla battaglia di Col enso vi furono 7\0 ferrl i : s ull'I m bruni r e de llo s tesso gio r no t utt i i fe r ili s i trova vano ospedali d a campo ed il gio r no dopo ospedali slazionar·i.
A Spio nkop i VOO ferrti. cadu ti su llo p un ta d' una collina in l uogo i w p t·aticobile pe r ca r ri, dovettero esse r e t ra!<por tali al b asso per sentier i; i l !<Oio o speda le d a ca m po de ll a 5' b r iga ta r iceve t te 2 1 u ffic iali e 326 uom ini di t ru ppa; eppu r e t utti i fer·iti e r a no a le t to n ello n o Ue . Alle 8 d el matti no successivo l'ospe da l e da campo dellA s• br iga ta ebbe l'o r di n o d i r itirata ; a lle 11 t ut ti i f e r·iti er·a no in v ia per Spear m ans H ill e l'ospedal e pro nto pe r la pa rt t-nza . M a dove g li ·ospeuoli da ca m po e bb ero m aggio ri d i ffico ltà ru nella mar('i a d i lo rd Robe r·ts cho po x·tò a ll a libe rHz ione di Ladys mit h e Kimberl ey, alla p r igio nia eli Cronje e te r minò colla pr esa d i I n q uesto d i co rrtmui combatti men ti e s ten t i, le p or tafe ri ti e gl i ospeda li da campo avev a no do" ulo a ll eggP. r ire il l o r o baga glio, per c ui dopo l a ba tta glia d i Driefo ntei n i 400 fe r i l i non po terono esse r tut ti r icover a ti sotto l e tende dell'ospe·
dale e, siccome e ra inter rotta la com un icazione con K im berl ey, l'ospedal e dell a s• di visione, temporaneamen te im m obilizzalo, li r icove r ò solto capan n e coo tetto di fango.
70
RIVISTA Dl TEC:-I ICA E SERVIZIO MED I CO MILITARE
Parecchie volle gli os pe dali d':l campo s i tr ov11rono il fuoc o nemi co: cosi il 22 febbraio 1900 v e rso il for te Wyl ie, il 1· ma r cio PoarJeb tl rg, l' CC. Qu es ti falLi non sono dovuti ad inl'rtwo n e della r onvcnzio ne di Ginevra, ma a ques to c he, colla porta ta d ei fucili •Jdicrni, le bandiere di ne utralità non s ono vedute n l'> ri cou osci ul e .
Osp edali (Scat i ona r y H ospital}. - So no ospedali d u 100 le>lli divi!'ibili in due s ezioni d e s tinali a r ice \'ere i no n a di s tanzA e ch e corri!'pO•llle r e bbe ro agli o!" pt>dali d i tappa altr1 F in cllc le t r uppe combattenti ope ravano in vic inanza d elle linee fe rro,·ial·ie lo !'i faceva direllamenle d11gli ospe dali d a c a m po ai tren1 o!'.pe rlali: ma col l'a llonlonamenlo dalla fe iTOvio e 1•ano incominciate le d iffi co ltà. F u pe r ò nn f<' IÌI'e pe n>< ie r o que llo del Gallwny, d i d t>st inare l'M peolale n. 4 co me ti nel lo di congiunzio ne tra l'os pednle da cam po e l'ospedale un 16 carr i ti r ati da louo i, 5 carri pe r f,·riti o g nuno tirato da 10 muli, c-arTi pe r viveri ed acqua, cavnlli por i medi c i ; di,: po rr Pva tlap pr im11 d 1 3 med ici, poi di 10 , ai quali veune ad il ce iPbl'C c h ir·ur·go !'-rt' Treves. os pedale fu p o i in g randito lino ad avere lr•lti: quon, lo e•bbr l'ordi ne di •·itira ta il 2[) gen naio con teneva 150 feri li non su cu rl'i : 1800 uomini furono comfrrrdati per lraspo rtar li s u bar elle a Fre re dis lanto 2;; mi g lr a in glesi.
· Osped ali rt enerali (General - Conispontlono ni nos tri lerritodali cd hann o Ulla do tazione di i'> 20 letti (20 pe1· ufficinh e :)1)0 pe r trup pa) che pe l.'ò durante la guerra fu p01·tata a 1500-1700 le lli !n tutto furono stabiliti 14 gene•·ali, il' n. l in Wynberg- nelle ca;oe r m e , il n. i so uo tend o , il n 3 in Rond e bosch po i a e Kronstadt. il n. 4 in Moo i ri,·er sotto tende , il n 5 in W oo rl s tock in parte i n ba•·acc h e, •l n 6 in Nauwp oo rt, il n. 7 in Es lco urt, i n. 8, 9, 1 0 in Bloemfoulein.
:\ e lla scelta del pos to pe r gli o s pedali generali si te nne il dovuto c o nto d elle ragio ni igieniche, della vicinanza della fe rrovia e della r• cchezz11 d'a c qua I sis temi di smAltimen to dell e fe ci va riaro no a seconda degli ospedali: per lo più erano racco lle i n bottini mobili, che ve n i vano trasportati da gl i indigeni in località lontane dall'os pedHle eJ info s s alon e il contenuto , e r ano di s infetta li pr ima dell'us o in un recipiente pieno d i sos ta nze antisettiche. I n un ospedale le fe ci furono bruciate, in un altro cot te poi e;;portate.
Le baracc he erano di lamiera di ferro r ivestite in te rn amente di legno, p r o vvedute di tutti i comodi: letti in Jerro, tavolini da notte, sedili, ecc. I n pa r ecc hi ospeda l i v'erano pu re dell e biblioteche e dei giornal i. La r;al a d'ope ra zio ne e r a pe r lo p1ù in una baracca special e, illum ina la ad elettricità, ri ccam ente provvista di strumenti, di sterilizzatrici , e dell'apparecchio di 1'adiogratì a. L 'acq ua a bere ei'O filtrala coi Be r kefleld o coi Cham be l'land.

Si lame ntò molto la man c anza di buoni cuochi e l'impossibi lità d ella p r eparazione delle uova e del latte in sufficie nte quantità. lin os pedale impiantò :ma latte r ia p 1·opria, n e lla r1 ual e si s terilizzò il latte c ol s is te ma Aymord.
Per ave re un'idea dell'es te n s ione s ervizio ospedali e r o basti il di1·e che furon o im piegali nel Sud-Africa medic i militari e 380 med ici civi li ('l m E'd ico OJmi 2i'>7 u omini t, 666 infermie r e e 5668 infe rmieri. Letti disponibili 18600 (l letto ogoi 11 ,8 uomini).
Treni trasporto mala ti e fe r iti. - Ne furono aUivali sette. I n genera le no n erano formaLi c he di 7-8 vagoni, non potendo lunghi treni percorrere le linee
RIVISTA DI E SER VIZIO MEDICO 71
montane. La dispo;;izione era· generalmente la seguen te: 1' vagone camcm da baj!no, 2 posti per uffìcia li , 2 posti per infe r miere; 2° va gone came r e ùa le tto e da pranzo per i m edici e camera d'ope r·azione; 3°, 5° e 6° gli scompat·timenti pe r malati , ogn un o p er 18 malati o fe l'iti e 4 p os ti per gl"infermi eri ; 7• c uc1na, fìll ri , ghiacci aia, ca sson e per acqua, di!\pc n JS a. I n ogni va gone v'e ra un lavan dino ed un closett. P e r la freque nza delle in le1-ruz ioni il servr:.: io d ei tr erti ebbe mo llo a s1.ffrir ·e e spesso i malat i non po tero no avere in tempo il vitto.
Naoi - ospedali. -Ne furo no adattate dieci per· iltr llspo r to dei malati e fer iti in I ngbi lterrr•a : al c un e furono adi bile come osped a li galleggianti in Dur ban, spe· cia lme ntP. per r icove r o dei t ifosi
Il via gg-io ui m a r e che durava tre settimane ebbe un ottimo ef1ello s ul deco r so d e lle ferite che nella massi m& pa 1·te e ran o già gua r ite all' a rriv o in I nghillerr·a. La Prin cc ss oj W ales portò dalla cillil del Capo a South11mpton 174 fe riti di Magge rfon t.ein e Modde r ri ver se nz a pet·de•·e un solo uomo durante il
Infermiere - L'eser cito ing lese ha un corpo d'infe rmiere« arm y nursin g serv ice )) . L 'as pirante deve e sser e inglese da i :!5 ai 30 anni, di fami g lia ci v ile ; deve presentare un cer tifica to di se rvi zio Lriennele in un ospedale civi le, un c ertificato m ed ico d1 buona costituzi on e e d ichiarare di esser e dispos ta a senire 5 anni fu ori dell a m ad re patria. P er d i pi u devono essere sottopos te ad Wl se rvizio di prova della durata di s ei mesi alla s cuo la di Net tl ey. Han no d iritto a p en s ione
Le • nurses » in gles i n on so n o infe rm ie1·e n e llo stl'elto sen so , ma hanno al· l'incir·ca le mansioni del le nos tre s uo r e .
Soeiela volontarie tli soecorso ai mala ti. - Sotto la di r ezione d e lla Cr oce Ro ssa , il cui de lega to e ra il colonnello Youn g, agivano le tre società: la societa nazionale per soc cors o ai m a lati e feriti, la societa pe r il trasporto de i feriti di S . Gi o v11nni, e la societa delle iofer·mie re. Il depo s ito principale e ra Citta d el Capo: di li i doni erano in viati a g li os pedali; un secondo depo s ito fu in seguito is tituito a Durban, un terzo a Bloemfonte io
P e r con to della società di si impian tarono una se ri e di ospedali, come il Yeomanr y che di spose pe rfin o di 1000 letti con compa gnia di porta-feriti, lo Scottis h che u e ebbe 520, l' Australian c he an che carri p er ferit i, il Portland, il Prin ce ss Chris tian, Lan g mann capaci di 100 le tti ; s i allesti rono navi-o spedali come il Mai ne per 200 letti, la Princes of W ales per 186 malati, i yacht Golden Ea g le. Sunrise ; s i allestirono ambulan ze come quelle da montagna di un Pars i indiano, treni sa nitari co me il Princess Chris tian.
In ques te formazioni sanitari e volontarie preset•o stlrvizio parecchi dei migliori chirurghi inglesi come Mc Cormac, sir Treves, s ir Stokes, Watson Cheyne, Makin s, Kendal Franks, Cheatle, Thomso n, si r J ones
Anche il pro fdssore di chir urg ia di Nettley, colo nnello S tevenson, pre se parte alla guerra.
Decorso e trattamento delle ferit e. - Molte sono le pubblicazioni uscite s ull a natura, sul decorso de lle fe rite , per cui c redo inutile l'indugiarmi su questo argomento . Ril evo solo ch e le les io ni da proiet tili d'a r ti glie ria non differivano pe r nulla in gravitA da q uell e delle g uerr e a nte cedenti e che dal feb b ra io 1900 in poi i Boe ri si di pallottole sp unta le (sojt nosed bullet) che giunte
A contatto delle o ssa o di tendini si deforma vano a fun go prod uc endo lesio ni

72 RIVISTA DI TEO:\IOA E
MIL I
SERVJZIO 111 EDIOO
TARE
bea più gr·a'vi che i soliti pr oietti a mantello. In il 20 p. 100 dei feriti il proiettil e rima se tra i tessuti. Contt·ariam en t e ai r i8- nltati de lle ricerche !:perimentali, raramente fut•ono osservati eiTelli esplosivi. Il ;;hok non fu osservato neppure nelle lesioni di o r g ani impor tant i. Rari i d issanguamenti sul c ampo. t·ara l'emorragia libera, più frequenti le emorr-agie sécondari e e l e inters tiziali luugo l'asse delle estremita.
Le ferite ebbe r o quas i costantemente de co r so asettico, il che é stato attrihll ito: t• a lla pulizia della fe rita ; 2° alla natura asettica della ferita; 3° all'aria pu ra ed asciutta del Su d-Africa; 4' a che raramente pez zi Ji vestito fm·ono trasportati nella fedla. Circa quest'ultimo ratto si nota c il e, a condizioni eguali h a la s ua impor ta nza la qualil.il della stoffa : co;:i fu rono ri scontrati rar·e volte pezzi di khaki, piu spesso pezzi di flanella, spessissimo il ki lt (camicia) scozzese.
Le cicatrici, piccole c oiOe cicatric i di acne, hanno spesso dat o origine a dolo r i «d a distu rbi d i mobilita.
La medicazione io prima linea fu falla asciutta: anzi, essendo s tat o osservato che col machintos h del pacchetto d i medicazione le ferite suppu ravano, s i o r dino che non venisse più usato Semplicissima fu anche la medi!!azione a gli ospedali: la•:atura c o n sublimato e m edicazione a sci utta.
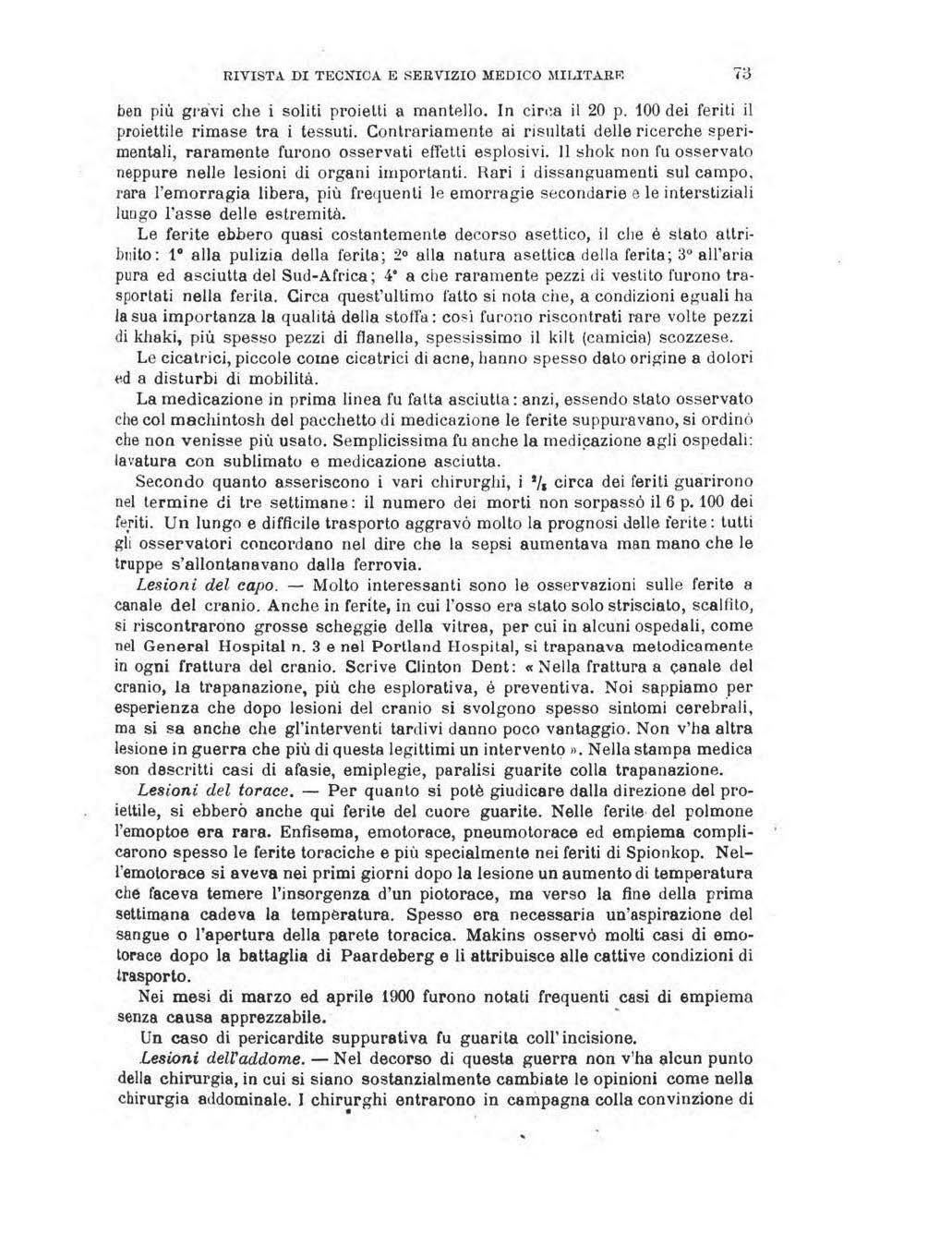
Secondo quanto a sse riscono i vari chi ru rghi, i 1/ 1 circa dei feri ti g uarirono ne l te rmin e <!i tre s ettimane: il numero dei morti non so rpassò il 6 p. 100 dei Ce,riti Un lungo e diffi cile trasporto agg r·avò molto la progn osi Jelle ìerite: tutti gli osservatori concorda no nel dire c he la sepsi aumentava man mano che le truppe s'allontanavano dalla fe rrovia.
Lesion i del capo - Molto inte ressanti sono le osse rvazion i s ull e ferite a canale del crani o . An che in fe rite, in cui l'osso era stato solo strisciato, s cal fito, si r•isco ntrarono g rosse scheggia della vitrea, pe r c ui in alcuni ospeda li , come nel Generai Hospilal n. 3 e nel Porlland Hospital, si lrapanava melodicamente in ogni frattu ra del cranio. S crive Cli nton De nt : fr a ttura a canale del cranio, la trapanazione, più che esplorativa, è preventiva. Noi s a ppiamo per esperi enz a che dopo lesioni de l cranio s i svolgono spesso s intomi cerebrali, ma si s a anche che gl'interven ti tardi vi danno poco vantaggio. No n v'ha altra lesio ne in guer ra che più di questa legi ttimi un intervent<;> ». N e lla s tampa medica son dascr itti cas i d i afasie, emiplegie, pa r alisi guari te colla trapanazion e .
Les i oni del torace. -P e r quanto si potè giudicare dalla direzio ne del proiettil e, si ebbe ro anche qui ferite del cuore guarite. Nelle ferite· del pol mo ne l'emoptoe era rara. Enfisema, emoto race, pneumo torace ed empiema complicarono spesso le fe rite toraciche e più specialmente n e i feriti di Spionkop. Nell'emotorace s i ave va nei primi giorni dopo la les ione un aumento di temperatura ché faceva temere l'insorgenza d'un piotorace, ma verso la fine della prima settimana cadeva la temp e ratura. Spesso era n ecessaria un'aspirazione del sangue o l'apertura della par ete toracica. Makins osse r vò molti cas i d i emotorace dopo la battaglia di Paardeberg e li atLribuisce alle cattive condizio ni di trasporto.
Nei mes i di marzo ed aprile 1900 furono notati freq uenti casi di empie ma. senza causa apprezzabile. •
Un cas o di pericardite suppurati va fu guarita coll'incisione.
L esioni dell:addome. - Nel decor so di questa guerra non v' ha alcun punto della chirurgia, in cui s i siano sos tanzialmente cambiate le o pinioni come nella chi rurgia addominale. l chirurghi entrarono in camp a gna colla convinzione di .
RIVISTA DI E SER VIZIO MEDlCO
Ja par ntom izzare ogni qual volla dalla di r ezione della fe rila si doveva a mm e ttere un a l esione dell'intestino. Queste opin ioni mular·ono m a n mano che : 1" aumentarono i casi in cui tali ferite g uari v a no senza operazione; 2° dalle lap a · r o tomie si constatava c h e coll' inte rv ento si s trap pa vano le a desioni della fe rila. Così rife ri sce Treves che mentre cercava la ferita intesti nal e, ad un tratto fuoruscì ùe l gas, segno che si e ra ria perta una ferita g ià r iu n ita. 11 maggiore Oic!;, p r o fe ssore alla scuola di N e ttley, cosl spiega il decorso b enig-no della ferita dell'intes tino. « L ' intestino è stato colpito quasi sempre io stato d i vacuità. la pe r di ta di sostanza e ra piccola e d era to sto chiusa dalla mucosa e dalle anse v icine, per cui era impedita la fuo ruscita del c onte nuto. Lo shock p r·o vocato dal proiettile Mause r era cosi Jeggie r o, che la peris lal si continuava a funzion ar e e con ciò la muscolare impicciol iva il fo ro faci litando l 'adesione ». S ia questa la g iu s ta spiegazione o non, é un fallo constatalo che nel Sud- Africa l e feri l e d'a r ma da fuoco dell'addome decorsero senza peritonite e guarirono nella p ropo rzi one del 60-80 p. 100.
Il perico lo de ll e ferile pe r foranti dell'addome è in dipendenza piu dell'emorragia che da l e sioni de l tra tto intes tinale.
Non entro in m aggiori de ttagli, essendo l'ar·gomenlo già s tato trat tato dal collega Rossini s ull e colonne d i questo giornale Volendo r iassumer e, diremo c h e s tanno pe r l 'operazione (TreYes) i seguenti momenti:
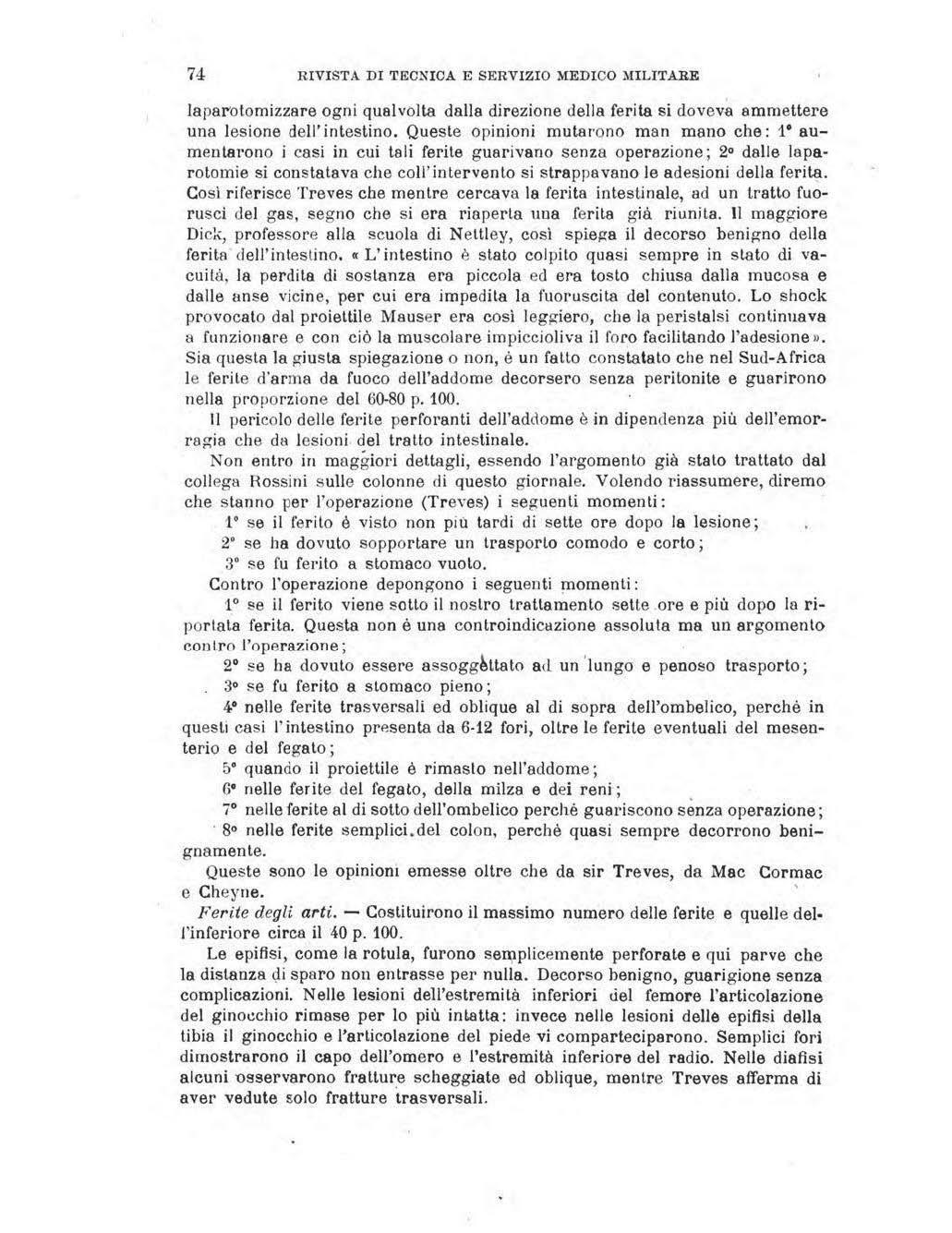
1• s e il ferilo è vis to non p1ù tard i di sette ore dopo la les ione;
2• se ha dovuto soppo rtare un trasporto comodo e corto;
3• se fu fe 1·ilo a sto maco vuoto. Contro l'ope r azione depongono i seguenti momenti:
1° se il ferito viene sotto il nostro trattamento s ette ore e più dop o lo ripo rtata ferita. Questa non è una cont roin d iCl:lzione assolu ta ma un ar gomen to contro l'operazione;
2° se ba dovuto essere a d un ' lungo e penoso trasporto ;
3° !"e fu fe rito a stomaco pieno;
.
4• nelle fe rite trasversali ed oblique al di sopra dell'ombelico, perché in q ue sL1 casi l' intes tino prP.senta da 6 -12 fori, ollre l e ferile eve ntuali del m esenterio e del fegato;
o• quanào il proiettile é rima s to nell'addome;
G• nelle ferite de l fe g at o, della milza e dei reni; i 0 nelle ferite al di sotto de ll'ombelico p e rcl1é guariscono sènza ope r azione;
· So nelle ferite sempl ici.d el co lon, perchè quasi se m p re decorrono benignamente
Q ueste sono le opinionr emesse ollre c he da sir Treves, da Mac Cormac e Chey ue.
Ferite d egli arti. - Cos tituirono il massimo numero delle ferite e quell e del· l'i nferio r e ci r ca il 40 p. 100.
Le e pifis i, come la rotula, fur ono sell,lplicP.mente perforate e qui pa r ve che la distanza c.li sparo non entrasse per nulla. Decorso benigno, g uari g ione se nza complicazioni. N elle lesio ni de1l 'estre mi là infe riori del femore l 'arti cola zione del ginocchio rim ase per Io più intatta: invece nelle lesioni delle epifisi della libia il ginocchio e l'articolazione del piede vi com parteciparo no . Semplici fo r i dimos tra ro no il capo dell'omero e l'estremità in.ferio re del radio. Nelle diatlsi alcuni -osservarono fratture sche ggiate ed oblique, mentre Treves afferma di aver vedute solo fratture tras versali.
74 RIVISTA DI
TECXIOA E SERVIZIO MEDICO MILITARE
RIVISTA DI TECNICA E SERVIZIO MEDICO MILITARE
Spessissimo proiettili trapassarono grosse articolazbni come il ginocchio senza le dere i capi arti colari.
Non sempre dalla granJezza del foro d'uscita si po tè amm e ttere od esclude r e l'esistenza di frattura.
Le frallure e rano da prin0ipi o asettich e e tali si se il ferito poteva rimanel'e cinque gio rni all'osp edale: nelle frattur e di coscia l'esito era liiicuramen te letale se il ferito doveva traspo rtato su car ri per un lun go tratto. Le amputazioni furono rare. Su 30 fratture di coscia , o sse rvate nel Ge· nera! Hospita l n. 2 in \\'ynberg, solo una volla si dov e tte amputare .
Gli e siti felici s i devono anc he alla radi ogr·afia, co lla quale si poterono tosto diagnosticare la s pecie e l'este n s ione della frattura, la esis tenza di proiellil i nascos ti nella fe r ita e di li bere: esportale l e quali, la ferita guari va senz'altro.
Ottimo fu il risultato delle fe!'iLe arti colari. Dent dice « Io non ri co rd o in questa guerTa un c aso di m o rte tr·a i fe riti de l ginocchio e le les io ni di que s to genere son state frequ e nti >)
Le reseziooi furono rare: le lesio ni del gomito g nariro no quasi tutte senza an chilos i.
Quanto snpra vale per le ferile ùal Maus er. P e r le ferile da proiettili d'artiglìe ria è spesso segnalato come causa di m o rt e il s hock: nei casi, in cui s 'amputò immediatamente , la morte avvenne 3-4 ore dopo l'opHazr o ne.
F e rile dld tronchi ne r oosi - L e lesio ni dell a colonna ve rlebrale ebbero una fo rte mortalità, esse di edero o r igine a poralisi, terminanti con esito l e tale. Dent parla di una commozione dei dovuta alla grande forza del proiettil e e ch e si diffonde a d al l'o r o d'entrata. Le nevralgi e consecutive all'impi g liamento ùe i nervi nel le cicatrici furo no fre<[Uenle causa d'inte rventi operativi.
L'arma r.tman da ria. - Se l'umanità di un'arma si giudica dal num e ro dei m o rti e feriti e dal numero de i m o rt i. in seguito all e ferite, noi possiamo co ncluJe l'e che il fucile attuale é più umanitario, ina non nella misura c he s i atte ndeva. Infatti riun endo insieme 11 battaglie principali LI'Oviamo che vi furon o 708 morti e 327:1 ferili cioè che il rapporto dei morti ai feriti fu all'in circa d i 1: r. co me nelle guer r e napoleoniche, n ella gue rra italiana e un po' meno che nella prussiana-austriaca (21: 100) e nella l'ranco-tedesca (2-l: 100).
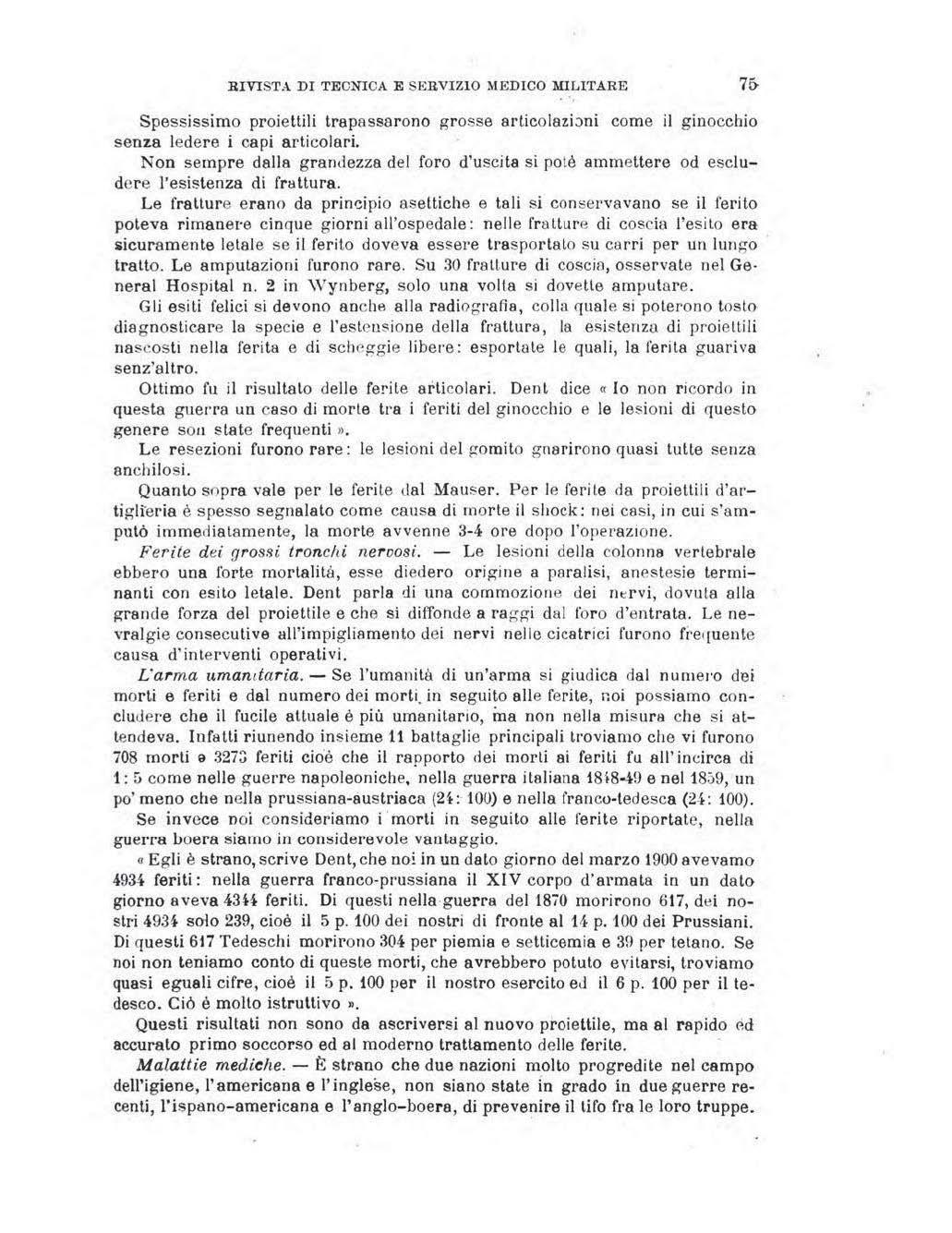
Se invece n o i consideriamo i ·m o rti in seguito alle ferite riportate , nella guerTtt b oera siamo in con,;ider·evole vantaggio.
a E g li è strano, scrive Dent, che noi in un dato giorno del marzo 1900 avevamo 4934 feriti: n e lla guerra franco -pr·ussiana il XIV corpo d'armata in un dalo giorno aveva 43H ferili. Di questi nella guerra del 1870 m o r·irono 6 17, de i nostri 4934 solo 239, cioè il 5 p. 100 d e i nostri di fr•onte al 14 p. 100 dei Prussiani. Di q uesti 6 17 Tedeschi m o rirono 304 per piemia e setlicomia e 39 pe r tetano. Se noi non teniamo conto di queste morti, che avrebbe ro potuto evitarsi, troviamo quasi eguali cifr e, cioè il 5 p. tOO per il nostro ese rcito eJ il 6 p. 100 per il tedesco . Ciò è mollo istruttivo •.
Questi risultati non sono da ascriversi al nuovo proiettile, ma al rapido ed accurato primo soccorso ed al moderno trattamento delle fer·ile.
Malattie medie/te. - È strano che due nazioni molto progredite nel campo dell'igiene, l'ame ricana e l'inglese, non siano state in grado in due guerre recenti, l ' ispano-americana e l'anglo- boera, di prevenire il tifo fra le loro truppe.
L e sono dAte dal doll. già pt·esidente oeii' Am e t·ican m edica i Ass ociation, « il campo di co ucP- nl!·azione era sa no, ma il comandartte non solo no n te ne \·a alcun cunto dei de l m ed ir.!o capo, ma coll'esempio pet·sonale eccitava i so ldati a trasg r edi r! i. Il ri sult.ato fu quale s 1 dovev a attende re : su 50,000 uom ini ne ammala r ono circA 12 ,000 e circa 1000 mo ri1·o n o per m a lattie che s i s ar·ebbe ro potuto evitare ». P e r l' Inghilte rra, qu el lo che avvenne nel Sud-Africa e ra s tato pr eveJuto dal p1•of. Ogs ton pochi m esi p rima della g uerra « a teme1·e che in caso di guer r a noi vediamo ri pete rsi g li ot•rori della guerra di Cri mea. GtA in tempo di pace devono e ssere ch iamali iii aiuto i medici civili » Lo rd W o ls eley n on aveva certo co ntribu ito a rialzare il m ora lP de gli ufficiali medici. Nel s uo « Soldie r s poc ketboo k • av eva chiama lo medico « la quinta ru o ta del carro " e scriLLo che '' le sue p ro poste sono b uone quan do sono ac cetta le • Durante la d'Egi t to aveva t enuto il medico capo mollo lo nta n o dnl quarlier generale.
Benc he'o moralmente e numericamente inl:'ufncicnte, il Royal Arm y medica i Cor ps ad em pi su l campo di batta glia e negli o spedali brillantemente la sua missione La C om missione incaricata di s tu dia r e l e ca u se della diffusione di epidem ie nel Sud-Af•·ica p ro pose l'is tituzi one di uffi c iali sa ni ta ri esclus ivamente destin,a,ti a so rv egliaJ'e la salute delle tru ppe . Ed il Comitato di sanità militare p1·ussiano nel i90 1 appli cava questo pt•i ncipio : • In caso d i g uerra la collaborazione di specialisti in igiene e batteriologia po t- teranno nuovi vanta g,!O\'i per la prevenz ione d elle mala ttie infettive. Come i chirurg hi cons ul e nti impiegheranno la lo ro abililil. nelle sezioni di sa nità e ne g li ospedali da campo a vantagg io dei fe riti. cosi g li il{ienisti mette1·anno la loro scienza a conl•·ibuto pe r ten e re lontane dall'es e rcito le infezioni " ·
Le principal i malatlie r iscon trate n el Sud-Aft•ica furon o:
1• Camp ( emrr. Col pi i s olda ti ap pena giunti sull'altipiano. I sintomi culminanti e •ano: di arr ea e vomito, raramente feb bre . Dopo 2-3 giorni avveniva la g uari llio ne, lasciando un mslessere per 1·2 settimane. Era tratt.ata con laudano e dieta lattea . ·
2• Veld so re (de rmalilis vesciculosa) ma latlia cutanea pii.t fr equente negl i uomini a cavallo. Nel co ntenuto vescicolare si trovarono diplococchi o lo statilicocco pioge ne aureo. '
3° Dissenteria, che fu leggiera, quantunque molto e ste s a. I medi c i incolparono il vento del Veldt (devii) che trasportava i germi morbosi, le perfrigel'Rzioni. Le feci, esaminale batteriologicamente, uon conte nevano am e be, ma solo batterii del g ruppo del coli e s lreptococch i.
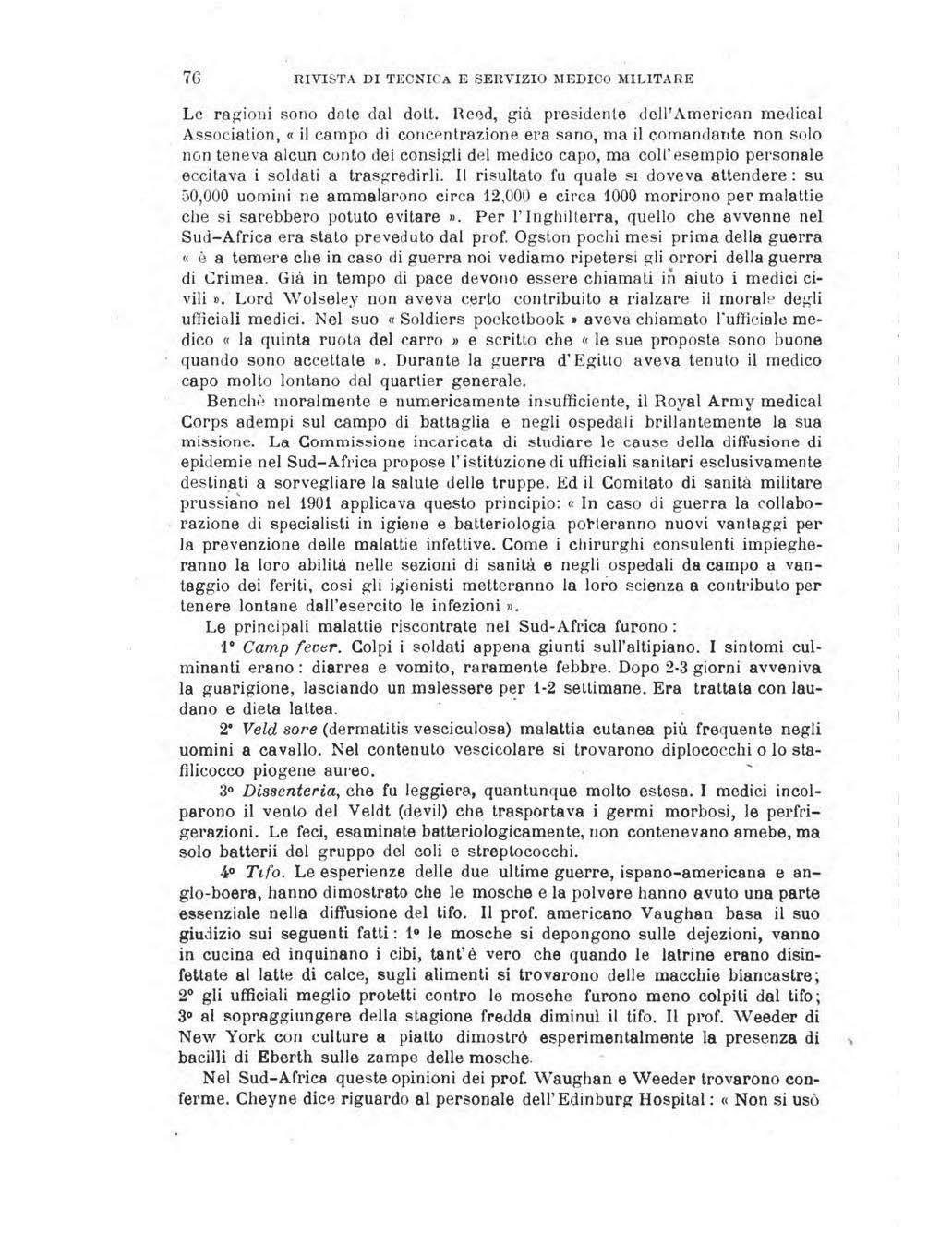
4° Tt (o L e esperienze delle due ultime guerre, ispano-americaoa e anglo-boera, hanno dimostrato che le mosche e la polve r e hanno avuto una parte essenziale nella d iffus ion e del tifo. Il prof. am e ricano Vaughan basa il suo giudizio sui seguen ti falli : to le mosche si depongono sulle d ejezioni, vanno in cucina ed i nquinano i cibi, t.ant' è ve ro che quando l e latrine erano disinfettate al latte di calce, sugli alime nti si trovarono delle macchie biancastre;
2° gli ufficiali me g lio protetti contro le m osc he furono meno colpiti dal tifo;
3° al sopraggiungere d ella s tagione fredda diminul il tifo. Il pl'Of. Weeder di New Yo rk co n c ulture a piallo dimo s trò e spe r iment.almente la presenza di bacilli di Eberth sulle zampe mosche.
Ne l Sud-Africa ques te opinioni de i prof. "\Vaug han e Weeder trovaron o conferme . Cheyne dic 'l riguardo al personale dell' Edinburg H ospitai: « Non si us ò
7G RIVISTA
DI TECNICa E SERVIZIO Ml!,ITARE
un a goccia di acq ua non bollita, le l'atto rie che fornivano il latte fm·ono attentamente s orvegliate . Sece> ndo il mi o pa ree e no u è questione d i acq ua o di lat te, ma di po lvere fl mosche. La polve t•e è in spirata e degl utita, le mosche tra· spo rta no il ge rme dalle la trin e e g li a limen ti e l'infezione avviene per due grandi vie d' a sso rbimen to , i polmo ni ed il cana le gast ro in testinale >>
Spesso un regg ime nto , occupa n do un a ccampamento infetto, si con ta g iò. Cosi il :.!• r eggime nto Vorcester, immune dal tifo, po t' latos i a Bloemfonte in, un campo g ià o cc upato da un reggimento di Pa a r debe r g, ebbe n e lle tr e settima ne dopo 278 m ala ti di tifo. ·
Non a bbiamo ancora la statistica completa delle epidem ie di tifo avv e nute nel Sud-Afl'ica: da una comunica zione al Parlamento l'isulta come fino n l dice mbre 1900 e ra n o s tati colpiti 19,101 uomini ed e r ano morti 4233 = 22,16 p. '100. contro il ltfo. - Do poché il prof. Wri gh t de lla sc uola d i Ne tley pubblicò sul L ance t del 19 sett embre 1896 la sua me mo ria sull a va ccinazione an ti tifo idea, furono fatte delle p r ove su ll e tru ppe indi ane n el 1898 ·e 1809, il cui risu ltato si rileva da lla statistica dello stesso Wri gt :

Non vaccinati 8460: ammalarono d i tifo il 25,17 p. 100, mo rir on o 2,71 p. 100 de lla forza ed il 10,6 p. 100 d ei malati.
Vaccinati 2835: ammalarono di tifo il 9,25 p. 100, mot•irono 1,7t> p. 100 della fo rza e d il 18,5 p. 100 dei malati.
A Lad-ysmitb s i e bb er o i seg uen ti risultati:
No n vaccwati 10,529: a mmalarono di tifo il 141 ,4"1 p 1000, morirono il 31,24 p. 1000 della forz a ed il 22,1 p. 100 dei malati.
Vaccinati 1105: ammalarono di tifo il 20,52 p. 1000, morirono il 4,6\l p. 1000 dell a forza ed il 22,8 p . 100 dei malati.
li colonnello Ceyley, medico capo deila Croce Rossa scozzese nel Sud.\frica, fece inoculare il vaccino a tutto il personale dell'ospedale e nessu no ru colpito dal tifo : della 2• seziono un so lo infermiere non e ra vaccinato e fu il solo colpito dal tifo.
Il Birt scrive : " Di 9H tifos i non inoc ulati m o rirono 135 = 14,25 p. 100, mentre di 263 tifos i stati vaccinati 6-18 mesi prima moriro no 18 = 6,8 p. iOO. La durata media d ella malattia fu pei primi di 28 gio rni, per i secondi di 15 g iorni.
Ellit e Was hbourn del Yeo manr y H ospital ebbero in cura 121 tifosi vaccinati ed ebbero la mortalitA del i,4 p. 'LOO, su 556 n o n va ccinati la m ortalità del 10,9 p. 100. Nell'ospe dale ammalarono 2H vaccinati colla mortalité dell' 11,4 p. 100 e 157 n o n vaccinati colla mortalità del 14,6 p. 100.
Al ritorno degli uffi ciali medi ci dal Sud-Africa ebbe luogo alla " Mtldical Society " di Londra un vivo dibattito circa il valore preventivo del siero antiuroso e parecchi med ici riportaron o statistiche atfatto o pposte alle precedenti, mentre si fece ril e vare che il tifo non conferisce che un' immun ità t'elativa. OsTINO.
RIVISTA DI E SERVIZIO MEDICO MlLlTARE 77
R I V I S TA D ' I G I ENE
G. BonN E. - VaoolDazlone e d va.oolll&Zlone .- (Parigi, C. Naud edit., 1002) .
Il autore, che fu re latore alla Came ra francese nel dicembre l 901 della nuova •·elativa alla protezione de lla salute pubblica , in una inter c s !>onte pubblicazillne dimostra an cora una volla i bt>nefìci efTtl lli dell a vaccinazio n e e ri"acc inazioue obbligatoria.
Nel pl'imo capito lo, fa uno studio completo della vaccinazione in Francia dal suo principio fino ai nostri gioroi; mostra come pe1· effetto dello misura applicate, il Yniuolo sia quasi "comparso dalreserc•t.o francese, e i benefici e ffetti che s i sono ottenu ti ue ll n ma d re patria co n le terribili epid e mie che anco1·a infì et·isco no nell e cl'l lon ie , dove il cod1cc s anitario è disgrA7.1alnmente, almeno per o ra, dil'f.cllmente app licabile.
In llll l'<Cco ud o capi to lo fa uno s tud io co mpm·alivo della vacc i nazione n e lle diver"e potenze d'Europa, dimostrando i m e ravi glios i ri s ultati u e i paesi dove la vACcinazio ne è obbligatoria e non tr as c urand o di cita •·e i l •·ito rno di epidemie vic•!CIIIi in lng hilt•) rra ed in al c uni c antoni della Svizze•·u, dove la leg,tte s ulla vaccinazione ò s tata m oùi(icata
In co n adatti argomenti, co mbatte tu tti que lli deg li anlivaccinalori, e dimo!< Lra c he non !'ìo lo la vaccinazione non predispone od alcuna malattia, ma che. al con trari o, gli ant•chi vaiolosi sono per l'avvenire in una condizion e di min o r rc.-islenza verso gli a ge nti . Patog-eni, e che se qualche cosa pred i!<pone alla morbosità, è bensì il vaiuolo cbe si deve inc r iminai'!', ma gia mma i la rivnccinazi o n c.
SpPcial i capitoli sono dedicali all a pratica, s ia allo scopo di st udiare l'applicazione della lPgge in Francia e ne lle colonie, n e l mod o migliore ed il più a ccessibile, !l'ia allo s copo di forni re le cognizioni più complete e precise sul vaccino, sui di versi metodi di va cci nazione, sulle indicazioni e le co ntro indicazioni eh questa piccola opet•azi o ne.
Sulla fJuestione poi dell a rivacci nazioue, l 'A. vi ene a queste con cl usio ni: c he la m edesima s i r ende n ecessaria ad epoche det ermina le, ogni otto o diec i anni , avendo cura di a pplicare il vaccino intensivo ai soggetti che sembrano r e f•·allnri; c!lc in tempo d'epidemia, le r i vaccinazioni debbono esse re immediate e generali, anch e nPgli individui che, un o o d ue anni avan ti, furo po inoc ulati co n s u ccesso; c he la legge attuale, rende ndo obbligatoria la rivac.ciuazion e a 1l anni e a 2 t anni, ri sponde perfettamente allo scopo pr ofilattico. te.

78
MISCELLANEA
Corpo sanitario m i litare co ioniale. - È stato p r esen ta to al Cong r esso degli Stati Uniti un prng-:Llo di legge pe t• la creazio n e d.' uo Co rpo sanita ri o co lon ialt.! a sim1!!l ianza dj q uello che ha l' In gh ilte rra in ln rlia e l'O ia uda n el le sue colo nie. Sco po d t q ues to Co rpo sar e bbe quello di attendere al !'<ervi zio sanita rio militare e civile io quelle r egion i le quuli, bench•:· apparte n o:n ti alla Con!'edet azione, ne so n o separa te per raz za e ubicnzione. E difficile, d ice il pr ogr.lto, che si trovino medi c i in numet·o s u mciente pet' r ecat·si ad e!'<ercitar e sollo i tr·opic i, a meno che non abbiano un forte ince ntiv o a farl o : é diffì r.i le p ure che m t'dici non !!'pecin lmente vet·sali nella r hll:lll·gia e me d ici na tr opicAle essere di efficace ai uto alle autorità civili e mi litm·i nell<:l varie c.on tin go nze . La c r enzione del Cot·po s arJitario colon ia le ad ogni inconveniert lP, specialmente n e l se rvizi o d e l Corpo d i polizia e altre forze in digene. E ssa ,·ireb be p ur e a col m a r e i v uoti che lasce r a n no i medi c i il c ut servizi o scade per legge e o ri ch iam are nP-ll' cse r cilo i m ed ici perman Pnti che ora s tanno ai tropic i. Ai vantaggi s i aggi un ge qu ello de lla mi11ore spe s d.
Le cantine milit ari n ell'ese r cito degli Sta ti Uniti. - Semb ra che la soppressione delle cantin e militat•i nell't>Sf' l'Cito americano sia sta ta causa d i gra vi inconven ienti poich é il n umer o degli ubbriac hi e delle man canze di!!'ciplina ri è olt remorlo c resci uto.
In un r np porto che l'amminis trazione gene1·ale dell'ese rc ito lt a fal lo al Ministero della g uerra, d opo av e r fatlo r ilevare accennati inco nvenien ti, p r opone la r icos titu z ione dell e ca ntin e .
Scuola di m edicina milita re n Pg li Stati Un iti d'A m e r ica. - P e r impedire che il C o rpo sa nita ri o mili tat·e abbia rlelìc ienza d i medi ci il dot t. W Newbu rn , propo n e c h e s'ist ituisca una sc u ola di m ed icina mil itar·e, la quale, a si mililudine de lla scuola dei cadetti in W es t P oint per la fante t·ia e le altre a 1·mi, sia come il semenzaio d egli uffì ciali medici. Gli alli evi dopo un c orso, pet· es. di .i anni, fa tto co n pr·ofesso ri scel ti daJ Corpo san itari o militat•e oppure dall' nnivers ilil , e conseguita c he abLìano la laurea, enlt'er ebbero n e lle file dell'esercito. (.''v!ed. R ecord, 22 no v e mbr e 1902).

Le do nne e il se r oizio sa n ilario in guerra. - È opi ni one gene r a le <:lei chirurg i che hanno p r eso parte a g u erre che l e donne n o n possono essere impiegale n elle fo r m a 7.io ni sanital'ie de l ca m po di ba tta g lia Il do tt Klilln e t·, che fu il medico capo de ll'ospeda le inviato al Tra nsvaal dalla Croce r ossa teclesca, é di lull'allro p ar·ere.
Nel B o ll ettino in ternazionale de lla Croce rossa s i legge infatti:
• Il dott. Kiltlner h a fallo una v olta di più l'espe r imento d e ll' ut ilità estr emo d'ave re un pe r sonale fe mminile. ed é gi unto a ques ta co n clusiOne che no n so no cbe le suo r e che a ppa rtengono ad associozioni ri g ida mente regolam en t a te, che sono c o m pletamente formate e beo disdplioate, c he possono e ssel'e mandate !ul campo di battaglia all'estero. Quan do le acce nnate condizioni sono soddila s uperiorità rl e lle donne sugli uomini è innegabile d al Ialo della sobrtetà, den'ordine, della pulizia e della abnegazione. Ciò non !;ignifica però che s i po ssa far a meno infermie ri' poichè nel disb ri go di ce r·ti obblighi le forze masch ili sono indis pensabili " ·
Sostitu• i one de lla zuppa al caf!é nell'ese rc Uo f r ancese. - Con re cen te determinazione, il Mi niste ro della g ue rra fran cese, in seg uito a g li esperimen ti stati fatti presso v arii corpi d i truppa, ha d eciso di lasciare all'arbi tl'i o d ei comandan t i di corpo di sos titui r e la zuppa al caffè con zucche r o a seco nda della sta gio ne e dei servizi speciali de lla truppa.
nnori a tm medico militare i n Spagna . - Il do U. An gt! l La rra y Cere zo , medico ,iell'e se r c ito e a lla scuol a <.h med ici na militare d i Mad r 1d, ò stato r ece nte m en te n o mina to m embr o de ll"aecade mia d i m ed ici n a di quell a città, titolo mol lo a mb ito d ai me d ici spagn uo li , poiché il num e r o degli accade m ici è molto li m ita to, e le elezioni a vvengon o per All u cer imonia n ella q uale il ne o elello p•·onunzi6 un bell issimo disco r :<o, a ssisté in forma uffi c iale anche il Minis tro dell a guerra, con un g r an numc r't} di notab ili tà mili tari.
Gli s tipen.dii dei medici milita r i n ell' India. - Ecco la nuova ta bella delle paghe app r ova te dal Gov e rn o dell' India pe r gli uffic ia li del Hoyo l ) f edicnl Co1•ps <:he s ervo no nel l" l ndia: (l r upia = ci r ca L. 2,20)
T ene nti . . . . . . . . . . . 420 r upie al meM (tlno ra 3:10)
Ca pitan i. 475 " " ( n 350)

De tti co n p iù di 6 anni d i s erv izio 530 • •• ( u 450) 10 » ljf>O n n ( !'i)Q)
Ag li uffi ciali m edici add e tti a g li ospedali é inollr e a sseg nala u n a inde nn ità d i ca rica co m e seg ue:
N egli os ped ali d o aoo e p iù letti » 200 » » » 100 )) 50 ))
ru pie al 180 • 120 n 60 o
m ese » •
Congresso m ed ico egiziano. Al Con g res so m edi co c he ha avuto luo g o al Cairo dal ::!0 a l 26 dicem br e u. s. il Corpo s'anita rio M I n os tro e se rcito era rap· prese ntato da l ca pitano medico pro!'. Tro m betta , uffi c ialme nt e' dele g ato dal Mi· nis te r o de lla g ue rra. Il Min is tero d ella marina e r a rappresen tato dal m e dico c apo pro f. Pas q uale.
Lo ruo ta bile - Il s ig. Saint-Pau! ha pu b blicat o ne lla T ou r a ine m erlieale t: na pro pos ta chl', s e fosse tr o vata attuabile, de! c he mol to dubitiam o , po rte rebbe una ve r·a rivo luzio ne n e l modo di marc ia r e delle tr u ppe
E g li p r·opone l'adozio ne par o gni due soldati di un v e i colo a ruot e, facilme nte s monta bile in due parti, ch iamalo rou le-sae, quale pose r ebbe ro un o sop ra l'altro d ue zaini. Dur a n te la marcia s u lle s trad e F:li zaini sa re bbe r o trainati s ul rou le-sac. Abban do na n do la s trada , i solda ti s i caricherebb e ro s u lle s palle g li zaini, piu un a m e t.à p er ciasc uno de ll'a pparec chio s m o ntato, c he l'auto re ass erisce di p o ter ridurre a un peso min imo
Distin.:Jion e a un f arm a cista mi li tare. - Il R Is tituto Lo mbard o di Scienze e L e tte r e ha c o nre rito il premio di fondazi o ne Zanetli al fa rmacista militare cav. Eduardo Baroni pe r i ,uoi imporlanli lavori s ulle Prep arq•ioni del materia le ase ttico da med ica tnra, sulle S olu;ioni ster ili:u a fe p er i nie:: ioni iporl erm t'che e s ulla C reol i n a lif}u ida e so lida stati eseguiti nella farma c ia centrale militare e p;ia noli ai l ettori d i q uesto g iornale.
La fon dazio n e Za nelli a ssegna il pre mio a quei farmacis ti italiani che con la vori o riginali r agg iungano uno scopo qualunque r iconosciuto e g iud icato utile al pr ogresso della chimica medica.
Al di s tinto collega i nos tr i vivi r allegramenti.
Necroloaio. - A Firenze , il 5 gennaio , il maggiore m e dico della t·is<' rva Carbon i Ra imondo.
Il D i r e t.t.o r e Dott. F. LANDOLPI, maggior generale medioo.
Il Rede.t.t.ore
D.• RmoLFO LtvJ, ma g gio r e medico.
Roma, 1003 - Tlp. E. Vog hera. GIOYA!'INI SCOLAR I,
so

GIORNALE MEDICO
DEL REGIO ESERCITO
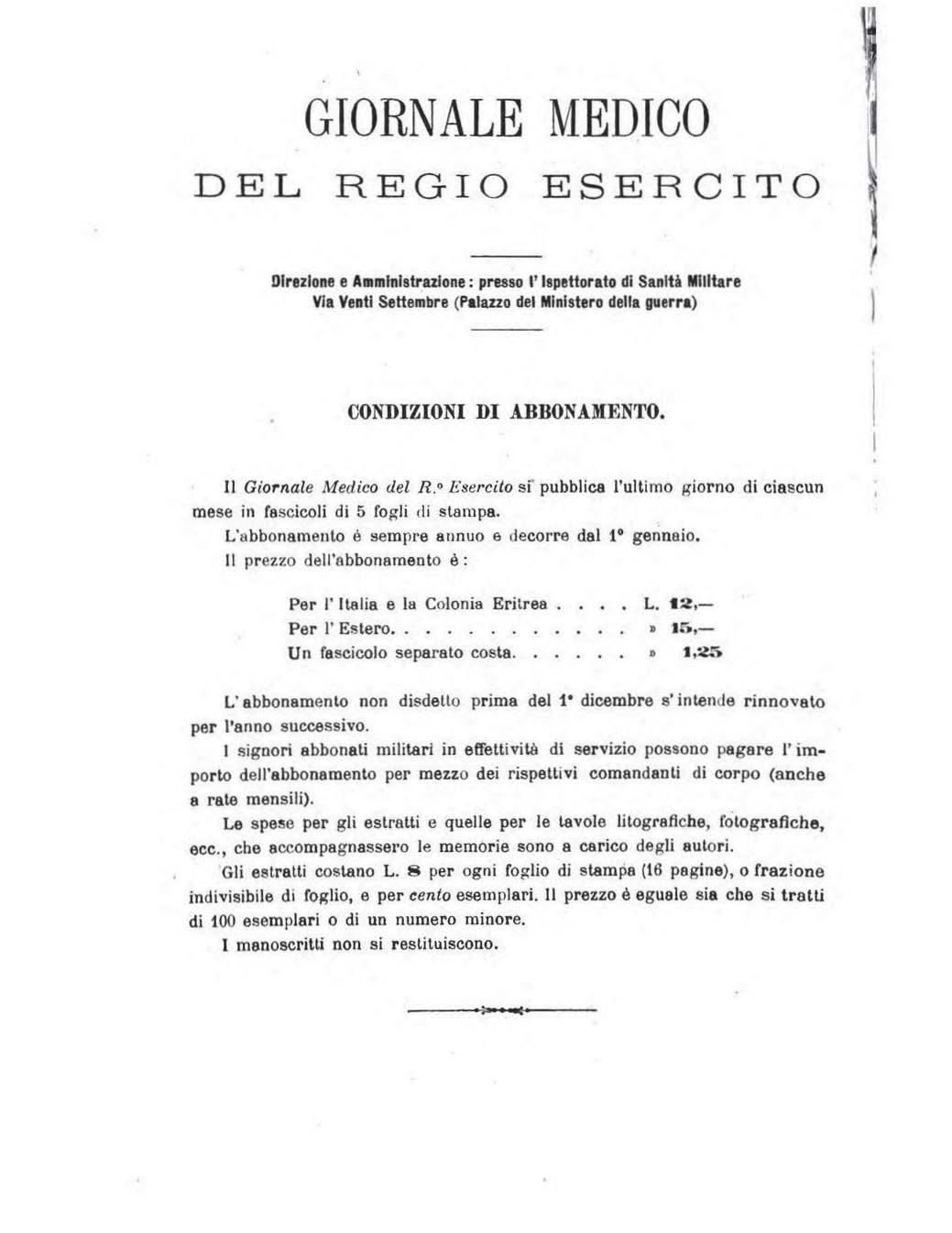
Direzione e A•mlnlstrazlone: presso l' Ispettorato di SaniU Militare Via VeDtl Settembre (Palauo del Ministero della guerra)
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
Il Gior nale Medico del R. 0 Esercito sf pubblica l'ultimo giorno di ciascun mese in fascicoli dì 5 fogli el i stampa .
L'a bbonamento é sempre annuo e decorre dal 1° gennaio.
Il prezzo dell'abbona mento é:
Per l' Italia e la Colonia Eritrea .
Per l' Es tero. . . . . . .
Un fascicolo separato cosla.
L 12,-
» 16,-
» 1 ,25
L' abbonamen to non disdetto prima del 1' dicembre s'intende rinnovato per l'anno successivo.
1 signori abbo nati militari in effettività di se r vizio possono pagare l' imporLo dell'abbonamento per mezzo dei rispettivi comandanti di corpo (anche a rate mensili)
Le spe!le per gli estratti e quelle per le tavole litografiche, fotografiche, ecc. , cbe a ccompa g nassero le memorie sono a carico degl i auto ri.
Gl i estratti costano L. 8 per og ni foglio di stampa (16 pagine), o frazione indivisibile di foglio, e per cento esemplari. Il prezzo é eguale sia che si tratti di 100 esemplari o di un numero minore.
1 manoscritti non si restituiscono.
. l
SOMM A RIO
MIEBOaiJE ORIGUIALI

Tromllltta - La cinescopia del dott. Ho l t h·.
Bono - Sulle allerazloOJ !lell'emopocsl nella morte per Spilla - Le perroru.loni tJmpaniclJe pat.o loglche in mpporto al .;cryizio milit.ut·
Glanl - Sopra un caso di paramioclono con RIV1 8TA DI GIOR..-AI.I ITALIANI ED F. IIITERI .
RI VIsta modica . . . . . . • . . . . . . . .
ltlvista chirurgica . . . . . . . . . . . . . .
Rivista d1 oculisUca . . . . . . . . . . . . .
fth lsta tll anatomia o llslolol(itl normale e pJtologla.
fuv lsta di malat tie veneree e .tell a pelle ll lvlsta di e medico militare.
ltlvtsta d' Igiene. •
araOa
Conferenze sclentlfiehé deg'li m'miari
a&JseeUanea • • V. l'lndiu mi!' cltlla copertina.
PUBBLICATO l>llbh' 01 SANITÀ l
LI PAS(;. 11 1903
ANNO
Blbllo
. . · · · · · · · ·
• Pc&!/. gt 87 9!1: • 119 l'l/Q. l i;; • f36 i 37 i 38 t39 44U l4't f 5(i l ìSG 458
• ROMA • P. l'Avviso nella .3" -paginll della Copetttin& .
DlFtEZlONE ED AMMINlSTFtAZIONE
ROMA • Palu2o del MlnlBtero della Gu er r a, V.la XX Sett embre
Criuni
Krebs, Kl e lne
lehle
Salus
Rlegler
Blanc
INDlCE
DELJ ,A R I V I STA DI ITALIA NI J<:n
llt\ br; .\lt:ttii.A
f ' - r\iVJ!'ta 'llllCtu·a ,. rrlllr;a
1111 r hU tll tiPI rarwl!e f'UU aurt uueulu t:rHIIIt'U
:;ull'a--orlllmeulo sali o11 rhinona
:;ul ciel hartllo ltllco nello sltUIO de1 mal:t.ll •h 11111.
r ·II&I{IIH'I h:H'lt rl Òf?'lla OirtPrit.e •
1 u<t tlel r"culo unru
111\'ISTA
f!IVISTA Ili uc: rt, I:HICA
Harrles Jones - Sul r:tP itor lo 11 g lauro ma n la l mml"" ' , ,.n rtlllllll'itC
Staal be r g. - lan-11 •h m u.'r" nrlra ramera alltP<'ill rA dl'il'orc htO . ...•
lli\' I:'I'A Il i Ai'IAT<nllA F: FISIOI.UC;I\ E
f'o (l 137 i vr
Casarlnl l.'o• rgograO:. ru nolc (elrllnc:t , lill lllll;orHI/ ÌIJ ronoht.ioJJll p rtn to· lu;.:Whl' , . , , , . • , , , . , f' llf}
lltl'l$1',\ 1>1 \IAI.\ t'TIE OI': I.I.A I'E:t.LE.
Schollz Sllll'llt0tl"lllll dt·• R ontge • <ull" 11ello >Ialo •h ,.alntr •• " ''Ile mniMIII'. l'a q. 139
Ili E :<f.RI'IZIO Mli.IT ARV.
B.ronl. Il dunino •lr :"ta lO • • l'a(}. I lO
Bonservlzl )l.ol,on<l anuual1 olorne.,t•ri . . . . . • . . . . . . .
Ferrle r - :-111 hn -nlle r<lu<r ' " S•'tlltthih <11 f.r • a ro;on• 1 rt!ulta u •IPIIC •art,fiJ,tWoll1
Valllard - L" •'ltrltol In Areodenll <la pro)voc.•tt; mezz1 rer ,,,,., t·mr n
lèYI 1 Lemerre. - Proli'.,,, Ilella fehbr e 11f01•le. . . . . . • . . . . . . . . •
Dop1er. - S111 la lh' l lor-•lr çolle poh·eriuaziont dr uua 'oluzol•ll" •l• Cu rmulu.
De luca. - l:mca In Fo<;!(ta . . . . . . . . • • . .
Gatti - C:alzatur.< 11:1•nica • • •
T ira bosc hi. - c;h anima li propa!(at.ori olella peste lmbhomc •
P ulnl.- Ul 111 nuo\u per pre<a d1 cam pioni d'ar<(Ua a >f.OII I•
Bai a rdl. - l.a • lingualill • n ella borra de• sani e del dlllcml •
Casagre ndi. - Sulla rt r••rca delle LOss1ne hacterid•e neg h o rg311i •

Caugr a ndi. - Vt•molisona e la leucoh.>toa . . . . . . . . . .
Val enti. - l h t nu ovo ra ptdo procedimenlo pe r h1 colorazion e dei IM llen. . . .
Berlrand e c trnens. - l.a ma la r ia
tng hl ll erl - )1•11" e d e ll' uda ltamenlt> de l hacillo ,, ' 1\'Cr•' urlr' potahile • • _.
Lo mm el. - Sull:t co nosce n:ta tlella tena.c rta de l v1rus
Ltme lne - Sullo s vilut>flO della tubercolosi n ell'escrcll c> in r·arportu •·ollu tu ltrr · mlo<i r:tmiliarol n arfl UlSIIa pnma fiell'incorporazione , , , , ,
BIBLI OG RAFIA
Calliano - oleme utan s ul • primi s occors i · a ri Sc uola Slrnaritnuu l'a{l l 5:1
CON I'EHENZE OF.r.l.l OSPIWAI.I MILI TARI Pa(J. I G6
MISCEI.i.ANI':A . . . . . • . . . . . . . . . . l'og .
f'a (l. l ! '\ • 13:1 lVI • CJ l t 95 l\' l
• l'rlfl. 116
f'aa U':l • 143 t U U 6 1\'1 ,., • 147 , , • U 9 l\'1 h'l t ;;(l l l\ l l 5 l •
LA ClNESCO PIA DEL DOTT . HO LTH
OEl IIIF ETTI Il i HEF H
olel dOIL Etlnu>ndo Trombe tea . onedoro!1 bhcrr, ,,. (
P er noi med ici militari, che andiamo avidame n te in quei metodi diagnostici i quali ci pe rm ettano di fare, n el modo più ra pido ed esa tto, la. dete r minazione dei vizi di rofra.zione, e dteappunto per ta l e moti vo - diamo la preferenza. alla schiascopia, deve rius cire di particolare interesse l a recente scoperta. rlel dott. Holth di Cristitmia, l a qunle viene precisamente a d arr icchire l'oftalmo logia di un nuovo metodo facile e pratico per la d eterminazione in parola.
Questo metodo, che l'autore chiama CinescopiCL (da muoversi, e guardare) e che, per mia. personale esper ienza , credo potrà essere utile nella. pratica medico-militare. fu scoperto dall' Holth per pu r o ca so - com e già. avve nne per la. schiascopia - durante le sue esperienze sull'amaurosi indiret ta per lissazione, e in un modo che merita. d t essere riferito, perchè contri buisce a. r enderei r agioue del fenomeno diott r ico.
Fissando col suo occhio destro, e ad un metro di distanza, un piccolo disco 'bianco di 3 mm. di diametro sopra un fondo n e ro, egli osservò che, l'a mmiccamento. l'oggetto subiva una l eggeriss ima. de· viazione in basso e un po' "in fuo ri ; il quale fatto egli credette dover attribuire ad un movimento del suo occhio, sinergico con l 'ammiccamento. Ma. ripetendo l'esperi enza. e stu di and one m eglio i particolari, l'Holth si accorse ben presto che là cagione era. tutt'a ltra. In v ece di ammiccare, egli ab bassò d inanz i al suo occhio destro in fissazione un cartone nero situato a 2 cm . dalla cornea.; ed osserv ò che n e l momento preciso in cui l'orlo del car tone penetrava n e l campo pupilla.re, l'oggetto di fissazione subiva il medesimo s postamento i n b asso e un po· a destra. Tale fenomeno, ben più distinto che con l'ammiccamento, diveniYa.

MEMOR I E
r. - GIQrnnlf mrdlco.
addirittura spiccatissimo quando l'ogget t o era posto alla distanza di ti m et ri (S n ellen), per <.:hè allora l'orlo d e l cart one spinge\·a, per cosi dire. dinanzi a sè, dimost ra ndo fino all'evide nza che l'ammic· cameuto c il supposto movimento sinergico d 9ll'occhi o e delle palpebre rlo\·evano esser messi fuori causa
L' ll olth, pensando allora a lla refrazion e del s uo o cchio, cbe, infatti. ri\'ela\'a. un leggi ero astigmatismo mis to ( - l,i5 D nel m eridian o qu as i Yer t ical e , e - 0 ,5 D nt'll"orizzoutale) ossern) che quando faceva mno· vere in basso l'qrlo orizzontale del cartone, l'oggetto n on sub iva uno spos tam ento ri gorosamente v er ticale, m a bensi alquanto obl iquo. parallelo al meridia no principale miope; e che quando impr i· meva. all'o rl o verticale del carto ne dei movimenti di later alità, l'og getto s i spostava in senso in vers o, parallelamente al meridiano principnle iperm etro pico. CorrPtfA la sua ametropia, egli n o n ossen·ù più alcuno s p osta mento p er parte dell' oggetto posto a 6 m. rli distanza, qua lun que fosse il mo\"imento impresso al carto n e .
Queste espe ri en ze preliminari e puramente a ccident1di, che risalgono al 18 \.Ju e che l'autore d ovette in te rrompere pe r atLeud e r e ad altri lavori, co::;tituiscono il vero punto di partenza d ella scoperta del metodo , la C')Uale n on avvenne propriamf! u Le che l'ann o scorso. qua ndo, cioè , esaminando un malato in cui og ni d etermina zione obbiottiva della r e· f razi on e e ra resa impossibile dalla ristrettez7.a della pupilla (sinechie pos te ri or i), e la ri cer ca subbiettiva co n le l enti di prova e co n le scale murali riusciva infruttuosa perchè r as-.icurat.o co utro gli
infortun i sul lavo ro, simula>a l'= ( l' H o lt,h -;i domandù se l'osse rva zione fatta qualche anno prima n on an·ebbe p ot uto dare un utile risulta to, trattandos i non già di migliorare l'acu cozza '\Ìsiva. d' un occhio ametrope, ma b ensì d i riconoscere la scomparsa di un m o Yi· m e nto che precedentemente era visi bile.
L' Holth, ad unque, ripr ese le esperienze su sè s tesso al punto in c ui le aveva lasciate, e potf• constatare ben presto come f ossd assai proferibile sostituire l'orlo del cartone con una fessura di l R 2 millimetri d i diametro prat icata nel diaframma. medesimo; e che in tali condizioni. se rocchi o ametrope senza accomodazione fissava un oggetto ab bastanza lon t an o men t re s'imprimevano d ei movimenti p e rp endi· colari al grande asse della vedeva sempre ques l'oggetlo animalo da m01'imenti, fino al momento in cui g li si poMca r/inan:;i la lente r;o,·1'elliva della sua amet1·opia. Assodato questo fatto impor t ante, l' Holth ripetè l'esperienza su l simulatore, collocando a 6 metri di d i stanza nn dis co bianco di 10 centimetri di diametro. ed invitando l'individuo a

.,, ) ,.\ C ' ISI<:SCOPJ.\ DEL. D OTT. IIOl.Til
fissare tale oggetto attraverso la fessura Ja.rga l millimetro. Imprim e ndo poscia dei movimenti al diaframma l'ossen·ato dichiarò subito di vedere l 'ogg et t o muoversi in se n so in \·erso fino al momento in cui l'osser-vatore gli pose dinanzi all'occhio in esa me un a len t e + 3 D: all o ra ogni movimento scompar ve; inoltre - fatto mo lto in teressanteusando tutt e le preca uzioni necessarie in simili casi, r ·Holth riuscì ad accertare che con detta lente p os itiva di 3 n, l'acu tezz a v isiva uguale a ( {) mentre che , malgrado ogn i sfo rz o. l'individuo non
accusava prima ch e V = :o
Fu questo risultato impreved uto ed incoragg tan te ch e indusse l'a utore ad estendere le sue esperieuze ad un gran · numero d i indiv id n i aft'etti. dalle am etropi e più. di ve rse ; e s iccome in ess i l'es ito co rrisp ose costantem ente all'aspe ttativa, così il nuovo metodo venne acquistando una -,;era impronta scientifica, in modo da potere oramai a buon diritto prem1ere posto accanto agli altri n ella pratica oftalmol ogica, con a lcune indicazioni speciali di cui fa r ò cenno f ra poco.
Ed ora du e parole sul me toclismo di esa me e
diott rica del fenomeno scoper to dall' Holth.
sull'interpret.azioue
Str ettam ente parlando, per procedere all'esame cinescopico n on è punto necessari o essere provvisti de ll'ap pa re cchio s peciale fatto costruir e dall'au to re (ci nescopio) , di CllÌ tralascio la descrizion e per no n d ilungarmi troppo; basta ave re a disposizion e un'ord inaria sca tola di l enti d i pro va, dove, come è not o, si trova pure n n dis co metallico muni to di fessu ra stenopeica., la quale serve benissimo allo scopo Da un cartonc ino si ritaglia un dis co di ò-10 0entimetri di diametro, e lo si fissa co n uno spillo sopra un pezzo di stoffa o sopra una tabella nera appesa al muro: a 5-6 metri da questo punto d i mira, si antepone all'o0chio in esame il disco munito d ella stenopeica, che si fa muov ere rapidamente in d ù·ezione pe1pendicolare al SitO g1·ande asse, e successivamente senso dei due meridiani principali dell'occhio s tesso. Ossia, per s piegarmi in modo anche più chiaro: ten endo la fessura i u di rezione trasversale dinanzi all'occhio, le s ' imprimono dei movimenti dall'alto in basso; e, in un secondo tempo, ten endola in direzione vertica le, le si imprimono dei movimenti di lateralità, attenendosi, in tal guisa1 lo scopo di esaminare la r efrazione di entrambi i meridiani. Ecco allora quello che si osserva:
L ' em metr ope che guarda attraverso la fessura mobile, vede l'oggetto lontano immobile. Con una lente di + 0,25 D, l'oggetto si muove nello stesso senso della fessura stenopeica perchè lo si è reso miope ; con una.

Sl:OYO MI<:'L'ODO D !A(l:OWST!CO DEl DTFF:TTI DT llE.FR.I%;t!l:'iE 1--iJ
(
lente di - ù,2ò D o di - 0,50 D , può dars i che L'ogge tto resti 1mmobi le a cagi on e del potere acc omodativo; ma co n la l ente di - 0,75 D o di - l D, l'ogg etto si sposta in senso in ver so , perchè lo si è r eso i permetrope.
Il miope vede l'oggetto spostar$i n e llo stesso :!enso d ella fessura.; e la lente negativa più debole che fa v ede re r oggetto immobi le in· rii ca il g rado d ell'ametropia. bisogna tacere tuttav ia che l'acco· del soggetto può neutralizzare l'azione della lente neg ati,·a (fino a circa - l D j, per modo che l'oggetto r esta immobile; ma se si applican o lenti superiori, rindi vid uo n on tard erà. ad accusare movimento dell'oggetto in senso inver so (ipermetropia) I n altre parole: nella miopia n on corret ta, l'oggetto si sposta n el medesimo senso d el la fessura quando l'oggetto stesso è situato al di là. d e l r e mo t o; si sposta in senso inverso quando è situato fra il remoto e l' occhio; rimane immobi le quando si t rova. prec isamente a l r e mo t o; il che può perm et · te r e di determinare approssima ti vamen te il grado della mio pia anche senza l'aiuto delle lenti; infatt i se, per esempio, l'ogge tto è immobile a 50 ce n t ime tri, la miopia sarli. di 2 D.
Nell'ipe, ·met,·op e l'oggetto di fissaz ion e si sposta in senso !nverso alla fessura; ma se il g rado dell"a.metropia è debole, può dars i che !"oggetto resti immobile per l'in ter vento dell'accomodazione: però, co n · trariamente a quan to avvi ene ne ll" emmetrope, quest'immobi li tà persiste se si fanno passare delle len ti con vesse d iaanz i all'occhio in esame : la len te positiva più for t e che permette an co ra di vedere rogget to immobile e q uella ohe corregge l'ametropia.
Nell'astigmatico si può d eterm inare con la oinescopia la di r ezivne dei meridiani p ri ncipali, non chè la loro refrangenza: ma siccome questo è un meto :io che r ichiede, pe r parte dell'individuo in esame, una certa sottigliezza di osse r vazione affine di distinguere il movimento d e lroggetto, così, nel caso !'pecial e dell'astigmatismo, non l o credo preferibilt' agli altri metodi che già a bb iamo a nostra di sposiziono, mentre - ri · peto - nei semplici d ifetti di refrazi one sferica lo ri tengo v eramente prezioso.
L a spiegazione diott rica del fenomeno di Ho lth è sempliciss im a. Nell 'emmetrop ia, tutti i raggi provenie nti dall'oggetto lontano (par alleli) si riuniscono a l fuoco princ ipale dell'occh io, vale a dir e sulla re t ina . U na fessura stenop eica. posta dinanzi all'o cchio in esame, ed animata. da moYimenti v er t icali, n o n permette che a d un certo nume r o di raggi di penet rare s imul t aneamente n ell'occhio ; ma non si osse r va alcun mo vi mento del l'ogge tto poichè i ragg i emanati d a q uest"llltimo vann o tutti a convergere in u n medesimo pu nto della. retina.

LA < JNESCOPLI DEL D01vl' H OLTII
N ella miopia, la retina s i trova, come è noto, al di là del fuoco principale; quando si fa muovere la fessura stenopeica dall'alto in basso, i raggi corrispondenti alla fessura stessa subiscono, dopo l'incrociamento al fuoco principale, uno spostamento dal basso in alto; ma, sec ondo la legge della proiezione rovesciata, tale spostamento è percepito dall'occhio in senso inverso. Dunque l' ogget to da c ui emanano detti raggi sembra animato da movimenti omonimi a quelli della fessura.
Nell'ipe?·meti'Opia, la r etina è s ituata in avanti del fuoco principa le; e se si fa muo ve re la f essura dall'alto in basso, il fasc io dei r aggi non i1w.,·ociali si muove pure dall'alto in basso sulla retina; ma per la legge della proiezione rovesciata, è percepito come se si movesse dal basso in alto Dunque l'oggetto da cui parto no ques ti raggi sembra animato da movimenti inversi a quelli della fessura.
Come si ved!e, il metodo cinescopico, la (;Ui applicazione ed in terpretazione non sono meno semplici di quelle della schiasco pia, può venire utilmente impiegato, per Ja sua rapidità e novità, nella prat i ca medico-legale militare, sopratutto in quei casi in cui a l vizio di r efrazione si associa una così notevole diminuzione di acutezza visi va, r e ale o simu lata, che renda infruttuoso ogni te11tativo fatto con l e ordinarie scale murali. Mi sembra inutile il far rilev are che la cinescopia non potrà mai sostituire la schiascopia p er l a semplicissima r ag ione che quest'ultima ha tutti i vantaggi dei metodi obbiettivi . mentre la prima ha tutti gl'incon veni e nti dei subbiettivi; ma s i po· tranno benissimo a ssociare i due metodi nei casi ora detti a scopo, per esempio, di controllo; tanto più ohe, secondo l ' esperienza dell'au to r e ed a quanto me ne disse in proposito l'egregio collega dottor Ped razzoli, il metodo cinescopico permette un 'esattezza di ricerca che si spinge fino a ' /-. di dio.ttrìa per ciascun meridiano.
E g iacchè ho parlato per incidente dell a schiascopia, aggiungerò ancora che l'Holth fa giustamente notare che se i due metodi offrono nn punto comune, e cioè l'osservazione di movimenti la cui di rezi one varia secondo l'ametropia, le diffe r enze sono però cosi profonde da farne d u e fenomeni diottrici assol utamente diversi. Infatti nella schiascopia, è l'oggetto stesso (ossia il riflesso della sorgente luminosa) che si muove , e la sua immagine si sposta ne l medesimo senso sul fondo d ell' occhio, qualunque sia il vizio di refrazione da cui quest' ultimo è affetto : è soltanto il movimento apparente che è diverso. Nella c inescopia, invece, l'oggetto è immobile, e i movimenti r eali dell' immagir..e sulla retina cambiano realmente di direzione secondo la varietà del difet to di refrazione. l movimenti appnrenti differiscono anche secondo le ame-

'METODO lilAGXOSTICO DEl DiFETTI DI
;:,;)
REh'RAZI OXE
t r opie, ma sono in se n so i n ve rso dei movime n ti r eal i. E an cor a: nella schiascopia l'ampiezza e la rapidità. dei movimenti so n o inversamente proporzionali al grado dell"amet r opia; \·a.le a dire, più questo g rado è meno i movimenti sono estesi e rap idi: meutre nella ci ne· scopia l'ampiezza e la r apidità de i movimen t i sono dir ettamente proporzionali al g rado dell'ametr opia; e cioè, più quest' u l timo è l' levato . più i movimenti sono accentuati. Ho in animo di proseguire nel gabinetto diottrico di que!'<ta Scuola le esperienze già iniziate cirea questo nuovo ed interessante metod o di diagnosi delle anomalie di refr azione; ma intanto ho creduto opportuno di all'attenzione dei colleghi affinchè vogliano speper co nto lo r o, in specie su Il'abbonda nte materia le che viene fornito dai r epa r ti di osservazione, e no tarn e i e i di· fatti dal punto di vista de lla pratica medico- mil itare. N on è impro · babile c he, provando e ri pro \·audo, s i riesca a migliorare ed a perfe. zionare il metodo stesso in modo da r e nderlo forse anche più esatto e più conforme all e esigenze del nostro servizio; ed a qnesto propo · sito d irò che non sarei alieno, per ese mp io, da l sostitui r e al s e mplice disco di car t.one che rapprese nta l'oggetto di p ro va, l'otLotipo del Lau · do l t, di cui è innegabile la superi oritù. sn tutte l e a ltre scale tipografiche; ma modificato secondo la p r oposta che gia feci in altra occa· siono (l ) ; ossia disegnandolo in bia nco su fondo nero. Iu tal modo, adottando la dist a nz a fissa di 5 met ri , oppure variandola cambiand o contemporaneamente le dimensioni dell'or.totipo stesso, noi potremmo avere, pu r e usando il metodo ciuescopico, un criteri o più preciso ci r ca. rac utezza visi va dei soggetti in r elazione con la loro ametropia. :'Ifa di ciò sarà il caso di discorrere un ' altra volta, quando, cioè, g l i esperimen ti si sia.n fatti più numerosi e si a b bia acquistata la certezza che il m etodo può riuscire realmente utile al nostro esercizio giornaliero di mechci l egali; poichè, in caso contrario, meglio var rebbe nou la:>ciar e la. viu. vecchia per la nuova, e limitarsi a considerare la cine · come un interessante fenomeno di oLtica fisiologica.

I,A DJ::J, DQT'I'. nol.'l'll
(l) TnOII IIKTTA. - L'iu{lueu :cc cl elia lttee n ella dcl•r m i wc;ioue vi$ iom. (l;ior·u. nml. tiri Il O'.<e1·rii<J, t gOO).
Laborator io di mlc roscopla dell'os pedale militar e di Terl no
SULLE DELL' E\10POESI NELLA \!ORTE PER FREDDO
""'Pr he >J I(•rl lllPili:J.h " ''' olo tlor Oome ni <'O D o n o, tenenl,-- ffi('4hro ud Ju 1l puu
L'argomento io imprendo a t ra ttare brevomeute fu già oggcLLo di ri cerc he da parte di alcuni cu ltori della pa tal ogia sperimentale ; pochi accenni se ne hanno nella clinica, dove pure nn eleme nto e?.io logico di tanta impor tan za non sfuggì. alratte nzio ne degli anti chi cu l to ri della med ic ina .

In questi ul t imi tempi, per ope ra specialmente d e i medici legnl i, si rife rì con uniforme insistenza intorno ai cara tte ri mac'ros copici e spett roscopici del negli individui mort i per ass ideramento; si invocar ono l e cause t ossiche a s piegare r a lterato dina mis mo nerv oso (D e lla Rove r e) (1), le ecchimo:>i sottopleuriche e la. sidcr os i di il'usa nei visceri Mirto) (2) come r e pe r t o a n a tomico costan te in questo genere di morte. ma · p oco si a ccennò all e alterazioni istologiche d egli e leme n t i :>auguigni.
Un magg io r e co n t r ibuto venne portato dai fisiolog i {Kùlz, Lu c iaui l I 'J J, che ril e·,·ar ono l'e molisi da freddo ed il co nsu mo rapid o de l g l icogeno del fegato e dei muscoli negli animali costr(>tti a s viluppare molLo calore per manten er e elevata la. propria t emperatura.
Accennare a qu an to si scrisse sopra questo argo men to sareb be opera. lunga. o certamente n on conveniente per i limit i impos ti alla presente trattazione: solo riassumerò breveme nte i lavori che meglio a.ll'erma.ro uo i rapporti fra l'alte rat a. crasi sanguigna per l 'azi ono emolitica del freddo e le modificazioni necessaria men te indo tto, per le llltera te loro a tti vità., negli organi emopoetici.
81
111 UP.LL A - Allem:ioni i<llll•a l ulogic!.e worlt pt>' {retldo (IUct$1!1 di F1·uuall'i11. l ' 19110, \hftTO. - /.1 uchimo1i I Ollopleurirllt n e lltt mm·ft per freddo (Giornale di mtdiCilln lrgnlf. l
11 1\•>LZ. - f·eJIIChrc{l {iir· C. 1890.
3• l.lCIA\1. - Tr(l/1!1/1) di /l!il)/c>{Ji(l, 1901.
.Ì!: noto che il Pap penheim (l ) in alcune ricerche sugli spermofili durant.e il sonno invernale, osservò che il sangue si t r ova ridotto ad una quantità strettamente necessaria per mantenere la vita. La milza aumentata di volume contiene una grande ricchezza di emosiderina. e cellule racchiudenti globuli rossi: il midollo osseo in stato di metaplasia grassa. Al ritorno della primavera, al momento del risveglio, uno stimolo invade gli organi della sanguifica.zione : il midollo diventa rosso, fu nz ionante, con abbondanti forme mitotiche di leucociti, di linfociti e di no rm oblast i.
Simili fatti ebbe ad osservare Bizzozero (2) n el midollo osseo della rana., che nell'inverno si presenta allo stato di midollo grasso, laddove ne ll'estate si converte nella varietà di midollo rosso. Questa metaplasia ha un valore caratteristico che si ritiette sulla costituzione del sangue; il rapporto fra i leucociti e i globuli rossi, che nell' invernO è. di 3,8 p. 100, sale a 8 , 97 nell'estate.
Reineboth (3) do p o raffreddamenti prolunga t i vide n egli an imali una forte riduzione dell'emoglobina per un'imponente emolisi. Questa avviene per un processo intra.vascola.re analogo ai fenomeni della coagulazione, il quale conduce ad una intossicazione e ad un decadime n to nei processi della ossida.zione. Per razione globulicida. del freddo il sangue s i carica di emoglobi na , ollde la. presenza de lle s trie di assorbimento dell'os siemoglobina n el l" esame spett roscopico del siero centrifuga to.
Ze n oni (4) n e l sangue estratt o dal dito che era stato lungamente immer so nel ghiaccio, osservò speciali forme degenerat ive policromatofil e e discromatofile dei globuli rossi, le quali equival gono alle form e d i dege nerazione endoglobulare .
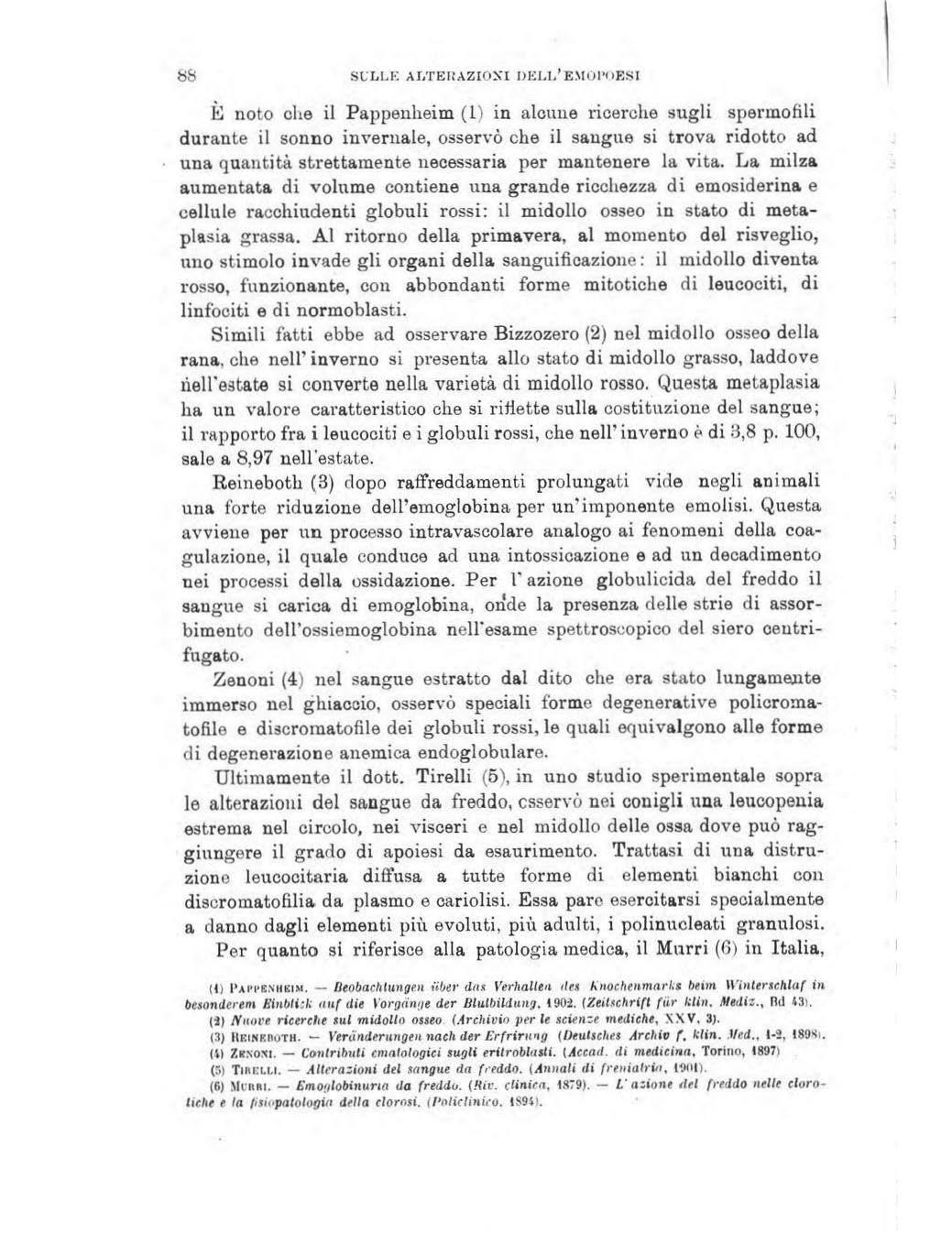
Ultimamente il dott. Tirelli (5 \ in uno s t udio sperimentale sopra le alterazioni del san gue da. freddo, csserYÒ n ei conigl i u na leucopeuia estrema nel circolo, nei v iscer i e nel midollo delle ossa dove può raggiungere il grado di apoiesi da. esau r imento. Trattasi di una distruzion e leucocitaria diffusa a. tutte forme di elementi bianchi con dis cromatofìlia da plasmo e cariolisi. Essa paro esercitarsi specialmente a danno dagli elementi più evoluti, più adulti, i polinucleati granul o!>i.
P er qu anto si riferisce alla patologia medica, il M1uri (6) in Ita lia,
(I l I'A ••vENIIEIM. - IJeobachhmgm i i be•· <LM Verllalle•• llu beim ll'iotttr&chlll( i11 b esondu em Binbli ; k 1111( die l'oJ·glill!lt der 8lulbil!Ju1t9. 1 902. (Zti!8chr i(l (ii r klin. Medi-:., Od 431
(!) IVII OI' t rictrcltt sul midollo oueo (Archi v io p er le &cim:e rnedicht, XX V, 3).
(
3) IIEIIIEOù Tll. - Vtr<Ì ildtrllll0t ll nac/1 dtr Er(rirnog (/)eulscllts Are/l ili (. klin • .1/e d.,
(Il 7.11'0:'<1 - COJllrlb!lti cmalol ooici su!)li eritJ·obla$11 (Acca d il• Torin o , 1897)
TIIIULf. - Allcra:ioni dtl &li ngue da ( •'tddo (Amwli di (rw ialri11 ,
(G) - Emoat obinur111 d a (reddv. ( !lic r linir a. 18 i9). - L ' a:a on t 1/t/ ( l' t ddo ntllt d oro -
ll cht f la /tSw pa/ol ogin d t lla clor osi lf'nl i clm icv. t S9$ 1
St:LLJo: AJ,TEIV.ZI0::\1
Kobert e Schwostek (l, 2) in Germania descrissero una part icolare. entità morbosa sotto il nome di emoglobinuria parossistica da freddo . Essa predilige gli individui pallidi, e retisti ci, nevropatici, ed è cara tterizzata dalla p resenza d i emoglobina nelle orine quando una perfrig era.zione anche leggiera, quale qu ella che si può avere mettendo nu piede nudo per terra, induce un disturbo nella circolazion e. Ehrl ich (3) spiega l'emog lobinuria co me conseguenza dell' emoglobinemìa dovuta ad un'intossicazione probabilmente di origine renal e Il reperto de l sangue è la miorocitemia.
Nella convinzione che lo studio dell'an omia da freddo nelle sue forme più evolute potesse for nire elementi di qualche intere;;se clinico e d anatomo- patologico, ho intrapreso una seri e di ricerch e allo scopo di determina r e le alterazioni del sangue e degli organi emopoetici nelle lo-ro alte rate condizioni di funzio nalità per l'azione di ba.sse temperature.
Nell'inizio delle mie ricerche mi sono valso di giovani cani a corto pelo, es ponendoli, nelle f reddissime notti del gennaio 1901, sulla vet ta del monte Fraiteve (a. s. m. m etri 2800) m a senza risultato.
La sen sazi9ne del freddo su questi animali di grande resistenza agisce come stimolante che provoca, per azione riflessa, una maggiore attività nei processi della di ges tione e fo r se in quelli me tabolici della nutrizione. Dopo 24-48 ore non si ottiene una mo d ifica_zione se nsibile nel peso e nella temperatura di questi animali.
I conigli rasati del pelo e messi i n ambienti ra ù'r eddati, per condizion i non facili a valutarsi, presentano una resisten za che varia da poche ore ad otto o dieci giorni. Alcuni muoiono rapidamente coi sintomi di adinamia, di anestesia e paralisi del t r eno pos teriore: il loro re· perto necroscopico è allo ra un ingorgo dt'i polmoni che si riempion o eno rme mente d i sangue (pa ralisi del polmone) con emorr agie diffus e specie sottopleuriche.
Altri acquistano per così. dire un'immunità per il freddo, subent rando in essi all' apatia. iniziale, un ad attamento a temperatu re progressivamente diminuite a parecchi gradi sotto zero.
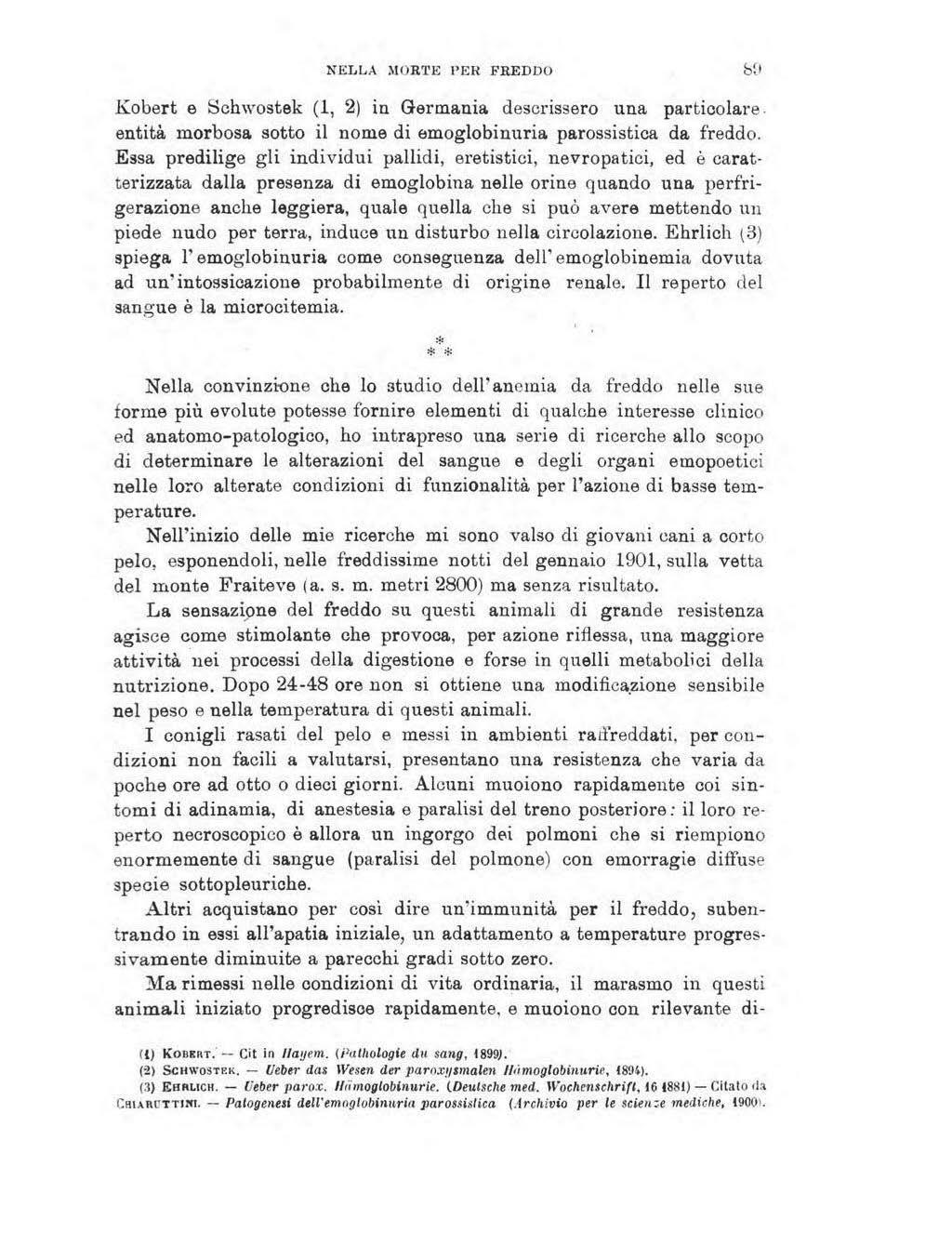
.Ma rimessi nelle condizioni di v ita ordinaria, il marasmo in questi animali iniziato progredisce rapid amente, e muoiono con rilevante di-
H) K onBRT. - Cit in 1/ayern. (i'uiiiOLogle dlt sa11g, 1899)
{2) ScHwosTeK. - Uebn· da; IVesen der J>aro:x:yrma l eu 1/tìm oglobitwrie, 1894).
(3) EHRLI CH - Ueber Jla r o -c. 1/rlmog loblllurie. Weulsche m ed. Woch emchrifl, 16 1881)- Ci lato da
CRIAII liTTiln - Palogene&l deiL"tmrJglobi nurit• paros.lislica (Archiv i o per le sciett;e mediche, 190()\
NELLA liOR'l'E PER FREDDO
miunzione del loro peso che ha un ris contro in una notevole riduzione d e l volum"' e in una più iu t ensli colorazione dei visceri. Il reperto ist.o· logico è in (]Uesti casi identico a qne llo che si ottiene nello studio del marasmo :;perimentale per proteine batteriche già descritto dal prof. Ce· .;ar is- Demel (1), ,·alea dire, una g rande distruzione di globuli r ossi e la deposizione di pigmento ematogeno in molti tessuti e specialmente uei reni e n ella milza.

Risultati più uniform i, quando si ha cura di mantenere il mezzo frigo ri fero ad una te mperatura presso a poco costante di 12 gradi sotto zero ci dànuo le cavie adulte da 600 a 700 grammi òi peso. Occorrono però speciali attenzion i; le variazioni rapide di freddo, qua li si possono ottenere aggiungendo sali od acidi alle miscele comunemente impiegato, fanno insorgere in questi animali un t r emito che prelude di poco alla morte per collasso. Perciò gli appare cchi finora adoperati sperim enta.tori consistenti in casse metalliche ci rcondate dai eomnni mezzi frigoriferi, per il rapido e,;aurirsi della reazi one chimica, danno temperature per lungo tempo non uniformemente basse. Ad ov,·iare a questo iuconveuiente ho costruito una cassa a doppia parete di zinco, circondata da ghiaccio fon dente, e fra lo spazio metallico interparietale ho fatto circolare un liquido a basso punto di solidificazione (serve per questo egregiamen te il petrolio) ratTreddato previamente a 25 gradi sotto zero da un lungo setpentino imme r so in un miscugli o di ghiaccio trito e clorur o di calcio cris talliz zato.
Si può cosi per lungo te mpo ottenere n ella camora. centrale una temperatnra costante ed uniforme di 12 g ra di sotto zero. U na diminuzione più -.ensibile di questa è sempre fac ile ad ottenersi con agsuccessive di una miscela di sali (cloruro di calcio e nitrato di potassa) al prim1tivo miscuglio frigorifero.
È necessar io avere in pronto diverse basse tempe ra t ure per saggiare la ,·aria resi::;tenza degli animali e studi arne la successione delle alterazioni nello diverse condizioni di ambiente raffreddato.
Le cavie racchiuse nell'apparecchio pote vano r esistere un o spazio di tempo var io da 24 a 28 ore, trascorso il quale morivano con una rile vante riduzione del loro peso, con ische mia delle ente e dei muscoli e eongestione marcata dei visce ri.
Cuore tu rgido di sangue non coagulato; polmoni cougesti con mac· t:hie ecJhimotiche sottopleuriche; milza rigida a superficie di taglio bruna; fE-gato co ngesto e reni apparentemente normali.
!Il)
{l ) .. - t:orll.-ilmlo ••Ilo sL11diu tlt l 7RI1rfii!IIO di >lltdllillll, T ll· nn o, IS!IG.
:\:lido llo osseo rosso splen oide in qualc he pun to emo rragi co ; n essu na tro m bosi n e i v asi t anto periferici che profondi.
La diminuzione in peso d egl i animali che in parecc hi cas i p otè r a g · giu ngere fino il 25 p. 100 sta. a dimostrare un 'usur a r apida, esagera t a dei t essuti e I)UÌ ndi la for mazione di toss ici che agiscono sul sangue-.
-\Ilo s co po di seguire le s u ccessi \e modifìcazioni del san gue e dei visceri le rice r che e matologiche venne ro praticate co ll"emomet ro del Fleis ch e col conta.globu li di Thoma.-Zeiss nei momenti vari di es peri me nto, s ia all'inizio di qu esti per ter mine di paragone, s ia dopo traparecchie o r e d i azio n e del freddo e gli animali sacrifi cati co ll a puntu ra de l bulbo. L 'esame microscopico v e nne fatto a fresco sopra p· pone ndo semplicemente il v etrin o alla gocc ia di sangue, o diluendo con \'io lett o di metile i n cloruro d i sodio, oppu r e co n acid o osm i co all' l p. 100. L e fi ssazioni col metodo di Nikifo roff, con quello dell'Ehrlich venne r o colorate coll'eosina e violetto di metile od eosina ed emntOssi lina.
U n p r imo fa t to che s 'i mpone è la riduzione rapida d e ll'emoglo bi na che da. 85 all'emometro del Fleisch discende prog ressiv am e nte a 60, 50 , fino a ragg i unge re i -10 gradi nella cavia morente. Di pari pass0 co l Tho ma- Z eiss si ossenra, co me fatto costante, uua progressiva diminuz ione ni globuli r ossi c he da 4 ,500,000 s i r iducono a 3 ,900,000 fino a raggi un· ge r e i 2 ,500,000 ( l l.
Anc h e da parte dei globuli bianchi bo ril evato alcuni fatti in rapport o alle mutate cond izioni d e l san gue. Ad un primo periodo d i emolisi fort e c he colpisce i corp u scoli r ossi e l'emoglobina s 'accom pagna dopo cinque o se i or e di p e rfrige razi one uno stato di iperl e u cocitos i che iò i mantie ne alta e cos tante fìno a 12 ore di espe rimen to : in seguito p er gradi s i esaurisce fino ad avers i una leucopenia nell'animale mort o .

Q u esti fatti hanno un riscontro in certe condizioni patologiche e quali si possono ottene re con inie zio ni end ove n ose di pro· teine batteriche negli animali (2 ) o per l'azione prolung ata d i bagni caldi.. La le ucit osi in questi casi sarebbe allita nel sig nifi ca to che Ehrlich attribuisce alla parola, (multinucleib· ne ulrophile H ypel'let d iOC.iJlo.çe)
• Il Rl;ult.Jii oJtlcn no Il ma!lgio re merl ico don.
n el <nn s tudi o cii••·
••trJ.:h• peY v al'in; l o111 termlcfl e - Giorna le med tco del r eg io Esercito , t 89ti i l f'11\ CI!•ARI• lltillfll Sull'll= i on t dd Vel•n i ball•rici $UI midollo d ttle 01111 - Il. di ru..,J..·.u ' · T•> r no l
:'\J,;I.f, \ l! O ltT.E l' E l( Hl
esercitandosi essa con prevalenza sugli elementi polinucleati neutrofili con esclusione quasi dei mononucleati.
Ora, contrariamen te, a quanto ritiene Hayem, la immissione in circolo di molti globuli bianchi non è conseguenza di produzione patologica del tessuto midollare linfogeno, intesa a r iparare il sangue distrutto, ma. attesta tmo scompiglio nella circolazione del midollo (Zenoni) (l ) per cui le cellule bianche vengono distolte dai loro focolai di produzione. I residui dell"emolisi e di altri elementi distrutti a.ccu· mula.ti nelle lacu n e venose della milza vengono a poco a poco immessi nel ci r colo ed allora esercitano una chemiotassi positiva come quando si inietta direttamente nel sangue un 13stratto di organi parenchimatosi.
Il reperto microscopico del sangue prelevato dalle cavità. del cuore e dalle giugulari dimostra la poca tendenza degli eritrociti a disporsi in pile: la diminuita loro colorazi one, onde l'aspetto di clorociti; non forme di necrobiosi o disfacimento di globuli.
I n alcuni preparati si può vedere qualche normoblasta a contorni circolari e nucleo uniformemente ed intensamente colorato. N el periodo di le.ucitosi una abbondanza di polinucleati neutrofili (colorazione colla triacida· di Ehrlich) e qualche cellula eos inofìla . .Ambedue queste specie di elementi col progredire dell'azione perfrigerante scompaiono nei preparati allastiti dopo 15, 20 ore e le rimanenti cellule bianche sono rappresentate da leucociti monouucleati e linfociti della varietà piccola.
Vedremo in seguito nel rep erto istologico dei visceri il dei globuli polinucleati: per ora basti accennare che, progressivamente alla. diminuzione dell'emoglobina del sangue, la milza si carica di emosiderina sia allo stato libero di blocchi nelle lacune della. polpa, sia. inglobata nelle cellule pigmentifere o in quelle connettive di sostegno.

La siderosi avviene in ogni caso per gradi come dimostrano i metodi di Stieda e di M&.caleum per mezzo dei quali si possono ottenere a. piccolo ingrandimento, delle serie di colorazioni nei preparati, che vanno dall 'azurro tenue o di lieve pigmentazione nera, fino al bleu car ico ed al bruno intenso.
( I l Otllt allern;ioni degtnemtive trih·ol!lastl ntll"auemia per11iciosn.- Policliuico.
!l:! Slif,f,f;
ALTERAZI<J:'\1 llEf,L1
•ul. V, m.• 1898
JfidfJ llo osseo - Lo studio del midollo osseo ha messo in rilievo dei fa tt i che si devono riferire all'alterata sna attività emopoetica. Sono scomparso le lacune di grass o (del r esto scarse nella cavi a) per una sostituzione densa di leucoci t i polinucleati ed in alcuni pun ti da zone emo r ra g iche sparse irregolarmente nel- campo microscopico I leucociti polimorfi stann o raccolti in gruppi di elementi a scarso pratoplasma con nuclei ratratti o frammentati, a cromatina fortemente tingibi le. I n alcuni p u nti, f1·ammenti liberi di protoplasma e colorantisi co me la sostanza nucltlare rapprese n tano se n za dubbio dei nuclei di cellule le quali banno compita un'ultima lo ro involuzi one dissolvendosi nelle parti loro costituenti.
Anche le cellufe eosinofile sono più numerose che allo stato nonuale. e a granuli a var ia tinzione coll'eosina Ma quello obe più s'impone nel reper to è una proliferazione di normobla.:;;ti, di grandi cellu le nucleari in cariocine si e di forme di passaggio. L e partico larità delle loro strutture risa ltano m eglio nei preparati ottenuti per e f)U indi fissati a 120• gradi sulla lamina di rame o per dilacerazione in acido osmico in so luzione fisiologica di c lo ruro di s0dio (soL aci do os mico alri p. 100 p. l ; so L fisiologica di cloruro di sodio p. 5, Foà)
In allora si possono osservare facilmente le differenti forme di globuli ross i nucleati, da quelli a scar so protoplasma e nucleo relativamente pallido fino al n ormoblasta a proto plasma omogeno alr1uanto splendente e nu c leo centrale unifor 01emente ed intensamen te colorato
La loro presenza in g rand e quantità nel midollo segna una eritropaes i, intesa a riparare per una rigen erazione di globul i rossi , l e gravi condizioni d el sangue stesso. I me gacariociti presen tano delle alter az ioni degne di nota; in alcuni è e\·idente un fagocitismo nel protoplasma di elementi incolori; sono nuclei o f rammenti n ucleari in una spedie di vacuo lo o in una z o na incolo i:'a che rappres enta forse un resto di protoplas ma non più colorabile colle ordinarie sostanze. I nu clei cetJ,trali qualc he volta sono ragrinzati mori fo r mi con ineguale distribuzione d ella cromatina: in alt r i e semplari il n ucle o è solo rappresentato da frammenti. Cosi cos tituiti i megacariociti che sono elementi squisitamente fagocitari a t t es tano l a loro iuvol uzione per esaurita fu nzione.
Anco ra nel midollo si trovano rari accumuli di pigmento for mati da più granr1li accollati insieme con riflessi di ram e n e lle sezioni colorate coll'eosina. Q u alche volta liberi, questi granuli ù i pigmento so n o
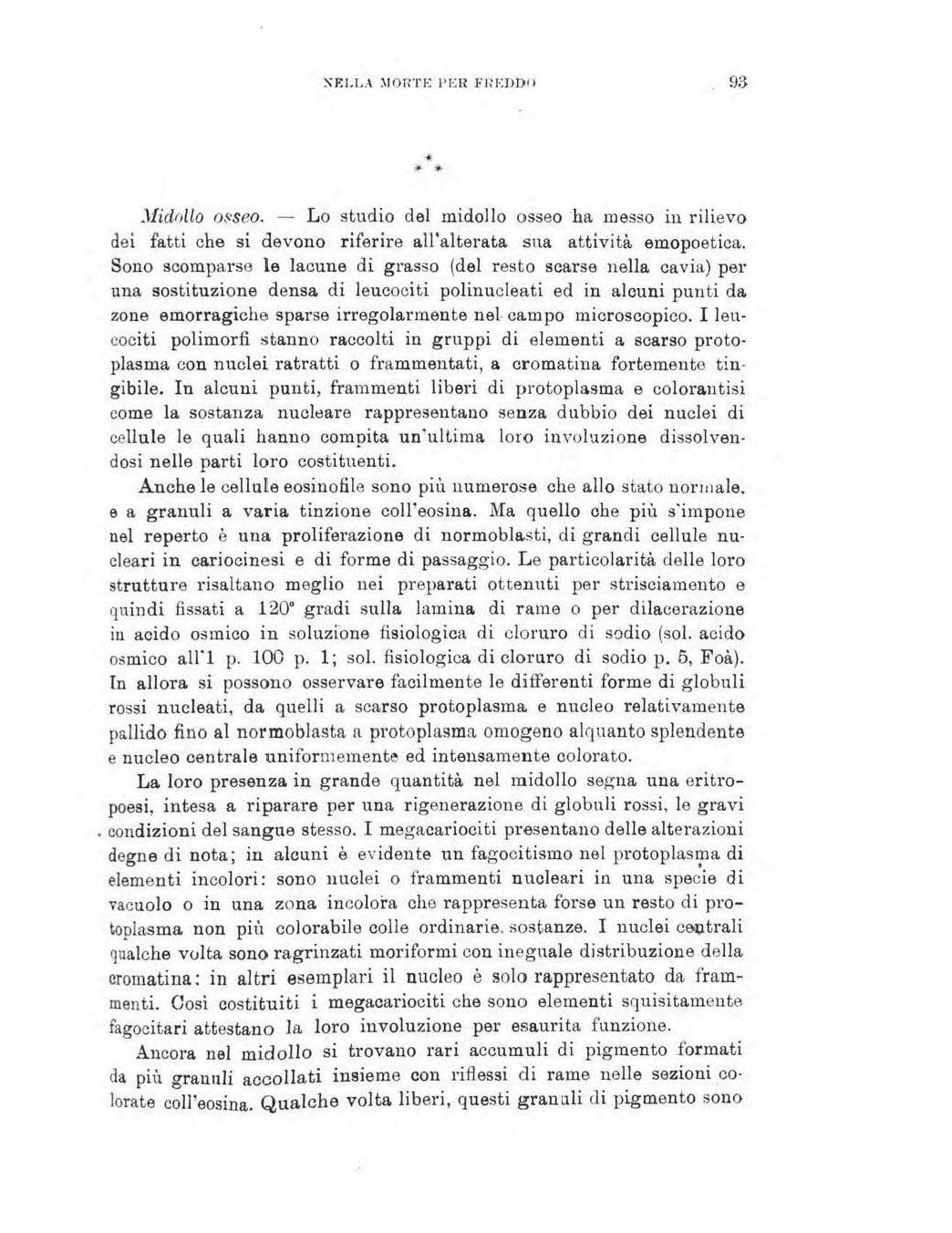
:->F.I.I.A I'ER F!IEDDII 93
più spe;;so ra0colti nelle 'cellule bianche e col soltidrato d'ammoniaca danuo la r eazione dell"emosiderina.
.lfil :;a - Le -;ezioni a piccolo ingrandimento si p resentano congeste con i vasi dell'ilo beanti a pieni di saugue. Con le ordinarie colorazioni, una dill'usione di ematico invade le lacune della polpa lasciando liberi i follicoli linfatic i e le trabecole connetti\·e. Nei vasi dell' ilo, nelle guaine tubulari della capsula , le stes.;e zolle di pigmento le 11uali pe rò nella sezioni trasversali del l"organo manife,:tano un sito loro di elezione nella zona periferiea sotlocapsulare. Esse danno col ferro cianuro di potassa e eoll'acido cloridrico (Stieda) la re az ione del ferro.
Vi ha dunque nella milza, e special mente n ella. zona sottocapsnlare di essa il principale rifugio del pigmento che deriva dal san gue distrutto.
A più fort e ingrandimento queste zolle appariscono or a libere f ra gli e le menti de lla p ol pa. ora ing lo bata nelle cellde pigmentife re o iu CJ no li e connetti vali d i sostegno. Con e,.;se ,;i vedono str om i incolori ed ombre di globuli r ossi (&hallen) rid otti ad anr-lli vnoti; normoblnsti, l eucociti polinucleati e parecchie ce llule eosiuo fìli non però così a bb onda n ti come ne l midollo. S onvi inoltre microciti C>d eritrociti in stato di frammentazione. F r a gl i elementi della. p olpa e soventi a.uche nel lume dei vasi si vedono delle g r andi cell ule moncmucleatc con p r otopla..;ma. inglobante un am masso granulare, le quali molto probabilmen te si possono identificare cogli elementi de:scrit.ti da Foà e Ca r bo ne ( 1 ) e (jttindi da Cesar is-Demel 12) nel marasmo prodotto da proLeino bat· !.eriche ed attestanti una fagocitosi in atto.
I follicoli l infatici non presentano alterazioni d i so r ta.
)la quello che maggiormente risalta n e l rep erto de lla milza l: il numero stragra.nde di megacariociti di fo r ma div e rsa perchè in p e ri od i vari di involuzione. i quaìi embolizzano gli spazi della polpa. splenica
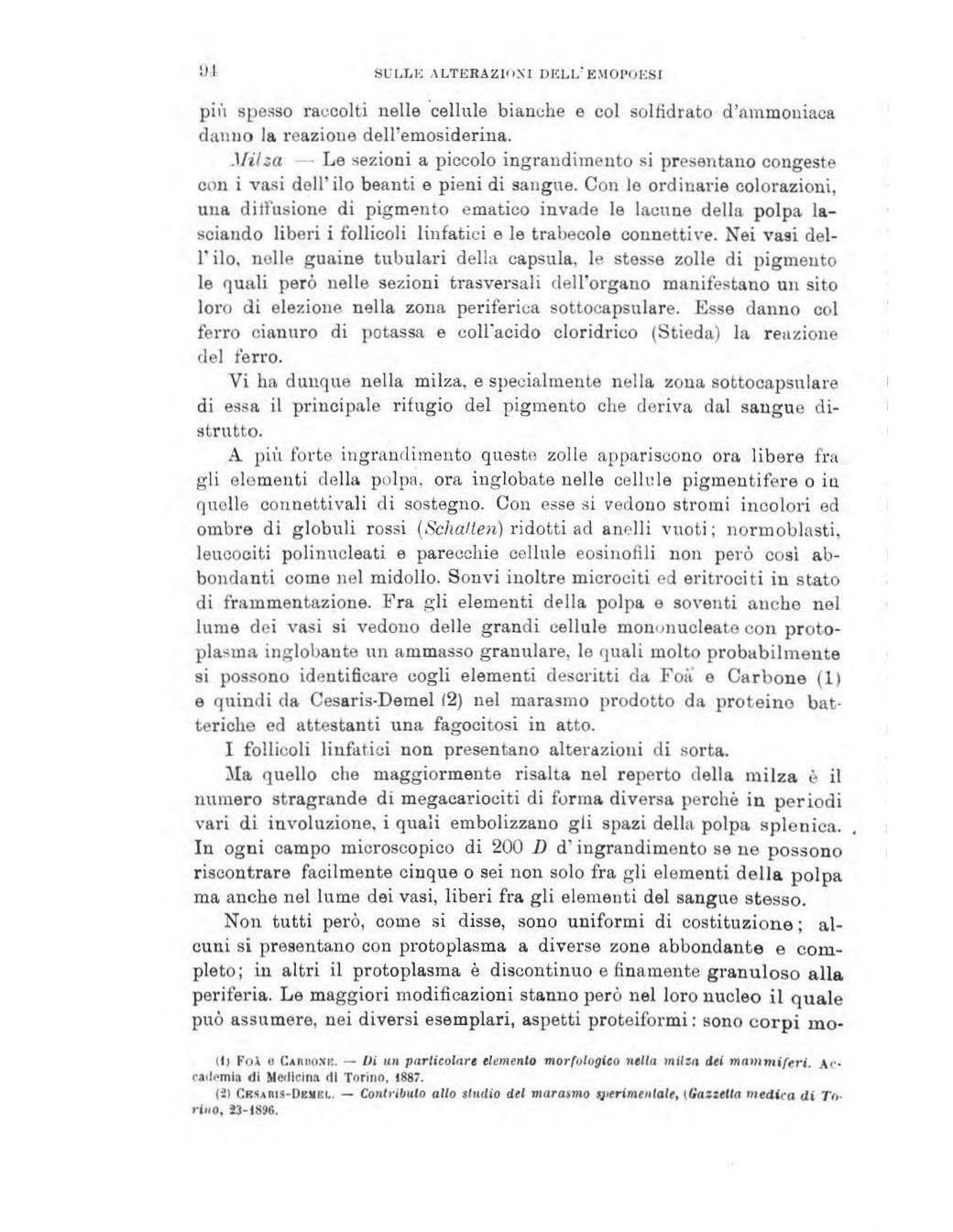
I n og ni campo microscopico di 200 D d ' ingrandimento se ne possono r iscontrar e facilmente cinque o sei non sol o f ra gli el ementi della polpa ma anche ne l lume d ei v asi, liberi fra gli elementi del sangue s t esso.
Non tutti però, com e s i disse, so no uniformi di costituzione; alcuni si presentano con protoplasma a diverse zone abbondante e c ompleto; in altri il protoplasma è discontinuo e fi n amente granuloso alla p eriferia. Le m agg iori mo difi cazioni stann o però nel l or o nucleo il quale può asstlmere, nei diversi esemplari, aspetti proteiformi: so n o cor pi mo-
llJ Fol o - Vi Wl particolare elemento mor(ologlco m1l:n dei mamm i(tri. A •··
c·a •l•'mia d i Mecllcl na 111 To r ino, t 887 - Conh·cbulo allo sluclio del marasma l)le r lmelllalt, 1Ga:zelln mtdira dì T n· t' I liO, ! J- 1896.
!)l St.:LLE ,\LTERAZIII:-;1 01':1.1; E)IOI'IJESI
riformi foltamente tingibili; coroncine spezzate a semicerchio, o nu cl e i discontinui con distribuzione anormale dell a cromatina anche nelle migliori fissazioni in liquido di Flemming o n ella soluzione di snblimato in liquido di Miiller (Foà). In altri nuclei ancora la lesione è maggiormen t e manifesta perohè banno p e rduto qu a si ogni po te re cl i colorazione coll e sostanze nucleari, onde l' aspetto loro di nucl ei a c on to rni pieghettati, deformati a forma. di clava.
Da questo r eperto vediamo dunque che, oltre al deposito di emosiderina nella milza, come avviene per una quantità di v e leni ematici (pìrodina, fenilidrazina, cadaverina) p er l'azione lunga del fre ddo si può avere ancora. un tras porto di elementi midollari i quali distolt i per alterato circolo dai loro focolai di origine o p er cause t ossiche da al te rato ricambio rapidamente involuti, vengono trasp orta t i embolicamente e deposti nelle lacune della polpa splenica. In condizioni n orm a li , nelle milze di animali adu l ti non si trovan o quasi mal normoblasti e megacariociti (Foà) : la. loro prese nza perc iò in qu esto caso coincide con quella di molte forme simili nel midollo e qu i ndi è ammessibile un legame fra gli uni e gli altri: u è in ana to mia patol o g ica mancano delle analog ie: .K(illiker vide d elle emazie nn cleate n ell a milza di un individuo morto di tu b ercolosi ossea. a lento decorso; Ebst ein (l) nella carcinosi metas ta t ica d e l mi d ollo delle ossa ; Va gner e Pollai (2) in milze di mixedematos i.
Vedremo r identico f atto ripetersi con qual che varie tà nel polmon i.
Dominici (31 parla di una germinazione nella milza di el emen ti d e lla serie mielog ena. Ques ta. revi\·isce nza si produrrebbe in virtù d i un processo proprio d e l tessuto mieloid e che esiste allo s t a to latente in determinate r egioni e specialmente nella mi lza tl nei g angli i linfa tici.
Per l'influenza di condizioni varie di anemia, di processi settici, la funzione emopoetica. sospesa ma non dis trutta riprendereb b e i suoi caratteri in forza di un processo istogenetico locale. È un rit orno ad una modalità di fatto della vita f etale. La finalità di ques ta trasformazione mieloide sarebbe quindi una rigenerazione di elementi figurati del sangue andati distrutti.
I n molte condizioni patologiche ed in molti sperimenti si son po· tnti mettere in r ilievo dei fatti che contraddicono alle supposizioni
l'l; Cit. in ZENO:-il. -Sulle allem::ioni aegli erilroblanti. (Pol i clillico, 1898).
(3) O o lltNICt. - Sur l' hiJiolopie de la rate a l'eta! n orma/ el pat/lotogiqt<e. (Arch ives Alcdici n e

>.'ELJ,,\ l'ER l>'IIEU.VO ! lj
{l ) Eo<TEI:-i.- /Jlulbt{uude Ilei metastal i$cher Cat·clnose dt l 1\uo chenllliii'Ckcs ( ZtiiSchr. {. l>lin. )/( d • 30, 1896).
t , t90t).
del so pradetto autore; ed una penetrazione nel circolo di cellule giganti del midollo osseo venne già trovata da Lubarsoh (l) in casi di operazioni sul femore e di ca.rie tubercolare delle a r ticolazioni; da Maximow (2) nei gravi traumatismi degli arti.
Poà. (3) ha provocato l'embolismo di questi elementi nei capillari del polmone mediante l'inanizione, con le iniezioni di filtrati di diplococcus lanceolatus, nelle scottatu re estese, con le iniezioni di l ecitina in seguito a salassi ripetuti.
Trovò inoltre delle gravi alterazioni di circolo con lesioni diverse dei megacariociti ed il concomitante fenomeno d ell'embolismo di nuclei giganti in seguito ad iniezioni endovenose o sottodurali di staphilococcus aureus o con iniezioni endovenose di latte non ster ilizzato r·icco di bacterium coli.
Nei polmoni delle nostre cavie assiderate l'embolia di megacariociti non fu possibile dimostrare costantemente ed in ogni caso; in sua vece si trovò nei capillari polmonari nui:nerosi ammassi embolici di leucociti polìmorfi
A questa migrazione, a questo movimento di el ementi spremuti d al midollo nel circolo venne da Lubarsch stesso dato il nome di miel ocinesi; la ,quale si stabilisce ogni qual volta una causa altera profondamente la circolazione sanguigna, già per se stessa molto variabil e, nel midollo.
Il trasporto embolico di questi elementi midollari nella milza e nel polmone ha per finalità. la distruzione successiva di essi.
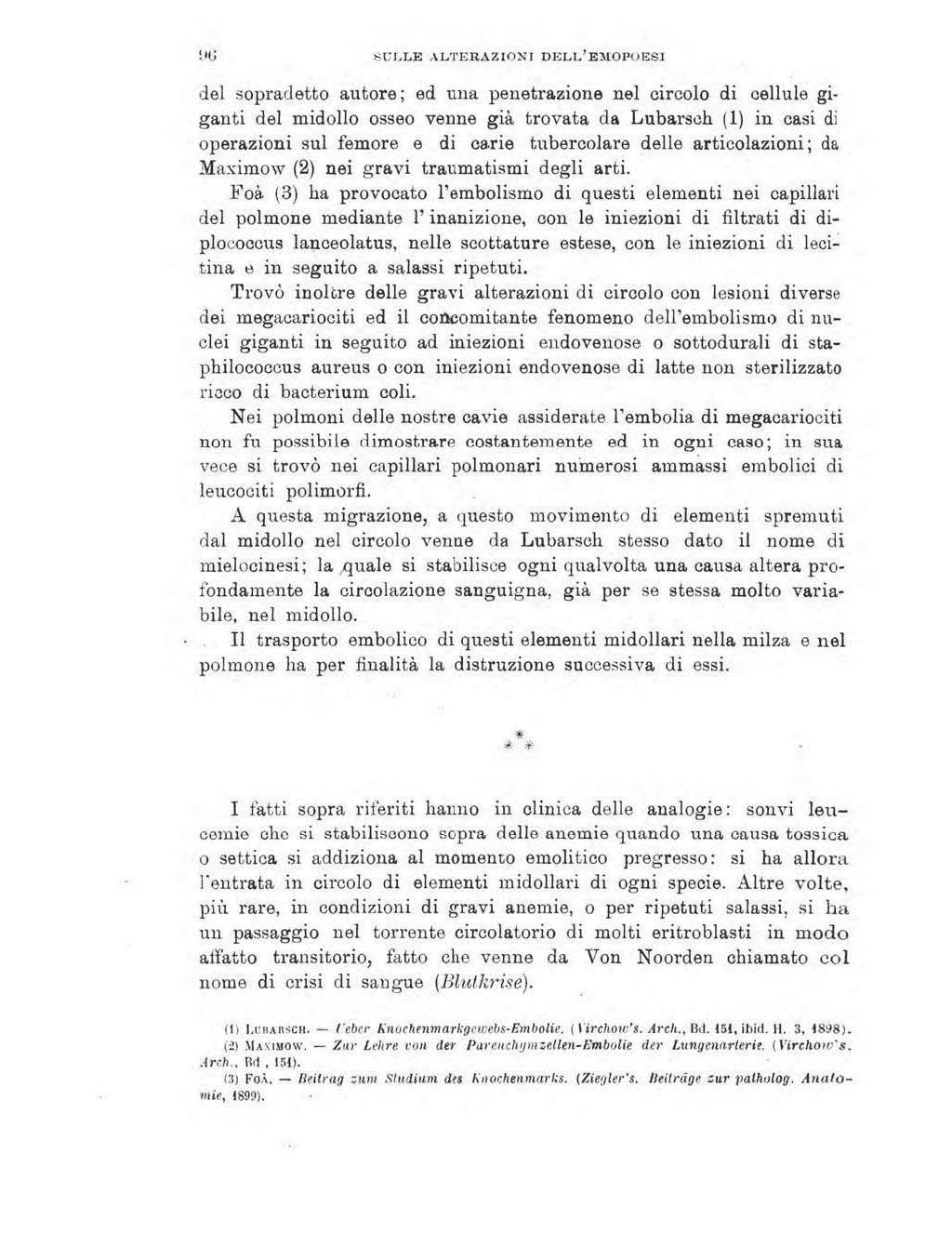
I fa t ti sopra riferiti hanno in clini ca d elle analogie: sonv.i leucmnie che si stabilis cono sopra. delle anemie quando una. causa. tossica o settica si addiziona al momento emolit ico preg r esso: si ha allora r e ntrata in circolo di el ementi midollari di ogni specie. Altre volte, più rare, in condizioni di gravi anemie, o per ripetuti salassi , si ha un passaggio nel torrente circolatorio di molti eritrobla.sti in modo affatto transitorio, fa tto che ve nne da Von Noorden chiamato c ol n om e di crisi di sangue (])lutkrise ).
( t ) J. u"An , cu. - l"ebn · 1\tl orhnunarkgru;el•.I ·Embo/ie ( l'ircl!o w's. A•·cll., Od 151, ibid. 11. 3, 1898 )
(2) - Z 1n· der P<J.l"ttlc li !Jiti Ztlleu-llmbolie d e•· ltmy en twlerit ( l'irclw w ·s
• llr! , 151)
131 Fo,\, - llt itrag Sl udi11m ats 1\t!O r.henm a rl:s. (7.ie(l l er's. /Jeilriig e :::ur 11alholog. Au a lomie, 1899)
Dal complesso dei fatti ematologici ed istologici risulta che l'alterazione del sangue da freddo ha un riflesso nelle condizioni patologiche dell'apparato emopoetico: quivi infatti si ha un eccesso di distruzione ed uno scompiglio nella preparazione del sangue: la distruzione globulare è dimostrata dall'imponente siderosi nella milza: l'alterata sangui.fica.zione dall'anormale eritropoesi midollo; l ' alterato circolo infine dalla. presenza nella milza e nei polmoni di elementi midolla.ri estr a nei al sangue stesso e distolti d al loro focol a io di produzione.
Come condi zione emolitica principale, comune de l r esto a tutte le anemie, deve invocarsi l'alterata composizione del plasma sanguign o pe r sostanze tossiche ingenerate dall'azione def freddo per l'alterato ricambio, ed esse stesse eccitanti le proprietà emolitiche normal i del midollo osseo e della milza (1)

Ai signori colonnelli medici dott. Randone e dott. Gozzano i miei ringraz iamenti per g li obliganti aiuti a me prestati in queste ricerche.
Torino, aprile 1902.
:\ELLA )!ORTE PER l''R EDDO D7
( l ) 80TTA7.7.1 - La milza come organo emoeatatonistico. (Sperimen tale, 1894)
i - Giorllal e medico.
LE PERFO RAZIONI Tlli PANICHE PATOLOGICHE IN RAPPORTO AL SERVIZIO MILITARE
Nell'inverno del1890, in seguito ad un'estesa epid emia di influenza, ebbi occasione di osservare e di curare numerosi casi di otiti medie nell'ospedale milit.are di Caserta. Posteriormen te, nelle molte s edute dei Consigli di leva a oui ho assistito e nelle visite degli inscritti all ' arriv o a i distretti ed ai reggimenti ho sempre rivolto special e attenzior.e a lle cosidette otorree, seguendo, per quanto mi era dato, l'esito di esse, sia dopo i periodi di osse r vazione, sia dopo i sol iti rimandi per rivedibilità, sia infine dopo le licenze di convalescenza di breve e di lunga durata. Le prime conclusioni, che mi apparvero evidenti, furono quelle che riguardano il pesante e inutile far dello dei rivedibili, che si trascinano con un a costanza direi quasi meccanica, ingombrante e ciecamente fatale a ttraverso l e successive leve fino a raggiungere il per iodo critico dei due rimandi, e la troppa ed importanza che :;i annette all'esistenza della secrezione, senza stud1are la natura, la patogenesi , e sopratutto la sede delle dive rse affezioni dell'orecchio, ohe ne possono essere la causa.
Io ritengo tale argomento degno di uno studio serio ed accurato, anche per l'importante e progressi-vo numero di malattie dell'orecchio, che annualmente vengono osservate, curate e giudicate dai medici militari.
Difatti, sfogliando le Re l azioni medico-statistiche annualmente compilate dall'Ispettorato di sanità militare e le Relazi oni annuali della Direzione generale leve e truppa presso il Ministero della guerra, riguardanti due decenni successivi, si leggono le seguenti notizie:
Nel decennio 1880-1889, ammalati en t rati ne i luoghi di cura. per . ()liti, otm·r·ee n. 12,218, morti n. 44.
Nel decennio 1890 -1899. curati n. 15,694, morti n. 31.
Gli eliminati n el decennio 18!-10- 1899 furono in numer o di 3358, dei quali riformati n. 13;;5, rivedibili n. 1638, inviati in lunga licenza di convalescenza n. 365.
 Stnoloo olel dott. '1'. Spin a. capotano mro llco
Stnoloo olel dott. '1'. Spin a. capotano mro llco
Nei Consigli di leva in 10 classi, 1870-1879, i soli riformati per affezioni auricolari raggiunsero il rispettabile numero di 4789, numero che è sempre inferiore a quello dei rivedibili per gli stessi motivi.
In due soli anni, 1898 e 1899, furono complessivamente inviati in osse rvazione negli ospedali militari per le malattie dell'orecchio n. 1898 inscritti!
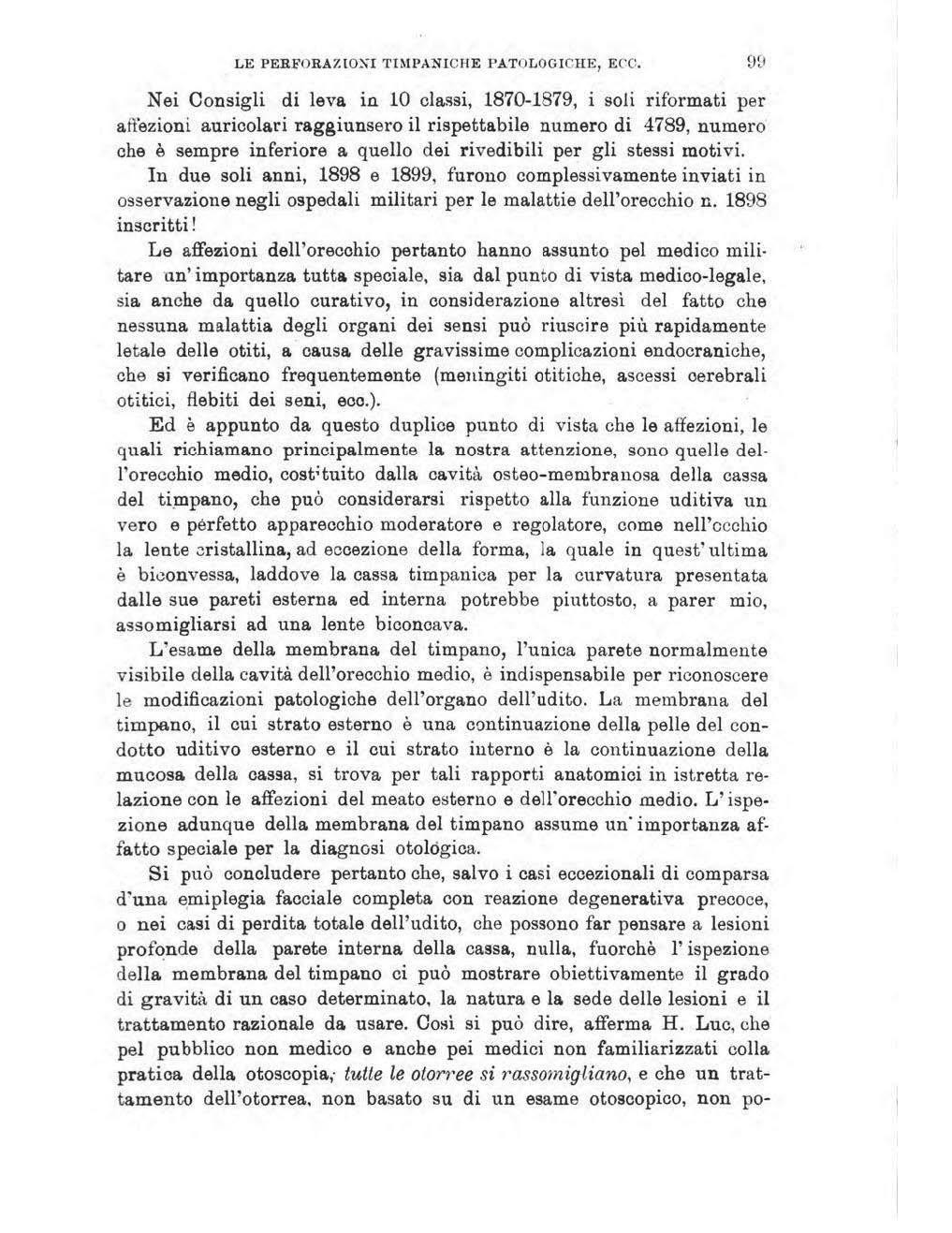
Le affezioni dell 'orecchio pertanto hanno assunto pel medico mili· tare un'importanza tutta speciale, sia. dal punto di vista medico-legale, sia anche da quello curativo, in considerazione altresì del fatto che nessuna malattia degli organi dei sensi può riuscire più rapidamente letale delle otiti, a causa delle gravissime complicazioni endocraniche, che si verificano frequentemente {meningiti otitiche, ascessi cerebrali otitici, flebiti dei seni, ecc.).
Ed è appunto da questo duplice punto di vista che le affezioni, le quali richiamano principalmente la. nostra attenzione, sono quelle del· l'orecchio medio, cost;tuito dalla cavità osteo-membranosa della cassa del tip1pano, che può considerarsi rispetto alla funzione uditiva un vero e pérfetto apparecchio moderatore e regolatore, come nell'occhio la lente ;::ristallina, ad eccezione della forma., la quale in quest'ultima è biGonvessa, laddove la cassa timpanica. per la curvatura presentata dalle sue pareti esterna ed interna potrebbe piuttosto, a parer mio, assomigliarsi ad una lente biconcava.
L'esame della membrana del timpano, l'unica parete n ormalmente visibile della cavità dell'orecchio medio, è indispensabile per riconoscere l e modjficazioni patologiche dell'organo dell'udito. La membrana del timpano, il cui strato esterno è una continuazione della pelle del condotto uditivo esterno e il cui strato interno è la continuazione della mucosa della cassa, si trova per tali rapporti anatomici in ist.retta relazione con le a ffezioni del meato esterno e delrorecchio medio. L' ispezione adunque della membrana del timpano assume un· importanza affatto speciale per la diagnosi otol6gica.
Si può concludere pertanto che, salvo i casi eccezionali di comparsa d'una emiplegia facciale completa con reazione degenerativa precoce, o nei casi m perdita totale dell'udito, che possono far pensare a lesioni della. parete interna della cassa, nulla, fuorchè l' ispezione della membrana. del timpano ci può mostrare obiettivamente il grado di gravità. di un caso determinato, la natura e la sede delle lesioni e il trattamento razionale da usare. si può dire, afferma H. Luc, che pel pubblico non medico e anche pei medici non familiarizzati colla pratica della otoscopia; tutte le otor1•ee si rassomigliano, e che un trattamento dell'otorrea, non basato su di un esame otoscopico, non po-
LE PEBFORA7.lOXI TtMPANlCHE PATOLOGICHE, ECG 9U
trebbe essere che un trattamento rntinario, em pirico, nella cui scelta il ragionamento ed il discernimento non hanno alcuna parte.
In base a tutte queste considerazioni e tenendo _inoltre presenti le osservazioni cliniche dei più eminenti otologi contemporane i, che hanno dato risulta ti abbastanza costantemente uguali ed esatti, le perforazioni della membrana d el timpano che accompagnano sempre i prooessi p urulenti cronici dell'orecchio medio, costituisco no a mio avviso uno dei criteri diagnostici e prognostici migliori fra tutti gli altri mezzi d'in· vestigazione, che la moderna scienza otologica possiede per lo studio delle affezioni più import11.nti dell'orecchio.

Le perforazioni della membrana del ti mpano si disti nguono in co ngenite, traumatiche, chirurgiche e patologiche.
Le perforazioni pato logiche della membrana. del timpano sono sempre accompagnate da perdite di sostanza più o meno circoscritta e potrPh· bero meglio chiamarsi, a mio parere, ulcerazioni perforanti, specialmente nel periodo in cui è ancora in atto il processo morboso, che ne è stata la causa: verrebbe così semplificata la classificazione, in perforazi oni propriamente dette, che comprenderebbero le traumatiche, le congenite e le chiru rgiche, e in ulcere perforanti della membrana del timpano. Queste ultime possono essere l'effE>tto di miringiti, ma ordinariamente rappresentano insieme alla otorrea le conseguenze costanti de lle otiti medie purulente acute e c r oniche.
Nelle forme acutissime poche ore dopo il principio dell'infiammazione si comincia ad osservare un piccolo ascesso della grandezza di un grano di miglio nel mezzo della membrana, ordinariamente nella parte po· steriore e nel secondo giorno si riscontra già la perforazione; mentre nalle forme croni che il posto della perdita. di sostanza è per lo più il quad rante antera-inferiore, ed allora avviene un processo u'loe rativo c he si approfonda dallo interno allo esterno La grandezza delle perforazioni varia d a quella d' una punta d'ago fino alla distruzione completa della membrana: ma l'estensione della perdita di sostanza non dipende nè dalla durata, nè dalla intensità. del processo purulcnto. La form a. è spesso rotonda o ovale, ellittica, più raramente semiluna.re o angolosa; le perdite di sostanza situate sotto il manico del martello prendono una forma pronunziata di cuore o di ren e (quest'ultima sopratutto si osserva. frequentemente). Pertanto la forma e la grandezza si modificano molto col gonfiore variabile dei bordi e coll'essudato e colle gran ulazioni che li ricoprono. Circa il numero delle perforazioni. generalmente
l'apertura è unica, numerose osserva zioni hanno stabilito, che la membrana. può essere perforata. in parecchi punti. Spesso vi ha perforazione doppia., una davanti, l'altra dietro il manico, separate da un
JOO Lli: I'ERFORAZIO:Sl TDIPANIOHE PATOJ,OG I CHE
ponte che unisce l'estremità inferiore del manico al bordo inferiore della membrana. Rarissimi debb ono ritenersi i casi di perforazioni 111 tre o più punti , e quelle a guisa di crivello con un gran numero d i fo rellini (osser vate da Bonnafont e da Schwar t ze nelle s uppurazioni difteriche, tubercolari e piemiche) .
Il rimanente della membrana che limita la perdita della a caus a dell' essudato depositato sulla sua su pe rfic ie o nell'interno del tessuto, prende una colorazione irregolare, gia.llo-ve r da stra. o g rig io-rossastra, che si stacca fortemente sulla mucosa r osso-scura della cassa ; ta lora prende un'appa renza granulosa uniforme o lisci a, v villosa, o vellutata. Il bordo della perforazione è ricoperto da essudato, ovvero con tornato da una linea rossa e talora coperto da piccole papille. Il bo rdo è libero, dalla parete interna d e lla cassa, ovvero qua e là in c on tatto immediato con essa; spesso la parte posteriore si appoggia al promontorio, mentre il bordo an teriore resta libero e getta un'ombra sulla parete i n terna della cassa situata più profondamente . Nei ca si d i piccole perforazioni i l manico si distingue raramente a c ausa del gonfiore dello strato cutaneo; n e ll e grandi a perture, al contra rio, in oui il tessuto della membrana è distrutto intorn o al manico. questo conserva la s ua forma e la sua posizione iniziale, e penetra liberamente nell'apertur a perfora.tiva., ovvero apparisce ing randito parecchie volte del suo diametro, o tirato in dentro, colla sua estremità inferiore in contatto colla parete interna della cassa, ovvero, infine, esso è racco rciato dalla distruzione per carie de lla s u a estremità inferior e od an che c ompletamente soppresso .
Ma di ben altra importanza diagnostica e prognostica è la sede delle perforazioni patologiche della m embrana. Bisog na a. tal uopo distinguere la membrana del timpano propriamente detta, dalla membrana rl a ccida di Shrapnell , ed inoltre suddi v ide re la prima in du e metà, o quattro quadranti, e la seconda in tre s egmenti , anteriore, mediano e Il punto di r evere 1n tutte q u este divisioni-e suddivisioni è ,;empre la co rta apofisi del martello.

La pm·s flaccida (ch e è fatta dagli stessi elementi della pm·s tensa. m a molto più rudimentali , talohè per la sua minore resistenza ba avuto l'appellativo di flaccida) è limit ata in basso da due grossi fasci di fibre, c he dalle due spine dell'ane llo t impanico vanno al processo breve del m ar t ello, formando così i due legamenti timpano-malleolari anteriore e posteriore.
Le perforazioni in genere si distinguono in centrali, intermediarie, periferi che o marginali, e totali. Per perforazioni ce ntrali si p ossono inten d ere quelle che si trovano immediatamente al disotto del manico de l
IN R APPORTO AL SERVIZIO MILI TARE 101
martello e hanno distrutto quelle fibre raggiate che ri mangono libere dalle fibre circolari. Perforazioni intermediarie sono quelle che risiedono tra il manico del martello e il margine della membrana: periferiche o marginali quelle che corrispondono immediatamente al margine osseo.
Le osservazioni cliniche in numero molto rilevante raccolte con acCluatezza e diligenza dai più autorevoli otologi hanno stabilito le segu euti sedi più frequenti e più importanti.
Jlem br·ana del timpano p1·opriamente della:
l. Perforazioni centrali e intermediarie nella metà inferiore;
2. Perforazioni marginali della metà inferiore;
3. Perfo:ra.zioni nel quad rante postero-su periore;
4. Distruzione quasi completa della membrana.
M embrana di Slwapnell:
l. Perforazioni sottili al davanti della corta apofisi;
2 . Perforazioni marginali del segmento anteriore; .

3. Perforazioni al di·sopra e al di dietro della corta apofisi;
4. Perforazioni marginali o totali della membrana di Shrapne ll con perforazione del quadrante postero-superiore, o totale della membrana del timpano.
Ho preferito questo raggruppamento per sede delle perforazioni, siccome quello che meglio corrisponde ai fatti clinici, più freq uentemente osservati, e in cui gli autori sono più conco rdi nella valutazione diagnostica. Altre più minute suddivisioni sono, a parer mio, troppo artificiose già stabilito per l e esperienze cliniche, che le perforazioni come t ali hanno un valore molto differente per la diagnosi: noi vediamo dietro processi apparentemente simili alcune perforazioni terminare colla 1·e· .c:tilu lio ad inlegnun organica e f unzionale, mentre in altri casi avere esito con distruzione di una più o meno estesa par te della membrana. del timpano e con disturbi funzionali permanenti di alto grado.
Il Mi.iller (Jena) prende in considerazione i processi morbosi aeuti. Nella sezione inferiore della membrana una piccola perforazione intermediaria è sempre la co nseguenza d'una otite m e dia purulenta acuta, la m embrana de l timpano presenta tutti i segni d'un'infiammazione acuta ed anche la anamnesi (il paziente non fu mai per lo innanzi malato di orecchi), l'etiologia e il rimanente esame clinico parlano per un processo acuto dell'orec chio medio. Queste perforazioni, ohe si formano per solito nelle infiammazioni acute, in quanto hanno la loro sede nella. metà inferiore della membrana del timpano e sono intermediarie, possono iu.
102 LE PERltOTnztO.:H 'l' IMl'AXICHE l'.ATOLOOTCIIE
generale essere considerate come benigne: finiscono con esito favorevole e può avvenire una perfetta restilulio organica e funzionale. Un'altra forma benigna è quella a. zaifo o a cono: es.sa avviene nei casi di piccole perforazioni intermediarie nella metà inferiore della membrana del timpano ed anche nella sezione superiore an teriore, in cui i bordi granulano scarsamente, si sollevano a forma di tromba s ul live llo della membrana e formano un cono cavo, dalla cui sommità sgo rga pus. Appunto nella epidemia d'iniluenza 1889-1890 ho avuto occasione di osse rvare ben molti cas i d i perforazioni a zaft'o nelle otiti medie a cute purulente, e sempre si ebbe a constatare esito favorevole.
Un' eccezione della prognosi in generale fausta delle perforazioni in· tettnèdia.rie dèlla sezione inferiore della membra na del ti mpano nelle su ppurazioni acute sono, secondo l'esperienza clinica, quelle che hanno sede nel cono luminoso. Esse sono da. considerarsi ·come infauste, fibre perchè finiscono male e producono disturbi funzionali p'3rmanen t i. Le del cono luminoso sono più stirate, più corte e più forti di quelle raggiate circostanti e formano come un liga.mento dell'estremità del manico del martello; da ciò proviene che nelle più o meno es t ese distruzioni delle fibre del cono luminoso il manico del martello, privato del suo normale liga.mento inferiore, si ritrae in den t ro, e che le fibre raggia.te prossimiori si tendono più fortemente, venendo così ad essere disturbata la. loro normale nutrizione ed in conseguenza la loro tendenza alla rigenera.zione.
Tutto ciò dimostra che non può essere s pontaneamente possibile una chiusura cicatriziale delle perfo razi oni in questa. sede. Noi evi t iamo perciò anche con molto rigore, nelle infiammazioni e nei catarri acuti d ell'orecchio mèdio, di fare la paracentesi in vicinanza del co no lumi· noso, ma la facciamo nella metà poste riore.
L'esperienza clinica ha stabilito, che in maggior proporzione di quelle del cono luminoso si trovano in un grandissimo numero di suppurazioni croniche dell'orecchio medio le perforazioni a rene, a cuo re e totali con isolamento del ma.rtello, e sono accompagnate da notevoli d isturbi funzionali e da una serie di molestie subiettive, che richiedono t utta l'attenzione dell'otoiatra.
Le perforazioni centrali si presentano innanzi tutto a forma di rene, e poi se i margini si distruggono più o meno, prendono allora la forma d i cuore. La distruzione può raggiun gere un grado più alto, cosicchè persiste solo uno stretto lembo di membrana nella sezione superiore, ov vero può rimanere solo un lembo periferico rasente l'anello timpanico. Se anche questo viene distrutto insieme all'ultimo resto superiore della membrana, dalla forma. di cuore si arriva alla distruzione totale della

103
membrana del timpan'o con isolamento del martello. n manico in tutte queste forme o resta nella sua n ormale posizione, ovvero è ti r ato in dentro spesso fino al promontorio, e allora si mostra accorciato in prospettiva come un pun to o come un corto bastoncello. Ciò dipende dal fatto, se i l tendine del t enso re è distrutto o conservato. Il manico del martello può apparire bianco, e in tal caso esso è denudato delle sue parti molli, ovvero può essere rivestito ancora della onte, della mucosa e del periostio e la sua nutrizione può avveni r e in quantità sufficien te. Può diventar cariato in singole porzioni, ovvero è inte ramen te distaccato dai suo i liga.menti ed esfoliato.
Se invece il martello non è esfoliato e ris ente an cora l'azione del tendine del tensore del timpano, il suo manico n ello stesso modo come nelle altre perforazioni del cono luminoso, spogl iato del suo normale ligamento, si ritrae Yerso la. parete interna. della casa ed anzi di tanto per quante fibre raggia.te sono distrutte intorno ad esso.
L e perforazion i periferiche o marginali della. sezione inferiore d eli a me mbrana del timpano debbono sempre far sorgere in n oi il sospetto che si tratti di una carie circoscritta dell'anello timpanico. I primi fenomeni in simili cas i non provengono dalla. membrana, ma dal cercine osseo: si riscontra dapprima, in quest'ultimo, rossore, gonfiore e fo rm a granulosa.. e dopo avviene la perforazione. La. membrana del t im pano può essere distr utta per un tratto più grande dell'anello ti m panico, l'anello stesso può essere diviso e distrutto in singoli frammenti, ovvero può formarsi un solo grande pezzo necr otico.
Ben diversamente procede il fatto nelle perfor azioni della. sezione superiore della. membrana. In simili casi veniamo coll'anamnesi a sapere, che il paziente già. da lungo tempo, con o senza. interruzione, soffre di otorrea, ovvero osserviamo anche che la otor r ea resiste ostinatamente al nostro trattamento e che la perforazione non vuoi chiudersi , ovvero che si chiude per breve tempo, e po i ogni volta si riapre e che il paziente si lag na di dolori di breve durata, spesso acuti, terebra.nti, localizzati alla. par te malata, e· dimostra un aspetto cachettico; allora. possiamo con grandissima probabilità. concbiudere per una carie della. cassa. Per regola si tratta, come insegna l'esperienza. clinica. di carie della testa e del collo del martello. Nel caso che sia coinvolto i l settore posteriore. od a n che che si siano qui riscontrati i primi fenomen i di perforazione, tratta.si d i carie del corpo dell'incudine. Spesso scola da tali perforazioni un pus fe tido, icor oso. Non e raro che la. perfora7.ione non sia. Yisibile, vuoi perchè i suoi bordi siano fortemente granulanti, vuoi che attraverso di essa. sporga no delle granulazioni del fondo della cassa., ed anche degli ossicini, e cosi il suo lnme è ingombrato ovvero addiri ttu ra otturato.
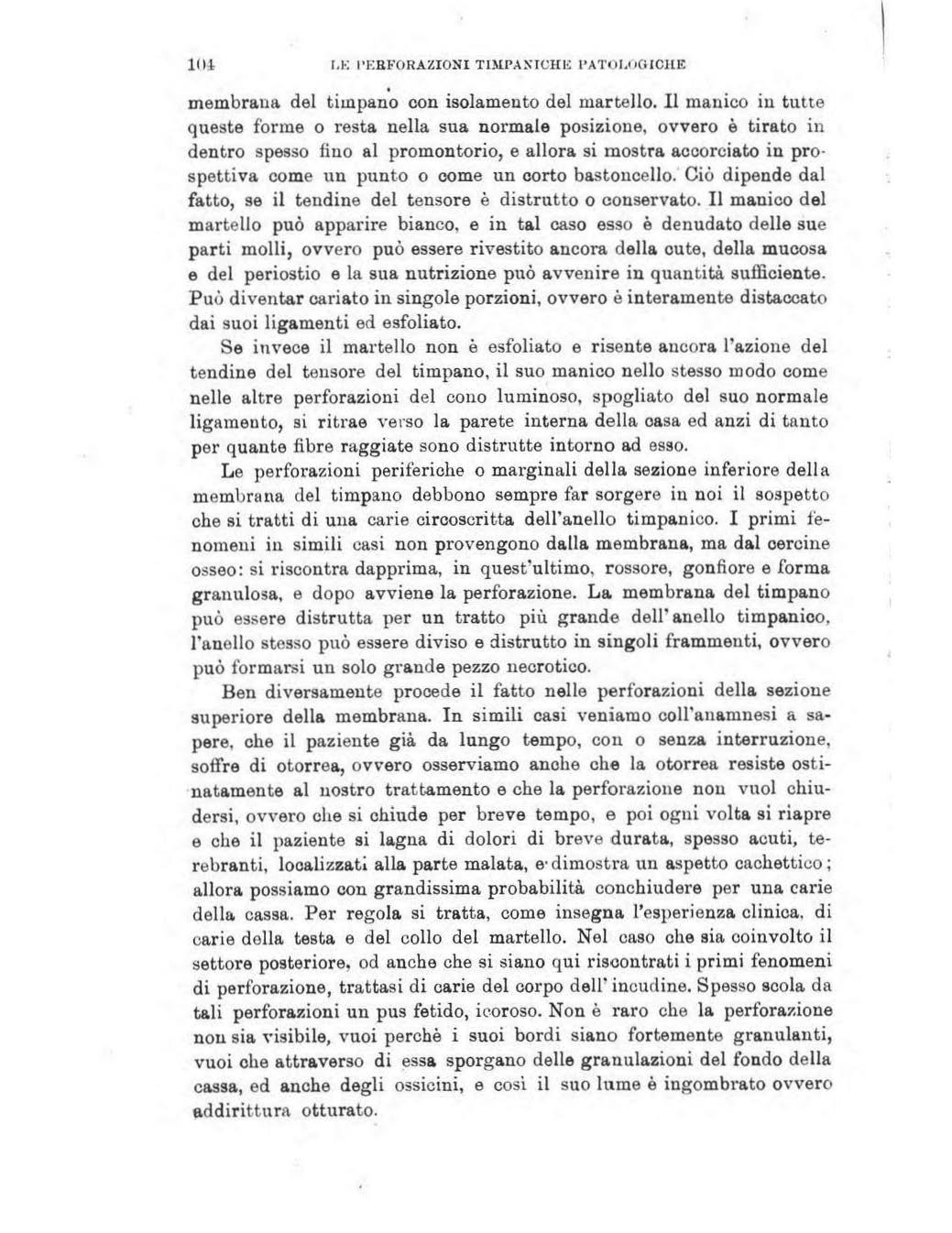
111.1: l. E PERFORAZIONI TlllPA:\lCHE l'A'l'OI.oO l CHE
Non bisogna dimenticare, ohe spesso la qualità d ella s ecrezione d à svariati ed importanti ragguagli sopra i processi morbosi dell'orecchi o me dio, e che perciò, per esempio, dobbiamo distinguere rigorosamente fra pus bonum et l au d abile e pus tenue, icoroso, fetido , come per lo più si trova nelle lesioni ossee, e ohe inoltre la prominenza di granulazioni esuberanti e facilmente sanguinanti, ovvero la. comparsa di d etriti di osso necrosato ci permettono dì fare importanti conclusioni. Possono altresì fuoruscire dalle perforazioni masse colesteatomatose, spontaneamente o dietro iniezioni nella cavità timpanica, e l'esperienza clinica ha insegnato che masse di tale specie costituiscono per lo più l'indicazione d'importanti interventi chirnrgici operativi.

Per poter emet tere un giudizio clinico e d edurre posoia u n apprezzamento medico-legale coscienzioso sui varii processi purulenti cronici dell' orecchio medio, bisogna me ttersi in grado, in un dato caso, d i porre la diagnosi di sed e delle varie localizzazioni della. suppura.zione. ed inoltre di stabilire se esista. o meno una. lesione ossea. È appunto s tudiando volta a volta. la sede della. perforazione timpa.nica che no i possiamo fare tale diagnosi con una probabilità che si avvicina. alla s icurezza assoluta, sentenzia e dimostra. E. Leitert di K onig sberg in una magistrale ed autorevole relazione riportata nei n .'' 39, 40 e 4 1 della M il n chener medi cinische Wochenscltr i /'l del settem bre HìOO.
L 'orecchio medio è una cavità complessa e consta. di tre cavità seco ndarie, separate più o meno perfettamente l ' una dall'altra..
L ' esper ie nza cl i n i ca ha stabilito , che le pe1·jorazioni timp rtn i che, consecut i ve ad una suppU1·az i on e p?·olungat a , si m antengon o semp 1·e so l ame n te nell e p osi z i oni p1·ossimi01·i alla sede p1'i nc ipale de l p r ocesso pw·ulr.nto. A seconda pertanto che la suppurazione proverrà dalla mu cosa della cassa o dal suo p eriostio, dall 'attico. dagli ossicini. dall' antr o, si osserveranno determinate perforazioni timpaniohe e potranno così stabilirsi i caratteri differenziali delle varie forme di otiti medie purule nte croniche in quanto al decorso, alla gravità, e alla durata d ell' a.ifezione.
l. Nelle suppurazioni croniche della mucosa. della. cassa la perfo· razione ha luogo nella. metà inferiore della. membrana. del timpano o ve il pus esercita. la s ua maggiore pressione, e cioè intorno all' umbo, da· vanti, sotto o dietro del medesimo. Quando la sede principale d ella su ppurazione sia la tuba (malattie croniche faringo-nasa.li}, la perforazione è n e lla parte anteriore, e cioè al di sotto od anche di tr onte al-
IN RAPPO RT O A L ilEHVI Z I O MU.IT A R E 10;)
r ostio timpanico della tuba. In questi casi si possono escludere in modo quasi assoluto le affezioni dell'attico, dell'antro e la carie delle pa r e ti della cassa, e degli ossicini. Per la esclusione di queste gravi complicazioni e per il fatto, che il detiusso del pus avviene facilmente e sufficientemente, le perforazioni centrali ed intermediarie della metà inferiore d ella membrana del timpano, debbono considerarsi come le più benigne, anzi dirò anticipatamente che esse sono le sole perforazioni che permettono una restitutio ad i n teg1·um organica e funzionale in un tempo relativamente breve.
L 'estensione della perforazione, che da piccola ha forma ovale, di media grandezza ha forma di rene, e g rande ha forma di cuore, può arrivare alla distruzione della. metà inferiore della memb rana rispett ando solo un piccolo lembo marginale, ma non inf1uisce in generale sulla prognosi, la quale·si mantiene quasi sempre fausta.
2. Le perforazioni marginali della metà inferiore d ella membrana., sono prodotte da. carie del pavimento, o delle pareti anteriore e posteriore della. cassa, secondo che esse so no situate sui segmenti inferiore, 1\nteriore e posteriore del cercine osseo. Quand o la perforazione abbia se de marginale circa nel punto medio ante riore della memb rana, la causa ne e una suppurazione relativamente forte della tuba, che può diffond ersi alla. parete anteriore dell'attico. Il loro decorso e lungo, anche per la cu ra forzatamente palliativa a C'li bisogna limitarsi, a llausa della vicinanza d'organi importantissimi (bulb.> della giugulare, n er vo faccia le, carotide interna)
3. L e suppurazioni, che hanno sede principale ed esclusiva nell'antro, Jà.nno nna perforazione nel q uadran te postero·superior e della. membrana. In questi casi di suppurazione prolungata il processo lungo dell'inc udine si caria, c tale sede di perforazione e, secondo Leitert, patognon omica di tale lesione ossea. O ve in seguito la supp u razione dell'antro s i e s tingua, mentre invece si mantiene la. ca.rie dell'incudine, che anzi dal processo lu ngo proce de sempre più in alto fino a raggiungere il corpo, la pe r forazione si allarga in alto e indietro fino al margine osseo. La. prognosi e sempre riservata. Alcuni autori (KE>erner e Stacke) uon hanno grande fiducia nemmeno nella. precoce estrazione dei due ossicini este rni, che è l'operazione in tali casi indicata.
4. Ntllla. distruzione quasi completa. della. membrana del timpano, uou rimane che uno stretto lembo periferico, che lascia vedere in basso e in a vanti la. .finestra. rotonda, in alto e indietro l'brtioolazione dell'incudine e della. staffa, e nel bel mezzo i l manico del martello. In tali casi Leitert esclude la. carie dell' incudine e ammette una suppurazione prolungata isol ata della mucosa. della cassa. Ad ogni modo la diagnosi si può fare

!Oll PERFORAZI0.\"1
C!lF:
'TIMI'A.\"I CHE PA'l'OLOGJ
colla ispezione di r etta, resa possibile dalla estesa perdita. di sostanza ed inoltre osservando la. provenienza. del pus e la posizione delle gra· nul a.zioni fungose. La prognosi è però sempre riservata. anche per il fatto che vi si complicano lesioni delrattico e delle cellule mastoidee.
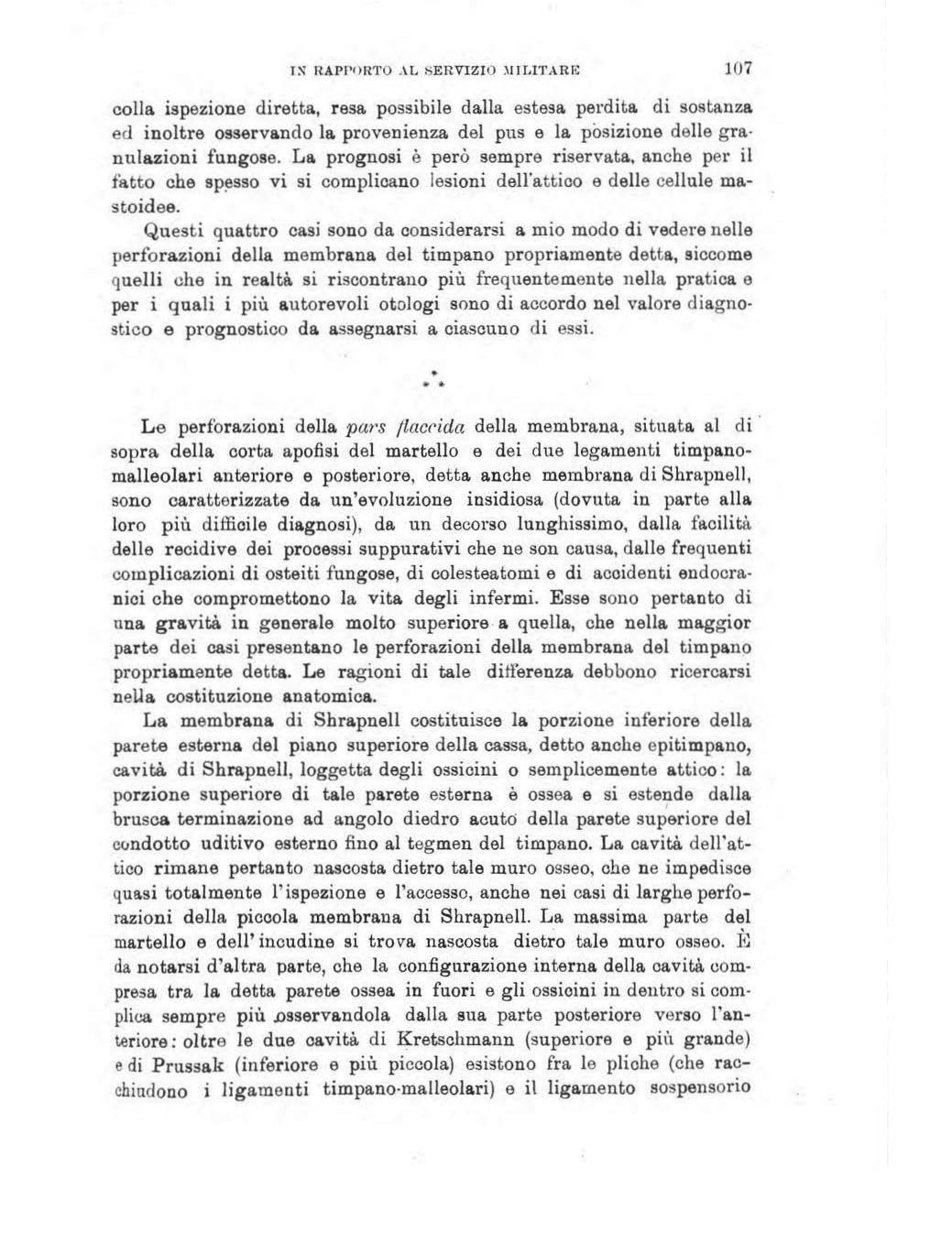
Questi quattro casi so n o da considerarsi a mio modo di vedere nelle perforazioni della membrana del timpano propriamente det ta, siccome quelli che in realtà. si riscontrano più frequentemente nella pra.tica e per i quali i più a utorevoli otologi sono di accordo nel valore diagnostico e prognostico da assegnarsi a ciascuno di essi.
L e perforazioni della pa1·s flacrida della membrana, situata al di sopra della corta apofisi del martello e dei due legamenti timpanomalleolari anteriore e posteriore, detta anche membrana di Shrapnell, sono caratterizzate da un'evoluzione insidiosa (dovuta in parte alla loro più difficile diagnosi), da un decorso lunghissimo, dalla facilità delle recidive dei processi suppurativi che ne son causa, dalle frequenti complicazioni di osteiti fungose, di colesteatomi e di accidenti endocranici che compromettono la vita degli infermi. Esse sono pertanto di una gravità i n general e molto superiore a quella, che nella maggior pa r te dei casi presentano le perforazioni della membrana del timpano propriamente detta. Le r agioni di tale ditl'erenza debbono ricercarsi neUa costituzione anatomica.
La membrana di Shrapnell costituisce la porzione inferiore della parete esterna del piano superiore della cassa, detto anche e pitimpano, cavità. di Shrapnell, loggetta degli ossicini o semplicemente a tti co: la po rzione superiore di tale parete esterna è ossea e si estende dalla brusca terminazione ad angolo diedro acuto della parete superiore del condotto uditivo esterno fino al t eg men del timpano. La cavità. dell'attico rimane pertanto nascosta dietro tale muro osseo, che n e impedisce quas i totalmente l'ispezione e l'accesso, anche nei casi di larghe perforazioni della piccola membrana di Shrapnell. La massima parte del martello e dell'incudine si trova nascosta dietro tale muro osseo. B da notarsi d'altra parte, che la configurazione interna della cavità. compresa tra la detta. parete ossea in fuori e gli ossioini in dentro si complica sempre più .osserva.ndola dalla sua parte posteriore v erso l'anteriore: oltre le due cavità. di Kretschmann (superiore e piu grande) e di Prussak (inferiore e più piccola) esistono fra l e pliche (che racchiudono i liga.me nti timpano-malleolari) e il ligamento sos pensorio
llAPPI)RTO \L 107
del martello un gran numero di foglietti estes i da. una par ete all'altra e intersecantisi in tutti i s ensi, che formano alla loro volta un de d alo di loggette comunicanti le une colle altre, ma solo per mezzo di orifizi s tretti, soggetti ad o bliterarsi facilment e. Tale sistema di cavità co m u· nica inferiormente col piano inferiore della cassa., men tre posteriorsi apre m ol to più largamente in facci a all'orificio dell'antro mastoi deo, che è qu asi il suo prolungamento, ciò che spiega perfettamente la so lid ari età patologica frequente dell'attico coll' antro.
La teoria che riconosceva la causa delle s uppurazioni della cassa (pia n o infe ri or e) nelle infezioni faringo-tubar ie, mentre in quelle dell 'attico ammette va l'origine esterna del condotto uditivo (furuncolosi, ecc. ) è stata vittoriosamente abbattuta dallo Schmiegelo\v (di Copenagen), il quale ha negato la persistenza. del forame di Ri vi ni ed ha stabilito l'origine comune d ella affezioni dei cavi accessori dalla cassa. Lo stesso Schmiegelow espone un paragone molto ingegnoso t ra le cavità mastoidee e que lle di Shrapnell: l 'antro petroso colla s ua cavità semplice, a cui succede inferiormente la-disposizione complicata delle cell ule ma· stoidee, sarebbe simile alla cavità posteriore unica. di Shrapnell (aditus). a cui succede anteriormente l' intric a.to sistema areolare.
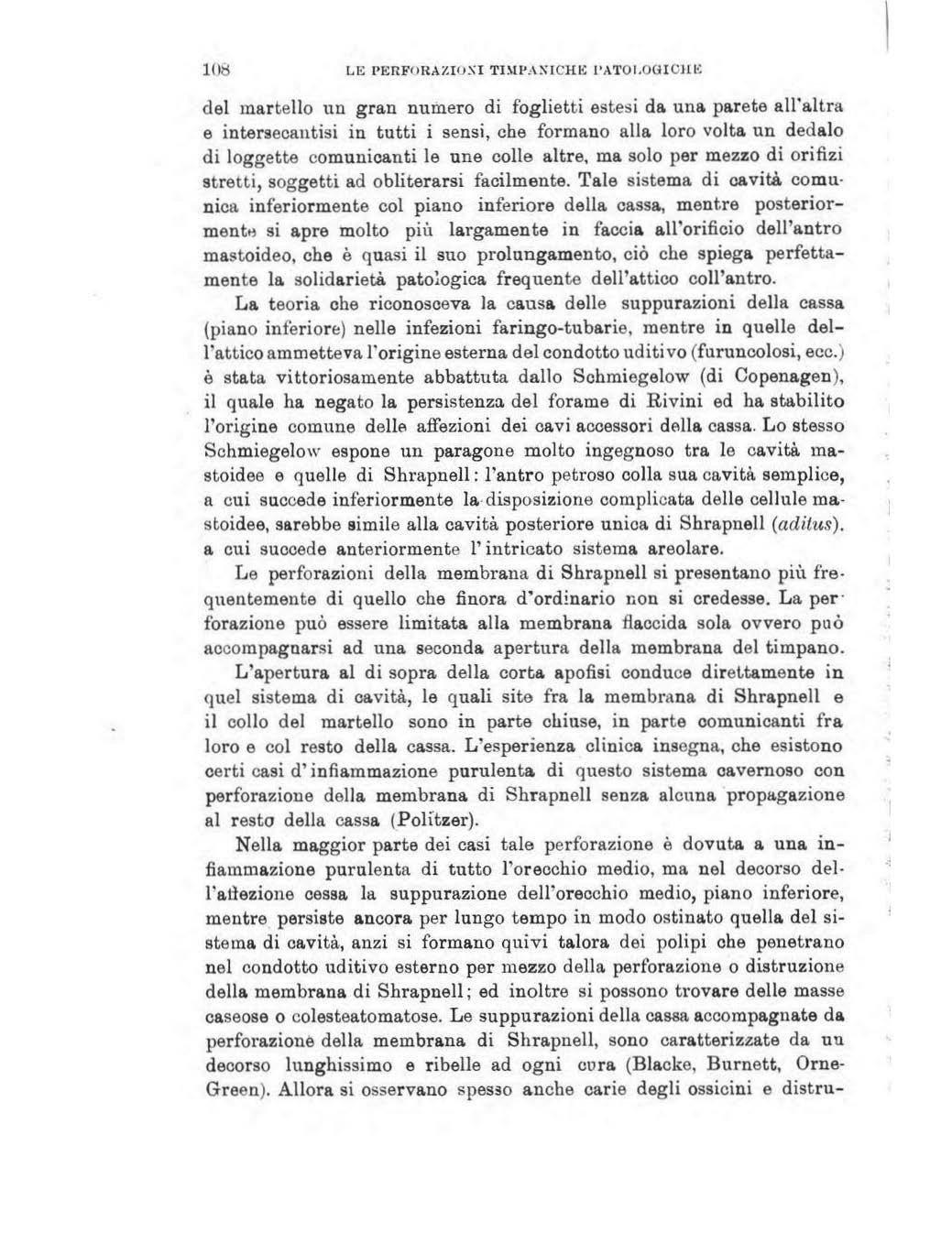
L e perforazioni della mem brana di Shrapnell si p r esentano più freque ntemente di quello che finora d'ordinario non si credesse. La. per · forazione può essere limitata alla. memb rana flaccida sola ovve r o può ac co mpagnarsi ad una seconda apertura della membrana del timpano.
L 'aper tura al di sopra della corta a pofisi conduce direttamente in quel sistema di cavità, le q uali si te fra. la membrana di Shrapnell e il collo del martello sono in parte chiuse, in part e comunicanti f ra loro e col r esto della cassa. L'esperienza clinica insegna, che esisto no ce rti casi d'infiam mazione purulenta di questo sistema cave rnoso con perforazione della. membrana di Shrapnell sen za alcuna propaga zione al r es to della cassa (Pol 1tzer).
Nella. maggior parte dei casi tale p erforazione è dovuta a. una. infiamm azione purulen t a di tutto l'orecchio medio, ma n el de corso del· l' atiezione cessa. la suppurazione dell'ore cchio medio, pia.no inferiore, m en tre persiste anco ra per lungo t empo in modo ostinato quella del s istema di cavità, anzi si formano quivi talora dei polipi che penet rano nel co ndotto uditivo esterno per mezzo della. perforazione o distruzione della membrana di Shrapnell; ed inoltre si possono trovare delle masse caseose o colesteatomatose. L e suppurazioni della cassa accompagnate da perforazionè della membrana di Shrapnell, sono caratt erizzate da un deco rso lunghissi mo e ri belle ad ogni co re. (Blacke, Burnett, OrneGree n ) Allora si osser vano spesso anche carie degli ossic ini e distru-
LE TBII';\:'\lCHI<:
zione del tessuto osseo della. parete esterna deirattico, donde risulta nella parete superiore del condotto uditivo este rno un foro, ohe in certi ca.si è cosi g rande da mettere allo scoperto una gran parte dello spazio super iore della cassa [Politzer).
Il L eitert ritiene che, quando la suppurazione abbia sede an che od esclusivamente nell'attico, la perforazione avviene attraverso la membrana di Shrapnell, e che quando l'antro compartecipi la suppurazione e cosi grave che tale memb rana. viene distrutta sino al margin e della. parete an ter iore dell'attico. Possono coesistere due piccole perforazioni della. membrana d i Shrapnell, ovvero una perfor a zione estesa di. questa membrana insieme co n una distruzione della membrana timpa.nica, qua· drante postero-superiore.
Possiamo stabilire quindi anche qui quattr o tipi clinici di perforazione della membrana di Shrapnell , assegnando a ciascuno di essi i l valo r e diagnostico e prognostico ammesso dagli otologi più autorevoli conco rdemente.
I. Le per forazioni sottili della membrana di Shrapnell situate al davanti de lla cor ts. apofisi indicano suppurazione isolata dell'attico senza alcuna lesione ossea. L a prognosi però è riservata, sia per le considerazioni di sopra accen nate, sia ancora per le opera zioni che si richiedono per assicurare il deflusso del pus:
n . Quando oltre rattico compartecipi anche rantro, la. suppura zione è r.osì grave, che la membrana di Shrapnell viene distr utta sino al marg ine della parete anterior e dell'attico. Prognosi riservata.
IIL Le perforazioni al di sopra ed al di dietro della corta apofisi del martello indicano sempre s uppurazione dell'attico, però con carie della. testa dei due ossicini estern i. Prognosi riser vata sotto tutti i riguardi.
I V. L e per forazio n i marginali o totali della membrana di Shr apnell liCCo mpagnate da perforazioni del quàd rante postero-superiore o totali della membrana del ti mpano propriamente detta (pars lensa ), indicano sempr e carie dell'attico e dell'antro. Prognosi ris ervata, anche perchè si rende necessar ia l'operazione radical e.

Oltre la sede delle perforazioni è anche di grande importanza per la diagnosi e prognosi e quindi per la valutazione medico-legale, l'esame de lle secrezioni diverse che da esse fuoriescono.
Il Luc afferma che la bacteriolog ia delle suppurazioni de ll'orecchio non ba u n interesse speciale; qui come altrove si trovano mic robi pio-
llAl'l'tJI'tTO AI, SEHVIZIO AllL!TARE ]()!)
• •
geni (stafilococco albo e aureo, streptococco, diplococco pneumonico), e microbi non piogeni (bacillo di Koch, bacillo Kleb9 Loe:Aler, microbo piocianico) ed infine dei protei ed altre specie proprie delle fermentazioni putride nei casi di pus fetido. I microbi specifici (b. di Koch, e di Klebs-Loeffier) mancano sovente nei focolai suppurativi che si sYiluppano secondariamente nei soggetti affetti, ovvero l a loro proporzione in rapporto ai microbi piogeni è per solito talmente ristretta, che la loro presenza è palesata molto difficilmente. L'esperienza di molti anni ha dimostrato che il pronostico d'un caso determinato dipende molto meno dalla specie microbica. che dal numero e dalla virulenza speciale che i microrganismi ricevono dal carattere della malattia primitiva (influenza, scarlattina) e dal terreno proprio del soggetto (deperimento generale, cachessie, diabete, ecc.).

Si aggiunga d'altra parte, che le culture pure non costituiscono la regola in queste ricerche micrografiche, e che per l o più le diverse specie piogeue si presentano associate.
I microbi piogeni provengono a bitualmente dalla cavità naso-faringea, dove non è raro incontt"arli anche allo stato normale, pronti ad entrare in azione sotto l ' influenza di una causa patogena determinante. T alora l'influenza del freddo, o una causa accidentale '(irrigazione, immersioni, lavacri) aumenterà singolarm ente la probabilità d ' infezione della cavità dell'orecchio medio, determinando bruscamente la penetrazione nel suo interno di numerose specie microhiche traspor· tate dal liquido. Più raramente l'infezione proviene direttamente dall'esterno, p. es. in seguito ad una risipola facciale, o alla penetrazione di un corpo estraneo, od anche per il fatto della penetrazione d'a cq ua im pura n el condott o uditivo nel caso di una perforazione timpanica preesistente.
. La presenza dei microbi caratterizza le forme infiammatorie e quindi è costante negli essudati di tutte le otiti, anche nelle forme catarrali più benigne e a liquido chiaro; il che ci spiega la possibilità della. comparsa d'accide n ti intracranici in tutte le specie di otiti.
Nei casi in cui non vi sia sospetto di lesioni tubercolari, e l'esame batteriologico del pus abbia dato esitq negativo, come succede abba· stanza sovente, il prof. Masini suole praticare la iniezione delle granulazioni, tolte dalla cassa, nel peritoneo della cavia, poichè questo annienta il valore d ei piogeni e lascia sviluppare i noduli tubercolari e così talora ha potuto constatare notevole sviluppo di noduli tubercolari nel peritoneo, nèlla milza, nel fegato, anche in soggetti che non avevano al cuna labe ereditaria in famiglia.
110 LE l' ERFOHAZIO J\1 TDIJ'ANICHE PATOLOG ICHE
Oltre l ' esame delle secrezioni purulente, è importante per la diagnosi e per la prognosi la constatazione dell ' esistenza di alcune masse epidermoidtt.li, costituenti un tumore curioso, che non s'incontra quasi mai in altre regioni dell' organismo, voglio accennare al colesteatoma.
Sotto l' infl.uenza. d'un meccanismo ancora molto discusso (teorie di Virchow, di Schmiegelow - di Mikulicz, B ottcher, Kiister - e finalmente di Bezold, di Ha.bermann), la. superficie interna del focolaio suppurativo diviene la sede di una formazione di tessuto epidermiforme, di natura maligna, che entra. tosto in putrefa.zione ed esercita alla sua volta sulle pareti ossee contigue un'azione infettiva ed ulcerativa., le cui conseguenze possono essere le più gravi. Il carattere affatto tenace delle lesioni consecutive e la minaccia costante di frequentissime complicazioni intracraniche per la. facile denudazione della dura meninge e quind i per la diffusione dell'infezione sia in alto alla cavità aracnoidale e al lobo sfenoidale del cervello, sia indietro al seno laterale e al cervellet to, rivestono sempre tale gravità da g iustificare un pronos t ico costantemente riservato e da consigliare agli oto-chirurgi un intervento ope· ra t ivo radicale.
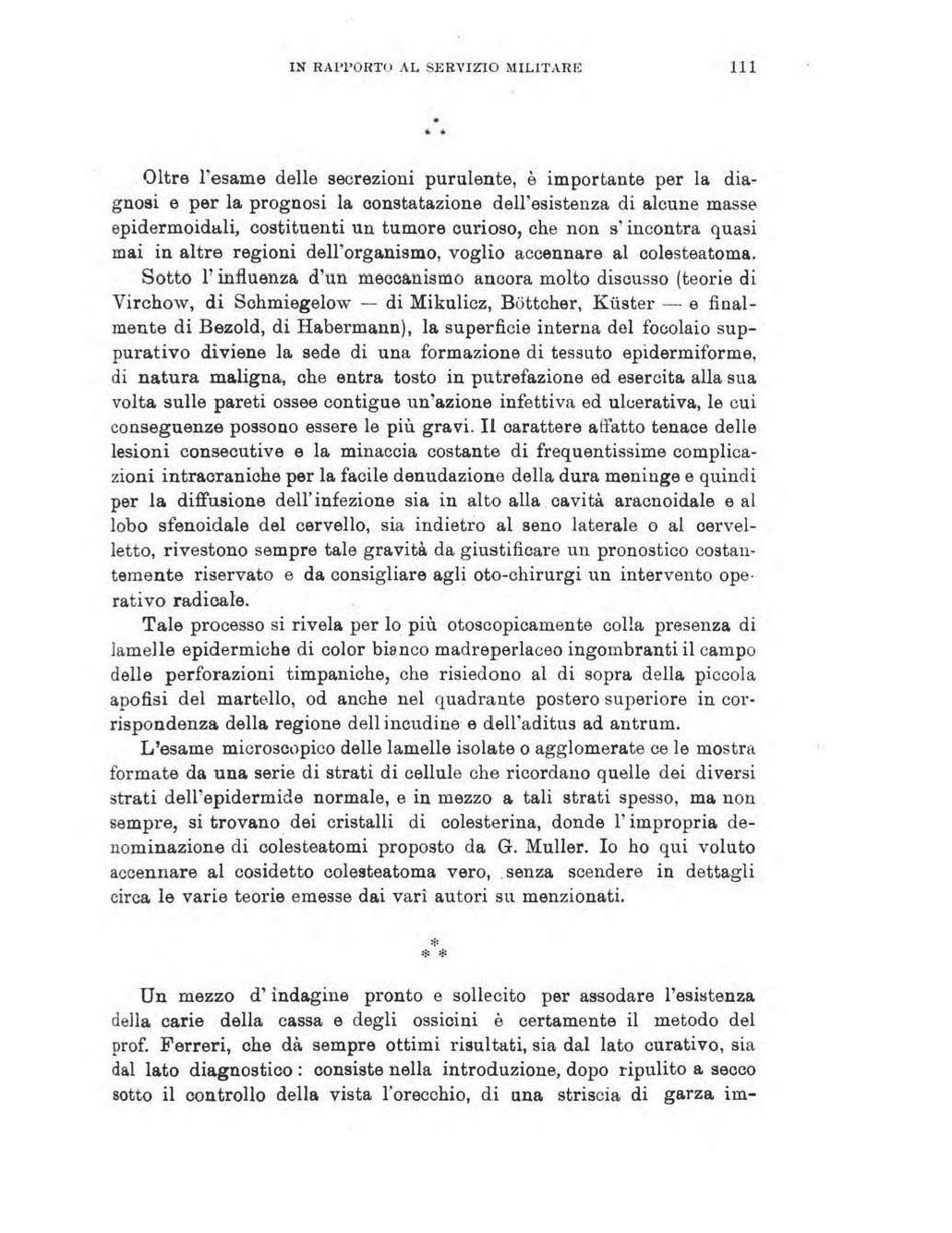
Tale processo si rivela per lo più otoscopicamente colla presenza di lamelle epidermiche di color bianco madreperlaceo ingombranti i l camp o d elle perforazioni timpaniche, che risiedono al di sopra d ella piccola apofisi del martello, od anche nel q uadrante pos tero s uperiore in corrispondenza della regione dell incudine e dell'aditus ad antrum.
L'esame microsCt)pico delle lamelle isolate o agglomerate ce le mos tra formate da una serie di strati di cellule che ricordano quelle dei diversi strati dell'epidermide normale, e in mezzo a tali strati spesso, ma non sempre, si trovano dei cristalli di coleste rina, donde l'impropria denominazione di colesteatomi proposto da G. Muller. lo ho qui voluto accennare al cosidetto colesteatoma vero, senza scendere in d e ttagli circa. le varie teorie e messe dai vari au t ori su menzionati.
Un mezzo d' indagine pronto e sollecito per assodare l'esistenza della carie della cassa. e degli ossicini è certamente il metodo del prof. Ferrari, che dà sempre ottimi risultati, sia dal lato curativo, sia dal lato diagnostico : consiste nella introduzione, dopo ripulito a secco sotto il controllo della vista l'orecchio, di una striscia di garza im-
IN RAl' l'O RTO AL SERVJ2':1 0 MILITAR I!: 111 ••
***
preg nata. in una. miscela di derma.tolo in glicerina a.l 10 per cento, face ndovela rimanere 2-! ore. Nel toglierla si vedrà che il lembo estremo dell a garza rimasta più a contatto diret to della cassa attraverso la perforazi one timpa.nica in alcuni casi si mostra annerito, in altri con· serva il suo colo rito giallastro. Il fenomeno è dovuto ad una reazione chimica che avviene tra il dermatolo, che è un gallato basico di bismuto e il gas solfidrico ohe si s volge dall'osso cariato, formando il sol furo di bismuto.
Sempre quando esistano delle perforazioni timpaniche, anche a scopo diagnostico si può adoperare la cannula di Hartma.nu, la quale rende ottimi servigi specie nei casi di abbondanti s uppurazioni con odore cattivo, completata immediatamente dopo dalla specillazione fatta per mezzo di uno stiletto d'argento (a gomito fisso in vicinanza de l suo manico) , a cui si può dare qualsiasi cu r vatura secondo i casi. Con ta.l mezzo si potrà apprezzare la. mobilità d'una vegetazione, di un poEpo, o d'un sequestro osseo, la friabilità d'un punto osseo cariato, ed infine nel caso di suppura.zioue dell'attico con lesione del teg men la. sonda maneggiata. con dolcezza e precauzione potrà talvolta permettere tale diagnosi importante.
Tutti questi metodi diagnosti ci sono resi p ossibili dall'esistenza di perforazioni timpa.niohe. Ne esistono anche altri più o meno caduti in disuso, specie per la. diagnosi della. tubercolosi dell'orecchio che è pi ù rara di quanto si crede (secondo il Garbini è nel rapporto del dec imo con la. carie semplice) e sono le iniezioni di tubercolina e il metodo diagnostico del D e Rossi (enucleazione del ganglio o dei gan· gli linfatici prema.stoidei, loro esame microscopico e successi va. inoculazione nelle cavie).
Finora si è sempre trattato delle perforazioni timpaniohe accompagnate da. un processo purulento in atto: ora. è necessario aggiungere che fra gli esiti abbastanza frequenti delle otiti medie purulente cronich e, dopo l' arresto della suppura.zione, bisogna. contare la. persis Lenza. delle apertu r e della .Membrana del Timpano per la forma zion&

lB LE I'ERFORAZIONI TIMI'AXICHE PATOLOGICHE
d'uno strato epidermico sui bordi della perforazione. Avviene di pre· ferenza nelle grandi perdite di sostanza che si este ndono fino all'anello tendineo, ma si trovano spesso anche piccole aperture che durano p er tutta la vita. Lo Schwartze attribuiva t ale fatto alla calcificazione de i bordi, ma Politzer ha constatato in parecchie autopsie che il bordo d elle perforazioni permanenti non deve sempm il suo colore bianco carico alla calcificazione, bensì ad un accumulo di cellule epiteliali cornee, ed ha osservato inoltre che alcune ap erture perforative si cicatrizzano sovente nel mezzo di segmenti completamente calcificati dalla membrana del timpano. Le cause anato miche della persistenza del)e aperture perforati ve, il cui studio avrebbe certamente una grande importanza anche P!atica, non sono dunque ancora ben conosciute.
Non tutte le perforazioni che r estano lungo tempo aperte debbono esger e ritenute come permanenti, perchè si osservano talora dei oas i, abbastanza rari in verità., in cui l'apertura perforativa non si cicatrizza che parecchi anni dopo.
La pratica c' insògna che quelle perforazioni che occupano i due t erzi circa della membrana del t impano non si ch iudono quasi mai, scrive il prof. Grazzi.

W reden fa notare che nelle otorree, quando il manico del martello st è esfoliato o distrutto, la coesistente nella membrana s1 chiude con grandissima difficoltà.
In pochi tessuti d ell'organismo s i nota una così grande attività riparatrice, come nella membrana del timpano. Il Politzer descrive un caso, che egli dice la più estesa rigenerazione della membràna del timpano da lui mai osservata, in cui in seg uito ad una otorrea a destra durata 17 anni la membrana. era ridotta ad una stretta striscia periferica e in cui in meno di due anni t a le ampia apertura e ra.si co mpletamente chiusa senza alcuna aderenza colle parti profonde. .
Colla cura. dell'acido tricloracetico dal 10 al 50 per cento talo ra si poterono chiudere apertu re ragguardevoli per grandezza e per posizione (perforazioni marginali ), in cui il processo originario era trascorso da due anni.
Per ciò che concerne le alterazioni dell'udito che accompagnano le perforazioni asciutte o permanenti, numerose osservazioni antiche avevano già dimostrato, e molti moderni autori convengono, che si può avere un potere uditivo quasi perfetto, pur presentando la membra na del timpano alterazioni notevoli, quali p. es. ingrossamenti, intorbidamenti, cicatrici, calcificazioni, e perdite di sostanza anche estese.
Il Secchi (Bologna) in una sua r ecentissima e geniale pubblicazione (Torino 1902) dal titolo La finestm rotonda e la sola v ia per i suoni
medico.
I)< RAPPORTO AJ.- SEHVIZIO
8 -
fìiorRalt
dall"m·ia al labi1·in to, afferma che le perforazioni grandi, medie e pie· colissime non vanno mai disgiunte da limitazione della percezione dei toni bassi, e per gli altri suoni sarà. tanto più facile che siano avvertiti per intensi t à e durata, quanto più la perforaz ione è anteriore, quanto minore è lo spostamento del martello. Processo breve molto sporgen te e manico molto rat t rat to , se coesistono con perforazioni, vanno spesso compagni a deficienza pronunc iatiss ima d ell'udito, sempre con la mancanza di a ccomodazione: sia che la sorgente sonora si vada allontanando o avvicinando, il limite di udibilità s i trova sempre alla stessa distanza. Quando si può ottenere che la perforazione si chiuda p es. con la causticazione dei margini con acido triclorace tico, il miglioramento, che di solito se n e otti ene per la funzione u d itiva, nou avviene mai a mano a mano che la perforazione si chiude, ma solo d o po chiusa e spesso immediat amente dopo. In nna persona sana la perforazione artificiale della. membrana , fatta. in qualsiasi punto, anche nella pa1·s (laccicla, ma. in guisa da garantirsi che resti aperta anche se piccolissima (' / ,.0 della superficie della. membrana. del timpano) porta sempre innalzam ento del limite inferiore, diminuzione notevolissima (' / 3) d e lla distanza a cui si sentivano i suoni esattamente uguali e misurabili, perdita dell'accomodazione.
Anche nelle alterazioni permanenti e persino nella distruzione degli ossicini , che s pesso accompagna no le perforazioni s ecch e, il linguaggio morm orato pu ò ancora essere sentito ad una g rand e d istanza, purchè la. base della. sta tl'a s ia mobile nella finestra. oval e e la me mbrana dell a fines tra. rotonda non sia ispessita (Politzer)
Nelle perforazioni permanenti pert.anto il pronostico è s favorevole. se dopo l'arresto della suppurazione rimane un'alterazione grave dell'udito , che non viene modificata. n è dalla do ccia d 'aria, nè dall'applicazione d ella. membrana timpanica. artificiale, ed è addirit t ura infaus to quando l'alterazione dell'ndito aumenta progressi va.mente ed è accompagnata da rumori subiettivi.
Le perforazioni asciutte finalmente rappresentano un pericolo permanente per chi ne è affetto, perchè dispongono il paziente alle recidiv edei processi flogistici della cassa, mancando a questa regione. importantissima dell'orecchio l a sua naturale difesa contro le cause reumatizza.nti e gli agenti infettivi esterni.
V. Uchermann (Cristiania) nel 6" Congresso Internazionale d'etologia di Londra. (1899) mise fuor di dubbio l'esistenza. di otiti medie reumatiche ed inoltre l'esistenza di affezioni auricolari reumatiche indipendenti nei reumatici, sotto forme di o ti ti medie sierose, semifìbrinose, e di sclerosi secondar ie a. decorso progressivo; pur soggiungendo però

114. I.E !'ERFOH AZIOXI TlUPAXlGIIt: I' AT O f.llv lCJll>:
che i oasi d'otite reumatica senz a manifestazioni generali sono eccezionali. Hartma.nn nello stesso Cong resso ricordò u n malato che si svegliò com pletam en te sordo dopo aver passato nei boschi una notte fredda . D ' altronde è risaputo, scr ive il prof. Masini, che monti, valli, ca ldo, f reddo, stagioni, temperature , venti, pressione bar ometri ca, rarefaz ione d ell'aria, umidità, pioggia, scariche elettriche, danno luogo a modificazioni app r ezzab ili nell' udito e n egli organi dei sensi in genere, che come organi d i difesa presiedono alla percezione di tu tti gli st imoli del mondo esteriore. T ali modificazio n i sono più notevoli specie negli individ ui affetti da postumi di otite media purulenta, dimostra i l prof essar Ma.sini in una memoria preventiva intorno ali' influenza d elle vicende a tmosferiche sull'organo dell'udito allo stato di sanità e di malattia (1897)."
È stato da qualcuno asserito che le estese perdite di sostanza della mem brana d el timpano non sogliono provocare infiammazioni acute de lla cavità. timpanica, qua n tunque i germi patogen i contenuti nell"aria abbiano libero adito per penetrarvi, mentre l'infezion e di essa avviene sem pre per il tramite della tub e. T ale domm a tica asserzio ne è tassa·· ti vamente conlira ddetta da tutti gli otologi, che io ho potuto consultare, tra i quali Politzer, Luc, Lei te r t, Miiller, Castex, C!aouè, De R ossi, Burger, Masini, L evy, Ostino, eoc. Il prof. Grazzi, al quale mi permisi di sottoporre ta.lo questione, mi ri spose nel giugno p. s con una lettera gentilissima, nella quale mi conferma:
« esse re egli convinto che n elle p erfomzioni abituali (vecchie ) della «membrana del timpano la i nfezione avviene anche pe1· penel,·a::;ione
«eli ge1·mi patogeni dall'esle?'no: egli ha \"eduto molle volie indivi dui, « che avevano da mol ti anni una per for azione se cca del timpano andare incontro al riacutizzamento della otite ed avere nuovameute
• secrezione purulenta dl\ll'orecchio d opo un bagno con penetrazione
«. d'acqua dal condotto uditivo esterno . Giudica q uesta una prova lam" pa.nte della. possibilità non r-a1·a dell'infezione d1.1.ll'esteruo ».
Basta la penetrazione di poche goccie d ' acqua nella cassa in seguito ad un bag no od anche nel lavarsi il viso, una corizza comune, o la riacutizzazione d'una rino-faringite cronica, perchè il processo già spento si ridesti con tutti i pericol i e con tutte l e sue possibili conseguenze, scri ve il capi tano medico Ostino nel suo aureo libro Guida alla diagnosi medico-legale della sordità.
Io credo di a ve r cosi esau rito il compito propostomi dello studio delle perforazioni ti mpaniche patologiche, sia riguardo alle loro varie

IX RAPPORTO AL Si;RVIZJO lJ!)
• : .. "
forme e relativa importanza, sia. in quanto al loro valore diagnostico e prognos t ioo, in ispecial modo nei oasi oroùioi, per stabilire la sede del processo morb oso patogenetico. Coll'osservazione clinica della sede delle perforazioni timpaniohe e coll 'a iuto d egli altri criteri diagn ostici di sopra esposti, alla loro volta sono r esi possibili dalla esistenza delle perfora?.ioni, come l'es·1me batteriologico dell6 secrezioni e delle masse colesteatomatose, il metodo del prof. Ferrari per accerta r e l'esistenza di una carie ossea, la specillazi oue e l a iniezione sperimentale delle granulazioni nel p eritoneo de lla cav ia, uoi ci mettiamo in grado di. fare in qualsiasi caso un 'esatta diagnosi di sede e di natura di un det erminato processo morboso dell'orecchio medio e di emettere, m base ad essa, un sicuro giudizio m edico-legale.
È notorio il d etto di \V ilde: ((Fino a che persist.e un'otorrea, niente può dire se fìnirà, nè come, nè quando, n è ove essa condu rrà »
Tutti gli Stati sono unanimi nel considerare l'otite media purulenta come un'atfezione grave da provocar e l'esenzione temporanea del ser· vizio militare p la riforma. Frattanto il rlecorso, le complicazioni, gli esiti delle otiti medie purulente essendo molto variabili, i provvedimenti med ico-legali variano secondo i diversi casi.
Accertata mediante l'esame otoscopico, scrupolosamente eseguito, la sede e l ' estensione d'una perforazione timpanica coesistente con snppurazione più o meno abbondante, si può concl uder e se trattasi di se mplice affezione della mucusa della cassa, ovvero d' infiammazione cronica dell'atti co o dell'antro mastoideo, ed inoltre se esista.n o o meno lesioni delle pareti ossee o degli ossicini. L 'esistenza delle complicazioni ossee si può controllare co n l 'esame microscopico del pus, colla specillazione e col descr itto m etodo del Ferrari.
Dovt·anno a parer mio mandarsi rivedibil i tutti gl'individui affetti da. perforazi oni centrali e inte r mediarie della metà inferiore e del quadrante antera-superiore della membrana d el timpano propriamente det t a (infiammazione cronica della sola mucosa della ca.ssa. e della tuba), comepure quelli che presentano perforazioni marginali DE'lÌ siti ora. indicati, perchè le les ioni ossee, di cui queste ul time sono l'esponente, sono d'ordinario in tali casi limitatE' all'anello ti m panico e quindi circoscritte esuscettibili di guarigione n e l periodo dei rimandi.
Per contrario, dovr eb bero essere ;enz'al tro riformati i portatori di perforazioni estese e mm·ginali nel quadrante pos tero-superiore della membrana. timpanica propriamente detta e n e i tre segmenti della mero-

llG J.E: l'f:RFORAZIOX( TIMPANICHF: 1',\TOloOOIClJJoj
• .
b rana di Sbrapn ell, perchè data la tenacia e l a fa cile recidi vità. de lle l esioni, ch e ne :ton o caus a , ed inoltre la necess ità. d'interventi opera ti vi, che alterano spesso anche in modo grave e permanente la funzione acu· stica. robbligo della rivedibilità si dimostra ne lla pratica un p rov vedime nto costantemente inu tile ed insufficiente nou solo, ma d'ag gravio al bilancio, di danno al buon reclutament•J e d'ingomb rante agglo meramento alle gi à a tfollate sale dei r eparti d'osser vaz ione d egli ospeda li e dei Consigl i di leva.
Io sono intimamen Le convinto che sarebbe desiderabile che r elenco de lle i nfermità. stabilisse senz' altro come causa di ri forma le olili "lerlie purulenle cmniche, se complicate ad infia mma:;ioni dell'attico o dell'ant1·o mastoideo, o a lesioni ossee estese, ovve/'0 quando siano di na lut•a colm·e e colesteatomalosa .
N el lib r o d ell'Ostino è rip ortata l'opinio ne del generale medico tedesco Villaret, il quale n el 1899 non ha trovato a ltra plausibile ragi one del co ns tat a t o aumento d elle malattie dell' orecchio nell'esercito t ed esco se non nel fatto; che dal 18S2 in poi erano stati ammessi individui con perforazioni asc iutte. E per contr o da un'inchiesta sulle m alattie d ell'orecchio esegui ta nell'egercito austriaco nel triennio 1897-1899 d a qu e l Comitato di sanità. mi litare s i può fra le al t re t rarre la d e duzione, esse re esagerato il pericolo seg nalato dagli otoiatri, che sotto l'in f1ue n za delle ca use mor bose inerenti alla vita militare le per forazioni asciutte della. membrana t impanica siano occasione alla. riacutizzazione dei processi pu r ulenti già estin ti dell'orecchio medio {Gi01·nale lltedico del1·egio esercito, gennaio 190'2, pa.g. 93).

D n ostro e lenco delle infermità passa sotto silenzio tali speci e di per· fora.zioni, quindi van no giud ica te secondo il grado d ella. diminuzione dell'udito a cui talo ra si accompagnano, cioè in base all'art. 60.
Però presso altri Stati esse sono prese in considerazione esplicitamente:
Da nima,·ca: « L'otorrea. cronica con perforazione permanente del tim pano causa l'inabilità completa al servizio militare ,. .
Nor·vegia : « L'otorrea cronica e la p erfor azione per manente del t impano causano la r iforma. ».
Get'mania: « La perforazione per manente del timpano rende in a.· bile al servizio ». ·
Austria: « ..... Del pari (rende inabile al servizio ) la p erforazione per· manente d e l timpan o, esistendo ancora o essendo già cessato il p r ocesso morb oso che ne era la causa ».
IN RAl'I'ORTO Af, SERVIZIO MlLI'l'AitE 11 7
*••
ft'J·a ,u; ia: «La perforazione d el ti mp ano senza otorrea è compatibile col servizio ausiliar io :t.
Dopo le considerazioni g ià. d i so pra. esposte circa l'influenza delle cause reumatizzanti , circa la possibilità non t·m·a dell e i nfezioni dallo e;;te rno, c infi ne circa la frequente di d i minuzione de ll"udito, agg ravat a. dall a necess ità di po r tare costantemente lo stuello di cot o ne, che hanno gli indi vidu i portatori d i perforazioni timpaniche asciutte, io non esi to a dichiarare che esse dovrebbero motiv are l'inabilità p ermanente, in ispecial modo se estese o coesistenti con affezioni croniche anche l eggier e del naso o del faringe.

Genova, luglio 1902.
B IBL I OGRAFI A.
Lf:uTF.nT. - \l'elclmi :>tuudptmkl diil·[rn 1cir j et= in d er FrorJr drr T l<eropie cli t·otl f ;c li et· ll illtllllu·eit rrutl!l"' ·
) I ULLI:R. - /Jedfuhmg bestimmler T rommcl[ellper(oralìonen. CAre/ti v fu•· 11/irwhtilku ncl<', ' oL fnsr.
r. or.n..:. - f"tl!f r f.11rits der (;eh .irkuoch t l cht11 ( V. Rcsocou to u e lla Z ef lrclm (t (iir w l. 3H, 26!1).
1.. OI.AU- - B ncykl nf>•Hi i e dtt· 0/trtnhtllktm d t, 1!100.
F'. - L r m•alflll l • pt·o[ts!ionoli dell'o r uchio tlti 1oldatl. \\'tosha•lrn, 190!
1( l.r,_ - LtrOtl tu•· les &11pfi!U'Illious de 111 0!/WIIt ecc.
O'Til\0 - l rnltrl o lfr rn i d i wr11 dtll' ol i le medio o·onitll. (f.iortt alt tlltdlco d t i e>rrc,to, (t•hhr;un t !J()t ).
Gft At71. - l'tr{oraziot n lit11Jl<l lllcl•e.
\JR nO ,YI. - lltlldunulo t li111ro ( 4 •cll. llol 0101. , '01. X' la<r. t • e 2>1 l i )IARGARI A - Rtlldtcmtlo clmico tla :utuo. llal. Olol. ' 'al. IO". fa< c 3•).
S. G B:-.TA. - llts,routo sta tulito clwaco dall'anno 1894 al 31 dicembre C:eno,n, 190'!-
A. Beuoccn10. - Sul volvre ecc. della sede ddle p er (vra:lom dtlln membrana d ti IImpaiio, er e. 1901 (<'en t o ehniri).
\'. l't:IIER)I "s. - L fl afftclious d e l' oreillt. dts maladltl d t l'orrillt, anno t !lO<l. (In m 11. - ln flutllz a delle ••lundt almo,(eriche sull' or!J<JII O dtll'wlilo olio slul o d i sa u lla c di rn •tlaltìa, t 8Qi.
C. 811:111 - t:•ca lr• =:az i on•• d1 f!U(ora :ioni drllo memlirantt 'dtl timpano. ( Arc/1. /lal. 0/oiO!f. , '0· lume !l", 1900)
CA< n ;x - Le• mtdu ln t ltg(l/t clans lfl dt l'ot·e•lle, ecc Wull elitu et flt t mol r u de l o S of?rt lllrt<ÌBf d'OIII(O!JiC, tmnt• X l!Il.
Il. C:r.A<ll'l: - A {fectiOlu dt l'orti/le et ap11111de mililair e. ( ll!dlel itrs ctr., parte Il Jlll;:. 10 1110 X lii, 189it.
FEnn s n1. - ctiflfJI!OSi della ll•ber colosi nell e cr uurchc d ell'ar eccli i o I A rclt. Ilo!. Ut olo(/. , vol. X. 2•1.
C:. SKI:CIII. - La /Ì II rstt·a r otondo é l cr An l a v i a pel suotd dllll'tll·in o / lt:birllliO, Torl u o, 1!)()2.
''· ZIIIII>' IUI ANN - Ltr fisiologia. tJ •II'o•·aau•t t An •11rtes de• m t1 l nd ie! tle l'o;·,•lllt. er·r., t :\01•. pnrtc t, 11 6).
118 LE PERFOR.\ZI0.:-1'1 TIMPA:\ICR E PATO'LOGICIIE, ECC.
SOPRA UN CASO DI
Essendomi occorso di osservare n e ll" os pedale militare di Parma un caso di pm·amiocl ono a ccompagnato da access i di natura istero epilettic a, la cui comparsa è in rapporto a malatt ia di natu ra mi crobica, ho creduto bene di espo rn e la storia piuttosto dettagliatamente, prese ntando essa occasione a considerazioni speciali dal lato non sol o d e lla eziologia di detta manif estazione morbosa, ma di altre ad essa affini che in questi ultimi tempi hanno d a to luogo ad esp erienze e ricerche che gettano un po' di luce su questo campo.
P... Lucio di anni 21, della frazi one di S. Vittore comune di Salsomaggiore, celibe, contad ino, :figlio di ignoti, non sa dire nulla delle malattie sofferte nella prima età. Ricorda che sui 12 anni abitando con la famiglia che lo allevò, ebbe a soffrire duran te l ' inverno di dolori alle ginocchia senza però notarvi ingrossamen to e che tali dolori erano stati cosi intensi da obbligarlo a letto per 20 giorni circa. Migliora to senza soccorso nè di me dici nè di medicine, potè solo ripr endere i n modo completo il suo lavoro nel mese di maggio. Nell'inverno successivo, i dolori sono ricomparsi meno intensamente, p erò, tanto da poter accudire a piccoli lavori: non ha avuto mai febbre.
A. 16 anni a mm a l ò di .polmonite d estl'a, della quale fu curato per 24 giorni circa n ell'ospedale civile di Borgo S. Dannino; durante tale malattia si sono iniziati i disturbi motori alle gambe che al presenhe 5Ì notano. Ricorda che or sono due anni; in un mezzogiorno di aprile e senza causa che lo potesse spiegare, fu colto da un accesso, con perdita completa della coscienza, tanto ch è nello svegliarsi si meravigliò di trovarsi a letto assistito dalle persone di famiglia; da quella vo lta sino al 26 aprile dello scorso anno non ha avuto più convulsione alcuna.
Nell'anno 1899 durante l'estate recatosi a. Salsomaggiore per la. cura. balneare che gli aveva consigliato il medico, in causa. dei dolori alle ginocchia da cui era. tormentato più o meno intensamente nella. stagione invernale, fu obbligato ad interrompere i bagui, non risentendone alcun

lliJ
ISTERO-EPILESSLl Prr il d ott v r PieCro t;;iaai, capitano m••l ico
giovamento. Venuto sotto le armi nel dicembre dell'anno 1900 perchè assegnato alla cavalleria, il giorno 17 fu inviato a questo ospedale milita re essendo affetto da angina catarrale 1 accompagnata. da dolori all& ginocchia; vi rimase per 74 giorni; durante tal periodo fu cur.a.to con salicidato di sod a, ioduro di po tassio e massaggio. Non avendone risen t it o che mediocre g iovamento e continuando ad a ccusare i soliti disturbi, fu proposto a rassegna speciale e mandato rivedibile. Ripre · sentatosi nel marzo successiv o al distretto militare di Parma, ricoverava nuovamente in quest'ospedale per dolori all'articolazione delle ginocchia ; il P non accenna che abbia sofferto di altri accassi convulsi vi.

E same obbiettivo. - Nutrizion e g enerale buona.; colorito roseo. Cranio a tipo brachicefalo co n leggera plagiocefalia sinistra; sulla fronte vi ha una piccola cicatrice dovuta a scottatura essen do caduto nel fuoco durante il primo accesso sopraricordato. Nessuna stimmata dbgenerativa di qualche rili evo nella sua persona: organi della circolazione e del respiro normali. L "addome trattabile senza traccie di tumefazione anormale, presenta il fegato e 1a milza nei confini a loro spettanti. Le orine nulla. offrono di caratteristico essendo p er quantità e q ualità normali.
Sistem a nervoso . -Nulla si rileva a carico dei n ervi cranici; intel· ligenza e percezione in armonia col grado d'i struzione dell'indivi du o, non esis t ono tic. La visione s ia monoculare che binoculare si compie bene, solo si ha una diminuzione leggera del cam po visivo; i cqlori sono ben percepiti anche nelle sfumature. Le pupille ampie ugualmente, reagiscono egualmente bene allo stimolo luminoso. Gli arti snperiori so no ben sviluppati con muscolatura valida e pannicolo adiposo d iscre to T ono muscolare uguale d'ambo i lati, i movimenti anche i più minu ti e delicati, si eseguiscono regolarmente senza essere accompagna t i nè da scosse n è da tremori; n ess una alterazione nel senso muscolare èd in quello di posizione degli arti; la forza dinamomett rica è nei limiti fi. siologici d a ambo le parti. N or mali i riflessi cutanei e tendi nei; nessun d isturbo vasomotorio ed il P... non accenna a speciali sensazioni. Il ri flesso addominale e il cremasterico sono alquanto esagerati.
Gli arti inferiori pure c on sviluppo regolare non presentano nulla di s peciale nell'atteggiamento loro quando egli giace su pino. L ' articolazione del ginocchio destro è ingrossata alquanto più di quell a. di sinistra e tale ingrossamento è più a carico della sua. parte inferiore, cosicchè le fossette rotulee sono appe ua accennate ; però i movimen t i sia attivi che pas!'li vi si compiono in modo normale d'ambo le parti. La pelle di colorito normal e è facilmen te sollevabile in pieghe, il senso muscolare non alterato. Non sono al terate le varie specie di sensibilità,
120 SOPH .-1. Cl\ (' ASO O r
così la reazione alle correnti faradica. e galvanica.; però la eccitabiliti\, elettrica appare alquanto maggiore ai muscoli addominali ed alla radi ce degli arti inferiori, non potendosi dir nulla. a. riguardo delle ginocchia e delle gambe, perchè ogni esame viene interrotto da tremore a scosse che descriveremo in seguito.
L'ammalato è facilmente impressionabile, si commuove e piange per un nonnulla; non esistono zone isterogene. Se si cerca di provocare il riflesso rotuleo colla percussione o il clono del piede o semplicemente di saggiare la sensibilità. dell' arto ed ancora se lo si fa scendere dal letto, tosto insorgono oscillazioni ritmiche, cloniche che dapprima len te . vanno aumentando man mano sino ad aversi un tremore continuo che si propaga, però con intensità. minore, a sinistra e che dopo aver raggiunto un ma.r.im u m va gradatamente scomparendo. Tali di contrazioni ritmiche, oscillatorie antero posteriori e che nel loro acme n si estendono anche al tronco, sono dolorose, perohè l'ammalato piange e cerca ogni motivo per evitarle, tanto che egli incede a rilento, circospetto, quasi barcollante e si appoggia al muro. La volontà n on ha azione alcuna su tali contrazioni che si destano pur anco toccando il piede coperto, stando l'i ndi viduo a l etto. Nell'insieme le oscillazioni ' descri· vono una parabola, il cui punto culrpinante rappresenterebbe anche il loro di int-ensità.. Esse du rano dai cinque ai dieci minuti secondi, ma cessano più presto se ne è distolta l'at t enzione ; durant e il loro succedersi nè gli arti nè il corpo assumono alcuna attitudine passionale o posizione speciale. Il gion:.o 26 aprile mentre il P ... trovasi seduto in giardino, d ' improvviso e senza emettere al cun grido, cade a terra e, chiamato d'urgenza. il medico di guardia, ques ti potè constatare, perdita incompleta. della reagendo a sensazioni dolorose ed a dolori forti e provocati, midriasi notevole con reazione pigra allo stimolo luminoso. Il bulbo ocular e ruotato in alto: le palpebre animate da ammiccamento; il riflesso congiunti vale conservato; la. bocca chiusa fortemente e con le labbra cope rte da. lieve spuma; il riflesso addominale e cresmaterico scomparso il clono del piede. Tutto il corpo si manteneva. rigido, disteso, scosso da. tremore continuo e di tanto in tanto subentravano cont razioni toniche dei mus coli del dorso e della nuca così da. piegare ad arco il tronco. Polso pieno frequente; respiro rumoroso. I toni del cuore normali ma accentuati. T a le accesso durava dieci minuti circa. ed il ritorno al benessere era. piuttosto lento. L' ammalato si ricordava. bensì dello iniziarai del male, ma. nulla invece di quanto era accaduto nella. sua. durata; lo :;vegliarsi non fu seguito né da emissione di orine o sperma nè da. poliuria e la lingua non offriva traccia di morsicatura.

CON ISTERO-EPILI!:SS iA 1:!1
Le orine esaminate subito dopo l'accesso non contene"'an o uè albumina nè glucosio. i fosfati erano alquanto in eccesso.
Nei giorni successivi compar vero di bel nuovo accessi di tal natura, aumentarono di frequenza, a cquistando un deco r so sistematico così da s ucc edersi ad intervalli regolari ad es. a lle tra del mattino, alle 9 ed alle 15 di ogni giorno, sempre con la stessa fenomeno l ogia. Essi possono pur anco ripetersi dietro lievi emozioni e specialmente è da notarsi, che basta pe r destar li la presenza del medico curante nelle sale degli ammalati anche quando non sia veduto dal paziente. I nterrogato sull' esordire delraccesso egli risponde che questo gli è preannunziato da un senso di oppressione al petto pe r cui si sente venir · meno il respiro, gli si oscura la vista e perde in tal modo la. cono· scenza.. Le varie cure tentate specia lmente coll'uso interr.o di bromuri non apportarono giovamento alcuno; que lla. coll'ipnotismo proposta fn rifiutata dall'ammalato; perciò avendo anche il soggiorno nell'ospedale indotto in lui un certo grado di anemia, fu proposto a rassegna per l a riforma e così dimesso il giorno 6 maggio, dopo es· servi entrato il 3 aprile.
Il caso or a descritto potendo presentare qualche d ubbio se non d i simulazione, almeno di esagerazione, in special modo per quello che ritlette la natura. degli acoJessi convulsivi, venne tenuto in sospeso per la sua comunicazione affine di aver prove sicure se i fa t ti sovranunciati continuassero, e difatti informazioni a,;sunt.A rla fonte attendibile e da persone competenti, nel lugl io e nell'ottobre ora scorso, sono a confe r· mare che il P va tuttora soggetto a convulsioni e che ultimamente ricoverato nelrospedale civile di Borgo S. Donnino p er ferita riportata. in rissa, venne colà per due volte colpito dai soliti accessi.

Rispetto poi al tremore notato mi si permetta di dubitare che, da t e le condizioni intelle ttuali, la professione del paziente, è molto diffic ile per non dire impossibile che egli abbia potut o ri correre ad un tal genere di simulazione che importa una. mente assai più elevata e cond izioni speciali di coltura che nou era lec ito supporre in lui.
Ciò premesso, nel caso presentato dal P .. . parmi poter ammetter e che si trattasse di pa·ramioclonio accompagnato da accessi epileltifm·mi, nè cred o potesse tale forma confondersi con altre affin i . Casi simili vennero descritti da molti e per non citar nomi forestieri accennerò a quelli riferiti dal Murri, dal Verga. e Gonzales, dal Seppilli ed ultimamente dallo Schiipfer, la cui descrizione meglio si attaglia al nostro caso, dove e il modo d 'insorgere dell'accesso e il suo decorso farebbero anzi pro· pendere tratta rsi più di una forma di natura istero- epilettica. L a man· canza però di dati a namnestici, il tempo relativamente breve che fu
l:H CAS O DI
all'ospedale, i pochi mezzi curativi tentati non ci autorizzano ad asm·iverla alla. fo r ma descritta. dall'Unverr icht cioè di mioclonia famigliare con accessi epilettiformi alla quale vuolsi assegnare un posto speciale nella patologia nervosa.
S'ulla sede delle lezioni anatomo pa t ologiche d elle mioclonie, diverse sono le opinioni, e mentre al cuni come il Murri ammettono una loaalizzazione cerebrale nella zona motori a, altri in vece propendono ad ascriverle quelle della parte ante r iore del midollo spinale, come lo confìrmerebbero le esperienze del Turtschaninow a mezzo di avvelenamento negli animali con sali carboli ci. L'epiless ia che venne osservata come complicazione alla mioclonia non potrebbe esser considerata, come da molti si vuole, quale complicazione causale ed ammettendo per epilessia l'originE.' c erebrale e pe r la mioclonia quella midollare, si po t rebbe nei casi combinati pensare che il processo morboso abbia oltrepassato il confine del primo neurone e forse più propriamente abbia cominciato nel secondo neurone e si sia poi esteso al primo: quindi meglio converrebbe che in tali casi la sede della lesione s ia n e ll'asse cerebro-spinale.
Di fronte a tali asserzioni, da altri ricer ca to ri e t ra <] Ues ti dal Friedreich nessuna lesione fu ri sco ntrata n ei centri nervosi ed è perciò che co me eziologia della mioclonia. venne r o messe in campo come causa lo spavento ed al tre neur osi (neurasteuia, isterismo ); mentre altri ancora appoggiandosi alle esperienze d e l Turtschaninow ricordate avendo trovate contrazioni fibrillari analoghe in malattie di natura infettiva, co me nella malaria, nel tifo, nella difterite, la farebb ero dipendere da fenomeni tossici ; come sono di natura t ossica le mioclonie che si hanno nella. uremia nella intossicazione di piombo, ars eni co e m ercurio.
La mioclonia. quindi non cost ituirebbe una forma nosografica s peciale ben definita, ma non sarebbe che un sintomo di altre malattie e come vuole i l Rey mond, sindromi che si sviluppa no sopra un fondo di dege nerazione neur opatica ereditaria od acquisita e che dipendere bbero tutte dall'isteria. In questi u l timi tempi però in cui la patogeuesi d elle malattie ner v ose va acquistando nuova luce e nuovi indirizzi, mercè p11zienti ed abili ricerche istituite da coscienzios i osservator i e che una par te delle lesioni che prima si cred evano si ne rn. atel'ia e puramente d'indole dinamica vennero ris contrate in relazione ad alterazioni materiali d,el sistema nervoso centrale (cerve llo) da microorganismi piogeni 1stafùococco piog. aureo, diplococco di Fraenkel, streptococohi...) ed al riguardo vedansi le osservazioni di T ribonlet, Eberth, Meyer, Cesa.ris Demel, Guizzetti, Singer; sono di opinione che all'iste ria. bisognerà p er l'avvenire assegnare un campo sempre più ristretto come produttrice dell e contrazioni mioclonicbe, mentre l'azione di agenti patogeni spe-

CO); l STERO·El'ILESS'I.I 123
ciali e l oro v eleni su date parti del s is tema nervoso cere bro- spinale-, v arrà a s piegarne chiaramente la eziologia e sarà. possibile in tal modo una classificazio ne di forme ner vose nosografiche che ora so no con fuse con altre ben diffe r enti.
Ritornand o al caso no'>tro, abbiamo che il P .. . na to d age u i t.ori ignoti, epperò in cond izioni che posso n o fa vorire o determinare una er editari età n ervosa speciale (senza escludere che uno de i g enito ri stessi potesse essere o epilettico od a ffetto d a n e r vosi affini ) ammalò a. 16 a n ni di polmonite destra e che fu durante tale malatt ia che si svilu ppò il paramiocluno. Che nel 18 97 venne colpito da un accesso di p r obabile natura epilettica e che lo scorso an no,v enn e ro presenzia.ti da m edici d el ros p edale militare ripetuti accessi di natu r a indubbia istero- epilettica. Che dalla età di 12 a nni s ino all'epoca di n ostra osserva zione andò ri petutamente ad attacchi di reumatismo articolare. e ne fan fede le alterazioni che s i riscontrano s p ecialmente al ginocchio destro.
Da. tali effetti è lecito ammettere che l'agen te che h a dato luogo alla polmonite o i suoi prodotti, si sia localizzato alle parti motorie del midolio spinale ed a bbia dato così origine a l paramioclono e che il r e umatismo arti colare ne abbia coadiuvato non solo le sue manifestazioni , m a colla s ua insistenza d eterminata la propagazione del ce n tro spinal e all a zona motor ia del cervello, di qui gli accessi epi lettiformi in sogg etto co n sistema nervoso forse ereditariamen te predisposto e favo rito da. condizi oni speciali, n on ulti me quelle della lunga d egenza n ell'ambiente dell'osped ale militare.
Ma ques t a. è semplicemente un'ipotesi, ohe, se bbene abbia probabilità p er i ris ultati d ell'es perienza del Guizzetti e di altri sop ra cita.ti e per le a.llìnità. t r a la corea, la mioclonia. e simili processi m orb osi, pure ha bisogno di esse re suffr aga.ta da da t i di fatto, i quali, a quanto mi costa , fi n ora. tra polmonite, reumatismo a r tico lare e mioclonia.

J :.H :-.•II' HA l ' S CA:-0 D I I'Af{.\MIOCL 0:'\0 COS I S1'EH'l El'!l.E SSI.\
RIVIS TA MEDIC A
Dottor GIOVANNI GRJXONI, t enente medico mil itare diL& Clto41agnoal. - Rivi sta sintetica c ritica.
l so ttili mezzi cl'iudo g ine, fo r nitici dalla fisica o dallo. chimica, llanuo r eso solo certe diagnosi etiologiche p r ecise e raftìnale, chr , tino s poco tempo f's , erano appena m odesto aspirazioni.
La più r ecente delle con(jui;;te fatte dalla medicina in qu ('s t o campo è l a ci t odia g nosi, fondata sulla valutazione d egli elementi cell ulari rinv enuti nei \'er l"a menti 11ier o si.
Le riCtl i'Cl1e, che prese ro le m osse ùai cel ebri !avol'i di Ehrlic h sulle div er se vari eta di glolJul i bianchi, furono dapprima frammentaJ•i e, incc 1·te, sl egate. Già Ehrlich s t esso nel · t RQi! aveva con s tatato la p r esenza di !euco citi mononuc!ear·i nelle pleuriti in seguito \Veolwo•·th, nel '1896, rinvenn i', nel liquido cefalo-rachidiano dellE' meningiti t ube,rcolari ,lmfoc•li e qualcl1e polinu· cle ato, e, nel 18!'li, Bernheim e M oser cons tatarono, n ella s l e!>sa a ffezione. la pr esenza di m ononucleali e, qualche volta, di polinucle ali, come n ella menin· !!ile cer ebro-s pinale ac uta.
Da queste osser vaz •oni gli autori n on tras sero alcuna illazione, perciò cadd-?ro in oblio.
Contem poraneamente Korczyri ski e \Vernicki, dopo lun ghe ed accurate iodu ini, intuirouo il ropporlo esistente fra l'etiologia di un ess ud ato ed 1l va1•io modo di degli el ementi morfologici, e proposero d• utilizzare, per la diagnosi dei v <• r sa m enti pleurici e peritoneali, lo studio dei gtobull bianchi. E"si riten n ero l!h e i pl eu r ici semplici c ontenevano, qua ..i l'SCI usi vamen t e, linfocili, m eutre quelli con tencleuza alla suppurazione, in prevalenza, po· li nucl E> ati. Wiuiar scki insistello anch'esso sull'importanze dei linfociti nei v e•·:si ero;.:i.
A ques ti autori quind i é do vuto il merito cl elia scoperta di ques to uuovo mezzo diagnos tico, che uelle l oro mani diede ri sullati c onform i a I)Uelti riferiti dal!'l• osl'e r valm·i successivi.
Wid91 e Ravaut, moltiplicando l e ri ce rche , ne ri cavarono un processo ge nerale di es plorazione, utilissimo alla clinica, che c hiama r ono citodiag-nO!li (giugno 1!)00)
L e diverse specie di globuli bianchi compiono nell'o1·ganismo funzioni mull•ple importanti, sin nello !>lato fisiologico che io quello patologico: essi con -
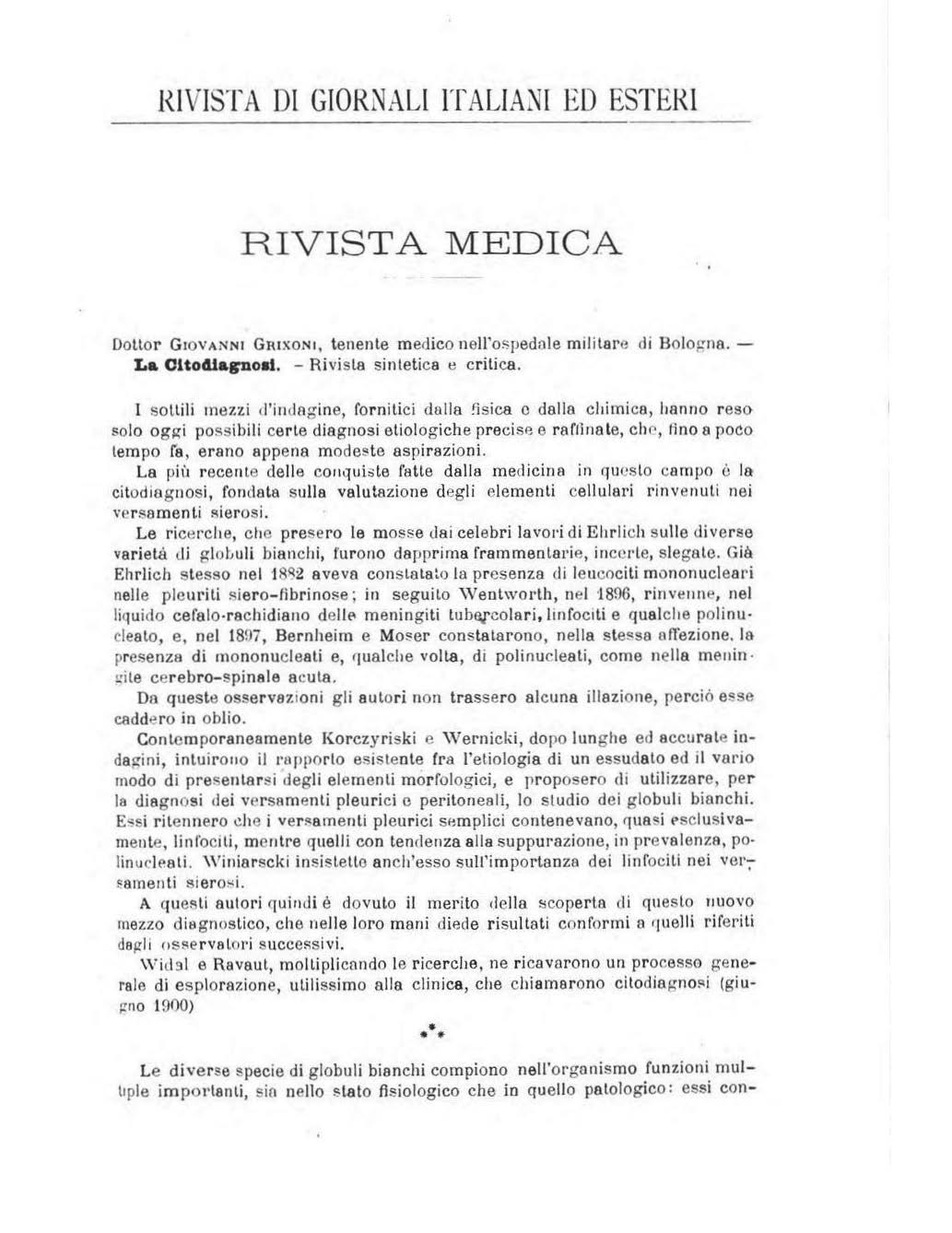
RI VISTA DI GIORNALI rr ED ESTERI
• • •
corrono alla uutrizioue dei no!'mali ed alla difesa dell'o•·ganismo malato, distruggendone i veleni ed aspoetando i detriti nocivi, inerti e vi venti, che l'ingo mbrano.
La funzion e di lotta e di difesa di f{Ue'<li va ri elementi cellulari è diversa, <li verso f{uind i è il significato d ella •·eazione leucocitaria nelle malattie. Sebbene n o n si sia ancora in g •·ado di attribu ire un valor·e preciso a ciascuna formula leucoci lica , è pe r ò assodalo che i poli nucleari neutrofìli o microfagi sono i veri agenti di dife!'ia dell'org-anismo di fronte ai microbi, specie nelle infezioni acute (st1·eptococco, pneumococco, ecc.). l mononuc leari o ma crofagi cont ribuiscono alla pulizia del l'o rganismo, inglobando e dislrug'gendo tutto ciò che è in via eli atr·of!a o di degenerazione, ed inollre ese•·citano un'azion e fa)locilaria sui parassiti piu volumiuosi e su quelli delle infezioni croniche (lube rc olosi, malaria, ecc.). l linfociti non hanuo alcuna propri eta fagocitaria.
nli eo;;inofìli no n hanno, r•·obabilme nte, una funzione attiva ne l la difesa dell'o r ganismo, essi sarebbero, piu clte altro , testimoni della salute.

La presenza perciò di uno o di un aHro elemen to cel lulare in un liquido patologico J epooe pe r la natura dell 'ag@n te patogeno provocatore. Nelle malal· tie acute. dove la reazione di difesa locale dell'organismo verso un ge rm e è intens a, si l' itrovet•anno, quasi esc!usivamente, i polinucleati, mentre invece avranno il predominio i monuclea r i ed i lifonciti n elle malattie dove la reazione ù debole o quasi nulla.
Su questi dali ha il s no fondamento la citodiagnosi.
Allorch é si vuoi procedel'e all'esame citologico di un essudato o di un trasudato è necessa1·io raccoglie re asetticamente par·ecchi grammi del liquido, e tosto centrifugarlo per 3-5 minuti.
In gene rale l'esecuzione immediata di questo pl'oce:<so l'ispa rmia la defìbrinazione ciel liquido stesso , il quale tiene, alle volte, impi gl iali nelle sue mag-lie tlbrinose g li elementi figu ra ti, sopratutto i polinucleari, J' e ndendone difficile ed im perfetta la se parazione, e, per ùi più, im pedisce che gli elementi citologici subiscano col delle profonde alterazioni.
Il sedimento vien raccolto e disttlso su vetrini copi'ioggelli, f{Uindi seccato , all'at'ill, o flssalo cou alcool assoluto ed ele•·e a parli egua li. Ho potuto constatare che pe1· la citodiagnosi il miglior liquido fissatore é quell o •·icordato de l Nikifo•·oiT; g li altri liquidi usati in tl matologia mi hanno dato risultati meno netti, come quelli che infatti se1·vono sopratutto a metter in evidenza proprietà 'od altet·azioni speciali de lla parte corpuscolare del sangue. I prepa r al i si colorano preferi bilmente con la tionina, che si fìssa sui linfociti meglio ancora de il'ema leina.
L'esame citologico è ora praticato, a scopo diagnostic o, su tutti gli essudati e trasudati.
Numeros i osse rvato ri hanno tentato stabilire speciali formule Jeucocitarie per ogni malattia, ma l'accordo non è completo. Non é inutile perciò determinare lo st.nto presente della questione e rilevare quanto ci sia di definitivamente acquisilo al la scienza, e quanto abbia ancora bisogno di ulteriori conferme.
12G RIVISTA JI!EJ)lCA
\
•••
•"•
R ia ss um o i ri s ul l.a ti de gl i e sami cilo lof!ici nelle div e r se malatti e : PLEURITI.- Di una pleurite siero-fìbrinos a riesce o ltremodo difficile stabilir-e r etiulogia. I clinici france s i riteng o no q uasi unanimame nte, c.lopo Land ouzy, che tutte le pl e uriti primitive, c osì delle a j'ri{lore, sono di na tura tub e rcolare . Ques to ass olutismo è combattuto validam e nte, f1·a g li altri , dal Muragliau o. l repet·ti anatomo-pato logici e le s tatisti ch e non riu sciro no a de cid ere la controvers ia. La patolo gia veterinaria arruffò ma gg iorme nte l' inu·icala matassa: i i cani e le c he son o c o lpili spesso da ple ur·ite r e umati ca s ierotìbrin osa so no, fea gli animali domes ti c i, i meno s ogge tti all'iufe zi on e tub e r · co lare.
P e r decide re pt•aticamenle una ques tio ne che d e ve s ervire di fon dam e nt o ad una c ura razionale si e s cogitarono perc iò d ive r-si mezzi.
C hauflard e Gombault proposero rìniezi o n e ui e ss udato pleur ico n ella c avità peritoneal e di animali s us ce tlivi tli co ntrar1·e la tub e rcolosi; i risullali JW l'Ò n on son o decisivi, perc hè come l'esito n eg a tiv o non nutor izza ad esclude re, i n mo do a ssoluto, l'infe zio ne tube1·colat·e, e sse nd o vi altr e caus e che. attenuan d o o dist t·uggl: n do i b&cilli di K o ch , possan o fal s a1·e il repe1·to, c osì il ri!:'ultato posi tiv o n e lle ca vie é d'u opo s ia multi plo pe r e><se r ra s>' ic urant e .

Anch e le iniezio ni d i tub ercolina ne g li infermi insufficie nti , pe r c h è devo n o e sse t· fatte su sog g e tti a pirellic i, c io ch e s i p uò aver di rado, e cl inoltre perché non può sempre dimos t1·ars i c he la r·eazi one feb brile sia do vuta ad un foco laio pleul"i co.
N è g aranzie ma g gio ri dà il me todo d elle colture : il bacillo d i Ko ch, s•··mpr e scars o nell' e ss uòalo , può non s vilup pars i perc lt è atte nuato o m orto , oppu r e pe r c hè s opraffatto u a altri g ermi.
La quantità d i fibrina, invocat a com e au s iliario alla d ia g nos i, u o n dà r is ulta ti s oddisfacenti , av e ndo le pit't re ce nti rice r che d im os t1·a to c lte essa é, s pe · cia l mente, in rapp() rto con la inte ns ità d ei fenom e ni infiamma to ri.
La crio s co pia , la diaz o reazion e ed il c r ite rio de lla p ermeahilita pleurale s i pale sarono insufficienti od inutili
La s t essa siero-d iagnos i non può fo rnirci, pe r or a almen o , un a p rova c erta .
La c itodiag nos i invece ci forni sce ammaes tra menti d i valore m ol to piu g l'llo de Inol tr e la sua tecnica é semplice, facil e , cele r e e d a ssolulflmunte innoc ua .
Ne lle pleu riti t u be reolar i la fo rmula cito log ica è caeatterizzala da lla preva· len za a ssoluta dei linfociti s u gli altt·i e le menti ce llulari.
Widal e Ravaut, fin dai pt·imi lavo ri, osservarono che nelle pleuriti s ierofib r in ose s emplic i, prirn i lioe (ple uro-tube rc olo s i di Landouzy) si rinv e niva qualche ra r a cellula endo tel ial e , polinucleari (2 %) e numero:>issimi linfociti mescolati ad eritroc iti. Al co nlJ•ario ne lle pleuriti secon d arie dei tubercolotici si osservano abbondanti polinucleari. Que sta ultima formula però non e an co ra definitivamente s tabilita. Ravaut s tesso divide le pleuro- tubercol osi secondarie in due c ateg orie: que lle pochissime con te ndenza alla gua1•igio ne, ne lle quali il reperto cellulare è ide ntico a quelle della pleuro-tube rcolo s i di Lan·louzy ; e quelle. piiJ numerose, a decors o ct•onic o, in c ui i polinucleari, per la ma ggior parte, s i alterano e poi d iminuiscono continuamente di num ero. Nei du e cas i la differenza essenziale risiede, secondo Barjou e Cade, nel fatto che nella tubercolosi primitiva della pleura i microfagi solo al principio, e p oi scompaiono quando cessa la reazione infiammatoria di cui erano testimoni. Se esistono ltlsioni polmonari invece, sopratutto ulcerative, i polinucleari per-
RIVISTA MEDICA 127
indefinitamente nel liquido. l cile si trovano nelle pleuriti primili ve non rnppresenlano, secondo T a r chetti e H ossi, una fnse di delle cellule epiteliali della siet·osa, come sostengono W olfl' e PatellA, ma devono esset·e r itenuti, almeno per la gran come veri linforiti.
L'e5'ame dell'essudato è opportuno farlo a più ripre:;;e ed in epoche diverse, potché u n solo eo:arul' può in errore. Può accadere infatti. che al ori nrip!o di una tuberco losi pr tmitiva della pleu1·a a hbia no lA pr evaltmza i polinue fin le rell ule endoteliali, che pet•ò, in b r eve, si dilrguano, quasi del tullo,la"iciando il campo ai li n fociti, che aumentano in senso inver·so. In questa r.wma l e cift·a dei linfoctti ct·esce a misura che ci si allon tana du ll'inizio dellll pleu1•ite, e diviene immutabile dopo ltt 3" Qutndi solo la fu r mula ci· che si olli••ne dopo quest'epoca autor izza a fAI' dtagnosi.
Le ple uriti intlammalorie sono caratter izzale dall'abbondanza d t alementi polinucl eari.
L P variazioni IJUAntìtalive esistenti n elle divH r se specie di tal i affezioni non infit•mano l a rego l a g-ener ale
l polin uc l eori so no abbrmJanlissi m i e quasi unici nelle rare form e di pleu · r ite st r eptoeocc11:a; meno numerosi (50-!lO o;.), ma ca ra tteris ti ci, nel le ple uriti t(foidi. Qui tal u no ha osser vato Jei rno nouucl ea ri abbo n· dan ti e t alvolta' deglt i n pr opo r zioni notev ol i Nelle p l eu r iti pneu.mo· niche i polinucleari sono ,accompagnali da csllu l e enuoteliali isol ate o sa l date in ammoRsi.
P are ch e d al numero degl i el emen t i polin ucleari si possa trarre qual che cr·1terio esse ndosi osse1·vato c he quando la malattia t ende a guarire si ha una dim inu zione di '1'11 li fatti non sono ancora definitivamente s tabiltti.
K el r eumatismo pleurale J arvis osservò due for m uli>citologiche: nella pleu· r ite reumatica, conseguenza di uno stato iufìammator1 o d el polmone rinvenne
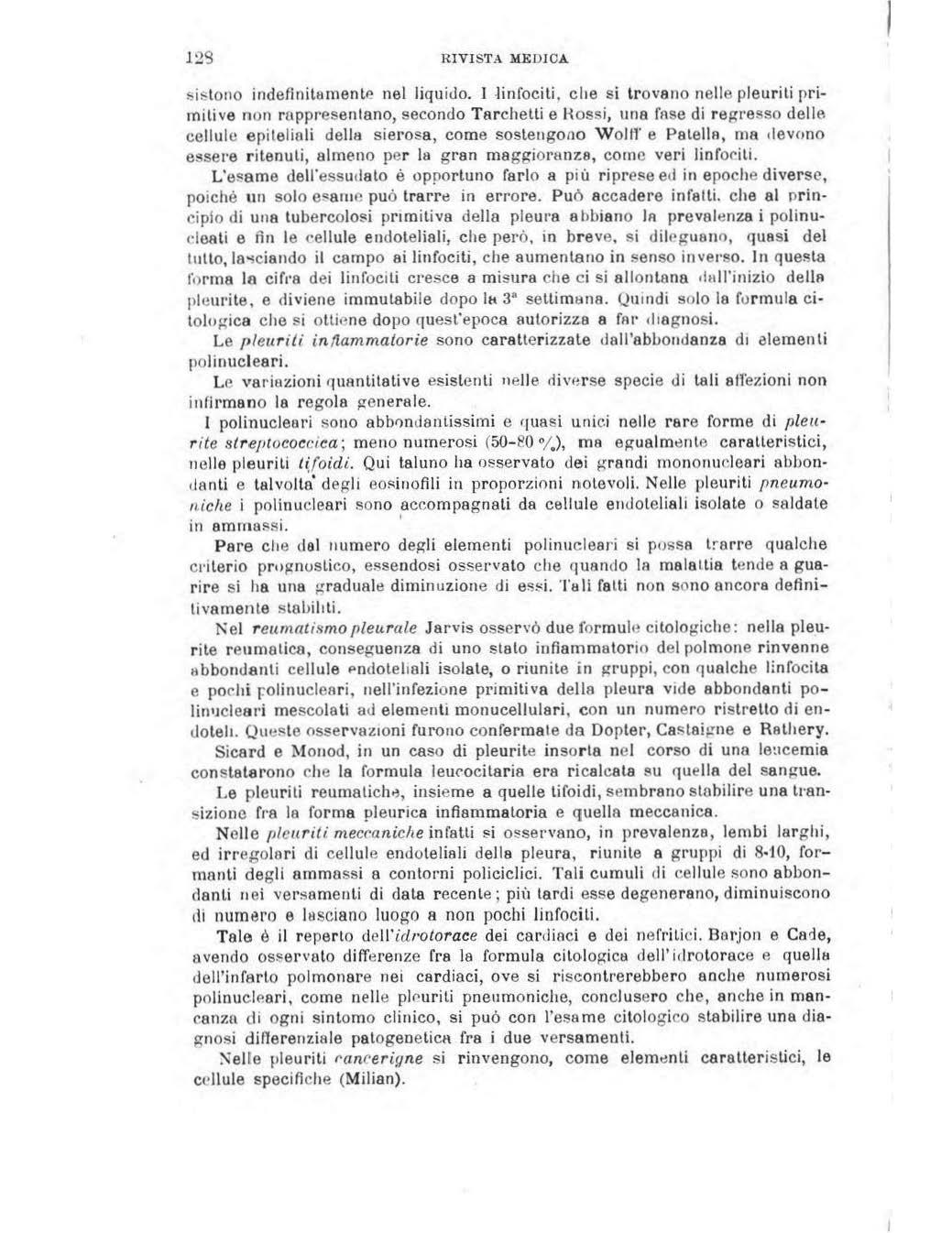
11 bbontlanli cellule Pndoteholi isolate, o r iunite in !Zruppi, con IJUalche J:nfocita e pochi rolinucleo r i, nell'infezione primi l i va della pleura V tde abbondanti pO[in•JCieai'Ì mescol a t i aù element i monucellulari , con un nume ro ri stretto di enùolelt. osservazroni furono confermate da D opter, e Rather y.
Sicard e Mouod, in un caso di pleurite i n sorta n e l corso d i una le:tcemia cons t atarono ch e la fo r mul a leucocilar ia era ricalc ata su quell a del sangue.
Le p l euriti insie me a quelle tifoidi, sembrano stabilire una tr·an<s izio ne f• a la forma pleu r ica infiamma tor ia e quella meccanica.
N elle pleuriti mecC'aniche infatti s i Ol!ser·vnno, in preva lenza, lembi larghi, ed i r r egolari di cellule endoteliali dell a pleura, r iunite a g1·uppi di 8·10, forman t i degli ammassi a con tom i policiclici. Tali cumuli di cellu l e sono abbondanti uei ve 1·sam en t i d i data r ecen te; più tardi esse degener ano, d i minuiscono rli n umero e lasciano lu ogo a non poch i li nfoci ti.
T al e é il r epert o d ell' idr oto raee dei ca r diAci e dei n e fr i ti ci. Barjon e Cade, avendo OS!"el' ''a l o differenze fr a l a for m u l a ci to l ogica dell' idrot or ace e quelli! dell'infarto polmonare nei car diaci , o v e si riscon t r·e r ebber o aoche nume r osi poliouclf'ari , co m e nelle piPurili pneumo n iclte, concl u sero che, anche in man· ranzo di ogni si ntomo clinico, s i può con l'esame ci t o l ogico stabilir e u n a d i a· gnosi d i llerenziale patogeoetic11. fra i due v er samenti.
:'\el le pleuriti ranrerigne r invengono, come caralleri stici, le cdlule specifiche (Milia n).
l2S RIVISTA MEDIOA
Nell'emotora ce Tuffier e Milian si va lse ro della cilodiaguosi per sorveg liare l'in,orgere de lla s uppurazione, e ritennet•o che essa dà inseg namenti piu util i del decorso della tempe ratura: quando i numerosi polinucleari per• sistono oltre il 25' giorno, un processo e certo. Achard e L oe pet· fece ro identica constatazione.
E sponendo schematicamente lo stato attuale de lle nostre con os f!enze s ulla ci t{)l ogia dell 'essudato pleurico si può t·iteneJ•e che la preoalerua d ei lin[ociti depone per una pleurite tr.;./Jere,olare, quella <lei polinucleari per una pleur ite infiammatoria, quella dr•gli en doteli per una pleurite meccanica. Naturalme nte n e l formulare questo bisogna tP. ner conto delle variazioni r1scontrate n ella formula cilologil'a delle pleuriti recenti, e della possibile esis tenza di focolai caseosi vicini, che spiel{ano la presenza di polinucleali nelle forme lubet·colari.
Le ri ce 1·che sperimentali di controllo (Widal 'e Ra vau l) diedero ri s ultati aL quanto div ersi da g li esami clinici, e dimost1·aro no come esistono circos tanze che possono variare fin la formula fondamentale d'e ll e pleu r iti tubercolari. ,
Il Pate lla, approfondendo le ricet·che del Wolff sulla morfolo g iA d egli s udati pleurici, mise la s.:>rdina agli inconsulti entusiasmi di coloro che giuravan o, in ogni caso, sul valore a ssoluto della cilodiagoosi. E g li, pur essendo d'acco r do col Widal s ul si;;niflcato dei d iversi e leme nti cellulari, r itiene c he i linfociti de g li essudati non hanno nulla di C'Jmun e con qu el li de l sangue, poiché sarebb ero semplicemente nuclei superstiti d i cellule endoteliali alterate da un processo di picnosi. Egli affe rma pure, in seguito a numerose r ice r che i n oitro, c he gli eleme nti ritenuti globuli polinu cleati non son al tro c he c ellule endoteliali con cariocines i atipi ca o con carioressi. Per decidere l'interessante ques tion e occorrono num er ose ed accurate ricerche is tol ogic he ed istochimiche.
PERITONITI. - La citologia dei liquidi peritoneali e meno progcedita di quella degli ess udati pleurici; ma i r isultati, pur essendo meno netti, confermano in modo generale quelli ricordati.
Lucatello che in tre di pe riton ite .li natura tubercolare la fo rmula Ieucocitaria era nettamente linfocitica. Tale rep e rto fu prezioso in un caso di diagnosi mollo difficile. Widal, AchaJ•d ecc. notarono che nelle asciti tubercolari il numero dei linfociti e dei mononucleal'i è sempre notevolmente superiore a qu e llo dei liquidi peritoneali di altra. natura.
Nelle peritoniti cron.iclte dei neoplasmi benigni o maligni (cisti ovariche, fibromi, cancro) abbondano in modo manifesto le cellule epitel iali. Anzi Tuf· fì er e Milian riten g ono che, con l'esame citologico, si possano diffe renziare, i11 modo assoluto, le peritoniti tubercolari dalle cisti d e ll'ovaio, g iacc hé in queste s i una gran varietà di cellule, fra le quali le piu caratteristiche son costituiLe da elementi rotondi od ovalari contenenti molti vacuoli, e da cellule cilindriche con ciglia vibratili.
Nelle asc i ti meccaniche da stasi dei cardiaci e dei cirrotici è abbastanza caratteristica l'abbondanza degli endoteli rispetto ai linfociti .
Anche qui i polinucleari testimoniano l'esistenza di fenomeni infiammatori a cuti {Oopter e Tauton, Iardini, Tarchetli e Rossi). Conviene però rico rdat e che a lcuni ritengono vi siano versamenti a fo r mula linfocitica , la natura tuber colare de i qual i non é confermala né dall'esame clinico, nè dalle ricerche batteriologiche. Così l'esistenza di vP.rsarnenti indubbia-
9 - Giorrtale mtdSco.

RIVISTA MEDICA 12U
tn1•ntc lulie r collu·i con po linuc le os i (Tarchelli e Ro ss1) o co n eodoteliali (Patella) . Que!" ti r isul tali contradditori ct•edo pos s a no trovar la spiegazi o ne ne ll'epoca in c ui fu p r aticata la r·icer·ca, e si comprendono con la o sse naz io ne di W ollT che la formula leucocitar ia é diversa s e co ndo lo stad io della mal a ttia.
MExJNGITt. - .\l e no c hiaro è il repet·to cito logico del liquido ce fal o -rachidi a no in alcune malattie del sis tema nerv oso centrale

Ne lle m eningit i lu iJe rcola r i la cilodiag n osj è mals icura , an che p er c he i l infocili non s ouo es clusivi Il i qu es te fo rm e . I nolt1·e osserviamo quant o sono di scordi i ri s ultati de lle oss e r vazioni clinich e : \Venl\\ ot•J.h, Dernheim e Mos e r, Widal , Sicar·d e R avaul rinvennero un man ifes to pred o minio d i li n fo ci ti (qu es to r e pe r to é confermalo dalle ricerche l' peri mentali) ; invece Lewkowi c z, Ma•·con -M utzner, .:-.I ery tro varono un numero so vra b bo ndante di po linuc lcari. Qualc he altro o sse rvò li nfocilosi nella m e oingite loco lizznla alla base, e polinucleo s i all'inizi o d ella forma cereb1·o - s pinale , ma, an c h e in ques ta, quand o il pr·ocesso di venta c r o nico , s i ha mon o nucleosi. L e ind a g in i di Concelli e Flamini a me paee po ssano conciliare reperti cos i di RpAI"ali, e perci ò so lo iu appa1·enza c ontr·addilori. Essi in numerosi cal"i di meningite tubercolare n olat•ono c he la s ov rabb ondanza d i po linu cle a ri co tT ispo ndeva o ll'os is tenza di 11U1neros i b di K o ch nel lifJu ido cefal o -ra c hidiano , mentre alla muucauzo di es!>i ft•ce va ri l'c o nli'O la linfoc itosi.
Ne lle m en i n aiti ac ut e invece la po lioucleo ;;i è c erta, CO!' Lanle , spicca t a . Wiùal S icord c Grdìo n l'osse r varo no n e lla men i ng i te r ereb ro - sp ina :e epidemica ; altri nella m e nin g ile da sla/ìlococco c da pne u m ococco Ravaul ed Aubo urg la c ons ta!.9ro no dop o un ' iniezi o ne intravertebral e di cocai na fa lla a s copo an cs tc liCO In qu es to cas o vide r o c he, dopo por hi g ioi"O i, i po linuclcari aveva no ced uto il pos to ai linfociti, i quali , alla lo r o volla , sco mparv e ro in IJre '"e . Ques to repPrto, che te" limonia l'andau1c nto di un proce;:so infìa m maa c uto Ye t·so la gu l\ ri gio ne, si ri pr od uce , s e h he ne con ma g!! ior·e leu le zza , in cas i di mala llie infe ttive. S ica rd e Brecy, La bbC e ri fe r il"co n o appunto cas i di m e nin g ili settich e, ove la guarigio ue et'a co n fe • mala da lla . ;;co m pars a n e l liquido rachi J iano d e i linfoc iti c he a ve va no s urrogato i prim itivi polinucleari. Ed Ac ha r d e La ub r y in un ca s o di meni n gile dt p lococcica d eco r rente co n ria culizzazioni e remisl"ioni, po tero n o con s tatat•e un par!lllel o mun e nt o d1 polinucleari o di li n foci ti.
I n lulli Erli indi vidui c h e no n p r esentano al c un 11egn o obbiellivo di le.o:ione de l s is tema nervos o , né alcun disturbo funzional e c he p ossa far sos pettare l'in s o r ger·e p r ossimo di una affezione organica, il lifJuid o cefalo-1·ac hidiano é p r ivo di e lementi cellulari.
Tale è pu re nell"alcoolismo subacuto e cronico , n e ll ' idro1·giri s mo, nell'epiless ia, nella pat·anoia acuta, nel de li rio di perscc uz.i.me, ncilo foll ia ipoconòria r a, nella corea ec c . (Nageolle , S e g las, Iamel, Dup1• r e Devau x, Dufour, e cc.)
Ne lle forme d i menin g ismo lega te ad infezion e tifoirle, pn e um o ni ca. eri s ipelatoso, •·eumalica. ma nca n o d el pari i leucociti. Va t in l e Me1·y con s ta tar ono, i• v e ro , linro citosi nella s e mplice cefalea che accompa,:ma il ti fo, ma é du bbio ch e iu qu e l caso gli a c cide n li nervos i esis tesse r o reulm e n te 11inc m a · leria, tanto piu che Doptet·, in ca s i simil i di m enin g is m o tifù id e nulla rm\"e nne. Ed é a ccertalo c he le prese nza di t> lcm e nti cellulari nel li-
130 RIVISTA l\IEDIOA
quido rachi d iano é ind ipendente da cause generali Infatti io un leucemico a g1·ado elevalo (480000 globuli bianchi pe!' 1674000 g lobu li rossi) non si ebbe nel sed imento alcun elemento fi gu raLo (F errar)
Invece s i con s tata la presenza di num e rosi liofociti quando esiste un 1rr1· tazion e cro nica delle menm g i, an che se n on sve labile co n allri mezzi di
Nello zo na, c he s i tende a rit eu e re malattia infe ttiva a deco1·so be ni gm", e pa re dov uto ad una alte1•azion e spinale o men inge èl, fu cons tata ta Jinfoci losj cos tante da Sicard e Brissaud, transitoria da Achard L eopse r e LaubJ'Y· Lo stess o re pe rto si rile vò in un a ltra de r matos i, che qualcuno t•ecentemente ritenne le g ata a lesio ne o rgHn ica del siste ma nervoso proba bilmen te di natura infettiva, la malattia d el Dultrinr;.
Widal osservò pure abbondanti liufoc ili in casi di seconrlaria e l er::ia r ia; Re g is in sifilitici e d in sijil itici con neu ra stenia p repara li tica Ba b ins ki e Nageo tte li risconh·arono nume r osi in lu tt i g li indiv idui che presentavano, anche isola to, il segno di Argy ll·Ro bertson, il quale pare costante nella s ifilide, e dipendente da alterazione d e i ce ntr i nervosi.

Nei soggetti colpiti da tabe e d a pa ra li8i gen e ra l e fu tro vata l infocitosi costante e manifes ta. Onde Mercie r ritien e che la cilodiagnosi pe rmella d i differ e nziare la paralis i g e nerale da ce rte forme d i al c oolismo e di psicosi che posso no si mularne i l del:o r so. vVidal v ide cambia r e la formula linfocitira in polinucleare nei pa r alitici con fenome ni ces sati <luest t pe r ò, i liofoc iti to rnarono in pr evale nza.
Nella sclerosi a placche Carrie1 e trovò !inforitosi con abbondanti !JOiinuclear i; l'esame citologico é invece negativo nella ps eudò- s c lel'osi d i natura i.sle ri ca.
M ALAT TIE cRIR URGICHE - Anche in fjueste malattie la formula risp onde sem p r e all'an da mento a cu to o cr on ico de lla inferm1tà , e spesso a!la causa <ii essa.
ìdìopal:co si ha un num e ro scat·siss imo di e le meuli cell ula r i, <:os t 1tuiti , quasi in total ila , du cellule e nd o te l•ali. Mo llo spe sso n el liquido furono o s servati anche (Barjo o e Ca de) spe rm atozoi, proven ienti vero si m ilmente dall e p iccole cisti epidid imarie o testicolari, che, sa1·ebbero caus a, seco ndo alcuni , di tali forme t>ssen ziali di iù1·ocele.
Ce llule endo teliali si osservan puee n e ll' id r ocele cronico, s in to matico di una affezione s ifìlilica. Pare che la pr esenza d i e ndoteli s lia o. desig nare una lesione to t•pida. Su lla cos tanza de lla formula in questi casi, e sul valore etiologico di essA furono sollevati dei d u bl:..t.
Ne ll'idrocele da orchite blenorragica s i hanno se m pre ab bonda ntis s im i polinucleari, che scompaiono quando il processo diven ta c r onico.
Nella form a t ube rcolare si osserva linfocitosi spiccata (Widal, Tuffie t·). Per evita re possibili errori' diagnostici di sede, con vie ne ri co r da r e co m e Suillard riten ga una tuberco lare capace di influenzare nel senso linfocilico u n versamento an che lontano: idrocele e tubercoloSi polmonare. I linfoc iti in ques to liqui do mostra no, secondo Iardini, più che negli altri, la lo ro de rivazione da epiteli d ege n erali.
In tutti idroce li, di qual unque natura ed e tà essi siano, si può osserva1·e una r apida ed abbo ndante compar!la di polinucleari, iniettando in loco una .sosta nza modift caLrice , o irt•itando, in qualsiasi a ltro modo, le parli circostanti.
RI"VlSTA M EDICA 131
N o n fu an cora s tabilita una formula c ito! of!ica s ull' ùl roemutucele.
N ell' idrartrosi si ebbero dal D opler ri su l tati co ntr adcli l loi'Ì. A ch ar tl e L oepe r OS1'ervaron o cos tante prevalen za di polioucleari nel r wmatismo a r ticolare actdo; Widal , Ravaul, L oeper n ell'artr i t e reumatica ed in quella IJle n orra gica. Se que!':t8 ultima affezion e decorr e senza feb b re, s i rinvengono solo li n for ili.
:'\'ell'arlrile tuiJe r l!ola r e sierosa od a granuli ri siformi s i ri levò semp1·e linfocitosi. Identico ri s ulta to d 1edero le r icerche sperimentali sui cani. solo che al l' in iz.io della artropatia si a ve\'8 predominio di polinuclea r i (A chard e Loerer).
Le iclrart rosi meccaniche ase tti ch e contengono quasi sola mente endoteli.
A nche n ei traumalismi cranici la fu , (] ualc he volt11. , adoperata con Se il l 1quido estratto con !1;1 p untura lo mba1·e conti,' ne !';a ngue, s i può atlc rmar e con cer t ezza l 'esi!< tenza di una o, alm en o, di una (·outusione ce reb1·ale (T uffìer) Fanno difet t o in dag ini citol og1che piu minute.
J.a r eazi one leucoci taria fu pur e studiata nelle IJolle, nelle rescicolt• , n e lle pustole di varie malatlie (herpes zo ster, vaiolo, d ermati t e e1·petiform e del Ouhl'in /l, scotltl tUI'e, ecc ), ma n o n si ebbero molto p r eci s i.
Incerta é ancora la p r ova (7el vescieatorio, che A oger ed J osué Pl'8tì('.al"ono in m o lte malattie, e che, secondo loro, dar ebbe prezio si in segnamenti s ul pronostico di m olte infezioni.

UHINI>.- L 'esa m e citol ogico fu es eguito anche sulle urine dei cardiaci dol Maml ock, c h e o ltenne risultati differe nti a seconda dei ca si. Negli individui con asis to lia atipica eglt l'in\Lenne emazia e cellule renali pi g mentate. Nei car diaci albuminuri ci , n ell' ori na dei quali mancano r1uasi del tutLC\ e l ementi cP llulori, s i tratta in gene1·ate, s eco ndo l'auto re , di albummurie pasf'egger·e, che cedonCJ pr·esti sf'i mo alla digitale e che rivelano un p1·0babilo rallen tamento della cir·colazione a l i vello del rene sen za lesione o r ganica di quest' o r ga no. N ei casi di infezione e sla si mic roscopi co ri vela l' e:;istenza di emttzie e di po linucl lllt'i.
rice r che hanno bi1'0gno di essere estese, poiché s u questo camp o si puc', fa ci lmente incorrere in errore, es"endo noto che an cl1e l e urine normal i contengono, sebbene i n scar sa q uantitiJ, elementi cellulari d i diver·sa nat ura P p r·ovenienza (cellule epiteliali uretrali e ve scicali, polinucleori e qualche el'itr oc·i ta)
Dal le ric c 1·che fino ra fatte s ulla citodiag nosi possiomo dedurre ch e l 'e!<ame c itol ogi co, malgrado i num er osi ri s ul t a t i dubbr , è u n'ollimo m ez zo d'inda gine cl inica che non deve esser mai tras curato, dappoiché no n ra1·e volte fu stab•lire ('0 11 certezza una diag nosi c he senz'esso riu sc irebbe oscu r tl, dìllicile c f o r se 1mpossibilc.
Bol ogna, dicemb 1·e 1902.
B I BLIOGHAFIA.
- Arc/liv o{ P edrio!ir<. 1896 - e - \l'ime•· k/111. IV•Ich. 1897.c - l 'r:eglflll n. 17·18, I SOG. - WINIAR<KI. - l ekar•ka, u. 13, 11!96. - \\' 1o AL e ti AVA UT - Soci e! é d e biologie, 30 j u. 191)().- R••' • UT. - 'l'll r&e clt l'at·is, 1901.
- RAVA UT.- Ca:tllt del hO}Jftau.c, D :>1, UARJON e CAlllt.- Arc hi ot& ytll , dt ttltt.l. UIIIJ, , IOOi.
- W OLFF. - 1/trlilltr ktin. \l'orli , n 45, 1901 - UI BU LAFOI' , - St ma f llf Ved , 11 '8. 1!101. - BAli· noNNSI\ - Ga:•lle t.les hopilllou:, ]11. 190!.- Wsoi!R.- Dtull. med. 1\'ucll, n 16, 190! - ACIIARil e I.OBI'HR.Ym•tJtcuu: pl'tce•l rs d't'i'loralion, l'aris, 19tH. - BAnJos el C>nl!. - Snclc!t· de i9 JU. 1901 ;
132
RIVISTA MEDICA
,1/e.d • 6 jmll. t 90t. - - Re11 u t de Jl td. n. IO, l !l()j. - JARUI NI - Ri(onna onetlica. vol. 1\', n. 2.1-'ll, 190'l. - J H VIi. - Thue Pari$. 19()!. - SoCARD e - So cieti du Joopil(tu .r , dee 1900. - - ller/ineo· klin. W oc lo, n 6, l !Ire.- Noc•II LK.- Revlll m ed. de Nonnand i e, 1001
- OOPTBR. - Sociele de l1iOIOQU. U ju. t !Ire. - L UCATE I.L O - Xl rOnD . di m ed icina, 1001.- T UFFI SI< e M oLUN - S oci eté de biolog., IO a vv. !90 1. - T ARCIIET T I e Rossr - La clinica mtd. ltalla•oa,
- P ATKLLA.- Sucitt à D. Alighieri, 190!.- Ri(Onlltt il/ed. , vol. I V, 190t.- W mAL, SIC ARn e RAYA UT. - Societ e d e biot. 13 oct. 1900 - Ms•coHn, J on- no Y. MARIB , Ren•.- l:on(l1'ts (rau ç. des med. el n eurol , 1 7 aout 1901. - Gn,.·ro N. - Snci el è d e llio lo!lie, 5 jan 1901. - Honsc n r>: l. u.Forlsclrri ll d • lltd., ti, Xli, 1901. - e NA<.RO TTR - Soci el c m ed. du lwpilaux, !4 1901.
- \VooAL , Soc.uo, o. - Ibidem, 18 j an 4901. - OuP« P. e - Ibidem i ju. 1901. -
- Thest de fJordtau.r. 1901.- t\ Ar. &ons c J uut.- Sociele 111. d rs hopi/aux, 11 jan.
- 0AR JON P C ADII. - Soc iet e d e /IÌ()! Og. , 31 m :oj {VO:'I. - T UHIIIR O MIUAN. - /bidtll , 5 j an. t90t.OcFou n. - Soc. d u ho-pii • Il oct. 1901. - 1\or. ER et J oiUt:. - f'reue m ed 8 mai 1901 - Mn IAN, G A STON, J uliSBLliE. - de derma/. , 6 novemhre t90J , - i:nA UHAno, ACHA Rn, I.Alll', WonAL, IJUFOU R, TIIIBIBR GE e RAI'A UT. - So cielé m td. d ts lUl)>itau r, !l 110 \'Cnlbrl) 51C AII O.- U /iq!lldt ctphal o-ra cllodltr>, Pari; , Ma,;son ed. 190! - - Th e.le de Pa ril,
KR EBS - Un ouo 41 gangrena 4el faringe t A ngin.a Vin c :n.li :-) oon andamento oronioo. - Deu t. med. Wo c hen sclì r , n. 1 7.
I n u na sig nor a d i 40 anni trovò la parte s up e riore ton s i lla sinis tra co perta di mem'brane s pesse, feti de, fo r lemen te ad eren t i, a spo r tand o le quali r es tava. il tess uto ul ce r-at o ; il pilastro pos t er io r e s inistro pa lato e ra infiltra to ed u lce ratQ ; i ga ngli linfatici solloma scellart s i e r ano tumefalti talmen te a sinistra, da ragg iun ge re pcrllno il \' Ol um e di una mela. L'am m ala!11 non aveva affatt o cefa lea né si osservava febbre. L'e s ame micro scopico de lle ulcerazio ni de lla tonsilla dim os trò trattars i di una infiammaz ione superfic iale d i o a tura ulce r osa e nec r <•lizzante; nell'inte r no dell':l masse ne croti c!1c ve n n <' rinvenuta una gru n de q uantita di lun g hi bas tonc ini ai bacilli del noma. L'A. a s portò tutta la tonsilla. Fallo ciò, s i vide che i foco lai gan g renosi g iungeva no fino all'estremità late rale della ton s illa. l prepal'ali diedero lo s te s s o rep e rto m icrosco pico. L'A. riti ene cerl(l che n el suo caso s i tralta t>se della cosidetta angina di Vincent; certo p e 1·6 che i n quest' ultima manca la gra nde profondità del la n e crosi, come pu r e l'anda mento c ronico .
È da avv e rlire poi che i bacilli visti dall'A , almeno co me vengono da l ui descri tti , non hanno mo lta ra sso miglianza con quelli trv, ati Vince nt nelle for m e di angina cile da lui ha preso il nome .
G B. M B.
KL E I NE. Sall'a•sorblmento 4el salt di ohlDiDa. s. 45 9.
Zeitscltrf. II!Jg ., Bd. 38,
Allo scopo di stabilire qu a le fosse la forma più ad atta della so mm i nislt·azione del e hini110 ne i varii <'asi di malattia e ne lle più va rie ci rcostanze, l'A. ha e s eguito de lle r ice r che sull' a ssor bimento e sull'elim inazione del chini no. Dappr ima le pe r sone che s erv ivano da e s perimen to emettevano le urine, poi p r endevano il chini no, coll'ordine di conservare le lo r o Ut' ine in tanti matracci. Nelle urine il chini n o veniva precipitato con a c ido picrico, il picrinat o dell'alcaloide ve niva de c o mposto per mezzo della soluzione di p o tass a , il chinino ve n iva asp ortalo col clo r o formio, e dopo avere evapo r alo il cloroformio e aver seccato a 120o, de term iDato per pesata. Il chinino veniva somministrato a l mallino, dopo mez z'o ra da che la pe rsona in espe rim e nto aveva mangi a to, a sto maco

Rl\'I STA MEDICA 13;:1
digiuno, un pa n ino , e il cibo Ye niva a ss unto due o re do po l'inges lione ùel chinin o ; cosi facen do , n e lle s eguenti 2i ore il 25-38 °/ 0 d el chinino in ge rito pass ava nelle ul'ine. Tra d ue e se i ore do po l' l' e lim iua:t.i•>ne pe r le uri ne e 1·a g ia ar!"ivala a cifre c tevatt>, la ma g gior pat•te del chinino era già ;;lata a s;;o r l>i ta n e llo s tomaco. N e i d is turbi duraturi de lla di ge s tio ne l' e fTe tto \e rap e uti co ap pare n o te vo lmente abbassato . S e il pazie nt e pre nde i l c h inino a s to ma co pien ù, l'ass or bimento può e s se r e imped ilo in modo A»so l uto. Contro la amminis traz.ion e d e l c hinino pe r la via retta le, s i é fallo va lere c he a d e tta r eaz io n e alcalina de ll'intes tino r e tto, il c hinino vi e ne a sso rbit o mal e dal crasso L'A. ha trov a to elle, s e ai pazienti s i p ratica prima un\•nle ro c lis m a allo s co po d i la vare e poi s i sommi nistrano g rammi di c hinino in 100 cc. di acqua pe r a num, n e lle successive 24 o r e il 17.5o;• di c hinin o v iene e limina lo colle urine. Jn un pazie nte , n e l qual e l o r e dopo il c lis te re c o nt e nente chinino, s i e b b e una d e fec a zi o u e , ve nn e trovato anco ra dopo 17 o re J e t ch ini no n e tte Se alle volte s i o sservano in s eguito ai c ti;;te ri di c hinino delle vi ol e nte scar iche al vi ne , s ono da combattere con a ggiunta di ami do o di un altro vei col o po i:: !Jè ciò n o n s ar e bbe una cond izio n e favo!·evole, l'assorbim e nto ess endone pregiudicato L'A. ha ottenuto buoni ri s ultati m e t·c é l'a ggiunta di al cun e gocce d i c ocaina o di tintura li' o pp io.
ì\e i t r opici è d ivenuto abituale i n qu egli individui che n on l o ll e r RnO il chinin o p e r bocca, il pt•atic ai·e ini e zio ni s oltoculanee, r.d esiste l'opinio ne che mezza d ose pe r in iezio n e sollocuta nea p r oduca il m edesimo e ffetto ch e la dos e inti e ra so mminis trata per bocca. il bic loridrato di c hinina viene eliminato in 2 i o re cir ca 1' 11'10 de l c hinin o e impiegando il cloridr·o.to, l' eliminazione è un poco ma ggi o re, ciò ch e va pe rfettam e nte d'acco t·ùo col fallo che s ommi nis tran d o il chinino per via i pode rmica n o n si pPodu cono ronzii alle Il c hinino inie ttato so lto lo pe lle non vi e ne n c onchc eliminalo in g r·an quantit à pe r il tubo i ntes tinale, ma in gt•an parte precipita in s ito e no n viene e liminato che in un lun f!O p e rt odo di te mpo. Non è e scluso che e ffe ttivamente u na tale circos tanza p ossa e ssere di g rande inte r esse pe r la profilas si e la te rapi a de ll a ma laria, poiché pe1· me zzo delle in iezioni so ttocutan e e vien e pr o vnc ala un'a zio ne m o lto d uraturn de l c h inin o .
G. B. M. B.
I E HLE. - Sul reperto del baotllo tlflco nellG sputo del malati d t fo .(Wien. kli n. W ochenscltr., 1902, n. H)
L'A. ha eseg ui to te s u e t•icei·c he s u 23 ca l' i. Nei ca s i di fe bbl'e t1fo ide c omplicati c on polmo n i te po te r o no 8 pesso esse i' dimos tra li i bac illi del t ifo tanto n ell o spu to quanto n e l s u cco po lm o nare. In questi cas i lo s puto aveva se mpre , cor r i!!po n dente rn e nte al ca1·a tte r e e m o r ra g ico de ll' infiltrazion e pneumonica, un a spe tto tipicamente emorra gi co. l bacilli del ti fo s i pre;;entavano s ia in c ultur a p ura, s ia anche ins iem e ad altt•i mict'OI'gani$mi, e par ticol armente col bacillo d el l' inliuenza. I no lt r e , a l conl rat•io d i quanto altri av e vano o lte nulo, an c he n e lle bron c hiti clinicamente ed anat o mi cament e n o n complicale esisto no i bacilli del tifo ne g li sp uti.
Se a nch e un'i nfezione da una ad altra pe r sona per mezzo degli sputi pol,·erizzali a ppare poss ibil e so lo in una proporzione bassa, pur tutta via un'in-
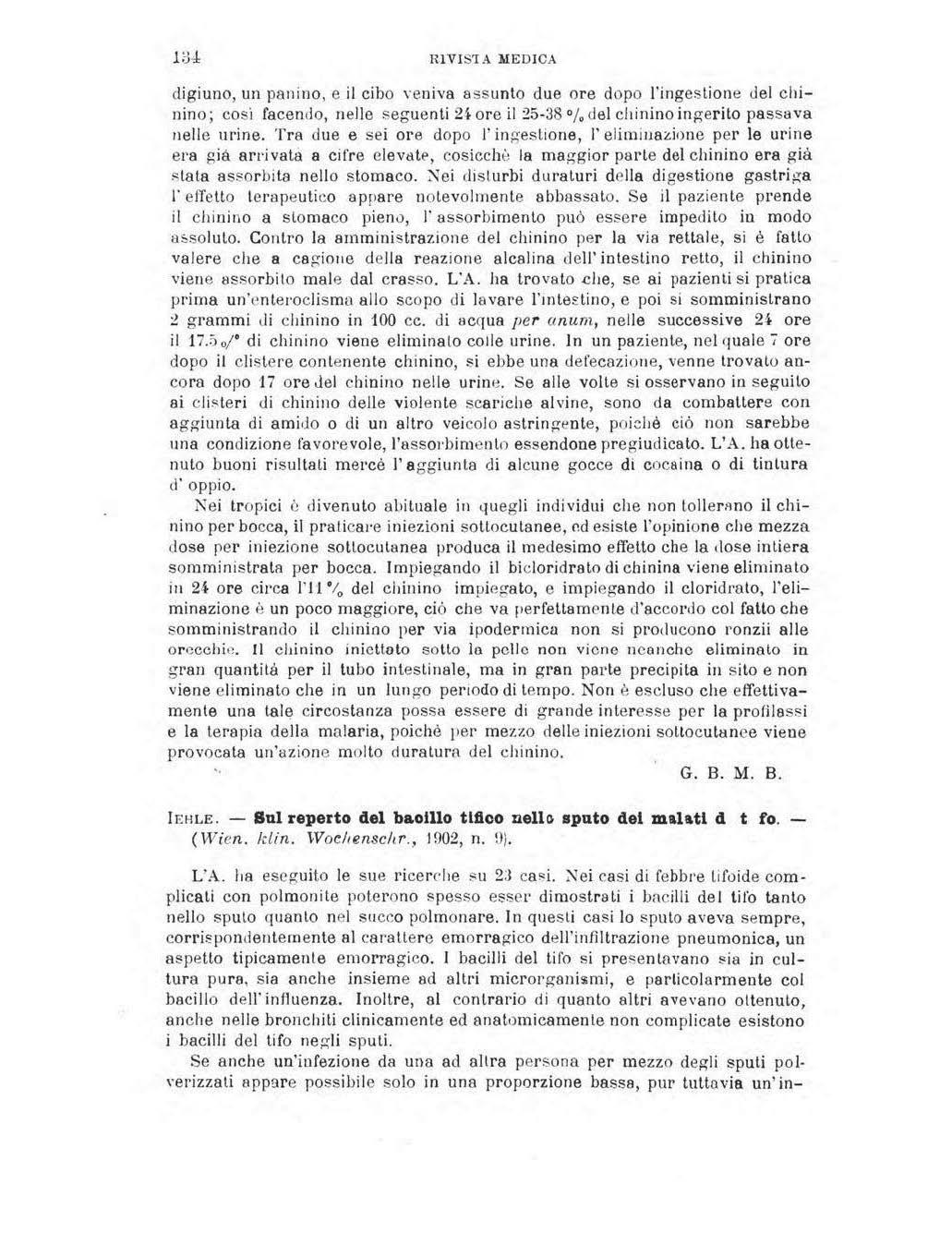
13! R.lVI S'IA MEDI CA
fezi o ne trasmessa in tal mod o non s i può esl'ludm·e. E s iccome i bacilli de l tifo si r iscontrano ancora per molto tempo do po la ftne dell a ma latti a, cosi lo spu to de i tifosi e de i convalescenti di tifo cie ve u gualmente che le urine, sottoposto ad una acc urata disin fez ione
G. B. l\1. B.
- La diagnosi baoteriologloa della difterite. - ( P r a ger meclic iniscfte Wochen .st hr , 1902, n. 15).
Nel suo r·a ppot·to pr·esentato alla societa de i medici ted esc hi in Pra f!a, l'su· tore esp r imeva il vo lo che il più spesso possibile fosse fatta in ciasc un caso la diag nosi baLLe ri o logica dell a di fte t·ite. Ciò é stato r eso po >ss ibile Ja l tempo in c ui i l L iillle r scop r·r il bacillo della difter·ite, r icon osci uto come agen te spe· cilìco di questa malattia, e può farsi agevolmente sia pe r mezzo delle c ultul'e sier o di Lofller, sia colla dop p ia co lo r azi one descritta dal Neisser, co•iccllé é fac il e t•isco ntrare la presenza del bacillo di rte t•ico co n sicu r ezza e in breve te m po Ch e la dia g no s i batte riol og ic a della difterite sia l'alta, é tanto pru in quanto la diagnos i clinica loscia al le vo lle in dubbio; infatti in 100 casi di difie rile in cui l3 i e ra in dubbio, 5olo 26 volte s i potè fare una dia gno;;; i pos iti va. A pp unto in ques ti ca si du b bii, n e i quali la te r apia infl uenzato dalla dia gnos i, la p rova bacleriologi ca a cq uista un gra nde valo r e, ed anz i rl suo maggior valore vi e n d alo specialmen te dai s uoi r appo r ti colla profila ssi; giacche tali casi, nei qual i la dia g n osi è ince r ta , possono ve nire isola ti pe r tempo, e d i n tal g uis a l'ulte ri ore dilfu s io ns de i gP.rrni v iene im pedita
 G. O. M. B.
G. O. M. B.
RrKGLER.- Uua x-e azione estremamente seiUilblle dell'acido urloo . - ( Wien er metl. BUi.tt e r, 1 90 1, n. 45.
Come l'A. ha potuto osserva r·e, l'acido fo s fo mo l ibdico é un reallivo dell'ac ido urico il qual e è do tat0 di un' es trema sens ibilità. Si prendono cinque centimetri cubici di una soluzio ne la qual e contenga an c he 1 p. '100,000 soll.a.n lo rli ac idn uri co (é da avv e rti r e p e r ò che anche gli urati !';j co mj) o r·tanc.. n ella stessa J118· l'ispetto al reatlivo ), si aggiunge una punta di coltello di acido fosro'molibJico, e da ultim o si aggi un gono 10·20 gocce di una soluzi o ne concentrata d i o di ammoniaca ; si manifes ta allot·a un a intensa colo r az ion e bleu . Anch e nell' ur ina diJ·ettamente l'acido u r ico e gli ur ati s i dim os tran o con tale reazio n e, che si pratica allora nel mod o seguen te: l cc. di urin a si allunga con 4 cc. di acqua, poi s i a gg iu nge il r ea tli vo e infìu e la so luzione sadica. L'u rina si colora <'Mì in bl e u.
Anche i cor pi analo ghi all'acido uri co, come lo g ua nina , l'alloxan o e l'alJ,,xanli na danno qu es ta r e azione, mentre non la danno l'urea, l'allanto ina, l'acido os;:al ico, l'acido i ppu ri co, il gl u cosio, l tl creatino, la c r eatinina.
RIVI ST A li!EOICA 135'
G. B. :\1. B.
RIV ISTA CHI RURGICA
Br..A NC. - La f orma anemlo a del oanoro de llo •tomaoo. - (Jo urnal de M t•cleci ll e el de Clti r urgié, dicembre 100 1).
ha des critto solto il nome di forma anem ica del cancro dello s toma co un co n<'t'O di fo rma particolare caratt erizzala dal fallo che i s intomi an e mici predominano pe r m odo da far· commettere a ssai facilmen te uu errore di d iagnosi.
Il dcc(lt'so ordinArio di quest'affez ione è il segu ente. l si ntomi non so n o qu el li di un' atn•zione gastrrca, ma quelli di un'anemia pe rni ciosa . L 'err ore ò fotol e per chi non é pr·evenuto. S olam ente 'l'esame del sa n g u e permette, ne ll' iniz1o, di rilevare la differenza. Pi ù tard i, quando co mpaiono i segni g a s tri ci (vo miti, e matem esi, tumore). è faci le la dia g nosi, ma n ei primi mesi, vale a diro nell'e poca utilP, l'ematologia è la sola r iso t·sa .
L'inizio è insidioso; si notano talvolta dolori di s tomaco, ma poco acce nlt:ati , insufficie nti pe r decide re il malato a cons ultare il m edico. l prim1 si ntom i so no quelli dell'an emia. Qu es t'anem ia i• il s intomo predominante pet· n on di re uni co. l sintomi funzionali c he la manifes tan o son o s tord imc nti. ronzii all e orecchie, debolezza, anche sincopi. l segni obie ttivi di ques t' an emia sono a n co ra piil co t·atteristici: il soggetto ha un pallore cadaveri co, sovent i un po'verdaslro, come le vere clor otiche. Le mucose so n o scolo ralt>. senza !.'a ngue. l lel!umenti sono alquanto ed ematosi; talv o lta il viso i• ger mente go nfi o. Ques to é il ti po di un'anemia g r avis!'ima che viene anche co nfe r mala dall'esame del s angue
L'evol uzione di questa forma di cancro dell o stomaco é m o llo lenta.
L'e!<i lo ne é fat ale co m e pe t· tulti i cancri dello sto maco, ma devesi notare c he in ques ti sogl!etli l' interven to chi ru rgico dà mi g lio ri r isu ltati che n egli altri
Gli opera ti riacquislano l'a ppetito, le forze e mig lio rano nell'anemia. Bl a n c c ita un malato, il qua le dopo q uattro m esi dall'operazione h11 potuto r iprend ere la s ua pt•ofe!i<sione d i barbie 1•e che :s veva dovuto inte rromp ere
Quanto all' inter pr etazione pa to g-enica di que s ti falli, essa manca an cora di base ce rta ; parrebbe che le lossioe cancerosi' o de lle infezion i so praggiunte abbi ano un'azione s ui globuli del sa n g u e.
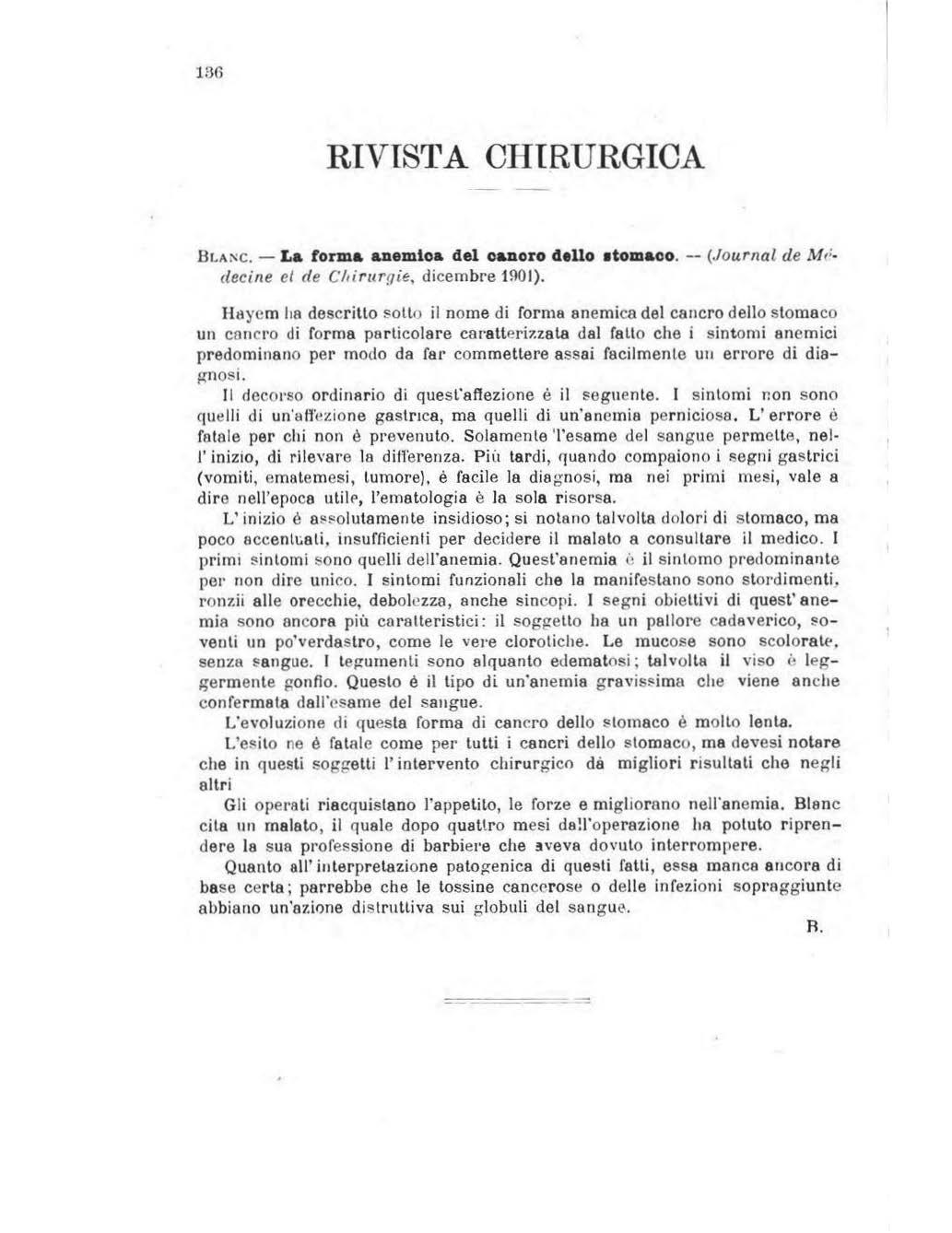
136
R.
RI V IST A D[ OCU LISTICA
HARRIES JoxEs. - Sul r apporto tra 11 g lauooma e la t rombo1l delle v ene retllllohe. - medi(·a l Journal, 18 jan. 1902).
Il r apporto del glaueoma con le alte razi o ni dei vasi r e tinici è sta to per mollo tempo ogg etto di di sc ussione fra gli o ftalm olor:i ; ora però norJ man c ano nella letLeratura dei cas i, c he mettono bene in evidenza il nesso etiol ogico fra queste due en tità morb ose. É importante specialmente al riguard o il lavoro del W ehr·li ( Are/t. o.f Ophtalmolog!J marzo 1900), che tratta del glaucoma secondari o a retinil e albuminurica. Noteremo però incidentalmente a questo proposito che il Miquel. il quale é stato uno de i primi a studiar·e e aescrivere la trombosi delle vene reiini che, allarma che la tens ione intraoculare non i>i trova mai aum eotallt nel coeso di quest'affezione.

I quattr·o casi r·ifer iti dall' H::rrries J o nes dimostrano, che il glauco ma pui1 manifes tarsi in conseguenza dell a troml:>os i unilaterale della vena centr al e della ret in a complicata ad arterios clerosi , ma senza retinite alb11mlnurica.
Dei 4 casi, in 3 il t;l auc oma si sviluppò acutamente in un periodo di tempo di c irca 6 settimane dall'accidente r etinicc. ; in un caso solo si tra ttava di g laucoma c r onico. I n 2 casi il glaucoma si verificò nell'occhio non affetto da trombosi.
La prese n1.a di emo r ra g ie sulla superficie e nella sostanza dell' iride dimostrava che l'arterioscleros i non era limitata ai vasi r e tini ci, ma invadeva a nche le arterie ciliari; quest'ultima circ0stanza è natur almente una g rave con· tro indicazione per l'irideclomia, iu vista d e lla possibilità di una gl'ave e morra gia intraocul are in queste condizioni.
Il significato clinico di qu es ta complicaz iono nei eas i di t r ombosi in modo capitale s ulla prognosi, la quale è r elativamente m igl iore in molli casi di trombosi semplice, re sidua ndo sempre ne;rli indi vidui, dopo ristabilita la c ir·colazione e rias.:;orbite le e morragie, una discreta visiva.
D'altra parte il manifestars i consec utivo di falli glaucomatosi acuti rend e la prognosi g ravissima , in vista dell'insuccesso quas i inevitabile d e ll'iridectomia.
S. R.
STAALBERG. - Una l arva 41 mo1oa nella oamera a nteriore dell'ooohlo.
(Hygiea, settembre 1901, analizz. nella 8emaine m éclicale, 5 febb r ai o 1!)02).
Il curioso esempio di corpo es trane o oculare rifer·ito dallo Staalberg n on avrebbe, a quanto pare, altro prece dente nella casuistica che un altro caso pure molto recente d el K r autner.
Un bambino di 5 anni c urato inutilmente da 5 o 6 mesi per una rib elle cherato- congiuntivite destra. Fattolo visitare dallo Staalberg, questo constatò nella camera anteriore, un po' al disopra del forarne pupilla re, un corpicciuolo cilindrico segmenlato, lungo 1 cm. circa, g r igiastro e trasparente; vi era
137
III Oill'e chcr alitl! C•)n ipopion. Il c•H po estran t:o os:>et vato a varie t•i pr esc pr esen tav o pr e t'o rme, dirnen>:ioni e posizion i diveJ•se; s i cc hé s i pensò ad una lor va d' i u!".etto In ratti, prnlicnt.a una chera to tornia i nferior·e a l embo, si es trass e la l a rva m el.lioute una pinzella da iridec to rnia.
L'esi to dell'oj•e r azione non fu molto fel i ce, es>:ent.losi manifestata. er·nia <..lei YÌ t!'eo t:>d indo-che ra lile. per r ui sol o dopo 6 m es i s i ebbe la g uari g ione, r e:; i,l uandonc pe r ò unA fù l 'le oparilu corn eol e con riduzi on e considerev ole del
Il cor po esll'aneo era una le J·va J i llff flOcl e r rna boois c he è una speci e di es tr·o bovino. Pare, c he questa lar·va, pùrtendo dal c uldi sacco congiun l ivale inferi o r·e, ri cctlocolo abitua le d t!i cor pi es t ran ei, abbia per fo r a to il limbus, per.et r·ando co si nella c am er a a nteri o r e . Del r es to uon è nemm e no impossibile ch e essa sia ar1 i vata n ella cam era an t er·ior e, seguendo l a g uaina Jel nervo o t t i co; poichò ne i bovini si tt·ova no frequen t em ente di q ues t e l ar·vs nell e m espina li e c r aniche . S . R .
DI E E
c ,SAHIN I. - L 'ergografi& crnral e (ele t trica e volontaria) in certe oon4l:lliooi normali e patolog iche. - ( A r e/tio. ila/ d c biologie, tomo XXXV I II , fase . l l ). ·
L 'A . serv endosi cr·urale del pro f. Pall'izi, ha intrapreso una :=:er ie Jt allo scopo di mi sura r e il laYoro mu scoiAr·e ar tificia l e e natu ral e delle m embra infedori nell'uom o, ed i cangiame nti attribuibili ad alcu ne condi zi o ni di sa l ute, a d i st urbi m ot ori e a c er te condizioni det ermina te d e.,perim en to. La t•eg ione musco lar·e speri mentatA fu l' in sreme dei fa sci de l
')Und r icipite es te nsor e, riun i t i v et·so il I'Ol u l o .
Le co iJ(:Iu s inni di qu es to l avoro sper imomla l e so no l e' seguen t i :
Il l avo r o muscolare della gamba pr eseuta un massimo ù "alti vità n elle o r·e 1•omeriùiane, ma v er·so sera si ri scon tt·a una n ote vole diminuzione d'enet·:zia, wr nore an che d eii'AnPrgia sv ilu ppa la ncll t3 pr irnL' o r e del la gio rnata. L a fat ica prit g rand e dell e membr'll pel vi c lll', all a fine d ella :.rio rna ta, è dovu ta men o al· !'esau ritn ento dE'i cenlt·i ner vo!!'i c he a ll e fot ica periferica , a un' i ntossicazio ne Inca)!' dei muscoli i p 1ù a un l avo r o co ntinu o.

L'eta avanzata deler·minu, in gene ral e, un csA urim ento del l Avo r o mu scolu re, ma piu accentuato nt>lle membra i nferi o t•i .
Col l'er :zografì a c rurale, el ettr ica e v olontnr ia, si mello no in evi denza l e localizza zi o ni dello fatica n ei muscol i delle m em bra inferio 1·i, del erminole da 'ce r ti d i m es tie1·i e di occupazi o ne e da diver ;. i e!"ercizi fi sici, c i di:"o rd i n i della funzi one mnsccla r e n el 1e mnln lt ie e in l i ll10r-l>OJsi.
138 RJVISTA 1) 1 AX ITO mA E FhlO LOG IA XOR)IALE E PATOLOG I CA
L'al cool, a piccole dosi, determina un'aumento del l avoro musco lare, più nelle membra inferior i che in quelle superiori. A forli dosi, pro duce uno s tato di depre5'sione più notevole nelle curve cr·uroli che in quelle b r achiali. Paragonando c rgogrammi ar·titìciali e naturali, tanto per la gamba che per il braccto, l'influenza dell 'alcool sembra, nella fase ipocinetica come in quella ipercinetica, più intensa su i ce ntri n ervosi cl• e su gli apparf'cchi neuro-muscnlari della periferia. te.
DI VENEREE E DE LLAPELLE
SCHOLTZ. - Sull' lDflUeDza d e l raggi RoDtgeD IUlla pelle Dello 1tato dl 1alute e nelle malattie. - (Arch . .f. D ermat ol. tt. S!Jpll ., Bd. 5!J, S. 87, 2il u. 42 1).

Dagli esperimenti che l'A. ha eseguito su giovani por·cellini, la cui pelle é ogni ra pporto mollo simile a quella uma na, ha a cq uis tato In ronvinzion e che nelle irradiazioni coi ra ggi Rònt:rC'n !>Ono appu nto ()uesli ragg i. e non le scaric he elettriche, i <Juali CO!>t•tni"'couo effdtivam en t e il fallore efficace; ed inoltre é risultato che solo i dotali di poca forza di penetrazione si dimostr·ano i più alti vi. L'azione sulla pt'llt> non si eser cita solo sul luogo di entrata dei rag lli. ma anche s ul luogo di uscita, mentre gli allri Ol'l!ani c les!>uli solo in piccola porte sembrano es!>er e iufluenztui. In oltr e nelle più intensive ir radiaziOni l'ozioue si esplica clinicamente dopo pareccl1i e ra11giunge il suo punto culmtnanle di regola solo dopo alcun<! !<eltimane. Un'a7.iClne bet.lericala viene eserci tato dai Rijnlgeo soltanto in lieve grado. Le rice rche istologic h e di111ostrarono che i raggi X iotlui:::cono primitivamontf' in modo predominante o escl us ivo elementi cellullari ùell11 c ute. i quali si allf'rano per una l e nta degener azione. mentre il t essuto connettivo, il te ssuto elastico, il muscolnre e il carlilllgineo sono alterati solo le).!g••r·mente c seconcln riarnente. In prima linea la degener•azione sì eseJ·cita !>ttlle cellule epiteliali, in minor g r ado s ulle cellule degli or·gani gh iand ola ri, d er vasi, dei muscoli e del tessuto connettivo. Non appena Cfiso ha un g raJ o, sì osse t•va la compars a di t;na reazione infiammato;·ia co n forte di l ala7.iooe vasaio, imbi· bizione sierosa dei tessu ti, disposizio ne pe rifer i ca dei leucocili uell' inle r·no dei vasi, e copiosa migrazione di globuli bianchi attr-aver so le l oro pareti. l n conelusione i leucociti penelrauo io gran numer o nella mas!>a d ello cellule decd asportano i prodotti della loro completa distruzione. P er l ' ullel'iore e\'11luzio ne e la lenta gua r igione delle ukerazioni sono di grande impor t anza probabi lmente l e modifìcazioni vasali.
L' azione esercitata dai ragg i Ri)n tgen sulla pelle molata i• anuloga alla preceden te. N el lupus i principali falli degenerativi si esercitano s pe<·ial men t e sulle cellule giganti ed epilelioidi dci noduli Juposi; i casi dì guari;:done radi-
IUVJS'l'A DI MAL,\T'rJE E DEf,J,A PELLI·: 130
·l '!
cale devono dipende re probabil mente dall'infiamma zione r eaLtiva. La principale impor·tunza del t rattam ento consiste i n questo, elle a cagi•me d ella degc· uer11 zio ne pr·odolLa sui noduli luposi, la i nfiammazione r ealliva viene ad esser·e concentrata precisamente sulle parli ma late.
Nella parte clinica del suo la vo r o l'A tratta p r ima di tutto della tecnir a delle appli cazioni dei rn:.rgi Rùntgen a scopo terapeutico e r ife r is ce sugli esperimenti da lui eseguiti su 200 pa zienti alla choica d i Breslavia. Nel lupus vo i· gare tale metodo p r estò m olteplici servigi, e specialmente ne lle lesioni di alto del naso e delle labb r a, più che alt r o, non solo in rapporto a lla cos mesi della ma anche per ciò che si r iferisce alla puarigione definitiva. A nche ne l lupus si oltennero dei risultati molto soddisfacenti, sebbe ne appar e ntemen le non duratu ri. Nelle malattie del cuoio capelluto e d ella bar ba (Fa vo, Tricofizia, Sico!<i e Follicol iti della barba) l'azione prwcipale si eserrilò sulle zone pr ive di lesioni e per la guarigione definitiva si potè osM r val'e che e ra necessar io un coovenrente trattamen to consecutivo, fatta eccezione dei casi lievi di s icosi e ili follicolite. Ne ll'acne vo lga r e e rosacea i fu r ono sola m ente limi ta ti, mentre spaRso fu r ono vera me nte notevoli negli eczemi, nei qual i special m ente il prurilo scomparve con ra pidila. Ne lla psorinsi il più del le volte s i ottenne una gua r igione quasi co m ple ta , in al cun i cosi una g uar igione a ddi r ittura completa deliP etnore!'lconze , ma non indugiarono a presen tarsi le rec idive. I n a lc u n i ca.3i ù i lichen c r ouico, di liclten r ube r plan us, di micosi f un goide, d i c arci no m i dell a cu te, di ve tTuche, di prurito vutva r e, i r·isult Rti ottenuti fur ono tah da a nuov e ricerc he. Senza l'uccesso invece qu esto metodo cura tivo fu usato in a lcuni casi di lepre .
G. B M B.
RIVISTA DI TECN
IC AESERVIZIO MEDICOMILITARE
E. l. farmacista militare. - n ohbll.uo 41 ltat o (comunicazione fat t a alla Societ8 P iemontese c'igien e - dicemb r e 1902).
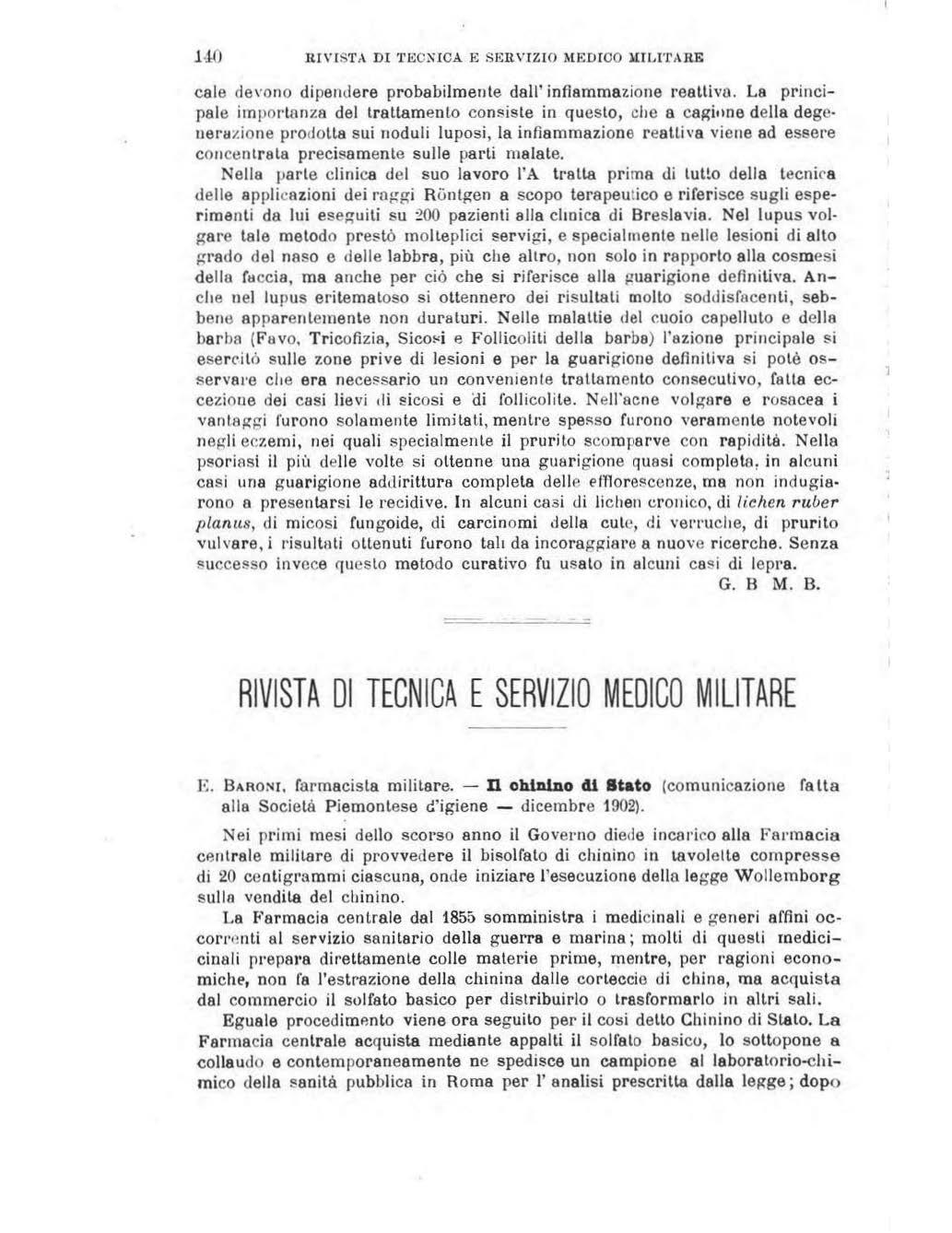
Nei pr·imi mesi dello scorso a nn o il Governo diede incar·ico a lla Farma cia cent rale m ilitare di prov vede r e il bisol fato di chi nino in tavolette comp r esse di 20 con tig t•am mi ciascuna, onde in iziare l' ese cuzione delln legge W ollembor g s u lla vend ita del ch inino.
La F a rmacia centra le dal 1855 so mm inis tra i me dic ina li e affi ni occor t'•!nt i a l ser viz io sani tario della g uerra e marina; molti d i q uesti m ed icicina li p r·epaJ• a dire ttam e n te c o lle m aterie p r i me, mentre, per r·agioni eco n omi c h e, non fa l'es t raz io ne d ella c hi nina da lle co rte ccia di c h ina, ma a cqu ista d al commercio il solfa t o basico pe r dist ribui r lo o t ras fo rmar lo in altri sal i.
Egua le pr oced imP. nto v iene o r a s e gu ito per il cosi dello Chini no d i S tato. La Far mac ia centrale acquista mediante a ppalti il solfato basico, lo so ttopo n e a colla udo e con tempora neame n te n e spedisce u n ca m pione a l lab ora torio-ch imico della sanitll pubblica in Roma per l' a na lisi pr escrit ta da lla legge; d o p o
1 !0 RI\'ISTA DI Tb:Cl\1CA E
SE:RV!ZlO ME.O[QO lULl'rARE
questo duplice cont r ollo, accertaLo che il solfato ha i r eiJUisiti voluti dalla fat·macopea urnciale del regno viene n e i labo rat ori dell a Farmacia cen tral e lt·asfo• mato in bis olfato
Per la s uddivis ione in tavole tte è nec e!'S'&rio soltopo rre la !'Oslanza a speciali ope razi on i per le quali le s ingole pa r ticelle pos!'ano odel'irc fra di lo•·o CO!'li che la sos tanza ste ssa posta ne lle apposale ma cchine acquisti la fo rma ed il pe!:o voluto
Il bisolfato di chinino viene folto stìori•·e alla temperatut•a di circo 60' fino a ··he 100 c hilo gramm• perdano da 19 a 20 chilo:;•·amm i di BCfiUa di c ri slalli z7-Szione. Si la q uanlilà di corrispondente a ll'acqua pr rdula pe r riav e re il peso d i 100
È ev ideu le c he in tal m odo la pe•·ce nluale del principio altivo non vi e ne ll'enoma m e nte alterala e che tavoletta di 20 centigramm i contenendone 16 c.l i bisolfato s fiori to e 4 di lalto!'iO, é co me con tenesse 20 centi g rammi di pu r o bi· solfa to c ri stallizzato, poiché illallosio, in questo caso, tiene il posto di quella par te di acqua di cris tall izzazione che il bisolfato ha perdu ta colla s fì o rilura . de l la ttosio o zucc he t·o di latte fa vorisce la disg r egazioue c la solubilit.à ne ll'acqua della tavoletta com pr essa .
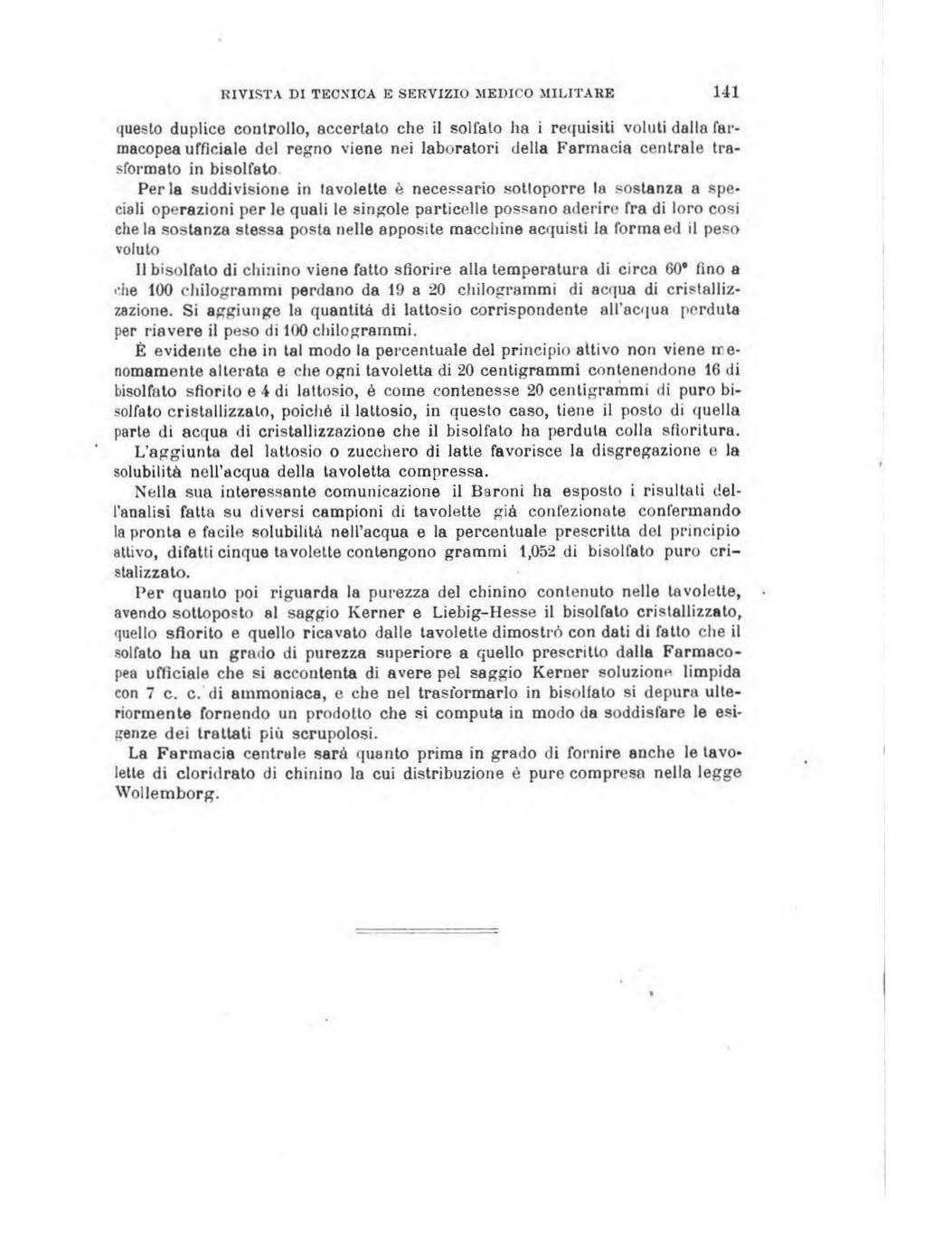
N!:llla sua interessante comunicazione il B a r o ni ha e sposto i ri s u ltati dell'analisi fa lla su diversi cam pion i di tavol e lte gi a confezionale co nfe rmando la p•·onla e fa cile sol ubilità nell'acqua e la percentuale pr escritta del pt·incipio atllvo, difatti cinque tavolelle contengono grammi 1,052 di bisoll'ato puro c r istalizzato.
P e r quanto poi riguarda la pur·ezza del chinino contenuto n elle tavolette, avendo sottopos to al saggio Kerner e Liebig-HeS'se il bisolfato cri stallizza to, r1uello sfiorito e quello ricavato dalle tavolelle dimostrò con dati di faLlo che il solfato ha un grado di purezza supe r iore a Guello della Fa r ma copea uffic ial e c he s i accon tenta di avere pel saggio Ker ner sol uzi o n P limpida con 7 c. c. d i ammo niaca, c che n el tras ìormarlo in bisolfato si depu r a ulte· riormente fo rnendo un pr odotto che si computa io m odo da soddis fare le e s idei trattati più sc r upolosi.
La Farmacia cenlrttle sara quan to prima in g rado d i for·ni r e an che le lavo· Ielle di clo ri d rato di chinino Io cui dis tribuzi o ne e pure co mpresa nella legge Wol lembor g.
RIVISTA
E
141
DI TEO:-.'IO.A
SERVIZIO lliLITARE
RIVISTA D'IGIENE
8oN SEIWI ZI. -Malaria ed &Dlmalldomeatlol. - (Cor r iere san itario, anno Xl V, n. 4, 1903).
Il Bon se rvizi, med ico provinciale, in ques ta breve nota a ccenna ad alcuni fatti da lui o sse rvati nella pro vincia di Mantova, i quali presentano un notevo le inte r esse per· l'epidemiologia delia malaria, ed an che pe r le misure profilattich e le q uali po ll'e bbe ro d e rivarne.

Nella provincia di Mantova l'anoph eles è abb o ndantiss imo, spec ialmente nel basso manto vano , ove tro vansi le co n d izi o ni tellul'ic he e meteorolog iche più favorev o li a l s uo sviluppo. La difficolta d ello scolo dei canali di irrigazion e produce •·is tagni di acqu a amp liss imi e la te mp e ratura estiva è ad attatis sima all o s vi l uppo delle zanza•·e Ora l'A: h a po tuto os s erva1·e come le s ta lle s iano infes tate da miria di d i an oph eles, mentre nelle a bitazioni dei co ntadini le zanzare o mancano, o s ono s cars issime S e poi vicino alla casa colonica vi è la villa s ig norile, qu es ta è a ssolutame nte immune da g li anofe li. È ques ta la ragi o ne per cui in luog hi m o lto malari ci vi s ono case s ig n o rili di villeg giatura d el tutto immuni da malaria.
Qu es ti fatti , a dire il vero, non hanno nulla di nuo vo . A tutti è n o to che g li an o feli predili go n o le stalle, ed ognuno che ne vogl ia far ra c co lta v i si diri ge co lla certezza di lrovarne g ran copia. Sono invece inle 1·essanti l e de duzioni che l'A ne trae Infatti e g li elice c h e ques ta p redil ezion e pe r le s talle non d e ve r e car me ravi g lia, poichè tali inse tti dall a vis ta impe rfetti ssima, hanno inve ce l' olfatto fini ssimo, che li g u ida Rlla ric e rca di sog getti da pun ge r e . Si comp r ende pe r c iò com e g iungendo ad una cas a , pt•eferi s cano invade r e la s talla anziché le camere di abitazi o ne. Perciò chi vuoi cerc are gli anofe li, deve lascia •·s i g uid a r e dal s uo naso. La con clus ione di c iò è ch e le stall e dife ndono le case d'abitaz io ne dall e zanzare, ed in fatti nella p arte bassa de lla p rovincia di Mautova, in festa ta da innume revoli anofeli, la p o polazione è d en s is sima e l a morlalila molto bassa , seg ni mnnife sti che il luogo è salub re
L' A. e sclude ch e ciò possa dipe nd ere dalla a ss is te nza meJi ca mi g liore che altrove e dal maggior cons um o di chinino, ed invec e riti e ne c h e s ia in rapporto col fallo che o g ni casa ha la s ua stalla , e c he i buoi, più fa cile p r eda de g li a nofeli, p r oteggo no l'uomo, nel s e n so che g li an o fe li stessi non hanno il biso g no di pun g erlo. Ciò è provato dal fatto che n elle rare case c he non hanno stalle, gl i anofeli son o molto più abbon danti nelle abitazio ni, e le famiglie sono infes tate dalla malaria.
La città 'di Manto va poi fornisce un'alt r a pro va d i ciò . Alla perifet•ia della città abita una popolazione mis erabile e sudi cia , e le zanzare provenienti dalla campag na vi si fermano e no n sentono il bisogno di invadere il centro , abitato da pers one ricche od a g iate, e , ciò c he più importa, pulite. In ques to caso adunque le person e misere e s udicie fanno la p9 r le dei buoi, e s o ffrono m olto per le febbri, mentre il centro della citta ne è immun e . Se invece la c itt à d i
Mantova fosse circondata da stalle piene di buoi, l ' A. t: convi nt(> che la popol azione verrebbe in modo per vi a indiretta aù essere pr otetta dall e 7.anzare e dalle febbri.
L ' A. quincli preconizza questo m ezz o d i profilassi, cl 1e chiama la protezione deg li animali, l a quale sarebbe un m ezzo non disprezzab ile, a n che perch i' di faci le esecu zi one, e superiore ad al c uni m et où i o r o in uso, flual e l a pelro l ei zzazi one degli s tagni. I n questo m odo si spieghHebbe l'utili tà costatattt j'rt\l l · camen te, dell!l c ullura intens iva Tutto c iò n o n può aver e un valore assoluto, e n on s i può p t·etender e con ques to mezzo soltan t o di far scompari1·e la malaria da un dato t u1-rilor in. L 'A utore è il p rimo a riconoscerlo, ed a ggiun ge che ques to mezzo non po tra C"'rt o garPggiare colla protezione meccani ca e colla profilass i a mezzo del chinino Ma l'idea è originale e buo na. e m eriterebbe di esser p1·esa i n con siderazion p, giacché è sol o dall'insieme oi varii sistemi cho s i può sperare di cumbat t ert1 Pfiicacem ente la malaria. G. B. M . B.
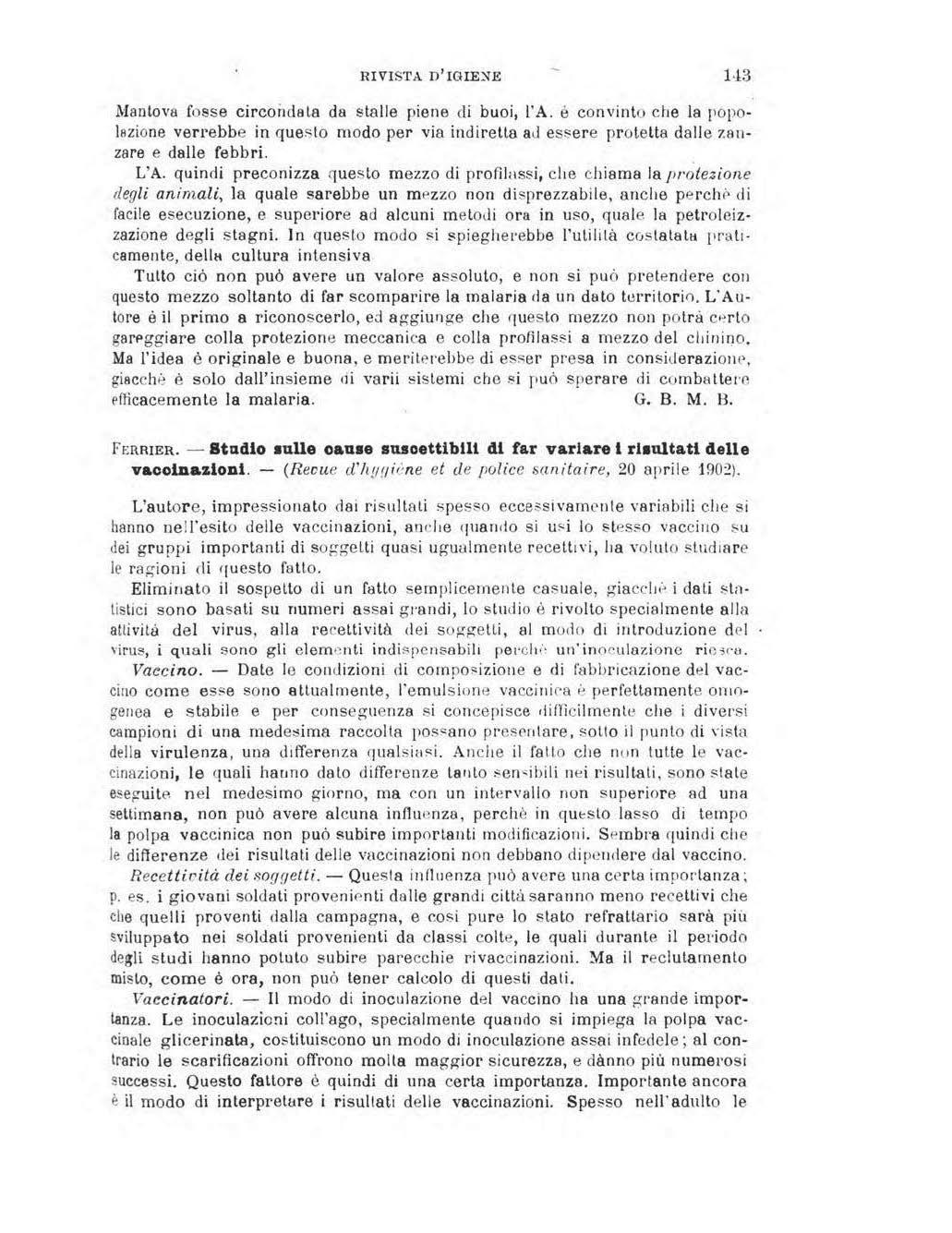
rER RIER. - Studio sulle oauae auaoettibllt di far v ariare l rlaultatl d ell e vaooblaz.lonl . - (Recue d'hyyi,:n e et cle pulice .sanitair e, 20 apri le
L'autor e, impression ato da 1 risultat i spes;:o vari11bili elle si hanno ne l l'esito delle vA ccinazion i , a nr·l1e quando si u ::- i l o s tf'SE<O vaccino dei g ru pp i impo rtanti di soggetti qua si ugual m ente r eceltl\ i, ha YO! uto studiA r <' le ra gioni d i l(uesto fatto.
Eliminato il sospetto di un fallo semplice1ne n te i dali tisl lci son o basali s u numeri a ssai grandi, lo studio e r ivolto specialme nte a lla atlivila del virus, alla re re ltività dei al m odo di i11troduzione d ('l i qu a li so no gli elem•'nli indi51pcnsabil l pe1·c hi· un' ino C"ulaz i onc r ie wu .
Vaccino. - Dale l o condi zi oni di e di fublwicazione del vaccino come esse sono at tualmen t e, l'e m ulsione vnccini r a i> per fetta m ente omogenea e s t abil e e per co n seguenza s i concepisce d iffici l mente c h e i divel'si campi o ni di una rned e:;ima raccolla pos"ano prcsr11 t are, solto il punto d i della vi r ulen za , una d 1ffere nza qualsit1SÌ . An che il fal lo che n11n t utte l e vaccinazioni, le quali haiJOO dalo differenze tanto :<en"ibili nei r isulta ti, sono state n el medesimo g io rn o, ma con un inter vallo non s u peri or e ad un a settiman a , non può ave re alcuna influPnza, perchè in qutsto l asso di t empo la polpa va ccinica non può subire impo rtanti mod ificazioni. SPmbr a quin di elle le diRere nze ùei risultati delle vuccina:Gioni n on debbano dipo!u dere dal vaccino.
R ece tti rila dei Questa in nu enzn può aver e una certa impol' tan za; p. es. i g i ova ni sol dati proven i f' nti dalle grandi c itta sa r anno m eno re ce ttivi che che quelli pr oven ti dalla ca mpagna, e co;;i pu r e l o stato refr alta 1·io sarà piu svilu ppa to nei solda ti pl'ovenienli da cl a ssi col le, le quali durante il pel'iodo degli s tudi hanno potuto subi1·e parecchie rivac ci nazioni. il r eclutamento misto, c ome è ora, non può tener calcolo di ques ti dati.
Vacci n a l ori. - Il modo di inocu l az i one d el vaccmo ha una g rande importanza. L e iooculazioni coll 'ago, specialmen te quaudo s i impiega l a polpa v accioale g li cerinala, co stitui scono un m odo di inoc ulazio ne assai infedel e; al co ntrario le sca rificazi o ni o ffrono molla maggio r sicurezza, e dànno più numet·osi successi. Ques to fa.llore ò quindi di una certa importanza Impo t'lan t e ancora è il modo d i interpretore i ri sultati delle vaccinazi oni. Spesso n ell'adulto l e
RIVISTA D' 1-13
p us to le vu cciniche s i presentano con ca ratte ri atipi c i, a ve nti l'as pe tt o di s empli c i a c uminale, se nza apparenza d i ve re pustole Ques te efllore<we u zo va cciuali , mancanti di caratteri nett a mente de finiti, non so no però n e lla po rte d e i ca s i, che pusto le auteutiche, ridott e nel loro s vilu ppo perché il va cc·i no è s tato impiantalo in un terren o poco recetti vo. Malgrado c iò, esse però so no capaci d i confe rire l' immunilé. come re ce ntemente hann o dim os tra lo Hert hic r, L em o ine, Ca!' lere l. L' dei ri s ullati delle va ccinazio ni p r esen ta d u nqu e in certi cas i q ualche d iffi colt à; ecco pe r c h è una vC\ Ila il r t•gola men to s ull e va ccinazio ni auto J•izzava a far figurare nelle >- Lati,..tic he i •·is ullnlt in ce r ti. All o s tato pre s e nte il r egolame nto presc•·tve ch e i cn :- i d u bb i de bbo n o co n sid erarsi co me ins uccessi, ma da ciò •·•s ulta che mentre q ual c he va ccinaLOre ne lla tema di ins et' i1 e un ins u ccesso nella c ate1-!0I'ia deg li esiti vos itivi é di un ' es t1·ema seve ri la, qua lche altro al co ntra l'io ,. di un o llimi s mo forse esaget·ato. Da ciò p ossono evide ntem e nte ri l'l ultare m o lte disc t·e panze ne lla valutazio ne dei ri s ultati; l'is ulla quindi necessari o il l'iSLA bilire la cale g oda d ei ca!'i in ce1·ti.
\n ch e qu es te co ns id erazi Cl ni s ul ùivePs o m odo di inte rpre ta r e i ri s ultati de lle va ccinaz io ni, non s embrano pet·ò all'autore sufficienti per is piel'are la divel'!'-ité !ì pesso tanto c o nsiderevole fra le s tatistiche dei diversi operatori.
Conc lusioni. - P er poter app r ezza1·e con una c.erla e sattezza la reale alti vitti di un virus vaccinico , occorre bas a1•s i, n o n so prts una s tati l' ti ca isolata, m a so pra l'm s ie me dei risultati ottenuti in crr·costanze diffe renti, da differe nt i vn ccinatori.

Il s uccel'SO dell e inocu lazioni uo n dipende t<O i tanto dall'atlivilé. de l vaccino n dalla re cetti vità deg li individui ; esso d i pende an c he in g ran pa rte dal modo d' inoc ula z io ne e dal mod o con cui gli operato ri interpretan o i l'is ulla t i.
Allor()ua n do s' impieg a un va ccino di luito , c o me avviene pe r la polpa glicerinata , le s carilicazioni s o no di gt·an lunga pre feribili all ' innes to coll'ag o.
Il co ntrollo delle in oculazio ni vaccinic he può dar e d ei ris ultati variabili , a s eco nda della mallgio re o minore severità co lla qua le s ono inter p r e tati i ris ultati. Per fac tlitare ques ta intel'p retazione, s arà bene fa1· an che dei cas 1 ùu hbi, s a pendosi c he 111 magg1o r parte di ques ti corris po ndo no ad e s ili positivi. te
L. V AILLARD.- L& oarne In oouerva . Aoolden tt da •••a provooatt ; mezsl per preveDlrli . - (Rec u e d' Hyg ie n e et de t•o l ice sa ni laire, :!0 ge nnai o , 1002) .
L' A. pre melle alcune conside razi o ni sul m odo rli fabbr·ica•·e le scu lole di carn e in conse rva ; de s crive gli accidenti che qualche vo lta !'le g uon o l'in g es tione di ques ta carn P, s ott0 forma di e pidemie ; enumera le ep idemie avv enute negli ultimi dodici anni, nei militari in Francio, e che furono in num e ro di 1\ c o n un so l caso però di morte.
I s in to mi sono quelli del botulismo, e s i prese ntan o o in modo s ubitan e o o d o po un ce r to tempo. Perciò vi sono fin da principi o du e qu estioni da ris o lvere , s e possono cioè esi s tere de lle sos tanze tossiche n e lle carni in con se rva, e se le cons et•ve stesse pos sono contenere dei ge rmi vi ve nti, copac.i di pro vocare un ' infe zi o ne
Riguardo ui vel e ni chimici, non si pu ò parlare di vele ni minerali , né di ve1eni pr odollis i per l' inve cchiamento della carn e . S i dev e quin d i a ll o
144 IUVJSTA D' I GIENE
i potesi: o ch e la sostnnzo tossi r. a sia originar-iamente contenuta n ella carne delranimole che Ila se rvito alla fabbricuzionl', o che !lÌ é fo J•mata po"leriOrmente alla macellazione, nel cor-"O della fabbricazione e pel fatto dt una ,.e).!elazione m icrobica su carn e ori gina:•iamen te sona, o che, infi'le, st 6 fo rmata più tardi ancora la chiusu ra della e pel fnltl) dt una col tura microbo lo sconosciuta.
Quesli fatti possono verilìcar<>i: infn lli una car ne può e-<!':er <! to.. "ica in Or!· zme sia p('rché proviene da animali alfaticati, l"ia perché i mctie!limi !':ono an•malati (afl'ezioni piemiche e Pnterite, oppu r e puù diveni r tossi ' a durante la fabbricazione o in se:zuito a r ila t·rli nel chiudere le o a imperfezioni accidentali o fraudolente durante il lavo ro. Numerolie sono l t- con<>erve chE', la sterili zzazi onr, dei ;::-et•mi viventi. Le e!>perienze dell' A hanno climol<lrato elle il 70 p. 100, ed anehe più delle conserve contengono dei g ermi e che fJ U\'!I t i !!ermi pOil!=<Ono rima nervi !'enza pe rire prt· 5, G, od anche i' an n i. l germi tt•nvati n scatole fut·ono !'em pr·e aer obi, gli ana erobi, se esi s tono, si sviluppano prima e fan110 •·•conoscer e per lo s vil uppo forte di gas e per le alt(' rHzion i vi s ibili dJt' s i manifest ano nnc he all'estern o nel l e scalo!('. Il perc hi> poi gli arrob i vi,·ano e n o n vPgelin o, ciò lo s i deve nlla d'osRi;:reno. All' i nfuor i del· unn fe!'surn qualunque, una piccola t·o ttut·a d t' lla scotoln che perm etta r dt>ll'ario, può far vege ta l'C i I n o llt·e è da OS!;ervars i che spes!'o, aperta la scatola, l e cat·ni non ,·engono consumate subi t o, e' l abbandonate all'aria liber·a. speciulmenle tfes tate, m ol to facilmenle p0!1"0no dar luO!tO a dei In gene re , di raro si trovano ger mi facilmen t e vulnerabili: comu n emente l<i lt·cwtmo il iJ sottile e le divet·!'e vat·ieli• del mewtte rico, il quala ultimo inlervien.:J attivamente nei fenomeni di f,..rmentazi one. I n oltre l'A. ha riscontrato un batter io spont lan te che, s\'iluppnndos;i nei mez zi adtiizionali con car·ne sviluppa un odore solfor oso a"t>Si forte, ed anche un bacillo corto, as!'ai a spot e ovoitli, l e 1..ui cultu re esalano un ndore putrido; iooltr<> dei bacilli non victni ai p r olei ed al b. termo. r iscon tr ò il iJ. entcrtlidis di G•it'lner ed il ba tter i o di Van Ermen gen. Le inoculazioni ne:;:li animAli !'nlo in un caso fur o no seFtuile da efTI! tli
Tull i questi ra tti dim0l"lr ano che le carni in conserva mal stel'ilizzale, e una carn e in può esi'e1·e clannos:a o per·•·hé fu fab bri ca ta con carni malsane , o percliè fu fabbricata male, ù perch•l i JWOccs:si •li fobbr·icAziono non r ealizzarono la !òlerilizzazion€1 della ca r ne.
L e mi s ure da pt·endersi pet• impedire gl i accidenti prov oca ti dalle r·a t•ni in conse1·va debbono quindi t'i gua rdare:
to L a sorveglianza sanilal'ia degli animali destinati allo co nfezio n e d elle conserve;
2° La pt·opri e tò, o piuttosto l a pu r ezzo, rasepsi dci pr ocessi di l'abbt·irazione ;

:J0 La ster i lizzazione delle carn i (118'- 120• per ùue or e).
A q u este r accomandazioni se ne deve poi aggiunger E' una, di carallet·o imperativ o, ossia la rapidilà di succel'sione nell e diverse oper·a zio ni dt fabbricaztone. le.
RlVlST.\ D' IGIE:SE
U : vr e - ProaJ.as sl urlnarla della febbre tlfolde . - (Bullet. dt• la Soc. mr=dic. des !tòpitau.r, 12 dic. 1 90t).
Dimo<.trata la pre!:enza del bacillo di Eberlh nell'urina dei tifosi, e dimostr·Alo au rhe che spesso la vescica si trasrorma per più mesi e qu al che volta per· più annr in un termostato dove si formano col ture pure Ji bacillo, si com· Jl r ende quale importanza debba avere per la profilassi del ti fo, la distruz ione di que!llo nuov o focolaio di disseminazrone del p-erme ti foso.
Gli AA. citano una pro,·viJa m isura pl'esa nell'esercito tedesco colla quale or dina di esaminare dal lato balleri ologico l'urina di lulli i soldati che hanno od hnnno a,·uta la febbre tifoide. Alcuni medici inglesi e tedesrhi poi nei rasi di balleriuria o di cis-tite eberlhiana, dr fnr prenclere all'ammalalo 0,50 a 1 g r. di urotropina pura per giornn duranto lulla la malattia, s ia 2 gr. pPr gio rn o per una settimttna, a partire dal 21• gio r no della febbre tifoiclc. Ques to medicamento fu impiegalo e studia lo nella sua azione batlericirla .;:ui batteri del tifo nell'urina, dallo Schumburg.
Si pu6 anche impiegar" il sa lolo ed il lavaggio della ves r ica. le.
C11 DoPTER. - Sulla dl•lnfedone del looaU oolle polverbzazlonl dl una s oluzione 41 formolo . - (Reoue d'lt!!{Jiene et de police 20 febbl'aio 1902).
L'A. usò la soluzione segut>nte: formolo del commer·cio, al 40 p. 100 cm r . 2i-, acqua !)76 e m e. La polverizzazione venne fatta coi comuni apparC'cchi. N o n si ebber·o inco nvt>nienti di sorta. La sterilizzazione delle polveri non si ottenne, pero il numero dei germi si lro,·ò diminu ilo n ole volmeole, e, !:alvo le !>por e, la ma;.q::ior parte degli altri germi, sopratullo quelli che eventualmente possono divenir patogeni, perdeller o la lol'o vegelabililà.
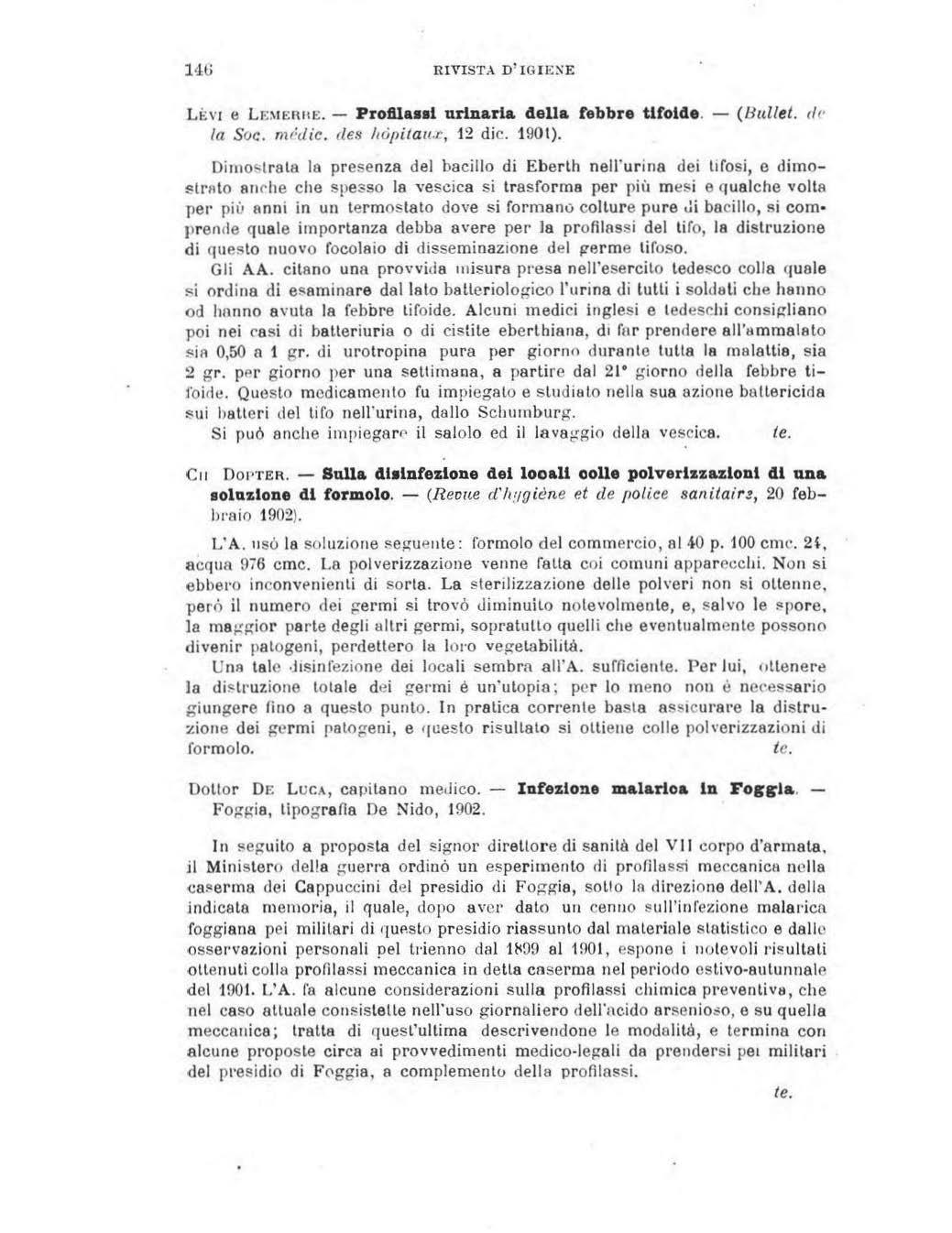
Una talc> .Jrsinlezrone dei locttli sembra all'A. sufficiente. Per lui, ottenere la di!:truzione totale dè i ;?ermi é un'utopia ; pe r lo m Pno non è nc ce!:sario gi ungere fino a ques to punto. I n pratica co rr ente basta ass rc ur·at•e la dist ru:lione dei germi patog-eni, e ttceslo r isullato si otlieue colle pOI\'e r izzazioni ùi formolo. i c
Dottor DE L ucA, capitano medico. - Iufezlone malarlo a lu Foggia. Fog-g-ia, tipog rafla De Nido, 1902.
l n seguito a pt•oposta del signor direttore di sanità del V Il corpo d'armata. il Mini stero del!a ord inò un esperim ento eli mercanica nella <:&!'erma dei Cappu ccini d el presidio di Foggia, souo In rlir·ezione dell'A. della indicata memoria, il quale, dopo aver· dalo uu cenuo su ll 'i ufezione malar' icA. foggiana pei militari di rJUP.sto presidio riassunto dal materia le sta tistico e dall e Osser·vazioni personali pe l tr·ienno dal 1!1()9 al 1901, espone i no tevoli r•isu ltali ·Ottenuti co lla profìlassi meccanica in detta CtJSet·ma n el peri oclo esti vo-autunnale' del 190 1. L'A fa alcune considerazioni sull a profilassi chimica preventiv11, che nel caso attua le consislelle nell'uso giorna li e r o dell'acido arse nioso, e s u quella meccanica; tr atta di q uest'u ltima descrivendone le moda li là, e termina con alcune proposte circa ai provvedimenti da prendersi per militari del pr·esidio di F<'ggia, a complemento della profilassi. te.
14li RIVISTA D' lGH::\E
Oollor GJ\TTt, medico di t• cla sse della r egia marina. - O&Jzatur& lgl entoa. Spezia, tipografln 1902.
L'A. allo di trovare una calzhtur·a, la quale lasciando si piede tutti i ''an la Ergi elle dalla ab1tud ine di andare a piedi nudi. non ne abbia ::h incvnvenienti e la rozzeLza, ha il seguente tipo di !'Ca r pe. Il tomaia s1 inserisce alla suola per m odo che la linea 1ti union e delimiti una fi. corri spondente a quella elle si olliene sopra un di ca rla, facendo perpenchcol armenle una punta scr 1venle attorno margme del piede, •tuando questo si con tullo il peso d tl co rpo sul piano ùi soslt'gno. Il lacco 6 largo e basso. L'estremi hi anlel'iore della suola è rellan golare e lnrga abbastanza perclu'• le dita possano durante il carnmintlre, rettificare spontaneamente la l o r·o direzione e riacquistare la l o ro li berlà. del l0111aio in aYanli deve estoer·o un centimetro e m ezzo più ol tre del limite più avanzato ciel piede. I l tomaia poi pre!'enla due aperture, una nnlf'riore, che ha h\ lì;.ru1'8 di uno stretto obli'Juamenle di retto di dentro infuori o rl'avanti indietro, e corl'i sponde alla linea di m o ,•i meuto dell'articolazione melalarso-ralaugeA, una poslo r·iore, che corrisponde al colmo del piede La porte anteriore deltomaio prote gge l e dii a ; le sue pa1·ti laterali ripar·nno i m argini del piede; lA parte posteriore ci r co ndo il i m u ll•·oli, e si in uvauti in dul' linguette che si ..:an fermagli o a,, m aschio eJemminn, ap nfl ua piil l=IOPI'8 della linea di movimento del collo del piede. Con rJuesl i dali e con qualche modilìcazion e, non essenziale però, l'A. pr·opone po i divel''lÌ modC'lli piu ele!!anli, o dctotinati ad alcuni esercizi speciali. come la marcio.
Questo tq>o di calza tura avrehbe, l'A., il vantag::10 di JH!r·mell>'re al piede la ma ssi ma mobilita, eli permettere atto rno al piede uno llber·a ci r colazione d'aria, di rendt>re obbligat o rie le ablu zio ni quolirliaue ai piedi, di fA\'Orire la r t>si s t enza del piede alle var·iazioni dello tcmper·atura, elevando il coefficiente m trin seco di r egolazrone della termogenesi locale, tli es!'e1·e ecouo mica, di essere bella ed elegante.
Un m odello speciale figuralo nella tavola annf'l'l!'a alla m Pmol'ia, !'a r ehbc appr·opriato p1--r le truppe, e l'A. con questo tipo di calzatura, che suro•bbo un:l combwazione di antiche calzature greche e romane, r iti1me di a, er· ri solto uno clei problemi piu interessanti dell'ig-iene d el piede. te.
TIRJ\IIOSCHL - GU anlmall propagatori della p este bubbonloa. :'\ o la t • . Le pulci dei ratti c dei topi. (Bollect. della Soc . .oool. ital. 190:2). - ì'\c•la 2•. L e pulci dei ratti e tlei topi e la della (leste da rutto ad uomo. (f-olicl. 1!'102). - Nola 3". Mus decumanus e mus rattus. del mus rattus in Italia. (Bollr.lt. della Soc. zool. ilal. 1902) . - Beitrau .)U r Kenntniss clt:r Pestepidemiologie. Ratten, Mtiu.•e, und tl!re (.'1r ch r. 1/yg. 1903).
In lulle questo nole preventive l'A. espon e alcuni ril'lullati ric Pr· cht> sui raUi e sui lopi, e sui loro parassiti cutanei. E anzilullo dellaglialamcnle desc1·ive une specie nuova di pulce da lui trovata su di un top olino delle c11se (M us muscultts L.) in Roma, e per la quale propone il nome di HrJSirichoPS!Jlla tripectinata. Poi premesso un a ccurato cenno bibliografico, riassume nel seguen te quadro sino tlico le varie specie di pulci da lui osservate !'UIIe diverse specie di ratti topi in Italia:

HlVIS'rA D' IGIE:o>E u;
clec:11manttS Pali. (!fa tto d elle cJ. iao iclte) :
Ce r atoph!JIIw; fnsc ia tus
l'uiPr T schb (ahbonde olc);
J>ul•·J' irritnns L.
('tenop.,ylln fllusculi D ugès
. L . e ,\fm>. aler-a nd rmu s Gt'•ofl'r. 1topo lll'rO o topo dc i telti):
Ct• •nOfiS•Jila musculi, D u:;!ès. (abhondantisc;imo) ; fasciatus. Busc. (sca r so);
P ule r T scltb . (scarsissiuw);
Puler it·rilans L. (:>ca r so) ;
Sa rc opSf!lla gallinacea \Ve sti r. (sca rs. o);
.\ltts musculus L (lnpolino òctle case):
m us•·ul i Oug (abbonda n l i!'!<t m o) ;
r·eratc,fJh!fl/us .fasciaws B osc. (SCiti'!'issimo);
tritu:ctinato, Tii·ab. (scarSIS!'I m )
.\l u8 L (topo selvatico) :
C l erWfl·ç!,lla musculi, Du ft. (a bbonrlu nte)
.4 roicola suiJte rranefl.ç, SPI ys ( topo Cer atoplr!flltt R Bosc. ("carso).
In !!-<'gu ito l ' A. in ba!'e a numerosissi me esperi enze f tl lle s u !'o' st esso c m mo lle altre per son e, so!'liPne c he le due di pulci più t.liiTus e sui ralli e t opi (Ce r alotlllltllns Bosc. e Clenop.<ttlla 1/)IISCltl i, Du g) no n pungono mai l'u om o, an che dopo 3 o 4 giOI'ni di digiu no, de nli'O il qual t empo lutle muoiou o di fame piuttosto c he ,li umu no E"!;'6 q uiodi n un po!';:on o l ra"pO rlar e nell'uo m o il germ e dt• l la pe!-te colla l 01 o puntura. Di ta l e tra;:porto, dolo che esso sia po!'si bile pos'lono in\'ece essei·e iu cnlpA l c P11/e r ser ra tirl.!fl!!. T srhb (pulce del can e), e Pule:r L. (pulce d,.JI'uo m o) che pungono !"uo mo, c delle qua l i la prima t" fr c •Jllenle sui t·atli delle chiav i che e su l topo nero o dei t et t i, e l"ttltra è I"fll'!l i o tutt e e due l e !'pet·ie. A ggi un g-e che !'econdo le Psper it-nze anche le pulci dei pipistrelli e par t icolarmen t e Ce f' alopsttlla ocloctena , K o l. non l'uo mo, e che invE:ce lo punge subito, succhiando poi a h111go, la pulce d el r icciO ( PIIlt•x e r i nn t'ei, Bo udu'), e ciò coulra r iam enle a lrasset·zione d i Ga lh-Ynle i·io; che c:ot lauln !' U la pulce dell'uomo e s u quella del c ane e non su la pulce del ricc i o, ha J·isconu·nto Il fallo già ossei·vnto da Zir ol ia che nell'atto ;:tl•s<:o del "Ucchiar,.. cssp lancinuo dall'opP r tura anale d ei zampilli d i che le dut! d i pul ci più diffuso su i ratti e sui topi saltan o poco e difficilmen t e, il che r ende piu dil'lirile la diffusione dl'lln l1t'!'le per l o r o Infin e l'A. dopo Hvere accennalo alla d ivet"!'ll impol'lfln za attri buita a l comun e rat to delle c iiiavi cltP (Jfus dccrcmanu.ç, Pa l i ), e nl ratt o n er o (M rntlus L .) pr r la di fl'u • i o ne della pe"-le, e dopo ave i· ri as::unlo i cot•otteri dlfferetlZi n li fra la pri ma spPCi t' e lll \·ar iet ù ole:ranrl r inn della !'econdo, tw tl!!l!i llnJ<c nl c uni nuo\'i, lrn c u i impo r tante CJUell o della p r ese nza plat•i ilnliani cln lui e!:'aminnl• l di solo 10 mamm el l e n el Gio ll'I·., i ovi'CO di 12, come è il ca "o .lfus decum an rt S, o d (· ll o l'le!'!'() .Hrtff ratltt:f in fine elle i l J1M 1:'1' o I'elnlivn m t>nle raro tw lla !'Il Ft forniA lipito, è ancm·a invece abbastanza dilfu!'o, !<pecinlm r nte in e Otlche n<'l l e pi ccole ctllò, nellA ' li ri elà aleutntl ri na. le.

.. ... J lX D 'lGIEXE
P.u:1N1. -Di ua auovo appareoohlo per pre1a eU oamplonl d 'aoqua a 1oopo battertologloo. - l\t oJene, tip. Soliani, 1902.
Fra i tanti a pp11 recchi per la p r el!a de'i campioni d'acqua in profonditù, a scopo batteriologico, m eri ta d<'gnamente il suo posto quello ideato dal do li. Panini, il quale consiste esse nzialmente in una a rmatura m Ptallica con p1ede pesante, entro la quale sta collocala una botliglill a tappo smerigliato facilmente amov1bile. e sco r r e un'asta la quale nella sua estrem i ta hA un cons:egno mobile destinatoad atTerrare e a tenere solidamente ll!<!<a to il tappo d Ila boltiF"Iia. l ntrodolto nel telaio la bottiglia chiu!-'a, previamente ster il izza te, e n.. al tappo l'asta verticale, si fa disce n dere l'ttppat·ecchio r.on 11pposita fune nelra r qua, e r aglliu nla la voluta profondità, si Lenrle un'altra corda colle-:ata all'asta ve rti cale, e con essa f.i innalza il tappo; dopo pochi secondi rilascia ndo quest'ultima fune, il tappo ricadrà nccessal'iamente ent r o il collo della bottiglia, e si polru allo1·a far risalire l'appa r ecchio.
Questo a ppa r ecchio se r ve specialmente pet• le profondi la medie, n on maggi o l'i di 18 metr i, ed ha fa llo già buon a p r ova, {liacchè ha ser vito per la pt•es a di piu di :!000 campioni d'acqua i n occasione di u na n u met·osa ser ie di ricerche batterio logiche fatte per conto dell'Ufficio d' igiene rl e l comune di te.
BA raRnr. - La • Btreptothrtz liDguaU1 » nella booo& del 1anl e 4el 4lftertol.- (fJollet. della Soc l.ancis. rifgli osped. di Roma, fase I l. anno XX II, 1902.
L'autore ha studiato u n germe c he travasi nella boero degli individui sani e rlei dinerici, che per i caratteri mo r fologic i e colturali appartiene al gruppn della St r eplolhri:r:, eu è smonimo del cibrio o lin[Juale, il quale può facil mente tra r re in errore, dovendosi fare la diagnosi della difte!!ia per le sue fo r me elevate, che pe1' i suoi p:ranuli. Per differenziarlo non ba«tano i p r eparati colora ti semphcemen ll.l o c o l metodo di Ne1sset·, ma occorre anche del metodo di colorazione dei grauuli di Crouch .J oli Brtt nst ei n. SpPc1almente col metodo di quest'ultimo autore, i della St r ep fothri :r linnon si colora no, mentre invece si colo r ano quelli del bacillo dinerico. le.
CA S AGRANOI. - Balla rloeroa 4elle to11lne baoterlohe negli organi. - (Boli. Jella Soc. Lancis. degli osped. di Roma, fa,.c. Il , anno XX If , 1902).
Oa ur. a se r ie di ricerche sul pr oposi to, l'autore ha concluso chA nei s ucchi degli organi deg li animali mor ti in pr eda all'in fe z ione tetanica e difterica, o morti ui difteri te e di te ta n o, no n sono di m ostra bili colle i n ocu lazioni dei s ucch i s tessi in cavie sane, le r e lative tossi ne; che le dosi m ini m e m ortali d i tossi ne di fle r icn e tctanica. e quelle di abr ina non s i l'invengono ne1 succh i delle cavie inocula te. ma che le tossine stesse si r it r ovano solo q ua ndo sono state inoc ulate in quanlil8 molte volte mortali; che per trova re il vele no telan ico negli organi, giova e!lrarre gli orga n i spappola ti preferibilmente co11 soluzioni alcali n e, inocu landnne poi il p r ecipi tato a lcoolic o seccato. Co n ques to pr ocediment o si può d imoil veleno te la n ico nel sistema nervoso cP. n tr ale non solo negli a n imali infe ttati spe r imenta lmente o morti, ma anche nell'uomo. te.

RIVISTA D' lGlE:"E lJD
CA <;AGRANOI. - L 'emollaiua e la leu coU•lna 41ploooooloa . - (llollet. clel/rt Soc. Lanecs. rlrgli OSJ•ed di Rouw, fase. Il , anno XXII , 1U02).
In Sl·guilo a numerose esperienze, l'autore dimostra che le emolisine diplo· cocciche non !'i pr·oducono nelle brodocollure di lulle le va d età di diplococco; eh••, quando e si!'lono, hanno le proprietà dPlle emolisme di tutti i germi eposuna costrluzione a quella delle tossi ne; che inoculando le bro · docollure e m olitiche nei si aumentano Io p ropri eli.t dei sier·i; che l'emolisina prodotlasi nell'or·ganismo degh animali infetti non ha a che fare con qu,•lla delle brodor<•ltu r e.
Dalle r·rcer·che sulle leucolisine, si deduce poi che esistono delle ,·ari elli Ji diplococco le quali, indipende ntemente tla una emohsina, pr oducono una s tanza che Ira proprtelà leucocidiche e leu coli tirhe, che lo proprietà leucoli· tica delle brod ocollure di diplococco può dimostra l'si anclte col metodo bioscopicQ di Nf'isset:' e Wescberg, che razi one delle leucociJ ine non é inibita dal dci sani, ma lo é da qu e llo degli animali infetti o immunizzati, c che trattando animali con estratti leucoci tlic-i é possibile imparlir·e ai sieri degli animali s;Lessi analoga azione anlilcuc0cidica e renderli r·esis tenli all'infezione diplococcica. te.
VA L ENTI. - Un nuovo rapido procedimento p er la oolorazlone del ftagelU del batteri. - (.ttli della R. A ce di Scien:oe, Leltere ed A r ti, in \Jorlena , seJ'ie l I I, voi. V).
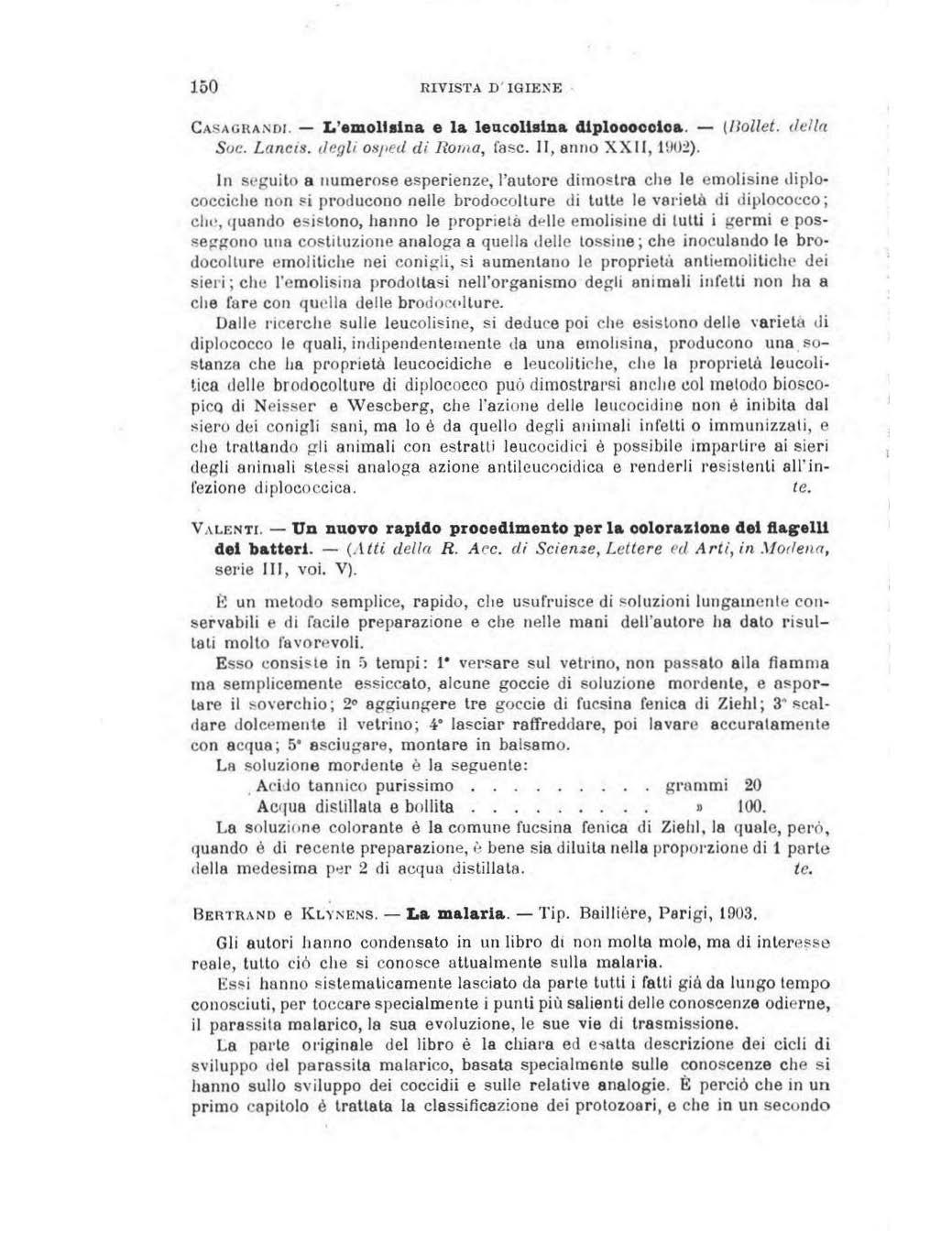
i!: un metodo s emplice, rapido, eire usufr•uisce di f"Oiuzioni lungamente conservabil i e di racile pr eparaz ione e che nelle mani dell'autore ha dalo ri s ultati mollo ravort>voli.
E sso consiste in :> tempi: t • ve r;::are sul vetrrno, non passato alla fiamma ma semplicemente e;::f'iccalo, alcune goccie di soluzrone mordente, e asportare il 2° tre goccie di fucsina fenica di Ziehl; 3• scal· da r e dolcemente il vetrino; 4• lasciar raffreddare, poi lavare a ccu ratam ente co n a cqua; s• asc i ugare, montare io balsamo.
La soluzione mordente è la seguente: AciJo tannico purissimo g r·ummi 20 Acrrua distillata e bollita 100.
La soluzi<.ne colo rante è la comune fucsina fenica di Ziehl, la quolo, per·o, quando é di re cente preparazione,,., bene sia diluila Mila propor·zione di 1 parte della medesima 2 di aequo distillala. te.
BER TRAND e KLYI\1!::-JS.- La malaria . - Tip. Bai lliè r e, Parigi, 1903.
Gli autori hanno condensalo in un libro dr non molla mo le, ma di inleres;::e r oa le, lutto ciò che si co n osce a ttualmente s ulla malar·ia.
Essi hanno s is t emalicamenle lasciato da parte lutti i faUi già da luugo tempo conosciuti, per toccare specialmente i punti più salienti de lle conoscenze odie rne, il parassita malarico, la sua evoluzione, le sue vie di
La par·te odginale del lib r o è la chiar·a ed c-;alta descrizione d e i cicli d i sv iluppo del parassita malar ico, basala specialmente sulle conoscenze che s i hanno sullo sviluppo dei coccidii e sulle r e lative analogie. È perciò che in un p r imo cap riolo é lrallala la classificazione dei protozoari , e che in un secondo
150 RIVISTA D
IGIENE
'
é esteto:amente svolta la storia naturale d e i coccidi, specialmente del C. Selwbergi coi suoi du e cicli d i sviluppo (Schizor!onia) e sessuale (Sporogonia), con rtualche cenno su i coccidi più import anti riscontrati nei divers i anima li, e sulla tecnica speciale per le osservazioni.
La terza pnrle del libro tratta de l parassita della malaria umana, nomenclatura e c lassificazionP, para,siti della terzana, della q uartana e de lla feb bre tropicale, diagnosi mic r oscopica della malaria, co n trattazione anche delle alterazioni ri g uardanti gli elementi figura li del sangue.
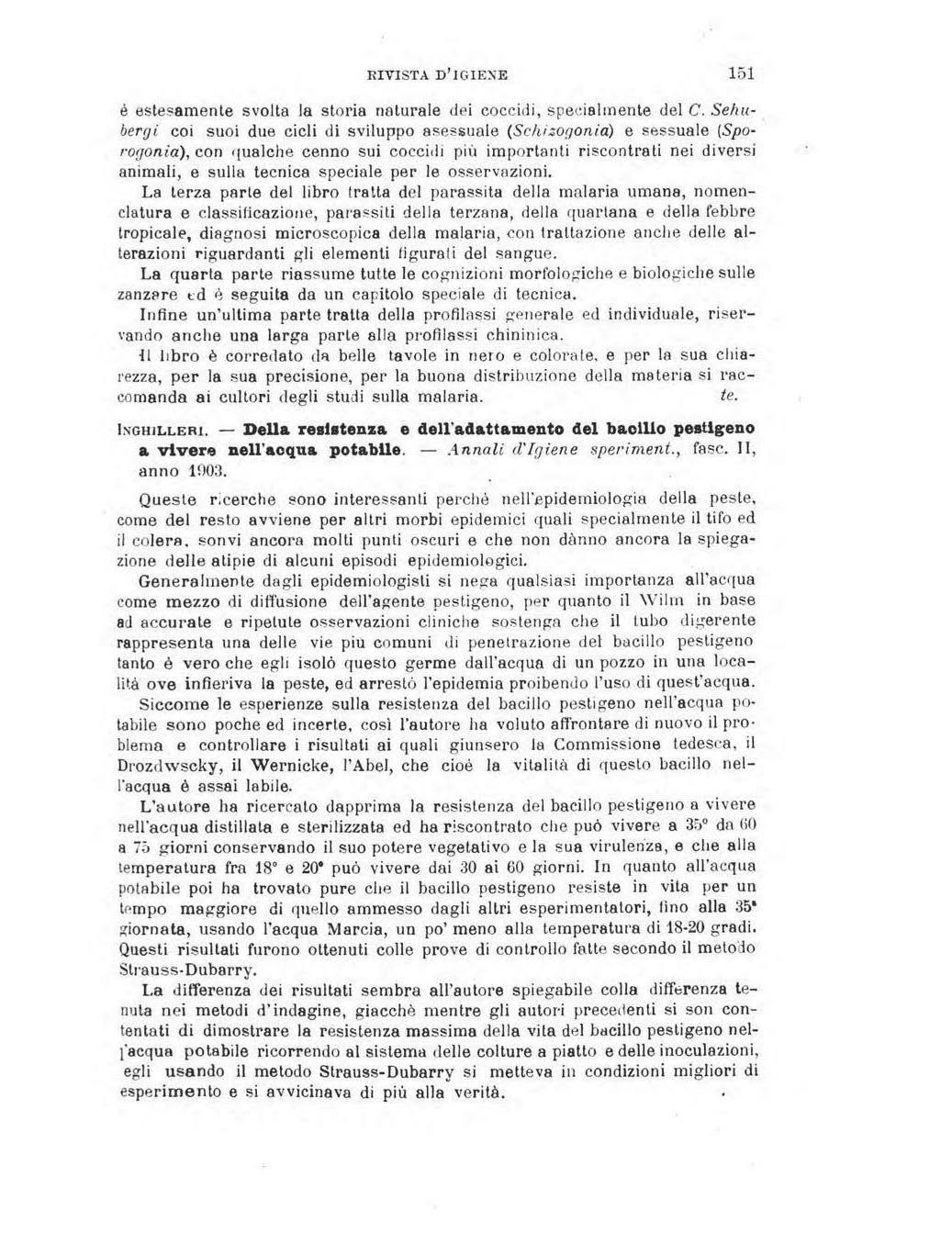
La quarta parte rias s ume tutte le cog nizi o ni morrolo g ich P- e biolo gic he sulle zanzare t:d seguita da un capitolo speciale di tecni ca
Infine un'ultima parte tratta della pro filAssi ge n e rale ed individuale, ri se l'l'tllldo anche una larga parte alla profila ssi cb in inica .
H libro è corretlato di\ belle tavole in nero e colorate. e pe r la s ua cldare zza, pe r la s ua precisione, per la buona distribuzione della mate1·ia s i racco manda ai cultori degli studi sulla malaria. te.
I NG HJL L ERJ. - Della re•l • ten sa e dell'a dattam en t o del bacillo pe.Ugeno a vivere nell'acqua potabUe . - .4.nnali rl'lgiene speriment., fRSc. Il , anno 1!103
Queste r .cerche i nter·es!:'anti per·cllè n ell'epidemiologia de lla pes te , come del re sto avviene per altri morbi e pidemici quali !:'pecialmeule il tiro ed il colera. sonvi ancoi'B molti punti oscuri e che non dànno ancora la spiegazione de lle atipie di alcuni episodi epidemiolggici.
Generalmente dagli epidemio logisti si nega qual s ias i importanza all'acqua come mezzo di dilfusione dell'agente pestigeno, per quanto il Wiltn in base ad accurate e ripetute cliniche sosteng"a che il tubo rappresenta una delle vie piu c o muni ù i del bacillo pestige no tanto é vero che egli isolò questo ge rme dall'acqua di un pozzo in una località ove intì eJ•iva la peste, ed arr estò l'epidemia proiben do l' uso di quest'acqua.
Siccome le es perienze sulla re sis tenza del bacill o pest1 geno nell'acqua po· labile sono poche ed incerte, così l'autOI'e ha voluto affrontare di nuovo il pl'O· blemn e controllar e i risultati ai quali giunse1·o la Commissione tedes ca, il Dr·ozrlwscky, il Wernicke, l'Abel, che cioé la vitalità di questo bac illo nell'acqua è assai labile.
L'autore ha ri ce r cato dappt·irna la r esistenza del bacillo pes tigeno a vivere nell'acq ua di s tillata e s terilizzata ed ha r! scontrato che può ''ivere a 35° do (iO a 75 g iorni conservando il suo potere vegetativo e la s ua vir·uleriza, e che alla te mperatura fra 18• e 20' può vive r e dai 30 ai 60 gio rni. In (]llanto all' acqua pota bile poi ha trovato pu r e che il bacillo pestigeno t•esiste in v ita per un ll' mpo di (]ne llo ammesso dagli altri esper imenlalori, lino alla 35' giornata, usando l'acqua Marcia, un po' meno alla temperatur a di 18-20 g radi. Questi ri su ltati furono ottenuti colle prove di contr ollo fatt e secondo il m eto'do Stl'au ss-Dubarr y.
La d ifferenza ùei risul tati sembra all'autoi·e spiegabile colla difftòrenza tenuta n e i metodi d'indagine, giacchè mentre gli autor·i p1·ecedenli sì son contentati di dimostrare la r esistenza massima de lla vita del pestigeno nelf acqua potabile ri corren do al sislemtl. delle colture a piallo e delle inoculazioni , egli usando il metodo Strauss -Dubarry si metteva in condizioni migliori di esperimento e si avvicinava di piu alla verità
RIVISTA D' lGIE:s'E 151
Altri espe r imenti di t·e tli a o;ludm r e l'a lotlamentu del bacil lo pesligcuo a ,·ivr•t'e nell'acqua potabile r!unos traronn che fenomeno della r ela tiva scarsa r esi!'.tenza ciel bacillo pei' igeuo a v ivere nel l'acqua in confr onto alito l'pecte idriche non e!'pt'imo? all t'O se nun la diversa idone itil a viver e in quelle condiziont d'am hre nle e ad utilizza r e il mate r iale nutrilizio. I nfatti col ti va ndo successivamente i l in acqua sempre meno ric ca di mate ri ale nutrit izio, e a tempt> ralura sempre min o re , a , ·,·icina ndosi ntan m ano alle condizion i nahll'ali, otlenne tHIR r esr!>lenza ma ggio r e del bacillo arrivando fino a 120 p;io r oi. Quc to fallo dim ost r a, secondo l'auto r e , eire n on è la deficienza o la natura del mRleriale nutr tlizio, la te mperatura disgenes•ca. la presenza di a ltri g erm t p i ù p rop t·ii all 'ambiente, che ostacolano nell'espet·imento l'ndallam ento del bacillo pestigeno a viYere e a tnolliplicarsi in u na da ta acq ua pota bile, m a le condrzioni stesse dell'esperimento le q uali uon permettono c he l'elasti c ità di odallamenlo del pr·otoplasma b atteri c o si ese r ci ti, e s i o ri gi nin o co:>i delle nu ove cell ule do tate di specia le t'esis tenza. le.
LOMMI!.I - Sulla oonoaoenza della tenaoltà del vlrua aoarlatttnoao .(.\1ii.neh. m ccl. W oehensch r ., 1901, n. 29).

I o un pi cCI>IO istituto di ed ucazi o ne, pe r baml•ini so t di o di debole udil11 presso Zona. is tituto il era situato ad un a certa di s tanza da tutte le altl' e abita zi on i, i l 10 o llo bre 1900 un ra gazzo ammalò d i sca rl attine; egli veune iuvial o a lla clinica unive rsitaria, ::ruari, e fece r·itorno alristituto il 17 novembre. 21 ::riot•ni più tardi il !:'uo c o m pa gno di stan za ammalava J i scarlattina Quest1 fu s u bi to po rtato nella stanza d'iso la mento dell'istituto, ove ri ma se un gio rn o; poi fu inviato alla clinica, dond e fu dimesso guarito il 19 febbraio 190 1. rimase ad abtla r e col suo co m pagno di came ra. senza che si ma nifesta sse una nu o va in fezione. La camera di isolamento dell ' istituto fu con ogni caute l a dtsinfe ltata pet· mezzo della fo rm aldeide. e più tar d i nel corso dell'in ve rno fu abt lata da un a di 16 anni, la quale ebbe co nti nui t• prolungati r& (:porli altri abitan 1.i della <"asa. Dal 9 al 15 apri le la sta n za venne occupala da uu ra flazzo di 9 anni. Questi il 20 a pr ile ammalo di scat'lalti na. e cioè pr ecisa me nte 133 giorni dopo che in qu e lla stanza aveva dimo rato il raga zzo m alato di l"ca rlatlina N on si può ce rt o amtne t te r e che l'infezione s tato comunical a cli r e llame nle d a quesrull i mo , co me el'a accoduto la volta p r eced e nt e. E siccom e u n'al tra so r gen te qualsiasi d' i nfezione s i può esclud e r e con b isog na amm e ttere che il virus sca rl a tt inO!'>O s ia rimasto nella s tanza pe r 13:3 giorni virulento e capace di trasmette r e l'infezioue. Che la ragazza abbia abitalo pe r m esi la s tanza ed abb ia avu to rappo rti co ntinui cogli altri abit a nti della cosa senza c he manifes tasse al cu n c aso di scn rlatlina, dim o!'>lra che il t•·aspot·to dell'infezione pe r m eno di una te t·za per sona s an a e est r e mame nte r aro.
Ciò non re ca m e ro, iglia, O\'e si t•ill e Ua che vi é m agg io r probabtlilà di r Accoglie t• e il mate rial e di infezio ne con u na dimo1·a d i un' o ra s01tanto in un luogo infetto, ch e 11011 ro l c o ntallo co n una perso na s ana c he fa ccia da inle t•mediar io . Qu esto caso in ollre dim os tra c he il ti m o r e lat>gamente ùitfu so de lla trasmi>:sione della scarlattina pe r ope1·a dei m edici non è punto fo nda l o.
L'i mpo rtanza ma ggio r e d •·l caso r rfe rito d all'A . sta senza dubbio. ol tre du rata della virulen za de l , ·iru s scll t' lattinoso, specialmen te nel ratto che il virus stcs!.'O s i era mantenuto vi\' O ed atth·o malgrado 11nn accut•ata disinfe-
T!IV1S l'A
zioue de lla stanza c on fot• malina. Ciò di mostra q uant o debb a e!'sere losa la disin fezione degli ambienli ove hanno soggio r nato scarlattinosi, e come molte volto le noslt·e disinfezioni coll11 formaldeide, col sublimato, ecc.. riescano in e fflc ac i. G. B. M 8.

laMOtNE - Bullo •vUuppo della tuberool o•l polmouare uell'eaerolto tu rapporto colla tuberooloal fam.lgllare o aoqutalta prima dellluoorporazloue ( .4rchices de M i:r/ecin e e t/i Phar r. wcit· .\tilitai r es, F éo r1 er, lflO:l)
l documeut i forniti dalle t•icerche nnotomo - patologiche e da gli e!"ami r a dioc;copid (Kelsch t' Boi sson), dall e pr ove colla s iero-reazi on e agglutinante (Rouget), e d alla compar·sa d i antichi focolai tub et·colari n el caso di m Alattie in· f?tlive (Armando Lafeuille) rlepongon o in favore ddl'opi['lione g ià e spr·essa dal· J'i,pet tor e m e di co generale Colin, che nell'es e r ci to la lubercolo!:'i é più spesso impo rtata c he per contagi o, poichè i soldati so no sprs!-<O afTelli da focol ai t ub e r colari la tenti, il cui r is veglio é r•r·ovocato dall e fatiche e dalle malattie i nfe ttrve.
Se il te rt·eno organico ha g t•and e importanza nella morbosità tuber cola r Ede li'ese r c il n , non ne ha una mino r e il contagio nell e case r m e e al di fuori di esso pei rapporti colla popolazione, special m en t e nell e grandi cilta, in c ui detta m m·· bosilà at:m e nta co l numero degli abi tanti. (Anton y).
E: ce rto che fra gli in d ividui che diventano tu be r·colos i duranti' il se rvi zio militare, gli uni nel mom e nto dell a loro incorporazione. sono in stato di tu be r colosi latente, gli all r·i, almeno in apparenza, sono perfe tlam t: nt e s ani, e cont r ap;gouo la ma!allia nei r eggimenti.
L'A , allo scopo 'di s tabili re a q uale delle due categol'ie appartiene la m aggio r pa r te di quesh t u bP r colosi. ha creduto opportuno di ag gi ungere all e osse r vaziou i r icavate da ll"ana to m ia pa tologica, dalla radioscopia e dalla s ie r o-reazione a)!glutmante i l"isultati delle r ice rche cliniche. proseg uite per un per i•Jrlo di dieci a n ni.
Egli tenne co nto innanzi tutto de lla tu be r colosi lamiliare, i ndi dei contatti 1r olungati con lisici es tran ei alla fa m iglia e intìne degli antecedenti per!'lonali. Ll' o!:'servaz1oni da lui r accol te si basano su 3 193 casi, per ognuno dei quali flll ·ouo asc:unle informazio ni sullo stato di !>alul e de i genitori, frat elli e so r elle , su ogn1 couta tlo sospetto coi pa r enti, amici, com pag"ni di lavoro e di abitazione. s ulla du r11ta d ella pt·omiscuitè, possibilità dell"iso lame nto, professione ecc., eli mina ndo le notizie poco attendibili.
El=(li ha dh·iso g li uomini esaminati in due i 0 uom ini nati da gen ito ri tube r col osi e vissutr co n essi o s tati in co ntatto con q ualche t ubercolo!:to, o aventi dei p r ecedenti pet•sonali so5pe tti (pleut·ili, bronchiti rip e tute e cc. ) 2° uo mini in•len ni d o ta be familiare e n on aventi mai contatto prolungato co n tub CI'CO iosi. Da llo SIJOgl io di q ues ti dali è l'is ultato che su 319:3 uommi, 877 furono co lpiti dn tube rcolosi dura nte la loro p e r manenza solto le arrni.
SullO' aiA di 3193, i 85, pr•ima dell ' in co rporazion e, e r an o s tat1 iu conta tto p t'O· lunga lo con perso ne affette da tube r colosi polmo nare, e di questi, 522 avevan o vissuto in con tinua promiscuità coi loro ge nito r i tuber colos i, nell a parte dt!ll'in fanzia e dell'a doles ce nza , 24 con amici , c ompa gni o padroni, m orti poi di l i!'i polmonar e. Fra que!' ti uomini, 239 avevano presen tato antecedenti per\'on ali sospetti, Si av e vano soflerto di pleurite e i 75 a cc u !'a vano b r onc hiti tuili
RIVISTA D' IGIENE lù3
gl"inverni, ad eniti ce t·vicali suppura te nell'adolescenzn, ascc>ssi h·eddi co:;Lah e qualcuno em1•tlisi.
Sul Lotai P di 785, hanno presenta t o sollo le a t·mi d ei sin tomi di tubercol o$i polmonare 536, ossia 68,28 p. 100. Di esst, ::!!l6 = j5,22 p. 10r> avevano m e no di u n an nn di serv izio e 2 iO = 4i,77 p 100 erano soldati anzia111 con più di un auno di o::en·izio.
Queste cifre di notano, secondo l'A., che è tt·opoo esclu!II\'O il cl'i terio di alcuni os servatot•i nell'ammdlere che i soldati , dtvenuli tubercolosi nel pl'imo anno di :oer viz•o, !liano degli ereditari i e che welli anziani tubPrcolo!li rapp1·esenti no i contagia ti nei t•eggimenti.
La tubCJ·colof'i acqui sila prima dell'arruolamen t o, influisce sullo sviluppo della malattia sia n c>i soldati g10vani che negli an liani. Questa constatazion e é interPssante, oltre elle dal lato teori co, anche pe1 chè fu proposto di riformare, con grnlifìcazionr, tutti quell i elle contraggono la tubet•colosi dopo il primo anno di l'\el'vizio.
T ale proposta è basala evi dentemente sopra dati
1·: confOJ·tanle ed utile ril ova t·e elle 2i!J f•·o i pt•einft!Lli non sono divenuti tubercolosi solto le armi, il che dimos tra che l'ered •l a non pt•orluce nr:;cessariamenle i suoi ell't.Jtli, quando i soggetti hanno perduto i poco dopo la nascilu, oppure dalla na!'rita ><Ono stati co mpletamBnlo dai loro congiunti.
Resta cosi ron ft••·mal() d r>oncello che l'e•·ed11à tubet·colut·e ha pocn impo1·tonza di I'I'OlllO Al COilll.lgio in l'amigliO.
Il numet•o do!!li uomini sani, divenuti tubpt·colosi sotto le a•·mi, ò quindi r idotto a 3ll = :38,40 p. 100, cioé poco più di un ter zo sullotnlo di 377 Ammalati.
Su 3U, ummala r ono di tubercolosi nel p1·imo anno 12i e .21i n el secondo e te1·zo a nno di servizio, nelle p1·oporziooi r ispettive di p. Il)() e di 63,63 p. 100.
Hicapilolaudo, sembra dimostralo che il mag!.!ior numero degli uomini colpili da tubercolosi polmonart' nell'eset·cilo sono giun ti ai cot·pi già inretti dai ge rmi speci fici ; che que;:ta preinfezione é tl erivata non solo da,:.tli ascendenti, ma anche dai collaterali e pet· mezzo dei contatti al di fuori della famiglia o da una lube•·colosi comunque acr1uisila prima dell'incorporazione; che iulìne l 'eredità o la tubercolosi familiare eset·citono la stessa influenza tanto s ui giovan i so l dati che !'Ugli anziani.
L'A., coi documenti ria ssun ti in questo lavoro, ha voluto porre in rilievo la net:ess•LA di una inchies ta rigol'osa sugli anlrcenti familiari e pe r sonali meglio che 1• r crlita rii delle reclute all'allo dell'arruolamento, e concludo col dirP che tnle antimnesi, in unione alle misure combinale della sta lut·a, del perim elt•o tol'<ICico e del p eso, permetterà un apprezzamento p1ù rapillo del va l ore tìsico dci :;oldati e uu'eliminnzione precoce dei candidali alla tubercolo f'i.

RIVISTA
l
P. L.
BJBLIOGRAF JA
DotL CARLO CALLI ANO - !forme eleme nta ri sui • prlml aooo onl • a d uao d e lla Scuola Sa.ma rUana d'Italia. - T o rin o , Ti p. Bat·avalle e F alcouieri, 1903.

L'a u tore 1\ troppo n o to pet·clté facci a di t·ico t·dare quanta l>enemer enzn egl i s i sia acquìslata col laYo ro e colle oper e, specie col Ma n ual e: . ·oc.corai di cui !<i fe ce già ce n no in ques to giot·uale nel n . 6 del 190 1.
Ora il dolt. Calliano ci pre seuta uu altro Manuale : Sorme el eme nt a ri sui pr imi socco r si, che ri sponde ad un vero bisog n o tanto d el per sonale oddrtto alle Sorieté di a ssi$<lenza , e di co l 01 o c he ric o prono pubblici e privati ulli c i, •1uantv d'ogni person a g entile che lt'O \·isi a dover pres tar soccor so od un fe r tlo o malato.
Con tìna ir·o n in il Calliano fa ceva gia osservare in un s uo Al'li col o su lla mot·te d i Emilio Zola, co me tutti i giornali di Francia s i s ia no clifl'u si nei più minuti p artico la r i tl ell'esnrn e chimi cn de l r; an gne, pe r s tabilire c h e l'acido ca rbon ico !'i et•a trovato in quantità pi (t che suffici ente per cAgiona r e la mol"le ciel gra nde r oman zi ere , ma c he o::cennò a i primi socco t'!'i appres tati allo Zola, c co me s ia l ogi co quindi ammettet•e c h e n ullo s i fe ce p rima dcll'a r·rivo dt• l mecllco, al cui sopra ggiunger e - dopo un'ora di ansiosa attesa - l'asfisc::id aveva avuto l Prn po di compiere il s uo mi 3fatto
I l c a so pietosv di Zola <·onfc rma sP mpre piu la s entenza di Es mat·•: h: Qua nt i ch e si snrebber o potuti salvare muo i ono mi seram en t e ogni anno, per ché SU!lO degli astanti ha saputo lor o allprestnre in tempo il soccor so oppor tuno •.
·P e t· potere però e!lser e util i ad un ferito o ad un infermo, fa d'uopo, nice giustamen t e il Calliano, avere s tudia to a mente cal m a l e cogn izioni i primi impiegando il tempo v olu to a fine di ben comprenJt'rle c d i acquistare il giusto cri terio della lor o impol'lanza pratica, g-iacciH'· è nece'!sa rio t·icorrl are c he è gtà un buon socco r so quello di non .fa r etei male, e che S•! i soccor·s• d'urgenza d ebbono es!'e r e att uati p rontamente, debbono, da chi non ò me lico, essere limitati all'indispensabile.
S ulla guida di questi sac r osanti p ri ncipii, il Calliano con molto e chi arezza, espone i vari at·go m<!nti cominciando dalle nozioni pt•in<'ipali sulla struttura e !;tull e f unzioni uman o , pas!ìa nd'l quindi a trattore d ei primt soccor ;; i n elle le!'Jioni violente, e poscia nei malo r i improVYi si e nei mot·bi i nfetti v i ad ac uta manifesta zi one, terminare co n un breve e comorlo r iasdei melzi naturali e delle sostanze d'uso ccmune la cui applicazion e può in m ol ti casi con s iderarsi come un primo socco r !'o.
Non v'ha dubbio c he ques to lavor·o del benemerito dott Calliano sin clelia ma!'Js im a import.anza per ogni ceto di pe!'sone, vuoi n ella vita civ ile, vu oi n elle :.'pecia li contingen ze del set·vizio militare , e però no i l o ra ccomtmrliamo vivamen t e ai coll•·ghi com e un utrlissimo complemento dell e istruzioni l at·i c he s i impartiscon o più specialmente ai soldati aiutanti di sénitu.
lu:>
l t•
SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
In questa nuova rubt·ica c i prop o niamo di ofT1·ire un i ndice sommario degli at·gom c nli scientifici svolti nel le r iunioni mensili degli ospedali, con che c r e<liaroo di fat' c.osa g r ata ed ulile ai n os tri studi osi lel l ori.
POtçhè la r is tretta capienza del nostro giornale non ci pel'metle di pubblicar e tulli i buoni lavori che ci per v engono, valga almeno questa enumerazio n e per dare un' id ea d ella alli vità s ci entifica dei n os tri colleg h i.

Comincia mo collo spoglio dei processi v erba li delle confer enze tenute nei m esi di dicembr e e di g e nnai o prossimi pe1·venute all' ispellot·ato di ;;anitA dal pr-incipi o dell'anno fino al 18 febbraio
A L ESS AND RI A (genna i o). - Com unica:. ioni : tenon te colonnello m edico BooB ro Eugen io : So pra un caso di f r attura de l r adio s i nistro, con dimostr azion i ra diog t·alìche
ANCONA (di cembre) . - Memo,.ie letle : sotto tenente medico BARATTIN I Rio: S ull'alimentazi ooe dei diabetici
BA Rl (dicemb r e). - Memo,.ie lette: sollo lenente medico di compl em e nto PA LCarm i no: La dia1.0reazione nella e nella prognosi della febb r e tifoidea.
AOLOG:\'A (gennaio). - A1cmol'ie letle: t er 1ente m ed ico GRIXONI Giovanni: S1llla r• i vista s inteti ca.
BHESCJ A (dicembre). -Me morie lette : lenente medico FoRESTI All.let•to: S u di u n caso di em oglobinur'l8 pa r ossi slica -Ca pitano medi co C:EVASCrll Catullo: L'as ma bronchiale del naso .
l o. - Comunica;ion i: so l Lo lenen l e med iro di complemento CALINI Cesa r·e: Su un c aso di paral i si acuta ascendente
C ASERT A (gen n aio). - Com unica:oion i: tenen t e m edico CALBNOOLI Saveri o: Su un caso d'influenza c o n s intomi m eningilici.
CHIET I (d i cembre). - Comu n icazioni: capila no m edico o· ETTORRE A l fr edo : Sop r a un caso di probabi le t ubercol osi di ambo i r eni.
F I RENZE - Comunicuzioni: tenente m ed ico MARRI Ezio: Sull'in · Le rvento io caso di idoce le comunicante, con test i colo atr·olìco ed ectopico
LI V O HNO ( dice mbr e). - M emo,.ie leite: sottotenenle med ico di compl em ento
l'\EPI Arturo: P atogenes i e cur a dell'acne r osacea . -Capitano medico S ANTORO Giu seppe: Un r•a r o ca so di aneurisma falso lf'aumatico alla piega del milo
MESS I NA (dicembre). - Memorie Ielle: t enente m ed ico F IO REN TINI Emilio : Fe1·ita di riv oltella a t>copo suicida, con fot·o di entrata del p r oiettile i mmediat amente in nanzi dE-'l mealo ud i tivo ester no destro ; penetrazi one n ella cavità o r bi taria s ini str a e di stru zione del g l obo oculare
MILANO (gennaio). - Comunicazioni: capitano medico APR OSro Roberto : Sulle immunità. (gennaio). - Conwnica:oioni : Lenente m edico SARTI Vi tt o rio: Su l
DE(;Lf MILITARI
rept:rlo anatom opatologicu di una ferila d'arma da fuoco alla r egion e :>op•·aioidea per suici dio.
lo (dicembre). - capitano medic·o GnoTTI Carlo: Prese nl.a· ziooe di un militare affetto da tumefazione al piede destro, e di un altro af· fello da sordità completa insor ta rbpentinam en te.
PADOVA (dicembre).- Comuniea;ioni : tenente C<•lonnello meJ1c0 CARAOO:-IN A Antonino, diretto•·r : Considerazioni sui casi cimi ci piìt impo rla n li e sugli indh·idui sottoposti ad o«servalione medico l egale. '
PALERMO (dicembr e). - M ('mo r ie Ielle : tenenlP medico Cl AURI H osolino: Sindrome cerebellar e simulante un ascesso del c ervello olitica.

SALER:\'0 (d1 cembrl.'). - .\lemorie le tt e: solloteneute medico di compiPmento
S1c-. Gaetano : Su di un caso di cisti da echi nococco r e t r oper itoneale nello ipocoodio sinistro.
lo ·"''morie lette: solloteneule medico di co1n pl em c•n to GuARIGLIA L o r enzo : Sulle infezio ni biliari.
SAV I G LI ANO (dicemb••e) - solloteneute medico di co mpiemeoLo LEONE Adolfo:· Sullo cal colosi bilia•·e.
lo. (gennaio). - Coulinua a llnisce la l ettura della memor ia sopt•acilala.
TO RI NO (dicembr e). - Conwniea::ioni : sol to l enente AMERI O l talo: Stori a clinica di un'appe ndicite.
lo. (gennaio) - Comunica;;ioni : sollolene nte m edico MART INO Torquato: Storia clinica di una i nsullicienza milt·alica.
VENEZI A (dicem b••e).- M em or ie lette : sollolenen t e medico LEVI I ginio: Sui calcoli ::;a liveli del dotto di W arlom con i pe•·plasia della glandola solloma· scellare. - L o s tesso dottor LEVJ h a poi fall o una co111unic azione sopra e!'pC· l'ÌI'nze sue perso nali s ulln cura dell'arterioscle r os i co l siero d i Trune ceck.
VER O N A (dicembre). - Jif emo r ie lette: cttpitaoo m ed i co B eR.-: ucc• Giovu nni : Dell'eudemia gozzi gena al consiglio d i leva di Vi cenza. - Tenente medico VALERIO Gi u«eppe : Contributo sperimenta le' alla r.hi r ur:.:ia traumatica del pnl m on e.
So n o inollr·e pervenute alla direzione d el g-iornale l e memori e : MENNELLA Arc an g elo, capitano med ico : Az1one e delle acque di Salsomaggiore. - htHRIACO Pietro, colonnello medi co : Sull'a7.ione degli olluali fu ci li da e specialmente del fucile ilnliano di pi.. colo cal1b r o Studi s perimenl.ali. - :\1ot.INARI Mario, tenente medi co : Conll•ib:.tto Alli\ P7.iolng•a c c ura dr>lle oliti t!slerna e media.
Medagl ia Ma urizian a. - Con decreto de l 5 rebbraio 100:l é stata concessa la mt•do;.dia mauriztana per m erito militare dt dieci lustt·i al mag giore m edico tspellore comm . Luigi Lai.

L'Illustre !{enerale, che è, anch e per età, il decano del corpo sanitario, :>i abi.Jta le nostre vive relicilazioni.
Per ri chia ma re in vita i morti a pparent i. - Il do ll. G. W. Cr·ile consiglia nel Clecela n d .\.fedieal Jour n. all'uso co mbinato di iniezioni intravenose di adreoaltna, artificiale, e ritmiche pressioni sul c uore. Con questo metodo sono sta ti r ichiamati i:l vita degli animali dopo t 5 minuti di m o rte apparente.
Libera lità amer icane per le biblio te che med iche - Il benefico miliardario Ca rd opo aver rondalo n egli Stati Uniti pO<'O m e no che 400 biblioteche per la cu lturA generale, è ora inteso a beneficat·e la cultura medica Sovvenzionato da lui, ha ripre so le sue pubblicazioni l' lnclex m ccl icu s , periodico un icameo te alla indicazione bibliogra fic a di quanto si pubblica in merlicina in tutt e le pa r li del mondo . Ora , a qu a nto apprendiamo dal Mediefll Reco r d c.ic l 3 1 p-ennaio, Carnegie ha donato 250.000 lire al Collef(io medico di New York per il mantenimento della biblioteca, col pollo però che il Collegio ne spenda di s uo altre 250.000. Di queste i signori Vanderbilt e Griscom ne hanno offerte al Collegio rispe ttivamente 50.000 e 25.000.
XI V Congresso medico lnternazioaale a Ma drid.- Com'e noto ai nostri letto ri il Cong rC!' SO avra luogo dal 23 al 3U aprile Hl03 . T r a le sezion i in cui è diviso il Conp- r esso ve ne é an che una di medicina militare. l t<>mi proposti alla di· in quel"la sezione sono i seguenti:
Jo La f(ueslione della tub ercolo si Cl<erci li. Relotore T reller - 2• l m edicinali compressi nell e dotazioni di materiale sanitario in campagna. Relatori Ub ecl a y Correa! e Mazzoni ( Roma) - 3• lnOuenzo della vita militare sullo sviluppo delle malaLtie nervose, ed in parlicolaru delle Rel ato r e Salinas- 4• Igiene delle truppe di ter r a e di mare sulle coste occidentali dell'Africa. Rt!la torc An gelo Fernandez Caro - r-.• Pr·olila!.'si delle malattie veneree e sifilitiche eserciti. Relat ori R od ri g uez Vosquez e FaVI'e ( Roma)6• : nrt!t·merie di comballimento nelle navi da guer ra moderne. R elatori Redondo e Colelti ( Roma).
Oltre a ciò è libera la presentazione d i comunicazione, purchè di a rgomento medico- militare.
Col oro che si propong-ono di rat·e qualche com unicazione sono pregati di rn un ùare al piu presto al generale il titol o e il ria ss unto (Pl'Pferibilmente in lingua francese) pe r·che possano esse re s tampati nel progra mm a p r ima d e ll'apertura del Cong resso . P61 viaggio a Madr·id da l conflne franco-sp agnuolo e dai porti e viceversa é accordato il t•ibasso Jel 50 p . 100. Sappia m o pure che, tra il3aprile e il24 ma gg io si potranno avet•e dci biglietti col 50 p. 1 00
(Il Il fasricolo er a gia pronto per la stamp:. ' IU3n<lo sop rav ve nne lo sciopero dogli operoi tipograO. PrcmPnflocì di mett erei' Jl r Ps to al corrente , lo pubblichiamo tal r1ua le; e per ciò domnndi3mo ' 'ema al lellorc !e tro"e ra, specialmente io questa rubri ca, <1ualcht notì1.ia che non <l più
l' liJH :NIIS OELLA N E
(I l
A
· .
di riduzione, in partenza da Madrid, per la visila de lle più c itta della Anche le ferrovie fra ncesi hann o a cco rdat o il 50 p 100 rli ri duzione. L o ferr·ovie italiane e l a g e neral e farann o un identico Quanto agli all oggi è gili in funzi o name nto un appo!=;ito ufficio (indi rizzo: Sl' r oire d es lodu XIV Congre s nu;d i cal incernalional Madrict ) che può &ssicurare a llvggio e vitto compl eto sia in alb e r ghi c he in case pal"lico la ri a p r·ezzi co mpr·e$i fra 13 e GO pesetas al giorno (l peseltt = l li r a; ma la moneta s pa g nuola perde circa il 30 p. ! OH n el camb!o) . Madri J e la Spag na intera si prepar·ano ad tlC('O· glie re degnamente la grande sol ennila scientifi ca . Il R e Alfo n so darà una ga rd" n party ed u n rtcevimenlo a Corte. Il Munici pio s ta o rganizzan.Jo una fe s ta generale e p r o babilme nte una r appr esentazi0ne di gala e una 1·o r rida de lo ro s Le vat·ie sezioni poi avranno speciali e s cursioni, vi s ite e festesrgiamenl i P e r ulterio ri info r maz ioni o al seg r e tario del Co ng resso : <.lot to r Fernandez Caro, Facul t lld de m edicina , Mad r·id, o al segretario del Comitato italiano pror. Filiberto i\Iarian i, Clini ca m edica, Genova.
Terzo congresso Internazionale di Talassoterapia. -Si ler·rà a Hia r l'itz da l l !"l al 21 ap rr le, cioè alla vigi l ia del cong r esso di Madrid, c he si apJ"e il 23 apr ile. Son o all'ort!ine del gio rn o le s eguenti tre questioni:
1• Ri s u ltati d el sog-giol'llo sul mar e sopra i fenom P. m interni della nutriz io ne.
2' Efl"elli della cur·a ma-rina dal pun to di v is ta della della tubercolosi.
3° Influenza <.lei sogg ior·no sul mar·e e dello cu r a mar·ina in ge nere su ll"apparato ca rdio-vascolare.
Prezzo della quot izzazi o ne 10 franchi. Per i nfor•rnazioni al segr etar·io dott. Segue!, 68 BouleY&rd Male !:>lter bes, Parigi .
Dichiarazione obbllgato"rla e dichiarazione facoltativa di malattie diffu sive . - N e lla s ua del 20 l'a·ccad e mia di m ed icina di P arig i, dvpo lunga discussio n e, a cui prese r o parte Lave r an, Broua r del, L l•o n Co lin , Vallin, Chau\·el ed al tri , ha s tabilita l"obbligato:rietà della di c hiarazione a se uM della legge dt>l i :i fe bbr·aio '1902, pe r le seg ue nt i 13 malattie: Febbre tifo idea, tifo vaiuo lo e vaiu oloi t!e , scarlattina, m o r ùillo, d ifte rite , milia r e, coler·a e malattie colerifor mi, peste, fe bbre gialla, diss e uteria, infezioni puerper·ali ed ortalmie df' i ne o nati (quand o però non s ia r eclamato il segreto professionale pe r il parl o) infi n e la m e ningite cerebrospinale epidemica.
S ara invece facoltativa la d i chia razi one pe r le seg ue nti malattie : tubercolosi polmonare , pe rtosse, influenza, polmonite e bro n copolmoni te, r esipola, orecchion i, lebbra , ti gna, congiuntiviti purul e nte ed oftalmia gr-anulosa. ques te malattie, la l e gge non -esime il medico dall'obbligo del seg-reto professionale; e perc iò la di chi ara z ione uon può farsi s e non col consenso del malato o dAlla famiglia.
l dentisU militari agli Stati Uniti. - F i no da l :! febbrai o 1901 gli Stati Uniti banno o rganizzato un · co rpo di dentisti militari. Sull'atti vità di questo corpo l'ultimo Reporc of t/w Surgeon-general o( the A. r my fo r t li e fis '· al !}ear e nding June .'30, 1902, dà interessa nti rag g uagli. Il CO!'PO dei dent isti militari (Corps of De n tal Surgeo n s) s i c o m poneva al 31 di cemb r·e 1901 di 2S <.l e nlis li, dei q uali 9 destin ali alle truppe stanziate n e l ter·rilorio dell'Unione, uno a Cuba , un o a P o rtorico, e g li altri 17 alle Fil ippine. Nell'anno co m prP.so fra il 1• lu-
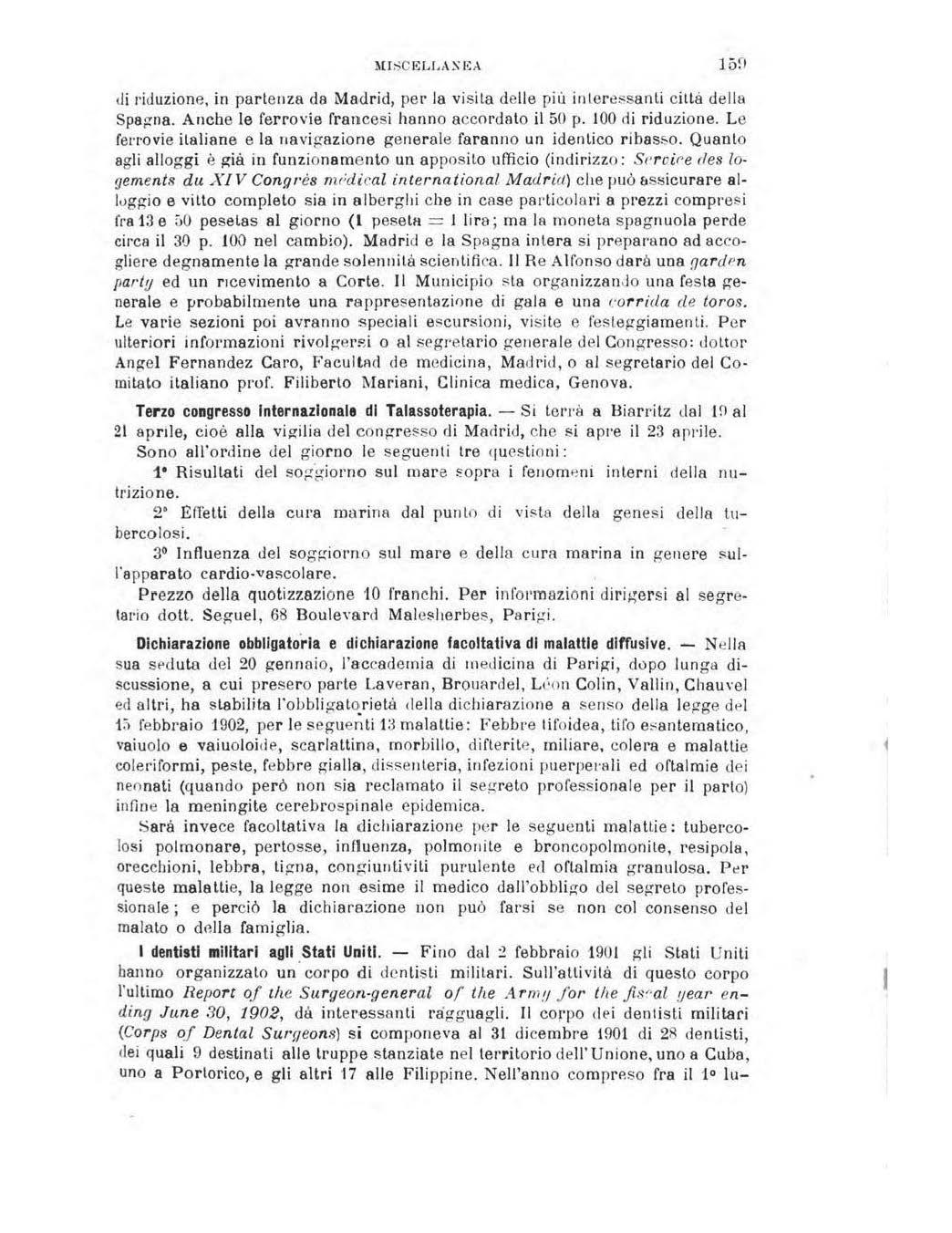
EA
!!lìo 1!10 1 e il :$0 ;,?iugno 1902 fu r ono c urati in lutto Ul48 militari p et· malattie drnlal'iP.. I l totale clt•lle cur e, cd opet'a7.ioni ru pl:!t'ò di 1:3,\!18, di c ui :no" Alle F ilippi ne. T r·a le oper azioni, il pn1 è dato dalle otturazinni (:0:1;,); m f' n!J•e l e l'st r azioni non furono che 2072.
Diploma per t'esercizio della ottometria. - Gli ottici dello Stato th Nuo\'a-Y o r k hanno promO!'SO un'a g itazione p er ollener e c he !!ia proibito l'es('r ct z io J lla - os«io della ri cercn e determinazio n e et ei difetti di r ef•·azione e oli nrcomodazionc e della correzio ne di detti di fetti ro n lenti -alle c ht> uon s11rannn mu nile J1 appo!<ito certifi··ato r ilasciato da u na commi s!'i o ne d i -;poc i;di!.'ti. l m edtci sarebber o na t ur al m ente dispen!'uli dt tJUe!'t" cc rltficalo.

Dal aterlale sanitarie di guerra dell' neretto swizzero é s tat o tleci ;.o di toaliere r iooloformio sn!'li tu endol o con al tro anlisellico pulverul ento, c he pro bo bi lmeule il viofor·rni o
Ufficio di informazioni mediche a Parigi. - Per 'luei coll egl d c he s i pr opougono di vi Rilsre Pari gi, riul'cirà inleres!'au t e il !=<llpe r e che, p et• del dott o r Blondel. il municipal i! di r1uel l a metropoli ha la istitu7.ione d i un ufTi c to tli infr1rmazio ni mediche Questo uiTicio !<a t·ù, a quonlo pst·c, i nl'tall ato alle I'Aco llt\ di m edi cina, ed avra pri nc ipalm ente lo sr.opo d i fo1·nit·e tui t Atn onte ai mt>dici str an ieri tutt e le io fo rmA zio ni po<l;;ibil i s ull' iu sep:namen t o nlli ciale e lib et·o. o;;pedali e l e cliniche, sui se1·vizi di m r!d i ca e d' igien t•, n on ch e l e ind i cij zion i per ;;ona li r ela tiv e ai tn ed ici t·csi tl<>u t i nella cupi tal t>
La Croce rossa giapponese ha .:elebrato ne ll'o ttobre sco1·;;o i l 2:)' ann versat·io rlcllo SUA r.mdozio ne, con una festa !'tr aordmaria, 8 c ui inter v enne l'Impe r atrici' m persona. Co m e in lulte le m an i f,>s tazioni elci ctvil e, cosi anc he i n ques ta caritatevole e patr iottica istituzione, il Giappone ;;i è m P!'«o al pl'imo posto tra l e nazioni , con una rapidita !'<conoc:ciu ta in Eur opa DA una c(Jmunicazinue del gegreta rio g-ener ale, S. n i ra yama , al comt ta to central e della Cro c e r o;;!<a di G inevra ( Bull. internai. de la C roi r -rovge, jan,·. 1903) a rp r encliamo che il nume r o de• soci 6 di 822,K, 5. nella p r opot•zione c iot> di l su nbitantt della popolazione tota le d ell'Im pero. Il c a pi tal e della c::rnzn con tnro !.di immobili e il m aterial e d'ogni :o:pecie. ammonta a yen ( l on = f1•.
Necrologio - A Pat·ig-• il 11J g ennaio m or • il ce lebt·e oculi s ta Panaf;. Era n ato nel l x3:l fl Cefal o nia, n elle l ;:;nJe Jon ie. Da g-tovineLto l"i r·ecò a c l o v e co mp iè tutta l a !' uo carri era l"Ci enliflco e si na tu rAlizzo cit tadin o france se• P er l o -;ue molle p ubbli cazion i , tra c ui t:n T r ulta l o compl eto d i m al ollie orc ht, per i lunghi nnn i consacra li oli' i n!.'egntnnen l o, Pn n a <s la sciu n el palrim o ui(J scien t ifi co una l ar!!a traccia di !"è . ·
Noti nmo auclie c hP ne l '1870 e z li se t·vi la Francia, se<·oud a pAtrio , co m e m eJic o militare ; e che i n occa!'<ione della r ece n te g u er rJ t tut·co-::tTeca <>g li Av eva in A ;; ue spesi', nn'ambulnnza dn m11nda r si in Gr ecia.
Jl D> re t. t.or<o: Dott. F. LANDOLFI, magg ior generale medico.
Il R edélt.t.Ort \ D.• RtD OLFO Ltvt. ma $.!,:nore med ir.n. il.,rua, ltl•· E \ ' u j;lll•ra.
'.· . ...._
AVVISO
Il presente fascicolo nostro giornale era. gitì pronto per la tiratura quando sopraggiunse lo sciopero <loglj operai tipografi. Premenfloci (li rimetterei in }lari piìt presto che sia possibile, pubblichiamo intanto tale quale il fascicolo attuale, riserban(loci di pubblicare in ILn solo ·fascicolo triillo i num eri di :.\larzo, Aprile e Maggio.
LA DIREZIONE

•.
GIORNALE DEL REGIO
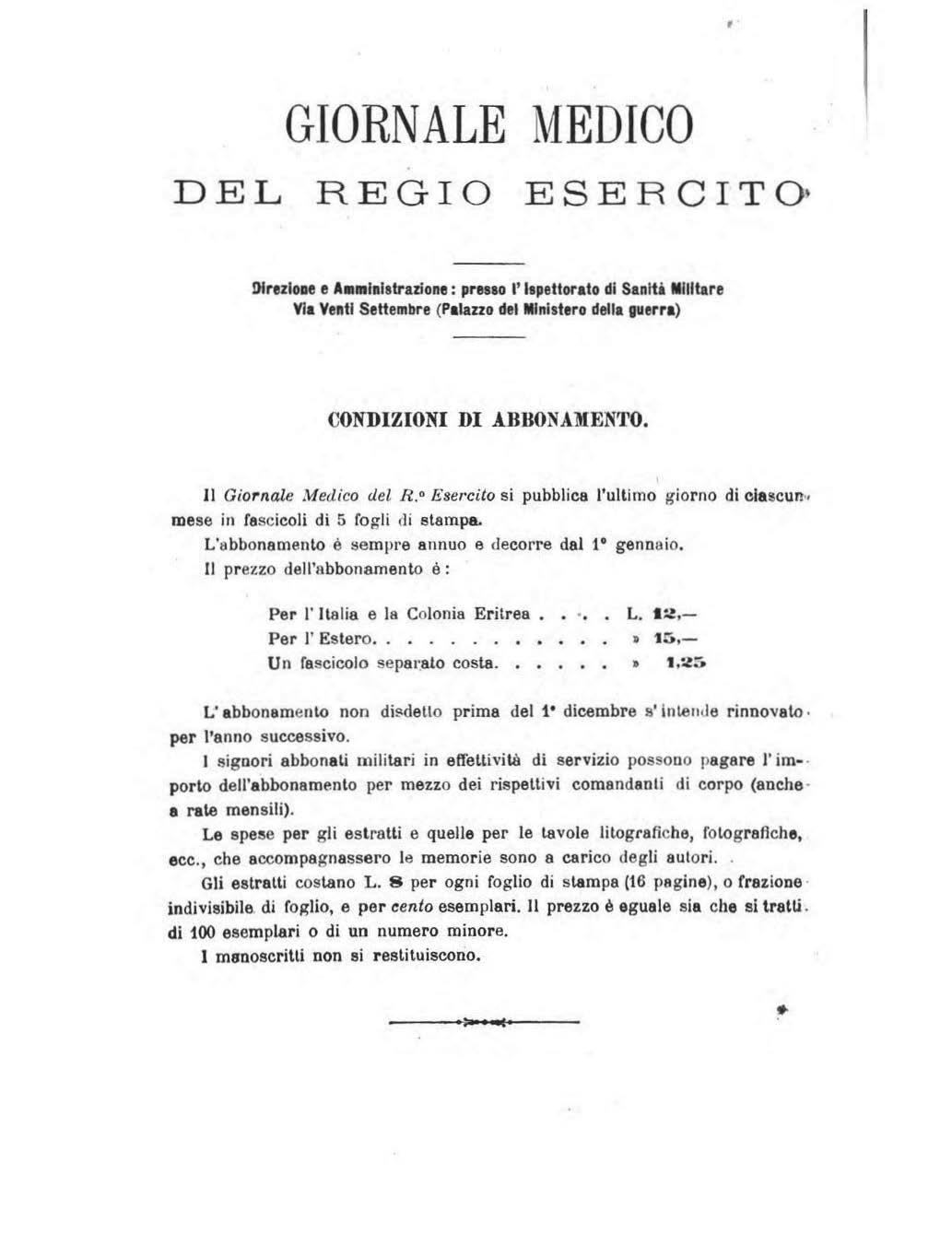
!Hrezloae e A••lalstrazione : pre11o l' ltpettorato di Sanità Militare Via Ve11t1 SeHembre (Paiano del Ministero della guerra)
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
Il Giornale Medico del R.• Esercito si pubblica l'ultimo gio rno di ciascun·• mese in fa s cicoli di 5 fogli di stampa.
L'a bbo namento è sempre annuo e decorre dal 1• gennoio.
Il prezzo dell 'a bbonamento è:
Per l' Italia e la Colonia Eritrea • Pe r l' Estero . . . . . . .
Un fascicolo sepa r ato costa.
L. 12,-
• 1C.,,. 1 .:l:;
L'abboname nto non prima del 1• dicembre s'intende rinnovato . per l'anno s uccessivo.
1 signori abbo nali militari in effettività di s ervizio possono pagare l'i m- · porto dell'abbonamento per mezzo dei rispettivi comandanti di corpo (anche · a rate mensili).
Le spese per g li es t ratti e quelle per le tav ole litografi che, fot()gra flche, ecc ., che a ccompagnassero le memor ie sono a carico degli aut ori. .
Gli estratti cos tano L . 8 per ogni foglio di s tam pa (16 pagine), o frazione · indi visibile di foglio, e per cento esemplari. Il prezzo è eguale s ia che si tratti . di 100 esemplari o di un numero minore.
l msnoscritli non si restituiscono.
•
SOMMARIO
MF.MeaiJC OaJGI!IAI, I
11Urla041. - Sull'ru:100e degli a!LURII fucili da guerra. ecc. • • • T........tta. - Il lr3Cnma in Kg1U0 .. . • . . . . . . . . • . ar a - non co muni d1 una fo:r1ta d'arma rb fuoco
BtriiiÌclcl. - llell'endemia nell& p r ovincia di CarraW - Anco r a dell'uso del cloroformiO co ntro la Lenla.
Fiorontllll - Ricer che su d1 un caso d1 ror \Jora emorrRglrn, ecc. •
•rnlol. - teotosessaotatre ernie opernto ne lo spedal e mlllt.o.rc di Messi na •
Funaioli - Varietà anatomica rara del arter ioso di W•llis.
caoo1a - J.e fratture dBI metatarsl In gegulto a marce • aJVIIIITA BI GIOaii&J..I ITALIAI'II EIÌ IE8TEal
l 'fig MI
tl3
!61
S73
• \184
• :189
i96
301
• 305
R.wlsta paq. 309.- Rlvi s·a r!l png. 330 - Rivis ta paq JU
- Rlvlsla d1 pag 361 - R1Villa 111 Of' Uiistica. pag 361. - Rivista rll anatomia e fbiolog.a normale e paro iQ!flca, p!lg 374 - lllvl$13 di malatrl e veneroe e della pelle, prag. 377. - Riv ista tll tor•peulica paq. 383. - 1l1visla di tecnica e ser vizio mP.d1eo milllare. flllQ. Rivist.l di bltterlologla,,,, /1 388.- Rivisti\ d'igiene. paq
- Rl vhta blbliograOc.,, pag. 393.- scif!nt•llcfle o1egli n•pedali militari, pag. 395. - Miscellanea, p a g. 397 (V. l' l n<lice m li' lnlfriiO dtlla coperlilla).

DIREZIONE ED A MMI NISTRAZIONE
IlOHA - Paluzo delllJalltero Gaerra, Via XX Sette•bre - ROMA
P UBBLICATO
c· • l• \ .' FASC. 111, IV e V 190 3 :l i MAR7.0, :lO APR. :H M Af.f. IO
DAltù' ISPETTORATO DI SANITÀ
.: .. ..
RlYTS'l'A DI HTOR.NAL I TTA LT ANf ESTBlU
RI\'ISTA NROICA
Jantl - La miourditl' reumalica arola
l llltt - Malaria a rorma ttroide

Rl bls. - L' anuria calcol osa rinessJ
Rabln - ProRiassi c della sulla conoscen1.a tli affezione • • •
Courattt - Nuovo metodo per la dei bacill t d• Korh negh SllUit le rn•col. - Sintumt dPIIo ad PnopattA tracheo b ronchiali
Rouel. - Ricerca della colorante del sangue nell'orina - Curn degli ac di lebbre palus t re con una rntst urn loolo· iudu r at:t
Savage. - Enumerazione d•i leuroctLi nella praticn giornaliera
Pretbraaoheniii J - Per la caststtca ptomairuche
Bu r ntl - l.a cu ra medi e& ·
Rollnltn - Albumlnurta. lpostattca oli •
Frr.ch - r: Arlrt> na.liun nolla pr.lic.' uro logica
Huntl. - Ocile cu tanee nell e malattie dei vts•cri a hlomlnnli e t or:.rlri
SaulldiiJ c Ruuel - Cianosi cronica . . . . .
O' Sulllnn Beare - Un rlrnell o ln clt!! eno co ntro la rchbre nmoglohl nurica
Nepau. - lmnortanta olc ll'esa me del sanguo. n•lle affezooni aolrl o minali
Strada o - Su l valor e r1el m etodo Pior ko" nrlla ohagno11 harlcrìologlca olei addominale • • •
SaundbJ - mot rico· e cvn<rcu tl va 1111alazione <ltllo> s lomaco. • •
Rtnon e Ctraudel. - Delle oev rlti l><>s t poe umooiche
RIVISTA DI NEVROPATOLOGI A
Harttrnbtrg - Solln nevrosi d 'a ogosclll
Fuola - Con lrtbulo cli ul co a lla co nos ccnt a del l'innervozoonH ,.:rtAia toria •
ParniMIII - l.e anomalil' del (IOiigono arterlo<o di \\'tllls ueì criminali in rarorJOrlo alle al· rerazlonl elc i cervello e c1el cuore •
l oellhart - l.a cura rnerrurt:>.le 11e lla tabe
Ctnl Itala - P rlnco rui a!pP r $•lli • rumìgatus e R3\llSCI'rli • •
Panegrossl - Sulla dlpleJ!ra racciale prnfenra •
ltlllrand - aslero-saturnioa drl nen o r ac1ta iP • • •
Panlc/11 - Conlribolo allo stul1tO dr lla sr lllio.lr rnaiiJlna e pr ecoce • •
Ceni - l .'u<ooe del succo J:3$ll o-eulerico sulle spo r e • • • San11a Salarla - Nole cltnlche su due o;.ervaztOni d• In sogge tli -eplle llicl
Ceni 1\ P ini. !.. l a to.>Sidta tlel nesdi al ìfnati. • •
EIII Otlto - Ancora un rMo dt paui.t ptllas:ro$;1. . . . .
Ptlllu l - f'allt clinici in r ap po rto ai c he cirwnttano tumori cel'\lhr:tlt . . . . • . .
Robtt - S ulle Ila salurnlna rtiVISTA. CHIIl URGICA.
Mo mllurg - Sullo ror ile del l o race P drl loro trattamento
Rog t r . - Contrthnto allo st u rho clinico dcll'eri5illela.
Rouln t . - l.'arl re nalln a nella prnUo·a chirorgt ea
Opptnh ti m - lln eh tnmo rt' •Ici m idollo
Jaboular - Chir urgia cle ll o a rlc r ie, s na iu alcune nt 11oll ' ttr l eria re.: m o ra • , • , .
Wa11ermann - Conlri!Juro n l •i!ftoiOcalo rli.1:;:nnsti co dP IIa leu corltn<i ue ll'nJOJl60oilclle
Augtrtr - 1111 crrc hrall dn l punto tlt o t iologico tlta r:: ur.-!lco
OmDrtdannt - l.o rcallnre
RIVISI'A DI UTO-R INO-l. AiliNGOIATI\IA
De Rou. - eaw rnle emorrnl!le3. . • . . .
Mulltr llch - Nfttroot •ù Oi'C r:t7.io ni s ulla a poli:>i masloi rle
Conctlll, Comlla, Fli6- Bonauola, Mallel. - !)egli cle llft iarinlio
IIIVISTA Ul OCU I.ISTICA.
Ferna•dez - La stt•ri li7LUH>ne Ilei rerr i in ortalmolo!(lll
Tarr ltn - l'c rror"lloue tra umaltca tlel dur. globi ot·tilari rla prolelltle lll ri voltflla, è per· dita co rnltlela •lell'ol(a tto , &alaatwtkl - n elle nllera lioui •Ie lla • ro•ea cenlralts • n ella mlollia
(Per l a conrio1104;lont dell ' indice vedali l a llOfll"a 11• ddln coperffna).
CE
INDI
l'ag 3()9 JUI 3H 3 13 314 315 3li Il i J I K hl 3U li! 3f l U4 3!6 Jt ij h i 1\'t Poq . 3311 33 1 333 331 335 ,,i 330 337 338 IYI m 340 341 "' PoJg. 3U 316 J IK Pau Pag, 355 359 361 l\11 361 363 361 3ò6
SliLIJ'AZ IO NE DEG M ATTUA IJI DA GllEillt!
8 DEL FUCILE lTALIAì'\0 DI PICCOLO CA LlBBO
J\ CONFRONTO CON OUE LLO DI MEOlO CA LII!IIO
Nei tempi passati, g li effetti dei proiettili si studiavano solo nei feriti sul campo di battaglia, ossia in base alle osservazioni che si fa· cavano in guerra. Oggi che il metodo sperimentale si è largamente, e con tanto successo, esteso a tutti i rami della medicina, l'azione dei proiettili si studia anche sui bersagli inanimati, sui cadaveri umani e sngli animali vivi, e con ciò si acqu ista un valido fond amento razionale e pratico per giudicare e curare le ferite da armi a. fuooo nelle guerre future.
Negl i ul ti mi anni del secolo scorso e specialmente nel periodo di tempo in cui l'armamento degli eserciti era in via di trasformazione, furono in gran voga. gli studi sperimentali sull'azione dei nuovi proiettili. Delorme e Chava.sse, Chauvel e Nimier in Francia; Bruns, Reger, v. Colar e S chjerning in Germania; Habart in Austria; Bircher, Bovet, Brunner, Kocher in Svizzera; Demosthen in Rumenia; La Garda in America; Davis in Inghilterra, pubblicarono i primi e più notevoli lavori sull'argomento.
Gli esperimenti che sono oggetto di questa. pubblicazione, vennero iniziati nel1894 e proseguiti negli anni successivi, finchè fui alla Scuola d'applicazione di sanità militare, ossia. sino all'anno 1898. Furono praticati: ool fucile italia no mod. 18 70-87, del calibro di millimetri 10,35, con cartuccia. a carica di pol vere nera e proiettile non incamiciato, e con cartuccia mod. 1890 a carica di balistite e proiettile ri vestito di
Il - GforHale mtdleo.

MEMOR I E ORIGINALI
Stu<ll sperimentali del colonnello mellico r . lntltriaco lillero docente di medicina operatoria al R. Istitu to di studi superi ori di INTRODUZIONE.
ottone ; e col ftlci le mod. 1891, d el calibro di millimetri G,5. I tiri si eseg uirono sempre con cariche intere ed a distanze reali ( 1).
In traprese le esperi enze più per sodclisfare alle esige nze del corso di chirurgia di guerra, di cui ero incaricato, che allo scopo di aggiungere nuove indagini c irca l'azione degli att uali proiettili, a. quelle già fatte con maggiore competenza. e con maggiore larghezza di mezzi, da chirarghi militari e non militari di altri p aesi, non ebbe ro e non p otevano avere un grande sviluppo. Nondimeno, riunendo e riordinando il mate riale a poco a poco ottenuto nei di versi corsi, mi lusingai che qualche deduzion e pratica. s e ne potesse t rarr e. Epperò, mi indussi a farne una breve comunicazione a l Congresso internazionale di medicina, tenutosi a Mosca. nel 1897 (2); e sin d ' allora mi proposi , proseguendo gli esperimenti nei limiti oonserititimi dai mezzi posti a mia disposizione, di f a rne oggetto di n n a pubblicazione più estesa. più particolareggiata.
Ma, traslocato dalla Scuola nell'ottobre 1898, non mi è s tato finora possibile, per dive rse circostanze indipendenti dalla mia volontà., attuare siffatto divisamento. Non credo, ad ogni modo, che il ritardo noccia alla opportunità; poichè, sebbene in questi ultimi anni siansi presen · tate, con inaspettata frequenza, le ocoas ioxu di osservare sull' uomo vivente gli effetti dei nuovi proiettili, pure i dati incerti e spesso fra loro discrepanti, raccolti dai vari oss ervatori, hanno fatto sentire ancora, direi quasi, più vivo il bisogno di ul te ri ori studi speri mentali in proposito. Ed infatti, Nimier, Habart. La Garda, Doye n, Loison ed altri, hanno di recente pr aticato e pubblicat o interess anti esperimenti sull 'azione dei proiettili sia delle armi portatili, sia. delle armi d'ar tiglieria.
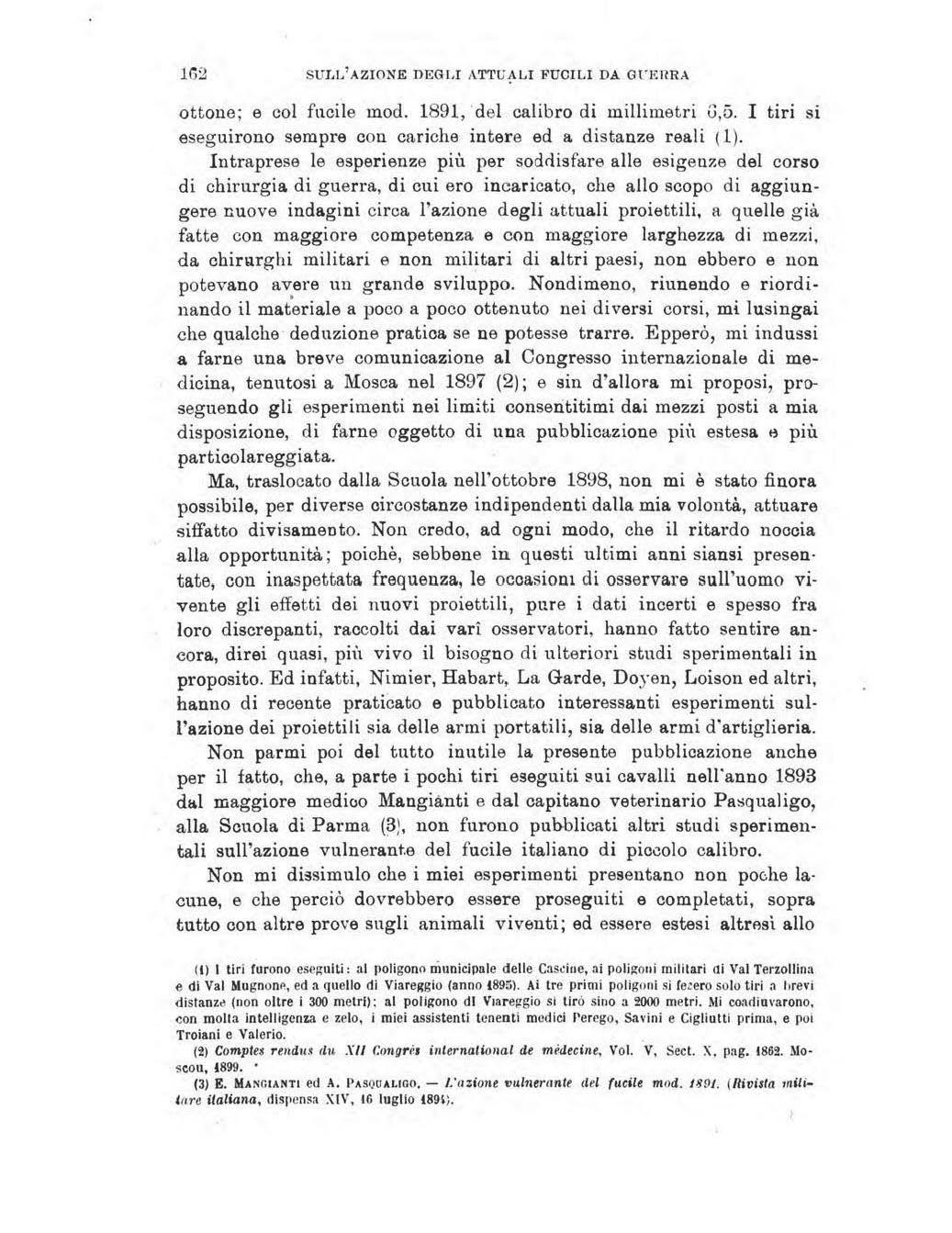
Non parmi poi del tutto inutile la presente pubblicazione anche per il fatto , che, a parte i pochi tiri eseguiti cavalli nell'anno 1893 maggiore m edioo Mangianti e dal capitano veterinario Pasqualigo, alla. Scuola. di Parma non furono pubblicati altri studi sperimentali sull'azione vulnerant.e del fucile italiano di calibro.
Non mi dissimulo che i miei esperimenti presentano non poe:.he la· cune, e che perciò dovrebbero essere proseguiti e completati, sopra tutto con altre prove sugli animali viventi; ed essere estesi altrAsÌ. allo
( l) 1 tir i furo no eseguiti: al poligono oiunicipnlc dell e ai poligo ni militari al Val T e rzollina e di Val Mugn onP, ed a quello di Viarej!gio (anno Ai tre primi po lig oni sì retero s o lo tiri !tre vi dis tanzi! (non oltre i 300 m etri): al poligono di Vm r eggio s i tir6 s ino a WOO me tri. Mi co.1nlu vnrono, con molla intelligenza c zelo , i miei assis tenti t enenti modici l'e rcgo, Savini e Cigliuttì prima, e poi Troiani e Vale rio.
Co mpie$ r endtu Xl/ r.ongrr s i n t ernaliona.l d e midecìn e, Vo l. V, Se<: t. X. pag. 1862. Mos eou, 1899. •
(3) E. M.u.;r. IAI'ITI ed A. PASOOALIGO. - J:a zio tlt "ulnerante del fucile m od. 18 91 (Rivifla tnilit ore italiana, dlsl'c nsa Xl\", 16 luglio 1891) .
lG2
ALIBRO,
studio dell'azione d e i proiettili nuov e armi d·a.rtiglieria.. Ma , per mol te e diverse ragioni, devo lasc iare questo cò mpito ad al tri ch e potrà. a rle mpierlo assai meglio chE' io non sia in grado di dMc rive re gli esperimenti, li divider ò in tre gruppi: il primo. circa la penetrazione ed i cangiamenti fisici del proiett ile ; il seJondo, ci rca l'azione del proiettile s u bersagli Yarì inani mati; il te rzo, circa l"àzio ne> V'l.lnerante sul corpo uman o e sugli animali vi vi È una ripartizione un po' artificiale, massime per il primo ed il secondo gruppo, gi auchè taluni esperimenti potrebbero trovar posto tanto nelruno , che u e ll"altro; ma giova., a me pare, all"ordine ed alla chiare?.za dell'esposiz ione.
CAPITOLO L
Dat i balistici.
P remetto alcuni dati
Le 'armi co n cui si praticarono i tiri, furono, come ho già. accennato, il fucile Yctterli- Vitali, m od. 1870-87 ed il fucile italiano di piccolo calibro, mod. 189 1.

li primo, del peso di chilogrammi 4, 370 senza sciabola- baionetta e di chilogrammi ò,0-17 con sciabola- baionetta. e cinghia., ha il cal ibro di millimetri 10.3.j; è a rigatut"a elicoidale con 4 righe dirette da si nistra " d<;stra; il passo delle righe è lungo millimetri 66. La car tuccia, da p· pri ma del di g rammi 33,3, colla carica di 4 grammi di polve re u era. e c ol proie ttile di piombo non incamiciato, del peso di grammi 20, fu rido tta. (mod. 1890), ed è ora, del peso di grammi 2 9,8 e lnngbezza. di millimetri 6 4,2. È composta. di una carica di balistite del pe:10 di grammi 2,40 e di un proiettile rli piombo rivesti to di otton e, del peso di grammi 16 - grammi 0,20 per millimetro q - e d ella lunghe,.za di millunetri 24, -os:>ia di calibri 2,3 ci r ca.. Colla carica di pol vere nera ed il proiettile non rivestito . la velocità iniziale era. di 435 e la gittata. di me t ri 1800; colla cartuccia. mode ll o 1890, la velocità iniziale si elevò a metri 6 L5 e la. gittata. mas. si ma a metri 2600, la forza vi va. iniziale ra g giunse chilogrammetri 244,9, la vel ocità. di rotazione iniziale 932 giri, il coefficiente di pressione iniziale chilogrammetri 2, 749, e la frec'cia d e lla. traiettoria. (ra.denza), a. 400 metri, si abbassò a metri 1,296.
1l fucile mod. 189 1, del peso di chilogrammi 3,800 sciabolabaionetta. e di chilogrammi 4,280 con sciabola-baionetta e cinghia.. ha il calibro di millimetri 6,5. È a rigatura. a.d inclinazione progressiva
DKL FUCILE
fTALlANO DI PIOCO L.O C
RCC 163
con 4 righe dirette da sinistra a de:> tra; il passo della vite è lungo, alla b occa, millimetri 20. La cartuccia, del peso di grammi 22 e della lunghezza di millimetri 76, contiene una carica di balistite ( l) del peso di grammi 1, 95, e:l uu proiettile di piombo rivestito di maillechrw l (80 parti di rame e 20 di nichelio), del peso di grammi 10- di grammi 0,31 per millimetro q di sezione -e della lunghezza di millimetri 30,5 ossia di calibri 4, 7. La velocità iniziale di traslazione è di metri 710. quella di rotazione di giri 3500; la forza viva iniziale, di chilogrammetri 269; il coeffic ie nte di pr13ssione, di chilogrammetri 7,904; la gittata massima, di metri 3200; la freccia della traiettoria, a 450 metri, è di m e tri 0,72, a 700 m etri, di met ri 1,32, a 800, di metri l ,GO.
I principali dati relativi alla ptmetrazione sono, per entrambi i fucili con cui si praticarono le esperienze, quelli ra.ppresentati nello spe cchietto c he seg ue (2 ):
d'w"'' l'-'mio" dHmo
"' ' mm. spessa 1 mm 1a m .. (8 fogli verticali (9 rogll verticali rorte dolce ;;:; o j a contauo) a contatto) (rov ere) (pioppo) um1da asc iUlla
1 Fogli l Pflgli
Penetra1.1one sino alla profondita
cali di metri:
I tiri collettivi col fucile mod. 18 91 contro muri di mattoni ad una testa (metri 0,14) ed a. più teste, hanno provato che, a 500 metri, anche un muro di una testa costituisce un efficace riparo per le truppe collo· cate dietro di esso; a 200 metri , per costituire un sufficiente riparo per le truppe,· occorre un muro di tre leste, ed a 100 metri, di quattro, ossia di metri 0,5G (3).

(l ) Alla balistite si " sostituita la la <JUa le contiene una certa quantita d'idrocarburo , invece dell ' anilina.
(t) milo m·mi t sul liro p t r l a miltzia t erritoriale ; cd /stl"luione rulle at·mi e 11er la fanteria, \ 'ot. 1/.
(3) Istruzione 1ulle armi e sul tiro p er la (a uteri a. l'ol. Il
16,! S ULL'AZIOSE DEGLI ATTUALI
FUCILI DA. GUERRA
l'"'"l"'"ìs.:-[-;."-
l f ogli l
l
... . ammac·
::8 forati cati 1
100 5 7 2 0,2 \!4 l 0 ,58 1 0 ,410 0 ,3i0 \ 500 o 3 5 l 0,151 : 0.295 . 0 ,390 0,54 U Fucile mod. 1870·87. /1000 o 2 3 l 0,082 0,144 0,350 0,360 \ 1800 o o l 0 ,024 0,042 0,240 0,200 l l ) 100 3 3 'i 0 ,3ìri 1,106 0,250 o 340 Fuc ile mod. 1891. 500 o 3 4 l 0,264 0 .533 0,640 0,720 . t1000 (l 2 2 l 0,122 0,311 o560 l 0, 480 \ 2000 o o l 0,051 ! 0,091 0,lj50 l 0 ,300 • l
forati ·
CAPITOLO Il.
Penetrazione Cangis.menti fisici (risca.lda.mento, deformazione e fra.gmenta.zione) del proiettile.
I. EsPE1UM.ENTr.
a) Tiri su tronchi di albero.
Distanza 100 met ri Proiettile di millimetri 6,5.
l. Due tronchi di pino, un o del diametro di 40 e l ' al t r o di 35 centi metri, sono sucoe3sivamente dallo s t esso proiettile n e lla diperpendicolare a quella delle fib re .
Distanza 75 metri. Proiettile di millimetri 6,5.
2. Un tronco di pino secco fu traversato in direzione delle sue fibre per un tratto d ella lunghezza rli 95 centimetri, uscendone il proiettile non deformato.
3. In un altro tro nco di pino secco il proietti le s i arres tò, legger· mente de forma to, co ntro un nod o, dopo aver scavato n el legno un canale c ilindrico de l d iametro di 5 millimetri, lungo 86 centimetri (fig. 3• )
b) 'firi nella sabbia u m ida ed asciu t ta. - {Poligono d i Viareggio ).
Distanz a l. 3, 5 metri. Pro ie ttile di millimetri 6 ,5.
4. Si eseguiron o dive rsi tiri su banchi di sa bb ia umida ed a sciutta d ella spiaggia.
Il proiettile non si approfondò mai oltre i 20-30 centimetri, ma scop piò sem pre per la rapida fusione del nu cleo, deformandosi enormemente e riducendosi in fra ntumi (fig. 2", n. 5, 11, 12).
c) Tiri su lastre metalliche
Distanza 50, 100, 150 metri. Proiettile di millimetri 6,6 .). C inque lamine eli piombo dello spessore, c iascuna, di millime t ri 2,5, disp oste parallelamente l ' una dietro l'altra coll'intervallo di 3 <?entimetri , e fissate in modo da formare un sistema r igido di 13 centimetri di lato.
A t utte le suindicate d istanze, le cinque lastre restano perforatP. Le p e rfora zioni , circolari od so no un poco più picco le alle più brevi distanze. ma le loro dimensioni crescono progressivamente dalla prima all'ultima la stra; cosicchè, men t re nella prima lastra misu ran o millimetri di diametro, n ell'ultima hanno un diametro di 3-4 centi metri. Gli orl i sono netti e regolari nella prima lastra, ma
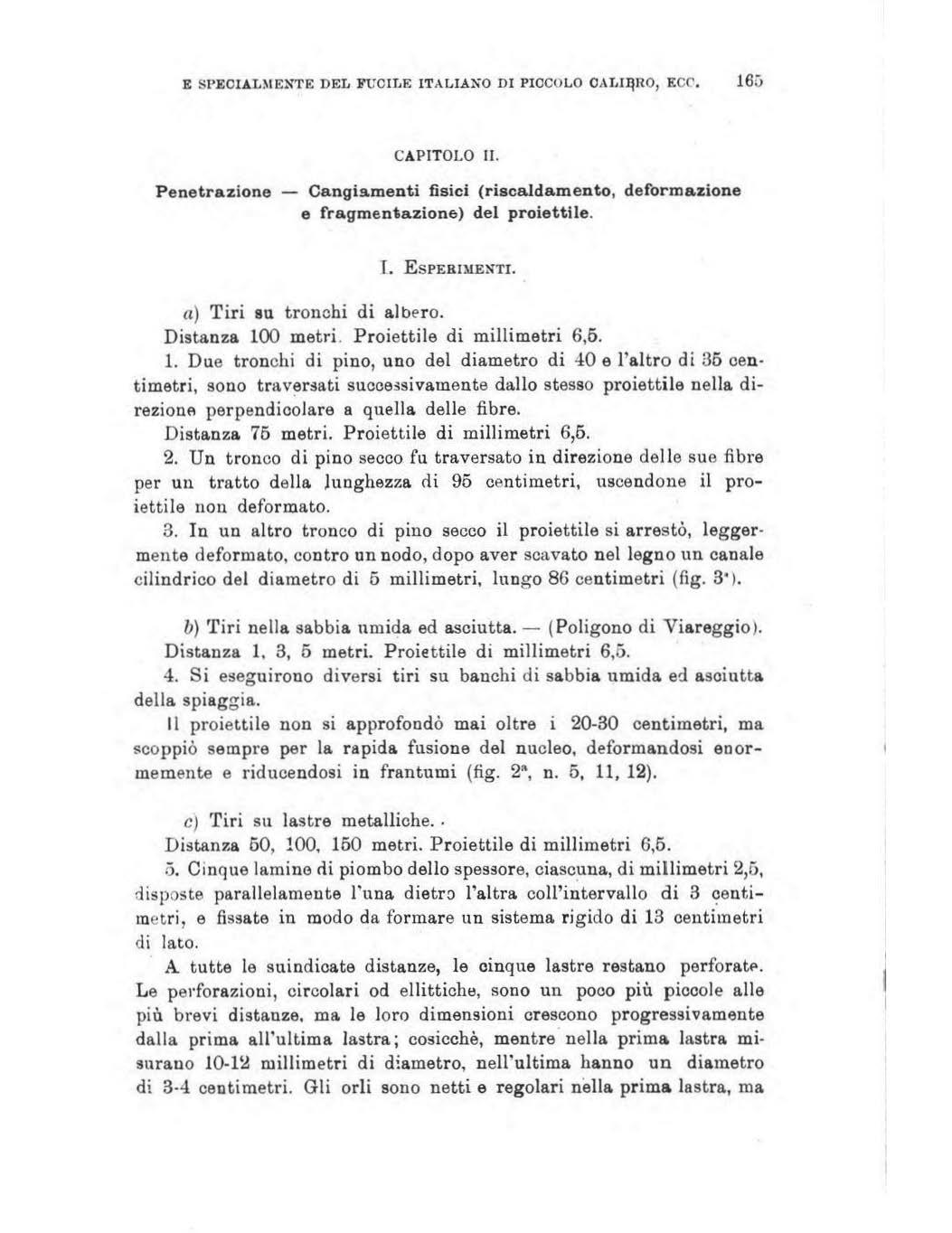
E DEL F UC ILE ITALIANO DI PICCOLO OALll!RO, E CC' 16CI
circondati da un piccolo cercine di lam nlle metalliche arrotolate; uelrultima. lastra so no roves c iati ve r so la .; uperfi c: ie po:;teri o r e e co n profonde dentellature, alcune delle quali di aspetto granu loso p e r parziale fusione de l piombo. Nelle lastre intermedie, le dimensioni ed i contorni delle p:!rfo razioui Yanno grad atamente A.vl·icinandosi a quelli detrultima; e co"i. ciasc·1na perforazione, uelrinsie me del siste ma, acl)uista l'aspetto di uu i10buto colla base all'ultima las tra (fìg. 4' ..t-H ).
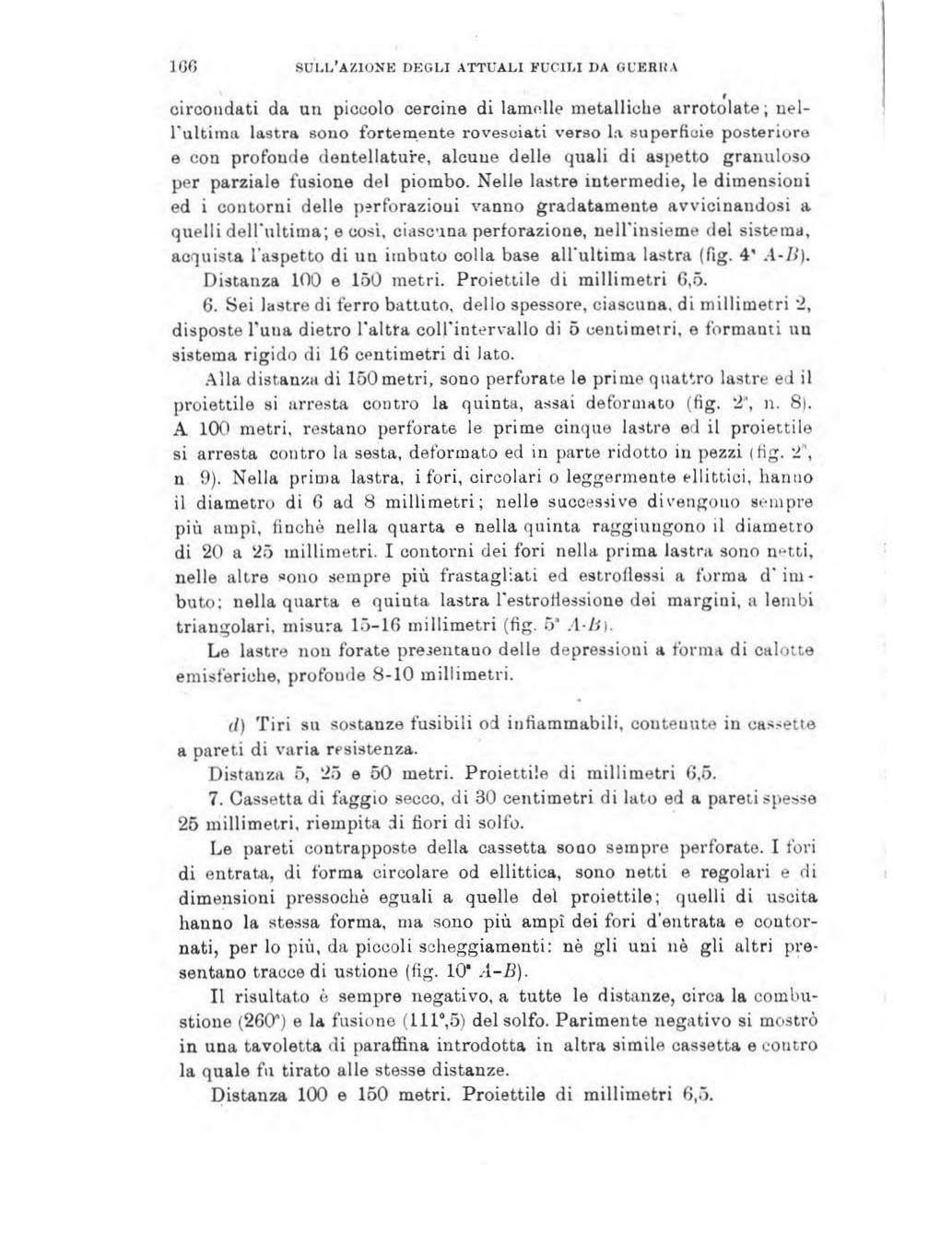
Distanza 100 e 150 metri . Proiettile di millimetri 6,5.
6. Sei lastre di ferro battuto. d e llo spessore, ciascu na di disposte l'una dietro l'altra coll'iote n·allo di 5 metri, e fMmaoti un sistema rigidi) di 16 centimetri di lato.
Alladistanzu di 150metri, sono perforate le lastre eù il pro iettile si 1trresta con tro la quinta, assai defo rOJilto ( fig. n. 81 A 100 metri. r estano perforate le prime cinqu e la:.itre ed il proiett ile s i arresta contro la sesta, deformato ed in J,>arte ri dotto in pezzi n 0). Nella prima lastra, i fori, circo lari o legge rmen t e t-llittici , hanuo il diametro di 6 ad 8 millimetri; nelle s,·mpre più ampi, finchè nella quarta e nella quinta ra ggiu ngo n o d diametro di 20 a 25 millim et ri . I contorni dei fori nel111. pt·ima la \!tm sono n .-tt. i, nelle altre <>ono se mpre più frastagl:ati ed estrolles;;i a t'ùrma d'i mbuto: nella quar ta e quinta lastra r estrotlessione dei margini, a lem bi misu:-a. l.j-16 millimetri (fig . 5· : l l n
L e lastr'3 non forate pre;eutauo dell e depre;;sioui a tormt\ di cal rJlte emi sfe riche, profonde 8- 10 millimetri.
cl) Tiri su o:;ostanze fusibili od infiammabili , couteunte in ca,.·ette a pareti di l'aria r esistenza.
Distauzn 5, e 50 metri. Proietti!e di millime tri 6,5.
7. Cassetta di f11.ggio secco, di 30 ce ntimetri di lato ed a p!Heti :;pesse 25 millimetri , riempita ::li fi ori di solfo.
Le pareti co ntrapposte della cassetta sono sempre pe r fo r ate. I fori di e ntrata, di forma circolare od ellittica, sono netti e regolari e di dim ensioni pressochè eguali a quelle del proiettile; quelli di uscita han n o la !-òte:;sa. forma, ma sono più ampì dei fori d'entrata e contornati, p e r lo più, d 1L piccoli s c heggiamenti: nè gli uni nè gli altri presentano tracce di ustione (fig. 10" A - B).
Il risultato ù sempre negativo, 11. tutte le dis tanze, circa la co mbustione (260") e !11. fusi o ne ( 111°,5) del solfo. Parimente negativo si mos tr ò in uoa tavo letta di paraffina introdotta in altra simile cassetta e contro la qu ale f1 t tirato alle stesse distanze.
Distanza 100 e 150 metri. Proiettile di millimetri 6,3.
l GG SULL'A:I.lO::-IE DEGLI ATTUALI FUClJ,I DA GUERII.\
8. Cassetta fatta. con lastre di ferro battuto, dello spessore di 2 mil· limetri, e divisa in cinque compartimenti cou tramezzi dello stesso me· tallo e dello spessore, distanti fra loro .) centimetri: i compartimen ti riempiti tutti di fiori di solfo.
Alla distanza di 130 metri, souo perforate le prime quattro lastre ed il pr oiettile si arresta deformato contro la quint.1.. Nessnn indizio di comb ustione del solfo: solo qualche segno di fusione nel quarto e, soprattutto, nel quinto compartimento, attorno al percorso dal proiettile.

A. 100 metri è perforata anche la ')uinta lastra ed il solfo si fonde nel terzo comparti mento e si fonde e brucia nel quarto e quinto. Il proiettile d e formato ed in parte fuso, si ferma nell'ultimo compartimento, avviluppato in una c rosta spessa ed a de r ente di solfo fuso in parte bruciato (fig. 2 ', n 10) Le le depressioni a forma di callotta hanno caratteri identici a quelli già descritti al u. 6 (fig. 6' A · 11).
Distanza 50, 100 e 150 metri. Proiettile di millimetri 6,5.
9. Cassetta di fe r ro la minato, colle pareti di 2 millimetri e co l dia· metro ante ro - posteriore di 20 ce ntimetri, divisa in du e compartimenti eguali da un tramezzo dello stesso metallo .e dello st.esso spe::;sore delle pareti. com par timento poste riore viene . int r odotta una tavoletta di paraffina, dello spessore di centimetri.
Il t iro a 150 metri dà risultato negativo risp etto alla fu-::; ione della parstfiua: quello a 100 metri fa n otare qual che indizio di fusione lungo il canale scavato dal proiettile nella paraffina stessa, e spl.'cialmente in co rri>' pondt!nza degli orifìci di entrata e di uscita ; a 50 metri i segni di fusione dell a paraffina sonCI spiccatissimi tutt'intorno al tragitto p ercorsovi dalla pallottola. In conseg u e nza, a 100 m etri il proiettile r ag· giunse la tempdra tu r a del punto di fusion e della paraffina - 60°-65" - ; a 50 metri super ò que.-ta. temperatura.
Nelle lamine di ferr o le perforazioni presentano uaratteri del tutto simili a quelli riscontrati nelle alt re l astre dello stes:;o metallo e dello stesso spesso re. Nella tavoletta di paraffina i for i ,rentrata e d'uscita, per lo più ci rcolari, sono larghissimi: del diametro di 44 a 55 millimet ri e rispettivam e nte (fori d'uscita) di 55 a 77 millimetri. I fori di entrata sono contornati da un largo cercine e da qualche fe n ditura; quelli d'uscita hanno l'o rlo estroJlesso ad imbuto e circondato da ammassi di paraffina opacata e granulosa - tiri a i)O metri - evidentemente risultanti dalla fusione di questa sostanza (fìgu r-1. 7' A-B e fig. 16' .1-8) (1)
(Il An ch e nei liri lastre di roombo, di cuo si e fatt.1 parola al 11 ;;, si chllc ro Ilo rusloM del meta llo : upruo dei contorni c d• i rras!Jlgliamcnti dei ror>, goccoolc sparse •li pio mLo lu$0. tali segni b en manlf<_,ti si n o tuono solo nolla quarta e OJUiuta e nel toro a :;o mN ro; a maggiore distnnxa ru;J metri) e rano ajlpena accennati.
E DEL },'t:CILI': JTALIA:\0 ili PICCO LO 0ALI.BI?0 1 ECO. lu7
Il. CoNSIDERAZIO N I CI IlC A LA PENETRAZIONE ED l CANGIAM'ENTr FiSICI DEL PROIETTILE.
Questo pr imo gruppo di esperimenti, per quanto limitato, pare a me ab b astanza dimos t r ativo, inqua.ntochè \'ll.le a dar piena conferma, anche pel fucil e italiano di millimetri 6,5, alle deduzioni d eri vanti dagli stud i sperime ntali al riguardo, cogli altrifnoili di piccolo calibro.
A. dar r agione di tale mia affermazione, mi sia lecito fare una r apid a disam ina.
Pe nell' a:;inne. - Che la forza di penetrazione sia a ssai elevata nei piccoli c alibri e tanto maggiore qua nto minore & il calibro, è dimostrat o, anzitutto, dalle qualiti fi s iche e balistiche d el pr ùie ttile, e se· gn'ata mente sua form a più allungata, d alla maggiora d ur ezza e m inore deformabilità, dalla velocità di rotazione aum entata . Ed inoltre, co me f 1.1. n otare il ge n erale Wille, poichè il bisogno di forza viva p er o ttenere de terminati effett i eli penetrazione, dimi ntlisce in rag i on e della. diminuzione del diamet ro del proiettile, avviene che la pallottola, di millim et ri 6,5 a 2000 metri p ossied e, co n una fo rza viva molto mi· nore, la stessa fo rz a di penetrazione de lla pallottola. di 8 millimetri a. 1000 met ri ; e se questo. a 3000 metri esercita piuttost o un'azione co n · t und en te c he penetrante, l'altra passa da parte a parte un uomo a n ch e al di là d i 4000 metri.
J. Rugue t, in 1111 suo stu dio dei pro ie ttili m oderni (1), a.fi erma ch e se nei corpi dur i, co me p. es., l'acciaio, si confr onta la penetraz io ne di due proietti li di cal i br o n otevol mente diverso, p. es. il proiettil e di 8 millimetri e •tuello di millimetri 6,5, si osserva che essa è pressocbò la stessa, a 'elocità eguale, con una leggera s uperio rità a favo r e d e l proiettile d i 8 millimetri. probabilme nte in ragione dell a sua maggior e massa. I o n on ho esperien ze proprie al riguar do; ma dai da ti di pen etrazi one circa. i proiettili dei nostri fucili di millimetri 10,35 e di millimetri G,5 , ra ccol ti nelle t ab elle annesse alle fslr tt:;io ni su lle m·mi e su l tù·o per la fanteria. e per la milizia t errito ria le, ed in parte riportati di sopra, risulta che, dalla di 300 metri in poi, gli' effetti d i pe ne trazione su lle lastre di acciaio fnrono re a lmen te eg uali, od un po' maggiori, colla pallottola di 10,35.

Non pertanto, s i sar e bbe molto l on tani dal ve r o, se s i vo lesse da ciò concludere che il proi ettile di millim etri 6 ,5 ab bia una fo rza. di pe-
(t) J II UOU ST - Du Gl'm ts a ( eu d t prlil ca l ib rt aclrttl ltmtnl tn W'UICt d ans lt• ditrérenlu m·miu tic. ( GaJell e d ts f hi]lllaou·, 1896).
lGS SUI.L7AZIO='\E D EGLI ATTUALI FUC ILI DA GUF.RI1 A
netrazione minore di quella del proiettile di millimetri 8. La superior ità, rispetto alla penetrazione, progressivamente crescente col diminuire del calibro - almeno per i calibri finoggi adottati , ossia sino al cali bro di 6 millimetri - è dimostrata, oltrechè dalle ragioni t eor iche teste accennate, altres ì dalle prove speriments.li, numerosissime, e dalle osservazioni sull'uomo vivente.
Non è q11 i il luogo di riportare siffatte osservazioni ed esperimenti. )ii limito a notare come dalle esperi.mze di D e mosthen e di Grigoresco col fucile r umeno di millimetri 6,5, me:tse in confronto con quelle istituite da altri con a ltri fucili di piccolo calibro, sia risultato che la forza di penetrazione del p r oiettile di millime tri 6,5 è di un terzo maggio re di quella del proiettile di 8 millimetri ( l).

I miei esporim enti, sebbene condotti da. quell i del Demosthen e differenti da essi per la distanza de i tiri ed anche per la natura dei bersagli adoperati, hanno r ivelato, come si può v e dere dall'espc sizione che ne ho fatta innanzi, efJ"etl i di p e11et1·n=i one del nostro fucile m od. 18 91, fm ·se superior i. certo n on in{'e1·iol'i a quelli del fucile r·umen.o dello stesso calib1·o (2)
Le esperienze di penetrazione fatte sui cada veri. dal Bmns, dal Demosthen e da altri, con diversi fucili di pic:;olo calibro, banno confe rmata la s uperiorità del 6,5 millimetri sugli altri calibri più grandi.
1\fer itano, d opo ci ò, una bre ve menzione i t iri sulla sabbia secca ed umida della s piaggia. I risultati ottenuti con que:>ti tiri, sono confo r mi a q uelli di analoghe pr ove fatte in Inghil te rra col proiettil e Mannlicher pure di millimetri 6 ,5 e con quello Lee-Metford di millimetri 7,7 ; ed an che ai dati riportati innanzi dall' s u lle armi e s tt ll iro pe1 · la (lLnl eria. E ssi rivelano la grande res istenza che oppone la sabbiaco n lieve differenza a carico della sabbia bagnata - alla forza viva del pro iettile, nou solo, ma m ostrano pure come, alle brevissime distanze, i cangiamenti fi sic i della pallottola, e specialmente la più facile e più ril e vante deformazio ne, 11"' attenuino di molto la forza di penetrazione. Egli è parciò che, nei ti r i al disotto di 100 metri, si hanno pene trazioni nella s abbia. notevolmente minori che a maggio ri dis tanze.
(Il - litudcs f.t;pei"IIIIWilllu sm· l"actio•o du projccljle cuirau r d11 (11sil 41timu ichtr. oou u•au modl'!e I'OIImaln de nullun r lru 6,5. - llu.:;orrst, tSJ4
tt l Riass um o i prlno·ipali <lo peno•W11.ione. che d ermwo rt e lle oli
\Ila dost n7.n di mel r l Il proiettile •li 6.5 nulltmetri p.·rlot ru qu ,llro las tr e olo rr rr o laminato d e llo •t•P"ore, t"i asr una, rll ! milllme td prorlucen rto ne lla quinta una rt e rre <s ooue a lnrrnn rli calo tta semi· lfen ca : tWrlu ro puri' a lla trr' la;.rc d eliO SJlC.«ore rti 4 millime tro Jlnrornenl e , a t t m• trl nell'a h•te ;e.:r:o, uo r1irezionP d • lle fibre, s ino :t\4i ce ntimNro ; nd la,:glo scc:co s ino e nello -In ,t irclion e pe rpen rlo(o l.tre alle llhrt- s inoa 6; ccntlm••tro. A !5 mrtn
tn•erso una rh
13 millime tri. Erl n 100 metri. do po av er un soecu di '<'ilaturn •li legno• do t1ur rcia, doa metro di 40 centimetri. pPrloro una tavola do toKio o '!S cento· m•tro e re• t•l In un"a ltr::l profondota di a cen tom etro.
E SrECIALMENTE DJ<:L FOCif,E DI PICCOLO 0ALIDR01 EOC 1G9
Riscaldamento. - La questione della temperatura del proiettile, e dell'influenza che que::ta può esercitare sulle alterazioni del bersaglio, ha richiamato l'attenzione dei chirurghi militari sin dai tempi di Bartolomeo Maggi e di Ambrogio Pareo; i quali per combattere la teoria che le fe rite d'arma d a fuoco foss ero ferite uste, instituirono degli esperimenti, da cui risul tò che le pallottole dei fuci li allora in U'>O, potevano attraversare un sa.cco di polvere senza infia.mma.rla, e quindi non si riscaldavano a tal da produrre ustione delle fe rite.

In questi. ultimi anni, la questione è stata risollevata e studiata con larga copia di prove sperimentali, sia per l'in tlnenza cbe l'elevata temperatura del proiettile eserciter ebbe sui cangiamenti di forma del pro· iettile stesso e sulla produzione di certe lesioni, sia per l'azione steri· lizzante che da tal uno si volle attribu ire al proiettile ris caldato.
Sono diverse lo cause per le quali il proiettile può anda r e incontro ad un aumento di temperatura.
La prima der i va dal di es;;o colla massa gassosa emanante dalla combustione dell11. polvere. .1fa, sebbene. la temperatura di questa massa gassosa sia molto el e vata, pure i gas agiscono per così breve tempo sul proiettile ed in modo così limitato, che solo una piccolissima, parte di calorico possono ad esso comunicare. Un'altra causa consiste nell'attrito contro le pareti dell'anima della canna; ed Ì11 realtà, questa causa, di poco conto quando si adoperavano armi lisce e pallottole sferiche. ha acquistato importanza colle armi moderne. per il forzamento del proiettile nella rigatura della canna. per la sua forma allungata, e per la molto m aggiore celerità dei tiri. Vi è poi come terza causa, l'attrito durante il percorso aereo d el proiettile; de l attrito s i hanno prove 3perimentali n elle immagini fotografiche del proiettile in m o vi meutu. I n fatti, le ri cerche d i J ournue, d i Salcher, di Riegler e sop ra ttutto di l\fach, hanno rivelato la formazione attorno al proiettile in moto, di una spP.cie di cuffia o, meg lio, di guaina d'aria compressa, costituita I l ) da un'onda. cef'a lica di addensamento, da. un'onda caadule di rarefazione e da uua. serie variablle di onde intermedie. Ma, quale influe nza sul la temperat-ura de lla p a llottola abbia rat t n to cui questa. va iacontro nell'aria, secondo la sua fo rma, la ,-elocità. ond'è animata, ed a ltre circostanze, gli e sperimenti non d ete rminano. La. stessa cosa. può dir;ji delle altre ?ue cause la cui in tl u enza sulla temperatura del proiettile no'n può essere, neanche approssima tivamente, valutat.a, nè coll"esperimento n è col calcolo.
Seco ndo Richter, la. pallottola di piombo, al suo uscire d a un fucile rigato a retrocarica. si ris cald erebbe n e lla superficie, ad un g ra do' va-
( t) M.1 c 11 - \\ 'eìtere Ver•uche iilur PrOJtCWe. - 1\' icn, 48%
lìO SULL'AZIO:SE DEGLI ATTUALI FUCILI DA GUERRA
riabile da 100• a. 300" (1), ma. il calore s:!emerebbe durante la. co rsa in p r oporzi on e delle di:Jtauze. Quindi, anche volendo accettare gli apprezzamenti del Rich te r, sarebbe ridotta a be n poco l' in tluenzn d el contatt(} coi gas della cari ca. e dell'att rito nella. canna, e :>arebbe addirittura negati va que lla dell'attrito nell'aria. I n ogni modo, per i proiettili irwa,,ziciati, conviene tener presente che la rapidità. colla quale per corrono In tra iettoria im pedisce che il calor ico abbia il tempo di propagarsi per cooduc ibi l ità in tutta la massa del proi ettile, e perciò il meta llo si trova ad una temperatura superiore a quP.llA. d el nucle o nel momento dell a. penet r azi o n e nei cir co:;tan za. questa n on pri Và d'interesse d al punt o di Yista chirurgi co.

Lo sv i l nppo di calorico c he deriva dall'arresto rep e n ti n o del proiettile co ntr o il è di ce rto, f ra le varie cause di riscaldame nto del proiettile s tesso, per noi la più importa nte; è quella d a cui più direttamente può di pendere l'i n fluenza de!la temperatura della pall o ttola s ull e alterazioni d ell'oggetto colpito.
I n bas e all a legge d e lla trasformaz ion e delle forze, se tutta la forza viva ond' è animato il proiettil e qu ando urta contro i l bersaglio, s i tra· sfor masse in calor e, si avrebbero temperature elevatissime.
SEocondo i di H ag enba c h, se una pall ottol a di piom bo in moto colla v e locità d i 400 metri, si fermasse di botto, s i riscalderebbe oltr e i oso·. C olle n uove armi, la velocità del proiettile è tanto c he alle brevi dis tanze si pot r ebbe ro av e re tempe r atu re d i 800"-900'. Ve ne.sarebbe d'avanzo per la fu:lio ue de l piombo ( 33-l") del nucleo, ed anche de l metallo del1mtnlello . .Ma vi sono delle c ircostanze c he r e nd ono flllaci i calcoli teoretici. Anzitu tto, solo una part e della forza vi va. si t r asfo rma in calore, e questa tanto minor e, quanto minore è la resistenza, oss ia quanto maggiore è la d efo rmabili tà àel bersaglio e del proiettile stesso. In secondo luogo, n on tutto il cal or e svi luppatosi si comunica al proiettile: una. parte non piccola si trasm e tt':l al be rs agl io, e vi s i in pro po r zioue co r rispondente a.llll. conducibilità di el'!·;o per il calo r e ed alla s uperfi cie çli contatto.
Quindi, la que.> t ione è stata studiata. sperimentalmente e. come ho già. accennato, su vas ta scala, d a Beck, Reger, Richte r, Kikuzi , Ko cber, v. ùoler e Schj e rning, Demosthen.
Non è il caso di ripo r tare qui g li esperimenti e le co nclusioni dei varì sperimeutatori. Bas t&rà ra.mmentare che dalle ric erch e s pecialmente
111 e•pc r•en1.e di v Schjero in:; sarebbe r is ulta to cbe 11 proiettile <l mantello, per eiTet tB del la tcmperntura !lei gas della polve r e e dell'attri!Q canna. non si rìsc,Mer e1Jh6 o l tre i 6S•-;oo dopo un sol colp o o pi u eo lr>i tiratllrn l amente. :\!• tirantlo ra pi<lamente colpo colpo, la tt'm· si Plewrcbbe In tal e m•sura, che •lopo t OO col pi sparati In t m iooli e mezzo, Il nuc leu <li piombo en trereboe in rusiune (334• ).
E DEL FUCILE ITALIANO Dl PI
CA LIDRO, ECC, l il
CCOLO
di v Colar e Schjerning, di Demosthen e di K oc her è risulta t o che il proie t tile dev' esse r"' animato di una f orza viva mol to elevata. ed inc ontrare, od av e re incontrato, una grande r esist enza, perchè, colpendo il la. sua -temperatur a raggiunga quella di fus ione del piombo In co ns eg u e nza, i proiet tili moderni, n el colpirs e traversare i bersagli umani, n on sono, di r egola, in grado di produrre u s tioni n e i tess uti viven ti. e n e mmeno l'accensione deg l' indumenti dei colpiti . Ciò potre bbe acc ad e re so lo, quando il proiettile a vesse d ovuto prima s uperare os tacoli m o l to r es is tenti; ma, i a siffatti casi , l'elevazi one te rmica non è diffusa al nu cleo; in egual misura. che alle parti es terne rl e l proie ttil e, e si disp e r d e con m olta rapidità. D'ordinario, an c11e attraversando oss a reil proi ettil e non si riscalda. oltre i 65' -70'. e solo raramen t e , u r ta• ·d o contro ossa. compatte molto dure, può una. t e m· p e ra tura. di 95• ed anche maggiore. Quanto poi a. il' influ e nza d e l oal i bro . è l ecito pensare che, stante la maggiore facilità con cui i proie ttili più pic 0oli, per l'aumentato coefficiente di pressione, p oss ono trasmettere la. loro forza. vi va a.l bersaglio, il ril'loaldame nto di es5i d e bba rela t ivamente minore, ossia. in ra.gior.e inve1sa. del calibro.
I miei espe rimenti hanno provato o, dirò m eg lio, oo nftl rmat o c h e il proie ttile p oco deformabile d e l fu c ile i t aliano di pi ccolo calibro , al pari d i que llo degli altri fll c ili analoghi , e Mgnatamente del fuoile Mannlic he r rum e no di eguale calibro. p e r pote r" a cl') nis tare e determinare nel be r s agli o una. tempera t ura pari a que lla d e l punto di f L t · s io n E> d e lla paraffina - 50"- Go• - d e ve p ossede re una v d oci tà. e quiJJ.di una fo r zi\ vi v a r esidua , assai c:o nsid e rev o le ed inco n t rare una r esis t e nza, ch e s olo p e r c uo tendo un oss o co mpa tto p otrebbe t r o vare u e l corpo urr. sno. Per n s caldarsi p oi sino al pu n t o di fu s io n e ù e l - lll ",ò-occorre un 'ele \rata forza viva r esidua {tir i a "Ime no d i 150 metri ), ed una. r esis te nza. tale nel b e rsaglio (quat t r o lastre d t fe rro laminato, ciasc una d e llo s pes sore di 2 millimetri ). che a ssai diffic ilmente s'inco ntra n e l corpo umano; e per riscaldars i s ino al grad o de lla combusti one d e l solfo - 260' - è una. forza. vi va (d istanz e 100 m e t-ri), ed anche una r esistenza assai maggio r i Iufìn e, per realizzare una tem· p e rlltnra. corris pondente al punto di fusione piombo - 334•occorre una. forza viva e levatissima. (tiri a. al disotto di 100 metri), ed una. resistenza nel bersaglio (quattro di piombo dello spes· so re, c iasc una, di millimetri 2 ,5), che nel co rpo umano non :;'
De( m·,na:: i o ne e f1·agmen ta : ione. - La. questione delle deformazi o ni dei proiettili, tanto importante nella chirurgia. di guerra, è studiat a. sper ime ntalmente sin dai tempi di Dupuy tren e di Langenbec h. Oggi gli espe r imenti su animati . ed inanimati e l e

172 SULL',IZIOXJ;: DEGLI ATTU ALI .FUCILI DA GUERRA
.·ì :. . .,·l -.·::.. : e ,, -. .._ ( , . •· : · .. .., ''l
osserv.tzioni sui campi di battaglia· hanno provato che i proiettili moderni, a mantello, si deformano più raramente dei proiettili a ntichi, non rivestiti; ma le deformazioni e le fragmentazioui, specie del metallo di rivestimento, concorrono più di p rima ad accrescere razione vulnerante del proiettile.
l proiettili possono deformarsi sia fuori che dentro del corpo umano; e le deformazion i possono svariatissime. I p rin cipali t ipi di quelle dei moderni proiettili incamiciali sono deformazioni della laterali. della. base dtll proiettile; scoppio e riduzione in frantumi del t1ucleo e del mantello. Vi hanno poi delle alterazioni atipiche, costituite da fenditure con distacco parziale o totale dell' involu cJ ·o: da fuoruscita di parte o di tutto il nudeo; da parziale distacco e frantumamento del ntteleo e dell'involucro, ecc. Queste deformazioni atipiche si verificano specialmtlnte nei colpi di rimbalzo. Nei quali, per altro, il Lavai ha Oi!serva.to .che molti del proiettile Lebel, pur essendone fuornsc ito il nudeo di piombo. avevano conservata la loro forma a guii!a di tanti astucci vuoti (l). Contro le ossa del corpo umano le deformazioni atipiche sono assai rare, e si po:.sooo verificare 3010 alle me d istanze.
La. teoria e l'esperimento hanno mostrato, in modo non dubbio, che i .;angiamenti di forma del proiettile derivano principalmeute datla.. forza viva oud'esso è auimato e dalla re:sistenza del bersaglio: quanto maggio r e è la fo rza vi va del proiett-ile, quanto più g rande è la resistenza che iucontra, tanto più facile e più rilevante è la sua deformazi v ne. Cangiamenti di forma ed elevazione di temperatura della palla, piucchè essere due fenomeni dipendenti l'uno dall'altro, come fu creduto da taluni, sono effetti della stessa causa: l'w·to violento della palla cor•ll·o la dell'oslacol J .

l'ero, alla produzione delle varie forme e gradi di alterazion i del concorrono di versi altri fattori. Tali sarebbero, o ltre le condizioni è el tiro ed i caratteri fisici del bersaglio : la costruzione del proiettile, ossia il modo come il mantello è unito al nucleo; la composizione chimi ca dell' involttCI'O; l'essere questo completo od incompleto
.h: noto che i proiettili così detti compound si deformavano menodegli altri, e che, in generale, le deformazioni sono molto più d ifficili nei proiettili il cui nucleo ùi piombo è meglio e più saldamente unito &l mantello. I proiettili rivestiti di rame si sono, poi, mostrati più soggetti_ alle deformazioni ed alle fragmentazioni, di quelìi rivestiti di acciaio; ed i loro scheggiamenti sono più acuti , taglienti e laceranti.
E SPEOlALliENTE DEL
ITALIANO
173
FUCILE
DI PICCOLO CALIBRO, ECO.
!Il Eo. t A u L . - dc
r gu, n. 6, 1891.
Chiru
Io il proiettile svizzero, nel ' quale solo l'ogiva è ri,·estita da una calotta di acciaio ej, il corpo del nu cleo è a nudo; le pallottole inglesi d um- clu m, il c ui l'iveslimenlo va gradatamente assottigliandosi dalla base in avanti. sino a mancare del tutto a li,·ello della punta: le alt.re pallottole inglesi, adoperate nella campagna del Sudan. col nucleo privo d' inr:ohtc:l'O all"estremit,t dell'ogiva. ed incav11to. sono tanti esempi deli a g rande influenza che r incompletezza dt>l mertlu eserci:a sull a deformabilità del proiettile. Nella pallottola svizzera, secondo Bin:uer, le deformazioni si verificher.. bbero nel òO p, 100 dei colpi co n lesiouE'I osst!a; e dalle osservazioni di Bri.\oner risulta obe anche una deb ole resistenza, p. es : quella che la punta del pro· iettile incontra battendo contro il terreno, dà luogo all'incurvamento del corpo de l nucleo sulla calotta dell' ogiva, ed alla ridnzione in frantumi del nucleo stesso. Nei proiettili inglesi modifi cati f., inveee. la parte anteriore della pallottola che si espande e Ai riduce in pezzi fra la sua base cm·a;;za la e la resistenza e:1terna.
Hanuo alt resì influenza sulle deformazioni, rangolo d' incidem:a del proiettile, i l suo movimento di rotazione ed il modo di percuotere il bersaglio: di punta, colla base o secondo un diametro obliq u o. Quando il proiettile batte di punta, il corpo fa. per così dire, da roortt>llo sulla punta e l'appiattisce, e se la violenza. è grande. può anche ridurst in frantumi tutto il proietti le (Nimie r :. Lo stes:1o meccanis mo, ma in senso invers o, si determina. se urta colla base. Allorchè poi obliqua· mente, av v iene uno schiacciameoto late rale. s p ecie della punta, ed an che un'inflessione angolare, più o meno pmnunziata, d e lla punta. sul co rp o Nel corpo umano e degli animali le deformazioni dei proiettili .incamiciali avvengono con varia frequenza.
Nelle espe rienze di v. Coler e S cbjer ning verificarono nella pro· porzione di 17,9 p 100 contro le ossa dei cadaveri umani e ddl ò4.5 p. 100 contro le ossa dei cavalli, e, risp etto al totale delle te r1te, in ragione del 4.5 p. 100 nel corpo umano e del 14 p. 100 nel ca vallo (l ). Liibe ris co ntr ò il 24,5 p. 100 contro le ossa urna.ue ed il 60 p. 100 0ontro le ossa dei (2). Il p roiettile rumeno di mlllimetri 6.G, a man te ll.o di acciaio nicbelato, andò più volte incontro a deformazioni e frantumam enti nelle esperienze de l Demosthen. Oltre a quelle verificates i contro bersagli meta.llici ed anohe nei tiri nell'acqua, sono notate varie deformazioni, per lo più d i punta, contro le ossa compatte (tibia, omero) a 600 ed a 1400 01etri, e due anche contro ll' OS$a

(l) V. C0LRR UNO ScBJI!RSING. - Ctbtr dù Wirkung und Btdtulung der W>IMI Jlo'114(euenoatrm ( Medi;inai-A.bltilung del prt uuischtn liritOI·Min1•14rium•. Derlin, 1894)
(!) L. LUHR. - l'orluunoen der Jiriegs-Chirurgie. Derlin, 1697.
liJ f:OLL'AZ10NE
DEGLl ATTliALt FLTII,i DA Gt:EflRA
'l .. ·,
del cavallo ; fra. c ui è d egno di ·nota. il caso di un proietti le che, dopv ave r e attraversato a 15 met ri quattro ossa, f u trovato rid otto in 19 p ezzi nell"ultimo focolaio di frattura ( l ). Il Mangianti ed il Pasqualigo, su 3 4 proiettili d el fucile italiano di millimetri 6,5 lanciat i contro cavalli, contarono 4 deformazioni (2 )
L e più rilevanti alte razion i di forma dei proiettili mode rni, nel corpo umano. ed anche contro be rsagli inanimati, furono ris contrate fino alla distanza di 1200 metri. A partire da 1600 metri, le d efo rmazioni diventano assai più rare e si presentano quasi sempre sotto fo rma di schiacciamenti della punta.
Nella più parte dei casi (secondo L iihe in tutti) le deformazioni nel co rp o umano avvengono contro la sostanza corticale dell e ossa lunghe ed, in particolar modo, contro le diafisi: la cresta. della tibia, la linea. aspra del femore, sono le parti contro cui più fllc ilmente il proiettile si d eforma. Le ossa durissime del cavallo danno luogo, specie alle brevi di stanze, allo scoppio e ridu-z;ione in frantumi del p r oiettile lv. Coler-Schjerning). Il Liihe (3 J opina che sulla produzione e sul grado de lle deformazioni eserciti molta influenza. l' angolo sotto il quale !"osso è col pito, non la distanza; ma è da. notarsi che le esperienze del Lflhe furo no fatte solo sino a. 1200 metri.
Nei numerosi tiri da me eseguiti contro bersagli di varia resistenza. ed a di \' erse distanze, osse rvai cos tantemente la d efo rmazione del proiettile contro le las t re metalliche: contro le lami ne di ferro, alle distanze di 100-1 50 metri il proiettile di millimetri 6,5 si deformò enormemente, presentando lacerazioni e dista.cco e grande schiacoiamento d el nu cleo (fig. 2•, n. 10). Nel legno, sol o una. volta che il proie ttile si arrestò contro nn nodo, si ebbe una limitata depressione della punta. ( fig 2', n. 2 ) Nei tiri, a. brevissima distanza, contro la sabbia della s piaggia, il proiettile scoppiò sempre rid ucendosi, come ho già precedentemente accennato, in una. massa infòr me ed in minuti pezzi (fig. 2', n. 6, 11 e 12} .
Per la b r evità delle distanze di tiro, le lastre di piombo furono sempre tutte perforate, e quindi non fu possibile raccoglier e alcun proietti le. Però, nei tiri fatti a. 100 metri contro cassette contenenti ciottoli o pezzetti di marmo, col proiettile di millimetri 6,5 e con quello di millimetri 10,35 rivestito di ottone (cartuccia mod. 1890), tanto l'uno che l'altro proiettile scoppiarono, riducendosi in minuti pezzi il rivest imento ed in una. massa. informe il nucleo di piombo (fig. 2', n. 6 e 13).

SPECIALMEISTE DEL FUC ILE ITALJA!\ 0 DI PIOCOJ,O C' ALIDRO. E CC, liu
111 01110STII B11. - I.OC Ci l li A!<GU:OC TI e PASQUA LIDO. - I.OC cll •l1 Luu a - Op. cl!.
Per la stessa ragione dianzi accennata, ossia per la brevità. dell& distanze, non fu possibile raccogliere proiettili nei tiri su pezzi di cadaveri e sulle ossa fresche o secohe.

Ad ogni modo, i dati da me ottenuti non fa nno che confermare, per il proiett 1le del fucile italiano di millimetri 6,5, i risultati degli esperimenti e delle osservazioni relative agli altri proiettili di piccolo calibro. Tali risultati si possono riassumere nei seguenti corollari: r n proiettile a mantello si può d efo rmare, e non con troppa rarità s i deforma, a tutte le distanze infenori a 1600 metri. 2" La deformazione può arrivare sino all o scoppio ed alla fragmentazione in un gran numero di particelle. a· Il p l ·oiellile cos i diviso, e pel·icoloso assai a causa della sua tessitura non omogenea, e segnalamenle a ca·usa dell'in· vol u Cl'O che, massime se è di rame, s i lacera in pez.:etti acttti e la· glienti 4• il proiettile si deforma n el corpo umano stesso, l'effetto nocivo varia sec.:>ndo il grado e la specie della deformazione. Se è solo schiacciato, con o senza lacerazioni de l rivestimento, l'allargamento della. supe r ficie di contatto ed il rall entamento della oorsa ne este ndono e prolungano l'azione e concorrono, coll'eventuale aumento di volume e colla irregolarità. della. forma, a di minuire l'azione di penetrazione e ad accrescere quella laterale; on de je1·ile estese, irregolari con concussione delle parti vicine, e più gravi ef!"elli esplosivi, ltl dove esistono le condi:;ioni fisi che fav o,·evoli . Se poi il proiettile scoppia e si ridu ce in frantumi, l'azione vulnera.nte dei tanti piccoli proiettili che si mettono in mo vimento, è aggravata. dalla loro fo rma a. s pigoli taglienti ed a punta a c uta; per il quale fatto, s'insinuano nei tessuti lacemndo vasi e nervi, senzachè s ia facile 1'intt·acciarli e t·imuovel'li.
o• Allorohè il proiettile si deforma fuori del corpo umano, colpendoloper lo più di rimbalzo, le ferite sono estese ed ù·regolm·i, sp esso moltep lici. m a, di 1·egola, po co pJ·ofonde.
Effetti dei proiettili su bersagli vari.
I. E s PERIMENTI.
a) Tiri su bersagli elastici.
Distanza 50 e 100 metri. Proiettile di millimetri 10,35 non r ivestito, e carica di polvere nera.
Distanza 200 e 300 metri. Proiettile di millimetri 10,35 rivesti to di ottone e carica. di balistite.
17tl SULL'AZIONE DEGLI ATTUALI
FI.JCILl DA GUERRA
C APIT O LO 111.
l. La mina di caucciù dello di 3 millimetr i. A 30 e lùO metri, fori circolari del diametro di 13-4 millim e tri, circondati da una zona. nerastra larga 5-6 millimetri; a 200 e 300 metri, fori più piccoli, di circa millime tri di diam e tro, con anello nerastro largo 6-7 millimetri: tutti i fori, a contorni netti e regolari Alcuni colpi ad incidenza obliqua hanuo prodotto p erfomzioni di forma ellittica col massimo diametro di 6 7 millime tri e colla zona scura parimente ellitti ca. più alta in corrispondenza dei du e poli dell'ellis si (fig. 8 ")
Distanza 600, 1000, 1500 e 2000 metri. Proiettile di millime tri 6 ,5. Lamina di caucciù del lo spessore di 4 millimetri. A GOO e 1000 metri, fori circolari - qualcuno ellittico causa dell'in cid e nza oLbliqua del proiettile - q uasi puntiformi, del diametro di 2 3 millime tri, circondati da un anello brnno dell'altezza. di c irca millimetri 2 ' / ,; a 1000 metri, qualche piccola dentellatura nel contorno dei fori di us cita. A 1600 metri, perforazioni puutiformi come se prodotte da uno spillo, c ircondate da una zona nera.stra, della. larghe zza d i millimetri 2 '/. a partire dal centro del foro; ap e rtura di uscita, a contorni sfrangiati.
A. 2000 metri, p erforazione di forma ellittica, col massimo diametro di -! minimo di 2; apertura di uscita. rappr esentata da una fessura d e lla lunghezza di 10 millimet ri , senza. perdita di sostanza (fig. o·).
b l Tiri su tavole di legno.
Distanza 5, 23 e ùO metri. Proiettile di millimetri 6,5.
3. Tavole di fa.ggio secco, dello spessore d i 25 millimetri rappresenta nti le pareti opposte di una cassetta riempita di fiori di solfo (v. n. 7, cap. Il e fig. l(} ' .4-B) .

Distanza 100, 200 e 300 metri. Proiettile di millimetri 10,35 rive:!tito di ottone, e carica di balistite.
4. Tavola di f!l.ggio secco, dello· spesso re di 25 millimetri. Fori di entrata circolari od ellittici, di dimensioni un po' minori eli quelle del proiettile (diametro 8-9 millimetri), a. contorni netti, tagliati a stampo; trami ti cilindrici con pareti Leggermente cincischiate; fori di nscita del diametro di 9-10 millimetri, a contorni sempr e m eno r egolari a seconda delle distanze, con scheggiamenti piccoli e limitati e con fessure nel senso delle fibre del legno (fig· . 11' A.-B)
Distanza 100, 200 e 300 metri. Proiettile di millimetri 10, 35, di piombo compresso, e carica di polvere nera.
5. Tavola di quercia, dello spessore di 20 millimetri. Fori di entrata circolari od ellittici, del diametro un po' minore di quello del proietti le (8-10 millimetri), a contorni netti circondati da un piccolo anello bruno: alla distanza di 300 metri notasi qualche piccola den-
l! - Gior11ale mrdico.
DEL l-'C"CILE ITALIANO DI I'IC Cù LO CA L1DRO, E Cl ' , 177
tellatura. marginale. Fori di uscita sensibilmente p i Ì1 grandi, a contorn i sfra ngiati o scheggiati, talvolta (a HOO metri) ra ppresentati da fenditure con scbeggiamenti estesi sino a 2-3 centimetri; tragitti a pareti frastagliate, e leggermente imbutiformi (fig. 12" A JJ ).
Distanza 600, 1000, 1500 e metri. Proiettile di millimetri 6,5.
G. Tavola di que rc ia dello spesso r e di 2ii millimetri. Fori d'en· tra ta. circolari od ellittici, a contorni n e tti, di dimensioni minori di quelle del proiettile ( diametro 4 - 6 millimetri) ; solo un colpo a. 2000 metri produce un foro d'entrata più piccolo, bensì, delle dimensioni del proiettile, ma a contorno irregolare e cincischiato. Tragitti 1\ pa· r eti più o m e no ci ncischiate, massime verso il foro di uscita ed alle maggiori dist anze . Fori di uscita abbastanza regolari, ma di forma e dimensioni variabili a secoTJ.da dell'angolo d'incidenza del proiettile (<t 1500 e 2000 met ri , più grandi dei fori d'entrata) a. contorni più o meno frastagliat i, e circondat i da fenditure più o meno estese in ra· giona della distanza del tiro (fig. 13' A JJ). A 2000 metri il proiettile, dopo avere perforata la tavola di CJUercia, passò pure da parte a parte una traversa di abete spessa 4 centimetri.
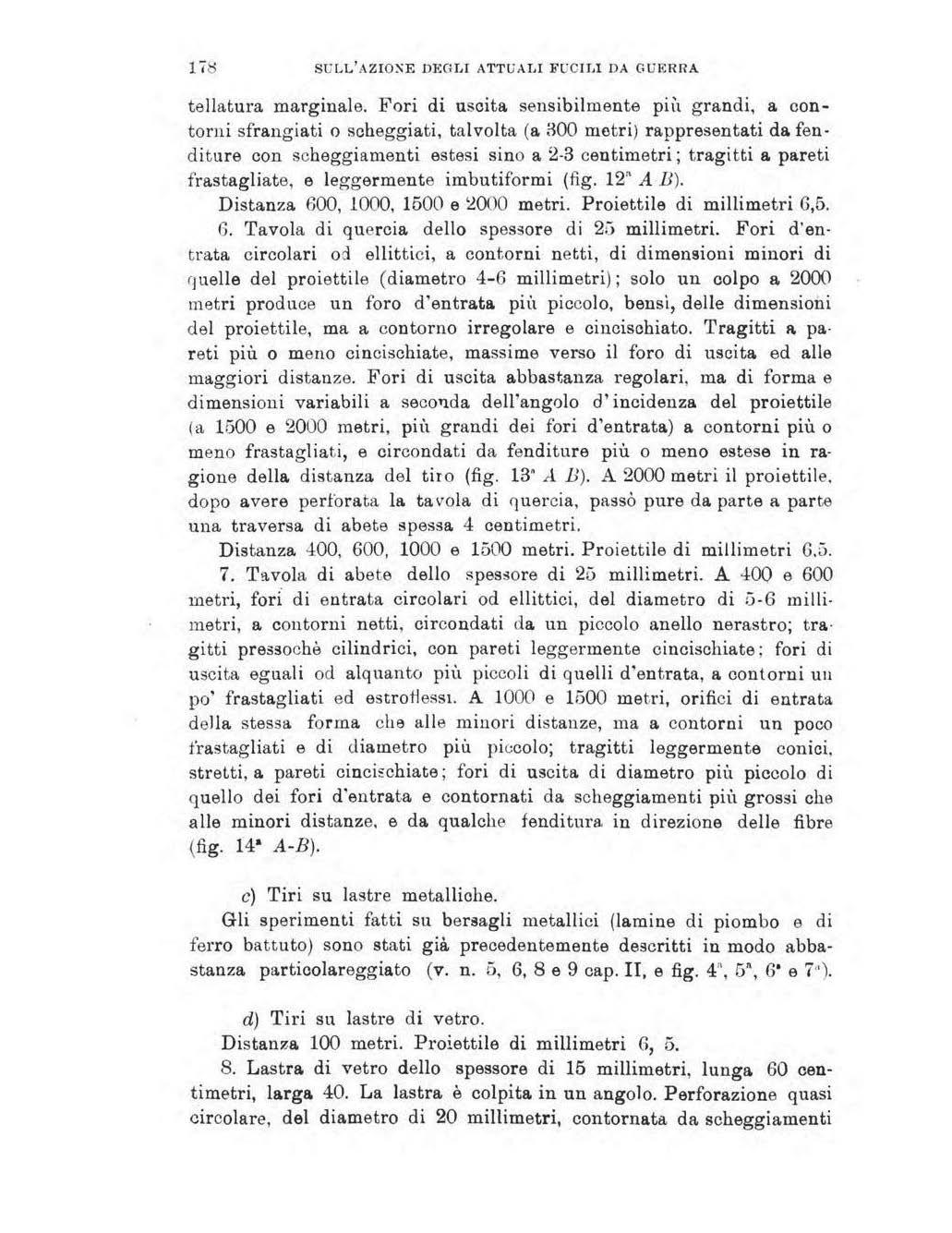
Dis tanza 400, 600, 1000 e 1500 metri. Proiettile di millimetri 6.5.
7. Ta-vola di abe te dello spessore di 2ò millimetri. A 400 e 600 metri, fori di entrata circolari od ellittici, del diametro di ò-6 milli· m e t ri, a contorni netti, circondati da un piccolo anello nerastro; tra· gitti pre.ssochè cilindrici, con pareti leggermente c incischiate ; fori di u scita eguali od alquanto più picco li di quelli d'entrata, a contorni un po' frastagliati ed estrofi essL A 1000 e 1600 met.ri, orifici di entrata d e lla stessa forma che alle minori distanze, ma a contorni un poco frastagliati e di diametro più pi ùcolo; tragitti leggermente conici. stretti, a pareti fori di uscita di diametro più piccolo di q uello dei fori d'entrata e contornati da scheggiamenti più grossi che alle minori distanze. e da qualch e fenditura in direzione delle fibre ( fig. 14• A-B).
c) Tiri su lastre metalliche.
Gli sperimenti fatti su b ersagli metallici (lamine di piombo e di ferro batt uto) sono stati già precedentemente descritti in modo abbastanza particolareggiato (v . n. 5, 6, 8 e 9 cap. II, e fig. 4", 5', 6" e 7·•).
d) Tiri lastre d i vetro .
Distanza 100 metri. Proiettile di millimetri 6, 5
8. Lastra. di vetro d ello spessore di 15 millimetri, lunga 60 cen· timetri, larga 40. La lastra è colpita in un angolo. Perforazione quasi circolare, del diamet ro d i 20 millimetri, contornata da scheggia.menti
17. SULL'AZIO:\E DEOI,I ATTUAI,! JlTCJJ.I DA C.Uii:RRA.
e fenditure este;;e in tutti i sensi, cosicchè la lastra è ridotta in frantumi tanto più piccoli, quanto più vicini al punto colpito ( fig. l5' ) Alla distanza di 200 metri, su di un a lastra di vetro delle stesse dim e nsioni che la precedente, s i hanno risnltati quasi identici.
e ) Tiri su sostanze plastiche.
Distanza 50, 100 e 160 metri. Proiettile di millimetri 6,5.
9 Tavoletta di paraffina, dello spessore di G centimetri, collocata n e l secondo compartimento di una casse tta di ferro laminato (v. n. 9 ca p . II e fig. 16' A-B)
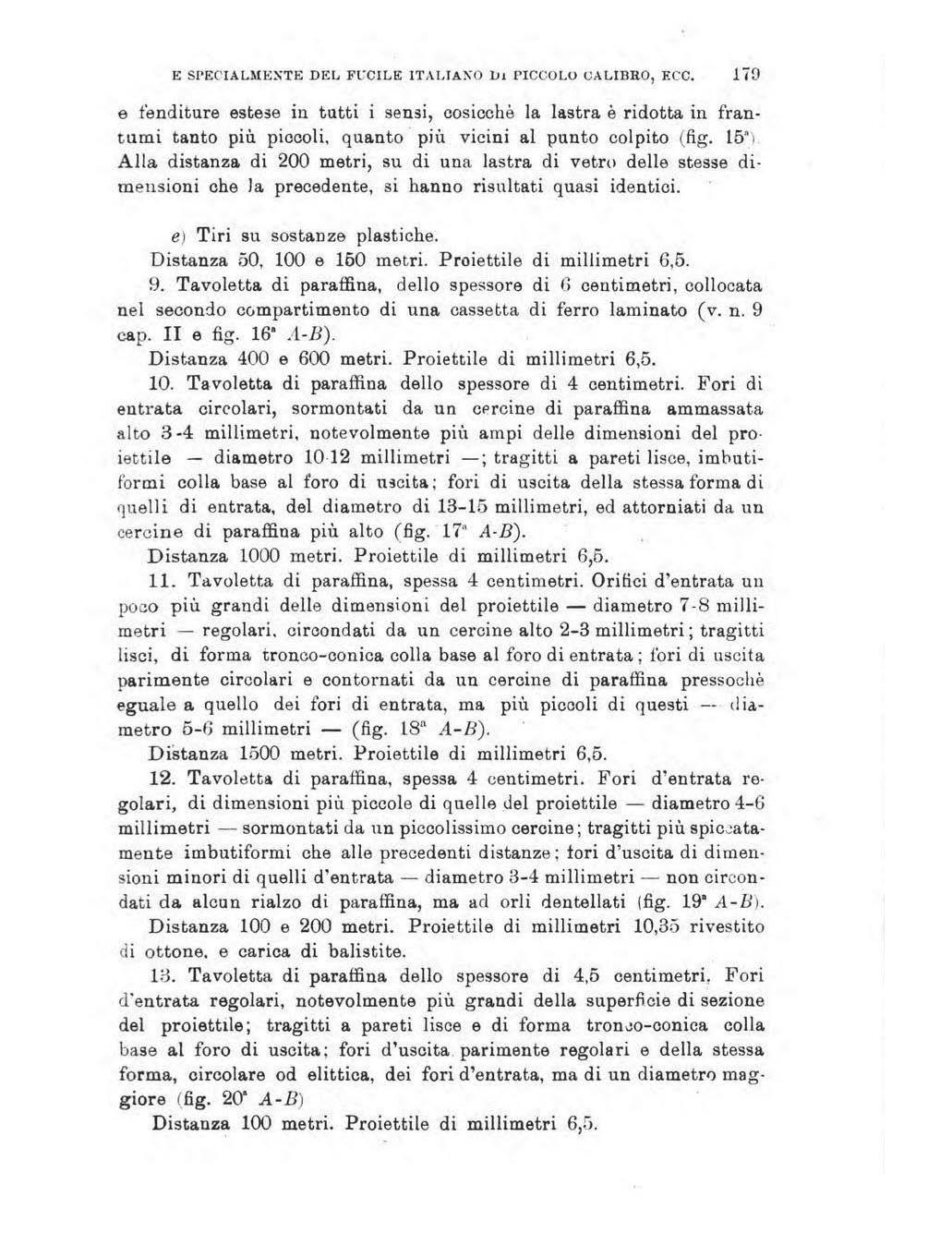
Distanza 400 e 600 metri. Proiettile di millimetri 6,5.
10. Tavoletta di paraffina dello spessore di 4 centimetri. Fori di entrata circolari, sormontati da un CPrc ine di paraffina ammassata alto 3 -4 millimetri, not evolmente più ampi d elle del proiettile - diametro 10-12 millimetr i -;trag itti a pareti lisce, imbutiformi colla base al foro di tu cita ; fori di uscita d ella stessa forma di que lli di entrata., del d iametro di 13- 15 millimetri, ed attorniati da. un cer c in e di paraffina più alto ( fig. 17' A-B).
Distanza 1000 metri. Proiett ile di millimetri 6 ,5.
11. Tavoletta di paraffina, spessa 4 centimetri. Oritici d'entrata un poco più grandi d elle dimensioni del proiettile - diametro 7- 8 millime tri - regolari. c ircondati da un cercine alto 2-3 millimetri; tragitti lisci, di forma t r onco-conica colla base al foro di entrata; fori di uscita parimente circolari e contornati da un cercine di paraffina press o ch è eguale a quello d e i fori di e ntrata, ma. più piccoli di questi d ia.me t ro 5-6 millimetri - (fig. 18" A-B) .
Distanza 1600 metri. Proiettile di millimet r i 6 ,5.
12. Tavoldtta di paraffina, spessa 4 centimetri. Fori d'entrata re· gola.ri, di dim ensioni più piccole di qu elle del proiettile - diametro 4-G millimetri - sormontati d a nn piccolissimo cercine; tragitti più me nte imbutiformi che alle precedenti distanze; tori d'uscita di dimeu· s ioni minori di q uelli d'entrata - diametro 3-4 millimetri - non circonda t i da. alcun rialzo di pa raffina, ma a d orli dentellati {fig. 19' A-H ).
Distan za 100 e 200 metri. Proie t tile di millimetri 10,35 rives tit o d i ottone. e carica di balistite.
Tavoletta di paraffina dello spessore di 4 ,5 centime tri, F o ri d ' entrata regolari, notevo l mente più grandi della superficie di sezione del proietti le; tragitti a pareti lisce e di forma tron0o - conica colla bas e a. l foro di uscita; fori d'uscita parimente regolari e della stessa fo r ma, circolare od elittica, dei fori d'entrata, ma di un diame t ri) maggiore ( fig 20' A-B)
Distanza 100 metri. Proiettile di millimetri 6,5.
E S I'EC' IALM.,;XTE DEL Fl:CILE lTAI.lA:\0 1.11 PICCO LO UALIBit O, E CC. l j!)
1:1. Tavoletta di sapone dello spessore di -± centimetri Fori d' entrata circolari, di dimensioni molto maggiori della. superficie di se· traversate del proiettile - diametro 16-18 millimetri- a con· torni sormontati da un cercine alto 6-7 millimetri; tragitti di forma tronco·conica colla base al foro d'uscita, ed a pareti lisce; fori d'us cita della stessa forma , ma più grandi di quelli d'entrata - diametro 20-25 millimetri - e con tornati da un cercine più alto 8 a 10 millimetri(fig . 21" A-BJ
Distanza 100 e 200 metri . Proie ttile di . millimetri 6,5, e proi et· tile di millimetri 10,35 rivestito di otto ne, e . carica di balistit e.
15. Tavoletta di sapone, spessa 3 centimetri Fori di entrata regolari, di forma circolare, di dimensioni notAvolmente maggiori della superficie di sezione trasversale del proiettile, e sormontati da un cer· cine -più o meno alto di sapone ammassato; tragitti a pare t i lisce, e di forma tronco-conica colla base al foro di uscir.a; fori di us c i ta più larghi di quelli di entrata, ma parimeute regolari e della stessa forma. Le dimensioni dei fori sono sempre relativamente più grandi aila distanza di 100 metri, che a quella di 200, e nei tiri col proiet· tile di millimetri 10,35 (fi g. 22' A-B )
/') Tiri su cassette metalliche {cassette di latta. delle dimensioni di centimetri 35 '>( 23 X 23, e con pareti d ello spessore di l millimetro ) vuote e ripiene d'acq ua o di sostanze umide.
Distanza 50 metri. Proiettile di millimetri 10,35 di piombo co m· presso, e carica di polvere nera.
16. Cassetta. vuota.. Fori d'entrata e d'us cita piccoli, eguali o poco mag g iori delle dimensioni dol proiettile; estesa fenditura prodotta da un colpo tangenziale; nessun ' alte razione nella forma della cassetta.

Cassetta di segatura di legno umida. Foro d'entrata circolare con margini rovesciati indentro e del diametro poco magg iore di quello del proiettile; apertura di uscita rappresentata da una larga irregolare con grossi lembi estrotlessi; rigonfiamento delle pareti e sconnessione delle saldature della parete a. cui corrisponde l'apertura d'uscita.
Cassetta ripiena d ' acqua. Foro d'entrata. regolare, di dimensioni poco maggiori di q nelle del proiettile; apertura. d'usci t a rappresentata. da un 'estesa lacerazione con perdita d i sostanza e con margini frasta.gl iati ed estroflessi; deformazione e rigonfiamento della cassetta in tutti i sensi oon distacco d elle saldature e larghi crepacci. specie nelle commessure della parete a eu i corrisponde l'apertura d ' uscita (fig. 23' A-B-C)
Distanza 100 metri. Proiettile di millimetri 10,35 di piombo compres so, e carica. di polvere nera.
180 SU LL' AZIOX!!:
DEGU A'l'TUA LI FGCILI DA GUJ!:IiRA
17. Cassetta vuota. Fori d' entrata e d'uscita poco più grandi delle d imen s ioni del proiett ile ; qut'-lche lacerazione prodo t ta. d a col p i tange nziali ; n ess u na alterazione di forma nella casset t a.

C a ssetta ripiena di segatura di legno bagnata. F o r o d 'entrata di fo rma c irco lare, d e l dia metro di 11 millimetri e con marg ini entrofies.;; i ; foro d'u sci t a r ap presen t a to da una larga apertura irregola r e con le mhi est ro fl essi; defo rma zione e rig on fi ame n to d ella cassetta co n m o lc re pacci e lace ra:r. io ni a lembi r ovesc iati in fu o ri, a lcun e d e lle qu.1li l;we razioni , pe r sco nness ione e dissal d a t ura. d e lle paret i.
C asset ta piena d'acq ua. Foro d ' entrata circo lare con orlo entroflesso, del di a metro d i 11 millime tri : ap ertura di u scita r a ppre sentata da una a mpia. lace razi on e verticale con perdita di sostanza e grossi le mbi s olle vati e ro vescia ti in fuori; de formazione e g o nfiamento d ella cas· setta i n tutti i esteso crepaccio p er dissaldamento della parete io c ui tr OV&!ii l'apertura d ' usc ita, dal la t o corrispon d ente del fo ndo ( fi g. 24" A B -C1. . \
D istanza 200 m e tri. Proiettile di millimetri riv es t ito di ottone. e cari ca di balisti te
t8 . Ca ssetta vuota.. Foro d'entrata r otondo co n co nt orno en t rofl esso e dentellato, di dimensioni poco magg iori di qu e lle del J.lro iet tile ; foro d'usci t a alquanto più piccolo. pari mente r o t o ndo, ma con cl e ntellature p iù pronunziate nell'o rlo estrofles:;o: ness una a lterazione d i form a ne lla c a.ssetta.
C11ssetta piena di segat ura di legno umi d a. F oro d' e n t rata eg uale per f o rma e dimen s ioni a quello della casset1.a vuo ta; a pe r t ura d'uscita. costi t uita. da un crepa!lc io VArtical e di centimetri 5 X 19 ; rigonfiamento d elle pareti laterali d ella cassetta.
Cassetta ripiena. d'acqua. Foro d'entrata come qu e llo d elle d ue cassette precedent i ; f oro d ' uscita. rapprese ntat o da una lace razione verti c!lle s enza perdita di sostanza., d elle dimensioni di centimet ri 10 x 27, i nt e r secata d a u n'altra, orizzontale, più pi ccola; cass etta molto defor· mata e gonfia in tutti i sensi; sconnessioni dell e pareti, con larghi cre pa c ci ( fi g . 25" 11-B- C).
Distann 100 metri. Proiettile di millimetri 6,5.
19 . Cassetta· vuota. Fori d'entrata e d ' uscita circolari, d el diametro el i G millimetri; fori d'entrata a contorni netti, quelli d ' uscita. a. con· to r ni e stroflessi e legg ermente dentellati; lacerazioni irregolari con margini frastagliati, per colpi di rimbalzo.
Cassetta ripiena di segatura di l egno imbe Yuta d'acqua. Foro di. en t rata circolare ed a contorno leggermente depresso, di diametro eguale a. quello d el proiet tile; foro d'usoitd. irregola re (fig. 26• B),
1': Jo'UU H ,l!: ITALIANO DI PI C CO LO C ALIBR O, E C(' J 8 l
del diametro di 2 centimetr i, contornato da. piccoli lembi estrofle:>si e da due fenditure lineari; c assetta deformata per gonfiamento delle pareti e sco nnessione delle saldature, con molteplic i crepacci più o meno estesi ed irregolari.
Cassetta rie mpita d'acqua. For o d'entrata di fo rma e dimensioni eg uali a quelle del proietti le; foro d'uscita irregolare, col massimo di a metr o di 30 millimetri, e contorna to da piccoli l embi rovesciati in fuo ri ; cassetta. d eformata, rigonfia in tutti i sensi; estesa lacerazione in una delle pareti , con perdita di sostanza e g r o:>s i lembi accartoccia ti; altre lacerazioni più limitate (fig. 26• A-lJ C).
Distanza 200 metri. Proiett i le di millime t ri 6,5.
20. Cassetta vuota. Foro d'entrata ci r co lare, a contorn o leggermente dente llato e d ep resso, del diametro di 6 millimetri; fo r o d'uscita p arimente c ircolare e dello s tesso diametro, a con torno estrofl esso e f rastagliato ; bcer aizoni diverse, prodotte da colpi di rimbalzo o tangenziali ·
Cassetta ripi ena di segatura di legno imbevu ta d'acq u a. Foro el i entr ata rotondo, del diametro di 6 millimetri; for o d'uscita rapp r ese ntato da un crepacc io a margini frast ag liati ed accartocc ia ti; rigonfia· mento della caisetta, co n sconnessio ne della saldatura f ra la pare te in cu i e il t'oro d' u scita ed il co perchio.
Ca.:;setta ri l) mpita d'acqua. Foro di eutrata della stessa fo rm a mct r o di I)Uello della vuota; fo ro d'uscita rapp resentato da. un c repaccio co n perdita di sostanza e con lembi estroflessi , largo circa 20 mil lim etri e lungo 45; cassetta defo rma ta e gonfia in tutti i sensi; delle pareti con fenditure, una delle quali e,;tesa a tutta l'altezza cassetta (fig 2 7" A- B - Cl.
Distan za 600 metri. Proiettile di millimetri 6,5.
2 1. vuota. Foro d ' e ntra ta. circolar e, ad orl o netto leggermente depr esso, e del d iametr o eg uale al diametro trasverso de l p r oiet· ttle; foro di della stessa forma. e di mensio ni, a contorno e rovesciato infu ori: no tasi un 'aper tura. irregolare a piccoli lembi estrofl essi, per un colpo obliquo.
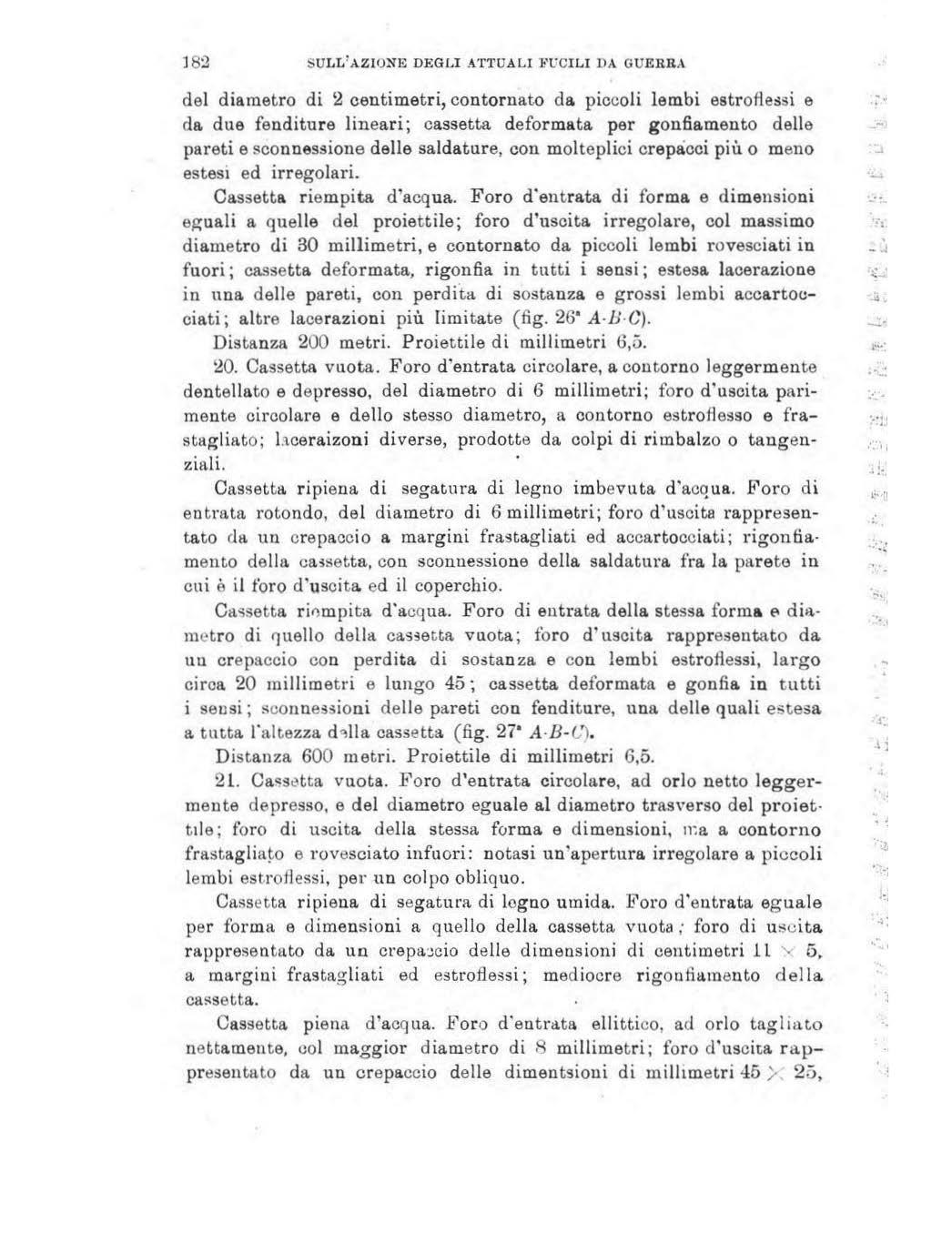
Cassett a ripiena di segat ura di le gno umida. Foro d'entrata eg uale per forma e d imensi oni a q u e llo della cassetta vuota; foro di u sl:i ta. rappr ese ntato da un d e lle dimensioni di cent imetri l l " 5, a margini frastagliati ed est ro fless i; med ioc r e r igonfi am ento della
Cassetta piena d'acqua. Foro d'eatrll.ta ellittico . ad o rlo tagliato nettamen te, co l maggior diam e tro di 8 millime t ri ; fo r o d ' us cita r appresenta to da un cre paccio d elle dimentsioni di mi lhmet ri 45 > 25,
182 SULL'AZIONE DEGLI \.'l'TO A LI }TCILI DA GUERRA
-.. ··· :· :.1 _,, 1•·"J ·, .. . '
con grossi lembi accartocciati; mediocre gonfiamen t o della c..1.ssetta ; sconnessione della saldatura n e ll'angolo più vicino al foro d'entrata con una larga fenditura molto irregolare, accompagnata da pe rdita d i sostanza. Notasi un altro fi>ro p er colpo di rimbalzo, di fo rma irregolar· mente ellittica, col maggior dimeatro di millimetri (fig. 28 ' A.· B · C) .
Distanza 1000 me tri. Proiettile di millimetri G,5. Cassetta vuota . Foro d ' entrata ellittico, co n orlo leggermente frastagliato ed entrotlesso, del diametro massimo di 9 millime tri ; foro d ' us cita circolare, a co ntorno leggermente d e nte lla t o, del diametro d i 6 millimetri.

C assetta pie na di s egatura di l egno irp b evu t a d'acqua Foro d ' entrata e llittico, col maggio r diametro di 8 millimetri, a contorno l egg erm eme dente llato; foro d ' u s cita costituito da un a pi ccola fenditura con p e rdita di sostanza, Jelle dimens ioni di millimet ri 15 >: 7; gonti a.m e oto appena accenna t o della parete iu c ui tro vil.s i il foro d 'uscita e d i una. d e ll e pareti c h e fanno angolo con ei:lsa..
Cass.,tta riempita. d'acqua. Foro d' entrata circola re, depresso, c incisch ia to , d e l diametro di 6 millimetri; foro d ' uscita irregolarmen te d el diametro di millimetri 20; a co nto rn o frastagliato ed estro tl esso e seguito da una p iccola fendi t ura con m a rgini parimen t.e estroi !essi; liev e rigonfiamento d e lle paret i. No ta ns i, come n e lla ca ssetta precedente , a ltre perforazion i p er colpi successivi ( fig. A-B· C').
g) Tiri :m cass ett e metalliche ri empite di pezzet t i di marm o o di ciot t o li.
Distanza. lOù met ri. Proiettil e di millimetri 10, 3ò, ri vesti t o d'otton e , e c ari ca. di balis tit e
A. Cas:>ett 'l. rip iena di pe zzet t i d i marmo arro t ondati; B. Cas· setta ripi e na di picco li c iotto li. F o ri d ' en t ra t a circolari od ellitt ic i a conto rn i e ntr otit!ssi , di dimens ioni pressocb è egua li a q uelle d el pro iettile; b o zze piil o m en o pronunziate, prod o t-te d all' u rto dei c io ttoli o de i pezzett i di marmo co nt ro l e pare ti d e lle casset t e ; leggero gonfia · mento delle cassette ; perfo razioni irreg olari c lace ra.zi oni , cagionat e , pa r t e da frantumi di pro iett ili , pa r te da schegge di ciottoli e di pezzi di marmo, distaccate e d islocate. I proiettili arrestatisi nelle casse tte, sono tut t i eno rm e me nt e altera t i p er distac co del nu c leo dal ri ves t i me nto e ri d uzione in f rantumi dell'uno e dell'al t ro ( fig . 30' A -JJ ).
Dis tanza 100 metri. Proiet tile cl i millimet ri 6 ,5.
2-l. A. Cassetta riempi t a. di pezzet t i di marmo arro t on d ati. B . Cas· setta ripiena. di ciottoli. Fori d 'entrata per l o più circolari , di dimens io n i pressochè egua li a q uelle del pro iettile, e d a co ntorni netti , l egger-
E DEL b' l'C li, E lH l'lCCO L O C ,\ ECC 188
mente nessun gonfiamen to delle ca ssette; bozze appena accennate nPlle pareti; perforazioni irregolari e lacerazioni. speci e nella pareto oppo:;ta a quella ove sono i fori d'entrata, e prodotte, parte da fra ntumi di proiettile. pa r to da schegge di marmo o di ciottoli. N ot asi che tali perforazioni e lacerazioui molto più limitate di quelle ù e lle analogbe cassette della. figura p recedente; wa 1 proiettili arrestatisi nelle casse tte, sono parime nte alterati per scoppio e riduzione in una massa informe e d in frantumi (fig. 3 1• A-B e fig. 2•. 11. li e 13).
JI. CoNSIO RRAZ IO:Sf OlliCA GLI EFFETTI DEI PROIETTILI :'U llgRSAGf.I VART.
Per come lE' diverse parti del co rpo uman o reagiscono all"azion e dei p r oiettili. od, in altri termini, in qual m odo razione dei p roiett i li si modifica la strntt.ura ed i c11ratt.eri fisic i dei dive rs i tessuti dell'organismo vivente, n on sarebbe r o bastate le prove spe ri me nta li limi tate ai so li oadaven ed agli animali vivi. L .a disposi zione a n atomica delle parti; l'intim a oonnessionA che esse h anno fra loro; la contemporaue a o ff'esa d i tessut i ed or gani forniti di caratteri fi sici dissimili, ed altre circostanze, avrebbero r eso siffatto studi o. o ltrechè m a lagevole, in completo.
Egli è perciò , che qt<asi tutti color o i quali si sono occu pati de ll'importante questione, hann o istituito una ser ie più o meno estesa di espe ri enze su bersagli inanimati, aventi, in modo tipico, i caratte ri fisici delle \'ari e par ti dell'organis mo v i\·o, per poter voi r iferire a queste i risultati delle pro,·e sperime ntali.
I o non ho la pretesa di aver tr ovato nulla di nuovo in un campo già esplorato. Jutesi. come ho a cce nnato i nnan zi, d i fart' uno stud io di confronto fra gli etf'etti dei fucili di me d io e piccolo calib ro l'esercito italiano: e di Ye d e rt=> ,;e il fucile italiano di picJ0Io cali br o s piega sui bersagli di,·ersi, n n' azione E>g uale a quella dei fuci li delll\ specie in uso negli alt ri ese r citi. Ed è sotto questo doppio punto di vistu., che mi propongo di fare una bre,·e disamina dei vari gruppi di esperimenti.
Be,-sagli elastici - Dall e esperienze del Buscll col proiett ile Chas sepot, del calibro di 11 millimetri, n on ri,·estito, e da q ue lle del Birc.:he r col proiettile Vetterli svizzero di millimetri 10,40, s u lamine di caucciù, risultò, co m· è noto, che colla velocità r esi dua di circa 400 metri si producono perforazioni ci r colari od e llittiche, secondo l'inc id enza od obliqua del proic> ttile7 e r on nn orl o nerastro, conc entrico col foro Le perforazioni misu raY a no app en a '/ , della sezion e t ras,·ersale della p:-tllottola.

· .
L e esperi e nz e s ucc es:>i ve coi proiettili di piccolo c r.libro, fatte dallo ste3sO Birche r , dal Kocher e da al t ri, hanno provato c he questi proiettili producono sui be rs ag li elast ici, d ei forami netti, puntifo rm i, ma che . insieme alla zona. n e r astra onde son o ci r condati. r aggiungono. a u n di presso, le di111ensioni d ella s ezione trasver5ale del pr oiettile.
N e i miei esper imenti s u lle lamine d i c a ucciù, col proiettile di millime tri 10,35 del fucile V etter li i tal iano, alle distanze da 50 a :300 me t ri. si ebbe r o, come ho già esposto, fori del diametr o di 3 a 4 mi ll imetri, a co n to rni n e tti, e ci r co nda t i (fo ri di e ntrata) da un a zona s c u ra di circa 5 millimetr i di r ag gio a par!ùe dal centro del f or o ( fig. 8 ') ; e nei tir i col proie t t il e di. millimet ri 6 ,5 d e l fucile mod. 189L, alte distanze di 600 a 2000 m et ri s i o tte nn e ro pari mente forami r e· go lari, d e l diametr o di 2 a 3 millimetri, e co n una zona nerastra. larga circ a m illim et ri (fig. 9•). Le perforazioni più piccole, quasi pun t ifo rmi , ebbero alle maggiori dista n ze.
Adunque, l e prove sperimentali eseguite co i fu cili dell'esercito italiano. bann o pienamente confermati i risultati dell e esperienze fatte altrove con al tre simili armi, e cioè, ch e sui bersagli le per(o· m:: ion i sono notevolmente min01·i delle della l1·ascPnale cl el p1·oieltile, e la diffe renza è in r ngione di eln· stic ità dell'oggello col pilo ecl anche della d isl(ln:;a del tiro.

Il proiettile, in siffa tte c ircostanz e, per lo più, esercita , come di ce Koc her . un'azione di ctmeo, per la q ual e le molecole de ll'ogget.to sono re"'pi n te la.teralmentt:l ed ammassate. non asportate; e p oi, in ragione di elasticità dell'ogg c3 tto stesso, riacquistano più o meno co m · p letamente la loro posizione primitiva.
Q ue.;to m eccan ismo di pro duzi o ne delle perforazioni nei corpi el a · stic i, e dall'areola b runas tra che oirconda i fori d'entrata, e ch e segna, precisamente, l'estensio n e dei punti di c ontatto del proiettile col
L':' perfvrazioni con pe r dita di sost.a.u;,a si uei uorpi e la3Lici, quando i l diame t ro trasv e r .iale del proiet&ild e co nsiderevole, op· coi proiettil i di piccolo calibro, quando la velocità è molto elevata. cos icohe il proiettile asporta nette le molecole che inco ntra.. Ci ò p t ò rla r ragione d e lla diminuzione delle dim e nsioni diametrali dei for i 1;o l dell e d istanze.
He1·sagli clu1 i e f 1·agili. - Gli esperimenti del Bircher sulle tavo le di a bete e di querc ia hanno provato che, se il proietti le è animato da mol t a forza viva, produce perdita di sos tanza. netta: l'azione si l imita alle sole molecole direttamente toccate; e ne ri sultano tragi tti r e golari. a. pa r e ti lisce, e di dimensioni pressoche eg uali a qu e lle della pa l io t:.ola.
E SJ>EOIA L MENTE DIU, ITALI A :s'O DI P I CC'OLO C A LfllR0 1 E CU. J8[>
Questi caratteri sono tipici , allorchè si tira con proiettili d'acciaio o rivestiti d'acciaio. Coi proiettili di piombo, i tragitti regolari, lisci, nettamente intagliati, si hanno, secondo Bircher, solo quando la resistenza ohe oppone il ber3aglio, è molto debole; e perciò nel legnoque rcia, molto duro e resistente, i tragitti risultarono, per lo più, im· butiformi , con pareti cincischiate e con fori d'entrata e d'uscita contornati da scheggiamenti, e molte volte rappresentati da e proprie fenditure. Anche nell'a bete secco il proiettile Vetterli svizzero, specie se an imato da forza vi va poco elevata, produsse canali conici, con pareti irregolari e frastagli ate.
I proiettili a mantello e di piccolo calibro, in ragione delle loro qualità fisiche e dinamiche, determinano nel bersaglio alterazioni più regolari e più nette. Ciò è emerso dalle ricer che dello stesso Bircher e di altri sperimentatori.
Non dissimili furono i nsultati delle prove, abbas tanza numerose, da me fatte a diverse distanze e coi proiettili dei fucili dell'esercito italiano.
Infatti, n ei tiri col proiettile di millime tri 10,35, di piombo compresso, alle brevi distanze (200-300 metri) si ebbero,. nelle tavole di guercia, forami d'entrata circolari od ellitti ci, eguali o poco più piccoli delle dimensioni della sezione trasversale del proiettile; .ma i tr a :
gitti erano imbutiformi, ed a pareti fras taglia te, specie ve rso l'apertura di us cita, la quale si presentava sfrangiata e co ntornata da scheggiament.i, e era cost ituita da. una fenditur11 irregolare ( fig.12·).
Colla stessa pallottola rivestita ùi ottone ed animata di maggiore forza. viva, si produssero u e l legno-faggio seczo, tragitti pitl regolari, con aperture di u scita a contomi meno sfrangiati, e non a.0 compagnate da scheggiamenti molto estesi (fig . 11").

Col pro iettile d el fucile di millimet ri 6,5. tnttochè siasi tirato a. d istanze molto più grandi (da GOO a 2000 metri), s i ebbe ro n e lleguoquercia fori d'entrata a contorni netti; canali cilind ri c i o legge rmente tron co-con ici, con paret i rdgolari , un po' hastagli 11.te ve r8o l'orific io d'uscita; aperture di us c ita eguali a quelle d 'en t rata o poco maggiori e parimente r egolari , ma a contorni più o meno ci ncischiati e talora con schegge: l e d imensioni dei for i e dei t ragitti, sempre più p iccole di quelle de lla sezione tra5versa.le del proiettile, in ragione delle d istanze; e, pure io ragione delle d is tknze, più pronu nzia ti e pi ù este:;i i f ra stagliam e ut i e gli s:::heg g iame nti dei contorni (fig. 13 ') .
I tiri sull'abete secco, fatti collo stesso proiettile, produssero t ragitti ed orifi ci d 'entrata e d'uscita più regolllri e più n etti, eò a reti e contorn i meno f ras ta gliati l fig . 14' ).
186 StiLL.'AZlO::-ìE DEGJ, I ATTUALI DA G UERRA
Le esperienze di tiro sui vetri e segnatam ente quelle n um e rose eseguite dal Kooher, hanno mostrato che, alle brevi ed alle grandi distanze, i proiettili moderni producono nelle lastre di vetro fE>nditure e frantumamenti più o meno estesi; ma, alle medie distanze, vi possono det erminare fori semplic i o con poc he e limitate fessure.
N e lle prove da m e eseguite a 100 ed a 200 metri col proiet tile di millia.tetri 6 ,5, si ebbe sempre la. completa riduzione in della lastra di vetro (fig. lo•), e con frantumi tanto più grossi, quant o più lontani dal punto colpito.
Infine, dai tiri contro le lastre di fe r ro e di piombo è risultato c he, alle. brevi distanze, da 50 a lòO metr i, le perforazioni dei be r s ag li metallici sono di forma regolarmente circolare od ellittica, ma s e mpre a contorni tanto più frastagliati, quanto maggiore è la resistenza del l>e t·· sagl io e quanto minore è la forza. viva r e-sidua della pallottola. Le dimensioni diame trali dei fori sono poi considere volmente ruggiori di quelle della sezione trasversale de l proie tti!<!, e tanto maggiori, quanto più è deformabile i l proiettile e, soprattutto, quanto meno res i s t e n t e e il metallo e mino r e è la distanza del ti r o.
Da tutto qu es tv gruppo di esper imenti de riva il seguer:te corollario: le cagio w 1le cla i p 1·oi--llili d elle m ·m i por·lalili (la gtfe1 ·r 11. , ne i cm ·pi d w·i. sono tanto più nelt.e, 1ey olm ·i e C' ù·coscr·itle ,1uanl o m agg i01 e è l a {or ; a v i va e m ilWI' e l a def OI maùil i là l el JJ1'0i ell il 3 e rw o n lo p i n è d ebole l a 1es i sten ::a d el ber sag lio : nei corpi Mollo gi li, l e a lte,·a;;io tti pi ù r egola1·i e più l imila le t.:OI 'risp o•1do n o ad t tn a {01 ·:: a v i va di m t.dia i nte n sità.
Soslo n ze pla st i che. - Prima di fare qualc he cons iderazione in t orno ai ri s ultati d e lle mie espe rienze di tiro nelle sostanz e plasti che, reput o no n inu t ile uu breve cenno sul meccanismo d·azione dei mod e rni proie ttili nei bers agli in genere; e ciò far ò s e nza entrare nelle varie ed a.qtrus e teorie degli autori, ma es ponendo sempliceme nte il c oncett o che io mi son formato della
Il proiettile agisce sul bersaglio sia n e lla direzione del su o m o vime nto, sia in direzione obliqua o perpe ndi colare a quella d el movimento.
primo caso esplica, come dice il Kocher, un'azione di pen el1·a :; i one, e penetra realmente nell'oggetto, se la forza viva che a c1uosto trasmette, supe r a la coesione degli elementi mo lecolari: nel secondo caso spiega un'azione lateral e, agisce, cioè, anche sugli elementi più o meno lontaui dal punto colpito. Le due azioni, osserva il Kocher, sono fra lo ro in rapporto inverso: quel che facilita la penetra.zione, non favori s ce razione l,tera.le, e vic everila. Così, il volume del proiettile, l' allarg amento dell a sua s ezione trasversale, le deformazioni, deprimono l'azion& d i pe netrazione ed es altano l'azione laterale.

E SI'ECJ II, MENTE DEL FOCILE ITALIANO DI PICCOLO 0ALIDR01 ECC.
Ciò è esatto, ma ha d'uopo di qualche diluc idazione.
I p•·oiettili attua li hanno, com'è noto, una forma cilindrica allungata con punta. og i vale, e sono animati da un movimento di propul· sione in avanti e da un movimento di r otazione att.orno al loro grande as :>e. P e r la q ual cosa. allorchè il proiettile incon t ra un piano resistente, imprime ad es so, per effetto del suo movimentù di pro pulsione, un urto a guisa di un co lpo di marte llo (Nimier) , e se vince la coes ione movi p€>netra per l'azio ne associata di martell o, di cu n eo, a causa della sua forma, e di ll ·a p a n o, a causa d e l suo movimento di totazione. Si c o mpre nde come il contributo di t)Uesto triplice meccanismo n e lla produzione dell'eff etto vulnerante, deb ba variare. secondo m oltepli ci circostanze, attinenti sia alle qualità. fisico-dinamiche d el proiettile, s ia ai caratteri fisici, e quindi al grado di r esistenza, del ber:>a.glio.
Intanto, il movimento di r otazione è quello che, a mio avviso, vi contnbuisce meno, per il fatto - già posto in rilievo da v. Colar e Sch.i erning, Habart ed altri - che, data la grande velocità. con cui il pro ietti l e attraversa il bersaglio, vi compie tr0ppo pochi giri nel bre· vissimo t e mpo che con esso sta in contatto, per poter esercitare una grande sull'effetto vulneran t e. Ad ogni modo, n on si può disconoscere l'azione disgregante che un corpo in forte rotazione es plica sulle mol ecole colle quali è in contatto, imprimendo a qnes t e un mo· vimento elicoidale.
Ora, se per poco si analizzano questi meccanismi, si v ede che il proiet til e n o n spiega la sua azione soltanto sulle moleco le che incontra lungo il s u o asse di percussione, ossia n e lla direzion e del s uo mo vim ento d i pro pulsione, ma anc he lateralmente, cioè in direzione angolare a q uella d e l movimento di propulsione.

Ne l me ccanismo p er colp o di rnar·tello le molecole prima urta te t ras mt» t.to no l'ur t o a quelle sottogiacenti. e così d i 11eguito, sino alle moleco le es t re me. Ma ciascuna molecola urtata reagis ce alla sua volta, per contraccolpo; cosicchè si dete rmina non una sola onda di movimento, una serie di vibrazioni molecolari secondo la dir ezione del colpo. Però, p er il fatto stesso della coesione molecola re, l ' urto · si trasmette au c he alle molecole vicine e tanto più, quanto maggiore è la res i3tenzn. dell'ogg etto alla penetrazione e quanto minore è l'attitudine del proiet· tile a p en e trare. Si stabilisce, quindi, an c he un'onda laterale, seguita, al pari dell'onda dire tta, da on.de secondarie nello stesso senso.
I m ov imenti combinati di cu neo e di /1·apano facilitan o bensì l ' azione di p en etrazione , ma concorr ono più specialmente a determinare l'azione la te ral e ; giacc h è l'un mo vimento si so prattuttc respingendo
18)) S t:LI /,\ZIONE DEG LI ATTUALl FUC ILI DA Ot:ERRA
l11.teralmente le molecole, e l'altro cercando d i superare la resistenza dell'oggetto alla torsione, mediante Io sfregamento che il proiettile in rotazione esercita sulle pareti del tragitto.
Da questa breve analisi del meccanismo col quale il proiettile in moto agisce sul bersaglio, si pu ò intendere, senza bisogno di scendere a più minuti particolari, l'influenza che esercitano sull'in te nsitù. ed estensione delle alterazioni, la natura, la. forma, le dimensioni , i caratteri fi sici del proiettile e d ell'oggetto colpito.
Bas terà fare una sola considerazione. Il meccanismo dell'azione e della reazione reciproca. del proiettile e d el bers glio, si riass um on o, co me ben e oi!servano il Nimier ed il La.val ( l ), in una. trai!m issione di forza: tutto ciò che mod ifica. questa trasmissione di forza, modifica necessariamente anche gli effetti prodotti. Dati due proiettili ohe possiedano la stessa forza viva nel momento in cui colpiscono il b ersaglio, poichè, com'è noto, la forza. vi va è rappres e ntata dalla formola: i due proiettili possono essere animati da. differenti velocità. ed avere differenti masse, s econdo le formole equivalenti:
l F - m '/ v· - 2 / ed
Ora. gli e tfetti sul bersaglio poi!sono essere diversi, secondo la durata e la superfic ie di contatto dell'uno e dell'altro proiettile coll'oggetto (;Olpito ; ed è facile intendere come la durata del contatto dipenda. prin · cipalmente dalla velocità del proiettile e dalla resisten:r.a che alla sua progressione oppone il bersaglio: il mezzo più resistente fa maggiore ostacolo alla corsa del proiettile e prolunga cosi. la durata del c ontatto. Parimente, la superficie di conta.tto più rende più diffi cile al proie ttile di attraversare l'oggetto; la qual cosa favoris ce la trasmissione della forza viva. all'oggetto stesso, Rino al punto che il proiettile piu ,·o lumino3o può esaurire tutta la sua forza viva ed arresta.rsi nel bersaglio, e l'altro abbandonarvene solo una parte e contiuua.re la corsa con quella, onde ancora. resta animato. Questa è la condizione più fre · quante degli attuali proiettili di piccolo calibro dotati di una velocità. assai elevata, po::o deformabili, ed abbastanza stabili nella loro traiet· toria; e ciò spiega anche come la. maggiore velocità. non basti a com· pensare il minor calibro e la più costante integrità. di tali proiettili.

E SPE( ' IAI.llENTE DF.L FCOII.E IT \LIAN O DJ PICCO LO C AI.IDR O, ECO 18 !)
Il Il :-iiWIER c E l. I.AI' AI - l.u ruojectilu dts armts t:U gutl'rt. l.eur acli v 11 o"'""'·nnle l'ans 1899.
È però evidente che il proiettile, il quale, o per '\a maggiore resiche incontra, o per la maggiore massa, o per l'allargamento della sua superficie di contatto battendo obliquamente o di tra.ver,o, o per il maggior volume acquistato deformandosi, prolunga la sua permanenza in contatto col bersaglio, esplica una azione laterale pre,·a· lente su quella di penetrazione.
Da ciò apparisce che le due azioni sono in un certo antagonismo fra loro: entrambe der i vano dalla forza vi va. da cui il proiettile è animato, ma talune circostanze che favoriscono l'una, sono sfavorevoli all' altra. l
p1·oiettili di piccolo calibro, o pa1 ità delle altre <:ondiàoni, spie!Jano u n 'azione laterale più limitata e meno intensa
Allorchè la pallottola penetra con prevalente azione di martello, ossia -staccando e ricacciando davanti a sè le molecole che incontra, produce una pE'rforazione cqn perdita di sostanza., ossia a stampo od a canale, se· condo lo spessore delroggetto. Qu11ndo, invece, prevale razione di cuneo. le molecole sono, per la più parte, respinte ed ammassate lateralmente, e la perdita di sostanza è poca o nulla, e le perforazioni sono più pic-cole. Nei bersagli elastici, come ho già. accennato, - p. es. nella cute ed in altre parti molli - i proiettili di piccolo calibro, specie se animati da non molta velocità., producono, a preferenza, perforazioni per azione di cuneo; nei corpi duri - p. es. nelle ossa - se la velocità è elevata, determinano, soprattutto, perforazioni a canale.

Se noi consideriamo il piano nel quale il proiettile penetra., come costituito da una serie di circonferenzt> concentriche al punto di penetrazione (Kohler, Nimier), possiamo formarci facilmente un'idea del modo con cui si determina l'azione laterale per effetto del meccanismo di cuneo. Quando il proiettile s'impegna nel bersaglio, esercita una pres sione laterale comparabile a quella che produce su di un anello l'introduzione in esso di un fusto conico il cui diametro trasversale, verso la. base, sia maggiore del diametro dell'anello: il fusto , naturalmente. non può passare se l'anello non si dilata; e se non è dilatabile, se ha un indice di elasticità minimo, si rompe, ed i di frattura formatisi nel primo anello, si riproducono, per lo stesso meccanismo, negli auelli ad esso concentrici, finchè non vien meno la forza viva necessaria.
L 'azione laterale può manifestarsi diversamente, secondo la varia intensità. della forza vi va. del proiettile rispetto a. ll'indice, di coesione molecolare del bersaglio.
Se la forza viva è relativamente scarsa, si hanno nei tessuti molli ed elastici le contusioni e le lacerazioni, e nei tessuti duri, come le ossa., le fenditure.
Quando la forza viva. supera di mol&o la. coesione moleco-
HlO SULI}AZIONE DEGLl ATTUALI
FUCILI DA GUERRA
lare dell'oggetto, l'azione laterale si estrinst'lca col distacco e proiezione in distanza delle molecole, ossia come dice il Kocher, con un movi· menlo rli lancio e con effetti esplosivi. Nei corpi frag ili, come il vetro, le o3sa, ecc .. gli effetti di scoppio si determinano sotto forma. di fratture, di scheggiamenti e di fAnditure; ed a misura della quantità di impresso alle particelle staccate, queste, ag endo come proiettili secondari, co n corro'lo ad a ccrescere ed estendere le lesioni nelle vici nanze. Nei liquidi non occorre una forza viva molto intensa per spostare le molecole della massa fluida, ed, a causa della qu11si inco m· pre3s ibilità di questa, la scossa viene trasmessa immutata, in tutti i sen<>i, all'involucro nel quale il liquido è r acchi uso. Inoltre, per la poca coesione e la grande mobilità delle molecole, la forza viva del proiett ile si scarica. per co3Ì dire, più prontamente n ella massa liquida; e cosi si spiega come nell'auq ua libera il proi ettile di piccolo calibro, anche a. brevissima distanza, si arresti e si defo rmi dopo un tragitto di m. 1 ,50 a 2,ò0. Nei co rpi elastici, infine, la spostabili tà delle molecole e molto gran de, e gli effetti es plosivi sono tanto minori, quanto più elevato è r indice di elasticità d el corpo, ossia quanto più prontamente ed esattamen te le parti s postat e possono riprende re la loro posizione primitiva. Nei g radi pit\ elevati la te r a le s ia sui corpi umidi, s ia s u quelli secchi e f ragili, ha. luogo lo sminuzzament o in tutti i sensi ed il dislocamento dei frantumi ; n ei g radi m ed iocri avviene la. formazione d i un canale imbutifor me colla base al forarne di uscita.
Pre messe queste considerazioni , Yengo alle mie esperienze sulle sostanze plastiche; le quali esperienze furono praticate appunto p er stu· dia re le al terazio ni del b ersagl io, de rivanti dall'azione la terale dei proiettili dei fuciii in u s o n e ll'esercito i t ali.ano.
I tiri vennero eseguiti, oltrechè s ull e lamine di piom bo, di cui ho g ià fatto parola, su tavolette di paraffina e di sapone; sostanze che si prestano assai bene allo sc0po, a v end o il pregio di fissare e ripro durre fe delmente l'effetto del pro iettile.

Sulle ta•olette di paraffina., n e i Liri a 100 ed a 200 metri, e su quelle di sa pone alle stesse distanze, si ebbero. come si è già esposto, col pro iettile di millimetri 10,35 ri vest ito d i ottone, orifici d'entrata regolari e di dimensioni tanto più grandi della sezione trasversale del proiettile, quanto minore era. la distanza del tiro ; ed orifìoi di U.icita pari mente regolari, ma notevolmente più larghi di quelli d'entrata e ci rcondati da un cercine più alto di sostanza ammassata (fig. 20' e 22a) .
Nei tiri col proiettile di millime tri 6,5 sulla. paraffina., alle brevi distan.ze (50, 100, 150 metri), ma dopochè il proiettile ebbe superato una forte resistenza (d!le lastre di ferro, ciascuna dello s pessore di 2 mil-
E S PEC IA f,ME:S'I'E DEL l!' OCJI ,E ITA f.! ANO DI PICCOLO Q ,\ LIB RO, E C'O. 191
limetri), si ottenn er o fori d 'entrata e d'uscita di dimensioni 7 a 9 voltemaggio r i d i qnelle della sezione t rasversale d el proiettile, imbutiformi colla base al foro d'uscita, e circondati, specie i fori d'uscita, da un gros::;o cercine di sostanza amm assata (fig. 16"). Nei tiri a 400 e 600 metr i collo stesso proie ttile, i fori d'entrata presentarono un diametro quasi doppio di quello della sezione trasversale del p ro iettile ; q u elli d i ns..:i t a , pressochè tr iplo, e un cerci ne di paraffina più alto del rialzo c he so rmontava i fo ri d'entrata. A 1000 metri. s i produssero fori d 'entrata e d'uscita egualmente che a 400-600 metr i, ma più stre tt i rel ativamente alle dimensioni del proiettile, con ammasso d i paraffina contornant '3 i f ori , più limi tato, e con tragitti di fo rma tronco ·con ic a, ma colla base non già all'orific io di uscita, b ensì a quello d' entra ta. Infine, a 1500 me tri, si ebbero d'entrata ancora più p iccoli e con rialzo circolare appena accennato; fo ri d'us cita piccolis3imi - de l di amet ro di 3·5 millimetri- co n orli dentellati e n on sormontati da a lcun cercine; tragitti p iù spiccatamente imbutiformi (fig. 17•, 18• e 19').
Eguali risultati di edero i ti ri sulle tavolette di sapone. Infatti, all e distanze di 100 e di 200 metri, le dimensioni d e i fo ri d' entrata e d'uscita e la forma dei tragitti si presentarono d e l tutt o analoghe a. quelle ottenute alle piccole distanze, collo stesso proiett ile di millimetri 6,5, nei tiri sulla paraffina: si ebbero, cioè, fo ri di d imensi on i considerevolmente m aggiori di quelle della sezione tras,·ersale della. pallottola in r agione inversa d ella distanza ; tragitti regolari ma imbutiformi colla base al foro d'uscita, e cercini di sapone ammassato più al t i alla distanza di 100 metri che a quella di 200. Si notò po i, anche più nettamente che n e i tiri sulla paraffina, come i diametri dei fori e dei tragitti e l ' al tezza d egli ammassi di sostanza sorm ontanti l e aperture, fossero relativamente più pronunziati, a p ari tà di d istanza, nei tiri col proiettile di millimetri 10,35 (fig. 21• e 22' ).
Deriva da q ueste prove che gli effetti dell'azione laterale tanto dei proiettili di m ed io calibro (proiettile del Vetterli italiano di millime· tri 10,35) q uanto di quelli di piccolo calibro (proie ttile del fucile italiano di millimetri 6,5) sono assai appariscenti sulle sostanze p lastiche.
Tali effetti si presentano molto rilevanti, quand o il proiettile & ancor a animat o da una f orza v i va e le vata, e s ono sempre in ragi one diretta d ella forza viva stessa, e qui ndi in ragione inversa della di· stanza. D'altra parte, sono pure in ra pporto, a pari tà delle al t re condizioni, colle dimensioni de l pro iettile; cosicchè, il proiettile cl1 medio· cal ib1'0 produce enetti di lat e-ral ità maggim·i di quellv di piccolo ca libro. Ed infine, quando il proiettile si deforma, l ' azione l ate ral e si esplica.

1!)2 DEGLI
A'I'1't:AL1 Ft:ClLl DA GU.ER I<.-1.
co n iutensir...\ ed esten:>ione t11.nto maggiori, quanto minore diventa razioue di penetrazione. e corpi umidi, co,tlenul i in 1·ecipienti a pareti l'iyide.Un cor po inco mpre:;sibile o poco compressibile, co me r acqua od un altro liquido qua\:;iasi, può, per effetto della pression e esercitatavi, an dare incùntro a mod ificazioni di forma., ma n o n di volume; e, secondo il noto princi pio di Pa.scal, se il liquido è co ntenuto in un recip ien te chiuso. la pressione e:!et·citata su di un punto della massa liquida, si trasmette con pari intensità. in tutti i sensi, ed è propo r· zional e all'intensità. della forza premente ed alrestensione della parete a oui si trasmette. G li etl'etti, poi, dipenderanno anche d alla natura e dai earatteri fisici del recipiente.
Applicando questi priucipii cl'id1·ostatica all'azione dei proie ttili sui bersagli cavi, ripi en i di liquido o di sostanze umide, si è cercato di dar ragi one degli e ffetti che essi producono, variabili non solo secondo le gnalità balistico-dinamiche del proiettile, ma altres ì secondo· le diverse condizioni dell'oggetto colpito. Infatti, se si tira con velodi 300-400 metri contro una vesc ica piena d'acqua, si vedrà la vescica scoppiare e racq ua venir fuora con eguale rapidità in tu tte le direzioni. Lo scoppio mancherebbe solo, quando la velocità o, meglio. la forza vi va del proiettile fosse così bassa, da non s uperare l'indi ce di elasticità. e di resistenza delle pareti della vescica.
Se poi s! spara, come hanno fatto Bircher, R eger, K ocher , e n oi abbiamo ripe tuto, contro una cassetta. di latta pie na. d 'acqua e chiusa. da ogni parte, si vedrà. pa.rimente gonfiarsi il r ecipiente e fenders i in Lu tti i sensi, con una certa. prevalenza nel senso dal tragitto che il proiettila percorre. E se an che si lascia. la cassetta parzialmente aperta in qualc he punto, ad es., d ella. parete superiore (come noi abbiamo fatto iu taluni espe rim enti), nn getto di acqua. sarà, bensì, spinto in alto a t traver:;o l'apertura., nell'atto in cui il proiettile penetra. nella liquida, ma il re c ipiente rimarrà egualm e nte lace r ato per effetto della pressione lateral e.
Sui recipi enti riempiti di sostanze umide si osserv eranno gli stess i fenomeni, i quali, però. saranno in ragione della maggiore o minore di liquido oude la sostanza. è imbevuta.
D'altra parte, quanto maggiore è la ve locità, quanto più grandi sono le dimensio ni d e l proiettile, ed, eventualmente, quanto maggiore è la deformazione di questo, tanto più ri levanti saranno gli effetti . . esplosivi.
La t eoria. della pre:;sione idraulica, emessa dal Reger, sebben e a ssai $6ducente, non è accettata. da tutti gli autori per spiegare la differenza

J:: >'PJ<:l!AI.ME:STE DEl. IT \I.I.\:-1 0 DI J>JCCOi h f'A1.1DII0 1 ECC. 1!,J:3
13 -
Gio r na le mtdiCv
degli effetti che il proiettile produce su di un ,·aso vuoto, ovvero riempito di liquido.
Senza vo lere qui espo rre tutte le ragioni c he si adducono contro tale teoria, basterà notare come, mentr e la pressione idraulica si fa sentire con eguale intensità in tutte le direzioni, l'azione del proiet· t ile, in real tà., si pron nnzi soprattutto secondo la direzione del tragi t to da esso .percorso. Oltre a ciò, non vi ha proporzione fra gli effetti c he si determinano sulle pareti del vaso, ed il volume del proiettile che attraversa il liquido : secondo i calcoli di von Colar e Sohjerning, si può attribuire ad un vaso deformato da nn proiettile di piccolo ca· libro con 620 metri di velocità, un aumento di capacità corrispondente a più di 300 volte il volume del proiettile; mentre è noto che lo stan· tuffo di una pompa idraulica determina un aumento di capacità nel vaso, precisamente eguale alla riduzione di volume che si effettua nel co rpo di pompa. In consegue nza , la pressione idraulica è, per lo meno, insufficiente a dar ragione degli eftetti Ili scoppio nei casi eli cui si t ratta.
Egli è perciò che von Colar e Scbjerning, Kocher, Nimier ed a ltri assegnano un notev ole contributo, nella produzi one d e l fenomeno, allt\ mobilitazione delle molecole liquide, le quali, per la forza vi\'a ad esse comunica ta dal proiettile, acquistano una potenza vulnerante propria. È questa la te oria della p1·essione id,·odinamica.
Il W oodruff ha cer cato an che di spiegare il meccanismo con c ui t a pressione idrodinamica agisce. II proiettile. egli dice, nell"attrave rsare un a massa liquida, determina un -.;-uoto per lo s postamento delle mole · cole liquide, comparabile a quello che s i effettua d iet r o la mano imme rsa co n nell'acqua, oppure di etro l'elica di una. nave. Dalla formazione di questo spazio vuoto de riva l'espansione di tutta l a massa liquida, e quin di la press i one laterale che essa ese r cita sul suo coutene nte; e ne l deriva inoltre, un'altra. scos3a di ri torno, qua ndo le m olecole s postate. esaurita la loro energia, convergono n e ll o spazio vuoto per riprendere la loro pr imi ti posizione: si d etermina in tal modo, una serie di mo. v imenti ondulatori, d' intensità decres centa, al ritorn o della massa liquida allo stato di riposo.
L e esperienze da me fatte col proiettile d el Vetterli di piombo compresso e con carica di polvere nera.; collo st.esso proiettil e rivestito d i ottone e con carica di balistite; e col proiettile del f ucil e 1891, di piocolo calibro, mostrarono, a me pare, in m odo abbastanza evidente, gli etfetti della pressione idrodinamica, ohe i menzionati proiettili possono provocare. Sulle cassette ri empite d'acqua o di segatura d i legno umida si osservarono s empre i segui caratteristici dell'azione espl osiva: gonfia-

19+ Oli:C:I.l ATTUALI !l \ Ot:l>:llUA
. : • ·:t .. ·::: .. • l. -:a .·· -·''· .. "'·
men t o de lle paret-i; distacco ed allargamento d elle commessure; lacerazi<mi i rregolari in tutti i sensi, ma con prevalenza nella. direzione del tragitto del proietti le; fori di uscita l arghi 6- 8 volte più della sezione tras'i7ersale della pallotto la; contorni di questi fori dentellati ed a lembi (tì g. 23", 24", 25", 2G• e 27a). Fu, per altro, sempre notata la diminuzione d'intensità. delle alterazioni, in ragione delle cosicchè, col proiettile di millimetri 6,5, a 600 metri non si ebbe che un semplice e moùe ra.to gonfiamento della cassetta contenente segatura di legno umida, ed etfet ti di scoppio relati vamente limitati in quella. ripiena d'acqua., ed ·
a 11)00 metri non si manifestò alcun effetto esplosivo, ma solo un gonfia m ento appena accennato tanto nell'una che nell'altra cassetta. (fig. 28" e :29") Le al terazioni poi fu r ono sempre meno pronunziate nelle cas!lette segatura umida., che in quelle riempite d'acqua.. Ed infin e si <Wen ;a,·ono guasti apprezzabilmente meno 1·ilevanli, alle b1·evi distanze, col p; oiettile d i millimetri () ,:).

Adunque, questi esperimenti n on solo hanno confermato i risultati di q uelli analoghi precedentemente da altri praticati, ma hanno most,·uto altresì che i proieU ili eli piccolo calib1·o, sui be1 s:.gli umidi inc rps nlati e sui ,·ecipienli ripieni di lùjuido, p1·oducono effetti esplosivi u'' po' min cwi di quelli cagionali dai p1·oietlili di maggim· calib r o: t ali enetti si estendono, g,· ,ulatamente attent wli, a più g,·an cli dislanze. Ciottoli e piccoli pezzi di marm o, co n tMuli in r·ecipienti a pw· et i l'i rjid e - Le poche prove fatte per dimostrare gli effetti della così de tta pressione secca, o, meglio, della. mobilitazione di piccole partice lle dell'oggettq colpito, diede1· o , -isult«li ?nl'no appm ·iscenti di quelli descritti dal A"oc he1·.
I tiri a 100 metri col proiettile di millimet ri 10,35 determi nar ono un mediocre ri gonfiamento della cassetta., e delle impressioni a forma di piccole bozze sulle pa.reti , con varie lacerazioni per etre tto della dislocazione di pezzetti di marmo e dei ciottoli, e della. fuoruscita di t'rantu mi d i essi e dello stesso proiettile. Col proi ettile di millimetri 6,5 , all a. stessa distanza, ed anche a distanze minori, le impressioni sulle pa reti della cassetta furono sempre poco notevo li e poche e limitate le la cera.zio n i (fig.' 30" e 31' ).
Dopo cio, pa.rmi ancora una volta dimostrato il valo rd d eiJe prove spe rimentali sui bersagli inanimati, per lo studio deiie lesioni dei tes· suti ed organi rlegli animali e segnatamente dell'uomo vivente. E, per ter mo, possonsi riferire a.lla classe dei corpi elastici, la pelle, le sierose, le ìasce aponeurotiche, i tendi ni, i n ervi, tuttochè questi t essuti abbiano
{;(}efficienti di elasticità molto diversi; ai corpi solidi e rigidi, le ossa; ai liquidi ed ai corpi molto imbevuti di liquido, i l sangue, la bile,
E SPECI.-\LME:\TE DEL FOCILE ITALIANO DI Plt' CO I,O CALIDRO, EO C } $lò
l'urina, il contenuto in testinale, il cervello, il tessuto midollare ctell& ossa lunghe, gli or g ani parencbimatosi del ventre, eco. Queste ultime pa rti , j ucapsu late dai tessuti d ella prima o della seconda specie, presentano le condiz ioni fisiche pe r dar l uogo alla pressione idrodinamica. No n dimeno, s i compr e nde co me una esatta e rigorosa applicazione delle leggi fisiche alle lesioni che i p r o iettili possono produrre nell'organismo vive n te, n on sia possibile per m ol te ovvie ragioni. Onde il bisogno di estendere gli studi sperimentali, come in r ealtà. si è fatto, anC'he a ll'azione d iretta dei proiettili s ui cadaveri umani e sugli animal i dvi.
C
APITOLO IY .
Effetti d ei proiettili sul· co r p o u man o e s u gli animali.
I EsPERIM&NTI.
a) T iri su parti di cadaveri. Distanza 100 metri. P roiet t ile d i millimetri 10,35 con rivestiment(} d ' ottone, e cari ca di ba listite.
l. Cranio vtwlo. - Larga. apertura co n perdita di sostanza (co lpo tangenzia le), che d alla regione parietale d estra si porta indietro gradatamente allargandosi, sino a ci r ca. 2 centimetri al di sopra dell'in io n : tale ape rt u ra, l unga lò centi m etri, raggiunge n ella regio ne parietale la larghezza massima di 3 centimetri e di 6 nella r egio n e occi pital Ì> . Dalla pe rdita di sostanza si diramano cinque fessure che si portano in diverse direzioni, percorrendo un tragitto più o meno lungo. U na. d 1 tali fessure, partendo dal margine sinistro della porzione occi p itale della p er d i t a di sostanza. decor r e sull'osso parie tale corrispondente, parallela alla sutura lambdoidea, e si divide p oi in due rami, l'uno d ei quali si p er de sull'osso parieta.le stesso, l'altro r aggiunge l'asterion e si bi fo r ca, al la sua volta, dietro l 'apofisi mastoide, per circoscrivere una soheggia libera de l diametro di circa 2 centimetri, fra l & d e tta. apo fisi e la basila re. L e prime qua ttr o fessure limitano anch'esse due grosse schegge libere (fig 32")

Distanza 100 metri. Proiettile di millimetri 10,35, con rivestim on l;(} d' ottone, e carica d i balistite.
2. Cran io pieno di soslan:;a ce1·ebrale. - Colpo obliquo nella regione frontale, un centimetro al di sopra de ll'arcata orbitaria destr a . Foro d'entrata ellittico, a contorno netto ma tagliato a sghembo, col
lflG SGL
I}AZIONE DEGU \1TUALI FU('ll,t DA CUERI{ A
maggior diametro in senso t rasversale, di 3 centimetri; foro d'uscita nella regione occipito-par ietale destra, r appresentato da una v a sta ed irregolar e perdita di sostanza, del diametro massimo di 12 centimetri. A tale estesa perfo razione fanno seguit o una perdita di sostanza a spese delle ossa parietale e f r onta le, la quale congiunge il foro d'uscita con qu e ll o d'ent rata, ed una soluzione di continuità posteriore, parimente con p erdita di sostanza, che si estende sino al grand e fora.me occipi· tale allar gandolo. Inol tre, al foro d'entrata segue pure un largo crepaccio con pe rdita di sostanza, il quale 'Si porta in basso ed in avanti nella t'ossa pterigo-mascellare destra, interessando rarcata zigomatica. la grande ala e l'apofisi pterigoidea dello sfenoide, nonchè la faccia esterna dell' osso mascellare superi ore, con ape r tura dell'antro d'Igmoro. Infine, dalle descritte perdite di sostanza si di r ama n o in tutti i sensi numerose fessu r e, alcune de l le quali si perdo n o nel le ossa d e ll a vo l ta, altre si po r tano verso la. base del c ranio ed alle ossa del la fac cia., ci r\'endo molte schegge libe r e di varia forma e dimen sioni ( ti g. 33' ).
La sostanza cerebrale. f uor uscita i n g ran par te, lanciata, mista a picco le schegge e polvere ossea, in tutte le direzioni, anche alla dis tanza di 3-4 metri. La por zione r imasta presentavasi spappolata ed in parte ridotta quasi in poi t ig l ia.
Di'3tanza 50, 100 e 200 metri- Proiettile di millimet.ri 6,5.
8 Cranio vuoto colpito da più p,·oietldi. - Fori d'entrata ci rcolari od ellittic i, nett i; fori d'uscita u n poco più grandi di quelli d 'ent rat a, alcuni abbastanza regolari, a con torni più o meno dentellati, al t ri rapp r e sentati da perforazioni irr t>golar i con pe rdita di sostanza ed compagnate a fenditure più o meno lunghe (fig . 343 ).

Distanza 100 metri. Proiettile di millimetri 6.5.
-1. G1·anio pieno di ce1·ebrale. - For o d'entrata abbastanz1:1. di forma ellitt ica, poco più grande della sezione trasversale della p allottola , in corrispondenza della s utura fronto ·pter o·parietale sini itra; perforazione d'uscita con e!'tesa perdita di sostanza, nella rt>;;io n e frouto-pinietale d e l lato opposto, avente i l maggior diametro fii <: irca 11 centimetri; fessure p i ù o meno estese, partenti da un lato e da li'alcro della perdita di sostanza; lacerazioni diverse e sch eggiamenti nelle ossa della faccia., specie de l lato destro (fig. 35').
:::)i notò l a f u oruscita a b r andell i di par te della sostanza cerebrale, a poi vere ossea ed a piccole schegge; e lo spappolamento della parte r imasta. in sito.
Distanza metri. Proiettile di millimetri 6,5.
5. Testa d i uomo ad"lto. - F oro d'entrata nell"orecohio destro , in co rrispondenza d e l meato auditivo esterno, contornato d a piccoli
E DEl, FUC ILE ITAI.I A::\0 D I l'ICCOI.O C'AI.IDRO, Et 'C , l!li
scheggia.menti; foro d'uscita nella regione temporale sinistra: il foro cutaneo i r rego larmente circolare, a. contomi frastagliati ed estrotiessi., del diametro di circa 3 centimetri; quello osseo più ampio e più irre· gohne, continuantesi con una frattura. commiuutiva. con perdita di sostanza., estesa. an ch e alla corr ispondente r egione fronto- parietale; fessure diverse più o meno lunghe, partenti da.lruno e dt1Iraltro lato della perdita di sostanza; frattura comminuti va con p e rdita d t sostanza nella regione fronto-parietale destra (fig. 36"). Sostanza. cerebrale lanciata a brandelli in tutti i sensi, specialmente dal foro d'uscita e dalla breccia della regione fronto parietale sinistra; quella rimasta. in :;ito. parte spa.ppolata, parte, luogo il tragitto percorso da.! proiettile, ri dotta i n poltiglia.
Distanza 200 metr i. P r oiettile di m. 10,35, con rivestimento di ottone, e carica di balistite.
6. 1'est a di uomo adulto. - Forarne d'entrata nella. sottorbitaria destra, abbastanza rego l are, poco più grande della sezione tra· sversale del proiettile: il foro cutaneo ad orlo netto, entroflesso, qu è llO osseo contornato da piccoli scheggia.menti; foro d'uscita nella regione occipitg.le, associato ad estesa perdita di sostanza anc he dell e parti molli esterne, le qtU:.li sono rido tte a brandelli. La breccia. ha il massimo diametro di 8 centimetri. Notasi un'altra vasta p erdita di sost.tnza ossea nella regione fronto-parietale destra. Fessu re molteplici portansi in vario ;;enso dai lati d elle dette lesioni (fig. 37"). Una parte considerevole di sostanza cerebrale Yenne lanciata fuori a. brandelli, specie dal forarne d'uscita, sino alla. dis ta nza di circa due metri: la. parte rimasta in sito era spappolata e, lungo il tragitto percorso dalla. pallottola, rid otta in poltiglia.
Distanza. 100 metri. Proietti le di millimetri 6,5.
7. Ossa lunghe dell'm·fo infe-;·io,·e, disseccale. - N. L Perforazione opifisaria della tibia E'oro d 'entrata circolare, n etto, di p oco maggiori di della sezione trasversale del proiettile, circà 3 centimetri al disopra d e lla superficie articolare inferiore della tibia.; tragitto di forma. quasi cilindrica, a pareti nette; foro d 'uscita. abbastan za. regolare, del diametro di 7 millimetri, contornato da. piccoli scheggiamenti.
N. 2. Ferita. a doccia nella tub erosità anteriore della. tibia.; a.lr ra ferita. pure a. doccia. nella superficie articola re inferiore dello stesso o:>so ; ambedu e per colpi tangenziali.
N. 3. Frattura co mminuti va d e lla diatlsi del femore co n molteplici schegge libere e co n considerevole perdita di sostanza, specie i n co r -

198 DEGI,l ATTU.\LI FUC ILI DA GUERRA
xispondenza del foro d'us cita.: focolaio di fra.ttum della lunghe zza di 7 centimetri (1 )
N. 4. Frattura diafisaria comminutiva. del femore con nume r ose sc hegge libere ed estesa perdi ta di sostanza, in corrispondenza del foro d'uscita: focolaio di frattura di 8 centimetri (l).

N. 5. Perforazione epifìs aria. del femor e con foro d'entrata. circ olare, net to, poc o al di sopr a della linea in t ertrocanLe ri ca anteriore; tragitto ..:ilind rioo; fo r o d'uscita. poco al di sotto d e lla. linea inte rtrocan t erica po,;teriore ; di dimensioni alquanto maggiori di quelle del foro d' e ntra t a. e d e l proiettile, conto rnato da piccoli scheggia men t i. Altra. perforazione metafisa.ria, -:1: ce utimetri al di sotto d e lla precedente, oon orifìcio d'en· tra ta. rotondo, nettamente tagliato, e con oritieio d'us c ita più grande e contornato da piccole s c hegge e d a f e nditure mol to limitate.
N. 6. !ferita a doccia per colpo tangenziale. 8 centimetri al di sopra de l condilo esterno del femo r e, co n perdita d i sostanza, e d a contorn i irre gola ri , dentellati ( fig. 38•)
D istanza 100 metri. Proiettile di millimetri 6,5.
S. Oss1t lttnghe dl'll'(l •·to inJ"e··iore, Ji·esc he . - N. 1. :F'rattura comminuti va diafisa ria della tibia. e del perone , e on schegge e f.. ssure. sopra t tutto in co rrispondenza de l fo ro d'uscita: focol a io di frattura della lunghezza di ci r ca 10 centimetri.
N. 2. l!'rattura comminuti va della diafisi della tibia - 3• inte rioreco n molte plic i s c hegge libere ed estese fessure, massime dalla parte de l foro d 'usci t a: focol&.io di frattura lungo S centimet ri.
3, 4, 3 e o. .Fra.tt ure comminutive in divet·si punti della dia.fhl i del fe more, uo n molte pli c i s c hegge libe re, più pi cco le in pross imità. del puu t o colpito e più nnmerose e d es t.ese in corris ponde nza. d e l forarne d'u3 c ita, e co n fe s;;ure dirett e in vario senso e taluu e pro lunga.ntis i longitndinalmeu t e - n. 3 e 6 - sin quasi alla lin e a dia6s o-epifìsaria: focolai di fratt ura di lunghe zza variabile da 8 a 12 uentime tri 1 l )
lfig. 3 9 ) .
Distanza. 10 0 me tri. Proi e ttile di millime tri 10,35, di piombo c o mpres;;o, e cari d i poi ve re nora 9 l dest ro. - Frattura comminuti va d e lla dia.fisi del rad io. Foro d' e ntrata cutan eo, r otondo, tagliato a stampo, piLt piccolo de lla s e zione trasvenmle d e l proie ttile, nella regione dorsal e - a· medio - dell'avambraccio; foro di uscita nella regione an te riore , r apprese ntato da una lacer azione i rregolare della ou te c on perdit<t di sos t anza ,
l ll l,e allerazu>nl J!OCO es>rntloso Ilo' o.to ado pc rnre 11 1•er rlco nt pu rre le t f"ht",!C't.
i,; SPECIAI.ME:\ 'n; OEI. Fl"C' II.E lTALIAXù D I l'Il"f'V I.O C.II.IBR01 E CC. l!)!)
della lunghezza di 4 centimetri; frattura c omminutiYa del radio con numerose sc hegge e fessure, specie in corrispondenza d e l foro d'uscita. Alcu n e schegge libere sono proiettate iu distanza. insi eme a della p oi vere ossea, e conficcate nelle parti molli, le q uali tutt'into r no al focolaio di frattura sono lace ra t e e rid otte a brandelli: focolaio di frattura lungo circa 4 centimetri (fig. 40" e 62 ')
Distanza m etri. P r oiettile dì millimetri 10,35, di piombo compresso, e cari ca d i poi vere I!dra.
Distauza 300 metri. Proiettile di millimetri 6,5.
10. A1·/o i,t{el'i01·e sinisl1·o. - Frattura comminutiva diafisaria d e l femore, prod otta dal proiettile di millimetri 10,3ò. Orifi cio cutaneo di ent ra ta, circolare, n e t to. del diam etro di 11 millimetri, sulla faccia anta ro-in te rna della co;:;cia, circa 10 centimetri al di sop ra della della rotula ; apertura di us cit a a f'orma di larga fen dit ura con marg ini ft·as tn · gliat i, la qu a le dalla piega de l popl ite s i prolunga in alto pe r 12 c e u· timetri; frattu ra comminuti va dell'osso con numero!:e scheggo libere e fessure, massime in corrisp ondenza d e ll'apertura di uscita. A lc une se hegge sono dislocate ed infitte nelle partì m olli. che tutt'intorno al focolaio di f raLtnra present.ansi rido tte a brand e lli: foeolaio di f ra t· tura della di circa 13 centimetri.
E'ra tt ura com minutiva d ella tibia prod otta dai proiettile di m illimetri 6,ii Foro d'entrata nella fa ccia an t eriore - 3" superiore - d ella gamba, di forma ovale ad orlo frastagliato . col maggior diamet ro di 9 millime tri; foro d' u scita nella regi one p oster o- interna, anch'esso ovale, a co ntorn o cincischiato ed estroflesso, col maggio r diametro di oltre 4 cen timetri; frattura della tibia a più schegge. alcune delle q uali libere ed in fitte nelle parti mol li, e con t re fessure, di cui una si es tt"n de l o ngitudinalme n te sino a poca distanza dall a linea diafiso- op ifis aria s uperi or e; parti molli circ.os tanti alla frattu ra più, o meno lacere: focolaio di frattura d ella lunghezza di c irca 7 centimetri (fìg. 41" e ù7' ).
DistAnza 100 e :200 metr i. di millimet ri 10 ,35 cou rives t ime nto d' ott one, e carica di balistite.
11. ;l1·to in(e1·im·e de.l'/ro. -Frattu ra comminuti va del femore, a 100 met ri. Foro d'en t rata nella regione antero -esterna - a• inf.,riorede lla coscia, r ot ondo, a stampo, del diam etro di 9 mi!li metri ; foro d i uscita nel la. regione o pposta, n ella stessa f orma di q u ello d'entrata, ad orlo frastagl iato ed es trofi esso, de l diametro di 15 millime t ri ; lacera.· zi one irregola re dell e parti molli poco al di so pra ed all'inte rn o della base della rotul a. ; alLre lacerazioni pi ù piccole n ella reg io ne anteroesterna de l ginocchio; frattura del fem ore con !:Chegge libe re. dis i o·

200 DEGLI A T TUAI,! FUC ILI D \ Gf'ERRA
n ei tessuti molli, specie in corrisponde nza del foro d'usci t a, e fessure in vario senso; parti molli circostanti alla frat t ura, ridotte a brandelli: focolaio di frattura di 12 centimetri.
Frat tura comminu t iva delle ossa d ella gamba a 200 metri. Orificio d'entrata nella regione antero-esterna - 3'' infe riore - della gamba, di forma ellittica, a margine entrotiesso, col maggi or d iam etro di 11 milorificio nella. regione oppos t a, pure d i forma ellitt i ca, ma. mol t o più largo ed a contorno den t ellato ed estroflesso ; frat tura a più frammenti della tibia e d el perone, co n schegge libe re proiet ta t e in distanza, sopratt utto in corrispondenza del foro d ' uscita, e con f ess ure in varie direzioni ; parti molli circost anti, l acerate: focolai di frattura della lunghezza di 12 centimetri nella tibia, di circa 10 nel per o ne (fig. 42", 43' e 59") .
Dis tanza 200 metri. Proiettile di millime t ri 10,35 con riv estime n t o d' otto n e , e carica di balis tite.
12. A r to in{e?·io1·e de stro. - Fratt.nra comminutiva d el femore . Foro d'en t rata di forma ellittica, n e lla fa ccia anteriore es t erna. - 3° mediode lla coscia, col massimo diametro di 9 millimetri, ad orlo nett o, ent rotl ess o; foro d ' uscita nella regione oppos ta, cost ituito da una larga rotondeggiante, del mass imo diame tro di 3 centimetri; altre piccol e lac erazioni prodotte da sch egg e ossee f uoruscite; frattura d e l fe mor e a mol t epli ci frammenti , con piccolo schegge libe re, dislo cate ed i nfi t t e nelle parti molli, e con fenditure in varie direzioni; parti molli circos tanti, ridotte a brandelli: · focolaio di f ra ttura d ella lunghe zza di circa 14 centime tri.
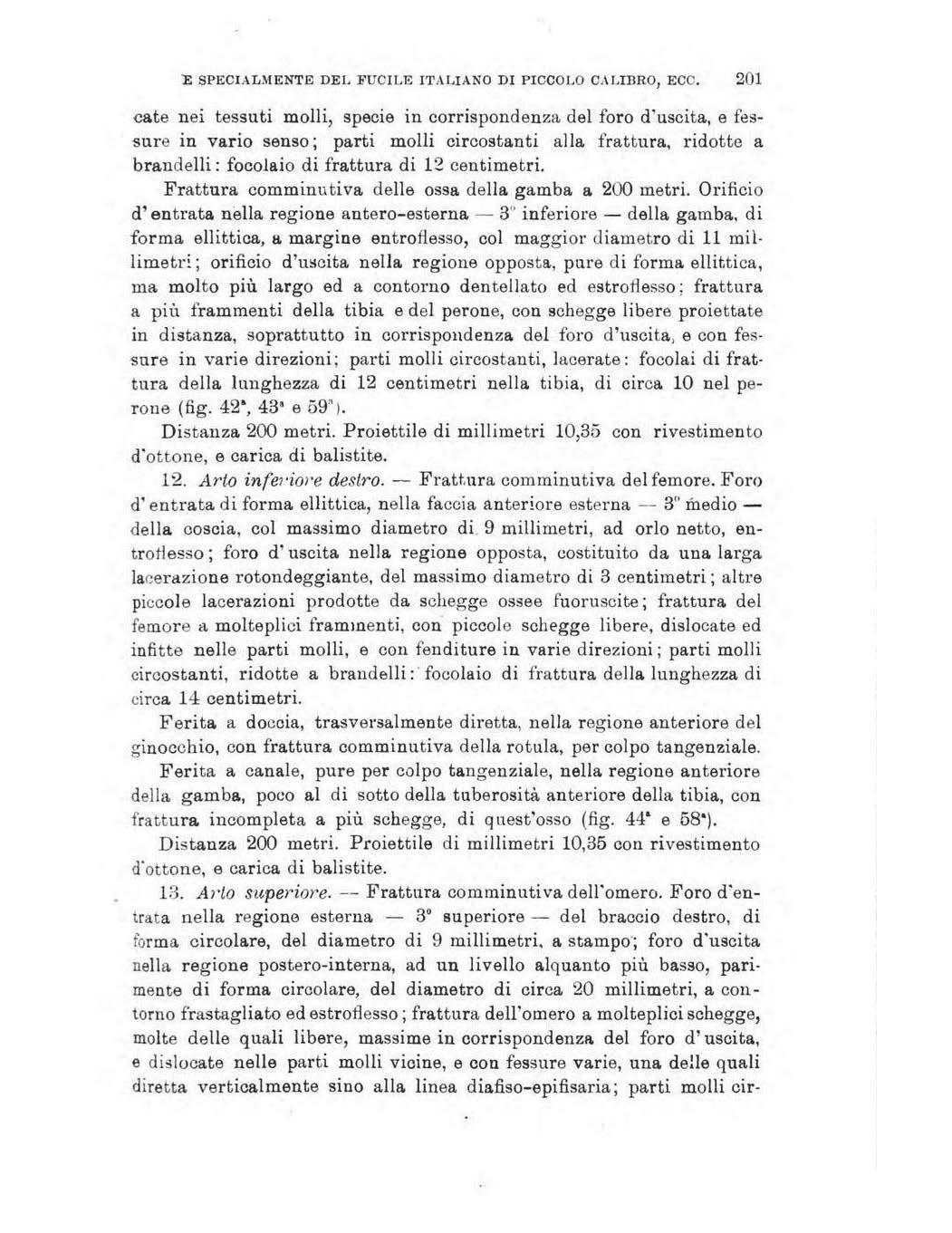
Ferita a doccia, trasversalmente diretta, nella r egione anteriore d el g inocc hio, con frattura comminutiva d e lla rotula, per colpo tangenziale.
Ferita a canale, pure per colpo tan g enziale , nella regione anteriore dell a gamba, poco al di s otto della tuberosit.à anteriore della tibia, con f ratt ura incompleta a più scheg ge, di qu est'osso (fig. 44" e 58' ).
Dis tanza 200 metri. Proiettile di millimetri 10,35 con rivestimento d' otto n e, e carica di balistite.
13 . Ado su pe1·i ore. - -Frattura comminuti va dell ' ome ro. Foro d"ent rata ne lla r egione esterna - 3" superiore - del braccio destro, di tò rma circolare, del diametro di 9 millimetri. a stampo·; foro d'uscita nell a regione postero-interna, ad un li vello alquanto più basso, parime nt.e di forma circolare, del diametro di circa 20 millime t ri, a conto rn o f rastagliato ed estroflesso; frattura dell'omero a molteplici schegge, molte delle quali libere, massime in corrispondenza del foro d'uscita, e d islo cate nelle part i molli vicine, e con fessure varie, una delle qua l i dire tta verticalmente sino alla linea diafiso-epifisaria; parti molli cir-
"E SPECIALMENTE DEL FUC I LE I T ALIANO DI PICCOLO CM. IDR0 1 E CO. 201
costanti lacere ed a. brandelli: focolaio di frattura l ungo ci rca 10 centimetri (fig. 50• ).

Distanza 200 metri. Proiettile di millimetri 6,5.
14. A1·to superim·e. - Frattura commi nuti va dell'omero. Foro d'eu· trata nella regione anteriore- esterna- a• medio - del braccio destr o, di forma ellittica, col massimo diametro di 6 millimetri, a contorno netto, entroHesso; foro d'uscita nella r egione opposta, della stessa. forma del foro d'entrata, col maggior diametro di 15 millimetri, ad orlo fra· stagliato e rovesciato in fu ori; frattura e. molteplici schegge, tal un e delle quali libere e dislocate fra le parti molli; dive rse fenditure , di cui due dirette longitudinalmente in alto ed in basso sin quasi alla liu ea. diafi so-epif.saria corrispondente; tessuti molli circostanti, lacerati: focolaio di frat t ura della. lunghezza di 7 centimetri (fig. ò l ').
Distanza 100 metri. P r oiettile di millimetri 6,5.
15.. l?'/o supe1·im·e. - Frattura co mminu tiva del radio. Orifìcio d'entrata nella regione esterna - a• medio - dell'ava.mbrll.ccio sinistro, di forma circolare, del diamet r o di 5 millim etri, ad orl'> netto ed entrofl.esso; foro d'uscita ra ppresentato da una fenditura con p erdita d i sostanza, a margin i cincischiati, lunga centimet:-i a,:j, nella par ete opposta dell'avambraccio; frattura con molteplici schegge, parecchie delle quali didlocate ed infitte nelle parti molli; di\·e rse piccole fessure in vario senso; tessuti m<' Ili circostanti, lacerati: focolaio di frattura di circa 6 centimetri (fi g. òa•).
Distanza 200 metri. Proiettile di millimetri 10.33, di piombo compresso. e carica di polvere nera.
16. A l'lo in{e1·iore. Frattura comminuti m del femore. For o d'ent rata n e lla r egione esterna della coscia sin istra - 3° superio re, -. d i forma. ellittica.. col massimo diametro di 10 millimetri, tagliato a stampo; foro d'uscita. nella regione posteriore-ix:terna, rappresenLato da laceraz ione con p erdita di sostanza, lunga circa 7 centimeLri, a l emb i estrotlessi; frattura a più frammenti con schegg" libE're, disloca t <', e con varie fessure dirette in senso obliquo e longitudinale; tess uti m olli vi cini, più o meno laceri: focolaio di fratture della lunghezza di cin.:a 10 oentimeliri (fig. 54•)
200 metri. Proietti le di millimetri 6.5.
17. Al'/o in(e1·io;·e. - Fra.ttn ra commiuutivn del femore. Orificio d'ent rata. nella regione antero esterna - o• medio - della cosci a destra, di forma circolar e col diametro di 6 millimetri, tagliato a s t ampo; for o d'uscita pure ci rcolar e, del diametro di 30 millimetri , ed a. contorno frastagliato ed estroflesso; frattura con schegge, m o lte delle quali infitte nei m olli, e con fes.;ure in vario senso, specie
202 SU t.I:AziONE DEGLI ATTUALI .b'UClLI DA GUERRA
.-.) : . .••·-· • 1.:. ::;:) . ::-r,. · . ..: '!:; . : ' ' .. :._.. ... '. ' <
in senso longitudinale ; parti molli circostanti più o meno lacere ed a brandelli: focolaio di frattura esteso per ci rca IO centimetri (fig. 55').
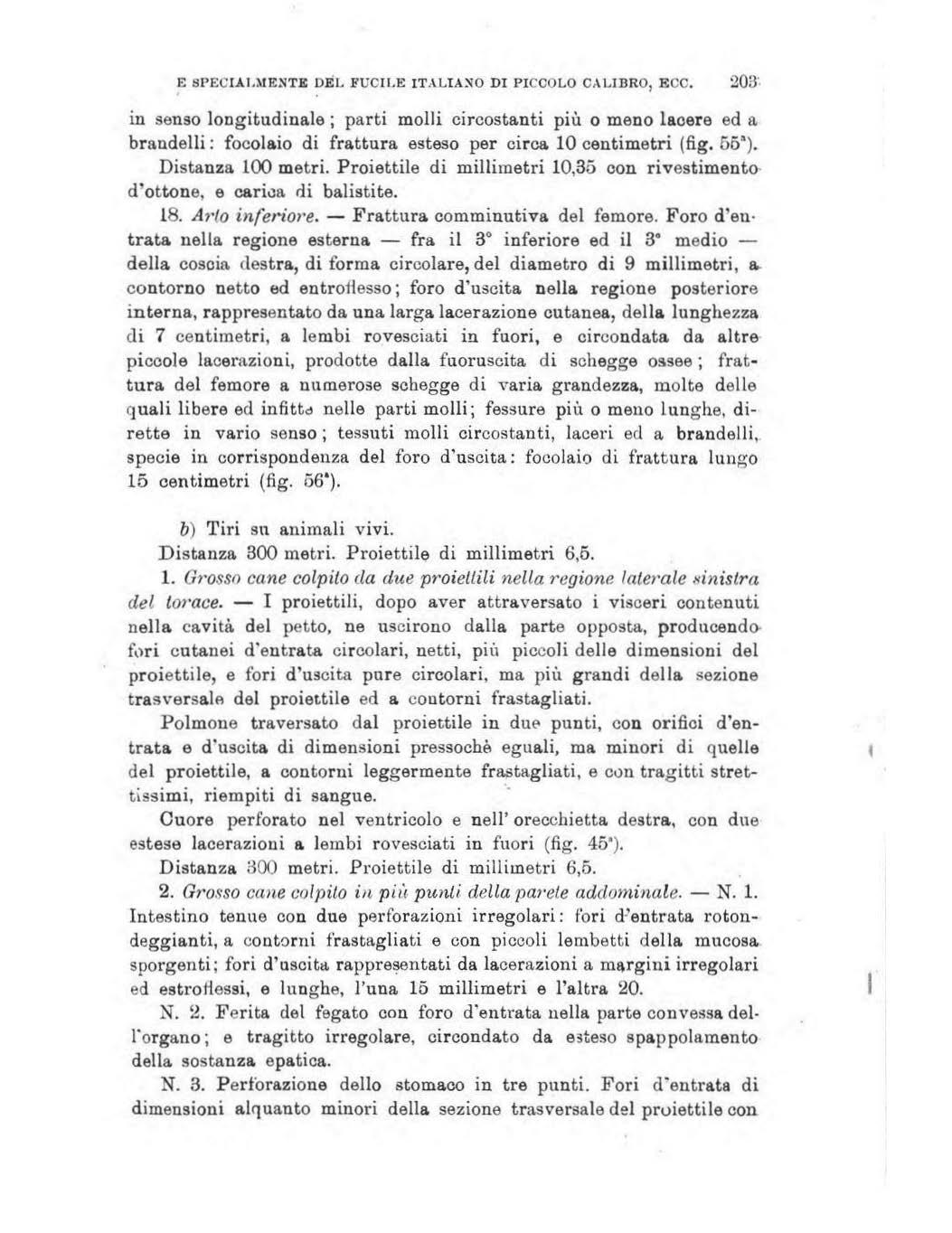
Distanza 100 met ri. Proiettile di millimetri 10,35 con rivestimento d'ottone, e carioJa di balistite.
18. A1·to in(erio1·e. - Frattura comminutiva del femore. Foro d'eu· trata nella regione esterna - fra il 3 ° inferiore ed il a· mediodella coscia destra, di forma circolare, del diametro di 9 millimetri, a.. contorno netto ad entroiiesso; foro d 'uscita nella regione pos terio r e interna, rappresentato da una larga lacerazione cutanea, dell a lunghezza di 7 ce ntimetri, a lembi r ovesciati in fuori, e circo ndata. da altre piccole lacerazioni, prodotte dalla fuoruscita di schegge ossee ; frattura del femore a numero:>e schegge di varia grandezza, molte delle quali libere ed infitte! nelle parti molli; fessure più o meno lunghe, dirette in vario senso; tessuti molli circostanti, laceri ed a brandelli, specie in co rrispondenza del foro d'uscita: focolaio di frattu ra lungo 15 centimetri (fig. 56•).
b) Tiri su animali V JVL
Distanza 300 metri. Proiettile di millimetri 6,5.
l. Grosso cane colpilo da due proiellili nella regione laterale 8inistra del to1·ace. - I proiettili, dopo aver attraversato i visceri contenuti ne lla cavità. del petto, ne uscirono dalla. parte opposta., producendo f,lri cutanei d'entrata circolari, netti, più piccoli delle dime n sioni del proiettile, e fori d'uscita pure circolari, ma più g randi della sezione trasve r saiA del proiettile ed a c on t orni frastagliati.
Polmone traversato dal proiettile in due- punti, co n orifìoi d'entrat a e d'uscita. di dimensioni pressochÈ\ eguali, ma minori di quelle del proiettile, a contorni leggermente frll$tagliati, e C\)n tragitti stre ttissimi, riempiti di sangue.
Cuore perforato nel ventricolo e n ell' orecchietta destra., con due estese lacerazioni a l embi rovesciati in fuori (fig. 4o·).
Distanza 1300 metri. Proiettile di millimetri 6,5.
2. Grosso cane colpilo in più punti della par·ete addominale - N. l. Intestino tenue con due perforazioni irregolari: fori dJentrata rotondeggianti, a contorni frastagliati e con piccoli lembetti della mucosa sporgenti; fori d 'uscita. ra.ppre!?8ntati da lacerazioni a margini irregolari ed estroHessi, e lunghe, l'una 15 millimetri e l'altra 20.
N. 2. F e rita del fegato con foro d'entrata nella parte convessa dell'organo; e tragitto irregolare, circondato da e3teso spa.ppolamento della sostanza epatica.
N. 3. Perforazione dello stomaco in tre punti. Fori d-entrata di djmensioni alquanto minori della sezione trasversale del pruiettile con
E SPEC IALMENTE DEL FUCILE ITA LIA::>IO DI PICCOLO CALIBRO, ECC. 203
sporgenza della mucosa; fori d'uscita di forma r otondeggiante al pari ddi fori d'entrata, ma pitt grandi ed a contorni irregolari con piccoli lembi della mucosa estroftessi (fig. 46•).
Proiettile di millimetri 10,135 co n rives timento di ottone, e carica <ii balistite.
3. Grosço cane colpilo i11 due ptml i della t·egione lole,·,-,le sinislNt del tm·a,·e. co n fori d'entrata ci rcol ari, netti. di dime nsioni p ressochè eguali alla sdzio ne tras,·ersale del proiettile, e fori d'uscita. nella. region e opp ostot, r otoudeggianti, ma a conto rni cincischiati e di dimensioni notevolmente di rtuelle dei fori d'entrata.

Polmoni perfo ra ti in due punti, con fori d'entrata e d'uscita c irco lari, a contor ni leggermente frastagliati, più piccoli della sezione trasve rsale del proiettile, e con tragitti strPtti e ripieni di sangue.
Perforaz ione del ventricolo sinistro del cuore, col foro d'uscita rapda un'est esa lace razione irregolare, r. margini dentellati ed estro flessi (fig. 4 7" ).
Distanza 300 metri. Proiettile di mi l limet ri 10,35 con r ivestimento di otlone, e carica di balistite.
4. G1·osso ca n e colpilo nella t·egione ipocondi'iaca de.çt,·a. - Ferita del fagato nella sua faccia convessa. con molteplici fdnditure a forma raggiata; e ferita corrispondente al foro d'us cita, irregolare, con estesa perdita di sostanza, n ella ftlccia. conca\·a deJ:'organo (fig. 48' ).
Distanza 300 metri. Proiettile di millimetri 10,35 cou ri ,·estimenro di ottone, e cari ca di balistite.
5. Orosso cane colpito in clire1·si punti del vent,·e. - l. Fer ita della milza, co n foro d'entrata nella faccia convessa dell'organo. di forma circolare, di dimensioni pressochè eguali a quelle della sezione del proiettile. 11. contorno dentellato e da cui partono cinque fenditure a raggi: foro d'uscita nella faccia opposta, ir r egolare, ampio, con m olta perdita di sostanza. contornato da fenditure.
N. 2. P erfo razioni intestinali r appresentate da due fori d'entrata. nell'intestino tenue, di forma ellittica, col maggi or diamE-tro di circa 10 millimetri e con sporgenza della mu cosa, e da due fori d'uscita notevolmente più' grandi dei fori d ' entrata, irregolari e contornati da picco li lembi estro/lessi (fig. 49'j
Poichè mi mancò l'opportunità di eseguire t.iri sui cadaveri e sugli animali vivi n distanze maggiori di ;{00 metri, dovetti. per forza.
!imitarmi a studiare quasi e<>clusivameute gli e!fetti esplosivi dei pro-
JI.
E
C:oNSIDERAZIOlH CIHCA GJ.r EFFE1'1'l DEI P.ROI K1'1'fl ,f SUL CORPO UMANO
SUGLI A:s'IMAL{.
iettili delle armi adoperate nelle es perienze. Epperò, le po che considerazioni che sono per fare, r iguarde ranno principalmente l'azione e splosiva dei proiettili stessi.
Fra le tante teorie emesse per dar ragion e dell'azi one esplosiva (te01· ia d ella lempe;·a lw·a o d e lla (ttsione, di Hagenbach, Socio , Coze, Ri chter; delt'a;;ione dell'a1·ia, o de l p1·oiellile aereo, di Melsens; della tJel'Cussione, di Bec k, Bornhaupt, Delorme ; della l'O/ az ione, di Busch; della iclraulica, ài Reger e Bircher, e d e lla p1·e:;sione i cl1·od ina mica, di von Colar e :::>chjerning . Kocher, Nimier; delle onde oscillcwti, di K o hler; delle rib;·a;;ioni, di Cascino; del mo vimen to e p ro ie;; ione delle molecole, di Booomo) a me pare n o n s iavene alcuna che possa. spiegare completamente ed in tutti i casi il feuomen o.
Non è qui, di certo, il luogo di fare la critica. di tutte queste mol'te plici teo ri e. Nè, d'altra parte, per poterle c onvenientemente dis cutere, mi senti rei capace di entrare in minute disquisizioni di meccanica.; molto più che alcune di esse sono circondate da tante sottigliezze, che, p e r verità., se valgono a fare ammirare l'ingegno e la dottrina degli autori, non so di quanta utilità pratica. possano esser e.
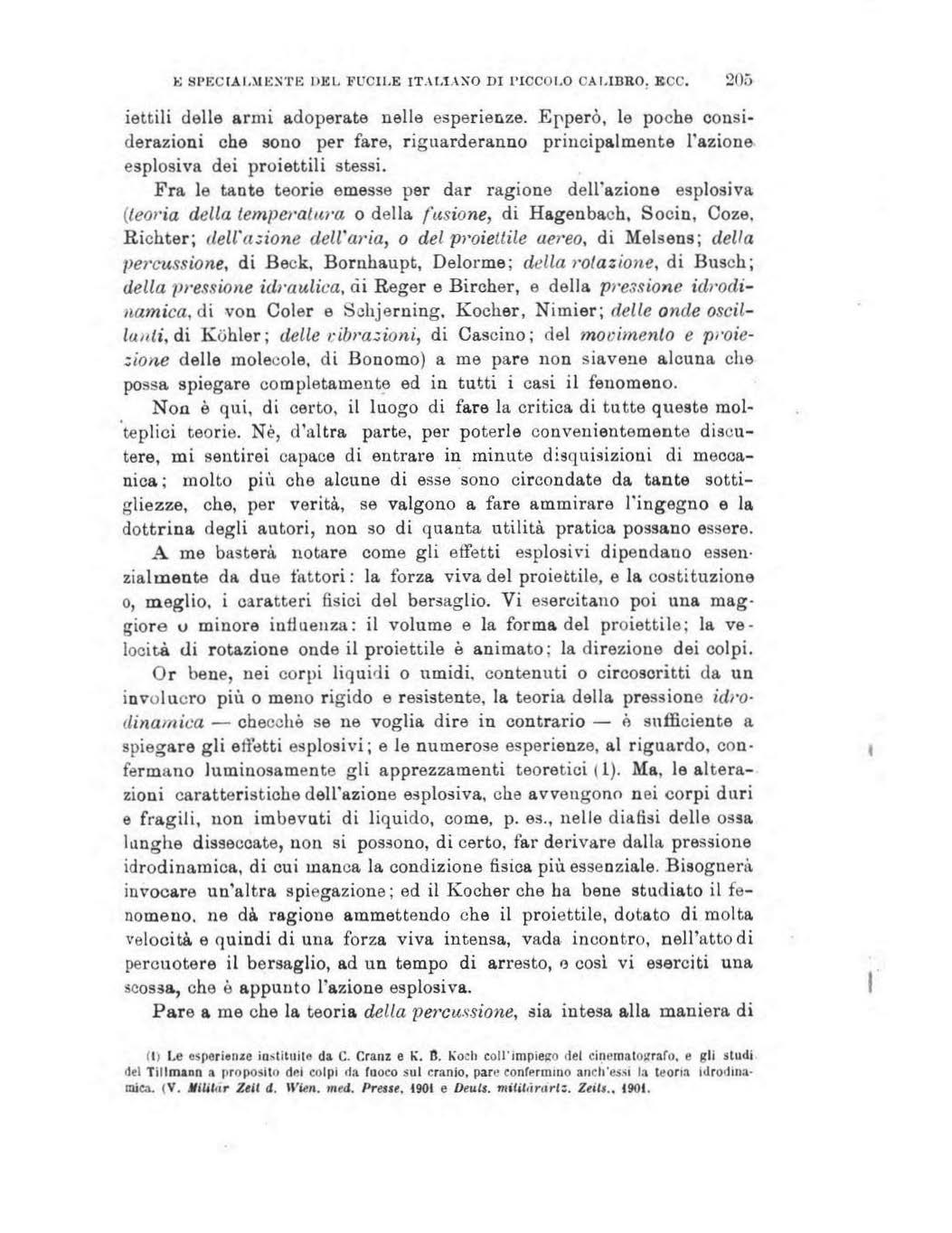
A me basterà notare come gli e ffetti esplosi \'Ì dipendano essen· zialmente da du e ta t tori: la forza viva del proiettile, e la costituzione o, meglio, i caratteri fis ici del bersaglio. Vi esen:itano poi una mag· giore v minore intluenza: il volume e la forma del pro iettile; la veloci tà <.li rotazione onde il proie ttile è animato; la di rezione dei colpi.
O r be ne, nei co r pi liquidi o umidi. co n tenut i o circoscritti da un in vo i u cro più o meno ri g ido e r esisten te, la teoria della press ione id1·o· tlinattlù:a - cbecc hè se ne voglia di re in contrario - À sufficiente a spiegare gli es plosivi; e le nume rose es perienze, al riguardo, co nfermano lumi nosamente gli apprezzamenti teoretici ( l ). Ma , le al te razioni caratteristiche dell'azione esplosiva, c he avvengo no n ei corpi duri e fragili, non imbevuti di liquido, come, p. es., nelle diafisi d elle ossa lunghe disseccate, non si possono, di ce rto, far deri va re dalla pressione id ro dinamica, di cui manca la condizione fisica più esse nziale. Bisognerà invocare un'altra spiegazione; ed il Kocher che ba bene studiato il feno me no . ne da ragione ammettendo che il proiettile, dotato di molta velocità e quindi di una forza viva intensa, vada incontro, nell'atto di pe rcuotere il bersaglio, ad un tempo di arresto, IJ cosi vi eserciti una. scossa, che è appunto l'azione esplosiva.
Pare a me che la teoria della percussione, sia. intesa. alla maniera. di
r; SPECIAI.:UE);TE IlEI. FUCILE !T \141.\:\0 Dll'ICCOI.O CAI.IDRO. E CC 20u
Cl> Le espe r ien1e in ,Ji tuilo da C. Cranz e 1\. B l\ h coll' de l cinemalo!: raro. e gl i s tudi del Tillmann a tiPI col pì rla looco s ul c ranio, pare conlermono an ch"e:;;o la t eo ron odrollona· ( V. IIIUin r Ztll d . ll'len. med. Preue. 1901 e Deuls. milil<ir1a rl:. Ztils 1901.
D elorme (il quale sostiene che il proiettile , animato da una forz a vive\ -elevata, produce effetti in distanza per quella. che egli chiama attriz ione indiretta , s ia alla manier a di Bornhau pt (il q ua. le fa. dipendere gli effetti esplosi vi dall'azione di cuneo che ese r cì te rebbe il proiettil<l), possa dar rag i one dei fdnomeni esplosivi in tutti quei casi nei quali fanno difetto le condizioni fisiche per la p r ess ione id r aulica o, meglio, idrodinamica, Del r esto. an ch e la teoria delle onde oscillanti del Kohler, e quella delle ·vibra;; ioni molecolad del Ca,s cino, spoglie di tutte le dottrinali onde sono circondate, come pure la teoria, più semplice, dello sposta me nto mo lecolm·e del Bonomo, si p ossono, a mio a vviso, rannodare alla teoria d ella. pe1·cussione; la quale, in sosta.nza., fa derivare le alterazioni esplosi ve dall'et:: ione laterale del proiettile, ossia, con a l t r e parole, dalla risultante della forza viva onde il proiettile è animato, e delle specia li condizioni fisiche favorevoli del bersaglio-
U na questione di molta import anza è: se i proiettili di piccolo calibro producono effe tt i esplosivi più gravi o m eno, d ei proiettili di m edio calibro.
Teoricamente, se si considera il magg ioT volume e la maggiore deformabilità dei proi ettili di medio calibro non incamiciati, >'Ì dovrebb e d ire ch e le alterazioni in distanza, che essi cagionavano, avesse ro una. gravezza maggio r e di quella delle alterazioni der ivanti dall'azione esplosiva degli at t uali proiettili di piccolo cali bro ed a mantello. Ma, d 'alt ra parte, la velocità. più elevata e la forz a viva più intensa compensano. seco ndo t.aluni, la minore d efo r mabilità e la più ristretta s n pe rfi cie di sezione trasversa le nei proiettili di piccclo calibro; e qu indi razione esplosiva da essi esercitata, sarebbe eguale o maggiore e s i estenderebbe a più grandi distanze, di quella dei proiettili di medio calib ro e di solo piombo.
Dalle prove manometriche di co nfronto, fatte dal dal Gori, da l Bruns, pare sia risulta to che i proie t t ili di piccol o calibro spieghino una pre,;sioue idrodinamica. minore d i quella deri vante dai proiettili anr.ichi. Bruns trovò che la pallottola di 11 millimetri n on d efù r mata, ese r cita. una p r essione doppia di quella che pu ò dare la pallottola d i 8 millimetri se si deforma: la di fferenza cresce in ragio n e de l grado della defo rmazione.
I primi espe rim enti praticati con cariche r idotte da Cha.uvel e Nimie r, Bruos ed altri, confermarono i risultati delle prove manometriche. Ed il Kocher, in seguito a d una lunga serie di tiri su diversi ben;agli e con diversi pro iettili, ed a numerose misurazioni fatte col manometro ed an che co n uno speèiale apparecchio (Stauchappa1·at)
inYentato dal tecnico Schenke r , venne alla conclusio ne chela maggi or e

'206 SUI,T}AZIO;:\E DEGLI
A'ITUAI,I FUCILI D.l. GUERRA
Yelocità non vale a cou trabbilancia. re la minore massa ed il minore \'Oi ume dei m oderni proiettili, e perciò ques t i sviluppano un'azio ne esplosi va se mpre meno intensa, anche con una. ve locità molto più e le· \·ata ( l ' . I n o ltre. da. alcune prove fatte col fucil e nord·americano di millimetri 7,5, con quello russo di pari calibro e col fuè ile inglese Lee :\Ietford di millimetri 7,7, nonchè dalle osser vazioni raccolta nella campagna del Chit.ral, e n elle guerre c ino·giapponese, ispa no-americana ed anglo boe r a, parrebbe confermato che r ealmente i proiettili dei fucili di piccolo calibro spieghino un'azione es plosiva più debole, in c on fronto dei proiettili di piombo molle e di medio calibro.
Convi e n e, pero, tener conto di un'altra serie di fatti, i quali con· dur reb be ro a d una conclus ione a :fatto opposta . N e a ccen n o i principali. D el orme e notarono, nei loro esperimenti con cariche r ir!otte, che la z ona es plosiva de l p roiettile Lebel di 8 mt llimetri era più e,;te,;a d i quella de l proi ettile Gras di 11 millime t r i, e gli effetti e rano più g ravi, specie nel le diafisi delle ossa l un g he. I noltro, n e i piccoli ?.con tri av ven uti a brevissima distanza a Btala ed a. Niirsc ba n in Au:>tria , fu r ono osse r vate alte razioni assai r ilevant i, secoudoche riferinmo B ogd anik ed Habart, per l'azion e esplosiva s pieg a t a dal proiet · tile de l' fucile Man nlicher di 8 millimetri; ed an c he n e lla guerra del Chili si ebbero les ioni più g ra v i p er l'azione esplos iYa d ello stesso proiettile Manulic her, c he p er quella di proiet tili di maggior calibro. lntine le nume ro:>e e ben n ote esperi e nze i n stituite da v. Colar e S..:hjern ing ( 2) col proiettil e di millimetri 8,1 del fucile tedesco modt>llo 18S:i ed an che co n proiettili di altri f u cili di vario cali b r o, e '1Uelle di Demosthen col proietti le d el f uc ile Mann licher rum eno di md li metri 6 .5 (:i) riv elarono se m p r e le p iù estese e caratteristiche alte razi o n i in tutte la part i soggette alla pre:;sione idrod inamica. Ed Habart. più tardi, t irando sugli a nimali vi vi cou proiettil i di H, di 6,5 e di 5 millimetri, dice no tato che quest i ntt.i mi s piegavano una az•o ne esplosiva maggiore che non i primi ( 4 ) .
Parrebbe, dunque, poter dedu r re da quesfaltra serie di esperimenti
os s e rvazi ou i, che n egli attua l i proiett i l 'influenza nl'yatica della ·lim inuzione de l calibro su ll'az io ne es plosiva. sia non soltanto co rapeuma sopravau7.ata. da quella positiva dell'aumen to d ella velocità.
111 1\oCHHR. - Zur L tltrt vm1 dw Schu&>rnwdell lu>·cfl l\ leìnkaliber yuclto5•e 1895.
In.- J)le l'erbPUtruug dtr Guclwue v. Slundpunklt d. //1"n cuulul. - (Alli doli ' X l Congresso merlico lnterna>.lonnl•·. Vo l. \ n oma. 189:i)

l ! r e n un d :'CIUP.H:OCISG. - l"eber d1 e IVirk lm{lllnd Kl'ieg!<harurg l <cl<r 1/(cltu l uw, de•· ntuen u,,,d(tu"trafftn. IJt a,.,,tilf l " n" dtr au l' rraus•schell /\l'irys-.lh llio l cri11m 5
flt>rhn , ! 891.
1J1 - l .oco cii.
1 l lluuT. - 1\le incn liber 1111d J..rieg•- 4•tl,li/;, \\'ic n un<1 l. ei p1. ig. 1890.
F: S I'EC IAL.Idf:STE DEl, FUCILE lTALl.\XO DI Plf'COLO C t\LIDRO. E CC 20i
Su questa question e i miei pochi espe rim e nti h anno forni to, se non m'inganno, un contribut o di qualche valore.
Os.M. denudale e 1'i veslile di padi tllOlli. - Cosi i t iri sui orani rives ti t i o d e nudati delle parti molli esterne e s ulle ossa lunghe degli arti, come 'quelli sugli animal i vi\·i, mostra r o n o, con su ffi cien te chiarezza, che g li efl'etti esplosivi prodotti dal fuc ile di millimetri 6,5 e rano sensibilmente meno intensi in confronto di que lli de l fucile Vet· terli di millimetri 10,35, non solo; ma che anche quest"ultimo fucil e ca g i o n ava. alle brevi distanze, alterazioni più gravi, fJUando era ado· pa rata la cartuccia d el proiettile non incamiciato e con ca ri ca di polvere n era , aozichò la cartuccia mod. 18 90 col proie ttile a mantello di otton e e con cari ca di balistite, quantunque la velocità. di questo proiettile foss e molto maggi(ore ( V. figure relative).
Silfatti nsultati trovano una ben chiara conferma in quelli otten u t i n egli esperimenti sulle cas;;ette metalliche; i quali esperi menti, co me fu g ià notato, provarono altresì che gli effetti esplosi vi del proiettile di millimetri G,5, pure essendo un poco meno gravi, continuano a mani· festa.rsi, sebbene molto attenuati, a distanze più grandi, che qnelli del pro iettile di millimetri

I tiri sulle o3sa lunghe, fresche e co nfe rm a ron o le os· ser vazioni del Kocher relativamente all'az io n e esplosiva. dei proiettili delle mod erne armi portatili, anche ind ipendenteme nte dalla pressione idrodinamica. Infatti, n(!i col pi diafisari delle ossa disse cca te, col canale midollare vuoto, si ebbero fratture co mminu t ive a. schegge molte plici, parecchie delle quali d islocate p e r etl'elto della cosi det ta pression e secca (troc h ene P1·esRzmg). Ma le schegge furono sempre meno numerose, più grosse, meno proiettate in distanza, ed i focola i di frattu r<l. più limi tati in estensione, che nelle ossa fresche col canal e midollare ripieno de l suo contenuto normale (V. figure 38' e 39'); il che è in p erfetta armonia col r isul t ato delle prove fatte s ulle cassette metalliche rie mpite di pezzetti di marmo e di ciottoli.
Gli stessi tiri sulle ossa tnbulari e quelli sugli arti rives t i t i di parti molli mos trarono pure, in modo evidente, la differ e nza. degli efì'etti nella parte meta(ìsm·ia ed in quella. in con fronto colle al te razioni diafisa rie. Nella metafìsi si ebbero, bensi, fori e t ragitti contornati do. f es· sure e da scheggiamenti, ma non estese fratture comminutive; e nelle epifisi si ebbe ro quasi sempre forami e t rag it t i n etti e regolari. d i rado
a. co ntorni frastagliati e scheg giati. Parimen te n elle ossa. piatte de l c ranio vuoto e del bacino produssero perforazioni ti piche, di tor ma. circo lare od e lli tt ica, ed a contorni quasi sempre n etti ; solo nei colpi tange nziali o di rimbalzo si verificarono l esioni irregolari, a forma di
:208 St:LL'AZIONE DEGI.I ATTUALI F t.:C ll.l 1), \ OUJ,;t{R \
' . . l .... ..:.,., . ' .... . ' .. '•' l' .,
fenditu re con perdita d i od a for ma r otondrggiaute co n conto r ni scbeggiati.
Tessuti molli e m·gtt1L i ctwi tm·i. - Non meno importanti e uaratte risticbe fu r ono le lc·sioni osse rvate nei te;;sut.i molli e organi

c u te, t r a n ne pe r colpi tangr n zia.li e di rimbalzo, si ebbero sem pre fori d' entrata r egola r i , a s,;;ai più piccoli rl··lle dimensioni della sPzioue trasversale d e l p r oietti le, e cir co ndati da ana zo na n er astra più o meno ap pariscente. I nvece, i fo r i d'uscita, d'ordinario andr' essi regola r i e poco più g ran di della sezion e trasve r;;al e de lla pallotto la, talora. an che più p iccoli , assu nse r o sovente prvpo rzion i enormi, flllando il proiettil e a veva f ra tturato commin u tiva me n te nu osso. I n t al i cas i, p e r lo più, a.ll 'ori fi cio d'ent ra t a , de lla for ma e dimensioni abituali, seguiva un largo c an al e conico, opp u r e, ma ss i me nei colpi co l pr oiet.ti le di m illimetri 1 0,35, una vas t a escavaz ion e c ircosc r itta da tessuti lace ri, spa ppolati, ed n n fo ro d ' uscita irregolarmente ci ncì:whia to, di p i ù cenLimet ri di di a metro, co n larghi l am b ì mu scolari sporgenti, tendini d e nuda t i e pe ndenti a l di fuo r i, e eo n to rna to da le mbi cutanei scoll ,,ti e d eccbimo cici: p icc ole prÌ\'e di periostio e polvere ossea cos pa r gevano, co me s ì è det.to, tutti f1uesti tessuti in siffatta guisa a lterati .
Nei col pi sul cra nio i guaiti del le pa.r t 1 molli furono a ncor a p iù Sopra tut.to, pe r effetto del proiet.tile di mi llimetri 10,:35, >i verificarono e no r mi lace ra.z ioni co n g rossi le m bi cutanei ir rego la r i, p.:nrle nt.i, e con s papp olament.o, fuo r uscita e proiezione della s osta n za. cere brale a. piu metr i di distanza
I nfine. r ispet. to alle le:iion i viscerali, le mie poche osser va zioni di ferite del pDltll tote d i!fer iscono notevol mente da q nelle del Dt- mosthen ( l ); inqua ntochè, ne i cani v i vi r isco nt rai a l terazioni.po l mo n ari molto m e n o gravi rli ot.tennLo dal lJemosthen n ei cavalli. Sia col p r oietti l e di mi ll imetr i 6,5, sia uon que llo di mill i mE>tri 10}35, alla distan za di 300m. si ebbe r o t ragit.ti rego la r i, a paret i liscie, di forma f)H as i cilin· drica, d i d imansio ni m in ori della. sezi one del p ro iettile, e circo nd a ti da una lim itata i nfil t ra zione s an gui gna del le:>suto pol monare, sen za a pp r ezza b ili tra-.:ce d i effett i es plosivi; for i d 'entrata. al'IRlnto pi ù piccoli d i CJII e lli d ' uscita; poca q u a nt ità di sang u e n el cavo pleurale . Il c;twr·e, co lpi to in di asto le i n entra m bi g li a nima l i in cui ebbero l esio ni di CJnes t'orga n o, prese nt ò m olto appari scen t i gli effetti e,.plos ivi, rappresen tat i da largh i forami d 'uscita, a contorn i irregola ri. cmcischiat i ed a. lem bi estroliessi, e da lacerazion i e fessu re ste!late,
111 Dlli•JSTII":< - l. vco C>l.
Il - Gionwu med ico.
E 1,:\1E XTE DI:: L f'CCJI,f': l'l'A D I Pl CC!! l.() C'A I.IU IUl. !-:C ' C. !.!()!)
pa.1·tenti cl ai forami stessi; ciò specialmente n el cuore colpito dal pro · iettile di millimet ri 10,35. (V. fig. 4 5' e 47' ).

S ono d e.l pari degne di nota le l esioni degli organi addom inali. Nel {egalo il proiettile d i millimet ri 10, 35 produsse una larg a. perforazion i:' con molteplici f e nd iture a. forma stellata in corrispond enza. del foro d'en trata, ed un'estesa. perdita di sostanza, circondata da una larga zona di spappolamento del pa re n chi ma, al posto del fo r o d'uscita. Col proiet· ti le di millimetri 6,5 si ebbero alterazio ni p oco dissi mili : or ifiaio d 'ent ra ta rotondeggian te, frastagliato, non mol to ampio; tragitto imbutiforme , e foro d'uscita as:;a.i a mpio e circondato da un'es t e sa 7.ona di s pappolament o. In complesso, effetti di scoppio in ambidue gli esperimenti; un poco più limi t a ti col proiettile di piccolo cal ibro. Nella miba colpita dal proiettile di medio calibro, i fenomeni esplosivi si me.ni festarono pa.rimente cl)n aperture. d'entra tn contornata da fessure , co n t ragitto imbu t iforme e co n ori ficio d'u s0ita largo, irrego lare e c irco ndato d11. tessuto spappolato.
Finalmente, n e llo sto"wco e nell'intestino s i ott enn Ci ro, coll'uno e co ll"altro proietti le, perforazioni complete, con orifìci d' e n t rata pressochè u g uali alla sezione trasversale d ei proietti li, eù a conto r ni frastagliati , e oou orifici d'usc ita più ampi. più irrego lari , più c incischiati, talora rappresentati d a la rghe lacerazioni: nelle fe ri t.e in testinali fLt :;em pre osse rvata, specie in corris p ondenza dei foram i d'us cita, una perdita d i sostanza minore nella mucosa che n elle altre t uni c he, con teude nza a. fa r ernia. N e l cane colpi to dal proie tti le di millimetri 6,5, furono tro v ate tre anse inte:;tinali pertomte dalla ;;te;;sa pallottola ; i n quello colpito d al proiettile di millimetri 10,35, furono trov ate quattro perforazio ni. Emerge n cttmnenlP da lttlfo ciu, che f zwo c·ome l't 1 lwo p1·oietti l e JW01Tucono, nel/n delle b1·evi distanze, te più g1·ani al/era::ioni, come accennaro in nan :.:i, il picco lo calib1·o detenniwr t'ffì:lli espios i ri un J?CICO più lil)zitati .
CAP ITOLO V.
Azi one vulnerante degli attuali proiettili di piccolo calibro, in general e .
Ed ora, prima di ve nire alle co nclusio ni , che, a mio parere, si p otrebbero t rarre dagli studi sperimentali d i cu i ho fatto parola, no n sarà inopportuno porre anche !). ui il qu esito: le model'lle at ·mi a (t(Ot:'J p ortatili drt g ue1-ra hanno n n: a.= ione vulnf''ante maggio1·e o minore d i quella , Ielle stesse m·mi priMn in uso negli esf';•cit U Con altre parole: i p1·oiellili dell e m ·mi n/Inali drr fanlet· io, ,ne,·i tano r e;·ameHle la qunfi-
2HJ RUJ.L' AZTO:\E DF.OI.I ATTU \I.I Fl:Cif,l DA
; ,.,. .· : ..... . ' .r: ...
fir·a; ione data ad essi da B nms e ripet uta oggi da m olti, di proiettili umanitari ?
E sporrò in breve i miei modesti apprezzame n ti fondandomi, piucchè stud io t eo rico dell'agi tata. questione, sui fatti raccolti uei nume · e svaria ti e3perimenti , e, sopratutto, nei c ampi di battaglit1. delle ultime guerre.
S e si prendono in le qualità. balisti co-din arui che deg li attuali f uci li di piccolo calibro, in confron t o con quelle delle armi d a inoco portatili prima in uso, si è tratti ad at t ribuire ai primi un'azione vulnera nte assai maggiore.
E per f e rmo, la vel ocita i nizùtle da 400 - 450 m etri è salita a 700-740, e. nei minimi c alibri, a 1000 metri e più ; le telocità 1·esidue, uaturaJ. mente più elevate, si mante ngono, in prop nrzi o n e, pi it alte alle grandi dis tanze, che non n ei proiettili di medio calihro ; la. ve locità di ?'ola;ione è piucchè triplicata (da 700-800 girii al m " , a 2600-3600) : è au mentata anche la (01·za v i ca, ( F :=. 1\f X :) giacchè, sebbene sia dimin uita la massa della pallottola, è cresciuta in maggiore propo rzion e ia ve locità; il coe((icienl e di e quas1 triplicato .

Inoltr e, la (cn·za d i peneb·a;ione è molto maggiore che nei medi calibr i . an che quando sia r e lati\·amente i n dife t to la forza viva; dap·
il bisog n o della forza vi va per ottenere effetti di penetra zione eguali, dimi nuisce in ragione dell a diminuzione de l diametro. La forma !JOi degli attuali proiettili, la loro du r ezza e minore defo r mabilità. e l'a umentata velocità di rotazione, co ncorrouo efficacemente a manteIJere più intensa la fo r za. di pen etrazioue.
La gillalrt delle nu o ve armi è di ci r ca un t e rzo maggiore per il fucile -li 8 millimetri, e pe r quelli d i minimo calibro e più che raddopp iata, potendo sor passare, nel c alibri in fe riori ai 6 m illimetri , i .jOOQ met r i. n proiettile di millimetri G, 5, in grazia de l suo piccolo diametro, si cal co la. cÌJe avrà d 'u0p0 di sol i 2,500 a 3 chi logra mmetri di forz a vi\·a , e di una r>!locita r es idua. di 70-75 m etri, per poter m ett e re un u omo fuori com ba t· ti mento; Je quali condizioni eo rrispondo u o ad una distanza. di flllliSÌ 5000 oetri. La t.raiettoria è molto più cosicchè lo spaz io battuto '!estend e sino a 500-600 metri. E la 1·upidità del ti1·o ò più c he q ua·lruplic a t a. colle armi a rip e tizione in uso; ma coi fucili a cari camento auto ma ti co può raggiunger e i 100. 120 colpì al m inu to. f: v e ro che i •:olpi ef ficaci non procedono in guerra, in r agio n e d e l numero dei ti r ati iu una d ata unità. d i temp o; ma una fitta grandine di palle, >.:aglia.te in breve ora contro le m asse n e miche, non puù mancare di pro:lurvi effetti d isastros i, 11 uand ·anoh e le palle ohe col p:sco no n o n su-
DEL FUCILE DI PICC OLO CALJBUO, ECC.
perino, o n on ra ggiungano, co me alcuni vorrebbero, la pro porzione stabili t a dal W ol ozkoi, d el O, 25 p er 100.
Infin e, se i moderni proiettili in crtm ic iat i sono meno defo rm abili, le loro d efo rmazioni e fragmentazioni riescono più d annose, perchè i piccoli peni ac nti e ta g li e nti del m etatlo di rivestim e nto s'insinuano nei teils uti fer endo vasi e n e rvi, e p e netrandovi in modo, che ne è estremamente di fficile la ricerca e l'es t razione. Anche la maggiore facilità d i d e viazione, cui il pro ie ttile allunga t o può andare incontro, i n fluisce ril evan t emente sulla s ua az ione vnl nera&te; poichè battendo di traYerso, proò uc:e bensì d e lle lesi o ni m eno profond e , ma più es tese e più irregolari, e p er ciò più gravi.
A con f t•rma d elle particolarità. or ora ricordat e, rip or to nello s pecchio seguente (pag. i principali dati balisti ci di co nfronto f r a il fu cile prima in u so e q u ello al p r esente adot t ato in taluni eserciti.
La conc lusion e derivante dalla rapida disamina che abbiamo fatta , si è ch e la potenza b ali s ti ca delle armi da fuoco portatili attuali è maggiore di q u e lla de lle corrispondenti armi prima in dotazione negl i es er· citi. Parrebbe, anzi, che tale potenza aumentasse col diminuire del calibro; tantoch è un compet en tissimo tecnico, l'Heb ler, giunse a dire che il p roiett ile di 5 millimetri è q uasi tre volte superiore 11. que-ll o di 8 millimetri.
Ma il potere v ulneran t e d el proiettile non proviene solo dalle qua· lità balist tche dell' arma ; dipende altresì, e molto, dall e qualità fisich e del proiettile stesso, e segnatamente da l suo volume, dal suo peso, dalla sua forma, dai punti di contatto che ha coll'ogge tto colpito. Se f0sse altrimenti , uu piccolo spill o, lanciato contr o il corpo •;.mano con una velocità s t raord inaria, dovrebbe po t er produr r e l esioni più g ravi di un colpo di coltello, t irato con assai minor e violenza. Ecco perchè , p er quant o s ias istudiato intorao al così d e tto fucile d ell'a vve nire, non si è rius c iti a s tabilire q ual e p ossa e debba essere il mi nimo calibro a ccet· tabile.
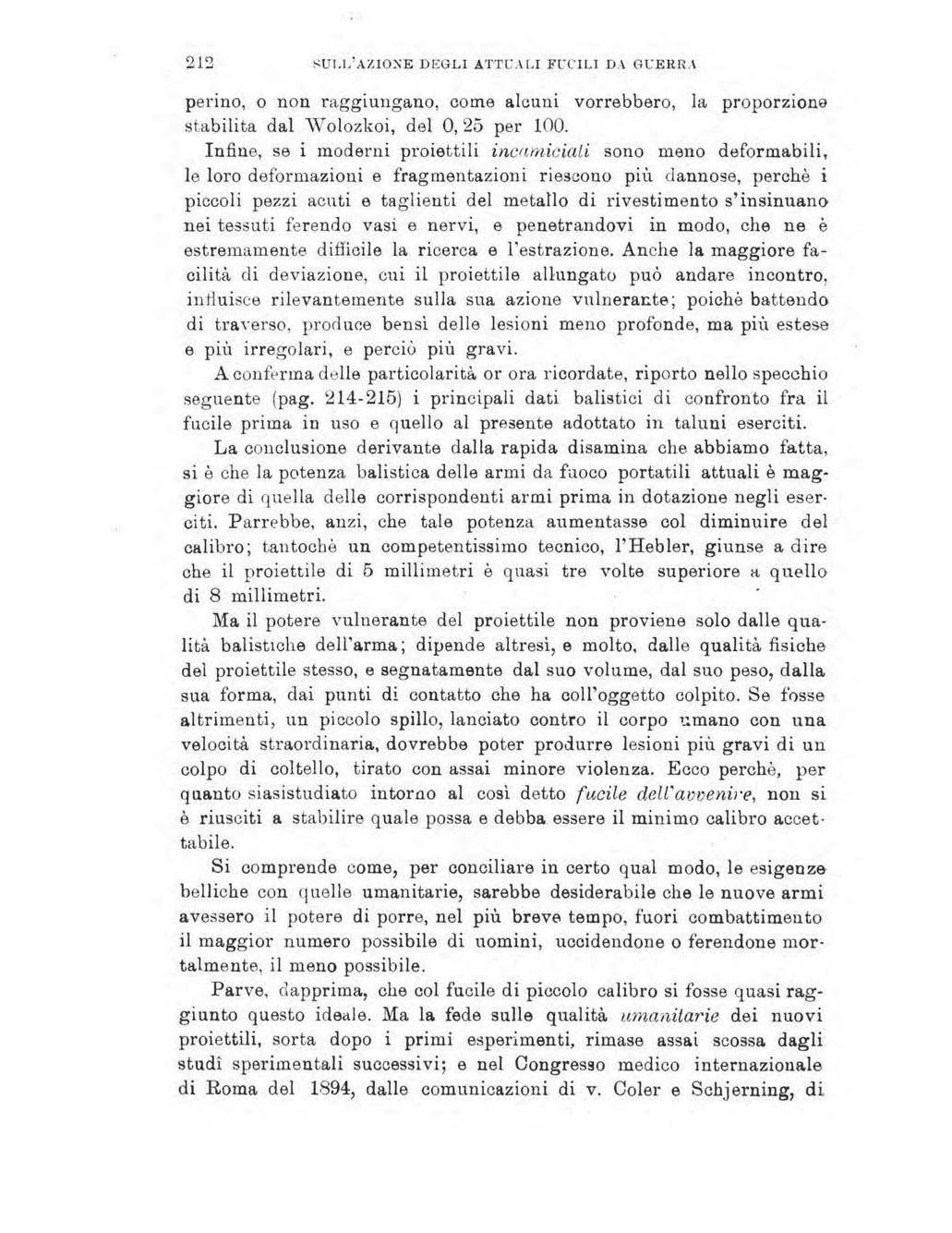
Si co mprende c ome, per conciliare in certo qual modo, le esigenze b elliche co n q u elle umanitarie, sarebbe desiderabile che le nuove armi avessero il potere di porre, nel più tempo, fuori combattimento il maggior numero p ossibile di uomini, uccidendone o ferendone mortalme nte, i l meno possibile.
Parve, da pprima, che co l fucil e di piccolo calib ro si foss e quasi raggiunt<> ques to ideale. Ma la fede sulle qualità umanitarie dei nuovi proie ttili, sor t a dopo i primi esperimenti, rimase assai dagli st udi s perime ntali successivi; e nel Congresso m edico internazionale d i Roma del 18 94, dalle comunicazioni di v. Col ar e Scbjerning, d i
213 :-;Ul.I 'AZI O.:\E DI::GLI A'l'Tt:.\1 1 FCC' ILl D \ O l: ERR \
Demosthen, di Ha.bart, di Tosi, di \Verner, parve derivare questa conclusione: l'azione t:t&lne?'ante delle nitOre w·;,ti e supe1'Ì01'C a fjttella delle
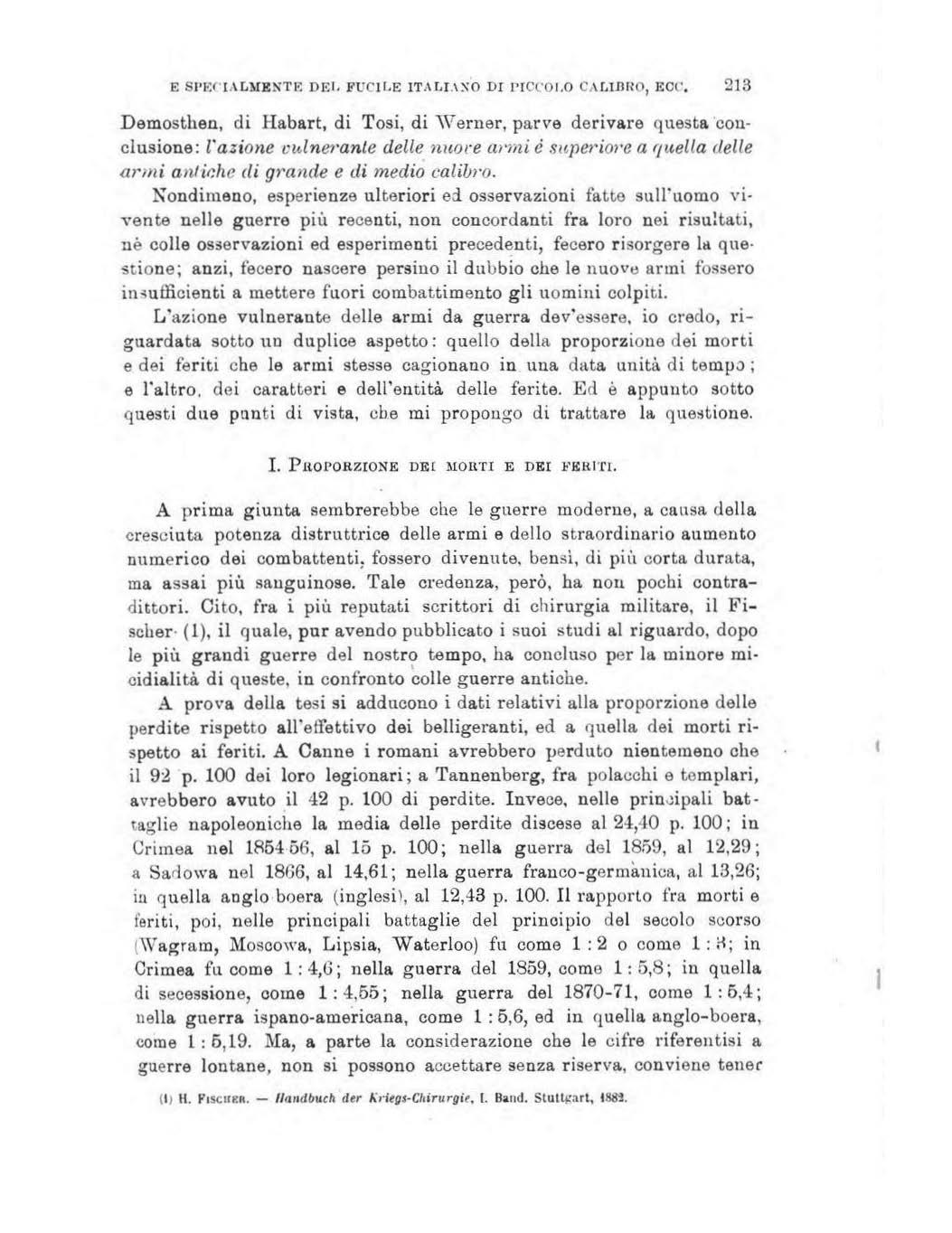
i anf ir:he di gra,tde e di medio calibro.
Nondimeno, esperienze ult:.erior i ed osservazioni fatto sull"uomo vi\'ente nelle gue rre più re ce nti, non concordanti fra loro nei risu!tali, nè colle osse rvazioni ed esperimenti precedent:.i, fecero risorgere la que· stion e; anzi, fecero nascere persino il du bb io che le anni fossero a mettere fuori combattimento gli uomini colpir.i.
L 'az io ne vulnerante delle a rmi da guerra dev'essere. io cl'edo, riguardata sotto un duplice aspetto: quello della proporzione dei m o rti e dei feriti che le armi stesse cagionano in una da.t:.a. unità di tempo; e l'altro. dei caratteri e dell'entità delle ferite. Ed è appunto sotto qu esti due p unti di vista, che mi propongo di trattare la que:ltione.
I. PaoPo&zroNE DEr MonTI E DEI -"'EHITL
A prima giunta. sembrerebbe che le guerre moderne, a causa della cresciuta p otenza distruttrice delle armi e dello st:.raordinal'io aumento nume r ico dei combattent:.i; fossero divenute. bensì, di più corta durata, ma a ssai più sanguinose. Tale credenza, però, ba n ou poc hi contraditto ri. Cito, fra i più r ep ntat:. i scrittori di chirurgia militare, il Fiscber · (l), il quale, pur avendo pubblicato i suoi stud i al riguardo, dopo le più grandi gue rre del nos t r o tempo. ba concluso per la. micidialit:.à di queste, in confr onto colle guerre anti che.
A pro,·a della tesi si adducono i dati r elat ivi alla. proporzione delle perdite rispetto all'effettivo dei belligeranti, ed a. c]uella dei morti ris petto ai feriti. A Canne i romani avrebbero perduto nien temeno che il p. 100 de i lo r o l egionari; a Tannenberg, fra polacchi e tomplari, a vreb bero avuto il 42 p. 100 di perdite. Invece, nelle prinJ ipa.li battag lie napoleoniche la. media. delle perdite discese al 24,40 p. 100 ; in Crimea nel 1854 56, al 15 p. 100; nella gue rra d el 1859, al 12 ,29; a Sarlowa nel 18G6, al 14,61; n e lla guerra. franco-g ermanica, al 13,26; iu q uella anglo boera. ( inglesi), al 12, 43 p. 100 l! rapp orto fra m orti e feri ti, po i , nelle principali battaglie del principio de l secolo scorso (Wagram, Moscowa, Lips ia, Waterloo) fu come l : 2 o come l: H; in Crimea fu come l: 4,(); nella gue r ra del 1859, come l : 5,8; in quella di secession e, come l: 4.55; nella guerra del 1870- 7 1, come l: 5 ,4 ; nella. guer r a ispano·americana, come l : 5,6, ed in quella anglo-boera, come L : 5,19. Ma, a parte la considerazione che le cifre riferentisi a guerre lo n tane, non si possono accettare senza riserva, co n viene tener
E S I'Jo:( l.\ LMKNTIO: DEl. Ft!CI LE !T.\ LJ.\ :\O Df l'fC("OJ.O C\ L1DR01 E Cl'. 213
11 1
H. PcscueR. - 1/audbuch dtr l.l"iegs·Cliirurgit. l. Band. Slut 4:art, 188i.

Su LL 'AZI Olo:E DEGLI ATTU. ILI FOCHA D.\ OU ERRA compa r o th e ra·a Il f ocll r a n li tt • S T A T l li O D E L l. l D E l F Ul: IL l Cali bro Lu n- l.unghezu (:lhP7Za Pe-o In 111 l mm. mm. CAJchri :!r. l lT'tr ndl 1867-73 . ) Antico 11.- 25.7 :! :3 :1-I. UU A n s tria Mode r n o Jlannl •cker l S88 -90 t! .- 81. 8 4. () l i>.81 ' l \ Antico Gras 1874 11. - i i.5 Frnnci n. . ì Moderno Lebel l 886. 8 - JU.OO 3.8 15.00 l l Antico M auur 1b7 l 11.- :li3.G \! .li Ge rm:tnla . / Mod e r no Mauur 1888-91 i.9 30.8 3.8 14 \i! l I ngh ilte rr a A ntico ilfartìni-Henry 18 71. 11.4 3 30.0 :! .'7 3l. ltl :.loderno 1889 . l '·l 3:l. 1 4 .l Antico Vetterl t- Vttali 1870 · Si. ·l 10 35 2 4 .00 :.'.5 l". (1\1 Italia Mode rn o A'rag-JiJrgensen mori. 18!)1 6.5 30 .5 4."; 10.;,•· t :\ntico B erda11 n. l e 2-1871 111.66 2ll.li5 2 24.]11 lll odernr• M o$fn 1891 7.62 30.5 l .li 13."";11 f-:tati Uniti dell'\ · l A n ti co 1Ri 3 11 :15 26.25 :1.3 23.:- \! meri ca del Ko rd. 1 Mode rn o Spritlg fiel d l 892 'i.(i 32.00 ..J. Il H .2:l Spqgna An tico Remi11glon 1fl6i - il 11.- :!L) :!.5 •25 111 Mo de rn o ltfa t' Ur 1892. 7. - 30.9 ' L a l 1.:2 2 l A nti co Vctter li l 867-71 IO .'l :24 .21 :! :J 20. I H ' vizz e ra . i Mo der no Rubin·Sch ,;lidt 1889 -!1(; . 7 .5 30.:3 1.0 13 .H l l l Antico ll(artl"tl i Henl'!f l Sil. Il .43 !10.() 2 .'7 31.] 0 Rumaniu ., Mode rn o Ma n nlichtr 1892 6 " :n.2 4 ,1-< l u .:3:! .i) 111 La ' 'elor. ta d• rotaJ.1one dei proie ttili antichi tl<··ilb'a fr:t i OO ed 800 )liri a l m " - J.a m a. im
"' rruollo model'uo di taluul
P ROIETTILE QUALIT \' DALlSTICO-Dli'iAM ICilE

E S PEC!At.m:::'i'l'E Dt,;L Ft;CILK ll'.ILIA:'iO DI PICCOLO C \LIBRO, ECC'. 215
Cot ffi· l Vel ueita Forza \'clocatà c • te l Gittata t h CO liPu <nao:n: in iziale iur11alt! rolJ7.100C l'fei,IOOe ffi!b>llnl\ l 1 luiT.Iale m (i l m. 11irl 111 P io mbo. 450
2.3u3 Id rin•sli to d 'acciaio u2o 309.5i>i u.1ss l Prorubo 450 .lì:> HIS 2.t>IO Id. riv. di maillcchort . ol O 344.192 :lt.i:!i u.sn Piombo 44;) 251. 4!11 2.'JS:2 Id. riv d'ac ciaio nichela t o u40 28tl.Oll l :!ulio :>.Si5 38UO l'aomllo Ilo ;L 4 5 4 ' l d. ri1·, di maillechort. 1)30 :l"2U.1 0 :!li:> 13. 038 2\JfJO Id. ri ,.. d i ottone u l5 2 14. 002 i l 2 2. i -19 2;)50 Id. rn· di mall lccho rt ilO 2u2.12 ' ;j;)\)U 'I.'J26 3200 P 10m b o 440 :2.t>i2 Id. rh. di mail lecho rt. t.i43 :lil.uou :!tiSO :>.!1";1! Ptombo Il:! 2ii2.";;);) Id riv. di mailleebort tiiO 2t):l ,4 % l'io)IDUO 4:23 I d. riv. di acciaio ni cbela t o 6!)0 :Il l. \)(l 331:) ; .luu 1000 Piombo. ·135 l d.. riv ùi acciaio alla puota li:lO 2ti!l. 00 2:Ji0 0.6\ll :WOO l'iombo .Jiu Id. r i v. di acciaio e ma!llecbor t 740 :!8t:UO :16ù0 8.031 3600 1 ,• r •HC ilrl • tla 1110 Ilo ca hhro v-caii:I\J. in mtoruo m.
l
conto delle molteplici vicende, le quali, indipen dentemente da ll'azione vulnerante delle armi. valgono a far •ariare. e di molto, la. proporzione delle perdite . p oi alla mortalità., vi esercitare un· influenza non di poco momento, talune circostanze che i o direi estrinseche, e sopra tutto r insufficiente o inadeguato o ritardato soccorso: c1uanti f eriti, non gravissimi, sono morti sul campo unicamente per tale deplorevole circostanza? Sotto questo rispetto, oggi è scC' mata., e scemenì. più ancora in avvenire, non solo la mortalità consecuti ,.a (la quale dal 29 p. 100 in Crimea, discese a.ll'll p. 100 nella guerra franco-germanica ed ancora di più nelle gnerre successive ), ma altresi la mortalità immediata sul campo stesso di battaglia; e ciò, in grazia del sempr e più perfezionato funziona mento del servizio sanitario in campagna, e dei progressi della tecnica curativa.
Un esame, anche poco profondo, delle percentuali delle perdite nelle Yarie guerre e nelle varie battaglie, mostra come le medie abbiA.no tanto ma.ggior valo re; sotto il punto di vista dell'azione vnlneraute ùelle armi, quanto 'meno so no comprensive. Bisognerebbe, quindi, poter :>empre ragguagliare le perdite (morti e feriti) alla forza. effettivamente impegnata. nei singoli combattimenti, e tener conto altresì della durata di questi o, meglio, del numero delle cartucce sparate.
La proporzione delle perdite stabilita dal RaYaton, al tempo dello gue rre napol eoniehe, del 10 al 12 p. 100 sul totale della forza effetti va., e anda ta incontro a. grandi sbalzi. specie nelle ultime guerre, a seconda delle condizioni fisiche e morali delle truppe, delle condizioni d e l terreno, delle armi e della tattica. della. posizione di offensiva o di difensiva dei belligeranti. E ciò, se nza. tene r conto delle guerre coloniali. nelle quali le o rd e combat tenti, semi-selvagge, si a vventano im· petuosa.mente sul nemico senza cootarlo e senza pensare agli delle 1\rmi moderne; o, d'altra p.ute, la. loro fero c ia le spinge ad uccidere anc he i prigioni eri o co loro che sono impotenti ad offendere. Egli è per f!neste circostanze speciali, che nolla. gue rra del Sudan, a Orndurman, le perdite dei rlervi'>ci salirono a circa il 60 p. 100; ( l ) e nella guerra. ita.Lo-abis;,ina, su circa 10,000 combattenti italiani ad Abba Cari ma, ne morirono 4316, ossia. più del 43 p. 100 (2).
Cito qualche esempio di guerre non coloniali.
A Sadowa, il 3 luglio 1866, prussiani ed austriaci erano in numero pressoobè eguale, circa 220,000 uomini, da ciascuna parte; eppure, le perdite degli austriaci asce:iero all' ll p. 100, mentre qnelle dei prus·
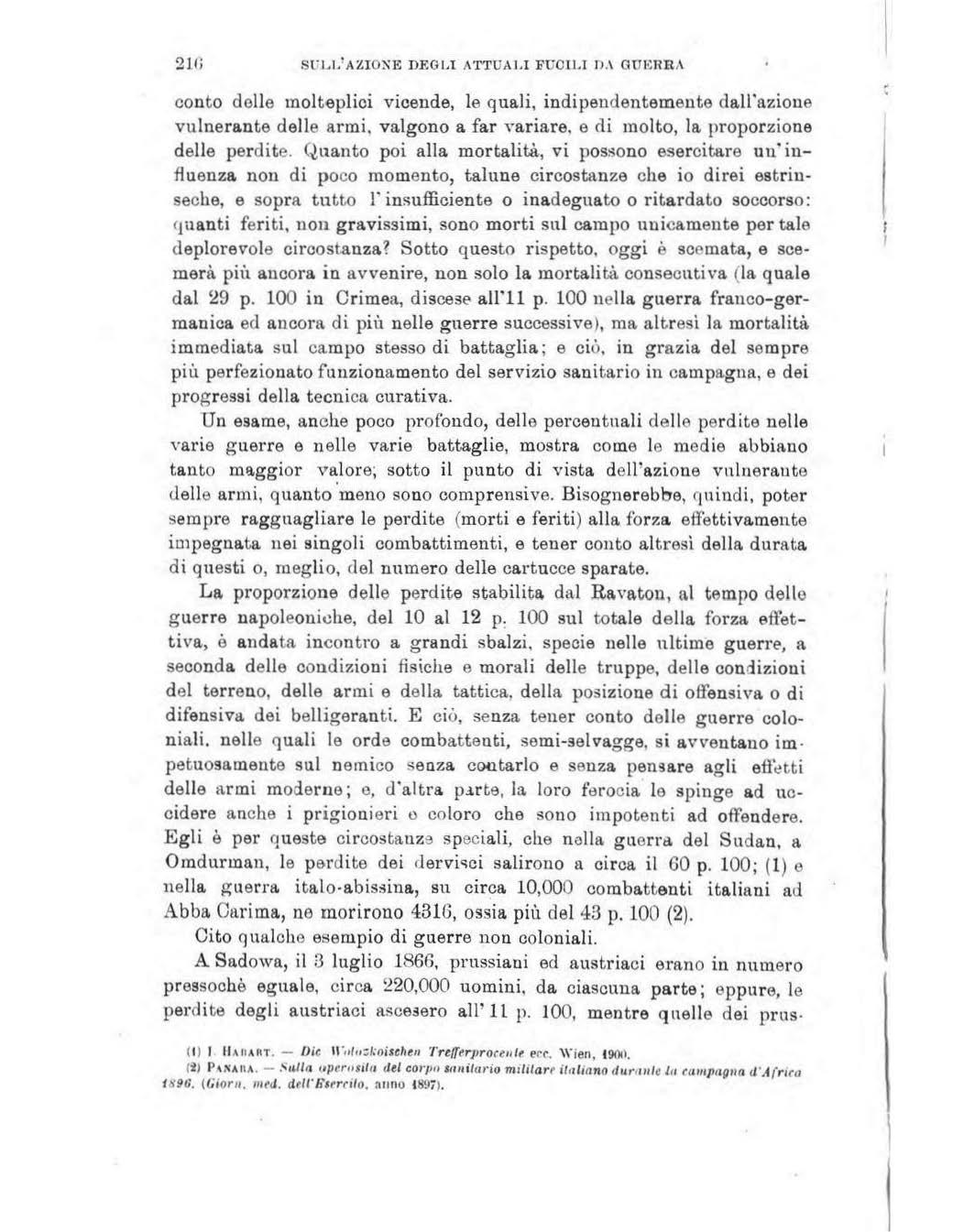
( l) l IIAIIART - Dic Trefftrproa ulf er r W1en. 19()1.
tt l P•NAilA - ·'•41/a del cOI'JI" stwllcu·io m1l1lar• 1/11l1nno d,,. ,,,,e 111 t <wlpngnn d ' A { rt w
( G1 0r11. m td dtl/'h'atrfiiO. aun o t 89i )
2W sn_.t."AZIO:\E DEGLI ATTUALI FCCII.l 0.\
siaui non superarono il4 p. lOO. Ma gli austriaci combaLtevauo coli"antico fucile Lorenz ad avancarica, ed i prussiani erano ar mati, di già, del fucile Droyse 1 a retr ccn.ri ca, col qua le potevano tirare cinque colpi mi· rati al minuto.
Nella campagna del 1870-71, !"esercito tedesco perdette il 10 p. 100 snl totale delle truppe mobilitate ( ll7,000 uomini, circa, fra feriti e morti s ul campo). Ebbene, solo le battaglie del primo mese della campagna costarono la metà. di tali perdite, le qual i caddero quasi per intiero sulla fanteria. Alla battaglia di R ezo nville-)lars-la.-Tour del l G agosto 1H70, le perdite dei tedeschi ascesero. in ore di fuo co , al 21 p. 100 dei combattenti; Ìn\·ece, il 18 a:;osto, alla. battaglia di Gravelotte-S. Privat, le perdite tede:iche non oltrepassarono il 18 p. 100. Ora, questa minore proporzi one di m orti e feriti, in confronto di qu e lla relativa alla battaglia di Rezonville, è la prova più eviden te della fallac ia delle medie fondate sul ragguaglio delle perdite colla forza numerica dei grandi riparti; dappoicbè la battaglia di Gravelotte, n g uarda ta. nei suoi particolari, ri su lta più sanguinosa di quella di Rezonville: la prima divisione d ella guardia, infatti, in sei o re di combattimento, perdette il 26,8 p. 100 e la seconda il 2 H,7 della forza impegnata nell,'azione; ed il solo at tacco di S. Pri,·at costò, in meno di tre Q"re, il 35 p. l ÙO di perdite alla fante ria che vi prese parte.

lh.a veniamo più direttamente alle perdite che possono cagiona re le auuali armi a e di piccolo c"libro.
Anche prescindendo dalle altre qualità. b&listico-dinamiche delle nuove armi. basta rigaardare la rapidità del tiro e la. radenza della t raiett oria, per esse re autorizzati ad ammettere ohe l& battaglie d' og· gidi debbano essere più micidiali e produ rre perdite ingenti in breve spa7.iO di tempo. Si è detto che il fucile a ripetizione ed il gran nu· mero di cartucce poste a disposizione del combattente, a nzichò giovare. a nebbero nociuto alla. efficacia del tiro di fronte al nemico. Il sol· dato, lasciato a. se stesso, si atfret terebbe a sparare non puntando o puntando male, e cosi le sue munizioni con poco o nessun risultato. Ma, a parte altre co nsiderazioni che qui fuori luogo, mi li mito a notare come la facilita di maneggio e la maggiore precisione dell'urma e, soprattutto, l'aumentata radenza della "traiettoria valgano a correggere ad esuberanza l' inconveniente suaccennato. E per ferrno, colle armi ad avancarica era. enorme il numer o dei colpi per· duti: nella so la b11ttaglia dì Lipsia., la fanteria francese, secondo il colon nello Sphor, sparò tante cartucce quante ne furono con su mate dai corpi d'ar mata tudeschi in tutta la campago.a. 1870-7l; e, come dice il Clausewitz, si spars e tanto piombo, quanto era il peso del corpo
E SPECIALME:\Tii: DEL Ft:CII.E IT,ILIA:-iO DI PICCOLO 0.\I,JDRO, E CC 21 i
di ogni uomo ucciso. Invece nella. guerra di Boemia, i colpi effica ci fu r ono in ragione di 0,3 p. 100, cd in quelli\ franco-germanica. di 0,7, cioè, rispetti,·amente, 333 e 1-!3 cartucce sparate per ogni indb:iduo colpiti).

I l 'Volozkoi. <>o m' è noto, calcolaYa al 0,25 p, 100 i colpi efficaci colle armi portatili attuali, ossia. che occorrano 400 colpi per ferire un co mbattente; e questa proporzione è stata. accettata da. tecnici e da. autorevoli chirurghi militari. P er mio conto, è da. ritenersi gerata.. Secondo tale rapporto, ammesso che ciascun soldato sparasse in media, in una batt'lglia., 150 cartucce - il che è tutt'altro che improbabile nelle condizioni presenti di armamento e di munizionamento individuale - si avrebbero 3 colpiti ogni 8 combattenti, vale a dire il 37,5 p. 100 di feriti e morti: una proporzione enorme, moltv lontana dai risultati delle ultime guerre ( n elle quattro principali battaglia della guerra an glo- boera la med ia d ei morti e feriti inglesi, rispetto alle forze combattenti. non oltrepassò l' 11 ,60 p. 100) Ad ogni modo, potrà forse non variare di molto, nelle guerre fLlture, la proporzione delle perdite risp etto alle grandi mas:Je mobilitate; potrà for se anche, in ragione della più breve durata delle campagne, essere minore che n elle guerre antiche, il numero assoluto delle vittime de l fuoco; ma devesi f11.talmente prevedere un considerevole aumanto di perdite in u n limitato spazio di tempo, rispetto alle truppe impegnate nella. lotta.
Taluni autori hanno \'Oluto fì:isa r e delle cifre. Heuyer (1) inclinerebbe ad ammet te re la froporzione del 25 p. 100 rispetto al numero dei combat tenti;' Habart, il quale a ccetta la proporzion del \V olozkoi :2) calcola che le perdite di nna àivisione di fanteria potranno ascendere sino a.l 37 p. 100; H. Fischer (3) valuta il totale dei colpiti rispetto alle forze presenti, in ragione del 22,5 p. 100, assegnando all'incirca il 18,75 alle armi da. fuoco portatili, il 2,75 all'artiglieria e l'l p. 100 alle armi bianche; Roskiewiez co mputa. le perdite complessive al :2-1 p. 100, e Grossheim a circa il 20 p. 100 (4); infine, Sall e (5) p resume che nelle battaglie offensive la. percentuale dei morti e fer iti potrà. oscillare fra il 25 e e:l il 35, mentre in queUe difensive la limita hl 14 ,5 p. 100. Noi, senza sottilizzare troppo s u questi apprezzamenti, rn.. zionali !)nanto vuobi, ma sempre ipotetic i, possiamo attenerci 1\d un11. media approssimativa di 20 a 25 p. 100 di pe rdi te totali. rispetto
( l ) F.R -/,t S.TVIU d t dt 1/Ttmihe ligllt. fArcii. d t nttd. el de ph!ll'. mit, 18'H, (21 J IIAJI ART - D&e 1\'olu:koa''CIIt Trt/ft •-p•·u ce nlt 111 Thcorie u1Hl l'ro .cis. Wi cn. t 900.
13) lt lt> CICt de lllnlf lUI' le ChllntJI de flaloille ( \", Arth ntW. btlQtl, (4) l)tul tnihl 1894
·5) SALLE - Aade- m e moirt du midtcw mililoire Paris, IVOO
218 SUI.l)AZ IO:-I E DEGLt A'M'UALI FI.JI'll.l DA CUERIL\
J' ef!"etlivo degli uomini impegnati nell'azione ; compresivi i mor ti e · feriti per effetto delle armi d'artiglieria (3 a 4 p . 100 e fo rse anche se si tien conto dell'attuale armamento a ti ro rapido ) ed il piccolo con· tingente ( meno dell'l p. 100) che potranno dare l e armi bianche.
Ma quale sarà il rapporto fra morti e fra feriti gravi e feriti leggeri ?
Come ho già. accennato, la proporziene dei morti sul campo in rap· porto ai feriti, è andata incontro ad una graduale diminuzione nelle guerre più a noi vicine, sino alla ragione di l : 5, l : 6; ed è, per conseguenza, scemata., pa.rimente, alle forze combattent i , giacchè,. men tre nelle battaglie del principio d el secolo scorso si elevò all' 8 , al 9 ed al 12 p. 100, discese poi al 2, all'l p. 100 ed anche al disotto.
Ora, dai pochi dati che si possiedono circa le guerre, anche non coloniali, combattute colle nuove armi, pare e merga un aumento, anzichè una diminuzione, della mortalità immediata, in confronto di q uella. ch e verifì cavasi colle armi di m edio calibro. Nella gue rr a ci vile del Chili" del 1891, i congressisti, colpiti dai proiettili del fucile di medio calibro, ond'erano armati gli avve rsari, ebbero l mor to ogni 3 feriti; mentre i co mbattenti de l parti t o opposto, i balmacedist i, colpiti dai proi etti d el fucil e Mannlicher di 8 millimetri, ebbero una mortalità ass ai maggiore, co me l: 1,6 rispetto ai fer iti; che an zi. il 2 1 agosto, a. Concou, nelle truppe balma.ced iste vi sarebbero sta ti 1000 morti e solo 700 feri ti ( l ). Nella guerra cino-giapponese, i giapponesi ebbero l morto su 3,3 fe riti ; ma è da notare che i chinasi non erano armati d i fuci l i di piccolo calibro. Nella guerra ispano-americana., la mortali tà. imme· d iata. f u in ragi one di l: 7,5 nelle truppe degli S tati U ni ti (2 ). Però, nelle quattro importanti battaglie d ella campagna sud-african a d el 1899-900, a v venu te a Be lmont, Graspan, Modder-River e Magersfontain, la percentuale dei morti rispetto agli n omini colpiti, fu d el 19,26, ossia , co mE", h o già not ato, nella ragiore di l : 4,19 feriti (:3).
Tutto sommato , credo si p ossa ritenere come non molto lon t an a. dal vero la pro porzione del 25 p. 100 di mortalità immediata (ossia n e lle prime 2•.1 ore) rispetto al tota le dei colpiti: in altri termini , l mo rto su 4 colpiti. 'ra.le pro porzione è co nforme a quella ammessa da. ll 'Rabart ed dal G rossheim. Per contrario, abbiamo ragione
( t ) v. ll v.nvt:. - l.u rle la ouen·e civile "" Chili m 1891. ( A• ·ch cle med navale, t89S).
J-L Ntiiii!A. - Le ttrv• ct <le sonU pe11da11t l•• guerre ci vile dM Chi/ 1. ( Are/L de mtd. et de pharm. m al ., 1893).

( 9!) V. L •• blnmrtl de (}Ut•·re pa.· nrmts u {w dali& l"armù dt! Ùatl·l"mt tll 1898 et 18!19. (.A r e h de rne l d d e phm·m m il t !IO/).
(3) G 11 . - Sur!Jica t txp•r•mcu i11 Soulh ·.l{rica 1899·900. - Luorlon , 1901.
E SPEClJ\!.ME..'ITE DEL FlJCl l.E ITAI.I.\NO DI PJCCOLO
2JD
CALIBRO, F.C('.
di sperar e in una rilevante diminuzione d e lla mortalità. consE'cutiva; la quale ttella gue rr a ispano-ame ricana non sorpassò il 6 p. 100, e· n ella anglo-boera, il 5 p. 100 mentre nella guerra di secessione ed m •tnell a del 1870-71, si elevò, r ispe tt ivamente, al 14,3 ed all' H p. 100.
In I)Uanto al rapporto fra feriti gravi e fe riti Lon gmo r e, in b ase a.i dati statistici . delle guerre antic he, a>eva stabilita la proporzione dei feriti graYi rispetto a q uelli leg ge ri, come l: 2 . M olti oggi c re dono c he, colle armi moderne, le lesioni lievi debbano superare quelle gravi assai più c he guerre passate. Secondo i sostenito ri di op inione, le lesioni r ealmente gravi , come quelle del cuore, d e i g r ossi Tnsi, d el cervello e deg li altri orga ni vitali. po rtan o la m orte s ullo ::;te;;so c ampo di battagl ia; delle f e rite che poche saranno ver amente pericolose e che non possano seguire un d eco rso asettico mercè un pronto ed adeguato trattamento.
In un mio precedente la voro (1), fondandomi s ulle osservazi oni c he a.llora s i possedevano, e sui r isultati deg li esperimenti, e, prec is amente: frequenza delle l esioni d egli or gani cavitari e d e lle rag ie, sulle più estese lesion i ossee ve r ificantisi anche alle grandi di· stanze. sulla maggiore fa c ilità d' i ncontrare ferite mofteplici n e llo stesso individuo e pe r lo stesso proiettile, ecc., espressi l'avviso che non solo potevasi presumere una maggiore mortalità immed iata nelle guerre avvenire, ma altresì c he doYesse crescere o , per l o meno, non scemare la. quantità àei fe ri ti gravi rispetto ai leggeri.

Or;t, quntu n que i d ati forniti al riguardo dalle ultime guerre sieno r e lati va mente scarsi e non molto precisi, è lecito, tuttavia, dedurne che nelle guerre fu t ure il numero de i feriti gravi t<arà, co n tutta pro· babilità., minore c he n e lle guer re antic he. Dalle più impor tan ti pul> · h lica.zi oni oi r ca gli effetti d elle a rmi p vrtatili m0derne, uella. campagna di Uul>a. ed in quella. del Sud-Africa., eme rge appunto qu es ta d eduzione ; eri inftttti, nella. guerra ispano ameri.;ana le ferite semplici delle sole parti molli ascesero alla proporzione del Gl,S p. 100. e ad una zi o n e pressouhè eg uale ne lla guerra sud-africana. È d'uopo però n otare che gli e ffetti d ei pro ietti li d'artiglieria furono molto diversi, cioè assai piu gravi: tanto le palle t te di piombo degli sh,·apnels, quanto le schegge -delle gt·anate produssero sempre, come fu osse rvato in partiaola.r modo nella gue rra del sud-africa. (2), lesioni atipiche. l arg he , irregolari, fa-
( I l La tlrotlorziouc di'i morti e feriti nelle guerre e n e ll e g uer re futuro. ((;ll)r n mtd.
•lei R. 11196).
l t
• RtoiJachtu.np• n ùbrr i m B otrtn-1\rif(Jt IA• ch (v.• /../w.
O• l l "urg , 1901)
I.IJ AR> - /.u tlhtig nt m tlll1 de la guerre Suci·A(>"iCIIi llt. ( t..e C11 duc ; P , 100!-9011
SULL'A ZIONE OEG l. l A'l'TtJ.\ LI FUCIL.I D l OUERILI
talmente soggette alli'nfezione; ed anche le più. grandi devastazioni e mutilazioni, per specialmente delle granaLe E:splosive del èannonerevolver Vichers-Maxim.
Bircher, riferend osi soltanto agli e ffetti dei fucili di piccolo'" calibro, aveva stabilito questa proporzione: s u 100 colpiti, 25 morti, 15 feriti gravi, 60 l egg eri; ecl Habart: 25 morti, 20 ft:riti gravi, 55 leggeri. :\Iohr ( l ) dai dati delle più re ce n ti gue r re deduce una propo rzione quasi identica a quella del Bircher, e precisamente: su 100 ferite per a rmi da fuoco di piccolo calibro, 25 mortali, 15 gravi cbe lasciaco il ferito più o me no invalido, e 60 che guariscono completamente.
A me pare che, per quanto importanti, g li insegnamenti che deri,·ano dalle ultime guerre e segnatamente i pii; documentati di essi, quelli delle campagne ispano-americana ed angl o- boera, non si possano applicare. iucondiziona.tamèn te e senza riserva, ad una grande guerra che st combattesse in Europa, fra eserciti di milioni d'uomini, in regioni dense di popola zione, ed in condizioni tattiche. logistiche ed anche morali, tanto diverse da quelle in cui si svolsero le operazioni gnerresche a Cuba e nel Transvaal.
Per queste 0onsiderazioni, reputo più accettabili per una grande guerra avveni r e, i rapporti fissati dall'Habart, anzichè quelli del Bircher e del .Mohr. E volendo scendere a dei particolari pra tici, anche dal punto di vista del servizio sanitario, formulerei nel seguente modo le proporzioni: su 100 colpiti, morti sul campo 2ò, feriti gravi non trasportabili a distanza 20, feriti non gra·;i ma. bisognevoli di !llezzi di t raspo rt o 40. feriti l eggeri non bisognevòli di mezzi di trasporto 15. In quanto poi alla futura. sorte dei feriti, ossia alla mortalità consecutiva. ed alla guarigione più o meno completa., le ben note percentuali del Longmore r2 ) potrebbP.ro essere così modificate: detratto il 25 p. 100 di mortalità immediata.. si av r ebber o circa 6 morti negli ospedali, I.:J guariti con imperfezioni più o meno gravi e 54: guariti completamente.
In conclusione, per quanto le presunzioni circa le perdite, la mortalità, il rapporto fra ferit.i g ravi e leggeri, possano variare secondo un complesso di circostanze, attinenti al ter r eno, al morale trupp e, alle varie fasi del combattimento, alla zona. della traiettoria nalla quale le ferite avvengono, !!.Ila maggiore o minore prontr,zza ed efficacia del soccorso, si può tuttavia affermare con fondamento che, pel' effetto delle

( l ) M OHR. - Schuisvl!f"lel:uuoeu d11r'h J.:leinkalibl"i(le Gercehre, lptcìtll tltJCII den Br(ahrunow tl t r ltl::tn Feld;;uge. ( A rch. {rir k/111. Chir. - t90!).
La proporzione stabilita dall.ongmore in base alle statistiche J clle guerre antiche è : iO morii s ul campo, l! negli ospedali. jl :mariti con reliquati richiedenti pensronc, 4; guariti co m pletamente . Le cilre rornite dall'esercito degh Stati Uniti, iu st"guito alla lspano-amerrcana, seguano mr !_Z rande miglioramento: .>u 100 colpiti, 1t morti sul campo, 6 negli ospedali, 9 guariti incompletamente, 73 completamente.
::<PECI.\ DEl. Ft:C il.E l T.\ I.IAXO DJ Pli 'COI.O ( ',\I.IDRO, E CC . ::?21
tllluali al'llti di piccolo . calibi'O, é aumentata la qt,antilà delle pe>·dite in ?'appo1·to al nume1·o dei comballenli, e cosi pw·e la pe>·centuale della mortalità; solo abbiamo ,·agione eli un minor 1mme1·o di fei'iti g.·aci ,. spello all'ingente di ferili
IL CARATTERI ED DELLE Fli:RITE.
Guardiamo ora. raltro lato della questione.
Dopo i primi esperimenti del Bruns, i quali, com'è noto, lo indussero a qualificare per armi i moderni, lo Sr.iles, al contrario di altri precede nti sperimentatori ed osservato ri, diede, coi suoi studi sperimentali sull'azione del nuovo fu0il e americano di millimetri 7,5, una agli apprez:-.ameuti del Bruns. Vide, infatti, che il proiettile di que8tO fucile produceva nelle parti molli, ferite n ette, non lacere n è con· tuse; nelle ossa, di rado fratture comminuti ve , e spi ega va debo le azione esplosiva: insomma, cagionava. l esioni meno gravi, che il fucile di medio calibro prima in uso. Risultati analoghi si ebbero da talune esperienze sui cadaveri, fatte in Rus.:;ia co l fucile Mosin di millimetri 7,62 .
Nella guerra c ino-giapponese, il Dugald C risti e notò dell e ùill'e renze ril eva nti fra le terite prodotte dal fucile Murata di millimetri 8 e quelle cagio uace dal Martiui-Henry di 11,-.1: millimetri. Il primo determina1·a ferite cutanee p iccole, pnntiformi, regolari, con fori d'tmtrata e d'usCita pressochè eguali, e nell e ossa perforazioni n ette, senza n è scheggiamenti; man.:avano gli eft'etti esp losi1·i, poco cousidere,•ole era lo traumatico. Un soldato, con perfo razioue del ginocch io, potè fare lunghe marce, e, ciò non gLta.rire colla piena. reintegrazione funzionale d ella giuntura; tre feriti, co n lcsioue del p o l· moue. guarirono pure ben e e rapidamen te. Per contrario, i proiettili di antico model lo pro tl ussero le più g ran di de,·astazioni: le ferite e rano q uasi t.utt.e inc]ui nate p er elfetto di pezzi di 1·estimeuta. cue la pallottola ,.j av t.! va. introdotti; ed, in molti casi. l e lesioni ossee degli arti .e rano talmente gravi, da imporre l'amputazione imm ediata.
Osservazioui consimili furono neg li ospedali di Tient-Sin sni f e ri ti col fucile Murata, da. una. parte; e su quelli colpi ti d1dle palle dei fucil i, Snidar di millimetri 14,1 e Martini-IIenry di 11,4 millimetri, dall'altra parte (l)·
Nel Dahomey fu no tato che i proiettili del fucil e Lebel non arresta· vano se mpre, al momento, lo slancio del nemico, di cui un gra n numero

Slit.I.'AZllllS'E DEGLI ATTCAL I FL'Cit.l DA Gt'ERR A
111 V. lllts>u•·u par l r< m·mu dt Jltlol rtdi br·t. Are/r. mcd. bti(J -
di feriti, anche perforati da parte a parte, arrivarono sino alle linee francesi senza cadere (1) .

Nel Chitral, il fucile inglese Lee-Me tford di millim.etri 7,7 non sem· presi mostr ò abbastanza efficace contro quelle orde selvagge. Gruppi di nomini esposti ad una fitta grandine di palle sarebbero rimasti fermi , se nza cadere nè ripiegare Il generale Lowe riferisce .che dei prigionieri, con due o t re ferito, pote rono marciare p er 10-12 chilometri, senza. m ostrare notavoli sofferenze Un uomo colpito da sei palle si rec ò da sè al posto di medicazione, e guarì. Un altro, condannato alla fucilazione pe r spionaggio e colpito, a 12 pass i, pure da sei palle di cui tre attraversanti il pe t to, fu lasciato co me mor t o, ma p otè rialzarsi e fuggire, p er essere po i arrestato alla distanza di circa -!00 m e tri. Fu per ta li fatti che gles i si de cisero a modificare p er t ruppe co loniali il proiettile del LeeMetfo rd, sostituendo a quello completamente ri vestito di mrtillech ort, il cosi detto proiett ile dum - dum, del qu al e fecero uso nella campagn a -::on t r o gli afridi. In vece, s pedizione contro i. dervisci si valsero di. un'a l t ra modificaz ione dell o stesso proiettile del fL1cil e Lee-Metford, ossi a dei proiettili a came,·a o ad og ì t)a incavala, coi quali. ebbero ragione degl'impetuosi d ervisci, infligge ndo loro quasi il 60 p. 100 di per d ite.
Senonchè, l e osse rva zioni de gli stessi inglc:st in guerra, e le i nte res· sr, nti esperienze del Bruns t2) hanno mostra to che i proiettili con tali modificazioni producono; b ensì, alle bre,•i distanze (200-300 metri per la pallottola a Cflmc,·a, e 400- oOO per quella cltun-dum), d e lle lesioni più ma per la l oro fo rza. di p en etra z iou e assai ridot.ta. sono meno effialle m edie ed alle grandi distanzd - ossia alle di::ta.n ze ordinarie dei com b a tt i men ti colle armi moderne -, che non i proiettili a mant ello co mple to e seuza. incavat ura all" estremità. a nte ri o re de l nu cleo. La. qu al cosa n10l dire c he. per effe t to dell e suaccennate :nod inc azioni, si re,;er o più gra vi le feri te p er se s tess e efficac i a ridune i co mbattenti a ll' impo ten za, e n on si r esero sufficienti le t'e ri te insufficienti: si ottenne pre c isamente un effe tto contrario a q uell o eh& si voleva conseguire, e, per g iunta, antiu;nanita1·io . Ond' è che, sia per le r ag ioni ora es poste, sia pe r ottemperare all e conclusioni della Conferenza dell"Aja, gl'inglt•:<i, nel Sud -Africa, a bba ndona rono i proiettili a camem e dum - r/um, rit o rn ando a quelli a mantello c'ompleto .
Nella. campa;gna italo-abissi na del 1806, le truppe i tali at;te di spedì-
m Il fucile LebP I nel Suda n fran cc<e, ne l 189S, no n s i rnostr ò info. rio r c al(li anti chi fucil i di medio cali bro per l'i n t cnsita de:;:li efM ti prodotti (F INOT L e service de san l è, etc. Arc/1 d e "'td. mi!. - 1900).
BRoss. - l/ebe,· die ll'it•ktmq d er Tl1bingen, 1898.
l'••be•· die ll'it·kung der llo/ll$l) il zengucttosse Tu hl nge n, 1899
E S PEClA L"MENTE DEL F UC I LE !TAI,IANO DI PICCO LO CALIBIW, ECC. 223
zio n e erano annate, com'è noto, di fucile Vette rl i- Vitali1 di med io calibro, e quelle etiopiche, di armi diverse, ma sempr e di calibro supe· riore ai 10 millimetri. Quindi, dal punto di vista det razi one vulnerante dei proiettili di piccolo calibro. q u ella campagna non può avere un' im· portanza diretta. Tuttavia, i medici italiani poterono constatar e, in numerosi casi, come lé lesioni. sia delle parti molli sia delle ossa, erano sempre più limitatate, meno disastrose, quando prodotte dai proiettili eli calibro P.iù piccolo ( 1) .
guerra gre:::o- tu r ca del 1897. il fucile a caricamento unico Peabody-Martinì di millimetri 11,43 decise le sortì della campagna contro il fu ci le Gras di 11 millimetri oo.de erano armati i greci. Le armi di piccolo calibro dell'esercito turco rimasero g iacenti nell'antico Serraglio a Costantinopoli. In conseguenza, questa guerra non h a por· tato alcun contributo alla soluzione della questio n e éhe ci occupa. Ritiulta però che le poche ferì te cagionate dalle armi di piccolo calibro, di cui erano armati alcuni volontari greci ed alcune brigate turche, presentarono gli stessi caratteri di relativa. benignità, osse rvati nelle altre guerre. Di maggiore interesse per noi sono i tatti che emergono dalle re· !azioni chirurgiche circa. la campagna. ispano-americana., nella. qua le le truppe deg li Stati Uniti adoperarono il fucile Krag-Ii.irgenseu di 7,6 millimetri, e quelle spagnuole il l\fauser di 7 millimetri, Riassumo le pa r ticolarità principali: shock locale pooo intenso; effetti esplosivi sino a 300 metri, ma. as3ai rari, a causa. della distanza. alla quale avvenivano ordinariamente i combattimenti, e delle acoidentaì ità. de l terreno (nonchè, come ben nota il Laga.rde, a. causa della speci ale gravezza. delle lesioni. per la quale an-e nendo il più spesso la. morte immediata, gli effetti esplosivi sfuggono all'osservazione del medico ); emorragie, in generale, poco gravi: su 1400 feriti nella campagna di Santiago, nessun mo r to di emorragia esterna e nessuna legatura. di Yasi importanti sul campo di battaglia (2) ; ferite delle parti molli co· stantemente lievi ; rare le f ratture comminutive delle ossa lunghe, al di là della zona esplosiva: s pesso il proiettile scavava. una gronda n ell'osso senza produrre la frattura completa; raro l'inliervento per rimozione di schegge; fe r ite articolari b enigne : 20 ferite perforanti del ginocchio gua rirono co lla. semplice occlusione asettica e l ' immobilità Fu praticata 'Jua.lohe rara. amputazione, solo per lesioni dei proiettili d'artiglieria: nessuna. r€sezione primaria. Furono piuttosto numerosi i casi di permaLenza dei proiettili nei tessuti: ciò si osservò in parti colar modo nei fe-

(l) PAiiARA - Sull'operosila dtl COI"JlO 1anilario mi/ilare 1lulia11o dunanle la campagM d".f· (rieti 1896. (G i or11. mtd. del R utrcilo, t89i)
(:l) l.AfaftnF:. - JJitUIU'ft par lts ball•s des (11sah, de calibre reduiC. ft:omp. rtrld du Xlii Cono · de mtd. ($tcl. de mCd. mll.). Pari l. 1901 )
DEGLI ATTL'.\L I FUCILI D.\ <J!"ERI"IA
riti americani, e fu attribuito al fatto che g l i spagn u oli, general mente, cominciavano il fuoco a grandissime distanze. Molte ferite penetr anti del cranio non r iesci r ono immediatamente mortali, e non poche gua r irono; tuttavia, la proporzione dei morti per tali le!!ioni uon fu inferio r e a quella delle guerre prdcodenti (86 p. lCO, di cui 16,44 negli ospedali ). Le ferite pe netranti del torace, con lesione del polmone, fu rono ac;sai meno gravi che in passato, e la proporzione di mo r talità consecutiva per silfatte lesioni (25,3), molto più però, in più di '/l dei c&Si vennero osservate complica..zioni, e segnatamente l'emotornce ed il piotorace (1) Le fer ite penetrttnti dell'addome cagionarono una mortalità consecutiva elevata 163,9 p. 100), ma mino re che m Ile guerre pas· sate (87,2 nella guerra di sece5siona, 69,4 in quella del 1870-71 ); l'intervento diede risultati p unto incoraggianti: Sll lO laparatomie, 1 guarigione e 9 decessi. I n generale, le fe ri te per proietti l i di piccolo calibro ebbero decorso asettico; rar amente fu r ono trovati nelle ritagli d'abiti od a l t r i corpi estrane i apportatot·i di ge r mi i nfett i \·i.
Infine, dalla numerose pubblicazioni relat ive alla guerra sud-africana (nelle\ quale gl'inglesi i l lo r o L ee-Metford col pro· iettile ad incamiciatura completa., ed i boer i, il fucile Mauser di 7 mi llimot.ri) 12 ) eme rgono le seg uenti principali pa r ticolarità:
Azione laterale poco p ronunciata, ed effetti esplosivi mo l to rari; fer ite cutanee, con o r ifici e tragitti stretti e r egolari, apche quando erano rnolto considere,·oli le lesioni profonde; p erò, per colpi di rimbalzo o di le ferite assumevano i caratteri d i quelle pro dotte d agli aotich i p roietti l i; tranne nelle fer i te per p roiettili d'arti· glieria, il dec or s) asettico costi t-uì la regola: circa. nell'88 p . 100 dei casi si ebbe la guarigione senza suppurazione. e ciò non solo per i car atteri benigni delle ferite, ma anche per l'aria sana e secca della. regione sud-africana (3) ; ferite dei vasi non così gravi, come gli ment i avr ebbe ro mostrato: nessun morto p er emorragia esterna. e ciò pe r chè la strettezza dai tragitti n ei te3suti sovrastanti favo r iva l'emo· stasi e quindi la. gua r i g ione, oppure !.:1. formazione d i aneu r ismi t rau· ma tici, i quali furono riscontrati con discreta frequenza; per emorragie interne la m or t a lità immed iata non si verificò in p ro p or zione
f il - lllrnure' de 11' po itdn-. par armes li (eu J'tllll twl la guerre ll l lpmlo-amcrical" e. ( A re/l. d e mrd ti de ph11rm. 11111., 1899)
( t ) SCcontlo Il rlott. 1 He.rz (v. A rch. de 1/éd fl de Pl.arm. m il. 1903) 1 adoperarono anchr

11 lo Snider Pii allrl fucili 11i mel1io calibro ma m numero assai rlstre tlo; a partire rlal felJbrah• t !IOO, r.•cero thO di un proiettile Mau<er mod1llcato, Il ril•esllmcnto alln punta P d1 pr,uettlll con lnci<lonl nel mantello, per reorlcrli ruù delurmahill.
(3) 1\UTT:-11111. - Er(ahruiO!JW aus <km Sild·A(rlkalliSCMil 1\ruo e, t8flfl· t900. Tulungtn, t OOO.
W
- Trailmtnl dta bltuurts dt oue r rt. (Are/t. de méd el eh pllarm. m !l., t 901).
15 - G ietr llale med ico.
E OEL FUCILE lTAL TA:\0 DI PICCOLO OA I.LBR0 1
maggiore, che n elle gue rre passatt-. R ispetto u.lle lesion i ossee: nelle epifis i e nelle ossa s p ong;o3e. sem plici perfo r azioni, meno ne i colpi a dist.anza; n elle dialisi, frequenza delle frattu r e l ongitud i n al i ed oblique. rarità delle frattu r e trasverse fratture commioutive a un ùip r esso come negli esperi menti: notata la f requen za della fr attura tipica. ad ali di {w'(alla: tessure pe r lo più a rr estate alla linea diafiso- epifisar iH.: fo r i c utan e i d'uscit a., nei colpi a bre,·e distanza con frattura diafisana. per l o p1ì1 frastllgl i ati e larghi siuo a 5-G centimetr i nel lo r o maggior di iHil&t ro. di uua sorprdndente, assai r a r ame u t.e accompagnate da su p pn ra zio n e nel loro decorso, sovente guarite in po;}h i giorni: s u 9Z fer iti al ginocchio, :.28 pote rono r ipreaJera se r vizio d u r aute la campagna (l l.

L e l esioni de l capo si mostr a r ono g r aY i pressoche come nel le gue r re pe r ò si ebbero pa r ecch i casi di g ua r igionP, per colpi A. v venuti q uasi sempre a lle g r and i di s tan ze : fa notata r e3i stenza d i ta lu n i te r iti , i ad o n t a de lla pe rforaz i onB del cra n ic .::on l e,;i one de l oerv e ll o, r esta r ono in p ied i e potero n o a nche u.un minare per qualche tempo. La t r apauaz ione p r ima ri a d ett e u na g r l'\ u do m o r t'ilità. La poca g r avezza delle fe r ite polmo nar i per effetto dei proi.etci l i di pie ;o lo ca· l ibro. è stata pienamente co nferma ta nella gue r ra sud-afri ca u a: Hil· debrandt su 42 feriti al polmonf', ebbe solo 5 morti, e l [ akius dièe che le les 10ui polmona.ri si mostrarorw m e no gravi di que lle dl:llla sola parete toraci ca La. g uar igione fu , in generale, rapida: mo lti po t e r o no lasciard il letto dopo 12 -14 gio r ni; n on mancarono però le comp l ioa.zioui, r emoçorace; l o pneamotorace si r is..:ont r ò r a r amente. L e lesioni alt.ri orgin i toracici, massime quelle del c u ore e dei vasi, si most r arono pari mente gra vi, e mortali ne:le stesse p r o · po r zioui, cho n olle gue r r e p r ecerlenti. Le ferite deg l i parenc hi· matosi d ell'addo me prese ntarono u na benignità rel a tiva, mo l to consi de· r evole, fatta eccezione eH-quelle avve nu te a corta. distanza, qu a ii se npre rapid ame n te mortal i par g li effetti e:>plosivi. Quelle dell o stomac o e de ll' i ntestino, s pes 3o nu me r oile per effetto de ll o stesso p r o i ett il e, s i mostrar ono e nc h 'e:>s e me n o g r a vi. d l qu a n to aveva no f a tto gli espe rime n t i, e ciò pe r il n umero r il e van t e el i g uar ig ion i s p ontanee c he si ve r ifica r o no; a dete rmina re l e qu ali, u n co n t r i b uto i m po r t a nte è d o v u to, co mò n ota il Dick , alla. po;a intensità d ello shock. onde la magg io r e fac ili t à d i co n t r az ione de i marg ini d ella feri t a.. G l' inte r · v en t i fu r o n o egua lmente f a t ali c he n e lla g uerra is pano·a meri c a.n a, oos icc hè tutti i chi r u rg hi d i venne r o as tensio n isti, compresi il Tre v e 3 ed
( l) - l.or. clt.
- uptrienctl i11 So u i/1-A{ricu. Loodon . 1901.
.il Mac-Cormac, il quale esprimdva le sue impressioni colle seguenti parole: « in qu esta guerra un ferito all'addome muore se lo si opera; sopravvive se lo si lascia tranquillo ( l).» Fn osservato che la guarigione spontanea è più facile nelle lesioni del colon a3cendente e del r etto, e che le altre ferite del cubo gastro-intestinale seguono quest'ordine di gravezza crest:ente: stomaco, colon d iscen(lenle, colo n l1·asverso, i ntestino tenue (2). Un'altra osservazione, fat.ta dal l\Iak ins, è che le ferite intraperitouea!i dei visceri addominali, compresa la vescica, si mo· strarono, iu g .:mera!e. meno gravi di quelle deUe porzioni di tali visceri non rivestite d i peritoneo. Si notò, da ultimo, la perniciosa influenza del t raspo rt,o massime se lontano, sul decorso e sull'esito delle d11gli Ot·ga:li ea vitari, non solo, ma 11.ltresi sulle ferite- fratture del bacino. dell'a.uca, d9lla co3cia.: i migliori su,ccessi in questi casi si ebbe;·o, quando i (e,·ili pole,·ono essere lasc iati in ;·iposo p;·olungato e ,·imtW,.eJ·e p;·ematw·amenle la p;·ima medicazione, falla con mate;·iale asetl i co, secco e pel'meabile.
Nei va.ri scontri so.>ten uti in Cina dalle truppe in te rnazionali di s pedtzione, u el 1900, il numero dei feriti non flt gran rle; nè tutte le ferite furono prodocte da armi di piccolo calibro, giacchè le bande irr egolari cinesi emuo armate di fucili di tutti i calibri e di tu t ti i m o·· delli. Perciò, le poche notizie che sono state pubblicate in proposito (3), hanno p e r noi un'importanza assai limitata. Ad ogni modo, le parti· co larità relative alle ferite prodotte dal Mauser di 8 millimetri, adoperato dalle truppe regolari, confermarono pienamente quelle rae c olte nelle guerre di Cttba e del Transvaa!. Dalle relazioni dello Schlick e dell' Herhold, addetti alle truppfl tedesche di spedizione (4), emerge che: i colpi da fuoco perforanti il cranio furono immediatam e nte mortali anche a 800 m.; i colpi perforanti il collo produssero una grandissima mortalità; però lo Schlick segnal a una ferita della. carotide primitiva
{!J o.· Ilei In laparotomia nelle ult imP :ru rrre no n hanno, a mio avvis o. il nodo g c•r<liallo crrcn tale o re rn?.il)ll (j nella n os ll'a pralit·a Ili
1\cl Tran:;vnal, lliCI! Il l.t•jn rs (V. articolo gia citato), In lnrnrotomla fu (alla in In COIH1izloni deplorevoli; e•l atiduce, a prova, 1 he il rlott. flippcl riJie l.aparal omr e im Kde9e. - Ar ch. {ur A'li11 , Cl1ir. l90ìll. s n 16 casi di quest'ollernzionc ola lui racrolll , solo in 6, co n 3 guarijliMli, tro"" c he s ' intPrvenne nelle prime n orn; in al cuni de;.cli altri lO s i ricorse all'arto opera ti vo pNOno al J- o -4• giorno c dopo tra spo rti piu o mono t! i <a, trosi.

Cio s tante, non è lecito rinunziare sistemaliramentc nella chirurgia di guerra ad unn operazione che in molti c.1si é !"unica anwm <li salvezm tlcl ferito, c dlo1 rapvresc uta una dello ma g;::io ri co n']Uiste della chiruraia mooterna. Converra, JJillllosto, pronedero a che non difetto le co nclizioni del succcs;o, co mrrcsa <]uclla della swci11fe altitudine tecr1ica del chirurgo. In ca5o co n l171rio senza !lubl•lo, prereribile Il\ cura JSI>rttanle.
(!) MAKt:iS. - Loc cit.
(l) V. - L'ambu.tance <le ta brìgade dt$ troupes dt la guerrr. pttldant l'expédilion <le .Chine. ( Arch. tlt mw. et de phnrm. mil., 1901).
IIA GA - QutlqoJel re(ltxw•u "',. lu bltlmrtl par bolles dt pelit calibrt. <Le Caducèe, 100!).
(4) v. DeutJ. militnròrt:. Z <•t• .• 1901.
E DEL lWCILE ITALIANO DI PICCOLO CALI.BRO, E CC. 227
guari t a. colla. sem pli ce medi cat ura compressiva; le fratture diafisarie,. an c he a lle brevi distanze (300-500 m.) , furono molto limitate e con schegge poco numer ose; le lesioni degli arti inferiori, assai più fre· que nti che q uelle degli arti superiori, ed assai frequente la permant:Jnza del proiettile nella. feri ta; m olto raro lo shock traumatico.

Dll qu esta rap ida possia mo \ede re come le ossen•azio ni fatte in guerra non abbiano, in massima, in fi rma.ti, ma piuttosto co m pletati i dati s perim entali, colmando ta lun e lacune, che l'ins uffi c ienza dell'esperimento n on poteva a meno di laiciare. Ed, in realtà, le osservazioni e gl i es p erim enti sono concordi circa i del le variel esion i , come, ad es., que lle della. zona espl osiva, le ferite d e i vasi sanguigni, l e perforazioni intestinali; ma sulla. maggiore o mino r frequenza di s iftatte lesioni , sul decorso e sugli es iti loro, le osse rvazi o ni hanno d ett o quel che non po t eva, di certo. risnltare dagli espe rim enti. È duuqu e priva di fondam ento l'accusa che taluno, co u tr oppa di si nvo ltura, ha voluto rivo lgeru ag li studi sperimentali sull'azion e d e i proiettili d e lle nuove armi, affermando che i risultati di questi studi erano stati oontradetti dall E\ osservazioni fatte sul campo di battaglia e nei luoghi· di cura dei f eriti
Do po tutto, quel che più importa si è che, mentre le ferite prodotte dai fu cili di piccolo c alibro hanno realmente mostrato relativa benignità, ness un fatto è venuto a confermard il sospetto della loro· a ridurre i colpiti alla di combattere.
CAP ITOLO Vi.
Conclusioni.
])all'esame complessivo degli esperimenti e dell e osservaziom mtorno all'azione dei proiettili delle attuali armi portatili da guerra, si possono trarre, a me pare, le conclusioni seguenti :
1• 1 proiettili dei fucili di piccolo calibro, dotati di una grande forza di pene trazione, la mantengono tanto più elevata alle grandi distanze, quanto più piccolo è il calibro dell'arma, anche se la forz1:1. sia r elativame nte minore.
Alle brevi distan ze la forza. di penetrazione può essere attenuata. di molto, quand o il proiett;ile urti contro un oggetto assai r esistente, a causa della g ran de facilità con cui, in tale circostanza, il proiettile si riscalda e si d dforma..
2• Il riscaldamento del proiettile di p er sè n on esercita, in ge n erale,. nn' influenza apprezzabile sulla azione vulnerante di esso. Nè può dar
228 SUI.l!AZ IO!!:F. DI!QJ,J A'l.'TUALI FUC ILI DA GU ERRA
:iuogo aq ustioni nel corpo umano; ammenochè il proiettile abbia inco ntrato una grande resistenza prima di colpirlo.
3 • Le deformazioni sono più rar e nei proietti l i incamiciali; ma l'infl uenza aggravante che ese r c itano s ull 'azione vuluera.nte, è m'aggiore, a causa della facili tà di distacco de l mantello, e d ella riduzione di esso in frantumi acuti, taglienti e difficili ad estrarre dai tess uti .
4 " L'azione la t erale, e quindi l'azio n e espl osiva, è rel ativam ente meno intensa, nei piccoli calibri che neiproiettili di medio calibro, p erchè l'aumento della 1Jelocità non compen:1a abbastanza la di m inuzione d e lla su perficie di sezione del proiett ile ; si este nde però sin 0ltre 400 metri.

L'esperi enza' d elle guerre ba p r ovato che gli effetti espl osi vi si ve · rifi cano co n poca frequenza; ma non sono me no grav i di quello che hanno mostrato gli esper imenti.
5° Di regola, il proiett il e, p er se stesso, non infe tta la fer ita. S e sono colpite parti cope r t e da indumenti , i rit ag li di questi penetrando n el canale della ferita, posso n o, bensì, portarvi dei germi, ma l'influenza -di essi si può, in massima, cons iderare come poco efficace ri spetto al· l'infezi one. Lo stesso valga per i mi crorgan ismi che possono proveni re dalla pelle della r egi one colpita (1 )
s• La proporzione delle p erdite ri s petto alle fo rze com ba ttenti, -è considerevolmente au mentata. colle armi moderne, ed è pure dive· n uta magg iore quella della mortalità imm ediata ; solo sembra in diminuz ione, il rapporto i fe riti g ravi n que lli l eggeri.
7° E più frequente che in p assato incontrare molteplici lesioni sullo stesso individuo; e non è ra ra la presenza del proiett ile, o di parte di esso, nella ferita.
s• Le ferite cutanee sono, generalmente, rappresentate da fo ri regolari, di minori, s pecie il foro d 'entrata, di quelle della sezione tras versale del proiettile.
Le lesi oni dei tessuti molli, in genere, sono, a tutte le con · siderevolmente più lievi, che in p assato.
L e ferite dei tronchi nerv osi e dei tendini si presentano co n mag.giore f requenza, ma so n o, in generale, più n ette e più r egolari.
9• L e ferite dei vasi sanguigni sono tanto meno f requenti, quanto -più piccolo è il diametro trasversale del proiettile ; cosi pure quell e prodotte da schegge ossee.
Le e morragie este.rne, tranne nella zona. esplosiva, sono più rare, perchè la strettezza dei tragitti e la piccolezza delle ferite vasali
(l ) Il TAVSL (Re,Mr'ha exp i rlm entalu sur l' in(ection d la duin(ecllon del plalel par armu a ( eu) trae tlalle s ue indagini, deduzioni opposto a qu elle degli altri sper imeotatora Nondime no, vu r ritenendo ordinariamente infette lo lerite prodotte dagli auuali proiettili, la -cura semplicemente occluslva, ase ttlc:J\ od aotlsettlea. nelle prime formazioni sanitarie di g uerra
E SPECI A.LME:STE DEL FUC ILE ITALIANO DI PICCO LC CALIBR O, E CC. 22\:J
favoriscono l'emostasi11. spontanea. Sono più frequenti gli aneurismi· tnm ma tic i.
10' Nelle os;!a piatt.e, nelle ossa corte, n e lle epifisi delle ossa lunghe · e quindi nelle articolazioni, le perforazioni nette e regolari sono tanto più fr equenti, quanto più grande è la forza di penetrazione e più pie· colo il volume del. proiettile; onde la relativa ben ignità di siffatte lesioni, di f)Uelle arti co lari, per e ffetto delle armi di piccolo · calibro.

u· N e ll e OS;!a tubula.ri, e specialmente nella.loro' diafisi, le lesioni più fr equenti sono le fratture comminuti ve: l'esten3ione dei focolari di frattura, la grossezza d e lle schegge, il numero di C)Helle libere. la dislo cazione di esse e quindi le lesioni delle parti molli circostanti, sono in ragione, oltrec llè della distanza del tiro, della superficie di sezione del proiettile. Perciò, le lesioni dells ossa lunghe sono anch'esse meno gravi. che in passato: in massima , la loro e pw m rappm·to colla maggiore o minore ampiez:;a delle solu.zioni di continuo cutanee, che col grado ed estensione della frattU?·a.
12' Le ferite del cct.po, gravi e spesso mortali egualmente che nelle · guerre passate, per etì'etto dei col p i vi cio i, mostrano, al le grandi di:>tanze,. una minore gravezza e danno un maggior numero di casi di guarigione.
13° Le ferite del polmone sono tanco meno gravi e più facilmente guaribil i, quanto più regolare. e più . stretto è il tramite della ferita e quanto minore è lo shock traumatico; il che è in rapporto colla ridu· zione del calibro . L'esperienza delle ultime guerre ba pieuamente confermati questi apprezzamenti, mostrando la insperata frequenza delle· guarigioni delle ferite polmonari.
Le lesioni degl i altri vis::eri toraci ci danno i l medesimo contiu- · gente elevato di mortalità, che per effetto dei proiettili di medio calibro.
14' Le ferite dei visceri cavi dell'addome, sebbene più numerose nello stesso individuo e per lo stesso proiettile, mo9trano maggiore · tendenza alla guarigione spontanea, di quelle prodotte dalle antiche armi.
Le ferite degli organi parenchima.to3i, fatta eccezione di quelle della. zona esplosiva, presentano un grado di benignità assai maggiore che · m
Dopo ciò, si qualifichino pare per umanitarie, se si vuole, le armi portatili attuali di piccolo calibro. Ma gli esperimenti, e fe osservazioni fatte nelle ultime guerre hanno ormai sfatata la leggenda della. loro insufficienza a mettere fuori combattimento i feriti, la leggenda delle m-mi che non uccidono.
Il che non sempre le ferite ad impedire all'uomo di
230 SU LL'AZIOXE DEGLI ATTDALI
FUCILI DA G U!WRA
co ntinuare la. lotta. può dipen d ere, oltrechè da. cause individuali, dal grado di civiltà delle masse combattenti e da tanti al t ri fattori d'indole mor ale, etnica, ecc. Egli è perciò che degli esempi d i str aordinaria tolleranza, e talvolta di u na r esistenza veramente p r odi giosa , ai t raumi an ch e assai gravi, si sono avuti in tutti i tempi in tutte le guerre e co n tu tte le armi. D'altra parte, colle nu ove armi si sarebbero verificati in una proporzione più larga solo nelle guerre coloniali. Si può fortemente dubitare che il combattente euro peo, per qnanto possa. essere animato da alti sentimenti, a b bia. la di cui so no dotate le or de semibarba.re ed efferate d ell'Asia e de ll'Africa.

È intanto, che nelle guerre avvenire, p er il numero eno r me di combattenti, pe r la. rapidità. delle ope razioni, per la. grande cele r ità. dei tiri, noi dobbiam o aspettarci, in b r eve tempo, una f]Uan tità. assai ele· vata di fe r iti da soccorrere, sia pur minor e il numero dei feriti gravi : un vero profluvio d i tra u mi, c.ome qu a lcu n o arg u tamen te ha detto. E, si può agg iungere, accanto ad un pt·ofl.uvio an che maggiore di malattie spontanee; giacchè, diffic ilmente, i p r ogressi d ell'igi ene moderna a rri· vera.nno a rendere la proporzione dei mal ati infe r iore a. quella dei feriti.
Nobile, pe r tanto, i l mandato della m edicina e della. chiru rgia mili t are, ma arduo assai nelle guer r e moderne! tanto più arduo, quanto maggiormente oggi s'impone la prontezza del soccor so e dello sgombero; quanto maggior e è diventata la responsabilità. de l medico di fronte ai progressi d e lla scienza e soprattu tto della te ra peutica ch irurgica.
BIBLI OGR AFIA..
Atll&T - flnt11u/ de ch iru rg it d 'arm et. PJris
- l'tb• r d/t kr otfllthirur giscu 8 fdl'1tlun.Q der •w•m - Re rlln. 1891.
llsc u. - Ccbir die Wtrkun g m ndrrn cr Gtu:thrp • fl}tcliltn insbuondtre dtr 11eruhmn l·
::ene11 Pan:tr- grschO<St nu{ dm lhlt rilthtn 1\•irper - l,elp7.ig, 188:;.
B , C/ih urgi e d Srhuuverl•l:tmgen Jlihl til"lir:ll. Br{allrungcn. - Frelburfl. 1!17:1.
B1R t tnm - der lirieosh t• lk•md•. - llase l. 18F8
- Neu e U nl ersuchunom 1i be r d/e IVirkuu u der 1/and{eu ertvll fftt<. - Aarau, 1896-g7, - Die \Vit k,.,l(l der Ar/llleritf1t<ehnsu. - Aarnu. 1899.
OLOc u - /Jie l 'tutll;glichkdl, dtll Verwundtl-.n an{ dem Schlnchl f elde 1/il { e :ubringen.- Uorllo, 1899.
- W irlwnoen der mnder llen Feuer wn (fm - Berlin 1899.
8Rc:<s. - Die t;eschrmw/ rlwng lltr "'""' kleinkali/n r g•weh r e B i n Beitrao :ur Reurlllellu11g aer Schuu w untlm in ktm(Ugen 1\-rieqe n - Tu hingen, 1889.
- Ueber die IV/rkung und krltgs ch irurgluhe Bedeulung der <el bsllaclepisl o l c syslem ,1/atlle•·.Tubin lfen,
C A5CINO - Armi dii {U oco porta/ili. La pmllrazione. - Modena, 1897.
C n.ov sL et - Traile prnliq11e cl-. chil'"tlrgie cl "a rm u. -' Pari<, 1890.
v COLKft und Sc tiiiiONIN G. - l"tber dtt Wirkung uncl /Jt dtulung dtr nt11en llmld ·
{r:uerrca(fen Mtcl t :lttai· A bltil>mg del preussische11 1\riegs· lli nut eri llml. - Bt-rlln. 1894.
- Guida leortco·pralica del medico m i lilart in campagtw. - Tori no, 186!·63
Coc,n N.- A lda dt thirtHf1U de guerre.- Pari•, 1897.
1': 'DEL FUOfLE lTAl,lA:-iO DI PI CC'O J.O OA I IDR O, 231
I>KLOKIIK Trllltt• dr fl"•rrt. - Pari<, 1888 e 1893.
UR»ù'TIIEN.,,., U]JU/JIIftllrrl-. ,. l'acliou du prnjull/t tuÌr'lllltdu {ulil.llunuluMr, noutlrtm m n ltlt ,..,..,,.,,.,. de G "'' "' 5. - nurarc<t. h!91
K-col\\ t:n.K•. - lllt dttrc kltmkalt/Jngt t;nrthr. - 189i
I':S»AHCII. - 1/(IIW /mc/t der Ttchnik. - l\ 1cl, 188l.
FKotKKhll 111 CAVAI LIUILKùN& - /,11 cl;irurgoa di guerra Ì•o rupporta al IIUOV& ]>rooelhli di pircolo eohlwu. - T11mo•1.
f'o";'"·"" ''"""'"'' d···· J..negscldru r gtr. - Slutt::art.
II AB•IIT.- D u <irsc 1oO<s(r. lfJf dtr Gt!Jt'lllffrr/ u •hrt \\"oen. UJO
Ut1 JII"O)tclll• 1ulurlr tl dt l t urs rapporlr actc la c/ururglr dr (JIItrrt. - ,\autr,, 1891.
/}111 J\1, mkulolu r u, d" llrllmodlung dtr Sehusaorunden 1111 Ftldt - \\'oen, 1894 1\le<IIWIW•r 1111<1 J..r• tu•"Jtptok. - \\"1cn un 1 :.<·wzo,:, 1896 /Jae T•t/ftrp>octlllt 111 Thonrrt IH>d Jly a.J.U dt• Slllliiiiii IJitll•lt• un 1-"tldt.\\'!PII, Der Sl•uod dtr· im l\r1rp t rwd dit dtr'""' ""'"'''/t<licuslr 1111 F;ldt. - 1900
Ili'!\ PY.I.IJIW. - ,1/noutalc da ctoirur gia di gturrfl. Tra ol. 1tnl., P. 1':. Mnnnyra - llomn, 18i6. •. - l ' uler•uclullt{)m uber dte plu"k"llscloe de.· il.lt wkullbt r p r v}•clllt. - TuiJingen,
1\ucuf:u. - Die IVirkunysovtist dtr wnderlltu 1\ltlnt/t>t•er llr-l;esclloue18:!0.
Kuiii.KII.- me IIHorlertltll il.l'lf{/8Wil/Ttll, illl" ! Hnllt'iklll llf) lt. ilare v•o en wnrligu Slonl·llore 1\!it•kiLII,? nu{ das lutilr 11. Ziel. - Ber illi, l t!9i.
KurT,..KH. - Br(ulor·owoeu uui dtm Siidu{f"ikrmi.<e/itll Kroroe JIIV!J·>OIJIJ -TuiHII· < 10 1 t9()() ,
c - f"tll. dar Priucap d. :ri lgfmnu. 1\ritglll"lmdo•rrballdPI - o.·rlin. ISili
L OSIIIIUIIK. - (; om <hn l / ooiu l"iu; 1/ae;r cllruclcri$lic - l on•lon. t8ii
I .IIIIK - l "nrlrmnpru oilltr 1\ro eysc/ilrur g lr. - ll1••hn, 189i - l ' crrll(he iJbrr 18!•6.
MAN GI ANTI ,. - 1.'11:o011t dtl {ouilt, mod J89t.- (RitmliJ 111i/alare IÙJitMIO, Ul$11. Xli', 16 IS!II I.
MAHUM - l {tuili che'""' uualurw - /Ri l'i1111 d'arliglatria e pmìo. anno 189i. \"ol. Il ).
- l-"ur lt.atnt g• n Ul,tr - \Vh·n uod t887
NKUOollf•ll - 1/andlllteh dtr - Lelp<OJ:, 18it.
NU"IIAUII.- Cmogt B•nhrkungru 1\r,.!lschirurgae.- :lluncheo. 1Si7. et I.AVAI•• - /.t$,pr'lljtcloln du armes de gutr>'t; ltur ar/lnn uuhuirnn/e - t>art<. 189).
/,u r:rploll($. lt1 Jluutlrrs. projrtlilrs ltur "chon ti lturr r/T•I< 1'11/nerartlr.l'arh, 1899
Ut l' m (cc h oll tll chlrllrQit d'arm•t; irolulirm dts bleuure• d t gue. rt - Paro$, 1900. l.t$ annu blnneht&. ,,,.,. ocltnll el leun t tfflJ vulurrnnll - l>n11<, 1900
Traalemml d.n 11/tnure.< de {lutrr•. - l'aros. 1901.

PRITTI. - COrJ(trtn:.e d• lrflUI11(110loyi•i t an ouer·ru.
- .1/anualt d i m•dacuturt. {a.caoturt ed appartcr.hi ptr· in gou• ru. - Pi•loiÙ, 11186.
- Dit l;twt/u·.ehuSSII ' Uotdtn dtr l' tiiZFil. - .St'"''''Urj(, 1884.
- Nwt /Jtoba chtoonotn ub t;touh r.chanu; rmdm.- ncrlin, Ul87.
RICIITRR - A llpcmr mt dtr Sclwut•trlel:uufletl ili 1\rltgt. - Dresla u, 1877.
SALLK. - Aldc mému11't du mPdecm mlhtn ir·e - 1!100.
SCHII.L. - Krarga chirtu·oi<eht s 'fll&chmbuch. - 188:1.
SCII JKRNING, T IIULK u V - Dle SehO<nctrleJ:ungrn. - Hanohur;;, 190t, 5KOIIK. - llauualt d 1 elllrurgio d1 g u errn. - N31JU1i, 188i.
SKroKo. - der - Stutt:.:arl , 1893.
232 :;u t.I,'A ztONE DEGLI ATTUALI
J,'OCILI DA GUF.nR,,, Ere.
l ( i l
IL TRACOM A IN EGIT'rO
Fra i ..-ari argomenti portati a ll'o rdin e del giorno e discussi nella $ezion e o f ta.lmogica d ell° Congresso medico egi?.ian o, quello ùel tracoma assunse ta.le importa nza e tale ampiezza di sviluppo, da impor s i a t utt i g li altri e da occ upa r e, .-.:i può dire da sol o, tutte le sedute, notevoli sem pro por i l num ero e per il valore .degli specia listi che vi prese r o parte . 'l'ra g li oftalmologi egiziani, ci te rò il dottor Moh amed Eloui B ey . già professore alla scuol a di m en icina del , Cairo; il dottor Same h B ey, medico capo della C linica ofta lmo logiua nazion tde di l{alaoun, il dott or Bayoumi Fathy , il dottor Mohamed Chaker B ey, ecc Tra i francesi, il Baudry, professore a Lilla e il Gayet, professore a Lione: tra gl'inglesi, il d ottor Keun et Scott e il d ottor Fischer: tra i russi, il professore Wic h e rkie wi c z: tra gl' italiani, oltre il delegato uffi c iale del .Ministero della guerra, i dottori Guarino e Fenaltea; tra i grec i, i dottori I acovidès, Démétriadis, Didikas, Lakah, ecc (l)

La dis c ussione sul tracoma, c h e io cer cherò di rias sumere n olle su e linee principali - p oi c h è ri tengo che i suoi risultati siano f econdi di ut.ili risul tati an che pe r n oi in Italia s i svolse intorno alle sei questioni seguenti :
l" se esi sta in Egit to un 'oftalmia specialP c h e mer i ti l'appe llativo di « egizimw
2• concetto clinico ed, anatomo-patologico delle g ranulazioni: rapporto di queste con l e oftalmie purulente;
3• C'O Dtagiosità del tra.COma;
4 ° eziologia e propagazione;
5 " profilassi;
6° cura.
( I l Le sed ute si tenoero uc l rannteatro di chimica della sc uolads med icina, attigua al grande osp&<lale Karr-el-Ain ed alla ram osa moschea omonima.
flelazione del C.'lplta.no med ico dottore IEdnuoodo Tronobe&c lihero tlocen!t' rli o rta lm ol<,gi:l delegato da. S. K il Ml ni:Hro clelia Guerra al rn ed•co inte rnazional e t•nutosi n Cai ro c1al 19 al Oicemhre l!)()j
Se esista • un'oftalmia egiz iana • pr opri ame nte dett a.
L·c,prt>s<>ione di o(talniia egiziana fu usatn l a prima volta - e si diffuse poi uni,·ersalmcnte- in occasione della famosa oftalmia t'pidemica che scoppiù nell'esercito di spedizione francese in Egit.to· eia BonapartP, nel 1708; e, piì1 tardi, f1-a lo trnppo inglesi clw, dall':Rgitto, ritornarono in Inghilterra ( 1800·801-80:2) j dalle quali truppe - francesi ed ingl esi - la malattia si propagò per contagio in tutta l'Europa. )la è conforme al vero il sostenere, come fecero il Lawrence, il Ja..,ger, il FatTe!, il Mac-Gregor ed altri, che l e no;;tre t:onoscenr.e ;;u tR-le affezione ·morbosa datino soltanto dall'epoca dellegrandi spediz ioni francesi ed ingl esi in Egitto? I n umerosi ricordi storici riferi ti dal dottor Gambedi an (di L i one) nella sua t(•si, e dnl dottor Sameh Bey al Congresso p arlano el oquentemente contro le afferma?.ion i degli autori suddetti, e ill uminano d i nuova luce una questione così. lungamente discu ssa : mi restr ingerò a far cenno dei fatt i principali .
Ippocrate (450 anni av. Cristo) descrive l'oftalmia. granulosa, le sue complicazioni e la sua cura, metten done anche i n rilievo i l cara tter& epidemico. ·
Erodoto (4fJ0 a\. Cristo), il quale, come è noto, visitò l'Egitto a scopo scientifico, ci narra che Ciro, re di Persia, richiese ad Amasi re di un medico famoso per combattere un'oftalm ia epidemica la qual e desolava la P ersia.
CE1lso (50 anni av. Cristo), nel suo trattato di medici n a, ci dà un'esnttrL descrizione della granulazione, che egli c h iama e divide in due forme: u n11. acuta, caratterizzata da intensi fenomeni infiammatori e da un'abbondante secrezione purulenta; ed una cronica, con sintomi poco accentuati ed a decorso l entissimo È poi interessa nte il notare c h e · l'espressione tracoma si trova tanto nei libri di Celso q u anto in que1l i di Galeno.
Jt noto cho gli oculisti roman i avevano d ei si g ill i o de lle tavol ette di pietra. su cui erano incisi i nomi della ma latti a, del uolliri o e del medico: om, in qualcuna d 1 codeste tavo l ette fu trovato i l nome del colli rio che si usava nella c ura della asperitas, della l ippitttdo e del t r aclwma; le quali e,;pressioni ci indicano precisamente il morbo di cui c i occupiamo, e provano che le legioni romane furo n o colpite da ll' oftalmia granu losa .
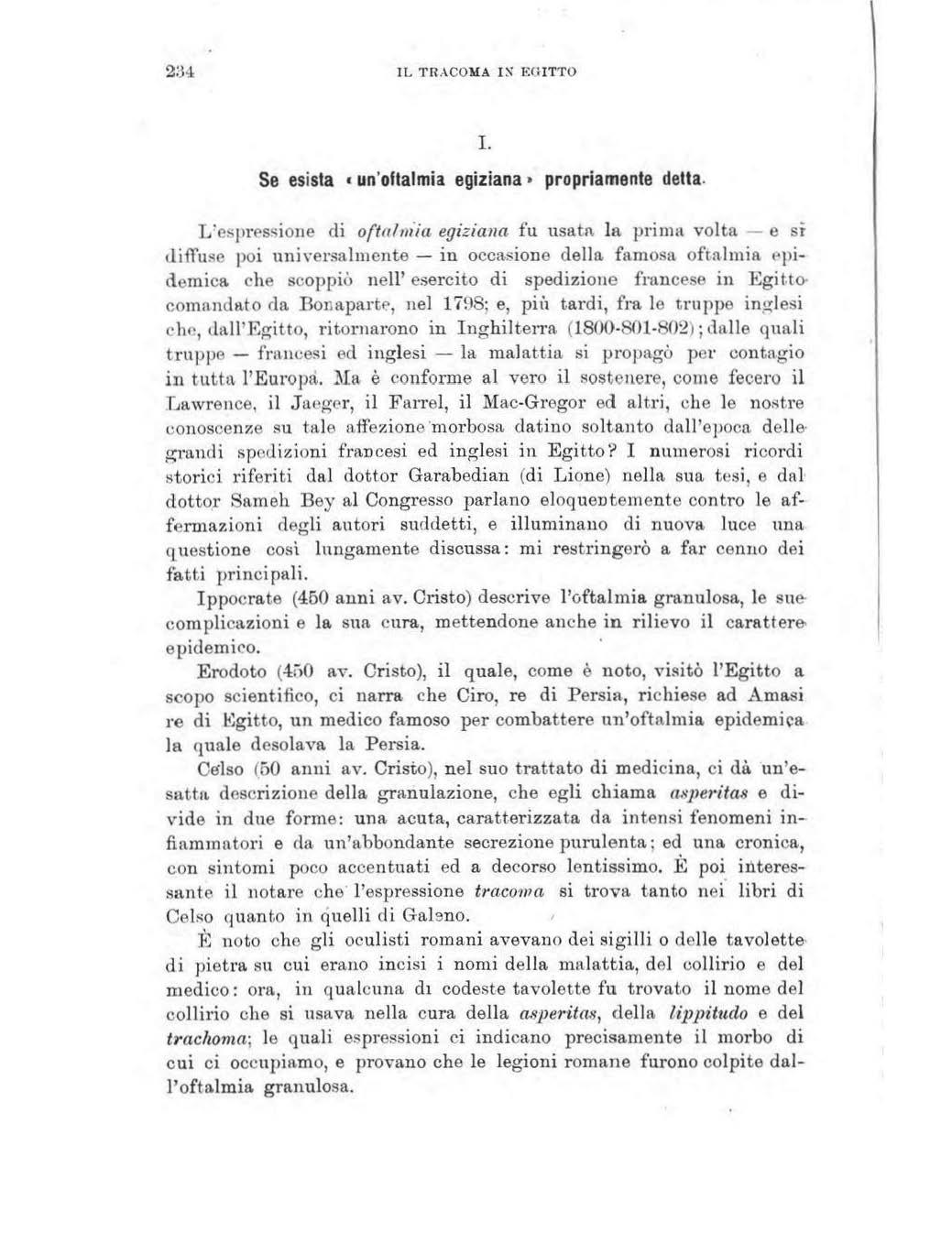
IL TRACO MA 1:\' F.ni'M'O
I.
Eble, nella s ua monografia su lle affezioni oculari d elle truppe, c i tn, parecch i documenti relativi ad un' oftalmia ch e nel 13• secolo, r egni> sotto forma epidemi ca in m olte città d'Europa: Berlino, Breslavia, Roma, Torino, L ondra : l a cni lnnga durata (tre-sette me3i ) ci fa. pe rlsa re all'oftalmia granulosa.
Cunier parla, nel suo Trattato, di un'oftalmia contagiosa che imperversò nel Belgio n e l 14" secolo.
Alcuni autori d e!I6• secolo, fra c ui Amlttus, Lusita nus e Fai.Jricius, descrivono un' oftalmia co ntagiosa che, in certe condizio ni, ass umeva nn carattere epidemico.
J on h Huxham descriv e pure un 'oftal mia epidemica che egli osse r vò in Inghil terra e che ora chiama semplicemente oftalmia, ora l-ippituda.
Secondo il \V i llmarck ( Contributo alla liiOI'ia del traco mu in Fi11tancli a) gli Svedesi Acrel e Kalbor n e av r ebbero dato, tra il 1759 e il 1 7G2, descrizioni esattissime di alcune epidemie tracomatose scoppiate in Svezia e sopratutto in Finlandia.
Finalmente nel Tratta to del Guérin pubblicato a Lione nel 1 783, si trovano delineati con grande preci sione i caratteri delle granulazioni cougiuntivali.
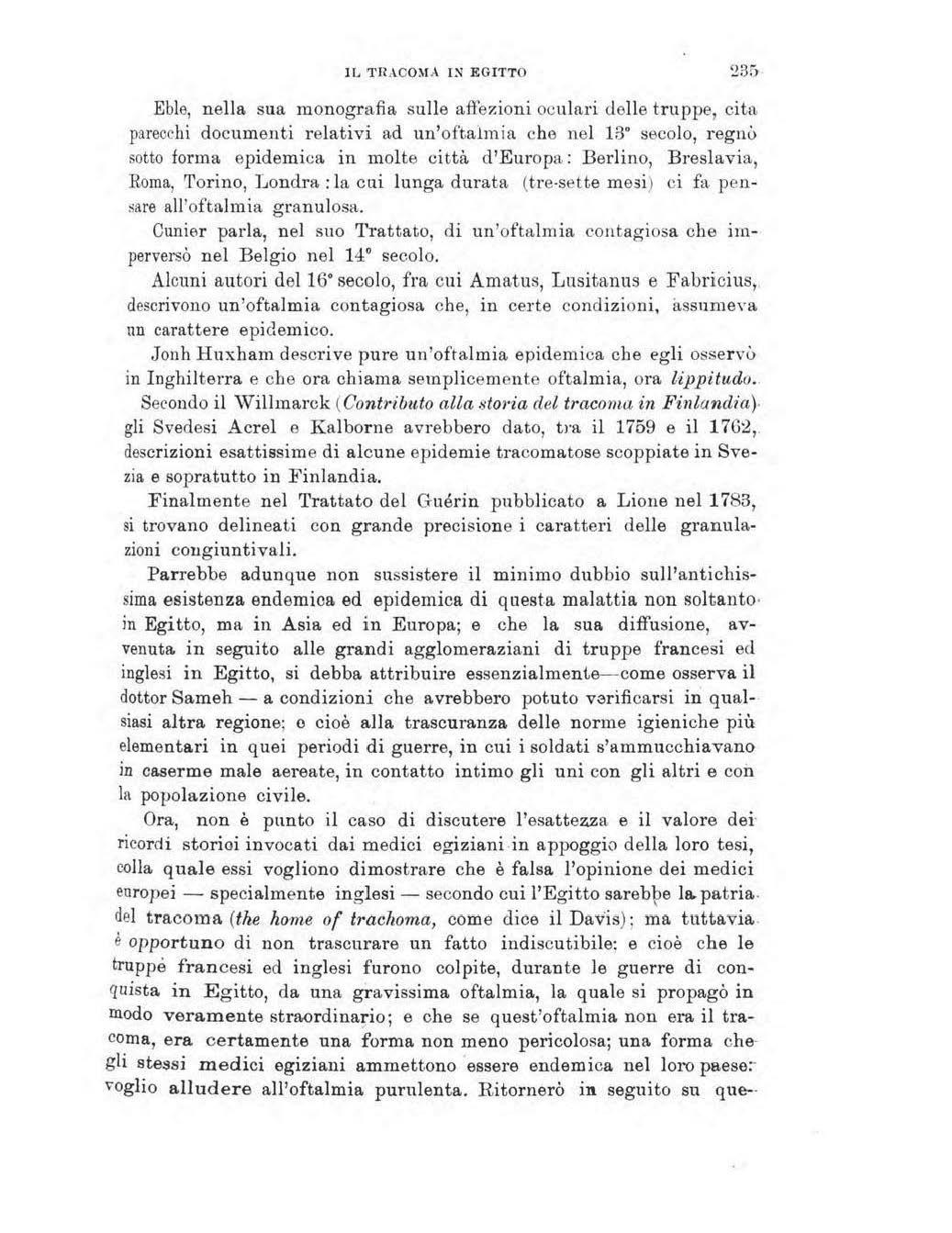
Parrebbe adunque non sussistere i l m inimo dubbio sull'antichissima. esis tenza endemica ed epidemica di questa malattia non soltanto · in Egitto, ma in Asia ed i n Europa; e che la sua diffusione, avvenuta in seguito alle grandi agglomerazia.ni di t r uppe franc esi ed inglesi in Egitto , si debba attribuire essenzialmente- come osserva i l dottor Sameh- a condizioni che avrebbero potuto varificarsi in qualsiasi altra r egione; o cioè alla trascuranza delle norme igieniche più elementari in quei periodi di guerre, in cui i so ldati s'ammucchiavano in caser m e male aereate, in contatto intimo gli u ni con gli altri e con la pù]JOla.zione civile.
Ora, non è punto il caso di discutere l'esa ttezza e il valore dei· ri cordi s torioi invocati dai medici egiziani in appoggio della loro tesi, colla quale essi vogl iono dimostra re che è falsa l'opinione dei m edici eu ropei- specialme nte inglesi - secondo cui l'Eg itto sareb pe la. patria del tracoma (the home of t1·aclwma, come dice il Davis) : ma tuttav ia e opportu n o di non trascurare un fatto indiscutibi le; e cioè che le truppe fran cesi ed inglesi furono colpite, durante le guerre di conqu ista in Egitto, da una gravissima oftalmia, la quale si propagò in modo veramente straordinario; e c he se quest'oftalmia n on era il traco ma, era certamente una for ma non meno peri colosa; una. for ma che· g li stessi med ici egiziani ammettono essere endemica nel loro paese:voglio a llude r e all'oftalmia purulenta. Ritornerò i n seguito su q u e--
l L I:\' E GITTO
st'nhima; ma intanto mi preme insistere sopra un punto che ha, secondo roe, un a grande importanza nella questione che qui c'interessa; e cioè, che in Egitto sono assai più frequenti che in Europa tutte 'le forme di cong i untivite p urnl enta, e che trs. queste - da quanto potei coustatare io stesso - ha una prevaleuza non dubbia l'oftalmia prodotta dai vari microbi della suppurazione (gonococchi, stafìlococchi, -streptococchi, pncumococchi, cocchi d iversi, e, in qua lc he caso, il bacillo di Koch -Weeks) Non mi parrebbe quindi diflìcile i l dimostrare che la denominazione di egizùma data all'oftalmia, che fecè strage in Eur opa dopo il rit orno delle truppe francesi ed inglesi dall'Egitto, na·sconùe puramente e semplicemente un errore diagnostico; nel senso, cioè, che ..:on essa si volle ad ogni costo intendere il tracoma, m entre effettivamente si trattava di un ' oftalmia purulenta. E in qual modo potè diffondersi e mettere così profonde radi c:i in tutte ie scuole oculistiche di Europa? A mio parere, per i tre fatti seguenti:
l" l'aver attribuito al tracoma nn complesso di sintomi che appar tengono invece all'oftalmia purulenta:
2• l' aver più tardi credùto che il tracoma fosse una conseguenza necessaria di ogni oftalmia purulenta;
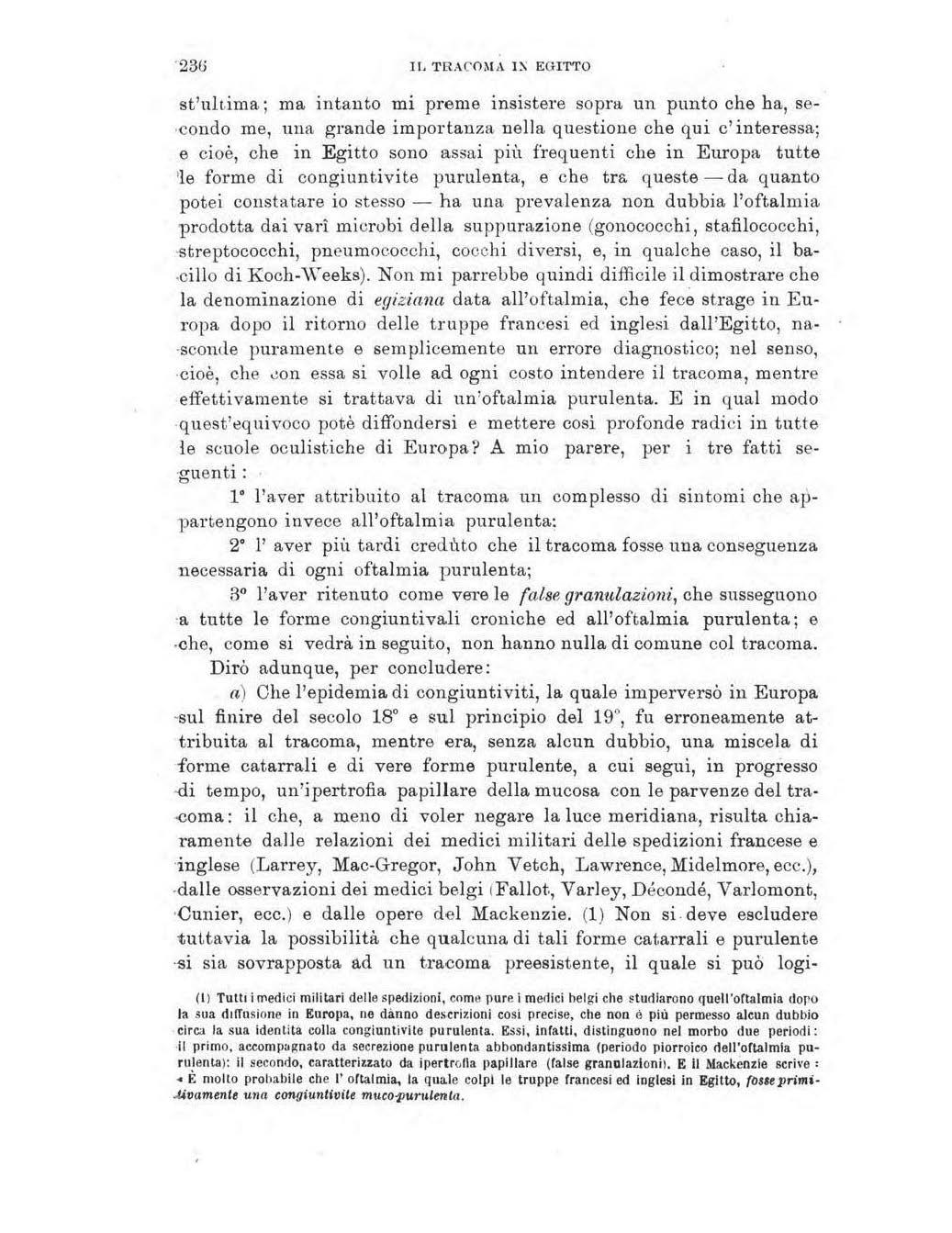
R0 l'aver ritenuto come vare le ( ctlse granu,lazioni, che susseguono
·a tutte le forme congiuntiva.li croniche ed all'oftal mia purulenta; e -che, come si vedrà in seguito, non hanno nu lla di comune col tracoma. Dirò adunque, per concludere:
a ) Che l 'epidemia di congiuntiviti, la quale imperversò in Europa sul finire del secolo 18" e sul principio del 19", fu erroneamente attribuita al tra.coma, mentre era., senza alcun dubbio, una miscela di forme catarrali e di vere forme purulente, a cui seguì, in progresso -di tempo, un'i pertrofìa papillare della mucosa con l e parvenza del tra.il che, a meno di voler negare la luce meridiana, risulta chiaram ente dal le re lazioni dei medici militari d elle spedizioni francese e i nglese (Larrey, Mac-Gregor, John Vetch, Lawrence, Midelmore, ecc.), -dalle osservazioni dei m edici belgi (Fallot., Varley, D écondé, Varlomont, ·Cunier, ecc.) e dalle opere del Macken zie. (l ) Non si. deve escludere tuLtavia. la possibilità che qualcuna di tali forme cat.arrali e purulente sia sovrapposta. ad un tracoma preesistente, il quale si può logi( l l Tultt i !Tiedici militari delle spedizioni, coms pure i mer!ici helgi che studiarono quell'oftal mi a dopo la s ua dtffusione in Europa, no dànno descri7.ioni cosi precise, che non è phi permesso alcun du.bbio circa la sua ldeotila colla congiuntivite purulenla. E:;si, infatti, distinguono nel morbo due periodi: Il primo, da secrezione purulenta abbondantissima (periodo piorroieo dell'oftalmia purulenta): il seco ndo, caratteriu.ato da ipertrulla t>aplllare (false gr an ulazl onil. E il Mackenzle scrive :
• È molto probabile che l'oftalmia, la quale colpi le truppe francesi ed Inglesi in Egitto, ..U"amenle una congiuntlvile muco1Jurtllt1111o.
236 li. TRAC"OMA 1:\ EOI'lvrO
camente suppon·e c he fosse import ato, e non esporta to da,ll'Egitto: ma ciò c h e si deve esclude re in modo assoluto- co m e dirò m egLio in seguito - è il co n cetto c h e pare abbia dominato a lungo fra gli oftalmologi; di un rapporto , cioè, di cn.u sa ad effet to fra l a congiunti v ite catarrale o purulenta a c uta. e il vero tracoma, il quf\le è una m a lattia. tipica, ben definita, a dec0rso essenz i al m ente cron ico, prodotta da. nn agente speuifì co tuttora S<'Onosciuto.
b) C h e n on è g iusto indica r e il tracoroa co l nome di oftalmia egiz iana, essendo dimostrato c h e il t raco ma egiz iano è clinicame nte e d istologicamente .ide n tico al t racom a europeo, e che non furono le truppe fra n cesi ed ing l esi q uelle e h e lo trasportarono in Europa, per la semp li cissima ragione che già. vi esi steva da secoli.
c) Che è innegabil e il fatto di una m agg i or e gravità e frequenza de lle congiuntiviti catarrali e purule nte in Egitto; ma neppur esse costituiscono punto una forma a sè, la quale assuma, in quelle r egioni , ca ratteri così peculiari rla a n torizzar ci a ··l ind icar!a co l n om e di oftalmia eg iz iana, quasi c he si t ratt.asse di uni\ congiuntivite catarra le o purnleuta diversa da quelle c he si verificano in Europa
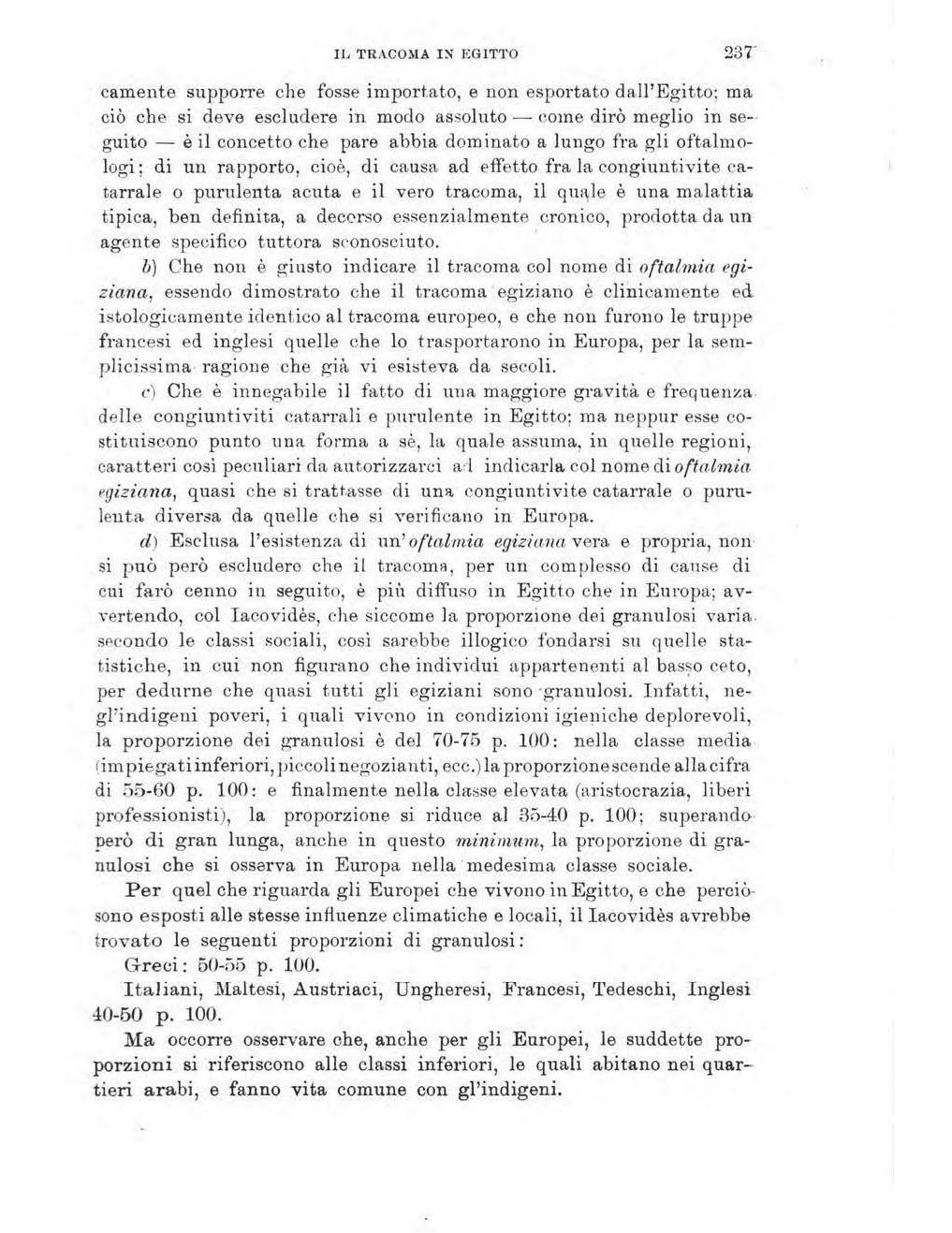
dl E scl usa l'es i sten:ta di nn' oftctlmia egiz inn a vera e propria, n on si p uò p erò escludere c he il tracomA, pe r nn com!Jl esso di canse di cui farò cenn o in segui to, è piì1 d1ffm;o in Egitt.o c h e in Europa; av,·ertendo, col lacovidès, c he s icco me la proporzione dei granul os i sPcondo l e c lass i sociali, così sar ebbe illogico fondarsi su <pell e statist i c h e, in c ui non figura n o c he individui appar t enenti a l ceto, per dedurn e c he quasi tutti gli eg iziani son o gra nulos i. Infatt i , neg l'ind igeni poveri , i quali viv0no in condizioni igiep i c he deplorevoli, la proporzione d ei granulos i è d el 70-75 p. 100: nella classe media rimpiegati inferiori, piccoli n egozianti, ecc.) la p r oporzionesce nde alla c ifra di 55-60 p. 100: e finalmen te nella classe el evata (a ris t ocrazia, libe ri p rofessi onis t i), la proporzione si ridu ce al 3n-40 p. 100; s upera ndo però di gran lunga, anche in questo minimmn, la propo rzi one di granulosi che si ossarva in E uropa nella ·medesima classe s ociale.
Per quel che riguarda gli Europe i che vivono in Egitto, e c h e perciòson o esposti alle stesse inftuenze c limatic he e locali , il Iacovidès avrebbe tr ovato le seguenti proporzioni di granulosi:
Greci: 50-05 p. 100.
Italiani, Maltesi, Austriaci, Ungheresi, Francesi, Tedeschi, Inglesi 40-50 p. 100.
Ma occorre osservare che, anche per gli Europei, le suddette proporzioni si riferiscono alle classi inferiori, le quali abitano nei quartieri arabi, e fanno vita comune con gl'indigeni.
IL TRi\CO:\lA I:-< EGITTO 23 T
II.
Concetto c linico ed anatom o- patologico delle granulazioni. Rapporto di qu es te con roftalm ia purulenta

I congressisti sono cl'<tccordo nell'ammettere c h e in EgiUo si o!';;ervano tre forme di granulazioni de ll a congiunti\'a, le quali, del r esto, trovano nu preciso riscontro con quelle che si O:st<e r vano pure i11 Eu r opa. l'r ima forma,: c h e il dot.to1· Eloni chiama f r anca, il dottorSameh J3ey, grctl/ltlazioni primitirl! . e, i l dott.or Iae:ovidès, grm111l azioni t:1·1·e: ess<l, decorre sovente i n moù.o subdol o ed i navvert i to dall'iudiv id u o; è caratterizzata da Ull g r an numero di piccole sporgenze più o meno l:oto n de sulla congi untiva del degli angoli e de l forn ice superiore; transluc ide, di colo r grigio o grigio -giallognolo, le quali rappresentano altrettanti piccol i tumor i, a l t r ettanti tuborcoli; come li chia!Jla i l ùe \\ ' ecker, e costitui scono da :;è 80le llt malltttùt. Queste granulazioni hanno un deco rso essenzi n.lmente cronico; non danno in principio- e neppure sompre - che una secrezione insjgnificaute, la quale si trova ro p presa., i l mattino, nell'aHgolo interno dell'occhio; e possono percorrere tut te le fasi rlr l la loro evoluziona esse r e a ccompagnate da alcun fenomeno infiammatorio acuto
Senlllda forma, mista o papi/lo qra11ulosa. - La congiuntiva, resa pi l1 vn lner,J.b ii E' dall'infez ione granulosa, div iene un terreno a;;sa,i vorevole all'!l.ttecchimento di vari alt r i agenti specifici, qua l i sono: il gunococcodel Nei!>ser, i l baci ll o del K0ch-\Veeks, quello de l L oeiHer, 0 •'C In cni presenza può essere dimostrata coll' esame batte r iol ogi co. In tal caso l'affezione p r esenta una sindro me più complessa risultante d<J.Il'a,-sociazione di d u e fo r me mot·bose, in cui pr edominan o s i ntomi in R11lll ma to r i acuti, sopra tutto il dolore e la scc r e7.ione. Re all o r a s i esamina l a conl! iUntiva, si ved r à, accanto alle vere g r anulaz i oni, u n ' ipe r t r ofìa della mucosa, consi stente in p i ccole sporgenze d i color rosso, c h e nascondono più o meno completamente l e granul az i o ni t i piche, e r endono spesso molto diffic il e la diagnosi d i q u este ul t i me
1'e1 za j(n-ma: t"pertrofia papillm e .11empl t"ce, o f ahe g ra1mlazi oni. -
Que:>t' i pe r t r ofi a, che risi ede su lla congiunti v a tar sal e e n el f or nice su p er iore, dà a queste pa r t i l 'aspetto ve llu tato caratter istico del la for ma papillo-granu losa. con l a qua le fu ed è spesso con f usa. 'l'ali fa lse g r anul azion i , che da Cel so fin o a n o i b a n no inge n e r ato se mp re dubbi, ince rtezze ed err or i c irca l'origine, l a n at ura. e l a diagnos i d e l t ra com a , so n o fr equenti ssime in E g itto e si osservano so pratut t o in q uegli ind iv i d ui
Il. TRACOMA IN F:GlTTO
<:he hanno sofferto di ofta lmia purulenta, o di quals i as i altra infìamma'lione co n giunti val e passata allo stato cronico . Lo svilu ppo di quest'ipertrofia. papilla.re è tal volta veramente straordi nario; ed io ne v i d1 un -caso tipico nella clinica ocu l i.stica. ùi Kalc:\oun diretta ùal dottor Sameh Bey; caso che trova i perfettll.mente confo r m e alle desc r i z ioni fatte da l Iaco vid ès . Trattavasi di un bambino di circa. un anno, i l quale aveva sofferto un'oftalmia purulenta qualche mese prima, e che presentava uu'ipertrofia papillare della congiuntiva palpebrale superiore così SYiluppata, che vi si potevano contare gli strati ipertrofìci costituiti da papi lle peduncolate; e la. palpebra era. così tumef,ttta e deforme da offrire l'aspetto di un grav issimo edema.
Il dottor Eloui Bey insiste sul fatto che queste ipertrofie pa.pillari co nsecutive, come già ho detto, all'oftalmia purul eHta., sono spesso scambiate con le asperi tà de ll a forma franca e della mi sta; donde avviene che si app li ca ad esse l a cura del vero tracoma (caustici, spazzol amento de lla congiuntiva, ecc.) 9 non si fa altro che tnlsfoxmare un'alfe.zione relativamente Jeggiera. e transitoria in un'infiammazione m o lto grave, la quale poi un gran numero di l esioni corueo-congiuntivali . Eppure un esame accurato delle parti permette t1ua.si semp1·e di distinguere nettamente queste false g r anulazioni dai ve1i noduli tra comatosi. Dal punto di vista clinico, questi u l timi si presenta no come tanti punticini sporgenti, arrotondati, grossi come capocchie di "Pillo ed anche meno, più visibili cou una lente d'ingrandimento elle ad occhio nudo; me n tre le false granulazio n i, dovute a sem l'lice i pertrofia papillare, sono gonfie, molli, facilmente sanguinanti, talvolta appiattite l ateralmente per reciproca pressione, e possono ragg i1U1gere lJerfino l'altezza di u n m illimetro e mezzo : inoltre, a differenza di l[Uanto avviene n e l tracoma, esse non lasciano ma i, quando son giunte a guarigione, alcuna t r acc i a a t rofica o cicatriziale sulla congiuntiva Dal punto di vista anatomico, poi, occorre tener presente che le vere granulazioni si sviluppano altr esl. sul r ivesti mento corneale e sul li m bus, dove non esistono davvero papi l!e che possano ipertrofizzarsi ; il quale fatto basterebbe da solo a di · st i n guere le due forme; ma v'bilo di più: la natu r a delle vere granu lazioni k essenzialmente diversa da quella delle ipertrofie papillar i, poi..: h è ment r e le prime sono cons iderate come vere e proprie neoplas i e analoghe al tu b ercol v (Soemisch, de Wecker}, le seconde sono costituite sol tanto d a llo sviluppo esagerato deg li el ementi nQrma.l i della congi unt iva, sotto l'infl u enza di un'i n fiammazione ac u ta o c ronica de lla congiuntiva medesima
In q u anto al tracorna t:ero, t u t t i i congressisti concordano ne ll'amme t te r e che esso ha semp1·e un d eco'rso cronico, in cui tuttav i a alcun i

IL TRACOMA IN EGITTO
fm i quali - per non citare che i più competeuti - it rlottor SR.meh :R"y e il rlottor hcovides, notarono non fli rado delle leg-· giere esacerbazioni indipendenti da ogni affezione sonapposta., le quali insorgono, di preferenza., in ed in estate, si manifestano con un'iniezione congiuntivale pitt accen tuata, con scarsa con fotofobia, e si dileguano in po<·Li giorni mediante il riposo E'd una semplice medicazione, lasciando le ,·ere granulazioni nell'identico stato primitivo. Però si deYe ritenere come un fatto confermato e indiscutibile che, in linea generale, il traccnna non ?lutui(ellfft mai con infiammatori t:iolenfi, vale a. dire con spetto di un ' affezione morbosa. a decorso acuto; e che ogni qualvolta in un granuloso si osserva - indipendentementP dalle esare rbazioni estive ora accennate - una sindrome di acuzie ca ratt erizzatA. Rpecinlmente da abbondante secrezione, bisogna subito pensare c he al tracoma si sia associata un'altra forma morbosa la quale sarà dovuta,. secondo i casi, al bacillo del Ko cb -Wee ks, al gonococco, al pn eumococco, ecc.: tanto è verv che, guarita la ma:la.ttia I'OVTapposta, si osservano di nuovo sulla i caratteri tipi ci del trncoma, precisamente quali si presentavano prima cl1e vi si associasse la. forma estranea acuta.
Le di'l tracoma ribelle o trascurato si osfiervano, in Egitto, nell'ordine di frequenza seguente, che. come si vedrà, è a un di pressoquello che si verifica in Eurnpa, fatta eccezione per il panno.
l. Inourvamento del tarso e denazione delle ciglia (e ntropion e trtchiasi ). - Sono molto comuni in Egitto ed hanno sede preferì ta.. nella pal superiore.
Ectropion. - È quasi esclusivamente limitato alla palpebrainferiore.
3. Panno. - Può dirsi abbastanza raro (783 casi su ll,GOO malati, ossia appena il 6 p. 100, secondo Eloui Bey), e le poche forme che se n& osservano son que lle tenui e carnose.
4. Blefarite - :Mentre, in principio, è in rapporto diretto col tracoma, più tarùi assume l 'aspetto di una vera e propria blefarite pustol osa, a cui seg ue co ngiuntivite cronica del fornice inferiore e madarosi parziale o t otale.
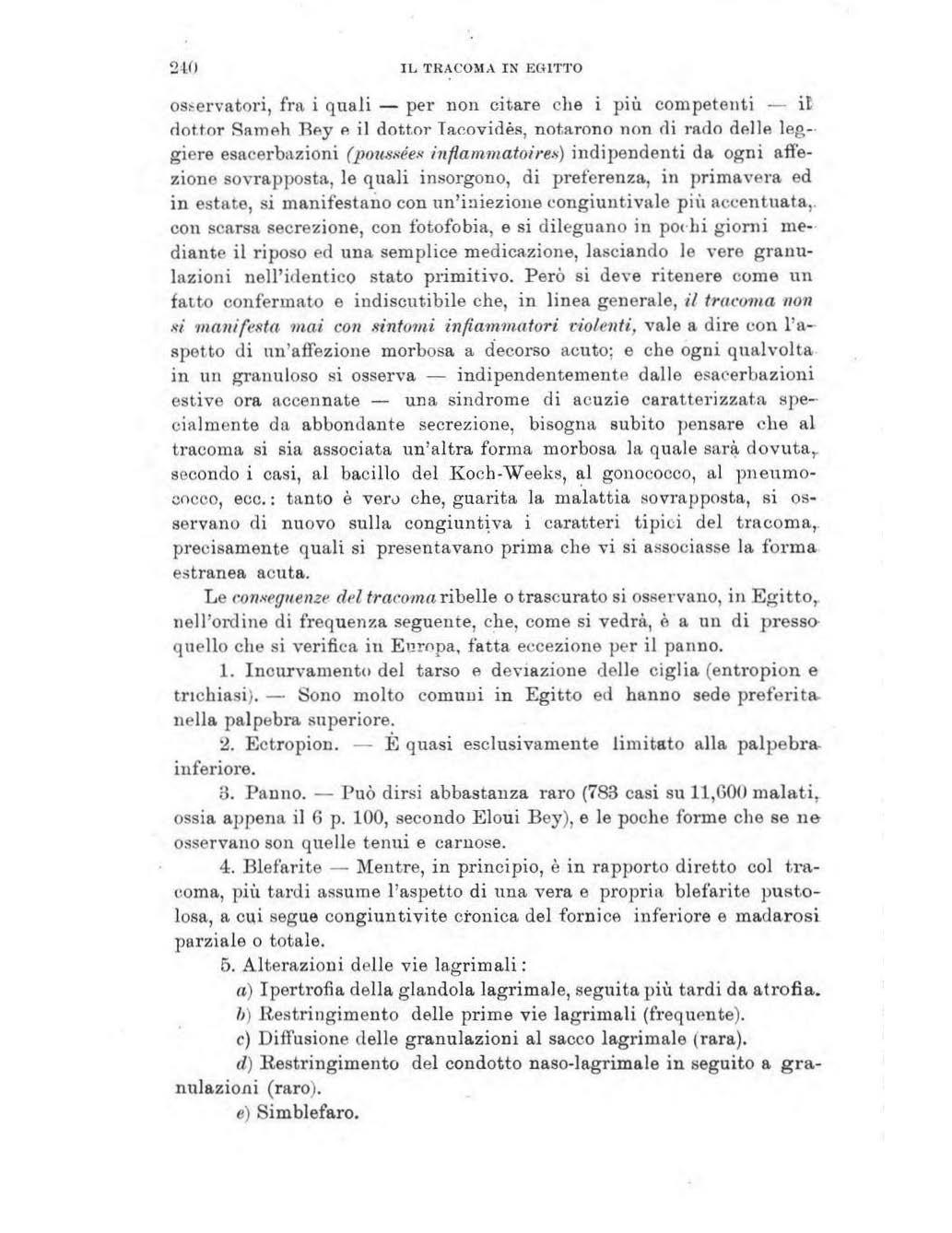
5. Alterazioni delle vie lagrimali:
a) Ipertrona della glandola Jagrimale, seg uita pil1 tardi da atrofia.
h) R estringim ento delle prime vie lagrimali (frequf'nte).
c) Diffusione delle granulazioni al sacco lagrima!e (rara).
d
) Restringimento del condotto naso-lagrimale in seguito a granulazioni (raro).
e) Simblefaro.
IL TUACOMA IN EGITTO
( 1 Granulazioni d ella congiunti>a bulbare.
g) Xerosis della congiuntiva e della cornea ( rarissima) .

Se i risultati delle osservazioni cliniche sul t ra coma presentati al Congresso furono di grande imporumza, come lo furono quelli - e lo vedremo fra po('O - r elativi all'e?:iologia ed alla profilassi, ugual eosa non si può dire dei risultati delle ricerche batteriologiche ed ana lomopatologiche, c h e non ci ri>elarono proprio nulla eli nuovo. l\[a O<'COrre a vche di ciò nessuna colpa può fa tta agli oculisti egiziRni, poichè questi due ultimi argomenti non fra i temi del programma nflìciale, in cui si dierle invece il primo posto alle questioni di eziologia e di profilassi, sulle quali si deside ra\·a piit specialmf'nte di udire i pareri dt>gli oculisti d'Europa . Dal punto di ,·ista batteriol<,gico adunque, si concluse semp licemente col Morax: «che l'agente parassitn rio del tra.coma non è stato messo ancora in ev idAnza, e cltO sembra dù.vvero che esso ostinatamente a tutti i nostr i mez7.Ì di cn l tun1, L\ tutti i nostri esami microseo pici. » Dal punto di vista logico, si che il tracoma è fot·mato di co rpnsro li agglom<>rnt\, rotondi e linfatici che, uel loro insieme, c i appui :>c·ono come pic!('o)e glandole o follicoli linfatici , descritti dall"Ivauoff c·ome vere e proprie ueo formazioni glandolari ricoperte da epitelio è !'par;;e nello Rpt>ssorc della. congiunti va: si com·enne ancora, col fiiclwl figlio, che il t.rncomn. non è superficial e, invadendo esso gli strati linft1idi: f' si <:onr ln se defini rio, q nasi colle stesse parole dell' Ad1lario, nn proees..:o in fin nllnatorio croui co a f:>cola i, dovuto, con ogni probnbilità, ad un ngelltt> spec ifi co. e carntteriz?:a.to dalla produzione di noduli liufatici che filli'<c·ono per r e in seguito a n ecrosi par?:ialo 0 ad nno S\'Uotamt>lllO nJI',•,tPmo più o meno completo, dando luogo ad uno ueo-produzioue <·onnettintle con cicatrizzazi one t·onsel" ntiva nello strat o ;ldeooirlt> della muco:-;n.
Dopo quanto h o riferito circa le varie forme di granulazioni e drca la loro nnluru, ben poco mi resta a dire sui rapporti fm 1Jflolmi(l purulenlct l' trcu·onw. Insisto anc;ora u-na. ,·o lta su l fatto ben c-om provato cho in Egitto s'incontrano tutte le forme di congiuntiv ite pnrnleuta. con magg iore fre1 1nE>nza che in Europa; e c h o, mentre 1' oftalmi a dPi neonati uon nu lla di caratteristico, avendo cause sintomi e dt>corso perfettomen te identici t\. q ne l li che si servano 11ei nostri pnesi (a1l ecce zione, tuttavia, delle enormi iper t rofi o papillari consec utive !, l'oftalmia prodotta dai vari mi c robi df'lla suppumzione
1Sta.fi1ococco, streptococco, cocchi diversi, ta l volta anche il bacillo del Ko ch-\Veeks, oltre il gonococco), la quale può dirsi veramente endemica. in Ecritto, presenta invece questo di speciale: di non insorgere che o eccezionalmente d'inverno, e di ll.::!sumere, per contro, un ver o e proprio
t6 - r;tornnle mtdico.
11. TRACCIMA DI EGITTO 241
andamen to epidemico nei mesi di estate, seguendo una curva. la. quale r aggiu ngo due massimi: l ' uno i l 30 giugno e il secouùo il 15 ottobre per tenninare poi verso la fine di novembre. Durante i mesi ca ldi, quest'oftalmia. colpisce indifferentemente bambini , adulti e vecchi ; ma. eli preferenza i primi dai due o t r e m esi di vita fino ai nove o dieci ann i , e, in generale, tutti gl'individui già affetti da zioni o ds. una qualsiasi infiammazione dells. con gi uu t iva ; i qual i è ben raro che passino l'estate senza. p agar e il t ribu to a questa nuova inft!zioue, da cui traggono origine numerose e grav i complicazion i co rn eali.
Quest'oftalmia. esordisce ordinariamente con un senso di bruciore e d i puntura che, dalla caruncol a, si estende ben presto a tu tta la con gi un tiva; al quale segL1e, dopo qna.lclte or n - e in ciò consi ste il caratt eri stic:o - tutta l ' imponente sindrome d elle f orm e purul ente, dall' ede ma palpeb ra l e enorme allo sco lo abhondantd di pus; as-;ocia.udosi, si può dire, in un so lo i due p eri oùi tipici eli s iffatte oftalmia, quali !:l iam :,;oliti di osservare in Europa: e <:ioe: il periodo d'i11filtrazione e qnello piorroico. Ora, in qua le rapp orto sta quPsta congiunti vite eol tracoma':' Lasciando da parte, prr adesso, h\ l or o rispetti ,·a ezi ologia in cni si so r pre ndono pun ti di conta tto st,retti:;simo, e t<>i1cndoci esch•si\·nmPnte n e l ca mpo cl inico, s i può nffrnuare in mocio non dubbio cho qui non si tratta già. di un rapporto di causa ad effetto come si è creduto }Jer molto tempo. ma bensì d i un a t:Oronel senso, cioè. che l'oftalmi a pnrulentn vieni' a SO\Ta pporsi ad un traco ma. preesistente, il quale tracoma. a-çe,-a n',;O la congiu n ti,·a. terr eno propizio aJlo s\i lnp po dei ,·arì piogeni. Di q u esto fatto, t·h<' pant•bbe non aver bisogno di dimostrazione alcuna o c he pure è tuttorn discusso, il Iacovidès offre due provr coucludenti :

1n (i-l' individ ui g ranu l osi , ch e contrassero in fc'Stnte l 'oftalm ia purulenta, ricorrono soll eciti all'octÙista. e, dopo l e cure opportun e, m igliorano <' guarisco n o in uu periodo di tempo che oscilla fra i diec i e i quindici g iorni: ma essi non cessa n o perciò di es!;ore ancora e se mpro granul osi come prima, n è le granulazion i da c ui so n o a ffetti si arrostano punto u e l loro de corso cronico; c h è a11zi ne seg uon o tutte le soli t o fas i, como so n on fosse co m parso alcun fatt o acuto .
2" L'csnm o batteriol ogico del pus, ch e scola co ngiuntiva durant e l 'e voluzio ne dell'oftal mia purulenta, dimostra, iu quasi t utt i i cn.si, la prese nza dei microbi c he l ' hanno proùotta Ora, essendo noto che, durant e l 'evolnziouo delle granulazioni , non s i riuscì mai fino ad oggi ad isolare alcun microrganismo s pecifico, s i è costrett i ad afferm are ch e la form a purulenta provocata dalla presenza d e l gono -
2J.2 Il. IN E G I T T O
cocco, d e llo stafìlococco, del pne umococco, ace . è vorameuto un'infiammazione nuova, al tnwoma, col q ualt.> non htl, s i può dire, c h e rap porti rl i Ticinan za.
All'opinione del Iacov iJè;;, dell'Eleni B ey e del Sam<'h aderirono t utti i l'o m prrso il dottor Lakah, il q ualc. autorizzato dal prof. .Ahadic (a.;s<'nte ) di c hi arò c h e <tttf'st'ultimo n o n lm mai sostenuto c h e l'ofta lmia te rmi nasse, in Egitto, con una congiuntivite granulosa; ma ha affermato. iu,·ece, c h e l'oftalmia pur ul e nta è m pli ccmcnt.o una cau sa che alla granulazione co ngi unti va le.
Il prof. Baudry (di Lilla) riass umendo, in fi n e, l ' important e di..:cussicme su q_uesta partf' de l programma, concluse colle sPgue uti dicltiarazi oui:

«Come la co ngiautivite purulonta non è a c n trL del traroma, così qu es t"ulti mo 11 0 n è una d t? rivazi one d elltt prima. I o p osso n.ff'Prmare, pe r c•onto mio , di non n.n•r ntn.i illrnco mo .-n ccf'rlcrCI ad lllllt qwth;iasi d Plle num t-:-osr congi nutiviti pnrulcnto che ebbi o• tas ionCI di c urare in trent'anni cJ' p;;e r cizi o pro fess io nale . B duuttne logìco l'am m ettere che i medici, i qunli o..:srr \'arono i l tnw vma. in aù un'oftalmia p urul cnta guarita, si tro,·arono nel aver che fare con ammalati a ffetti in anteceden za da g ranulazioni a d eco rso ins id ioso •.
St>!J JHUe non si trntta\a - io mi pe rmetterò di aggiungere- di quella .!'cmpliC"e ipert r otìa papi llaz e. la quale segnc spe.-..:iss im o le infiammazioni purult- nte d1·lla congiu nti,·a, o s i prese nta sotto l'aspetto eli fals e grcw u.la z iMii a cui dobbia mo tanti errori diagnostici e tanti in successi t e- ra p e u tic·i.
Contagiosità del tll'acoma.
Tutti i congrel'lsi sti - meno uno, com e dirò fra poc-o, - fii mostrarono concor di n ell'a mmettere la contagiosità de l tmcoma, r if er endos i alle i nn umerevo l i o::se rvazioni giornaliere dei m edici pratic i , a ll e inoeulaz i oni con esito posi tivo (Sattler) eù al caso elassico di inoc u l azione accidentale rife rito da.l Chi bre t (l ) .
(l) Tra tta s i rle ll'au to ·o;servnzione <lei do ttor Rivers , il quale riferisce di aver con t ratto Il tracoma rice•endo, nel l 'occhio d es tro. uno spr n1.zo di succo semiliquido proveulente dallo del noduli che il s uo occhio ammalo t re rlopo il destro, ti Ri•er! tl<c h ia r a, coo grande sto•cismo, di essere soddisfatto di aver a•uto il tracoma, poten do fornire, In tal modo, una pro' a d' Infezione di retta
Il. IN EGITTO
Ili.
Il dottor Eloui Bey però notare come, dal punto di vista c lini co eù eziologico, occo rra divi de re le granu lazioni in J<ecclle e nenfi, poichè mout r e queste ·ul time suno co ntagi ose, le prime non lo sono pun to. P e rò, quando si parla di secr ezione, non s i deve già int e ndere - co me f o rse qua lc u no p otrebbe s upporre - un vero scolo di pus dnlla r ima palpebral e a simiglianza di qhanto avviene nell'oftalmia pnrulenta. : mlt una scarsa trasudazio ne eli liquido mucoso commisto a. lagrimE', che apparisce tah·olta nel deco r so d Al lracoma 1osacerbazioni estiv<') e si troya coude nsat o, il mattino, neg li angoli dell 'occhio.
Contro l'orif!;ine infetti va del tracoma e, pe r c'o ns eg nenza, eont r o la Hua co ni,ag ios ità s pecifi c a, so r se il dottur distinto oc nli stn italiano esercente al Cairo, il qnalP, l a qu es ti o n e da un punto· · di v ista nu ovo e o rig ina le, e basandosi s u a lcune osser vnzi oni p e rsonali, v('nn o o. t·on(·)ud (;' re c h e il traco ma è il ri s ultnto di u11 ' infìl.tra?.io ne lent a, n olla muco::;a, d elle tossine el imin a t e dai diversi mic r obi 1 quoli hanno el etto domic ilio nei fornici d e ll a co ngiuuth·a; nel s<•nso, c it)(·, c he, irritando il sist.e ma li nfatico e le g lan dol e te rmi na li, questo tossi ne darebb e ro lnogo l entamente a quella ue of ormazi one ch e 'ien detta traco ma. Quindi, poi c hè quest'aff'!zione non si svilu ppa sele:t.ion e .;u tale o tal altro pu n to d e lla. per effet t o di un micro r gfl.nismo specifico, ma è il prodotto di un'azione c himic a irritante c h e proviene dalle Sf'cr e zi o ni tossic h e dei mic·rorganism i più diver.;i , il Guarino ne esclude l a natura infetti,·a, ed amme tte che la s ua propagazione in Egitto sia in un rapport.o intimo e co:>tante con l e infiamm azion i congiuntivnl i che prf'd ispo ngono la mucosa a l l'infiltrazione delle tossine: in fiammazioni c h e, nel la maggior p arte dei casi, sono o nhbandonate a sè stesse o mal c urat e .
'K o n pnò ll <'g'I\I'Si che i l dottor Guarino, facendo fronte co raggio:;am entc nlle vivaci opposizioni di quasi tuttl i abbia indionta lllH\ nnova ,.i11 di ricerche e di studi la qmd1'. nelle prc:>enti incertezze, pot rà. for se co ndurre un giorno al ht soluz ione nell ' i n t e r essant o probl e ma; ed io dic hi a r o ch e n e fui lie to come it a liano. ]Ifa tmttanrlos i finora d i una se mpli ce opini one p e rsonale non convo.lida ta da faLLi po · siti'i' Ì, nou disapprov are la _p ropo sta del prof Wic k orki ew icz, il qunl e pros ie. leva in que l g io rno la s<'d n ta, di r esl rin g<>re, c ioè, l a disc u ss ione in l im i ti assai modesti: e di co nl'iudere c h e, q u antunque non c i sia n oto ancora l 'age nt e specifico (come, d e l r r>sto n o n c i è n oto pel morbill o, per la. scarl atti n a, ecc. ) pure tutto c i porta a rl ammott or e che il traooma sia una malattia infettiva e minen tem e nte co ntagi osa.

214 IL TR.-\CO MA DI EGITTO
IV.
Eziologia del tracoma e sua propagazione.

Seguendo i concetti svolt.i dal dottor Eloui Bey diJ!anzi al Congresso, jo dividerò le cause predi8pnnenti del tracoma in g ontlrali e particolari; intendendo per le prime, q nelle che spiegano la loro influenza più o meno in tutt i i paesi; per le seconde, ·qnelle c he, in Egitto, sono specia li o predominanti. Vediamol e brevemente.
Cause generali. - Tut ti gli agen t i capaci di congestionare direttamente l'occhio, di irritare meccanicam e nte la co ngiuntiva o di e&poiTe l ' individuo ai pericoli di una infezione mi cr obic a, favorisco no in generale l'azione del g erm e s peci fieo delle granulazioni. Appartengo no perc iò a questo gruppo l e condi:r.ion i climatic h e ed atmosferic he da una parte, e dall'altra l e condizioni individuali e quelle di ambiente .
a ) Condizioni climatiche. È n oto uhe il calore, l'umidità e gli sbalzi ·d i t.em peratura. sono altrettante cause pred isponenti alle infiammazioni oculari, l e quali, infatti, sono comunissime nelle regioni basse ed umide de l nord del Belgio, nei pae si piatti ed a cq uitrinosi dell'Irlanda, della Polonia, della Russia, suìle coste marine d e lla Sici lia ( 1) . Ma se tali cause agiscono dappertutto con maggiore o minore intensità, bisogna però dire c he in E g itto sono senza confronto più gravi, poichè quivi sp iega no un'influenza. cumulativa. Si verificano, difatti, sbalzi di temperatura di 15°-20 ' in una stessa giornata; il calore vi è intenso per circa sette mesi dell'anno; e, infine, l'umidità vi è grandissima, sopratt ntto durante la crescenza e l'abbassamento d e lle a eq ue del N ilo. A questo proposito, anzi, il Iacovidès osserva che il calore umido, il quale p esa sull'Egitto dal magg io al novembre, con un 'm(t.ximtbm che si mantiene quasi invariato dal settembre al15 ottobre (c r escenza del Nilo) e produce sofferenze di gran lunga maggiori che il cal ore secco, diviene non soltanto una causa predisponente di prim 'ordine al tracoma per tutti gli abitanti, ma altresì un nemico terribile per chi g ià ne è affetto. Veno le sette di se ra, egli di ce, uu granuloso che ha passato, fino a quell'ora, più o meno bene la sua giornata, si decide ad andare a respirare una boccata d'aria sulla terrazza di un caffè; ma, dopo qualche minuto, asciugandosi il s u d ore che gli riga le guancia, avverte nn senso di molestia nell'atto dell'ammiccamento, quasi che avesse dei
( l l Si consulti, a propo<ito del trdcoroa lo Sicilia, la dotta conferenza fatta al 1° Congresso medico siciliano, il W 1001, dnl colonnelilo med>co ALvARO, e pubblicata coi tipi di Francesco Lugaro, . Palermo: Contributo ali carla nosogra/lca della Sieilia
IIJ THACOMA IN ECHTTO 245
granelli di sabbia negli occhi (noduli tum efatti per razione d el calore umido) . Egli allora li stropiccia come per libcmrsi di quei corpi est ranei, ma sente invece aumentare Ja m ol estia, a. cui si aggiunge la scarsa secrezione di un liquido vischioso, che si va raccogliendo a poco a poco negli angoli della rima palpebrale: l ' individuo si asciuga e ripete le fregagioni, ma gli occhi si fanno sempre piit r ossi e dol e nti; cosicchè non trova alcro scampo che correre a casa p er lavarsi e per sfuggire gli effetti nocivi dell"umidità.
Questa è la sorte di tutti i granulosi che osano uscire dopo il tramonto del sole; n è altrim e nti &.vv iene a coloro che, abbattuti e rifini ti dal caldo eccessivo in una camera chiusa, aprono l e finestre e si espo ngono alla brezza umi da della notte: ess i si il matti no colle palpebre incollate, talora e con le congiuntive fortemente iperemiche. Ma l'importanza dell 'umidità qual e causa predisponente alle infiammazioni congiuutivali era già stata segn alato., in un modo c h e più preciso non si saprebbe desiderare, dal LR.rrey nelle sue « Jiemorie • sfortunatamente poco lette ed ancor meno apprezzate. « L' oftalm i a - egli scrive - cominciò ad invadere la divisione Dessaix c he, nell'Alto Egitto, era impegnata contro i Mamelucchi, quando i soldati dovettero restare a lungo nelle barche galleggianti sul Nilo. • E in un'altra. parte agg iu nge:« Nella battl'lglia di Abonkir (21 marzo 1801) sostenuta contro gl' I nglesi, nello spazio di circa settanta giorni, tremila uomini passarono all' ospedale affetti da oftalmia; ed fl da. notarsi che, in tale battaglia, i soldati, affranti da continue fatiche, si trovarono costr etti a. bivaccare su di nn suolo oltremodo umido; anzi , i loro accampamenti subirono un improvviso allagamento fino alle rovin e dell'antica Alessandria, avendo i nemici rott.e le dighe dei laghi. • E ancora più innanzi: « Nel mese di giugno del 1801, il passaggio dei venti nord-ovest e la piena del lago Ma.y dyeh, le cui a cque bR.gnarono il campo, fecero succedere alle ferite una oftal mia ribelle la quale colpì alt1·i tremila • Finalmente egli osserva.: « che l 'oftalmia non attaccò sempre i reggimenti francesi co n uguale inte nsità: molto diffusa e grave nell'anno VII (1799), fu limitata e benigna nell'VIII (1000); la qual differenza si deve attribuire alle marcie faticose per deserti privi d'acqua, dove i soldati passarono brudall' ecces i vo éalore secco all'umidità de liR. notte. • E n on meno esplicito de l Larr ey è l' Assalini, i l quale faceva pure parte della spetlizione in Egitto: « Esponendoci all'aria della notte - egli scriva nel suo Jlmmal e di chi1·urgia - noi eravamo presi immediatamen te dall'oftalmia, sebbene !R. pol vere e la sabbia fossero sott'acqua. • Fin da quel tempo, adunque, le influenze climatich e sullo sviluppo

2!6 IL TRACOMA IX EGlTTO
del tracoma o di qua lsiasi altra forma di co ugiunti>ite, erano perfettamento conosci u te ed apprezzate secondo il loro giusto valo re; ed i o ho vo luto citare qui le osservazioni di quei due insignì chirurghi dell'esercito napo leonico non soltanto per appoggiare con nu ovi argomenti, c he, viceversa poi, son vt- :chi Ji oltre un secolo, l'opinione ch•gli oculisti egiziani; ma altresì perchè souo lieto di poter dimostrare, og ni qnalvolta mi se ne porge l'occasione, che gli uffi ciali medici furono sempre pari al loro uffi c io, nè tmsc uraron o mai, neppure in tempi poco favorevoli e tra ditfi coltil. e pericoli, eli studiare e di indagare le cause dello malattie che infìeriva.no n e lle truppe, e di compilare perfino relazioni accnrat.issime tra. un' epidemia ed battaglia, incer t i dell'oggi o del d o mani, non a.'l"idi di gloria , quasi privi di mezzi e di aiuti, ma animati da un altisl'imo sentimento del dovere che li spingeva fino al nobile sncrifì c io della vita. Rico rd o, oltre il Larrey e l 'Assalini, a titolo d'onore, il D esgenettes, il cui nome basterebbe da solo ad illustrare il corpo sani t ario militare che segui l'esercito di B onaparte in Egitto.
b) r.e condizioni indi'l'iduali che aumentano la recett.ività per le granula?.ioni sono: la trascuranza. delle norme igieniche (di cui parlerò tra ttando delle cause particolari), la miseria fisiologi ca, l'e tà (infanzia, adolescenza); ma sopratutto la scrofola e illinfatismo che in Egitto son co munissimi, particolarmente nelle classi inferiori. Il Iacovid ès, basandosi sulla sua lunga esperienza, dice, a questo proposito, che questi due stati contribuiscono a. r er.dere l'individuo un terreno favorevole a co ntrarre il tracoma, donde l'estrema frequenza di quest'ultimo nelle persone linfati che e scro fol ose; e che, in un gran numero di bambini e di adolescenti tracomatosi, la cura delle granulazioni associata a quella ge· nera l e, diretta a migliorare la costituzione, gli ba dato !lempre i migliori risultati, avendo notato che la guarigione delle prime non si otteneva mai se non col miglioramento o colla radicale modificazione della. seconda..
An c he gl'individui che attendono a. certi mextieri, come i fabbricanti di sigarette, i tagliat.ori di tabacco, i lavoranti del cotone ecc. che vivono in m ezzo ad un pulviscolo irritante, nonchè quelli che debbono es porsi all'umidità della notte, come i giovani di caffè, sono particolarmente disposti a contrarre il tracoma. E in questa categoria noi dovremo pure comprendere i cocchieri, i palafrenieri, gli stallieri e i soldati delle armi a cavallo, i quali, sotto questo punto di vista, non si trova no certamente in -éondizioni migliori degli operai anzidetti, poichè, oltre all'espors i per parecchie orf\ del giorno alla polvere irritante che si solleva durante il governo del cavallo, subiscono altresì, per turno di servizio, l'influen;-.a. del caldo umido delle scuderie, a cui si aggiunge l ' azione penetra.ntissima dei gas ammoniacali che si svolgono dalle lettiera.

Jl, l'RACOMA EGITTO 247
c) Circa le çondizioni igienic/.le di vita e circa le abitazioni, h t<. v vi ben poco da aggiungere che non sia noto: le case di terra o di pietra senza intonaco ed umide come son quelle di alcuni villaggi; i tappeti e le tende che abbondano nelle case dei ri cchi, e che raccolgono nei loro tessuti i germi patogeni, so n condizioni, le quali, quantunque risiedano ai due punti estremi della vita. sociale: tuttaYia si associano e contribu iscono a l danno comune, favorendo la produzione di focolai infettivi diversi e pericolosi.
Catu<e particolm·i. - Queste ca u se, alcun t> delle quali spiegano un'influenza esclusi va ed altre un'influenza predominante in Egitto, sono le seguenti:
l" Trascura11za della pulizia. Veramente la si dovrebbe considerare n ella persona e negli ambienti; ma l'una forma è cosi compenetrata n ell'altra, cho uno studio isolato delle medesime riuscirebbe incompleto. Non occorre c he qui intendo parla.re soltanto delle classi più povere.

Mi fu narrata in Egitto una curiosa leggenda. Volendo Allah costruire una città ch iamò a mc•;olta i suoi migliori artefici e, fatto p alese il suo progetto, ordinò loro di realizzarlo, aggiungendo ch.e questa città non doveva avere rivali. Gli architetti celesti si misero a ll'opera con tutto l'impegno; ma ahimè! quando ebbero terminati i l oro lavori, Allah non vi trovò nulla di nuovo e respinse sdegnosamente r.ol piede monumenti, palazzi, catapecchie, moschee, cittadelle, giardini. Di tutta questa miscela straordinaria. di r ottami, il caso fece poi la città del Cairo. Ebbene, la leggenda ba ragione: il Cairo rappresenta l'assurdo in tutta l'estensione del termine; e come racchiude nelle sue mura quas i tutte le razze e quasi tutti i costumi, così riunisce il fasto delle maggiori capitali alla. miseria dei più oscuri villaggi; lo splenrlore dei quartieri aristocratici, q u tdi son quelli dell' Ec:békiyé e d' al ributtante sudiciume del vecchio Cairo e, iu parte anche. di quel l abirinto di strade che si stringe attorno al Mouski, dove, coll e piast re e co ll e .st.erline, si ammucchia il pattume di uUA. popolazione di rivendLtglioli.
Cbi, prendendo il coraggio a due mani, ha visitato di proposito certi q Ltartieri arabi del Cairo, comprende facilmente come vi possano dominare, diffondersi e perpetua1-si le malattie infettive ; poichè 11.0n soltanto vi sono trascurate le norme più elementari di pulizia privata e pubblica. ma. si assiste purtroppo ai più gravi reati contro l'igiene. Viuzze strette e tortuose, alcune delle quali senza uscita. e senz'ombra di lastricat o, dove, in tutte le ore del giorno, si pigia una. folla cenciosa e strepitante, fra. cui si aprono a stento un varco lunghe processioni nuziali, cortei funebri, venditori ambulanti, file interminabili di cammelli e branchi
248 Jl, TRACOMA IN ECU'l'TO
-di somari, lasciando sul suolo uno strato di lordure, che n essuno pensa a togl ie r e, e in cui ruzzolano caro e bambini. E in queste viuzze, che nel loro insieme, ci danno l'idea. della Corte dei miracoli, vi sono certe basse e sudicia in cui sono stipati migliaia d'individui della classe povera in mezzo a rifiuti d'ogni specie; e botteghe d i ci barie, di tabacco, di stracci, di mille altre cose indefinibili, che invadono mezza. la strada, impregnando l'aria. di odori acri e nauseabondi che mozzano il respiro.
Tutto questo nel Cairo, a pochi passi dall'incantevole parco dell' Ezbé/;iyé, dove una. folla. a llegra ed elegante piglia. il fresco tra i palmizi e le euforbie, al suono di una banda. mili tare inglese; ma è ben peggio quel che si osserva nei villaggi indigeni, in cui i fe/lahs abitano con le loro famiglie e con l e loro bestie in veri tuguri fabbricati col fango del Nil o, senza finestre e, per conseguenza, senza luce; composti di un solo ambiente che serve da camera da let to, come lo indicano alcune manciate di p aglia sparse sulla onda terra; da c ucina: perchè una pentola, ritta s n due pietre, sobbolle alla debole fiamma c h e si svolge da. Ilo ster co disseccato di animali; e talvolta anche, co me dice il lo.covidès, da latrina.
Il fellah, che è sobrio, paziente, attivo, capa ce di l avo rare da mattina a sera sotto l a sferza del sole, ' colle gambe nell'acqua o nel fango; che mangia pochissimo e sopporta ogni privazion e sen za. lagnarsi, sciupa. questo invidiabile corredo di buone qualità con una. trnscuranza. della sua persona., che sembra. perfino incredibile. Egli va per lo pi ù a piedi nudi; porta - ma non sempre - un paio di calzoni di cotone l a rghi e co rti, ed nna specie di camicia azzurra, bianca (di un bianco sudicio) o nera - il così detto galabielt - che gli scende fino ai piedi, che n on va quasi mai in bucato e che serve a tutti gli usi, compreso quello di asciugare i piedi dopo le la.va.ture fatte prima delle preghiere, e di passare poi sulla faccia.
Il Koh. ci consiglia, trovandoci dinanzi ad una signora elegante l affetta da tra<:oma, di pregs.rla di tog1iersi i guanti e di presentarci il suo fazzoletto: dopo qualche e sitazione - egli d ice - qu esta sigllora. oi mostrerà l e unghie orlate di nero e un fazzoletto sndicio. Io non so se il consiglio del medico t edesco sia il risultato di serie osservaz ioni o non piuttosto un tratto di spirito; quel che è certo si è \:he dinanzi ad un fellah tracomatoso, basta gettare uno sguardo sulla balza. del suo galabieh per comprendere come egli intenda la pulizia personale.
2° Con'metudini, usanze, pregiudizi. - Per dim ostrare, ee pure è :a.n<lora. necessario, che il galabieh può divenire un potente mezzo d i

lL 1:-1 E GITTO 249
inoculazione del tra.coma, farò cenno di una consuetudine del basso· popolo, la quale, per quanto antica. e consacrata da Polibio nelle sue storie, non è tuttavia meno pericolosa. Quest'autore racconta, adunque (libro X.Y ), che Agatocle, fratello di una. regina d'Egitto, mentre a.ssiste,·a ad un'assemblea popolare in Alessandria, si asciugò gli occhi col proprio .manto; il quale atto poco si spiega fn.cilmente qnando si coosiùeri, col Winckelmann, che i fazzoletti non erauo in uso presso gli antichi (1 ) Orbene, il (ellah segue cento volte l'ora l'esempio di Agatocle, poichè, avendo la c onsuetudine di soffiarsi il naso colle dita., se lo stropiccia. poi col galabielt o colle maniche, e quin(li si asc iuga. gli occhi malati colle stesse parti del suo vestito. N è è raro il caso di vedere Id madri asciugare colle dita gli occhi dei loro figliuoli affetti da. congiuntivitl3; e d'incontrare per le str ade del vecchio Cail'O, o sulla po r ta di qualche capanna d'nn villaggio, uomini, donne e bambini con gli occh i secernenti e col le guancia r igate di pus, senza che, nella l oro apatia, pensino a liberarsi di q ue l sudiciume. Ma questo fatto non deve punto ma.ravigliarci; anzitutto perchè il fatalismo rende il fellah impassibil e nelle circostanze p i ù gravi; e se egli si vede colpito da un'affezione contagiosa, nu lla tenta, nulla fa per difendersene, pers u aso com'è che il male viene da D io: in secondo luogo, perchè, appunto per quel che riguarda le congiunti viti, hav vi in Egitto il deplorevole pregiudizio d i non l avarsi gli occhi malati che l'ottavo giorno dalla comparsa dell'oftalmia.

E giacrhè ho toccato l'argomento delle lavature, dirò ancora che una delle cause più importanti della. propagazione del tracoma risiede - cc>sa strana! - in un antico precetto religioso, lo scopo del quale era essonzial mente igienico: intendo di alludere alle abluzioni.
Come è noto, i musulmani devono pregare cinque volte il giorno, all'ora indicata dal muezin dall'alto dei minar eti: l' all'alba (.sou bh);
2 " a mezzogiorno (douhr); 3" verso le tre pomeridiane (' asr); 4• un po' dopo il tramonto ( maghrib) ; 5• quando è già calata la notte, ossia circa un'ora e mezza dopo il tramonto ('ichè) Prima della preghiera, ossi debbono l avari!Ì il viso, le maui, le braccia e i piedi; ed a tale scopo, nel cortile di ogn i moschea, vi sono dei grandi bacini di acqua sto.gnante (méda8), in cui centinai a di per sone, la metà delle qua li sono affette da tracoma, vengono a far e le loro abl u zi oni; il che vuoi dire che, cinque volte il giorno, l 'acqna di codesti bacini viene inqu inata dn. migliaia d'individui, e che a l trettante persone ·vi vanno a..
(l ) Il plu antico testo, h• euì sia fatta men zione <lei Il segucntP, preso dalle sulle • et odonla sunt panni longi, qui et o raria vocantu r a quibusdam. Haec fere QUI in pala t 1um ibanl senatores ge reban t ; lllis u tebantur ad emuogendum et essp uendum. •
250 l L TRACOMA IN EGITTO
pescare i q-ermi che le prime vi hanno lasciati coll'imntergervi i piedi e le mani, a cui è pressoc hè sconosciuto l'uso del (1).
Il Iacoviùès ha segnalato due altre usanze pericoloso dal punto di vista che ci interessa; una delle quali è limitata al basso popolo, ma,.,sime a quella parte <li esso che abita nei villal!gi; l'altm e comune a qua:Ji tutte le c lassi so,·ia.Ji. La prima di ta l i usanze. fon tia ta sopra. un pregiudizio inconcepibile. consiste con llll'zzi e modi stranissimi , il volto dei fanciulli allo scopo 11i imbrnttirli, e :>Ottmrli così al pericolo della pazzia. La seconda, diO'usa spel'ialmente fra le consiste nell'annerirsi gli orli delle palpebre I!On una sostanza p ol verulenta. chiamata 1\.ohel, la. quale viene stemperata dai ric c hi in un J;iccolo r ecipiente d'argento: dagli agiati, in tnzza di porcellana: dai poveri, nel co.vo della Ulano; e portata sui margini palpebrali per mez?.o di nna spatol a d'arge nto dai primi, per mozzo di un pennello dai soconJi, per mezzo di un semplice pe zzo di Le-gno dai terzi. Qnando si pensi che. tanto n elle clossi piLl agio. te quanto nelle povere, lo stesso recipiente, la. stessa spatola, o pennell o, o pozzo di l egno - non ma i lavati - servono a tutte per:>one della famiglia e t alvolta anche agli amici e conoscenti, si comprenderà facilmente come quest' u sanza. sia. favorevole all' inoeulazione ed alla propagazione di un gran numero di malattie congiunti\a.li e in ispec ial modo del tracoma.

J.o stesso Jacovidès richiama aDcora. l'attenzione su duP cause che, secondo l ui, debbono figurare fra le predisponenti al tracoma, e queste sono:
a
) l 'i ngestione esagerata, da parte del basso ceto, di una specie di pesce salato detto {ìs11iha, con l'aggiunta. di aglio e di cipolla.;
b) l 'abuso di al cool sotto forma di vino e di liquori, che non solo · e co munissimo fra gli Europei e i copti, ma ben an c he fra. gli stessi musulmani, a. cui, tuttavia, l a rel igione proibisce tutti gli alcoolici.
ù r a, non v'ha. dubbio che tanto pesce salato quanto l'alcool, che sono irritanti per la mucosa del tubo gastro-ent eri co sopratntto nei paesi c aldi, lo sono ugualmente per la. oonginntivale che, noi lo sappiamo, non attende, si può dire, che una lieve irritazione per di.,enire granulosa, quando concorrano diverse cir costanze favorevoli, di cui in parte ho già d etto e in parte dirò fr<1. poco.
g• J>olcere. - [l dott or Eloni Bey insiste lungamente su questo fattore, che in Egitto ese r citerebbe la sua influ e nZ!1. in due modi :
(Il Se la quale consuma •nnualmenle plù d i 400 m•lio ni di libbre Ili sa1Jone, nr dirru,o In E111tto rm Il• clns•l .nfer1orl. si a l'<IUi<t.-rel•l.e un nuo•·o e non meno glor1oio tllolo d1 benemereou, po1ché col mirare lli rc llamenl• •113 puhz1a personale, st co mbatte uno del plu lleri· colosi focol ai del lraeoma e porulenta.
IL TRACOM.\ IN EGITTO 25!
agente m eccani co irritat ivo c he prepara il terreno congiun t ivale .all'infezione granulosa; e quale veicolo diretto dei germi infetti vi del tra coma . ·
Seuondo questo distinto oculista egiziano, la questione d ella polvere r ende più intima, dal punto eli vista e ziologico, l'analogia del tracoma colla tt1bercolosi; poichè nello stesso modo che le pol veri inerti in trodotte nei polmoni di individui, i quali esercitano certi mestieri, vi producono un' irri taz ione costante da cui poi hann o origine lesioni croniche, cosi queste poi veri inerti, trasportate nell'occhio, i o irritano e danno luogo a congiuntiviti . E fin qui non si avrebbe o he una semplice azione meccanica; ma v'ha di p i tl: come la polvere inquinata da sputi di tubercolotici può trasportare i germi specifici nei polmoni di individui sani, cosi la polvere inquinata da materie provenienti da con giunti ve tracomatose può t rasportar e il germe granuloso negli occhi .

Ben in teso che questo modo di contagio non si verificherebbe che ' nei luog hi ove la polvere pnò essere infettata dalle secrezioni oc ulari , tle quali vengono abbandonate all'aria od alla terra con grande indif·ferenza, sia durante la pulizia (rara, in verità) degli occhi ammalati, 1Sia n e l soffiarsi il naso colle dita, che è -- come ho detto dianzioons ue tud ine generale dei poveri; o! trechè e molto probabile che i ragazzi, lanciandosi reciprocamente, e per giuoco, delle manciate di polvere sul viso, si scambino gli uni cogli altri i germi infettivi.
Per rend e rsi conto, dice il dotto r Eloui B ey, dell'azione della. polvere, basta gettare uno sg uardo sulla statistica de i granulosi nei var1 quartieri del Cairo e nei nwttdiriehs ( provincie), poiche risulta da essa Che la proporzione dei granulosi è in quelle zone in c ui lo spazzamento e l 'annaffiatura delle strade son più trascu r ati (vecchio ·Cairo 80 p. 100), osservando tuttavia che la polvere sabbiosa dei luoghi secchi come H élouan (51 p. 100) sembra non abbia l o stesso potere nocivo della polvere che si solleva dalle terre agricole in regioni umide (Fayoum 81 p. 100)
Il dott or Lakah, associandosi all'opinione del Mora:x, si dichiara recisameute contrario alle iJee da l dottor Eloui Bey, ed è inclinato a credere piuttosto c h e il modo principale d 'infezione traCOmatosa sia il contatto diretto, E infatti egli dice che in tutte le sue ri cer che batteriologiche sull'agente specifico delle granulazioni - il risultato delle quali fu sempre uega.tivo -potè accertare che quest'a· gente, non ancora isolato, non vive più di trenta ore nella pol vere; il che proverebbe come quest'ultima ha soltanto un'azione predispo:nente irri tando la congiuntiva, ma non già. un 'azione infettante. Si
252 IL TRACOMA IN EGITTO
potrebbe però obbiettare a questa osservazione del Lakah che trenta ox:e di vita bastano all'agente specifico del tracoma per infettare centinaia di persone, sopratutto quando soffiano i terribili venti del sud caric}li di sabbia; e C'be queste trenta ore di vita si moltiplicano all ' infinito per il non interrotto inquinamento della polvere dovutaalle cause accennate dianzi. ·
4° Mosche. - Tut ti i congressisti so no concordi nel ritenere che questi insetti rappresentino veram ente il più co mune ed il più pericoloso veicolo di propagazione, non so l tanto d e lla cong iunti vite pu· rulenta, ma benanche del traco ma; il q u a le fatto non può parere straordinario quando si ponga m en t e ai fattori di cui h o fatto cenno parlando della trascurauza dell'igiene priYata e pubblica nelle classi infe riori e in certi quart ieri ; e q uando s i sia constatata de la enorme q n an tità d i mosche che si ad d ensa n ell e ( A"outtabs ) nelle bott.eghe, nelle case del vecc hio Cairo e d ei vi llaggi indtgeui, do v e esse spadroneggiano indis turbate, gettandosi a nu voli sopratutto sul volto dei bambini, da cn i n ess uno p ensa a cacciarle Ho veduto p iù vo l te d ei bimbi attaccati al seno materno, sui q nali le mosche eran così fitte da non l asc iare allo scoperto che qualche raro lembo di pelle; e dei ragazzi, i quali, dopo aver succhiato un pezzo di canna da zucchero, sopportavano l 'assal to di nn esercito di mosche con u n a ta le indifferenza d a dar r agione al dottor Eloui Bey, il q uale si most ra convinto c h e lo strato d i sud i c iume, da cui sono avvolti, d iminuisca la loro se nsibilità c n ta.nea. Insomma. in un collegio, in uua scuola, . in un a strada dove s i trovino riuni ti dei ragazzi, ciascuno può osservare , se gli bastan l'animo e lo s tomaco, una miriade ùi mosche turbinanti co n l,'apidità in cre dibile dagli occhi de ll' un o a q u e lli de ll·a.l t r o, soffermandosi con predilezion e s ugli angoli in tern i dell e palpebre dove si accu mula la sec rezione, e tras portando in al tre congiuntive la flora batte ri ca più vari a e p iù pericolosa c he si possa immag in are.
Riferirò, a questo proposito, le pa role dell 'Ho we, il quale dice che se si. espone ad una t emperatura co nveniente, e per 24 ore, una lastra di gelatina su cni abbia camminato una mosca, s i constaterà che ogni punto, su l quale essa ha stri scia.to l e zampe, è segna to da un a col onia micr obica in cu lt ura; e ricorderò l e osservazioni de l T acbau e dell'Eloui B ey, dalle quali ris ulta, iu modo non dubbio, la parte att i va delle m osche ne1la trasmissione della co ngi unti vite granulosa. nei 1\otLttab.s frequentati da fanciulli sudtci dell e classi sociali inferiori fatto di grande interesse e di non minore importanza dei preceden t i si è quello che il numero delle mosche aumenta dal m ese

IL lN EGITTO
di marzo alla fine di ottobre, raggiun genrlo il ma.rilllum in in cui maturano i datteri c he - co m e è n oto - attraggono potentemente questi insetti: ora, è proprio du rante quei mesi zhe le oftalm ia assumono il carattere epidemi co ; ment r e durante l'in,erno, in cui il u umero dell e mosc·he di.m inuisce, lP oftal mie non so n o che sporadiche.
Del resto, l' O.l:Ìone delle mosche sulla propagazione delle congiuntiviti - in specie della. purulen ta e della granulosa - non pnù davvero passa re come uu a. novità del l ° Congresso m ed i co egiziano; poichè fra. i libri sull'Egitto, che mi >enner o sotto gli occhi prima della mia partenza per il Cairo, ne leiisi tmo molto interessante, scritto da un profano a lla medi c ina, in cui mi colpirono alcuni pass i relativi !l f'punto a ll e mosche, e che, quando fosse mutata l a data, parre bbe ro l' espressione d i osser va:r.ion i recenti. Il li bro ha pe r titolo: L' Rgypfe, TILI·c,'/ et i e l' autore è nn certo Gisquet, il qua l e viaggiò in lungo e in larg o l'Egit to ne l 1844. E cco ciò che egli scri ve a pag. 209-210 del primo volume :

c La caoso de l 'ophtalmie égypt ienne on l 'n, cherch ée partout; le scalpe l d e l ' argumenta.tion s'est promen é sur tous l es poi n ts d e la question; mais peut-H re a -t-o n oub li é l ' agent le p l m; a ctif de la propagation de cette infìrmité; a g i t Elles attaquent avec tant d' ach a rn Pment et de persévéran ce, qu' il est a.bso lumen t impossi bl e de s' en ga ran ti r. On l es cha.sse u ne fois, d ix fois , ce n t f ois : m a is lorsque la fatigue, la tra.spiration excessive les moyens de la résistance aux agressions incessantes d e l' insecte ailé, on s'abandonne for c6ment, on laisse agir l' ennemi, on est vaincu. Quatr e mois de séjour en Égypte suffisent pour vo us endu r c ir contr a les piqùres des mouches ; alors elles vous dé vorent.sans q n e vons so n giez à les déranger.
c L es gens tlu penple n 'y font pas attenLion et ne les senten t pas: et q ua nd un h omme ou un enfant est atteint de ll.Uelque ma.lad ie cutan ée, qua.nd il a sur l es yeux, la bo uch e, le nez, etc., un e plai e, un mal q uelconque, l es m o uches s'y ama.ssent co mmc un cssaim d 'abei! les ; e li es se fl()uri s:;ent d ' nn sa.ng corrompu, de matières puis e11 es vo nt se poser ou se r eposer s Lu une a.ntre figure . Ne peuventel les poi n t alors. a vo ir à leurs ai l es, à leurs pattes, à leur trompe qn.é lq u e par tie de ] ' humeur visqueuse coneenan t les principes de la. mal adie? Ne peu t ·il pas résulter de l eur piqftre une sorte d' inocula tion? N'est-ce pas enfiu de cotte ma.ni ère q ue l'infirmité se tra.nsmet d'un malad e à une perso nne bien portante? J ' a.ba.ndoune ces idées aux homm es de l'art, aux observateurs capables d' en a.pprécier l e coté faible ou la j ustesse »
IL THACOMA lN EùiT'J'O
Kessun lato debole - aggiung o io - ma giustezza di osservazioni -e di ragionam ento , quali s i potre bbero d esid erare in un medico moderno, a c ui non f ossero ignoti i più re cen ti studi sulla propagazione delle mala ttie infettive.
P er con<.'!l ude re, d irò che la co nvinzione dei co ngressisti c i•·ca l ' eziologia. del traco ma e dell'ofta l mia. pnrulenta è quella c he il dottor . 'am e h Bey espresse n e l suo rap porto; cioè, che la p reponde ranz a spetta ; senza al cun dubbio alle co ndizioni igieniche più che a lle climatiche ; la qual cosa è luminosamente provata da llo s t ato sanitar io dell'esercito d'occupazione, che risiede in Egitto da più d i vent'anni e che - da quanto risu lta daìle statistiche annuali e dalle informnzioni ufficiali fornite dal m ed i co capo - non fu mai soggetto ap'invasion e d elle oftalmia, se si eccettuano alcuni casi insignifi co. nti di co ngiuntivite catarrale, iden t i ci a. quelli constatati in Inghilterra. E informazioni quasi ugualmente confo r tanti si ebbero dal medico cap o dell' e sercito egi ziano, il quttle dichiarò di n on nver mai osservato una insolita pr opagazione dell e oftalmia fra. i soldati. N ess uno vorrà n ega r e c h e q ueste condizioni cosi soddisfacenti dell e truppe sia110 d o,·ute alle n orm e igieniche presc ritte ed osservate collo scr upolo piil rigoroso; ed io so no lieto di aggiungere che il nostro ese rcito si t rova, da questo lato e per le stesse ragi oni , in condiz ioni non me110 soddisfacenti di que> llo inglese ed egiziano, quantunque in certe zone , come ad ese mpio in Rici lia., il tracoma. sia m olto diffuso nella popo · !azione civile (l ) ; del che va data lode grandissima a lle antorita sanitarie mili tar i, ai comandanti di r eggimento ed ag li uflì ciali medici dei corpi, che tut ti conco rron o, nella sfera de lle loro attribuzioni, a prescriv ere. a diffondere ed a. far osservare qu e l co mplesso di norme igieniche, da. cu i dipende uni cam e n te la salu te di un esercito e, p er co n seguenza, la sua forza.
v. Profilassi.
Il dottor Eloui Bey, tanto benemerito per la guerra. a. tutta ol tranz1.1. da lui iniziata già da parecchi anni co ntro il tracoma nelle scuole, che ne sono il fo colaio più pericoloso, presentò al Congresso una. serie di proposte profilattiche radical i , che, qualora venissero adottate dalle a.utorita governati ve e dai cittadini, riuscirebbero per cer to a
(l ) C!r. la gìa eil3ta conferenza del colonnello medico ca v. Giuseppe Al va ro, in cui sono esposto eons•derazionl molto interessanti. e son rife riti dati di ratto di grande importanza sulla diffusio ne del tracoma In Sicilia
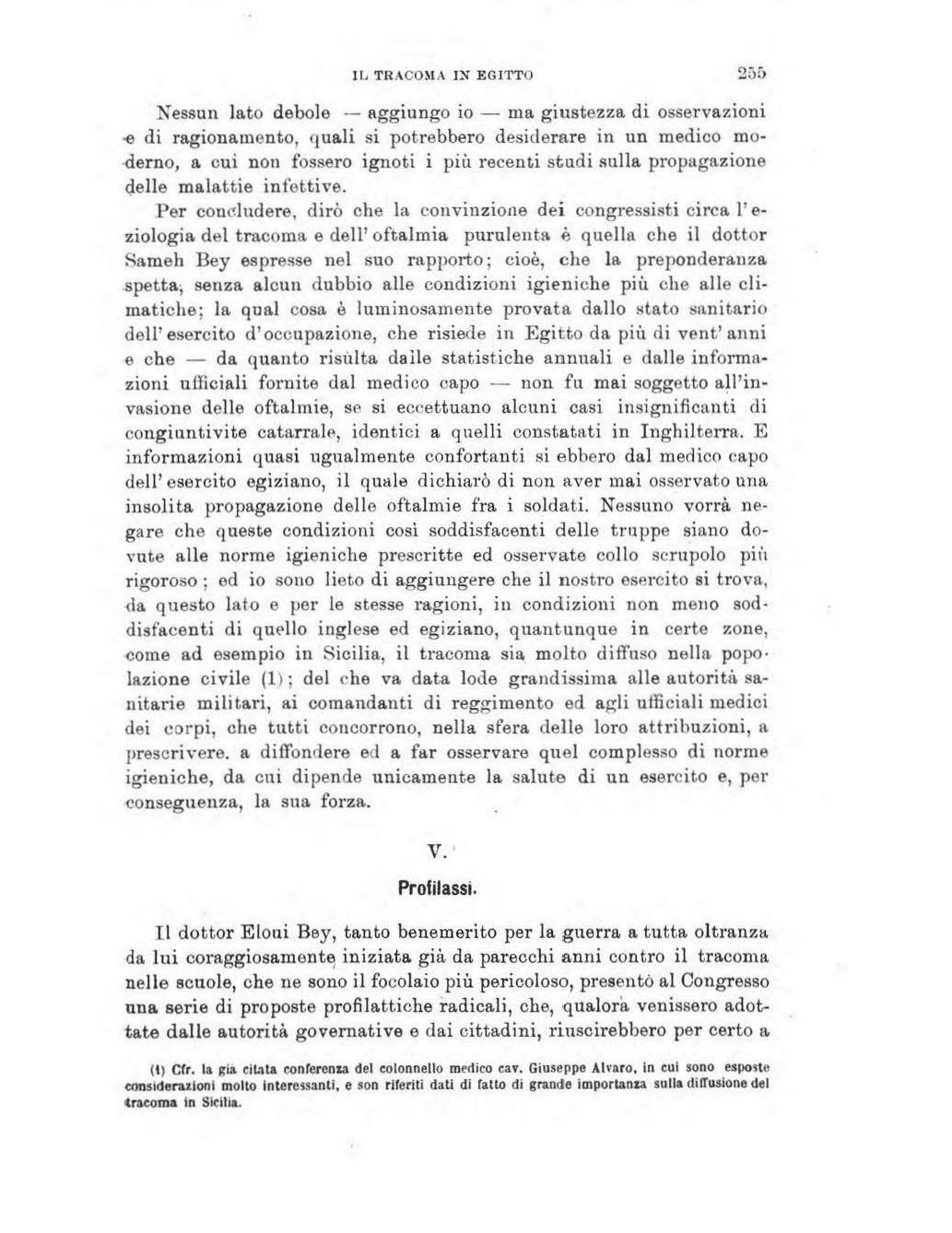
IL IN EGITTO
liberare un g iorno l'Eg itto dal t erribile flagello delle oftalmia, come s ' è >is to nel B elgio, iu Olanda, in Fran c ia ed in ] talia, d ove l'affezion e fu circoscritta in al c une poche reg ioni.
)la p rima di riass um e re codeste prop oste, che sono opera di una men te illum i na ta e m oderna, mi piace ùi ri fe rire q ui tutti i miglioramenti introd otti n e ll e sc uol e egizian e dal 18.'-12 fi no ad oggi , vale a dire duraute il pe riodo i n cui Eloui Bey e bbe r incari c o de lla lor o i s pezio ne sani ta ri a; cs5endo persu :tso che se, da n oi , m o lto g ià si è fat t o in tal senso, n o n poco c i res ti anco ra da fare. e s ia u t ile il con oscere i m e zzi impi ega ti da c hi s i è messo arditamente s ull a via di un l a rgo ri ordinam e n to ig iAni co d elle sc uo le, co n l o s co po b e n defi nito di co mba t t e re il ma le n e ll e s n e radi ci e di r e u cle r e, n ello s tesso te mpo, il t erren o ad a ccogli e re i gt• rmi di qualsias i malattia infe ttiv a .
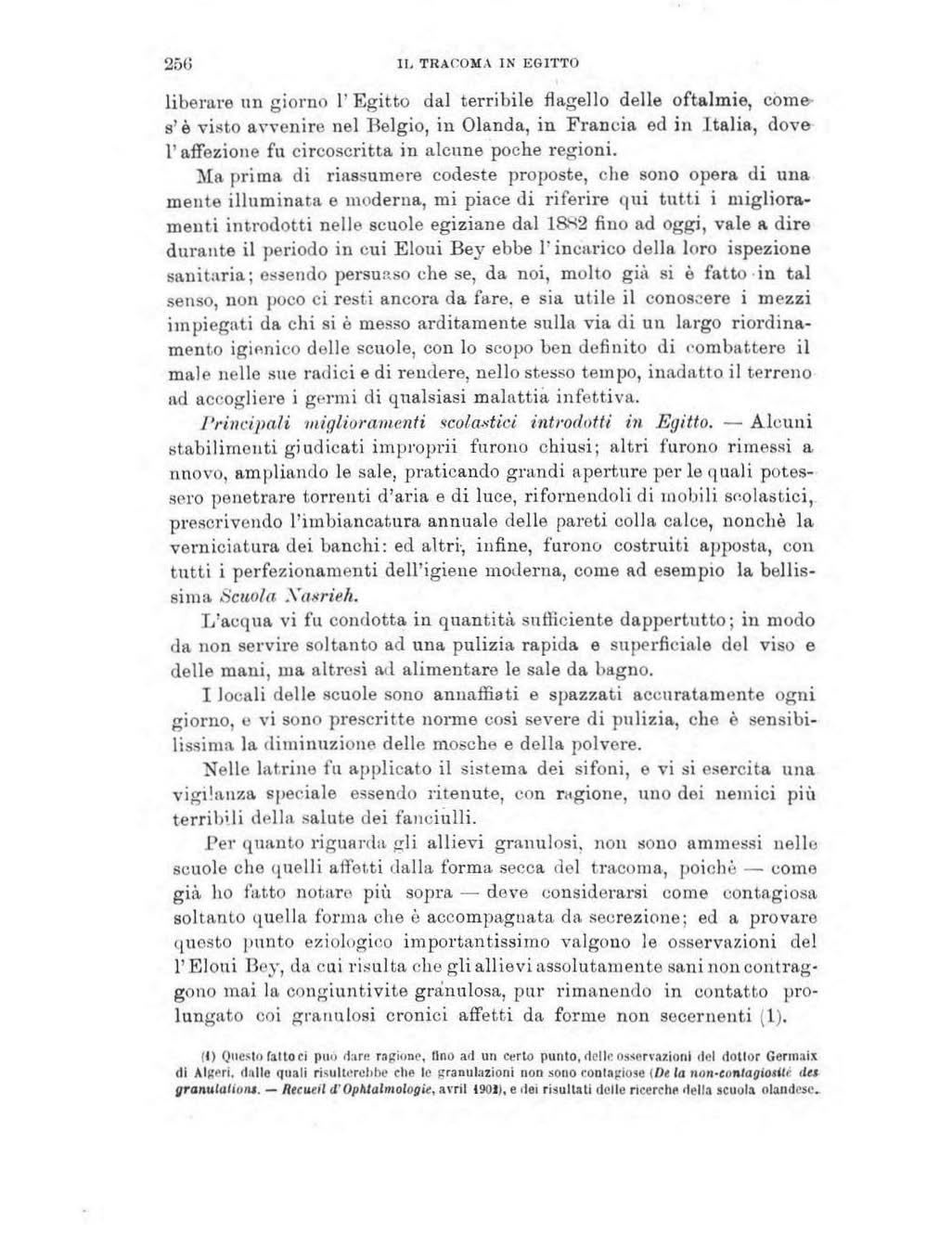
f'rincipali 1aiglioram enti introdotti in Egitto . - Alc uni s ta bi limouti giudi ca ti i m propri i fnrouo c hius i ; altri furon o rim ess i a nnovo, ampliando le sale, praticando grnndi aperture per le quali p ot esse ro pe ne tra re t orreuti d'aria e di luce, riforn endoli di w o bili SI'\Olas Li ci, pres criv endo l'imbiancatura annuale dell e paro ti colla calee, non chè la v e rni c ia tura d e i banchi: ed altri , infine, furon o costruiti appos ta, co n t n tt i i p erfe zionamenti dell' igie ne moLlerua, come ad esemp1o la b elliss im a Scuol a Xa.•m'ell.
L'acq ua vi fu co nd otta in quan t ità s nfli cien t e dappertut t o i in mo d o da no n se rvire so l ta n to a d una. p ulizia rapida. e s upe rfi ci a le d ol viso e d e lle mani , ma. a ltresì ad a lime ntare le sale da bagn o.
I Joca li de lle sc uol e sono annaffia t i e spazzat i a cc urata m e n t e og ni g iorno, o vi so n o p r esc ri tte n orme cosi se,·er e di pul i zia., ch e è se n s ib il issi m :l. la d iminuzi o ne d ell e mosc he e d e lla po lve re .
N e lle la trin e f n ap pl i ca t o il sistema d ei si fo ni , e vi s i eser ci t a. una v ig1!n.nza s pecial e essendo rit e nute, con r11 gion e, un o d ei u e 111ic i più terribili d E> ll a s alu te de i fa JH.;iulli
.Pe r qu anto ri g uRrd a allievi g ranul osi. n on s on o a mm ess i n e ll o sc uol e c h e qu e lli affet.ti da lla secca tl cl t raco ma , p oic h è - come già. h o fn.t.to notrLrn più sopra - d ove co n s iderarsi com e co n t agi osa soltA. n Lo tluc ll a f orma ch e è a ccompa g ua ta da scc rezi 0n e : eù a provaro q u os t o pn nt o ezi ologi co i m porta.nti ssim o ,·nlgono l e osserVRzioni de l
l' Eloui Bcy, d a c ui ri:<ul tA. c b c gli allie vi ass ol ut amente s ani n on co ntrag· g o no mo.i la co ngiun t ivite grà nulosa, pur rim a n cu ù o in co ntatLo prolungiLto coi g rauu losi cronic i affetti d a f orme n on soccrn e nti (l ).
(l ) fatto ci puo ti are Uno ari un ee rto punto. tlcll r tlc l rl o ll or Germa L t di da llo qua li ch e le j:tranulazio ni non so no ro oi&!!ÌOie la n OII·eon taoioslte des granulall o111 . - Ruue1l a Ophlalmologie, avril 190J) , e rle• de lle m e rc ht tlelln sc uota o i3Ild rsc.
256 11. TRA C'OMA lN EGITTO
Ogni allie,·o co n forma secc rn e nte era mandato, in princ ipio, al polic linico di Du.rb-el-Oamnmiz, institnito specialmente per la :c ura degli scolari; ma. dopo la so ppressione di questo stabilimento, gli a llievi furono - e sono anche oggidi - obbligat i a c ura rsi a. domi c ilio, nè vengo no riammessi a frequentare i corsi se non prese ntano un certifi cato del loro me lico, in s i dichiari che ogni ;;ecrezionf" è ::com parsa e che è eliminato ogn i pericol o di co ntagio. poi al medi co della scuoh\ - il quale ha l' in c o.rieo d i fari' og ui gi orno la visi ta sa nitaria degli allievi -- il decidere se sia il ca so di riammet te re lo s colaro granuloso, oppure di prolungargli il co ngedo .
L' not- t urna p er gli allievi interni fu oggetto di studi speciali. La car rdela fumosa e vac illante, c he prima si concellcva aù ogn i gruppo di undi c i scolari, fu sostituita con una lampada a pe trolio rtttificatO, p oi col gas, e finalmente co n lrt. lu ce elettric o. (scuola Nasrie lt).
Per e cce:HO eli premtnzione, il num e ro d egli interni fu nd otto nl minimo: od ai pa dri rimast i ven n ero d es tinati ampìdormitori e un da. t oilPtte pe r ciascun o; osservando co n c he le catiu e ll t', gli 8.Sl· iugt\roani, ecc. servano ad s tre ttamente pers onale.
L e vaca nze, c h e avevano lnogo al ( m ese c h e varia a.nn c ), furouo soppresse- il che u o n fu piccola vittoria - e sos tituite con le va. cn.n ze di estate, che è la. stagione più propizia in Egitto allo, diffusione delle ofta lmia.
Vennero stabi l iti esercizi di ginnastica pe r rinforzare gli organismi ·degli allie vi o per mod ific1ue, nei limiti del possibile. le cost ituzi o ni linfa tic·be.

Tutti gli all ievi, s e nza ecc-e zione, so n o sor vegliati d 1\i maestri pe r quanto at-: iene alla. pulizia del viso, degli occ hi e degli abiti: e d ò loro severam <'nte proi bito di tener c hiusi c ibi e dolciumi n e i cassetti perchè attiran o le mo,che.
\ tnlt<' 4 uest o innovazioni, che già hanno dato notevoli fruttitantoc h è la propo rzi o ne dei gmnulosi nelle sc uol e, che era d e ll' 8 :-l p.lOO nel l H.'·I4, si rid nsse nel J al 32 p. 100 - il d ot_tor Elo ui B ey ,·orrebbe auco ra lo seguen ti, c he formarono ogge tto di un !'!uo rapporto al .\lini stro della pubuli()a istruzione, e il riassunto del qua l e fu comunicato al Co ngre;;so :
.Lcqun. - Aum eutarneanco rala <Juantità in ogni Koutfab, affin c hè gli ;;,:olari c: he vi giungono sudici dalle loro case, possano - prima di entrare i H classfl - lavarsi abbondantemente le mani e la. faccia, a sciugandosi poi <'O n gli rli cui c iascuno deve essere provvisto.
Im biancamento delle pareti. - Si dovrebbe prescrivere che tutti i h"ottltab.y fossero i m biancati colla calce una volta. l'anno, e che i pavi-
17 - Gw,.,aale medaco.
Jl. TRACO.MA J:S EG11'TO 21ii
1 ,
menti fo ssero riparati e pu liti i l p i ù spesso possibile ; dei qua li servizi, adottando il consiglio dei dottori Samy e Ziwer d ovrebbero essere inca.ri cati parecchi domestici.
Latrin e. - Tu tta P attenzione del le autorità dovrebbe portarsi su questi locali che, malgrado quanto già si è fatto, sono ancora i n gran parte d ei focolai di fermentazione, che ofì'rono ai microbi patogeni i più fa vo revoli me7.zi di cultura. È necessario, adunque, prescrivere che le fosse siano vuotate più SO\ente, e disinfettate almeno due volte la settimana con tutti quei mezzi che l ' esper ienza. indica come più effica.ci. lmp edi1·e il pol'Derio 11elle .çcuole . - A questo scopo si ra ccom anda in special modo :
a ) di collocare sulla porta di ogni scuola una reti cella di ferro od uno spazzolone, affinchè chi entra trovi modo di pulirsi le calzatur e;
b) di stendere nei cortili u no str.ato spesso di sabbia granulare da cambiarsi frequentemente, onde impedire che i granelli di v en uti t.roppo fini vengano soll evati dal vento .
·c)' di sostitui1·e alla granata, allo spazzolino di penne ed allo spolveracciolo un panno leggermente bagnato, a cui la poi vere ade r isce benissimo.
Isolamento dei granulosi.- Si proporrebbe di istituire, n e lle vicinanze di due o tre A"outtab8 un'altra sc uola. destinata escl usivamente ad accogliere i nuovi allieYi sani; mentre quelli granulosi sarebbero ma.udati nei primi insieme con gli a n tichi.
/ ,acoro intelletiuale degli !ICOlari.- Quantunque i programmi scolas ti ci d e ll'Egitto non siano piu densi di materie che quelli d ' Europa, tuttavia bisogna tener conto di certe condizioni speciali: ad esempio dell'ereditarietà, del c lima. e del modo di nutrizione. Sarebbe quindi ne cesssario :
l " prolungare la durata degli insegname n ti, ossia distribuire le materie in nn maggior numero di anni: e quando ciò non potesse efil numero di queste materie; OI.Ltlllt: udos i, 1u entrambi i casi , un uguale vantaggio da Iato igienico;
2 ° rendere attraent i le ri c reazioni, e proibi r e che nell e ore, in cui queste hanno luog o, gli a li i evi rimangano in classe per qual siasi moti v o;
w· prescrivere delle passeggiate i:>truttive in nei dini del Guiseh, nei musei, alle Piramidi; obbligando i professori o g l i assiste nti a intrattenere gli allievi in conversazioni sull e anti c h ità, sulltl arti arabe, sulle piante, sugli animali, ecc. Queste lezioni fatte ali 'aperto sarebbero indubbiamente meno faticose che gli studi ordinari, ed eserciterebbero un'influenza. benefica sullo spi.rito deg l i scolari;
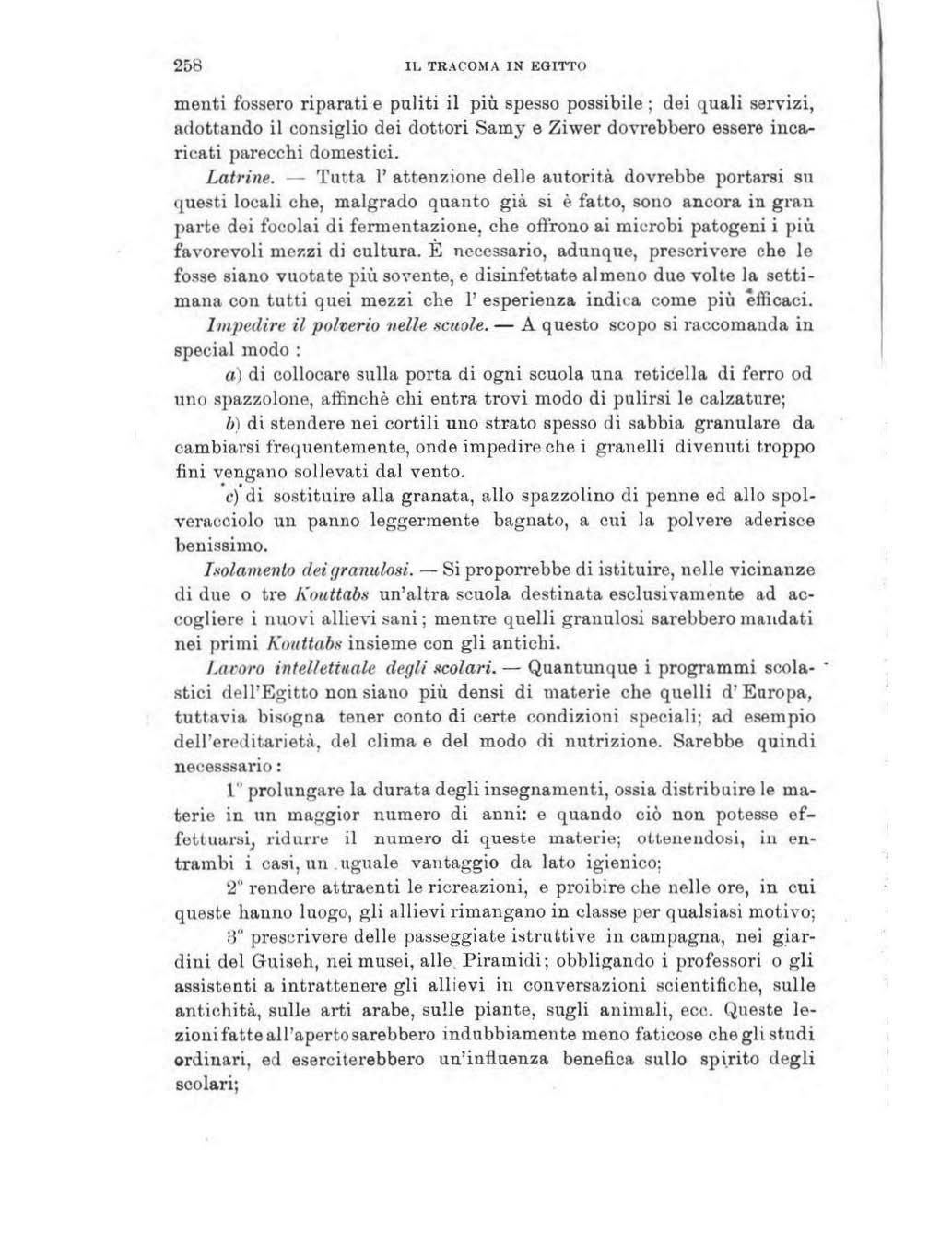
258 IL TRA COMA IN EGIITO
4" dare un più largo sviluppo agli esercizi fisici, e int1·odurre pos1libilmente una lezione di canto arabo (l}.
Banchi ;;colastici e po&izione degli allievi.- L'importanza di una regolare posizione dello scolaro è ormai riconosciuta da tutti, potendosi -e>itare con essa un gran numero di malattie oculari (i n specie di refrazione) e di deformazioni del tronco. I maestri dovrebbero perciò ri co r-dare le norme seguenti :
Lo scolaro, nella. posizione seduta, tenga i piedi poggiati a piatto sul pavimento, in modo che la gamba formi un angolo retto con la. coscia, e q nesta. col tronco.
In tale posizione, egli deve scrivere senza assumere un atteggiamento forzato; cioè senza curvarsi sul quaderno e senza alzare le spalle.
La distanza che separa gli occhi dal quaderno deve essere almeno di 25 cm. L'allievo, che non potesse leggere e scrivere a tale distanza, dovrebbe essere sottoposto a visita medica.
E dopo avere cosi riassunte le norme igieniche più importanti, già adottate o da. adottarsi nelle scuole Egiziane, alcune delle quali sono purtroppo trasc urate nelle scuole a urop ee, farò cenno delle di progene1·ale contro il tracoma, quali vennero presentate e votate dal Congresso.
Alle ca use climaticl!e, si deve opporre l'Astensione
-e l'imboschimento, con c ui si renderà il clima più uniforme e si diminuirà la poi vere.
Per quanto si riferisce alle abitazioni, si prescriva. l'imbiancamento annuale delle case con la calce, al principio dell'estate; e, relativamente ai villaggi, un decreto ordini che, in av\·enire, tutte le abitazioni siano costr uite secondo le r egole igieniche, in base a tipi speciali e a. piani prestabiliti, come si fa. in Europa. per le case operaie;
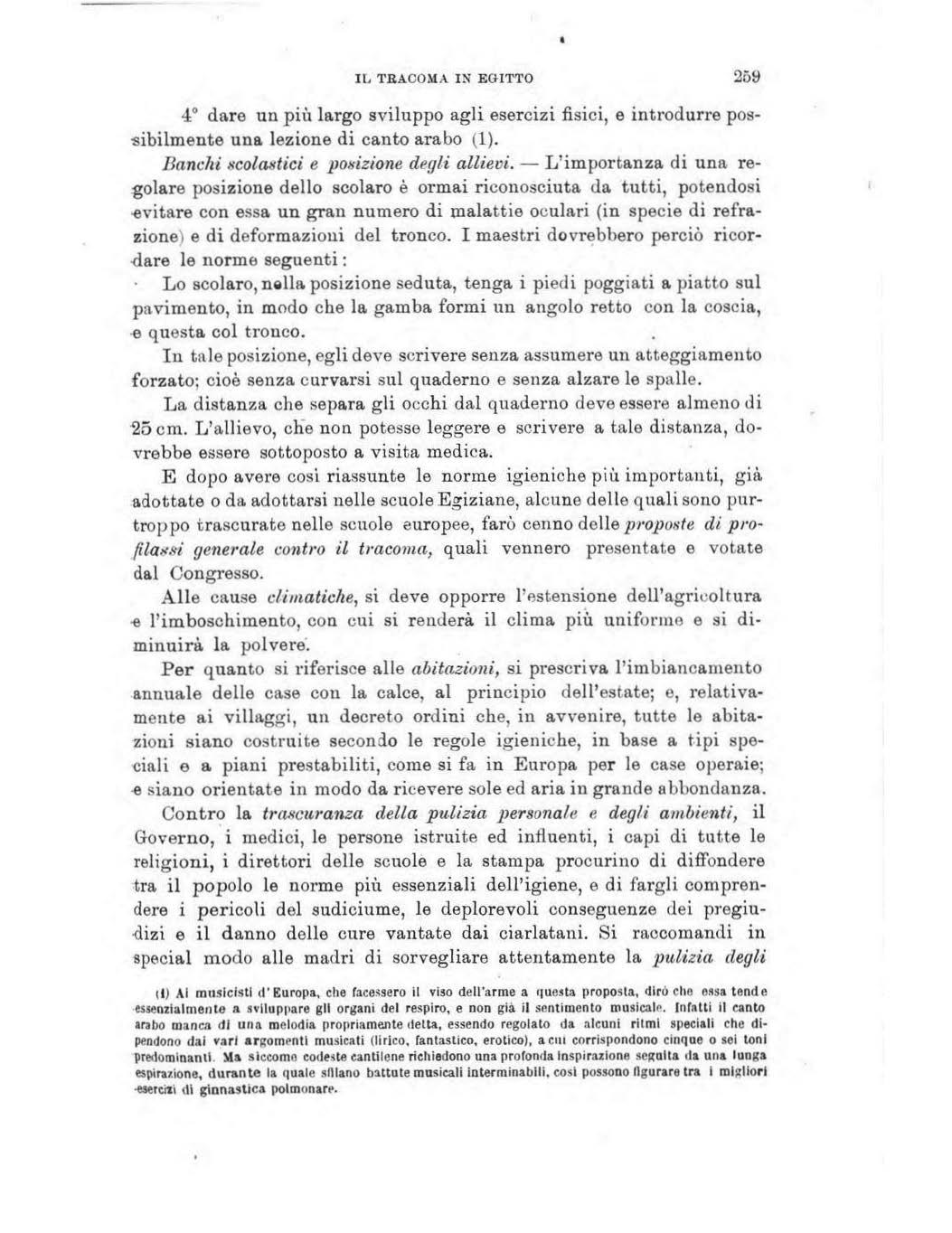
-e siano orientate in modo da. ricevere sole ed aria in grande abbondanza.
Contro la della pulizia jJersonale e degli ambie?iti, il Governo, i medici, le persone istruite ed influenti, i capi di tutte le religioni, i direttori delle scuole e la stampa procu rino di diffond ere tra. il popolo le norme più essenziali dell'igiene, e di fargli comprendere i pericoli del sudiciume, le deplorevoli conseguenze dei pregiu-dizi e il danno delle cure vantate dai ciarlatani. Si raccomanùi in specia.l modo alle madri di sorvegliare attentamente la puliz ia degli
il) Al m u sicisti d'Europa, che il viso de ll'a r me a r1ues ta propos ta, dirò che oRsa tende essenzialmente a sviluppare gli organi del respiro, e n on già il sentimenlo musleaiP. Infatti il canto arabo man ca di una me lodia propriamente detta, essendo regolato da alcuni ritmi speciali che dipendono dal vari mu sicali (lir ico. fantastico, erotico), a cno cor rispo ndono cinque o sol toni predominanti )la slccomo codt$te cantilene richiedono una profonda lnspiruione seg uita da una longa espirazione, durante la quale sfilano b:l.ttote musiealllnterminablli. così possono fig urare tra l migliori -estrcno di glnnMtlca
IL TRACOMA l:-1 EGITTO 2ò9
occhi dei loro figli, l&.vandoli almeno tre volte al giorno: e ai medici di abolire a:-;solutamente l'u>:o del pennello per l'1.1.pplicazione dei medicamenti nelle oftalmia; poichè ha dimostrato che esso è un agente potentissimo d'inocu lazione dei germi infetti -i.
Passando dall'igiene personale a quella generale, si fauno voti che tutte le città e tutti i villaggi o;ian provvisti abbondantemente di acqua pura, come mezzo di pulizia. e come be>anda; aggiungendo, a questo proposito, che l'acqua più adatta a tale scopo sembr erebbe E-sser quella della falda sotterranea, come si ebbe occasione di constatare durante .epiòemia colerica di Tantah, e come dimostrarono i pozzi istantanei, a cui ricorsero i medici a Moucha.
Dotlmdo il paese di codeste opere necessarie, edificando fontane pubbliche e gratuite in ogni città, e costru endovi uu n. buona canalizzazio ne secondo il sistema di tont lÌ l'ègout, si può es::cr certi che l'effetto quasi immediato sarà. una diminuzione enorme non soltanto delle oftttlmio, ma b en anche delle altre malattie d'infez ion e.
Si domanda inoltre di ospedali pei granulosi, e la fondazione di policlinici per i malati d'occhi nei vari q n artieri delle grandi cittù. - simili a quello di KaLaoun del Cairo - sotto la direzione di medici oculisti, i quali abbiano fatto almeno un anno di pratica. in una clinica oftalmologica.
Si propone finalmente eli abolire i médas (bacini d'acqua stagnante) del! t' mosc hee, sostituendoli con chiavette (robin el8) pér le abluzioni): la. q ua.le proposta è, fra tutte, la. più coraggiosa perchè co lpisce direttame nte una delle us11.nzo tradizionali più radicate n el popolo, e, nello ste.,;so tempo, un precetto religioso, le cui modalità sono stabilite dal Corano. Nessuno, io credo, fara le maraviglie se, dopo aver indicato le mosche come uno dei più pe-ricolosi mezzi di trasporto dell ' oftalmia purnlenta e granulosa, il dottor Eloui Bey non abbia poi fatta una. prvposta più specialmente diretta a combatt erle e a distrugg orl o. Poichè questi insetti prediligono il s udi ci).lme e vi si moltiplicano in modo stm.ordi nario ( l ), è chiaro e, col provvedere elfi C'acemente alla pulizia. personale ed all'igiene pri va.ta. e pubblica s i riuscirà a. togliere acl essi il terreno favorevole di vita e di sviluppo e, per conseguenza, a. ridurne il numero in nn breve periodo di tempo e iu propor?.ioni molto sensibili.

Il rapporto del dottor Eloui Bey fu approvato all'unanimità dai congressisti; e, in seguito a proposta del professore \\ri cherkievi cz,
(l) In condizioni una sola produce W.OOO la rve, rlascuna delle IJUIII può in pochr giorni a liro "!0,000: tantoch ll si é çhe la drscendenza di h'e mosche divorerebbe Ul\ ca,·allo morto plu presto d1 un leone.
2o0 lL l:S EGJT'l'O
-venne formulato - in base al rapporto stesso - un voto da presentarsi al Governo egiziano, il cui significato fosse quello di dimostrare che le proposte fatte dal relatore sono l'espressione delle idee di tutti; e -di invitare le autorità ad unire i loro sforzi a quelli dei medici, onde raggiungere p'iù presto e piu facilmente uno scopo che sarà fonte d'incalcolabile benessere per l'Egitto.
Debbo aggiungere ancora che all'interessante discussione sulla profilassi del tracoma presero parte tutti gli oculisti egiziani e un buon numero di quelli stranieri; fra questi ultimi, il dottor Osborne, -che insistette per l'istituzione di colonne volanti di medici i quali do· vrebbero recarsi, durante l'estate, nei villaggi onde far ricoverare negli -ospedali i tracomatosi gravi, nonchè procedere alle necessarie disinfezioni; e il dottor Guarino, il quale, olta e a sostenere la stessa proposta - che è infatti molto logica- consigliò: l" una serie di utili indicazioni per combattere le superstizioni e i pregiudizi delle classi infe· riori; 2• di comprendere certe forme di oftalmia nel gruppo di quelle affezioni che richiedono la disinfezione dei locali; 3• di rendere ohbliga.toria la denunzia nei casi di oftalmia purulenta e granulosa; 4• di invitare lo Stato a fissare una somma per far fronte a tutte le spese (l ) .
Non v'ha dubbio che le proposte dei dottori Osborne e Guarino, ottime per ogni riguardo, saranno prese in considerazione dal Governo ed .appoggiate dagli stessi medici egiziani, non appena questi ultimi abbiano provato la soddisfazione di vedere adottate le proprie, per quel ·giusto sentimento di orgoglio nazionale che li fa desiderosi di aver la precedenza sugli oculisti stranieri nella lotta che si combatte nel loro paese contro il tracc·ma..
Per dimosrare, infine, che il voto formulato dal Congresso circa la profilassi delle oftalmié non è e non sarà platonico, riferirò qui una notizia. giuntami dal Cairo or son pochi giorni, la cui importanza non sfuggirà ad alcuno: Sir Ernest Casse), con vinto dell'utilità urgente delle misure profilattiche proposte dal dottor Eloui Bey ed a p provate unanimamente dal Congresso, ha messo un milione di franchi a disposizione del Governo, affinchè si costruiscano policlinici oculistici ed ospedali speciali al Cairo e in Alessandria.

IL TRACOMA IN EGI'M'O 261
(l) La seconda e la ten.a di tali proposte sono identiche a quelle che il COlonnello medico Al va ro no dal tQ maggio 1110:1 al Congresso medico siciliano.
Cura .
La discussione sulla cura del tra coma fu piuttosto animata, ma - per noi europei -poco interessante, non essendosi fatto altro che dpetere cose note, e confermare ancora una volta la grande incertezza in cui si trova il medico pratico quando è costretto a combattere una malattiar la cui patogenesi è avvolta nel mistero. in poche parole i metodi di c ura proposti dai vari oratori.
Il dottor Sameh Bey dà giustamente una grande importanza alla. cura preventiva, consigliando di lavare spesso gli occhi con acqua filtrata bollita, a cui si siano aggiunti dieci grammi di allume per litro. Il trattamento medico, cui egli ricorre in ogni caso di oftalmia, è quello· classico noto a tutti; però insiste principalmente sui punti seguenti:
a) iu tutte le oftalmia acute, preferisce i mezzi semplici, leggierir privi di ogni azione caustica. Ed io m'associo pienamente a questo suo modo di vedere - salvo, ben inteso, per quel che r iguarda. le congiuntiviti purulente- perchè, massime nelle fasi di una lieve congiuntivite catarrale, i colliri irrita.nti e spesse volte impuri, non fanno altro che aggravare le condizioni locali;
b) usa il nitrato d'argento alla dose di 0,50 a 2 gr. p. 100, secondo l'intensità e sopratutto secondo il grado della. secrezione; e supera ben di rado la proporzione del3 p. 100, facendo ordinariamente una. sola cauterizzazione giornaliera;
c) usa anche il protargolo con buoni risultati, alla dose di p. 100; e, come collirio da. adoperarsi dall'ammalato due o tre volte il giorno, nella proporzione del 5 p . 100;
d ) qualche minuto dopo l'applicazione del nitrato d'argento o del protargolo, introduce nel fornice congiuntivale inferiore una piccola quantità di pomata borica al 5 p. 100, o un po' di vasellina pura.;
e) nella cura del tracomr:., prescrive il trattamento generale, che rinforza la costituzione degli individui scrofolosi e non scrofolosi ma deboli. Nelle granulazioni acute (pottssées ricorre alle instillazioni di a<.: i do picrico a) 0,50-1 p. 100; o a quelle di violetto di met.il e al 0,30-0,50 p.lOO, associandovi lavature ripetute con soluzioni antisettiche diverse, alternate con l'applicazione di compresse fredde evaporanti, imbevute delle soluzioni medesime. Nel periodo cii stato, la cura proposta. dal Sameh consiste:
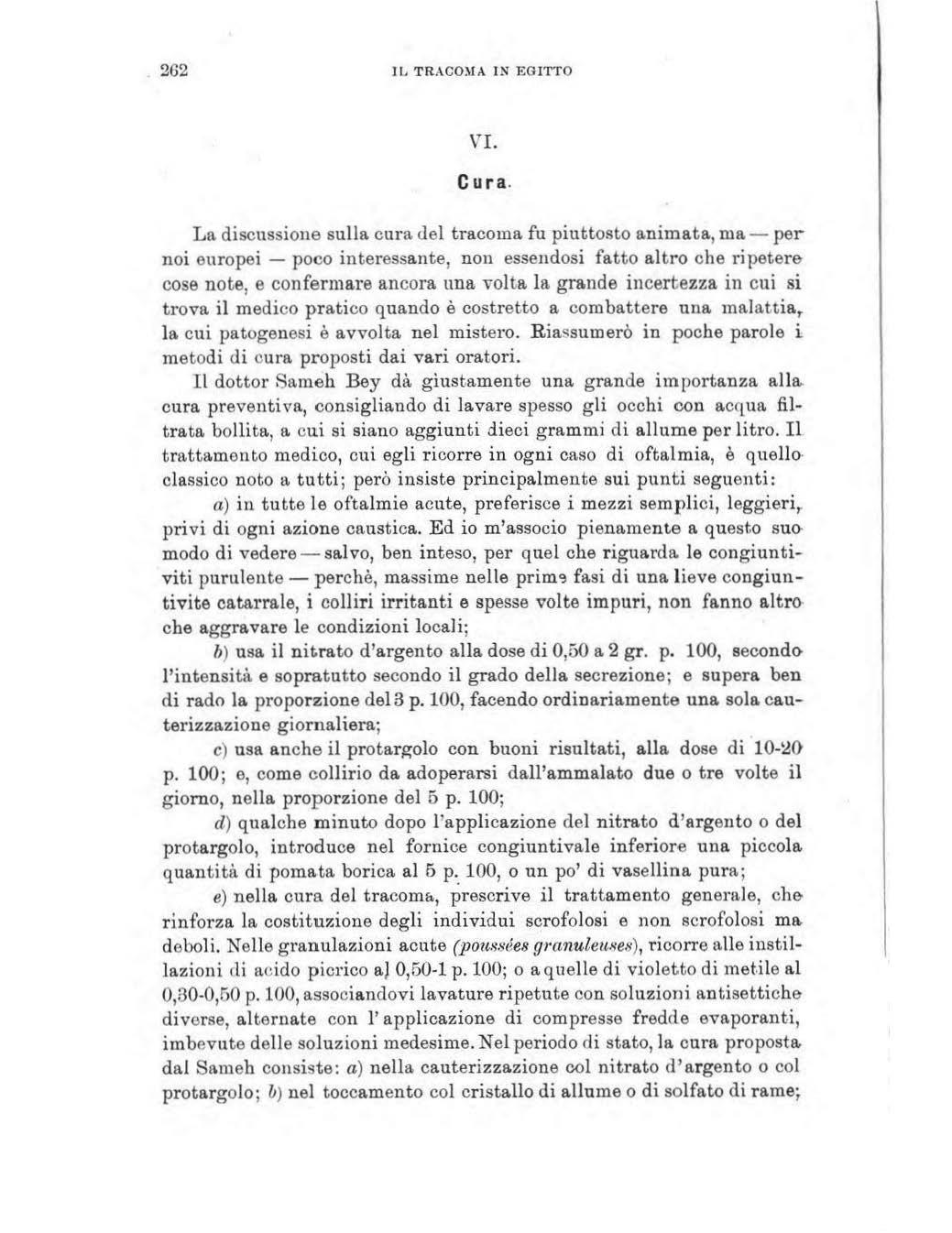
a
b) nel toccamento col cristallo di allume o di solfato di rame;
) nella cauterizzazione col nitrato d'ar gento o col protargolo;
262 IL IN EGITTO
c) nelle frizioni congiuntiva.Ji con ovatta imbevuta di soluzione di sublimato corrosivo all'l p. 1000; d) nel caso che i mezzi ora detti falliscano, ricorre alle scarifìcazioni seguite, nei giorni successivi, da frizioni col sublimato o coll'acido borico in polvere; avvertendo- mi permetterò di aggiungere io- che quest'ultimo metodo (acido borico) fu già. consigliato parecchi anni or sono dal nostro P edrazzoli.
Usa pure sovente, e con molto profitto, la polvere di pa.paina pura o unita all' a cito borico (l su 4 ) ; affermando che il massaggio papainico provoca leggiere emorragie congiuntivali e rende la mu cosa molle ed uniformemente liscia dopo poche sedute. Quando le granulazioni sono ribelli a tutti i mezzi consueti, egli fa la seguente operazione, che chiama mista parche sudd ivisa nei varì tempi seguenti:
l" scarificaz ioni superficiali parallele;
2" raschiamento col coltellino;
s• schiacciamento colla pinzetta dello Knapp;
4" spazzolamento ( brotJsage) con uno spazzolino a denti speciali , imbevuto d'una soluzione di sublimato, o cosparso di polvere borica;
5" abbondante lavatura antisettica seguita dall'instillazione d'una goccia d'atropina e dall'introduzione di un po' di pomata borica ne l fornice co nginntivale inferiore.
Nelle granulazioni primitive, oltre i medicamenti accennati dianzi, il Sameh raccomanda le leggiere applicazioni di tintura di iodio e glicerina. a pa.rci uguali, oppure secondo la formola seguente:
Iodio 0,30
Ioduro di potassio 0,40
Ghcerina o vasellina liquida 10,00
Il òottor Lakah afferma che lo spazzolamento della congiuntivo. tracomatosa, fatto conoscere in Egitto dal prof. Abadie nel 1891, è la cura che egli preferisce, avendo visto migliorare ed anche guarire con essa parecchi casi, i quali datavano da tre o quattro anni e si erano mostrati ribelli ad ogni trattamento. Quando le granulazioni sono accompagnate da una congi untivite subacuta, fa delle scarificazioni seguite da applicazioni di glicerolato di sol fato di rame allO p. 100: e, ottenuta la guarigione della forma accidentale sovrapposta, pratica lo spazzolamento.
Il dottor Eloni Bey, nella forma secca del tracoma, rovescia la palpebra - previa la cantopl astia., se è necessario - e fa quattro o cinque scarifìcazioni più o meno profonde secondo l'alterazione congiuntivn.le, quindi stropiccia la superficie sanguinante con un batuffolo Ji cotone coperto d'una miscela di solfato di rame e di acido borico. Poi, quando la reazione infamma.toria si è fatta meno intensa, continua il t ratta-
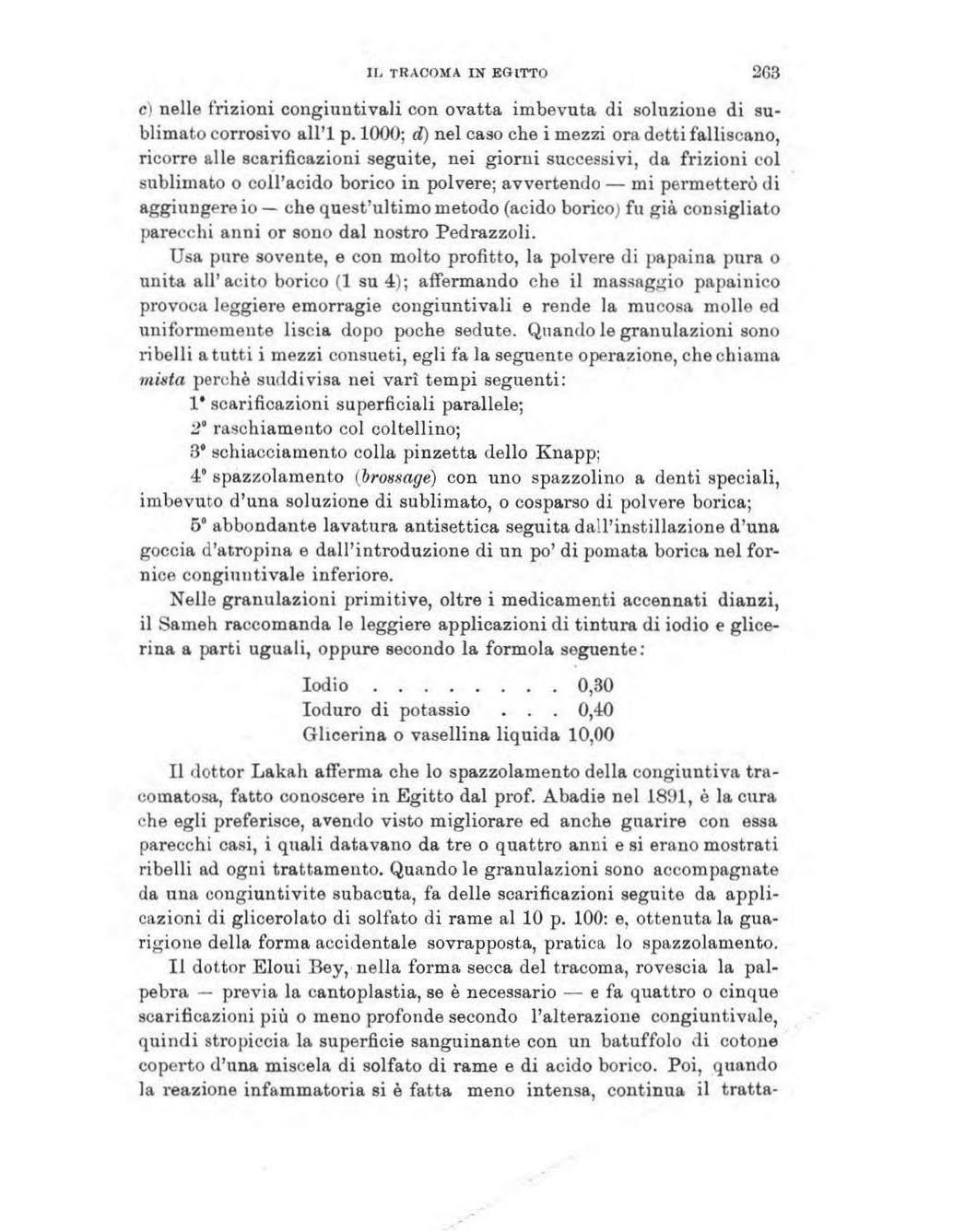
IL TRACOYA IN EGlTTO 263
mento stropicciando la congiun tiva. con del cotone imbev u to d' un a soluzione di sublima.to a ll ' l p. 1000. Nelle forme subacu te, egli si l imita. ad il nitrato d'argento in una. sol uzione a.ll 'l-2 p. 100.
Il professo r e \Vi cherkiewicz vorrebb e a nzitutto che non si dimenti casse i l principio c h e la cauteriz zazione della congi un t iva non deve e:lsere profonda: ri guardo poi ai casi di infil traz ione acuta, egli si mostra. con vim o che la frizio n e della. congiuntiva con un batuffolo di cotone imbevuto <l' una s oluzione d i snblimato all' l p. 1000 ed an che all'l p. 100 sia utilissimo e p rodu ca. una potente reazione capace d i di:;truggere le g r anulazioni in brevissimo te m po; osservando che lo spazzolament.o della congi un ti va non eser cita altra azion e fuorchè quella di f a r penetrare gli antisettici negli strati pitl profondi della mucosa, dove s i trovano l e granulazioni .

Promesso c h e è tutt'altro ch e nuova., debbo di r e c h e tanto il \Vi c h erki e wic z quanto g l i altri oculisti, i q ua l i vnntarouo il s ublimato nella c ura d el tracoma, n on fecero altro <: h e descrivere, quasi fosso una novità, il metodo di cu ra proposto dal Guaita fin dal 1886, c h e or mai una ser ie lunghissi ma di brillanti ri sultati
Il prof. Gayet sostiene che, in generale, si abusa dell'interveut.:> chir urgi co nel t racuma; ed io condiv ido pienamente l'opinione de l ven erando c lin ico di Lione, avendo visto più d ' una volta che le scari licaz ioni troppo generose e l'escissione delle pieghs del fornice superiore danno luog•> ad eiiti c icatriziali cosi disastros i, che si è tentati di esclamare dinanzi ad che sarebbe stata assai pre feribile una guarigione spontanea. L o stesso Gayet vanta poi l 'azione del solfato di rame in t utti i casi d i tracoma; mentre il prof. Bandry e il dvttor Chedoudi manifestano un parere diverso, preferendo, il primo, il nitrato d'argento in soluzione dell'l p. 100, massime nelle forme secernenti; il seco ndo, la soluzione di su bli mato al 2 p. 1000, dopo aver praticato l o spazzolamento della cong iuntiva.
ll dottor Ia.covidès, sempre chiaro e preciso n ell 'espressione del suo pens i ero, dichiara che, dopo avere sperimentato tutti i mezzi indicat.i dai precedenti oculisti, dà prefere nza al seguente metodo d i c ura:
N elle forme umide del tracoma (agglutinazione m att utina), ri corre a l nitrato rl'argento in soluzione al 2 p. 100; nelle fo r m e secch e, c ioè senza la min i ma secrezione, al solfato di 1·ame puro o mitigato; nelle complicazi oni corneal i recenti, a l iodoformio ; n e i casi di ulcerazio ni già. cicatrizzate, a lle pomate di precipitato giallo e di ittiol o (3 p. 100) Trova utilissime le scarifì cazioni nei casi in cui l a congiun t iva è co n gesta e turgida; come pure l o schiacciamento e lo spazzola.mento n e lle al t r a forme in generale; non tra scu rando mai l e lavature antisettiche f atte -se oc-
2G4 I L TRACO ll A IN EG I TTO J
.corre - dal malato stesso, per le quali egli preferisce, secondo l'intensità {}ell·aflezione, il bi-ioduro di mercurio (l p. 20000), il lisolo (l p. 2000), -o il borato di soda (15 p. 1000).

E giacchè ho c itato il Iacovidès, riferirò an che il m etod o di c ura da lui raccomandato nell'oftalmia purulenta, della quale p ure s i dis cu sse a. lung o nelle sedute medesime in eui si trattò della cura del tracoma. Nella. suddetta f orm a morbosa, egli dà una parte prepondera.nte alle grandi lavature della congiuntiva malata e dichiara di av e r acquistato una taJe fiducia. in codesto semplicissimo mezzo da non esitare ad afferm are cheo può guarire un'o ftalmia p twttlen ta soltanto con abbondanti l at•at ttre rip etute ogni ora Tuttavia, siecome non è possibil e avere co ntinuamente sottomano il proprio malato, stima ne cessari o di fare, n ello stesso tempo, delle cauterizzazioni, per le quali egli impiega costante mente il nitrato d 'argento al 3 e a l 2 p. 100. Aggiunge che illi quirlo da impiegnrsi p er lA lavature può essere una soluzione antisettica qualunque - da quelle mercuriali a lle boriche - avvertendo che non attrib uire un valore ·esage rato alla composizione chim ica..delliquido, perchè ciò c he agisce, in tali casi, è la corrente che t rascina via. tutto e pulisce la congiuntiva. Ritornando alla cura. del tra.coma, farò cenno, per ultimo, delle idee manifestat A in proposito dal dottor Guarino , le quali si allontanano alquanto da quelle degli altri congressisti, perchè prendono p unto di p artenza dal concetto originale che quest'oculista si è forma to della pato· ge nesi del tracoma. Qualche volta, egli dice, il metodo m edicamentoso dà. buoni ris ulta ti: ma ciò avviene perchè esso elimina o attenua - con la sua azion e prolungata - le forme microbiche d ei f orni ci e, p er co nseguenza, e limina o attenua n ello s tesso tempo le tossine. Se, allora, s i ha -da fare co n un individuo di costituzione robusta, o a nche co n un inpividuo debole che venga assoggettato a cura ri costituente, il tracoma si rin.ssorbe e guarisce.
Il Guarino, però, non na,sconde la sue preferenze per il metodo chirurgico, il quale, secon do lui, è qu ello che vince più spesso direttamente la malattia.; ma invece di ricorrere a quei m etodi complicati, cht·esigo no tal volta perfino l'ane stesia. g enerale, egli ne consiglia un o ch e ri c hied e preparativi semplicissimi Pre via una lavatura antisettica molto a cc urata, produce l ' a nestesia loe;ale coo la cocaina, e quindi fa del l e scarifì cazioni verticali , s upe rficiali e v i c inissim e l e une alle altre, che rip ete tre volte la settimana; avvertendo tu ttavia che Je lavature abbondanti, prima e d opo l e scarificazioni, rappresentano una parte important issima nella c ura e debbono perciò falte parecchie volte durante i1 giorno. Quando è decorso un m ese, egli si restringe a fare le scarifi.ca:zioai ogni quindi c i giorni, e cosi prosegue fino a. guarigione completa .
IL TRACOllA IN EGITTO 2G5
La lu nga discussione sulla cur a d el tracoma fu poi riassunta moltt> felicem ente dal prof. Baudry con le seguenti parol e, c h d delineano n e l modo più esatto lo stato di una quest io ne che i lavori del Congresso non hanno, purtroppo, fatta. avanzare n e ppure di un a l inea verso la. sol uzione llefinitiva:

« Ad una patogenesi incerta corrisponde una terapia oscilla nte fra.. i metodi più di versi; tuttavia. si può d ire che il n ostro a ccordo è una- · nime sopra un punto: 1·ù;pettare, cioè, la m u cosa per qu,an to è p o.'fsibil e, rinunziando a tutti quei metodi che la di.-;truggono. Del r esto. l a. c ura deve variare secondo che la f orma del tracoma è secca o secernente, di ffu sa. o. l ocalizzata; per conseguenza, ora riesce bene la medi cazione general e e l ocale, ora., invece, s'impone il metodo nhirurgico ristretto in limiti ben e stabil iti. Adunque, finchè non ci sarà completamente nota. l ' intim a natura d el tra coma, con viene eclettici nella sua terapia, e r egola rsi secondo le numerose parvenza de l morbo. •
Mancherei ad un dov ere di gratitudine e di cor tesia. se, prima di c hiudere questa r e lazione, non es primessi i più v ivi ringraziamenti a tutti gli egregi colleghi egiziani che m i accolsero e mi trattarono con vera e cordial e amicizia., e mi furono guide dotte e gentili nelle visite alle clini che, agli ospedali ed ai laboratori, dove io se ntii, ,:on gioi a, fremere un nuovo e potente soffio di vita, c he spingerà fra non mol to l'Egittoa lle più a rdi te n e l campo della scienza, le quali non saran n omeno gloriose di quelle ri po rtat e nel campo dell 'arte, e che formano, d a.. tanti secoli, l'ammirazione d el mond o.
Firenze, marzo 1903.
266 Il, TRACOMA IX EGITTO
- -=--===
CONSEGUENZE NON COMUN I
DI UNA FER I 'rA D'ARMA DA FUOCO·
NOTA CLINICA
Boschi Beniamino, allievo carabinier e della. classe 1880 entrò nell ' ospedale militare ùi Roma alle ore 10.30 del ,24 maggio 1901 per ferita transfossa alla gamba destra prodotta da un colpo di rivoltella.

Riferì che verso le 8 dello stesso giorno,. trovandosi al tiro a segno, al poligono dell'Acqua Aeetosa, mentre rimetteva la pistola d' ordinanza nella. fondina, scattava. a.ccidenta.lmente il cane e il proiettile lo colpiva. alla gamba destra Soccorso prontamente dal san i tario presente, fu subito dopo inviato all'ospedale. Quivi si risco ntrò il fo -rarne d'entrata nella regione poplitea tlestra, circa nel mezzo di essa, di forma. ovale, largo circa l cm. e lungo circa 1 / , , a margini netti, lievemente introflessi, cori un alone ecchimotico del diametro di circa un soldo ed il forarne d'uscita nella regione antero- interna ti ella gamba destra, al 3" inferiore, irregolarmente circolare, a bordi sfrangiati ed estrofl.essi, del diametro di circa l cm. Gli indnmenti presentavano forami corr ispondenti ed erano intrisi di sangue. Nonostante la pro-fusa emorragia sofferta, le condizioni generali erano buone ed il polso abbastanza sostenuto, soltanto si osservava. un certo grado d i pallore del viso e delle labbra.
Disinfettata accuratamente la cute della ferita, si notòche l'emorragia era cessata dal forn.me di uscita. e continuava, ma molto scarsa, dal forarne d'entrata, cosicchè si applicò una medicatura. a piatto con garza iodoformica, stimandosi inutile qualunque intervento. Non vi erano alterazioni della sensibilità tattile e dolorifica , i due p iedi avevano quasi la. stessa temperatura e colorazione.
l\ malato di carat,tere apatico non accusava quasi alcun dolore.
La sera ebbe tempet·atura normale e riposò bene la notte. Il giorno susseguente, rimossa la fasciatura, si notò cha l'emorragia era
261.'
del dott. ••a r b i• B im•, maggiore medico, a<ltleUo allo spedale militare di Roma
·ce..;sata, che il terzo superiore della gamba era alquanto tumefa.tto e dolente alla. palpazione, e che la. se nsibilità. del piede era diminuita, i;auto che non avvertiva più il contatto delle dita. Vi era febbre e stato saburrale. Nei giorni successivi si andò a poco a poco manifestando cianosi delle dita del piede destro, la quale si estese gradatamente al dorso del meta.tarso, poi alla pianta, seguita dapprima dalla formazione di flittene e poi lentamente da complet.a mummificazione delle dita e quindi dell'avanpiede fino alla interlinea di Lisfra.ne.
Contro netto processo riuscirono inutili gli impacchi caldi, l e fasciature di m·atta e le applicazi oni di bottiglie calde a vermanenza -continuate per circa 20 giorni non attenendosi che lievi aumenti termi ci, irrego lari e progredendo sempre pii1 l'anemia.
li lH giugno nel dorso del piede s i vedeva già delineata la linea di demarcazione. Il 2:3 giugno, aggravandosi sempre più le condizioni generali ed estendendosi già la linea di dema r cazione tutto intorno alltL l inea articolare metata.rso- tarsi ca, si stab ilì di procedere ad un a.&to operativo demolitore.
La Ptrogow, dapprima ventila ta, si dovette abbandonare stante l'infi l trazione sieropurolenta. della r egione sottoma.lleolare interna. Pro cedetti perciò all'amputazione della gamba al 3° in feri ore, col metodo circol are modificato con l'inci sione del Lenoir per il più fac il e arro· vesciamento del ma.nichett<J. Si suturarono separatamente il p eriostio, i e la ente, quest'ultima in senso antere-posteriore lasciando uno stuello di ga.rza iodoformica. nell'angolo posteriore della ferita (i nferiore durante il decubito dorsale) per essere la cute della. gamba ed il tiOttocutaneo piuttosto infiltrati di siero, dubitandosi per ciò di una guarigione per primam. Nei giorni successit"i all'operazione si ebbe soltanto qualche aumento di poc hi decimi nella temperatura vespertina.. Il 2 luglio si tolsero i punti e si l a per fetta cicatrizzazione salvo, si intende, nel luogo dove era rimasto lo stuello. LavatA. la ferita con soluzione di sublimato, questo venne riapplicato continuando abbondante gemizio sieroso. Il G, rinnovata. la medicatura, si ri scontrò la piaga in buone condizioni, ma il moncone era gonfio in corrispondenza dei gemelli e la. pelle era lucida e tesa.. La palpazione del polpaccio era dolorosa. Il malato febbricitava. ed aveva-lingua p atinosa.. L'esame dell'orina non forni va alcun lume diagnost i co.
[ u queste condizi on i si arrivò al giorno 14: lug lio, allorchè si diagnosticò un aneurisma sp urio trauma tico nel moncone destro, essendo la pulsazione espansiva ed il soffio caratteri stico av vertiti distintamente nella faccia autero- interna del polpaccio. La cute de lla gamba nel giorno sussegue n te si andò facendo bluastra, mont re l'epidermide

:2(':3 OONSV.:GUE:s'ZE :s'ON DI UNA PERITA D1Alt!lA DA FUOCO
si sollevava qua e là in flittene e la tumefazione aneurismatica guadagnava terreno in basso verso la superficie di sezione del moncona ed in alto verso il poplite. Contemporaneamente la secrezione fuoriuscente dalla piaga granulante residuata all'amputazione andava assumendo aspetto e odore icoroso e negli ultimi gi orni anche le granulazioni cedevano il posto a detriti cangrenoo>i. 1n segu ito ad unanime parere di t.utti i sanitari d e ll'ospedale si deliberò di procedere ali"amputazÌOne della al 0° inferiore che eseg uii il giorno SUC · c....ssivo 16 luglio quando già la cianosi e la tensione della c ute del monco ne fa cevano t.emf're gravi complicazioni. Il m etodo seg ui to fu il ctrcolare, la cute i n sen so trasversale. L'atto operativ o e la narcosi cloroformica furono ben sopportate.
All'esame del pezzo anatomico si riscontrò un vasto aneurisma sp urio nel lato interno e poflteriore del moncone esteso dal poplite fino a circa 2 dita trasverse da ll'estremità inferiore, origi na.tusi da u oa larga. finestra esistente nella tibiale posteriore. I muscoli contigu i erano sco llati H.mpin.mente, il connett ivo e la cute infiltrati di liquido. Verso l'estremo inferiore del monconc, il sottocutaneo era di aspetto gelatinoso e i muscoli di coloriw giallo sporco, emananti odore cancrenosu, oosicc hè era da prevedere c h e, aspettando ancora, il sangue dell' aneurisma si sare bbe fatto strada all'esterno aUra verso il piccolo strato che i tessuti ancora opponevano.
Il luglio si tolsero i punti passati a tutto spessore, il 25 gli altri riunenti la sola c ute e si riscontrò una riunione pe r primam perfetta. Il mese di agosto trascorse intero senza alcunchè di notevol e.
Il mala.tosegui va un trattamento r:costituente dietet it·o-farmaceutico, onde combattere la pro fonda anemia in cui versava e solt<mto >erso gli ultimi giorni d e l mesfl incominc iò ad alzarsi onde abituarsi alle grnccie.
L '8 settembre, quando già egli stava provando l'arto artificiale e già erano pre.;soohè ultimati gli incombenti pre.;c rit ti per lo. giubila.zione, cadde nf'll'anùare alla l atrina esse ndogli ;;drucciolnta una d e lle gruccia su l pavim e nto bagnato e nella caduta urtò l 'estremo del moncone contro il sed ile eli marmo Immediatam ente il moncone si tnme· tèce, divenendo dol ente alla palpaz10ne; nei g iorn i successivi si aggiunse edema. ed arrossame nto della cute, febbre contin ua ed in nl· timo n n a. distinta. fluttuazione in corrisp.mdeuza del l a cicatrice. Per tali fatti i l giorno 12 si praticò una incisione s ulla ftlccia posteriore della coscia., <lalla c icatrice in su per circa 12 cm., dando esito ad nn discreto em.atoma, in mezzo al quale si trovò l'osso scollato per c\rca. '2 cm. Si. za.ffò con garza. iodoformica medicando poi, more so-
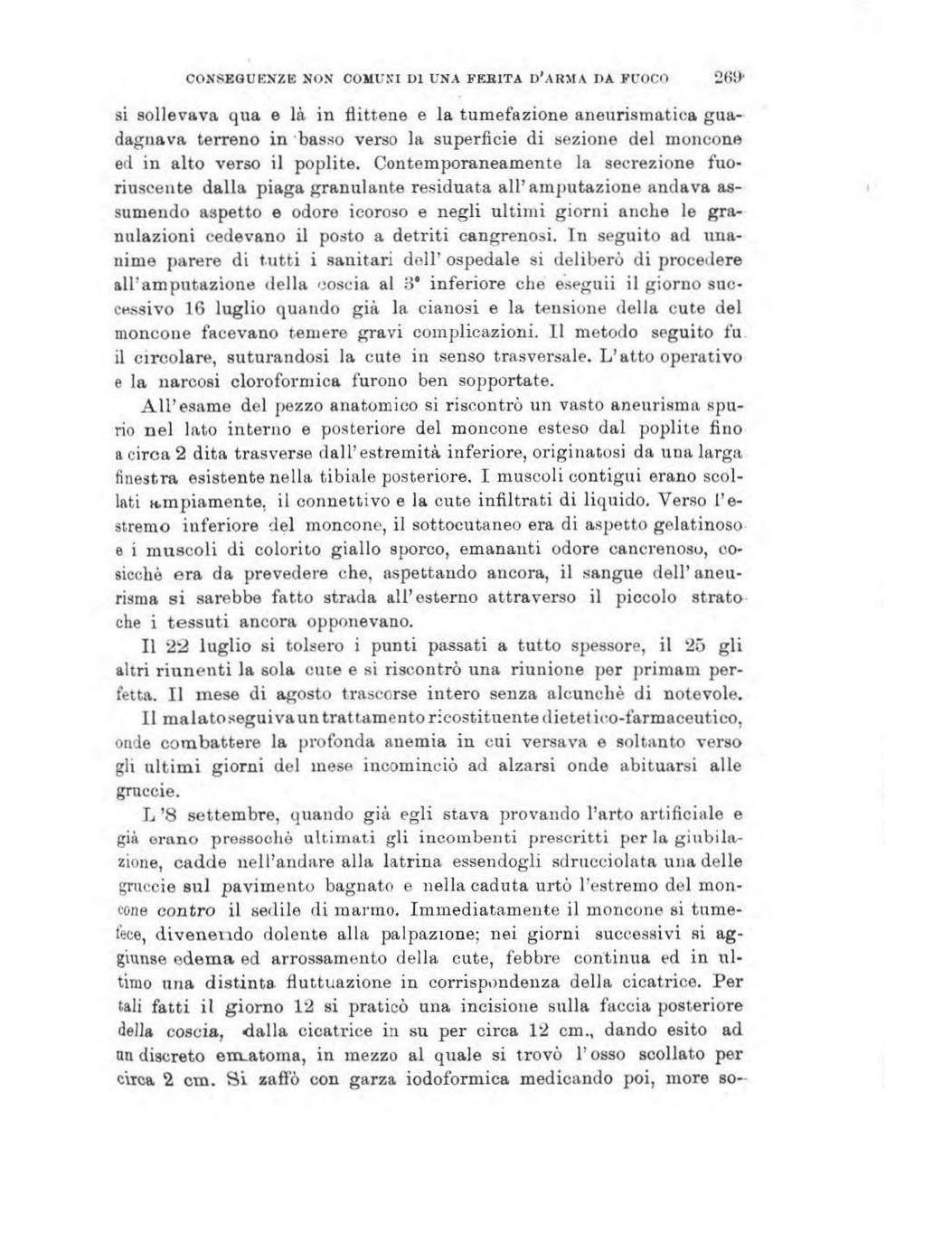
COXi;EGUEXZE N0:-1 COlW:\1 Dl UNA FERITA D'ARliA DA lft:OCI) :!f3U•
lito. Il 2li eRsendo ricomparsa la febbre che da qualche giorno era cessata, si esam in o d iligen temente la cavi tà e si riscontr ò profondamente l'esistenza di un ri stagno d i pus. Si sbrigliò allora ampiamente il fond o della ferita, dand o esito a scarso pus ed a piccoli sequest ri ossei , dei qua li molti altr i aderi vano all e parti moll i.
Non riusccndosi a dis ta ccare questi, stau te il dolore dai te nt ativ i , il 28 si cloroformizzò l'infermo asportando col cucchiaio di Volkma.nn tutte l e scheggie aderenti ai mus coli ed alla superfi cie del femore p ri va del periostio per circa 10 cru . Si zaffò con gat za iodoformica applicando poi la solita medicatura.
La c icatrizz azione di questa eno rm e cavità. ri c hiese molto tempo, m a fin a lmente il 21) marzo u s il B oschi potè essere inviato al p aese na t i vo perfettamente guarito e fornito di un arto artificiale del quale sapeva già servirsi bene
Il caso sopradesùritto n on ha presentato particolari difticol tà. diagn ostiche n è operatorie, ma non è però co mu ne per l o. seq nela di acc identi che hanno prolungato per tant i mesi la degenza del mala to.
S i ccome d'altra parte n ella giornaliera pratica d' ospedale s i prese n t.au o più spesso i casi sempli c i c h e i difli cili, così 11011 m i è se mbrA.to del tntto inutile presentarl o ai collegh i potendo fornire soggetto a. discussion i non prive di insegnamento per l'esercizio quotidiano.
'l'rovand0ci infatti di fronte aù un inel i '·iduo ferito in una r egi one d elicata come i l poplite, ci possiamo doma.1ulare quale siA. la linea di di contlotta segui r e; iu te rvento o astensione? È questa una domanda a cui in tesi generale non s i può risponclere con si curezza. Cer to clia.gnogt icanclo o anc he sospettando fortemente une lesione arteriosa, rintervento si impone, ma q u ando il sospetto non è fondato a !';u(licienz a. i mode r ni trattatisti sono, co me ò n oto, concordi nel preconizzare l 'astensione e l a merlicatura occlu siva semplice.
Ora, secondo il Dm·aulie, la di agnosi di ferita di arteria si p u ò dedurre, quando l 'emorragia. siasi già arrestata, dai ti crite ri: quan tità di sa ugue perduto in un dato spazio di tempo, imbibi;r.ione e scollamento dei t essuti prodotto dA.I sangue infìltrato, stat o anemico del pa;r.i ente e finalmente 0ompleta cessazi one de l pol so nei rami periferici del vaso ferito.
Tu tt i questi sintomi n e l nostro ma)A.to mancavano : so lo vi era. lo stato anemico general e, ma ques to trovava ampia spiegazio n e nel lungo trasporto c ui era stato assoggettato l'infermo. (Dal poligon o dell' Acquacetosa all'ospedale mili tare co rrono, anche per la v ia più breve, più d i G km. ). Date perciò ques te co ndizioni di fatto, non essend o a ccertato. l a ferita. arteriosa, anzi essend o appena sospettabile,
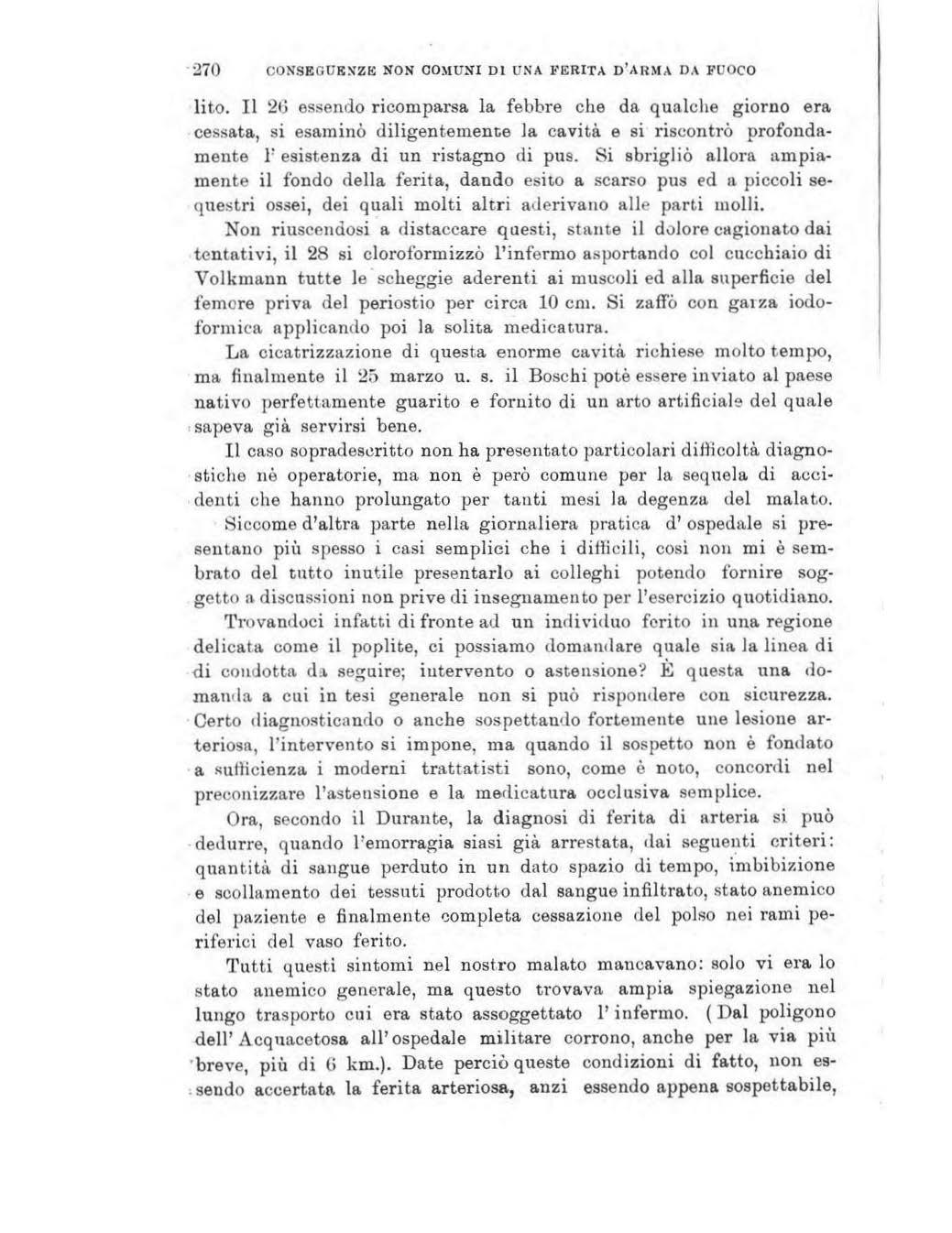
270 CONS E GU E!'>ZE NON COllONI DI U NA ltERlTA D ' AlUlA DA FUOCO
l a via da seguire, non poteva essere che l'astensione da. ogni intervento cruento.
Non app ena si scor ·ero i segni della diminuita c ircolazione periferica n ell 'arto ferito, si modifi cò logicamente il giudizio diagnostico dapprima. ad ottato, e si ammise l 'esistenza di una. le'iione arteriosa. o <iella poplitea o di uno dei ram i di questa. 1'uttavia essendo già iniziati i fenomeni asfittici sembrò inutile p r ocedere ad un atto operati vo in <t ua.nto ch e la l egatura di un vaso già trombizzato non avrebbe potuto portare al cu n miglioramento n elle condiz ioni circolatorie pc · rifericbe e si preferì di affidarla alla provvida vis nallll'll' medicatrix sperand o ch e il c ircol o colla teral e venisse a rimediare in par te, 1-1e n o n in tutto, alle condiz iOni creat e dal traumatismo. Quanto a lla patogenesi si pensò che il proiettile avesse proJotto soltanto una piccola lesio ne di continuo nelle pareti a rt eriose, c h e ost ruita. in primo tempo da un coagu lo fosse stata poi seguita d a uu11 trombosi più o m c uo diffusa.: fa.t,to questo superiore alle risorse del l 'arto. I ucora.ggiavauo a spe rare in un es ito soddisfacente le parole di 'l'illaux « ue le calibre d e l 'a.rtòre po plitée est co mplètemen t obstrué, il n e survient pas ne gangròne au p ied, parce q ue la circuln.ti on collatér o.le est assurtie griìce it. l'ann.stomose de la g rande anastomotique asec la récurrente tibiale » . Quando poi si vide la mummifìcazione affermarsi d istimnmente e progredire si venne a pensare che il t ronco ferito fos!;e uon la popl itea , ma il tr onco tibioperoneo ram mentand o anco ra l'avvertimento dello 'fillaux « lorsque le tronc t ibi o-pé ronier est il est à. peu près impossible que la tibiale an téri eure, ne le soit pns en temps ainsi que la. r écur rente t ibiale antérieure, qui niiit de cette deruière, et dans ce cas la d u pied est fortement à craindre »
S i noti che il 'l'illaux dice questo pa r la ndo degli aneurismi •eri nei q uali il disturbo di circolo si manifesta gradatamente e viene parallelamente compensato a poco a poco dalla dilatazio n e delle varie anastomosi, quindi l 'esito infaus to era tanto più f ortement cì crain dre nel caso nostro, dove il disturbo di cir colo si e ra prodotto quas i improv visamente per effetto di un trauma.
Il vaso ferit o era ne l nostro caso la tibia le posteriore e non il tronco tibio peroniero; ciò spiega la limi tazione della mummificazion e a.l solo avan-piede, dove le anastomosi tra i suoi rami t erminali e le altre arterie del piede, (rami che vanno dalla piantare interna alla pedidia; dalla piantare esterna alle due peron ie re anterior e e posterior e e alla dorsale del ta.rso e del metatarso e in fine i rami perforanti anteriori e posteriori c he stabiliscono comunicazioni con le interossee dorsali, senza co n tare l'abboccamento diretto della planta.re

CONSEGUEYZE NON OOMOYI DI 0 :\A ];'ERITA O'AHldA DA l W OCO 271
estorca con la pedid i a.) sono troppo sottili e t roppo lontane dalla pompa.. cardiaca - specialmente quan do essa è affievolita. per effetto dell a. emorragia- per poter supplire alla deficienza di irrigazione sanguigna quando sia legato il vaso principale.
Una volta cominciata la mummificazione bisognava naturalmente ra.ss<'gnarsi nlla demolizione del piede attendendo l'apparizione di una. l inea. di demarcazione bene netta anche senza. aspettare come opi na. il Tilla.nx proprio fino a quando < tm sillon profond a séparé le mort du vif, lorsqne les parties ga.ngrenées ne sont plus rattachées an r esto du membra quo par le squelette ,._
Allo scopo di conservare il più possibile, si era proposto l'osteop l a.stica di Pirogoff, benchè circa i risultati lontani di questa, gli autori non siano ancor1t perfettam ente d'accordo nell'ammetterne la bontà; tuttavia vt si do\'ette rinunciare per le rag ioni esposte nella storia clinica scegl iendo l'amputazione sopra Resosi manifesto l'aneurisma spuriv non era forse i l caso di apri rl o francamente come u11 ema.toma. andando a ll a r icerca dei capi feriti e legandol i secondo i pre1;etti clinici moderni?
Anzitutto è bene rammentare che Forgue e Reclus preconizzauo l'amputazione come c ultime ressource réservée pour les a.nevrismes la.rges, infi l trés dans toute )'épaisseur d'un membro», come era appunto quello col quale si o.vt>va a fare . Inolt r e, come già fu detto, la piaga. residuata all"amputazione sopramalleolare aveva preso aspetto cangrenoso cosicchè era eia peusarsi che, anche gLtaronclo l'anE-urisma, si sarebbe dovuto poi ricon-ere a l l"a.mputa.ziont! a ca.usa del processo cangrenoso che, &\"'endo già invaso i tessuti la cui era stata diminuit.'l. dall"esistenza. dell'aneur i sma spurio, sarebbe :-;tnt() diffi c ilmente dominabile con gli ordinari mezzi
Infine la. legatura della tibiale posteriore o magari del tron co tibio peroniero, per essere la ferita molto in alto, ci avrel..be esposti alla cancrena totale del moncoue già profondamente alterato, co.:;icchè, piuttosto elle procedere ad un ' a. m puta.zione in 2° t e mpo sen za nessun vanLn.ggio del malato, anzi con ùanno evidente per il ritardo portato alla guarigione, si aecettò l'idea. dell'amputazione d'emb lé01 pure esHendo convinti, . come dice argutamente i l Lefort, che così facendo non s i app licava un procedimento terapeutico nello stretto della parola; ma si tmttava sempl icemente di c sauver la vie dn malarle, sans guerir sa maladie ».
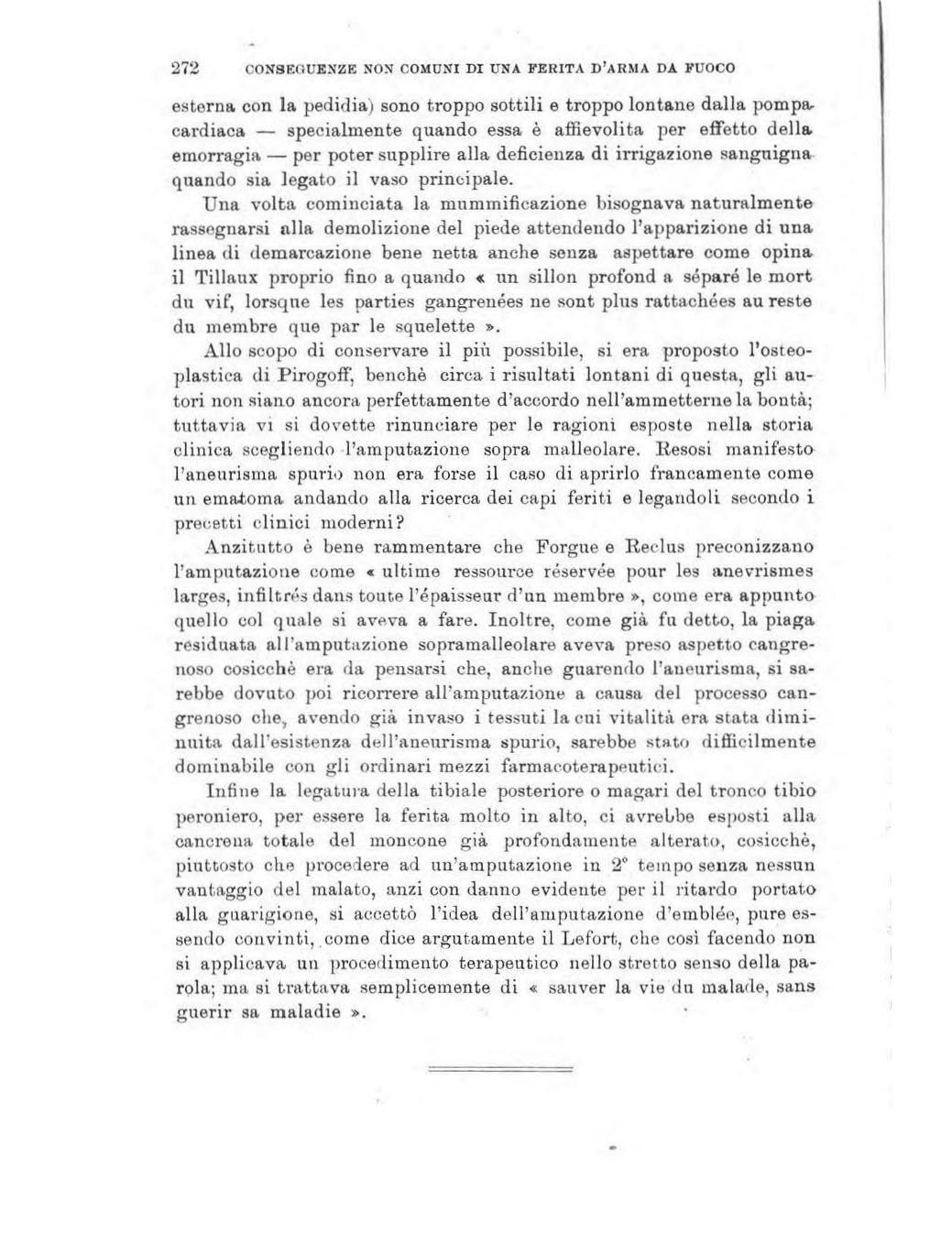
272 CONSEOUENZE COMUNI DI UN A FERITA D'ARMA DA FUOCO
DELL'ENDEMIA GOZZIGENA NE LLA PROH NC IA DI VICENZA
Comandato ripetutamomte quale perito presso il consiglio di leva di Vi cenza(l ), mi accinsi a queRto brelve stndio approfittando della conoscenza dei luog hi e deg li abit;Lnti della zona alpo:,;tre di detto, regivne, tenendo conto dei dati rar.colti sul sito e dell e informazioni assunto dai co lleg hi m<>dici condotti dei vari centri gozzigeni, basandomi sopratutto r isultati forniti dai varii consigli di Jova nt'll"ultimo dC'renuio (1890-HJOO), risulta t i c.:he come è ben not o, rappresentano un vero campionario qualita.tivo delle mal attie dominanti in una datl\ regione, ed assieme sommati la vera estrinsecazione della vita di una nazione.
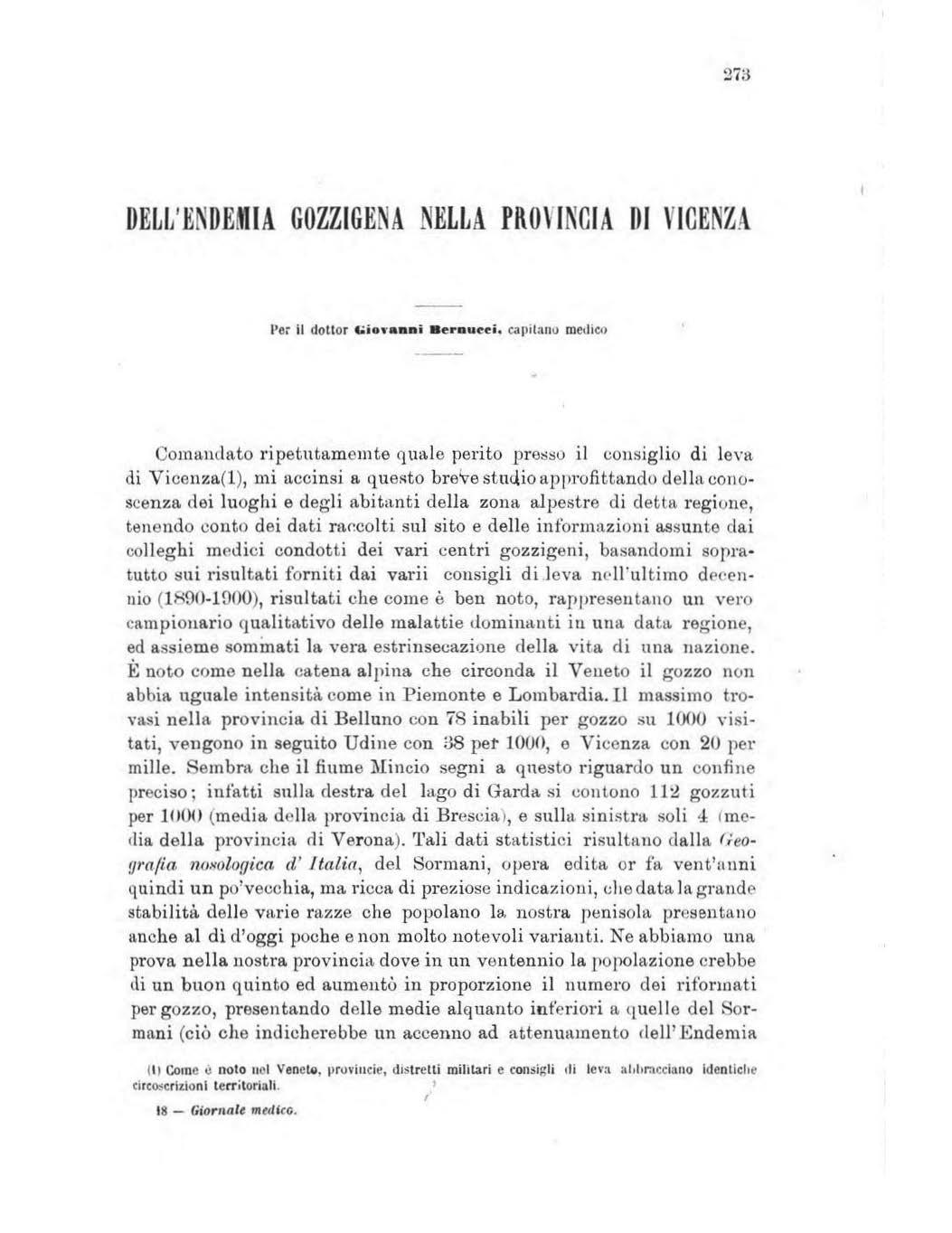
È noto come nella catena alpina ch e circonda il Veneto il gozzo non abbia uguale intensità come in Piemonte e Lombardia. Il massimo trevasi nella provincia di Belluno con 78 inabili per gozzo su 1000 visitati, vengono in seguito Udine con 38 per 1000, e Vicenza con 20 per mille. Sembm che il fiume Mincio segni a. qnesto riguardo un conflue preciso; infatti snlla destra del htgo di Gard<l. si eon lo no ll:l gozzuti per 1000 tmeùia. della provincia di Brescia 1 , e sulla sinistra soli 4 emedia della provincia è! i Ver ona) . 'l'ali d atri statistici risultano dalla rreo[p·afia no..,ologica (l'Italia, del Sormani, opera. edita or fa vent'anni quindi un po'vec.:chia., ma ricca di prez iose indicazioni, che data l a grandE' stabilità. d elle V!trie razze che popolano la. nostra penisola presentano anche a l dì d'oggi poche e non molto notevoli varianti. Ne abbiamo una prova nella nostra provincia dove in un venteunio la popolazione crebbe lli un buon quinto ed aumentò in proporzione il numero dei riformati per gozzo, prese n ta.ndo d elle medie al q nanto infe riori a q uelle del Sormani (c iò che indicherebbe un accenno ad attenuamento cieli' I::ndemiR
(t 1 Come u noto uot Venew, IJr<lvincic, dostrclli mihlari e consigli 1li leva at.hracciauo tdentìch e corco,;crltionl te rritoriali
18 - Giornale mtillco
l'er Il dottor GioYaani •erauee i . capotanu metloco
in parola) , ma non clate iu egual misura dall'in t N'O con i inge n te annual e agg irantesi intorn0 a C>OOO inscritti, ma ben::;ì nella quasi totalità d a quello fornito da l imitata :r.ona ci r cosc rit ta n poche subalpine Nl a rari piccoli centri g o:r.zigeni p osti allo sboc<'o delle varie nella piunnra. T opograficamente considerata l" int t.> ra p•·o\"incia prese n ta n el sno assieme nna pa rte' montan a, c he è la piit nordi c a , prevalentemente fogg iata ad al tipia ni. l'Oli ce ntri d'abita zi o ne, 11.d un'al te zza media di lUIJO m e tri ; una mediana d i piccol e valli, qua.li dirette da nord a s ud , q u a l i dR o\"est ad est, e da ultim o la pnrlt> piana della pro, inc ia, i n mezzo illla quale ele,asi affatto isolata la c a te na d e i colli Beric i. d'origine vulcanil"a , co n altez ze di p r•co s u periori ai 3110 m Atri. - Or bene, mentre sngli altipiani so n o rari i ca,:i . dj gozzo, mentre q u est i manca n o q uas i co m pletarnC'nte nella pianura, C'entri gozzigeni abbastan za importanti t ro\ausi n e lla reg i o ne preal pin a c ollin osa, nelle verdi, fresche e rid en ti , alln te del Chiampo, dell'Agn a, del L eogra e dell'Astico , limi tat i quind i a por:r.ionr- dei distrotti a mmini st.rnt.ivi d i Schi o, Yaled Arzignano. P erò an c h e in q neste essi n o n sono u nH'genea.rue n te distribui ti: anzi a questo riguardo Lr0v iamo d e lle \aria·
.7.i o ni n1 e ntre nel co mune di Tretto s i va olt.re la m edia e norm f' del 250 pe r mille, altri , - i<:ini n on l a m ed ia del per mi lle . Parrebbe c he i f ocolai de ll'ende mia siano più s piccatamente tre; n no gravissinhl M·eute centro nel co m une d i Tre t.t o, p r opagantisi co n int e n sità mo l to minore nei finiti m i d i T o rrebel;ic ino, \"alli dc i. 'ignori E't i in alcun<> contrade rurali de l co mun E> d i Schio: u n secondo attorno al eomnue di \ e lo d'As tico, estendent«.>si n l fin i timo di Arsiero. c!l n n terzo a,·ente sede ue ll'altn. \"alle de ll'Agn a . nella pnrte rurale et1 alp«.>,tre del eo111unt:' eli H ecoa ro , con cpHdt·he infiltrazione nelle vicine co mnnitù di K o ,·alo e Valdagno, econ poca intensità attrawrso il coutraffMte di )(arana ne i ùne com nni di Cr e::pador o ed Alti ssim o testi\ de ll a valla t ;l del Chiampo Ciò che a prima Yista ril eYasi in d ett i crntri, s i è l !t m a u canzt\ qunsi a:-;solut R. di g oz7.u t. i n e lle agglome r azion i p iù impo rtanti di popol az io n e, m e ntre I" t> nd Pm ia co miociil a manifestilrsi . e la s i tr O\"'R. piit che evidcnt c in q u el le fmzi o ni clte ffl.c·enclo pnrtl' cl t• l co mnue m e d Pr;im o ROliO di11poste ad e.;so d'into rno .
Dn. ciò un a II Olf' v o le s a ltmtria d iffu sion€' che- p ol r Pbbe dar lnogo a1l osse rv!t:r.i o ni in te r essa nt i, po ic h è l 'endemia spes:,:o da fra:r.i o ne tl frazione . . \I tri rent ri go zz igen i , ma d' in t€' n s itit molto attentmta, litro· vi amo n«.> i com li ILi collinosi di Lugo \i ccntino, 1\[agrè, )[arano, posti a llo sbocco di V a l d'. \s liC'o, ne lla p iannra, centri piecoli e poco ntti,i, d0\"0 e l" ill('rzin della \ita inte Ji ettm\Jt> SO!:O fattori cert o

DEI.!.' E:\DEML\
11vu ùi.sf:Jrezzavili nella ricerca delle o r igini L11. pianura Yeneta non h a endemico i l gozzo come la. Lom bardia (Sorma.ni pa.g. 16'l J, e soltanto alcuni casi sporadici si riscontrano, com'ebbi p i it sopra a rile\·are. in comunità di pianura..
Le condizioni topografiche ed orografìche del suolo, inter vengono in rl ubbia.mente come agente importantissimo nella. patogenesi del gozzo
•Sorma.ni, pag. lli3), e cosi osser vasi come nella. regione alpestre de l distretto militare di Vicen za l'endemia si estenda in località. poste fra i :!:)() ed i 'i()O m. sul l ivello del mar e; al di sopra di tali altezze, come arl esempio nell'altipiano di A siago popolato da quasi 30,000 abitanti

NELLA l' &OVINClA D I V l CENZ A 215
. ......... . ..... . : • ... \ "' • ...... \ ....·.. • +-· • k
" 7Z - •·
farDII'mrt u1r /11 n,J, J, Z.JOpumd/, t:r:sdult. rr..kn:na/1 P'r fOZZ,, yMn J'""ua. /J()
e posto in m edi a a 1000 m. sul mare, ri levasi qual ch e caso di gozzo ma in f orma sporadica., ereditario in qua.lehe famiglia, limitato· a qualche contrada delle più remote. Tal fatto collima perfettam en t e con le osse r,azioni di altri autori che in \alla.te eminente mente .gozzigene riscontraro no una. raritù dell'endemia. nei villaggi posti o ltre i !JOO m su l l ivello del mare. (Pedra?.zini, f ;ozzo e creti11ismo Ì1l raltellina ).
Il cretinismo, fratello germano del purtroppo non è sco nosciu to n e lla zona gozzigena in parola. ma t rova.si ad es ·o associato in una proporzi one molto ba.,sa, vale a dire del 4 p. 100, c ioè c h e sta in r e lazi on e sopratutto al fatto che nei gozzuti del Vicentino l ' ipertrofia della. tiroide rappresenta. puramente una malattia. local e, arrivo. ta.nto in rari <'asi. a.l go'if1·e p/,Qngeant o n rero en dedan8 Jei Francesi, è quasi sempre cistico, con rari cas i di gozzo vascolare ass ociato ad abnorme sviluppo aneurismatico di tal una dalle arterie tiroidee; compatibile quindi con l'armonico sviluppo di tutti gli a.lt1·i orgtmi e f u nzioni. Fortunatamente nel caso nost1·o que lla degenerazione di cui il gozzo sarebbe i l primo t orm i ne ed il cretinismo l'ultima. tappa arresf.ossi al primo gradino (liall, .gw· maladies mentale.,) e non arrivò alle s ue estreme conseguenze c he in rari casi ed in un a perceutual e molto limitata1 ed organismi non ancora. indebol iti da un 'er edità compromessa, seppero opporre alle tendenze d egene rative tale re:<istenza che queste n on potHono esplicare la propria influenza. che s ulla sola. tiroide di cui disturbarono lo s Yiluppo.
Come ril evasi da.lrannesso quadro stati stico la zona della provincia. di Vicenzn dove il gozzo è endemico, assegnando a d essa. limiti molto vasti, abbra ccia non più di 12 comuni (s u di cui componesi l'intera r egione) co n una popolazione di JI1Jj/!l a bitan ti ( S U 447,935 dell'intero distretto _) . I con fini geograficamente ris t r etti della zona. g ozz igena in paroln e la poca appariscenza dE'l magg ior numero d e i casi, secondo il mio modo di vedere, spieghe rebber o co me fin ora medi<'i e naturalisti l 'abbiano del tutto tras curata, m e n t rP. l'endemia i n parola, fìn dalla. pitt remota antichità, attrasse l'attenzione d egli stu dios i e dei governi là. dove presentandosi sotto f0r ma eli vero flagello este ndent esi F:U larga superficie e colpen do buona parte d oHa popola.zion <' virile, m ina cC ifl,vft cl ' iste rilire le fonti dell'intelligenza e d el pubblico e privato.
Conosciuta. appena l' e ndemia gozzigena, l'at tenzione degli autori fu na t uralm ente rivolt.a a cercare qual fosse la ragione che indu cesse una cosi profonda e degradante alterazione nell'organi;;mo degli individui che ne erano colpiti (Plinio, Vitruvio, Ulpiano, PCC ) Come in

27(; DEl.!.'
GOZZIGE:-IA
COMUNI :!l' !:2 lì 16 :2:3 2 !) 51 74 43
presente classi di levR 1 i:07.ZO nel e- l go a gro,,a Cl ro ormal l fiPrgol.o gros- l gozzo c l l ISH al 1 R3 !lO (;:j JGO (i l 48 87 108 IO.l 2Rl 150 2:W
ùpol
»
p r•ovincia 39U25G 1 1 olale 44 t 9:lv.
del rimanente della pro vincra • N. 408
» »
cen nio l nclolccennio per gozz() sa l gola g rossa 1880 l !Z t:ii t"" > Y. (") ;;: ::! < z N :.t-:> -· -1
provincia "

Alti ssi m o Arsiero · . Ct•e;:pado ro Lugo Vi ce ntino Mag r•è Malo. Ma rano Vicentino R ecoaro Tot·t•ebel vi c ino T ret to Valli Velo d' As ti co :m.) 4SI8 2G21 2723 3281 6057 63 }7 -i:1H 5fi;j( 26RG 2:.:1 4:)1} 2:JG 2 \l i 41)} 625 3;} 596 ·1 1)!) :t!} ;>!H 280 P
rimanente
H 27 i3 ( t; l \) 22 li liG 67 4!! Riformati
" ,, •
. i i2 a u i IO R 1 1 24 2} o_;> 1:2 55 li:2 51 112 .H (ii 7!) [):2 207 · t u8 n:-
•
riman
nte
Puvo'adon c l\um eru co m · \ lloforuwt • l'l'l' , llofooma to Media pcr111111e .llcolia l'•rnoiil ù per mille ' msc rilli <.lell<' 1 , d 1 ,. d 1 olei r iforon:oli rifo rmai o N. fl.
azione de lla zouu gozzigeua 481i79 1 • _ .•
pe r gozzo e gola grossa della zona gozzigena nel dece nn "o N. G01.
.Media pe r mille de i r·ifv rmati pe r gozzo e gola grossa de lla zo na gozzigenA ne l dec e nnio N . .J2:J.
»
e
t an t i altri punti dello scibile umano ci troYiamo anche in tal ca..;o di fronte ad u n numero pitt c he ril e nmte di t eorie c he ci r e n tle un po' scettici sul Yalore delle medesime. Il Saint Leger c ita non meno di 3 1K autori che t ra ttaron o del g ozzo con di>erse teo rie sn lla sna. genesi , come ad es. l 'ori g in e del gozzo d alle influenze m et.er eol ogiclH', dall'aria, dall a luce, dalle stagioni, dalla temperatura, da ll" esterna configurazione de i luoghi , dalle razze, dagli in su lti meccani c i , dai tmumi. dalle permanenti costrizioni coll o, ecc .
V ol endo indicar e fra le numerosissime teorie quelle che sembrano le 'più att<>ndibili abbiamo:
l " LA. teoria idro tellnri ca . La teoria cl'iodurazione insufilciente.
n• La t eo ria mi c roparassitar.ia.
4" La teoria dell'intossicazio n e miasmatica.

-;,o te01·ia d e lle cause multiple ) [ i propongo or a òi r affro nta r e breve m ente le diYrr.sfl tt:'o r i e 'tJ ll le ,·oncli;-.ioni fl coi dati statisti ci della zona g ozzigew.1. in r.same, undf' YederCI st> esse vi troYino un diniPgo od una. co nferma .
1" T m RIA wnoTF:Lr.eni C,I. - È hL più an ti ca d i tu t te. Ad essa a cl·enn<mo Vitrnvio, Plinio, Ulpiano n el periodo r om an o, e nel Ri unt;c imento l a mente enc ic loped i ca. di. Paracell:lo, sostenu t a r ecentemcn tedal Longnct, dal Bonuet, Saint Leger: Ga.rrigou. ecc. Qu esta teuria att ri buisce il gozzo ed ilnetinis m o alla Rpeciale natura di certe ac'l' '& t!d alla (orma::io11e geologica dt•i terreni sui q uali t alchi> trasporf er eb be1·o talttni materiali con a z i OII t' yoz: igel/(1. l sosten itori di tale teoria s: appoggerebbero sopratu tH• fatto c h e effet ti\"a.mente, in talun e l ocalità g ozzigeue, il rifornimento di buone acque po t ab ili di ede luogo a d una diminuzione dell 'endemia
P erù, m e ntre ciò non v e rifi cassi in modo costan te, co.me 'tt va sto campo eb tJe aù osse rvare r ecente m e nte il Pedrazzini n ella. Val tellina, c h e ge HPJ'alm e n te fornita d' ott ime acqu e p otabili vide aumentar!:' llPgl i, nltimi anni l 'endemia in parola, de>esi n otar e come l11. massima d i-
-.;t:ord ia r eg11i nel campo degli rtmmcl o vogli on o in d it·a re qu11.le si a la natura dP I st;olo cau sa dell' e nd e mia e la ness uu a loro ,·onoscenza d ci supposti mate ria li g ozzige ni. Così lo :-icl, e id e r ed il 13ir c h e r ri co nosco no nel terreno g iurass ico un suolo immun e da g••Z7.o, ment.re n on è d ell o stesso parere i l Ko ck e r c h e n e l cantone di Hf' rn a r isront rò sn tal i formazioni un' int e n sn. zona. lil.ntnJn!;a Parlm <'llt i il vnol dimostrare che gozzo e c retini smo s i Oise rnm o di l•r<'l'•·l'l' nza su t e n e ni argillosi, calcare i mi cacc i. cd iJ Grange su quo·l l i appa r tP n enti al lias, al trins . alle marne, ai cn.l cari dolom itici. in
DELL' .E :-lDEllA GOZZIGE:\ A
uere ai te rr en i m o lto anti chi, soltanto tutti vanno fa.ci !mente d ' accon lo ne l ri co noscer e immuni le formaz ioni vul canich <' N e l n ostr o caso :;a.r ebbc fuor di luogo diffondersi sulla struttura clelia zona in esame ; n e lle prealpi vicen tin a p r edomina il calca re in t utte le svariate sue fo rm e, n on esclus a la do lomi tica.

Ora m entre ta l fo rmazi one geolog ica s econd o àlcnn i (Billol) sa r e bbe spiccàtamen t,e go zzige na, secon do altri Je a cq ue calcari e magtws iach!:'
:<a r ebbe ro inYece c tii cac issime nella c ura del goz zo, ed animali cui v e nnero n no n ebber o a. risenti ru e alcnn noc mnento Dfl l r e,.:to pf'r p rovar e rinnocuità di tali f ormazi oni geologiche basta citare l'e:;empi o dfllle Alpi Veneta ehiamate 'l'edC'schi per antonoma:;ia: 1\alcl.'ftl" Alpe1t (.-\lpi Calcar i), nell e lJUali vediamo l'e nd emia gozzigc11a prese nta re, come Lo accetma t.o precedentemente, un· in te n si t;\
1\s:>ai m i n or e c h e n oi Piemonte e nella Lombardi <\. centro di 'l'retto trova.n:;i numerosi strati di caolino allnminiuo potassi<·o) form az ione antic·a azoica. e pltfeozoica, perciò favore vol e t>ccondo alcnni al goz zo; ma s imili f ormazioni, ed anche più trovansi nel la n ostm pe nisola a 'l'olfa (V iterbo) e n elle ir;olo d'E l ha c di se nza c h e q uivi risco n t risi la benchè menoma. traccia di gozzo. Uo n c lu· dendo, la t eoria idrotellurica più che prescntasi fae ile a d i nt uir:>i, un'osservazione s u pedì cial e, ma n o n r C'gge u n a sana critica bt1.-sata to s u co nfronti s imilari.
' l'EOII! \ DF: Lr: ro m·RAZI OXE - Ji'u lo Cha.ti u che pf' r primo emi:w ta le tro ria tChatin, l' étiol orJù • d u goìtre. 18 1i! l ) Egli &'\""reb b e che la ri cc h ezza di iodi o su lle mon tagne ed in gen PJ"f' nei luoghi molto Plevati è mi no re che nelle rc•gioni di med i a altitudine, l n. d('usità. dc i \·apori ùi la lo ro sc;t rsa forz a e lastica . D a li <' se m p l i c i p renwsse o.ntcceden te mente enunciate risul ta come to le teo ria non si pos..:a menomnmente applil:at·e nel nost.ro ca.,.:o dove tntto all" opposto l a. zo na, fra medie tli al tezze m o lto limi tato fra i i50 <·gli tiOO m., eh(\ :;C'<·ondo la teoria dello Ch at.i n dovrebb ero goner e dei tan ro benefici va.p ori d'iodio. Del r esto basterebbe ci to.re In obbi ezi on e c h e ne l Salisburghese ri uco d'aC([UO carich e di iod io, !<Ono abbo ndantiss imi gozwti e cretini .
;3 ° 1'!-:QHIA M lt"IW I'ARAS >;ITARI \. - Il J{lebs !1.\TObbe S<.:OJ>C'l"tO neJJ e ac.: t1u e d e l tia li sb urg h e,;e e di al c une r egi,mi gozzigene di B oemia. a lc uni infusorii del gener e navic ulae che sc<·ondo l 'au tor e S(L rebbe ro ca u sa dell 'encle mia in parol a . .Birc her esaminando m olteplic i a cq ne in torritorii g ozzigeui avrebbe ris contrato frequ e ntemente in esse una ditLtomea (La accompagnata da bacilli r.. forma di ba:::toncino o di virgo l a, c on mo\"imenti serpe nt in i a i q uali '\""Orrebbe attribuire la Cllus a
);ELI .A DJ VI CE::\Z \ 27[)
del gozzo o del cretin i:-:mo; non li descrisse però pilt minutamente, nè cont.inuù le ,;ne ricerche con i metodi suggeriti dalla tecnica odierna. Da ultimo in Italia Lnstig e Carie, esaminate 2G acque diverse della Valle d'Aosta <.·on le odierne ri cer che lHttteriologiche, non Yi riscontrarono i microrganismi del Klel>s. mn, però rilevaron o come tutte fossero ricche di diversi bacterii: fra i quali specialmente costante un microrgauismo c he lictuiferebbP la gelatina, moltiplicanùosi con estensione caratteri:ilÌc&. anche a Lemprratura elevata: proprio soltanto delle acque sospette gozzigcne, ma <'he innestato su d'a.nimali in cultura pura, non riu scì menomamente patogeno. Ulteriori ricerche in qnesto sonso finora non Yennero JJraf.icate, ciò che è in troppo apt'rto contrasto co11 l'attuale di ricerche batteriologiche, mentre allo stato attuale In, teoria. in paro la mal}f'l1crehbe assolutamente di quella dimostrazionP che richiedono le l eggi dell'od iernn. pamssitologia (isolamento dPll'"gen tt' patogeno, sua c ultura pura, riproduzione della forma morbosa).
J." 'l'..:o•n ,, nr.I.L1 IN'l'OSSIOAZIONE MIASMATIO I.- A qnesta teoria n0n mancano valorosi sostenitori qua l i il vingtriuier, il Liicke, l'Ilirsch , .:\Iorol, Kuberli, 'l'ourJes ed il sommo Virchow ed in ltnlia la Commi ssione Lombarda del 18(j J Si ammette cioii che in certe 1'egioni .çi compia tl?la putre{aào11e ocl una {Prmn1tazio11e fica vegetali• od ani111ale, della quale {'{lria J'i('eve e scioglie le emanazioni P le per la a tutti gli indit:idni che altifultlmente rit·ono in quell'ambiente. More! la putJ·éfuction sp1:cijique e parla di emanazioni di essa che si a'i·vici nercb bcro al miasma palnstr<> di buona memoria.. Più recentemente il uni formandosi alle moderne teorie sulla. malaria (Soc. Mc!d. d es HùpitPa.nx, lH!lR), des c risse un'ematozoario simile a.l malarico che tro'i·ò llel sangue di giovani gozzuti, la di C' ni forma nve,·a avnto nn rapido ,.;nluppo, declinando pnre rapidamente. l n tutti i modi la tE'oria dell'inminsmatil'a presuppone l'esistenza di acque stagnanti, tlistendent<''lÌ· in paludi di maggiore o minore esteusion<>, meutre invel·e 11ella no>ltrn. zona i fiumi sonvi torren7.iali nè le 'allatP strett<' e rocciose p ermettono ad ess i di dilagare, talc h è la zona go7.zigena. della no:;tra provincia, formata in genere di località eminentemente salubri, rebbesi in posizione inversa. 8iccht-ln. teoria mÌa!>ma.ticn. per 'Lnanto rignnnla la zona gozzigena del Vieentino, è c_ont.rarin ai fa.tti.
i,u Tl·:onrA m:1.1.E t'AU-<P. Ml'J.TIPLH:.- U Yirchow pure essenùo so:-te· nitore della miasmatica, cosi si esprime: Yon aedibile clw tw tauto aff tvo t•cl in·itativo sùt occa$iona to nto dalla 11/llllcau:a di t'IW lt' caltse dt'l go::zo non c(,•bbono. e·'·'·l'r rirerctrll! in 1111 80lo unico age11te, ma ilmede., imo dea molteplici

OF.J.L' GOZZIGEXA
fattori i ed il Ferrus cosi enuncia. la teoria. in parola: L' di tma cauMt uuicet è i11lt11WlÙJSibile, quindi per piegare la ge11esi del/'emlemùt con una .'limultetneifù di elen1enti produttori e d'azioni combinate. E col Ferrns si schierano la Commissione Sarda, il Verga, il Bottini e molti medici e rolatori eli comun i e pro">incie italiani e stranieri.
Ora stabilendo che cosa debba in tendersi per cause multiple, mi [J&n" che due specialmente sieno gli argomenti da prendersi in seria considerazione: La consanguineità dei matrimoni i da. unA. parte e sopra.tntto il genere di vita dall'altra. Ben noti sono i danni provenienti da matrimonii fra. consanguinei, danni che sopratu tto si manifestano co11 malattie nervose in genere ed incompleto sviluppo delle facoltil in ispecie. Nelle contrade rem ote, nei va!Joni profondi, lontani da qualsiasi umano consorzio, crescono e si moltiplicano fra ù i lùrO gli abitanti dei rari casolari, e se nella popolazione vi ha un difetto anche minimo, questo si trasmette e si esagera. - Così accndf' auche n ella nostra zona, OYe precisamente nelle piìt lontan e, prive di facili co muuicazioni coi centri maggiori si annida l'endemia gr>zzigena.. Ora aggiungendo a tutti gli inco nvenienti della consangnineilil. quelli derivanti da una vera segregazione ove manchi qua lsiasi !-ttimol o alla vita psichica, ben si comprende come vi>a. e prosperi tale endemia. Aggiungasi nel caso nostro che disgraziatamente la zona. in parola è dell'inter,a. pro>incia la sola OYe, indipendentf'mente dnll'enrlt- min in discorso, si osservi una. vera fisica miseria, talc b è n,nnualmente f,,rnisce ai consigli di l èva una percentuale media ùi 3 !1 riformati p. tOO inscritti: mentre la media del rimanente della provincia si aggira into rn o al l:J p. 100. - Ed è proprio in questa miseria fìsica della popo· lazio ne rurale di tal une comunità montane, miseria. causata dalla scars a alimC'ntazione, dal sudiciume e dal vivere stipato, associata ad una natura.lo predisposizione dovuta all'ereditarietà che ritengo ri!.'ieda la ··ansa. prima d cll'alligna.mento di tale endemia (l). - N è mancano all'oppostv esempi storici di popo1azioni nelle q n ali le migliorate condiz i on i igieni<:he e sociali ridussero alminim um la naturale predispo5izione al gozzo ed a,) creti nismo, indipendentemente da provviste d'acque· potab ili; come ad esempio avvenne a Friburgo nel Baden ed in tutta la. forestn. Nera, n el 'Viesenthal, nel Fedberg e n ei dintorni di H omhrrg e eli Ambruch (2!. Conclndendo, mentre a mio parere nessuna
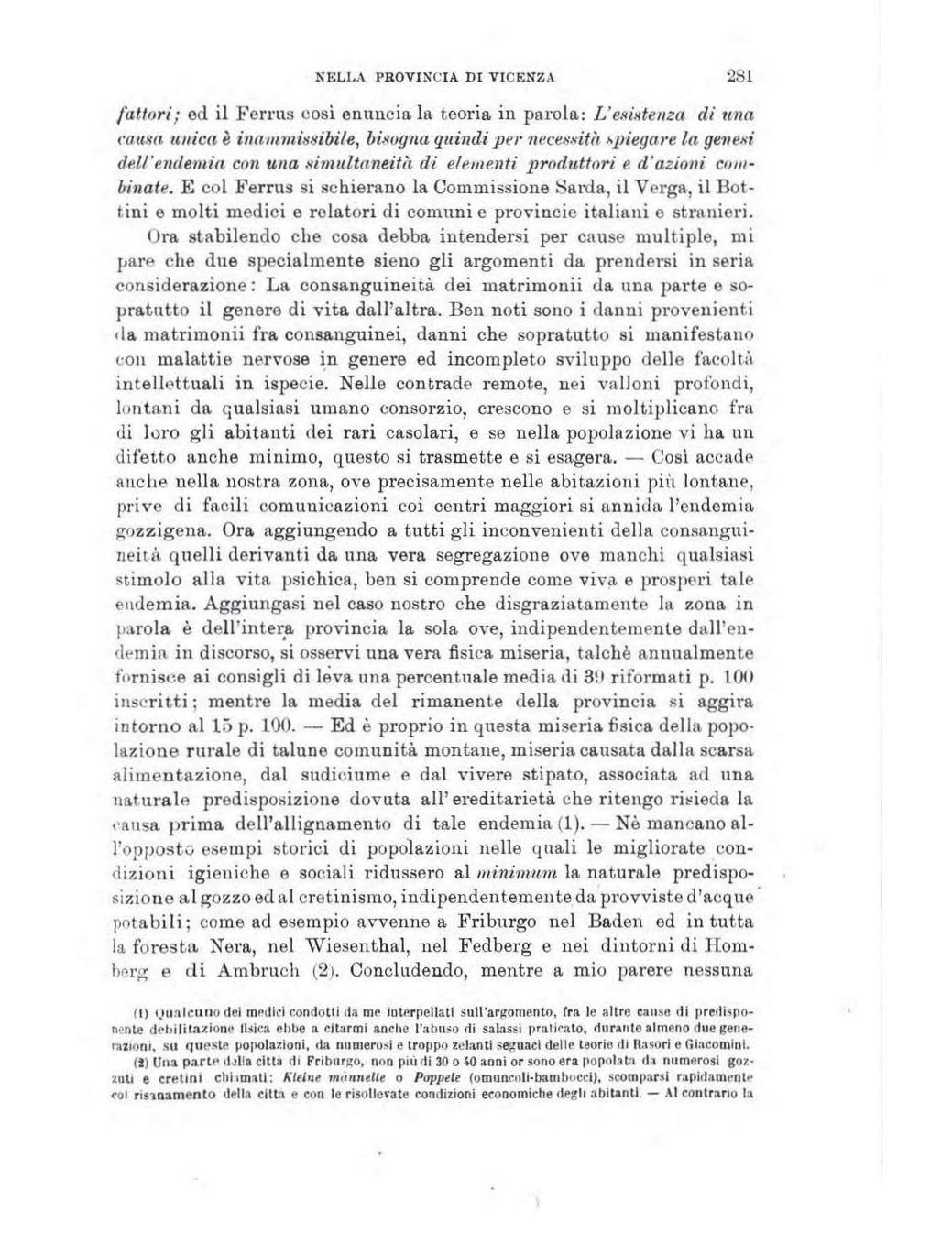
I l) •.'u:•lcuno del mr!licì condotti tla mr loter(lellati sull 'argomen to, tr:1 le altre causo di n"nte dl'IJi litn>:ionc e hbe n rlt.umi anche l 'abuso rli salassi walirato, t1ur.1nto almeno due genernzoono. su fJUl'SLE' porola7.ioni, tl:l nume r osi e troppo zelanti sey uaci del\ P teorio do e Cllncomìni.
(!l Una parti' oiJila clttu eh Prihurgo, noo poù Ili 30 o 40 anni o r sono era popolal1 da numerosi (!07.· zuto e ere t mi chi ounti: 1\lti•u mo•nndlt o Poppelt (omuncnll·bambuccll scompa r $1 rapiclnm,•nlf' rol ronoamento dPIIn cllta e con le risollevate condizioni economiche flegh abitanll -Al contra ro o
NELLA PROVH\C IA Dl VI CENZA 281
delle teorie esclusiviste messe innanzi r egge ad una sa.na c riti ca, presentando argomenti spesso contraddittorii, que lla delle cause multipl e offre almeno una serie di dati e fatti p ersuasi'i e pe r fettamente comprovati . Con ciò non è detta certamente l ' ultima par ola, nè esaurita l'eziologia del gozzo, sonvi an co ra troppe i ncognite cl'azioni combinale e eli elementi produ ttori (F errus) . :lla, secondo il mio modo di , ·eden· è t r acciata in tal modo la retta via, seguend o la quale no n si correrà piìt il pericolo di inutili e dannose d ivagaz ioni.
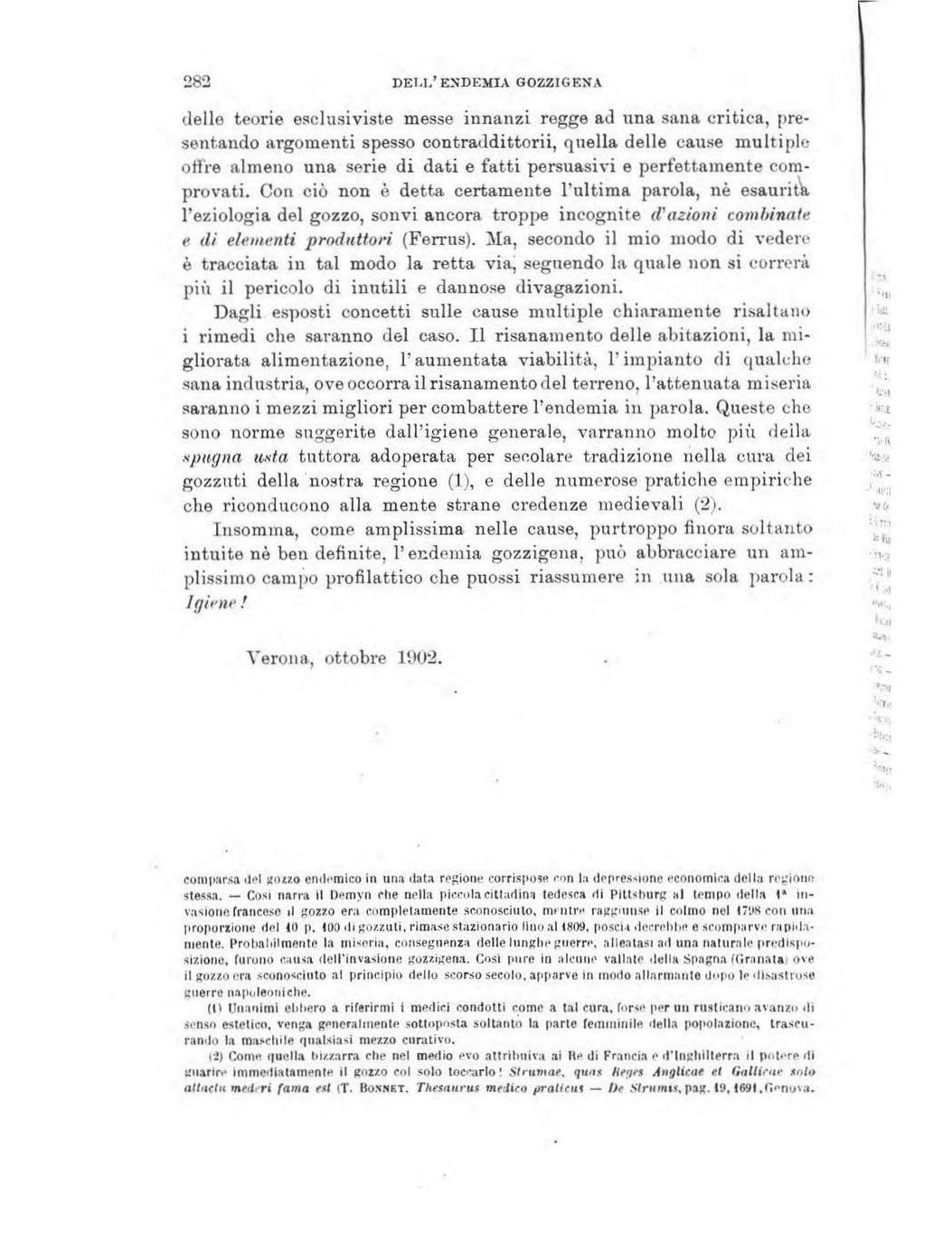
D agli esposti co ncetti sulle cause multiple c hi a ramente r isaltano i rimedi che saranno del caso. Il risanamento delle abitazi oni, la migliorata alimentazione, r a ume ntata viabilità, l'impianto d i qualc!JO ind nstria, o ve occorra il risanamento del terreno, l'attenuata m iseril> !laranno i mezzi migliori per combattere l 'endemia in paro la. Questo eh(:} sono norme snggerite dall'igiene ge nerale, vnrrauno m olto pitt deila tnttora ad operata per tradizione n ell a cnra de i gozzuti d ella r egione (1), e delle numerose pratiche e mpiriche ch e ri con ducono alla mente strane credenze medievali ("2 ) .
Insomma, come amplissima- nelle cause, purt r oppo finora sul tanto intuite nè ben defin i te, l ' e.r-demia go zzigena , può aùbracc iare un amp lissimo ca.miJO profi lattico che pn o:ssi riassumere in utta. sol a parola: l [J Ìl•/ti! '
Yerona, ottobre 1902 .
compar.<a ol o'l cn<lo•mlco in una data r ef;iou e ror ri<I>O'P r•>n la dPpre:<-> onr Pco nomio•a dcll11 rr::onuo iteHa. - Co<o nnro a il Ormyn rh e nr lla picc.>la terlc<ca <11 :. l IPOlJlO tic lla t • ml'a<lou o ol er:o t"Offill lr tam ente sconosci uto. m> n t•·•· ral't!='"'"r il colm o nel cou u ua jlrO j\Ortio u e rtrl I O r. t OO "' gOlZUii. rim a.<esta z> onario li n o a l t 809. olt• t•rt•h iJr e .<roJmp ;o ri'P mptol:l· ru en te. Prnhnhil mP.ntt• la m i•rrm , Co>loseg u•nzo delle lungltt·l!uerro•. allea tn s> no i una natural e '\ I ZIOIH!, rui'OII O fle lrm va,lo nc gOZ7. 1g'C Oa. Cos i pau·e in niC UIH' vallnlr della :)pngnn (fi rnoal& l il gouo t• m ,cono<ri ut o al principio dfllu scor.;o secolo, apparve m modo nll:mu:on te dnpù lo d i,astru<c ((l UUaJliOll CÌiioC rO a riferirmi ( nlPfliri rondOtli C"Offi C :1 tal c ura. fM, <' j1rr Ull rUStir.1!ltJ :\\:lll1.11 IÌI
St'O'\Il geucrahnentf• >Ottopn<ta >Oi tautO la par te !CIIliUÌCIIIP •Iella j)OIIO iazlonc, l ra>CU· rando la ma:-chtlf rtu lll"in l mezzo cura.U\'O. qualla 11111.:\rra nel medio p\"0 attrihuila ai n.• di franco:\ p cl" hu:hilterra Il r• •l•'rP eli ;!Jlar lro• ommctti:ltRmPntP il col solo toco·arlo! Slrunoat. quM ll•fl•& Anglicat et r."l/i,•tr•• 111lv lr ii•ICIII m tdc r i (am a td tT . BOSN6T. T heSIIIII" IU m tdi co praiiClU - Ot $1rowu <.fl)j(. 19, t 69 t ,(òenu'"·
282 DELL' E:SDEMJA
GOZZI GENA
., '·' 'l o\ • l .: ' ' .... l l """ , _ ·-· ,, ...
INDICE BIBLIOGRA..FICO
l. lloTTINI. - d el collo. llllnno. 1896.
G. SoRIIA!II - Geografia no•ologua dell"llalia. Roma. l f:S l.
3 A. D•LL. - Ltço•11 1ur llt maladltl mtlllalu. Pari <, 1879.
1. Su:n·LKG RII. - Sur lu uwtu du crtlinilme d du goilrt on,
5. f. P•oRA7.ll!ll. - Dtl 11o::o e dtl crelin111no m \"altellina. Mrlan o.
6. 1 - Rechtrch fl mr lu cautts ''" !}llilrt. ( Comptu r end d t l"•l((ldemie dt &ertnces, 1866, vol.
7. V. ALLAIIA. - St<lla cauea del crtlinitmo. Milano, 11>9!.
8. H ORUCIIt. - Note mr l'etlologie dt< goi/.re. (Co mpie rmd.,, t omo 69).
o. Relazione della commissione n(lminata dn S. M. il Ile di s.1rt1cgna per ,; tudinre il creti nismo. Torm o 18!8.

IO. Rela zione !Ici R. J,omhardo cretinismo e in l o mbardia Milan o , 1861.
11. ROZ AN. - Btude ,.,,. t' filologie d" ooilre (ll ev. rle '"''""· de mlid. mìl. Ili scrH'. \"Oi. Xl.
Il. F GAH•roou. - L 'endémie d11 goilrt d d u crélini.!me en vimgée dnus lts Pyrèlrl'fl rw pol n l •le oue de &U rflpporl& a vec la 11nhrre gèologittttt d11 101. ( t;a:; ell e 1/ebdomtrdu&>·t.. n. 17· 18) ,
13 H - Die \"t rcmdtrt41l!Jtll der Slruma und dts 1/alsum{•lll{)tS dfr lltCI' Ill tll lt' tÌhrtlllt ll ilitrirditnsles. (lnaugur. Di&m·ration. llasei.
11••\. HIR <C u. - Kropf trnd Crelillll»ms. llandbt<th der l'o!lwtooie. Slllll·
j!nrd.
l:i Tn. l"o rkommen und \"trlhtiltm!) d t t 1\rnp{ts lll Cqnlon ller11. El•• Dtrlrug sur 1\tii/IIIIUI dtr Ursnclttn dtr 1\rop{bildung. l'lnn. 1896.
lò \\". OtACHIR. - Dtr tndemilth e ArQp( tmd atlne fle;itlurnrrm "'" 11nd ;um Crt·
ttnllmu$ Ba!el. 1894.
li CAn t. e. - Ctnlrolblatl (ur 1888, n. 9.
L, <rro. - l/tber die E!iologie der tlldt•ni .chtn 1\r op{es. ( l'erba lltlltwrrm d t i .\' Colt{Jrtuu :u llerlln. JS90. 01nd II 0 J.
19 G ;>;AUIIANN.- l'tbu d e11 1\rop{ rmd dt•ltll Behandl""D· :\lu nchen, R. VtKCIIOW - (;t iChtorihlt. Vol. 111. S. 59·60. Berlin:
11. C. ESI'!ALD. - Die h'rkrankungtn de•· Schildrtist•.tnr •ìdtm •<n d. t:rttfllismus \\' en, 18%. uber 1\rop{ und trtlinùmu& Oas•·l.
:!3 r. 8o:c:<KT. - TlltiCIUrus m(ditu·prolicus. Dt llrumu 19 tìeno\a, 1691.
!•. G. fEKRC <. - fltch trttl sur l'etiologie du goilre. Paris. 189l.
DI Yl C'ENZ.\
ANCORA DELL'USO DEL CLOROFORMIO CONTRO LA TEN lA
Por il do tt C:ele•Uno Carracio, maggrore medico
Nella conferenza scientifica del maggio 1897 alrospedale di Padova feci u n a comunicazione sull' « Uso del cloroformio contro la tenÌa », <:he poi fu pubblicata nell'anno stesso sul nostro Giornale Medico del R. Ese1 ·cilo nei numeri 8 9 (a.gosto·settembre) . I n essa davo conto di 7 casi di tenia curati col cloroform io, aggiungendovi in nota un ottavo curato posteriormente alla comunicazione. Avevo adoperato la seguente ricetta:
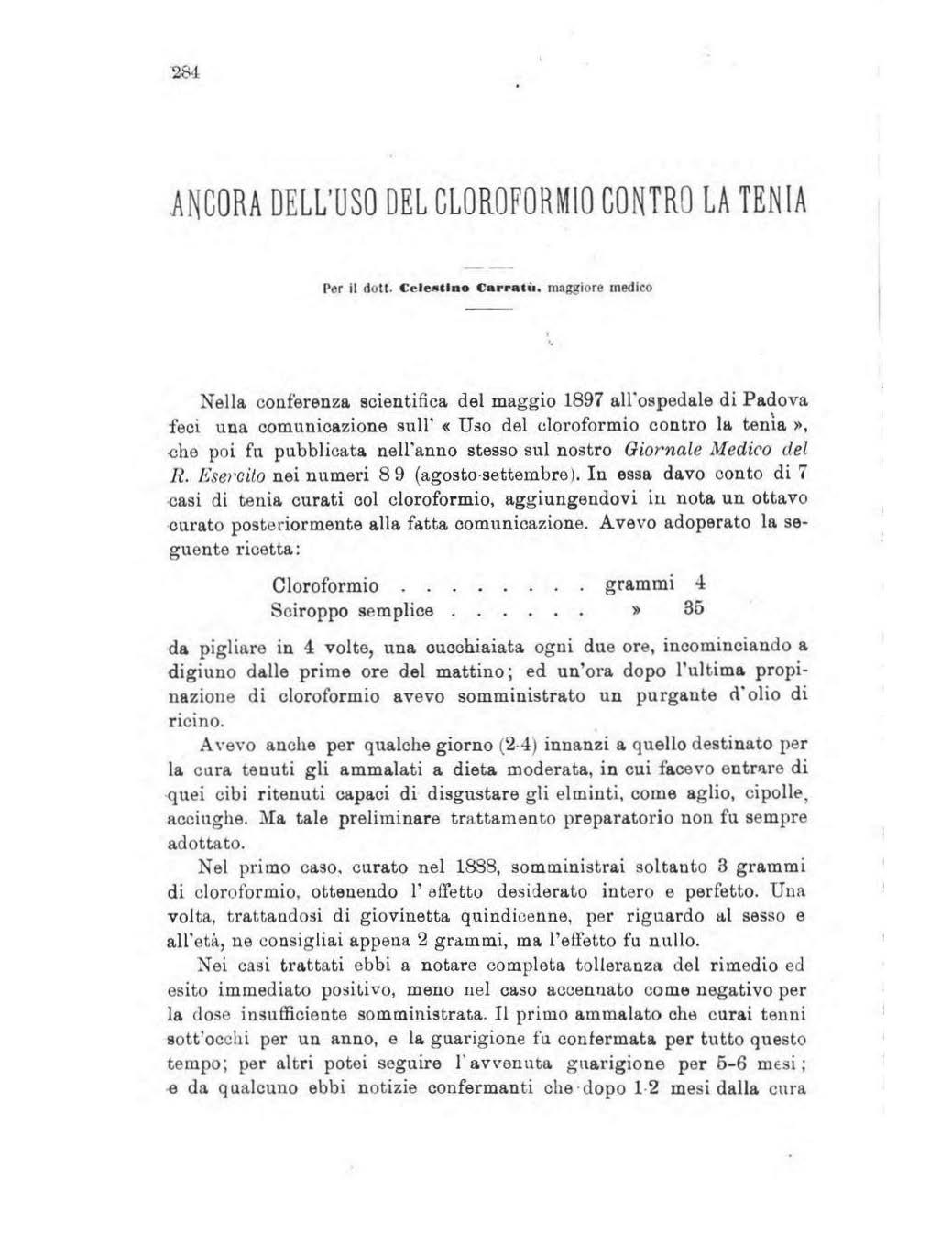
Cloroformio Sciroppo se mplice grammi ,!, » 35 da pigliare in 4 v olte, una. cucchiaiata ogni due ore, incominciando a d igiuno dalle prime ore del mattino; ed un'ora dopo l'ultima propinazione di cloroformio avevo somministrato un purga nte d'olio di ricino.
A vevo anche per qualche giorno (2 ·4 ) innanzi a quello destinato per la cura tenuti gli ammal ati a dieta moderata, i n cui f a cevo entr11.re di quei cibi ritenuti capaci di disgustare gli elminti, come aglio, cipolle, acciughe. .J!a tale preliminare trattamento preparatorio non ftt sempre adottato.
N el primo caso. curato nel 1888, somministrai soltanto 3 grammi di clorofo rmio, ottenendo l'effetto desiderato in tero e perfetto. Una volta, trattandosi di giov inetta quindi ce nne, p er riguardo al sesso e all'età, ne co nsigliai appena 2 grll.mmi, ma l'effetto fu null o.
casi trattati ebbi a notare completa to lleranza de l rimedio ed esito immediato posi ti vo, meno nel caso accennato come negativo per la dose insufficiente so mminis t r ata. Il primo ammalato cha curai tenni sott'occhi per un anno, e la guarigione fu confermata per tutto questo tempo; per altri potei seguire l'av venuta guar igione p er 5- 6 m esi; e da qualcuno ebbi n otizie confermanti che ·dopo 1·2 mesi dalla cura
non s1 era ancora ripresentato nessun feuomeno di elmintiasi intestinale.
In verità. non rin v enni mai la testa della tenia; ma ciò fu p er in· sufficienza di ricerche.
Il capitano medico Aprosio, in seguito alla mia. pubblicazio ne, fece noto nel n. 12 (dicembre 97) del medesimo gio rnale che egli a v eva fatta la. cura. della tenia. alla mia maniera con piena sin dal 1886 n ell'os pedale militare di Torino; e ch e, avuto qualche insuccesso, modificò il metodo dando fin 4 grammi di c loroformio in una volta. e da 6 ad 8 in tre volte, senza. notare alcuna eccitazione g enerale del soggetto; n è ve lesioni organiche o funzion a li d egli apparati digestivo eù urinario. E contava già 60 casi curati.

Intanto essendomi stato riferito che in uno d e i mi ei curati era stata. vista. la riproduzione della tenia ed avendo se ntito che qualche collega non aveva ottenuto alcun successo neppure immediato dall'uso del cloroformio. la mia fede nel propug nato rimedio rim ase alquanto scossa.
Ma una nuova serie di 10 ammalati di tenia avuti a curare nel· rospe::lale militare di Alessandria dal marzo all'ottobre del corrente anno 1902, di 9 dei quali feci oggetto sommario della conferenza di settembre in d e tto ospedale, non solo mi ha. riportato alla pristina fidncia. nella proprietà. tenifuga. del cloroformio, quant'anco mi ha con· vi n to che esso m"ri ta la preferenza sugli altri rime:iii congeneri.
Fatto sicuro dell'innocuità. de l cloroformio per l ' ammalato, mi son messo in questa. nuova. serie ad usarne la dose di 6 grammi in 3-4 volte. Il cloroformio adoperato è stato sempre quello dal cloralio in uso per le narcosi nei nostri ospedali. Gli ammalati non si sono mai lamentati di alcun notevol e inconveniente n è durante il giorno della cura ne in seguito; anzi in dud ammalati h o ripetuta. la. cura a. distanza. di tre giorni senza che gli organi digesti v i o di altri apparecchi organici avessero mos trato minimamente di risentirsene . Sicchè a raffronto dei disturbi più o meno gravi e duraturi negli organi digesti vi e p erfino di fenomeni di avvelenamento prodotti dagli altri tenifughi, compresi i preparati' di felce maschio, il cloroformio nella toileranza da parte degli ammala t i mostra dei vantaggi incontesta.bili.
A:SCORA DELL'USO DEL C LOROJ..'ORMlO CO:\TRO LA TENIA 2 85·
. * *
***
In tutti i oasi si è ottenuta. l'emissione del verme per lo più intero in una. sola. scarica alvina co n tratto lunghissimo di collo sottile da potersi ritenere ch"' anche la testa fosse caduta; e molte volte l'espulsione fn fragmentaria. La testa fu una volta rinvenuta non alterata e riconosciuta/ alla rente della specie di tenia inerme : fu mostrata a parecchi colleghi; ed una volta fu rinvenuta deformata da non potersi di-stinguere nei suoi particolari.
Le altre volte la test a non fu rin venuta, ma ciò non significa che non sia stata. emessa. È stato difficile ottenere che gli ammalati e gli infermieri conservassero tutte le feci da doversi esaminare e può ben la testa essere caduta nelle feci non esplorate; ed ino ltre la maocan za di un adatto sta.cciv ha impedito di fa re l e ricerche minuziose e rigo'l"ose. Però le asserzioni a distanza di parecchi mesi dalla cura che la tenia non si è riprodotta cos tituiscono prove di non minore importanza nel!"attestare il successo. Due volte il rimedio alla prima fallì; .e fu appunto in questi due casi che ripetei impunemente la cura dopo tre giorni ottenendo l'espulsione del tenace nema.tode. Dunque dalla constatazione della testa due volte rin venr.ta e dalle assicurazioni . in -ambe le serie dei casi tra ttati che a distanza conveniente di t e mp o la. guarigione era conservata emerge inconfutabile l'efficacia del cloroformio contro la tenia.
Non voglio però negare che possano verificarsi degli insuccessi. ma in ciò il cloroformio sta alla pari cogli a l tri vantati tenifughi. Infatti tra i miei curati della prima e seconda serie figur ano quattro che avevano inutilmente già fatta. la cura: l col cusso ed altri rimedi, l con preparati di felce maschio e 2 collo specifico Violani che è a base anche di felce maschio. Anzi fu uno di questi ultimi che avendo preso già due volte i l Violani senza pro fitto fece vedere la testa della tenia dopo l'uso del cloroformi o.
Per altro credo che forse certe volte si parla di recidi ve a torto, p ot endo certe ritenute r ecidi ve rappresentare niente altro che uno sviluppo, posteriore alla cura, di tenie preesistcmti allo stadio inattao0abile di cisticerco oppure assunzione di nuovi germi col ritornare d egli ammalati all'uso di alimenti inqtliuati loro abituali.

Mi nasce anche il sospetto che alle volte il tenifugo quale che sia fallis ca pel fatto di sommiuistrarlo quando la teni·a. ha gran pa rte d ella. sua lunghezza rimanendo in conseg uenza più tenace; e
<:iò succede allor chè per constatare la presenza del verme si dà un purgante che n e espelle dei grossi tratti. Così ho verificato due volte.
286 AXCO RA. DELL'OSO DEL CLOROFORMIO CONTRO LA
TENIA
E curioso è il caso che accenno: un ammalato, preso il cloroformio, c o minci ò a cacciare il verme, di cui oltre due metri erano già. fuori dell'ano: ma siccome l'espulsione procedeva. lentamente, l'ammalato credette ,;ollecitarla facendo trazione sul verme; questo si spezzò e non ue venne più niente fuori nè in quella nè nelle successive evacuazioni; fìn cllè passati tre giorni ripetei la cura con pieno esito. Sarebbe bene P•1 rciò dare i tenifughi quando si può pre:iumere che la tenia non sia di v t3 nLata corta e nel caso differire di alcuni giorni la cura.
Ho vol uto riparlare dell"uso del cloroformio contro la t enia non per vanità nè per effimera contesa, m a perchè stimo, a torto od a ragione, di rendere un buon servizio ai medici ed agli ammalati, sembrandomi esso rimedio degno di ave r e diffusione a preferenza degli altri tenifughi s tante:
l" la sua non intrigata ricettazione e la facile e sicura poso l ogia;
2 '.J la sua tolleranza ed innocuità assoluta da parte degli ammalati a segno da potersi ripetere la cnra, se occorre, a breve inter>allo (2- 3 gio r ni ) senza il più piccolo inconveniente;
a· la sua efficacia non minore di qualsiasi altro rimedio;
4 ° la. sua. non trascurabile mitezza. di costo in paragone di altri mezz1;
5" la sua comodità di uso, non essendo neppure necessa ria una p rev ia preparazione
L e norme per la cura sarebbero in riepilogo le seguent i. Premessa o non la prt'parazione di etetica, si dà Cloroformio gramm1 6 Sciroppo sempl ice. » 60 a digiuno in 3 o 4 vo lte a cucchiaiate ogni ora e mezzo, sommi nistrando una dose purgati va di olio di ricino dopo un'ora circa. dall" u lt ima propinazione di cl oroformio.
Questa è la prescrizione di massima, ma non vi è niente di assoluto. La quantità efficace di cloroformio può essere anche di 3·4 grammi e può spingersi, secondo l'Aprosio a 7-8. È il caso di regolarsi un poco secondo le condizioni e l'età dei soggetti. Anche l'intervallo tra le so mministrazioni può variar e da l 'a :.! ore.

A::i'C ORA DELL' USO DEL CO NTRO Là TEXIà 287
***
Il cloroformio per ò deve essere di buona. qualità, della. purezza. di quello usato per le cloron arcosi. E ad ogni ripresa bisogna rimescolare bene la mistura p rescr itta, la quale deve essere contenuta in rec ipiente ben tappato.

Come il cloroformio? Uccide il verme o l'a ddormenta ren· dendo meno tenaci i snoi mezzi d'attacco? È probabile, come pensa pure l'Aprosio, che sia quest'ultima la buona interpretazione, ma non si hanno dati positivi per sostenerla. È bene però .non ritardare la. somministrazione del purgante e che questo abb i a sollecita azione, perchè nel caso che il verme sia soltanto stordito e non morto non abbia tempo di ridestarsi.
Alessandria, novembre 1902.
288 AN CORA DELL'USO DEL CLOROJ,'ORMIO CONTRO LA TENIA
RICERCHE SU DI UN CASO DI PORPORA EMORRAGICA
l\EL DECOB SO DJ AIH:.\ITE
Essendomi occorso di osse rvare n el nostro reparto un caso di porpora emorragica in un individuo affetto da adenite inguinale, ed avendo cr eduto di riscontrare in esso del l e particolarità cliniche e patogeni che c he mi parvero degne di n o ta., valend omi del p ermesso e d el consiglio de l sign or maggior e medico Scaldara, capo r eparto, h o voluto illustrar l o. E credo che, considerato l'argomen to impor t an te e l a in cert ez za di vedute c he, malgrado le m o lt eplici ri cerc h e, r egna fin qui su questo punto della pato logia medica, non sia del tutto inu ti le qualunque con tributo s ia. pur m odesto
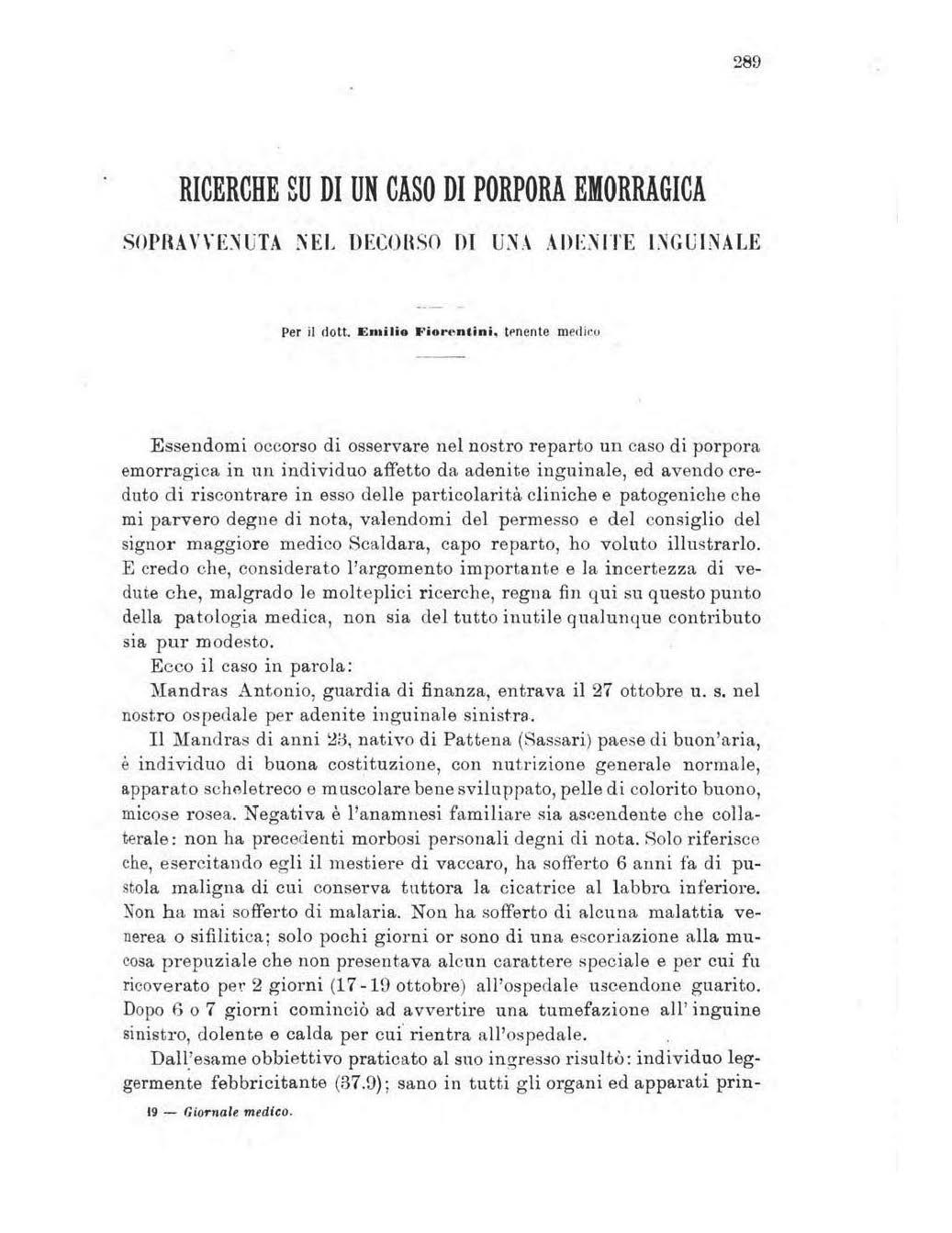
E cco il caso in parola:
Mandras Antonio, guardia di fin anza, entrava il 27 ottobre u. s. nel nost ro ospedale per ad enite inguina le s ini st·ra.
Il l\fandras di anni :Jij, di Pattena (:=ìassari) pMse di buon 'aria, e individuo di buona costituzione, con nutrizione generale normal e, apparato scho letreco e muscola1·e bene sviluppato, pelle di colorito buono, micose r osea. Nega tiva è l'a namnesi familiare s ia as<!en deute che collanon ha precedenti morbosi personali deg ni d i nota. Ro l o r iferisc e che, esercitando egli il mestiere di vaccaro, ha sofferto 6 au ni fa di pustola m a ligna di c ui co n serva tuttora la c i catrice a l l ab bro. inferiore. Non h a mai sofferto di malaria. Non ha soffer to d i A.lcnna malattia venerea o sifiliti ca.; solo pochi giorni or so no di un a escoriazion e alla mucosa prepu z ia. le che non presentava al c un carattere speciale e per cui fu rico ve r ato per 2 giorni (17 -10 ottobre) all 'ospedal e. uscendone guarito. Dopo 6 o 7 giorni cominc iò ad avvertire una tumefazione all ' inguine sinistr o, dolente e calda p er cu1 ri entra a ll'ospeda le Dall.'esame obbiettivo praticato al suo ingresso ris ul tò : individuo leggermente febbricitante (87.0) ; sano in t utt i gli organi ed apparati prin-
19 - r.iortHlle mtdlco.
289
Per il doli, Emilie ••io rtm &ini. tPn ente m edko
ci pali; da parte del tubo intestinale: lingua )ievemente patinosa, anoressia, stitichezza accentus.ta. Vi è lieve tumore di milza.
All'inguine sinistro osservasi una tumefazione dalla grossezza. di un uovo, di forma. allungata, col massimo diametro diretto nel senso della piega. inguinale, tumefazione dolente alla pressione, di consistenza dura, con cute leggermente arrossata, ma. mobile e sposta.bile. Nulla agli organi genitali.
\enne ri tenuto che il quadro sintomatologico osservato fosse dovuto al p roces ·o infiammatorio esistente, quando la mattina del 29 si manifestò, senza causa apprezzabile, emorragia della mucosa della cavità orale, che resistette a.i comuni mezzi emostatici, e la sera apparvero numerose macchie emorragiche sparse per tutto il corpo. Con l 'esame obbiettivo osservansi s u tutto il corpo, ma specialmente sulle regioui estensorie, numerose macchie che dalla grandezza di una testa di spilla arrivavano a quella di un centesimo. Per la massima parte erano isolate, in alcuni punti, speci e al torace, divenivano conflu enti. Il loro colore variava da quello rosso per le più piccole, a quello bluastro per l e più grandi, non scomparivano alla pressione; le più piccole non facevano rili evo sulla superficie cutanea, mentre quelle più grandi erano rilevate, dando l'impressione come di piccoli tnmoretti.

Nei punti dove co nfluivano, erano circondate da un alone giallastro che dcgrada\a sino alla cute normale. Alla cavità orale osservavasi emorragia dai borJi dentali delle gengive e sulla mucosa delle guancie, delle labbra, della lingua come delle bolle ripiene ùi sangue e di colorito nerastro.
Tali fatti durarono 3 giorni con temperatura che arrivò al massimo sino a 38.1 c poi andarono man mano regredendo.
Le petecchie, la fase regresiva abituale, <'rann già. in \"Ìa. di risolu?.ione, q ua.nùo la sera del 4 no,embre si ebbe nuova emorragia dalla cavità orale, epi stassi abbondanti e nuova eruzione cutanea con i medesimi caraLteri della prima volta: si ebbe nuovamente ele,·a7.ione termit:a, non mai n.l di sopra di 08.1, e quinrli, dopo qualche giorno, nuo\a di tutti i fatti senza alcuna complicanza da parte ùelle articolazion i.
La tum efazione inguinale si fin qui stazionaria: ma c.ol reg1edire dei fatti generali ancor essa si avviò verso la risoluzione sponta.nea.
Le petecchie cutanee lentamente e gradatamente scomparvero ; ancora. per qtLalche giorno si ebbe epistassi e poi nulla più: la tumefazione inguinale rapidamente diminuiv a di volume sino a scomparire completamento, ed il 28 novembre l'indi,·iduo fu dimesso guarito completamente.
2HO RICERCHE SU DI UN CASO DI PORPORA EHORRAOIOA
Duran t e tutta la cura si usarono i comuni m ezzi emostatici: inie·zioni d. i ergotina, ergotina e percloruro di ferro per via interna: due -volte si do ve tte ri co rrere al tam ponamento anteriore del n aso .
La semplice e sposizione d el quadro sintomatico, avutosi n e l nostro infermo, bast a ad i s ti t uire il co n cetto diagnostico
N on possiamo parlare di emofilia; la mancan za di er editari rtà. e eli an tecede nti emorragici personali, il manifestarsi degli accidenti e m ofiliaci al minimo traumatismo ed in conseguenza sempre di un traumatismo1 eli fatti traumatici, nel nostro caso l a esclu dono: e cosi possiamo escludere le varia forme di porpora da ingestio ne di sostanze t ossi che, e di porpora reuma.toiùe per l 'assenza di og ni co mp licanza da parte d olle articolazioni.
Per il deùorso, p er la curva febbrile e per i rip etuti esami del sangue prati cati, possiamo escludere la malaria: vi era, è vero, lieve tumore di milza, ma questo panni più giusto debba esse r co nsid erato come l 'espressione di una infezione generale, come più sotto dimostrerò; e pe r via di escl usion e d o b biamo arrivare alla diagnosi ùi porpora infetti va.
Di questa, come il risap u to, si fa oggi una forma c lini came nte, se non pa.t.ogenBticamente, ben caratterizzat a, nettamente separata e le ricerche batteriologiche hanno confermato appun to quanto già la c linica e l'anatomia patologica avevano prima in tui t o. La porpora, entrata nel novero delle malat tie infettive, è stata o ggelto in qu esti ult imi ann i di numerose ri cerche, m a la questione della sua. patogenesi è l ung1 dall'essere risol ta, e poco tempo f a il Rendu riconosce,·a la profonda o:;c uri tà c he ancora avvolge il proble ma.
· Di questo si è conosci uto un nuovo dato, ma. la soluzione d e finit iva. s i aspetta ancora, o meglio, come dice Gargano, si aspetta. la dimostrazione dell'esattezza di qualcuna delle tante soluzioni trovate.
Si contano ormai t1. d ecine i microorganismi che s i so n o i solati da i vari i A.utori: 1\.l eu s una m on ade emo rragi ca, Ceci uno stafilococco ; Wa tso n Cheyne, Barthe lmy, BalMr un microc occo, Martin rle G ima.rd credette di trova.re in uno stafilococco iso l ato il mi cr obio specifico. Lrtzerich segnalò co m e a gente specifi co n ella po rp ora un batterio c he otten n e in c ultura e con c ui si infettò di porpora; Gua.rnieri, V assale 'Reher, Hla va, tr ovarono l o sta.filococco
Tizzoni, G io vannini , Babes, K olb, riprodusser o co n un bacill o, trovato in ca s i di porpora emorragica, la m a lattia negli animali. Anto11y,

SOf>RAVVF.NUTA :SEL DECORSO Dl UNA ADENITE INOUIXALE 201
•**
Lebreton, trovarono lo stafìlococco piogene a.lbo1 K l ano,t e L a.nnois e Cormon t, \ Vidal e T herese, lo streptococco; Bona.rdi e Claisse il pneumococco, Neuman i l bacillo piocianeo. Silvestr ini e Baduellostafilococco piogeuo albo ed in un caso quello , ·
Come si vede i reperti sono troppo numerosi Per una. ipotesi sulla pa.togenesi delle porpore e se nell' insieme non fanno che ribadire nella mente che debba. trattarsi di una infezione, lasciano sempre insoluto il problema di quale infezione si tratta.
Un po' di luce vorrebbe ora portare un'ipotesi di Can·1ére. Questo autore ba studiato in modo completo dal Iato batteriologico un casodi porpora semplice ed ha ottenu to dal sangue un microorganismo che presentava tutti i caratteri del bacillo che .A.cbalme e Thi r o loix e lo stesso Carriére hanno descritto ne l reumatismo articolare acuto Qnesto fatto fa concepire al Carr ière l a speranza che si possa g iungere alla rlimO$tL·azione dell' u nicità pt\togenetica della poliart.t·ite acuta e di a l cune delle a ffezioni emorrag iche, confe r mando q uanto già g l i a ntic h i avevano ideato: però per i l nostro argomento è interessante i l fatto· del polimorfismo dal Carri ére osse r vato ne l suo microbio, da l che potrebbe$i dedurre che forse molti dei repert i fin qui avuti nei casi di porpora si possono ridurre ad un solo.
Fatto così un breve riassunto sommario sullo stato attuale della. quistione sulle ricerche e sui reperti avuti, passo acl esporre le indagini fatte nel caso nostro.

L'esame microscopico del sangue, sia a fresco, sia in preparati colorati non mi ha rile,,ato alcun che di anormale. Non ho riscontrato alterazioni n.pprezzl\bili della forma e del numero dei glob u li rossi, nè presenza di gormi di alcuna natura. o di altri elementi patologici. Ho pensato allora di studiare se vi fosse contenuto batterico nel sangue stesso per ml'zzo di culture e, per potere controllare l'eventuale repE-rto batteriologico 1lel sangue con quello del bubone. unico fatto morboso apprezzabile nel nostro infermo, ol tre i sintomi cutanei, di fare delle cult nr·e anco dal contenuto del bubone medesimo.
Per la preso. de l sangue ho u snfruito una scegliendola f ra l e più grosse e rilevate. Ho sterilizzat.o la parte con alcool, acq u a disti l lata, acqua sterilizzata: poi ho fatto una piccola i ncisione con un bisturi sterilizzato al calore, e quindi con un'ansa di plati no, ho fatLo la disseminazione del S<tngue nei var'ì mezzi tli cultura.
Per i l bubbc:.ne mi sono SE:'rvito di una siringa, modello Lollini: l' h o introdotta nel suo spessore, poscia ho ripulito l'esterno dell'ago dal sangue che vi poteva eRsere r i masto aderente ed ho fatto l e disseminaz ion i con quel po' di sostanza che con ripetute aspirazioni si era intro-
292 ' l R I CER CHE SU D I UN CASO DI PORPORA EMORRAGICA
'
.dotta nell'interno dell'ago. Ho poste le culture in termostato, quelle di gelatina a 20°, quelle negli altri mezzi a 36°. - Al 6° giorno cominci ò Jo sviluppo in brodo e poi al 7• anche negli altri mezzi.
I caratteri culturali sono i seguenti:
Cultura in gelatina. - Si presenta lungo la superficie di innesto sotto forma di una patina poco lucida, simile a gocce di cera con marispessito. La gelatina non viene fi.uidificata.
Cnltura in agar. - Per infissione notasi sviluppo scarso, granuloso, superficiale rotondeggiante. Per strisciamento si ha sviluppo leggermente ril evato, a margini appe n a sinuosi, lucido, di color bianco sporco con acqua· di condensazione torbida.
Cultura in brodo. - Il brodo è intensamente ed omogeneamente intorbidato. - Alla superficie prosenta sottile pellicola. - Evvi sedimento mediocre che agitando la prevetta si risolve in piccoli fiocchi.
Si colora bene coi co muni colori di anilina, ed all'esame microscopico appaiono cocchi aggruppati a cumnli come un grappolo, senza linea .di scissione marcata.
La presa del sangue venne fatta il giorno 29 quando già l'eruzione era al periodo di acme. Si ripetè il giorno 2 quando le e:ffiorescenze, e cutanee orano in via di risoluzione, e Je colture rimasero sterili. Essendosi il giorno 4 novembre avute nuove emorragie dalla bocca e dalla .cute, si rifece la presa del sangue si ebbe sviluppo di un germe che per i caratteri culturali e microscopici era iri tutto simile alla volta precedente. Dopo parecchi giorni poi che l'emorragie erano cessate la cultura del sangue restò nuovamente sterile.
Si praticò anche ripetutamente l'esame chimico e microscopico dell'urina, e mai altro e lemento anormale si potè constatare eccetto dell'emoglobina disciolta.
Da.lraspetto culturale e dai caratteri microscopici del ba.cillo isolato si può fare la diagnosi di Stafilococco cereo albo. È questa una varietà di stafi.lococco, che finora era ritenuta. sfornita di potere patogeno, identificato e distinto da Lehmann e Neumano. per l'aspetto speciale che assume nella cultura e perchè non fluidifica la gelatina.
E sso venne isolato dal sangue d'ind ividui affetti da porpora emorragica già nel gabinetto di Patologia Medica di questa Università. dal dott.
P. Fiorentini ed il ritrovarlo anche nel nostro caso assume perciò una importanza grandissima: oltre che conferma le ri cerche di quest'ultimo.
Ho voluto aggiungere anche la prova sperimentale, ed iniettatolo in cultura. in brodo (1/4 di cent. cubo) nei conigli, mi ha riprodotto costantemente non già. la porpora, ma una piemia, con formazione di ascessi multipli, e col pus di questi ascessi inquinando dei terreni nutritivi ho

NEu DEOORSO DI Ul'\A ADENITE INGUINALE 293
ottenuto in cultura pura lo stafilococco suddescritto . Di questi reperti· sperimentali mi sembrano degni di nota quindi i segu.enti fatti:
l • La p r esenza dello stesso stafilococco nel sangue e contem poranea.mente nel succo del bubone.
2" La scomparsa del germe dal sangue, col rimettere dei fatti generali emorragi ci, e la sua ricomparsa col ricomparire di questi.
3" Il reperto dello stesso batterio negli ascessi manifestatis i nel coniglio e quindi i l fatto che un germe può, a seconda del terreno o di condizioni speciali , variare di virulenza, ed assumere proprietà piogene· che normalmente non ha.
Questo dal lato sperimentale : da l lato clinico poi troviamo anco un appoggio logico ai dati dello sperimento: difatti troviamo che vi è una caratteristica concomitanza fra manifestaz ione del bubbone e fatti emorragici : questi com paiono pochi giorni dopo dello sviluppo del primo ecollo scomparire di essi anco l'adenite regredi9ce fino a completa riso-· luzione. Da questo fatto clinico confortato dal reperto sperimentale,. credo possa dedursi che nel nostro caso vi è fra adenite inguinal e e porpora il rapporto di causa ed effetto.
Ci siamo trovmti di fronte ad una vera forma di porpora infettiva., ad una stafilococcemia; l'escoriazione primitiva del ghiande è stata l a po1·ta d'entn1.ta., la ghiandola infiammata la prima stazione in c u i lo sta.filococco diede segno sua attività; la porpora l'effetto dr trovarsi esse un circolo dopo aver vinto la barriera. ghiandolare.
Si potrebbe qui obbiettare perchè nel nostro individuo in luogo di produrre una. semplice infezione generale abbia prodotti fatti emorragici. Entrerei in un altro campo molto più vasto, irto di maggiori difficoltà, bisognerebbe proporsi il problema del diverso modo di manifestarsi del le infezioni nei vari individui.
Qui caùe giusta però un'osservazione generale, ma che interessa da. vicino l a clinica: noi cioè possiamo avere rlei germi che infìa.mma.nole ghiandole linfatiche, ne sorpassano la. barriera., dànno luogo a generali manìfestazioni senza produne la suppurazione delle ghiando l e stesse e poi per le forze vitali de ll 'orgamsmo si eliminano nel mentre· che l 'affezione ghiandolare risolve spontaneamente. E questo fatto è da tenersi presente in quei casi, di forme sicuramente infettive che si chiamano anco criptogenetiche, e che passano poi a. guarigione senza che se ne possa intuire il punto d i partenza, che probabilmente risiede· in una ghiandola. profonda, non apprezzabile dai nostri sensi e la cui infiammazione, come ne l nostro caso, risolve spontaneamente senza esitom su ppura.zione.
Giudicati cosi i fatti alla stregua della indagine clinica e del re-
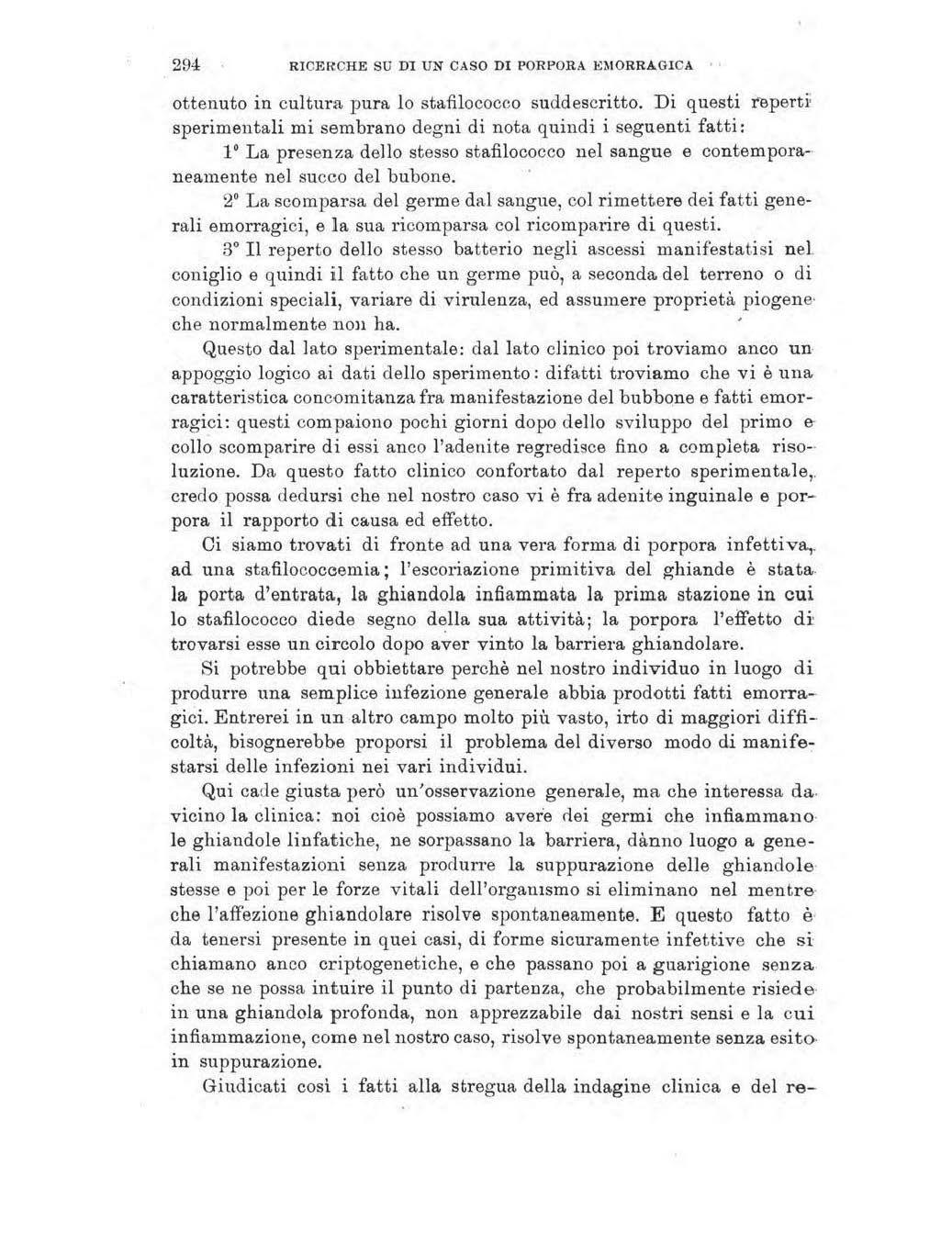
294 RICERCHE SO Dl UN CASO Dt PORPORA l'MORRAGICA
pe rto s perim entale, en t rando n el campo g en er a le de lla patol ogia d ell e porpor e, credo o rmai n on p ossa p iù me ttersi i n d ubb i o l a esi sten za d i vere por po r e infe t tive : ed i l prob lema d e ll a lor o patoge nesi sar eb be, come sop ra bo ri co rd ato, risol to se uni co ge rm e fosses i sempr e t rovato: m a. in vece, essen do va rio il reperto batt eri co, a n c h e vo len do con sotti le ana lisi ridurre molte d e lle forme n uov e descritte a d una. sola., n e r ester e bber o p ur sem pr e trop pe per concludere s u l 'unic i tà patogE>uot icn. de lla. p or por a. Per c ui all o stato a tt u a le d ella. scienz a l e conclusion i ch e megl io sodd i sfan o so n o q ue ll e a c ui a r r iva r o no Bad u e l e Ril vest riui n e l J 8U7. Esi ste cioè un g ru p po d i por po r e b e n d e fini te d ov u te ag li stafil ococc hi ed accan to a qu este altre in c ui l ' a ffe zion e è d etermin ata da qn <'gli stessi bacilli che produ co n o affezioni e morragich e negli a nimali o s peciali cond izioni patologi ch e d ell ' organi smo , ta li le scarla t tin e, l e t ifoidi e morragic h e in ind ividui con diatesi emorragica, e infine da batteri i normalmente n on pa.t ogeni ma che lo diventano sotto l ' influenza rli s p ec iali condizioni del tutto ignorate.
Mess ina, 2 di cembre JD02.
BIBLIOGRAFIA
linu ta;:u - h t m o rrllllo aqutl Parts, Alexaodre Cocco• 1883.
liA I<TIJO U K (i i iiA I<I> - lJu Purpu r a ht m orT/Ia:Jfq•u primili{. Pnris. Sl(>inhell. 1888.
l>I L\"K!TRINI K IIA oU &L.- J,e in{t: aonl emorra{llt ht fttll'uom o. ( P olldanlco, vo l IV , li., 18!l7)
a...HIIAION e NII UIIANS. - IJa ll t rlOI O{I I IJ. - l rtperll bal1tra ol o111<1 n ella porpora (Rivilta cntica di clinica m t dlt a , 1901 ).
P. I'IO• I!II T IS I. - Hactrche baturioluQi t he 1u tre cali di porpora in(tlli va ( Ciiluca m e dic a ila· laana , 190i).

f;0PRAVVJ.: :>U1'A NE(. DEC'O RSO DI A DENITE IN GUIN \LE 2!liJ
Per il dott. Eace nio Miaiei . maggo ore medoco
Nell'ospedale militare principale di Messina, dal 26 marzo 1809 al 21 agosto 1902 vennero operati ben 163 erniosi, dei quR.li due soli prese nta rono ernia crurale. Di queste operazioni, 90 furono praticate dall o scrivente; 40 da l maggiore medico Carino; 18 dal capitano medi co (o ra maggiore) Abbate ; 2 dal tenente colonnello medico Adelas io ; 2 dal maggiore med i co Scaldara; e 2 dal capitano medico Cusmano. Vo r nia inguinale aveva sede a destra in lOG individui, a sinistra in 47, ed i n 8 era bilaterale; tre sole volte essa si presentava come r ecidiv t\1 ad operazione radi cale eseguita circa tre anni prima. Per il grado di sviluppo, tratta vasi g en eralmente di bubbonocele: trovo, infatti, c he e mergono, come particolarità, annotate una so la punta d'ernia, due casi di ernia interstiziale ed 11 oscheoce li ; ed in qu es ti ul tim i , tratta.vasi di tumore 4 volte a destra e 7 a. sini stra . Se la pochezza delle cifre n on s1 opponesse, sarebbe il caso di domandarsi perchè, mentre l'ernia inguinale è in genere due v olte più frequente a destra. che n o n a sinistra, troviamo poi, che nel s u o grado di massimo sette volte sopra 11 casi, essa albergava ne lla logg ia scrotale sinistra. Se il canale inguina.le destro offre quelle speciali condizioni ana.tomicha, congenite e probabilmente ereditarie, p er cui l'emia trova in esso la sua sede di elezione; v i sarebbero poi a. sinistra. altre co ndizioni anatomiche, per le quali dessa, tosto superata la resistonza. dell'anello esterno, più facilmente o più presto discend erebbe in basso, per rendersi scrntale? E potrebbero tali ccmdizioui anatomiche consistere soltanto nella maggio re ampiezza d a lla. l oggia sc rotale sinistra, alla s ua radice particolarmente sfìanchta dallo sviluppo ve uoso dei plessi funicolari, sempre prevalenti a sinistra? o n ella brevità maggiore del ca.nale ingui nale sinistro, risp etto al destro, co n stata r-a c0n mis ure da Jobert e Malga.igne?
(l) Questo bre,•e artic.>t o del dott ra parte di un piu l unJ!o e complrsso lavo ro s ull e opera7.i o nl chlrur(tichP e s u molli Im portanti casi clinici da lui s tud io ti nello spedale militare do Mt•.ss ina. Pt r le esrgewe dello opuoo, ci siam o dovuti r on te ntare di strnlciarne queolo capitolo.

296
ERXIE OPER.\TE XELLO SPKD .\LE )IILIT.\RE 01 ,l>
Molto interessanti sono le particolarità anatomo-patologicbe, che -si riscontrano durante l ' erniotomia, questa vivisezione della molesta infermità . Nelle 94 operazioni da me fin qui eseguite, ho trovato, per <>rdine di decrescente frequenza, n el reperto estrinseco dell'ernia propriamente detta: l'idrocele cistico preernia.rio del funicella, i lipomi collaterali talora bene organizzati e duri, l'idrocele comunicante . L'i-drocele cistico fu osservato nelle sue infinite varietà di forma, volume -e consistenza; ma, fatto notevole, sempre con sed e od almeno con radice nel canale inguinale, e più o m eno lungamente peduncolato e mobile; quello comunicante, poco od assai ampiamen te comunicante, mai molto voluminoso, si rinvenne sempre, com'è naturale, vuoto di liqilldc, all'atto d ell'op3razione. In un caso, l ' idrocel e preerniario, del volume di un grosso uovo, comunicava, mercè non breve colletto -capillare, vuotandosi in un imbuto perìtoneale, lungo otto ce ntimetri, -c he co stit uiva il sacco, evidentemente di recente formazione, per iscorrimento. Questi fatti, abbastanza frequenti a ris co ntrare, dimostrano, parmi, come non di rado" l'origine dell'ernia sia dovuta ad un idrocel e, nei giovani, o ad un lipoma., nell'adulto, preesistenti: questi tumori, infatti, non agis cono soltanto sfiaccando e sfibrando i tessuti, preparando quindi la via di discesa al sacco; essi, ancon•, premuti dalla tensione positiva addominale, venendo così sempre più ad estrinse-car si, si tiran dietro il periton eo, col quale avevano intimo legamE>.
La teoria meccanica di Garengeot, Coo per e Scarpa, la quale spiega la. origine delle ernie colla pressione eccentrica, superante l a menomata resistenza delle pareti add ominali, trova dunque, appoggio e co nfe rma, anche nei ricordati reperti ; essa vale per gran parte delle -ernie addominali e per tutte le c rurali, nelle quali ultime, oltre allipoma, sono soventi i gangli ' linfatici, che si rendon causa di debilitamento locale e di disposizione alla mal attia.
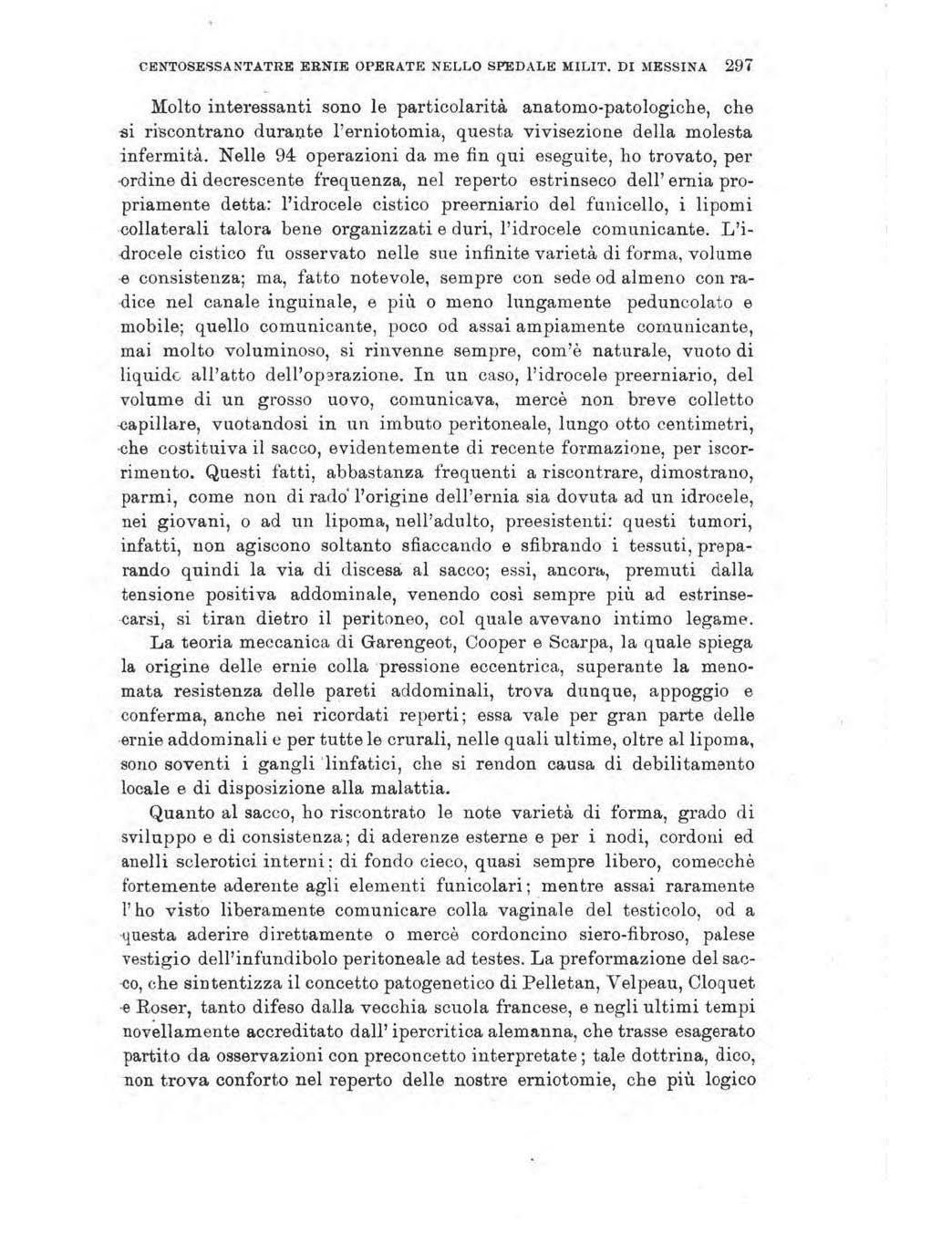
Quanto al sacco, ho ris contrato l e note varietà di forma, grado di sviluppo e di consistenza; di ad erenze es terne e p er i nodi, cordoni ed anelli sclerotici interni; di fondo c ieco, quasi sempre libero, comecchè fortemente aderente agli elementi funicolari; mentre assai raramente l'ho visto liberamente comunicare colla vaginale del testicolo, od a
1.J.Uesta aderire direttamente o mercè cordoncino siero-fibroso, pl\lese vestigio de ll'infundibolo peritoneale ad testes. La preformazione del sac-eo, che sintentizza. il concetto patogeneti co di Pelletan, Velpeau, Cloquet ·e Roser, tanto difeso dalla vecchia scuola francese, e negli ultimi tempi novellamente accreditato dall' ipercri t ica alem&nna, che trasse esagerato partit.o da osservazioni con preconcetto interpretate; tale dottrina, dico, 11on trova conforto nel reperto delle nostre erniotomie, che più logico
CENTOSE8SANTATRE
OPERATE
ERNIE
NELLO SPEDALE MlLIT. DI 297
argomento di sostegno offrono per la. ricordata teoria meccanica, cal deggiata dt\ Scarpa, e per l'altra, di tra.zioue, difesa da Rust, Benevoli eMorgagni.

Jl SllCCO, adunque, è di nuova formazione piÙ speSSO che nOn SÌ creda, an che nelle ernie oblique, così dette di forza: esso si stabilisce e poi accresce per iscorrimento peritoneale, in conseguenza. della trazione eccentrica operata dai piccoli cistici e formazi on i lipomatose, o della pressione endoaddominale per minorata resistenza parie tale in dati punti. Questa, co m'è noto, consiste in un debilitamento anatomico, congenito od a1·quisito, in corrispondenza della fovea. peri toneale interna. ( ernia inguinalo d iretta, dell'età avanzata) o dell'anello crurale; o nel dilargamEinto, abnormemente più ampio, dell'aponevrosi del g rand e obliquo; o nella. notevole brevità ilei canale inguinale, o più speciale deficienza delle fibre muscolari del piccolo obliquo e del trasverso addominali. E poi notevole, che questi segni di locale insufficienza anatomica noi li osserviamo più spiccati o più evidenti nei casi appunto in cui vi è stata ernia infantile, o semprechè persiste pervio l'infundibolo peritoneale, come tipicamente verifichiamo operando l'idrocele comuni cante, consociato o n o ad ernia; mentre nelle varietà opposte di atresia, atrofia. e scomparsa dell' infundibolo, noi, nùn molto spesso, posRiamo questo· sotto forma. di cordone fibroso o di anelli e piccoli cistici, o per eccezione come diverticoli fun i colari della vaginale propria.
Se ho per poco insistito in questi particolari, ·a tutti ormai noti, si è perchè r('gna tuttavia. confusione nel con cetto patogenetico delle ernie. Senza essere esclusivo, io avrei voluto dimostrare, che la preforma.zione del sacco è caso poco frequente, sicchè male operano quei pratici, che· credono basti alla. cura. radicale la completa estirpazione di quello. Del r es to, tale dottrina, del sacco preesistente, non spiega. le ernie dirette ed oblique interne inguina.li, e, molto meno, l'ernia crurale, tanto frequente nelle donne; nè si concilia. col fatto della possibile recidiva che il p r of. Galea.zzi di T orino (1), per le sue indagini sopra 840 operati in quell'ospedale Mauriziano, valuta a 5,71 p. 100, entro due soli anni dall ' operazione, e che, secondo l'inchiesta Parassi (2), si è riscontrata neli'H,7 p. 100 deg li inscritti della c lasse 1881 di leva. precedentemente già operati di ernia. Quest'ultima percentuale panni più attendibile o· prossima al vero; certo le due recidive, da me operate, datavano da circa tre anni dalltt prima cura radicale. In una di esse l'ernia si era ripresentata ;;correndo all'esterno del tendine del retto addominale, tra.. q U(.'st.o e la cicatrice operatoria, del resto fortemente organizzata; nel-
I l) La clinica chirurgica, n. 6, t 899.
(i) /.e ablhla:ioni alla milizia (lnchiesla a i di ltva ) GiOr0&4/e *t· dico del R. Burcllo. tOOJ, rase,
2!18 ER:"'lll: OPERATE :-/ELLO SPEDALJo; MlLI'l'. 0 1 MES.<;INA
ra.ltra, per opposto, la nuova ernia arasi formata all'esterno del funice lio sperma.tico e della cicatrice operatoria.: erano due bubbonoceli, ohliq uo interno il primo ed esterno l'altro.
Questa poss ibllità. alla recidi va, deve imporre al chirurgo la buona sce lta del met.odo, ed insieme la più rigoro;;a ed esatta esec uzioneoperatoria per la. cura. raùica. le ; nella q naie non solo dobbiamo conseguire una guarigione per prima, ma questa. dev e essere cosi perfett,a da premunire dfl>lla recidiva. Io per ragi o ni anatomiche, bo sempre ritenuto preferibile e, sopra t utto, perfetto il metodo Bassini, operando solo tre volte diversamente, e cioè alla Bottini in due ernie in guinali, e col procedimento del 'l'ricomi in ernia. crnrale; i risultati, che adesso cominc i ano ad essere esattamente controllati, mi CO U\'Ìnco no d'esse rmi bene apposto. E nell'esecuzione minuta e precisa dell' erniotomia inguinale, come fu magistralmente insegnata dal Bassini, io ho sempre più che altro specialmente curato, l • di trasportare q nanto possibile all' estlerno il funicolo spermatico, e con. esso il nuovo anello i nguinale esterno, da una parte; 2° di · pe rfett.amente occludere, dall' altra l'angolo interno dalla ferita operatoria., collocando un fortissimo punto di sutura., che affrontasse il muscolo retto addominale sulla cresta pubica e contro l'inserzione del ligamento di Falloppio. Delle mie 92 operazioni, ne conosco una sola recidiva, nell'unico caso di ernia inguina.le strozzata, operata (l ) di ' urgenza, e guarita éon limitata suppurazione eli un angolo della ferita; del resto 11i può dire che tutte le erniotomie (163) dell'ospedale militare di Messina son guarite perfettamente, per prima, fatta eccezione se vuolsi, del precedente e di due altri casi, non miei, nei quali il primo ooali to venne parzialmente a mancare.

Poche ultime parole sul trattamento del sttcco erniario. Adottando· la co mune pratica dell ' estirpazione di esso, dopo avernelo perfettamente isolato, e tiratone fuori quanto più possibile del suo infundibolo peritoneale; e dopo ligato q nanto possibile più in secondo i casi, circuendolo con laccio previa trafittura, od attraversandolocon punti incrociati od a catena, o serrando} o come borsa da tabacco: io, prima di affondarne il peduncolo, uso spesso coprirne questo coD. un rivestimento sieroso improntato dal sacco stesso. E ciò dopo aver veduto, operando l'ernia recidiva, che il peduncolo reciso aderiva fortemente colla cicatrice operatoria; deducendone, che per tale sua fissazione, il sacco novello aveva potuto, per distensione, facilmenteprodursi, a spese del residuale infundibolo peritoneale, forzato lateralmente al nodo di aderenza.
(l) Era il primo caso di ernia che si operasse in spedale, r., tlopo qualch e ter.talivo lnrruuuoso tll tnliS, si decise sollecitamente alla chelotomia seguita da cur a radicale.
Ol'ERATE :-a:LLO S PEOALE MIL11'. DI .MESSI
299-
NA
Por altro, tal e pratica parmi la più semplice ed insieme sicura, per conseguire coll'estirpazione del sacco e dell' infundibolo affere nte, quella garanzia, che Lucas- Championniére disse essenziale, contro la recidiva; in opposto della dubbia efficacia della torsione di C. B. Bali, della. sutura alla Barker del peduncolo contro la. parete soprainguinale, o dell'nggomitolamento del sacco stesso a riprese infilzato con filo che lo fissa sopra dell'anello addominale; processi tutti c he lasciano un incomodo torsello organico aderente, e creano, vicino a <i uesto, un nuovo infundibolo peritOHPale.
In breve, il mio pensiero è questo, di fac il i tare i l meglio possi· bile l'affondamento libero del peduncolo e di prevenire l ' aùesione organi ca di questo contro qual siasi piano, e meno an cora. colla cicatrice ·Operatoria; per tal modo, suppongo, al posto di una depressione perit oneale, Ri costituisce un bottone prominente sulla superficie libera ·del p e ritoneo.
Ecco qui, poi, uno specch i o dimGstr ativo di tutte l e operazioni ·d' emia eseguito nell'ospedale militare di Messi na, dal 26 marzo 180!) al 21 agosto 1902 compi lato coi dati di documenti uflìciali.
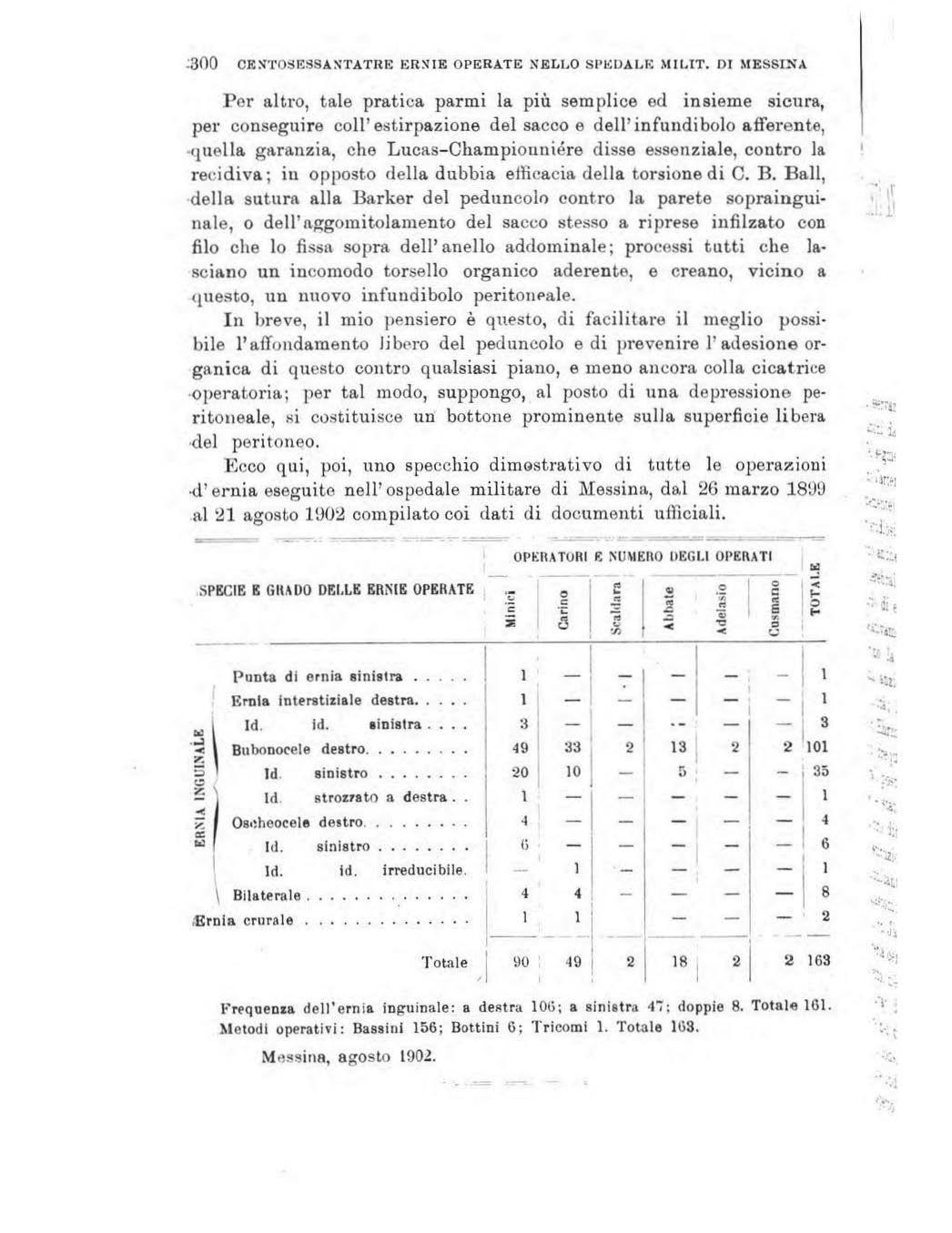
:300 CE:-ITOSESSA:-IT.ATRE
OPERATE XELLO SPI':D.ALr: MILlT. O r
OP"RATORI g !'iUMERO OEG I.I OPEI\ATI SPECIE g GUADO DEI, LE SR!ìiE OPER ATE ., l o < ;:: o .. c 1·c: c .g " "' o 'ii 8 -;; .::> o; Si 1" < 'C " , < u Punta di ernia sinistra l .. = l Ernia interatiziale destra .. l l \ Id . id. liDÌ8 t ra. 3 9 Bubonocele destro 49 33 2 ' 19 2 2 101 7. 10 1 5 Id . sinis tro . 20 5 35 Id strozrato a d estra =l %. destro 4 a: bl l ti. sinistro G 6 Id. id. irreducibile =i l Bilaterale . . 4 4 8 .'E r nia crnra l e . .. . .. 2 T otale \lO 49 2 1 18 l 2 163 F r eque nza dell'ernia inguinale: a deRtra 10G; a sinistra 4i: doppie 8. Totale 161. Metodi operativi: Bassini 156; Bottini 6; T r icomi l. Totale ltlS. agos to 190.2. •· f l ··-! . • c..::_, .......· ... .}, .. ... ·: .. :.:.,, .. .. . ., .. .Z. ' • . .,, ... \ .. ' ·
YARJETÀ ANATOM ICA RARA DEl POLI GONO ARnRIOSO D l WILLI S
L'osservazione attenta degli ànatomici ha constatato spesso notevolr dev iazioni dal tipo normale nei varii lati d ell'ettagono eli Willis.
Nel segmento anteriore di esso, Bichat, Meckel, Oberstein e r trovarono l'arteria comunicante frontale, ora tripla; ora (e ciò più fredoppia; questa dupli cità notasi pure nel mio soggetto.
Al t ri studiosi, quali Barbieri, Bianchi, e·co. ne rilevarono la mancanza. Fur ono anche osservate anomalie di origine, di decorso e di rapporti nelle cerebrali ante r iori: ma il fatto più i m portante, messo in vis ta a riguardo di esse è quello del loro dii!tacco da una sola carotide.
Relativamente ai lati medii del poligono, Meyer, Hildebrand osservarono la prove nienza delle comunicanti posteriori dall ' arteria silviana, anzichè dalla carotide intero'; Verga e Barbieri ne videro· la duplicità; Incoronato notò la mancanza di ambedue; Morgagni, Vicq d'Azyr, Ehr mann ne misero in chiaro l e variazioni di calibro.

Più freq uenti ancora sono le varietà morfologiche delle arterie cerebrali posteriori, co;;tituenti i la ti occipitali dell'ettagono arterioso. Spesso è stata constatata la mo d ificazione del lQro volume, in rel a zione· al calibro different e del tronco basilare: in casi più rari fu no tata una sostituzione di origine e di decorso tra la cerebrale posteriore e· la comunicante posteriore, le quali peraltro conservavano la normale loro anastomosi.
Il dott. Jarjavay ebbe la fortutia di scop rire l'origine dalla carotide dell'arteria cerebrale occipitale, la quale 110n contraeva alcun rapporto nè d iretto, nè indire tto, col tronco basilare. Cas i consimili a questo, da Ia.rjavay descritto, non sono stati riferiti, almeno che io sappia, neppure n ei trattati più recenti ed autorevoli di Anatomia. A me, che giusta il consiglio del prof. Bonomo, avevo già da vario tempo amo· rosamente indagato la. disposizione anatomica del poligonv di sotto l'aspetto delle sue varietà in rapporto alle varietà morfologiche
30!
Nota del dott Gaetaao F uaal o li , tene nte med ico
delle circonvoluzioni cerebrali, è caduto sott'occhio un caso somigliante a que llo di Iarjavay: e per la sua rarità ed importanza anatomica mi sono deciso a farne oggetto di comunicazione.
La va ri età. del mio caso riguarda adunque l'origine de ll'arteria cerebrale posteriore destro. ed il modo d i terminazione del tronoo basilare.
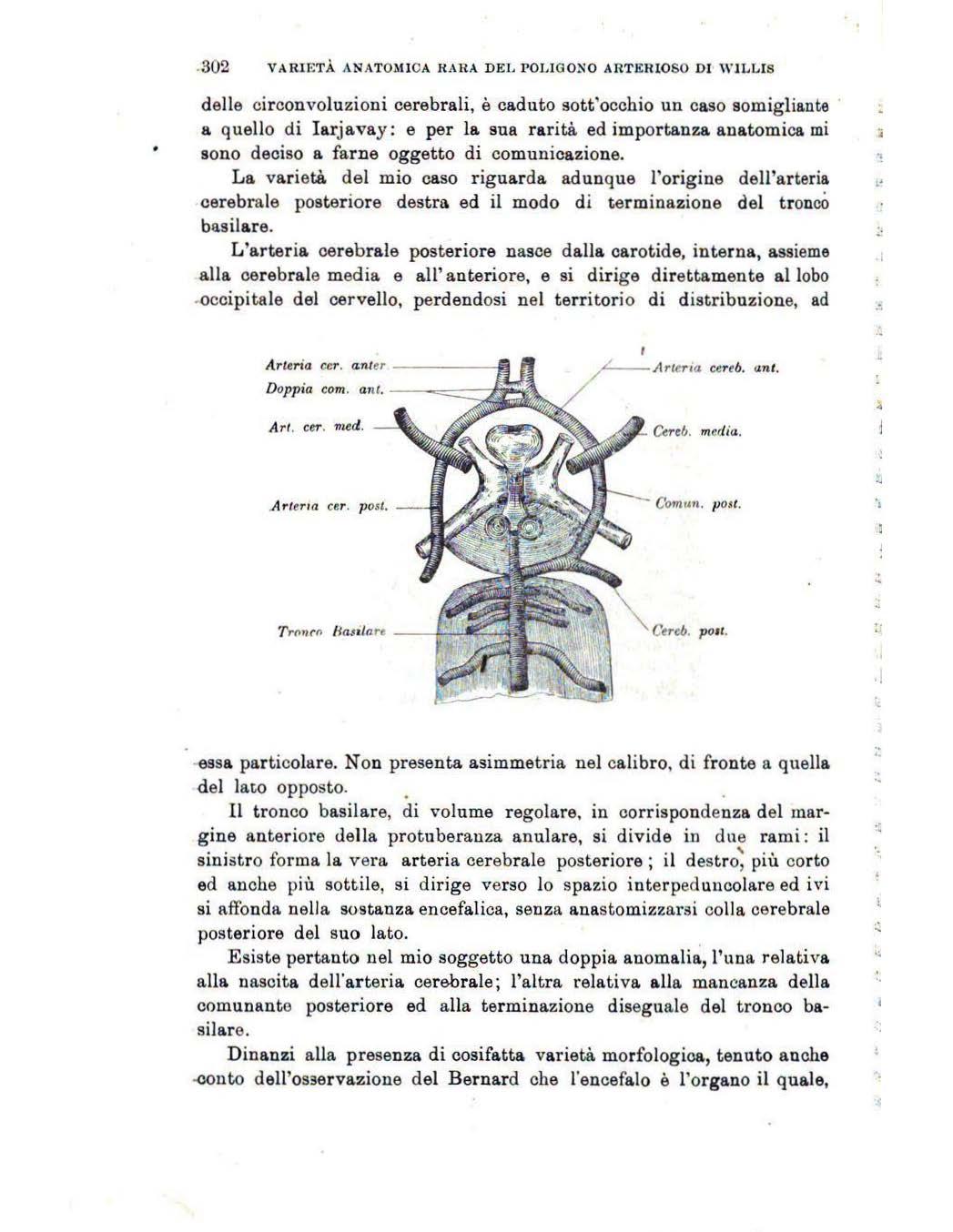
L'arter ia cereb rale posteriore nasce dalla carotide, inte r na, assieme alla cerebrale m edia e all' anteriore, e si dirig e direttamente al lobo -occipitale del cervello, perdendosi nel territori o di distribuzione, ad
Aru ria ccr anter
Doppia co m an t.
Arr
essa par ticolare. Non presenta asimmetria. nel calibro, di f r onte a quella del lato opposto. .
Il tronco b asi lar e, di volume regolare, in corrispo n denz a d el margine anteriore della. protuberanza anulare, si divide in due rami: il sinis tro forma la vera arteria cerebrale posteriore; il più corto ed anche più sottile, si d irige ve rso lo spazio inte rp ed un cola.re ed i vi si affonda nella sostanza encefalica, senza anas tomizzar:> i colla cerebrale posteriore del s uo lato.
Esiste pertanto nel mio soggetto una doppia anomalia, l'una relati va a lla nascita d ell"arteria cerebrale; l'altra relativa alla mancanza della comunante posteriore ed a lla terminazione diseguale del tronco basilar e .
Dinanzi a lla presenza di cosifatta varietà morfologica, tenuto anche dell'osservazione del Bernard che l"encefalo è l 'organo il quale,
302 VARIETÀ ANATOMlOA
HAIU DEL POLIGO:SO ARTERIOSO DI WlLLIS
--=:::::-:;;ll:
ctr med .Arter ia ce r p ost.
l /L-- Artcr•a ce rt b. an i
Cereb media.
Comun. po<t
Ctrcb poli
4 ·, .l ·. ..
pm di ogn i altro, mostrasi sensibile a ll' in flue nza del circolo sa nguigno, meritava di esaminare le circonvoluzioni encefaliche, nell'intento di vede re, se alcuna di e più specialmente quelle ir rorate dall a cer eb rale poster io re, cioè la prima e seconda te m poro-occi p itale, la terza te m porale, le tre circonvoluzioni occipitali ed il cuueo. presentasser o qualche notevole particolarità.. Però n on osta u te la diligente osse r vazione, niun a a normal i tà mi venn e alla vista. Ciò peraltro non diminuisce l'i mportanza a n a tomica del caso esposto: costituisce an zi un argomento a favore di quelli, che sostengon o che, se e::iste un a corre lazione tra l.o stato dei gi ri ce rebrali e la disposizione morfologica d el p o ligono arterioso della base, questa cor relazi one non è cosi stretta, ·da non p otere subire entro certi limiti una qualche modificazio ne.

Il caso sop rariferi to, a p ar te le co n siderazioni di anatomia comparata e di psichiatria, ohe può ispirare, ne sugge risce anche a ltre d'in· teresse chirurg ico.
Il chirurgo deve tener prese nte, nell'atto in cui l:!i a cci n ge alla legatura dell a carotide primitiva, la p oss ibilità di una irregolare costituzione del circolo sotto·encefalico arterioso, la qua le, do p o la le· gatura del tronco carotideo, spiega un'influ enza si n ist ra su la. nutr iz ione e la. fun zionalità del cer ve llo. È noto che le mol teplici e delicatissime funzioni di questo viscere so no mantenute integ re d a una ricca ed atti va circolazione, a cui co ntribuisco n o le d ue ve r teb ral i e le du e ua.r otidi interne, largamente a nasto mizza te tra loro.
O ra. l'allacci atura unilaterale dell' ar teria carotide primit iva, c he sia praticata sop ra un soggetto presentante un'anomalia. nel poligono di "\\illis, identica. a quella. da me osservata, rende necessa riamente anemico tutto l'emisfero cerebrale des tro e tog lie al circolo venoso ence fatico u n a fo r za impulsiva co nsider evole per il decorso regola r e del san g ue: da ciò disturbi gravi nel campo della coscienza., della motilità, della sensibilita, e negli atti cardio- polmon ar i disturbi che possono condttrre, e infatti spe5so conducono a morte . E vi e motivo di cr edere a parere mio, che q u asti distu r bi debbd.nO piu accent uati nei casi di a llacciatura. della. carotide com un e in un soggetto come il pre sente, a nzi chè i n caso di legatura. praticat.a in qualche altra v ari età. di conformaz ione del poligono ar te ri oso.
Riferiamo ci , ad esempio, all'osservazione di Barbie ri e Bianchi, relativa. alla. mancanza di anasLO mosi tra le ar terie cerebr ttl i a n te riori. La. l egatu ra unilaterale de lla carotide primit iva condu r rebbe in q u esto caso alla brusca soppressione della i rrorazione sang uign a nel territo ri o della. ce rebrale media ed an terior e; ma. l'esistenza dell'arteri a com unicante posteriore, la quale mette in diretta comunicazione la cerebrale
VAR!ETA H AI(A DEL POLIGOXO 01 \\'li.I.!S ;j()3
posteriore colla carotide ·interna, ripara in buona parte alla improvvisa perdita sanguigna, provocata dalla legatura della. ca.rotide comu ne : Jaddove nel mio soggetto l'allacciatura d ella llarotide primitiva prodno& repentinamente l'anemia in tre grandi territori i cerebrali; corticali ; inconveniente questo che non può esse re sufficientemente eliminato dalla. duplicità d ell'arteria comunicante anteriore.
Dinanzi all'even tualità di cosiffatte conseguenzE.' dell'allaooiaturad ella carotide, rese più gravi anche in presenza di anomalie dell'e t tagono di Willis, si intende facilmente, come sia accettabile oggi l'opinione di Lefo rt, W eber, Guyon, ecc. ohe sostengono ch e, nelle emorragie della carotide esterna n o n possibili ad arrestarsi colla legatura. dei monconi v asali in loco vulneris, non devesi praticare la legat ura.. della carotide comune, come gli antichi usavano di fare, ma quella del tronco carotideo estemo stesso, per quanto sia. di più difficile esecuzione. E così, mentre non può più seguirsi la pratica. dei vecchi chirurgi re lati va alla cu ra delle emorragie nel caro po della carotide esterna, diviene più viva la questio ne, se in vista di anomalie vuoi pure an che rare nel poligono di Willis sia da eseguire l'allacciatura della carotide primitiva nei casi di aneurismi della carotide interna. Dalle osse r vazioni cliniche e anatomiche che gli studiosi praticheranno, dipenderà. il g iudizio definitivo intorno a queste controversie.
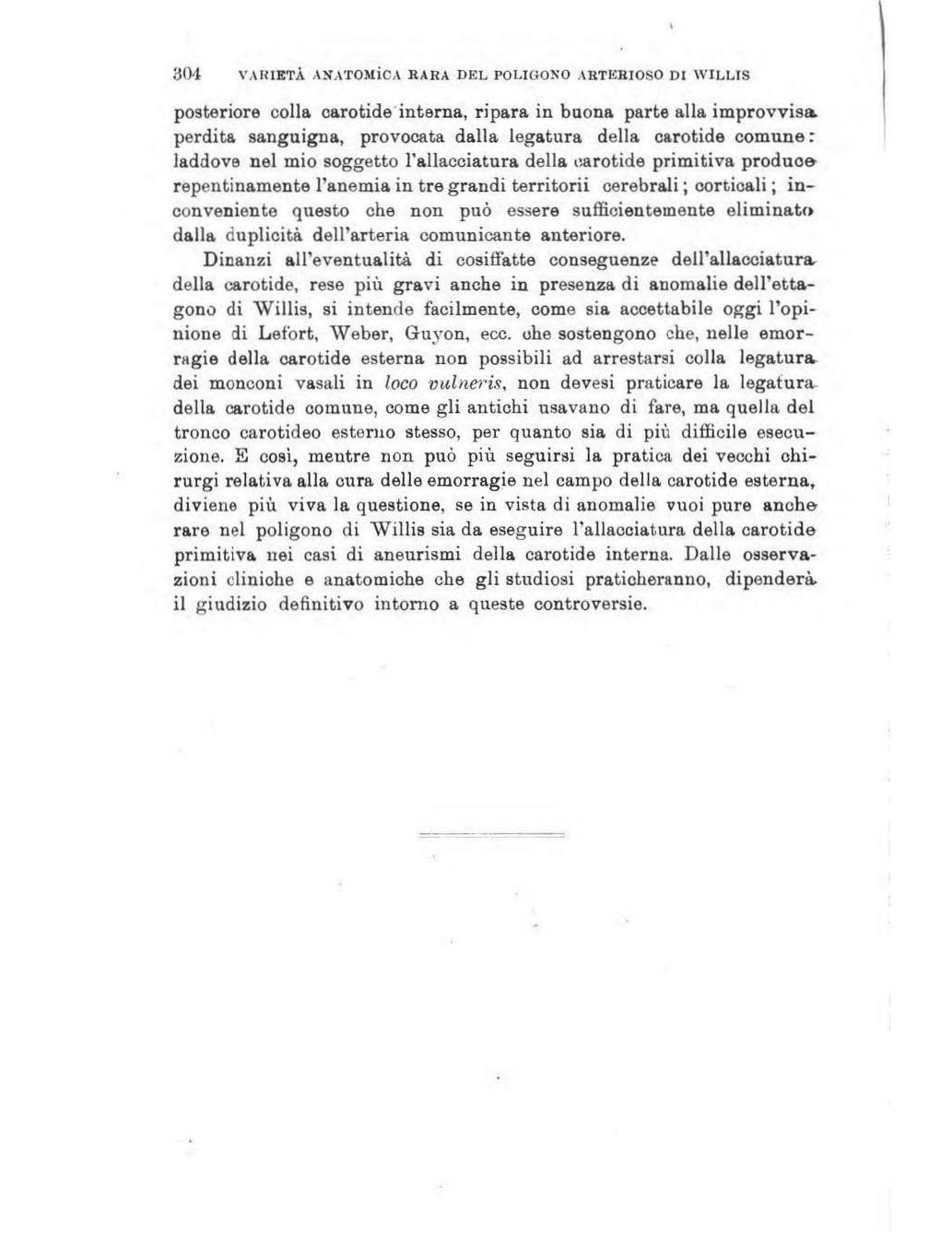
ij()t! VARIETÀ ANATOMiCA RARA DEL POLIGONO ARTERIOS O DI WILLTS
LE DEl IN SEGUITO A
L e fratture dei m eta t a.:·si iu g en erale su11u t ra.ttato dalla maggior parte degli autori quelle poi prodott e dall e marce, c h e nel t rattato di Dnplay o L{éclu;;; sono qualificate spontaneo, non :;on o per lo più Ciò dipendo d a l fatto che so no poco non quasi llhtÌ la di frattura, ma bensì quella eli periostite osteoplastica (Ponzat), storta metatarsi ca (Brei t huupt), sy ndes m itis metatarsea ( W e iss bach), piede forzato ierJ, edem n. cl e l p iede 1medici militari tedeschi ),
È nn11o co nq uista de lla radiografia la. couoscenr.a Oli!Uta di un a tal e lesione per le ricerche d e l Kir:::hn er, Maunoury, De Holstein, Schi pmann, Thie l e (ùi H eide1berg), :lla.ré, ecc. Nessuna memoria italiana, ch'io sappi a, c st.a.ta finora pubblicata s u tale argomento

I o ne h o osse r vato 12 casi, eù ho sempre riscontrata errata la diagnosi del med iço del CQ rpo.
C r edo tfuindi di far cosa u ti le, allo scopo di difl"onder e la. con oscenza anche tra noi di tal e fatto morb oso. di tessere un qu adro, pi ù ch e mi è possibile completo, basandomi, sui casi osser vati da me e sulla bibli ografi a molto scarsa c he ho potuto riscontrare .
D'orclinltrio la frattura dei me tatarsi si ossona nel soldato di fanteria nel primo anno di servizio, in seguito a marce col carico dell' eq uipaggimeato; alle v o lte in seg u ito a salt i o n ell a cor sa, specialmente se fatta d opq la marcia. In parecchi dei mi ei casi ho osservato che l ' arc ata p i antare era. più acce n tuata. d el normale (piede cavo), e che qua l cuno, sebbene sano, esa di costituzione d elicata, alquanto linfati co. #
In genere avvi en e o camminando su di una pietra, o attraversando un fossato, qualche volta guadagnando un'erta ripida: altra volta
Il) \J na m emo ria IJiu ro l e.<a s u que$10 argomento oi stata IJUbblicata dallo s tesso .1 utore nel P oUdlnl co, vol X.C 1903
- Glormllt mtdlco.
•
Per il Oo>ltor • ·ilippo C•eeia. mcdocu llt.
mettendo il piPde in fallo, o cadE>ndn malE' dopo nn od ur t ando col pi0de la radieP di un albE>rO. '
Nei ta'l i in cui l' origine non può Yenir chiarita prc,•isamente, si c·onstata c h e i dolori sono esorditi in coinl'idE>m:a con una mA.rria. forzata.
In base a n0zioni anatomic·hA 1t me s ia facile co n cepire il mec·cnnismo delle fratture dei metatarsi intermedi in seguito a ma.n;o o a tmnma apparentE-mente minimo. Quando, >'otto l'influenza dPlla fatica, i mnscoli del piede indE>boliti pE>rmettano il rilasciamento dei lE>gamenti, si ha che l ' a>ampiedE> poggia sul snolo principalmente con il e 11" metatarso, e ol anchE>, quantmlflue men0. ron il quarto. A ciò s i rhe l'avampiede subisce nelle marce nna certa violenza o pf'r urt o in piccole pietrP ed iuegnaglianze di o anche verchè, dumnte nnn c-orsa, o dovendo guadagnare un lnogo elevato, tutto i l peso del corpo graYita sullA. parte anteriore, mrntre la pnrt€1 posteriore \'tE'ne tcnnt.A. piìt o meno tl isrosta dal suolo (Ste.chow).
Per t.utte queste ragioni, un colpo, anche li e ,·e, tl-a--nn ett.PIIllosi snll'avampiC'cle dall'innanzi all'indietro, può non piìt agiro nel l·ll·imo che è il più saldo di tutti, ma trasmE>ttersi, per intere', in uno dci intermedi. Se il colpo ngi;;ce in sPnso obliqno, de\'ia lateralmeute e quindi ne rliminuis,·e In fo)rza: ma se la. clirezioue. f:o•c:ondo cni la pre;;;sione agis('c, coincide < ' OI\ ] ' nssf' Jo ngitutlinnle del metatar;;o, può risnl tan1e una frattura (Do H olst0iu ) Questa s i produce preferibilmente. st>r0ndo h• mie o;.;sen·azioni, non J1PllA. parte nw,lia. come gli autori dir·ono, m:t piit ;;pPcialmf'nte nell'nniono <lei terzo anteriori' éo11 il h·rzo medio, ed infat.ti è- qut>:>hl lR porzione m<'no rPsi,.tPntt>, pC'rc hè piì1 sotti le, ed inoltre perch.> il pnuto di ossificazione sceonolàrio si salda con il primiti\'O Ira i 1G ed i 18 anni . l,a. fra.ttnm più frequente è quella del ;l" mf'LUtar:;o, pcrc·hi• più lungo, pitt sott.i lo e più fisso nella basP. Inoltre, la pnrte- posteriore clrl 2• m Ptalluso contenuta. eomP in nÙ incastro, formnto dn.l 1 ° e :!• cuneiform e, av>iene che qnantlo la direzione tlPll a. forza ngist·C' m se n:'lO ob liq no, e<;!'endo fissa l 'estremità. art i colare , q n C'sta. de\e nPccssn.riamente fare nrtare la basp del 2• metatarso co ntro il margine anterior(l di uno dei cuneiformi suddetti e specialnH•nt.e coutro il l " che è più spot·gon te, donde la possibilità della frattura di Amm(lttendo il descritto per )p fratture d<'i
è dedurre che osse non debbano ritenPr,;i t;tne<•.
L a frattura il più delle ,·olte avYiene a o print·iptllmente ha. sede noi 2" metaLA.rso, meno frequent e nel :{•, mt'no nncorA. nel 4°, ed ecceziotu1lmente nel 1• e :t. La radiografia. dimostm. anche nf:'i cao; i in cui non "i è a\nt0 srricchiolio, il piìt dellf' 'nltf' nua linea.

:30•j Lli: 'FRA1'1TRF. OEI r :-; SEGL' I't'O ,\
di frattu r a netta, che interessa un solo metatarso, con direzioni diverse, m1l per lo p i ù obliqua o trasver:::a, od ancora a forma di V, a bet:co di flauto; lo spostamento d'ordinario non si produce per ragioni ben n ote.
La. diagnosi è possibile poterla fare i l più d Pile volte senza i l suss idio della radiografia. Quando, dopo di aver constatato, al momento dall"a •'cidente, una. tumefazione a l dorso del piede ed un dolore localizzato i n un metatarso, caratteristico. >;Ì r i scont ra pitl tardi un inspòssimento anu lare, si potrà essere certi della esis tenza della frattura.. D'al tra parte, spesso si resta raghi dei due segni precedenti per aWermare la esistenza di una frattura nelle OQsa. lunghe.
In caso di dubbio altri sintomi, ecchimosi, crepitazione, mob i lità anormale, convalideranno l a diagnos i. Il callo consecutivo al le voUe potrebbe confondersi con una periost ite, ma. tal e causa di errore è facile eliminar la con l'esame acc urato.
Curate bene, ques t e fratture . decorrono in gene re in modo benigno; ed in due o tre settimane possouo guarire.
l ..a cura migliore è l a. seguente: r i poso a letto, fìuch è non si sente l1en•· i l callo, massaggio e mobilizzazione.
Condu.Rioui.
L La frattura dei metatarsi è abbastanza frequente, non la ea,; isti ca di ess.•• inferiore all e altre, almeno ne l confronto dei traumatici ricoverati nell'ospedale militare di Alessandria
:a . La diagnosi di essa è possibile, il pit1 delle volte, senza l'aiuto della radiografia, purchè se ne co nosca il meccanismo e siripensi alla possibi lità eli e:;sa ne l le evenienz e sunnotate.
3. La frattura, il più delle >ol te, avviene non nella metà d el la diafìsi, bensì nell'uni.:me del 3" anteriore con il 3' medio, e nel 2• metata r so è possibile la frattura clella base per il meccanismo suddescrit.to .
4 . Nel rec lutamento è necessario tener presente che 110n so lo i piPd i 1)iatti non sono adatti alle marce, ma anche i cavi ( volta pianta re accentuata) per le ragioni già esposte.
•;>_ Avvenendo l a maggior parte di tn.li fratture nèi p r imi mesi di se rviz i o militare, quando cioè non esiste allenamento, bisogna, nelle ese r citaz i oni delle l'eclute, aver presente la possibilità d i tale lesione e d infor marsi a criteri razionali tecn i ci nella progressione degli sforzi. La corsa poi non è mai prudente far la eseguire, special mente in indi>idni non allenati, dopo un surmenage dei musco li dei piedi , potendo allora faci l mente ver ificarsi le condizioni favorevoli per l e produzione àel t rauma in questione.
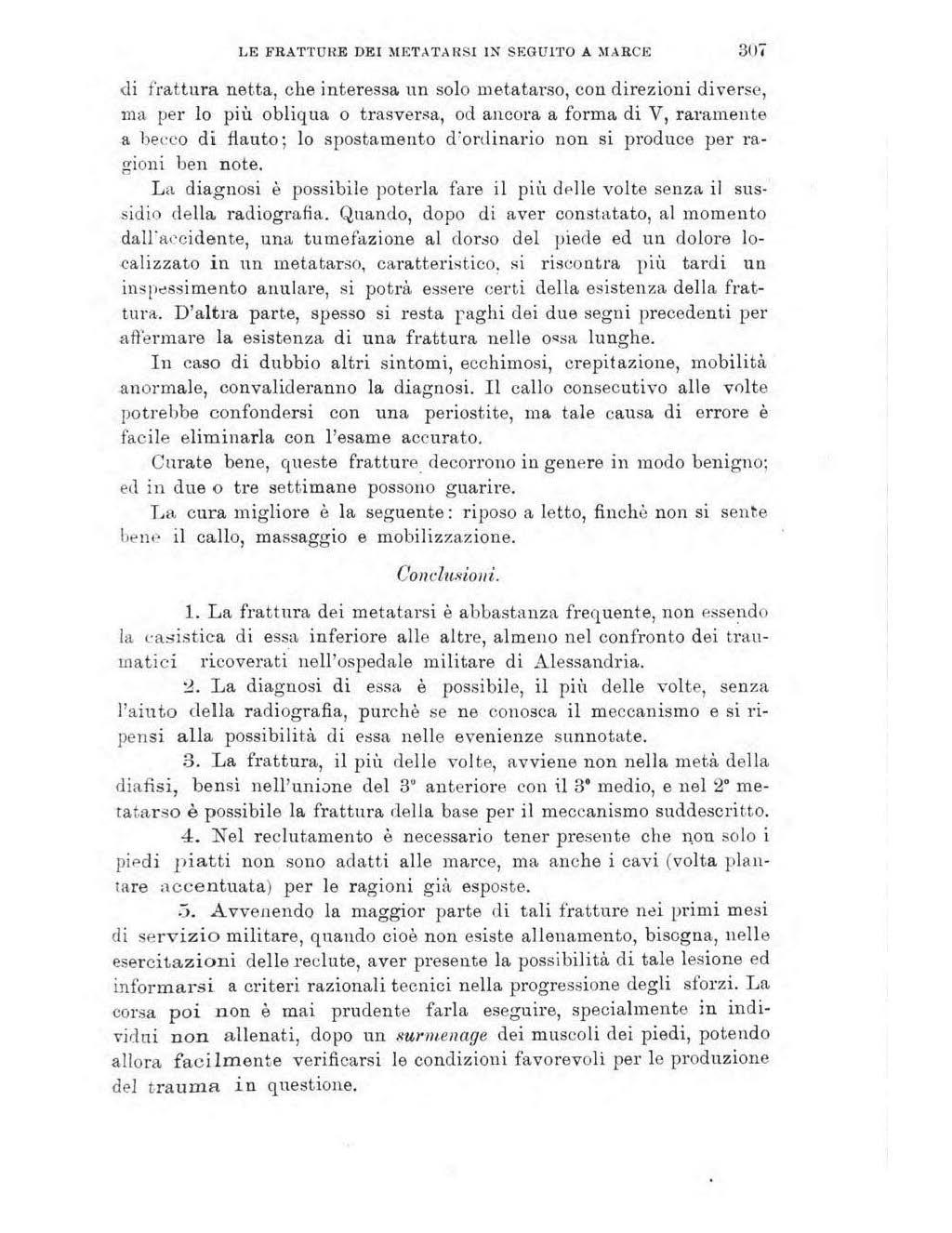
LE lìRATTOHE DE I I N SEGUITO A 301
G. J,a diagnosi di tali fratture è molto importaut e e ben aragione il Kinnisson di ce, nel trat tato di Duplay e Réclus, c he la scoperta d i es;:;e t, una delle applicazioni più intere ssanti della radiografia. E ciò tanto per il lato t e rapeutico, quanto, e questo in particola.r modo pe r il m ed i co mili t are, per il lato m e(lico-legale Ed iuvero essendo, per lo più, tal e affezione cons iderata comfl una periostite, non si redigP l a dichiarazi one m eLlica, che sempre si suole fare nelle l esioni traumatiche. Ed un tale fatto potrebbe aUe volte p ortare pregiudizio non lieve ad un individ uo che si è procurata una siffatta les i on e, cau sa d e i s uoi malanni, comp iendo il suo dovere di soldato.

308 LE FRATTULIE DEl M E 'fAT.\RSl IN S EGuiTO A :I.IARCE
RIVISTA MEDICA

J A:"'OT. - L& mlooardtte reumatloa aouta.- (.lou r nal de .'vfédecin e et rle Chiru rqie, dicembre 1fJ02).
P e1' lungo tempo si é considerala l a miocnl'd ite r eumAtica COIII(l 11na vf'ra raritil, ma pubblicazioni recenti hanno d1mostralo che questa mioc;u·d ilo riscontra nbbaslanza frequentemente, prin cipalmente n ellr> l'lll'me !Zt·avt rlf'lla mal attio, ma, fallo degno di n ota dal punto di vi s ta de lla dirtJ:nns i. precP denle delle artrop11lie non é necc::.saria per<'hè il l'eumati;;.mo i ntet·essi il llliOcardiO.
Qu asi ><empre l'Afl'eziono é Intento e ftt d'u opo ri ce 1·cnrla : " ' mAnifes t a dappr11nA con la dehol ez7.R del c uor,.., coll"opp1·es"ionr, ro l dolore. con la sin"ope c cnn un l e!Z!ltf'I'O edema per1ferico
Se, I'iclti amala l'alte n7.ione del m edi1·o da detti S<!gn i , s i il cuore, ,.i po;osono rif< conlrare: l'aumenti) IA.Ivolla P. l'tJPiJo del l'otlusilà ca!·cliaca, l a diminuzione dell'in tensità dell'urlo della punto, l \;8 i sten7.a di "Orfì funwma li o di un rumore di 1111
La dis pnea, la ci anosi, il ' do lore prer-o rd tale sono i se;:mi funzi o nali piu tmpo rla n li.
I nfine l'intensità dell'inf,.t:ioue, i di coli:'I.><"O cardiaco elle /l:OIIt> devono far· temere l a miocn r.litc.
Ec co d'altronde, secondo !-:ìtul'ger, qual ,. sarebbe l'evo luzione della malattia.
Nel coi·so di un l eggiero attacco di r eumali " mo o l'US"C:luP.ndolo do po un hl'e ve periodo di apparente san itù, la lesio ne cordiaca è annunciala !'nbilamen te dall'agitazion e, da un !mllore crescent e e dn un a spe tto di ansi età "Pe'' 'àl e. sles<>o t empo si n o tano dispnea. di'l iri o, e talv o l ta , omili L<'naci, Questi sintomi tra sformano un ra ffèzi o n e l ic ,·e in malattia :;tr avissima. Un ololnre al cuor·e e una f<ens;ib i lilit speciale di que><la regi one !<Ono sel!'ni fr equenti
è•l i mportanti. Si po!:Ssono avere una elevazione della temperattll'8 ed
IJII RC<:ele r amell\0 del pol sO e della re spirazione, ffifl que!\(1;1 e inceppala 6
1l malalo si melle nella posi1.iou e s•·dula ed an c he si pi<';;n iu avanti per lr·ove r e q ua lche sollievo.
L'eo;ame diretto del cuore fa ril e va1·e gli accennati Sl'g-ni fisi c i.
Nei c asi g ra vi, con e si to letale, s i ri scontrano chiaramente i ;:eJ<ni eli s fìnimen to ca r diaco.
F'o rtuna t a mente la g unrigione è frequente e senza che J'e:;ti traccia della mal aLt ia.
Qu&nd o sopt'Agj:tiUnJ!e la morle, essn può avvenire im provvi same nte, ciò ch e non è raro. oppure pr ogressi va mente col m eccani s n1o delle asistolie abi-
RI\'I STA DI GIORNALI ED ESTE RI
tunli, ma la Ont> veram ente tipica della miocarrlile r eumatica acuta 6 l'asi' l •lli& r apida col suo dpcorso fatalmente progressh·o in quella fo rm a che ha ricevuto il no m e di rcumaLismo a forma asistolica È sopra tutto in -1uesti rns i elle si IH'Od uce ra pidamente la d1 l ntaz.ione ca rd1aca che è ca ratteri stica 1lella Jniocn rdite, quando il c u o r e perd e la sua •·esislcm.a e si dislt>ntl c •·e.
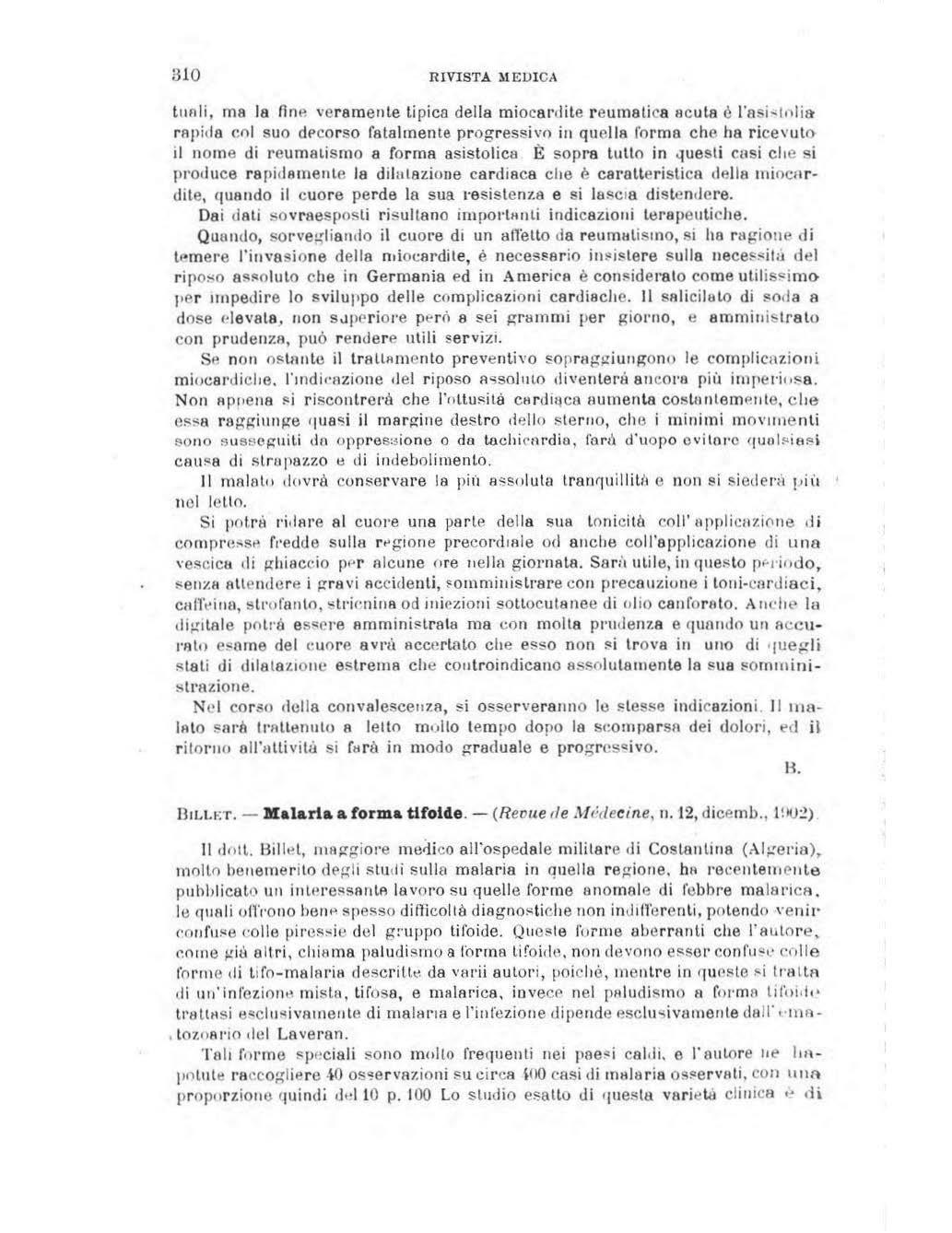
Da i dal i !-lovra esposli r isultano impo•·LHnli i ndicaz1011i
Qua ndo, il cuore d• un alletto da reumu lismo, s1 ha rttgio ne d i l'in\'&sione della noiocardile, é neces sario s ulla del rip o,.;o assoluto ch e in Germania ed in Amer ica è considerato co m e ulll is"imo pe r 1mpedire lo sviluppo delle cctmplicazioni cardiache. Il sali ciluto di Mda a dose 1·levata , non s.Jpe ri o l'e a sei g r 11m m i per giorno, e ammiu i '-lrato con pr udenza, può r ender e u tili serv izi
SP n on oslllntc il trallAmento p r even t ivo le compli cazioni miocardicbe. l'mdicnzione del r iposo A<>solmo diven teril an co•·a piil impe l'ito!"a Non apnena si riscontrel'à che l'ntlu!'ita ctt rò rljca a umenta coslnntemf'nle, elle cs"a quac:;i il destro dello s t er11 0, cho i miuimi mo\'une nli s u ssegu iti dn oppros:$io ne o da t.achi <"nrdi a, l'ara d'uo po ovi ln•·c quol!'iaRi causa di slrupuz.zo u di indebolimento.
Il mRiato d(lv r·à con servare l a pit'1 A>"so l uta lranfJui l l illt e n on si siedE.> J'ù ,, iù • n el l etto.
Si pntrti • i d111'e al cu o1·e una pa r te rlolla sua lonici tà coll' applicnz,0ne di comp r·e-.st> r,·edde sull11 r ,.gione p•·ecordiRie od anche coll'applicazione di u n a ' ' e!'lcicu di g-hi acc.io P" r alcu ne nre 11elln giornata. Sar:'t uti l e, in questo p;·•·i,.do, ;.enza All rndc re i s:rra vi Acc i de nti, con p•·ecauziune i Loni-card•aci, cHil't>iua, s trofan lo, "L•·i('nina od 111irzioni souocutanee di o lto canfor a t o. Andt t' la dil-!•tsle pnt•·a esc:r•·e llmmini!:'trll l a ma molta p•·uden za e qulllrdo un l'lllo del <·uorP avr•ù llCCPrl:tto che esso non l'i tr ova in uno di !';lati di dllataz,onc 6!';lrema che controindicano as!';n lulamente la sua sonmlini!-.lrazione.
N l' l cor:;o della convalescenza, s i osse r "era nno le indicazion i I l 1118lAto l'arà IJ'Allenuto a lelto mollo t empo dopo la !:won tpar sn dei dolor1, t'd H r itorno all'nllivilà s• rt<rà in modo g r aduale e prog resc: ivo.
Ou.. t. ET. - llllalarla a forma ttfot4e . - (Reoue de .\.fMe eine, n. 12, d i cPmb .. I !HJ:?)
Il tloll. Billt>t, metiico all'ospedale m ilita r e di Cost.an lina ( A I;:e•·ia), mollo bene m erito studi sull a malaria in q u ell a re g i o n e. bll •·e<·enler11 eute p nhbli catfl un itttPJ'essAntA !avo •·o su quelle foJ•m e a no mole di fobhre ma laJ'ICA. le qua l i o fl'l'o no hent> ><pe!=;so diftìcollà diag no!<Li rhe non indrlforenli. potendo , eni •· con fu !<e <·olle pil'è><>liL· d el g:·uppo li fo ide. Ques te f'ornte aberrauLi c he l'Aulo r·e, come ,.:iu altri, chiA ma a l o rrn a lifo i rle. no n de\'ono ei"SO I' con fu"•' crolle fMnw d i l 1fo-m alm·iR desC!'ill<' da vRr·ii auto•·•, poiclre, monlre in qur!:'lO '-i t• a t lA di nu'inf'czinno• m ista, tifosa , e m11lar·ica. iovec<' nel pA iudi5rno a fm·mR tJli)tolo• t•·attH Si e"CIII,;i v a•ne nte di malar1a e l 'infezione dipeude esclu 'iivamente da ll ' • lliA·
Lo7.naJ'IO del Lave1·an.
Tal• fn 1·me so no m olto frequenti nei poe'"i caldt. e l'autore 11t.> pntnll:!
!'U cu·ca iOO cAsi di m11laria OS!'ervRLi. con lillA propor ziono quindi <11·110 p. 100 L o slutlio e!';allu di qne!<ttl. cliuicR •' di
310 Rl.VlSTA llEUlCA
H.
grande importanza, poi chè quando uo n si fttcci a una pr·el' i sa dia g nos i, l e con st>guenze più pos sono sopr·avve uire pe r la salute e la vita del paziente.
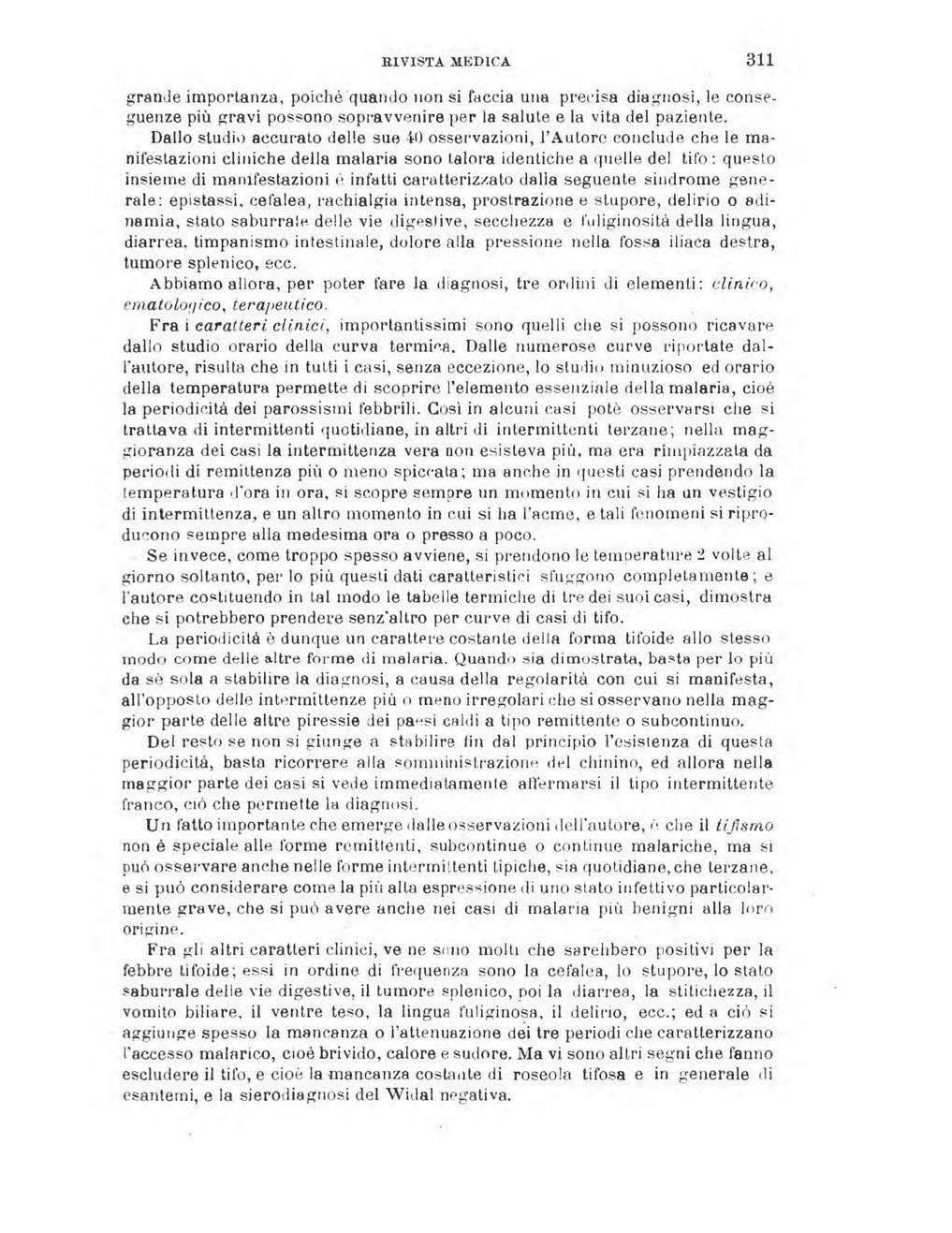
Dallo studi•> accur a to delle sua 40 osservazioni, l'Autore co nclude ch e le ma· nifes tazi o ni cliniche della malaJ•ia so no talMa identiche a del liro: di mAnifestazioni (• infatti caratter·iualo dalla seguente s ind r ome r ale: eprs t.S!<Si. cefalea, r·n chialgia inten sa, pr•oslr azione e s tu por e, delirio o adina m ia, stato del le vie seccl1 ezza e l'uliginosi la dPlla lin gua , diarrea. timpan i smo dol o re alla pr·essi one nella fossa iliaca des tra, tumore splen ico,
Abbiamo allor·a, per· poter rar·e la d iagnos i, h·e or·.tini J i cle menti: el in iN), i co. te r·a,•eu t i co.
F r a i ea ,.a lle ri clinici, i mpor·tanlissimi so no quel l i che si poss ono dallo studio orario della c urva ter·mi,.a, Dalle n u m ero se cur•ve l'i por·late dalraulore, r i sultA che in tu t ti i senza eccezi one, lo slurli o ru inuzioso ed o rar·io della temper atura p ermette eli sc oprire l'elemento essenzin le d e lla malaria , cioé la p eri od icilà dei parossismi febbr·i li. Cos ì in al c uni easi po tè os:;erv tu·s r c lte s i trattava d i intermittenti quotidiane, in altri di inlermittc nti n ella dei casi la in t er mittenza vera no n esis tev11 più. m a et·a rilll pin zzala da periodi di r emìtlenza più o m eno spi c<·ata; ma anr:h c in •rucsti casi p r endendo la te mpe ratura d ' o r a in o r a. "i scop r e !:!em pr e un in c ui ;;i ha un di in l ermillenza, e un a ltro momento in c ui s i ha 1'11cmc, e la li fn nomcni s i r i p r·o"empre 11lla med esi ma ora o presso Il poco.
Se invece, come t r oppo s pesso avvie11e, si 1we ndo no le tenwera tut·e :! al giorno soltan to, pet· lo più ques ti dati caralte r is tir i com pletamente ; t1 l'autore co,.trtu endo in ta l modo le tabelle termi che di tt'e d ei ca s i , dimos tra che s i potrebbero prende l'e senz'altr o per c ur·ve di casi di tifo.
La per·iodicità è dunque un ca raltPl'e costan te d el la forma tiro ide allo s te sso m o d () cnm e dt:ll e altrè forme di malnria. Quundo :5i8 dimos trata, bal<t8 per l o IJÌÙ da sè sola a s tabilire la a cu usa della t• egolarilù con cui si all'o ppol:'to del l e inlr> rmilte nze piu n m "' no c:he si osser·vano nella magg ior· pat•le delle altre pire ssie Jei pa..,>'i c!l ld i a tipo t·emittentc o subcontinuo.
Del r el"lo l"6 no n s i n s t flbi lire fin dal prin c i p io l'c:; is tenz a di questA per ioù i cità, basto rico rrer e Rlla r!t·l chinin o, ed all o t•a nella rna !!gio r· parte dei casi s i v ede irnmedral.tlmente all't> r·m ar s i il ti po inter mitte nte fl'anco, c:rò c he permette ]1;1
Un fatto impo rtan te che e m er·ge dalle o,;:;ervaz io ni de l l'n u tor·e , i• c h e il tlj1smo no n é speciale alle l'o rme r l' mill en ti, o continue malariche, ma l! l puo O!'-SeJ·vare an che nel le fo rme intr;rmi ttenti tipiche, "i A quotidiane, che Ler za 11e e s i p u ò co ns i derar·e com e la più alla espr e.'l..:.i one d i un o SLA to infettivo parti cola r·mente grave, c he si pu o avere anche n ei casi di malar ia più ben i g ni nlla l n r n
Fra g lr altri t:aratteri clinici, ve ne St illO m o lli c he sa r c hber·o posi ti v i per la febbr·e tifoide ; es" i in o rdin e di ft·equenza so no la ce falea, l o s tupot·e, lo s tato :::abmTale d el le , ie d i gesti ve, il tumor e :=:plenico, poi In J iatTea, la s ti tiche zza , i l vomito b iliure. il ventre te so. la lin g uA f'uliginO SII. il delirro, ecc.; ed o ci !) si
I'I!Zgiunge spesso la manranza o l 'atte nuAzi one dei tre per·iodi ch e cara tterizzan o t'accesso mala r ico, c roè brivido, calore e s udo re. Ma vi so no al t ri segni ch e fa nno escludere il tit'o, e la mancanza co:sl nrtle di r oseola tifo sa e in ge nerale rli esan temi, e la del \Vi J al
R.1 VISTA MltDI CA 311
Fra i cat·alleri d'or ,line ematologico rA. pont> in p rima lirwn il reperto dt'l pa r tl!"!'ita ;:pecifico, che ha tro vato senza eccezione. Qu i rA. segue l e l<'Ot'le del Laverun che noti sono troppo d'accordo con •1uellt• degh autori iwliani e ledPschi. Mn tutla\•ia risulta che la forma lifuide i• di g ra n lunga piit frequente iu •1uella f or·ma d'inf,·zione che noi chiamiam o estivo-aut un nale, e che l'auto re com e paludismo pr i mario. Ct ò. concor da col fi\llo ch e i r'lsi furo no in rwm<•r·o di :w nPirag•1stn, l'<'llembr<' C'd o ttobr e, P l'oltnnto 4 in maggio, giugno e luglio
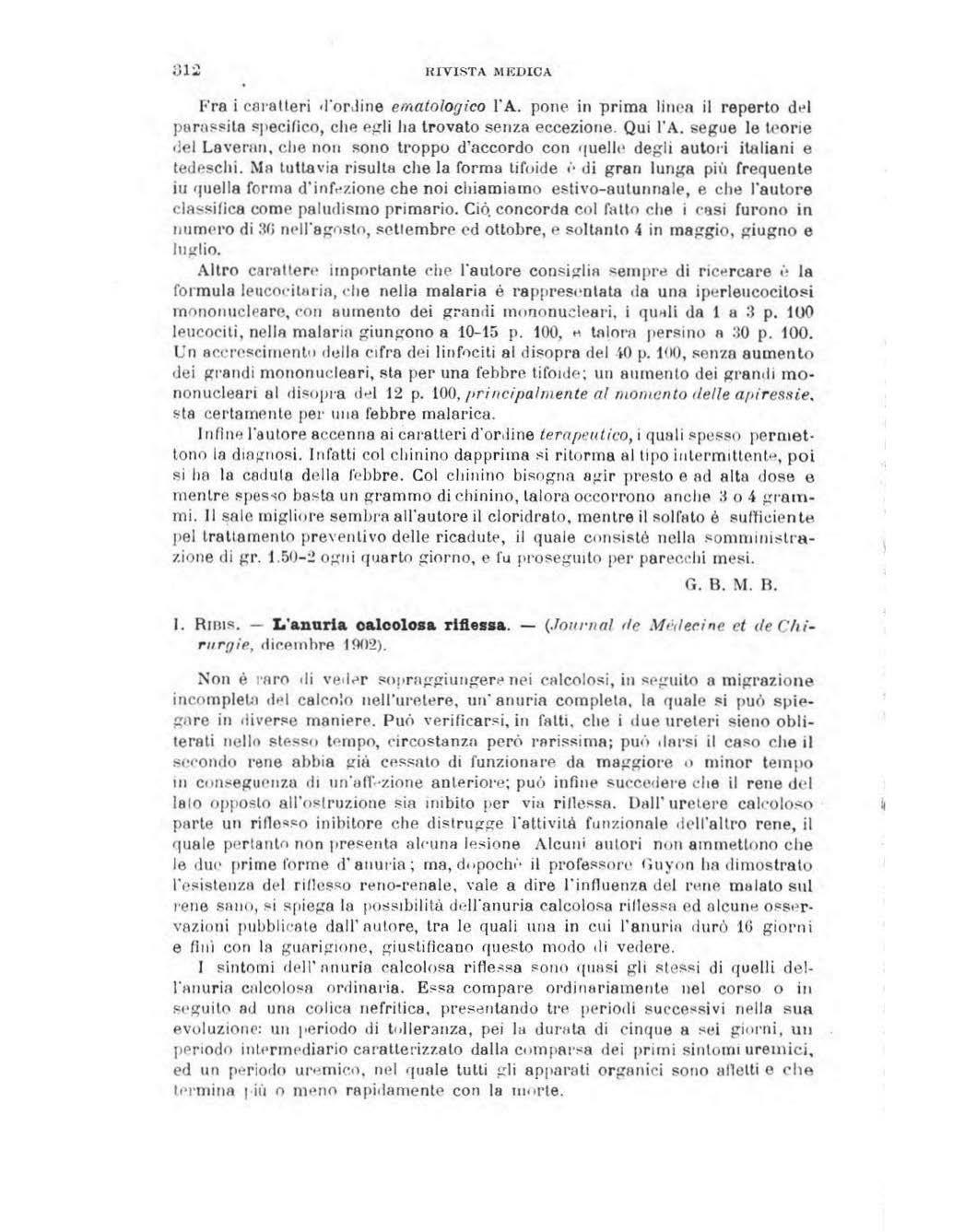
Altro cnr·Atter P 1rnpnr•lanle che rautore "61l1 Jll'<' di r 1c,. r care i• la for m ula leucn<·itll l in, \'he nella malaria è rap p1·esPntata ol a una i pcr leucocilosi m n nonuclrarr, ron aumento dei morwnu::lea 1·i, i d11 1 a :1 p. 100 IPUCOCili, ne ll11 malariu giungono a 10-15 p. 100... lillnr·n per smo 11 :lO p. 100.
lJn arc·I'N<riruE'nln dclln c1fra d ei linft)citi al disopra rlel '•0 p. 100, ;:enzo aumento dei mononu cleari, Rta per· una f ebbr e lifoHif•; un aumento dei ,c;t1' an d1 mononucl ea rr al d i l'opl'a d J 12 p. l OO.t•rincipalmenle al momento delle at•i r ess ie.
!:'la ce r·tomenle pel' u11a l'ebbre rnal a r·ica.
Jn flnl3 l'au tor e acce nna ai cA r·alle r·i ò'or.line terapeutico, i Cjuali pe r mettonn la l11folli col c hinin o dapp r ima ,. j rilo rma a l trpo poi l'i ho la cadut a d ella f'f' bbre. Col c hin i no bil'\ogna a;.!ir pl'esto e Ad alta dose e rr1entre bo >< lo un g r·amm o di chinino, Lai OI'A occo r r·on o A nella :-1 o 4 ,ltl'ammi. Il sAle migl io 1·e sembl'aall'autol'e il cloridr·ato. mentre il so lf'l-ltO è pel tratlamPnlo pr e\'E'IItivo delle ri cadutP, il qua l e cunsis; t ò ucll n l"o mnrlnr :<trazione di gT. 1.50-:! og11 i cJua rtn giMno, e J'u progcgurto pet• mel<i.
G. B. M. R.
l. Rm1R. - L 'anu ria oaloolosa riflessa. - (.lourna/ dp .\11•tlet'ine el e/e C'llirur!JiP, tlirPulhre l !l<l2)
;:o\011 e l'flrn di \'11 d.-'r !'lll>r ll:.rg'ÌU111!6r t' ll('Ì ClliColosi , Ìt1 a m igrazio n e incnmplet;1 < l t>l ca lcn!n un· anuriA completA, lA quale ;:i può spiE'· in •liver l'e maniere. Può \' Pr ificarl'i, in fal t t. che i due urele1·i l'ieno obliterati nello stl''lSo t Prn po, c·r r co!" tanzn però I'Ari;:;:ima; puù olor·!"r il C8l'O c he 11 >wrondo 1·ene abbia giit CPI'\l'nlo d1 funzionare da ma g-gi01·e u minor t empo 111 d1 un'ull'·zione può in fine l'\urct>der·e ch e il r ene d el Ialo all'o;:li'U7.ione 1'\ia uubito per vin 0!111" urc ter·e call'olo-.o pa rte un r ino c:n inihitore che l'altivita funzionnle dl'IJ'allr·o r en e, il I]Uale pPr tantn non prN<enla alc·unn le,-ione Alcuni autot•i non a mmettono c he le rluc• prime l'orm e d' an ur·ia; rna, dnpoch•., i l p1·ofe!"l'\on• hn dimos trat o l'r·::isten:r.R dl·l r·l'nO I'ì'nal e, \'Die a dire l'innu enza dol l'l-III E' m a lato sul
1·cne f\nno, >-i sp ief,ta l a poss1bili ta dt·ll'a nuria calcolol'a r·illos.:<n l'd o lc un .. o;:s,>r\'Szinlli p ubblic·ate do li ' nutore, lrfl l e quali u na in cu i l'anut•in d urò 16 gioi' n i e fini con l a g unri ,a 1one, que!'-to m odo oli v ecl1we.
l l'intomi tiPI l'n n urio ralco l o!<a rifle .4sa ROII<l qm1f\i g li l'le!"!'-i d i quelli deiI'Rnuri n rmlina r·ia. E " "a compare nel corRo o in ad un11 colica nefrilica. pre><enl.llndo trE' per io•li s u cce:<sivi n t> lla s ua evoluzJOn(': un J'C r iodo tli l uller anza, pei 111 ùunrla di r inque a :<ci R1orni, uu pPrrod(J IIILPI'mPdiario car·atter i uato dallR cnmpRr·:<a dei pr1mi 1'\into rlll uremi ci ed un r•·riorlo Ul'••mir·t\, nel 'tuale tulli !:li appar·ati organici Hllelli e che lo'l'll lina 1 ii1 n nwno rap idamen te con la
HfVll'TA MF.DIOA
Questa avvi ene dal d ecim o al rlodicesimo a parli t•e tlall"in i zio dell"n!'trnzi o ne u r et t> r ale e v erso il secondo o t erzo g iorno dopo la co mparsa de,:rh acctdt>nti u r emìci o piit esattame nte dei di!'.tur bi ne rv osi e in pa t•licolare dei tra!'tll imeoli mu!'co l ari. Tuttavia, nell'an ur ia ca!colo:-:o, il per iodo di l ollet·auza può e!'ser e notevolmente prol ungato e gli accideuti t'Bramente il periodo uremiro.
La !'i eflettua or, hnariameute in pi eno per i odo di t ollt>ra uz a, nf'll'tnizio del per iodo d ' uremia, o nel cor so delh1 ra!'e d'inlo:<!'i<'BL.ione, !'opr attttllt) qu11 ndo dominano i dis lurht g nstt·o-inle!'linah.
l fenomeni prin cipali che annun cia no la gua ri gioue son o la ri compAr."ll dei dolori che si er nno in l!ene r ale calmati dut anle tu tto il pe ri odo d el l'anuria (ti malAto p u ò avere la sensa zi o ne della m i:zraz tone del C<"llculo Vt!t'!'O la vescica), unA diarrea profusa e soprattutto unR po liuria, fr equente m en t e co n l'ociata ad albummut·ia
La d i !'linzi one fra que!'la forma d'auuria e l e altre non (• !'.ern pl'e fn ci l r.: rss a si dt!'.lingue dall 'a n urta culcolosa doppin , !'.OJlt'<J l lu llo pet' l' alq ua nto minot·e deg-li a cciden ti, e dall'anut·io r:sterica. pc r cltè qul!s L'u l timll può pe t s i !'t e r e m()lto Lotupo pt·odurre il minimo di,Ot'd i n e nell' prore le sovenli per acct'f<" i r•ip o tuti, aller·n ati con altri ne v r opalici.
La diagn o!li sarebbe pero im po t·Lante, perc ltc lo c ura varia l'rco n do l'ot'igin e d ell'onut ia.
N ell'i nizio <io ll' anuria, il trattamt>n to p uò essere pu r ame nte nwtl ico. L'intl i c az tone pt·iu ctpol e • . dt :ì Up!Jlire al tti elimtnnzione det p r incipii ef<c t·e· ment i zi co i dt•as t tci. S i daranno anche Lallui cu l d t prolungati e diurettche ( r f'f(i me latteo), lo g licer ina ad alle dnl'i u 100 g'ram mi). Si po trann o pure p r ntica r e co n pruden za il mas:sag-J!iO d ell'u r e l e r e, l' el e ltt•izzazione con le correnti con t inue, la c lot·ofo r mizzazione pr ofondA e p r o lun g ata.
N on si dov rà pero insis te t e nell'uso ol ei m e1.zt medi<'amento!lt e, se l'anuria per!'i!lte, rat·;) d'uopo inte t·ve ni r e clti r ur gica mente : si dovrà pra· ti carc la oefr ot omia , lu q uale. 80ltanlo, po trà sa h •a re t i malato dai pericoli del l' m ·t>mia B
RoarN. - ProAla..t e terapia della tubercolosi , basate aulla o onoaoenza del terreno dJ questa affezione -(La Semaine \lr;dica le, n. Hl02).
L ' A. già in u na pt·cce.fe nte comunicazione ave,·a dimos tralo c he in lutti i lubrt·co l otici. dall'inizio al t ermin o della ma lall ia, gli f:ca mbi r c!'.p irato ri i n IHtmen l o . L e ultct·iori ri cerclw, fa t te c0 n l aiuto del d o lt . Bi ne l, hanno as:oodalo clte la dei discendenti da tuhet•co lotici pre!'.e nlano s.;.ambi in aum e nto, m entre 'lUes li s i mo,;tran o in diminuzto n c n eg-li stai i anta g-l)nis l i della l i><i , n el l 'at•lt'iliflmo etl an c lte nella scrofo l a, l ert·e no, dov e non germ ogliano c he le tuh et·co l osi l ocal i.
D11nque la esaget·azi o ne st:ambi respi t·ato ri una delle cond izioni de l t er r e no della ti si.

L. e ri cer c he in ha nno pure d i m ostralo c he la iper alli vilé degli !!camb i r t'sp it•alt)r i pu ò esl'erl! a cfJ ui!' ita e clte lo s trapazzo, solt o LnLtc le fo rm e , e !'alcooll!>tno esagera n o ti c himismo respiratorio, a l pari d ella eredtla .
Ciò po"to, lr·e cons est:uenze i mportanti: 1° dala l a i col'l anza di questa mo deg-li <>camhi re«pi r atori. dest::a p uò coodiuvaJ•e t>fricacem onle la
RIVISTA ME DlCA 311:1
diagnoc;i JH'ecoce dt'lla lisi, f!G ando quesla sia 2° la stessa m odiflcar. ione p•'t·melle di r iconoscPre la predisposizione alla lisi; 3• la m edesima i nfìne apre una n uova via alla pr olìlassi, giacché tuUo r·iùuccsi a t•ice r ca r e qua li sono lP. MstanzP m edicamentose e q uali .i tt·attamenti, capaci di limitare l'altr· tudine dell'or j:tunismo a fissare troppo ossigeno ed a produ r r e t i'Oppo aciJo ca rbonico.
Il lnvoro enPrj!ico e sostenuto duplica ed an che l t•iplica r espir·atori; dunque il c!Pve cM tiluire un ecrell enle se1lativo por !.di stl'S"i. An ch e l'attitudine del corpo contribui"ce a far ,-ar i are il chimismo respi r atori o, sapPndosr che s1 esala m •nor e quantita di acido ca r·bo111co quando s i è coricAti. anziché 'J Uando !'i é sl'duti. La m:::pi r azione dell'aria calda e sec<·a non unifor·memente in tuLLi i Lisici; pP.rCIÒ prima d'invia r e uno di costoro i n un clima caldo e secco, occo r re pralica r e l'esame del chimismo respir·alorio, p r ima e dopo l a inspiraz1one dell'aria cal da e secca, tratten e ndo coloro. n ei ' f ilAli !!li scambi in Rumen tano dopo la prova. l climi caldi ed umidi debbono ec.;se 1·e sconsi gliati.
La in.,>pit'HZione del l'at•ia frèdda, m en tre non fa l a capacitA r espi r ator ia nt\ la q t1an lilit di ossi gen o assorbilo dai diminuisce il tas!lo dell'acido carbonico pr odoUo e dell' ossi geno tota l e con!lumato; du nque i cli m i freddi se m hrnno conveni r e a lla m ag-!!ior a n7.a dei tisici, pur·cltò pc r·ò la supPrficie cuta nea non subi srR r·afft·eddamenlo. i'\on è po.,sibi!P sLAbi l ird unn uniforme per l e a lllltulini e pllr l'ar ia mar'llla, essPndoue o•IT.- t Li f<ubor·dinati a molti fallot•t indh•idua l i.

T ra i medicinali r apaci di diminuir'e gli scamb; t• esp it'atori, l'A. l'otto eli fe[.:Hln d1 merl uzzo, Rlla dose d i 250 grammi pro d.i1• Cl; il Lar·ta t·o ::>libinto a dosi frAzionA l P ( l cenligr. a !) cenli::rr .); l'ar:;.-niuto di sodio, l'ars<'n ! lo di pota""'ll (mtll. :>) ed infin P. il cacodilnto di !'O,ltl (da 5 a IO ce ntlg"t'. ). Gli ar:>Pnlcali usat1 a doppie delle pre<'edeuli fann o acrelerRre gli !'rr1mbi r e"Jlii'Alol'i; SI poc;sil•de dun•1ue un rrtlerio della dos>' med1camento!' a optinvt, la qnnlo:l nou ,-a mai superata. c•1
Col'HATTE. - 11'uov o m e todo p er la rloe roa del baollll eU Ko oh Degli •putt. - (c;a!'. helnl. rlcs se. mt=d. cf,• B•,rdeatu, n. 49 1!102).
L'rwiMe e"rnne un n1r nvo melodq pP r la t·ice1·cn dei dPIIII lul•(•I'<'One::li !<Jllllt. E"'"O c Jll<;ic;te n el praticare le opcra1.ioni:
1• fore 11na misc<'la di:
Sputi IO c. c. Acq11a 100 c. r., Li sciv1a di soda IO
tnt ,.. RJI'ebollizione a!!ilan<lola r·ostalltPill1'11ll' f i no noi l •ttenere li .ptidn omO).{•·neo, t r·allandone una pa t·tc. ad e»em11io :W ccnlimutr·i <'libici. con quattro ).{IICI'ie di Al'i do acetire e 'Jlltlllt'O ce ntinvnlf'Ì cubici di emul><iollflndo il lulln l'o t• l onlell l e. tosto In rorrnrt1.ione d'un prcr i p1tato che Mie r:II Jito rapidnmcnle alla supt>t•iore rl el lifJuido. $1 l'idil'olvn allo1·a tulo prPcipilllto ron di soda, fot•tern Pnle dopo di PtPI'C, lnsda ndo poscia riposare la mi>-celn. Si constalA la rormst.inne rapidn .! 1 un'Hnl'llo alla s11perliril' di sr ·pHrflzll\ne dcll'eh·r·e e d!:'lli'Juid•>. 1:: in tai o an··llo cfm Lt•m·u;.i la rruas1 tots lth i d e1 bac·tlh L1 th ercolar1 contenuti nalll •(l ti lo
' 314 R I VISTA M:XDIC A
cosi trattato T ale anello, da p1·ima p i u o men o vo lumino!lo; poco a poco s'asso tti g lia fino a formare una li eve pe llicola . Si t olgono allora dei frammenti d i tale pellicola e se ne fanno p r e parati colo ran do l i col metodo di Zi e! , non a·•endo i bacilli nulla ùel !e loro pr op ri ehi color anti.
T ale processo d ov1·ebbe 1'end e1· utili sPrvi:z-ii n ei c as i dubii di tube,·colosi polmonH r e quand0 con altri metodi r eper ti negativi, come pur.a nelle dimost r azi on i p rati che i n l uo:;ro delle C•li lurP d• bacilli d i K och sP.m pr e p eri col ose
Sa 1·ebbe ulile conosce r·e: qua l' é lA reazi one; se questa è spe· ci tì ca F-p:Iti contenenti bacil li di K och, se es sa puos!'i applic are ad altri liq u idi patolog ic i , come liquidi pleu r ici ecc. ciò ch e sa r ebbe di gl'ande importam: a pr: t· la di a gnosi d i natura di tali ess udali.
G. B.
Si ntomi delle adenopatle tTaoheo -bronohtaU. - Rivista sintetica del ca pitano m edico GrovANNI
Ge n eralit à - La d el!e adenopAli e tracheo- bronch ia li data in g r an parte dalla é necessa ri o conm:cer e es allamente la si t uazione dei gan g lii - Tali f(J rmano qualll'o !!ru ppi:
J • i"> r etra cheo b r onrhiole tles lro, collocato nell'ango lo forma to dalla trachea co l b r on l'o destr o.
2" Pt•etra c heo-br oncili a le s i nistt·o, collocato nell'nngolo Lracheo - b r o n ch i ale sinistro
3' In le r·tracheo-lJronch i aiP, colloca lo di bifor cazione dell a t t·achea
4' Jnter bronch iali, o v vero gangili si tuati a livello dell'ilo e nell'intern o dei· polmoni ( Poiriev)

l tre primi g-ruppi si addosF-ano n!IP pa reti torRciche distri buiti in due zone: !"u lll:l. a r ect gang:ionart> ante r io r e, co rr isp(lnde al manubrio del l0 stern o ed alla po rt e inte rna dei due pr·imi sp11zi i inte r·co!'t.ali e della cla vi colo: l'alt r H, area .,anulio nare posteri o re, ro rri f'ponde allo spazi o i nle r'scapolo- vei·tebr ale da lla settima cervi ca l e alla te1'za do r sa le.
Sintomatolor1 ia oenera/e - S i ntomi - All'ispezione avvel'tef'i r·Aramenle liPoe deformazione dell"area va n{Jliona re ante r iore, m entre é più frequente certo grado tli insp i r ato,.ia dPll'epiJZa!'Ll'Ìo, d ella f•>S$8 so ttoslernal e e dl•gli spaz ii inlercostu li, indi C811le la ditlìcoltà che pr o v11 l'a r·ia a P"netrare nel petto, causa la ;;tenosi tr·acheo-bronchiale. D' o r·dinario poco intensa, osserv asi la dimin uzione ttnilate r alc toracir·rJ, che può, a andare, compli carsi con 1·etrazione t orHci ca a"sociata a ed atrofia m1r:::colare. l movimenti più l ungh i, e rolle ntati, mPntre il cum·e batte p iù f r·equentemente.
ra li se!lni, fo1·niti dall' i spezior1e, sono Ol'dimwia m ente poco marcati, talvolta, perfino , rnanruno comple t'8m enlr.
La eccezionalm<.'nle p r ovvoca dol o r e perm etten do di r ileva r e l a presen z a di masse neopla"ticlle a livell o dell 'a rea gAngl innare ante ri o re. Co n In, percussione pr atici'\! a i f'gge rrn en te, rlelle aree :;rang-liona r i, si noterà cost ante eleoazio ne (7e/la tonalirà, delicata, ma che talo r a pnò g iu nger e fino alrasso luta matlP. 7.za. T ale l-'eg-uo é m ol l o impo•·Lante.
A ll' ascotta:ione u n segno d' impor tanza capitale, é il sol/lo interseapolooer· tehrale, tale soffio avvertes i in tutta !"area ganglionat•e po steri or e: or dinaria-
RIVISTA .\JEOICA 315·
mente rli tonalità elevala, di timbro rude. \·eramente tnbari o, può a-.sumere anche un tim b•·o cavi lario od an fori co; tah·olla vela to nell'inspi raz•one, s1 nola specialmente nell'espirazione, vamtbili s:;imo, s·ar.compa p;oa spesso od obbas>:amenlo della voce ed a tosse.
Alra scolla zion e del polmone, dirr,inuzione unilaterale del mu r nwre of'scicola r e in con lra"lO con la sonorila nor male del polmone e con la con!Jestionc tlelle lmsi.
Di lnlti tomi flgiri i più impo1·tanti !'Ono:
t• La mall,..zza ; 2• il soflio luba•·io; 3•1a dim111uzione unil a t erale del murmu r e veo::cicolare; 4• la conge'-l ione d elle bac:i.
SutttH1!1 fun ;;ionali. - Compressione delle rene.
1• T'ena cara Sllflerio r e: sl11Si al capo, alle membra !!uperio• i ed allo p11rte s uperiore del torace, donde dilalazionP delle vene soll ocutan PP. svilurpo tii cit·colazione collater ale (mamma r ia rnte rn a, intercm> tali, t:>pill&!itrica, "olLocutanea a ddominale e tc.) nella quale il !"ungue procedi' dRII'alto nl edema dt-!lln ft•c cia, degli a rti SUtJeriori e d ella pa,.le l'tr(ll' l'iore del tora ce, cianosi delle labbra, tot•por·e inl,..lletlua le, cefalea, epi!'-ll:i!>Si etc.
:!' l 'e n e polmonar i : conge!ili one pHssivu de l poilnone, che può dal' lu ogo l'l ciPi l t>. fulm i nanti; idro lnra ce. delle arterie. - Rara del!'ao1·ta, si r i;;co nli'H lfllvolta delle con diminuzione del p0lso co t't'i sponden te ; dell 'arteriA polm on81r e co n em otti si fulminanti; delle arterie bronch iali con polmonare. elci n erl'i - È inter essato sop r atutto tt molto eli il pres:entandosi con tosse strzzosa violt •uta, ad acrc:>"i sop•·atutto al m11ttino ed alla ;;era, senza espettorato. sp.,sso con vom1Li dopo gl i acre;;si. TlllOI'u si ha cli!\pnea continua o pa r os;;i«lictt, che talvolta r AI!!!iunge gr·»,lo e carhlteri d'asma (rasma llanglionare di Joal l, mentrP L11 l altra not11nsi ncces;;r di pecloris con modificazioni del polso e !iOpralullo laclticardia. srntomo f{uesl'ul t imo Ja atl1·ibuir·si a par·alisi del va 1:0
E<-,endo co mpresso tl rico rrente di sini.,tra si Avr·anno fenomì'ni d'erd lfl· mento: «pflsmo della f!IOttide: ilto laringeo, e«nftt:::ismo; oppu re par alrsi d"lia corola vocAle di si ni;;Lra, donde voce rauca. bitonale.
:\ella comJ1 r essione del .fre nico avrassi dolore a lla prf• S!:Iione del collo fr·a
1 tlue capi dell<> sterno- cle ido-ma!'loideo, Jun )!o i dello !!lc.'r'nù, all'an-
:.:1'10 talora m ollo pronuncrala.
E""endo compre.çl!o il si noten111no disturbi oculo-papillori del Ialo cor·risponrlPnle e nella pat·alià i; c mid riasi.

H i;;conLr-nsi cccPzionalmente pa r alisi dei n er vi inler cos:lali. di comt•ressioHe trachoto · bron e hiale si pOS»ono vel'iflca r e con l t1 ::<indi'ome e!'o posta, mentre quella. da d('{l'escf, rto !'i mfnrifeslerà <'On di sfsg-r a vomito esofngc·o et.c.
Variabili sono i sin.iomi generali : tal vo lta s i ha f cbb l'e, sudo1'i freddi, cache"«ia. Luberco lnre; tal'altr·a, 'flH• sti sin tom i tì!'i ci sono poco marc11li e s i J'iducono alln sola 8no r·essiA ad un certo J..:l'ado di d im o'"'r AtnPnlo
Ncll'ndiJilo l e adenopatie lrtJcheo -bronchrali sono costanti nel co r01 o della luber·r•oiO!'-Ì polmonarc, mA spe::<sol aten ti.
Quando in un mal n lo "i constala : 1° delle m odifkazi on i r es:pi r·111.orie tle!rlr n p ici; 2' i Stlgni di adenite ;J• congc!'tione dd le ba;;:i (,intorno ùi F<' r net) !li p"n '-i t o!=:lo ad uno tubercolosi iniziale.
31G RIYISTA MEDICA
Le aden opatic in pa r ola, n ell'adu lto, po!<'"on o nnclw di o r rgine rwoplas lica (cancro pleuro-polmona le, e5iofageo el c. ) , o linfoodenitrca ; se la linroadeni t e re !'ttn l ocalizz ata ni rlel m ediasti no e non si accompag-na alla leucem i a, i l diagnost i<'o é dei più os.:uri
G. B
Ros<> s L. - Rloe r o& dell& aoat&nz& ooloraa.te de l a&nl'ae Dell'ort.D& . (Bollet tino chimico tarmaceutico, n. 1902).
L'A consig-l ia il m etodo, di facile applìcttzione Ile r i cc r·che chimico·cliniche:
S i acidin t a fo rlt>men le l 'o rin a in e'"ame con acido acetico e la !';i co n e;:unle volume d i etere; :::e s i fo l'rna una emul s ione per la ril evante quanlitll di albumina. facllrta 111 dell'etere mediante rofl'red damento in oc•JUB g-lliaccia tfl od an ch.., cnn di p oche gocce di a lcool. Cio fatto decanta l o s-lmlo clc!'eo in un tubo di saggio, n el quale l'liu u o gili !<lnlo• vt• r•ate alcune di acq u11, a gg iunge ndo vi gocc e di o li o · 8!'!'0 11Zi ttle di tt·etnentina ver.c hio, ori anc h -< f> - 10 ;!O<:ce d1 a cqua oss 1genata r·econ te tn en te p•·cpa rata. Si l e;.rgPrm en t e ìl tu t t i) v1 si addi z i o nan o 10-20 gocce d1 u11a al c·oo li ca di al oe l>orbados (cir ca del 7 "10 ) ; poscia !<i scuole fo rtem en t e. ·e nell'01·ina esis to no anche t r acc3 minime di !>oslanza colo rante del sangue non !'vclabili con l'e!'ame speltroscop i<"o . s1 ha in 1-3 m inu t i un Arro ssam(lnlo e\·iden t e J ello strato acfjuoso C. Q.
E. R EGNAULT. - Our& degU &ooeaal dl febbre p&luatre ooD UD& mletur& lodo ·lodura ta . - ( Reoue de nv>deeine , setlem bre).
È u oto come cor risponda al momento in c ui il p r' tnzoar to l"peciflco !'t m oltiplica p er divisione. P resi in q uel m o m ento, i, sa lt di cluuino, penet r ano t r oppo tar di in circolaz ione per po t er ag•re efficacemente. Cin c hH non l'lt può o tt enere con i sali di chinino, può. SPcondo l'11uto r e, aver e con l'u"O d• una roi !'tu r a iodo iodu rat.a. sriunse a l 11l conce u avt>ndo sperim enta i menie osse t·vat o co rna in oitro le t os!'ine s1eno o d i!'Lt·ulte od a ttenuale da una mistura io rlo- iool ur11l8, mentt·e l'iodio e l'iodu r o di pene t ran o nel torrente cir col a lnrto con tale r 11pid il.A da tr·ovar ne le traccie oelle u r111 e da quindicr a venti m inu tr dopo l'a l:;!'òunzione di Lah rim edii.
PArtendo da tali conce t ti, egli la r gameute la mis tura in parola sullo tru ppE' coloniali r·esid r nli nel T o n chino e su l'le st es!'o, quando da lla !'Omminls l r azlorw dei so li di c hinino non otteneva alc un
H imase sor p •·eso della ra pi di tà dei r·i su lt.aLi oltenuti: qu indici minuti dopo l'as:3 unzio n t:' d eliA mis tu r a in paro la , r il evò un mi g lio ramento m ar calissimo; scomparsa dei bl'ividi assie m e al senso tli leggiera an gosci a cito d i so vento li acco mpa g na, m entre la l'espirazione d iveuiva più ampia. e la pelle, che era sec• a e ca lda si l'i copl'iva di un leggier o umi< l ore di, entando fr esca adopera la seg-uen te mistura : T intura d i ioclto e i oduro di potass io: ana urammi IJ ttattro. -Acqua distillala g r ammi cento.
Som ministra un èu!:chiaio di caffè di tale mis tm·a a l principio dell'a ccesl!o un sec ondo c ucchiaio da caffè q u indici o venli minuti più tardi se tarda a produr·s t il

RlVlS'I'A MEDICA 31 7
l!n cucchiaio da c11ff'! contiene venti ce nt1,cr ammi •h iodut·o di po ta ssio e v enti centigrammi di tinl!u·a di iodio, vale a dit·e un pò meno di due CE>nlip;r·ammi di iodro puro.
L'uso dell'wdio e ioduri contr·o lt• febbri malariche non c una novità: ma tutti gli autul'i che ne pa r·lano consigliano la cura i od rea soltanto prrma dt>!.dr accessi o nei cast d1 mentre ottenne brillanti r 1,.ullnti ùal rmp1e!.!n Anche durante gli
La soluZIOne ioclo·to ·JuratB d.-,·e es!"er· C(lnsidet·aLA c:ome un co mplement(l del chmino e d••l bleu d1 m ... tllenfl. non comi'. un !"uctetlaneo. La chinma l'imane lo !lp ··Cihco della mnlar·ia, ma dev'es!'er pr esa pr·1ma dc>ll'apparirP della fehbt•e, in tempo per· l'evoluzione del p r otozo&riU; Altrettanto dtcasi del hleu di m etilen e. La so luzione wdo· iodurata imlicata al prinl'ipio dcllj durante l'accesso, sio che il tltinino J•n·so anteriorment e abbia avutn un'azione insufficiente, sia ch e, com e avvirue frequentement••, il mRiato, non p re vedendo l'acres!-'o, non abbia preso il chinino.
La cura iod o-iodul'ato non è di ostacolo alla assunzione dei Ili c h in in a onde preve nir·e glt ven turi ; soltanto la.«ciare l <•mpo, alla rn istur·a iodo-iodur!'llu. di scomparire in gran par·te, pe r• t•vi tarc le in<·ompaubililà ch imi che di t a li r1mecli. G. 13.
\Vu.LIAM SAvAI;e. - Enumerazione del leuooottl nella pratica glGrnallera. - (L rwcel, settembre
L'('uumera.:ione dei IE'ucociti stante la suA grande impo rlall78 ed utilità nella p r11t1 C1! dovrebbe es ..er !!empltfìcata al punto ùa r eude rla o q11nlunttu e nwdH:o pt·atico. Il m etof! o Tl10ma-Zei ss non può drrsi pratit:o percile ri<·hiede due ditfer enli operazi o111. una per la conta dct globu li r (}s,..i, l'altra pel' la conta dci lmmchi, e c1ò importa l' di due d"·erse so luziOni e d1 dt\'er·se pipelle, uolwhé In rwce.«situ di a,·er a disposizione una quaulitit tf1 Sll!lJ;!'ue piuttosto cnn>'iole r·e,·olc, lo c he !:<pecralmeute in certe cla"!:'l soci11 l i ò drllicrie ad otlf'ntlre, l'lfiulando 1 pAzienti di assng!!etlal'si a pr·of('ndo> puuture. quali sono ll(' (' llhlo quan.lo vo;!lia ot ten ere una di!>CI'ela quantità dr rr cort·er·e ad aspirazione o a cnnw nppunto ,. per· otlt• lll'l't' ri!-'ult11li Att endibili.
In vi,l» di cio, l'A. ha ce r c ato di stabilire una fornrula matematica ondo.> nppltcnrt• rapidamente il metodo tl1 Stengd (dt>!cr·itlo ampiamente m Ttrentictlt Ce n tw·!, Practice o( .\fetlicinf:, \'Ol. VII).

l di questo par·ecchi : l• Soltanto unA vollA deve ra c('O).:IIP r,;i i l Sl.llljXU(', giaccl1i> la stessa Jlt'epAr·azione S61'Ve p<>l' !a COIIUl dei !-{IO· buh hianclti e dei r o.- i; Soltanto una 11ip elln , ba::;la al h) Se iglobuli lmm c hi i"llllO uumer·osi i"i possono contAl'e nei quadnHini 111lu p;uisa dei r·11><s i; 4• Benché il rneloolo sia più esatto impiegando unn diluzLone a l in 10, tu ttavia RoùJisfscenle pP.r· la pratica.
Tutto cio impot'la non solt!lnlu una g ran de ecc.nomiu di lampo rnn onche tlil I'ISu llali più esatti del la conta falla con due ii!-epar·atl d1 sangue
tC<'O in breve il moù us fa ciendi:
Si nstt la pipetlll piccola del Thoma-Zei ss (•1uella che serv e per la conta Jei 1-!lubuli r ossi) e si as:pira il sangue more so/ilo fluo al segno L racc•ndo la di-
.:3JS TUVISTA MEDICA
l uzione con il liquido di T ùi sson, o con quello di Sherringlon. l globuli r os si si contano com A di r egola; per· i globuli bianch i si proceue com e segue:
Si solleva l'oculare lino a ch e il diametro del campo visivo comprenda un numero intero dr qustlralini (ossia in a ltr e parole finclte il limite del campo v i sivo a ::rti estremi di un diametr o, coincida cun i limiti dei due quad r·ati ni P.S lrem i). Il numer o dei quodra tini che sor;o s ituati lungo il diametro s i i ndichi con x

Si contano qui n ii tulLi i leucoci li c he si tr·ovano nel ca mpo v i sivo, senza t ener con to dei quadratini, e si r rpele la con ta per d iversi ca mpi vi s ivi, avendo c ura c he s iano -r ealmente e sempr e - compi nuovi, indi con una semp li ce divisione si o ttien e la media dei leucoc ili contenuti in osrni cam po visivo e <yuesta media sia y. (Come sempr·e la medra sar•à tanto più esalta quanto §!iore sarù il numero dei ca mpi visivi osser·vati).
L a fo r mula da applica re , esse ndo il diluito a l in 100 e: N _ 5,000,000 !l - l'l
nella •ruale N è il uume r o dei l e ucociLi per milli metro cubi cCJ
D ella f or·mula der•iva dal seguente calcolo: ;,: = numero intero dei quad r a· tin i contenuti lung o u n d rametro. Esse ndo il lato di un quadralifiO di millimetr o, il dìametr·o del campo vrsivo sa ré = ,;-' e quindi il l'it ggi o (r) = :r •
Rammentando che la superficie di un cerchio è r. (p X l a s u per fic i e rle l campo vis ivo sar ti ( r O)'Sia 2 7 2 X ( r giacch é il può 9'.> co n sufficier)te appr o ssimazione con la fr azi one7 • (ertuivol en te a 3,H28 in vece ol i 3, H16) Esse ndo la pr o fo ndità della camer·etla del porlaoggetli
uguale a 1 / 10 di millimetro, la c nbat1r r a tli un campo vb:;i vo l'O rà = ( 2 -;2 - X ( rX - / 0 ) di millimetr o cubo , e ques ta sa r·a l a quantità di sangue con ten ente i l nu· mero 'l d i I eucociti , (es!'endo !J la m edia tro ,·ata conlaudo i l eucociti in parecchi campi)
Da ques ta equazio ne pa!'<sa alla quantità di leucoc ili co nt enuta iu l mil7XWX40XIO X't 56,U01l tt lrml'tro cubr co, uguale a -· = 11 x ' -' , e rl sangue fu dilui to a l p cenro, mollipltcure pe1· cen to, cio é u .;are l ' cr[uazi o nc trovata da l l'A . cioè N= !j .
Ln conta dei Jeuc ociti ri esce facile perché es>it s on o co l o riti dalla sol uzione impiPgaLa per la diluzron P..
La formula del liquid o d 1 T o isson é i ufalti:
M eli! viole tto. .
Cloruro di sodio.
So lfato di sod io Glicer·ina . . .
A c.:{ua distillata
gr. o 1
» 8 )) 30 cmc.160
soluzione non si mantien e a lun go , deve c•ssere perrettamonte chiara e po3c:ibilmen te fìll r a t a g iusto al mom ento di u sa rta. L. F .
RIVISTA 319
P A. PREOI1RA,..cHeN;:,Kv. Per la oaslllttoa delle paraUsl ptomalnlohe . (l)eulsche Z eitsclt r i.fl .fiir .\'ercenkr. 1902, Jt;:,pensa :l).
Una donna d1 4U anni ed il figlio di quindici in seguito ad abbondante indi pese_, (bRrlJo) e di alteralo, ;:.ubi•·ono 1111 processo di vera iulo stcazioue, nel qual\', ct6 che é im 9ortant e ed estremamente r a r o, m anca· vano i d1sturbi initiali acuti gastro-enteric o, mentre furono ;;:picca ti ssuni ' lueila nervosi.
Questi ri co•·davano in parte la m 1astenia ed in parte una poliencefalomlel ite ( tonica). Qua!'i Lutti 1 muscoli del corpo e1·ano colpili d a fatti t••tanici, ma qui'Jii inne1·voti dai nervi cervic!l li (mu.,coli dt-IIA cleA"lutizione, maslicazJOnl!, ra,•ellu e de>(li occhi). estre mità supl'l'iori eo l i mu!'coli de l cinto scapola1·e. uon cht! gli eleva t ori delle l>palle, erttno colpiti in 1110do piu senSibil e infer1orL Tale stato tetanicn muscolare si sviluppo in al cuni in direzione discPndPuLe (cioè clall'alto Al baso:o). Mauc avano ass:>lutamente disturbi di sensibil tth, e disturbi psichici, vescicnli e dell'tnlestinc t'ello. fu•·ono le asten ie ne osserva te nel della malAttia. Dopo t•·entR gio1·ni. ambedue i malati cominciarono a migliorllre•·a!Jitlament e, ma ;o.o ltanto dopo novanta gto1·ni da lla snbil a intc,ssicazìone rotevansi con,:;iderarf' co m e perfettamente guar·iti. G. B .

.lAME!'\ HuRNP.T . - La cura medloa dell' appen41olte . - (Lancet - oliolire 1902).
Il consiglia di operare in og-ni ca!>o nel quale non si abbia un miA"Iioramento dentr o le 48 ore <>al massimo dentro tre giorni, e questo consiglio e dal med1co d'ospedale. Nella pratica privata se il paziente •·•fiuta l'operuzione, che cosa può fare il medico per giuslifica1·e la sua pres<>nza a l letto del malato ? L'a sserzione di Osler «non esiste trattam.:nto medico per l 'appendicite i· troppo pessimis ta.
Per il dolor·e, qualunque ne l"ia la sede (addome in totalità, fossA ilia<·a destra, r<•gione 1ombere) o il carattet•e (sord o, colico) \'A ha trovato effìcacisl"ime le fo:nenlazinni di trementina r innut>Vandole senza tJ·egua non appena si raffre ddano. Applicandole invece ad intervalli non ftuwo c he accrescere il mai Pssere. Il lol'O uso va cv nlinualo fino a che il dolore e cessalo. il citt1 a v. viene di rego la dentro le 4-8 ore. In segu ito si può tornaro alle romentazicmi pe1· aiJ evi ttre il dolore lanciuaule seguita talvolta ùun111Le i pri111i g1orn i della malattia an c he dopo la cessazione del dolore uculo.
Al cuni medici pl'<'Scrivo no le fomenlazioni feniche, ma queste sono mal,;iCUI'a n elle mani di infermieri inesperti.
L'uso continuo del ghiaccio, lodato da m o lti pt·atici non é scev •·o di in convenlenLi.
Anzitutto diminuisce la sensibilità cosicché al m ed ico uno dP.i criteri pPr !leguire i p•·ogressi rlella malattia . I noltre il Applicalo a lun go, ditmnutsce la •·esi!'Lenza della parte, cMa da evi tar·e su tessuti gia pe1· sé doliceli e facili a necrosar si. Come rsg-ola poi è da notare ch e i pa;denli ri sentono maggior sollievo col caldo anzichè col freddo.
l ves cicAnli oggi gioruo sono abbandonali, e lo stesso va vel'ifi cfllldosi per la tintura di jodio. L 'uso dei cataplasmi, COi nmendevole secondo varii scri llori,
3211 !H VISTA
quando l<i stia f01·mandù la nlccoltH marcio!:'a , è dall'A. conrla11n8lo come ca· pa ce di indebolire il paziente.
L'u so di morfina anche in min i m e rlosi capaci appena di alleviare il dolore senza produrre 11ssopimenlo é pur es!lo condannalo dall'A. pe1·ché spesso può tu r·bare la di ges tione P.d il polso, e pe r chè i pazienti si comportano nel m odo più svariato di fronte acl un tal e farmaco
La nausea ed il vomito J i rad o o llrr il secondo giorno eccello n ei g r u vi ra si n ei quali in so r g a pPritonite, ad ogn i mod o po ssiam o co mbattere tA l i si ntomi con somministrazion e di ghinccio o 'cii bevande e prin· cipa lmente con appo!->ita d1eta Il vomito si tiene a bada da 0.80 a 1.20 di liquido di cascara (f. i.) ogni sei ore, tin o H 2.50 - 4 gr&mmi m•ll" v anlifJualtro M e. Ove si Cl'eda utile, ad ogni dose potranno aj!giunfCel'si 30 eentigr. di tintura di belladonna (f. 1.) .
Le dosi d i cascara sono stomachiche e n on 11giscono ch e !':ull'int es tino, cosicche sono se11 za dann o rrualora d ate con pruden:z:a all'in i zio della malatLia.
Lfl fr Pquenti miUurizioni sono un !'in to m o noioso sul rtuale g li ordinari libri Ii i 1es1o serban o nn per fetto P. c he tuttavia P. d 'uop o comballc re 11er IH ca lma d(! l pnzrentP e m er itarne la fidu cia .
A quf's to fine l ' A s i serve della tinturH di !fiusquiamo alle dose di gr.1 .80 P<''' o vvrar·e norr solo alla frequenza del m •tto , 111a anche allo sensaziOJae che lo occo mpagna. Questo s1ntom o de l r esto non dura oltr·e il l ei'ZO o quat'lo
La cefalia é un allr·o sintoma cornunissi1110, esace r bandosi verso sera , bruo pul santA
dE'Ila fenacetina l'A. credH eire r isponda la Vt!s cica di ghiaccio.
La nutl'izio ne de l pazient fl •·ichi ede s pel:i ol e r·iguordo. Nece ..sario é l ' uso di una t a1.za a b Pccuccio ond e il n o n abbia a fare il menouro movimento.
L'A. prescrive un cuc c l naino da cafTé di di bue due or e, alternHto con un cu cchiaino da caffè di cog nac nell'intervalli ; e !alle co n d'o r zo o a cljue aln l!in e.

La sete s i co rnbRtte con ac qua c alda o facendo s ucchiare pezzetti d i Rhiaccio.
Il latte 110 11 diluito pt·oduce abl tufll rnente e dnlot•i per distensione dello stomaco e degli i ntes tini.
A nrhe dopo ce...sala la f ebbr e e t orn ata la t emperatura al n ormale bi sogna es.,er molto ca uti nell'aurnentare la dieta, cominciando con mines tre p olla cee.
Ca lmati i dol ori o pPr l o meno dim inuili si l'icopre la parte infiammata con co tone t rH tt enuto da l eggP.ra fasciatura.
Si de ve co n sigliare il paziente ni star fermo pee quanto é possibil e, giaceu !o sul dorso , giammai sul Ranco sinistro, giacché in taln po· i:' tZi one l'ap pe ndice vieue ad e&sere s tirata . L. F.
D ott. RoLLt::';TON.- Albumtnurla lpoata tloa 41 orlglne aplenloa . - (Lanc ct, marzu ).
Falkenheim ne l 1R84 (Deu t. Are/t. jur klin. Med. ) descriss e un caso di albuminur·ra inlermittente in un uomo rli 50 anni , da c irrosi e patica con ipertrofla splen ica notevole. L 'albumina si r iscontrava soltanto dopo che il pazi ente aveva giaci uto in letto s upino o s ul fianco si nistro; non s i riscon21 - Giornale medico.
RIVlS'rA MEDICA 321
tra ' ' A SP il ma l ato tl eco mbeva sul lato des tr·o ovvero bocconi. Da c i ò la spiegazione che l'a lbuminuria f•l l'Se dovuta al fallo .mecc anico d ella cornpr essrone e!"el'<:itata dalla m rlzH !<Opra la vena reuale !'!Ìrll:.<tra.
L'A ha seg uito tre ca i ne' quali o ccorr evtt lo sle$SO fallo I n uno trail ava di ova nzat.n p;li til lri due erano m a iali di cr rro si epatica con ipertrofia splenic a l'uno. eli a nemia !>plenic a l'altro
L 'uri na o ltre essere a l bumino sa era intensamente col or11ta com e l'uri na da !>lA $1 d"ll e ca r dio patr e E' bene ten er la possi bi l ità di tali a lbuminude lra n:;ito rre m ecc ani ch e o nde non gabellare se nz'altro come albuminurico un paziPnle 111 !' eguilo ati esame praticato so pra un cam pione d' urina t o llo dalla quantità t otal e emessa nelle 2i ore, qual'é O!'drnariamente il s i stema in uso n e:::li osped ali
Am: h e esam i nando l ' ul'ina del mattino , i risultati po st> ono val'ia r e òa un g i orno All'altro , o secondo del decubito t enuto nel so nno.
L'albumina tran s rtori a in oltre non è fallo co stante nell' iperlro tla >'plenica, n t\ d rpc ndc dal grado d i i pertr·ofia, pote ndo aver·e piuttos to relazione col g ra do Ili t•rla!' c iam c nto dei li!lamenli peritoneali che t e ng-o no in la milza, pt• ec n m e avvie ne per i distu r bi da rene mobi le. lno llre secondo l' Aut01·e potrebbe avet·e influ enza an c he una qual c he alte razion e r enale, e he, lat ente allo stato normale. fat•cbb e t•i!<entrre ltl nzione n o n a pp ena v1 si uniss e l'ingorgo ven oso. Di l'alti in uno d ei c asi os sec·vau, l'a l buminuriA tran s itoria era sco m parsa dopo un pc.ri o do di d egenza 11ll' o spedale , per ri comparire poi do p0 un lie v e u l lacco dl influ enzA
L ' AI!)urninuria i poslati ca si co m po t•ta proprio all'oppo«Lo della al b um i nuria c i c lrca , lullavra no n e dello che non po!>sano ca s i di '1UCsta ultrma. quali l'albumin uria a pp Aia quanJo i l pazi en te s ia cori cato e scompaia d urAnte la s tazio ne La di tal! casi puo ammelle r s i in S"guito all e re cenli dr EJ !::l ( Mùnch. m ed 1902) dim os tranti ch e nell'albuminul'ia ci c lica, l'apparizione dell 'albumina è colles.ra ts alla d ebol ez za d el po l so cosi cché !>6 co n regola t o e ;;::<- r cizio musco l are si sialza la funzio ne cardiac a. pu ò otleners i la scom parsa d ell'albumi na in s i eme co n una più copiosn ù i ure" i.
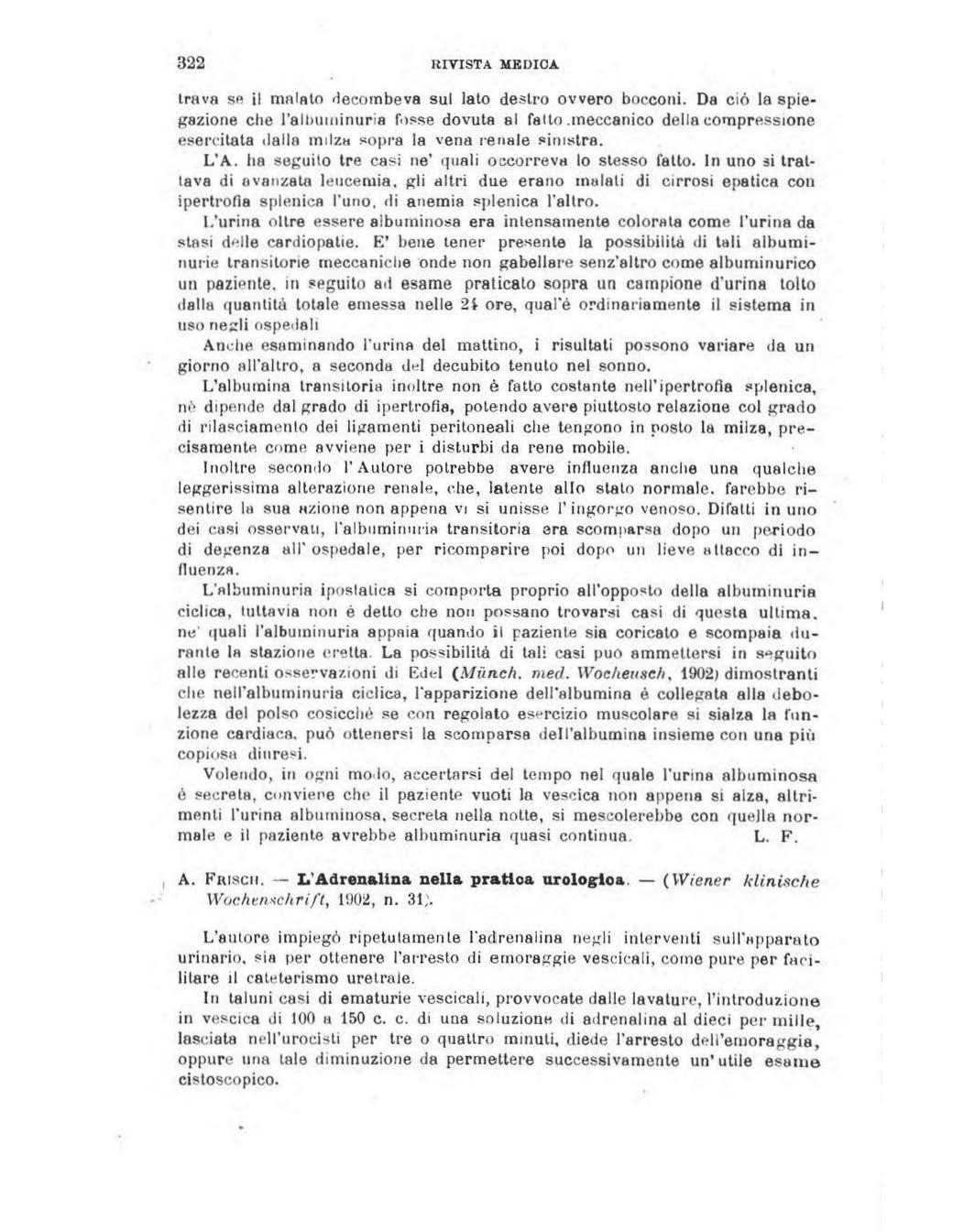
V ol endo, in m o IO, acce t tars i del t empo nel f) Uale l'urma al b um i nosa ò :>ecr ela , con v i e Pe Ch f' il paz i entP vuo ti la n o n a ppena se alza, altrim e nti l'urrna al bu min osa, sec r·eta nella no tte, s i mescolet•ebbe con fJu eJia n o rmal e e il pazi ente avreb be albuminuria flUS s i co ntinua L F.
A. Fncscu . - L 'Adrenali na nella pratioa urologtoa . - ( Wi e ne r klinisch e I!J02 , n
L 'autore impi egò rip etulamenle l'adrena l ina n egli inte rventi sull'uppa r alo urinari o $ia pet• ott enere l'al'l'es lo di ves c i t ali , como per f tH' ililat•e ti urett•a Je.
In taluni c asi di ematuri e Yesci calr, provvocale dall e lavature, l ' inll·oduzione in v e!'crca Ji 100 1:1 150 c. c d1 una so luz:ion11 di adrenalina al di ec i pe r· mill e, lasciat.s n ell'uroci -; ti pe r tre o quattro mrnuli, diede l 'arr·es lo d Pil'emoraggia , o ppure una tal e d rm i nuzione da permettere s ucces sivam ente un'utile e same ci s tosco pico.
322 RIVISTA liE DIOA
LA sles"a soluzion e devesi impi egare per l'estirpazio ne endoscopica dei 11eoplasmi. Nell'es tirpazi one dei neopla!'mi, prev1a cisto lomia, il tamponamenlo COn un po' d'ovatta imbevuta in unl;l sol uzione al mill efl imo pe1•mette di oper Are su di un campo perfellamente dond<:! fa cili tata l'aspc•rtazione completa del tumore col suo peduncolo e la ric er ca dei ueopla smi minori vicini. Ma tale·az.ione è bentosto da una bisogna quindi praticar e un'accur ata sutura della ferita oude evita1·e emoraggie consecut•ve.
L ' 1stillazio ne di qualche goccio di una so luzio ne nl millesimo nel punto dove comincia lo stl'ingim ento uretJ·ale, facilita molto il cateterismo; ugualmente ne l!'i pertrofìa de :Ja pros tata, un 'i st illazioue di uno a due cent. cubici di una !'Oluzione al millesime•, facilita d ella !!'Onda , impedendo il s anguinare dell'uret ra. Da ultimo l'auto•·e usò l 'Ad renalina in tre casi di r ilenzion e uri n osa acuta co mpleta datanti da C[ li alc he giorno; dopo l' i s t i lla zi o ne d ell'a· u rennlina al rnill e!Simo, i maiali, in capo a. quattro o cinque minuti, pote1·ono tlfl't! lLu a l' e una minzione volontaria, apprez zabil e, pe r quanto incompleta. Co n linuando le insti ll azioni, per pAt'ecr.hi g iorni di seguito, s'ebbe una completa gua r igione, ottenuta in maniera mol to più ra pida dell'ordinario. I mpiegò sempre 4a c:eguenle

HAENEL. - Delle lpere ateale outanee nelle m alattie del vtaoerl addomlnalt e toraolol . - (Mii.nchener m edie. Woc!tensehri[t, n. 14).
L 'autore, ri cercand o i territori i iperestetici segnalttti dall' H eaJ, li lta generalrnente trov a ti: Egli adope1·a la s te>< sa lecnica di tale autore e spt•sso usa , pe r ricer c are l'iper es t esia, la sP topli ce punta di una ma ti la; cosi puri:!, egli asser •sce che una de bole corrente faradica pet·mette di rilevar·e l'ipe re stesia Nelle sue ricerche ebbe cu ra d i eliminare i presentanti stigm ate d ' i ;;ter ismo, pure •1uelli tro ppo gio vllllÌ o troppo v erchi
Co si polé const atare come nelle malAlli e ùi cuore, nello s to maco, dell'intesti flo. d ei polmoni si l r oviuo l'I'Ai m en t e delle z. m e i per es te ti c bc s u lla pel le; ma t:> ll zone non ha o n o quA;;i mai la s tesooa topografia El'se !SOno pe rtlno da un g ior no all'ultro, tla un'ora al l 'all!'8; ;.pes!!'o mancano del lutto
E s tuù l8ndo le vari A m o rb•JSe ;;otto tale t apporto tr ovo come : Nelle tube r colosi polmona r i sia imp ossibile da re una l eg!]e generale. Spesc:;o .al principio d i una tubercolo s i polmonare ri contra si un tratto c utaneo iperestetico dove la per cu!Ssione e l'a scolta zi one fanno r ileva r e il maximum d elle l e;;ioni, ma tal fatto non é cos tante.
l tube r col osi dei dolol'i cervi cali o intercostali c he, spesso sono accompsgnati da ipe!'es tesia cutanea.
In una fa se ultel' to r e dt tale affezione, quando la fe bbre etica è pPrmanenle, non osservans i più iper es t esie cutanee l ocalizzate, ma bensi dell e v er e inter·costali, nei quali casi si po;;sono ritro vare i punti d o lorosi del Vall c ix.
E saminando, solto tale aspetto, val'ii malati di p n eumonite dell'apice e della base, percuotendo sul lato malato, pur ri s vegliando, com e é ben natura le un
RIVISTA MEDICA 323
soluzione: Cloridrato d'adrenalina Cloruro di sod io Acqua distillata 0,10 0,70 . 100,00 G. B .
dolot'e un po' più vivo che .sul lato sano, non l'iuscl mai a li m i tare un vero. ep,·oprio t eJTilOriO !5egmentario di iperalgesia. Eguale ri sul tato ottenne in casi di enlìsem11, di bronch ite cronica, di dilatazione dei bronchi e d i sclerosi polm onah.
T r ovò invece iperestesi11 cutanea nelle affezioni cardiache con distu r bi di compen!-o. Nelle malattie dello stomaco trov ò zone iperestetiche nella proporzione del 49 per cen to. Egli dice non estslere alcuna f r a le malattie organiche come l'ulcer a e le malaWe funzionali dello stomaco, nè i n ra pporto a lla fre!Juenztl dell' iperestesia , n 1> in ra pporto alla sede ed all'estensi one delle zone.
I n cmque ca,i d'ul ceJ'n ddlo s toma co con emorragia, mancava il dolore e con e.sso l' iperestesia N eUa m età det casi il lerritorto i per a l gesico s upera va i limiti segnati allo stumaco dall' H ead
I nvece l'autot'e tt•ovò, nelle affezioni gastri che, 1.1n pun t o speciale do l oroso alla faccia postet·ior e d el mu.:;col o deltoide.
Da u ltimo A"li accidenti a cuti che supravengono da pa rte dei vi sceri so tto diaframmotici, ed in particolare la pe•·fo razi one deilo s t o ma eo, >iOIIO accompagnati da un dolo•·e avente sede ne l t o r ace (dol o r e dorsH i e, s<: apola•·e, inte•·sc11polar e).
Nei cosi di peritoni t l.l genel'alizza ta d 'orig-ine sconosciuta, la p 1·esen za di tal e dolore t orac i co ha g ran de importanza, essendo esso causnto co 11 molta pt·obabilit.A da l esio ni dei visceri soUod iaframmatici, accennando specialm ente ad · una perforazione dello stomaco; tal ché, vol endo intepvenire a ddo mi nale portata sulla r egiu n e epigas trica.

Da ciò ri s ulterebbe che l'oppo rtun 1 t a di un'intervento o rneno potrà da lla conoscenza di lu!i dolori r iflessi , quando essi si pr·esentiuo con una g r Hnde rost anza.
G. B.
[lotl SAUNouv e dott. Ru ss&r... - Olan oll oroulo& l ne •plloabUe. - ( The Lanc et, febbt•aio 1902).
Gli A.A. consrdrrano il raso da es!:' t descr rtto e alll'i tre descr itti n el Boston M edica i Jou r ttal (drcembre \)!), marzo 900, g11J:,rno !lùl) come llppar teuentl ad una nuova en tilit clinica, non ancora aualomicamenLe l siu t omi p1ll salienti sono: la ciano.si, la debolezza muscolare e del numet·o delle emazie.
dalle quatt1·o s t o ri e cliniche i caratteri comuni, s i o vrebbe il quadi'O nosogntlico:
T utti i puzient1 aveYano piu di 45 anni d i età Il sesso non h11 inliuenza.
Tutti pt'esentavano cianosi es trema.
Tutti pr esentavano g r Ande aumento dei co •·puscoli r os;.i, financh e al doppiodel nor·male La emogl obi na p ure aumen tala, ma n on in proporzi o ne dell 'au· delle emazie· l c o r puscoli bianchi in num ero normale o appena di poco
In tutti l e urine pt·esenlavano Lt'acce di albumina con ci lindri ialini.
In tutt1 si noUiva inieziOne delle cong-iuntive.
In 3 malat1 i si n tomi predomindnti erano la debolezza e la pros trazione; uno dei tre presentava i noltre angoscia pr·ecord ia l e e palpitazione. Il 4 • so ff l'iva d i di spnea .
324 RIVISTA MEDICA
I n 3 vi era l!rave cefalea. Notevole ingrandimento della milza e piccolo aumento del si osservarono put•e in 3 pazienti.
In due casi si ebbero e m orrag ie gengiva li.
Ugu alm ente in 2 macchie pigme ntarie sulla cute.
I n un vi e r a Itterizia.
Stante la sca r :>e7.za J i dati anato mo·palologici g li A.A . non espongono alcuna ipole!"i circa la natut·a Ji tale infermità, limitandosi a riconosce r e Jq somiglianza c.:o n i due r-asi di cranosi con,aenita con iperglobulia e senza lesione -cardraca, r ecentemente rifer•ili dal Weil ( Semaine méclicale, luglio 1901) in un o dei qu" lr vi era an che ipertroMa splenica con marcate alter•aziuni del timo e de l midollo os'>eo.
L'e!';Lrònla debolezza mus colare pol!•ebbe altresì far na scere il che ros:se dovuta ad alterazi o ni delle capsule soprar enal i.
Ciò pre•nAs!'o , ecco per le maggiori particolarita un della storia -del caso s lud ralo A.A.
Il paz•Pnle, di 48 anni, fu all'osp ed ale di Birmingham il 24 aprile 189 1, pe r males!:'ere gene rale e dolori per tutta la persona datan ti da 5 ; raccontsva che da flUSsi :1 mes i n on !:'i sentiva b ene e soffriva di forti mal di capo. All'ospedu le si ri scontrò tumor ùi milza. tracce di albumina nell'urina (avente una densità di 1010) e null'altro, s alvo un'a bno r me pigrnen tazione alle mammelle e qual c he chiAzza di pigmento al tronco.
Il paziente fu dimesso il 16 maggio guat·ito, rimanendo tuttavia inalterato il tumor di milza.
Nel gl!n nai o 1898 Il paziente fu riveduto e riammes!'o nell'ospedale . Presentava allora cianosi pronunciatissima, ed dolori alla tes ta e per tutto il co rpo, sopratullo a destra, datanti da G settimane. Già da circa 8 mesi an dava peraltro sògtretto a dolori addominali pit'l forti al mattino che non avevano r e lozione coi pAsti e che cessavan o nel decubito.

L 'ana mn e,oi raccolta con cura fu di poco aiuto La madre era morta di tubercolosi. Il paziente, salvo la b r eve infermità pe r la quale era entralo allo ospeda le nel 91, ri co rdava soltanto una breve itterizia all 'e tà di circa 30 anni. una febbre gastl'ica a e una infezione sifilitica a 19. Aveva semprç condo llo vit.s. co moda e senza Soltanto da un paio di m esi aveva cominciato a dimagrire fl a sentirsi dev ole al punto da non potere stare a in piedi o alzarsi dopo essersi c urvato, cosiccllè aveva do vuto smetter e il lavoro.
Una notte anzi, essendo sceso dal letto, era caduto a terra rimanendov i disteso fino al maUino p e r incapacità di muoversi. Quanto all' in ser ge re della cianosi non poteva stabilirne la data.
Durante la degenza nell'ospedale il paziente si mostrò apatico, risp o ndeva con lentezza, l'attenzione e la mmoria e rano diminuite, la fav ella impacciata.
La te mperatura e ra subnormale ; la faccia cianotica !:'pecia lment.e il naso; le dita eleva te; le congiuntive iniettate; le pupille miotiche.
La cute del tronco lieve mente pigmentata specie n e l lato sinistro, la parte inferiore delle gamba chiarame nte bro nzina. Le vene superficiali dell's.ddome dilatate.
La milza giungente nno alla linea mediana, a:la allezza dell'ombelico, era dura e alquanto Lesa.
Il margine infdriore del fegato sporgeva di poco piu che un cm. al disollo costale, lo regione della ci!!ti fellea era alquanto l6sa.
RIVISTA KEDICA 325
Il cuore era normale, il polso in media 96, molle. L'urin a albuminos11, della densità di 1012 , con epitelii e leucociti ma cilindri, in quanti tà dt 1100 a 1500 eme. gio rnali eri, con una media di circa 26 gr. d'ur..a.
Il 1.' ftlbbraio la conta dei globuli r os.-i dava 9 milioni, senza aumento dei bianchi. La H b era 120 per cento. F orma e dirnensaone delle emazie normale. Non ollenendosi verun fu dimes<>o il 20 marzo, ma 4 fZiO rni dopo fu riammesso essendo caduto in di assopimento. La cianosi e ra crescaula e vi era manifesta itterizie. Il malato era ancor piu apati co, ris poaadeva appena e pt>rdeva le urine senza accorgersene. La conta d e i jZlobuli ro!:'Si p raticata il 25 marzo dava 7,:360,000.
La temperatura era 36,8. Durante i giorni seguenti le cose peggiorarono, la cianosi crt>bbe, meratre l' illerizia dimanui va, e il pazien t e m o ri 1'8 aprile.
Alla u ec ro{'sia si trov6 il cuore ipertroftco specialmente nel ventricolo sinistro; la mitrale pt•esen tava altet·azioni di v ecchia data.
Le pleure erano aderenti, i polmoni in go r gati. Il e i rem tngrandili, ancot• più la Le capsule soprar&nali. ro sso bt•une, piccole e mo ll i. I l cervello Il midollo osseo norma le ad occhio nuùo. Il timo non fu is pezioraa Lo.
Cosicchl', contro le speranze nutrite, l'esame post morlem non diede alcun lume diagnostico.
Or. o· SULLlVAN·BEARI:. - Un rlme41o ln4tseno oont ro l a febbre e mogloblDurlo& . -( Tht Lancet, febbraio).
L'A., vicP.-console a P emba (Africa orienlale), ha sperimentato con successocontro tale malattia il t•imedio impieg alo dai medici indigeni (waganua).
Il rimedio co n siste in una di rad ici di una specie di ca!lsia che vegeta n ella Est-Africa equatol'iale aal Hvello del mare fino all'allltudine di caa·cn 700 metri.
Q uesta nu ova specie del gene re Cassia (ord. Legumioose) é stata descrilla esattamente nel Pharmaceulical Journal (30 oov. '90 1 e 18 gen. '90::!) da E M. HolmE's, curator e del Museo della Sociela farmaceutica inglese, sotto il nome di Ca.qsia Btareana in onore dell'A. La descrizione è qui riassunta : E un alber·o alto òa 6 a 10 me tri, sottile, con foglie composte, lunghe da 20 a 25 cm. fot•mate da 8 a 10 paia di foglioline, elliliche glabre. Fiori piccoli, giallo-canario, venali di ro sso scuro, disposti a corimbi. Baccello lun go circa iO cm, largo 2 1/ 1, !>pesf'o circa t cm, glabro, sepimentato, con semi ovali nerastri, non cil'· condati da polpa. È mollo simile alla Cassia abbreoiata Olav. ma ne differisce per avor la siliqua pialla e glabra e i semi ovali, e pet•ché g li stami Juugha pre...;e··lnno a metà un ri go nfìamerato.

I l metodo indigeno pea· preparare il decollo è il seguente: Si tagliuzza una pot·ziono di r·adice tn pezzi da 2 a 3 c m tli e una di q ues ti si fH bolli r e per circo mezz'or·a in 4 a 5 litri ùi acqua. N e risulta un liquido ro•M., c uro che f'i :<omministr·a al paziente in dose di una tazza da té ogni 2
op pure ad libilum se ha molla sete.
Lo sles!òo de cotto é adoperato an che nei c a si di ema turia semplice - non febbrale - ..:he é tanto comur.e tra i negri.
326 RIVISTA :W:EOJCA
L. F .
L a co•·teccin dell' albero ben po l verizzata è pul'e usata per· medicare ulce ri, sembra con buoni ri s ultati .
L'A. pr ocurato!.'i g rAn quantità d i •·Aclici, ne fece pre parare un es tratto fluido concen trato id r on l coo lico rlalla casa Christy e C di Lond ra e con qu es t o ha prati cato numerose <> s per1en ze teropeutiC"h€'. associandolo o sost1tuendolo alla deco zi one in rlige na, la crual e dt>l l'esto , parimenti efficace. l risultat i otte uuti ott i mi ; e m o llo incorag!'ia nti ,;ono quelli avuti adoperando lo stesso r·iJnfldio, contro la febb r e remittente nella quale In cbiuina si dimostra p1i1 dannosn che util €'.
Tale malattia abbaslanza comune ni!II' Afr·ica orientale co mincia con m a lles gen er a l e, sP.guito preo;to do ci! falt>a front11le e rla dolor·e so r lo ai l o mbi. l muso1n LuLli dolenti c ome se il puzient·1 fo sse s t nlo bastonatll, la s i r icopre di speS!Hl patina, vi è co ns tipazi on€', r·aram ou te biliosa. Costante i> la n>rusea e il vomito. La t e rnperatur!i eleva g-ia al I·H'incipio dell'attacco tlno a lflo e piu, ed ff'a fJil e'll O mass imo e un minimo di quasi 38°. S pe!'\sO hanno sudo r·i profusi che, tutlav a, n o n nbbass1:1nil la temperatur·a. Il pazie 11te emf'lna un odore ac ido, caratteristico della malattia. La cong iunti va, la c ute sono di colorito iller·ico, e così le urine.
Quan to ali .. .febbr e emogloiJi nnr ic a é n ••to che i s u oi sintomi ca ratteristici sor1o 'JUallr•o: l pe1•termia vomito, i tterizia, e colorito bruno delle urin e Quest'ulti m o è dovu to alla presenza di H b o meta Hb, ed è cnsr im pr essionante da Aver se r vito di base per il nome vol ga re della malattia nelle c olonie •nb lack water feve r
La cau sa ùel la malattia è una t ossiemia con emolitici cosl estesi c he il f.:gato non basta p i u a tra sformar·e Lulla la H b m essa in libertà, ma ne laia sfuggi re una parte p ei reni, i quali divflngono per·ciò sede di nefrite coQ i (Olrave talvolta da condu1·re all'anuria e c on seguente uremia.
La perdita di Hb, l 'u ltn e il vomito incoercibile provocano una pr·o fonda de pl'essio ne del !"istema n ervo so, c he, unita ai danni dipendenti r ende la mnlaLlia in discorso una delle più formidabili.
Quanto alla causa prima é ancora incerta. La cachessia m alari ca é certauu! nte una causa predisponente, mu l 'ammini strazio ne d i c hi nina contro la mala•·ia non l'avu ri sce la febbr e emoglobinurica come vuole il K ocb
l nfalLi l'A. ha v eduto detta febbre i n indigeni m ai c hin•zza ti, c ome pure Ila veduto r estal'lle immuni ind igen i ed eur•opei malarici e chin i zza ti in Zanzibar· tJ Pemba e viceversA esserne colprti dopo c o m piu ti nelle re gioni dove la febbre emoglobiourica in m odo quasi e ndem 1co '
Fmo ad o r a l'ar·senale terapeuti co si era m ost rato inefficace con tr·o tale rualaaia La c!Ji niua può convenire nei casi associali 11 malaria 1n atto, Altrimenti r i esce piu dannosa che utile, il ch e trova s:pi egazione n ella dc K o ch ch e , c i oè , l a chinina eser cr ta un' in fluenza d i struttiva sopr u le emazi e malate.

È utile la ch inina altresì come i ndiretto profil at tico, in q uanto che, impedendo la co m par sa di g ravi infezioni malar ch e, si rende m eno p robabile l ' insor gere della emoglobinur·ica. Altri rimedi il cui uso già a priori non era saldamente ba8ato, son già da temp o tra scu•·ati, come il tannino, il perclorur·o di fe rro e Cosi l 'acido bo r ico propos to come antise ttico Non r·Psta perciò c he au g urars i c he altr1 sperimentatori sia no concordi nelle concl usioni d ell'A cosi favorevoli al nuovo r imedio
L. F
RIVISTA M !!:D ICA 327
E. NEPAU. - Importansa dell'e•ame del nngae nelle &4'edolll addomln&U - (The Brit. med jour., novembr e 1902).
Dopo una lunga esposizione dei v arii processi di tecnica emetol ogica e de• caratteri (Ielle differenti !<pecie di l eucociti, l'aulo•·e espone i ri sulta t i fornitigli dell'esame del s angue nell'appenrllci te.
l n-22 ca si d'appendicite acuta, il numer o dei leucociti era i n m edia d i 27 ,900 pe•· millimetro cubo; di essi R4,9 per 100 erano poli nuclea r i e 0. 4 eosinofìl i l n H casi di a ppendicite s ubacuta o c ro nica. lA l eucocit•)Si era soltanto di d i eu• il 63,1 per ceu to di polinu clee l'i e 2, 1 d i cosinofìli. De ult• mo, l'esame di 5 casi di appendicite acuta. fa llo dopo l'operazi o ne, prime della pa rt!! nza del meleto dall'ospedale. d1ede ri sulta t i identici a 'f Ueli i r iscontrati uell 'ttppendicite cr onica (10,5()(} leucociti, 60,1 per CPnto di polinuf'leari e 2,5 d i eosinofll i).
Da ultimo, l'a u to r e, dA i ri su ltati dell'esa me ematologi co t.li allr• 13 ca's i di affezi o ni dcll 'otldo m e a ll'infuori dell'ap pe ndic ite Osservò, in ge ner·al e, co m e i • numero dei pnlinudeari fosse m eno eleva t o e quello degl i più e levato che n ell'appendicite t1eu ta.
L'autore è del par ere che il chirur go, thlvanti d i uu'eppendi cl t e, non s i debba pl'ivare di u n dato c os ì importa nte c o me ')U ello, fo r nito in t ali cAsi, dall'esnme del sangu e. G. B
F . S rRADA. A. PASINI. - Bul valore del metodo Plorkow•hy nella 4lagDolll baoterlologloa del tlfo addominale . - e delle cliniche, n 6, 1902).
E' noto a gli sludi o"'i il m etodo con;;igli ato ria i Pi orkow;)ky onde s tabi lire una d iagnosi dilferenziale fra il bacillo del Lifd ed il bacteriu m coli (l). Secondo quest'autorP dopn sole 20 o r e le colonie del bacterJUm coli si differen· zi er ebber o da q uelle del bacillo del tifo perché queste ultime presentan.st più piccole e Lrasparenl•, fil amen t ose e con numer osi prolungamenti peri f t!t• ia, talv olta d i lunghezza doppi11 olel d iametro d ellt1 Mlonia. Gli Rutori riscon-. Lraro n o su 2} <"asi d' in fez i one lifos11, com e 20 voll e il r epe rto, co11 l 11l m t>todo fosse nettamente posi ti vo, contr ollando le l o r ù e"pe ri cnze anche con la prova de l Vi dal.

ni levaro11o com e 1111a delle maggiori rliftìcoltà del m etod o Pio r!wwsky fosse quella di dover mantenere le col ture a d una l em pe r atut'a costa nte 1ii liquefocendo,.i, com e è n o l o1 la gelatina a 23° e r·• t artlanclosi notevolmente lo !>vilup!)O delle t:olonie ad una te m pera tura inferi ore ; perci ò consi g li11no l'a s.:gi unta di picco le quanlitA d i agar, 0,3, 0 1•· ottenen do cosi cho l e coltur e piall e si manten g ano solide Ono a 2'•0 -26'.
È 11ecess ar·io c he l'o rin a impie,ra ta pl'oven ga da individu• a die ta p t·ev al entemente v eRelale, ::iò c h e fav o t·isce la con secu tiv a spo nLan ea tr asfo rmazi one d eii'Ot·ina da Mida in a lcalina.
(l ) preparazione ne è la Orini\ umana no rmal e (tleso speciOco loto), lasclatlt d iventare alcalina spontaneamente (t4·4S orel; si pPptooiua al 1/ t •;,; st aggiunge Il 3,3 ' /, di gelatina; si holle per un'ora a bagno ma r ia a 103', si Hltra l'aiuto tltl calore, si dls l ribul•co i n prove tte e si ste rtllzn a 100' per 15 minuti due gio rn i consecu tivt , qui o 1i si ran n n colt ure piatte che si ten. gono ad una di tl"-!1'.
328 RIVISTA M EDICA
Però il grado di alcalinità non deve esser troppo spiccato, cosi che, dopo ,'aggiunta della il Hlez:.:o abbia reazione neutr·a o l egget•mente al-calina.
:Vlediante esper ienze comparative con colture pure di labora t orio, gli autori cou statat•ono che lo svi luppo dtllle coloniP nel baciJio del tiro e del 'bacterium coli é mollo più rigoglioso in piatte fatte con tolto direttamente dall'ammalato che in quPlle se m inate con coltur·e di laboratorio, ed i car·atteri differenZiali fra colonie di tifo e di bacterium coli vanno mano mano scomparendo nelle co!Lute di con l'invecchiare delle stesse.
Concludendo, secondo gli autor·1, il metodo · Pio r ko\wky corri sponde allo scopo, qmmlunque di preparazione diffic ile, ed i risultati contradittori dei di. versi autori si possono spiegar·e in parte con la d ifficoltà d i avere un mezzo di coltu r a adarto, speciAlmente per quanto si riferi scE> al grado di abtlin i tà uell'urina, in parte col fallo che le colture vecchie di laboratorio perdono l oro dilferenz,ali.

G. 1:3.
'R. SAUNOIW. - Oaaervazlonl •ull' luufiloenza atonloa motrloe e oonaeoutlva dll&taztone d ello atomaoo . - ( T he Brit. m ed. jour., now! mbre 1902).
L 'autore viene alle Li
1 • La di la !.Azione aton-tca dell o l"LOm RcO é un'affezi one comune; est-a os'- servn!'i con •loppia fr•<'querl7.8 m•lla donna in conf1•onto dell'uomo. Il suo massimo di frequenza notasi fra i 20 ed i 50 E ssa è diec i volle più frequente della dilatazione per os truzione che generalmente moslrasi do1]0 i t r ent'anni.
2o E ssa è orrginata da nevrasl t>nia o da una debilitante pro lungata, che può essere llssociaLA a nevrastenia
3• Non vi sono sintomi caraller rstici n/> fra il grado di dilatazione e la gravità rl ei sintomi
4° La dragnosi non puossi rar·e. n ella g rande dei casi, che mPdianle la dil11tazione dello stomaco mPdiante Acido ca r bonico. ottenuto fa· cendo tnghi olli re al molato 120 gr di bicarbonato di soda e 90 g r. di acido tarlarico.
:-.• Il prognostico non dipende dal grAdo ai dilatazione, ma piuttosto dall a durata d,..i si ntomi, dallo stato r.tenerale dell'infermo e dall'efficacia del m etodo cur·ativo.
()• Il metodo curativo l'Ara quello della n evraslenia, assistito dAil'u<>o di qualche rimeoio La dida sarà indicata nelle complicazioni .ad esempio nE>IIa gastrite.
7• La enternslomiH occorr·e tAlvolta qual m etodo radicale di c ura.
G. B.
L. R t:NON • E. GsRA uo..:t.. - Delle nevrttl po•&pneumoulohe . - (Archioes gén é rale s de Médecine, ftlbbraio 190JJ.
Le nevriti postpneumoniche sono raramenle segnalate. Come nelle altre malattre infellivll e spedRlrnente n ell A difterite osser·vansi anche nella pneumonile, ma in rari casi, de lle parali;;i aventi gr·ande rassomiglianza fra di loro, tutte manifeslamenLe da intos:;oicaz i one.
Le nevriti pneumoniche debbonsi col l ega le alle altre altera zioni del ne-vra ;ose osservate nella pneumonite e come queste Jebbonsi altribuir·e all'azione
RIVISTA MEDICA 329
di to:::sine Recrete dal pneumococco. T alune epidemie di pneumoni te sono ricche, in particolaJ' mouo, di manifestazioni nervose.
Ad impregnazione :l elle sfere psichiche devesi riferi1·e il clelirio deli& pneumon i te e le pneumonili C!)rebrali dei fanc i ulli, degli a lcolisti, l e psicosie
Se sono in parlit.:olar m odo in l eres!late t.. zone psicomotor ie ciom i nano le convulsioni e le p8 J'alisi (meoing'smo nel fanciullo, emiplegie post- pne umo ruche, di!'turbi pe r eticr del br'accio, della faccia, contrazion i dei muscol i . dorsali). Pa r im en t i si notono talora taluni dis tur bi oculari, quali l'ttmbliopia, la cromopsia, la sordità senza lesioni iufettive dell'orecchio, il r itmo d i Cheyne-Stokes.
Debbonsi rirerire alla zona bulbare i vomiti patog nomic i dell'ini zi•l d el!& pneumonile, e sopra t utto i disturbi d'inuerv . 1.ione cardia ca cne accompagnano e S"gUo)IIO la del resto di benigno pl'OIIO.stic o
Bi sugna ricorJar·e ino ltre le 1\ l tet•azioni dt'lle zone vaso motric i e secretorie ch e ,.i manif<Jslano con eruzioni erpeti che , con 1.ona, orti car•a. sudori ed e!"tJntemi su·lorali, in qual c he caso con l'albuminuria , tutti r.:nomeni dati dall'i nto,;sicazione del nevrass e.
Come epoca d ' appar·izione di tali manifestazioni tos;siche abbiamo il princ opio della defervescenza, e p iù di frequente i pt·imi gio•·ni dellla convalescenze. fAllO IIOlfllO d'altr onde anche nelltt febbre tiroide ene!IA Jirterite.
Sembt•a che la tossina i mpregni t ardivame11te i oppur e elle richieda. Llll cer•to tempo per rna nilesl.llre la propria azione.
Il ].H'ognostico di tali accidenti nervosi non !JI'eseuta un g ra u ,Je pe •·icoiQ_ L s nevri te pneumocoecica è faci l mente guar1bile. Sol tanto in t.aluni casi bi':lognerà rare dell e t•iserve, giac.;l!è non è 11npossibile vedere le altE>razioni ne rvose pneumococcicht' avere una r eale i m por·Lanz:n nella g11nesi di diverse mulattie de l nervoso.
G. B.
RIVISTA DI NE VROPATOLOGI A

L'A •:osi i punti princi pali di un'accur ato sno studio sulla d'angoscia, studio frullo di lunghe osservazioni praticate s u mollissi mi soggetti presentanti la nevrosi in par·ola:
l
• L a nevro!'i d ' anlloscia, che dal F reund di Vienna venn e pe.r l a prim& volla descritta co me tipo morboso auton o mo e distinto delln nevrastenia, è caratterizzata, nella fo r ma pura , dai seguen t i fenomeni:
a) sovraeccita:d o ne nervosa gene ral e ;
u) sta t o cronico o di att esa ansiosa;
c) accessi di ongoscia parossislica, con di:::pnea, palpitnzioni, sudor ir !Jrofusi, ecc ;
330 RlYlSTA DI NEVROPA'l\OLOGIA
P. H AHTI; MuERG. - Sulla nev ro•l d 'a.ngo•oia . - (Reoue de Medecine, Agosto).
cl) eo ua\'ale11L1 de lla crisi d'angoscia e c ri si r urlimen tali, <fuah: disturbi cardiaci, da stut·bi r espir-alorii, disturbi digesti vi, ve t·tigini, pfaresl• ·sic, fenomeni muscolari , fenom eni scca·etorii, fen omeni congestizii, distut·ba ut•innrii, variAzioni della nutrizio n e gener11le. ecc.:

e) lb bte eo l O!'SI'!'l<i on!.
Di tutti que-;u !'a nto mi il p u co»lon te e é l'angosciA. l disorduu funzionali !'on o pau o meno vuriabili, si a;.sociano diverilamente fi'O di loro e poso:ono rimp taaarsi fa'A di loro.
L e fuhae sviluppano merce l'aiuto ed il l oro ogge tto, dipendt: uuicamen l e dalle ci r cm•lAnze.
Le nevro<>i non hanno esc lusi vamente' sessuale, com e vo l'rebbe il Freud , ma possono esser pro lolle da qual siasi fati r n, sur· e !'aurimento, traumalisrn o del sil<lema n er,·oso.
:lo Dall'ezio l ogia e dai s intomi clinici, consistenti in disord i ni rircolatorii, e viscerali, si può supporre che lo nevrosi d'ango!tcio abbia per sed" il sastema n ervo so simpatico. Essa dimo;;trerobbe una falica. urùl!laaH·i· menLoJ del cornu la vtlra nc vr·astenia dinòla la ;;tancllezzo del sistemi! cerebro-spinale Tal c hè sembra legittimo di!llingore r e la nevrosi d'11n · ({O SCt u, malolt!O del sirnpa t aco, c a a·atlerizzata dall'an gnsciu, dolla n evrasteni o, malaniu d el sistema cerebro - spi nale, caratterizulla doll'o slenia. T uttavia, ri!\COIIlrandosi nella vita fa ci lm ente associale le ca use di esaurimen t o d ell'uuo e d<'l l'allro sistema, P. naturale si a·isc ontrino associati nelle l'orme mis te, t • sin tomi dello nevrusi d'angoscia e della nevrastenaa.
\. • La d enominazione di nevrosi d'angoscia ri esce ut1le per di stingue r e della uevraslenia, ter·mane ta·oppo largo, un gruppo naturale di sin t omi rappre eutunle tuw malattia primitioa tlell'enwtioiui, che costituisce il t erreuo d'elo-zt o ne pea· lo svrluppo delle fobie. l n oltre il suo meccanismo rischtara sin;.wlarm ente la ps•cologia dellt\ paure morbose e porta una dtmo· strazion e clunca eloquente in f11vore della dottr i na della prioratè della vito ef· rettava nella rormazaone delle robre e delle
fl.• Il trattam ento curat ivo consiste nell'ord i n.'lrio delle malattie nrrvose quale: igrene, ri poo:o, i solamento, idroterapia, eletlt·acita, calmanti (oppio), curtl loca li, ccc. ' l dal>lua·bi po:;ichici. l e fobie, ribelli m ollo spesso alla ipuo tica, saranno cum battuti ro n successo col metodo de:;:li eser cizi dt progt·i!ssivo adal· lam lln l o, r ipetutt dal malato a sua insap uta , solto la personale direzione del IDt>dico.
G . B .
F ASQL.\ - Ooutrlbuto ollnl oo alla OODOII08DZ & 4eU' luu•rvuloue sa• t atorl a . - (R•oisla rli patologia ne r oosa e m entale, n. 2, 1002).
Lf's li 10i di ce in geuere che i nerv i de l gus t o il g l ossocd il lingua! ; il primo pe r la btlse, il secondo pet• i due anle· r iol'i ci r ca della lingua, cui danno pure sensibililil tattile t: general e. M11, pou'ndo il gusto abolilo se nza la scompar;;a di queste due ultime senStbtlitil, i fi s iolo gi ammettono c he lanlo nell'uno, qnanlo nell'Aila·o nea·vo, l P flbre del gusto sono distmte da quelle tattalt , fallo qu11s t o non tlimo-.trato finora IX ner"o, 111entre per quello lingnale pare la soluziont> ciel problema stia·
RIVISTA DI NEVROPATOLOO IA 331
nell11 cor·da del timpan 0, che si unisce al ram o Im gualc del V pet· costituire il ne rvo omonimo.
La questio ne della innervazione del gusto in gt>ner·ale non é ancol'a •·isolta, varie e co ntr·Adiltorie essendo le opinionr emesse. l nfalli per la parte anteri ore -dello mucosa Mche dalla o!'igine delle fibre gustatorie contenute rwl n. lrn g uale, v'ha chi crede che esse pervengano solo per la corda del timpanc> (Luss11na, Duval ecc.} e che arrivino tanto per la corda d el timpano, quanto pPr il ramo linguale ciel V, che in siem e costituiscono il n. lrnguale ( Karl , Schilf): u la o ri l-(inur·rll delle fìb r o in .tiscor><o, v'è chi l'allr•rbrrr!'ce al n . f11cral e , perch a consider a l'arcessorio di come di spettanza d el VII (Lu ssana;, chi nl per ché hll climoslrnto che qu es to occPssorio di Wr·isber•g p r oviene dal nucleo del IX -{Duval ) . c h r in via gene!'ica dal IX stesso (Karl) a chi inlìrre dalle r adici del v. In quanto poi a ll'inne rvozio ne .Iella parte posteriore della mucros a linguai P, se la rnnggi o r·anz11 dei fisiologi rit i ene che >'ia dovuto 1:11 glossofari ngeo con .fl!Jre proprie, non marr cano quelli che ne dubita no e PrJsle r amm ette pro. babilc rhe lìbre pnt·tenti dal c .. rvell o lun!(o il lrigemino passi no poscia al ram o Hnguale rr on ma allraverso lo cor·da del timpano e che nello
lcrnpo 111tre fibre prhvenienti dal Lt•igemino possarro da ultimo congi ung ('r " i col glo;:;:ol'a Pingeo. lrr mezzo a tantA di opinioni l'A. appOI'lH il !'UO contributo c lrllÌ{'O, r iferendo due casi d'indrvidui aflelli da g r avissrma ed inveterata nevr,;lgia del f11c crale, i quali, Opt>rali di r esezi one della 2" e 3" brunca del V con t}Sportazion.: d c>llo parte 111iiacente ganglio di Ga!:'Set·, pr evia c rani ectomia 11lht Kr·au!>e A rLiey, p r eseutaro•1o la guari gione completa della malallia, ma .. bber o un di " ttn·bo g-usltttol'io nella regiome lat erale s tnr stt·a della metà ante· r u1re della compres11 la pu;rta, immediatamente d opo l'atto operativo. questo n ell'anes tesia gusta tiva quasi completa per i quattro sapori fo ndamAn tal i (amaro, dole.., salato, Hcidcl), accompagnata da anestesia laltile e d l n rifl ca. L'in se ns ibihlà per i sapori d o po una dierina di giorni cominciò ad .allo• nuarsi , e dopo un pai o di mesi circa non rimase che qualche mcerlezz11 n el grudizi o, speci11lmenLP- per l'acido, il quale ven i va l' i conosciuto con r i tardo ed 'ttlle veolte co nfuso ru l ;:alalo e col clolce Però t:empre, anche dopo molti mesr dA l l'operazi one subita, la sens•bilità gustativa di sinistt·a rima se legger· m ente ottusa, ri spcllo a quellll di destr a Il dis Lur·bo :;cu;:tato r io non potava in qualche mvdo drpendere dall'anestesia l8ttih pt•c>ololtfl si nel1 11 regione anteriore della lingua in seguito al Laglio d ella 3• hrancn dPl v, fra l'altro il ritorn o dPl gusto pr·ecedelte di mollo quello <Iella Sl! nsibilrlil tattile. N é po t ev ano iovocars r distu rbi va somolori o lrofici, perc hé per razi one va so molorin va ricordato che la dil11tazìone va!lale l'd il t·ossor·e della punta della consecutivi alla eccitazione d el capo periferico del n lingual tl, !'On•> dovuti a libre vas o dilatHtr·ice fornite dalla corda del lirnpann, ch e con tutto probabilità le ri ceve dul ;:i mpatico. I n quanto por alrazrou e tronco, pat•e eire la co rda del timpano co rrt enga fibre al1'erenti, c he lranrro innuenza note vole sui Lrofici dell a lrrrttua, e n ei malati in dr· scor so la corda del timpano non er·o s tnta pnnto lt>!>a.
L'A. cred•J eire rl in pnr o la ciipemla d alla sezione di flbr·e !>pecr· fi che; e lu sezione della 2' e 3" bt•anc li del V è a\' VP.nul.a a livelln .del ganglio Ji Gasse r , ammelle: t• .:Ire il lrigemino ha realm ente fibre gu>'IO·

.:382 RIVISTA DI NEVROPA'l'OLOOIA
"' ·
to r ie proprie, che vanno aliA parte anteriot•e e d alla punta del la lin).':uA o direttam e nte pel r am o linguale di q ue s t o ne r vo, o passa! 1do IH'i rna nella co r da del timpano, p. t>. attrave r so un ram o del gl:lngl io otico; 2• che amm esso ch e quest'ultima pos'.!egga u nA parte di fibre gustatorie di spelt-stlza originaria del trigemino, ciò non che essa possa averne d i a l t ra provenienza, cioè,. dell'intermed iario di Wcis berg e del glossofat·ingeo. Anzi bisogna amm e tle: e nella co r da timpani c a la e s 1s tenza di fibre specr fl c he d i '"ar1a o r 1gine pe r spiegarsi nei casi r1fe ri t i la pers is tenza di una qua lche se n s ibil ilé g us tato r ia nei pr1mi g iorn i dall'atto o p erati v o e d il ril o ruo in €!t'a n pa r te di qu es ta sensibilità. n e i per·iod i successivi.
S eb be ne i casi in parola n o n pe rme tta n o di risolvere il quesito se le fìbl'e g u s ttJtori e fornite dal trige min o passano o in tutto o in parte pe r il ram o linguale e per la corda, pure bisogna amm e ttere c he quelle passin o o in lutto o in parte pel ram o lmg uale, altrime n t i non s i potrabbe spiegare come sia s tato · osservato che la ths truzione delle due corJe n e lla c avil il tim pani c a non ha de terminato l ' indebo liment o de l gusto nella r Pgione ante r i o re d ella lingua IPr·evosl) e co m e la s e n s ibililé sparisce rtel lutto do po !a sezione dei n. linguali, m e ntre persiste, sebbe ne indebolita, d opo la dei due n. glosr o fariugei e d e lle due corda.
Del resto va ricordato che sono parecchi i casi clin i c i ra ccolti an c he rece nte mente, i qu a li parlauo in favo r e del concorso del nella inne rvazione
PARN!SE r Tr. - Le anomalle del poligono arterto•o 41 WUU• nel orlmloaU 1n rapporto a lle alteraslonl del oervello e del ouore . - (Ar chivio dt spic hia tria, scienze 11enali ed a ntropolog ia cr i minale , ra se. I , 1902).
Tr·a i caraLleri degè n e rativ i dei c rimmali, quelli che s ul tavol o anato mi co spe!!so richiamano l' allenzione dell o specialis ta, so no l e anomalie num e r ose e fr e f!ue nli del circolo a rte t·ioso della base del cer·vello e p1ù del pol igo n o di Willis, come è dimos t r a to dalla ri cca lelterttt ur A esiste nte
L'A. mette nd o a proRtlo d materia le llcie nlifìco de l H eclu!'<o rt o di Al essand ria , ha intrap r eso u na se r·ie di r·ice r c h e s ul cer vello e sul cuo r e d i 87 c riminali , distin li in otto c ateg-o rie il crimine co mmesso; e cioé, om icidi , a ssassini, uxori c idi, la dri di st ra da, ladri comuni. ho rsRtu oli e fa lsa r i, stupratori, anarchiei (?) E g li è venuto al le seg- ut: oli co nclus ioni:
t• Il polig on o arteri oso di Willis presenta nei ct·iminal i numerose anumalie di orig m e, d i sviluppo, di d u·ezione, dan do il 65, 5 1 p. •fo di pr o porzione ; il ma-.simo d e lle anomalie si h a specialmente n e lla m e tà sinistra del circolo di Wi llis.
2'11 ce1·vello risente l'inlluenza d e lla c irco lazione s angui g na, poLendo questè an o malie determina r e t·allenLamento nella nutrizione, un g rad o inferiore di organizzazione d e i ce ntri nerv osi co n fenomeni di ar1•esto di sviluppo, d i degener azione. Frequenteme nte e g li ha trovato il p eso di ques t i cervelli poco elevalo (73 56 per 0 /o), a ssociato ad alte ra1.io ni a natomo- pa to l ogi c he c o muni meningi, ai va si, alla sostanza cereb r ale (11nemia ed i pc r em ia meningea, spaodilneutl nei ventl'ico li , fo colai ate r omas1c i , r ammollimenli ecc.)
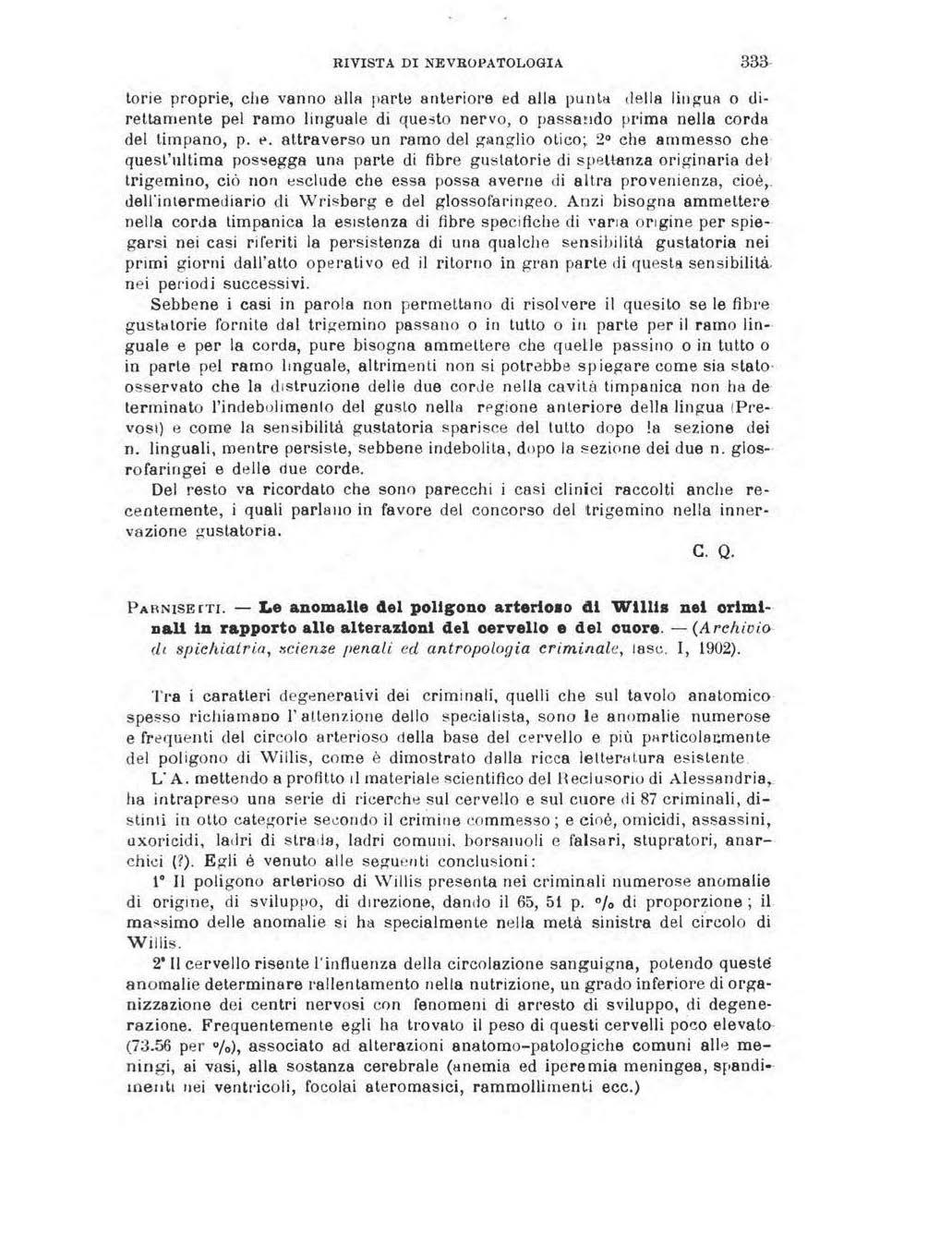
RIVISTA DI NEVROl'ATOLOGIA 333-
c. Q.
3• Lo s vilup po de l cuore s embra esse re in l'apporlo con l e anomalie del circol0 di Willis ll peso di qu es t'orga no fu minore della m e dia norma nel 75, 86 p . 0 /o dei criminali e di questi il 49.42 p "lo all e anomAl ie de l poligono arteri os o di Wiltis; anzi a ssociate a q ueste ultime si rt »contruno pure les ioni analo mo-palolog tch e più g r avi de l l'apparecchio t: ard iaco- vascolare, qua li atrofia ca1·diaca, in s uffi ci e nza val vola r e, ipertrofìa del ventricolo
C(J.
- La oura merourlale nella ta.be . - (Monatsh e.fle .ftir p r akt iDermatologie, n. l, i902).
Per lo passato curava la tabe anche nello stadio paralitico con un ene1·· gico tratta mento m erc uriale, s enz'aver se mpre b uo ni risultati, anzi talvolta arrecando danno all'infermo. Oggi si ri co rre allo stess o trattamento , adoperandol o però ne l pe1·iodo iniziale della mala ttia o pr eatass ico, ed i r isultati sono migliori. D'o rdina r io s i u s an o l e fo rti dose e si prescrivono per lun go tempo d a 4 a 6 grammi di un g u e nto mercul' ial e p ro die pe r fr izioni; lo s t esso A. ha prescr i tto 3-6 g rommi di questa sos tanza, da l'i pe tersi p e r 25-60 frizio ni, ottenendo alle vo lte ri s ultati poco feli ci ed ancue poco lieti, m nssi me poi qlllmdo s i mani fes tava ne l malato un certo g r·ado oi an e mia ed il peso del co rpo subiva una for le d iminuzione.
l n vista d i questi fatti, egli cominr.iò a f'ar rare per og ni pe r·iodo d i c ura 20-25 frizioni con 2·3·4 gra mm i di un gu e nto me r c uriale pe1· do s e, badando di SO!'pendere il trattamento q uand o il peso de l co1•po tend eva a diminui r e o quando gl i amm a lati cominciavano a far s i pa llidi ; i risult ati ottenuti e rano
Usa va anco r a q ueste altre pr eca uzi oni: -d urante la cu r a i mai a li dovevano 4 a 5 volte nella fars i un bagn o a 3 t•.:Ho C. , d ella d urala di 10 ·15 minuti ; - essi dove van o pure far e u na specie t1i cura di r i poso, cioè, r estare a lello per 12 o re (10 di notte e 2 ll l pome rt ggio), li be ri di muovers i nel r esto della g io rno la, ma poco; - a!'tenersi dall'alcool, dal taba cco, o ùa qua ls ias i altra sos tanza - l'i!Jele re la c ura og ni anno (Erb ).
Se le fri z ioni m e rcuriali n on potevano fars i, l' A . pra ti ca va 20·25 iniezioni di g r. 0,01, d i sul>li ma to in adalla s oluzio ne; le iniezioni di s ali mercuriali insolu· bili e l'uso in te r no del m e r c urio non hanno co rri sposto . Parimenti non ha o ttenuto alcu n buon ris ultato dall'uso de ll' ioduro d i po tass io.

Ecco i dati statistici da l ui riferiti: - In i:l anni ha c uralo 95 l abici, cioè i2 nel pe l'iodo pr·eatassico e 23 in quello atassico De i pr·imi 22 ha nno fatto un o o due di cu r a: 3 sono m o r ti per malattie inle r·co r renli; 1 si è suicidnlo; 69 han fatto 3 o più periodi di c ura.
Di q uesti \i9 sono sta ti trallali con la cu ra m e r·c urialll 58 ne l periodo iniziale cl e lia tabe ed 11 nel p e rindo atassico. Non c)Stanle la c ur·a, 10 de i 58 sono peggio rati sem pt•e più, andan do soggetti a tisordi ni n ote voli di coordinazione negli arti inferio ri ; 3 hann o avuto disordini vescicali e c r·is i gastriche, ma non incoo rdi naz ion e dei movimenti; 33 so no migliorati e la malattia si è parzialmente ar·resta ta, non r esiduaudosi che la rigidità della pupi lla e l'abolizione del rifl esso r ol ul eo m e ntre i dol o ri la ncinanti s i sono a tte nuati ; 12 infine hanno . oresentato compl e to de lla tabe con la cessazion e de i do lori anz iJ e Lt i.
.:334 RIVISTA DI NEVROPATOLOGI A
Il ri s ultato felice s i è o ttenuto dopo 4 a 6 periodi tli c ura, c ioè do po 4 a 6 ann i; in un individuo , di d e b ole c os tituzi o ne, ne l qua le i periodi di cura sono s tata falli 2 anni, si é n o tato ch e i dol o ri hHlcinanli s o no ricompa r·s i ne ll'anno in c ui n o n s i fa c eva la c ura , e la tabe si iJ al'res tala solo quan do s i è potuto p r at1care la c u ra p er 3 anni c onseculi\'i.

N egli t1 tabi ci, curati col metodo so pra ind icato durant e il pe l'iodo atass ico, .j ri s ultati sono s tati meno lode voli. lnfalli in 2 s i è o tt enuto l'arres to compl eto de lla malattia do po 5 pe r iod • di c ura, ce ssando i diso rd ini ùe lla co o rdina zio ne e quelli vesc1cali; in 9 la malattia è se mpre prog- re d ita.
Le c o ndizi o ni g do e ra li d ei ma lati sono se mpre mi g lio ra te dop o ogni di cura m e r curial e . c . q .
.CENI e B eSTA. - Prlnolpli to••lol degli upergtlll " famlg&tu. e flave-
•oen• ». - (Rioi:J la spuimentQLe d t .frenialria , d1ce mb r e 1902).
Nell' ultimo num e r o de ll' ann o sco rs o di qu e:;lo g io rnal e fac emmo un cenno -dell " st ud io im po a·tantissim o d e l Ce ni circa a spe r g illi ne ll'etio log ia e nella palo g-e nesi de lla pell agra
Que s to nuovo lavoro è il seg uito d i quell o, e s i pu ò d ia·e la prova ultima e de cis iva. per dimostrare c he dalle s pore de i du e caus a della pella g r·a, s ono seg regate delle sos tanze tossich e
L e esperie nze, c ondo tte con tutto scienlifico, pe rmetto no agli auto r i di v e nir e alle 8eg uenti co nclus ioni, che I ' iporti a mo integr11lmente.
1• Colla di gesti o ne pro lungata in al cool e d in e te1·e d i patin e re centi di -11-çpergillus (umig atus, s i o tten g on o dell e s os tanze do ta le di un potere tos s ico virul e ntissimo e di c a ra llere gpe ci fico Sostan ze tossic he di a lliviUl a s sa i minore e solo coll' e tere s i otten gono .da ll e pa t ine r ecenti di !l aoesce n s.
2• l princ ipii tossici sono legati e sclusivame n te all e spore d e i du e suddett i ifom iceli, mentre dai lo r o mice li non s i possono estrarre tossici d1 al cuna natu l'a
3• P e r l' aspe r {li ll us .fumig at u s le p1·oprie tà sono in ra pporto in par·te coll a q uantità de lle spore, in parte, e più, co n speciali ca t·atteri di sporJficaz iolle de l g erm e.
In g ene rale s i può d ire che il p o lare è tnuto min o r e q uanto ma ggio re é lo s vilup po di mi celio e tant o ma g gro r e quanto p iù n e tti s o no i caratte ri d i maturità delle spore. Il m e zzo nu t ritiv o su cui il ge rme é sviluppato n o n ba rm po rtan z a s peciale .
.t• Il potere tossico de ll'es tratto di asp er g illus f umiga l us sciolto in acqua e lasc iato a sè J iminui sc e piu ttos to r ap ida mente; esso res is te inve c e all' e bo llizione pro lungata ed al sog g ioa·no in al co ol.
A. M.
PAN EGROSSI. - Bulla dlplegla faoolale perlferloa.- (Ri ci sl a s peri menta le eli Freni atri a, d icem bre 1902).
Sono riportati tre ese mpii d i paralisi dop p ia dei fac ciale, completa in du e e quas i com pleta n e l te rz'o. L'abolizione de lla funzione dei muscoli mimici di en trambi i lati dava alla facci a l'apparenza di una maschera. In t ulli tre i casi la paralis i fu giudicata periferica 1• per la esle nsiooe di essa: 2° perché la
RIVI STA DJ NI!: V.ROPATO LOGIA 335
paralis i si era lim1lala o fin dal suo insorgere o poco do po solamente al del fa rcia le, c i ò che no n svvi ene se essa è n u clt>are o sopranuclen re, nel quat caso, insie m e a i ner vi del V II paio, n e v ent:rono colpili altri cer ebrali c.. s pina li: 3• per il modo di c o mportarsi dei musroli pnrall elizzaLi r ispetto alla co rl'enln g11lvanica, essendo cioè invertita la dell'E>ccita bili ta eleltric'a, la I)Uale mvere è conservala nella paralisi da o ri gine cent1·ale.
L'A. pas!la poi a lla diag nO!'I d1fft>renziale di 'l Ut>Sla m alalli& abbn <: tanza rara r 1s petln ad altre s10ct r o mi note :-Iella !Jaralisi lablo-glo!I!'O l a ringea della funzi one musco l ar e n on si estende alla parte super ior e della facria, e la m imica n o n è a!Jolila. A o che il m od o d'invader e e di dell ,. due malattie è divei"!'O, giacc hè n ella dipl cF!ia facciale l a paral isi è r apidA 111 enlJ•ambi i ldli, sia o no co ntt! m porauea, nella paruh:c<i labio- g l ollso- laringE>a invece p1·ima son o col p1 t e le labbra, e poi la li ngu11, il velo pa l alino, 1a la r inge ere.; ed in sieme alla paralisi s i ha anche l"atrofia dei mu scoli, l ' una e l 's ltra p.,rò lcnU:unenle. Nella poliencefalile ;;upPrio r t> s i ho ;;pmpre sinto m o c h e non si veri fica qua si mA i n.-lla pa r a li si d oppia dt-lla for·cia Nella atr ofia mu!\r olare progressiv a a form a giovani l e, che InvAd e dalln fa cci A, l 'atrofin e la paralisi muscolare è ancora pi ù l enta ch e nell a parali si l abiomentre la di plegia fa cciale é ra pidisl-lima.
L ' A m elle t erm i ne alla p rima pa r·te di flU es \ o s tu dio inte1·essante l"iportando schematicamenle in ta vole sino llic he lulli i casi di diple;:ria facc1a le fl. nora O!'Scrvati , c he n on o llrepas5an o i novanta in lu llll la l ellertJLUI'A , e di c ui i primi esempi r imo ntano a Cbris tison nel t 835 e Ro•ll nel 11H6. Da qu es ta l! crurota r a ccolta s1 r ileva anche che le co use più frt>IJIICnli della mAlattia f ur o n o r o lile doppia, la f r attu ra del cranio, la sifilide, il ratrreddamento, qualche malalli1:1 oppure la sin rh·ome r·Appre!<enta tu1 epifenom eno d 1 una ne· vrit+-' multipla. Il pun to i n cui il ner v c fu inleres«alo Il num eeo delle volte f u il canAle e l i Fallopio L'esi to della malattia fu la guA r i gione quando e!.'sa dipendevo dolio sifilide, d al ralfl·eddamento, e !>pe!>SO a nche quando er a una manifestazione della nev r ile m ullipla ; i l più dellE> volle si ebbe la m or t e quando la Ji;>l•'gia d i pe ndeva da o lile di natura tuber colare , da basllarP, o da frottu1·a dell a ba se del cran1o A M.
Jn!';SERAND. - Paraltllllltero - l&turulDa del nervo radiale. - (L yo n médical, · !· d1cembr e).
Le dS!'OCiozioni sono ommPsse indi scutibilmente, non os t a nte che i l numPr·o dei casi rifel"ili sia tutt o r a sca r 110. L'osse rvazion e dell' A . ho interesse pra tico, tanto p rù c he in si mili casi de l· j:riudiz io diagnostico è la prima condizio ne d el s u ccesso d E' l ll'&tlame nlo

Tra t ta s i di un di 29 anni, cou parulis i radial e destra delle piil spi cca te. presentando In mano penzolon i ed in p1•onazione. È ti pografo d i m e8li er e od 1nollr e ha alla facc ia interna delle go l e le macchie ardes iach e d escri tte da Glube t·; si c red é perciò ammi ssibi l e la d iag nosi di paralisi r adia l e saturnina
P erò un esam e più completo dimostr ò pa rticolari t ali, da rend ere dubbia la oolla nntur·a della l esi o ne ln fatli anzi tutto la paralisi era unila t era le, sor ta all'improvvil<O (nel bel mezzo d'u n pranzo la mano si r ifiuth al suo serviziO, sen za che l' individuo fosse col pito da i cl u !>); di p1ù il lungo supmalo r e
33G RIVISTA DI NEV R OPATOLOGIA
,, • LI ··li ··": .\ .. ··C!. <;. • o •!.l; . _,
·. < •• •. . . ....
er11 interec; salo in ::.i eme ag li e;.. te n sori, fsllo ecce1.ional e n ella pnralisi !'alurnina, la perditA della m o lilità no n era limitata s tz·et tam ente ai inn ervali dal ra d iale, es i s tend o altresì lieve del n. m ediano (fìesHori) e de l n. r ubitale (rnterossei ed ndd ulto r e del polli ce). I nfine nota vas i an es te!!i n pr ofo nda, interessante l e tre m ndalrtà della Sè us ibrlilà e limitata superim•m en Le da un a lin ea c ircolare , c h e a pr·incipio occupava la piega d t> l gomi to, ma che rlopo una quindicina J i giot·ni er a discesa a livell o dell'union e dt> l terzo !" nperiore co l terw m ed i o dell'antibraccio d e:<Lz·o.
Del l'es to non al r o fht mu sco l ar·e, non rn odifi ca zt o ii P. nei r i fl essi, n ou dolo ri spontane i od alla prt> ssi o ne, n on alter azi o ni della l'eazione elo>ttrica.
Dunque l a diagnosi di ptu ali s i sotn r nina pura n o n era del lutto acceLlabile, nè s i pote va amm etter·e la esistenza d' un focolaio cor·e bz·a l c o tn idollal'e, nè una lesione del ple"so bl'aclt i ale o delle s ue r adici Re s tava per ci0 l ' ipotesi dell'iste ri s mo, la quale s i tr ovò co nfm·mata dal ri scontro d' una zon a isteroge na al fiauco de;; tr o e di un le;;:;:er o r esk in gr mento del CV speciDimenLe pcl verde.
L'A . op ina qui n on IL'altarsi di pa rali si i s terica essen1.ial e, ma di i s teri ca si n t o matica di oril<ine to:::sica. I nfatti i nervi del m em bJ·o s n per·r ot·e d es tr o trovandosi per l ' influen za d ella intossicazione saturninn in stato di oller·azione funzionale e fo r se organica, bas t ò dro il m a lato la p1·edisposizi one nevropatica, perchè i s in t.onri i s teri c i po te s;;er o manifeslal's i nella zo na i ntecq
PANICIII. - Contributo allo studio dellaalfillde cerebrale mallgna e preoooe . - (Ri ois t a sp e r imantale di f reniat r ia, dire mbre 1!)02).

Di questa della si fìlicl e , di cui ebbero ad occuparsi r ecen t emente il M ingaz zini , il fo'inke lnburg, il Lann o i s, il F OU1'11i et', i B r a sc h ed altri, l'A. riporta un t:aso in un giovane di 27 anni, importantl\ per la f!Tave zza d ei sin t om i , pt• r l'esito l etale, e per il r e perto nec roscopi co - A pOC\) pi(r di un Arlllo di distanza dalla infezione, l'iofer·mo fu preso nel cot·so d i uua nolle da emtplej::ia !=< pastica ed emianest e nia si nistra ; r o Lazione d el cApo e degli o cchi a d estt·a ; emianops ia bilaterale destra. Il suo :otato an dò gradatamente a ggravand osi; e po co dopo il coma e l a morte.
Alla n ecroscop ia l'u r,) rmolala la anatomica:
An e uri sm a dissecante del 2• ramo d ella Silviana de>'lra. An euz·ismfl del t•am o della Si lviana sin i stra. Jei gi r i dell'in sula d es tra. capsulo-talamica destt·a. Le caratteri sti che anatomiche r i scon trate n ell' arteria di Silvio di destra, erano quelle proprie delh1 at'Lerite e dell' aneuPisma si fìlitico.
In al ca so proprio l'A. n e r iassume uno s imil e Ji si fili d e cereb rale pr ecoce d'osse r vazi o ne del pr o f M i ngazzini. Anch e in questo dopo un anno dal !"ifì loma si ebbe paralisi del fa cciale e dell' ipog l osso e debol ezza arti d i destra. Dopo la· morte, avvenuta per pneumonite interco rr ente, s i trovò: in s pessimento diffuso della pia in co1·rispondenz}i d el ponte ; malacia della parte dci g iri rolandic i a sin i s t r a e del polo tempor ale m edesimo lato.
Due osservazioni pt•aticam enle im po r t anti fa l'auto re circa questi due casi, :H - GI OI'IIale mtàico.
RIVISTA OI NEVROI'A1'0LOG 1A 337
e l ' che en t r a mbi gli infermi abusarono di al coolici dopo l'infezione lueti cA, il cit a vttl c ad accr••scer e l"infausta influenza della s ifilide sui vasi, c o me a'·t!vano !!ltl notato il Mingazzioi ed i l l' ' i nk eluburg.
2o la dlicacia della cur a specifica cominciata più presto nel pl'imo caso, " praticata energicamente in en trambi fin dalle prime gravi malllft•sta ziom. A. M
- L 'a:r.lone del auooo ga•tro - entertoo sulle apore aapergiUarl.(Rioi!lla di /"renia tria. dicemb1·e 1 002).
Sempre faC••ndo sel-(u ito al suo lavo r o sull'etiol g ia dellA pellagr a r A. !'Ì ò p r oposto con fJUestn s t udio di spiega r e un fa llo notnto opnunto in quello, e ci•1e c hf' le .,por e c! Pg li 8"P61'1!i lli {umigatus e .flacesC"ens i n oculate di rettamente lH'gl i orsroni o n••lle vie !languignf' 'Jann o l uogo (pseu do-tube rCIIin!'i) m entre 111 gr. ril·e per bocca p r oducono l ' intossicazione. il c ui qua· d i 'O ,:tene r ttle ò ra ppr l•,-entalo dalla pellagra.
Qu est o d iver so modo di comporta r si delle s t esse !'par e n o n poteva essere t 1 ovnto c he e"'er·citnta s u di IMo dai s ucc h1 g astro -inlt'!'llinali, quando cntr n.n n nel Luho digerente.
L'A. perciò l e ha a que!';la azione, e poi le in ocula t e nelle c1wiu, ed h11 pol.nto cuncludt> r·e da 'luesla espe r·ienza che i s ucchi r rci, e s;>er.i aluwntl' qu<'llo Pn le ri co, possono dirt> Ll a sul pol•• r·c• germiuotivo .Ielle spor e trsner gillal'i, e possono così mdireLtame11te agire nel ca m biar e il qua, ]i-o morl.lo!lo a cui e-.;se danno normalme nlf.! luogo quaud o e•rtrano di u 11 animale. Queste spor e intar.cal c dai suddetti I<H'O pulenziahtà conservano pel'ò l e IOl'O propr ietà t O"-'IChe, e pn"c;nno dett> l'minar·e un in loi"sicamento inwce c he l' ll "p<' rglllosi comuno. Cosi nei pella:rrosi, le spore eut1·ano nell'or;xamsmo per l e vre Jiger·euti, flll""biiO 111 s,..guilo n el cir·colo, si locali zzano negli or g ani A nei t essuti ed iv1 SC'nza !1viluppa1·si in 8"per·gilll, ma r e!ltando allo s t a to di !:<pOr<', determiuano i no ti f••nomeni di inl•lSSICamcnto maidico. A M.

::; ,.'1:-.'i\ SAI,A RIS. - Note ollnlo he su due oaaerva zlont eU ID aogg ettl epllettlol . - (Ricis ra di Patologia e M e ntaLt>, vol. V II , l 1).
Qu es t11 si ntl1'omc de!lcritla per la prima v l)lla dall o Jaccnud. che l e diede il
n o me di per dUett i rli coor dina:oione aLLlomatica, fu in segu ito illu- ·
!ltr a t n dn Hl rwq e dfl tanti al u·i, e dopo esse r e st Ata considerata com e una malattin " la m Hg-gi•,r parte dei neur opatologi ammelle in essa una maoi-
d i cu i anz i può cosltLuir e l'unico
In q nalchu cuso rar o per o questo disLut•bo nerv oso si può tro vare co n alh·e n ev J'Ol'i non !< Ì8 l'ist eri!lm o , o con psicnsi 11 naLur·a com u l ' ipo condt'iA, la mnlinconhl. In slupid!ta.
n e vt'a!'t en ia c\ !>lnla vista da da B i nswanger 6 Petren 6 nel l a t>pilf'!<,iu no n ru OS"-<'rvatll finora che quattro volte.
l due tasi O;c;!>ei'\'Ali tlall' A. si ve!'ifìca no per en tr·amb i i nsona di due gio va ni <'pilcttici ri cove r111i per· •JUe!' tU malattia nel m ani comio, e nei quali il più a ccur nto esame somalir.o non fucP la m enoma stigmate isterica. Ciò non
338 RtviSTA DI NEVROPATOLOOU.
, ,, l • ... .. , ,. . ' . a ... • ..
•
•·•
meno lA su•drom!! di asta<:ia - abasia fu tipi<: a , trovandosi in e;;<: i l ' dt?IIA f\>rza mu<=colare, lo !!lato nor·m nle della sensibilità e dei r iflessi, mentre Pr sn•l irnp0.5"il>ilitali i movimen t i dell"in::e:S:::o e la !<lOzione erella, pur re:::tando C•>nJ>erva t.a la potenziahla di e!'e!luir·C' altr o movimento coJ'[Ii arti iurer •ori, stando gli inrermi !<dra•at i o !'eduli, e potendo perfino camrniuarE', ma cu r ;.-on i.
n elle du t> rorme che può avere la a:::t.asia-ahnl'ia. secondo lo Char·,·ot, l a pa rn litica e I'Ala"·iru ( •presl"ultima divi!'a in core irorme e i ca"i olell' A. pre<>en\1\110 '(lleiiA paralitica. I n quanto Il decorl<O poi UllA ebbe un 1wola llle11 t0 c r o n1 ro e si mantenne invar·i ata per qunllro anni, con alternativ e d r miglior·ume11li e pe;.:g10ramenli, mentre l'altra ebbe cnrallere acuto ed esito in znar·i:.:ione r•ap1d a
L' A "i soll'drrna nlflttAnto !<U j carutlel'i degli a ccec;!<i prl!"entat• dai !C'Uni inrerrni. r"' r d11no..;tJ•are che E'S'' era no prellameute ep1leLtici, e rra i caratter i difTe'l'enziRii e!!li chi molt'l impo r lllnzn almo lo di cnrnportar!'i rl,..i n +' lle urine trO\'ALi SC>) t•si in entra mbi, e specialmente i taJTo-i, m en tre ne l l'isterismo ;;i vt!r•ilica l'inver·,..ione di essi, r aggiuugen<io i rosfati q nasi la fJl'OP•)rt.inne
•li Hl culin i D'a ltra pa1·te per·<i a nche fJlle!'ti cttsi potrehber·o di Af'pO!:!.!iO a l la Letwia Jelle un i ti\ del le n evro!<i, i ste r•" m o ed epila!'!'iO, com.. i l Ron cn roni ed il Ton1n i sostengono, e come l 'A. tende> 11d nu11 n •Uere. A . M.
Ct-::'lr e PrNI - La toiSlolU del sangue negU allenati. - Sflt' r im e•tlalr di jrl'fliatri't. dicP mbre 191!2).

S11 qu rc;t<) Ar;? " mento , giil trattato da pnrecchi, gli \A. hanno portato il l·•ro cnn1r1 bulo. !<jle1•imenl11ndo col !Ciiel'o dt>l sa ngue rti 81 diverJ>i Blllllllll:ltl cl1 mt'nte, iniellandolo nelle cAvie non pPr via endovenosa, ma nel r•ritonl'o, nllo -<cupo di un)oedi r ,.. che dei coAgoli ::;r fo rma5l'er o nel cuor•e destr·n e n»:l'a r-tcria polrnounrt'.
Come ind •ce dell11 to<>l'icJtà fu l' abbas;;:amen to della 11('!!11 ani mul i d1 eooperimenlo, e!'cludendo tutti g-li altr'i rttUi che potevan<) C""t're eli ' ' ar·•nzioni ind1viduali, e cile non pote,·ano for·mare un cr·itt>r•io ciro·a la ' lu,..sl1oue da asc::mlare.
1 risullnti più 11nporLanti ovuli dngli autor 1 so no i seguenti :
Il srcro dt>.l sangue dci lipt'lnanincl gra,•emeute depr essi fu piir lOs!'ico ùi rtudl o de,..di ••nHnnloli Il rui tono er·a più pnrnlitici ebbe cin'lue volte rorte i potet·n11a, e lre volte la mor te l-enza abbA!'l'"Oill•·nto delltl lt •mpPra t ur a. Due Hllri ca!Cii non d1r.dero r·i;;ultati unportnnti.
D!li !<ed1 ci epilettici rli cui ru s t uù i aln la Lossidta del in 12 le Mc i llfl· zi on 1 i pole t·micl1e va•·ior·ono di pochi gl'odi, ed au :!he quando lo te m per·a tu r n !'l al.>ba-;!"1) d1 part:cehl g•·atli, er-!"a si r i!'lubi l i prnnlanumle n elle condizioni nn•·rnali. I l sangue i n lAi uni di questi 12 infe-r m i er·a stato estl'atto fJUalch<>
l!inruo Q()pll l'acre o, ed in altri dopo poche ore. Kegli allf'i quAttro rn"i le caviè m o,..lt'aJ'!IIlO di avc!'e un abbassamento d i t emperatura pii• St'n!<ibllt> che ne1 primi dodici, da lenlO I'Jalzamento, o da mo r te.
Unu volla sola si ebbe nella cavia i niettata un con vul si vo, 1'11e, l:'eco ndo altri sperirncntotorl, sar ebbe co stante io seguito all'iniezione oli siero
RIVISTA DI NEVROPATOLOv l A 83D
di degli epilelli ci. - fu cnn c·lusione d1 questa lor·o lunga ser·ie dr esper·ie rrz e _g- li autnr'l affermano di non ave1· potuto s tabilir·e dati certi di Ziaz,one dr indo le generale lra il potere tossico del siero di sang u e degli indJvi .J ur n orma li e qu•• llo degli alr enati, e d i nv n aver ri scontrate var,azJ o ni cos tanti d1 nota lro le diverse forme Ji alienazione, r.é nelle diverM fasi rli calma o di ece Jltnnento d ella stessa f or·rna.
A. M.
G ESPOS!TO. - Anc ora un o a1o di pazzia pellagroaa nell'Italia m e rldlo· nale. - (Il .\lan icomio, anno VIli. ::\. 3).
Lo eli l']ues to terribil•{ elle !'\econdo i dali ra c•·ol u dal Forna,.ari produ ce 11 0 11 m fl nodr m o rti all'ann o, ed i mporta una perdita a llo SlHto di sei mi!Joni d1 lire, 11011 ha mHi di'iuleressal'e vivAmente gli scien· ziali, ed è ope ra Al ta mente uma11itam1 d i qu es t1 la vera JHttura Jel m01·hn é couos e:iula, e se in grazia di con oscenza. é JivHnlalo in un avvenire, speriamo, non mollo lonturro, la <;omplela d i dal n os tro
L 'idea geniale de l Lombro>;o cir ca l'inquinamento d el J::"l'anoturcn da pa rl dei par·11ssrti e dell e lo r o to"< sine C(J me causa della malattia. è ina lt erata nella s ua . ess:r nza, e so lo gl i ultimi stuJi del Cerri hanno mo>"IJ·ato cl•e, se n on il penicillum, l'OliO du'l varietà di asper gil l us f1Ue l l e che infe"lanrl o il nHti'l ed i pr odo lli, prod uco no In JWilag r·a. La recentement e a ppro vala dalla no"' ll'tt C'lmera dei deputati, su pr·c,rnsla dall'nn Badaloui ,_i é infor·mata Ap p unto a questi cr1le ri 1; e salvo al cune In f' nJe che il pr·ima fe c e r·JI 'l VAI'9 e sull e quali andt o l'nulo•·e in • i st e, come quell o de l la I'Hcollà di pote r J',,r·e c onsumaJ'e il gra no al le b o.:;;tie od a scnpo in .!u · c o.p1·rublie cl1e tri s te nota di irr fei'io r•itil nostra rrsp(' lto ao.J altr·i Jh)J•OII c ivrli vado r-r slo a e per• sempre
lnlnnt o l'A. 1'1;1 rilevare c he lA no rr é nn prhilegi o d ... !la sola ilHi ia ma ch e dei c asi s i sono a\·uti anco ra rr elln Italia m ridionale, dove la mi h: diffus1one' di è do vutn p ilt alle buone condiz10 11i cli• uali c he, anzichù , a miglror·t! igiene, e a Que.;; to l'a t to non solame nt e i, re,; o n olo dalla relaz ro n u del !' ou. Badalo rd, ma rla pubblicaz rorri antiche e r ecenli, come quelle del C•lrl'<itani fh1 dal l l'l t7. e poi d<d Venturi e del Ventra, c he d.imos trano che la pcllagra sei'peg:!ia twgiJ Abr uzzi, P LI;!lie, nella Campauin, ed anche in Sicilia. Il ca so cl 1e l'A. ri porta si vel'iflC'ò nel Molrse, in un paese gia allri ne eran o :;tuti e 11e erano an cora C!luicamen le esso presenta l e solite note e psichiche Jei casi di lfled ia inteu;;ilà, nult•izione scaden te, po l>'i 00 e co mpressi bili; "Offio anemico s ui focola i cardiaci; pel le SPCC8 lucente ed intensamente pi g m <> ntn ta ; andatura rifi f'ss i lendinei esagerali; tremore rnt euzi o n n l e ; 1pocstesia tattile; ìpere!; tesin dolorifica. Dal luto psichico si ebbe l entezza delle per t.:ezioni, cl e liA m c>mOria, UÌ altenziOnt', Sll perfiCJiliitt\ d i g'Ì Ud izÌI , nffi.,volime nlo sentime nti, e finalmente allu ci J,azioui uditi\·e sotto l'orma dt unn voce che irnpnneva dr buttars i nell'acqua. Fu appunto in s<>guito a ! un t en tativo di suicidio c he l ' inferma, una povera contad ina, f u rico\·e ra lo n«! mapico mio di Noce ra, dove, in gt·azia delle cure opportune, g uari c ornpleramente. A. 1\1.

310 RIVISTA DI
P ELt.tz zL - Fatti ollnlol ecl latologlol i n ra pporto al rammollimenti, ohe clrooncla no oertl tumori oerebrall.- (Rioisla di patoloyia e men· ttt le, 1, Wl>:!)
C n uomo, r acoverato nel mAnicomio di Tor·ino, 11 vanti a n ni, é a lfr•tlo t! a emiplegra, causala, secondt) rife1·isce l' allestazrone grudiziat·ia. da Gli nttncchi eprletlici lo hanno r eso in grtln pa1·te irr-e"ponsabile delle sue f\Ltt•na; é dr umore irritabile, di qnalsia!e>i n on puo tene r si in alcun luogo, alle volte di cAsa, re sl.a ndo pe r m olte oa·p •·ome s,·enuto e morto dal fr·eddo. Non c red rta psicopatica o neuropaticA; dA 10 anui e eanipl e!!rCO a sinistrA ed inc apace al l avo r o, da 2 Anm lr11 dato evidenti dr p azzi a. Ila f r t'fJueute dell' urina , r a r a delle l'ecci; con"er·,·ato il r·rfle.,so pa l el lare n destra, mentr e quelli tendinei a sinisu·a !<Ono ine"plo r aloili, çh a (l.lominnl i ed i cremasle rici nulli, i pllwtar1 dimi nurti ; le pupi ll srmme· tr11'lre. ma larùAm Pnt•l r eagenl.i a lla luce. d 1minui la a;;sa i la sensi1Jili 1a vif<i VA e udita va; laeve disn rtr i a, anemo ria indebolito, esagera ta m otivilti, um o r e dt'p 1'6S"0 .

Fu fa lla diagn osi di dt•rne r zn pos t-np opl ellica, c ile P!'\J.It>lò il s uo CO I'SO in qu ·d .: h e m el'e e l ' individuo muri pe r f:! ra,·e ma r asm o, senza m o i avesse preo:entn to nel manicomio oc c·es!' i cnnvull>i vi
L ' tlutopsia rtim ostr ò un tun1or·e, 'IUanto un unvo di J.CRIIiml, c hi' dAl la pll'co:a zona cor tica l e aderente al la m c n in,a-o l"-i approfondivi! nt>lla !"os tanzA hrRncu del l obo fr onta le di destr a e che era n otan te in un l i qurd•> c1 trino t1·a· l-pa rente, rh-co c.ii fi occl11 amo r·tl e d i f r ammenti di sosla nza rwr·vn!'l:l rammolhla. llato f!Ut sto r epe r to, :-.1 c r edé appro fondi re le IHitlmrro:.-tu.:he per '6 .e r e -e !"i r ilt•ner e il tumor·e come pu r o r·cperto cJ'autopRi a ( l) R1·
-.nltn che l'individuo era tli normale intellii!P.nzn e di a tti vita n o11 comune, o\'e·1do r i"pa rm ia l o un di cr..to peculio; che b••vev11 molto vino. senza nbhriR·
•·«r"i, e eire non ru mar sifl litico ; eire ven;o i anrri <"nmin clil a snffr rre rli epalellici, attribui li ad un g ran de dre n 43 aiHll per· l'adula iu 1111 a r c epilellico r imase par·eti co del bt•accio sim s t r·o; che la par e-=1 d l.
,. art•> 11 1f,• r io r·e dello ste"so lato comi nciò .i-:'1 anni più la1·di, pr·ogredeodo rar·i f arnen l •·: che mai e bbe cefa le11 o vom 1li; che le fa co ltà mentali si RlterAr·ono •lot :l anni, quando l'inrlivitluo, dalo fon do At t'Ì <;parm i per ché iu c pace allovor·o, , , tr'•J'•'• in miseria; chP per d u e volte f,J in Ull r icover·o a T OI'ÌIIO, don le fu ggì ur•·• »ti:Htan ,fnst alla vita ch iusa e m o u o to ma.
l.n di a l.{ rro!li di tumore cer ebrale poteva m es!'a innanzi Jln dAi pr imi l'l• 11 delltt malattia ? Sì, se avuto il dei rlnti Anllmne!'ll ici r·a dopo la morte del L 'insor ger e della monopl egia brAch iale, t•re ·et.lutll g-ia da tempo eia frequ enti Accessi cpi letli d, indicav a sicuro mente uua ie"IOne a focolai o noi Lr olLu mu.tio delle ci r con voluzi oni I'Olandiclro; rl e l ' 81-(gr ava r si dello stessa escludeva q ua l siasi fallo c ircolatorio pa ,, egf<!'r o od aller·azione funzi ona l e. La epil essia essenzi ale p uc'l da r l u ogo a 1nonoplep;ie, se le con vul!'iOni si manifestano dopo la na scr ta o uf' lla pr·ima 111f9nzia; a llo rn pe r ù ;;ono in cam po speciali processi patologici del Ilo Nedi adulti i foll r di par·esi o dr paral i;,i in ac.i a cce">si sono 11 \', 111 - La diagnoJi dei tumori end utl pa;:;, e J11 frtqrtttua 111 dn ""' drlh rtputi d' arii•JPIUI. Wior meJ. del R. ,' se rcilo, 1901 pag. tlllJ)
RIVISTA 01 NEVROPATOLOGIA 341
Nò l'i poteva incolpare il tra u mH (r.arl u\a), mancanrlo
..ne ùt'l r rani o o del cuoio capell uto in della regione rolandi cu .
P ero manr·ovano gla altri sin tomi, che vtolt:sser o a confortar e la Jt lutno re Coord ina ndo i criteri ùiajZnostici, poteva avan zarsi la diAgnosi di l»sione orgHmca cerebrale, s atuata nella c orteccta in corri spondenza d ella porZIOne arwtli u tlell, ci a·convoluzioni r olan diche; la mancanza dei si ntomi tfi lesione dei awa·vi cr·nnari, la gt·a ''ità e la nella deli m itazione della monoplegia appoggiflvsno In M d e cor ti cal e .Iella lesione e potevano fino ad un certo pun to spieper·claé manc11vano i srntnm i general i .
11 pt"<l g r o>dir c della l e!>ione !>pie;nwa il g r aduale estende r si dei sintomi pa11ll" arto inferiore; il sopravvenire dci sintom i della demenza dopo lArtli anni dotrrnizio d1•lla malattia compr·ovava che la diffusione e j::h effetti della le'-tOne s ua lobi frontali er ano avvenuLi ta r div11mente e per ullrmo
Ma i fnlli cltn rci non sono in perfetto rt::wontro co n quell i anatomici Il tu m or e (tc:ndnte l ioma dalle e a•i cco d i el ementi !'i ea·a iniztato dal punto ccrti ca le del t erzo pol'Leri ore della fa• o n l ale me1lia e n o n dal l a pot·zione media Jelle d i destt·a; gli epil ellici si erano u'·uti pe r it•t·itazione l oca le dtJ!Ia paa·l.e , n on p er· compress ione ed aumento d i t en'li o ne t>ndocr on i cn o per nllra a z ion e d ,ffusa. La m onoplegia era de Le rminAl !:t dull11 interr·uziond d e lle vie m otol'i e dal disotto de lla cort ecciA r pl u livn al sina!"lro, i nterruz ione dov uta a s uo volta non dal tum n t"d, rna Ja zonll di t·ammn llimento ci r c·ondante lo stesso. notevole l a l'ln1ordinaria l u ngh na d•"i decorso. r\ei comu ni trallati , n nelle r''reutt, c:i Ammetle un oleco r ;.o di an n i e n el cas'l ri ft>t•alo fu di anni; ciò P in r·npporto ron la n atu ra del tumor e, la l enlc7.za del svaluppo, la rP"I'l!•nza del c:o!ZuHto. L"ac;-.olut m nrac·Rnza per 25 anni di OJZni d " iudcbolimenlo pc:tchico ''Il spaeu ,la con la della lesione, col grndua!e
t>tl lento <Iella >"les--a, che dRva tempo al compc n ;:o, co m e ,., llC("Ot·da cnn la leo rio dr B anc!ti
Il r eperto .iimo•lro non diminuzione l i cl e· m enta n en•o-.i c·oa·Licala ; in altre parole, mo litic11zioni rlQvute A put·a e sempltce ntr·olin. LP prccole ' 'enP Pd arter·te e ran o nu nwro;:e e n01·mali; dunque ne l t"U"O in d ac;co t·•o 111 cOtn!W"""ione eser·cit11ta dal tum ore non può bnslar•· s dar t"th.dona d" un t•amm ollimento co •i esteso. che non è Sl>•eA"abile con la opanione tlt> !.tli auatomo - pntologi, i quali rauno tfel"ivare i rammollim enti dalla comprel"f<io ue d••i pit;col i va!"i e tRlv olla tlu uar· obltterauto (ma«!'ime n ei sifilomi e tubercolt). L'A. c a·ede che la ga•an•le dAl rammollimento !'iR detea·minnla tlalla compt·ec:sione eset·cilal!l ò al li quido sle!'!"O cr rco udanlo il ttunn r e. lir;ui l o, che C" t"lnmente <loveva trovarsi in u no s ta to di t"t1rle len,.ione, c ui l11 sostanza hianco cerebrale uon o ffri va ;;u fli c i l' nle a·e s:il:'l<·nz.a, t"llllll nendo per c iò g a·aòatHmenle co m pr essa, t•uu•m o llila e rliiilt•ut l a.
PnOil" T.- Bu lle plloopatle da tnto11loazlone eata.rnina - (:, 1u n aséS!if'll ri t"r
{ii r P !l!fChia t r ie vncl NeurolO!Iie, Bd. Il , II. 6, 190 1)
L o stuJio delle p,:icosi sulurnirw i' del intet·esse in quan to ch" di\ una tdt>A ddle analogie eziologici t •; dimostra cltr !'e in un coso particolare l u avvelen amento del sistema è dovuto al pioml)(). in altr i cn«i. in cui

IUVJSTA Dl
C'J·
.. ..... • l " Il : ,. .• , ! • 't • :.. l · ' : za. l
i velen i sono poco conosciuti c non metHllici , il meccRni s mo ùelraltcrazione delle cerebrali deve e,.!:òere in moùo analogo.
L' .\. su due sul' o;oservazioni e sui cll«i òel r eg110l r ati nella letter atura. propone rli;otmg-uere h.' p-.;icosi in d ue graud1 CAtegorie; psicus1 acutt•, ps1cO!"I crouh;he.
Quelle del pr1mo gruppo pre!'lentuno nella dei il truaùro sinto mntico dell'amenza nel :-cnso ùi M ey1wrl: eli rad o in l'i IIOlaiiO pure stati deliranti acuti analoghi a f!uelli che po!>sono o;oservarsi negli alcooli«ti e negli epilettici. D' or linal'io ;oi ha uno <-la di conrusi one m entale n alluc inazioni "''i ve e i udil1ve, con agitazion e 1noloria p iii o men o in ten sa. l malati nell'ac um e del d o• h rio si pr·esenlano vi o l euli, iu:<ouni, prvf.Hul amen te allucir1ali; hanno sete intensa, ingoiano mu"ticare 1 (Hichi nlinwnti, di cu1 ;.i null'ono; digrignano i di'n li, hanno contratture in !.Crupp1H)uscola r i L'CC. Alla mentale allucinntoria, alla eceita;:irut> ;;;e!.!ne l o ;otnto caratlerizzut o da apRLin. si torobia, mut leaa ; l o ;.tulo !>oporo:;o alle voilt' può preceder e f!u ello COnl'il :<iona tP. Non d1 1·aJo Ìll que;;te f111'nle ac ute in'<•JI':.tono ;;;tali di HIISietit analoghi a quelli tklln iniO:<!'I<'IlZione Alroolica. Ln

p•·r lo p1ù p r onta, anzi ca ralteri,;tico i l mi ;.d iol'tlmenlo rop i do dop() AdaltH curH. Alle volle ,;i Ila il HliH t'o 1'1118 croniCH p, di r·aòo an c he l' e"il" leta l e, dovuto n(•l ma ggior n um r o dt>i en« i a l opill'llici nd oltet·uzinni r ard •ache o 1·enAii.
L ., p;;:icn:<i cl uuicl 1e saturnine pe r IQ più t'llPI"'";;;.·nlutP dn d lpre;;;;ione dt>l !-l<'lltimento, da nllucin11zioni div e1·se col pt·o l.uu i uio di quelle u c ntenulo 1 enn:<o torri lìcanlo', da i lee dclirauti. Si puù pul'e ave'''' cefnlt•a, verli;..:intl, lrPmore. epilettici, r.mzio ro ntinualo èlgli orecchi cc' L'ammalalo rllìulfl il ci ho. pcrchi• :-o i crede avvel enalo; v· hA insonnia, di.,lurbi inle!>li noli, parai br, n111socoria, della pa r ola, contt·allure, t •· mo1·e audutu•·a O"c lli Anl••, d1 Ro mberg ecc.
La forma ct·on1ca può all'acuta; il deli1·io Il culo gua r 1sce, r ammalo l o l' orieu tamento etl un o relativa lucidità delle per s1!:'le la debolezza d• meu10r 1a, il diretto tlel crilico, e si pu ò arr ival'l' perlinù alla demenza. Dopo la saturnina si può pu1•e a \'cJ·e il fJuOùrn ti ella :s ind r ome di K o rsak o fT (psico!li poline!lritica), come del •·e!"to puo succed c•·e anche in segui to cronico.
La pr ogno!-li delle psicos-i salurnine croniche è perciù mollo più di quelle acuto.
HlVJ::ìTA D I :-/EVROI'ATOLOt:IA
--
RIVISrr A CHIRURGIC A
- Bulle ferite pe netl'antl del toraoe e •u.l .loro t rattamento . Studi m ed i co - militari ed i t i per cura del Ministe1·o d ella p ru l';:i:lno.
- (Ce nlra/ !Jl alt ju r Chir. , n. 35 , 1902).

L'auto 1·e d a• tu es to p 1·ege v o l e l ovo 1·o fa ril e\'are anzitutto un fa llo, a s uo parere I.J €'ne sc<·er·tato, emesso dall'esame dei rappo1 •ti m edi co -mili ts r•i , a sarebbe che In JH'O;.{IlO!'Ii ferilo penetr anti del t o r ace Msoggeltale a Clll'tt, Il comin ci are d lll l'opoca Je l t •i eco lo c allbi'O, <i di molto migl ior·ata. N o n tuttr pe r ò concordano iu qnol' la opinrro at e; tra questi il L i'rhc di K u nigs berg, i l qual e q ues ta "PJH )I!gianriMi ul ra ppOl'lo medico-militare s ulla g uerra i spAno-amePicana.
N"' l a\•o r·o c he q ui si t·iassume l'i prendono nalu1·al rnt• nte in esam e l'o !tanto 'fUOIIP fer1t o ponctr HIIli del t or·ace che so11n a ù una morte immt>diala s ul c ampo di bllllHg-lia fi che 'lllindi Yenn e 1·o in c ur•a Ol'pedali D i f'I'Onll• alle car ubiate coudizio ni d ei n u o , ·i tempi si f'a senlir•c più viv o il de rin òi un nu o vo st udio si nteti co di ques te l esioni ed il di \' f' ni r e ad u nn tli quHnlo lì nora fu ri portato dagli autori sull'ar·go m en to: s0 1to qne"lO r·i;!'U&rdo il lavo a·o di ha colmAlo una lacuna.
N el consuler are i t r e !'i n tomi car di nali Il i una l esi()ne polmonalp. cioè pneu moloral·e, cnlì"P ffill e"te r no ed emo rra gia, e da nolllrsi iu prrmo ch e esl'i sinlorui JlO!':;ono tutti rnauca r e. e sono enumerate l e condizioni capaci d i farli mnrware. A ssa i r nramen t!' sru g;:!ono all'osserv azione le em orragre l e quali sonn anclrl' ! t• piu peri colo-<c Tra glr altr•i feno m eni !'ono da nottu·si: l'ernia del polmo ne, lo lo!<se e la dispnea. la q uale ultima , se s i t1·a tta di l esione unilatel'a le, n o n e mol to :;rt·llv e . se pero l a l esi one é doppra suole e:>l'Cr e di un grad o ll"''-ai ele\'lllo e pe1·rcoloso compll'sso la di11gnosi n on è dillicile, pure l al v o llll i fenom eni po sso no e<:J:el'e lievi. La lesio ne i ;::olala dr·lla pl eura è r iconosciuta possibile an che nr-lln ((' l'I le cl'a r•mo da fuo r·o Il doror;::o i> divPr so a secon da che i· a, venula OJlfllll' n o la pen plra zione di inf,• tli\'i. N ell'ulti111o coso il pneum olorace !' i r i llSl'Orbe l'Ollecitomen tf', p<Himenli si a,;;::or he In spandimento :oa ngui ;:ruo e la esterna si Cl<'at1·iz1.a Nella !le rnpli ce fe r ila della pl t·l!ra cos ta l tJ no n ha luo go di so lito la adesion e tl<'lle ùue pogrnc pl <' uri chc, e ci ò è tla allribuir•" i t'I l f nllo elle di 'rr equenle s r fo r m ano essudati m entre quando so no !es t co nlern pol'lln eam entc en l r amiJi i f ogl i elLi pleu1•i ci, essi si salda no l' ubilo e l'ess udato rel'La
Alla penetrazione di ge rmi i nfettivi J'cmpiema, oppu r e p1·ocessi n ello s t esso polmone. Circa la formazio n e di e!<!<udati dilfu !<i o sacc o tr 'algo tl uanto fu tfello di sopra. L a p leurite adesiva è un l'e nomen o relativam .. nro fA \'OI'Cvole, perelit\ C!'Sa com e mezzo ,Ji protezione conlr " la
31-J.
M& andre Erli e!;!'udati sa ccn ti possono romp et•s i, ed Rll o ra il processo puo m,·adere Lut to lo spazio plt>urico. Gli essudati sit>rosi essere rari; per lo p1ù souo pmulenti, spe so An ch e irn1·osi. L'mfi l tl'azione pn('umouica iutorno al canale della reri t ft esser frequenl , ma rP s ln mal'c- her oto rlallo spawlimento nel cavo pleul'ir·o. Il piu delle volte fJUeFla infìlll'n7.ione finisce coll'm.!u r lmenlo o culla r el raz1on" del le;;su l o. no n mai coll a t·i•luZIOIIt! semplice e n ::> rm a!P. :\'t>i wsi pe!!'giori l'esito consiste n1 pneumon 1e cron1che c s uppur at.ioni, laho lta anche 111 infiltrazio ne icorosa di tullo 11 po lmoru"' e nella sep.3 i me questi P::siti fetnli , come pure g li asc-ess1 del polmone, sono sompre oipt>ndenti della permanenza di cor pi estranei.
LH pro$!nosi é 1ncerta. La pre;::.,nza di corpi estr·anei é sempr·e pericolosa. Le lt>sroni rl'ambrdue i pulmo n1 come pure le fe1 i lP del 1liu frAmma e la leSIOne di (jilalche addomi nale, dnnno la p1·ognosi piu infausta. Se il d1afr11noma è fel'ito in grande f'stens11Jne, avYiene qtrAsi se1np1'C il pO!'Mg"gro der VI · SCt'l'i Arld o minali nel tot'ar;e pr·oduc.mdusr la piu forl!' dispnea.
L u teeupia deve A!'<pellante; torna opp o rtuna l' ocdusione anti sP lli c·n oppu 1'e semplicernenlf' nseLLica della fer·ila; n on é da r accom andar si lu sutura primal"ia, ma pi utt osto In sMondaria, quondo co l cambi are del l'appar ecchio non s1 lr0\"8 n tò m at Pria le né r.. ubre . Se poi sia megl io alla imm ediata della l'eJ•iLII secondo senza d rsi nft:lzione, oppu r e alla di-' i nfezione p l'i maria cnnw fa K le tt n ell e ferite da pun ta del torAce, è anCùr·a questione indecr!"a. N..Jie fer ite già infet te, se 1-!l'andi ed ncc•HnpAgnate da p1·ocedet'e a sbr igliamento e fognatura ed u coprir·e 111 fl'rila con appaPecCIIiO Al\Sal rsteso. A dell"ontore ltt Jì!"infeziooe primaria dintorni della fe r ila ha molttt iniportaoza per l'ulleriol'è deco r so dellt1 lesione. Se s i ri l!o nosre la fer1la olell'arlerìa marnmal"ia interna o di un'arlt> rifl intei'COstale, qu..sti vasi debbono e!'lser e lr:.rati in Sf'no alla ft!r ita «tes"a ; ><e a qne«to non si d evesi allacci are la mammari" inter na in uno !<pnzio inlerco!"lale superior e <·d inferio1·e occorrt:!ndo an che colla pre\'la r eset.1une dr rwa <'ar·tilagine cosLOie.

Solo quando uno stravac:o sia copioso Al g1·a lo da ccoslltuire pericolo di vita, é da r a t• comandarsi la pu11z1one, o meglro la irrcr«ionP, pe1· dar es rto al sangue stravH5talo Pt!rò non de\·e!"i d imen li<'A r e ch e la rwese nza di uno s t l·ava«o c011lituì scc per s•• un mezzo di e quindi di ernostnsia sulle rer·i te dol polmone e che dopo l evatn questa comprt•ssione ri compari "ce racilmenll' I'Pmorr'A,!!i a.
:';e lA soluzione rli gelatina ap;iscn realm en te come emo-,Latico non é a11cor·a
Il !"aiMI!'n nC'II'PmOI'I'af{tfl polmonnle non P. nean c he dA mettere irr questio ne. Secondo F i ::;drer i l riposo ll!'soluto P l'op;•ro sono i mezzi prir ellì caci con ti'Od i es::;a. Le n l tre dev(lno t r·atta rsi co i sol iti mrtodi i n uso.
Ln del per·rca r dio è a ltr ettanto r ara qu anto quell n i sol ata della pleu r a; é p rò merro I"AI'Il ne l le ftl l'ite da punta Possono anche esser e l'o!'i t e I n paret i del cuor e senza rhe ne vengan o aper te le cuvit.à. Nelle feri to do purrta
In IP!;ion e no n pe r fo r ante detle pareti del cuore avviene piu oli freq uente eire nelle ferile d'armn ua ruoro : tali rer·i te scHro M olto più di r aro il pro1 .. llile rimane confìccnto nel!.. pareti o a t t ra ver!"a tutto il cuo1·e !;Crrza npr·ire le Crl\'Jta derorrendo nltraverso il !>ello. È notato a nche che l'e ffetto di lali fe r ite
1:> natur almente di ver·M a se t·orrda che il cuore viene colpito nella sistole o tlella diast ole, come purr è not ata la possibilità che la parete del cuc..r'e venga
Hl Vl>)'l'A vllli!Ult(HIJA
lesa sen za c h e i l pericardi", g ia d i mostt•ato dagli ;:pt•di di ll eic!em·eir.JJ.
Trala scia nd0 rli pASSAr e in r·ivis ta qu11nlo viene dello sulla sul decorso e ;:ulla fe rite del C:!Or<' , c i l imilt-r emo a nota r e che da l r'autore vie n in r il i evo l'impo rtanza del tamponamenlo del cuor e condo il metodo di f\tlse E g li condanna la esplot•azione c o l l e sonde ed invece ra cco mAnda dr dtlaiA r e la feritn e di appr of'tmdare i tagli a s tt·ati e tanto pet· acceriHt'e la I'J'll•nlrl all o di a pr·ir e i l pcr i co r dio ed evacuarne· i l co 11tenuto All ' incon t rfl no n appr·o ,·a la punzio ne del pericardio per vuo tare lo stt·avaso pet·war·d •co
Sono speciticnti :38 c11si d i sutura del cuor e t o l ti da lla odter na lelteralut·a chiru r·gi ca, tutti per fe r ile da punta con 16 esili di = p . 100. ;-!elle f•·t·i te d ' at·n•a 011 fuo co finn ad ora fu fatto cinque volte il t en t ativo di art•es ta e l'em')r't'a):!il1 rolla sutura, ma ;:empt e !'<enza favorevol e t·isultato. Ci ònulla ostante dopo i bei t·is ulta l i chP s i snr1o ollenuli colla sutura nelle ferite da punta, s i può asset·ire con n PI Ie del cuot·e e indicato l'inl e l'v!:!olo chi r urg i co anche quandf'l non vi sia indi caz ione vital e. La sutura de l cuor e è l'unico mezzo sicur·o per tog l iere il pet·i colo de lla emo t·tagia. C. P.
H. RoG"R. - Contributo allo .tudlo clinico dell'Erisipela.. - (Archicts (lt;nèrales de m ed ccine, l uglio 1!10:!).

Tal e stl.!dio é fru l lo di t :>n8 di ri :;i pel a. n!'<Sel'vaz io ni fatte dall'auto r·c dut·unte i l suo sc•rvtzio nell'os,.eclal e d'i sola men to della citlù di Pari gi. E;iolouia. - Soltanto 2 :) dei t·i sipelatosi o50.c;e r vali avevano Avuto conlallo co n allt'i mo l ati rli srmil gen ere; n Pg!i allri ca"' i la ma la ttia ebbe proba!)ilme11te o r igine dall'esulla mentu di germi ]'Uilulanti s ul l a cule e !<UIIe mucose di iudividui cito presen t avan,.. una <:e r ta t al qualo o ereditario o pc• rsonale
Part•ebbe avessero una cer t a influ enza la stagione (p ni f r equente nei me si cnldil ed i pe t•cbè spesso a ccomp agnal i da abrasi ou i c u tan ee)
rlella mahlllia. - NL'IIa metà ci era dei mesi OS:'el'vati. princi piò coi brividi d t fred do, as socioti a l vomtlo so l tanto n el 5 •l o d ei casi.
Co n l rar·i amente all'asserzione classica, co min ciò rarttme n te con un' llngin a. r·itieu t.J che spesso c ii> ch e i pazi euti acc usa no per· mal di gola non s ia c he l'etl'etlo d i dolor·ose premo11itri " i. Più rli so ven te o sserv ò coriz za ptu o m eno inlen ;;fl, LAivolln accompag-nata da epi stassi. La malattia inizi o!'<si al na so in oltre 1!:1 m e tà dd <'tt!'<i osser valt .
Swrli Ili a'cuni sinto mi - QuanlutHi u e non vi sia roppo r to a ssol uto fr a l'ìnlen!i" i lù e la tlur.nta del movime nto f ebbr i le. può affermare in modo g enerale che la J'ebb t·e >;i l a nl o l li Ù per fJUAn l o r•s!:a è in t ensn. P er ò i11 mclti casi, ma l gTa.J o un"elevM:ionr l el'mi cl'l di 40' o dt }Q• fl, il rno, imenlo febb r i l e cessò complctnmente dopo 2 n t r e gio rni.
Ehbe ad osser va1·e f't·ei'Juentem"llle ti de l i i' io, speciolmente negli uomini , e nel maggio t· numer·o der casi in a l cool isti. In questi ebbe a notare in pa r i tempo un certo grAdo di i pe r·trofia del f ef!a lo assoc i ala ad ulbuminur·ia de l fe g-a to, c h P. r·iscon tl'6 f r •'• ! ue nli l'!'<i ma negli uomini , coesiste'a spesso con l'al buminuria nnchc in non alcoolisti, cio c he s ta a dimo s tJ>are
RIVISTA CHIRURGJCA
ancora un a volta l'azi one dei reni e tlel nel l'or·contro le intossrcazioni l'albuminuriu p r ecede le man i fc>=luziorri delirnnli, talvoltA l e
Disturbi car·draci da rum ori di galonpo e da soffii e-.:lra-ca r · draci, vennero osser vati in circa il 32 ·r. d ei casi. Tutti questi soffii erano rn••· sosrstolil'i.

Rit•adute. - Si pr·esen t ano o r .i i nar·iameole in m odo brusco. T alv.. ltA il d ella faccia s i produce •1 uasi di botto, !lenza che s i posc:o dir·e in qual punto c ominciò la nuova Quanolo le r·icadule sono inlen!-e. e-1sere accom pagnale da disturbi ner·vo-<i. T alora vide delle arlrop•llie p u atieno-ll t!mmoni collo, o degli ascc>=si del cuojo cal'pelluto. Supp ura•ion.i. - I n olt r e l!lOO o:;servazionr, vide appa rir·e nl'Ct''"'Ì in a lcune di tol i suppurazioni era no minime, altre i u vece co rr <>r.le r·c·,·oli. Deg ni di noLA gli a <>ce-.si delle palpebre, genPra lmenle di lunga clurnlo P a c<·o mpAgnoti dA !lfacel o. Si conc;ta l a r l)no ino i LrH, con abbustan1.a fre•ruem.a. suppu r azi oni delle (Jarti vi cine alle Affette da ri !lrpela. Cosi vid e appArire rlue o liti f'd un'amigdalite ll ò mmo n osa dop•>
Complicazioni polmonari. - L e t o t·uc iclr o lA ri!<ipe la sono g rand em e n te influe nzate dalle Sla!:ri onì. Sopt•atutll) l'reqtwnli nei m e!:li el i Marzo eri A pt•il e in f!Ual c he cao;;o s i espli cano se m pl icern o nte con u ll'interrs a bro nc hite, eire talvol ta. e> t endendosi ai piccol i bron ch i, prC!'t-lnla'<i l'i· b PI Ie alle praticato cure eJ in buona parle cont t·i buisce Alla di'Ilo stato g-ener·ale.
Distn r bi n. errosi. - In ca!" i o'lse n ò. rrtlllle wanifesla7.iOrH' nervosa più frequente. u na :>ind r ome cons i'l lPnlt-l in una pa r <'"i de:te membrA i 11feriori , corr ipere ;:.tesia cutAnea eù e<>na<'t'azrone dei riI n talunt casi la paresi si estese anche alle m embr·a supP.ri or·i: J:IIA · r it·ono nello s pazro d i 5 a 12 gior·n i
.\,ft>rtaltlti - Su l adul ti chP ebbe in cura, 9 1 socco •nhellt•ro ,·aie a dire unA morLalil:t totale ci el 6, l per cento.
P erò come un cer to nnmer·o di mula li '-Occom hette a l tr:l'alf,..zil)ne Anler·i or·e, es;;oendo;:.i sviluppata la rr<>ipela nel perrodo ultun", oppu r·e e;:.sendo j:!'uar·ita ht r h:;iprla quanrlo sopravv11nne, pP r· la lllht'le. Toll1 tali casi. la mo rtAl i tà Hl 5. 4 p,..r cento.
COII!:>itlero : ioni terapeuliche. - L'autore ri nunciò comph: t!lmcnle nll'u.::o d 1 !•l•m ate , d'empiaslri e d i coìlotiion destinAli Ad arres t are il prodell'e r e"ipela , non a ,·cndo fidu c ia alcuna nell'elli cndn di r imerlii ch e C!!li lrovn sempre cl(llali di q11ali la ter·ape ulica Qulll e trallarnenl" lncale le compre"'e ca lde r·i nnovale frequente m ente luotl) rli r isipel11 dello fA ccia comn delle m e mb1·a. In quel' cAso, ' lllllndo adl)pr·a dei bagn i locaii in solu zi o ni leggi., r·e di 1111lo di poLa<><;a all'uno per· 10,00'), faéendo in seg ui to ùelltJ fnsc i n tur·•· cort (;tt17.8 in n n
l miglio r i risultAti li ottenne dalle a pplicazion i d'Ac -l ua os'lr).rormla neulrnhzza ta. Quanrlo lo r i s ipeiA delle m t>mbra Assume un decor><o in•1u re tnnt c ntiopera uelle injt't.ioni di una soluzione d i bi carbonato <li so In al } per IOOIJ. p ratre o •t trultr o dA 5 o fi rent11 n etri cubir i , aliA periferia d t> lle lesioni, n attorn i') Ai pun t i CtldU t i in sfttc!'IO. Se la lemper•allll'8 é eleveta C l 'adi 11arnia pt·oronda adopera il bagno lPpido Ja :!8' a l :32", r accomandando la m as;:ima
BIVIS'l'A CHIRURGIO A 347
nei nvanzati in eta. n ei qual1 può prodursi il colassu N el de lir·io specia lmen te trallau tosi di a lcooli s li, somministra un m ezzo litro d i vino co ntenen t e O g ramm i. 10 centis:rommi di estrat to dandolo nella giornata a piccole cio ;i. Tal e rimedio ù ben sopportato, e di miuu!f't:e ra pida mente i disturbi nervosi
0 1p end endo il delirio da te mperAmento nev1·opalico consiglia i sedativ i , spedi valeriana a lla rlo se di 4 a :'> g rammi, il b r omur·o di sodio o di cal ci ù nlla Jo;;e d i 2 g ra nmi e per lA notte un di solfonale o d i trin nale.
Non si ad opr e ranno gli antipi1·eli ci se n 1>n qnanrlo la febbre rive"'le ca ratter e interm 1tlenLe con esAce riHJZIOni ve!<per• t ine eJ allora si prescriver·ann o da 0/JO 11.! l di solfutn di c hinico nelìa m allin ota.
Tal i metodi curati vi sono del r esto quelli la di cui a pplicazione ser,·e lli bA se alla t er11peu : i ca g ener·ale delle infel tiY e. G. B .
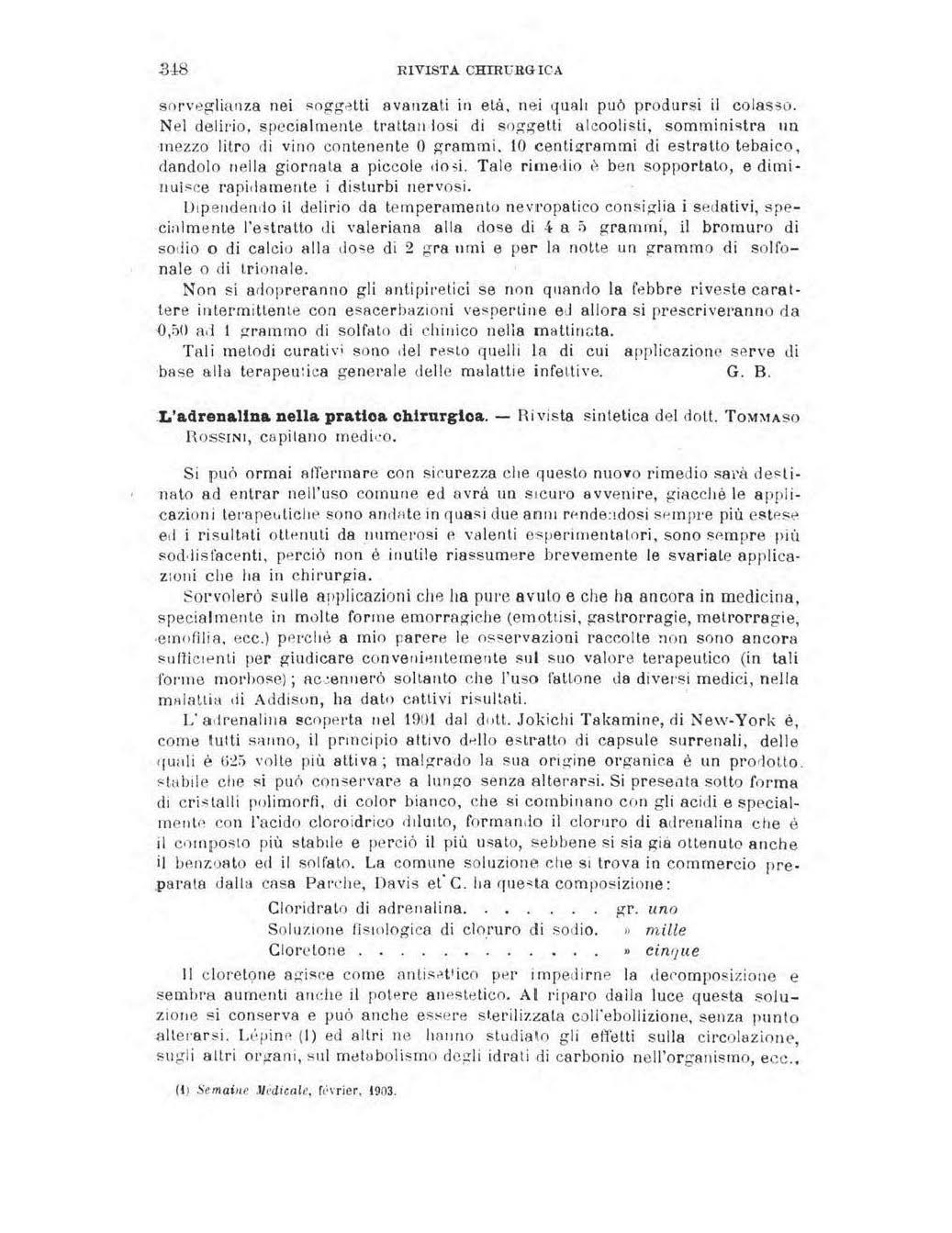
.L'a drenalina nella prattoa o htru rgloa . - 11i vista sintetica d el doll.
H oss rNI, capitano m edko
Si put\ ormai con sirure1.za c he !JUesto nuovo r•imed io ::<ei'i l nAto ad entra r nell'uso comun e eù av ra un srcu r·o avvenir•e, giaccltè l e a ppl ic azhuti terapeL.liclll• sono A11d 11 te in qua;; i due arnnr rr•nde: !dosi SP il1 1H·e più e!i'lPSt> ed i ri s u ltAti oll••nuti da numet·osi fl Vlllenti sono ;;pmpre più sodolisl'acentr, p pr·c iò no n é inulile riassum ere brevemente le sva r iate app li ca· z 1o ni che ha iu
:=:ot·voler ò s ulle a ppl icazio ni c l te ha pure avuto e che ha ancora in m edic ina. specialm ente in mùlle forme emo rragiche (emottisi, metrorra g ie, e m orìlia , ecc.) p PI·che a mio parer e l e r·accol t e sono ancora ;;uflict,..nli per giudicare s u l s uo valm· e l et•apeutico ( in tali for·mc mot·IJo;;e) ; so l tanto c he l'uso fellone da d i versi medic i, n ella mH lnttitl di Addi son, ha datn colli vi ri ;; ultnli.
L'adrenalina sc opel'la nel l!lOI dal dutl. Jokich i Takamin e, rli New-York é, come lutti !S>lnn o, il pr1nc ipio attivo d...IIo e;;;tr·at.to di capsule surrenali, delle 'fUi di é volte più alLiva; malgrado lu s ua organica é un pro •lott o !"ll:\bd(' che l'i put'l con-;er·vnr a a l nng-o senza Aller·Arsi. Si presenta solto f 0 rma dr c ri.:;ta tti P''limo rfì, ùi c o lor bianco, c he si combinano C(•n g li acid i e specialrnenll• ron l'ucidn clor·o1drico d1lu rto, formando il cl o r •Jro di adrena lina che è il cn m po;;to più :;labile e perci ò il più u sato, se bbene s:i sia g ià ottenuto anche il benzoA tO ed il sol fato. La co mune so luzion e che sr tro va in comme r cio pre · p a r·n ta dal l a cn sa PatTI! e, Oavis et' C. ha que.:;ta composizione: CIMidr·ato di arlr·eualina. gr un o Soh m o ne li l'<w logica di cloruro di !'loJ io. " mille C tor t tone . . » cin.t1ue
I l c l o r el q ne a;..:i"'''e co me nnli;;<'L1icn pt'l' r mpedi rn t> la deromposiF.ione e sembt•a aumentr andre rl potPre Al t·iparo daila luce que1>ta sol uzro" o s:i conserva e può anch e s r.er•ilizzata c o ll'ebollizione, senza punto Alt erarsi . Ll• !Jin r ( l) ed altri ne h !l iiiiO studiai!) gl i eft"elti sulla ci r·co)lazion(', !'U;.tli altri or_gan1, ,;nl melubo li!' tn o rl cstli idr·ati d i carbonio n ell'org anis mo, ecc .,
(l ) .Se mai>IP Jl<·dicai P, flol"rier. 1903.
3±8 RIVISTA
CRIRT.iJlGICA
e quanto alla tooosi cilit dell'adrena lina U :pine ver-rebbe alla cooclus1one cl1e 1:> mollo los!'ica. ma che n on hA azione cumuletiva, il che fo r se è dovuto alla pron ta 0!':3td8Zion e clu• subisce n lrorl!ani s m o.
0 <"1 I'PSlfl rolle piccole dosi che SI nella pratica, in quesli due ooo1 di prova. uon souo stati mai o;:ser vAli nell'uomo !.!li elfelli t ooos1ci che cou do"i ha L···pinP, n c r suoi esperunenl i sugh an1mali Quello che e cer·to si é. che l' nd l'enalrna nou ha r1vali , co m e vaso-costrittc.re il più t> rH•r·g•co c he ,.i couo:<ca. Lu :>ua a zione é e l oca le : sommioistr·Rta iutt>rnumente determ i nò 11umenlo do>lia Len;:ioue ar·ter1nsn su l cu11re e tun ica d,.. IJP. arter•e t erm inali. Appl1 ca ta loenl mente olirno!' ll·a nzione eJ emostRliCR forltssima t>d Rll' rs c h em ia c he no• dt>ri,·R si "'""ocia IIAlu r almenlt> l'llut>.ste;:ia.
Si potr·t>bbe pensare che alla diffw:;ioM dP.II' u;:o prnt1c0 dell'adrenalina ;::i opponctA il prenn Plo>vfllo che tìno a •paalchu m es'1 l'a ot•a tli circn :Wo 0110 (: ) l'rmachi al clll l ognunmo (l) ra e l!ià sce:;o a propo t'7.aoni un po' pi ù mn pensuudo c he si aJopern in snlitzione al mill esuno e c he Lut t o al più se 111:1 IJOlrù di qu.,:;tu, irnJJtcgare uu centi m etro cubico, la 11 0 11 pun ruppre senLnla clw, al massi mo, ùa veuLi cen tes im i ogn 1 ap · plicAz•onc e molLo piu rid o tta an co ra , quenòo s i adoperi un i to olia soluzio ne da cocAina come l a p!lr te dei ch irurg hi sogliono u sa rl a.
È sLRto ti B roun (l) che con uno studto sperimentale accu r ntiss11no e completo, ha tlimosLmLo che l'adrrnal i na unata ad una so luzio ne di coc aina ne t•af· f.ol':ta l 'aztOn -< an ••s telica e tltl prolungtl l'ellcl tlo, re s tan rto la proprietà t>mostatica d e lla adrennlina steoosa; pùrò, per cltò ciò Rc cada, lA dell'a Ire· na,lina tmpi es;!'alR, nnu deve un milli g ra mmo e la soluzione nou cle\•e avea· dell'l su 10,000. In pralica ques to si otti ene ag;zi un gendo due o tre gocce al massimo della sol uzio ne di adrenalina al millestmo, per ogni siriuga Pra valz conl enenle un g rammo tli soluzione Ù1 cocaina al 'l t p. 100
E ven endo piit par ti col armente alle applicazi oni pr·atiche, vediam o, c he gli oftal molofli, i quali ltanno pÒluto constatare che una goccia di solu zi one all'l p. 1000 msti i i Ata nella congiuntiva toglit>, per due o r e almeno, qualun•rue lracc aa di preesi s Lente inllammazio ne l'adopet·nno su larga !<<'ala 111 qua 'li tutti gli interventi opPrativi oculari ed alc uni asseri scono che ha pel'an eS!>O la en u cleazi o ne del globo oculare cvn la pP r dita di poch(• goccio di E l 'associan(o alla cocai 11ll, ai miotici, ai midri... tict.

A t:c !:o più usata é nell a p r atica dove il T J'ivas (T hése de Bordeaux ! !)():!) p1·ima, e poi I ' Hah n (2), il L ermoyez (:J) e molti a ltri l'ado· pe ra no nei casi rta COI'tzza, ri nite miringite, m a m eglio n egli intr r veu t i crue nti, com.., n el l 'abla'l.aon e dol cornello i nferior e, nell'aspo rlazioaw ùi ve getazioni adenoidi, nel r aschiam ento d i larin gili t ube r col a t•i, n ell' estr azione di corpi estrau ei della fo st>o nasale, n di tum o ri del cavo rino - faringeo n eli<' trmsi iiOtomi e, ecc., e sem pre unita alla cocaina Tulli sono co ncord i nell'urnmeltore la r apidissima i schemia delle par ti su cui agisce e pennellandone la piluilaria questa diviene di bollo bia nca e retratta.
(I l UftA Cs. - Archlll (u r lihnische Cllirurgie, 67 Band.
( 2) L'al$rnall•w eà il 1uo 1110 itt otorlnolariii!]Ologia ( Bollettino dtlle malattie ortcchlt, 11a10, gola, G,
(3) L Eft MOT!Z. - Un grnn tMdicamenlo dell'avvenire. CPrt31t lledlcai( 37, i mano t !lOl)•
RIV I STA CHIRURGIC
A
..
C o<>i put'l! nella r hirurgin denta ria Rallier ed allri per assi c urare l'nnestesia a lnpt> rnno In mis.;(' )a di coeain a e at:lremliiua. Uno tiPi prlm1 nd el'pel'imenlarla n ella clinica è stato il Darlrma ( l) nella chir unW\ tl\'1 11' v1e urinAr'iò non c red e che pns5A mollo utile nell'urelrolomia inlt>t•na, op.-raw1ne per !IÒ poco dohll'o-<a e p oco e l ugualmente 11011 repulii chr a r·r·Prheru vanln,(:!.!io in nlleztOo i v esci cah rwll e quali l'em ••r· i.: il fallo pt't>dominalllP, per..:hè sr riu sciru ac l Jl•·r <Jualcl te w·a, qu<'"'IA t·int •pnril'8 ben p r P.slo con la l'le;;!l'a e ror!<e co11 lnl.•n"ilU: invece. tl ' tH·co r Jo con A lh11ran, r eputa utilissimo l' im p1PilO rlo l l'o Il'•· uahna inl>lil ln la n e iiK Vt>!'lcÌI.!A, per pn'llicare la ch>loscopia t' p.-r o1ff.-renziur11 una , .e'lctt: ale tla untt emorra>ria l'!.'nAi t>, n ella <JUAit• ullima for'lll8, nt>«suno i nflu l• nza potrebloe avere una in !lli llnzioue di adrenalina i11 ve cica: 111oltr·t> l' P<> ame ci"-lno:copico !'i r ende po:>sibde con quel'la PffiOl'la l'ia temponutro. mentre in presenw di unu ve!>cicll sangurna n on i· po5sibile pl'ttl lral'lo Infin e l'adl'l"nRiina rende più f!lrili le manovre ci sto!';cop i che dirninu t• •,.Jo I n f>e n!'ihtlita loc:ale del IIIAialo. I n lA i i ca!'i ba st ano :!0 a 30 delhs so l u:done Ai m e!<l'tl a contat to tiri collo vescicalo,: dPII'n r etrn e rl ll" pot·z•on o mem b •·anol'a e 5 a IO min u ti dopo !'li può apralicAr·e la crl'tos copia
Q••onto ai r e«lrin::rimenli ut·etrali B11 r trina "itme alla conrlu;;iono r h e ogni
qnét l vr•ll a sono r o mpl i cnti rla o !>pOE<tno dt!ll'uretrfl, conw fr·('t )Uen t•• rncnle avvirne, 1·atl•·ena!Jna 1•iuseirà ulili<:sima. gia echè nPssuno pu ò m eltt>l'l' i n duhht'J il v11ntag;,:IO di ope1·are in un c;annle precedo> ntPmenle decongos ti onllln ed ane '< LE'ttzzal P e•· lo 111eno il suo I'HI·il !ZIHHlag-na t·e d t- llempo Al med tco che rius c•1 r ù piit f11c1!menle a l'Or·pas!l'ar e i resll'injlrm enti che appai "ll'J ì nv inc•lulr e l evrl•'rli sotfer·enze Al mli l ato.
Cont mpOrttnPnmenle a lla pul.hlicAzionP. del lavo r o tlt>l Ba r l r inn, Friscl1 di Y it•nna (:!) pubblic11va pure un su •l stu lro !>pe rmw ntale nell " IIIA I Atti e ge111 Lou r1 nsrio, veJt ••rlt )O Ile i rlo-nuclte eo n du!==Ìulli dd 13ai'LJ'IIIIl, ><ull'i m p1ego Jrfl'ad r euolllla Elllr ne hn fn lto tiiiC' h e uelt' t::>Lir)'a:r.i•.'ne di tum ori ,·e;:cicali, m ed inn l•' ilta!!'lio <:o vt•a pubtco ed ha 111011re ot t enuto olli mi t'Ì'-ultati nel cat('lerismo e u ello rileuz ionr d'urinA pe1· ipet·Lrofìa pt'O!IIatica.
Stnndo cnl'l le co;: e, neso:una mei'O\'ig-lia che anclre nt>lln
l'Ai e P <.pecialmPnl,. n ell a p•crola chirurgia, l'aol r e11alino I'Pndert' grandi SS I'\'I:!Ì come emo!' tilli co ed ano,lel rco : e son numero-.i a!IMi gli espc t•iment u t o ri in e lutti CO IICOI'dl e mio pt'Ojlrl8 ec;pCl'iPIIZA Cgiacc h o• \'i c>ne c;ornu nemt: nt•\ im pic:;:-A lfl nella clinira clri rnr !.!icJ dei iK R. UnivPr-<rla 1li H oma dir·,•tln d11l pmf. DurRnl l po-.so affer·mar e dw é ri cono!\Clllln ver·0 qunrtlo All'erniA il l k11un o: !te CIO•· l'nd •·t• nalina rall'o> r7.a l' l' 111.ione <lo•lla cnc o •nn t> c·l1e l ll "UR ap pl icn1.i o ne é sPmJH·e da iuten ;;n vas<'-cm•tr·izione e dn Hb•JI IZH'II O della ;:en!'ihililà ul dolnr·e l n n c;:l'UII coso h n vi s to (com e .l n ukuni r. i tem e) alla IHirerw linica una n olevol t> va !'Odi lotaziom.) in rno .l n , rla p r ovl')ca re r•il e \'anli emnrrngie n è h o mn i potuto osse l' vJtre e llelti n el la mmima dose n ella quale è sta ta sempl'e implC!!Il lll ·
I l pt·or. UUJ nnle J' im pi ega sempr e unito alla coC' aina nelle proporzioni d i :l gor•·ie di sol uzione di adre11 al rna al millesimo per Ot{nr siringA Prava tz p1en a
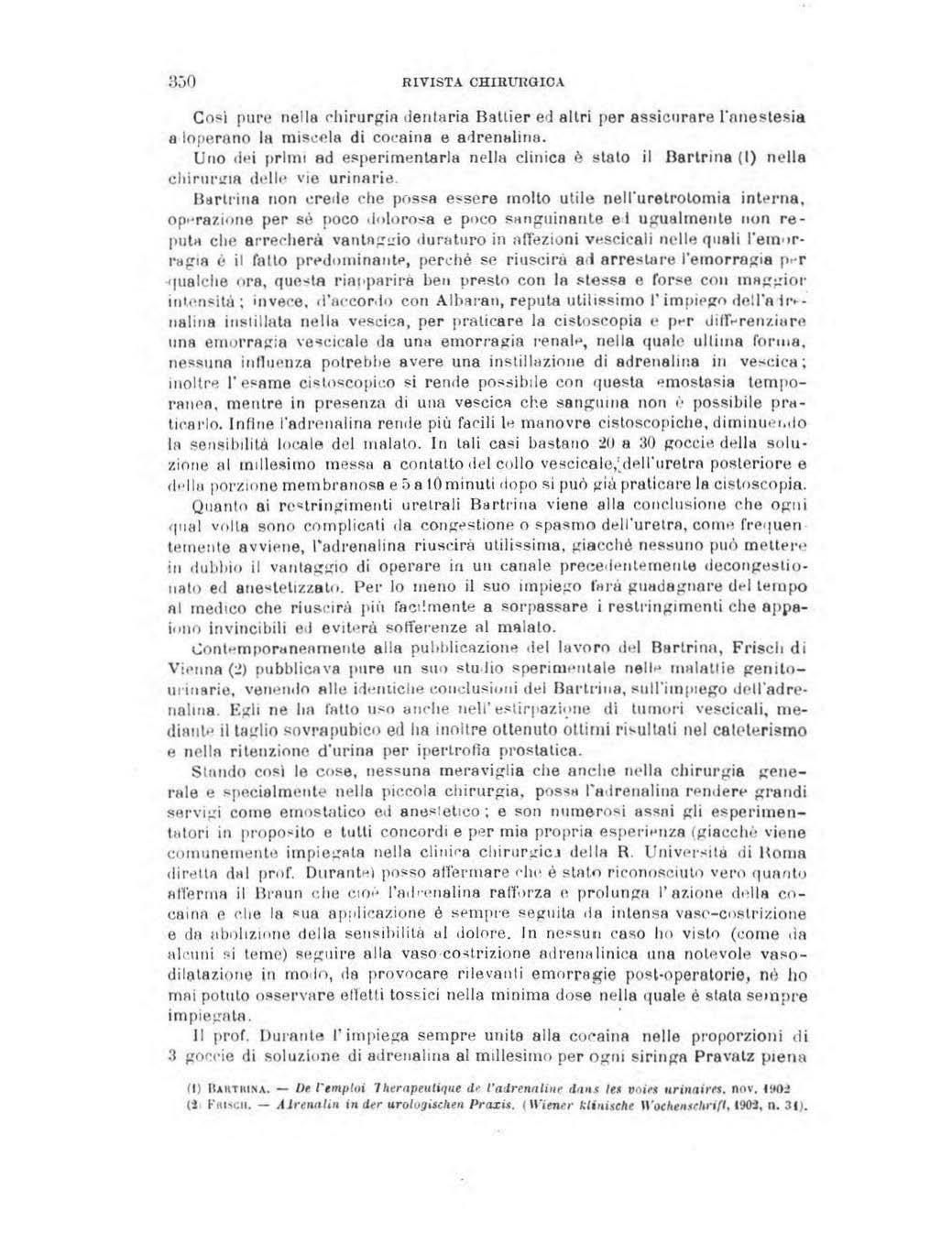
Il ) D• remp lm "l hunpeul i flllt d • l'adrenrllu"• tl r101< ••nun•rn. nn\', WO!
A1t't llll l<11 111 dtr urolugi$c/mr P ra.xù. ( ll"1tnrr klitii$Cht ll 'ochtn<rlll'r(l, 190-J, n. 3 1 )
:}jO
RlVISTA CHillUUGIOA
-
ili soluzione di cocaina al p 100; facendo ripetute 1111ezioni ipoa l ermiclle .attorno al campo opera t orio: e in tal modo pratica aper tura di ascessi, recE>n· tazione di fistole, plastiche cutanee, estirpazione di piccoli tumori e verllno li'Bcheotomill d'u1·genza e sempre con buon l'lsultato anestetico, sia emo· statico. È s tata anche pi'Ovata l'applicazione topica della soluz1o ne a ll' t p. 1000 direttamt!r.le sulle superfici sanguinauti, m a non sempre ha dato buoni r1 sul· tali e si comprende fa ri lmente la l'e morra gia paren chi matosa lra<>por·tn con !'t\ il principio medicamentoso di e!'trin!:'ecare la sua Azioni' va<:.O·CO!>lrillrice.

Un'ultima prali<'fl 11pphcazione Jells adrenalina l'ha proposta il Le ;-o.;oir, cnutr o le emo r1·oidi ed anche Boacha1·d ha antto occas•one di coustnta re che la ap;•licazione d 1 un ta1npone di cotone imbevuto nPII11 soluzione al mille!'imo, è !'lata Sll;:uita , in meno di un'ora, dalla Jecongestiune delle Vl'ne tum efatiP: e M. ;\lOs!'IO di T nlo;;;o l'ha trovdta anche ellicace in un raso nel quale il pac · chetlo emo1-roiùario turg-<!scente ed irt•iducibilf' minaccia\'A di strozzar!li. che un1;1 medicazione col"ì semplice 11 senza alcun in('onveniente, lllt'l'ila di t'l'.Sei'O in analn{!he cl r ca,sla n:te e 1n tal i casi si potrebbe ancl1e odope1·ar•e 111 pomata assocuw.!o da l a 5 ;!I'Amllli .Iella scìl uzi n ne di aù1·enalina al millt>;;;imn, co n g r. di lunolina.
Roma , l!) oprile lfi'J3.
Un ouo 41 tumore del mid ollo •plnale . - (ll erl in e r H'oc!tenscltrijt, n. l!, l !)0:!).
È una n!"<>e rvazion o clinica inte r <'s"ante sia pe r il •tuadro fonon 1euolo:.:ico della compres!'ioue uniiAter·ale del midol lo spimtle, s•o anr hc perc:hi· h1 din · J!nO"i potò i<labili r!'• in vita.
TratkH!I di tlll uomo sui •tual·anrann i. che accu!'ava dolor e ipnroncl r 1o <>ÌIII'<tro. c;pecinlmentc alla 1111lervala dalla s· e g• raclll' e dolore ritenuto dot>pr 1mo di or1gine rcumattca, pos ·ra (nPvrall-'ift in e 'Jilin li lrnltat o conseguentemente. Ma i ti'Rllamenli ini1:18li non a p • roda1·ono A nulla. e dopo brevi so<>le il dolorP di,•enne conliouo e coo:,i in· to?n-o, dA irnpediru Al certi dalt movimenti e da costrin gPrlo o l t> ner;;;1 dor·:w ed incliuatn a sinistra.
All'e :>amo pr·nticalo dall'A. non v enne ris contr·ata alcuna drrol'nutù delltl col01111a v PrtebrAie; In tlt'e-<!'.lo ne e la percusl"ione delle apofl!'i spinose dP IIA e 5" dorsule ,leter·mim1vano li eve .Jolnr·e. La i spezione 1\ello tJddomf' fH· r va rilf'vor'' lA cica tr f('e ombelicale al!juanto dev1ala a dPi<ll'a e lA pn r et e ocllcJminah• si11i•t ra un poco appianata. L'esam e eleLLI·ico, diflicilo pPr l'abbondRIIte pannicoln adipc•so, dimostrava che i muscoli addominAli di que;oto ln l o non si contrar:vtuiO ne ppu re sotto l'a:tion e corr ,..nti flll'lldi ehe molto tnten ...c. Il ritl O!<l'O addorninnle mancante a sinistr·a. persi;;tenle a destr'll. Dal re<: lo non di!'turbi af,•Jia sensibilità nè alla 1·egione dolente n l• o 'JUeiiR dorst11e; non ulterR ziuni e sensitive, non alterazioni dei rifles!l i AA'Ii arti inferiori.
L'A., baflnndol"i sulla perf'islenzn e sulla intensata rlel dolore, !'lulla muncunza del riflPsl"n a ldnrninale a sinis tra, sulla pare:,i atrofica cle1 1nuscnli o l f!om inall del lato ammnlalo c red è, ammissibile la esistenza di un tumore netrinterno del l'anale v•·t·tebra le; pPr·ò, potendo pur tmttarsi di sponùilile (Pnta, con!'igliò l'indiviriuo ùi ! Mtar'è il husto di e di tornare a farsi Ofll'ervare dopo un erto tempo.
RIVISTA CHIRURGICA 351
tJ n nuovo esoamP, fallo t r e !<l'ttimane dopo, fecP. rhe la pa r C'"i d··i mu<>co li addo minali tlt'a aumentala ; ch'o! la sens1bihtù della t'e1t10ne omb•>l1cultl· (' olell'ipOC()Il !t'IO sinistrO nei territor i inner val i dalla 8 " e !)" radi Ce dllt'SH)S ernsi falla o ttu sa ; che l l'l gJ mba d esh a pref'enta va term o- aueslc sia clt g r ado uote,•ole. Ven1va quindi ad a"SOdar·si la d i agnosi di tum o r e enolo v ertet>rale compt'i monte le r adici spinali. Si discusse circa r opportunil8 dell'mtervento ma si deci!"e per l'a spellaltva, consiglian do nll'ammalalo J'uo:;o ·lo•Ila iothpi na e dell'aspirina come a ntinevralgici e la ron tinuazlone olell>uf-lo, col quA lP i rn o vinwnti della colonna vertebraiP si compievano con m111!giore fa cili la. t\1 11 le co udizioni d l malato in br eve peggio1·aro no :>empre pni. La Sinne nel dorsale non diede 11lcun r1 sulta to; sopravvenne la paraplej.!ia, r ef- tan do l'al'lo infer io1·e sinist1·o complt>lamt>nle para lizzAto e IJnell" ole!'tro con In sola possihilita di el:'egui r e i m ovi m enti de l p1eùe; i r ilh•ssi leu ollnci n cwe si n o ta vano pu1'C il clono ciel pit•de e.l Il rn cno di Babi ll !<ki; inolt r e dol ore a cintura, Si p r ocPdò nllor a se nz'a l tro all'atto ope1·nti\•n. Aper to In rf\ chid•• ed i n cis a la oh u·a m eni:lf!S, si r inve nn e in corr i sporodenza della 6• " " l'lebra dorsnl e un tumorr, dell n p. ran til'zz a di unA gTossa noce avellann; l umore, che ve1m e 8!<porlnl<> !>e nza punto l edere g li elemen ti nerv o:;i c"n ti gui.
L'e!'n m o mi c i'Of:COplt'o dim os trò ll'llltarsi di li b i'Oma, che aveva pa1·zialmenh' suloila la degener azione mixotnatosa
IntAn t o 1'1nfr•rm n o r .- dopo l'allo ope r a t ivo non pii.J al c un doln1 e ed Pl'll nff11llo l ilh·l'n; il pl·ogredi in m r>do contm uo; la par·fl!<embravll r•i«o)\·el'"i, la vesci ca si !>vuotava spon ta neamente. M11 al 4° gio rn o soprAvvenne la felobrtl con irrequietezza. ollusotà del f'ensor1o. m eteori :>mo, vomito, la chical·dia e tachipnea: l'am malalo m n1·i dopo qualche Altro per Ji cer ehro-spm61e purulenta. co m e venne conft:l'· mato dnll'aulopsill.
L'A ri corda gli Altri poch i Cll"-r c l i n ici di tumore endove1·tel>r·Aii consacrnt1 nellA lellerntLJI'8 (Gowers, Schlesin !!'er , B1·uns ecc) e con cl ude 5ulla r aziouah tù dell'interveul" c hil·urg1co nel casv da lui o-.ser vato, nonostante l'e,;ilo letale soprn v,·, , nuto. <"'/· JAnout, \Y - Cblra rgla d e lle arterie , aaa appUoa sloae la aloune lealonl d ell'arteri a f e mor ale . -(La Se m aine m édtcale. n. f!O, 1902).
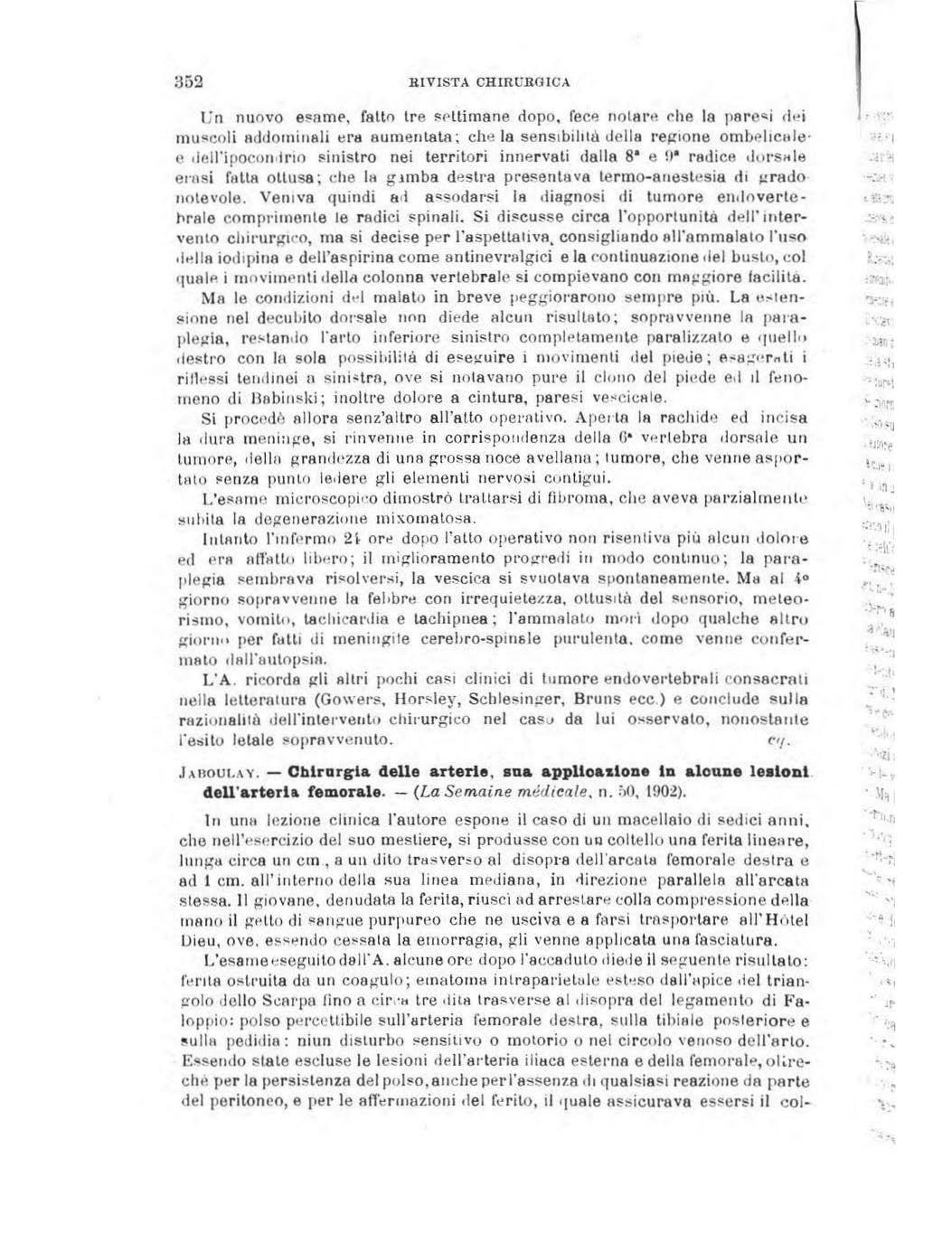
In unn chnica l'autore espone il caso di un mAcellaio di f'ediCi an ni, che nell'!',;t• r ci zio del suo m estier e, si prod usse con UIJ coltell <• una f er·it.a lineAre, lu ngu cil·ca un c m , a uu Jito al disopr·a femo1'al e ùeslra e ed 1 c rn all'inte rno della sua linea m PJiana, in tl i 1·ezion e parall elo all'arcatn sle!<sa. Il giOVAne. den udaLA la feri t. a, riu scì n d arl'es t ar..: eolla compref'sione d P. lla 111Atl0 il f!t> llo di "tl ll l!' lle purpur eo che ne U!"Civa e a far si li'Mpor·t.are a ii ' H•'\te l Oieu, ove. 8!'"" 11tlo ce>'!'ala la en ro rra gia, gl i ve nne appl 1cata u na fa scia tura.
L 'esame !'eguito dall'A a lc une o r e rlopo l'accadulo diede il sPguen l fl l'i l'lul talo: ft> t'ltfl O>'Lr'uila do un coagu lo; e matomB intr apar·i t!lule da ll'r1pi ce del Lrian!!'Oio dolio Scfii'(JU (ìno o C:ÌI',·tt tre ditA a l d i><Ofl1'8 del l t>g11 m en t o di Fal oppio: po l so su ll 'arteria destra, sulla tihiA ie po-.te r ior e e !'ullfl pedidia: niun tlls tnrb o !'ensillvu o m otor io o nel ci r colo ' ' enoso de ll'a rt o.
E<>!>enclo state Pscluse l e lesioni rlell'al'ler ia t>Slel'l18 e della femo1·ol<>, clw per la per s i ;;;tenza d el po l;::o, anc he perl'a,.senza oh qual"iaf'i r eazione da parte del peritonco, e per l e del ft' rilo, rl •Juale us,icu rava esser ;::i li c ol-
RlVJSTA
CRIRU.ROICA
l . -· "' l r. · ·: .. ···1"'1 . •• lJ, • "1. .. •'. \h • r-lfl .· '', " l· , ,..
telln per soli 2 cm. al piano d .-Ila paro>le addoallr1bui la Il Ila ferila dei epigastri ci. Pe r ò, nel timo re di una infezion e e di r morragit' secondarie. l'autore allarF!<'I l 'or •llci o d elle r.-rila .. ,.egu en done il decor!'O m olto obliquo in basso e al d1 M llo dell'a•·cala c rural e, in c i;::a flll t'!'; IA e me;;sa allo scoper·to l'arteria ro• m orale, ll llrav..r!'O numerosi coa${uh , rinv enne n ella sut• parete an!erio re una soluz ione di contwuo travel'!'llle di poclti mrn ., ottu rata da un coaf!ulo .
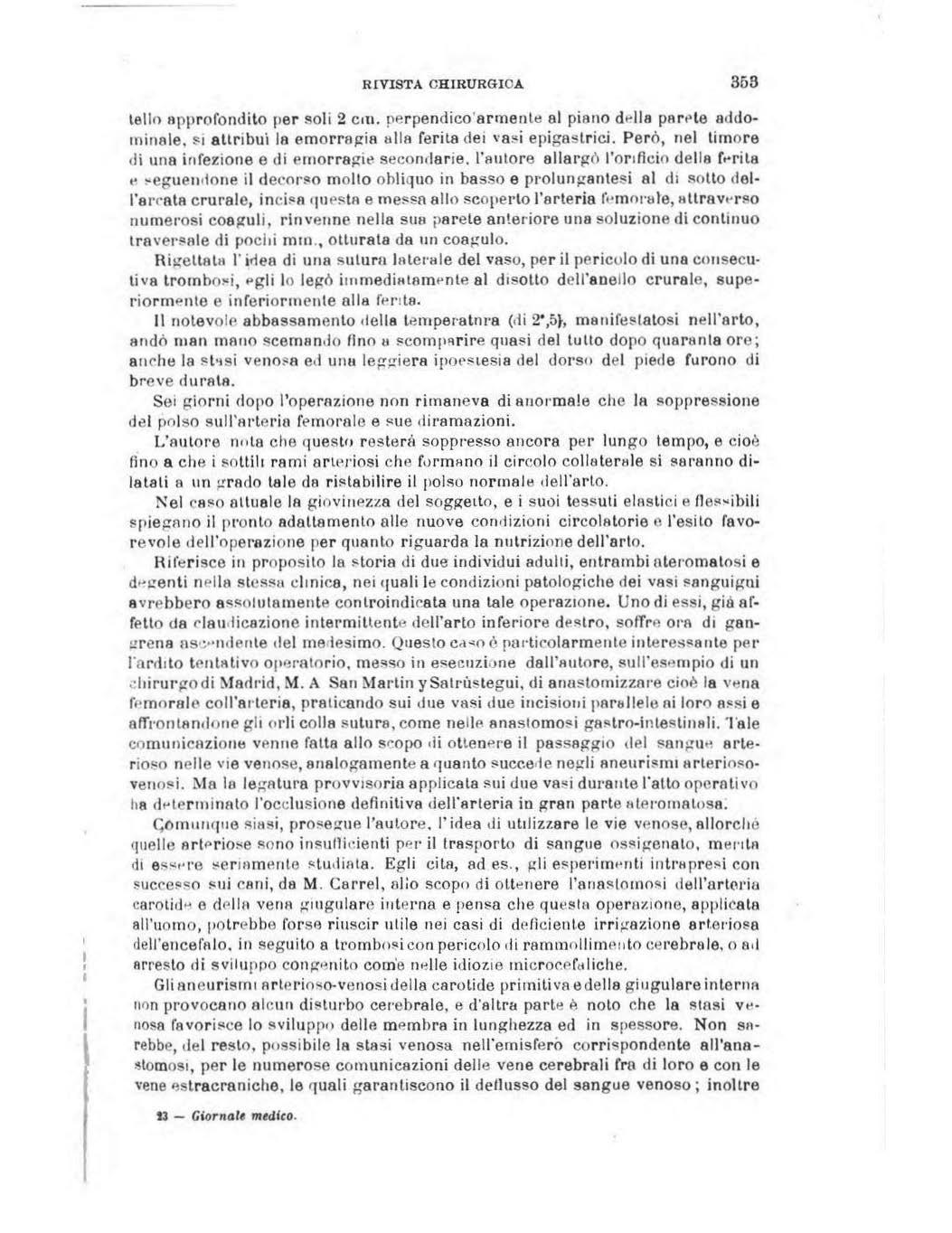
l' i tlea di una suturn lAlcntle del va so, per il pericolo di una consecuti va trombo:-i, Pgli l o itumediHLam nte al dtsollo d ell' anel lo c rura le, supee inferiormente olia ft>t'Jta.
ll nolevolr abbassa m ento della l a mperatnra (di 2•,5h n e ll'arto, andò man mauo scem11nd o llno 11 quasi del tutto dopo qua r anta ore; auche la !' t'l si v eno;:a ed unu le:rJiiera ipor;::tesi a del dor·so d el piede furono di breve du1·ata.
Sei g io rni d o po l'operazione nnn riman eva di anormale che la sopp re !';sion e del rolso s u l l ' lll'lerio fE'mor·olo e d i ramazion i.
L 'a utore nuta che ()Ues to r eslerit soppresso ancora pet• lungo tempo, e cioè fìno a ch e i so ttili rami artl ' I'Ìosi c he f,>rm Ano il circolo si dilatati a un !!rado tale da ri ;;tabi lire il polso normal e del l'arto.
Nel c: a f<o ollualc lA del e i suoi tessuti elAs ti ci" spieP"nno il pl'onto adallamenlo alle nuove con dizioni ci r cola t orie o l'esito favor e vole clell'opet•azione per quanto r iguarda la nutrizione dell'arto
R ifll ri sce in proposito l a ><loria di due individui adulti, entrambi n l el'omatosi e d"tzenti n f> llo !!lcsr< c li nica, n ei cruali l e cond izio ni patologiche dei vasi !'a ngui gni a vrt>bber o ac: Miutamenle controindicata una tale operazrone. Uno di essi, già a freno da l' lau.ticazi one intermitlent .. dell'arto inferior e des tro, so ffr o Ot'a di g en!!rena os ; ..nclente tlel me !esimo. Questo è pac·t icola rm eute inte r es.,a ute p<' t' J'ardt t O t entAtiVO O(ll!l'fl tO ri O, messo in 6!'CCIIZiù116 daii'Rulore, di Ull dtiruq!O di Mad l'id , M. A San :\larlin y Sal!·ùs leg ui, d i anastomizzo re cio!'> la v t> na fPmo ral c coll'a• t eria, praticando sui due vasi ol ue iucisioui par11 lle lo oi lor0 A!'SÌ e affl'Onloncl nue gli M li colla !'=Utura, com e nelle anastomo!li ga!'lro-i ntestinAii. Tal e co municAzi o ne vPnne fatta allo sropo di o t teof're il dPI a•·ter lo<>O nrlle v1e venose, analogamente a ()U a nlo !:'Uccede aneu r ismr Hrlerio;::ovenn!"i. lo legatura provv1sorio appli cale su i due va"i dUI·ante l'allo oper ativo ha d ter n11nalo l'occlusione de finitiva dell'ar teriA in g ran par te KlPI'OillAtc>sa.
c;o muuque ;;iasi , p r o;::eg:ue l'auto r e . l'idea tli utilizzare le v ie vf'nose, allorclt o quelle AriPr io,..e 'lono in sull i den li pPI' il trasporto di sAngu e os!'-i f.!e nalo, m tm tA d1 &!"'-'•·l'e I:'C r l nmPnte ;::tu.lin l a. Egli cil.ll, ad es., espe1·imo•ull inti'Hpre,.i con ;::ui c eui, da M . Carrel , oJ:o scopo di o ttenere l'auo;;tomMi dell'art(lr•iu carotid e di'Ila veuA 1-!•ugula r e intm·na e pensa c he operoz cnne, a pp licata all'uomo, po trebbe for se riu scir utile nei casi di d e11c iente irri gazio ne art.edosa dell'encefnlo. in seguito a trombo!'i co n pericolo di ramm o llim l'n l o ce •·ebrale, o od ar1•es to di svi luppo com'e iùioz1e mi c r orrfttliche.
Gli ancuris 1n1 arl c> t·i o"o-ve nos i della c arotide primi ti va e della giugu lare interno uon pt·ovocano a lcun di!>turbo cer·ebral e, e d'altra parl!! À nolo che la stnsi v enosa revo r iE<ce lo sviluppo delle IDPmbra in lun ghezza ed in spessore. Non snr ebbe, del resto, possibile la stesi venosa nell'emisfer o all'anaper le numerose comunicazioni delle ve ne cerebrali rro di l o ro e con le vene P.stra craniche, le 'JUOii g arantisco no il dellusso del sangue veno so; inoltre
RfVISTA CHIRURGICA 3158
! 3 - Giornale medico
la l egatura della vena g it.Ig ulare non d et ermina né l ' edema nè alc un alh·o di stul'b o cer ebral e
Egli s i r i promette, da que!\ti esperimenti, ri s ulta ti brillanti per l a chirurg ia dell e arteri e e co nc lude co l d ire c;Hcl in ogni ope ra z ion e di ta l genere co n v en·a. ad ogni m odo, ten er pre senti l 'e ta, la d iatesi, e la div er sa c os liluzio ne d el te ss uto v ascolare. P L
Do ll. \V A SSERM A NN , a esistenle nella c linica chirurg ica di M onaco - Contributo al algnUloato dtagnoatloo della leuoooltosl nell'appendlolte.
ì<: m e1i to d i Cursc hm11nn di ave re indicu to, che appe ndiciti ad ess uda to fibrin oso s i la sciano dis tin g uere, in un numero prevalent e dei casi , p e1 • m pzz o d E' l conteggio dei l eucociti anc,1ra, q uando allt•i sintom i, co me l'andam e11to delh1 l t> mperalura, d el pol so, ecc. n o n pres tano alcun a ppoggi 'J a lla dia(otn osi l ca s i di a ppendic ite, no n termirw nti in s uppurazl one, s i caratter i7.zan o re 1· la produ zi o ne d i una iperleu cocilos i , rel ativam ente piccol a , CO ilstnta bi le so lta nto al rwincipi o della m al attia. Se fin o dai primi !Zi o rni d ell'aff ezio ne m o rb osa l"i perl eu coci t osi te nde ad el evar,:i ed a un allo grado è da su ppor re , l'eco ndo Curschmann, la fo rmazi one di un'appe ndi ci t e s u p pu r ata ; ed in tal c aso è i nd i ca ta la cura ch i rurgi ct) . Un nume t•o d i leucocili di 25,000 è p: tà mollo sospetto.
Allo sco po di .•.onlro llar e le v ed ute di Curschmann , il dot t. \V asse t•m a nu , d i ett·o de l p r o f. Ila stu di a to i l c o u1pOI'ta.menlo dei l eu coci l i IH:•IIe vAri a f <J rme d i appendicite, nE:Jl'i nlento di vedere, se in realtà es i s t e n el d ec< >J'SO de l la in par0la il feno m eno l e ucoci tari o e se esso sia co sta nte in m odo dtt '"al er e, com e base per la ò iag nosi clinica e per la t era pia
A tale !"copo W Hssc l'mann è ser·vito di una serie di ca si clinic i , c upita t i in vol'ii ann i solto la s ua o sse rva zione nella clin i ca tl i M o n aco e ripo rta n el s uo la,·oro l e pt ù importanti s to r ie clini c he, i t•isultati dell'esame del f;an g ue e de ll'allo opera tivo . quand o occor .'<e e c ita a m o del l o il sel<u e nte:
S V. pi llo1·e tii M è Af•collo ne l l a c lini ca il 31 ma ggi o 1902
S tat o p r e sen tr - Soffre da o tto g iorni do lo ri nella r egion e a ltlominalc deSlJ''' · a c ui da d ue g i orn i s i é a ggiunto il vo mito . T e mp. :3i, 5. Pol so 80, re g ola n!. Color e dell a c ute e d<>lle mucose pallido Lin g ua im pa niata.
31-l. N ell'atldu me m iJderalo meleol'i smo N ella r egione ileo -cec ale si palpa una r E'sis l euza, ove il s uono di pet·c ussi o ne é ottuso ed ove si s v eglia dolor e in un punto specialmen te, e r1ui di stantc dall'o mbelico e da lla spina il i ac a ante r o su perio r e. N. dei l eucoci li 22,600.
1-6 g iu g n o 190::?. P o l so e te mp . normali . N. de i lencochi 24,600: i d o l o ri eedo no all'applicazione di v escic he di ghiaccio; la re si s tenza, l'o tLust tA n ella r egio ne ileo- ce cale so no rid o tti.

Ogl'\i due g i omi i l pa ztenle em r ttc spo nta neam ente f eci molli.
G-8 g iu [.{no Po lso i l:i Tem !J. 36,7. Num ero dei l eucoci ti Il co r po resi stente n e l quadro infe riore d t!slro de ll ' addo me é q uasi del t u t t o scomparso. Stato del pazi ente è assai buono, tanto c he eg li do manda di esse re me!'so in lt b erta
Su lla buse de l v alo1 e ùei l euco c ili è pro pos to l'a tt o oper·ati vo
Ope ra:;ion e . - 'IO g iu g no 190:2. Narcosi eter(;'a. I n ci si o ne tipi ca n el s e gm ento inferi o r e des tro del v entre.
RIVISTA CHIRURGICA
I ncise l tl parti cutanee ed il peritoneo, di!òtaccate le ad erenze tro le anse in1estinal i della regioue ceca le, si presen ta l'appendice perforata, nuotante in una -e avìté pien11 di pu«, ove ò ri scontrato un calcolo f eca l e.
Lavaggio d el cavo appendicelt.omia e drenaggio del cavo m ede<:imo.
L'operazio ne ha buon esito, e do po essa s i rid uce poco a poco il numero dei l eueocili fino al normnle.
Da que!'lo caso c linico e da mCtltissiml altri consimili, W n!<Sel·maun lira la che la lt>ucocilosi è la più sens1bde •·eazione di fro nte ad un p roces!'o infetlivo !<Uppuralivo d ell'ap pendice e C'he ha quindi, riai punto di vista un valo •·e mttggwre de lla frequenza del pol«o e dell'andamento della tempdratu•·o
Ri cerche comparative, •·apporlo al numero dei leucociti, eseguite da Wa sser· mann 111 Altre malattie chirurg1che, quali &!';r essi prostatici, pt:wanefritici mi-sero 111 chwro, che In l encocilosi, che si può verillca1·e durante ill 1li'O decorso 11011 ,., cosi co«tan te n è co<:i significan te, come la. leu.:ncilosi, legata all'appendicite.
In ultimo Wasserrnann ripnrla le osf'ervazioni di e Scllnitzler, relat1vP all"iporleucocito;;i nell'appendicite, o;;servaz.ioni porfuttamenle concm·do nti colle sue e te rmina d 1cend•' clt e il fenomeno leucocila.rio nell'omnioni appendico lari è da riLener·si come s into m o sicuro di un proce!<so s uppu r ativo gl'ave ileo - cecale, sia che s i accordi C•JII e altre manifestazioni della malatti a, sia cho pr eceda gli altri sintomi clinici della t<uppurazione, sia che 111 oppm:izione agli altri segni, solo ci clichiar1 la sel'ielit della situazi one; quindi tale sintomu aiut.a nnte volmenle il medu:o nella diagnos i difficile d ella appenJicite e nella cura ddla stessa ma l attia.

F UNA IOLI. (l\lonar o di Ba vicJ·a).
AUGERgR - 011 a110e u t cerebrali dal punto 41 vis ta etiol o g ico dla g noatloo . - Lezi one
Da vari ca"i <li rerebrali, verifi cali!<i da individui ofTetli in olile media cronica , Au p;er el' ha lrallo o cc a"ione per Illustrare 11 tema importante d egl i asc...ssi òell'orgono cereb1·ale. Riassumo dalle leztoni dell'illustr·e clmico tcdesr·o ciò che vi si contiene Ji più no tevole ri spello all'eliu l ogia e diaguosi d ello form a iu discorl'O.
Premessn che l'etio l ogia è molteplice, Augerer disting-ue cerebrali di embolicn, gli ascessi collegati ad otite media croni co supp.lrata, g l i a !:lr.es«i di naturo traumati ca, ascessi elle si pos so no sviluppar·e in cer ti tumori del c·erv ello o gli ascessi idiopatici.
embolici. LH principale cereb•·ole embolico ò rappr·esen t.aLo ma l attie polmonali suppurati ve, quali la bronch ite putrida, l'em p rerna e la gnng ena An cora la lul>ercolosi produco, speci e 'luand o ;;i ;;ono formale le caverne, a scessi di tal e carattere. La sede degli ascessi cer ebra l i di nrigine polmonare Il il mantello cerebrale nel ter sito r io dell'arteria sil viana. In seco nda lmea viene in considet·azione i l lobo occipi tale
Mollo pii.t di rado é un'endocardite sellica od una suppurazi one nella cavilé .addominale la cau sa dell'ascesso.
RIVISTA Cll:lRORGlC A 85n
A c;cessi !=<LAti o sservati aucora d nrante su ppur azioni articolar i ed osse en ei ll t.>g tn o ni. Au ger e r· ha molLe volte co n !'tatat o nel cor so di os t eomieliti mas uppurati ve nell'or g ano cerebrale.
Fra le m al ollia d 'm l'ezi o ne c he producono pi l! s pesso a scessi metastatic i , A uger er lll)rnina il tifo, la scarlatti na , l a d rfter·ite: i n ques ti c a !!l trattasi d i em bol i a d t>ll e p iù piccole at•te ri e, pro babilmente de ll e cosidelle embo l1e m icrococciche.
C11 u sa fr Pq ut> ntc di a sees!! i c er ebrali é rotite media cr·onica s uppurativa ; ca::sH m o lto meno fr equente è l'o ti te acuta. M o lto p eri col ose sono l e sup p ud ell'o 1·ecch io c he com pa iono dopo infezi oni ac ute, quali la scarlatt1na, dil'lct·ile, ecc.
La sede cercbraie otilico è l a corrispo ndente parte temporal e od il corri f<J.IO !ldente emisfer o d el cerv&ll ctt o: nei bambini é di g ran lunga- più il t o bo te mpor a l e
A rca uto all'a .:;cesso otitico si deve pur e r icordare l'ascesso cerebrale di o r i gin e na sa l e, m ollo raro.
Ascr•s so traumati co Cie.scnna les ione oss A crani c he può c o ndurr e alla fo 1·mnzione di per lo più quaudo una fel'ita cutanea é colh:.gala alla lei:' ll) rte
Dì l'asc esso traumatico compat•e entro i pr imi riue mesi d& Ila lesione, 1n via ecce zi onule dopo un numero di m"si. La sede c orri s po nde abitualmente al punto di azione d el tr·auma.
A l t r a ca teyo r i a di ascessi cer ebr ali è cos t ituita dalle s u p pur az ioni c he si s viluppAnO n ella gommtt sifiliti ca , nel t ubercolo per etr tto di agenti
Infin e ò parl ato e sì parla d i a scess o i diop'\tico. Au gc r er acce tta, a s pi ed i la inter pr etazion e d i MRI'lius, second o c u1 l ' ascesso i di o pati co si svilu p]Jerel>be solto l ' mfluen za del mi•:ro- o r g auis m o della m ening ile cerebr·osvinole
6J)IÒeiOIC8.
N e gli ascessi del ce 1·vell o s i dev e disti nguere la d i aRnosi di ascessi co m e tali e la dia gno"i d i sede de ll' a" ces,., o.
N e l pri mo caso gi u ngono in c o ns1.t et·az ioni le seg uen ti di.,t utzionl:
Trombosi dei sem t U na s tcura d1a sWO!'i tra ra scesso cer ebrale o ulico e l a tro m bosi dei non è in tutti i cà si possibi l e Si può so l tanto r i unit•e una ,.,ur ie di che con pr ob ab il 1 l à parlano pe t· l'una n per l'a ltra aiT•! Zio ue.
P•• r l a tr o m bosi del se no depongono la feb b r e al l a , l"accel\'razio ne d el pol l"o, d i ogni d isturbo della co sc1e oza, l 'e\"en lual c t r o m bosi pal pabi l e della int•• r·ua: tali s into mi d evono naturalmente r iscoolrar·si i n un sog!(ello, c he rli o lite m ed ia cronica.
Prù p <'r l'uReesso ce rebral e io passivi di parl ano l a l e ntez za del polso, t em pc1atura nor male o di poco aumentll ta, 1lisordini d ell a co sci enza.

I n m odo deci s ivo s lP. p er l'ascesso ce1 ebr·ale la comparsa di ' Jualche espresso s into ma di focolaio.
p ,. ,.ò di non depone c ontr o l 'a llce ss o d el c erv ello.
L n n o vrite o ttiCA é in ambed u e le malattie ugualment e frequent e.
La pHpi l iA da s las i é più frequ ente n ella tt·ombosi dPl seno.
L f>pwme nin.g i t e purule n.ta . Ques ta fo r·ma m o r bosa co nta tra l e sue caus e , al ptwi dell"ascesf<O cer ebr·ale l"o t1t e m ed i11 pu r ulenla La differ·enziazi o n e o tfr· e spPs!ln d i ffi coltà. Stanno in favore ù ella Jeplomeningite il d eco r s o acuto. l'alla f ebbre, il polso fre •1uente, il d elirio, l'ag itazion e m o toria, ri pere-
356 RIVISTA ORIRURGIOi
cerebrale gene rale, i dolori di schi e na, la retrazione a bar·ca de l ventr e la paralis i di n e rvi de lla basedel c ran io , il quadro of'talmoscopico, n ormAle. Più per l'ascesso cerebrale parla no il d ecorso s uba c uto de ll' affe zion e, il de· c o r s o normale o qua s i norm .. Ie d e lla te m peratura , il pol so le nl{), l'assenza de i dol o ri alla schiena , d' iperes tesia jZe n f' r ale e di parali s i dei n ervi de lla ba !'-e , la pres enza di n e vrite o ttica. Il r is ultato de lla puntura lo m bare il d "C•s i vo . ;-.le li' a s cesso cerebral e il liquido cerebro ·s pinale è chiaro , e non c ontiene bat· -te rii, méntre nella leptomen in g ite s up p urata é tOl'bido e può conte ner·e batterii.
Ascesso extrad urale: è piu fre r1ue nt e mente g enerato per e ffetto dell'o tite med ia che n o n l' a s cesso cere brale . l segni c linic i so n o n ell e due aff1•zioni
Dal punto di vi st.a dia g- no sti co s i con s ideri c he l'asce sso cere brale Ab bas ta nza s p esso, l' a scP3SO e xtr·a dural e g iamm a i, prod u ce puri e dirett i s into mi di focolaio Sintom1 ind ire tti s i p ossono prese ntar·e in am betl u e le fo rme m or bose .
In molti· cas i pe rò n o n è possi bile un a s icura ' dia g nosi che p er via o pe r a tiva.
Emor-ra gie extrad ur-a li,_subdu r ali . La diagnos i s i impone n e i ca s-i t r a umat ici. È da r ifi f' lle r e che i seg ni de lle e mo rra g ie me ninEZee s i pe r lo p iù immed iatame nte al trauma: l'a s c Asso ce r ebr·Ale s i manifes tA a !<so i più ta rdi va mente Si noLi anco ra che l'epiles.; ia d i lackso n è pi tl ft·eq uenle negli asce ssi traum a ti c i che ne lle emorra,!de menin g e e trauma t1c he.
E n cefaiite em or r agic a trau matica: o for ma rara e ,. ; e s plica·con sinto mi, seg u e nti immediatamente a l trauma .
cron ica lim tla trx: co m pare talvo lta do po traumi. Quan do la fe bbre è a ssente , no n s i può fare di ag nosi; s e e s iste la fe bbr·e, è da a mm e ttere l' a scesso cere brsl e
T r-om bos i ar te riosa de l cer oello : è p reced uta g eneralmente da seg ni pre·cur·sor!, d o lor d i te!:-18, verti g ini, a cce !:isi d i li poti mie e si prod uce in tre e ssen· ziali co ndizi o ni; malattie dei vas i a rteri osi, debo lezza di cuore e modlfì c azi o n e dell a cos tituzi o ne sangni g na.
S i devon a rico r dare i segni di focolaio, inerenti alla tromb osi dei va ri rami •at te rio s i.
Il s intoma d e lla tromb osi dell'arteria ce rebral e ante ri o re è una monople)lia dell'arto inferior e de l lato o ppo sto del corpo, d ipendente d a rammollime nto del lobulo paracentrale e del quarto superio re de lle du e circo nv oluzioui ro· lad inche.
La tro mbosi dell'arteria cerebral e p os te riore dà luogo di re go la alla emia n opsia.
La trombo si deH'arteria s ilviana co n duce ad una tipica emiple gia cr ociata co n pa rtec ipazione del fa cial e e de ll'ip nglosso .

Ne!l'ai!ce sso s ono frequ e ntì le o scillaz io ni termi c he lievi , che mancano n e llA trombosi, s alvo chè no n es is tano co mplicazioni. Do lor di tes ta e s e n s ihilita loca le alla pe rcussi one s ono piu fr equ e nti e più forti nell'as cesso L'e pilessia pa rzial e depon e pe r l'ascess o .
T umo r i cerebr-ali: ricon nscono , co me causa , ancora i traumi ed in tal caso specia lmente la dia g no s i differe nziale rendesi n ece s saria . ha un decorso più acuto, c he non i tum o l'i, le el e vazi o ni ter·rniche stanno in· favore di -u n a s cess o cerebt·ale, men tre la p apilla da s ta s i depon e più per un tumore.
RIVISTA OHIBURGIOA. 257
topiea dt' !lli ascessi:
N eJ:rli asce<>si la diagnosi topica é d esignala Psclu'-ivamente dai· sinlorna a focoloio e alla locale sensibili t à alla percu!' sione. Fra i sintomi a fo · colaio •·eclamano la più g r ande attenzione qnelli prima compaa·si . Se subentrano a cct•s.;;i convulsivi pa r ziali, è da considerar e in quale terr itori o muscola r e· e!'"i cc11nincmo.
N el cac: o che la sensibilita local e di per c ussione e i clin ac:i d i i o non i ndichino il medesimo luogo ma si contradicono, si deve dare più valor e· ni secondi che alla prima.
endocranico di Ol'igine olilica sorgono due princi pali qu eslioni:
t• È un cerebr a le oppure cereb ellarer
2• Posto c he sia un ascesso ce1·ebr a l e, si l ocalizza n PIIa regione temporale o sinis tr a?
1' Allorch é s tabili to un nscesso n el cet•vell,llo, notasi un'incoor dinazi one nei m o vim enli, per cui il sog,:telt o pre senta un'andatura inceJ·La, vacillante e procede a ga m be divat•icate. Oltreùichè si osserva pure una notsvol e t•i giùità delln nuca
Il ni sLHgm o compare con disug uale fr erruenz a n egli a sce:;si cerebrali e cerebnllari, poiché t! piu fee11u en te n ei c er ebellari.
All'op pùSLO segn i munifes t i di disordine n ell'associazione d elle, idee, em iparesi, ind i ,.ano una l esione cerebrale; le dell'oculo-molore sono fr equen t i n ell'ascesso d el ct:rvello; sintomi bulbari (d isartrie), emianopsie compaiono purll frequentemente in ques t'ultimo
Anco la consta tazi one del luogo di localizzazione dell'ascesso otilico p uò esserci di g uida per la diag nosi di sede dell'a scesso endocranico. otitico della cassa del timpano si diffonde con facilit.a ul lobo temporale cer ebr al e per la via del tegm en timpani: laddove l'ascess od elle cellul e masl oidee si pr opa ga con più facilità al cervelletto per le vene emissarie.
Rispe t to alla frequenza, gli accessi cerebellari son o assa i Fiù r ari dei cerebrali.
2' Da qual e parte del cervello è l'ascesso? T ale questi one si ri sol v e bene nei cosi, in cui è presente u n' uni ca olile m edia, giacchi' in tali condizio ni l"asce!!so da lla parte dell'o lile.
Più difficile e In ri solu zi on e della questione quando l'olite med ia è doppia.
L'e sam e olologico p uò da r e pochi criter i al ri guardo: esso permette di con· sta t are che il processo di carie penetra piu consider evolmen t e da una parte, dall' altra e fa quindi supporre che l'a scesso si localizzi d al Ialo più fortem ente attaccalo .
N el la del1cienza dt criteri fornili dall'esame otologico, noi do bbiAmo aLlen er ei ad altr e conside t·azi on i.
La di considerevoli disturbi della l ofJ uela in un a scesso cerebra l e depone pea· l a sed e si ms Lr a.
Se esi!; te una tale dtfl'ereuza di ampiezza nel for o pupi llare, l' asce;;so Lrova si dallo porte dello pupilla più ampia.
Nel esista una paralisi dell"oculo- m o t ore , l 'ascess o F:iace rlallalo del ta parnhsi n •• r vosa.
Il della deviazione co n iugala degli occhi è, secondo Auger er, lropp() in<!oslante e di nessun valore

3G8 RIVISTA OHIRURGIOA
1
La 1liaf!oosi di l1lca lizzazione dell'ascesso, fatta colla perC'Ul"sione cranica, é di irnportanzn !'ecorularia.
La topica cerPbrale traumAti co non otrre diflicoltà, se pen!'a cht> l'a!'Ce!'SO corrisponde alln parte ove il trtiUrna ha agito, er ·e.lronahnente al punto opposto.
G. F UNAIOLI. (Monaco dr Baviera).
M L. - L e fraUure 4all'utr&galo . - (Re!'lte lit> chi rur gie, n. t 1902).
In quu'-i tutte le O!'!'ervAzioni di fratture deii'Aslraszalo, rilevac;i come acriunn caduta sui piedi da un luo!!O elevato. f.; per· strapparncoto che sr producono tali frAtture.
L'osso si rompe pl'imitivamentP. solto la trazione dt-i lef(amenti che vi s i attac ·auo. ma rw:ecl:l dr l'rconuscere per causa i movimAnlr di abduzio ne o di ad· duz.io rw, come frnllur·e malleolsri. le fratture si producono nel m ovimen to dr lles"ione del piede !lulla garnba.
Nel maggior numero der casi, le zone d'inserzione legame11tose su ll'as tragalo non !<Ono interessa t o riai t.ratti frallul'ati.
Tali zone limitAno fra di esse un certo numero di territol'ii dove si aggr·uppano lP linet! di rrolluru.
zone d'ìnser·zione legamentos'e sono dal la to inlarno: >iOllo l o faccetta articolare 11 mo· di virg11la, la grande impronta del legamento Libiu-astra· galeo mentre il lop-amento tibio - 11stralo(al eo auterrore non invia che un fasl·io a l luto inll:lrno; dal Ialo esterno, soltan to del legamento anteriore allo del collo. Alla faccia pO!!leriore, i due tubercl'li limitanti la scaualatul'a del lungo flessore propl'io rla ll'alluce; è al ed all'inruori, tal volta 11 lla base rlel tubercolo ef<ternn, rhe finisce Il l .. garneuto poslt>ri ore. Da ultimo nella faccia inferiore il l iflamt>nto po!<IO nel seno del wrso.
Ora nei m ovimenti di tor sione io avanti etl in ruori, il gruppo laterale op· pO!'lO nl rn ovimrnt.o, si t ende per intero, ed il ri sultato ne é l'l !llrappamen to mA IIeolore. Snttanlo sr tendono i fasci antf'rio ri, òcboh che facil mente si r ompono permettendo l o srlrucciolame nto del piede iu avHnli. fll·s i one piede sulla gAmba, d HI lat0 interno leo po'<Lf'riore, il piu forte di lulli, si tt>nde rapidamente nello tempo che i fa«c .. lli trbio-tn•traj:(Hier anter·iori si rilasciano , dal lato esterno il peroneo-al"lroogaleo postt•r·ior·e, orizzontale invece d't>sser· verli ra l e, sr tende mollo meno : ò insomma il legamento trbio-astra galeo postel'ior•e. in se r·to a tutta lA supHficie in c:critta nl!lla v i rgola a t·Licolare interna dPll'nslrag-nlo, che sol l evu ln p»r'le posterior·e de l l o stesso e au alloutanarll) dal
Lu al>lragolo-cAI<:anen che tendeva produrre la flessione del pi de g'ambo. P quindi per· ag"enle 'luasi ivo il fortissimo mt>nto libio-astra[.{aleo po!<teriore. Il l egamentu che imped isl!e qualsiasi dia· sta !>i in tal é il lìgame11lo robu stissimo tl el seno del tar·so, centr·o dei movimenti dell'ac;tr·Alogo J<ul calcagno.
d i falli clinici e dalle ricerche l'isulla ch e si possono le fr atture dell'astragalo i n frattu re trnsversal i del collo e
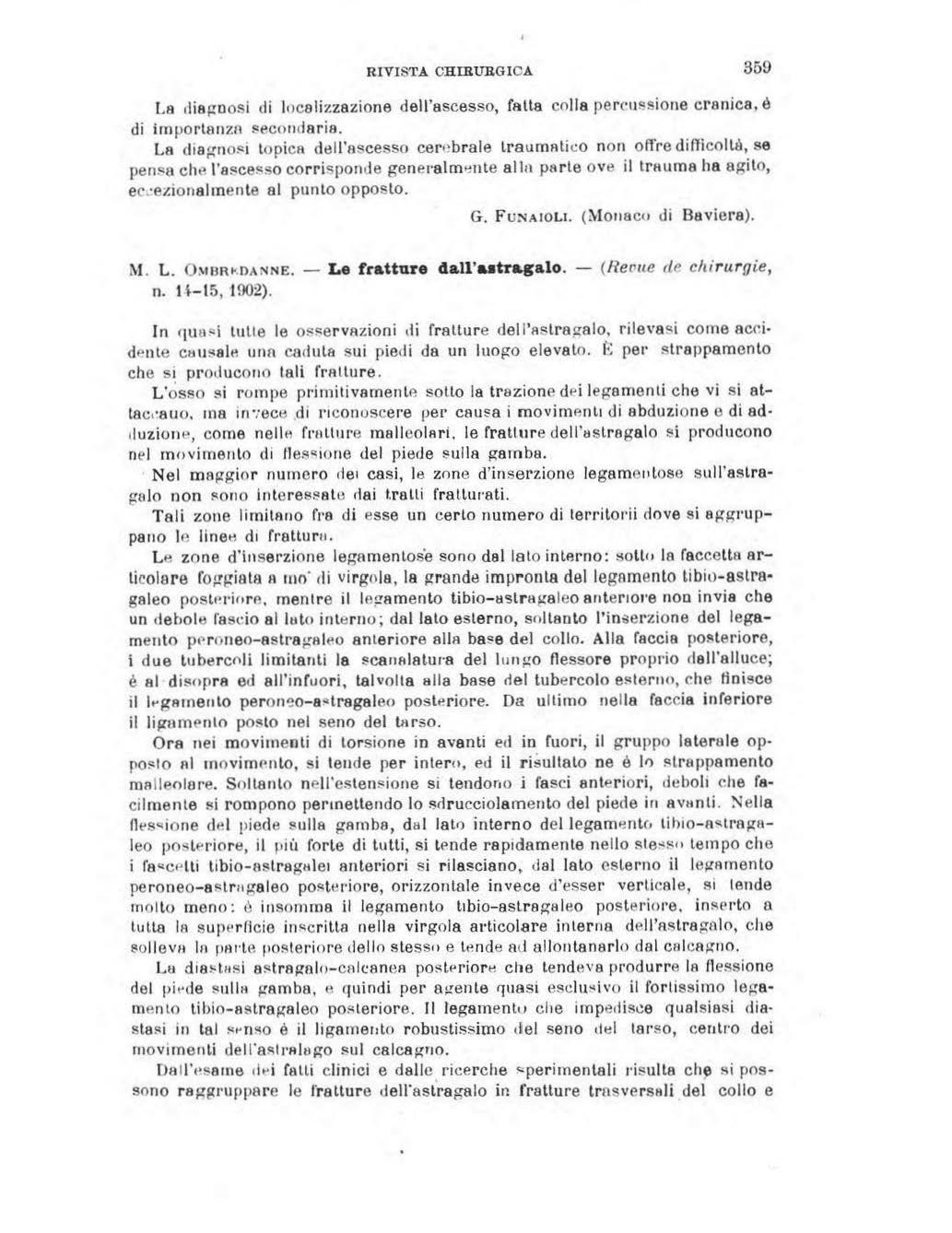
RIVIS'l'A CRmURGIOA 359
del cor1>o, fraltUt·e sagittali, fratture dei luber co li astragalici poste r iori, fratt ur·e co mrwnutP, o con schiacciamPato osseo.
Frtt l lu re tle l collo e del corpo. - R isultano quasi tutte da traumi c he hanno colpito il piede in fles sione La linea eli f ralluJ'a è sempre o bliqua i o b11"M ed ind ctro; essa comincra in alto, talvolta sul collo, t11lv ol ta sul bordo an l ,..rior della troclea, o a 12 milllmilri clallo stesso, oppure in pi en o sulla super ficie ar·trcolare posteriore d t> Ila fascia infer i o r e del!' il frammento antPriore é sempre ten uto fisso J11l lega m ento del sen o del tàrso. Tali caratter i non si possono che col meccanismo di flessione del piede sulla gamba. Tal fallo si r itrova in tutte l e esperienze e nel numero delle osser·v azi o ni cliuiche nelle qu111i n otasi una Cfldula lallo nt>.
F ratw re sagittali del co rpo. - TAli fratture fur·o n o otte nute olatl'autor e mediante ne..srone e t or sion i continuale d... l piede.
Se a l la ll<.>»sro ue del piede si infatti l'abduzione e la r o tazione este rno è il pr.tente l egamento tibi o-aslr-agal eo che da >'Oio il bi·accio di le vu dt' l l'n«tr aga lo : talv o ltn e sso si r o mpe, lulvolra str11pp11 i l rnalleolo interno. Se legamento e m11lleol o resis t ono, la le va cede e si rornpe; il lcf.(anH•nto slrappu allora e tras cina il fra mmento inter no d ell 'as tra gal o ch e può cssr r e ta i o l'n u il'Ual e alla m ela di'l corpo co mpr ende le f ratt u r•e ><agilla ' i e le frallu r e del c un eo po st er o-C'!<Ier n o dltl ne rappre sent11no , in certo m odo, t<o ltanto il primo grado . Fratture dei tttbercoli poste r iori. - Sem b r ano drpender e dall'oumentalll o dimi nurta cut•vatura della facetla aslr agalea pot" l er·iore. Sperimentulmeute appaiono come un o stntppameuto rlei labbri dd ;.olco osseo del fl essore proprro dolo dlllle l amine fibrose che ri!'pelt ivarnente vi si inseriscono c0 11 frequenza di l es ionr ug ual e p er i due tubercoli e so pr alutto coesistenza dello s trappo di e ntr Amb i.
F r at ture per scllia cciamento. - s·os;.ervan o molto raram en t e in c linica , poiché l'astral-!alo fi ssalo come cuneo f ra l o schcletr·o Jella ga m ba e q u ello del sprovvisto di qualsiasi inserzi one muscol are che possa fissarlo dir-ettamente e soliclalmente, d eve fac i l m <>n le sfuggire allo sch iaccr amenlo.
Sr trova SO\'ente, nelle fratture dell'astr ag11lo, un ct>rlo numero di segni ordinarii d ell e f r llltur·e; gonfiezza, ecchi mosi, crepitazione, ecc. Di ptll, n el mllggior oum t>ro dei casr, no lasi trt,tslazione del pied.., in d en tro con o senza rove s<'iamenlo d l prede, facendo guardare i n denlJ'O la suA fa ccia plan t a r·e All ' rn fuor·i di questo grande tipo clinico, l e fratt.Jre d el c<H'po dell'Mtraga o non patrann<> ess:er co nfer·rnate che dopo l 'esamo r ad i ografico.

Le der lubercoli poslerio r·i, un po' vecchl t', dann o !'iJèl'I!!IO lu ogo a i feno m eni dell'achillorlinin e dP II11 plel'llalgiA.
Dal punto di vi ;.La l.er·npeutico, é fuol'i dubbio e ir e l e f r•arLur·e del <:oli o e del corpo, pol=lsono ta l o r·a c r•rr!S igliar e t'astra gal n l o mia. !!i impo n e Lra llAndo si di fru l t ura aperta Trat tundo!< i .li frallul'a dei pos l er·ior i, l 'au t ore, in un I'B So nel q u ale l 'ammalalo E'l'& afl',. lto da lungo tern po d a r·ibelle a c hillodi o ia, r·iolf'at; ciò i l fram m ento oss..o cau sa del dolore, m ed iante un'i ncisione pra ticata a livtlll o del b ordo ester·no llel tendin e d'Achi ll e
G . B.
860 RIVISTA CHmU.RGIC.A.
M. o E R os A, capitano m ed ico. - TTaohelte oatarrale emorragloa . - (A rch . ila/. di otol. ecc., vol. XIV, fase 2)
L o spaven to degli ammalati c he hann o em es!ò'O uno sp uto sangui gno p uò esse re vinto molte vo l te Jnll'csAm e L ' e1norragia può v cnit·e, ol tre c he dalla bocca , tlal naso, dalla far iuge . ros a factl e a ri levar e. tla lla e dalln pa1·te s u pe1•iore della trach ea: b en inteso quaudo é esclusa l a tubercol osi. Delle laringee si é occ u pa to il prof. Ar.slan (A r eh. i t d 'ot ol., 190 1). Il Il cata r ro t r ach eale e morragico fu s tu diato dapprima dal M assei. ed ha una !lcars issim a biblin{Zr slia. una affezi o ne calal·rale della parte p iù alta d <' lla t r 11chea, che s i sviluppa i n i ndiv1dui co n eostitn:zione oenosa, in seçcuito a cau!'e meccanico:fun:zionali. Durante la fona· zione il te1-ritorio so ttoglo llico subisce variazioni d i pression e, per cu1 si ha uno s ta to catarral e crqnico della mucosa ed in seguito alterazione e r ollura dell e pareti va sal i. L'e m o rragia viene 11d accPssi c he s i ri peto no ad intervalli più o m eno In stato genet·al e o r dinariamente non si a l tera. Co l lo specchi o laringoscopico, d urante la respi r azione 1n·o fonda, S I veli o no i primi 3 o 4 anelli lrach Pnli , e quindi s i ve de l a mucos a iperemica con forte s viluppo della r f' te vn scol s re. Il Massei ha descritto tre tipi : 1' va s i parall eli agli ane lli trach eali; 2' vwsi che d al basso s i di ri gono in alto vet·so la s u perfi c ie inferio re delle corde vocali e s i uniscono a f orma di V capovolta; 3' vasi dispo sti a 1·ele co n tipo indetermin ato. Qualche volta si vede il punto p r eciso ove è avvenuta la -emorea gia. Non si deve emettere giud1zio ah: uno sen z.a un acc ut·ato esame semio l ogico e batterio l ogi co.
L a cura é: , enerale col ri poso, l 'ergot i na. l'h yd ra slis , e loeale con pen ne!· lazioni di 1:1dre nalina, e più tardi con pbtlllellazioro i di nitrato di argeulo o d inalazioni di cloruro di zin co L ' A r ife ri sce due casi ti pici di tale affezi one studiati nella clioic11 del pr o f. Ars lan . Questi d ue ammAlati fut·ono opportunamente curati con asilo d i g ua ri g io ue, cbe permane tu ttora da vari anni.
MuLL E R RtcH. - lfeuroal ed operastoot aulla apoftll ma•tolde.- (A refi io . .fil r Oh r ., LIV, p 223).
sono i d ieci casi ri po rtati in cui de l e neurosi { ep1 l essia cor ea , i steris mo, p azzi a m es truale) o guarirono o dietro un intervento opera ti vn s ull'spoRsi 11111 sto i de.
Tali non si po t evano considerare a ri{! esse • nel :senso di cioé dipendenti dalla malattia IIUricolar<', percb è F(li a ccess i cessava no completam en te dopo l'ope r azion e, c i oè ad u n·· poca in c ui l a m a lattia auri co lare non -eru ancora g uarila.

3fìl
fntlni'Ì d eli A guarigiouP, seconuo Muller, poLrebhPro eHse r·e 8'"enzinlmen Le t re: t• la nar·cos r e lo shock opera t o r io: 2' la pPt'dtla di sangue; 3• l'in tluenza dt•l tr·all11m cuto s uccessrvo.
Il p t·rmo ha un effetto dt>l tullo men tr i t•is ultati notati dall'A. furon o p1ù durevoli. Qua ulo al secondo. e per rtuant o .. i all'epilessia sap pr11 mo clw i l K och er l'accesso epile tti co quale un disturbo c ircolatori o prodo llo da di pr t•ssione iulra c r anil'he in una a bnormP Pccr tabrlt la di c Prli pu nti della corlt.'ccia re rP hrale.
Or·a l'azinue rlell11 pcr drt11 di SArl!-! Ue n >'lla lrllpa naliouP della mastoide e sus· !'eg-uen ll' cranioto m ra cons i s l el'ebbe appunto io ciò che è impedila l'elevazione di pl'ession e rntracranica, epperciò cessano gli arcessi eplldtici. Con tro que!lt' op1111 0ne pl'r'O s tunn o le obh iezi o ni: non é dimos trato an l'o r·a che l 'acc sso epr l elt rro sia dell'aumen to di pressione io tr ocranica , po· t e udo dars i che ques to !'in invece conseguenza di f!u ello: in !"econdo si ottenoc r·o risul t a ti c uraltvi ottimi anche in neurosi per· l e 'IUali non è Amme ssa In palogen esi dr K oclrer.
L'azione tl elln per•tlita di san.aue e del successivo drena ggio si po treb be in altro mod o coi mutamenti d i irrorazio ue sa n!'ui gn a d<'lle vicine r eg10ni cer ebr ali ed inrl11'ellamen t e con quelli delle aiLre pat·ti de l ce rvello, i quali mutamenti porterebbero di nutrizio n e d>'gli elf'm en li nerv osi e di con se jluenza un'al t eraz ione della l o r·o f un zi or:e.
I sogge tti che più benefl carono dell' o perazione furono i giova ni dai t 5 ai23 flltni ed i n c ui la neurosi c! a tava da non lungo tempo.
L'A. vte11e alla conclu sione che "le neurosi complic anti una otopatia non so lo no n con troi nd icano un'ope raz i on e sulla m as toide ed una c rani otomia , m& nel dubbio del l' intervento, costi tuiscono un argo m ento a fuvore • e c he • nella cura chi rurgica d ell"epilessia non bas ta l'a!Jer·tura t emporanea della cavil8 cranic a ma e c on sisd iabile il per un certo in nell'esportazione di cer t e porzioni del cervello • .
G. O
Co NCETfl, CoMB4, FtL È-BONA7.ZOL • , MASSEt. - DegU uoeast aottomuooat de lla larlDge . - (A r c hio. italiano di la r in!JOioyia, gennaio 1902).
Nel 1800 il prof. Massei di Napoli descrisse, per p r imo, una aflezio n<> s uppurat i va del laringe simulante il croup cd alla quale dell e il no m e di a11cesso p t> r i - t ro c ltP.o-laringeo.

Secon do questo autor·e, la sede dell'ascesso è nel tratto ipoglottico, a livello dei p r·rmi anelli l'arlilagi nPi del la tra c hea, ma l11 s uo provenrenza, sarebb e pe· rilarlll fre a, o me!.lliO pPrilr·a ;·henl c, co 11 in fi llrazione ed invasione se<'Ondar ta ne l sollo mucoso della Il pun to preciso di partenza sa r ebbe la de· licalissi ma catena gnoglionare descritta n el 18D<l da L eva l-PicquPc ltef e Gouf(U e rthl•im, pos ta laleralro e "te alla t ra c heA lungo il decor so del n er·v o ri co rr ente.
· Altrr auLo ri s i occuparono dell' ascesso lAr·ingeo, e per non cita re c he gli i ta lio ni, tro viam o nPIIa letteratura c asi descr rUi dali' E g idi , dr:d Co mba , dAl B o nazzola e dal T anturr·i .
Ora il Co ncelll , p cdi aLra di Roma, riprPnde l'argom e 11to otl Avendo potuto osserva r e qualche malato che g uarì e qualche altro caso segullo da esrt o l etal e, cre dett e di r i l ot·nat·e sulla pelol.!enesi della malaUia, con c ludendo ct. P gli
SG2 RlVJ S'I'A DI OTo-RINO-LARI.!'IGOU.TRIA
'
endolaringei son o di au toctona e non dall'es terno. L'A li l'iferi!'re a penetr11zione di piogeni, 11ttrave r Eo qualche della mucosa, nel te"suto !>Ott om ucnl'o e a lol'O pr oliferaz10ne in loco.
Il Ma"Sf'i, pr imo illustra tore della malatlta , ri<:ponde vivaremente, e Ct·a le altr e r uFiort i n favore deliA pr orli'la dottrinA ri fe r isce u n caso riportat o dal dotto r Granl B urrow;., i l quale hA fatto uno studio clinico sulla diltet·ite. hosato s u 209:3 casi curat i nell'ospedale ci vile di B o::;ton
S1 tratta va di una ba1n bin a rli 20 pol'lata all'ospedale con g rave s teno!:i ...a. Fu praticata la inlubaziou e, ma non riu scl•nd o que<>la amil.!lior·a•·e lo l'tato dell' m ferma, ;.i fece una rap id-t in cisione sulla linea mt"dia na de l collo. m11 invece di in contr are la trachea, il b ist uri a p r i una silecoccia so tLo la fasci n cer• vicAi e che contene va pus dPnso. L'infer ma guarl. Non v1 et·a stato gonftot·e del Ct1llo e Lullo, all'esterno, a ppar·•va not male. Vi sono asct•s!li che !>imulano la d1fler11e, e ve· ne so no d1 c he si mulano la st e sa molatlia.
N oi dobhiatno e s!'\ere grat1 ai c hiari AA. di aver e chiamata l 'attenzione d ei colleghi, sopt•o ma l attie tanto g ravi , e qualcl•e volta non diagnosti ca te, p er la> rarità con cui s i p r esentano, per l a indocilila dei pa zi e nti, e pe r Ua rapidità con cui lalvolta co nduco no ati esito l elale Q uesti a sces!li lari ngei, una· volta t•i conosc iuti, richiedono l 'interven t o chirurg i co
RlVlSTA DT OCU LIST ICA
DIITT SAN ros FenNANoEz. - Lastertllzzastone del ferri ln oftalmolosla. - (A r chiros de Oflrt lmologia hispano - {lme r icanos. 3 1902 \.
E n olo che lo finezza dei fer r i, e sopr alut to dei coltellini. usati in onAlmo. logia li ren de facilm ente alter abili dall'azione dt al cune S'Istanze per l'anlisepsi; o r a, l ' A. , d11po av<' re t> li minato qualche pr·odollo inoffen !liv o da q uel'to pun t o d i vis ta , e!C'pone i ri sultati delle sue espe rie nze fa lle con gli strum en ti della sua clini ca (Ava na).

N elle tre e!'perienze egli usò un numet·o ug uale di coltellini della st essa quali tu: nello prima li pull soltanto co11 del co tone s t erili zzato ; nella seco nda, li tenne p er un C"rlo t e mpo in una soluzione d i fot•molo all' 1:500 (form o l a del• Landol t); e nella l o• r za, impiegò la soluzione di ossicianuro di mercuri o (formo la d e l Volu cle). N ,;lle med esime condizion i di t empo, e do po aver fatto delle culture in brodo s t erili7 zato, o ttenne i r i·mltH t i seguenti: n ella p rim a cul tura. n egativo; sl;}cnnda e nella t erza, il ri «ultato ru pos itivo e, per di piit , due coltellini v ennero r esi in ,.et·vibili d ai !:a li di m fl r c ut•to
L ' A. descriv e l e esperienze fatte dal dotl A cos ta cnn dci co lte llini f]ua si n uovi di una sca tola in u so. e con altr·i giunti da una fabbri ca, con cui ottenne un negati vo so l lanlo dopo averli slroRn ati con del co toroe idrofilo. Per co n•.ro, altri cnllelli ni di germi sviluppati su agar, non si poterono rend er !' quautunque ross•·ro s lali for•t emenle slrollnali, allo· scopo di togl ier e le cu lture.
RIVISTA DI OCULISTIOA 863-
M.
Ri ulta da co d es t e che i coltellini pro venienti dalla fabbri ca, c us t od iti n ei l o ro astucci ed eslrall! nel momenlo stesso dell'in t erv ento oper a· <tori (cataratte, i r i tectomie, ecc.) sono sterilizzati medilmte l a sola frizione col cotone ster ilizzato.
Gli altri s trumenti (fo rbici, pinze, ecc. ) esigono g li ste.'\si r i guardi che qul'lli usati in chi rur gia generale
Ten RrEN - Perforaslone traumatica del due globi ooula.rl da prolettlle eU rivoltella, e perdita c:ompleta dell' olta«o. (Soc. rl'o/'lalm d i Par i{! i, mer1.o 1902).
Le perdite di entrambi occhi in selluito a ferite orbrto-oculari de p r oiet· liti d i rivoltella o di fuci l e é r·elalivamente r a ra, ed é quasi sempr e la cons eguenze di un t en tativo di su i c idio. infalli, in un lavo ro r ecente. unse a questa c on cl usion t>: elle fr·a coloro i quali t entano d i suicidar·si a ppli· -cenrlo l 't.mn a contro la tempia, sol tanto il bO p. 100 l o 'Scopo, e il 30 p 100 di que lli che !"Opravvi v ono, perdono la vil'tu d ell'occ hio des tro essend o la canna d ell'armA appl icata quasi sempre sulla l o mtJia rl ostl'a. Qu e!'to fatto é la conseguenza de lle disposi zi o r.i anatom iche della r eg-io n e Ll' mporale : tutta la a nteri o r·e di quest'ultima, cos t1tuita dell'osso zigomaticQ e dal m o htre in avanti e dalle g rande ala dello sfenoide in di etro, ccrri <:.po nrle all'o rbita e non al la cavi tà c ran ica. Il proiettile penetr·anell'ot·hita d el lat0 corri spo n· dente, e se la f:u a forza è ba;;:tante, può anch e attraversare le ma sse laler•a li dell'etm oide o pen 13Lrare nell'orhita opposta dannef!giando più o m eno l 'altr'occhio.

Ma la lesione si mulltluea dei due occh i s'i ncontr A rttramente.
:"1ella g uerra franco - pru ssiana del 1810-71, !'U 860 fer·it e dell'organo vi!livo, 313 proven ivan o da p r oieltiii; e. su questa cifra, 28 vol t e soltanto furono rnter·es ali e ntrAm bi gli occhi : la c eci tà compie t a n o n venue r iscontraw c he 9 volle. •
Acca uto ai ca i semplic i, in cui la sola visione é altera t.a, por re altri casi compl icati da lesioni \'icine (nervi m otori dell'occhio, ca · r otidc. ('ervello. n er vo o l fallivo), fra cui quello r1ferito è \'eramentt> i nteressante. Tr atta vasi d i perdita r omplc ta nella vi sta con atrofia d ei due globi ocular1 e con abol izione dell'ol fatto con secutive ad una ftWi l a d i pr o iell1le di rivolte l la di grosso calibro. Co m e era d i m o!'- tralo dalle prrfora-zione simu ltan ea dei due bulbi e da lla l esione del neno olfattivo. il tr!igil t o l"t>guito dall a palla dovette e!lsere m o lto o bliquo; e mollo probabilmente - la quale fu l'a ccol la da occor;:;e prima pre,;so il ferilo, e prese ntavasi mo lto cl e fo r·mata - u scì dopo aver perfo r·ato obliquamente il g lobo oc nlare s inistr o , da d entro in fuol'i P da d ietro in avanti. L'ano smia com tJiela o!lser·val a in codes to ferilo sembra doversi attr•1buire ad una f rattura c •mminuti v n della lamina, c ri brosa del l'etmoide prodolta dal pruieltile n el suo passeg gi .J da un'o r·bita nll 'alll·a; e ben c hé l esa me rinoscopico n on abbia dalo a l c un ri su lta to, nou s i può - A motivo del Lra f!ilto del pr·oiettile - rensar·c ad una l esione o liwllo dell'apofisi ma bensr ad una lesione situata nel la p arte tutt' a ffatto super10r e delle fosse ns!"ali.
La perdita del l'olfuLlo rn codesto individuo, perm i se all'A. di stu diare m olto iJl'ne le sensazion i pu r·am enle di cu i se ne descr rvono q uattro: i
.3G4 RIVISTA DI OOULISTIOA
E
T.
sapo!'i dolci , gÌ i amari, i salati e gli a cid i. Certi auto ri, fra cui il Val entin e i l Ouval logller·ebbero al gusto questi due ultimi sapori; la quale opinione combAttuta dal Vintschgau e dal Gley come inesatta conti ene tuttavia una parte di ve r·o, poiché nel caso ri portato dal T errien , mentre i sapori dolci ed· amari el'ano perfettamente conser·vati, era no molto diminuiti i sapori salati ed acrdi; questi ultimi, anzi, I"{Uasi aboliti.
Fina l mt>ole l 'osservazi o ne in par·ola dimol'tr·a ancora che l'assenza o la disi ruzione dei nervi olfallivi produce necess,wiamdnle la perdita dell'olfatto, il che era gia amme>;so dalla maggior par·tl! degli auto ri, malgl'ado che, in alcuni C8si, s i fosse osserva•.a la conservazi one de l senso d ell'olfutto dopo la pr rdita dei ner•vi oll'attivi {Lebec, Te stut). Per cvnst!g ae nza vien messo in chial'O che il compenso per rA'Irte dei filam enti del ll'lgemino, ammesso dal Fischer·, nou es!sl e, poiché nel ferilo o sservato dal T err ien, il trigemiuo noo era s t ato in· teressato e quantunque il tr·aumatismo risalisse a1:J mesi, non es isteva alcu o fenomeno di compenso .
E. T.
- Delh alterazioni dell a. • rovea oeutrall• • nella miopi& (Recu ei l d'ophwlmologic, l VO:!, 11 . :-!•.
V'ha un certo numero di ma la ttie oculari che localizzano di preferenza in una o in allt•a parte dell'occldo, e vi risiedono a lungo, pr ima che l'e!=:ame oftalmoscopico sia riu scito a rivelarle: fr ·a que«te bisogna annoverare le atr·otie c o r oideali de1 miopi, le delle coroiditr maculari.
Que s l'aliez ion e che s'incontra molto frefJuentemente negli occhi miopi, sfu$lf!e mesi ed ann i ad ogni Mservaziorre, porc hé mentr e l 'oftalmologo, esaminando J'occhro all'ofralmo:::copio, concentra tutta la sua atlenzio ne sullo stato della coroidea, sul nervn ottico, pd anche su lle parti vrcin e aiiR .foo(;a c entralis, non si accorge che precisam ente in ques to centro vi sivo esisto no dei punti alterati, dell e strie, del!li essudati e dell e chiazze alrQ· fic he cot·oideali chl'l, :::enza molto estesi. non costitui sc ono meno la cagione princip ale della diminuzione v isrva.
Il motivo pel' cui noi commelliamn (ju e::: t"erTor·e di diagrroEti dipende dnlla rol'i zione s te s!"a della r·,.gione pre detta, l a c ui immagine oftalmoscopica si tro va :::ul tragitto dell'asse utlico e pt: rciò dal r i nesso lumuwso de l ceulro della cornèa: vede molto fa c ilrn ent"l tullo il fond o dell 'occhio, la papilla ottica e la co t'Or dca, m entre la macula lnf.ea si trova ve lata da quel rillesso i n un esame supel'ficrRie ad immagine
E fu appunto per r i mediare arl un tale i11 conveniente c he l'A. fio dal 1899 (Società france!IO d'o ftalmolog ia) di usa r·e una l enle prismatica, la quale fa deviare il riflesso centrale e pe rmettendo di collocare l ' immagine de lla macula a lato del l'inesso medesimo, fa sì che l'osservatore si formi una nozione d i tutln la regione in e!'m me. Pratìcando l'esame oftal m oscopico con la lente pl'ismatico, l'A. riu scì appunto a r·iconoscere delle alterazioni macular i al l oro inizio, in individui i quali, io apparenza, non presentavano altri vi!'ivi che fatica e astenopia.
atrofìe coroideali della m11.cula non !:'ono punlo in ra pporto con un grad(} elevato d i miopia ; ed a questo proposito l'A. non c r ede di poter accettar·e l'l'lpinione del Fnchs che " le alterllzioni coroideali della mnctda lutea s i man.ife··

RIVISTA DJ OOUIASTlOA 360.
s tan o •f uanrl o la miopia ha un g r·ado mollo elevalo o Al con tr·ario, l e moc ulari s ' incùnlrerebber·o tanto nelle m iopi e deboli dr 2 e di 3 ùiollrie, quanto nelle forLi di 10 c 15
Queste allt>r'azioni - di cosi grande importanza anclre nalla pra t i ca medico porchè ci danno ra!!i o ne di certe diminuzroni ve no le \'Oii, ch e non s tann o in ra ppor to col g r ado della m iopia - hanno u n si:.miflcato ro m ples!'\o e prove ngono in parte dalla distensio ne dci vasi cor o idei che, cor 1 l 'al lungament o del diametr o enter o- posteri o re dell'occhio nella mi op•a danno luO!N a r otture vascol ari, ad emorragie cleli a mRcula c ad nbrino- plastici nei d i ntorni di quest'ulti m a. Esse, poi, ac•1uistano tan t o maggitl r e in 11uant o che invadono facil mente le parti vicine della r tJ linA, spe<' i almente lo str ato di H enle, e vi formano d elle mlìllraz io ni a fo rm a slella ta dovute senz'alcun d ubbio ai globul i essudali v i a l bumm o rdr eire si di stinguo no m ollo ben e, all'esame oflalmoscopico, into rn o alla fove n s t es!i'a Le r icer·che del 1\'uel hanno dimos tralo quanto tali infiltrazion i possono t>slenrlers i in s uperfic ie e spesso r e, drsso ciando e djsorg anizzando l e par·Li cos titutive della ret ino : pi ù tardi, se l'intìammazio ne acuta sparisre e gli essudali l'>i dil eg ua no, riman e un t e:;suto c i catl'iziale bian co che occupa l o macula e che p r oduce, per un o scoloma centrale più o m eno lar·go o d t>. tìnitiv o.

Si noli ancora c he l'aeu l ezzo vi!i'i va r isen t e w oIlo (H'ec• IC8 111 61l l A p- li l l i di que!<L'a ltora;,:io ne maculare: in princip io v 'é nna speci e di de t'o 1·ma7.10ne d egl i fissa li, prodotta da un solleva m ento de lla r etina cnn !-CCULivo da to d eliA cor oide a o livello d ella macula, per· cu i i co nto rn i d egli oggt>lli stess i si f.:dnppi ano ed o ra a ppariscono l!urvi o ra spo r :.renti, orn interrollr in qu alch e punto cJA m archia e da sco to mi che r en do no im posQibile dc i pa rt icolari. E evidente c he un occ hio in tali condrzioni no n è J)iù capace di esegui r e alcun lavo r o utile, ed a stento distingue i cu r·at t eri.
1'\o n c r·ediarno inopportuno il far• cenno dell a c ura di codeste aiTo>zinni tlella c ura che de ve esser e m ollo ener grca e.! inlrn pr esa nell'u uzio clelln rnalatlla. I l Galc'zowsky consiglia anzi tutto i derivati\'i !!'ollo fo rma di sangu rsughe alla tempia e diPtro le or·ecchi e, e di ven tose alla ti UCR: in secondo luoi{O, quei colliri• d1e pos so no far con trarre i vttsi r etiu i ci e cnroiJei, e da, a ques to r•rguaròo, la pr·pferenza alla su rrenalina ed all'amamt•luta.
Il collirio cii s urTen alina (esl1·11 UO dr glandola s urrenale doso .l i cP nliflnunmi pe r IO p. r·ammi eli eccipien:e) instillato una o due volle al giorn o nel SRCCO
L ' omurnelina s i pr escriv e preferibilmente sotto forma di compr el"se ca lde o rr edrle; e lo !';O iuzione a Lél uopo im piegata è l a
A cf(ua di still ata di lauro-ceraso
A equo drsti l lala di l a ttuga
A cqua !l istill a ta se m plice
Arnnmel ina
gram mi 25
50 225 0,75
L a com p r•esse si a ppl i cano s ull'or.c hio c hiu so e vi si Lon(òiono (per un'o ra il mattino l' l o sera) per mezzo di sacchetti di gom ma riempiti di g h i acci o e di acqua cal da alte rnativam ente.
l prepara t i rn er curia li e i odali per u so intern o, 8 !Z ÌI'anno fav orevolm en l e pe r ri s tabili r e cirt!olazioue normal e dell'intero organ is m o e per fa cilitare la ciCllh'izzazion e dell e pa r ti a!Lerale della macula. E. T .
.366 !lrVISTA DI OCULISTICA
D ott. ltf: M rCA S - La prognosl 41 alcune malattie generali 11eoondo certe mantteataztonl ooularl. - ( Rec ue d d ' ophta l m., J!llh:!. n. i)

In un gl'l\11 nu1nero di mala llre g enera l i insor:;:on o dei distur·bi ocular·i, or•a ac-cid entali , ora , i n vece, dr prod .-r1 ti dalla malatti a ge11 er ale s te ssa di r ui sono iln s mlomo o una ("Orn plrr Azi o ue. l o cula1·i d i •1uesto 8econdo g ruppo p ossouo servi r e t1 s t ab i l i re i l pro no !'tico dl'll'affezron e m o r·bosa
L e ulc rr·(• co rneali, la <·heralorn alacr a , !'smaur osi i rn p1·ovvi.::a de lla co nvalescenza e l'em.-rnl opra nell'rnizro d i q ues ta sono dr cattivo Augu1•i o n el mo r billo . L'e «oftAlm o brlnl ... ral e t' la c heratomo lac ia nel v iJ iuo l o, la cec ita impr·ovvi!'a nella perlM;"e rend o no H!'Sal cu pa la progn osi Ji qullsle dut> rnR i allie . La sco mpn1·sa d t> i d rs turbi oculari nel botuli -" rnO fa prf'!l agi J'I' il te1·mine de ll'afTeziolle: la ptosr rl opp ia accompagnala da parali si d»ll'ocul o motor·e esterno e da é s pe!!!IO seguita da mo1'le , quando inso r ge nel cl ec:OI'SO d'una fehb1·e t i fo idea. Nel colora, le ecc himosi con g-iuntivali e l e c hiazze n era s tr e !l ulln sch' I'Olica fann o un fAtale, precrs a m ente come l'a fl!l enza dnlle l'razro ni m enl1•e che la guarigione é rll'oballile se le pupil l A reagisco rw bene
l disturbi oculari della si filide - anche l'i r ite - devono fa r temere una nrulattia ·c on J•ipe•·cu ..s io ne sulle meningi o midollo. L a comparsa d: unti rerinite o Jr tura dia betrca é di cattivo augurio , e l e vMiazioni d ell'ampii'Zza d'accomoclazro ne le vari azioni d<" lln g l i cosuria dn una morte più o m en o r apida quand o una r etrnile so pravviert t' 11el co 1·so d i un m OI' llo di Bl'ig ht. L ' ineguaglianza pup i lla r e co n midriasi molto prù dal Ia l o dove Ir a >"ede la lesi onP, in sorta C'Oi pdmi sinto mi d e llu v o i monil e e pè•·sis t enl e d UJ•o nte la mAlattia ed anc he per un ce rto tempo dopo la d ef,\rv csceu za, i> un !"into rno c he fa p• esngire la m e ntre c he u11a d i ll'erenztt pu pil:a1 <' min i ma o pttsscg g el'a é di p1·ognos i infau11ta, S e nei ve cc hi n o n d8 1n11 l altre d elle vi e la g l'imal i si con s tata no d elle ulce t'P co1'11ea lito•·prde, fA ci lmen te infettAt e , s vil u ppantesi c: enza appa1·e nte, mollo ri servu t i ciJ•ca l'llvven1re del mal'l l O
E. T .
GALF; t. o w s KJ. - La fo rmalina e Il suo uso lD oonllatlca - ( ll ec11e il d'oplttalm, n 7).
La fo•·maliua ,, un pr epurato p ul'issi mo eli fo r malde ide c he quantunque !'O· lubi l c fa c ilmente iu tutte le p1•oporzioni, nell'acqua di:i lillnlo iocolo r a , con>; eJ'va tuttavia un c e•·Lo a l'Orna etet·eo e ir e no n ò punto dlsaggraJ e vo le .
La sua g r ande s olubilità 11e rende l'us o molto vanta g gioso in oltredr ò non esc;en do nè l o!' o; i ca nè i rritante, pu ò es sere fn c ilm c nte prescri tto come a ntisPllica, a J'elativAmeltle assai eleva l e , nella c u r a delle fel'itt> cor· neall o so p•·atulto se si aggiunge alla s ua soluzione acquosa qualche altr·o prl'paroto caln1ante, astringente o ri!<olv ente
Da pa r ecc hi 1111ni l ' A. lrn bandrl9 dalla terapeut ica antisetti c a il avenùo cooslalato ch e, in cerli iodividn i, una so luzione anch e debolr diviene tossi c a ed irr itante; e ricor r e>, i nvece, ai prep11rali fenici come antisettici nelle operazi o ni, a g giunge11do vi un po' di nafto lo. Ma - eg li so g giunge - la for-
RIVll'l"rA DI OC OLISTIOA 3G7
m ulinH presenta t'Pa li vanlag gi s u luni gli allri antisettici n ella cu r a delle af· fez•on i purul en te della congiuntiva, nell e orla lmie b l enorra g i che e i n q uelle
dt>i neoneli, com e pure nelle cura delle ulcere r odenti e degli ascessi perforanti della cornea, poil'hé 8!"!"9 d i str ugge fAcilmPnle tntli i i m piPgA ta - come l ' A . con ...iglia - solto fo rm a di l ozioni o di polverizza zioni applicat& pa t'E'cchie volte al giorno sull'occhio aperto.

Ecco l a fo rmola della soluzione che l'A. adopera in lali casi:
A rqu a di!>tillata di l auro- cera so
F o rm alina . . . .
A cqu a semplice
Clor idrato neutro di cocain a
(Si indichi: soluzione anth;etti ca).
gr. 25 0 ,75 " 2i5 0,15
La formalina vien e pure usata c on g r·ande vant.aggio so lto forma tli J.IOmat& cura tlelle cht:ratili et·peliche e delle b lefaro-congiuntiviti , secondo la. fot•mola segnante:
Lenoli na \.,.
Cl or td re l o di eu caina
Cloridrato di form a lina
(Si tn d i ch i : pomat.a per g l i occhi)
Da intt·odursi 1-2 v olte il g ior no .
gr. 10 » O,O:J " 0, 10 E. T .
Dttt'uv-DuTE:IlPS. - Due c ui dl cecità completa. perals tente , aenza.lestonl otta.lmoacoplohe , c onaeonttva a l eggerl..tml tra.umatlsm t della reglon• oculare Istero ·traumatlsmo. (Soei élc frane. d'o,,fualm., Congt·esso olP l 190..!)
La prima OS!>CJ'Vazione SI r irel'tsce ad un operai o tli 3R anni c he, n el 1895, fu t·olpito al viso da uno strofì nar do imbevuto di trementina. Subito dopo, egli con statò la per dita compleLH della vista nell'occhio !!inistro ed u na diminuzione n ote vole di quella rll>lf'occhio destro, che non la r dò a scompa rire pu r e co mplel omPnte. Q uatlro anni più tar cli, quAnd o, c i oè. il mnlato s i presenlò alla visita del med1co, !>l rilev ò l'ebolizione cvmpleta della vi sta in en tt·ambi Jrli o cchi, senza alcuna olterez ione e con perft>lla conser vAzione clei rille!>si puptllari allA luce: perm anenle, con asc;enza di ogn i movimento d i a ssenza di ammi cca mento nell 'i mprovviso avvktnamento di un Ogj<elt o a ll'occh io aperto. Zone di anestes i a cutanea d i s:<em•nat(•: sinil'tra del lo lin:,!ua: Anosmia s ini l'llra: d idell'acut ezza uditiva a sini stra. Conservaz io ne della sen sibilita cornea l e. di sturbo m o t or e ; nessun sintPm o ce1·ebral e. L'in ft> rm o fu o sse rvato per il periodo di lt·e anni, e la sua cec ità per si s t e, roi m edesimi caratte ri d n sei or1ni e m ezzo es!'en dosi d im ostrata r ibelle acl c ura.
La seco nda osset·vazione s i riferi sce ad un opera io eli 2:.! ar111i , il quale fu co lpito a lla fa ccia ed agli occhi da una fiamma tn un ca lo1·ifero. Subito dopo l 'a ccid1• nte, in sor se un d i stu t•bo de lla vista inferi o t•e) nonc hé impossibilità a di riger·si da !>O lo. L'esame, fatto tr e g •o •·oi dopo il traumnlismo, no n fece ril evare t r acct d alcuna di u slioni , nè a lcuna l esi o ne ocuiMe. F ondo dell'occh•o no rmal e: ritlessi p upillari con servati, m algrado l 'assenza d i OJrni per c ezione luminosa.
3G8 RIVlSTA
Dl OOULlSTlOA
Gli as;>i o tti ci er ano l et:.ze t·menle in pm-izione di ripo>.o; n o n esi!'to>vo C(luvorgenza, non urnmiccarnento rill e:<so d elle palpebre; non fo lofoh ia oè spasrni ocula1·i. co m pleta della fac cal'l dai due lati, eccclluale le cornee; genet·olc dt'llla lmgua, delle braccia e delle gaanbe. A ssenza del r iOes:>o faringeo e da santomi cerebr11li. La ceclllt da llll 1111110 e m ezzo non ORlante che :-i SIH O teutate tulle le cure opportune.
I n questi due la siuu,la4ionr lleoe dù,tinata no n n e: roncergen;a n e flltpil/are Non si puo enunciare r i po t e"• di una delle vie otti c he anlea·tori. a motivo dell'assenzA dt c':.: ni alterazione della papilla dopo parecc hi aum di o!'3et·vuzioue, e della pcrsi!'lenza dei rifl essi pupilla ri. L ' esis teuza di una delle vie ottiche vusleriot·i o dei centri , i c: tvi corlic11lt no n può neppu re e ssere a mmessa, poiclaé l'i sa r ebbe dO\'Ulu produrre all' improvviso t' simullaneameute in pun ti simmetrici dci due emisftll'l nel motnenlo in ;:ui ebbe l u ogo il l eggero Lr·aumMis m o: n •·, d ' altra parte, es isteva alc uno di quei sintomi che accompagnano semp re Lali le!'io ni.
La soiA c.Iiagn os i che atlualmenltJ é quella di amaurosi mal gt·a do la dur·ata della ceci tà e l ' a sse nza dPI ,;uo solo ele111ento di cc rlezzu: l a gua r igione
E. T .
CmLLIEZ. - •anlfeatazlonJ o oul a rl d e l diabete .- (.luu r n a l d c .\lèd ec i11e et de Clti r u rgie, otto bre I !)U2).
L e compl icazion i oculari elle pos sono nel cot'>iO •Id diabete rela t ivamente ft•equènti, l'l t per 100, e tn o lto variaJte. Sulle si riscont r an o i fo r uncoli, l'antra ce o piullo>-l o gli o rzolUo li , e l e er uzioni l 'czemal<•:<t•; la r ipetizione e la re siste nza di queste alle r·azi oni al traLiamenlo o r dinario nwllo no sulla via della diagnosi
La muscolalur·a oculare oc.l eslri nsl'l'a é fre• Jueu temente In t!i lesioni d' origine !.:'licosurjca. Tulli i muscoli po ssono esser e atl'c lti da par·a· ltsi, ma qucHi 1'11e innerva il m o tore ocu lare comune sono i più or·cl inar•aurnt•nte interes;.aLi. 'l utto questo g ru ppo muscola r e può C'-sere atretto, ma il pau spe<>so ne è colpi lo un solo tnu ::;col o, I'C:evalore d PIIO palpebr a superior e per esempao. Que sl<t paralisi é :wvenli associ a la a quella del fa cc •ale, s pectalmen t e d ell a brau ca innervatric e delrorbicolat·c. I n alc uni ,.a,.i, lulli i muscoli di un sol o occhi o sono alletti con lutti i inrwr\'aLi daJ fncciale Qu es ti at·crdenti po s,..on o fugaci e n on durare c lae 'lllll lclae :;;ctli rnana; sono quell i che ro mpoiono nell'in izio delle rna111fcs lazioni diabellclte: quelli inve<·e che sopt·agginugono iu un p eriod11 avAnzato del diabete e che dip••ndouo da un'emorra,l!ia per iusullo a popleltit'orme, non gua r iscono Cl)mpl etamente.
La par alis i dello sfì nlere pupillare ù pur e U118 lesione pre,·oce dovuta s o l un' int.os:oicaziouc

La corn eA é sov,mte colriLa solto diverse for·m e.
A nche l'irite i' una delle l esioni più fa·equentemenle os:sorv ate.
:\la l'atTeziouu oculare più fr equen te nei distJetici 6 cerlam cn to la cslars lta: de Graefo riferi sce> d'averla osservata nel 25 pe r· 100 dei diob e tici; ma questa p r oporzione è esage rala , pe•·ch•., il diahete presenlt:uHiosi abitualmente n ei - o Kgetti che ragl'(iu n g o uo l'e t.à delle calaratle seuili, fa d'uopo eliminare i c as i in cui vi h a semplice C"oesistenza di calaralta e di diabete, sen za r elazione di c a usa ad effe t t o.
- Gior11ale medico.
DI OCULISTICA
An cl te la r e tinile s.i ri sco ntt·a frerptentemente, solto du e forme: l'essudati va e remo r ra.a:ica.
Un punto da seg na lare, si e c l te le lesioni relini c he s i p r oduco no n el periodo avanzato del diabete e coi ncidono coi foruncoli, cogli aut r ad g an gt•eno si, colle e mipl egie. La ma ggio t· parte degli Autori lo rite ngon o pro@:l't>ssive e non a cco rdan o una !<opravviv e nza s u pe riore ad u n anno ai malati c he n e so no affe tti , m a ' 'i so no m olle a q ues ta r ego la, e Chilliez h a osservare alcuni casi di questo che so no mi g liorati ed h a nn o sop r a viss ulo molto più lungame nte
La prognosi gen eral e di qu este aiTez ioni é impot tanle a conoscere: dapp ri ma s ono in gene r ale riud:zi o di un agg ravam ento del diabete, e per aHra parte, s e si prende in particolar e ciascuna les ione, si n ota che le affez io ni infiamma to ri e de lle pa l peb r t? non presentano gra,·ita che a cagione della flebile della vena oflalmicn coi s uoi pe ri co li. Le pa1·alisi muscolari sono g ravi se sono il ri s ultato di e mo rra g ie , perchò, oltre a non gua t•irc completamente, f'Hnn o te m e re e m orra g ie C'e t·ebeali. Le della co rnea, dell'iride e , del c r is tall ino posso no e ssere IZravi pe r gli a ccidenti locali. Le r etiniti , le coroiditi son o gl'avi, perrhe sono molto spe!ò:>O il fenomeno precursore di e m ormgie cerebrali o de l co ma, co m e pure per il fallo che di minu iscono no tevolm e nte la funzione visiva.
Il trattamento d egli accid e nti ocula r i co m pr·ende p r ima ùi tutto quello della ca usa: fa d' uopo so ttopo rr e i malati al t·egime _co mpl e to, ma prog r e ssi vame nte, con ocu late7.Za. La medicazio ne locale de lle manifestazioni o c ulari ù la s tessa d i quelle che s i ad ope ra or·dinal'iamen te pe r ciasc una di dette lesioni . ma !>i do vrà n e lle lesion i suppu 1•ative avf'r più Cul'a dell'antisepsi, pet·chè i di ah el.ici guarisco no co n più difficoltà. La qu es ti one veramente intet·essante da l punto d i vista delltt cura é la parte ope t·ato r ia. L ' Aut o re é di pare r e che s i debbono ope r ar e i dia betici, m a elle però s is n eee!':sario prendere al c une r•·eca uzioni: la p rim a è di ri d urre la quantità dello z ucchet·o al minimo c o n una più vi go ro sa oss:e rvanz11 de l r c•gime, e, se ciò no n bastasse, co n una medi cll zioue appl'opriata. L'an tipit·ina è, sot to C( ues to p unto di vis ta, il m edic amento di sce l tn . S i presc r1 ve o.lla dose di 2 o 3 gt•am m i al giorno durante i diec i gto r·ni e ll e precedo n o l'o perazione; e se qu es ta 1 '1 be ne e seg uita, i1 t·i::;ulla to finale é e ccellente.
P tzoN . - Teoria meooanloa della vl•lone .
Pizon p r opone di sos tituir e alla Lt?orin dPII' azio11e chimica della luc e s ull a porpor·a rtl tini ca, di cui so no 1m pr eg nati i l>astoncelli, u na tPoria mt!ccanica. Aven do elle an c h e n egli organi vis ivi t•idolti ad alcuni eleme nti, tanto n e i ve r tel> eati quanto negli in verlebi·ali, i g r anu li pig m e ntari che accompag nan o se m pre le c e llule visi , ·e sono costanteme nte an imali da movimenti r apidi paragonabili a •ru elli di al c uni mic r ococchi , l'A. suppone che codesti g ra nul i tr a ggano la lot•o ene t·gia dalla luce. sotto forma d i un movim ento vib r·atorio che essi trasmettono, a lla lo r o YO!tll, ai coni ed ai bastoncelli con cui s i t rovano i n co ntatto : la scossa mol eco la re ricevuta i n tal mo do da lle cellule visive s i p t•opaghel'ebl•e po i lun g o il n er vo ottico fino ai ce nt r i nervo s i e nc efalici.

370
RIVISTA DI OCULISTICA
B.
Questa spiegazione la quale t oglie ogni importanza all'esistenza <della porpo r a relinica, r ende pure inutile l'ipotesi formulata da Young e da B e rnard sulle diverse eli fibre n ervose: in compenso, essa permette di uo certo numero di fenomeni ancora oscuri, come la visione dei -crJ!o ri, i l daltonis mo, i fo s feni e la vi sione degli albinL Prendeucio alto di fJU esle vedute del Piznn eri Attendendo la loro conferma da Altri falli sperimentali e da altre ricer·c he, non possiamo non ricordar·e gli studi e le ricerche del n os tro Ang c lucci, i cu i ri sulta t i positivi per·m ettono fin da o ra ùi enunciare, non già un'ipotesi, ma una \'era e pr•opr·ia t eo r ia della visione.
E. T
VACHER. - Influenza. d ell& oorrez lone to tale d ella mlopia. tal1ao deoor• o progre11lvo. - (Soc f rane. d'oplttalm., Congl'esso del H>02)
La mag:zior parte degli oculi sti hanno la c on suetudine eli non corregger·e che parzialmen te la miopia e di pr·e!"crivere delle lenti che portano il punto prossimo a 3:l cm. circa, considerando l'accomoda zi o 11 e co me favore v ol e al miglioramento del difetto. Altr·i, invece, come F i.i r ster, Ri;:ley e Dor·y, sono parti€{iani ddl a cor•·ezione totale; ed a qu es ti, molli allr·i se ne ag f( iun sero dopo rullimo congresso di H eidelberg
La corr ezione in co mpleta è inc apace di far perder·e gl i atlep-g iarnenti vizi os i che, s econdo F ù rster, sono le CIHJ!"e principali della progressione deliA mior)ia. ri s ultante da du e fallori: ncc omudazio11e e convergenza; mentre la tota le ri stabil i sce il par·allelismo tra fjuesle ùue funzioni e r·enùe all'occhio la funzi o nalità di lulla In s ua acc omodazion e.

In cerl1 casi bisogr.a !"opprim er·e la c o nver·ge nza soppr·imendo la visione bir10c ulare da viciuo, mediante un diaframma alte r nativHmenle dinanzi a cia scun occhio. Siccome la della miopia raggiunge il suo massiJno tra i sei e i dodicr anni, m entre più tar di progredisce molto più lentamente, c osì è necessario sorvegliare gli occlii miopi a datare dal sesto anno di etli; evitar·e che gli individui avvicrnino gl i oggetti a m eno di 30 cm., e corr eggere t otalmen t e la lor o miopia
E. T.
V JG NES .- No ta aal l' adrena.llDa. - (Soc f rane di oj /almologia, Congre!'!so del 1902) .
L' ad r enali na é il princrpro alli vo del succo d elle capsul e sur-reoali, di cui si assicura la conser·vazio ne sc.:ioglie ntlola nella soluzione fi siologica di cloruro <Ji soù io c o n l'aggiunta di 0,5 p. lUO di clor·ctone l l clor·elone è un anes tesi co elle si ottiene dall'azione della pola ssa causlicn su pa rt i u g uali di cloroformio e d i acetone, etl é un potente g:e r·rn icitln La soluzione cosi ottenuta è nettamente i sche mizzanld della congiuntiva normale o patologica e, nello stesso temp o, legger·me11te au estesi\:a per via del cloretone: essa non produce alcun dis.turlJo nell'epitelio corneale, non modifica, il poler·e n é l a t ensio ne endoc ulare. i nfìammazio;li cougiuntivali e in quolle super'fìciali ùe lla cornea, essa l e sensazioni dolorose, mentre ch e il poter·e g:ermicida del cloret one spi nr;a una favor e vole iPOuenza s ul decorso dell'affezion e
RIVISTA DI OOULISTfCA 371
:\ellr ir·ili r il ia r i , facilita dei micl ri:1l r ici , e lo stesso fa pl!i m iot 1ci n el g laucoma, rimauend o per ò esclu;:.a uoa particola r e azione anti !:iauCo m e emos ta tico. può esse 1·e im pie g-ata in ce rte em .1rra !!16 llllroc uiMi , oltrechè e!'<"8 dimmui;:.re lo spa nti i mento "anguil{no duran te l e opera zioni. in ieme con lu cocainA, p r oduce un'a nes tf'"lll più r·apida e più com ple ta. Sec-on do il T er ,.on , l'aùrenalina ravot·isce la f.[u ari giOhe delle cong-iuntiviti ipe r em1che ;,ecche e delle scler1ti. c he, come é noto ;:.ono l••naci.
A p r opm: ito di fJuestn sl t's:< a sos t anza, il c i alP.ZO\\':<ki d1ce d i a ver e scoper to ir1 e;:.c::a delle fJURiil iJ ecn>zionali che le un valon ' rrPIIa c urf! d t cer to: affew11ti oculari c r oniche quali souo: le '-cler ili t'elllnRlir hP: le r Ptirnli emorra:;riche: le t r o rnb •1si l'et;nic h e: l e embolie retini che t r nli<'he ctoprllari. L 'alione fisi •ol ol!i ca local e piu inlel' e!lsante per l'ocut> quella va "o-costrit liva : alcune della sol uzio ne nll' 1/ 1000, o In Ci! liO del collll'l o, di cui qui si trascrive l a ro rm ola, p1•od uco no rapi Jamenle u rl'l sclu::ntia la quale 3ù - UO minuti:
Cloridrato di ad r enali na d i P ot it id . di co ca i na id di pil ocarpina
Acqua dis till a ta
O fl r OL
Ogr·.
U p;r·. Ul
10 g r.
I l collir·io d i ad!'enal ina allo stato fr.esco é a pnP-na color aLo; 1na, dm:i r apiclanwnte, t i nge in br·uno più o men o c u"po: duoque co n · ser·varlo al l' ipm·o dell'uria e della lu ce
Il cln r id r uto di arh·omalina del P liL d iede al Ga lezow :>k i r i>mlt.ati a !'sai m igliori a cq uoso di glandole e perc1ò egli l o r·accou11mda m modo spprialr'. E. T.
nALto:/.0 \\ "iK l. - Delle o ftalmle elettriche . - (Ree w il rl'oph talmologie. l !}11:!. lllllll. Il'.
T ra le varie ftJ r me di o ftalmia el t>llr ica che i l descr ive n el suo lavoi'O è importante la forma ambliopi ca per· le me· che n e po">'Ono dt> l'i"lal'e.

L'A . s i domau ·la a nz itutto se l'a mbJ;opia Plettri ca è un distu1•bo ' ' i si ,·o prolunga to, prodo tto dfllln lucP intensa rl ala dall'elettr·rcità. a c ut gli occhi sonu, ai nostri co;:.i fr·l'•ptr nlemente es po!:> ti ; e r•itiene sia importan t e il r b·pon. d er e a t a l e •tu rs lio ne, tAnto pi ù chP, quale per ito giuJiziar·io, fu spesso r ichie::to d'un pa r e r e nwdico -legRI P.
l' di ma te riali del .fon do oculrt r e Pe r r i solve 1·e il prob l ellla, bi;,ognel'é 111 p r imo l uog o r·ice1·care se oppu r no , del l e le!lioui eta pa1•te del la I'etina e del nervo ottico. Secondo l'A. vi sono de ll e ambliopie senza e pa re cchi c !t e si occupar·on o di tal e non r·iuscii·ono a èi !:>l iogueJ·e al cunA l esi one di f) Uesto Etenere.
:!' FotoJ'oln'rt. L 'eccitazione della r e tina p r odo tta dalla l uce 6 grave: v'ha d ella fo tofob ra c he può )li un 11er e fi no alla lac rima zi o ne; e, nello t empo, si o s::e1•va una co ntrazio 11 e pupilla r·e r•rtl essa e irregolar·e nei d ue occhi, men t r e la I'CBzio nc della luce diurna sull'occhio e alfello in sensibi l e. Chiudendo ed a pren do alte rnatrvam ente la pal pebra, si p r ovoca la di latazio ne o la conll'azi onc pupi lla1·e e n ormal e in en t r ambi gli occhi.
3 72 RIVIST A DI OCULISTIO,\
3° Scolomi cent r ali. - L'A. li ha incontt·ati qualche volla, li mitati ad ttn!l :zona ci r colare beo ci rcosc rilla, più sovente di forma ovale e il punto di fissnzione: rassomigliano molto· a scolomi toss ici, più spacia l mente nicotiuici; sono vaghi, mal definili e perct ò p0co du limilabili. P e ro non sono n l'fatto persis tenti e si dilegu ano a poco a poco sollo l' iutlueuza de! riposo, d P. Jle applic azioni fre lde, ghiacciale e di qui:Jl c he r imedio cahnanle, co m e il collit·iu di cocaina, di dioni ua e d i daturina lu due casi di ques to g e nere, l'A. -rico,·se al seguente co llirio, che venne ben lolltwato dall'infermo e che calm o ra p tdarn ent!;l l'eccitazio·ne uervo s a rlella r e tina :

Acqua di s tillata di lau1'0 ce1·as o .
Acqua distillata semplice
Daturina . . •
f> gr. 20 g r. 1 milhgr.
Co nsiglia ancora, tanto nell e fotofobie ch e ne sdi s •·oto mi- oltre ai suddetti colliri - le do cce d'acqua po l verizzata, della durata di 4·=> minuti ed applicala tre o quattro volle il giomo sugli or: clli aperti, mediante un .polvel'izzatot·e a vapore .
A tale scopo si adop rera una soluzione di b r omut·o di S()rlio e di di o nina, che st versera nel bicchierino dell'appal'ecc hio, e di cui ecco la fo r·mola:
Acqua distillala . . . 275 g r..
Acqna di lauro- ce ras o 2:) gr·.
Dionina. 30 c e nligr.
Bromuro di sodio . . 1 gr.
Su g li aflelti da fo tofobia si appli c heranuo inoltre de i sacch etti di cauc· ciu p ieni di ghiaccio p e s to, due o tr·e volte il giorno pe r u n paio di s P- ttimar:e. e :>e ne ollet·ranno ri sultati soJdisfacenti.
E. T.
SE:-; II RAL. - Un oa•o eU eredo-•Ulllde ooulare oon lulone delle mem· brane profonde . - (Soc. rCophtalm. rle Paris, lug lio J\!02).
Le conclusioni elle l'A. trae dallo sua osse rva zione clinica s o no di ta le in· leres;;e e r iass um ono i n m odo cosi completo le no rm e terapeuticbe da seguirs1 nei casi di s ifilide ocula re e r edita ria, che le rip ortiamo qui pe r e steso. t • L 'eredo-sitìlide p 1•oduce molto frequentemente la cheratide inter·stiziale, la quale spesso sensa lasc iat·e alcuna traccia, 'JU&lunque sia stata la cura g e nerale a dottata : ioduro di potassio o mercu ri o .
:2• La t•ecidiva è frequ entis sima, sop ra (u tto quando un primo attacco ha l»!<ciato de lle opacità sulla cornea; e s sa ò sempre m o lto perché rag::riunge allora le membrane profonde e comp r omette la funzione vi s iva . P e t· ev i1.8rla, è indis pens!lbi le una di t re auni, i niz iat a dopo la prima manife· l:'tazione. Il ioduro di potass io, usa to isolatnmente, non rius ei -nel caso dell'A.ad impedire la recidiva.
ac Dinanzi a un caso di che r ati te interstiziale, non dimenticare che la s cr o fol a acco m pagna spesso la s ifllide ere ditar ia e dà all'affezion e una tenacia notevolissima. E.
T.
RJVlSTA Dl OCULlSTlCA 373
L. RosENBEnc. - Altert.llont del midollo •plnt.Ie oonsaouUve ad antica.
amputa:llone dell'avambraccio. - (.Vel(rol. Centra li.Jlall. 8!-:"0SLO 1!102)
Le lopogrnfia dci centri dei divc>r .;:i delle memhr n gr•ic-in del midollo spinale è ben lungi datres.;:c> rd .;:tata esattamente clete r·minllta.
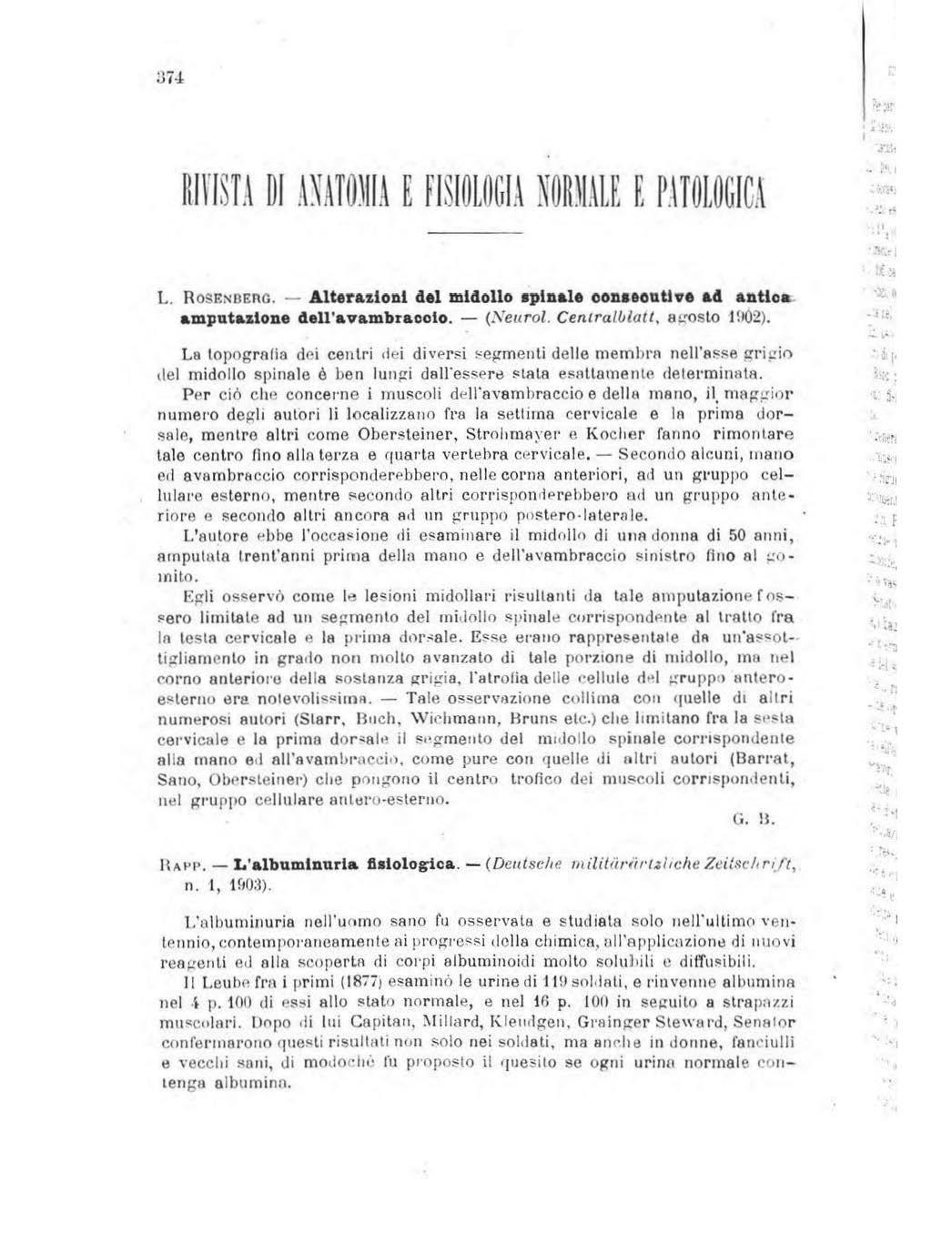
P Pr ciò c lw concerne i mu.;:coli dt-ll'aYambracc io e delltl mano, il. ma g:;:ior· numer·o deg l1 autori li l oca lizzano fr·ll la settim a ce t·vics l e e l o prima dorsale, mentre altri co me Ober sleiner. Strohmflye,· e K och er fanno r imontare tale cen tro ()no allo terza e qua1·ta v ert ebra C(•rvica l e - Secondo alc:uni, 1nano eri avambra ccio corr·i sponderPbber·o, nelle corna antel'iori, ad un g t·uppo cell ula l'e estern ll, mentr e !'\econdo altr i c orT isponric>rebber·o l!l d un gr•uppo an t eriOI' e e .;:econdo alll'i ancora Ad nn f! ruppo
L'autore l 'oece.;: ione di esam inare il mtd ol l n di unn do11na di 50 anni , a rnpututa trent'anni prima dello m ano e dell ' tt\·ambraccio l'<inislr o fin o al ::ornito.
os.;:er\'C) co nae 1., lesioni midolla1·i t·isulla nli Ja tale nmpu ta zionP r os!imitale ad un del midolln .;:pinalt! al trntto fra In testa cerv icale e la pl'ima El';:;c dA u n'a""Oll azliam c nto in grado non mollo A\'BnzRlo di tale po t·z•one di midollo, rnu 11t' l rQrno anteriore della g t·il,da, l'atrofia delle rellule di'l g ru ppn antero · e"ter no nolevoh<:c:i m R. - TR ie osservt)zione cnllima con q uelle d1 altri numer o;:;• autori (Sta rr 11nch, \Vicltmann Hru n;:; e le.) che lunitano f t·a la SP"l8 ce1· v icale e la p r ima il .;:,.gmeuto del m1dollo spinale con·•spondente alla mnno ed nll'avamlll',lC..:Ì•). com e pure cou 'JUCilo di olll·i autori (Barr·at, Sano, Obrr :;Lei ne t·) che pnngouo il ce ntro Lt·ofico dei muscoli corr•sporulenli, nel gt·uppo ce llulare
G. B.
IlA l'P.- L 'albuminuria fl•lologica . - (DeHisr:he n. l , 1fJ0:3).
L 'o lbuminuria nell'uomo sano i•J osserva ta e s tu dia ta ;:;o lo nell'ultim <• \ 'C ll· L<>nnio, c:onte m po ranoament e ai pr·og1·ec:;:;i della c h i mi ca, ul l 'app licazione d i nuovi rea ::,rcnti eJ all a i'iCoperl n di coa·p i albumi noid i m ollo sol u hi l i c di ffu !>ibiti.
1l L eulw Crn i pr imi ( 187iJ e;::am inò le urine d i l l!) soldn li , e l'in venne al buminA
11el p 100 di PS'< i allo sta l o n or male, e n el i 6 p. 100 in seguito a str·apnzzi mu"<·olnl'i. llnpo di l ui CopilRn, :\l illa r d, 1\. lewlgen. Ste w a 1·d, Senalor confal 'lllOrono r isultHli nun !'<O!o nei soldali, ma in don ne, fa nciulli e \·ecchi !Ioni, Ji mododal• ru pl'oposto il r1ue::ito se ogni urino no r male ''"Iltenga o lbuminn
DJ E f iSWLO GfAXOR)IALE E .' .· . l l .,
·:t •
_, :
• f .. , . • t:, • •!j .· ' < r: .• l " l .., . . ' ' • .,
Per parte sua l'autor e, analizzando l e u1·iue di molti r adelli della !'Cuoio di vi riscontrò successivamente, neg l i anni HlOO-O t-02. r af.(Ft"u•mle\'Oii quantità di albumina e cioè, Cra 49 esaminali, nel 12,3 p. 100, fra 41, nel 12,:! p 100, e frll :>2, n el 13,5 d. 100.
I n occasione delle tre viRi le mediche annua li , a cui sono sottoposti i cadetti, e!!li e!'aminò 1572 saggi di urine, emesse tra le o1·e 2 e :1 pom , da 1/ , ora a l 1 t ore dopo il pasto, e r iuveonc nel J0.7 p. 100 Ile• cas•, albume da pie· colt> tra cce fino ad l p. 1000.

I n 105 campioni di urine r accolte al mallino dopo le fatiche e gli esf'rcizi t!inniiRtici, O>'!'la dopo il lnvoro com piuto i n po"izione e r etta, s<·opr i pu1·e al· bumma nel 28 p. 100 dei ca!:'l.
E_gl1 usù l e pr ove di H eller , dell'ebollizione e dell'acido acet1co e d el ferro- · rumu r·o di potassio.
Il Rapp passa in rivisi.R l a opinioni de i V!lrl autol'i sulle ca usi' c su l m eccani!'mo fi Rio-paLologico di ques ta albuminuriH, deuominnln d B nn<'h•l cic licn
In f!Cneralol al c un i am m eLt ono che essa abbia in conseguenza di zi mus('olar•, da r e ni n ormali e indenni auchL! da ogn i precedente mal attia; altr·i la ri g uardano come conseguenza di l c!'iion i tlo:.:i slic he o degoncl'aliv e, o di muta m e nti (perdita di elaslicit.a) dei g l o meruli da per grcs><i pr ocessi patolog•ei. Fu puro atll'ibuila aù anoma lie di'l r icamb io m ateriale, a nel S11t1gue d i albumine facilmente t:liminabi li, Hll'alimo, ntozioue prevnleutomenle albu minoide, sptlcie n ei dispeptici, e d infine Ad alterazioni de i n,.,.,.i r enali tr ofìci o va somotori, di oriJtin e rill cssa.
Il SenalOt' SCfrnula quali cause occasiouali il lavoru mu<wolal'e, la dif!"' · i bairui rr eddi, gl i s trapazzi intt'lleltuali e le emozioni.
L a 1nlermittenza d i ta le albumiouria der iva, secondo dal meto .lo d1 ,·ita del poichè se egli sta in po!lizione dir•lln, elunina ulhumina, duran te 11 r1J>Oso a letto, non pi ù E;..:li perciò cred e ch" nel dulia posizume '>rizzont.ule a lla ve•·ticalc (al..:and osi dal letto) l'i produca nt>i ••eni 1111a dilal.llz .on e vn!'<ale e uno shock dei ner vi \'8 !<•1molon, dalla cui tluratu dq>entle •1uella dell'albuminur·ia {lllbuminuria orto:>l ali tn)
Senator , aslra en(lo dallo scat·so conlenu t•l albmniuoso olell'urintt no1·male dipendente dal distacco eventuale degli ep•leiii dCI tubul i t·enali e dalla luro par·zial e di,:ct•·uzione. pensa c h e la vot·a all>umiuu ri a fi,.:inlo:z •ca sia dNormiuata oJa tra!'uùat.ront! o da f<ec t·.nrone dcf!li epiteli • de1 1-(ltllllt:ruli, 111 ra ppo rto colla varia JWCSSIOne o vel oci tu della cort·ente l'OliA co mpu$izione del o CO:;.(li stim oli del f< i"'le ma nrrvoso.
L eube è di parere che l 'alb uminuria orto!'talica non der·i"i da una causfl puramento mec<"auica 111 staz i ont.l er etta, poiclu! si dovrehbe !luppo r l't' chr i r eni o i IOI'O va si uno sp0stameu to, il clio è invtwosimilo, anche perchi• i r eni mobiii non pro ducono d i sovente a l bu m inu t'IO . E:.:li opina quin•li che il lavoro mnscola t•e p r ovochi o favor·i s('a l'a l bum i11u r iA, 1na am rn elle sempre uroa in dividuale, consistente in uua maggior e peJ·ositu congenita del l'epitelio glo me1·ulare.
E!Zli disti n gue sani con filtro t•enale permeabile in m odo u!:'::;oluto 0 r elativo all'albu mina, e soggelli con filtro r euale totalmente
Il nostro autore e:<pone mdi il r isultato òelle sue s ui cadelti della di M onaco, c onfermanti il c araLLer·e intermillenle dell'albuminu r·•a.
RtVIST \ DI UiATOMU 1 ; 1-'lSlOL•)Cò iA SOR:UALJ::
I'A1'0LOiòiC A 375
1 1
in r Pi az i n ne a l lavo r o !!iOt'nalierc:.. e al riposo n o tturno, P In perfetla d ell a m& "!'t ma parte dei suggrtti sottopos ti ad e!'pedmenlo.
L'ecritozion e IIPI' VO!'O e il s urmeOA p-e i•llelletluale, p t·ndotli el'ami, ebbem sem p re i l l o r o espon ente n ell e urine sotto fot·ma di albumina.
Come r ousr' pt'Pd il<po nenli son o se!(nalaLP r a nem111, ' '' s ,·ilu ppo corpo re o l a J< tal ura PcceJ<s Ì\ amenle t>l c , ata, la d "LI"el tezza del si s t ema va sa l e 1 d tsturb t f unzion nli cardinc i P l a rl t"PO!?-i zio n e neuropa lics
L'autor e i nfine accenna all'im p!l rtanza della d im•ren zia l<:> fra albuminurlll e !?-l ati pa tologici con a lb um 111u ri a l'f't'cie pe1· g l' iudi vi dui che de bbono ron lt' ar t•e m atrimon io e al'l'i c urazioni sulla , ila , o a !'pirano ad Pntrar•· n elre!'e r c tto.
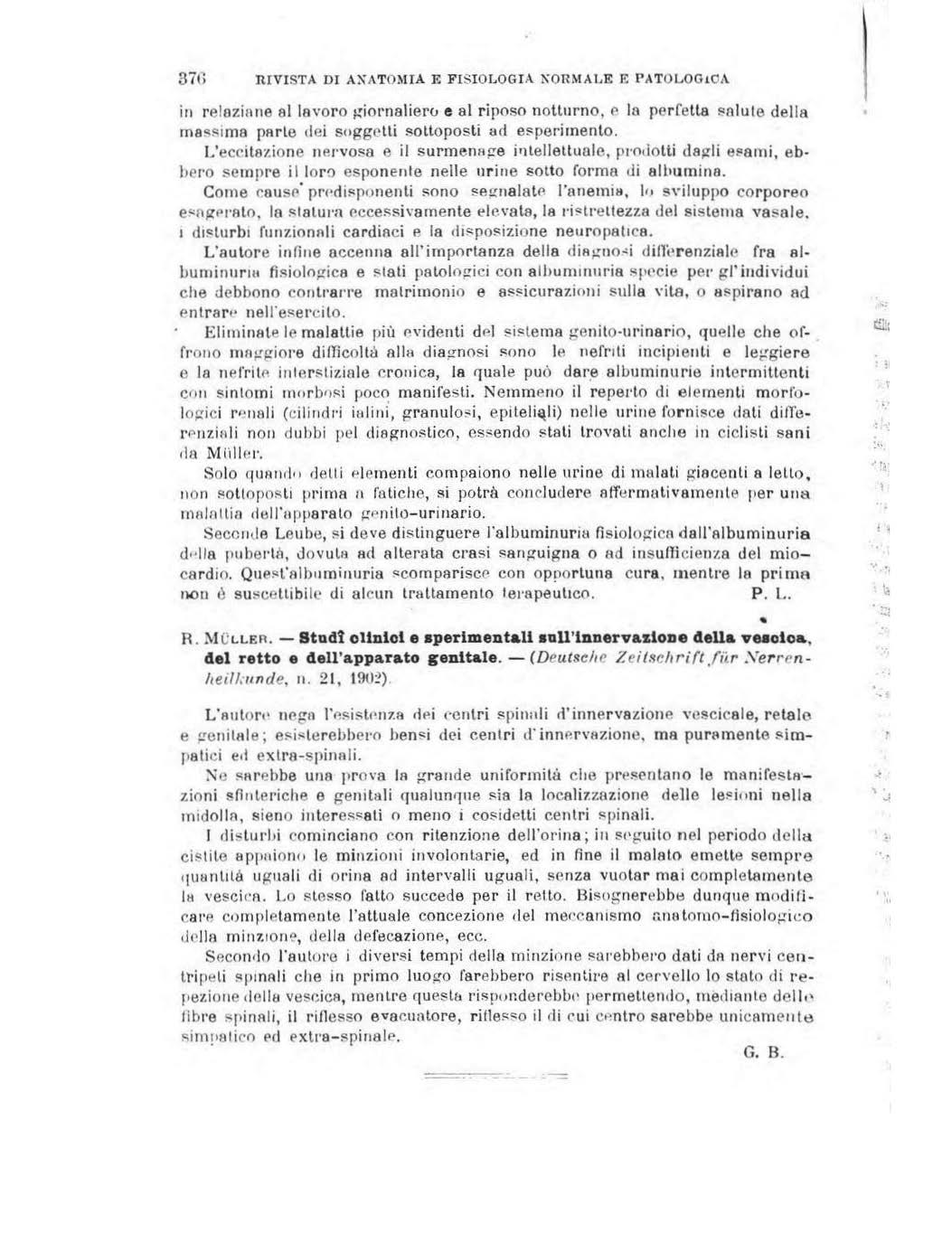
le malallie più Pvide nli dPI sistema ge nito -ut•inario, quell e che o ff r·ono d i ffi colta dia ):!nOsi l'o no l e n efrrti inc ipr enli e l ef[giere e la n Pfrit(> int er st izia lc rroni ca, la ryual e può dare albuminurie inlc rmilte nti cn n s into mi rn o r b•)si poco manifes ti N emmeno il r epet to dt el em entt m o rrol ogici rr•n ali (c il i 11dl'i i Hi i ni , nelle lll'ine forn isce dali diiTer l' nzi ll li no n d ubb i p el es"'endo stati tro vati an che i n c i cli J< ti sani rla Miilll'l'.
Sol o qunnd" delti Pl ern enti compa iono nelle m·ine di malati g ia centi a letto, n o n prima a fo lic hA, si potrà con cl udere atferrn tllivame nte per una m nl ntti a d ell'u pparato gt•nilo-urinario.
Secc nde L eube, si d e ve dis tingu ere l'albumi nuritt fi s i ol ogi co dall'albuminuria Ù••lla p ub et·là, J o vuta ad alterata cr·a si san g uigna o ad ins ufii c i enza d el mioc ard to. Que!>l'al b nminuria «com parisci' c on o p por tuna c ura . m entre la primA no u ò su sce tti bile di a l c un tra ttamento let apeultcn P 1..
R - Studt ollulol e aperlmeutall auU'llmervasloue della veaoloa , del retto e dell'apparato geDltale . - ( De utscltt> Zeil.,rhri(t .fii r S e r rr nhetll.ll n de n 21 , 191l:?)
L'Au t o r .• I'PsisLPn7.a tiPi t·enlri spina li rl ' inner valio n e v esci c al e, r ela l e e !!enitAi e; eJ<i, te r eb be t·o ben coi d ei cen t ri tl' innervazion e, ma puramente !.'-impalici ed ex tr a-spinA li .
;o\ 1' SAI'Pbbe una prova 111 unifo rmitit clte prt' s<>n l ano l e m tl nifes tazio ni sflnte t•i c he e gentlali qun l unrpte !.'-i a l a l ocali7.ZilZ ione dell e le!= i o ni nella rn tdoll n, sien o inter essati o m eno i costdelti ce ntri spinali.
l rli l'l turhi r o minciano ron rilenz i one d e ll'o r•ina ; in n el period o ùc lla cis t i t e a ppni 0 11o l e minzio n i i11vo lonta rie, ed in fìne il m a lato em ette sem pre qullnttla up:nali rli o rina ad intervalli up:uali, senza vu otar mai l tt L o !>.LC!'SO fallo s uccede per il r etto. Bis og ner t> bbe dunqu e m odi li. c ar·P c•>mpi Ptamente l'attuale concezione d el m e•·cant smo unolnmn - flsiolop c o di'Ila della dl'fecazion e, ecc.
Secondo l'aulo t·o i divet·s i tempi della m i nz i 0 ne !'U r·ebhei'O dati dn n erYi c enl ri pPLi c he in primo fa r ebbero ri sentit·e al ce cvc llo lo sloto d i r el'ez io ll P del l a vesci ca, rnenLt' e ques t& permeLl e ntlo, me,ltAtHO dc ii.• libt•e >'p in fll i , il t·iflesso evacuoto re , r itles"O i l rl i c ui c• ·ntro s are bb e c;rmpn t ico E'd PXt t a-spinalf'.
G. B
3iti niVISTA DI AXA TO MIA E FISIOLOG I A KORMAI.E E PATOLO G t C A
•
. ' . ' . J ..
RIVISTA DI MALATTIE VENEREE E-DELLA PELLE
1\I. J G. Nuovo oontrtbuto allo stndlo del baolllo della sUlllde. - (Deulsche Wo che n.sch ri{l, n. :i0-5t - :,2, 1902).
Gli autol'i pt·endono com e punto d ' appoilgio delle loro r icerche il fatto che uu indtviduo slfllilico che pr·esenti lulta l'npparenza di perfeltu :::alule, :::enza alt-un l'intorno c hP riv eli un'infezio ni! specifka in ullo, p 1J i'l irtl"eltar·e una donna sana
E ssi ricordano le numerose osservazioni nel'e quali vef.!g on s i dei sifilitici aver rapporti con donne sane durante armi interi, senza contagiarle, mentre sP una ò1 tali donne rim a n e incinta si constata o l'iniezion e del feto (eiA che accade piu spesso), oppure rfel feto e della mAdre.
Da tali fatti bisotznerebhe concluder e che é proprio nello sperma che il vi· r·u" sifìlitico dura piit lungame nte e col maximum d i virulenza e ch e là devesi ricerca r e il bacillo !IliO s pecifico.

A tal P. scopo g'li autori uslwono delle placeule fl'e sche, r igor osamente l'lerilizzale, nelle quali inocularono dell o spel'ma fl'e sco di sifllitici. l r i s ult31t furono costanti.
Dopo ventiquattr·o o meglio dopo quaranlollo ore, apparvero, placente ittocuiAlP, delle piccole colonie, poco visibili ad occhio nudo, simili a goccioline di che in Sdguito assnmevano una ti n la grigio scura. L"e!'arne microsr·opico diede a vedere dei busloncini grossi, gontli ad una delle estr e· rnilil, spesso traccia di degenerazione granu l osa, all i nP.ati come i ba><toni d'una staccionata. ·
Le lor'o dimensioni sono da 4 ad 8 1J. in lunghezza. da 0.2 a 0.3 IJ. i n spesso r e. La loro for ma ri cor'da quella. dei bacilli difterici, le lor o dimensioni quelle clel /Jacillus sr;btilit.
Si lasciano colorare facilrnénle, !<pecialmente dal v i oletto di genziana; si moi':lra r ono poo; i tivi al Ga·am.
:'\ o n si possono ottenere nella l oro tipi ca, coltivandoli in brodo od Non potendo;.i ottenere tali bacilli nelle piAcente tenute come testimoni e non inncui Ate, bisogna ammettere che sia no dati dagli spermatozoi.
T n li bacilli possono essere ulteriormente colli vali in siea·o umano, degener a n cio però alla terZfl. generazaone, e ri d ivenlando virulen li se nuovamente inoc ulati su placente.
G l i autori pa·ati car·ono tali esper imenti in trentanove casi di sifilide in pieuo periodo infettivo. I n tutti quf>sti malati venne esaminato lo sperma e messo in evidPnza il bacillo car alter·istico. ·
Come controllo esaminarono i n egual maniera lo sperma di quindici vecchi !-' tfllitic i ad infezi0ne quas i es tinta, ed in Lutti l'esame dello sperma , mediante placenta re , diede risultAti CO!'tanlemente negAtivi.
377
Ptocede•Jdo nelle loro ricerche tentarono di comunicare l'infezione sifilitica al porco. Per.!iò fecer o r ipet ute inoculazioni su tali animali, di ;>rodotti di ulceri infettanti , ed in capo di un t er·mine medio di trrnta giorni, vider<' a p pari r e un'esantema ri copr ente gli or$tani genitali ed una parte delle m embra postel'iori. Erano ma cchi e talvolta i sol ate, tal'al tra confluenti, ro sse ed a superficie er·osiva, d ella dimensione di una lenticchia. Macc hie ro sse e brune erano pur visibili sull 'addo me e sul t ora ce.
Da ultimo gl i autor i fnn11o r·ilevare com e i bacilli ottenuti in tal modo, dall'inocu l azJ one di sperma fre ;oco di sifìlitici in pl acente, fossero perf etta mente uguali a quelli ottenuti in pari modo, ma innestando delle sezi<'ni o dei frammenti di ga ngli linfatici sifilitici.
G. B.
G. - Dell'u1o del formolo nella cura dell'tperldrosl plantare . - (.1 r chioes de M edeeine et de Pharmacie milit., n. 1, 190:3)
L'applicazione della fo1·malina alla cura dell'iperidrosi piantare è razionale; essa rip osa sulla pr·opri eta di questo wrpo di for·mare con le mater ie or·ganiche (a l buminoidi, cher·alinose) un compo !:- to insolub ile, imputrescibile che col dissecc amento diventa corneo.
Pertanto il formolo posto a ronlalto con l'epider•mide pi antare l 'indurisce, l e fa subire quasi una tanniz zazio ne ; penetnmdo negli orifici delle s;laodol e sudorifere, ap-isce s ulle stesse e so ppr·ime la l o r o funzione fino a lla ri coslituzione degl i elementi mod i ficati o dislJ'Ulli. I noltr e i l fomwlo è un deodoran t i! energ i co eù un polente anliset tico.
P ertanto la.>ua applicazione a lla s n perficic piantare potr·A avere dep l i effetti multipli: deodorare il sudore quando questo è f etido, indurire l 'epidermi d e evitandole gli iuconvenienti della macel"llzione diminu ire o sopprimere p er un tempo va1·iabile la secr·ezione sudorale mod1ficando l'epitel io glaudula r e, da ultimo faci lihtre g uarigione eli'col'iazioui med iante la sua azione topica ed anti se ttica

Però la sua azio ne ri on i- permane11te, ma S(, l tan t o temp o ran ea , dura cioè finché l'epi t el i o dell e ghia nda ie s udo ri fare s ·é ricos trutlo allo sta lo n ormal e P er·ché durino g li em·tti della cu ra , r icor r er·e a nuoYe applicazio ni.
Con la solu z ione pura del co mm er·cio (al 40 p . 100) , bastano r1uatt.r·o impacchi al mattino, 1:1 ltlezzogiorno, alla sera, e l"in do mani mallina per sopprimere l'juaJg, asi sec t·ezione sud o ral e durante tre settiman e Co n soluzioni meno concenta·atc s i otti e ne lo efl"etto, ma pr•oporzi o nalmente biSO!{na p r olunp:are la cura. Si avrà cura di :ao n applicar·e la sol uzion e concentrala n egli spaz ii i nle r·digitali, n è alla fuccaa dorsale ddle dita, regioni do ve l a pelle é so ttile, deli eata e t1·o ppo sen ;;i uile.
In Ft'anc ia il rimed io in parola, e ssendo stato sperim entato in parecchi corpi di truppe a piedi, dind e favorevoli ss imi ri s ultati. Sembra abbia dato i mi g liol"i usato secondo i con s igl1 del magr:ioa·e m edico che l"ado pera fa· cendo p1•ati care, il p t•imo giomo, tr·e im pacch i (al mattino , al mezzogiomo ed alla sera) con soluzione di fo r mol o alla m eta, val e a dil·e al 20 p . 100; nel seco ndo giorno tr e a pplicazioni di ;;oluzi o ne pura, e nep:li otto gio rni consecutivi un sol u impacco co n la :::oluzion e pu ra I l hr ucio r e prov ora to talv olta d a tali applic11 zioni, sc.. mpar'e bP. n l oslo co n uu sempl i ce bagno d'acqua.
378 RIVISTA DI MALA'l'TlE VENEREE E DELLA PELLE
Pertanto il Comitato fran cese di sanità militare rac co manda, ai m edici del · l 'armala, l ' uso d i questo topi co, la cui applkazione é certamente inollen!'iva e sembr a costituire il palliativo di un'infermit.a pe l sold ato parlico· lermen{e penosa. G. B.

E. - G&DI'reDe prlmltlYe multlple della pelle. (Jott rn al de M érlecin e et cle Ch irurgie, ottobre 1902) .
La pelle può esser·e la H•d e di placche che si presen tano in condi7.ioni divc t•se: dopo certe dermatosi (zona, impetig ine ecc.), dopo l e febbri eruttive o nel co r so di certe diatesi, com e la siflhde o l'is terismo.
M 11 a fianco d! qut>stl CASt cunosciuti, di q ueste forme !'Ccondar ie, si rrsconlrano altre g angrene cu tan ee ch e compa iono spontanea m en t e o n elle quali la primtlivn, molto dillet·entemente apprez7.ata, è m o lto oscur·a.
Dei di qu e11 t o g enc1·e s i è occupato il Do Llo r E V eill on , lnsciando da parte le fo rrr. e seco ndari e e specialme nte quelle ch e possono r iferir•s i ris mo ocl essere comprese n elle g an g t·ene nervose
È di ffi c ile s tabi l irne l'e7.iOIOA"i a e su ventt non !.li put\ alc una cA uStl· plausibile a qu es t'otrezion e. Per ò, soventi il malato ha Rollc rl o anteriormento una l esione qualsias i, un a od una pun t ura il più comune m e nte. Tnl· volta anche lo stato ,:tenarale del malato era c attivo, ma m ol to il sng-· getto si trovav a m pe t·fc lla s alute. M o lLo probabilmente pe t'•'l deve essere considerala come una malattia infl:'lliva , propagotasi m ollo ver·istmìlmen l <:! per inoculazione.
ne sia, generalm ente nel l'inizio si os:set'Vh un'eruzione el'ilemalosa o papulol' a: poscia fJUe!' t i !li vc r si e lementi pnssoun presenta l'e una Pvnluzione val'iabile chtl s i può alle tre .fo rma se:zuenli: le Urll' h9cooo, lasciando al l o r o pos to una macchia m ollo per sis t e nte; ullt·e s i svol· ::ono come un ectima o r ttinario con gli !'tadi class ici d'mfiilr szione, ulcorazi on e cro3 ta e di cicalri7.7.azione per gmnulazioni senza perdrta di sostanza; altre infìnr si n ecr o lizzano n ella l o r o parte cen trale: si costitui sce una crosta n era rhe, ed Plt minan!l osi , la"cia un'ulceJ·az•onP, la qu ale, più tardi, avnì pe r una cica lrwe indelebil e, a tr ofica, supel'lici ale o p r o fo nda
Abboudc·nAlP a sè sl e"se, ques t e ulcerazioni, o gnn g r enot e, non ha nno alcuna Len tl euza ad OtTeslnrf'i. E;;:.::e si ecce ntrrcame nte pt·ecedute, alla pel'ifer ia, da un ce t·cine d i infiltrazion e r ossastra e li mitante d iott·o ad ess•> una zona d'ul ce razio ni put r·ed111ose o g t·onulanli mentrtl il centr·o é t•i cop er to da un c· eltivo t ess uto di cicatrice i nstabil e e tr oppo pigmentato. Cert e ul cera7.ioni, mal curale possono estendersi d i m ol lo, 111va· dere tutta la notic a, ò ltrepa,;!'are il sol co ed e!; l ende r si più o m eno ull'altr·a t::sse possono occupAre tutt e le r·egioni e n o tl so no c he quontlo s i lrovrwo ad un orifizio (o r ecc hio, ano) o in una r·egione t•spo!"la ai eo u rl'ica( ;>i cga g enito-crut·ale); in generale non danno né dolot·e. nè prut•ito . · La lesione. ora unica, o ra multiple, p uò inlet·essere anch e la mu cose bocc al e. Lo mala ttia si svolge per eruzioni, che s i susse:tuono in lleneral e rapido· meni(), sono d'tnlensité m o llo variabile e limi tate ta lvolta a qualche gemma un punto lim i tato del corpo, oppure iuvndenli di primo a cch ito un inter o arto s u periore , l ombnre, cosci a ecc. od anche o r dine Sl!i pu nti più l on tan i dell'epidermide
RIVI
STA DI lL\LATTI.E VENEIIEE E DELLA PELLE
I n sommn, rr>gnla rilà nel m odo di apparizione c he n essu na causa appr'euabi le poteva fa r prevedere Di gui!'a c lié d •l p(J (jualche t empo il m a lato pr·esenla all'occ hio lo spettacolo il più va r iato: lulte le les ioni descritte possono t r ova rsi neil() sle!';SO tempo sulla pell e, profonda e pur ul en la , vera gomuta, lino alla ci c atr·ice bianca e atr·oftca ne l centro, i n fìltra t a e ro>: sa alla per irer ia, v en11la d'azzurro e di r osa, stri ata dr lrste uler·ose, tal · v olla pirchetlata, di quà e di là, da uua nuova placca che si s vo l· g er·à nello stesso modo. Fa d'uopo c he una l'ebbr·e inten sa pr·eced e oJ Accompagna le e r uzi o ni elle durare e riprodurs i per l a durala di m esi .
Le curr> gerw r ali non hanno .Jato alcun risultato preciso . l mer curi ali, il judrJro polassico, l'arse ni co no n hanno agito per' nulla sull'evoluzioue normale dell'affezione.
LA cur·a v enne !im i tala a co mballcr e il sintomo: m edicazioni umid e d u rante il per·iodo di formazi o ne della crosta o dell'e"cara; ù is ta cc ala questa, l a valur·e -:on anti;;.etticlte od aslr'mgenli, e c anter'iUHzi o ni col c lorur·o di zinco o col niirato fiuo a che il f ondo :sia dt! ler so e ben granulante. N ei casi ordinar·ii, l'ulcerazioue si a rr·es ta, e si ottiene l a cicatrizzazione. B.
DENTILLAC - La splenomegalla nel dUferentl periodi della slflltde aoqutslta . - {./onr n al de M édec in e et Chiruryie, n o\·emhre 1902).
Da numero:;P O"servazione f'alte dal dottor Denlillac risulta c he la milz1.1 P ingross111 11 nella tPilggior· parte dei casi Ji sitìlide ac'(u i sita e mollo precoce mente. I n questa splenomegalia si nola il più. c o ntempOI·aneam f'n l e all'ulcera. Venne r·i scootrata in s ieme ad acc i denli p r•imal'ii che datavano da 6, 8 e 15 g iorni. La s ua ipertrofìo è i o med i & di 8 a 13 centimetri di lunghezza 5 a i nel t r a sve rsal e Il della splenomenognlia coin('ide co l perio1:n pdmario
Nel perinùo s eco uùar·io, l a milza è g r osl'o, quando vi sono les ioni cutanee, mu cMé, anemia s ifil rti ca , quan.fo il malato n o n c stato sollopvslo al t r attamento Ma nel coi'SO del pel'iodo seco n dmio, quando la sililide non si maniresta con nlcuna erut.ione, la mil7.a ri l or·na piccola. Questa spl enomegfll ta p•·rò 11 0 0 l ta un·evnl uzione ciclica: é in rapp o r·l o con f{ l i accidenti; piccola. quando questi man cu n0 , gro!"sa. quando ess i compai on o di nuovo. Più Lo rdi, Yari mesi o va r i anni dopo r infezi o ne , si puo riscont r are le splenome g-alia sifìlilica in tutli i periodi dt attività de l l a s ifi l ide. P a re clte es!'a si a sopralulto i nflu enzata d1:1 lle seguenti c ir·coslanze: inten s i La dei fen o m eni che manifeslano l' mtens ità Ji cer·te les i o ni pa r ticolari, essenza di trattamento m ercu rt Ai a.
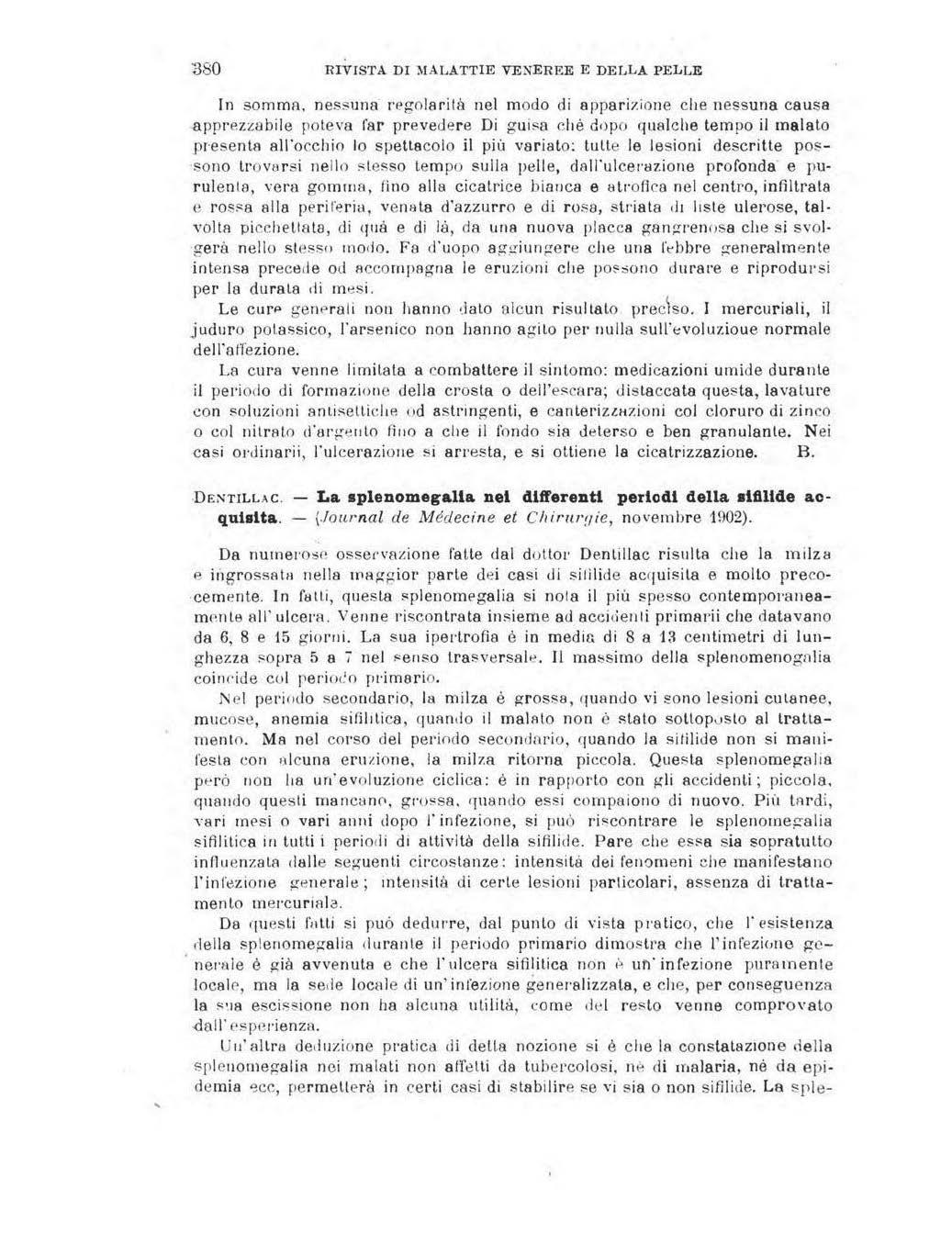
Do qu es ti fnlli si può d edu r r e, da l punto d i vi s ta pr·alico, c he r esisten za della dul'ante i l pCI'iodo primario che. l ' infezi< , no gcner·nle é p;ià avvenuta e che l ' ulcer a sifì l itica no n ul'l· infezione pur·arnente ! ocal <', ma la se.le l ocnle d i un'infezione gener ·alizzata, e ch e, per conseguenza la escisStro ne non ha alcuna utilitil , co m e dl'l r e!'\ tO v e nne comprovato <lal l' (•<:.po'r·ienza.
Uu 'a l tr·11 p ra lic11 d i della nozio ne si é clte la consta taz1on e nella spl c rrom egali11 nei malati non alfel ti da tu bc!'colos i, ne d i malaria, né da epi'3Cc, per m etterà in cer·ti casi di stabtlire se Yi s ia o n o n sifil ide. L a spie-
'380 RIVISTA DI E DELLA PELLE
nolllegal ia può oor.he se rvire alla si é infalli c he la milza era più gt·ossa ne i perio di alli, i della s ifil i de e c he al <:ontt·ario era più picco l11 nea period i latenti. F o r·sp l 'esa me della milza ne lle sifilidi latenti p• M ebbe far p rev t!d ere la dt acc ideutt in i mminenza di a pps· riziooe. In fi ne, J al punto J i vista t era peutaco , s i possono trar•·e le cunclus iona; che, l'ulcera s itllillca essend o la sede l ocale di un· a lfe.tione g enerale , é inuti le praticarne l' es ci s i o ne, non po tend o tjue ><la e" c i si o nt' a1·r es taa·e il di una malatti a g en eralizzaLa ; c he la gius t1fica l'ienamente la c ura s i filill ca intensa fin da lla compar sa d ell' u lce•·a, senza atte ndere la di acci denti sec ondari. B.
P. GALLOI S o Co t.: Rcou x. - Cara abortiva del forunooll oon UD& •ol ustone oouo, ntr&ta 41 locUo nell'ace tone.- ( G a ,;;eite d eo1 1/tip it a ll e, g c una ao 1003)
Tratta si di una , oa·iaote al trattam ento cl a ssi co abo rtivo d ei fo run co li, prati cato c o n la tiulura d 'iodio Gli auto r i , d i et•·o con siglio dt> l lo i'O primm•io IH'OChaotem sse, tJ'alla• ono numerosi fo r '-ln co li inc ipi enti con la soluzio ne l odo metal!o gramm1 quallro- A c etone grammi d icci.
Tale s oluzio ne PI'O"en ta tla r•·irna i coratl e ri li"ici tintura di 1odio, ma po:<cia at:quis ln un co l ot·e nero ed una c o ns sci•·o pposa F r esca sarebbe m e no ellk aee di 'l'•antlo é invecchiata , t• pPr da p1ù s i p•·eso nlf:'I'OIJhe anche più i r ritunte ; d o nde il di ado pet·a rla dopo 1;, o 20 ;.!I Orni di foiJbr ac ozion <>. S' bng nand o ne un batutro l o d 'ovatta e pol'tando l o a contatto dei b ollo nl infiammati c he cosi si c0pt·ono di una s pecie di ve•·uice nc -
ra•t,.a
Quand o 1l fo auotcol o non é a pe rto i l malato n o n ovve l'te dolodi !=Ort!l , tutl 'al pi (• n<•ta un senso di lie ve pizzicm·e. S e il fo run col o 1\ aperto, il bl'ucioro puù i m ·ecc ec;scre m ol lo vivo. Gen et·alme nle i fo run co li non ' UI>pu r ati sr o m paio no dopo :H OI'O dalla prima a p plicazione del rimed io. Cosi pur •· poll·a il ro run colo " co m pa rire ug ualmen te an c he •1uando al suo apico J'or malo un prin t ipio di s upp urazio ne.
Putunto , m e ntre l'io lo-ucdon e ha un'efficac ia m ollo p i i t potente della comune ti ntura d 'ioJi o, egl i e anc he più caus t i co e d e ve c;;se r co n prudt'n za.
Può p rov ocnre Ull volla una pii-co la fli c tena e d an c he unA l ieve esu lcerazione , m enll·c applica to sui bo tto ni c arnosi di un fo run col o uper lo, anconveni enti tutti lat·gamenle comp ensa ti dalla efTi cacin d el n meJi o G B

Uretrlte a c u ta d & sapone. •lmulante la · bleuorragla - llllezzl per dtagno · stloarla - (Semoin e .\ll;,{i c ale, n. :32 e {(3 d el 1902) .
Fra i s oldati della di Kars (Russia) infì eri t empo l'a una epidemia tli u•·utriti acute, riproducenti la s intomatol o gia della anft!zione bleuot·r a, t i pica. Il glande era fortemente iniettato e dul mento ' uretrale, arrossato e lumefallo, ruoru .;;civa, con la legge•·a pressione, pu s abbondante e spesso L'e;ame microscopico e1·a completament e negativo non solo t•i s pello ai gono· cocc hi, ma ancoa a a g li aiLJ'i elt:m enli figurali.
Il Sot·o tchinsky pet·ciò sospettò si trattasse di pro vocata con tneui chimici, ed infalLi riu sc ì a s tabilire che i soldati , intro lucendosi nel ca-
lUVJSTA DI llALATTIE VE:-/EREE E DELLA PELLE 38 1
·
.. i •
na ie uretra le de lle candel eU e di sapone della lunghe zza di centimetri, riusc ivano a pro voca r e la cotnparsa, dopo circa due o re, dei si nto mi carallerìslici della b leno rr•agia. Per assicura r e m agg iormente la rapida ecl impone nte manifes taz iO ne m o rb osa essi si astenevano nt>lle prim e o r e da!l'urinare. Siccome i fe nomeni infiammatori hanno una durala di soli due o tre giorn i, basta ri pe tere la manov ra a tempo oppo r·Luno per p r o l ungare a v o!onta la ma lattia.
L'esame m icro scopico n o n può che escl uùer e il sospetto d"infezione specifica, esso no n val e pe t•ò a de te rminare la natura dell 'agente fl ogogeno. Un a!ti·o medico m ilitare ru sso. il P o tapov, propose di utilizzare a q u es to scopo allr i m ezzi più alla mano ed e fficaci Raccogliendo s u una bacchetta cilindrica di vetro il sec!'elo uretra !e egl i notò che mentr·e il vero pus ha un a spetto giallo o bianco - g iallastro, sotto qualun•tu e luce, quello dalo dall'azione del s apone si pr·ese nla bianco-bluastro quando si osserva la ba cc hetta per r ifL'a:zrone e bianco-opales cente esa mi nato a luce rin essa. Stccome per·ò questo espe d iente non dà se m pr e urr r isu l tato netto, il P o tapov, nei casi dubbi , alla sect·ezione sospe tta qualche g-occia d i una sol uzione di bicarbonato di soda al1'1 p. iOO, ottenendo cosi dell'acqu a sapnna ta nei casi di ure trite da sa pone.
E gli co ns i)!lia di smascherat·e il s i mulator·e pro ducendo con qu e l liqui do, in sua pre!'e nz a, d e lle bolle sot'liandovi dentr o con una pagliuzza.
11 sapo ne i> an c he usato popolarmente cont ro la blenot't'aj:l'ifl c r o nica, n o n sem pr e perciò si deve ri conoscere nel suo uo;;o un m ezzo di s imula re la bleno rt·ag ia acu ta Gar.
F ounNtER - Cellultte gommou. pelviO& 1Ullitio&. - (Journal de M édecine et r/e Chiru r gie, nov"e mbre 1902).
Il pt'ofessore F ou rni er h a r ifel'i to a ll 'Accademia di medicina di P arigi sopra un cnso di tum o re si fìltti t:a del picco lo bacino presen tante la pa t'ti colal'ità di esse re com parso in un s ogge llo e r·edo-sifilitlco de l!" età di :H anni e c he n o n aveva fino a qu e ll'epoca presentato alcuna ch e potesse attribu i r e a lla sifilide S i tratLava di un uomo r'allido, cacheltico, afl"elto da un tum ore che pn reva la ves ctca • ' d il retto e che vari c hit•ut·gi l'a vevano c o nw s ide r a to co m e di na t ura s a1·comut osa. No n as tante le ri cerche e le iuves ti gazi on i fatte antecedenti, Fournier- nnlla ave va trovato di s ifilitico, trann e un a pa rtico lariia sospetta, e, cioé, una polile talità consid er evole c h e s i era manifes tata con la morte d i 12 fanciul li sop ra 15 frat e lli o s orelle del malato. P oco dopo, il fratel lo pr·imogenito d e l ma la to venuto a di dett e ricerch e , rife r i c hP il loro padre e ra s tato s ifililico. An che egli n on presentava alcuna sli mm ala, ma, m en tr e !' esll me o f talmoscop ico degli occh i per il malato n o n fece ril eva r e che alcune alteraz io ni r·udime nlllli , le q uali po tevano far sospettare un e r edo- s ifili ti co, per· il al cont:·ari o le stinnua t e di s ifilide congen ita e L'a no ce rt e . Fu pe rci ò is tituita s u hi lo la cura antisifl li t ic a (4 g r a mmi di iod ur o e 2 ce nti g rammi d i benzoato di m e rcurio in ini e zioni quo ti d iane) Oopo otto g ior ni s i notò u n eviuenle miglioramento ed in capo a d u e me.;;i la gua ri :;rione e ra com!Jlela.
Dal caso so vraesposto de riv ano vari i insegnamenti. In p rim o luogo la forma singola r e dell e infiltrazion i pelviche c he non sono sta le a n cora segnalate nella In seg u ito la d il az ione molto lat·diYa di 11uesta s ifilide ereditaria cile

ni'VIST A DI MAL ATTIE VENEREE E DELLA P I!:LLE
riman e 34 a nni senza co n alc un s into m o; come p ure l'a sse nza <.l i s timmata, dent e di cherati te ecc
A ggiungasi il fallo de lla polimo rlalità infantile c h e a v eva infì erit o s ulla fa mig lia del malato; qu es t o dat0 é dell a più g r ande impor t a nza per l a d iagnosi.
Infine il dei se g ni o ftalmo sc o pic i che po sson o Lsis ter e se nza m anifesta r s i c o n qualsiasi dis turbo app r•ez zabile d ella vi s l.s. E n el ca so in discor so (· da no tarsi ch e ques ti eran o manifes ti n el fra t ello no n mala to, fatto -<Ju esto di grande impo rtanza: in ca so dubb io, farà d' uo po esa minar·e· sempre i coll aterali e so venti s i tro v era nno in egsi delle s ti m mate c he per m etteranno di di ag nostr care la s i filide in un fra t el l o od in un a sorella p iù g i o van 1 B.
RIVISTA DI rrERAPEUTlCA

\ \ ' B uc nw AL n. - Dell'agurlna . - (Schles i sch e lle r lJe- Cor res;,o n tle nz, num er o 9, 1002) .
L ' ag urina è un sale di l eo bro mina, c he p r esen tas i sot to forma di pol re r·e bia nca , fa cilmente solub1 l e n ell'acqu a, di sa po r e amar·ogn olo sal so, d i r ea zi o n e a l ca l in a, contenen t e c irca il GO •1. di t eobromina.
A vr ebbe azio ne agli a l tri sa li rli t eo bro mina, q uind i d iuretica, ma m olto più del salici lato d1 sodio e teo brl) mina e d ella d iure tina. Co'! i l" A r isco ntrò, sommin istr a ndo una dose g iornal iera di 1,5 g rammi di agurina , un·11u me nlo d"or 1118 da 1500 o 4000 particolarme nte u ti l e ne lla c ur·a degli ede mi da mnla llie di c uo re o nei \' er sam enti covitarii M eno e rfl cace si dimos trò n elle nefrili n e lle cr ua li, c0me (• ben n o l o, ha im !>or l anza g ran d issima l a t o ller·anza, pei diureti ci , dei l" i ngo h m a lati.
L"A l a so mmi nistr o uni ta all'a cq• •a rl i m enta , per m ascherare alquanto il !'a pore o msrog nol o r i m edi o : . .
.\ c•1ua oli m enta dandone o g ni o r·a un c ucc hia i o da t.av o la.
g rammi ,2.;l g r·n mmi 400 500
Co n l8 l e f'M rnu l a s'ebber o semp r e o ttimi r isul t ati senza che si v er ificasse· alcu no degli in co nvenienti c he soglio no p r esentare g li altl'i diuretici.
G. B.
Rocr;:w c;LL - L 'elettricità nelle malattie renali . - ( The l\'ew - 1"or k m edical J ou r11 al , n . 3 , 1902)
Contrariamente all "o p inio oe gene r a le, l ' A. c rede la cura elelll'ica possa dare buoni ri s ullati anc he n el trattam ento delle malattie r enali , purc h è s ia d i lunga -dura ta, per s i s tente, gio rnali era
RIV I !:)'I'A 01 TEHA.t'E UT l OA 383
Si sa che t r a la semplice ipecem 1a r ena le e le Je;.ion i a na tomi che ca r atter·istiche del mol'bo di Bri gh l non v'h a limite ben definito; se '1Uindi notasi nel Ll'attalllen to d1 queste malattie u n miglio r amento pe•·m anente, debbonsi ammeUcr<' semplici condizioni d'ipcr t!mia r enale. alLiva o pass1va, non po t endoi<t tanto facilrnPnt1· curar·e ed arrestare le fo rm e di nefri t i g ra v i con le le!<IOni dri lt'-<suti e con l a de!..("enet·a zione ra r atlerislicu.
M tl le ro r 1ue in d•sco •·so non si cu•·auo Jlf) con l'elellricita ne con qu&l!<ia;.i altro rn Ptntlo, •nen lre è poss1bi le di arresta r e il p r ocesso Ougi!'lh.:o
A cc)ll!.!'C><lii:ÌO col diminuire la pression e samruigna e col facili tar e l a IHiilà del r ene, r euden lo per vii i t ubuli renal i Solo CO"' s· impediscono l e graYi complicazioni, !-:Uill'endo quei ca;.i nei quali non si sono ancora ve r iflcale lc!'ioni inamo\·ibdi.
EbbP-ne lu elt"llric•ui ad ele\'ula t ensione fuvorisro appun t o le condizioni r i •·colalorìe t> la funzionab•lltà e;;c•·eto•·ia ciel l'ome, r egola ti m etaboli"mo o r g anico, l'ipl'istlllanclo lo condizioni nor mali; e quale i mp:>rtanza abbi a questo fAlLo 8i faci l mente, se per poco si r1 0etla cile oggi l 1:1 causa p i ù delle mAittllie •·enali va r icerca ta nell'unpe •·fell(l od incompll'lo m eLabu)l,.:mo, ri sultante da u nA n u to-in tossicuzion e I n fa lli i p t·odotLi, parzial mente t rasfo l'mo ti pel deficie n te m etabolismo , a n zìchè attra ver sa r e I'C?pl t el i o r enale IH' I' O!<!<CH"e no r malmen t e c•sc •·eti per i tub uli r c,na l i, s i so ffet•ma no oòdi venendo una sor gen t e diretta d' irritaz.ione, causa d ' ins u fficienza r e naie e per nno di gra ve lt•!'ione oq!anica .
I l metodi.sm o dll segni ••si ne:dlu cu ra eletlr'inJ i n di!'corso, secondo l'A., s-a· rehbe il Co r renti .farru/if'/te acl alla - Un elettrodo rope •·to da ><pug-na o ei a cotone •d•·ofllo va applicato e compr·esso for t emente sulla •·egrone renate. Lll dur ala della ,.:pdulll cl1•\'·es"er e dapprimu di IO minuti e poscia aumentala gTadatam eute lino " minuti, secondo la t oller·anza indi\•iduale. L a
111Lensitil d<'lla ro rr ente va s<'condo la sen sibilità del e spiata •JlltiSI Ono alht d1 dolore. ricorc.lundo che le corr enti di media mt ensihi hanno poco valore. Siccome lu cute presenta lu piu u na volla eh..- sia pt> net r ala dalla co•-renle, questa si d•floode racil111ent e e pii• rorle sarù la ten,.ione iniziale: più ,:tr ande ne "arà la diffusione e piu potente l'a7.JOIIe lontana rl ella :'uf!erfìcie cutanea.

Co r rente stociea. - V a umtame11Le od alte•·nativamo11le alla corr ente faraJiCll od alta te>n,.•one, sulla quale pre;.f'nta il vanlallgJO rli poter e:;:::er e a s;rr·ande f r equenza e lt'n;::ione, mc•nlre é minimo il dolore e mìnor·r sono i dist urbi motori. Pe r le !'tUO vibrazioni infl u isce !<Ul l a cil·colazione e sulla combu stione; i nfatti la !'9.nguigna !'i abha!<sa al m omen to dell'appli caztone dell 1:1 corrente pfl r poi elevar·si, donde a u men to dc> ll a c iJTOlo7.io ne re nal e con vonla !.qz i o non i nJifl'l! r ente n ei cnsi dt pa ssiva. Nella i1ie •·e m iu r enale la cor r en te sta l ica conco r re a far di m inu it•e l o s.tall> ipe1·emico e l'aliJumi n u r ia, r i a t ti va u do la ci r col azione. l ùiu •·etici adoper ali conlempo t·aneumente r iescon o di gr•a n je giovamen to pt>r chè, m entr e a um entano l a sanl!uigna, accr·escono pure la quantità di ac•tll8, t'IJC si emette Il m eta b olismo ol'gonico d ' o r d ma r io le vicend•• dello ci r colazione; i n fatti migl i ora non a ppena m igliora no l e r.oru.l izi oni ci•·culalori e del re ne.
C. Q .
31:34 R IVISTA D1 T ERAl'EUTWA
RIVISTADI TECNICA ESERVIZIO MEDICO MILI TARE
- D e lla ra ohi-cooatntzz aztone n e lla ohtruTgla dl gue rra .(Le Caducee, u. 5, 1902) .
Studiando la rachi-cocai nizzazione solto il punto di Yis la della chil'u r g i11 di guerra, l'A., che e un medico militare e c he ha s tudiato nella clinica del prof. Ma yd l (Praga) l' uso delle inie zio ni inLrarachide e di cocuina e spe cialmente di cloridato di eucaina, si propone i seg uenti quesiti: a) quali n e so n o i vanla!!'gi nella chirurg ia di guerra' li) s i può adoperare la rachi - cocain izzazion e nelh1· formazioni s anitarie del campo di battaglia?
I vantaggi di questo metodo sono multi pli. E per vero con esso s i ha:
l. La sopp r essione d egli allarmi durante, s ia dop o l'an es tes ia c lol'Ofor mi ca, allarmi , c he ri chiedono pe r un lungo periodo di lc mpo la pr es enza· de l chirurgo o d'uno dei suoi assistenti, e pur troppo il tempo é limitato in. chirui'g ia di guerra. ·
2. Me ntre la clorofOI'mizzazione ha numerose conL!'oinùicazioni, il meto dodi Corning-Bier non ne presenta che una capitale: l'età avanzata del soggetto. Or be ne. non é il caso di mellerla innanzi per l'elemenlo militare, costituito il} massima di g iovani. Tra le dell'anestesia clorofo r mi ca merita n o so prattutto d i esse r e ric o rdate le affezioni degli org ani del respiro, tantofr er,uenti durante una campa gna; fJU es ta con troindi cazio n e n on esis te pe!' la rachi - c ocainizzazione, e ssendo s tata usa ta a nche negl'ind ividui con polmonite (ledlicka). Le medes ime osse1•vazioni vanno fall e per la ete ri zzazione, alta qua le bisogna pure a ggiung ere i pe ri coli de lla luce a i•tifìc ial e, so ve nti Jlecessaria nelle fo r mazio ni sanitarie de l campo d i battaglia.
3. La r achi- cocainizzazion e, secondo l'A., può a dope t•at·s i, o ltre che neg-l'individui co lpiti da affez ioni d egli o r gani respiratori , nei fe rili aven ti altr e infermita (p e rito niti, disturbi card iaci ecc .).
4 . No n è necessaria la prese nza di uno s peciale a!'siste nte; e l'ope ra to re n o n é distraUo da alcun allar me durante lutto il te mpo dell' alto o pe1·at ivo.
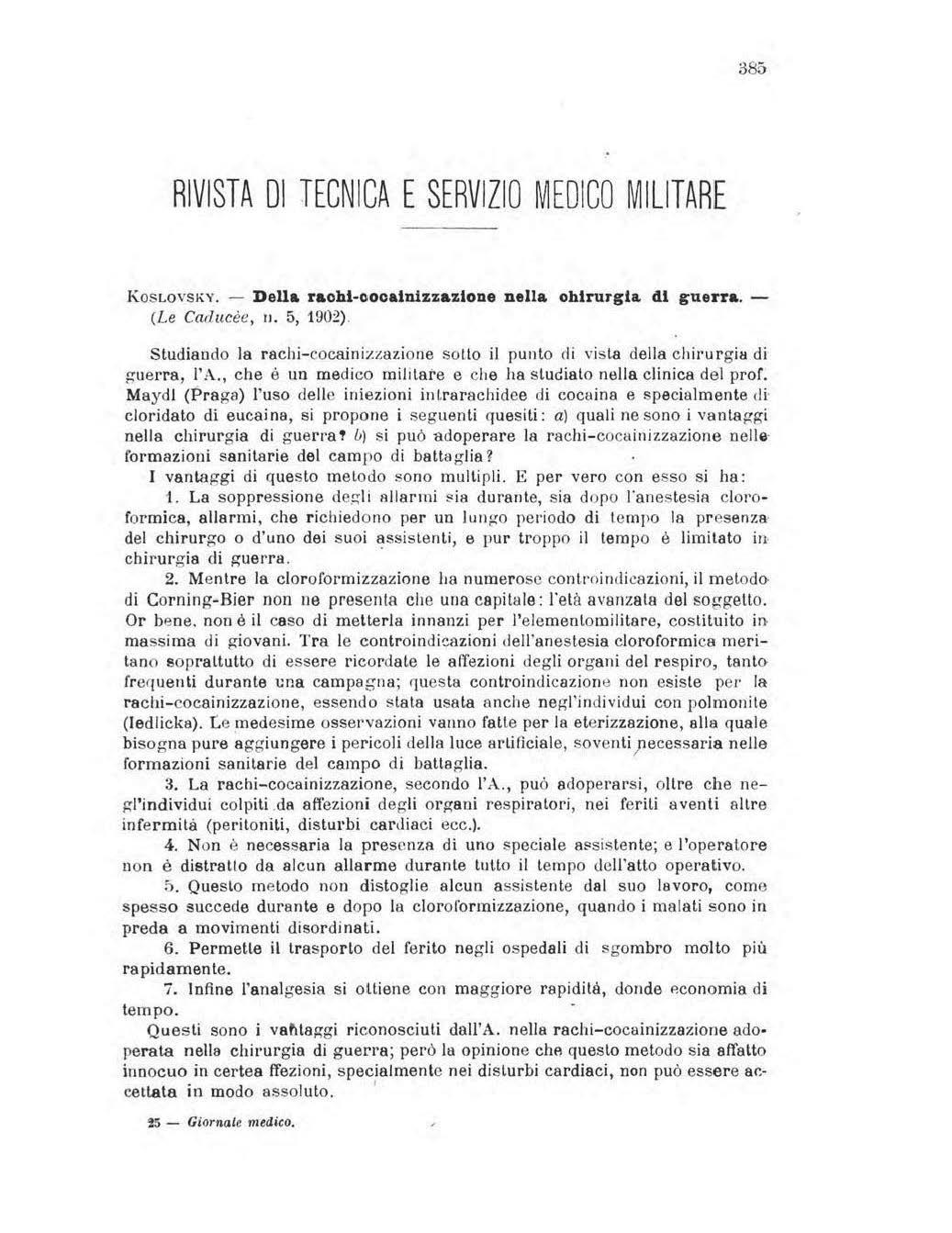
!J. Ques to me todo n on disto g lie alcun a ssis tente dat suo lavoro, como spesso succede durante e do po la cloro l'ormizzaz ione, quan do i ma lati sono in preda a movimenti disordinaLi.
6. Permelle il tr a spo r to del ferito ne g li os pedali di sgo mbro molto piu rapidamente.
i. Infine l'analgesia s i ollien e con ma gg iore rapidita, don de P-conomia d i tempo
Questi sono i vafltaggi ri conosci uti dall'A. nella rachi-cocain izzazione ado· perala nella chii·urgia di guer1·a; pet•ò la opinione chA questo m e todo s ia affatto innocuo in cer tea ffezi o ni , specialmen te nei di s turbi cardiaci, non può essere acce ttata in modo a sso luto. '
!5 - Giornale m edico.
385
Ci r·ca poi il !';<'condo egli dichiul'n c he il rn t>lorlo in di'<cor·s,) n on pre· i'enlA a l c unn dilli col tù 1wr· e"sere Altunto n el le sanitari e d el campo di ballaglra Co n t'":i'O inl'nlli s i o lli enf':
1. Semplicità del l'i i'lrum en tar·i o . rn odirihi dlll p r ezzo di costo dell'eucaina a pa r·ai!'one di'i clo r·ofol'rnio.
2 Fac i l ita di prepa rar e la soluzi o nd a nche stabilimenti d i pr·ima l i · nra. Pe r· s t er·rlrzza r·e I n soluzion e bai' l.a ri scal da r la una p l'ima volla per mezz'o ra n 70°. aspettare poscia un fJua r lo d'ora e risca lda rla nuovamen t e; la esperienza dimos tralo che no n è rw cessaria una t erza operazione Che se la soluzrone fu sterilizzata in pr(\cedenza, ba,;la rr scalda rla solo una volla per m ezz'Ma, o nde s i nl>h ia ogni !'.i c u r ezza. D el r esto ,·a ri cor dato c he all'oppostn de ll a cocaina, i> un antisetti co, e c he 80110 r·m i ssi m f! le infezio n i in seguito a l "UO uso, co me ha dimosLrato al Con g r esso di J\l osca ( Il)()()) Uyje1 ' o witsch , i l f[Ua le no n aveva a vu to in 78 casi alcun fen o m eno d'iofe1.io ne, noelle nel l a parte di qu es ti l a soluzione non fo sse stata sterilizzata.
3 . Quand'an che, per òil'e llo di t ec nica o qualsiasi altra causa, non si f osse o ttenuta l'ana lgesia col metodo in discor so. il tern po im pi egalo pet· la i nrezio n e nella th:ll'·•ucaina no n sar eb be pe r du to, avendo la espe t·ien za d1moslra lo che a ll ora il so nt lù anes te sico p uò oU\lners i appena con qualche iualazione di clo r·ol'r)r·rnio ( Demm le r)
4. La pratica di r1u e,., to tMlodo :;i appn111J e fa c ilrnente, bastando una mezz'ora pt> r abitua r vt s i.
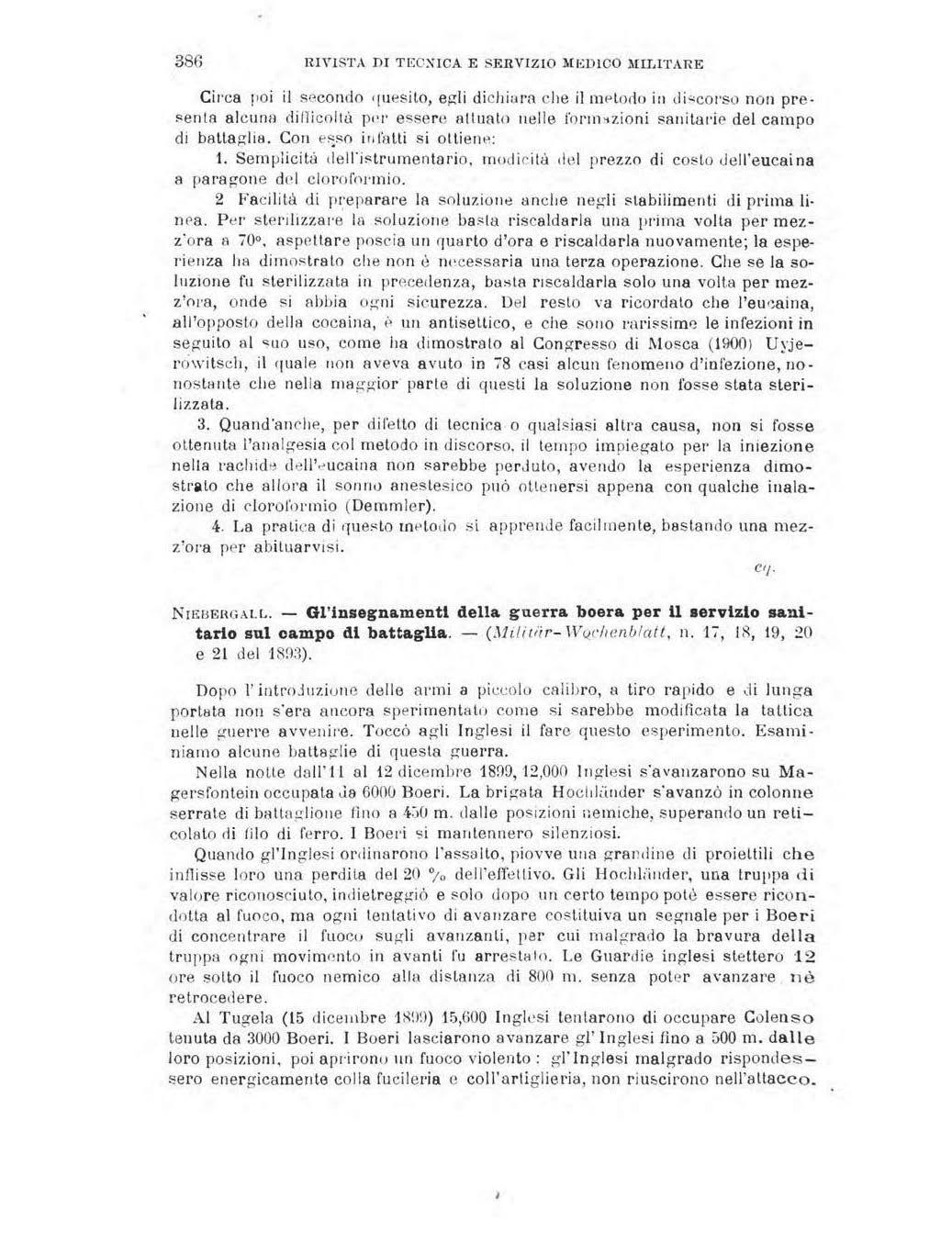
NnWEHGAlL. - Gl'insegna.me ntl della. gue rra boera per U 1ervlzto S&Dltarlo sul campo dl bat tagUa . - (.\1 Liitii r- IVu.c/lenb l atl, n. l'i, l i\, 19, 20 e 2 1 de l JS!l:1).
Dopo l' i ntro.lu7.ì u ne delle ar·rni a pit.:t.:Olu calibr o, a liro ra pido e ,li lun g a por tata non s'era ancora spe t•imen lalo rome s i sa r ebbe m odrfìcata l a l alli ca nelle g-ue1'1'e a vv en it·e. T occò Ingles i il faro questo cspe t•imen l o . Esami· n iamo al cun e bat t agl i e di (]uesta g uer·ra.
Nella n olle do li' I l a l t 2 d i cembce 18!)!:!, 12,000 I rr:rlesi s·a\'anzarooo su Magersfontei n occupata Ja 60()(J B oe ri. La b ri gata H ocldiinJer s'avanzò in col o nne serrate di batlllglion c lì no a 4:Jù m. dal le postzioni nemrche, s u peran do un reticolalo di fi lo di fen o l Boel'i o;i manlenrrer o si l enz ios i.
Quando g l' In glesi o r dina r ono l'a ssa lto, piovve un a g r ar'dine d i p r oiettili c h e inl1 isse l o ro una per d ita de l 2\l ";o dell'effett ivo. Gli 1-locilbnder·, una truppa di va lor e r iconosciuto, indieLregf!ÌÒ e sol o dnpo un ce rto t empo pot è e ssere ri co ndotta al fuo co , ma ogni t en tativo di a vanzare co;; t,luiva un segnale per i Boeri d i concen trAre il fuoc" s ug li avanzanti , pa1· cui malf!rad o l a bravura della t r uppa ogni moviml)nto in avanti fu L e Guardie ingl es i stettero ·12 o re solto il fuo co nemico alla distanza ò i 800 m. senza poter a\'an zare né r etrocede r e
A l Tugela (15 dicen1b r e 1!>,600 l n g i L'si t en taro no di occu par e Col en so Leuut a da 3000 B oeri. l Boeri l asciaron o avanzare g l ' In g l esi fìuo a 500 m. da ll e l oro pos izioni. poi apr·ironu un fuo co v iol en t o: g l'In g lesi mal g rado ri spondessero e nerg icamente colla fu cileri a c co ll' a rli gl iet·ia, non r i u:;,ci !'ono nell'attacco.
38G RI V I STA nr TECXICA E S F.RVl ZIO
I
l(U,lTARE
]I(ED
CO
Qualche cosa di simile avve n ne a Spionkop dove gl' ln g le!:li erano 20,000 co ntro 4000 Roeri.
La f!: Uerra boe r a c' i nsegna adunrrue che colle armi morle r n e i movim enti d'attacc o so no diventati m olto più diffic ili : ci ò che in pace si compie in minuti i n guerr a può r ic hied er e delle o t e : so lo dopo ur1 fuoco continualo, ut iltz;t.ando le depr·ess i oni ed i t•ipa r i d el terr eno , facendo slm l zi e co lla s upet·iot ità del fu<)CO, si potr a ava nzare. Le perdite sat·ann o tanto maggi ori quan to più ,:, il t erren o, e rruanto più s i é pr ossimi al nem ico.
N e consegue d al punto di vista del servi;d o sa n ita rio, c he sa r ehbe assur do il pre tendere d' impieg at·e i l personale sa nita rio n ella linea dei cacciato r i ecce llo nelle pau se del fu oco I l fer 1to s8l'à abbando nato a si· du r ante la l otta e non avrà altr a r i sorsa c he il pa cchetto da medicazione. Il pe r so nale sa nitari o !'i fermera in pos iz10ne t•iparata il più vi c mo poss1bile trnppe : d'allra Ra •·te i fe riti di mnrciare già i stin tivamente questi r·i pari Tali ripari nei n o::; tri ter r eni C"Sistono tanto piu che una truppa non può assol utarw' nte in t err eno !'cope r to.
Dala la maggtor impo rta nza de lle cop e rtut' e n e \'Ì Cnl;l la n eces!'lita che l 'uffici ale m edico si fami gli arizzi co i p r oblemi t attici , poie he il comandante delle truppe in quf'sti momen t i di lotta avr·à luLt' altl·o pel C8po che d are ot•di n i pel posto d i m edica zion e pe r c ui il dirigen te il sNvizio sanitario sa rà lasciato alla pr opr ia iniziall \'8 e dov r a put· badare c he nella scel ta del pO!'to di medicazione si e v i t ino rrue i punti che possono es!'er e d'ostacol o al libe r o movime nto -delle truppe.
I l posto di m ed i cazione avrà nell e gue rr·e avvenire un còm p ito b en più g r a ve che i n passato, per chè la sezione sa nitit coll a portata dei nuovi fu c ili uon po trà v en ire in aiuto se- n on in determinaLe condizioni del tet'reno A Man Pmm en o un portaca rtucc1e potè gi un ger e s ul campo di batta gl i a . S'i m pone pe t·ciò un aumenl(• delle f o t·ze ausiha r ie al posto di medicazione, ciò rhe, sen za aumento d el p er sontt le sani t a ri o s i polr<:'bbe ottenere t'i corr end o a l pPrso nale della sezi on e. Que!' ta interveneiJbc solo q uando il com batlim e11to avesse pt·es.a una piega deci siva , tanto più che co ll'enorm e pu r tata del-: allunle e coll' estensi o ne di terren o c he occorr er ebbe a l s uo installa m en to, non potl'ebbe funzion are du r an t e l'a z iO ne. Con f) ttes to ripiego s i avrebbe a11c lt e il c he, la truppa a va n z<lndo, il pe t·so nal e sanitario aJdelto vi il pt•opr io repnr to, al la sezione il comp ito d i continua re la cu ra dei f t!t·ili e rli elfellua rne l o ,:gomber o.

l n tal i condizi oni e da domanda r s i se non snrebhe da el i minarsi la sezi one d i !'Hnilil, traspol'tando i feriti direttamente dal posto di m edi cazi one a l l' ospeda l e da cam po. Gr a nel 1870-i l nel m ag-gio t• numer·o di ba t t aglie g li ospedali da campo agi r ono su l co m po ste sso ri spar·miando ai pot• t a feriti ed ai feriti un penoso trasport o. Sor·ebbe p er ciò indicata l' assegnazione d egli ospeda li all e dh·isioni
D a ta r enorme ci fra dei colpili, i 24 carri p e r f eriti g r avi pr t· ogni corpo d' at·_ mata sa r anno in s uffi cien ti e l e requi >'izio ni non so r tirann o b uo n effello ch e Ìll poesi f'i cchi ed a cultnra F o t•;; e la so luzio ne del p rob lema si troverà nell'adoz i one di au tomob i l i pet· il servizio sanitario.
Ri sulta dall e e>'pe ri enze della g uerra sud -afri caoa ch e i pl'0ietlili a m antello d i picco lo cali br o an che pl'Ovenienli da piccole distanze, se colpi scon o solo le l'arti m olli, pro duco no ferite c he hanno te ndeuza a r apida e compl e ta guarì-
RIVISTA DI E SERVIZIO MEDICO MILITARE 387
S i può ammelle•·e c he i fdriti l o>gg ie ri costituiranno la metà dei ft- riti _ Il nemico avendo t ullo r interesse d i imposse8sar;;i d i qu es ti feriti che be ro tosto atti a il di1·ige nte il se rvizio s anilurio dovrà curare che questi s iano al più pr e s to riuniti in l uo g hi di riuni o ne e sulla zo na delle ta ppe
RIV!STA DI BATTERIOLOGIA

A. P ASINI. - Sulla presenza dl olglta nel bacUlo del Rlnoaolerom& ed. oaaervazlonl sul fen.omeno dl agglutiname nto dl tale baolllo. - (Renlliconti clell'Associa;io ne M edico - Chi r u r!Jica eli Parma, n. 4-1 902).
L ' Auto r e dimo!':l1'8 la p1•esenza di ciglia n el bacillo del Frisch ed i ra pidi p r oress i r eg1•e ssivi che subisce tal e mi cror ganis m o in coltura. Le ciglia, dimost rate col metodo D e- R ossi , non provengono da l bacillo endoca psulare, ma da lla capsula; hann o una lun g hez7.a che varia seco ndo l'età de lla coltura ; in is t1 is c ie su agar in v e nt iquattro 11re non oltrepass ano mai que lla del bacillo. I n cultura di tr e o quattro gio rni le ciglia sono allun g ale ed o ltre passano di uno, due, tre volte la lun g hezza del bacillo ; d1 più allo 1·no a ll a ca psul a !'. i rorma un'alon e m e no inte n sa mente colo rit o, da l quale tra f!gono o r ig ine le cig lia. I n colture mano ma no più v ecc hie i prolungamenti cigliari s i allungan o ancora di più e le caps ul e a ss umon o aspetto vescico lato; esse fo rmano un·alone debolmente colorito attorno a l bacillo diradante spec ia lmente in vicinanz a di qu es to.
l n colture da l f• a 20 giorni di eta, ol tr e all e delle fo rm e si osse rva no molle capsule cosi alte r ate, priv e d i bacilli e m ollissimi di questi u l tim1 affa ll o libe ri.
l n tras porti di co lture aventi da 15 a 20 gio rni di e tà si trovano bacilli provvisti di capsule e ci g lia; qu es te non s i t r ovano invece in traspo rti di col ture c he hanno ragg iunto od o ltrepassato il mese di eta.
Il J't>pe rLo ha impo rtanza specia lmente riguardo alla qu es ti o n e dei rapporti che passa no fra il b a c illo di F1·isch e q ue llo di Fri edldnde r, c onfe r e ndo a l primo un n uovo dalo m o rfolo gico che ben lo diffe r e nz ia dal secondo .
P r ove fatte sul potere a ggl u t inante d el sier o di s an g ue di rin osclero malos i J ' isp e tto al bacillo di F r isc h e di altri sieri n ormali e pa to logici i n varie di luizio ni s ull o stesso microrga nis m o , hanno co nd otto !"au tor e a co ncludere c he de lto potere esiste n e l siero di sangue di r in oscleromatosi , ma n on è ad esso ci fico.
G. B .
388 RIVISTA DI BATTERIOLOGIA
G. O .
RIVISTA D'IGIENE

A. - Contributo allo 1tudlo della eztologl& della rabbi& .- ( Bollet. della S oc medit:O·t:hir. tli Paoùt. - Comun i cazrone falla nella seduta del :!7 marzo 1903).
E" uolo quanto si s ieno aiTaticnti gli scien zia t i di ogni pao,;e pet· tr·ovare la soluzione del pt·oblema eziologico della rabb ra, e come non sieno sca rsi col o r o ch e pet• m ezzo d i osse rvazio ni, piu o meno disr: utibil i, hanno r•iten ulo lo patoge110 di r1uesta malattia qual e appar t,.llP.n te alla cl a11se dei protozoi.
Le recen ti ri cer c h e del d o tl. N egr i m edt.ano però l a piu alta considerazi o ne sia pet· l tl p r ecisione con c ui sono state co ndotte , !Sia per i risultati ve· ra mente impress ionanti, d elle ri cer che stesse. Et;"l i avrebb B osservato nel sisler na n erv oso d egli animali t•abbi osr la pr esenza co!< lante d i uno specia l e mict·Ol'ganis m u c he tull o induce a riteuerb si debba es t r iver·e f r a i p r o t ozoi.
l risul t at i piu chiar i si sono 11vuti pel can e, e specia l mente in quelli infettati sper imentalmente con iniezione soltoJurale di viru s di s trada capa ce di fa r socco111bere in circa 14·15 t:io t·ni. R icerche assai nume r o!<e furon o i s tituite pare sui e si ebbe campo anche di fa r e osser vAz i oni su cani i d r ofob i per morsrcatm·a d i altr o Anima le idrofo b o, cd in un caso a nc he su ll'uomo.
I l per m ettere i n e v idenza questi spec iali é m ro lto.se mplice, e ssi si vedono m ollo b ene a fre!< co !<pa ppolanclo un poco di so<: ta n za n erv osa in una sol uzion e debolissima d 'a cido acetico, e n elle sezi oni coi co muni m <>zzi di col or·azione. Il me"Zzo di coloraz ione per ò, e che dt lfe r en z ta 111 m odo cos lunlo iu qu es tione, è quello di 1\l ann al Lh•u di metilene ed eosi na.
Una delle !'ledi di predileziOne dell'ot·;<anismo è quasi cos tantemente i l cor·no d' A mmone, m A sr tr ova anche n el cervellello, n elle cellule ne t•vose della cor· t eccul ce t·ebt al.., neli.:J cell ule ne r vose dei nuclei d i'Ila e nel ponte, in del midollo ellungato.
l pa ra !'>=ili lro vansi >=ituali n el p r otoplusma dt'lle cellule nervose, speS!'IO IH'I (Jl'Oiungumenti, so no di s variata d im en sio ne lino ad avere un mossimo dtat ueii'O di 2:!·:!3 !J., hnnno form e va r ie r otoude. a pet·a, allun:;rate, e rac chi!!· clonu u e l loro p t•otopla sma dei corpicciuol i con contomi b en netti, in numero var·ia b1l e , ed o t•a di dim en sio ni t utte eg uali, o ra d i dime n!' ioni.
L'A. ehlJo l'occn sioue di esaminare il sif<le nw ner voso di quattr o cani r·a b· biP,..i vo!.{an ti. ed iu tre di ques ti trov ò i caratter isti ci microrgani s mi. L r inornl azi on i ne i di mostra r ono che per questi tre trallavt. si Appunto d • ra bbitl , non co::oi pel qua l'lo ; i n quest'ulti mo caso l e ri ce r·cl•c i st o l ogiclre fur on o
Ui f r onte a questi ri sul tati, 1' A. non esita a dichi arare come spec ifico della r·abbt a speciale par·assitu ch e pone nella cl asse dei protozo1; si a ugura per ò c h e al tri confermino i risultati delle sue ri cer·che pe r r isolve r e defìm li''amen le il pr oblema dell'eziologia della rabbia. t e
B8D
:VI RoSE N rn - Ketodo e atempoJ:aneo dl coltura 4l mlorob! ana eroblt. in menl llquldl .
Ai numerosi met o d i di co l t u t·a a nae r ob ii a ttuatmen t e in u so, l'A , p r opo ne d i so sti t u i r <! i l c he egli c h iama m e todo de i l u ui tap pati. Il tub o d i di br o do , o di f(U Ais i asi a l t l'o mezzo l iqui olo, vi en p1•i vato d'aria m edran t e un'ebu ll izi on c di al m eno t r enta m 1nuti, m entre ,c o ntem po r an eamen te v ien so tto po;; to ad u g ua l e p r•ocess 0 un pallone contenente de lla l anoli na .
Si vet·sa i n c ia sch ed una pt'OYella d ella lan o l ina, in m o do c he l a col o nna l i quida de l nw zz o nutr ilizio v en g a s u pe1•a 1a d a un c ent• e m ezzo di de lta sos ta nza. L e pr·o vette Co!'- i p r e pa ra te s i fu 11no bo l l ir e pe t· un q uarto d ' o r a , rac· endo le qu i nd i ralfr ed(l are i l più ra pidam en te po::.sibi l e Allora t utto sarà pr o 11 t o
P i ù spedilamen t e a noo ra potra ssi al!' g iunge r·e d ella l anolina f usa a lle p r ovett e conten enti i m ezzi n u tl'i l izii e po r·Je q uiò1 d i n c ll'anto c l ave a 120• d u r ante m ezz'ora
L e pr ovt!lle, cosi p r e par a te, sono im perm ea bil i ; per basterà f ondere s u d 1 un ):>ecco Bun sen i l tm·acci o l o di lano l ina . ch e fo nden dosi a 42o n o n al t era m en o m amenle i m ezzi nu triti v i. l t ubi cos ì p r epRI' a l i , p r esenter·ebber o il c hr ma 1.i pcJlandoli, s lanl e l a colonn a di l a no lina l rqu i da , perm ane n le m e>nte p r o l elti d el l'o da Quaado lutto è t ermin Ato , s i z·icolloca no le pro v ette i n un d'AciJ ua; l a lan o l i na s i n 1pp r•en le, ed i l tu bo vien pos to nel l o stufa sen za c h e nul la abbia pe r·so del suo valore T a l i pr ove tt e tAp pate s i posso no l'igcnerat·e d opo J ue m esi e p i ù sollopone ndo l tl ad una nuo va ebol l izi o'u e d i un quar to d ' o ra di d ura l a.
G l:J.
l. SCII \Y O:'>I EIL - Cara tteri dlffe ren zl a.ll fra l'a gglutlna.zlone d e l ba c ill odl f te rl oo e del ps eudo-dlfterlc o . - ( \ Vie ne r /, Un , Wor.!t e n s c!t r- tft , rr nYe mb r e J!Jù2).
L'a utor e trae dl:l ll e sue r icr!t'clie sull'n r go m en l o l e seg-uenti cn 11 cl usi oni :
1° t_; n !'Ìe r o ollenutn p C'r· i m1111111izzazi o ne con b aci ll i d i f lCI' I C i , ag{:!l uli na i n 8 llo g t'ad o i bt cill i d i!'Ler ic i
2·. Il sirro ap-g lu li no n t• lln RleS!"O g r ado dcl:: i e!'o di ca vallo rwrrn a l t>, i blld ll i pseu do -di fle r i c i rd ol t ri baci l li.
3" L 'aggluti nazi o ne c·ol s ier o d i !!l'Odo e levato pe r m e lle u na zio ne fra il v er o b Ac i llo ol i fle l'ico ed il pse ndo-dil'teri co.
4°. Il sier o o llennlo pP I' nn mu n iu.azio nr: con il pseudo- bn cil lo no n a !!f!lutino che que!'-la specie d i bacill i.

Il no n c du l o Ja u rùmi co ba ltcl'io .
G B
I< ocH - Sulla profila s s i de l tlfo a ddominale. - ( Fer iiltenl/ù:hl.tn(lett atcs flem (Jt'b des l l ert 2 1. B e rli n •l HJ(J:l}
I l p m f. K och con ,.. h r se m r r o l o d i :" lin g u e i n ogn i st11.lio J·elati vo all e p iù g- t·av i n ra l al 1 i e epi d•·mi c iH·, h fl v ol u t o tratt ar e an c hè. l a pl·ofil ll"'l i de l tiro fa ce 11don c ogget to d i u na Jo tt8 conr,, r·enza p1·es;:o I'A cca demitc impe r- ato r e r: "glit:lmo nel la seù 11ta de l 2S ri .. ve m h i'P- 1902. L 'aq:om eu to é l r·atlfltO spcrial m ente per· c1ò cil e r inctt e l a sa n i tà mili t are, ed è p c r crf • che-
3f)0 R TVlSTA D'lOIE.NE
stimiAmo uti le r ia!'sumere i pun ti prin ci pali e piu im portanti della co nferenza
L ' A comincia a dimostrare com e i l tifo addominale sia una delle p iU peri col ose epidemie belliche, e l"icorda che nel l A gue rra ft ·lmco-prus!?-iona l'e!<ercilo tedes co ebbe 73000 a mmalali di tifo con HOOO morti e ello recentemente !"esercito inglese nella guerra contro i boe t·i eb t>o dolle per di t e ril evanli<>sime. Non nega c htl per g li sfor z i con e•H·di ed tHliv i dello am ministrazioni mil i tari, il tifo sia andato mau mano decre!:'ccn do, ma ciii si rifl ette sp"cialmente alle mis ure pt't'!-'C nelle città, n1 c n tt·e n on è cosi in campagn a , duran te le m anovre e dun.utte l e guerl'e. La t•agione d i que!<lll fa tto la trova in ciò che me n t re n elle citta multo t} s tato fallo, e m oltu !<i sta facendo per provvedere buona acqua potabi l e e pPr Asportare l e materie feca li, nelle c am pagne invece nul111 si è fallo e vi sono d1ffìco ltà g ravissime in propoo;ilo ; nelle campaf!'li C anzi, ammesso put·n che si prcvvede r e del la buona acqua poll'!bile, 1111 pro b l ema quasi insol ubi l e quello della t•imo zi c,n e deiiG materie le qual i dP I re!< to sono tanto pi ll 111 conlRl t o dell' uomo, in qua ntochc sono utilrzzate come conc·i me e portate campi. po t ando i get·mi ti fo:-1 r ien trare ti t nuovo um<tno o con le \'e t•du re o !'im ili , o per inq:tinamen to dei cot·si d ' ac(jua, delle fontAne La poi delle il fallo ·c!1e dovunque, nelle stradr, accanto alle ca!'e, si possono trova 1·e ma te r·ie f eca li e queste pos:sono esser e tra"portate coi p i l'di ne l le abilaz10n 1, sono t utt i coeffìclt't•li clte fanno si c he d L1fo è nelle canlpa).!ne sempr e m o llo freCJ uente. ORte queste condizioni, si in Lend e quind i come un e"ercito i n nr11rci a, un di l ru pna a ll ll manovt·e pòs!'a co n facilità in fettarsi e lt·nspori.Hr e poi illit'o d i tappa in l 11ppa o in g uarnig-ione, fJU ando ri ent t•a

Venendo alla profilassi , l'A. ri corda ancora cho i due capisa ldi pet' •m t·i!'!lnamen l o loc-al e snno IB bu ona ac·qua pota bile e la p t' Clltla rim nzione delle mate ri e ma n on si dissimula l e itnmense diflkolltr che nelle campal!ne si alla at tullzione •li quo!'te mi:<ure, e pcrciri vol g•1 l o !<g uardo a qu.'gli all ri mezzi, a quellt1 al tr e vie che piu r apidamente pO>'<!';On o condurre alla m e ta. t•icor .londo 'fllnnlo !<i è fallo pel cnlt!rn e. per la m alaria. Anche nel cole r·a, com e nel tifo, le reci d eg-l i tt mrnalu l i hanno una importa n7.a CAp i tale come sorgente d' in l'ezi one; tuttnv ia im piegando m t·zzi enc t·g ic i per im pedire il cou tatto dello rualeri e f•'ce li col l'uom o snrto, e qu indi i s(,Jnmento l'l disi nfezi one, pr·ovverlendo><i d i buona acqua potabile, valend o!<i d ei tn igliori mezzi diagnr):::tici batteriologrci pe t' un n d ia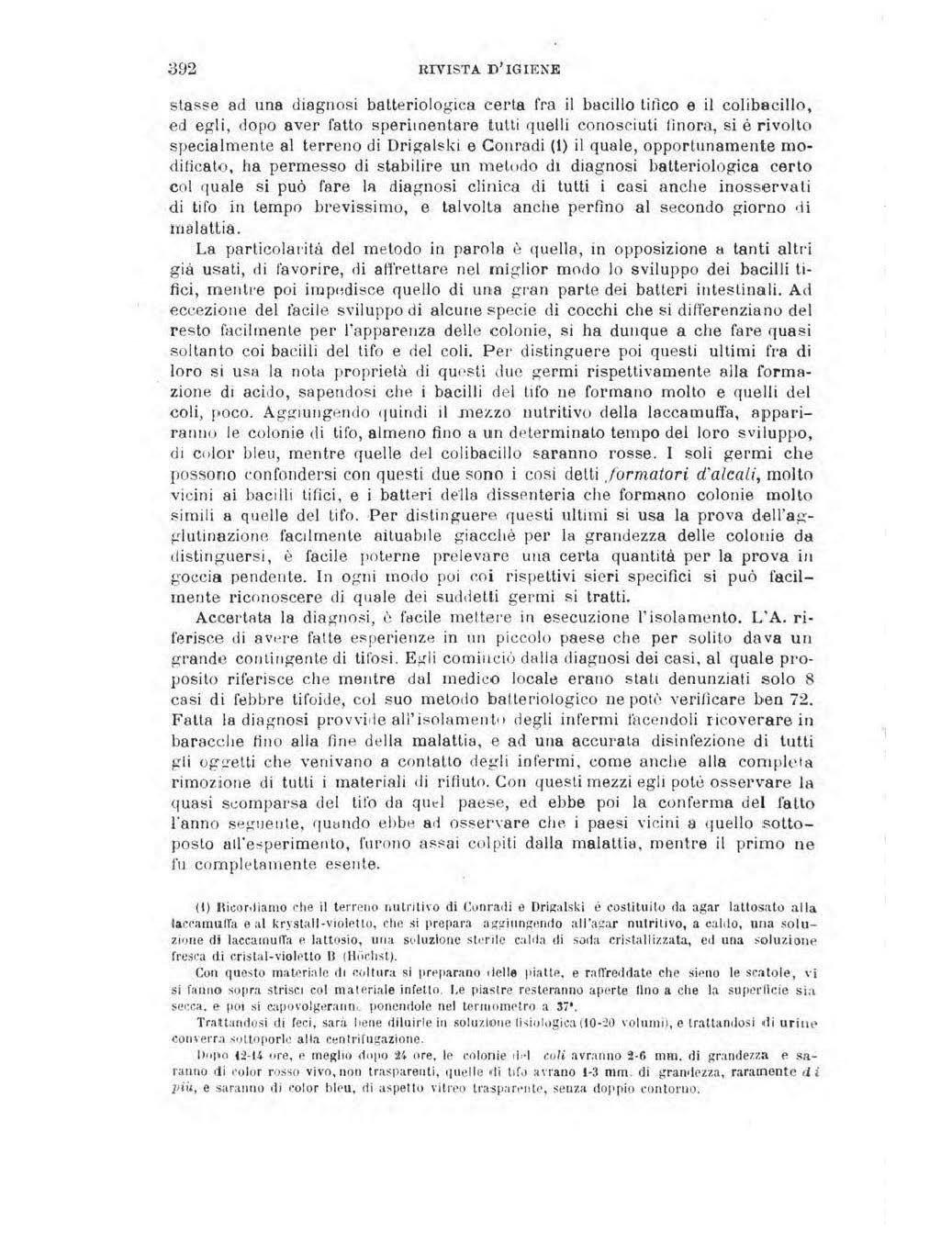
(l) llico r.llotno r he il t er r Puo nuLrrtil o di Cu nracli c Drisc:d s ki e cos liLuilo <la agnr latio s ato alla tacramuiTa o al kryst:tll-vr o iN liJ, r hc si pre pa1·a nutritivo, a ca lci o, una so lnZJ•Jfl e di laccamuiTa latLo sio, ur1a s tolutlo n c s l.•rJI C C;t (d a di sor l:t cri <lallizzata, cci una ' oluzi Oll!' rl.i e r i; l a l-, io iPtlo n Co rt matnia le cii Pt> llura • i prPpnrano delle pinliP e r:ln·redc1ate che siNtO le srnto le, , i si fa nn o s triSCI co l ma lf• ri:tle inre u o l.e p ias tre r es t e r·anno a pe rte lino a c he 1:1 s upc rllcJC s i a e- pm si po nc ndol c ne l l<' r m omr trn a 3i•.
Tra.ttan"us i d l sar:t heue rti1u ir le in soluzione li "ioh •g h:a ( t0-:10 ' olun11 1, c tr:'lttantlosi •li urilh'
«Ji tnr orlc alln
ll••1• n 12 -14 u r e , ,. mc Rir" r1u p<J :H nr e lr 11··1 culi nvr>uu o mm. eli g ra nde1.za f' ra un o d i ··•Jio r ' '""' vi\'O, n o rr quelle oli •nan o 1·3 m m di raramente ll i ]liu, e snra un o d1 r·olo r hlru. di a spello t r aspa r .·utl•, se nza d o ppio
392 Rrvi STA. D' lG lE l\ E
Come c hiusa della dotta confere nza, il K och fa v edere che la proHiassi non i: divet·sa pe1' l e Jiverse malattie, ma che per tutt e si tratta del m edesi mo p rinc ipio, giacché ciò che si impiega da temp o pe r il colera, ciò che é stato impiega to da poco per l a malat·ia, e c 1ò che ultimam e nte si è fat to pel tifo. può essere usato an c he pe1· tutt e quel le altl'e malattie c li P. posso::o per tempo e s i c uramente esset·e diagnosticale e u ellc ' JUa li pO!'sibilè rend e re innocuo l'agente inl'tl ttivo. Vi é un gran numc't'O di malallie uelle queste condi· zio11i si tro van o, cos·t dicasi della diflet·ile, d ella t ubereol os i, e fot' ·nnche per la clissentel'Ìn a pt·oposilo della quale s i s tanno l'acendo s tudi.
É spe rabile che estendendo qUt•sli principii ad altd luog hi, con ada tli mezzi finanziari, con un personale istr-uito e pt•eparalo, si giunga non sol o a diminu i re n o tev o lmente, ma a l'al' spa rire LJUas i de l tutto le epidemi e di tifo.
TESTI.
RIVIS'rA BIBLIOGRA.F IOA
Dott. G. BoRliHt:se, ffiAI!' giore m edir.n nella riserva - llovara eU Stotll a, note eU antropologia, demografia e •ootologla . - (M essin a, ti p. dei Tribunali 190:3. U n Yol. di pag. 22(1) .

L'eg-regio auto re. gili da qualche anno allontanatosi dal s ervizi o alli\·o, oc· cupa in un modo altatn ente l ode vole g li ozii del ben meritato rip oso dedicandoli allo !>Ludi o del s uo paese nativo . A un pt·eceden te volutnello intito lato: Swrrfl di Nooara di Stcrlia segue o r a questo, cl1e come la :;toria natttrale ùei Novaresi.
L'A. li studia da l lato antropo logico; poi ne con!>icl er a il m ovime nto demo· g ra lico, l'aumento della popolazione, la prolificita, l'emigrazione ; poi la patologia socillle : suicid i o, pazzia, N on sarebbe co nsenta nM allo scopo del nostr o g ior-nale J ' adJentrarci in una analisi Cl'itica di r1ues ta oper etta. Ci c on t en ti amo di ai nostt·i lcttol'i non sol o com e u t tle indicazione bibliog l'afìca per coloro c he si interessano allo slu dto igienicQ e demografìcu delle classica t et-rll d 1 Sicili a, di questo così VIJS to, r icco e campo di studi, ma anche come un buon esempi o c d un ammaestram en to, che ci m•IStt·a come i l m ed i cn militare colto ed allivo può pure, a t empo avanzalo, render bul) ni se t'\• izi alla cultu rA paesa na.
Dott. DE' Ro><s1 - La 1t&tura de g li ltallanl e l ' incremento In ea1a verl li cato•l. - (Firenze, lip. Ji Salv'llOt'e Londi, '190;!). ·
ha pre«o in esame le s tati s ti che d el l e teve delle clì!ssi del 185} al 187K. che hanno fot•nìlo io tutto piu eli selle milioni e to ezzo d i Ctfra eno rm e, e che sa r eb be basttlnle a dat·e stabilità d i l e7goe fl quAlu nque ueduztont:l analiti ca, se non vi in quelle s t atistiche diver:-'e cause di errore e di confu><ione (sposlamentì del l imi t e miuimo d i s l8lu ra p<' l' l'i donetlit , val'inzionì della du r ata tlt•Jln rivedibilitli, modtlicuzioni nt>llt:: Yoric norme ;,:ul
RIVIS'rA BIBLIOGRAFICA 393
re clut.am entu) L'au t ore ha però, con lungo e paziente lavot·o Cl'ilk-o, minn l Rm Pnle anftlizzato que!>le influenze perlurbalrici, l e !Ja eliminale per quanln ha potuto, in m odo da poter s icuramente c h e l e variazioni r iscontrAte n ella s talut•a rlur·ante il per i odo preso in esame d s pnndono a 'ariazi o ni della costituzione fi s ica dei vi!>itali .
Sia dei valori medii. s1a da f(uel l o dei wdori !'eri fl li. l'gl i Yi ene alla confortante conclusi one che la s lnlura degli i l alioni si è andala i r1 q ue!>l o t em po I E.' nlame nle mll pr·op-ressiv11mente accr escendo
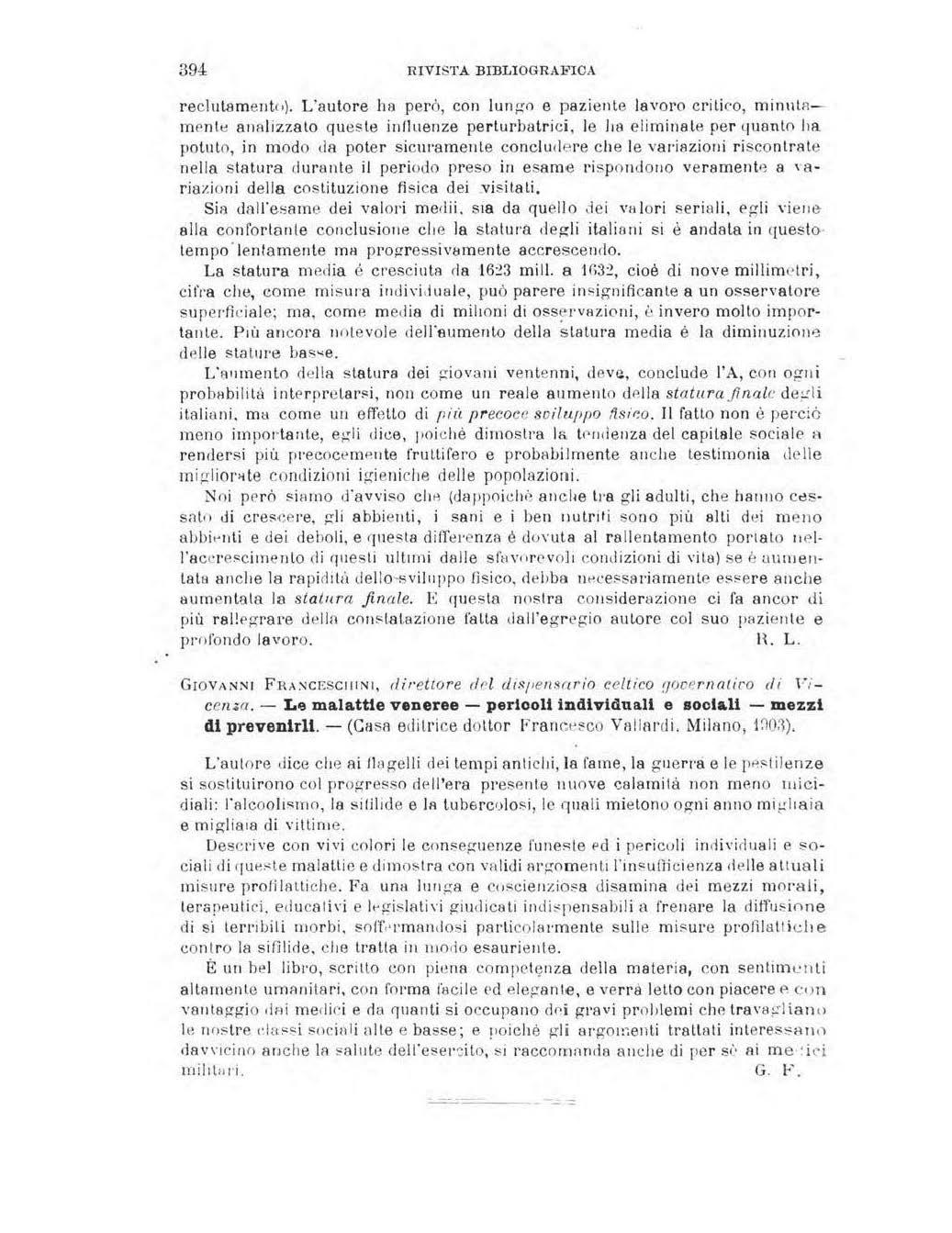
L a statura mr.dia é c r·esci nlR rl a 16:!3 mill. a c ioè di nov e millimPtr·i, ci t'1·a c lr t:, come m isura i nd h ·iciual l', può parere a un O!'Servatore s u pel"fkia l e; ma , come m ed ia di milio ni di e invero mollo im po rt an te Prù 811 co r·a notevole dell"aumento della statur·a m ed ia é l a diminuzion '3
ÙPlie SlBLlll'e IJas "e.
d ella statura dei l!iovan i v entenni, d evc, concl ude l'A, c o n ogn i prob»b i li lti inlerp l'elat•!: i , non come un r eale a u m en to dPI Ia stn.tura jìna l 1· de !.!l i i tal ioni. mu co rn e tu r oR'ètlo di [Jiù p r ecoct• s oiluppo /lsit:o . Il fall o non è per·cic m eno irnpor t.ante, dice, poi c hé d i tn os tr·a l o. lPn de nza del capi ta l e socia le H r ender::; i più. pi·ecocem P.nte fru llife r o e pr·obRbilmente an c h e tes tim o rria tlclle cond i zi on i ig-i enic l re delle popola zioni.
Nrri pP rò d"avvi;:;o ch<J (dappo i c h•; anc lre tra g l i adu lti, c he hRn no CèS· snt11 Jì c r e><('f' t'e, abbienti, i sa ni e i be n 11utr rt i sooo pitt alli òPi m eno alJbio·nti e dei debol i , e f(ne sta d i ffer C' nza é do\"Ul a al r all en t amento por'tato rrPl· 1'8 Cl'I'E!!"Cim e nlo di f(lle s li ullnni dalle sfu \·oor e vnll cond izioni di v ila) s e è au nrenanche la r api rlt tù dello-sviln ppo fisi co. d ebba es,ere anche aumentala la sl a l ttra fin ale. E qu es tn n os tra con s ider az io n e ci fa ancor di più ral! eg-ra1·e dPIIn con l<laLazio ne fatta dall"eg r o.'gio autor e col suo paz i <•nte e prnfondo la ''or o . H. L.
Gro v ,,NN r F TIA :-' CESCIIINI, direttore d r> l cel tico di t ; _ cc n•rr - L e m a lattie veneree- pericoli individuali e soci&ll - m e zzi dl prevenlrll. - (CH sa editr ice do tLo r fran c•·:::co Vnl l nnli. Mihwo, 1:1!1:1),
L'au to r e di ce e ire ai ll11gelli dt>i tempi anli clri, l a fame, la g uer r·a e l e si sostituiro no col prog r e!;;;:o dPII 'era nuo ve non meno rrticidial i: l"Rlcoo li"'mo, la sifilide e l a Lu berc •)l O!: i, le i"JII Il li m i etono ogni anno mi;.draia e m igliata rli \"illinr e.
Dese i·i,·e c o n vivi colori le con ;:eguenze funeste Pd i peri culi inolivirl nal i e ;:ocia l i di que te m alattie e con \ 'a lidi m·gom enlt J'm;:ufìic i enza o! r lle at i u a li mis u r e p r oli latti ch e Fu un» lun ga e cco!'cienzio!"a d i samina de i m ezzi m nntli, l erapeu t iri. ('ducal i\"i e l... gi;:lAti,·i gllttlicati ind i,:pensahili a f r enar·e la di tfu;: i o ne di si l erx• rl.> it.i m or bi, snff,•,·rnond o:oi p8rli col at-menle s ull e m i;:ul'e profìlatti t.: h e c o n t r o l a s i f11ide che lralta. i n mnolo esauriente.
E un bP l libt·o, scr i tto con pit•ntt della materia, con sentrrne n ti altamente umAni lR r·i , con ror·ma t"a c i le t' d e lel!a nle, e v err a letto con piace x·e P co n vantaggio dai merl ic·i e da f(llanti si o ccupano dr i gt·avi pt'<1hlemi c he tra\" a;:lia rltl l e rr r,;:; tr e t·l a ;:<:j soc i nli nlte e basse; e poiché gli trallflli
rlRvl·tr-in r> a rJche lR ;,:al ule >< r t'Rccorrwnrla auche di per s<'• Ri m e · i ,•i mil1tari. G F
394 RIVISTA BIBLIOG RAFICA
SOMMARIO DEG LI ARGOMENTI TRATIATI
( fh l VI·.RUALI l'ER \'ENLTI "l.l.' I SPETTORATO DI SANJT,\ MILIT rH: DA L 19 FP.au n .... ro AL Hs )tAGGro).
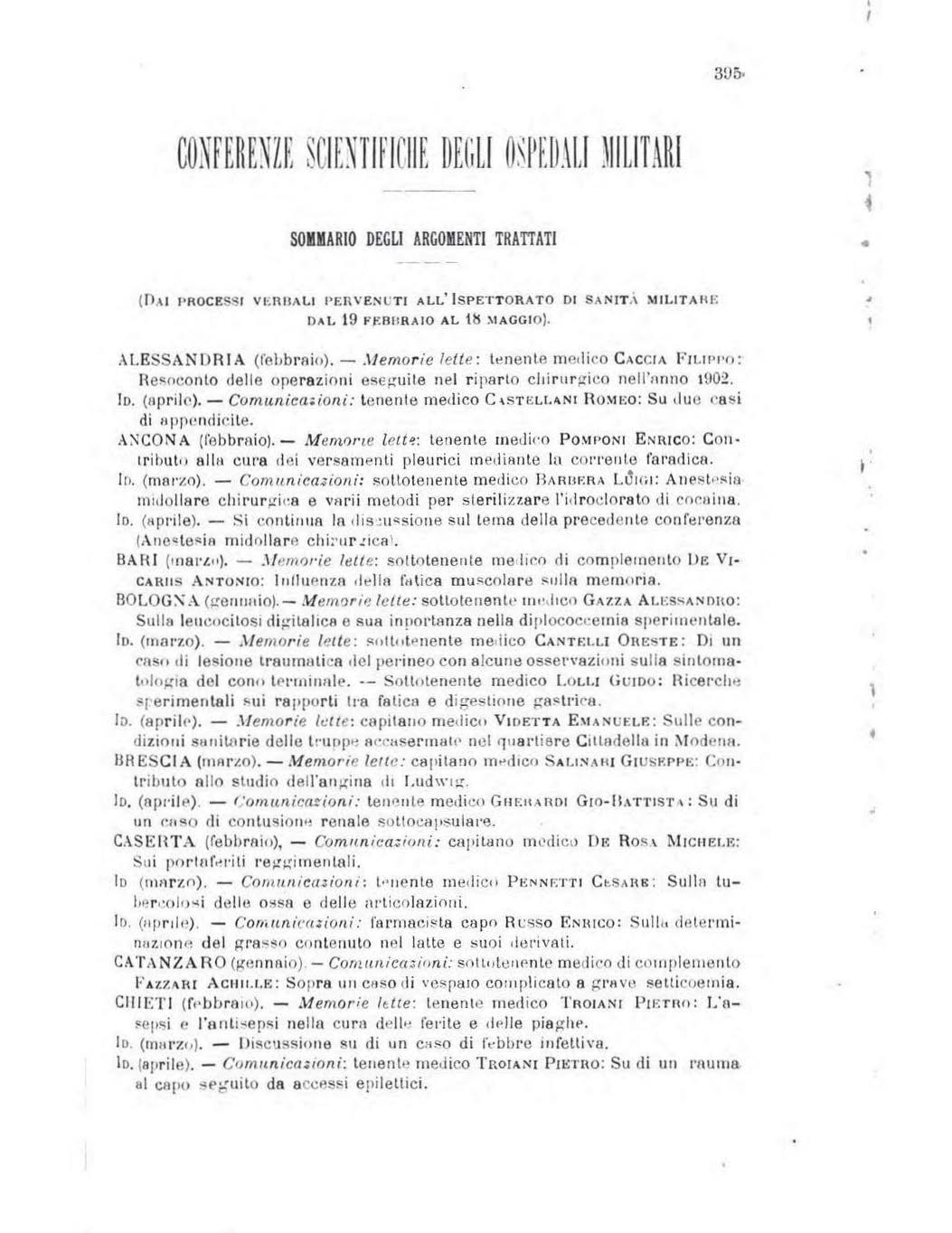
\LE SS A!\ DR l A (febbr·aio) - \J emo r ic Iell e: nente mcdi<·o CACCIA Frl.tPI'O: ReRo co nlo delle ope raz io ni eseuuile nel ri pa rl o neii'Mmo 1t102 . l o. (Aprii <' ).- Comunica;ioni: t e nenl e medico C\STt::LLA.Nt Su due I'S"i di u ppt•ndic·ite
A:-ICON A (l"ehbr nio). - M enw n e lt>L k t e ne nte m edi1·n POMPONr ENnrco: Co ntributi) al l n c u r·a d ei v er·l';am f' nti pleurici mediAnte l u CIW I'e rtl e fat·adi ca !il. (mat·zo). - Comunica,;;ioni: !';Ol lot enente medico B,,nuEn ,, L urr. t: All est••sitl e vArii m c t nd i pe r ste rilizzar e l'idroclora t o ùi rnrni na lo. (11pr·ile). - Si <·on tinllfl In su l t ema della pr•ecedente conftll'enw (Ane"loc:in mid o llarfl ch i ;·ur !tca l .
BAH ! (• n8t'ln). - .\lt•morie fett e: snllnlenenle me ltrn di com plrtnen to IlE VrCARIIS ANT ONIO: l nl!ttf'llZA .J.,lln ftttica OO U!'COIU r e )0:11111\ m em or ta.
BOLOG:"\ \ (!!C IIIIIIiO).- \1emor1e Ielle: sottolenen lt• ult'dtcn GAZZA A r.r:S'-'A:"'OI\0: Sulla l encocitosr di ;:italtca e sua i n pOI'LAnza nella sp!'rlltll'lllale lo. (u1ar•zo). - \leuwrie sntlnt<>nente me iico CANTELLI Oru:'5TE: Ot nn rn!'u di Jeo.ione trau matica tlclpcri n eo con sulla !'<t lllomalnltH!Ia del cono ll'l'llllllRie. Sollolenente medico LoLI.I (ÌUIDO: nicer·ch., "'l er rmenla li ra pporti Ira rati cR e dìges:tione g-al'll'iru.
lo. (apr ii!•). - \lemo r ie lr:tte: capri an o m edico VwET TA Sullt' condi ztolli snnitll r ie delle lnlllpP. Al'<'a!'ermalt• llèl rru ar·tiere Crlladella in ;\l odr•nfl.
13HESCIA (mnrt.o). - Me morif' le/l!': capilano tnt'diCO s .... l.I:"'AIII Contrilmto a llo studio dt l.u d\\'1!.!.
lo (opl'ilt>). - r·omunica:-ioni: l eni' n te medico Gtl"""nDr GIO·IIATTIST': Su di un r·u"o el i co ntu sio n•· r enale
C.\SE il T A (febb rnt o), - Comtmica;;ioni : capitano tn••dìC< l I )E Ro«1 l\I rcner r;;: Sui p0 t'ltl f ,..l'iti lo (lll>lrzo). - ComttlliCa:ioni: L··ncnle medicn Pt::NNETTI Su lln tul •r ·oln i delle c dell e ;u·tico iAziol ti. l u. (np r tlt•) . - Con.uni('a::ioni: fot'nlac•Ha capo R t.:c;s o ENHICo: Snll11 dnte r·minuztnnH del con t enuto 111'1 l atte e suoi dorivoti.
CAT ANZARO (Knnnnio) - Conwnica:;ioni: snlL•1knrn te m ediro di ccH 11p lemonto
F ,\Z7.AHI Actllt r.F: : Sopra u11 d i ''C!<pUIO co•npli ca to a g l'li VI' ;.ett i tcJe tnia.
CIIIETI (fP b b ra H•) . - \1 emorie Idee: LPnenl•' tn edico Tn o rANJ Ptf':Ttln: L'o(• J'a ulP-eps i nel la c urn d··ll•· fe1·ite e d••lle p ia ghr
l o (mll t'7.c,J. - l lt!'Cll '!Sione su di un Ctt!'O di l't·bbt• e 111fcttiva.
l o (apr ile). - Comllnica;toni: tenenl•' meJico T aorANI Punno: Su t!i tlll r·ouma ttl cApo da accPS!'i epilettici
• ) '
(g f> nuai o). - Conwn ica.:; i on. i: l e nente medi co ne NAPOLI FERDI ·
N,,;.:uo: Sull'azion e tera pe11Licll della luce.
l o. ( fehh rai o) - l enente m ediro T o :-:unTJ PtETno: Contributo nllo !<lud i o del valo1•e diagnostico del r·odano.
l o. marzo). - .\1emorie lette : sottotent!nlo m ed i co di compl emen t o SPERONI
F c BDINA:-:oo: Con t ributo d i osser vazioni e d i r ic1·r che s pet•imen lali sulla cu ra dietet ica delle nefl'i ti.
(feb brai o ). - J1em orie l ette: cnpilano m edico SANTORO GIUSEPPE : S u un trs umatr!:' mo dell'o recchio smrstr o, complica to tla a tresia della c o nca e !'egu ito da
l o. ( marw). - .\femorie lette: c ap itano m edico CANNA>\ N ICOLA : Sulle altera· z• uni olella vrsta in ra pporto alle m3latti e del cervello.
l o (A pr·i le) - d ello dell'ar{!om ento tl el me:u• pr t>ced enle.
1\1ESS I N A (t.rennaio) . - M elllo r ie lette : ten enh' m e,iico D'.\ MORe F nANCEsco:
Sto1•ia c hnica e consideraz•oni s u di un co so di a scesso co n gos t i zio alla r egiono dorso Io m bare destra.
l o. (febb r·aio). - .\femo r ie :e tte: ma !!g1o r e m edi co MICIIEI.ANGELo: He· soconto eli n ico dt:ll'ulli m o trunestr·e 1!)02 de l riparto chii'UI'g:i co
M ILA:\ 0 Com un ica-io ni: t enente medico C ASTOI.D! ETTORE: Sull o i n iezioni so Lloculance di sier o golalinato
I n. (a pr i le). - Com un ic a:;ion.i : t e nPnte m ed ico CA STOLO I ETTORE: z i on, s ulla cu ro d t lla sifilid e col m et odo Sca r enzio l'atte n el l a Colonia E 1•ìtretr.
NAPOLI (nra r·zo).- Comunica •ion.i: m Hggior·e m edlt'O DB CESAR E ZACCA !\IA : Sopra nlcu ni casi di malattia del \\' eri e sulla palogcnu:oi deg-li iLteri iu fet· tr vi, con d imost razioni mic r oscopiche.
NOVA H.\ (f,·bbrai o). - Memorie lette : rnedico An or: r:-" o Sul ser vizio !'Snitario in campagn a
PAOùV.\ - Comunica;: ion i: capilano medico M AGGF:rTA
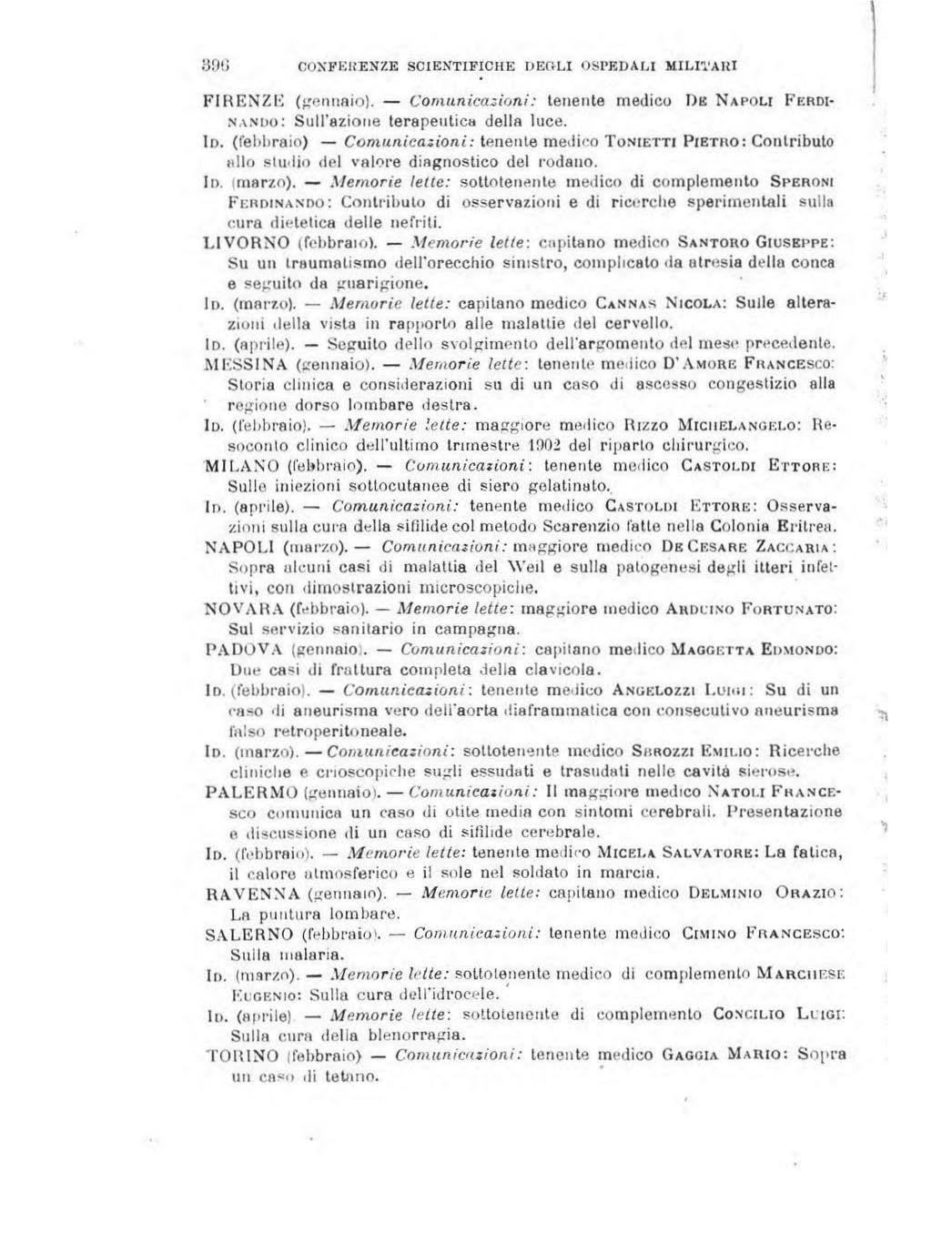
Oul:! C8"i ùr frat tura com pleta Jella ei a vrcola. l o ( febbr·aio - Co mu nic a; ioni: t enente m ed i co AN vELo zzr l.uwr: Su di un t'll"O oli aneuris ma ver o dell'ao rta diafram matica con t•o nsecu t ivo nneuri s ma fnlso r·etroper i t o neale. l o. (lllarzo}. - Coliwniea: ioni : sottotenente m ('dico S n Aozzr E,m ro: Ri cer-che clinich e e cr·roscopi<-he su;.:li essuduli e trasuda ti nello cavità sit>r·ose
PALER;\1 0 (ge n naio ).- Comu n iea iu ni: Il meJ,co :\ ATOI.I FnANCE· sco comuaica un caso ùr otite m eù in co n si ntomi cerebrali. l'r·esent.azione e di ..,cu!'sio ne tli un coso di sifilide ce r•tJbrale.
l o. (f,•bb rni o) - lVIe m orie lette : t enenle m edko M rc ELA SALVATORE : La fatica , il ra loro ulmn;:;ferico e i l !\Oie n el !>Oidato in mnr·cra.
RA.. v A (::xennaro). - M emo r w lett e: capitan o m edico O RAZIO:
L A puntu1'8
S ALERNO (ff'bb 1·a io 1 . - Len ente m eJico CIMINO FnA Ncesco : Sulla rnolar1a.
lo (mart.n) - \lemo r ie lt•lle: so tto len ente m edi co di com pl em eulo M ARCII ESI:
fo:t' GF.Nro : Sulla c ura dell'iJ eoet-l e. '
1u. (tlpl'ile) - M emorie lette: sottoten c nle di complcmènlo L r: ror:
SullA c urA del l o blenorrn g ia.
T On iN O l fe hbr1110) - Conwnicr1 • ion.i : tenen t e m rd ico GAGGIA M AniO : S op ra
1111 Cll"o di t etn no
..
3!)G CON FEli"ENZE
AHT
SOIENTLFICHE DEGLI OS J>EDAr, r MILI'l'
L:O I:-lE - Comunica:ior11: tenente medico PERAONJ GIOVANNI : P ostumi di l esion i multi ple alla spalla per cAduta in una rrana.
lo. (rebbra i o).- Comurlicruioni: m ed ico MICJI!I::LI L UIGI: Prese ntazione di un «·aso di di"torsio n e del polso cou probabile fra ttura del r ad 10 siniflli'O.
EZ I A (p:t>nn ai o). - Comunica:oioni: sollotenemo m edi co di complemento
LUIGr: Frattura completa delle cos tol e d i sinistra dalla 2 " alla 7" .
lo. (marzo). - M rmo rie Ielle: sotto t enente m edi.:o BARILE FELtCB: Rapporto trd la miopia e la il linf8tis mo ed il d eperim ento organ ico.
Vt::RONA <gennaio) - M emorie leite: sotlolenenle medico di complem 11nto
BoRRI ANuRBA : Sullt1 a cidi lA o rinaria in rappor to a l alc uno de rmopa tie.
lo. (rebbra io). - .\le Ttlorie lette: med1co 0Rt.ANill GIOVANN I : Sopra un ca!'O di p!<eudoleucemia !<plenica osservato nello stabilimento idropin1co di Reconro.
Sono inoltJ•e pervenute all a dirt>zione del ;!i o r nate le l'CjWl'llli memorie:
PA SCAU; ALHEnTO, capitano medi co : Amaurol'i tranl'ilor·1a pPI' detonazioni d'twmi da fuo co. - T ROIA N l PunRo, len ente m edico: Studio cl'ilico s perimenltile su lla chiru1·gia dello slo maM. - T u RSINI GIOVANNI, cap itano m etiico: La triplice, s Lel'ilizzalrice o vapore a tre usi.- PERASSI ANTONIO, capiume 1uedico: Appunti di chirur·gio applicabi l e su l campo di I.Jallaglio.SFonz,, Ct.A lJDIO, col o nnello medi co: Sulle scll l o lette rli cA rne di b11 e in co ne s ulle bocce tte d i brodo c oncen t rato che s i p1·eparano in CasArn lla. per li R. E se r cito
1\IISC ELLAN E A
Ringraziamenti cordialissimi re ndiamo a tutti que1 per 10d1c• m aJ i ci J' ltaliu e l'ester o (e sono invero mollis" imi), che, annunziando il cambia m ento di formato del nostro giorn ale e il s uo nel secondo ci nqutJn Lennio rl1 vita, hanno avuto, per el'SO e pe r •l cor po di cui si onora di esser e il rap p••esentan te, parole di si mpAtia e di encomio.
Il r egolamento pel serv izi o sanitario dell'esercit o france1e ha !' Ubilo diverso •no_ tliflrazioni con dec reto del 31 marzo. Una delle m odifica zioni più Importanti i• che i dirello r i di !'anitil dei co 1·pi d'armata sono specialmente inca ri c ali della sorvegl ia nza dei locali e delle truppe dipl'ndenli. A questo !<Copo essi sono autoriz zati a vi !'i t e improvvise delle inrermerie, degli ospedali o delle sale militari degli ospedali civili. A !tre modiftcazioni tendon o a r ender e più spedita l'applicazione delle mis ure i gieniche
Gli ufficia li medi ci francesi, giust o una circolare ministerial e del ;, ma1·zo, saranno d'ora in avanti liber i di p u bblicare lavori scientifi c i solto ror·ma d i articoli, com u n icazioni accad emiche, opuscoli o libri, senza la preventi va nulorizzazio ne del mioi"tero, la quale er a fin' or a obbligatoria.
Per ò la pubblicazione di altri scritti qua lsiansi, non aventi uno stre tto car attere scientifico, contmua ad esser e condizionata all'auto rizzazione mi n i sleriale, come p er g h al tri uffic1ali.
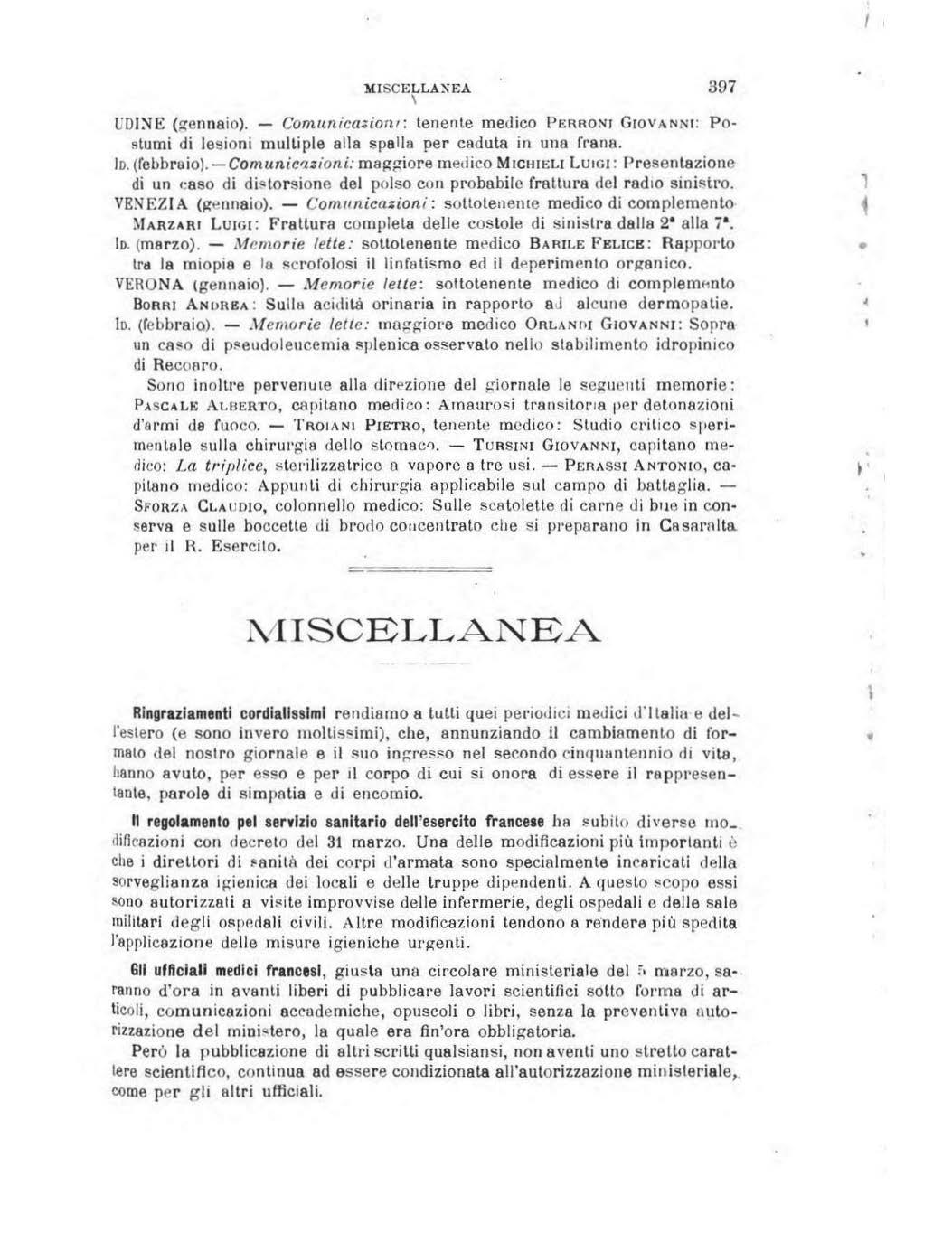
\ 307
l 1 • •
Guerr a alle zanz are in Indi a. - Da una cor·r·ispondenza a l Lance l del 18 aprile appr E!n diamo che, all'inten t o di in t er'L'!':Sare anche i privati alln d i s truzione delle zanzare, il Governo di B ombay ha d ecis;o di confer·ire quattro premi, risp ettivamente di 41JO , :WO, 200 e 100 r•upi e, per lavori d i sulla distri buzione e sui costum i delle z11nzar·e nei villaggi e nelle città, e per espe ri menti sul mi::diOI' m odo d i distruz ione.
Guer ra al t opi. - L e autorita sanitarie di ;'\1anilla, costituile attualmente dagli ufficrali m P.clici american i , hanno d elr berato misur e energiche pe r vincer e la epidem ia t.li peste, che va diffonde ndosi alle F il ip pine. O l l!·e alla cr P.azione di uno spedAie p er g li appe stati , e ad altre mi sure di isol ame nto e di é stnto orf.!anizzato fra g li indig eni un c orpo di uccisori di t opi I:..e case dove sono tr·ovati dei topi sono inoltre disinfellate e ch iuse per qualche t empo.
Ma ben d iver samente C0 t' r·ono l e cose in In d ia. I l munici pi o di A l lahabad, t r a l e misure pi'OtiiRltrche per prevenire l'estensi one della peste bubbonica, aveva sanci t o anc he ryuella della distruzi one dei topi. M a la c ommiss ione ind»ll'esec uzione !>i è trova ta di fronte a una decil"a opposizione per• pa r·t e d egli nbil!mti, a cui, come é n o to, la r Pii$ò(ione vi eti\ l'uccisio n e di qualsia!'i animal e P er·cin, se è v er o qua nto scr ivc I' A llahabarl Pionee r , la c ommi ss ion e lru dovuto i stituir·e una speci e di rec lu so rio . nel quale i t o vi sarebbero mantenuti a spel"P mnni c ipal i , fìnch i · il perico lo d ella peste non sia Per l'alimen taz i o ne dei t op i furono s tanziate -i2 r•upie al m ese.
Missio ne scienti fic a alla Coloni a Eritrea - Vio::to l ' estendersi e l'aggrav ar s i di val'i c epi zooz i e nei ho vini, il Gove rnato r e dell' Eri t r·ea h a ri c hies to una Comrn i;.l'io n e tecnica incaricala di studi are la ll ll LUI' a del morbo, il suo m oJo di Pl'-lf'n!3i o ne e i m ezzi pet· arre!' tarne la diffusione c o mrni;:;;.ione, del t enente medico Gi ovanni i\Iemmo, che ne è il C"a pot del t en ente m " dico F er·dinando MaJ·toglio, e del teuen t u vet e r inario Car·lo AdRni, •\ grà partita pPr' Mn:<saun, f ornit a d i lutto l'occor·rente p e r l'im p\anlo di un co m ple l rl gRbinetlo balle r·rologico .
Nuovo osp edale militare a Londra - Questo o»pedale, coslr·uilo sul lu OIZO J e lle onlicl re p ri l!ion r di Millba ok, è n ema i p r oss imo ad Psser t er}ina to, erl in parte è già occ upato. :Sar à capa ce in lu Lio dr c it·ciJ :Wn l etti. Si compone d i 6 fabbricati distiu li riu niti lr·a l oro da pa«saggi coper·ti. I l costo totale sa r ebbe ùi ·too.oou slerlrnl'.
Lotta contr o l ' alcoolismo l ell ' eserclto francese. - Il M i nis tr·o d i' Ila :;ruerr·a J,a dir·antalo ai co r· pr di lr·uppa d1 avveetim enl i »u!l'nlcoo li s rno e Hli suoi da nni o peri co li , !'-latnpati in fvrma di manifesti. Que:>li sla ffi ]'Ali dov rann o €'ss er·e afli Sl'-1 n elle came r ate, perché i sol.iuli li abbiano contin uafl)ente sntlo gli occh i . Essi sono s tat i compilati dallél direzi o ne j:iene r ale d ell'a ss il' lenz a pubbl i ca
Il Congr esso medico interna zionale di Madri d l'i cil iusP. dopo un' alternar·si di sedute scienlifkhe e d i !òplendlde fes t e, il 29 apr•ile. Con1e ò purtroppo fa c ile in riuni on i di questo gen er n, v ere fi ere scientifiche, non man ca l'o no, a quanto élpp r·etHliam o dai giornnli, g li iuc ouvenienli, speci a lme nte per que l che r i g uarda rl servizio defrli tl l loggi e per· la ius uflìcienle d ifesa del povero cong-r essista cc.n lro l' iu gOI'digia della
P er ò tutti i r educi c he abbiamo interroga ti, e l a voce sless!'a della lt.impa,

398 MISC ELLA::-IEA
sono unaHt m t nell'afferma r e che il bu o n volet'e dei col leghi s pag nuoli, l a cor<italità, la generositA de lle lo r o accog-lie nze ful'On O supe riori ad ogni aspettativa
E s i no tò m a ggio r mente nella s ezio ne di medic111a, m i litare, nella quale alla prover b ial e cavallere!:'ca cortesia spag11 uola si anche la co rdia lila c• )Q <'pirito di came rat islllo che r e g na fra i medici mili ta t·i di t utte 'e nazioni.
li nos t rQ corpo sanitario e r a u fficial m ente r appresen tato c o lonnell o medico cav Sforza, q ual del mi n iste r o de l la guerra.
Intervenne r o pur e al Con g r·esso i captt a oi medici Galli, Me nn e lla, Be rnucci, -il farm a cista capQ Bompi ani. Il colonnello Sfo r za ed il r r maci sla capo Bompian i fu r ono nominati pres id e nti ono r a r i nelle ri speltt ve sezioni. De lla nostr·a m ar ina 81'8 rappresentante nl'fìc ia le il med ico capo Coìetli. Pres e pure po1• te alle riunio ni d ello sezione di m e d icina mi li l.-a1'e i l colouneliQ medi co Santini, deputato a l P a rl amento . Fu r ono presentate comunicazi o ni dal Sforza, il quale rife r i a lla !"e zione mi litare s ulla prPpar·flzione de lle ca r ni in con s e r va P. dal capitano medico i\•Iennella (all a sezione d' ig it> n e ) su l tema Tube r colos i e matr im onio. F ur on0 anclae comuni cate le re la zio ni dr cui e 1·ano stati incat•ica ti il colonnello medico Favl'e ed il mai!'; io re m e di r·o Livi, ri spett ivamen te u lla milita re ed a quella di a nato m ia e anl r o1,ol ogia.
Fu molto amm iralo dai medici miltlal'i lo sple n di.Jo ospedale m ilita r e d e lla guarnigione d i Mad r id a Carabunchel.
Longev ità . - Vive an co ra io G r·ecia il colonne llo Mav r oyeni, n a to ne l l'isola di P uro n e l 17!J8.
Era t1ppe nA laureato in m e d icina, quando, scoppiata la guet-ra d e ll' inrli pendcnza g reCi!, il Ma Vl'oyeni s i a1' J'Uolò t ra gli inso rti e p r ese pat•te a più di uno
Co me é di reg ola ne lle lo ng e v ità eccezio nal i, il colonnello gode anc o t•a di una alli vita e d i una vif!Oria slt·aorùinat·ia. Sc1•ive e le)!ge senza oc c hiali; d o rm e, mangi a, d ige ris ce, pa ssel-!'{o!ia,' eome l'a. E g li s i propon e di ra gg iunge r·t· l' t: té. di una sua !'<O t·ella, m o rta di 115 anni.
Annuario Sanitario italiano - È stata pnbblica ta la t•wza annata di C'JUesto annu ario, cb 1:1 offre l' e lenco generale di tutti i italian i (medici , v e le r ina rii e lavatrici) l sanitarii sono classifìcati pe r Pl'ovincie e pdr Co muni.
I l volume d i q ues t'anno, elegantemente r il egato in te la , contiene a n c he un elenco de l perso nale delle faco lta m odic he d e lle univ c r »i ta ita l iane.
l nosll' i ttbbona ti che ne vo le!"se t·o copia, al pr ezzo ridotto di L. 3, non ha nno che da manda r e una cartolina va g lia all ' ammini s trazione deii'Anuuario Sanitar io, V ia Ges ù· Mi lano.
Il gran premio Riber i di L. 20000 è stato c o n ft> r rto daii" Accarlr mi a d i med ic ina di Torin o all' eg r egio prof. Ac hille S c i avo, deii' U nh·er sitA d i Siena per i suoi studi i s ul sier o
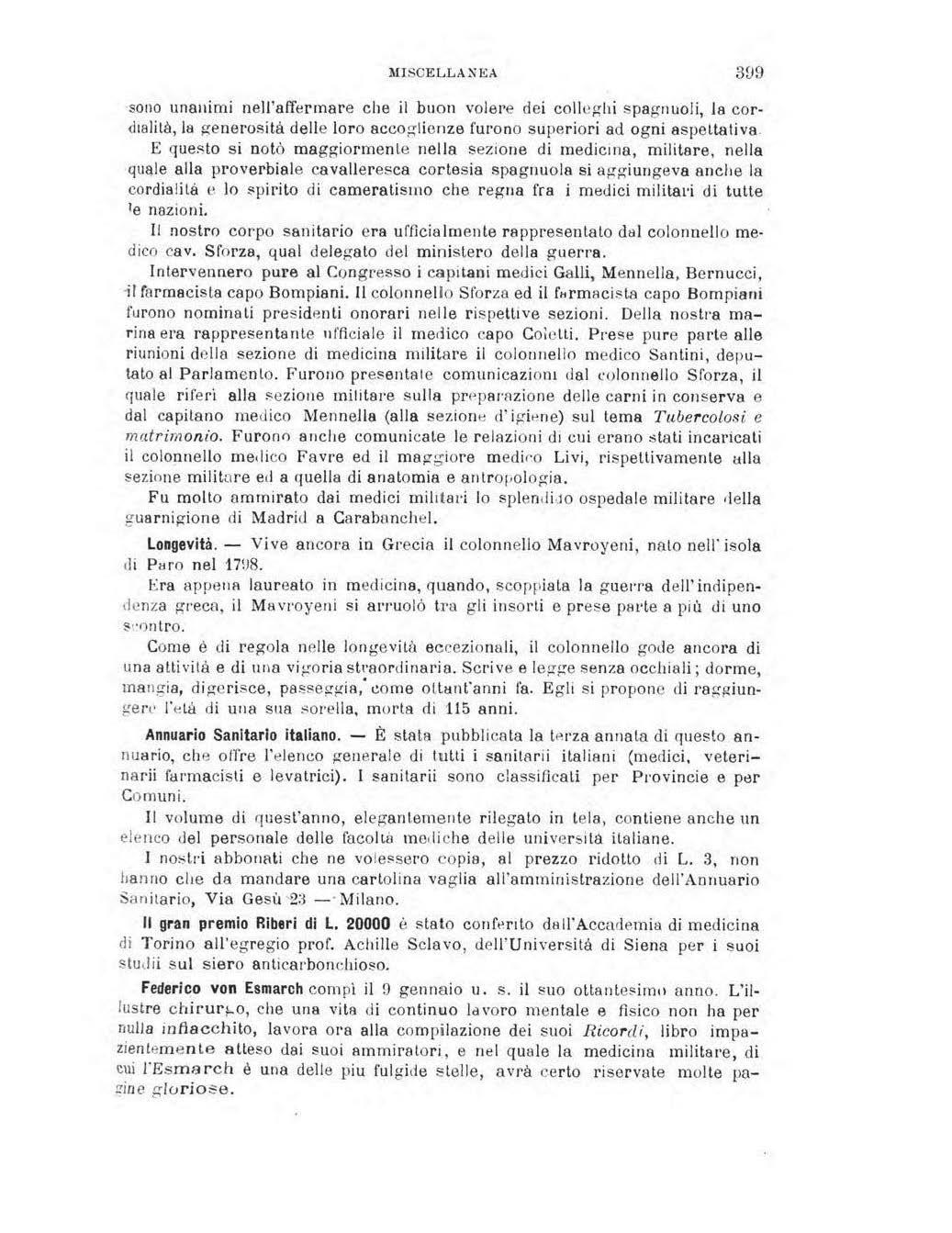
Federico vo n Esmarch compì il !J g en na io u . s . il suo onno. L'illusLre c he una vita d i co ntinuo lavo ro m e ntale e fi s ico non ha per nulla infiacchito, l av o ra o t•a all a co m pilazione d e i s uoi Rico rdi, li br o impazien le m e n le Rtleso dai suo i ammirato r i , e quale la m edicina militat·e , d i
C\li I'Esmarch é una delle pi u fulgide avr•à ce r to r iserva te m olte pa!!ine glo r io se
UISCELLA X EA 3fJ9
Concorsi - Premio Bu(nltni - E' Ape r to fino al 3 1 ollobre il concor·so al Premio Bufalini, di L. 6000, 1e r un' o pera s ul tema seguente, proposto dallo l'<[PS"O rll•tl'<trr fondAtore:
• Po'Ila l'evidPnza dell a necel'sil.à di a ssic urare al solo metodo sperimen ta le
• la ve r •lé e l'o r dine di tutte le l'<Cienze dimos l r·are m una pl'ima pa r te. quanto
« ,·rramf'ntf' sia da u!'arsi in og-ni scientifico at'j!omrnta r e il meloJo suddello, ed in una seconda pRt'te, quanto le si n golari l'Ctenze !>e ne siano pro,·alse
• nel tempo trascorso rlall'ultimo concorso fino a •l ora, e como possano esse
« t•icoodursi nella ptù fèdele ed inliet•a osservanza del metodo mede.,imo •.
« MA CRI:I.Ifl i3UFALINI •
Per ullt>riori informazioni cit·ca le condizioni del concorso l'ivolgersi a lla can<·elleria dell a SL'Zione med1co- chiru r gica dell' lsliluto d t 'll ud1 'l uperiori in Ftren7.e.

Concor so pe r una memoria sull'irtiene del bamb ino dal 2' al 7' anno d'età. - E' aperto il conco rso a un premio di L. :;on, indetto rlallll Cooperati,·a fa rmacrutica di Mil11no, ><olio il patr·ocinio ddla R. soci e la italiana d' i!lieoe.
L 'opu;.rolo rlovt·à Psse re di circa r;Q - (jU PRI!in<>, di fo r malo 15 X !l, ca r allere co r po 8. Dowà esse re t·edatto in forma fucile e pianB.
Il concOt'!'O si c hiud e il :lO settembr e I!JO:l. I ndirizzare i manol'c t•it.Li alla clelia R. !'OCietà italiana d' tgiene ( Milano, via San Paolo, 10), pt•esso la quale si potranno anche aver e ultet·iot•i indicazioni sulle n o r m e del co nco r so.
Premio '/lLinfJuennalc Zannetli. - E' aperto un concorso O•to al t5 Rprile HlOl, pe r un premio di L. 500, da confer i r si all'aulot·e della miglio r e tn"· lllOr·ia sul tema: Chi r ur[! i a dell'ulcera !laslricrc e dee postumi della m edesima uii'AccadPmis medico- fi!:'ica fi o r entins, via degli Alfani, 3.l.
Premio E'nno - Sander. - L'associalione dei chi rur g hi miliU.ri degli Slati Un 1ti melle a concorso pe r l'nn no 1903 il seq-uente tem a : TI! e di(faentinl tiiannosis oj typhoid jeoer in. its enrliest stayes. :'\oo è ind1cata la <lata pr,•cisa dt•lla del concorso. Il p r em io consiste in una meùuglia d'oro del va· lo r P di 100 dollat·i.
P e r ulteriori mformazioni rivolj! e rsi al seg ret ario dell'associazione, l\lajor Jarnes Evt•lyn Ptlcher, Carlisle, P a. (Slali Uniti).
Nec rolegio -A a Lecore (Firenze), il 18 OJH'ile, mori il colonuello medico in l'iposo Siloio Ballerini. Era entrato i n se rvizi o nel 18.",9 ed a,·eva preso pa rte olle campagne del 1859, del ISG0-6 1 e de l 1 66 ed alla rep r O!I!'ione del Et•a direttore dello spedale militare di Firenze, quando, lasciato il ser\'izio per la leg:.t•' sui limiti d'età, si ritirò alla quiete del s uo paesoll o, nel quale era nato IHhli 12 febl)t·aio l83:l, e dal qnul e la s ua mor te fu pian ta s iccome quello di un instancnbile e disin te r essato benerattor c.
Il D t rot.t.ore
Dott. F. L.&NDOLFI, maggior generale medioo.
Il Redat.tore
D.• RtDOr..Fo Ltvt, ma p-g10 re medi co.
Il o ma. 1003 - Ti!•· \ 'u:;he ra. GoO\'A ss1 (itrttllt.
400

-
GIORNALE MEDICO
DEL REGIO ESE R CITO
Dlrezloae e Aatm lnis tra zlone : presso l' Ispettorato di Sanità Militare Via Veatl Settembre (Palazzo del Ministero della guerra)
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.
Il Gio r nale M edico del R. 0 Esercito s i pubblica l'ultimo gior no di ciascun mese in fa scicoli di 5 fogli di stampa.

L'Abbonamento é sem pre annu o e decorre da l t • gennaio.
Il prezzo dell 'a bbonamento è:
Per l'Italia e la Colonia Eritrea
Per l' Es tero. . . . . . .
Un fascico lo sepat·ato costa.
• L. 12,-
• 15,-
• 1 ,25
L' a bboname nto non di!.'detto prima del t• dicembr e s 'intende rinnovato per l'anno successivo
1 signori abbonati militari in effettività di servizio possono pagare l' porto de ll'abbonamento pe r mezzo dei rispettivi comandanti di corpo (anche a rate mens ili).
Le spese per g li estratti e quelle per le tavole litog r afiche, fotografiche, ecc., che a ccompa g nasse ro le m emor ie sono a carico deg li autor i.
Gl i estra tti cos tano L. 8 per ogni foglio di stampa (16 pagine), o trazione indivisibile di foglio, e pe r c ento esemplari. Il p rezzo é eguale sia che si tratti di 100 esemplari o di un nume ro minor e.
l manoscritti non si restituiscono.
,
Slora.. - Sulle sca tole tle di carn P di bue In conserva e sulle boccette di con· cen trato c he si preparano In Casaralta {BoloJrna) pu il regio esercito
Mollnar l. - Con tr ibuto alla e7.iO IOI!ia e cura otill esterna e tnedi:t
Yaltrlo. - Contributo sperimentale alla c hirur11ia traumatica del polmone.
DI G IO RliAI.I ITAI.IAl'll F.8 IF.8TF.a l
Rivista modica • •
Riv b ta chirurgica •
Rivi sta d1 ocullsticn •
Rivis ta di anatomia & flsloloj(ia normale e patologica

Rivi sta di mnlallle ven eree c pello . . . . .
lllvi!ta di
Rivi sta di tecni ca e servizio medico militare. eli batteriologia.
Rhlsta d' Igiene.
Conferenze scienttn che degli os pedali mìlilari
Ylsccllanea
(V. l ' lndlu ntll' i111trno della copertina)
r Pt:BBLICATO •.4 011Itlt, ISPETTORATO Dr SANITÀ MllliTJIRE . ,, .., ..... ANNO LI FA SC. VI 1903 30 GlUOl\0
ARIO
801\IJM
••aeeaiE o•IGil'IAI,I
• · · · · ·
DLREZIONE ED AMMINISTRAZIO NE ROMA • Palazzo del M..ùtbtero Guerra, VIa XX Settembre • ROli.A ( l l Pog 401 . ,,. • 4!6 Pag. 447 . • 464 • 466 • 408 47 1 415 • 47G 478 • 4i9
bric·ati, residui di nn antichi:ssimo convento, so rgono le numerose c•pPre rrcPnti, costrntte per gli scopi della la>o r azione.
ll c·orpo principale di fabbrica, a due piani, lungo 7:> m. e largo m., Jist<'ntle>:i longitudinalmente da est ad o,·est, pre!ieutadne inluugo il ùt•corso e si uni sce, vPrso est, perpendicolarmente, qna;;i nel mezzo, nd nn altro fabbrieato, pure a. due piani, lungo m. e l nrgo m. Di questo antico edifizio non si utilizza per la hworazion<' che il piano teiTeno, pssPnclo i l primo ed il S<'condo piann destinati a magazzini e ad alloggi.
L<' opere m11rariP, af!giunte in tempi r écE'nti per l'ampliamento dei lrH'ali primitivi, consistono in una grande tettoia a snd, in c ui !'i s,·olge parte priucipale della la\orazione; iu un grande fabbri<·at o nord, in cui trovansi le stalle esteme, il mattatoio ed alcuni magazzini: ed in una se rie di fabbricati separati, come le nuov(l stalle, i nno,·i locali per la la,·orazione drlle fmttagli<' e la del la c:a>:ntta per il custode., per l'nssistente de l g<>niomi1i t are su l del grande via le di Mcesso lo stabilimento, il corpo di gunrclin sinistrn del detto vint e, ambedue in vicinan?,a d e lla lmrri<>nt; il loco.lo per fa.bbricazione delle cassette di legno e dei (·artocci di 1·artone-enoio legg e r o nella tettoia dell'antico l!"'orte GalliC'ra.
Tutto lo e chiuso da ogni la to e possiede, oltre numf'ro-;i cortili interni, vasti prati, cd è provveduto di acqua potnbilP, pro\'euiente dall'acquedotto di Bologna e da nn pozzo artc"iano. st·:l\'ato in tlll cortile interno. \ :ran quantità di twqna del snttosnolo t ro,·asi all'a peno nel fossnl o che ci r conda l'antico F ortC' mcnt l'C', pari.<' posteriore clelia fabbrica, lung') la via )f,lscnrdln, scorrono, in nn a canale l tn !C' ac11ue dC'll'A posa. O\'<' s'imnwLtouo i rifiuti tlc·lla la\'Onlziolle.

J)p, cri \'<•rÌI somma.riamen te le pani priuci pali df'llo stabi l imE'nto: lJor,·ù-ro- 'l'rovnsi sulla ;;t.raÙ(l. nazionale immPclint.:llHPnl<' dietro il binn,rio del Yaporino dPIIa. d<'l tram pjp,·r· d1 Ccnl.o B ologna. Il ÙPtto tmm t> collegato con In stazi1me ferrovinria. della città e qnaut.o primo. lo snn\ purE' con l' intt·rnn (lelln. fablJl'Ì(·a.
A od a sin ist r :1. della bruTÌ Pra i terreni ,;on o isolati dai YÌ· tini l'nn unA. reto metallica di filo di ferro zincat.0, sosten uto. dn, ritti di fuJT<J. A sinistro. ]n, deLta r ete tcrmÌll!\ al fossat.o c h e ci r conda. il Fnrtc> G:dlient; a destra dt• ll a barri<>ra ÌtWCl'l' si esp lica. pal'!l.llelnmrn!t• nl gr:uulr Yiale, fino al muro dell'E'X
Stalle.- Oltre io stall e PScernP, capaci di bo,·i o l<' sLa lle interne\ nelle quali si tengono in ltSSerYazione specia Le g li animali
\
il giorno che precede la loro macellazione, esistono altre cinque stalle, di recente costruzione capace ognu na di 12 bovi.
Tutte le stalle per il loro c uba ggio, per l'abbondante aer.ea.zione, per l'illuminazione naturale ed artificial e, por le spaziose mangit.toie, in las troni eli cotto, per l'abbondanza di acqua potabile di cui sono prov>iste, e per le speciali loro fognature corrispondono a tutti i principi della moderna igiene.
Pm co per bttoi. - Davanti alle nuove stalle trovasi buon tratto di terreno ad uso parco per buoi.
Locali per la pulit"ra delle frattaglie e la separazione delSono stati costrutti recentemente, lontano dallo stabilimento, in luogo isolato, ma in vicinanza. del corso d'acqua dell'Aposa.. Con essi ò stato sistemato un servizio impo rtll.nte ed è stato eliminato l 'incon>eniente del cattivo odore, che esa.la.va dalla prolungata. cottura delle ossa.
I l ocali sono ampi, bene aereati ed illuminati, provvisti di una caldaia a vapore della Ditta 'l'osi di L egnano, di tre grandi caldaie per la cotturA. delle ossa. e di acqua potabile in abbondànza.

In essi trovasi pure il digestore sistema Rastelli, per l'eventuale sterilizzazione e mncerazione di buoi rifiutati per tubercolosi où altre malattie.
Dai detti locali si accede, per mezzo d i un passaggio copert,o, al mattatoio.
Jlctttlltoio. - Questo può contenere circa cento buoi ed è quinùi molto superiore a i bisogni dello stabilimento. Il del tntto impermeabile, è .provvisto di chiusini idraulici e di adatte pendenze. Le pareti, pure impermeabili, sono provviste di cunette speciali in <'emento con relati,•a tubazione o robinetteria per acqua, potendosi t·on tale sistema ottenere completamente la lavatura di esse.
La luce vi penetra abbondantemente dall'alto e dalle num erose fi- • nestre la tera.l i delle pareti.
Oltre i quattro muri di sostegno, il tetto è sorretto, da dicci pilastri contrali in m.uratura, riunit i fra l oro da arcate ovali di rinforzo a due ordiui. Altre venti colonne in ghisa, per ciascun lato, servono per sostenere il tetto e la soLtostante armatura. In q nesto local e tro>asi q nanto può occo rrere per ferma m -i bovi da abbattere e per l e operazioni successi ve.
La fognatura del macello è collegata con quella di tutto l'edificio .l[acello inte1·no. - E limitrofo al mattatoio, col quale è in comuni- · cazione mediate ferrovia. aerea. ove scorrono le relative rotaie pensili pel tra porto dei quarti de i buoi.
E SULLE DOCOETTE Dl BRODO CO:\CENTRATO, ECC. 403
!.
N ella parte sn periore del locale trovausi otto serbatoi i n cemento armato, ove è raccolta l'acqua del pozzo artesiano. Tali serbatoi, sempre pieni ùi acqua, cont ribuiscono a l\Onservare al macello unA. temperatura relativamente bassa e costante.
Ct,cina. - È ampia, bene aereata. ed illuminata, con pavimenti e pareti impermeabili.
È provvista di numerose caldaie a doppio fondo per la prima cot· tura della carne, di grandi tavoli di marmo pel disossa.mento della. carne cotta. e di quanto altro può occorrere a scopo di cucina.
E sistono pure in detto locale quattro forni per la preparazione dell' arrosto.
tettoia. - È un grande fabbricato d i recente costruzione, aggiunto al fabbricato antico, parallelo ed in comunicazione col p iano terreno di esso.
In questo locale trovansi tutte le macchine nE'cossarie per la fabbricazione delle scatolette aggraffate, tutti g li apparecchi ed utensili occorrenti per rie mpire le scatolette di carne e di brodo e le cal1laie a p res:>ione per la cottura definitiva di esse.
È in tre navate, so rrette da. due ordini di colon ne di ghisa e da muri longitud inali e trasversali, rafforzate da catene mari tate e saette in ferro.
All"illuminazione naturale, oltre numerose finestre delle pa reti, p ro,·vedono did soffitto parecchi ed ampì lucernari.
Tettoia per la ptditttra delle scatolette. - Tro\asi a destra ed in fondo alla grande tettoia ve:·so nord È nna sala bene illumina ta. da tre grandi finestroni e da due grandi lucernari sul tetto.
!.oca/e per la preparazione del brodo - Si compone ùi du e ambienti, provvisti di quanto è necessario per il digrassamento del brodo e la sua. concentrazione n el vuoto.
l.ocHle per la fai.Jbric(tzione delle di leg110 e dei cartocci eli cartone. - nell'antica tettoia del forte Galliera, adatta ta a tale scopo e provvisto dei rela.tiù motori e di tutte le macchin e e gli utensili necessari.
J.ocali accessori. - :Meritano inoltre di es:;ere ricordati l'atrio ù' ingre;;so, ass11-i 0onveuiente e decente, il r efettorio per le operaie, la guarùaroba., il locale delle caldaie e dc i motori a vapore, fra i quali primcggi1mo quelli della Casa Tosi di Legnago, i numerosi magazzini a pianterreno e nei piani superiori, la sala di riunione per gli uffi. eiali, i l avatoi provvis t i di numerosi rubinetti con acqua calda, e ron vasche appropriate e rela tivi scarichi, e le vane latrine per operai e operaie.
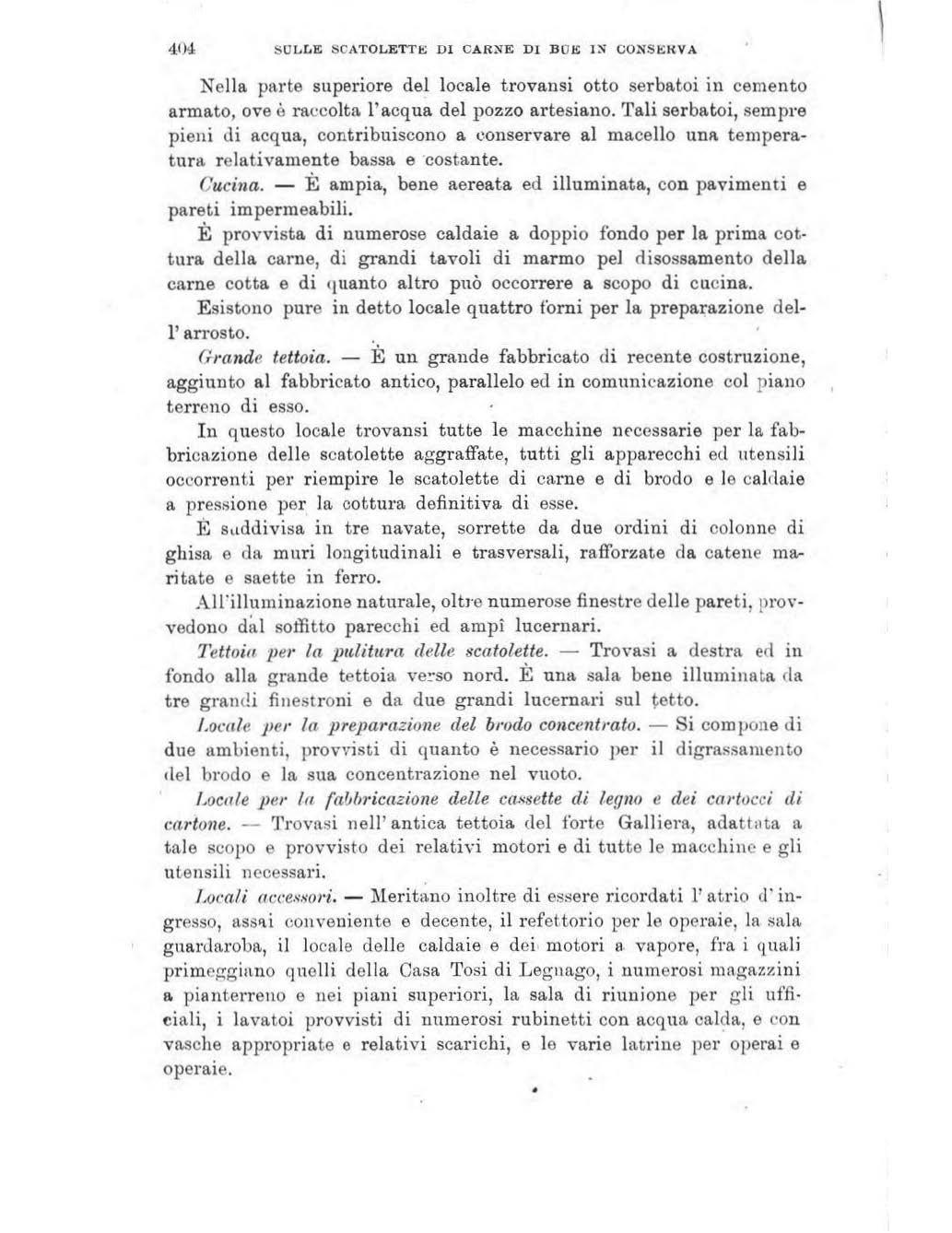
41}'! SOuLE SCATOLETTE DI CAR::<IE DI B OI!: I:\' CONSEttVA
Inoltre tutto lo stabilimento è provvisto di completa fognatura ll canali di grès, assai larghi, collegati a numerosi chiusini idraulici doppi, del tutto inodori ed a. due pompe centrifughe per il sollevamento e l'immissione dei materiali di rifiuto nella vicina. canaletta delle acque dell'A posa.
Quasi tutti i pavimenti dei vari laboratori sono coperti di cemento e completamente impermeabili, come pure impermeabili sono quasi tutte le pa reti, specialmente quelle dei due macelli e dei locali in cui si lavora la carne.
L'illuminazione naturale è largamente assicurata per ogni dove da. numerosissime ed ampie finestre e da numerosi lucernai sui tetti; quella artificiale da num erosissimi rubinetti e lumi a gas (1 )
Abbondante è pure l'acqua potabi l e, tanto per la cottura della carne, quanto per la nettezza e la lavatura di tutti i locali.
A tale scopo rende servizi straordinari il detto pozzo artesiano profondo più di !)!) metri, scavato in vicinanza delle ca ldai e e dei motori.
Per la lavatura dei locali in cui si manipola la carne cotta, si fa uso tli acqua b ollente.
Insomma lo stabilimento, sebbene trattisi in gran parte di locali antichi e riattati, corrisponde abbastanza. bene ai vRri scopi della lavorazione. Esso ha bisogno urgente di cella frigorifera il cui progetto è allo studio e di locale dei bagni per operai.
Sarebbe pure necessario che fosse meglio sistemata la grande tettoia della lavorazione, suddividendola in tanti riparti paralleli, separati mediante grandi invetriate tra.sver:iali e trasportand o altrove i macchinari per la fabbricazione dei gusci nonch.! le caldaie a pressione per la cottura e sterilizzazione della carne nelle scatolette.
Si otterrebbe in tal modp quella razionale separazione dei servizi, che si osse rva nelle fabbriche di conserve alimentari , costrutte a tale scopo all'estero, nelle quali in generale al mattatoio succedono cella frigorifera ed i locali rispettivamente separati pel disossamento de lla carne cruda, per la prima cottura della ca rne, pel disossamento della carne cotta, per l ' iscatolamento di essa., per l' immillsione del brodo nelle scatolette e per la loro chiusura e sterilizzazione definitiva.
RvoLG n.t:ENTO DELLE LAVORAZIONI (2). - I bovi di razza. nazionaiP, di qualità scelta, di età. dai 5 ai 9 anni, perfettamente sani ed in ottim o stato di nutrizione, ma non soverchiamente grassi, sono introdotti vivi
Cl l All'lllumln:ulonc n gas sara quantoprlmn quella elellrira.
( t) Le principali notltle sono riportate eta l Cajlltoll d'oneri per la prPparazio,e e la rornlturA atl impresa •li sutolette di carne di bue m e eli boccette dì brodo concentra to pel R. • dalle r elative di srniz io Interno.

E SULLE BOCCETTE 01 BRODO CONCENTR ATO, ECO. 405
nelle stalle esterne e visitati da un capitano veterinario assistito dalla commissione di vigilanza composta di ufficiali e d i specialisti.
Sono assolutamente escl usi le vacche ed i tori.
l buoi accettati sono tenuti in osservazione ed in riposo, almeno per 12 ore, ed in questo tempo si somministrano ad essi beveraggi rinfrescanti e piccole quantità. di fieno.

Dopo tale periodo i buoi sono di nuovo visitati d al capitano '\eterinario e tale Yisita si ripe&e immediatamente prima della loro macellazione.
L'uccisione del bue si esegue colpendo l'animale tra la. base del cro.aio e la prima vertebra cervicale, con stoccata dall'indietro in avanti , in modo da raggiungere il midollo allungato.
Appena abbattuto, il bue è scannato con la recisione dei granrli vasi del collo, in modo da ottenere uu pronto, completo e perfetto disl'languamento dell' animale, il quale poi, spogliato della testa, dei visceri e degli organi tutti, è l asciato sotto pell e, in (rol/alttra almeno per 12 ore.
La frollatura si otterrà più razionalmente ecl igie ni camente qnando sarà costrnt ta la cella frigorifera, ora allo studio, trasportando in questa i quarti di bue e conservandoveli alla temperatura di 4 ' come si pratica nelle fabbriche simili di conserve alimentari straniere e in tutti i matta.toi ben diretti.
Oopo 12 ore i bovi sono ridotti in quarti e disossAti nPl macello interno, sono suddivisi in porzioni non superiori a mezzo chilogramma per renderue p-iù facile la prima cottura. Per lo stesso scopo sono separate le carni di bue di difficile cottura. (collo, escluse le prime tre "'\ertebre, i quarti anteriori ed il costato) dalle parti di meno difficile cottura (muscoli dorsali, della. groppa e della. parte inferiore della coscin.) da quelle di facile cottura ( filetti, punta. di 1'etto e muscoli dell11. parte superiore della coscia).
Queste tre qualità. di carne sono rispettivamente cotte in caldaie a doppio fondo, aperte, con acqua. potA.bile all'inizio d ella. prima oottura giornaliera, e successiv11.mente per altre tre cotture nel brodo bollente, in moclo che 600 kg. di ca rn e in quattro cotture di li'>O kg. sono cotti la prima volta in 75 litri <l'acqua potabile hollente e nelle tre successive nel brodo bollente.
Durante le quattro cotture la carne è sal ata e condita con q uantità. diverse della miscel11. seguente :
Sal m arino
Pepe Garofani .
kg.
g. 60 g. 30
4()1; f:GLLii: SCATOLE'I'TE DI DJ .BUI!: IN f'fl:O:SERVA
Di questa miscela s i aggiungono rispettivamente kg. 3, kg. kg. kg. 1.500 a ciascuna quantita di 150 kg. di carne durante l e rispettive cottur e.
Si ritiene che l a carne abbia raggiunto i caratteri della mezza cottura, quando ò divenuta d i colore rose o -pallido e non sanguina punto, taglia.ta a caldo in varie di r ezioni
La carne è allora. estratta. dalle caldaie e distesa su adatti graticci di ferro zincato, perchè sgoccioli e si raffrE-ddi in parte, indi a caldo, è spogliata dei piccoli ossicini, dei tend ini, delle membrane aponeurotic he e di t u tte le masse di grasso aderenti ad essa.
La carne, così preparata, divenuta del t utt o fredda, è ripartita agli operai incarica t i d i metterla nelle scatolette.
In ogni sca.toletta devono essere posti non meno di 200 grammi di parti muscolari di carne, completamente raffreddata, egualmente ripartita, per quanto è possibile, nelle varie scatolette. Non appena ri e mpinte l.e dette sca.tolette, vi si aggiunge il brodo bollente, ed imdopo esse sono chiuse e poste nelle caldaie a pressione per la cottura definitiva. Il brodo, con cui si riempiono l e sca.tolette, proviene dalle successive cotture della. carne. Esso è digrassato d ella densita di 1000• a 50° C , ed ancora bollente è spinto con pompa entro apposita. conduttura di ferro, sterilizzata ogni mattina col vapore ad al ta pressione e munita di adatti rubinetti e di relativi apparecch i, pel ve rsamento del liquido in ciascuna scatoletta.
Cottttra definitiva. e sterilizzazio11e cleUe scatolette - Nelle calda ie a pressione la carne contenuta nello scatolette è <;Otta e sterilizzata per un'ora alla temperatura di 120°,1) C., quindi le scatolette, ancora assai calde, sono estratte dalle suddette caldaie.
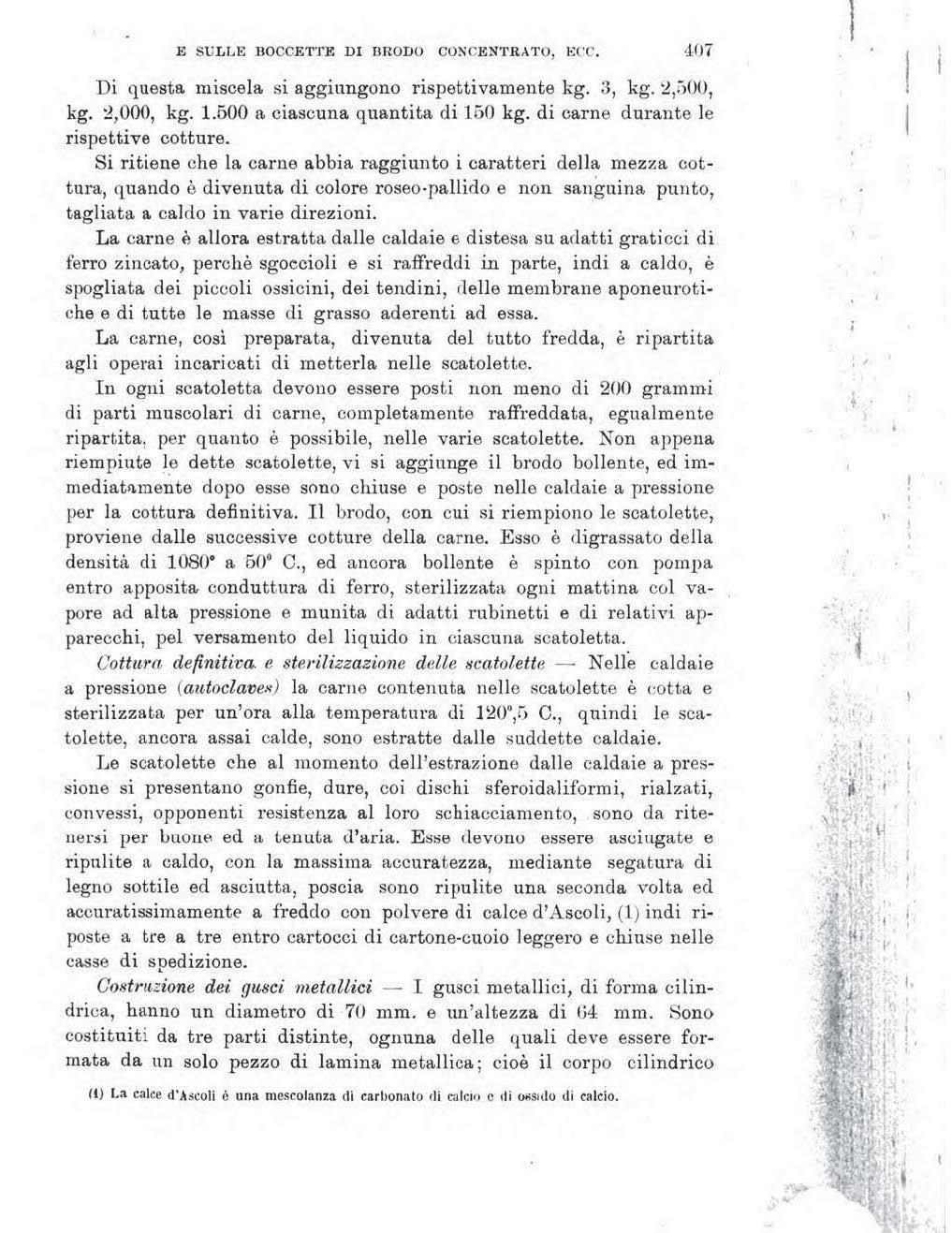
Le scatolette che al momento dell'estrazione dalle caldaie a press ion e si presentano gonfie, dure, co i dischi sferoidaliformi, rialzat i , convessi, opponenti r esistenza al loro schiacciamento, sono da ritener:si per buoue ed a. tenuta d ' aria. E s:se devono essere asciugate e ripulite a caldo, con la massima accuratezza, m ediante segatura di legno sottile ed asciutta, poscia sono ripulite una seconda volta ed a freddo con p olvere di calce d'Ascoli, (1 ) indi riposte a tre a tre entro cartocci di cartone-c u oio leggero e ch.iuse nelle casse di spedizione.
Co.gtl·ttzione clei gusci metallici - I gusci metallici, di forma cilindrica, hanno un diametro di 7U mm. e un'altezza di G4 rom. Sono costituit i da tre parti distinte, ognuna. delle quali deve essere formata d a nn sol o pezzo di lamina metallica; cioè il corpo cilindrico
Il ) La calce d' Ascoli il una m esco lanza di carbona t o rl i calc1n o rli 01>S1do di ta l cio.
E SULLE BOCCETTE DI DRODO CONCENTRATO, ECC. 407
l ; J . & .,
e duE' disrhi ci r co lari, costituenti rispetti,·amen te il fondo ed il coperchio
La l11ttn è d i prima qualità, preparata con stagno puro e priva affa tto <li arsenico, di piombo e di zinco, f a bbricata al carbone di legna, soda, duttile, malleabile non arida nè fragile, omogenea, be n Ja.minata e le,·igata, senza gromma od perfettamente stagnata. n. doppia stagnatura trasversale e \erticale, senz a s f a,lda.ture o denu da7ioni d i sorta, ed esente da qualunque traccia di ru g gine. Deve e:>sere della marca Chm·coal , nazional e od estera.
Per i l·ilind ri de i gusci deYc avere l a spessez za di mm. 0,30 a 0,32 e pesare da. k g. 2,350 a kg. 2,4o0 p er metro qnadra.to. P er i fomlelli e l'Ope r c hi deve avere la spessezza di m m. a 0,27 e pesarC' da k g . 2,050 a kg. 2,1il0 per metr o quadra.to.
Lo stagno deve essere fino, puro, in pani, dello .Y f1·etto.
Il co rpo è formato da una l am in a di la tta re ttA.ngolare, dell'a ltezza di 70 mm. e dfllla lun ghezza di mm. 22!) '/2 arroto lltta e co ngiunta ai. fluoi due lat.i corti.

I f0gli di latta, che servon o pe r la preparazione dei cilindri, sono prima sq nadra t i, poi tag li ati in tanti rettan go li. de lla lunghezza d i mm. e dell'a l tezza tli mm. 70. Ques ti r ettangoli. p oi so n o arr otolati con macchina c ilindratrice e q uindi aggraffati co n macchinA. nggraffatriee.
A ciascunA. tlelle basi del cil ind ro cosi formato A costi tuente il corpo della scatol etta è praticato un bordo pieg11oto ad angolo quas i r etto, dell'altozza di rom. 3 circa., media nte macch ina bordatrice. linea di <·onginnzion e è saldata accu ra tamente mediante salclatOio a gas con puro stagn o ed usancl o per mordente la stearina.
I due dischi, cioè il fondo ed il coperchio, sono del diametro ùi rom. 8!> co n ri salto e dne corone opposte, stampa ti co n matrice e punzone, portatP dalle r e la t.ive tmnce.
G li A. n e llini di can cc iù, che servon o per assicurare la c hins urn. erm etica delle scat o lette, sono lunghi mm. 230 circa e d evono avere il peso di centg. lì2 c iascuno.
'l' ali anellini sono applicati a caldo- con macchina speciale a rotazi o n e n e l l ' angol o del risa l do dei fonde ll i e dei coper chi.
Con macchine aggraffatrici è riunit o il fondello al co r po del cilindro . Quanù o poi il gnscio è riempinto con 200 grammi. di carne a me zza cottura e con 20·30 grammi di brodo concentrato, è aggraffato il coperchio con altra macchina aggraffatrice.
La scntoletta a.ggTa.ffa ta è di gran lunga su periore a <ptella saldA.ta., sia da l lato igieuic0, come da quello economico.
40H Sl:LI,F. SCATO LET1' 1!: DI CA!tNE Df Bt:E
Le prove istituite colle due specie di scatole hanno dimostrato che l'una e l'altra, se ben costrutte, poste sotto la campana di una macchina pneumatica, non dànno luogo ad alcuna perdita di brodo, nè diminuiscono di peso. Si possono perciò considerare a completa tenuta d ' aria. Per le scatole aggraffate v ' è da notare che l'anellino di caucciit disteso sui fondi e sui coperchi, non si modifica. punto per l'azione di alte temperature Una certa quantità di esso, tenuto per più ,di due ore nell'acqua alla temperatura di 125° C, d opo il raffreddamento ed il prosciugamento tutti i suoi caratteri primi ti vi . Sottoposte l e due specie di scatolo agli effe tt i della pressione idraulica mediante adatta pompa, per determinare la resiste nza del loro involucro, si potè che le scatole delle d u e specie, senza differenza notevole fra di loro, resiston o ad una pressione interna a freddo di 3 atmosfere e mezzo per centimetro quadrato . A l cune scatolette resistettero sino alla pressione di 5 atmosfere .
Per provar e l'effetto che pote va produrre in esse la forza viva di urto. si fecero cadere l e scatolette dall' altezza dJ due metri od inoltre si produssero artificialmente diversi urti di uguale forza jn molti punti della scatola e si potette determinare che tali urti non sono in massima molto no civi tranne che quelli in vicinanza ai due punti in cui l'aggraffatura de l c ilindro è unita al fondo ed al coperchio per le scatol e aggraffate e quegli urti sul fondo o sul coperchio, fatti in vicinanza delle saldature per le scatole saldate.
Passata un'acc urata v i sita a. circa 10000 scatole aggraffate, ch e erano state portate dai soldati nello zaino durante le grandi manovr e, si riscontrarono in esse pochissime ammaccature.
Da tali prove si conchiude :
l" Che l e due qua l ità di :;catola hanno la stessa resistenza;
2° Che quell e aggraffate resistono agli urti megli o delle saldate, essendo p rotette dai due b ordi sporgenti.
Rap idissima poi è la costruzione dei gusc i metallici aggraffati, esegui t a per l a massima pa1-te da ragazzi. Con al cune macchine, come ad esempio con le cilindratrici, le bordatrici, il lavoro si esegue con tale velocità, che le rjspett ive squadriglie di operai rimangono spesso inoperose in attesa di nuovo lavoro. Il ritardo è quasi sempre cagi onato d ai saldatori dell' aggraffatura verticale dei corpi c ilindri c i.
Per ottenere la completa chiusura ermetica delle scatolette è necessario ch e l'anellino d i caucciù disteso sia chiuso esattamente nella aggraffatura, e che non lasci interruzione di sorta nel margine circolare.
P er d iminuire il numero di scarti , che in lavorazioni ben dirette non deve superare il 2 per cento, serve molto bene in sostituzion e

E SULLE DOOCETTE DI DRODO
COX('f.:XTRATO, E C C 409
degli anellini di caucciù, la pasta .Jms costit,nita da un cemento e da. amianto , la quale è distesa in modo uniforme su tutto il margine esterno dei fondi e dei coperchi con macchine speciali della casa E . W. Bliss e degli Stati Uniti d'America.
)la la s<:a.toletta aggraffata supera di gran lunga quella saldata per la. facilità. con coi il bro1 lo è ' e r;;ato nella. prima, a. coperchio aperto, mentre nell11. seconda dE'n Pssere iniettato attraverso un fo1·ellino capillare, con grande dispersione del liquido e con perdita di tempo e nnmero considerevole di scarti, percbè è poi necessario di otturare il detto forellino con goccia di stagno, operazione sempre delicatissima e di facil e successi,·a avaria durante la cottura definitiva delle scatolelte a 120",5 C. scatolette il contenuto non trovasi a contatto che con lo stagno purissimo della. latta, mentre nello saldate Io stesso co utenuto è a contatto con la lega di stagno e di piombo.
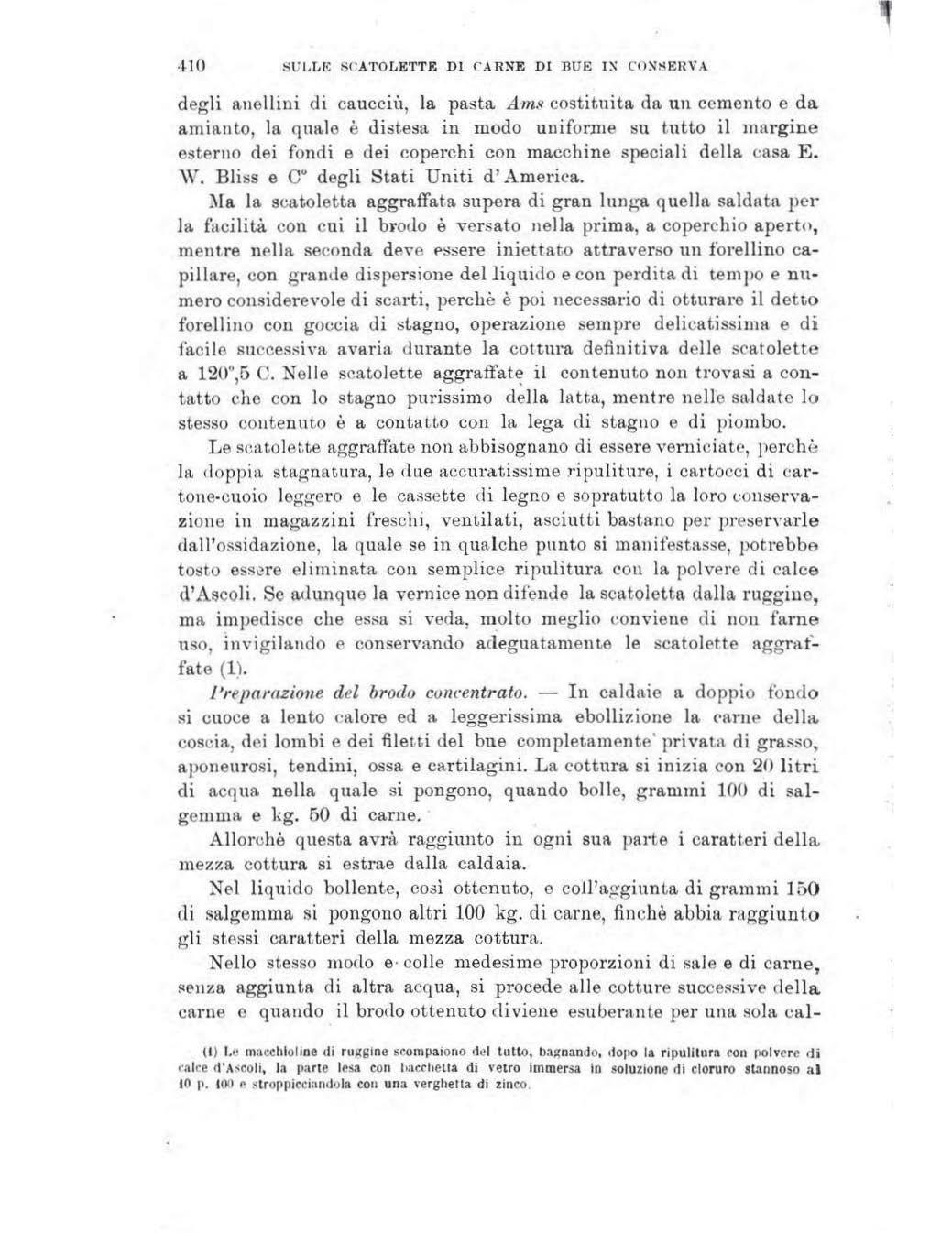
Le s1;l\.tolette aggraffate non abb i sognano di essere vemi c iate, perchè la doppi,• stagontura, l e tlue .-wcmatissime 1·ipuliture, i ca,rtocci di cartoue-cuoio legge ro e le cELssette di legno e sopratutto la loro t:onserYazione in magazzini freschi, >entil ati, asciutti bastano per prese n·arle clall'o:;sidazione, la qualo se in qua l che punto si manifestasse, potrebbe tost o eliminata coa semplice ripulìtura con la polvere di calce d'A11coli. Se a•lunque la vernice non difenJe la scatoletta dalla. ruggiue, ma impedisce che essa si molto meglio co nviene di non farne u so, itH'igila.ndo e conservando adeguatamente le scatolette aggraffate ( l ).
/'r eparazio ne d el brodo cuncentralo. - In caldaie a doppio fondo s i cuoce a lento c·alore cd a leggerissima ebolli?.ione la C'arne della. coscia, d ei lombi e d ei fi le1ti del bue completamente' privat;\ di grasso, aponeurosi, tendini, ossa e cartilagini. La cottura si inizia con 20 litri di n.cqua nella quale si pongono, quando bolle, grammi 100 di salgemma e ],g. 50 di carne.
Allorchè questa avrà raggiunto in ogni sua parte i caratteri della. me7.7.a cotLura si estrae dalla caldaia.
Nel liquido bollente, così ottenuto, e coll'a.g-giunLa di grammi 150 eli salgemma si pongono altri 100 kg. di ca,rne, finchè abbia raggiunto gli stessi caratter i della mezza. cotturn..
Nello stesso modo e · colle medesime proporzioni di sale e di carne, aggiunta di altra acqua, si procede a l le cotture succef-li<ive della carne o quando il bro(lo ottenuto diviene esubemnte per una sola cal-
(l ) 1.•· macc hlolooe di olc l tutto, bagnando, o!opo la riputlturn ron polvere di ra lre rt'A,coti, In parte con ,,,aheua di •'etro immer>a In soluzione t! i cloruro sl.1.nnoso a l IO l'· 100 s troppiccoantlu ln con una verghetla di zinco
.j.JQ
SUI,LIO: SC'ATOLETTE DI \ARNE DI RUE
dai a, s i veraa in altre caldaie nelle quali si eseguiranno altre cotture di carne.
Il brodo in tal modo ottenuto, addizionato del 3 V. di sugo d'arrosto di volta. in volta preparato, è versato in vasche metalliche ben stagnate, a doppia parete, sterilizzate prima con vapore ac que o ad alta pressione.
In dette caldaie il brodo è tenuto alla temperatura di SO• C. pe r circa due ora per la separazione del grasso e quando questo sarà asceso alla. superficie del l iquido, si spilla. il brodo dai rispettivi robinetti di scari co e si versa su filtri di lana., tenuti a. caldo in apposito apparecchio, per il digrassameuto.
A.llorc bè poi dai filtri, per operazioni ripetute, il brodo esce completamente limpido e di colore giallo-citrino, si immette per aspirazione n e ll'apparecchio concentratore a vuoto ove è condensato, operando alla. temperatura. di 4;;• e con una rarefazione di ()f> centim.
Dopochè il brodo avrà raggiunto nell'apparecchio la densitli di wso· c. alla temperatura di c., ancor caldo è introdotto nelle boccette di vetro, ben pulite e sterilizzate, per la durata di un 'ora, a lla temperatura di 110" C.
Le boccette di vetro banno sul collo, a 2 cm . circa dal margine libero, una particolare strozzatura con sporgenza n el lume intemo di un cercine c ircolare, ove si adatta. un dischetto di gomma rossa, sterilizzata, di ottima q ualità e sopra. di esso si applica s ubito un tappo di sughero di Spagna, finissimo e compatto pure sterilizzato. Il tappo di sughero è fermato alla. boccetta. con filo di ferro stagnato.
Immediatamente dop o l e boccette subiscono una prima sterilizz azione alla temperatura di 85-90" C. per la durata di un'ora e n e i due giorni successivi, a. distanza rispettivamente di 24 ore, altre due sterilizzazioni: la prima all a temperatura di 8 5 a 90" C. per la. durata di 30 minuti e la seconda alla temperatura di 80 a 85• c. pure p e r 30 minuti.
Terminata la terza sterilizzazione l e boccette sono paraffinate e pescia avvolte in carta p ergamena. e in c arta da imballo e quindi riposte cassette di s pedizione.
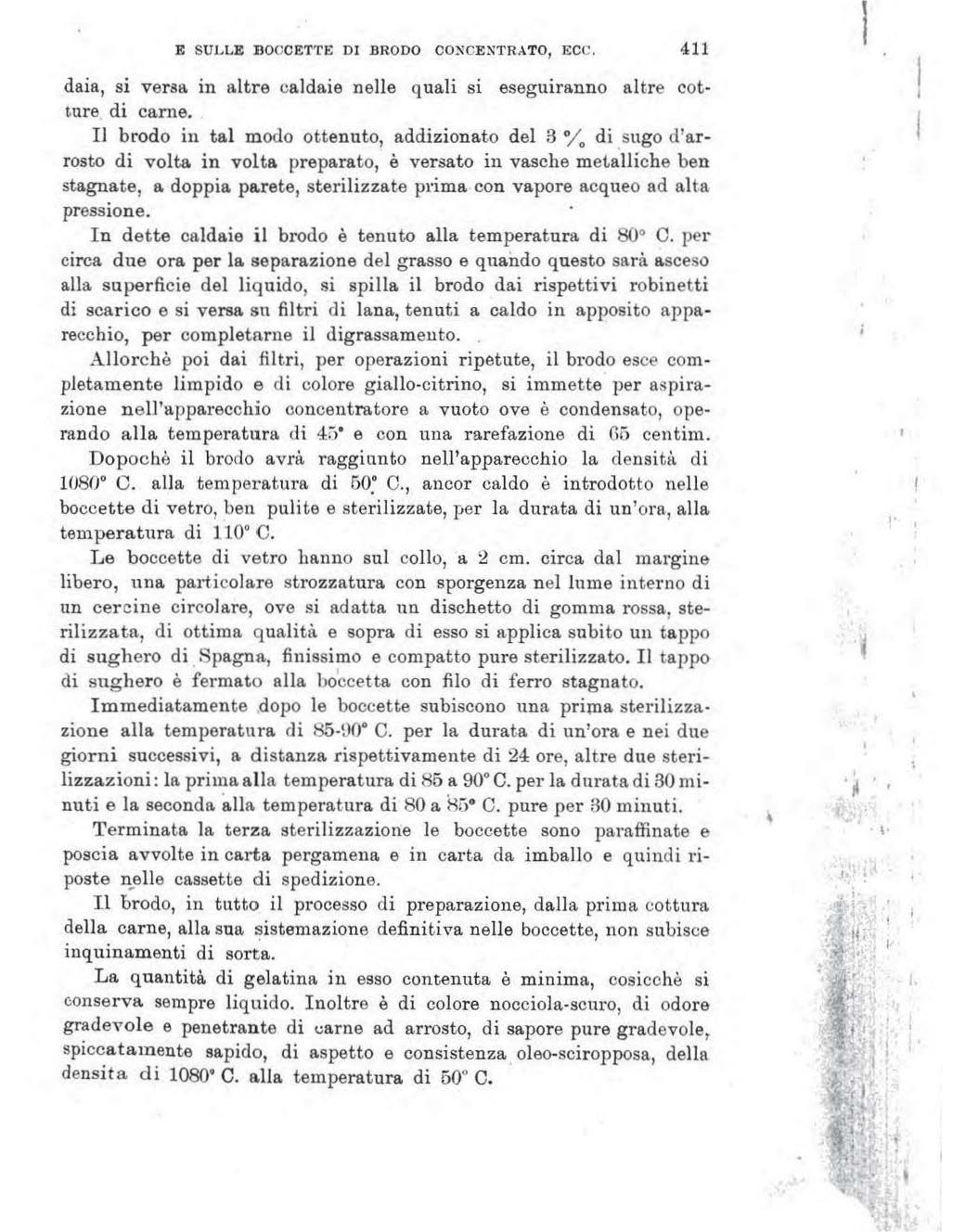
Il orodo, in tutto il processo di preparazione, dalla. prima co ttura. della carne, alla s ua s istemazione definitiva nelle boccette, non subisce inquinamenti di sorta.
La quantità. di gelatina in esso contenuta è minima, cosicch è si conserva sempre liquido. Inoltre è di colore noc ciola-scuro, di odore gradevole e penetrante di r..:arne a.d arrosto, di sapore pure gradevole t spiccatamente sapido, di aspetto e consistenza oleo-sciropposa, della densita di 1080" C. alla temperatura di 50° C.
E SULLE DOCCETTE DI BRODO COXCENTRAT01 ECC. 411
.. l • t ,.
Per brodi ristretti si di l uisce in acqua bollente nella. proporzione di 1 a per brodi ordinari di l a 18 coll'aggiunta di un po' di sale.
Questo brodo si prepara principalmente per malati in circostanze -di mobilitazione e di guen-a ed è assai bene adatto al suo scopo ( 1)
XonJJ.E PF.R LA F'ABDRICAZIOXE nELLE co:-:sE:RVll: DI C'AR:'\E. - Per la sistemazione completa di una fabbrica di con:;erve di il professore Yaillard ( 2 ) raccomanda:
1 ° Vigilanza sanitaria. degli animali destinati alla preparazione delle conserve;
2• La. proprietà o piuttosto la purezza, l 'asepsi dei processi di fabbricazione;

ao La sterilizzazione rigorosa delle scatolette.
I. J'igilanza sanitaria degli animali alla p1·epar(lzione delLe - A Casaralta la vigilanza. su tutta la lavorazione è completa. E ssa è ra-ppresentata da due commissioni mi l itari, l'una. di vigilanza, l'altra di collaudazione .
Fanno parte della commissione di vigilanza un capitano med i co, un capitano veterinario, quattro ufficiali commissari, l'ufficiale co n· tabile consegnatario dello stabilimento, un farmacista militare ed un capo-tecnico '"l'artiglieria. Questa commissione è posta sotto gli ordì n i del direttore tecnico, il quale la ripartisce in modo che le varie operazioni, di giorno e di notte, siano sempre invigilate rigorosamente. J...a commissione di collaudazione, la quale esamina i prodotti prima della. l or o accettazione definitiva, è costituita. da un ufficiale superiore, presidente, da. un ufficiale superiore medico. commissario, vete r inario e da un capitano commissario, segretario. .
JJaci. - La razza. di buoi preferita. e aùoperata. quasi esclusivamento per le lavorazioni di Casa.ralta è quella. bolognese e delle Romagoe, decantata per la delicatezza e la bontà della. carne, e per la. proporzionale ed armonica struttura dello scheletro."In queste regioni mollo olovata. ò la quantità dei bovi; il peso medio dolla. oa.rne dei buoi di pianura in quarti è di kg. 400, quello dei bovi di montagna. di kg. 380
Alle razze bolognesi si avvicinano molto le veneta di Cittadella. e del Friuli, quelle m archigia.ne, e speciaimente le toscana della Val di Chiana, quest'ultime con carne finissima e costruzione rego l are dello su heletro ed enorme peso dei quarti, in media 600 kg.
{!) :-;el prrft•zìooamentl per la preparazionP. del brodo conrentralo mi è utilissima lt1 Cùllabora1ionp del dlslinto farmacisL'l miiilare signor Francesco Vaccaro, al quale p!orgo sentlll mentl.
(t) VAILLARD. - t.es constrvt& de viande. ( llevue d ' lluglène et de pollce •anllaire, gennaio e r..lJ. òralo 190l)
-112 SULLE
SCATOLETTE DI CARNE DI BOE CONSERVA
Nelle razze pia.centina, parmigiana e modenese, trovansi bovi con carni delicate, di peso molto elevato, in media 400 kg. in quarti, ma in esse predomina spesso la tubercolosi.
Nei bovi che si macellano a Casa.ralta. rarissima è la. tubercolo.;i e 'utte le alterazioni patologiche che si riscontrano nei visceri si riducono per lo più alle cisti da echinococco, frequentissime nel polmone e nel fegato, rare nella milza. e nel rene. ·
Dalla lavorazione sono esclus i assolutamente i bovi tubercolosi ed in generale tutti i bovi malati per affezioni piemiche, setticemiche, enteriti ed in generale anche se semplicemente febbricitanti. Sono parimenti esclusi tutti i bovi rifiniti dalle fatiche o semplicemente stanchi da lunghi. viaggi. Questi ultimi nou si macellano se non dopo un riposo di uno o due giorni.
Tali precauzioni sono del tutto n ecessarie perchè i veleni della. faticn. (leucoma.i ne) e l e tossi ne dei microrga.nismi patogeni, sopratutto di quelli piogeni, non sarebbero completamente distrutte nelle due cotture della carne e potrebbero rend ere le conserve poco gradite, di difficile digestione ed anohe nocive, uagionando disturbi gastro-intestinali.
Sulla scelta adunque dei bovi nella fabbricazione delle conserve italiane di carne non v'è nu\ln. da. osserva re, perchè è ottima sotto tutti gli aspetti.
II. La proprietlÌ o la purezza. l'ci8epNi dei di fabbricazùme. - Questo sublime ideale potrebbe ra.ggiungersi soltanto quando si potesse di celle frigorifere ben costrutte, nelle quali il raffreddamento si ottiene con la. liquefazione dei vapori di am· moniaca o dell'acido carbonico e di locali in t;UÌ potesse consen·arsi asettica.mente la carne cruda e cona e di nn personale ben istruito, in cui massimo fosse il cu lto della. nettezza.
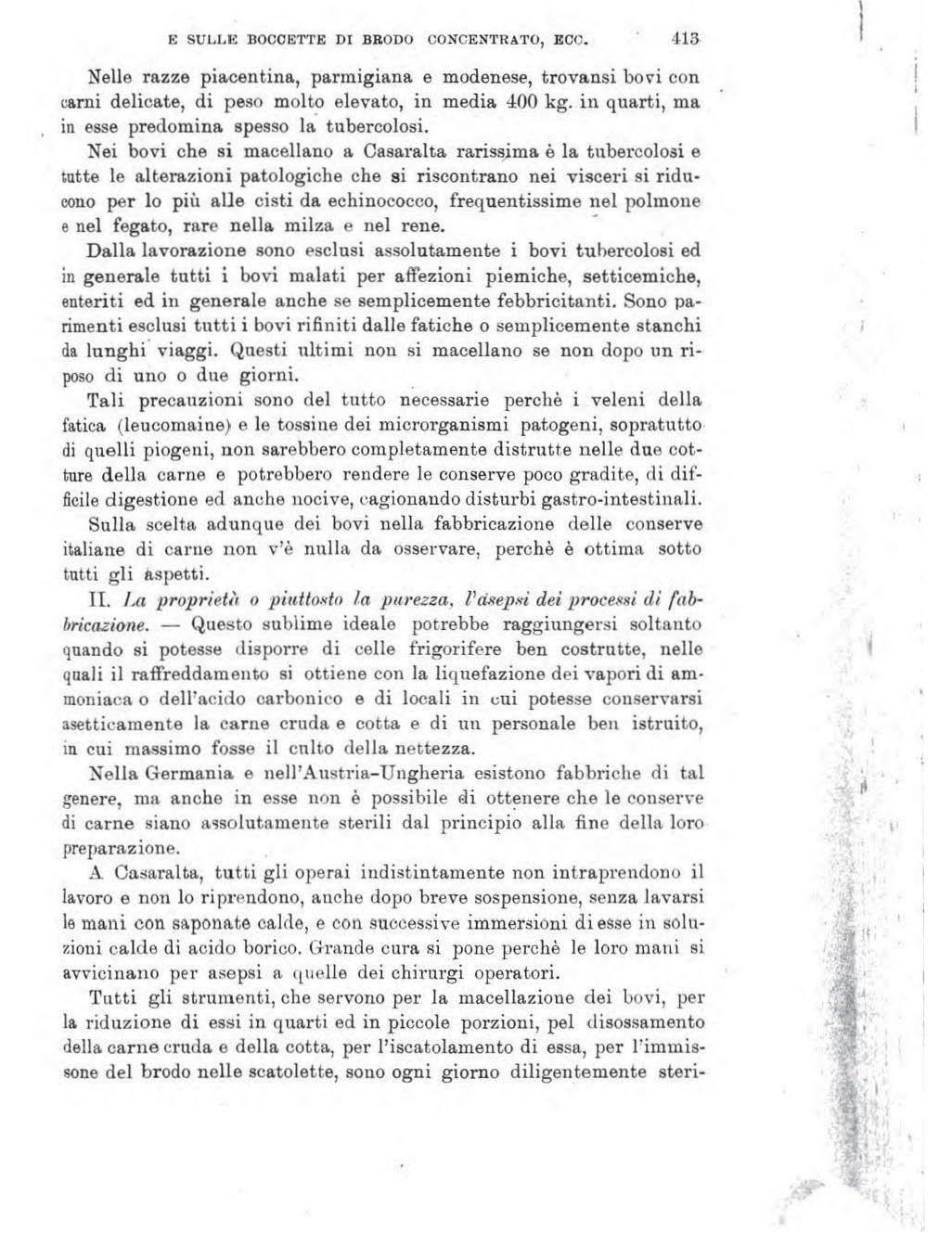
Germania. e nell'Austria-Ungheria esistono fabbriche di tal genere, ma anche in esse non è possibile ài che le consen-e di carne siano a<>solutamente steri li dal principio alla fine della loro preparazione.
A Co.:laralta, tutti gli operai indistintamente non intraprendono il lavoro e non l o rip1·<>ndono, anche dopo breve sospensione, senza lavarsi le matli con sapouate calde, e con successi,e immersioni di esse irt soluzioni ca lde di acido bot·ico. Grande cura si pone perchè le loro mani si avvicinano per a <Luelle dei chirnrgi operatori.
Tutti gli strumenti, che servono per la macellazione dei bovi, per la. ridnzione di essi in quarti ed in piccole porzioni, pel disossamento della. carne cruda e della cotta, per l'isca.tolamento di essa, per l'immisso ne del brodo nelle scatolette, sono ogni giorno diligentemente steri-
1:-.: SUL.I.E DOOOE'l'TE Dl .BRODO CONCENTRATO, ECO. 413
lizzati nell'a cqua bollente addiz iona ta d i carbona to di sodio come si pratirn. per gl i istrumenti chirurgici. Gl i operai devono inoltre avere i capelli t.1gliati corti e la barba rasa. e ad essi son o rinnovate vestaglie di lnxo ro 'lua.si ogni giorno.
) l a non astante tali pre::auzioni rigo r ose, la carne si infetta durante la ma cellazione dei bo,-i e durante la. frollatura di e:isa per specie di mi c r organismi fra. i qual i predominano il carulican.-< e lo piogenex a/bus e varie specie di bacilli . . \i suddetti, che si m oltiplicano grandemente durante la frollatm·a la qual cosa non a v\-errebbe se potesse disporsi di cella frigorifAra. si nelle operazioni successi ve dell a riduzione dei l•ovi in q narti ed in piccole porzioni , lo au.reu .-, il tetragenus, la sarcin a alba ed altr i.
Tu tt i questi germi sono d istru tti, ad eccezione di quelli s p o r ifi c ati, durant e ln. prima cottura della carne, però una seconda invasione di mic r(\rgau ismj più nume r osa e peri colosa vPgeta. sulla carne cotta si n o ali n izzazione defin i ti v a. Nell e porzi oni di Clu·ne che hanno subito la. prima cottun1., posta sui tavo l i dì marmo pel ra.ffrelldamento varie s p ecie di cocchi, i l bacillo del pseudo-totano, stnph!Jl.()j}!JI)IjCI!es il bacillus albus, il bacterilHn ed una pa.rtil·olare 1·eptotri.r (G r i x o ni).
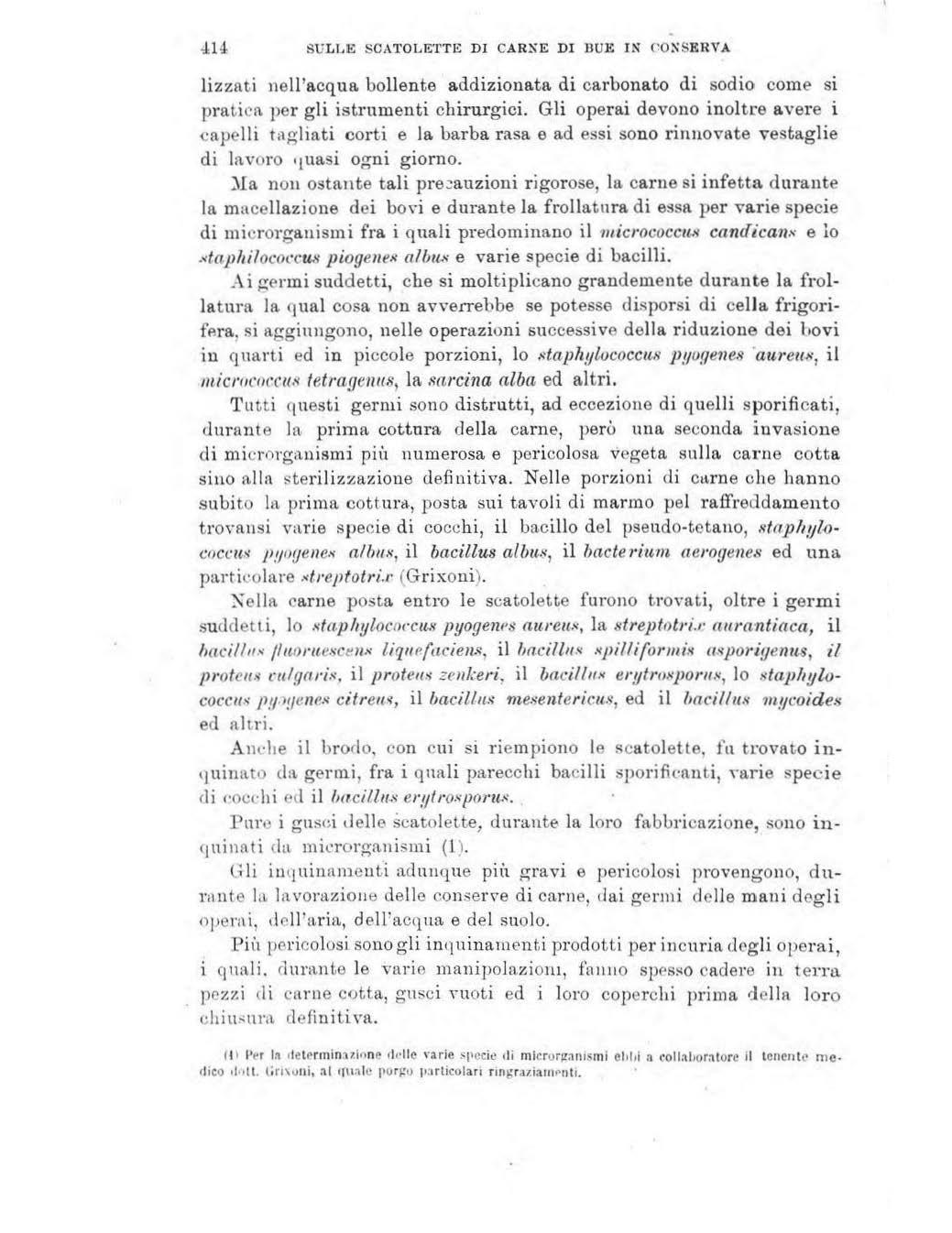
XellR. rarne posta entro le sc ato l ette furono tro,·ati, oltre i germi suddetli, lo pyogenf'S mtreus, la strepfl)tri.•· am·antiaca, i l hat'illn• i l spilli(ormi11 il proteu.-1 il proteai zen l·eri. il bacil/u.< lo .ilaphylococcu• il ed il bacillus 111,1JCOides ed altri.
Anl"he il brodo, con c ui si ri e mpiono le scatolette. fu trovato inIJUinatt) cl:\ gertni, fra. i quali parecchi bacilli sporifknuti, 'arie spet:ie di c·oc..a·hi etl il lm ci!lus er.'/lro.•poru.,.
J>nr•' i gnsei delle sca.tolette, durante la loro fA.bbricazione, sono inqninl\ti da mil'rorgn.nismi ( l ì.
lili iuquinnmcnt,i adnuqne pi\1 gravi e pericolosi provengono, dul"ante lu. lavo razion e de l le co n ;;erYe d i ca.me, dai germi de'Ile mani degli O[Jemi. d <' ll'aria., dell"ac<pta e del suolo.
Più pericolosi sono gli inqui n amenti prodotti per incuria dogl i operai, i qnali. (l urant e le vario manipo laziolll, fa11110 cadere in terra )Jt'Z7.i di carne cotta, gusci Yu oti e d i loro coperchi prima rl e lllt loro clefinitt\'11..
l lt 1.1 l'arie -peciè do eloloo a •l tcnenL,• mc. <hCI) ol• olt. l ofl\lllli, fJll1lr (IOfJ!Il J!,triÌCOiarl
414 SULI.E SCATOLETTE DI CARNE DI DUE r N C'OXSB RVA
La mo l tiplicazio11e de i germi contenuti nel brodo e nella carne chi usi nelle scatolette sarebbe enorme, se non \t si ponesse subito rimedio con la cottura e steril izzazione definitive.
P er regvla generale a Casaralta le scatolette appena riero p i ute di carne e di brodo sono chiuse e poste nelle caldaie a pressione (autope r la lo ro cottura definitiva ed il tempo che passa fra la prima e la seconda cottura della carne è in media di 6 ore. I n tal modo è possibile di porre un limite alla moltiplicazione di microrga.nismi contenuti nelle scatolette e rendere difficile la loro sporificazione.

Xelle ltworazioni da me dirette tutto i l pr ocedimento fu così rapido c he dalle fi del ma t tino a lle r:, del giorno successi\O le carni d i r,o bo>i furono sistemate definitivamente nelle scatolette
IIL La rigo,·o.,·a delle scatolette. - Per ott.cnere una sterilizzazione completa delle scatolette di carne bisogna tener presente l a regola seguente, ammessa da lungo tempo nella tecn i ca bacteri ologictt.
Ogni sostanza che è por tata e mantenuta per venti minuti a ll a te m peratura di L! o" C. o per 15 minuti alla temperatura di 120",5 C. 1n.pore acqueo sotto deve essere tenuta per rigorosamente 8terile. Tali temperature non modificano per nu lla il valore della carne o la resistenza del metallo delle scatole t te (l ).
Il pro f. E P fuhl, (i ) studiando coi suoi collaboratori dott. H. Bisc hotT
E' dott. \ Vintgen la penetr azione del calore entro le scatolette di carn e di Ime, dimostrò che per ottenere un a sterilità completa, st>nza alterazione delle qualità organ olettiche ed alibili della carne, le scatole del contenuto di GOO g rammi devono essere tenute alla. temperatura di l C. per 70 minuti primi e qu e ll e di :WO grammi alla stessa tempe ra tu ra per 50 minuti primi.
Tal i ri:mH ati sono stati recentemente confermati pure in Fmn<:ia
Yaillard • .
I dPlicati ed ingeg nosi esperimenti del prof. E. Pfuhl hanu o elimostrato cbo la te m pflratura. nel rentro della carne, posta i n iscatole !li tre porzioni o del contenuto di oOO gmmmi, raggiunge !l!l0 ,75 C. dopo .:J O minuti, llfi",2:i O. dopo 7@ minuti primi.
Gli esperimenti furono eseguiti colle perfezionatissimo caldaie a costrnttEl dalla Sch wabeuthan e C. 0 di J:lerlino. gsse sono lli 1·ame, a doppio fondo, co n circolazi one esterna eli Yttp ore, munite rli d ne termometri e di due manometri, n no dei q nali r rg i strator e.
( I l VAl LLA un. - /,11 d e via n de. d dt ptrlire lome X X IV, u. . .!t1 ft·,•rif'r HlOi, Il i ).
F:. PF UHr. - dr t .llt•mng tle•· Temp r ralur:rmaltm e. hr die in Comprol · riontl>r«•l u sle>·ilid•·l wtrdtu.
E SlH,LE DI D RODO CONOE.NTnAT01 E('C'. 415
{ • !
T,e caldaie a pressione esistenti a Casaralta hanno un sistema di funzionamento alquanto primitivo, poichè il vapore acqueo, ad a lta pressione, penetra direttamente dal fondo nell'interno di esse P e rò le esperienze eseguite durante la passata lavorazione del febbraiomarzo d i quest' anno. con piccoli termometri graduati da no a 130° c. posti entr o la carne delle scatolette, banno dimostrato che dop o 20-30 m inu ti in cui il term ometro indicatore segnava 120°, 5 C., i p iccoli termometri posti nell' interno della carne seg navano in tutti gli strati delle scatolette, del contenuto d i 230 grammi ciascu na, la stessa temperatura di 120°,5 C., l a quale si mantenne invariata an ch e dopo 4<1-50 e GU minuti . ·
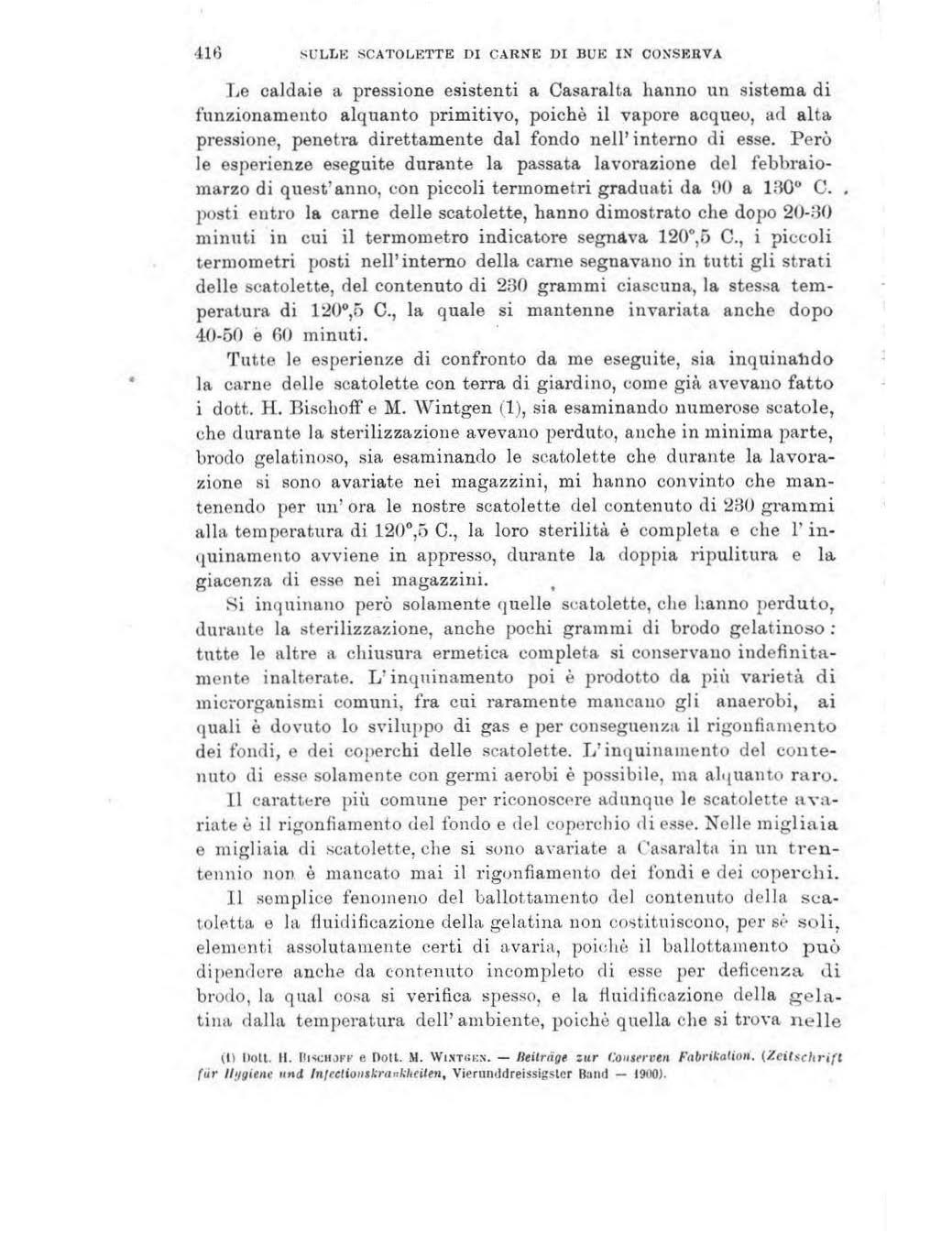
Tu tte le di confronto da me eseguite, sia inquinabdo l a ca,rn e d e lle scatolet te co n terra di giardino, co me già av e vano fatto i dott. H. Bischoff e M. Wintgen tl ), sia e saminando numerose scatole, che du ran te la sterilizzazione avevano perduto, a11che in minima parte, brodo gelatinoso, sia esaminando l e scatolette che d nrante la lavorazi on e si sono avariate n e i magaz zini , mi hanno convinto che mantenendo per u n' o ra le nostre scatol ette del co ntenuto di 2HO grammi alla. temperatura di 120°,5 C., l a loro steri li tà è co mpleta e che l ' inquinam en t o avviene in appresso, durante la doppia ripulitura. e la. gia.cemm di esse nei magazzini. ,
Si in quinano però solamente q u elle scatolett e, che l:anno perd ut o, ùuranle la sterilizzazione, anche pochi grammi di brodo gelatinoso: tnt te l e a l t re < t ch ius ura erme t ica com pleta. si indefin i tam ente inalterate. L" inquinamento poi è prodotto d a più varietà di mici·orga.nismi co muni , fra c ui raramen te mancano gl i anaerobi, ai q uali è ùo,·uto lo svi l uppo di gas e per consegnemm il rigonfiamento d ei fondi, e dei coperchi delle scawlette. L' iuq u inamento de l con tenuto di es:lC' sol am('nte co n germi aerobi è possibile, ma al•tttanto ra r o .
]l caratLe re più comune pe r ri conoscPre adunqnll l e scatol et te a.Yari ate tl i l ri gonfiamento d el fondo e de l copPrchio 1l i e;;se. Nelle migliaia e migliaia di scatolette, che si suno a\·ariate a l'asa. r altn in nn tre ntennio non è mancato mai il rigonfiamento dei fondi e dei coper c hi. li sempli ce fenomeno d el ballottamento del co ntenu to Ù('l]o. o fluidifi cazion e della. gelatina non co.;titni scon o, per si· ,:;o li, el emon f,i asso lu tameute certi di a varia, poÌ•;Itò il ballottamento può dipendure da contenuto i ncompleto di esse p er ù eficenz a ùi broclo, la qu al cosa si Yerifica spesso e la fluidifi cazione de 11a ge latina dalla temperatura de ll'ambi ente , p o ich e q nella che si tront nelle
111 Oott. 11 rto <ctt JFY e Oo ll Id. - Reilrngt l:ouur·ven Fnbrikoliou. (Zeit ..cltri{t {u r 11!11/ietae und l ll(rcliouakrn nklt t iltto, Vi eru ntldrei$sìgsl cr &·md - 19il0).
411) SCATOLETTE DI CARNE DI BUE IN
nostre s ca.tolette proviene unicamente cl al tessuto congiunti ,·o, gelatinizzato durante la cottura, d efi niti\'a a C.
qn incli una. g e latina a:;sai molle, di colore giallo-citrino co mo l'ambra. o c he a 18'' C. diviene liquida. poi la scatolotta. ò costituita. da parti di c arni pre ,·ale nte m eute musco lari, co mo sono quell e dei filetti, dei l o mbi, d ('lla parte superiore de lla cc,scia, la t!uantiLti. della gelatina. è cosi piccola che n on bastll. a far comlen:mre il brodo contenuto n e lla sca.toletta stessa ed allora il fenomeno del ballottamento si osserva fin da princ ipio indipendenteme n te da qualunque avaria.. Hi eo mpreude qu indi fac ilm e nte c ome il fenomeno della Jlnidificazione del brodo e della gelatina, per sè solo, non abbia grando importanza. Di fatto, in estate, per poco c he la temperatma nei Hlll.· gazzini in <.;Ui s i conservano l e scatolette raggiunga. o superi i 18" C., la gel at i 11a ed il brodo di esse dive rranno liquidi o spesso non xi addenseranno più n e lle :-;ucce:>sive stagioni fredd o, come avviene Jl('ll o nostre gelatine di laborat o rio, per usi hatte r io logici, c h e, liq u efaccndo:s i in estate, noH si rapprendono più n e lla snccessiva sLagiono invernale e neppure a ll a t e mpe ratura di 0"

N e i campi o noli e grandi manov r e es t i v e l o scatul&t.Le po rta tu e ntro gli zaini dai soldati, ba.llottcn\nno tutte per il rammollime11tO o la liquefazione della gelatina senza essere a\'ariale .
Co nsig lierei quindi di non far aprire l e sca.tulet.Le per dubbio di avaria, so non sono, an c h e in minima parte, rigonfìate, o so n o n o,;ahL dal conten uto di e:;:se odo r e. Per le scatolette c h e presentano il sPmplice feno meno del ballottamento e d e lla fluidificazione ge· latina, affide rei il giudizio defi nì ti v o al c ri t orio del medi co che dovrà ' ' isitarle, quando saranno aperte por la loro co n'iuma;r.io ne.
V ALOI!E :'\UTIHTIVO DI!:LE '-CATOLETTE IH C.\ H'\ l DI DUE IN ! ' OXSI!:II\' A.Il Peller in ( l ) nel lH!l!l e-;egui ri cerche chimiche sulle co ns erve ameri can e di cam e c h o s i usavan o s ino a poco t e mpo n e ll ' esm·cit.o fran ccs&. Le :scatole erano piuttos t o poichò c iasc uua. servi va per :-, razioni e co ntcn e Ya HOO gra.mmi di o :.WO grammi di brodo.
U valore nutritivo d e lle co nser ve fu dete rminato c himicttm e ntc , separando l e sostanze prote i che sol ub i li d<tll o insol ubil i ne ll'acqua.
Dalle suo r icerc h e l ' autore giunse a lle segue nti coucl usioni:
l " L e conse rve di carne amer icane co r r i spondono al pe so de ll a came cruda necessaria per fabbricarle;
2• Il loro contenuto in materie azotate è teoricamente c prati-
(l) Rocerche chimicloe Jull e conserve <Wttrictlllt <l i Clll'llt. (1/ev ue <1' /ly9iiu e fl<!lace su ><il(ure. :lo• o u obr e 18:19, n. IOJ
:!7 - Giornale med ico.
l!: UOCOETTE Dl BRODO !'ONCE:-<THA'l'll, l•:n·. 417
È
camento quasi uguale a quello della carne di bue, di c ui rappresentare il peso;
:) 0 8e si separano e si pesano le diverse sostanze albuminoidi di •fU('<>te conserYe s' incontrano d i fferenze grandissime in rapporto a lla. l oro r.atura e proporzione. Queste differenze dimostrano che conser-çe pre parate a soli due anni di distanza. non possono più fra l oro, poichè le une (conserve del 1894) ci oè dopo 5 a.nni dalla l oro preparazione, sono veri alimenti e le a l tre (co n serve del 1892) dopo 7 anni, non banno più al c un valore nutritivo.
Vàilla.rd (l ) non dà grande importanza alla vecchiezza delle co n:-;erv e e sostiene che una conserva ben preparata in principio, non subirà alcun mutamento col tempo, resterà inalterata.

Dalle sue impor ta ntiss ime ric erche egli conchiude che le conserve di <"arne possono divenire nocive per una delle cause seguenti:
J • se la sostanza tossica è originalmente contenuta nelle carni dell'animale vivo che servì alla fabbri cazione delle s catolette (animali stanchi o mala t i ); oppure:
;;(' essa si formò dopo la macellazione ùel bue, durante la. fabbrica zion e ed iu segu1to ad nna vegetazione microbica c he in>ase la. (•arne, sana in princ1p10; ovvero:
3" se Pssa s i formò an cora più tardi dopo la c hius nra. e sterilizzazione d ella conserva e fu causata da una coltura mi crobica rimasta sro nosci u ta.
Oerruti f 2 ) in un suo st udio chimico s ull e scatolet te di carn e in con!';l'rnl. c·h e si u snno nel Regio esercito italiano concbiuse:
l Qche la carn e in conserva. in uso presso il Regio esercito italiano c()nti Pne tutti gli el e m e nti di una buona preparazione:
es<>a, co me va l ore nnt.riti\·o, equivale ad una. quantità proporzionale d i cnrnt> fresca di bue, e corrisponde perfettamente a preparati c·ommcr c iali analog hi più a ccreditati:
:;" che sPbbene col trascorre r e degl i anni si ri scontrino indizi di po!;sihili al tem zioni specialmente negli albuminoidi, qnoste, anche dopo lo xpazio <l i do clic i a.un i , uo me nel n o;:tro caso, si mantennero cosi leggere eh non c he esse ve n gan o preso in tale consid erazione da xeon--ip;l i n.ro l'n:<r, ÙPlla carn e in conf'erva, anch e dopo nn dis<Teto periodo d' <Inni;
·l" 1·lte iniìne, son0 sempre da ritenersi inq uin11.t e e no cive l e scatole c·he presentano quello speciale rigonfia m e nto ai fondelli, rigonfia-
Cl) ! .es roo•r•· v es de v i tw rl f. (R•v11e ti' /f tJgwne el d e p ull rr acmiCaire, 30 se u cmhre 1000. c gcn· 190!).
12) Solll• &ealul ell e d ì rarne di bu" i11 i n 1110 nel Rt(lìO tstrcilo. (t;;ot un i • meauu d f l " ' '''o •u•·cito, n. G, 31\ l901 )
4-18 SULJ,J\ SC'ATOLETTE DI CARJ\Ii: DI DUE lN ('OXSEUVA
419 mento che si mantiene anche alla pressione ed indipendentemente dalla costruzione della scatola.
Grixoni (l ) nelle sue ricerche chimich é sul contenuto in acqua, azoto e grassi di alcune carni in conserva che si usano nell'esercito italiano, giunge alle seguenti conclusioni:
l 0 la carne in conserva in uso nell'esercito italiano, al pari di quelle più rinomate del commercio, non può avere il valore nutritivo della. corrispondente quantità di carne fresca;
2 • essa rappresenta il peso di carne cruda necessaria alla sua fabbricazione;
s• il valore nutritivo della nostra carne in conserva è quasi uguale a quello della carne lessata dei buoi della stessa. regione ed a quello delle conserve di Chicago: è quas i identico a quello della conserva americana in uso nell'esercito francese ;
4 • l'energia potenziale della nostra conserva. è superiore a quella. della carne fresca e della preparazione consimile in uso in Francia. Essa diminuisce man mano si procede dalle scatole fabbricate nel 1900 a quelle del 1888;

5 ° l a maggiore quantità di sostanze a zotate esistenti nelle conserve del 1888 in confronto di quelle del 189-1: e di quelle identi che del 1900 è d a attribuirsi in gran parte, all'aggiunta fatta, per ragioni di consen·azi.ono, di gelatina;
6° le ricerche e:;eguite non au torizzano a stabilire se le cal'ni con l'invecchiamento abbiano subito delle alterazioni.
In nna seconda memoria, lo stesso autore in collaborazione col dottor Panà s ul valore nutritivo delle carni in conserva di Casaralta, di antica. e di re cente fabbricazione, co n chind e:
• Che la carne in conserva di Casara.lta, tanto di r ecente ( 1901) che di ( 188R-18!14) fabbricazione, non solo ha, per la sua. composizione chimica, un valore alimentare presso che uguale a quello di carne les:,a.ta. di buoi della stessa regione ove la carne fu preparata, ed una som ma di energia. potenziale superiore a quella. della. carne americana in con serv a in uso 11ell'esercito francese; ma anche i principi alimentari in essa contenuti , se togli una leg gera differenza irr meno c·ausata. dalla ripugnam:a che si ha ad ingerirla dopo c he se no fa uso da qualc h e giorno, si prestano discretamente (mai però come quelli della carne fresca) e alla digestione e all'assorbimento nel tubo gastro-inte:;tinale e alla assimilazione nei vari tessuti dell'organismo.
E SULToE BOCCI!:TTE DI DRODO
CONCEN"l'RA'l'O, ECC.
Il) /li cisl« ct'ioiene e 1an llii pllltblica, anno Xlii, 190!.
(! ) P A!'lÀ asslslenle e G. GR1xo:-<1 medico. - Rit1isla ct'iolene e $0>111« pttbbllca, an11 u Xlii. 1!102.
« P er cui se il suo uso e da consigliarsi tutte l e volte che non s1 'può a vere a d i.-posizione della c arn e fresca, non deve essere continuato però por molti giorni, per il senso di ripugnanza. che esso susciterebbe. Per evitare questo senso di ripugnanza si potrebbe tentare di prepararla non in uno, ma. in più modi e con diversi condimenti; bisogna. avere presente che, perchè un cibo sia ben digerito ed assorbito, è necessario che esso sia. ingerito non con ripugnanza, ma con gusto ed appetito. »
Le conserve di carne devono servire unicamente per alimentare gli eserciti i n circostanze speciali e quando non è possibile disporre ù i carni fresche ben condizionate.
O iii. fin dall!JOO i dottori H. Bischoff e hl. Wintgeu (l) nel loro i m portantissimo studio sulla fabbricazione dell e conserve avevano fs.tto notar& ehe. le cousC'rve di carne non sono del tutte eguali in valore nutritivp alla carne di eguale qualità che si adopera n egli usi domestici; esse sono al 1lis0tto di dette carni, poichè non tutti i pezzi sono egualinente teneri e non di rado si osserva in parecchi uno sfibramento muscolare . Ma le conserve sono da anteporre sicuram ente alla. cà rne colla quale furono finora frequentemente nutrite le truppe in campagna, dovendo questa essere cotta immediatamente dopo la macellazioue nel bue, quando talora non è neppure cessata la rigidità cadR.veri(;a. In tal caso la came è sempre dura, quasi coriacea, e per conseguenza di t1ifficile diges tione ed assimilazione.
lnoltre le conserve offrono il gran vantaggio che esse possono essere allestit e f<lcilmente per le truppe· ed in poco tempo pronte pel loro consumo. Conchiudono perciò i due sopracita.ti autori, che le conscr'\c di carne sono lla considerarsi come il più utile e fino ad ora il miglior mezz o nutritivo. da rendere possibile una r ego lar e p::ovYista di carÒe per J'appron·igionamento delle truppe durante le manovre, ma piit specin.Jmcnte in guerra, inoltre pe r l'equipaggiamento di spedizioni militari e per parti te sportive.
Dalle Yari e opinioni sopra espresse può quindi dedursi: esse re prndente di rinnoYare ogni tre anni il quantita.tivo di conserve strettamento necessario per i primi bisogni della mobilitazion e delle truppe, e di preparare, durante la mobilitazione, le conserve occorrenti per gli nltc riori bisogni della guerra.
Oonclusioni. - Per la preparazione di buone scatolette di carn e di bue in conser\'a e per la loro conservaz ione è n ecessario disporre:

,tjl) SULLE S C ATOLETTE DI CAR:\E DI DUE IN
( l ) J)otl. Il D"CIIOPP dott. M. - /Jeilrcige ::ur Cot trvtn(abr•kalion ( Ztit <chl'i(t (1ir 1/ygttnc Utld ln(eclion&liratlkhtilm, 1900)
t • di buoi giovani, di prima qua l ità, completamente san i, bene r iposati ed in ottimo stato di nutrizione;
di fabbriche costrutte secondo tutti i precetti e le esigenze moderna igiene;

3" di caldaie, motori e macchinari perfezionati;
4" di personal e ben disc iplinato ed istr uito e che abbia. la massj ma cura della nettezza.;
:-l• di caldaie a. pressione perfezionate, con le quali si possa. ottenere una. sterilità completa delle sc.atolette .
il" di magazzini freschi, ventilati ad asciutti.
E SUL LE DOCORTTE DI DRODO ECC. 421
Bologna. W aprile 1903.
CONTRIBUT O
ALLA EZIOlJOGIA E CURA DELI1E OTITI ESTERNA E MEDIA
Per il dottor Marie M•liaar i, tenente m edico
Mi :;ia. perme:;so di portare un piccolo co ntributo alla eziologia, alle ri cerche batteriologiche e alla cura delle otiti, basato su una dozzina. di casi da me osservati, quantunque sappia di non dire cose nuove nè grandi, ma però utili e pratiche.
I cas i da me studiati appar t engono nella massima parte a militari (otto) avuti nella brigata d'artiglieria da montagna e 4 a borghes i di una età variante fra i 9 ed i 30 anni. Qualcuno degli individui ebbe re cidiva del processo morboso, ma pitl perchò non s'i attenne scrupolosamente alle prescri z ioni avute dal medico, che per nuovi fatti impostisi . Circa la durata dell'affezione dirò che in nessuno dei soggetti era da oltre se1 mes1 e m ag.;iunta farò notare i seguenti fatti speciali:

l" Dei casi da me osservati, uno riguarda una bambina . <li 9 anni tubercolotica, sulla <JLVtle furono riscontra t i i caratteri fisici della tisi polmonare e confermati con l'esame batteriologico dell ' escreato: h1\ una sorella scrofolosa p ure affetta da otite che data da due anni.
.. Un altro caso interessa uu borghese ri coverato all'ospitale ci>il t> p<>r tifo e colto alla fine del terzo settenal·io della malattia ùa un'otite media pun1lenta, co n perforazione ovalare ampia del settore in feriore della. membrana del timpano.
3 " Tutti gli altri casi riguardano individui san i, robusti , esenti Ja affezioni reumatiche l ocalizzate al naso o alla gola e mai stati soggetti a ma l attie infettive in precedenza (morbillo, scarlattiua, vaiuolo, tifo, sifilide, ecc .).
È nolo che, come qualunque altro te3suto delicato, anche quello del condotto uditivo, provvisto d i cute, di connettivo grosso stipato eli num<>rose ghiandole e di peli, può andar soggetto a processi infiammatori, che si possono ripet ere, o da localizzazioni per metastasi di germi infe ttivi, come hanno ammesso Bi.irkner, Schwartze, Pratrzek, Brieger, :::>zenPs, Htettc r ecc., o da fenomen i atmosferici ch e sono stati c;tpaci di modificare l 'ambiente a vantaggio dei microrganism i che vi ri siedono o fare perciò a cquistare a quei germi qualità tali (la ridestare, nn processo infiammatorio; o per l ' innestarsi casuale nel tragitto del condotto uditivo di ifomiceti e di germi che, per quanto non temi-
422
bili per sè, sono in grado di acquistare, per la natura costitutiva d el soggetto stesso, tali proprietà da farsi strada l'uno per l 'altro attraverso i delicati tessuti e con l'irritazione dei l oro prodotti di ricambio indurre un processo fl ogistico con trasformazione chimica. perfino del secreto ghiandolare.
Non è p erò a credersi ch e per i fatti suaccennati in un'otite purulenta al suo inizio, anche quando cioè sono in atto i fatti pitl classici dell'affezione, calore, dolore, rossore e comparsa di una goccia secrezione, sia così facile andare alla ricerca d ell'agente da cui la infiamma,zione è causata, tutt'altro; è solo allorchè il processo è da qualche giorno in atto e solo ùopo, diciamo così, che i fenomeni fl.ogistici hanno sorpassato il l oro acme che noi possiamo ricercare la specie dei microrganismi incriminati: sol ta.nto allora siamo c:e rti. di non fare un lavoro inutile data la grande scarsiLà nei miororganism i suscitatori del processo morboso. E questi microrganismi anzi li troveremo come nascosti e ann idati in variabil e q nantità, non mai in gran numero, sotto l e cellule ep idermiche, c.;ome hanno risc.;on trato· Cosassien, Libby, Hessler, Andre ws e come ho potuto vedere anch'io, ma ben rari in mezzo alla sec rezione puruleuta messi in evidenza ocon esa mi microscopici in preparati o co n colture.
Ricerche fatte con s istemi di c.;olture in brodo, in gel atine ed in a.gar su materiale raschiato, con nn ago-spatola di phttino steri lizza to,. da 88 condotti uditivi sani di individui mi died ero i :;eg nenti ri:mltati:

Stafilococch i :2R voi te ptococchi ;)f) »
:Uicrococchi 1:2 »
'l'etragono .> »
Bacillus buccalis
3 »
A.spergillus flaves<.:e ns l ,.
Muco r rbizopodiform is . ,.
t:iecondo anche Zanfal, Weichselbaum, F oà, Bordoni, Uffreduzzi 7 Ortmanu, Zorkendorfern, ecc. la .tiora. del condotto uditivo malato è ritenuta in istretta. relazione con q n ell a trovata nel la bocca t nella gola, nel n aso e nel polmone, ò quindi faci le iucontrare o gli str epto o stafilococcbi piogeni l aureo, albo-citreo, albo-cereo, cereo-flav o} o il t-etragono, o il bacillo di Koch o quello di Eberth, o il diplococco di Fraenkel o il bacillo di Friedlii,nder, o il diplococco intracellularis meningitidis - trovato quest'ultimo da, Frohmanu nel pus di un'otite media osservata, come complicanza di una meningite cerebro spinale - non è poi improbabile incontrare qualche ifomiceto d e lla fa miglia. o delle aspergilline (aspergillus fumigatus, tlavescens) o d elle mucorinee (mucor co r ymb ifer o rhyzopodiformis) o degli oidii , Tricopbyton tons urans, Achorion Schonleiuii, Microsporon furfur.
OONTRIDUrO ALLA EZIOLOGIA, ECC. 4:33
I o ste:-:so pote i riscontrare un caso di t ri cophyton in un ragazzo il q uale aveva comple tamente ostruito il condotto udi tivo d es t r o di cerume commisto a n um erosissimi ifì del sud detto ifomiceta.
Le ricerche da me eseguite sui condotti udi t i vi malati, vennero fatte impiegando sia il materiale di secrezione, sia, e ciò per tu tti i ca.si, servendomi d i piccoli frustoli d i mu cosa racco l ti su stuellini di cotone idro filo sterili7.zato fi s;,ati su nn port atamponi uso Gottstein. Con q u esto materiale da prima si fece ro numerosi d'isola· mento in scatol e di P etri con agar o g elatina, o i n bocce tte eli Erlenmeyer prov,·iste per metit di pappe di pol en ta o di pane alla Schill ; i nd i mo lti pr eparati L:ol orat i vari amente o col sistema 11 peciale della fo r ma batterica di l'lli si a n davb. alla r i ce rca o usando illiqnido di Zie hl o d i Gram, o l e so luzioni idroaJcoo lic h e comuni; da ultimo con le colonie isolate e fatte S\7 Ìluppare Sll mezzi liq uidi O SOSpese iu acqua di:-;ti lla t a sterilizzata era m essa alla prova la toss i cità de lla forma batterica i so lata mediante i nnesti n ella cavitit peritoneale di conigli o di ca \' Ìe .
T engo a ri co r da re c h e a ll ora quando mi capitava di dovermi servire di un a sosta nr.a ri ccn di croste per anda.re alla ric er ca degli ifomiceti, mi so n o va lso del precetto di Kra l, a mezr.o del q uale il Jnateriale s i disg rega pestandolo iì.nR.mente in u n mortaio insieme a polvere di acido sa.licilico sterile, poi p r esa d ella miscela con un ago di platino una. o d u t> an SE' e fatt e tre diluzioui m agar fu so a 42° C . veniva questo ve r sato in scatole di P etri .
I ris ultR.ti otten uti sono i seguenti:
1° caso. n. di Koch con p iogeni (a l bo)
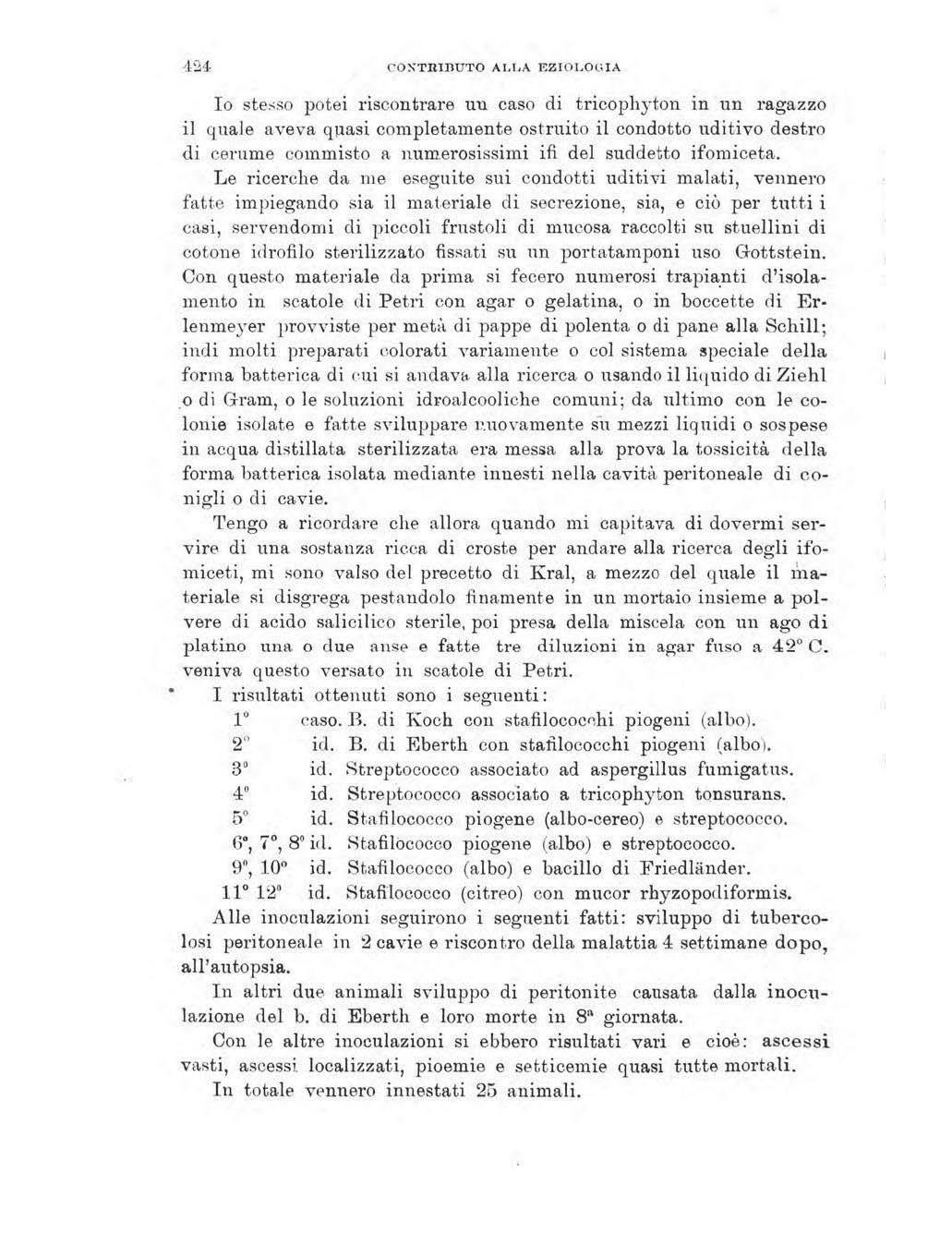
2 " id. B. di Eberth con stafilococchi piogeni (a l bo 1 .
3" i d . Streptococco assoc ia to ad aspergillus fumigatns.
4" id. Streptocooco associato a tricophyt on tonsurans
5° id. S t.afilococco piogene (a lbo-cereo) e s treptococco.
G•, 7°1 8' id. Stafilococco piogene (alb o) e str eptococco.
9", 10" id. St.afilococco e di Frie dlander.
n • 12' id. S tafnococco (c itreo) con mu cor rby zopocliformis.
Alle inoculazioni seguirono i seguenti fatti: sviluppo di tub ercol osi peritoneale in 2 cavie e riscon t r o della malattia 4 settiman e dopo, all'au topsia.
In a l t ri d ue animali S\Ìluppo di peritonite causata dalla inoc ulaz ione de l b. d i Eberth e l or o mor te in sn g iornata.
Con l e altre inoculazioni si ebbero risultati vari e cioè : ascessi Vitsti, as cessi localizzat i, pioemie e setti cemie q nasi tut m ortali.
In tota.l e vE> nn ero innestati 25 aui mali.
C'O STRlDUTO A ! ,!,A F.Z!OLOt! I A
Cu1·a. - Le sostanze medicamentose state introdotte nella terapia <>toiatrica e dalle <J uali questo o quell'autore ha. ricavato buoni "Vantaggi souo iunumore,·oli, è perciò quindi c he troviamo lodato ora il sozojodolo di sod io e potassio (Schwartze), ora. il dermatolo (Szeves l, 11 s alicilato di bismuto t Lermoyes), lo xeroformio (Heuss),la pioctanina. bleu (Cazin e Pratrzek l, l 'a miloformio (Biirkner l, il tetrabor a.to di sodio co n ac ido borico (Barth), la soluzione al 2 o o doll'ossicia.nu r o di mercu rio (Lermoye z), le cor renti di ozono t Stoker) e via di cendo.
Io per parte mia, mettendo da banda <tua lsias i preconcetto su o quel farmaco mi sono s forzato , seguendo un criterio razionale adottato da molti, di o t te nere la maggiore pulizia pos;;ibi le della partE' procu rand o di rimuovere con ripetute m edicazioni giornaliere, il detln;;so purnlento mediante irrigazioni abbondanti e cald e (32°-34• C.) d i una ,;olnzione al 3 p. J.OO di. carbonato di soda, finita. questa lavatura, se n e fa unà seconda con acqua bollita steri lizzata calda.
Asciugato p e r bene allora il condotto udi t ivo, con batuffoli di cotone idrofi lo sterilizzato avvolti su un portatamponi, veniva ri empito do l cemente e senza fare pressione di acido borico finemente polvera to. Sull'orecchio este rn o venne apposto uno strato di garza. imbevuta pure di so l uzione borica (impacco all'acido borico).
Con questo sist<'ma di c ura ho avuto ottimi vantaggi nell e otiti <:omuni non solo, ma ebbi a notare scomparsa e diminuzione della secrezione anche nei due e asi specifici di otite tubercolare ed otite eberthiana. se bbene si legga su molti trattati che la medicazione nei casi di oti ti infettive arreca p oco o nessun vantaggio.
CouclttJ{ione. - Da. quanto io ho p otuto vedere ed h o p i ù sopr a esposto concludo:
1° che l'otite esterna. e media è sempre, o quasi, dovuta ad una causa. microbica.;
2° c h e nel maggior n u mero dei casi si ha una vera e propria associazione ni mlcrorganismi, quindi non si può stabilire se sia più una specie che l'altra capace di suscitare il processo mot·boso;

3• che a m e pare che gli ifomiceti si più volentieri co n i micrococc hi piogeni che uon co n gli alt ri batteri ;
,to che qu esti ifomiceti non aggrava?O la malattia. Co negliano, li 10 febbraio 1903.
BIBLIOGRAFIA.
• d. !lftd. 188i, t R- t n. - FoÀ e 00RDO:>'I·U••rsnSoUZ7.1. • Zellsch r ( 1/yg., Rd l, 18-'!0. - GuNT II Ift.• lla klerlologla. Au fl. 5 - ScusRBR • Cmlralbl. {. Ba/cler., l Ablh. 8<1 17, 189:i. - f ROII IIA ifN • Deul& che mtd. \Vochenlthr. , 189i, Od 15, pa;t. 106.- 5 TIIBIIUIAUS. •
(. 1/IJg Btl 5, 1889 - - Vireh Arch .• Od. t jj), 18?1, p. 100 e segu enti.FnftBRI - Arehit:io /la ; iallO d'Otol og•a, Vol. IX, rase. t '. 7 lugl io 1900.
E C'ORA DEJ,LE OTITI ESTER:\A E ME DIA 42G
Ztituhr
CON TRIB UTO SPE RIMENTALE
ALLA CHJ RCRGI A TRAU.)1ATICA DEL ( t)
Di fronte al grande incremento degli st udi uhirurg ici moderni, agli ingenti progressi de lla chirurgia cranica ed addominale, ft·utto di ardimentose quanto feconde iniziati,e, sorprend e co me la chirurgia del polmone c i rappresenti am:ora un campo di studio così oscuro e mal d efinito, nel C]_ual e si accent u ano i più forti dispar01·i.

L e speci ali condizio ni anatomiche e funzionali del polmone, i di:;turbi, sovente letali, de l respirù e del c ircolo intratora.cico orJinariamente inevitabili n e lle ampie aperture della cavità pleurica., il n ote ,·ole nu mero degli insucces-;i, in parte dovuti alla grav1tà stes»a delle lesio ni reclamanti l'intervento, conferiscono indubbiamente ad ogni atto operati\' O diretto :;ull'organo respiratorio una gra,·itil, q u ale non ha risco ntro in alcuno altro ramo della chirurgia Di fronte a. tali fatti, per i quali i processi piLtologici e le lesioni traumatiche polmonari suscettibili di cura chirurgica ass u mono fisonomia ed importanza speciali, vediamo con meraviglia l'opera dei chirurgi, in compl<'sso assai manc hevole, svolgersi in mezzo ad una strana. incèrtezzn, non guidata sovente dal sano criterio di rintracciare nella. flei pericoli dell 'intervento gl'espedienti operativi pitt atti a combatterli, più spe::;so mossa da vedute non troppo in a.rmonitt coi bisogni della pratica.
1'u tto ciò emerge dai contribu ti di studio tanto cli11 i ci che spe rimeutali succeJntisi durante l 'era antisettica, dei quali, sebbene il presente la vo r o riferiscasi so lo a parte del complesso tema del la chir urg ia. polmonare, sembrami cosa i struttiva ed utile, a m('glio porre in chiar o il fin (' dell e mie ricerclte, dare nn sintetico cenno co mprendendo>i qn<tnto l'argomento otfre di piit interessante.
t i) Il rn: tcrla l c "Penmrnt•le dr rtnesto la,·or o venne raccolto durante l'anno 1001 nell'Istitut o di traumat ulu;:ra •Iella 'r uo ta dr mihLare.
120
Per il doli. Giu•eppe Wale ri o, tenente medico, addett.o alto mihtare di Verona.
Ha. mo l to semplicizzato il difficile compito delle mie ricerche storiche la pregevolissima. memoria dell ' insigne clinico di Siena. professor e Biondi (l) ricca di interessanti notizie e di indicazioni bibliografiche.

Il concetto d 'intervenire chirurgi camente in talune affezioni polmonari risale ad I ppoc r ate, c he consigliò l a cura chirm·gica dell'ascess i polmonari (2). T eoricamente sostenuta anche nel secolo XYII da Purman (3) e Baglivi, che ritenne poss ibile l'apertura di caverne tuberc olari, dettando le norme da segLl ire (4 ), poscia nel secolo xYm da Barry (5), Pontea.u ed altri , la chirurgia del po lmone ebbe felice inizio nel 1796 per opera del Taye, c he aggredì co n s uccesso una raccolta pnru lenta de ll'o rgano.
Questo stesso atto chirurgico eseguiva Bai ne l 18 0iJ .
Ri co r se ro successivamente a l taglio d e lla plenra e del polmone in nrie cir cos tanze di suppurazioni pleuriche e di a sc essi polmonari Zang nel 1818 (6) , Krim e r n e l 1830 (7), Stocke, Har t i ngs nel 1843 (8 ) ; ma la fac ilità degl'insu ccessi dovè certamente scoraggiare i chiru,rgi d e l tempo, distogliendoli da ulte ri ori tentativi.
hiEZI O:-IT INTRAPOJ,MONARI or sosT AXZE 1.U:D I CA ) I E:-ITOSE. - Ci rappresentano storicamente uno dei primi tentativi di cura dire t ta di certe affezioni polmonari dopo l' e ra antisettica . Ideate e p rati cate per la prima volta da Mosl e r nol 1873 in due individui, l 'uno affetto da e;;cava zione tubercolare d e l l'apice .polmonare desh-o, l 'altro da caverna bronch i ettasica (\l), ebbero posc ia n otevole impulso clinico e sperimeutale per opera di Riva, P epper, Friinc kel , Ia blonowsc k y, ShingletonTruc, L e pine, F ernet, Aruch ed altri.
Degni di speciale menzione sono i tentat.ivi d i terap ia antit ubercolare mercè le iniezioni intrapol monari escogitate da H,iva in Italia e dall'amer icano repper; il primo dei quali, in tre individui tubar· coloti c i, trovava di dubbia efficacia; ma ottimamente tollerate, le iniezioni intrapolmonari di sublimato corrosivo in soluziOnf,' d E> Il' uno
(I J no o Noo. - Contr ibuto atla chìru•·gìll p olmO>Hn·e. - (!.a clinìcrr chlru• gica , n. U , 1895, U5-459).
l!) l•o•ocnATE. - Oliere, clliz. L &llrt - Vo l. VII, Parigi 1855, pag. 65, 71, 89 e 96.
(3) I'URJIAN.- IV•md A rztn t!J FrA nkfurt - Pr. Cap. X, pag.
l' l BAGLJvo. - De prux ì medica ad prisco>>& obserua>Hli ration em rwocllnda. - Ro ma e 1696. Lob. Il. Cap. Xl,§ I X, pag S49.
15) E. lìARRY. - 1. Trt<1lìu on a conSt&mptior& o( l he l un gs Oublin 1a6, pag. 2. Trealis t M lllree d i {ferenL digutio tu. - Lonclo n. 1763. pag. 366.
(6) ZA:OIG.- Darsl ellung bWLiger Operationen. - Wicn 1818, tU L. 131.
(71 1\Rt!IR>I.- J ottrn. co mpleme111 Il e &e med. - Vol. XXXVI, 1830, pag 2i0 e seg
18) STOCK K e H ARTIS CS - Lond. 11/ed. Go:.. - l) ecem. !0, 18H.
(9) Ueber B t lwnlllo.n(/ UOfl Lungen 1\a uernttJ. - in der Seclion lur innere Yedicin ller Ver.;ammluog !loutsctoer Naturrorsche r und Ae rzte zu W iesb ad1m aro 23 Se plcmber
ta:3 e Berli11tr klinlsche Woclwuchrl(t, N. 43, 1873, S 509 566.
CONTRJDUTO SPERUI ENTALE, ECC. 42ì
:;n 1300 t l ) : mentre il secondo, guidato dai segni fisici, praticanl impunemente, in G individui con caverne tubercolari dell'apice, iniezioni intra.c·(witarie settimanali di soluzione acquosa di liquore di Lugo!, risultandone diminuzione di tosse, di espettorato e di Ampia riprova sperimentale a quest a tolle ranza del polmone all'azione diretta dei vari agenti chim ici diedero prin cipalmente Friinckel, Ia.blonowscky ed in Italia lo stesso Ri>a, cui spetta. il geniale intuito di a\'erne stabilita, con l'iniezione d i liquidi colorati. l'area di diffusione e di azione locale.

Friinckel con iniezioni giorng,liere di acit.lo fenico (1-3) 0 / 0 : di acido borico (± "/.) ; d'acetato d ' alluminio (2-G j '.); di ioùoformio in soluz i one oleosa (o "/0); dimostrò la presenza, nei punti iniettati del viscere, di aree co nnettivali più o meno indurite (H)
Iablonowscky ottenne dalle iniezioni di tintura di iodio e di soluz.ione fenolica al r> o;. fatti locali di pneumonite in te rstizi al e e modera ti processi necrotici con esito iu cicatrice, mentre a ll'uso d i iodoformio, so:; peso in olio di eucali pto, vide conseguire la fo1·mazione di ascf'lssi polmonari circoscritti (4) .
hlancleire ripetè largamente sugli animali le iniezioni sclerotizzanti da Oa.mby sull'uomo, ma. nonostante tanti incoraggiamenti sperimentali, la pratica delle iniezioni intrapolmonari, per un complesso di cose facil i ad intuirsi. non ebbe il favore dei chirurgt.
Era giustamente riserbata. maggiore simpatia ad altri atti meno incerti e dubbiosi, per quanto di gran lunga più arditi, quali la Pn enowfo)nia1 la l'nermU!ctmnia 1 la. Pnenmorr afia.
- Fu su tutte maggiormente ricca di fautori, e molti Yi ricorsero nelle più varie affezioni polmonari. Fu applicata. alla cu ra delle ci sti idatidee del polmone con riduzione dolla mortali tà, secondo i dati el i Neiser, dal 76 °/. al l!l al1 4 "/ •. Si c urarono con la pneumotomia gl'ascessi polmonari da Baudrimont, Ohurton e Littlewood, L eech, Irving, Monod, Segond, Terrier, H.ichard e da. molti altri ; la cangrena polmonare, le escavazioni bronchiettasiche e tubercola.ri, i focolai actinomicotici; si ricercarono i corpi estranei infissi n el polmone.
(l) A lllVA. - Sulla c11ra clirella della lubtJ·cololi polmonart con l ' ino11clazlone del r;olmon• molalo. - Archivio inltrttnzionale eli Laringologia ecc. A. 111. ra se l. pag. 3 • ti
(!l \\'. P><PPIA.- On locallrealemenl Ottflulmonary cavilie1 by lnleclionslhro11gh lhe brttl.lVall Am er i can Jourttal o( lhe medicnl IC itncu, Oct. !874.
(31 E. •• - &!Jtrimenldle Unler•uch ungtll iiber clen Bin{luu vo•l lllltclionen medi· .:nmenl•ju r Sub1l anzm in dar Lungengeu:ebe. - (Detll.•che meclicinltclle ll'ocllen.ellr'l(l, N. 4 f 881).
(4) IAOLO:.OW!KY. - Bxperlmenlelle l ! nlerniChWIIgen uber- - (Inaugurai Oi•sertatlon. I SSi).
.J-28 CO:'\TRIBUTO SPERIMENTALE
' ' -· -. .· .... o 11., -l. t ..,. , ... ·'· .. :.f
Secondo Hicherolle il t ag lio polmonare negl' a::;ces::si delr organo, specie se anfrattuosi, avreb be l1ato il 65 °/0 di guarigion i e nelle forme di cangrena circoscritta, ammesso un p r ecoce intervento, si di m ostrò su periore ad ogni cura medica. .
PNEUMI!:CTOlfiA. - Ebbe clinicamente maggiori contrasti ; ma fu al contrario oggetto ùi numerose ed interessanti ri ce1·che sper imentali per opera pri ma del Glnck, dello Schmid e Ma.rcus, poscia di Biond i , Ziino e Block.

G luck n ei cani e nei con igli giunse ad estirpare fi n tutto u n polmon e: ma la maggior parte ùegli animali soccomùette1 sah·o taluni nei quali la guarigione, secon do l ' A. s i stabili in l() giorni l l ) .Schmid, r esecand o la terz a e qnarta costa, apriYa ampiamente il torac·e ed, estratto dalla brecc ia divaricata co n un c ini smussi i n parte o totalme nte i l polmone, lo trafì gge"a, prima di asportarlo con tagli o cu neiforme, nella part.e più bassa con dopp ia ansa di filo, i c ui capi strettamente annodaYa :su lle due oppost e superfici a scopo em ostati co.
Allacciati i vasi eJ i bronc hi vis i b ili s ul la s uperficie di t agli o, praticava la s utura a str ati dopo di ch e, rimosso il laccio ed assicuratosi dell' emost.!\Sia, affo n da \'a il Yiscer e. 11o tevo le i l fatto che su 8 espe rim en ti ebbe li mor t i, tutti quasi per infe zi one, e Lrt> guari gio ni n l ).
::\.[a. r c us non eseg uì ch e cinq u e esper i menti su cani e co nigli; faceudo precedere la resezione polmouare, che praticava dopo avere in massa. legato il peduncolo, da una resezione multipla. di coste e conseg uen te ampia apertura del cavo pleurico. N on ottenne, c h e un solo esi to fortunato ed dist urba t i g li esperim e nti d<t forte disp n ea (3 ).
Al Biondi s petta se nza ù n bbio il merito del più compl eto lavoro sull'argomento. Questo ardito operatore in una sua prima pubbl icazione riportò i ris ultati di li5 eseguiti s u cani e co nigli, con 57 a spo rta zioni tot a li di n n polmone e tre r esez i oni parziali. L a tecnica seguita consistè nella resezione di tlut> coste, primà dell' incisione p leurica, e nell'estrazioue, attraverso la breccia j·oracica, del polm o n e, che, lega to in pross im1 tà del s u o peduncolo, e ra asportato con termocauterio . L a cav ità pleurica, prima d e lla sua chius ur11.1 veniYa deteJ"Sa co n s pug ne. e couspar sa di iodoformio .
( I l Tu. - t:x perim eutelltr 1/eilr(IIJ :ur f'raQe d er - (Oerlin er /:Uni&cf•e ll'ocllenschri(t. 1881. N. 41, S. 615)
( ! ) - R:rltrimenttllt St u dieu tibu parliellt Lungetwt l ectinn. - (Be r lin t•r /ilittisclle IVoc hemchrl(l, n 1881 pag ;37 ·i59)
(3) llucos. - Huhet·ches ··elaliuel a11:r: co n séquence1 d e l'exUrpalion e.rper imnt lale d e$ /)OU'IIIOIU. !Comp te s de> séa nces et mé mol r es lus a la Sociètt- d e Biol ogie rendant l'an néc 188 1 Séance· du 19 nove mbre, pag 3:!3).
L ' A. ottenne 36 guarigioni, riferendo gl'insuccessi a difetti di tecni ca.. Ne concluse, che l'estirpazione di un lobo o di tutto nn polmone n egl ' animali è ben tollerata e che, col perfezionamento della t ecni ca , possono essere evitati i pericoli intrinsioi dell'operazione t l ).
In altro importante studio speri111entale, pubblicato a lcuni anni più tardi ( 188-!), l'A. ricercando l ' efficacia della pneumectomia nella. cura della tubercolosi polmonare localizzata. riferiva i risultati di :21 es perienze, in cinque delle quali gli animali opera ti sopravvissero m ostrand o la. possibili tà, con la rim oz i one del processo specifico locale, eli una guarigione durevole (2 ) .

Prati cavano contemporaneamen te la pneumectomia. sperimentale Zii no, per scopi medico-legali (B1 , e Block, il quale con una semplice incisione con-isponde11te al 3° o 4" spazio intercostaJe, s ufficiente a raggiungere e legare l'ilo polmonare, potè sui conigli eseguire una rapida asportazione del polmone al davanti della sua radice, evitando la forte .dispnea (-1: ).
Di fronte ai numer osi ed incoraggiati risultati ottenuti sugli animali, ht storia non ci registra intanto ch e pochi casi ùi pneumecto mia e seguita su ll'uomo, con sconfortan te pred ominio d'insuccessi.
11 primo di t ali interventi viene attribuito a "\Veinlechner, i l qual e in un individuo con voluminoso mixocondroma, impiantato sulla parete t oraci ca des t ra, fu tratto, oltre che alla. re:)ezione di alcune CO:'l te, !lll"asportazione di metà del lobo medio del polmone destro, previa. app lic azi one d i un lacc io al di dietro del punto di sezione. L' indi-çoiduo mori <h• po :t! ore .
1\:ron lei n inter,e nne pftr secondo in un ca so pressoc h è simile. Trattavasi d i un sarco ma re c idivo impiantato s ulla o• costa sinistra co n di ffus ion e del processo n eoplastico al p olmone.
L'O., fi ssato con pinze l'organo allivello d e lla brecc ia. tora cico., ne aspo r t 1wa con un colpo di for bice la parte ammalata, praticando successiYam onte l'emostasia co n la sutura al ca t gut dei margini polm onari ed o lten e ud o guarigione completa in un mese·(5).
S t!g n ono i clne ca,;i di pueumecto mia praticata dal Rugg ). Nel primo d i <1 nes ti 1d on n a con localizzazion e tube rco la re a li ' apice smistro), r O..
( l ) 11 HtONI\t. - b'Mio·pazi01te del polmone - l:ont.-lbnzione sperimenln/t. - ((;io•·•tale I n/n·,a· z i OIIlllf rl,•/lr gc u11 :t pog I S'l2t (2! Il. ' ·'"'IICIIC.'Ciit·p •lio" bei t.rperimettlt lt locrtlisirt,r 'l"ubercotost .- (,lftd.
Il Jul t
... - S ull" ] Ja r :; ia le del poi molle. - ( Giornalt illltrna:ionalt lrim : c mr•licltr. 5o!l, H l Il t""" · - \"trlwndlun g des l'er tim ( iir ìnn er e .4/edicht, 5 Juni - ( DwiJtllt m etl i cì-
II Ì$t/ir 1\"ot llt!UChrt ( l n. H,
1\ nox r.E rs. - T h ora.r w und Lunge nre<etli o rt rctgen tlll f l •·tcitltdrentltn /lundzt lltu ·sn r c n ms
tllltr llt(>Jlt. llt 1l u n o. - j/Jtr l i ll t t• klinuch e 1\"ochtns rh rt(l., n
-1ao OON'l'RIDUTO
SPERHlE.'fTALE
liberata dalle fitte aderenze ed asportata la parte lesa del viscere, lasciò s u l moncone 12 lunghi Kl emmer, che r imosse dopo 3G ore: l a operat a , malgrado il promettente decorso dei primi giorni, m orì, p are, con sintomi di a vvelenamento feni co attribuito alla medicatura. Nel caso, riguardan te un uomo di 32 anni con tubercolosi dell'apice polmonare destro, le tenaci aderenze p leuro-polmona.ri costrinsero a desistere dall'operazione, e l'individuo mori dopo 3 0 ore co n f en omeni -&dinamici, attribuiti in parte all'operazione, in parte al digiuno, nel qual e egli avrebbe vo luto spontaneamente trovare la morte (l) .
Omboni praticò primo la pneum ectom i a per f eri ta polmonare d'arma da fuoco ; ma l'intervento fu an che seg uito da morte dopo 7 giorni per pleurite purulenta e suppurazione della parete t orac i ca (2).
Uguale risultato ottenne Biondi in un individuo affetto da bronchi etta.sia aggredendo il polmone fra la linea ascellare media e la po· .steriore. La morte avvenne dopo du e-giorni pe r gra ve infezione pleurale d ov uta all'i nqu inamento della sierosa col contenuto settico delle caverne broncb i ettasiche (B).
Eseguirono la p n e umectomia D emans e Tuffier per ernia polmonare; Block, ch e, come Rnggi, inte r venne con esito infausto nella tubercolosi circoscritta dall'apice; Lawson, che sembra esservi ricorso co n successo in una donna di 35 an n i con localizzazio n e t u berco]are a ll 'ap ice polmonar e dest ro. In q uesto caso l ' apice affetto fu estratto da a pposita breccia toracica, ed il pa.renchima, nella sua parte sana, trafitto con grosso ago a punta rotonda ed a margini sm ussi portante un doppio laccio di seta steril e, i cui capi servirono ad allacci are le due metà del viscere. E sci sa. la parte s u periore dell e dimensioni di un pugno, co ntenente densa materia tubercolar e, il moncone, di iodoformio, fu rimesso e la fe ri ta esterna chiusa senza drenaggio (4)
Infine G luà operò felicemente di resezione ]JOlmona.re un individuo con ferita del po lmone per arma da fuoco .
P:"l·:taronRXI!'IA - Gue rmo mprez felicemente- lo. p r ati cò nel 1892 in nn caso di tìstola bron co-pleurale (o); ma dopo fu essenzialmente adibita a lla cura de lle ferite polmonari.

Robert e Delorme s nturarou o i n secondo tempo varie fe rit(' del polmone; l'individuo morì d'anemia ( li )
Il ) - La teutiea della P>ltumectomill nell'uomo. - (Rologna, Nicola Zanic he ll i, 11185).
V. - J>neum ecto mia s in istra per (erila d'11rma dn fuoco r.on emo rragia. - (Milan o , l Xi)
131 !ltosor. - allu clli rttrgia potm mwre. - (La clhtica ch irJtrgim, n 189;, pagine
Brilish .llw. Journ., 3 gi ug no 1893·
(:•1 .\ ccademln di mei!iclna di Parigi. - (Tornata ciel 15 m:.rr.o ICJOJ).
(tò ) 0Sl OR IIB e - 1"11 CO?II/ r es d e Chirurgie 1893., paJ:
ALJ.A C HIRURGIA TRAUMATIC A DEL POLMONE 431
De Sanctis c :E'elicia.ni vi r icorsero con successo in un caso d i ferita di coltello dell'organo e si dichiararono di essa par tigiani come mezzo di emostasia e d'impedimento al propagarsi delle infezioni dal polmone alla pleura (l).
Vi11lia, mercè due lembi toracici a. S!JOrtello, potè raggiungere e -;uturare una. ferita polmonare.
Per ferita. polmonare intervennero anche felicemente illicheaux e Qui·nu.
Lodi di Roma (lH!ll ) suturò felicemente in un ragazzo di 1-:1: anni una ferita da punta e taglio del lobo superiore 1lel polmone sini ·tro, e due suture polmouali per ferita di coltello praticò l<'umi pure della Scuol a roma11a.
Nel l0 caso trn,ttan1.si di ferita del lobo superiore destro in un giontue di 2:l anni, nel quale la morte av\enno due giomi dopo per anemia: nel secondo caso la fçrita, larga 4 centim. e profonda 13, interessava il lobo superiore sinistro, e l'intrrvento ebbe es ito forLunato, perchù l'individuo sopravvisse, sebbene colto da pneumonite (:2 ) .
P or ultimo Paro:-:zani, attraverso uno sportello toracico ad angolo, scolpito nel lato sinistro del tlorso, sutura ,·a unn grande ferita da. pt111ta. e taglio del sottostante polmone da prima con ago cilin<lrico robuste anse di seta impiantate sul parenchima a .J. centimetri dall'o rl o della l esione per comprenderne r intero tragitto, poi curn pletando Ltffrontamento con due punti sul margine pw:-;ti nelJ'int<'rstizio compreso fra le prime.
Xonostante lo sviluppo di una pleurite pnrulenta, da. cui residuò un considerevole vuoto nel cavo pleurico. curato con plastica toracica. alln, Estlander, l'individuo guarì (3).
Hapido r:.nnto storico; ma nel quale figura per !'llcces!'ione cronologica quanto dì più interessante illustra questo importante ramo chirurgico. Astraendo dalla pratica delle iniezioni intrapolmonari alla ){on.,Jm·, per taf'ito f'Omnne conl'.l'lnso di prPvalAnt.e \"a l ore speri montale, dovev!l. la pneumotomia, per faci lità e semplicità ùi tecnica, per l'intervento di altri fattori favore,·oli al successo, nascenti do,lle stesse patologiche alterazioni fultzional i del polmono c preesistenza di pleuro-viscerali Hpontanee o provocate. atte a preservare la p l eura dalla possibile propagazione dei processi. sett i c i

(
t ) SANCTIS l. - f'erila da trtgli o dti110imone. Sutura. Guar i):ÌQI\•'.- CIIi( •lled ., 189,, 1. !18).
(t) ANTONIO htltrven l o cMru>·gtco nelle aravi (erile del pol>no11t.- (Supplcmclllo al f>ollchnico). anno 1898.
tJ) A. PAMOZlANI. - Cortlributo alla cllil·urola del polmone - ( AIIrtal i d i mtdicl•w tw vale, annò 18!19, f&Sl'icolo di novembre, pag. t\OH4 06)
$Pi;RIME:-<TA LE
podmonali o ad eliminare o l ctttcnuare i gr·avi disturbi
r.ttori iue\·ital>ili n e lle ampie c brusche aperture toracicho, vttl'ncm il maggior suffragio uella. prnti<·a. .\l contmrio la mol,j l i ti\ cv m pie la. Ilei polmone, indispensabile per la eseeuzivne della. 1m e umec to rn ia o della stessa pneumorratiu. collc>gando tali atti chirurgici cog l'in cvitnuili t> gravi disturbi itkl"l'llli f••rmazio11e del pnt ·unl!llomce vpemlorio. non pot.e,·a. ..;ot.tra.rre loro un"impronta d i i rn nwcf ialno. D.tlle molteplici mernori o clinidw e sperinw11tali. risulta inoltro
t>\·iolente ln parte antt<L dalla manifesta imperfezicme della. oporativa.snlla co nsiderc " olt' frequenza Ll<'lle complicnzioni sf't,t ichf', <·hc di laJHo elevar ono la proporzione degli insuccessi dopo la pw·umed<Jmia. .\.ppare infa.tt.i esser pintto:;to preval,;o il concetto di stabilire Jino
a. qual punto, compatibi le con l 'esistenza, potC'ssc: spinger.-;i la muLilaziouo del viscere respiratorio normal e o pato](ogico, anzi e lt e qn ullo di studiar e i lliCzzi più op portuni, pen·hè tale operazione, tli prr sè stessa risultata pussibilc e <li relat.iva innocnitil, fo s:-;o sol.t;n-.tta a quei fattori cl'ins nceesso mtsce nti chdla natura stessa. dPII'organo op<'rato. sorse con ciò l'imporlanto ttu est,ione, semprEJ di sc ussa, r c lativamentf' allu pratica della resezione o della sut u ra polrunuare, da cela> tali a t. ti operati vi tronwo bt lo r o maggi o re appl i m bi l i f tl ne Ila cerchiA. dello les ioni traumatid1e, :>t' convenga, ogni qualvoll<t quo..;tc no offrano l'ot..'casioue, ac c ingerc i ad un inten·ento diretto sul ,-iscer o f e rit o, o 'e non sia da. nnteporsi il c riterio di uua prndente astensione nei lim iti in cui mo lti df'i \"E'e chi l'11imrgi h1. consigliarono e u ()Jl pochi cont<> mp o ranci nncora sostengont>.
Studiare l'argomento e l·ercar e di coulribnin·i in via spE>rimrntale è sb\lo il cÒ Hl(>ilo ciel mio lavoro.
:\Ii è sembrato inlanto intore:<:-:ante associare al minuto stndio delll\ tt>l·nica chirurgica polmonarf' clelle ri ce r che di polmouare .:>peri mentale, c·Onlloue sotto il punto di vista de l la oppo rf unità dell"int.er"ento rlireLio vis<·ere Divir<i perciò il tflma, di studio in due parti:
prima dello quali mi pruposi di ric c n ;are, sulla dci pro<·cssi seguiti dai vari a.ntori, quali modalità operative, 1·elative all'aper tura del torace, alla sutum eù alla resezione polmonan·, più si arlaUino ad attcnu:tre nella lo r o gravezza e frequenza lo compl i<·azioni immediate o tardive proprie dell'intervento;
Nella. seconda di riprodurre sui cani molte ferile del polmo11c con armi da. punta, da punta e taglio e da fuoco per seguirne i rispettivi caratteri e>ol uti vi normali o patologici in relazione con l e condiz ioni del ferimento e col metodo c urativo prescelto.

,\LLA CJl lllVIWIA
Dt::L
THADI.\1'1<" \
POLMOXIO:
:!>. - lic•Jrllnle mtdlcG.
PARTE PRTMA.
T ecnica chirurgica p olmo na r e.
Ad ogni intervento diretto sul polmone corrispondono vari momenti operatori ugualmente importanti e merite\·oli di studio.
Prescindendo dalle pratiche della rigorosa antisepsi preliminare della parete toracica, essi ci sono rappr esentati: dall'apertura de l tora ce; dalla presa ed estrazione del viscere respiratorio; dalla temporan ea fissazi oHe all'esterno ed ischemia della sua. porzione operanda; dall'atto operativo diretto sul polmone (p ueumorrafia-pneumectomia.); dalla ri posizioue in eavità e chiusura della breccia. toracica.
APEUTUIU Dl·:a. TOllAOlè. - Sono noti i gravi disturbi del respiro prodotti dal pneumotorace operatorio
Ne s0110 principal i fattori la deficiente ematosi dovuta all'arresto funzionale brnsco di nua metà dell'organo respiratorio; la congestione del pol mone dell'opposto lato e, secondo Delorme, una diln.ta.zione acuta del c uore destro.
I chirurgi, c he considerarono ne cel:;sario l'uso di ampi sportelli toracici, giustamente annoverarono questo primo momento operatorio fra i più difficili e pericolosi, e sentirono il bisogno di rico rrere ad espedienti dc'>tinati in Yerità a non uscir mai dalla cer c hia. dell"esperimento; come l ' insuttlazion e polmona.re attraverso la laringe e la trachea, proposta da. 'l'uOier ed Jla.llion : l 'aum en to della pressione intrapolmonare merct> la respirazione di aria. compressa, c he e Longnet, con esporimenti sui cani, Yollero dimostrare di pratica attuazione.

Di snclat.Lo ai bisogni della chirurgia. tranmatil'a f. altresi lo sco llamento della pleura. parietale proposto da Tuflior, al pari della fissazione del polmone alla parete toracica con fili passati ad ansa, come consiglia Df'lorme, essendo indispensabile la maggiore mobilità del viscere fori to.
D eterminare il grado di ampiezza. del taglio tora.c i co è perciò còmpito di so m rho i nt.erosse c hirurgico; in proposito di ch e troYO ne cessa.rio distinguPrC' quell e indi caz ioni operativa, che sorgono da affezioni patol ogiche del polmone, alle quali, per le profonde modiftcazioni funzionali dell'orgn.no C' j!er la molteplicità de l le a.derenzr plcnriuhe, bene adatt.aus i gli nmpi sportelli, da quelle altredi provcui em:a purnmcnte traumatica, in PUi souo indispensabili l e piccole breccie pleuriche favorevoli alla faei l<' trasformazione del pneumotoraee opernt.orio da apert.o in <·ltiliSO.
CONT R IBUTO Sl'IW lM F:NT A J,K
_! ·n ··-· .., •''.j<) .. :.j · .. , "'..: • ., _,
Tuffier, Bazy, Quénu r accomandan o limitate aperture toraciohe, con· cordemente ai risultati ottenuti d a i vari sperimentatori, i qu ali tutti videro t urbati i l oro esperimenti dalla forte dispnea, eccetto il Block riusc i to ad evitarla operando a ttraverso semplici incisioni interco!ltali.
Di tale necessità. mi convinsero ben presto g l ' insuccessi di alcune esperienze preliminari eseguite d&. me a scopo di esercizio, nelle quali feci precedere ali' i ncisione pleurica una multipla resezione costale.
I n questi casi, coadi u v a ta dalla mancata protezione ossea l'azione dilace rante c he i violenti sfo rzi dispnoici eserc itavano sulla fe ri t a. t oracica, riusciva spesso vano stabilire di questa, soverchiamente ingrandita, una. temporanea ed efficace occl usione e la morte dell ' animale sol eva sopraY· ven ire a breve intervallo dall'apertura del tora ce col caratteristico qua.t r o dell'asfissia grave.
Col ricordo non lievi difficoltà incontrate all' inizio dell e mie ri cer che sorge pur quello dei saggi ad efficaci ammaestramenti, ùi cui mi fL l prodigo sempre l'esimio maggiore medico prof. Lorenzo Bonoroo, diretto r e d ell 'Isti tuto traumatologico della Scu ola di Sani tà, al quale è per me caro esprimere in queste modeste pagi ne i sensi della m i a g ra titudine e rico noscenza.
Val e nd omi della n otevole spostabilità degli arc hi costa li nei cani, l>timai perci ò oppo rtuno ad ottare i n tutte le mie ultoriori ricerche una sola in c isione intercosta.le, co ndotta a strati dalla cute verso la p leura. alla maniera. del Block, associandovi in taluni casi la. frattura sottope · ri ostea delle due coste li mitrofe in co rrispondenza. degli angoli del taglio cutaneo, per ci rcondarne i ti-atti mobilizza. t i con una o più anse di :.eta robusta (anse pericostali) .
Xell'una. e ne ll'altra c ircostanza., con g r ossi unc ini ottusi i margini dell'incisione, ho ottenuta una breccia sufficcnte alla. completa ispezione de lla cavità pleurica eJ a lla estrazione parziale o totale de l polmone, al pari della possibilità di una chiusurn. pronta ed ermetica del sa cco pleurico durante l'esperimento in grazia del facile accollarsi degl i ar c hi costali sul peduncolo del vi scere o per effetto de\l' e ln.sticità loro, se integri, o per mezzo d ello manzionate ans o di seta, ::;e fratturati .
Stab il endosi in tal mod o l e condizioni di un pnournotorace chiuso, la fu Dir. i one resp iratori a, dopo il primo m omentaneo t ur bamento, torna n\. bon bresto r egolare. Un tale arti fiz io mi ha permesso di asportarP int ieri lobi polmonari e tutto il polmone di un Jato, di sut:l rare molte ferite polmonari e resecare porzioni di par euchima l eso spesso sen z a gravi m od ificazion i nelle cond izioni generali tlegli animali in

ALLA CHli?OftGIA TRA.UllA T l CA DEL POLMONE 43ù
RM' JC \. - N e ll'ape rtura della cavi tà pl eurica, qnal ora il po lmo ne dai primi violenti atti espiratori non sia i n parte spinto all'esterno per il tramite della breccia toracica, t ende rapidamente a. r et rarsi Yerso la doccia co to-,·ertebrale, ove arrestasi immobile a n otevole distanza dal .: piano toracico. Questo fatto, aggravato dai profondi e t umul t uari mm·imenti c h e aumentano ari tmicamen te la profondità ed inaccessibilità rlel >isce re, rend e ogni tentativo d'intervento in sito piil che ù i ffìcoltoso impossibile.
Tu tti gli operato ri ebbero agi o di con stata re la considere ,·o le tolleranza del polmone ad og ni ma.nualità operativa; ma non cosi l 'nd attamonto, indispensabile per ogni azione chir urg i ca, della funzion e ciel r espiro all e cambiate condizioni fisiche d el t ora ce ampiam ente comunicante co n l'esterno. E da rit enersi perciò che so ltanto dopo l'estrazion e del viscere e l'occlus i on e temporanea della f erita pari etal e, trasformnnte il pneumotorace ope ratorio da ap erto in chiuso, potrà tranq u i li amen te esplicar si l 'opera tlel chirurgo.

P er la p r esa del polmone, in m o menti di urge nza, mi appan·eJ'O a datte l e rom uni pinze emos tatiche .Pean, Dillroth, Cocl•er: sebbene aventi il d ifett.o di co n t und e re e so,ente la parte anc h e se <lebitamente protette, provocando z one di mortificazione <:ec:ondaria più o meno f'Strsa. Si dimostra perciò necessaria la cosi r nzioJH> di una pinza, c he, per l'elasticità d e lle branche, ev iti a.zio ue contHsi,·a sul parenchima polmonare. costr uita su ll' identico pri ncipio dPgli euterostati di Gussembauer e in guisa da se rvire, oltre che per la prP..:a del >iscere, an che per l' ische mia temporanea e per la fissazione 1tll'esterno della s ua pQrzione ope r anda . L a prE>!:Ia e l'estrazion e del polmone devono effettuarsi con g ran rle rapidit à H o eli solito arlotta tn. la pratica di afferrare il viscere, e r etratto. per il suo margine anteriore m er cè una lunga pinza P ean, a hrn.uchc per qmmto è possibile elas t i che e riv estite con tubo di gomma,, introdotta in ca vità attraverso la breccia torncica amp i amen te divaricata co n un cini dall'assistente, e di sos 1i tu ire all' istrum ento, non appena possibil e, delle dit a per la defi.nitivn zio nf' .
Per fì f'sa r e ed isc heniizzare la porzione erniata del polmo n e mi so n o poi di un enterostato a branc he ric urve, applicaLo stre ttamente su l p el1 un colo visce ral e ra se n te il IJiano cuta neo. L'esperienza. mi h a peraltro mostmto n on esser talora sicuro un tal siste ma di fissazione p er la. tendenza d e l viscere a re trars i in grazia dell' elasti· citò. e riducibilità del suo parencbima. ma ssi me dopo la pneumectomia.,
Es'l'RAZIO:\E E -"'l Si'> \ZIO :\r: D F. L l'O J,l\!0:-."1<: ••F: J.T, A llRECCI.\ ro-
nel qmd caso ho trovato opportuno fissarlo al contorno della ferita toracica. con qualche punto amovibile di seta.
POLMO:-\Am:. - Trascurata dalla maggior parte dei cultori di c hirurgia sperimentale, venne anche nell'uomo, tranne poche circostanze, o rdinariamente sostit uita da altri espedienti imperfetti e pericolosi.
Cosi nella pneum er; tomia, dopo la impropria a pplicazioue di uno o più strozzanti al di dietro del punto designato per la sezione polmo nare, si preferì cospargere di iodoformio od escherizzare coo termocauterio il moncone anzi che suturarne la s uperficie cruenta .
A questa. e ad altre imperfezioni di metodo sono da ascrivere le frequenti e gravi complicazioni infetti>e, che con impressionante frequenza segu irono i tentativi d'intervento chirurgi co sul polmone sia nell'uomo che negli animali.
Snll11. ùegli esperimenti di LisLer e Ji Eurein, dimostranti le condizioni di asepsi dell'aria contenuta nei bronchi termina li, ove essa giunge pura e filtrata in guisa da far consid erare giustA.mente sterili gli strati perif('rici de l paronchitna. polmonare ed Ìltca.paci di contaminare una linea di sutura in essi decorrente, ho adottati per la pneumorrafia i ùue ottimi processi d i su t ma. intestinale ideati dal Lembért e dal D 'A polito.
Ho di solito applicatala sutura d el Lembert a punti staccati nelle piccole ferite polmonari, mentre di quella del D'..àpolito, iniziandola e terminandola. con un punto alla. Lembert, me ne sono valso nelle ferite ampie da taglio del viscere e _per la sutura dei monconi dopo la pneumectomia.
Il concetto informatore di un tal sistema è, oltre quello di affrontare con punti nascosti i margini della. lesione per contatto delle l oro superfici sierose, d i evitare, mercè l'abbondante loro introflessione, l'uso di punti perduti nella. profondità del tessuto . Ciò implica il bit-ogno di proporzionare la distanza d'impianto dell'ago dal limite della ferita all'ampiezza della superficie cruenta, in modo che essa corri-sponda. alla metà del maggiore diametro per ferite estese in superficie ( pnf'umectomia), alla metà dell'altezza per quelle estese in profondita.
P er la facile lacerabilità del parenchima polmonare ho trovato preferibile l'uso di sottili aghi c ilindro-conici. Mi sono poi valso per le suture indifferentemente della seta n. l o del catgut fine, dando a questo la preferenza nella occlusione delle boccucce beanti dei bron<:hi e dei vasi maggiori sulle superfici di taglio dei mon coni.
P:\EtnliW'l'OMIA. - Gli autori non ne studiarono, nfl dascrissero la :tecnica.

ALLA CHIRURGIA 'l'.llAUllATlC.\ DI!.L
La eseguo nel seguente modo : Sulle due superfici del polmone estratto dalla cavità pleurica, fissato sul piano costale e contor nato da un doppio strato di garza, che ne avvolge la base, completando l'occlusione della. breccia to r acica., pratico a. due centimetri dalla pinza fissat rice ( enterostato) una sezione cuneiforme mercè due incisioni oblique e convergenti in basso in modo da lasc iare sul moncone polmonare residuo, al dinanzi della sua. parte compressa, due leuibetti facili ad accollarsi per introtlessione dei loro margini liberi.

Detersa con qualche batnfolo di garza. imbevuta di soluzione di sublimato corrosivo al l ·;•• la superficie cruenta del mon co ne, mantenuta. esangue dalla pressione dell' enterostato, occludo con lacc i di catgut fine le boccucce beanti dei bronchi maggiori, nonchè quelle dei vasi visibili e poscia., in cambio dell' affrontamento diretto dei due lembi polmonari con punti intrapa.rench i mali alla manier a dello !=3ch.mid, ne praticò la ri unione con sutura. D'Apolito, che inizio con un primo punto alla Lembert oltre uno dei loro angoli di confluenzat infiggendo l'ago a l Y. centimetro di distanza dall'uno dei mA-rgini, passando a 4 o 5 m m. di profondità per riuscire a c irca un centimetro dal margine stesso e percorrere Iato P identico tragitto in senso in \erso.
Annodato questo primo punto, passo alla sutura D 'Apolito. c he pratico con punti lunghi da 3 a 5 mm. deconenti ad una distanza dai margini proporzionale all'ampiezza della superficie cruenta ed in sen so esattamente a. loro parall.elo.
La riil essione e l'acco llamento dei lembi pex: le rispetti>e super· fìci sierose è agevolmente facilitata dall'assistente mercè una pinza anatomica a branche an'icinate nel momento della trazione del filo di sutnra, che eseguo ogni due o tre punti, l'ultimo di cui, alla Lembert, appli co con le stesse modalità del primo. procedimento ha il vantaggio, di obliterare la superficie crue nta del moncone, riflettendo su se stesso ciascun lembetto polmonare, senza interposizione di runti perduti nella profondità del parenchima, impiantati cioè su te1·reno non $f.erile, Compiuta la sutura an che l'emostasia definitiva è per essa stabilita, onde, dopo la rimozione della pinza fissatrice, non resta che n.ff ondn.re nel torace il mQncone.
In alcuni esercizi eli pneumectomia, ho adoperate a scopo emosta tico due sottili lamine di osso decalcificato, fi ssandole sulle due opposte superfici viscerali, al di sotto del limite prestabilito per la. sezione, con anse di finissima seta tra.mpolmona.ri ad U coricato,
438 CONTRIBUTO SPER.IMEXTALE
strette in guisa da non ottenere che l'ischemia parziale della parte compressa per e vitarne la facile necrosi.
In questo caso ho praticata la sezione polmonare a'/, centim. dal punto compresso per mezzo del termo cauterio, fissando poscia il moncone all' angolo posteriore del taglio toracico.
Cmusuru BRECO IA TOHArrc.\. - Il taglio toracico intercosta.le se m pl i ce od associato alla mobilizza.zione dei tr<\Cti corri spondenti delle ùue cos te, togli e a que:::to ultimo t empo ogni impronta di gravezza e l o r e nde di rapida esecu zione, sia per la te ndenza degli arc hi costali ad aecollarsi, se integ ri, sia. per la f ac ili tà del loro mutuo avvicinamtmto in grazia delle des c ritt e anse pericostali, se fratturati.
Ho trova t o opportuno iniziare la s utura sul piano mus co l are profondi), trascu rando la pl e nra, i c ui margini f orte me nt e lacera.bili n on si pres tano a.ll ' affrontam ento
L 'es perienza d ' altm parte mi ha dim os trat o il fa e ile reintegrarsi nella s ua continuità del foglie tto plc urico parietal e mer cò la ricca atti \·ità. proliferatrice d e i s uoi e lementi.
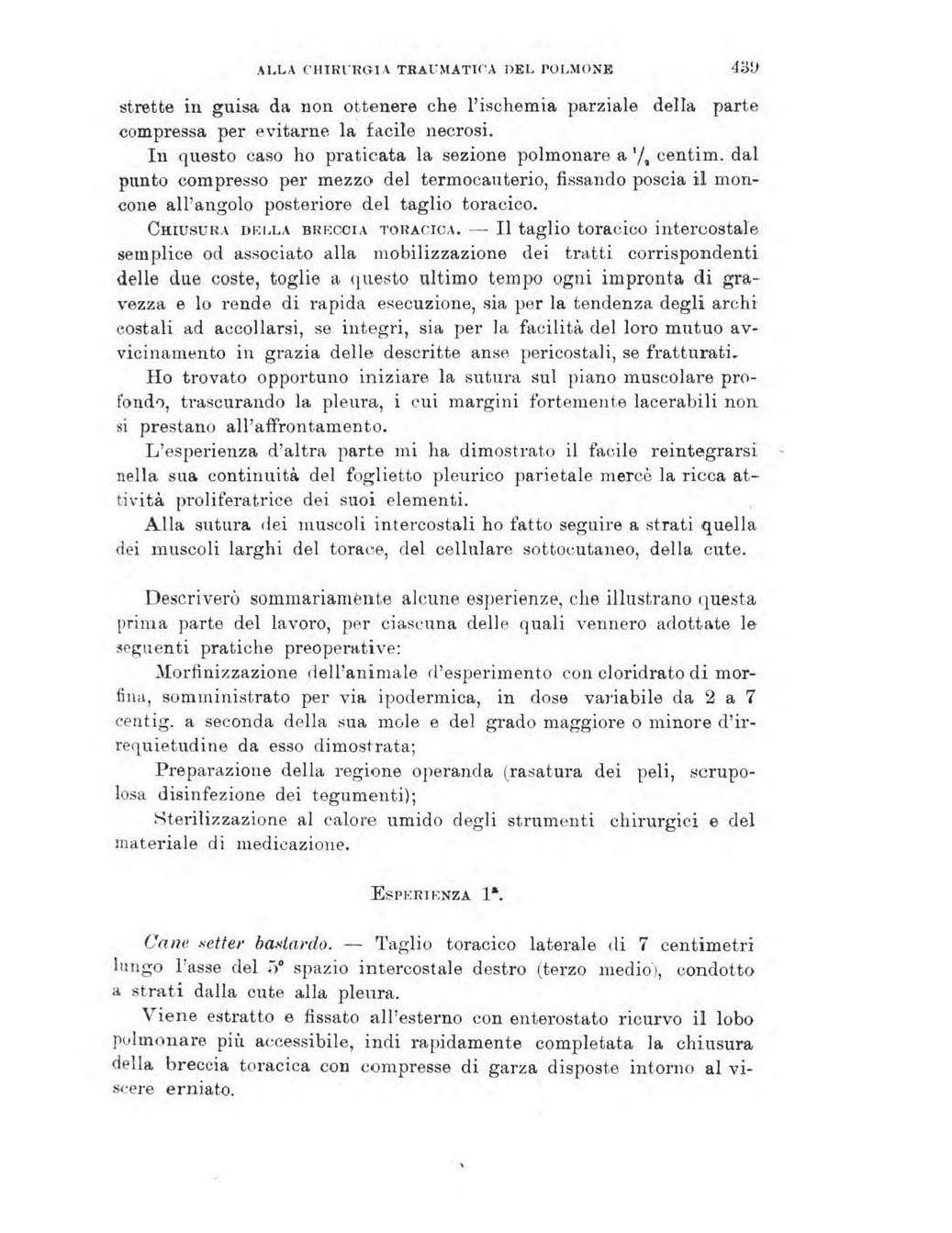
Alla sutura. d ei museo] i ìntercost ali ho fatto seguire a strati quella de i musco li larghi del torace, del cellulare sotto<·utaneo, della c ute.
D esc riv erò s ommariam en te alcun e esperienzE>, c he .illustrano questa prima parte d el lavoro, pt>. r d ell e quali vennero adott ate le pratiche preope mti,·e :
.\1orfinizzazione dell'animale (['espe rim e nt o c on cloridrato di morfina, so mministrato per v i11. i pode rmica, in d ose variabile da 2 a 7 ce n t ig . a seco nda della :;uR. mo le e del grad o maggiore o minore d'irre<l niet udin e da esso d imostrata;
Preparazione della r egio ne ope randa (ra:>atura dei peli, scrupolosa disinfezione d ei tegumenti);
!-Steri lizzazione al calore umid o d egli strumenti c hirurgi c i e del mate rial e d i m ed icazi one
()a m -'etfe r ba.'ltardt>. - 'l'ag lio toracico laterale di 7 centimetri ltmgo l ' asse d e l i">" spazio inter costale d estr o (terzo medi o"t, eondotto a strati dalla c ute alla
Viene estratto e fissato all 'esterno con enterostato ri c urvo il lobo pv !monare più a ccessibile, indi rapidamente completata la chinsura della breccia torac ica co n compresse di garza dispos te intorn o al viseer e erniato.
43:J
Unn nntero -pos teri ore, lu nga tre c€1 ntim. e pro li:mda. uno, e <'Ondot,ta. lun go la :.nperficie esterna ù el lobo ecl i s u oi margini sono tosto rinO' r ontali co n suLnra D 'A pol ito alla seta, ini.7.iA.ta e te rminatn COli pu n to alla L e mbe rt. Riiu trodotto il in ravitù , la f c:> rita toradca viPJH' :-:ut urat a a piani e protettn antisettiran•ente.
l :raw· dispuPa a tipo pre >a len temente inspirato ri o all'apertura e chiusura della CR\ ità plenrica: calma re:::pirat<'l'ia C(lmpleta nelr i ntcn·allo.
Hi .;u)tato anatomico imm ediat o.
Affrontameuto por introflessione dei margini de l taglio J•olmo nare co n liCVl' dPpr('s,;ione linc:>a re, nel cui fondl' deco rre ua ,;co:;ta la :::ntnra.
Hi s ultato tard i,o. ,_ Co nstatato d opo (iO giorni)
norma le, linea di s ntura r esa nppena ricon osc ibilt> d1\ uun t en no d op r essi onf.\ lineare. Vi corri s pnnclo nn sottile co rd oue d ' indnrattt cnt o d o Ynto a limit Rto riv es timento ccllln C't tiYo im·olgPnte il ;;o t· ti l r1 fi l o di sct.a.
l l.e (•Spl'rie nz(' o 3' . co n leggere vari anti n e ll' enti là tic l d iatui"IJi respirat o r i, corris pondo no pei ridullati all'espe rienza l•'.
E , l'EIHEXZA 4" .
l'iccolo cane lrarbunP. - Tagli o torncico late ral e di G cent illl. cond otto lun go l 'nsse del !.'pazio d est r o (terzo medio); m obilizzazione d e l tratto corri s pon denf l' delle due coste eù di dne peri rosta. li.
V f'ngono successivamente estratti dal torace il i 0 ed il H'' l obo polmonnre, lm lla. eui superficie inte rna è cond otta una lunga in cisio n e antero-posterior(' e rispetti·mmente suturata co n s utura D"Apo lito R.lla seta e co n ,; ntnm comune a punti staccati.

Alla introd uzione clel :l" lobo p olmonare segue la immediata c hius nrn. della t·avità. plau ri ea co n sutura a strati.
Di sp n ea in te n sa de l torace e durant C' l'estr az io nE> dei lo bi p olmonari; scarsa a lla chi u su ra.
Calma ro s pi ratoria nt, gl" inter valli.
G u a rigion e rapida Re nzlt inci denti.
H.isultato ann.tomi co (a -!0 giorni dall"esperiment(l).
Nel :&'' l obo polmonare libe r o da a.ù e r en ze- esi ste, come trac c ia e s teriore d ell a linea. di sutura, un solco e \i de nte ri coperto da plet.na con asp<'tio l eggerme n te madreperl aceo
Lnngo il decorso ùella suturR han·i uu conloue d' induramento formnto ùo. p a r enc hima sclerosato.
JIO CO:\TRID\iTO :-;I'JWDI F:NT II.E
ll terzo lobo aderisce per la sua faccia interna alla corrispondente pagina metliastinica e le ad erenze, formate da giovane connettivo, sono p i ù fitte e tenacr luu go la linea di sutura, circondata da tessuto fortemente indurito.
( Nell'esperic11za 5• la doppi& au tura è p ra ticata, con r isultati a un dip resso Ident ici, a ulla supe r ficie esterna del 2o e 3' lobo del polmone sinistro)
Cane -,;olphlo pù:colo. - 'l'aglio toracico l aterale di (i centim lnugo il 4° spazio iu tercostale sinistro (all'unione del :r medio col terzo posteriore) .
Viene estratto il 2• lobo polmonare e nella sua superficie esterna condotta un'incisione trasversale di 4 centim . in teressante metà dello spe;;sore del viscere. I margini della ferita polmonn.re sono riuniti co n punti Lembert continu i mediaute catgut n. 2 .
Al 5u giorno, momentaneamente riaperta la breccia toracica, il Tiscere è dj nuovo po r tato all'esterno, esaminato e poscia riintrodotto . La linea di sutura si presenta ricoperta da un delicato velamento fibrinoso e circondata da tessuto arrossato, lievemente consistente.
Entrambi gli atti openttiv1 ri escono ben tollerati.
Guarigione rapida seuza incidenti.
Risultato anatomico (a ::!0 giorni dal ;ao intervento).
Ferita polmonare cicatrizzata, ricoperta da pleura. alquanto ispes.sita ed opacata. Non vi esiste alcuna traccia del materiale di sutura.
EsPEI11ENZA
7 ''.
Grosxo cane dct gttardia. - fortemente denutrito per precedenti 1\tti operativi subiti.
Viene riprodotta l' esperienza 4"; salvo che la sut ura a punti Lembert continui è praticata con ca.tgut n. 3 montato sn ago lanceolato . Per notevole lacerazione del parenchima sta.bilitasi n e lla. trazione d ei fili gli estremi della l inea di a:ffrontamento sono con r obuste anse di 0atgut fissati al tratto posteriore della breccia toracica.

Notevole la mitezza dei disturbi respiratori durante tutto il de-corso dell'esperienza.
La ferita cutanea, per cessione di alcuni punti, stenta a cicatrizzare rd il cane ò sacrificato al 15" giorno prima della guarigione .completa.
ALLA CHIRUFWIA 'J'RAUMATICA DEL PO!,MONE 441
Risultato anatomico:
Ferita polmonare cicatrizzata ed aderente alla. ferita. toracica per un a. spessa stratifìcazione fi brinosa.
Vi si contengono, fragmenti di catgut non an cora riassorbiti .
[Le esperienze s• 9 " 10" 11" e 12" vennero r ise r bate allo studio della pneumectomia)
E srE IUENZA 8".
Cane se tte r basfoJ.rdo. - Taglio toracico di 7 centim. lungo il 6"" spazio in t':lrcostale d estro (terzo posteriore); mobilizzazion e del tratto corrispondent.e delle due coste ed applicazione di due anse pericostali.
La pneumectomiR, eseguita con taglio cuneiforme secondo la tecnica d escrit ta, cade sul terzo lobo polmonare, che spontaneamente impegnasi al momento dell'incisione pleurica nella breccia t-o racica.
Allacciate alcune boccucce ..--asa.li e bronchiali beanti sulla superficie di ta.glio del moncone, vengono i lembetti di questo affrontati per introflessione con s utura D'A.polito alla seta.
Ne residua nn piccolo peduncolo a forma tondeggiante. c h e, con la. rimozione della pinza fissatrice e dei 2 punti di fissazione temporan ea alla paret.e, si ritrae spontaneam ente in cavità.
S egue la snt,ura a strati della brecc ia toracica.
·Dispnea intensa all'apertura, lieviss ima alla chiusura del torace; calma respiratoria nell'intervallo.
Risultato anatomico (a 40 giorni dall'esperienza) : Pic0olo moncone form!!.to da pare11chima indurito con elementi 'asali e bronchiali atrofici.
La parte restante del polmone destro è normale.
EsPERIENZA H'.
Piccolo cane volpino. - Taglio toracièo di 7 centirn lungo ii spazio intercostale sinistro (terzo posteriore); mobilizzazione del tratto corrispondente delle due coste e applicaziJne di due anse pericostali.

Vengono succes;;ivamente est ratt i dal torace ed asportati q uasi per intero il 2• ed il W lobo del polmone sinistro, i cui monconi sono rispet ti,amente s u t urati con sut ura. D'Apolito e Lembe1-t continu.a. alla f<da, poseia affondati in cavità.
La duplice estraz.10ne si effettua in mezzo a i più gravi fatti d ispnoici, che si attenuano e s compaiono con l 'occlusione temporanea d ella breccia toraci ca.
442 ('0:-l'l'RIBUTO SPEBDIENTALE
Al contrario, ad esperimento compiu to, il cane non presenta ch e una leggera frequenza e brevità negli atti respiratori.
Guarigione rapida senza inc identi.
Risultato anatomico (a 25 giorni dall'esper ienza) : Piccoli mon coni costituiti da. parenchima l eggermente indurito con rivest.imento pleuri co pressochè normale.
La parte restante del polmone sinistro offr e un lieve aumento di >olume.
Esiste una notevole dilatazione con ipertrofia d el ventricolo destro del cuore.
l "ecchia cagna barbona. - Con intervallo di 15 giorni viene assoggettata all'asportazione del lobo su periore del p olmone d estro, ind i del :2• e del 3" lobo d el polmone sinistro.
La s utura alla seta dei monconi è eseguita secondo il processo D'A polito.
Entrambi gli atti ope r ativi, ben tollerati , hanno regolare deco r so ase ttico. Ne re s idua una maggiore frequenza e bre>ità degli atti respiratori , apprezzabile anche due mes i dopo l'ultimo espe'rimento, ed una sensi bile deformità drlla gabbia toracica per retrazione dtdla s ua metà sinistra.
Risultato anatom i co (a li:) giorni dalla seconda pneumectomia):

Piccoli monconi polmonari induriti ed atrofici, non aereati.
L a parte r estante rlei due polmoni presentasi n otevolme nte enfisem a tica.
Esiste una forte di latazione con ipertrofia di tutta la metà destra del cuore (oreccltietta e ventricolo) ; al contrario una n otevo le i.pertrofia concentri ca del ventricolo sinistr o
E -;rr.mKNZA 11 " .
cane da gtutrdia. - T aglio toracico ùi 1; centim. condotto· lungo il f >0 spazio si n istr o. Viene estratto dal torace, fortemente trasciMto e fissato nell'angolo posteriore fl el la in cisione il terzo lobo polmonar e.
il piano delle coste, sulle opposte supe rfi ci del viscere, dispo ngo due sottili l ami n e di osso de calcificato, a lte 5 mm. e spesse 2: trafiggendone tosto gl'estremi di poco sopra avanzanti il margine polmoHare co n ansa di seta e strettamente annodando li fra loro.
ALI,A CH IRURG I A TRAUMATICA DEL 443
Co u sottile ago lanceolato a larga cu rva e con seta n. 2 applico di poi, acl iutcn·allo di '/. centim . l'uno dall'altra e nello stesso senso, va r ie anse ad U coricato, compren denti lamine e viscere, i cui capi liberi e momentaneamente affidati due a due ad altrettante pinze Pean, sol tanto dopo l'asportazione del lobo polmonare, che eseguo incidendo col bisturi a '/, centim. dalle lamine ossee, con moderata trazione, co nùotta fino all'arresto del gemizio sanguigno dalla superfici e di taglio, annodo fra. loro.

Cauterizzata leggermente la superficie di taglio, il moncone è riintrodotto in cavitù e fissato al tratto posteriore breccia toracica.
N ote,·ole dispnea all'apel'tura ed al! a c hiusura del torace.
Condizioni del cane dopo l'atto operativo ottime.
Guarigione rapida senza incidenti .
Risultato anatomico (a 00 giorni dall'esperienza):
M:oncone duro,atrofìco, non aereato, solidamente aderente alla parete.
l n tn tta la sua prossimità la pleura parietale, ispess ita e di aspetto 1nadroperlaceo, si confonde nel denso tessuto omogeneo cicatriziale -corrispondente alla. parte del •iscere stata compressa dalle lamine ossee cd in cui sono conten ute l e varie anse di seta.
EsPF.RIENZA 12".
cane da caccia assai denutrito per precedenti esperienze subite. - Con le stesse modalità dell'esperienza 11" viene a sportato il lobo superiore del polmone destro, - praticando l'emostasia mercè du e lamine di osso decalcificato e fissando il moncone resi d llO all'angolo posteriore della ferita parietale.
un promettente decorso iniziale il cane muore al 10° giorno con sintomi di su ppurazione pleurica.
Reporto anatomico :
Il cav o toracico destro rac cogli e notevole quantità di pus fetido, ricco in detriti fibrinosi.
Per parziale distacco della parte compresa fra le lamine di osso decalcificato il moncone p olmonare presenta. nella sua. metà superiore una. superficie ulcerata. a fondo granuloso, da cui geme con la. pressione no t evole q ua.ntità di pus.
Nel tratto inferiore, non distaccato, la continuità è stabilita da sottil e zona di tessuto necrotico fac il mente lacerabile.
Le due lamine ossee offrono un legge ro grado di rammollimento.
l'O:\TRlBOTO SPERIM"XTALE
n maggior pericolo immediato di ogni azione chirurgica diretta sul polmone normale (nei cani) è legato all'influenza perturbatrice che sulla funzione del respiro e sulla ci rcolazione intratoracica esercita il pnenmotorace operatorio; il quale, ove sia mante nu to nelle condizioni di pneumotorace ap erto, conduce ad una rap ida morte pe:· asfissia.
Il pneumotorace chirurgico, chiuso ed unilaterale, altera m inimamente la respirazior.e, anche se aggravato da estesa mutilazione del polmone dello stesso lato, e non impedisce che nella pneumectomia parziale (per pneumecto mia totale deve intendersi l"a:-;portazione del polmone destro o sinistro ) la parte non erniata del viscere operando, durante l 'atto opemtivo, possa in parte espandersi e funzio nare (1) .
Negli interventi per sutura o per r e<:ezione polmonare dovranno perciò :,;empre prevalere l e piccole breccie toraciche, fac ilitanti la trasformazione del pueumotorace da aperto in chiuso.
Esiste nei cani un diverso grado di tolleranza a.l pneumotorace operatorio aperto, Llimostn1to dalla varia bill' intensità dei fenomeni dispnoici e dalla maggiore o minore x:apidità co11 lo. quale essi soccom bono.
L'esperimento dimostra che i l'ani emaciati, i deboli, i molto vecchi godono di questa maggiore tollerani\a.
Associando al semplice taglio inte r costale la mobilizzazione di parte delle due coste adiacenti, per il tratto che corrispond e alla lunghezza della. incisi one dei tessuti molli, n e risulta nei cani una breccia sufficiente all'asportazione di tutto il polmone di nn lato.
Fa\""Oriscono l' esec uzione della pneumectonia totale o parzial e e delle s uture da eseguirsi sulla superfh; ie convessa d el viscere in prossimità dell'i l o l e incisioni to raciche posteriori, che facilitano l'at·cesso alla doccia cost,o- vertebrale.
Sono della maggiore utilità tutti q nei mezzi, che rendono facile l 'accollamento degl'archi costali integri o fragmentati sia al peduncolo del viscere, dopo la sua estraz ione, sia fra loro durante la chiusura de11a ferita. toracica.
Corrispondono efficacem ente allo scopo l e robuste anse di seta perieostali da m e spe rimentate.
(1) tu alcune esperienze non riferite io questo lavoro, nelle quali non ru applicala la pinza cmo· stalica sul peduncolo del \'Jsccre portato all'este rno, si verìncarono attraverso Il medesimo, dopo· l'oc· elusione temporanea della breccia toracica, rreiiU Cnti irruzioni di aria, verso Il termine del· l'esperimen to.
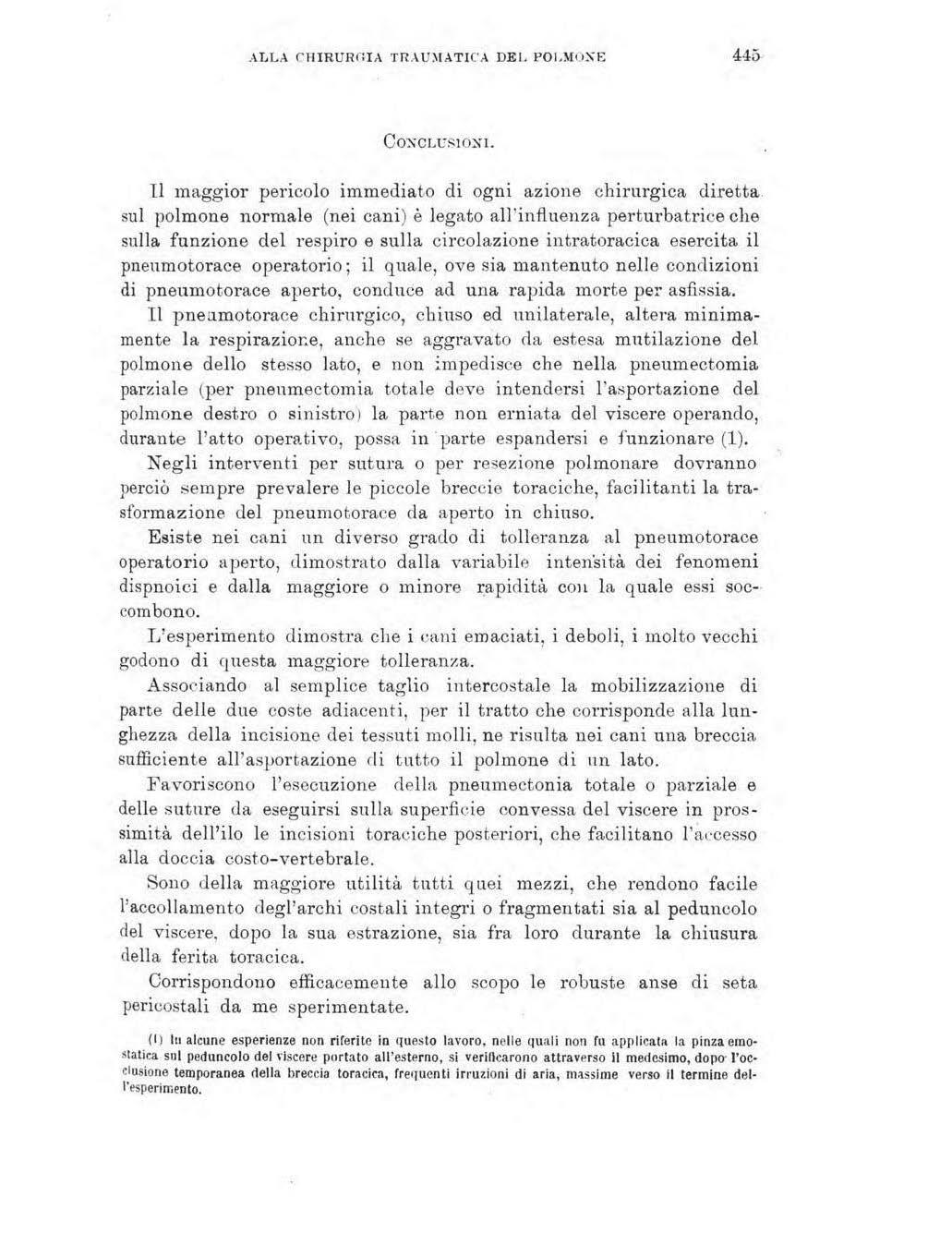
ALLA ('lflRURC:IA DEL 445 CoxCLUSJOXL
Per la semplicità di esecuzione e p ei loro risultati anatomici debbono n ella sutura polmonare avere la precedenza i due processi ideati dal Lembert e ùal D'Apolitu per l'enterorrafia. ol tre a darci una sutura nascosta, p rovocando l'affrontamento per introfl essione de i margini della ferita. consentono di evitare, specie nel trattamento <lei monconi dopo la. pneumectomia., la riunione delle snperfìci cruente con punti perduti.
L a pratica delle pneumectomia. è in n ocua, quando non si tralasci l' accurata sutura del moucone residuo, per la. q u a l e presta.si ottimamente il taglio cuneiforme facilitante la riunione dei margini nel modo sopra descritto .
La sutura d ei monconi deve essere preceduta da una accurata occlusione, da praticarsi con !accetti di ca.tgut fine, delle boccucce dei Yasi e dei bronchi visibili sulle superfici di tagl io.
Questa pratica co nsente di ottenere la cicatr izzazione per prima de lla fe rita c hirurgica polmonare e la costituzione d i u n moncone rego lare non snscettibi le di contrarr e ade renze.
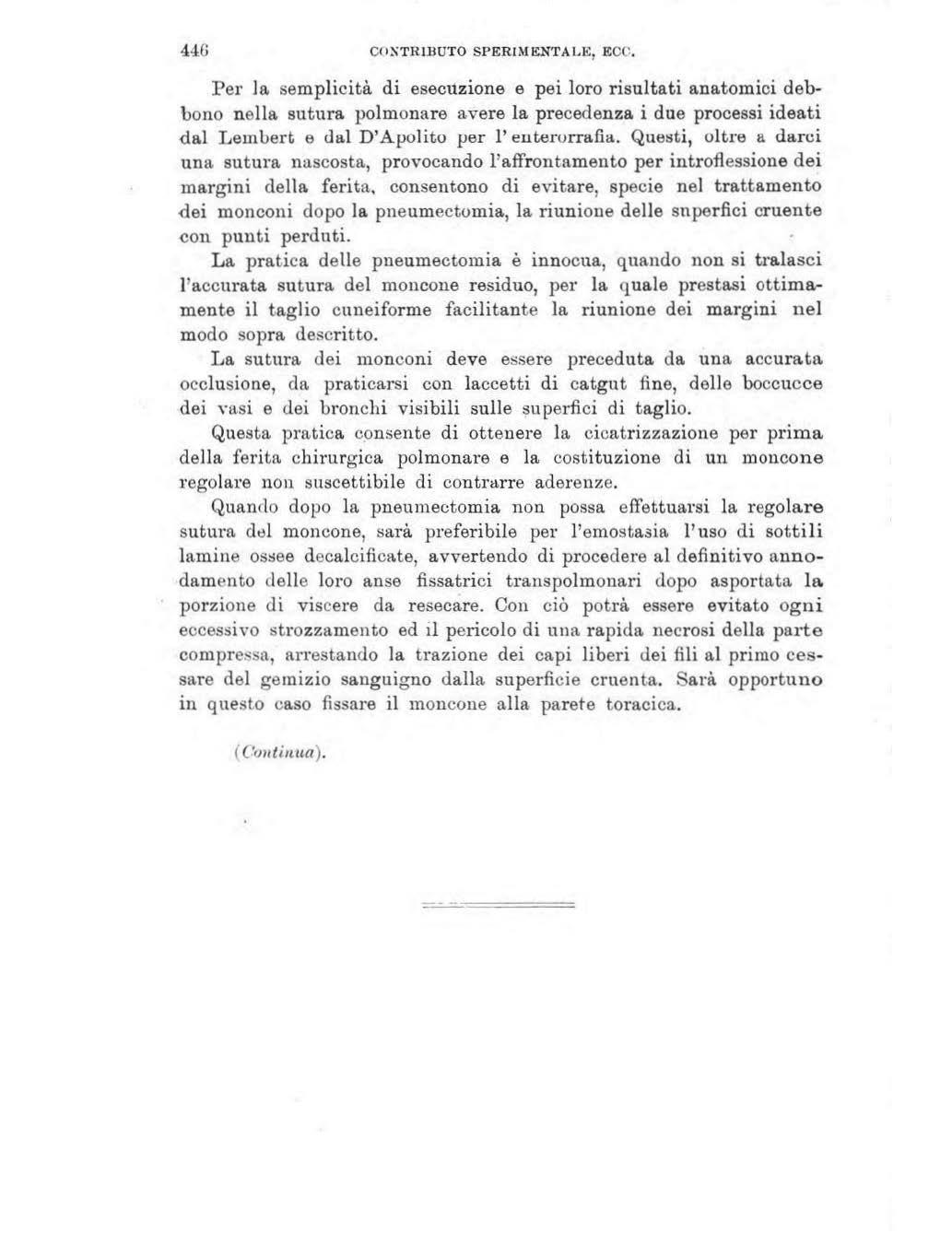
Quando dopo l a pneumectomia non possa effettuarsi la r egolare s utura do! mon cone, sarà preferi bile per l'emostasia. l'uso di sotti l i lamine ossee decalcificate, avvertendo di procedere al definitivo ann odamento delle loro anse fissatrici transpolmonari dopo asportata la porzione di viscere da. reseca.re. Con ciò p otrà. essere evitato ogni eccessi,·o strozzamento ed il pe ricolo di una rapida necrosi della parte compre,.;sa, arrestando la trazione dei capi liberi dei fili al primo cessare del gerniz io sanguigno dalla superficie crnenta. Sarà opportuno m q nesto caso fissare i l monco ne alla parete toraci ca
( C'outinua ) .
44G CCIXTnJBU TO SPERIMENTALE, ECC.
RI V ISTA MEDICA
A. F .-\.. K t NG- Un uuoyo tatto eUoloaloo della febbre ma larloa el uaovt metodl 41 oara ohe ne cllpendono. - (Med1cal Record, 2:1 ma ggio 1903).
Il dotl. King lta pubblicato con questo titolo una memor ia nel fasc i colo di febbraio 1902 dell' Amer. Journ. of the Med. Sciences. Egli ritiene che poiché la febbt·e malarica é stata prova t a essere una malattia parassitaria i cui porussismi son pi'Ovocati dalla sporulazione nel sangue di s uccessivi di pat•assiti è utile ristudiat·e alcune n ostre an ti che idee circa l 'influenza dei fatto1·i meteor ologici dell'etiologia di questa malal!ia. Per lungo tempo il calo r e solar·e é stato ritenuto di primat'ia i mpor tanza nell'eti olog-ia della malaria ma l'autore t'iliene che non esiste dimostrazione scien t ifica p er consider a r e il ca· !ore solare come un fattore etiologico, ed egli vorrebbe spiegare l'in negabile r elazione che e sis te tra i chmi catdi e la febbre mala rica sostituendo a l co ocelto di ca?o re quello di luce. Il dot t. Kin g quind i propone come ipotesi probabile che e la luce del sole e non il su o calore quella che dettH·mina sa n gue lo pe· rtodica sporulazi o ne dei parassiti. A dtmostr·aziooe di ciò egli cita i seguenti dali di fallo: l' L'esper ienza di molti ser.oli la q ua l e é stata addotta per provar e che il calore solat·e è la causa -:Iella febbre malarica può i nvece invocar s i a favo re della luce solare; 2° i paro!'<sismi di febbre intermillente non si avverano, com e t·egola, d t nolle al buio ; :3° la se ngibilila relativa e la immunità r elativa delle , ·ar te r azze umane a con tr11rre la malaria dipende dalla l r aspa r euza o n on relativa della loro pelle e probabilmente auche del loro sangue; 4' n ei paes t in c ui pt·edomma la malaria i casi aumentano con un tempo chiar o, e diminuiscono co n uo cielo coperto; 5° é antica tra dizione popolo re che per prevenire gli acres!!i febbrili o l r oncarli è opportun o tenere ammalo Li all"ombt•a ed evitare la luce !'\Oia r e; (i' il parassita malarico é un'amPba nuda: la luce r ossa aumenta l'atti vità dell'ameba mentt·e la luce v i oIella o pot·poro la dtminuisce. La luce di fl'u sa dal sangue 1 \ di rossa.
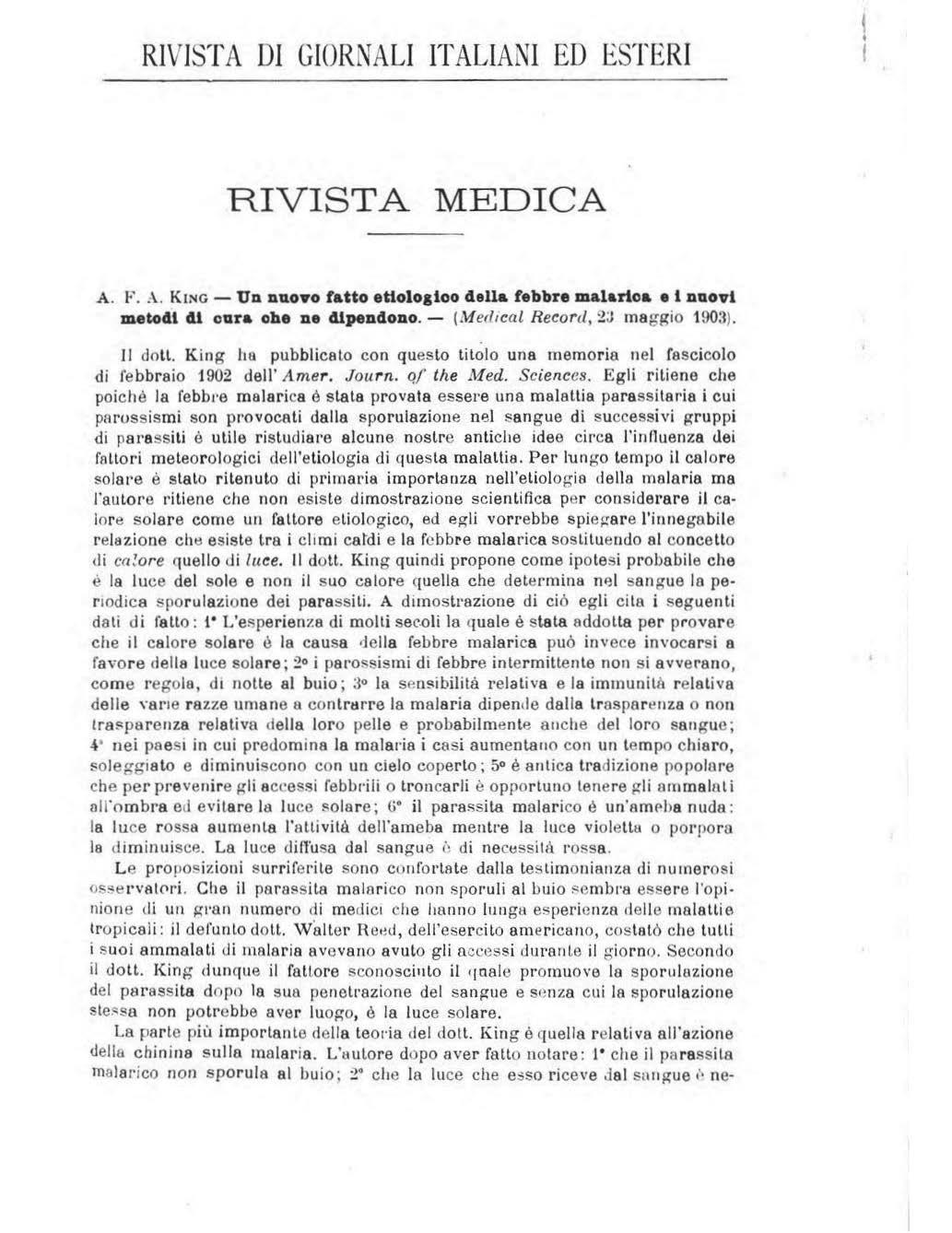
L e propo!>izioni s urrifet·ite sono confot·tAle dalla te stimo nianza di numerosi (IS:<e t·vat<>ri. Che il para!>sita malnrico non sporuli al buio ;;:embt·a l'opi· nione di un g•·an numero di medict rlte honno lungu esperi e nza de ll e malattie tropical i: il defunto dott. Waller Re t!d, dell'esercito america no, cos tatò che tutti i s uoi ammalati <.li mal aria avevano avuto gli durante il g i o rno . Seco ndo il dott. King dunque il fattore sconosci11to il qnale promuove la sporulazione del parassita dopo la sua penelt·azione del sa ngue e senza cui la sporulazione stei<sa non potrebbe aver luogo, è la luce solare .
La parte più importante della teoria ùel dott. Kin g e quella r elati va all'azione della chinina sulla malari a L'uulore d1)p0 aver fall o no tare: L ' che il pa r assita malat·i co non sporula al buio; :.!• che la luce che esso ri ceve dal su ugue ,., ne·
RI VISTA DI GlORNA LI ITALI AN I ED ESTERI
cessa1·ramenle 3• po iché secondo le dimO!'lrazioni di H a r r i ngloo e L ea rn ing rarneba p r nteu !' si mu o ve nella luce r os !'a e si a rr r e>' ta nella luce vio· l et:fl, lo stesso può a r gomentarsi per l'ameba della 111a l a1'ia, emette ropinione d re r a:t.ione l <n-apeutica de l l a chinina può esse re dovuta alla sua elle produ ce ra ggi violelli n el sangue.
La pr•owl ap)'ot·tata a fu vor·e di p>irle della teo r ia ha nn cer i o Sè non é d"l lutto decisinl. In p1·imo lu o llo si fa notare eire due allri prodotti v eg-e tali c h e 11 11 g raJ o n oleYol e di fluoresct' nza Rzzurra l'escu lina c ioi: e l a 1"1"11 :-'Sina , sono da lungo t empo no li com e r·imecli e lfiCtl Ci co ntro la m a l t1r·ia. Ma rwove piu con vinc enti sono per· dimostrar e eire la chinina a l t emp(l s tes!"o ch e produce nel sangue fa i sintorni della febbr·e. Simili r·i strllali furono ottenuti 30 ann i Ol' ::>o no ( 186/l) dagl i espe r i m enti dei clùllori Edun r du Hlwads e Gugli elm o Peppe r di FilA delfia. Gli Accenn ati esperimenti !'!an t e la l or o lun:rhezza n o n st pOS!'<OIIO qui l'ifet·ire, . 111a basti il dire c h e m l'dici prova t·ono in par·ecchi c nsi ei re l a 11uor Pscenza del s angue er a g-randem e11te dim i nui la pe r dfetto de l l a mal aria e c he in due cas i l a lluor escenz.a fu uumentala col r esalla Ji solfat o di c h i nina ouent!ndo guar·if!ione.
L"aulo 1·e !'piega quei cnsi in l a chinina non f! Uar isce , di cendo che i l par os!;'.if;mO febb1 il 1 • u nn é rleterminato dall ' o r·Ji 11 ario p81'8Sl'ila della te r zana o l]uarlarta ma dal l a forma m altg na d c!le !'emilune.
Secondo l e semilune no n si t r o,·ann generalmente circolazi o 11e peri feri c11 : si t1·ovan o nella milzA, nel f ,>ga tn, nel midollo d elle ossa, nel ce r wllo, nei più o!'curi ret:: l'ssi in c u i l e p1·oprieta fluor·esce n li della c hiu i na non posso no esercitare alcunA azi<me.

Sulla immunit;"t r r l aliva dei n egri a con tra1·re la malatti a il dotl. emette dell e opininni l e •runli sono in nrmonra colla s ua t co r·ia.
La l eo1·i a del dott King su ceinta ut en l e espo!" la più s u può esser e soggella u mol te c riti ch e essa m e r·ita tu t ta ratt enzion e dei m edici i n vi !' t.a d el iA ser ietà dell'autore i l quale fin dal 183:1 pr·ccorTeudn i t e mJ'i aveva m an ifl!l"talo l'opinione c he le zanzfi l'l' potevano la malaria
B t Nnt. - o..ervazlonl sul sangue del malartol reoidlvl a lungo periodo. - (f a (..' l in ic" 1110dr rna, 1!)0:!, n. 3:1).
Con una tecnica rnollo semplice. rna abba;:;tanza esalta, con s i sten t e nel pt·cudci v etr·i ni di sangu e be n e !'t r fllificalo, e;;siccal'l i , lir·nrci alcune J'ighe in vari o a sropo d i r epere. e col orarl i col bleu d r m o t i lene ed eo;;i na l"autor e ha ri cerc ato le va1 iazion i dci p-l o bul i bian c h i uei malarici a l unf!a d enza. rico r da le ri cerche anle ri o l'i sull'èt r gon,ento e rne t le in eviden z a il fatto che oggi è ormai assodalo, c hP- c ioè l a maggio r pa1·1e dei casi di mala r ia ne l pr. rindo epidemico !' !ann o a t•a ppr·N•enta r·e recidive dell"anno precedente. L e !'.UC r icet•cii C con f ermarli) upp unlo ques to co me pure confermano ' Juanto e ra giò n oto sulle var iaz ioni della fo r mula l eucocilar·i a nell" infezione 1n ala rica. Ecco l e con c lwdo ni a cui un ge l"auto re:
l " Che i l malar·ico e:: is l e in ogni s t agio n e dell"a nno, per impet•f<!z ion e Jr cut·a, o per so ver c hia l'l'si s t.enza dell"arneba malar ig ena.
2• Che f!ues t o c onc etto induce a consider·ar e il numer·o dei mala r i ci r ecidivi co me a ssai elevalo. b en piu el e va t o di quan to fino r a fu forse cr eduto.
RIVISTA
3• Cile la fot·multJ leucoctla t•itJ nelln mahlt'la tnl)dlfi<:a f.irantlè rn e11lc, 11,.,.ndosi:
a} A umeulo nella pt>t•ceuluale dei monouuclca r i. s ia "ia miuori:
o) Diminuziom• uel la l ' ercl'ntuale dPi polinul'l<'ali ueutrolll1;

e) Dimin uz 1on e uncnr piil fnrte nei polinucleuli l•ao:;olilt:
d) Onninuziono Ct>nshler evole uci pulin u cleali eo!<inolìh.
l• :ti 08"ervano falli dt>J!euet·ativi nel nutlrn e uel d ..i :iuroc1l1 mn;::-giori o miuor1. r ,..::.,(venb!'i iu una mintJre affinil.t cromulie& de l nucleo ed 111 falli di vacuolart:l.
s• Che laluni linfoc1ti ma!.;giori assumouo uua ronoa t11 cellula endoteliale.
6° Che an co nei h•ucnciti polinuclea ri neutr ofìli esistono nd nucleo e nel pr olopl a '! ma fal l i eg-uali di ti(';::-e,:c ra zi.,ntl vacuoiRre. G. B. M. A.
VACCARJ. - Le manifeat&zloDJ c u tanee nel oorao della malaria .- (La Clinica moàc r na, 1!)02, n. :>2).
L (• os;;e t· vazioni d i nel ll i un 'i nfezione malut·ica ;;o11o mollo rat·e. 1:: sta ta osflervo ta il pin spesso un'er uzione di o r·Licat·ia, e Jl8 1'ecclli auto r i ne fanno parola. Si ,} nnc lte II>'!'P r vata la po r·porA P J'er•peLn.
L"autot·e ha avuto occas10110 di Ol">'e r vare un ea,;o che t'1fe r 1sco ,_n re·i utalnent{•. Un timoniel'e della R. uav,• !.iyttT'ia viene collo da t'ciJhre, ac:eompagnala dA v o milo, l} lingua impan iaLa. Su tull o il co1·po s1 110lauo pomO di o ruca ria, vasli, poco l'il evat1, i rr egol ari, rossastri. 110n prurigino:-i. La fl•l1bt·<l cade la e l"ort1cat·ia. Uopo u11 nuo\·o acce;;:-o l11 febbre e d1 nr ltcal"ia. e poi, !lempre ati un di distan/.R, un l<'rzo llCC•·R,;o, Co!<iccltè O'>stt'\·ar·ono tre acce>'SI febbrili a livo l cr zano, e contcwpo1·aucamente tre l'rUZIOIIi di o rtt cn ria c h e con1pa1"1V8 llo coll a lebbre e con -..;.a spdriv11no.
I n pr indp1o si suppo'<e che >'l lrall11s!<e di un'o1·ticarin ao inyeslis, e furono 8vmmini<Ùra ti pm·gauti e di i nfettauli 1nlesli11>lli, c he del re;.lo furono incflicac 1: 111a in ,..E"guilo la per tOd1ci tà convin!"e i medic1 cu r anlt l"he si di mache ru confcnnata dalJ"c,.ame del !'iln).!ue. I l d11niuo !!uari rapidamonte tuiLI t ft>n o meni.
Cito In forma cu tan ea o;;,.entl la tlnll"autor·e fos,..e in d q ('tld.-nza dE'Il" inrezirme rnalar1ca, 11011 pare p08"8 m eLtet'SI in dubbio. Ma fA !!iustarnenlo 'a•·e como a t·ig-O!"t.l non po»>'a chiamArsi orticaria . l ni"Hlli 1 pont ti crn nn upprna rrlevat1, coufluPn li , it·r·egolari e !"CnZR pt·urito, 1"11ll1 eh·· non ;.i ''""''l'Vano n ella nrticAr-in. Quindi l 'm·ticaria da malat·in può d1sli n a:uer :-i nctllllnelltf! dnll•· altre lot·mtl n nte.
Quanto 11 1le CUU!<c di ta li PI'UZIOni da l'autore r·icordu l o va r1 0 ipoto::.i ,.tnesse fì no Ad per spie;..'flt'e le eruzi oni cu t anee nel eqrso di pr·ocessi 1nfell iv i. S i deve pensat·e una i rl'ilazi o n e di r ell a della cu t e, per l'climin(lz.iou e col su,!o r e dei p 1·odolli t'laborali dal para ssita, o a 1nod i ficaz i o ni istodci nucloi-proteidi, ca usate dall' i n rez.io ne 1 Opp ure si devu pr-: nsare a un fatto m ('ccao ico ci r colatorio per nurnet·osiss irni c mbn lt miCI"O!:'cop ici ? Od anche s i deve a mmellere un'azione dello sost.anze Los"ichr sui ccnl1'1 nervosi e m ispecie sui centri vnsomotori1
L'auto r e riporta l o obbiezioni che possono muoversi 11 <·iascutll.l d1 queste teo1·ie, e senza d eculer:>i in modo assoluto, lt: nde ad accettar·e l' id•:a sos t enu ta
'!'J
Rl :UEDH'A
- l:iorn(l/e mtdlco.
dal Larcdde, che l'azione dei corpi sulla c ute si ese rciti merce alteraZIO ni !:'8nl2'uigne, c he a loro volta sooo causa di quelle cutanee.
Da ultimo l"uutorn ricorda tre cAsi analoghi os servati ÒA lni AIIIAcP.tlentem entP, c c he erano c ertamente in r appot"to con la mala l'ia, sebbene non fosse sta t o fallo l'e'lume del s angue. Anche in quesl i gli i nfermi non avevano preso chinino e perciò n on si può suppo rre cb e fos se la della eruzione.
 G. B. M. B .
G. B. M. B .
- n trattamento clelia aoarlattlna col dero clel oon•aluoentl .
- (V e ut. A re/t. f. k lin. M ed . , Bd. "i"3, S . 616) .
Gi à da parecchi anni n ella clinica del Leyden gli ammala ti di po lmonite o ùi s Cilrlalllna v enivano curati col siero elle veniva estratto dai convale scenti tl i que«le mala ttie Bra 12'ià stata dala comunicazio ne antec edente mente di 1:1 casi. in tro dei quali la g uarigi o ne si era potuta manifestamente accele rare. L'autore Ila po t uto in comuniC<JJ"e altri tre uucvi ca s i, in due dei quali l'andam ento della malattia ò stato i nfluenzato fa vorevolmeute. La quantità di sie1·o d1 (' p er lo più è stata in iettata ai malat1, è stata di circa 20 cc , al c une voltf' poi sono stati ini ellali anche 40 cc. in una sola v o lta. Non 1 \ s tato mai Mservato alcun danno ptJl malato alll'ibuibile alle iniezioni
G. B. M. B.
s rn ,,us - 8al ohllotorace tubercolare oon oontrlbuto alla cllagno•l ohimica • mloro•coplca clet ••namentl patologtct. - (C haritt1·A nn a / Pn 1!}()2, pog.
U n o p('roio d ell'etù di -12 anni ammalò di 11na ph>urile , s ierosa sinis tra, e d i ed e r eazio n e pos itiva iu seg'•Jito a un ' iniezione di tubercolina fall a a sc opo d ia;ln ost ico. La pleu r ite I!Uari perfettament e. Due anni più tardi il malato am· malù d i un nuovo allocco acuto di fe bbre, e si costatò in lui la c o m parsa di un ' 'el·«am e nlo c hi l o!'o n ella <:a vi là pleurica des tra e n ulla ca vilà addo m i n ale Dopo la p untura di q ue«l e cavita s i o ttenne un sen !>i b ile mig lio ram ento , ma •l opo q ualc h e mec;P il mal ato mori impro vvis amente. L'autop!'ti a rece ril evare di una h·ombosi dell'arteria po lmo nale d es tra, ed ino ltre una lube r· c-n l os1 gen eruli zza t a, C'On comparteci pazion e purti colo rmenle a ccentuata d e lle m em b rane «i e ro se. >; Pil a c avita pl eurica s inistra es1s t t> va ancora un •·es1duo ,)el Ri PI'O!':O, il qualù ave,•a pe1·duto com pl etam Pnte il c orallere c h do!'O
Quautu11quo da di ve1·!.:i an l o l'i s ia s tata po !>ta i11 c hiara lu ce l'impOI'ttliiZA della t uber·colosi de l do llo lo r acico peL' l'o rigine de lla tube •·col c, si miliare, tuttavia in r1uesl o cu,.:n spcci ul o non è possibile ri schiar co n c ertezza il m eccani s m o s pe· <:ialc il q•wl •: la C'Onn essione del chi l olo•·nce colla tuber·colo si. 1 :: p r o bobile c li o le prod uzio ni tubrl"colal"i abbian o in,·aso per il dotto .tor·aci c o G n e ahhi ano ll!':Ut'oln le pareti.
.ji)l)
RIVISTA ME:D I OA
G 13. M. B.
RIVIST A CHIRU RGICA

B A R D. - L 'uo del •ltoae per praUoare e Umlt&re l& toraoent..l . - ( Reo. méd d e la S u i38" r oman de, nove tobre).
N el tratta m en to degli essudati pleu r itici siero- fì bri nos i l a lorace nlesi n o n v a esente d a fJ URi c he in conveniente; bisog na es trarr e abbas tan za liquido, o nde l'a mmala to n o t evolm ente solle vato ed il processo m or boso sia arr esta t o, m e ntr e d 'allra por t e non se n e de v e t og li et·e \ a nlo per n o n es po r·si a g r avi acci den ti e pe r fino alla m o r.te i sta n tan ea del l'i ndivid uo. Sono s tati p r opo!< ti v a r i m ezzi per otten et·e dolla t o ra centesi tutti i be nelìci , di c ui é co pace, !"enza es po r r e il pleurit ico 'a compli•·az i oni sp iacevoli ; ma, o si tra tti d el la limit>izi o ne a t•b i trari a d ella q ua n tìta di liquido da estr a r s i, o d ell'o!<pi r azio ne futta m o d eratam ente, o d ella ridu zion e ad un certo la sso della v elo ci tà el i !'!Colo del l iq uido m edesi m o, ness uno d i essi :;<oddisfa allo scopo , perc h •' n es!l uno t iene c o n to ù i u n fatto r e de lla p iù alla i mpo rtanza : l a fa cili ta pilt o m e no g ran de, co n cui i l polmone v i en e a rim pianat e il vuo to lasciato dal litrui do es tra tto.
L'A fì n dagli u lti m i t.em pi a veva adotta lo co m e c riteri o de l m o m ento in c u i c i si deve nella estra zione dell"e!lsn da t o, la c·o m pa r ss del la d ispnea. E' u n prez ioso, mo niJn esen te da c r itiche . Certi malati pusilla n i m i, e c h e s ubi«cono la to ra centesi a malincuo• e, ben p r es to u n sonM di opp r es<;ione, in par te pe1 • lo con trar io fJUelli che spera no i n u n a g-ua t·•g•o ne Ul ulo piu r npida per quanto più liqnillo veng-u Pslrall o, l"i c;;ror · z ann di l'!Opportnre t i ma lel"l<ere che p r ova no fJUanlo piu l u ngamen te po'ì!'.Ono.
P et· queste l'A ha voluto r icer care pet· l a opportuna indicazione ll n metodo obbieltiro, afl"all O i ndipenden t e del la volontà del ed ha il pr oce!"so:
Il vu otRmt>nLo del liquit!o deve pralicll r ><i, non ro n l'aspirlltor c, m a col mezz o di u n !<6mplice il Ll'(•qnal"li dell"appar ecchio eli Potai n serve beni!'sirno, p ur•c hé si a lali• al la stHl Lubu lalu r·a latet·ale un tubo di caucciu di un m etr o di l un1(hezza e ler minanlr5i in u n t ubo d1 ve tro, lungo c·ir·cu 2:; centim etri e CIII ca l i hro rnlern o ugua l e n quello dell a can nula de l treq u ar·t1.
l'o ppa r er.ch i o di l ig,..•tleme ute a selli co, s i tun·a l'e!<l l"o mi til di vPtr·o in u n r ecipie n te p i en o el i lirp ti cl o, posto s ul su ol o a l!1 Ln tl el lett o d••ll"o rn m a l a to e f1-1 la pu nlU I'8 col l t'eq uar t i i n co rr isponderLza dol l'8' spo zt o inle t·col'!lal e o·o r d ina r·in. fl UOndo ti r·ubinctto d el t rPq uarti è> fl l'er·to, si pmd uce il vu0 to n el l<ifon e; qua l o r a ciò no n succeda, !l'tn vi t a l'a m m a lAlo a I l lrq uido com i n c-io o !<Col ar·e e non apprua l e p r·i rn e gocce h nn n o por ta to v i a lo b oll e di aria conten uto n PI tubo, n e lo sco l o il tu bo d i caucciù co n ùue di ta ; n ello ste!<:>O t empo !l i pr·ende il tu bo di ve tro dul r ec ip i en t e, in cua pesca, o lo si tiene ù r itt o contr o il lor·a:!e del malAt o, in m olo che i n<'r oci ver tlcnlmPn te il tro<tuar li. Si cel"sa a llo ra di il t ubo tli ca u cciù e n el
4 5 1
tubo di vt>tro si avr·à una colonna lirtu itla , il cui li vello in rapporto ai movimenti respiralol'i; le nelle pleuriti essudative di media quanti Iii ne funno in f.(enerale variare il livello da 2 a t O centimetr i al dì so,,ra della cannula fl c l lre<Jua rti.
RilevatA l'altezza della colonna lirtuida, si rimette il tubo di vetr·o nel recipiente, ove JH'ima era, e si continua il vuotameuto dell"e!<Sudato; l'ipetPndo dopo un certo tempo la manovra pocanzi i ndicata. Siccome il livello di quest'ultimo n el cavo pleurtco si va man mano abbassando, le nscrllazio ni del livello della colonna li•Juida nel tubo di vetro si ri avvicineranno sem pre più al tr ertuH rli, ed infine si vedranno al di sotto del medesimo. Ebbene, quando l e delle si verifìcher anno presso a poco da l a 5 centimetri a/tli 8otlo della rannula del trequarti, bi"'n)Zna sospendere il vuotamento clell'essudato, nvrndo l'c!'perieonza dimostrato all'A. che in questo momento la pressione tnlrapleurale alla superficie dello sle!'SO ha r·ipreso il ,·alor·e del vu o to iulrapleurale - con di1.ione essenziale perché l'affezione decorra favorev olm ente.
Il pt·oces!'O in discor·so perde preci>'ione quando nrlla colonnn li'(uida si contengono bolle d'aria; per ciò qualo ra si verifichi evenienza. bifa r scolare nn po' del lirtu iclo ste!'SO per espeller·ne l'aria. Desso non é app l i cabile nei cusi di pleurite purulenta Se lo stolo del lirttlldo pare troppo cel er'e, !'IO no può moder·are la velocitil, d iminuendo l a lunghezza del sifone, e per·ciò si solleva più o m eno dal suolo il r ecipiente, entr·o cui pesca il tu b o di Yelrn .
I.'A. fin ot' A lrn aJoperato questo processo in una ventina di t o t·a cen t ••;:<i. Come rst•mpio del buon ri sulta to, citn il caso di un malato, n el quale i11 una solo !'r•tlnla pott! estrarr e ben 3:300 gr. d i liquido, ' luanLilà di lunc-a superiore a rtuella che empir·icamenle credesi rh poter· estr·at•r e in una volta; l'es>'udaln non si r·iprodusse e ben presto s'ini7.ic'l la convalusr·enza. [ n un altro caso il ,·uotamento drl liquido si sospese a liOO gr., prr·chè l e o>:cillazi oni del111 colonna liqutda nel t ubo di vetro er·ano da 9 a 1;> cm. al J i sotto del tr·e'luarti: dunrpte il ,·nola mento era l'taln spinto troppo oltr·e. Non ;::ucce!'c;e alcun llCCidentr, ma l'es<>udato si riprod u!'se t•api domen le ; dopo 2 l!torn i sr pr·nttrò di nuo,·o lo to rac en tesi, badando di arre stors r •lU&nrlo la rolonna liquida nel tu!Jn dt v etro osctllasse da 1 a 4 cm. al di solto della ca111rula f l e l trP•(ullrlt. Questa voltu il fu completo, nonosta nte che fossero stati estratti 1500 di essuda to , cioé rtuasi la quantità della seduttt (lrf'Ce,!ente. L '. \ . c r ede polc r spie la dinerenza dei risultati nelle dur t:osi ravvi c inate ed in condi.-:ioni presso a poco identiche, con la diiTo.>rf'nz.a della pressione intrapleurale alla fine dell'una e dcll'alt r·a ope ra z i one. C. Q.
G. - Sutura. olroola.re delle a.rterle . -(La Glinica clti r u r qic a, gingno t 902).

L'autnre termina il suo lavor·o con le seguenti conclusioni:
La s utur•a delle arterie é possibile nel le ferite l ongitudinali, oblique, in complete e complete.
Tale s utura devesi praticare accollando le superficie endoteliali di cia schedun Ialo, l 'una contr o l'altra, arrovesciando infuori i bordi della ferita. l punti di suturo saranno passati a tutto spessore attraverso la pat·ete.
1&2 RIVISTA CHIRURGICA
1 l
: · . .. l, .. ·.
Kilo
operando no n avt·assi a temere la fot·mazio ne di alcun rrstringimenlo dt·l lume del va so, né immediato come succede nei proces!'li di inflession e o d"tnvaginaziooe, nè consuntivo, como !l rcade co nsccuti vam.:nte alla form az i one di un lrornbo ·

Co:n pure non vi sarb pericolo che ahuian:>i a rormÒre llnell!·ismi, poich(· l a ciclllr ice che si forma è solida e CRpoce di snppot·tat·e la p rA ss ion e della corr·ente
00\-rassi adopel"are la a punti stacca ti, prllticnla cn n ago so ttile e C'In ;::••la m o lLo fine, est:lndendo a'lsolut!lmente il
T<!l genere di :>utura tl"OVIl le !'llO indi r.az r.,riÌ n elle reri le dei g ro ssi vasi corm, 1"11orta, la vena-cava, In ca roli (.IP, la succlavia , etc, n er casi di aneu r i :>mi traumatici la di cui pal'ete è islolngicamente norrnale. Non è oppo r tu no impi egA rlo quando esr:s te arteriosderosi. G. B
• -I oalooll •ali vari 4el oanale 41 Wharton e della ghiandola
•ottoma1oellare.- (Jourh.al cle .\1r:decine el de Chirurgie, ottobre l !lU2)
:-l"urn et·llSC teorie Rono E'rnesl:'e per "PiL•gare !11 forrnnzione dei c11lcoli l'aliva ri. Galippe ammet te nnr,zic•ne delle vie "fllivari pt·ndotta dai tnict·obi, i '(Uali, per un'a zion e nou ancora ben determinata, provoclt••rebbero la formazione dei c al coli. Ma Snbrazi·s e .lou ssaume IIPile HumPr"ose r ice t·t:h e l'al t e 11011 hanno trovato che poclti!<i!'irni mict•obi, pet' c ui occot·t•et·el >hf' r O nuovi stud i per confcz·mare la dotlrlll& di Galip pc l calcoli, ch e no11 ol;rt>pAssono di molto il pe"o med•o di 1111 gt amm o, !\Oli O compo..:;li sopra tullo di fosfato e di cat·bonato di culce congiunti a mat<' ria o rgani ctt Le che e""i producttno sono una dila t azione ùel rondo Uo est: zetore, una infìamtnazione c ronica <Ielle put•eli c h e può ca u,ar·e un» sclero!'i e l'au·olia della ghiandoh•. Mu è -specialmente n ella sintomatologia che si osservano alcune parlicolaritù def!ne di m e m. ion e.
l n cerLi Cflsi l'affezione può esse l'e latente e tal volto si so no ,.e,luli rnalati e!!'pelle r·e !'p<•ulaneomente un calcolo senza o lcun dolore. Alt r e volte, al c<• nlrario, il dolore compare bt·uscamente, acuto, lancinante, parossistico. l n cer ti casi, ness un sintomo l o pl'evederc; ollr·c vol te, si forma una tumefazione sul pavimento bot:cale, che diventa tes o, d uro, doloroso a l la pr e!'-<=ionE' . La deglutizione strappa dei g r idi al ma lato, ed il dol o t·e è vivo, nel momen t o del pas t o. Poco a poco la lar·e si tumefa e può pt•oporziooi considerevoli. L 'acutezza di questi dolor j il l o r o inizio il l oro rne cctmismo ed llllr i si ntomi concomil<ulti, come l a febb r e. l'inappete nza, l'eccrtamento cerebrale, le nausee ecc. han n o follo rlare a ques ti dolor·i il nome di colica sal rvare per analog ia colle co\iclte epatiche e nefritrche.
La durala di quesli do l o ri è va r iBbile.
L'inte r·millenza dei dolo r i s i può con la !Jrodu zi one di una specie dr solco alla super fi cie del cal colo che lascia pAssare abitualmente la iu p 1ccola quantità, ma che può otturarsi in seguito a d rve r se influenze, e 'IUindi cagionar-e i fenomeni dolot·osi.
I n seguito alle coliche si nota una congestione più o meno conside1·evole della ghiandola sottomascellare, plialismo e l'inferm o avverte come punture
RIVISTA CHIRURGICA 4G3
d'a:<o nella rf'gion e sopra- ioidea. Ma tutti gli aozid<! tti fenomeni scompa iono in gtmerale mollo rapi damen t e coll'e!>pulsione completa del cal col o.
Accllùe ch e il calcolo così carciato cor r o da e rompa i les· suti mediante l a sua super fic ie rugosa ed Esso vi apre allor a una via allraverso la mucosa del pavimento boccale ed esce per un ro•·o grande e beante : la flstota iRierna è formata.
Altre volte, il calcolo resta come incastonato nella che non ha potuto altra versar e: la qual cosa ha fatto c redere a m olli Autori cne i calcoli salivari non •·1siede«ser o n el canale di \Vha r lon.
In fine, rarisRimamente, il calcolo si a prP un pa<:saf!gio dalla p arte della pellt>. L a fo•·maz1one dell'aper tur a è pr eceduta da un flemmone che suppurA e dall'orifìci•l escono, in mezzo alla saliva , pus, ed uno o più calcoli. Queste fls t olo sono molle> ra re, ma sono ed i fenomem infiam· malorii che hanno accompagnai<> la loro fo rm azione sono g1à da mollo tempo scompa r si, mentr e esse persistono ancor·a.
In conseguenza della slasi saliva•·e che ri s iede dietro il ca lcolo, e intimi ra ppporti che esistono t r a il canal e di Whar ton e il mezzo bocca l e ricco di mic1·obi, nrtroccos ione di una qual siasi i nfluenzA ( lraumut1smo, into;;sicazione) posso no prodursi t:n'infezione od u•l'int!Ammazio ne de l condot t o elle p o'<sono tìno all a gh 1and ola sltoSM l flli c r obi favor·iti dfl llA r ilenziono deliA R11 1iva in num ero e in virulenza ed è appunto i n fiue ste con di zion i c he !l i pos«ono osser Yare degl i e deJ:h adeno-tlemmoni più o meno
In tali casi, si una tumet'11zione ta l volla c n orm t> del collo e di t ulla In guancia, i ganglii Jinfattci sono il cellulare e inlìlt ra lo e duro. e la é r o«sa e calda. Nell'interno della boc·ca, l'edcm11 é m o lto pruJIUI1Cialo e puo proYocnre accPssi di soffocazione; la é tumefAlla e prr.,enta profonde 1mpronle dPi denti, i margini edematosi. Il pav1mento bocrale è ros!>o cupo e un r eticnlo di vene Il molato ha ill!"()nflin. !<Cle t>d a11ort>ssia. l dolori sono acuti.
La J>l'!';.:no!'<i i· m ,gerwr11le m olto fllVOJ'P\•Oie.
Il traUnm!'nlo sarò profìlallico e curativo. Siccomo pare che i microbi delia boccA ravorn•cano la produz1one dei cAlcoli, :>1 cercllf'rti d1 sopprimerli u<:antlo anli!lellidtP. È facile procedere del calcolo.

Fat·ò d'11op() per 'JUAnto é estrarlo per l 'o•·iflcio u o rmal r con lej:rgieri se sarà il c aso. Se il calcolo è n el condolto, una l egl!'e'·a inci.,ione della ra ccolta ba"le1·é. per es trado J•estduando una fì tola pel''<l:"lPnll"'. H.
A ut;r.rum. - Uloer a g u trloa . - Sua diagnosi e cura. - L ezione <:linicA.
Il 1•r or. A uger••r, di r etlorP. della c linica ch i!' Urgica dPila ci tt à eli Mona c11 ho iniziAtO le !"Ue l ezioni riv o l gendo l' attenzione sluclen li n l r a pi l nlo impo!'lanle malaLLio in ra pporto alla chil'urgio.
Ft'tt mttlatt1e ha i l l ustr ato in modo speciale l'ulcel'l'l gaslri<:a dal punto di diagnost ico e cu r ati vo.
Hiccmoc:c·e che 111 l <'J'apia m od.-rna, meglio indirizzal!l, vanta molli casi di aual'ig10nP nell'u/cus rodens, ma deve anco ri c,\noscere che la croni cità dc lJ'ulce•·a da. in molti anche, poco ad 1to alla guarig:ono spontanea,
4u4
RIVISTA CRffiUROICA
un alto operativo nelle l'orme rno•·bose ribelli al trattamento igienico e medicamentoso s'impone Un alto operativo r eclama sempre conoscenza esatta e sollecita della nature e sede della malattia: donde la necessità di una sicurH diHgnosi. Ora l'ulcera g-astrica i• tale affezione, ch e non sempre si lascia net· tamenle del ineare, ma s i può courontlere con varii s tati patolo gici , in mod o parli colare:
a
) colle gastralgie n e roo:se. I n 'fUes te i dol'>l'i cedono per l o piu al massa;::-gio, alla p 1·essi one della regi on e e pigaslJ•ica, alla corrente elettri ca e souo influenzati da cause c he agiscono sull'umore individuale; ii contenuto g astri co non s ubis ce. come si v erifica al c un cambiamento;
&) neor•a/gie intercosta li irradiantes i nella r egion e epi g a strica. Il cede re dei dol o ri alla correntg el ettrica, la pre senza dei punti dolorosi in uno spazio inlercostale, la sensibilità a lla pr·essione di una piega c ut anea rlelll) spa zi o 1utercostale depongono in favore di una n evralg-ia inter·cos tal e;
c) ne nralgie epat i che. Quel"te s o:10 d i rliagnosi difficile e danno al chii"UI'go molt o pensiero. Ad ogni m odo la loro rarità, il do l o r e usteso prevalentemente su la r egio n e epatic a, l a p r esenza di attinenti all'isteria, l a nevra!;lenia metto no il c hirurgo sulla via di risolv ere la queslionn;
r1: coliche ep aliche. Se i uolorj uell'ulce ra 1f8Stl'ica sono assai vi o lenti, può na"cere il so>'petto d • una coli ..:a La rliagnof'i si pr c;;enta tan to più c.idfì c il e, poich • ., in ambed ue i casi gli accessi stann o in r elazione c o l c ibo. l c!'i teri miglio ri per la diagnosi tli co lica epatica so no dali dalla localizzazione dei Jolo1·i p1·evaleoli nella m et a destra d ella rt•gione ,;opr11ombeli ca le, dalla p•·ese nza di itterizia , da l tumore di fegato P- dal gonfio r e dell a v escica bil iare;
e ) coliehe intestinali ad epi gostri co. Il loro ca mbia r·e improvvi so di posto, lo stato anatomico delle an!<e intestinali, i •·apporli dei do· ! or i colla defecazione, l 'esame delle J"eci formano un c umulo di da ti basta nti a t rarr·e d'imbarazzo ;
j ) coliche n e.fr iticlte. Que,. te d anno meno ra cil nwnle occn:-:ioue a scarn· bio di dia g nosi, se s i pensa alle m od ifica ziùni uell'u r ina cd Hl m o do di irraggiars i dei do l o ri lun fCO giJ ureteri ed i l t es ti colo;
!J) rene mo&ile. Difficile é il c6 mpilo del c hirurgo, •tuando so rg e il dubbio di un tene m obil e Dol01·i v 1o lenti, molesti e dispep ti c h e, possono esse 1·e p1·odot t e dal 1·ene mobil e. An ch e ce •·ti disord tni di >iecrezione gastl'icu so no sta ti nolati nei c a><i d i r ene l'ipostalo. In ta li circostanz e i l miglior c rite1·io t> dalo, s econ do Au ge rer. Jall'applicazione d i un buon attorno a l v entre É Ja e>'cludere l'ulcera , se le molesti e, d o po tal e pratica , cessano;
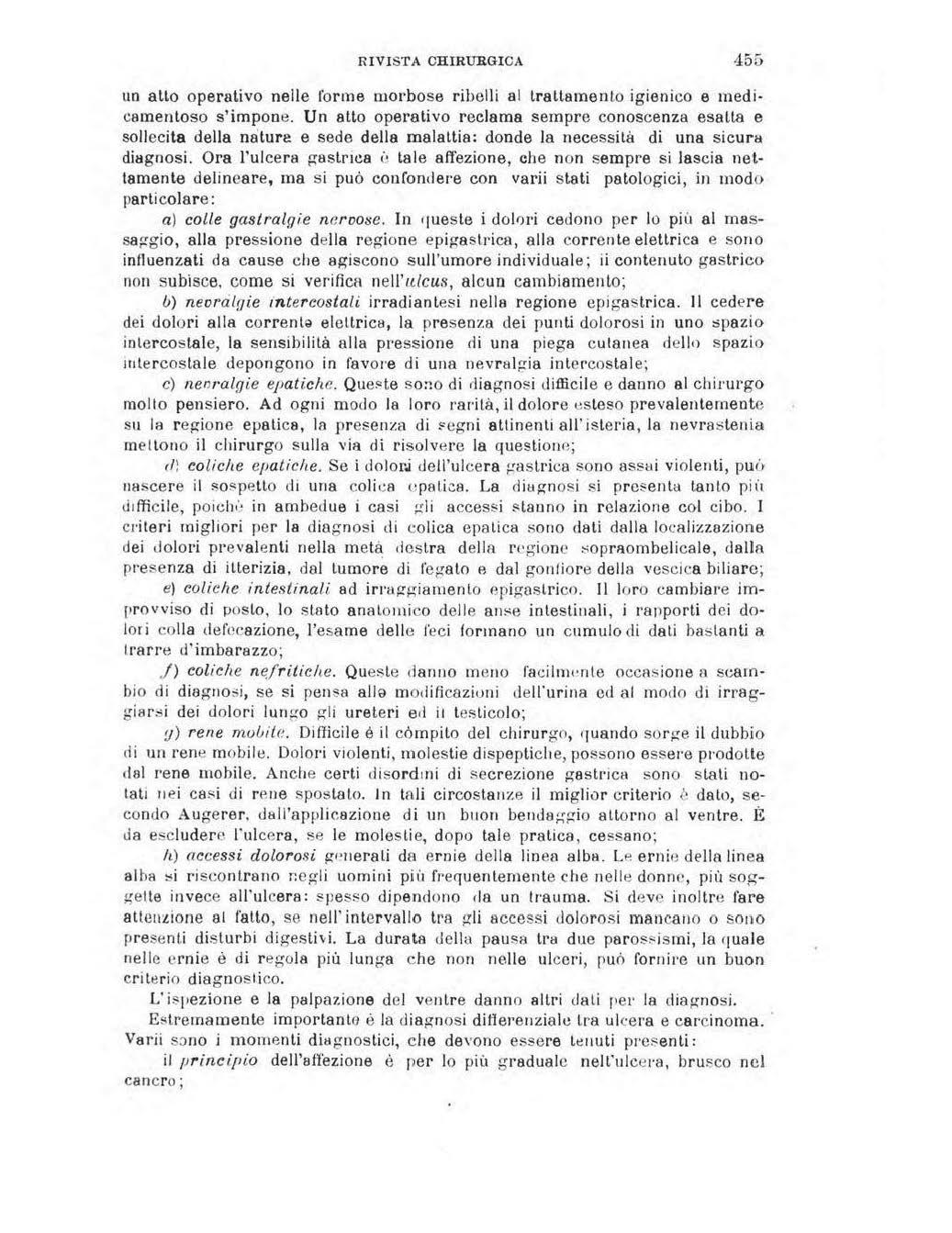
h) access i doloro s i da ernie d el la lin ea alba. LP. ernie della linea al ba ::.oi r1 sco ntrano r:egli uomini più frequentemente c he nelle do nne•, più soggelle i nvece all'ulcera: spes>'o dipendono da un trauma. Si de ve ino l tr e fare all en.tione al fatto , se nell' intervallo ll'A accessi man ca no o so no pre sen t i dis tutbi digesti"i. La durala della pau sa lJ'a due pa r os.,. i s mi, la quale ne lle erni e è di r egola più lung a c he n on n elle ulco l'i , può forni• •e un buon c r iteri o dia g n os ti co.
L' ispezione e la palpazione del ventre dann o all1·i dati pet· la d ia g nosi.
E!<tremamente importante è la uiagnosi di!1erenzia l c tra ulce1 a e car·cino ma. Varii s:>no i mom enti dia g n os tici, c he deYono essere t enuti presenti:
il p rin cipio dell'alfezione è per lo più g radual e neH'ulce1·a, bru >'co nel cancr o;
RIVISTA CRrRUBOICA 45()
il decorso (e c i ò é un carattere molto si nell'ulcera naollo oscillante con ed nel cancr·o è progressr\'O in pPf!gio;
la dura ta è più lun go nell'ul ce r·a elle n o n nel cancro ;
l'età é da prendec·si in considerazione colla più grande pruJenza: ad ogni m odo l'ul c,.. ra si suoi man if,•star e nell'e tà media; il cancr o com pare tra il 40' ed il HO• anno;
le co ru/i ; ioni di nulri;iune sono naturalmente prggio r·i del cancro, seiJbene alc uni maiali di ulcera 1111 ed una denutr izione n ole v o l r;
lo stato d ella lin!tiW non è da essa è ro ssa ed umida nell'ulcera, spessll cct ìanpu niata nel cancro;
l 'ai'Pelilo è o soltanto influenzato dai dolori dell'ulcus, assente invece n el can c r o;
l' eru/lazioTU' è l'elida e fre'luenle nel ca r c inoma, rara nell'ul cera;
i dolo ri !'O n o presenti n ell'u l cera lì no dal prin cipio della malattia; rari a vuo t n, si coll egano colla presn del cibo, si accentuano so llu la press ione e s i modificano col cambiamento di pos izione del paz.i.mle. N el cancr·o pOS!'On o maucare, m o no n sono mai in dipendenza del cibo e sono più di fTusi;
il t'Oiil ilo cornpar·t> precncernente rwll'ul ce ra ri scontr·asi per lo piu nel m n!'!=:imo dell'Hccc sso do l o r·Mo, un'o ra o due dopo l ' inges lione del cibo: dopo il v omito, i dolori ce!'!"Sno l\' el cancro 1.1 corn pfl rsa del Yomìl o è irregolare;
il vomito tli SO!l{l lle t'O!'SO parla per l'u l ce!'a. é raro n el C!lrcinoma, in cui ul>sume l'a!:>pe tlo di !i'edinaenlo di ca ffè:
i11 o r gon i (fef:"alo, ghian dole linfaUche della sopracla vi· col ar•c) depOnl!ono in favcwe dell'affaion e c arcin o matosa .
l' e sami? del eontrmuto {las t,.ieo dà i ri sultati: n ell'ulcera si trovano m ol li co r· pi ami lacei , n el ca nct o mo l ti avanzi di carne : il SU<!CO gastrico è di r egola ipe ra cido nel l' una ed ipoacido nell'allr-(l;
In moti/i l'i del/fJ stomaco è n ell'ulcer·a normal e, anzi qual che volta aumentata; n el ca nc ro é sernpr·e diminuita, e le rna!'s e di co ntenuto g a!'trieo Yomitate od estratte colla !'Onda !'ono abitualmente conside r e vo li;
il cont enuto n ello st omaco può p r ese ntare particelle di tumor e che 1n pr·epar·ali la!'ciHnO differenziar·e.
Au ge r er non trovA nr Il'urina c n el sangue alc una particolarita degna di nola llal punto rl i vi s ln didg nosti co
Primac hi· il chirurgo pos!'>a inlr·aprendere l'atto epe r·alivo, deve risolvere aneo ra un'a l trA i n te r e<::saute questione. l':sc lu!=>ala pre se nza rlel cancro. sr tralla nel con t·t·e to rli un' ulce ra f!l:JSt r·i ca n duodena le 1 l c riteri clill iti no n ba s tan o !'>empr·e per la dia g n osi: i seguenti son o i critet·i meno falla c i :
Dì r egola le ul cer 1duodena!i sono rat'E' e compaiono nelle per sone che hanno r iportato est ese br·uci oture
l! do lot e si manifesta l un go tempo dopo il pasto e s i localizza in vi cinanza del piano ombelr cal e sul prolungamento della l 1n ea par·astot•nale destra.

manca spesso ed il sangue fuoriesce per lo più dall'ano .
Non si può fat•e as':'egnamento su l l'itterizia, poiché compare di rad o Hi g uardo all a terApia de ll'ulcer·a è dell'sUo
IUVIS'l'A
CliiRUilGICA
<jpet·ativo nei caRi non rari eli ulec r a attiva. tena ce, che da facili emo1·ragit!. s,• tiene con to Ancora delle steno-<i c he si fl!'Oduconn in un t e mpo pi i• o m eno tard i- o e cl11• l'eclamano i n !ierond o L<>mpo un inler ,·eu t n t lli r ur:.:u:o, no n !1-i può far·o a mt>no di l'utr!l tà deltrallRmenlo o pel'Hli\'O, dopo 1 brillanti m od erni dt•lla addom inf!lt' in gen et·e e iu i Rpecie.
Da ta l'ultli tu di un·ofJ'·I'Atioue, RJ dl:!v e preft!rire la :ra!'tro - eute r o« t o mia o la r•'Rt·zionc? Tu le <JIIC"Itom· ,.er ia e m ot t o discus..:a dcvo• C;<"'Ct'e rou»i.te rat a dal punto di \'tSlt\ do•IIR plllO!.({'IIe:>i delt'ulcei a e tiA quello dell ' opt• ra tione in !-o•.
Ril>pt>lto allo gt>Jit'!it tlell'u lcera , R i Ammette o:.:!!idr "li la b!l'-'e 111 J'ICP r cltt• "Pt'· rim entali, che essR sin di Hl\lut·a trrfica, a tlil"ordmi di'l !'i'lt ema ne r voso gaslJ'JCn. :-.le d eriva r!le an ehe dopo l 'a blazione della sezione g-a1'lrico, St'dA della le!'io n e, ti m o t·bo puo r t:<'iol •, are ' ' uoi n ella c i calt'IC'e, ' 'U(Ji 11e1 tè""uti vicini; men•re la un nu ovo pilOTe), m Ptlo! in rl (l<)"'O lu pal'L" malilto e po11E' l o t< t OIIlll <"O 111 condizioni di poter·!:! •uodilkare 11 !IUO lrofis mo.
Dal punto di vi s ta della tecni cn orc•·aliva. la 6 mol to iHdog-u•osn, per icolosa e ri c l ued r JHlll soltant() m olto tempo nell'o•l'ecu7.iolle mn ancora m o lta abiliti! ope • ativa.

La 6 un'opera1.io nc m ollo pii1 sempli cr, obbiRogna di minor tempo , on·re minot i oper ati,·e, min o r• pe ri coli ed é m olto meglio dagli infer·mi.
Quindi l o gu!>tt·o- onter·ostomia è da e ocr tlSsa Augcr<H' ha po tuto -portar e a fo\'U Ori gione rompleta m olt i pAzi enti d i ul cel'n l!nstri t'll . o«tina la.
YoN H1 r>PEL.- La laparo tomta lD tempo dl g uerra. - (A rclti o. /ti r /,/ in Chi r u r gie, 1:1. Hl02).
La Rtor ia della lapnl'otom ia s ul co m po di ebbe a Jl&!"!<O r e per duo ,·asi, ba!'ate 111 prima !>lllle prove sper·imenlali, la !"eronda sulle re centi osser va· 1.ioni. NE' Ila pri ma In ma ::;.:iQranza clcgli a\'rvo a mmes«o l'lllt(' rv ento pre· <'OCP "I"-lemalico ai po<>li di socco t•so (Senn, K ncher), ma di p r eferenza all'ambula nza («azione di .;a n i t à): menll·c la m1oorau za r ileneva la laporotomia <'Om e Jrt·ealizzahile eol Ili Uti l e Nella !'econda fase, basala !'U prati c:h e Ol'\Rer vazion i, ini· ziala!'i co11 In C!O tnpagna di Ct:ba , m ol li conslota r ono la t enden za alla Rponltl lll'a cond annando l'intervent o , guaro•ndo i malati Mnza pral ica r e laporoto m ia di e m or Pn clo malgrad o essa ven i !':;e pt·aticfttll.
l c hr Il curare i fe r 1ti inglesi e hoeri sono ptll'ligiani ri se t·vati o avvPrsarii dichiaJ·oli della la par o lomia . l pri mi n o n l'amm r ttono c he uei casi d • Pmori·ag-ia iult! rna abbo ndante o di fu o ri usc•ta di mater1 alr> fcc al<· e d'infezione peritoneole (M ac Cor mac, Strehl, Treves, R ingc lletc); Makius mvece, conRigliu d'inler \'enir·e semp t•e <{Uilndo l e feritr d'a r ma da fu oco l r as\'ersali o ù antr r o-pos Leri ori intor t!ssin o i l tenue in t es t ino.
Gli ovver sat·ii d ella la paro t o mi a le oppongono i segut> nti l e f.:rite .penetr anti' guar•sco no freq uen tem ente sen za in lr>nrento, m e ntr·e l e ope rate terminano I'(Ua!'• se mpre con la morte; la diAgnosi di g•·ave ferila d'u n in par · l irolare d ell'mlcslino tenue, spesso r i mane dubbia ; spesso ò pnss ato il m o m ento -propizio all'intervento quando questo sa rebbe perm esso dalle circos tanze. I noltre non possibile pratica t· t a le allo opet·ati vo all'a mbul an za (se7.ione di l») per l'atlluenza dei reriti, per la mancanza d i !)et·i!onal e e sf' r cita t o e d i lo-
ILfVI:S'l'A OHIRURGIOA
cale riscaldato, per l ' impossibile asepsi e per l'i m possibile ulteriore t r asporto dell'operato.
•
Giunto il ferilo a ll'o"pedale da campo, le condizioni di ambiente son vi ma se il ier ilo arriva fin là, o si troverà. in uno stato disperalo, oppur e p otra guarire senza intervento chirurgi co di sorta.

Tuttavia l'a utore esprime la p r opria opinioue ammellenJo che praticando la lapa r otornia in condizioui convenienti. essa po tr·é salvare qualche fel"ito. Rili eue i:Jdicata la laporotomia primitiva nelle dodici prime ore nei casi seguentt: emorra gia interna, se l e cond i zioni g enerali n o n sono troppo dl•presse; ft! rile della vescichelll:l e dei canali biliari, per im pedi re lo scolo d ella b ile nel per·itoneo e l(enerale pe1· assorbimeulo; lacerazioni della vescica accompagnate da lesioni os!'ee del bacino; rerite d'arma da fuoco untero-posterio1·i o tra· 11 ell a r egionf' dell'intestino tenue o del colou tr·asver;oo, auche quando manca quall"IHSi l"egno di lesi o ne inleslinal l'; ferile oddominali in qualsiac:i direzione con ev1deute perforazione intestinale.
Si prHLicherà la laparotomia secondaria nelle peri toni ti f,re ner·aliz?.ate. sia elle d'un tr·atto oppure consecutive a s intom i d'ir·rilazione locale. Da ultim o l e ferile d'arma du fuoco oblique, situate frft l 'ombelico ed illìan co o senza foro cost1 tu i rnnn n un·inditazione t•elali va della laparo tom in O'-'plor·atrice, quando lo lesione vi!"cerale !':at•8 incet·ln.
nlla formazione snnitaeiR dove inter·venire, l'a uto r e r·iliene c he c iò non si po!>sa fa t·e c he O!Sped ali da campo. Egli p1·oporrebLe l'i»t ilu· zionu per divisione di u1fnspedale speciale o1·ganizzalo in v1 s ta della cura speciolf' tiPi fel'i ti All'addomi'. Tale ospedal e da campo per (lapai'Otomien- r(lld -ladnreth) dovrnsst installare in abitazio ni dislauli da tre Il quattro clulnmetri .tu l campo di e su d'una s t r ada ; dotalo d1 unA o due \ "(•lture ri serv ate al tra" porlo di1·etto d ei fHi ti all"nddome, sen za che essi debbano pns· S OJ'O dnll'ombulnm:o (se ziono .l i sanità!. Voreà o llcslrla, c !lo possibrle. una l'ala d"op!>rnzione, eiscaldala alla ,·o luta lemperolura da une s tuf11 a petrolio che dovr'à fa1' pArte d l maler rale de ll'ospedale, rige ttando assolulmnenle qualt en•ln dove è impos!'.ibrle evitare polvere, vnnto e•l umiolila. In tali ci r costauzP si c uren\ In m s«!>i ma a"epsi Al pe1·::onale ordinario s i do,•ré un che abbre fam il!'liar ità Mn gli interventi addomioali , co11 a lmeno due infermieri di fiducia scelti a preferenza fra quelli nelle sale d'operazione •Ic i g randi O!'pedali.
Gli operAti in nessuni::::simo caso po trann o esser evacuati prima che sieno tra scor·!' dieci o dodici giomi dall'allo operativo.
G. H.
Delle medtoa.stont emo1tattohe. - Rivista sintetica.
Stabi lendo quale principro che: i p r ocessi terapeul , ci clciJiiOJtO unUormarsi ai tisinlogici e che il maogior nnmero !Ielle m edica.Jioni r a;ionali all ro n.o1t 80/tO l'Ile dell e naturali e ri n forza/e, si ha uno sicura n el quali polranno essere g-li agenti dr difesa tlell'orj!anismo contro le e quole s1a il mecc ani::::m11 co mpl eta.
A ti a"sumHe Lai H t>ll'dlo i tre processi princq..1ali che s1s uc(·edono L' SI c:om• plelan o mulualmente sono : la ccst ri%ione lucnle, la coagulazione d e l sangue a ll\·ello ddla ft>J'ila vascolare, e la ripara;ion e di della .ferita.
1.158
RIVISTA CRmURGICA
Il primo d i tali (allori é il m e n o im po rtante, l' 0r ga nis mo può farne a men o, ma la stJa assenza rende l' emorr·11gia più vi ole nta, o più difficile la fo1·mazione del coagulo.
Il secondo fallare mollo più impo rta nte, quando manca può dar· lu ogo a grav i inconvenienti.

Il terzo ha un'imp ortanza no te vole, non avvenendo la ripa ra zione della ferita , il CQagulo, può r·ico min cia r e l'emorragia.
P e r a ssicurare tera pe uti camente l 'emosta si, bi sogn a provocar·e a livello della fe ri ta o un 'energic a vaso - costrizione locale, o un a coap;ulttzione loca le r apida e Se il vaso sanguinante é inaccesf;ibile si può interv enire utilmen te m ed iante una medicazi on e gene ra le va so-cos trittr·ice o coagulante. Ma non bisogna scor da r e che i metod i d i emoslasia l ocale sono se m pr e :::uper iori, e che vaso-costrizione e n o n sono che pr ocessi provvisorii e che la vera e m 0s tas ia definitiva e r•ettlizza la dalla ri p11razione vascola re.
l• Emosta tici oaso-eostrittori lo cali - Sono r·appr·esen lali dall 'az ione del ca lore e da quella dell' adrenalina.
Agenti fisici.- Le tem perature mode rate, pros:::ime a quelle de ll' or·ganismo, sono contrarie all'emMtasia p e r chè deter•miuanti una vasoddatazio n e favorevole all'emo rrag ia, all'opposto le temperatul'e dete rm inan o una vaso- cos triz ione locale efficace. Co:;:l ag-iscono il ghiacc1:o, l'ete r e polveri7.talo t•d il cloruro di e tile. T a li r imedi non t! n no c h e un'azione m omentanea s uccedendn ben tos to alla vaso-co:::trizione la va:::odilatazione.
Il calore è un age nte emostatico ben superi or e c c iò pe r l'azione ::: ua va5- 0cost r illrice e ['iù elle tutto per· la sua efficacia sul pr·ocesso diAstasico de lla pP l' la s ua inn ocu il à su i Lt>ssuti cui si l' azione :::ua favorevo le >'u ll' ulter·iore r i p& ra zione dei VAsi. La temperatura pii! fav o r evole é comp r esa fr·a i 45• ed i 50•.
Pe r ta nt o da tale pl'i n c ipio Alc uni (Trì rie r·) consiglia r ono g ra ndi lava lur·e Intestinali con acqua a 4:>• nelle eml)rragie de l tubo dige·r enle. mentc l'illust r e Doyen , n elle Oi'e razi oni chi r uqrichc p r·ojetla su l campo operatorio una corrente d' ac!Jua ad a lta pr·es!Sione, coagula ndo cosi le album ine del sangue ed ottenendo l' ewoslasi.
Aoen.ti clrim(t·i - Sono rappre 5-co tati da ll' a n tipirin.a, dallH .ferropirina , dall'ac,,ua o.ssio en ala , dalla cowina e dHII'adr e nalina. Per bocca, l'an.tiJi i rin.a non esercita azione emoslattca di SQrta; a l cont rari o è u n bu.,n va!"o - cnslr·rllore local e, usato specialmente nell' epistnssi, prendendtme delle od a sp irandone una solu zione concent rata dell'uno Hl ll'enta , oppur e i ndur endo prolìlatlicamenle le narici co n una pomata d'a n lipirina.
La je r ropir:ina uni:::ce alle prnpl'iel.à costriltl'ic• dell' antipil'ina il potere coa· J:u lan le del pe rcl l) rur o eli fe rro. È inl'alli una combi nazione rlt'i òue pr orlolli, sol ubil e in 5 pa rti d' acqua fr edda, in 9 d'acqua bo ii Pnle e nell'al cool, insolubil e nell'ete r e. N on è a ffatto caustica. Adoper·asi in poi ve r e, in solu zione al 20 p. 100, pe r insutllazioni, nell' e nell e emol'ral(ie dentar ie.
La stesse indicazioni ha r acr1ua ossi[!<' nata, tlecomponenlesi in acqua ed senza es:::ere menornamente oaustica.- L' azione della coca ina è poco dure ,·o!P. e può seguita da ernorraggie secondnrie.
Vaso-costrillrice pet• Elccellenza é l'adrenalina , isolata dal dall'estratto de lle capsule surrena!i cd usata finora sop ralullo dagli specialisti ( o ftalmologi, r·inologi, lar·ingologi ecc).
RIVISTA CHIRURG ICA
2• c-as o- co slr illori gen eral i. - Quando n o n si può ag ire dit•el· te m ente l'Ili foco laio em o r·ra!JtCO ri correre ali" azio ne cos trittric e g t'nc · r a l e di lutto il s i ..; t ema
L' em o, teti co <l t ta l t> re s t ud i at o è r ery oti na, s i adopera la polvere di cor n u tA a lla dn!<e di u no a due grA mmi , m entr·e in comm er c i o sono note le E t•gotiue d i Bo ujea n, Y o n, Lam11lle , Taur etf' ecc L'a z i o nP d el l" er:;rot io8 st P1 oni fc5: la 10 o :20 m inu t t dopo la !- Om m m istrazion e per l>occa , e d ue o tre m in uti d opo es<:ere illit•lll\ta so t tocuta rtf'Aill e ule
N ùht da te m po r em o to per la su 11 az.iort e el elti v a u elle utc r·i ne.. veu n e p u r e u o.; ata nellf' inteslrn ali e pol rno rra li ma con dubbi ris u ltati.
L' ammin i s tra ta fo t' m a d i fluid o, po<:siede un sapo t·e aruaro e usat11 sopra l utto in gr ne olof.( ia, v enn e ulltm a meule c o n-.igliatA assieme all'ltamama l ifl v truinica in certe affezroni v e nose, v a t•ico5:c, em o rroid At·i e, mH co n ri s ull8Li, fìn o t a se ml>r·a poco pr·o mettenli.
:lo coag u i MI/i loc a l i. - M e n t r e c he l u va!'o- cos Lrizi o o c é un pro· c m ostali co d' ur·g,·nza, r iJpiclo, ma p r·ovvisori o ed in co mpleto, la coagu· laz it>n e t! llll pr·oces•o em .);;tali ('O più tur·J iv., , ma si c uro, dd inilivo, sempre nec<.>sRa ri o.
Ahlmn d ona ti ogg idi i numerosi c oag ulanti li q uidi (ac qua di Rabel , liquore di J lo Ilo r. aequo d t>l Pa gliori, d el Capodiecr ecc) , ne so pr·avvive uno Rolo, il c loruro f/t .ferro , mtt df' ve s r rinuru. i are aul' he a qu es t'u l timo in cau .,a Jer nu· mct'O!Ii 11cci de nli l ocn l i c ui esl'ìO dà IUOI/ O una lu nga 5:P. l'ie di prr.d o Li i o rga n i ci ave n li no n so ltanto la pro pr:eti 1 di p r ovoca r'!' lu co ag- ul azio ne uorrun i P u L'I ma an c he di riufo rzarla. T nli t'ono i l j ilwi noyeno, cl e )o! rtln numt'rO •l' d'or ga ni. Ma l oca l e di ta li proJolli è poco pr·a t i co cau ;.a la dtfflcollo di con servarli
Esr<: t u u na che !JII it e;;;.er faci hnt:nte s ter•ilrz7.0 IA la gelatina i l di c u i impie:w q ua le e m .. rim o n lH tt l 1 !)f). - Es,:a de l l' t' mina r emo· s t ai'i !l:raz re a lle sue propr·teta d' ader·t>nz a m o l ecola re , vt ><<·osita , di g-eltficazi one e di COa l-;lli8Z lOlle, fa \'Or en do i no ltre la \'ilatita dei l eSSUtt e facihlandO C05:i l a loro r·rpar az i o ne P er ciò p-li inu esli ade ri ;;;cuuo pi ù ce1eremonte a l suo c ot!lalto, m c nt.-e m t!l:lio r·an o le u lceri, s pec 1olmente varicose, cope rto ù t uno !'ìl •·ato d t gelatina :z lice r·mala È dunque un em osl8 lico di prim' o •·dine . In !><.>guito Al s uo u so, :;1 i'legnnlar·o no occi dt>uli in fi• Uivi ( l et.an o, ca r·bonc lt io, e re ) , ma QU O"- Ii po tranno es •er evitati e !'i!!•'ndo per· la g e latina le s t e!"se g anun:i e d i fabbri ,·azione ri cl ti e8 le pe r r:-li !'ieri e p!'r gli esLralli o pot er·apic i.
Per· r emosta s ia locale servo no benissimo l e con centraLe al 10 p. 100 falle con ac•rua sa l ata (so luzione fi si o l ogi ca) e mef{ l ro ancora con acqua al ci o· rur·o ù i cal c io (l p. 100 ci r ca).
P l'imo di ado pe r a rl A la si s l el'ilizzerà a 100° d urante un' oro e meglio ancorA a 100 tre 1-!ior·nt di seguito durante mezz'orA, mau ten enJola nella s tufa fra dull sucee s i v e s L<>ri lizzozio oi.
Quando dovré esser applicaL'l su l erreai settici (naso, va g ina ecc . ) s arà tut anLi sell tco quale il feuolo , il sublimato, l'ac ido salicilico o c i o· ridri co al 1/ 1 p. 1000. Al m o mento d i se rvirs c n e si farà lique fare la sol uzio ne 11 bt,g-no-maria.

4GO
RIVISTA C HIRUR G ICA
: l
Ri assumendo, la medicazio ne locale con g elatina dovra ssi prati care ogni' qualvol ta il va s o no n s ia tro p po c o n ;:iderFYVo l e o q uando sia invisibile o sia difficile il •·aggiunge t·lo (cavitù inaccess ibili, rerit o anrrantuo se , organi molto va scolarizzati) . I nfine nelle en: o rragie a nappo d ell e muco se.
Emosta tici coagulanti general i - Que!>l o meto do re cente di emos l asia, fin ora non pres enta sufficienti ga ranzie etl é per g iunta mal c o no!:-ciulo .
Gli agenti princ ipali fin o ra adoperati a tale scopo sono la gelatina, il cloruro di calc io e l e $Oiuzio ni saline. La ge la tin a é ineffìc11 ce per l e vie di gerenti; dannosa per via endove nosa. Si dovt•a adop et•a r e per via ipod ermica .
Cosi venne usata da Lincereaux e P aule;;co n el 1897 pe r la cura deg li an eur ismi ( iniezioni quotidiane nel t ess uto sottocutan eo d ell' add o m e o alla r egione ·esterna della coscia rli 20 a 100 cub. di una soluzion e fi s iolo gi CA) Si osse rva tal volta un po' di d olore, più. di ;;ovenlll lo cale ed ipertermif!.
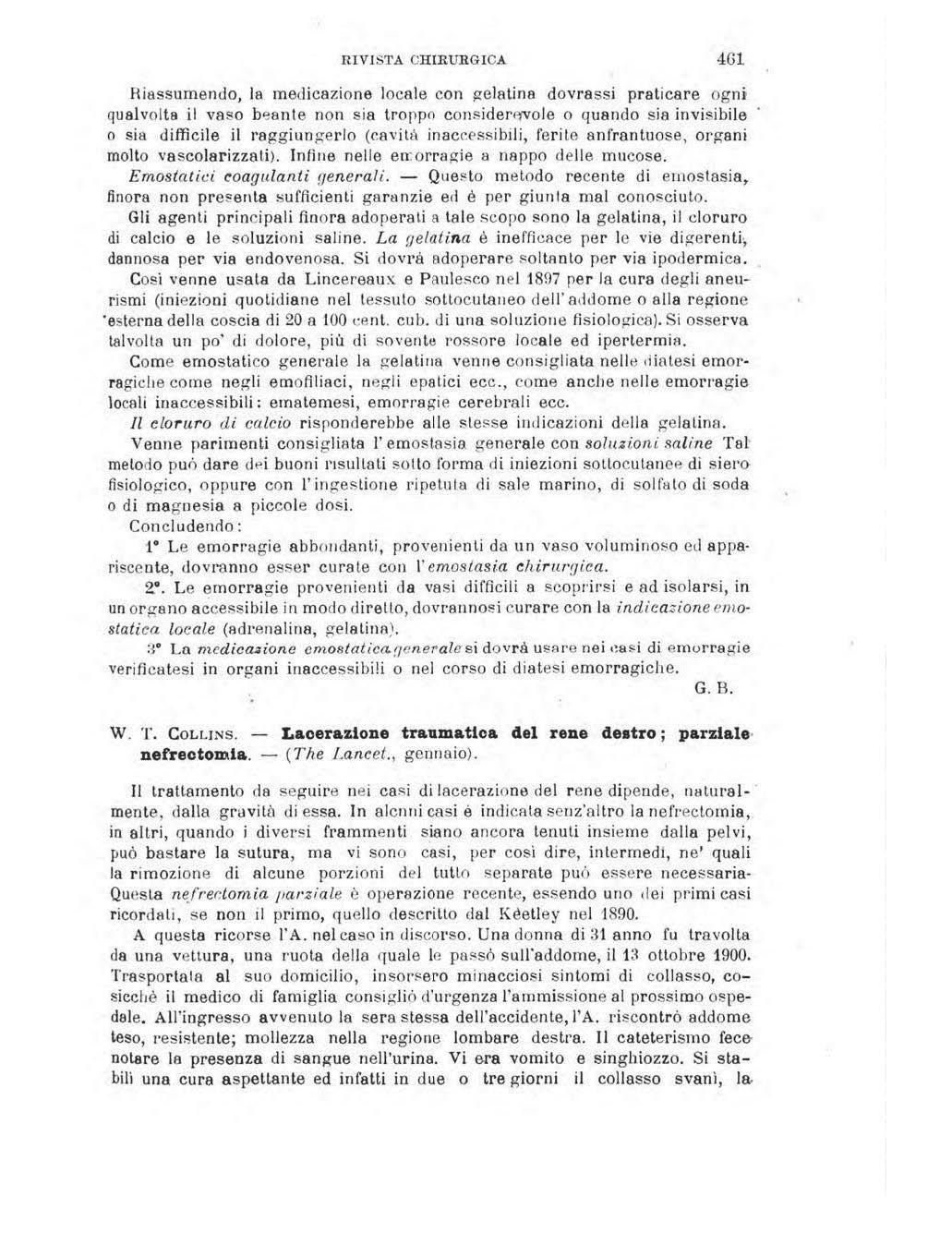
Co m e emos tati co g ene1·ale la g elatina v enne co ns i g l iata nell e cl i n t esi emo er agi clle co m e neg li emo tìliaci, neg l i e palici ecc , com e anch e n elle emor ra g ie locali inacces sibili: ematemesi, e morr-a gie cerebrali ecc .
il clo r uro d i ca l cio ri sponderebbe a l le s tesse iwli caz ioni della
V eone pari menti consi g liata l' e m os tasia gen erale c on Ml i ne Tal metodo pul) dare dt> i buon i l'lsullati so tto fo1·ma ò i iniezio ni so tlo c u l anoP di s ie1·o fisiol ogico, o ppure con l ' in ge;;ti o ne J'i pet u l a d i sal e marin o , di solra t o di soda o di mag nesia a piccole d osi.
Co n c ludendo:
1" L e e morragie abbo11danti, proveni enti da un va so v o lum i no!>o cd appa· r ìsce ote, dovra nno esser curale co n r e m ost asia chirurg ic a.
2". L e e morra g ie pro veni enti da vas i diffic ili a scop rir·sì e ad iso lars i, in un or g ano a cc essibile i n modo diretto , do vranno s i c urare con la ind ic a:::io n eem ostati ca loc al e (adt·enalina, gelatina)
:{• La m edica.; ione c mos t atica;,cn et' ale si do vra usa r- e nei di e m o rra g ie verifì catesi in org ani inaccess i bili o nel corso di di atesi emorrag ich e
G. B
W . T . CoLLJNS. L a cerazione traumatloa del rene 4e• t r o ; parziale · nefreotomla. - ( The Lanc et , gcun a io)
Il lratl.amenlo da seguire n ei ca;:i di lace•·azio ne del r ene di pend e, naturalmente, dalla g ruvilà di essa. In alc nni ca s i é indica ta seuz'a l tro la nef•·eclo1nia, in al t ri, quando i diver·s i framm enti s iano a nco ra tenuti ins ie m e da lla p elvi, può ba stare la sutura, ma v i so no cas i, per dire, inte rmedi, n e' quali la r i mozio n e di alcune po l'zio ni de l tutto separate pu ò esser e necessar iaQues ta ne.frer:tomia f' arz ia le è ope razion e r ecente, essendo uno dei p l'imi ca si rico r d alt, se non Il primo, quell o descritto dal r< èelle y n el 1890.
A ques ta ric o rse l'A. nel ca so in di sco t• so. Una donna di :H anno ru travolta da una v et t ur a, una I'U Ola d ella quale l e p o!'<SÒ s u l l'addome, il 13 otto bre 1900.
Tl'asp or t ata al s uo d omicilio, m i nacciosi s into mi di collasso, c osicché il medico Ji ramiglia c o ns i gliò d"u1·genza l ' ammissione al prossimo ospedale. All'ingresso avvenuto la sera stessa dell' accide nte, l'A . ri scontrò addome teso, •·esisten te; m o llezza nella 1•egione lombare des t1·a. Il catete rismo fecenolare la presen za di sangue ne ll'urina Vi e.ra vomito e singhiozzo. Si stabili una cura a spettante ed in ratti in due o tre giorni il collasso svanì, la.
RTVJST A CHIRURGICA 4Gl
mollezza nella regione lom bare scomparve, l'urina tornò d i colo r i t.o normale .non ri m anendo che il vomito ad intervalli.
Il 22 Ottobre mercè nell o r egione l ombare d es tra si eslras· c i rca 150 grm. di urina piuttosto fetida, del peso specifico d i 1020, in v i s ta di che il s uccessi vo I"A. p r evia an es tesia praticò una i n cisi one ileocos tal e di cir ca cm fino al per inefrio dando e.sito ad abbondanti coaguli san:.tuign i misti ad urina.

Esaminalo il ren e, vide c h e quantun ryu e con tuso la:;ciAva anco r a sper anza di re stilutio ad i n l egrum, co sicché sia bili di !asciar lo, .aspo rtandone soltanto al· c uni framm en ti del t utto il piu grosso dei quali er a del volume di una n oce.
LaYala abbondan tem en t e la cavità vi lasciò un drenaggio zaffa ndo all'in- · tor·no con g arza jdoformica che veniva r ;nnovala tre volte al giorno. Dalla ferila g eme"a costan teme nte urina nella quanti la g iornaliera di circa 200 em e. con se rvand osi acida
L'il novembr·e l'urina emessa dall'urelra era alcalina per una leggera cistite, ma quella Jluente dalla f erita si manteneva acida. Il 4 dicembr e del r esto i l gemi zio era e 1'1 1 piA g a era cicatrizzata cosicché la paz1enle .fu dimessa in bu o ne condizioni il 1 gennaio . L . F.
D uRA:"' TE. - O••erva:donl 81l oerte looallzzazlont cerebrali. - (Brili sh med. Jour n.al , 13 d i cembr e 1902)
Il ch irurgo dovrebbe contribuire più del fi siol ogo a ri so lvere certe qu es ti oni t u tto r·a in cir ca l e l ocalizzazioni cerebrali nell'uo m o Egli, infa tti , <:ost retto ad a p l'ire il per· rimuovet•e pr•odolli patologici, esegue v e ri ·esperimenti fis i o l ogici sull'uomo. È quanto f ece il Our·ante i n ti operazioni s ul c ran io Le conclu s i o ni a cui ,·enne sono le seguenti :
1' L e lesi on i dei lobu l i frontal i, speci almente quell e provocate d a n eosono quasi sempre accnmpaguate da grav i s<simi fenom eni di alte rala intell i genza: cio che p r ova i lobi fr o ntali, e pa rli col armente i pre frontali , devono e!!ser e cons ider ati come la sede delle più elevate funzioni dell a mente:
2• Il l'e ntt·o co r·ti c ale del l'ud i to è situato nei !o bi temp oral i: ogni centr·o e in r el al.ione coi due nervi uditivi ed il fasci o u dttivo d ire tto de v e esser e molto m eno attivo e pi u so tti le che il fascio ucl il.ivo incroc·iato;
:3o La sede d el cenlt·o pe r la sen ->il>i lilà generale e per• il se n so muscolare è nei lobi psri elal i; e dislur·bi gent> r•ale e del senso muscolare poo:;sono vel'ilìcar si negli arti i nrlipendenlHmenle da de lla mobilità;
t' P er la soluzi one dei v al'i p r oblemi con cer ne n ti l a funzi one dello> d i verse r ei!'ion i ùe l cerv ello un1ano, la chiru r g i a ope r ati va e l'anAtllmia pato l ogi ca !'<()IlO piu u tili della tìsi ol ogia spe rim entale. c he ha sol o animali a s ua disposizione.
G. O .
S c muoT . - Le•lonl reuall •ottooutanee uet mlllta rt. - (Deuts . militiirii r::tliche Zeitsch., n. 12. •J!J02).
E. K i:tsler nel s uo lavoro a la chir·urg ia ùei r en i ecc " • pubblica to n ella D e ntsche Chir urgie disp. 52 ùello sco r so anno, ha r acr.olto dalla l etteJ'alura medica monrl •tJle 306 casi di l e!;<ioni renali so tt ocu tanee. Le r elazioni sanitari e del l'esel·cilo o fl'rirebbe z·o a chi le cousullasse, un ri cco materia l e su t ale
462 RIVISTA CHIRURGICA
ad es:, dall882 a1189(), vi son regi strati 55 casi, c o mprendenti 50 contusioni e 5 lacerazioui renali sottoc utan ee, le quali essere a ggiunte td la s tatistica di Ki.i s ter.
Le cause delle con tusioni sono così ripe1·tite: calci di cavallo 2i, urti 5, colpi negli esercizi di sche1·ma col fucile 4, colpo di lancia 1, travolgime nto sotto un ca rro 1, salto al disopra della fune 1, caduta in una marcia 1, caduta sul fucile 1, caduta in un fossato t, cadute col cavallo 2, cadute da un luogo elevato 3: in 5 casi non è acce nnala la causA.
l malati guarirono, alcuni perù furo no riformati. Due ebbe ro sintomi co mplicanti di rene mobile; prese ntarono versamente pleuric1 o fenomeni di fl ogosi per itoneali o polmonari; uno riportò frattura della 10• costola nel lato colpito.
Le 5 lacerazioni reneli ebbero esito mortale. Tre furono prodotte d a forte calcio di cavallo, che s battè il pazie nte contro un can none, da caduta so tto un carro di fieno e da urto co ntro un'armatuJ·A; delle altre non é indicata la causa. Una fu complicata da lace razione. epatica; un 'a\Lra, con lacerazione del bordo inferiore del fegatn, fessura della s ua s up e rficie convessa e lacerazion e lo ngitudinale, di due centimetri, del colon sotloslaote, ha importanza anche per la sua analogia co n un caso riportato ,dal Ki"t ster, poiché, secondo quesli, non erano mai state osservate per lo innanzi complete soluzioni di continuo nel canale gastro-enterico, ma sole ecchimosi sanguigne sotlosterose.
Lo S c hmidt des crive un suo caso di contusion e semplice del r e ne s inistro da col po con tro il fianco, durante g li es ercizi di scherma col fu cile, caso che, col suo esito in guarigione, 1·appres enta il d ecors o co n!'u e to di tuli les ioni, malgrado i sin tomi iniziali molto grav i.

Eg li spiega la fre quenza ril c '"ante di queste contusioni nell"esercilo, ammettendo, co n Kii slE' r , che e!"Se predomtnano dal !(lo al :'!0° anno di vita e nel sesso masc hil e (9'."/.).
La mor·talilà che, per le lesioni . renali sotlocutanee semplici, nell'esP r cito è di 5, i 0/ 0 nella citala casuistica mondiale sale fino al :30, '18 °/o e l'autor·e attribuisce gli esili ra vo rev o li nei soldati o lia g iovinezza e J'o bust<• zza dei sogge tti, alla loro resistenza allo sliock ed alle emo rra g ie, alla min o re fr NJuenza delle infezioni secondari e, !"ponllmee o provocate, per le vie sanguigne cd urinarie.
Hi g u a rdo allo ezio logia, meritano attenzione lP co ntus ioni r enali prodot te negl i esercizi di sc hermn co l fu c il e Do g- li espe1·imenti del K iister sulle laceraz io ni renali che il ren e , in seg utto ag li ell'e Ui delia press ione id raul ica, res ta per lo piu lnceJ·alo, per•clti· vi e ne spinto co ntro la co lonna ve rléurale dalla cassa toracica compt·essa s u bitaneame nte o r.e1 · l'azio ne immediata del trauma o pe1· la contrazio ne spnsmndtca J'tfle l"sa dei mus coli addo min11li e etei diaframma.
L'anlo1·e cr etle che la !!'cherma col fu cil e o tl'J·a condizioni mo llo favor e voli a qtJ es to me ccanis mo tratunatico, poiché il so ldato p re:seula al l'avversario il suo fianco s inii'tro, piegando s ull'anca la co scia s inistra, co nll'aend o il muscolo p soas e oll'es lern o e in avanti il punto d' i nsrrz ione al piccolo tro ca nl('r·e. 11 mus colo quadratrl lomba r e en tra pure in azione pe r fì si'are solidamente il bordo inferiore del tora ce cont r o il c into pel\·ico. Questi muscoli, che separano il r ene d alla raclli.Je, lo spos tano all'innanzi e all'esterno , ravvicinandolo alla par·ete addo minale, mediante l' e la spo rge nza de i lo ro ventri in contt·azione. In tal mod0, mo lto piu cile nell e. condizion i normali , si res trin ge lo spazio en! r o cui può a g ire la pressio ne idraulica.
JUVISTA CH.IBURGIC A 463
RIVISTA DI OCULIS1'ICA

Nel comballimento r estano inoltr e esposti ai colpi dell'avversario due punti della parete lateral e dell'addome sottili e spr·ovvisLi di una pe r le del contorno muscola r e, e cio{• il trian!!"olo di Pelil e quello fJuadr·angolare, posto al quanto pill in allo, che è limitato all"es ter no e all'innanzi dal mu!'lcolo obliquo ester no, in allo del marfrine inferio re del dentato inferiOJ·e. all' inlE>rno e all'indi etro da e!'terno della guAina delresLensore del dorso e infer ior mente dall'obliI"JUO interno (Kusler). Co,, un colpo non par·ato può 8\'er·•· da nnose con;oeguPnze
Quantun•JP S delle citate contusioni r·enali dipendano da!.(li di di rinfor·za re, med iani e sterche o cuscinet ti , la corazza lnracieA di tr·alkcio, imbollila di alga marina , che si e<:lwnù•• dal collo alla CO'-cia cd è usolA in queste islr·uzioni. P. 1..
RIVI SrrA DI OCULIS'riCA
DoTT. Por>ov . - Cur& delle dlverae forme dl oongluntlvtte gJranuloaa oon le toatlll&zlonl dl aoluzlonl aoquoae dl lttlolo . - (!,a Clinirfue oplllalmoloqique. 1!J02. 5).
N ell' iu((·nlo di controlla t·e i risullnli ottenuti dai doltori e Bi•'•J,>. vitch ci1·cu il \'lllor•• delle i11!'li llazioni <ii f'Oiuzioni di itliol o neiiH <'U rli delle va•·ie for·me dr con!!iun tivilc g-r anulosa, li dntlol' Popov. mt>dit'O m i l1lare J'U!'M, a •rue!'to me:r.zo ler·apeutlf'o in :lO mal» ti: di cui U erau o affelli da t1·acomn IIIÌZiAlt>, l da !'ern(Jiice ccnHriun t ivite p-r·anulu<:a secca,() da tracuma complicato dn cllU!r-ro della e gli Alll·i l':' da congiuntiv•te tr·acomalosa croui<- a, con inllllrn7.ioue d iffu sa, 1pc r lrufìa ti••l saeco c secreziuue muco·purulentll abltr.ndanti;;::oi mn.
Per la p•·rmn c al...;.rorra d'infermi, ebhe la I"UIII'i!!ione uello Sp117.ÌO dr duecinrp t r !'<'ltimaue.. t'llt'(l di un mese e m ezzo per ht seconda: pe1· la terza. c:uaJ'i;::ione in du•• me'-i.
In 'JUBIILO ai lì ind•,·idui afl'elli da rperlrofia P da Hrlrllr;tiiOne
4 ,t:rUIH'Jronn dPfin Jtil·arneule dopo mesi e eli ollri la un notcvol" mi;:dm1·amenlo La solnzinne RC <fuosa impie;:ala dall'A. \liri» dal 10 al 20 p 1011, ed i· applic·ala 111 forma di collirio chP '-1 ln'<CÌH <·a lt:re 11 ;:: ccia 1;1 J:!occia pnrlr intt>rna delle p11lpeb1'e 1'0\'C,.rJnte e lenulc l'una oll'oltrn, lino a c·ile hl !'Cnsazione òi br·uciol'e, che provoCR. non a dissipat·!.i: in questo momento egl1 todie di liquido m edic8 11W11lP80 per mezzo di u•• tampone di eolonfl idrolìlo. Tal i rnstilloz1oni sono mente tolleJ'ate ben Js::;imo, c proi'OCtlno 1;'e11 saziou i mollo m e no doloro;;c di quelle c h e J•istil l tl iiO d all e n itl·ato d'arg-ento c col di •·arno
A noi, eire pur tr·oppo assisti amo cosi l'l'e'luenll'llH! Ille al deco•·so della co ngiuntivite gr·anul osa ed alla inutilità dei vari metod i cu r ali"i propo sti. r risu ltati ottenuti dal P opov c i debbon o somb•·a•·e veram en te !'li'BPI'· diriol'i, tanto pil! considerando il breve pe1·iodo di tempo in cui si ci.Jbe la gua · ri g1one. Perci<\ mentre ci r i pr·o metlramo di fa r e delle esperi enze in p•·oposilo.
raccomandiamo v i vamente ai coll g hi di impiegare tale c o ll i r io in Lulle l e fut'IHC tracomatose che cadran no solto la l or o osse t·vazione c<m p r Hghiera eli r en ern e noti i risu l tati.
Ricordiamo in lì n e, cile l'impiego Jell' iltio lo n elle all\lzio ni oc ula ri es te r ne non é nuovo, e che fu il dobto r Rh o, m ed i co capo della n•1s tru marina , il qualfl vi r icot•se per i l primo adoperando lo in fo rma di pomata (a l lilo l o I O p. 100 in l anolina) nella cur a del le blefa!'iti cil iari. Dopo di lui venn et·o il Luciani di Spezia, il Peten•, il Get·mani, I'E bersou, il Jaco vid òs, il e il Bialelli, il quale u l timo l o t r ovò efficace sopr attutto n ei tracomi con pan11 o corneale, ricorrendo alla formala deii'Eber son, che qui r iportiamo : lttiolo ammoni sco . g r . :>0
Acqua d i s ti l l a ta 40
G licer ina g t·. IO
Con questa sol uzion e s i pra ti cano delle pennell a ture della co n g iuntiva, a pal pebre rovesciate, co ntinuando le per qua lche secondo senza fare troppa pressione sul tessuto, f' facendole seguire da una la vatu ra m edia nte un pennello bagnato nell'acqua distil l ata. E. T .
E C ROVETTI - Sul v&lore terapeutioo del protargolo in ooull•tloa.
(Il Mo r rJagni, novembre
L 'autor e adope r ò delle so luzion i di pt·ot.argo lo al 2 % , e pe11n d l ature dello st esso rim edio al lO "f. i n p a r ecc tti casi di congiunLtvile a secre zi o n e purulenta, nei quali microscopicam ente era ::<la t a rilevata 111 p re senza d ei com uni pio geni• cou preYalenza del lo str-eptococco .
Ebbe ugual m e nte ad ut" a r e di !>Oiuzioni eli pro tar·golo al 2 0 3 "lo i n;; til late a goccie nel sacco nella c nr-a di po r ec<"ltic CL' nlin aia di c0ngi untiviLi catarr ali.
T anto nelle con g iuntiviti pu r·u lento come 11el le catHtTI"lli l!'altale co1 1 t al r i medio sempre ottenne ollimi r is ultati.
Non avendo il protat·golo a l cuna azione moJifica tl'i ce s ui natura lmente non può gio vare n elle affezioni in cui esi s te un' iulil tra zione profonda 0<1 un'iperpl asia drll cor·po papillare, qual i la co n g iuntivite g r anuloM, la follicola r e, la papillare , l a ecc. Per c i ò so no ben rircosct• itle e d elim i tale le indicaz io ni di tal r im edio in oculi s lica
Dai ris ultati positivi ,Le lle sue es perienze , l'a utor e l r ae l e consegu enze:
to Che i l protargolo 0 di facile App lica zi o ll e P b en to ll et-att).-
2" Che po ssinde in :;t'ado el eva ti ssi m o la propri età di non dar e pr ectp rtali in p r esenza di sos tanz e albuminos e, pet ciil du pref erir R i al nilt·ato (!"argento n elle chera t o- con g i unlivi t i , dov e per i depositi dei sali d"at·genlo nei l i nfalici corneali , sono a ssai f r equenti i pos tumi solto forma di opacità.
3° Che i l prota r g ol o , a nche a dose alta (20 ' /.), no u pr oduce 11uel senso di irri t azi o ne ehe pr·oduce il nitrato d' at·gento anche in dose t enue.
4° Che é do lato di una <luplice azion e : una antise ttica s ui m:cr obi palogeni, ed un' al t ra ·analges ica ed astr ingente sui t essu t i i nfìdmmali, ciò che gli ùà il pri mato sui medicamenti finora usati in oculisti ca nella cura delle congiuntivi ti purulente e cata rral i.
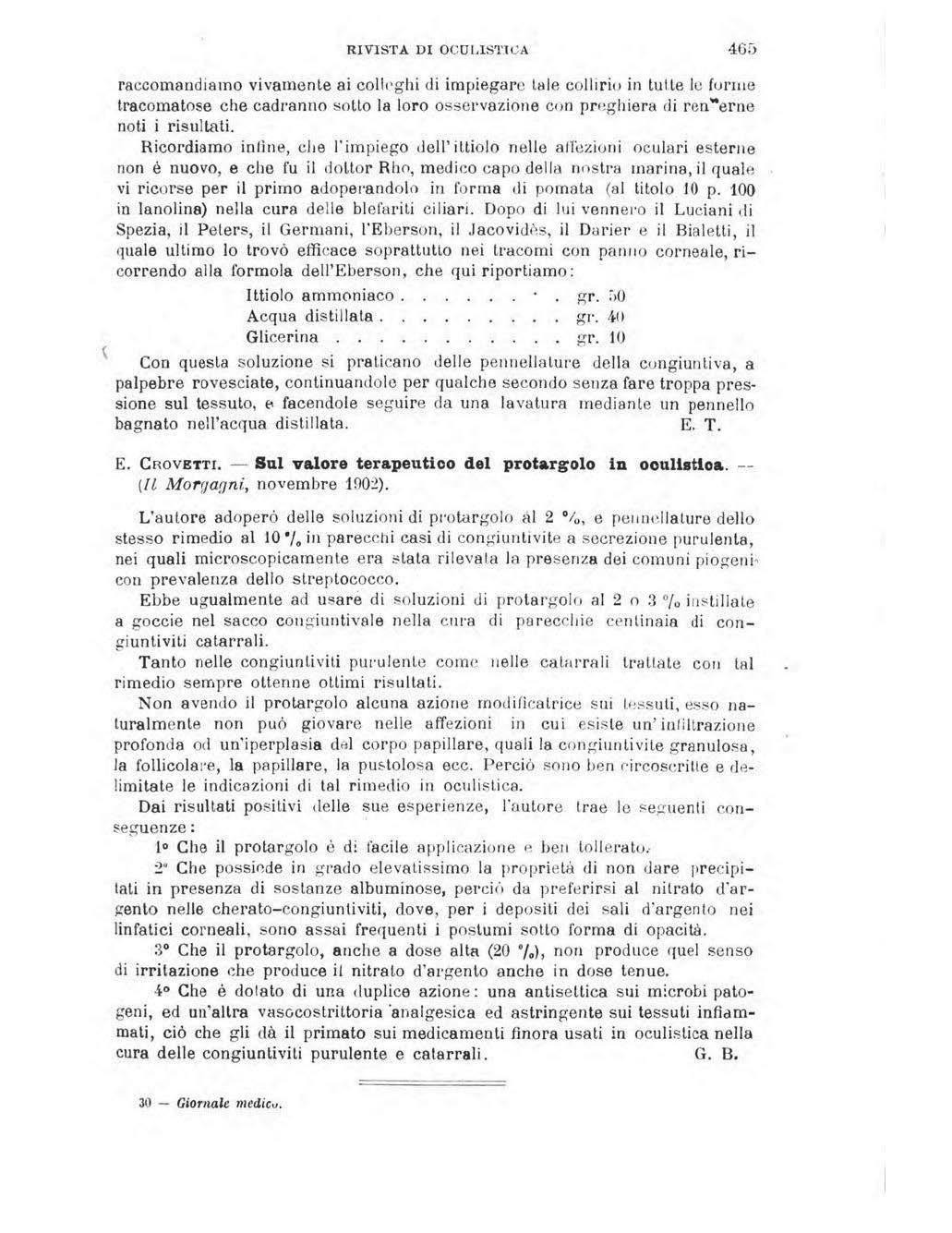 G. B .
G. B .
RIVISTA D I OCO LIS'l'l C A 46!>
30 - Glomal c medicv.
DJ ANATmHA E E PATOLOGICA
Il. CHr LESOTTr. - Colorazione elettiva 4et oWil4.raul - ju r wissensehaflliche Mikroskopie- Band XIX - 1902 pag. 161-1 76).
L'autore é oddello fJU ale ajuto al labo r atorio di anato mia palalogica dello Schmaus i n M onuco e d efini sce il suo nuovo m etodo di color azi o ne dei cilin· drassi con l'indica zi one d i metodo al carminio acq uoso c lo rid r ico.
I l SUfJ !>islema eli colorazione sarebbe indicato tanto per lo slutlio topogr aOco dei ci lindrassi normali come per quello dei ci lindrassi patologici
Ria ssum endo eg li a dopera il m etodo :
1' - I o Ii'(uido di Milller durante 4 mes i c più; oppure for·molo-M i'dle r (1 : 'IO) o formol o (circa 1 010l durante quattro giorni almen o.

2• I m pregna ::ione (sol t anto per i p ezzi fissati in formolo-MUiler od in form ol o). Soggi o rno durante 5 giorni nel liquido d' impr·egnazi one per le guaine midollari di Weigert.
In clusione in cel l oidina ; indurimento d ella e conservazio ue uei pezzi n el c l o roformio se no n si vuole c ol orar·Ji immediatamente. Soggiomo n ell'alcoo l a 70', se la tinta dei pezzi è troppo cari ca.
T agli p iù so Ili li ch e saré. possibile sopra tutto per la sos tanzo g rigia; in ogni caso non si sor possino mai i 20 IJ. Si e vi ti di spe!>!\Or c.
:.• Colora•ion e. Soluzione col orante : F11r· bollire du rante mezz'ora 1 f{r·.• di car minio nacaral ( Merck, Darmstad) finamcnte polverizzato, in ci r ca 2:lO c. c. d'ar:qua ; lasci ar· ri posa r e durante o r e; a ggi ungere una goccia di so · Juzione alcoolica (alcool a 70j ad 1 010 di acido c loridl'ico puro, p er c. c di carminio acquoso (val e a dire 3 c. c. per 100 c c.) ; scuotere fortemen t e, quindi lascia r riposare pe r o re ; p osci a traYasare per· liber·are la soluzion3 dal de· posilo (non filtrarla). q uindi cir ca 1: 1000 d i timolo pe r· preservarlA delle mulTe. l togli r esterann o almen'l 20 o r e nella color·ante.
1• Laratura d ei n ell'acr1ua di s tillata, procurando d i toglie r e lor·o l 'ecccso: o di polvere di ca rm i nio che an o rmalmen te s i fo!'lse depositata l"U i tagli duronte la <'Oiorazione .
R' Immergere i tagli duran t e 30 secondi in una soluzi one ocquO!'IO di perm1.1n gn nalo di po ta sse all'112.100, quin di pasl'orli dur·ante 10 a 60 secondi in una soluzi one a cquosa sa tura di acr do solforoso, lavare p oscie nell'acqua Rip e> t er·e l'opera zione ciiminucndo progre ss ivam ente i l soggiol'no noi fin c h é i prendono una colo r azione r osa uni f orme, però con dci maggior·mPnle tinti in r osso. Cambiare l e quando comiru:ia no tl!l alterars i.
!!• .A lcool 06, :t:i/olo [e 11icalo, balsamo d el Canaclà. Ossol'\'ond o alloro al microscopi o, i c ilindrass i c l e cellule ga uglio nari sararmo in tensa m eutl' eol oreti in r o$so ; novrogl ia e le guo.ine midollo r i r eslPranno com p l e tam ente
• l .! ' · ' • .., o'
i co r pusco li sanguigni, i nodi de lla nev r oglia, il tessuto connettivo non s aranno scolorati che parzia lmente
Cosi, sec ondo l'auto 1·e, il ca r min io quasi abbandonato io questi ultimi ann i nella tecn ica del sistema nervoso, avr·ebbe un' a z ione elettiva sui cilindrassi dando risultati migl iori di quelli ottenuti fino a l prese nte con altre sostanze co lorau t i od impregnanti.
G. B.
J. CRocQ. - Del meoo&Dl•mo del touo e del riJltt••l ueUo •t&to attu&l.e dell a .olensa. - (Journal de 1 \ eurologie , ottobre !902)
L ' autore, du esperimenti praticati sugli anima li e da mol teplici r isu l· tati dati dall'osservazione clinica, ritrae le seguenti conclusioni :
N e lla sezione delle r adici p osterio r i, si o s serva l'aboli zione del tono muscolare e l'abolizione di tutti i r iflessi.
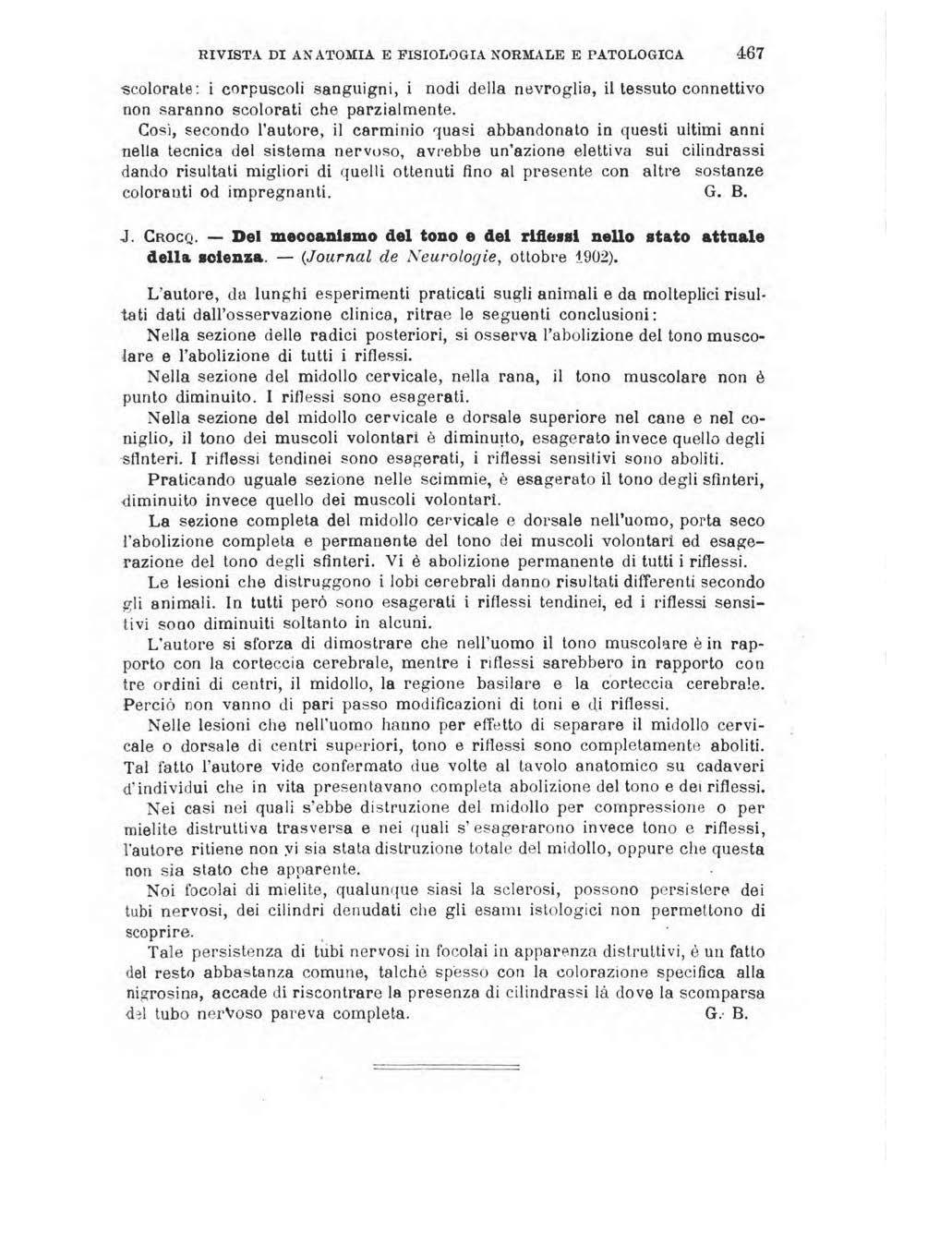
Nella sezione del midollo cervicale, nella rana, il tono muscolare non è punto diminuilo. I rifl essi sono esagera ti.
Nella sezione de l midollo cervicale e dorsale supe r iore nel cane e nel coniglio, il tono dei muscoli volon ta r i è dimiou!lO, esage rato in vece qu e llo degli -sflnte r i. I rifles si t o ndinei so no esag e r ali, i riflessi sensilivi souo aboliti.
P r aticando uguale sezione nelle scimmie, è esagerato il tono deg li sfinleri, d iminuito i nvece quello dei muscoli volontari.
La s ezione completa del mid o llo cervicale e dorsale nell'uomo, porta seco l'abolizione completa e per manente del tono dei mus coli volontari ed razione d e l tono d egli sfinteri. Vi è abolizione permanen te di tutti i r iflessi.
Le lesioni che distrugg ono i lobi cerebrali dann o risultati differenti secondo g li animali. In tolti però s ono e sag e•·ati i r iflessi tendin e i, ed i riflessi sensitivi sono diminuiti soltanto in alcuni.
L'autOJ'e si sforza di dimos ll·ar e che nell' uo mo il tono muscol'lre è in rapporto con la corteccia cerebrale, mentre i rrfle s si sarebbero in r apporto con tre o rdini di ce ntri, il midollo, la r e gion e basilare e la corteccia cerebra!e.
P e rci ò non vanno di pari pa s so modificazioni di toni e tli rifless i.
Nelle les ioni che nell'uomo hauno per di s eparare il midollo ce r vicale o dorsale di ce ntri supe rior i, tono e riflessi sono comple tam ente abo lili. Tal fallo l' autore vide confe rmato due volte al tavolo anatomi co su cadaveri d"individui che in vita p r e s en tavano comple ta abo lizione del tono e de• riflessi.
N e i casi n oi quali s' ebbe di s truzi o ne d e l mid ollo pe r c ompre s s ione o per mielile di s truttiva trasve•·s a e nei quali s' esa g e•·aro no invece ton o e rifl essi, raulo re ritiene non :vi sia stata di s trur.i o ne total e de l mi dollo, oppure ch e ques ta non s ia stato che ap pare nte .
Noi foc o lai di m ielite , qua lun ' JUe s iasi la scleros i, posso no pc • si s lert' dei tu bi n e rvosi, dei c ilindri d e nudati che gli esam• is to logi ci non permettono di scoprire . .
Tale pe r·s is le nza di tubi n e rvos i in fo colai in di s truttivi, è un fallo del res to abbas lan?.a comu n e, tal c h è s pesso con la c o lorazio n e s pec ifica alla ni g-ros ina, accade di r is contrare la presenza di ci lindrassi la dove la s comparsa
tub o ne rV oso pat eva completa.
G: B.
RIVISTA DI AN ATOMU. E FISIOLOGIA NORMA LE E PATOLOGI CA 467
RIVISTA DI MALATTIE VENEREE E DELLA PELLK
Dotl. H. WALS HA \f. - l raggi ultravioletti nel trattamento delle mal&tU• cutanee.
Già fin dal 1878 Do wne s e Blunt presentavano l e l or•o c onclusioni s ull 'influ enza dell a lu ce su l proto plasma, ma furono dimenticate fino al t892 quando i l \\' ar·d i suoi espe!'imenti s ulla azione della luce c on tro il bac ill o del carb onchio, dai quali concludeva l a luce so l ar e il put•itìcator·e de ll' aria e d el l 'acqua. Il primo che pen:::ò di utili zz are queste cono scenza in terap ia, fu il Finsen il quale venne a s tabil ire chu l a luce e messa dall' arco voltaico é piu efficacr, di quella solare nume1·ose esperi enze dello St1·e bel sopra cultu!'e contenute in r ecipienti di ,·etro con coper ch i di var·ie sos tanze.
Scopo d eii"A. i• slalo di contin uar e tali esper1enze n o n più in vitro, s ibbene contr o i bacilli vi venti nella pell e dell'uomo .
Ab ba ndonando la concezione vol g are del la luce per· una più dobbiamo considerar e la luce bianca co me i l ri sultato di vi bra zi on i el ettr ich e d ell"etere anzi soltanto come quel ce rt u gru ppo, quel la cer ta ottaoa d i vibr azi oni c h e possono stimolare la nos tra r e tina, mentre fl)rse il uumero di esse I)On viene da no i percepi t o Con !<peci al i si é giunti a mis u ra r e la lunghezza d'onda delle vibl'a · zioni che eosti t ui!'•;ono i dive 1·si colo ri dell0 spellr·o L'unita di misura è il milio nesi m o di millimetr·o ra ppresentato dal doppio mi ( !J. !J.). Tali lun ghezze di o n da discendono co me segne : dal r O!'>;O a l ver de. da 698 a 500 )J.!J.; dal verde a l blu da :,oo a \57: da l bl u al violetto 457 a 393 e per· i u ltr·a vi o l e tti da 302 in giù, fìnn a if)O e 160 e ro r '\e meno. Secondo l o Str·ebel le onde più c orte che si po>;so no av ere dalla scin t illa el et t rica pr·odotla da un r occh e tto di ioduzione ,·at•iRnu a seconda della nat11 ra degli elettr·od i.
Quanto a l le pt·oprl t à batte r·icidc è fuori di dubb io che sono appan naggio della porzione blu - vi o letta e ultr·a\"iolett.a, anzi lo Strobel ha p r ovato che i ullra vinlell i uccidon o i ballel"i anch e da sol i se nza luce v isibil e, e anche se p r otetti da l amine di qunrzo . I l F insen d'a ltro canto ha veJ uto c h e l a luce solare onrhe !'e concenlt"ata da l enti no n cosi attiva.
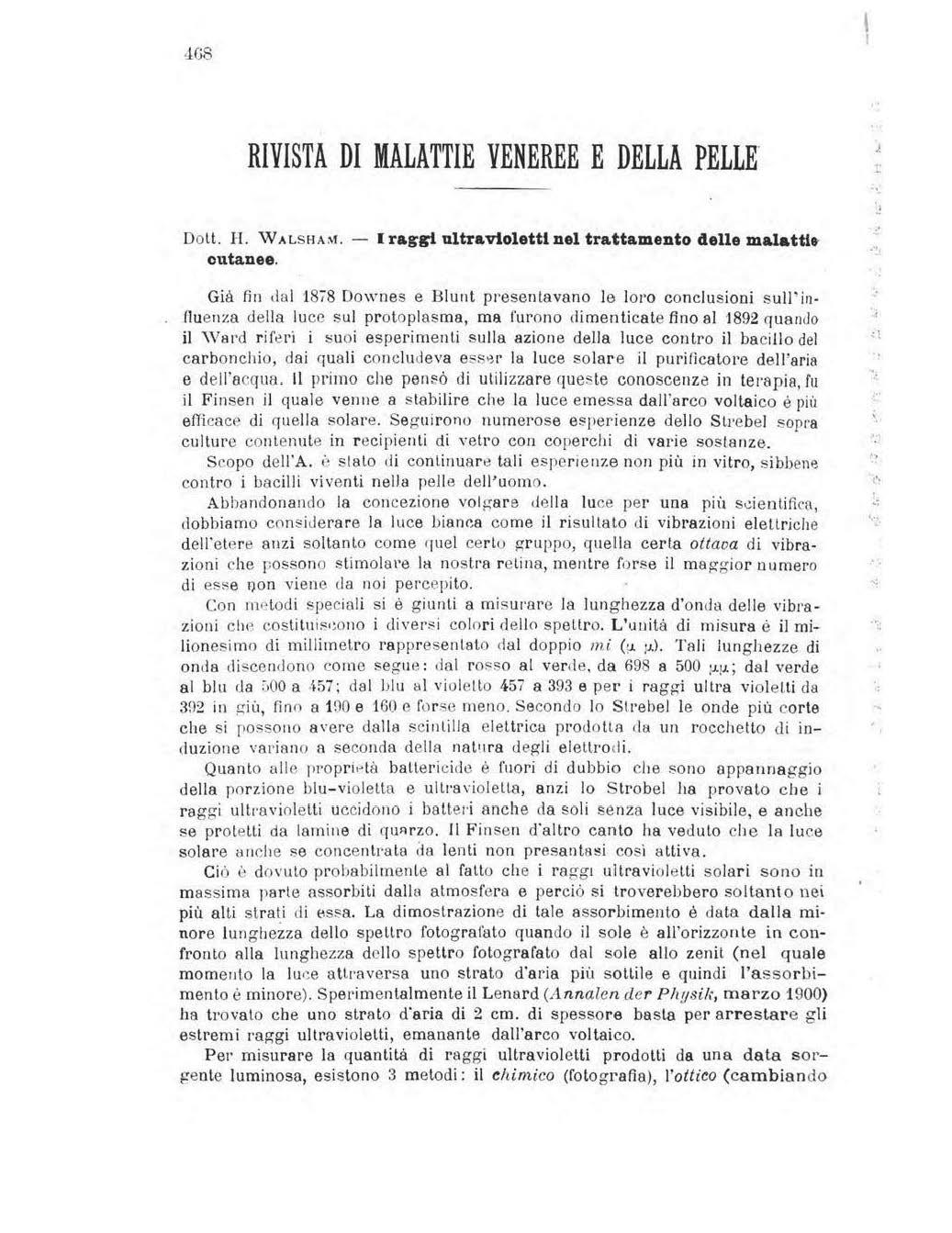
Ciò è dovuto p r obab ilmen te el ratto che i ra g-gr ultravi o l etti sol ari sono in m assima pa rt e asso r biti dalla atmos f er a e per c iò si tr over eb bero soltant o nei più alti strati d i La dimostrazione di tale assorbimento è data dalla mi· nore l ungbeÌza del l o spe ttro fotografalo q uando il sole è all'oriz zonte in confron to alla lu nghezza d ello spe ttr o fotografato dal sole allo z enit (n e l quale momen t o la luce altl'aver sa uno strato d 'a r ia più s ottile e quindi l 'assorbiminore) Sper•imental mente il L en ard ( Annalen de r Ph ysi k, marzo 1900) ba t rov ato che uno strAto d'aria di 2 cm. di spessore basta p er arrestar e g li estr·em i r aggi ultraviole tti, emanante dall'arco voltaieo
P er misurar·e la quantita di ra ggi ultravioletti prod otti da una dala s orf!eute luminosa, esistono 3 m et odi: il chimico (roto g r·afìa), l'ottico ( c ambian do
. .. _,
le onrle corle in altre ptù lunghe e pP-r ci ò vi sibili = fen o m eni di flu o t•escenza) e l'el ettrico (el ettroscopio a f oglie d'oro).
La fotografia dà ri sulta li qualitalivi ma n o n quanlilalivi senza conlat·e c h e è impos!:'ibile in pr alica o tt enere ug uale es pos izio ne, ug uale s vil up po e uguale sens ibilita d elle la s tre .
Le s t esso uccuse po!'sou o rn u o v ersi al m etodo o tti co s ia c he si usino gli schermi usuttli al barìoplalino, s ia c he ri r: nrra all e sol uzio ni fluoresc enti , senza dire r: h e l o s pess01·e com plessivo dei pri5ru i e l enti dello s pel l r oscopio e di circa 3 em il c h e po t·ta g ia no t evole ostacolo a l la pt·opuguz ione delle o nde p iù col'le, giacch é d e ve t eners i pr·esente c he i n gen era le qu a ndo più la o nJa e cortA, tanto minore è la !'lua pe ne tra zi one, ben c lt è abbia n 0tevole influenza la drver sa nalut·a dell'o stA co lo. Re s ta il metodo elettt•i co e di ques to s i è servito l'A. Esso è f o nJ a lo s ul fatto ch e le 01 1de e , l'peeialmen te quell e co rte, (into rno ai 200 1-l:J.) r endo no co ndu t to r·i i gas u ttravl' r so i qull li pa ssano, e tanto più quanto pif.1 esse sonu a bbon dnn t i . E cco il m orlu s j acierul i :
Sì c ar•ica con elettric ità Lui el et tro scopi o co mun e fì nc he l e d'o r o div erg ono fin o ad un Je t et•miu a to i'ln g olu. Si d 11•i g e allora la so Pg en le lumin osa contro la srera dell o a ppare cchio e si mi!'ura il t empo n ece!'\sar·io pc t· l oscar icarsi dì qu es to, temp o v Rri <lllle a secon da dell' i nte ns ità lu.111in osa.
L e con clus ioni alle quali é perv e nuto l'A. in seguito a m olt Ppl ici el'<per ien ze s ono m olto iuter·essanli ; n e r ipo r ' ti a m o qui soltanto due :
to Uno s trato dì g el a tina d ello spe sso re dì mm. 0 ,01- arr·esto co mpletam ente lutti i t·a g,a:i d ella lun g hezza d'onda sopraoo lata ( fl ci ò dil t'llgio ue della inesattezza del m etod o fol og1·afìco).
2° Un blocco d i g hiacci o di cm. 15 dì spesso l'e è quas i u g ui tlm en te penetrabile c o me uno stra to d i ari a di u g u ale s pessore.
Qu es t 'ultima notrzia è di u o tev o l e impo rtanz a ne l ..:ampo terapeuti co . I nfalli sec ondo il Fin sen i l ma f.(g i o re os tacolo all e o nde cort e, nel l ot•o passaggi 0 attraverso i tessuti, é da lo dal s an g ue, doude la nec essità d i ren der e a nemici i t essuti mala ti per faci litare l'azio ne ballet i ci Ja della luce La compre,;sion e era l ' un i co m ezzo usato fin o ad o gl[ì a q ues t o intento . in base alle proprie e s p et·ienze l ' A. con siglia di associare al la compressi o n e il fr eddo, serven d o s i di u n blocco di ghiacci o co me m eZ7.o d i c ompressione
L e antiche lampade a ci arco Òt1 10 amp. usate d al Frn i':en danno tro ppo cal or e , ma quelle ad alta t ens i o ne ed alta osci l lazione u sate dall'A dànno appena un decimo del cAlore di quelle, eppe rci ò un disco di g hiacci o spesso ap· pena :3 c m., ha una durata più c he bastevo le p er una l'<ed uta. In o ltre la super io r ìlà d elle nuove l ampade é dim os trala dal fatto c he l e anti che, quando si ano dello schermo necessa t•io a gara ntire la cut e del paz i ente (du e lemrne di quarzo dello s pessore complessivo di 5 mm. co n interposto uno strato d'ac qua di 13 mm ) n o n hanno più qua s i alcuna azione sopra lo elettrosco pi o a d'oro, sul quale s enza schermo s ì mos trano invec e co sì effic aci come l e nuo ve.

L'A. ha u sato per la s ua lampada e l ettro di di ferr·o, ma t'eceotem ente il dott. Brang ha pr·oposto lam pade a carb oni rafl'1·eddati m erc è cort•ente d'acqua il potere batter·ìcida delle quali sarebbe 60 volle superiore (Br i tish M edical J ournal, gennAio 1902).
La lampada della quale si ò s ervito l ' A. è m ontata sopra un soste g no maneggevo le, lung o ci r ca 30 cm. del diame tro di circa 2 cm. , ri gonfio alJa e stre-
RIVISTA
DI :MALA'l'TIE VENEREE E DELLA P E LLE 4GD
mila dove s i produce l'arco voltaic o dinanzi al quale può mettersi una laslt'a> di ghiaccio.
Ha trattato cosi n umerosi casi di lupus volgare ed e r itematoso, con più successo il pri m o c he il secondo. Le sedute erano lunghe da 10' a 15', la g uarigione è !>lata più rapida là dove la compressione era meglio effettuabile.
E' difficile dire se i raggi ultraviole tti r ispondono meglio dei raggi X. Entrambi hanno azione chimica, entrambi producono fluorescenza, entrambi scaricano l'elettroscopio, entrambi sono causa Ili dermatiti. Tutta via la de r matite prodotta dai primi si manifes ta presto, tal volla subito , e presto scompa1·isce,. m e ntre quella dala dai raggi X richi ede anche settimane a prodursi e settimane e rn e si a guarire. lnolLre per quanto riguarda i ragg i ultr aviol e tti siamosicuri che essi in vitro u ccidono i batteri, m e ntre la stes::'a sicurezza non s i ha per i ra ggi X, i qua li anzi, secondo taluni o:;;servatori avrebbero la propi·ietà di stimolAre lo sviluppo delle colonie.
L. F.
A. MouRNAUO. - Dell'ermofentle e del auo u ao nella oura de lla. alflllde . - (L' E r!ho m hlieal dn Nord, sP.llmnhre 1902).
Trallas i d i un nu o vo c o mposto or gano-metallico, contenente il 40 per cento di mercurio, solubilissimo nell'acqua, nel quale sono masceh r ate le reazioni del m e rcul'io, impiega to e s tudiat o a lungo dall'autore e racco mandato dall o stesso con argomenti desunti dalla chimica, dalla farmacodinamia e dalla clinica.
E.:co le conclus ioni a cui egli vi ene:
1° L'ermofen il e ha un coefficiente di tossicilà di 0,010 per via inlravenosa nel ca ne e nel coni :tlio, di 0 .125 pet· Yia soltoc u Lanea, di 0,20 pe1' in ges t1 o ne nella cavia.
2° T a le pmdotto è dotalo di proprieta anlh' egetalive di pl'imo oJ·dine.
3° È eliminalo ra pida mente dal r ene all o stato di composto o rgano - meltilli co
4o I cRs i cii sifìlide pr·imaria e secondat·ia in cui venne sommini s trat o , fin da principiO m iglt o i·arono sensibilm ente ed ebbe ro un 'e voluzione e benigna.
5" Nella cu r a della sifilide i ri sultati ottenuti furon o costantemente buo ni, talvolta eccelleui.
(i" L e sifi liJ i precoci mali g ne mi g i01·arono semp1·e . cd il maggior num e r o g uarì mollo J'apiJamente.
7° L 'e1·mofemle somm inisti'a lo per· bocca, ha il g1·unde vanta ggio di logli<'J'c> i num ero s i in co nve nienti fornitt dogli alLri sali di mer·curio . lnfa ni m ai produce 1J é gengi vite, nè sto malile, n é diarn a e fa rapidam e nte scomparire la s titichezza data dall'impiego Jegl1 altr·i sali di

1:!0 Le iniezioni sottoculanee d'ermofe nile sono mollo meno di tutte le altre iniezio ni m c> r cu riali, e d i risult.ati ottenuti col loro uso s on o altrettanto rapidi. 1\lai prov ocarono né edema, né nodosita, n è a scessi.
Per tali ragioni l'e rmofenile, secondo l'aulol'e, mel'ila d'esser conl:'id e ra lor,·a i mi gl iori antisilìlitici. G. R.
470 RIVISTA
DI MALATTIE VENE.REE E DELLA PELLE
RIVISTA DI 'l,ERAPEUTICA
Burro 41 oooco depurato (veg etallna). - (Archioes de mMecine et deplt ar-macie militaires, febbraio 1903).
Da qualch e anno è stato intt·odotlo il burro di cocco depura lo nella r a zione alimentar e d e l soldato, e molti co r pi di tru ppa ne fanno uso sia sos t iluendolo al gra :::so suio o sia ad esso mescolan d o lo. C ogli espe rimen t i faHi da lversac e Laroche hanno dimostrato che questo g t•asso vegeta l e viene assorbito nell a pr opo rzione del 9 7 p. 100 possedendo cosi un valore nutritiv o. se non s•Jperior e, almeno eg uale a qu e llo degli altri g rassi alimentari. Anche da l pu nto di vis ta econo m ico presenta una supe r iorità real e, costa lire 1,10 il ch i log ramma, è anidro, mentre la costa lire i ,50 e contie ne fi no a l 40 p. 106 d'acf(ua
Conse r vato pe r m o lli mes i e nella s tagione calda al contatto dell'aria non si alte ra Usato in diffe renti modi di coltura della carne e dei leg umi non m odifica la s ua compos izione chimica, n è le sue pt·opriet.à o r ganoleltiche.
In te ra pia la veg-e talina trove t•à utili app licazion i, é un m o lle, fo nde a 26°, i uoùoro, poco al tet·abile , può sostituire vantaggiosamen te, in m olli , casi, la la oolina, la sug na e la vaselina .
M. C.
HoMBERGER. - Modo di ammlnlltra rell•alloUa. to dhodlo . - (La Semaine médicale, n . 10, 190Z).
Ne lla pra ti ca giornaliera si preferisco di pre scr ivi' l'e il salici la lo di soùio a ll'acido salicilico pe r u so in lel'llo, percl1é p iù solubile n pcr·chò no n e s erc ita azione caustica sull a gastrica, come quest'ultimo preparato. M a esso noo é de l tutto esente de l secondo inco nv enie11te, sotto l' influenza dell'ac ido clo t·idl'ico conte nuto nell o s i decompo11e, dando luogo alla for mazio ne dell'acido salicil ico puro. Dunque per ovviare a questo fatto s arebbe n ecessario da uri Ialo neutral izza re l'acido cloridrico, r e nd e nd o lo inattivo, da ll'a llro favo r ire l'asso r bimento de l sa li c i lato, !ascia ndol o soggiornare nl'llù s tomaco il m e no possibile.

Ora l'A. , in base a nu m e r ose e:-:pe riem: e , con!iigl ia di somministrare il bica r bonato di soclio sia p rima, sia con te mporaneam er.le al sal icilato; in lal modo s ' impedirebbe all'acido cloridrico di ag ire s u quest'ultimo p r•epat•alo, e nel lo s tesso tempo si l'acJ!itet·cbbe l'assorbimento del sale m 1·diante l'acido ca r bo nico, che si forma.
Inoltre ra cco m anda di non amministra t'e il sa licilato sciol to i11 g ran de l) uantità di liquido, come co mun eme nte si pra ti ca, sotto il punto di vista c he una sos tanza irri tan te riesce meno nociva s ulla mu cosa g-astrica quando è sciolta in m aggiot•e quantità. di l iquido; invece b isogna da l'io in poco liqu ido, essendo cosi me g lio soppo rtato - fatto questo, che co nfe l'merebbe la o sservazio ne di altri , che , cioè, il sa lic ilato di sodio s parisce dall o sto maco con la massima J'apidità, quan do viene so mminis trat o a digiu no ( Mo r itz). Pi ù <· lungo
471
i l d r>! sale oello !>-lomaco e più pos s ibile si r ende la for mazione d r·ll'acido salicilico libo r o
I n per e\'ilat·e qualunque azione nociva sulla mucosa gastrica, i l salicilato di sod io Ya dalo in associazione a l bicarb o nal.o di sodio, in poca quanlita di liquide e a digi uno.
C. Q.
Trc11v. - L 'tpoolorlto dl oalce nelle I'OOttature. - (Reou e des n o u l'ea u.r. remldt' S, 1!JO:l, n . 2 .
L'A. r ;lccomtt nda l'u!;O di una soluzi o ne di c l o rur o di calcin sop1·atutto nelle s('l)tlature di secondo e ter•zo g rad o . E f,!"l i applica dappri ma sulle scottature del le r.o m pJ•es"'e spa lmate di vasel ina bori ca; dopo ventiquattr' o re , con tutte l e pr·ecauzioni aselliclte, apre le {litene, e quindi Jp. r·i copr·e con compresse i mhrvute nella seguente soluzione:
lpocl orilo di cal ce
A cqua di :> lilla la .
fìlt1·ata tai P soluzione, Yi aggiunp-e:
Alcoo l can forato .
gr. 5 900 g r\ .,
A ppen a ces:-a la secr ez io n e della sco ltalut'!l , si ro r·mano delle c roste !;ulJa pelle. l a c ute é tlis;;eccata, si può sospendere i l t rattamento umid ::: c , ri <·opr il'la eli nno di lan olina.
G. B.
RIVISTA DI TEC NICAE SERVIZI OMEDICOMILITARE
Doll. P E R K z 0nTt 7.. - Antl1ep11 ohlrurgica e trattamento delle le1lonl traumatiche nelle divene formazioni •anltarte durante 11 combattimento. - al X I V M edi<·o I nternazionale, ::\fadrid, wo:l).
L'aut or e el ce s ul 1;a rnpo d i battagl ia non è possibile di m ettere in pratica i p r ccclli r·igorosi dèlla per l'asepsi e l'an t i!:;epsi se le medica l u re n o n sono affidate a i med i ci militari , i quali soli sono in g r ado di i pericol i a cui un fe r ilo per una prima medicar.ione mal falla. Con!';iglia quindi particolari n o rme sul campo di battaglia per 11:1 cura di ferile semplici o compl rcate con emorr ag-ia e f r attur e, e riassum e t utte le nor·me del "'ervizio sanitario tanto sul campo d i ballagl ia, quanto n ell e di senili) e negl i ospeda l i d a campo.
Uà tno l ta importanza alla ùisin fer.ione del le mani dei chirur·ghi e deg-li istt·umenti, del materiale da medicazione e della s uper ficie delle fe1·ile, e (quando sono infett r ) d el l r agi tlo pe r cor so in PS!';e dHi proiettili. li chirur go milita r·e ha assoluto b isogno di operare e bene. e ta l e pra ti ca non posseggo no cert am enlt• i llli' dici cto'i corpi e in g rudo limi tato l a posseggono quelli ch e pre-
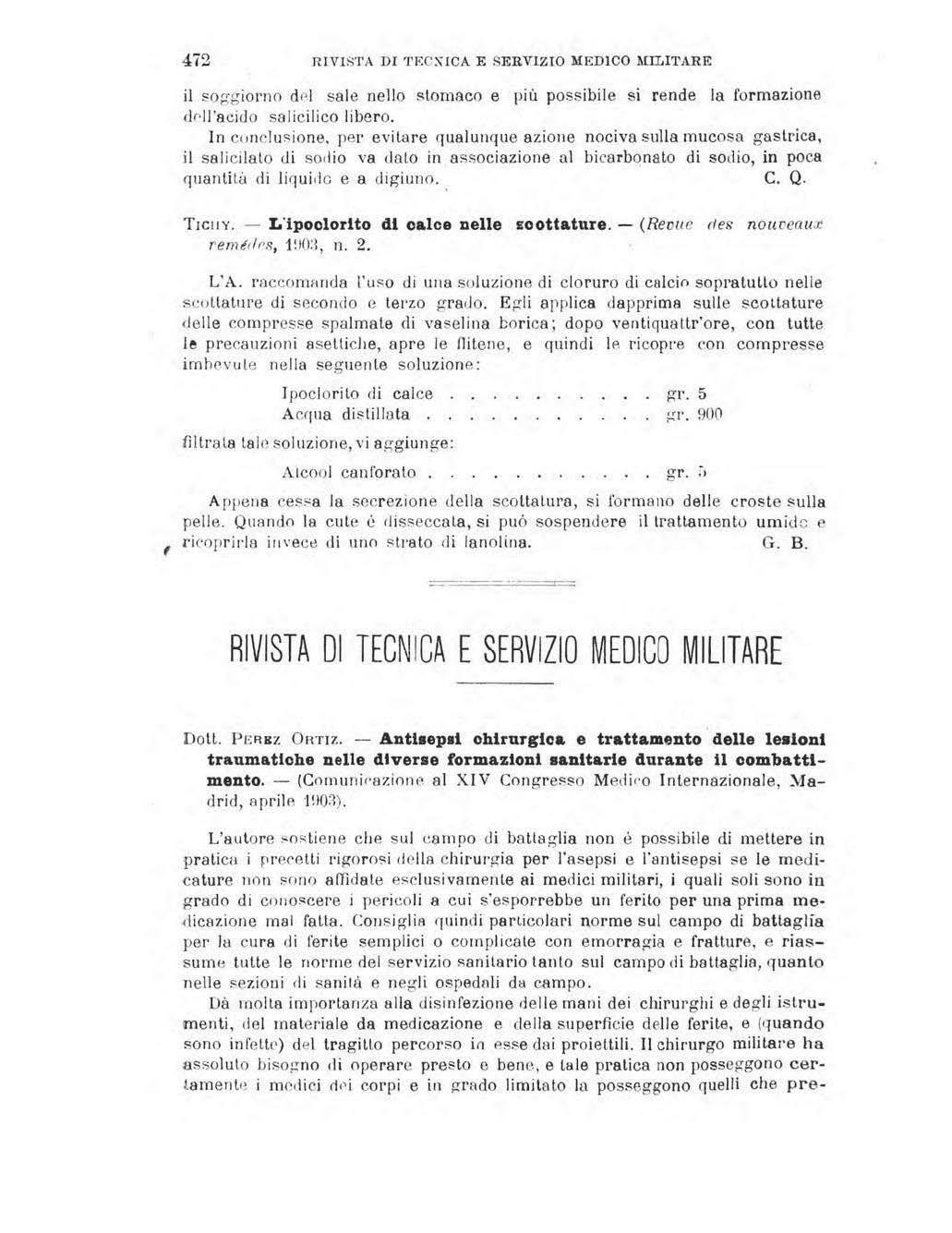
472 RIVISTA DI E S ERVIZIO MEDlCO MILITARE
----··
=
$l&no serv izi o negli ospedali, d'onde ·la necessità d i frefjuen ti co r si di m edicina operatoria pratica per gli uffìcia li medici .
L 'autore di ricor rere, all'occorr enza, an che all' iniE'ziooe di siei'O fisiologico io caso d i e mo r1·a gie gravi e di collasso e, quando ind icata, alla laparotomia por lesioni mtestinali. Dà pure speriul i per l a diugnosi o la cu ra delle pi ù \'BI'iAtc lesion i chi rur giche del , en l r e, del pt"ltO, d <'l collo, del cran i o e dell'apptu·eccllio genito-urinario con in t er,·ento allivo, se nf'c<'!•sario.
Tutle le pr incipa li opet·azioni dov re bbero e;:scr·e nelle sezioni di sanitù per non perdere lo prim a condizione es:<enziflle, cio•' il t empo d PII' iole r \'en t o chi r urgico. lnsi5\te par·ticolarmenle sulla n ecessità delle lapar·otomie, la cui tecn•ca dovrebLe ben conosciuta praticamente da ogn i m ed1co militare. Anche gli appa1·ecchi di •·adiografìa sat·anno 111 t alunr Ci r costanze ullltsl'li m i pe 1 · la d ingnol'\i dtli •:orpi eslra rtt>i e parlicnlarmenle per la localizzazione matemati ca el i ;:ede, pe r piani anatomici, dei proiettili.
L'autore cosi con clliude la s ua interessante comunicezione.
L'a nti ,..epsi e l 'a"epsi de,·ouo co,;tituire il m etodo e$clu>'ivo, specialmeute la prima, per la cul'a delle fe rite n ell e rltverse fot' mazio ni Uno dei punti pi tì irnpol'tnn ti del se rviz io Ranilal'io in g uc t ra t' pu r e l a buona o r ga nizzazione de l pel'sona le di lras pot•l o, della sq uatlra dci por ta ferili, i q uali dovt'Anno e"sere i s truiti ed o 1·ganizzati i n m odo da efl'e lluare il ser v izio di tra spOI'lO rapidam e nte dalla p t·ima linea alle d i sanità e da quest o agl i da campo.
Certi dettagli dtlllo chi l'ul'gia non possono realizzarsr sul campo dt battag lia; il chirurgo dove la sua all'occlusioue a nti settica della fe r ila, a l'emorragia e ad immobi lizzare 1.- membr·a fratturAle.
L a s ezione tli pet· l a sua situa zi o n e, pPr la dotaztonE' del per·sonale e per il materiale r egolamenta r e d i cui può dtsporre, è quella che esegue il lavoro maggiore di tutti i 1·eparti sunita ri , r ettifica , c ura e pratica le opera· zioni L'accura tezza di tulli questi interventi deve costituire il s uo principale per potet· r ealiz7:are i ver i etfeLti del m etodo.
11 mi glio r e emostatico è la legatu ra ; poi la fo r cipression e iu 11lcuni casi, e nell'emo r r agie capillal'i l'acqua ossigenata c l'antipi r ina. La fa scia elastic a sarà adoper a ta a<>sat l'a t·a m eute.
Il s ublimato, e particola r m ente l'acido feni co i n !<oluzioue concentr a ta calda, sono 1 mi Jdio!'i mezzi l ocali per la lava tura e la disinfezione delle ferit e.
11 mtglio r metodo d' immobili zzazione d efi n itiva è l'apparecchio gessa to (scaf!liola), per la !' Ua facile e rapi dA a ppl icazione, cht> as!'icura i l trasporto dei fet·ili a g r andi dil'llanzc , senza tirnor e che allon tan ar s i i frammenti ossei riuniti.
L e fratture aperto e co mplica le d evon o esser e disinfettate be ne con r eplicate l avature antis ettic he, p1•aticando osteoto mie ed est1·aendo lutti i co r pi es t r a n ei, e n on trascurand o mai l'ApplicaziOne di
11 c hiru r go mililut·e deve essel'e svelto e s icuro n ell'eseguire le operazioni, e ciò otte1·r a lavorundo molto nell'anfiteatro anatomico, r ipetendo, a l'egola. di a rte, le operazioni che occorrono g eneralmente nella pra tica dell a chirur·gia di g uerra.
Dei metodi c lassici di amputazione devesi sceglie r e quello A !em bi per trasfìssion e, fa cendo l'emostasia del membro sul t r onco principale arterioso, allo

RIVISTA DI E S ERVlZIO MEDICO MILITARE 473
scopo di evitare lega ture multi ple, che rendono le opez·azioni lunghe e laboriose.
Nelle ferile del cranio si regolarizzeranno i frammenli ossei, si sollever&nno quelli che comprimono le parli sottoslanti e si fa rà l' emostasia.
Nelle ferite del ventre, a spetlaz!one e tamponamento nelle leggere, laparolomia m ediana n e lle gravi, con perforazione delle an se intestinali e veJ•sad e lle sostanze s tercoracee nel la cavita addomin8Jl e. C. S.
HELPERicH.- Propo•te cll mezzi tmprovvt•att cll tra•portt per le fratture del femore. - (De uts cl•e miliiii.rart.;licl!e n. 5 , 1902)
L'autot·e, nelrintento di rimediare alla mancanza di speciali appat·ecchi nel materiale sanitario da campo dell' ese rcito germanico, per il tz·aspol'lo di milita r i aff.,tti do fratture de l fe more, dopo avere accennato alle difficolta che si i ncontra no nell'impt•ovvil'<are la sedia-ba rella ideala a tal uopo, lìn dal 18!)2, dal genera le m edico P o rt, propone d 'inlrodutTe nell'attual e barella re go lamentare alcune modifì ca zioni , le qual! per brevità t r alasciamo di descrivere, ma c.:he tendono a semplificarla.
Dc·;.;-na d1 Cf;Se re z•ipo rtata per la su11 pratica utililè, é un ' al tra proposta. che l' uutore fa , di u sa r·e, durtlnle il trasporto in bare lla, a sos tegno dell'a l'lo infe riore 1eso, un doppio piano incli na to costituito da due quanto il tP laio della barella, le quali f<OIIO COngiun t e fra lOrO ad angolo mediAnte due cerniere, o, in modo più l"emplice, con due fullicelle, per cui e s is tono foz·i. U n'alt r a funicPila inll·odolla in due fori, situtili in vicinanztl della pHrte m e diana de i lati inferiori, mantien e la n c•cesf'at·ia inclinazi one (c he dev'essere press' a poco di 901 dei due pia ni. Cia!O'c un lato es te rno delle a ssicelle e munito di una gz·ossa stecca di le(Ino, che in ba sso spo rge di pa c·ecchi cenl. oltre le stanl! he della barella e i m· pedisce i movimenti later·nlt ,!ell'a ppare cc hi o.
L 'assicella, su c ui si appog!!io la coscio, deve avcc·e un'alte zza di IO c m., quella o p po::. ta di 4:) cm., s u ppos to elle il fet·ito sia di media statura.
L'autt1 re assel'isce cht•, sovrappnnendo a tale Apparechio un mate ra s:;:inn di pB g lia, di co nv e 11itmle spessoce, e ada,(! ianclovi l'm·lo mfe Fi• IJ'e leso, si pz·ocura a questo un buon so:;:teg-no clastico cosi c he il paziente p u ù sopp(l t•lare un traspot·to anchl' lun go, e m anlenc>re se m pre la posizione più favoz·evole per J,. frallure de l femore, in grazia della c l•e il bacino col s un peso e se rcita sui fl·amme nti.
I n mancanza di asl"icelle, il doppio piano ì11clinatn polz·a e sl"el'e impro\·v •sato con te lai o pezzi eli r o to ndi convenientemente di s pos ti , su cui si ste nde ra11 no leli da tenda ecc. L 'appa re cc hio col n o n o ccupando m ulto spazio, può trasportato, in val'i m odelli, col materiale da campo.
Esso venne ap p c·o\·ato 1.111che dal g e n e 1·ale medico Porl, il qual e lo l'i ti ene specialmente ne cessari o per il traspoz·to dei rrallurali el i tal genere in montuol"i.
L 'autor e infine consigl ia di in segnat'fle t' uso ai po rta ferili, esso un m ezzo per· istruir li sul m odo di p •·es!at•e socco r so in questa specied'infortunio. P. L.

474 RIVISTA DI TECNICA E MEDICO MI LITARE
RIVISTA DI BATIERIOLOGIA

CH. N tcOLLE - M:o4Uloasloue del metodo di Gram oou la •o•tttustoue 41 una •oluztoue bromo- bromurata alla •oluzto,ue lo4o-lo4urata ordinaria . - (Bullecin de biologie, marzo 1903).
La soluzione bromo·bt·omurata offre gli stessì vantag-gi della classica soluzione di Gram: colora gli stessi batterii, lascia scolorati g li stessi agenti micro bici. Da l punto di vista pratico n on vi è alcun ad impi e garla, anzi talora i va po ri di bromo disturbano l'operatore, ma teo!'icamente et·a in· tercssante mostra re la grande analogia fra bromo ed iodio. La soluzione è la. s e guente:
B r omo
Bromut•o di potassio .
Acf(ua distillata. . .
1 gt•ammo
3 grammi
100 cent. cubi
Si versa il b r omo in un bicchiere, vi si a gg iunge il bl'omuro sciolto in un po' d'acqua; effettuata la soluzione, vi si aggiunge lentamente il r esto dell"acq u a, conset vando il tutto in bo tti g lia et•meticamen te ch i usa.
Uopo coloralo il pr•eparalo con violetto di genzia na a ni linato o feni cato, v i si versa sopra de lla soluzio ne bt·omo-bromurata. Decolorazi o ne dopo disidr·atazion e con l'alcool asso luto, olio d'anilina od essenza di g arofani. G. B.
STEf"ANELLI. - Coutdbuto allo •tudlo dell'agglutluazloue 4e141ploooooodl Friiuokel . -(Rio. c r itica d i C l in. m ecl., 1903, n. 3 e 4).
I n questo lavoro, e s eguilo o eli" is tituto per lo studio u c lle mal infe llive in B e rna de l prof. Tavel, l" t1uto re .si occ upa di una ques ti o ne mo lto im po t·tanl e !;ia dal Ialo sc te nlifìco sia dal lnlo della pratica.
L'agg lutinazio ne d el diplococco capsu lato lan ceo lato pet' me zzo del siet·o di polmo nitici o di animali infetta ti !' pe rim e ntalmenle , o meglio, immunizzati, c un nolo già da div e t s i anni. Ma l' appli cabilita di qu es to mezzo diagnostico alla pratica giorna lie r a non 0 Ancora cos i s e mpli c e come ' Ju e lla della s ieroreazione de l Wida l pe l tifo. Le diffi col t.a che si inco nlt·ano s ono piuttos to gravi, quale ad ese mpi•J la de li cat e zza d e l flerme, il quale no n può e sset e conse rvalo a lung o ne i comuni mezzi di cultura; infalli, come r on s ig liano Besao ço n e Griffon, il miglior mo do di cons er·vat•lo è ne l san g ue di coni g lio defibrinato, e l' av e t• sempre a di s pos izione del sangur di coni g lio comp lica già note volmente la cosa.
Ma a parte queste con dizioni spec ia li di co.:;e, vi é un allr o fatto che r e nde difficili tali rice r che; non tutti i campioni d i diplococco rea g is cono n e llo stesso modo s otLo l' azione di un sie t·o specifico L'auto re ha riv olto appunto a ciò la sua allemdone e lavorando s u di e ci campioui di diplo c occo, ha po tuto costatare che il siero di animal i immunizzati, s e agg lutina lutti i campioni quando é puro, non li agg l utina piu lutti quando é d iluilo anche nella debole proporzi o ne di una par te su due di brodo. Ecc o dunqu e una grande difflcolt.a pe r la
47&
pratica: trovare un campione d i diplococco ch e sia bene agglutinabile dai sieri spec ifi ci.
T uli differ enze tra l'uno e l ' allr·o campi o ne di1 oende dalla virulenza ? L'au· tor e t'ispon de oli uo, po i ch f. ha vi s t o che di f'ronte ad un medesimo siero dimo· s trur·ono il 1110!'\!' imo p ot er·e di Sf{fr l utinabi l i ta campion i dotali c.Ji viruleuz a mollo diver HL P erciò le ca use di questa ,·al'iabilità d ebbono esser·e molto l'autore cr ede d i potere atll'i!Ju it·e una g r·ande impo rtanza alla cap su la e a tu tte le c ond izi oni d i , ita del ger·me che possono modifica r e l o s vilupp o dPIIa cap· sula stesso . A ci ò ammettere é con do tto anche da una seconda s erte di espe· rienz c, i n cui h H s tudiato l ' azione del si ero antidifterico, antipestoso, antitetanico, anlltifoso e anlistr ep t ococ ci co sui s uo i dieci diplococchi Ha vis to cosi che il solo s ie r o an tipcstoso agi sce s u lutti i campioni di diplococco, e l'autore al· triuui sce questa tra il si er o aulidipl ococc ico e l' antipestoso al fatto c he &u che il bacillo pe stoso ha la capsula. Del r esto sono ormai varie le ri· cerche l e quali ad accor dare unA g t•and e imp0 rtanza alla pa rt e pet·if c rica dei g-e rmi (capsula, c iglia, ecc ) nel fen o meno dell'agglulinazi one
Per la prati c a intan to r·es ta se mpre più ditn ostr ato cile l 'af!'glutin azione del diplococc(, non é ancora un m ezzo d iagnoslico sicuro e alla po rtata di lulli ; e m c ntr·e in ttlcuue r::li ni clte si fa ques ta pt·ova, s i può dire. in m odo co rrente, in,·ece non è aneora faci le esegui t•la ospeda li. e peggio an co ra dal medico p r otico G. B. M. B.
R I VIS T A D'IGIEN E
I. STERNRERG - Ricerch e • p e rlme ntalt •ull'lofluen.za del baclW 41 Jtoch morti.- ( Cu rcralbl atl .fii r a./lge mein e Pathoton; e und patho loais che A nato· mie , n ovembr·e 1002).
L 'autore cosi ria ssume l e sue ri cPrc!te:
l bacdli di K oclt mor·Li agiscono come i bacilli viventi, ma la l o ro a zione é meno en er g i ca. ln i ellali in g ronde quantità originan o dell e tub e r colosi tipi che; m entre in pi ccola quantità da nno luogo a cachcsia mor·· tale a scad enza p t ù o meno lun g-a.
l bacilli mot·Li si coloran o molto lentamente; la loro influenza p alogena é dovuta ad una sos taow apparten ente al corpo d ei bac illi. sOl' LRnza c!t e t o llera m olto bene Anche l a "'ler·iliz.zazione prolungata col vap ore, mentre l'estrazio ne me· dian te alcoo l, e te r e o cl o roformio, diminui sce il pote r e specifico dei baci lli morti.
Tale patogenia car·atterisli ca, drtfer·cnzia il baci llo di K och da tutti g li altri bacilli si mila ri (pseudo-ba cill i tubercol osi), scalzando l 'o pinione di coloro che l a s tr·etta parentela di questi con quello specifico del Koch. G. B.
O. F. STRJCKER. - Il problema della tubercoloal o egU e•ercitl . - (Comu· a l Xl V co n g resso internazionale dt med i c ina, Madrid , ap r·ile 1903).

Co nclu sioni. - t • Nell'ese r c ito germani co la mortalita per tub er c olosi va c o ntinuamente diminuendo dal 18-i6 al 1900.
2° Anche la m o r·bosilà per tubercolo si negli ultimi 30 anni diminuisce sem; ibilmente nel d ello eser cito
47fì RIVIS TA D 1 1GlEXE
3• Il più gran nume l'o dei casi di luber·co losi si manifesta negli uomini, i quali al tempo dell'arru o lamento, erano atfdli da tubercolosi latente.
4• Il decreto rninisterial e , e manato r ece nteme nte, che limita e dimirruisce il nume1·o degli inscritli ù i leva da visilars i in ciasc una sedu ta ai consig li di leva. sa r à un fattore essenziale per la p rofilassi della tuber colos i ne ll'e s ercito.

5° Gli uomini con disposizioni e r edita ri e , o spossati tln m al attie preg r Psse, o infine che destano per la loro costitu <!:io ne qualche sospetto, devono essere invigila ti continuamente da gl i ufficiali m ed ici.
6° Il miglior·ame nto ùell'igiene dell A abitazi(lni, il miglioramento"dell'ig iene della nutrizione dell'et.à infantile sono la piu s icura profilass i d e lla tubercolosi per l'adolescenza.
7• Pe r la diagnosi precoce di una tub e r co los i latente o cco r•rerà fare rna g · giore u so de ll'in iezione di tube rco lina.
8• Minimo è il pe ri colo nell'escrç:ito . di un'infezione tubercolo.-:a dir e lla.
g• La cura dei tub erco ll)s i gel'manico è conforme ai p r incipi generalmente ammes s i nella patol og ia mod e rna; in la terapia è ig ienico-dieletica.
10• Infine no t.at·e che le grandi leg-gt sociali in vigore ne lrimpe t·o germanico, cioè la legge dell'assicurAzione eontro le malatti e, la legg-e analoga con tro l'invalidità acquis ita o pe r m a lattia o pe r età, infi n e la legge d e lla assic ura zione contro gli infvrLuni, co n tl'ibuiranno col te mpo ad eleva re In costituzione fisica della po po lazione. pe r anche quella de lle reclute
Attualmente l'impero germanico pe r la cla sse operaia in conse
L'A. tJ·o vò che , appli c andol o sulla pe lle bene nul e in luogo c aldo, si aveva la morte di queste primi dist urbi g ia do po 3 o 4 ore.
ra s a di coni g li e c avie tei n 2\-36 ore, cominciand o i L. F.
CONFERENlE DEG LI MILITARI
SOMMA RIO DEGLI ARGOMENTI TRA'ITATI
(
D .\1 P ROCESS I Vf:RI"IA LI PERVEN UTI ALL'IS P E TTORATO 01 SANiril. M ILITAR E DAL 19 MAG G IO AL 16 GIUGNO).
ALES SANDRIA (ma ggio) . - M e m o ri e l ette : tenente colonne llo m e dico Boa sto
Eu ge nio: So pra un caso d i c o mm ozione d e l la.birinto.
BARI (a p r ile). - Comrt nicazio n i : so t to t e n e nte me·l ico di c o m plemento PA L -
MmRr Ca rmin e : Sulla diazol'eaz ione M i fo l b b r icilanti.
BRESC IA (mA gg- io ) - Com unica.;;i oni: so tto t e n c n t e medi c o d i co m p l e m e uto
C t-11001 Vit to re : Su lla t e rapia 'lei g lauco ma.
478 CONFERENZE SOIENTIFICRE DEGLI OS PEDALI MILI'l'ARI
.·. ·:
:f'IRENZE (aprile). - Comunica;ioni: capitano medico PEREGO V1tlorio: Sulla cura conse r vativa e d e molitiva dei denti ne' militari, co n presentazione di una ca sse tta odontoialrica.
lo. (maggio). - Comunica;ioni: ten e nte med ico MARRt Ezio: Sop1·a un ca s o di pioemia otitica.
'LIVORNO (maggio). - Comu nic<U ion i : so ltotenenle medico MALTESE Giuseppe: Se nlla formazione dell ' urea c oncorra o no l'acido uri co .
MESS IN A (aprile) Memorie lette: sotlotenente m e dic o d i comolemento FERRERO Arturo : Contributo all o s tudio del la pleurite essenziale sililitica
MILA N O (maggio). - ComuniclUioni: lenente m edico CASTO LDI Ettore: Sulle a pplicaz ioni cliniche dal siero aolis tt·eplococcico nella ri s ipola .
'NOVARA (magg io) - Memorie le tte : te nente m ed ico VtROtLI Lui g i: U n caso di flemmone profondo ùell'orbita.
PADOVA (aprile). -Comunicazioni: m agg iore m edico VAI..LTCELLI Antonio: . Sopr a un caso d i derrnatopolimiosile.
SA LER N O - Memor ie le tte: sottotenente medico di co mpleme n to AP rCELLA S e rafln o : Sulle manifestazion i tardive della s ifilide

TOR I NO (maggio) - M emorie le tte : capitano m e dico CARTA MA NTIGLIA F ilippo: C e ntocinquanta narcosi col clo ru ro di e tile.
MISCELLAN EA
Inchiesta s ull a fatica muscolare professionale. - 11 siguo r A. M. Bloc h (Reo. s ei enJijìque, 6 gi u gno) ha fatto un'm chies ta o ri ginale c nello s tesso tem po molto utile, do man dando a una g z·an q uan tita di indtvidui dati ad esercizi muscola r i faticosi, pi'Ofessionali o s portivi, in fo r mazi o ni s ul m odo e sulla loca lila d ove risen tono maggiorme nte la fatica dopo l'ese r ciziQ.
Egli ha interpe llato fornai, fa bb ri, calzolai, cavato ri, cavalieri, a rtiglieri, fu nta ccini, pianisti, scbe rmitori, rem atu ri , ecc.
Il risultato più im po r tante e più prati co della sua inchiesta, é che ris ulla che la maggio re stanchezza o do lore i· accusata, rw i singoli esercizii, n on ne i mus coli che devo n o alternare continuamente con trazi oni e rilasciamen ti; ma in q•Jelli che devo no riman e r e pe1·ma neutementc co ntralti.
Cos't il fornaio cl1e ba im pas ta to p e r tu lla la n otte s i lame nta di òtanchtl zza alle gambe e no n al le bracciu. Il pian il'la sente ma f:gio r s tan c hezza a l do r so e al pella che non alle mani; il cavaliere o.i muscoli a ddutlOI'i de ll e coscie, il remato rP. ai pol pacci e al co llo del piede.
Da q ueste indagini ri s ull a la pratica c he !>a reb be n ccessal'io es er· cilare di più i g ruppi m usco la ri au sil iari. e inler mmper e , spesso, Ju ranle l'esecizio stesso, la pe rm anenza de lle co ntra zion i, tant o se n u sil iarie, co m e se conco!·renti direttamente a l lavoro; fa r far e, come in Ger mania, derrli eserc izi di scioglime nto del collo e del dorso ai fanta cci ni, presc ri ve r e una g innastica respirato ria pe r i cavalie ri, in te rrompe re te lun ghe marce a cavallo con picmarce, o corse, a piedi; ed in genere, ne ll' Ìll"l'gnanaen lo della g innashca, ftJre un po' piu la r ga parte ai movime nti dei mus coli lombari do r sa li e centrati. '
) MISCELLANEA 479
Lampada di sicurezza vivente. - H dottor M olil'lch di Praga hu co municalo aii'Acc&demra dt!lle scienze d i Vienna delle interessanti os"ervazioni sopr a un ballrrio l"o:<for·Pscente.
La luci-' eman·1ta dall e colonie d i questo batter io ò !\ lata sufficiente per per· rn etle r·e all'au t ore d i farne delle fotog r afie. Una bottiglia di uno o d u e litri pi eua di un !)l'o lo di cultura di tali balleri per mette la l et tura di un lermom el!·o o dr u n a uno o due metr i di drstanza. Potendosi l P. bo ttiglie t e ner o t> rm eti ea men l e chr use, ques to nuovo di lampada trovcr·ebbe una utile applicazione nelle poh·e riere, n elle m iniere, e in t utti i dove i mezza o r·Jinal'ir di rlluminazroue riescono per·icolosi.
Dentistica militar e. - U n'or•dinanza del della g uerra pru ssiano r ende ohblif!utor·ia la eur a della bocca dei rla a fRda r ;: i a dentisti civili, e n e "tAhi li'-Cl' ;!Il onora r·i.
Concorso all ' Xl premio Riberi di L. 20, 000. - l.n n. A cca dem ia d i medici na dr T 11r·ino conf,• rirà que>:<t o premi o alla oper a prodolla nel quinquen· nio nel cam po delle scienze medicl1e. A pa rilu di m erito saré data lo pr()l'erenzR n la"ori che co nco rTa no a mi glio rar e le condizioni igieniche doli ' l tolio.
l l nvol'i JlO!<l<Ono es:wr e s tampati o m anoscr·illi, in li ngutt italiana, fl'un cese o I Atirtn. Il lern pn ulile pe r· la pr ese ntazio n e !'.Cad e allr lt po m. del 31 diee m hl'e
Il pr euttn è d i L. :!0,000 d eJolla l a di manomorta.
Xl congr esso internazionale di Igiene e demografia - co ngresso s i ter·rà a Hru..;cllt'::< òul 2 nll'l:l del corrente anno . Sono invitate a prend er vi p»rle t utt t• Il' che si inter·es!'aoo alle questioni d' igi ene, di sa lubr ila, dr dt'mogr»fio rli sla t i--t ica biologtca.
Il co ngr·e..;so compr ende due d i ,·isioni: quella d' ! yiene, s uddivisa in -; se'luolla ol r D éltWflra)ì.a I l comi!alo ha pr epara t o un prog•·amma di nuro tet'U"t' f'Jllè'tioni da di;.culersi nelle sedute; e que.,to programma viene drin &!!li aderenti, i rtuali, per m eglio e;;ser pr·epar ali alle di cussi oni, r we\'lono pu r e, prima dell"apertura del dell e r el az•oni .;ornpilnlt• >:u ci a ,:;cu na rtue stion e. di f ran chi 25. del o r dina· t cu·p Prof Ru e F orgeur, 1 L iegi. Sulle ferr·ovie belghe n on e conces>:a alcuna r iduzr one = 11 D1rc tt o r c

41:)() :Ul i'C ELLA:-IE
Dott. F . LAND OLFI, mag gior generale medico.
Il Reca,.t.t.orc
O.• Rr oor..Fo Lrvr, ma:rgrore medi co.
l "l l l , l t \ i
11oma, t !l03- Ti p. E Voghera.









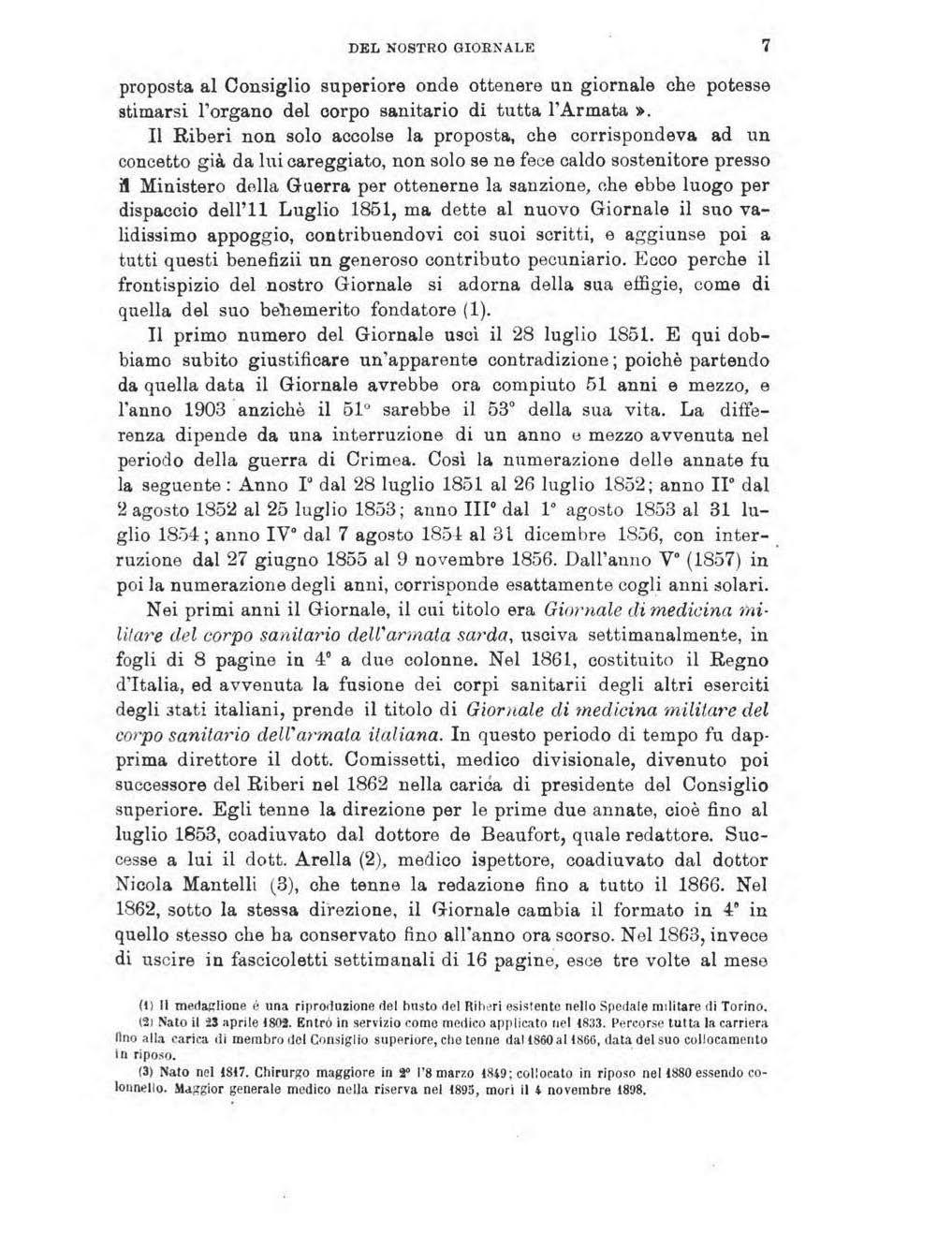

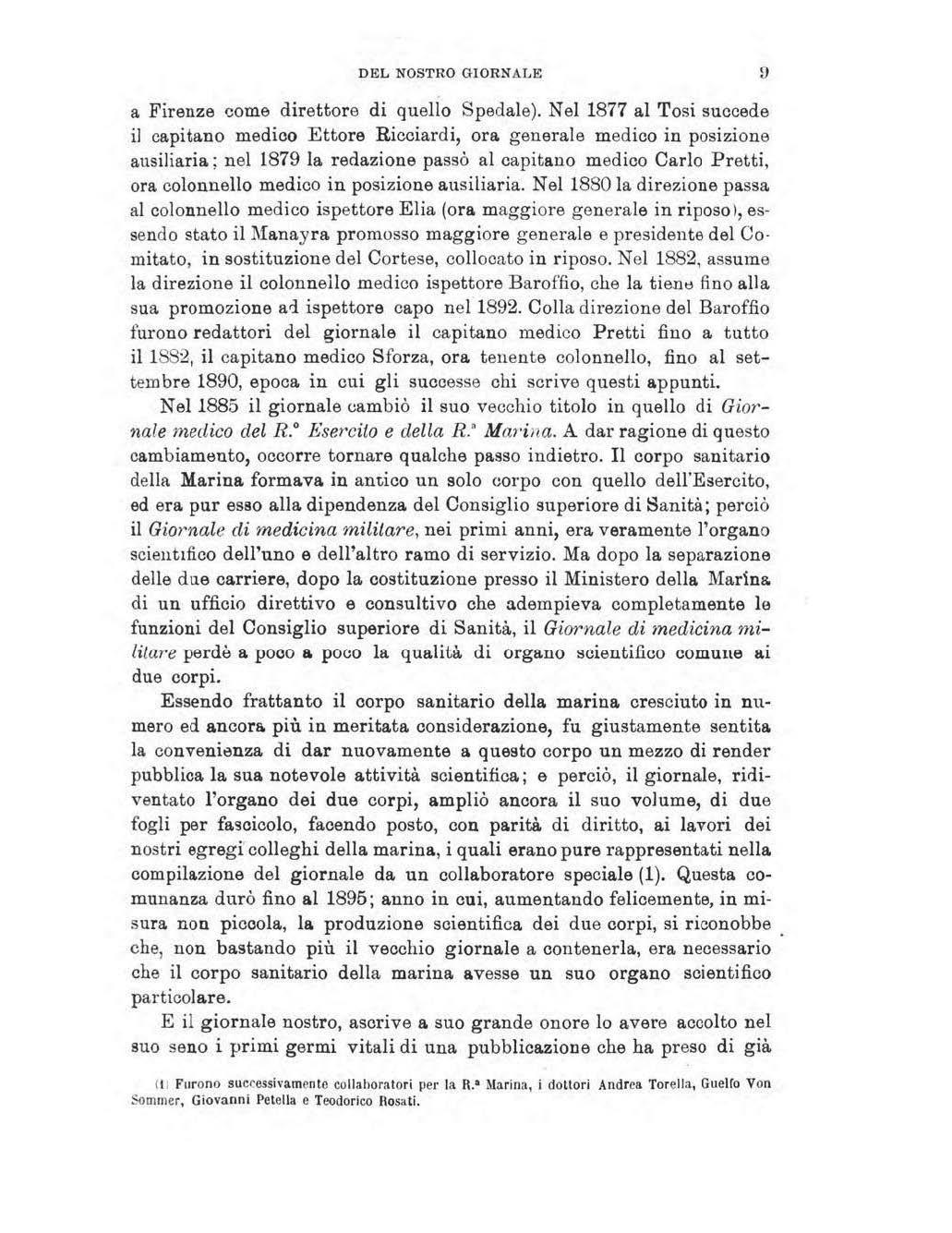





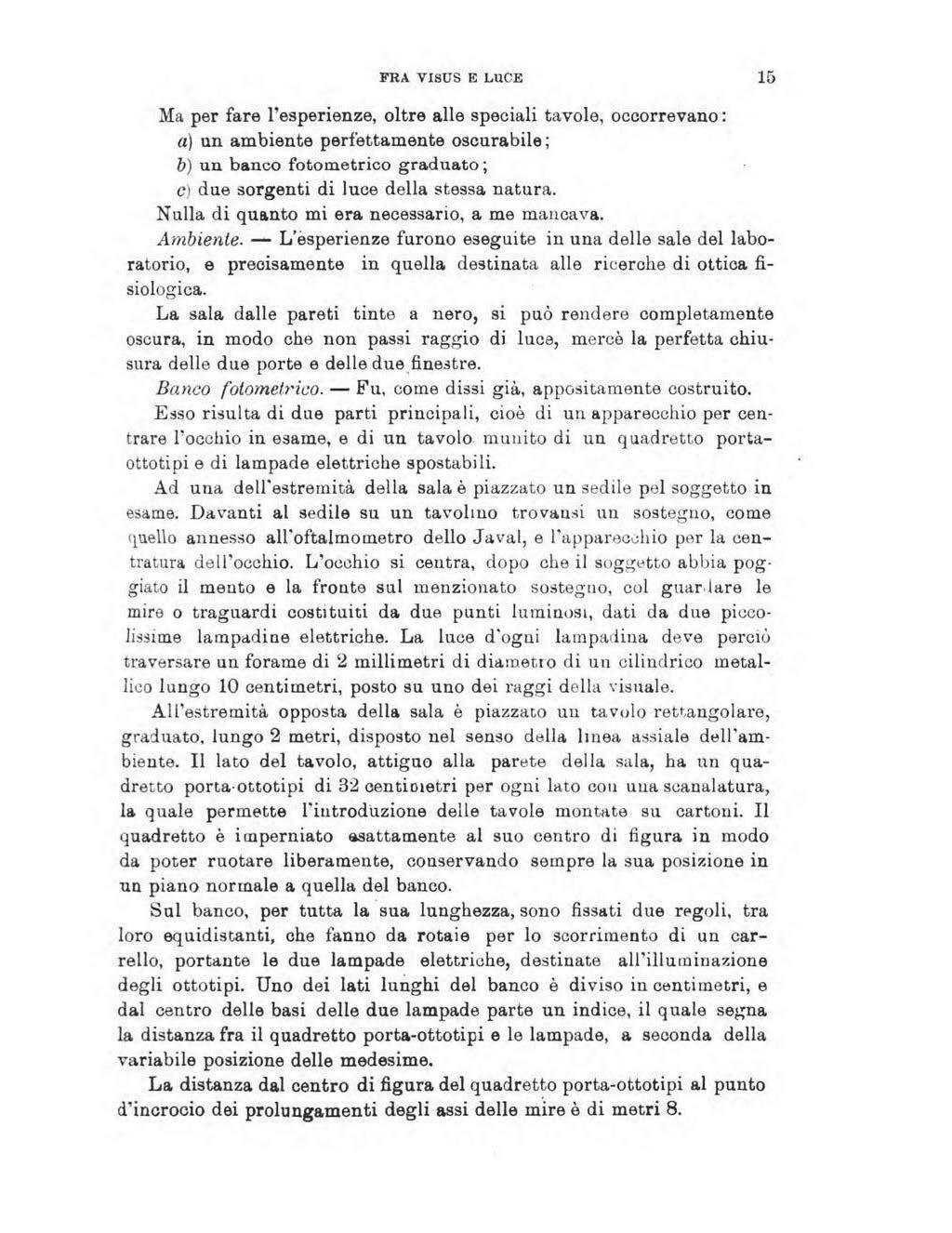
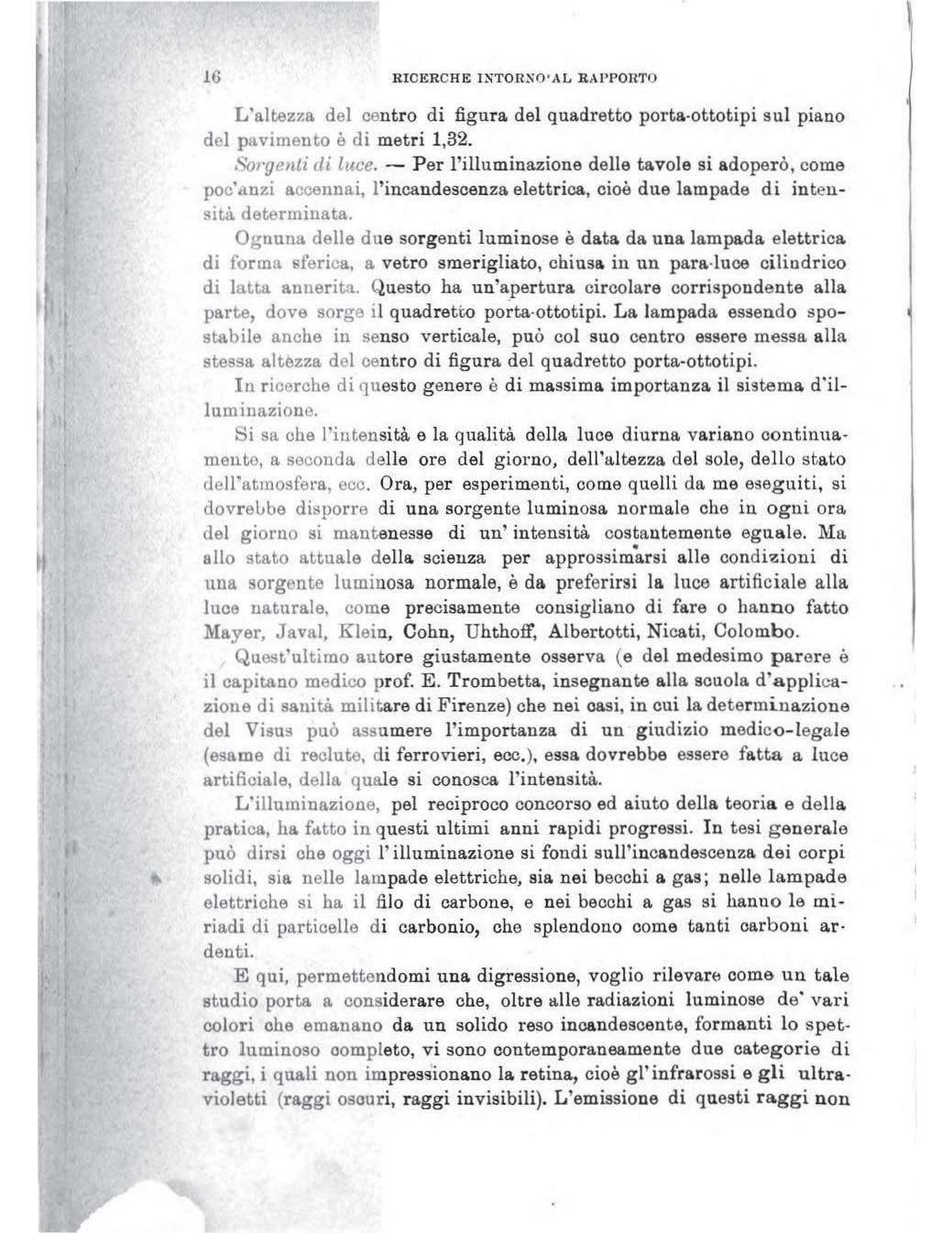

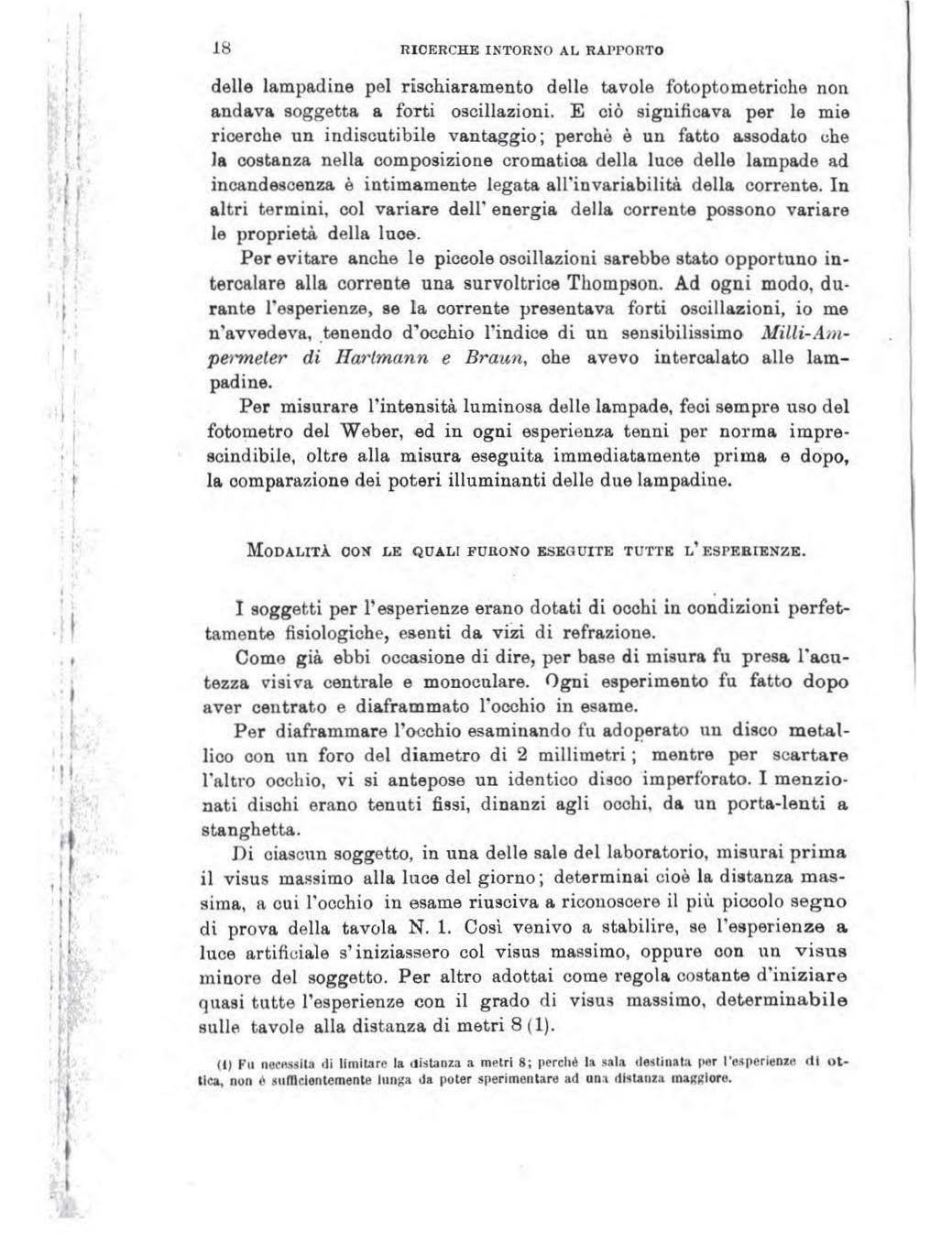

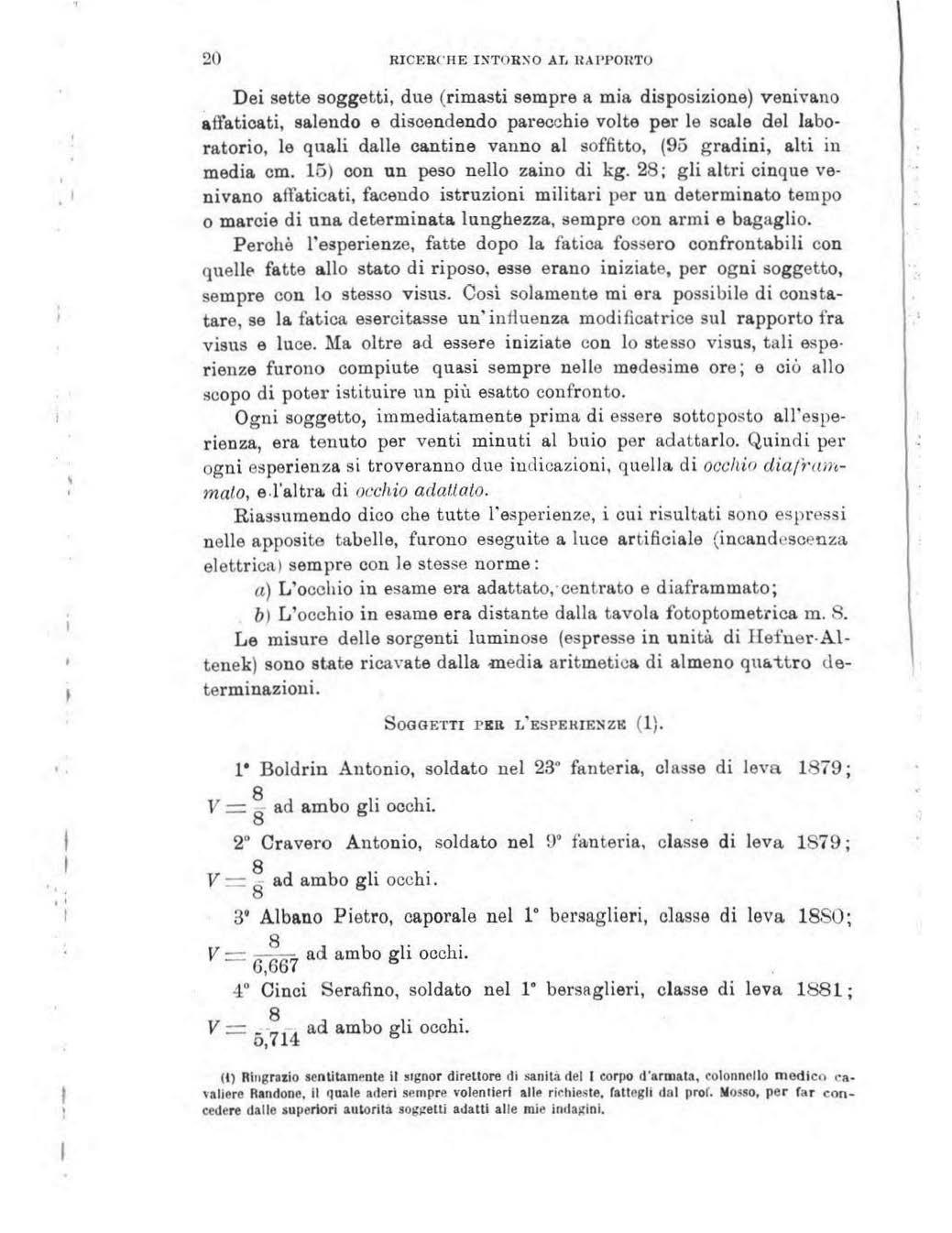









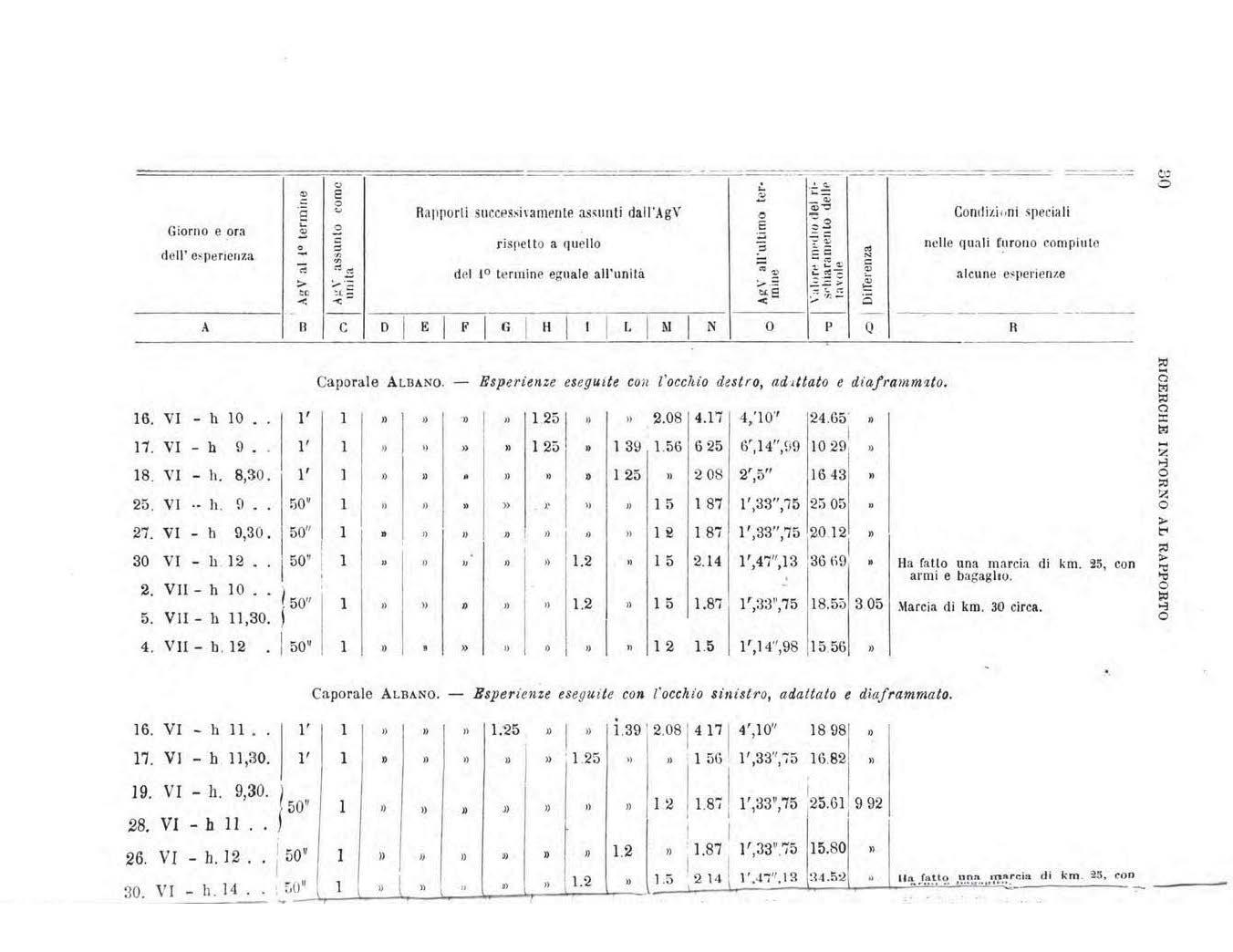

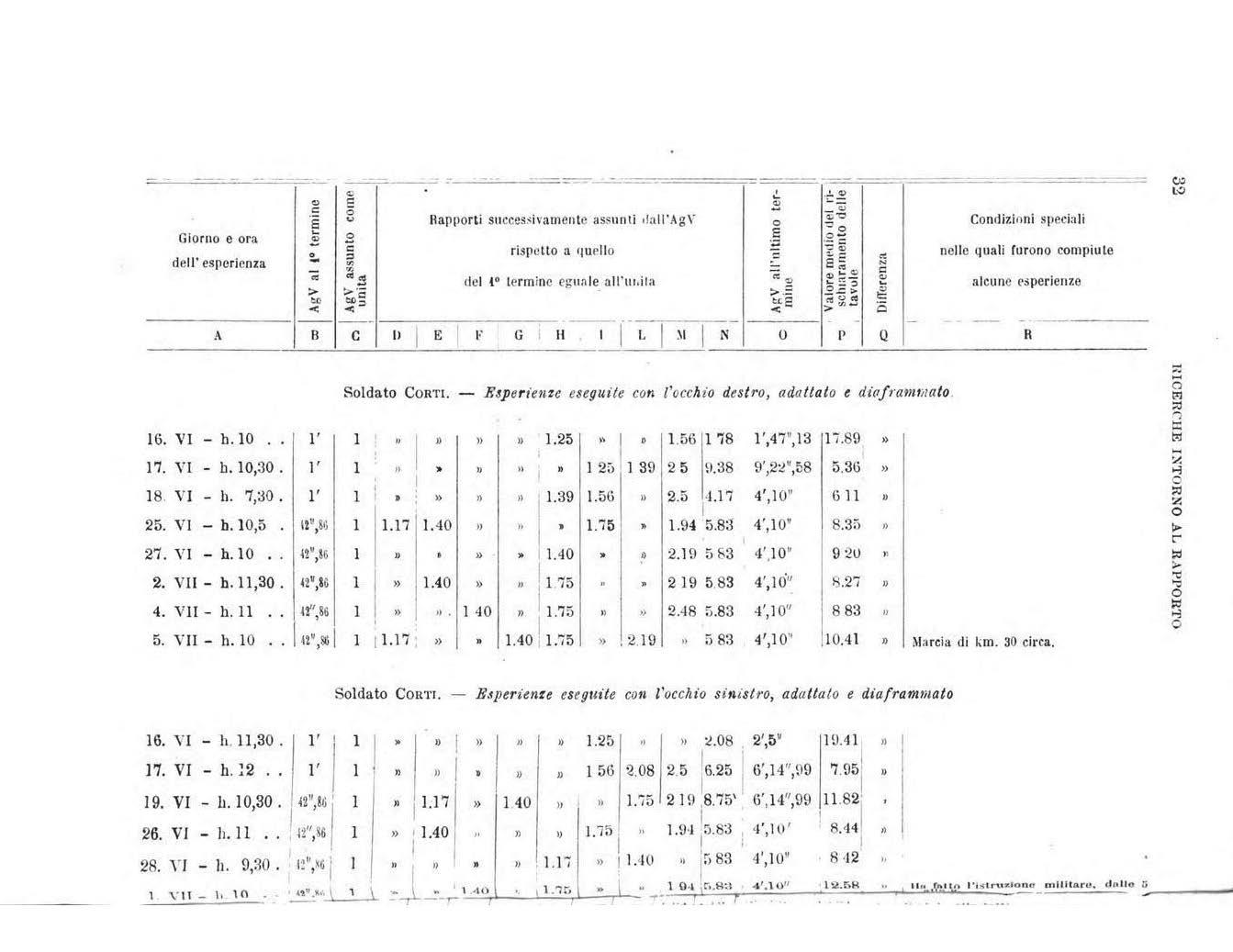

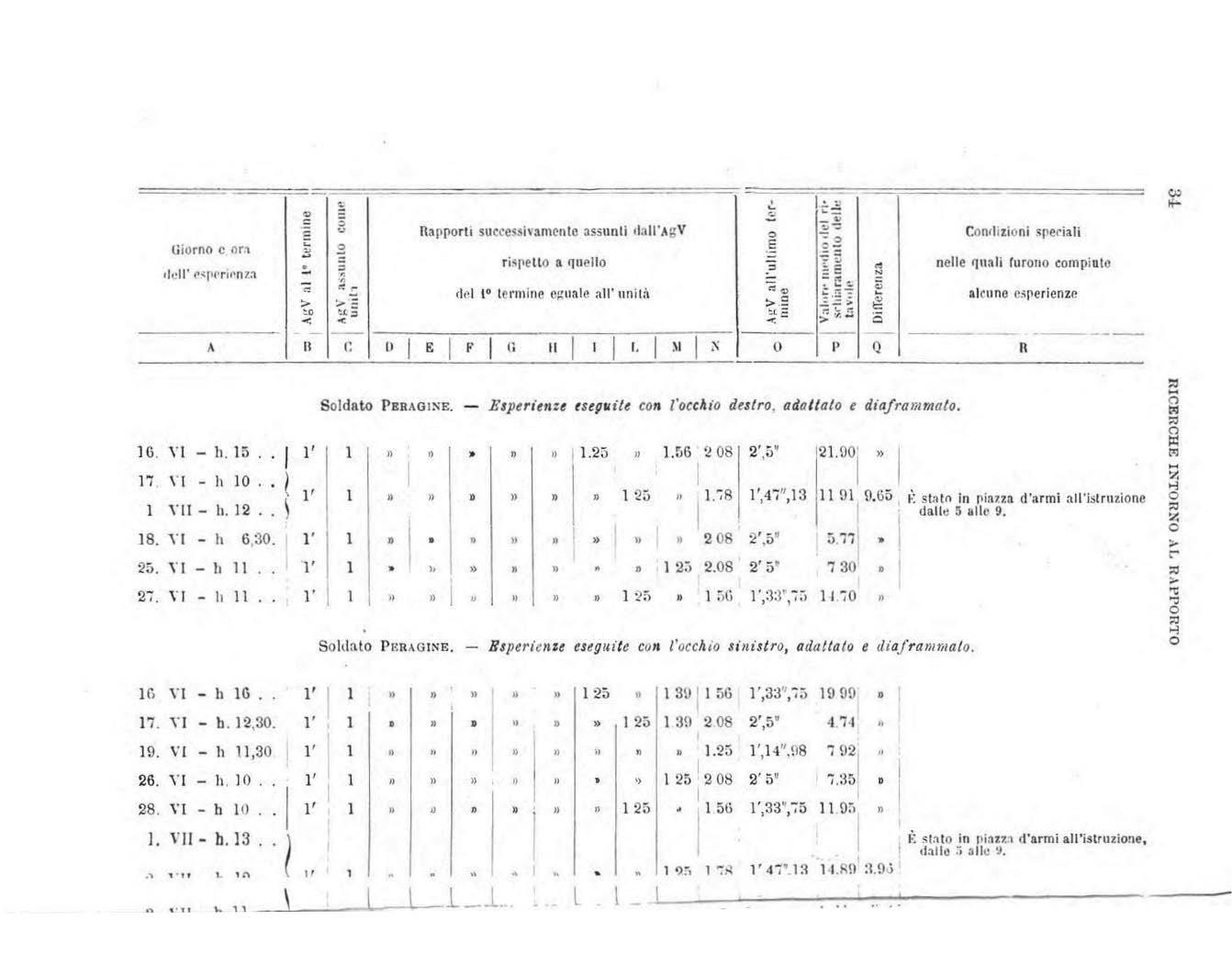

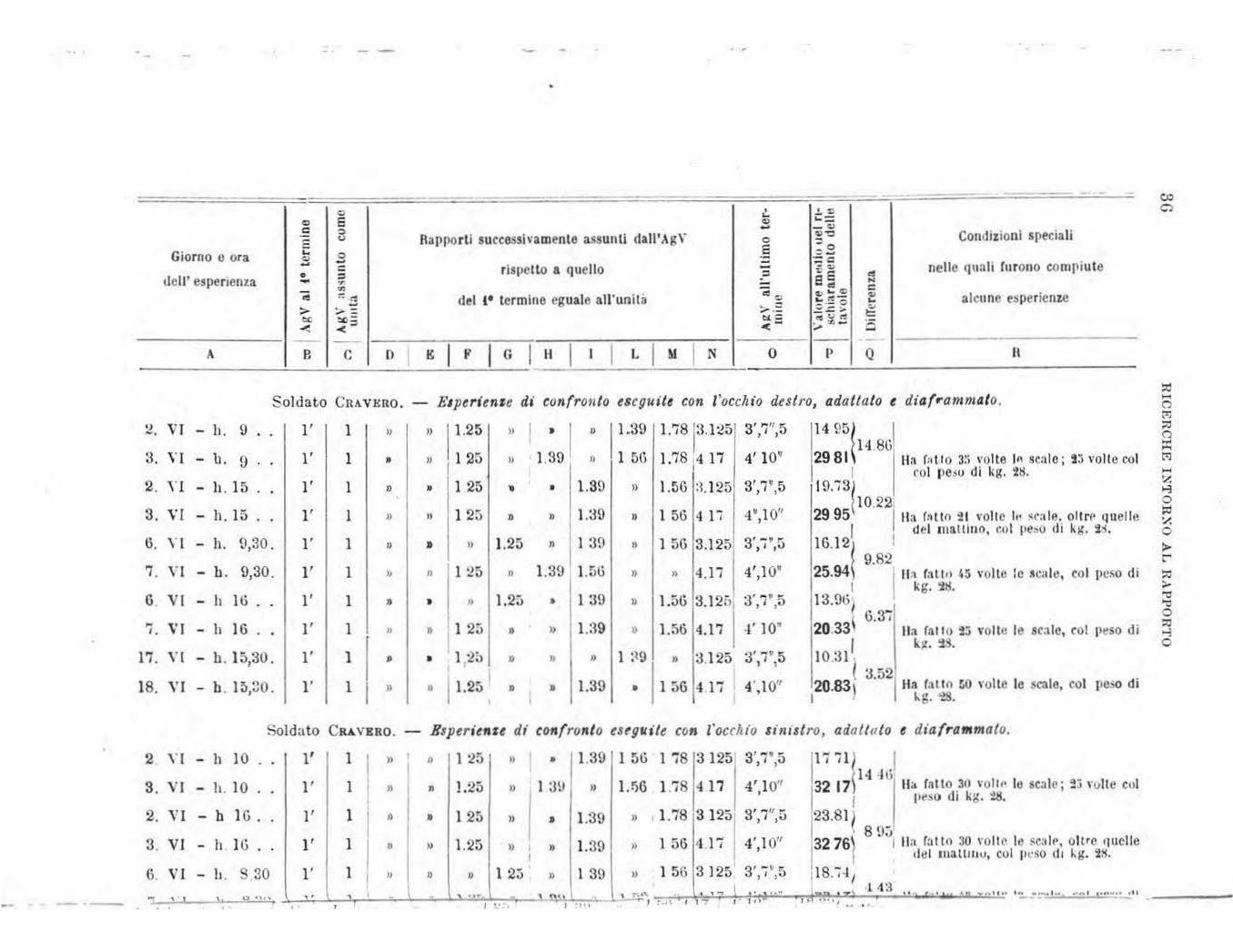




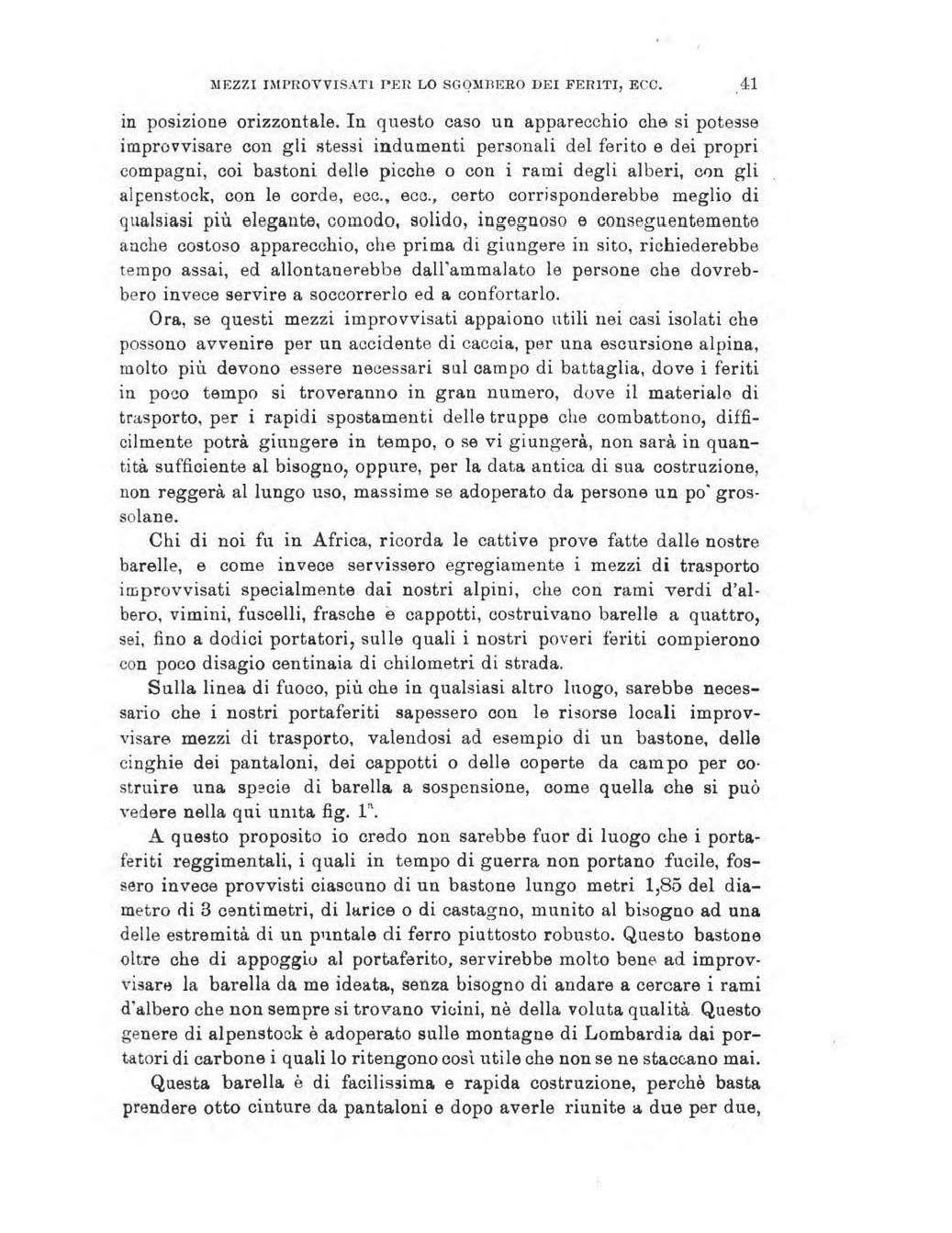









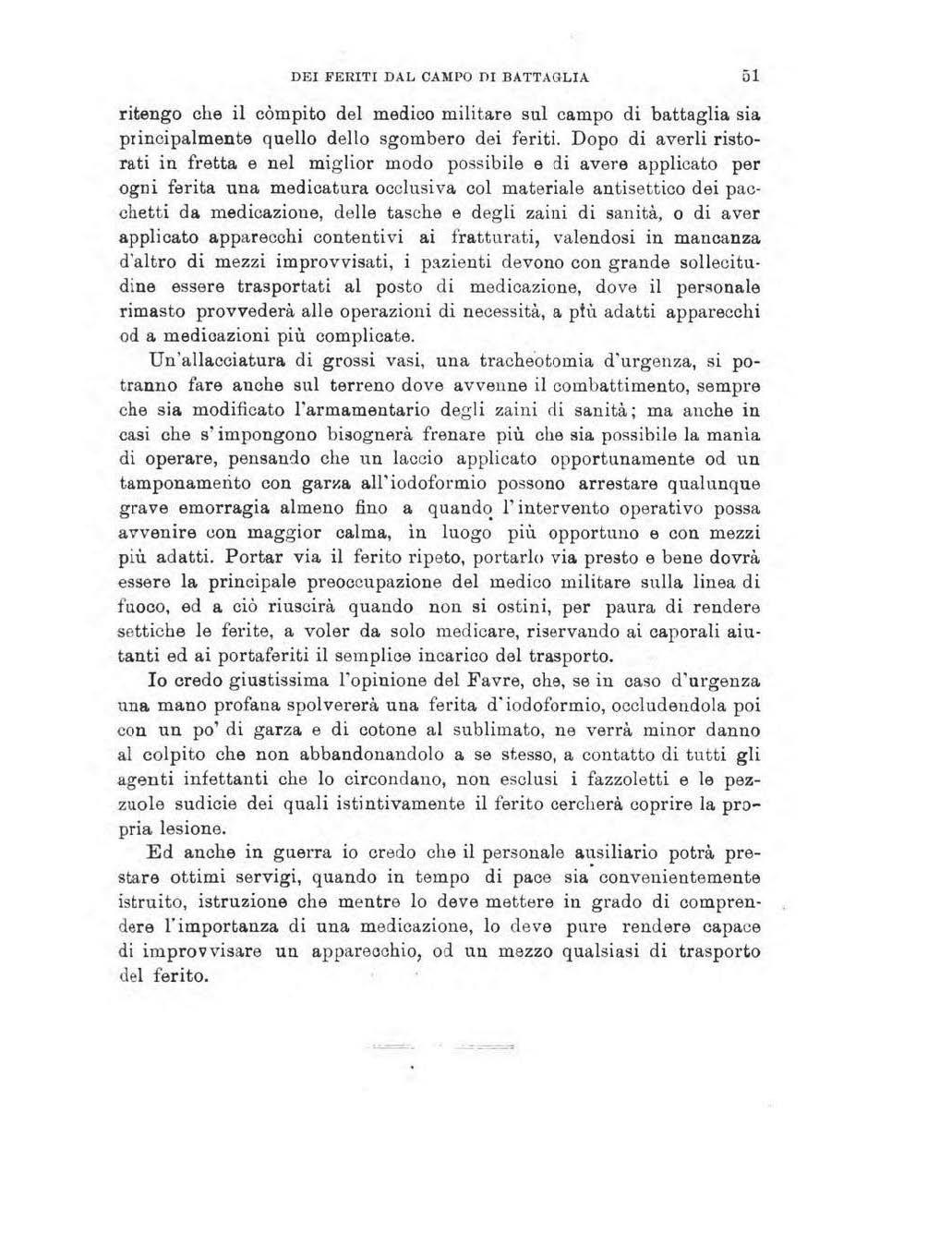
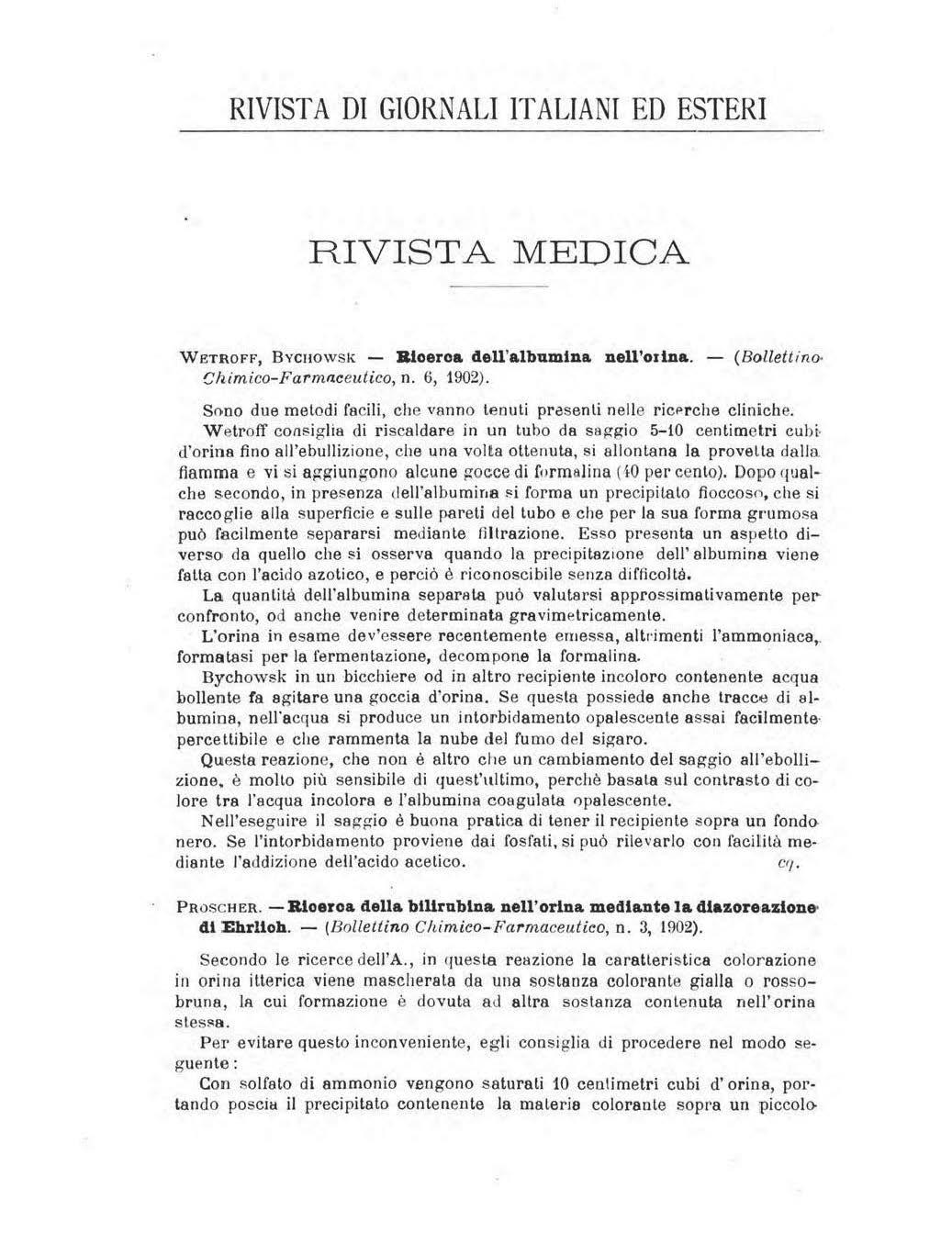



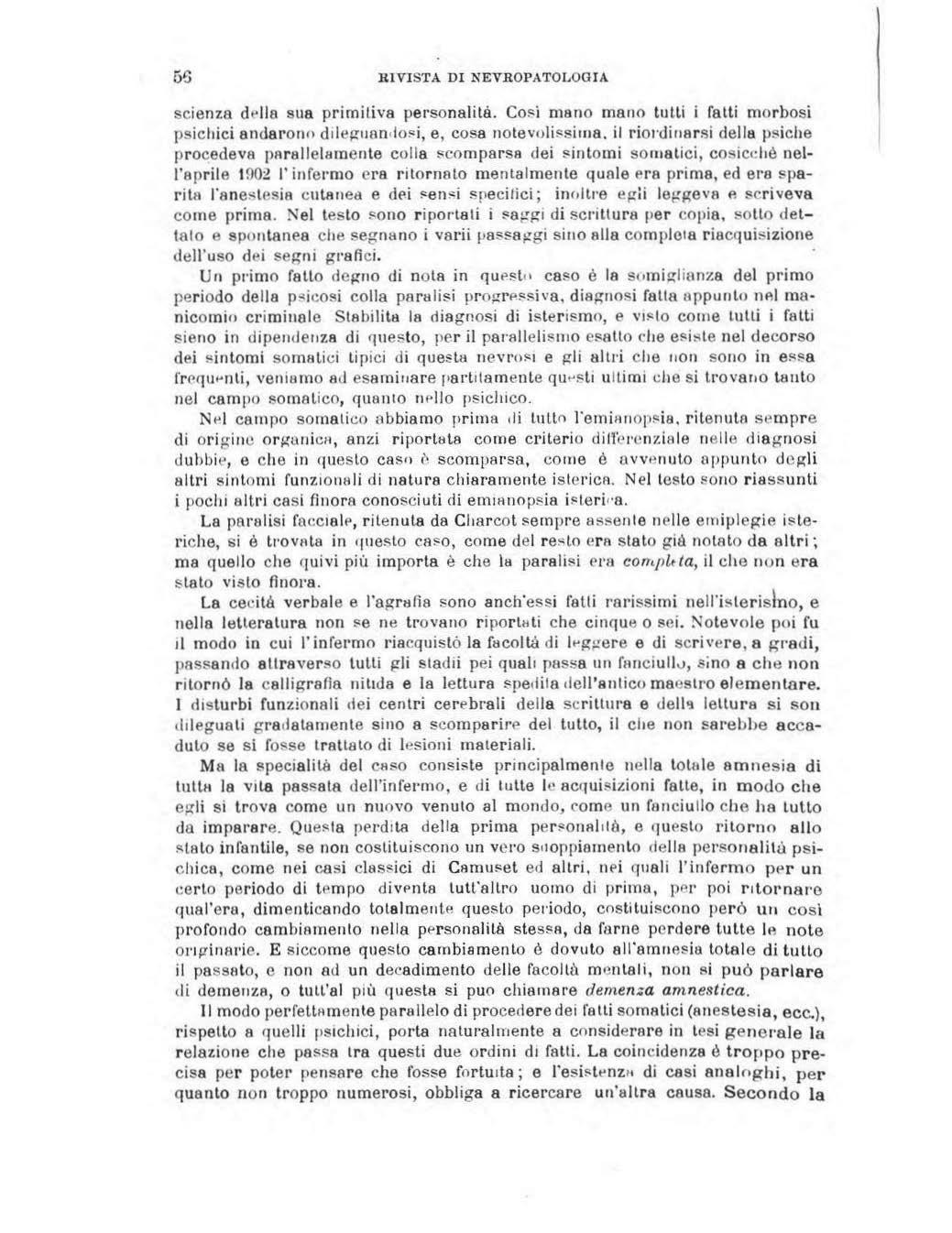
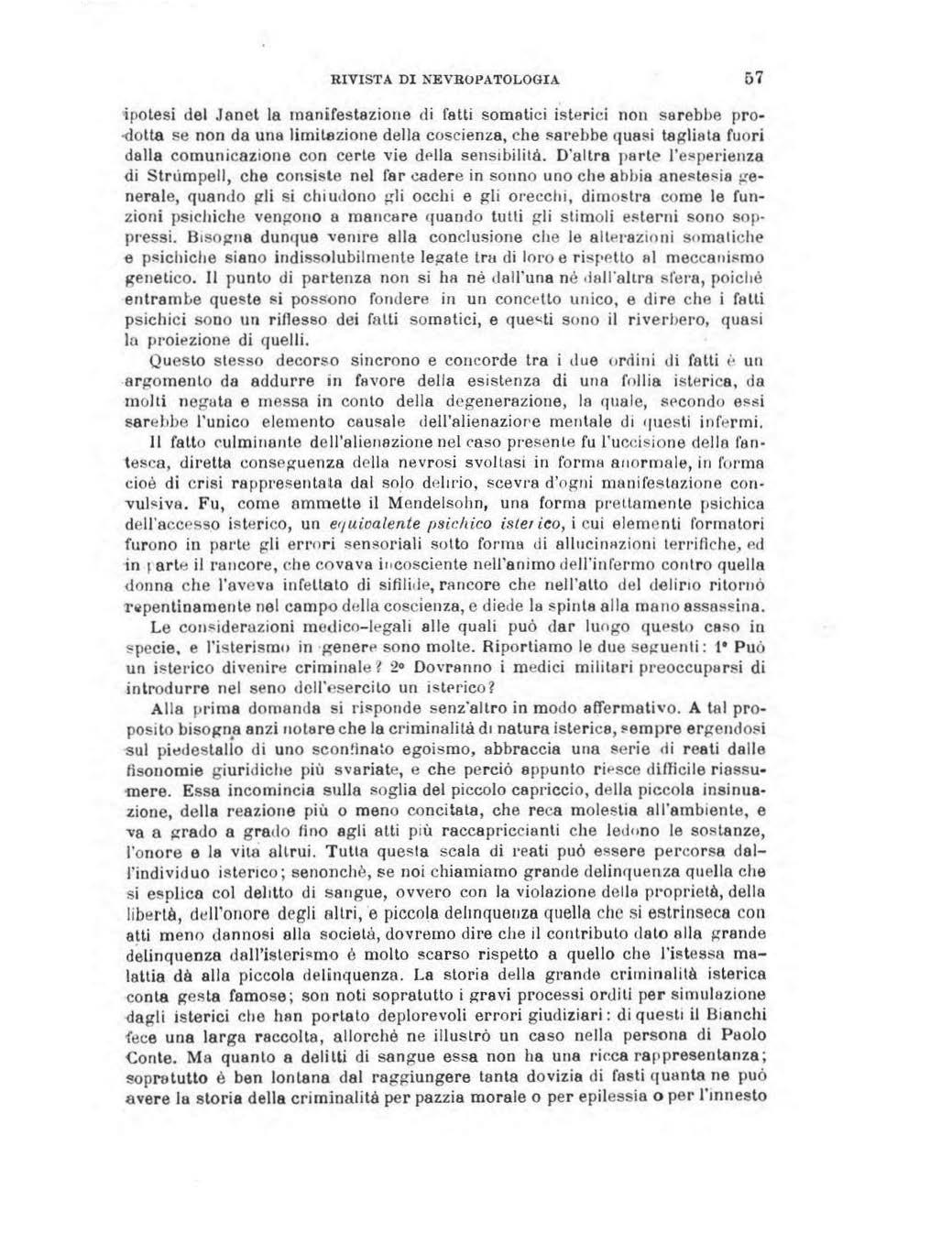







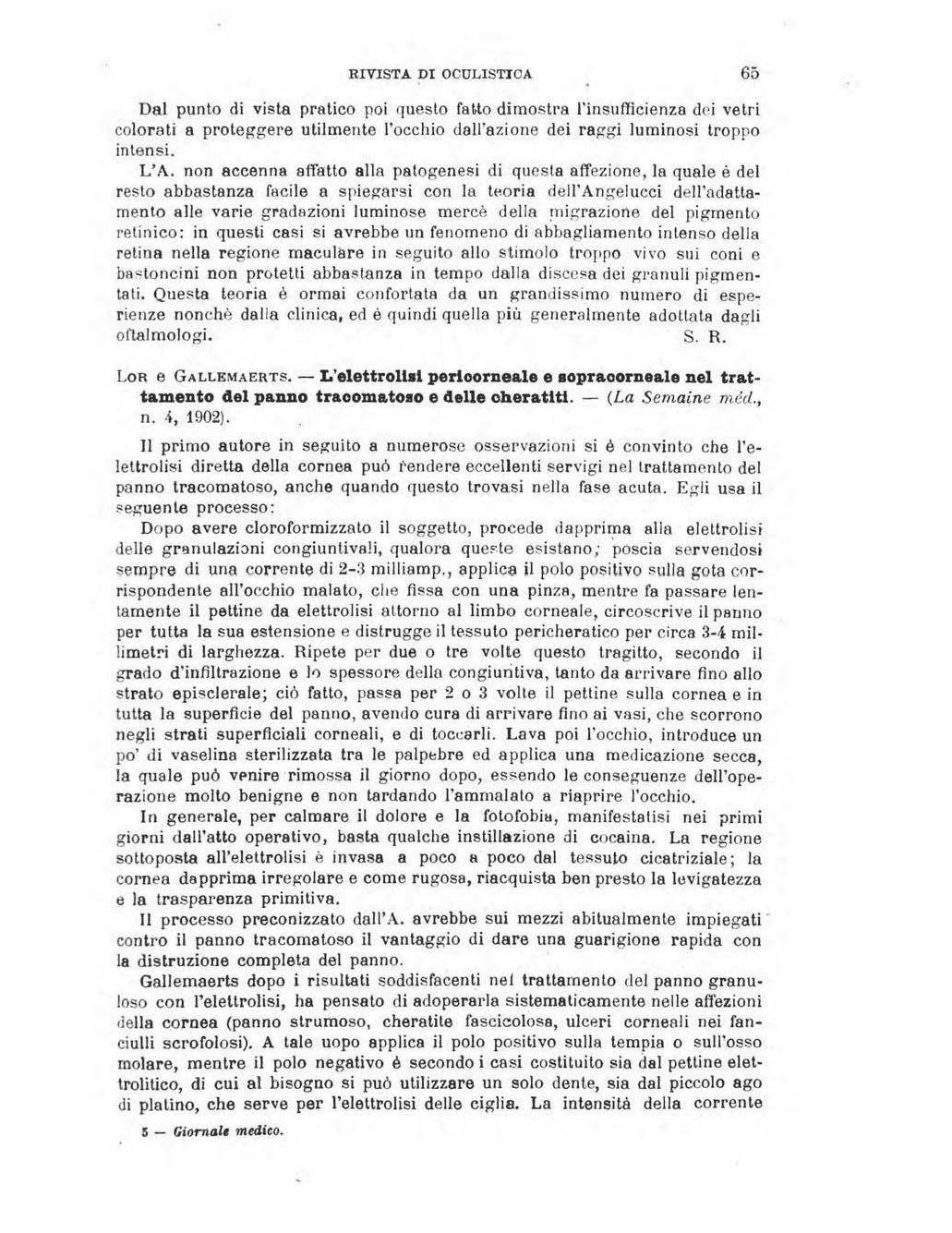



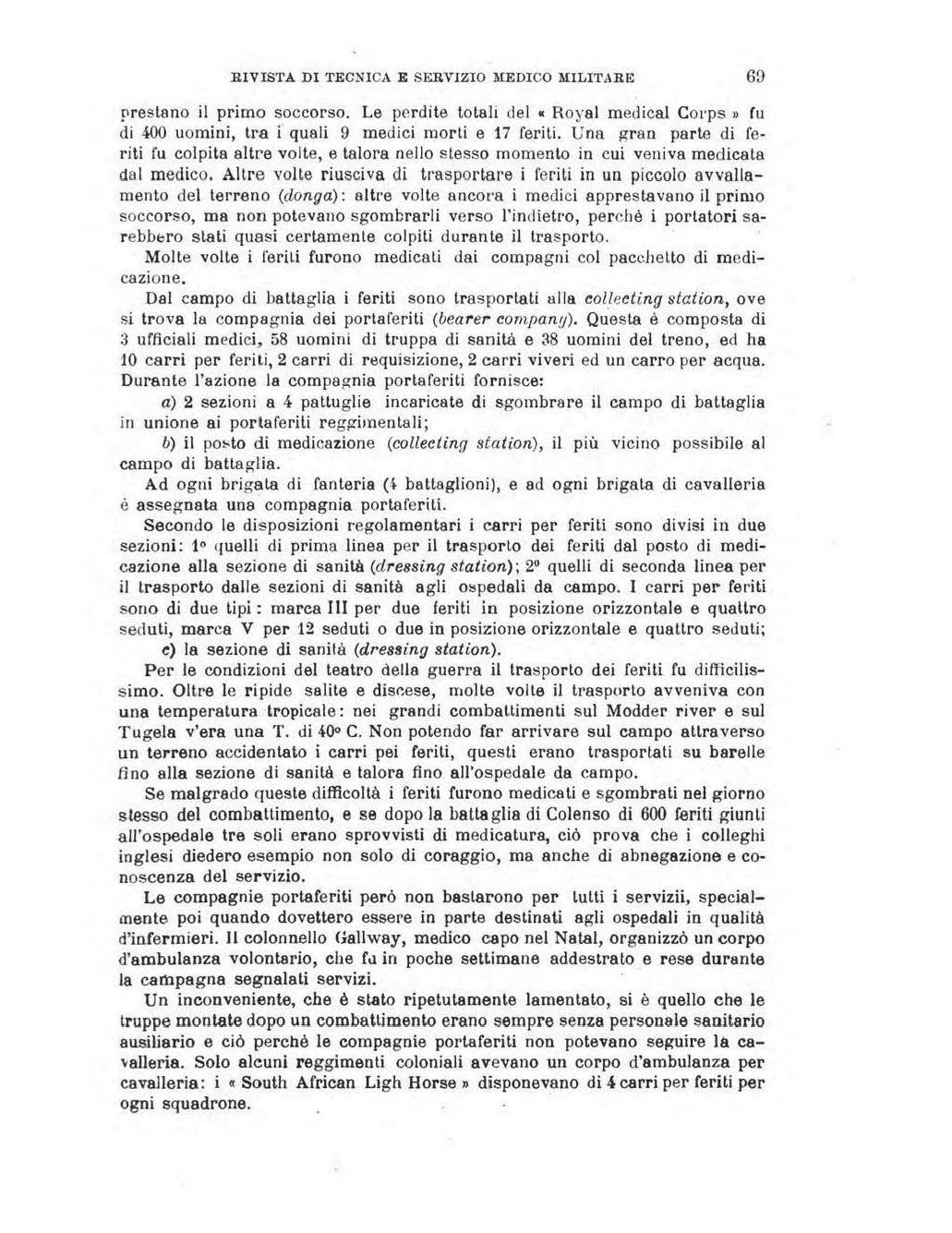



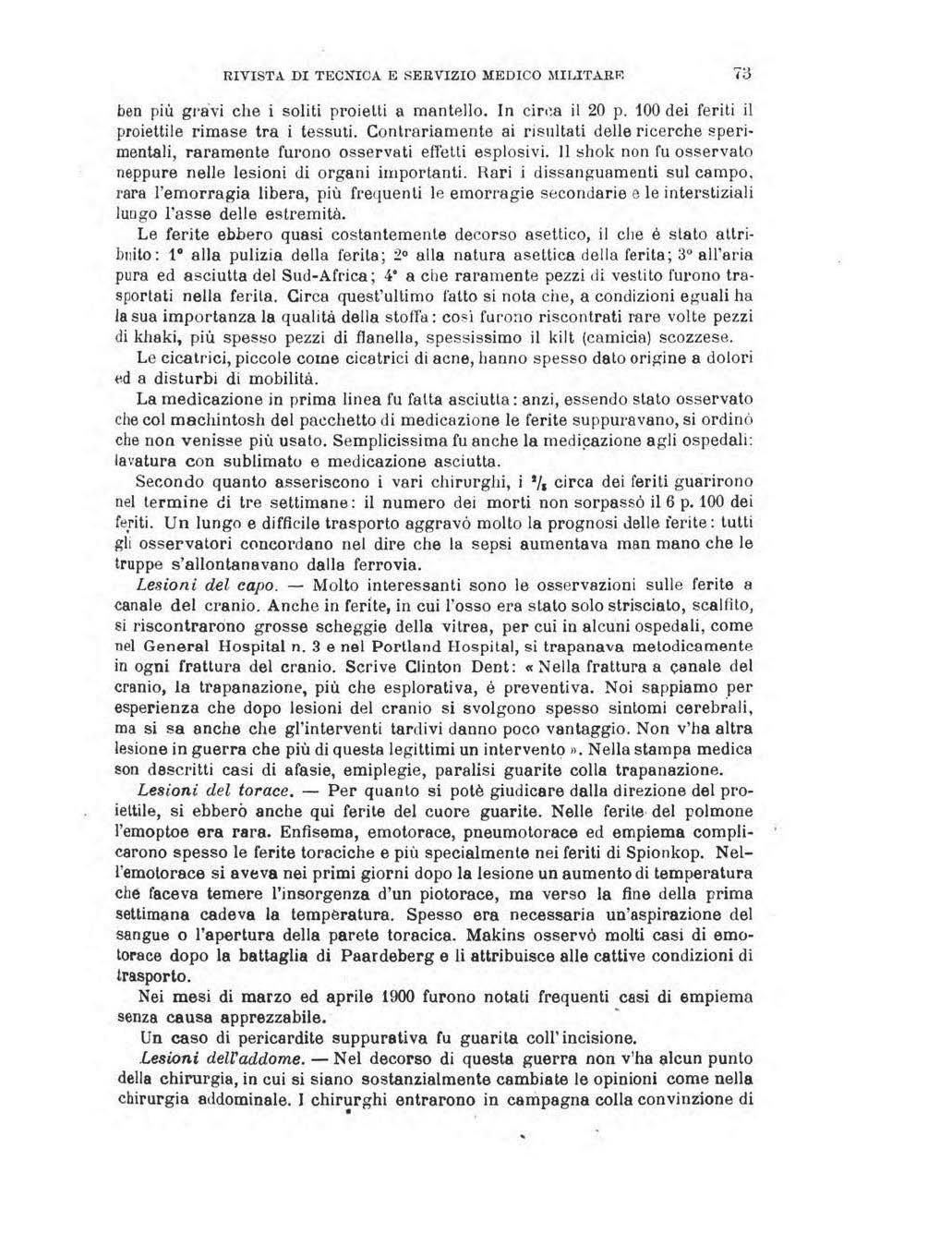
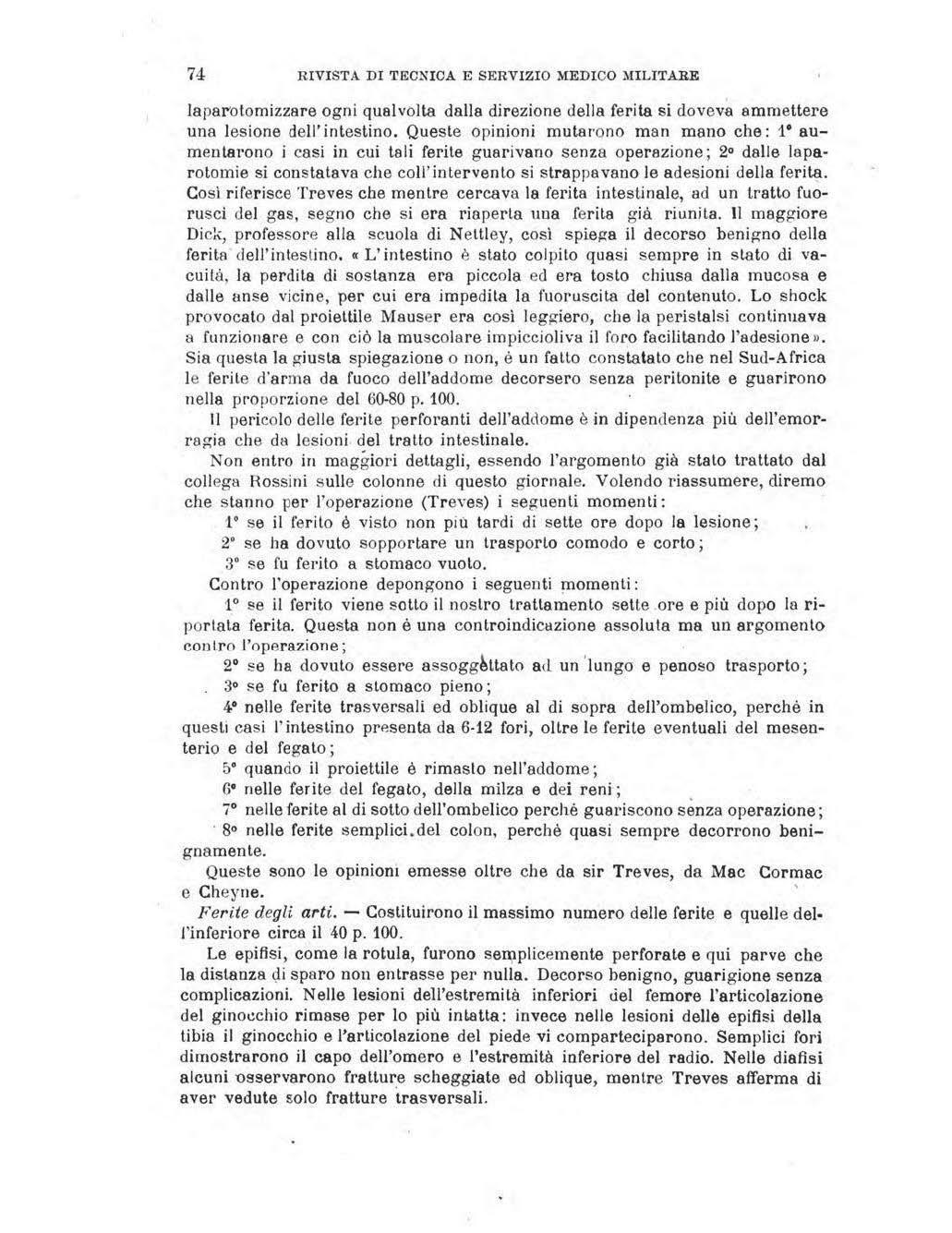
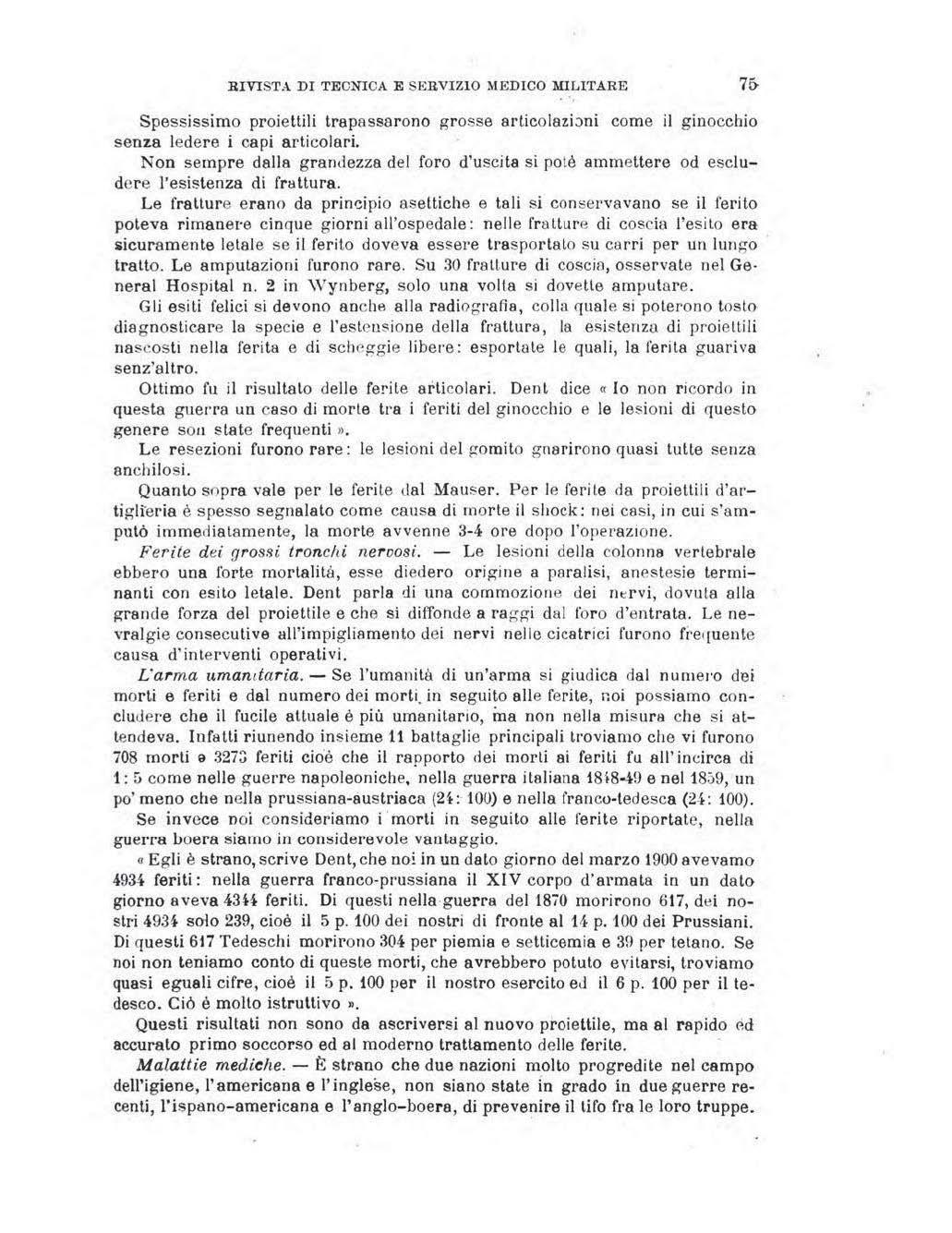
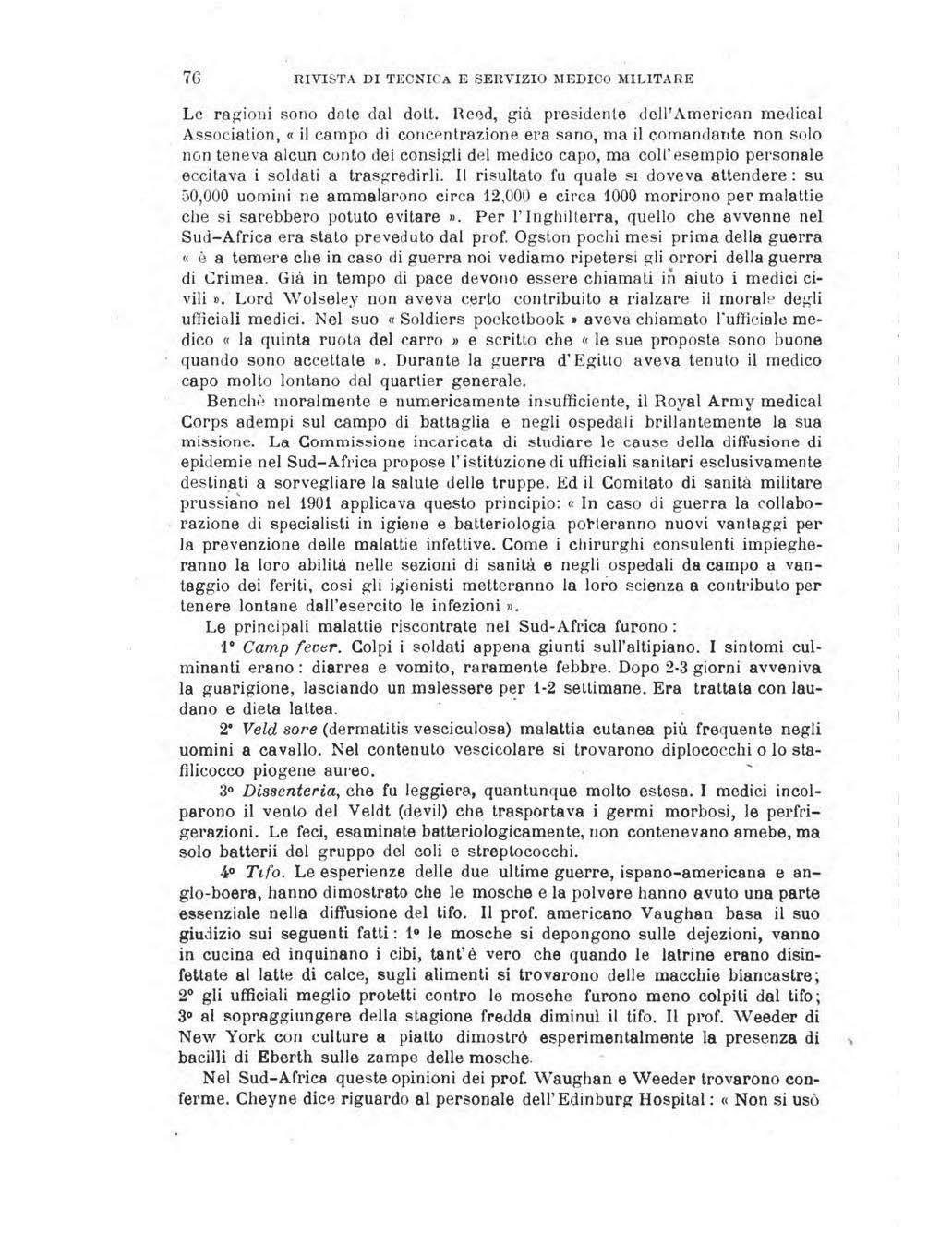





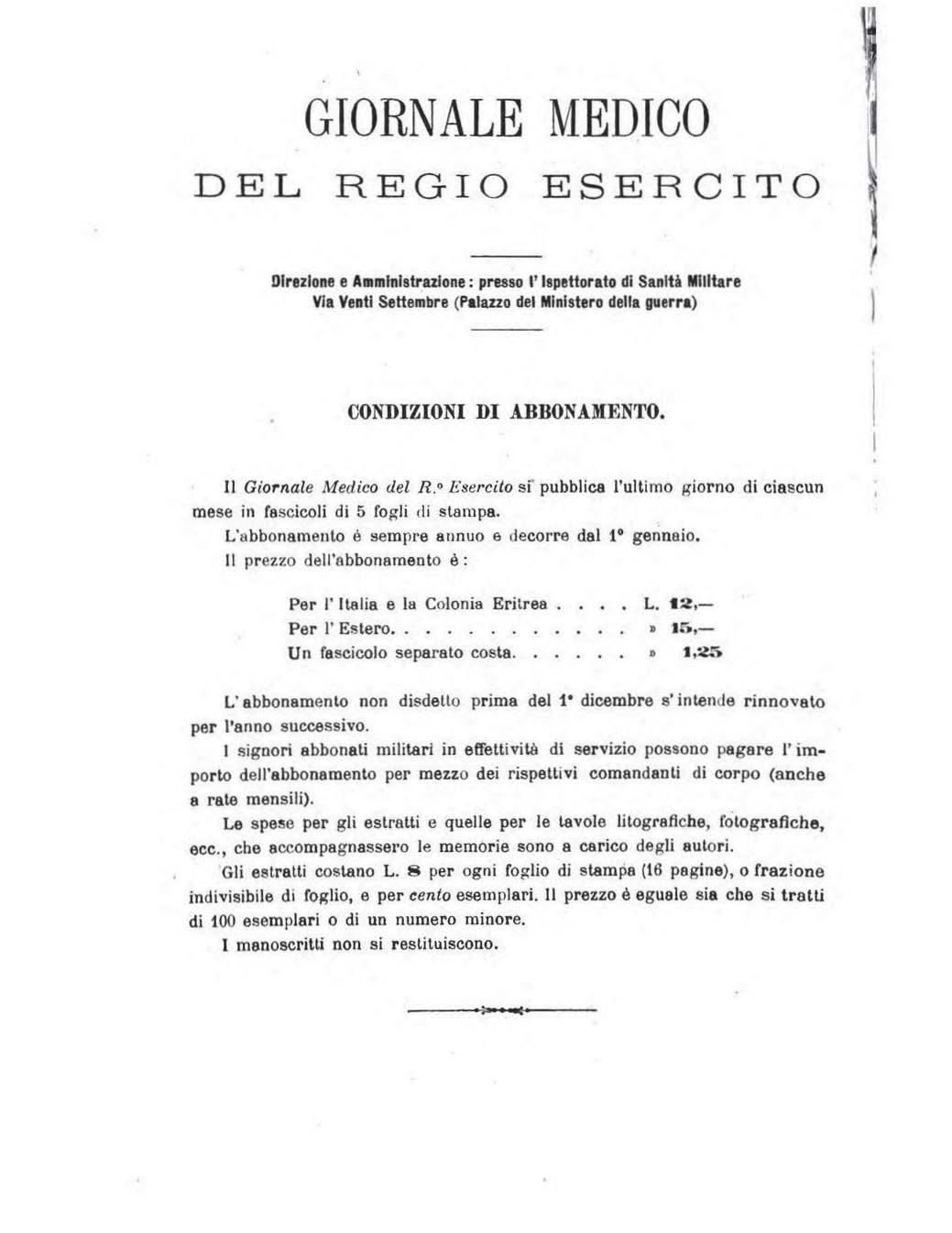









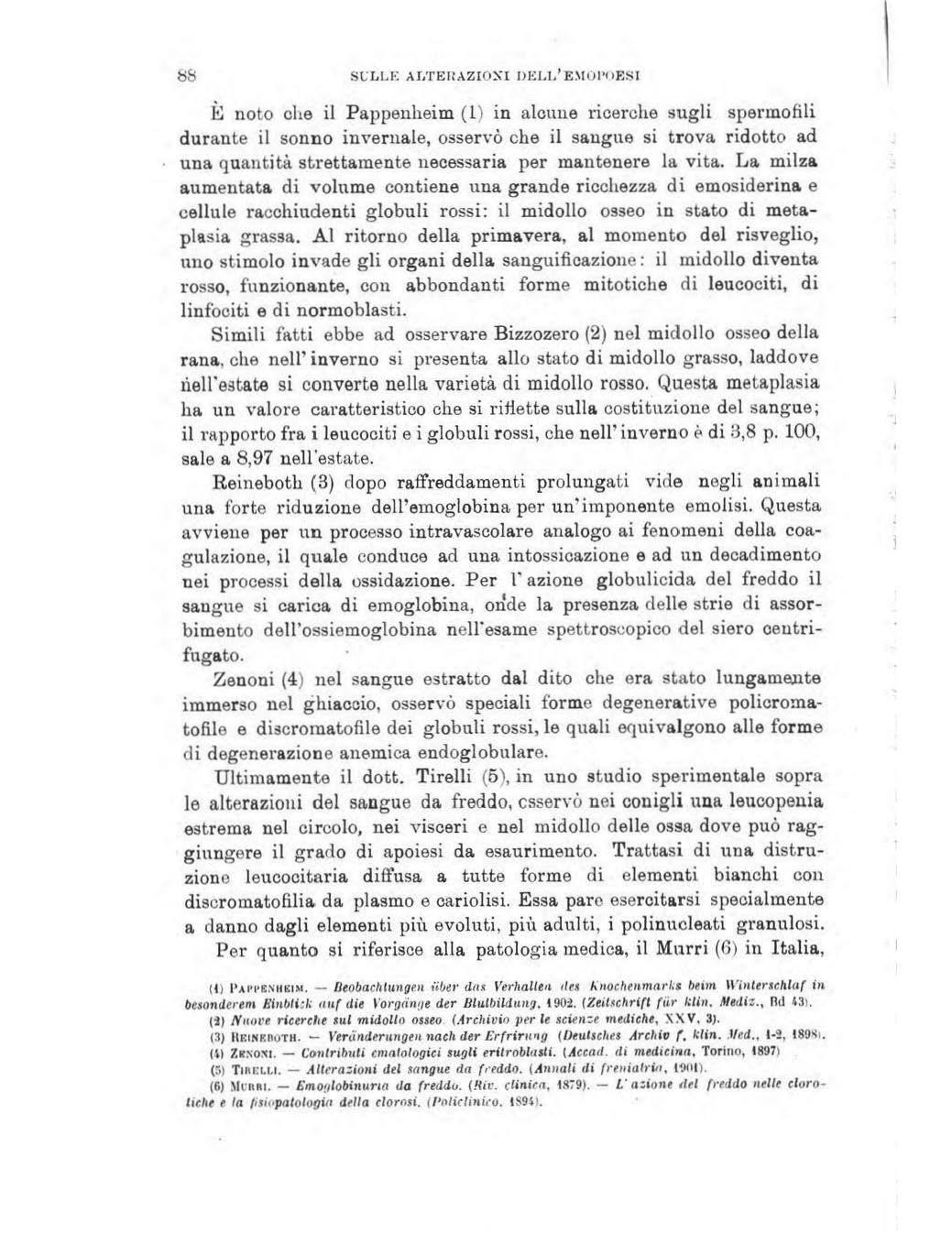
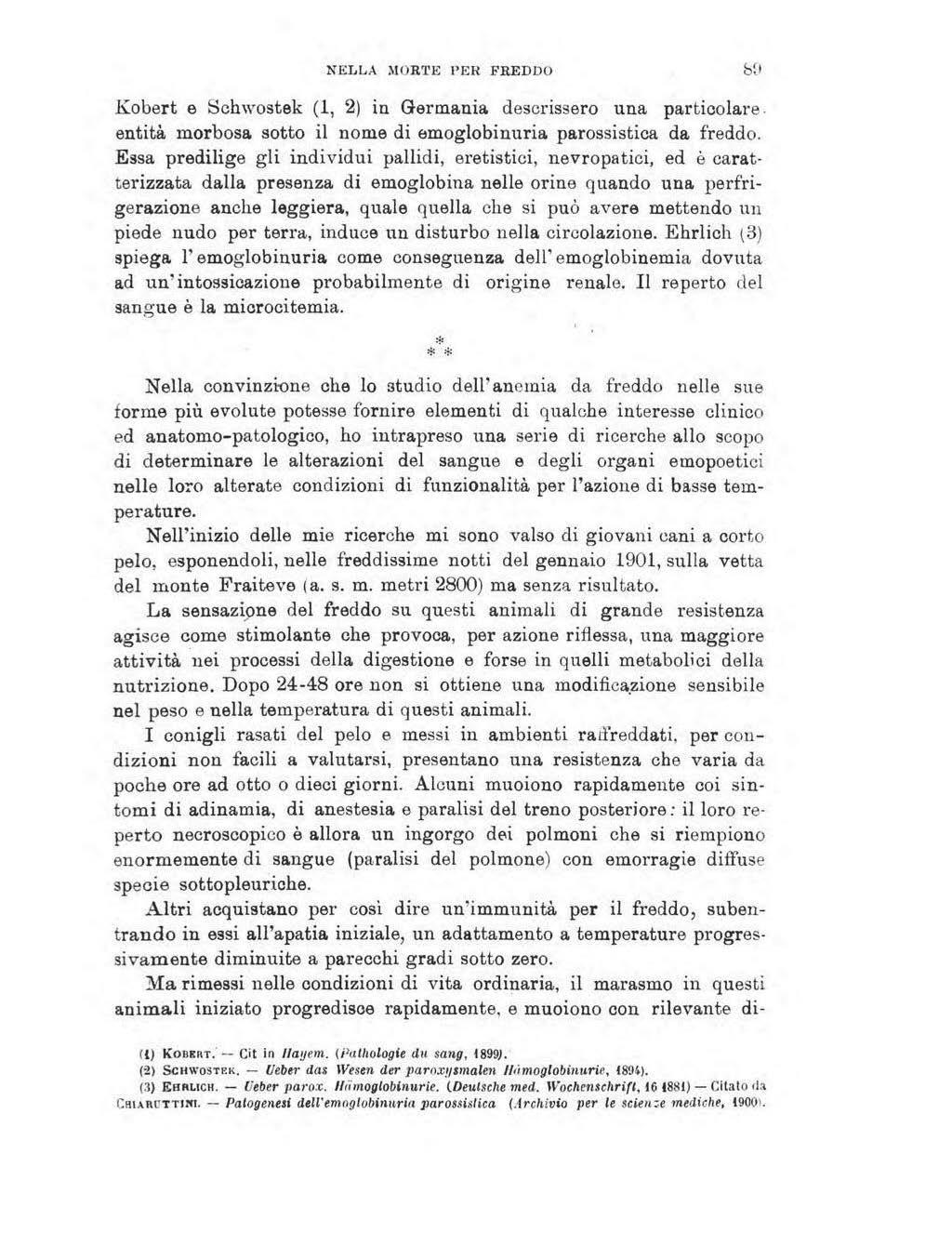



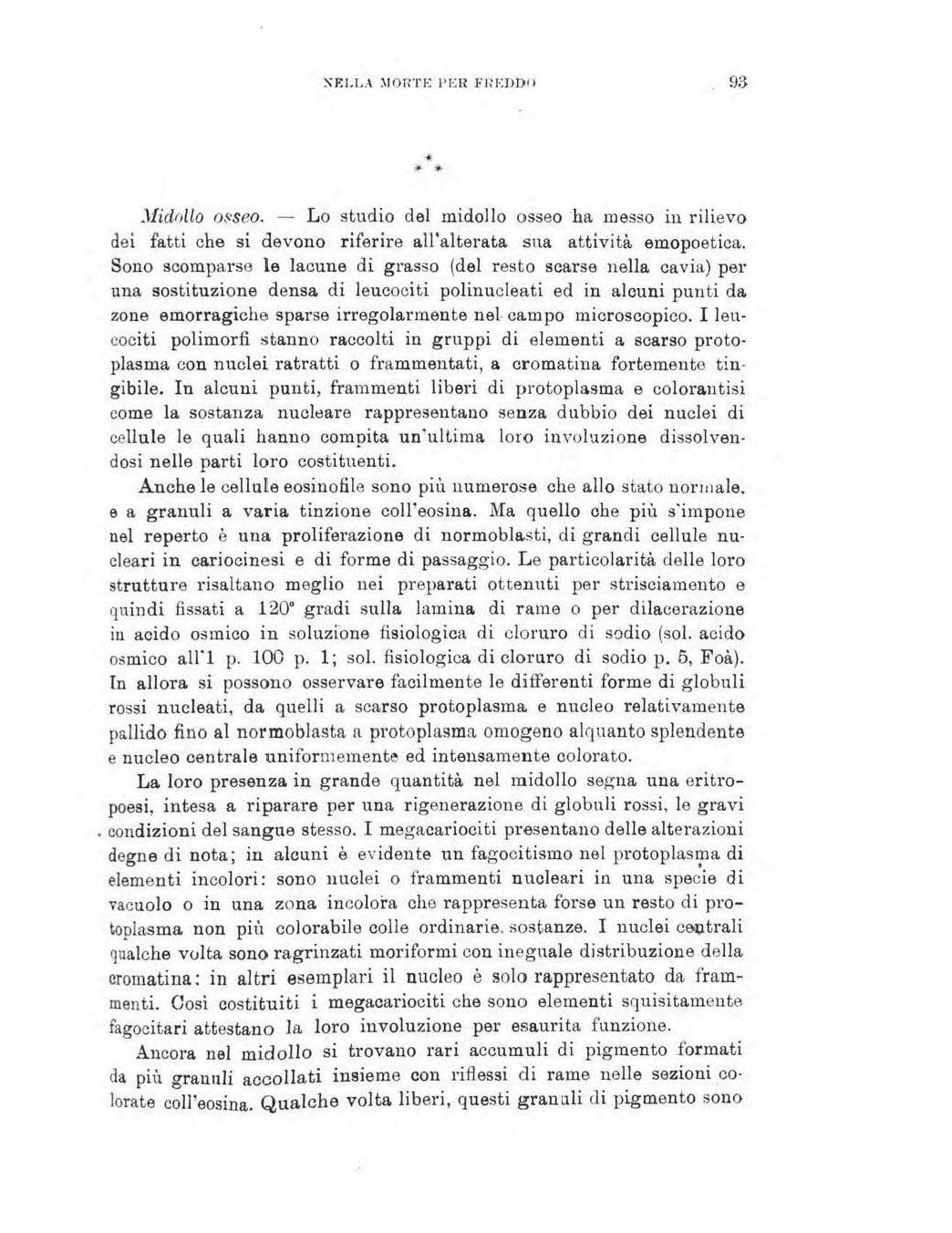
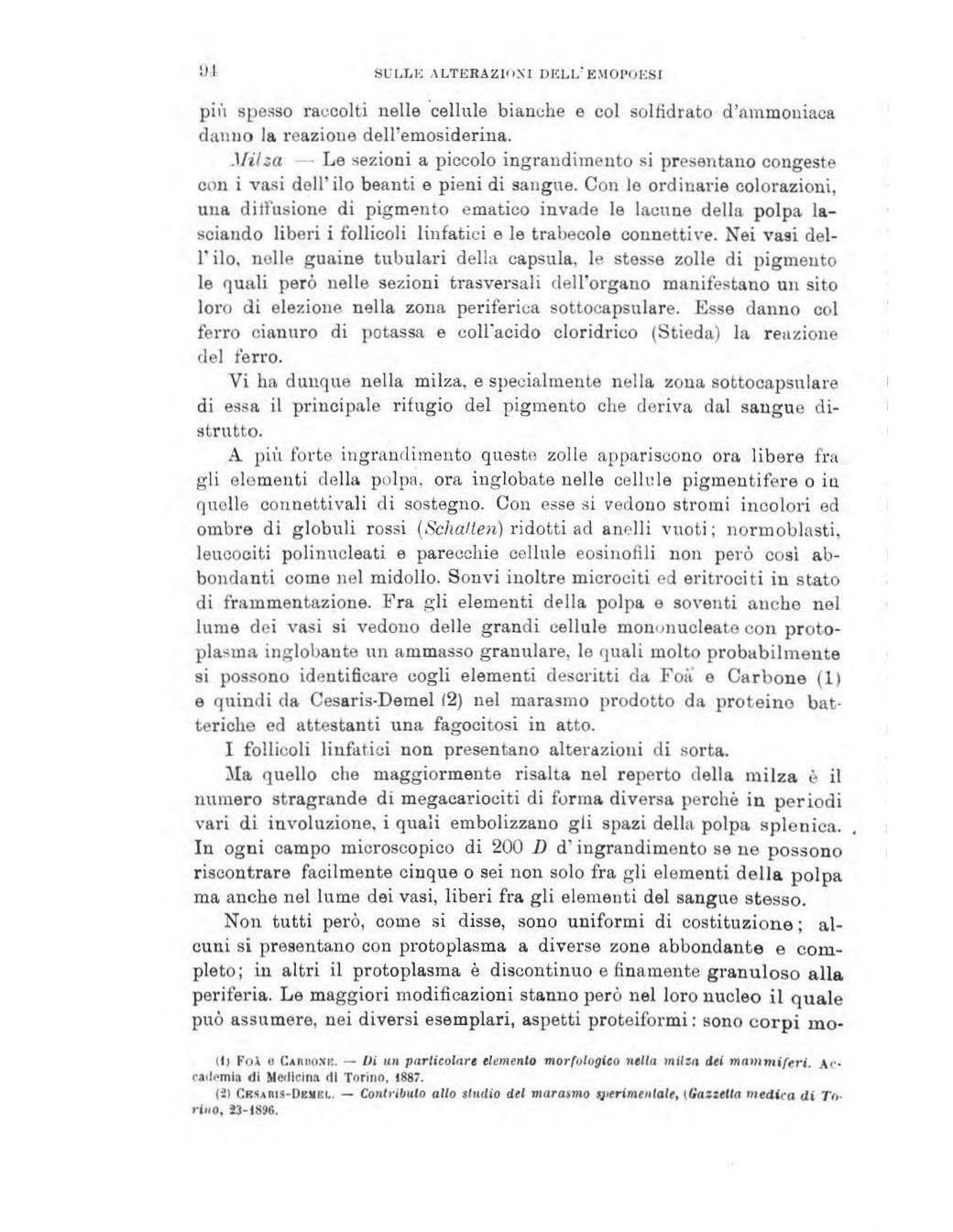

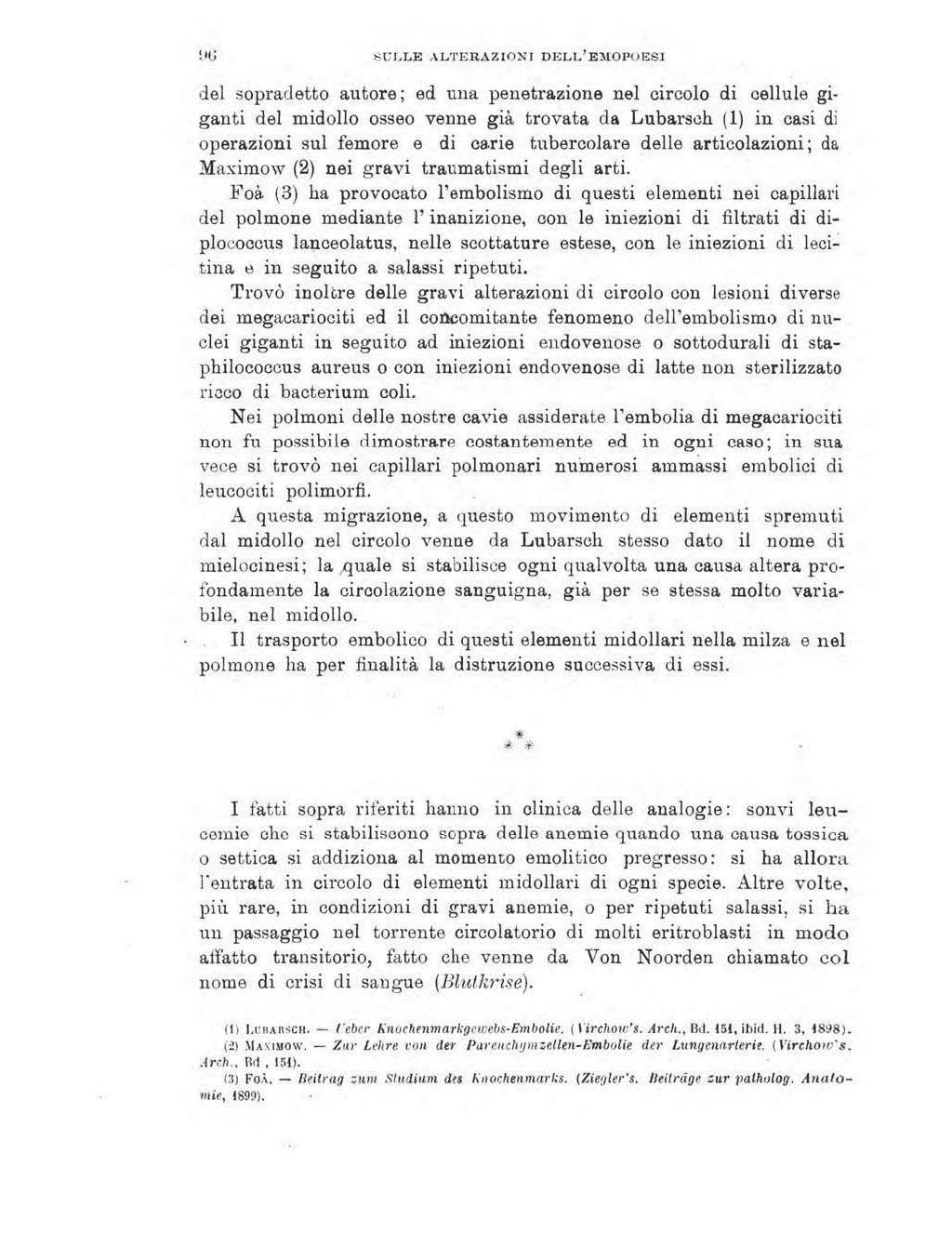

 Stnoloo olel dott. '1'. Spin a. capotano mro llco
Stnoloo olel dott. '1'. Spin a. capotano mro llco
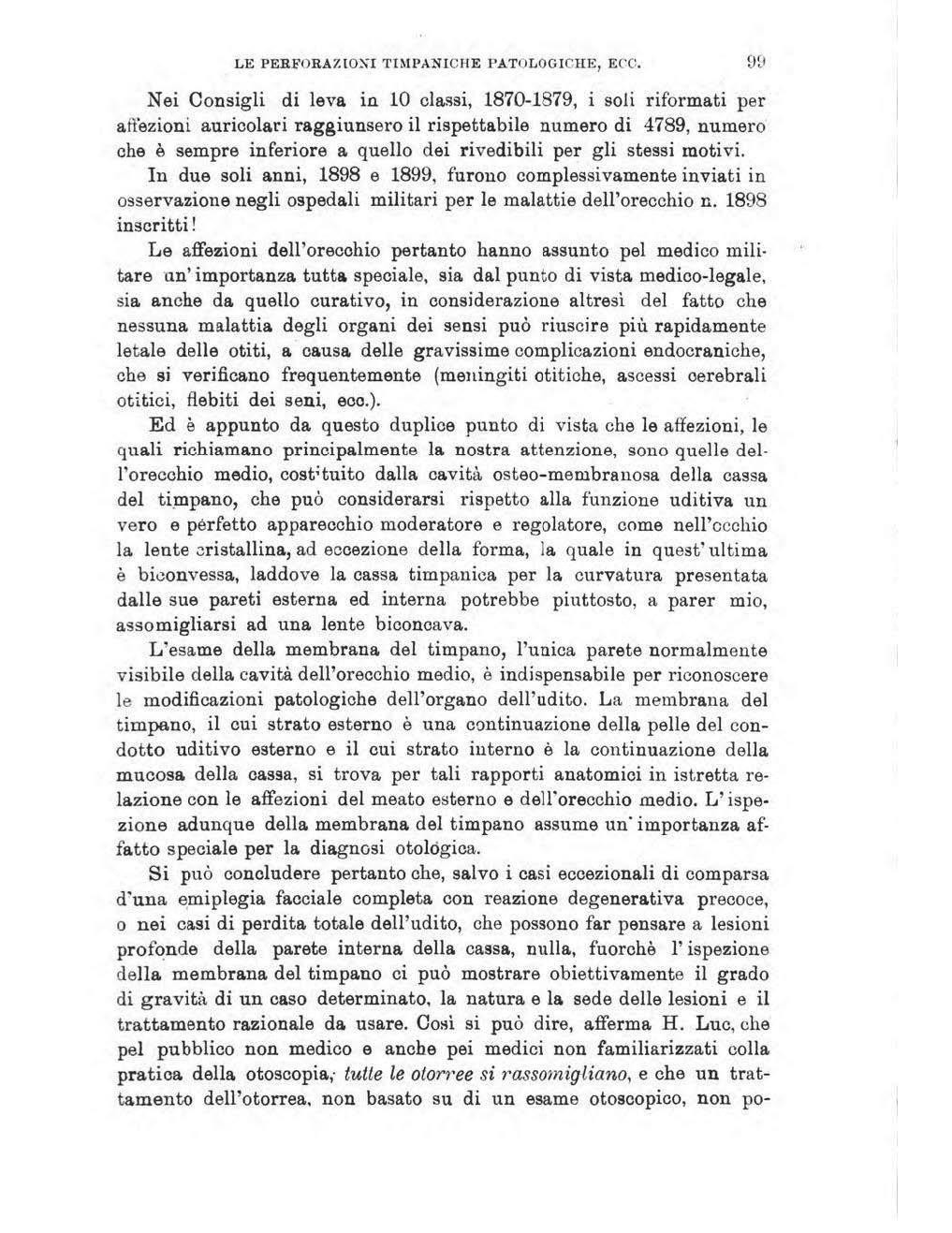




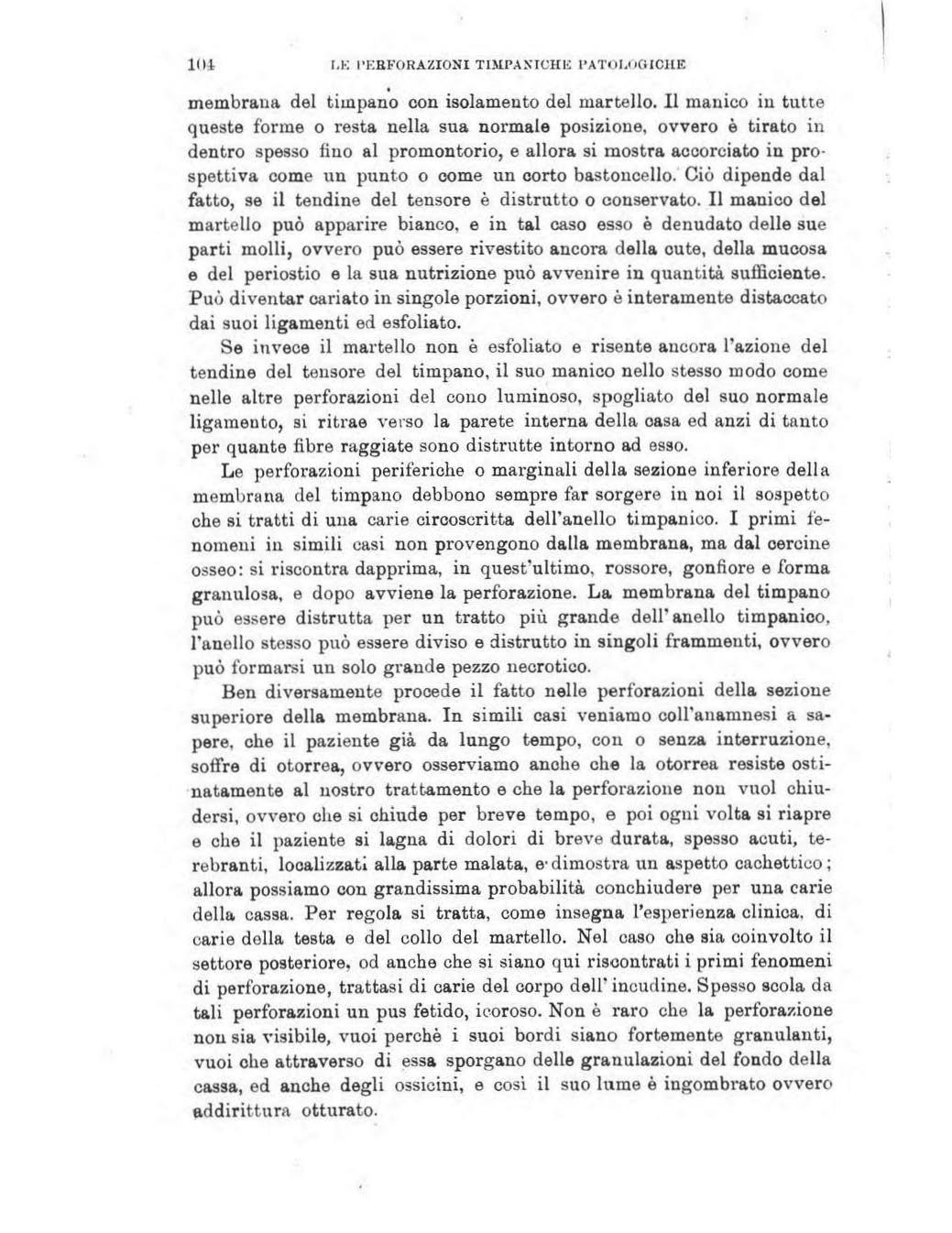


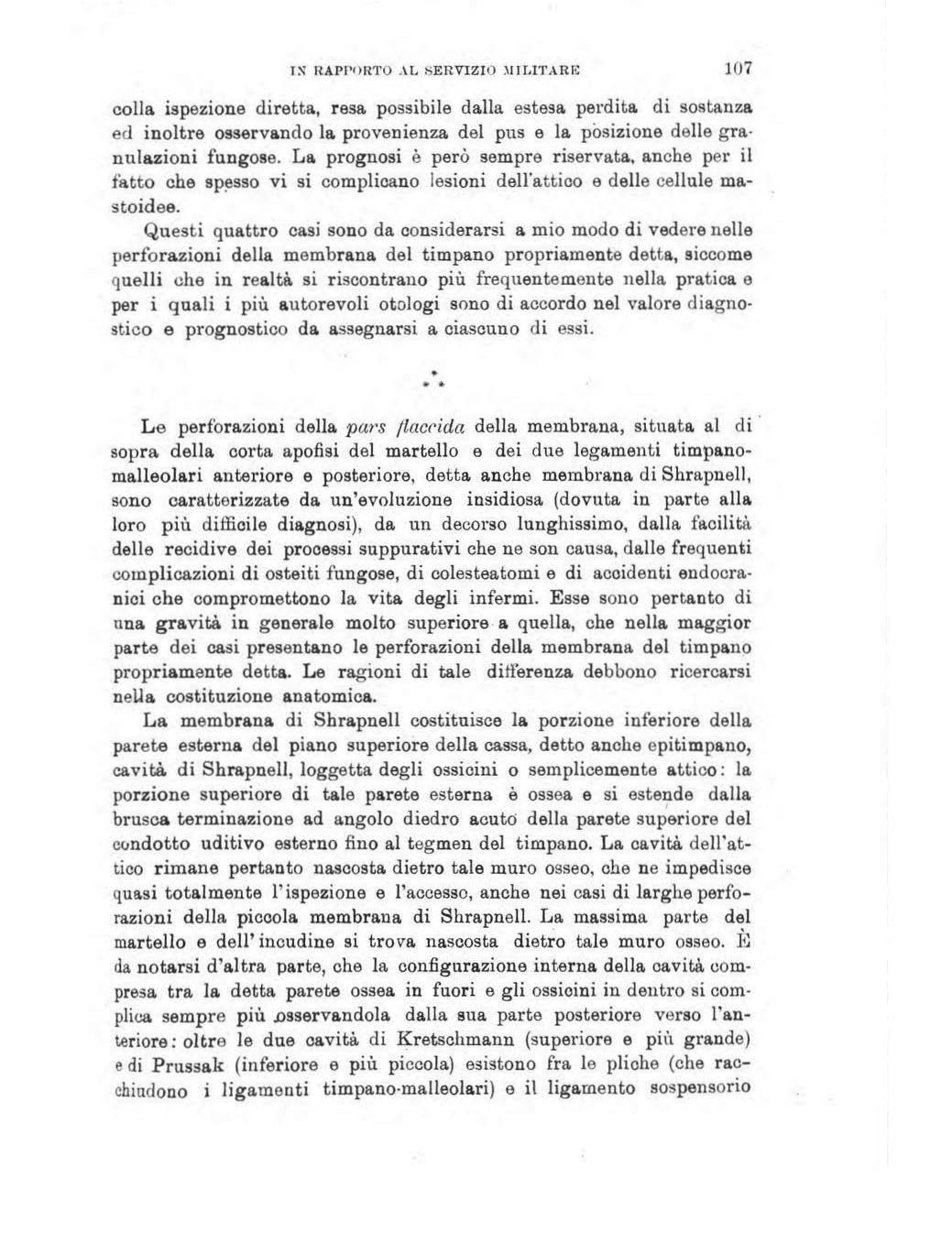
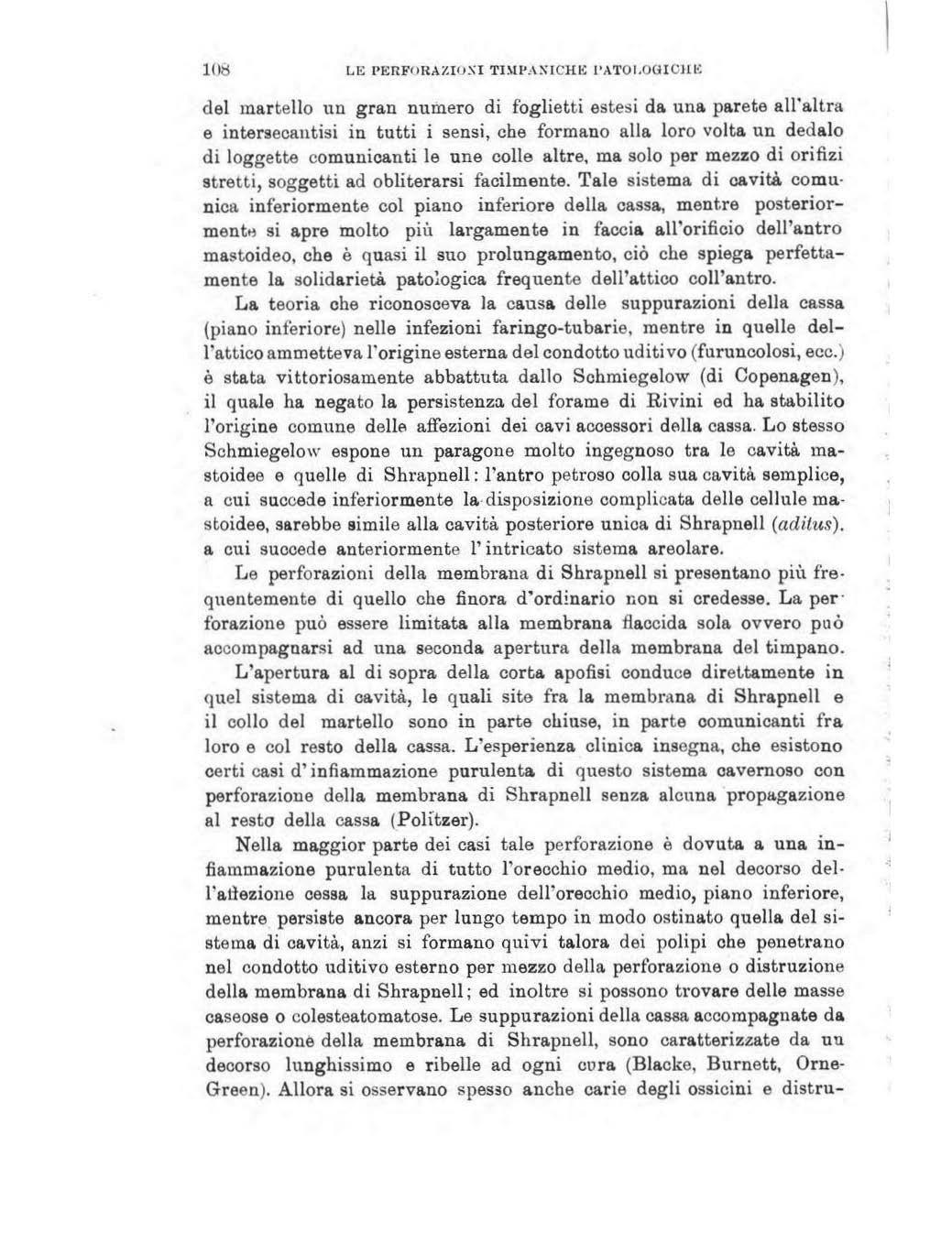


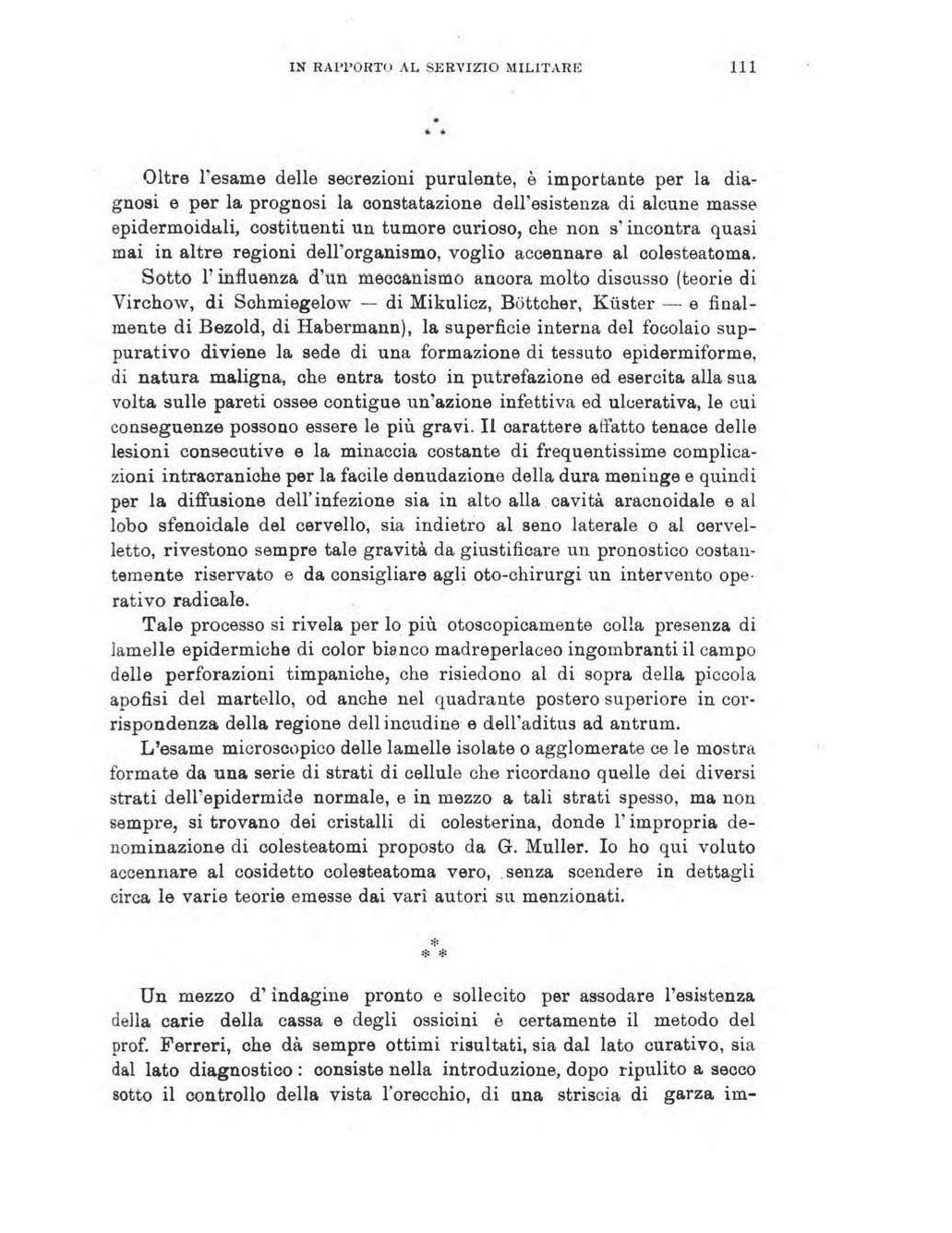













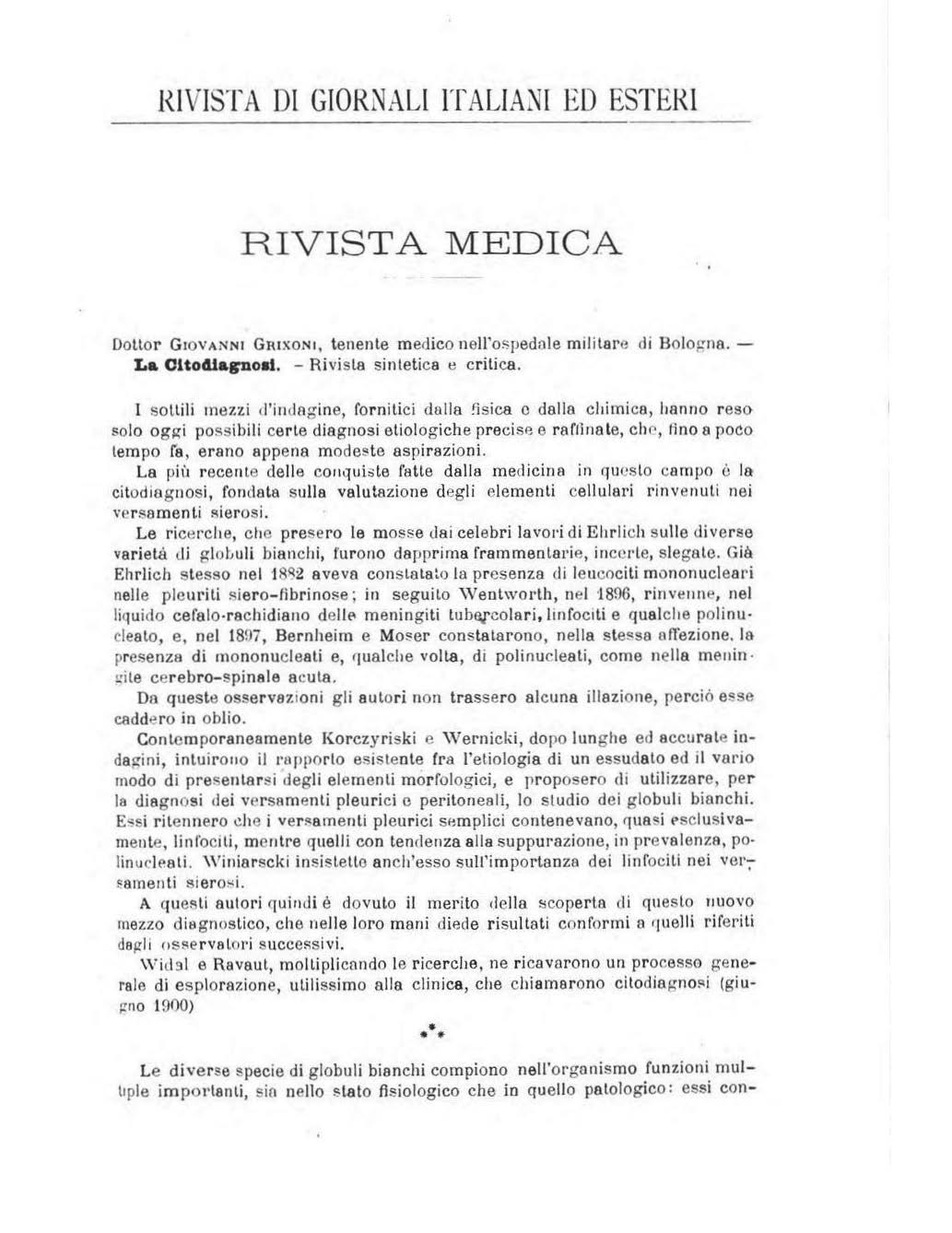


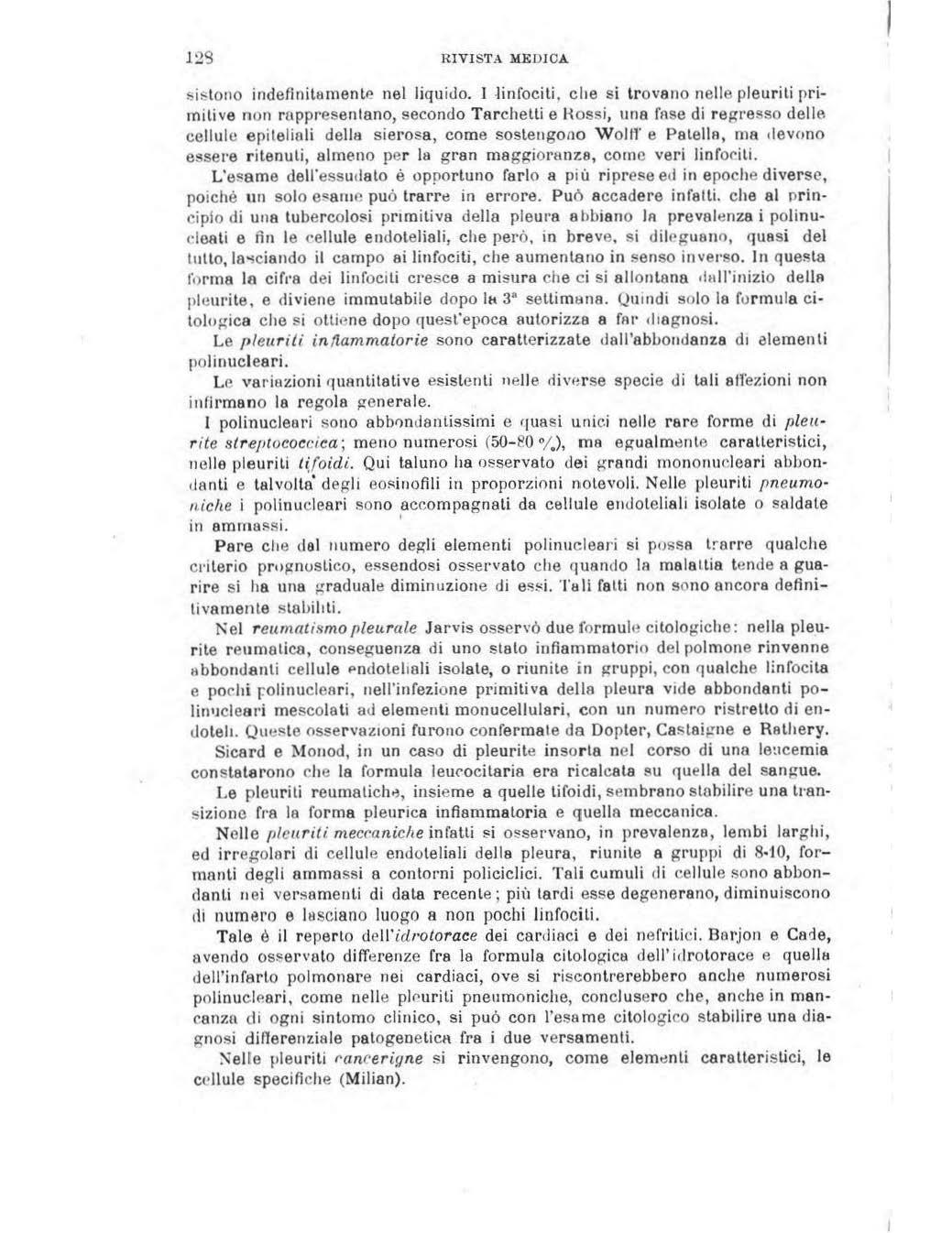





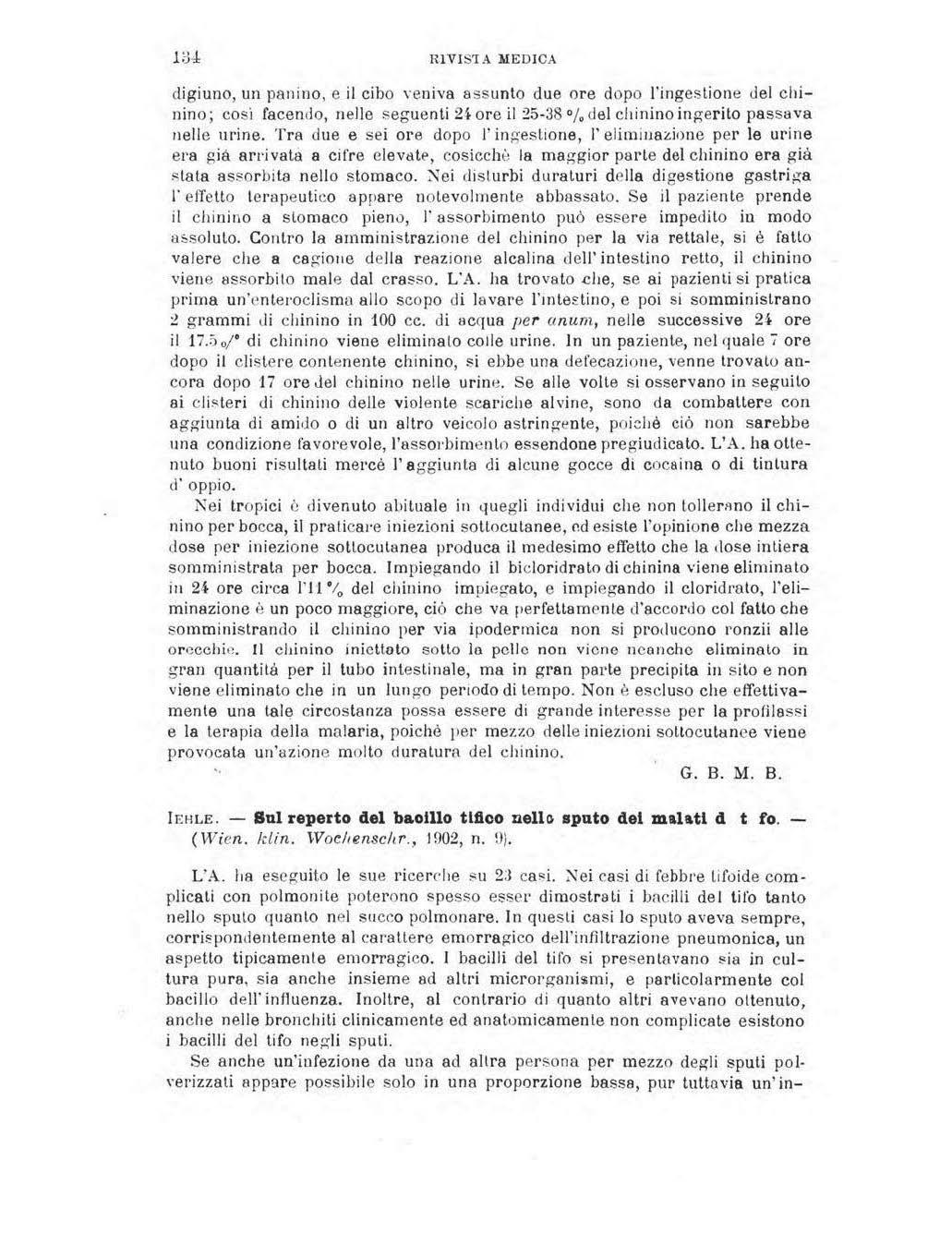
 G. O. M. B.
G. O. M. B.
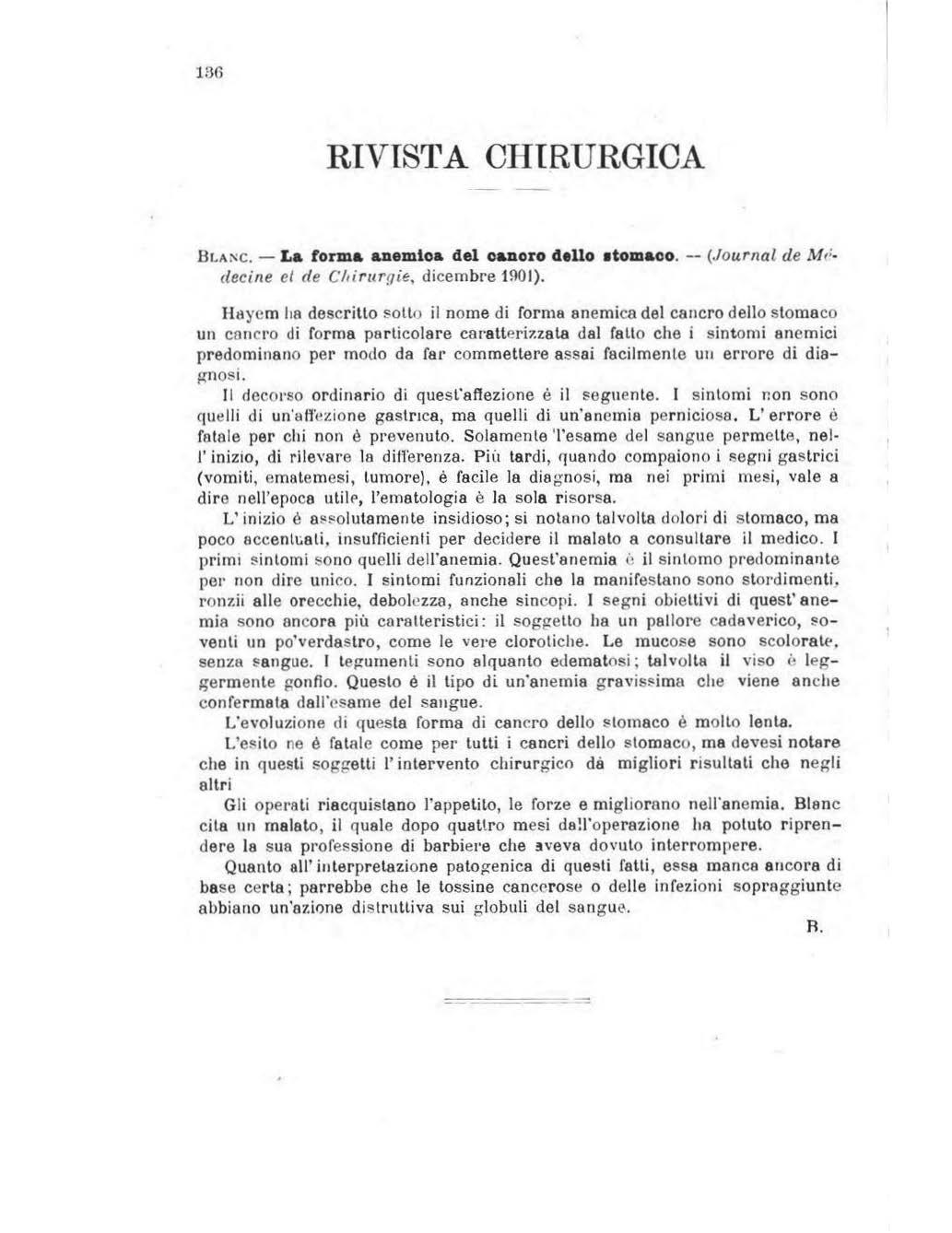



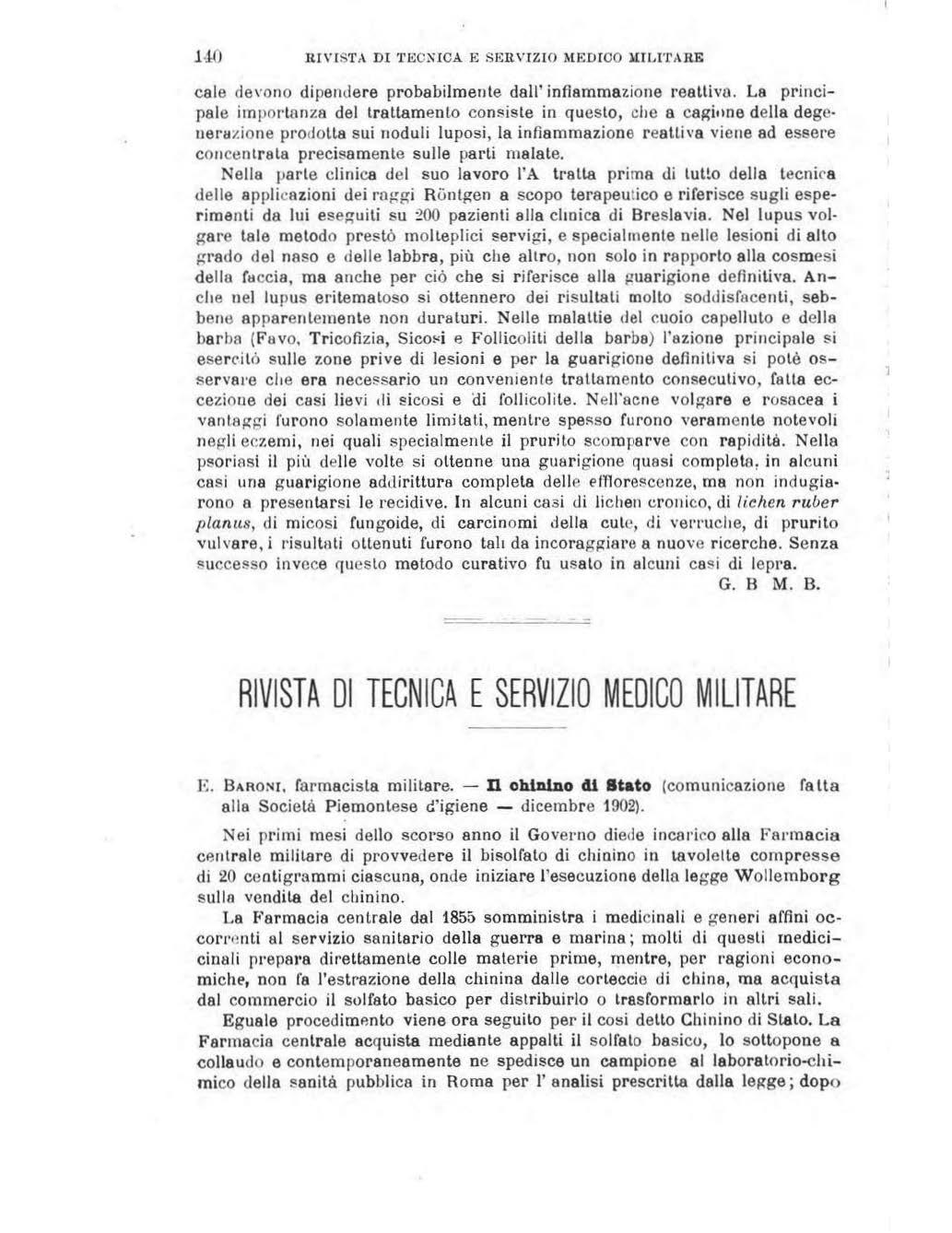
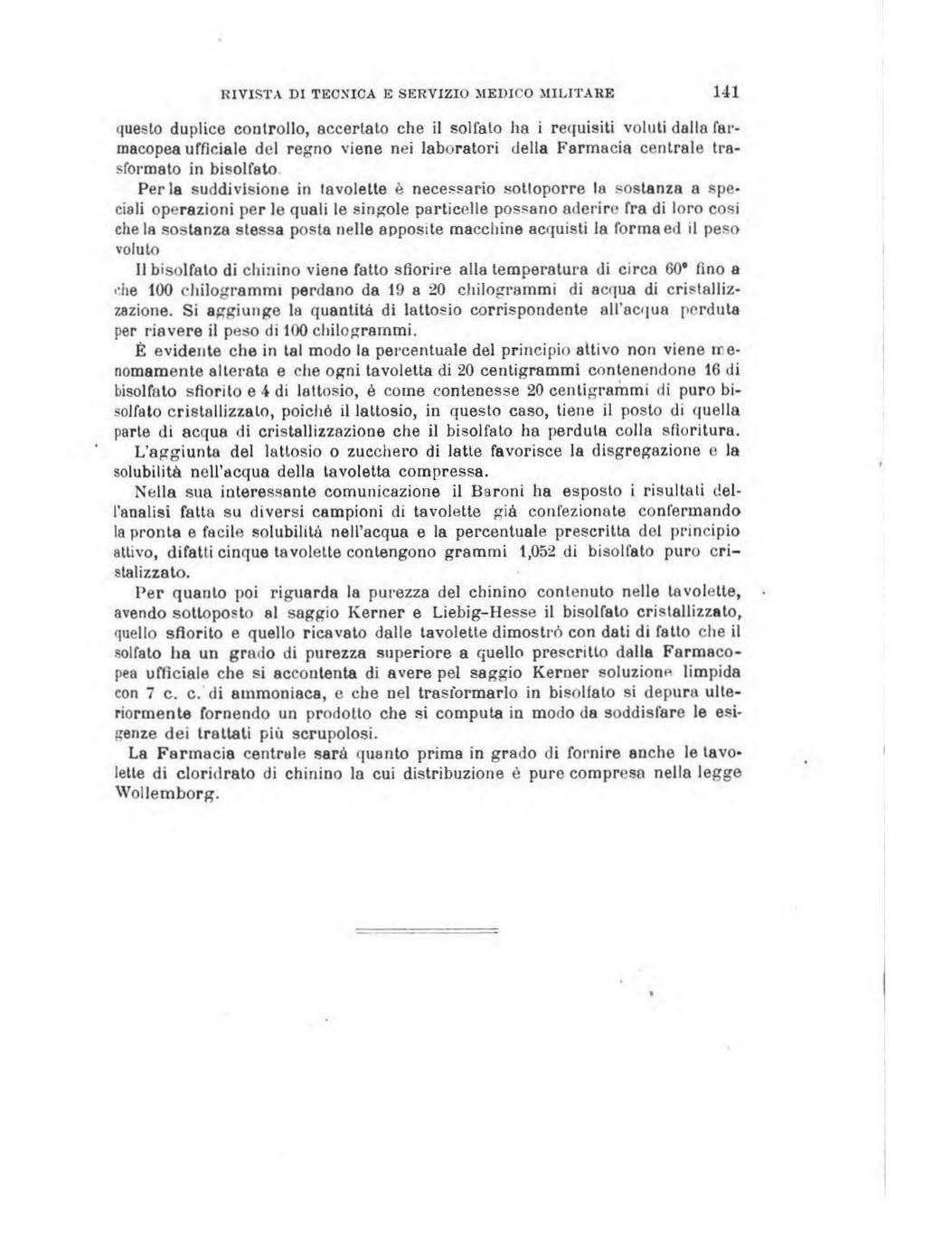

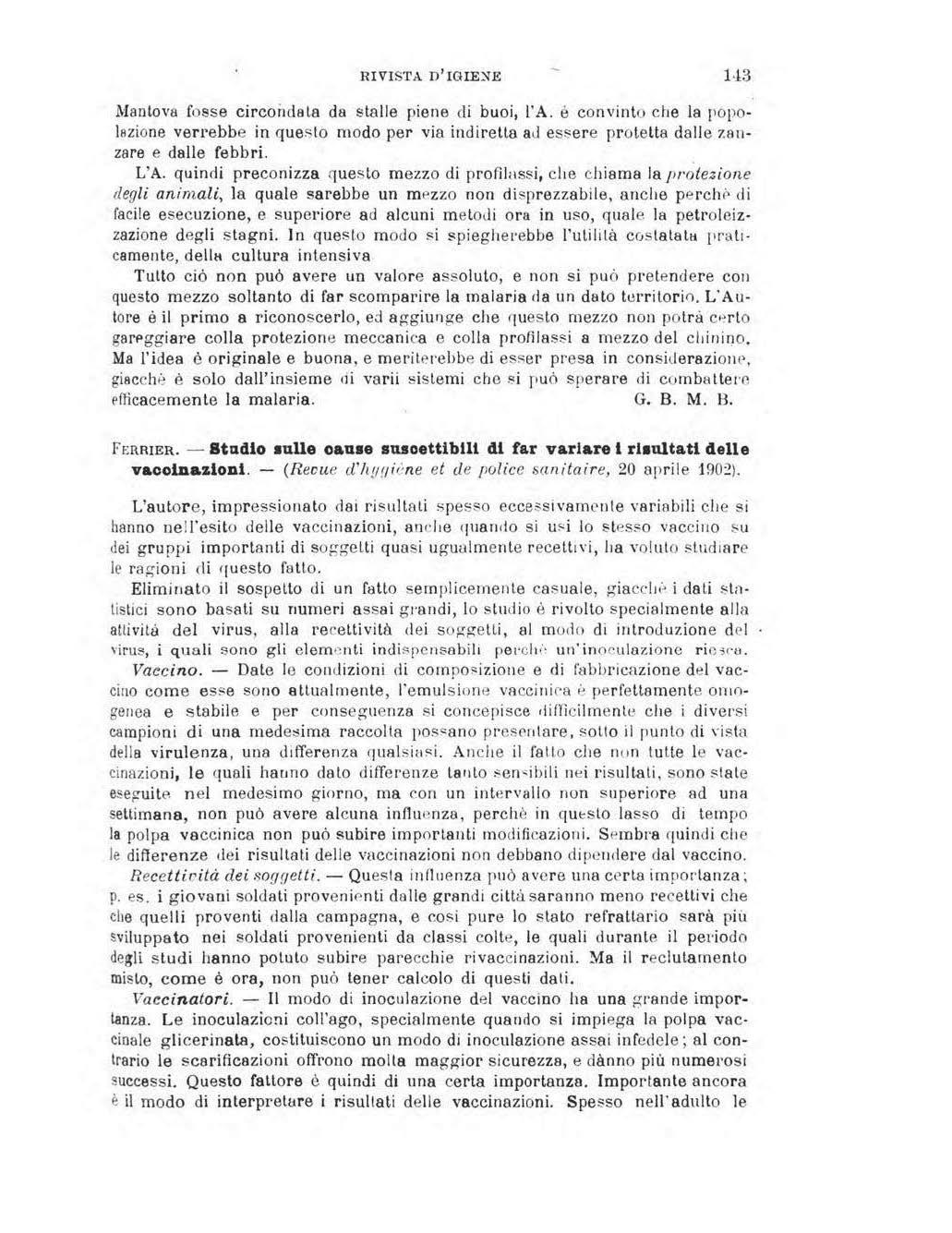


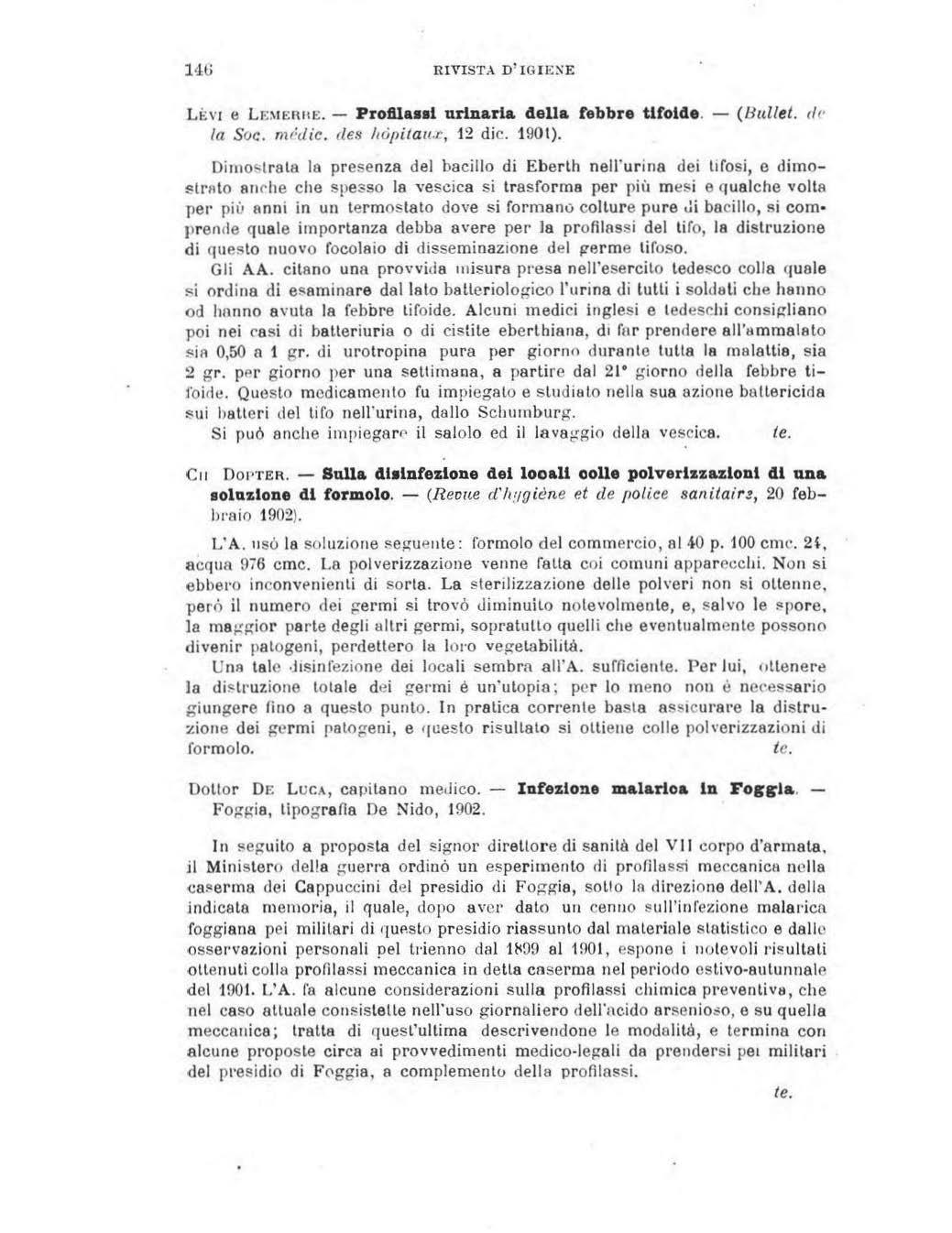



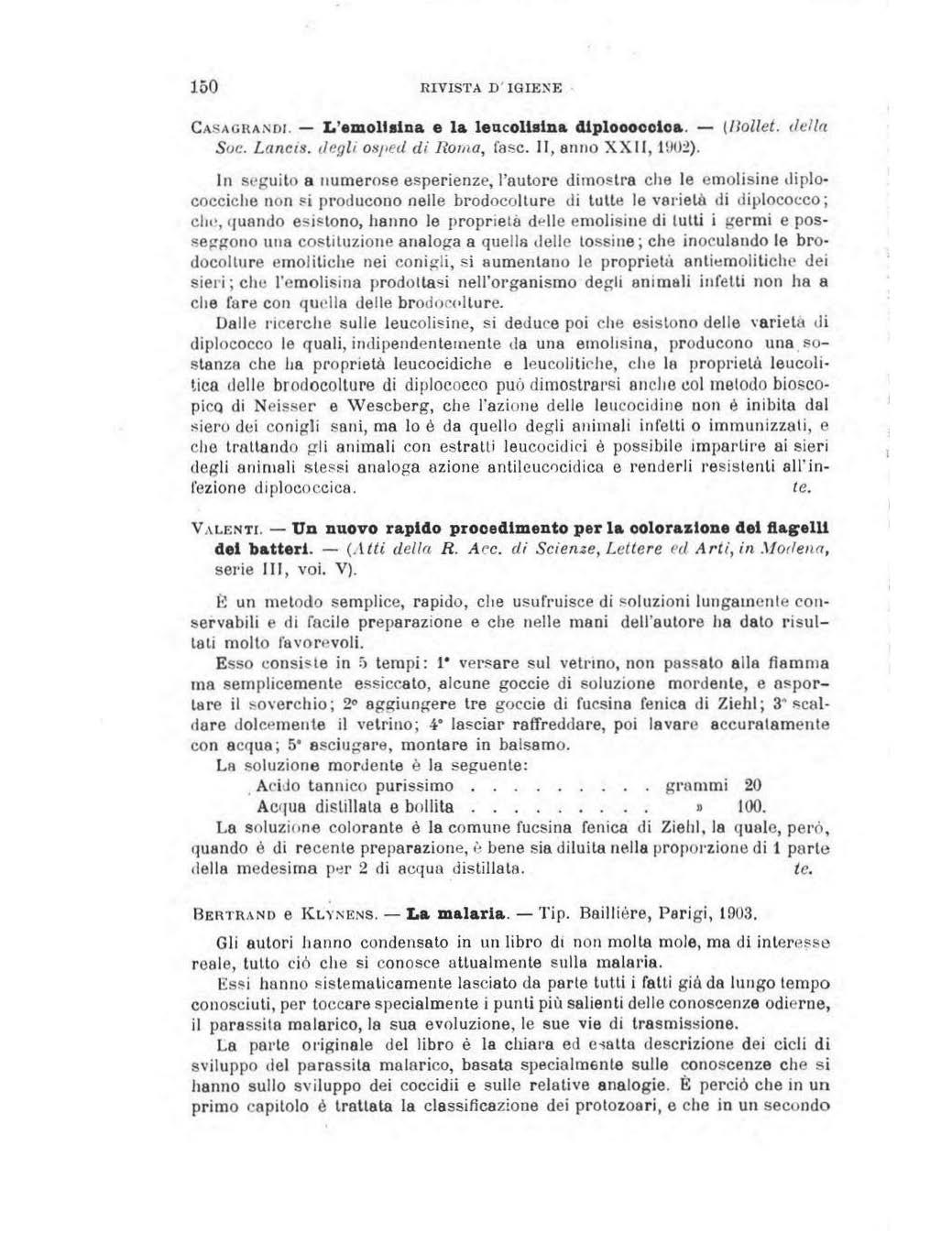
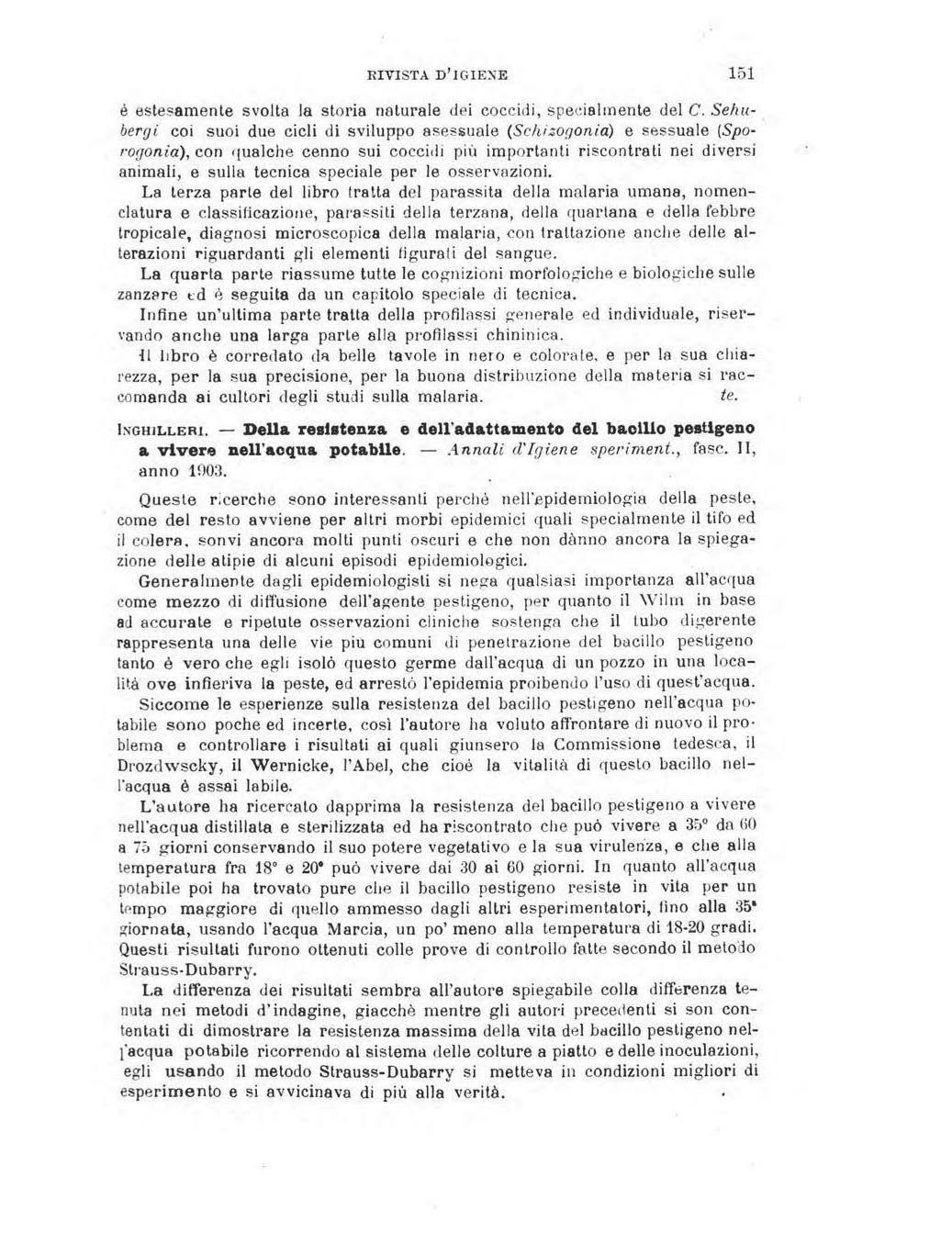







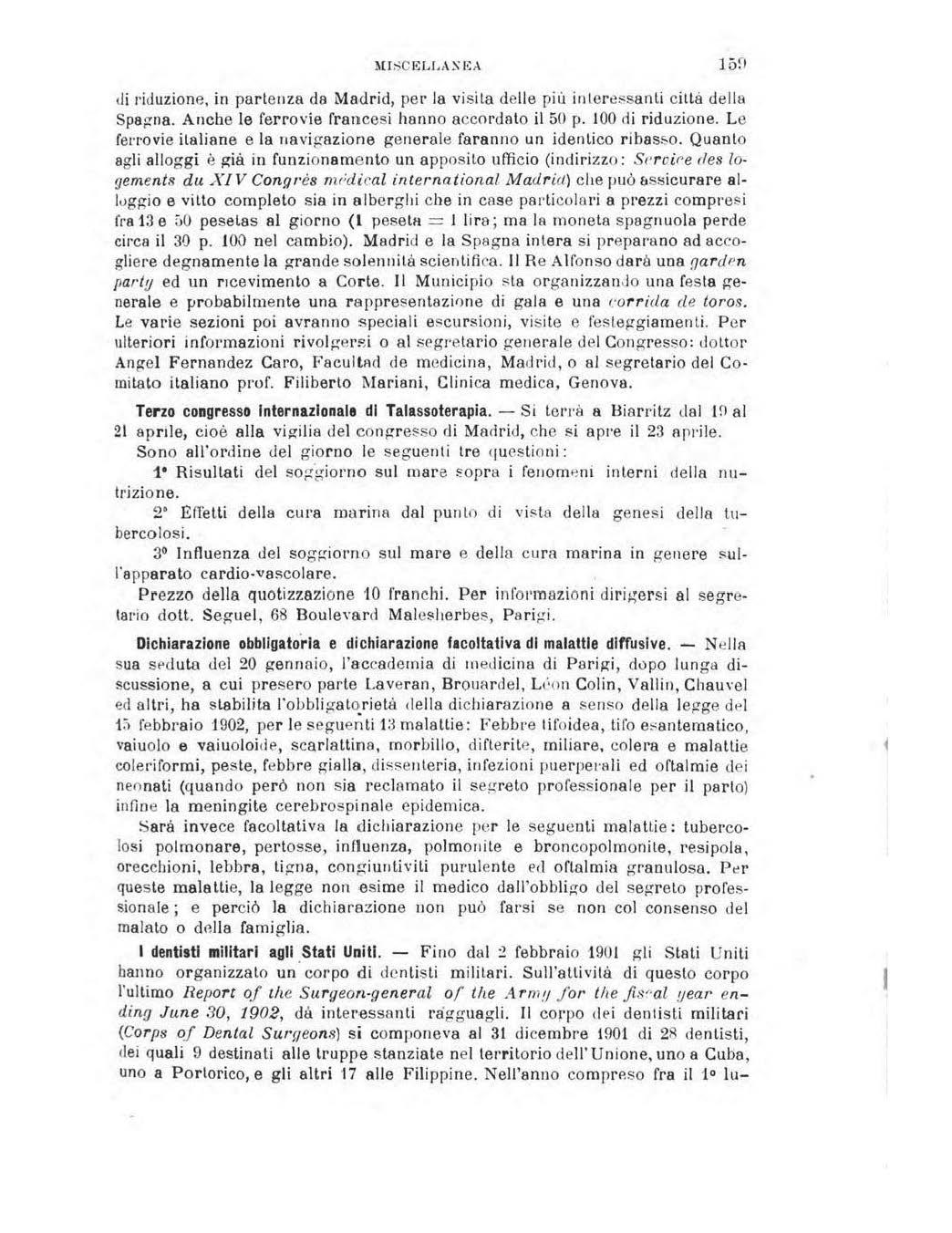


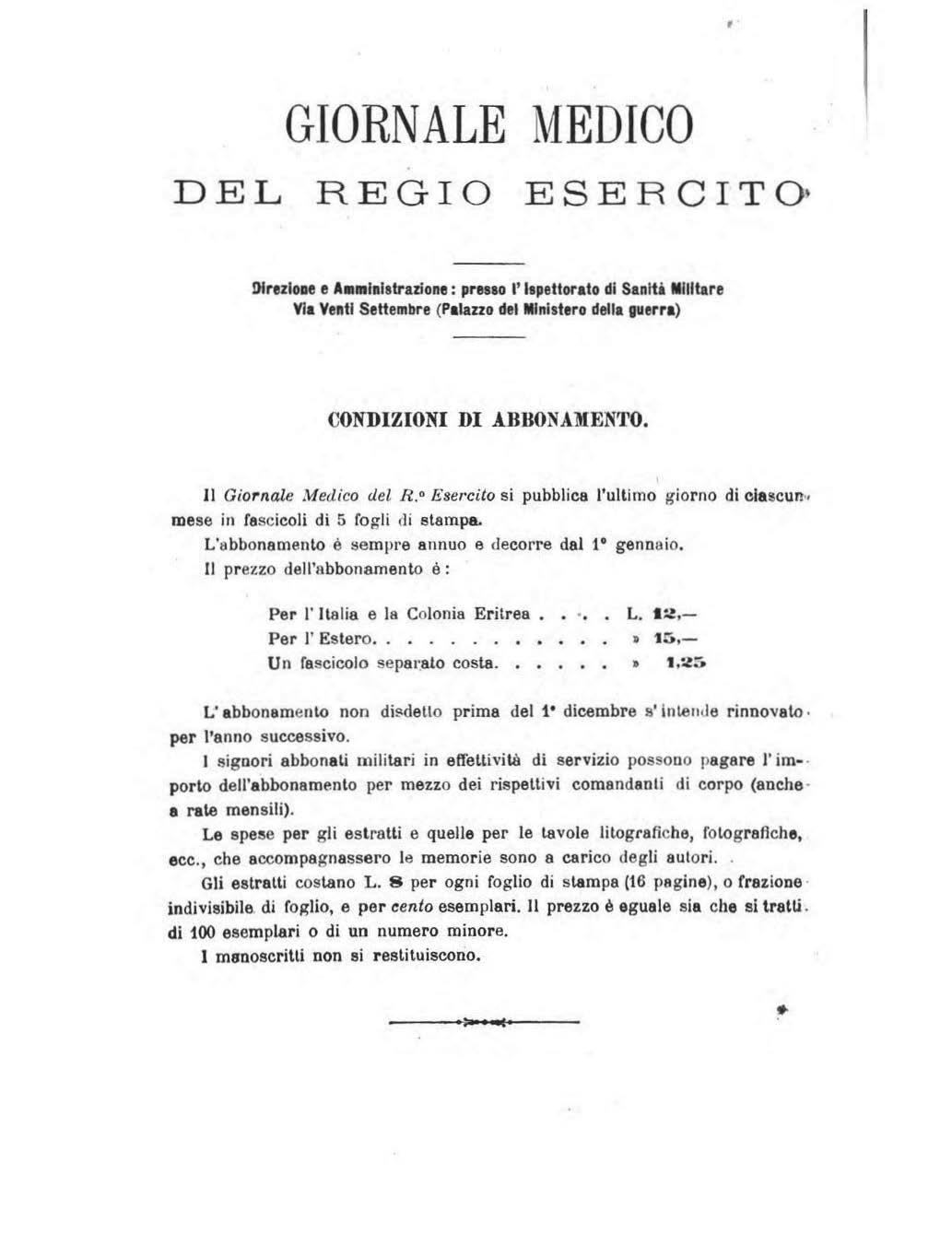



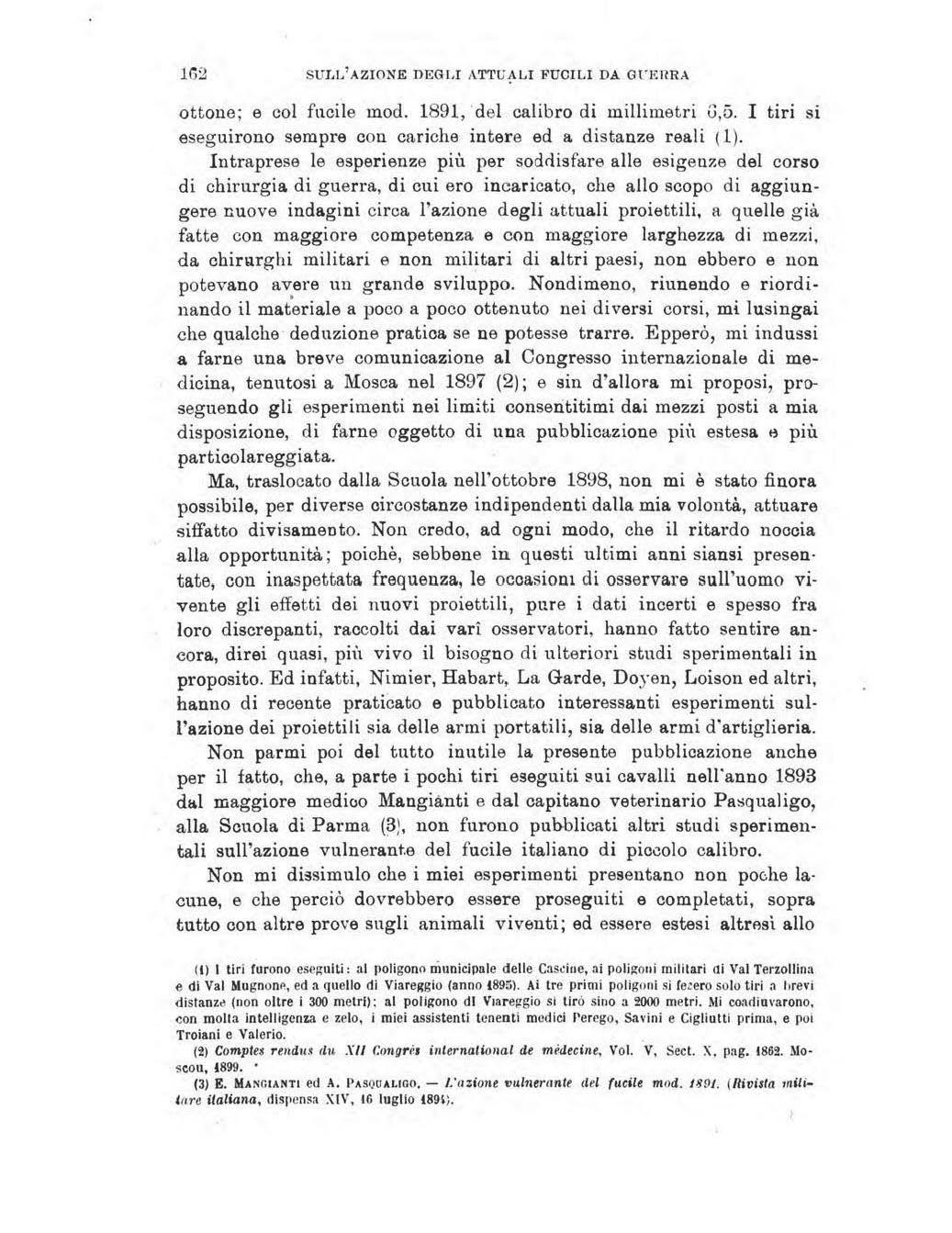


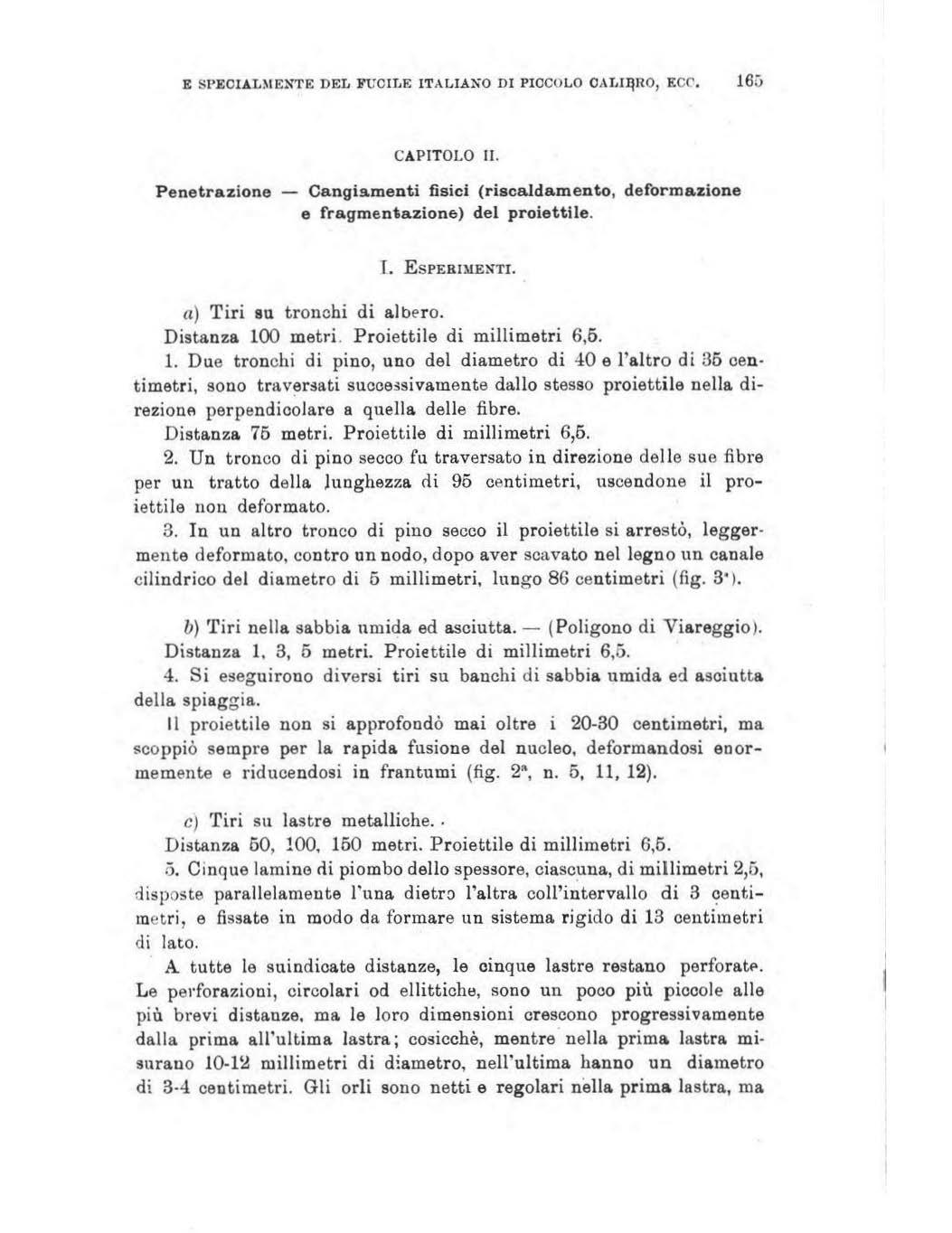
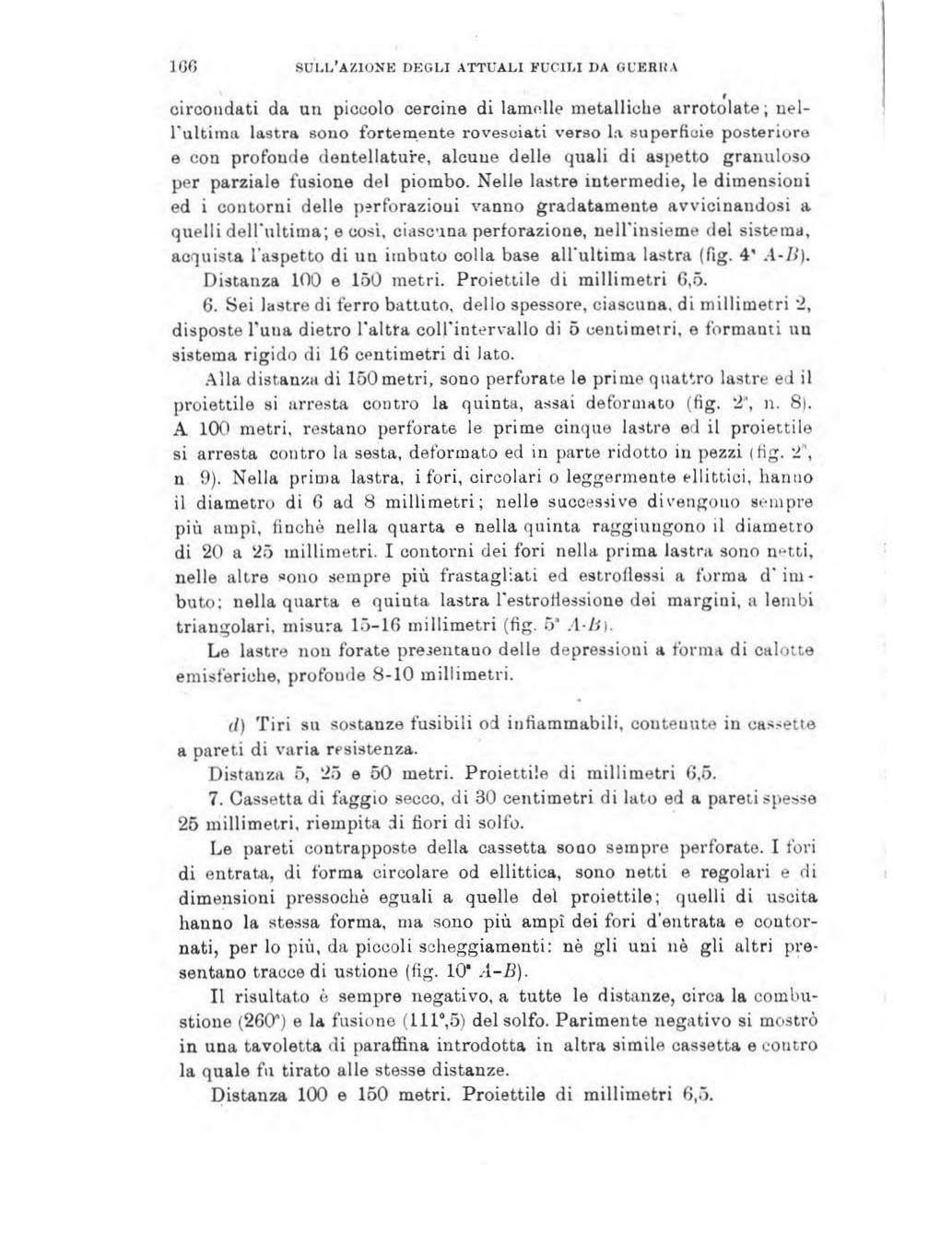











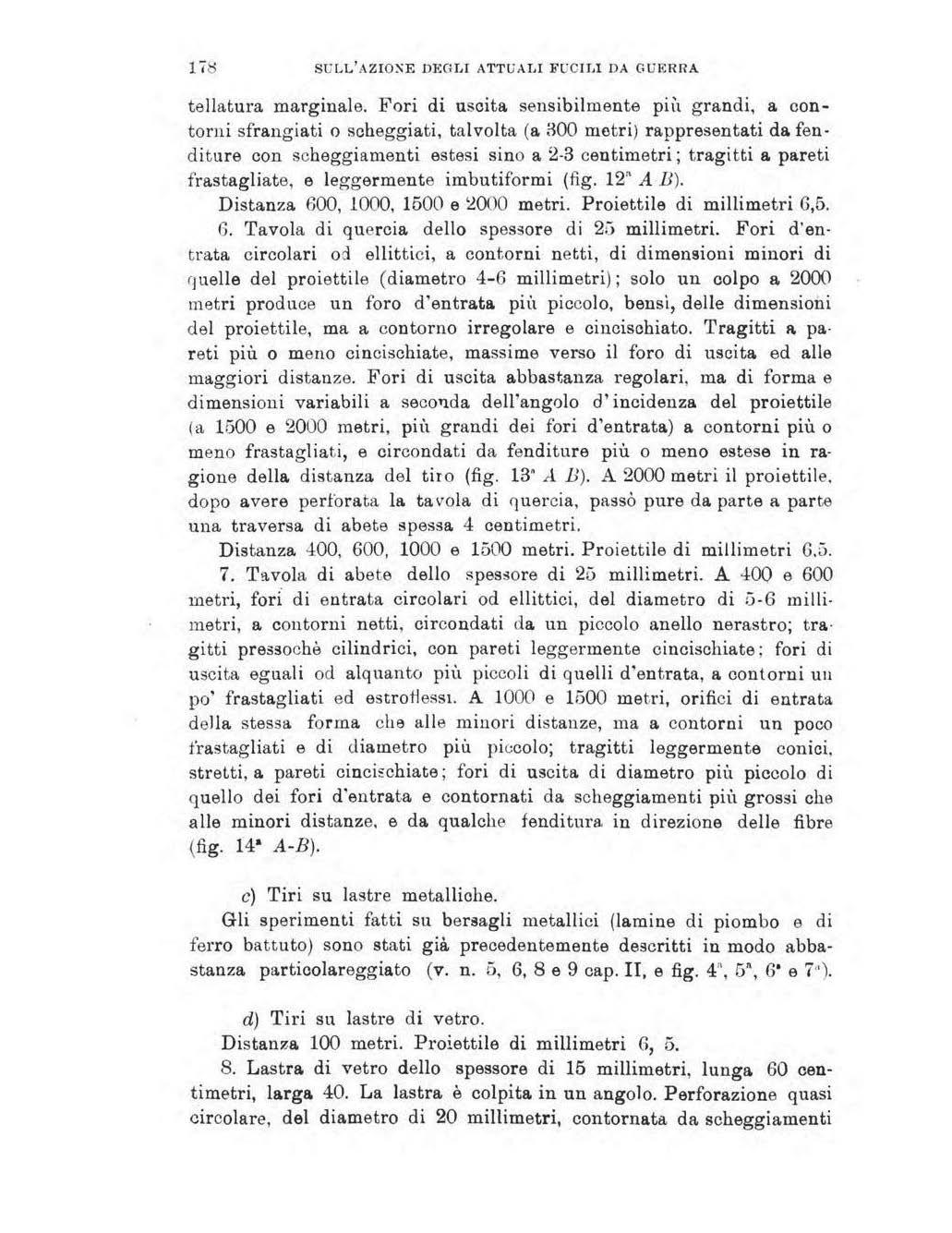
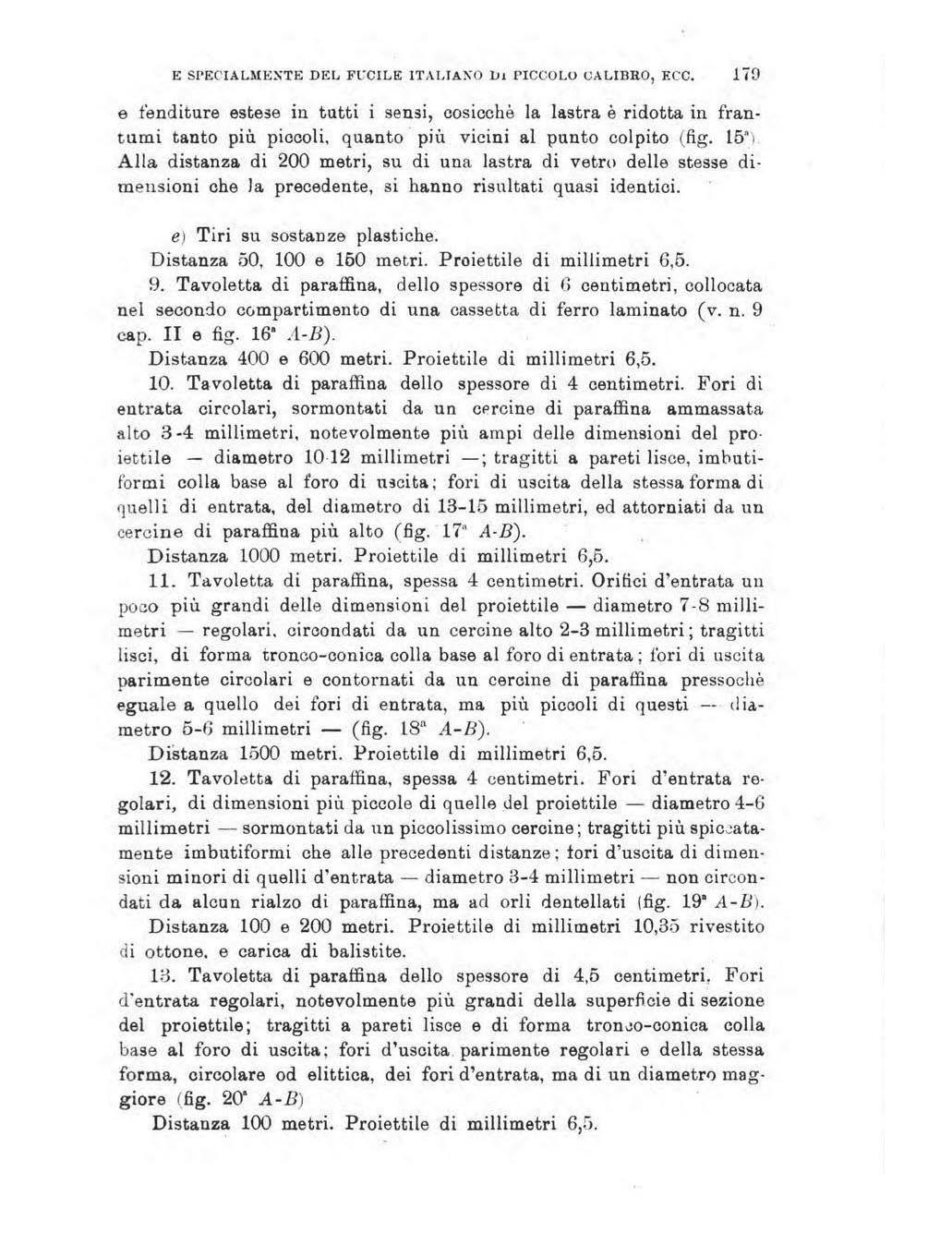


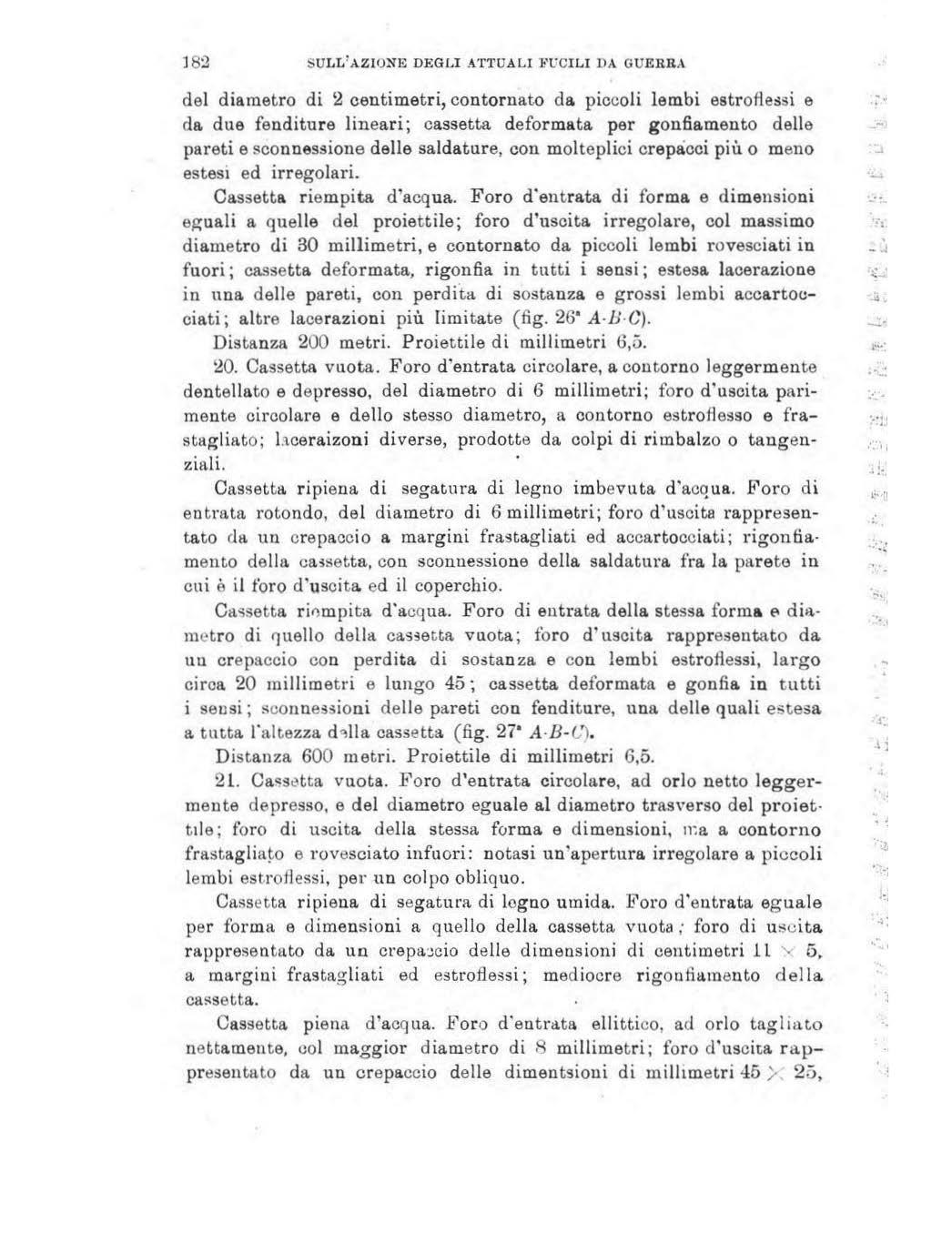


















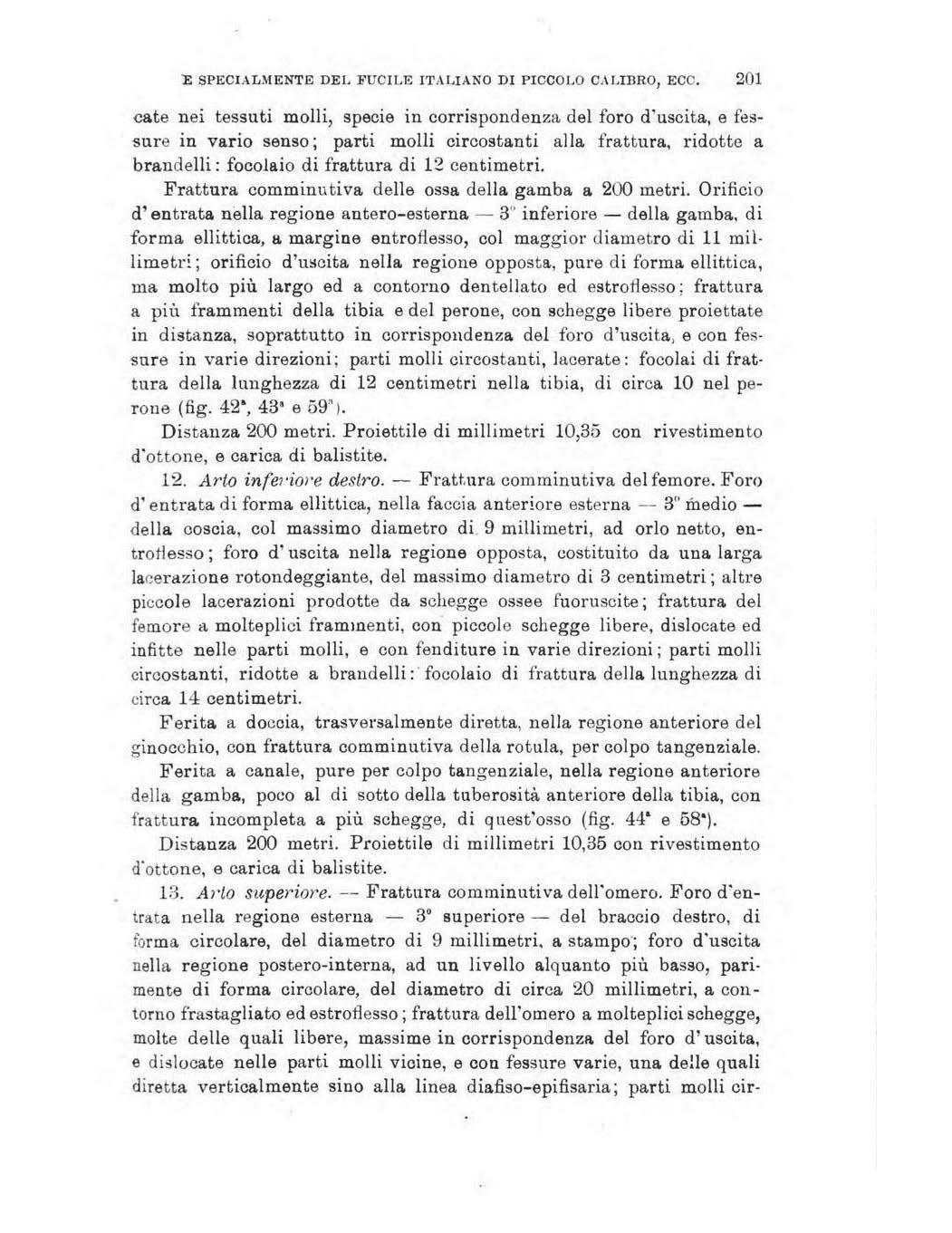

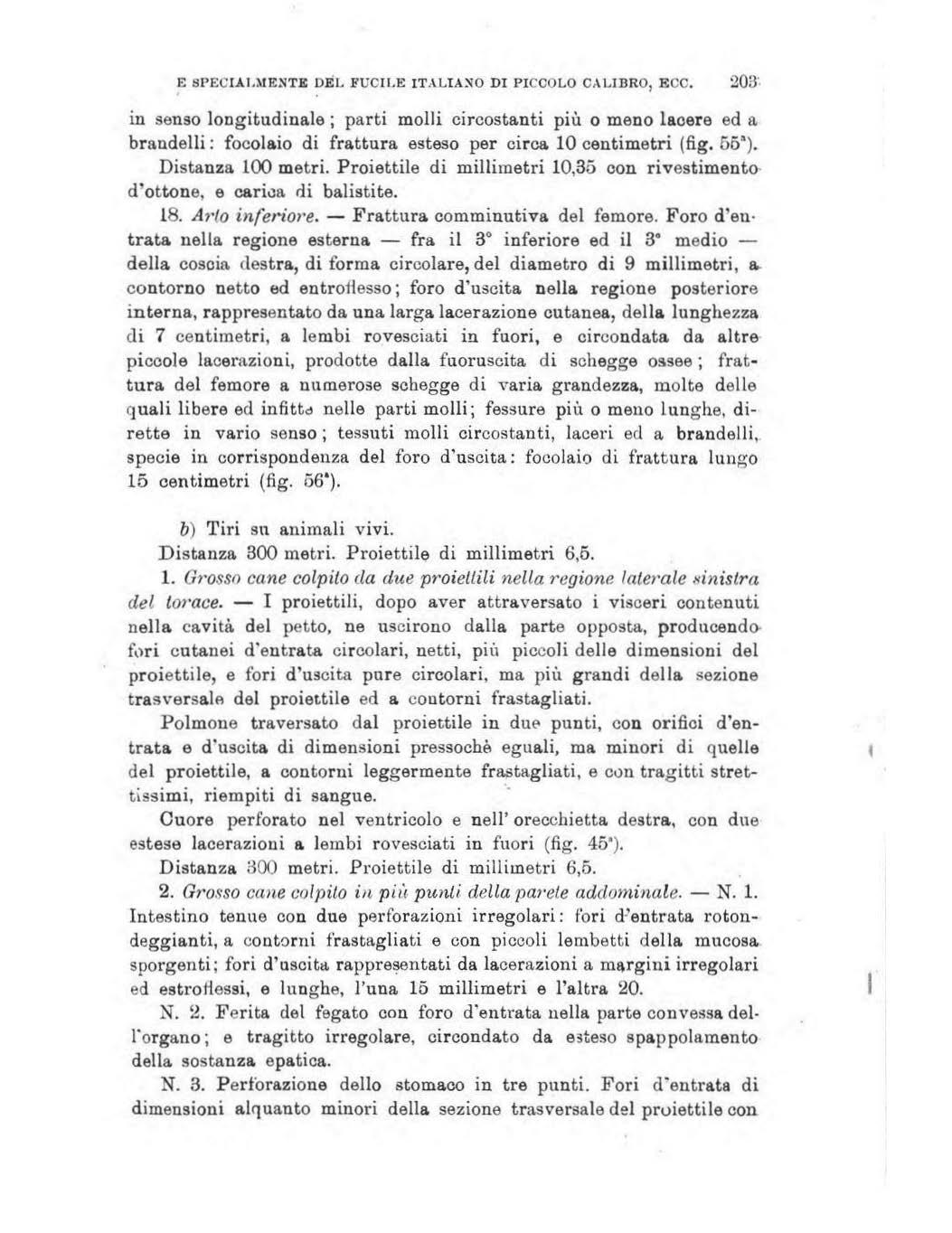

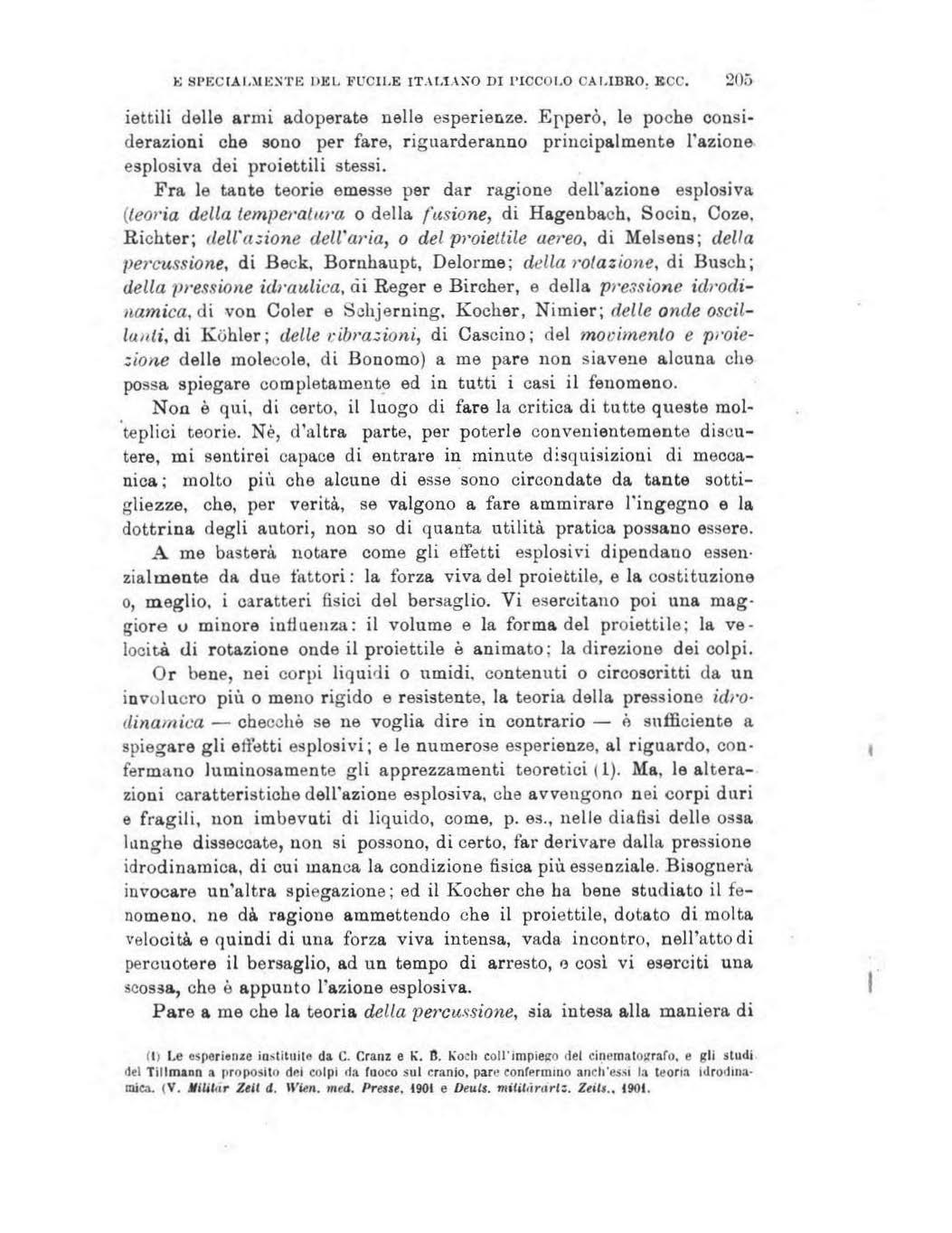






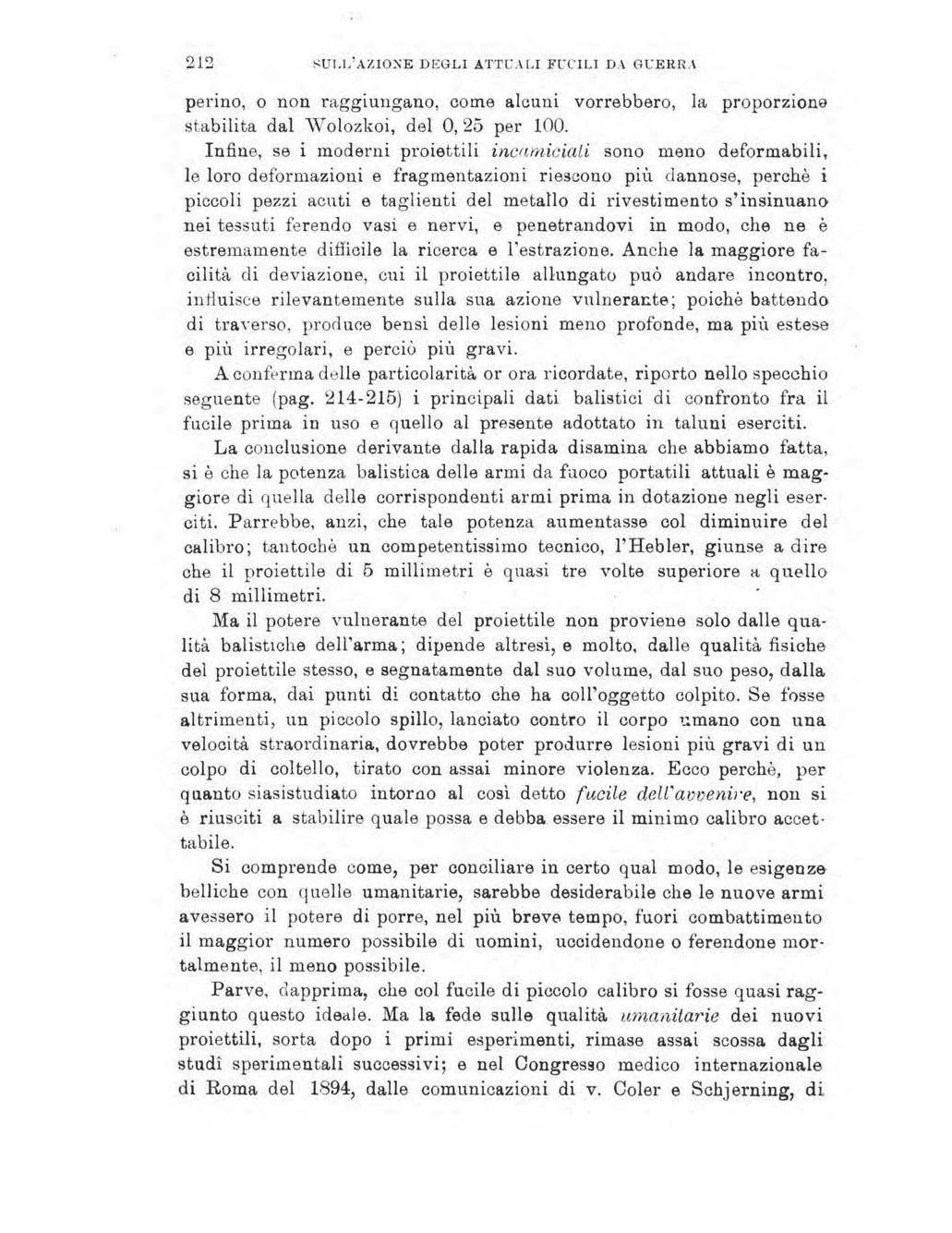
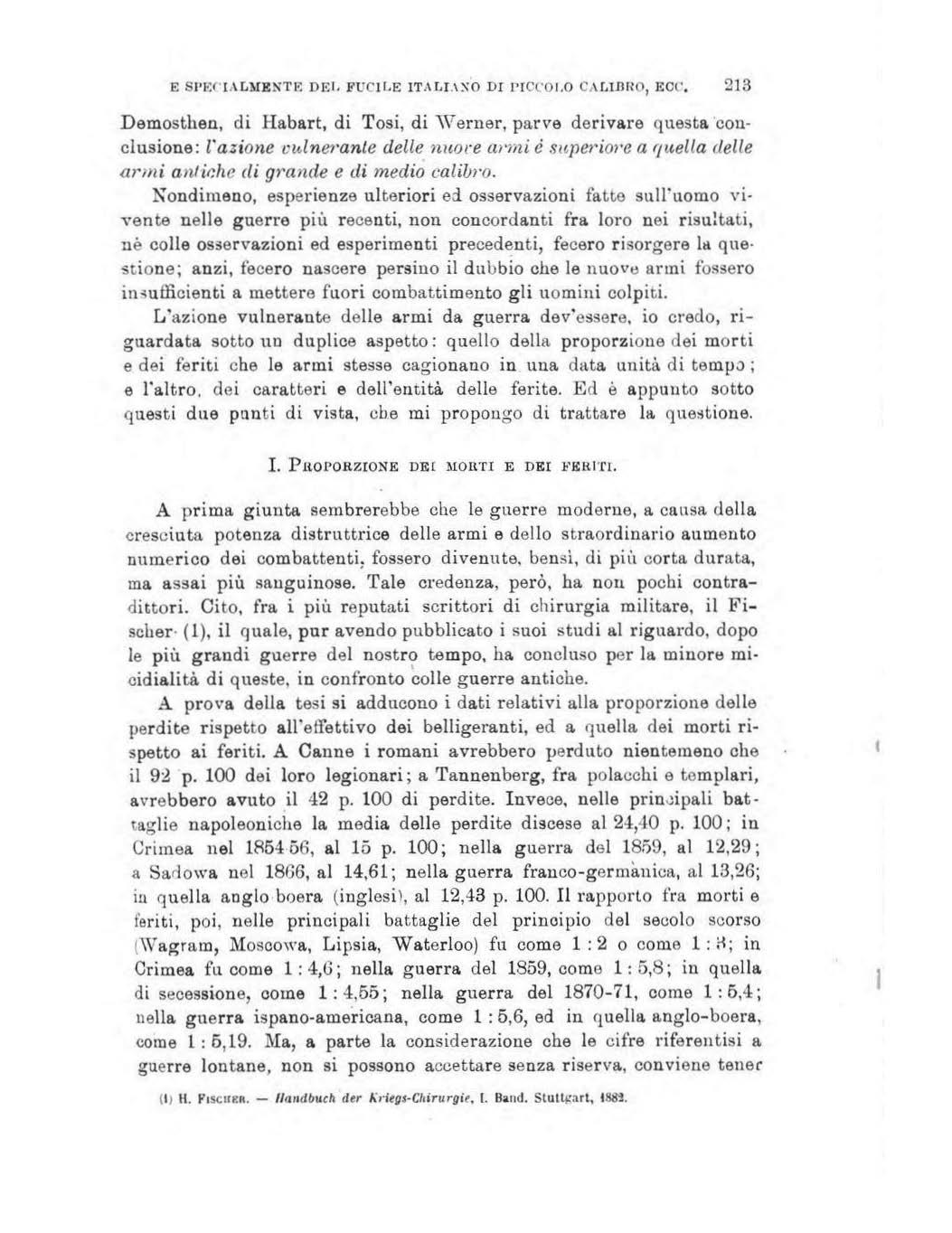


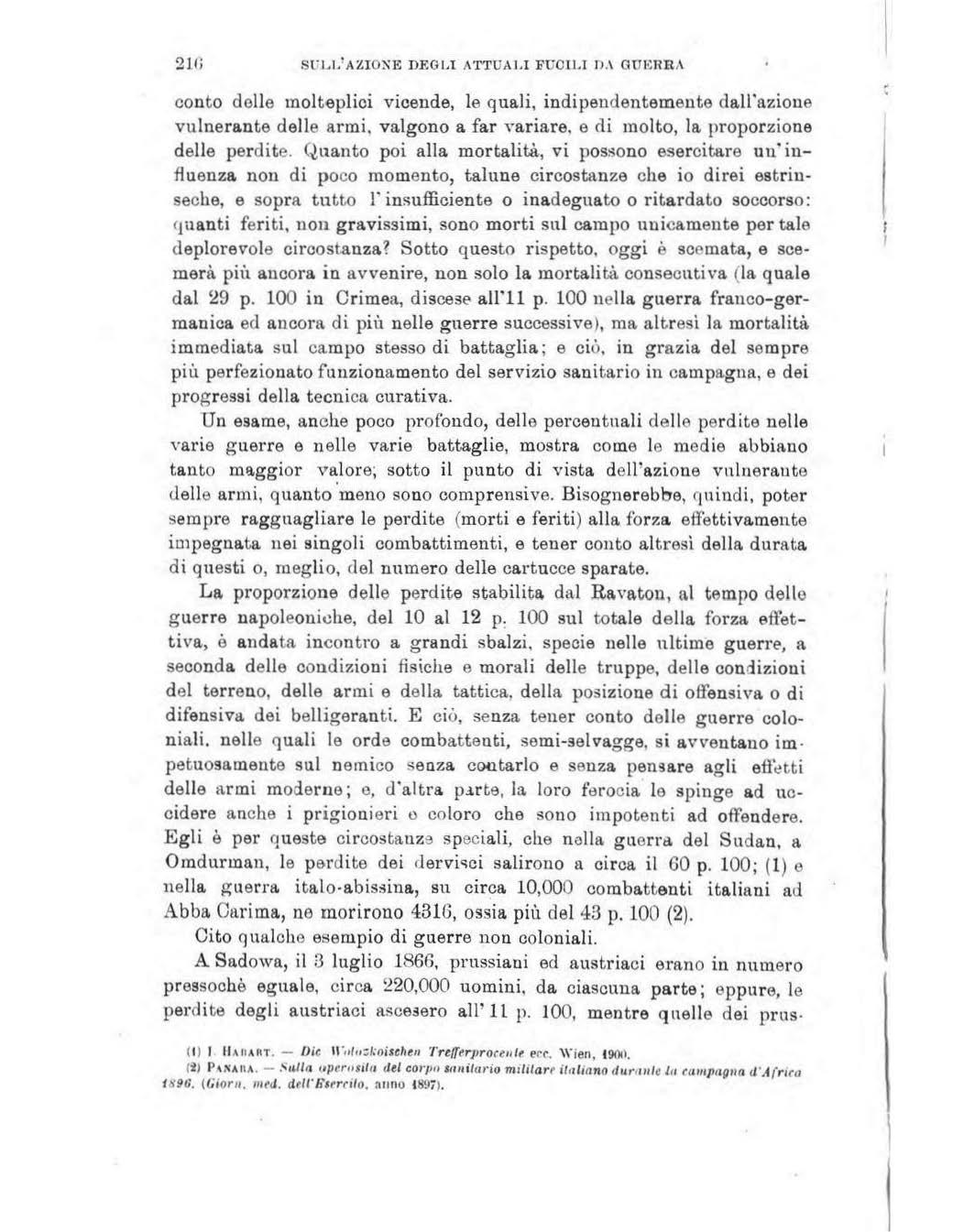

















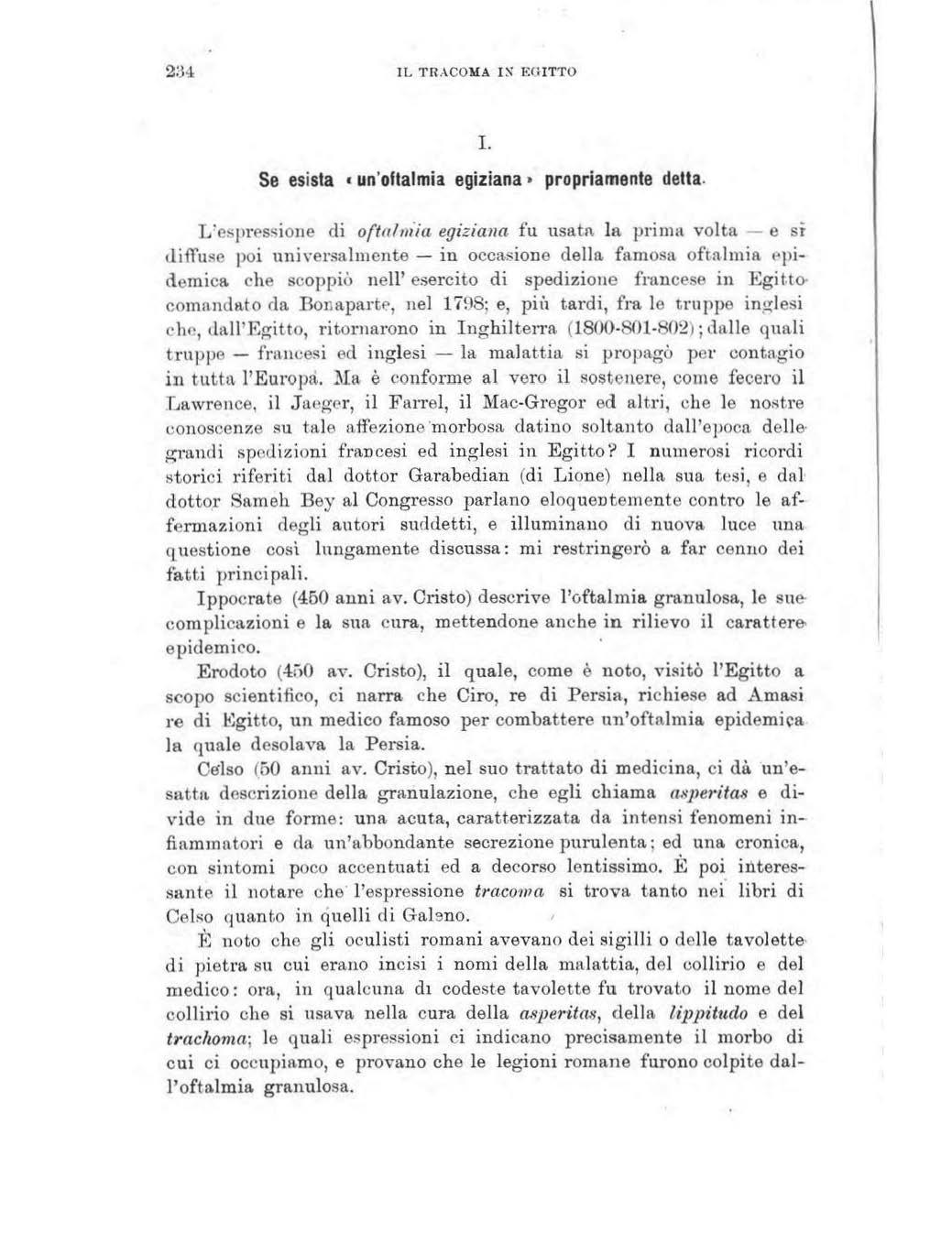
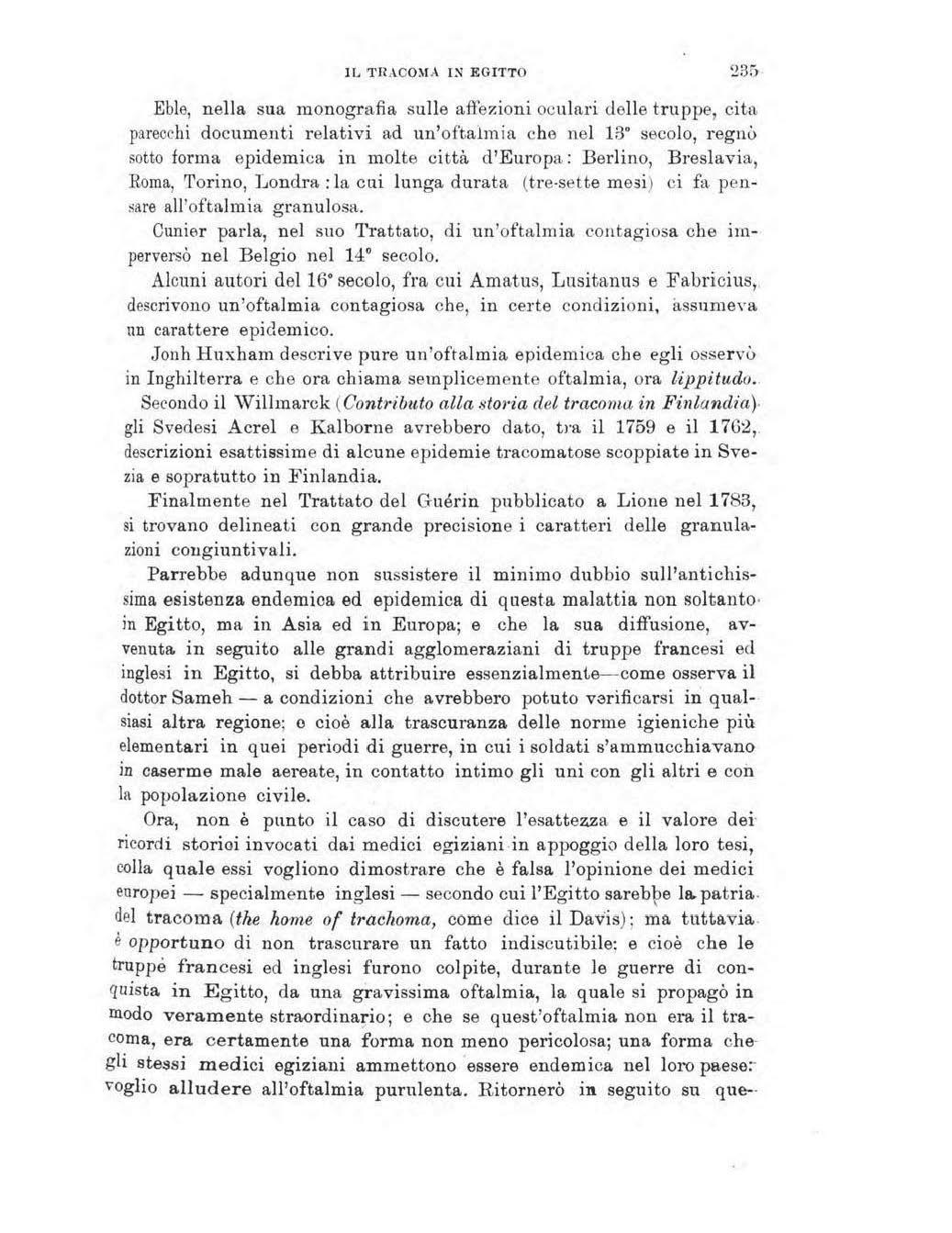
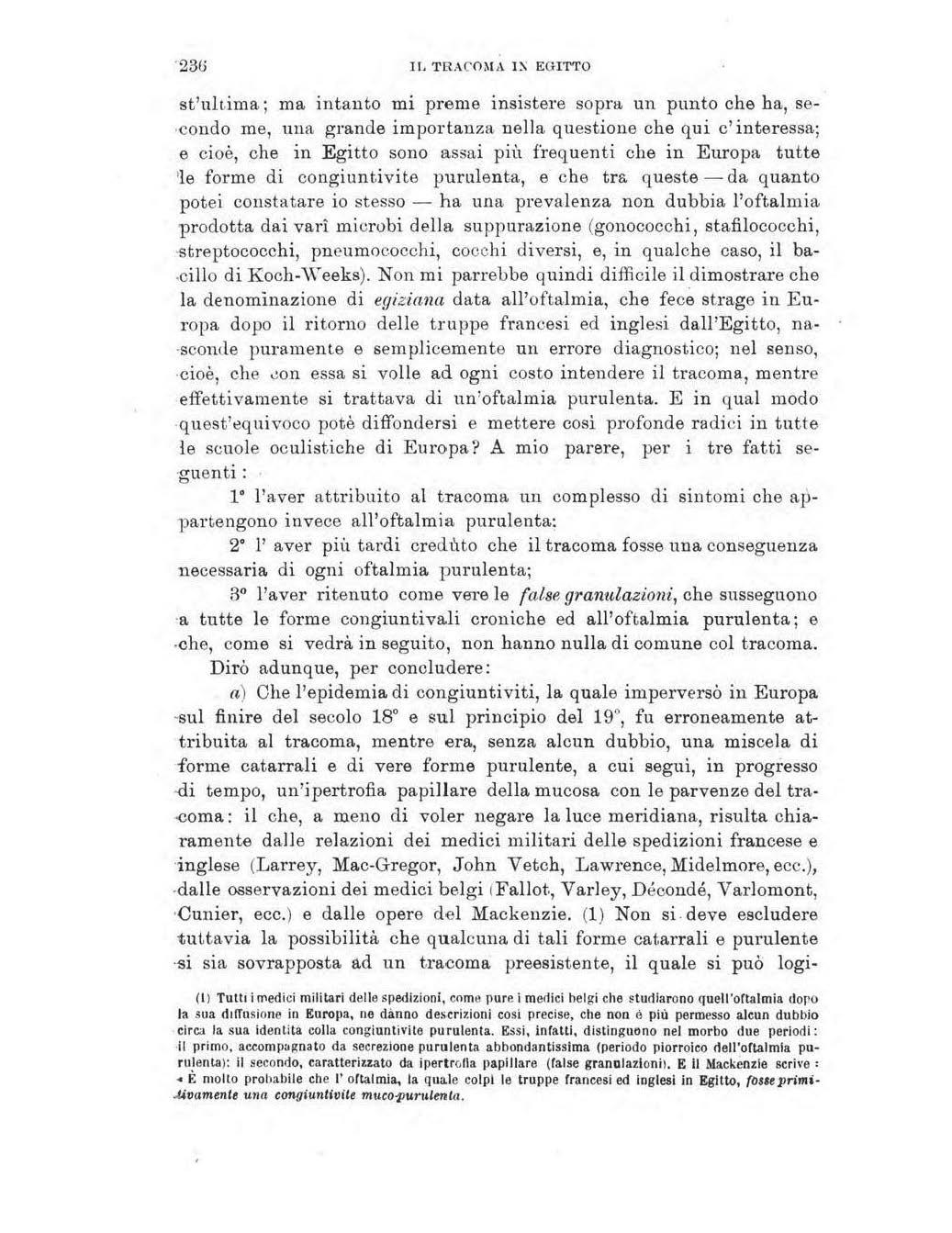
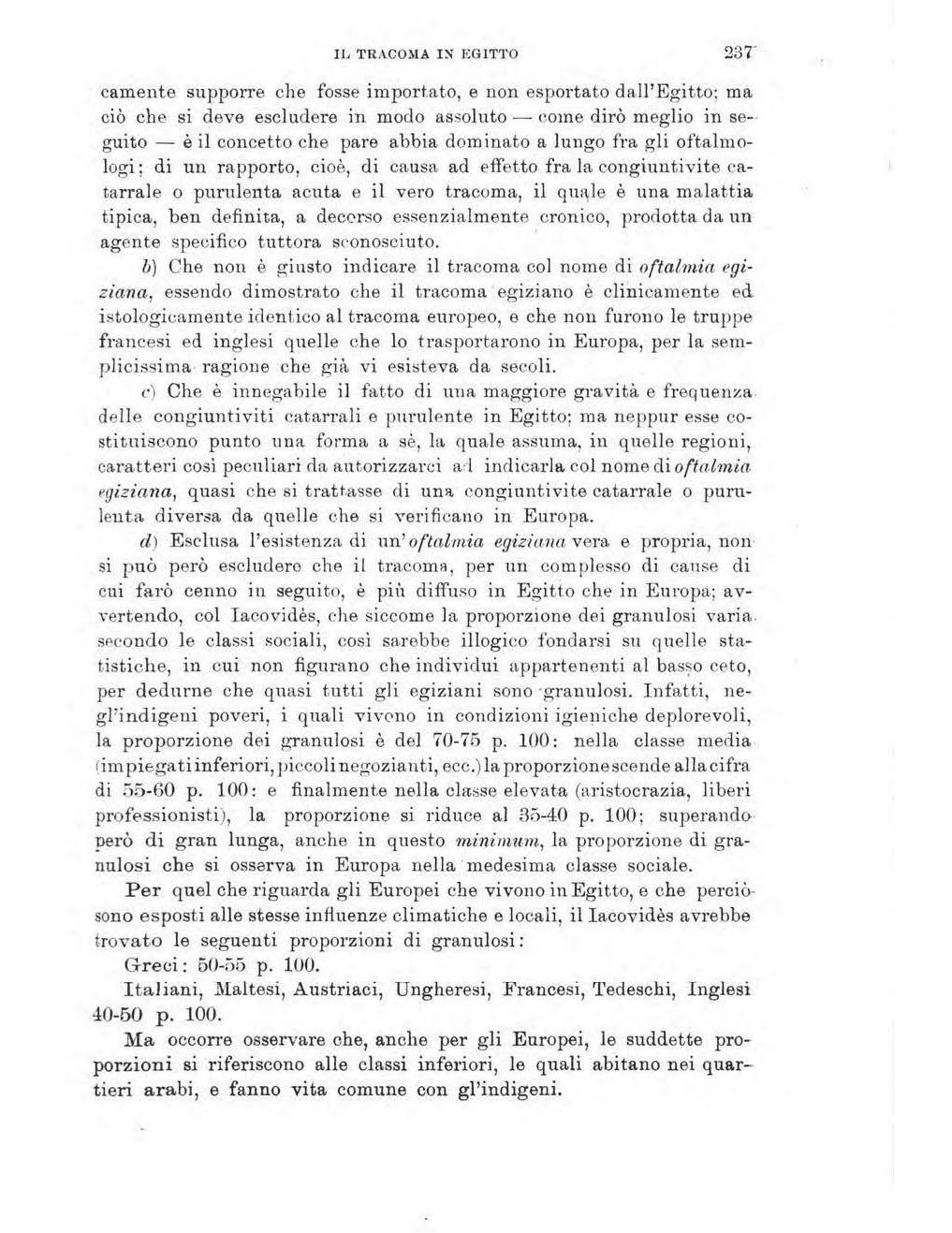


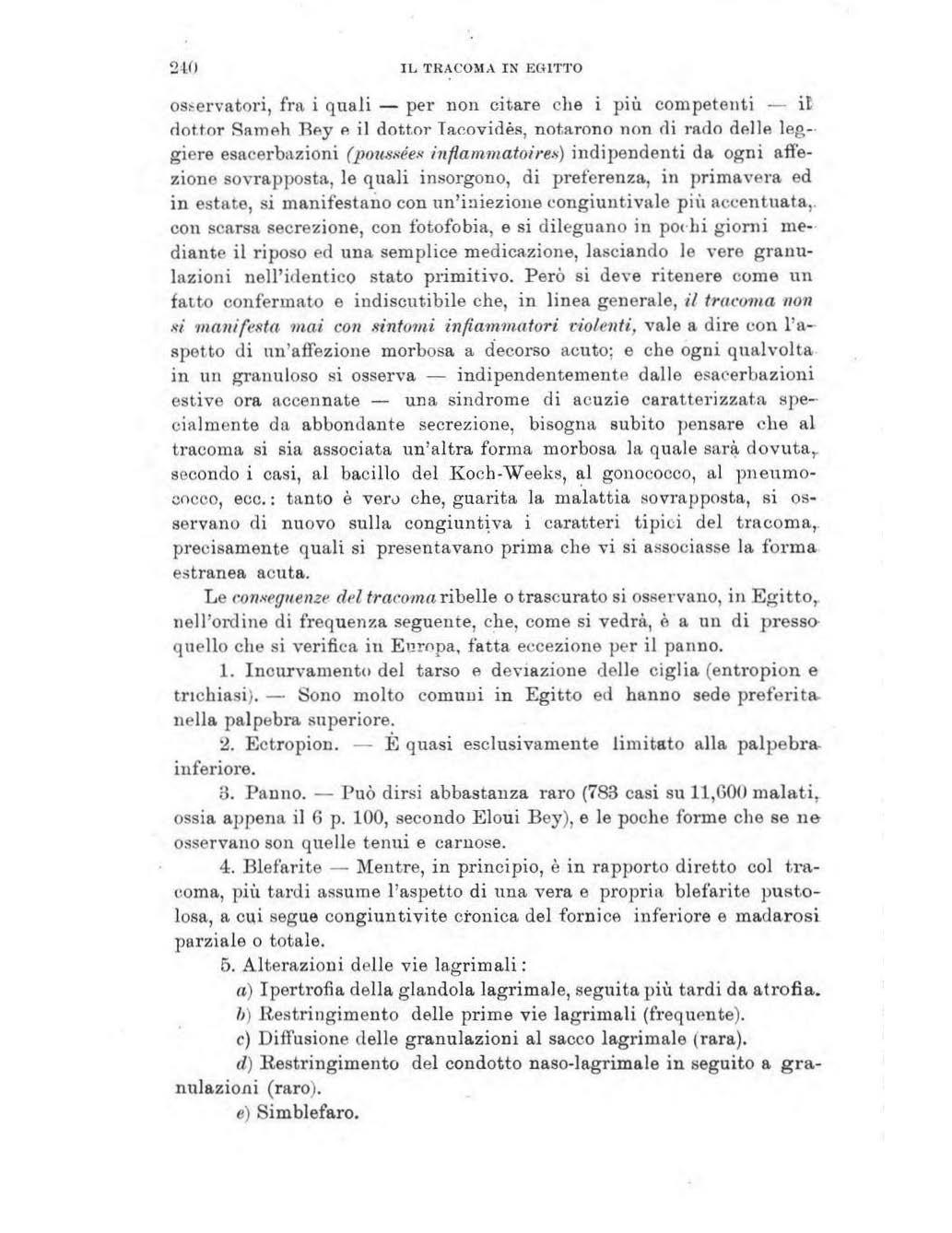














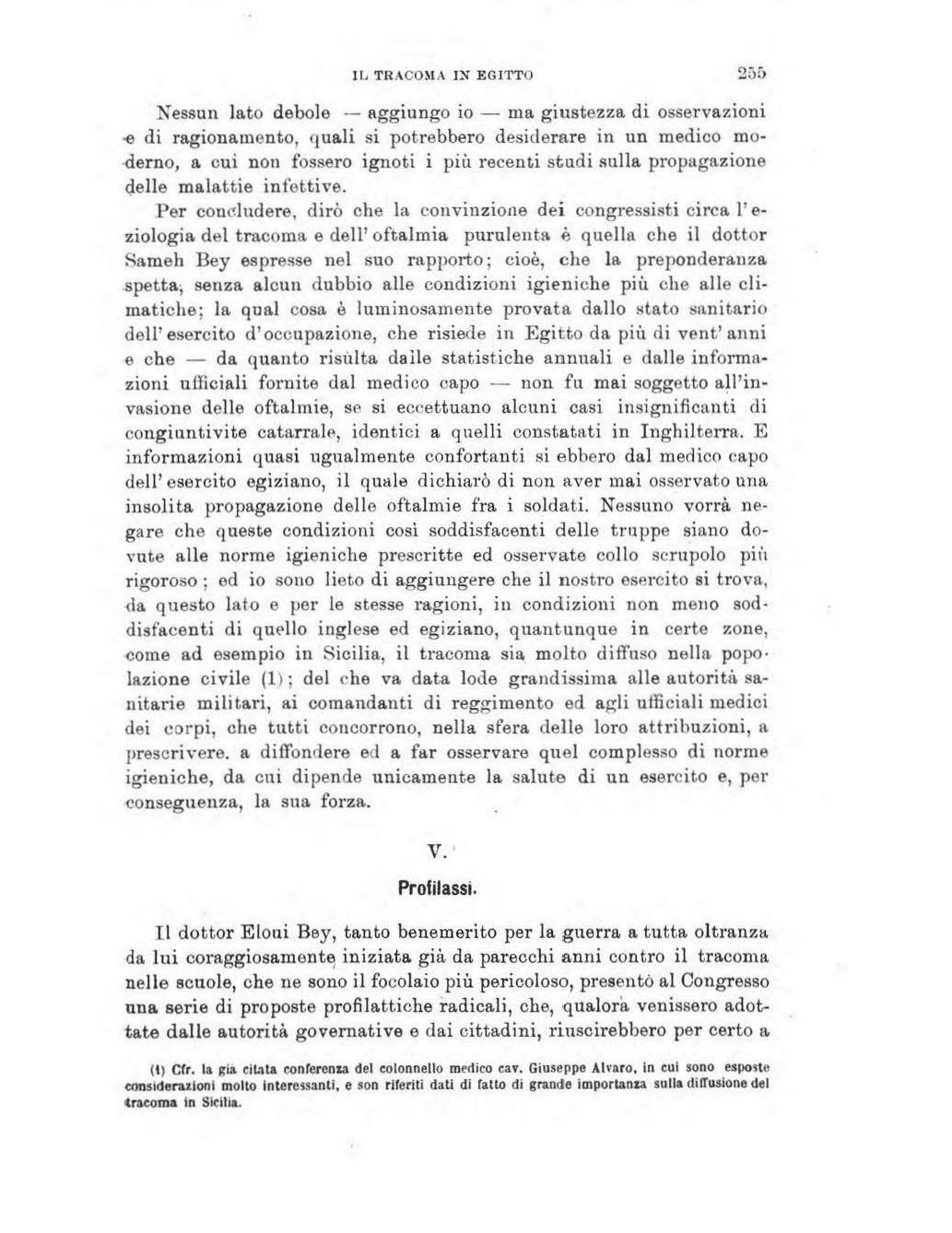
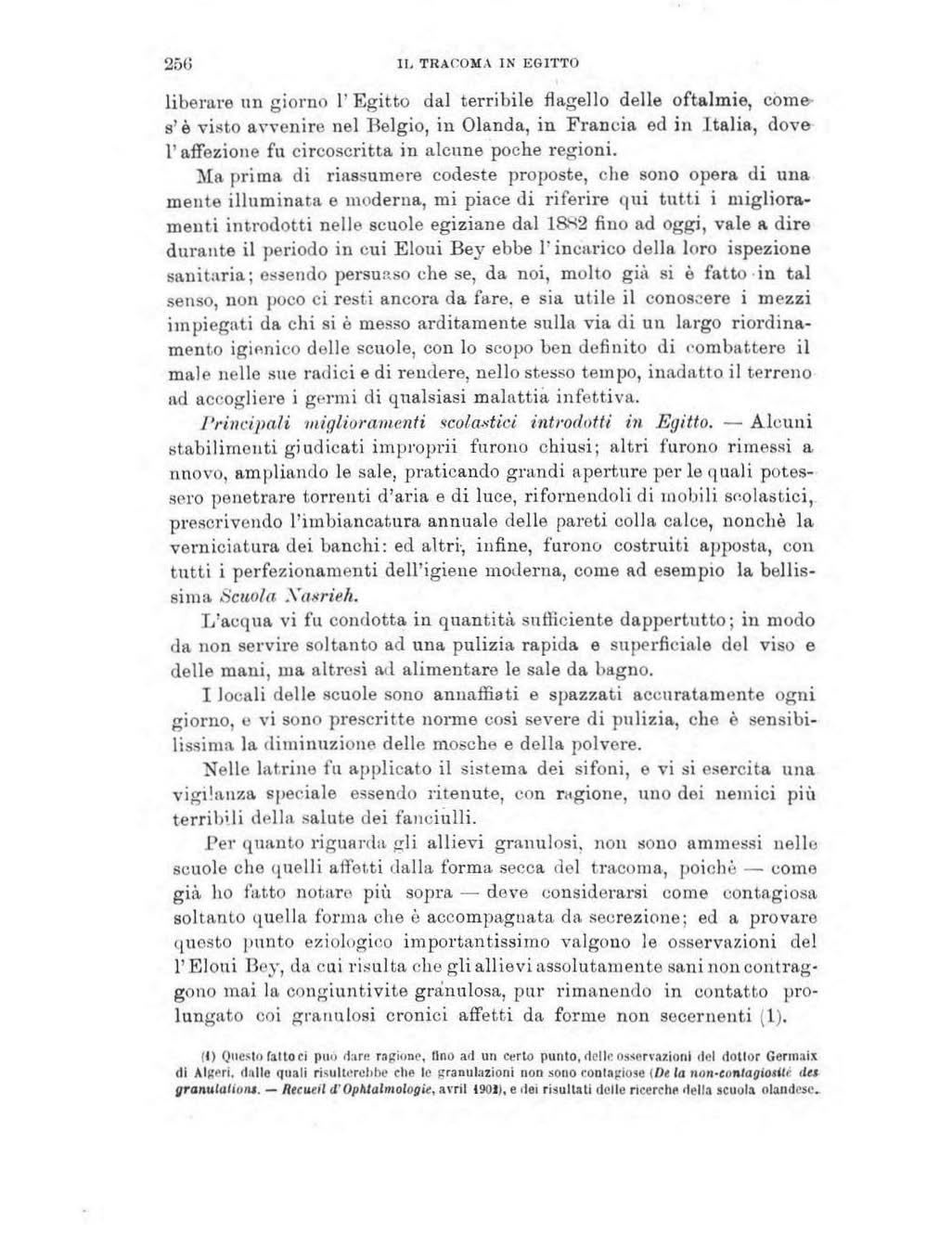

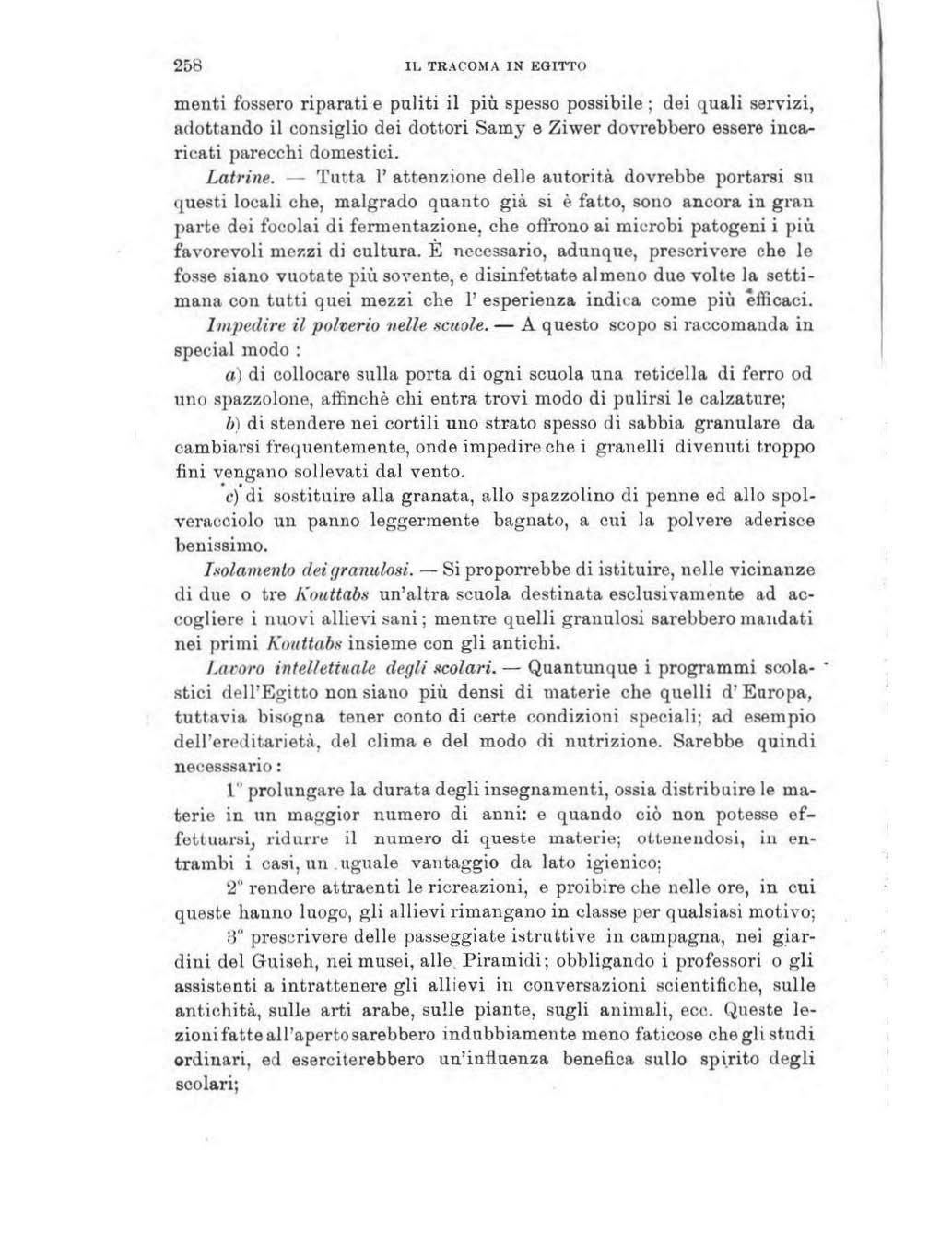
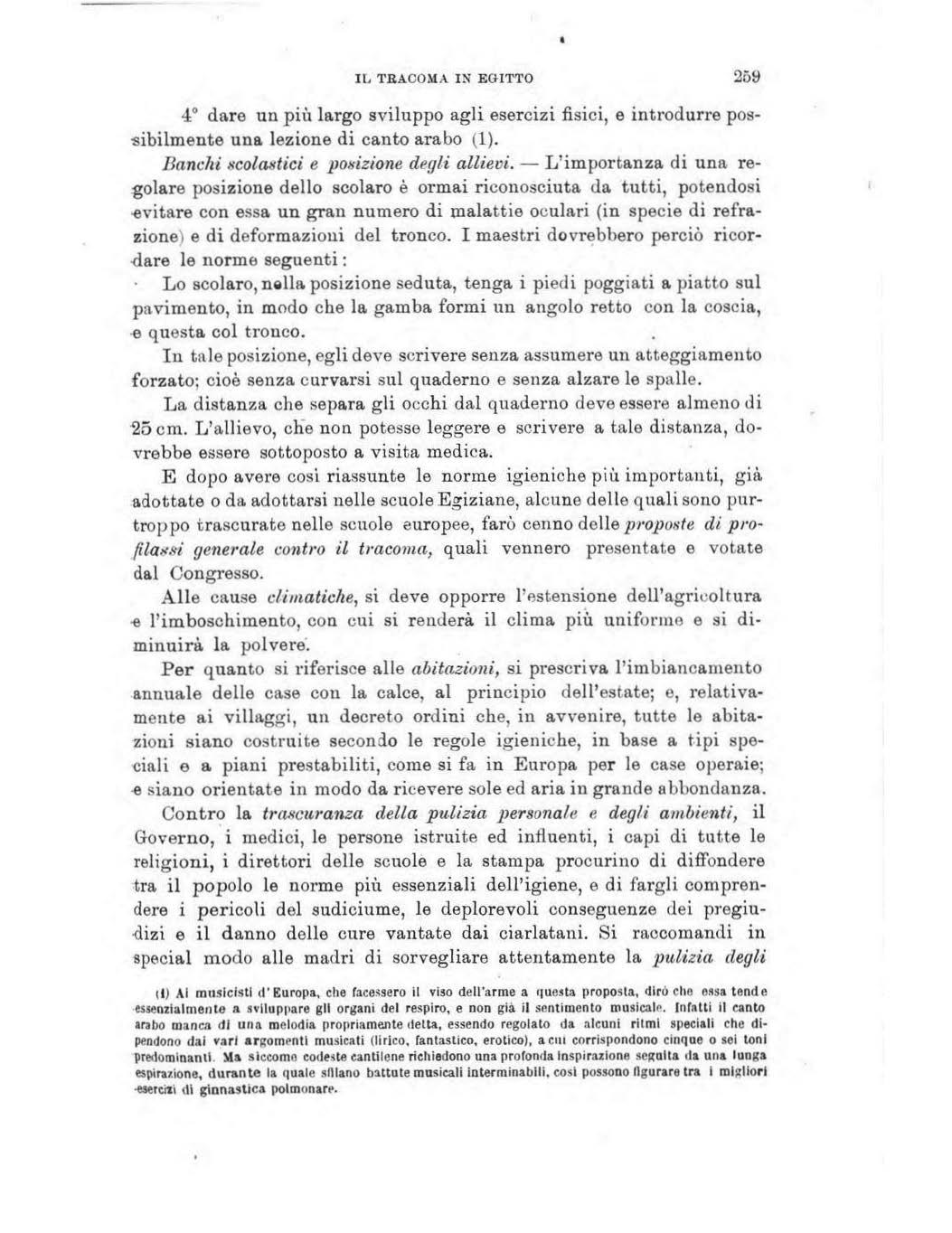


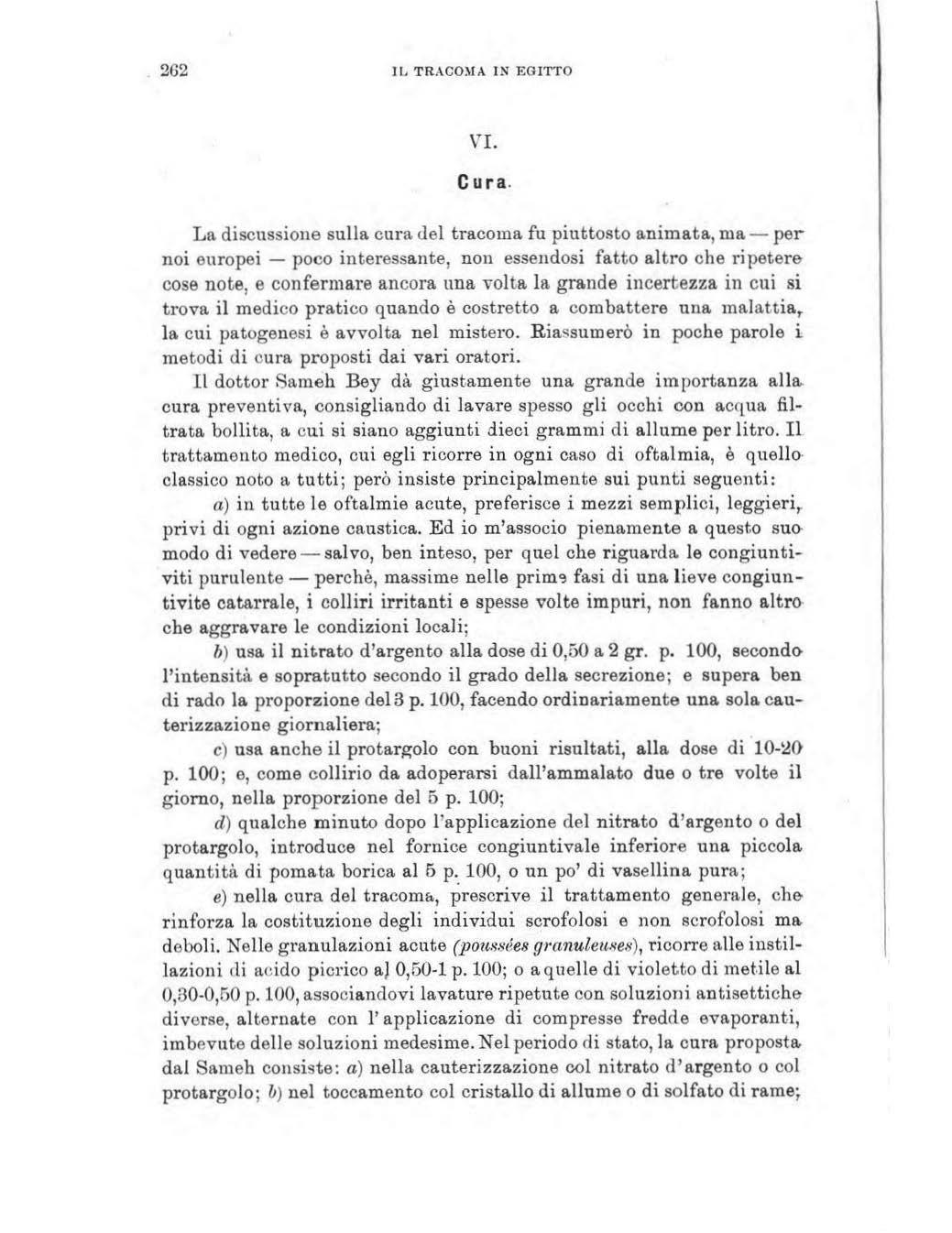
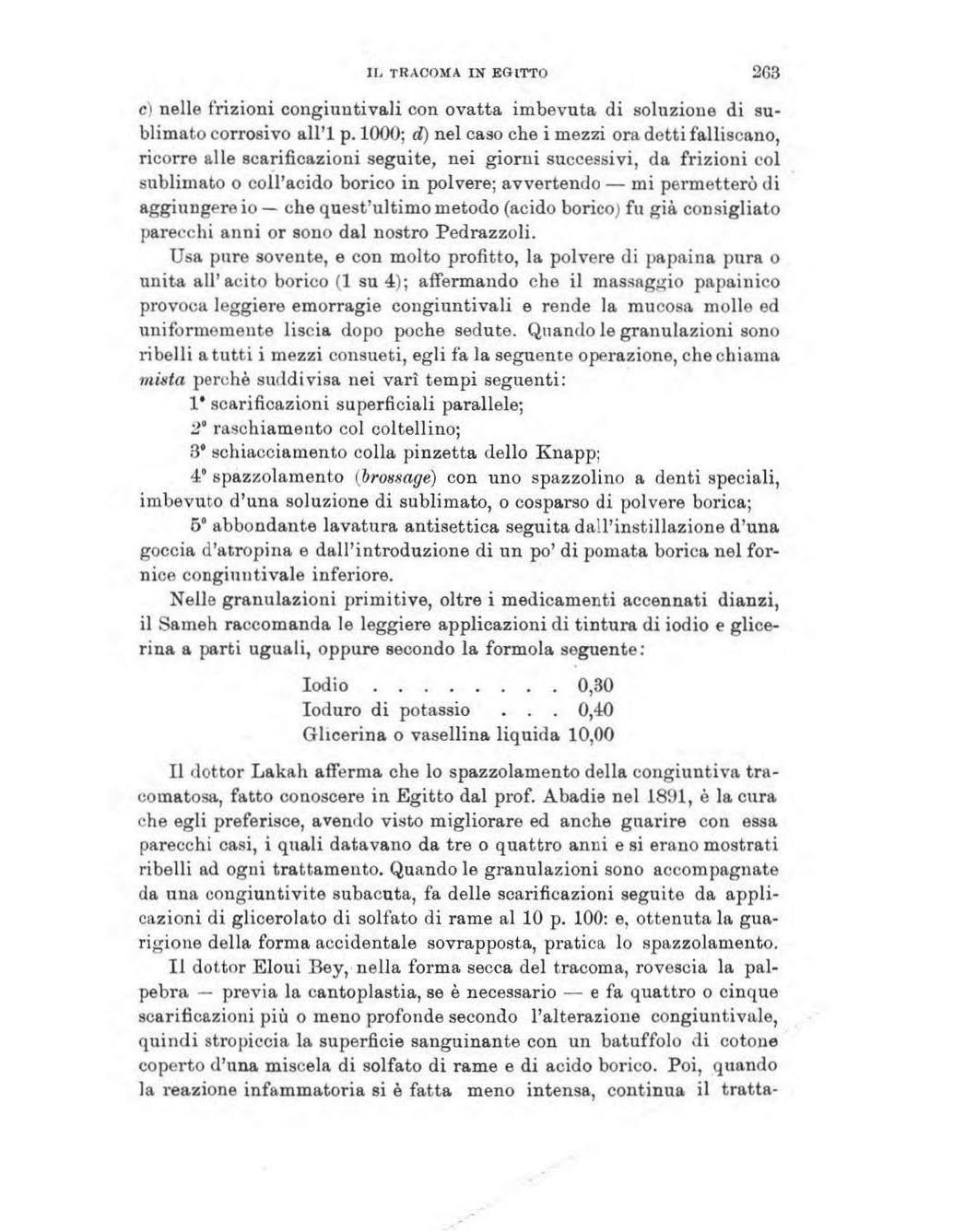





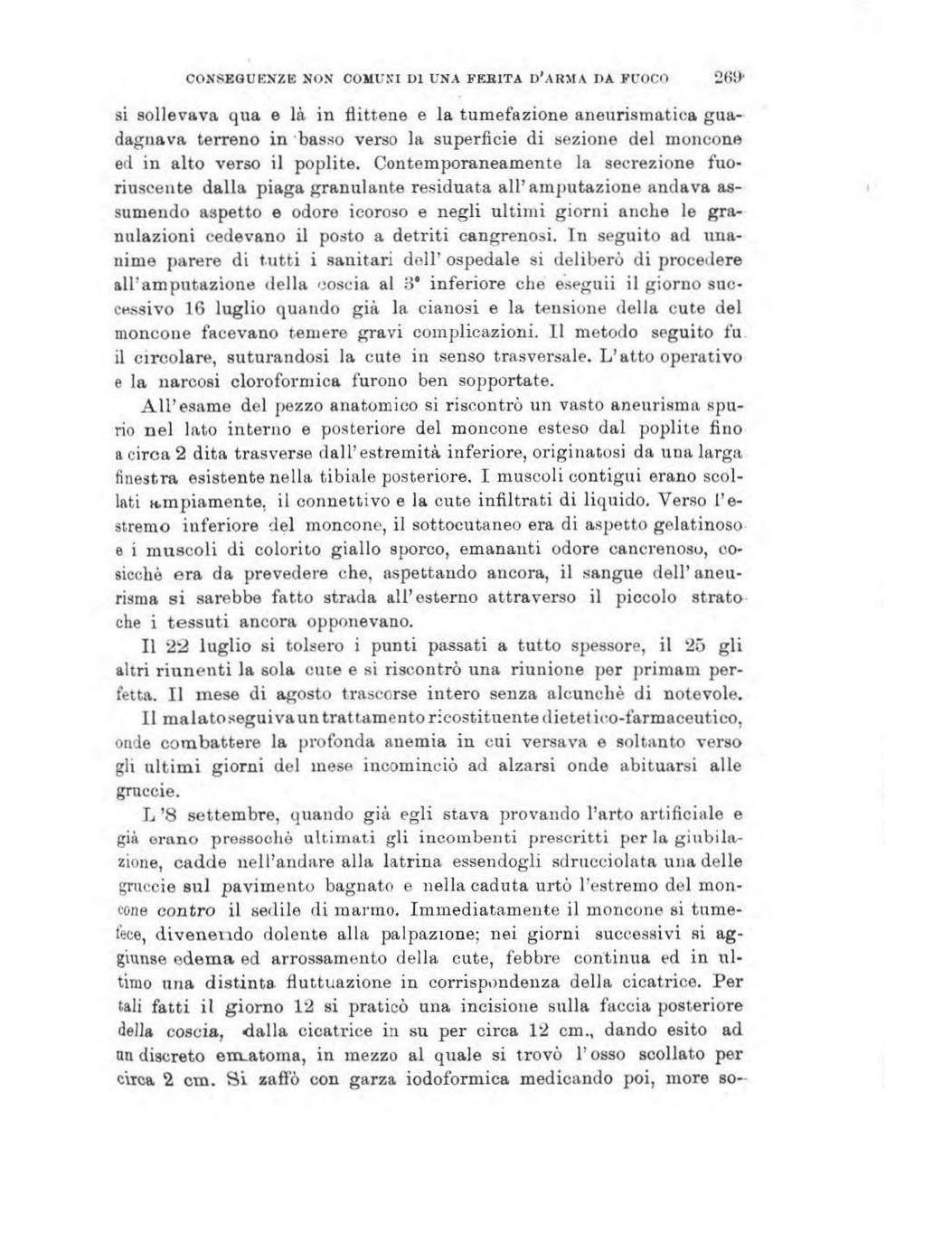
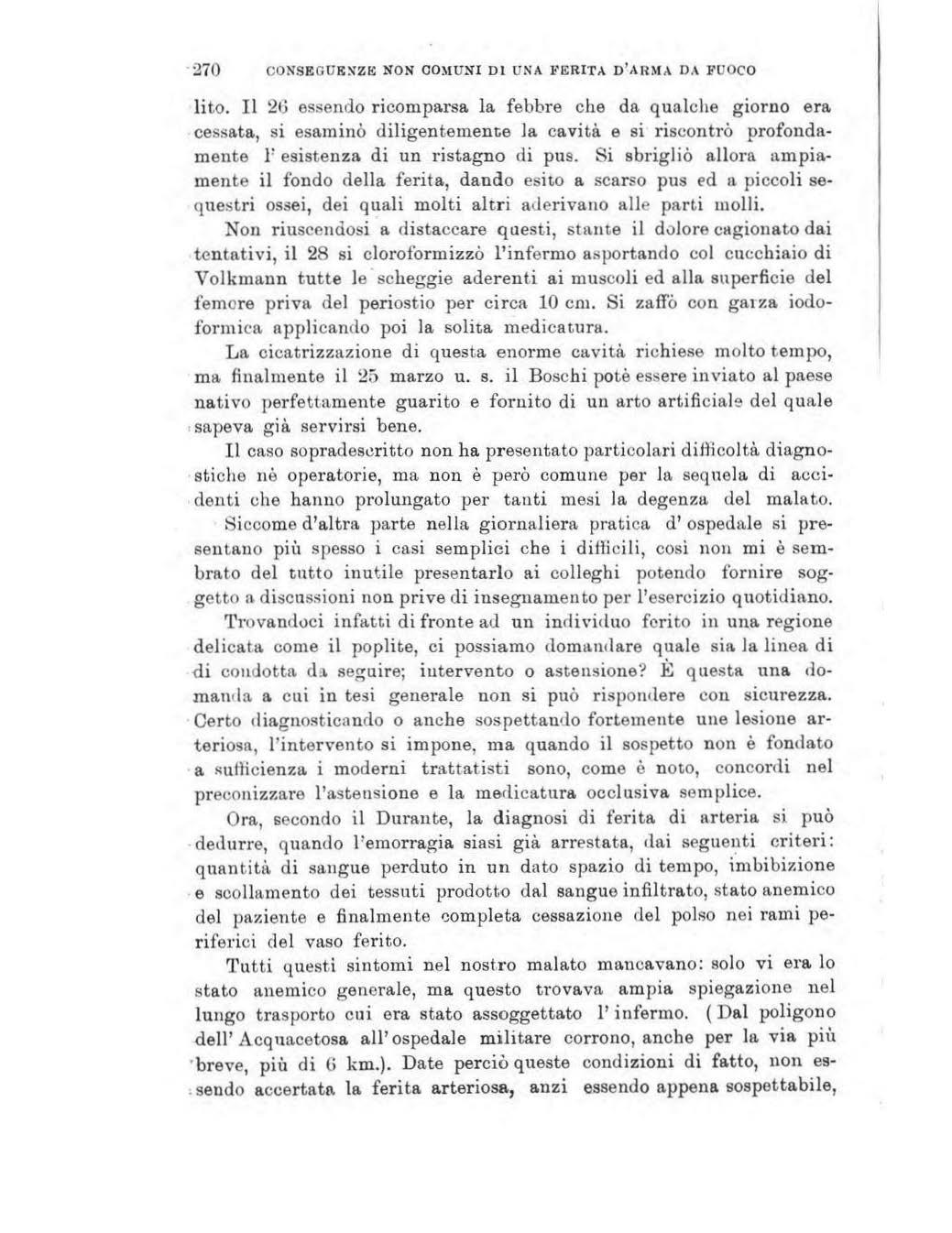

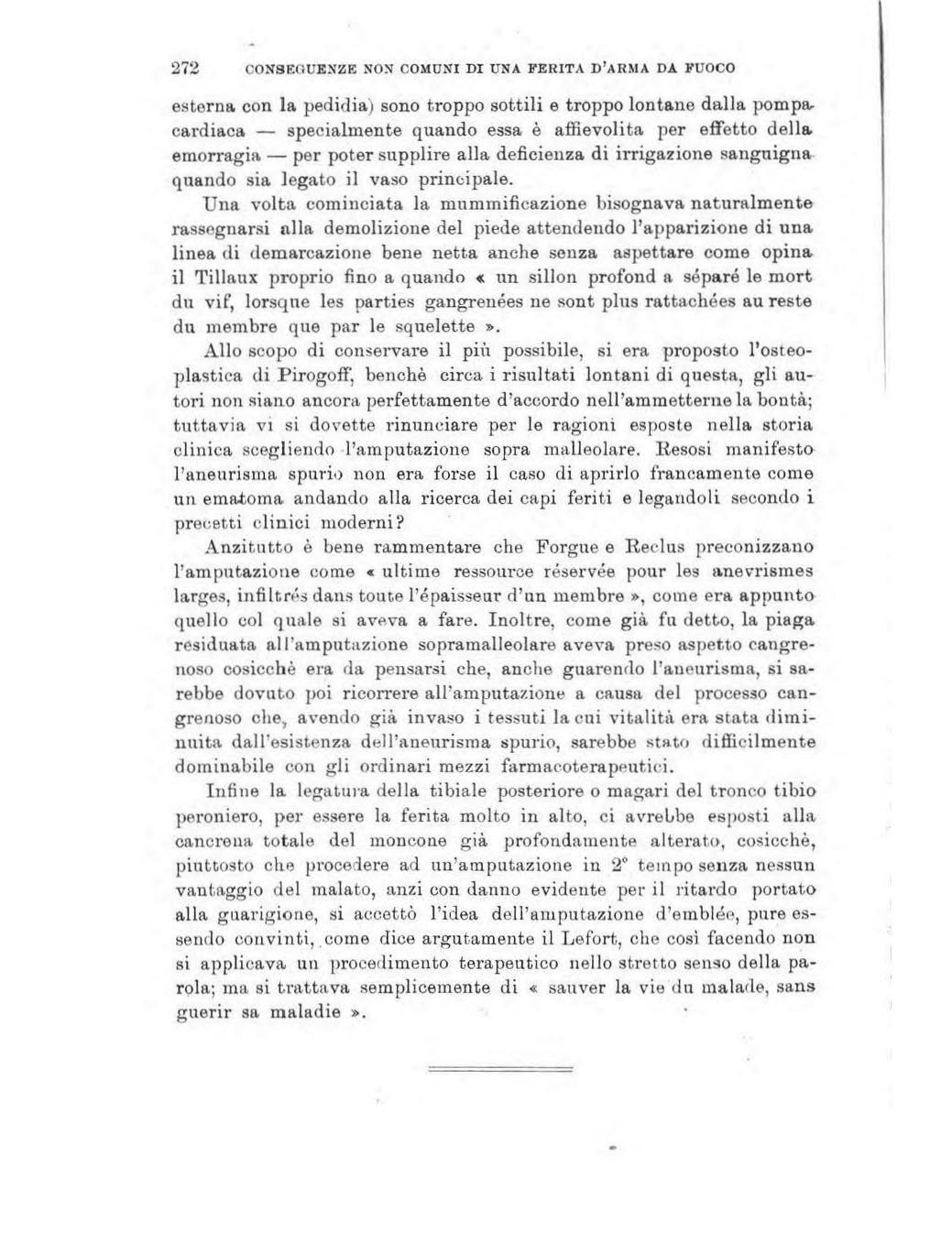
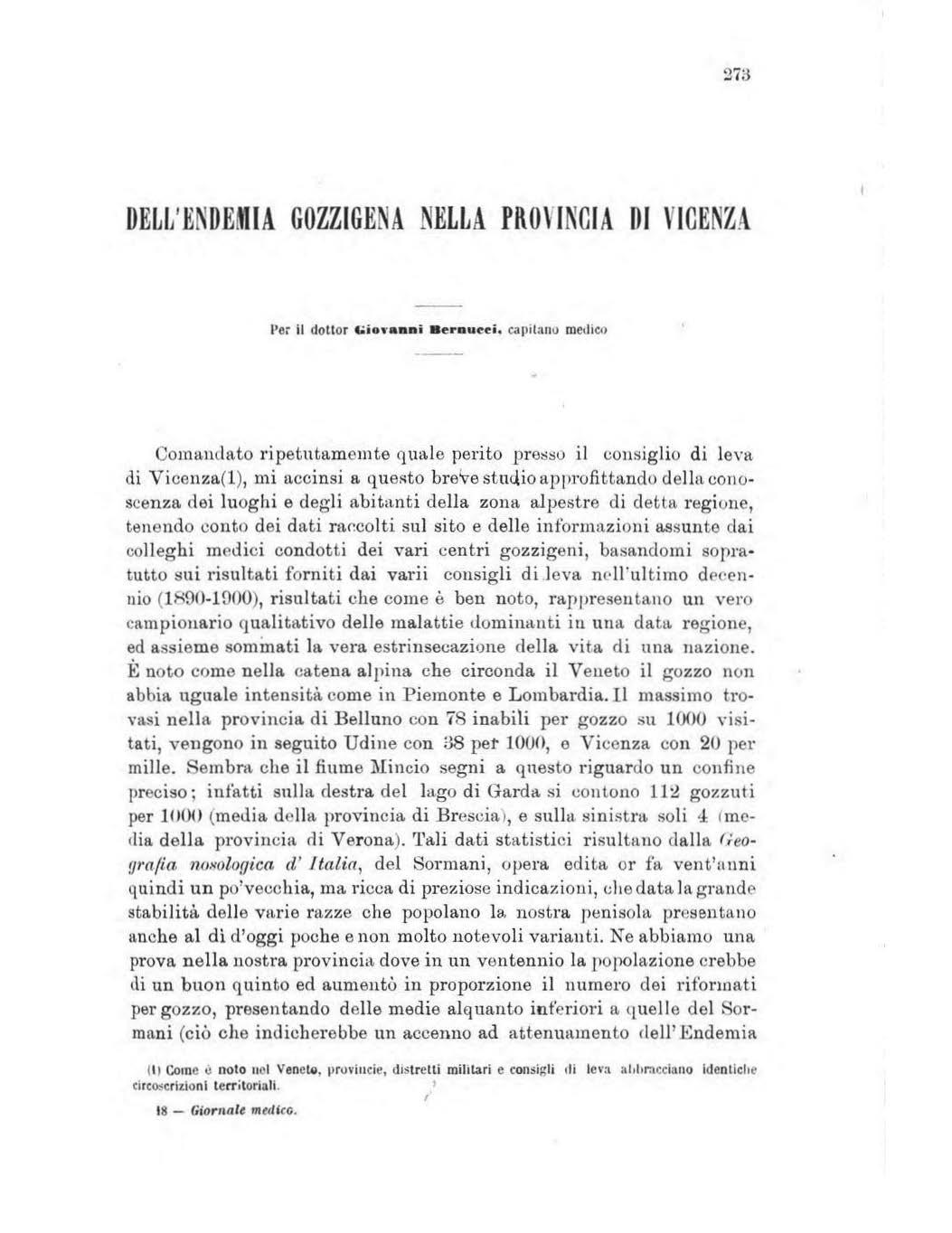







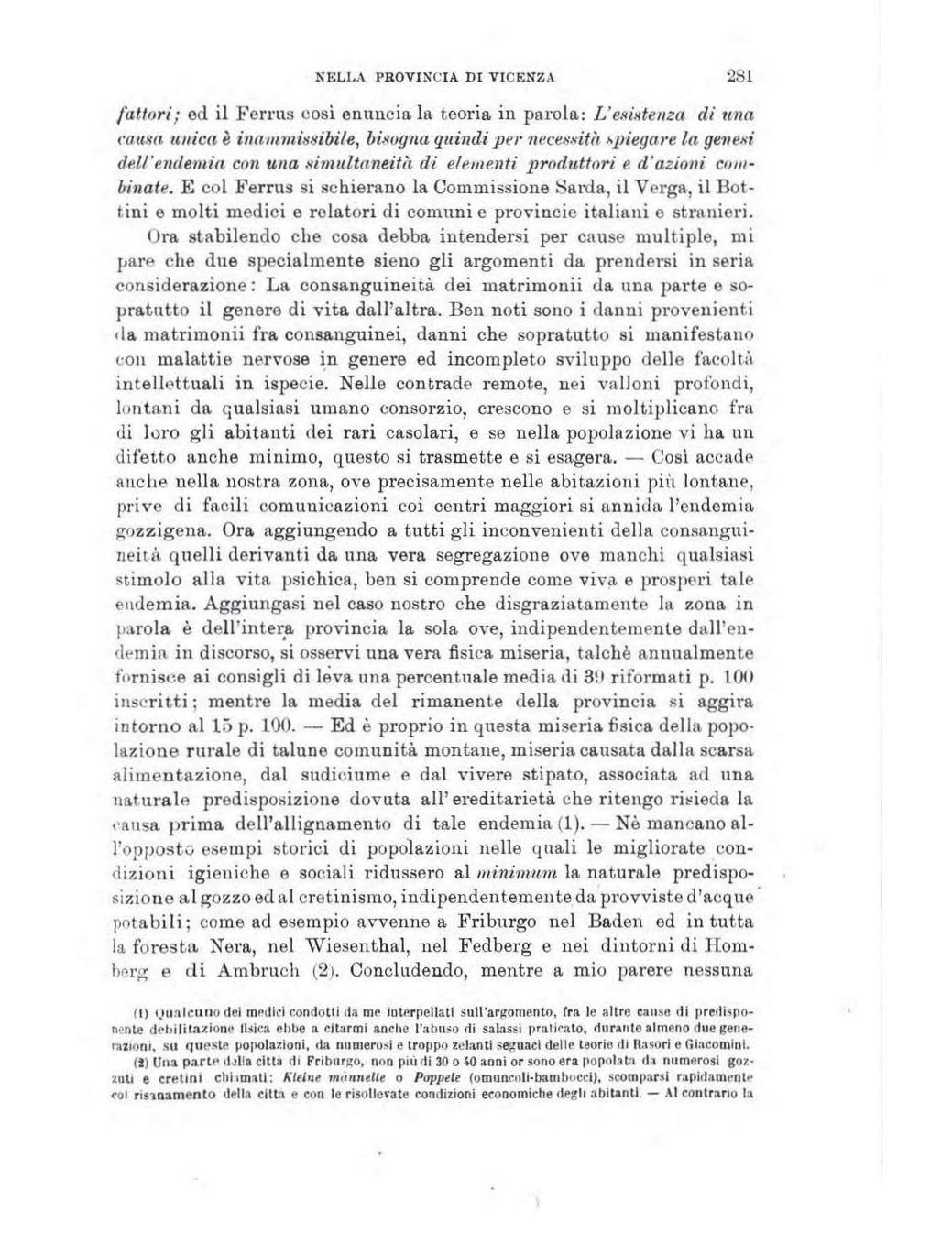
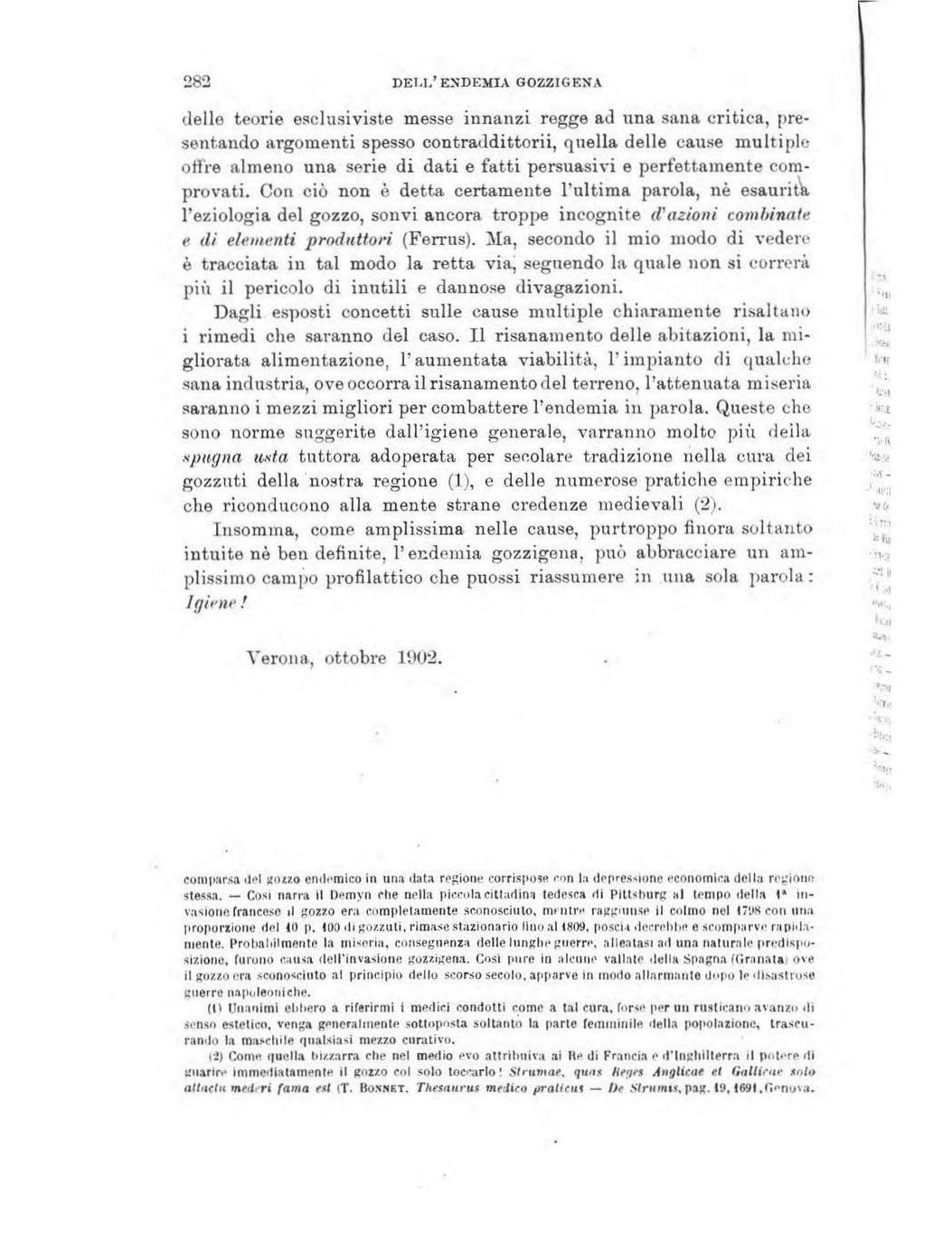

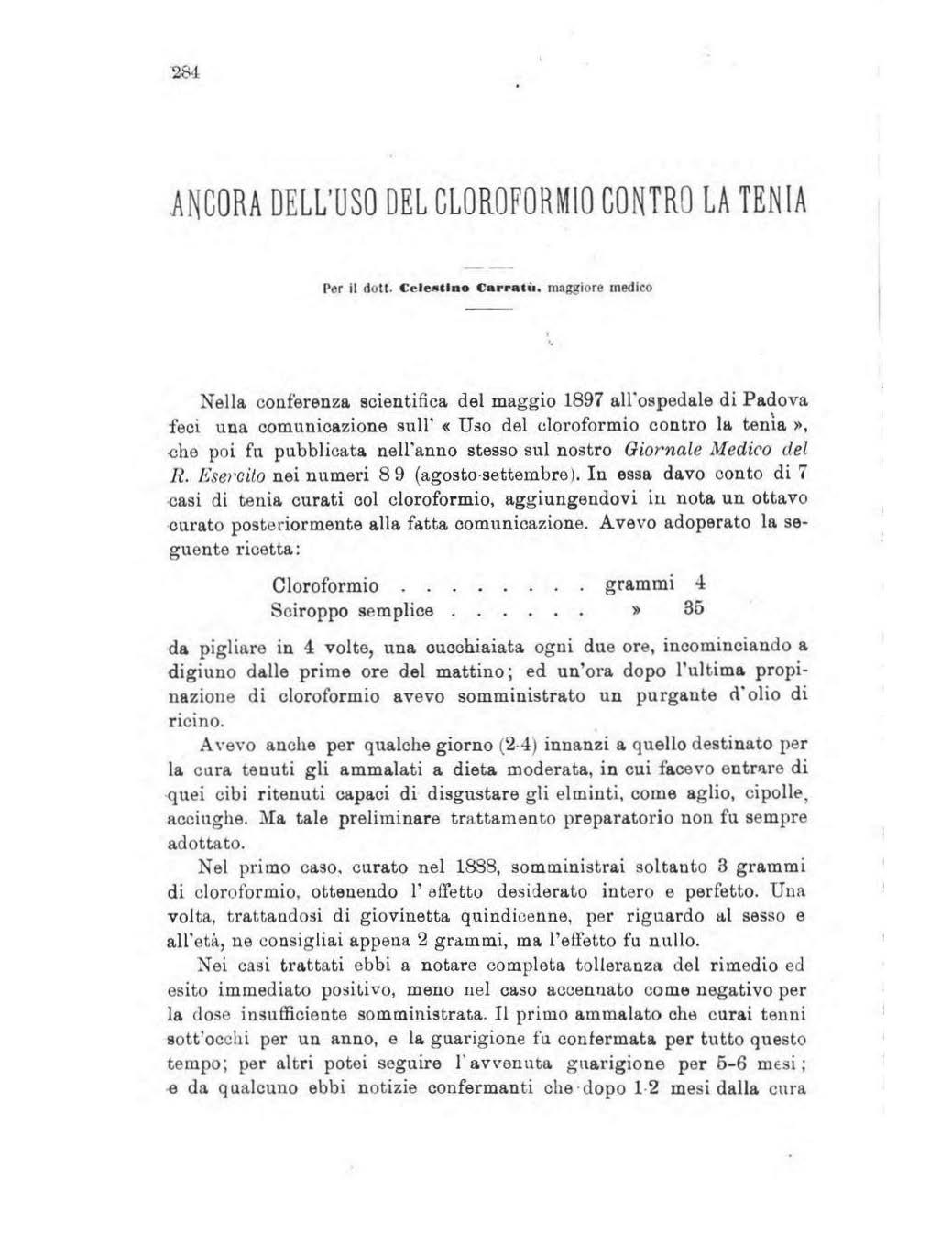




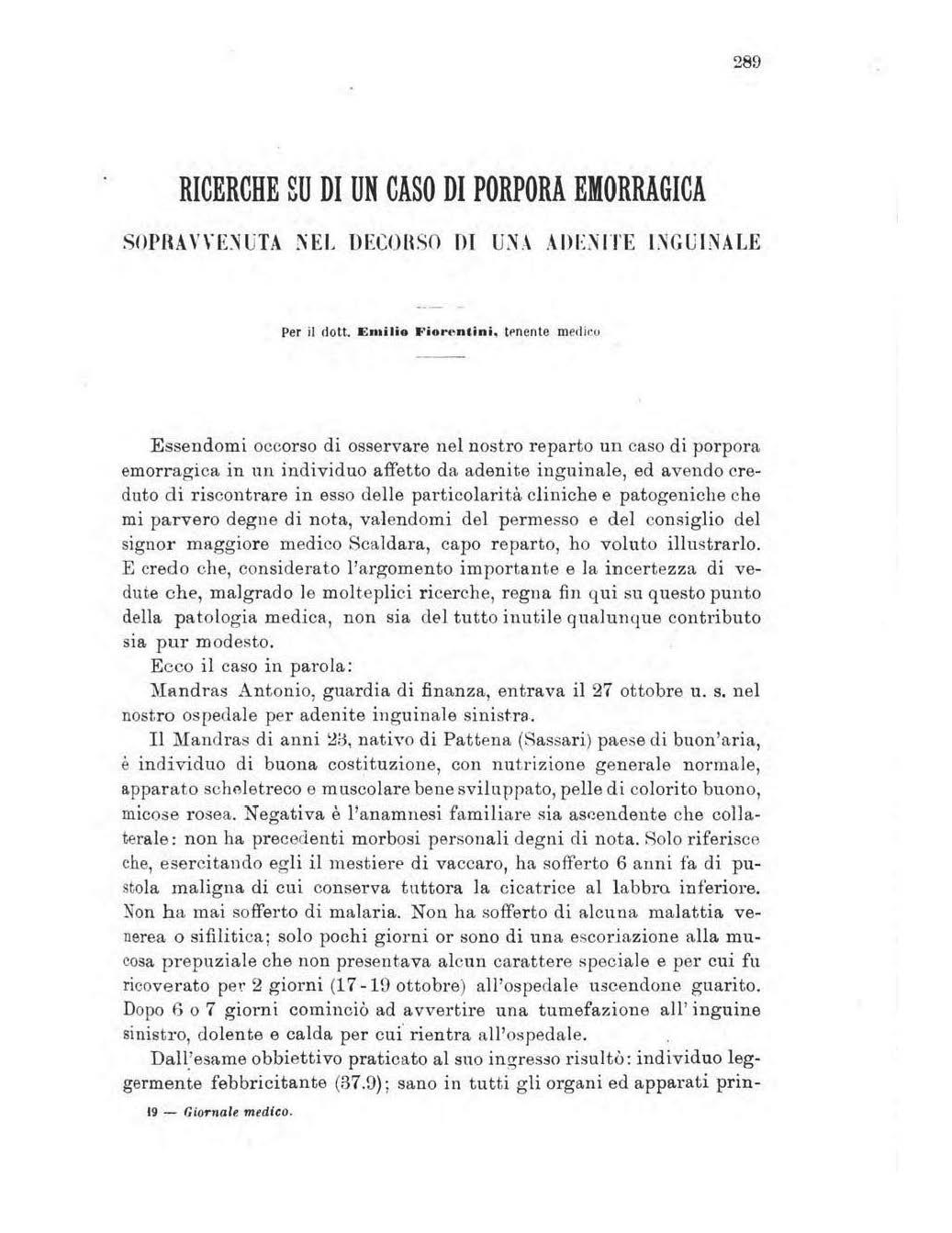




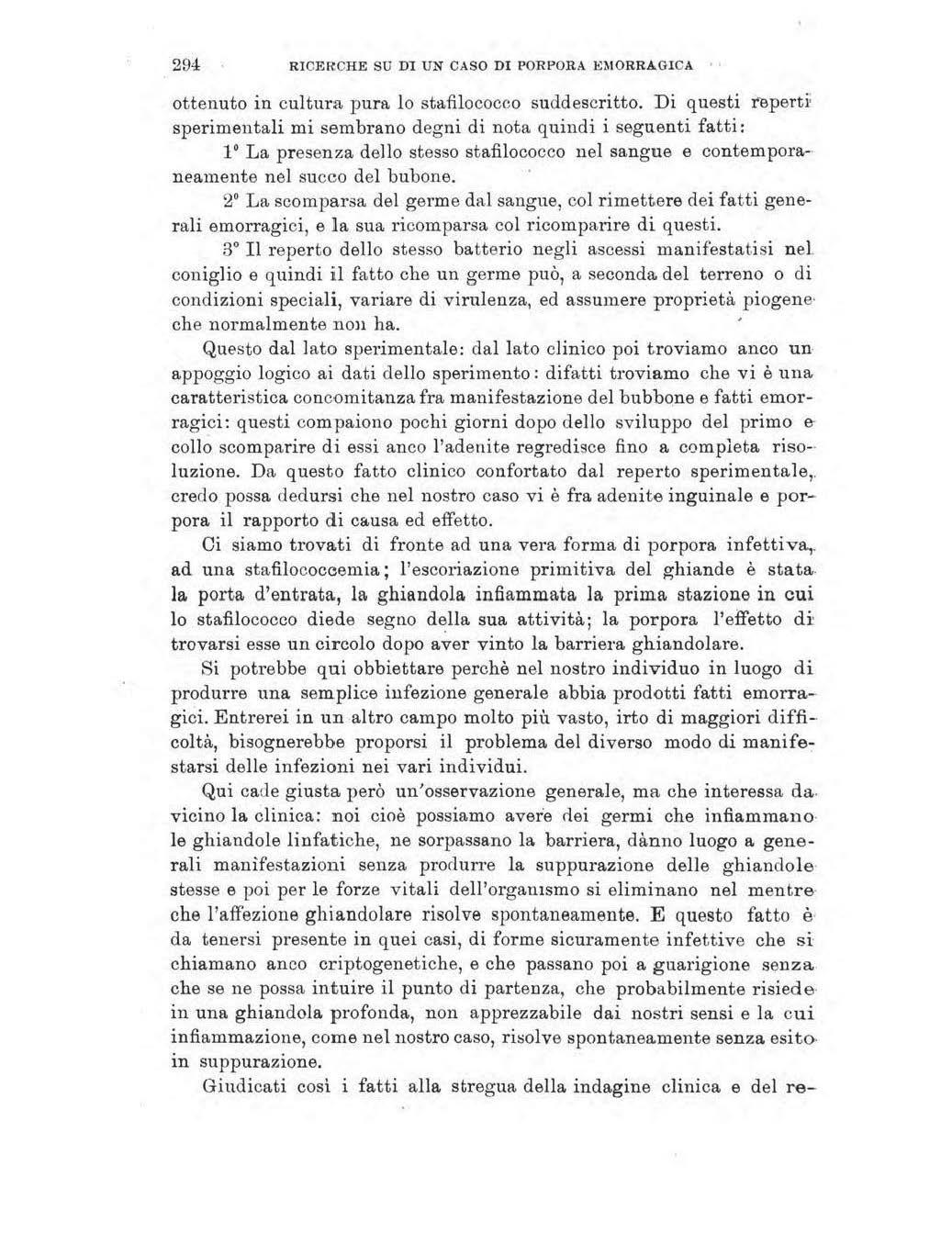


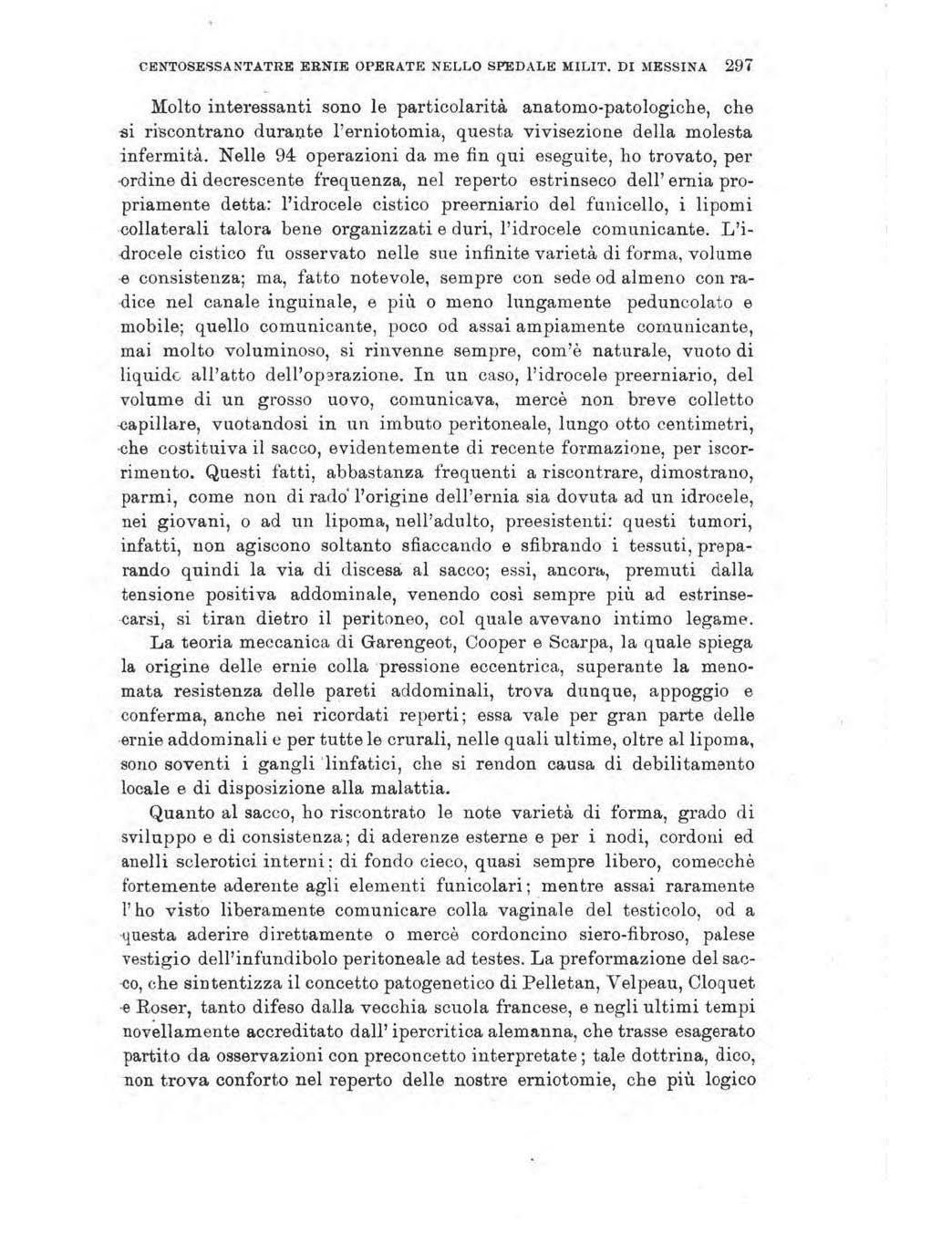


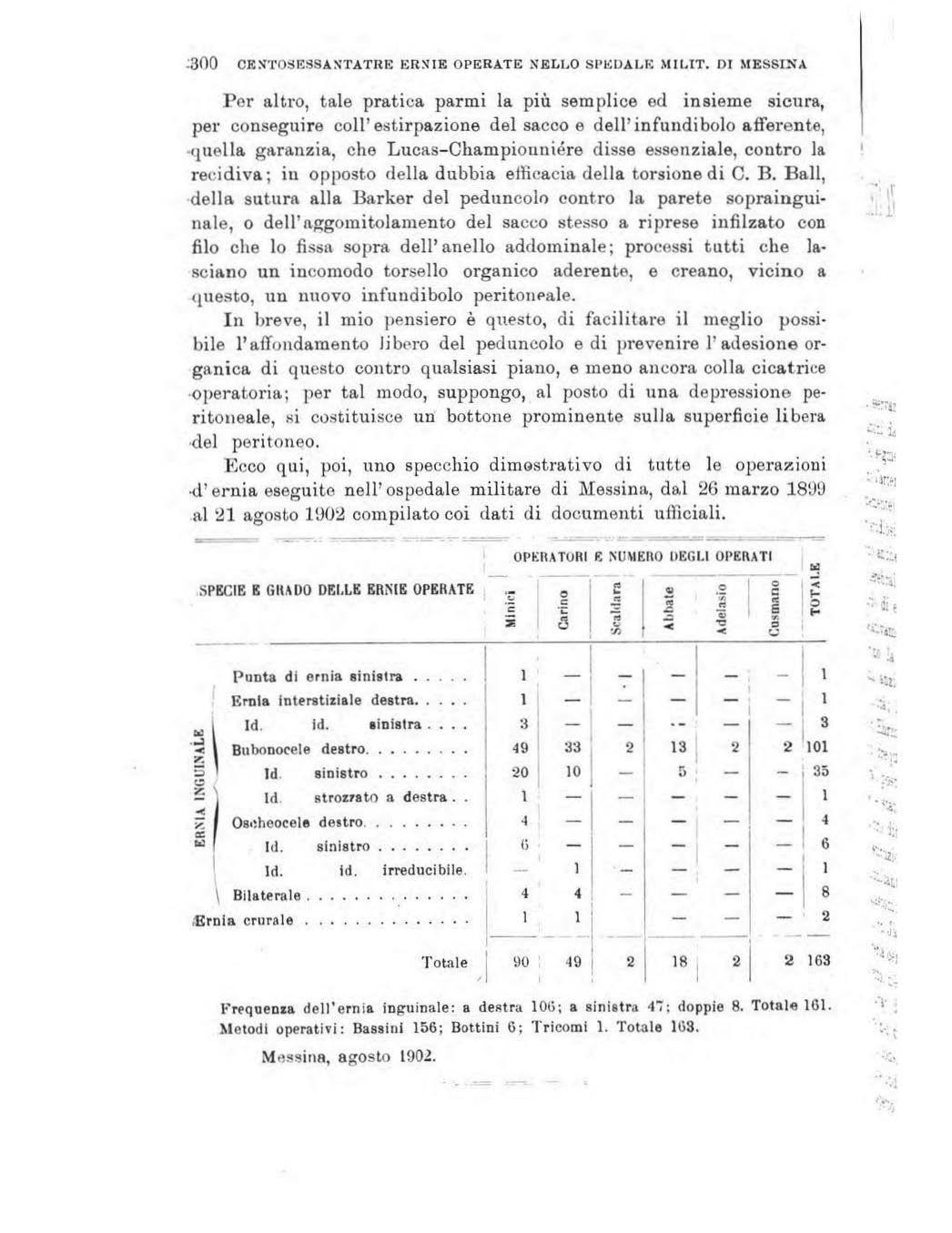

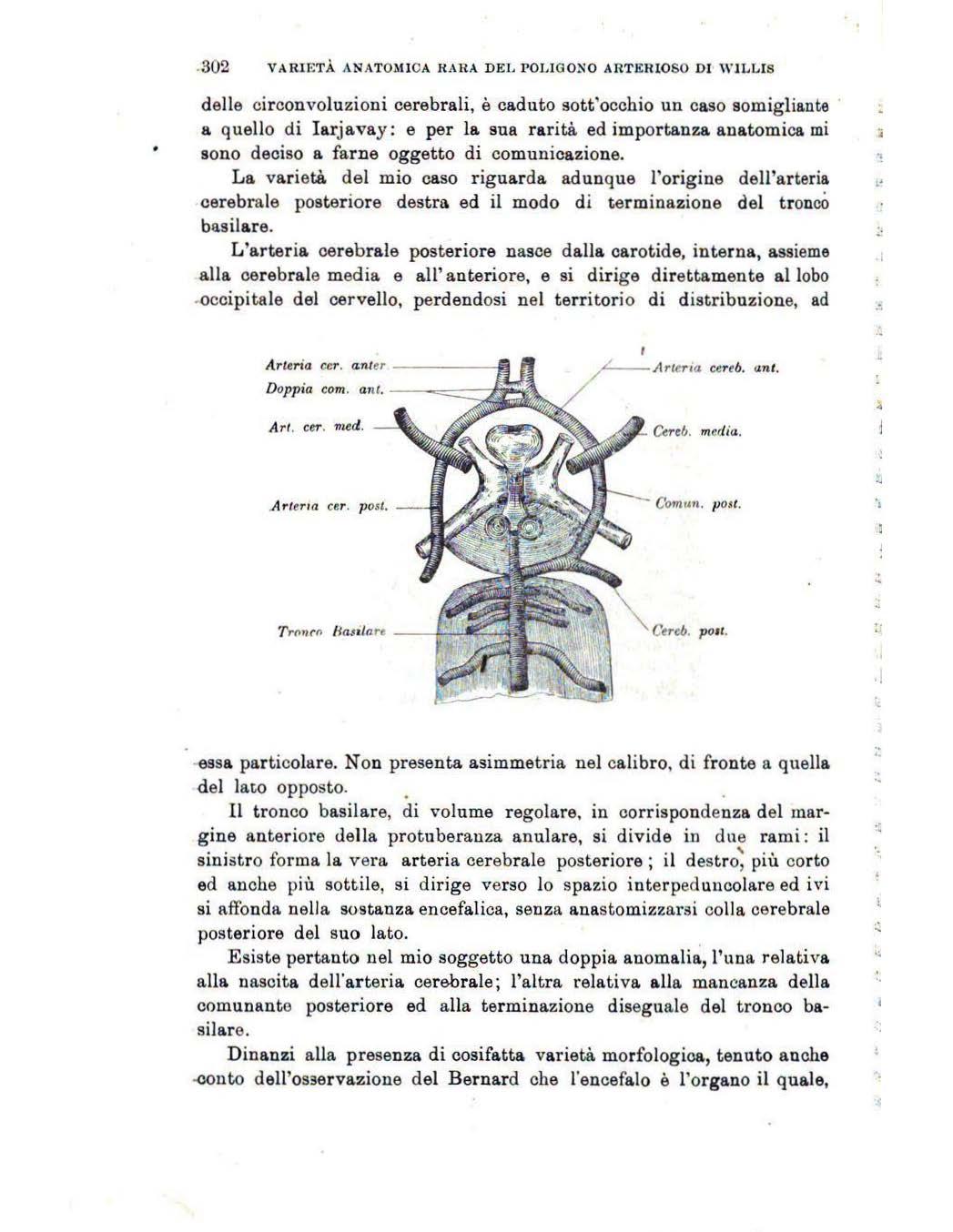

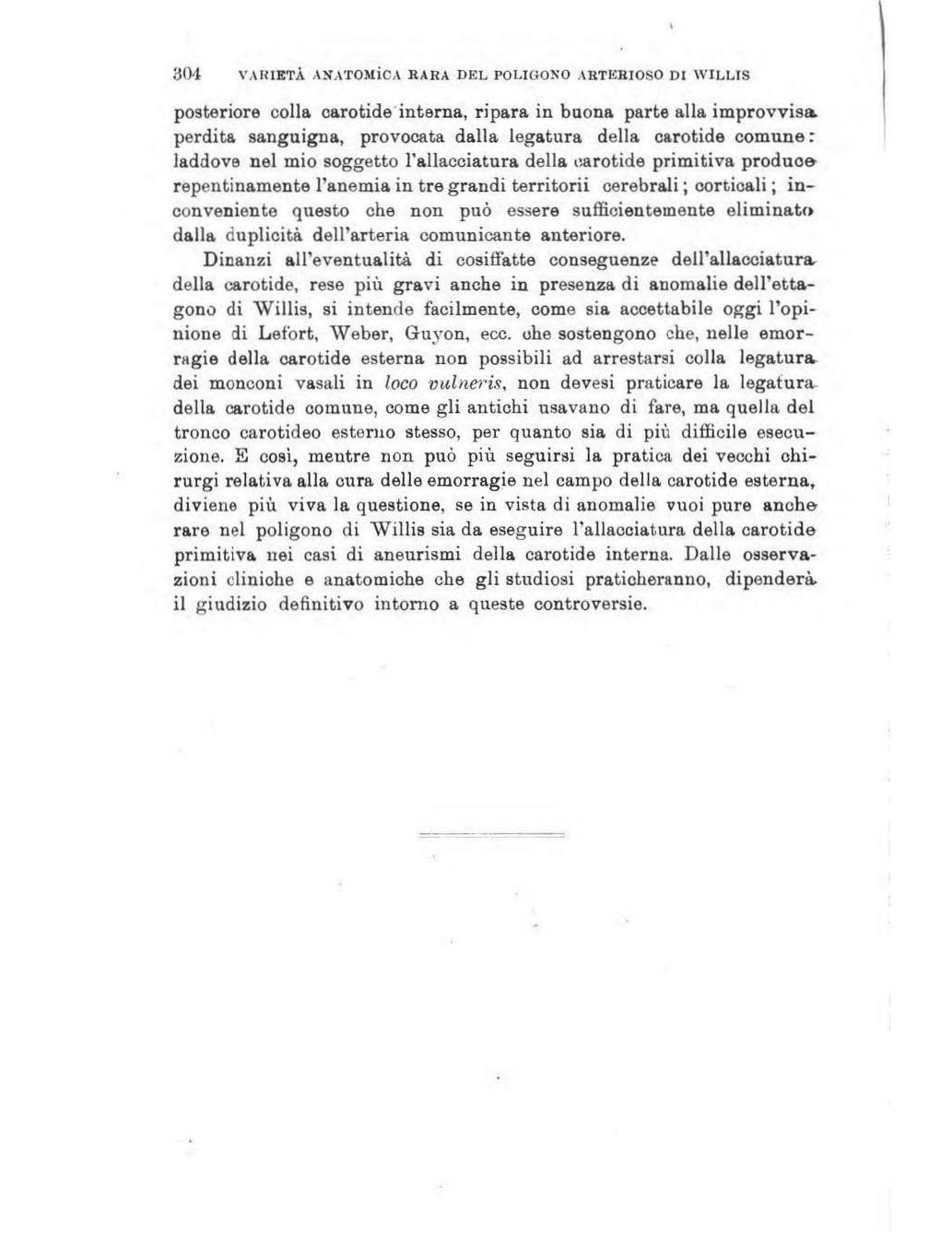


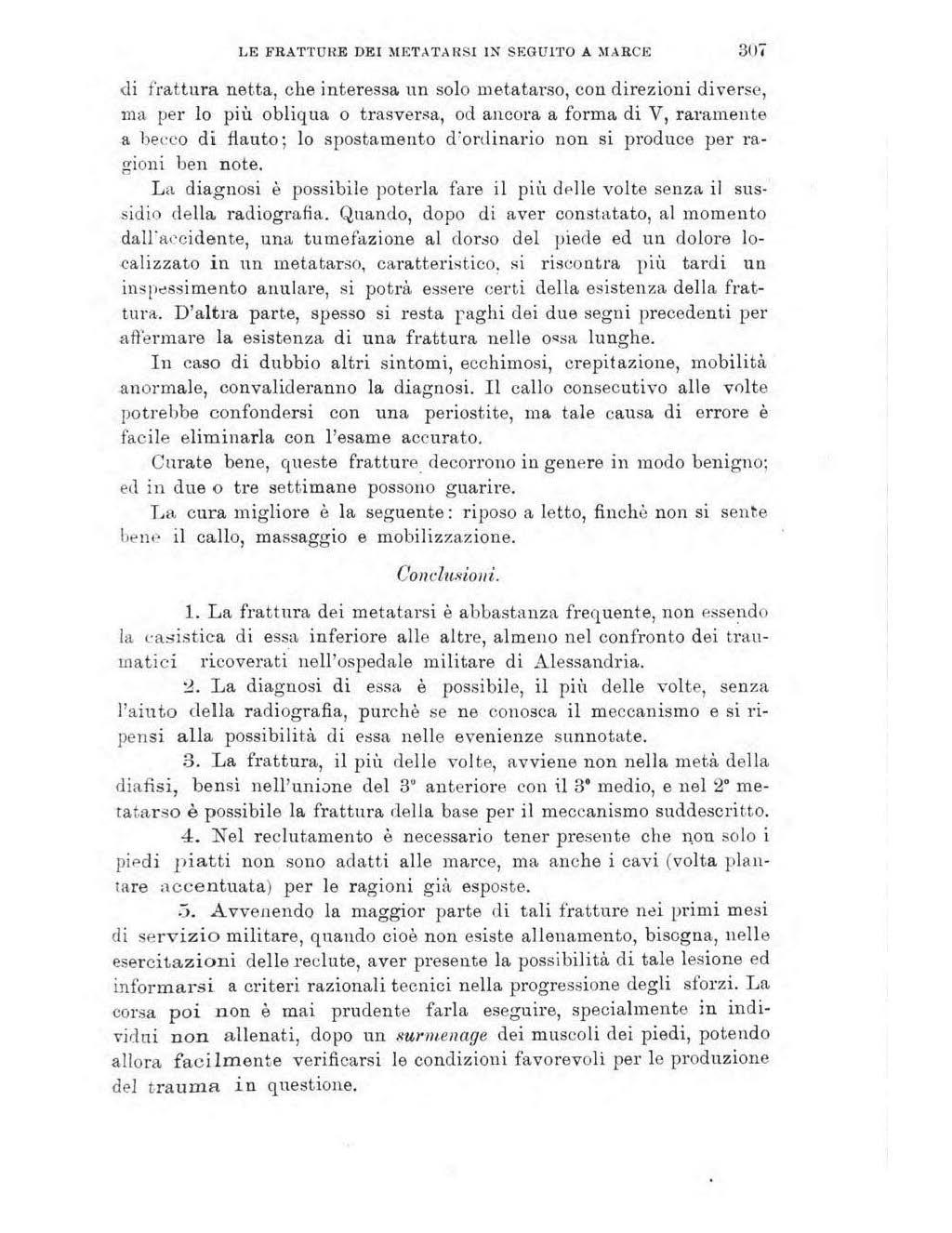


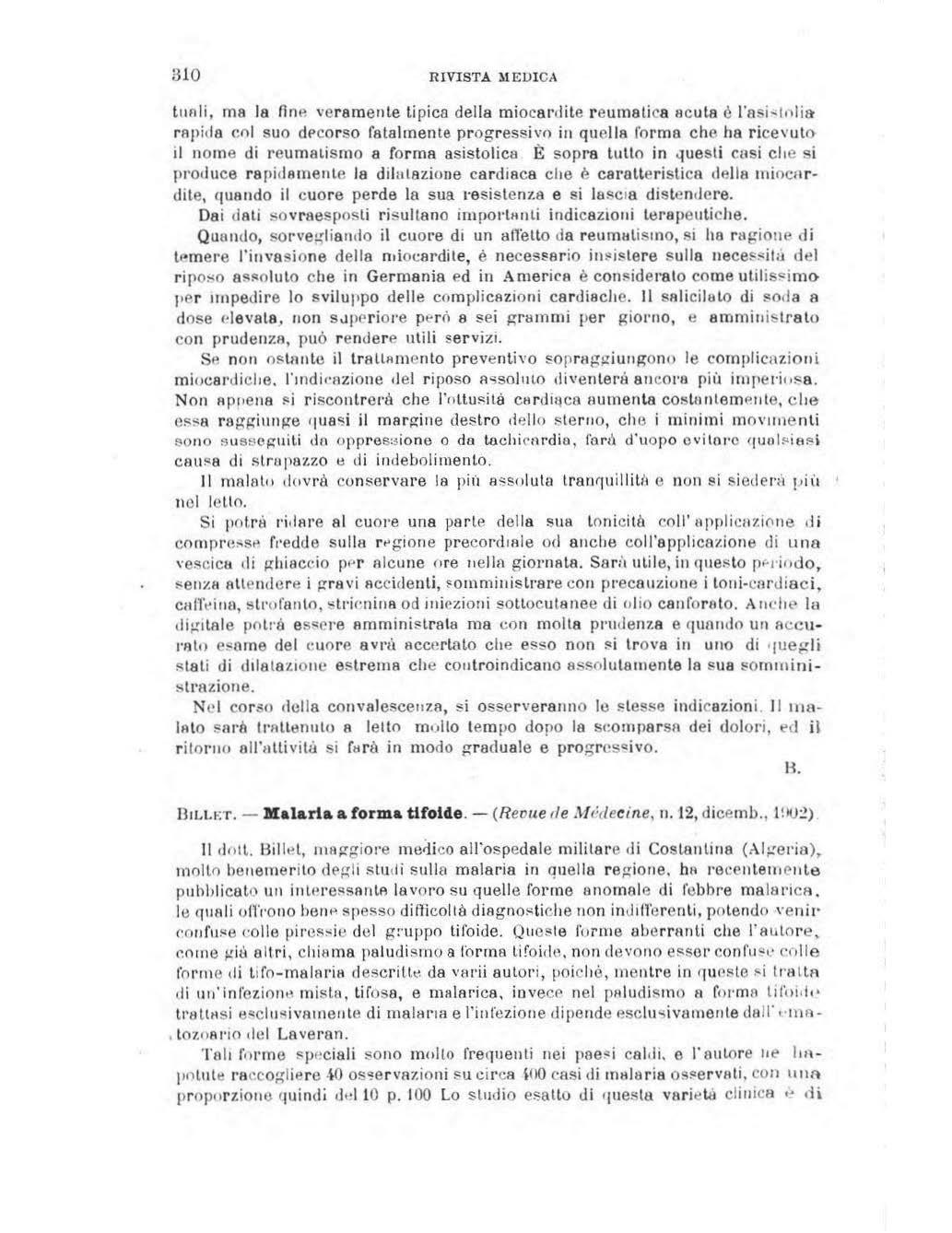
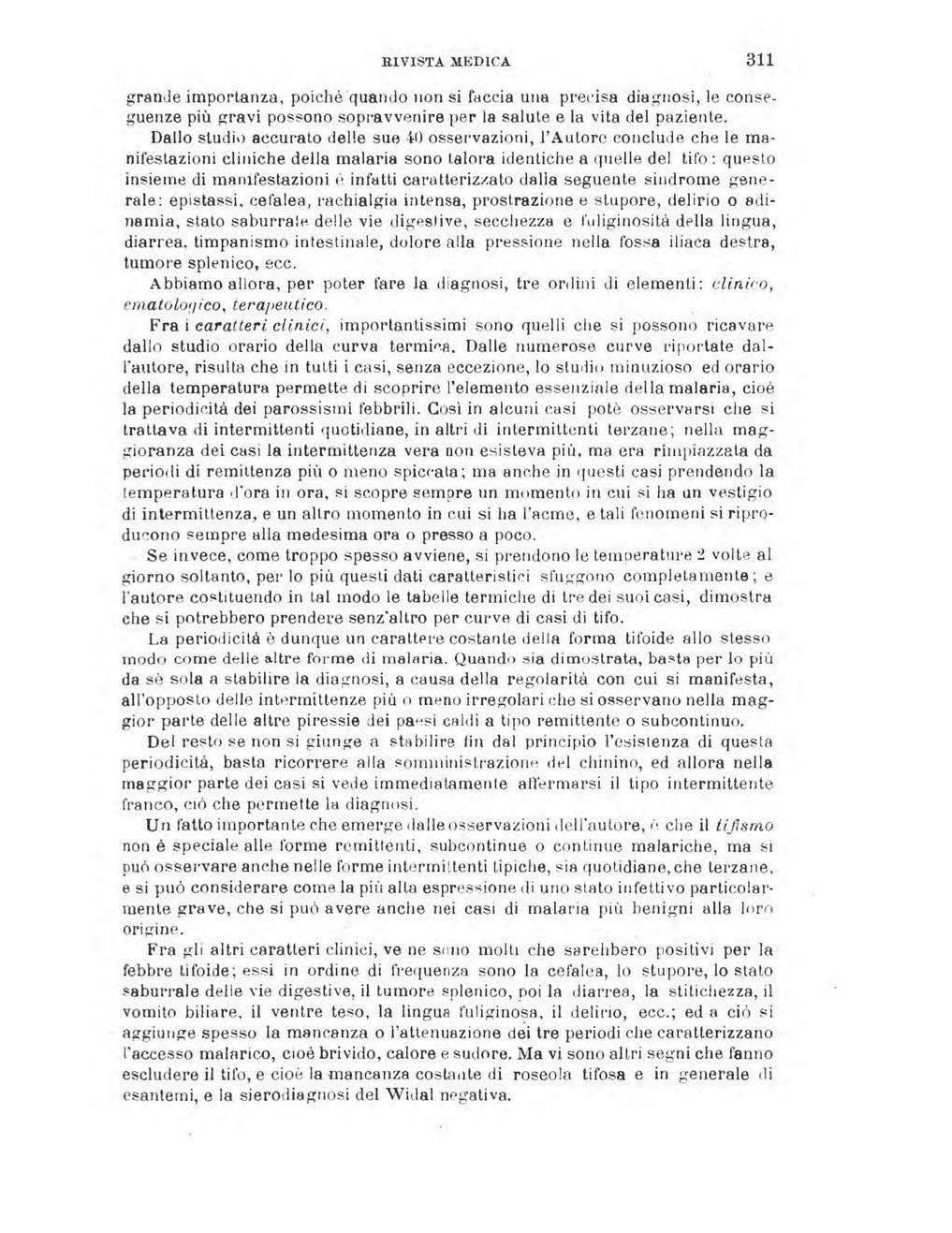
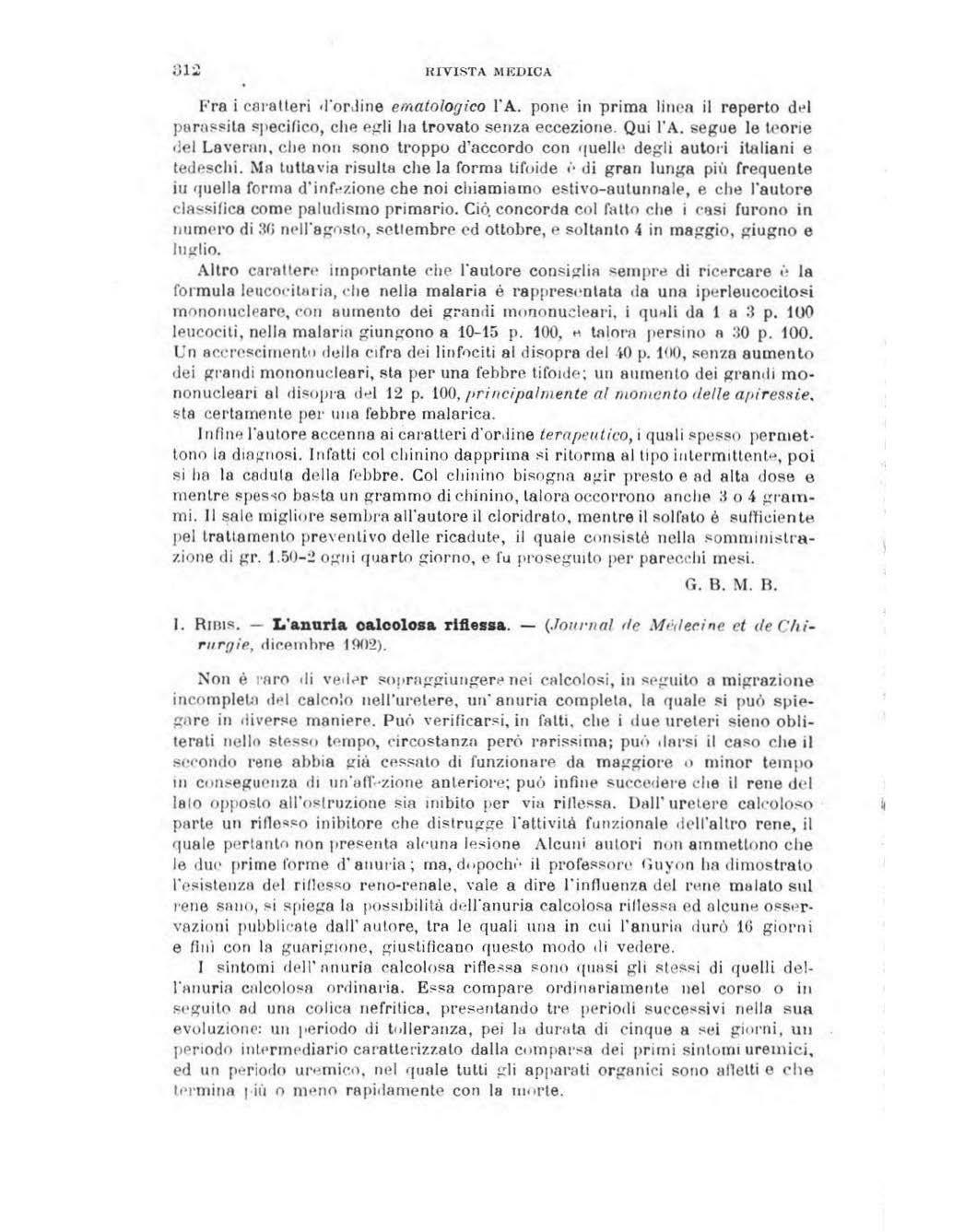









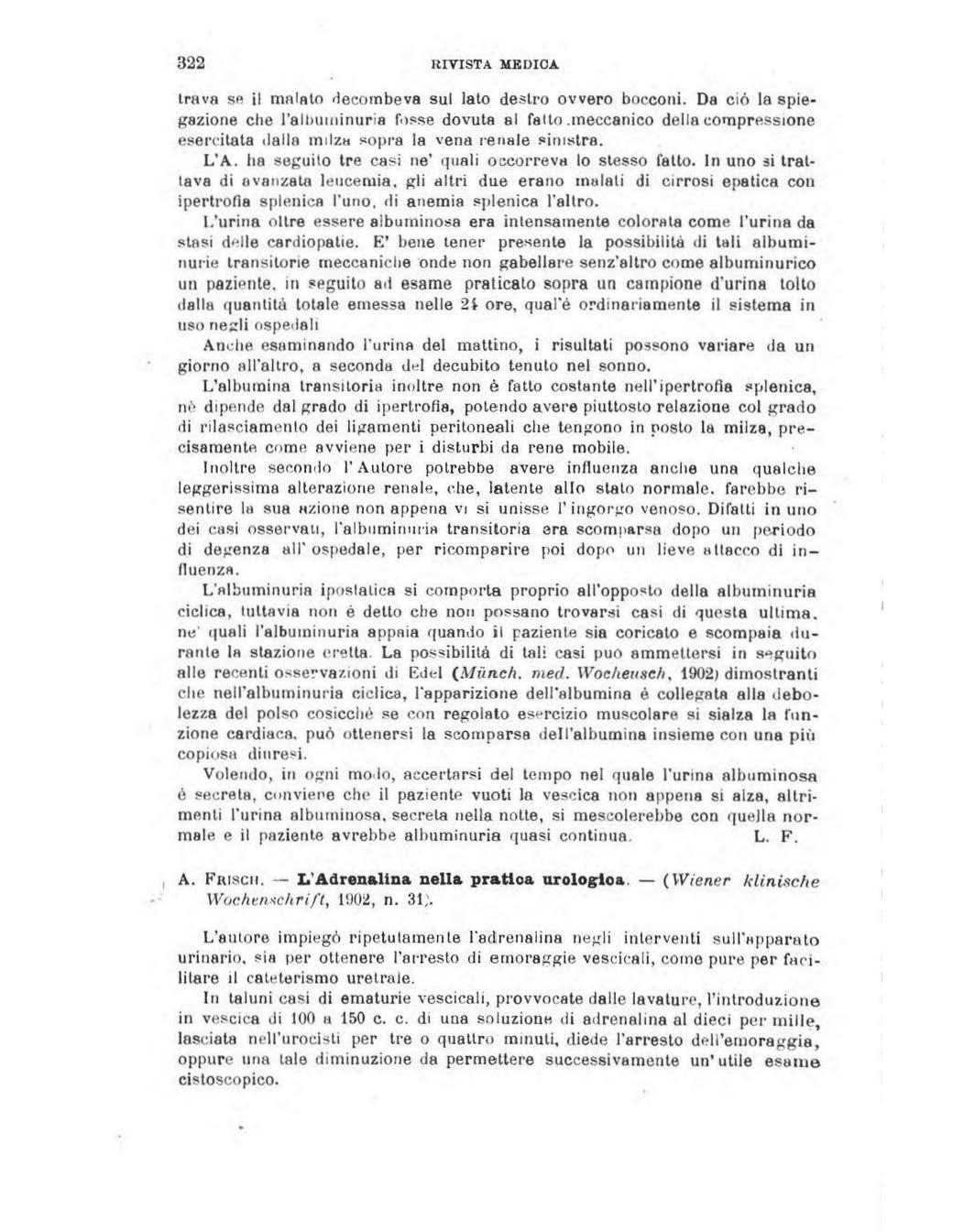










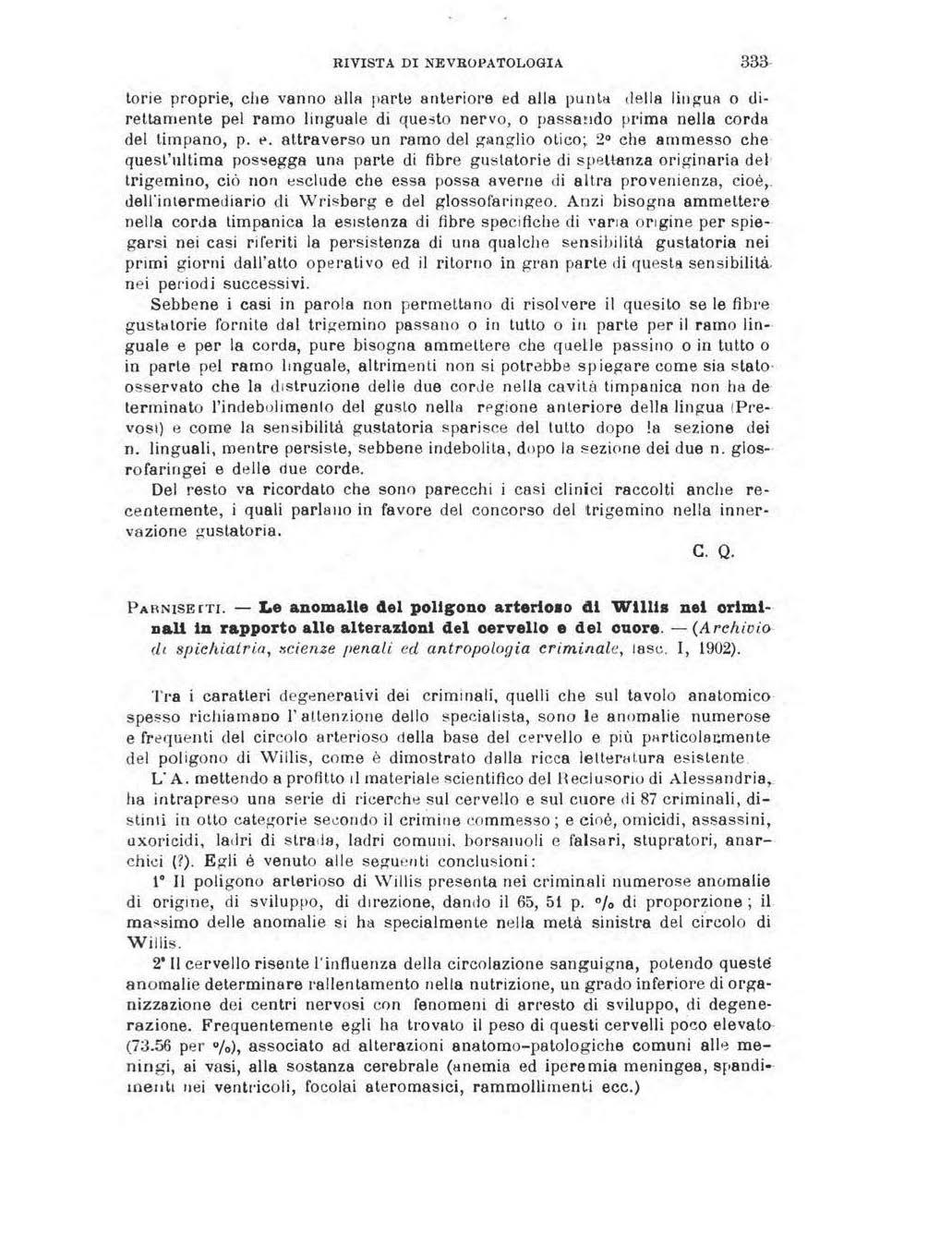














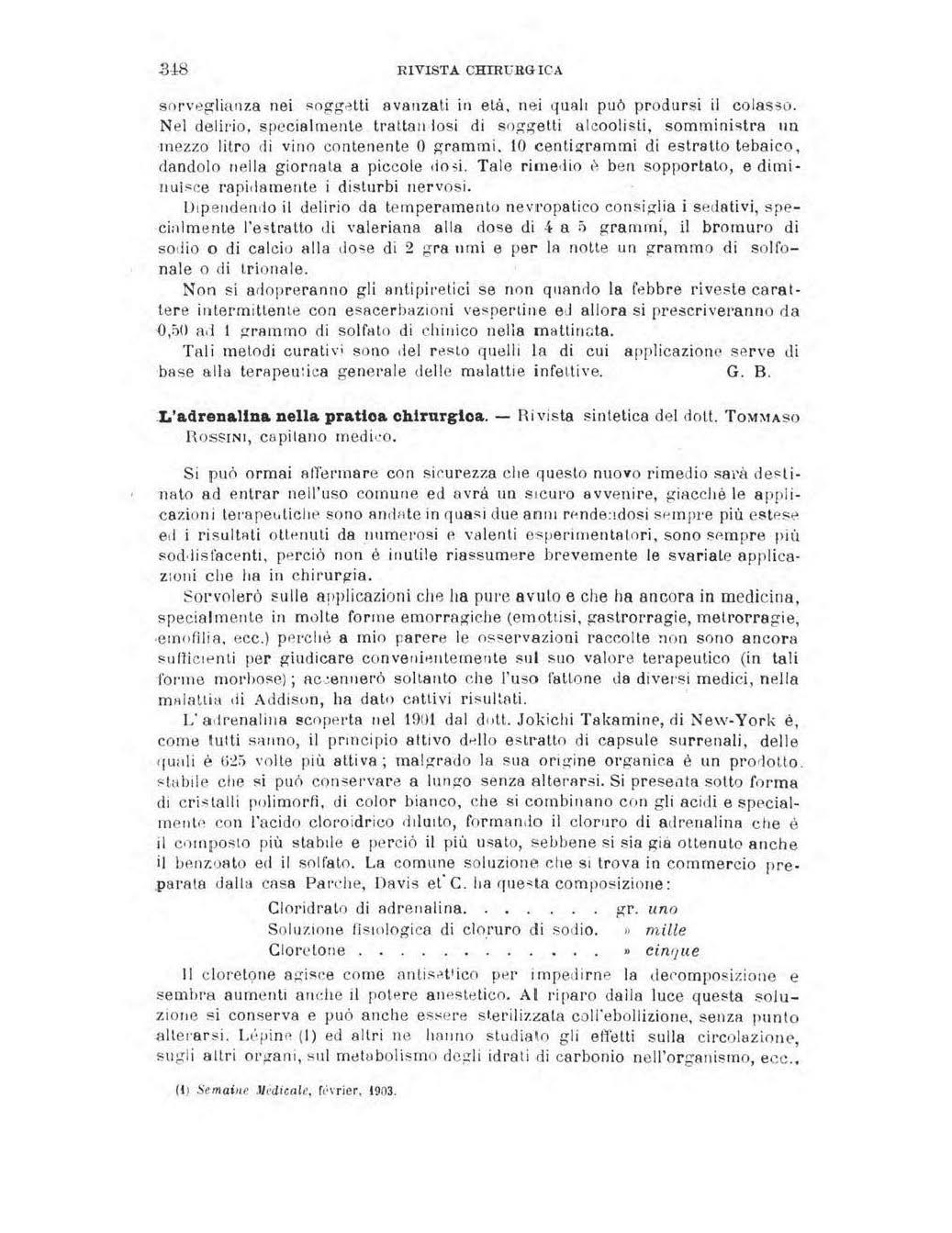

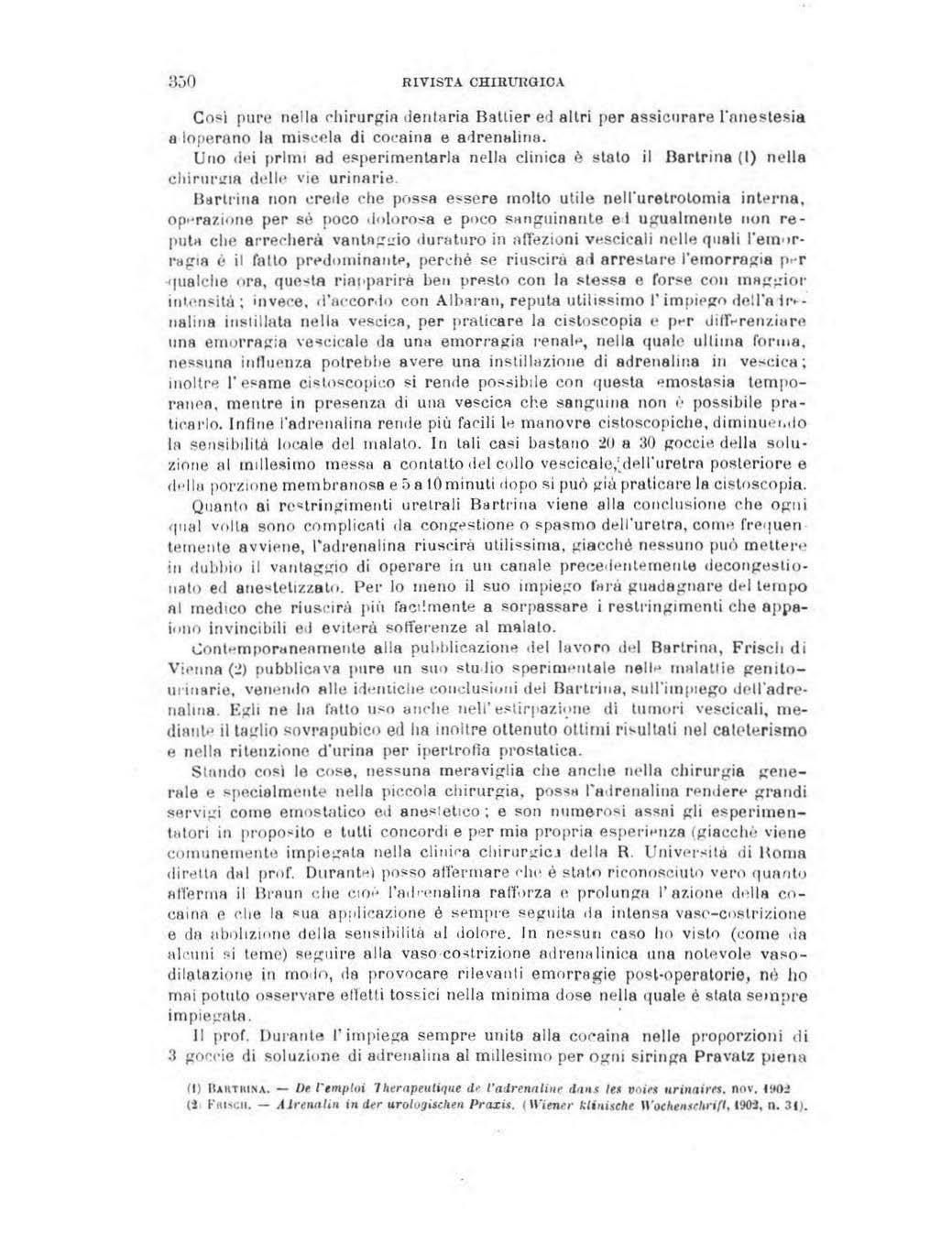

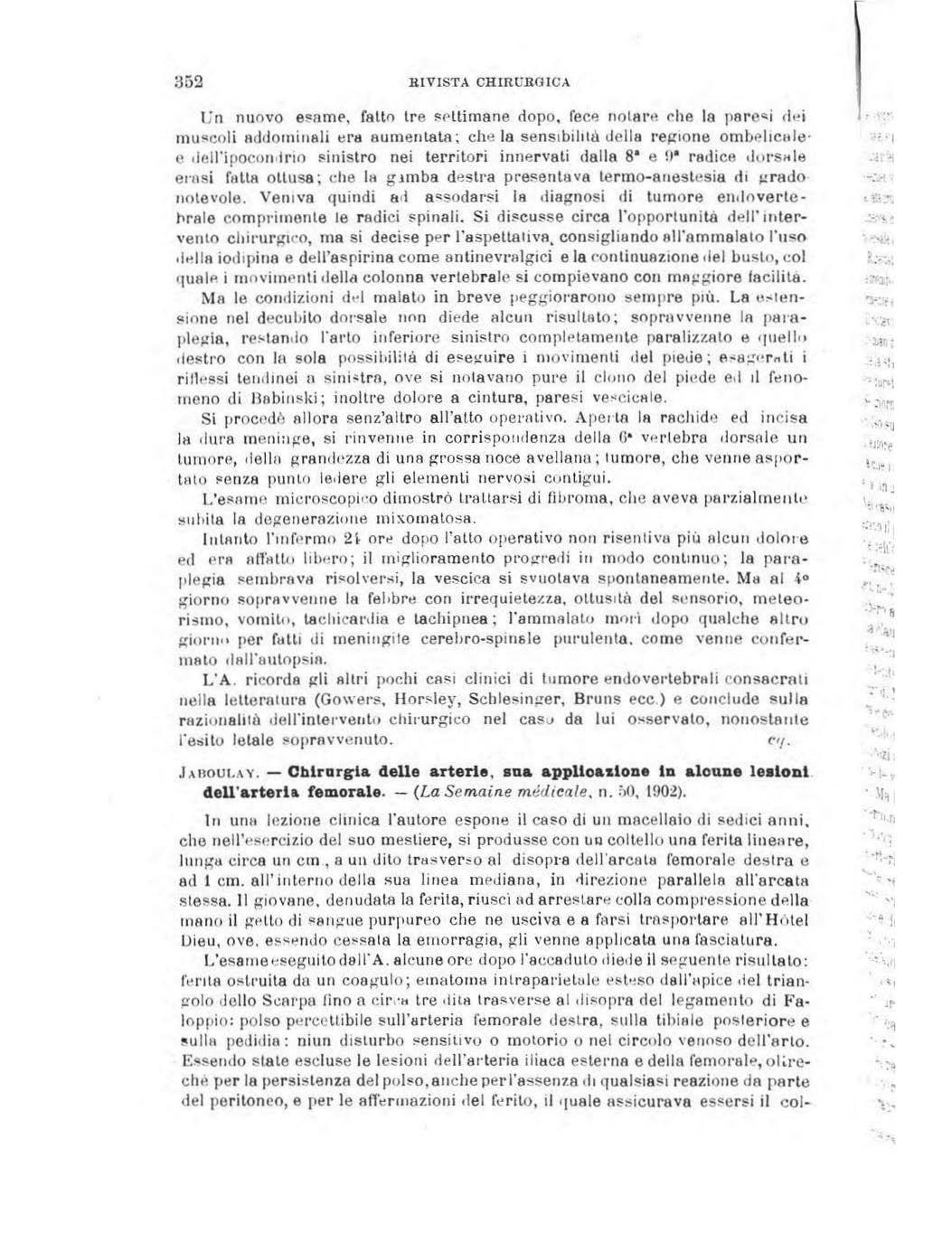
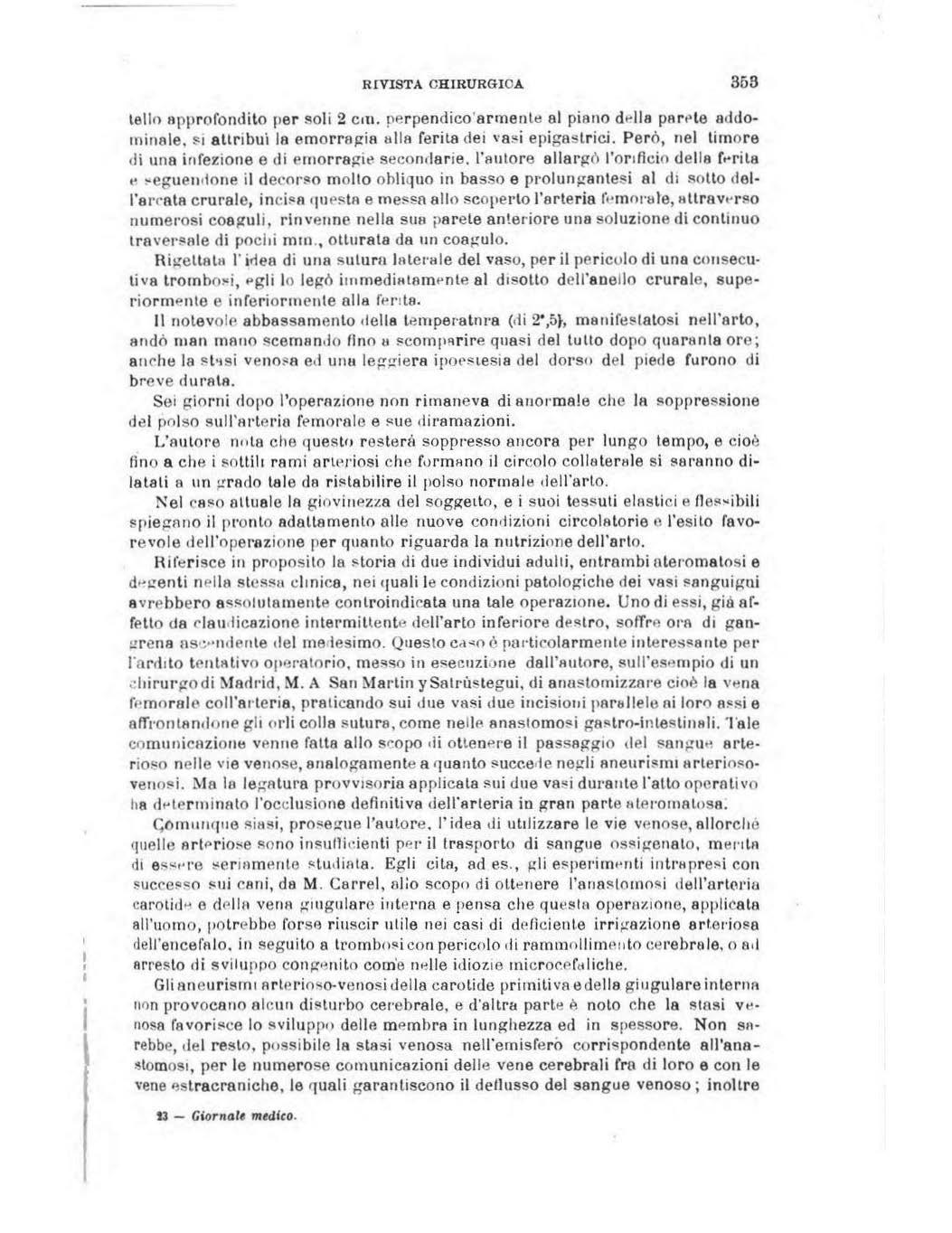





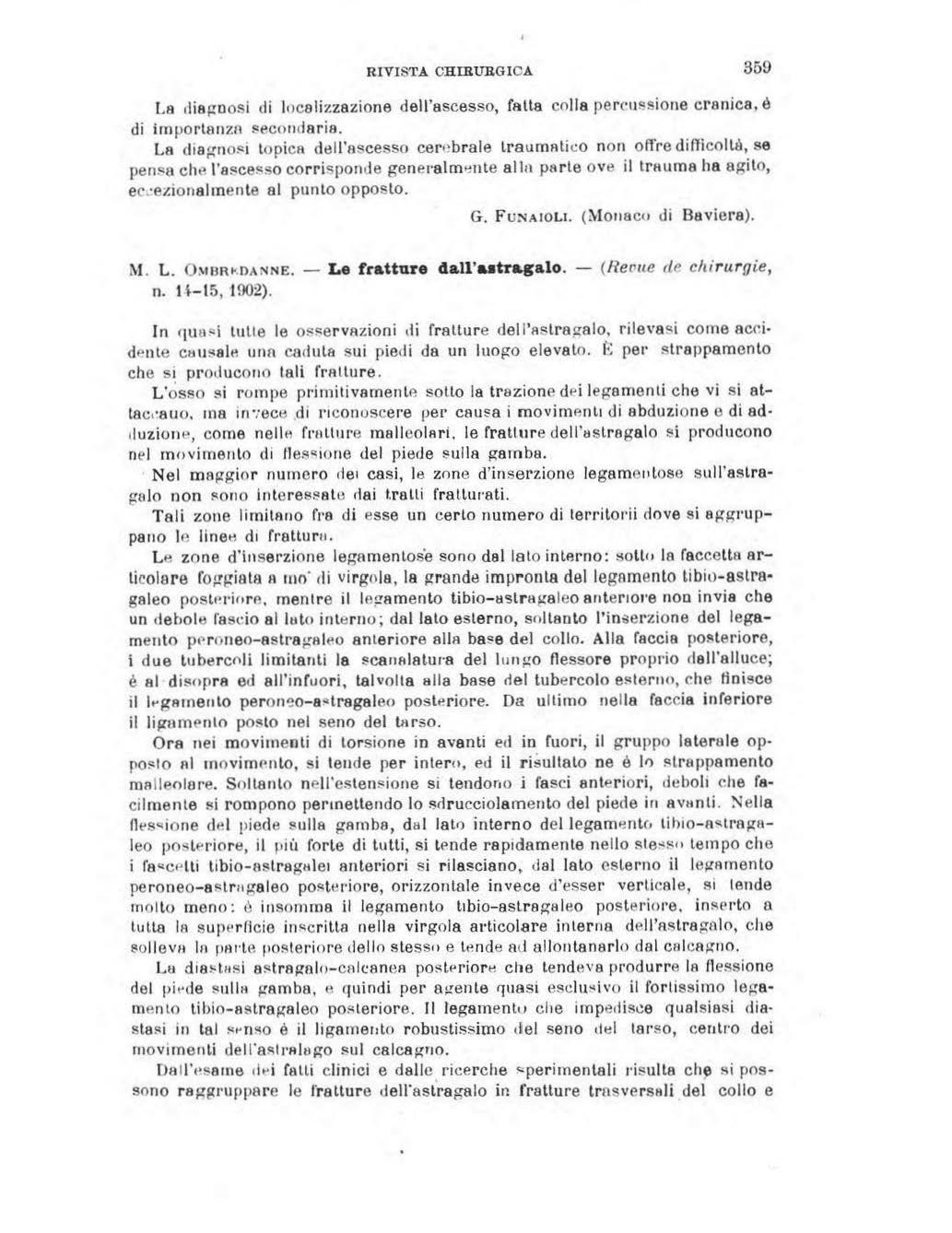














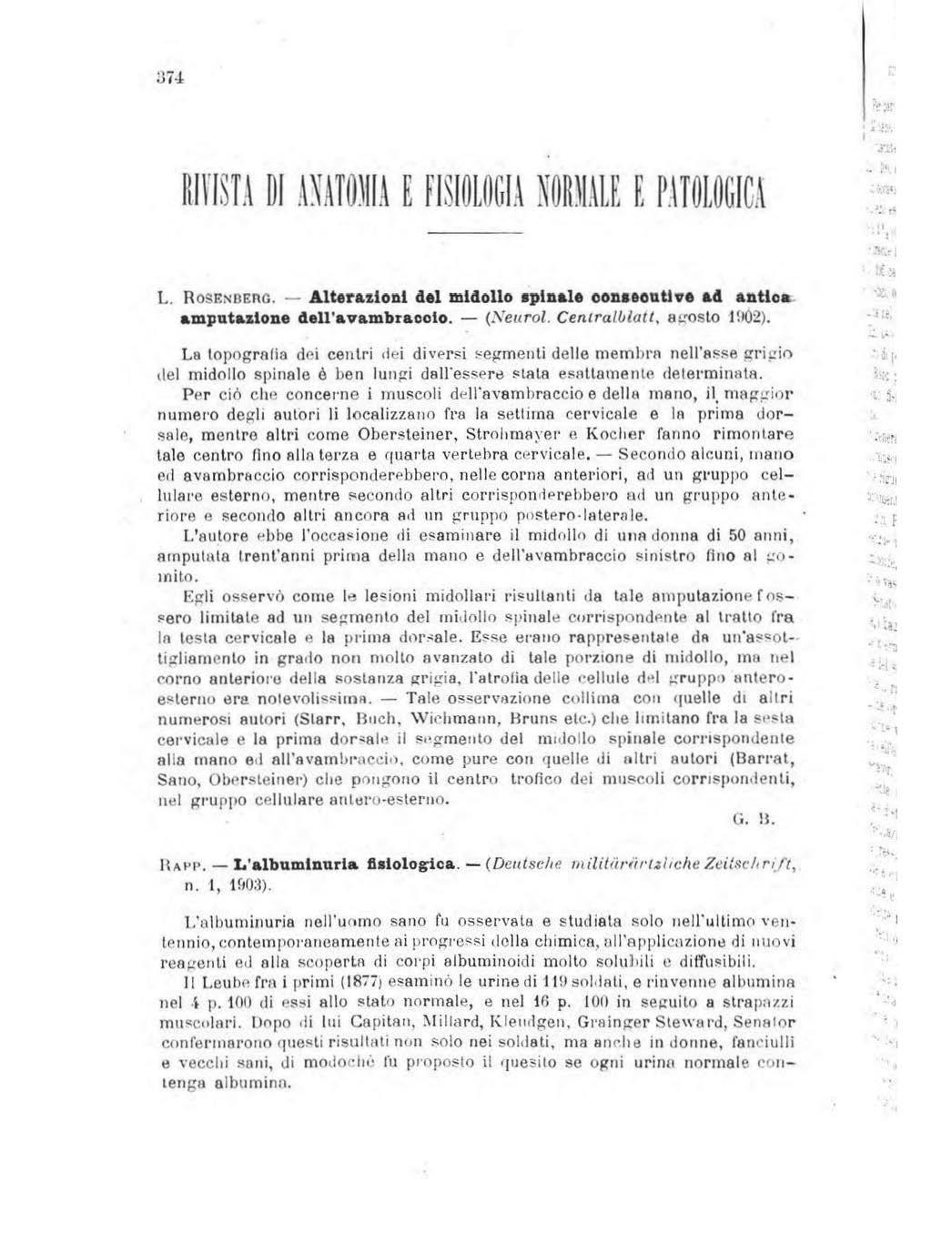

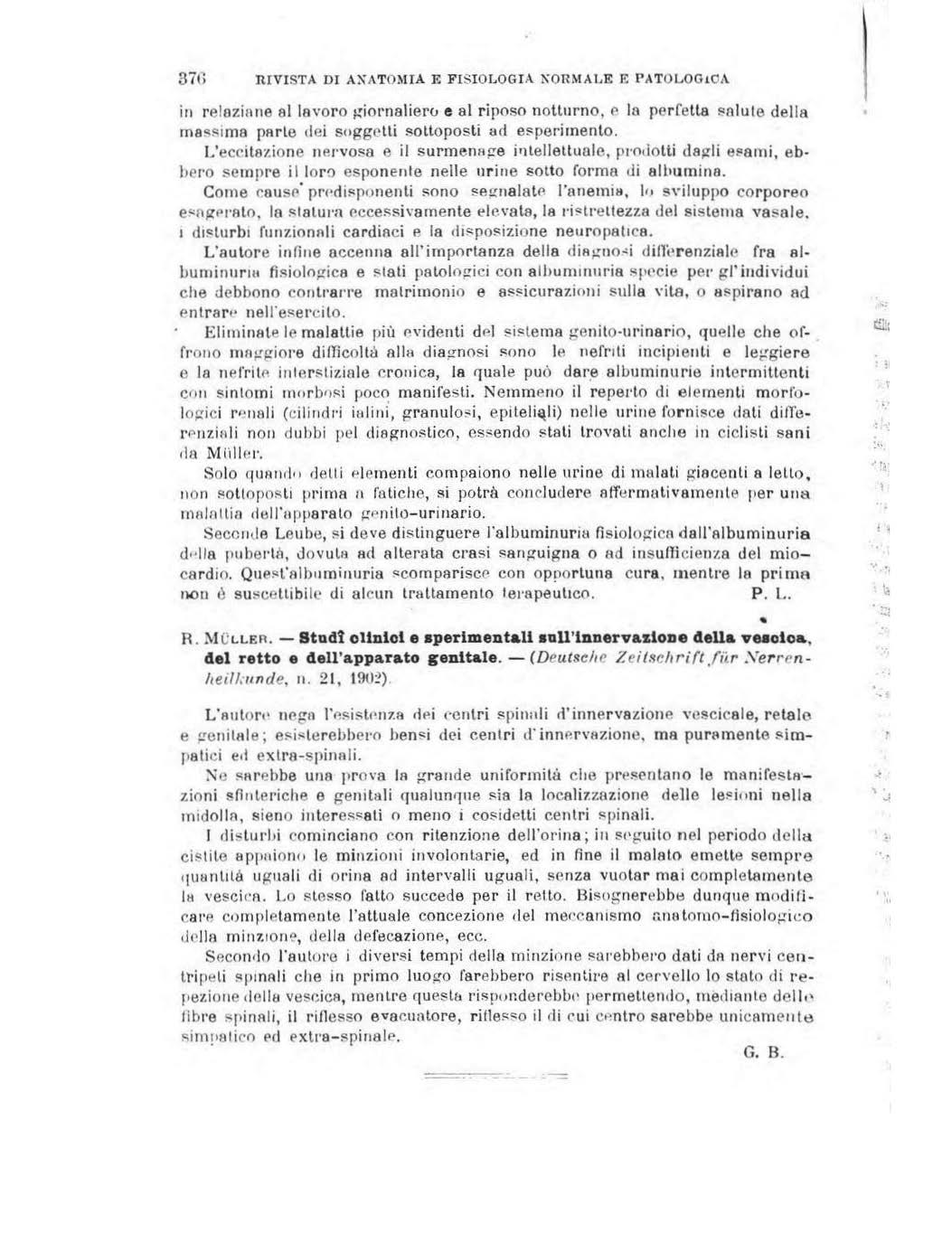



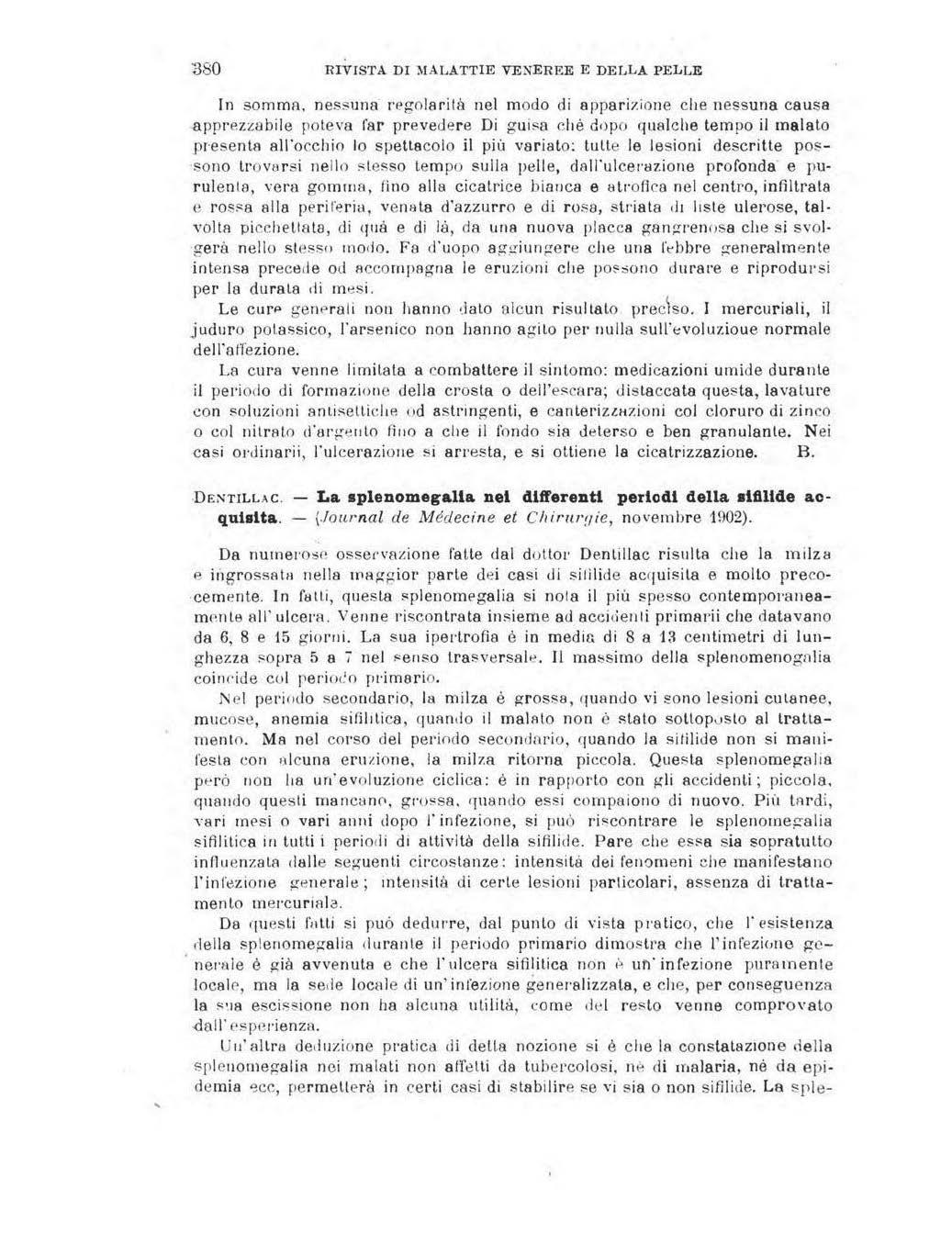




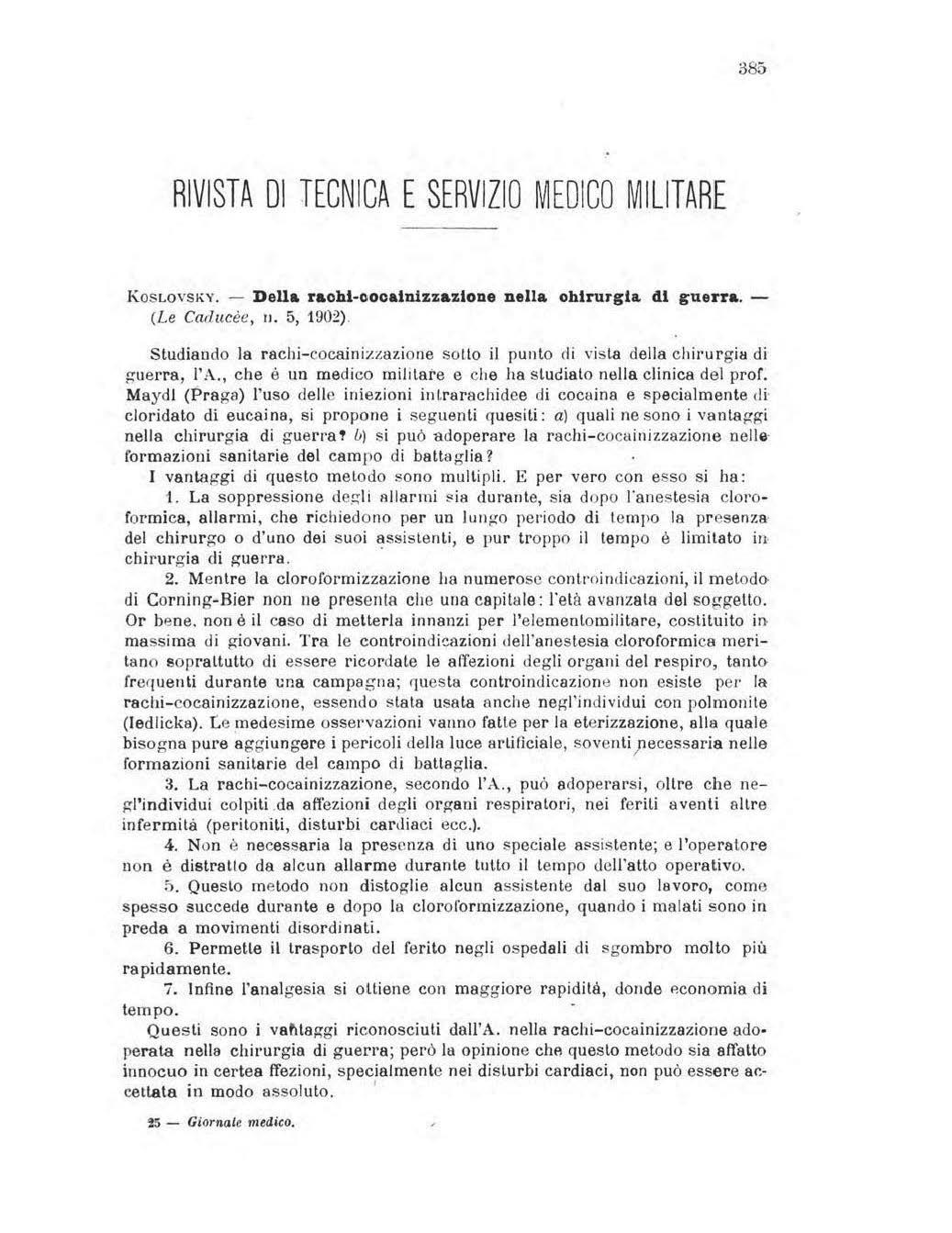
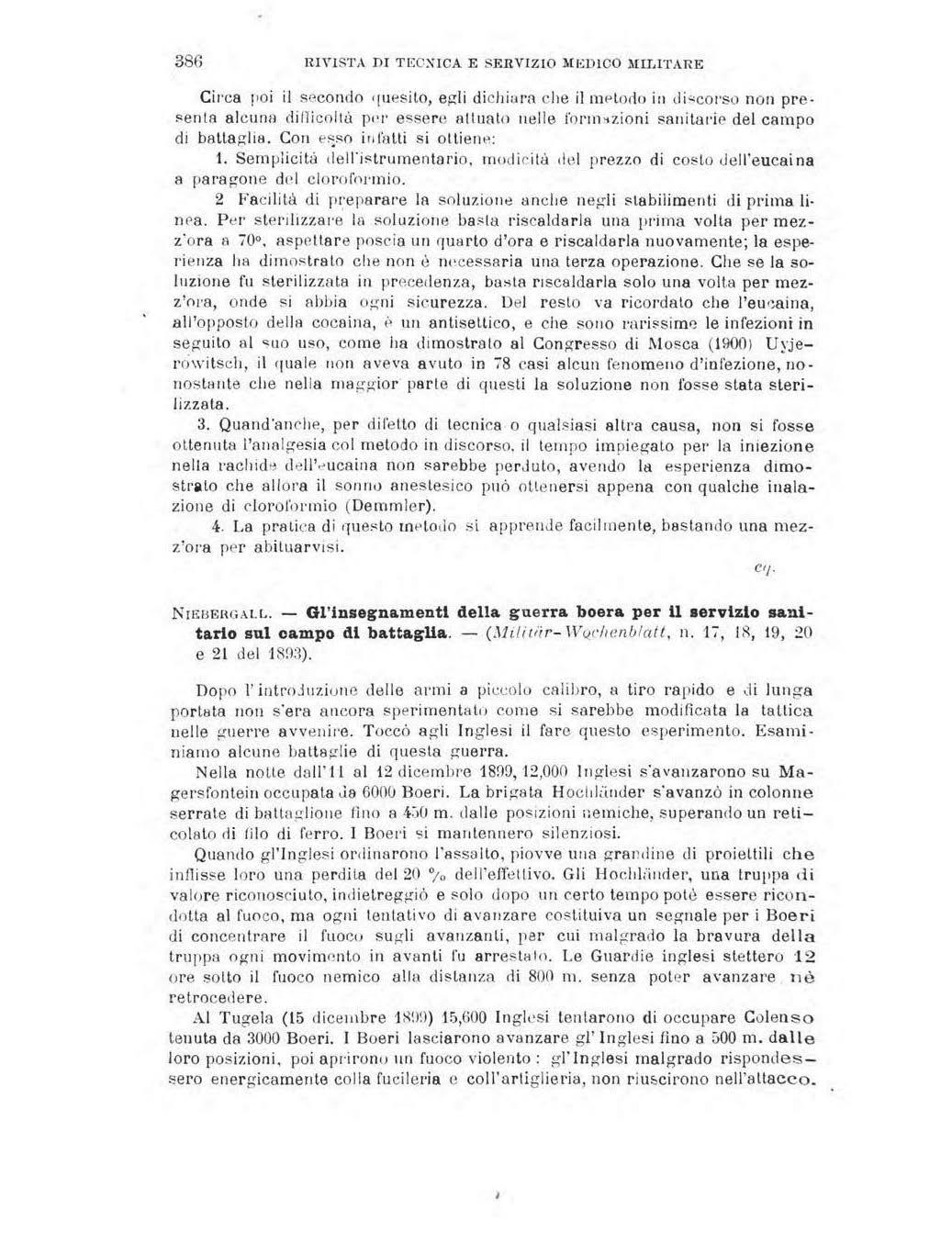





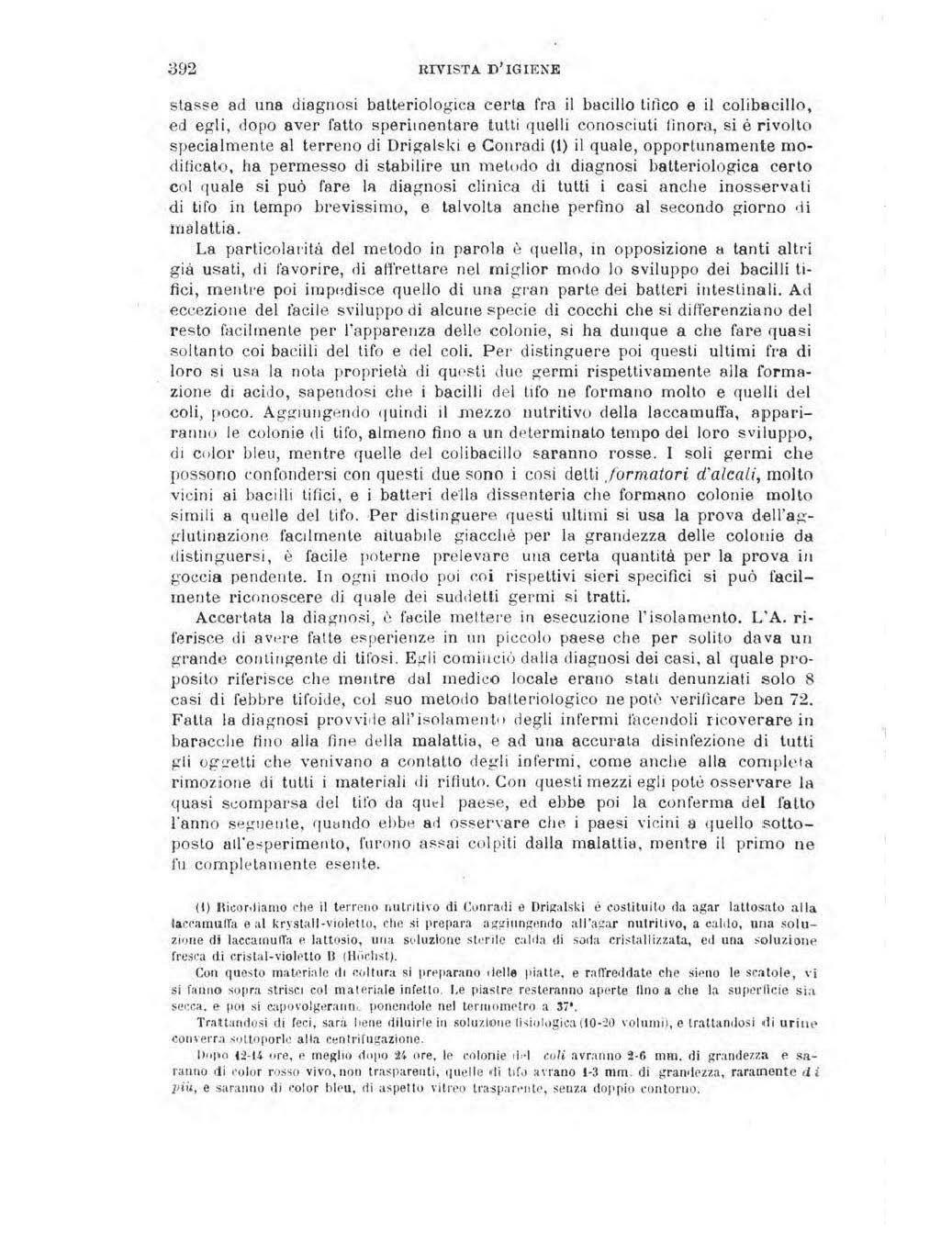

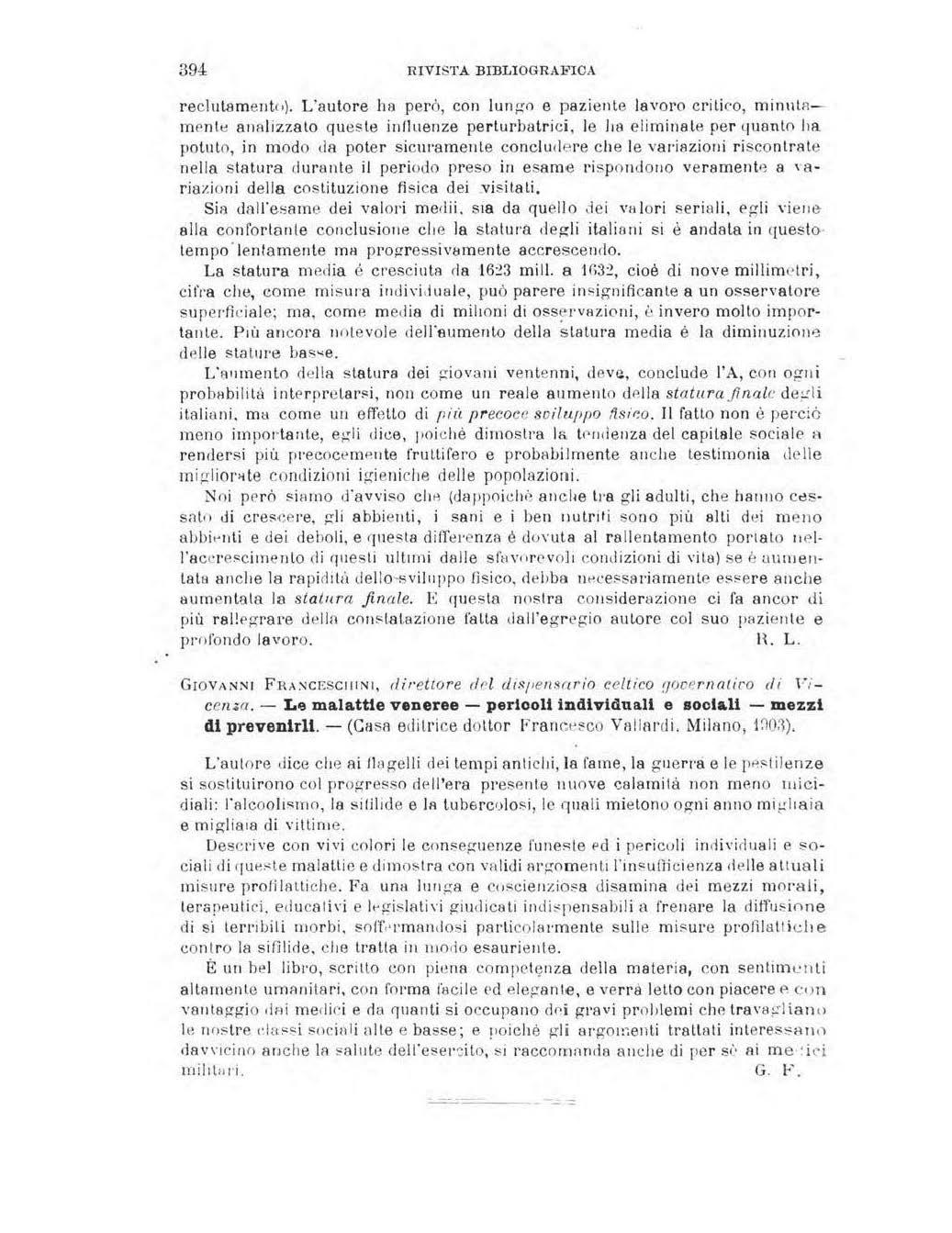
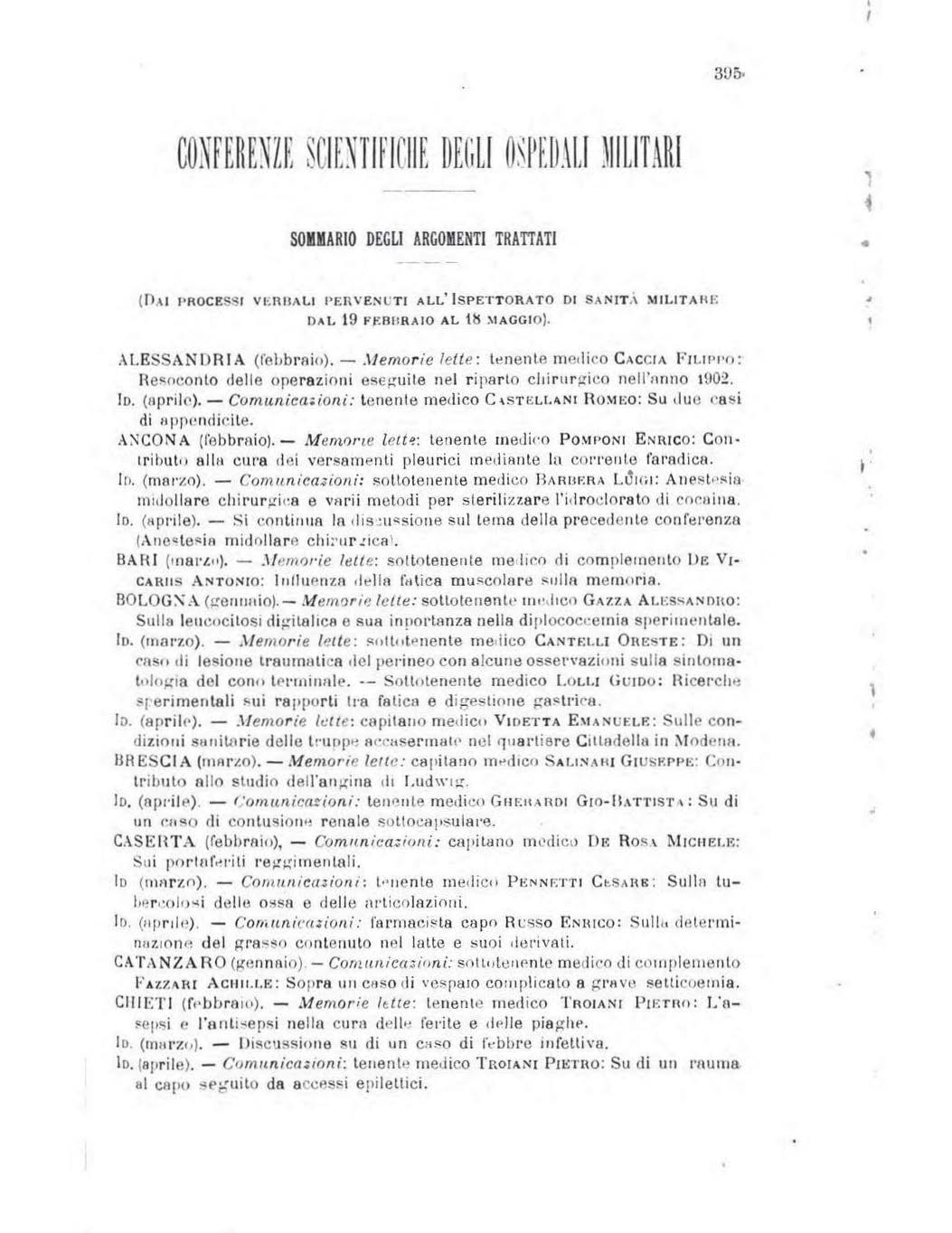
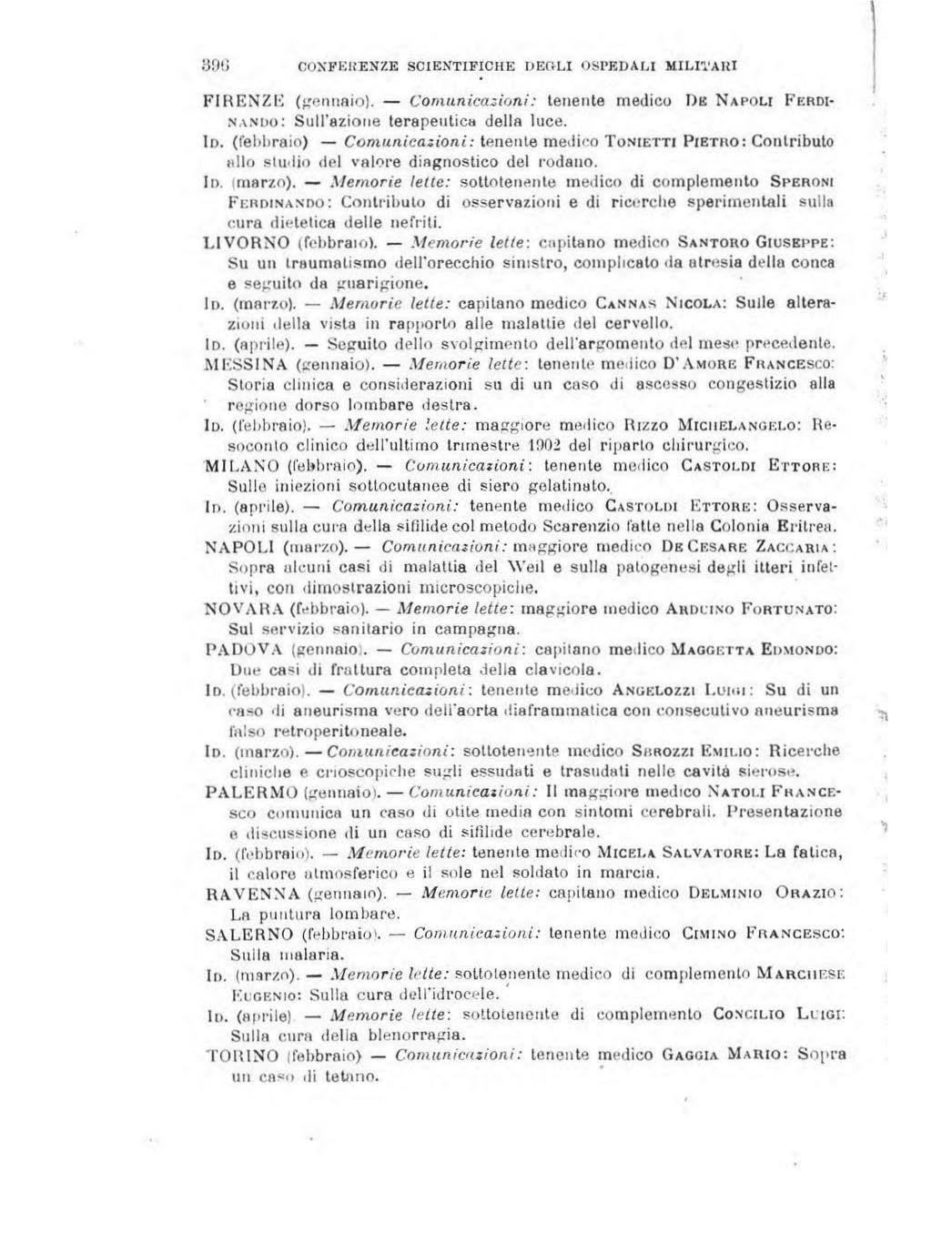
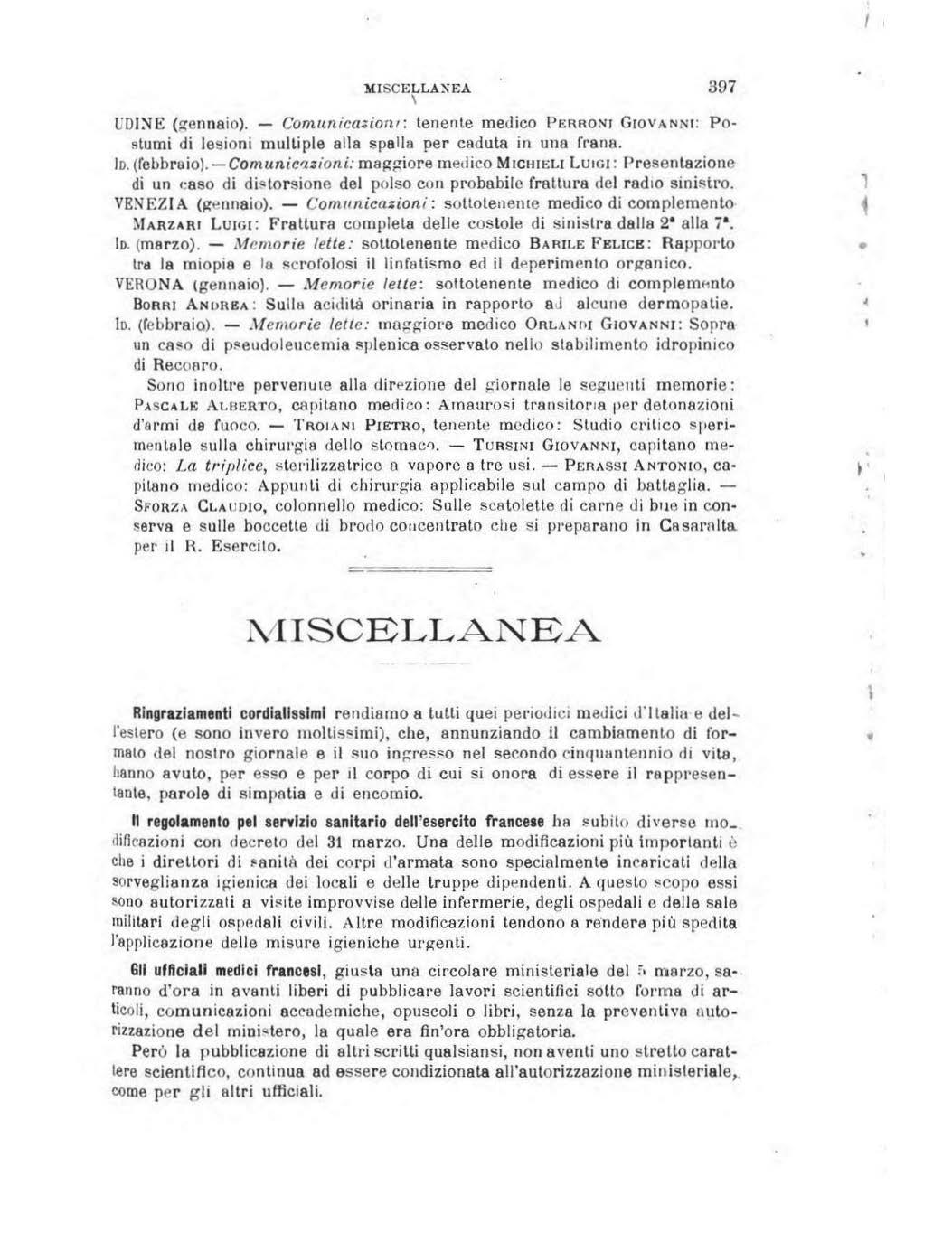

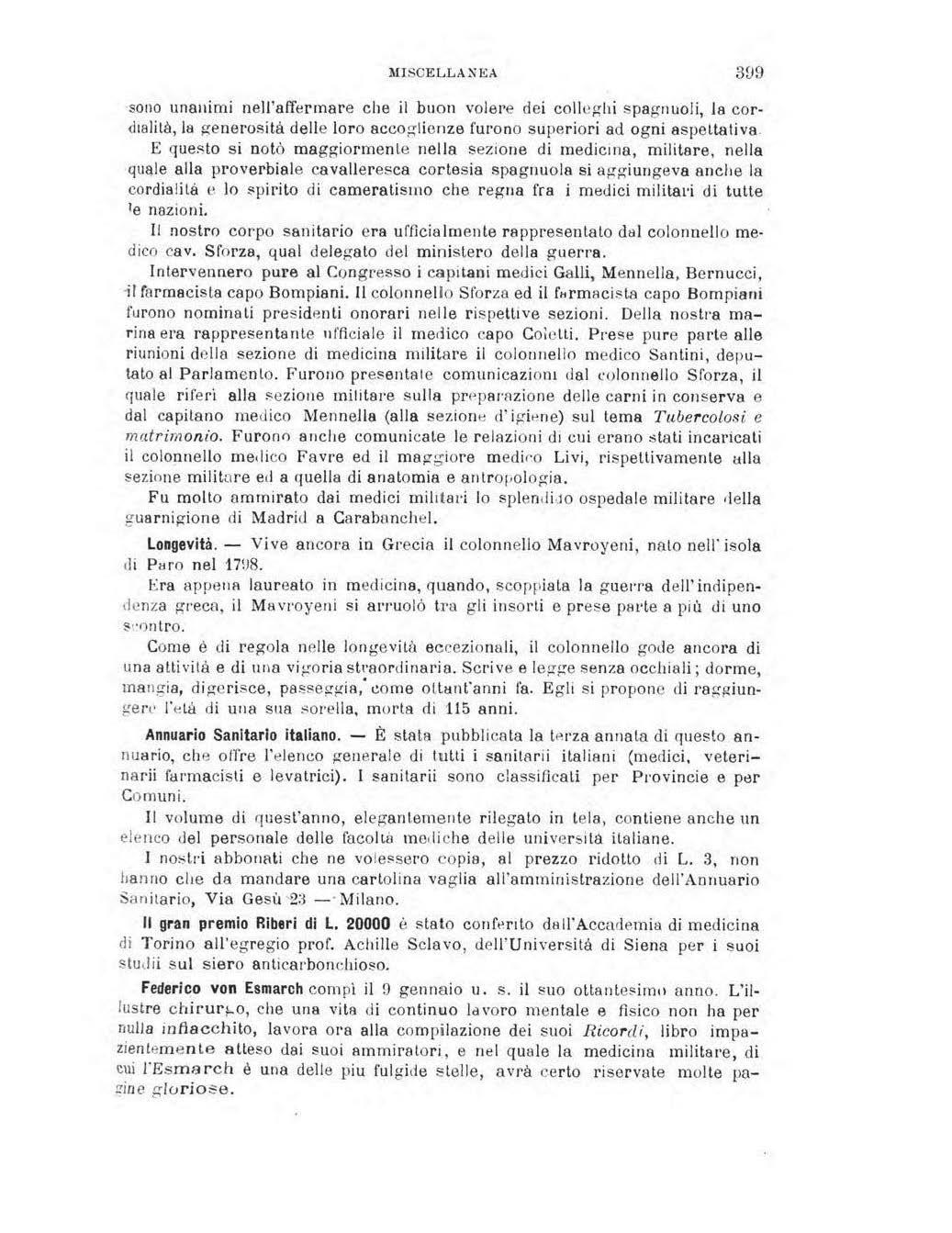






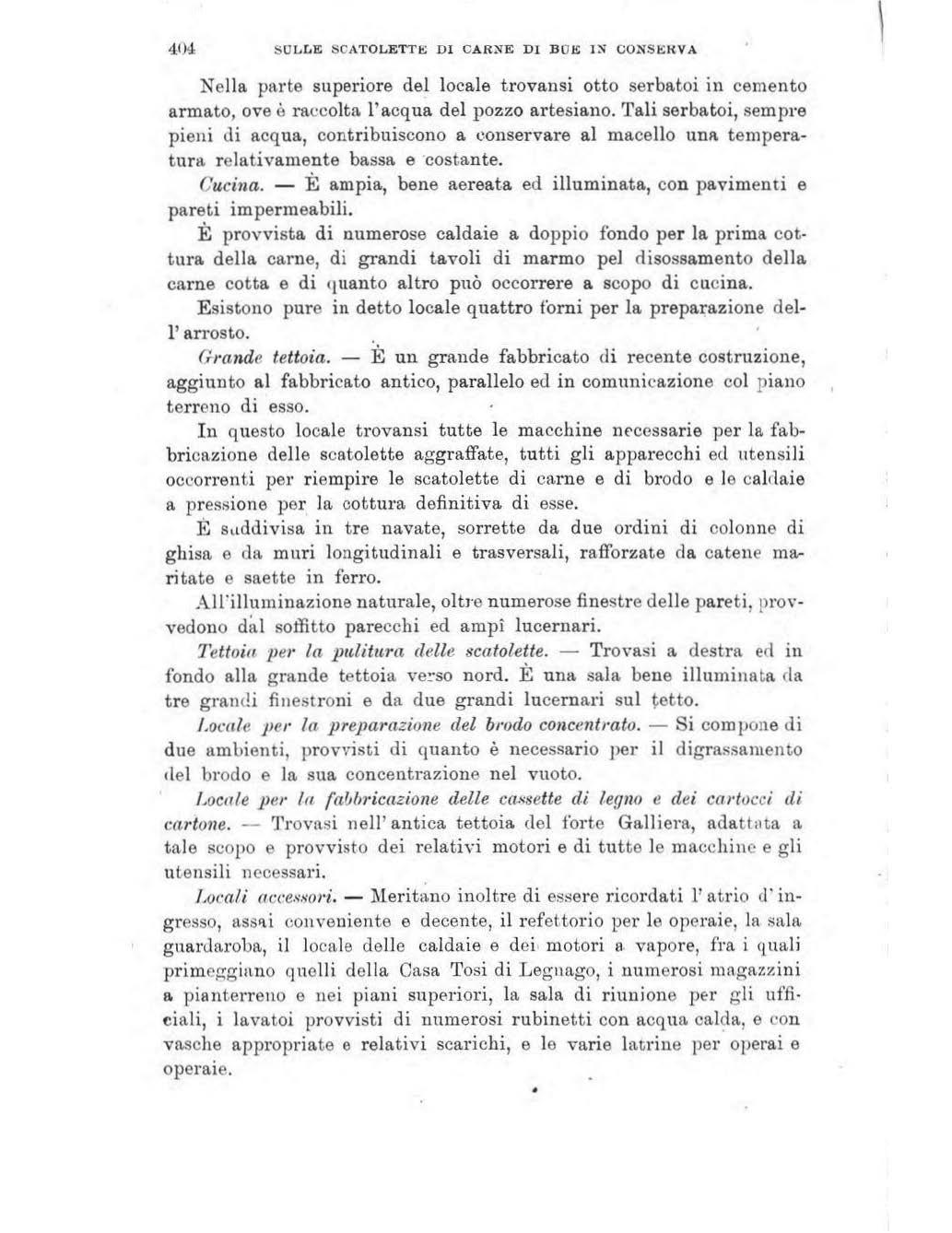


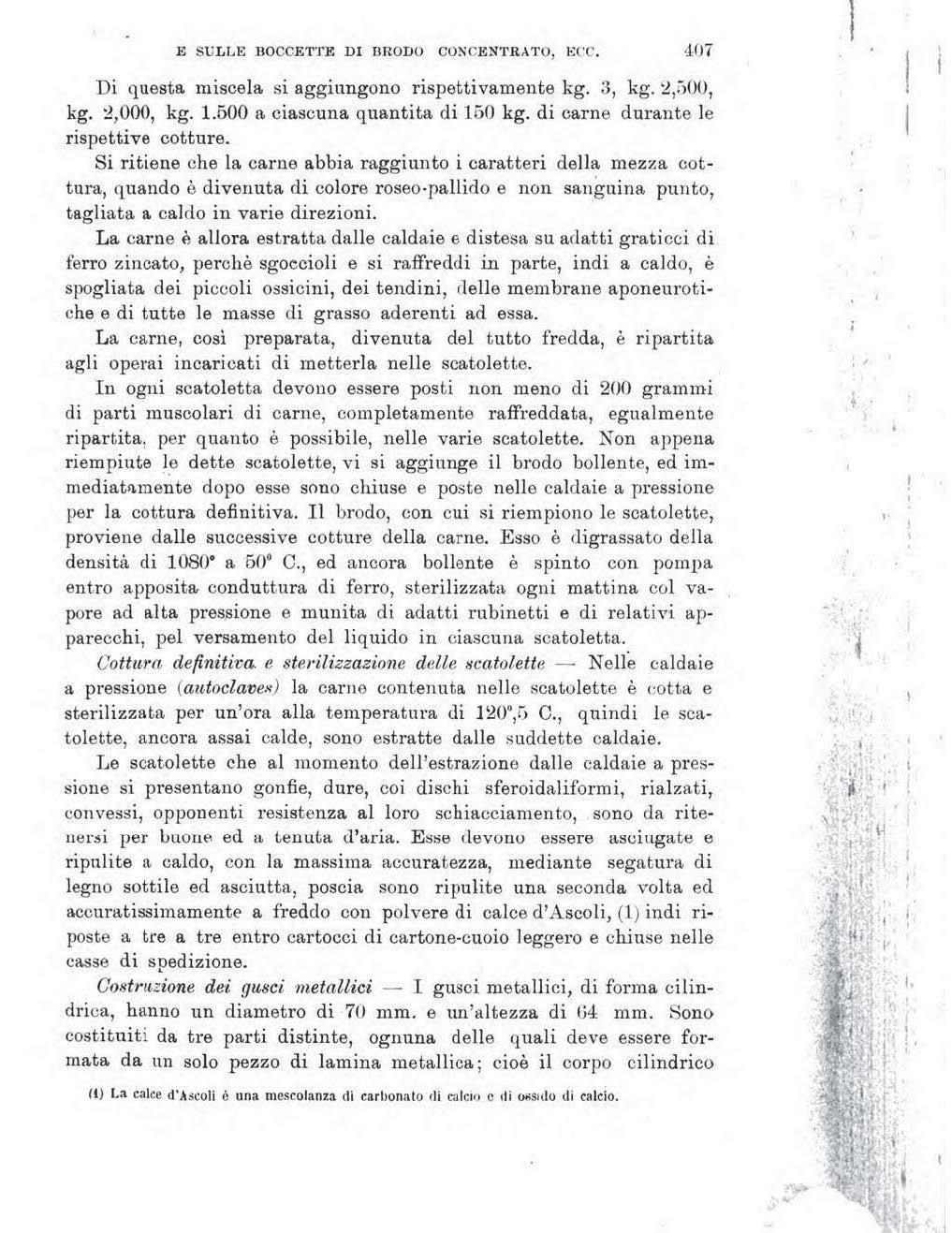


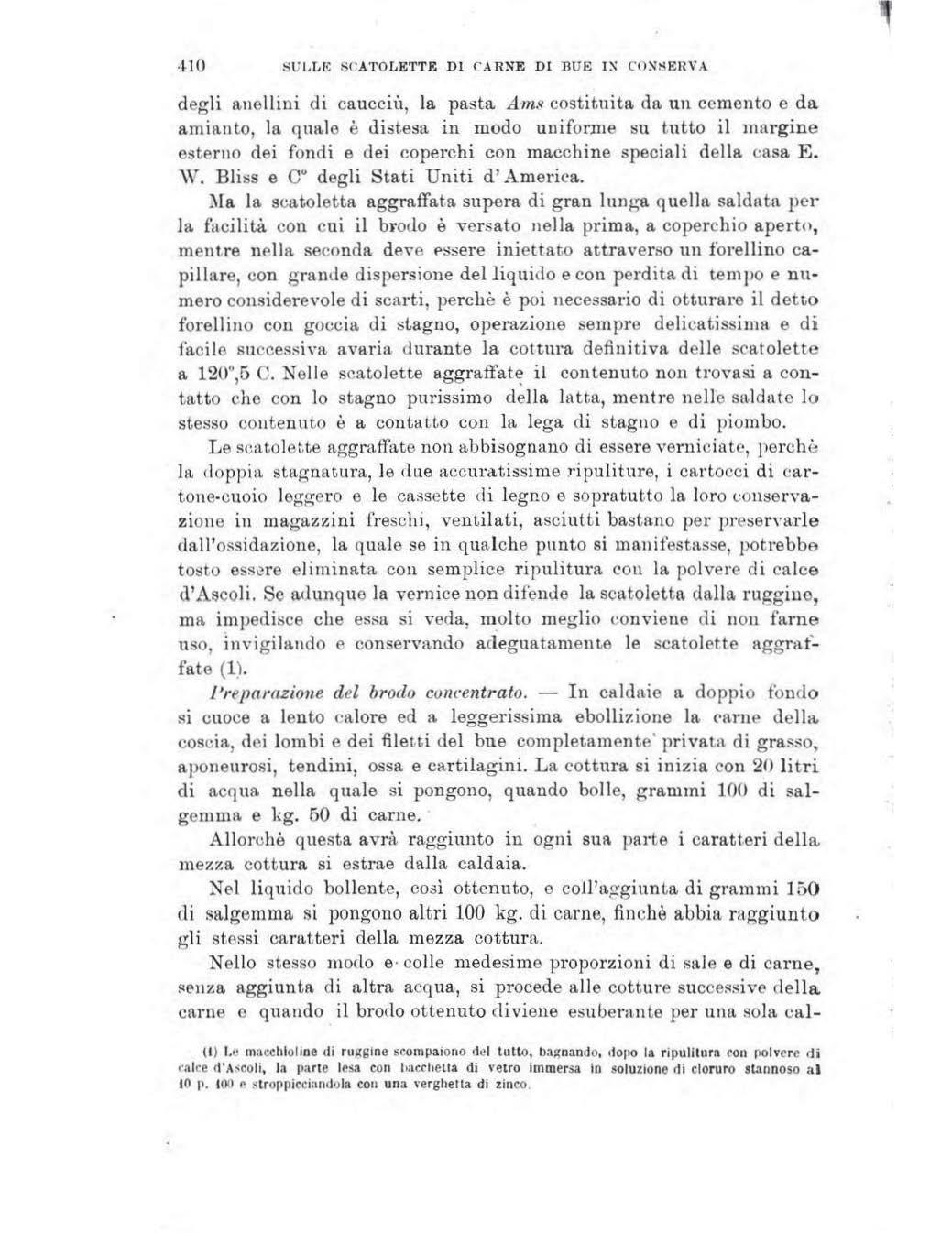
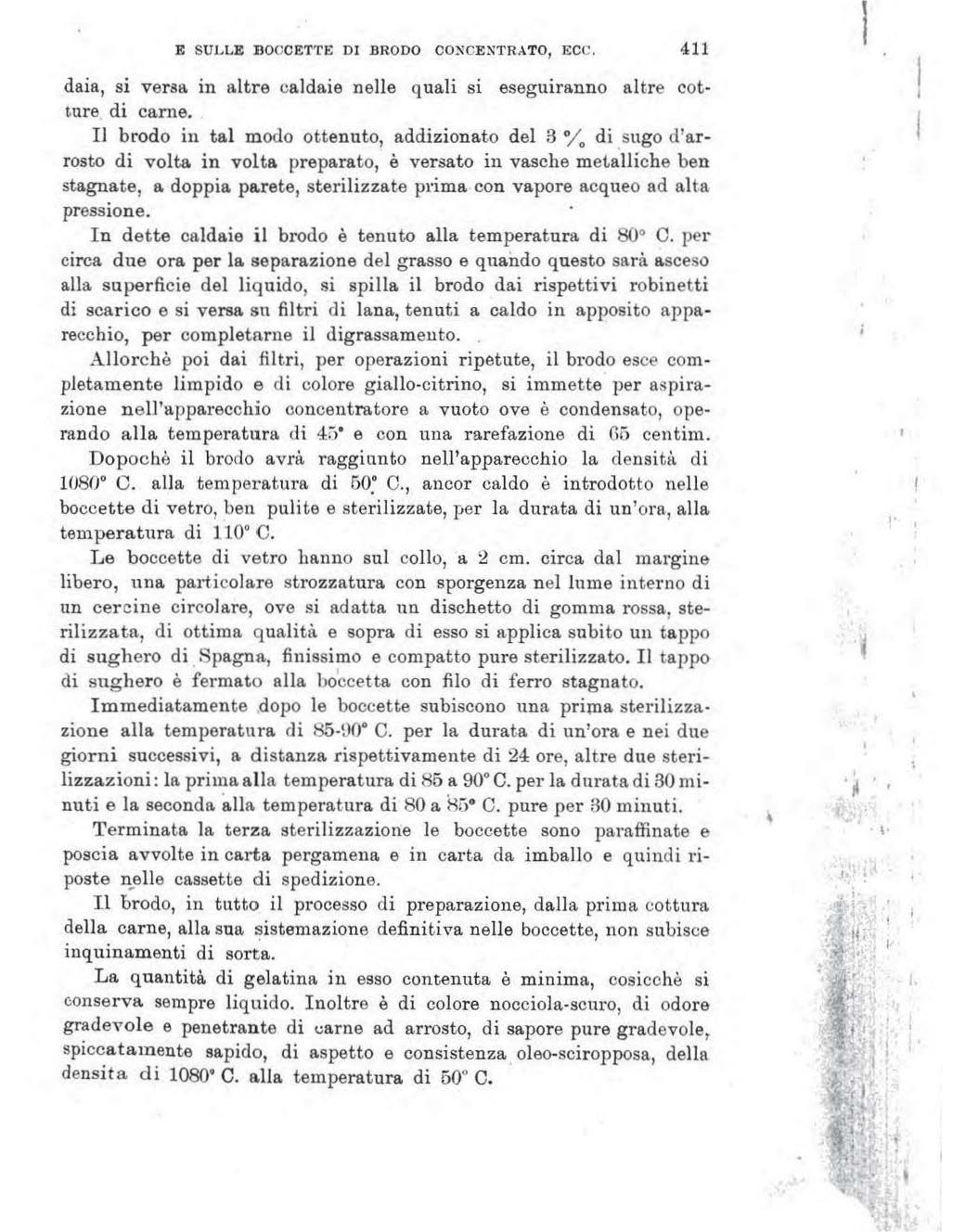

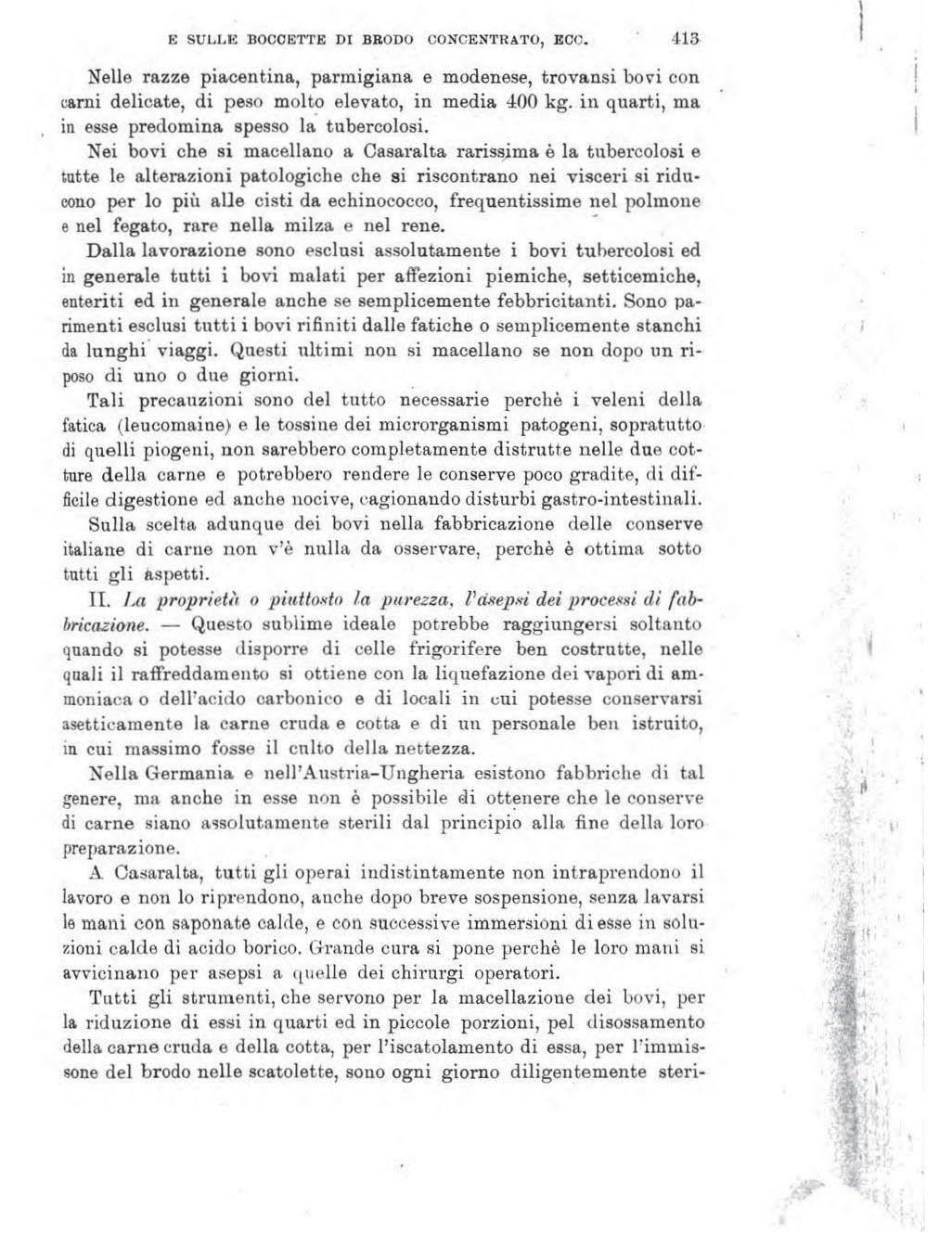
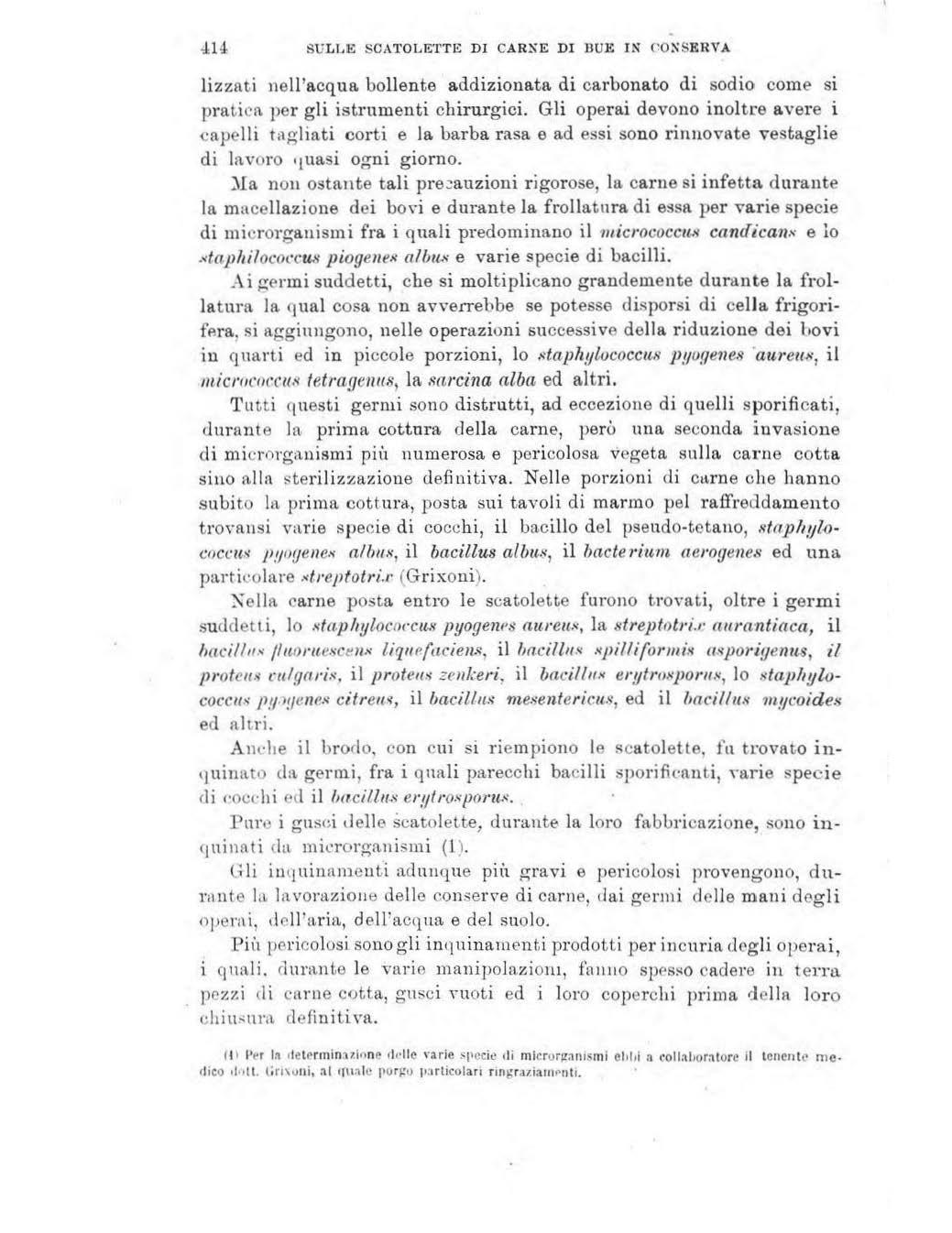

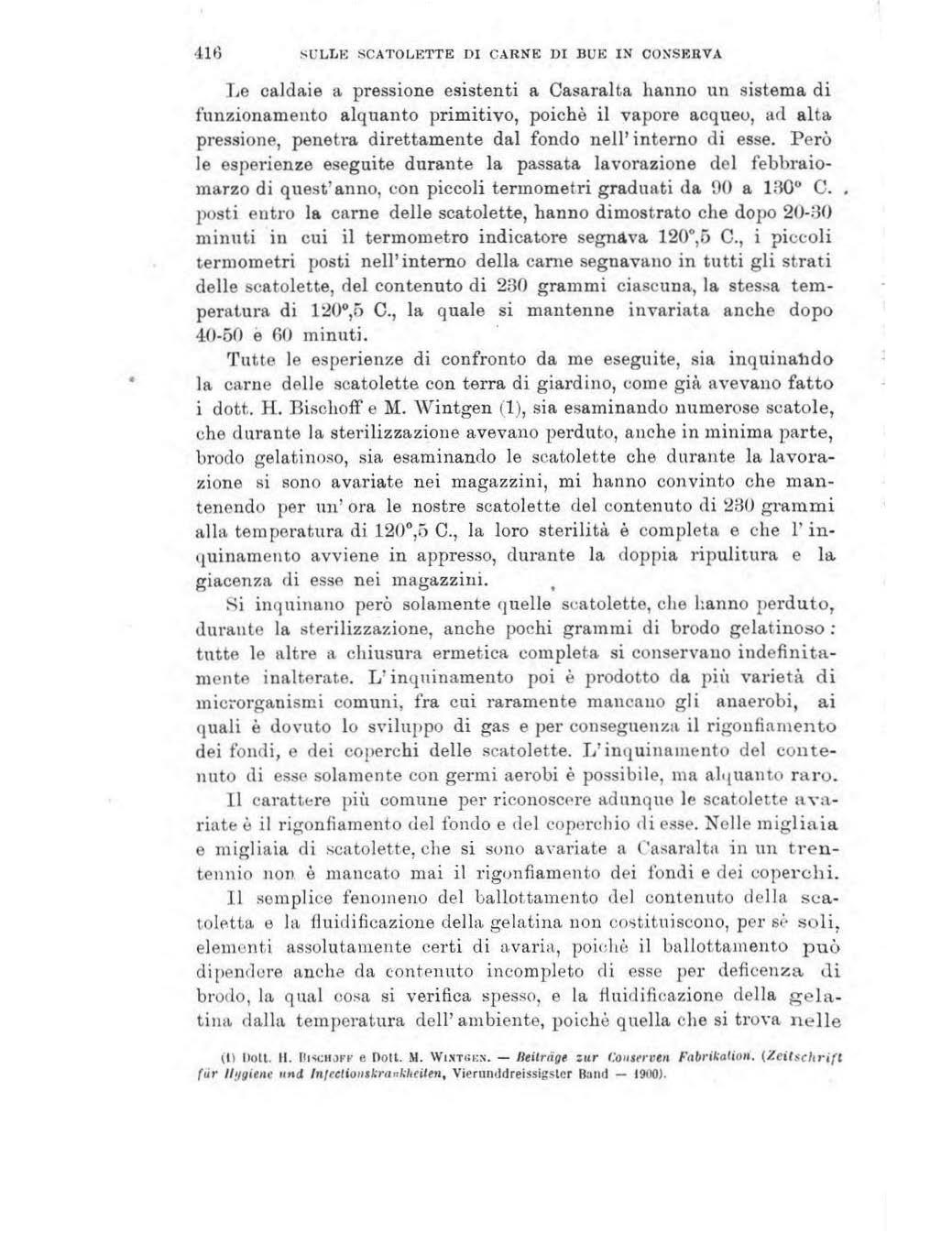







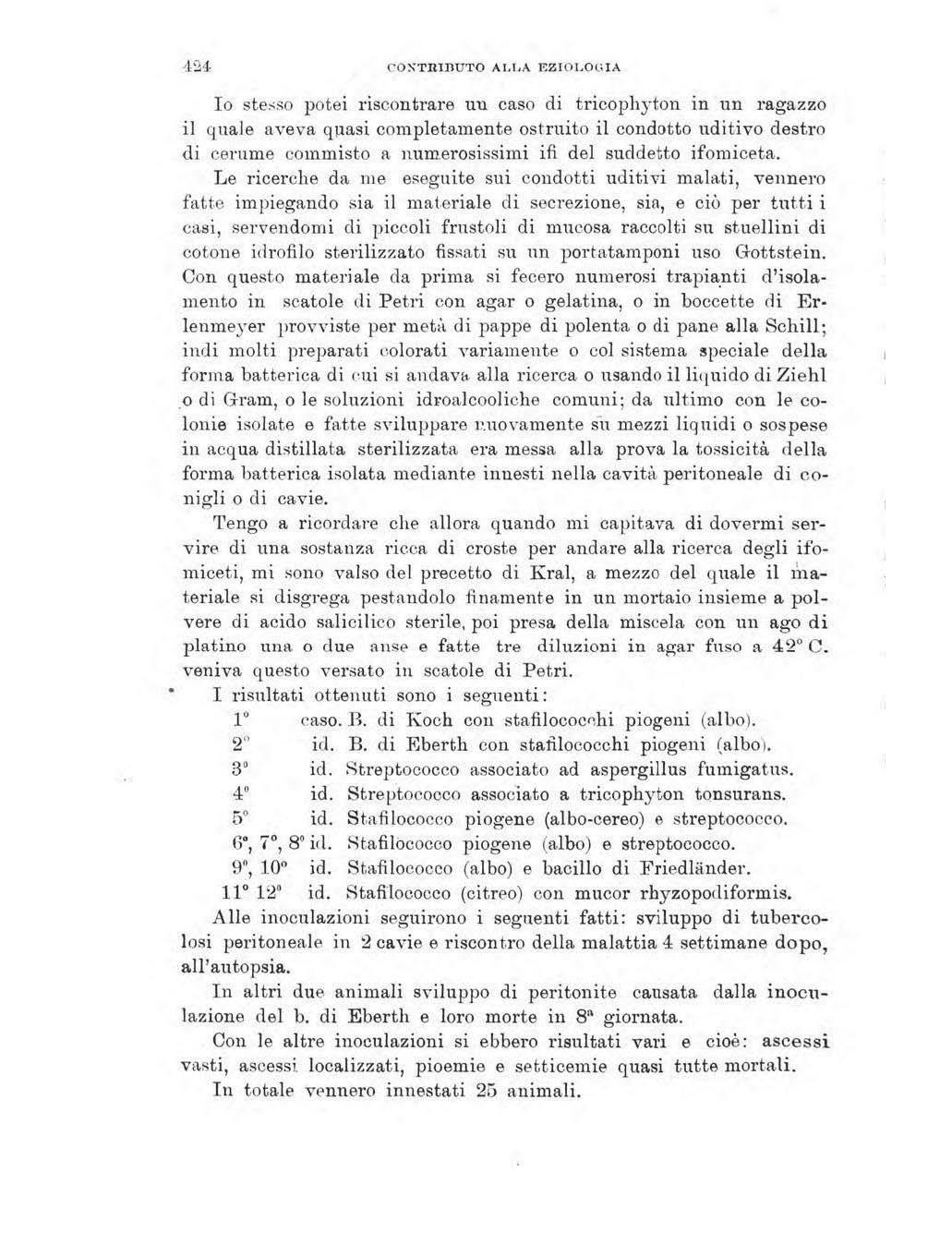














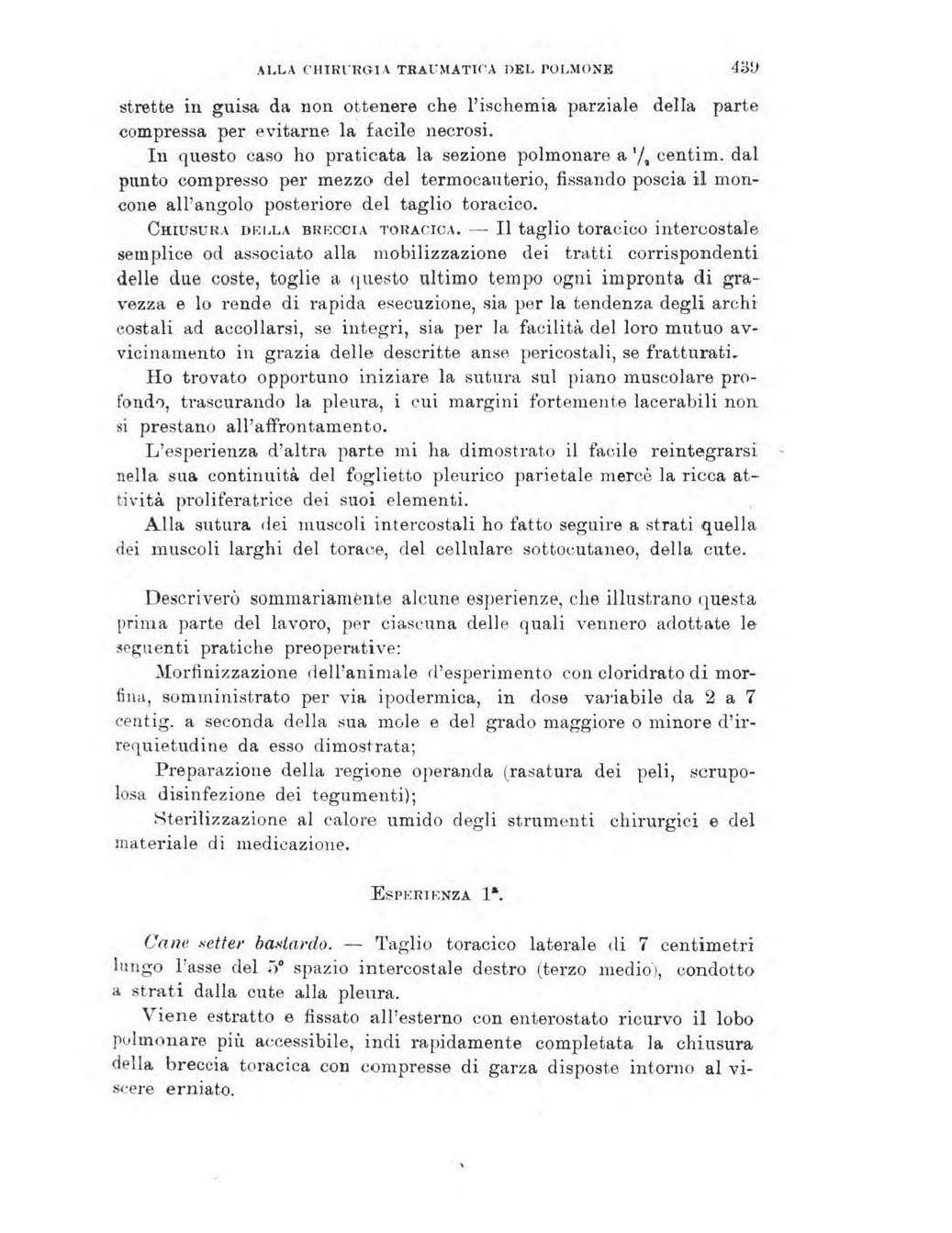





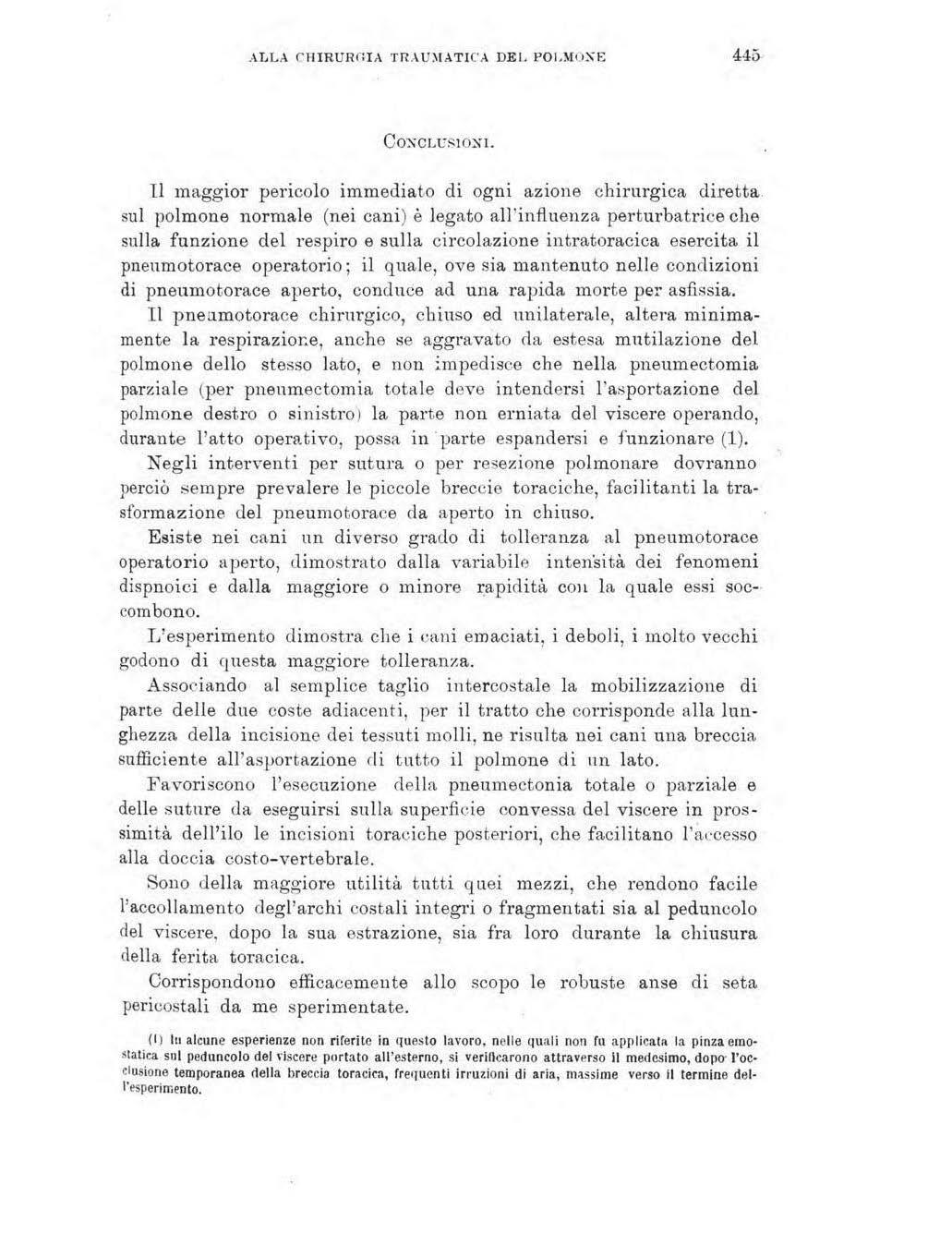
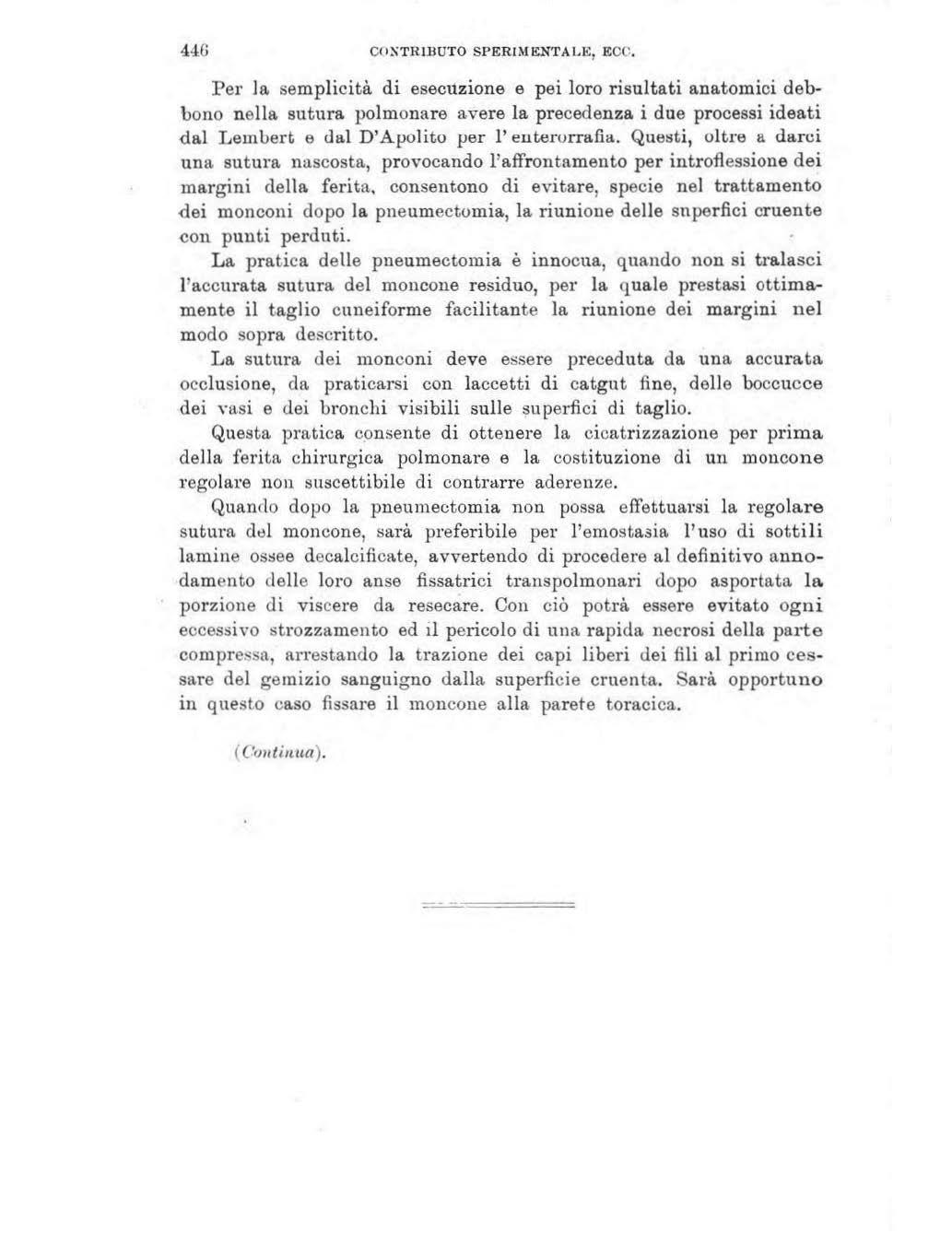
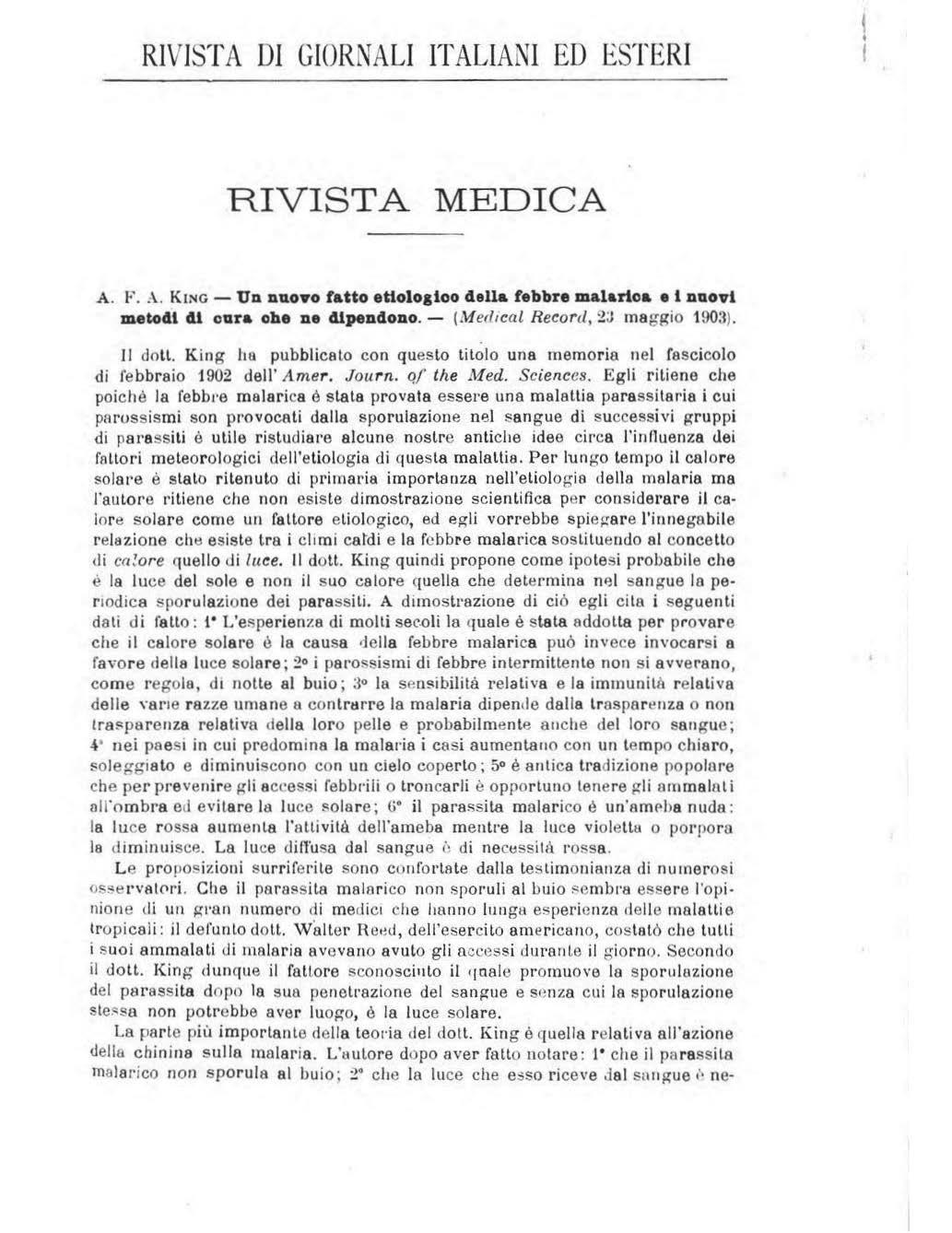


 G. B. M. B .
G. B. M. B .




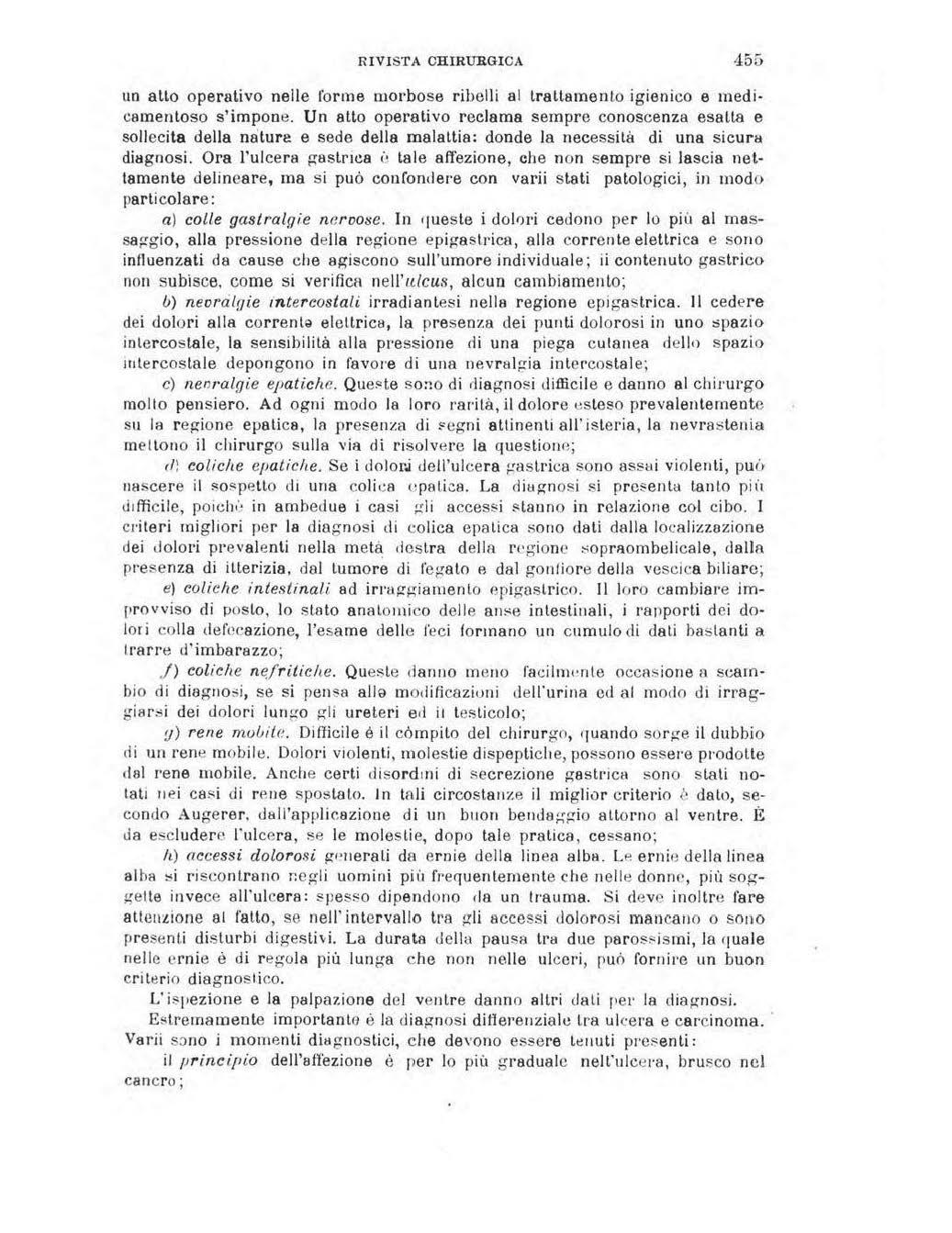





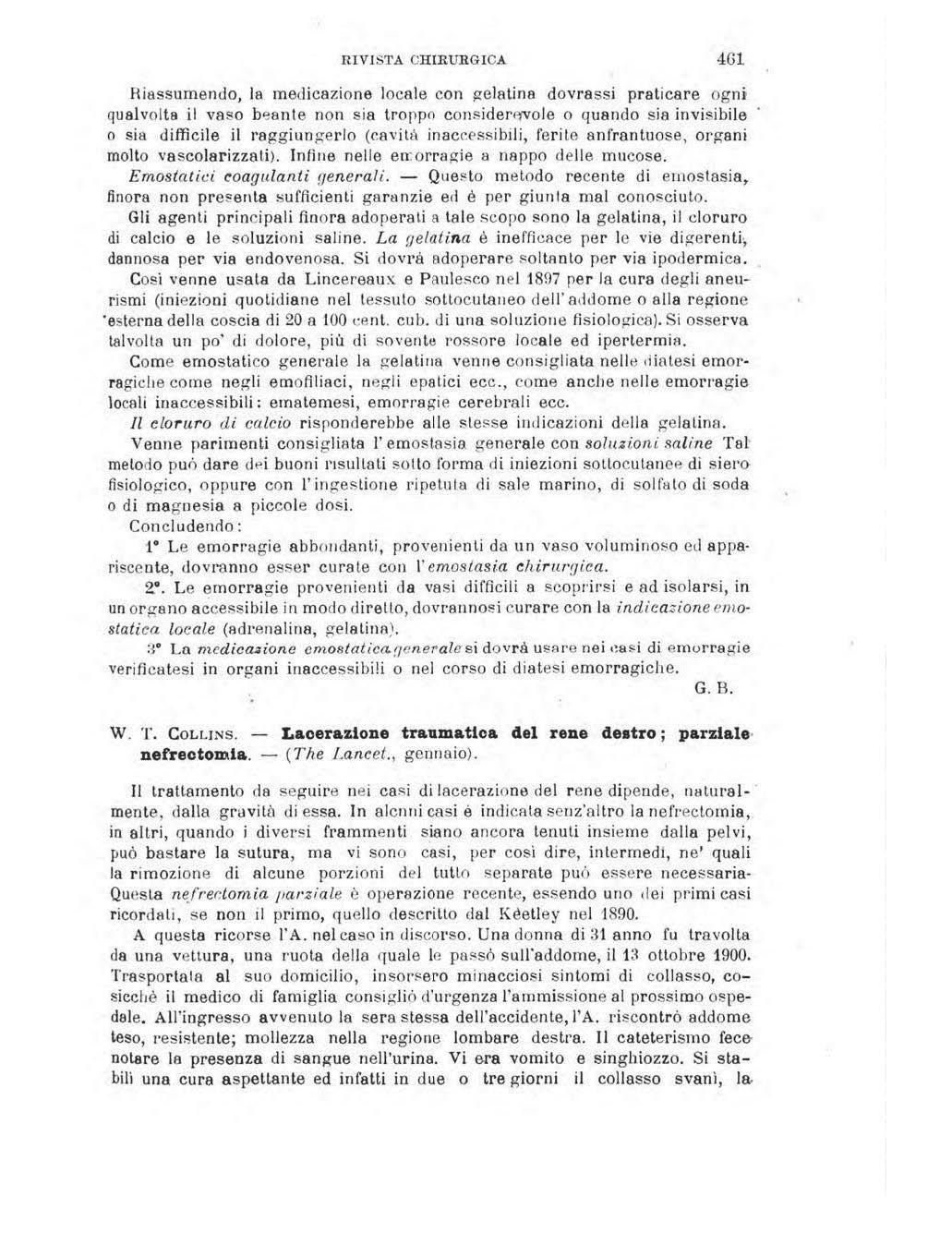



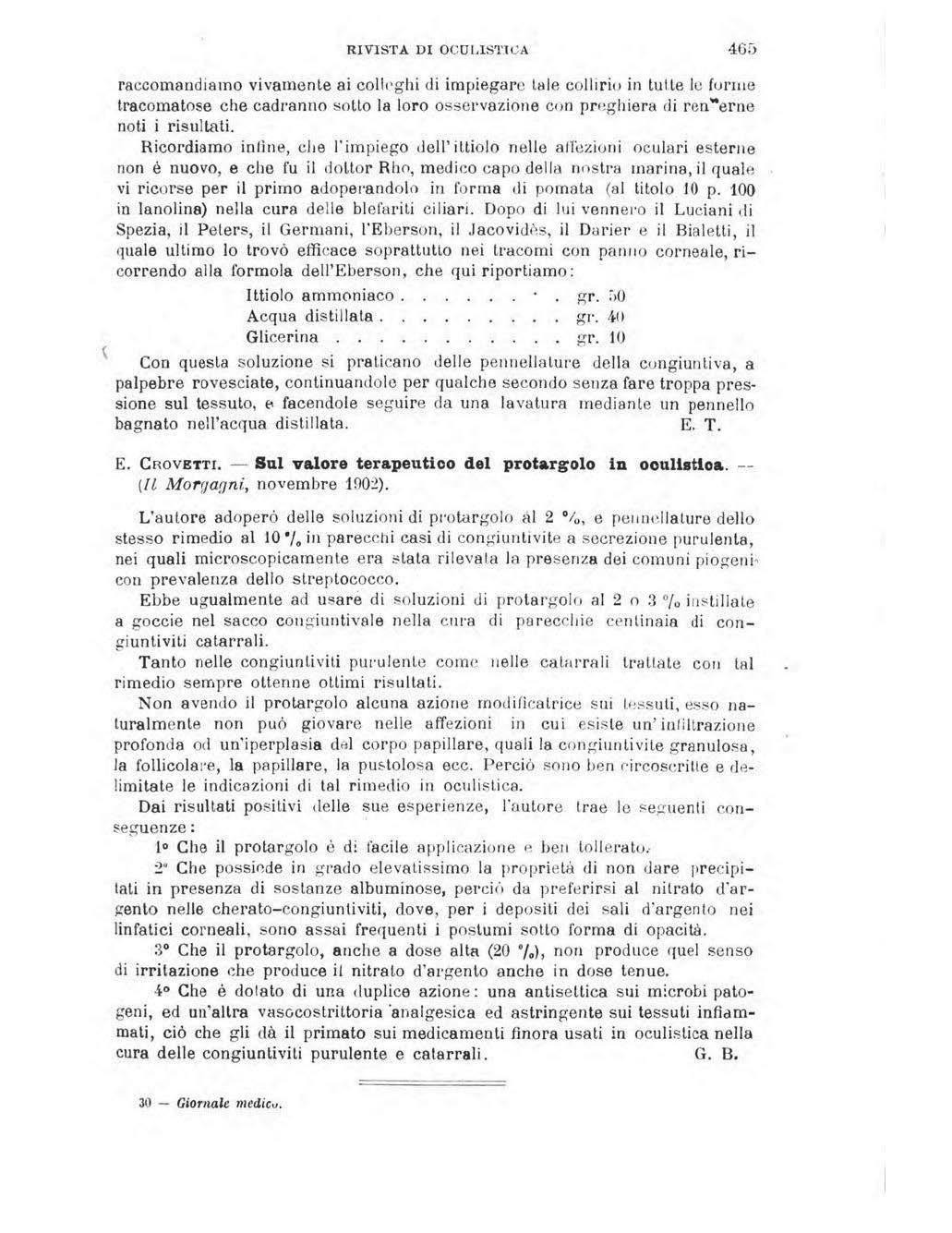 G. B .
G. B .