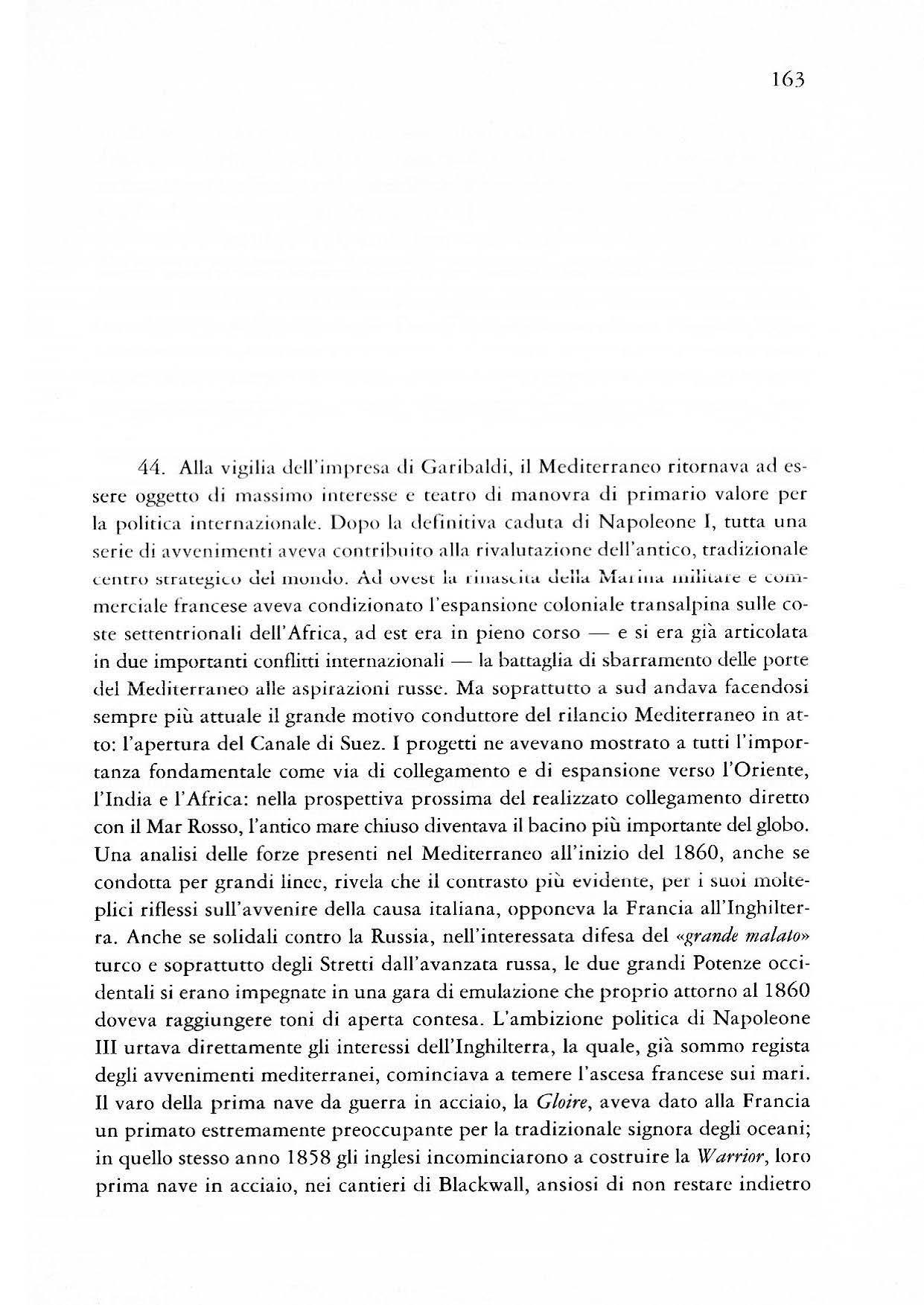
9 minute read
44. Sicilia e MeJiterraneo alla vigilia dell'impresa dei Mille
44. Alla vigilia Jcll'imprcsa di Garibaldi, il Mediterraneo ritornava ad essere oggetto di massimo inr<: rcssc: e teatro di manovra <l i primario valore per la polirica int<:rnazionak. Dopo la definitiva caduta. di Napoleone I, tutta una serie di avvenimenti avcv,1 contrihniro alla rivalurazione dell'antico, tradizionale
cc11Cro ~tra tc::g iLu Jd mu11du. AJ uvesr la ri11aSLÌla Jdb ;\f ai i,ia 11,ililale e ( ù1nmcrciale francese aveva condizionato l'espansione coloniale transalpina sulle coste senentrionali dell'Africa, ad est era in pieno corso - e si era già articolata in due importanti conflitti internazionali - la battaglia di sbarramento delle porre del :Mediterraneo alle aspirazioni russe. Ma soprattutto a sud andava facendosi sempre più attuale il grande motivo conduttore del rilancio Mediterraneo in atto: l'apertura del Canale di Suez. I progetti ne avevano mostrato a tutti l'importanza fondamentale come via di collegamento e di espansione verso l'Oriente, l'India e l'Africa: nella prospettiva prossima del realizzato collegamento diretto con il Mar Rosso, l'antico mare chiuso diventava il bacino più importante del globo. Una analisi delle forze presenti nel Mediterraneo all'inizio del 1860, anche se condona per grandi lince, rivela che il contrasto più evidente, per i suoi molteplici riflessi sull'avvenire della causa italiana, opponeva la Francia all'Inghilterra. Anche se solidali contro la Russia, nell'interessata difesa del «trande rnalaJo» turco e soprattutto degli Stretti dall'avanzata russa, 1c due grandi Potenze occidentali si erano impegnate in una gara di emulazione che proprio attorno al 1860 doveva raggiungere roni di aperta contesa. L'ambizione politica di Napoleone III urtava direttamente gli interessi dell'Inghilterra, la quale, già sommo regista degli avvenimenti mediterranei, cominciava a temere l'ascesa francese sui mari. Il varo della prima nave da guerra in acciaio, la Gioire, aveva dato alla Francia un primato estremamente preoccupante per la tradizionale signora degli oceani; in quello stesso anno 1858 gli inglesi incominciarono a costruire la Warrior, loro prima nave in acciaio, nei cantieri di Blackwall, ansiosi di non restare indietro
Advertisement
ai concorrenti d'oltre Manica. Nel medesimo tempo una notevole psicosi dell'invasione incominciò a diffondersi in Inghilterra, favorita sia dalla famosa affermazione di Palmersron - «Stearn bridged the G"hannel» - secondo cui l'applicazione del vapore alle navi avrebbe fatto un ponte della Manica, sia dal declino· di prestigio subìco in Inghilterra dalla CTorta negli anni tra il 1850 cd il 1860 O> .
Ma il primo teatro del contrasto era il Mediterraneo, dove si erano sviluppate le tappe decisive della rinascita marinara francese e dove cale rinascita aveva portato a conquiste coloniali di prim'ordine o a scoperte e ad ulteriori ambizioni C2> . L'ammiraglio Lalande, che era stato l'artefice della rinascita della Marina francese, aveva comandato a partire dal 1838 proprio la squadra del Mediterraneo, ed applicandovi i propri metodi nuovi aveva cream un scuola che aveva efficacemente contribuita a forgiare il nuovo strumento marittimo della politica francese. In Cina, tra il 1857 e il 1860 la partecipazione navale francese
(1) Cfr. A. J. MARDER, Tht anatomy o / British Sett Power, New York 1940, pagg. 66-7. Un grido d'allarme era stato lanciaro in Parlamento da lord Lyndhurst e dal duca di Somerset durame le discussioni politico-militari della primavera, cfr. anche " Il Giorn,ile di Romt1" del 9 maggio 1860: in luglio lord Palmerston avrebbe chiesto nuovi crediti militari straordinari, citando l'Eserciro e la Marina francese, dr. "L 'lltmtration '' del 21 luglio 1860, pag. 50. D'altra pnrte la rinnovata pres· sione russa contro la Turchia esigeva un rafforzamento della potenza maritrima, che non appariva in quel momento appannaggio soltanto della G ran Bretagna. Notava " T.a (;llzutta di ( ;er,nva ·· del 25 giugno 1860, sotto il titolo: «Prec,111zio11i della Gra 11 /J retag11a» , che erano in corso grandi appre·
<.ran1 C'nti d1(ensiv1 terrestri: ent il pt"riodo in cui per la dif"esa naziùn,1k l'rcvalcvano in lnbll!l1crr:1
i concetti della Brick a 11d Mor/ar School, ossia della scuola del marrone e calcestru,.zo, foncb ti sull'a J.>· prestamenro di forrifìcazioni campali lungo le coste. presidiate datresercito, in opposizione alle teorie dei navalisti, che assumevano doversi l'invasore fermare davanti ai suoi porti di partenza, valorizzando la potenza della flotta. Il giornale genovese constatava che ormai il vecchio principio, che voleva la forza marittima inglese capace di fronteggiare nme le altre potenze navali coalizzate, doveva considerarsi superato dalla esistenza di altre forti marine che, alleandosi, avrebbero potuto superare quelJa inglese. Un notevole movimento per riconquistare le posizioni perdute era tuttavia in atto in Gran Bretagna da parte degli ambienti navali, favoriti rlall'evidente valorizzazione indiretra della flotta che i fatti siciliani riel 1860 fornivano. "// Giornale di Roma " del 6 luglio dava
nutizi;l c.J j un l>a11d1ettu d1e era sraco tenuco a Lonàra, a Triniry 1-Iouse, ali'lsciruro marittin10, ii
25 giugno precedente; in quella occasione il Principe Consorte aveva affermato solennemente: «La vùa de/l'Inghilterra, noi tutti io .rentit1mo, è più Jlll mare che m ila terra. N oi non viviamo, wme i cine1i, 1opr,t .rtt1gni e .ropra canali; ma per tutto ove ondeggiano i flui/i detl'Ocermo, nei più remoti angoli dell,t terrt1. voi vedrete quei .flutti portare la vita d;;t/'lnghilterra, i prodntti dell'Tnghilte1·rt1, l'ind11Jtria del/'l11ghilterra ... » . Vedi anche M. GABRIELE, Lt1 Sicilia e il M editerra neo nel 7860, in li Veltro, Roma agosto-settembre I 960, pagg. 46-60. (2) Fin rial 1838 era staro scritto sulla Revue du Deux-Mondes: « ... dire che A lgeri è 11t1tt coionit1 vuol dire esprimeni male: i llgeri è rm Impero, 1111 Impero a due giorni di diJ!tm za da '/'olone»: cfr. SJLVA, ltalùi Frm1cùi lnghilterrt1 nel Mediterraneo, Milano 1939, pag. 75. E presto sarebbe venuto il tempo in cui PRÉVOST-PARADOL, nella sua France 11ou11elle, Parigi 1868; avrebbe lanciato il vaticinio del Nordafrica francese: «Po1sa venire presto ii giorno nel quale i no.rh·i co11cit1t1dini, troppo rim errati nella nostra Francia africa11,i , str,iripermmo nel Mt1rocco e nella '( 1miJia, e fonderanno finalmente quell'impero mediterraneo che 11011 Jttrà soltanto ,ma JOddiJfazio11e per il 11ostro orgoglio, ma sflrà anche a rt,m1e11te, nell,i fi1tr1rtt 1itr1azio11e mondiale, l'ultima risorsa della 1101tra grandezza»; cfr. SJLVA, Pig11re e momenti di storia ita liana, Milano 1939, pag. 397.
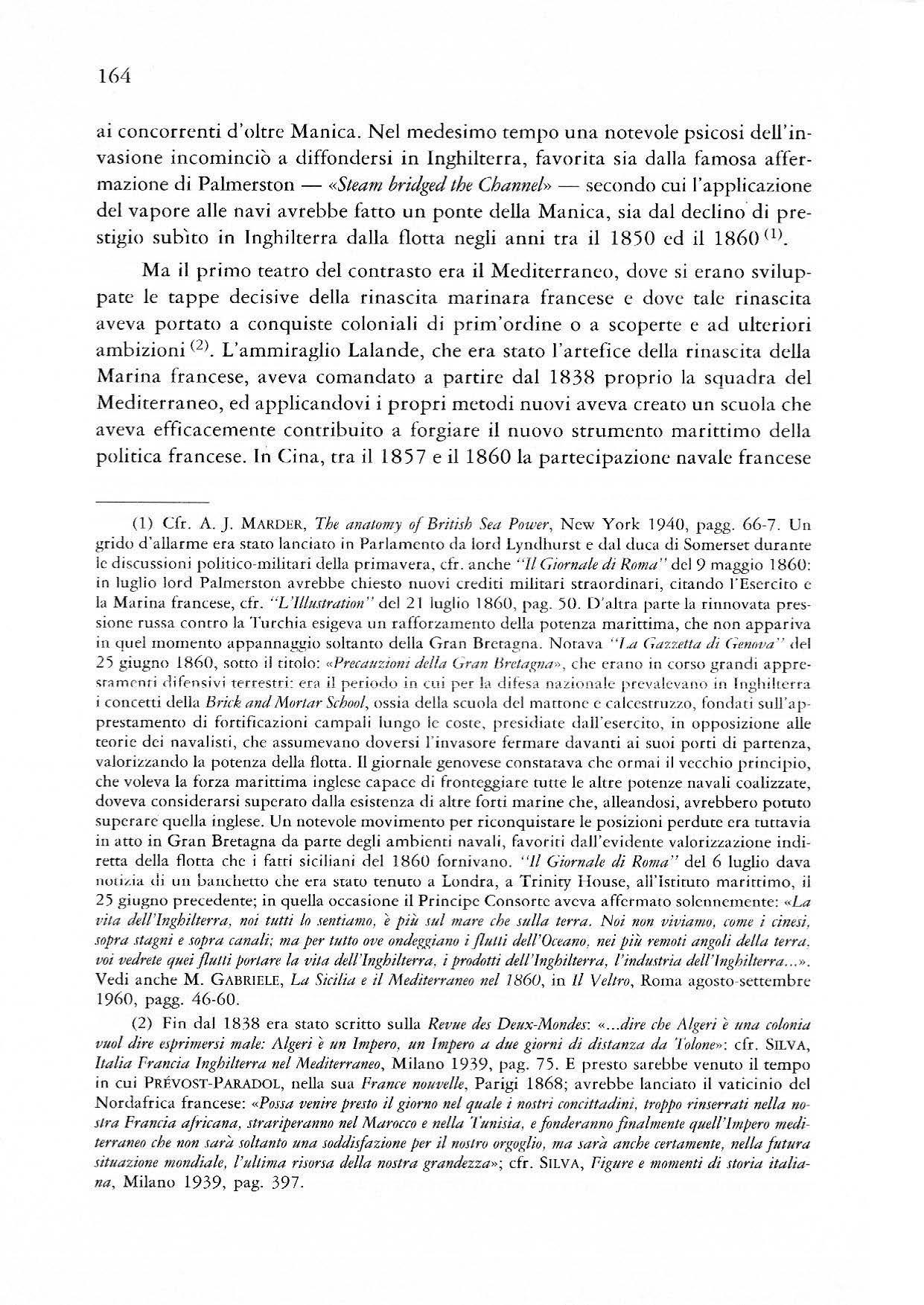
alle operazioni aveva talvolta soverchiato quella inglese e nel Mediterraneo, stabilita la fortissima base algerina, i francesi miravano al Levante e ad altri punti di forza che ne potenziassero l'insediamenro, già preoccupante per l'lnghilcerra. Londra disponeva nel Mediterraneo delle basi di Gibilterra e di Malta, delle Isole Ionie, e dei porti che le Potenze minori - Grecia, Turchia, Regno delle Due Sicilie, beilicati e principati africani - le offrivano, permettendole di far pesare appieno la superiorità navale britannica in ogni contingenza mediterranea.
Al tempo della seconda guerra dell'indipendenza italiana, l'Inghilterra poteva contare su un sufficiente controllo dei bacini orientali del Mediterraneo, dove alla decadente Marina turca andavano sostituendosi le Marine mercantili greca, austriaca e italiana, ma nel settore occidentale i rapporti di forza nei riguardi della Francia la trovavano in posizione non favorevole. Decisiva, ad ogni fine, sarebbe stata l'evoluzione della situazione nel settore centrale del Mediterraneo, dove l'Inghilterra, saldamente attestata a Malta e alle Ionie, si trovava a dover resistere alle velleir~ , di espansione navale della Francia. E il punto nevralgico del sertorc ccnu:ale, la vera chiave di tutta la situazione mediterranea del 1860, era la Sicilia. Il maturare degli eventi, le rivoluzioni, le guerre, avrebbero innestato sulla Sicilia tutto il problema italiano, alla risoluzione del quale le poce112e avrebbero dato ed orientato il proprio contributo in relazione al posto decisivo dell'isola nel hacino del Mediterraneo.
La posizione geografica della Sicilia ne fa veramente il centro del Mediterraneo. Al punto in cui i due bacini orientale cd occidentale comunicano, si trova in condizione di controllare i due passaggi obbligati di Messina e del Canale, naturalmente se le premesse geografiche sono sostt:nute da una adeguata politica marittima. Il Regno delle Due Sicilie consi<lerò invece l'isola come la propria appendice, come un possedimento insulare della Monarchia napoletana. E questa fu una delle principali ragioni che impedirono alla Aotta borbonica di pesare adeguatamente, in relazione alle proprie possibilità, nel bacino mediterraneo. Eppure la Sicilia rappresentava un punto focale di quei traffici marittimi per esercitare i quali il governo di Napoli si era adattato a pagare pesanti tributi ai potentati costieri del Nordafrica ed a stipulare gravosi trattati commerciali con l'Inghilterra, la Francia e la Spagna Ol. Ma lo sviluppo della Marina e la politica marittima borbonica furono sempre condotti in funzione di Napoli, per cui i porti della Sicilia venivano trascuraci e gli interessi commerciali isolani non tenuti nella dovuta considerazione. Questa politica si risolse a favore di Malta, che era riuscita ad attrarre nella sua orbita un traffico marittimo maggiore di quello che normai-

(3) Cfr. G. M. MONTI, L'espamione mediterr,mea del Mezzogiom o d'Italia e della Sicilia, Bologna 1924, pag. 355 e, dello stesso, La Marina mercantile borbonica e il rnmmerào marittimo, in "Rassegna Storica del Risorgimento", Roma 1934, pagg. 206 segg.
mente avrebbe dovuto farvi scalo. La Marina militare, poi, era nota m Sicilia soprattutto come strumento di repressione nelle mani ciel governo di Napoli, come si vide nel 1820 e nel 1848 <4). Mai i Borbone, malgrado la loro pur notevole opera in favore della Marina, compresero che la Sicilia costituiva un trampolino ideale al centro del Mediterraneo e che, se abilmente usata sul piano navale, avrebbe potuto permettere una brillante politica estera nei riguardi delle maggiori Potenze. Ferdinando Il, invece, si incaponì ad impedire che le sue navi uscissero dalle acque del Regno, nel timore che i contatti con altri Paesi contaminassero la sua Marina di spirito liberale. Tutto ciò non contribuì, naturalmente, al mantenimento dei migliori rapporti con l'Inghilterra, dalla quale i Borbone dovettero subire diverse umiliazioni <5>, senza che l'appoggio spagnolo ed austriaco valesse a sostituire la forza del perduto sostegno britannico. La seconda guerra dell'indipendenza italiana aveva dato modo ai francesi di avviare nuove dimestiche,:ze al di là di quel Canale di Sicilia che l'Ammiragliato londinese riteneva già zona nevralgica, e naturalmente ciò non aveva fatto piacere alla Gran Bretagna. Tuttavia, l'improvvisa fine della guerra e gli eventi successivi, le annessioni f' 11' rurbolenri vicende del dopoguerra immediato, ancora una volta avevano mutato i termini del problema italiano e schiuso ai politici più accorri prospettive nuove. Succeduco al conservatorismo di lord Derby il Gabinetto liberale di Palmerston poco prima di Villafranca, J'arreggiamento inglese mutò nei riguardi delle ambizioni irali:rne, f' mnrò in senso decisamente favorevole. La cessione di Nizza e Savoia contribuiva a far dimL"nticare in Italia il sangue francese che era staro versato in Lombardia per la causa italiana. Nello stesso tempo - in un momento nel quale l'Inghilterra temeva molco dalla Francia l'utilità di avere nel Mediterraneo una potenza amica, una potenza padrona della Sicilia, capace di minacciare domani l'eterno avversario francese, parve ai politici liberali d'oltre Manica di importani'..a estrema. Il governo di Torino, incanto, non sembrava propenso ad imbarcarsi da solo in nuove avventure di largo respiro in lcalia, timoroso che la volontà delle poteni'..e ostili non avesse a togliergli anche quelle conquiste padane alle quali, sopra ogni cosa, teneva. Ma la rivoluzione di Firenze, nell'aprile 1859, aveva portato la causa italiana al sud degli Appennini ed aveva aperto la via ad ogni altra eventualità. Incominciò, nella calma apparente, il ·1860. Torino e Napoli, come Vienna, Mosca, Berlino, Parigi e Madrid, avevano gli occhi fissi a problemi diversi, chi ai baratti di territorio, chi alle difficolc~t di poli,:ia, chi alle conseguen,:e di una strana pace.
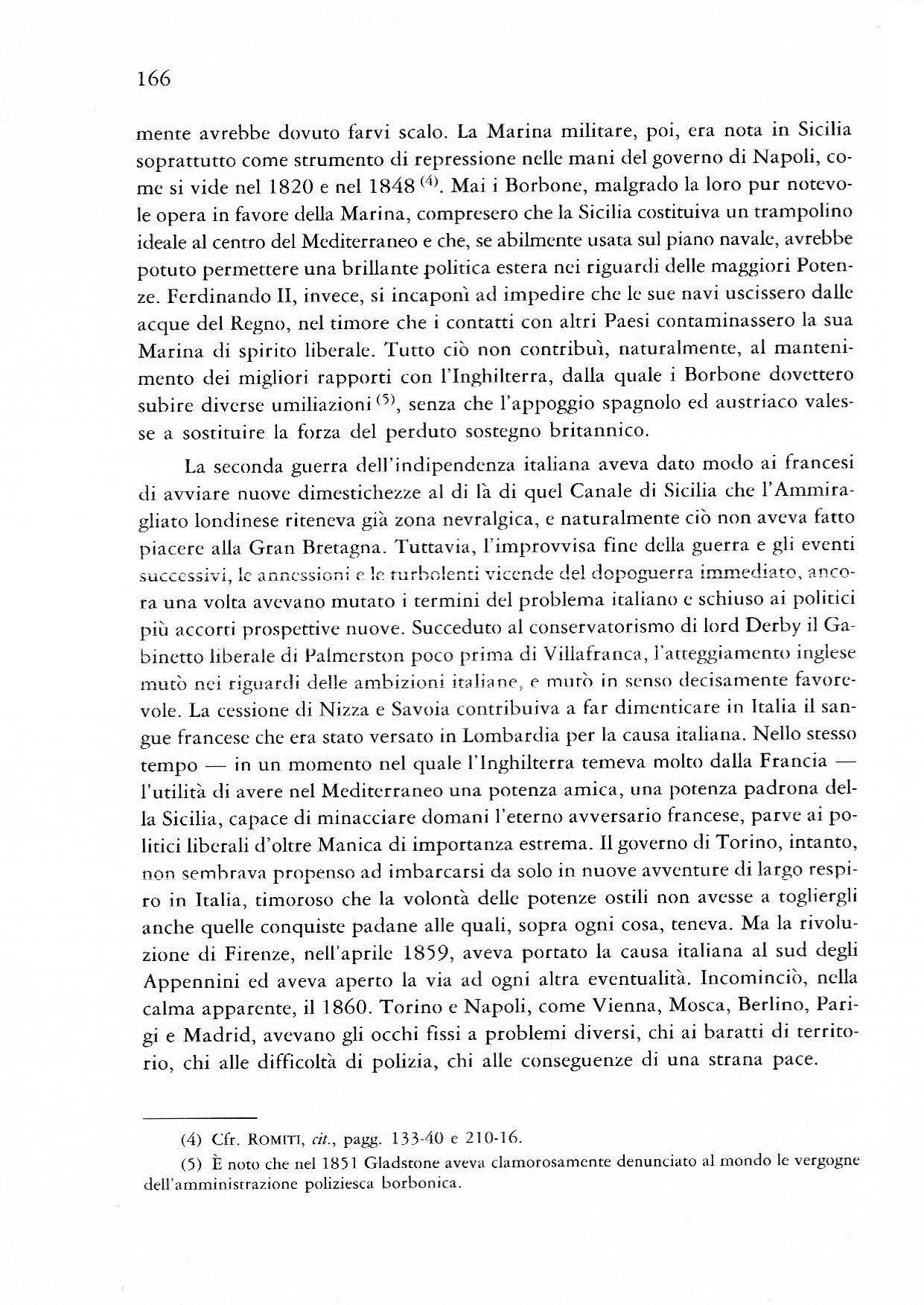
(4) Cfr. ROMITl, cit., pagg. 133-40 e 210-16. (5) È noto che nel 1851 Gladscone aveva clamorosamente denunciato al mondo le vergogne dell'amministrazione poliziesca borbonica.










