
7 minute read
15. Gli avvenimenti siciliani del 1860 decisivi sul piano politico e militare
Ma la tradizionale sensibilità politica britannica captava già nelle acque del Mediterraneo i segni premonitori di una crisi a venire, mentre le unità da guerra della flotta di Malta erano pronte a prendere il mare per seguire gli avvenimenti siciliani. Ali' isola erano fissi gli occhi del Foreign Office e dell'Ammiragliato. In Sicilia si erano avute manifestazioni di giubilo nel 1859, alle norizie delle vittorie alleare nella pianura del Po, e il flusso dei patrioti che emigra vano era diventato sempre più considerevole. Anche il contrabbando di armi e di polvere da sparo, operato dai trabaccoli maltesi, era aumentato. In Sicilia, oltre al console di Palermo, Goodwin, gli inglesi tenevano allora ben l L vice consoli, indice chiaro di un interesse che gli avvenimenti successivi dovevano pienamente giustificare <6> .
45. Lo sbarco di Garibaldi a Marsala cd i successi dd suo esercito in Sicilia, favoriti dai precedenti moti e dall'intervento massiccio degli isolani a fianco delle truppe garibaldine, determinavano gli orientamenti delle varie Potenze. Ma poiché Garibaldi agiva in proprio e - sebbene inalberasse la bandiera dd Re di Sardegna - offriva al preoccupato governo di Torino il modo di scaricarsi dinanzi alle potenze della responsabilità diretta; J'osrilicà dichiarata di quasi tut-
Advertisement
ri Ì !JUVl:fllj !:>lfi.lllicrj llU l.l c...uudussc.: al CdJi111t.:lllU I l ~ ,dht !>U!>l)c..; 11::,iu1t t: \..lelri111p1e:,,a. Uno dei fortori del successo fu certo il poco credito che quasi da ogni parte si dava alla spedizione di Garibaldi, per cui le successive prese di posizione erano regolarmente superare dagli avvenimenri. Lo stesso Cavour non credeva in partenza nelle possibilità degli avvt:nimt:nti garibaldini: tuttavia, abituato ed esperto com'era nel condurre un gioco multilaterale che gli lasciasse aperte tutte le strade, non ostacolò l'impresa. Come si è detto, egli si limitò a dare mandato alla flotta di impedire che i porti della Sardegna divenissero base d'operazione per i Mille, fece dirottare piì:.1 tardi in Sicilia la spedizione Bertani destinata ad invadere lo Staro pontificio e si barcamenò intanto a mantenere una formale neutralità fra le proteste e le pressioni delle potenze ostili.
Ben pochi, ne! maggio ! 860, si rendevano conto che dagli avvenimenti siciliani sarebbe derivata l'Unità d'Italia e, quindi, una situazione politica e strate-
(6) l vice consoli inglesi, al 1 ° gennaio 1860, erano:Joseph Rickards, inglese - il solo rerribuicu - a Messina; Luigi Marino, trapanese, a Trapani; Benjamin lngham, inglese, a Marsala; Samuel Clarckson, inglese, a Mazzara del Vallo; Ferdinando lmbomone, locale, a Sciacca; Lewis AJcxander Thompson, inglese, a Licara;John Carcs, inglese, a Girgemi; Francesco Bresmes, locale, a Terranova; Cesare Porcelli, <la Vittoria, a Scoglirti; Carlo Azzopar<li, maltese, a Siracusa e John Joshua Jeans, inglese, a Catania. Cfr. P.R.O., Londra, Foreign O/free, 70, 322, <love sono pure le rela%ioni, fondare sulle norizie fornire dai consolari, sulla navigazione e il commercio della Sicilia <lai 1857 al 1859. Appena poi la rivoluzione e il susseguente sbarco garibaldino arrirarono l'attenzione delropinione pubblica sulla Sicilia, la stampa si interessò dell'isola sotto ogni aspetto: il 26 maggio 1860 " f.'Tllmtrated f.ondon N ew.r" puhhlicò un lungo servizio informativo sulla Sicilia, nel quale la situazione geografica e strategica dell'isola era esaminata parricolarmente dal punro di vista militare e navale.
gica completamente nuova nel bacino del Mediterraneo. Ma questa situazione completamente nuova non si sarebbe probabilmente avuta se gli avvenimenti siciliani non si fossero conclusi con il passaggio dello Stretto, voluto e imposro da Palermo. L'azione politica della capitale garibaldina finì per avere un peso determinante, sia nei riguardi dell'unità italiana, sia, per necessaria conseguenza, sui nuovi equilibri mediterranei. Era dunque molto grossa, decisiva, la partita militare e politica che Garibaldi si trovò a giocare in Sicilia, dal maggio all'agosto, in guerra contro i Borbone e in politica contro i moderati liberali di Cavour. Dalla difficile giornata cli Ca lata fìmi alla sorprendente occupazione di Palermo, e poi a Milazzo, nella battaglia decisiva per il possesso dell'isola, l'avventura militare felicemente si svolse, tappa per tappa, tra lo stupore del mondo, in un'atmosfera non priva di toni romantici, che colpiva la fantasia e attirava da lontano molti spiriti generosi nelle fìle dell'esercito volontario. Ma il gioco degli intrighi e dei contrasti politici tra le diverse correnti italiane incominciò a dipanarsi, seguendo molti intricati fili, da quando Palermo diventò la capitale dello Stato garibaldino. Quando si dice Stato garibaldino si vuole intenclnt> ql•ell~ particolare forma di governo che ebbe vita in Sicilia, e poi in tutto il Meridione, fino all'autunno, in nome della dittatura di Garibaldi, il quale, a sua volta, si era autoproclarnaro depositario di tutti i poteri in nome di Vittorio Emanuele 11. Rispondeva, questo, alle conclamate intenzioni di Garibaldi di conquistare non solo la Sicilia, ma anche l'Italia meridionale e Roma, da dove, in sfida alla Francia, egli si riprometteva di proclamare l'unità italiana offrendo al monarca subalpino una nuova corona di re. Nuova perché avrebbe dovuto riassumere la volontà unitaria di tutto il popolo italiano e rappresentare, senza legami troppo stretti col passato della Corte di Torino, 1a nuova grande Italia che tutti gli antichi e recenti seguaci di Mazzini avevano sognato. Sarebbe stata - al di là di ogni accantonata polemica istituzionale - l'Italia redenta degli italiani, l'Icalia Jtlle grandi imprese, la cui nuova irresistibile vita avrebbe dovuto germogliare dalla passione bruciante dei patrioti, e non da abili manovre di alleanze o da machiavellici giochi diplomatici. Ma l'esperienza dolorosa delle insurrezioni fallite, degli improduttivi complotti che preparavano le repn:ssioni sanguinose, l'assenteismo del popolo, sordo nella gran parte agli ardori delle élites rivoluzionarie, parlavano contro la validità della tesi radicale. All'opposto, i successi del 1859, preparati da un'abile politica che puntava sullo sfruttamento delle rivalità internazionali, - interessando diplomaticamente la Francia di Napoleone III alle lotte del Piemonte contro l'Austria, - sembravano confortare le vedute del parriro moderato liberale. Da questo fondamentale contrasto di metodi scaturì in Sicilia l'insanabile dissidio tra i partiti di Cavour e di Garibaldi sulla strada da battere per raggiungere l'unità

nazionale. I radicali amavano accusare Cavour, colpevole del baratro di N izza, di non volere realmente l'unità della Penisola, mentre i moderati sostenevano che la realtà incernazionalc: impediva la conquista della unirà attraverso la rivoluzione, la quale avrebbe potuto essere foriera soltanto di catastrofi. Su questo sfondo di contrasto primario tra le due maggiori figure italiane del 1860, in Sicilia si mossero altre cozzanti passioni e interessi, dalle rivalità personali tra esponenti radicali ed emissari di Cavour ai motivi separatisti che una tradizione antica manteneva sempre vivi nell'isola. L'infelice scelta di Cavour che mandò a rappresentarlo a Palermo un uomo arrogante, inveleniro, fazioso e prevenuto come il La Farina, aggravò in partenza la situazione, senza che l'appoggio della flotta sarda, al comando del Persano, potesse controbilanciare agli occhi dei radicali quanto di negativo andava producendo a Palermo la presenza degli emissari di Cavour. La personalità di Crispi, inoltre, così inquieta cd ombrosa, portò nel i:orktail di uomini che si agitavano a Palermo una nuova carica esplosiva. 1 risultati furono apparentemente disastrosi: non solo Garibaldi non ebbe mai un governo efficiente su cui poter cont.ire, ma i sussultori avvenimenti palermitani con quelle sempre provvisorie alleanze locali di idee e di uomini portarono ad una rottura protoncla era le due pnuupah t"az1u111 pohllche 1Laiianc, che pure asserivano di avere gli stessi ideali m. La contesa politica tra Palermo e Torino si articolò intorno al problema dell'annessione immediata o meno della Sicilia al Piemonte, ed i radicali riuscirono ad imporre per mesi il rinvio dell'annessione. Essi riuscirono a procrastinarla fino alla liberazione dell"ltalia meridionale, che coincise con l'intervento regio organizzaro da Cavour, dopo il fallimento del tentativo di provocare a Napoli un moto liberale. L'abile Ministro di Vittorio Emanuele Il avrebbe dimostrato di sapersi adattare rapidamente all'evolvere turbinoso della situazione e trarne profitto, ma al partito radicale non va disconosciuto il merito di avere imposto da Palermo, governando tra difficoltà e disordini, la soluzione unitaria.
D 'altra pari.e, ,ìnche il crono dell'apparato militare e politico borbonico re-
gistrò i suoi episodi decisivi durante la fase siciliana dell'impresa dei Mille. La conquista di Palermo, la battaglia di Milazzo, il passaggio dello Stretto di Messina, segnarono sul piano militare il destino di Francesco II. In Sicilia le truppe regie conobbero, ancora più gravi delle sconfitte militari, le rese vergognose, le fughe, gli imbarchi avvilenti tra la derisione del popolo, davanti ad un nemico palesemente meno forte, ma più ardito e più fortunato, olcre che meglio condotto_ Giudicata sotto questo profilo, anche la grande battaglia del Volturno - la maggiore della Campagna - non ebbe forse l'importanza degli scontri e delle scaramucce che avevano portato i garibaldini ad impadronirsi avventurosamente
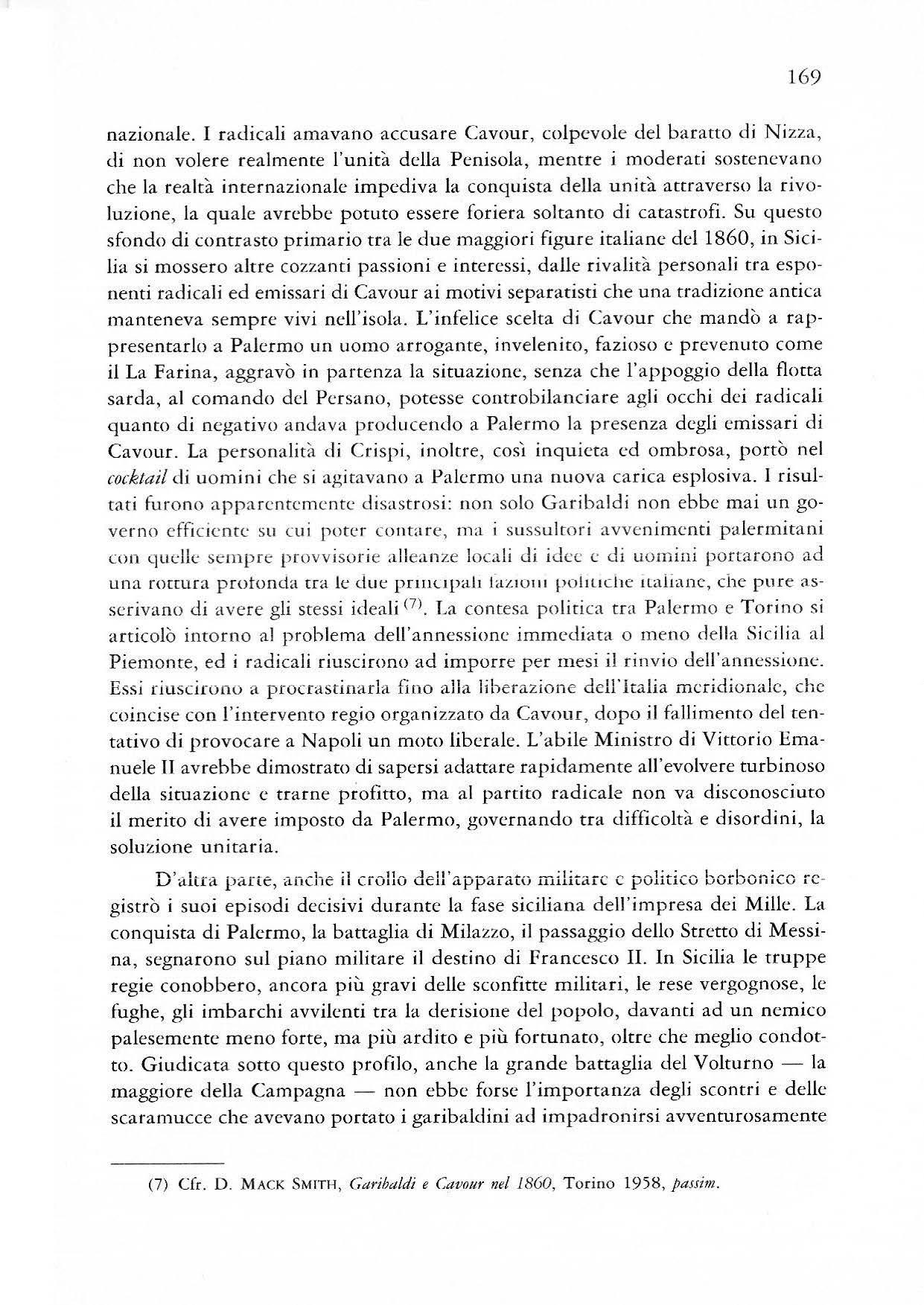
(7) Cfr. D . MACK SMTTH, Carihaldi e Cavour nel 1860, Torino 1958, passim.










