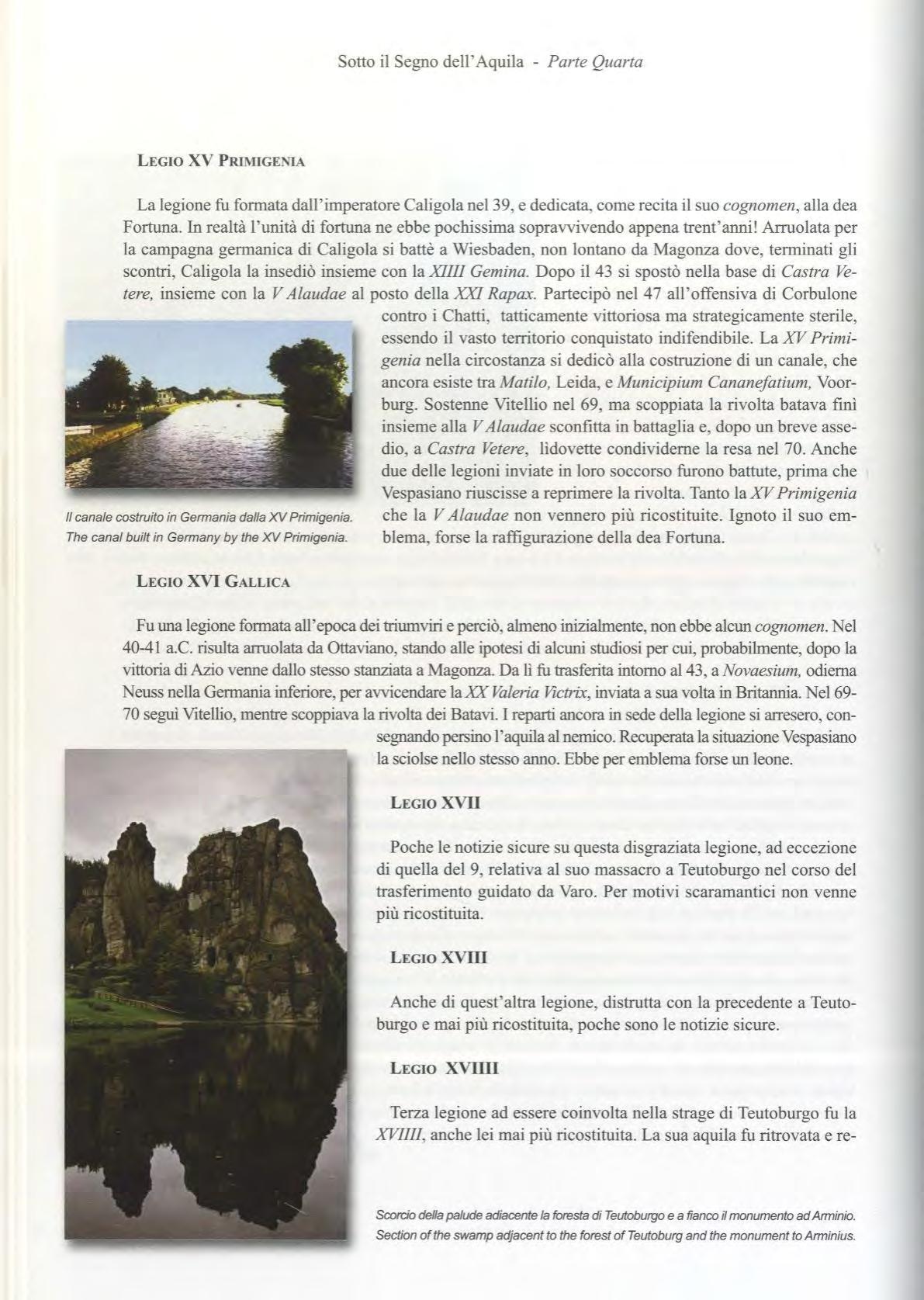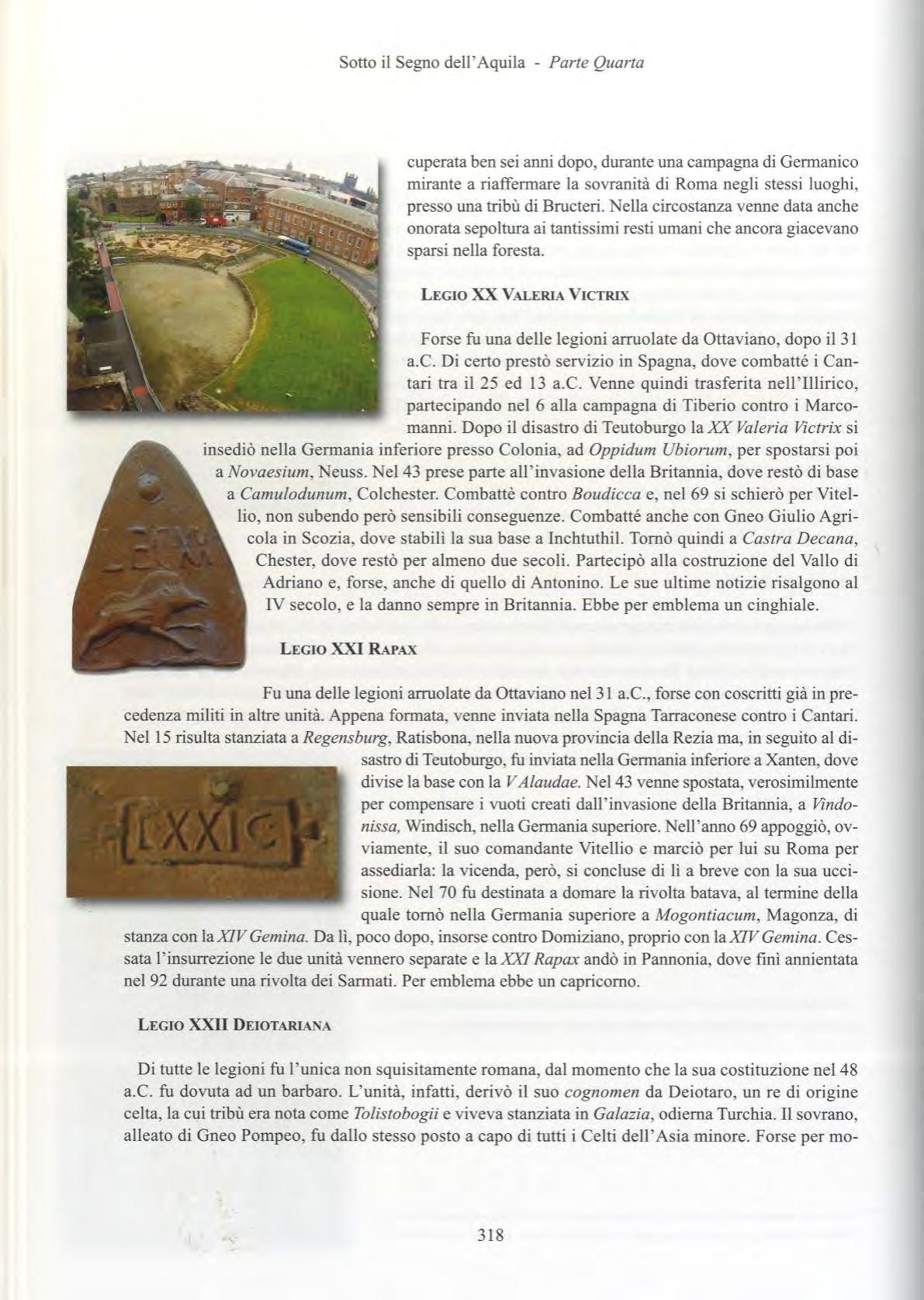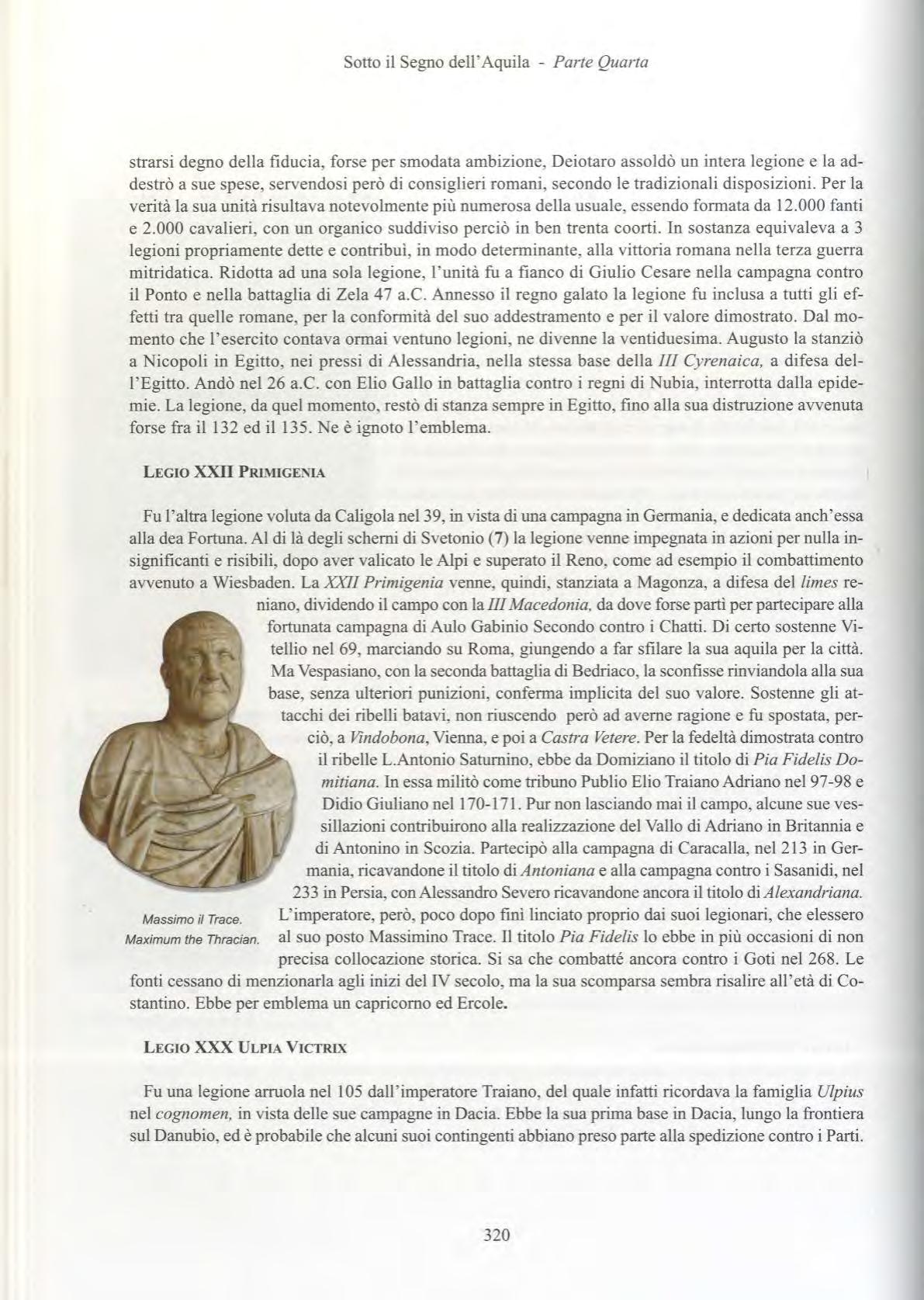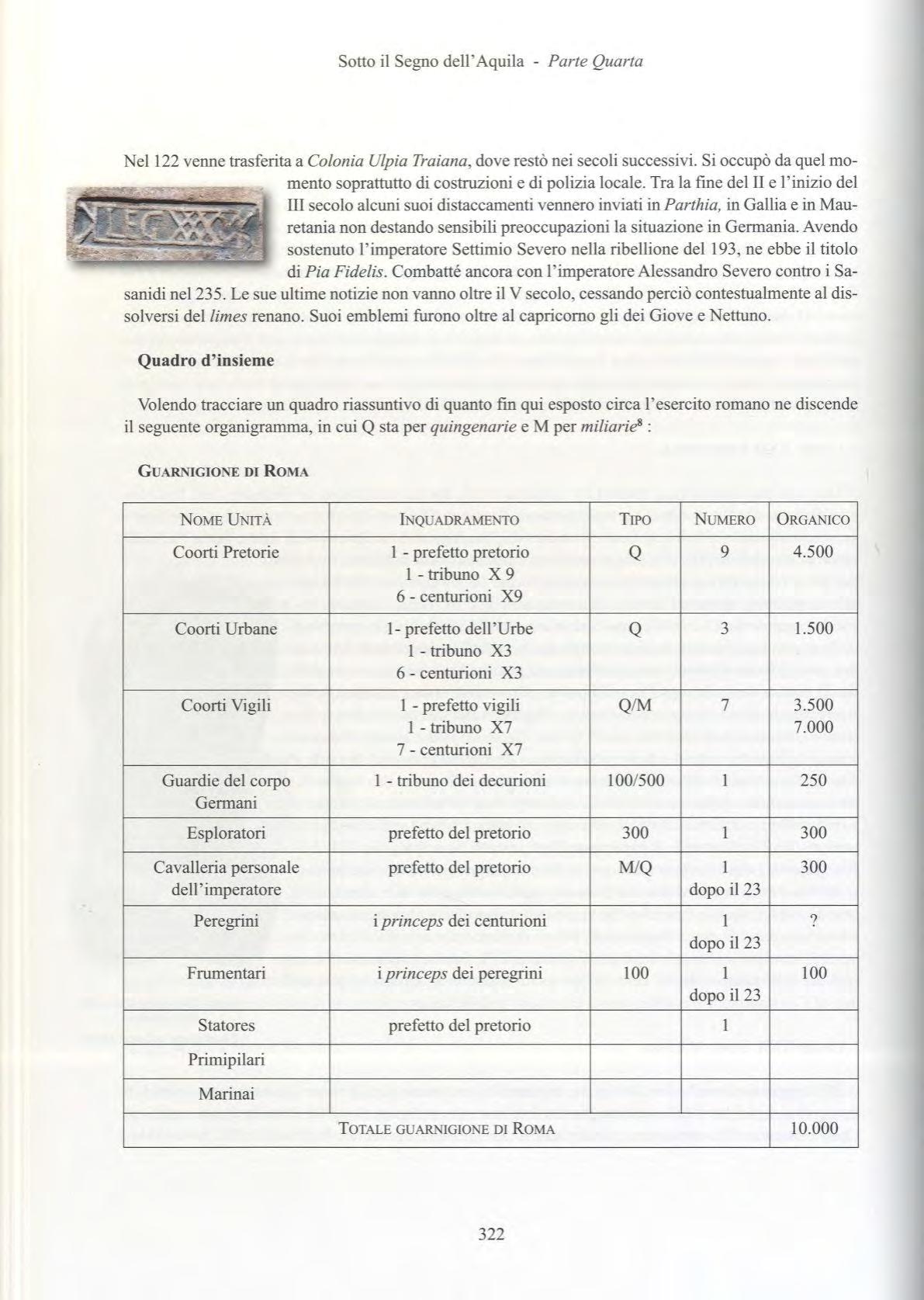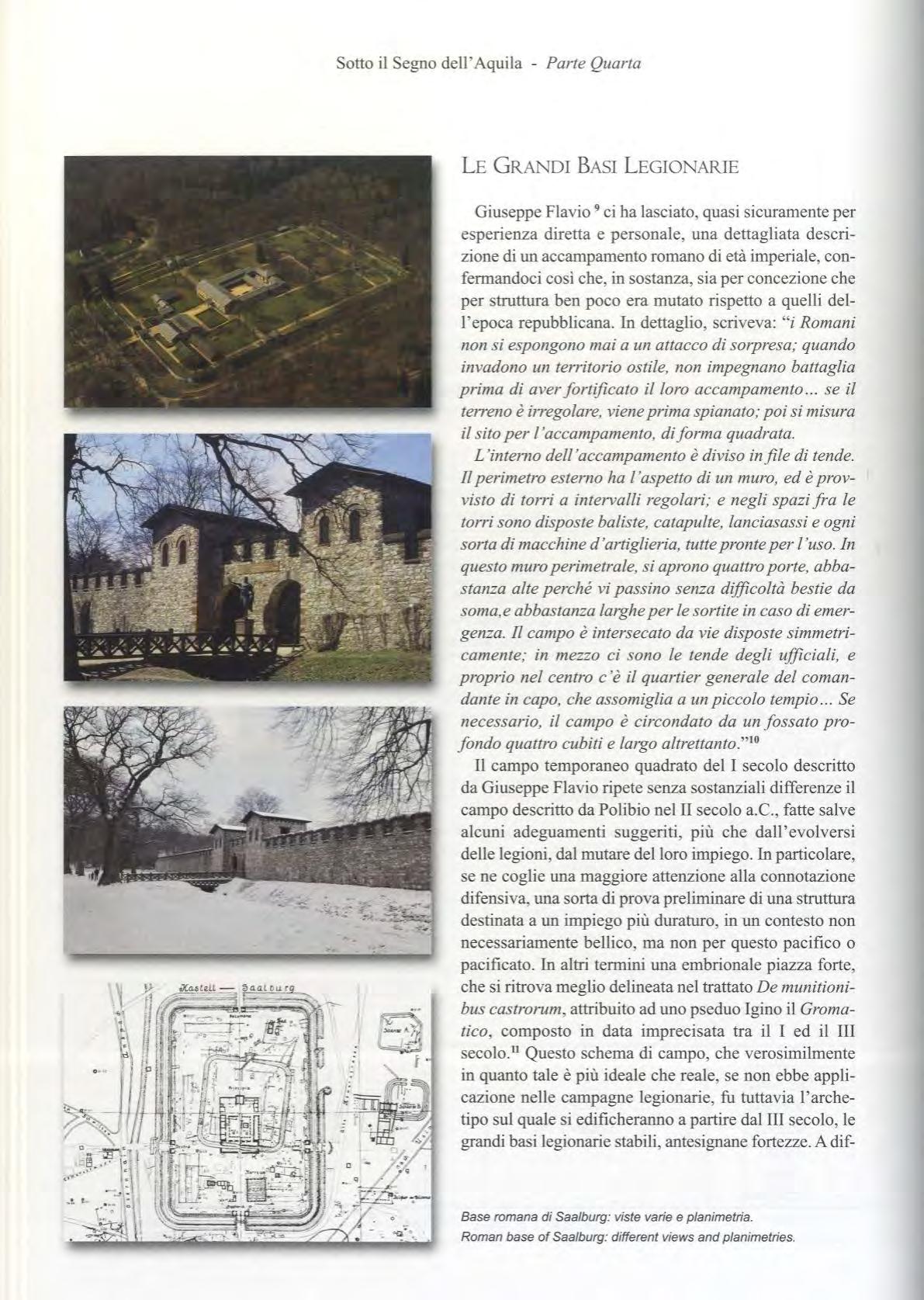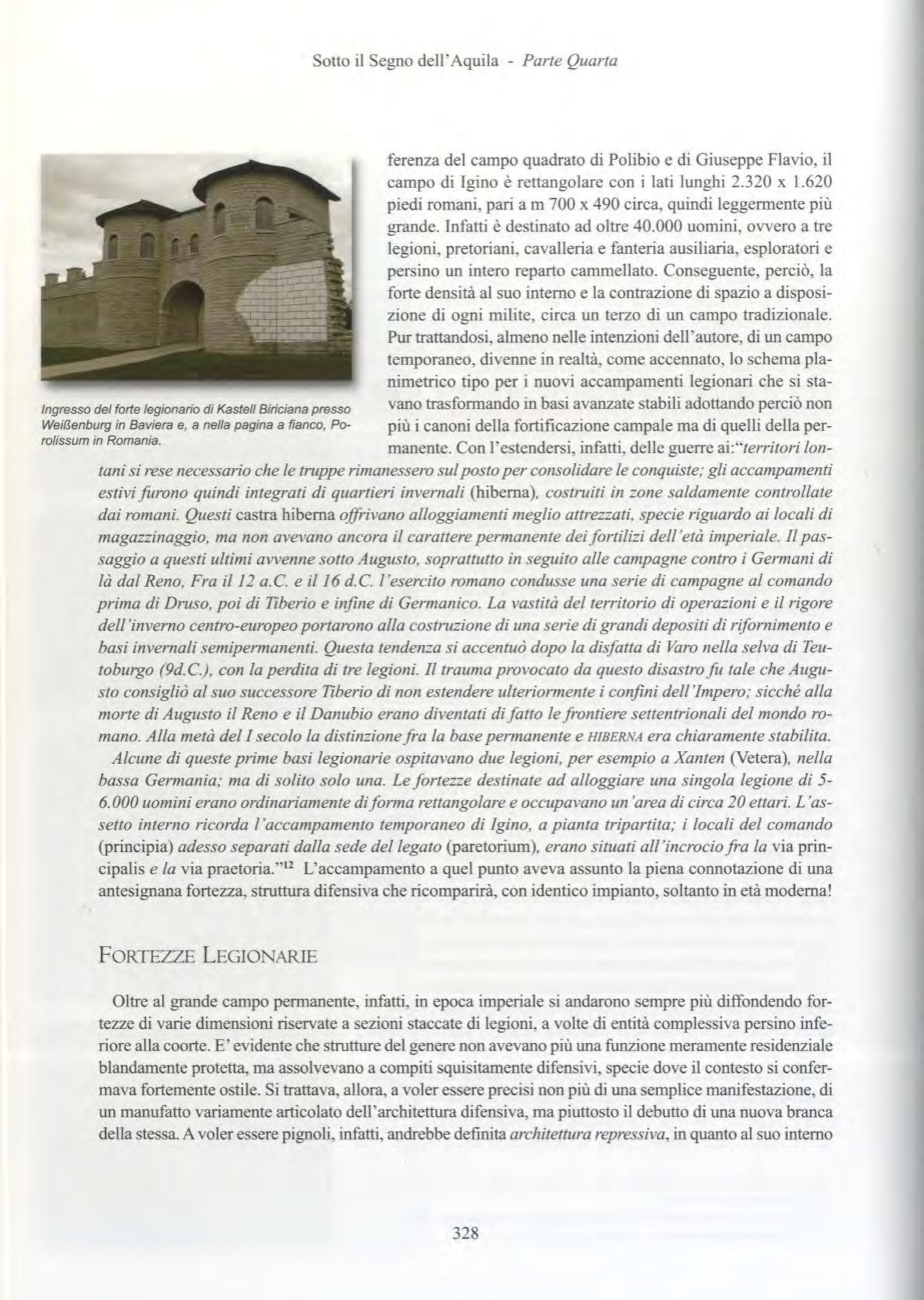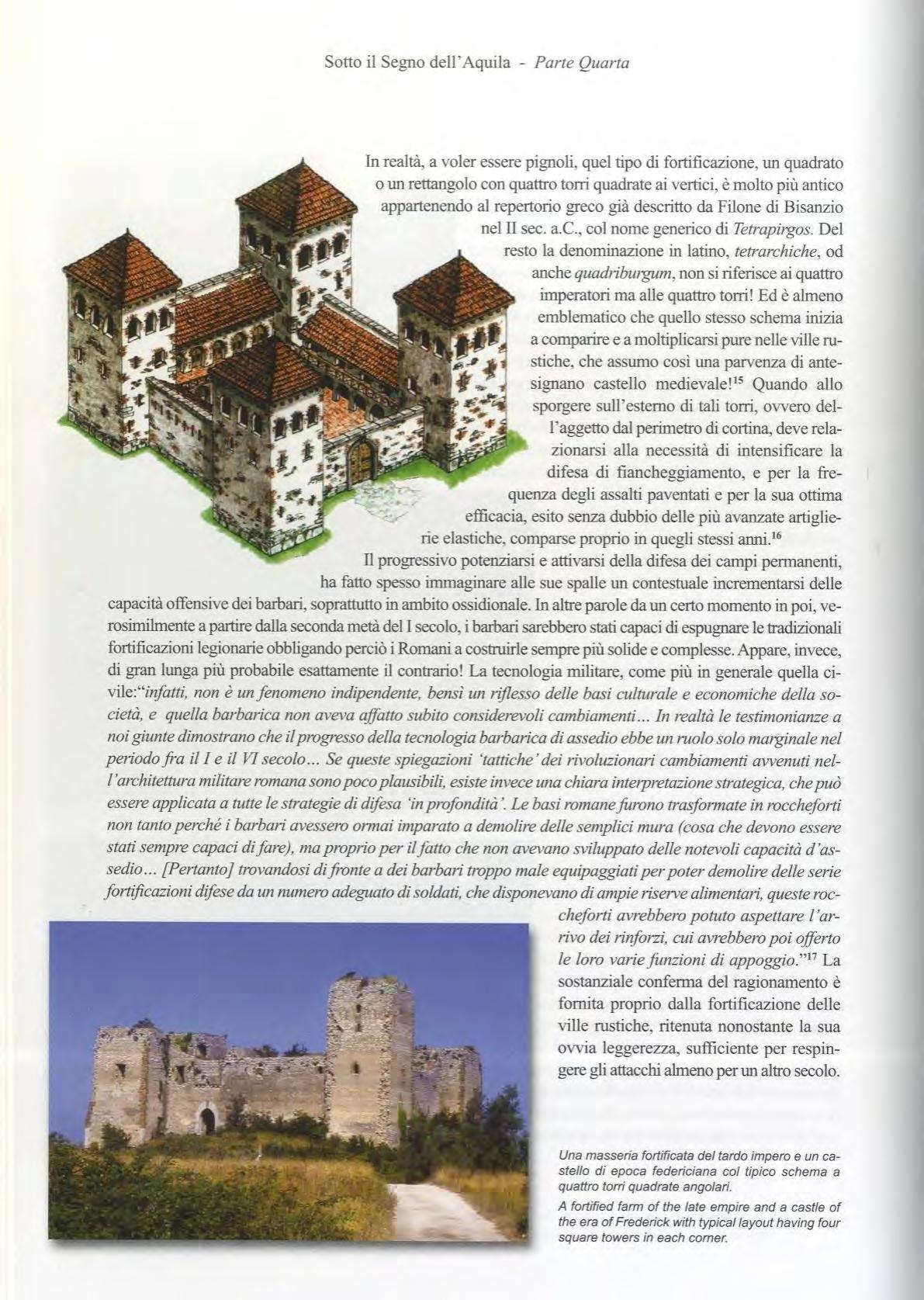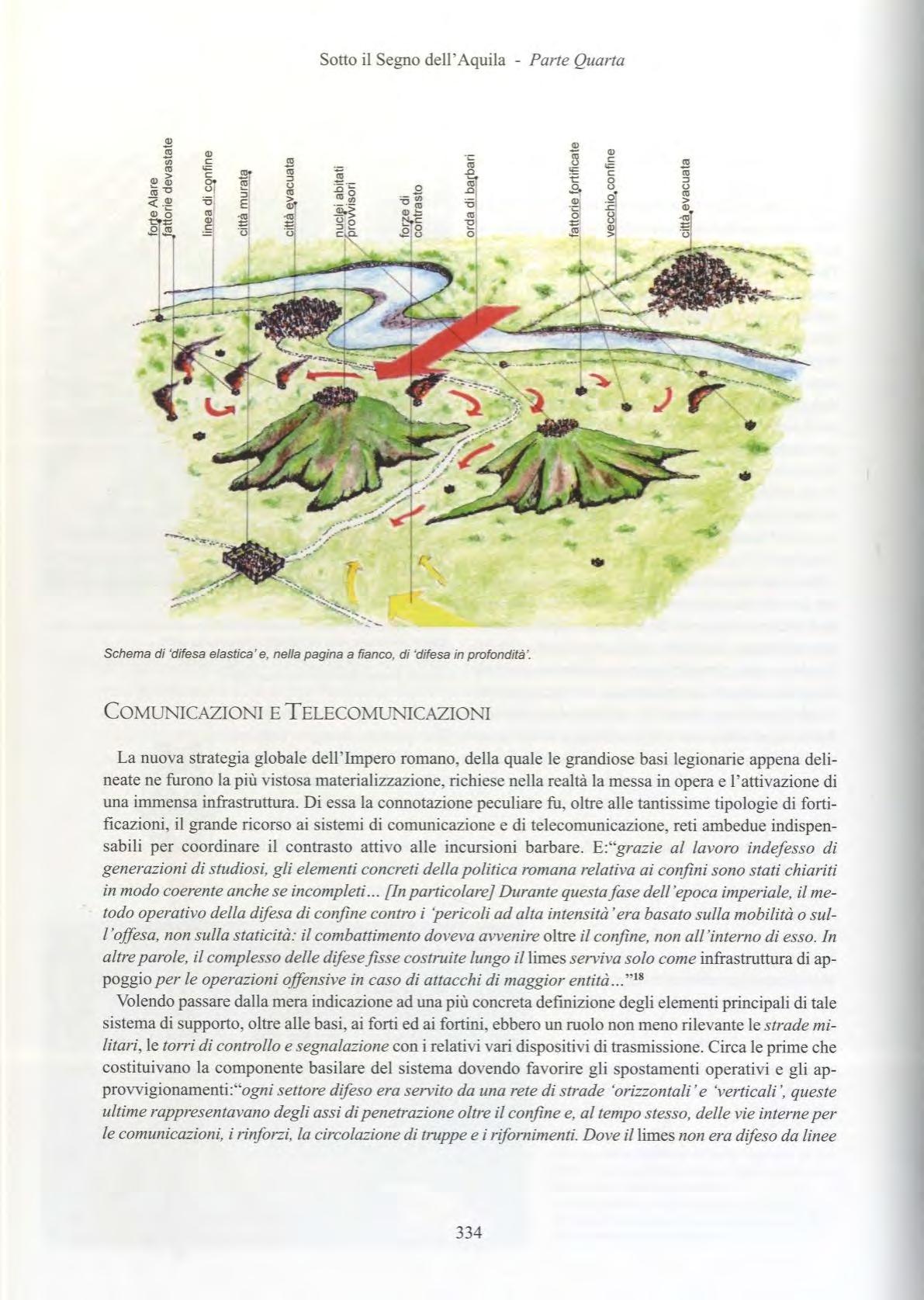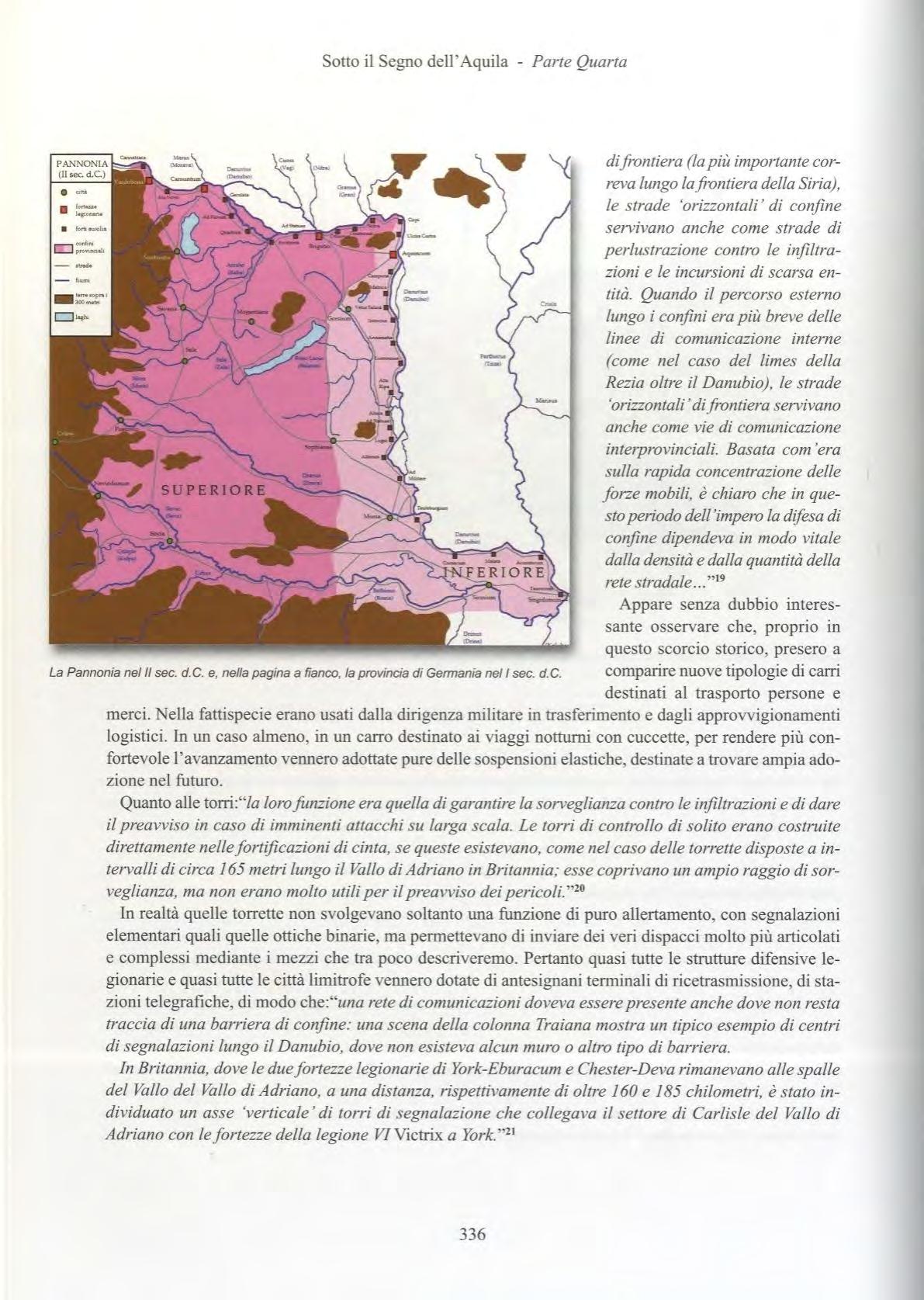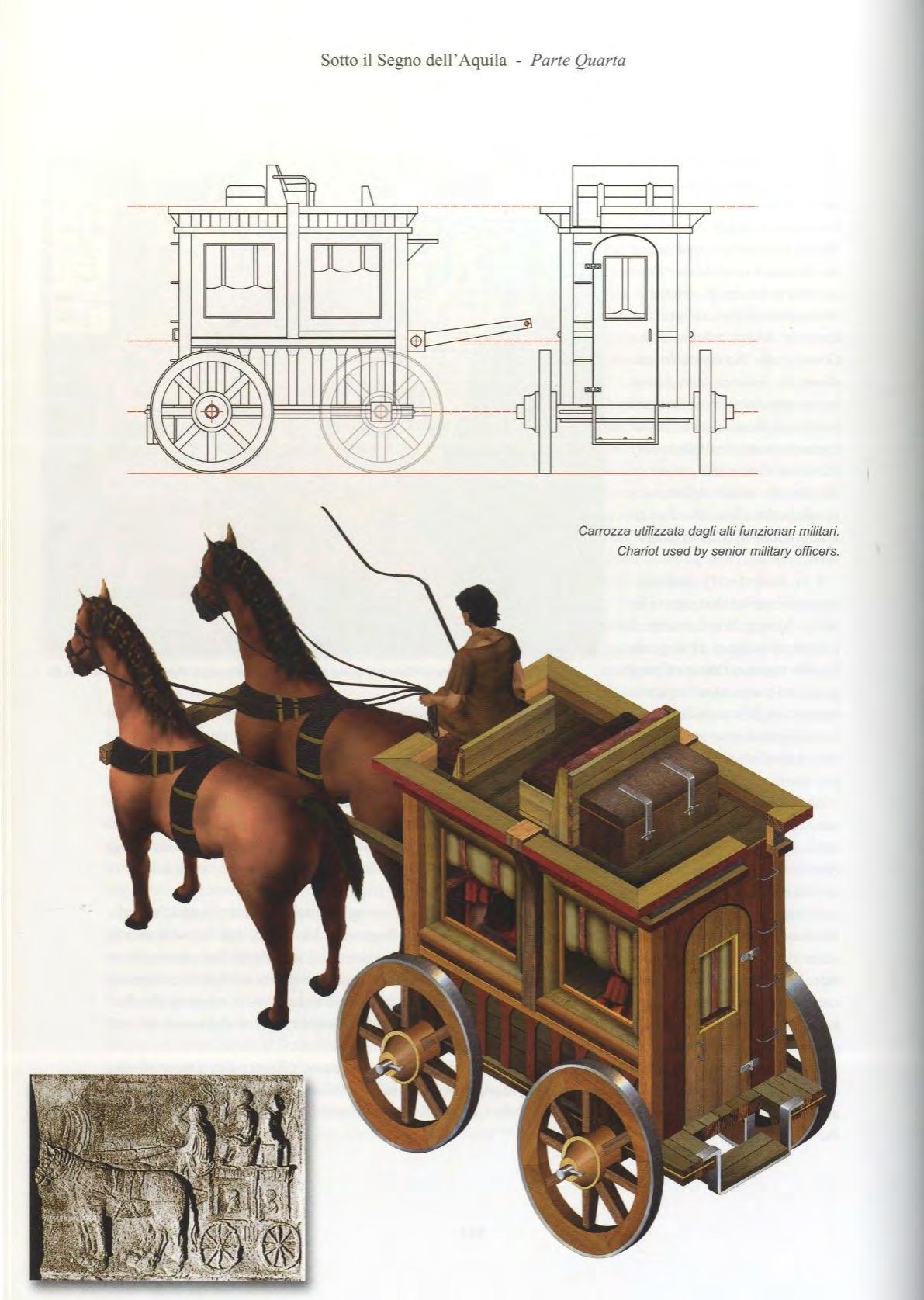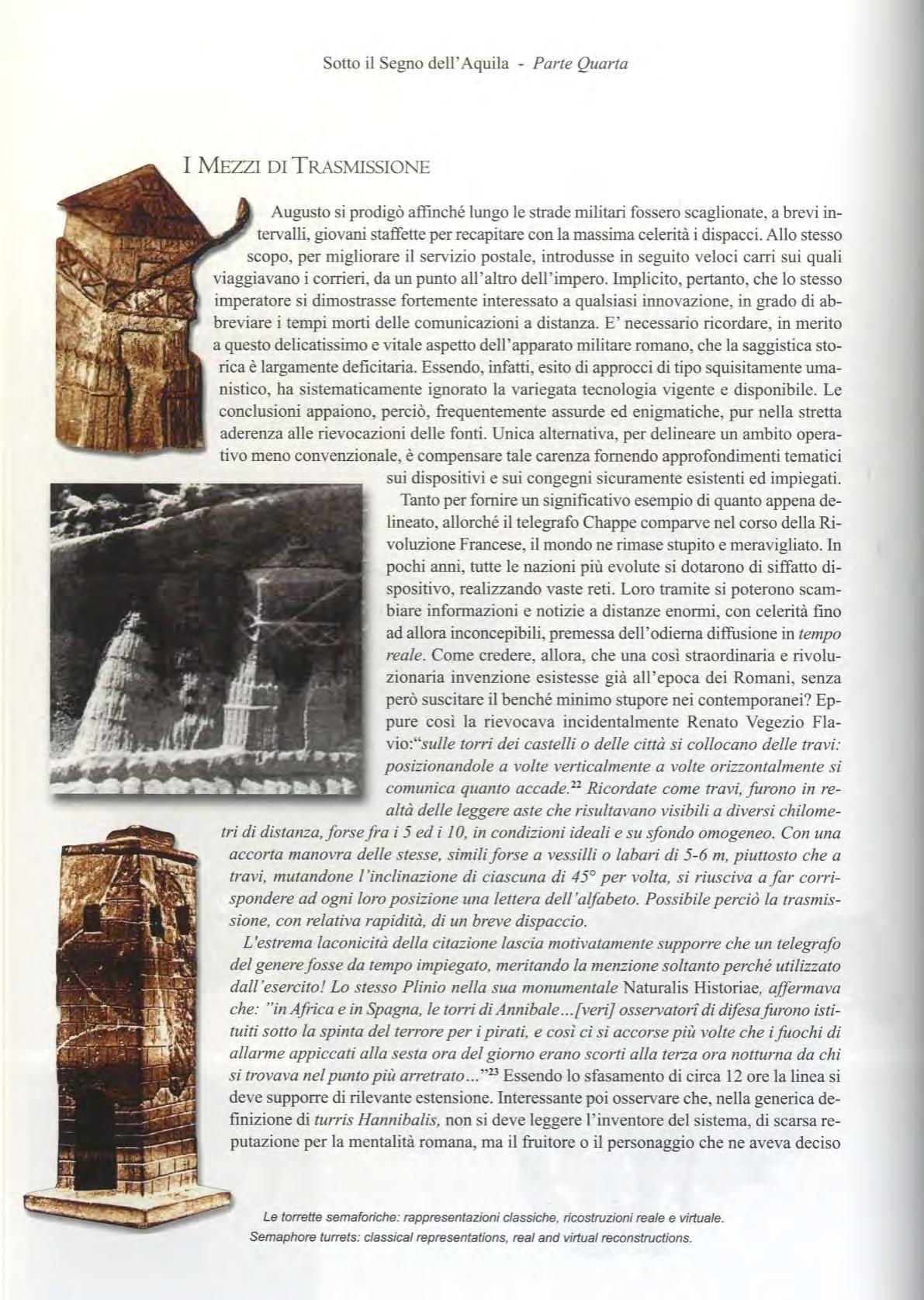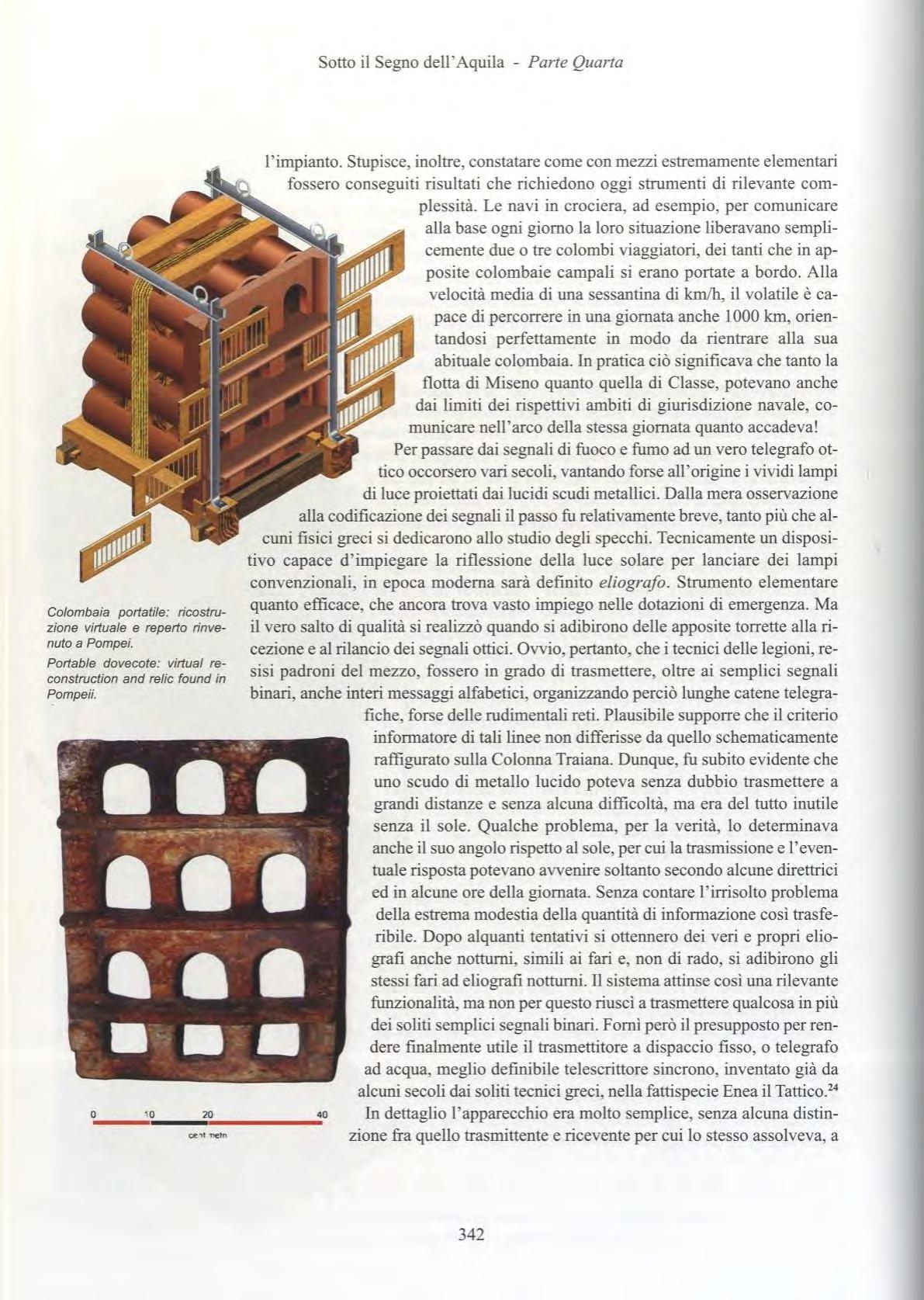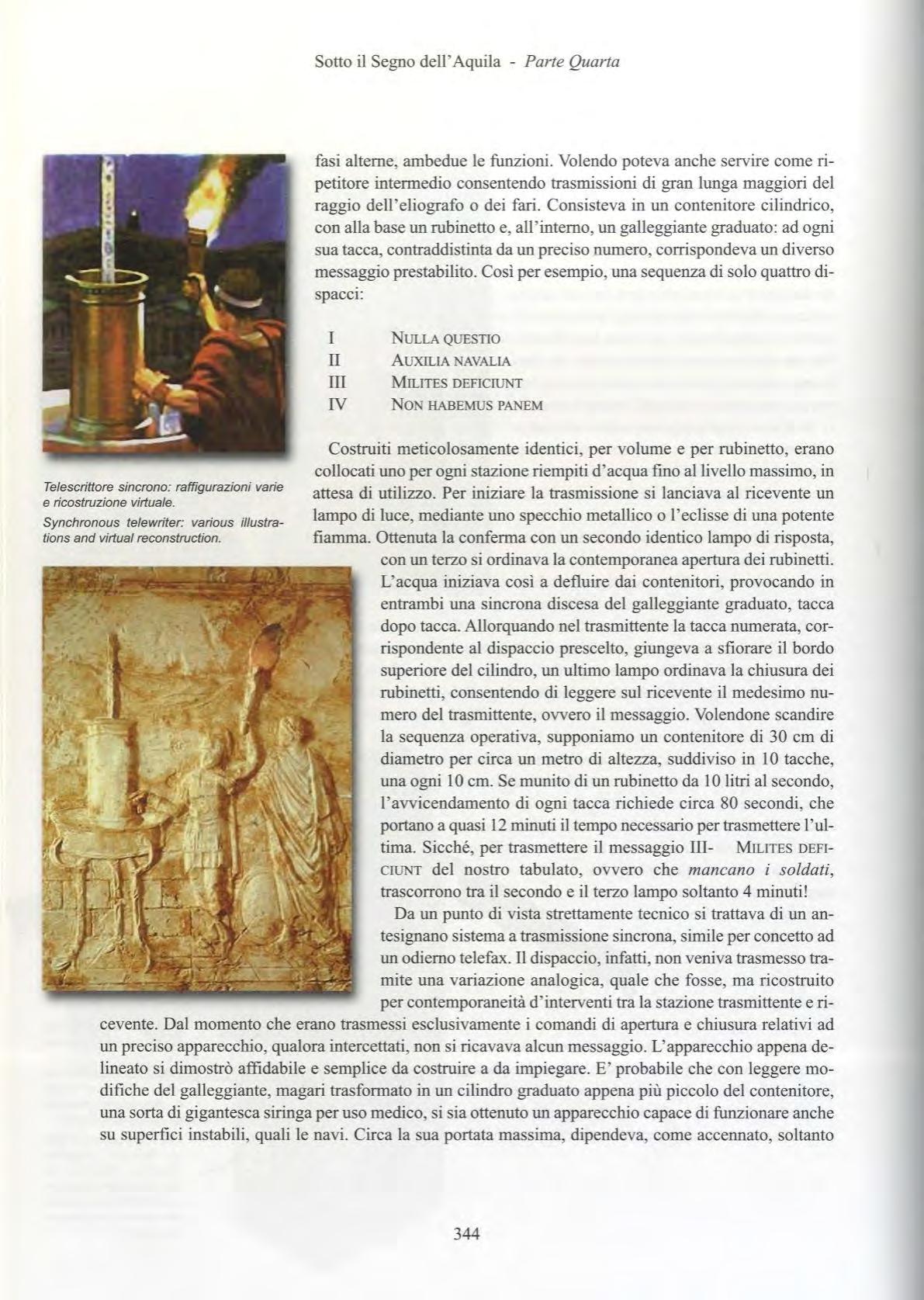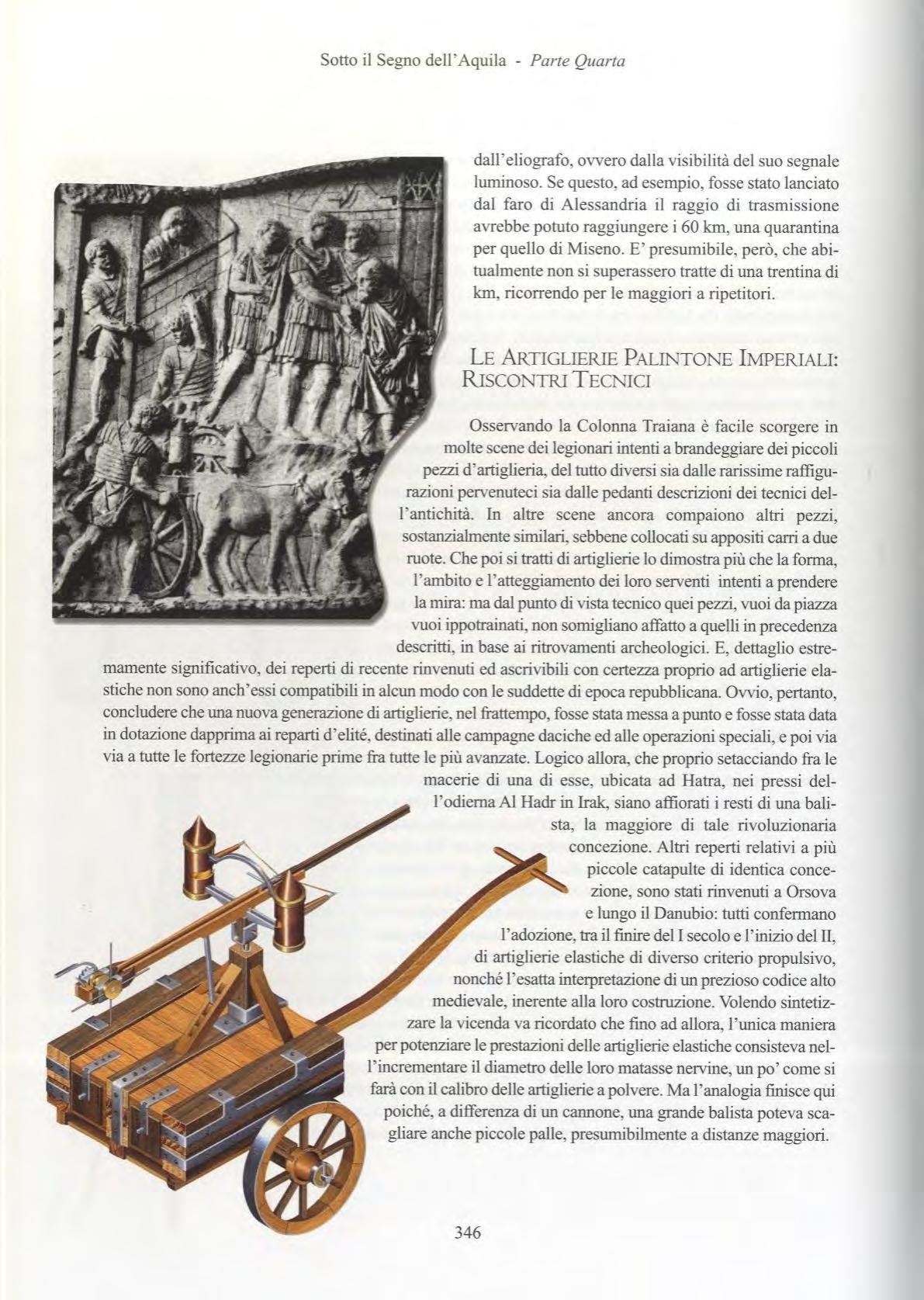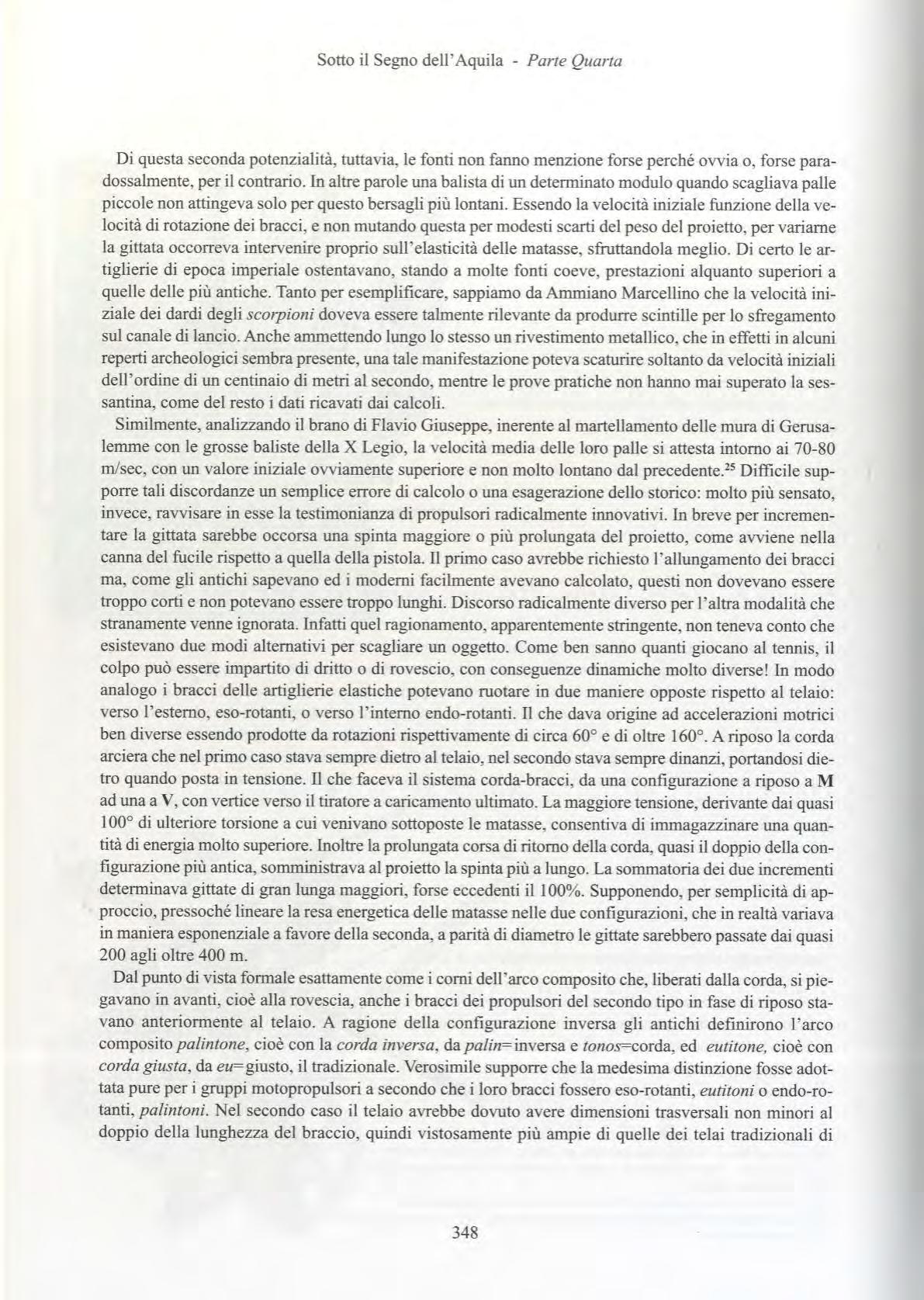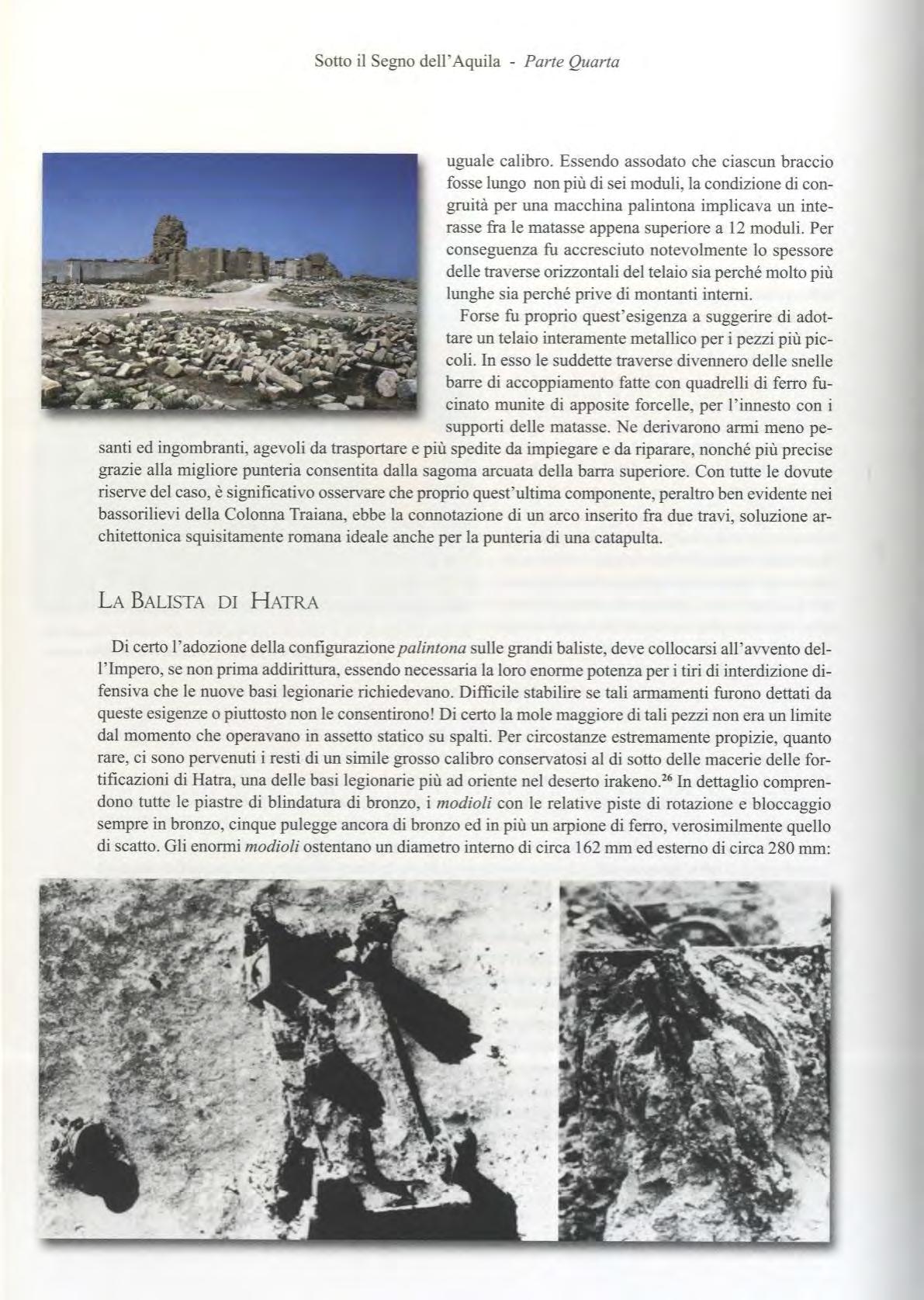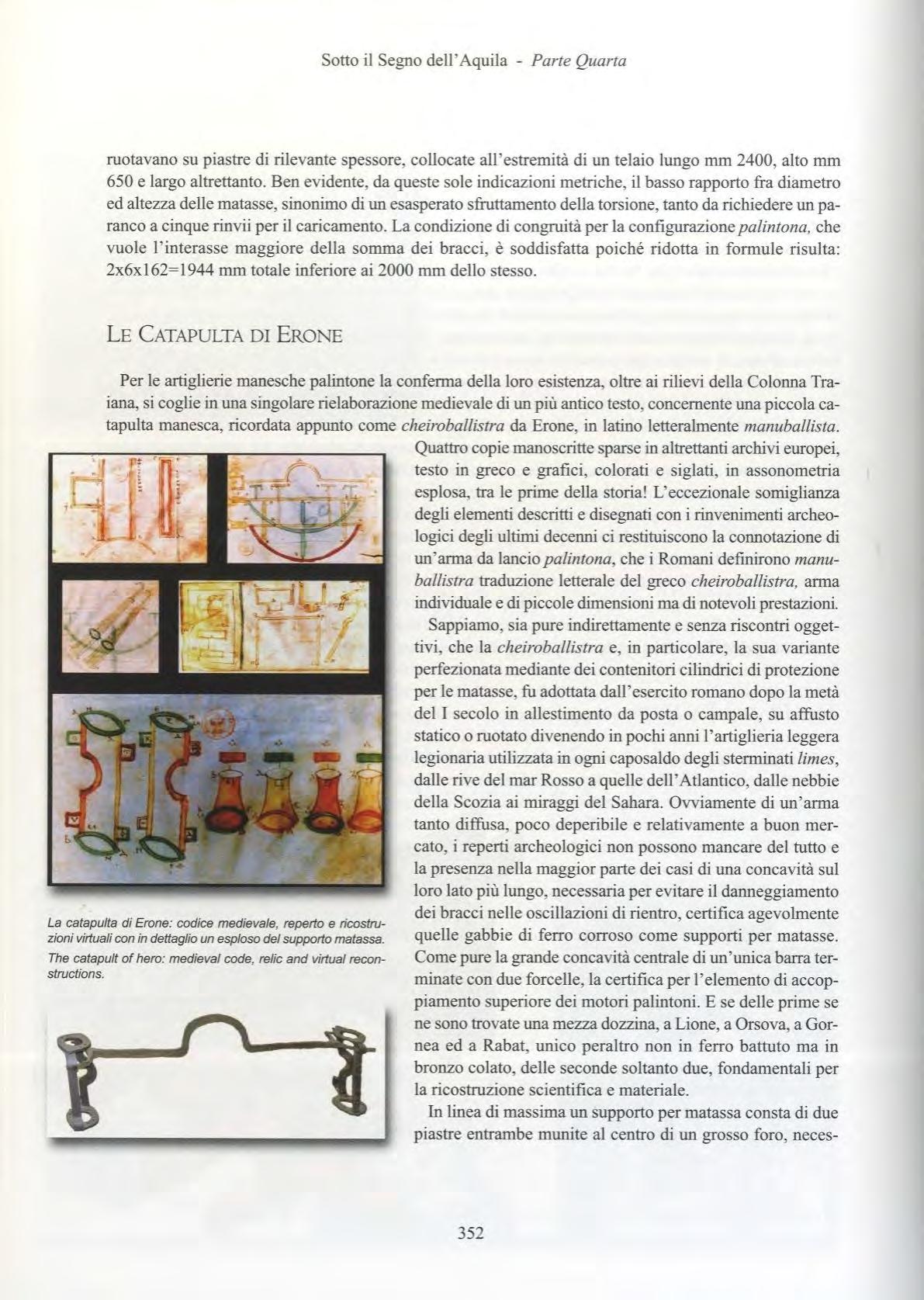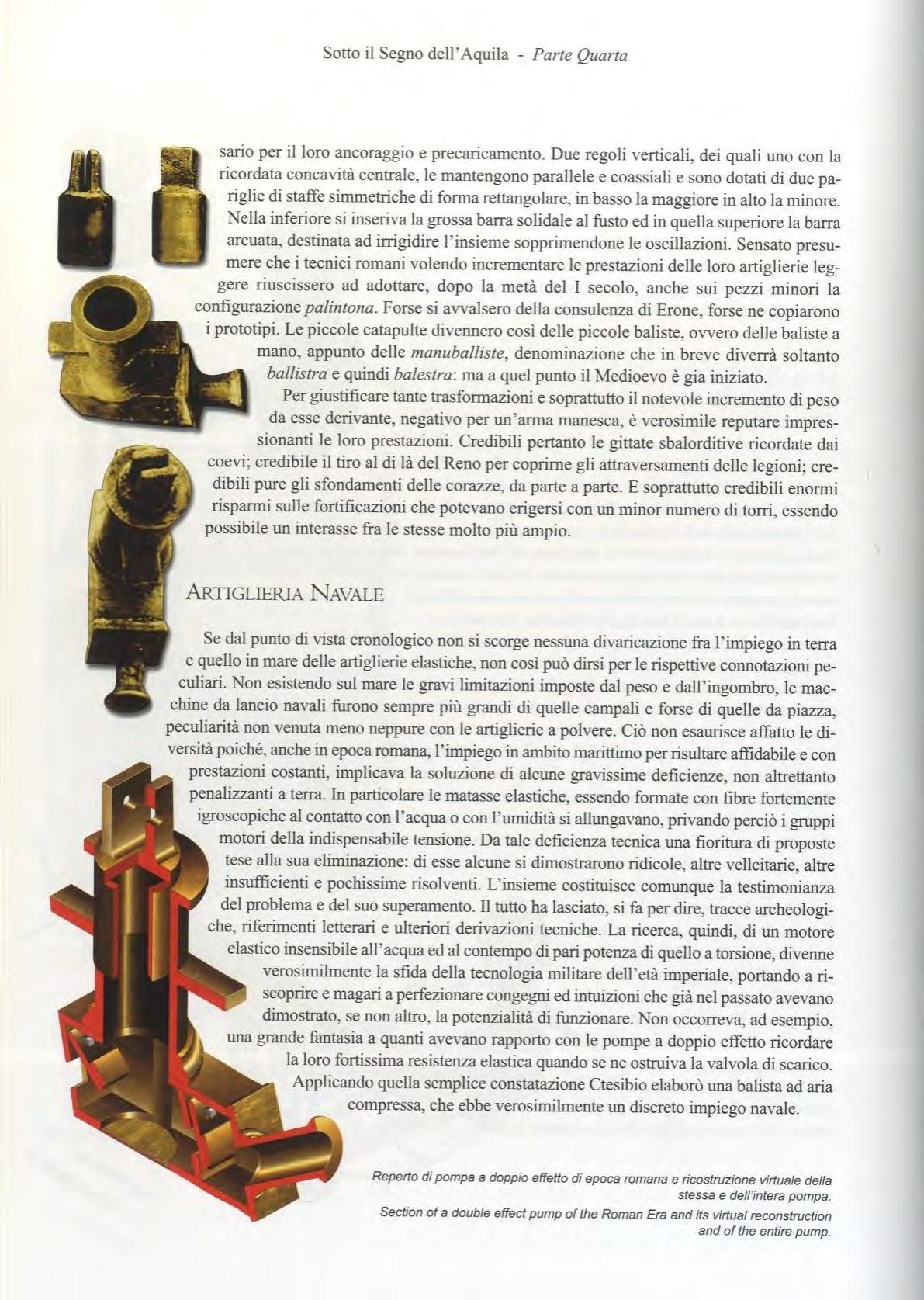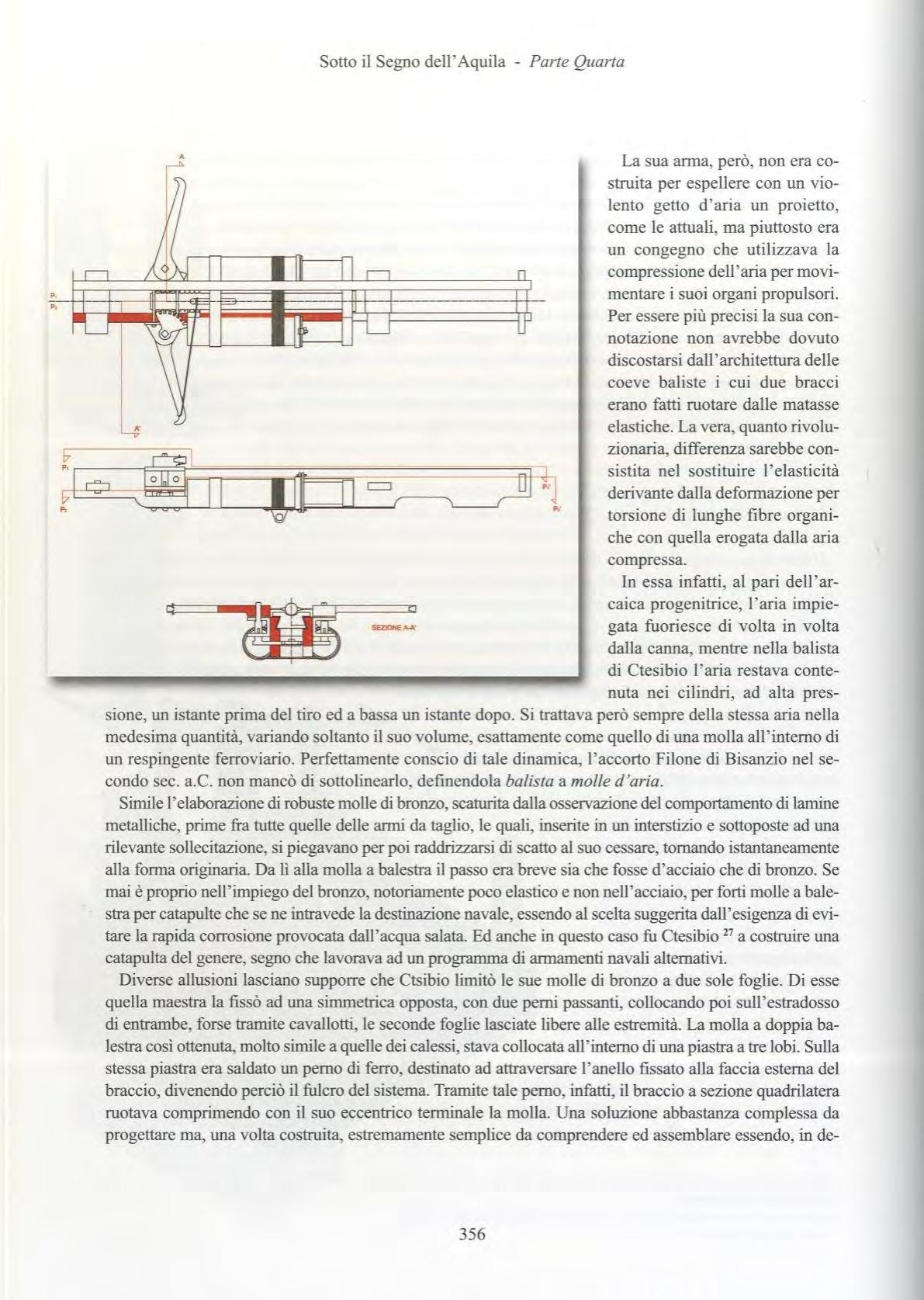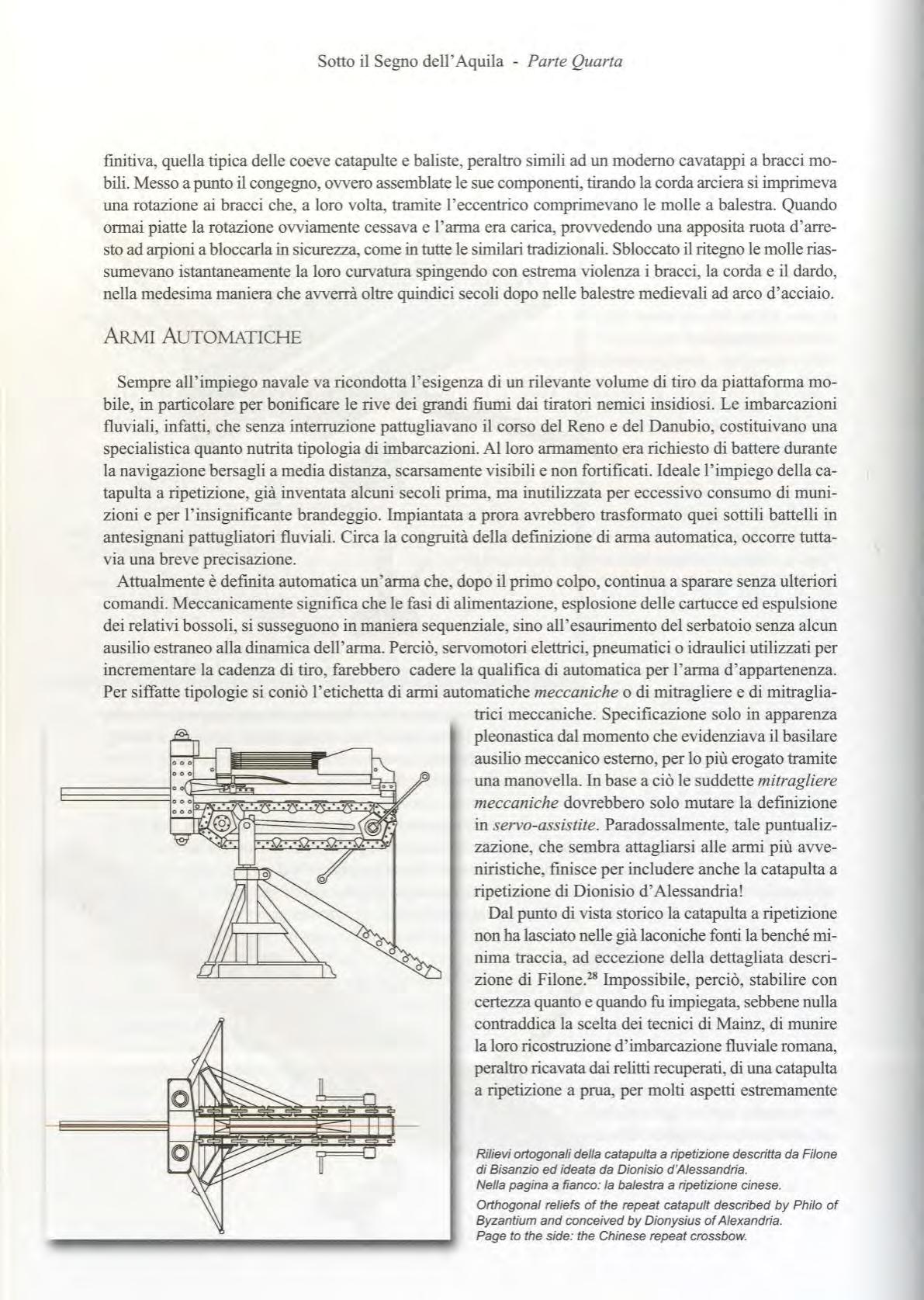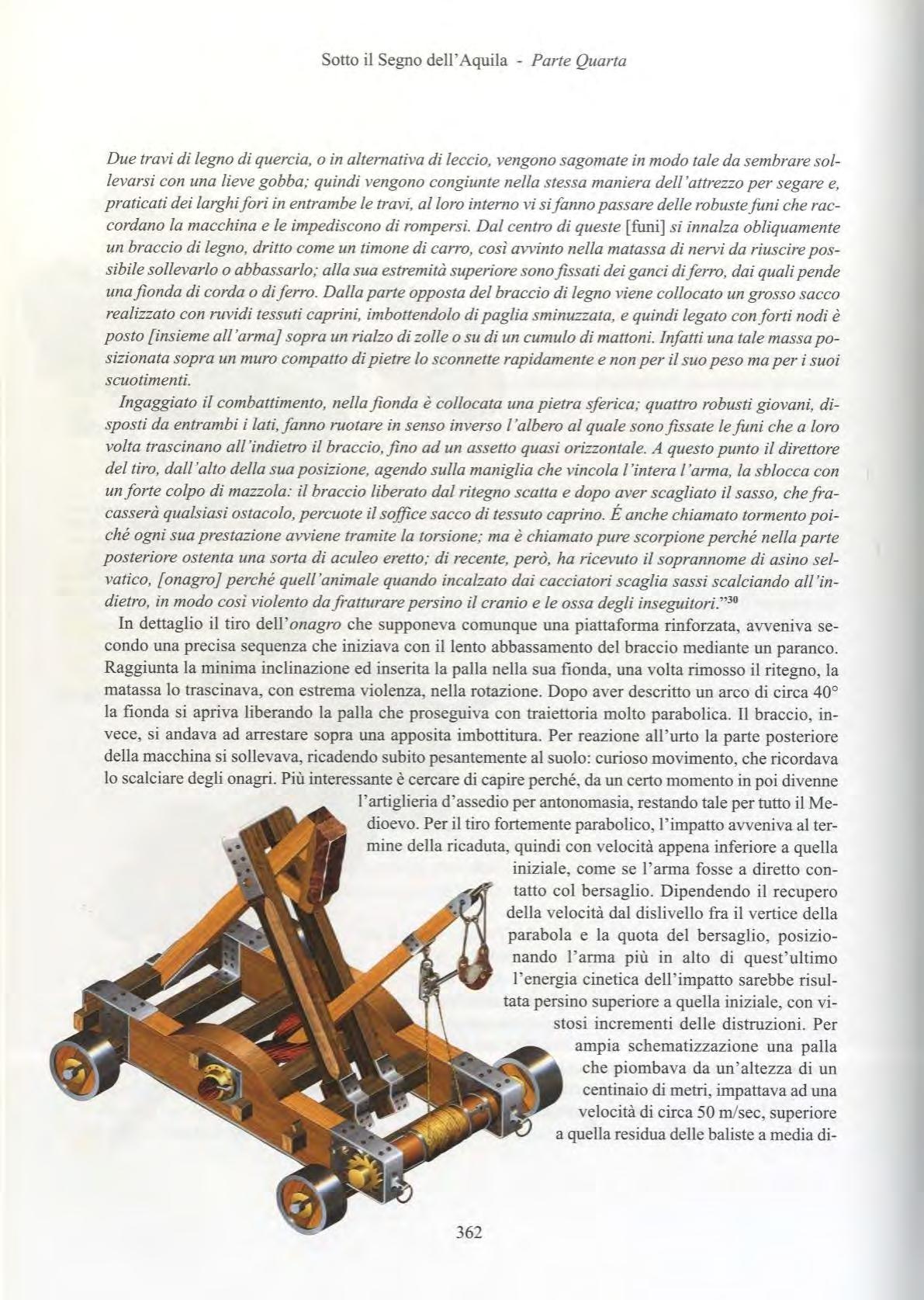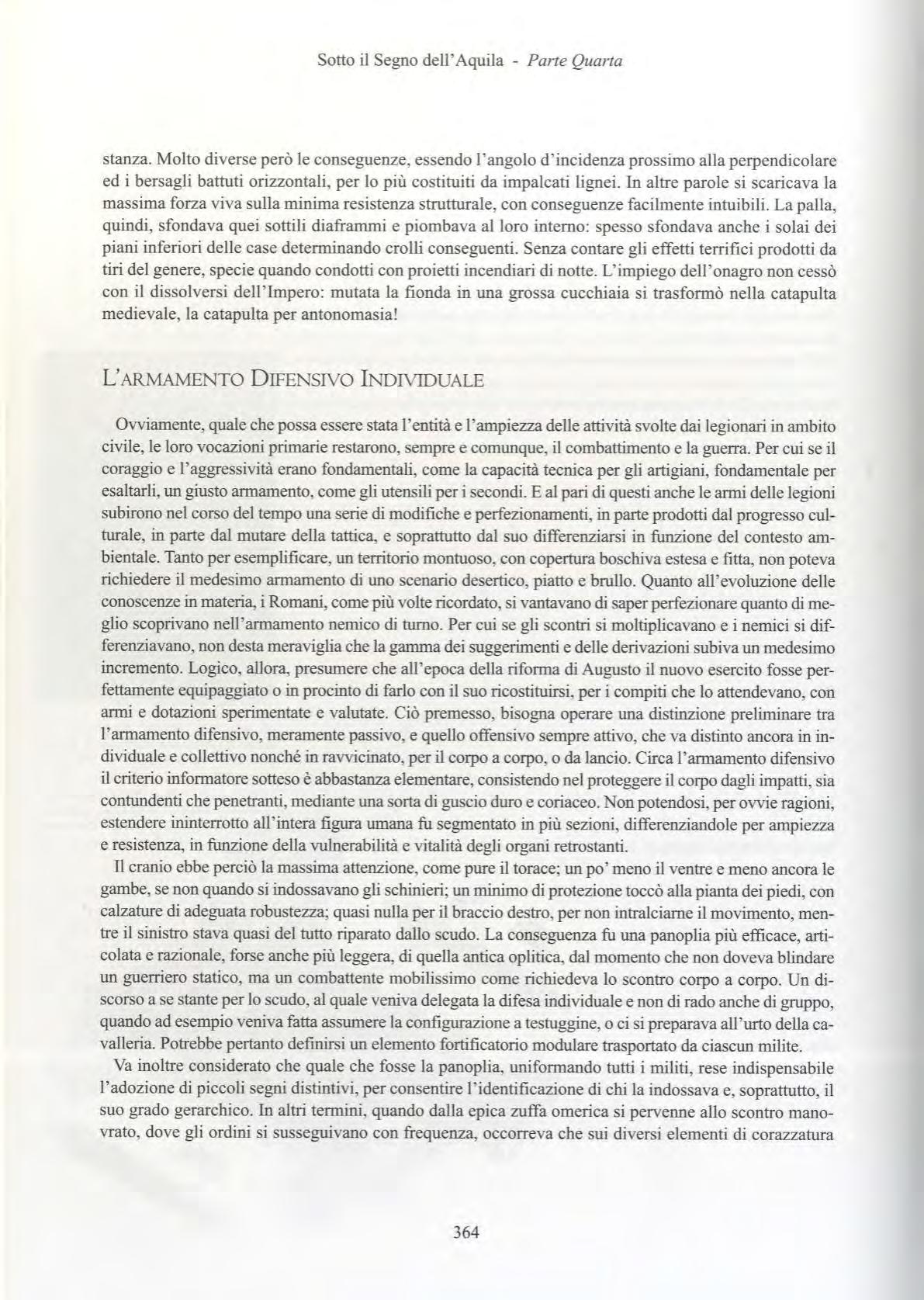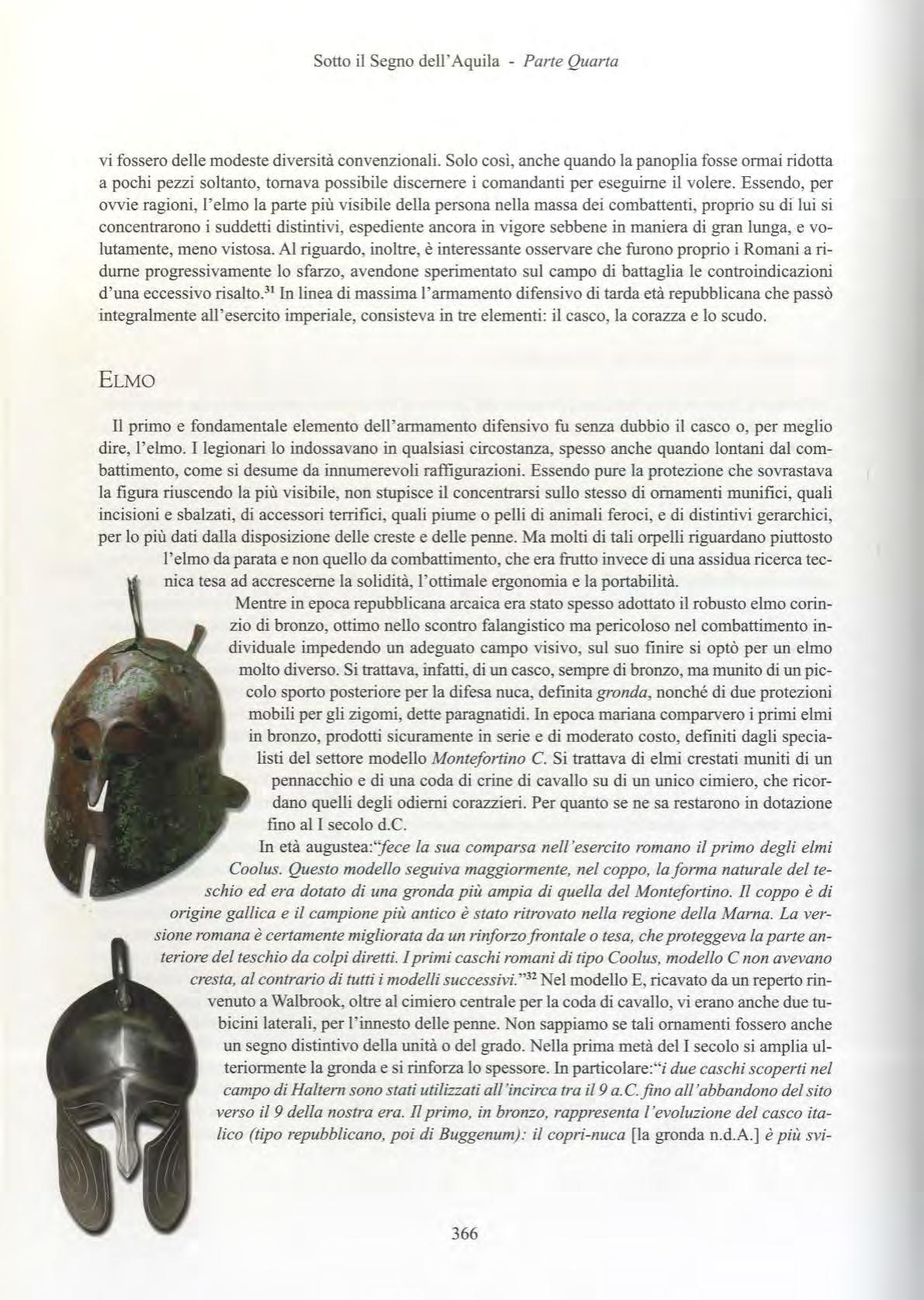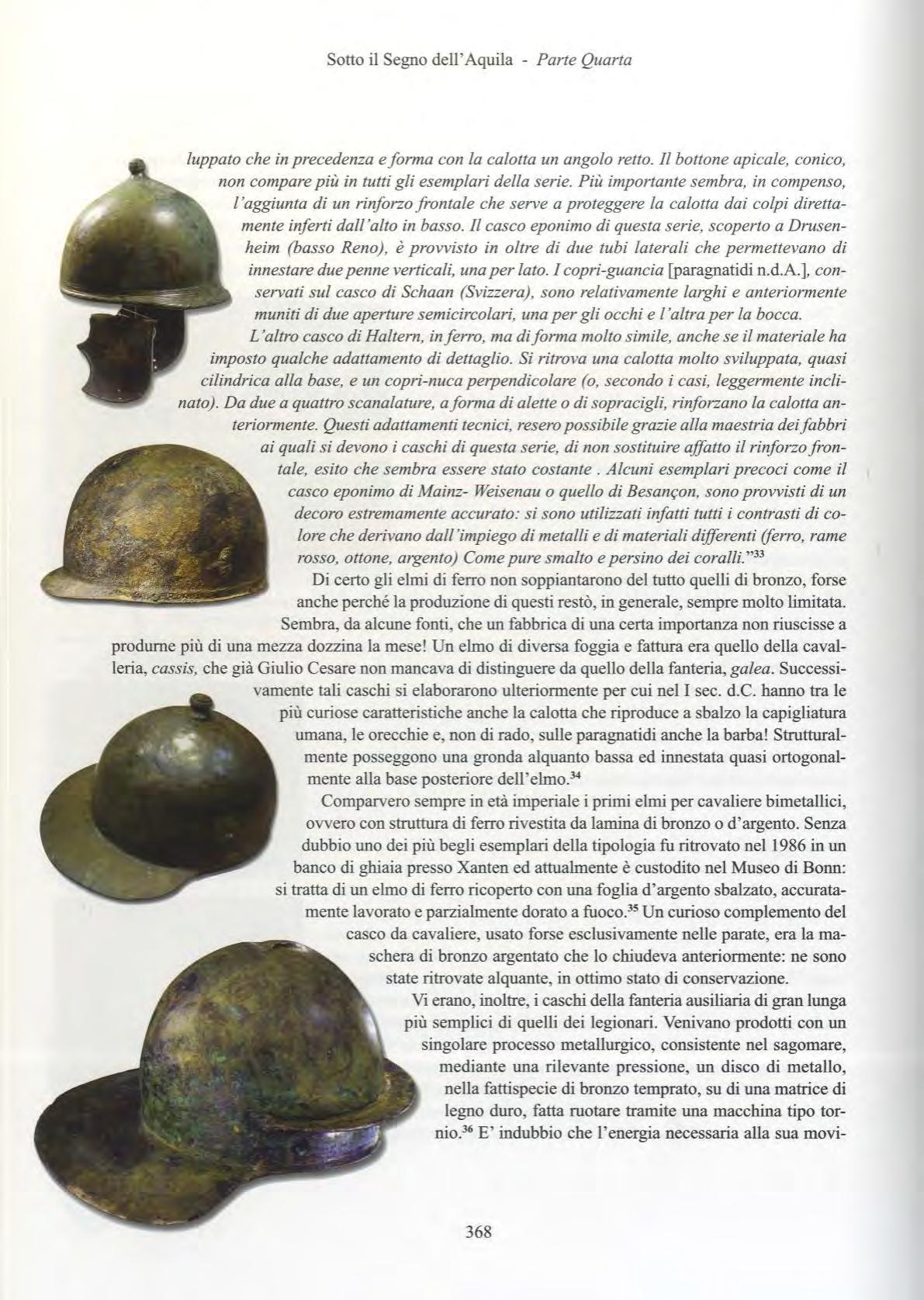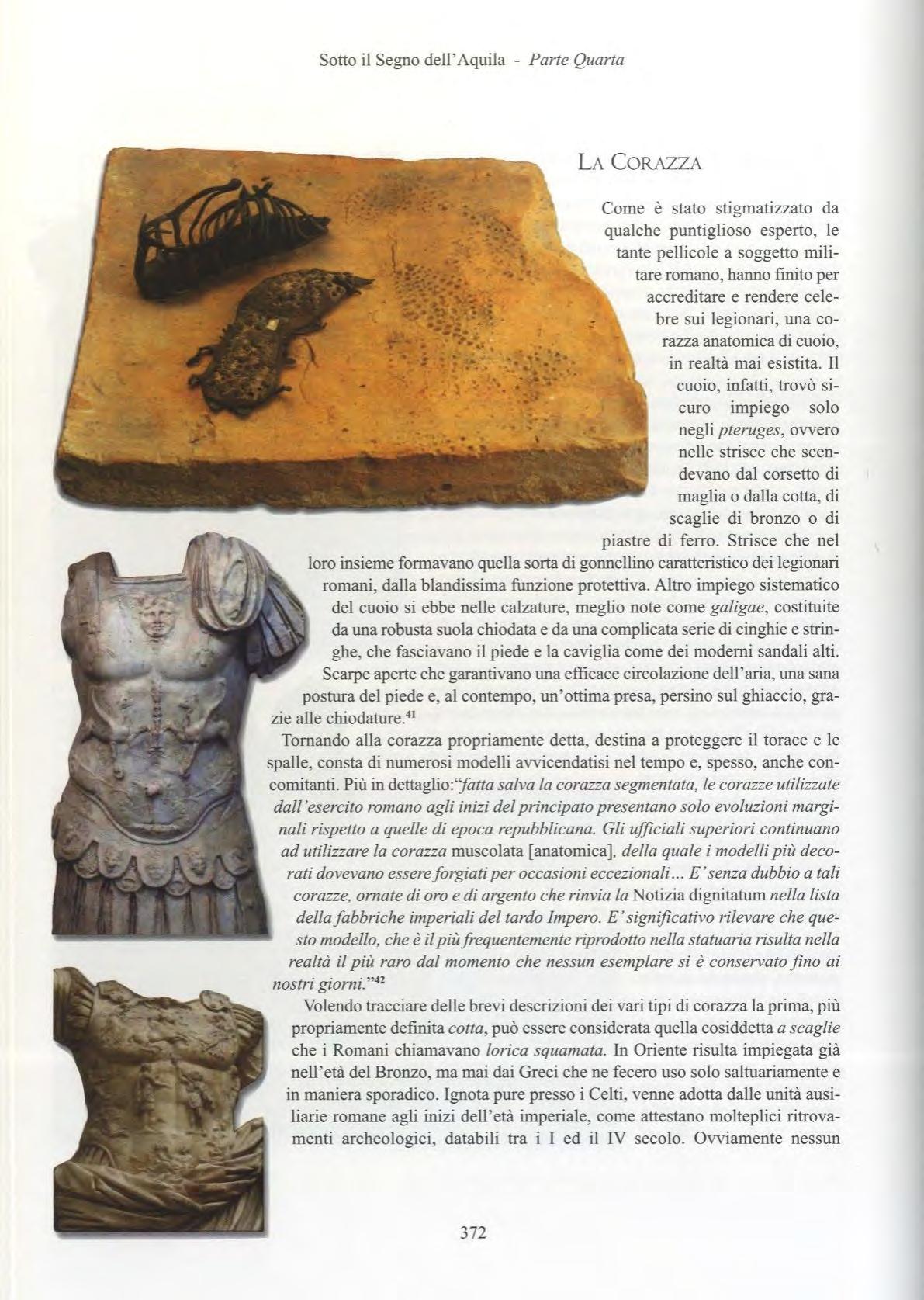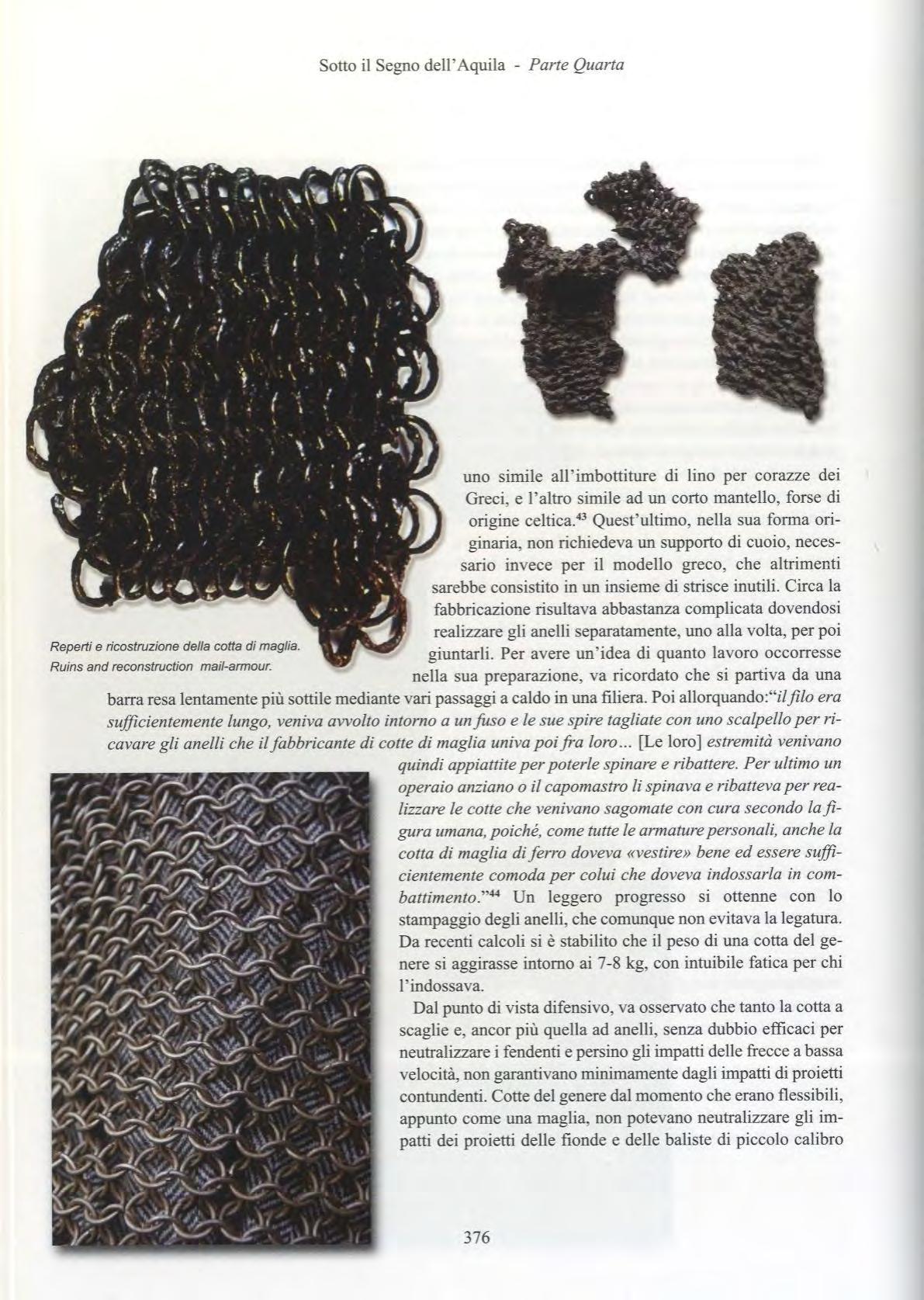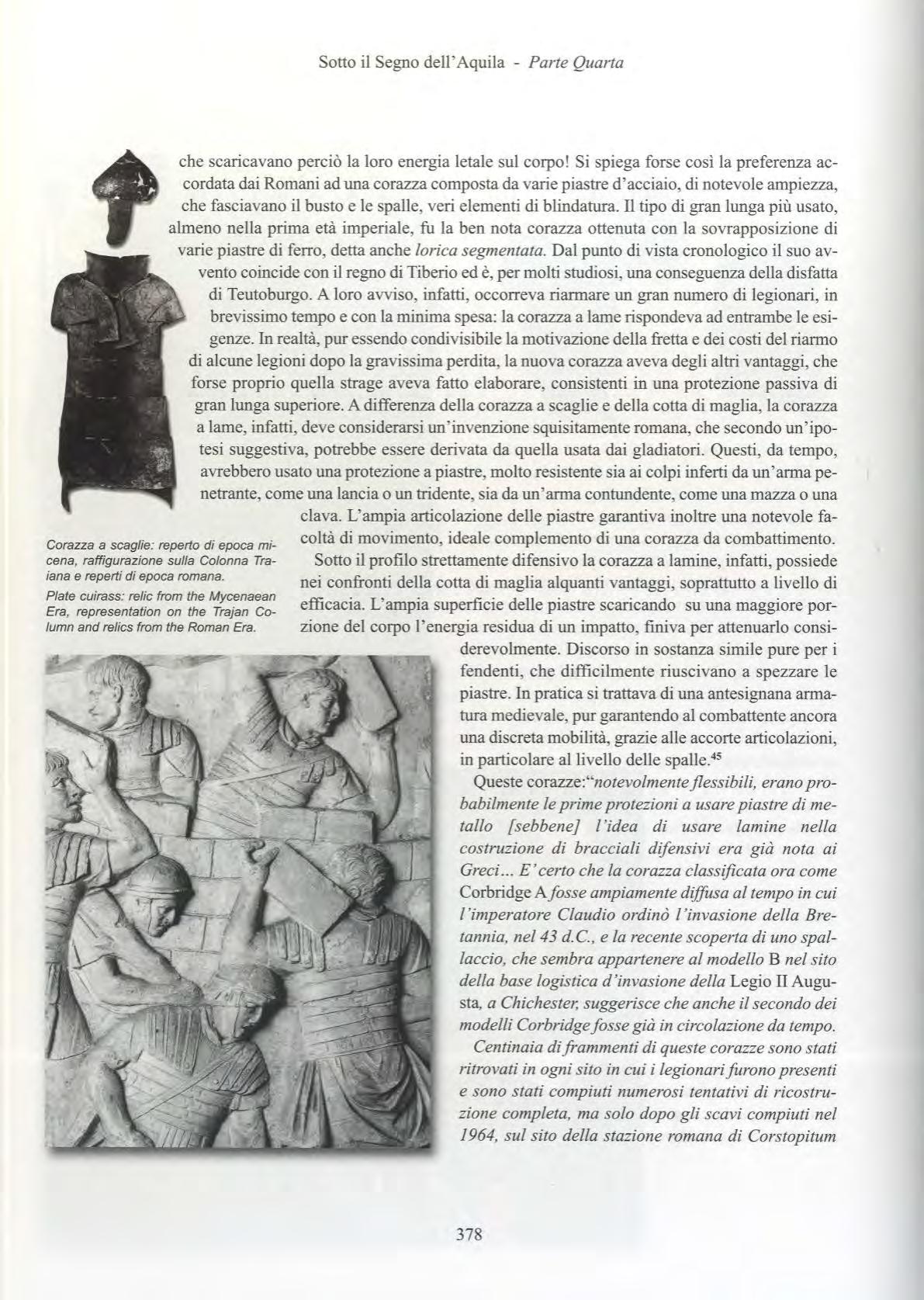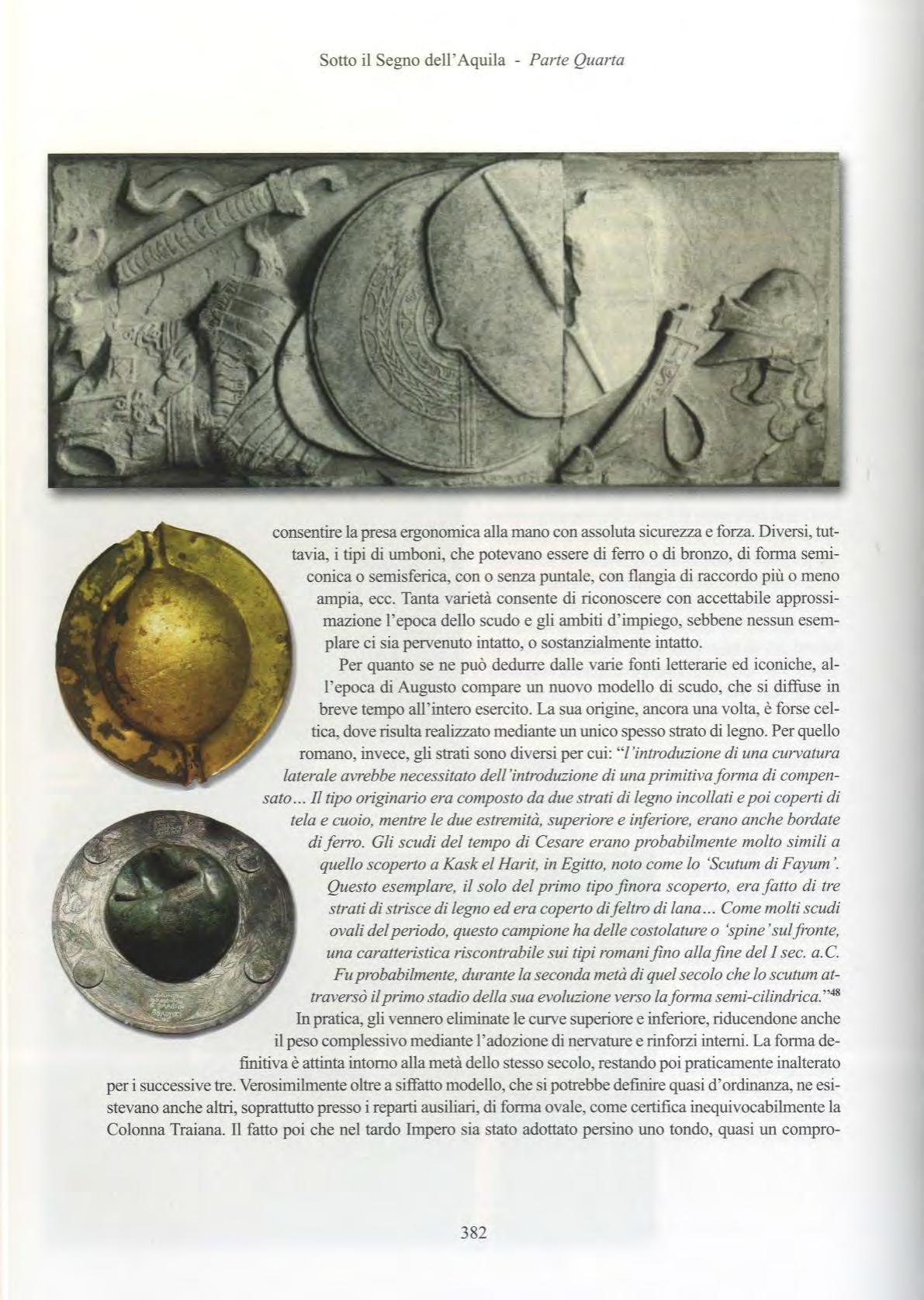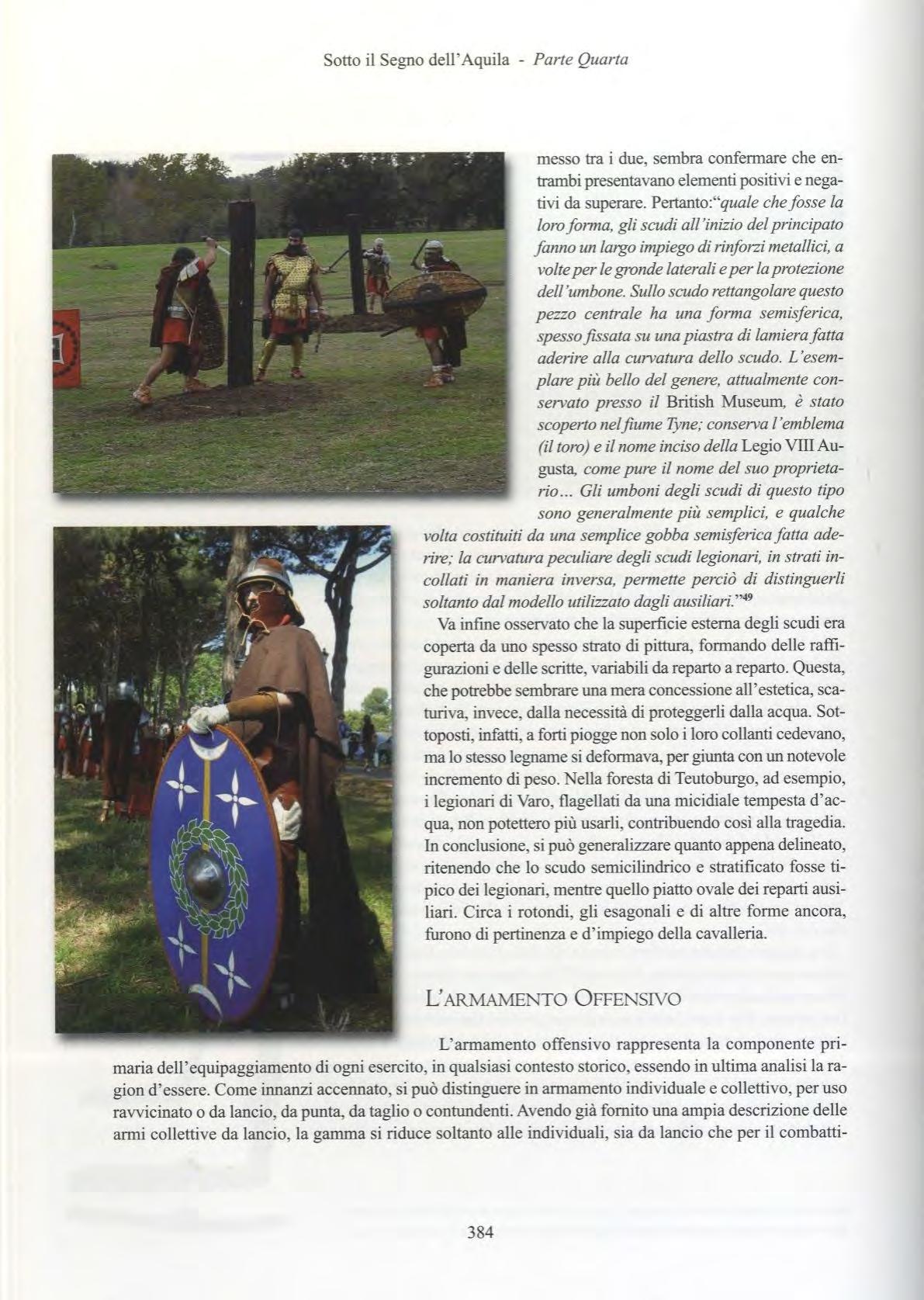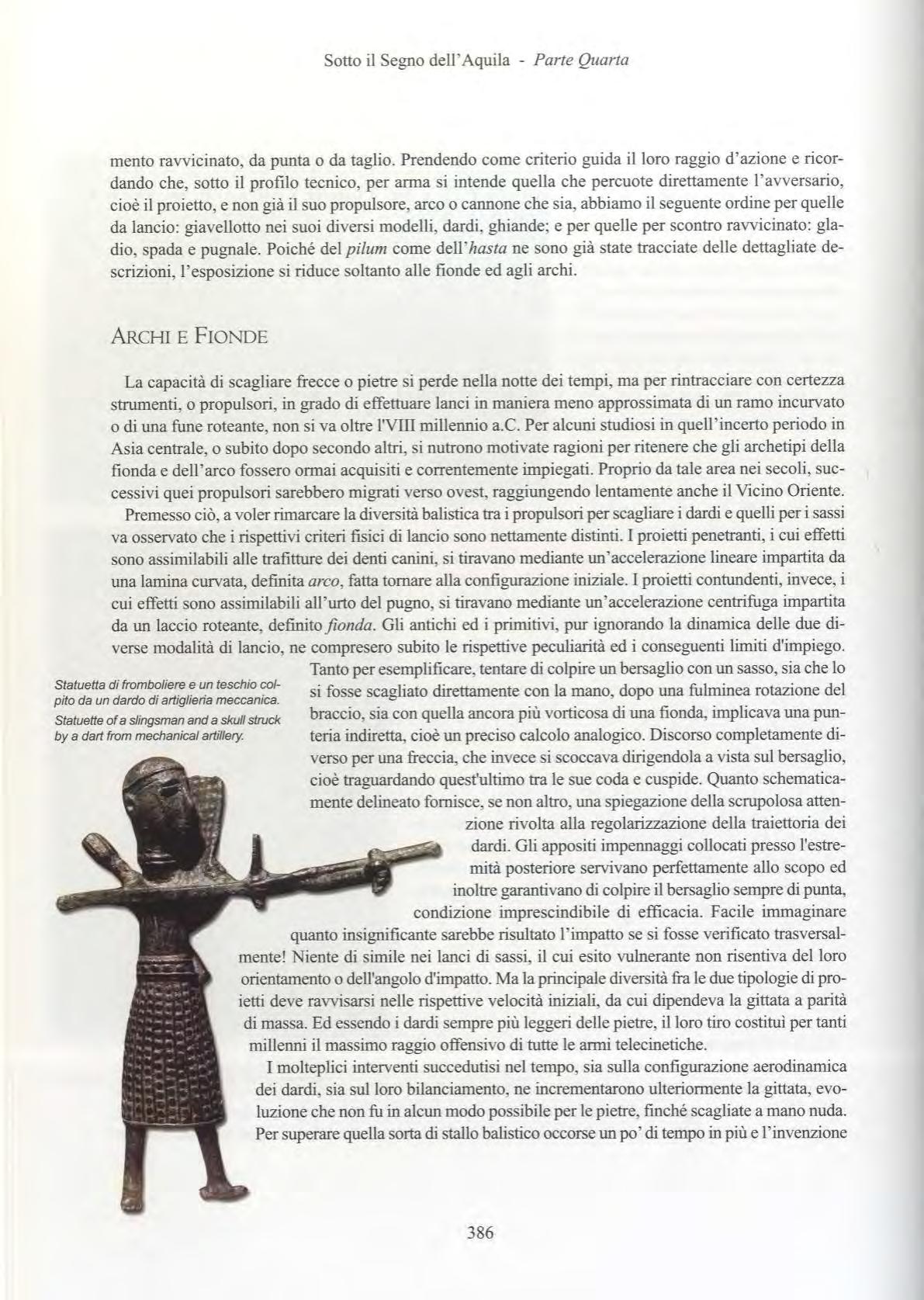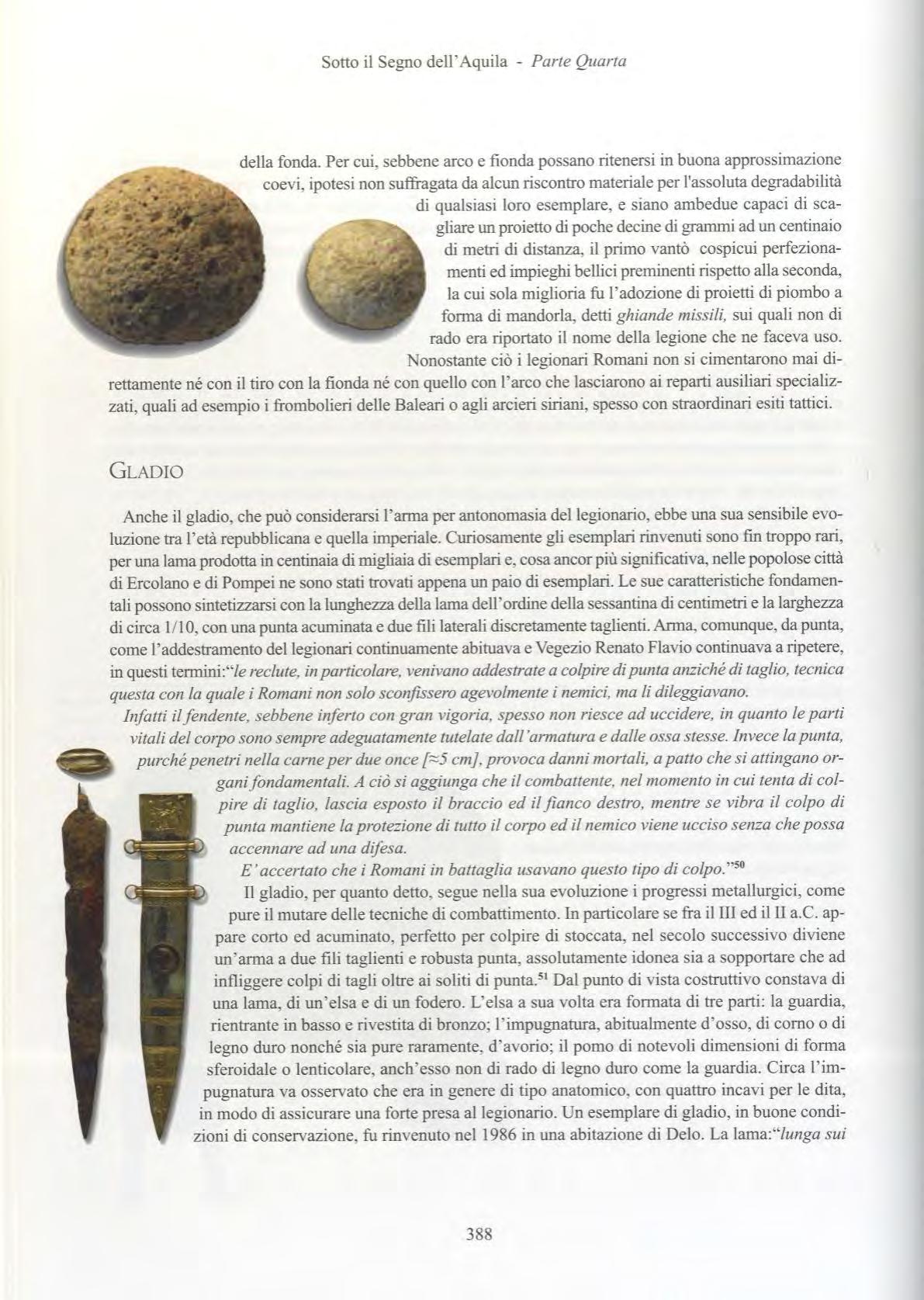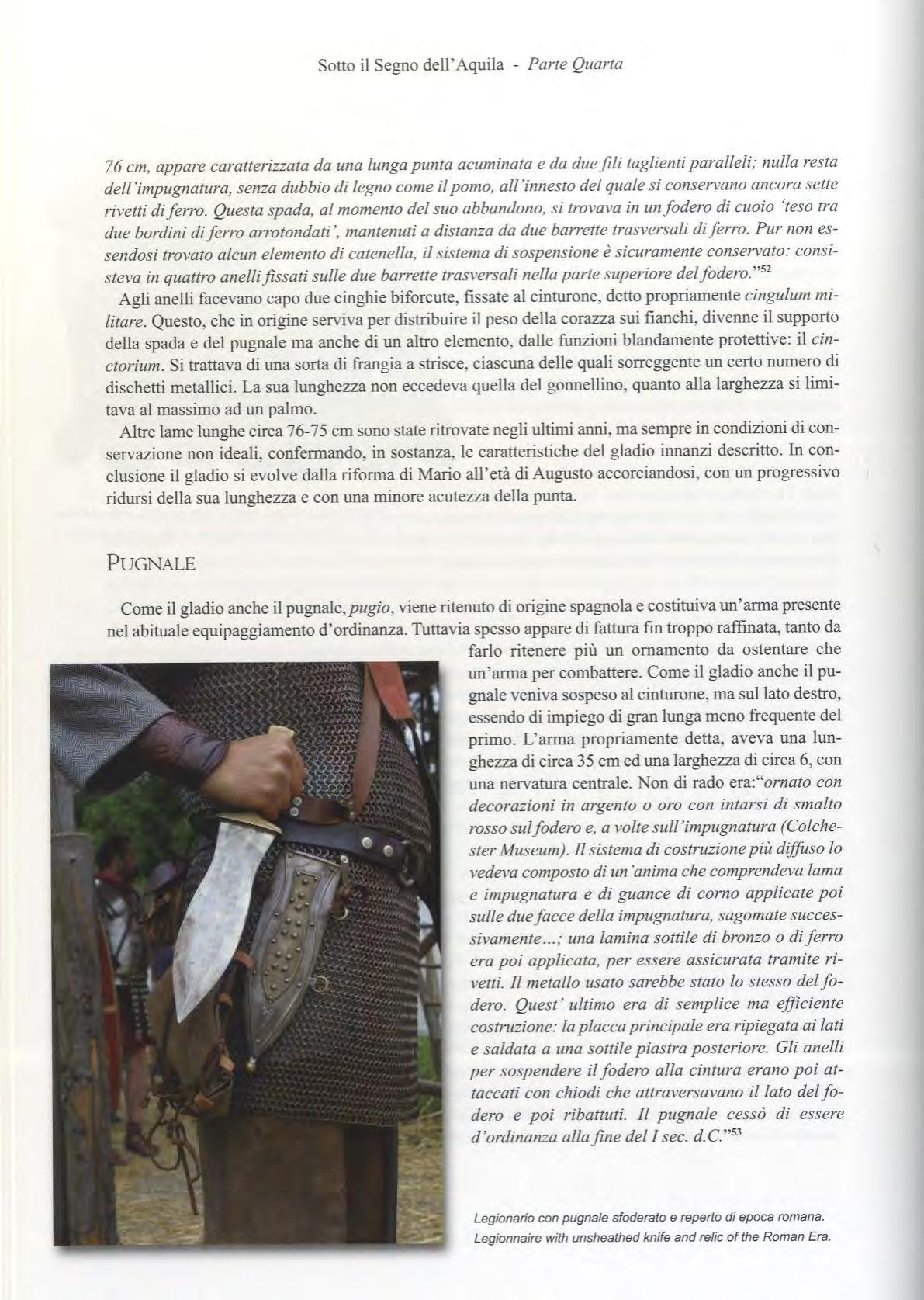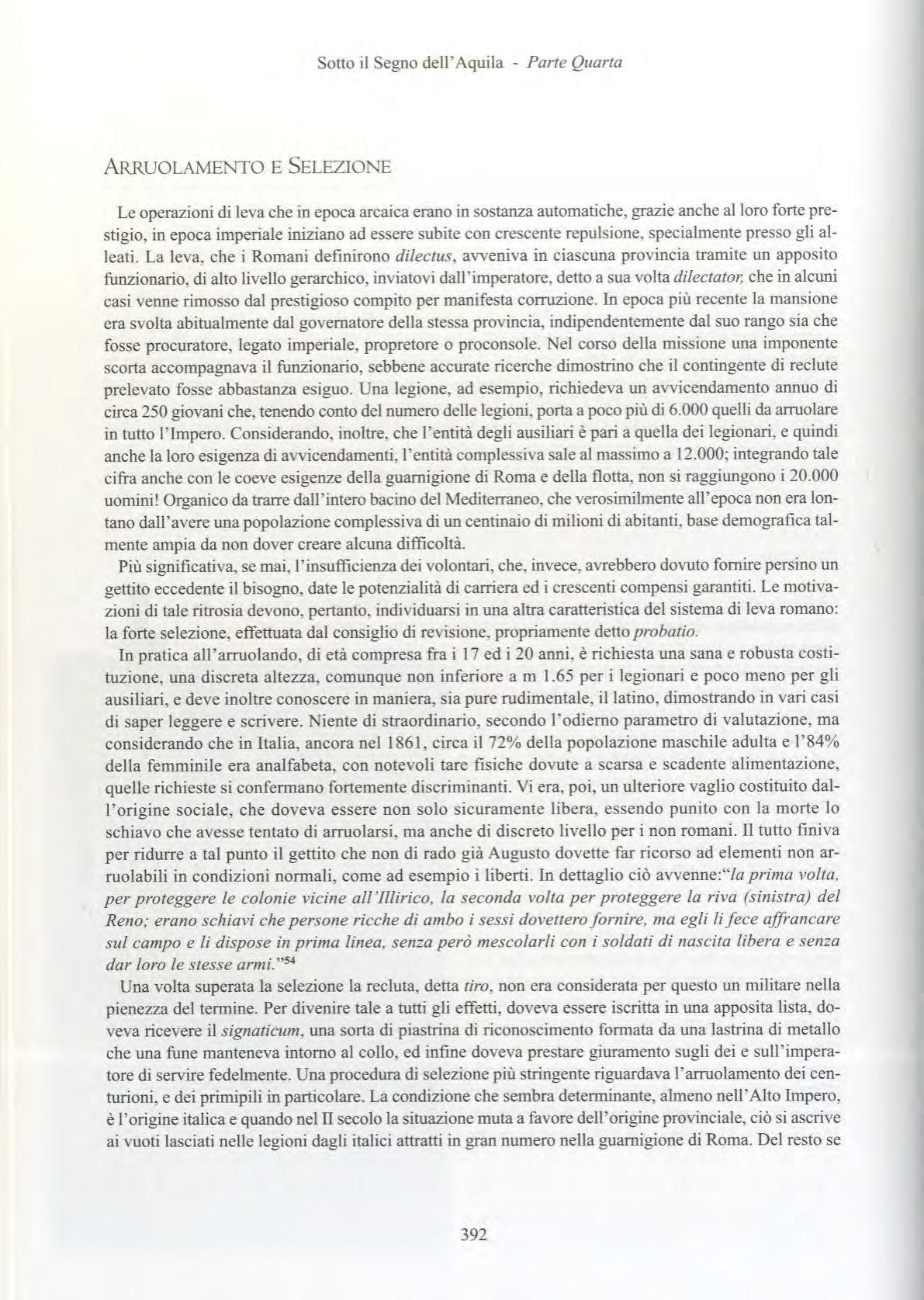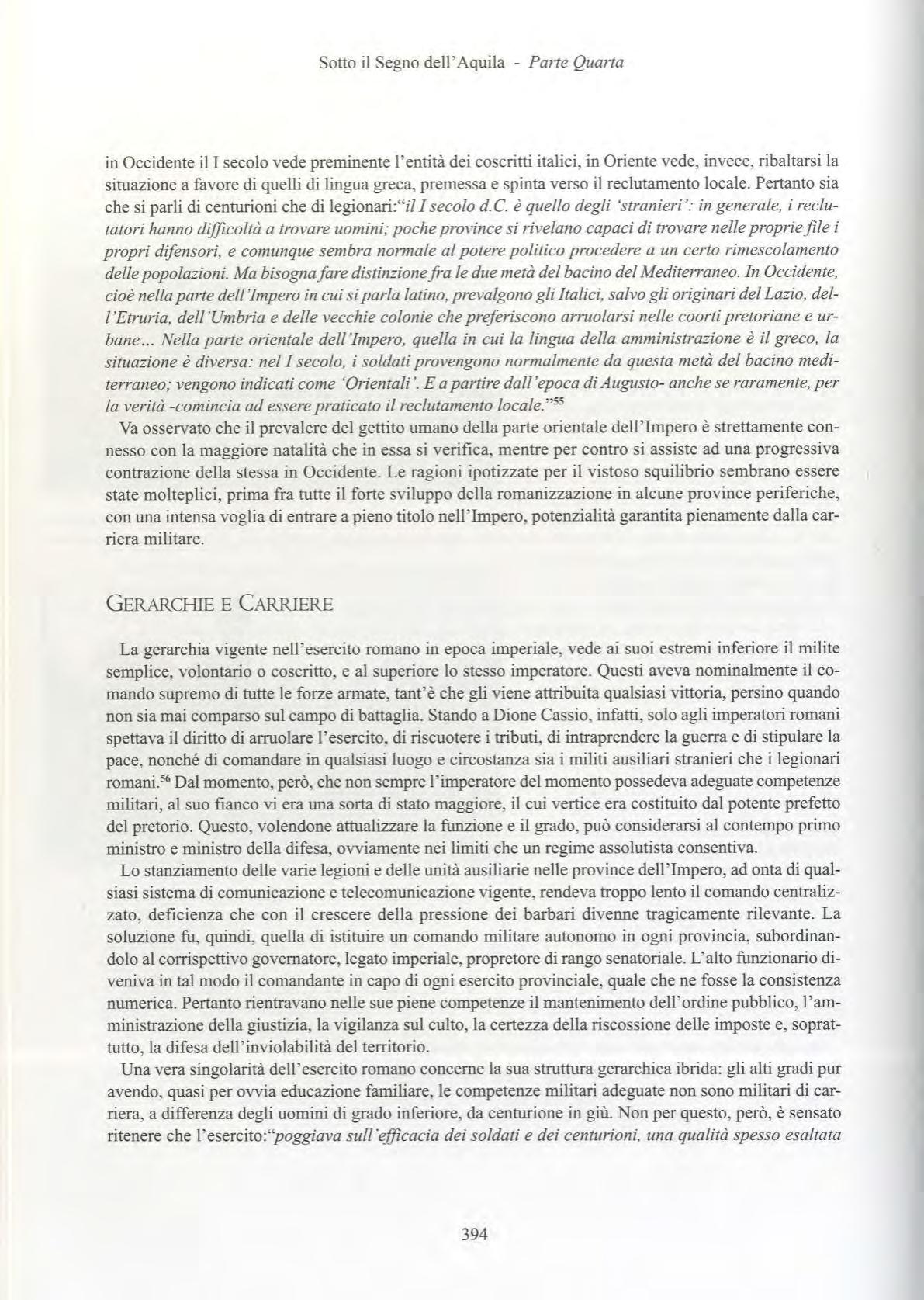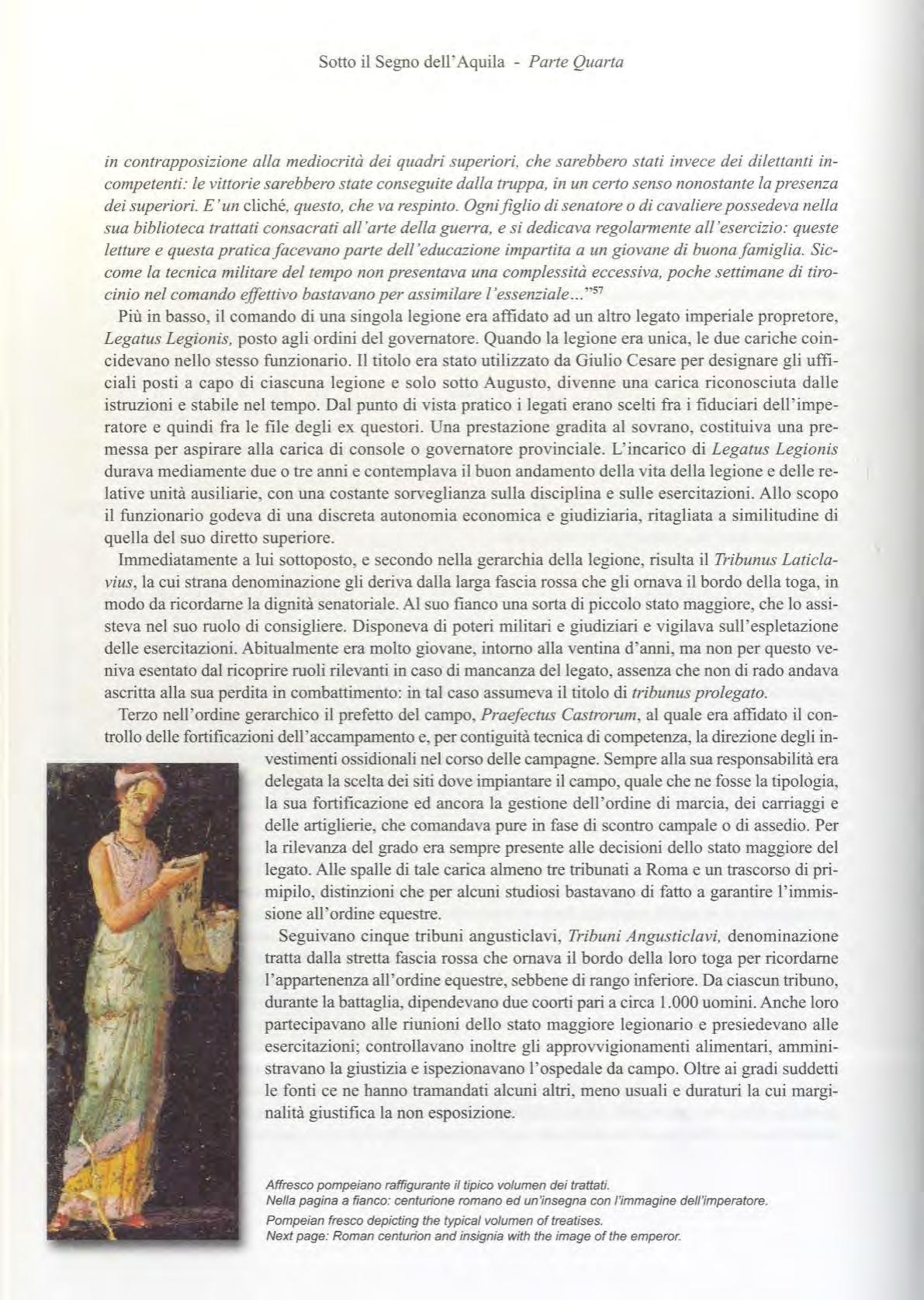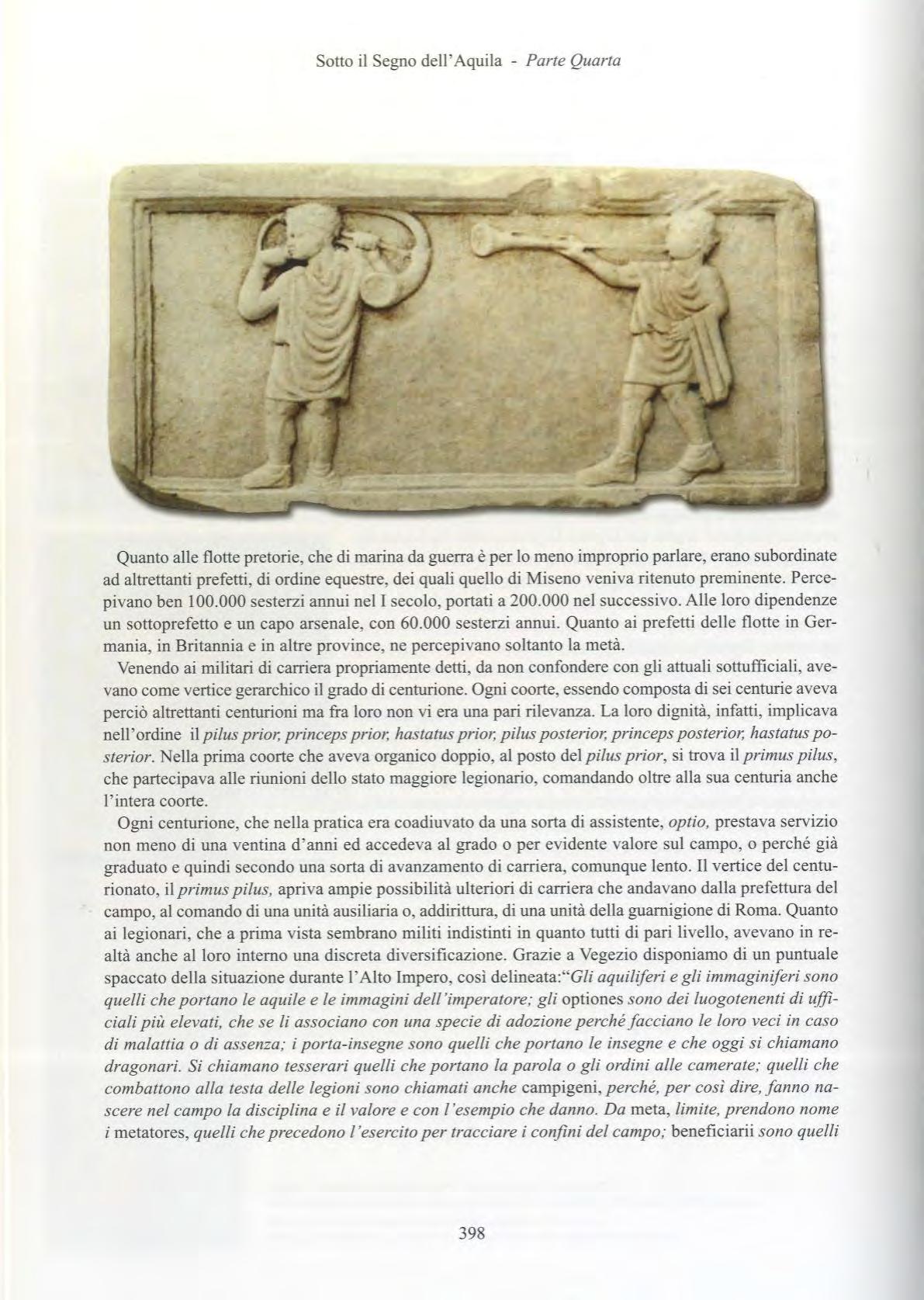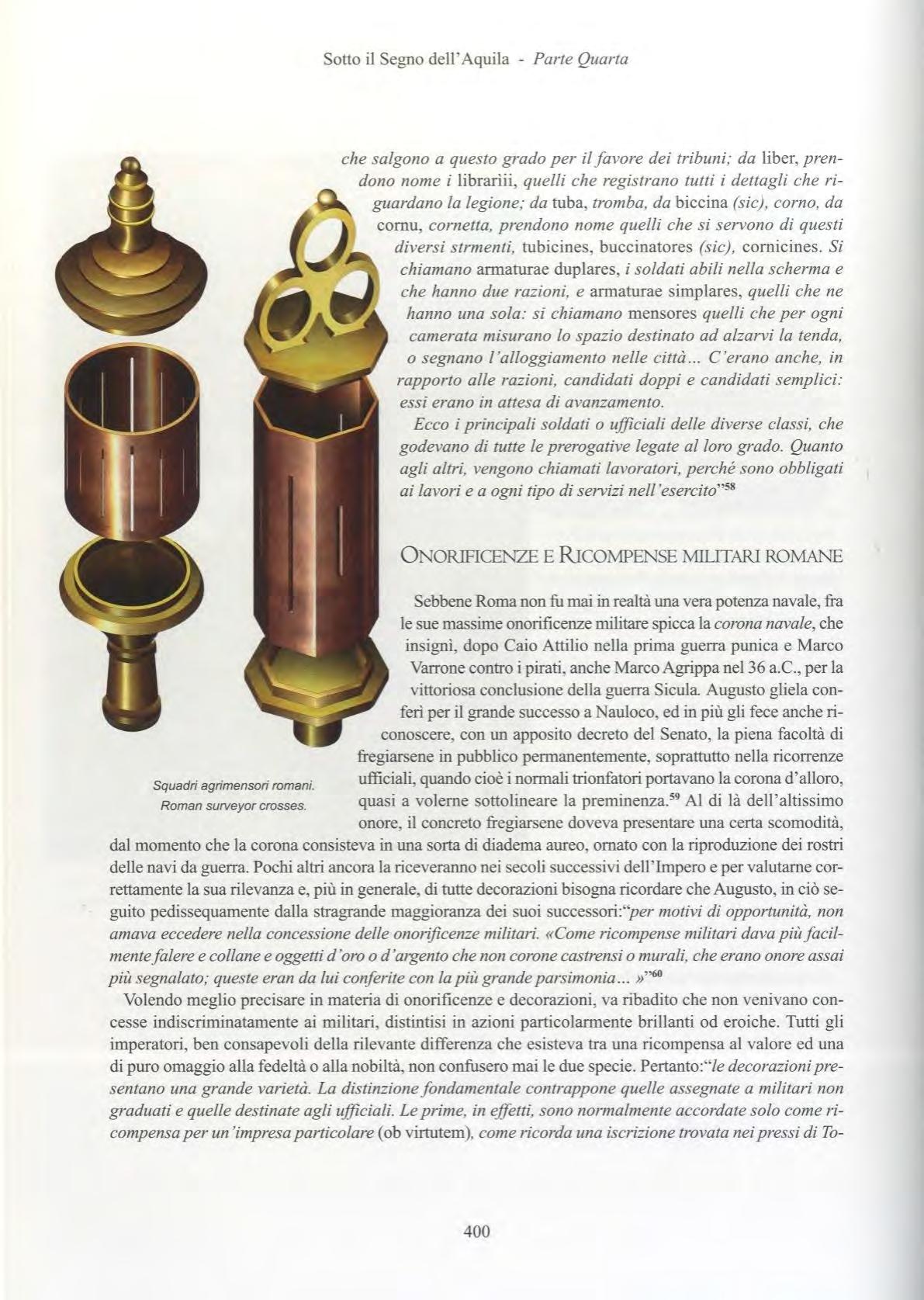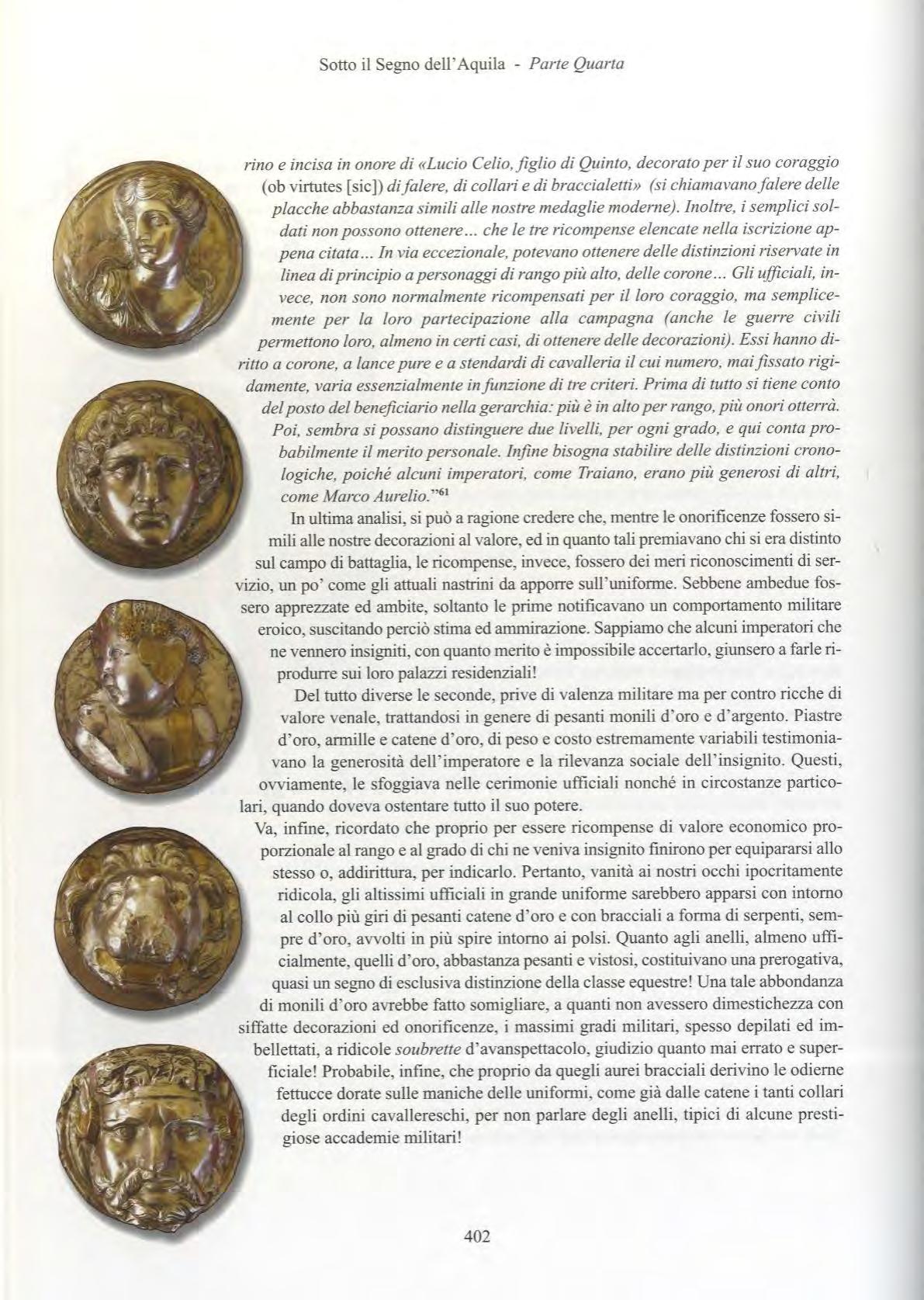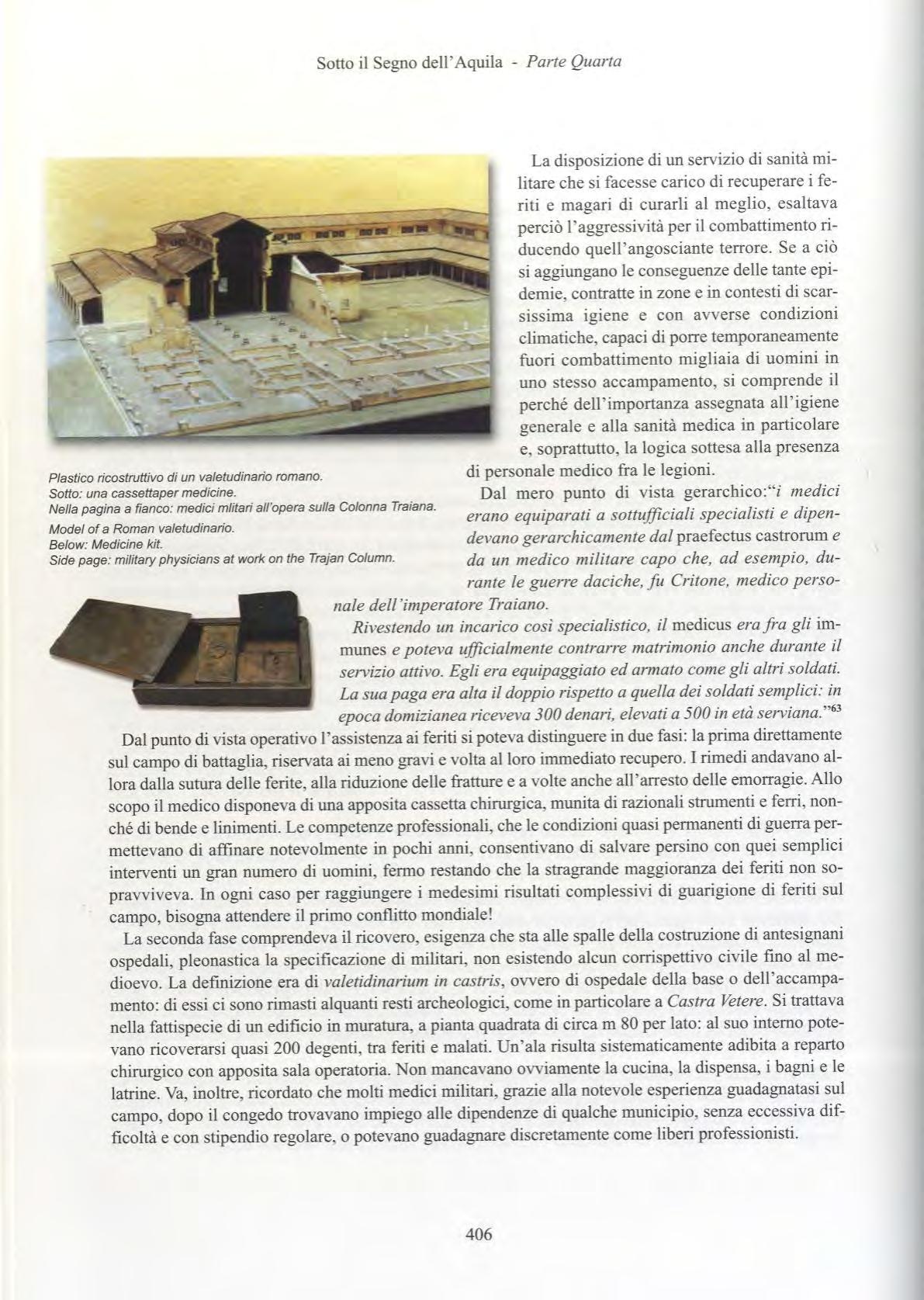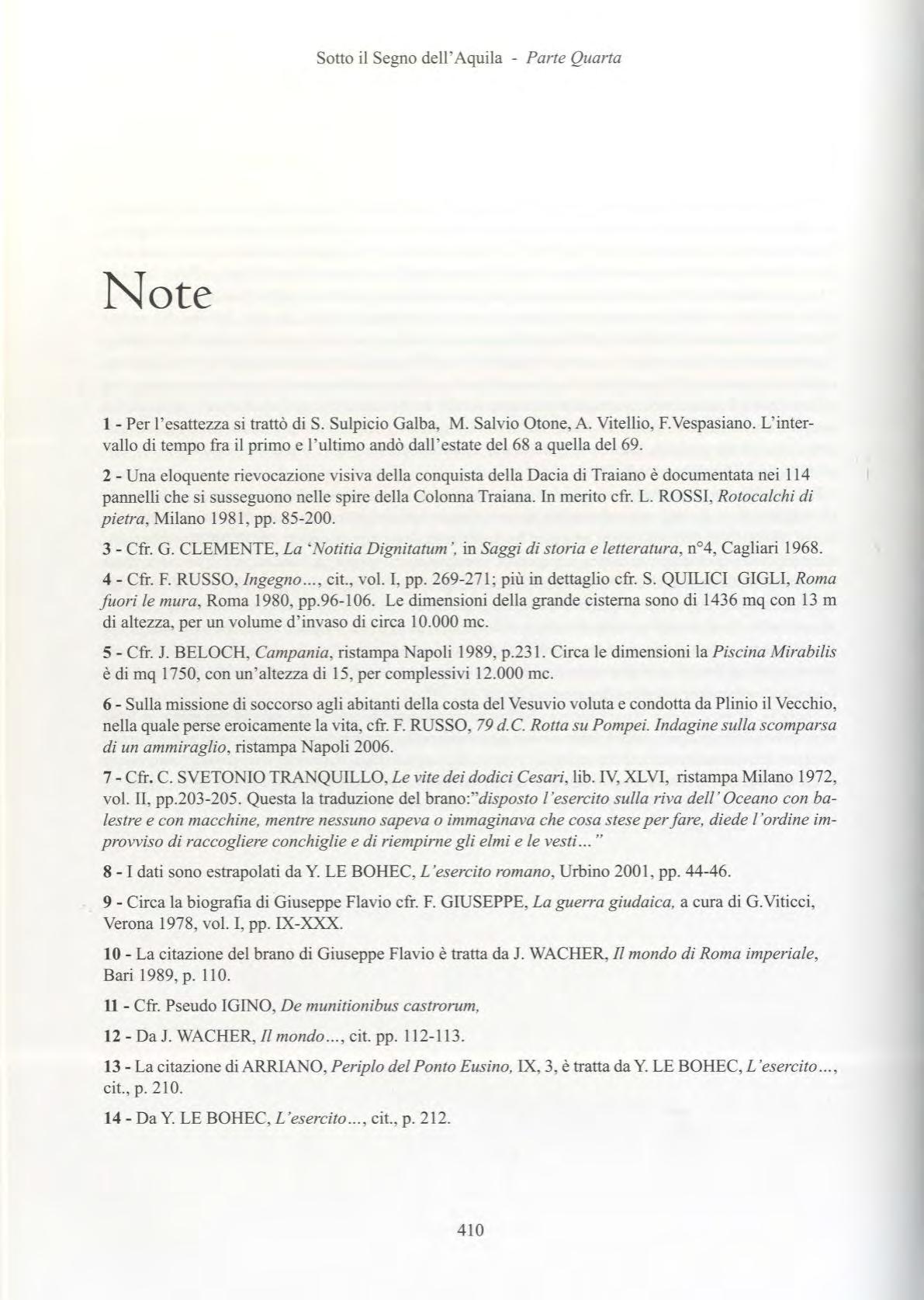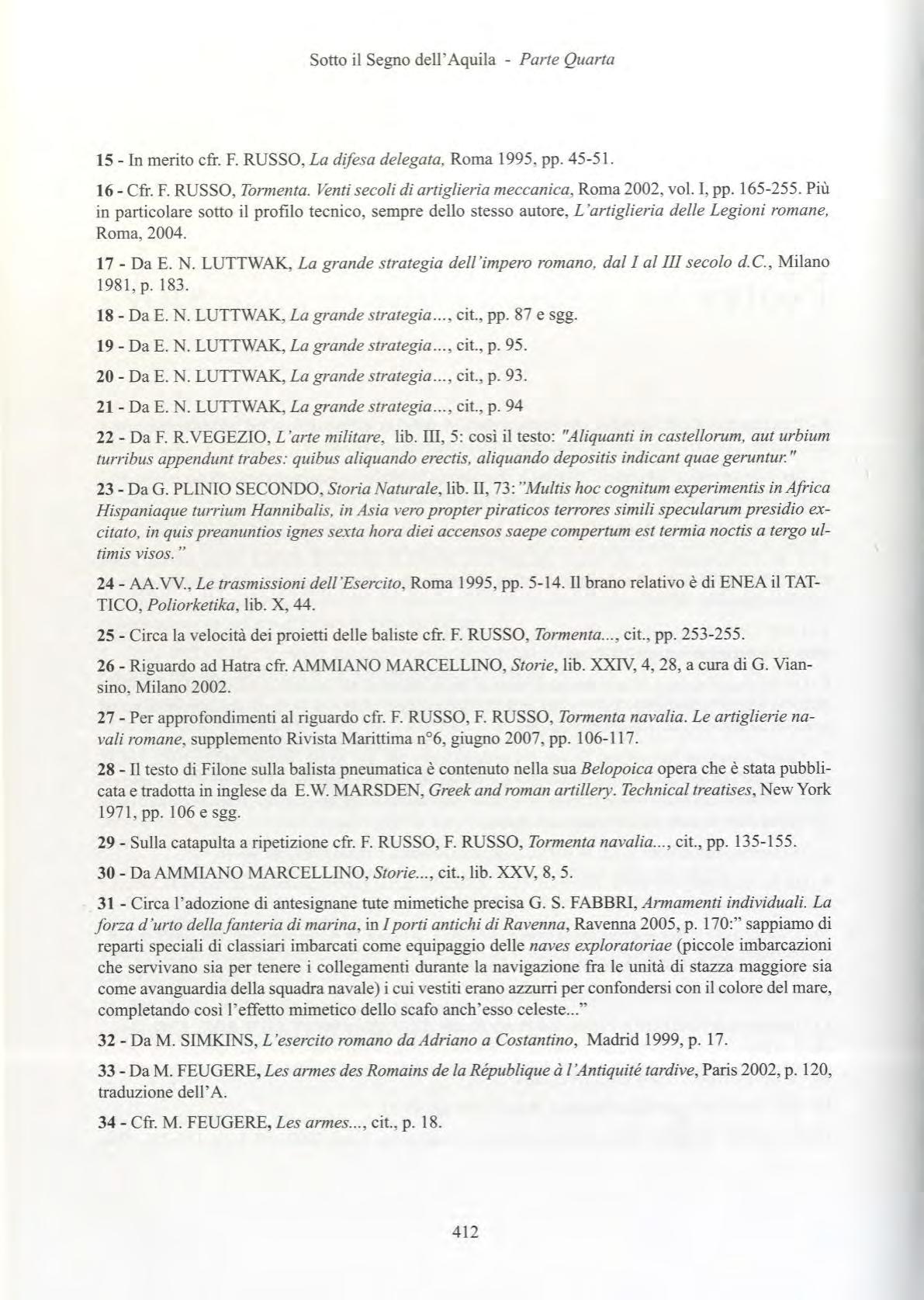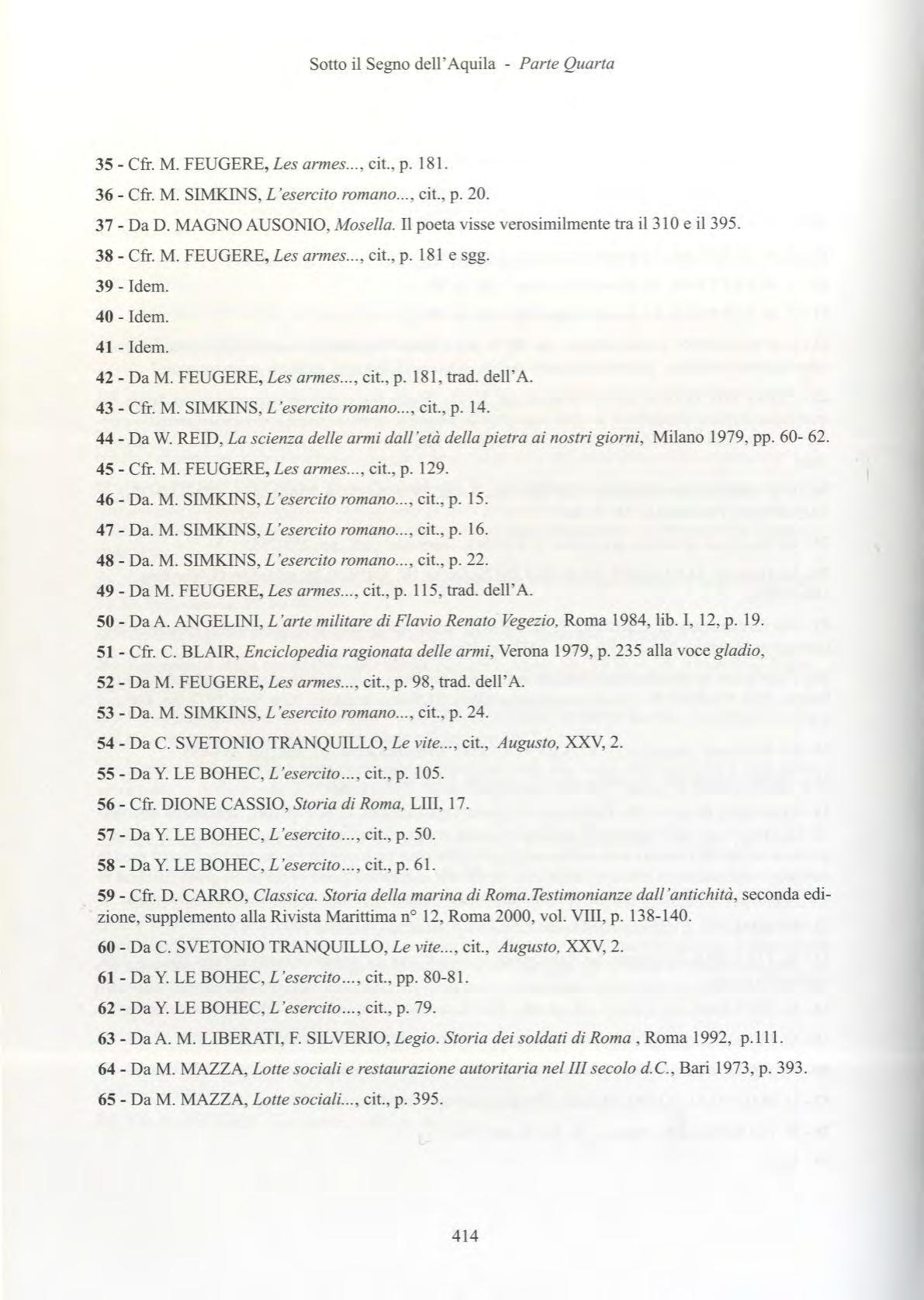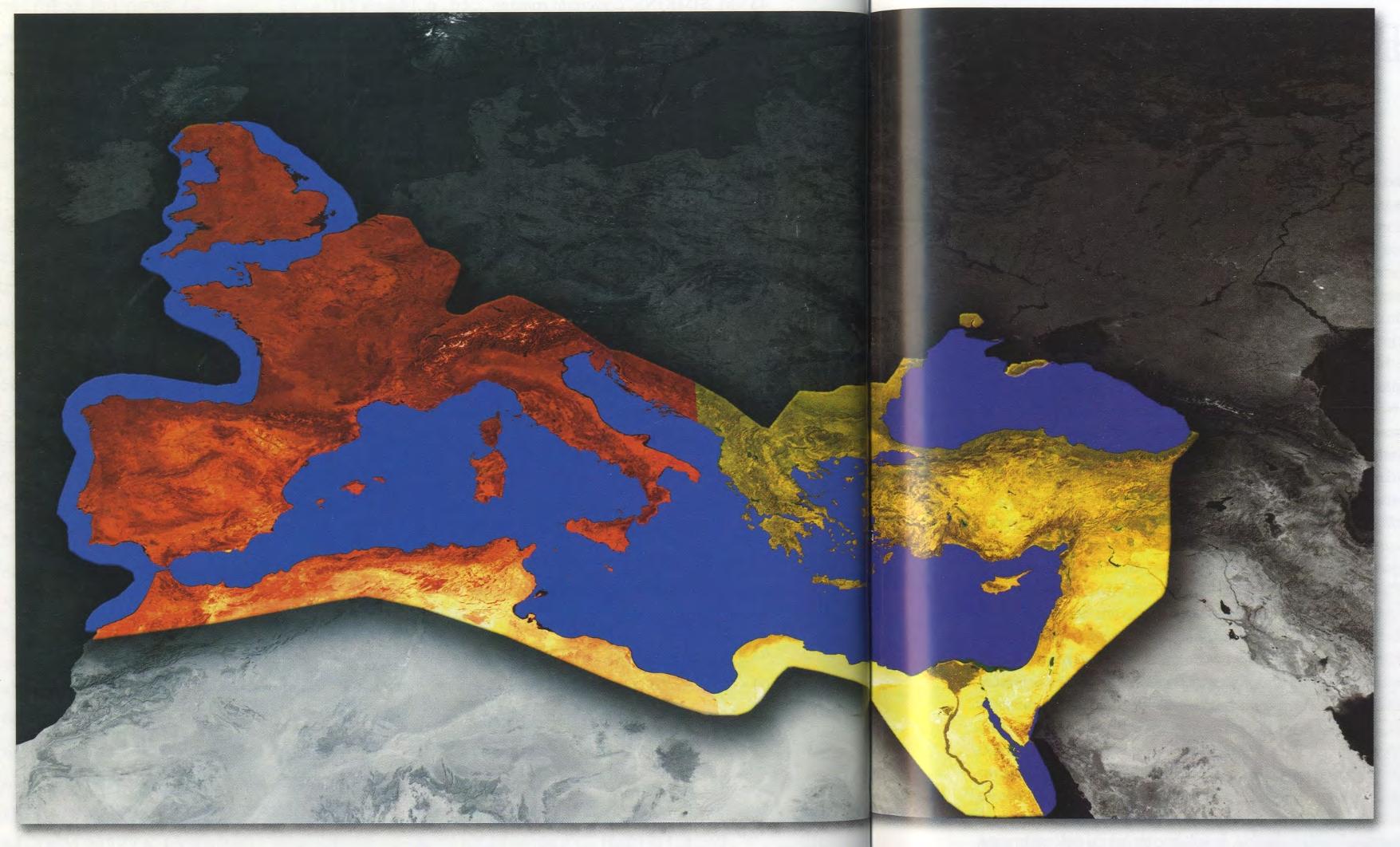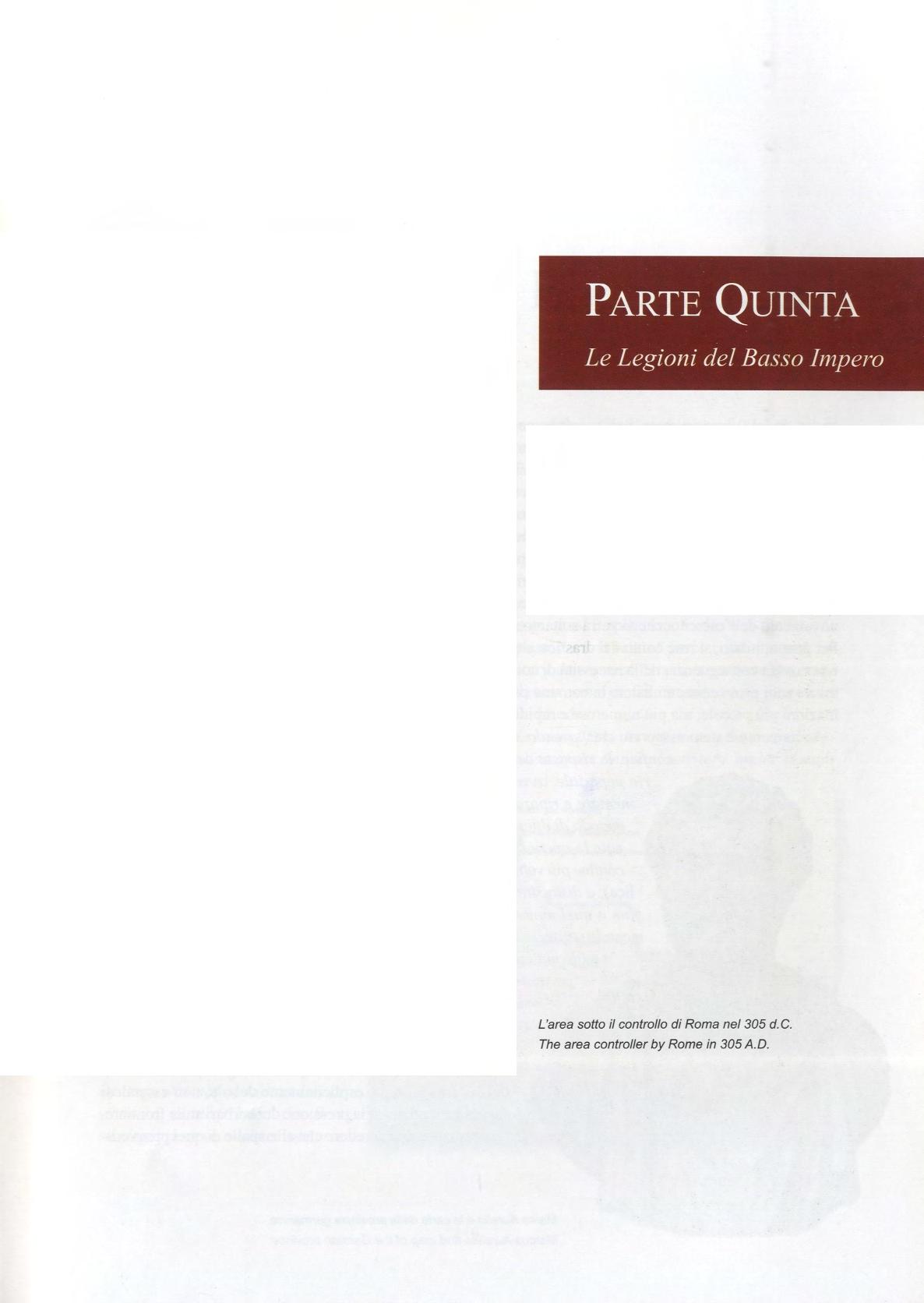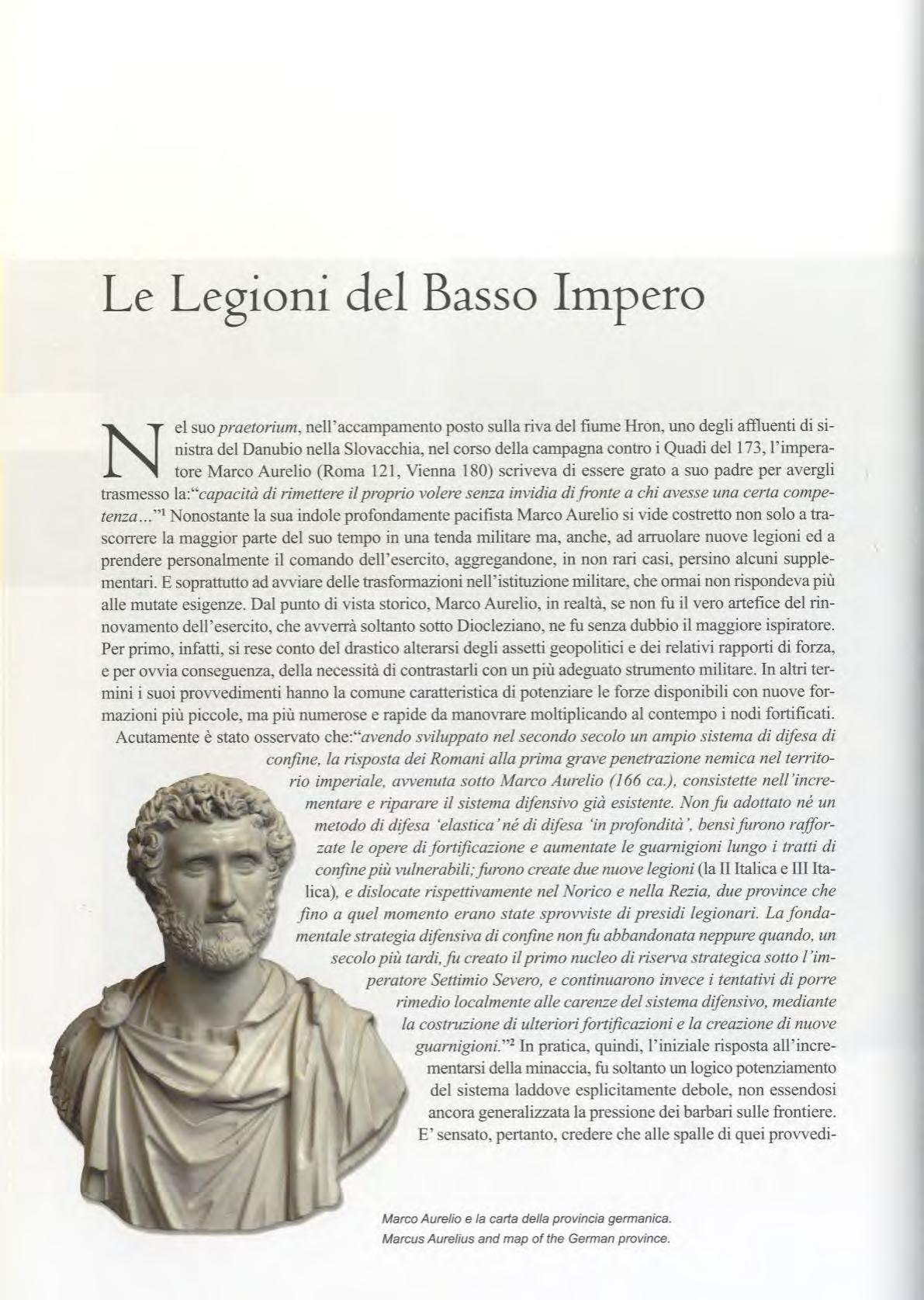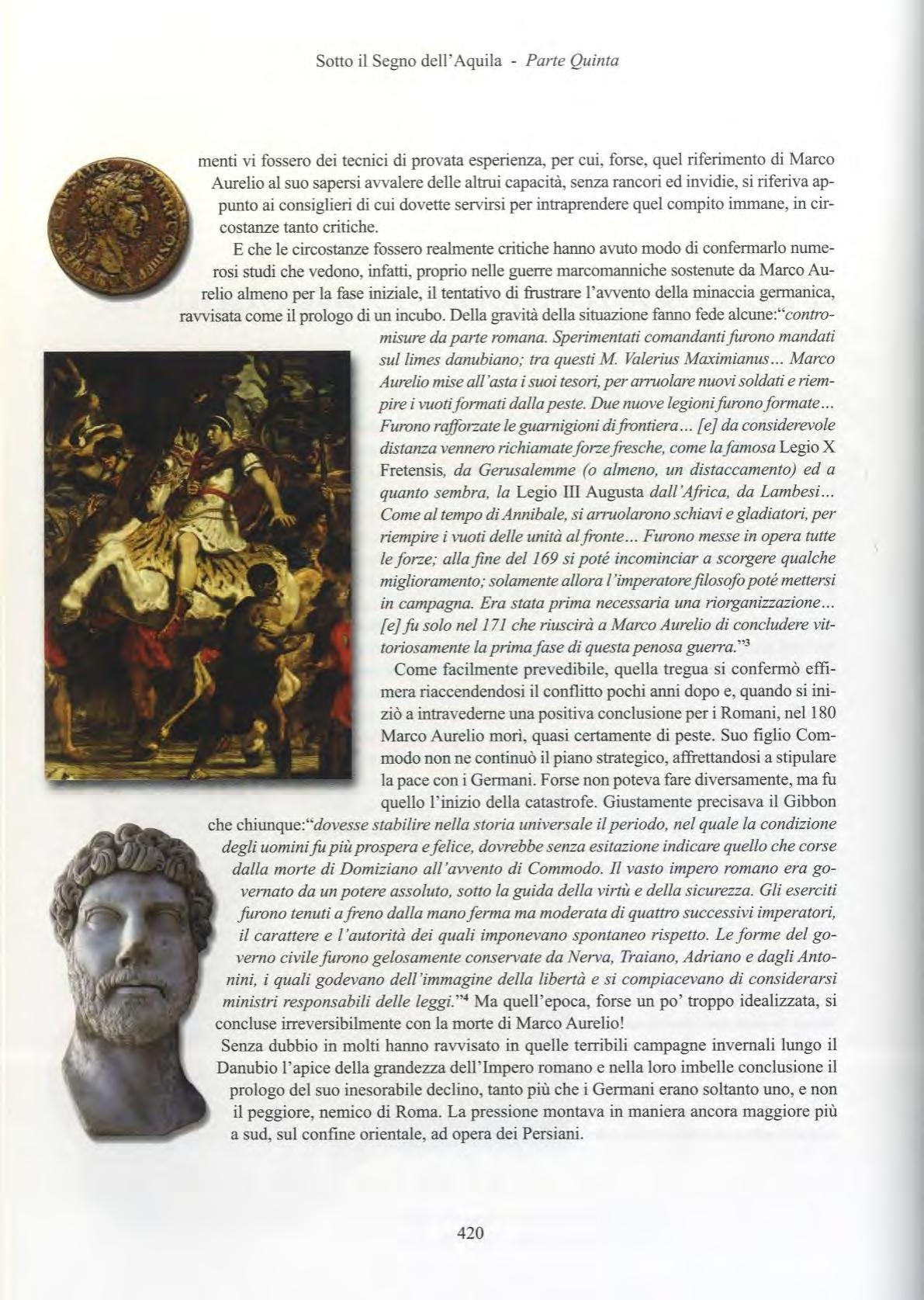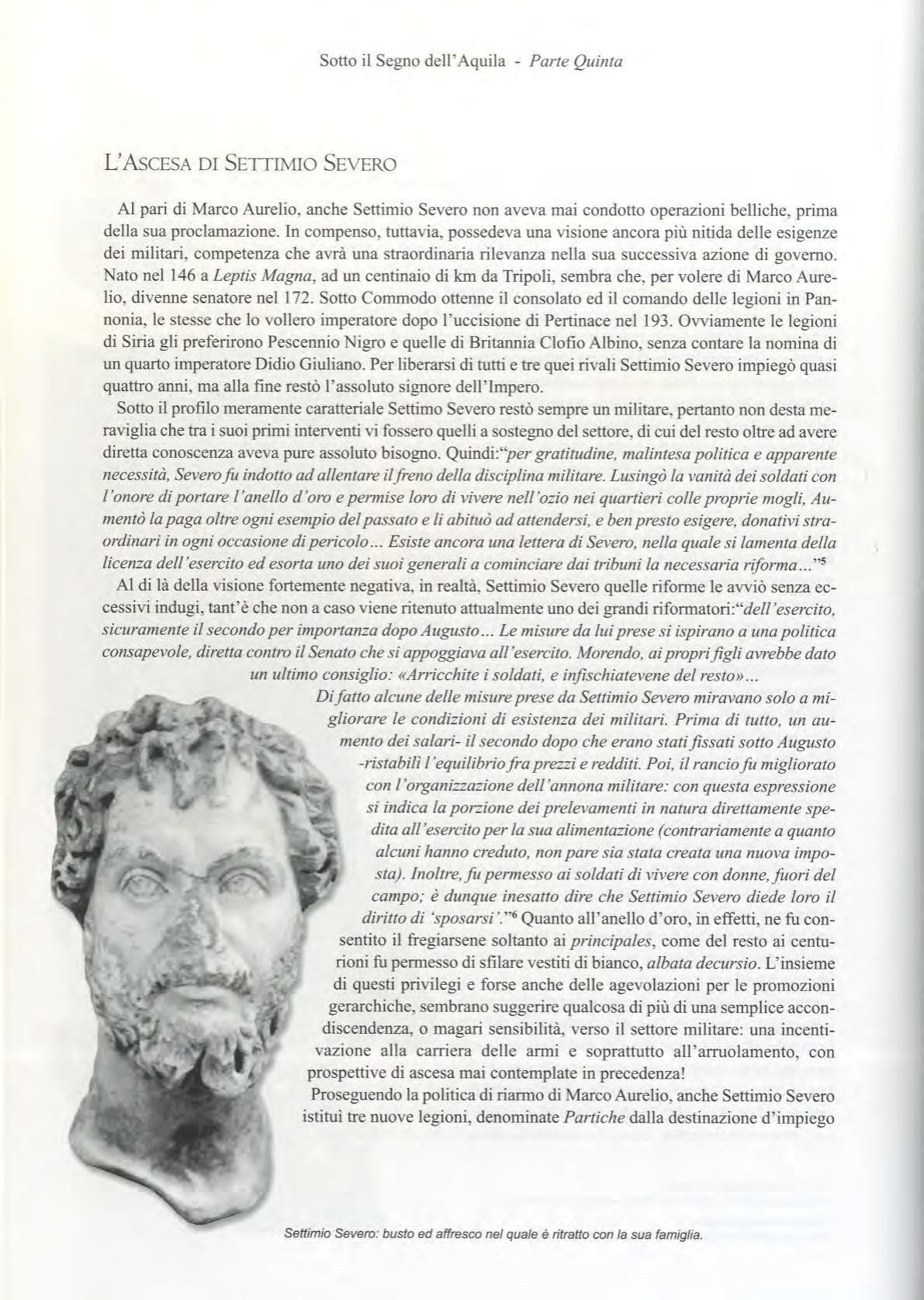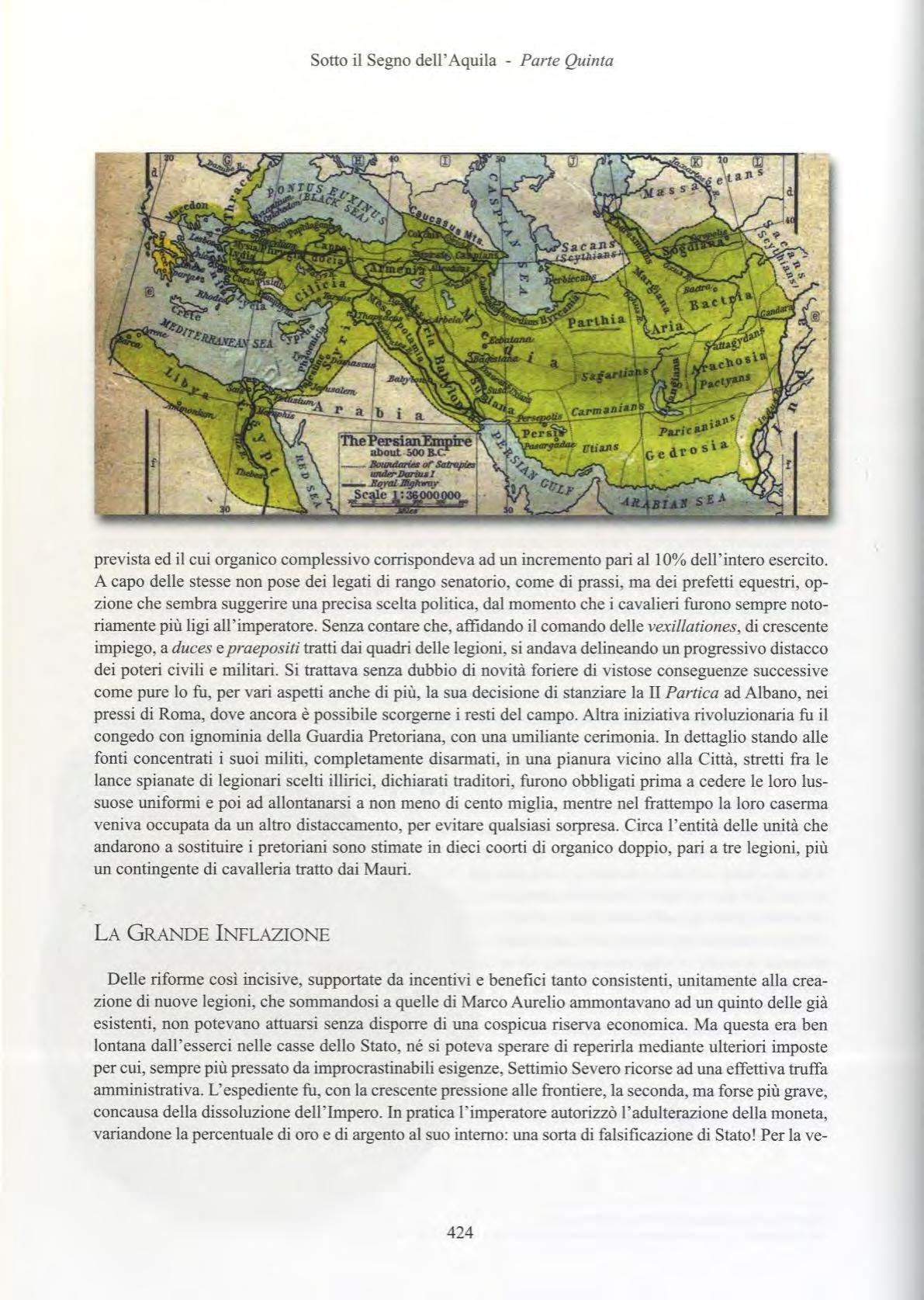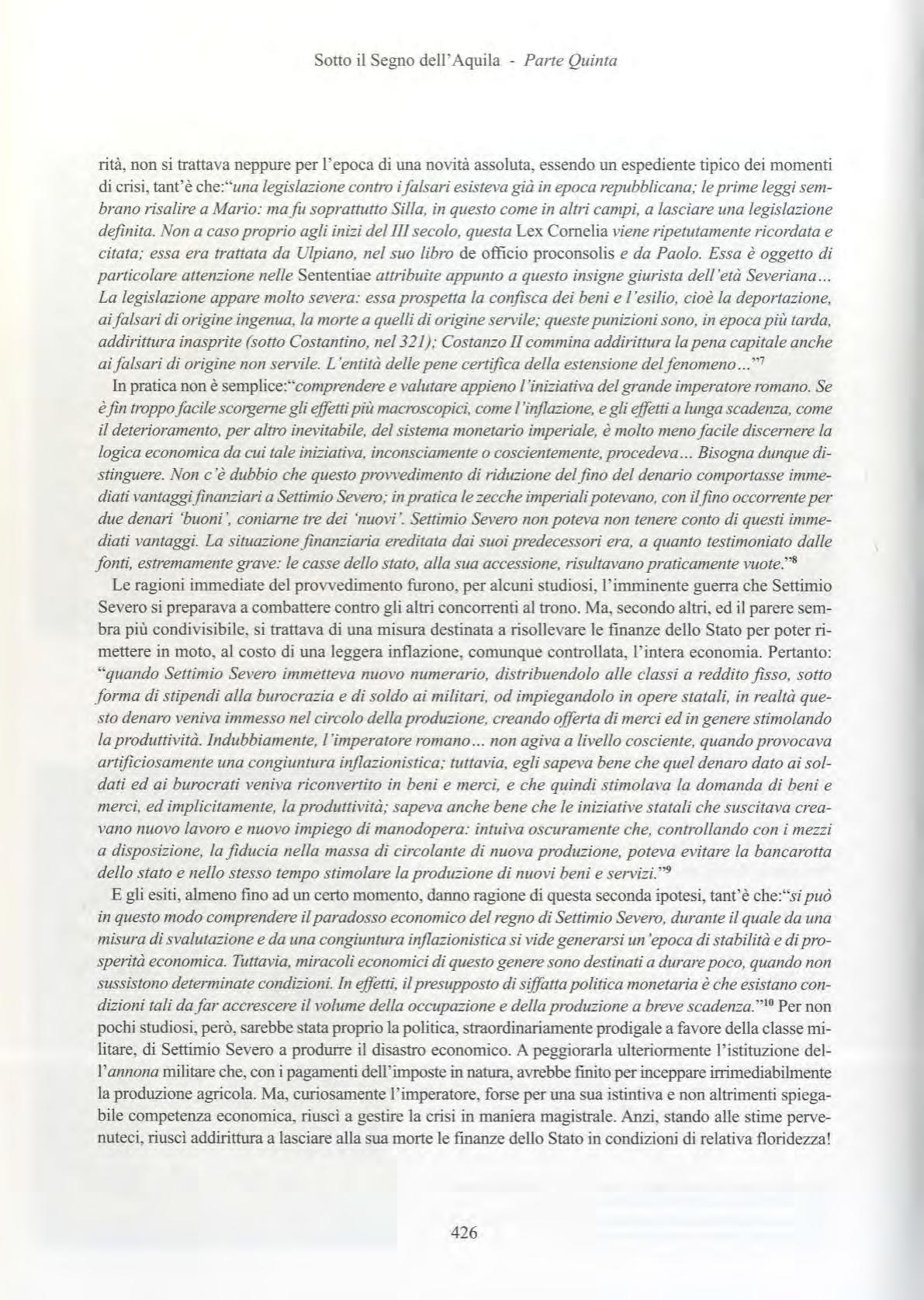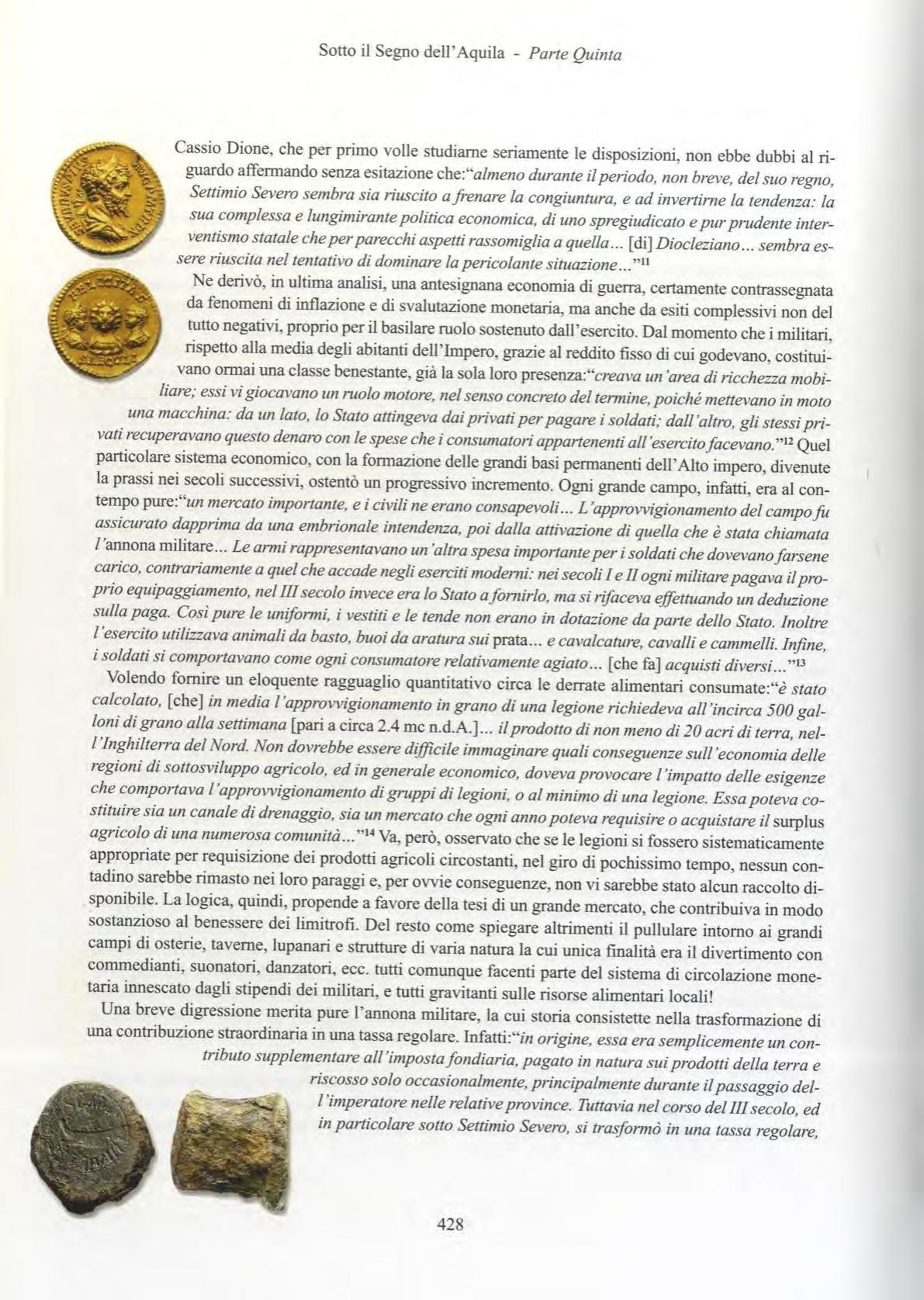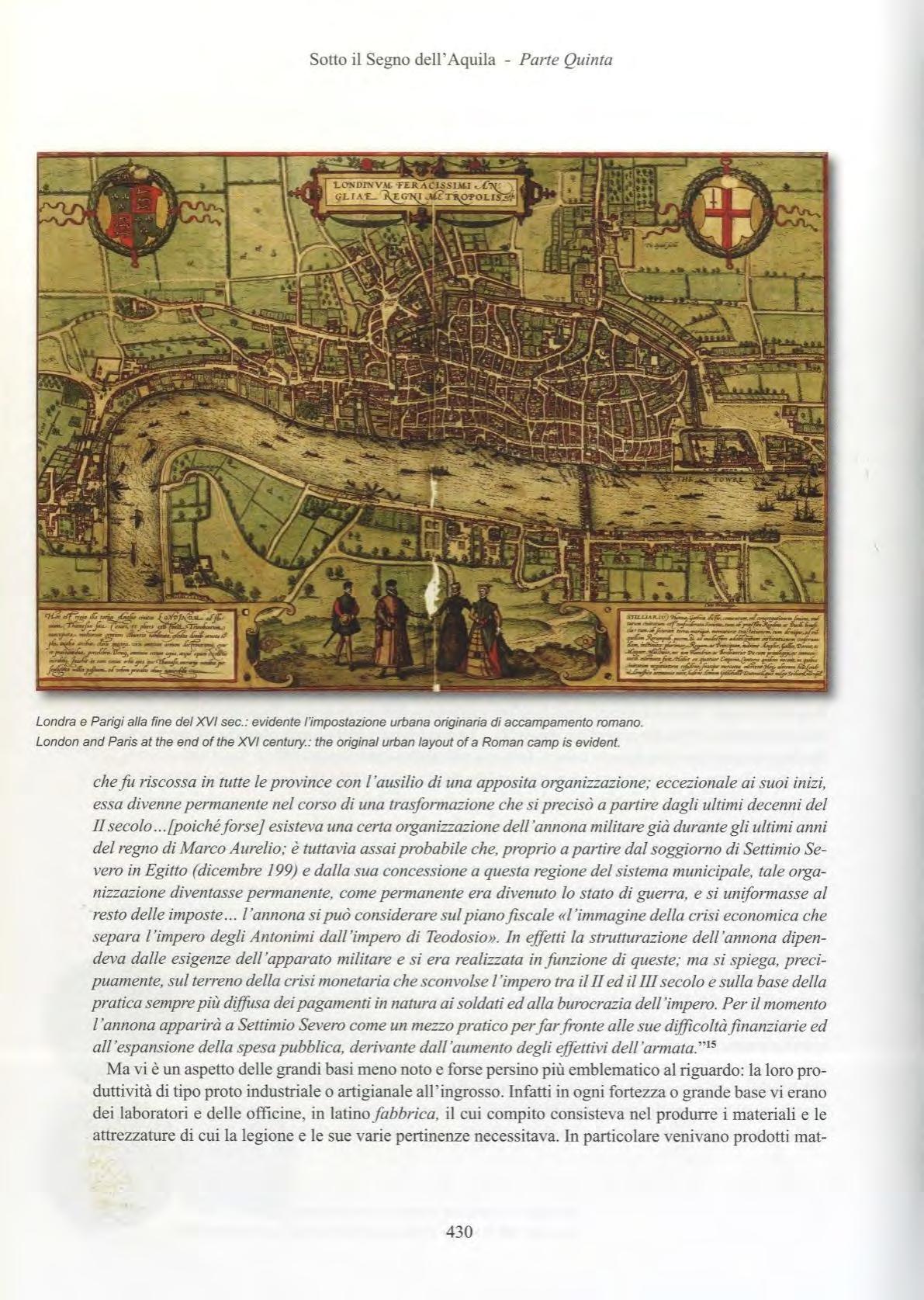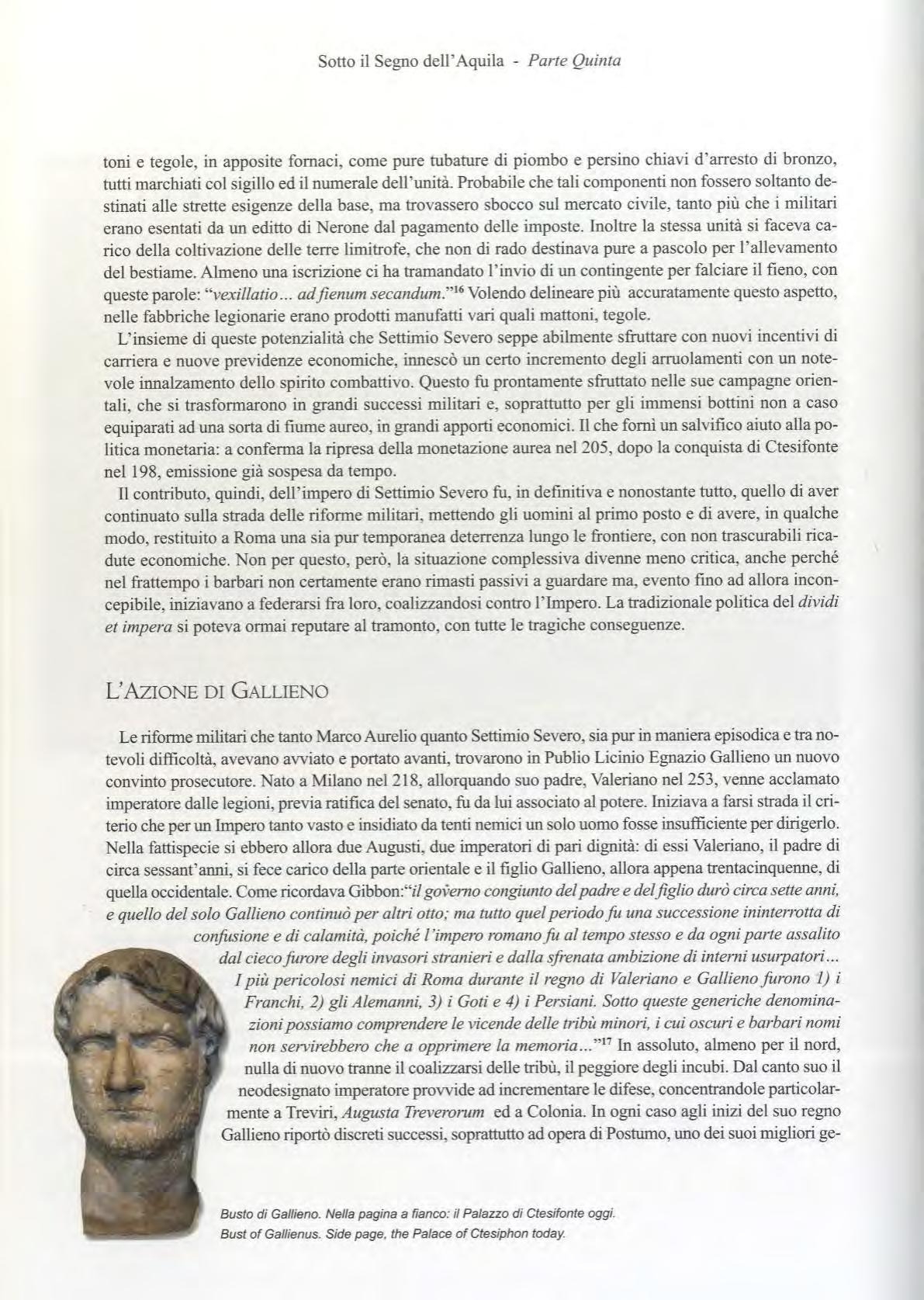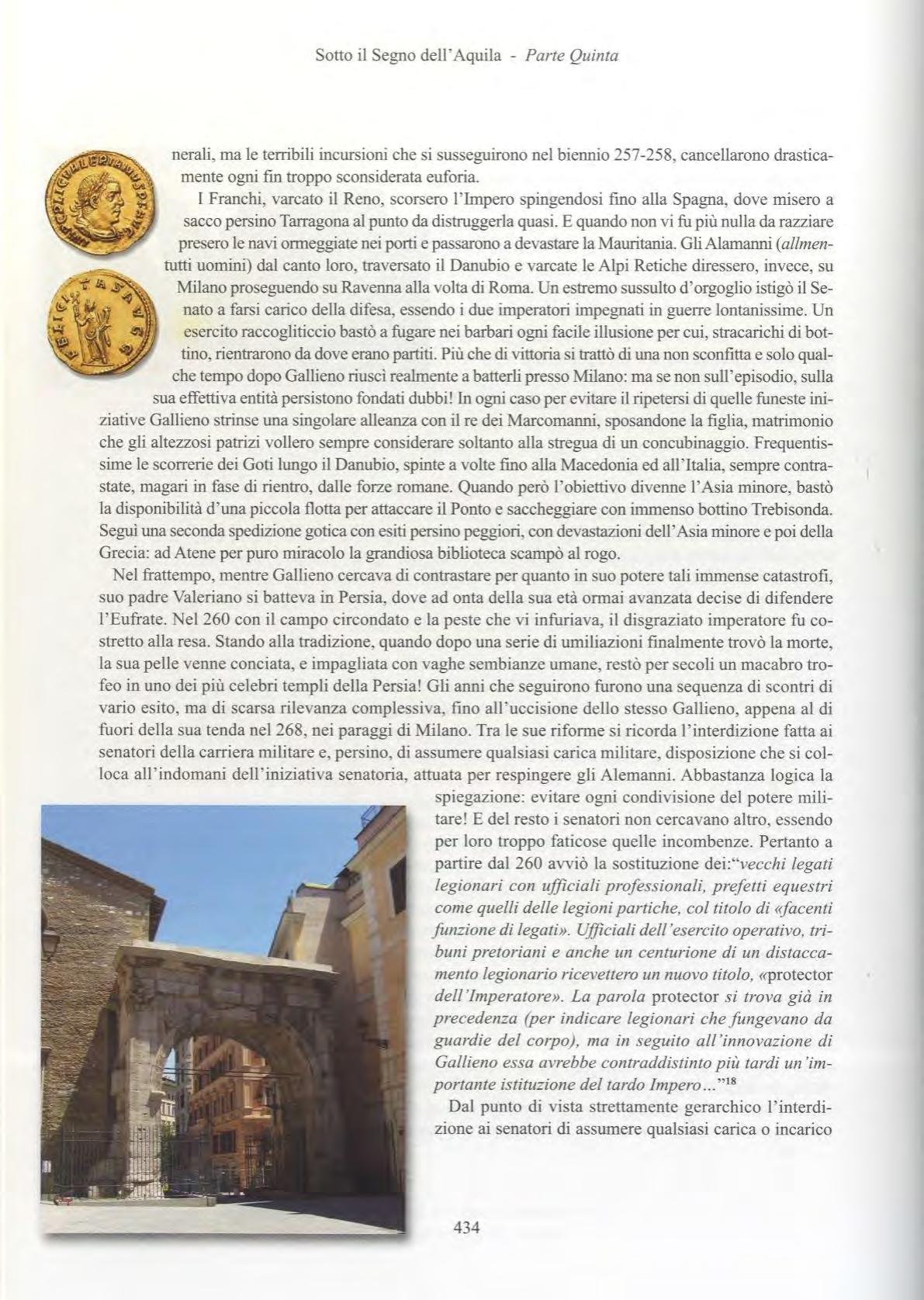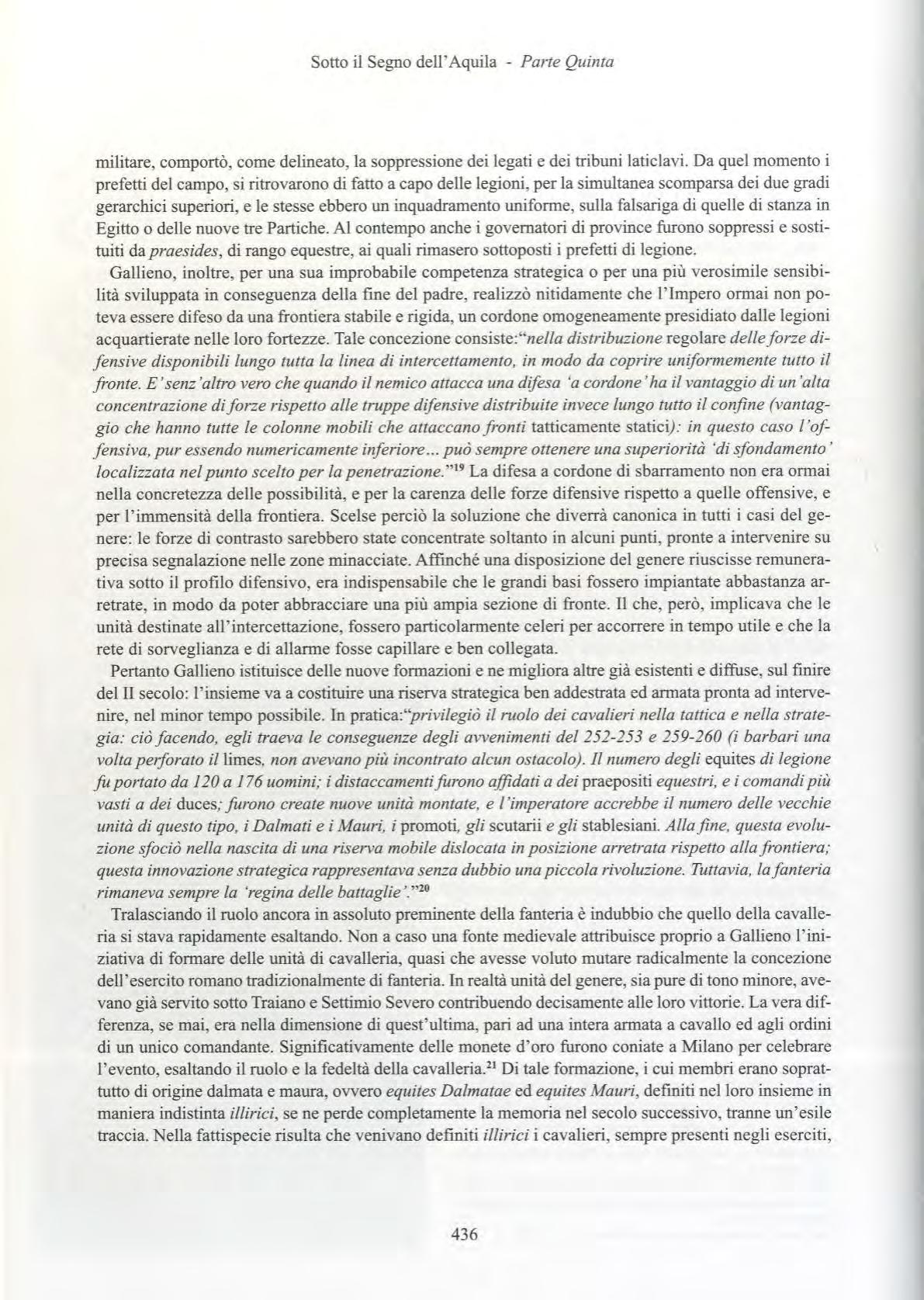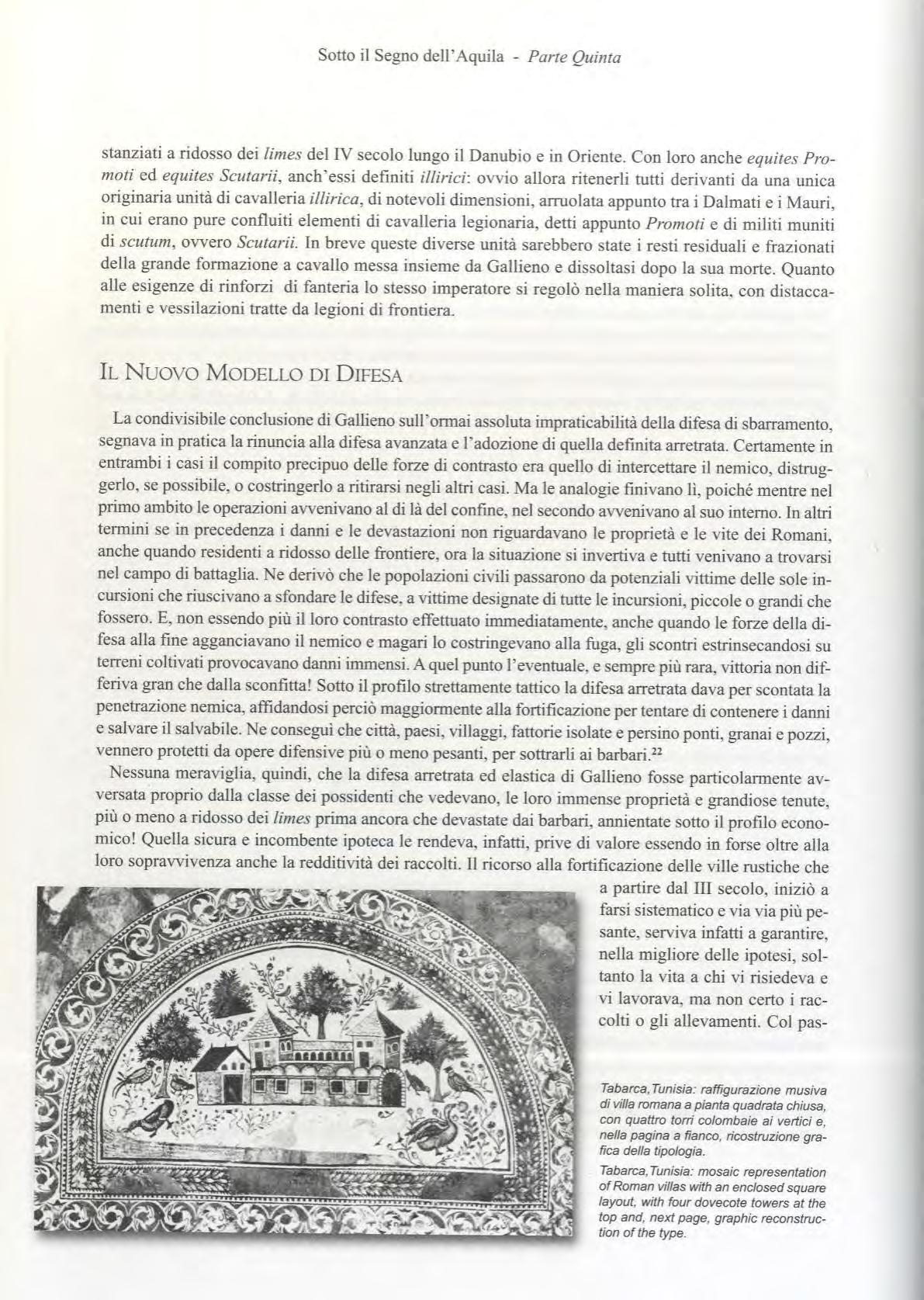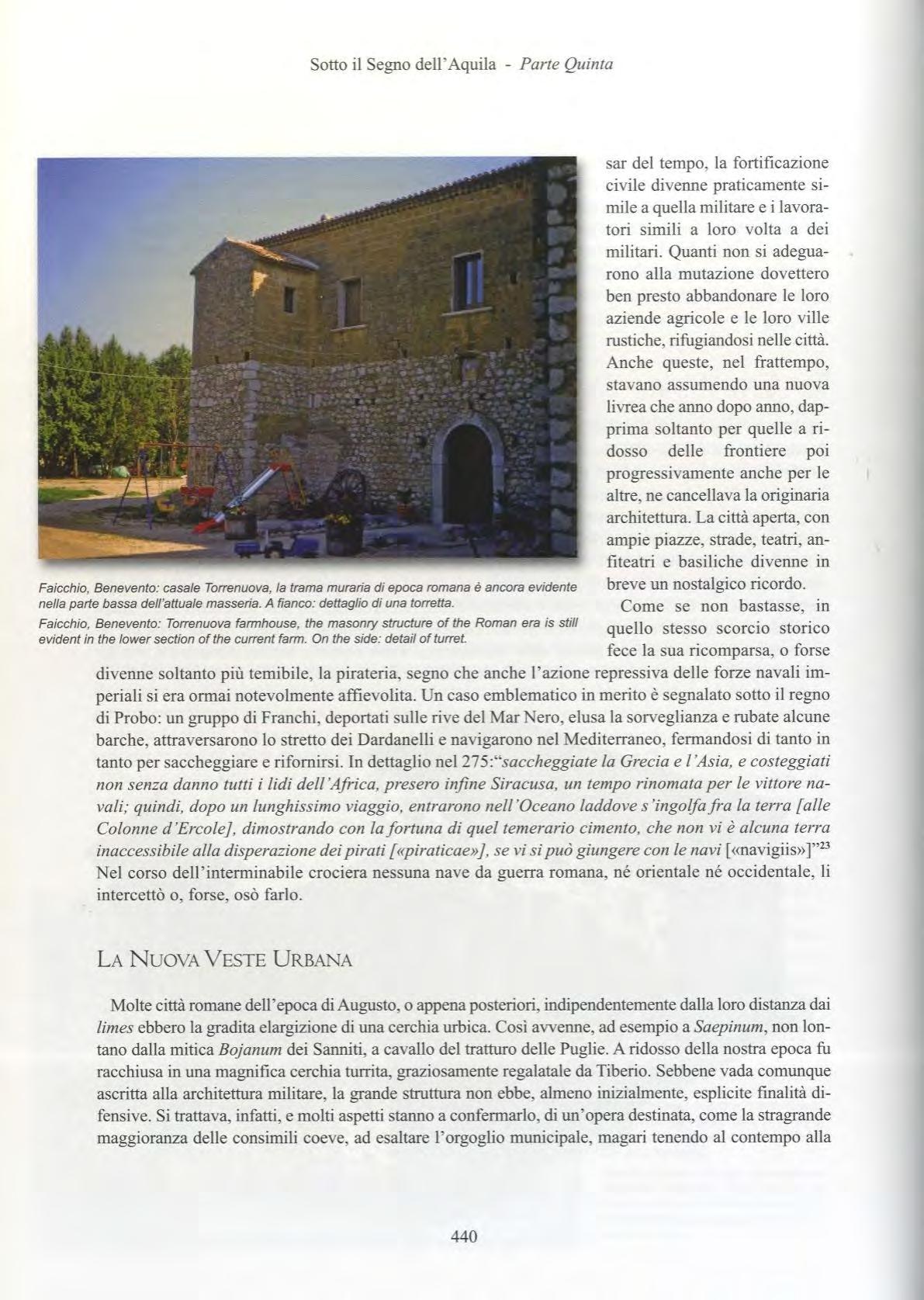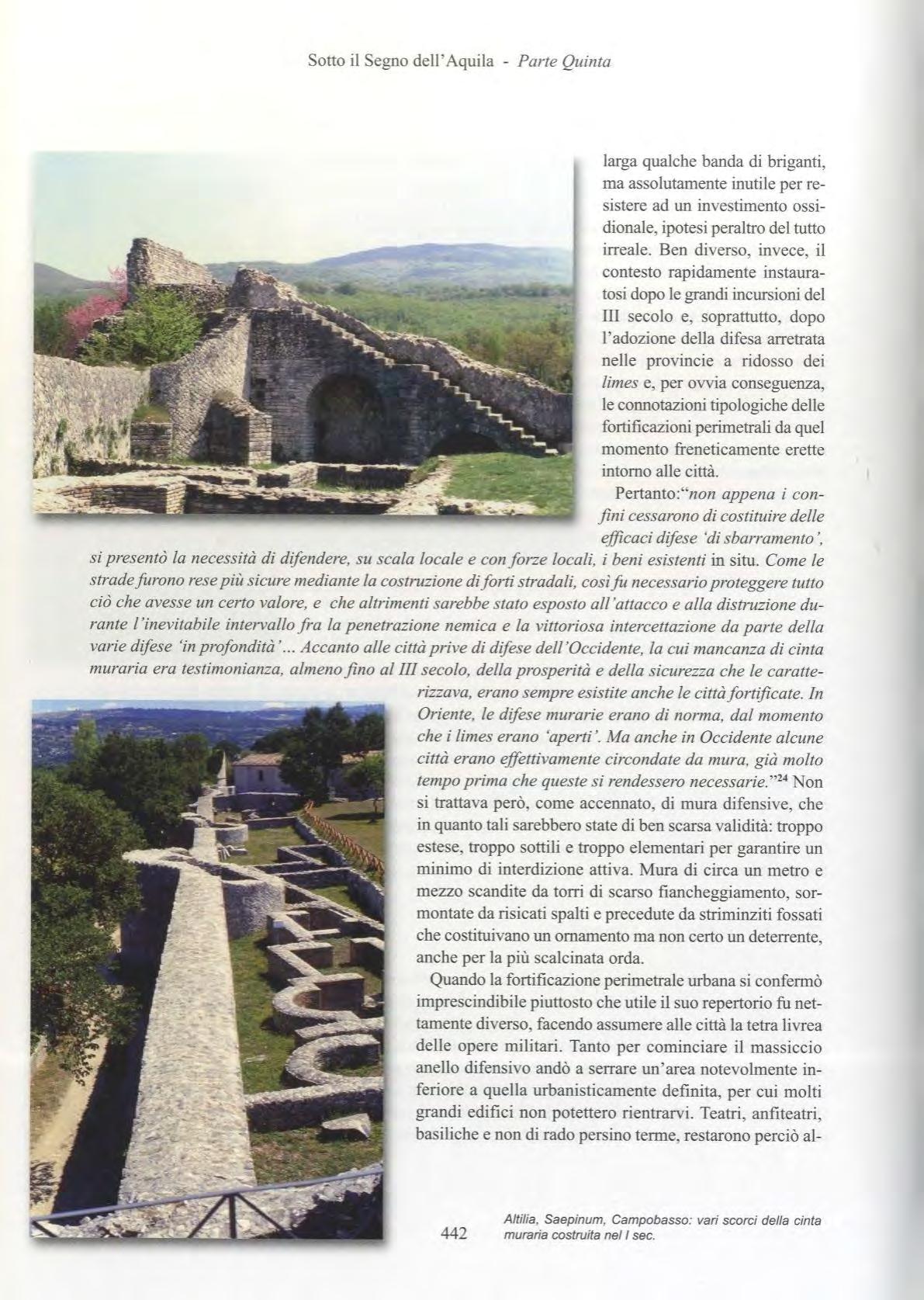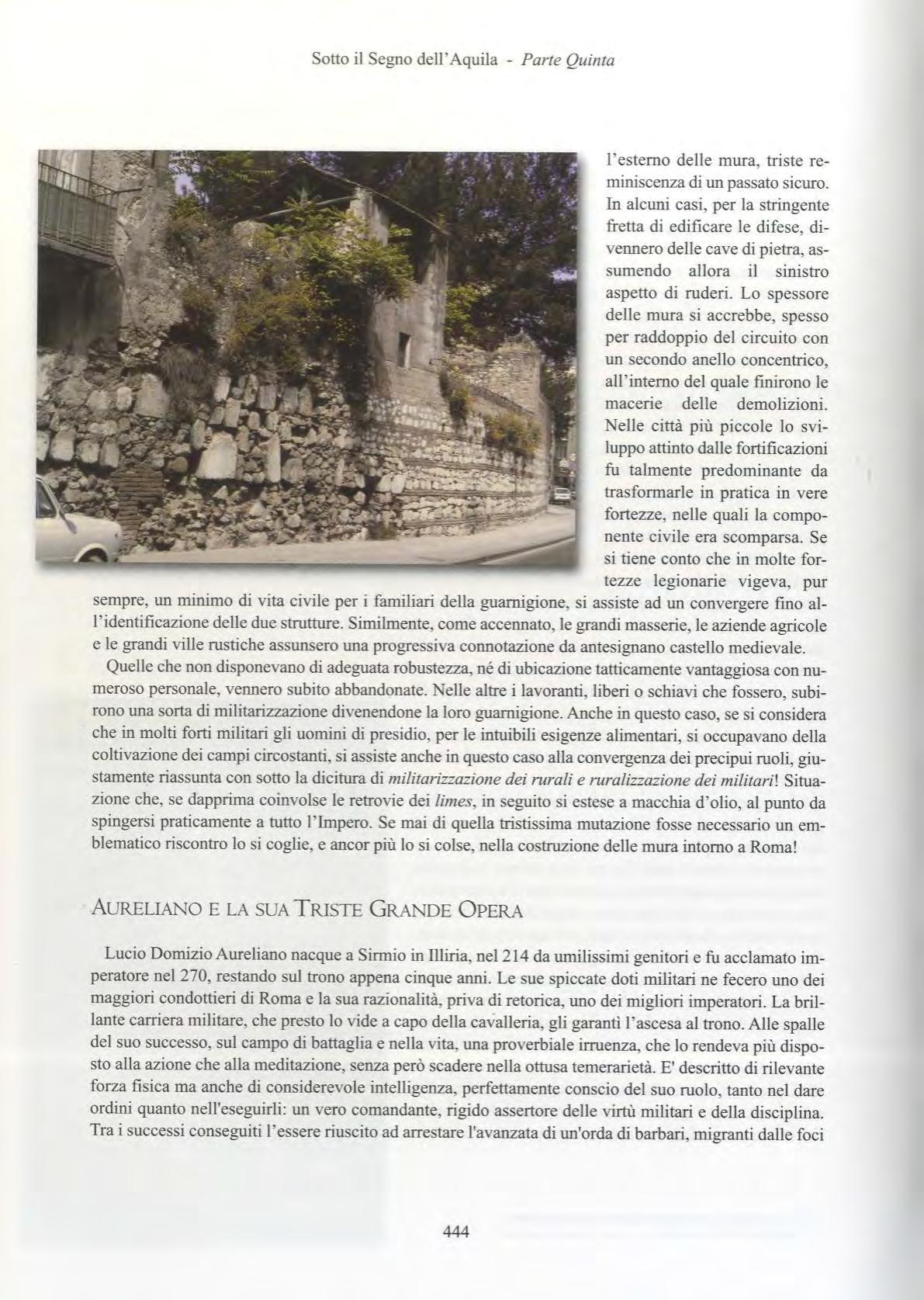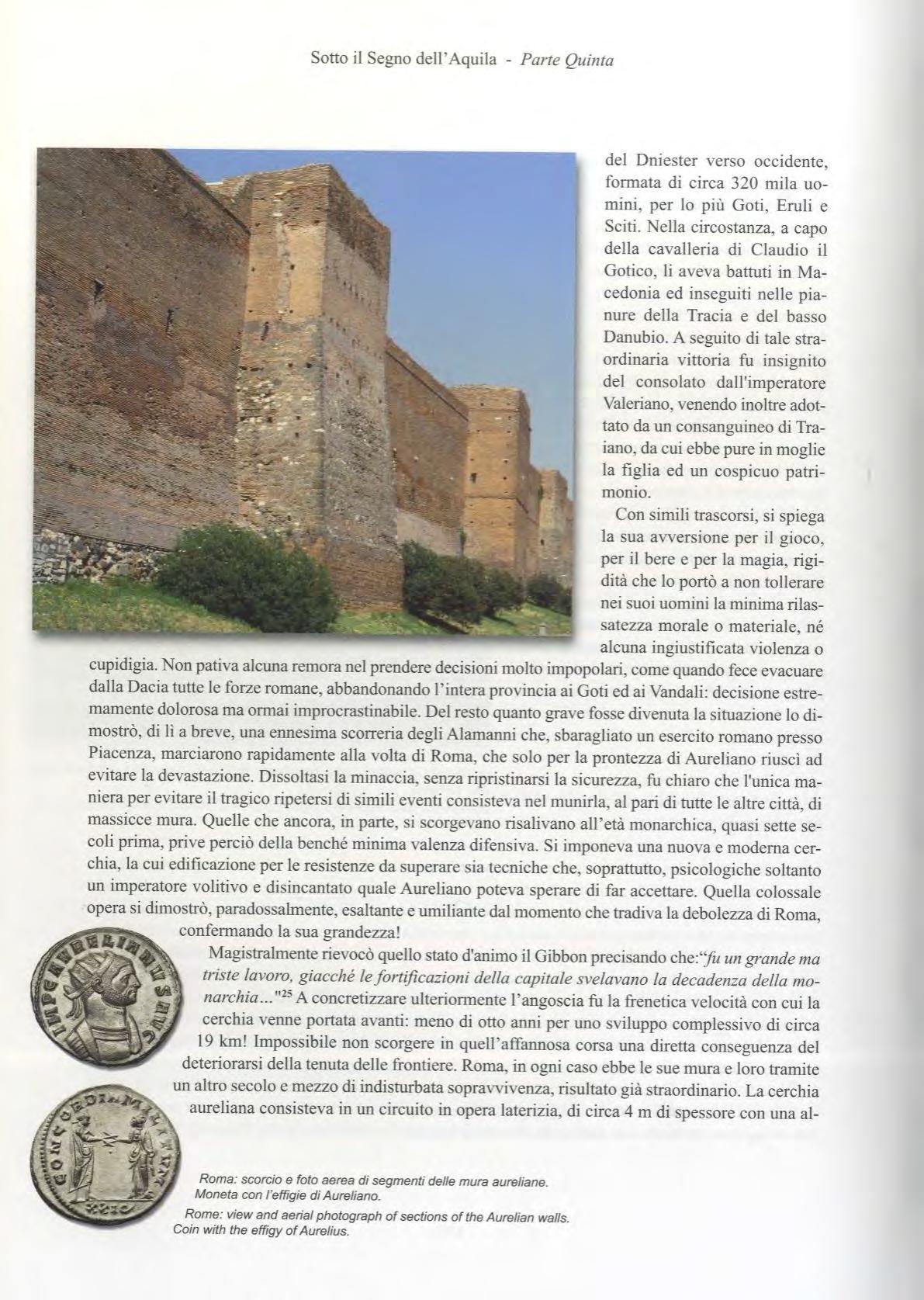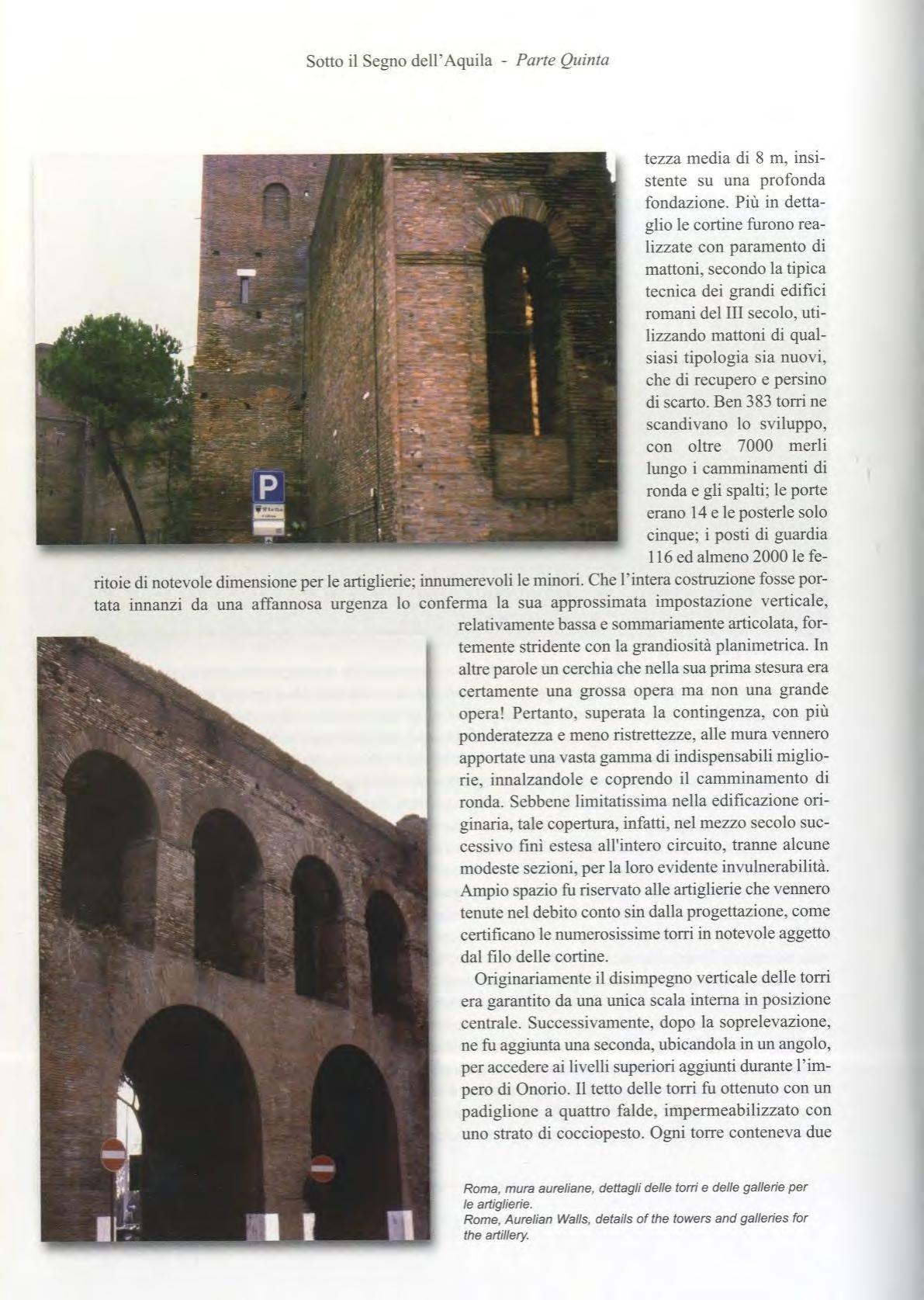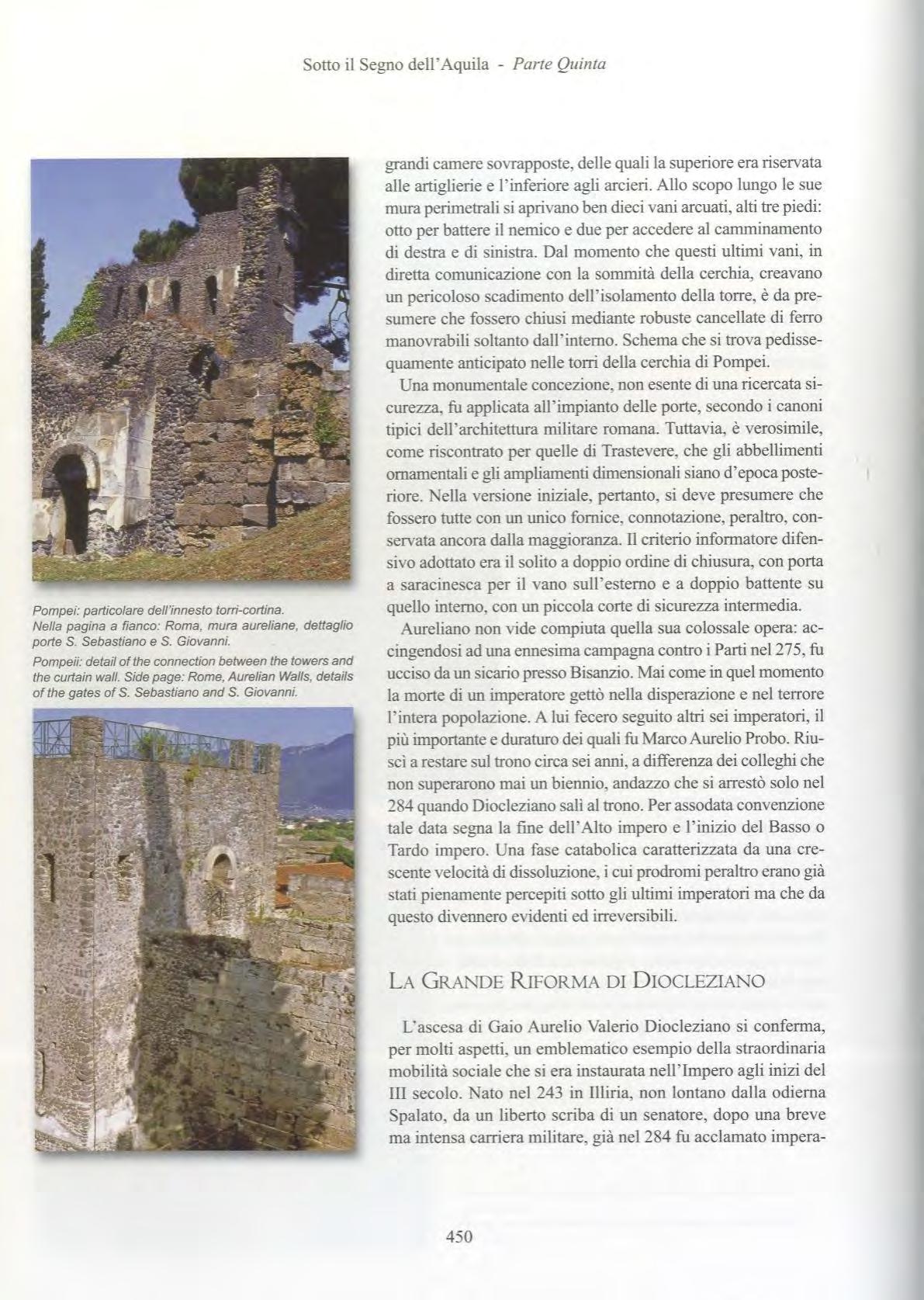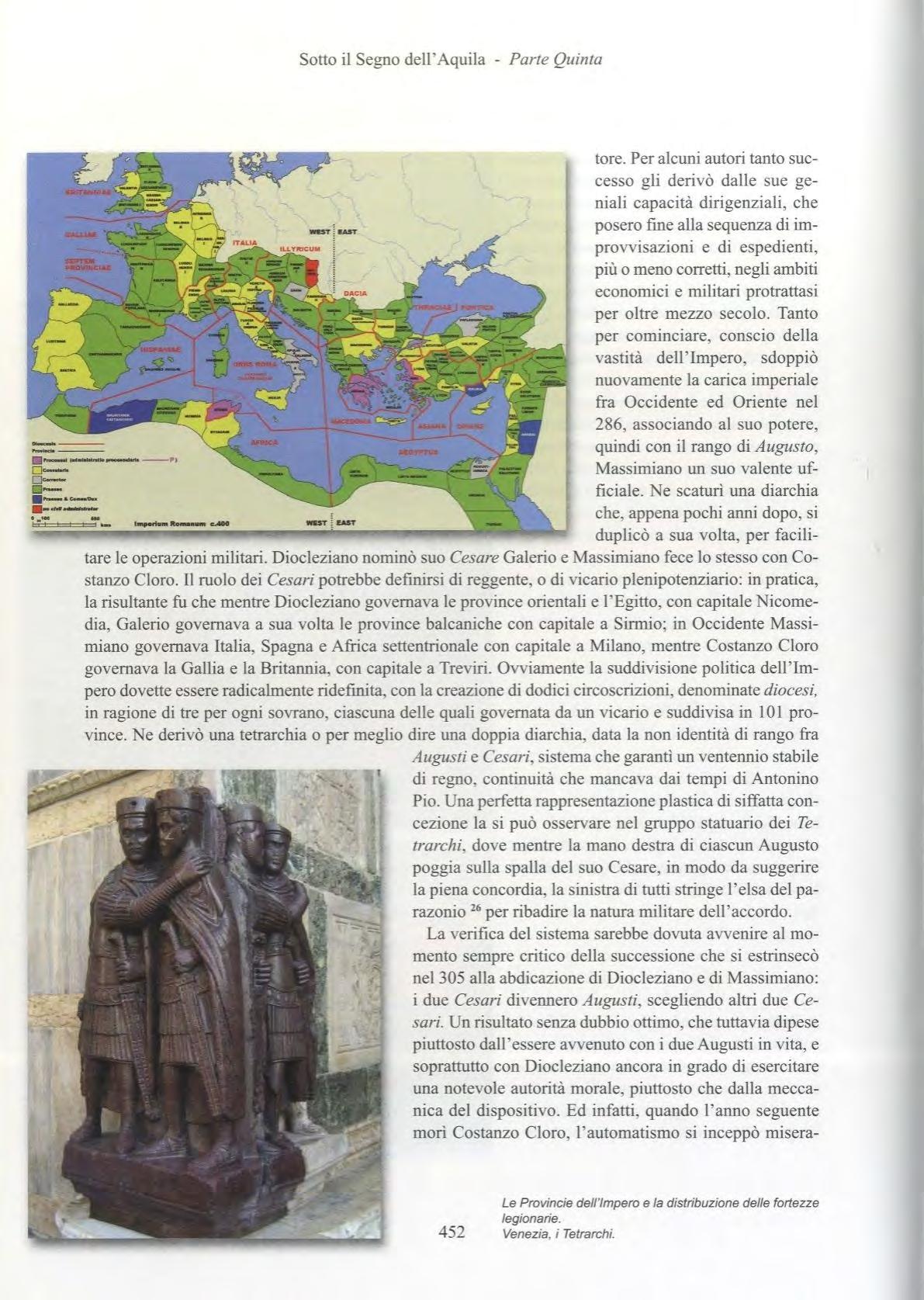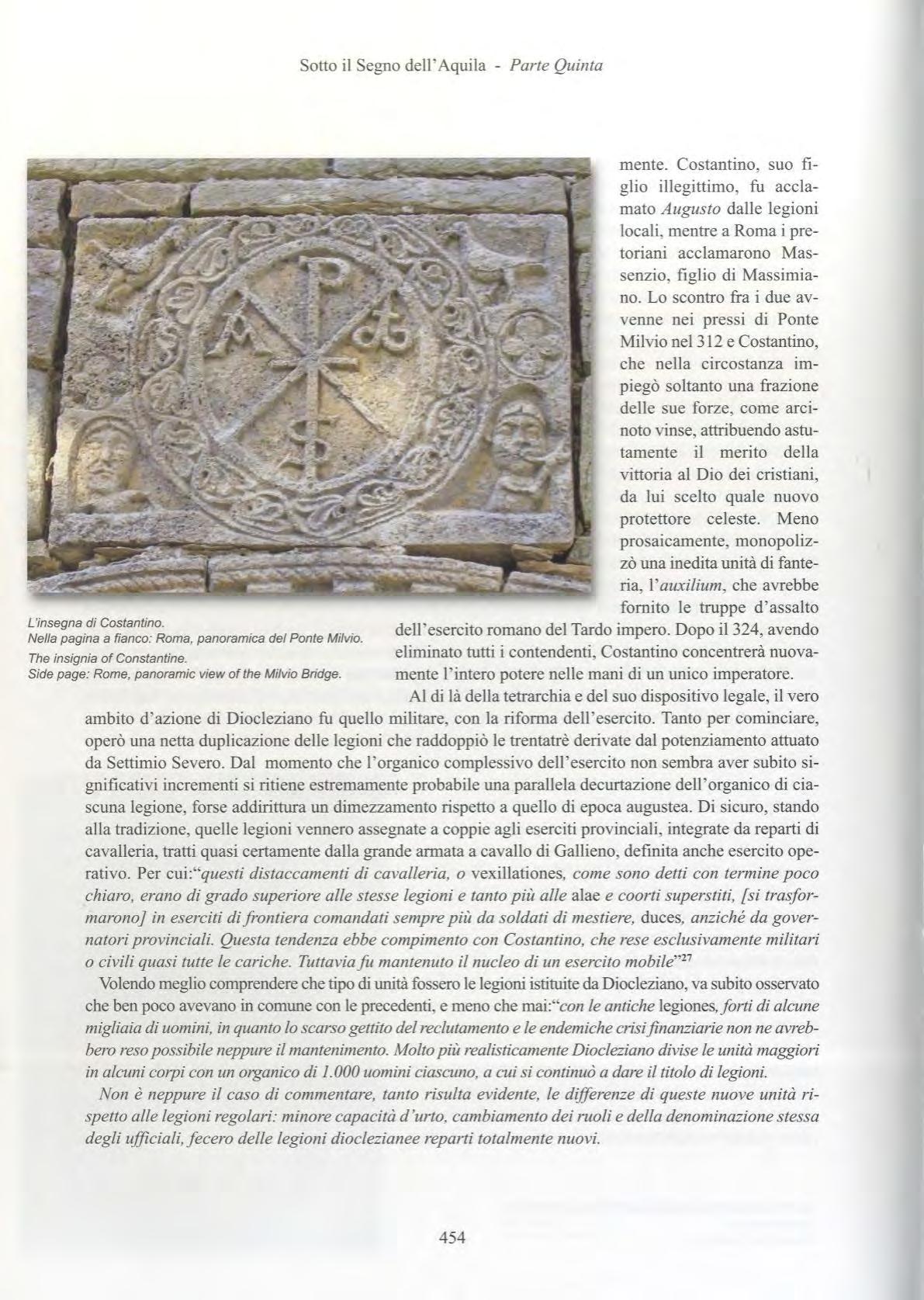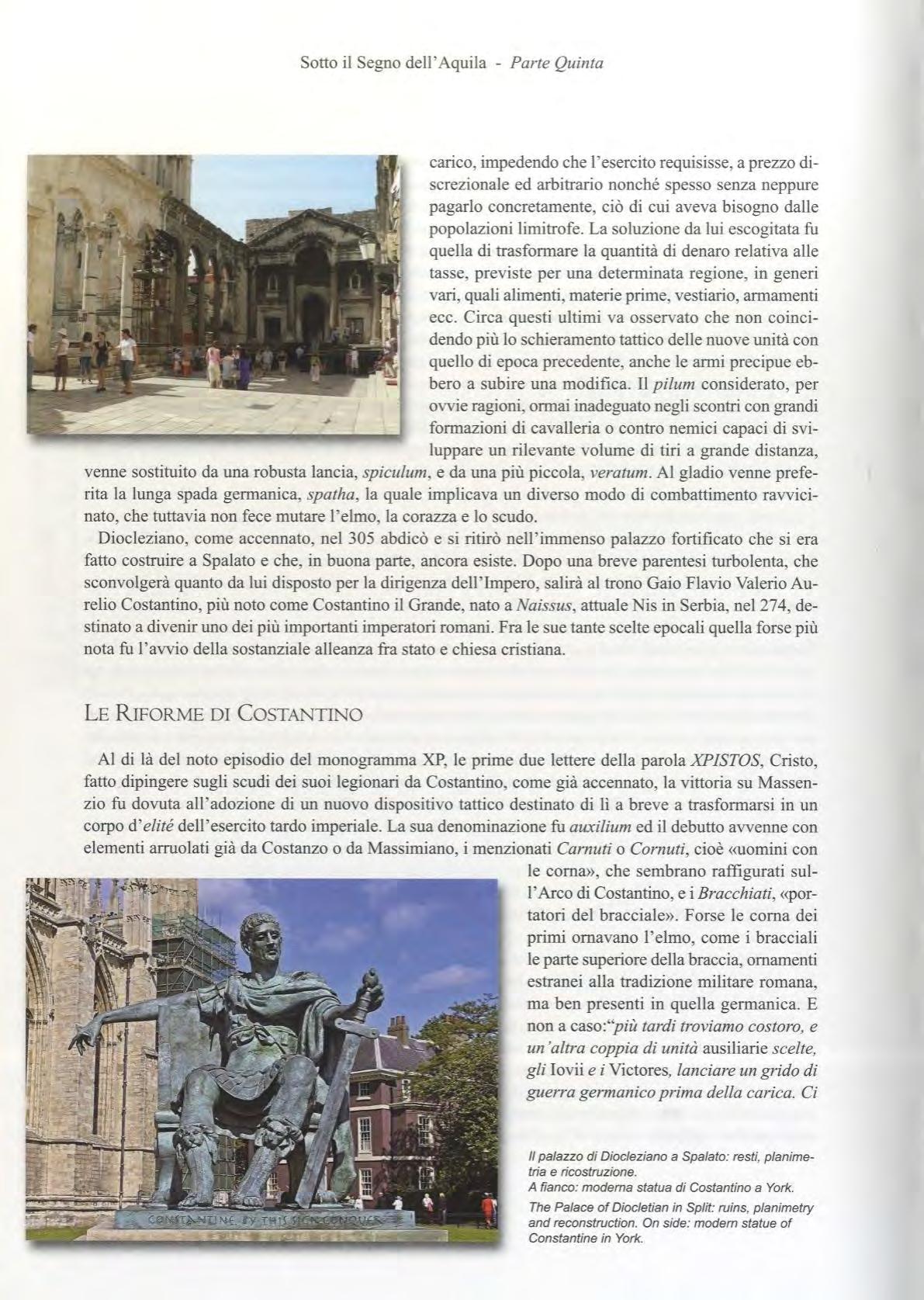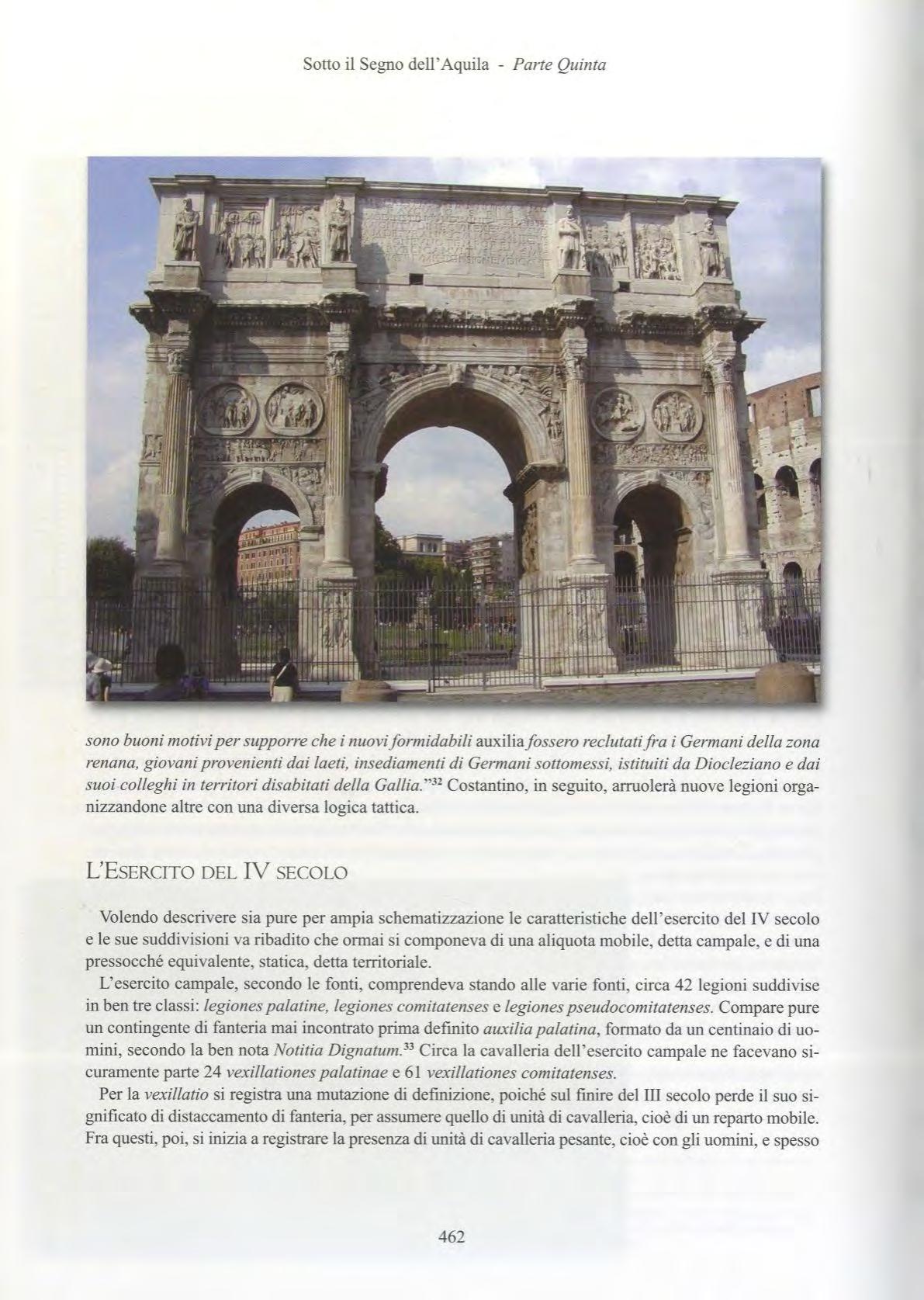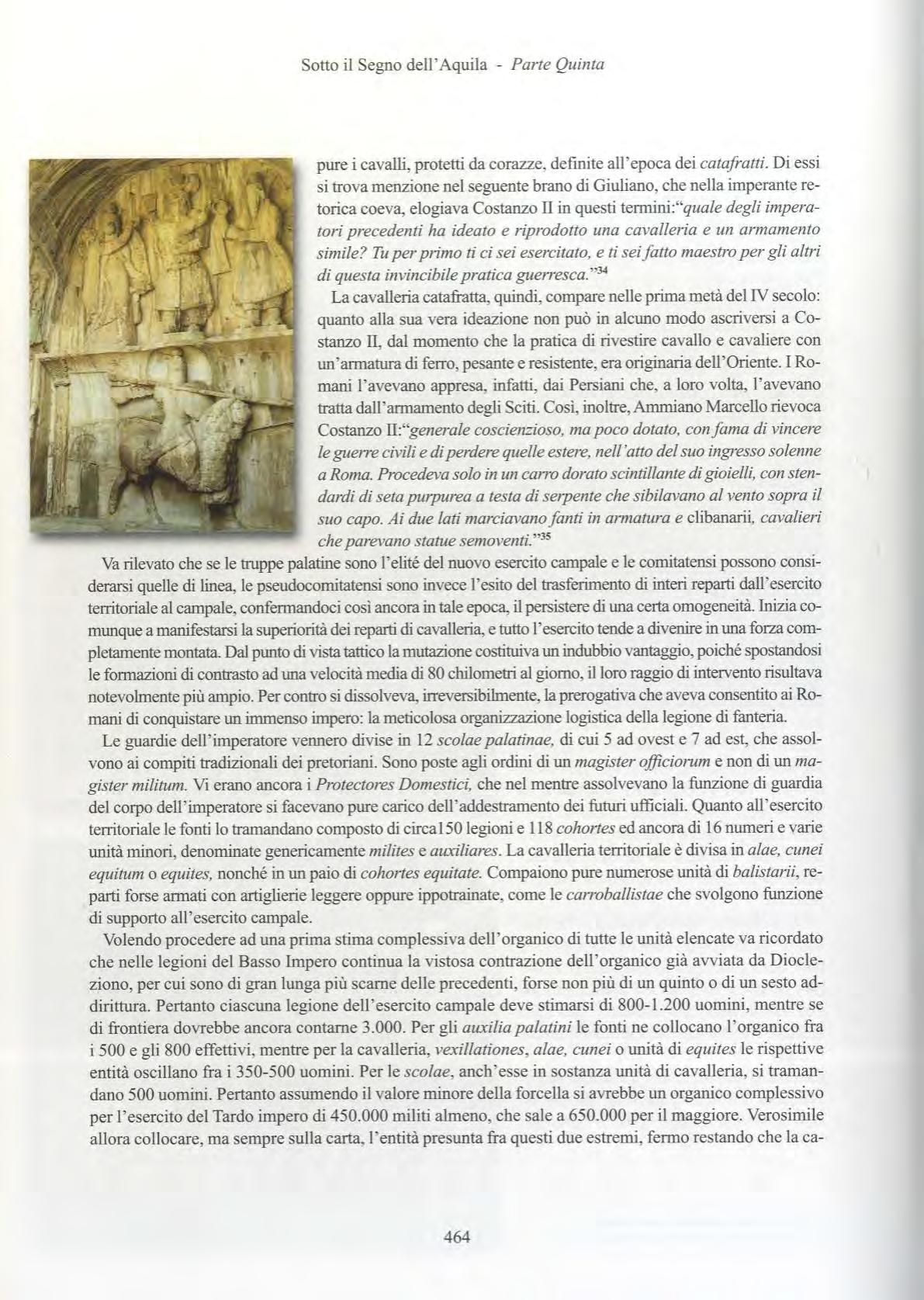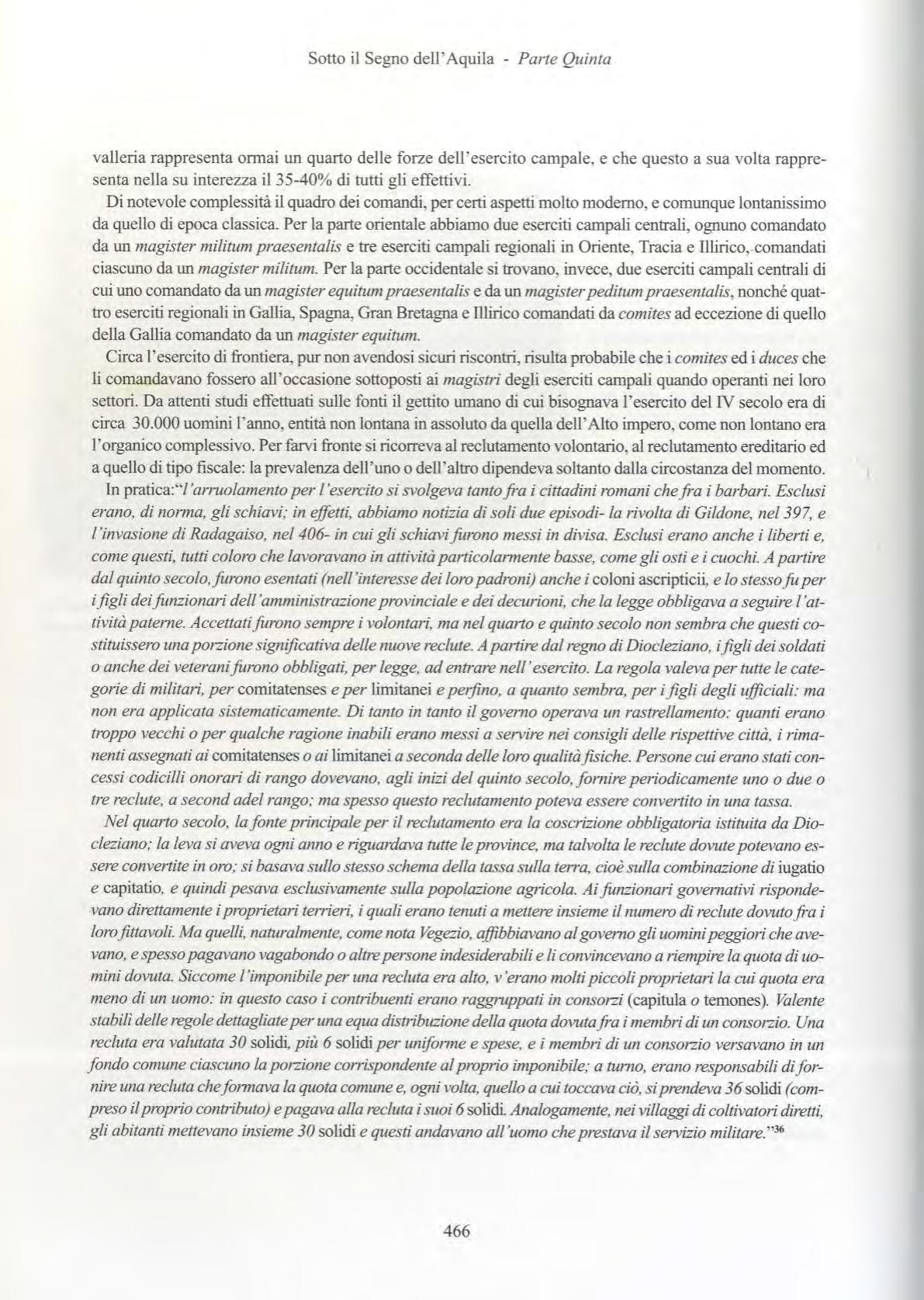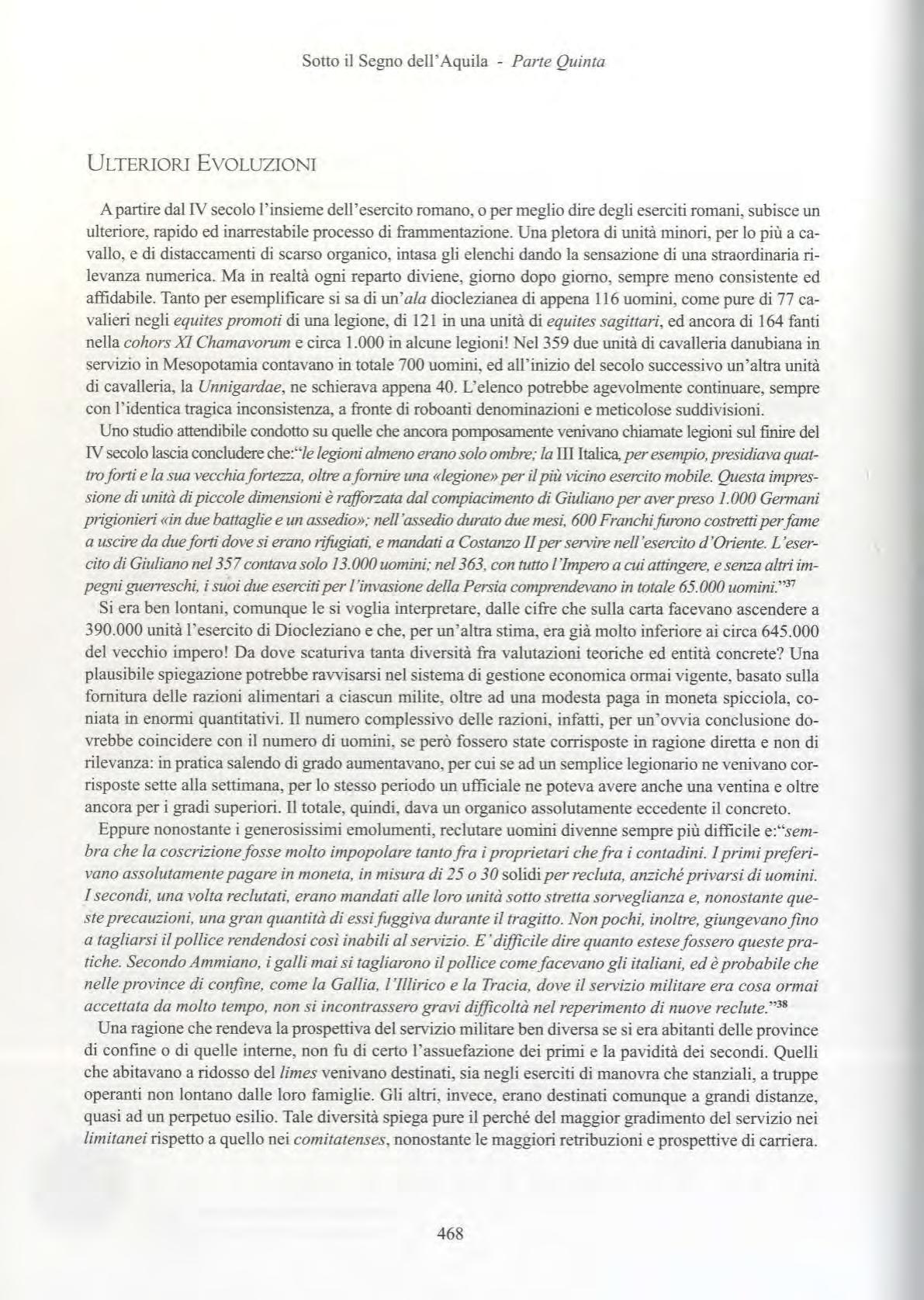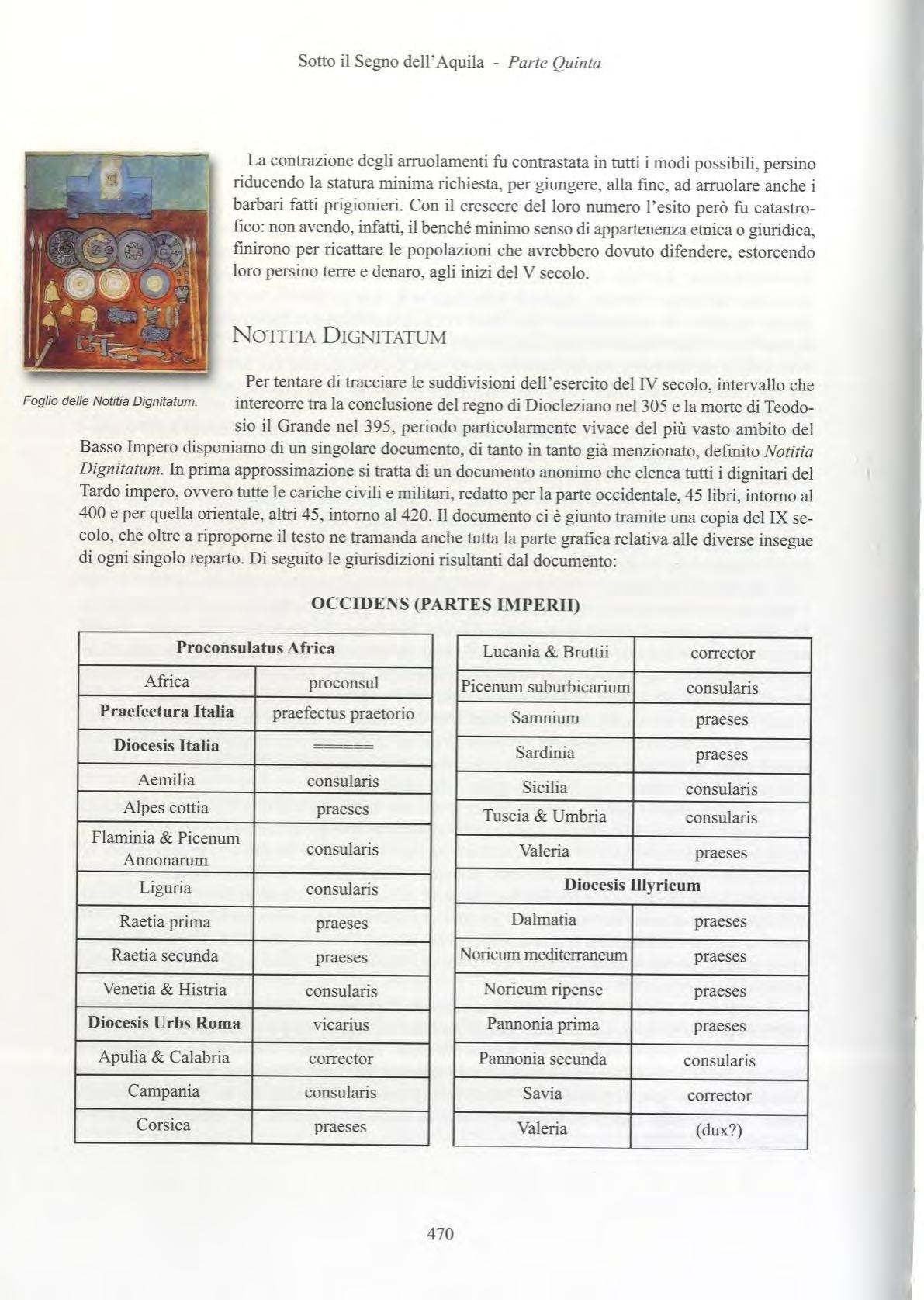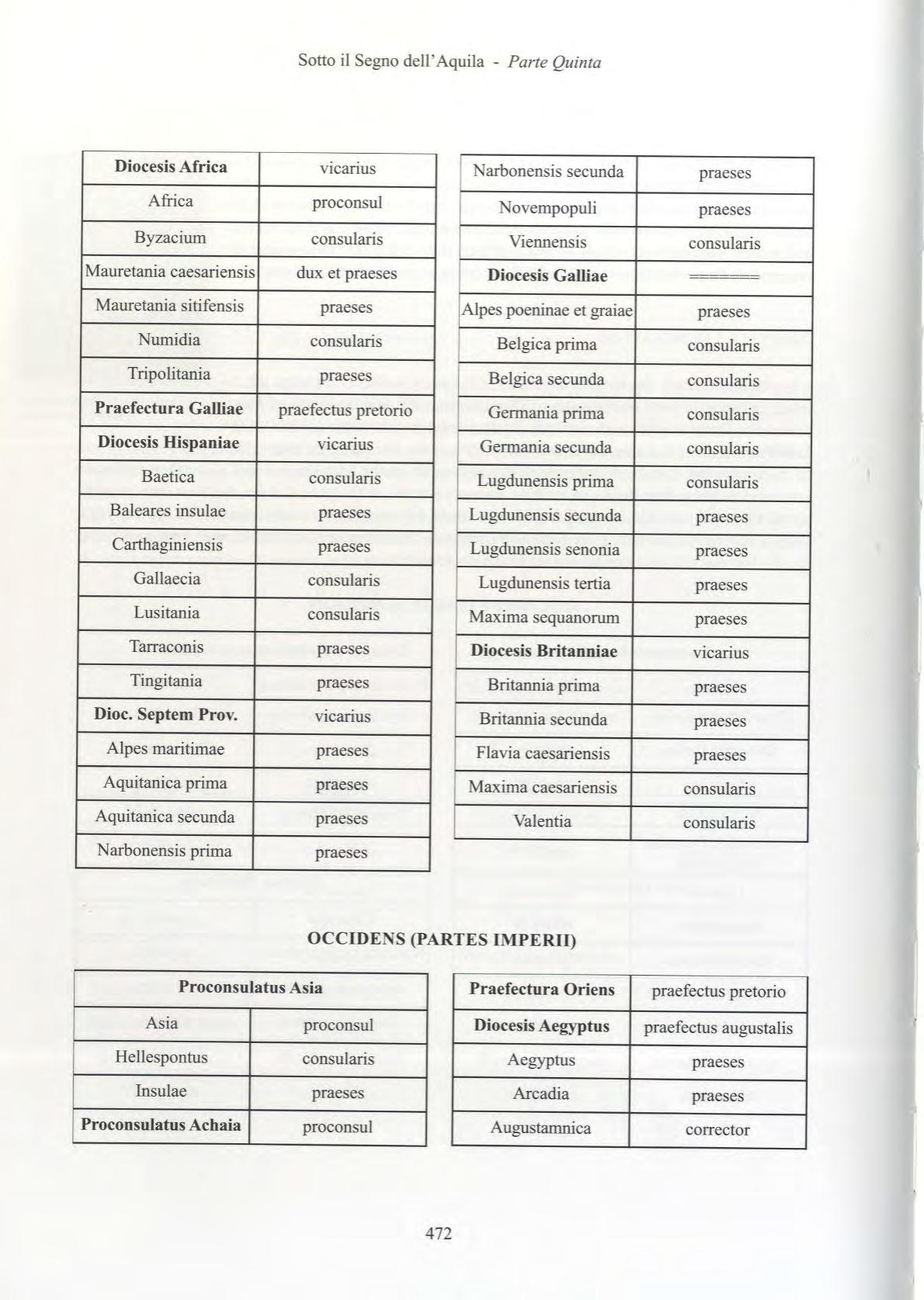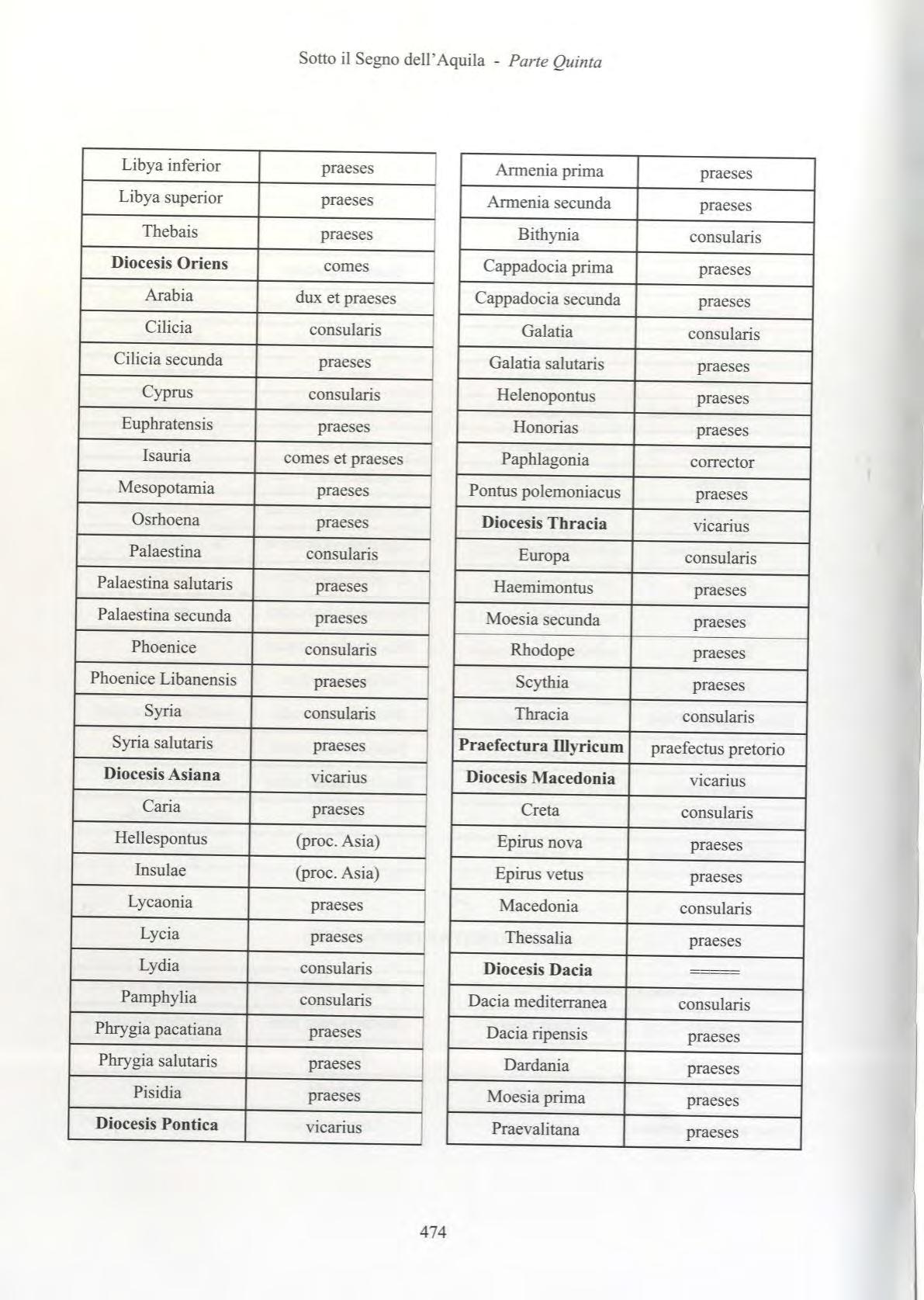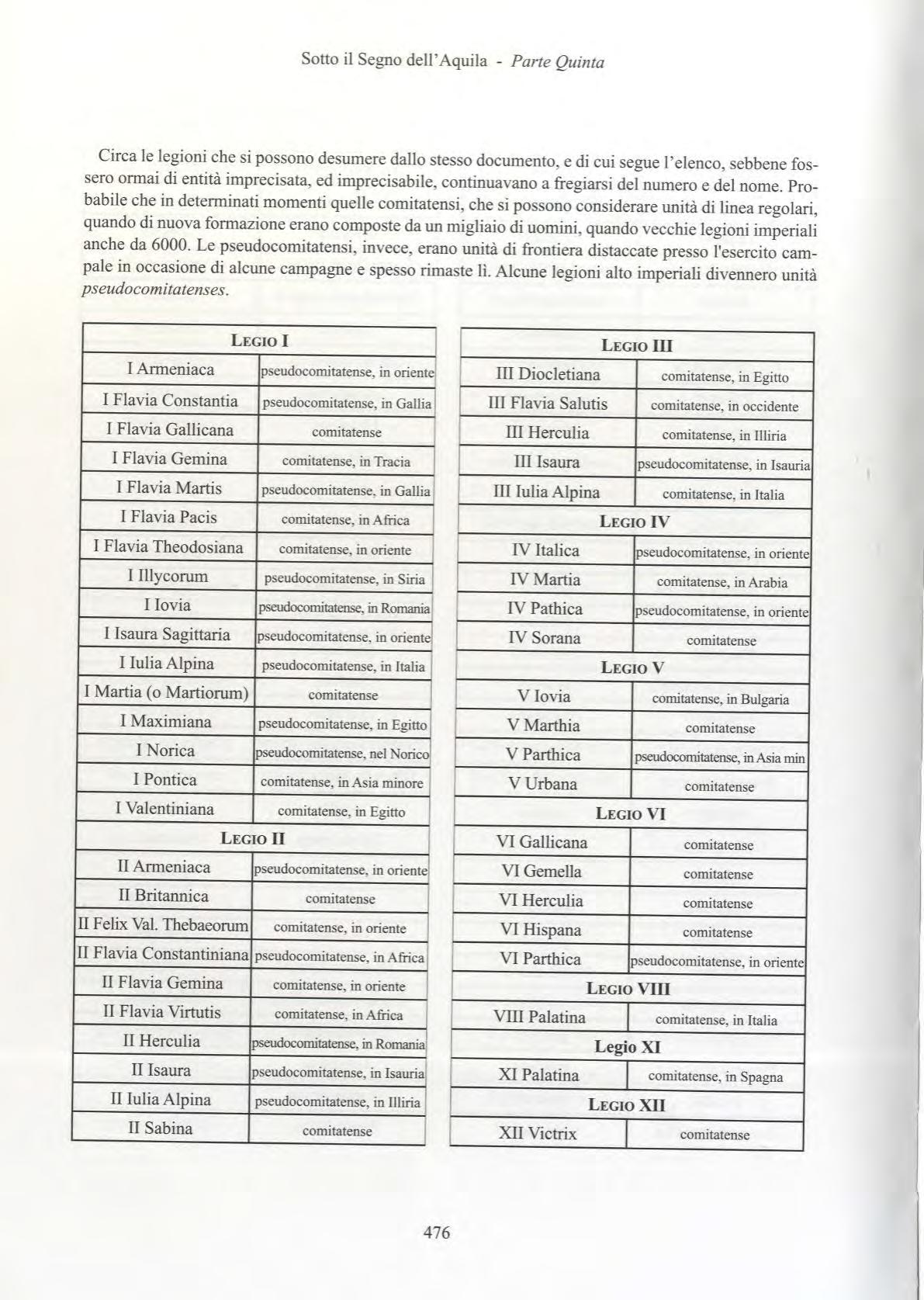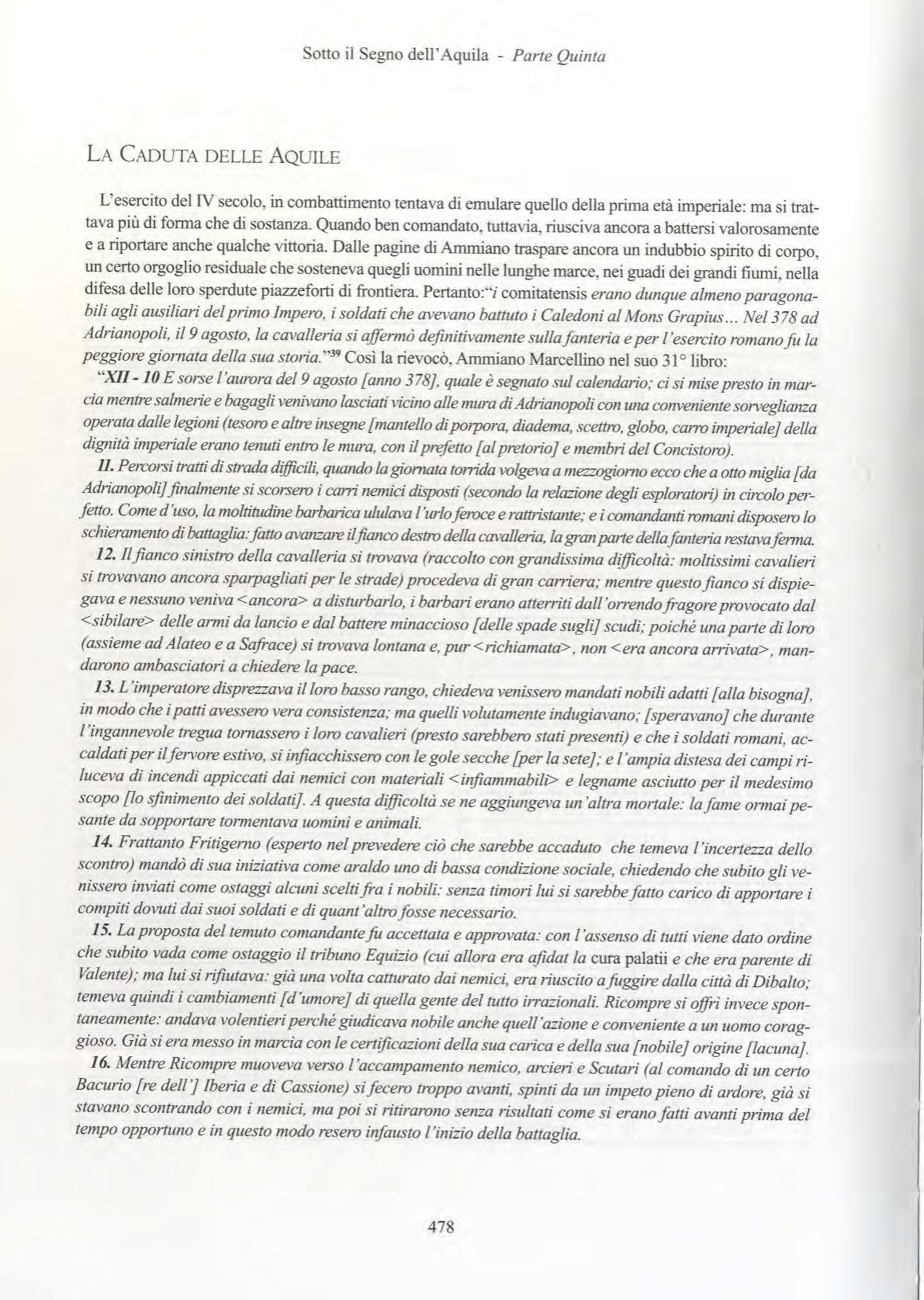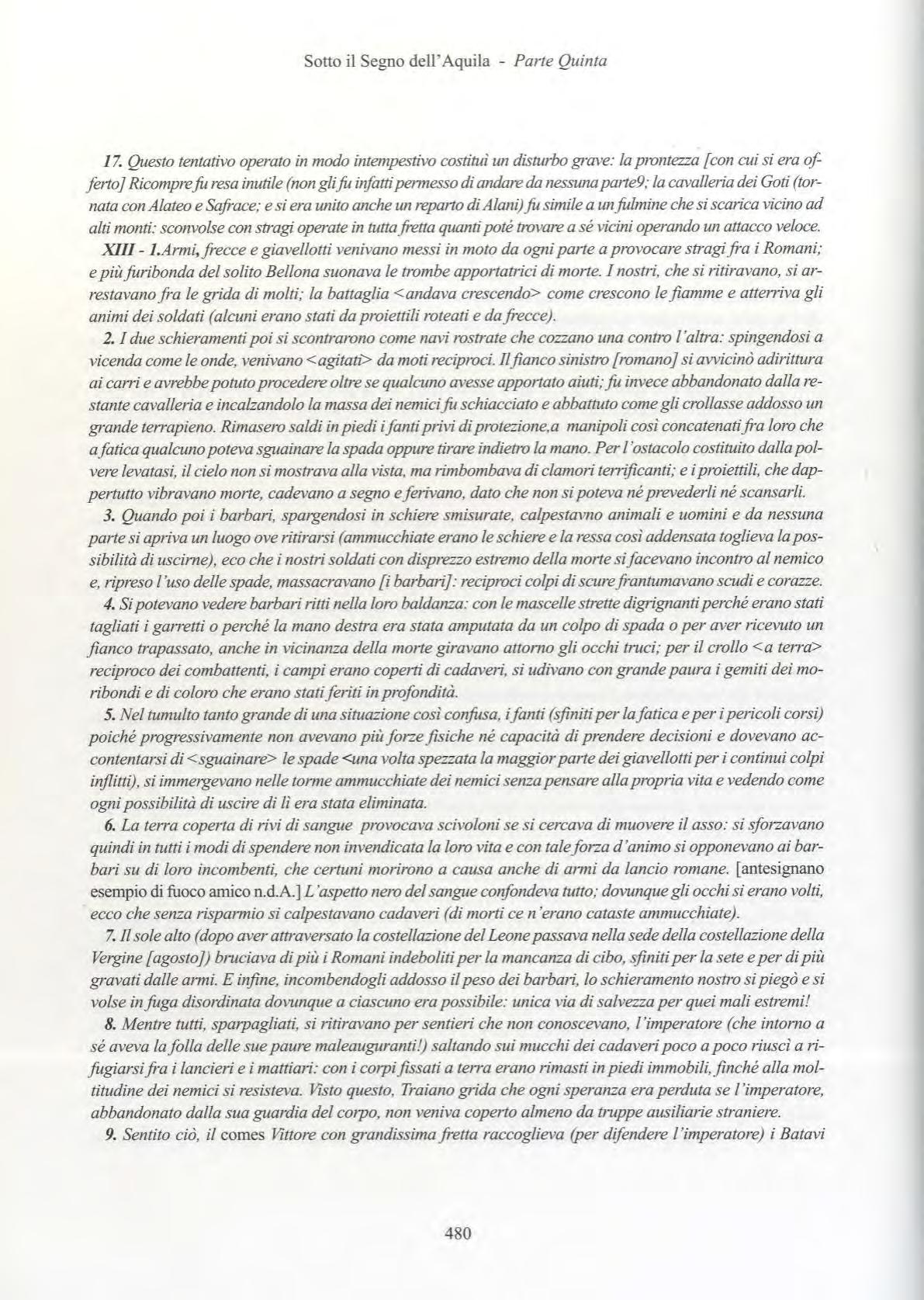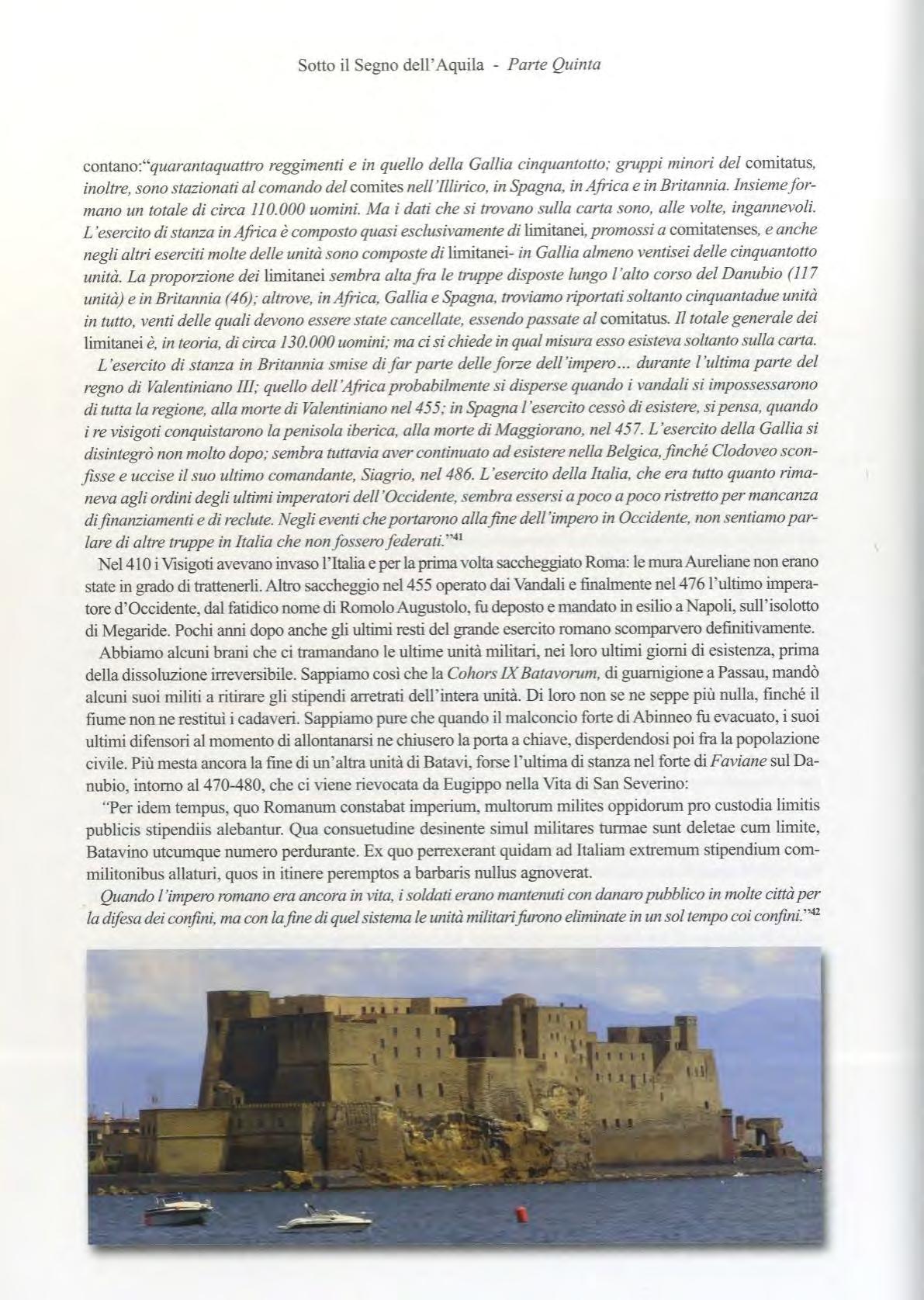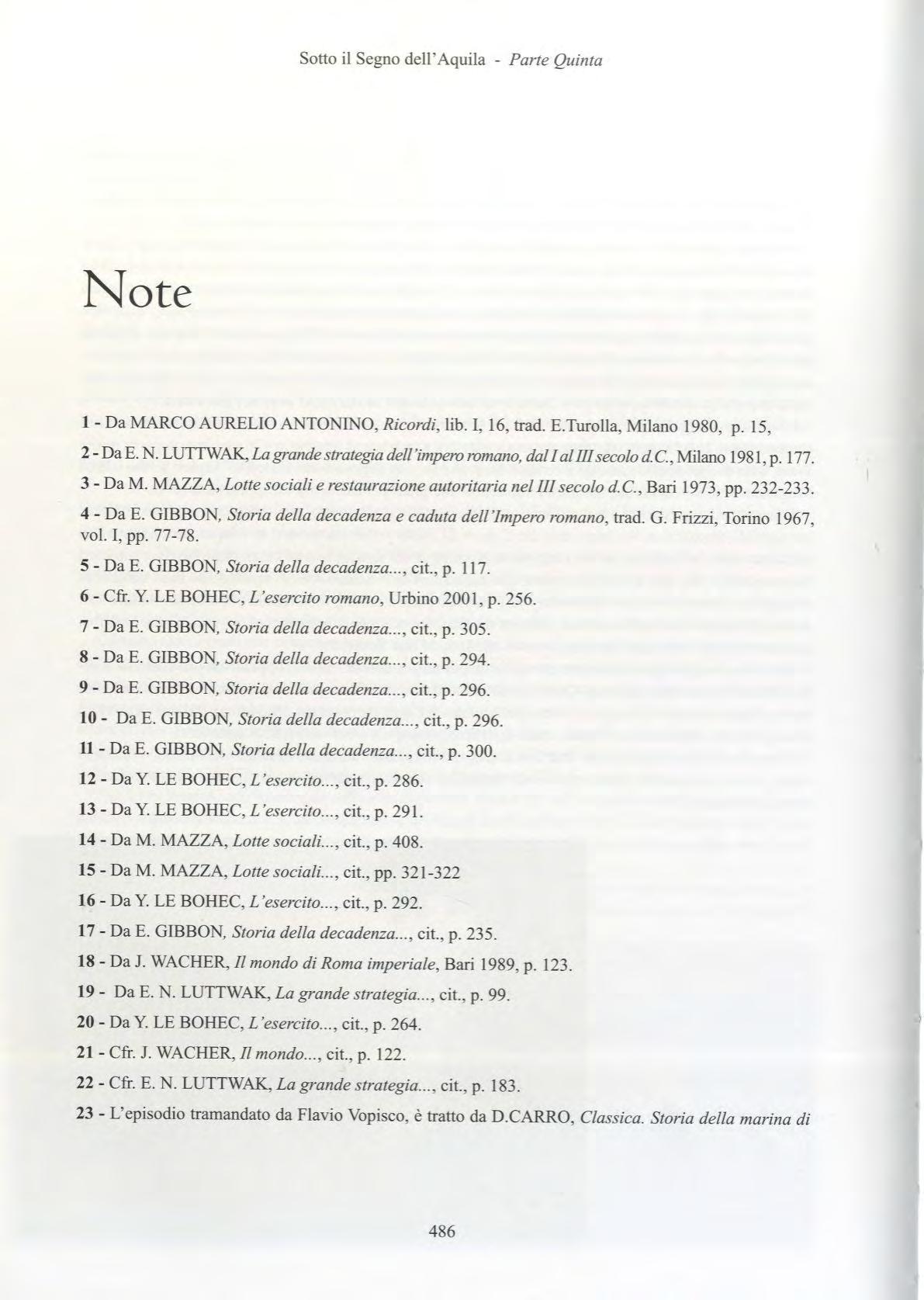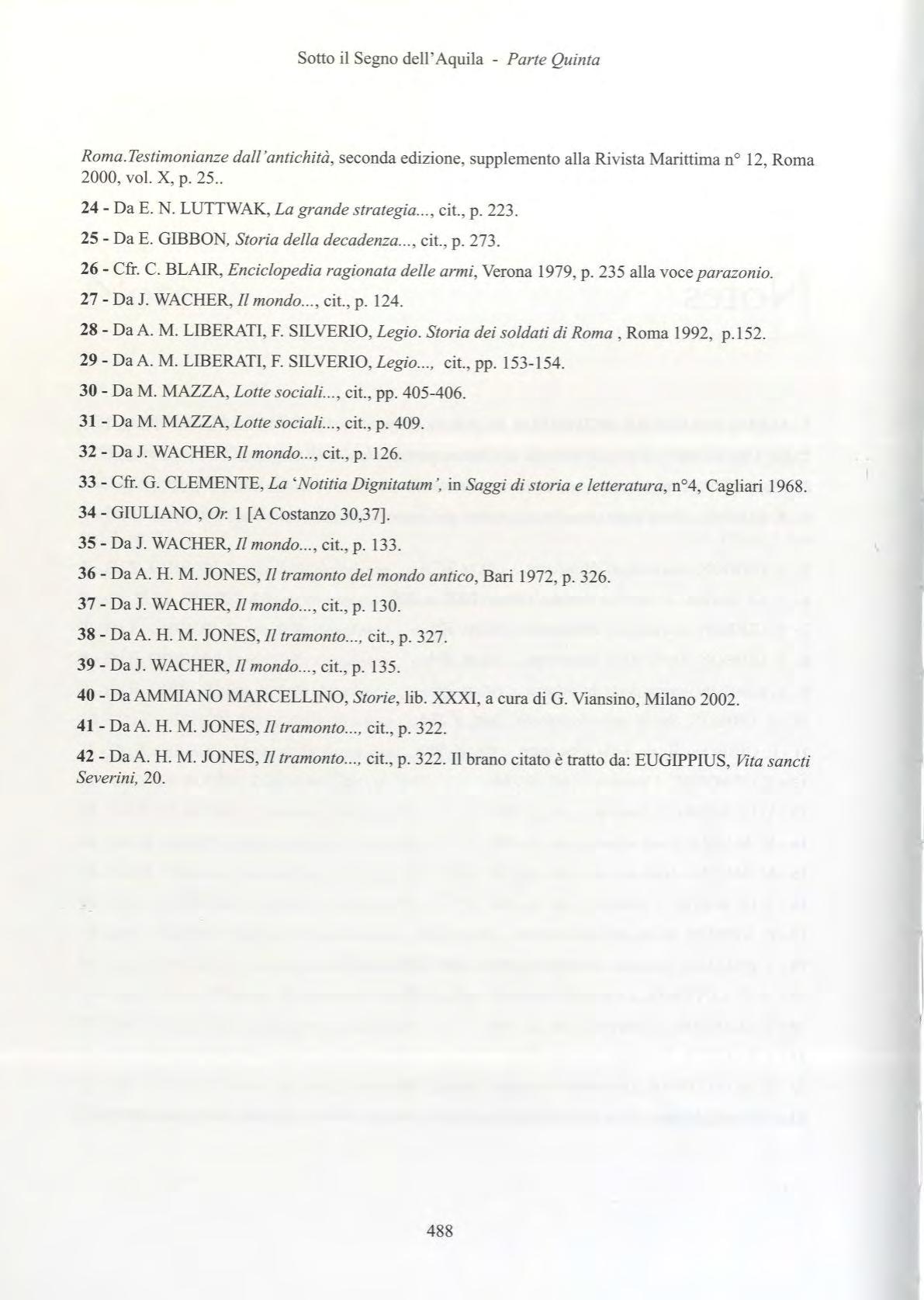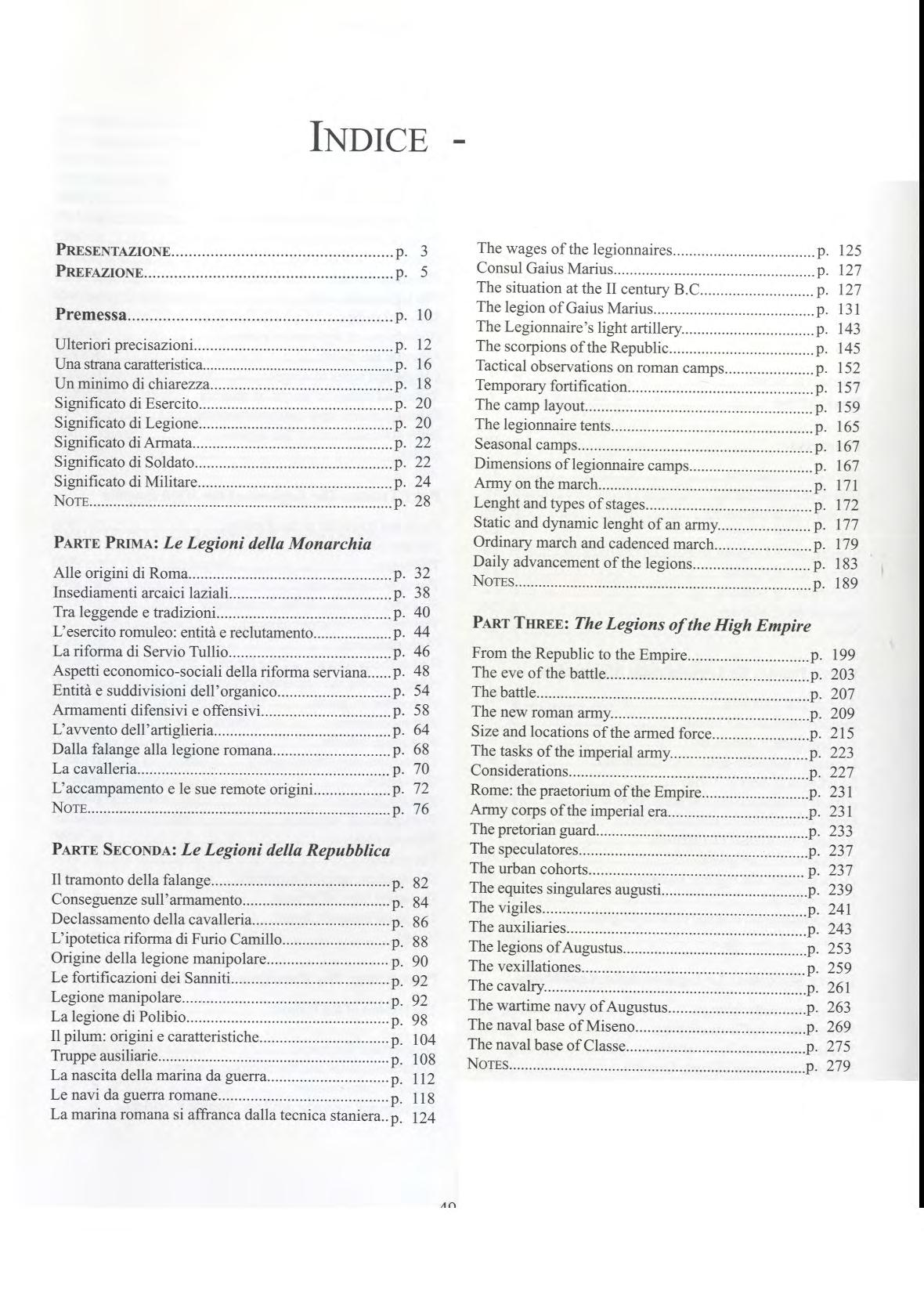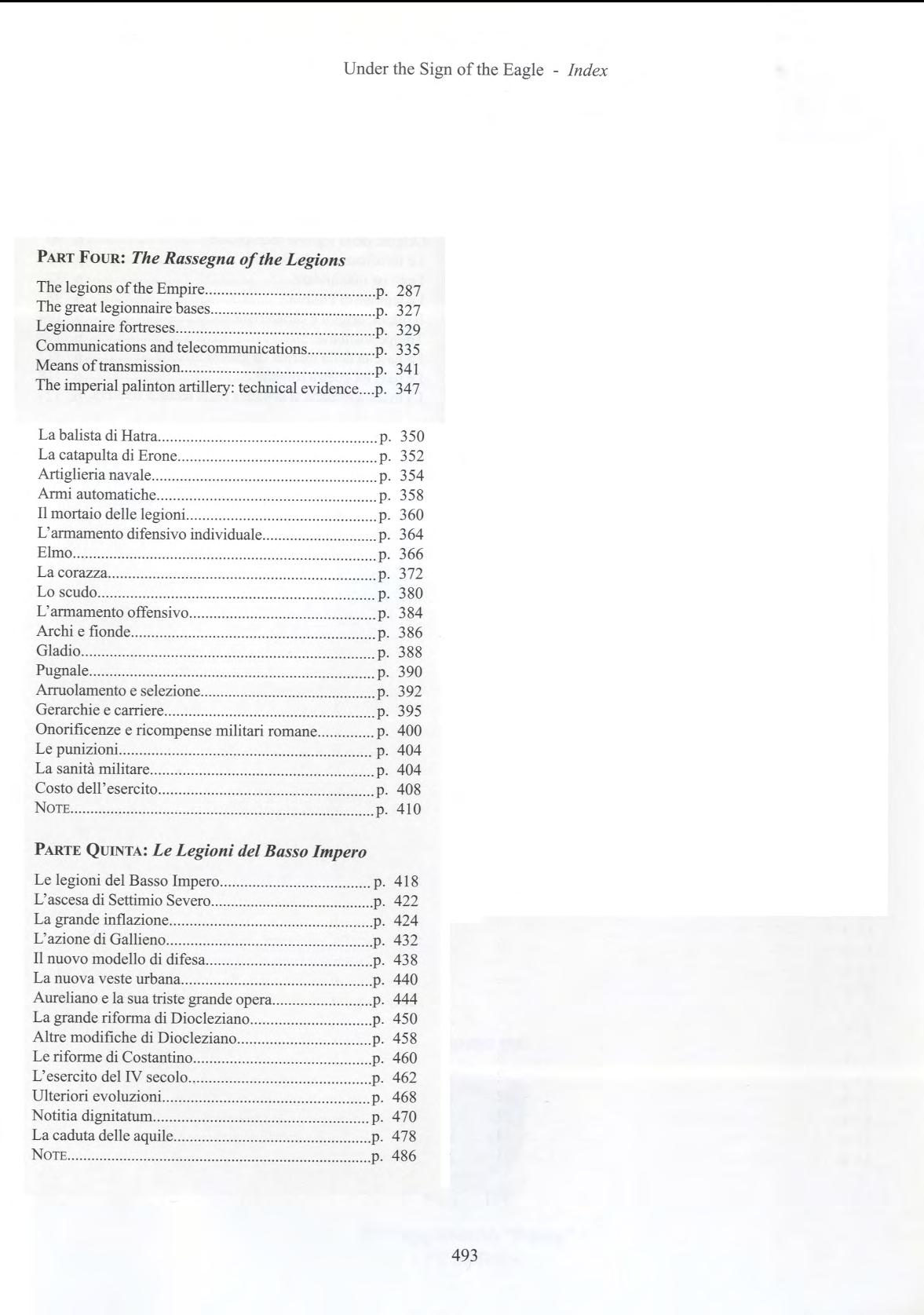Testi ericerche storiche:Flavio Russo Ricostruzionivirtuali, progettografico, impaginazione ecopertina:FerruccioRusso Tavole tecniche ortogonali:Gioia Seminario
Traduzione:Ju Di Martino
I diritti sonoriservati.Nessuna parte di questapubblicazione può essereriprodotta, archiviata ancheconmezzi informatici, otrasmessa in qualsiasi forma ocon qualsiasimezzo elettronico,meccanico, con fotocopia,registrazione oaltro, senzalapreventiva autorizzazionedei detentori dei diritti,
Allrights riserved. Napart ofthispublication may bereproduced, sturedin a retrievalsystem, ortransmittedin anyfarm orby anymeans, electronic, mechanical,photacopying. recordingorotherwise, without thepriorpermission ofthe copyrightowner
ISBN 978-88-87940-96-7
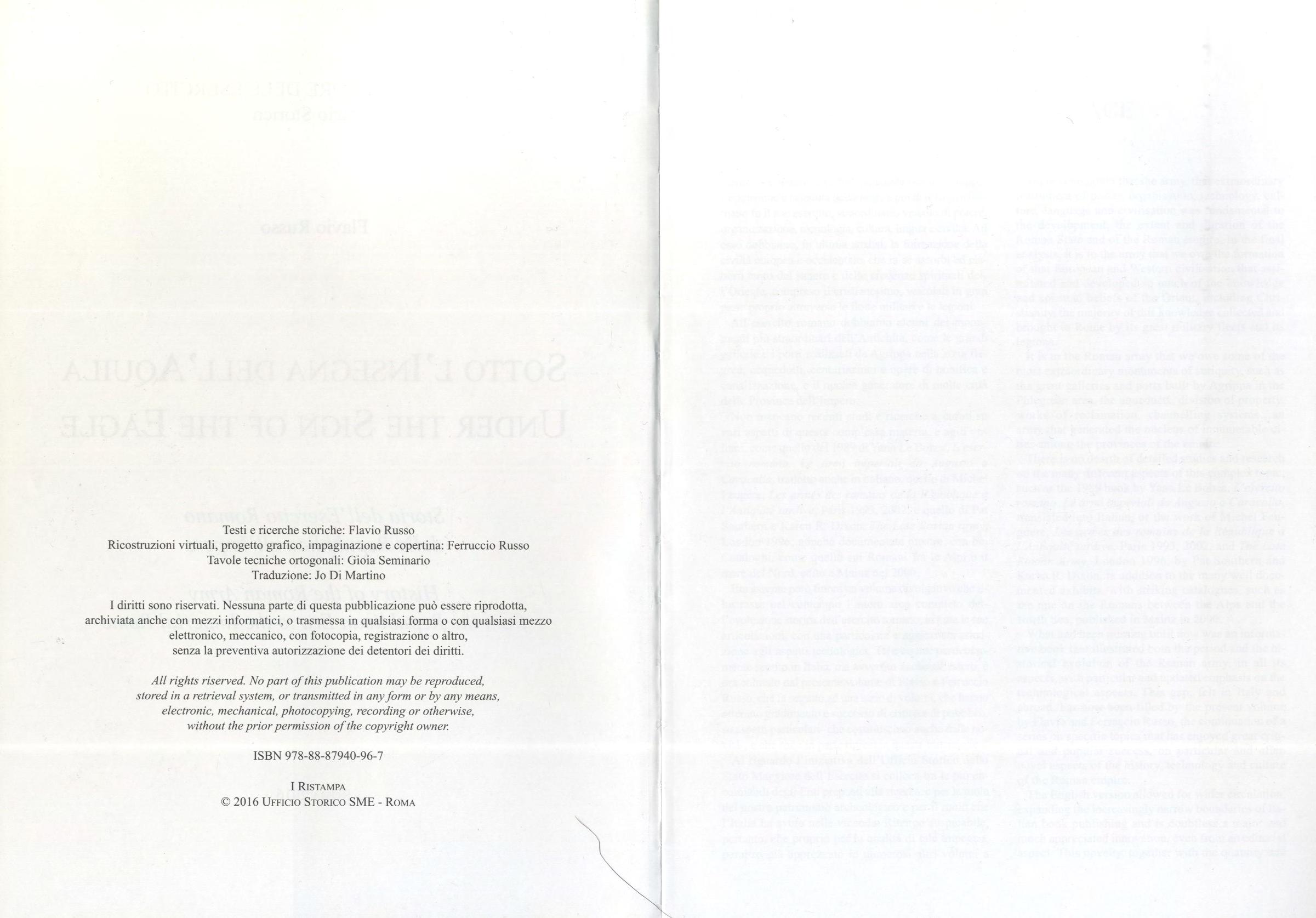
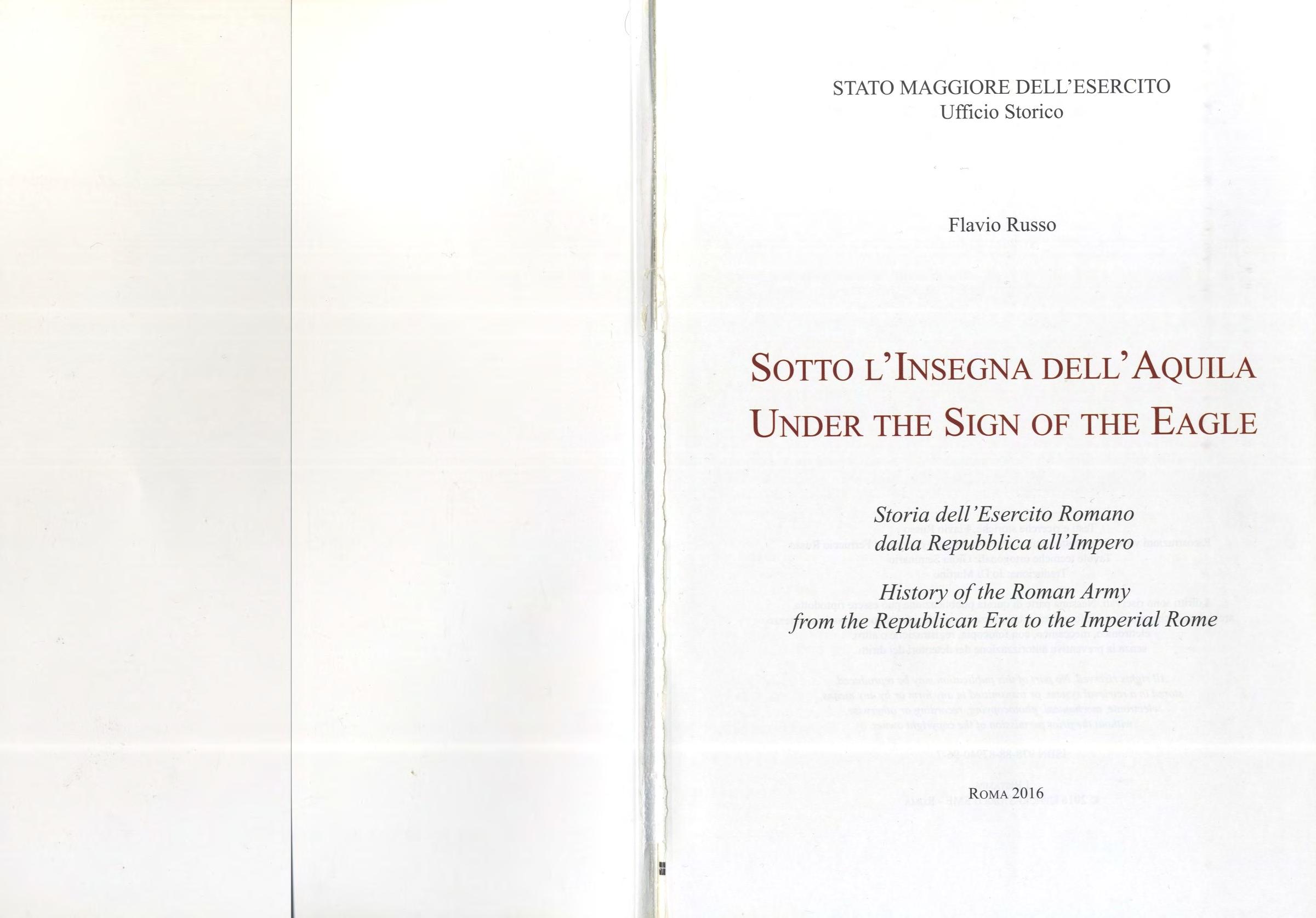
I RISTAMPA
@ 2016 UFFICIO STORICO SME - ROMA
STATOMAGGIORE DELL’ESERCITO Ufficio Storico
Flavio Russo
SOTTOL’INSEGNADELL’AQUILA
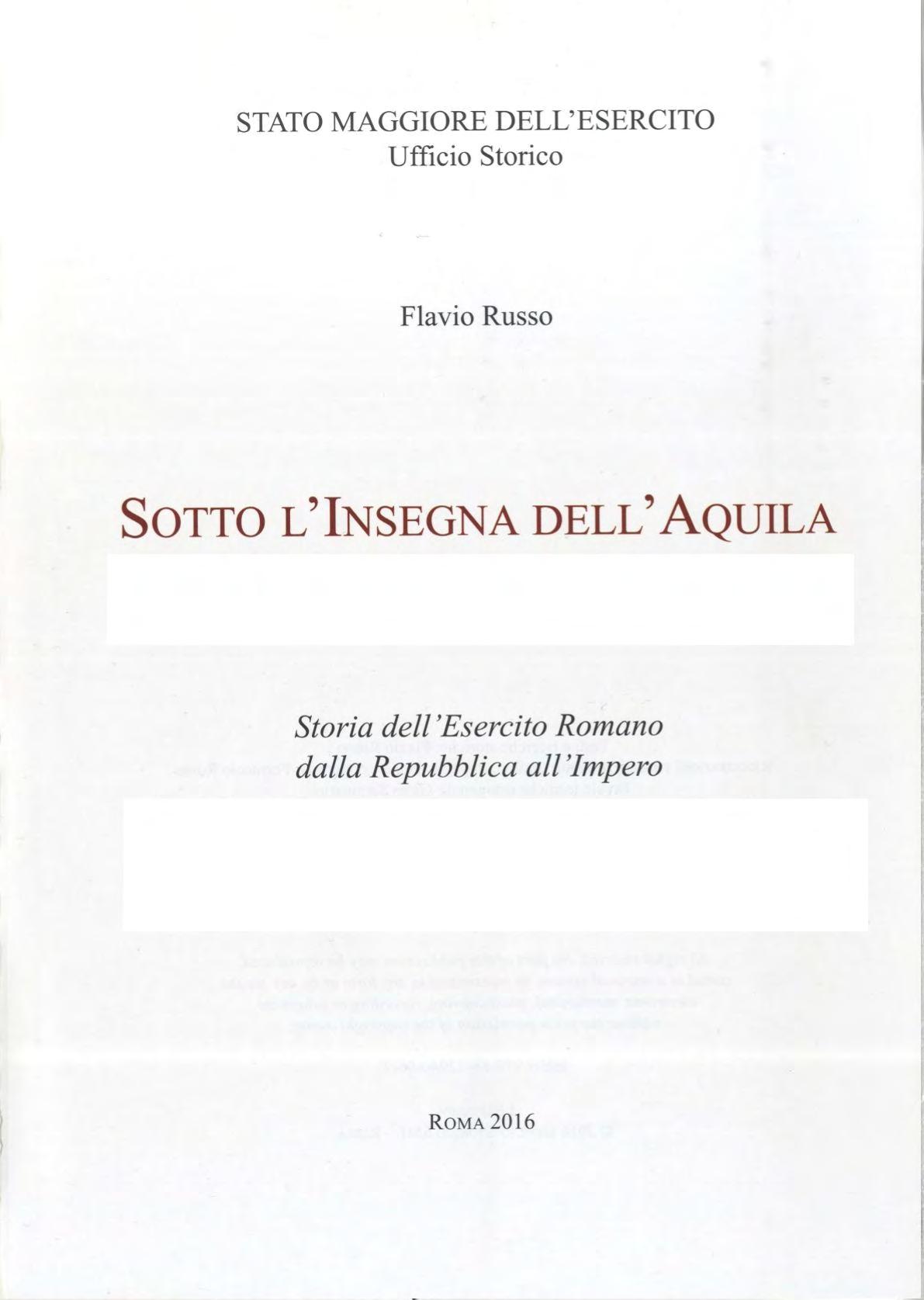
Storiadell’EsercitoRomano dalla Repubblica all’Impero
ROMA 2016
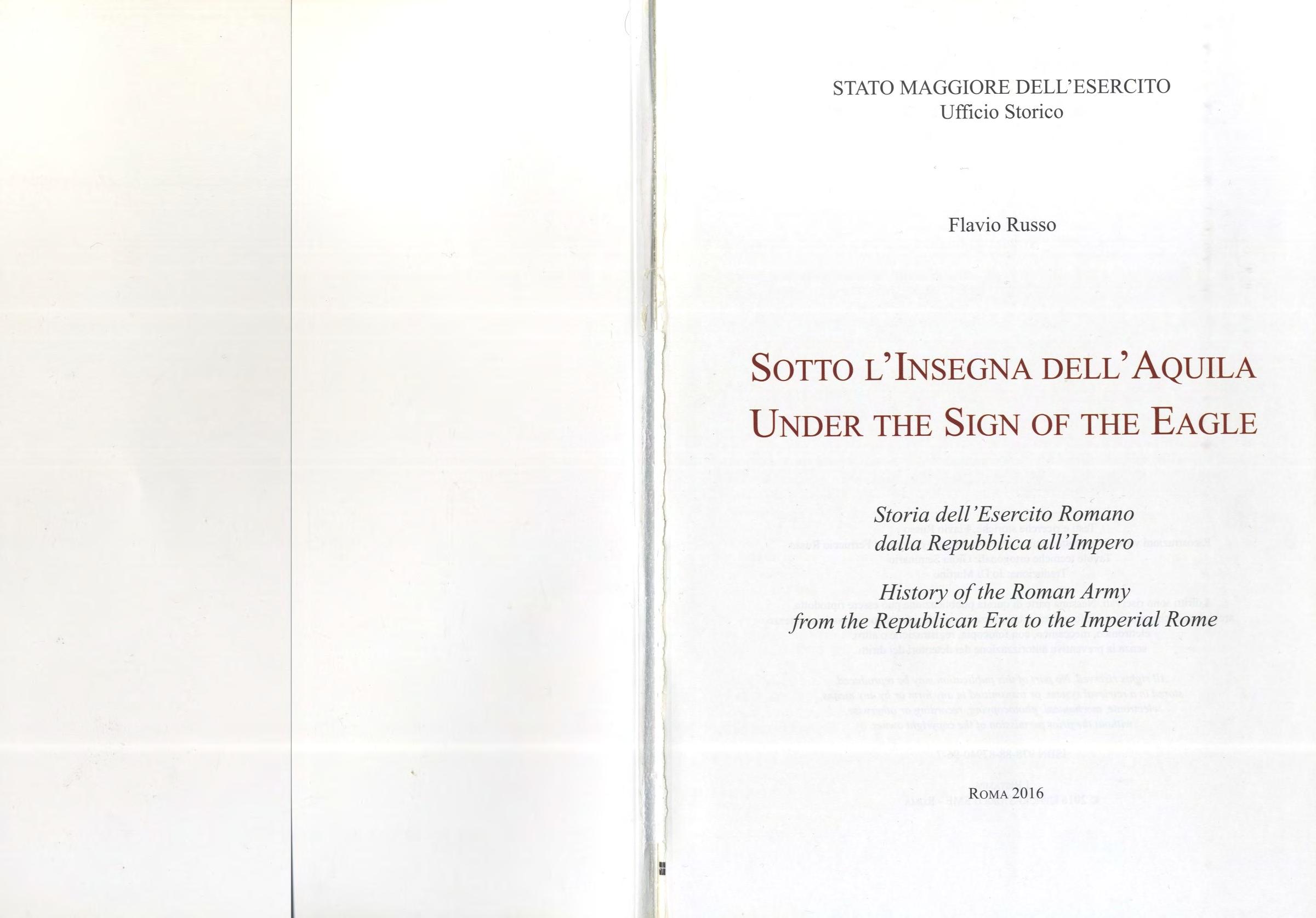
PREFAZIONE
PREFAZIONE
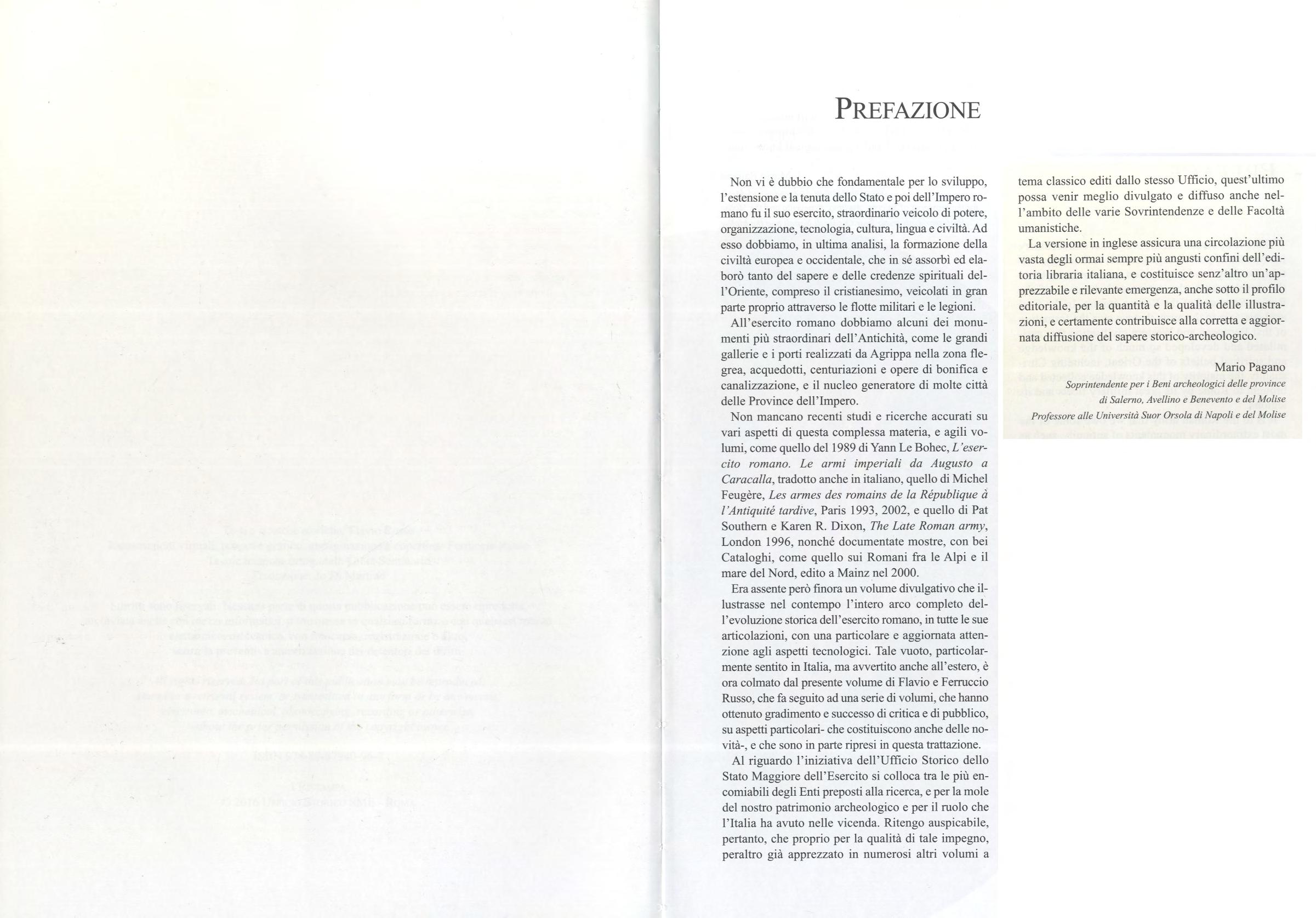
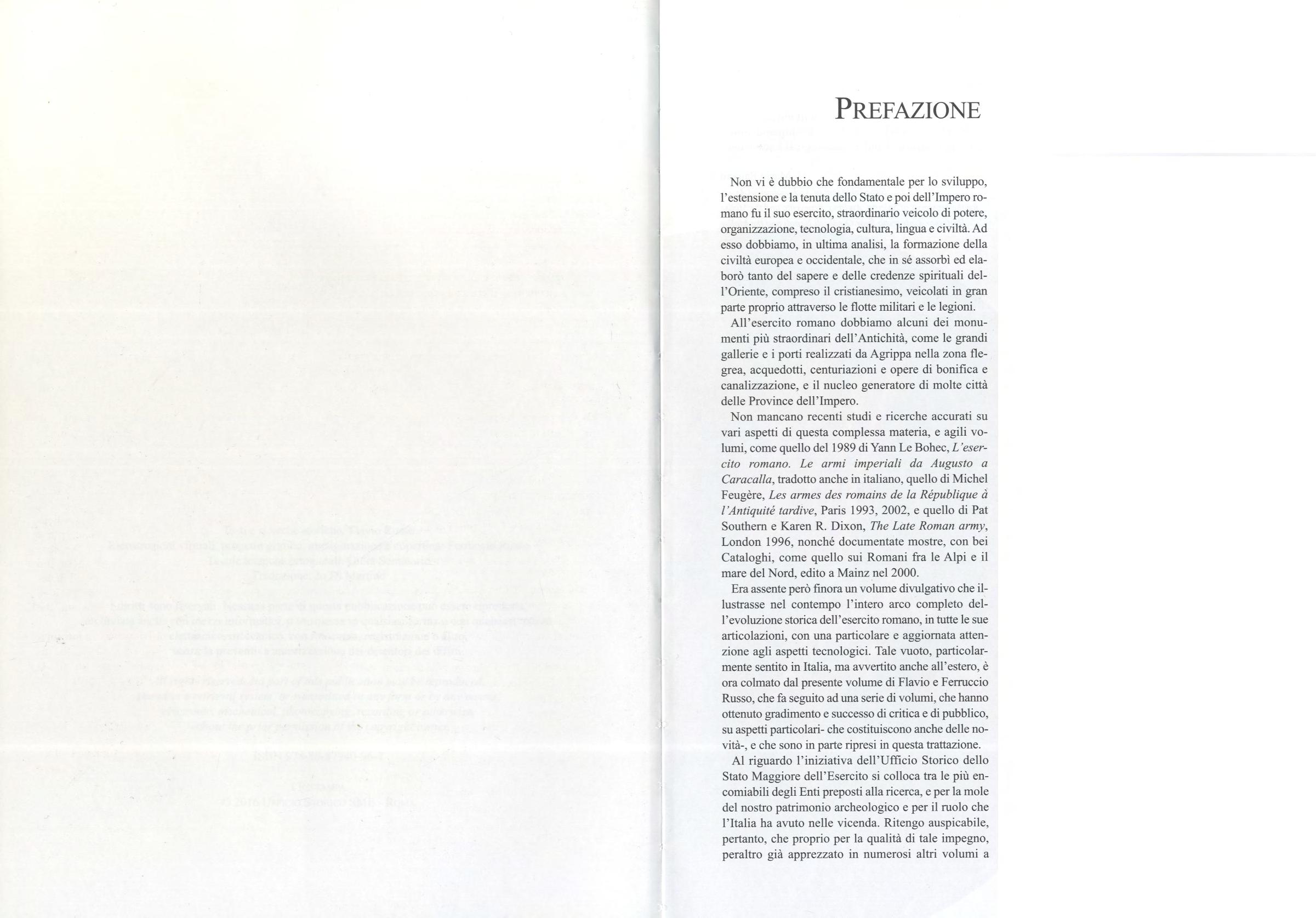
Non vi è dubbio che fondamentale per lo sviluppo, l’estensioneelatenutadelloStatoepoi dell’Imperoromano fuil suoesercito,straordinarioveicolodipotere, organizzazione,tecnologia,cultura,linguaeciviltà…Ad esso dobbiamo, in ultima analisi, la formazione della civiltà europea eoccidentale, che in séassorbì ed ela— borò tanto del sapere e delle credenze spirituali clell’0riente, compreso il cristianesimo, veicolati in gran parteproprioattraversole flottemilitariele legioni,
Non vi è dubbio che fondamentale per lo sviluppo, l’estensioneelatenutadelloStatoepoi dell’Imperoromano fuil suoesercito,straordinarioveicolodipotere, organizzazione,tecnologia,cultura,linguaeciviltà…Ad esso dobbiamo, in ultima analisi, la formazione della civiltà europea eoccidentale, che in séassorbì ed ela— borò tanto del sapere e delle credenze spirituali dell’Oriente, compreso il cristianesimo, veicolati in gran parteproprioattraversole flottemilitariele legioni,
tema classico editi dallo stessoUfficio, quest'ultimo possa venir meglio divulgato e diffi.lso anche nel— l’ambito delle varie Sovrintendenze e delle Facoltà umanistiche.
All’esercito romano dobbiamo alcuni dei monumenti più straordinari dell’Antichità, come le g1andi gallerie e i porti realizzati daAgrippa nella zona flegrea, acquedotti, centuriazioni e opere dibonifica e canalizzazione, e il nucleo generatore di molte città delleProvince dell’Impero,
All’esercito romano dobbiamo alcuni dei monumenti più straordinari dell’Antichità, come le giandi gallerie e i porti realizzati daAgrippa nella zona flegrea, acquedotti, centuriazioni e opere dibonifica e canalizzazione, e il nucleo generatore di molte città delleProvince dell’Impero,
Laversione iningleseassicurauna circolazionepiù vastadegliormai semprepiù angusticonfinidell’editoria libraria italiana, e costituisce senz’altro un’apprezzahileerilevanteemergenza,anchesottoilprofilo editoriale, per la quantità e la qualità delle illustrazioni,ecertamentecontribuisceallacorrettaeaggiornata diffusione del saperestorico-archeologico.
MarioPagano
Non mancano recenti studi e ricerche accurati su vari aspetti di questa complessa materia, e agili vo— lumi,comequellodel 1989diYann LeBohec,L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto a Caracalla,tradottoancheinitaliano,quellodiMichel Feugère, Les armes des remains de la République a’ l'Antiquite' tardive, Paris 1993,2002, e quello di Pat Southern e Karen R. Dixon, The Late Roman army, London 1996,nonché documentate mostre, con hei Cataloghi, come quello sui Romani fra le Alpi e il maredelNord, editoaMainz nel 2000.
Non mancano recenti studi e ricerche accurati su vari aspetti di questa complessa materia, e agili vo— lumi,comequellodel 1989diYann LeBohec,L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto a Caracalla,tradottoancheinitaliano,quellodiMichel Feugère, Les armes des remains de la République a’ l'Antiquite' tardive, Paris 1993,2002, e quello di Pat Southern e Karen R. Dixon, The Late Roman army, London 1996,nonché documentate mostre, con bei Cataloghi, come quello sui Romani fra le Alpi e il maredelNord, editoaMainz nel 2000.
SoprintendenteperiBeniarcheologicidelleprovince di Salerno,Avellino 2Benevento edelMolise Professorealle Università SuorOrsoladiNapoli edelMolise
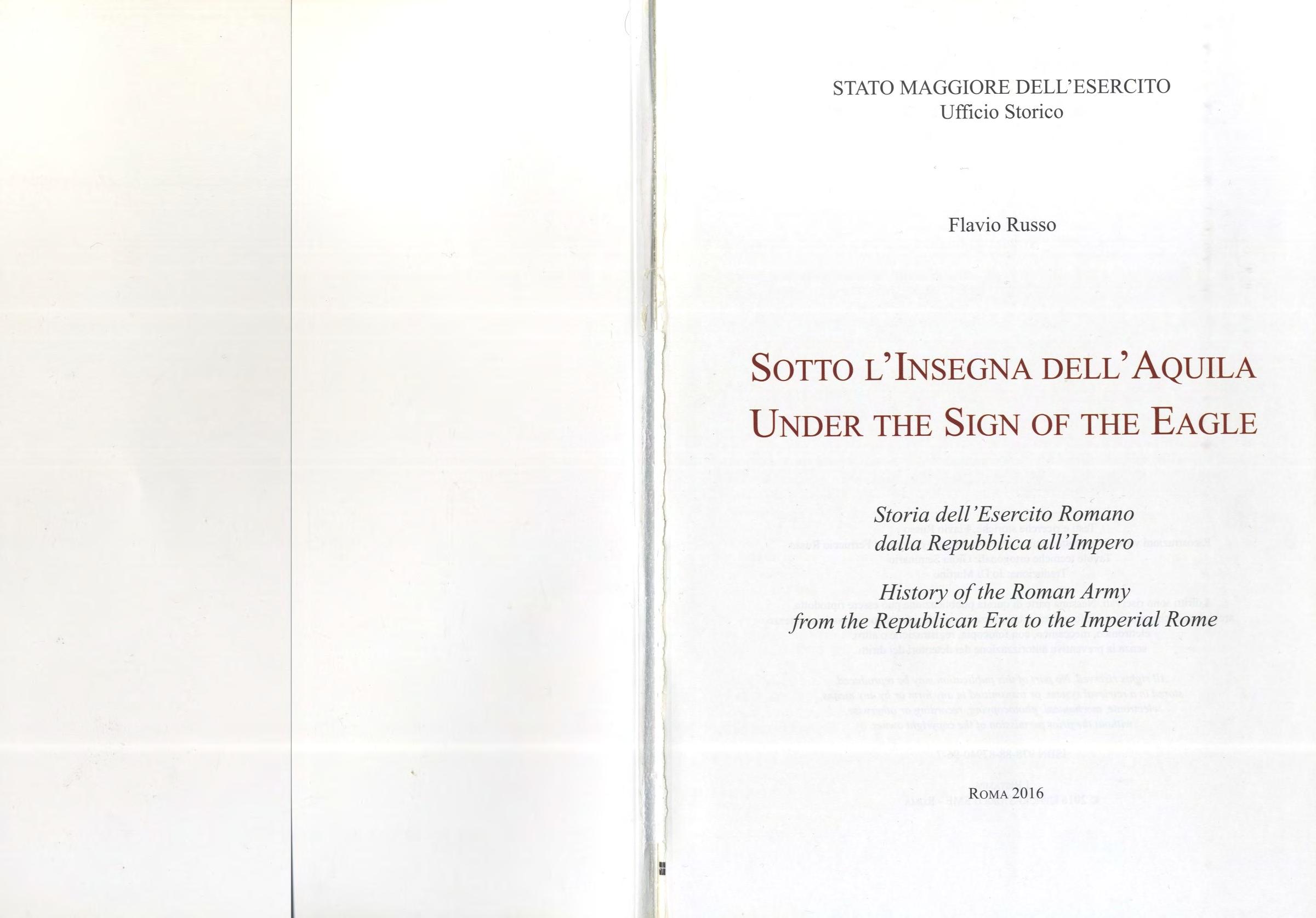
Etaassenteperòfinoraunvolumedivulgativocheillustrasse nel contempo l‘intero arco completo dell’evoluzionestoricadell’esercitoromano,intuttelesue articolazioni, con una particolare e aggiornata attenzione agli aspetti tecnologici. Tale vuoto, particolarmentesentitoinItalia,ma avvertitoanche all’estero,è oracolmatodal presentevolumediFlavioeFerruccio Russo,chefaseguitoaduna seriedivolumi,chehanno ottenutogradimentoesuccessodicriticaedipubblico, suaspettiparticolari-checostituisconoanchedellenovita-, eche sonoin parte ripresi inquestatrattazione.
Etaassenteperòfinoraunvolumedivulgativocheillustrasse nel contempo l‘intero arco completo dell’evoluzionestoricadell’esercitoromano,intuttelesue articolazioni, con una particolare e aggiornata attenzione agli aspetti tecnologici. Tale vuoto, particolarmenteseutitoinItalia,ma avvertitoanche all’estero,è oracolmatodal presentevolumediFlavioeFerruccio Russo,chefaseguitoaduna seriedivolumi,chehanno ottenutogradimentoesuccessodicriticaedipubblico, suaspettiparticolari-checostituisconoanchedellenovità-, eche sonoin parte ripresi inquestatrattazione.
Al riguardo l’iniziativa dell’Ufficio Storico dello StatoMaggiore dell’Esercito si colloca tra lepiù encomiabilidegliEntipreposti allaricerca,eperlamole del nostro patrimonio archeologico eper il ruolo che l’Italia ha avuto nelle vicenda, Ritengo auspicabile, pertanto, che proprio per la qualità di tale impegno, peraltro già apprezzato in numerosi altri volumi a
Al riguardo l’iniziativa dell’Ufficio Storico dello StatoMaggiore dell’Esercito si colloca tra lepiù encomiabilidegliEntipreposti allaricerca,eperlamole del nostro patrimonio archeologico eper il ruolo che l’Italia ha avuto nelle vicenda, Ritengo auspicabile, pertanto, che proprio per la qualità di tale impegno, peraltro già apprezzato in numerosi altri volumi a
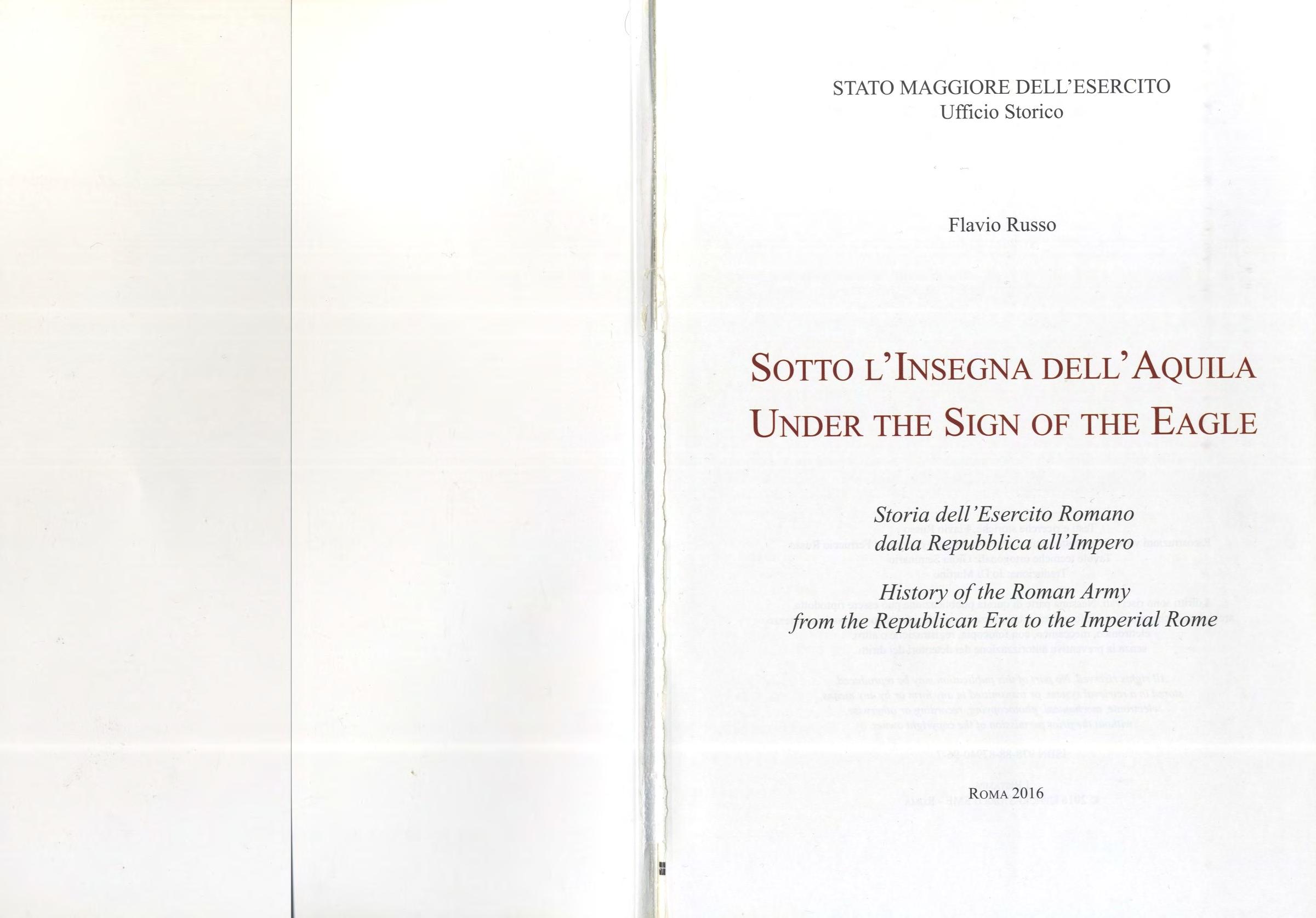

SOTTO L’INSEGNA DELL’AQUIL.
PREMESSA PREMISE
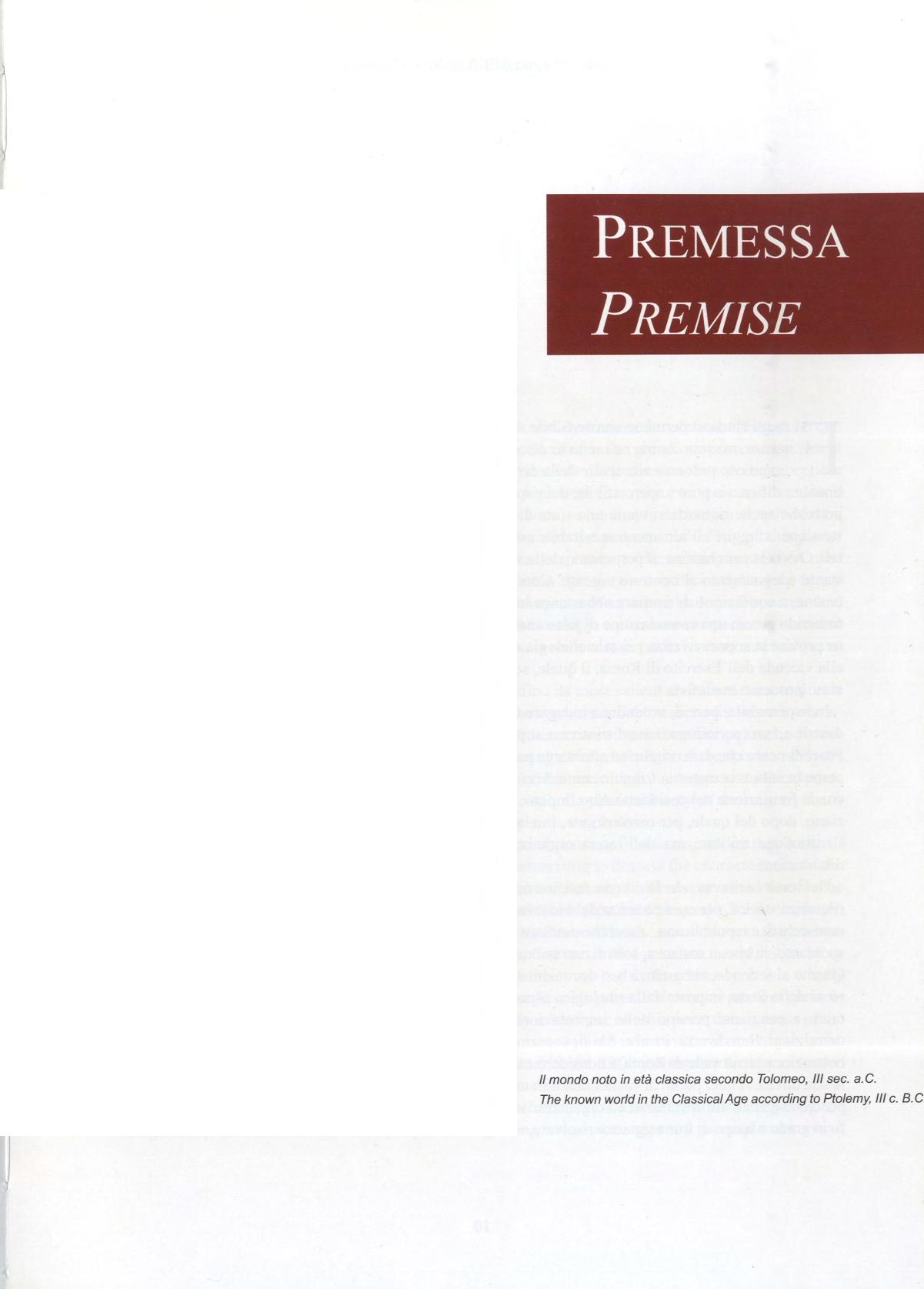
Ilmondonoto In età classicasecondo Tolomeo, lllsec. 3.0. Theknown Walidinthe ClassicalAge accordingtoPia/emy, lllc,B.C

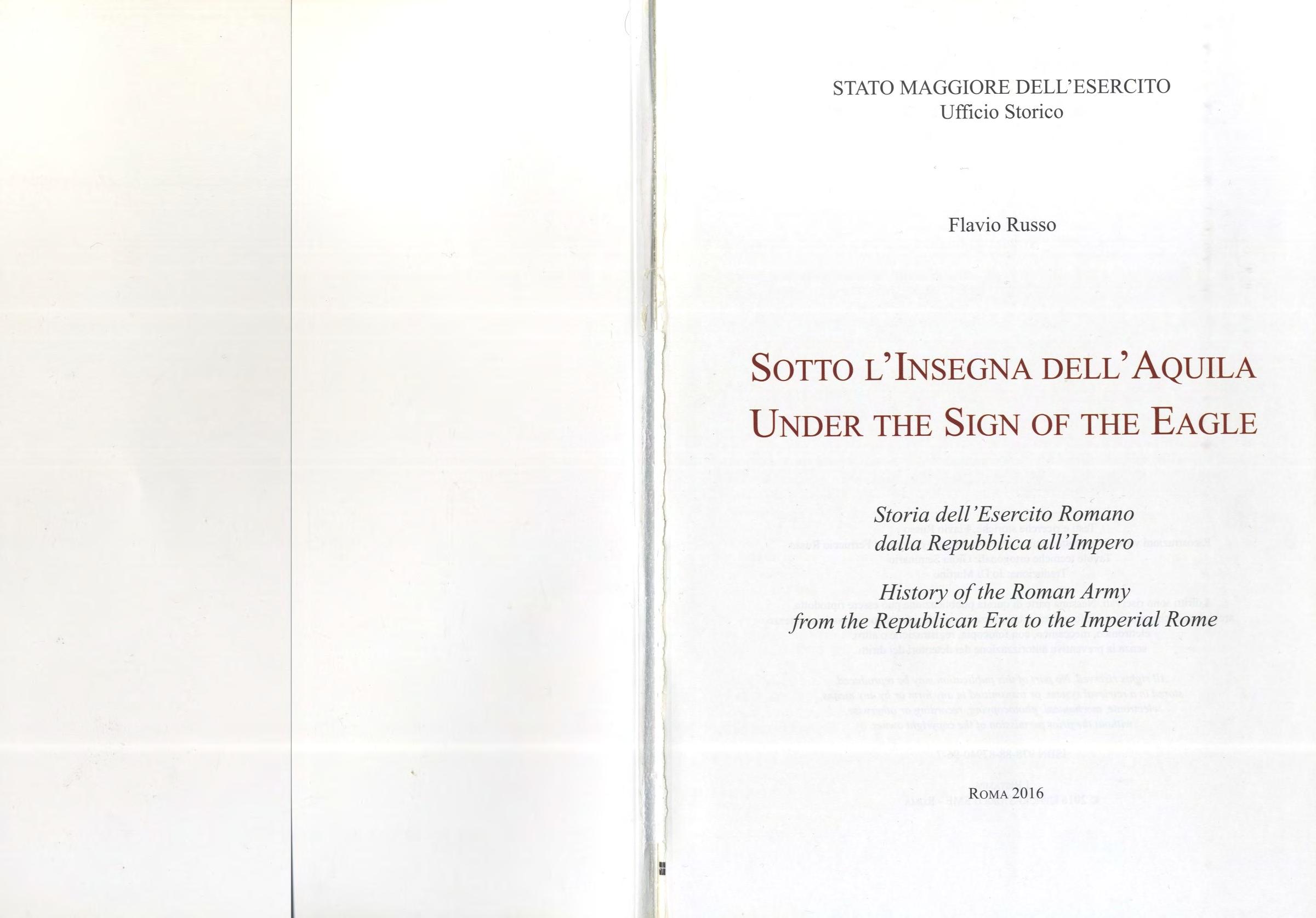
.} .:.‘ì .;}.j3.» -
ERE\’I$ DbXKIPT‘.G'
Premessa
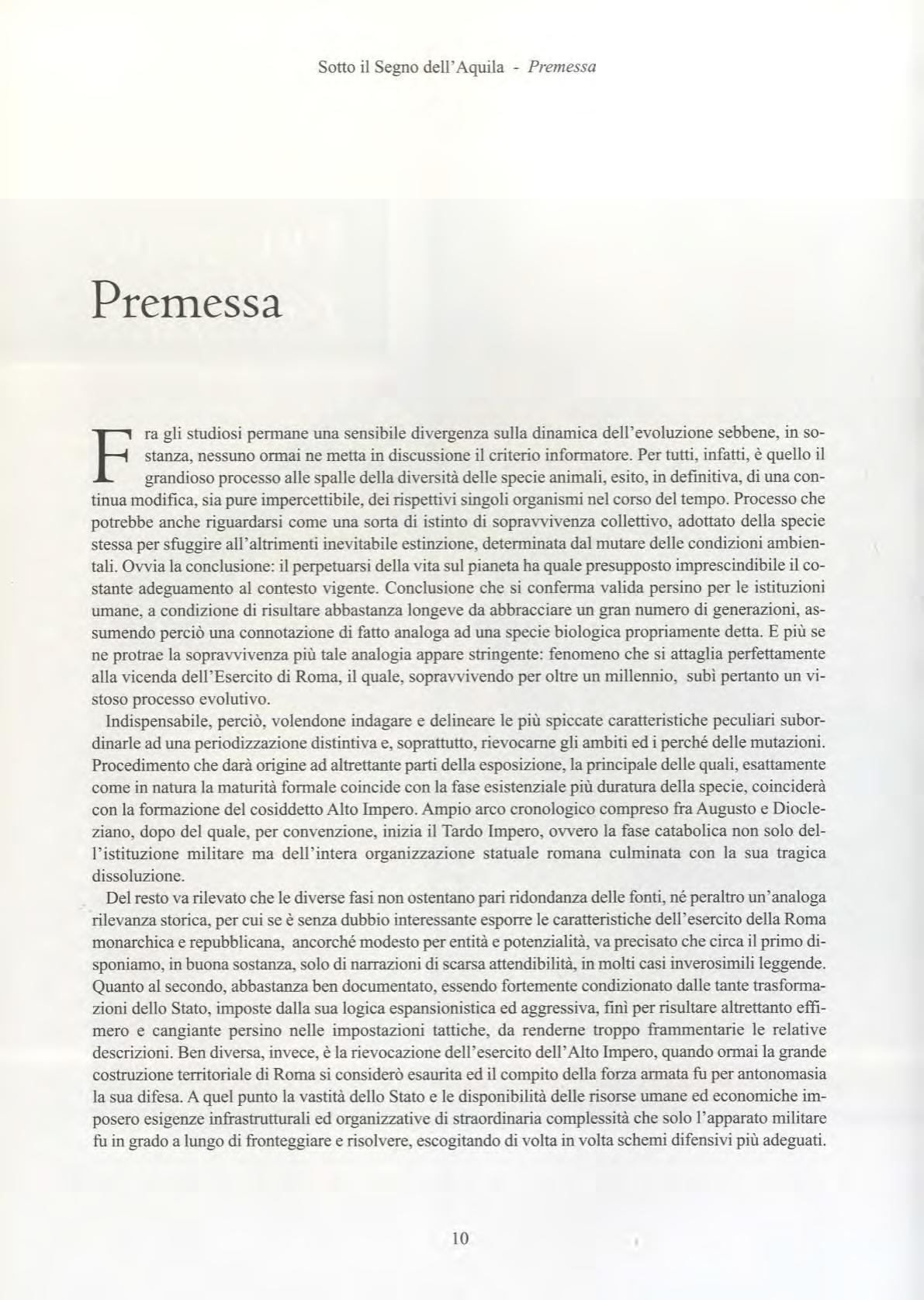
Fra gli studiosi permane una sensibiledivergenza sulladinamica dell’evoluzione sebbene, in so-
stanza,nessunoormainemetta indiscussioneil criterioinformatore.Pertutti, infatti,èquelloil grandiosoprocessoallespalledelladiversitàdellespecieanimali,esito,indefinitiva,diuna continua modifica,siapure impercettibile,deirispettivisingoliorganisminelcorsodeltempo.Processoche potrebbe anche riguardarsi come una sorta di istinto di sopravvivenza collettivo, adottato della specie stessapersfuggireall’altrirnentiinevitabileestinzione,determinatadalmutaredellecondizioniambientali.Ovvialaconclusione:ilperpetuarsi dellavitasulpianetahaqualepresuppostoimprescindibileilcostante adeguamento al contesto vigente… Conclusione che si conferma valida persino per le istituzioni umane, acondizione di risultare abbastanza longeve daabbracciareun gran numero di generazioni, assumendoperciò una connotazionedifattoanaloga aduna speciebiologica propriamente detta…Epiù se ne protrae la soprawivenza più tale analogia appare stringente: fenomenochesi attagliaperfettamente allavicenda dell’EsercitodiRoma,ilquale, sopravvivendoperoltreun millennio, subìpertantoun vistosoprocessoevolutivo.
' “' L" perciò, v ‘ ‘ ’ e * " lepiù spiccatecaratteristichepeculiari subordinarleadunaperiodizzazionedistintivae,soprattutto,rievocarnegliambiti ediperché dellemutazioni. Procedimentochedaràorigineadaltrettanteparti dellaesposizione,laprincipaledellequali,esattamente comeinnatura lamaturità formale "‘ con lafase più ““ dellaspecie, "‘ con la formazionedel cosiddettoAltoImpero…AmpioarcocronologicocompresofiaAugusto eDiocleziano, dopodel quale,per convenzione, inizia il Tardo Impero, ovvero la fasecatabolica non solo dell’istituzione militare ma dell’intera organizzazione statuale romana culminata con la sua tragica dissoluzione.
Delrestovarilevatochelediversefasinonostentanopariridondanzadellefonti,ne'peraltroun’analoga rilevanza storica,percui seèsenzadubbioInteressanteesporrelecaratteristichedellesercitodellaRoma e r perentitàe va, checircailprimodisponiamo,inbuona sostanza,solodi nan-azionidiscarsaattendibilità,inmolticasiinverosimilileggende. Quantoalsecondo,abbastanzabendocumentato,essendofonementecondizionatodalletantetrasformazioni dello Stato,impostedallasualogicaespansionisticaedaggressiva,finìperrisultare altrettantoeffimero e cangiante persino nelle impostazioni tattiche, da renderne troppo frammentarie le relative descrizioni.Ben diversa,invece,èlarievocazionedell’esercitodell’AltoImpero,quandoormailagrande costruzioneterritorialediRomasiconsideròesauritaedilcompitodellafor7aannatafuperantonomasia lasuadifesa Aquelpunto lavastità dello Statoeledisponibilitàdellerisorseumaneedecononrichermposero esigenzeinfrastrutturali ed ‘ ' di in ‘ chesolol’ militare fuIngradoalungodifronteggiareerisolvere,escogitandodivolta involta schemidifensivipiù adeguati.
Sottoil Segnodell’Aquila - Premessa
L'imperoromanoallamassimaespansione TheRomanEmpireatthetimeofItsgreatestexpansion.
Forse daquestasingolareneces scaturironodaun lato latrasfomrazronediuna compaginemilitare dalle forti connotazioni italiche in un esercitomultietnico in grado di operare e combattere in qualsiasi contesto geografico, dai torridr deserti africani. alle gelide foreste europee; dall'altro un corpo di spe cialisti ingradodicostruire strade.acquedotti.canali…porti ed ospedali.tanto per menzionarealcunesue sistematicherealizzazioni…Opere,siadettoper inciso,chevidero i legionari non soloinveste diingegneri ma anche, esenzaalcunarecriminazione, in Veste di manovali eoperai.Dalle tantc fabbricheeofficine delle loro grandi basi. fuonuscrvanomattoni e tegole.tubi dipiombo echiavi d’arresto…ferri chirurgici ad anni da lancio. E. dettaglioper l'epoca persino più aweniristico. erano il risultato di produzioni di serie,standardizzateedeconomicheper miglia dipezzi. Per ritrovare lacapacitàdi vestire ed armareun esercitodiquasi 500.000uomin . in modo uniforme ed adeguato.occorre attenderela rivoluzione industrialee le divisioni napoleoniche! In ogni caso fu lamedesima impostazione che ancora viene adottata dall'attualeindustria. Inestrema sintesi sitrattò del risultato della coalizione della forza edell’ingegno!
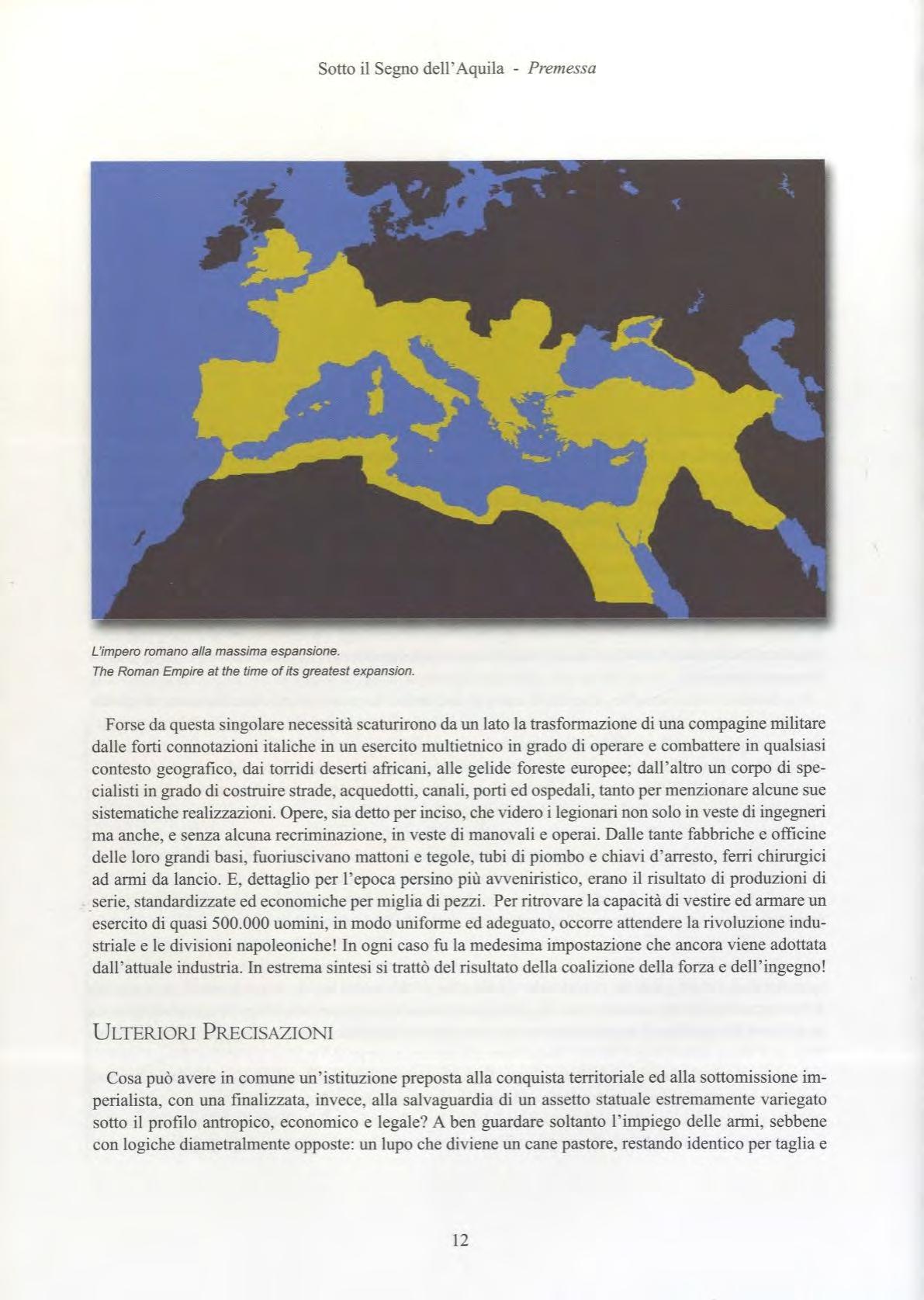
ULTERIORI PRECISAZIONI
Cosa può averein comuneun'istituzione preposta alla conquistaterritoriale ed alla sottomissioneime perialista, con una finalizzata. invece. alla salvaguardia di un assetto statuale estremamente \'anegato sotto il profilo antropico. economico e legale?A ben guardare soltanto l'impiego delle armi, sebbene con logiche diametralmente opposte:un lupoche divieneun canepastore. restando identicoper tagha e
Sotto il Segnodell'Aquila - PI?HIPHLI
perdentatura!Partendodaquest’ultimaconstatazione si può delineareuna rievocazione dell'esercito di Roma cheesuli dal solitostereotipotuttobrutalità eviolenza,massacrietrionfi,deportazionieschiavitù.Certamentequestitragiciaspettivifurono,sebbenediluiti in un arco di quasi dieci seco er il resto, però, si - trattò di ordine e legalità, di disciplina e civiltà, di progressoedibenessere…
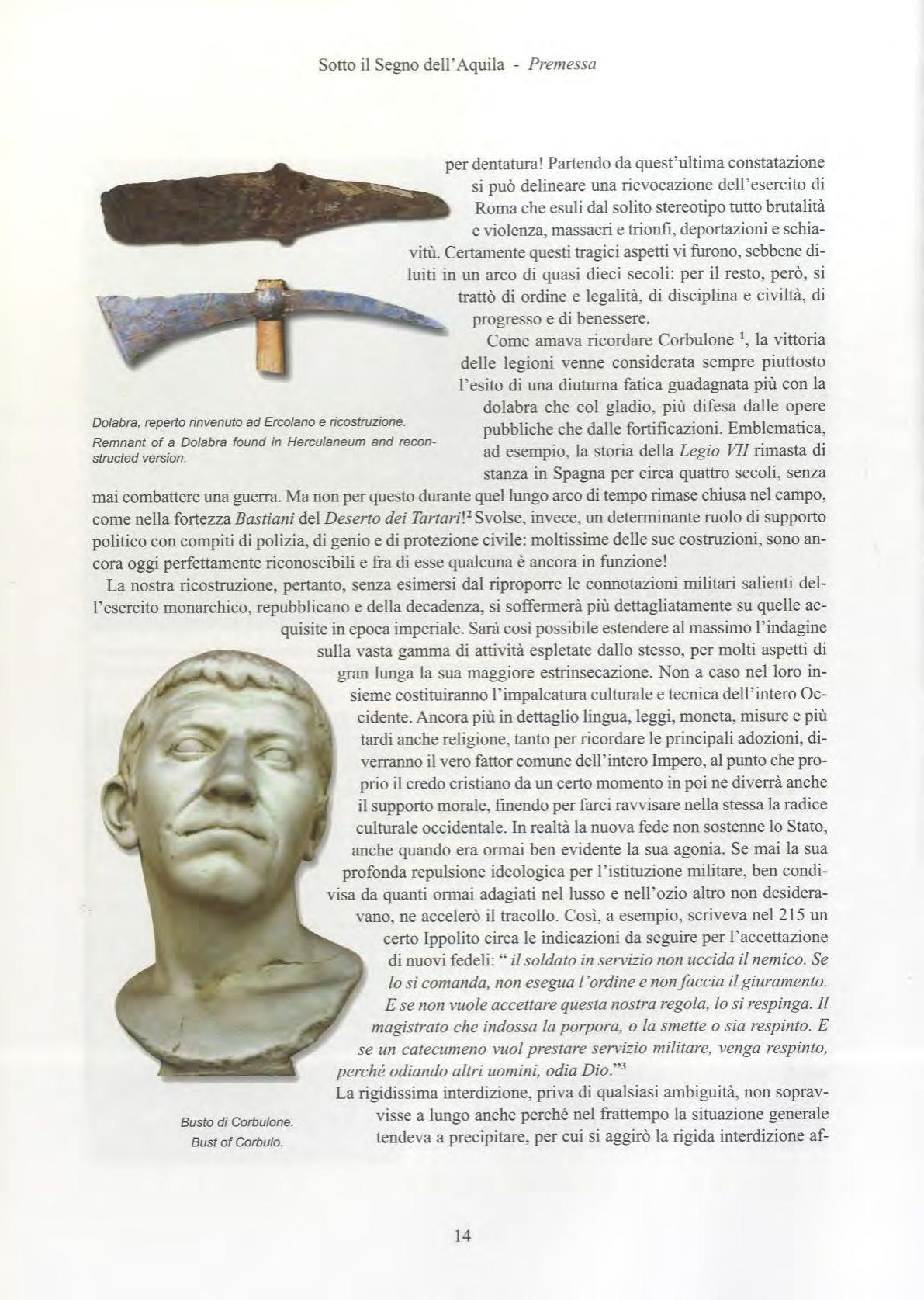
Come amava ricordare Corbulone ‘,la vittoria delle legioni venne considerata sempre piuttosto l‘esito di una diutuma fatica guadagnata più con la dolabra che col gladio, più difesa dalle opere pubblichechedalle fortificazioni…Emblematica, ad esempio, la storia dellaLegio VIIrimasta di stanm in Spagna per circa quattro secoli, senza maicombattereunaguerra…Manonperquestodurantequellungoarcoditemporimasechiusanelcampo, comenellafortezzaBastianidelDesertodeiTartari!2Svolse,invece,un determinanteruolodi supporto politicoconcompitidipolizia,digenioediprotezionecivile:moltissimedellesuecostruzioni,sonoancoraoggipuf -' " i.liefiadiesse ‘ èancorain£ ' '
Dalabra, repertorinvenutoadEmnlano&nbosvuzione.
La nostra ricostruzione, pertanto, senza esimersi dal ripropone le connotazionimilitari salienti dell’esercitomonarchico, repubblicanoedelladecadenza,sisofi‘ermeràpiù dettagliatamente suquelle acquisiteinepocaimperiale,Saràcosìpossibile estenderealmassimol‘indagine sulla vasta gamma di attività espletatedallo stesso,per molti aspetti di gran lunga la sua maggiore estrinsecazione. Non a caso nel loro insiemecostituirannol’impalcaturaculturaleetecnicadell’interoOccidente.Ancorapiù indettagliolingua,leggi,moneta.misureepiù tardianchereligione,tantoperricordareleprincipali adozioni,diverrannoilverofattorcomunedell’interoImpero,alpuntocheproprioilcredocristianodauncertomomento inpoinediverràanche ilsupportomorale, finendoperfarciravvisarenella stessalaradice culturaleoccidentale.Inrealtà lanuova fedenon sostennelo Stato, anchequandoera ormai ben evidente la sua agonia. Semai la sua profonda repulsione ideologica per l’istituzione militare, ben condivisa da quanti ormai adagiati nel lusso e nell’ozio altronon desideravano, ne accelerò il tracollo. Così, aesempio, scriveva nel 215un certo Ippolito circa le indicazioni da seguireper l’accettazione dinuovifedeli:“ilsoldotoinservizionon uccida ilnemico.Se losicomando,non eseguaI 'Ordineenonfacciailgiuramento. E senon vuoleaccettorequestanostra regola, lasirespinga.Il magistrato cheindossa laporpora, (:la smette(;sia respinta. E seun catecumeno vuolprestare servizio militare, venga respinto, perche' odiandooltr-iuomini, odioDio.“3
La rig-idissima interdizione,priva di qualsiasi ambiguità.non sopravBusmd:Corbulons… visse a lungoancheperche' nel frattempola situazionegenerale E…gfCornuto. tendeva a precipitare, per cui si aggirò larigida interdizione af-
Sotto il Segnodell‘Aquila - Premessa
Remnant al& Dolabra found in Hama/aneum and reconstruchdversion.
fermandoche ladifesadell’Imperoera ladifesadellaChiesa.ovverodellostessocristianesimo.lsoldati, perciò, avrebberocombattuto in nome di Cristoe quando fossero stati costretti ad uccidere la colpa sarebbe stata dell’aggressore che li aveva costretti! Ma ormai per molti aspetti quella sorta di ipocritarev sipiscenzagiungevatroppotardiessendostatocompromessolospiritocombattivo,giàseriamenteminato dal benessere edal lusso. Paghe viavia maggiori per allenare i renitenti. ed opere difensive semprepiù grandiose e costose tentarono di sopperire alle carenze di uomini: soluzioni che in breve innescarono unapolitica fiscaleesasperataebrutale,chefinirà perpeggiorareulteriormente lasituazione.Altermine della sua agonia l'imperonon cadrà per la pressione deibarbari, che inrealtà forse non vi fu mai, trattandosi (come oggi possiamo agevolmentecomprendere)piuttosto di una migrazione che di una invasione, abbastanza facileperciò dagestire eda canalizzare.Rappresentò,emolti studiosisonoconcordi alriguardo, il cedimentoaduna aggressioneinternacondottadalladilagantecriminalità,asuavoltaesito dellamiseria. Un circuitoperverso, un rincorrersi di fiscalisrno spietato,diblocco del mercato edi lati» tanza sociale,chesommandosiallarepulsioneper l‘attivitàmilitare,peraltroprogressivamentepiù invisa a tuttiper lagratuitabrutalità, prodotta dallaimmissione deibarbarinell’esercito, portarono al collasso l’Imperod’occidente.
UNA STRANA CARATTERISTICA
La scarsa solidarietà fra la popolazione civile e il comparto militare, manifestatasi pienamente nel TardoImpero,mostra i suoiprodromi giàall’iniziodell’era volgare. E,forse, i primi sintomidelloscollamento Era esercitoecittadini simanifestanoproprio nelle ricche città lontane dai confini,dove da un certomomento inpoi lapresenza delle legioni èpercepita comequellaprecipua di una forzadi occupazione,piuttostochediunaforzadifensiva.Se,adesempio,siosservapiùattentamentelacerchiadiPompei, sia perché tra le meglio conservate del l secolo sia, soprattutto,per essere sfiiggita in seguito alla catastrofe vesuviana del 79 alle successive abituali estravolgentiriqualificazioni,seneconstata una singolare connotazione.‘Per vari aspetti ricorda le maggiori cinte greche, edel resto anche questaerainbuona sostanzadifatturagreca,dove ladifesaerasostenutadaforzemercenarie. Il con— testo politico-economico, tuttavia, è ben diverso essendo quello della massima floridezza e dina— micità dell‘Impero, con l’Europa ormai in gran partepienamente assoggettata,con il Mediterraneo ridottoalagoromano,senzanavi nemichein grado di compiere incursioni: nulla, quindi, che potesse indurre a paventate un qualsiasi attacco, daterraodamare, Eppurelemura diPompeiconservanoletorri aggettanti sia all’esternoche all'intento, conservandopure in sommità, lungo il camminamento, un doppio parapetto, verso l'esternoeverso l’interno,caratteristicacherende l‘interaopera ingradodiespletareuna resistenza controinvestimenti alla città edallacittà!

Sotto il Segnodell'Aquila - Premessa
Pompei,IIa/ra.Dettagliodeldoppioparapettointento Pompe/l, Ita/y.DetailoftheInienordoublepar-ape!
In altre parole, mura strutturate in modo da poter reagire a investimenti ossidionali condotti da aggressori esterni od interni, comunque sempre contro la sua giamigione. La spiegazione in prima approssimazioneravvisaneldispositivounavolontàdiresistenza adoltranza:quandoanche lacittàècaduta le suemura continuano la lorofunzione,esattamentecome una piazzaforte rinascimentale. Ma il paragoneèfuorviante,nonavendolemuraurbiclrene'talefunzionenétaleconcezione:una fortificazionepe» limetrale quando cade ciò che circonda, non ha più alcuna finalità militare e alcuna possibilità di sopravvivere!Ovvio ‘ ’ cheil ,, , internofosse a nus-rare rivoltecittadine,testimoniandocicosiunapersistentedifiidenziversolafedeltàdeisuoiabitanti.Unafedeltànon diversadaquellachei Romanisiattendevanodairepartiausiliari,i quali nonacasoinpiù circostanzedefezionarono.Ladiffidenza,conl’affermarsidelcristianesimoecoltempo, lungidalrientrare si rafforzò vistosamente creandoperciò quasiuna dicotomiatra mondo militareecivile,chenon giovò certamentene' all’istituzione,néai cittadini, néall’Impero.
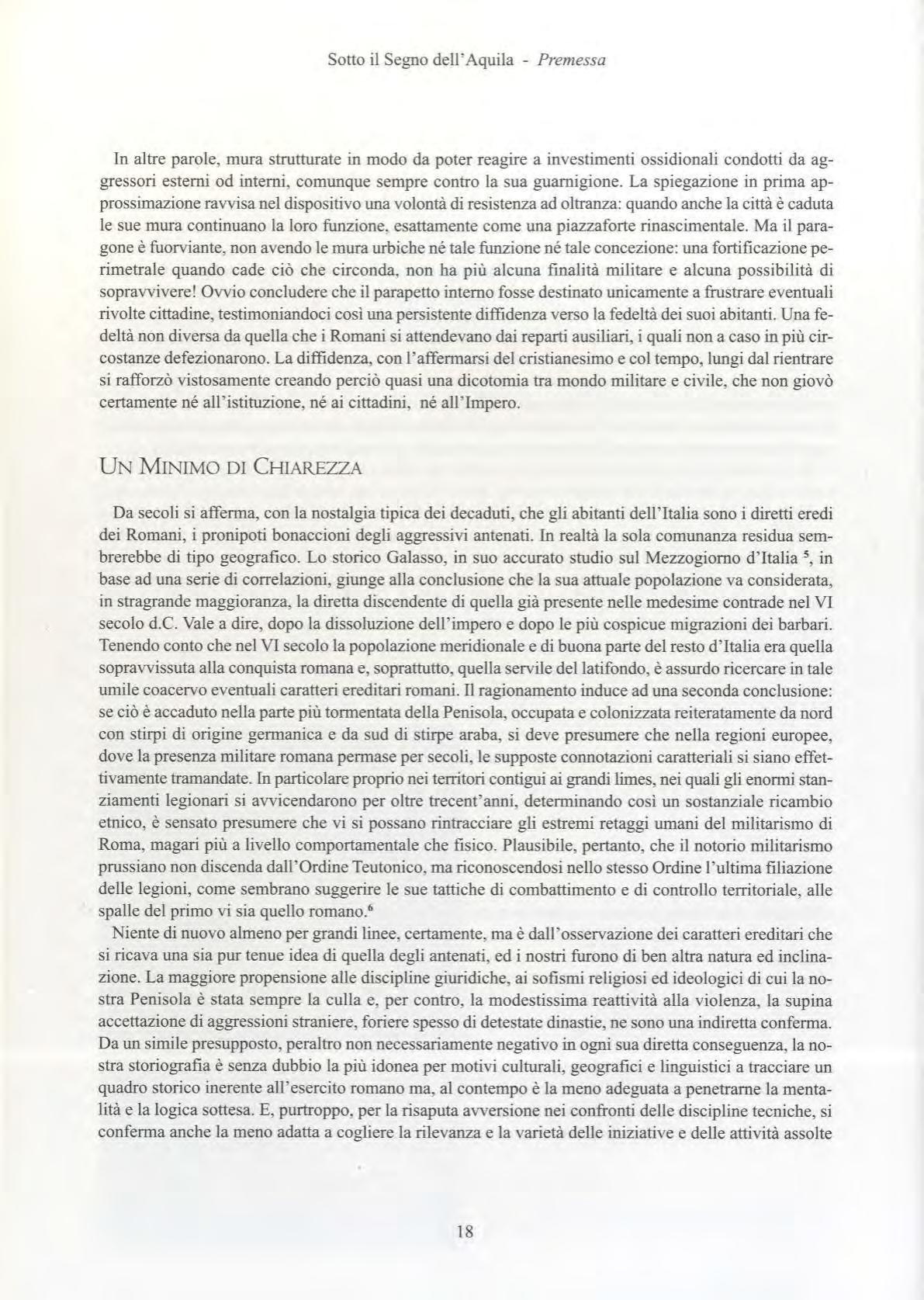
UN MINIMO DI CHIAREZZA
Da secolisiafferma,con la nostalgia tipica dei decaduti,chegli abitanti dell‘Italiasonoidiretti eredi dei Romani, i pronipoti bonaccioni degli aggressivi antenati. ln realtà la sola comunanza residua sembrerebbe di tipo geografico. Lo storico Galasso, in suo accurato studio sul Mezzogiorno d’Italia 5, in base ad una seriedi correlazioni,giungeallaconclusionechelasuaattualepopolazioneva considerata, in stragrandemaggioranza, ladirettadiscendentedi quellagiàpresentenellemedesimecontradenelVI secolodC,Valeadire,dopola dissoluzionedell’imperoedopolepiù cospicuemigrazioni deibarbari. TenendocontochenelVI secololapopolazionemeridionaleedibuonapartedelrestod’Italiaeraquella sopravvissutaallaconquistaromanae,soprattutto,quellaserviledel latifondo, è assurdoricercareintale umilecoacervoeventualicaratteriereditariromani.Ilragionamentoinduceadunasecondaconclusione: seciò è accadutonellapartepiùtormentatadellaPenisola,occupataecolonizzatareiteratamentedanord con stirpi di origine germanica e da sud di stirpe araba, si deve presumere chenella regioni europee, dovelapresenza militareromanaper-massper secoli,lesupposteconnotazioni caratteriali sisianoeffet— tivamentetramandate.Inparticolareproprioneiten-itoricontiguiaigrandilimes,neiqualiglienormi stanziamenti legionari si avvicendaronoper oltre trecent’anni, determinando cosi un sostanziale ricambio etnico, e sensatopresumere che vi si possano rintracciare gli estremiretaggi umani del militarismo di Roma, magari più a livellocomportamentale che fisico. Plausibile, pertanto, che il notorio militarismo prussianonon discendadall’OrdineTeutonico,ma riconoscendosinellostessoOrdinel’ultimafiliazione delle legioni, come sembrano suggerire le suetattiche di combattimentoe di controlloterritoriale, alle spalledel primovi siaquelloromano.“
Niente dinuovoalmenopergrandilinee,certamente,ma è dall'osservazionedeicaratteriereditariche siricava una siapur tenue idea diquelladegli antenati,edi nostri furonodiben altra natura ed inclinazione.Lamaggiorepropensione alledisciplinegiuridiche,ai sofismireligiosi ed ideologicidi cui lanostra Penisola è stata sempre la culla e, per contro, la modestissima reattività alla violenza, la supina accettazionediaggressionistraniere,forierespessodidetestatedinastie,nesonouna indirettaconferma. Daun similepresupposto,peraltrononnecessariamentenegativoinognisuadirettaconseguenza,lanostra storiografia è senza dubbio lapiù idoneaper motivi culturali, geografici e linguistici atracciare un quadro storicoinerenteall'esercitoromano ma, al contempoèlamenoadeguata apenetrarrre lamenta» litàelalogicasottesa.E,purtroppo, per larisaputa awersionenei confronti delledisciplinetecniche, si confermaanchelameno adattaacoglierelarilevanza ela varietà delle iniziative edelleattività assolte
Sottoil Segnodell’Aquila - Premesso
dallelegioniinogniangolodell’impero,fungendodabattistradadellaciviltà.Nessunameraviglia,quindi, che in materia non siamo mai andati oltre allericerche germaniche, britanniche, francesi enon di rado, persino, spagnolecheci limitiamoatradurre, nellamiglioredelle ipotesi.Paradossalmenteperciòlanostra lingua,chepiù ditutteleneolatine somigliaall’anticausata dai Romani,non èbastata a incentivare più accurateeserieindagini sullevicendedellagrandiosa istituzione. Il chenon manca diprovocare vistoseapprossimazionitecnicheegravi improprietàformali,deleterieinunaqualunquericerca scientifica, ma intollerabili conuna così strettaaflìnità etimologica.Per cui, tentando un diverso approccioall’argomento, ci èparsoutile procederepreliminarmente proprioadunapuntualizzazione etimologica circa ivocaboli ele definizioniche entrerannocorrentementenell’esposizione, troppo spessoconfusi.
SIGNIFICATODI ESERCITO
Il sensoetimologico, in prima istanza, è chiarissimopermanendo inalterato anchein italiano:esercito deriva dallatinoexercitusilquale,asuavolta, derivadallavoceverbaleexérceoche significaaddestra, tengo in esercizio. E fin qui tutto talmente logicoescontato,dagiustificarequanti tengono aravvisarvi unapeculiarità distintivadellanostra forzaarmata…La suadenominazione,infatti,non sirifà comelastragrande maggioranza di quelle delle altre nazioni, alla logica distruttivadelle armi, come ad esempio Anny per quella stanmitense e britannica edArmè per quella francese, ma all‘esempio pacifico dell’esercizio,del lavoro.Concettochesembravolerribadireilprimatodellacapacitàtecnica suquellameramentebellica implicante l’usodelleanni.
Nonfermandosiperòall‘apparenza,nellaFattispeciealsoloetimolatino.matentandodi individuareilpiù arcaicodalqualeasuavolta derivava,nonsfuggeperrestareancoraallatinocheilverboesercitarerisulta compostodaexcol sensodifioriedamérecol sensodispingere,per cui il sensosarebbequellodispingerefirarr',faruscire, stimolareeper ampliamentoconcettualefirrlavorare,sollecitare,Mancare einfine ancheaddestrare, Il che lungi dal dare conferma alla precedente etimologia, la rende se mai dubbia,non capendosicosapossa voler significarelospingerefilari,owen)chiedacosadovrebbeesserefattouscire.
Per altri studiosi la spiegazione e insita nella non derivazione dalla voce verbale arcé7e ma dal sostantivoaree,chesignificavafortezza, rocca dacuiilnostroarr-rz:intalcasoilsensosarebbefiroridella mcca,fuoridellafortificazioneeper estensionetutti quelli chevengono condotti fiiori dalle difese,ovviamenteperandarecontroalnemico.Significatosenzadubbiopiùcalzante.Rafi‘orza,inoltre,questaseconda ipotesi anchel’etimologia di arcocheviene fatta risalire al latinoàrcuscol significatogenerico di arma,dacuiderivòrin-eo,rerpr'rrgo ilnemicoowiamentecon l’impiegodelle armi. E quiil discorso torna al puntodipartenza,ricavandosi facilmenteil sensocomplessivodiuna difesaattivacondottacon l’uso armi: concezione senza dubbio calzante alla Costituzione, ma lontana dalla suddetta interpreta— zioneedulcorata,Inogni casoil concettodi impiegodellearmi è ben presente anchenell’etimodi exercitus, esercito,oracome allora!
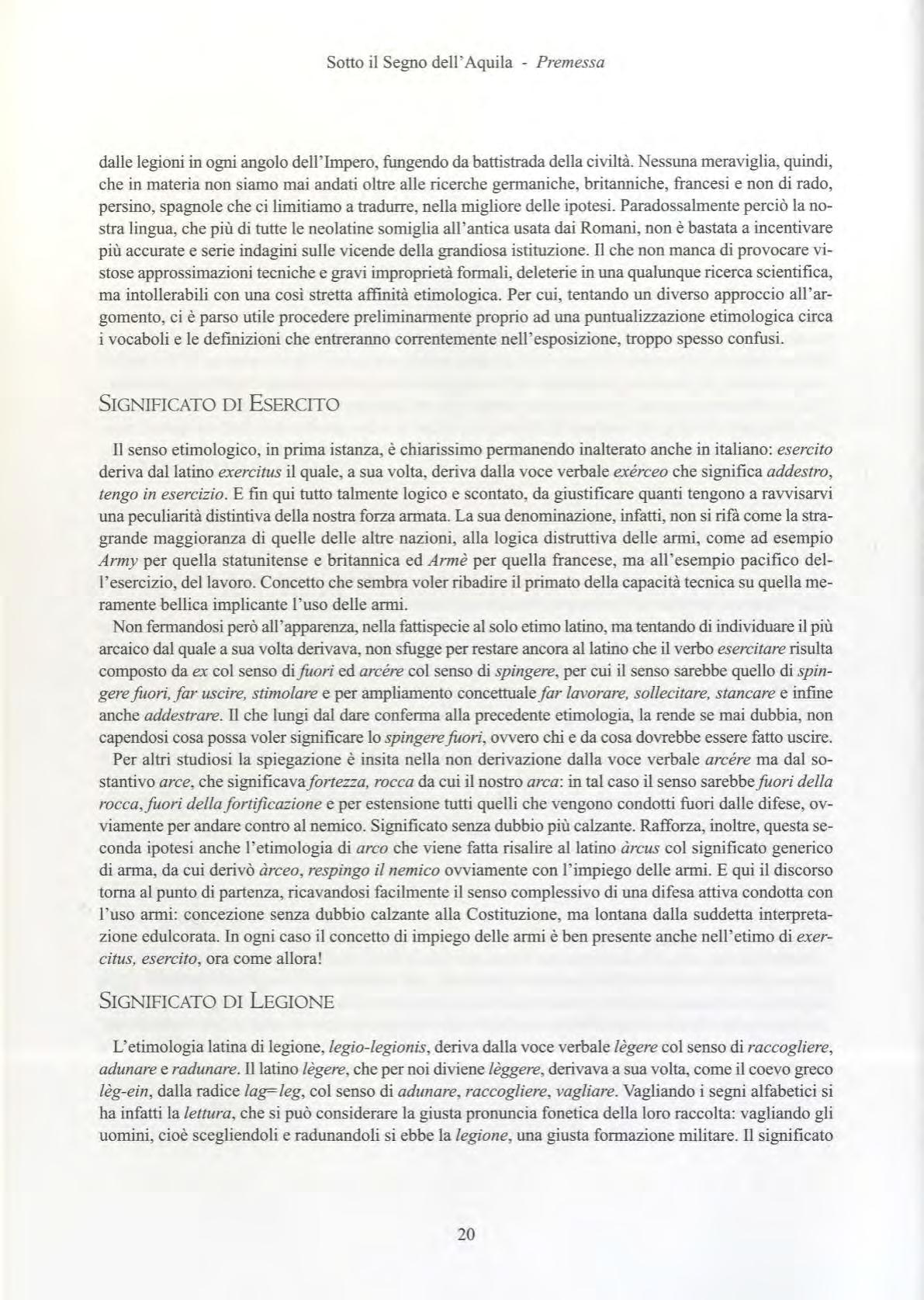
SIGNIFICATODI LEGIONE
L’etimologialatinadi legione,Iegr'o-Iegr'orrr's,derivadallavoceverbale !ègerecolsensodiraccogliere, adunareeradunare.il latinolègere,chepernoidivienelèggere,derivavaasuavolta,comeilcoevogreco Ièg-eirr,dallaradiceIag=leg,col sensodiudunare,raccogliere, vagliare.Vagliandoisegnialfabetici si ha infatti lalettura,chesipuò considerarelagiustapronuncia foneticadellalororaccolta:vagliando gli uomini, cioè scegliendolieradunandoli siebbelalegione,una giustaformazionemilitare.Ilsignificato
Sottoil Segnodell’Aquila - Premessa
20
quindi lascia trapelare che l‘immissione nelle legioni non era ne' automatica ne scontata,né, meno che mai.di massa comenelle bande medievali.dove l‘unicorequisitoerail farnumero. Quella accettazione costituiva, invece,una sorta di promozrone sociale,di un ambitoriconoscimento rimasto tale per molti secoli, quasi una qualifica senza della quale le can-icrc politiche ed amministrative più prestigiose sarebbero risultate tassativamente precluse.
SIGNIFICATO DI ARMATA
Il termine sin dal suoawentoha indicato esclusivamenteuna rilevante formazionedi navi daguerra. Inpraticaun numero sufiicientediuni diprimaria grandezza,per formarela linea dibattaglia.Attualmentee statosostituitoda[lotta,cheasuavolta non vanta alcunaetrmologiané ingreconéin latinoade guata. Stando al Guglielmotti, all’armata appartengono gli ammiragli. i capitani, gli ufficiali, i comandanti,i marinai.le maestranze,gli equipaggi.lagente. i rematori, i macchinisti. In ogni casotutti quanti avesseroattinenza con ilmare. le navi, il loroarmamento ele loro macchine, In epoca estremamente recente. oWero a partire dalla seconda metà del XIX secolo. il termine armataha iniziato ad es— sereusatoper indicarepure l’EsercitodiTerra,oparti diessodi cospicuedimensioni,generandoperciò confusionenella letturadei testi classici.
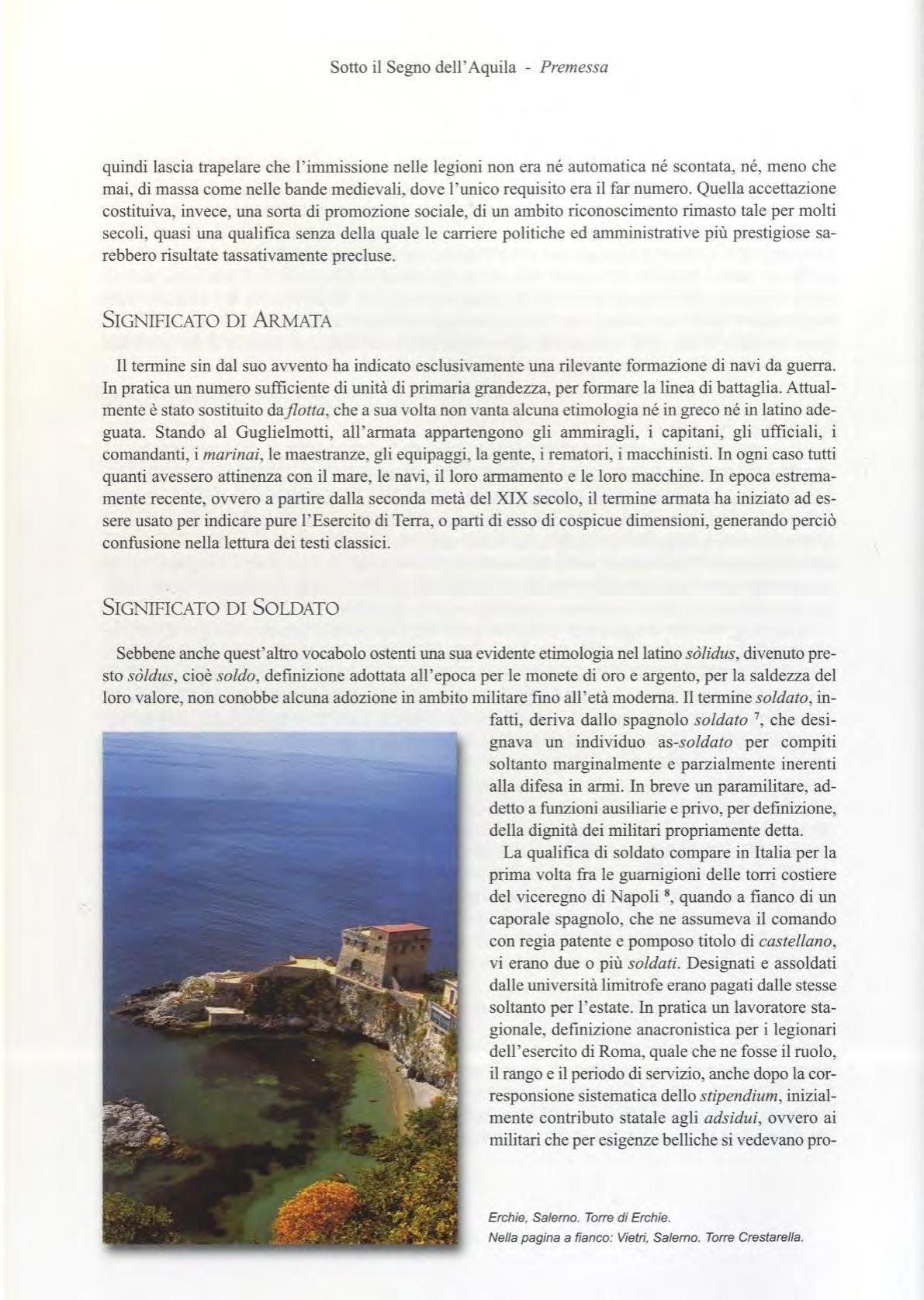
SIGNIFICATODI SOLDATO
Sebbeneanchequest’altrovocaboloostentiuna suaevidenteetimologianellatinosàlia'us,divenutopre stosàldur.cioèsaldo, definizione adottata all‘epoca per le monete di oroe argento, per la saldezza del lorovalore,non conobbealcunaadozioneinambitomilitare fino all’etàmoderna.Ilterminesoldato,infatti. deriva dallo spagnolo soldato ’,che designava un individuo as-roldaro per compiti soltanto marginalmente e parzialmente inerenti alla difesa in armi.In breve un paramilitare, addettoafunzioni ausiliarie eprivo.perdefinizione, della dignitàdeimilitaripropriamente detta.
La qualifica di soldato compare in italia per la prima volta fra le guarnigioni delle torri costiere del viceregno di Napoli “. quando a fianco di un caporale spagnolo, che ne assumeva il comando con regia patente epomposo titolo di custe11ano. vi erano due opiù saldati. Designati e assoldati dalleuniversità limitrofeeranopagati dallestesse soltantoper l’estate. in pratica un lavoratore stagionale. definizione anacronistica per i legionari dell’esercitodiRoma,qualechene fosseilruolo, il rangoeilperiododi servizio.anchedopolacorresponsionesistematicadellortiperra'iurn,inizialmente contributo statale agli udsidui, ovvero ai militaricheperesigenzebelliche sivedevanopro»
Sottoil Segnodell'Aquila Premessa
Erchie, Sale-mo. TonediErchie Nella pagina a fianco. Vietri, Salerno. Tome Cfestsrel/a,
lungare la ferma pure alla stagione invernale. Quantoal significatodel vocabolortipendium, che trova un strettocorrispettivonel nostrostipendio,derivavadastr'ps-stipis.una monetina di rame di infimovalore.Sensatoconcluderechealleorigini ilservizionon solofosseavulsodalsoldo,machequandocom— parve una qualcheremunerazione sitrattòdiuna modestissima indennitàper evitareaggravi albilancio dei meno abbienti.Dal puntodi vista storicoestando,almeno,alla tradizione l’introduzione dellapaga militareavvennenelcorsodell’assediodi Veio,protrattosi dal406al 396a.C.Verosimilmente lo siconsideròun espedientenon destinatoall’adozionesistematica,ma latrasformazionedellaguerradaevento armuale estagionaleinprassi continuaeincessante,finìperrenderlo indispensabile ed ovvio.“
SIGNIFICATODI MILITARE
Assodato chenon è correttodefiniresoldatigli uomini dell’esercitoromano, con quali termini venivano desigrratiabitualmentei suoicoscritti esoprattuttoperché?Tutte le fonticonvergonosuunaunica denominazione,miles, cioèmilite, definizioneattualmentedimodesta adozioneforseperché sembraattagliarsi piuttosto a membri di formazioni paramilitari. Corpi di fortecaratterizzazione ideologica edi scarsasoggezionealloStato,cheben pocohannoincomuneconun esercitonazionale.Peralcuni autori tuttavia, ladifferenzatra milizia edesercitova individuatanella temporaneità dellaprima enellapersistenzadel secondo.Inaltriterminiuna formazionechesiaggregainvistidiunabattaglia, odiuna cam— pagna stagionale,perpoi sciogliersial suoconcludersièsempreunamilizia. Nel caso,invece,cheresti permanentemente in servizio, senza alcuna soluzione di continuità, indipendentemente dallo stato di guerraodipace,va considerataun esercito.Posta cosilaquestionetutti gli eserciti dell’antichinà,tra cui quelloromano, fummodapprimamilizieesoltantoinun secondomomento,enon sempre,sievolseroin eserciti. Questa distinzione spiegherebbe il perché del protrarsi della dizione di milite per i legionari, anche quando a giusto titolo tali non erano più, dovendosi da allora piuttosto definirepedites owero fanti.Per i Romani,invece,il milesfu ilmilitarenellapienezza del significato.
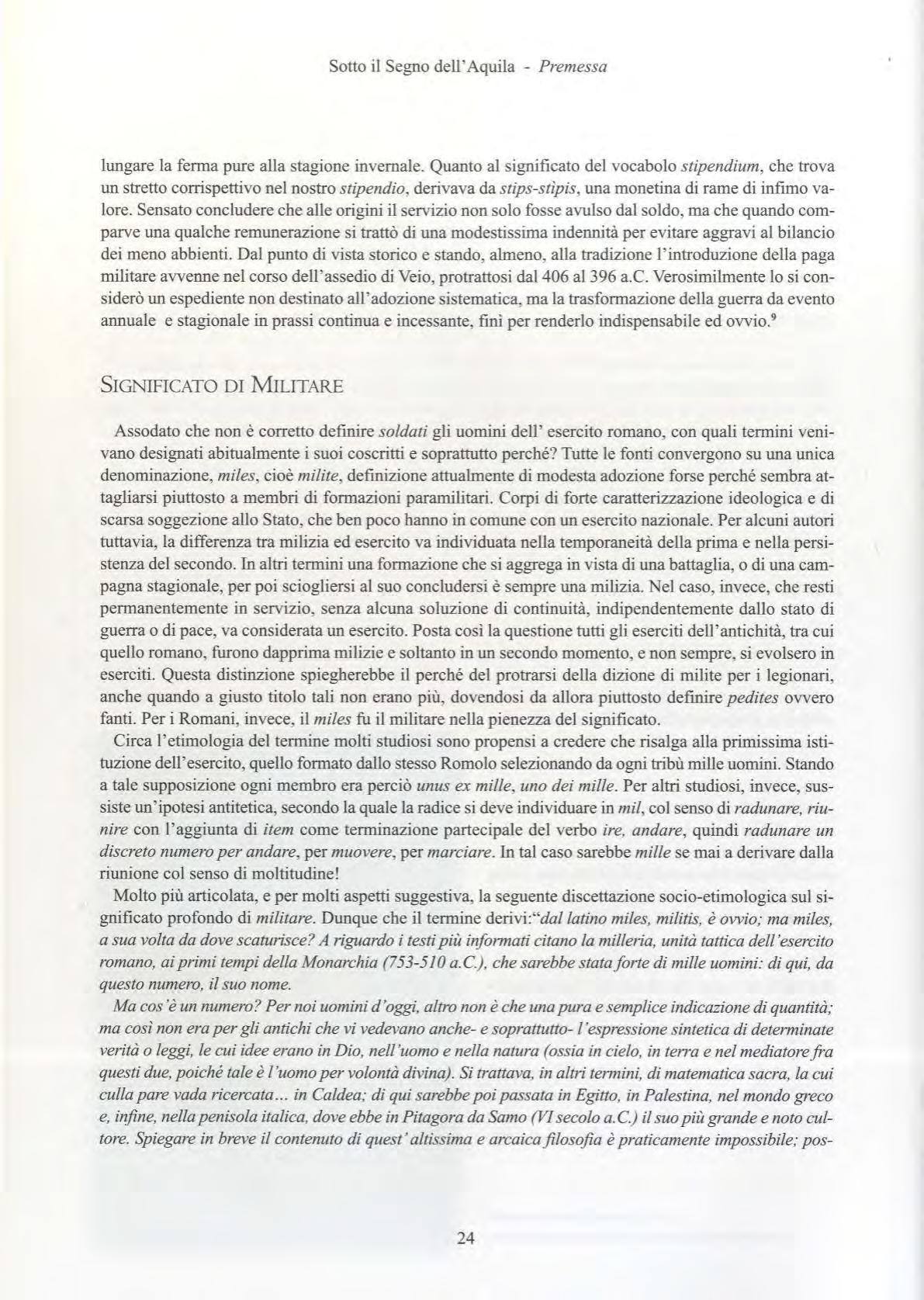
Circa l‘etimologia del temine molti studiosisonopropensi a crederecherisalga allaprimissima istituzionedell’esercito,quelloformatodallostessoRomoloselezionandodaognitribùmilleuomini. Stando atale supposizioneognimembro eraperciò unus exmille, una deimille.Per altri studiosi, invece, sussisteun’ipotesiantitetica,secondolaqualelaradicesideveindividuareinmil,col sensodiradunare, riunire con l'aggiunta di item come terminazione partecipale del verbo ire. andare, quindi radunare un discretonumeroperandare,permuovere,permarciare.lntal casosarebbemillesemai aderivare dalla riunione col sensodimoltitudine!
Moltopiù articolata,eper molti aspetti suggestiva,laseguentediscettazionesocio-etimologicasu]significatoprofondo di militare. Dunqueche il termine deriviz“dallatinomiles, militir, è ovvio;ma miles, asuavoltadadovescaturirce?A riguardoitestipiù infi7nnaticitanolamiller-ia, unità tattica dell'esercito minano, aiprimitempidellaMonarchia (753-510«.C), chesarebbestatafortedimilleuomini:diqui, da questonumero, ilsuonome.
Macos'èun numero?Pernoiuomrnidaggi,uhmnon è cheunapuraesempliceindicazionediquantita; ma cosìnon eraperinantichichevi " anche-e ,, l sinteticadi verità oleggi, lecuiideeeranoinDio, nelluomoenella natura (ossiaincielo, in terra enelmediatorefm questidue,poiche'taleel’uomopervolontàdivina).Sitrattava, inaltritermini, dimatematicasacra, lacui cullaparevada ricercata... in Gulden;diquisarebbepoipassata inEgitto, inPalestina, nelmondogreco e,infine,nellapenisola italica,doveebbeinPitagoraduSama(VIsecoloa.C.)ilsuopiùgrandeenotocultore. Spiegarein breve ilcontenutodiquest'ultimi…eomaicafilasofia èpraticamente impossibile;pos-
Sottoil Segnodell‘Aquila . Premessa
24
siamoperòcercaredidarneun ideacon un esempiocheserviràanche-esopi‘atlutto-aspiegareil velo Sir gni/icarodelnumero mille, equindianchedelvocabolomiles.Proviamoci.
Una è Dio,!'Essereprima, ilcreatorediognicosa, dacuiquindituttooriginaepromana:sicheinumeri aunacifracheloseguana-quellidadueanove-altrononsonocheivariaspettidelmondomanifestoemateriato.Dopoilnovevieneildieci,ilnumeroche...esprimeillivellodetta 'maleriaanimata’,lacuiazione produttrice simanifesta poi nella seriedinumeri compresa tra I ‘undiciei]novantanove. Diecisigni ca quindicheDio è innoi, nella nostra materia. Piùsu, oltreilpianomateriale, vi e nell'uomoun altrolivello, quellodellospirito, dovehannosedeisentimentielamisteriosaForza Vitale, quelfluidosottilechegliAntichicredevanoavessesedenelsangue...In termininumerici.siamosulpianodellecentinaiwossiadeinumeridacentoanovecentonavantanove-dovetuttooriginadallasecondapotenzadidieci(diecia]quadrato e ugualea cento)… Cento.ilcuisignificato è —ora losappiamo—Dio è in noi, nelnostrospirito.Similiargomentazioni valgonopoi, ovviamente, ancheper ilnumero mille (millee'uguale a diecialla terza) che, nel linguaggiodellamatematicasacra,indicacheDio èpenetratoanchenel!’animadell’uomo,ossianella terza eultima—epiù elevata-suacomponente.Dunque, lapurificazione. lacatarsispiritualedell’uomosiètrevolte compiuta:coldieciha vintolamateria, colcentoha quietatolepassioni, colmilleha sublimata ilsuospirito. E alloraognioscuratraccia diistintualila‘è ormaiscomparsa,etuttoin luiè candidoesplendente:il guerriero,perciò, è unicamentevotatoaun’idea,èprontoascenderein campoea combatterecomemiles inquadratonella mil/erio. Levocimiles emilleria qualificanodunquenon tanto unaforzafisica (quelladi un uomo, in un caso,edimilleuomininell’altro)quantopiuttostounapumpotenzaspiritualeeanimica, il massimocheal]’uomosiadatodiraggiungere...""
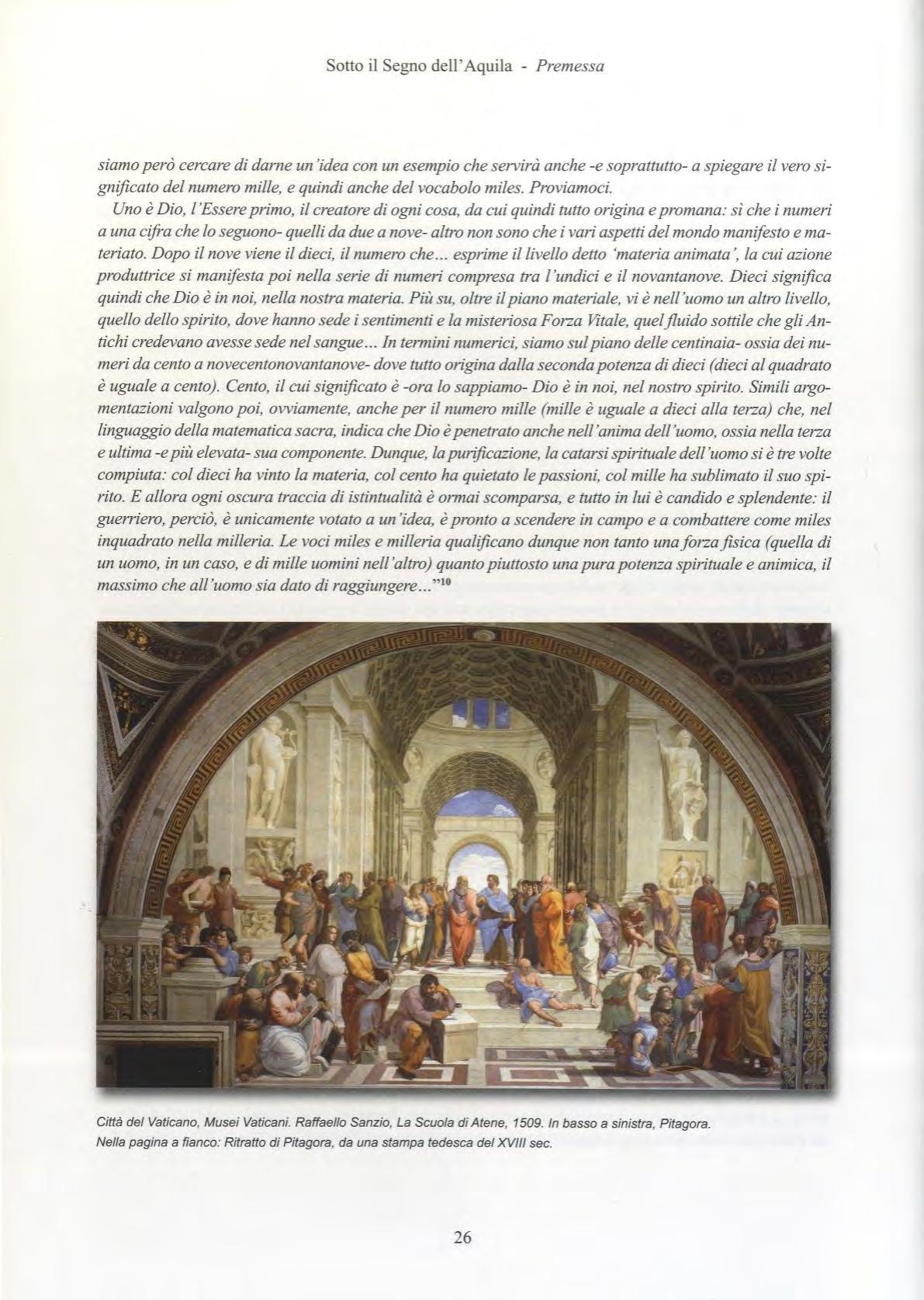
Sotto il Segnodell'Aquila - Premessa
26
Cittàdel Vaticano, Muse!Vaticani. Raffaello Sanzio, La Scuola dlAtene, 1509.Inbasso asinistra, Pitagora. Nella pagina afianco:RitrattodiPitagora, dauna stampatedesca delXVIII sec.
Note
1— Sullafigura diGaioDomizioCorbulonecfr.P.C.TACITO,Annali, libri l-VI.Perunapiù dettagliata esposizionedellasuaattivitàmilitarecfrM.A…LEVI,L imperoromano, Torino 1967,vol…I,pp.285—303.
2- Cfr…D. BUZZANTI,Ildesertodei Tartari, [*edizioneMilano 1940,
3-Lacitazione è trattadaU…BROCCOLI,L infernointerra,inARCl-IEO,n°11,novembre2007,p,]03.
4 — Cfr, F. RUSSO,F.RUSSO,89a.C.AssedioaPompei, Pompei 2005.,pp, 64-69.
5 -Da G. GALASSO,L’altra Europa,Milano 1982,pp.]9-ZS.
6 -Cfr.F. L. CARSTEN,Le originidellaPrussia,Bologna 1982,pp. 19—21.
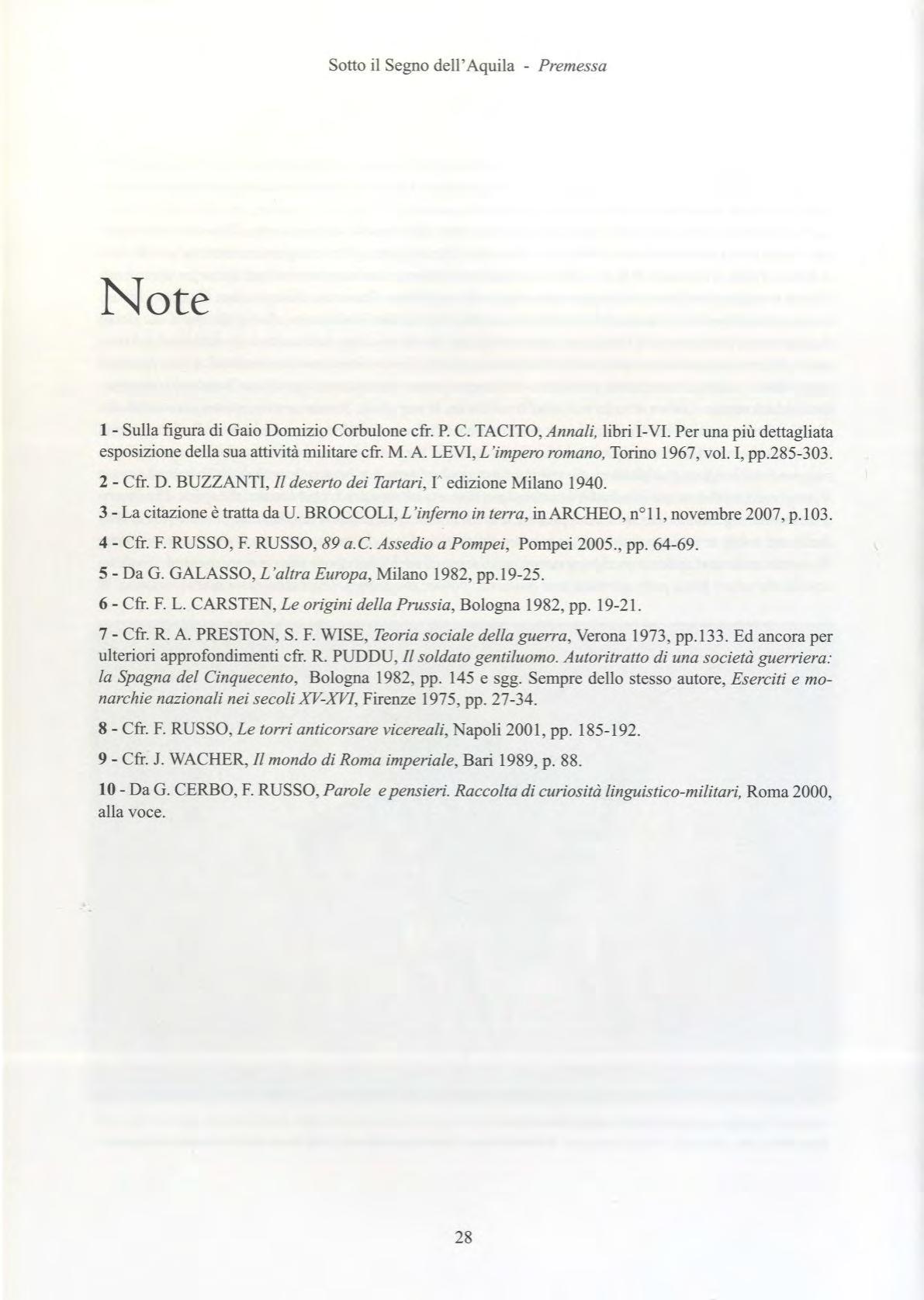
7 — Cfr.R,A, PRESTON, S.F.WISE, Teoriasocialedellaguerra,Verona 1973,pp.]33…Ed ancoraper ulteriori approfondimenti cfr. R. PUDDU,Ilsoldatogentiluomo.Autoritratto diuna societàguerriera: la Spagna del Cinquecento, Bologna 1982,pp. 145e sgg. Sempredello stesso autore,Eserciti e monarchienazionalineisecoliXV—XVI, Firenze 1975,pp.27-34.
8 — Cfi'.F. RUSSO,Letorrianticorsarevicereali,Napoli 2001,pp. 185-192.
9-Cfr.J. WACHER,IlmondodiRoma imperiale,Bari 1989,p. 88.
10 - DaG,CERBO,F.RUSSO,Parole epensieri.Raccoltadicuriositàlinguistico-militari, Roma2000, alla voce,
Sotto il Segnodell'Aquila » Premessa
28
PARTE PRIMA
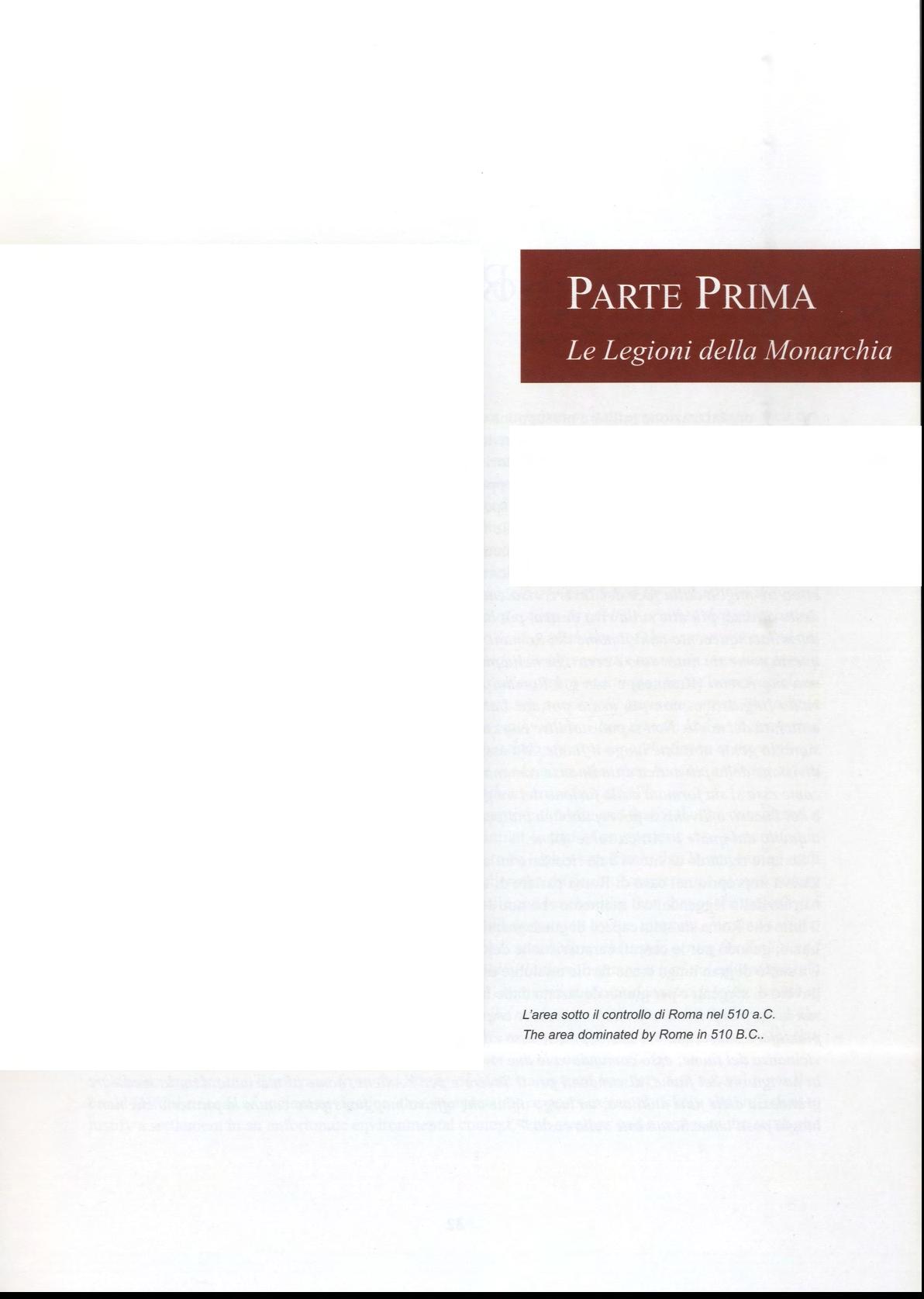
Le Legioni (lella Illom'rrchiu
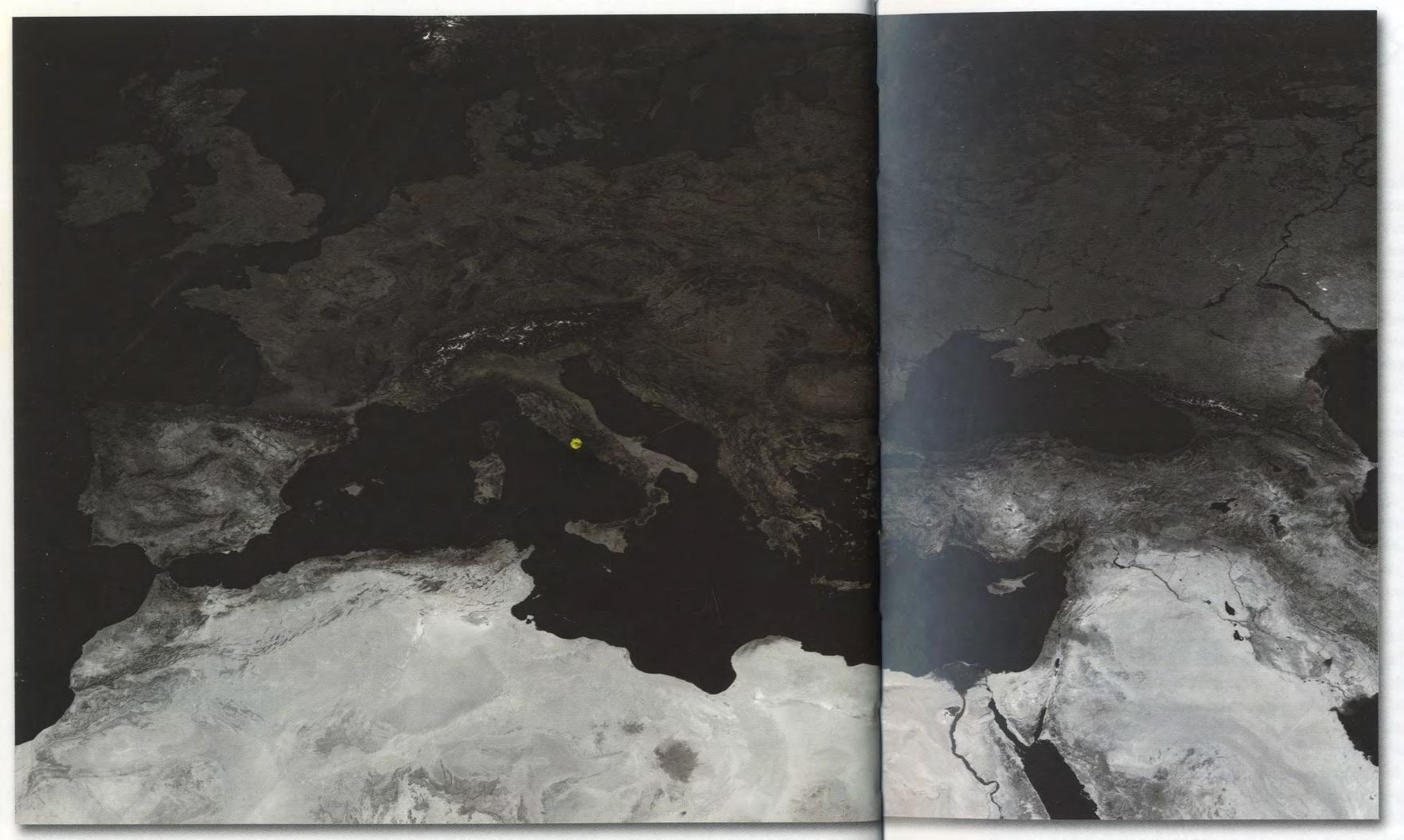
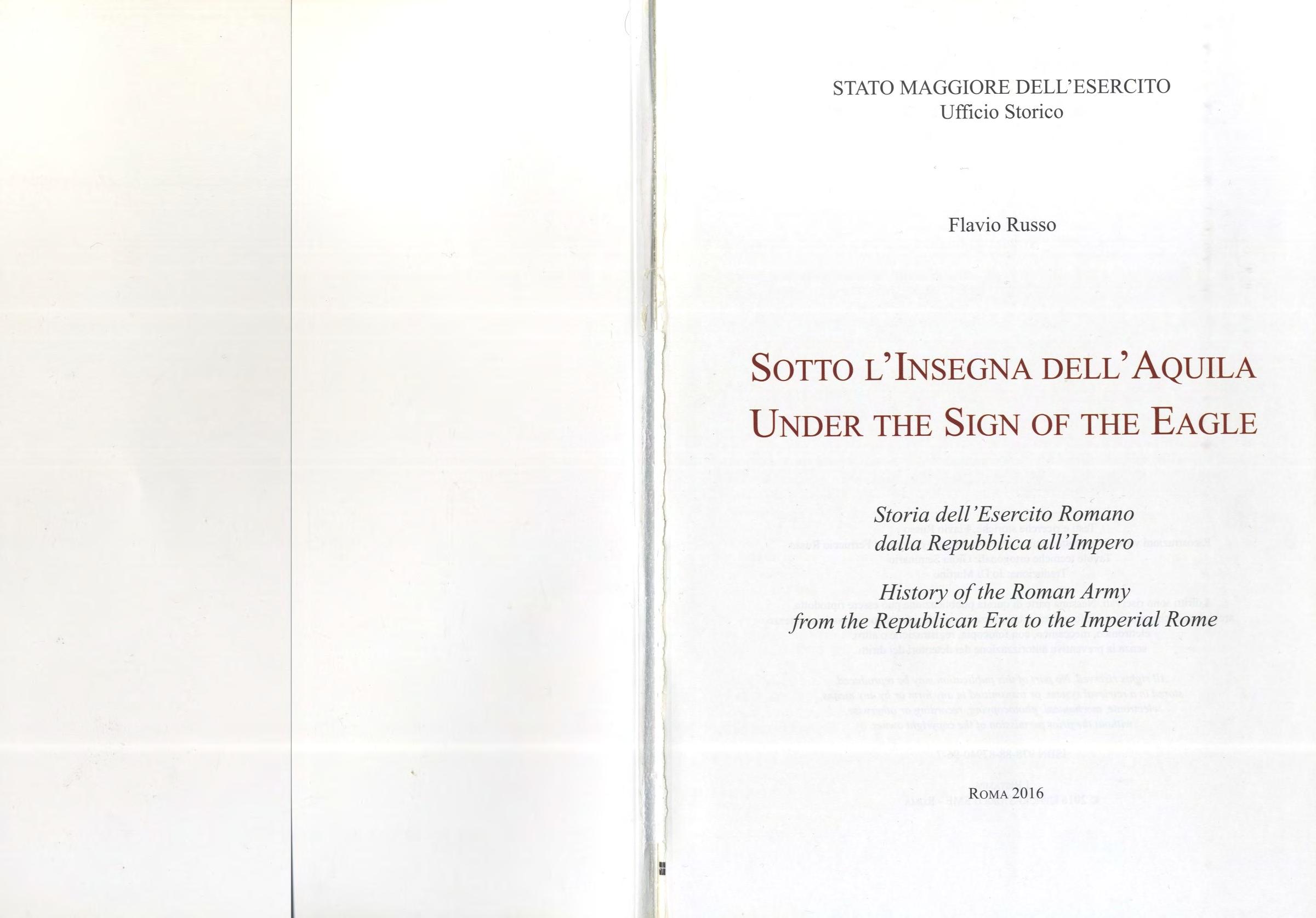 L'area sonoilcomm/la dl Roma nel 510a C The area dom/risiedby Roma In 510H.C..
L'area sonoilcomm/la dl Roma nel 510a C The area dom/risiedby Roma In 510H.C..
Alle origini di Roma
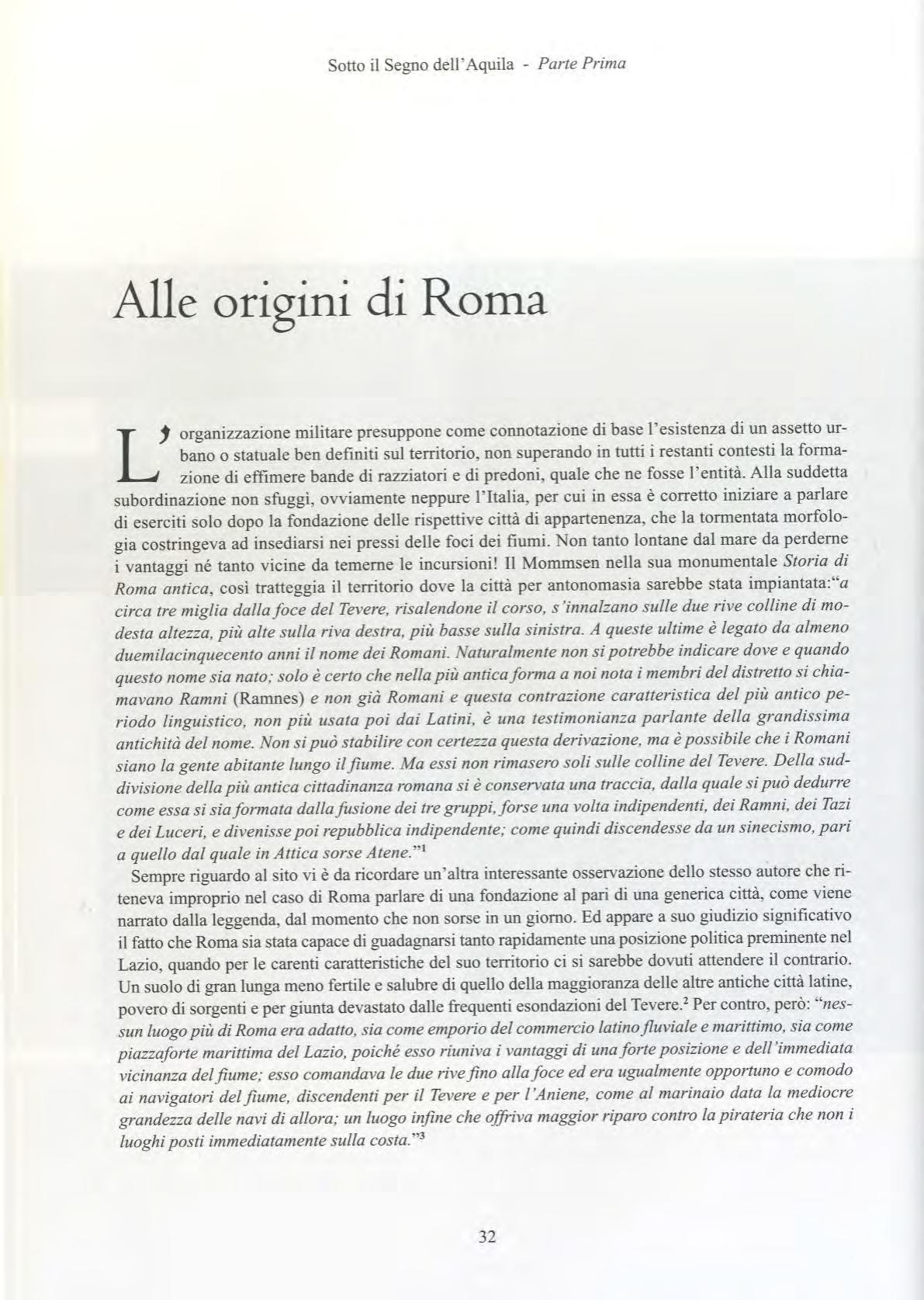
’ ' militare, ,, come ' dibasel’ ' diunassettour-
…
bano ostatualeben definiti sulterritorio,non superando intutti i restanticontesti la formazione di effimerebande di razziatori edipredoni, qualechene fossel’entità.Alla suddetta subordinazionenon sfuggì,owiamenteneppure l’Italia, per cui in essa è corretto iniziare a parlare di eserciti solodopo lafondazionedellerispettive città di appartenenza, che la tormentata morfologia costringeva ad insediarsi nei pressi delle focidei fiumi.Non tanto lontane dal mare da perderne i vantaggi né tanto vicine da tememe le incursioni! Il Mommsen nella sua monumentale Storia di Roma antica, cosi tratteggia il territorio dove la città per antonomasia sarebbe stata impiantata:‘a circa tre miglia dallafocedel Tevere, risalendo/te ilcorso, 5'innalzanosulleduerivecollinedimodesta altezza,più altesulla riva destra,più bassesulla sinistra. A questeultime è legatoda almeno duemilacinqaecentoanniilnomedeiRomani. Naturalmente non sipotrebbeindicaredove equando questonomesianoto;solo è certochenellapiù anticaformaanoinota imembrideldistrettosichiamavano Ramni (Ramnes) e non già Romani e questa contrazione caratteristica delpiù anticoperiodo linguistico, non più usata poi dai Latini, è una testimonianza parlante della grandissima antichità delnome. Non sipuàstabilirecon certezzaquestaderivazione, ma èpossibilecheiRomani riano la gente abitantelungoilfiume. Ma ersinon rimaserosolisullecollinedel Tevere.Della suddivisionedellapiù anticacittadinanzaromana siè conservatauna traccia, dallaqualesipuo' dedurre comeessasisinfonnala dallafusionedeitregruppi,forseuna volta indipendenti, deiRamni dei Tazi edeiLuceri, e’ ' poi ' , ’ comequindi ’ daun ' ' ,pari a quellodalqualeinAttica sorseAtene.”
Sempreriguardo al sitovi è da ricordareun’altra interessanteosservazione dellostessoautorecheriteneva improprionel casodi Roma parlare diuna fondazione alpari diuna genericacittà comeviene narrato dalla leggenda,dalmomento chenon sorsein ungiorno.Ed appare a suogiudizio significativo ilfattocheRoma siastatocapacedi “ tanto una., politica, nel Lazio, quandoper le carenti caratteristiche del suoterritorio ci sisarebbedovuti attendere il contrade Un suolodigranlungameno fertileesalubrediquellodellamaggioranza dellealtreantichecittàlatine, poverodi sorgentieper giuntadevastatodallefrequentiesondazioni delTevere.’Percontro,però: “ne?» run luogopiùdiRoma eraadatto,siacomeemporiodelcommerciolatinofluvialeemarittimo, siacome piazzaforte marittima delLazio,poiche' essoriuniva i vantaggidiunaforteposizione edellimmediata vicinanza delfiume essocomandava leduenvefinoalla/aceedera ugualmenteopportuno ecomodo ainavigatori del [ ume, discendentiper il Tevere eper ! 'Aniene, come almarinaio data la mediocre grandezzadellenavidiallora;un luogoinfinecheofi'riva maggior riparocontro lapirateria chenon i luoghiposti immediatamentesullacosta."3
Sotto il Segnodell’Aquila - PartePrima
I}
32
Sotto il Segnodell'Aquila - PartePrima
UmbertoNistn. 1919,tatoo/anodiRoma.
UmbertoNtstn. 1919,sena!photographofRame.
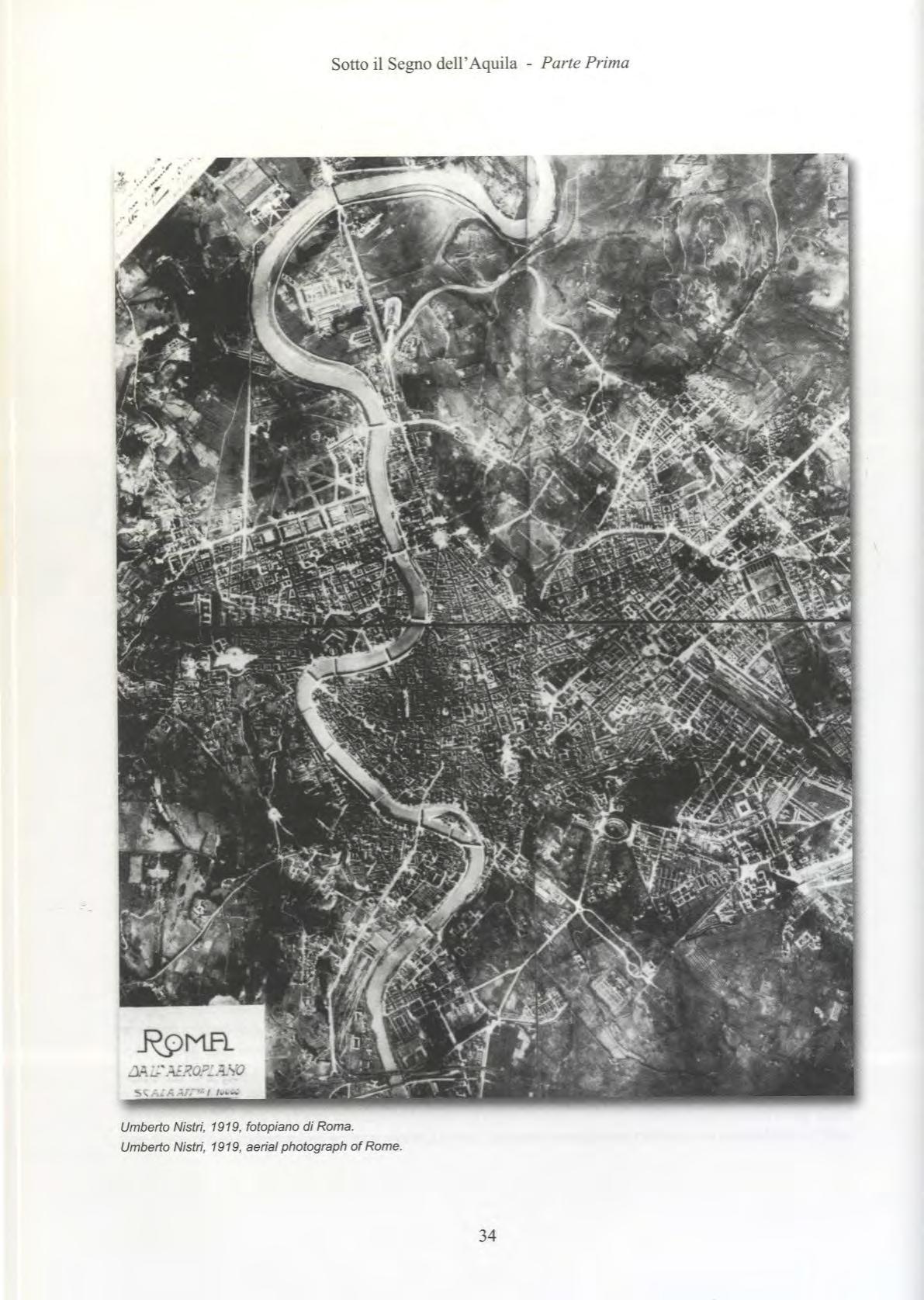
34
Con.iderandoche ilTirreno dallo strettodiMessina in suoffrepochissimi porti naturalmente validi per l'e 'genzedellanavigazione antica…questachiavedi lettura appareestremamente verosimile.tale dagiustificare pienamente un impianto in una morfologia ambientale infelice. con paludi @ acquitrini a sud e anord,unico discretoapprododaGaetaaCivitavecchia. in altri termini Roma avrebbe riprodotto 51apure inminiatura, quella che era stata la fortuna di Troia. una città-fonezzaposta presso la fece di un fiume, in un sitonodale per il controllo della navigazione mercantile.
Una scelta strategica che lascia trasparire la matrice militarista e imperialista della città sin dal suo esordioqualechefosse stato.Percui: "in questosenso, comeammetteanchela leggenda, Romaputì ere serestatapiuttosto una citta' creata chesviluppa/asi, efi-a le latine.piuttosto lapiù giovane che lapiù antica... Non epossibilefare Suppa oni se Roma sia Stata chiamata in vita da una decisione della lega latina, o dallo sguardogeniale di un dirnenticatofondalore di citta', o dal naturale sviluppodelle Caridi onicommerciali.“Dando perbuona l'ipotesi,e interessantericordare che la fortificazionedipiù frequente adozione negli insediamenti collinari, tipica dell‘epoca, era costituita da una mutazione corrente intomo alla cimao lungo la sua pendice. non necessariamente chiusa e costruita con grossi massi collocati a secco.La saldezzadella struttura,definita in termini tecnici operapoligonale. ciclopiea,megalitica () ancorapelagica. derivava proprio dall’inerziadei blocchi. mentre la sua prestazione difensiva dallacapacitàdi diluire le ondatenemiche. Inpratica una sortadi scalonechenon sipoteva superarevelocemente e eontemporaneamente in massa. con la conseguenza di consentire ai difensori il massacro degli attaccanti alla spicciola. Èper molti aspetti la tattica impiegatanello scontro fra gli Orazi e i Curiazi, trasposta in chiave difensiva
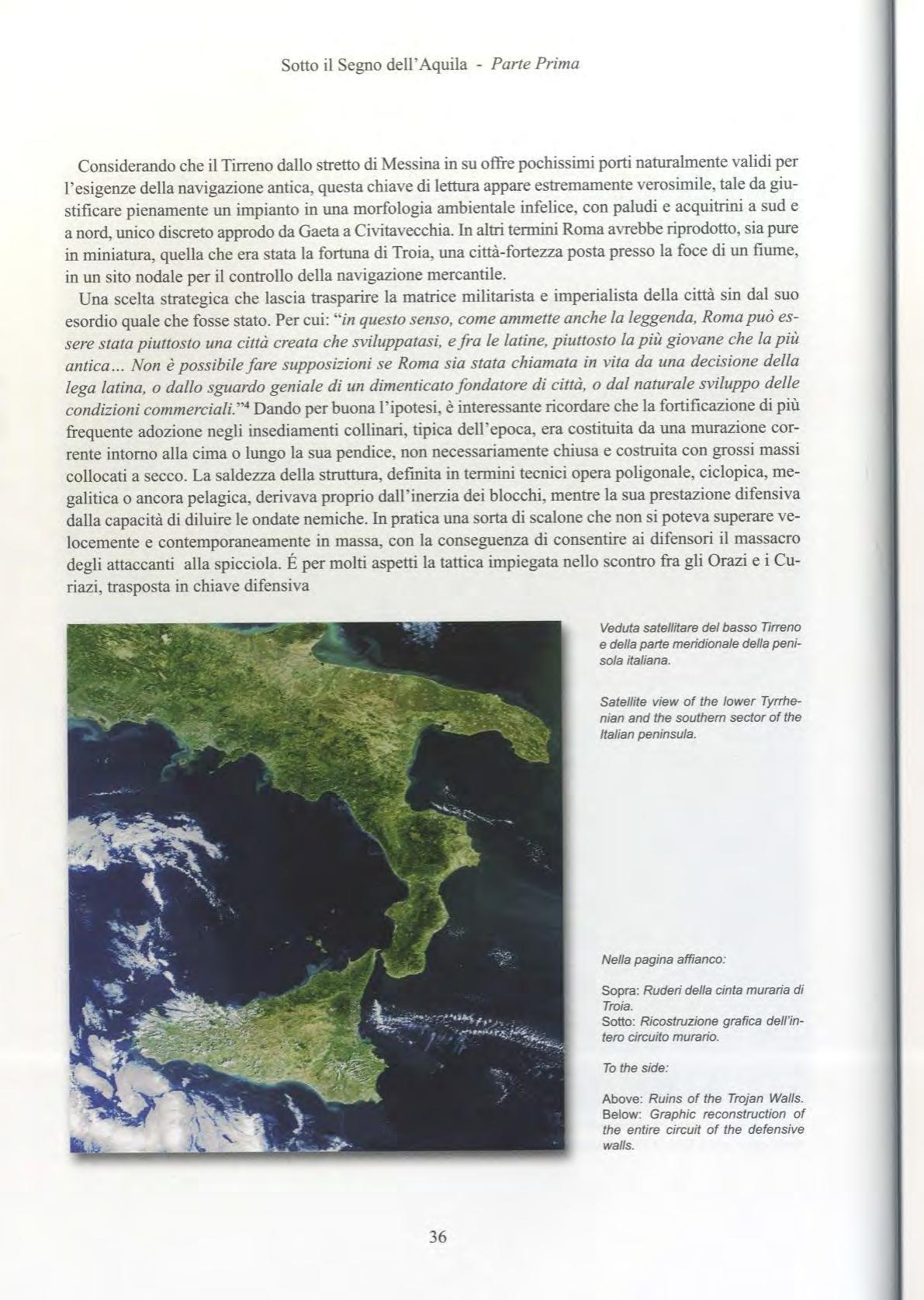
Vedi/ta Satellitaredelbasso l'arena edella parte meridionale della penisolaria/rana
Satellite view of the lower Tyrrhe— menandthesouthernsectorofthe Italianpeninsula
Nellapaginaall'ranco
Sopra:Ruderidellaetniamural/adi Troia.
Sotto: Ricostruzione grafica dell'/VP tero C/fculiomurario
To the Side
Above Ruins of the Trojan Walls
Below Graphic reconstruction of the entire crrcuri of the defensive walls
Sotto il Segnodell’Aquila PartePrima
INSEDIAMENTI ARCAICI LAZIALI
Selafortificazioneperimetmlenon dove\adi staccarsi dalla descritta, l’impianto della Roma primitiva non doveva a sua volta differire gran che dallo schema urbanistico precipuo dell'interoLaziocoevo.Indettaglio:“‘questiabitatiprimitivispessosfruttavano, volendoacquisireuna posizioneforte,lecondi:ioninaturalialienedal terreno,ponendosi sull'alto di dirupi che[aci/A mentepotevanoproteggerli...Unaforma di ap— pido caratteristico in tal senso era là dove un poggio siponeva alla confluenza di duefossi. cosi da avere in ultafiyrma grossomodo nione golare o rettangolare a due o tre lati naturalmenteprotetti, mentresolo]'allimolato.dovela collinacontinuavailrilievo versomonte, veniva adaverenecessità didifesa. Qui,spessoancora usando cond'wionifavorevolidel terreno, come una balza dominanteoilconvergeredivallecole laterali, la collina veniva isolata mediante uno sbarramentogeneralmentecostituitodaun muro eda unajbssa. Dioppidocosi/armatineconosciamomoltissimiedilsistemaeraancora mato inpiena etàrepubblicana.“
Il tipo di fortificazione appena descritto trovava ima sostanziale ed ampia adozioneanche laddove laconformazionegeologicadellepropaggini collinari invece che tufaceo era calcarea, connotazione geologica frequentissima lungo l’Appennino centrale, ambito della civiltà italica. Fortificazioni silîane venivano in generedefinitearx‘.nomechesiattaglierebbe. perfettamente, alla già ricordata etimologia di esercito.Vi è poi una curiosacoincidenzainsita inquestotipodi fortificazione:lasuadifesainiziale, peraltro quella più letale, avveniva scagliando lance e giavellotti sulle ondate che
AlcuneIomticazroniarcaicheinoperapoligonaledelt'areasannna,Dall'alto;MonteAcero,eTerravecchiadiSepino,ecc Ancientfortificatransa!theSamnrteareabuiltusingpolygo— nelconstructionmethod.Fromabove‘MonteAcero,andTen lavecchiadiSepino,etc.
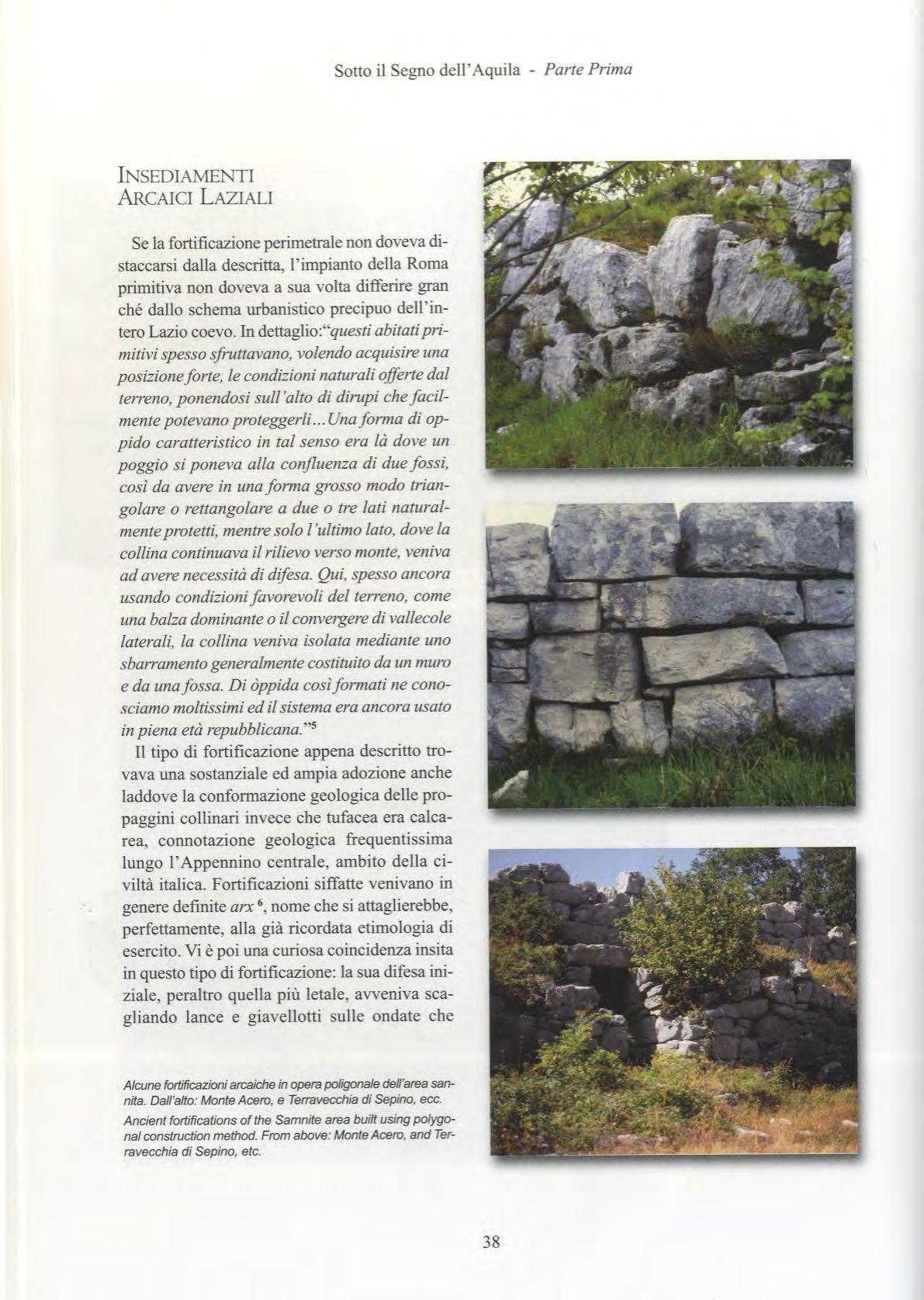
Sono il Segnodell'Aquila PartePrima
38
Sotto il Segnodell’Aquila PartePrima
tentavanodirisalire lependici, alpunto daconsiderare quellatattica complementare di quella struttura, Le duemaggiori etnieche si conteseroa lungo la supremazia militare. quella sannita e quella romana, trasseroentrambelalorodenominazionedallalancia:quiritisignificainfattiquellidellalancia,comesam— nitiilpopolodellasanniountozzogiavellotto italici)!"Del restoilriferimento allalanciasicoglieanche inalcunialtritermini latinicome,adesempioinpopulusaffineapopolari=devostore,chesiritrovanelle antichelitaniecon ilnomedipilumnuspop/us, lamilizia armatadi lancia,detta anchepilus.

TRA LEGGENDE ETRADIZIONI
Standoallatradizione il periodomonarchicodiRoma,quellodei famosi settereche siavvicendarono sui settecolli,va dal 753a.C.al 509a.C.Quantosiaverosimile una talerievocazione dinastica basta a dimostrarlouna semplicedivisioner. ognireavrebbedovutoregnaremediamente oltre33anni,successioneadirpocoportentosa! Inrealtà leoriginidiRoma,dopoladistruzionedituttelescarsefontiscritte provocata dallarazziadeiGallinel 390a.C.,rimaseroavvoltenelmistero.ScrittoricomeLiviotentarono di attenuarlo ricostruendo, oper meglio dire, ipotizmndo in età augustea quello che sarebbe stato un consonopassato per laCittà.Alla leggendasisostituìcosì ilmito, senza mutare minimamente l’irrealtà storica,pur aderendola narrazione, ditanto in tanto, aprecisi eventinodali.Pertanto sela rievocazione non risulta pienamente credibile,non èperòneanchedel tutto falsa, dal momento che ormai apparedel tuttoassodatounperiododigovernomonarchico, conclusositra il 500eil450a.C.Comepure assodato appareuna fasedidominazioneetruscadellacittà,cheinbasealletestimonianzearcheologichevienecollocataall’incircanel 600a.C.,subitodopo,in coincide…con lapavimentazione del foroper coprirela retedelle fognature.9
Prescindendodaqualsiasiriscontrogli storiciromani attribuirono,concordemente,aRomololafondazione della città e della monarchia: per la tradizione era pur sempreil nipote di Enea, il diretto legame geneticotra una città giànella leggenda ed una destinata ad entrarvi.Chimeglio di lui avrebbe potuto esserneil primo re? Meno prosaicamenteapparefin troppo evidenteche i primi quattrore costituisconouna sintesi di mitologia e dinarrazioni popolari relative ad eroi sicuramente esistiti, con invenzioni storichetese a fornire illustri genealogie alleprincipali famigliedi Roma.Abbastanza sospettala strana '‘ difigrre ‘ ‘ Romolo,ad ,“ , è il sovranoguerriero subito bilanciato daNumacheè,invece,il sovranopacifico.Analoga contrapposizionenella successivacoppia di sovrani,TullioOstilio eAnco Marzio.”Non può non rilevarsi la matrice etrusca del rituale di fondazione adottatodaRomolo ",il famoso solcotracciato daun aratro dalvomere dibronzo. Forse proprio inquestodettagliosicelal’intimaconnessionefralanascenteentitàstatualeelapiùanticacontigua, misteriosa esfuggente,dell'etniaetnrsca.Non acasol’ultimorediRomaviene ricordato come etrusco e la sua cacciata, per alcuni studiosi,potrebbe in chiave simbolica rappresentare l‘affrancamentodellacittàdaquellaarcaicadipendenza.Di certo:“con I 'avventodelladinastiaetrusca entriamo in un terrenopiù solido... E 'significativoilfattocheduedelleopereattribuiteagliEtruschi-ilponte sul Tevere eilporto di Ostio-fosserocondizioninecessarie alprogresso eal commercio. Faproprio in questoperiodo cheRoma sitrasformò in una città. I sistemidi drenaggio, la cinta difensivo delle muro, la costruzioneditempli, elerifiinne costituzionali attribuitea questoperiodo, tutto ciò costituisce !'aspettopiù importantedellacrescita urbana.Roma imparòdagliEtruschi iprincipidiarc/ria tetturo... DagliEtruschiderivòanche !’otganizzazionecomunitariaemilitarediRoma. Sipuòdireche ilsecolodella dominazioneetruscotrasfizrmà un isolatoinsediamento... in unostatomilitarecon un fortepotere Centrale"”
40
Roma:una deitrattimeglio conselvaù delle cosiddettemurì sen/inne,presso lastallone Termini Roms. una 0!thebestpreservedsemonsofthe Sen/ian Walls, locatednearthe Terminitrain station.
Ilegami,comunque,comeconfermal'archeologia,fraledueciviltàfuronoerestaronomoltissimi.Rapporto analogodelresto, peraltri aspetti epiù ingenerale.anchecongli altripopoli italici chepopolavanola Penisola,percui sipotr-ebbe giustamentesuppone unageneraleconsanguineità:tanticuginifiglidipochi fratelli! Romolo, quindi,perglituttistoriciantichifondòlacittà,mentrepermoltimodernisilimitòpiuttostoadunificareinununicoorganismo,unapletoradipiccolivillaggidefinitipogiedappollaiatisullevariecollineemergentidall’enor'rnepantanodelmediocorsodelTevere,cheunaseriedidrenaggi,perunosviluppocomplessivo diuncentinaiodichilometri,tentavadibonificaregiàdasecoli.ilnotostudiosofranceseDeLaBlanchercso— smnevainalcunesueopere,editenel 1882,cheRoma senzaqueidrenaggi,perlopiù costituiti dastrettissimi cunicoli,non sarebbeneppure potuta esistere!”Una confederazione di numerosi insediamenti inprima ap— prossimazione omogenei,abitatidaaltrettantetribù,chetrova confortonella tradizionemeno inverosimile.
Quasiavolerlaconfermare,ilcollechevidel‘infanziadiRomoloemoltodopolasededellaresidenzaimperiale,ilPalatino,ha ' ' alleindagini ‘ ‘ ' ‘ ipiùantichi ' " ' fattirisalireall‘800a.C, Di recenteè stataidentificatapure lagrottadovesecondolatradizione, in quello scorciostorico,lalupaallattò iduegemelli,anfi'attoriccamentedecoratoinetàaugustea,All’incirca contemporaneianche i villaggi sul Quirinale, sull’Esquilino e sulVicinale “, che l’accidentata morfologia dei luoghi, con profonde incisionieampi acquitriniavevaalungomantenutodeltuttoautonomi edistinti.sebbenenon distanti.Non può escludersi che adeterminare lo stringersidei contatti fra i diversi insediamenti fino alla fusionecon la for mazionediunasostanzialeunitàresidenzialedidiscretaentità,non futantolavolontàdiRomoloquantol’incremento dellapopolazione. In ogni casoquandociòavvenne.Romolo disposedella massa criticaumana per organizzarel‘archetipale forzaarmataregolaredi Roma.
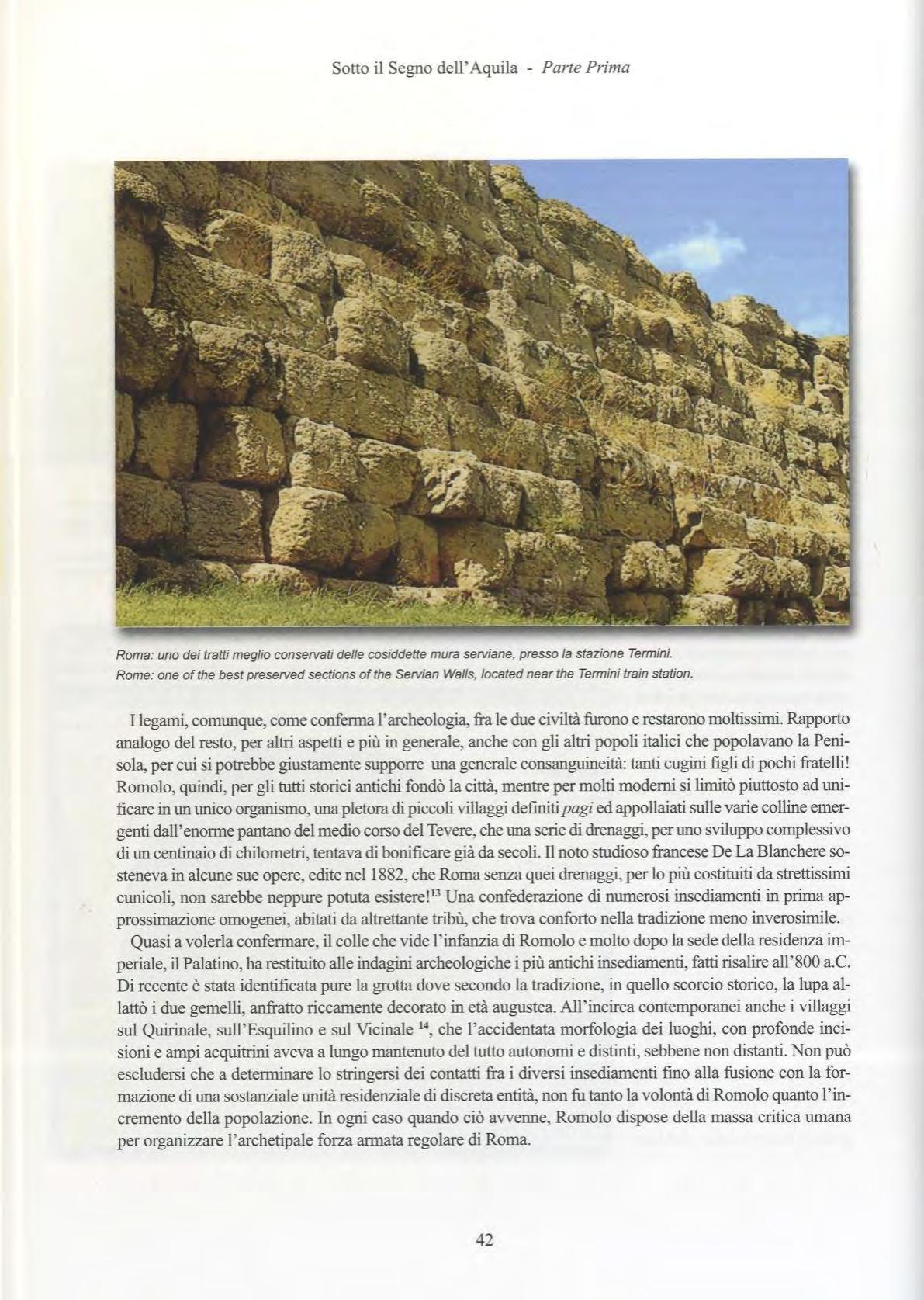
Sotto il Segnodell‘Aquila - PartePrima
42
L’ESERC1TO ROMULEO:ENTITÀ E RECLUTAMENTO
Inrealtà,comeaccennato,èmoltoprobabile chelaformapresceltaperquelprimoembrionale esercitofosseditipoetrusco,operlomeno siispirasseaquella.Maoccorse ancora del tempo perché potesse somigliare realmente al modello, per cui quando ci si riferisce all’esercito romuleo si intende una organizmzione alquanto posteriore. Di certo:“perquantoriguardaRomasisadallefonticheilsuopiùanticoesercito, alparidi quellodialtrecittà epopolidellapenisola, eracollegatocon lastrutturagentiliziadello Stato:leoriginarietrentacirroscrizioni(carie)incuieranosuddivisigliabitantiin relazioneal!'appartenenzaalletribùdeiTrties,Ramnes,Luceres,inquadrantr'diecicarie]’una, eranoingradodifarrrirediecicavalieriecentofiznti !’una,con un totalequindidi 3300 uomini.Ilrapportodiuna adieci tra cavalieriefiznti è indicativo della diflèrenziazione socialetra l'arirlocraziaagrariaeicetimediingradodiprocurarsi!'arrnamerrta:proprietariminori, artigiani, mercanti Sipuòritenerecheinquestafaselacavalleria.costituentelabasedell'organizzazionemilitarepiùantica, avesseancoraun ruolonotevole.Il comandoapparteneva alre chesiavvaleva di corna» daraiinsottordine,finseitril'mnioelerum(celereserano detti appunto i cavalieri), testimoniati anchepiù tardi innumeroditre, unaperognunadelletretribùgenetiche. Dell’armarnenloedellefirme di combattimento nulla è tramandato, ma sipuòpresumere chesiandasserogià uniformando a quelli dellafizlange oplitica, cioèconarmatura in bronzopesanteper ladifesapersonale,infasediintroduzioneinItaliadalmondogrecoorientale. Leguerredel tempo continuavanoa essere, comein età tribale,perlopiù razzieeassaltiadopera diquellicheeranoarruolati...“S
Ancheriguardoaldispositivoadottatoperlaselezione edilreclutamentoinetàmonarchicanondisponiamodi fontiattendibili,dalmomentocheneppureglistoriciromani neebberochiaraconoscenza,percuipuòsoltanto per grandi linee.Al di là della ripartizione tribalelaverasuddivisione,comeaccennato,eraquella basatasullecur-iechesembranoistituitegiàconlafondazionedellacittà.Inpraticaciascuna delletretribùgeneticheoriginalicontavadiecicarie,chesidefinivanopurecomune,eforniva centouomini di fanteriaediecicavalieri,nonche'anche dieci consiglieri,i futurisenatori. Sispiegaverosimilmente cosi chenella piùanticatradizionedi Roma siritrovino trenta cur-ie,percuisiebberotrecentosenatori,trecentocavalieri etremila fanti.Suddivisioneschernaticachefilprobabilmente comuneatutti i popoli di stirpelatina.
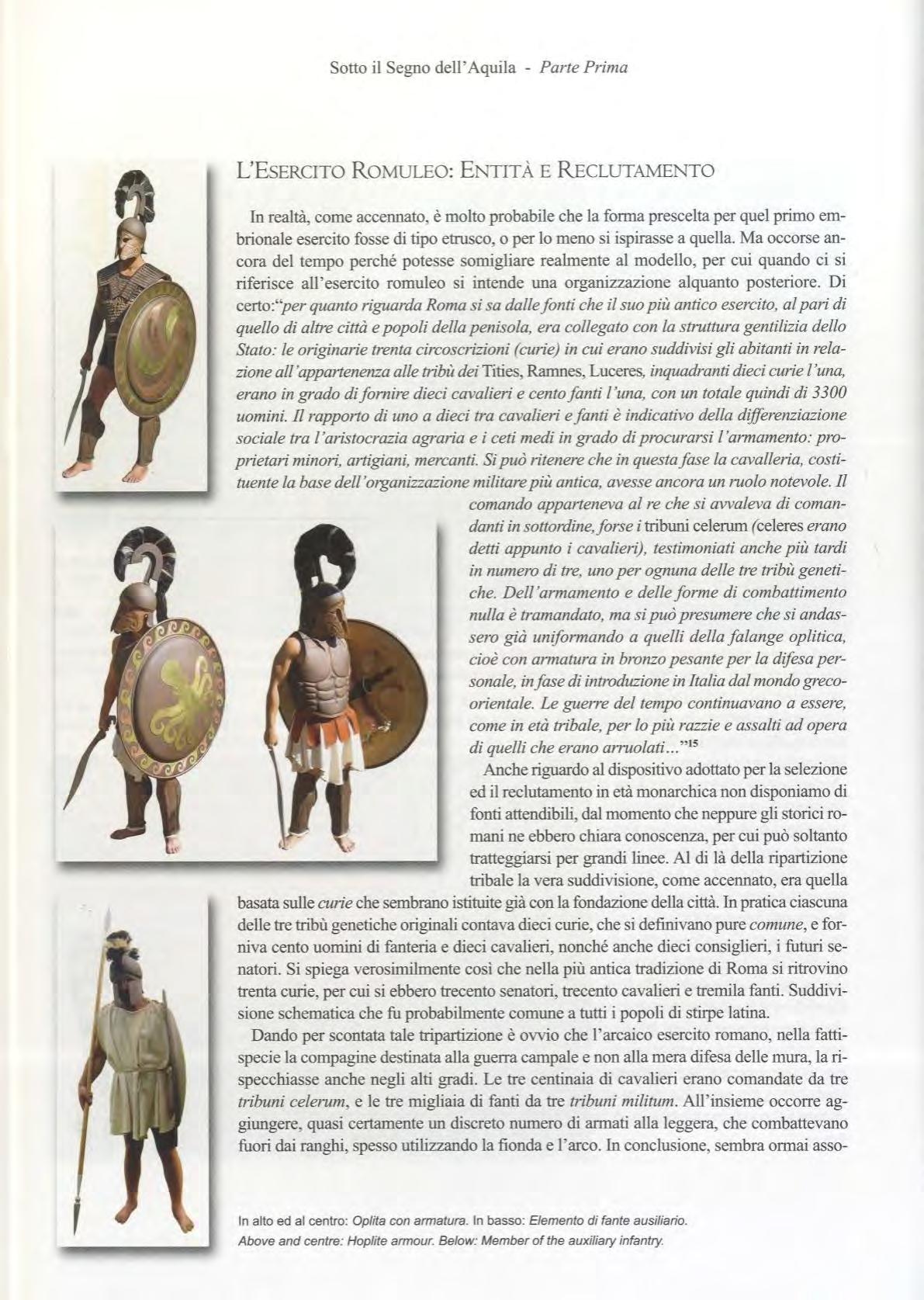
Dando per scontata taletripartizioneèovvioche l‘arcaicoesercitoromano, nella fattispecielacompaginedestinataallaguerracampaleenonallameradifesadellemura,lari— specchiasse anchenegli alti gradi… Le tre centinaia di cavalieri erano comandate da tre tribuni c‘e/eram, e letre migliaia di fantida tre tribuni militum…All’insieme occorre aggiungere,quasi certamenteun discretonumerodi armati allaleggera,che combattevano fuoridai ranghi,spessoutilizzandolafiondael'arco.Inconclusione.sembraormaiasso-
ln altoed al centro: Oplttacon armatura. In basso: Elemento difanteausiliario.
Aboveandcentre?Hop/itearmour. Below:Memberoftheauxiliaryinlantly.
Sottoil Segnodell‘Aquila — PartePrima
Sottoil Segnodell‘Aquila - PartePrima datoche quel primo esercito schierasseun organicoecce» dentei 3000peditese i 300L‘E/EYES, fornitirispettivamente inragionedi milleedicentodaciascunadelletretribùoriginarie.Ma soltantoaquelletre migliaia etre centinaia fu datoilnomedi legioneo.forse,neebbesoltantoleconnotazioni archetipali essendo, nella realtà. alquanto più modesto. In ogni caso si deve immaginare unaz‘fforza puramentepatrizia. L’afllusso dinuoviabitantidai colli circostanti,elaloroorganizzazioneinnuovetribù, lomutò in un esercitoprevalentementeplebea, aumentandoneal tempostessoledimensioni.
Questaorganizzazioneera tradizionalmenteattribuita non ai Tarquini ma a Servio Tullio, re inlermediofra i due"“
LA RIFORMA DI SERVIOTULLIO
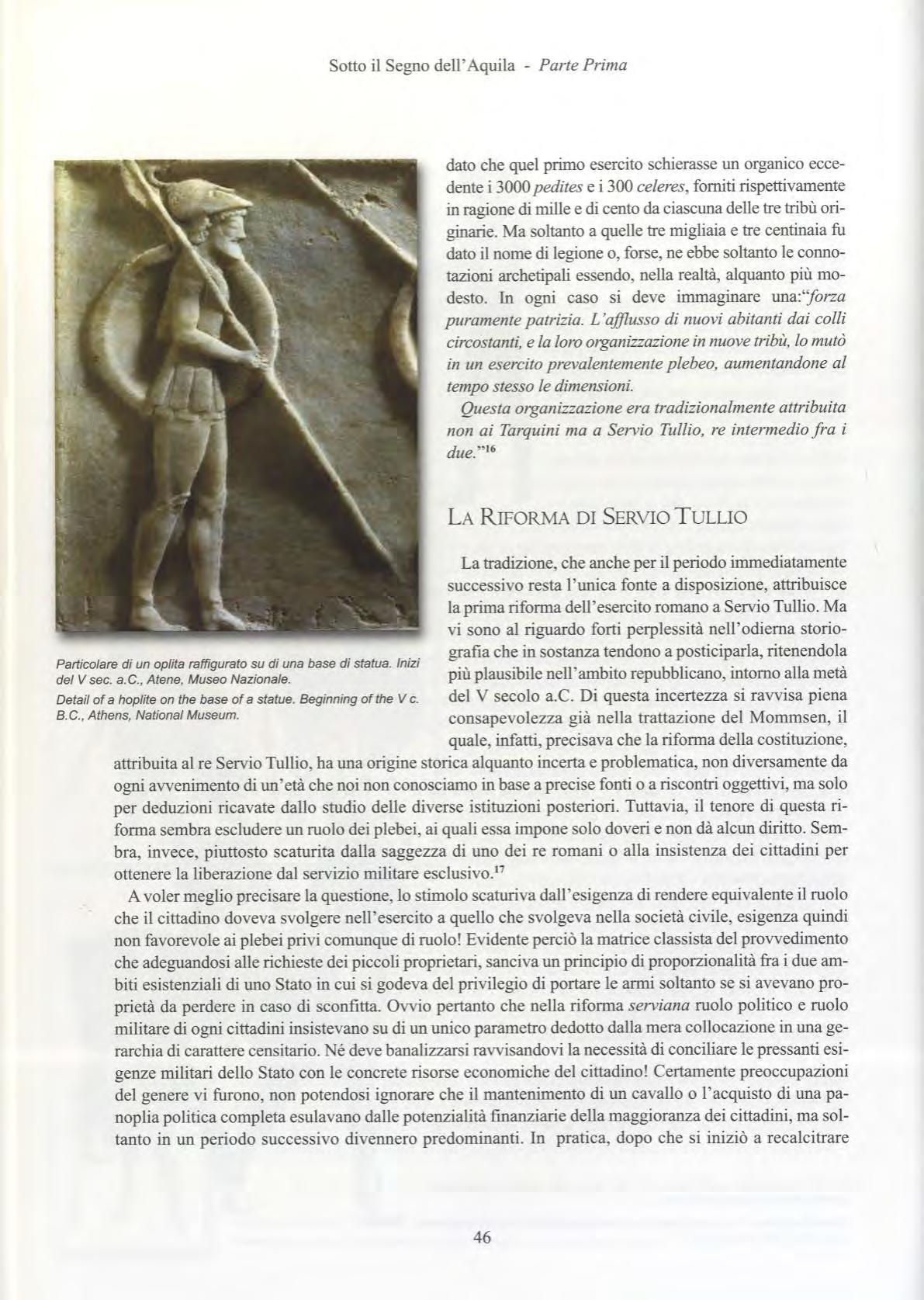
Latradizione,cheancheperilperiodoimmediatamente successivoresta l’unica fontea disposizione, attribuisce laprimariforma dell’esercitoromanoa ServioTullio.Ma vi sono al riguardo forti perplessità nell’odiema storiografiaeheinsostanzatendonoaposticiparla,ritenendola
Particolarediun Dplita raffigurato sudiuna base diStatua.Inizi deivsec,ac,.Atene, MuseoNazione/a piùplausibilenell’ambitorepubblicano, intornoallametà Detailolahopiite onthebaseafastatue.BeginningstilleVe. del V secolo aC. Di questa incertezza si ravvisa piena H.C.,Àthens' Na“°"alMuseum consapevolezza già nella trattazione del Mommsen, il quale,infatti,precisava che lariforma dellacostituzione, attribuitaalreServioTullio,ha unaoriginestoricaalquantoincertaeproblematica,non diversamenteda ogniavvenimentodiun’etàchenoi non conosciamoinbase aprecise fontioariscontrioggettivi,ma solo per deduzioni ricavate dallo studio delle diverse istituzioni posteriori. Tuttavia, il tenore di questa riformasembraescludereun ruolodeiplebei,aiquali essaimponesolodoveri enon daalcundiritto. Sembra, invece, piuttosto scaturita dalla saggezza di uno dei re romani o alla insistenza dei cittadini per ottenerelaliberazione dal serviziomilitare esclusivo.”
Avolermeglioprecisare laquestione,lostimoloscaturivadall‘esigenzadirendereequivalente il ruolo che il cittadinodoveva svolgerenell‘esercitoa quelloche svolgevanella società civile, esigenzaquindi non favorevoleaiplebeiprivi comunquediruolo!Evidenteperciòlamatriceclassistadelprovvedimento cheadeguandosi allerichiestedeipiccoli proprietari,sancivaunprincipiodiproporzionalità fraidueam» biti esistenziali diuno Statoin cui sigodevadelprivilegiodiportarele armi soltantosesiavevanoproprietà da perdere in caso di sconfitta.Ovviopertanto che nella riforma serviana ruolo politico eruolo militarediogni cittadini insistevanosudiununicoparametrodedottodallamera collocazioneinunagerarchia dicaratterecensitario.Nédevebanalizzarsiravvisandovi lanecessitàdiconciliarelepressanti esigenze militari dello Statoconle concreterisorse economichedel cittadino! Certamentepreoccupazioni del genere vi furono,non potendosi ignorare che il mantenimento di un cavallo ol‘acquisto diuna panoplia politica completaesulavanodallepotenzialità finanziariedellamaggioranza dei cittadini,ma soltanto in un periodo successivo divennero predominanti. ln pratica. dopo che si iniziò a recalcitrare
46
Sottoil Segnodell‘Aquila - PartePrima dinanzi al compitodi aiutarela comunità,riguardando quello che inprecedenza era statoun privilegio comeun deprecabile obbligo.“
Conlariformaserviana,contutteleriservesuddette,sipassòdall’organizzazionecuriata,chetuttavianon venne soppressa,all’ordinamentocenno-iato,dalnomedellacenturia. In dettaglioaifinidella levaServio TulliosuddiviseilterritoriochealloraformavaloStatoincircoscrizioniotribù,dellequaliquattrourbane, con inomideipiù importanti quartieri ovvero Suburana,Palatina,Esquilina Colina, eben sedicirustiche ilcuinomefutrattodallefamigliecheviavevanolemaggioriproprietà. La città,grazieatali innovazioni, neebbeun immediatovigorosoimpulsoallo "..…. ,resopiù "" dall" determinato dall’integrarsi con le antichepopolazioni diun grannumero di immigrati,attratti come sempre dalleprospettive dibenessereedi lavorocheRomaofiîriva.Forsefuronoproprioquellenuovepotenzialità chepermiserounapolitica di eSpansioneediprimatonel LazioaTarquinioilSuperbo."
Inpratica,ilnuovoordinamentodeicomitiacenturiarilasciavanellemanidellacomponentesocialepiùabbienteilpoteremilitare,distinguendoinbasealcensoilrangodiappartenenzaaifinidell‘inquadramentonell’esercito.Allo scopo,pertanto, l’interapopolazione maschile idonea alleannivenne suddivisa in cinque classi.Aldisopradellamaggioresicollocatonoicittadini ingradodiservireacavallo,echequindicostituivanolamiliziaacavallo(equites).Più indettaglio,standoaLivio:“coicittadinicheavevanoun censodicentomila assi o più si firma" ottanta centurie, quaranta di anziani e quaranta di giovani, chiamati complessivamenteprima classe:glianzianidovevanotenersiprontialladifetadella città, igiovania combatterefizori;comearmaturafiu'onoadessiprescritti!'elmo,ilclipeo,glischinieri, lacarme;questearmi, tuttedibronzo,dovevanoservirealladifesadelcorpo;armio_[fensiveI’unaeilgladio.[...]lasecondaclasse erafirmatadacolorocheavevanouncensotraicentomilaeisenantacinquernilaassi,econessi,traanziani egiovani,fitronofinnateventicenturie;armiprescritteloscudoinvecedelclipeo,e, trannelacorazza,tutte quelledellaprima classe. Stabiliperlataza classeun censominimodicinquantamilaassi;fixronofirr-rnate altrettantecenturie,distinteanch’essecon lostatocriteriodell”età:quantoallearminon v'eraalcratadif ferenza, trannechefizronotoltiglisehirrieri.Perlaquartaclasseilcensoeradiventicinquemila assi;altrettantelecenturie,madiverselearmi:fiuonoprescrittisoltanto]’astaeilgiavellotto.Piùnumerosiicittadini dellaquintaclasse,concuisiformaronotrattacenturie;essiponavanofiondeepietredagetto[.…].Ilcento perquestaclasseeradiundicimilaassi.Ilcensoinferioreaquthcompresetuttoilrestodellapopolazione; senefirrmàunasolocenturia,esentedallamilizia.Armataeordinatacosilafanteria,formòcoimaggiorenti dellacittàdodicicenturiedicavalieri;creòparimentialtreseicenturie,inluogodelletreistituitedaRomolo, mantenendoglistessinomicheavevanoavutoal!'attodellalorocostituzioneconsacratacongliauguri.Per I ”acquistodeicavallifidnonoversatidalpubblicoerariodiecimilaassi. Tuttiquestioneriricadderodaipoveri suiricchi.Ma essiebberopaimaggioridirittipolitici.Ilmfi”ragio, infatti,nonfixconcessopertestaatuttiirtdistintamentecon lastessaforza elostesso valore, secondolaconsuetudinetramandata da Romolo edosi servato dain altrire; mafa creata una gradazione, sichenessuno apparisseescluso dal sufl"ragio, ma praticamente I ‘autoritàfossetuttanellemanideimagiorenti, Infizttisichiamavanoavotareperprimiicd; valieri,poi I ’attantacenturiedellaprimaclasse:senonsiraggiungevaun accordo—ilcheaccadevadirado— sichiamavanoquelledellasecondaclasse;manonsiscesemaitantogiùdaarrivareall’ultirna.’“

ASPEiTI ECONOMICO—SOCIALI DELLA RIFORMA SERVIANA
Daun punto di vista strettamentemilitarei cittadinimaschi idonei allearmi,di etàcompresafrai 1718armi ed i 60,eranosoggetti al serviziomilione, sia che fosseroromani, forestieri o,persino, liberti a patto però di avereunaproprietà inRoma. E inbaseallasuaconsistenzaeconomica,dovevanoarmarsi
48
secondoleprescrizioniricordate,Vièdaricordare, al riguardo,una singolaredisposizionefiscalechefaceva riferimento ad una entitàdi base che era il podere. Chi l‘avesseposseduto interamente veniva inclusonellaprima classe,obbligatoalservizioconl‘interaarmaturapolitica; i restanti finivanonellealtre quattroclassi secondoun dispositivocheprevedeva l’inserimento nella seconda per ipossessori di 3/4 dipodere nella terzaper iproprietari diuna sola metà nella quartaper i proprietari diun quarto e nella quintaper quelli diun ottavo.Pertantotenuto contochesecondo:“laripartizionedelsuolousata inquei tempi, quasi la metà diessoera costituitodapoderi interi; ognigruppodicoloro chepossedevano tre quarti0la metà oppureun quartodipodere corrispondeva adun ottavoscarsodellapopolazione. Gli ottavidipodereeranotenutida un altroottavoabbondante…Per la leva dellafanteria eraquindistabilitochedifronteadatlantaproprietaridiunpodere interosiarruolassero venti da ognunodeglialtri tregruppieventotto dall'ultimo.““

Al di làdelladefinizione,chediper sénon è quantizzabile direttamente,acosasideve farcorrispondereuninteropodere,cioèaquantiettariodierni?Una seriedideduzioni,dalmomentocheancheinquesto caso nulla ci è pervenuto, lasciano supporre che fosse di circa 20 iugeri. Ora lo iugero, come l’etimologiasuggerisce,eralaquantitàditerraarabileinunagiornataconuna coppiadibuoi aggiogata, da iugum-giogo. Facile a questopunto equipararlo a circaun quartodi ettaro,ovveroa 2500mq. Pertanto ilpodereromano sidevesupponedicirca 5ettari,entitànon particolarmenterilevante soprattutto tenendocontodelladensitàdemograficadell’epoca Inognicaso,sebbenenonvengaesplicitamentetramandato un sistema del generepresupponeva un catastodella proprietà fondiariaperfettamente tenuto edaggiomato,dovenon solofossero =' i, ma fossero registrati ipassaggi diproprietà. Ilcheimplicavaunarevisionesistematicaeperiodica delcatastostesso,inmodo da disporre di ruoli anagraficiperla leva aggiornatieattendibili.
UNITÀ DI SUPERFICIE ROMANE
HEREDIUM pari a due iugeri dra 1I2ettaro
CENTURM pari a 100heredium, 200 iugeri,cirm 50ettari
Surus pari a4centurie.800iugeri,circa 200 ettari
Ai fini della leva,come accennato.lariforma serviana divise la cittàeil territorio limitrofodi appar. tenenza inquartieri,owiamentequattro,dettitribus,dacuiilgradoditribuno, Tuttaviaquestetribù, da non confondersi con le genetiche, devono intendersi piuttosto comedistretti, dei quali il primo comprendeva la città antica, il secondo la nuova, il terzo il vecchio sobborgo murato successivamente, il quartoquellounitoallacittàconlacerchiadi ServioTullio."Quasi certamentealdi fuoridiognidistretto il territorio " sarà stato " di sua, ', , in modo di renderesostanzialmente equivalente il numero di uomini di ciascun distretto. Qualeche ne fosse il criterio informatore, anchenelle definizionideidistrettisiravvisa nelleriformeservianeiltentativodi razionalizzarel’intero settoremilitare, Infatti nel suointerocomplessonon siriscontraalcunprowedimentochenon abbiauna chiara attinenza ()una esplicitarelazione al serviziomilitare.Persino la norma che escludeva dalle centurie, chiunque avessegià superato i sessant’anninon trova altragiustificazione senon quella inerente ai limiti di etàdel servizio…“
Da quanto finora delineato, emerge una sorta di paradosso per l’esercito romano monarchico, paradosso che permar'rà anchein quello di epoca repubblicana, I suoi membri per essere ritenuti degni di
Sottoil Segnodell’Aquila - PartePrima
50
farneparte eperesserviammessidovevanodimostraredidisporrediuncenso,ovverodiaveredelleproprietà fondiarie,Anzipiùrisorseavevanopiù dovevanospendereper rispettare leordinanze sugliarmamenti,Considerandoinoltrechel‘entitàdelcenso,puressendoconsiderataindenaro,erainrealtàrelativa adunpossessoterriero lacuiredditività non può considerarsicostante,il sacrificiorichiestonon appare indifferente e lasciaaditoa molti interrogativi… Perche' avendopiù terra si doveva sostenereuna spesa maggioreper andarein guerrainprima linea,dovelamortalità sipresume maggiore? Quale erailcriterio informatore di quella scelta alla rovescia, almeno secondo il nostro attuale metro di giudizio? Per cercare dichiarirez“l'insuflirienza diun interpretazionepuramenteutilitarirtica diquestaleggedipro— porzionalità dellefunzionimilitari epolitiche all’interno della città antica [edi Roma in particolare n.d.A.]spingerernol'analisiin un campoadiacente:quellodeifondamentiqualitativi. enonpiù quantitativi, dellacittadinanza…Inefi"ettiilbuonsoldatocoincidevacon ilproprietarioterriero, nonsoloperche'quelloerailtipodiricchezza difi‘ìciledasottrarre, in casodisorteavversa, allebramedelnemico, mentre erafacilefizrla con ibenimobili;ma ancheperché illavorodella terra…per ilcittadino e'una scuoladivirtù, doveegliimparalequalita'dell’accortezza,dellafina edellagiurtiziachecostituiscono ilfondamentodelvaloremilitare.?“
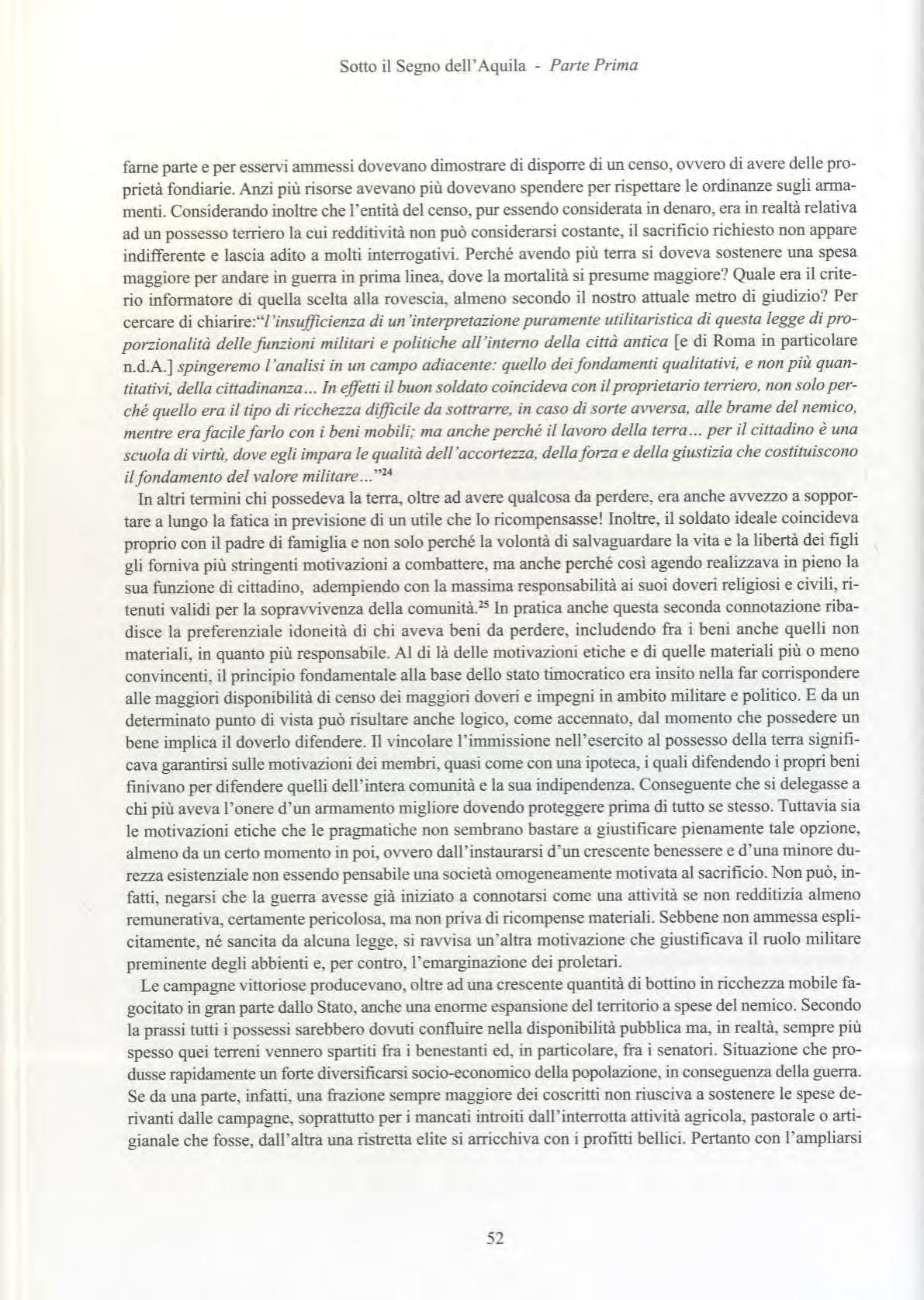
Inaltritermini chipossedeva laterra,oltreadaverequalcosadaperdere, eraancheawezzoasopportarea lungola faticainprevisione diun utilecheloricompensasse! Inoltre,il soldatoideale coincideva proprio conilpadredi famigliaenon soloperché lavolontà di salvaguardarelavita elalibertà deifigli gli fornivapiù stringentimotivazioniacombattere,ma ancheperche cosi agendorealizzavarn pieno la sua di ' ’ con la ' , ilitàai suoidove1i religiosi ecivili,ri» tenuti validi per la soprawivenzadella comunità.15In pratica anchequesta seconda connotazioneribadisce la preferenziale idoneità di chi aveva beni da perdere, includendo fia i beni anche quelli non materiali, in quantopiù responsabile.Al di là dellemotivazioni eticheedi quellematerialipiù omeno convincenti,ilprincipiofondamentaleallabasedellostatotimocrat:icoerainsitonella farcorrispondere allemaggiori disponibilitàdicensodei maggiori doveri eimpegni inambitomilitareepolitico, E daun determinatopunto di vista può risultare anche logico, come accennato, dal momento che possedere un bene implicail doverlodifendere.Il vincolare l’immissione nell’esercitoalpossesso della terra sigtificavagarantirsisullemotivazionideimembri,quasicomeconunaipoteca,iqualidifendendoipropribeni finivanoper difenderequellidell’intera ‘ elasua ” “ (‘ che si a chipiù aveval’onered’unarmamentomiglioredovendoproteggereprimadituttosestesso,Tuttaviasia lemotivazioni eticheche lepragmatiche non sembranobastare a giustificarepienamente tale opzione, almenodaun certomomento inpoi,ovverodall’instaurarsid’uncrescentebenessereed’unaminoredurezzaesistenzialenon essendopensabileunasocietàomogeneamentemotivataalsacrificio.Nonpuò, infatti, negarsi che la guerra avesse già iniziato a connotarsi come una attività se non redditizia almeno remunerativa,certamentepericolosa,manon privadiricompensemateriali. Sebbenenon ammessaesplicitamente, né sancita da alcuna legge, si ravvisa un’altra motivazione chegiustificava il ruolo milimre preminente degli abbientie,per contro,l‘emarginazionedeiproletari.
Lecampagnevittorioseproducevano,oltreadunacrescentequantitàdibottinoinricchezza mobilefagoeitatoingranparte dalloStato,ancheunaenormeespansionedelterritorioaspesedelnemico.Secondo laprassituttii possessi sarebberodovuticonfluirenella disponibilitàpubblica ma, inrealtà, semprepiù spessoqueiterreni vennero spartitifra i benestanti ed, in particolare, fra i senatori, Situazionecheprodusserapidamenteun fortediversificarsisocio-economicodellapopolazione,inconseguenzadellaguerra. Sedauna parte, infatti,una finzionesempremaggioredei coscrittinon riusciva asostenerele spesederivantidallecampagne,soprattuttoperi mancati introiti dall’interrotta attivitàagricola,pastorale oartigianaleche fosse, dall’altrauna ristretta elite si arricchivacon
Sottoil Segnodell’Aquila - PartePrima
52
i profitti bellici. Permuto con l’ampliami
delle conquistementre la stragrandemaggioranza dei coscritti cittadini si irnpoveriva, l’aristocrazia se— natoriale si appropriava degliutili che l’imperialismo romanoproduceva. In particolare si accaparrava, di fattoe spessoanchedi diritto,dellaparte migliore emaggiore deibottini di guerra, ovverodell’ager romanuschesiaccrescevaaoltranzaconleconfischediterritorioimposteaivinti."Comecon precisione ricordava Appiano"’,inbreve tempo diquegli ampipossedimenti illegaliz“iricchisene considerarono proprietari…Acquisiranograzieallapersuasione, oppureinvasero con la violenza lepiccoleproprietà deicittadinipoveri che confinavanocon loro. Vastidominipresero ilposto dellepiccole eredità. Terre egreggifitronoaffidateadagricoltoriepastoridicondizioneservile.perevitare I ”inconvenientechela coscrizionemilitarepotessefarpauraauominidicondizionelibera...Datuttequestecircostanzerisultò cheigrandidiventaronoricchissimiechelapopolazione... degliuominiliberi,per rifletta deldisagio, delletasseedelserviziomilitarecheliprostrava vennea diminuire./”’
Scusate,allora, concludere che l‘esclusione dei ceti proletari dai ranghi superiori dell’esercito, non fosse una mera conseguenza della loro incapacità ad armarsi in modo adeguato, deficienza che da un certomomentoinpoi avrebbepotutofacilmenteessererisoltaaspesedellostato,maunaprecisavolontà di esclusione…Pertanto sidevecrederecheilbasilareprincipiodella suddivisionegerarchicamilitare in funzionedellapropria capacità adattuarsi edel massimo interesse alla difesa, aveva finito per lasciare ilpostoadunaconcezionedeltuttonuovachesoloapparentementesomigliavaconquella.Inbreve ilpotere spettava a chi aveva un adeguatocenso,sem alcuna altra giustificazione! Stando a Ciceronotale singolareconcezionerisaliva allostessore Servio,valeadireaiprimordi diRoma,e semai fosserimastoqualche dubbioalriguardo fu elaboratapureuna teoria finalizzata a spiegarel’esclusione dal serviziomilitaredelproletariato."
ENTITÀE SUDDIVISIONÎDELL'ORGANÎCO
Daquantoappenaespostoloschieramentoadottatodallariformaservianapergrandilineepuòcosì sintetizzarsi: la legione romana continuava adessere, come era stata fino ad allora, la fondamentaleunità militare di fanteria;una falangedi tremila uomini, compostaearmatanella suainterezza secondol’anticamanieradorica.Tatticamentesischieravasopraseifile,presentandounfrontedicinquecentouomini equipaggiati di tuttopunto,coadiuvatidaaltri milleeduecentonon armati,detti velitesovelati,”Labasilaredivisionetra seniores,fra i 47 ed i 60anni,ejuniores, fi'ai 17ed i 46, lascia prefigurare una duplicità vigentepurenellemansionimilitari fraquellesedentarieequellecampali,ovverodiguarnigione nelle fortificazionie,più in generale.di difesaleprime edimanovra sultenitorio e,più in generale,di attacco le seconde… Proprioper quest'ultima trova senso la suddivisioneper censo, rese bene evidente, persinodalontano,daldiversoarmamentoindividuale.
Imilitidellaprimaclasse,infatti,dispostinelleprimefileeranodotati di scudorotondo, di schinie1i, di corazza edi elmo,nonché di spadaelancia,anni acquistatealorospeseedi loroproprietà. Il che, implicitamente,lasciasupporreuna certa variabilità formaleefunzionalefrale stesse.Inogni casosi trattava di fanteria pesante, corrispondente in sostanza a quella già definita dai greci degli opliti e schierata appunto nelle prime file della formazione falangistica. La seconda classe disponeva in sostanzadiun similearmamentarioadeccezionedelloscudo,cheeradi formaoblunga,sceltache, sempre implicitamente, sottintendeil venir meno della necessità della corazza.Anche in questo casoper comprenderelalogicadelleprotezioni bisogna fareriferimentoallaformazionefalangisticaedallasua tattica di combattimento, che più innanzi verrà schematicamente rievocata. La terza classe, manteneva le connotazioni della secondasenzaperò gli schinieri,altroriscontro della suaposizionepiù ar-

Sotto il Segnodell’Aquila - Parte
Prima
54
rctrata e quindi riparata, Seguivano la quarta, che disponeva soltanto di lance e giavellotti, senza alcuna protezione passiva, e infine la quinta. altrettanto leggera ma armata esclusivamente di fionde quandonon soltanto di sassi, L‘armamento da lancio & scoglionato in base alla gittata delpropulsore, davanti le lance capaci di colpire fino ad una trentina di meri edietrole fionde.capaci a lorovolta di percuotere fino ad un centinaio.Lo schieramento,pertanto appare accortamente calibrato per infliggerecrescentiperdite con il sen'arsidelledistanzeapartiredalcentinaiodimetri finoalla fasedell’urto. Assodato chedopola riforma serviana l‘entitàpresumibile degli arruolabili nel nuovoesercitofosse diun paio di decinedi migliaia diuomini, econsiderando l’organicod‘una legionedell‘epoca, sene deve ipotizzare un numero non inferiore a quattro unità. Per l'esattezza due coppiedi due. Pertanto quando necessario:“di solitosimettevano in movimento duelegioni; le altre due rimanevano come presidio:percuiInformazionenormaledellafanteriasicomponeva diquattrolegioniparia 16.800 uomini, di 80 centuriedellaprima classe.di20perciascheduna delleseguentitre, di28dell'ultima, non compresela duecenturiedisupplentinonchéquelledeglioperai edeisuonatori. Siaggiungeva la cavalleria chesommava a 1800 cavalli, un terzo della qualeera riservato aimembripolitici del comune; quandoperò sientrava in campagnasisolevanoassegnaresoltantotre centuriedi cavalli adogni legione.
Lo statoabitualequindidell'esercitoromano diprima eseconda chiamata ammontavapressochéa 20.000 uomini, il qualenumero avrà senza dubbio in generale corrisposto allo stato effertivo dei Romani atti a portar armi nel tempo in cui vennero introdotti questi nuovi ordini di milizia.””
Selagrandeunità tattica uscita dalla riforma serviana può ritenersi archetipale di quella che sarà in epocaposteriore la le— gione propriamente detta,diprecipua concezioneromana,tanto il suo armamento difensivo e offensivo quanto la sua modalità di schierarsie,so— prattutto, dicombattere appaiono di indubbia ispirazione greca.
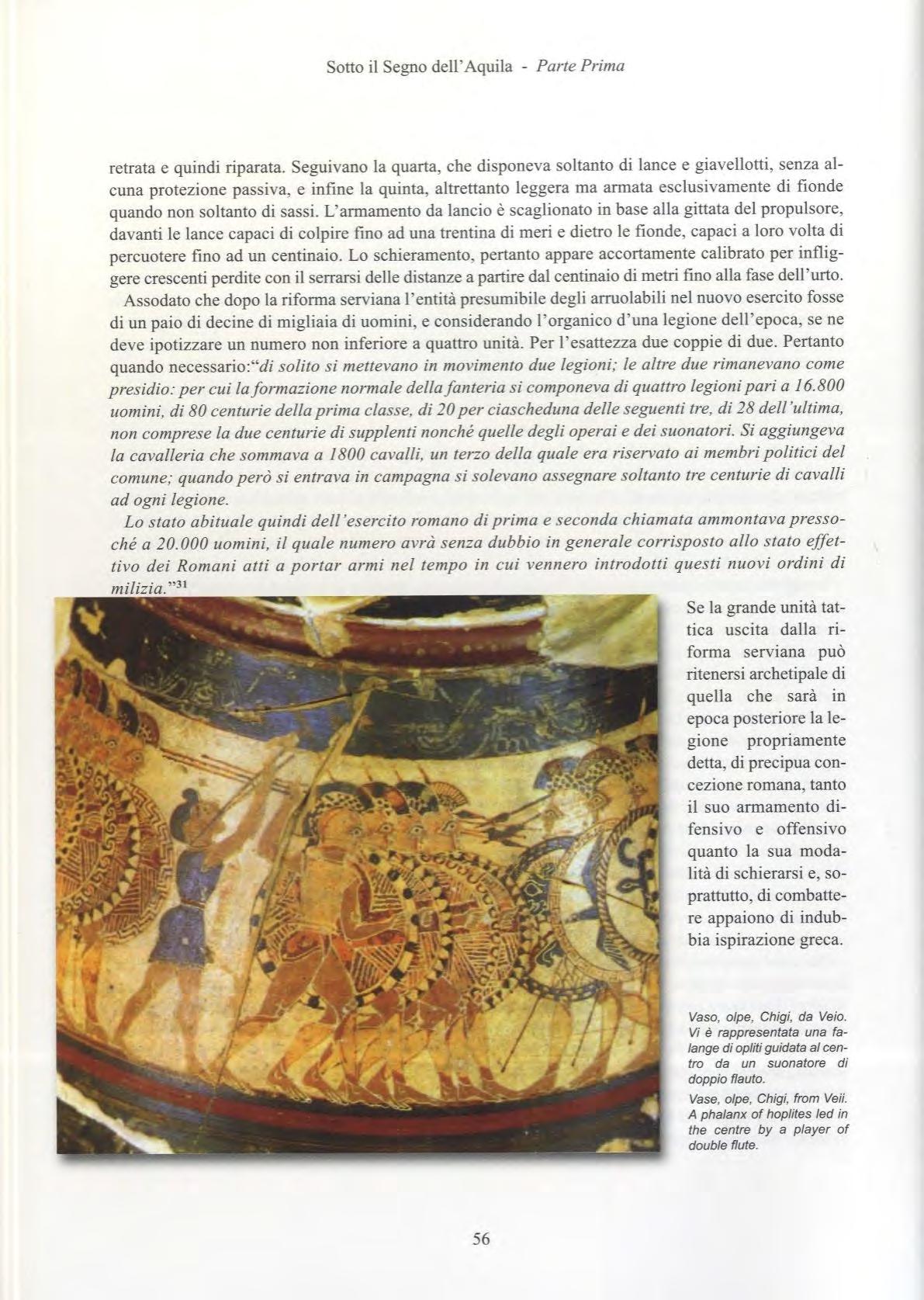
Vaso. alpe, Chlgl, da Veio… Vi èrappresentata una falangedioplìtlguidataalcentro da un suonatore di doppioflauto.
Vase, alps,Chigi,fromVeil. Aphelsnxofhop/itesledin the centre by .!player of doubleflute,
Sottoil Segnodell‘Aquila - Parte
Prima
56
ARMAMENTI DIFENSIYI E OFF sm, INDIVIDUALI E COLLETTIVI
Esattamentecome lafalangemacedone.cheattinse il suoapiceottimale in quella realizzata da Filippo ll eperfezionata dal figlio Alessandro. anche la legioneromana puòconsiderarsi discendentedallaclassicafalangegreca.Tuttavia le sueforti caratterizzazionipeculiari. il suospiccatoadattamentoa]carattere e alla morfologia del territorio centro meridionale. la trasformarono in una formazione tattica talmente originale da giustificame l’irrevcrsibile abbandonoal mutare dei teatri di combattimento.Nel periodo in esame,però, la sua derivazione dal modello dorico e ancora ben evidente. soprattutto quando si schierava in formazionedi combattimento. ovvero con le famose sei lineedi 500 uomini. La legionediquest'epoca, infatti,siconfermadi tipo oplitico, il che significa che l‘autore di questa riforma.pur adottando un re— clutamentosubase censitaria,restòper le modalità di combattimentoquella degli etruschi dellasecondametàdel VII secolo,in formazioneserrata,schierandodinanzi all’interoesercitouna solalineadi opliti armaticonl’interapanoplia, limitazionechederivòcertamente dall’impossibilitàdi dotaretutti con la stessa panoplia?Z Quantoal significatodi panoplia, il termine derivava dal grecopan. tutto. e tip/ia. armatura. quindi una corazzatura estesa alla maggiorparte del corpo.
Ma quali furonoipresupposti socialidell’adozionedellaformazione falagistica e, soprattutto, in cosa consisteva l‘annamento opl' 'co da renderlotantoonerosoche,magari inizialmente, sololeclassi più ab— bienti potettero permetterselo‘! Stando alla tradizione:“lo comparsa del]'annamentoopliticoediunaformazionedibattagliafandata sul sensodisolidarietàelospiritodi disciplina... [vannorelazionati]con l’ampliamentodelcoercivico. contemporaneoallanascitadellacittà. Manon vi è accordofraglistoricisull'elementoche, in questoduplice evoluzione, svolse un ruolo dispinta. Per alcunifu ilprogresso tecnico dell'… ciò che, " combattimento. costrinse]‘aristocraziaadassociare!insiemedeicittadini olla difesa della comunita‘ ea condividere. perciò, l'esercizio delpoterepolitico. Per altrifu invece il modificarsidel rapportofra leforzesociali1'elementoche,spodestando]'ar-istocraziadeisuoiprie vilegipolitici, determinòlacosti! zionediunaformazionedibattagliafavalevole alle azioni di massa, nonché l'invenzione di un armamento adeguato.Ma... sièpmposta recentementeuna terza soluzione, secondo laquale1afalangeoplificasarebbestatoinizialmenteun merostrumento tecnico alserviziodell‘aristocraria,prima diservireal]'ascesapolitica dinuovistratisociali."33
una nuovaf… di
Tralasciandodi approfondireulteriormente lagenesi dellafalangeedel relativo armamentoappare senza dubbiopiù interessante esaminarlodettagliatamente. Dunque. la maggiore epiù appariscenteconnotazione dcl-
Elmomacedone,SchinieriecorazzadibronzorinvenutinellatombadlFil/ppcliaVergine,IV sec,a.C.,Salonicco.MuseoArcheologlco.
Macedonianhelmet,great/esandbronzec…rassfoundinthetombofPhi/lipil,InVergina IV centuryE c,Salonika,ArchaeologicalMuseum.

Sotto
Segnodell‘Aquila -
il
PartePriora
StatuaequestrelnbronzodlAlessandmMagno Napoli.MuseoNazionale
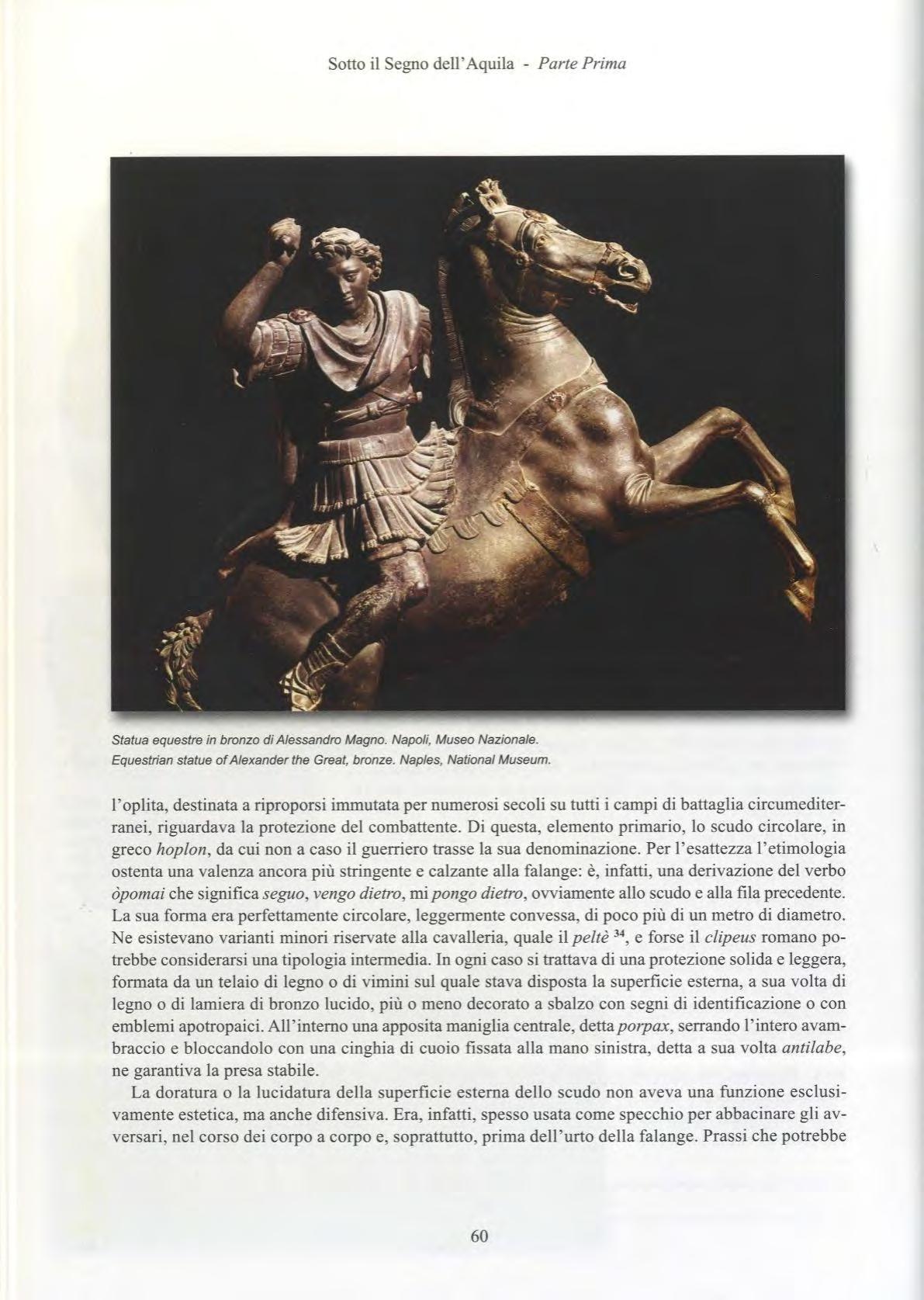
Earnest/tan stati/e ofA/exartderthe Great. bronze Naples. National Museum
l‘oplita. destinata a riproporsi immutata per numerosi secoli su tutti i campi di battaglia circumcditcr— ranci. riguardava la protezione del combattente… Di questa. elemento primario. lo scudo circolare. in grecoIioplolt. da cui non a caso il guerriero trasse la sua denominazione. Per l'esattezza l‘etimologia ostenta una valenza ancora più stringente ecalzante alla falange: e. infatti. una derivazione del verbo o'pomaiche significaseguo.vengo dietro.mipongo dietro.ovviamentealloscudoe alla fila precedente. La sua forma era perfettamente Circolare. leggennente COI“essa.di poco più di un metro di diametro. \le esistevano varianti minori risenate alla cavalleria. quale ilpeltè “. e forse il clipeus romano potrebbe considerarsi una tipologia intermedia. In ogni caso si trattava diunaprotezrone solidae leggera… formata da un telaio di legno o di \imini sul quale stava disposta la superficie esterna. a sua volta di legno o di lamiera di bronzo lucido, più o meno decorato a sbalzo con segni di identificazione o con emblemi apotropaici.All'interno una apposita maniglia centrale.dettap0l'pttx. serrandol‘interoavambraccio e bloccandolo con una cinghia di cuoio fissata alla mano sinistra. detta a sua \olta tlntiltib9, ne garanti\a la presa stabile.
La doratura o la lucidatura della superficie esterna dello scudo non a\eva una funzione esclusi— vamente estetica.ma anche difensivi.Era. infatti. spessousata come specchio per abbacinarc gli av» Versari. nel corso dei corpoa corpoe.soprattutto.prima dell‘unodella falange.Prassi chepotrebbe
Sotto Il Segnodell'Aquila - Par/e Prima
60
spiegare la diversità degli scudi della seconda fila. Dal momento che il diametronon eccedeva il metro, lo scudodell‘oplita non poteva coprireinteramente la sua persona, restando al di fuori la parte inferiore dellegambe equella superioredel torace. Divennero necessarie pertanto ulteriori protezioni metalliche, quali gli schinieri e la corazza pettorale, alle quali si aggiungeva un massiccio elmo di varie fogge. Spie» cavanofra queste: “caschidivario lipo,provvistiomenodiun pennacchio, diun nasale, di unfrontale, di un copri-nuca e copri-guance (paragnathides); coraz:e metalliche- rigide leune,foltediduepezzi, ventrale edorsale, che racchiudevano ilbusto comeuna campana oppuresimodellavano sulla muscolatura;più omeno morbide le oltre,perche'siscomponevano in una serie di elementi di bronzo cuciti su di una guaina di cuoio o di lino, oppurefermati accuratamente a una cotta di maglia; igambali, detti cnemidi, coprivano laparte anteriore e laterale della gambafra ilginocchio e la caviglia; eccezionalmenteinoltre (soprattuttonella seconda ine/à del VIsecolo, periodo dell'apogeo dell’equipaggiamentopolitico), si ebbero coscia/i,fasceper le braccia. cinture e grembiuli di cuoio {con la funzionedipara—frecce)."35
L’insieme dell’armamento difensivo trasformava l’oplita greco in un antesignanoguerrieromedievale, che appuntocome il suoepi» gono, doveva risultare estremamente lento e impacciato nei movimenti, tantopiù che.adifferenzada lui,non combatteva enon si spostava a cavallo, Capace,perciò, soltantodi un incedere lento, di un cadenzato avanzare in linea retta ed in una ampiaedapertapianura,morfologiaquestadifficilmenteriscontrabilenellecampagnedell’Italiacentrale.
Assurdo tentare di superareuna qualsiasi siapur modesta altura con una tale blindatura addosso.come pure supporredi mantenereun perfettoallineamentodellaschierasuterrenoappenamosso. La questione era della massima importanza poiché: “I'esito della battaglia diperr devaproprio dalla conservazione di questo ordine. Il che spiega la necessità di radicali modifiche nellafalange romana, resesi indi— spensabilinon appena ilraggiodiazionedelle legionisuperòlapianure lazialianordeasoprattuttoasud, Quantoal]'armamenlooffensivo del]‘oplitasiriduceva a una lancia dilegno, lunga/ra i 2 edi2.5m, dotata di cuspidedibronzo a di ferro, ediuna spada corta la cui lamapoteva esseredritta o curva, da',' sinei " '… "Una '4
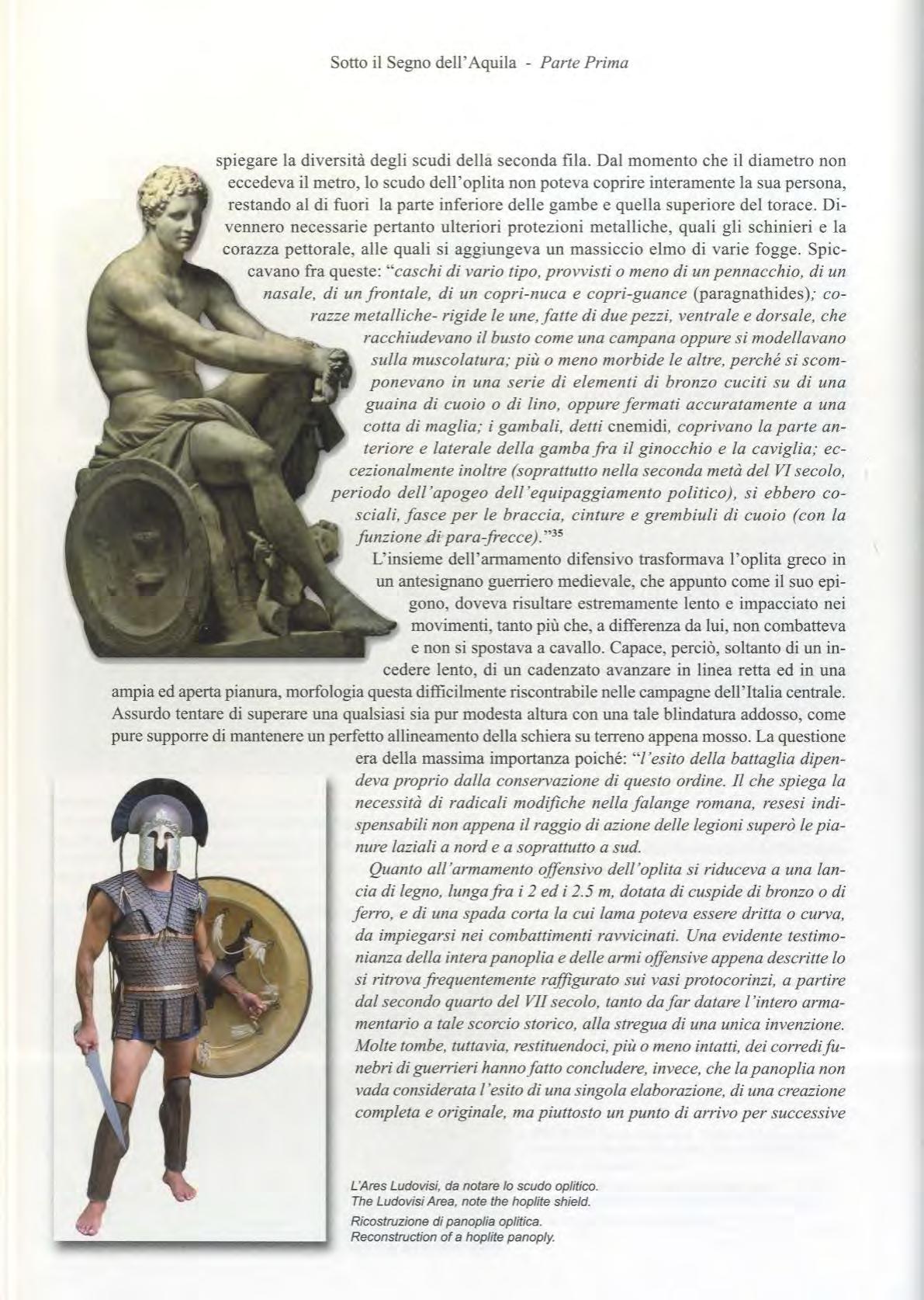
testimo-
nianzadella interapanoplia edellearmiofliznsiveappenadescrittelo siritrovafrequentementerafiîgurato sui vasipmtocort'nzi, ::partire dalsecondoquartodel VIIsecolo, tanto dafardatare[interoarma» mentat-ioa talescorciostorico,allastreguadiuna unica invenzione. Moltetombe, tuttavia, restituendoci,più omeno intatti, deicorredifu— nebridiguerrierihannofaltoconcludere, invece, chelapanoplia non vada considerata!'esitodiunasingolaelaborazione,diuna creazione completa eoriginale. mapiuttosto unpunto diarrivopersuccessive
Sottoil Segnodell'Aquila PartePrima
L'AresLudovisi, danotare lo scudoopiìtl'co. The LudawsiArea, nole thehop/ite Shield. Ricostruzionedipanopliaoplltlca, Reconstructionofahop/itepanaply.
aggregazioni, allequalicontribuironomoltecittà - greche lungo un arco cronologico di secoli. Si Splegtlnl? cosi le comparse di corazze ed elmi scaglionatinel tempo, tii/brina e concezione diversificata a partire dai primi ritrovamenti dell "VIIIsecolofino a quellidel VIa…C,”36 Che la panoplia risultasse gravosa da portare e troppovincolata alloschieramentofalangisticolo si ricava dalla tendenza al suoprogressivo alleggerimentoapartire dalV secoloa.C.Forse fuuna conseguenza delle mutare tattiche di combattimento chenon trovavanopiù concordi entrambi i contendenti ad un unico scontro frontale risolu— tore incampoaperto.Forse dipese dal voler con— servare quanto di efficace della panoplia anche per i fanti addestrati a combattere in ordine aperto,magarisuterreniaccidentati.Dicertogià dall’inizio del V secolo vi sono validi riscontri perritenereche lacorazzamorbida avessesostituitoquellarigida. Spessopoi anche ilberrettodi cuoioodi feltro,pilos,prese ilposto del— l’elmodibronzo.mentreapartire dallagierradel Peloponnesogli oplititralasciaronodi pomrelasecondalancia,inprecedenza tenuta spessodi riserva nella manosinistra.All’iniziodellVsecoloci sispinseancoraoltre,poiché lostrategaatenieselficrateequi paggiò i suoi opliti con un leggero scudo, e il tiranno Giasone di Peres giunse a rivestirli soltantocon una mezza corazza.”
L’AVVENTODELL'ARTIGLIERIA
L'alleggerimento delle corazzature e dellevarie blindature metalliche, non deve considerarsi necessariamente una conseguenze della constatazione della loro eccessivapesantezza. impaccio di cui si doveva essereperfettamente con» seiancheun’ora dopoil loroassemblaggio,ma delloscadimentodellaprotezione cheriuscivano ad elargire.In altri termini dell‘essere inutilmente troppo faticose da portare, constatazione cheesemprescaturita dallacomparsa di nuove armi odiun radicalepotenziamentodelleesistenti.Lepossentinavidi lineacorazzate,lecorazzateper antonomasia, scomparvero dai mari quando l’avvento dei missili le rese pateticamente vulnembili! La panoplia d‘acciaiodel cavalieremedievale dapprima siridussepoi scomparvedeltuttovanificata dall’impattodipochi grammi di piombo! Probabile, pertanto. che anche per il fenomeno appena descritto
Chieti,MuseoArcheologicoNazionale…statuaraffiguranteilredeiVestini,NevioPompu/ledro,de» dicatadaAninis,detta ‘guem'eiodiCapesunno‘
Chieti,MuseoArcheologicoNazionale:dischidicorazzainbronzo.conraffigurazronaasbalzodi unanimalefantastica.Vivsec.a.c..daAlfedena Ricostnizi'onedicorazzaapiastra.
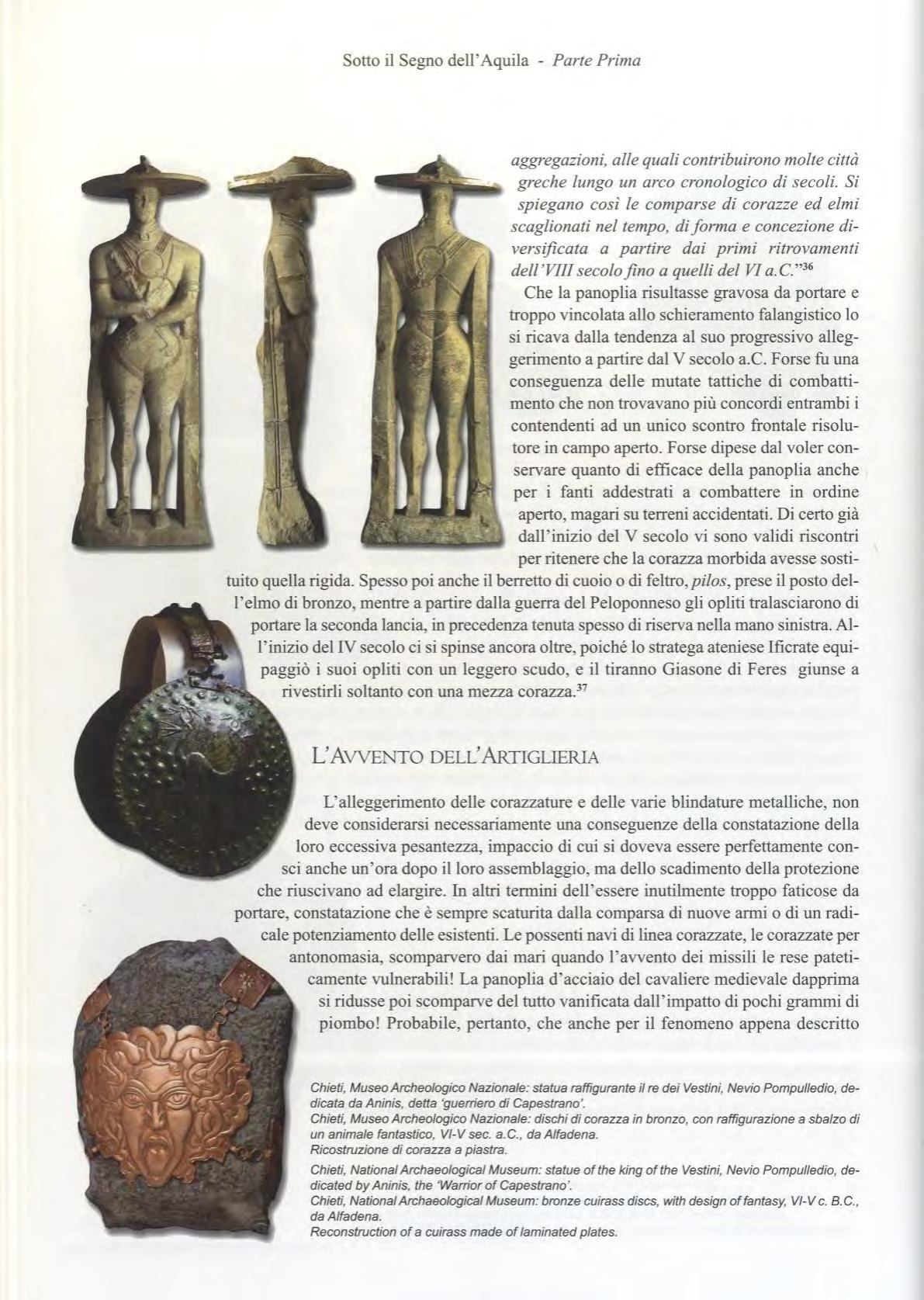
Chieti.NationalArchaeologicalMuseum:statueofthekingalti-reVestini,NevioPompu/lattia,dedicatedbyAninis,theWarrioraiCapestrana‘.
Chieli,Nations/ArchaeologicalMuseum:bronzecuirassdiscs.withdesignoffantasy,VI-Vc sc., daAlfedena.
Reconstructionafacui/assmadeallami'riatedplates.
Sotto il Segnodell'Aquila — PartePrima
Corazza anatomica Ill—IIIsec. a.C. Schinlerlin bronzo, stessoperiodo. Anatomiecuirassfromtheiwri:,s.c. Bronzegreaves,sameperiod.

abbia giocato un ruolo determinante l‘awento di un’arma che riusciva agevolmente a trapassare le normali corazzature e protezioni di bronzo rendendoleperciò inutili, E non èun caso cheproprio dagli inizi del IV secolo a.C. compare l'aniglicriaelasticaesiperfeziona rapidamente, segnoinequivocabile della suapiena efficacia,passando in brevissimo tempo da un impiego esclusivamenteossidionaleedifensivoadunocampale.Arma chesecondounaplat» sibiletradizionefudovutaalforteimpulsoaccordatoallasuaottimizzazionee produzione dal tirannodi SiracusaDionisio il Vecchio, già sulfiniredelV secolo a.C. Emblematica e significativa al riguardo la recriminazione di Archidamo.redi SpartaEra il 361edil338.il qualeosservandoper laprimavolta una catapulta importatadalla Sicilia…quindinonpercasodinanzialui.gridò:"oEroe cla, a cosa sen più la virtù militare delluomo/"."Esclamazione cheha un sensosolosesiriferisceall‘inutilitirdellapanopliaenon certoal combattimento che essendoravvicinatonon avrebbepermesso l'impiegodi tali armi.
Va ancora osservatoche l‘adozione di una odue lance diun paio di metri.da scagliarecon osenza propulsore. non era una peculiarità della falange.Questa. infatti, con la ricostituzione introdotta da Filippo Il il Macedone a metà del IV secoloa.C..ebbe indotazioneuna lancia.dettasar-issa.diforma edimensionetalmentediversaepeculiaredanon esserepiù nemmenoconsideratatalee.menoche mai, un arma da lancio. La infine.che il falangista manteneva con entrambe le mani inposizioneorizzontale.eraun’asta dalla lunghezzavariabile in funzionedella fila cui eradestinata. Perla quintafila.osestasecondol'epoca,comunque l’ultima della falangecheprendeva parte attiva allo scontrodelle sedici file complessive,
poteva raggiungere i 7m circa…Considerandochelo schieramentodabattaglia de» finitolargoavevaun intervallodi circa 1m fragli uomini.mentrequellodefinito serratodi circa la metà. la sarissa da 7 m era ancora in rado di fuoriuscire di 2 rn dalla prima fila. equivalendo perciò a quella dalla dimensioni uguale alle lance tradizionali.
Afiiancandositutte lecinqueasteespargendofra le testedei falangisti,al di sopradei loroscudi.formavanouna sortadi istricecorazzatoche avanzava i…, penetrabile. Un renangolo:"campanodifarrtidotatidipesantecorazza @armati di scudo e asta... Lafalange erapiù di una Semplicefolla di armati riuniti a mantenerelacoesioneeimpedirechesiapi'isserofizllepericolosenella riga/ron-
tale… Una battaglia tra dueesercitidifalangixtiera unaprova di,/orzod'urtoe
Sotto il Segno dell‘Aquila - PartePriora
66
divigore, con leduefi7nnazr'anecompattechelottavanofinche'una delleduerompeva iranghiesidava allafuga. In una guerra di questogenerenon c’erapusioper la strategia; una volta iniziata la batta— glia, l'individuositrovava sommersa in una massa di corpi copertidisudore, e, non esixtena'oneppure la nazionediriserve, non c’emalcunapassi lità diaiutida]!esterno“?9
DALLA FALANGE ALLA LEGIONE ROMANA
E’singolareconstatarechelafalangeellenistica,derivatadallamacedonetramiteaggiustamenti tesiadaccentuameulteriormentelepotenzialitàofi"ensiveascapitodellamobilità.ebbeil suovenicenella cosiddettagrandefalangeotetra/'alungarchr'a, Questacompostadi quattrocorpidi falangiminori.dette laxisofalangarchia di 4096 uomini ciascuna, per un organico complessivodi 16.384opliti, ricordava molto davicino la suddivisione in quattrolegioni dell‘esercitodi formazione serviana, di 16.800fanti.
Talecou' r 4 non può " 'unamera ' " bensì una ' "' '… .,… della più arcaica impostazione dell’esercitodi Roma.adattatonel corsodei secoli allemutate tattiche operative.Altra( siravvisanella ,, “ diuvv' ’ adeicaduti.Dal momentocheilvero problema dellafalangeeraladifficoltàdi sostituireconelementidi egualearmamentoicadutinelle prime file, le più esposte alle perdite, occorreva disporre di adeguati rincalzi. Ed appunto fra i primi prowedirnenti romani vi fu proprio quellodi teso a garantireun rapido avvicendamento dei caduti,inmodo di poterrapidamente chiudere le falleapertesi nello schieramento.Quanto al congruo armamento dei rincalzi fu disinvoltamente risolto togliendo la panoplia ai morti: una forma,quindi,diprestito forzato!
Prù in dettaglio. al fianco dei combattenti regolari. vi erano pure i non combattenti militarizzati chemarciavano con l‘esercito senza però prendereparte agli scontrisenon eccezionalmente.Sitrattava dipersonenon domiciliate a Roma,dette adcerrsr', epertanto collocate nei ruoli vicino agli obbligati al servizio.Da loro venivano forniti alle legioni operai a vario titolo,musicanti e, in particolare.un certonumero diriserve.che seguivano i ranghi ma senza alcun armamento. detti perciò velati. Quandonel corsodegli scontrisi manifestavano deivuoti nelle file, o anche prima ancora in seguito a malattie. questi prendevano le anni dei non abiliedegli uccisi subentrandoal loroposto.
Un’altra curiosapermanenzadellafalangeancoraravvisabilenella legione,derivòdal suoavanzamentoobliquo, con l‘estremità destra dello schieramento che sopravanzavaquellasinistra,quasicomeinunprincipio di rotazione. Il che dal punto di vista degli ambiziosi determinavalapreminenza tatticadelladestra sullasinistra,quasi chearnbissedi entrarepiù rapidamente in contattocon il nemico! In alcuni casiper ovviare alla deficienze si incrementòil settore sinistro.ma quello destro rimase sempre il più potente, superiorità che conobbeuna ulterioreesaltazionenella legione,nella quale la prima coorte manterrà sempre un numero pressochè doppiodi fantirispetto alle successivenove.
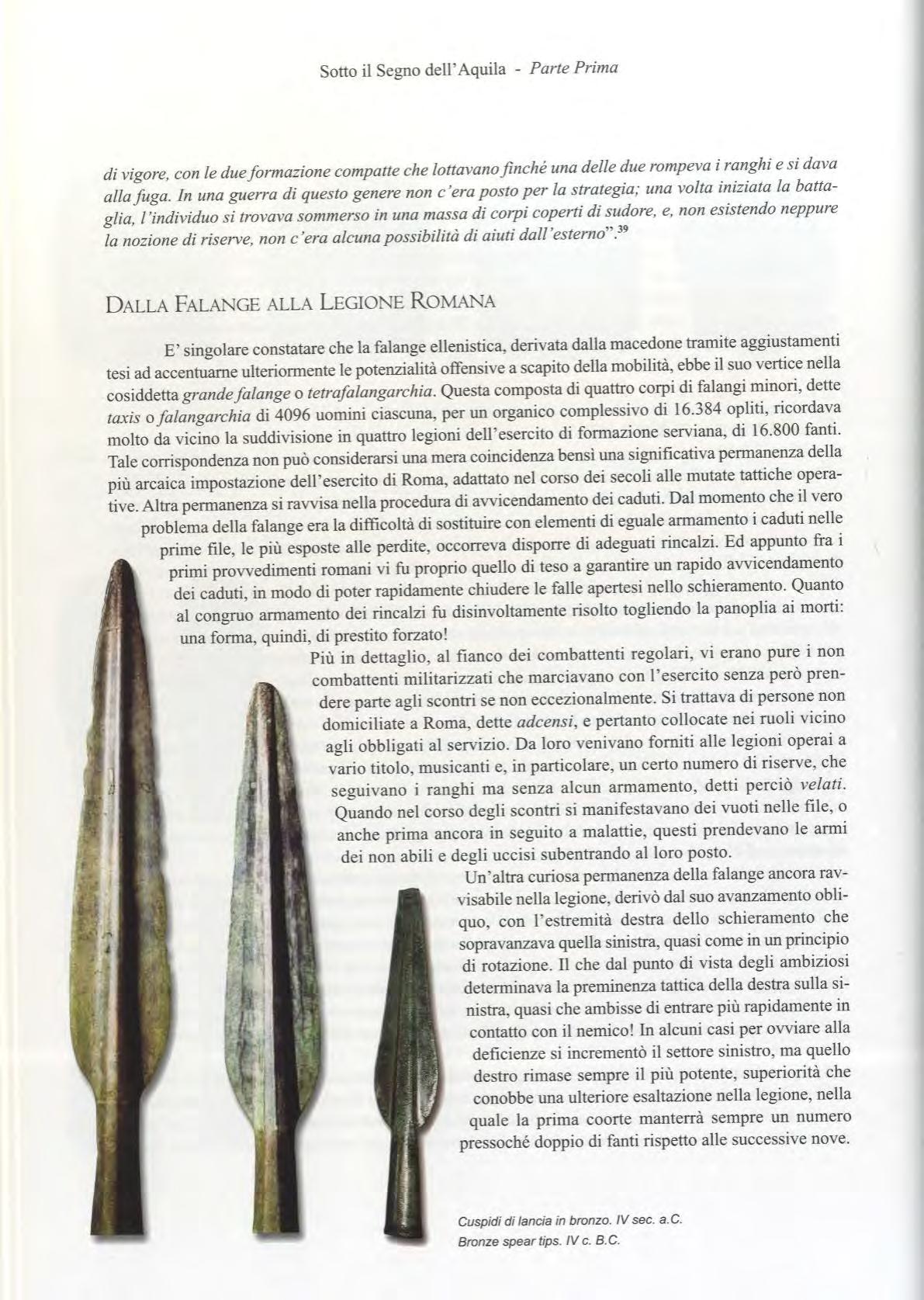
Sottoil
Segnodell'Aquila - Porte Prima
Casp/didilancia …bronzo.IVsec.ac anzespeartips IVc.ec.
Ilmovimentoobliquodalpuntodivista tatticodiedeorigineanchead unapiccola gammadimanovre. dapprima di mera compensazione quindi di larvata intenzionalità. Dalla abilità di conservare la regolarità della formazionee dello schieramento, infatti,dipendeva l’esitodello scontro, dal chela rigida ne— cessitàdiawiarcgli scontrisuterreniampi epianeggianti,di faravanzareleschierealpasso,di spingerle all’urto in sincronia, in modo di ottenere una spinta contemporanea somma di tutte le singole, per attingere il suo valore massimo. Ora dal momento cheriusciva praticamente impossibile evitare chenel corsodellamanovra i falangistisispostasserosiapure impercettibilmenteversodestraper avvalersidella protezionedelloscudodelvicino,occorrevarenderequel movimentoinqualchemanieraorganicoedar» morrico. E poiché gli urti delle falangi si susseguironoper secoli si finì per sfruttarequell’involontario spostamento verso l’ala destra, prima cercando di attaccare il nemico di fianco, magari avvolgendolo conuna parziale rotazione, mettendo cosi indiscussione il criteriodi impatto frontale.Nonostante questevariazioni che sicollocano nel IV secoloa.C.. il repertorio tattico della falangedi opliti restò sempre moltolimitato.“]
LA CAVALLERIA
Quandosiesamina ilruolo ela rilevanza che lacavalleriaebbenegli antichiesercit n generale ed in quelloromanoinparticolare,non sipuòprescindere dalricordarelabassa potenzialità diquest’armaper due gravi carenzetecniche: la fenatura a chiodi e la staffa.Si sa che da un certomomento in poi i Romani adottaronoqualcosadimolto simileaduna calzaturaper ilorocavallima sitrattapur sempred’un adattamentodiscarsaefficaciaepergiuntadibreveresistenza.Dalpuntodivistastoricotraiprimi adotarsidicombattentiacavallofuronogliAssiri,senzaperòandareoltreaduna concezionediarcierimontati.Inognicasol’entitàditalicavalieri,intornoalVil»VI secolo,ascendea 1500su20000 fanti,owcro di300ogni4.000 uomini.Curiosamentesaràlamedesima proporzione chesiritrova anchenell’esercito romano, 300cavalieri su4200 fanti,coincidenzacheancorauna volta non può esserefortuita.
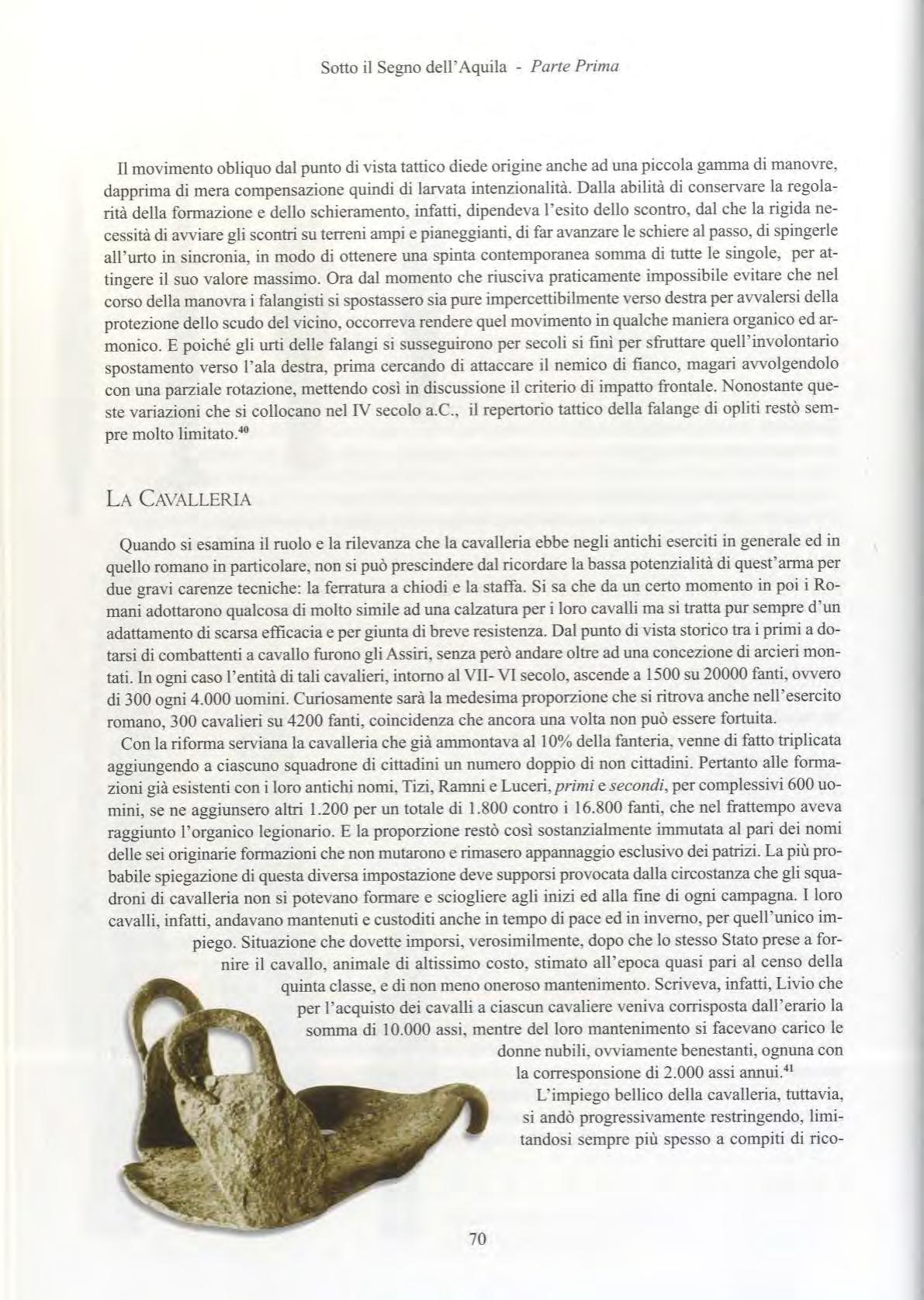
Conlariforma servianalacavalleriachegiàammontavaal 10%della fanteria,vennedi fattotriplicata aggiungendo a ciascuno squadronedi cittadini un numero doppiodi non cittadini.Pertanto alle formazionigiàesistenticoni loroantichinomi,Tizi,RamnieLucer'i,primiesecorrdi.percomplessivi600uomini, sene aggiunseroaltri 1.200per un totale di 1800contro i 16.800fanti, chenel frattempoaveva raggiunto l’organicolegionario. Elaproporzione restò cosi sostanzialmente immutata alpari dei nomi delleseioriginarieformazionichenonmutaronoerimaseroappannaggioesclusivodeipatrizi.Lapiùprobabile spiegazionediquestadiversaimpostazionedevesupporsiprovocatadallacircostanzacheglisquadroni di cavalleria non sipotevano formareesciogliereagli inizi edalla fine di ogni campagna. [loro cavalli,infatti,andavanomantenuti ecustoditi ancheintempodipaceed ininverno.perquell’unicoimpiego, Situazionechedovette imporsi,verosimilmente.dopoche lo stessoStatopreseafornire il cavallo, animale di altissimo costo, stimato all’epoca quasi pari al censo della quintaclasse,edinon menoonerosomantenimento. Scriveva,infatti,Livioche per l’acquistodei cavalliaciascun cavaliereveniva corrispostadall’erario la somma di 10.000assi, mentre del loromantenimento si facevano carico le donnenubili, ovviamentebenestanti,ognunacon lacorresponsionedi 2.000assi annui.“
L’impiegobellico della cavalleria,tuttavia, si andòprogressivamente restringendo, limitandosi sempre più spesso a compiti di rico-
Sotto il Segnodell‘Aquila - PartePrima
70
giizione. di insegrimento degli scon— fitti in fuga., di scaramuccia e a volte persino di mero trasporto. Ragion per cui senestudioun qualsiasiutilizzo in esercitazioni e manifestazione specifiche eperiodiche. In ogni casola storia della cavalleria romana appare afflitta da una serie di luoghi comuni, scarsamente attendibili. Si può addirittura concluderecheinizialmentesitrattasse semplicemente di fanteria trasportata, tanto più che il Lazio, al pari di buona parte della Grecia, non sipresta per la suamorfologia all’allevamentodei cavalli edal loroaddestramento.“
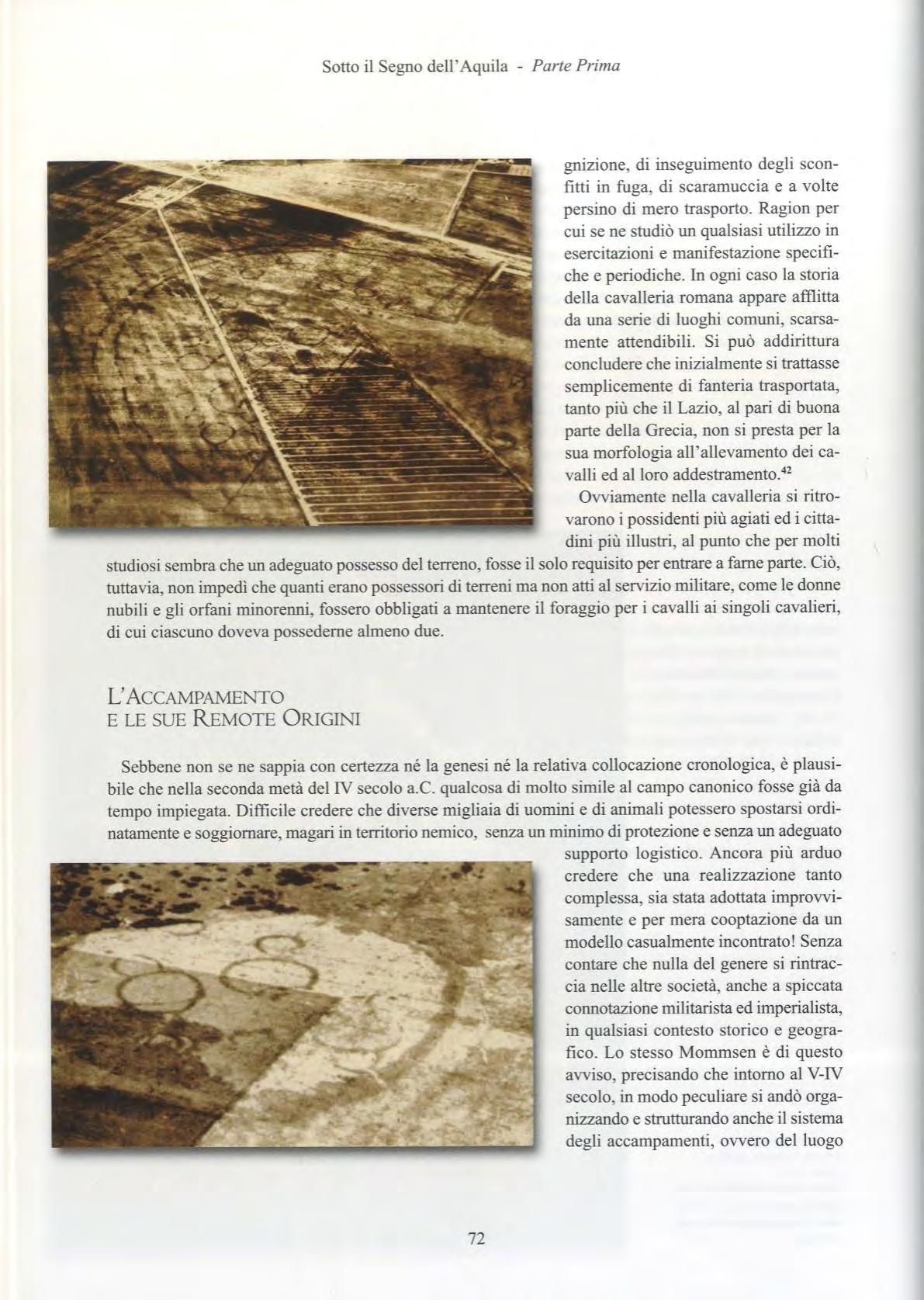
Ovviamente nella cavalleria si ritrovaronoipossidentipiù agiati edicittadinipiù illustri,alpunto che per molti studiosisembracheunadeguatopossessodelterreno,fosseil solorequisitoperentrareafameparte.Cio, tuttavia, nonimpedì chequantieranopossessori diterrenimanonattialserviziomilitare.comeledonne nubili egli orfaniminorenni, fosseroobbligati a mantenere il foraggioper i cavalli ai singoli cavalieri, dicui ciascunodovevapossedeme almenodue.
L’ACCAMPAMENTO E LE SUEREMOTE ORIGINI
Sebbenenon sene sappia con certezza ne' la genesi né la relativa collocazione cronologica, è plausibile chenella secondametà delIV secoloa.C.qualcosadi molto simileal campocanonicofossegià da tempo impiegata.Difficile credereche diversemigliaia diuominiedianimalipotessero spostarsi ordinatamenteesoggiornare,magariinterritorionemico, senzaun minimodiprotezioneesenzaun adeguato
supporto logistico. Ancora più arduo credere che una realizzazione tanto complessa, sia stataadottata improwisamente eper mera cooptazione da un modellocasualmenteincontrato!Senza contare chenulla del genere si rintraccianelle altre società, anchea spiccata connotazionemilitaristaedimperialista, in qualsiasi contesto storico e geografico. Lo stesso Mommsen e di questo avviso,precisando che intorno al V—IV secolo,inmodopeculiare siandòorganizzandoestrutturandoancheilsistema degli accampamenti, ovvero del luogo
Sottoil Segnodell'Aquila - Parte Prima
72
dove un corpo di militi sostava. magari anche per una sola notte… In ogm caso era sempre un ambito chiuso,circondatoda una più omeno blanda fonifrcazioneperimetrale che di fattoloassimilata aduna fortezza propriamente detta.“
In conclusione.dovendoconsentire lapermanenza dipiù glomi.opersino diuna solanotte di tano soldati, l'accampamentoarchetipalenon può supporsi moltodi\orsodauno stazzoquadrilatero:un recintodi terra di riportoricavata scavandoun fossatoanulare.munitoinsommitàdi unapalizzata continua.Soluzione difensivaarcaica ma ampiamenteadottata in Italiagià daoltreun millennionei villaggi danni e.dadiversi secoli.persino dalla stessa Roma. Non a caso la leggenda attribuì l'uccisione di Remo proprio al suo sa» crilego scavalcamentodel solco.simbolodel fossato.Perché.allora.non credere che l'accampamento le— gionario fosse una nuova proposizione. appena perfezionata ed adattata allo scopo, di quella remota concezione fortificatoria‘.’ Una testimonianza di ciò potrebbe coglicrsi in Frontino secondo Il quale.nei primi tempi.l’esercitoromano siraggruppava incabanae,owero …capanne.owiamenteall’internodi un recinto o di un fosso, come appunto ner preistorici villaggi cintari. assumendone perciò la connotazione precipua!
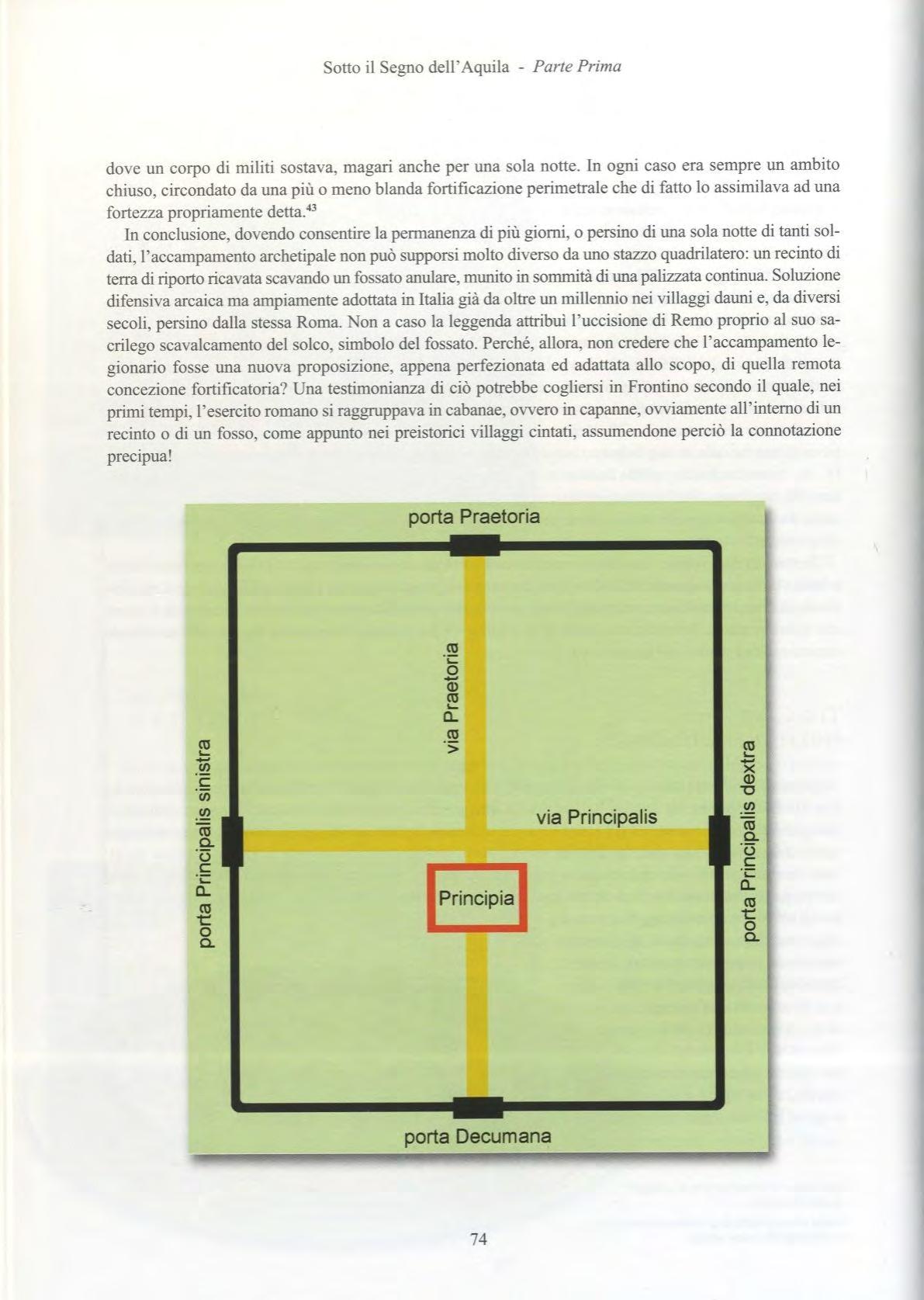
Sotto Il Segnodell‘Aquila - Pur-rePrima
porta Praetoria L ! ..2 o E n. @ E ‘S E "' 4-1 & >< E o (Il 'U … lll £ wa Pnnapalus % 1° .9- %. .. a. % Pnncupra … = E 8 n. porta Decumana 74
Note
1-DaT.MOMMSEN,StoriadiRoma antica, libroprimoDalleoriginiallacacciatadeirediRoma, ristampa Bologna 1979,vol.],p. 57.
2 -Cfr.T. MOMMSEN,StoriadiRoma...,cit.,p. 60.
3 - Cfr…T.MOMMSEN,StoriadiRoma...,cit.,p. 62.
4-Cfr.T.MOMMSEN,StoriadiRoma...,cit.,p.63.
5-Da L.QUILICI,Romaprimitiva eleoriginidellaciviltà laziale, Roma 1979,p. 148.
6-Cfr.F.RUSSO;lngegno@paura. TrentasecolidifartrficazianiinItalia,Roma2005,vol.I,pp… 97- 146.
7- Cfi’.G.TAGLIAMONTE,]Sanniti,Caudini,Irpini, entri, eracini,Frentani,Milano 1997,pp. 7-13…
8 - Cfr.A.BERNARDI,M.A…LEVI,LeoriginidiRoma. inLa Storia,Milano2006,vol…,pp. 107-128.
9-CfrB.CUNILIFFE,Romaeilsuoimpero, Bologna 1981,p.47.
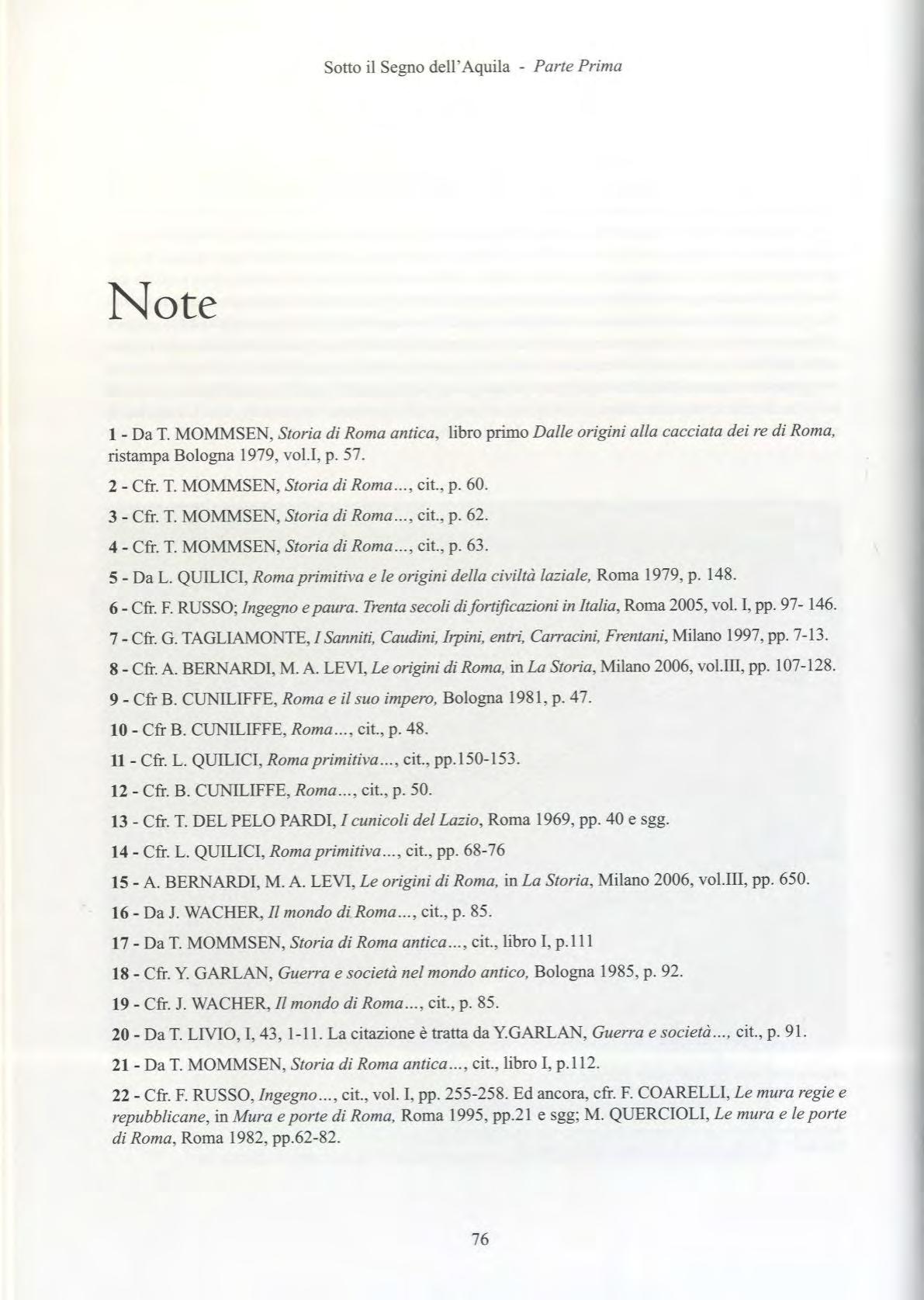
ll]- CfrB.CUNILI.FFE,Roma...,cit.,p.48.
11-Cfr.L.QUILICI,anaprimitiva...,cit.,pp…150-153.
12- Cfr.B.CUNILIFFE,Roma...,cit.,p. 50.
13 - Cfr.T.DELPELOPARDI,IcunicolidelLazio, Roma 1969,pp.40esgg.
14- Cfr.L.QUILICI,Romoprimitiva...,cit.,pp. 68-76
15- A.BERNARDI,M.A. LEVI,LeoriginidiRoma, inLa Storia,Milano2006,vol.lIl,pp. 650.
16 - Da .I.WACI-IER,IlmondodiRoma...,cit.,p. 85.
17-Da T.MOMMSEN, StoriadiRoma amica...,cit.,libroI,p…]11
18- Cfr.Y.GARLAN, Guerraesocietànelmondoantico, Bologna 1985,p. 92.
19- Cfr.J.WACI-I'ER,IlmondodiRoma...,cit.,p… 85.
20 — DaT.LIVIO, I,43, 1-11.Lacitazioneètratta daY…GARLAN, Guerraesocietà...,cit.,p… 91.
21 Da T.MOMMSEN, StoriadiRoma antica ,cit.,libroI,p…112.
22-Cfr.F.RUSSO,Ingegno...,cit.,vol.I,pp.255-258.Ed ancora,cfr.F. COARELLI,Lemura regia e repubblicane, inMumepartediRoma, Roma 1995,pp.21 esgg;M… QUERCIOLI,Lemura eleporte diRoma,Roma 1982,pp.62-82.
Sottoil Segnodell’Aquila - PartePrima
76
Sottoil Segnodell’Aquila - PortePrimo
23—Da T… MOMMSEN, StoriadiRoma amico...,cit., libro 1,p.116.
26—Cfr.Y.GARLAN, Guerra esocie
27-Cfi.APPIANO, Guerrecivili. I,7
28-DaY.GARLAN,Guerra esocietà..., cit.,p. 107.
29-DaE.GABBA,Leoriginidel!’eserr'itoprofessionale in Roma: iproletarielariforma diMaria,in «Athenaeum»,XXVII, 1949,p. 174.
Cio—Cfr.T.MOMMSEN, StoriadiRoma antica...,cit.,libroI,p.]14…
31-DaT.MOMMSEN,StoriadiRoma amica...,cit.,libroI,p.115.
Ill-Cfr…Y… GARLAN, Guerra esocietà..., cit.,p. 141.
33—DaY. GARLAN,Guerra esocietà...,cit.,p. 137.
34»Circa ilterminepeltècfr.F.RUSSO,L’artiglien'ndellelegioniromane, Roma2004,p. 53…
35—DaY.GARLAN, Guerraesociet cit.,p. 133.
36-Cfr.J. HARMAND,L’anedellaguerra nelmondoantico,Roma 1978,pp. 85—96.
37-Cfr.Y. GARLAN, Guerraesocietà cit.,p. 134.
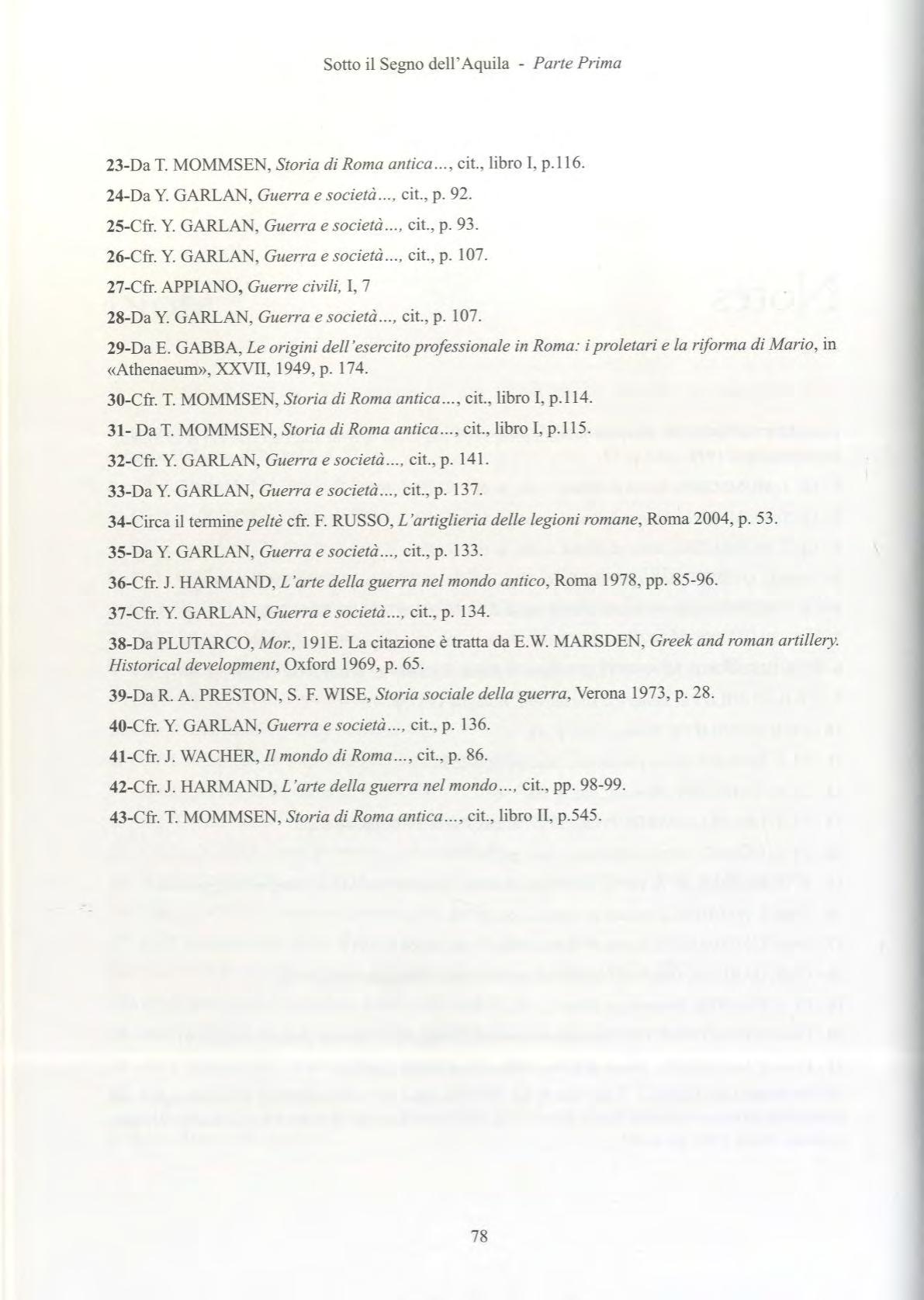
38-DaPLUTARCO,Mor, 191E. La citazioneètratta daEW.MARSDEN,Greekandroman ortillery. Historicaldevelopment,Oxford 1969,p. 65.
39-DaR.A.PRESTON, S.F.WISH,Storiasocialedellaguerra,Verona 1973,p.28.
40-Ciîr.Y. GARLAN,Guerraesocietà...,cit.,p. 136.
41-Cfr.].WACI‘HZR,IlmondodiRom...,cit.,p.86.
42-Cfr.J HARMAND,L‘unadellaguerranelmondo…, cit.,pp. 98—99.
43-Cfr.T. MOMMSEN,Sior-iudiRoma amica...,cit., libroII,p.545.
78
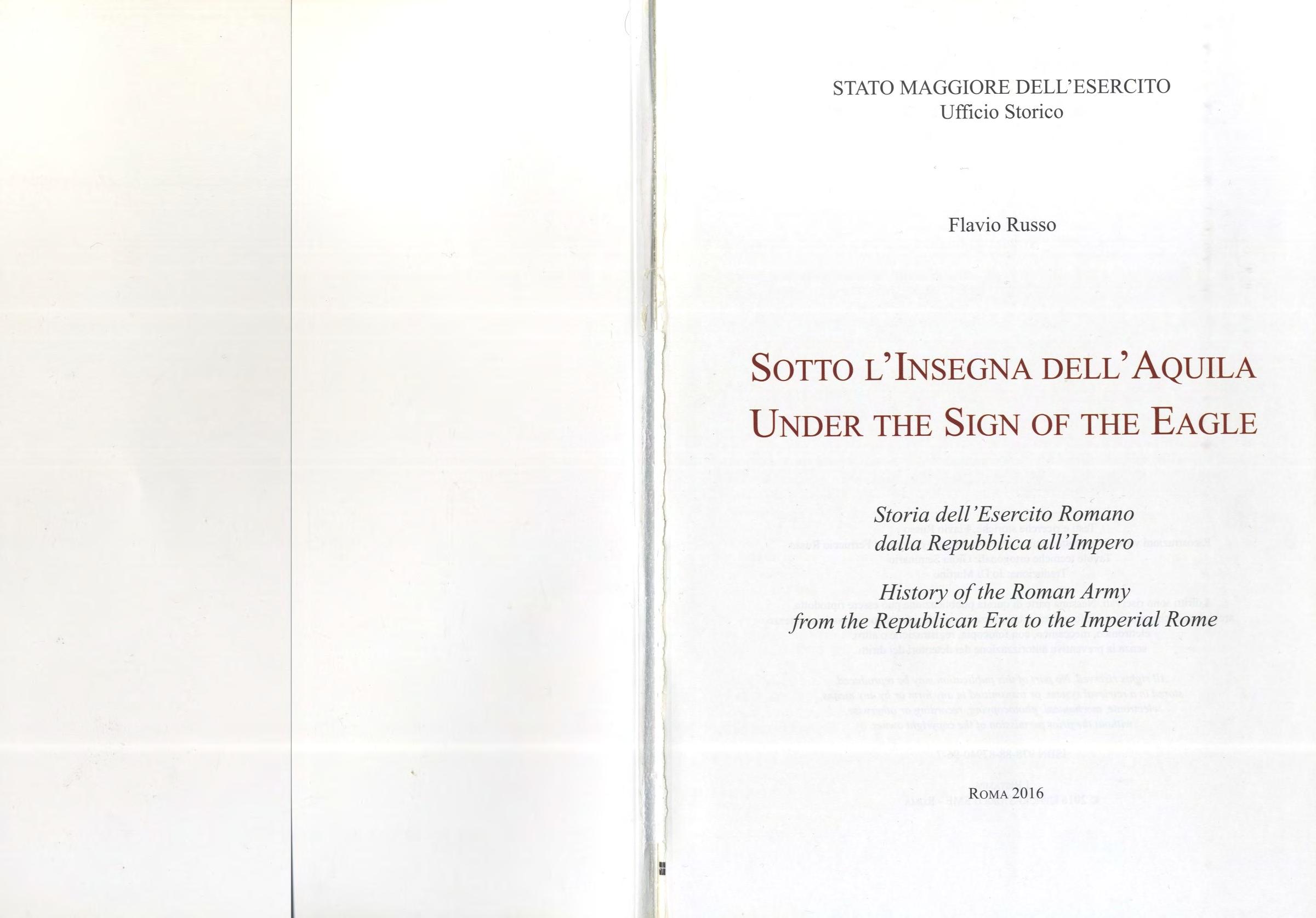
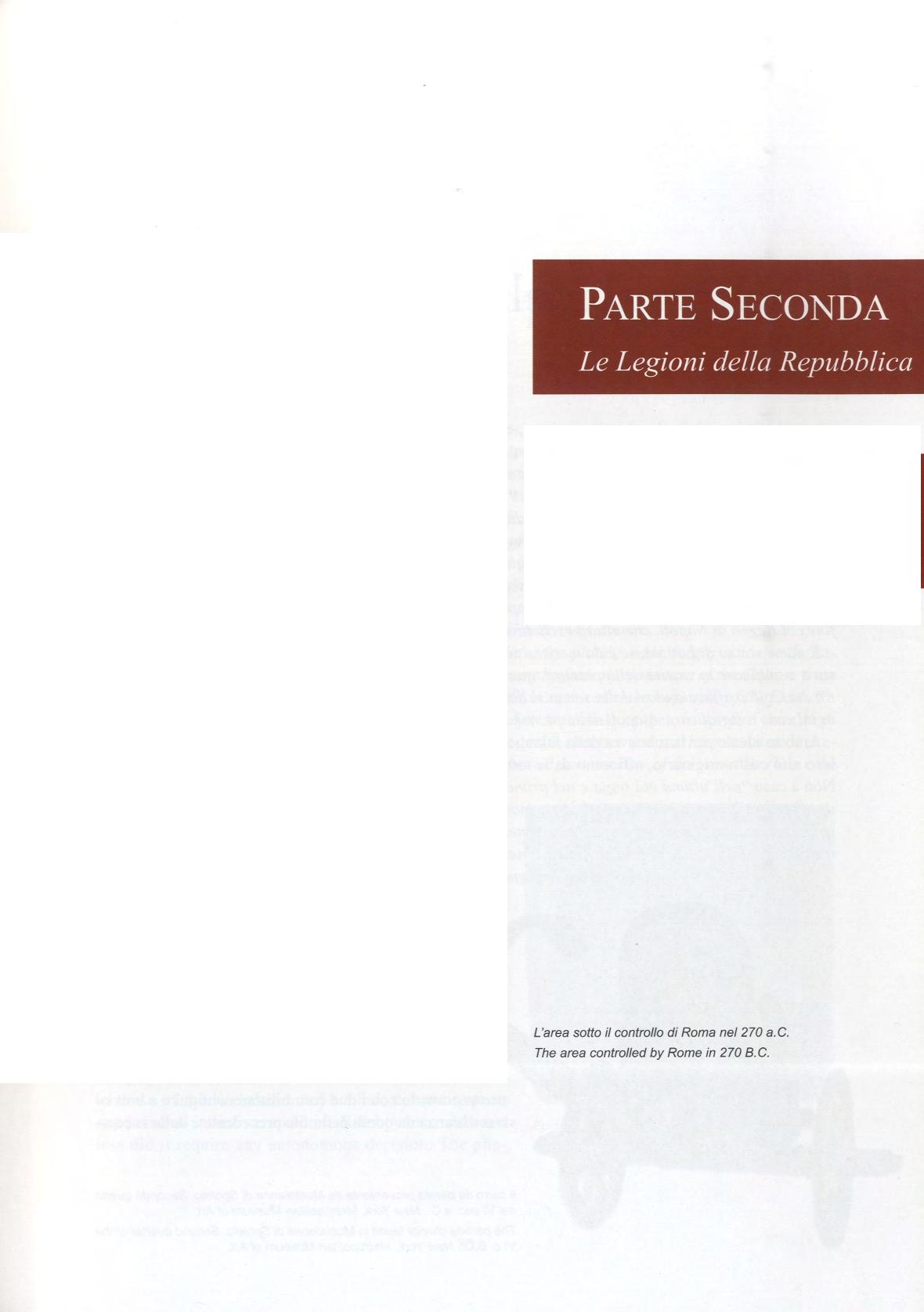
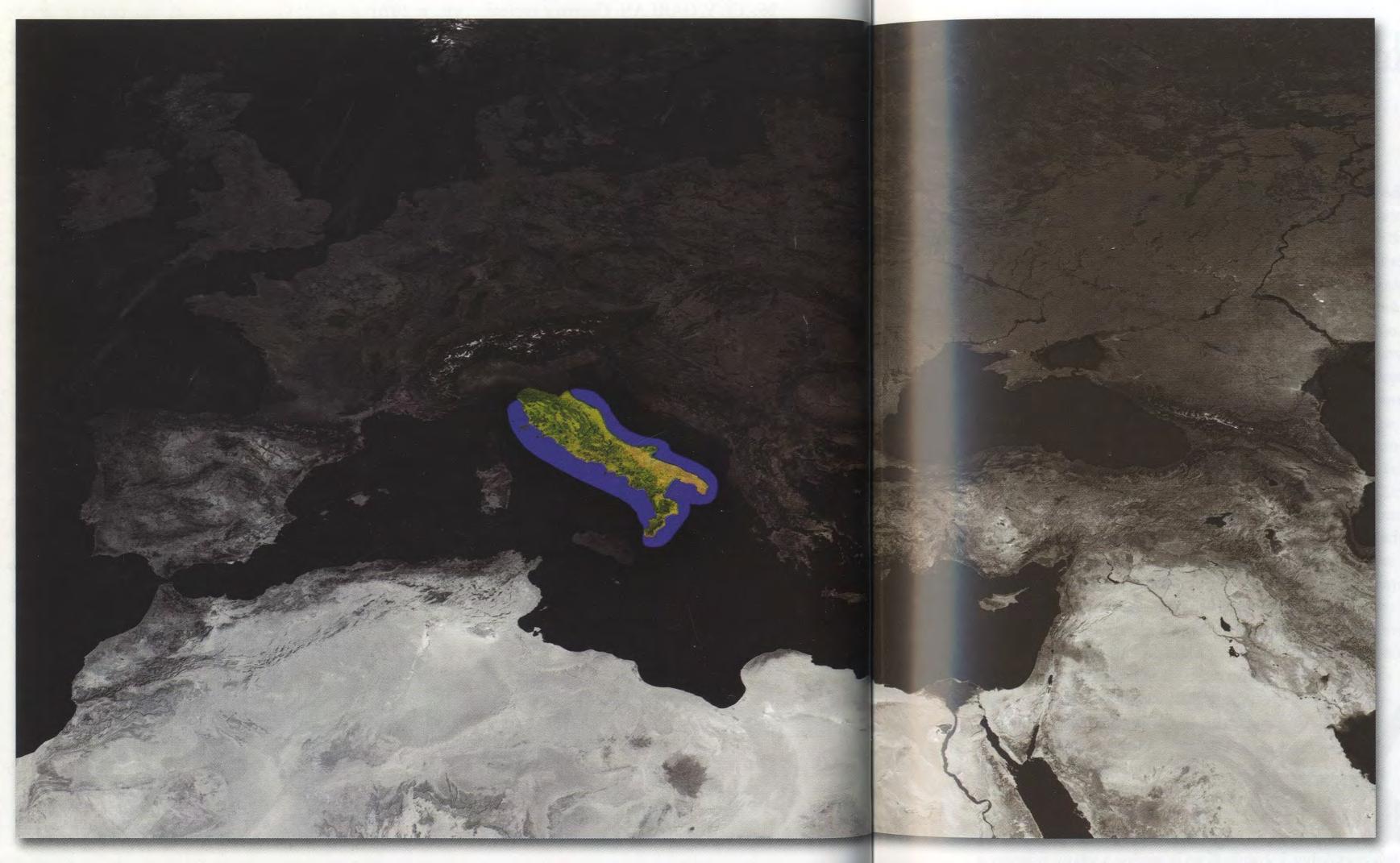
LcLegionidella Repubblica L'area Saltoilconlrollo diRoma nel 270a.C. Thearea contra/ledby Rome in 270H.C.
PARTE SECONDA
Il tramonto della falange
azioha una facileetimologia.lotus,che allude alla sua caratteristica morfologica più evidente: l‘ampiezzadellapartepianeggiante del suoterritorio,pressoche' orizzontaleepiatta. Sequalche smentitasull’aderenzadelladefinizionesembraderivaredallezonepiù accidentatedellaregione, ciòdipendedallalororecenteaggregazione.Per lastoriaciòawenne,nel 1870,col costituirsidellostato inaliano.per cui:“néin etàantica, nénelmedioevoedin etàmodemafinoaquelmomentoiltermineera statomaiusatoper comprendereanchelaregionea norddel Tevere, che costituiva la Tuscia, né la Saf hina, i cuistessinomi traggono originedagliantichipopoli che le avevanoabitate. Etruschi e Sabini, chepresentavanoun ambientegeograficoesoprattuttostoricoeculturaleben distinto.Finoallafinedel— [OttocentoperLaziosiintendevanola CampagnaRomanaeleregioniadessa meridionalifino alconfine colRegno diNapoli, cheallora esclttdevanoatii/ferenza dioggi, Gaeta eCassino
IlnomestessodiLatium, seeda mettersi in rapporto con l‘aggettivolotus {gr.platùs), ampio, largo, sta asignificarela vastità dellapianura, quanta senepoteva abbracciarecon lo sguardodall’epicentrodeiCollioa/fizcciandosidallasommitàdeirilievichelodelimitavano...IlterminediLatinistarebbe in talcasoasignificare «popolidellapianura».“‘
Ambito ideale perla manovra della falange, comepure per i veloci carri da guerra che, nonostante il loro alto costo originario, affiorano dalle tombe in discreto numero e in vario stato di conservazione. Non a caso:“nell’ultimaetà regia enelprimo secolodella repubblica (seal/) alloStatoromano riuscì di affermare la sua supremazia nelLazio mantenendola anchecontroricorrenti attacchidi aggressive tribùprementidal!’entroterraappenniniconeicuiterritoriessainvecenonpoteva tantofacilmentecontrattaccare data la sua rigida struttura... nemmeno adattaper operazioni di assedio: le città munite eranoquasi imprendibiliesenel396siera conclusocon successoquellodeeennale contro una città prestigiosa e munitissimocome Veio, losi dovette specialmente aun tradimento."2
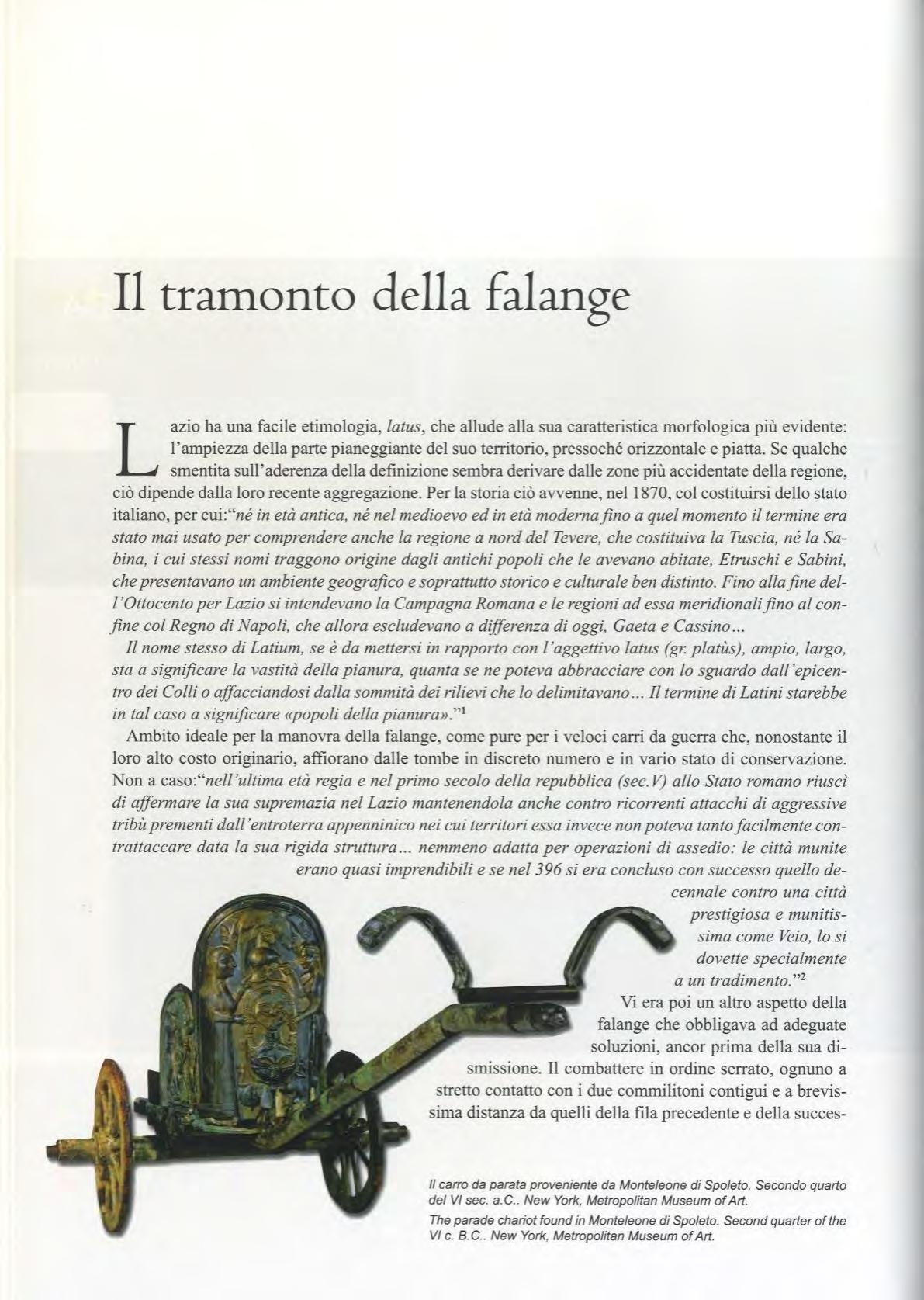
Vi era poi un altro aspetto della falange che obbligava ad adeguate soluzioni. ancorprima della sua dismissione. Il combattere in ordine serrato. ognuno a strettocontattocon i due commilitoni contigui ea brevissimadistanza daquelli dellafilaprecedente edella succes-
IlcartadapamtagravementedaMonteleonediSpoleto.Secondoquarto delVIsec.a.C..NewYork.MetropolitanMuseumofAtt.
Theparadechatta!loundinMonteleonea:Spoleto.Secondquartetofthe VIC ac.NewYork. MetropolitanMuseumofArt
siva,non richiedeva alcuna iniziativapersonale, alcunoslancioeroiconé, menoche mai, alcunadecisioneautonoma. Inbreveilfalangistacostituivail classicoelemento diunagrandemacchina,privodi qualsiasrvolontà chenon fossequelladimantenere fino in fondo la posizione. Limite chegli Spartani equiparavanoalla morte, per cui tentavano dalloscontroocon il grande scudo0 sul grande scudo! Spersonaliz— zazione tattica che garantiva anche al più ottuso e al più riot teso oplita di non sfigurareal momento dell‘urto.Pertanto, a quel tipo di guerriero bastava soltanto un insignificante addestramento ed una irrilevante capacità valutativa, oltre owiamente ad una massiccia costituzione, supplendo la conformità a qualsiasinecessità!
Con l’adozione delloschieramentomanipolare che,giova sottolinearlo,non fuuna liberaopzionema una conseguenzadelleperdite inflittesoprattuttodai duri Sanniti ’,la situazione mutò drasticamente. I legionari dovevano non solooperareinpiccoli gruppi,maanchesecondolescelteelevalutazionitatv tiche del comandantedi quellamodesta unità, siapurenell’ambitod’undisegno strategico risaputo. Ne conseguì quale condizione necessaria e sufficientepertalemodello,un maggioreaddestramentoedellereclute edei vari quadri.‘Nulla di più lontano psicologicamente dal vecchio ordinamento nel quale ogni combattente sorvegliava ed era sorvegliato dagli altri con identica severità.Una sua eventualedivergenm,ancorchèpossibile, lo avrebbe stigmatizzatoper insubordinazione eperribellione,un comportamentoanarchicoche lageometricafalangenontollerava.E.permoltiaspetti,lalogicadi combattimento che i Sannitiadottavanoeraappuntodi tipoanarcoide,guerrigliero,doveognipiccolissimo reparto. pur obbedendo a un capo, restava pienamente autonomo!Non appare casuale che forme di combattimento del genere si osservino, in qualsiasi scorciostorico,in tutte leregionimontuoseeche abbianosempreposto in seriedifficoltà ed,avolte.costrettoadesistere eserciti agguerriti evalorosi. I Romani,dopoi primi tragici insuccessi. appresa a loro spese la lezione. elaborato…)una radicale modifica dello schieramento tattico. avviando cosi una modernizzazione della loroistituzionemilitareed,inultimaanalisi,ponendointal modolebasi concrete per la loro espansione.
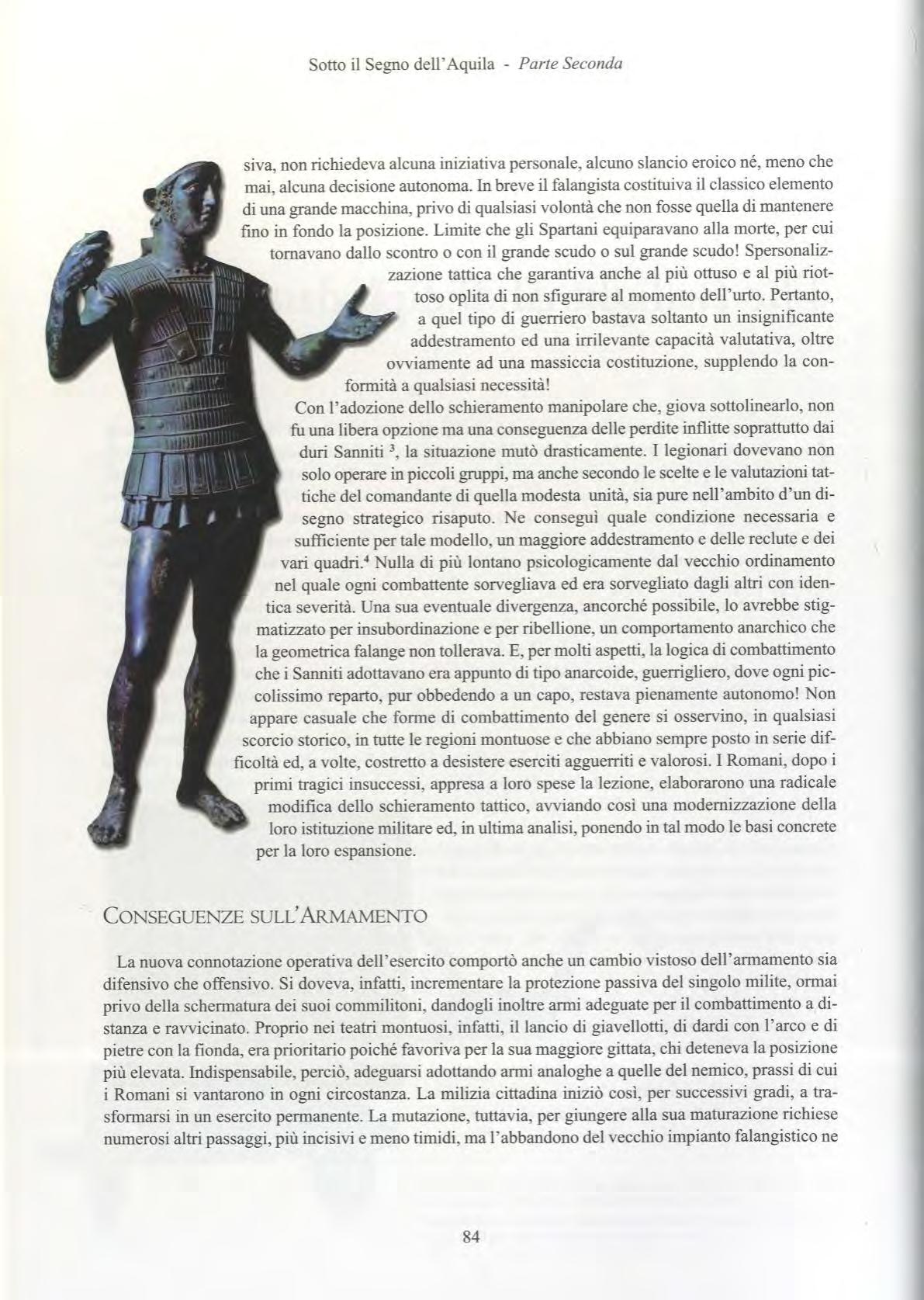
CONSEGUENZE SULL’ARMAMENTO
La nuova connomzione operativadell‘esercitocomportòancheun cambiovistoso dell’armamentosia difensivoche offensivo. Sidoveva, infatti, incrementare la protezionepassiva del singolomilite, ormai privodella schermaturadei suoicommilitoni.dandogli inoltre armiadeguateper il combattimentoadistanza eravvicinato. Proprio nei teatri montuosi, infatti, il lancio di giavellotti, di dardi con l’arco e di pietre con lafionda eraprioritariopoichéfasorivaper la suamaggioreauittata, chi deteneva laposizione più elevata ' " r ‘‘ perciò, : ’ armi ‘ _“ aquelledelnemico,prassi di cui i Romani vantarono in ogni circostanza. La milizia cittadina iniziò cosi, per successivi gradi, a tra— sformarsi inun esercitopermanente. La mutazione., tuttavia.per giungere alla sua maturazione richiese numerosialtripassaggi,più incisivi emenotimidi,ma l’abbandonodel vecchio impianto falangisticone
-
Sotto il Segnodell‘Aquila
Parte Seconda
84
fu senzadubbiolapremessa. E se la trasformazione non avvenne con maggioresolerzia,dipeseesclusivamentedal fortespiritoconservatore romano. Tuttavia un innegabile riscontrodelprocessoincorsosiravvisa nell’avanzamento del rorario, rorarius, che fino ad allora aveva potuto combattere per lo più come fromboliere,senzapotere sperarein alcun avanzamentogerarchico.Nel periodo immediatamente succes— sive, invece, sia pure gradualmente Scudosannitaraffigurata alcentro diuna lastra da si assiste ad una sua ascesa allaprima epoi alla seconda linea, ""’"U’Î’em"'”"e'a’ÎD‘
pergiungerequandoormairiccodiesperienza,nellefiledeitriaàìzgîîjfm‘frfìfcéîdrrglflîîslgeogtcîffifwolnî rii, cheper molti aspettipoteva considerarsi il nerbo non per numero ma pervalore dell’interoesercito}
Sel‘inadeguatezza della falangedivenne evidentee non procrastinabile quando le campagnemilitari di Roma laportarono fuoridalLazio,leprime avvisagliedell’esigenzadiuna profonda trasformazione dell’esercito rimontano al lungo assediodi Veio, condottotra il 386 ed il 396 a.C.Il suo abnormepro» trarsi per l’epoca, alpuntoda venir consideratounaretorica identificazionecon quellodiTroia, el’impossibilità di sospenderlodurante lacattiva stagione,implicaronoche ai legionari fossecorrispostauna indennità in denaro.Da quel momento la prestazione militare iniziò a configirarsi comeuna possibile attività,scalzandocosi ilconcettodi doverecivico,implicitonella falange.Anchenell'armamentoquello snodotrova significativiriscontri: gli elmidivenneropiù spessiesenzaeccessivirilievi, inmodo da favorire lo scorrimentodei fendenti; gli scudiovali furonomuniti di un bordo di ferro,per rendere anche essiidoneiaresistereaifendentieaicolpid’ascia.Efuinquestocontestochequasicertamente siadottò ilpilurn, un tozzogiavellotto,assurtoadarmad’ordinanzadel legionario,cheneportava ingeneredue. Circalasuaderivazione,insiemeallungoscudo,scumm,dall’armamentariosannita,derivadaun breve passo del cosiddettolneditumVaticanum, attribuitoa Ceciliodi Calanc.‘
DECLASSAMENTO DELLA CAVALLERIA
Comegià inprecedenza evidenziato, il ruolo dellacavallerianell’esercito romano, come del resto in tutti gli eserciti dell’antichità,era marginale ecomunqueben diverso da quelloche sosterrà nel Medioevo. Molte le ragioni e molte le conseguenze, fra le quali proprio per la sua marginalità il costo elevatissimodei cavalli, peraltro di piccola taglia, edel loromantenimento. Sensato conclu— derechesei fortioneridell’armacostringevanoaridotti organici,a lorovolta i ridotti organici non permettevano significativi risultati! Il che è sicuramente vero dal V secolo in poi, per la Grecia e dal IVper l’Italia.Fino ad allora,nelperiodo compresofra l’abbandonodel carroda guerra el’affermazionedellafalange, lacavalleria ebbeuna sua indubbiarilevanza tattica che forsesiparte alla base dell’affermazionedellarispettiva classesociale, supremaziapolitica chein seguitopasserà ai membri della fanteria tratti dai maggiori possidenti fondiari. La tesi, ovviamente, non trova d’accordo tutti gli studiosi ed alcuni fra loro giungono ad ipotizzare al riguardo due distinti periodi
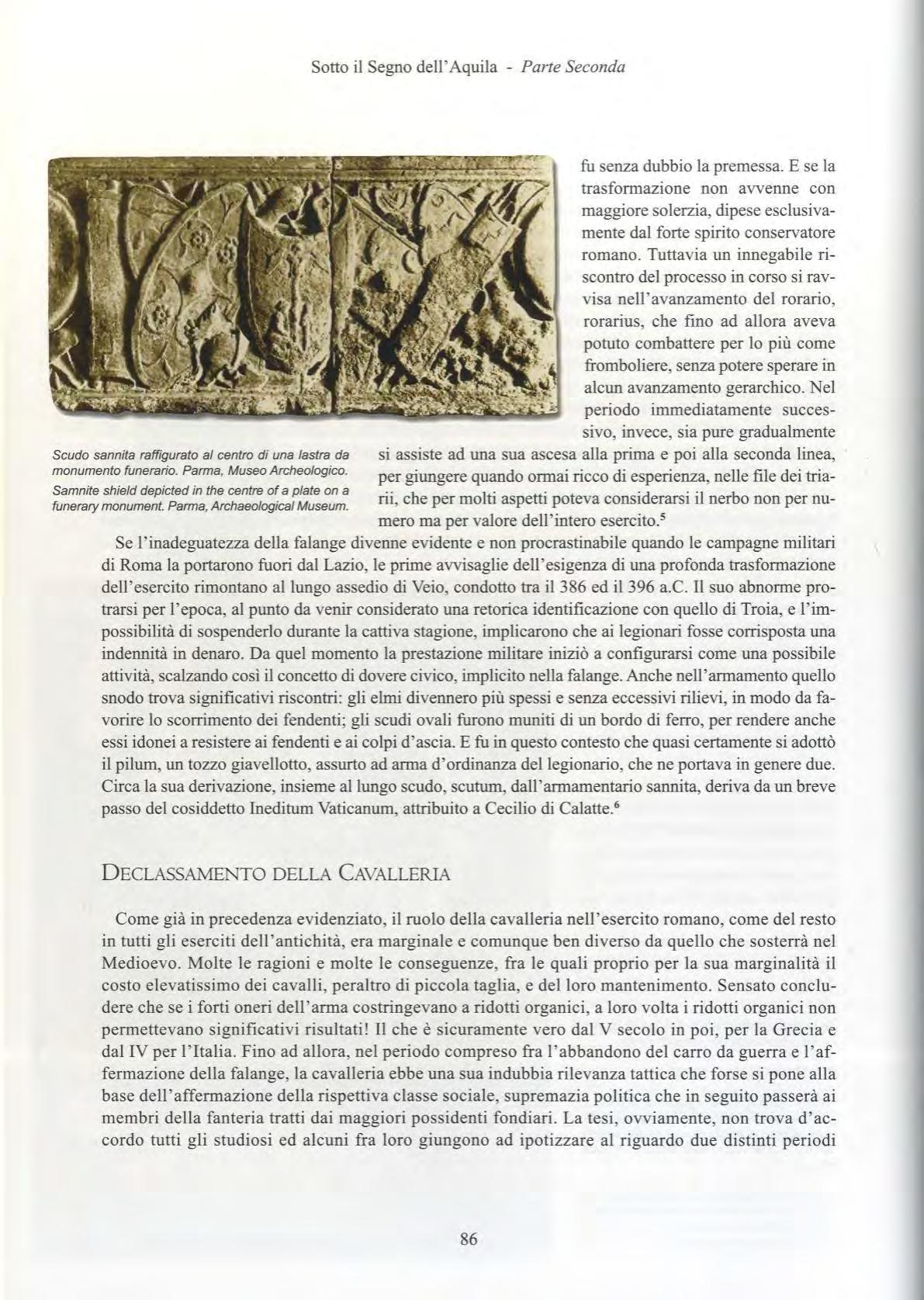
Sottoil Segnodell’Aquila - ParteSeconda
PΔ"E' M“”°Am"e°'°giw'
86
successivi,durante il primo dei quali sembra vigere una preminenza militare. sociale e politica della cavalleria, mentre il secondo appare carat» terizzato dalla formazione di eserciti di tipo po— litico. In questa fase l’aristocrazia equestre, ovviamente, avendo perso gran parte della sua rilevanza militare, riesce soltanto a conservare quella sociale e politica che comunque la svincola dalla diretta correlazione con l‘ambito militare assumendo le caratteristiche di un mero riferimento genealogico,’
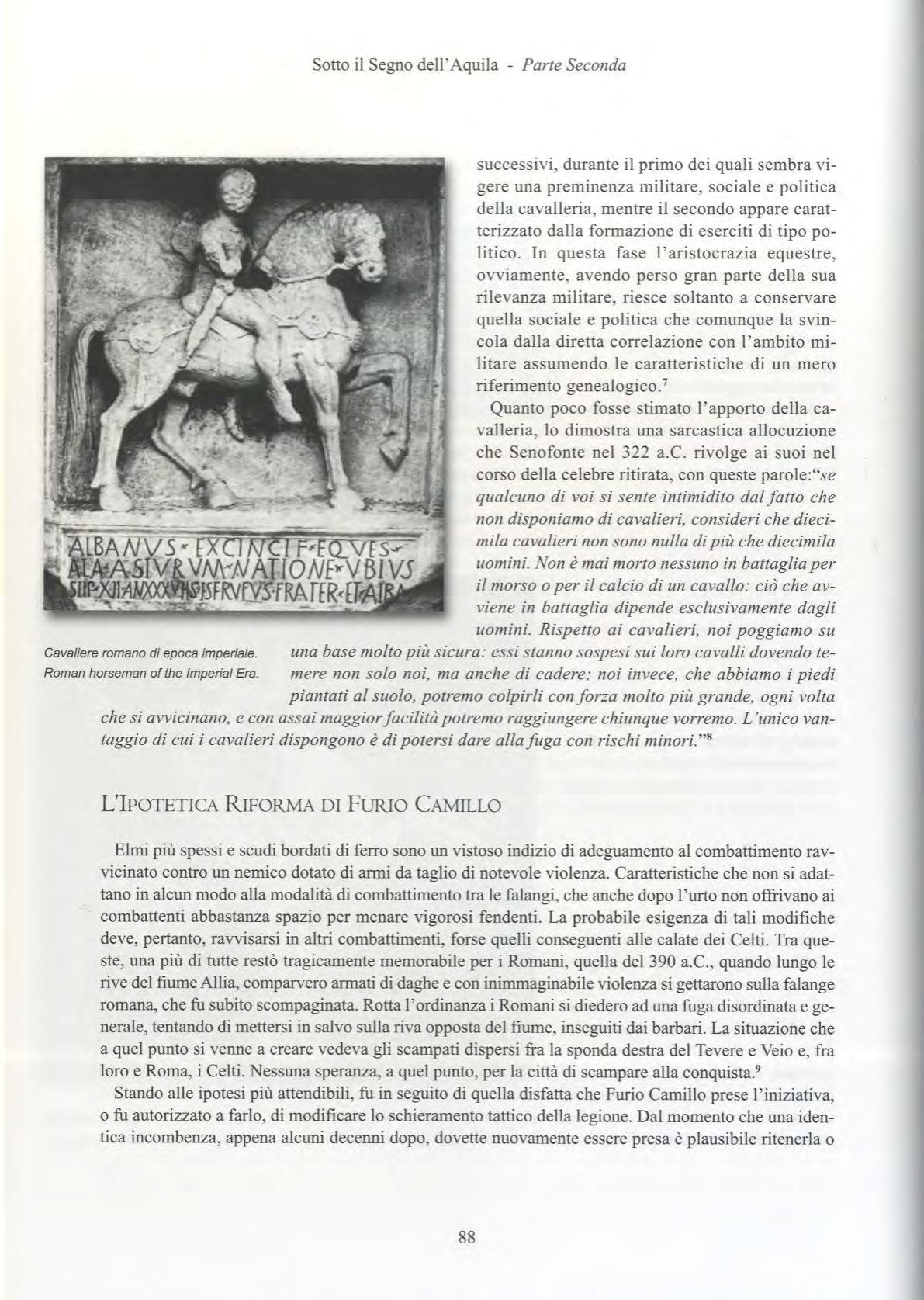
Quanto poco fosse stimato l’apporto della eavalleria, lo dimostra una sarcastica allocuzione che Senofonte nel 322 a.C. rivolge ai suoi nel corsodella celebreritirata, con questeparole:“;e qualcuna di voi si sente intimidito dalfalto che non disponiamodicavalieri, consideri chediecimila cavalierinon sononul1a dipiùchediecimila uomini. Non è maimorto nessuno in battagliaper ilmorso oper ilcalciodiun cavallo:ciòche av— viene in battaglia dipende esclusivamente dagli uomini. Rispetto ai cavalieri, noi poggiamo su Cavaliereromanadiepocaimperiale una basemoltopiù sicura:essistannosospesisuilorocava…dovendo teRomanhorsemanoftheImperialEra. mere non solo noi, ma anche di cadere: noi invece. che abbiamo ipiedi piantati alsuolo,potremo colpirli conforza moItapiù grande, ogni volta chesiavvicinano, econ assaimaggiorfacilitàpotremoraggiungerechiunquevorremo. L 'unicovantaggio di cuii cavalieridispongono è dipotersidareallofi4ga con rischiminori.“s
L’IPOTETICA RIFORMA DI FURIO CAMILLO
Elmipiù spessie scudibordati di ferrosonoun vistoso indiziodi adeguamentoal combattimentoravvicinatocontroun nemico dotatodi annidatagliodinotevole violenza. Caratteristichechenon siadattano inalcun modoallamodalitàdi combattimentotra lefalangi.cheanchedopol’urtonon offrivanoai combattenti abbastanza spazio per menare vigorosi fendenti. La probabile esigenza di tali modifiche deve, pertanto, rawisarsi in altri combattimenti, forsequelli conseguenti alle calate dei Celti.Tra queste,una più di tutte restò tragicamente memorabile per i Romani, quella del 390a.C., quando lungo le rivedelfiumeAllia,comparveroarmatididagheeconinimmaginabileviolenza sigettaronosullafalange romana,chefusubitoscompaginata.Rotta l’ordinanzaiRomanisidiederoaduna fugadisordinataegenerale,tentando dimettersi insalvosullariva oppostadel fiume, inseguiti daibarbari.La situazioneche a quel punto sivenne a crearevedeva gli scampatidispersi fra la spondadestra del Tevere eVeio e, fra loroeRoma, i Celti.Nessuna speranm,a quel punto, per lacittàdi scamparealla conquista.9
Shandoalleipotesi più attendibili, fuinsegritodi quella disfattache Furio Camilloprese l‘iniziativa, 0fuautorizzatoa farlo,dimodificare lo schieramentotatticodella legione…Dalmomento cheuna identica incombenza, appena alcuni decenni dopo, dovettenuovamente esserepresa eplausibile ritenerla o
Sotto i] Segnodell‘Aquila — ParteSeconda
88
parziale onon adeguataallenecessità. labreveuna mezza misura meramenteprovvisoria, che gli scontri con i montanari sanniti costringeranno ad una netta e radicale riformulazione. Sempre secondo il Mommsen, tesi che trova vasti consensi, fu proprio l’impatto con i Celti armati di spade che suggerì quella prima mutazione per cui, a suo dire, appare verosimile che con la suddivisione dell'esercito a blocchi separatidimanipoli sisiavoluto attenuare l’iniziale epiù furiosourto del nemico. Esito che in effettisembraraggiunto,percuilasuasupposizionesiaccordaconl’atîermazione,ripetuta inmoltenar— razioni, cheilmaggiore condottierodei Romani del tempo dei Galli, Marco Furio Camillo.ne sia stato il riformatoreanchedellalorotattica di combattimento,”
ORIGINEDELLA LEGIONE MANIPOLARE
Giustamente è statodamoltistudiosifattoosservareche:“quandoiRomanipenetraronoin Campania. la legionecomeformazionerigidapotémanovrareancorabene, ma quandovennein urto con iSanniti incombentieilloroesercito...[e]dovetteinoltrarsinel!'ennoterraappenninico, essasivenneatrovare in " '‘.si poserodegli ’ 'allenuove diguerraefi:allora che,per darlemobilità emanovrabilità, alposto della centuria sicreò, comeunità tatticapiù grande, ilmanipolo (cosi ' dalla difieno, ', ' in antica età I insegna), risultato dalla riunionediduecenturie;dalle60centuriedella legionesipassòin talmodoa 30manipoli.""
Loscorciostoricoincuidebuttòlalegionemanipolareèquasicontemporaneoaquellodeldebuttodella falangemacedone, propriamente detta dei sar-issofori. Sincroniadalla quale si deducepiù cheuna poco plausibile comuneesigenzaevolutiva,unacomunepercezione dell’arcaicitàperquelloschieramentoinadeguatoallenuove esigenze imposte daiteatri operativipiù accidentati,quali quelli dellaGrecia settentrionale edell’Italiacentrale.La contemporaneitàsemai fu dellaspintaespansionisticadi cui Macedoni eRomani sentironolo stimolo.Diverse,però, le rispettive modifiche, dal momento che i primi elaboraronol‘ordinanzaaranghiancorapiù serratieprofondi,mentreisecondilafi-ammentaronoinunitàminori articolateedautonome.Loschieramentocheinoriginecontava 8400uomini siscisseinduelegionidi4200 uomini ciascuna,destinateadundiversomododicombattere.L’asta chepotevadefinirsil’armaprecipua dellafalange,tenutaconentrambelemani, finiriservata allasolaterzalinea,mentre leprime due ebbero indotazioneun armadascagliaretipicadegliItalici: ilpilum.Utilizzatoquasicertamentenella difesaattivadellefortificazioniinoperapoligonaletantofrequentisullependici dell’Appenninocentrale".per la suatemibileefficaciapassòadarmarelelegioni.Perquantosenesa,venivascagliatodurantel’ultimafase dellacorsaprimadell‘urto,quando i due schieramentinon distavanopiù diunatrentina dimetri.
Iniziòcosì adincrementarsinelladinamicadellamutazionetattica, ilricorsoadannitelecinetiche,capaci cioèdi infrangerelalogicadelcorpoacorpo,percotendoadistanzeprogressivamente crescenti,tendenza da allora mai invertita…Un alieno,infatti, chepotesse, inun qualsiasi modo, assisteredaun altro pianetaall’evoluzioneumana non tarderebbemoltoa scoprire ilruolo essenziale sostenutodal combat» timentofradue contendenti.Ancormeno tempo impiegherebbeascoprirechelasuaimmutabile essenza consiste nel reciproco scagliarsi contro quantità di energia sempre maggiori e da distanze sempre maggiori. Sitratti della piccola pietra, lanciata dall’ancestralefionda rotante, odella sottile asticella di legnoappuntita,scoccatadaunpreistoricoarco,diunvorticanteboomerangodancoradellapalla dime» tallo sparata dalla violenta ossidazione dellapolvere pix-ica, la concezionenon muta… Muta, di volta in volta, lanatura dellaspinta, lagittatacoperta,lamassa delproietto epersino lasualetalità complessiva ma resta inalterato ilcriterioinformatoredellasequenza.Ancheun vettore balisticocontestatenucleari multipleepur sempreunaquantitàdi energia,enormenella fattispecie,destinataa percuotereilnemico
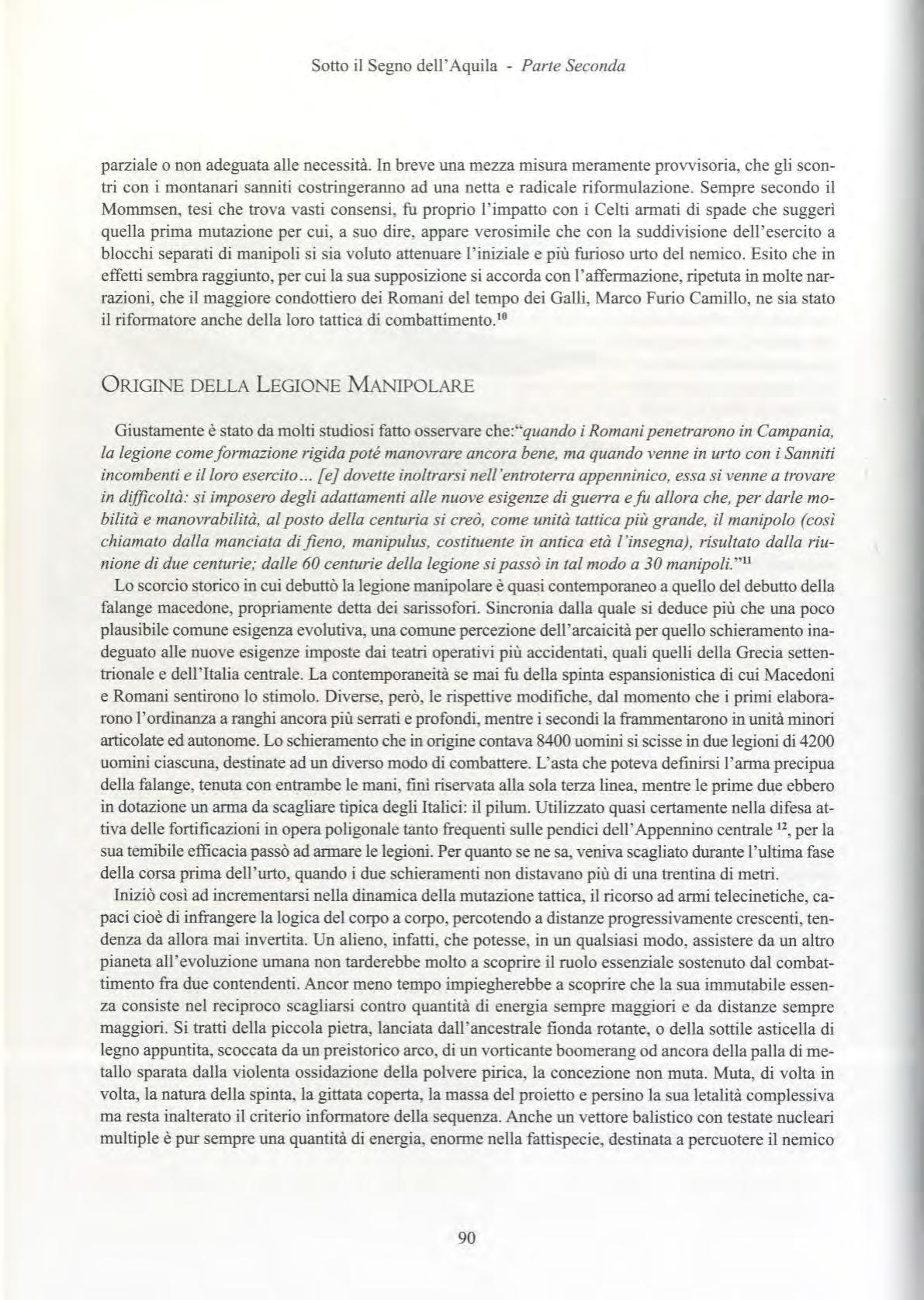
Sotto il Segnodell'Aquila - ParteSeconda
90
del momento, dovunque sitrovisullafacciadellaterra. Sedallariforma operatadaFurio Camilloe,soprattutto, dalle armi cheadottòomodificò affiora la natura dei nemici paventati ela loroprecipua modalitàdi combattimento, pure da questa seconda seriedi adeguamentitraspare un nemico ben definito. Un nemico che L adistanza, ‘, ’ condardi e=' “ equindi dil ’ ', evitando ogni scontrodiretto.
LE FORTEICAZIONI DEI SANNITI
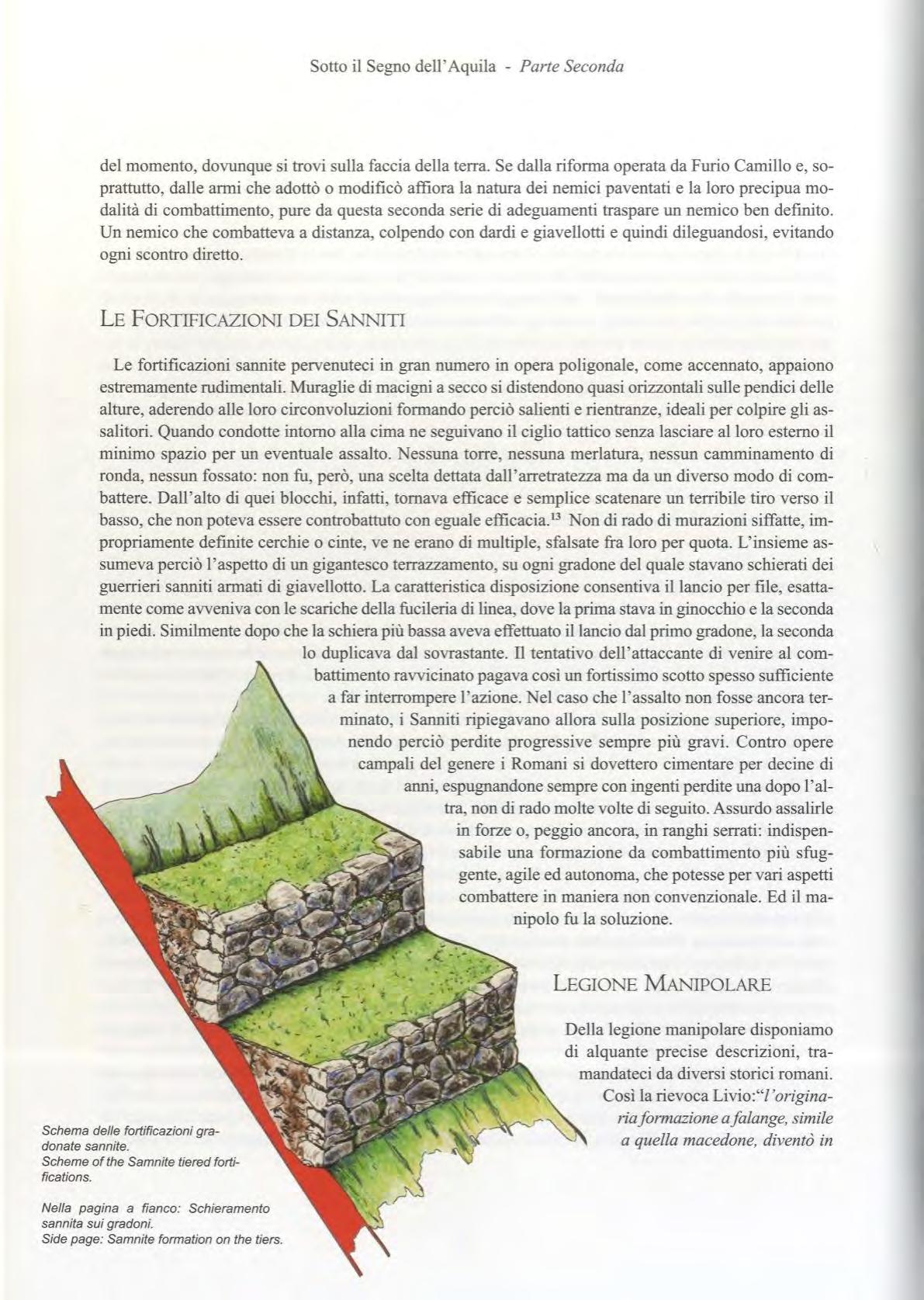
Le fortificazioni sannite pervenuteci in gran numero in opera poligonale, come accennato, appaiono estremamenterudimentali.Muragliedimacigniaseccosidistendonoquasiorizzontalisullependici delle alture,aderendoallelorocirconvoluzioni formandoperciòsalientierientranze, idealiper colpiregli aSv salitori.Quandocondotte intorno allacimaneseguivanoilcigliotatticosenzalasciare al loroesternoil minimo spazioper un eventuale assalto. Nessuna torre, nessuna merlatura, nessun camminamento di ronda, nessun fossato:non fu,però, una sceltadettatadall‘arretratezzama daun diversomodo di combattere. Dall’alto di queiblocchi, infatti,tornava eflìcace esemplice scatenareun tenibile tiro verso il basso,chenonpotevaesserecontrobattutoconegualeefficacia.“ Nondirado di murazioni siffatte,impropriamente definite cerchieocinte,veneeranodimultiple, sfalsatefia loroper quota.L’insieme&sumevaperciò l’aspettodiun gigantescotenazzamento, suogni gradonedel qualestavanoschieratidei guerrieri sannitiarmati di giavellotto…La caratteristicadisposizione consentivail lancioper file, esattamentecomeawenivaconlescarichedellafucileriadilinea,dovelaprima stavainginocchioelaseconda inpiedi. Similmentedopochelaschierapiùbassaavevaeffettuatoillanciodalprimogradone,laseconda lo duplicava dal sovrastante. Il tentativo dell’attaccante di venire al combattimentoravvicinatopagavacosiun fortissimoscottospessosufficiente afarinterromperel‘azione.Nel casoche l’assaltonon fosseancoraterminato, i Sanniti ripiegavano allora sulla posizione superiore, impo» nendo perciò perdite progressive sempre più gravi. Contro opere campali del genere i Romani si dovetterocimentare per decine di anni,espugnandonesempreconingentiperditeunadopol’altra,non diradomoltevoltediseguito.Assurdoassalirle inforzeo,peggio ancora,inranghi serrati:indispensabile una formazione da combattimento più sfuggente,agileedautonoma,chepotessepervari aspetti combattere in maniera non convenzionale.Ed il manipolo fu lasoluzione.
LEGIONE MANIPOLARE
Della legione manipolaredisponiamo di alquante precise descrizioni, tramandatecidadiversi storiciromani.
CosìlarievocaLivio:“l’originariaformazioneafalange.simile
Schema dellefortificazioni ra- . donatesen/lite. g
aquella macedone, diventa in SchemeoftheSamnìten'ered% fications,
Nella pagina a fianco: Schieramento sannitasuigradoni.
Sidepage:Samniteformationuntheriers.
Sotto il Segnodell‘Aquila ParteSeconda
seguito una linea di battagliaformata da manipoli, mentre la retroguardia eraformata di truppe di vario genere. In prima linea c’erano gli hastati, con quindici manipoli disposti a brevi intervalli. Ogni manie polo contava venti soldati con armamento leggero, cioè una lancia (hasta) e giavellotti; il rimanente eranosoldati muniti di scudo oblunga. Laprima linea consisteva delfior fiore deigiovani maturiper il servizio militare. Dietro a loro erano disposti, in numero eguale, i manipoli deiprincipes, soldatipiù anziani che avevano tutti lo scudo oblunga e armi migliori, Questo corpo era detto degli antepilani,perché dietro le insegne :’eranoaltre quindici linee di battaglia (ordines), ognuna divisa in tre aperti, laprima della quali era dettapilus. Ognuna di queste linee consisteva di tre vexilla. Il vexillum aveva sessanta uomini, due centurioni e un vexillarius (alfiere). La lineapercio' contava 186 uomini.Nelprimo vexillum c'erano i triarii, veterani esperti; nel secondo i rorarii, soldatipiù giovani e meno esperti; nel terzo gli accensi, soldati alleprime armi, e quindi situati nella retroguardia…
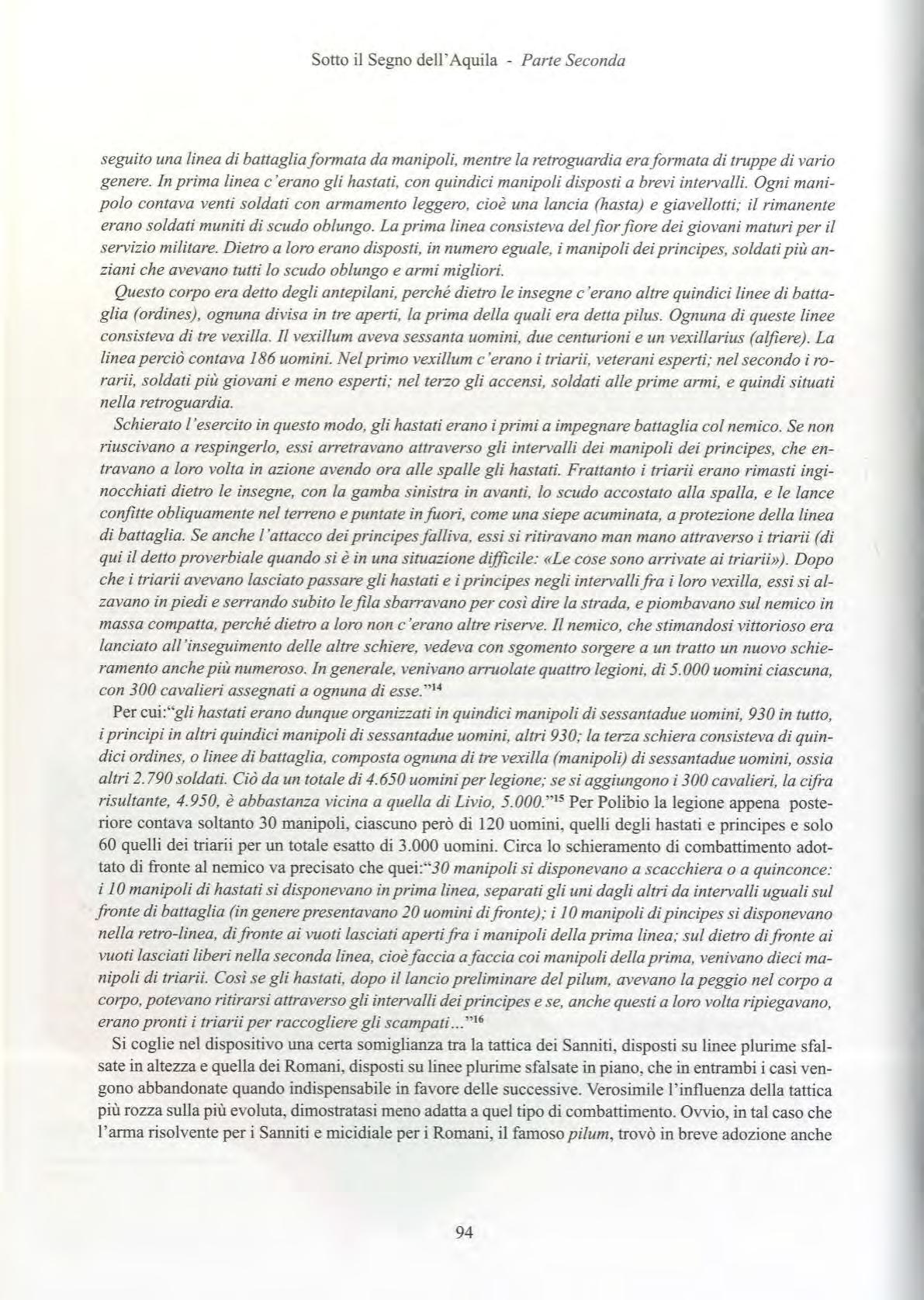
Schierato l ’esercitoinquesto modo.gli hastati erano iprimi a impegnarebattaglia col nemico. Se non riuscivano a respingerlo, essi arretravano attraverso gli intervalli dei manipoli dei principes. che entravano a loro volta in azione avendo ora alle spalle gli bastati. Frattanto i triarii erano rimasti inginocchiati dietro le insegne, con la gamba sinistra in avanti, lo scudo accostato alla spalla, e le lance confitte obliquamente nel terreno epuntate infuori, come unasiepe acuminata, aprotaione della linea di battaglia. Se anche l ”attaccodeiprincipesfizlliva, essi si ritiravano man mano attraverso i triarii (di qui il dettoproverbiale quando si è in unasituazione diflicile: «Le cose sono arrivate ai triarii»), Dopo che i triarii avevano lasciatopassare gli hastati e iprincipes negli intervallifia i loro vexilla, essi si alzavano inpiedi e serranda subito lefila sbarravanaper cosi dire la strada, epiombavano sul nemico in massa compatta,perché dietro a loro non c ’eranoaltre riserve. Il nemico, che stimandosi vittorioso era lanciato all inseguimento delle altre schiere, vedeva con sgomento sorgere a un tratto un nuova schieramento anchepiù numeroso. Ingenerale. venivanoarruolate quattro legioni. di 5.000 uomini ciascuna. con 300 cavalieri assegnati a ognuna di esse."“
Per cui:“inhastati erano dunque organizzati in quindici manipoli di sessantadue uomini, 930 in tutto, iprincipi in altri quindici manipoli di sessantadue uomini, altri 930; la terza schiera consisteva di quindici ordines. 0 linee di battaglia. composta ognuna di tre Vailla(manipoli) di sessantadue uomini, ossia altri 2.790soldati. Ciàda un totale di 4.650uominiper legione;se si aggiungono i 300 cavalieri, la ci ra risultante, 4.950, è abbastanza vicina a quella di Livio. 50007“ Per Polibio la legione appena posteriore contava soltanto 30 manipoli, ciascuno però di 120 uomini quelli degli bastati e principes e solo 60 quelli dei trim-ii per un mmie esatto di 3000 uomini. Circa lo schieramento di combattimento adottato di fionte al nemico va che quei:“30 ', "si’ a ' o a ‘ i 10 manipoli di bastati si disponevanoinprima linea separati gli uni dagli altri da intervalli ugualisul fronte di battaglia (ingenerepresentavano 20 uomini difronte), i 10 manipoli dipincipes si disponevano nella retro»linea, difmnte ai vuoti lasciati apertifra i manipoli dellaprima linea; sul dietro difionte ai vuoti lasciati liberi nellaseconda linea, cioèfaccia afizccia coi manipoli dellaprima, venivano dieci manipoli di triarii. Cosìsegli hastati. dopo il lanciopreliminare delpilum. avevano lapeggio nel corpo a corpo,potevano ritirarsi attraversogli intervalli deiprincipes ese, anchequesti a loro volta ripiegavano, eranopronti i triariiper raccoglieregli scampati...”“
Si coglie nel dispositivo una certa somiglianza tra la tattica dei Sanniti, disposti su linee plurime sfalsato in altezza e quella dei Romani, disposti su linee plurime sfalsate inpiano, che inentrambi i casi vengono abbandonate quando indispensabile infavore delle successive. Verosimilel’influenza della tattica più rozza sullapiù evoluta, disnestratasi meno adatta a quel tipo di combattimento. Ovvio,intal caso che l'arma risolventeper i Sanniti e micidiale per i Romani, il famoso pilum, trovò in breve adozione anche
Sotto il Segno dell'Aquila - Parte Seconda
94
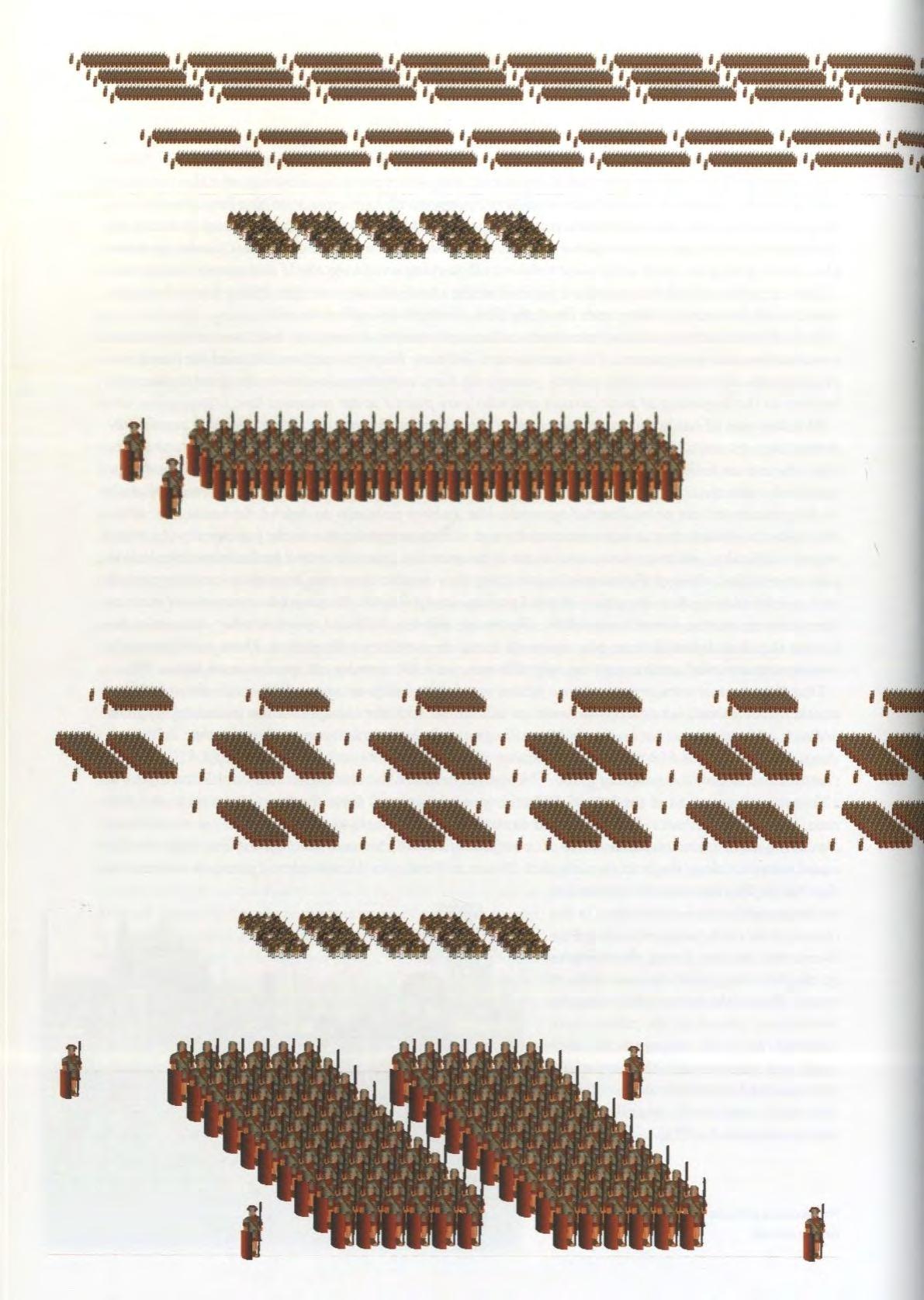
Schieramento legione manipolare secondo Livio. ln dettaglio unmanipolo al 60uomini,pan’ ad una centuria ed una turma di 30 Cavalieri.
Maniple legionformation accordlrlg to ley. Menlple of 50men, equal to ¢uryand a Squadron al 30 horsemen.
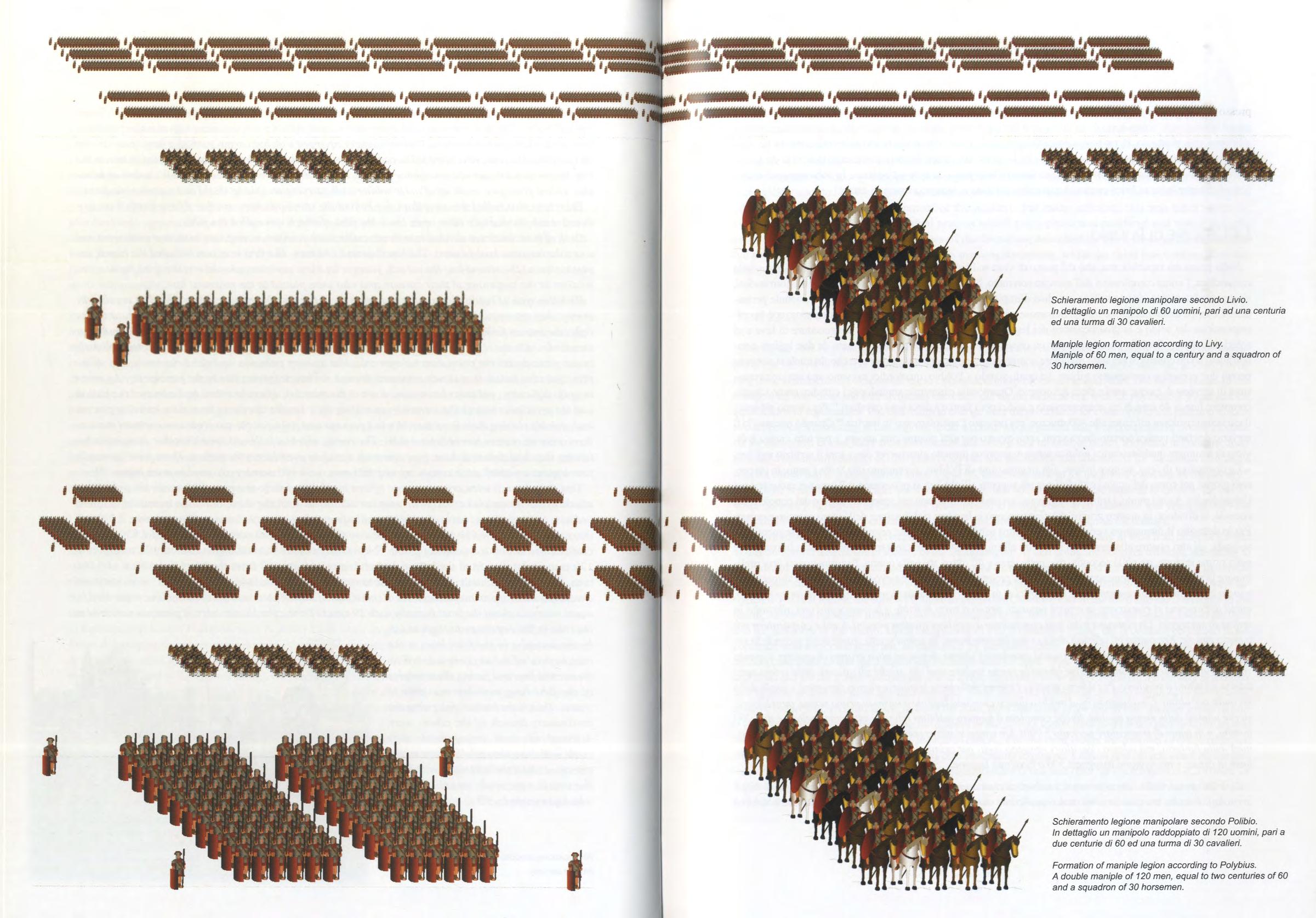
Schieramento legione manipolare secondo Politi/'a. ln dettagllo unmanipolo raddoppiato di 120 uomini,pen e due eentune di 60ed una tu!/na di 30 cavalier/.
Formal/on ofmaniple legio/'l according toPolyblus. A double manuale al 120 men, equal lo two cantu/les of 50 and a Squadron of 30 horsemen.
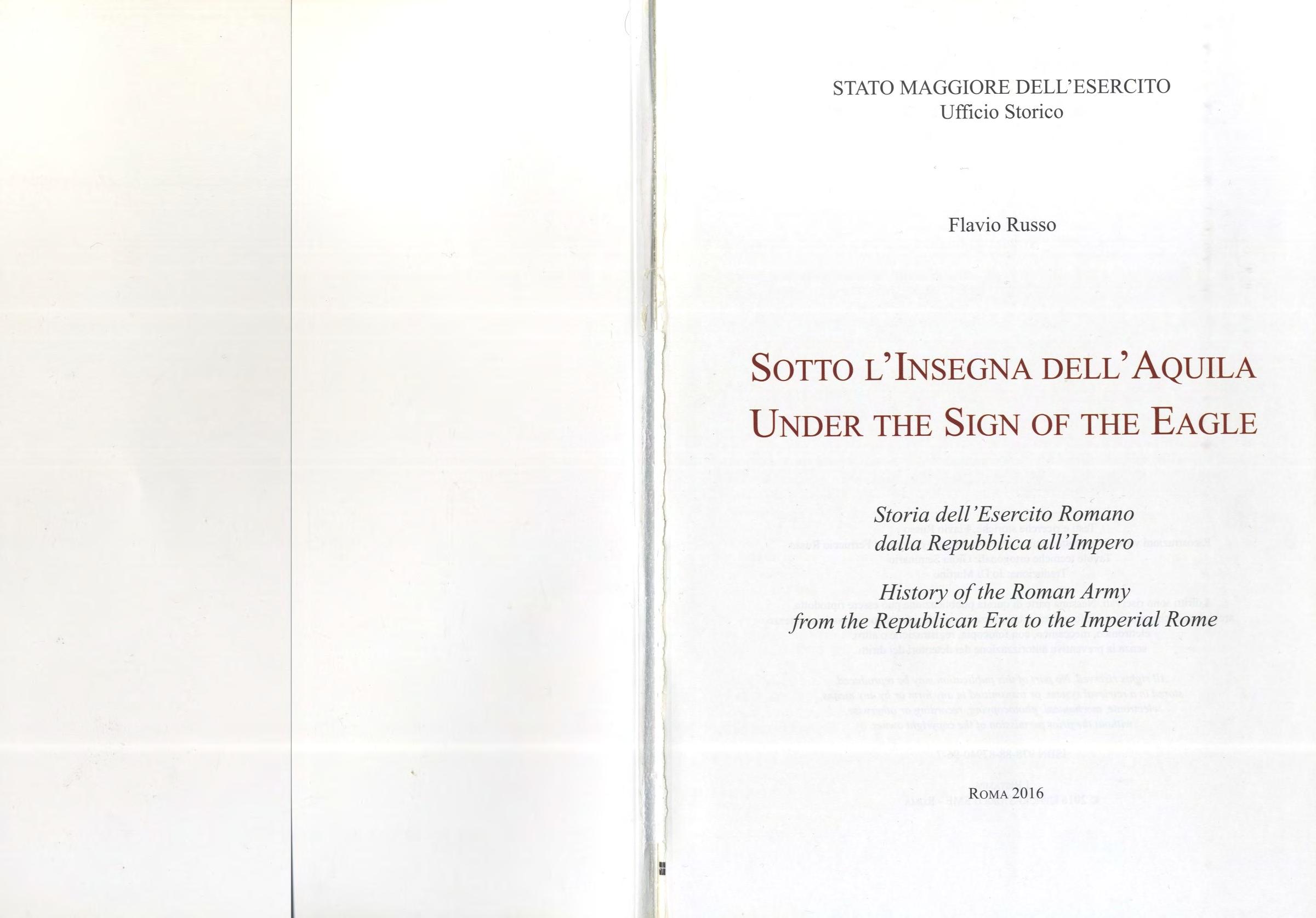
presso le legioni, per meglio ripropone la medesima tattica di scontro Adozione che segnò un tangibile passo innanzi nell’abbandono della falange Infatti, per molti studiosi, non si trattò di unpassaggio netto e brusco, ma di un lungo 4 e verificato - - in un ogni sua singola fase. In particolare si suppone che le prime due linee dello schieramento descritto da Livio, owen) quella degli bastati e dei principes fossero le prime e le sole ad adottare lo schieramento manipolare, mentre la terza linea continuò a disporsi a falange, sempre armata di asta.
LA LEGIONE DI POLIBIO

Nella prima età repubblicana, che dal punto di vista militare può considerarsi la mera continuazione della monarchica, l’entità complessiva dell’esercitononmutò.Mud) se mai lasua rilevanzastatuale trasformandosi, siapur gadatamente, da unamilizia cittadinad1mpiego mgionale a unaforza armataprofessionale permanete. Le tappe della hanno e la loro .. si ‘‘ in età " con la corresponsione del soldo e la qualificazione dei legionari. Dapprima però mutarono le procedure di leva e di selezione, alle spalle della coscrizione per un organico di due eserciti, ognuno formato da due legioni e subordinato ad unconsoleil cui statomaggiore comprendeva dodici tribuni, sei per esercito.In totale si avevano perciò due consoli e ventiquattro tribuni dei quali, stando a Polibio, quattordici avevano una anzianità mas— sima di servizio di cinque anni e dieci del doppio.Quantoalle campagne annuali che i cittadini erano tenuti a compierefino ai 46 anni di etàammontavano a sediciper i fanti e a dieci per i cavalieri.” Per i meno abbienti, il cui censo risultava inferiore alle 400 dracme, eraprevisto l’arruolamento in marina." Quandonecessario il servizio dei fanti venivaportato fino a venti anni, ovveroper altri quattro anni ancora, eper tutti vigeva il divietodi assumere qualsiasi caricapolitica senza averprima prestato almenoper dieci anni il servizio militare. Le operazioni di leva, sempre inbase alla rievocazione di Polibio, awengono una volta l’anno, inunprecisogiorno nel corso del quale i cittadini per età soggetti all’obbligo si presentano a Roma per radunarsi sul Campidoglio.Aquel punto, i tribuni più giovani, secondo l’ordine concui sono stati scelti o dal popolo ()dal console, si dividono in quattrogruppi che costituiscono la basilare suddivisione dell’intero esercito minano. Più in dettaglio il dispositivo vedeva i primi quattro tribuni assegnati allaprima legione, i tre seguenti alla seconda, gli altri quattro allatemi e gli ultimi tre allaquarta Quantoai dieci tribuni più anziani finivano due nella prima legione,tre nella seconda, due nella teme gli ultimi tre nella quam,Esaurita quesmfase preliminare laprocedlna prosegue secondo unpreciso programma, che così èrievocato dallo stesso autore:“Terminata ladistribuzioneeassegnazionedegli ufiicialiinmodo cheeiasazna legioneneabbia lostesso numero, quelli di ciascuna si riuniscono ingruppi separati, tirano a sorte le tribù, e le convocano una alla volta in ordine di sorteggio. Da ciascuna tribù essi cominciano a scegliere quattrogiovani di età e corporaturapiù omeno eguale.Fra questigli ufi‘icialidellaprima legionehanno laprima scelta, quelli della seconda la se» conda, quelli della terza e quelli della quartaprendano !’ultimo.Segue un altrogruppo di quattro, e questa voltagli uflicialidella seconda legione hanno laprima scelta ecosi via,sicché gli ufiîcialidellaprima sono adessogli ultimiascegliere.Per il terzogruppo, i tribuni della terza legionescelgonoperprimi, e quelli della secondaper ultimi. Continuandoinal modo a dare a ciascuna legionea turno laprima scelta, ogni legione riceve uomini della stessa qualità,finché completa il numero stabilito (cheper ciascuna legione è di 4.200 uomini, o in tempi diparticolare pericolo 5.000). Untemposi usavascegliere la cavalleria dopo i 4.200 uomini dellafiznteria; ma adesso i cavalieri vengonosceltiper primi, dopo che il censore liha selezionati in base al censo, e ne vengono assegnati 300 a ciascuna legione…
21. Fatto in tal modo [ ’arruolamento,i tribuni di ciascuna legione cuispetta questo compitoadunanogli arruolati, .? scelto tra tutti un uomo solo, quello che ritengonopiù idoneo, lofanno giurare che obbedirà
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte Seconda
98
ai suoi ufficiali e ne eseguirà gli ordiniper quanto è in suopotere. Poi gli altri vengono avanti, e ognuno turnopresta il giuramento, con cui si impegna a comportarsi come ilprt'mo soldato che ha giurato. C , i consoli ’ ! ’ordinedi ’ "' ai 'dellecittà confederate, dalle quali voglionoprendere i loro ausiliari, specificando il numero richiesto, il giorno eil luogo in cui i ,, ' dovranno ,, [. Le citta' ’ , ’ all'flll ' efanno prestare il giuramento nei modi già indicati e inviano isoldati con un comandante e un ufficiale addetto allepaghe. ] tribuni a Roma, amministrato il giuramento,fissano per ciascuno legione il giorno e il luogo in cui gli uomini devonopresentarsi senza armi, epoi li congedano, Quando isoldati arrivano nel luogo designato, [ tribuni scelgono ipiù giovani e meno ricchiperformare i velites, o truppe con armamento leggero; i successivi sono nominati hastati, Gli uomini nel pieno vigore delleforze sonofatti princeps e i soldati anziani triorii. (Sonoquesti i nomi usati dai romaniper le quattro classi di ciascuno legione, che tutte dWÌ’ÎSL‘OÌIDper età ed equipaggiamento). Li dividono in modo chegli uominipiù anziani detti tria— rii siano in numero di 600, ipriceps 1.200,gli hostoti 1.200, e tutti gli altri, ipiù giovani, siano velites (1.200). Se la legione consiste di oltre 4.000 uomini, li dividono nelle stesseproporzioni, tranne i trim rii. il numero dei quali è sempre uguale.
22. I soldati più giovani, i velites, devono avere una spada, giavellotti leggeri e uno scudo leggero (parma)… Lo scudo e rotondo, difattura robusta e, avendo trepiedi di diametro, egrande abbastanzaper fornire protezione. Hanno anche un elmo semplice, a volte coperto con unapelle di lupo o qualcosa di simile. siaper dar maggioreprotezione siaper consentire agli ufi‘r‘cialr' di notarepiùfacilmente se cornbattono coraggiosamente o no.
L ’astodi legno del giavellotto (hasta velitorr's) è lungo circa due cubiti, e spessa un dito; la cuspide è lunga unaspanna, appiattita e molto aguzza inpunta, di modo che si torce alprimo urto e il nemico non può più rilonciorla. Altrimenti la stessa orma sarebbe usato da entrambe leparti,
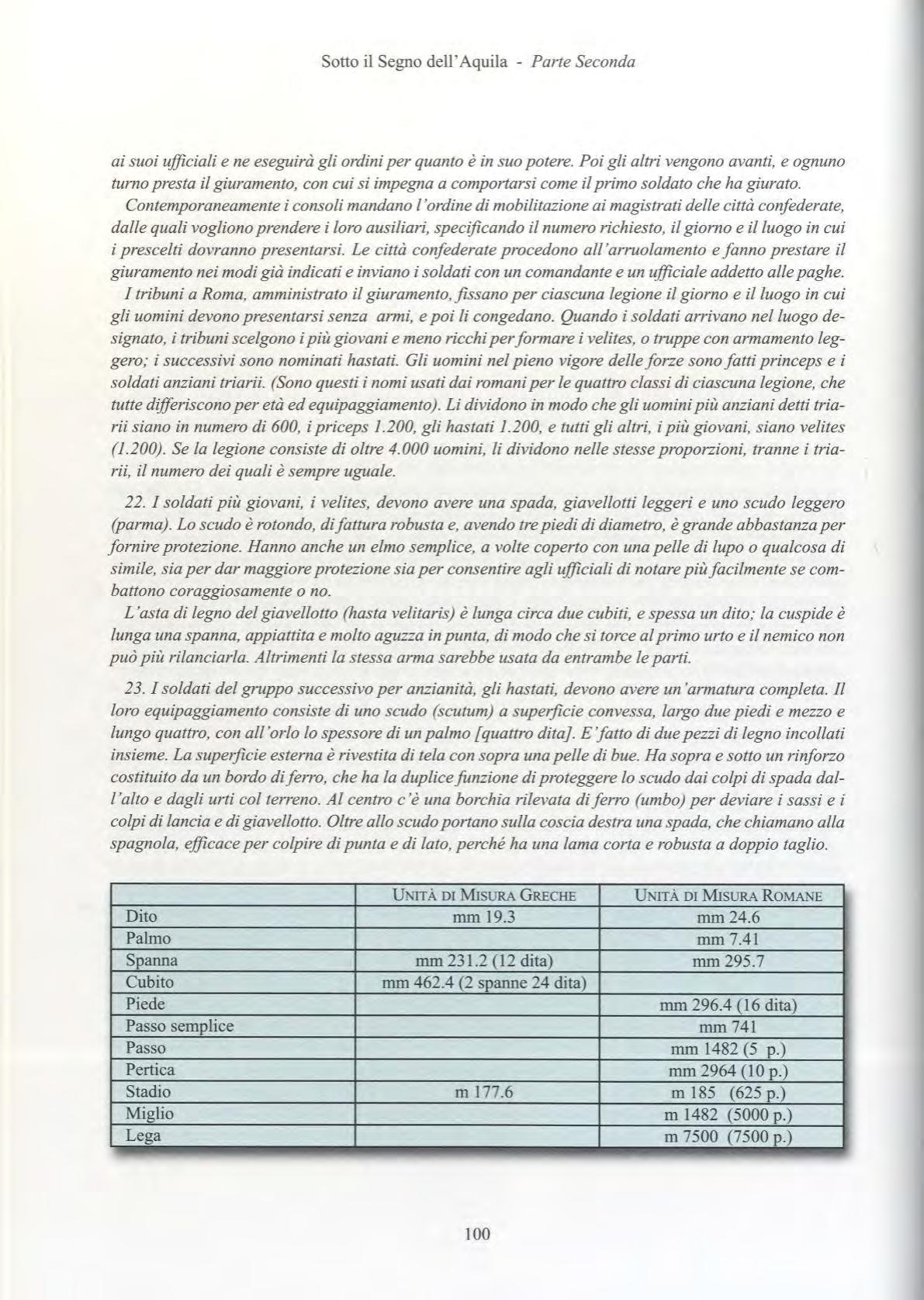
23. I soldati del gruppo successivoper anzianità, gli bastati. devono avere un 'annoturacompleto. Il loro equipaggiamento consiste di uno scudo (sc-ulurn) a superficie convesso, largo duepiedi e mezzo e lungo quattro, con al] 'orlolo spessore di unpalmo [quattro dita]… E 'fattodi duepezzi di legno incollati insieme, La superficie esterna è rivestito di tela consopra unapelle di bue… Ha sopra e sono un rinforzo costituito da un bordo diferro, che ha la duplicefunzione diproteggere lo scudo dai colpi di spada dal!’allae dagli urti col terreno. Al centro c ’e‘una borchia rilevata diferro (umbo)per deviare i sassi e i colpi di lancio e digiavellotto. Oltreallo scudoportano sulla coscia destra unaspada, che chiamano alla spagnola, eflìcaceper colpire dipunto e di loto,perché ho una lama corta e robusta a doppio taglio.
Dl mm
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte Seconda
Gli bastati hanno inoltredue giove/lotti pesanti (pila), un elmo di bronzo egli schinieri.
Ipila sono di duespecie,pesanti e leggeri Alcunipila pesanti sono rotondi e lunghi trecubiti, col diametrodi unpalmo, altri sono di unpalmo quadrato. [pila leggeri somigliano a lanceda caccia di dimeruioni convenienti, e anche il manico è lungo tre cubiti. Sono tuttiprovvisti di una cuspide diferro lungo come il manico. Questa è attaccata cosi saldamente al manico. essendoper metà infilata in esso efissata con numerosi chiodi, che in azione ilferro sipuò spaz…ma non staccare, sebbene alfondo, dove incontra il legno, abbia unospessore di cima un ditoeInazo; con tanto caroprovvedono ad attaccarlo saldamente, Inoltregli hastatihannocomedecorazione incimaall 'elmounpennacchio. con trepiume drittenereerosse alte circa un cubito, che sovrapposte al resto dell 'armaturafanno sembrare un soldato alto il doppio della sua verastatura, egli danno unaspetto imponente,contribuendoaseminare ilterrorenel nemico.
I soldati hanno ordinariamente anche una corazza di bronzo quadrata di circa una spanna che met« tono difronte al cuore e chiamanopettorale @ectorale), e che completa la loro armatura.
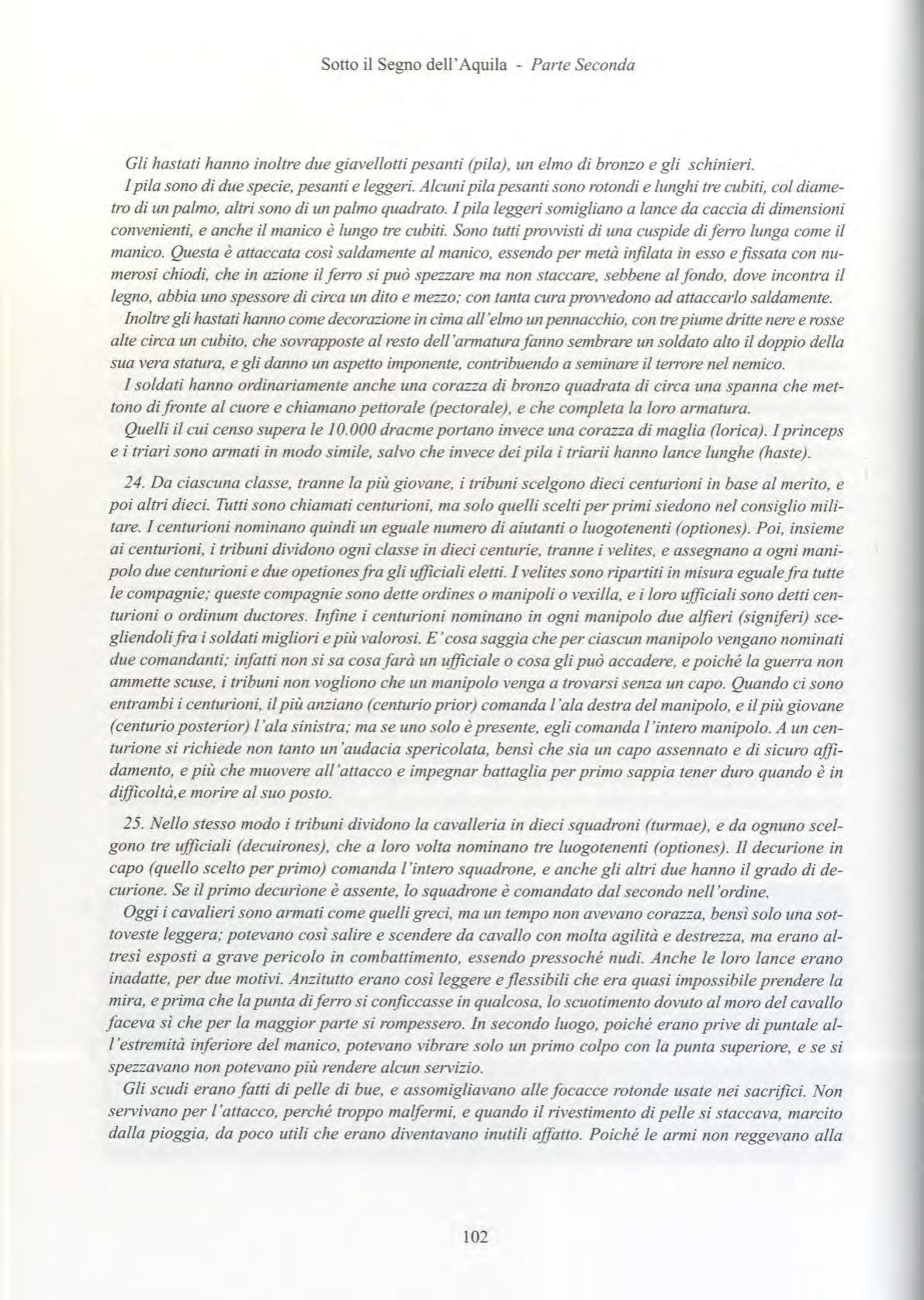
Quelliil cui censosupera le 10.000dracmeportano invece una corazza di maglia (lorica).I princeps e i triarisono armati in modosimile, salvo che invece deipila i triarii hanno lance lunghe (haste).
24, Da ciascuna classe, tranne lapiù giovane, i tribuniscelgano dieci centurioni in base al merito, e poi altri dieci. Tuttisono chiamati centurioni, ma solo quellisceltiper primi siedono nel consiglio militare. I centurioni nominanoquindi un eguale numero di aiutanti o luogotenenti (optiones),Poi, insieme ai centurioni, i tribuni dividono ogni classe in dieci centurie, tranne i velites, e assegnano a ogni manipolo due centurionie due opetionesfi'agli ufliciali eletti.[ velitessono ripartiti inmisura egualefra tutte le compagnie; questecompagnie sono dette ordine…?o manipoli o vexilla, e i loro ufficiali sono detti cen— turioni o ordinum duetores. Infine i centurioni nominano in ogni manipolo due alfieri (signiferi) scegliendolifra isoldati migliori epiù valorosi,E 'cosasaggio cheper ciascun manipolo venganonominati due comandanti infatti non si sa cosafarà un ufi'iciale o cosaglipuo' accadere, epoiche' laguerra non ammette scuse, i tribuni non vogliono che un manipolo venga a trovarsisenza un capo. Quando ci sono entrambi i centurioni, ilpiù anziano (centuriaprior) comanda l ’aladestra del manipolo, e ilpiù giovane (centuriaposterior) !'alasinistra; ma se unasolo èpresente, egli comanda !'interomanipolo.A un centurione si richiede non tanto un 'audaciaspericolata, bensi che sia un capo assennato e di sicuro affidamento, epiù che muovere all ’attaccoe impegnar battagliaper primo sappia tener duro quando è in diflìcoltà,e morire al suoposto…
25. Nello stesso modo i tribuni dividono la cavalleria in dieci squadroni (turmae), e da ognuno scelgono tre ufficiali (decuirones), che a loro volta nominano tre luogotenenti (optiones). Il decurione in capo (quellosceltoper primo) comanda [ 'interosquadrone, e anche gli altri due hanno il grado di decurione. Se ilprimo decurione è assente, losquadrone è comandato dal secondo nel! 'ordine.
Oggi i cavalierisono armati come quelligreci, ma un tempo non avevano corazza,bensì solo unasottoveste leggera;potevano cosi salire e scendere da cavallo con molta agilità e destrezza, ma erano altresì esposti a grave pericolo in combattimento, essendopressoche' nudi. Anche le loro lance erano inadatte,per due motivi.Anzitutto erano così leggere eflessibili che era quasi impossibileprendere la mira. eprima che lapunta diferro si conficcasse in qualcosa, loscuotimento dovuto al moro del cavallo fixceva sì cheper la maggiorparte si rompessero. In secondo luogo,poiche' eranoprive dipuntale alI 'estremità inferiore del manico,potevano vibrare solo unprimo colpo con lapunta superiore, e se si spezzavano nonpotevano più rendere alcun servizio.
Gli scudi eranofatti dipelle di bue, e assomigliavano allefocacce rotonde usate nei sacrifici. Non servivanoper l'attacco,perché troppo mal/enni, e quando il rivestimento dipelle si staccava, maretto dallapioggia, dapoco utili che erano diventavano inutili affatto… Poiché le anni non reggevano alla
Sono il Segno dell‘Aquila - Parte Seconda
102
prova, cominciarono afarle a! modo greco, che consente unprimo colpo i lancia vigoroso e ben mirato, essendo la lancia difattura robusta e stabile: e questapoi sipuò usare anche alla rovescia, colpendo colpuntale infondoal manico.Lo stesso valeper gli scudi greci, che essendosolidi e resistenti sono utili sia contro un attacco a distanza, sia per !’assaltorawicinato.
[Romani quando ne vennero a conoscenza subito imitarono tali anni,perche' più di ogni altropopolo essi sanno mutare ipropri costumi e tendere al meglio.
26. I tribuni, dopo aver compiuto la ripartizione delle truppe e aver loro ordinato di armarsi nella manieraprescritta lerimandanoa casa. Quandogiunge ilgiorno in cui tutti hannogiurato di trovarsi raccolti nel luogostabilito dai consoli (ciascun console quasisempre stabilisceper contosuo il luogo di riunioneper leproprie truppe, comandando ciascuno a meta‘ delle truppe alleate e due legioni ro— mane), tutti gli arruolati infizllibilmente si presentano; inflittiper coloro che hanno giurato nessun 'altrascusa è ammessa trannegli auspici e i casi difono maggiore.
Quando tutti, alleati e Romani, si sono riuniti,provvedono alla loro amministrazione e al loro addestramentododici ufi‘iciali nominati dai consoli, chiamatipraefecti sociorum. Questi inprimo luogo presentano ai consolifra tuttigli alleati i cavalieri e ifanti più adatti a rendere servizi eflettivi. Essi sono chiamati extraordinarii (termine che va interpretato nel senso di 'scelti’).

Il numero totaledeifanti alleati èper lopiù uguale aquellodei Romani; triplice invece è il numero dei cavalieri. Circaun ter20 della cavalleriaalleata e un quintodella lorofiznteria firmano ilcorpo scelto, Gli altri sono divisi in dueparti, che !'aladestra e l'ala sinistra.
Campiute come si addice tutte queste operazionipreliminari, i tribuni riuniscono i Romani egli alleati e si accampano tutti insieme”"
IL PILUM: ORIGINE ECARATTERISTICHE
Data larilevanza che ilpilum avrà in ambito tattico,è giustificata una breve digressione per meglio precisame le caratteristiche.Dunque in lineadi mmsima ilpilum fu un giavellotto e:“nella suaforma arcaica -comparve agli inizi del I Vsecolo a.C.- aveva un lungoferro tondo opoligonato appuntito, che alla base si infilava o accoglieva l'asta lignea.Il lungoferro delpilum risultavaparticolarmente utile soprattutto quando si combatteva con un nemico che adoperava una spada lunga (comeper esempio i Galli),con la quale avrebberopotutofitcilmente tagliare il legno del! ’asta.
Il pilum classico era di due tipi: quellopesante, formato da unferro di circa 70 cm con cuspide a tozzafoglia o broccapoligonato o tondo, asta infrassino con un diametro di 7,5cm e lunga m 1.40, munita spesso di calzuolo... L’attacco diferro poteva essere a lamella (che entrava in una apposita asola nel legno ed erafissata da due chiodi), agorbia intera o a mezzagorbia. Subito dopo l’attacco delferro con l’asta vi era unaghiera squadrata, o tronco-conica osferoide,per aumentare ilpeso. Il pilum leggero aveva lestesse misure di lunghezza,sia del legno che delferro, ma quest 'ultimoera notevolmentepiù sottile, con un diametro di circa 3 cm, ed eraprevalentemente munito di lamelleper il fissaggio. Questo giavellotto, nel lungoperiodo d ’uso,subì due modifiche, entrambe tese a evitare che scagliato contro il nemico, questipotesse utilizzarlo a sua volta,"m Circa le menzionate modifiche laprima venne attribuita aMario (ISK-86 a.C.) e la seconda di Cesare (IOD—44 a.C,).
In effetti nella dotazione d‘ordinanza dei legionari romani debutta dal IV secolo aC.,uno strano giavellotto,chiamatopilum. Lungo circadue metri,per quanto se ne sa e inciò insiste ladilîerenza con i coevi, venivascagliato abitualmente mediante l‘ausilio di unacorteggia,detta a sua volta amen…applicatagli immediatamente dietro il centro di gravità, avvolta con due opiù spire. Se alcuni studiosi presuppongono
Sono il Segno dell'Aquila - Parte Seconda
Ricostruzione dipilum mmsno &, nellapagina afianco, moneta che lo mtìîgulî in dotazione ad un legionario. Recansl‘mtîtion of a Roman pilum and, to theside, coin depicfing legionnairs withpilum.
per ilpilum generico unaorigineetrusca,altri,invece, propendono per una celtica,altri ancoraper una sannitica nella fattispecie, però, con l’amentum, come sembrerebbe avvalorare almenounafonte nonfantasiosa Di certolasua comparsasi collocanel contesto delle aspre guerre sannitiche e,soprattutto, della trasformazione della legione da falangistica a manipolare. In epoca arcaica, per la verità, anni con propulsori analoghi si rintracciano in Greciadove:“i giavellotti somigliavanomoltoallelance tenutedagli opliti e, in origine, dovevanopersino essere identici; tuttaviacominciaronoadifierenziarsene...per lalunghezza delfitsto eper le dimensioni della punta e delle basi metalliche che avevano alle estremità. Venivanolanciatiamano, oppurecon 1‘aiutodiunacinghia di propulsione fissata alla metà dell 'asta: in quest'ultimocaso, avevano unaportata di quasi 100 m. Proprioperché erano semplici, le loro caratteri stiche tecniche non ebbero modificazioni di rilievo sotto !”imperoromano.”“
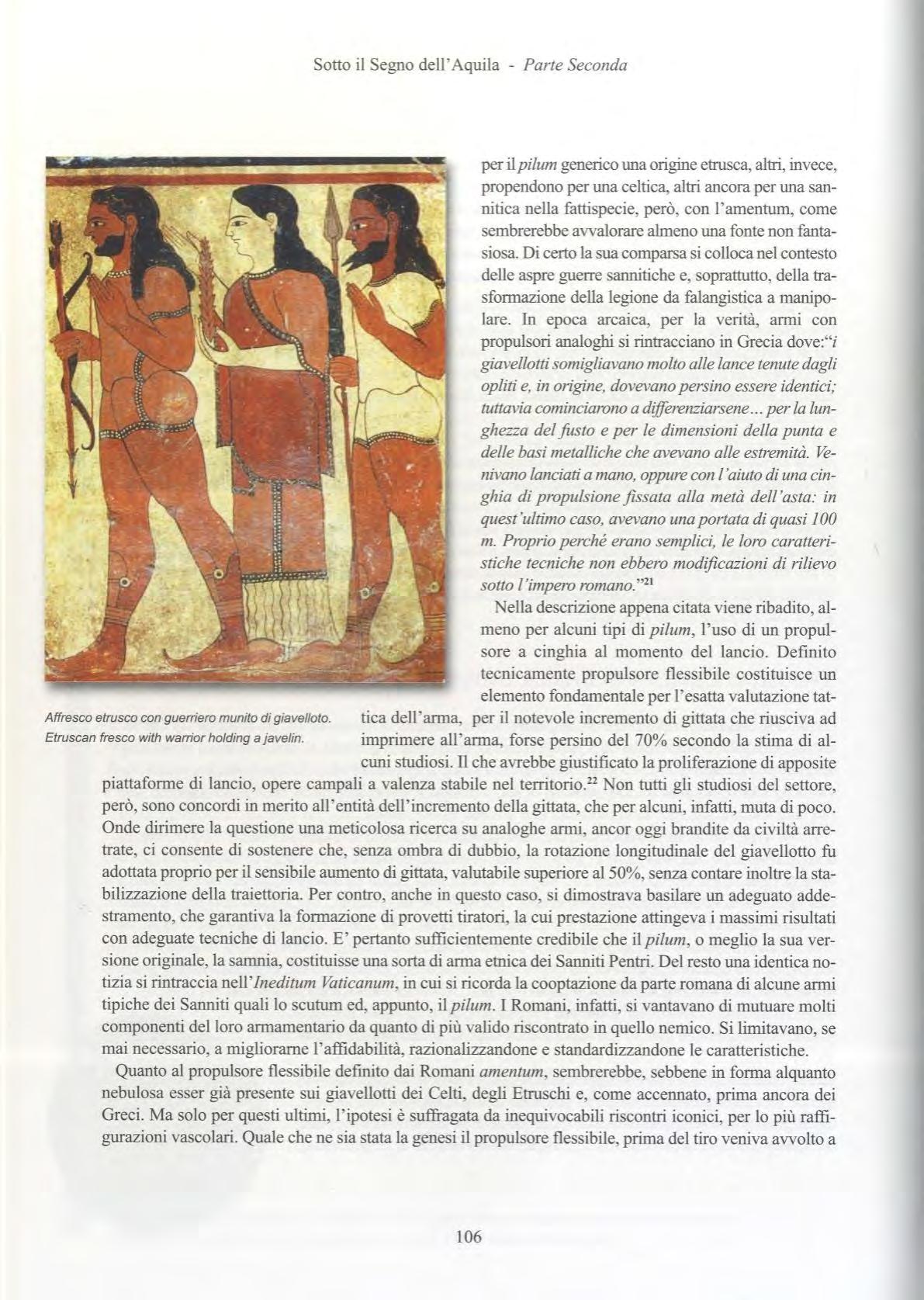
Nella descrizione appenacitataviene ribadito,almeno per alcuni tipi di pilum, l’uso di un propul— sore a cinghia al momento del lancio. Definito tecnicamente propulsore flessibile costituisce un elementofondamentale per l’esattavalutazione tat-
Afl‘resoo etruscooonguerriero munitodlgiavellolo. tica dell’arma, per il notevole incremento di gittata che riusciva ad Efruscan fresca wim warner holding aiavelin- imprimere all’arma, forse persino del 70% secondo la stima di alcuni studiosi. 11che avrebbe giustificato laproliferazione di apposite piattaforme di lancio, opere campali a valenza stabile nel territorio." Non tutti gli studiosi del settore, però, sono concordi in merito all’entità dell’incremento dellagittata, cheper alcuni, infatti,muta di poco. Onde dirimere la questione unameticolosa ricerca su analoghe anni,ancor oggi brandite da civiltà arretrate, ci consente di sostenere che, senza ombra di dubbio, la rotazione longitudinale del giavellotto fu adottataproprio per il sensibile aumentodi gittata,valutabile superiore al 50%,senzacontare inoltrelastabilizzazione della traiettoria. Per contro,anche in questo caso,si dimostrava basilare un adeguato addestramento,che garantiva laformazione di provetti tiratori, la cui prestazione attingeva i massimi risultati con adeguate tecniche di lancio. E’ pertanto sufiîcientemente credibile che ilpilum, o meglio la sua versione origjnale,lasamnia,costituisseunasortadi arma etnicadei Sanniti Penn-i. Del restouna identicano— tizia si rintraccia nell’1neditum Vaticanum,in cui si ricorda lacooptazione daparte romana di alcune armi tipiche dei Sanniti quali lo scutum ed,appunto,ilpilum. [ Romani, infatti,si vantavano di mutuate molti componenti del loro armamentario da quanto di più validoriscontrato inquello nemico… Si limitavano,se mai necessario, a migliorarne l‘afiìdabilità,razionaliz7andone e standardizzandone le caratteristiche, Quanto al propulsore flessibile definito dai Romani amenturn,sembrerebbe, sebbene informa alquanto nebulosa esser già presente sui giavellotti dei Celti,degli Etruschi e, come accennato,prima ancora dei Greci.Ma solo per questi ultimi,l’ipotesi è suffragata da inequivocabili riscontri iconici,per lo più raffigurazioni vascolari. Qualeche ne sia stata lagenesi ilpropulsore flessibile, prima del tiro veniva awolto a
Sotto il Segno dell’Aquila -
Parte Seconda
106
spirale intorno all’asta e al momento del lancio,trattenuto con il pollice, impar» tivaall‘anna unavorticosa rotazione intornoall’asse longitudinale.Più indettaglioilpilum ola samnia dei Sanniti.non riceveva l’impulso motore tramite presa diretta, owero dal palmo della mano come le tradizionali lance,ma attraverso lafulminea sferzata dell'amentum.al termine della corsa di lan» cio. La sollecitazione cosi impressain constava di due componenti,delle quali unaequivalente alla tradizionale traslativae l’altra.del tuttodiversa, rotativa.Circa laprima, allungandosi conlacinghia il braccio del tiratore, ne conseguiva una maggiore velocità iniziale e quindi una maggiore gittata. Circa la seconda va osservato che la rotazione imprimeva un efi‘etto giroscopico all’arma, lo stesso che al presente è impresso aiproietti dalla rigatura dell’anima. Esito delle concause un vistosissimo incremento di gittata e di stabilità del tiro,che acquisiva cosi potenzialità mortifere eccezionali.
E che ilpilum, proprio quello munito di amentum, non fosse una acquisizione effimera lo dimostra un brano del De Bello Gallico ” di GiulioCesare,incui l’autore racconta di aver ordinatoad un suo subalternodi scagliare all’interno di un accampamento legionario cinto d’assedio dal nemico e pertanto non raggiungibile inalcunmodo direttamente, un pilum con un messaggio legato intorno mediante l’amen- mm,per l‘esattezza: cum epistole ad amentum deligata.
In conclusione è giusto ritenere in merito che:“le lance usate nel! ’esercito romano venivano scagliate, per portate superiori, con l 'aiutodel] 'amentum,cor-reggia di cuoio avvolta a spirale sull'asta. opportunamente afi”errata, e la cui estremità libera rimaneva nella mano del tiratore... Questa Busto di Giulio Cesare. tecnica…ebbeilsuo apicefra i minatoridel WestRiding (Yorkshire), dove legare Bus! o!Jul/us Caesar. di lancio,nelsecoloXIX.potevano raggiungere i 340 m.”“ Unacuriosa estrema derivazione della micidiale arma e del suopropulsore. sopmwive nella notissima trottoladei bambini messa in rapida rotazione, intorno alla sua punta, per effetto della strappo dellafune!
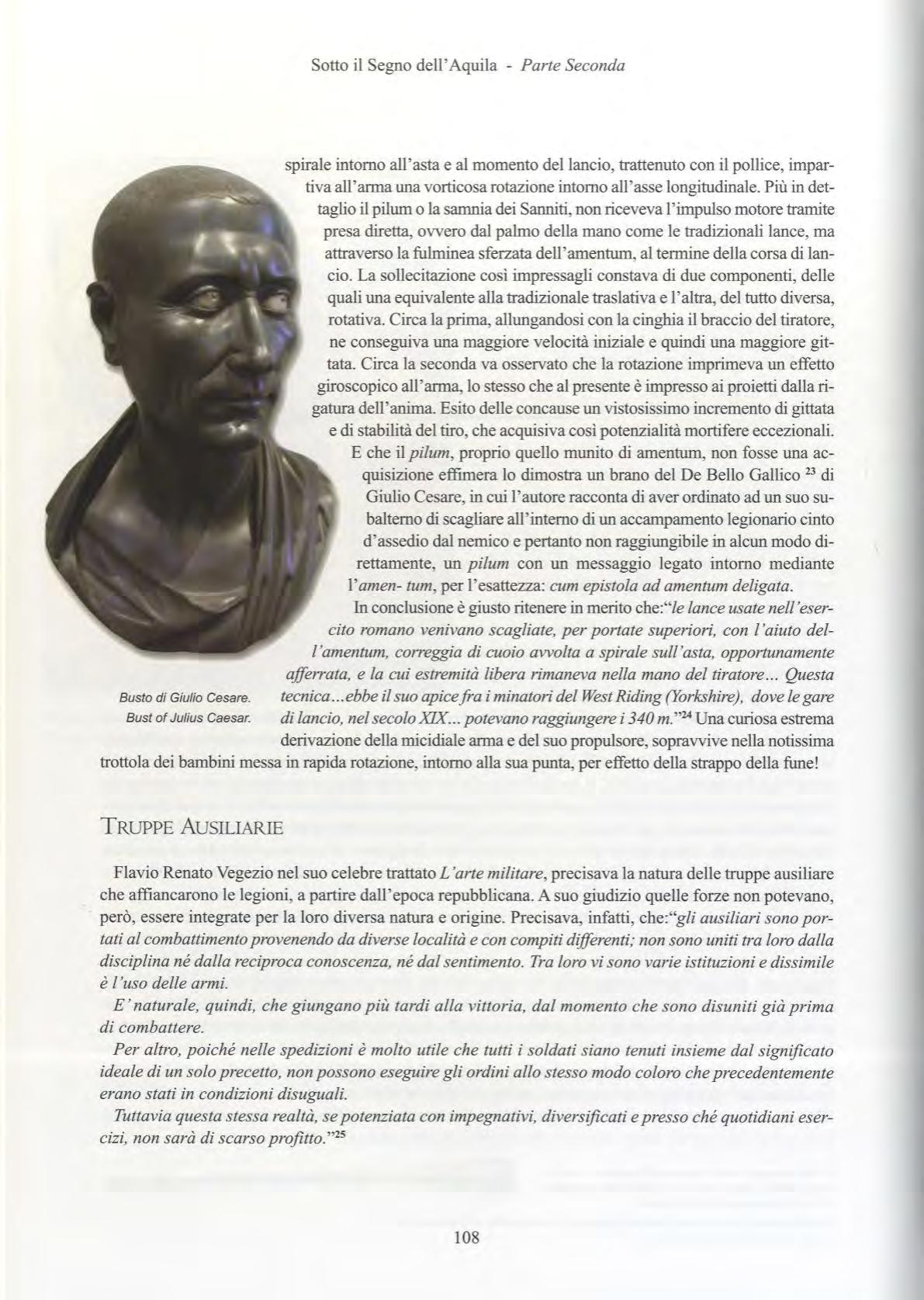
TRUPPE AUSILIARIE
Flavio Renato Vegezionel suo celebre trattatoL ’arremilitare,precisava la natura delle truppe ausiliare che affiancarono le legioni,a partire dall'epoca repubblicana.A suo giudizio quelle forze non potevano, però, essere integrate per la loro diversa natura e origine. Precisava, infatti, che:“in ausiliari sonoportati al combattimentoprovenendo da diverse località e con compitidifferenti; nonsono uniti tra loro dalla " '," né dalla ',, né dal Tra loro visono varie istituzioni e dissimile è 1’usodelle armi.
E'naturale, quindi, che giungano più tardi alla vittoria, dal momento che sono disuniti giàprima di combattere.
PEr altro,poiché nelle spedizioni e molto utile che tutti i soldati siano tenuti insieme dal significato ideale di unsoloprecetto, nonpossono eseguiregli ordini allostesso modo coloro cheprecedentemente erano stati in condizioni disuguali.
Tuttavia questastessa realta', sepotenziata con impegnativi, diversificati epresso che' quotidiani esere tizi, non sara' di scarso profitlo.”5
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte Seconda
108
L‘aver evidenziato a fronte dei molteplici svantaggidelletruppe ausiliare anchelenon inilevanti potenzialità che offrivano.rende la sintetica analisi di VegezioFlaviodi immediataefficacia. Gli aiuti/ia, infatti,potenziavano le legioni non tantocomepurorincalzonumerico, che in tal caso per le giuste obiezioni di Vegczio sarebbero state più di intralcio che di aiuto, ma come tmppe complementari che si occupavano di funzioni non altrimenti esplef tate. I Romani, ad esempio, rinunciaronoben prestoaltirousodell’arcoedella fionda, ma non alla loro effettuazioneche,infatti,fuaffidatada un certo momento in poi agli arcieri e aifrombolieridelleBaleari;similmente ben sapendo lo scarsoapportodella lorocavalleria si avvalserodi quella berbera ogermanica. Pertanto la finalità peculiare degliflllXilia nel corsodel combattimentoconsistevanel fomireuna certa flessibilità d‘azione grazie alla loro maggiore mobilità rispetto alla fanteria legionaria. armata pesantemente. E se negli scontri campali il loro apportogarantiva il controllodei fianchi delle legioni, ottenuto magari con vigorose carichedi cavalleria.al terminedegli stessiinseguivanogli sconfiniin fuga, Spessosvolgevano persino delleazionimilitari autonome di rilevante importanza senzaalcun intervento dei Romani,“ Dalpuntodivista motivazionalenon eracertamenteilsoldochestimolavagli arruolamentivolontarinei reparti ausiliari.ingeneredipocoinferioreaquellogiàscarsodeicoevi legionari,ol'adesioneal protrarsi della fermaper quelli imposti,ma il mixaggiodi ricevere la cittadinanza romana. Gli ausiliari,infatti,non eranoabitualmentecittadiniromanieil miraggiodi divenirlodopoventiotrenta anni di servtzioera sedu» cente.Inrealtà l’automatismotmcanieraprolungatanellefoneausiliarieedirittoacquisitoallacittadinanza sarà stabilitosoltantodall‘imperatore Claudio,con la fermaatrent’anni eventicinque di servizio.
Vi è, infine, da aggiungere che l‘esercito regolare non si fido mai ciecamentedelle tmppe ausiliarie per cui, non di rado, nelle circostanze critiche preferì privarsi del loro apporto. allontanandole, piuttosto cherischiare diritrovarsele contro. Vi era. però, un ambito che più degli altri era riservato agli ausiliari: quello navale. sia che fossero solocontingenti siachefosserosqua» dre complete: emblematico constatare che la definizione di socii navales in breve abbia finito per designare gli equipaggi delle navi romane, quale che ne fosse la loro origine concreta!
Inalto:Rlsl/acaztoneformazioniausiliarie, Inbassoasinistra Navedaguerrapo/iremi'in unrarobassorilievo.
Inbassoadestra:Nave daguerraromana oiiemiconiegi'onan'sulponte.

Sotto il Sognodell‘Aquila - ParteSeconda
La spiegazione dipendeva dall'awersione che il Romano aveva nei confronti del mare e del diverso modo di combattere sullo stesso…A differenza del cittadinogreco, che seppesempree senzarecrimina— zioni lasciare laspada per il remo quandonecessario, quelloromanorestòcostantementeun fanteper il quale lenavinon furonomaiun mezzobellico, ma soltantoun mezzo di trasportoonella miglioredelle ipotesi una macchina come quelle ossidionali. Ovvio.pertanto, che la loromanovra e la loro gestione fosselasciataalleforzeausiliarieoaitecnici. Una confermadi talerepulsionesicoglienel dettaglioche non appena gli Italici ac.l ' ' il dirittoalla " romana, . " di appartenere ai sociinavales!
Il checomportòuna netta distinzione framarinai elegionari,alpunto da farritenere sempreisecondi una sortadi sotto-militari,necessari ma non stimati.
LA NASCITA DELLAMARINA DA GUERRA
Secondo la tradizione, peraltro molto cara ai romani, la loro stirpeveniva dal mare: sulle navi infatti giunseronel Lazio i superstitidiTroia enon lontanodal mare siaccamparono, fondando il primo insediamento.Per frustratele lorocontinue scorrerie, i Latini li attaccaronofinendo col dar fuocoalle loro navi, verosimilmente in secca sulla spiaggia,Da quel momento il rapporto dei Romani col mare fu del tuttoabbandonato,fattosalvo,forse,un minimodipescaeditrafiìcomercantilelungolecosteantistanti ai loroinsediamenti.Eppure,comegiàricordato inprecedenza, Roma fiiubicata lungoilTevere,aduna ventina dichilometri dallasuafoce.per cui abuon dirittoandrebbeconsideratauna cittàcostiera,Ma in realtà delegòad Ostiailruolo discaloeportoper lenavi cheiniziaronoa intrattenere relazioni mercantiliconlaneonatapotenza.Unapolitica navaleobliqua.indiretta,stigmatizzatodallacelebreosservazione che la politica navale di Roma mirava ad evitare di averne una, scopopienamente raggiunto quando, conquistato l’interoperimetrodel Mediterraneo,tutto il bacinodivenneun lagoromano.
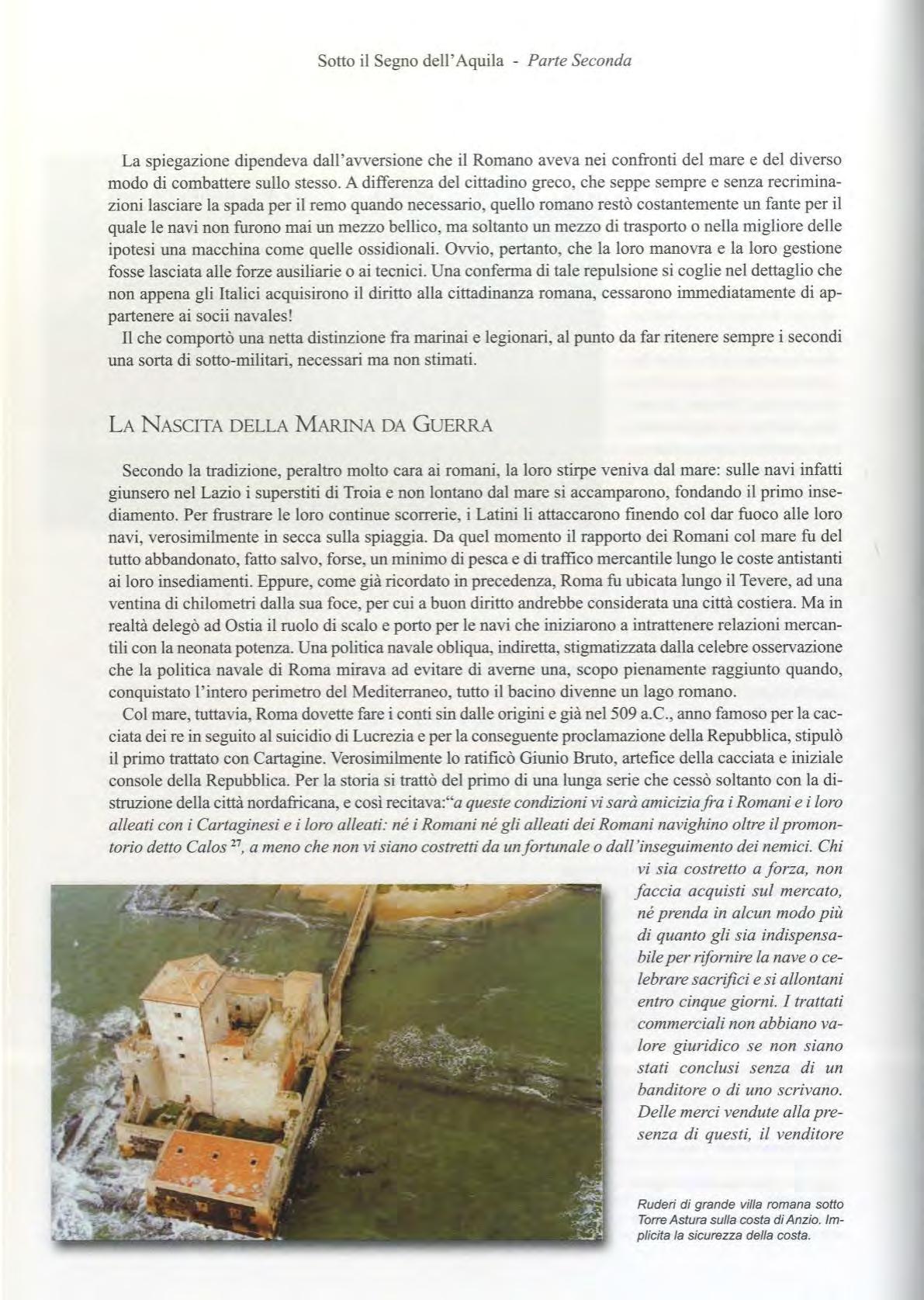
Colmare,tuttavia,Romadovettefareicontisindalleoriginiegiànel 509a.C.,annofamosoperlacacciatadeireinseguitoalsuicidiodi Lucrezia eper laconseguenteproclamazione dellaRepubblica, stipulò il primotrattato conCartagine.Verosirnilmente loratificòGiunioBruto,arteficedella cacciata einiziale console della Repubblica. Per lastoria sitrattò del primodiuna lungaserieche cessòsoltantocon la di« struzionedellacittànordafricana,ecosirecitava:“aquestecondizionivisartiamiciziafraiRomanieiloro alleaticon iCartaginesieiloroalleati è iRomaninéglialleatideiRomaninavighinooltreilpromontariodettoCri/os”.amenochenon visianocornettidaunfi7nunaleodollinseguimentodeinemici. Chi vi sia costretto aforza, non faccia acquisti sul mercato, néprenda in alcun modopiù di quantogli sia indispensw bileperrifi)rnirelanaveocelebraresacrificiesiallontani entro cinquegiorni. ] trattati commercialinon abbianovar lore giuridico Se non siano stati conclusi senza di un banditore a di uno scrivano.
Dellemercivenduteallapre senza di questi, il venditore
Sotto
-
il Segnodell'Aquila
ParteSeconda
Ruderidi grande villa romana sotto Ton'eAstina sullacostadiAnzio. lmplicifa la sicurezza della casta.
abbiagarantitoilpr )dallostato,se il Commercio E stato concluso nclv [Africa settentrionale a in Sardegna. Qualora un Romano venga nellaparte della Sicilia inpos-semo dei Curiagi» neri, goda diparidiritticonglialtri.] Cartaginesi a loro vallo nonfacciano alcun torio allepopolazioni diArdea, diAnzio. diLaurento,di Circeo. di Tatu racina, né di alcun‘altra città dei LatininonsoggettaaRoma:siastengono puredaltoccare lecittà deiLatininon soggettiaiRanzani equalora siimpu— iironiscangdialcunofi'oesse, la resti— tuiscono intatta ai Romani. Non costruiscono in territoriofortezza air curia:qualoramettanopiedenelpaesein assettodiguerra, è [onoproibitopassarvi la notte“”
Daltenoredeltrattatosiricava l’esistenzadiunaflotta daguerracartaginese,i cui attacchi lungo lecoste laziali dovevanocessare,manonquelladiuna simmetricaromana.Illimiteimpostoperlaloronavigazione alpromontorio di Calos,posto dinanzi Cartagine.riguarda il naviglio mercantile. che infatti sideve astcf neredal commerciareperqualsiasiragione.Chepoi vifossequalchepiccola unità romana adibitaallaguardia costiera è difficile accenarlo, come invece sembra alludere Polibio. Forse nel secolo successivo. la situazionesubìqualchemiglioramento alriguardo.tant‘èchenel secondotrattatoconCartagine.,stipulato nel 348a.C.,siosservauna maggiorediffidenzadapartepunica e,soprattutto.un chiaroriferimentoad incursioniromane.Cosi il secondotesto:“.4 questecondizionisistipula un trattatodiamiciziatra iRotnani, glialleatideiRomani, i Cartaginesi, i Tiri, ilpopolodiUtica ei[onoalleati… Oltreipromontorio diCalm, Martia, Tarsia, iRomaninon esercitinolapirateria, ne'ilcommercio.ne'flnidinocitt Nessundubbio,quindi,chealmenodallametà del IVsecoloa.C.navi romane.militari ocorsare.siano ingradodi sfidarelaprimatalassocrazia del Mediterraneo,fin quasinel suoporto. Ilcheconfermail crc— scemepotere che la Repubblica sistavaritagliando anche sul mare. Qualcheperplessità. tuttavia, sussiste sulla tipologia dellenavi cheVennero adottate, dal momento che la loro costruzione ed armamento non era né di facile attuazione nè di scarsa competenza. Quasi a voler fu—
gare anche quest’ultimo dubbio, si sa chenel 341alcunenavi daguerra,cat-
turateagliabitantidiAnzto.andarono acostituireil primonucleodella flotta T—
militare propriamente detta e forse anche l’archetipo strutturale da seguire,Ma.occorre attendereancoraun
trentennio per trovare nel 311 a.C. delle notizie certe sull'istituzione di Qu…«L')
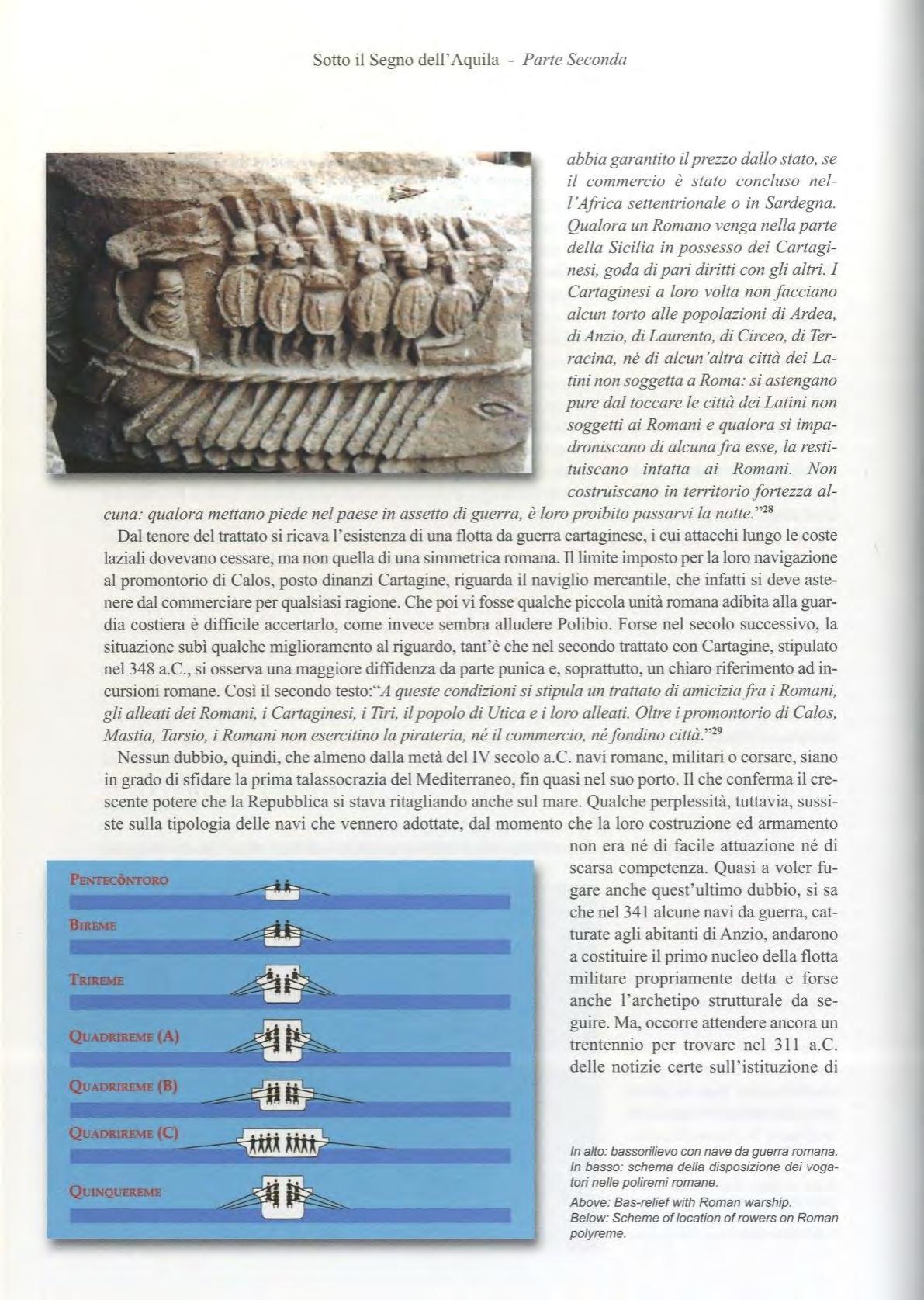
Quan—(A)
lnalto:bassorilievoconnavedaguerraromana. lnbasso‘schemadelladispostzionedeivoga? ioii'nellepali/emiromane. i!
Ahove:BasJeltefW/thRomanWalsh/p. Below.SchemeoflocatloriofrowersoriRoman poiyieme.
Sotto il Segno dell'Aquila - ParteSeconda
/È\
//È\
%
%
'ut"""
carichepreposteproprioal controllodella flotta.Nella fattispecie:“soloallafinedel1Vsecolosividero iromani, allora direttamenteminacciatinelloroterritoriodaipirati, preoccuparsi dellacostruzionedi unaflottiglia di20 navi, poste sotto il controllodei duonvirinavales classi:ornandaereficiendaeque causa; dopo di che, evitato ilpericolo immediato, siaflrettaronoa contare interamente sulla marina deglialleati?“
Ma, cometipico per l’epocaclassica, se le flotte si costruiscono rapidamente altrettanto rapidamente silascianodeteriorare,non esistmeancora alcunaistituzione deltipo diuna marina da guerrapermanente.Anche le flotte cheRomametterà in mare, fin quasi agli inizi dell'età volgare, furonodei mezzi necessari per le operazioni in corso, per il solo conflitto vigente. In definitiva una variante marittima dellemacchine ossidionali,anch’essecomplesseecostose,chefinito l’assediovenivano abbandonateo incendiate.Non vi èdubbio,comunque,cheunagrandeflotta romana fucostruitasottolaminaccia del— l’imminente scontroconCartaginenel 261 a.C.evantò una longevità inusuale… Standoa Polibio i Romani:“vedendochelaguerraandavaperlelunghe...sideciseroafumarsiunaflotta con lacostruzione dicentoquinqueremieventitriremi.Ma questoprogettopresentavagrandidiflìcoltà,perche' icostruttorinavali eranocompletamenteinespertidelmododiallestireuna quinquererni, datochenessuno alloroinItaliasiservivaditalinavi.””
Per avereuna idea della complessità del compitoche secondo larievocazione di Polibioi Romani si ,, .;ad " lanave ' era stata ecostruitaperlaprima voltanei cantieri di Siracusa,dain ingegneri assunti dal tiranno Dionisio il Vecchio nel 399 a.C….32 Di essa pur avendone numerose descrizioni dettagliate e diverse raffigurazioni non sappiamo neppure comerealmentestavanodispostiirematori,né seloscafoeracintodagrossegomeneditenuta! Sitrattavadiuna ' ‘ sia da " sia da governare compiti che non possono in alcun casoimpmvvisarsipermeta imitazione,per cui sidevenecessariamenteconcludere chelanarrazione costituiscenella miglioredelle ipotesi una semplificazionedegli eventi.
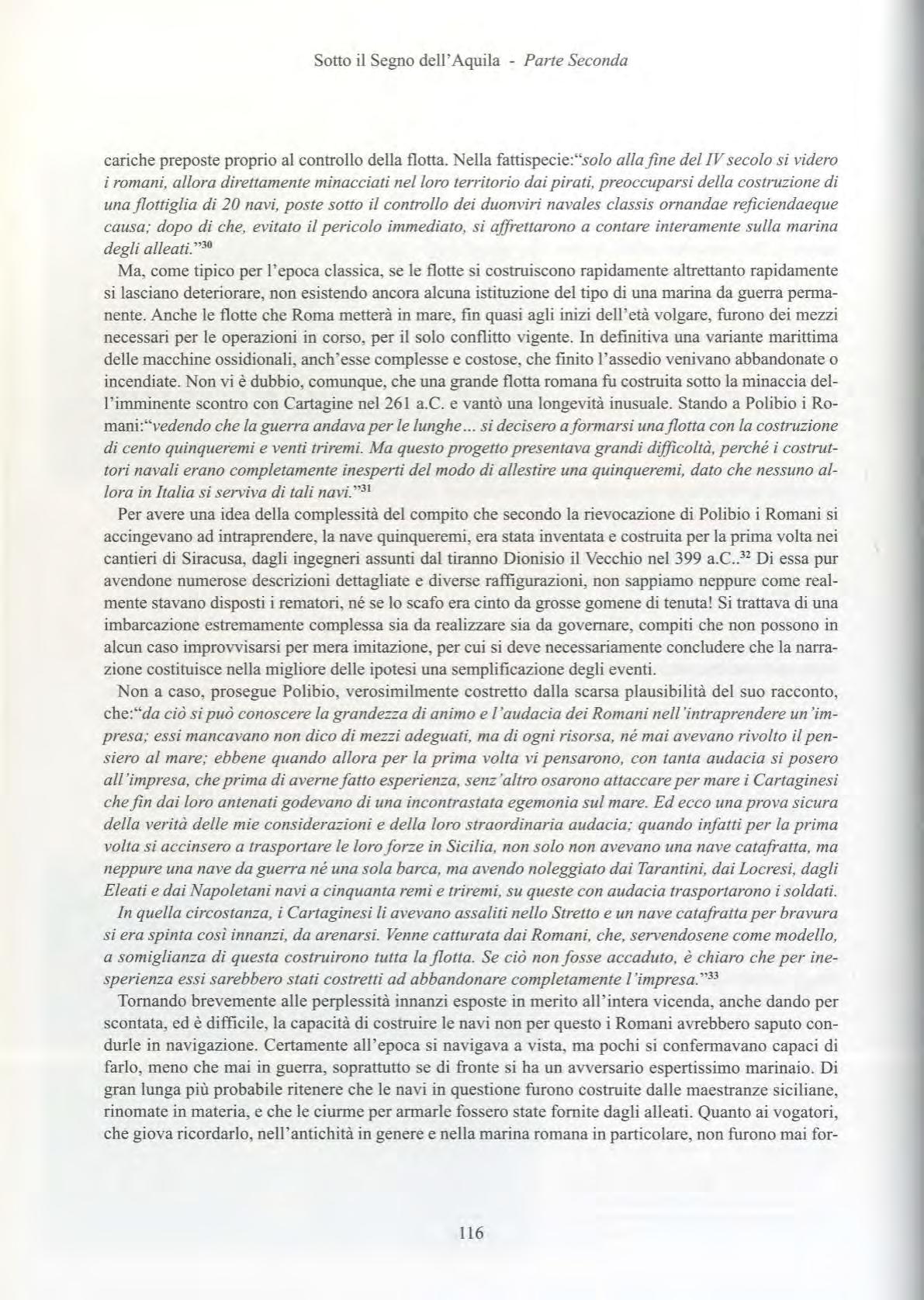
Non a caso, prosegue Polibio, verosimilmente costretto dalla scarsa plausibilità del suo racconto, che:“daciòsipuòconoscerelagrandezzadianimoeI ’audaciadeiRomaninellintraprendereun 'im— presa: essimancavanonon dicodimezziadeguati, ma diognirisorsa, ne'maiavevanorivolto ilpensiero al mare; ebbenequando alloraper laprima volta vipensarono, con tanta audacia siposero all'impresa, cheprimadiavernefinta esperienza,senz'altrousaronoattaccarepermare i Cartaginesi chefin dailoroantenatigodevanodiuna incontrastataegemoniasulmare, Edeccounaprovasicura della verità dellemie considerazioniedella lorostraordinaria audacia;quando infattiper laprima voltasiaccinseroatrasportareleloroforzeinSia a nonsolonon avevanounanavecata/”ratto, ma neppureuna navedaguerranéuna solabarca, ma avendonoleggiatodai Tarantini, daiLocresi, dagli EleatiedaiNapoletani naviacinquantaremietriremi, suquesteconaudaciatrasportarono isoldati. Inquellacircostanza, i Cartaginesiliavevanoassalitinella Strettoeun navecatafrattaper bravura sieraspintacosiinnanzi, da arenarsi, VennecatturatadaiRomani, che,servendosertecomemodello, a somiglianza di questa costruirono tutta laflotta. Seciò nonfosse accaduto, è chiaro cheper ine— sperienza essisarebberostaticostrettiadabbandonarecompletamente I ’impresa.””
Tornandobrevemente alleperplessità innanzi espostein merito all’interavicenda, anchedandoper scontata, ed è difiicile,lacapacità dicostruirelenavi non perquestoiRomaniavrebberosaputocondurle in navigazione. Certamente all’epoca si navigava a vista, ma pochi si confermavano capaci di farlo, meno chemai in guerra, soprattutto se di fronte si ha un avversario espertissimo marinaio. Di gran lungapiù probabileritenere che le navi inquestione furonocostruitedallemaestranze siciliane, rinomate inmateria, echeleciurmeper armarlefosserostatefornitedagli alleati.Quantoaivogatori, chegiovaricordarlo,nell’antichità ingenereenellamarina romana inparticolare, non fiironomai for-
Sottoil Segnodell’Aquila - ParteSeconda
116
Due belle immaginidella iriremiOlimpia ricostruita in Grecia. Rusticdlnavedaguerrarinvenutodinanzilacostad'islaele. TwobeautifulimagesoftheInremeOlympia,lewnslructed … ene.
Rosfrurn afs Walsh/pfoundoffthe Goes!0flslaei
LE NAVI DA GUERRA ROMANE

zati oschiaviallacatena ma volontari liberi e spesso militari. nella circostanza si trassero dalle legioni. Ovviamente subirono un adde» stramento singolare. cosi ricordato da Polibio:"mentre calura che avevano l'incarico della costruzione delle navi si occupavano della lara preparazione. gli altri raccoglie» vano [eciurmaesulla terra leesercitavano« remare in questa moda. In terraferma su aicunr'banchifacevano sedere presso iremigli uomininellostessoordinecheneiSedilisulle navi, ecallacatuviin mezzo ilcapociurma, li abituavanoapiegarsi indietropartanda a sé le mani, poi apiegarsi in avanti, stendendo lebraccia, « cominciare ea cessare ilmovimento secanda ! ’Ordinedelcapo.
Dopo chei marinai/urano allenati e lenavifurono varateman manochevenivanocompletate,fatte[eproveper breve tempo, proprio sulmare, navigarono lunga 1'Italia. secondol'ordine del console?“
Ingeneralevaprecisatoche,puresistendosenzaalcundubbiosindagliinizidell’etàrepubblicanaunama» rineriamercantile,non fossealtrocheperlapescaedilcomercio,l’esperienzaditaliequipaggieradeltutto inutileperlecoevenavidaguerra.Queste,infattiadifferenzadelnavigliomercantileesclusivamenteavela, infasedicombattimentoodinavigazionebellicaeranopropulsesoloaforzadi remi.riservandolevelequadre di cui disponevanoalle crociere di trasferimento.Navi tanto leggere e sottili,contanti uomini airemi, riuscivanoaraggiungerevelocitàsorprendenti,cheperòeranoingradodimanteneresoloperbrevissimi intervalli. Studiaccuratiedattendibili fornisconovaloriprossimi agli [15nodi,pari acirca21ltro/h.35Velocità chepoteva, siapur dipoco, accrescersi ulteriormente spalmandodi grasso l’operaviva.in maniera da ridurne laresistenza idrodinamica, Essendo la prestazione funzionedel numero dei vogatori, appareowio che labasilare suddivisionedelnavigliomilitare fosserelativa al loronumeroemagari anchedallalorodistribuzioneperciascunremo,piuttostochedain ordini diremi.
Quandoper ragioni d'urgenmallanavi veniva richiesta lamassima velocità per tempi prolungati, si univano i remi allevele,toccandovelocità mediedi circa8-9nodi, conpuntefinoad 11in condizioniideali. ll disporrediun motore, siapureumano, leaffiancavadallasubordinazionealvento.rendendolealmenosotto questoaspetto,moltosimiliallenaviattuali.Essendoevidentelaproporzionedirettafranumerodiremievelocità,aparità di altrecondizioni,leunitàdaguerrane impiegaronofinoadalcunecentinaia. Pertanto ledimensionifondamentalidellenavidaguerradipendevanopropriodalloroapparatopropulsivo:selalunghezza della scaforisultava funzionedel numero dei banchi di voga, lalarghezzadipendeva,invece,daquantiuomini sedevanosullostessobanco. Discorsoidentico,quandoibanchi stavanodisposti supiù ordini sfalsati verticalmente,Ciascunbancoimplicavaalmenoun metroemezzodi fiancata.percuiunoscafolungo45m nepoteva contenereuna trentina al massimo.Asuavolta ognivogatoreoccupavacircaun metrodi ciascun
Sotto il Segnodell‘Aquila Parte Seconda
118
Schemadl[ti/emedalleraffigurazionidella Colonna Traiana. A fianco:Ipotesiricodllllfivs diuna tl'irems romana, DravrnngafabilEme accordingtotheillustrationson the Tra/sncolumn. Totheside:Theoreticalreconstruction of & Roman tl'ilel'ne,
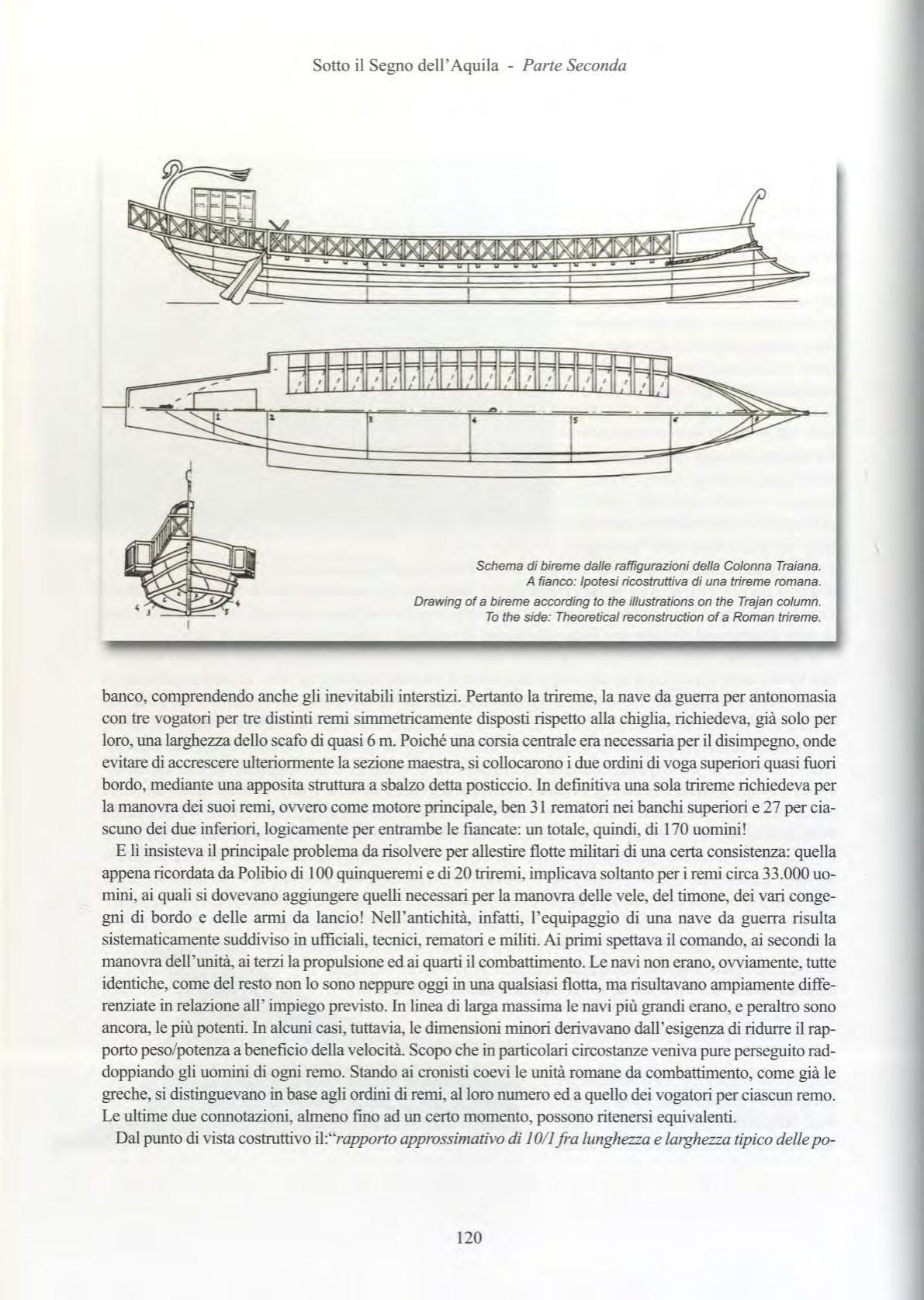
banco, comprendendoanchegli inevitabili interstizi.Pertantolatrireme, lanavedaguerraperantonomasia con trevogatori per tredistintiremi simmetricamentedispostirispettoallachiglia,richiedeva, già soloper loro,unalarghezmdelloscafodiquasi6m.Poichèunacorsiacentraleeranecessariaperildisimpegno,onde evitaredi …ulteriormentelasezionemaestra,sicollocamnoidueordinidivogasuperioriquasifuori bordo,medianteunaappositastrutturaasbalzodettaposticcio, Indefinitivauna solatr‘iremerichiedevaper lamanovradeisuoiremi,ovverocomemotoreprincipale,ben 31rematorineibanchi superiorie27perciascunodeidue inferiori,logicamenteperentrambelefiancate:un totale,quindi,di 170uomini!
Eliinsistevailprincipaleproblemadarisolvereperallestireflottemilitaridiuna cenaconsistenza:quella appenaricordatadaPolibiodi 100quinqueremiedi20trirerni,implicavasoltantoperiremicirca33.000uo— mini, aiqualisidovevanoaggiungerequellinecessariperlamanovradellevele, deltimone,deivari congegni di bordo e delle armi da lancio! Nell’antichità, infatti, l‘equipaggio di una nave da piena risulta sistematicamentesuddivisoinufliciali,tecnici,rematoriemiliti.Aiprimi spettavailcomando,ai secondila manondell’unità,aiterzilapropulsioneedaiquarti ilcombattimento.Lenavinonerano,owiamente,tutte identiche,comedelrestonon losononeppureoggiinunaqualsiasiflotta,marisultavanoampiamentediiîerenziateinrelazioneall‘impiegoprevisto. Inlineadi largamassimalenavipiùgrandi erano,eperaltro sono ancora,lepiùpotenti. Inalcunicasi,tuttavia,ledimensioniminoriderivavanodall’esigenzadiridurreilrapportopeso/potenzaabeneficiodellavelocità.Scopocheinparticolaricircostanzevenivapureperseguitorad— doppiandogliuomini diogniremo. Standoaicronisticoevi leunitàromanedacombattimento,comegiàle greche,sidistiuglevanoinbaseagliordinidiremi,alloronumeroedaquellodeivogatoriperciascunremo. Le ultimedueconnotazioni,almenofinoaduncertomomento,possonoritenersiequivalenti.
Dalpuntodivista il:“ ,,,, pp ' di] 0/1fia '' e '' tipicodellepo—
Sottoil Segnodell‘Aquila - ParteSeconda
120
liremiprogettateperraggiungerelemassimevelocitàsiconservòSinoallafinedell’emdella navidaguerraaremidell'untichittì. GlispeCiu/isti sono oggigeneralmente d'accordo sulla tesi che le lunghezze raggiunteda tali navi erano molto vicine ai Villari massimi raggiungibili con costruzioni in legno. In effettipareche,nelcasodelletriremiancorpiù sottili 'mitiintrinseci alla costruzione in legno sianostati addiritv tum superati. Anche se un complessosistema di mcr-lose, lenoni e caviglie univa ilfasciame dellanavein modo tale chelesollecitazioni venivano distribuite in misura considerevolesull'intemscafo,noneraprudenteflzrprendereil Fruadimanno,Aquileia;notareilcavodilensionedelloscalo. marea unaDimmichenonfossestataraflorzata dagrandicavi
RÎCOSIWZΰ"E …”a'e ‘”“”'"i°°” … chelacingevanodapruaapoppaecheeranostatisottopostiad Marblegrow,Aquileia;notethestresscableormehull.
unu tensioneconsiderevoleda un argano. Non sappiamodave fosserosituatiesattamentetalicavi,maparecheI ’eflettodicompressione cheessiesercitavanosullanuvefi)ssenecessariaper impedirealloscafi;diindebolirsipericalosamentequando veniva sottoposto a sollecitazioni.Illegnodipersé èpoco idoneoadadattarsi a giunti soggetti::tensione…””
Circa ledimensioni trasversali gli scafirisultavanomolto stretti,giusto sufiicientiper duerematori adiacentiicuiremiinsistevanosulbordodellamurata.PerragionifacilmenteiritJ.libilil’impugnaturadeireminon puòtrovarsimoltovicinoal fulcropercuioccorrespostarequest’ultimoversol’estemodellamurata, opiù all’internodello scafoilvogatore. Inpratica gli antichiricorsero adentrambele soluzionicontemporanearnente, senzasuperaremailemodestelarghezzeaccennate.Altrettantomodestoilpescaggiodi quellenavi, cheper alcunistudiosisuperavaappenail mezzometro, spostandoperciòuna relativamentepiccolamassa liquidaconunaconseguentescarsaresistenzaidrodinamica,vantaggioottenutoascapitodellastabilità.Parimentiirrilevantelospessoredelfasciame,compresofia3.5edi4 cm,pergiuntadilegnoteneroeleggero. Dalpuntodi vista strutturalelapoppasisollevavaaldisopradellalineadi galleggiamentosecondoun per— fettoarcodi cerchio,(accordandosi entrambelemurate nel cosiddettoaplustre che contribuivacon la sua massa astabilizzarelanave ’ il d’inerzia.D' dallegalerei'
tali,chepermoltiaspettineeranolediretteeredi,nellenavidaguerraromaneivogatoriremavanoaldisotto dell’unicoponte,nettamentedistintidall’equipaggiodacombattimento.
Per il conseguenteabbassamentodelbaricentroneconseguivauna migliore tenuta delmarechepermetteva,incasiestremi,dinavigareancheinautunnoinoltrato.Lanavedaguerraromana,quindi,adeccezione dellepiccoleunitàmonoremi,ostentavaunacopertapiattasimileadunmodernopontedivolo.Unica struttura sollevatalatorredicombattimento,non diradodoppia,collocatapressolapruaolapoppa,ma lonfino dalcentro.Quantoaglialberill]procintodel ‘ sempre dal che lagrandevelasidimostravaun’esca idealeperiproietti incendiari.
Dalpuntodivista storicol’archetipodellepolirernifuunoscafoconununicoordinediremi. Solointorno allametà del Imillennioa.C.simanifestaronosignificativiprogressi inmateria, dapprimaaggiungendoun secondoordinediremi,quindiunterzo,originandocosilanavetriremi.Arendereoltremodocompattaladi-
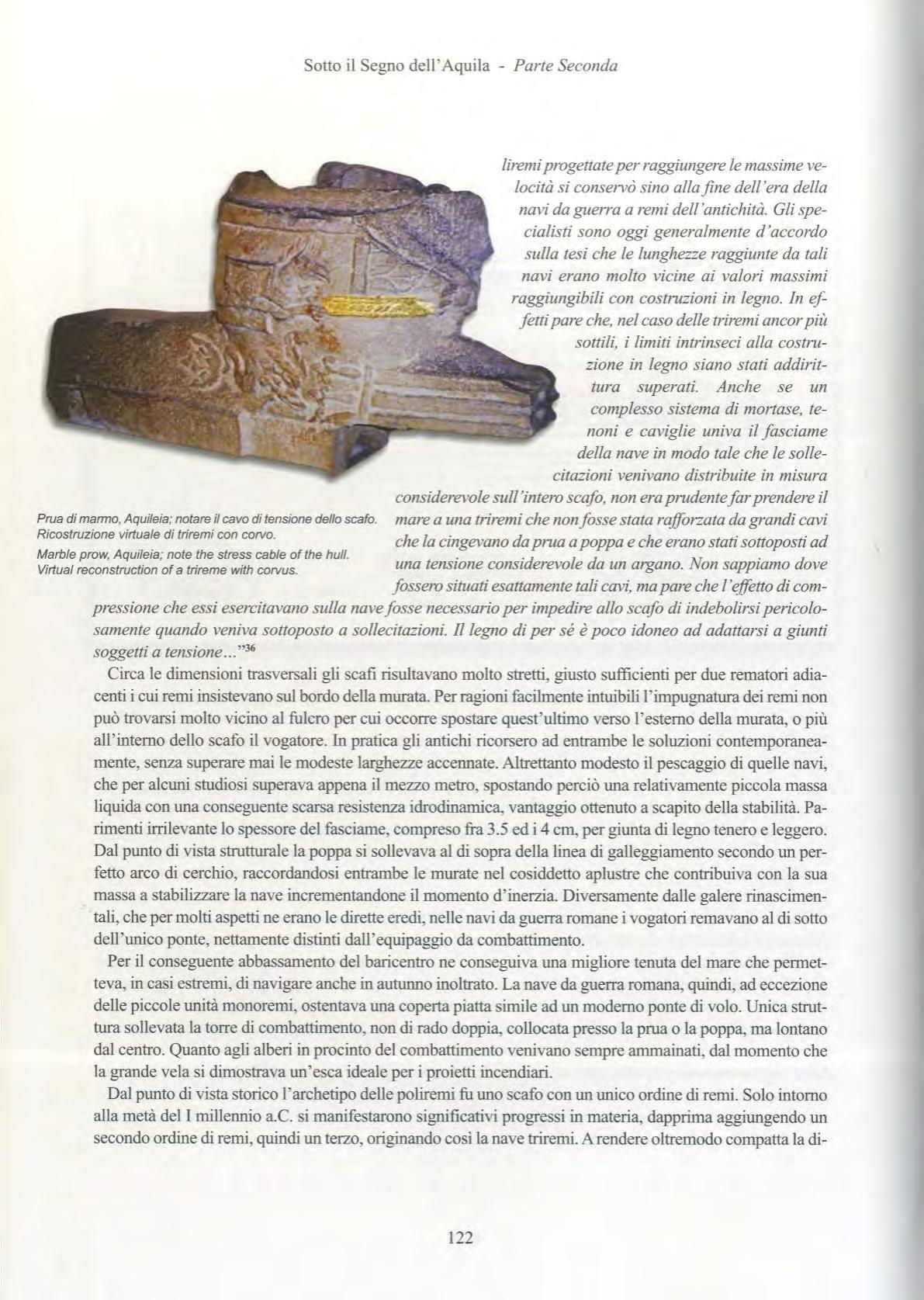
Sotto il Segnodell'Aquila ParteSeconda
wmla,,answmnara“mme……
.
122
stribuzionedei vogatorideivari ordini lungole fiancate,provvide la loro sistemazionesfalsata.Inpratica. gli uomini dell’ordine superioresitrovavano più avanti di quasi mezzo metro rispetto aquelli immediatamentesottostanti,spostatiugualmenterispettoaquelliancorapiùinbasso,Abbastanzaagevoleimmaginare l’assoluto sincronismorichiesto dalla manon dei remi per evitare inceppamentizsi spiega così la grande curariservata alleesercitazionisimulateaterra, giàricordateperil261 aC.,sarannosostanzialmentemantenuteoltreduesecolidopoanchedaMarcolesanioAgrippa pergliequipaggidellaflotta diAugusto,
LA MARINA ROMANA sr Al-TRANCA DALLATECNICA STRANIERA
Nel 260a.C.ilcomandodellaflotta,moltiplicandosiicontrasticonCartagine,passònellemanidelconsoleCaioDuilio…Questiz“vedendocheletardesuenavieranofircilmenteschivatedallaagilitàdellenavi punicheecheperciòsirendevanulla ilvaloredeisoldati, inventòlo«strumentobellicochiamatopiù ardi corvo»…”37Ancora una volta ilpragmatismo romano ebbemodo dimanifestarsi in pieno, elaborando il ' incorvoper l‘ “ atrasformareunoscontrodimezziinunscontrodiuomini.Grazieadesso,cometuttiglistoricinonmancaronomaidifarnotare,i legionari potevano trasbordare suiponti dellenavinemiche ed impegnarel'equipaggioinun combattimentoinsostanzasimileaquelloterrestre.Dicertoal suodebuttodovette funzionareegregiamentema,conugualecertezza dopo avernevisto il funzionamento lenavi nemiche si sararmo guardate bene dal farsiaccostare, rendendoloperciò inutile. Si spiegacosi cheinqualsiasi scontronavale di epoca successiva non ne venga fattapiù menzione! Questecomunquelecaratteristiche del congegnoz“aprua sialzava un 'antenna mtonda dellalunghezzadiquattroorgie[=7,1 In]edeldiametroditrepalmi [=22 em].Questaasua volta portavasullacimauna car-rucola,etutt'intarnoeraunascalafattaditravitrasversali,fissataconchiodi, della larghezza diquattropiedi [=],2 In]edellagrandezza diseiorgie [=”.7 rn], Nel tavolato era un faro oblunga chegirava intorno all“antenna alla distanza di dueargie [=3,6 m] dalla inferiore della scala.Lascala avevapureunparapetto chearrivavafinoall'altezzadelginocchioesistendevada entrambi ilati,per tutta lasua lunghezza.All'estrernilà era applicatouna speciedipestelloacuminatodi ferro, recanteincimaunanello,dimodochenelsuainsiemeloslrumenloapparivasimileaquellemaechinecheservonopermacinareilgrano.All'anelloeralegataunagomenacon laquale,quandolanave siscontravaconquellaavversaria, imarinaisollevavanoicorvipermezzodellacarrucolecheaeraal!'estremitàdel!’anbennaelafizcevanoricaderesullatoldadellanaveavversaria,oraaprua, oracon una deviazionelaterale,sulfianco.Quandoicorviimpigliatirineitavolatidellafaldanemica, avevanounito lenavi, sequeste erano congiunteper ifianchi, isoldatiabbardavanoda ogniparte, seerano unite a prua, a duea duesalivano infilaattraversa ilcorvostesso: iprimisidifendevanofiontalmente opponendogliscudi.glialtrisiproteggevano ifianchiappoggiandol’orlodegliscudisulparapetto?“
Nondiversamentedalleprecedentianchequellaflotta.tenacementecostruitaedarmata,unavoltaoonseguita lavittoriasuCartagineandòindisarmo,nonrientrandoancoralapoliticanavalenellalogicastrategicaromana
II.SOLDODEI LEGIONARI
Incrementandosi costantementel’impegnotemporaledei legionari,lanecessità dicompensarli inmaniera senon adeguataalmenosignificativadivennetassativa. Molti frai coscritti avevanouna famiglia damantenere, emoltiancoradei campichenon potevanopiù coltivarepersonalmente.Per cui,almeno inizialmente,più chedisoldonelverosensodeltermine, sideveparlaredirimborsospese,peraltroparziale,Tantoperesemplificarenell’età diPolibioilfantepercepiva mediamente 5assialgiorno,controi
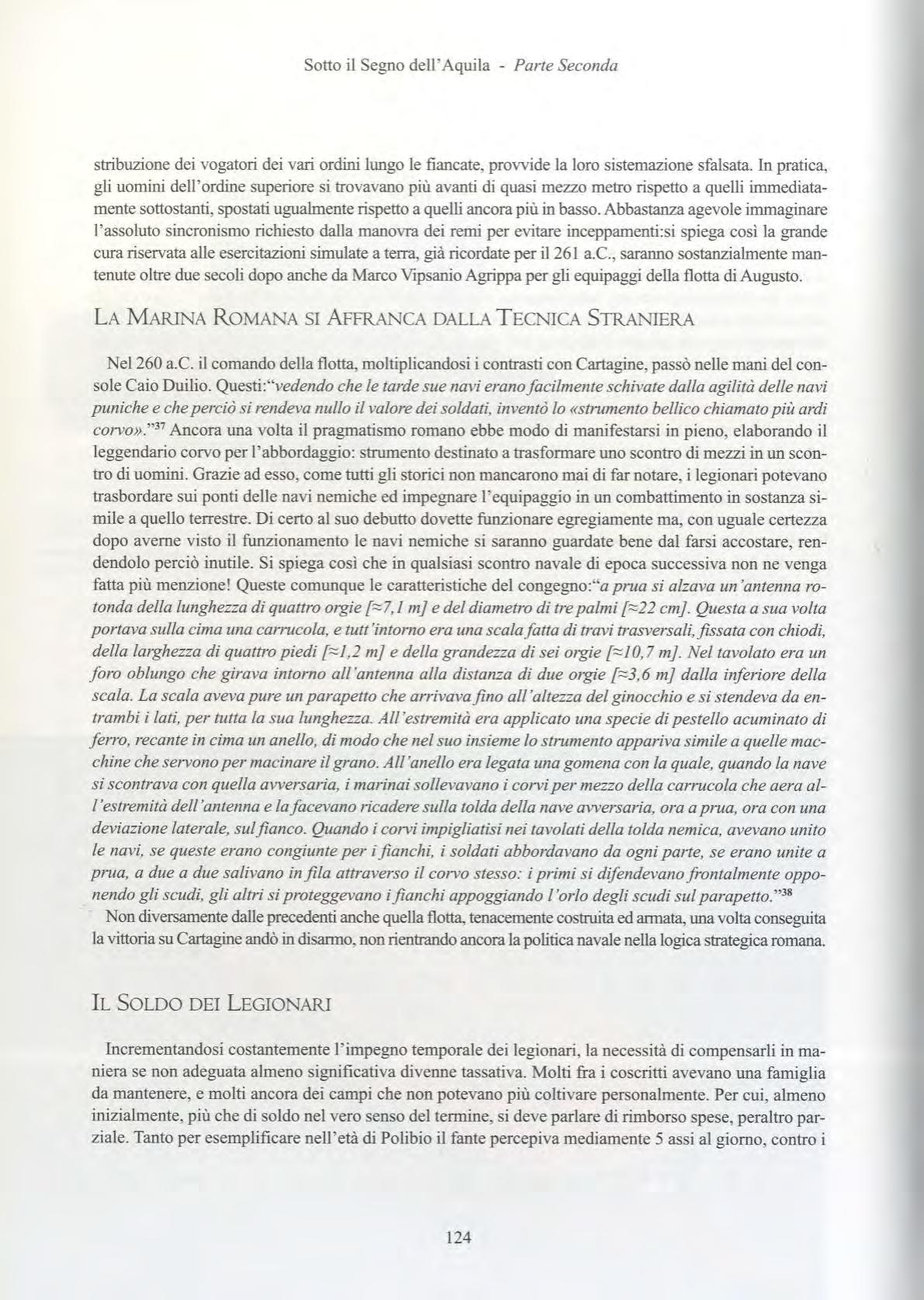
Sottoil Segnodell’Aquila - ParteSeconda
124
12diun operaioaRoma.Il compensoammontava perciò a 150assi almese,pari alorovolta acirca 10 denari,cherendeva lapagaannuadi 120…Dalmomentochenon siamoingradidistabilel’entitàodierna di corrispondenzapossiamo soltantoricordare che l‘asse era una moneta fusa in bronzo, introdotta durante il IVsecolo,che soltantoin seguitofuconiata. Con lariforma diAugusto sibatté inramepure, ed il suovalore divennepari ad V.di sesterzio, In ogni caso l'interostipendioannuonon bastava per l’acquistodiun soloschiavodi scarsovalore.
Nonostante ciòlacarrieramilitareiniziòadassumereuna suaattrattiva,tantopiù cheadintegrarel'intimo soldo pr… ’ i r' ‘ .:a- A‘ ‘ “ , infatti, le distribuzioni tra i legionaridiinteribottini fattisulcampo,oltreaipremi indenaroperipiùvalorosi.Nonraropure l‘aumento del soldodopocampagnevittoriose: ma lavera attrattivaconsistevain quellasorta di liquidazione corrisposta a fine servizio,costituita da un appezzamentoagricoloedall‘ammontare delle cifretrattenute, mesepermese,sullapaga.Ovviamenteigradisuperiorigodevanodipaghenotevolmentemaggiori,che costituivanoun ulteriore incentivo.
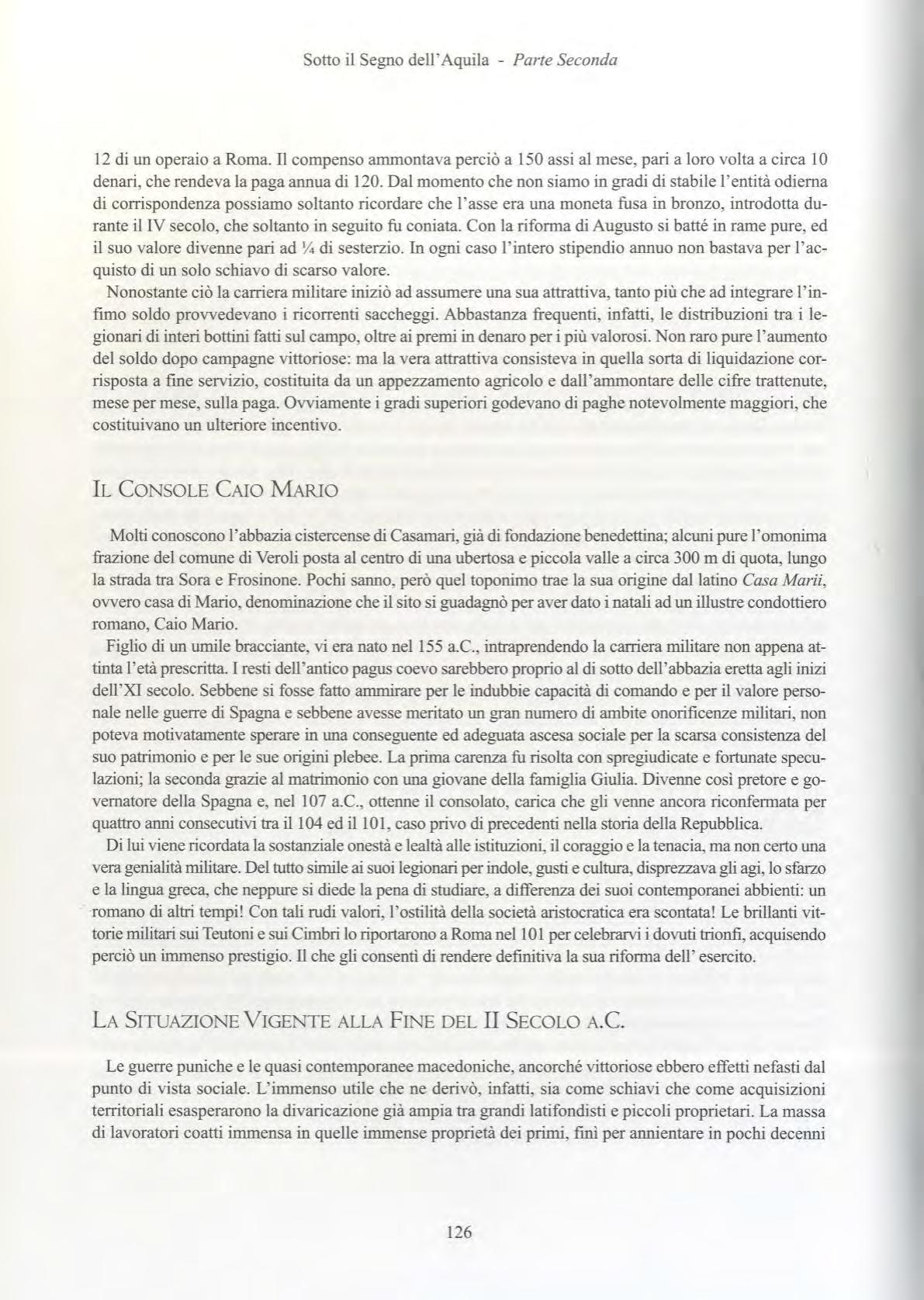
IL CONSOLECAIOMARIO
Molticonosconol’abbaziacistercensediCasamari,giàdifondazionebenedettina;alcunipure l’omonima frazionedelcomunediVeroliposta alcentrodiunaubertosaepiccola valleacirca300rn diquota,lungo la stradatra SoraeFrosinone.Pochi sanno,peròquel toponimo trae lasua originedal latino CasaMar-ii, ovverocasadiMario,denominazionecheilsitosiguadagnòperaverdatoinataliadunillusuecondottiero romano,CaioMario.
Figlio diunumilebracciante,vieranatonel 155a.C.,intraprendendo lacarrieramilitarenon appenaattintal'etàprescritta.]restidell’anticopaguscoevosarebberoproprioaldisottodell‘abbaziaerettaagliinizi dell’XI secolo.Sebbenesifossefattoammirareper le indubbie capacitàdi comandoeper il valore personale nelleguerredi Spagnae sebbeneavessemeritatoun gran numerodi ambite onorificenzemilitari, non poteva motivatamente sperareinuna conseguenteed adeguata ascesa socialeper lascarsa consistenzadel suopatrimonio eper lesueoriginiplebee. Laprima carena:furisoltacon spregiudicateefortunate speculazioni; lasecondagraziealmatrimonioconuna giovanedellafamigliaGiulia.Divennecosipretore egovernatore della Spagnae, nel 107aC., ottenne il consolato, caricache gli venne ancora riconfermata per quattroanni consecutivitrail 104edil 101,caseprivodiprecedenti nella storiadellaRepubblica,
Diluivienericordatalasostanzialeonestàelealtàalleistituzioni,ilcoraggioelatenacia,manoncertouna veragenialitàmilitareDeluntosimileaisuoilegionariperindole,gustiecultura,disprezzavagliagi,losfarzo elalinguagreca,cheneppuresidiedelapena di studiare,adiflerenzadei suoicontemporaneiabbienti:un romano di altritempi!Contalirudi valori,l‘ostilitàdellasocietàaristocraticaerascontata!Lebrillanti vit— toriemilitarisuiTeutoniesuiCimbriloriportaronoaRomanel 101percelebrarviidovutitrionfi,acquisendo perciòun immensoprestigio,Ilchegliconsentìdi renderedefinitivalasuariformadell’esercito,
LA SITUAZIONEVIGENTE ALLA FINE DEL 11SECOLOA.C.
Leguerrepunicheelequaicontemporaneemacedoniche,ancorchèvittorioseebberoeffettinefastidal punto di vista sociale, L’immenso utile chene derivò, infatti, sia come schiavi che come acquisizioni territorialiesasperaronoladivaricazionegiàampiatra grandi latifondisti epiccoli proprietari.Lamassa dilavoratori coatti immensainquelleimmenseproprietà deiprimi, finiper annientareinpochi decenni
Sotto il Segnodell’Aquila - ParteSeconda
126
il reddito dei secondi.Disperati e miserabili si riversaronoaRoma, inmasserapidamentecrescenti, tentando di sopravvivere di espedienti. Essendo l’immissione nelle legioni regolata dal censo, a quel generaleeprogressivo impoverimento,corrisposeun’altrettarrtavistosa contrazionedeicontingenti arruolabili. Il fenomeno attinse ben presto entità pericolose per la consistenza minima del— l’apparatomilitare, costringendoperciò ad una riduzione dei livelli economici minimi richiesti per l’arruolamento.
Venuta meno tanto la soluzione proposta dapiù parti di estendere la cittadinanza agli alleati, per l‘opposizione del Senato,quanto la riforma agraria voluta dai Gracchi, la situazione precipitò… In pratica:“in adsidui cominciarono progressiva-
RestidellasededelSenatodiRoma. mente a diminuire,siainseguitoa un nuturaleregressodemograRemainsofthesiteoitheRomanSenate. fico,siaperloscivolamentodegliappartenentialleclassimediedi censoverso iproletarii. Questiultimi vqueicittadini che, non appartenendoallecinqueclassidicenso, non eranocomputatinelnumerodicolorocheeranocostituzionalmenteabilitatiaportarelearmi—roggiunsero,perconverso, unusempremaggioreragguardevolezza numerica, taleche, a lungoandare, nonpotépiù essereignorata aifinidella levamilitare.
Gid nellestrettedellasecondapunica, sieradovutoricorrere,per raggiungere unapiù ampia utilizzazionedelproletariato, ulla diminuzionedelcensominimorichiestoperappartenereallaquintaclasse da 11.000a4.000assi, equestocifraavevaancoravalorequandoPolibioscrivevoversolametà delII sec.a.C. IlcontinuopeggioramentodellasituazionenelcorsodelIlsec.«.C.-èdal 159chelecifredei censimenti inizianodecisamente 11colore-obbligò intorno rtl 133-125 a.C. a ricorrere dinuovo alla stessa misura edilcensominimo dellaquintaclassefit ulteriormenteabbassatodo4,000 a 1.500assi: 76.000proletariifurono trasformati in adsidui, cometestimonia, tra l'altro il risultato delcensimento del125rispetto a quellodel131,ma ciònonpotémutarelarealtà, lacuigravitànon sfuggivaalleclassi dirigenti, in variogradopreoccupate.
Circaglistessianni siebberoitentativideiGracchidirimediareallasituazioneeconomico-sociale... Lacondizionedeisoldatiall'etàdeiGracchièfacilmentericavabile, siadallaben notoafi"ermazionediTi. Crocco, checolorocheeranoconsideratiipadronidelmondo, non avevtznoin realtà nemmenoquelcovilechepurposseggonoglianimali, siada!tenoredella legemilitaredi G. Gracca (123 a.C.)cheproi— biva alloStatodieflettuuretrattenutesullastipendiurn, certodateleprecarie condizionideisoldati.

Quando,pertanto, nel 10711.C. GuiaMario,perlenecessità dellaguerradiNumidia, sividecostretto adaccantonare il tradizionulesistema di levaper tribù eda ricorrere all'arruolamento volontario. la composizionedell’esercitoeragià, difatto,proletario. La misura diMario, che. tra l’altro,siricolle» govaal!istitutodeltumultusechetrovovaprecedenti,peresempio,nella levadel 134o,C., non apparve pertantodicarattererivoluzionarioenella realtànonfececheconfermarelostatodifattoprecedente…””
Questa modifica. solo apparentemente tecnica, in realtà ebbevistose conseguenze politiche, poiché i legionari daquel momentonon siinteressaronopiùgranchedellevicendepolitiche diRoma,ma esclu» sivamentedellalorocarriera,dellelororicompenseedellorogenerale.La fedeltà,infatti,divenivasempre più stretta verso chi li arruolava piuttosto che alla Repubblica, sempre più lontana ed estranea.
Sottoil Segnodell‘Aquila - ParteSecondo
128
Ulteriore conseguenza fu quella del confondersi dellemolteplici stirpi italiche in una unica classemili— vare,prima fusionenazionaledello Statoromanochedaun puntodivista meramentetecnico eraancora la città di Roma!Per cui simanifestò una duplicitàparadossale, trattandosi da un latodel sopravvivere diuna arcaicadimensionepolitica urbana dall’altrodell’avventodi una dimensionemilitare imperiale, ambiti antiteticicheproprio lariforma diMario iniziòarisolvere.Dicertoda:“un altropuntodivista la fazionepopolaresiavvantaggiòdellafusionecheoramaisierarealizzata nell’esemitofradij'Ìrer/tl'elementidellavarieregioniitaliche, inquantopotésembrarefiirproprialadifesadiquellecomuniesigenze economicheesociali, che, comegià detta.!’esercitoimpersonava... [In linea di massima quindi]nelI sec. aC. capipopolari"ecapimilitarisiidentificano... infatti con l’organizzazionedellemasse contro l'aligarchia, acon I 'usodiquestequando. comenell'esercilo, sonogià organizzate-.siveniva implicitamente a trovare quellaformula di azionamentofra le esigenzedellostato imperiale e la struttura del!'aniicoStatocittadino. che.nelpropriocampolamilizia avevagiàrealizzatoquandosiera trasformata, lunga ilIlsec.a.C.,sonolaspintadi imprescindibilinecessita‘, in esercitodipmfessione.”“'
Viera,infine,un‘altra seriedi conseguenzeinsitenella riforma diMario,più inerenti allacarrieramilitare.Per anticaeassodatatradizionevigeva nell’esercito romano una separazionenetta einsormontabiletragliorganici legionarifinoaicenturioni,cheoggiverrebberodefinitibassi ufficiali, elesovrastanti gerarchie o degli ufiîciali superiori. Nessun centurione, ad esempio, poteva sperare mai di accedere, qualeche fosseil suovaloreedil suocenso,al rangoditribuna»:militum,odipraefectusequitum.Con lariformamariana,chediedel’avvioall’esercitoprofessionale, quellapreclusionenon ebbepiùuna applicazionetassativa edinderogabile.Unnumeronon irrilevantedicasi,staaconfermarel’avvenutapromozionedaibassi aglialtigradi,soprattuttoquandosupportatadaunacospicuaricchemchespalancava persino l‘accessoal rangoequestre.
LA LEGIONE DI CAIO MARIO
Se le riforme di Mario ebbero un esito stravolgente sulpiano politico, lo ebbero persino di più in quellomeramentetattico.La sualegione,non acasoemersapropriodallaguerrain Spagna,risultò,in fatti,nettamente diversa dallaprecedente manipolare, più adeguataainuovi compiti eallenuove modalitàdicombattimento.La legionemanipolarecheavevasconfittolafalangemacedone,nonconfermò la sua superioritàquandodovette affrontare i Cimbri ei Teutoni. ll suo schieramentoaquinconce. oa manipoli sfalsati, si dimostrò inadeguato a sostenerne il poderoso urto iniziale. La loro tipica tattica consisteva appunto, nell’aprire lo scontrocon un violento assaltocondotto al centrodella formazione nemica. E gli ampi intervalli fra i manipoli, consentivanoagli attaccanti di correreedi incunearsi lira quelli della prima linea, fino a raggiungere quelli della seconda.A quel punto laresistenza iniziava a cedere.ritrovandosi tutti i singolimanipoli, emassimamente quelli delleprima linea, isolati ed accerchiatidaquellasortadimareaumana.impossibilel’appoggioreciprocofragli stessiefrale lorodiverse file, che singolarmenteprese non avevano la necessaria consistenza per resistere. La conclusionenon lasciavaaditoad .. …; idubbi:lo ‘ ' a ‘ dei ', " risultava fin troppo debole per sostenereerespingeretaletattica. Il vantaggiodellarapida manovrabilità garantitodal leggeromanipolo nel teatro appenninico, siritorceva contro in quello nordico. Neppure l’antica falange avrebbe fornitoesitimigliori.non potendoneanchelei sostenereun urtocentraleditaleimpetoeditaleviolenza senzaspezzarsi!
E‘ ’ ‘ sela i due classici, la ‘ ‘ scaturì dalla loro fusione:l'unitàtattica dibaseavrebbedovutoesserepiù consistentedelmanipolo,senzaperòperderne
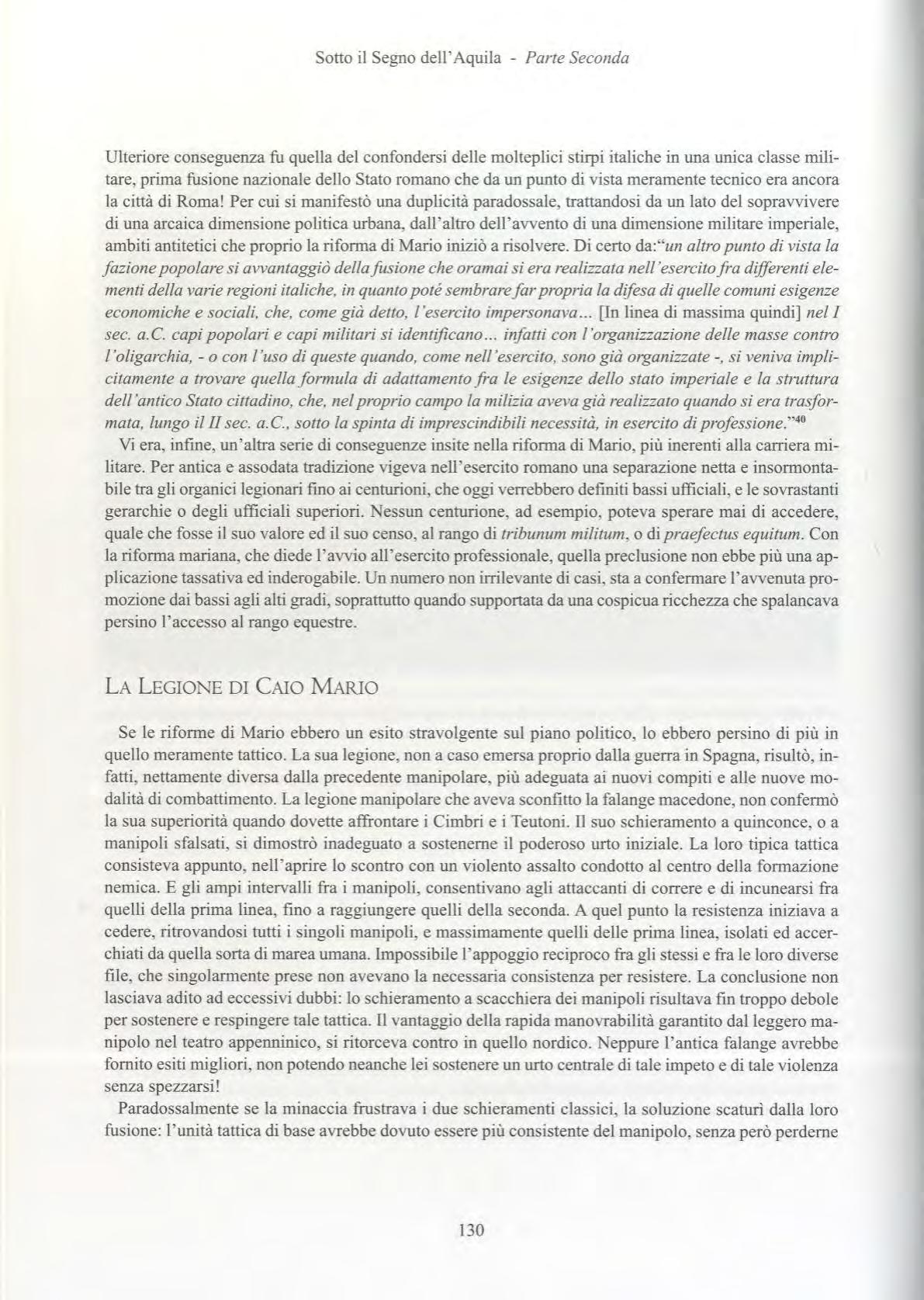
Sotto i] Segnodell‘Aquila - ParreSecondo
130
Schieramentolegionecoorte/emarlenedi 5000 uom/m
In dettaglio una coorte di 3 manipoli[armaticiascuna di2centurieda 60—80uomini.
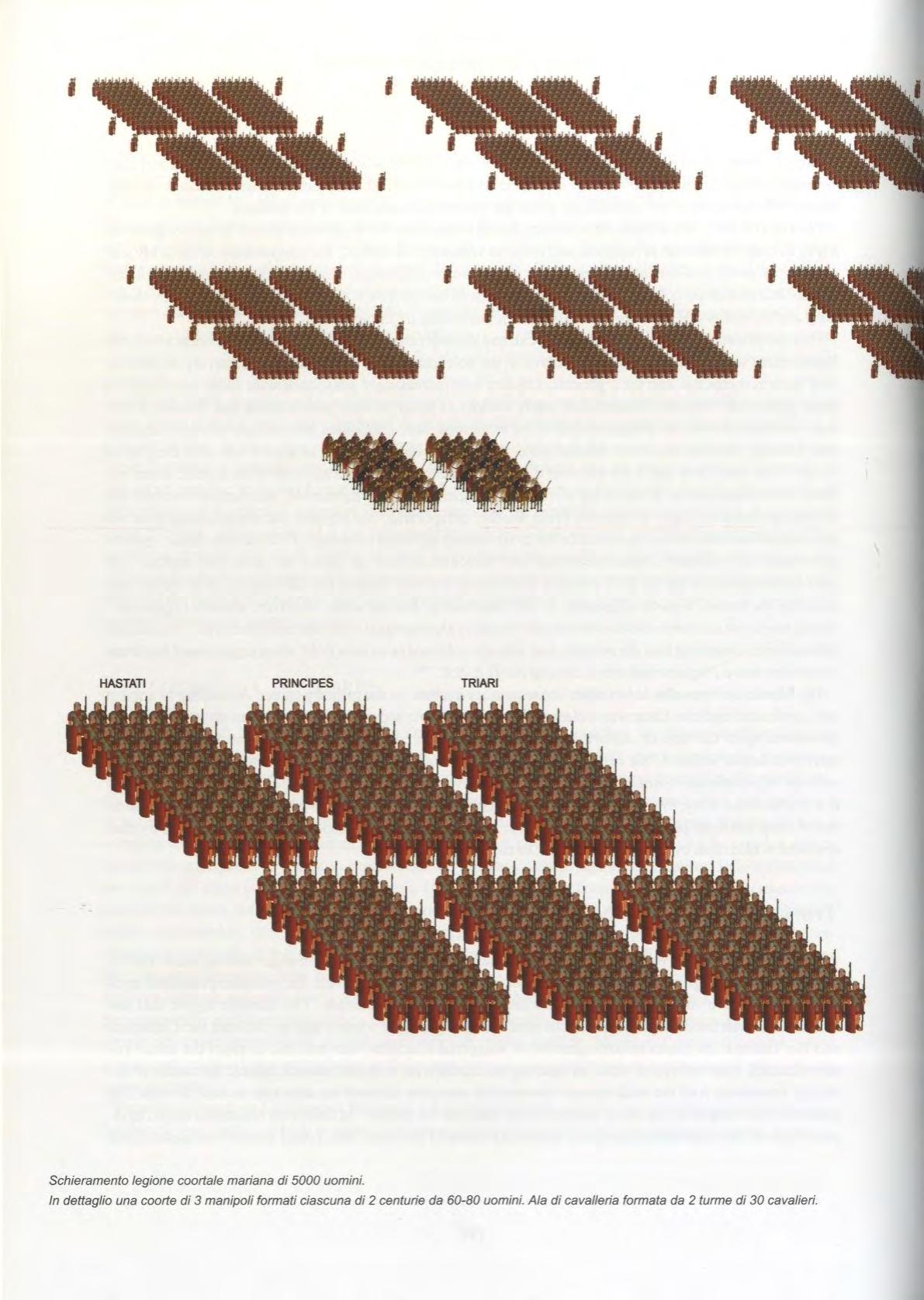 Ala dicavalleriafumata da 2 tumie di30cavalieri.
Ala dicavalleriafumata da 2 tumie di30cavalieri.
Leg/Uli cohortformation ofthe Mar/an per/od, numbenrig 5.000men. A canoriof 3 maniples, eachconsisting012 centunes of 60-80men. Cava/rywing cons/Stingof 2 squadroneof 30horse/lien
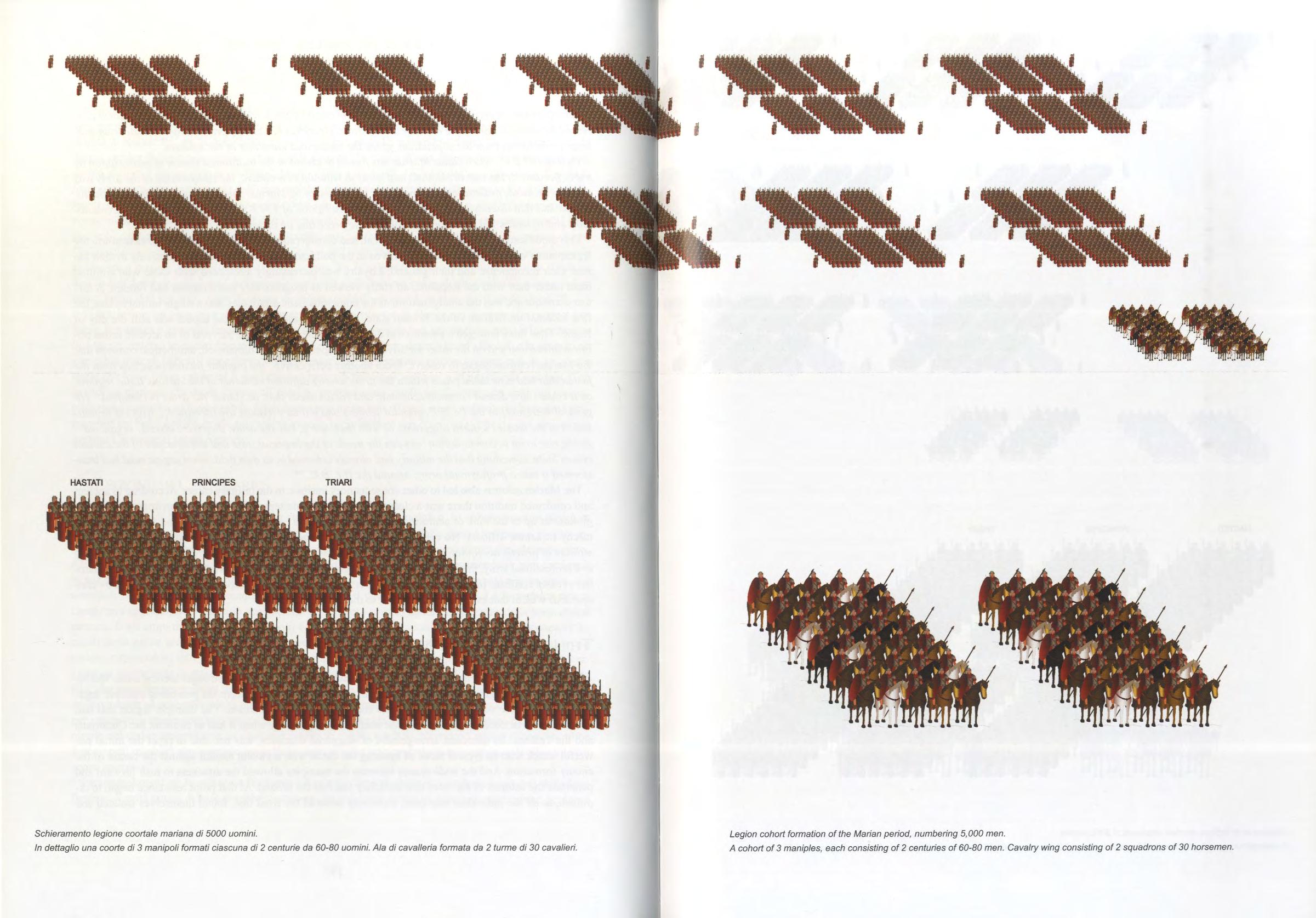
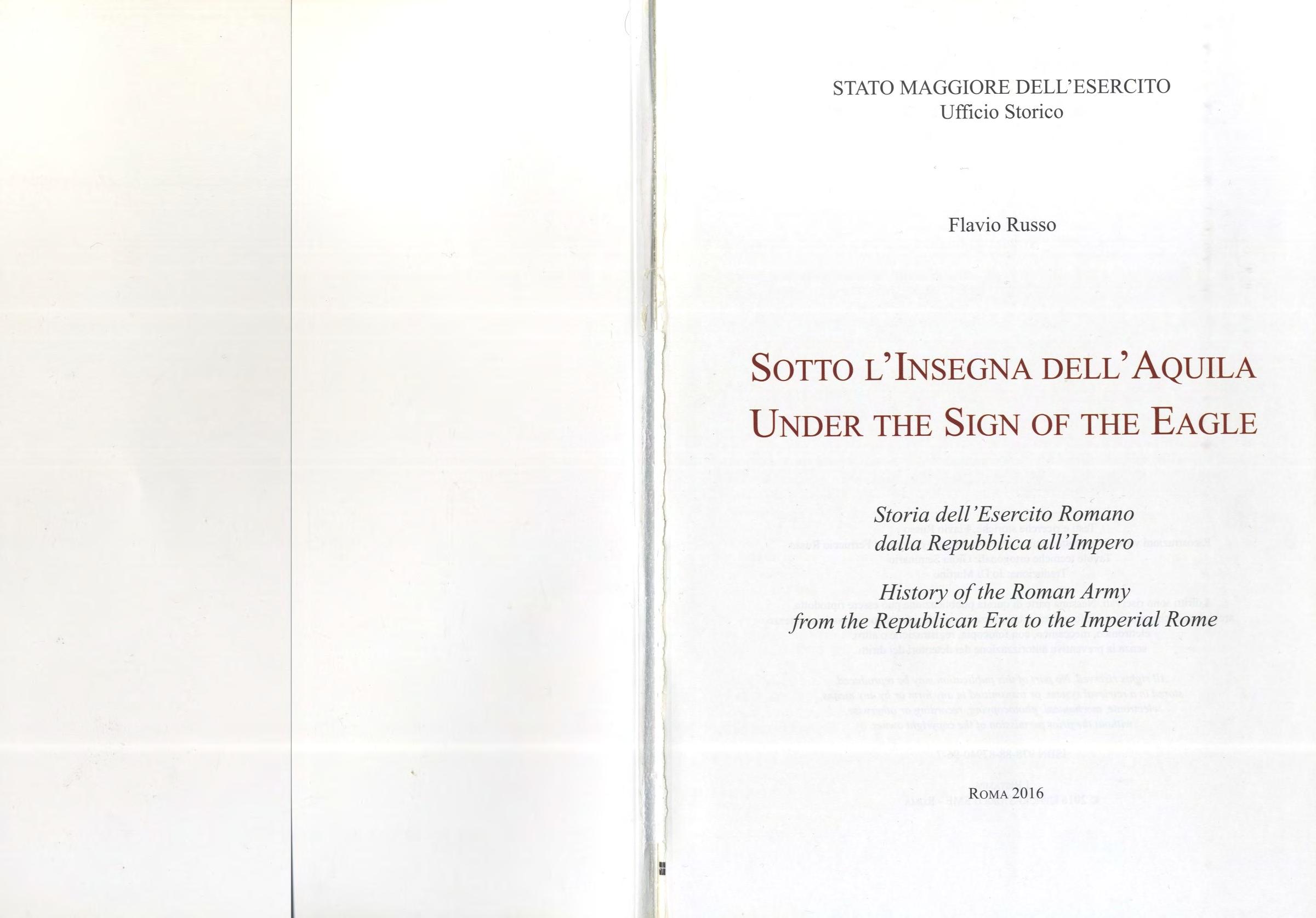
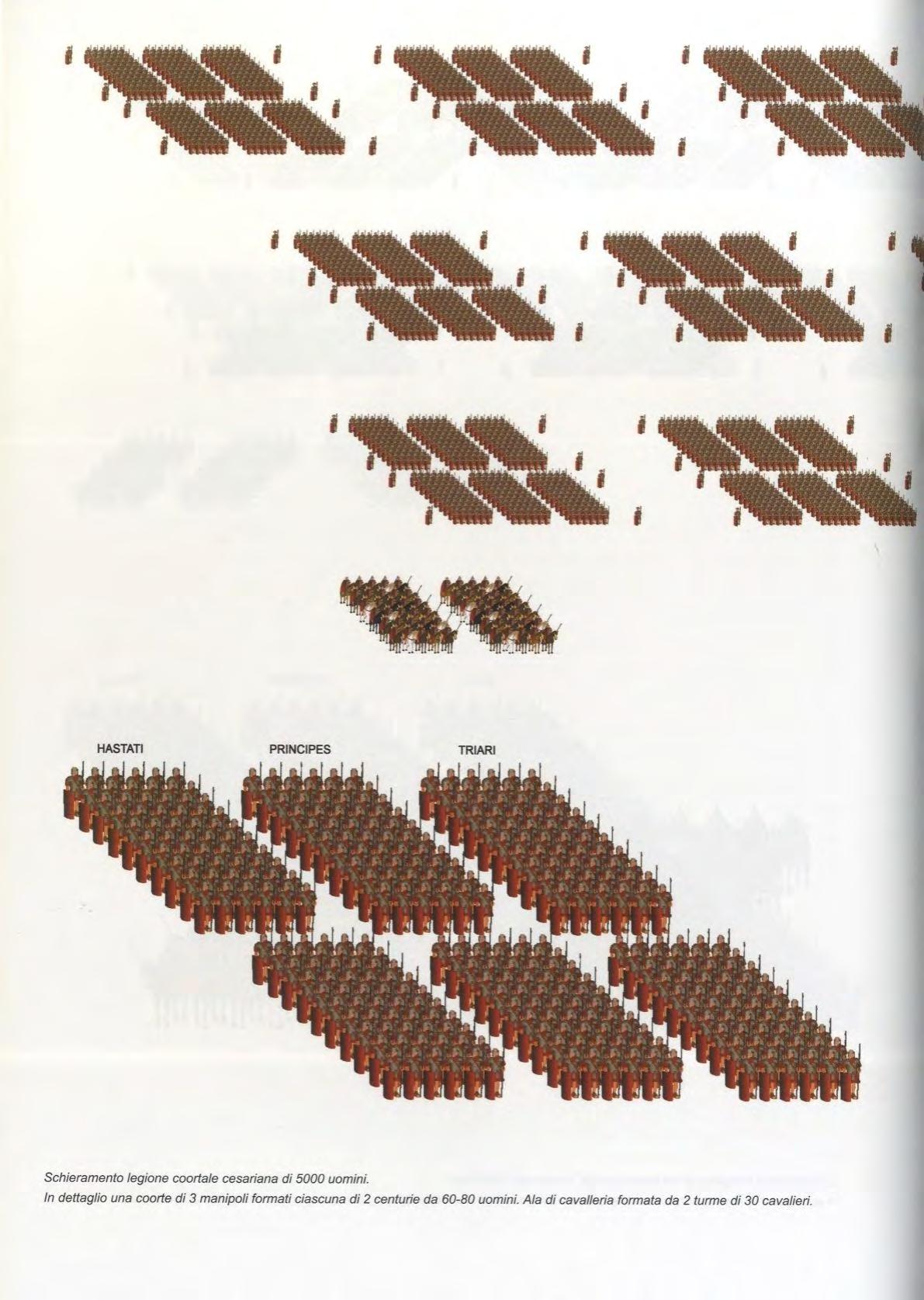
..“li"'-1 . ‘!" . “i‘l‘lhiwil‘il‘lhfl' ' "iii", ! Schieramentoleg/oris coortle Cesa/iena di 5000 uomini. In dettagliouna coortedi3 manipoli formaticiascuna di 2Dentun'eda 6080uomini.Ala dicavalleriaformatada 2 {unusdi 30cavalieri.
Cava/rycohoi‘tdetachmsntofthe Cosseria”era, 5,000 men. A canoriof3monio/es, each consistingof?ceniun'es0!60—80 men. Cava/ryWing consisting of2squadronsof30horsemen.
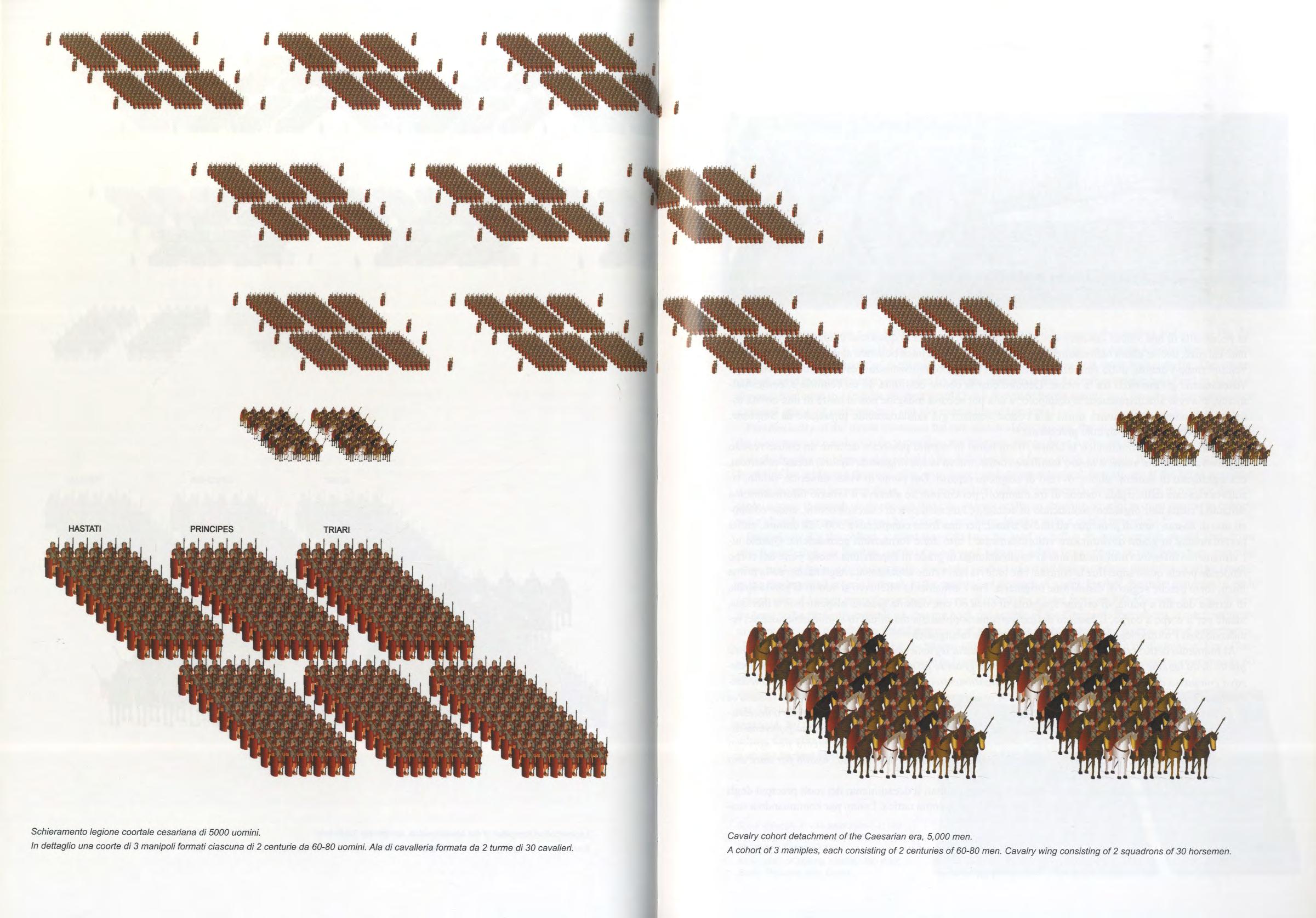
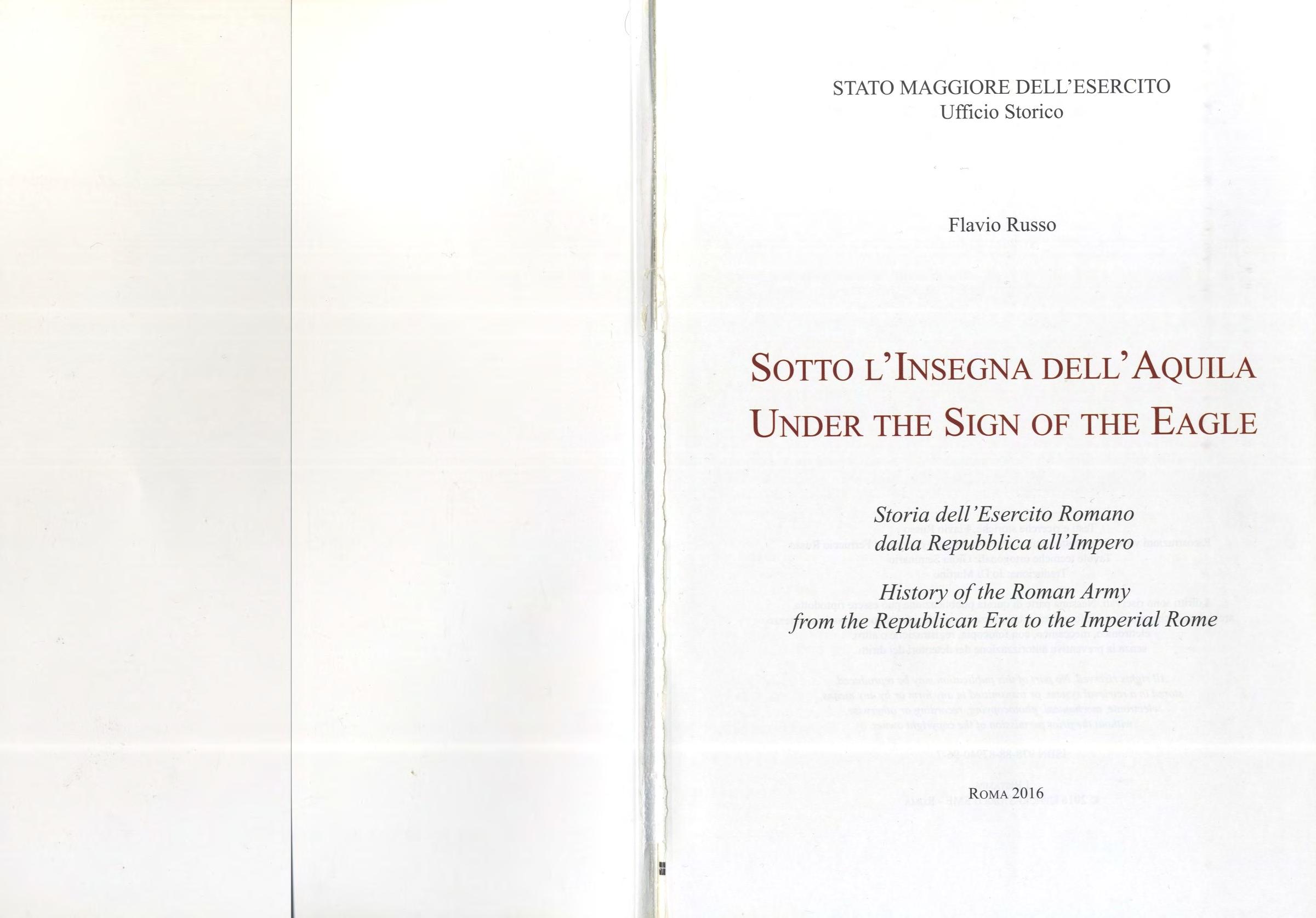
lapeculiarità di una veloce conduzione! Mario,pertanto, vagliata la questione eponderate le menzio» natecarenze,deciseallorarazionalmentedipotenziare laprima lineaponendo alposto deimanipoli,rivelatisi troppo deboli, delle formazioni tattiche di maggiore consistenza, restringendo al contempo vistosamente gli interstizi fra le stesse. Debuttò cosi la coorte costituita da sei centurie e, contestualmente, si avviòalla dismissione il manipolo: a una più accorta indagine non si trattò diuna novità as» soluta dal momento che unità simili alla coorte vennero già saltuariamente impiegate da Scipione, fornendoperciò a Mario un utileprecedente.“
Dal punto di vista etimologico la coorte, il cui nome in seguito passerà a definireun chiuso recinto impenetrabiletra cui anche il nostro familiarecortile.traeva la suaorigineda còhors.accus.cohonem, col significato di schiera. stuolo, ovvero di cospicuo reparto. Dal punto di vista numerico, infatti, ri» sultava ricavata dalla rigida fusionedi tre manipoli, per cui non ne alterava il criterio informatore ma soltantol'entitàdell’ ' "’ ’ ’ in A " itre 'r "di ' coorte. eranocompo» stiuno di bastati. uno diprincipes ed uno di triarii.per una forza complessiva 300-350uomini, entità perfettamente in grado di rintuzzare vittoriosamente l'urto delle formazioni germaniche. Quanto all’… difensivotutti ’ lo scudo “‘ ,, in gradodi coprireuna buona parte del corpo rendendoperciòquasisuperflualacorazza,chetuttavianonvenneabbandonatadainbastati dellaprima linea, forseperche' segnodi distinzione originaria.Per l’armamentooffensivosi adottò la solida spada di ferro a duefili epunta, di origine spagnola di circa 60cm, definita gladius hispaniensis o ibericus, idealeper il corpoacorpo.L’hasta fudefinitivamente soppiantatadal pilum di ultima generazione.recidendocosì l'ultimolegame con l‘antica formazionefalangistica.
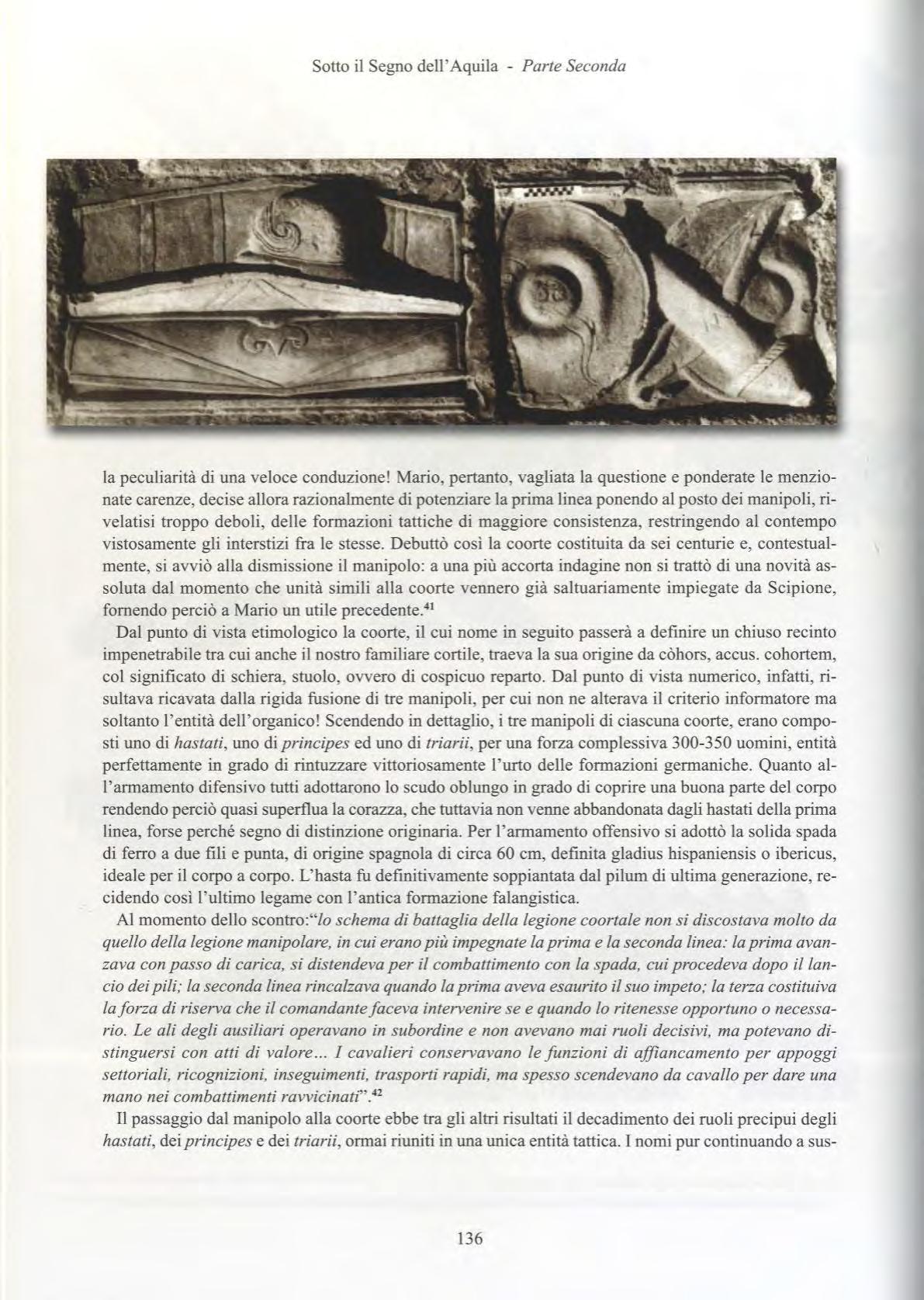
Al momento delloscontro:“loschema dibattaglia della legione mortale non sidiscostava molto da quellodellalegionemanipolare, incuieranopiù impegnatelaprima elaseconda linea:laprima avanzava conpasso di carica, sidistendevaper ilcombattimento con la spada, cuiprocedeva dopo ilIana ciodeipili,‘laseconda linearincalzava quandolaprima avevaesauritoilsuoimpeto;laterza costituiva laforzadiriserva cheilcomandantefaceva intervenireseequando loritenesseopportunoonecessaa rio. Le alidegli ausiliari operavano in subordinee non avevano mai ruoli decisivi, ma potevano distinguersi con atti di valore... I cavalieri conservavano lefunzioni di affiancamento per appoggi settoriali. ricognizioni, inseguimenti. trasportirapidi, ma spessoscendevanoda cavalloper dare una i.42 mano neicombattimentiravvicinati
Il passaggio dal manipoloallacoorte ebbetra gli altri risultati il decadimentodeiruoliprecipui degli bastati, deiprincipesedeitriarii.ormairiuniti inunaunica entitàtattica. I nomi pur continuandoa sus-
Sotto il Segnodell’Aquila - ParteSeconda
136
Sopra:ricostmzionidell'aquilalegionaria. Sotto.“statuetta rinvenuta adErcolano riproducenteun'aqui'la.
Nellapaginaafianco:particolaredelrilievodella vasca diun sarcofago.Roma, MuseoNazionale
Romano
Above: reconstruction of the iegions' aquila
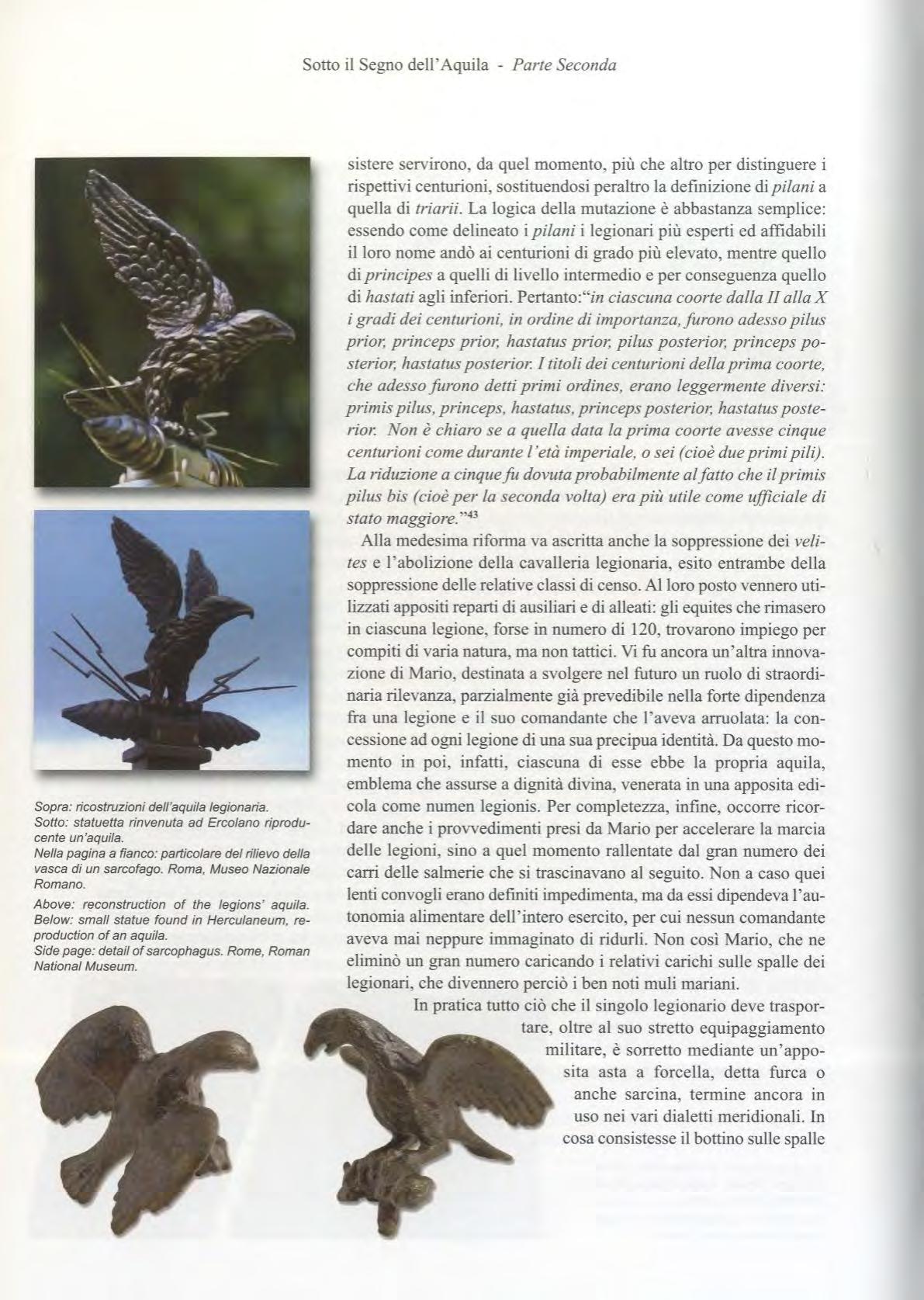
Below: small statue found in Horculaneum. reproduction oranaquila.
Sidepage:detailolsarcophagus.Rome,Roman National Museum.
sistere senirono. da quel momento. più che altroper distinguere i rispettivi centurioni.sostituendosiperaltro ladefinizione dipiloni a quella di ti'iarii. La logica della mutazione è abbastanza semplice: essendocome delineato ipilani i legionari più esperti ed affidabili il loro nome andò ai centurioni di gradopiù elevato, mentre quello dipi'incipes ::quelli di livello intermedioeper conseguenza quello di hasta/iagli inferiori.Pertantoz“zn ciascunacoortedallaIIallaX 1 gradideicenturioni. in ordinedi impuriun:a._lùr'onu adessopilus prio princeps prior; liastatusprior: pilu;posterior, princepspo— sterio hastattlsposterior: [ titolideicenturionidellaprima coorte. cheadessofurono dettiprimi ordine:, erano leggermente diversi.“ primispilar.princeps, liartuttlr.princepsposterior. ltastatuspasterior. Non è chiarosea quella data laprima coorte avesse cinque centurioniL‘Ollledurante]'ettìimperiale. asei(cioe'duepl'inllplll). Lariduzionea cinque/"udovutaprobabilmenteal,/iuta cheilprimis pilus bis (cioèper la seconda rolla) erapiù utile comeufficiale di statomaggiore.”"‘
Alla medesima riforma va ascritta anchela soppressione dei velites e l'abolizione della cavalleria legionaria. esito entrambe della soppressionedellerelativeclassi di censo.Al loropostovennerouti» lizzatiappositirepartidi ausiliari edi alleati:gli equitescherimasero in ciascuna legione. forse in numero di 120.trovarono impiegoper compiti di varia natura.ma non tattici.Vi fuancoraun’altra innovazione di Mario.destinata a svolgerenel futuro un ruolo di straordi» naria rilevanza.panialmente giàprevedibile nella fortedipendenza fra una legione e il suo comandante che l’a\eva arruolata: la con cessioneadogni legionedi una suaprecipua identità.Daquestomomento in poi. infatti. ciascuna di esse ebbe la propria aquila. emblema che assurse a dignitàdivina.venerata in una apposita edi» cola come numcn legionis. Per completezza. infine. occorre ricordare anche i provvedimenti presi da Mario per accelerare la marcia delle legioni. sino a quel momento rallentate dal gran numero dei carri delle salmerieche si trascinavano al seguito. Non a caso quei lenti convoglieranodefiniti impedimenta.ma daessi dipendeval'autonomia alimentaredell'interoesercito.per cui nessun comandante aveva mai neppure immaginato di ridurli. Non così Mario. che ne eliminò un gran numero caricando i relativi carichi sulle spalle dei legionari.che divenneroperciò i ben noti muli mariani.
lnpratica nrtto ciòche il singolo legionario devetrasportare. oltre al suo stretto equipaggiamento militare. è sorretto mediante un’apposita asta a forcella. detta forca o anche sarcina. termine ancora in uso nei vari dialetti meridionali. In cosaconsistcsse il bottino sullespalle
Sotto Il Segnodell'Aquila Parte Seconda
1 i r ’.
dei legionari lo possiamo rica\arc da alcune testimonianze coe\e quale quella di Cicerene.‘4Asuoparere il legionario.oltreallepro prie anni. trasporta delle razioni di Vl\'erl pei cinque giorni.equantoancora gli era necesse} rio nel campo. come alcuni utensili. quali la dolabraol'accetta.Ilpeso comple stimato oscillante intorno ai 26 kg. ma studi più recenti lascianoconcludere che in realtà si superassero persino i 40 kg! Alcuni autori giungono a circa 55 kg: e interessante ricordare chei lumi francesidurante il secondoinv pero portavano zaini di 35kg.

In realtà risulta probabile che i carichi oltre ad essere abbastanza \ariabili tra una circostanza c l'altra. lo fossero anche tra gli stessi legionari.Non tutti cioè eranocostretti a portare la medesima attrezzatura.o gli stessi og— getti.molti dei qualibastavano per una intera squadra. Assurdo. ad esempio. immaginare che ognuno si portasse le suestoviglie.la sua macina per il grano e si cucinasse da solo la sua razione enon.piuttosto. di concerto con i suoi orto commilitoni con i quali divideva la stessa tenda! Ne'. peraltro. la semplificazione di Mariopote\a eliminaretutti \ carri.datoche gli stessi servivano anche per le macchine da guerra. per le attrezzature del campo. per gli strumenti. lc riserve idriche e il foraggio del bes ame. In ogni caso con quel rilevante earico. il legionario. sempre a parere di alcuni studiosi "5.era in rado di percorrere tappe gior» naliere da 20 a 30 miglia (48 km]…
Il computo. tutta\ia. ancorché discutibile nella sua entità complessiva. è comunque relativo a percorsi su strada.cioèquelli possibili soltanto dopo la costruzione delle stesse a sua \olta successivaallastabilizzazionedelle conquiste. 0 solo per avvicinarsi alle basi di partenza dellecampagne. Queste.quindi.condotte in territorio iiemtco non potevano in alcun modo av\aniaggiarsi di tale infrastruttura l‘or— nendo.rendendoperciò I tempi di spostamento e di avanzamento delle legioni di gran lunga inferiori a quello su strada.
Rievocazionedialcunescenedlmalclainc…sonobenviSID/llleinsegneedInpanico/arelaquilaiegicnaiia Stampasettecentescaialîigwantelegionariconlasaremo
no dell'Aquila
- Pill'/L'Sc‘t‘(lillltl
\oe stato
L‘ARTIGLIERIA LEGGERA LEGIONARIA
Poco prima della distruzione di Cartagine, nei giorni della sua gloriosa quanto velleitaria resistenza alle forze romane che la cingevanod'assedio.tutti i cittadini si de» dicarono spasmodicamente a fabbricare armi e macchine da lancio. Ogni memoria storica riporta il sacrificio delle chiome, compiuto dalla mattone, per dotare le catapulte e le baliste dellenecessariematasseelastichedipropulsione (46),E quandoalla fine la cittàcadde,di tali artiglierie,di varia potenza e dimensione i Romani ne catturarono in gran numero. Non era, ormai,un’arma ignotanediavveniristicaconcezione,datoche anche le legionineavevanodatempodisimili,senonpure dimigliori,grazieaitecnici greci passati al loroservizio.Non sappiamo,però, al di la della tipologia che alcuni fortunati ritrovamenti spagnolihanno permesso di acquisire dettagliatamente "', quale fosse la dotazione per ciascuna legione nei contesti ‘ ‘della " , ' ‘ " né quali ‘ , negli scontricampali equali in funzionedifensiva, dapiazza, oda assedio.
Evitando perciò di entrarenell’ambito delle ipotesi e restando invece alla assoluta certezza deiritrovamenti èinteressantericostruire la coppiadegliscorpionirinvenuti in Spagna,quelloquasi intattorinvenuto a Meinl e infine il più malconcio rinvenuto a Cremona. Per l‘esattezza si tratta deirispettivi motopropulsori,cheappaionononostantelanonirrilevantedifferenmcronologicadi appartenenza,diassolutaidentitàformaleepienamentecompatibilifia loro.alpuntocheleflan—
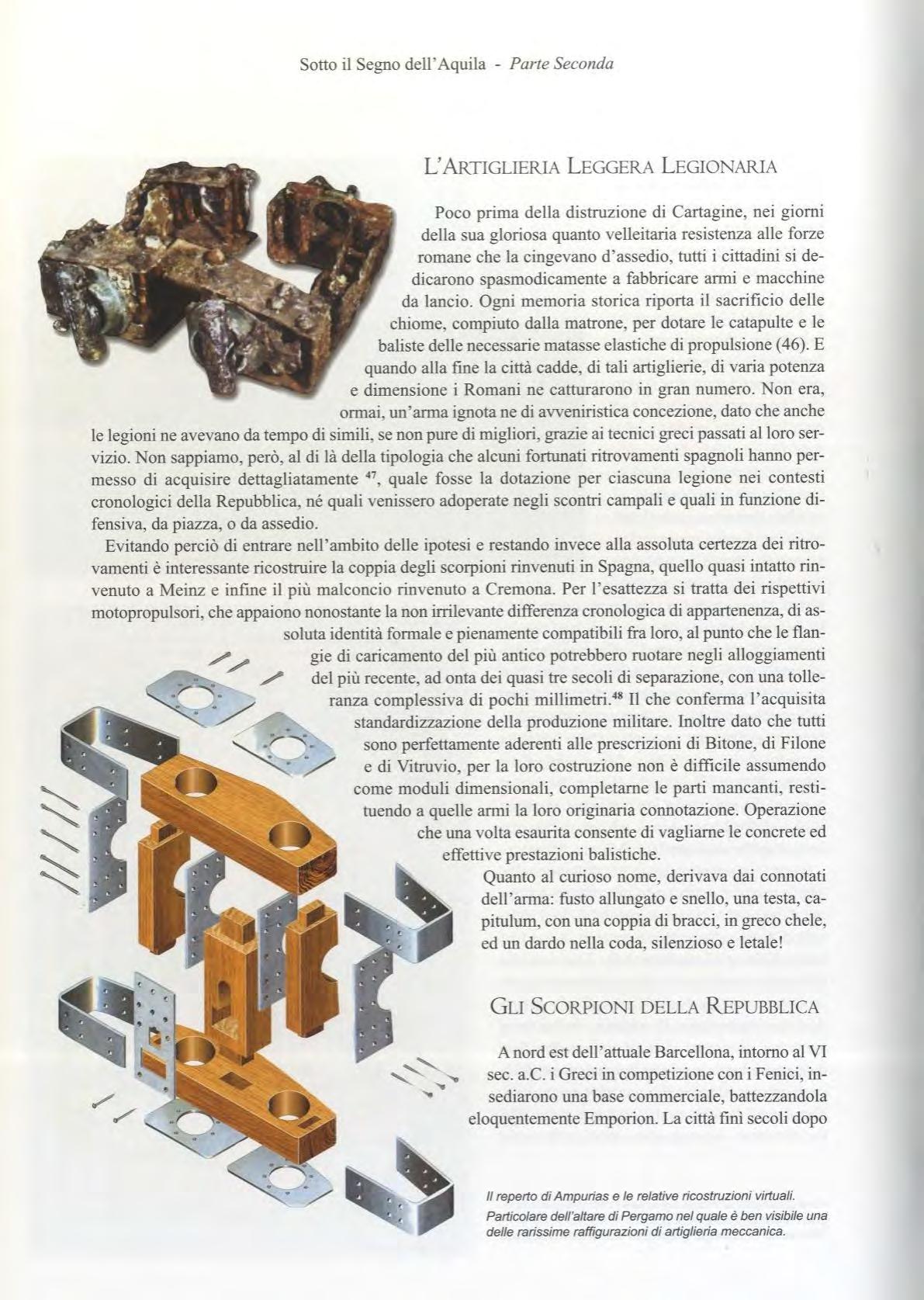
gie di caricamentodel più anticopotrebbero motare negli alloggiamenti delpiù recente, adonta dei quasi tre secolidi separazione,conuna tolleranza complessiva dipochi ruillimetri.‘s Il che conferma l'acquisita , standardimzione della produzione militare. Inoltre dato che tutti
sonoperfettamente aderenti alleprescrizioni di Bitone,di Filone e di Vitruvio, per la loro costruzione non è difficile assumendo come moduli dimensionali, completarne le parti mancanti, restituendo aquelle armi la lorooriginariaconnotazione. Operazione cheuna voltaesauritaconsentedivagliarneleconcreteed effettiveprestazioni balistiche…
Quanto al curioso nome. derivava dai connotati \ dell'arma:fustoallungatoesnello,una testa, ca— _g pirulurn,conuna coppiadibracci, ingrecochele, edun dardonella coda,silenziosoeletale!
GLI SCORPIONIDELLA REPUBBLICA
Anordestdell’attualeBarcellona,intornoalV] ‘ sec,a.C.iGreciincompetizioneconi Fenici, in‘ sediaronouna base commerciale,battezzandola eloquentementeEmporion.Lacittàtinisecolidopo
Sotto il Segnodell‘Aquila
- ParteSez-anda
//
\/
\\ \ /
Ilreperto diAmpun'as & lerelative ricostruzioni virtuali. Parfioolaledell'altarediPergamonelquale èben Visibileuna dellerarissimemlfigumzioni diartiglieria meccanica.
I!reperto dl Teruel,elasuascompostzione virtua/s Therel/'t:ofTeme/,anditsvirtualparts.
Sottoil Sognodell‘Aquila - Parte Seconda per ritrovarsi lungo il prolungamento della via Aurelia. col nome di Ampurias,dopolaconquista romana dellaSpagna.La pacificazione della regione non fu però ne' rapida ne' agevole caratterizzata dalla violentissima resistenza delletribù locali. L’apicedei combattimenti fuattintotra il 147edil 138a.C.conlaspietataguerriglia,meglionota come guerra di fuoco, condotta dall’iniducibilepastore Viriato, che in più circostanze sconfisse le legioni. La caduta di Numanzia nel 133 pose di fattotermineai combattimenti che,tuttavia, ripresero conbrutalità persinomaggioremenodimezzo secolodopo.Questavolta afarsene promotore fu non più un rozzo brigante indigeno ma un alto ufficiale romano tal Sartorio, di risaputo valore. Fini ucciso a tradimento duranteun banchetto pochi anni dopo, non prima però di aver inferto gravi ed ulteriori sconfitte alle legioni.” Nel breve intervallo che separa i successi di Variato e la morte di Sartorio si collocano l’usoeladistruzionedellacatapulta,parzialmenteritrovata nel 1912 ad Ampurias e della similare recuperata sempre parzialmente, nel corsodegli scavicondotti intorno al 1990neipressi di Caminreal.Per cui selaperdita della prima èrelazionata agli attacchi di Viriato quella della secondaallaguerradi Sartorio.
I rinvenimenti non possono considerarsi dei frammenti miracolosamente scampati alla dissoluzionedell’intera arma,ma solo dei componentirecuperatidacatapultenon riparabili. L'usura dellerispettive flangie di caricamento,modioli,portaadescludereche fosserodei grossipezzi di rispettonuovi.Ilprimorinvenimentoavvennenel 1912.negli scavidiAm— purias5“:il repertofu inseguitointerpretatocomeunpropulsore diuna catapulta romana della metà del Il secolo a.C. In realtà quanto riaffiorato daun remotopassato eranosoltanto lepiastre di ferro che rivestivano il capitulum di una catapulta di media potenza, 0 privo forsegià all'epocadeibracci.Ad ognibuon contoquelre» perto consentì diverificare il modo adottato per montare le matasse elasticheeper ritorcerle fin quasi allosnervamento. Il secondorinvenimento ", iù recente ed in migliore stato di conservazione. ha fornito ben distinta l’intera componentistica metallica di un analogo gruppo motore. Il sito di rinvenimento indusse a far risalire il reperto al I secolo a.C, Pur coincidendo in sostanza col prece» dente,perconcezioneedimensioni,tradisce alquante migliorie. testimonianza d‘un perfezionamentoapplicatoaduna macchinagià reputata efficace. Echetale fossereputata lo confermaun temorinvenimentoeffettuatoa Meinz, semprerelativo al solo gruppo motopropulsore di una catapulta eutitona. Uguali ledimensioni, leconnotazioni gene» raliedidettaglio:una soladifferenzarimar—
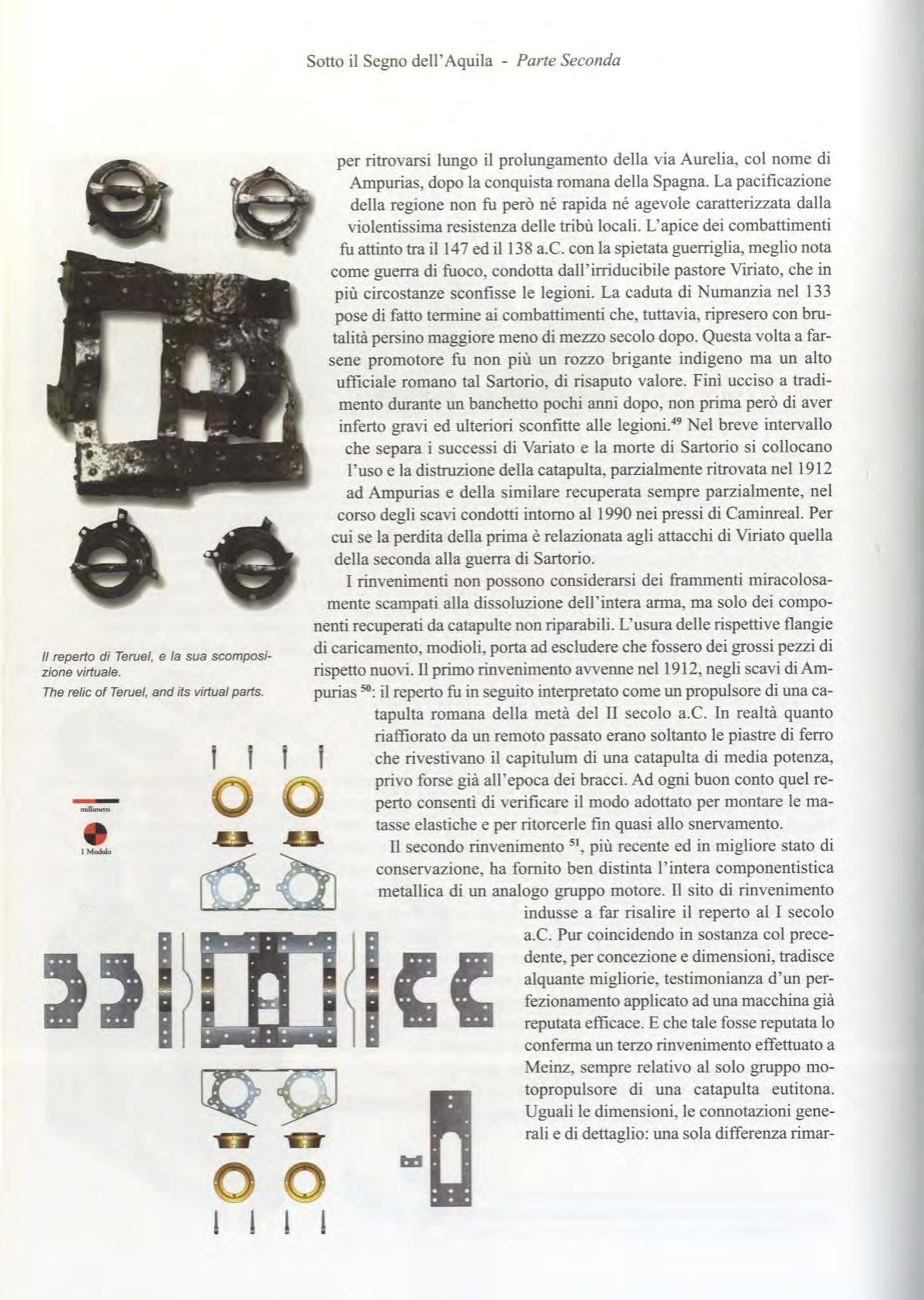
l
2 l
chevole,derivantedall’impiegodelbronzoper leblindature invecedel ferroel'adozioneancheditrepiastrefrontaliperproteggere meglio le matassa Arma più curata, forseperché destinata ai climipiù rigidi, databile con buona approssimazioneal I secolod.C. Di poco precedenti iresti diun quartopropulsore di unacatapultadianalogapotenza, rinvenutiaCremonanel 1887,masoloun secolodopocorrettamenteinterpretati. Sitrattòinquestocasodiottomodioli,sempredi identicaconcezioneformaedimensione,edi unapiastrafrontalefungentedascudaturaunicadinanziperentrambelematasse.Appartenendoanchequestaarma al I secolod.C.l'adozione diuna blindatura unica confermalatendenza dimaggioreprotezione pertaliartiglieriegiàosservatanelpropulsore di Meinz. Sbalzatasullapiastra laseguenteiscrizionesz:
LEGHH MAC
M VINICIO TAVRO. ….0 II CORV]NO...S
CVIBIO RVF INOLBC CHORAT... …RINC...
Cosìlaversione latinacenetta:
LEGIO QUARTAMACEDONICA
MARCOVINICIO ITERUM,TAURO STATILOCORVINO
(COS)CONSULIBUS
CAIOVIBIO RU'FINO LEGATO CAIOHORATIO PRINCIPE
chetradotta recita:
PROPRIETÀDELLAQUARTALEGIONE MACEDON'ICA
sonoIl.CONSOLATODIMARCOVINICIO, PER LA SECONDAVOLTA, E[>|STATILIOTAUROCORV'IINO, sorrol]…COMANDODI GAIOVLBIO RUFINO, LEGAm ESSENDOGAIOORAZIO,PRINCIPEDELPRETORIO
Una catapulta appartenentealla IV Legione Macedonica,costruitain età imperiale,un’altra forseap— partenente alla LegioXXX lacuipiazza erasituataa Xanten, lungo il Reno, sempredella stessaepoca, sostanzialmente uguali alle due repubblicane! Conferma esplicita dell’ottimo livello attinto dalle artiglierieleggereromanegiànel Il secoloa.C.,chedifattosarannoradicalmentetrasformateepotenziate, conun nuovo gruppomotopropulsore, solodopoil Il secolod.C…
Quanto all’artiglieria romana pesante e d’assedio tutto lascia concludere che fosse in sostanza del tutto similesia dalpunto divista formalechemeccanico ma, owiamente, di dimensioni maggiori. In pratica una sorta di ingrandimento di quella leggera: e di ciò la descrizione di Vitmvio da ampio riscontro. Sussiste,però, una zona di dubbiocircaun pezzo a tiro fortementeparabolico, quasi un antesignano mortaio, di cui se ne rinuacciano larvati riferimenti sin dal I! secolo a.C. nei trattati tecnici greci. La lingua, tuttavia, non deve trarre in inganno, essendo appunto il greco quella dei tecnici più avanzati, anche quando di origineromana oal servizio dell’esercito romano. Pertanto si può agevolmente concludere che quanto scritto da Filone in proposito alla cosiddetta arma monoancon, mono-

Sottoil Segnodell'Aquila — ParteSeconda
RepartodiCremona varimadia/l,lapiastradiblindatura[roma/eeirsslidialcunecomponentimeccanicheappartenenti.verosirnr/mente,alvenice/ioperricaricamentodell'arma.Nellapaginaafianco.lerelativeneosinizioniwriiiaii.unaVISianecomplessiva dell’armaeiasezionediunmodlaloutilizzatoperiatensionedellemalasse ReiicoiCremona:modioli,inefrontamouredpiaieandremnantsaivariousmechanicalpartsmos!likelybelongingtothewinch usedioloadtheweapon. Totheside,Virtualreconstructions,acomprehensiveviewoftheweaponandthesectionsaiamodioIususedtoiensethecoil, centimetri
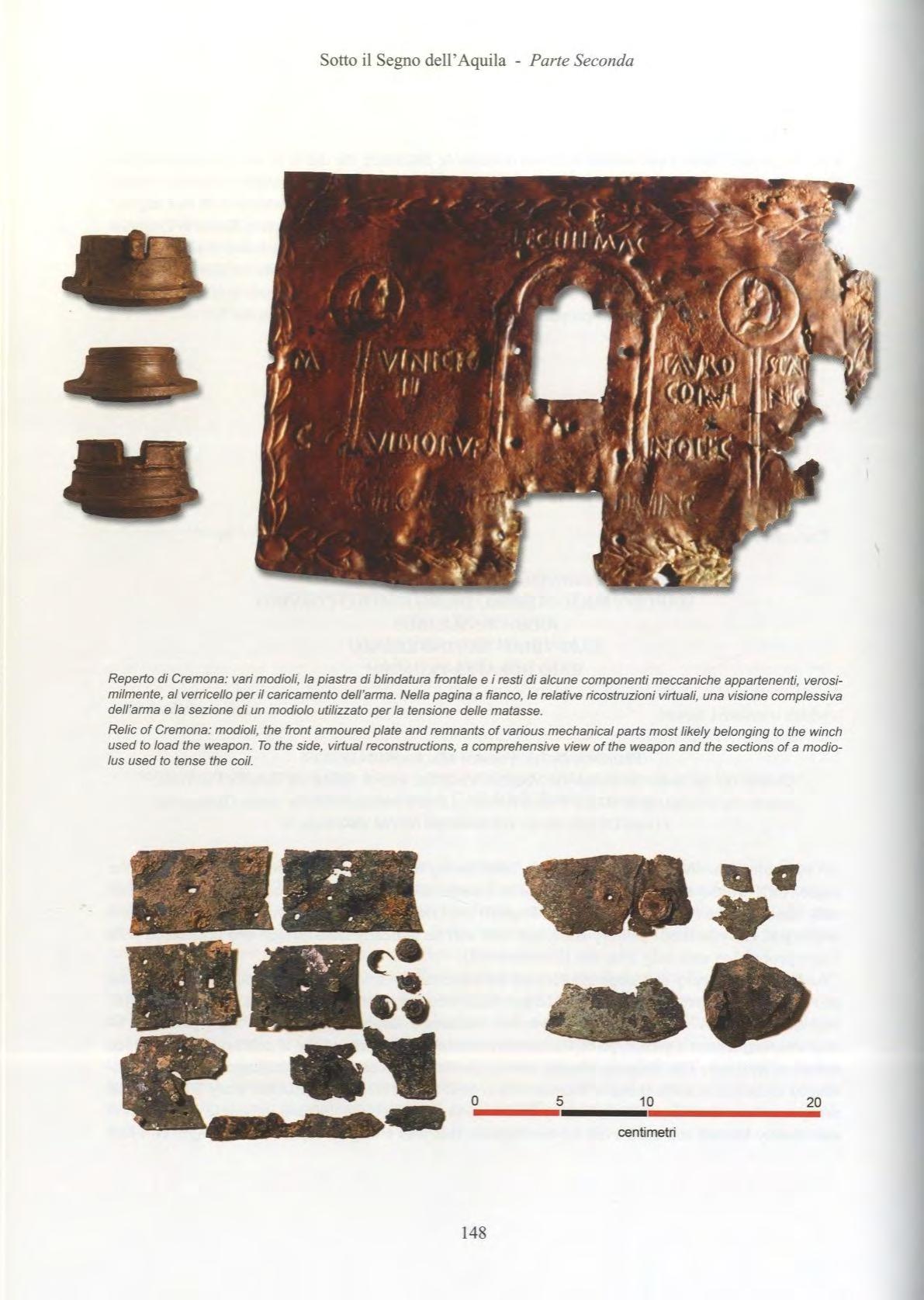
Sotto il Segnodell'Aquila - ParteSeconda J » iii/A… ' l’ .. .l' 'l ‘ W“)! V; i‘. ',i
148
braccio. fosse ampiamente noto e utie lizzato anche nelle legioni: in pratica si trattò di un’arma a matassa e braccio unici, sebbenedi notevoli dimensioni.ll suo telaio ricordava molto quello delle seghe a tenditore, dove, fatte le debite proporzioni alposto del listello vi era il braccio. Alla sua estremitàuna fionda ad apertura automa— tica. comandata dalla forza centrifuga, nella quale veniva collocato il proietto, quasi sempre una
pesante palla dipietra. Grazie al tiro arcuatodurante gli assedi era possibile battere l‘abitato dietrole mura, creandoperciò un effetto terrifico di straordinaria valenza. Questa macchina chericeverà notevoliperfezionamenti nei secolisuccessivi, darà origine sia alla catapulta siaal trabucco medievali.53
Se mai esistesse qualche dubbio sull’esistenza effettiva dell’onagro già nel I sec. a.C., vi è una singolaretestimonianza a Pompei. Sullatratta settentrionaledelle suemura sonorimaste centinaia di impronte balistiche prodotte dall’artiglieria d’assedio di Sillanel 89a.C.Lemaggiorihanno diametri chevariano dai |20 mm ai 160 mm con penetrazioni di circa 120140 mm con andamento normale all’estradosso delle
un'evidente improntabalistica impressasullaconinamurana settentrionalediPompei, dum/ite l'assedio di Silla dell’69a.C.
mura stesse, All’interno della Ricostruzionevirtuale diuna— -"«…, ,, -l , gm romano Cl a, 1110 e 50110 S a e l'1 ['OV3 e centinaia di palle di pietra, verisimilmente scagliate nel corso dello stessoassedio.Le seconde, tuttavia, risultano molto più grandi delle prime ed eccedenti i calibri massimi utilizzati dalle baliste: unica spiegazioneun‘arma che le abbia lanciate al— l’interno delle mu»ra. ovvero un’arma a tiro fortemente parabolico.

Sottoil Segnodell‘Aquila - PaneSeconda
An obviousballisth impression on thenorth wall ofPompe-ii, duringlhe siegeaf Silla in 89B.C. Witt/alreconstruction aiRoman anager.
OSSERVAZIONITATTICHE SUGLI ACCAMPAMENTI
Qualechene fossel'originaria connotazione, il campolegionarioromanodeveessereconsiderato una vera epropria basemobile.unarealtà costan tementepresente einnessun casotrascurata oapprossimativamcnte approntata, anchenei contesti operativipeggiori.Lacaratteristicachevariavanon eraperciònélasual‘on-nageometricanèilsuoimpiantofimzionale,masoltantolasuasoliditàcorn» plessiva. essendo commensurata alla presunta pennanenza enecessità impiego. Non a caso,in fatti,indipendentementedallafaticacheimplicava, lelegioninonvirinunciavaneppureperilbreve interwchdiunastriminzitatappanottumanelcorso dellemarceforniteodegli spostamentiveloci.Per cuipuòconsiderarsiuna regola imprescindibiledelleoperazionicampalilegionariespendere,inqualsiasi circostanza.metà dellagiornata inmarceverso il nemicoel’altrametàper formarel’accampamento Struttura stan— dardimtaediscretamentefortificataanchenellaconfigurazionepiùelementareeperlapermanenmpiùeffimera: ilchelofarebbeequipararedi fattoadunafortificazionemobile.unagigantescacoranaindossataadognisosta! Permoltistudiosiunaprassitantolaboriosaemeticolosacostituivaunaeccessivaperditaditempoediencrgia,sebbenel’essererimasta in vigorepertanti secolinell’esercitopiù combattivoedorganizzatodellastoria, dovrà pur suggerirequalcosa, Ad ogni buon conto, tutte le sere i legionari dovevano tassativamente trovareriparoall’internodiunrettangolofortificato.Sitrattavadicampierettialtemrinediognitappadi mar» cia,perun impiegoovviamentetemporaneo,castraesfiua,chelamattina successivavenivanoabbandonati. Differivano sia per consistenza delle difese sia per ampiezza dei campi chevenivano usati per intere stagioni. oper anni addirittura, detti anche permanenti, castrahibmra.statine.sia ancora per i materiali im— piegati non di radomassiccemuraturedipietra olatelizi.Sonoproprioquestestrutturechehannolasciato le maggioritraccearcheologiche tutt’oggi perfettamente evidenti.“
Volendomegliodescrivereunaccampamentoromano.chegiàagli inizidel lll secoloa.C.avevaattintola suaconfigurazioneprecipua.va ribadito che:“nella repubblica eal!iniziodelprincipato, ilmezzopiù caratteristica del]'lleebellica romanaerastato/'accampamenromobile. Allafinediunagiornatadimarcia, letruppelegionariave— nivano riunire in un luogo. sceltoprecedentemente Crm esl/emacura, equi,lavorandoperIreoreoanchepiù, sca» vamnoruttointornolrn/assaledidifesa,erigevalloun terrapieno.facevano una palizzata selvamî'arl' di elementi pile/abbricall' (pi/a mul'all'a} e il1finepl'alltavano le rende… Dairestiarcheologiciconservatiincertiluoghirisulta che ilperimetrodel]’accampamentopoteva averevarieforme, mentre lapianta internasembra cheseguisseuno schema fissa:leteMeeranobenraggruppareperunità intornoad
Xanten. Germania.Fotoaerea&planlmetnadelcampolegionario Xsnten.GermanyAerialphotographandplanimellyafalegion/vallecamp.

Sotto il Segnodell‘Aquila - ParteSeconda
l ;
un ’alnpiastrada aforma di 7”, chepecorreva il centro del campo in direzione dellazona risentita alquartiergenerale. Fra il loro interno del terrapieno e la prima fila di [ende veniva lasciato un largospa:iovuota.] criticimodernihanno spessoosrervaiochela sicurezza garantita da questo tipo diaccampamentonon era commensurabile all ' enorme sfarzo necessarioper costruirlodopoun giorno dimarcia, poiché senza dubbiola mobi» litàdell’eserczroromanoeranotevolmente ridotta da questa lunga elogorante row line. Tunavia, ancheselafragilepalizzata compositidapaleiriportatili aduepunte, ilfossatoprofondosolotrepiediromani, e ': ilterrapienoaltorola un metroenovanta circa nonparevanofizremoltopercomenereunforteassalto,sarebbeunosbaglio sottovalutareI 'mi/itàtanicadelledifeseti» pichedel!'accampamentomobile…
Perfino delle modestefortificazionidi terra (e deipaletti appuntit'l') sarebbero statisufi?cientiafrenare 1'unadiuna caf rica di cavalleria (edelresto i cavalieri nonmovevanodisolitoall‘attaccocontro [all'ostacoli):inoltre, lospaziolargosarsantapiedimmanifi'ailperimetroesterno elaprimafiladitende,garantivaunanotevole protezione contro lefrecce o le lance scagliata dainemici. Non solo, ma le ampiestradeallinternodell‘accampamenroavrebberopermesso, incasodiattacco,diadunaìeletruppeordinatamente.evitandolaconfusioneeilponicachenascono disolitoquandouna massa diperronedeveafinnarsiin unospaziolimitatoepienodiostacoli.
Tuttavia, gli studiosimoderni hanno senza dubbio ragione nell'evidenziare le deficienze tattiche di questotipodidifesa. Non era certopratica comunedeiRomaniconsiderarecomefortezza l‘accampamento assediato: una volta adunare, le truppe uscivano dirolitoper combattere il nemico in campo . aperto. dove lafi7lza d'urtodellafiznrzriapoteva averepieno efi"eito {sologliausiliariprovvisti diarmi dalancioparevanoottenerebuonirisultatiComba/tendodadietroilperimetrodel!'accampamento). Calnunque, eranosoprattutto lefunzioni non tattiche, che : rendevano]'accampamenromobiledeiRomanimoltopiù diunsemplicerecinlodifensivo, conferendoinun ‘impor— tanza senza confionlinel!’artebellica moderna: si trattava, infarti… di un espedientepsicologico estremamente L’ mace.
limgad.fatoverticale. ilforteromanodiShield.GranBretagna. Tlmgad,verticalphoto… TheRamanfortols/field,GreerBritain
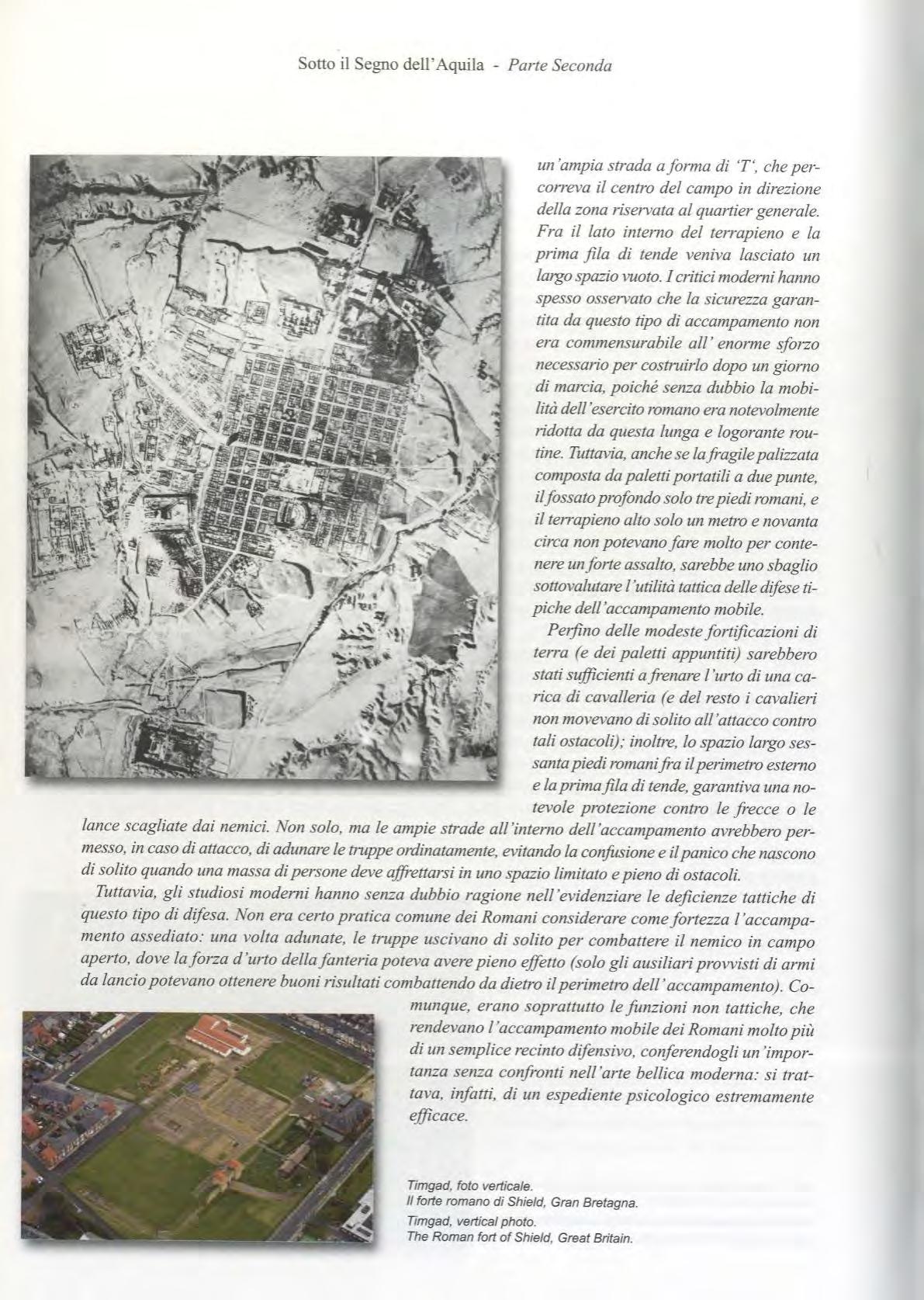
Sotto il Segnodell‘Aquila Parte Seconda
% il
ata chetene-
Inprimo luogo. un esercito in marcia in un territorio ostile espessoSconosciuto.poteva I7‘0\arenella /iuniliare struttura del!ltr't‘tiitipaniento un piacevole sensodi vieta re::a. Con il,tbssaio. ilterrapieno elapa rano Iwitum) gli sporadici indigeni e le liestiefemtît'. i soldatipoteva/in lavarsi. accudirealpmprto equipaggiamettiti. (anversa/’eedirert . in un atmosfera rilassata. Questosenso di sicure . avrebbepet‘ntewo loro di dorminesonnitranquilliediesse/?quindipl‘Dlll‘iperlamarcia ()la battaglia ilgiornoseguente. Quindi, ['abbtrtttilnenlo fisico ela_/iitica accumulata dalle truppe impegnate in unacampagnamilitarepotevanoessereinpartecompenr saredallepossibilità direcupero offerte da una notte di sonno.
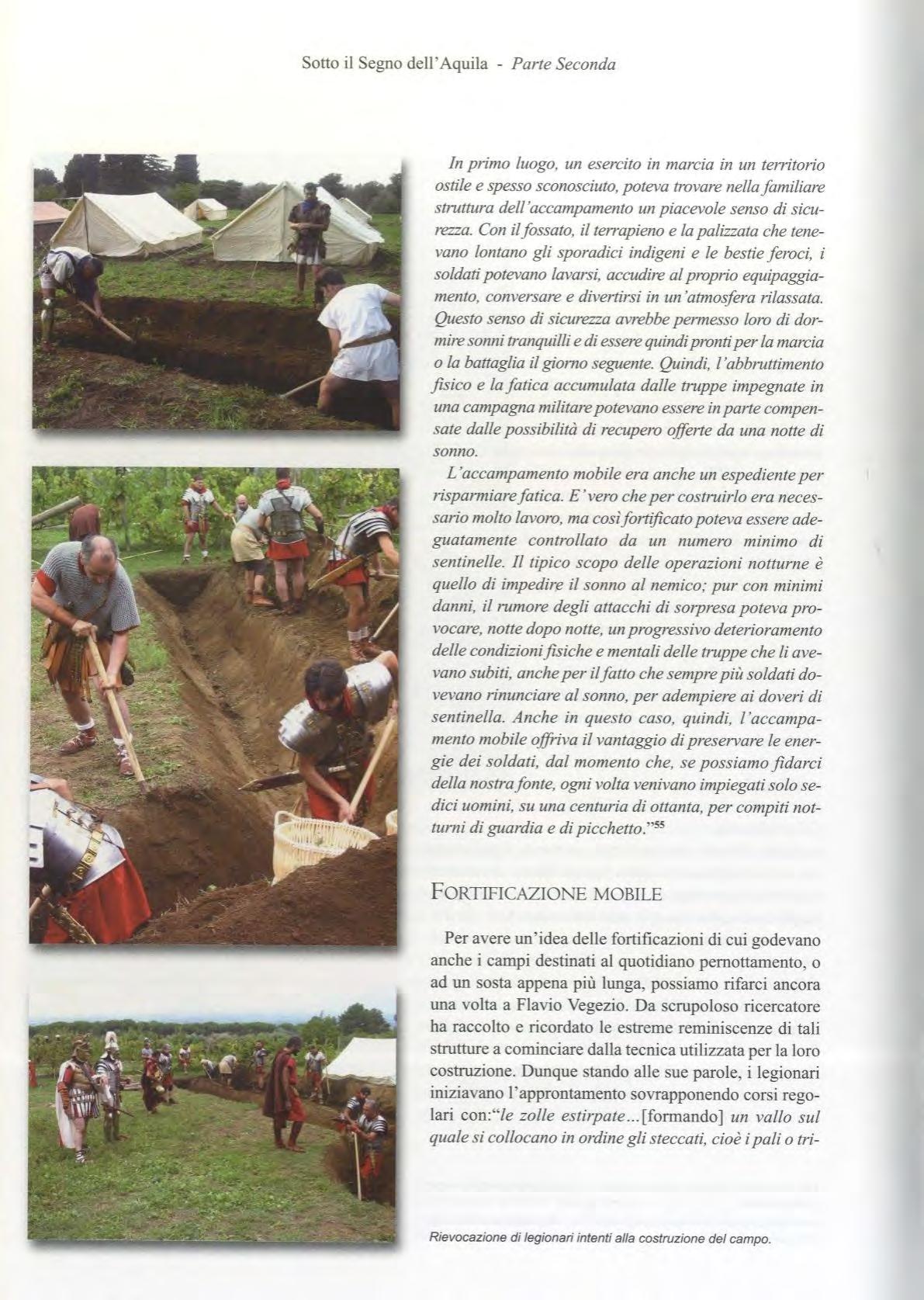
.\'truirlaera
pur con minimi
[accampamentomobile eraancheun espedienteper risparmiarefarica. E '\'erocheper (‘ sariomoltolavoro.ma cosìfortificatopoteva essereadeguatamente Controllato da un nur/iera minimo di sentinelle. [[tipico scopo delle operazioni notturne e quella di impedire il sonno altietnic darmi. iltumore degli attacchidi sorpresapotevapro— vocare. nottedoponotte. unprogressivodeterioramento dellecon oni/isiclteementalidelletruppeche[[aver rottoSubiti.atte/teperlljùtlvchesemprepiùSoldatidovevano rinunciareall'anno…per adempiereaidoveridi sentinella. Anche in quevto rasa, quindi, ]"accampamentomobileofii'ira ilvantaggio dipresentare leener» gie dei soldati. dal momento che. sepossiarnofidarci dellanostrafonte. ogni volta venivano impiegati vola sedicittatnim, su una centuriadi ottanta,per Compitinote turni diguardia edipicchetto."
FORTIFICAZlO. E MOBILE
Peravereun'idea delle fortificazionidicui gode»ano anche i campi destinati al quotidianopemotîamento. @ ad un sosia appena più lunga, possiamo rifarei ancora una volta 3Flavio Vegezio. Du scrupolnso ricercatore ha raccolto e ricordan lc estreme reminiscenze di tali struttureacominciaredallatecnica utilizzata per la loro costruzione. Dunque stando alle sueparole. i legionari iniziaanol'approntamento sovrapponendocorsi regolari con:"le :olle extii'pute...[formando] un vallo sul qualeSlcollocanoinordinegliStecca". ‘meipa/t a tri-
Sotto i] Segnndell‘Aquila Parte Seconda
necer
Rtevocazlone dileg/onaninte/i!!alla costruzione delCampo.
ES boli di legno. Lezollestesse, chetrattengono la terra
con[eradicidelleerbe, vengono tagliateintornocon
arnesidiferro:…si/bmwalteseionce [15cm]. larghe unpiede [29.55cm]elung/temezzo.Sela terra èpoco compatta tanto da non potersi tagliare come un mattone, allora con opera speditiva siscava unfossato largocinquepiedi edaltotre: da essa siaprominente I 'argine interno, affinchésicuro e senza timore si ri— posi I 'esercito..."“
Tomandoallasuacostruzione:“siè talvolta affermato che !‘accampamentomobile costituiva un elementodi garanzia dalpunto divista tattica,poiche'sele truppe romanevenivanosconfittesulcampodibattaglia,potevanosemprenflgiarsinell'accampamentoeprepararsi a combattereun altrogiorno. Questopoteva accadere, pero', solosele truppe sconfittedisponevanodiun accampamentointattoabrevedistanza,cosaimprobabile, datochedisolitolafortificazionididifesavenivanotrascurate. una volta abbandonato I 'accampamento. Tut— taviaquestaosservazionepuàesserevalidaseintesain modopiù sottile:niente. infatti, èpiù difiîcile che trasformarela sconfitta in una ritirata ordinata, evitando iafitgascomposta,percuil’accampamentodellanotte precedentepoteva costituire il naturalepunto diriassernbramento, giàprontoperschieraredinuovo ordinatamente ! 'esercito.
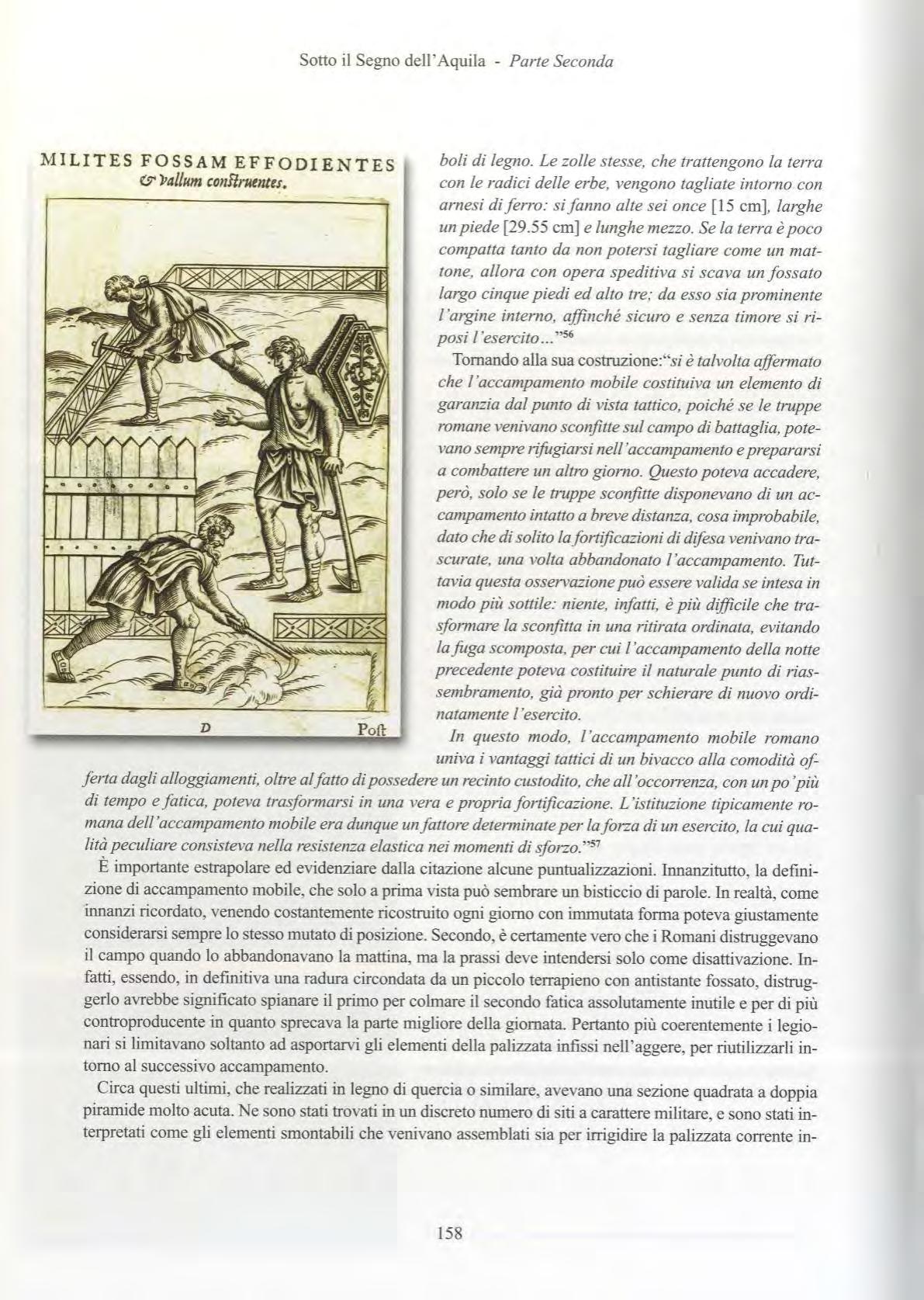
In questo modo, l'accampamento mobile romano univa ivantaggitatticidiun bivacco alla comodità offertadaglialloggiamenti,oltreolfattodipossedereunrecintocustodito,cheall'occorrenza, conunpo’più di tempo efatica,poteva trasformarsi in una vera epropriafortificazione. L istituzione tipicamente roy manodel]’accampamentomobileeradunqueunfattoredeterminateperlafarzadiun esercito, lacuiqualitàpeculiare consisteva nella resistenza elasticaneimomentidisforzo.”57
È importante esmpolareed evidenziaredalla citazione alcunepuntualizzazioni. Innanzitutto, la definizionedi accampamentomobile, che soloaprima vistapuòsembrareun bisticciodiparole. inrealtà, come innanziricordato, venendo costantementericostruitoogni giornocon immutata formapoteva giustamente considerarsisemprelostessomutatodiposizione. Secondo,ècertamenteverochei Romanidistruggevano il campoquando lo abbandonavano lamattina. ma laprassi deve intendersi solocome disattivazione. Infatti,essendo, in definitivauna radura circondata daun piccoloterrapieno con antistante fossato,distruggerlo avrebbe significatospianareilprimo per colmare il secondofaticaassolutamenteinutileeperdipiù controproducente in quanto sprecava laparte migliore della giornata…Penantopiù coerentemente i legionari si limitavano soltantoadasportarvìgli elementi dellapalizzata infissi nell‘aggere, perriutilizzarli intorno alsuccessivoaccampamento.
Circaquestiultimi, cherealizzati in legnodi querciaosimilare, avevanouna sezionequadrataadoppia piramidemoltoacuta.Ne sonostatitrovati inun discretonumerodi sitiacaratteremilitare,esonostatiinterpretati come gli elementi smontabili chevenivano assemblati sia per irrigidire lapalizzata corrente in-
Sottoil Sognodell'Aquila - ParteSeconda M]LITES F oS5A M EFF
DIEN
0
T
(?bullm…a.
"
158
torno al Campo. sia più verosimilmente per ottenere rudimentali cavalli di frisia. collocati nei punti critici più mlnerabili. I due tipi di proiezione certificatiper gli ac» cessideicampi ltitulus.ban-ieraFrontale.elaclavicola. ingresso obliquo che obbligava ]'avtcrsarioa esporre il suofianco sinistro.non diversamentedalleremoteporte scee.quandoavessetentato di violarla. necessitavano di un sistemadipalizzata resistente.ma smontabile.ss Pertanto.l'eventualeriattivazionediun campodapoco ‘ ’ sarebbestata rapida.‘ ’ riposizionare i suddetti pali. Ed appareoltremodo credi— bile che. in caso di ritirata o di disfatta in tenitmio sco» nosciuto.icomandantitrovasseroopportunoricondurrei legionariproprionell‘ultimocampo.non più lontanoper owieragionidimezzagiornatadi marcia, che ilpassaggio del giorno prima. spianando il terreno. aveva reso meno faticosa. Similmente. va sottolineato che il sito d'impiantodiun castranon veniva individuatostradafar cendo. ma accortamente previsto dagli esploratori tenendo contoche la sua distanza non dovevaeccedere la tappa quotidiana abituale,echedovevarisultarepianeggiantee.soprattutto.adiacenteadun corsodiacqua,adun lago0aduna grandesorgente.Sebbenelenostrepiù dettagliate informazioni al riguardo siano di epoca posteriore.lasostanzialeinvarianzadellaprassi ciconsentedi adottarloancheper tratteggiare laprocedura di impianto diun campoin epocarepubblicana.
L‘IMPIANTO DEL CAMPO
La prima incombenza. quindi, consisteva nel pianificareaccortamenteun itinerariochefornissetaliopportunità. quindi di individuare giorno dopo giorno il sito migliorealloscopo.Atale compitoera addetti siaalcuni ufficiali siailmetaior. cheapplicavanogli stessiprincipi ecriteri diun campopermanente.tenendo inoltre conto, quandopossibile, di evitareche fosse sovrastato da una collina o da una altura per non trovarsi sotto il tiro pro— venientedallastessa.Ideale.infine.un terreno lievemente inclinato in modo da favore il naturale deflusso delle acqueedei liquami ed una miglioreaerazione.”Volendo definiremeglioi legionari ei tecnicipreposti all‘approritamento del campo nonche' i loro rispettivi compiti. va
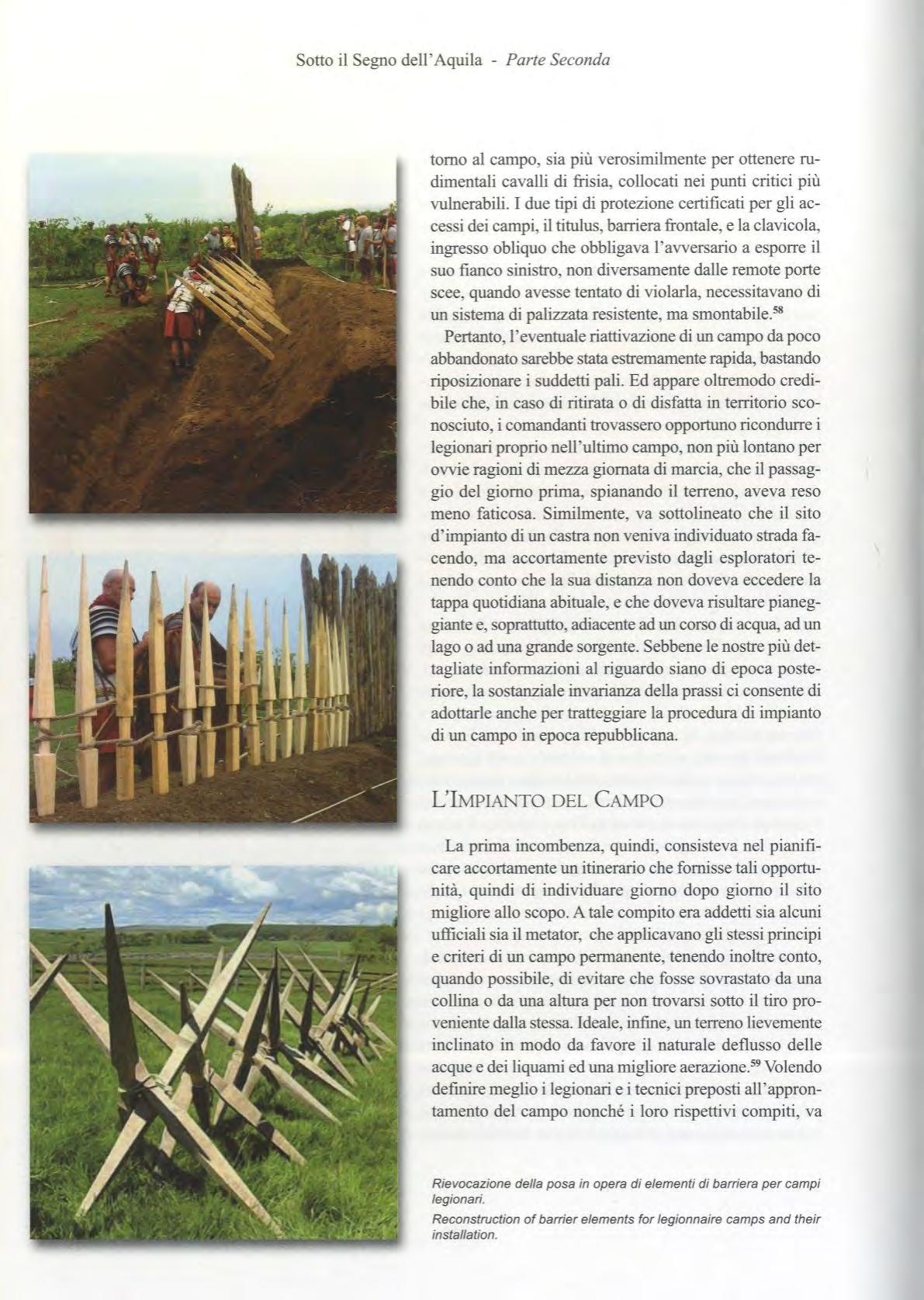
Sotto il Segnodell'Aquila - ParteSeconda
Rievocazionedellaposainoperadisieme/lildibarrierapercampi leg/onan
Reconstructionalbamelelementsforlegloltnalrecampsandtheir installation
osservatoche:"inizialmente,]"obiettivoeraquellodipotercostruireognisera, due rantelespedi:ioni. un Calliposolido. Ilmetatol: cheprecedeva la truppa, doveva trovare ilsito adeguato e ripartirepoi [eunità; ilgeotnelra (libralor) siassicw ravadellaoriz:ontalitzldellespianate.sicchélesuecompetenzesonostatespesso utilizzateancheperaiutaregliartiglierie,peresempio.perscavarecanali; ]'agrimentare(mensol')segnavalasistema:toncdellecamerate, delimitava [esupelfici appartenetitiallelegioniepoteva supplire 1"architetto...“
Venendoallaprassi concreta e plausibileritenere che.approssimandosi la fine della marcia. ma più verosimilmente intornoalla suametà.un tribuno ed alcuni centurioni, si trovano già sul luogo di tappa. molto avanti quindi rispetto alla testa della legione.odella prima legionenel casodiun esercitoconsolare composta sempre di due, forse alla stessa distanza a Cul si spingeva l'avanguardia. Ampio. quindi, il margine di tempo per osservare i dintorni.per valutare eventuali tracce insidiose. per accertarsi della idoneità del particolare sitorispetto a quelli ormai alle spalle. nonche' data l'assenza della truppa e dei carriaggi.per percepire ilsiapurminimorumoresospettool’assoluto silenzi ,persinopiù so— spetto, Significativamenteanche Flavio Giuseppe concorderà sulla estrema attenzione con cui veniva posizionato il campo, ribadendo la scrupolosa cura osservataper individuamelacollocazioneottimale.per livellarloepertracciarne ilperimetro. Tutto inessoeminuziosamenteregolatoecanonizzatoapartire dall‘istante dell’awiodella marcia sul fardell’alba.
Un’eco residua della meticolosa cura destinata al correttoimpiantodei castra lasipuò evinceredalle ordinanzemenzionate daVegezio Flavio. quandoormai tali struttureben raramente venivano realizzate. Precisava. dunque. con nostalgiail celebretrattatista militareche:“inprossimità delnemico.gliaccampamenti devonoesserpostisemprein un terrenoprotetto. daveabbondinoillegname, 10 strameel'acqua;inoltre,sesiprevedeuna lungapermanenza, siscelgaun luogo salubre. E'da evitarechenellevicinanzesierga un monteche, seoccupatodale ]'avversario,possa agevolarne [ 'ti/tacco. Ci sipreoccupi che ilcampo non sia soggettoadeventualistraripamentidi torrenti. chepossanocausaredisagialla truppa…”°‘Continuavaprecisandoche:"sidereancheevitarechein estate… vi sia acqua inquinata neipressi o l'acquasalubresia molto lontano; in inverno non scarseggiilforaggio()[alegna... [e]non sitroviin luoghiscoscesiofilari strada e, portando l‘assedio agli avversari, non presenti una difi'icile via d’uscita; non vigiunganodalle allureldardiscagliatidainemici…"62
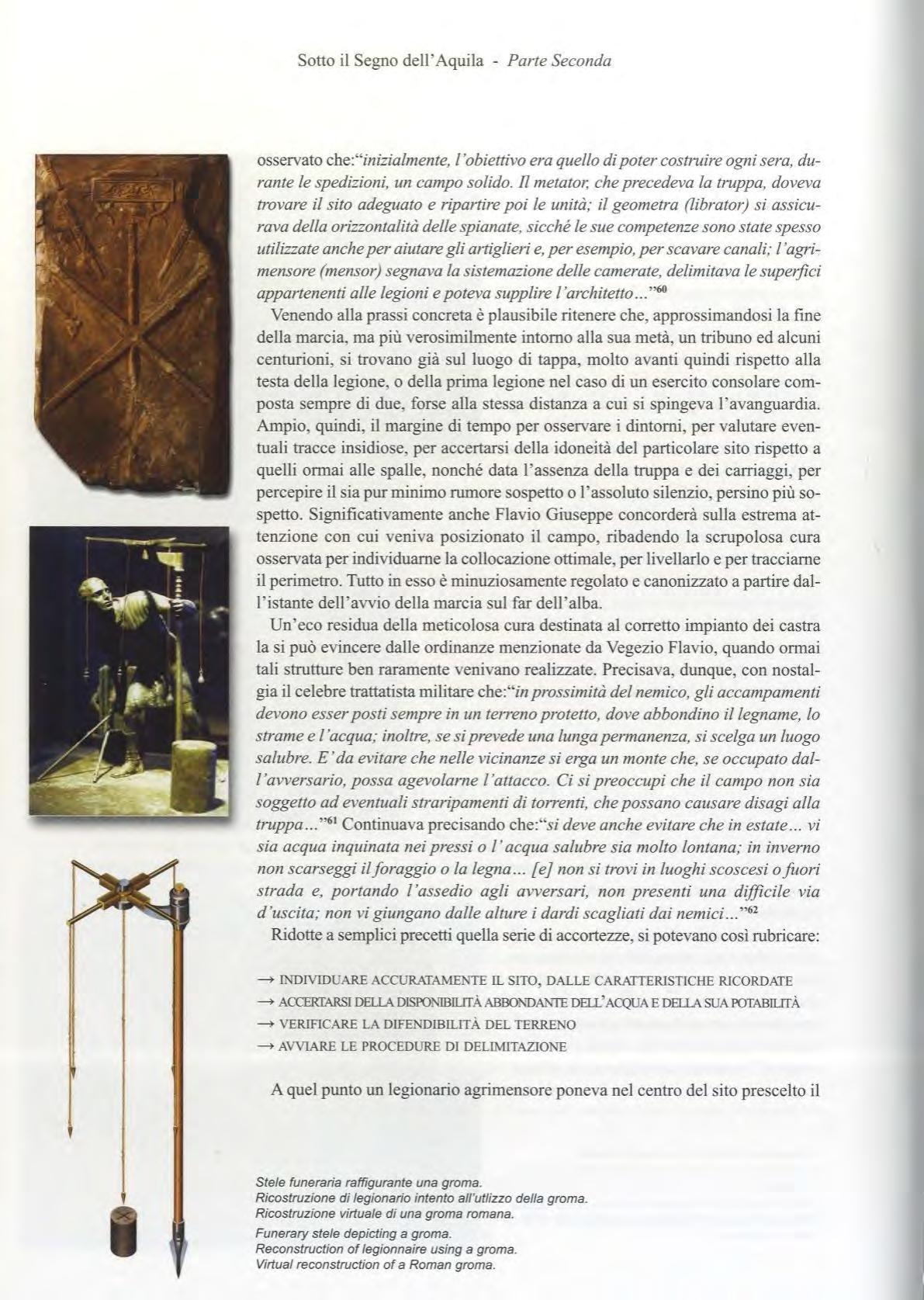
Ridotteasempliciprecettiquellaseriediaccortezze.sipotevanocosirubricare:
—> INDIVIDIJARE ACCURATAMENTE l.L SITO.DALLE CARATTERISTICHE RICORDATE
*? ACCEKIARSI DELLADISPONIBILITÀABBONDANTEDELL’ACQUAEDELLA SUAPOTABILITÀ
—r VERIFICARE LA DIFENDIEILITÀ DEL TERRENO
_) AVVIARE LE PROCEDURE DI DELIMITAZIONE
Aquelpunto un legionarioagrimensoreponevanelcentrodel sitoprescelto il
Stelefunerariaraffiguranteunagmma, RicostruzionediIegionanointantoall’utllzzodellagrams. Ricostruzionevirtualeuiunagnomaromana, Funemrysteledepictingagroma.
Reconstructionollegl'onrlail'eusingagroma
Virtualreconstructionof5Romangroma
Sotto il Segnodell'Aquila - ParteSeconda
suostrumentotopograficochiamatogroma.costituitodaquattrofili apiombo.traguardando i quali tornavapossibile faredei biffamenti suangoli di 90“.Ne scaturiva…)così delleprecise direttrici ortogonali che sarebberostate ilperimetrodel campoele suestrade intente. delimitando con il loro reticolo gli spazi per istallare le tende. E' interessante osservare cheforseil puntocentraledelcampoveniva chiamatoappuntogroma.61 In epoca suc— cessiva è probabile che la groma sia stata sostituita con la diottra di Erone, di gran lunga più precisa ed insensibile al vento. Lo strumento consentiva, inoltre, di impiantare campi non necessariamente ortogonali. configurazione confermata da alquantetracce residue.
Le suddette stringentilimitazioni. soprattuttonelle zone accidentate.finivano per limitare considerevolmente i siti idonei all‘impiantodi un castra. Il che conu-ibuiva a ridurre il normale raggio di marcia giornaliera:assurdo.infatti. supporre che alla spossante fatica di avanzare in salita sono il peso dell‘equipaggiamento si aggiungesse,pure, un incremento delladistanzadapercorrerepercarenzadi sitiidonei!Per avere una siapur vaga ideadi cosa fossel‘equipaggiamentocheuna legione dovevaponarsi dietro, è sufficientericordareche lenecessitavano.primaditutto.oltre500tende.alcunedelle qualidigrandidimensioni:tutte, coni supportiegli accessori,comunque di rilevantepeso.
LETENDEDEI LEGIONARI
A titolodiconsiderazioneitrattatistiromaniprecisanolaformaelecaratteristichedelletendemilitari lecui dimensionivariavanoinbasealledestinazioni.Quelladeilegionari.dettapapilioechericordasottomoltiaspetti l’odiernacanadese.eraformatadaduespioventi.similiaduntetto,sorrettidaun appositocavallettodilegno. Deipicchettidicirca40cm.sempredilegno.servivanoafissarlaalsuolomediantedelleappositecorde.Apianta quadratamisurava 12piediperlato,ovvero 10internied 1esternoperl'ancoraggio:inpraticacopriva9mqcon un altezzamassima di circarn 1.80edai latidicircain ].
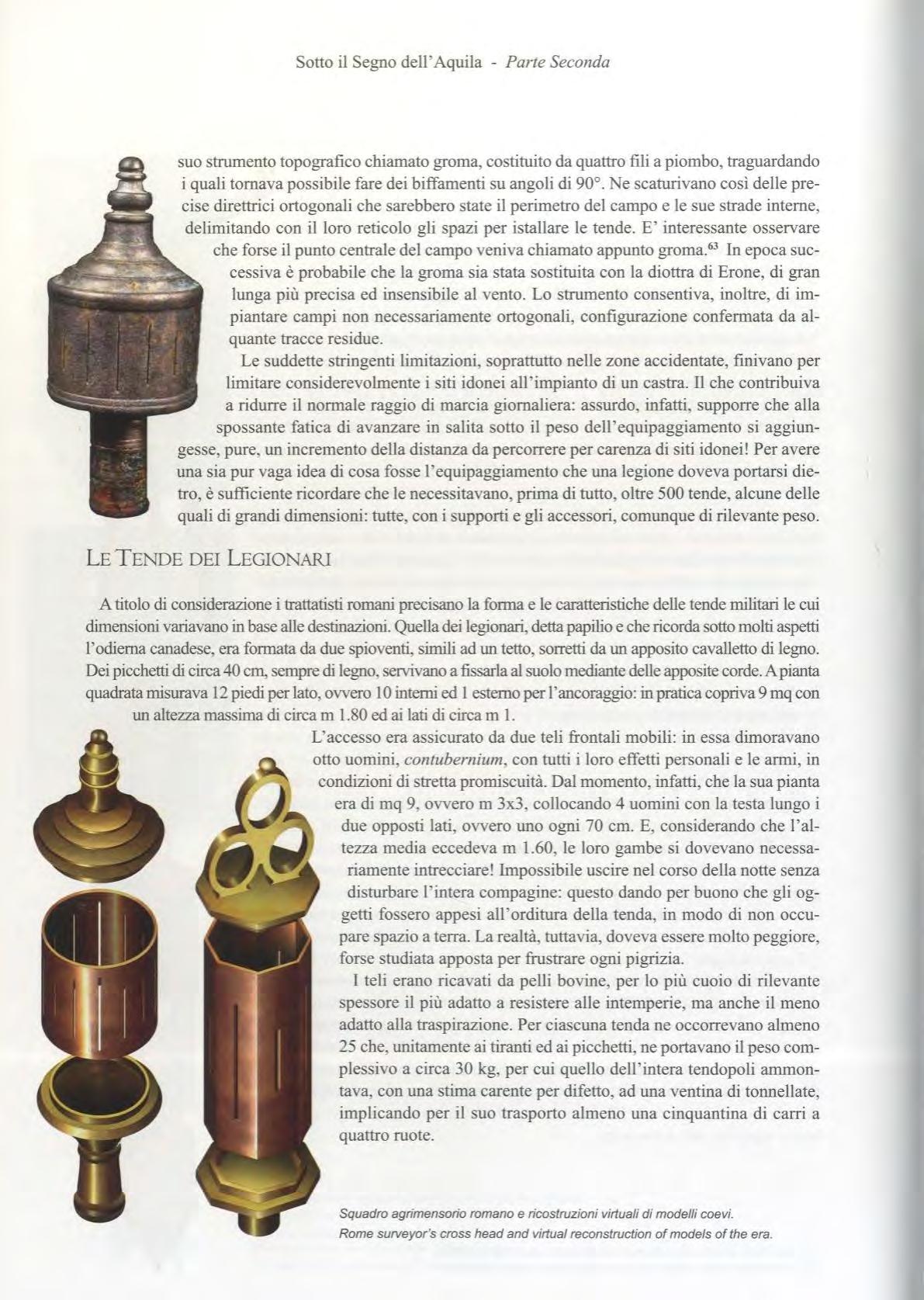
L'accesso era assicuratoda dueteli frontalimobili: in essa dimorava.no ottouomini.con/uberni'um. con tutti i loro effetti personali ele armi.in condizionidi strettapromiscuità.Dalmomento,infatti,chelasuapianta era di mq 9, ovveroin 3x3.collocando4 uomini con la testa lungo i due opposti lari. ovvero uno ogii 70 cm. E, considerando che l‘altezza media eccedeva in 1.60.le loro gambe si dovevano necessariamenteintrecciare!Impossibile uscire nel corsodellanotte senza disturbare l'intera compagine:questodandoper buono che gli oggetti fossero appesi all'orditura della tenda, in modo di non occupare spazioaterra, La realtà.tuttavia.dovevaesseremoltopeggiore. forsestudiataapposta per frustrareognipigri
I teli erano ricavati da pelli bovine. per lo più cuoio di rilevante spessore il più adatto a resistere alle intemperie, ma anche il meno adattoalla traspirazione, Per ciascunatenda ne occorrevanoalmeno 25che.unitamente aitirantiedaipicchetti.neportavano ilpesocomplessivo a circa 30 kg, per cui quellodell'intera tendopoli ammontava, con una stima carenteper difetto.ad una ventina di tonnellate, implicandoper il suo trasporto almeno una cinquantina di carri a quattroruote.
Sotto il Segnodell‘Aquila - ParteSeconda
Squadraagrimensonaromano &ncoslruzwm vlrluali di modelli coevi, Ramesurveyor'scrosshead andvirtualreconslructlon ofmodelsDfi/te era.
ALLESTIMENTO DEI CAMPI STAGIONALI
Sequantoprecisatodeveritenersitassativoper i campi mobili,ricordati comesubita tumultaria castra o aestiua,pertutti glialtri,invece,la fortificazioneperimetrale assumevacaratteristiche assolutamentemag» giori.specialmentequandosiubicavanointerritorionemico,oinvicinanzadelnemico. Pertanto, intali cir» costanzesiordinavaallesingolecenturie,inbase allasuddivisionedei compiti stabilitadai comandantidel campoedaiprinceps,diposizionarsi lungoi segmentiassegnati,edopoavercollocatoin cerchiogli scudi eibagagliintornoaivessilli, iniziarelo scavodel fossato,senzaperaltrodeporrelearmiindividuali.Il fossato,poi,dallasezionetriangolareconilverticeinbasso,misuravainsorrunitàunalarghezzadinove,diundicioditredicipiedi,chepotevanoincrementarsifinaidiciassettepaventandosiattacchinemicidiparticolare violenza, Lapreferenzaperunamisura disparideverelazionarsi allanecessitàdi lasciareunalarghezza sul fondodiun piederendendoperciòpiù semplicela suddivisionegeometrica…Finito lo scavosicollocavano sullaterradiriporto,costipatalungoilcigliointernodelfossoaformarel’aggere,rami etronchiappuntiti.“
Sepoi ilcampodovevafungeredabaseavanzataperleoperazioniinterritorionemico, secioèdoveva restarealungonellostessoluogo,assumevaladefinizionedi castrastativa.Sitrattava alloradi impianti pesantemente fortificatinondiradorecintati conspessecortinemerlateinmuratura,scanditedaalquanto torricilindricheleggermenteaggettanti.PersinoquandoicastraStativisostituironolebaracche di legno, chea lorovolta già avevano sostituito le tende, con strutture inmuraturan schema d’impiantonon fu stravolto,Divennesemplicementepiù grande,dovendocontenere. infatti,oltreallesuddettecostruzioni ancheleenormi stalleper i cavallieperglianimali ingenere,gliimmensimagazziniper iviveri,gli altrettantocospicuidepositiper il foraggio,leofiicinee,in alcuni casi,persino dellerazionali infermerie.

DIMENSIONI DEI CAMPI LEGIONARI
Ovviamente l’accampamentoromano, oltrealleduetipologiemenzionate, vantava una cospicuagamma disoluzioniintermedie, fermorestandoloschemaplanimetrico. Il fattorcomunedi tutte levarianti specificheresta ildatocostantedelloroutilizzo,chemaivennemenonelleoperazionicampali,comecitestimo— nianoPolibioperl’etàrepubblicanaeFlavioGiuseppeperquellaimperiale.ProprioPolibio,ciinformacon notevoledoviziadiparticolari,sullecaratteristicheeledimensionideicastra,chenella suaepocadovevano poteraccoglieredinormaancheunesercitoconsolareformatodaduelegioni.Ciònontoglieche:“imanuali di .… si ,, ancoradell' diquattrolegionidiun esercitocomandato daentrambiiconsoli.Ladescrizionepolibianadelcamporomanocoevohadatoorigineauna vasta letteraturadalXVsecoloinpoi, WalbankritienechelaspiegazionefinorapiùconvincentesiaquelladiP. Fraccaro, secondo il quale Polibio aveva sott’occhio un vademecum minano contenente la pianta di un accampamento,pianta cheinun testodelgeneredovevaesserequelladiformatipica.Ilcampo tipico'era ancorailcampodiquattrolegioni;ma Polibionedescrivesolounametà. L ’altrametà è identica,ma rove— sciata(disposta ‘schienaaschiena),avendoincomuneconlaprimasololalineadibase ScrivePolibio-« Quandoentrambiiconsoliconleloroquattrolegionisonoinsiemeinunsoloaccampamento, non abbiamo chedaimmaginareduecampicomequellodescrittodisposti schiena::schiena,Abbiamo dettochegliextraordinariidellafanteriasitrovano al]’aggerposterioredelcampo. Essi/armano quindiilpunto dicon giunzione,eilcampoadessoèoblunga,conun”areadoppiadiquellacheera,eilperimetropariauna volta emaza»”.“
Un’ideadimensionalediun campopergrandi unità ci èstatatramandatadaIginoche,inlineadi massima, segue al riguardo ancora i canoni e leprescrizioni tradizionali.A suoparere un grande accampa-
Sottoil Segnodell‘Aquila - ParteSeconda
mentocapacedi alloggrareoltre all'esercito regolare anche gli ausiliari, la cavalleria e… persino contingenti delle forze navali, doveva avere una pianta rettangolare e misurare In 687 x 480. Al suo interno i reparti vengonodisposti inmaniera diversa e…cosa ancora più curiosa. i legionari sono molto più ammassati. alpunto di avere a disposi» none solo un terzo dello spazio che ave— vano nell‘accampamento polibiano.“ Quest'ultimaosservazioneappareestrema— mente significativa, in quanto testimonia che I Romani non eranoper nulla propensi ad incrementare, oltre un determinato li’ mite. le dimensioni dei loro castra. forse perché divenivano indifendìbili o. più ve— rosimilmente. forse perché per il corretto impianto, richiedevano connotazioni ambientali esrremamenteinfrequenti. Dal punto di vista pratico ci èstatatramandata una formula empiricaper il dimensionamentodei lati del campo,così composta: IZZOOVC Lil.5 l ovvero lunghezza in piedi del latocorto di un campo, 1,deve esserepari a 200 volte la radice quadrata del numero di coorti destinate ad esservi alloggiate. Quanto al lato lungo, L, deve essere pari ad una volta emezzo quellocorto.A] di làdei limiti imposti dal dimensionamentovi eranoquelli strettamente connessi con l’ampia disponibilità di acqua. Data la presenza di tanti uomini ed animali. l‘immediata adiacenzacostituival‘unicamaniera perpoterne disporre in manieraadeguata.lnalcuni casi eccezionali. quandonon sipoteva impiantare il campo sulla riva di un fiume. soluzione comunque abituale, si costnrivano dei canali, non di rado interrati, in modo da collegare il campo alla sorgentepiù vicina onde frustratetragiche sorprese.Quasi semprefacevanocapoa grandi cisterne,dal momento che l‘acquaper leabitudiniesistenziali dei Romaninon erapreziosa soltantocomebevanda.“ Un campobase.pertanto, capace di ospitaredadueaquattrolegioni,molto raramente, epergravissime ragioni strategichesicollocavalontano da un fiume.La condizione imprescindibileaffinchépotesse avvenireera l‘assolutocontrollo del territorio circostante,dovendosi provvedere all'approvvigionamentoidrico con carribotte.
In definitiva laformazionedell' può “ i una ,. zata,ma non per questo approssimata ed eseguita senza convinzione. essendo tutti i legionari, dall'ultimo soldato al console,perfettamente consci della suaimportanza. Quantopoi al trasporto delle attrezzatureper realizzarlo,delletendedaimpiantarviedegli altri elementi indispensabili per lasuadifesa,sideve supporreper l’epocain questione,piuttosto someggiata che carreggiata.non esistendoalcunarete stradaleemal adattandosi icarrialloradisponibiliall’avanmmentosulterrenonon preparatoocon fortependenza,tipicoperaltro dell’Italia. È significativo ricordare che ancora in età modemaz“la necersita‘ di aprire cammini attraversoicampiimposelapresenza in testa allecolonnedinumerosilavoratori. donde]‘originedegli zappatoridelgenio," inoltresisentilanecessità didareallecolonneguiderifareedintelligenti:ud indicarealletruppe ilcamminoprovvedevanogliu_ficr'ali dellostatomaggiore. in Francia:marécheauz de [agisdaciò è nata laparola Iogistica“.“Abonor'me, perconseguenza, il numero dei quadrupedr che solo lentamente decrebbeinepoca imperiale,tant’èche la legionecesar'iana conrava, in lineadimassima, una dotazione di 600animali da soma e Silla.all'assediodi Atene. siservivadi circa 20.000mulattieri,”
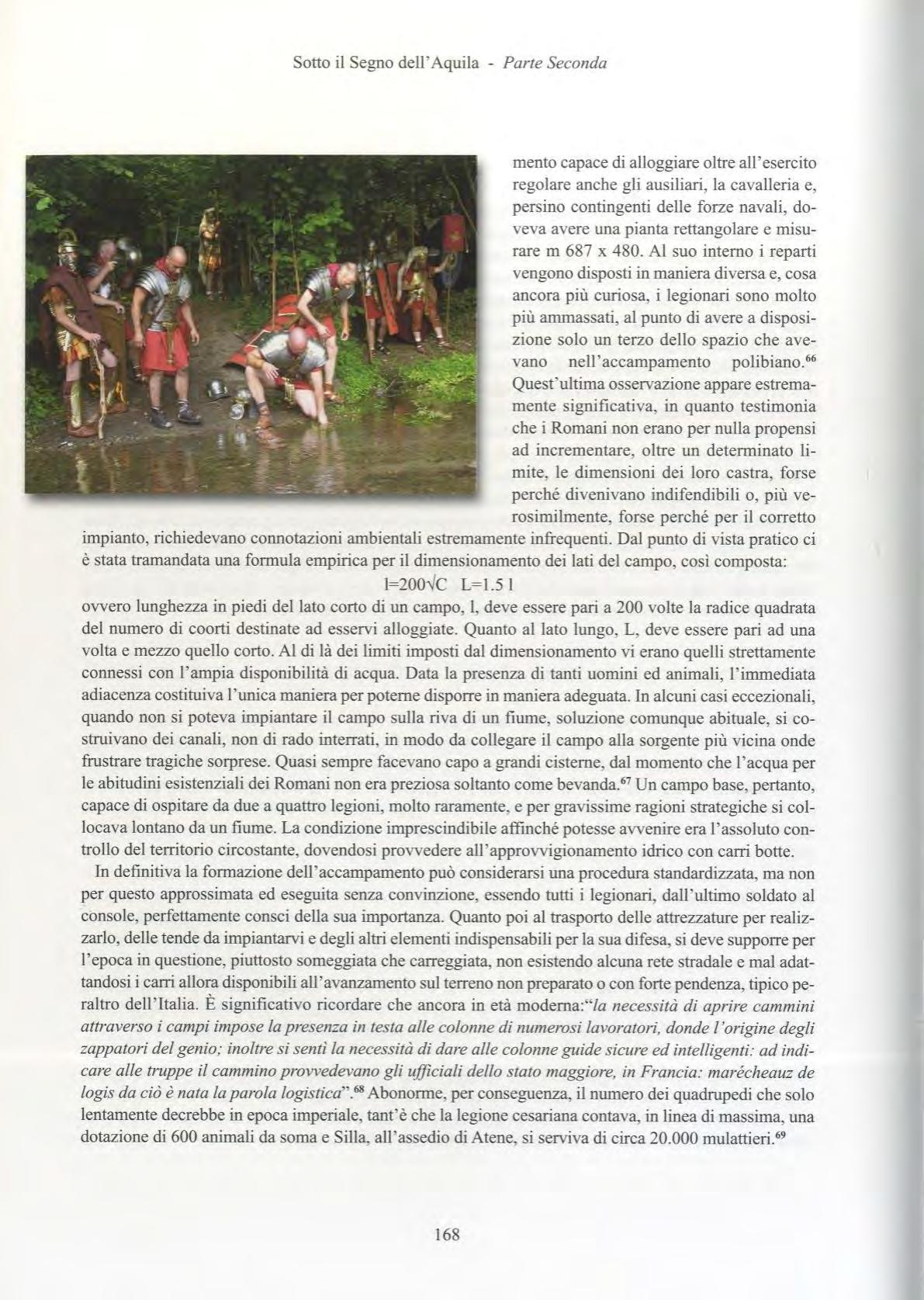
Sotto il Segnodell‘Aquila - Par/eSeconda
..
168
;.—
ESERCITO IN MARCIA
Esauriteleprecisazioni sull’accampamento,cheresta disicurolamaggioreepiù originalerealizzazione militare romana, un aspetto fondamentalenello studio sulle legioni è quello inerente alleloromodalità dimarcia eallerelativevelocità dispostamento.Dipeseromoltospessopropriodaquesti due fattori i successibellici e,soprattutto,ladeterrenzacheriuscironoad imporre.Disgraziatamentemoltoèstatofrainteso al riguardo, confondendo sia il tempo che lo spazio, quasi che la velocità di marcia sulle superbe stradeconsolaripotesse risultarepari aquellamantenuta prima della lorocostruzione! 0ancora immaginandograndiunità muoversiapassorigidamentecadenzato,comesolodapochissimi secolisiusa. Indispensabile perciò effettuare alcune altreprecisazioni per meglio valutare le effettive e straordinarie capacitàdegli esercitiromani in marcia.
Finoall’avventodelleferrovieedelloroutilizzomilitare"’,fralevelocitàdisposmmentodegliesercitidiNa» poleoneequelledellelegionidiCesare,èlogicocrederechebenpocofossemutato,essendoimmutata,perché fisiologicamente immutabileeralaresistenzafisicaallafatica,allafameedallasete,comepure leprestazioni muscolari.Ciòpremesso,standoallefonticlassiche,letrupperomanepartivanodopounacolazionemoltomattutina,verosimilmentesulfardell’alba,chenell’estatesicollocaperilnostroorario intornoallacinque.emarciavanoperquasimemgiornata.Considerandocheladuratadellagicmata,sempreestiva,eradicircasedici ore,lamarciasiprotraevafinoalletredicicircaDaquelmomento,ilrestodellagiomataeraspesopercostruire ilcampo, nonchéper lealtreesigenzemilitariepersonali." [Ichestarebbeasignificarealmenosene—ottoore dimarcia, interrottaforsedabrevi soste:maquantocamminovenivaeffettivamentecompiutoinuntaleintervallo?E,soprattutto,quantocamminopotevaconcertemcompiereun grossoesercito,con al seguitotuttele sueattrezzatureepertinenze?Primadiafii’ontarelospecificovaricordatochequandounacolonna:“ditruppa inmarcia è compostadellevarieanniframmirte.perquantopossa essereben regolata!'andatura,sonotutta viainevitabiliqueicontinuiurtiefermatequelcontinuaperderedistanzeefizrsfirrziperriprenderle, cagionati dallaspecialeceleritàdicuilevarieannisonodotate. Quest‘awicendarridiandature,piùomenorapide, cav gianosoverchiafirticaalletruppe,produceferiteaicavalliedallungainutilmenteladuratadellamarcia”.”
Principale eabusatoespedienm perevitaretali inconvenienti consisteva nelloscaglionarelediverse anni. ovveronel lasciare un discreto spaziofia un gruppoed il successivo,fungenteda ammortizzatore, anche a costodiallungarevistosamentel’interacolonna.Pertantosipuò:“dr're, cheilbuonandamentodiuna marcia dipendedallaandaturatenutadallatesta dicolonna.Sequestainconsideratamenteorafi”rettailpassoorlo rallenta,fasicheorlefrazioniperdono ladistanza edorsiurlano leunecon lealtre.Devequindimantenereun'andaturaregalaremodificandolaasecondadeicari. Corialprincipiodiuna marcia la testa dico— lonna deve camminarpiuttosto lentamente perdartempoallefrazionicheseguonodientrareagiusta distanza in colonna; attraversandounastretta,abitati,pontiangusti. ecc., deveafiettareilporro,pernonprodurre intoppo edevequindi rallentarlo nuovamente aqualchedistanzadallastrettaandenonfar perdereledistanze.Nelle salitebisogna evia tare che la Î2Xta di colonna ral/enti soverchiamente l'andatura, comebisogna evitare chenella dixcesa ['afietti troppo. Senon si cercadivincerelatendenza delsoldatoadi-
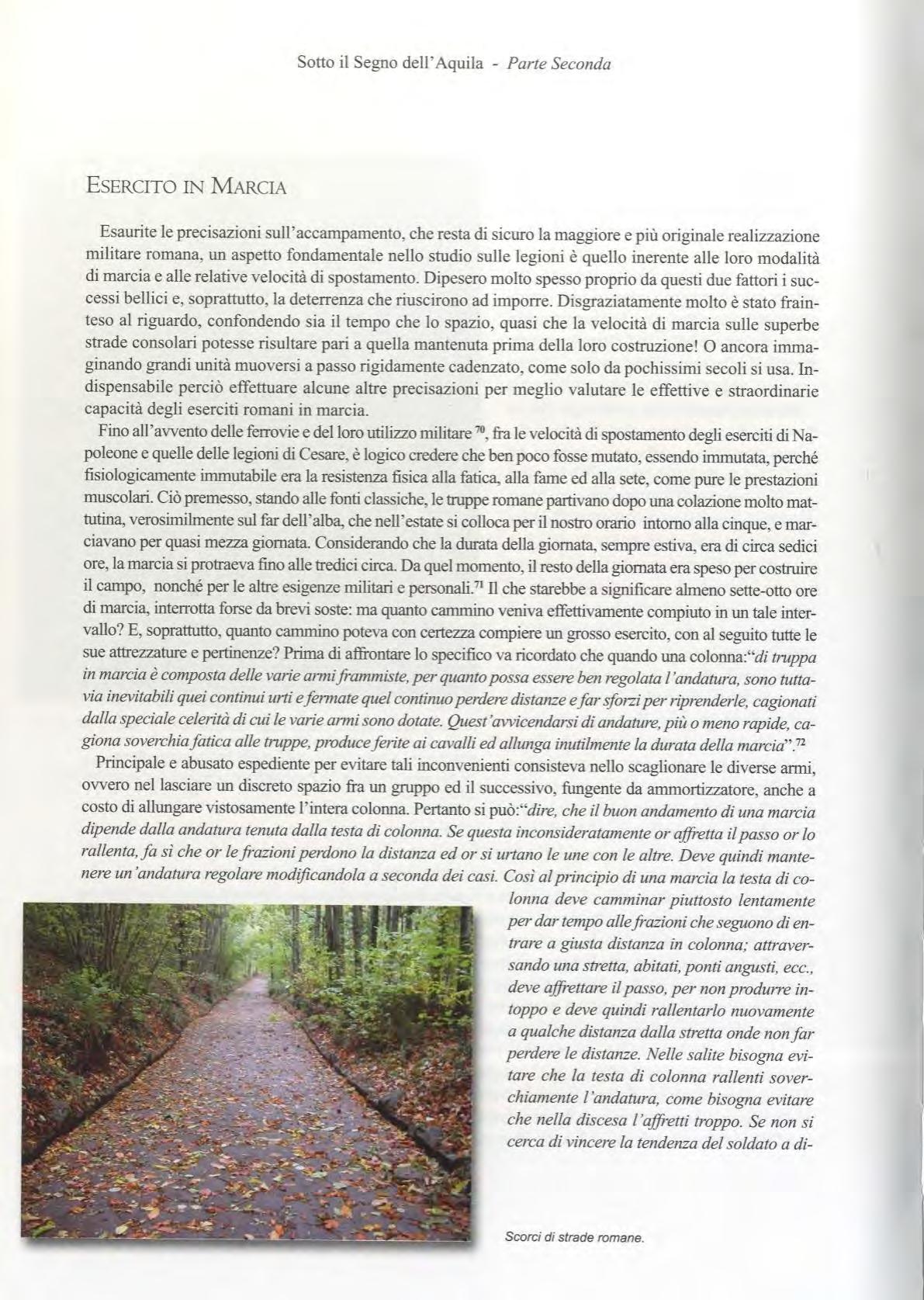
Sottoil Segnodell‘Aquila - ParteSeconda
Scorcidistraderomane,
minuire]’andaturanellesalitepelmaggiorsforzoche è obbligatodifirre. edimoderarneaprecipitazione delpassoagevolatadallediscese, siproducononellecolonnedimancia dannosiaccorciamentiedallunga mentididistanze, chementreriesconodifaticaalletruppesonsemprecausadiinevitabiledisordirre...“.73
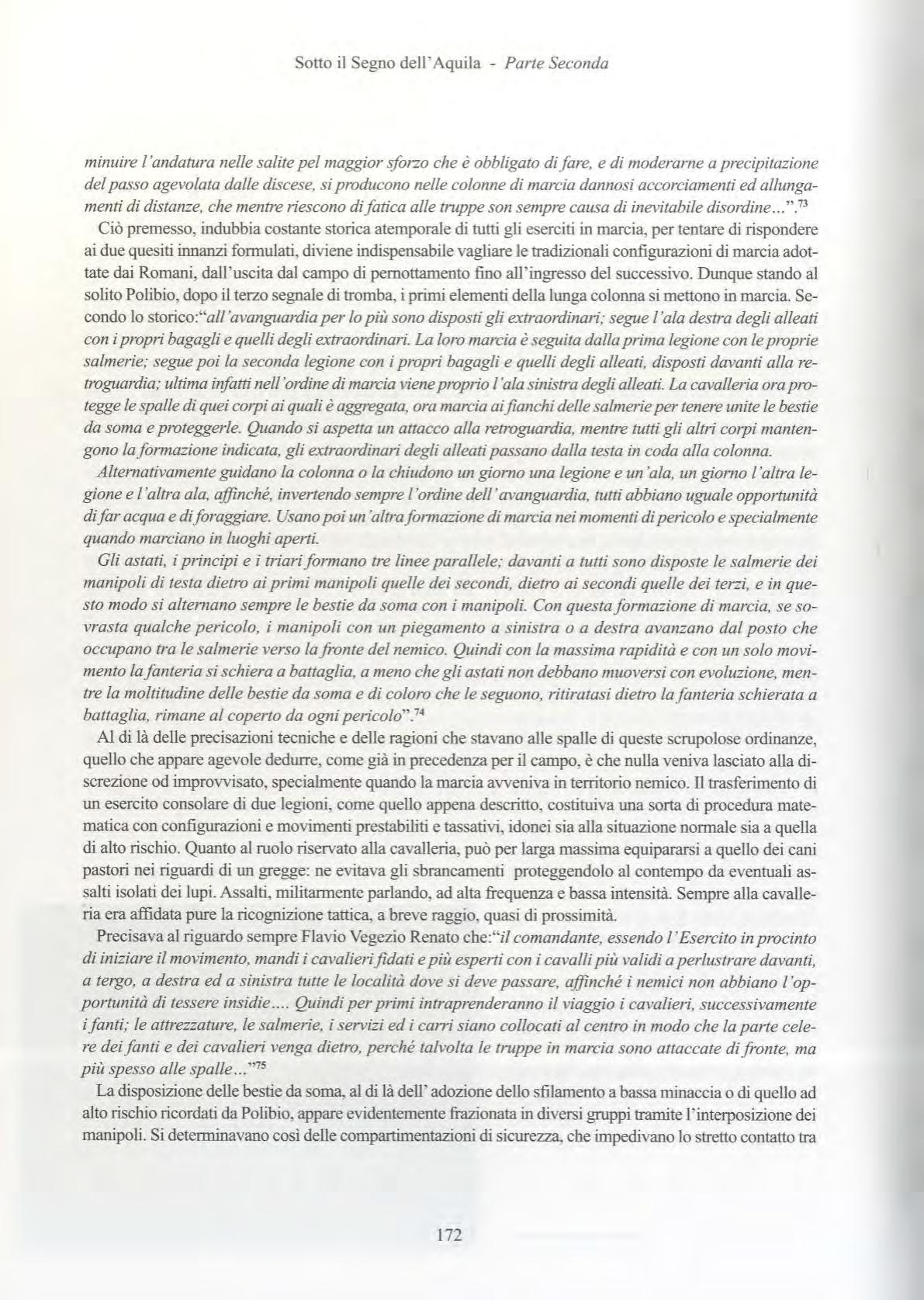
Ciòpremesso, indubbiacostante storicaatemporaledi tutti gli esercitiinmarcia,pertentaredi rispondere aiduequesitiinnanziformulati,divieneindispensabilevagliareletradizionaliconfigurazionidimarciaadottatedai Romani,dall’uscitadalcampodipernottamentofinoall’ingressodel successivo,Dunquestandoal solitoPolibio,dopoilterzosegnaleditromba,iprimielementidellalungacolonnasimettonoinmarcia.Secondolostorico:“all’avanguardiaperlopiùsonodispostiinertraordinarr';seguel’aladestradeglialleati conipropribagagliequellidegliartraordinari.Laloromancia èseguitadallaprima legioneconleproprie salmerìe,‘seguepoi laseconda legione con ipropribagagliequellideglialleati, dispostidavantialla re— troguardia;ultimainfiminell'ordinedimarciavieneproprio]alasinistradeglialleati.lacavaller'woraprotegelespallediqueicorpiaiqualièaggregata,oraman.-iaaifianchidellesalmeriepertenereunitelebestie dasomaeproteggerle. Quandosiaspetta un attaccoallaretroguardia, mentretuttiglialtricorpimantengonoInformazioneindicata,gliextraordinan'deglialleatipassanodallatesta incodaallacolonna.
Alternativamenteguidanolacolonnaolachiudonoungiornouna legioneeun'ala, ungiornol’altra legioneel’altraala,aflìnche',invertendosemprel'ordinedell’avanguardia,tuttiabbianougualeopportunità difizracquaedifi)raggiare Usanopoiun ’altraforrnazionedimarcianeimomentidipericoloespecialmente quandomarcianoin luoghiaperti.
Gliastuti, iprincipieitriariforrnano tre lineeparallele; davantia tuttisonodisposte lesalmeriedei manipoliditesta dietroaiprimimanipoliquelledeisecondi, dietroaisecondiquelledeiterzi, ein que» stomodosialternanosemprelebestiedasomacon imanipoli. Conquestaformazionedimarcia, sesavrasta qualchepericolo, i manipoli con un piegamento a sinistra oa destra avanzanodalposto che occupanotra lesolmerieversolafrontedelnemico. Quindicon lamassima rapidità econ un solomovimentolafanteriasischieraabattaglia, amenochegliast-rtinondebbanomuoversiconevoluzione,men— trelamoltitudinedellebestiedasomaedicolorocheleseguono,riliralasidietrolafiznteriaschierataa battaglia, rimanealcopertodaognipericolo“."
Aldilàdelleprecisazioni tecnicheedelleragionichestavanoallespalledi queste scrupoloseordinanze, quellocheappareagevolededurre,comegiàinprecedenzaperilcampo, è chenullaveniva lasciatoalladiscrezioneodimprovvisato,specialmentequandolamarciaavvenivainten-itorionemico.Iltrasferimentodi un esercitoconsolaredi due legioni,comequelloappenadescritto,costituivauna sortadiprocedura mate— maticaconconfigurazioniemovimentiprestabiliti etassativi, idoneisiaallasituazionenormalesiaaquella di altorischio.Quantoalruoloriservatoallacavalleria,puòperlargamassimaequipararsiaquellodeicani pastorineiriguardidiun gregge:neevitavagli sbmncamenti proteggendoloal contempodaeventuali assaltiisolatideilupi.Assalti, militarmenteparlando, adaltaliequenzaebassaintensità Sempreallacavalleria eraafiidatapure laricognizionetattica, abreveraggio,quasidiprossimità.
PrecisavaalriguardosempreFlavioVegen'oRenatoche:“ilcomandante,essendo 1’Esercitoinprocinto diiniziareilmovimento, mandiicavalierifidatiepiùesperticonicavallipiùvalidiaperlustraredavanti, a tergo, a destra edasinistra tutte lelocalitàdovesidevepassare, affinchéi nemici non abbianol'opportunità ditessereinsidie.... Quindiperprimi intraprenderannoil viaggio icavalieri, successivamente ifanti;leattrezzature, lesalmerie,iserviziedicarrisianocollocatialcentroinmodochelaparteceleredeifantiedeicavalierivenga dietro,parchètalvolta letruppe in marcia sonoattaccatedifionte, ma piùspessoallespalle…?“
Ladisposizionedellebestiedasoma,aldilàdell’adozionedellosfilamentoabassaminacciaodiquelload altorischioricordatidaPolibio,appareevidentementefrazionataindiversigruppitr-arnitel’interposizionedei " Si ’ cosìdelle ' ‘‘di che ,, " lostrettocontattotra
Sottoil
Segnodell‘Aquila - ParteSeconda
172
un blocco ed un altro. evitando il propagarsi del terrore fia gli animali nel caso affatto improbabile di attacco improwiso. La disposizionepotrebbe in qualche modo equipararsi al concetto dei compartimenti stagni dellenavi: serrandoli con massicce porte atenuta, siimpediscechel'accidentaleallagamentodiuno diessi,dilagandoperl‘interaunità neprovochi laperdita!
Quantopoi all‘avvicendamentoquotidiano di ciascunalegioneintesta all'esercito.con» fermasenzadubbiolanecessitàdiconsentire un più omogeneoforaggiamentoedapprov— vigionamenm idrico,matradisceanchelavolontà di equipararela fatica della marcia e, soprattutto. della preparazione del campo. Chi,infatti,avanzavaperprima sulterrenonon preparato,situazionetipicadellamanovra fuoripista,eraco— strettoacompiereunosforzonotevolmentemaggioredichivitransitavadopo.trovandoloormaisgombrodalla vegetazione, dai diversi ostacoli,nonchében battuto. Senzacontareche ilpervenire con diverse ore di anticipo,tantadovevaessereladifierenzatra latestaelacodadelconvoglio.implicavainiziareperprimi i lavori diimpiantodelcampo,Riguardopoi alladispo… tàdiacqualungolamarcia,èimplicitochel’itinerarione tenesse conto,per quantopossibile, non tanto per gli uomini, checon un oculatorazionammto potevano in qualchemodo sopperirvi,ma per i tantissimi animali,pernulla idonei a sopportarelafaticanel caldo senza un’abbondanteefi'equenteidratazione,Ragionechecostringe\m.neicasidi completacarenza.adaccampami perlanotteladdovevenefosseasufiìcienza,indipendentementedalcamminopercorso.0aservirsidauncerto periodoinpoi,dicanicisterna,comecenesonostatitramandatidivariotipodall'iconografiaclassica.Inogni casol’avanzamentonondovevamaiprolungarsi eccessivamenteportandogliuominieglianimaliallostremo delleforze.Una situazionedel generenon soloavrebbecreatoseriproblemiperlarealizzazionedell‘accarnpamento, ma incasodi attacconemicoavrebbecostituitoilprologodiuna irreparabiledisfatta.
ENTITÀ ETIPOLOGIA DELLATAPPE
Latappa,perciò,risultava sistematicamentepiuttosto inferiorechesuperioreallepotenzialitàmediedi marcia dei legionari, ai quali doveva essere sempre lasciata per quanto accennato, in qualsiasi circo. stanza e momento della giornata. abbastanza energia fisica da respingere un eventuale assalto. Questa pressante necessità spiega perché la successionedei campinotturni deveritenersi alquanto rawicinata, al punto cheun uomo senza fardello non avrebbeimpiegatopiù diquattroocinque oreper andaredall’uno all‘altro. immediatamente successivo 0 precedente. E spiegapureperche' ciascuna legione si incaricasse sol— tanto a giorni alterni di costruire il campo, lasciando all‘altra il compitodella eventualedifesa.
Unbassonellevoedunadecorazionediunpianoinargento,ram guranuuncano Ricostruzionevirtualedelcanobotteromana
A basrel/ef and& deco/allan un silverplate depictlngabarre!carl. V/rlual reconstruction ofRoman bar/'e!cart
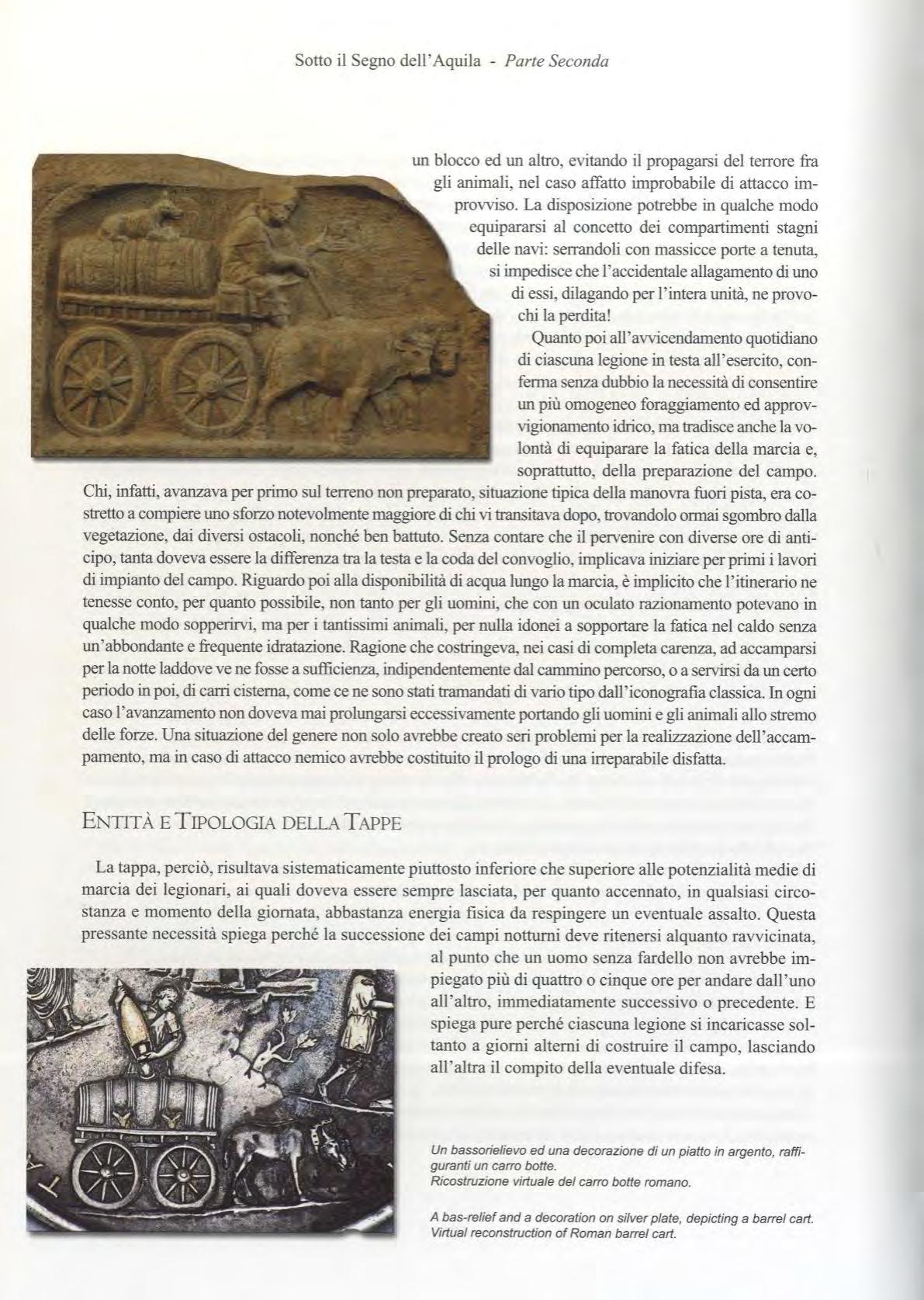
Sottoil Segnodell‘Aquila - Parte Seconda
Spessosièdataperscontata lacapacitàdipercorrere anche30km a]giornoper grosse formazionimi» litari romane, ed è ancheprobabile chetale straordinariorisultato sia stato, in rari casi, realmente conseguito. Ad un più attento esame, però, ci si accorge che quell‘avanzarnento avvenne o in aree pianeggianti desertiche o lungo assi stradali,senzasalmerieal seguitoesenza attrezzaturepesanti d’as» sedio.Delrestonon èun casoche laretestradaleromana fil lamassima infrastruttruamilitaredella storia, tesa appunto ad accelerare il trasferimento delle legioni. Per l’epoca repubblicana, tuttavia, non esisteva ancora nella sua articolata trama, specialmentearidosso dei territori centro europei, e lo spo— stamento,anchedipochemiglia, comportavadifficoltàrilevantiperunacomitivadi mercanti, immense peruna forzaarmataconicarriaggidellesalmerie.Quantograviefrustrantipotesserorisultarelosipuò arguiredaun significativoepisodio.Nel Ilsecoloa.C.Catoneperportare daPompei allasuafattoria,distante una settantina dimiglia, un frantoio per olivepagato 348 sesterzi,ne spese ben 280 per il trasporto! E non si deve affatto credere che fosse il frantoio a costare poco ma, senza alcun dubbio, il trasportoacostareenormementeperlesuddettedifficoltà.Dicarichidigranlungamaggioriunalegione in sposmmentodovevatrascinantedi innumerevoli.
LUNGHEZZA STATICAE DINAMICADI UN ESERCITO
Costituisceunadetestataquantofrequenteecomuneesperienza,ritrovandosifermiconl’autoincolonna davantiaun semaforo,constatareche,alcompariredellaluceverde,perrapidichesianotuttii conducenti aripartire,ilgrupponon sirimetteinmotoinmaniera compatta.Non sicomporta,cioè,comeun trenonel qualetuttelecarrozzeinizianoamuoversicontemporaneamente,percuilalunghezzadelconvoglio,fermo oinmoto, risulta semprelamedesima, restandorigidamente invariabile l’interasse ha ivagoni, Nel caso inquestione,invece,siassisteadun distanziarsidellefile,percuiungruppodiautoveicoliimmobiliforma unacolonnadigranpiùbrevediquandolastessa è inmoto.Ingenerale,allora,sipuòconcluderecheilmo— vimento sir'nulîaneodimolti autoveicolifiniscepercostiparii inprossimità delle sosteperdimdarli subito dopo.Andamentocheha suggeritolapittoresca definizioneditrafficoafisarmonica!
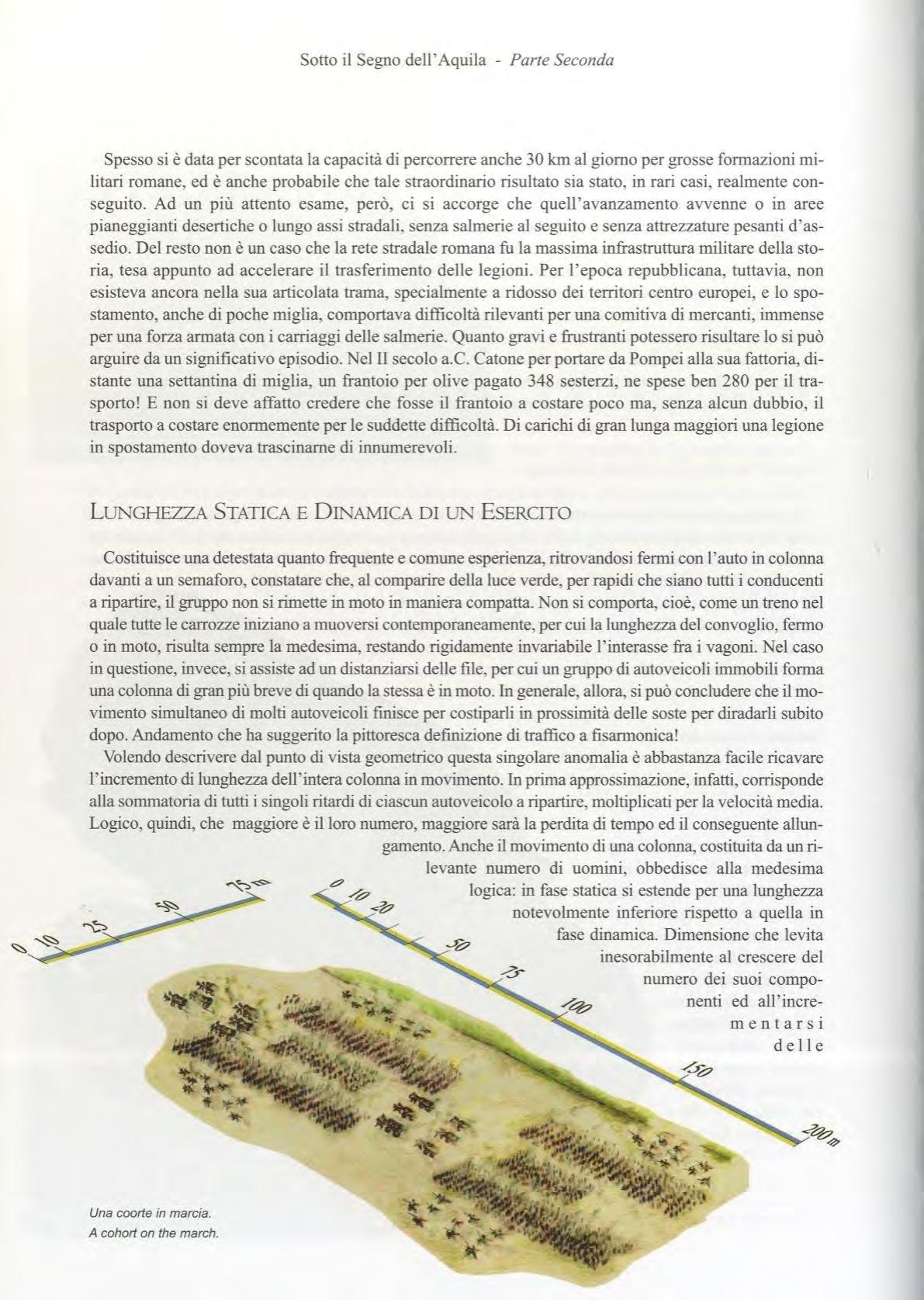
Una coorteinmamìa. A cohorton themarch.
.?
Sottoil Segnodell'Aquila - ParteSeconda
Volendodescriveredalpuntodi vista geometricoquestasingolareanomaliaèabbastanzafacilericavare l’incrementodilunghezzadell’interacolonnainmovimento.Inprimaapprossimazione,infatti,corrisponde allasommatoriaditutti isingoliritardidiciascunautoveicoloaripartire,moltiplicatiperlavelocitàmedia. Logico,quindi,che maggiore è illoronumero,magg'oresaràlaperditaditempoedilconseguenteallungamento.Ancheilmovimentodiuna colonna,costituitadaunri» levante numero di uomini, obbedisce alla medesima logica:infase statica siestendeper una lunghezza notevolmente inferiore rispetto a quella in fase dinamica. Dimensione che levita inesorabilmente al crescere del numero dei suoi componenti ed all’increm en t ar s i del l e Zr @ ’—’b
partenze edegliarresti.Per una rilevantecompagineda una certa t‘requenm inpoi, l’allungamento attinge valori tali da costituire l'immediata premessa del caos, come in precedenza citato. Il generale Palmieri nelle suecelebri Riflessioni critiche sull’artedella guerra, edito nel 1761,tentò di fornire una lucida descrizioneditipomatematicadelvistosofenomeno,Dunque:“selaprima/ila didritta(inlrzzprendendosila marcia Verso la dritta)fa ilprimapussa lunga unpiede, lusecondafilu cheseguito è costretta adaspettare che laprima le lascitantospazioperpoterfine unpassoeguale, la terza è cornetta adaspetlurela prima elaseconda,ecosiconsecutivamentetutte 1’altre;inguisa cheun taltempod’aspetmresiva ma]tiplicandosempreecrescendosinnll’ultima.ondederivanoduegrandissimiinconvenientichetuttoginrno :’orrervana:ilprimo diprolungarsi ilbattaglione, ilsecondochenonpossa tutta muoversinell’istesso tempo, anzichementreunuparte è inpiena mancia]’altrastiafenna:iqualiinconvenientidiventanosemprepiùgrandiquantopiù è numemta latruppa cheintraprendetalmarcia...”6
Tornandoall’esempiodelleautovetturefermedinanzial semaforo,volendolorenderepiùcalzanteaquestadiversarealtà interpretativa,occorrerebbesupporrefraleautomobilifermeun certonumerodi camion, ditrattoriemagaridicarrettitrainatidacavalli.ilmovimentosimultaneodell’interacompagineècondizio— natadalveicolopiù lentoepiù ' ‘ percui la ' ‘ " alcuniminutidopo loscattaredelverdel’ingombrocomplessivosarànonsoloincomparabilmentemaggiorerispettoaquellostatico, maanchesensibilmentemaggioredellacompagineomogeneacostituitadallesoleautomobili!
Pertanto, la disomogeneitàdellevarie componenti di un esercitoinmarcia contribuivapesantemente al suo allungamento ed alla sua lentezza,in misura persino maggiore di quella derivante dal numero dellatruppa. Le " ‘ intere di “ . adapportareingegnosi correttivi logistici eacutimiglioramenti tatticiperridurre quella deleteria connotazione che,il diversificarsi degli armamenti, rendeva invece semprepiù esasperante. L’unica soluzioneescogita fu l’introduzione della marcia cadenzata,ma l’innovazione non può in alcunmodo associarsi allamarcia delle legioni,essendoelaborata soltantonel XVIII secolo.
MARCIA ORDINARIA EMARCIA CADENZATA
Quandosiparladimarcia,ilpensierocorresubitoalbennotoritmocadenzatounò-duè,tipicoappuntodel marciare dei reparti militari indipendenternenuedalla loroentità.Per wri aspetti costituiscenon soltanto la connotazione emblematicadell’esseremilitarema,perlasuaintrinseca incomprensione,lapiù palese madellottusa ' ' dell’ ‘‘ checostringeadunamodalitàmeccanicaeduniformepersinonelcamminareAldilàdellafacileretorica,larealtàebendiversaelarimozionediquelluogo comune, fuorviante u .. imponeun' ‘ basilare’ ' Nel ’ si è fornitauna dettagliata spiegazionedeldimdarsiedeldisaggregarsi diuna colonnain marcia,nonché delle conseguenzechetaledeleteriofenomenoproduceinambitotattico.Gliincessantisforzi,tesidapprimaaridurnelamanifestazioneequindi asopprimerla,r " ‘ all" ' non giàdel ' a passo, cheforsetramite ilmilodeitamburi eperbrevitratti,dovetteattuarsigiàsulfiniredelMedioevo, se non prima addirittura, ma del marciare apasso cadenzato. E fir appunto imponendo due distinti comandi, primaallagambadestrapoi aquellasinistra,inbase adunprecisoritmotemporale,chesielaboròlaconcezionedellamarcia cadenzata.
Siparti infattidalpresuppostoche,seognisoldatoavessemossolastessagambaconternporaneamenteain altrieperun identicoangolo,nonavrebbeavutopiùbisognodiaspettarelaconclusionedelmedesimonio» vimentodaparte delcommilitone,antistante.Intalmodol’interorepartosisarebbetrasformatoinun unico bloccosincronoecompatto,ovvero,pertomarealnostroparagone, lacolonnadiautomobili sisarebbetra-
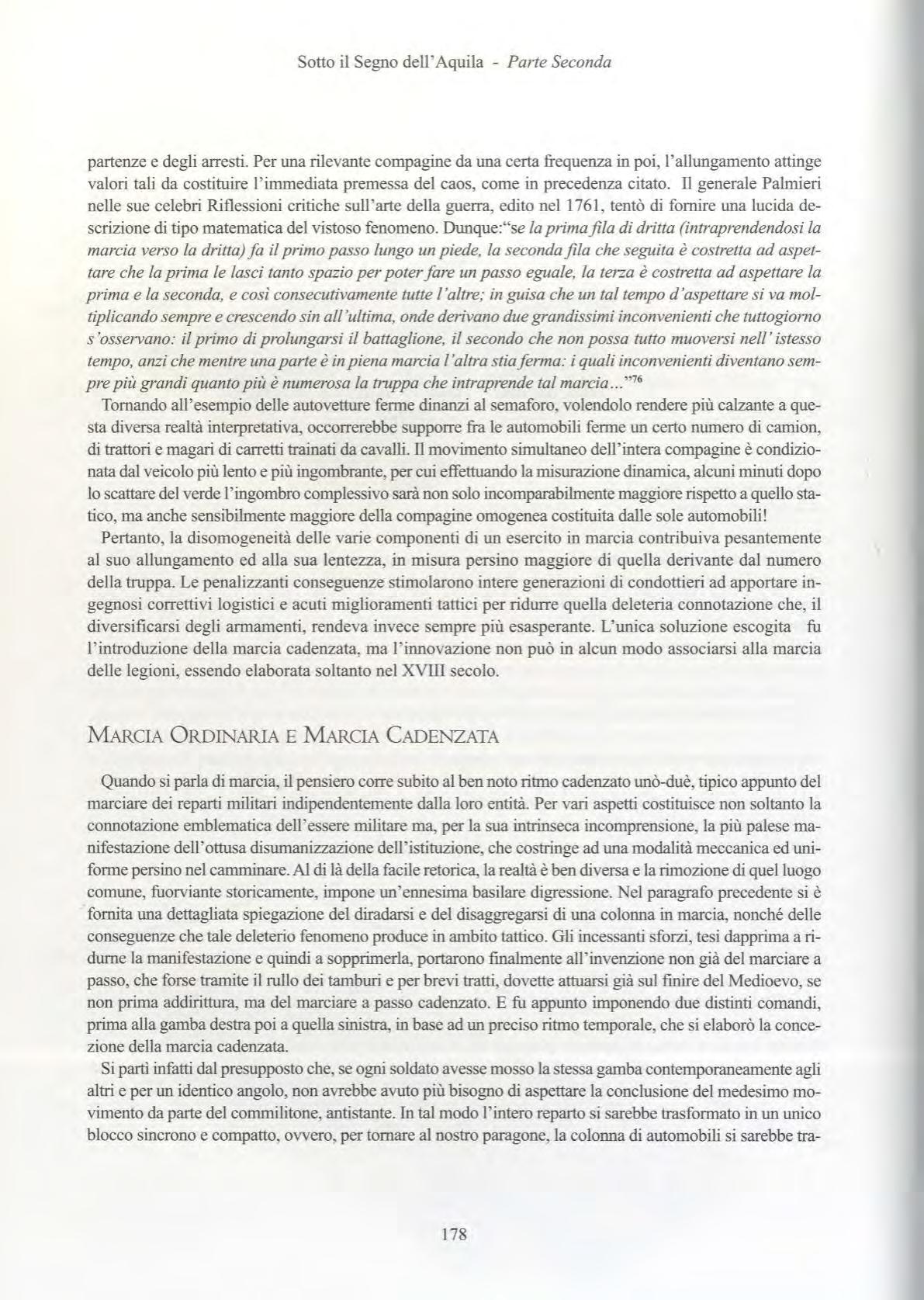
Sottoil Segnodell’Aquila - ParteSeconda
178
sformata in un convoglio ferroviario! In questo casogli ingombri staticicdinamici di una qualsiasi unità militare. grande o piccola che fosse stata.sarebberocoincisi cnon sisarebbepiù do— \utotener contodell'effettofisarmonica. Alcuni modelli egiziani di formazionimilitari in marcia. come pure alquanti bassorilievi ro— mani a soggettomilitare di età classica,traman— dano gruppi di guerrieri allineati, tutti con la stessagambaalzata.vistosamenteintentaquindi acompiereun passo. Il sincronismosottesoalla scena ha indottomolti studiosi a ravvisarvi una esplicita conferma della coeva adozione del passo di marcia cadenzato.Inrealtà è facilerintracciare altri Regi. anchepiù antichi, nei quali sonoraffigurati diversi frombolieri.dirersi arcieri,diversi nuotatori.tutti raffigurati nell‘identica posizione. senza chenessuno per questo abbia mai supposto che scagliassero sassi e dardi simultaneamente, né che i… .. comenella " ginnico-artistica!
La spiegazioneèabbastanza semplice,dal momento che sitratta di una tecnica di rappresentazione convenzionale, laquale,oltreacostituireun‘indubbia semplificazioneperl‘esecutore,fuadottatapersottintendereun gran numero diuomini intenti al medesimo compito nel medesimo lasso temporale. ma non per questoinperfetta sincronia!
Inpratica l’ideadi farmarciarei soldatidiun interoreparto.movendo legambenon solocontemporaneamente ma inperfetta sincroniaed in maniera geometricamenteequivalente,modalità definitatecnicamente dellamarciacadenzata.èabbastanzarecenteessendostataintrodottasulfiniredel "700.Precisava alriguardo ilgeneraleUlloache:“!invenzionedelpassodicadenza.introdottonelXVIII seculo. ègiustamentereputata da'tattici come quella che abbiapiù contribuitoa‘progresxi dell'artedella guerra. Difatti, movendosi il saldata uniformemente, conserva!'ordinenellerighe. acquista un 'andaturapiù comoda, equindiperrone più Spazioin minor tempo;sievitanoleondulazioninella marcia. edun battaglione Zullo intierosimuove comeun corporola… Consen'andosi lacadenza el'uguagliarcadelpasso, sipuo' nellemareerapidegiun— geredifrontealnemicoordinatamenteedurtarloinuna voltasumlm la suaordinanza. E daquesto(LrSl'eme edaquesta riunionedisfi2rzisiottieneilprosperosuccessonegliattua-h ””
Circa il significato di ordinanza, ricordava a sua volta il generale Palmieri chepuò considerarsiz“un compostodirigheedifile;chelariga 6 una seriedi uominisituatidaspallaaspalla, e Ill/”(I una seriedi uomini situatidapetto a schiena;laonde ilsoldato è in ordinanza, quae loraconservalasuariga elasuafila. Tastoche nexman-iseouna, eglie‘fimrdiordinanza, edil Corpo [titlodiventa disordinato...“ [Romani, quindi. allorché marciavano non potevano iispettare l’ordinanza in senso strettoperché non conoscevanolamarcia apasso cadenzato.di là da venire. Penanto ogni loro formazione era
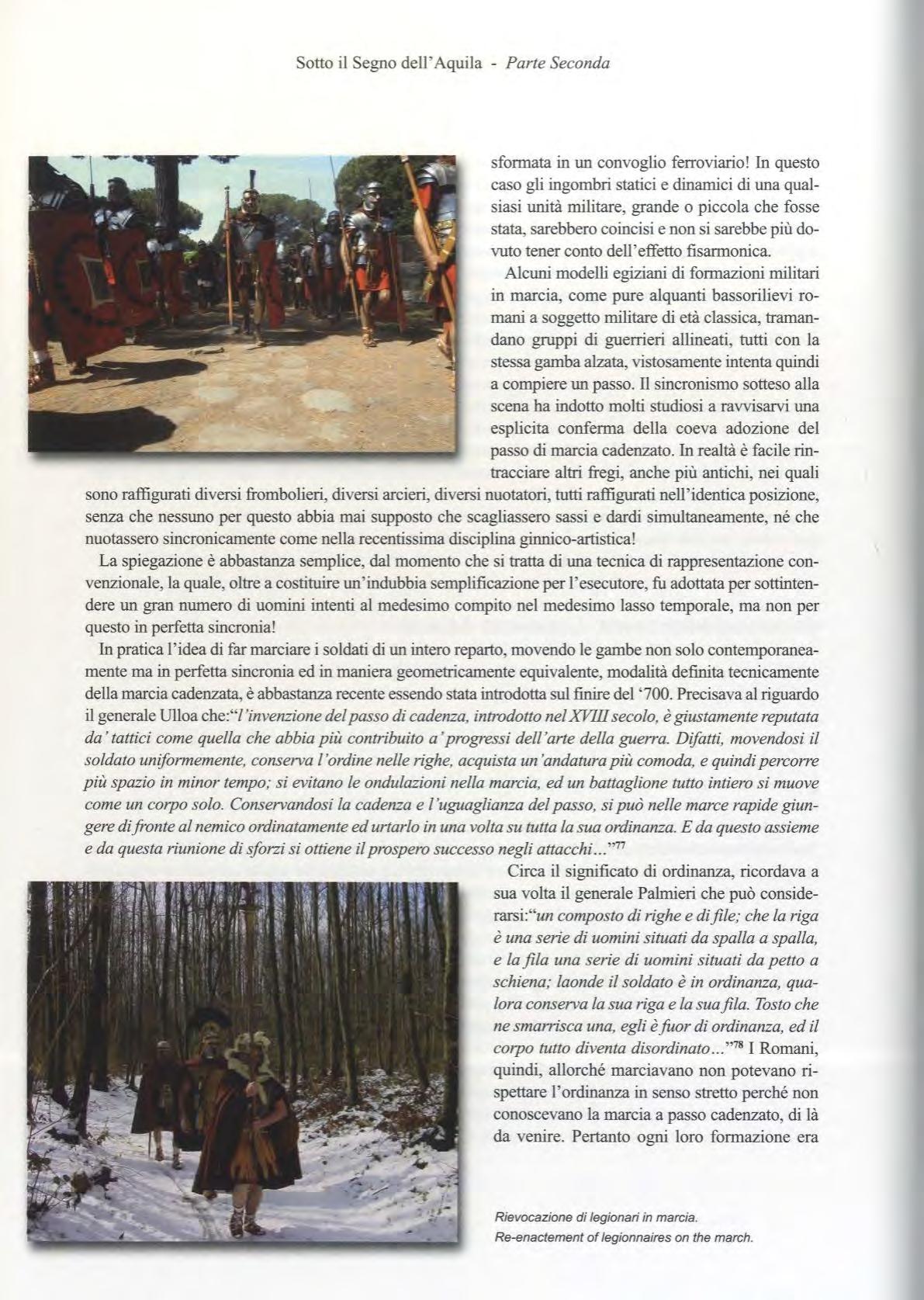
Sotto il Segno dell'Aquila - ParteSeconda
R/evocazlonedllegionari … marcia. Recnactementollegion/wavesonthemarch
soggettaalle ’ ‘ eall‘ giàev" Ancheinquestocasoletantissime rafiigurazioni lasciateci da innumerevoli artisti, tra i quali persino alcuni dei sommi maestri del Rinasci» mento, quandorappresentanoformazioniromaneinmarcia comeblocchi geometricamentedefiniti eregolarilofannoinevitabilmente,supponendolenoninsfilamentomainprocintodifarloovveroinschieramento. figurazioni non in fasedinamica ma statica,di eserciti compattati e frazionati nelle unità minori con in» dubbia ' storicama con ’ ‘L' ’ " geometrical
Larealtà filinevitabilmentemoltodiversaemenospettacolare,percuiquandosideve'ipotizzare sull’in» gombrodiunosfilamentonon si e lontanidalverosupponendoloalmenotrevoltepiùesteso,apar-im?diformazione, delloschieramentocheracchiuda lostessonumerodiuomini fermi.
AVANZAMENTO QUOTIDIANO DELLE LEGION1

Delincatoquantosopra,circalamodalitàdimarciadiunagrandeunitàromanaedellasuaconseguenteva— riabilissimalunghezza,restaancoradawgliareperconcluderel’argomentosullemodalitàdi trasferimento, quantocamminolastessapotessepercorrere inuna giornatadimarcia.O,per lomeno,entroquali estremi senedevecollocare[’estrusione.Ilche,ovviamente,equivaleadaccertarequalepotesse esserelavelocità dimarcia nellediversecondizioni.Ora,sebbeneal riguardole fonti coevenon manchino, va però ribadito cheessetramandanopiùcheildatousualequellospettacolare,laprestazione eccezionale,il primato, quasi secondoun antesignanosensazionalismogiornalistico,per cuitali afiemrazionivanno debitamente inter» pretate. Considerando,inoltre,chelavelocitàapiedipuòritenersiuna sortadiprestazionefisiologica edin quantotalenon soggettaasignificativimutamenti nel corsodei millenni, apparelecitocorrelare leantiche prestazioni conlemoderne, moltomenoarbitrarieed incontrollabili,non fossealtroper laregolarità della deltempo, " ’ dall’ corsodel sole.Eccoalloraalcunidati attendibili relativiallafiequenmdelpasso,dallaqualedipendelavelocitàoggicomeall’epocadeiRomani…L’unicadifferenza,avoleresserepigioli,consistenelriteneretalevalore,dopol’introduzionedelpassocadenzato,un numero esatto nell’unità di tempo, mentre inprecedenza fu soltantouna media, essendoperaltro difficile stabilirequalefosseconprecisione laduratadell’ora.Supercorsi giornaliericomunqueloscartononèstra— volgente,consentendoperciòlasuddettainterpolazione.
DunquestandoancoraunavoltaalgeneraleUlloa:“sidistinguonocinquespeciedipasso:quellodiscuolo, ci!'èdellalunghazadi2piedi.esenepercorrono 76alminuto[pariacirca 3 Ilm/h];quell’ordinorio,ch'è dellastessalunghezzadelpassodiscuola,esenefiznno 100alminuto[pari::cin.-o 4 lan/h], ilqualposso e'ilpiù comodo,perche' è quellonaturaledell’uomo,alquantopenipiù ollungatoepiù veloce; ilpassodi carica, di'èpiù velocedell’ordinan'o,esenefanno130alminuto[pariocireo5.1lim/h]; ilpassoginnastica, ch’èdi2piedie2pollici, esieseguireea diversigradidivelocità, esenepossonofivesino a I 75al minuto[pariacirca 7lan/h];finalmenteilpassodicorsa, ch'èlostessopassoginnastica alqualeperòsi dàlamassima velocità [verosimilmenteeitea 8 [cm/h]…
Lemiliziepedestrt'simuovonoalpassodiscuolaneglieseret'zit'elementaridelsoldatoenella scuola di plotoneedidivisione;alpflssoordinarianellemerce, nelleevoluzionidibattaglioneedilinea. neglieserv ciziielementoridelsoldatoenellascuoladiplotoneedidivisione;ulpassodicorteoedalginnasticanelle evoluzioniceleridilinea. Sarebbeperò utilecheilsoldatosieducosseoquestopasso in mododapoterlo sostenerelungamente. efarneuso in tutteleevoluzioniemovimentisulcampodibattaglia "(79),Pertanto, già:“eonquestidatisipotrebbecalcolareesattamenteiltempoincuisipen-omedalfantoccinouna datadistanza:avvenendocheInnatura de’diversiterreniefiequentiinterruzionineimovimentimodificano i risultamentidelcalcolo. L ’esperienzaperòcisomministraiseguentidati.
Sottoil Segnodell’Aquila ParteSeconda
182
Uno buonofonteria bene esercitatapuo'percorreresulcampodibattaglia unospaziodi300metri:marciandonell’ordineserrato, in 4 minuti;correndoin 2 '5”;marciandoinordineaperto, in 3 ‘40 ecorrendo in 2 ’2 Sopraun terreno mollein 4 'alpassoordinario;correndo, in 2 '5” colloprima ordinanza.ecollo secondoin 3 ’40”alpassoordinario, edi Z’4 "olpassodicorso.
Allorchéilterreno è inegualeepresenta unpianoinclinato, non sipuò ben valutarela velocità delmovimento, dipendendoessodallediverseinclinazionidelterreno, cherallentanooacceleranolomosso.
Sopraun terrenofermoedunito lafanteriapercorre 2 miglia in un’ora, e 4 miglia in 130’,standoordinata edunita; inordineapertov’irnpiego 55’perpercorrere 2 miglia e 120'per 4 miglia.Sopraun terreno molleeineguole,nelprimocasoiltempo è di 60'e 130’, enelsecondodi55'e120'...””
Ovviamentelevelocitàriportatedalgenerale,anchequandosonoriferiteall’avanzamentofuoripista,suppongonounterrenocomunqueidoneo,nonsolopiùomenoduro,macertamentenoncopertodavegetazione oparticolarmenterottoedirregolare,impervioetortuoso.Nonacasoproprioperevitarelimitazionidelgenere,comericordato, i Romanicostruironoimastraordinariarete stradale,ma insuaassenzailmovimento supisteapprossirnativamentetracciatenoneral’idealeperl’addestramentodelsoldatoatirarciare,costretto pergiuntaz“aportarlesuearmi,lesuerobe, etalora ilpaneperalcunigiorni;dunqueeglidev’esseresercitato a camminareportondoquestopeso. Lamancanza ditaleserciziofit chenellemarcesirenda inutile lamaggiorpartede‘saldutt'.Alcunirestanopervia, edaltrispossatiinguisache,seconvieneoperare, non hannoforzanéspirito.1Rornonisiesercitavano aportareilpesodi60libbre[cinco 18kg]camminandoal passomilitare. I soldatidiMarioacagiondelgravecaricosichiamavanomulimariani. L ’usoeI ’esereizio facedcheessiconto]irnpocciocamminasseropiù, econminorfot-icode'nost'rt'chenesonoliberi…”“ Ilche,però,rappresentapiuttostoun’ennesimaconfermadellaretoricachecircondavalelegioni,cheuna dimostratacapacità.Arendere lerievocazioni storicheancoramenoverosimili contribuisce lo stessogeneralechecontinuandonel suoragionamentoprecisava:“sesivuolenlpussoaccelerareilmoto, oaccrescere lospazio, addioordinanza, tutto è confitsr'one. Qualchevoltasifizilpassopiù lungoopiù sollecito, maper pochissimospazio. Questonon basta:, operdirmeglio, questonon servea nienteper il bisogno, Se una truppa deefizr 10o20miglia,perluoghidovepuòincontrareilnemico, eperconseguenzadovedeeconservar]'ordinanzae[«formadicombattere,facendoilpassoincuièstatoesercitota, edin cuisolosipuò sperarecheconservi]'ordinanza,habisognodiunmeseditempo.Masedeefor10.o20miglia, intreocin» queore,fizmestierichesiastatocosiesercitata,echeubbiaeseguitopiù volte,percompromettersichepossa farloquandobisogno. ] Romanisiesercitavanotrevolteolmesearmati, edinordinanza, ::camminarventi migliacolpassomilitare, valquantodire,altempodicinqueoreestive;ecitiperterrenotalorabuono9taloracattivo,occiocche'ol!’uoponiuna cosolorgiungessenuova...”
Aldi làdellesolitemirabolantipotenzialitàdei Romani, desuntecome accennatodallefonti senza alcun vagliocriticoesenaalcunariserva logica,èplausibile stimareperunagrandeunità inmovimentosudiun terrenopianeggiante oappena inclinatoe,soprattutto, senza alcuna interruzione una velocità media massimanonsuperioreai3leur/hnellamiglioredelleipotesi.Tenendo,però,contocheanchelaminimapendenza provocava suicarriaggi dellesalmerie,suitnin.i dellemacchine ossidionali edeipesanti nasporti delle attrezzature,deirallentamentiinproporzionedigranlungasuperioriaquelli degliuominiedeglianimali,tale valorenon dovevaoltrepassareilpaiodikin/lresemprenellamiglioredelleipotesi. Ivalori,tramandatida alcunistorici,notevolmentesuperiori,vannoritenutieccezionaliforseperchéconseguitiincondizioniasso— lutamenteeccezionali.Per lopiù, infatti,siriferiscono areparti senzacarriaggi, inmovimento sustradein ottimecondizioni,quindiconirrilevantipendenze,senzaguadidisortadacompiere,consoldatirelativamente aflardellatienella buona stagione.Sispiegacosìche:“n'guordoalledistanzecheleunitàromanepotevano percorrere, ÈRenato Vegezio... [tramondi] 5000passi in 5 ore con andatura normale, 24 miglia (34lun circa)nellostessotempo, conunpassounpo’piùveloce,poilacorsa. lacuidistonzonon eravalutabile.Si [84
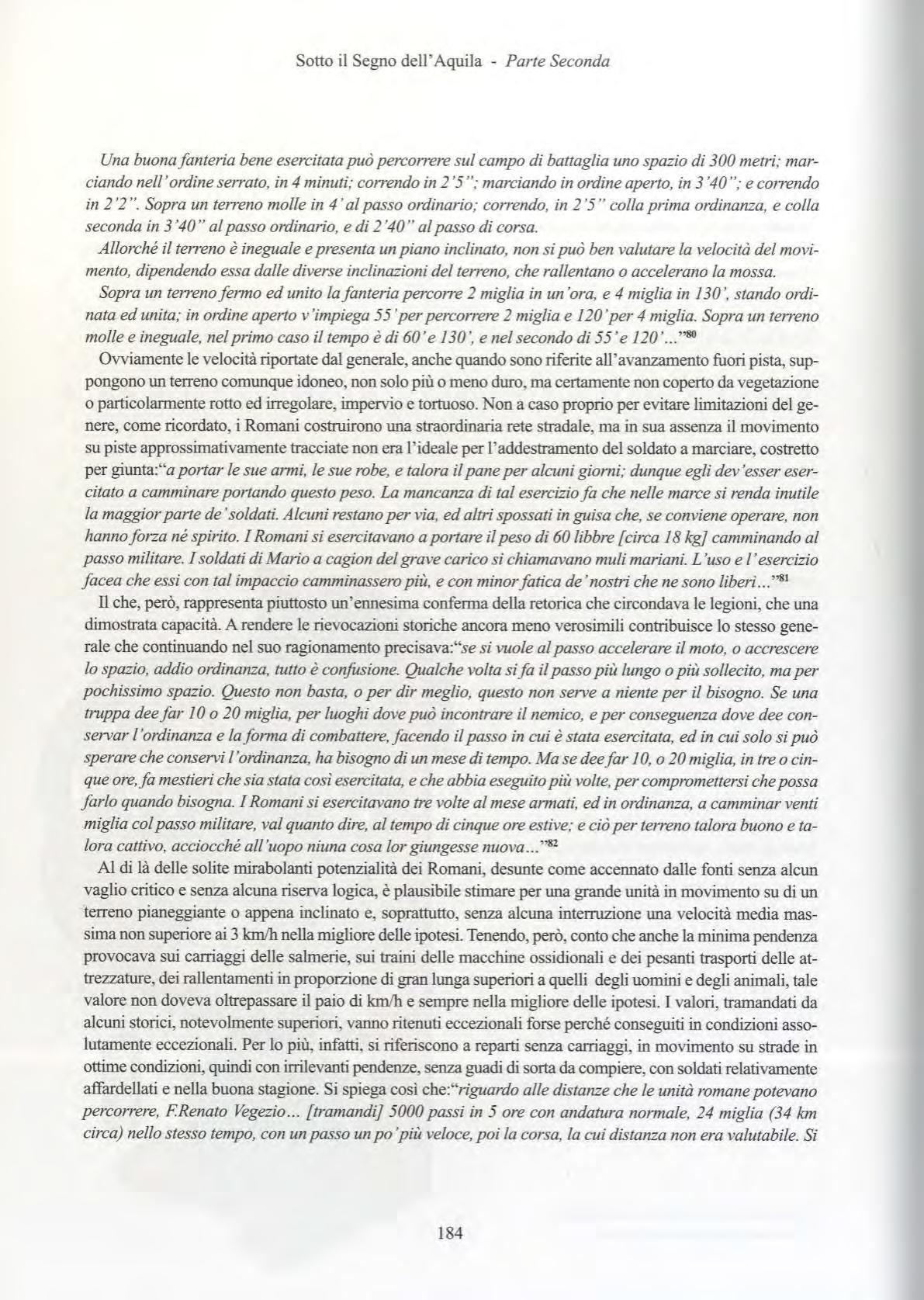
Sotto il Segnodell‘Aquila - PorteSecondo
tratta, comesipuònotare, divalorimoltoaltiovesiconsidericheil,/ante, armatoedequipaggiato,poteva tenereuna media di 7km l’ora…”m
Sesivolesseapplicareallaletteralasuddettaaffermazionenederiverebbe,perun esercitolegionario.una capacitàapercorrere una media giornalierapoco inferiore allacinquantinadi chilometri,entitàmanifestamente assurda.Inrealtà tenendo contoche l‘oraromana, in estate,duravacirca 15minuti più dellanostra le cinque di Flavio Vegezio divengonoperciò circa sei ed un quarto, incremento che abbassa la velocità media acirca5.5km/h, valorenon lontanodaquellovigenteper la marcia ordinaria. Per laverità,tuttavia, Vegezioprecisava,nella suamanieraprosaasciuttache:“secondolacadenzamilitaresidevonocontarecinquemilapassi in solecinqueore, mentreapassopiù velocenellostessotemposidevonopercorrereventiquattromiglia (35lon).Accelerandoancora,siotterràlacorsa,perlaqualenonsipuri definireladistanza copribilenelleoreindicate..."“Nei termini citati i dati sembranoriferirsiadun esercizioginnicotanto più chenon vi si fa menzione del peso dell‘equipaggiamentoedell’armamento. Pertanto i famosi 7 km/h, di fatto5,vannoriguardaticomerisultatisportiviincondizioniofiimali,unpo’comelevelocitàdipuntaattinto nellegareoquellemassimeindicatesultachimetrodellanostraautovettura,Infine,dandoper scontatoche l’interagrandeunità simuovesseomogeneamente,ifamosi 5 km/lrsarebberostatilavelocità ditutuelesue componenti, someggiateocarreggiate che fossero.Ipotesi estremamente improbabile dal momento che i carriromani,persino sustradapianeggiante, mai sonostatiingradodiprocedereadunavelocitàmedia eccedentei4lon/h,Aconfermarloalcunesempliciosservazioni:se,perassurdolavelocità deicaniaggifosse stataanalogaaquella dellefanterie,perché sarebberostatichiamatiimpedimenta?La loroproverbiale lentezza,invece,riuscivaesasperanteproprioperchéimpedivadimarciareallavelocitàconsentitadallegambe! BenpiùconcretiedattendibiliivalorifornitidalClausewitz.ilquale,aldilàdellacompetenzateorica,vantavaancheunaconsiderevoleesperienzadicomandodigrandiunità.Tenendocontocheilmiglioprussiano, propriamentedefinitodelReno,eraparialon7.5,asuogiudizio:“cirmlalunghazad”unamarciaeiltempo relativo, bisogna naturalmentebasarsisull'esper‘ienzagenerale. Perinaso-iesercitimoderni, da tempo è comprovatoche, una marcia ditremiglia [Tan22.5] e illavoronormalediunagiornata, cheper colonne moltolunghedevediminuirsifirrsefinoaduemiglia[lun 15],perpoterfruiredelleorediriposonecessarie atutti, inparticolareaifiaccati.
Peruna divisionedi 8000 uomini, unamarciaditalelunghezzainterrenopianoeconstradeabbastanza buonerichiede 8 10ore:inmontagna, da 10a 12.Sepiùdivisionisonoincolonnate[’unadietrol’altro, occorreunpaiod'oredipiù,tenendocontoanchedellintervallofialeoredipartenzadelledivisioniretrostanti. E ’percio‘evidentechelagiornata ègiàriempita abbastanzadauna marcia ditalnatura, chelostrapazzo delsoldatoperilflittodirimanereper 10 12orecolpesodell’-afiardellamentononpuòesserepostoaraffiontoconquellodichicompiaunapasseggiataditremiglia,perlaquale,sustradeabbastanzabuone, bastanoall’uomoisolatocinqueore…. Unamarciadi5miglia[Ian 37.5] richiedegiàun altdiqualcheora;e unadivisionedi5000 uomininonpotrà compierloarcheconstradebuone, inmenodi16ore.Selamarcia è di 6miglia[km45]conpiù divisioniincolonnate,sidebbonocalcolarealmeno20ore”“
IvaloriprecisatidalPrussiano “ unr- quantoin ’ ’ ‘ ’ ’ che i Romani marciavarro perun massimo di 6ore,ladistanmcheriuscivano acoprire in talicontestinonpo—
tevaeccederei7-8hne,neicasipiùimpegnativi,anchemeno,Ilperchénondeveattribuirsiesclusivamente al tracciato oaicarriaggi,ma allafrequenzaconlaqualesipresentavano i corsid’acquanell’avanzamento fiiori strada,Un qualsiasi infimo fossodipochi metri di larghezza imponeva ore di spossarrti fatiche indispensabiliperilsuosuperamento.Senzacontarechebastavaunpioggiadi mediaintensitàperrendereilterrenotantocedevoledafarvisprofondarelerelativamentestretteruotecerchiate,lacuiliberazionerichiedeva irnprobisforzielungotempo…Ilcheinfluivanonsolodirettamentesullapercorrenzamedia,ma,forseancor di più indirettamente,costringendoapausediriposo,
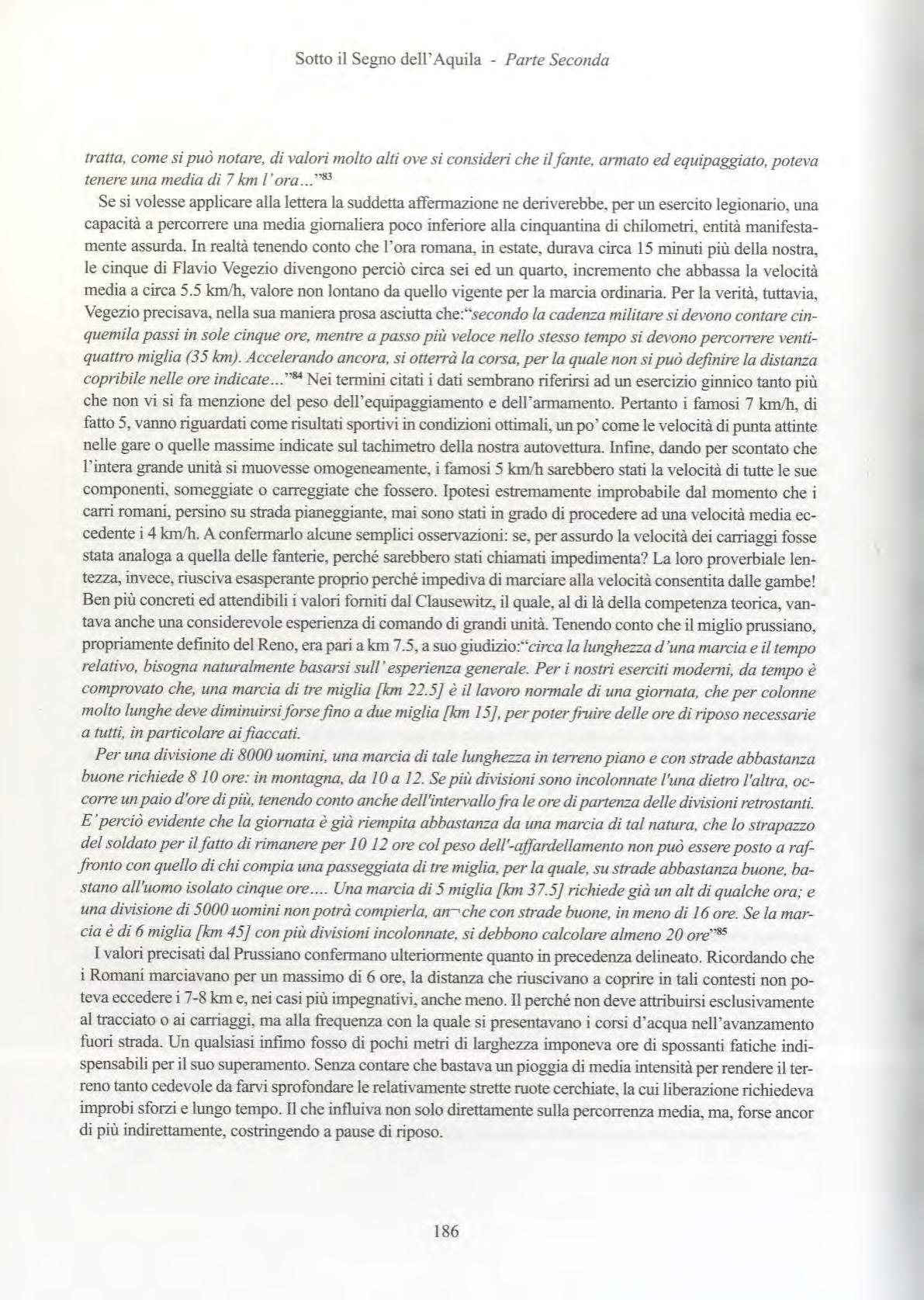
Sono il Segnodell'Aquila - PaneSeconda
186
Note
1 - Da L. QUILICI,Rama primitiva e le origini della civiltà laziale, Roma 1979,p.29.
2 - Da A. BERNARDI, M.A. LEVI, Le origini di Rama, in hz Storia, Milano 2006, vol.Ill, p. 658.
3 — Cfr. F. RUSSO, F. RUSSO, Indagine sulle Forche Caadine, immutabilità deiprincipi dell ’artemilitare, Roma 2006, pp. 145e sgg.
4 — Cfr. T.MOMMSEN, Storia di Roma antica, lib. II, Dalle arigini alla cacciata dei re di Roma, ristampa Bologna 1979,VOLI], p. 546.
5 - Cfr. T.MOMMSEN, Storia di Roma...,cit.,Vol. II, p. 546.
6- Cfr.G.TAGLIAMONTE,[Sanniti Caudinilrpini,Penn-i, Camicini,Frentani, Milano 1997,p. 13-21.
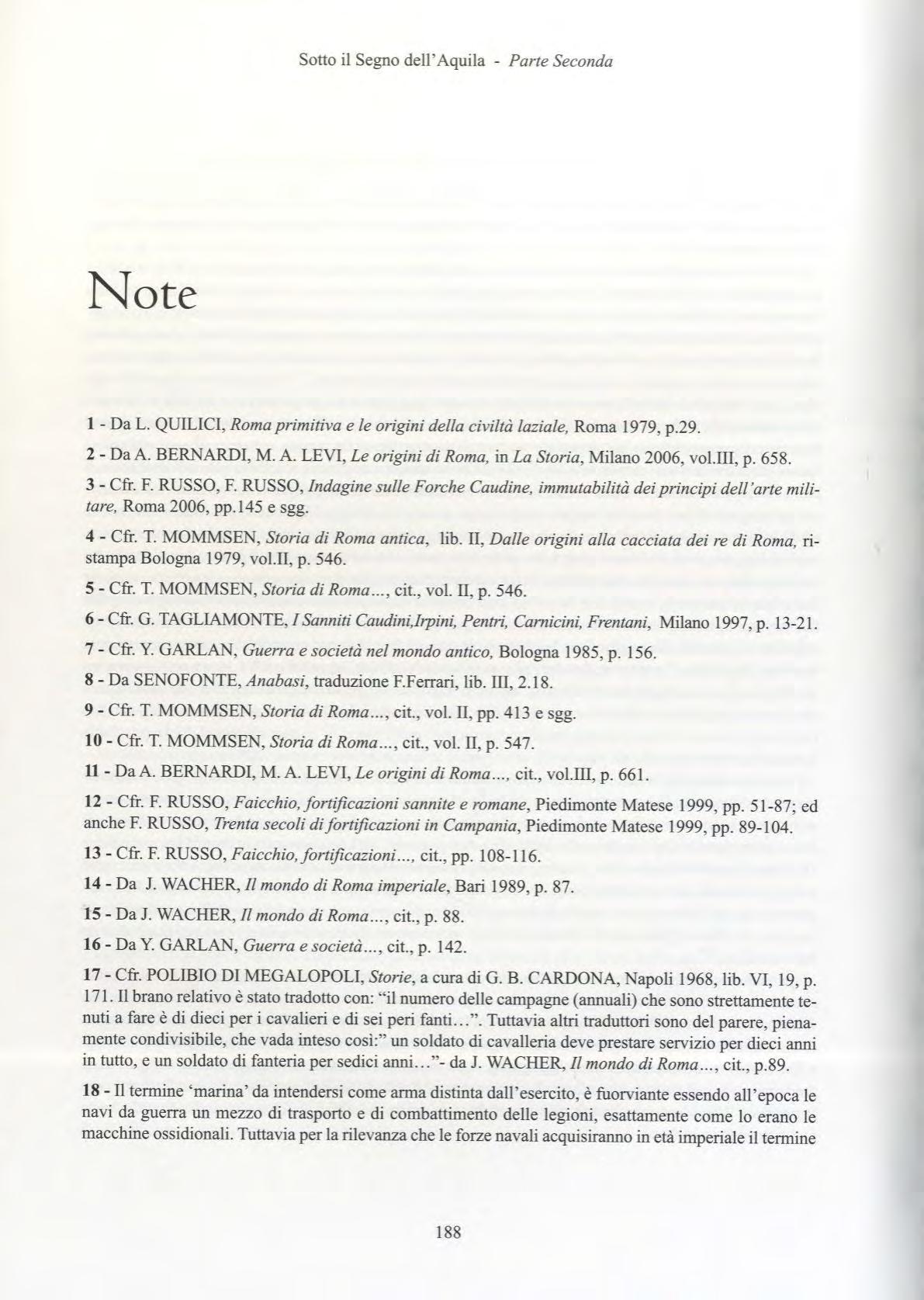
7 Cfi’. Y.GARLAN, Guerra e società nel mondo antico, Bologna 1985,p. 156.
8 - Da SENOFONTE,Anubasi, traduzione F.Fenari, lib. III,2.18.
9 - Cfr. T.MOMMSEN, Storia di Roma..., cit., vol. 11,pp. 413 e sgg.
10 - Cfr. T.MOMMSEN, Storia di Roma...,cit.,vol. II, p. 547.
Il - Da A. BERNARDI, M. A. LEVI, Le origini di Roma.... cit.,vol.IIl, p. 661.
12 - Cfr.F. RUSSO, Faicchio,fortificazioni munite e romane, Piedimonte Matese 1999,pp. 51-87; ed anche F. RUSSO, Trentasecoli difortificaziani in Campania,Piedimonte Matese 1999,pp. 89-104.
13 - Cfr.F.RUSSO, Faicchio.fizrtificaziani… cit.,pp. 108—116.
14— Da ]. WACI-lER, Il mondo di Roma imperiale, Bari 1989,p. 87.
15- Da J. WACHER, [] mondo di Roma...,cit.,p. 88.
16- Da Y. GARLAN, Guerrae sacielà…, cit.,p. 142.
17- Cfr.POLIBIO DI MEGALOPOLI, Storie, 8 cum di G.B. CARDONA,Napoli 1968,lib. VI, 19,p.
171.Il brano relativa e stato tradotto con: “ilnumero delle campagne (annuali)che sono strettamente tenuti a fare è di dieci per i cavalieri e di sei peri fanti… .“. Tuttaviaaltri traduttori sono del parere, pienamente condivisibile, che vada inteso così:” un soldato di cavalleria deve prestare servizio per dieci anni in tutto, e un soldato di fanteria per sedici anni..."- da ]. WACI-IER, Il mondo di Roma..., cit., p.89.
18- Il termine ‘marina’da intendersi come amia distinta dall‘esercito, èfuorviante essendo all‘epoca le navi da gierra un mezzo di r e di ‘ ' delle legioni, come lo erano le macchine ossidionali.Tuttaviaper la rilevanza chele foae navali acquisiranno inetà imperiale il termine
Sotto il Segno dell’Aquila - Parte Seconda
188
Sotto il Segno dell’Aquila - Parte Seconda
appare se non giustificato almeno giustificabile. Cfr. F. RUSSO, F. RUSSO, 79d.C. Rolla su Pompei. Indagine sulla scomparsa di unAmmiraglio, Napoli 2006, pp. 126-212.
19 -Da POLIBIO DI MEGALOPOLI,Stafie...,cit., lib.Vl, 20—26,pp. 170-176.
20 — Da C.BLAI.IL Enciclopedia delle anni, Verona 1979,p. 359, alla vocepilum.
21 — Da Y.GARLAN, Guerra e società..., cit.,p. 152.
22 - Cfr. F. RUSSO,Ingegno epaura, Roma 2006,pp.97-146.
23 -Cfr. C.G.CESARE,De bellogallico, lib.V,48.
24 - Da W.REl'D, La scienza delle anni, Milano 1979,p. 16.
25 -Da A. ANGELINI, L 'artemilitare di Flavio Renato Vegaio, Roma 1984,lib.ll, 2,pp. 44-45.
26 - Cfr.J. WACI-IER,Ilmondo di Roma..., cit.,pp. 113-120.
27-Ilpromontorio di Calos,corrisponde attualmente al CapoBianco nei pressi di Biserta, & nord di Tunisi.
28 - Il testo del trattato tramandato da Polibio, è tratto da D. CARRO, Classica.Storia della marina di Roma.“ doll ’ ' ' ' ‘ seconda “' ‘ alla Rivista Marittima n° 12, Roma 2000, vol. I, p. 18.
29 - Da D. CARRO, Classica...,cit., vol. I, p. 22.
30 - Da Y.GARLAN, Guerra e società..., cit.,p. 201.
31 - Da POLIBIO DI MEGALOPOLI, Storie...,cit.,lib.l, 20, vol. I, p.123.
32 — Cfi‘.DIODORO SICULO,XIV, 41, 3—42, 2.
33 - Da POLIBIO DI MEGALOPOLI, Storie...,cit., lib.l, 20, volo. 1, p.123.
34 - Da POLIBIO DI MEGALOPOLI, Storie...,cit., “13.1,20, vol. I, p.124.
35 Cfr. F. RUSSO, F. RUSSO, 79d.C. Rotta su Pompei..., cit., pp. 134—142.
36 — Da V.FOLEY, W.SOEDEL,Antiche navi daguerra a remi, inLe Scienze n° ......, pp. 95- 106.Per approfondimenti cfr. E. CECCHINI, Tecnologia ed arte militare, Roma 1997,pp. 48- 50.
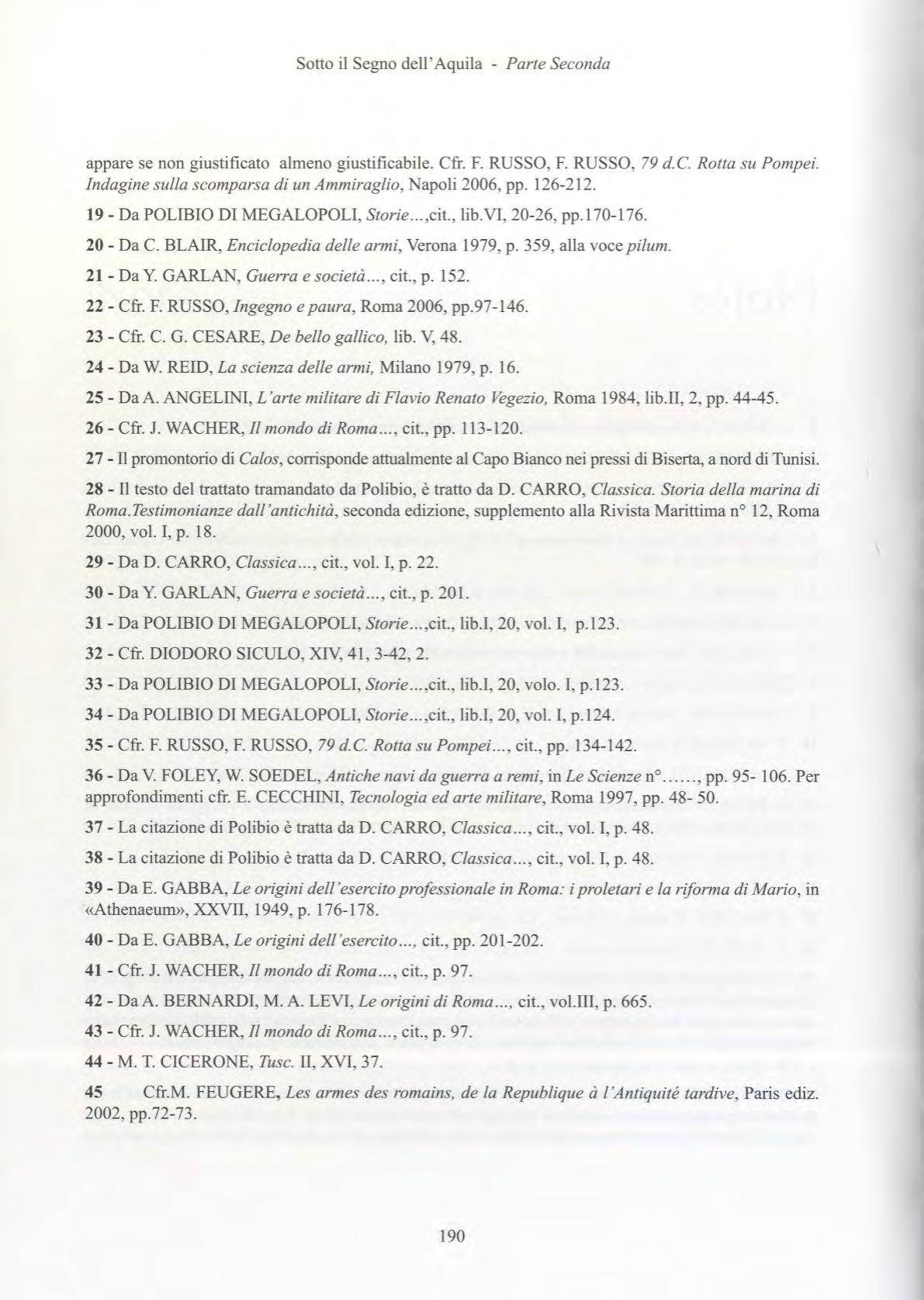
37- La citazione di Polibio è tratta da D. CARRO, Classica.…cit., vol.I, p. 48.
38 - La citazione di Polibio è tmtta da D. CARRO, Classica.…cit., vol.I, p. 48.
39 — Da E. GABBA,Le origini dell ‘esercitoprofessionale in Roma: iproletari e la riforma di Maria, in «Athenaeum», XXVII, 1949,p. 176—178.
40 - Da E. GABBA,Le origini dell'esercito..., cit.,pp. 201-202.
41 -Cfr. I. WACI-IER,Il mondo di Roma..., cit.,p. 97.
42 -Da A. BERNARDI, M.A. LEVI,Le origini di Roma..., cit.,vol.lII,p. 665.
43 - Cfr. J. WACI-IER, Il mondo di Roma..., cit.,p. 97.
44 - M. T.CICERONE, Tusc. II, XVI, 37.
45 Cft.M. FEUGERE, Les armes des remains, de la Republìqae a' l'Antiquité tardive, Paris ediz. 2002,pp.72-73.
190
46 - Cfr.F. RUSSO, Tormento. Ventisecoli di artiglieria meccanica, Roma 2002, pp. 176-177.
47 - Cfr. F. RUSSO, L 'artiglieriadelle legioni romane. Roma 2004, 121-169.
48 - Per l’esattezza i modioli del reperto di Ampurias, di camine‘real e di Cremonahanno undiametro d’innesto compreso fra 0 mm 76 e E mm 80.Pressoché identico anche il diametro dei modaioli di un’al» tra catapulta ritrovata in Marocco, presso i ruderi della città romana di Sales. In merito cfr.C. BOU'BE-PICCOT, Elements de catapultes en bronze decouven‘s en Mauretanie Iingitane, in Bulletine d 'archealogiemarocaine, TomoXVII 19874988,p. 213. Analogo pure il diametro di quello rinvenuto presso Lione, cfr.D. BAATZ, M. FEUGERE,Eléments d ‘unecatapulte ramaine tmuvée &Lyon, in Gallia,fouilles et monuments archeologiques en France métropolitaine, Paris 1981,pp. 201 e sgg.
49 -Cfr. T.CELO'ITI,Storia di Spagna, seconda ediz. Milano 1940,pp. 50- 51.
50 - Per approfondimenti in merito di' E. SCI-IRAMM, Die antiken Geschutze der Saalbutg. Bemerkungen zu ihrerRekorcrtruktion, Berlino 1918.
51 - In merito J. D. VICENTE, M. P. PUNTER, B. EZQUERRA1 La catapulta lardo—republicanay otro equipamiento militar de ‘LaCaridad ’(Caminreal, Teruel), inJournal of roman military equipment studies,vol.8, 1997,pp. 167-199.
52 -Al riguardo cfr. D. BAATZ, Ein katapult der Legia [VMacedonia aus Cremona,in Romische Mitteilungen, 87, 1980.
53 - La menzione è esposta nel V libro della Sintassi Meccanica di Filone, tradotto infrancese epubblicato da Y.GARLAN, Recherches depoliorce'tique grecque, Parigi 1974,pp.279-404.
54 - Da Y.LE BOI-IEC,L 'eserciloromano, Urbino2001,p. 209—218.
55 - Da E. N. LI] 1 WAK, La grande strategia del!‘imperoromano, dal I al III secolo d.C., Milano 1981,p.82.
56 - Da A. ANGELINI,L 'artemiltare..., cit.,p. 103.
57 - Da E. N. LU WAK, La grande strategia del!impera..., cit., pp.82»83.
58 -Da M. FEUGERE,Les armes des Remains de la République a I 'Antiquitétardive, Paris 2002,p.51, traduzione dell’A.
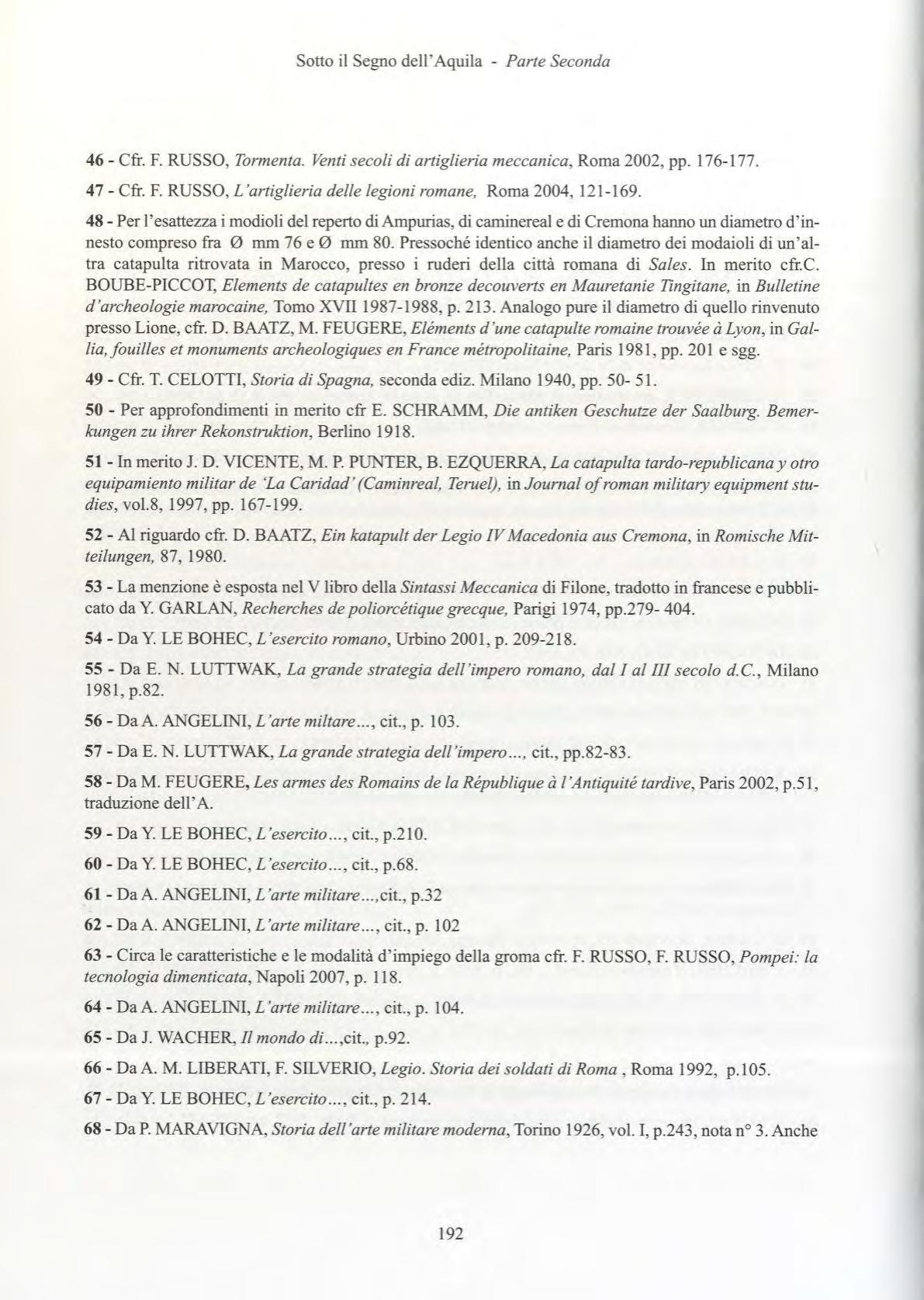
59 - Da Y.LE BOHEC, L’esercito… cit., p.210.
60 - Da Y.LE BOHEC, L'esercito… cit., p.68.
61 — Da A. ANGELINI, L ’artemilitare...,cit., p.32
62 — Da A. ANGELINI, L 'artemilitare..., cit.,p. 102
63 - Circa le caratteristiche e le modalità d’impiego della groma cfr. F. RUSSO, F. RUSSO, Pompei: la tecnologia dimenticata,Napoli 2007,p. 1 18.
64 - Da A. ANGELINI,L ’artemilitare..., cit.,p. 104.
65 - Da ]. WACH'ER, Il mondo di...,cit., p.92.
66 - Da A. M. LIBERATI, F. SILVERIO,Legia. Storia dei soldati di Roma , Roma 1992, p. 105.
67 — Da Y.LE BOI-IEC, L ’esercita...,cit.,p. 214.
68 -Da P. MARAVIGNA, Storia dell arte militare moderna, Torino 1926,vol.I, p.243, nota n° 3.Anche
Sotto il Segno dell’Aquila - Parte Seconda
192
in questo caso le pagine di Flavio Giuseppe sono di estremo interesse. Ricorda infatti lo storico che Vespasiano movendo con l’esercito da Tolemaideper invadere la Galilea,dispose: che in testa avanzassero gli ausiliari di lieve armatura e gli arcieriper respingere improvvisi attacchi nemici ed esplorare i bo— schi sospetti e adatti agli agguati; assieme « costoroprocedeva anche un contingente di soldati romani armati allapesante, parte apiedi eparte a cavallo.Dietro questi venivano dieci uominiper ogni centuv ria, cheportavano ilproprio bagaglio egli attrezziper la misurazione dell 'accampamento,e quindi igenieri delle strade sia per raddrizzare le tortuosità dei percorsi, sia per colmare i dislivelli. sia per abbattere la vegetazione ingombrante, afinche' !'esercitonon avesse a safiire i danni di una marcia dificile..."
69 - Da A. LIBERATI, F. SILVERIO,Legio..., cit.,p. 111
70 -Per inciso va ricordato che anche la prima ferrovia d’Italia, la Napoli-Portici, aveva come sua finalità di progetto il collegamento con i cantieri navali di Castellamare di Stabia, e di lì a breve con la piazza di Capua.In entrambi i casi strutture squisitamente militari.
71 »C1ì'. E. N. LUTTWAK, La grande strategia dell'impero romano.… cit.,p. 277, nota n” 6.
72- La citazione è tratta da Cenni elementari diArte Militare, Roma 1874,p.71
73- Da Cenni...,cit.,p. 74.
74 - Da G.B. CARDONA (a cura di), Polibio..., cit , vol. II, pp. 187-188.

75 - Da A. ANGELINI, L 'artemilitare.… cit.,p. 93.
76 - Da G.ULLOA, Dell’orte dellaguerra, Torino 1851,vol. 1.1,p. 175.
77 - Da G.ULLOA, Dell 'arte...,cit., vol. I, p. 50.
78 -Da G.PALMIERI, Riflessioni critiche sul! ’artedellaguerra, a cura di M. Proto, ristampa Mandria 1995,p. 545.
79 — Da G.ULLOA, Dell’ane..., cit.. vol. I, p. 51.
80 — Da G.ULLOA, Dell 'arre...,cit.,p. 52.
81 - Da G.PALMIERI, Riflessioni critiche..., cit.,p. 543.
82 -Da G.PALMIERI, Riflessioni critiche..., cit.,p. 546.
83 - Da A. LIBERATI, F. SILVERIO, Legio..., cit.,p. 11l.
84 - Da A. ANGELINI, L ’artemilitare..., cit.,p. 16.
85 -Da K. VON CLAUSEWITZ,Della guerra, Trento 1982,p. 389.
Sotto il Segui dell'Aquila -
Parte Seconda
194
PARTE TERZA
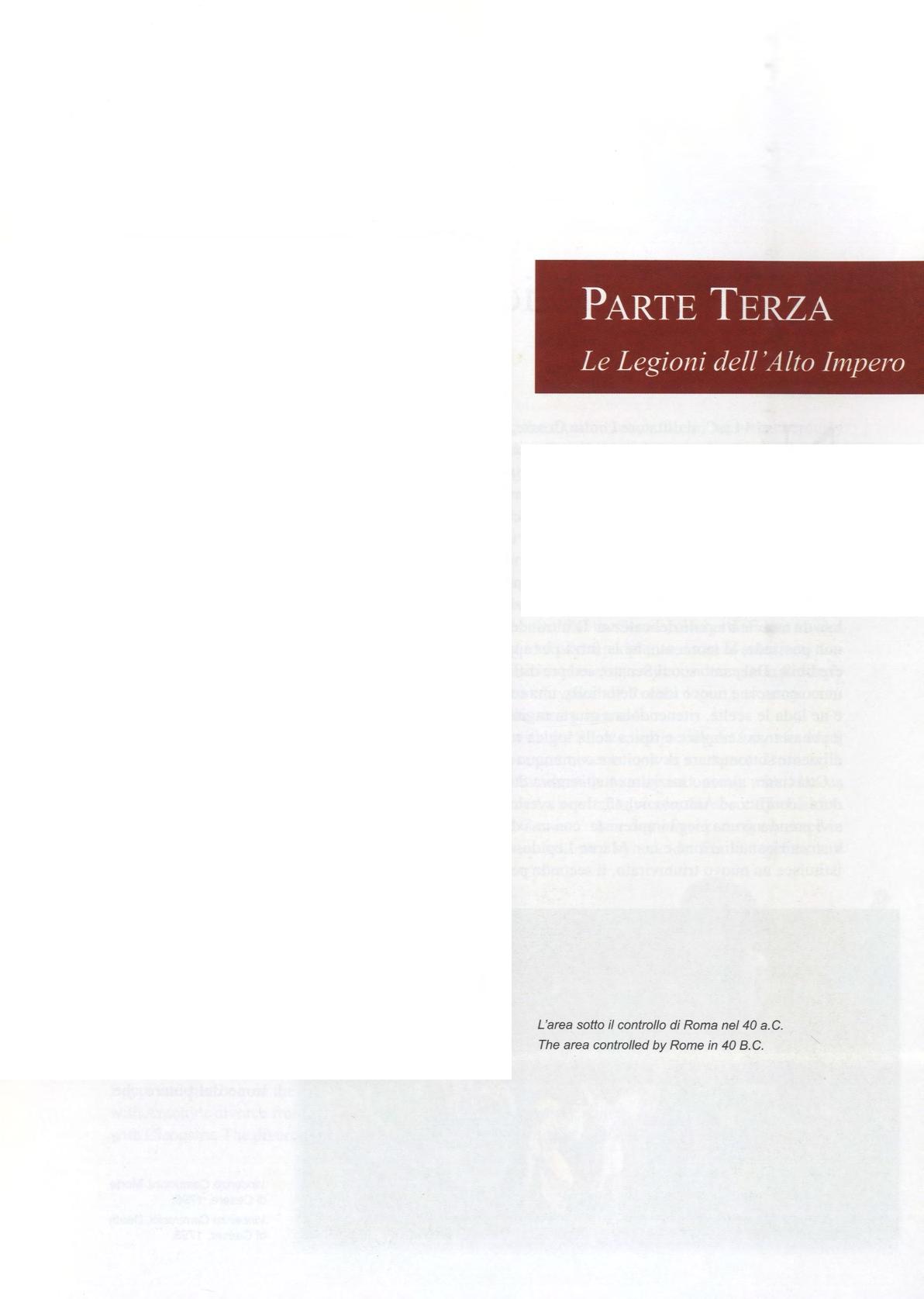
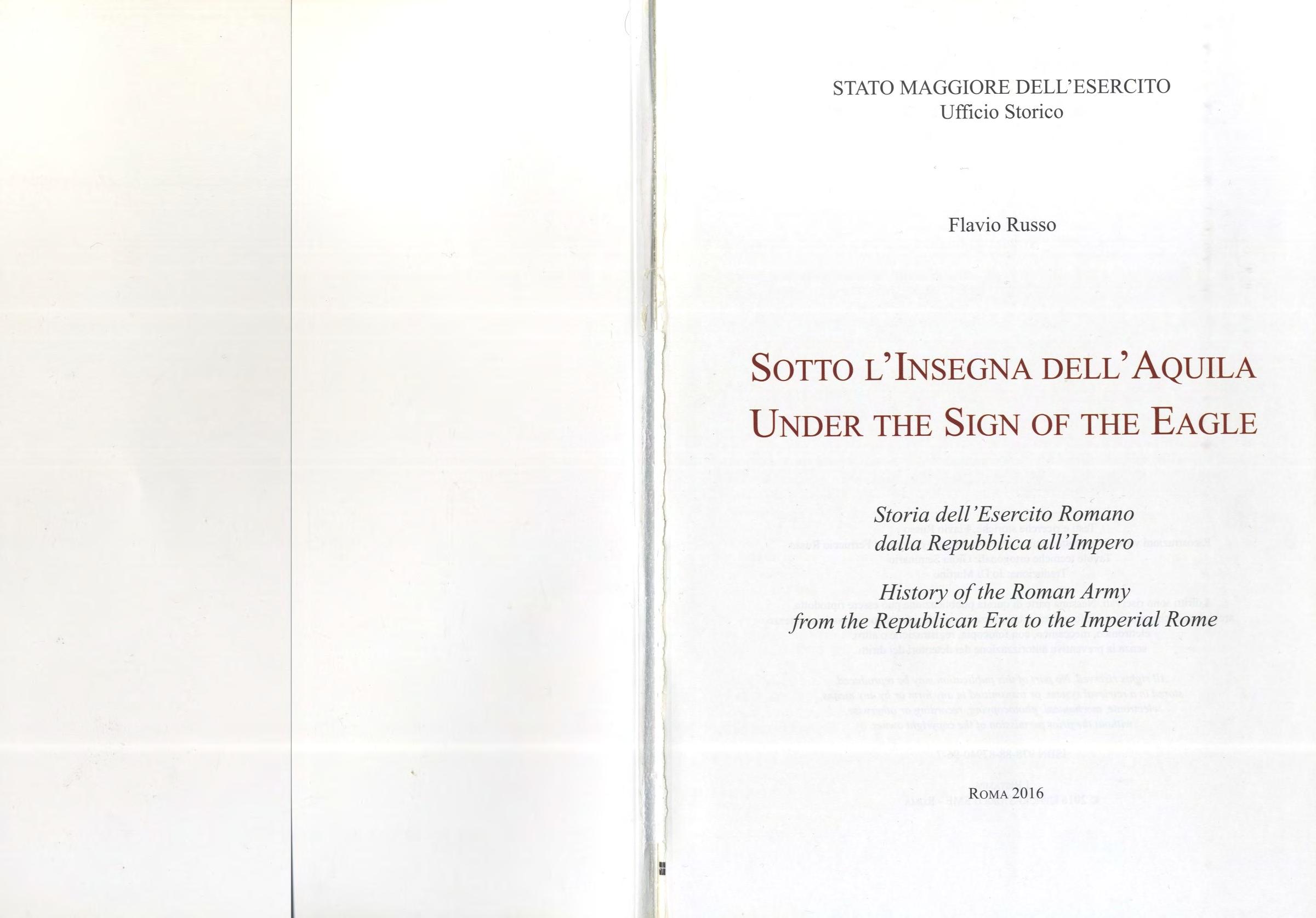
Le Legioni (lc/l ‘.—llm Impero
L'area satta il contra/lo di Roma nel 40 8.0. The area controlled by Rome in 40 B.C.
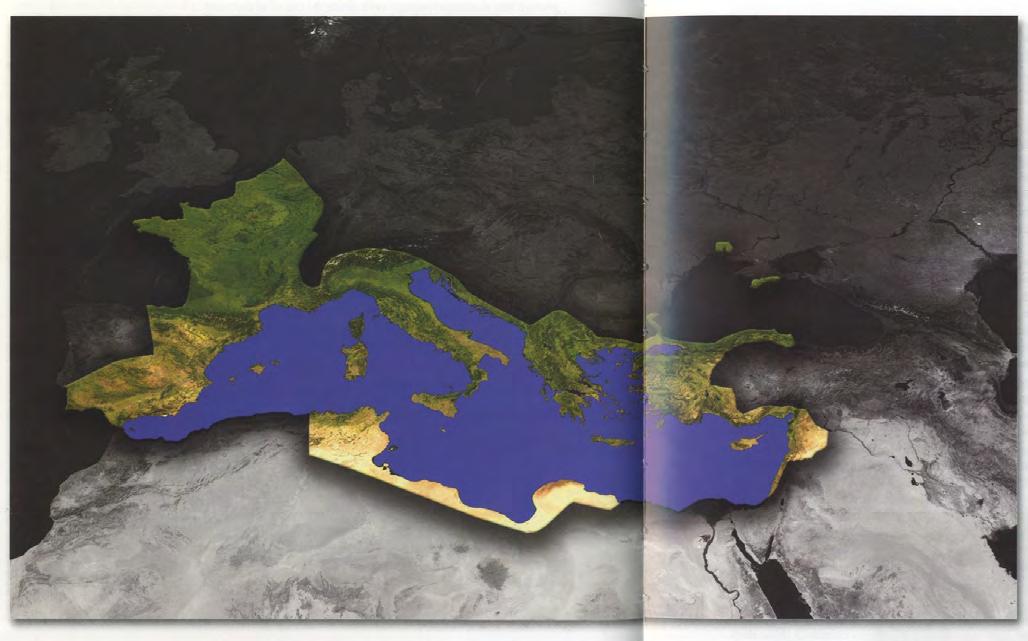
dopo astute trattative, nel 40 a.C. ratifica di fatto la spartizione dello stato ro» mano. Ad ogni buon conto due nuove entità vengono, però. rese solidali dai reciproci vincoli del matrimonio fra Antonio e Ottavia. sorella di OrtaViano.Z
L’Oriente, lungi dal pacare l'ambizione di Antonio. per molti aspetti sembra esasperala, complice anche la figura di Cleopatra, regina dell’Egitto e ultima erede della dinastia dei Tolomei.3A rendere esplicita la svolta il divorzio da Ottavia, nel 32 a.C., voluto proprio da Antonio per potersi unire con Cleopatra pure formalmente. Divorzio che sancisce in pratica la rottura del triunvirato e recidendo anche i già esili legami fra le due parti del mondo romano, richiede soltanto un minimo pretesto per farle cozzare. Forse nel provocarlo giocò un ruolo la temeraria regina, forse la diffidenza del Senato, che reputava molto rischioso il crescere di un’altra po‘ tenza non sicuramente soggetta a Roma, forse la volontà dello stesso Ottaviano, che ritenendo ormai maturi i tempi, decise di rompere gli indugi. Ufficialmente, tuttavia, furono solo le dissennate ambizioni di Antonio istigato da Cleopatra, le cause prodromiche della guerra che incombeva sempre più mminente ed inevitabile fra Roma e l’Egitto. Supponendosi, per intuibili ragioni, che gli scontri navali avrebbero sostenuto di certo un ruolo determinante nel conflitto, entrambi gli schieramenti incentivarono le costruzioni navali, che infatti febbrilmente vennero portate avanti in ogni cantiere del Mediterraneo. Di pari passo procedevano anche gli arruolamenti di nuove legioni.‘ Stando alle fonti Antonio, in breve tempo, riusci cosi a mettere insieme ad Efeso unaflotta di ben ottocento navi, comprese quelle mercantili ed onerarie. A sua volta Cleopatra gliene fornì altre duecento ancora, oltre ad una cospicua quantità di equipaggiamenti, di denaro e di vettovaglie, sufficienti a mantenere l’intero esercito per la durata presumibile della guerra. Ultimati i preparativi, la coppia intraprese alla testa dell’imponente formazione una sorta di crociera fra la costa nordafricana e la Grecia, soffermandosi ad Atene. Il loro intento appare abbastanza palese, mirando con quella ostentazione di forza a scoraggiare Ottaviano, inducendolo a desistere persino dal tentare una qualsiasi operazione militare contro l‘Egitto.s
Ottaviano, per la verità, apprese le informazioni, che con frequenza e precisione crescenti affluivano sulle mosse dei due, realizzò in pieno la sua inadeguatezza ad un imminente scontro e tentò nei limiti delle sue non irrilevanti potenzialità concrete, di accrescere ulteriormente il suo esercito. In dettaglio, le forze contrapposte ammontavano per l'Oriente a 100.000fanti e 20.000 cavalieri ",mentre per l’Italia a 80.000 fanti ed a un numero pressoché analogo di cavalieri. Quanto alla flotta quella di Antonio contava non meno di cinquecento unità da battaglia, di cui molte con otto o dieci uomini per banco di voga, di " io sfarzo e 7 Circa la di queste grandi navi,però, se ne deve supporre più che una idoneità al combattimento unamanifestazione di ricchezza, secondo l’ostentazione della ricchezza tipicamente orientale. Per il resto si trattava di navi pesanti e lente e, per consegnlenza, scarsamente manovriere e goffe nonostante i moltissimi uomini ai remi, per lo più schiavi. Ottaviano,per contro, poteva schierare appena duecentocinquanm navi da battaglia, essenziali nelle forme ma sottili e maneggevoli, agili e scattanti, perfettamente idonee alle manovre rapide di uno scontro manovrato. Vaevidenziato che il loro comandante, Marco VipsanioAgrippa, aveva aggiunto alla formazione un gran numero di velocissime libume, unità d’assalto corsare che, non a caso, erano state dallo stesso catturate proprio ai pirati della Libumia durante la guerra Dalmatica.‘
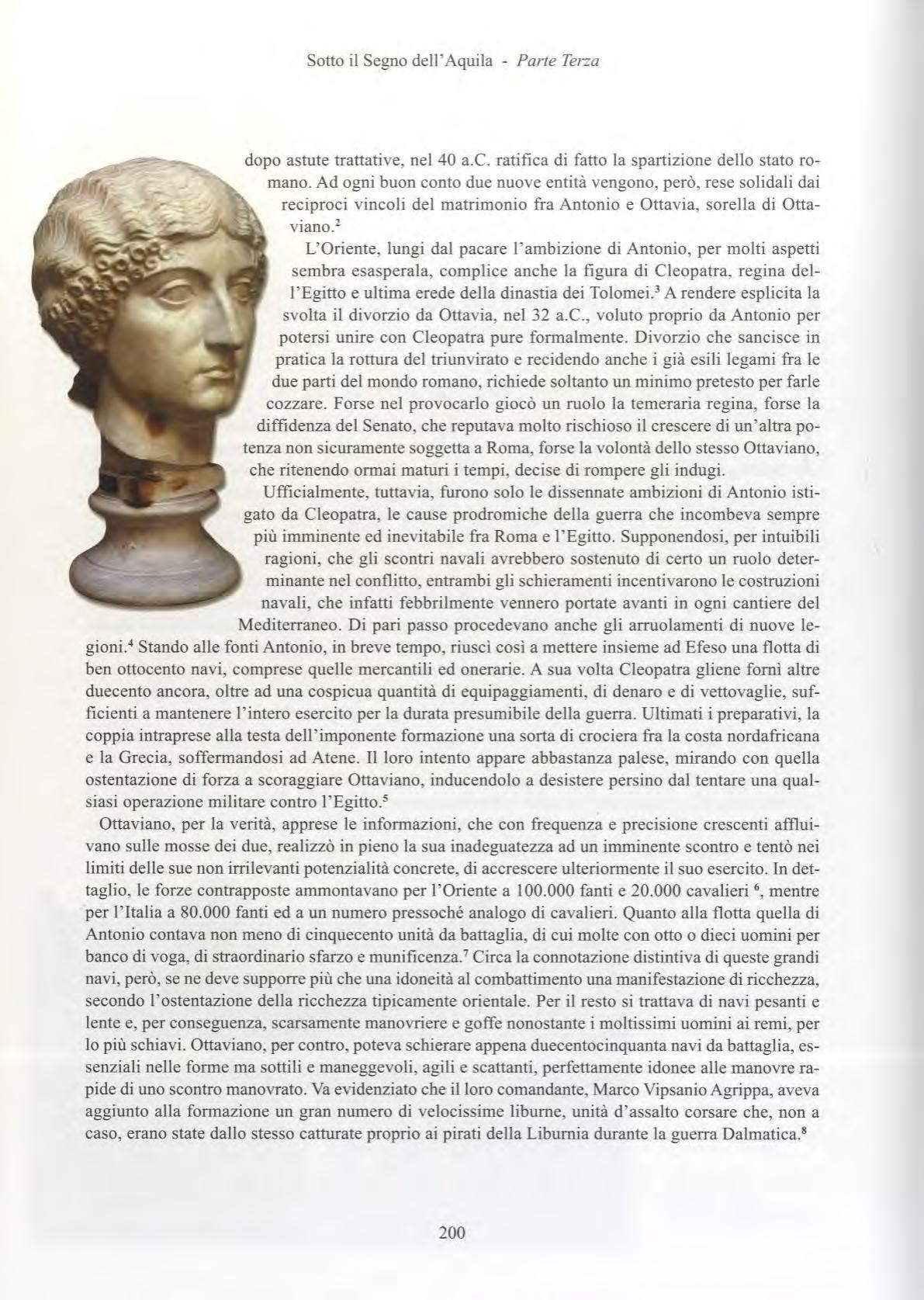
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte Terza
200
ALLAVIGILIA DELLO SCONTRO
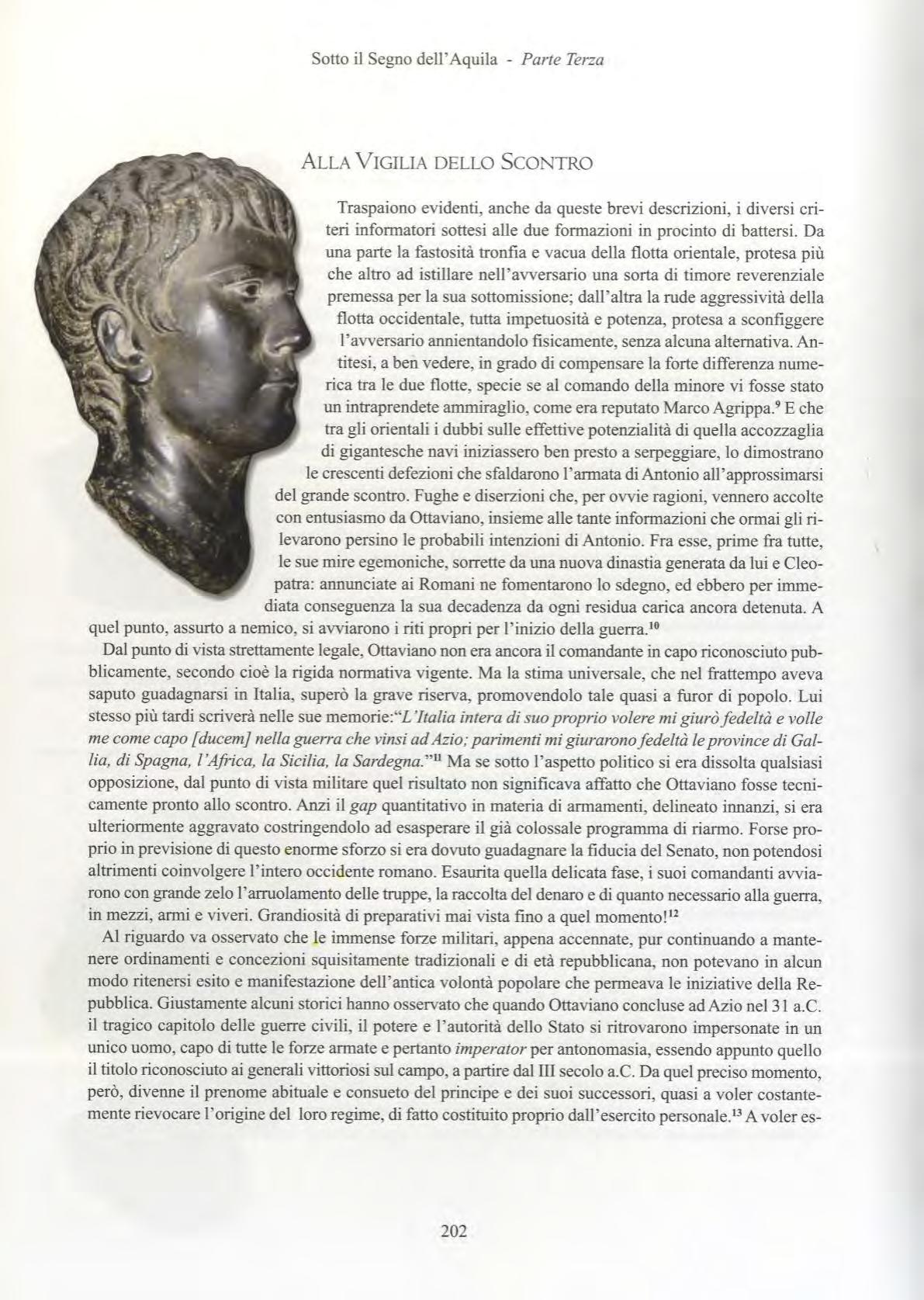
Traspaiono evidenti, anche da queste brevi descrizioni, i diversi cri» teri informatori sottesi alle due formazioni in procinto di battersi. Da una parte la fastosità t:ronfra e vacua della flotta orientale. protesa più che altro ad istillare nell’avversario una sorta di timore reverenziale premessa per la sua sottomissione; dall‘altra la rude aggressività della flotta occidentale, tutta impetuosità e potenza, protesa a sconfiggere l'avversario annientandolo fisicamente, senza alcuna alternativa.Antitesi, a ben vedere. in grado di compensare la forte differenza numerica tra le due flotte, specie se al comando della minore vi fosse stato un intraprendete ammiraglio, come era reputato Marco Agrippa.” E che tragli orientali i dubbi sulle effettivepotenzialità di quella accozzaglia di gigantesche navi iniziassero ben presto a serpeggiare, lo dimostrano le crescenti defezioni che sfaldarono l’armata diAntonio all'approssimarsi del grande scontro. Fughe e diserzioni che,per owie ragioni, vennero accolte con entusiasmo da Ottaviano,insieme alle tante informazioni che ormai gli ri— levarono persino le probabili intenzioni di Antonio. Fra esse, prime fra tutte, le sue mire egemoniclre, sorrette da unanuova dinastiagenerata da lui e Cleopatra: annunciate ai Romani ne fomentarono lo sdegno, ed ebbero per immediata conseguenza la sua decadenza da ogni residua carica ancora detenuta. A quel punto, assurto a nemico, si avviarono i riti propri per l’inizio della guerra.”
Dal punto di vista strettamente legale, Ottaviano non era ancora il comandante in capo riconosciuto pubblicamente, secondo cioè la rigida normativa vigente. Ma la stima universale, che nel frattempo aveva saputo guadagnarsi in Italia, superò la grave riserva, promovendolo tale quasi a furor di popolo. Lui stesso più tardi scriverà nelle sue memorie:"L ‘Italiaintera di suoproprio volere mi giurò/edelta‘ e volle me come Capo[ducem] nellaguerra che vinsi adAzia;parimenti mi giuraronafedeltà leprovince di Gallia. di Spagna, 1Z4fi-ica, la Sicilia, la Sardegna”" Ma se sotto l’aspetto politico si era dissolta qualsiasi opposizione, dal punto di vista militare quel risultato non significava affatto che Ottaviano fosse tecni» camente pronto allo scontro. Anzi il gap quantitativo in materia di armamenti, delineato innanzi, si era ulteriormente gg .; cos-n' ’ ‘ ad r il già ‘‘ , di riarmo. Forse proprio inprevisione di questo enorme sforzo si era dovuto guadagnare la fiducia del Senato, nonpotendosi altrimenti coinvolgere l’intero occidente romano. Esaurita quella delicata fase, i suoi comandanti avviarono congrande zelo l‘arruolamento delle truppe, la raccolta del denaro e di quanto necessario allagrerra, in mezzi, anni e viveri. Grandiosità di preparativi mai vista fino a quel momento!"
Al riguardo va osservato che le immense forze militari, appena accennate, pur continuando a mantenere ordinamenti e concezioni squisitamente tradizionali e di età repubblicana, non potevano in alcun modo ritenersi esito e manifestazione dell’antica volontà popolare che permeava le iniziative della Repubblica. Giustamente alcuni storici hanno osservato che quando Ottaviano concluse ad Azio nel 31 a.C. il tragico capitolo delle guerre civili, il potere e l‘autorità dello Stato si ritrovarono impersonate in un unico uomo, capo di tutte le forze armate e pertanto imperator per antonomasia, essendo appunto quello il titolo riconosciuto ai generali vittoriosi sul campo, apartire dal III secolo a.C. Da quel preciso momento, però, divenne il prenome abituale e consueto del principe e dei suoi successori. quasi a voler costante— mente rievocare l‘origine del loro regime, di fatto costituitoproprio dall’esercito personale." A voler es—
Sotto il Segno dell’Aquila Parre Terza
202
sere pignoli il formarsi di quella anomala struttura militare costituiva la conseguenza ultima della riforma di Gaio Mario, che vincolando le legioni prioritariamente al loro comandante conun rapporto di fedeltà diretta e personale, avevafinito per trasformarle, di fatto, in eserciti privati, costituiti daprofessionisti altamente specializzati, ma del tutto insensibili al potere politico centrale.
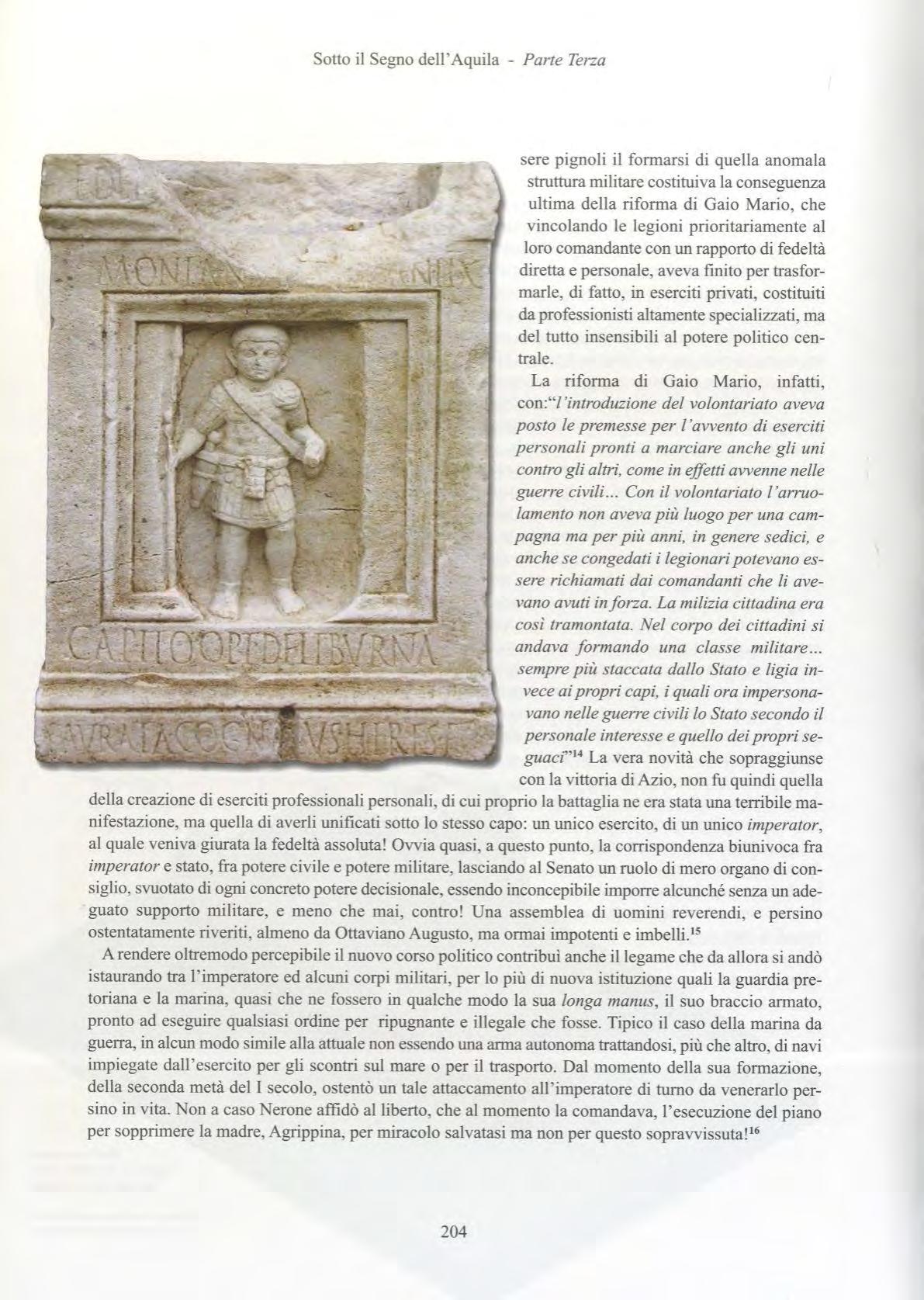
La riforma di Gaio Mario, infatti, con:“!introduzione del volontariato avevo posto lepremesse per ] 'avventodi eserciti personali pronti a marciare anche gli uni controgli altri, come in efletti avvenne nelle guerre civili… Con il volontariato ] ’arruolamento non avevapiù luogoper una campagna maper più anni, in genere sedici, e anchese congedati i legionaripotevano essere richiamati doi comandanti che li avevano ovuti inforza. La milizia cittadina era così tramontato. Nel corpo dei cittadini si andava formando una classe militare… sempre più stoccato dallo Stato e ligio invece aipropri capi, i quali ora impersonavano nelleguerre civili lo Stato secondo il personale interesse e quella deipropri seguacr”“ La vera novità che sopraggiunse con la vittoria diAzio, nonfu quindi quella della creazione di eserciti professionali personali, di cui proprio la battaglia ne era stata unaterribile manifestazione, ma quella di averli unificati sotto lo stesso capo: un unico esercito, di un unico imperator, al quale veniva giurata la fedeltà assoluta! Ovvia quasi, a questo punto, la con'ispondenza biunivocafra imperator e stato,fra potere civile epotere militare, lasciando al Senato un ruolo di mero organo di consiglio, di ogni potere ’ ' essendo ‘ , " " imporre ‘ ‘ ' senza un ade» guata supporto militare, e meno che mai, contro! Una assemblea di uomini reverendi, e persino ostentatarznente river-iti, almeno da OttavianoAugusto, ma ormai impotenti e imbelli.“
Arendere oltremodopercepibile il nuovo corsopolitico contribui anche il legame che da allora si andò istaurando tra l’imperatore ed alcuni corpi militari, per lo più di nuova istituzione quali la guardia pretoriana e la marina, quasi che ne fossero in qualche modo la sua longa manus, il suo braccio armato, pronto ad eseguire qualsiasi ordine per ripugnante e illegale che fosse. Tipico il caso della marina da guerra, in alcunmodo simile alla attuale nonessendo una arma autonoma trattandosi,più che altro, di navi impiegate dall’esercito per gli scontri sul mare o per il trasporto. Dal momento della sua formazione, della seconda metà del X secolo, ostenti: un tale attaccamento all’imperatore di turno da venerarlo persino in vita.Non a caso Nerone afiidò al liberto, che al momento la comandava, l’esecuzione del piano per sopprimere la madre, Agrippina, per miracolo salvatasi ma nonper questo sopravvissuta!“
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte Terza
204
LO SCONTRO
Le attenzioni verso le navi. per la verità. iniziarono con Marco Agrippa tanto che da molti studiosi e considerato, a giusta ragione, il vero fondatore della marina da guerra romana. Al di là delle equiparazioni, in ogni caso discutibili, le sue attenzioni per la flotta furono da unaparte dettate dalla consapcvo— lezza che la resa dei conti con Marco Antonio sarebbe avvenuta sul mare e.poco più tardi, che uno stato circumediterraneo non poteva continuare a mettere insieme navi soltanto al profilarsi di una guerra 01tremare, per poi farle marcire una volta conclusa. Per il momento. quando l'intero esercito fu pronto ed equipaggiato alla perfezione, verme concentrato a Taranto e a Brrndisr. dove si erano già ormeggiate anche le unità navali suddivise indue flotte. Lui stesso.non appena lo avesse ritenuto opportuno. avrebbe dovuto salpare con laflotta di Tarantoper sorvegliare lo Ionio ”.paventandosi un colpo di mano nemico dalla non lontana Grecia.Ma il 32 a.C. trascorse senza che le opposte formazioni entrassero in contatto. Agli inizi dell‘autunno la flotta di Antonio e di Cleopatra si ancorò all’intemo dello stretto golfo di Arta, alla cui imboccatura sorgeva Azio, e si preparò a sveman‘i.Antonio, invece, si diresse a Patrasso, dove controllò gli ultimi preparativi e schierò i suoi legionari un po’ dovunque, segno che anche lui temeva un probabile colpo di mano nemico. L’invemo, pertanto, trascorse così con i due contendenti in reciproca sospettosa vigilanza,scandito di tanto in tanto da qualche modesta scaramuccia. senza però ulteriori esiti bellici. Vifu, per la verità. un tentativo da parte di Ottaviano di forzare i tempi e di attaccare le navi di Marco Antonio con una squadra sal» pata da Brindisi. ma lo scatenarsi di una tempesta fece rientrare l'impresa. e non senza danni.
Nella primavera seguente del 31 a.C.. le ostilità in mare vennero avviate da Agrippa. che attanagliò l’Egeo con un rigido blocco navale. e da Ottaviano che condusse la sua flotta direttamente ad Azio, non lontano dall‘ancoraggio di quella di Antonio. Paradossalmente la situazione fra i due schieramenti andò in stallo: la proposta di venire apatti non fu accettata per diffidenza e quella di combattere non fu accettata per paura! Accorse allora Antonio che tuttavia non attaccò ancora.ma si limitò a semplici schermaglie e ostentazioni. Nel frattempo Agrippa conquistò Leucade e poi Patrasso con tutte le navi ivi stanziate. convincendo gli abitanti di C0rinto apassare dalla sua parte. Anche a terra la situazione di Antonio volgeva al peggio, susseguendosi sconfitte di poco conto, senza dubbio, ma emblematiche."
In questapagina: sopra. Vedutasatellitare del Golfodi Patrasso. sotto. lostretto di Corinto Nella pagina afianco: aureofatto coniare daAntonio per pagare le sue legioni e unbassorilievo conla battaglia diAzio.
On thispage. above.satellite view ofthe Gulf ofPabas. below. the Sila/l of Corinth. Sidepage areuscomed byAntony topay his leg/ons andabas-relief of thebattle olActium.
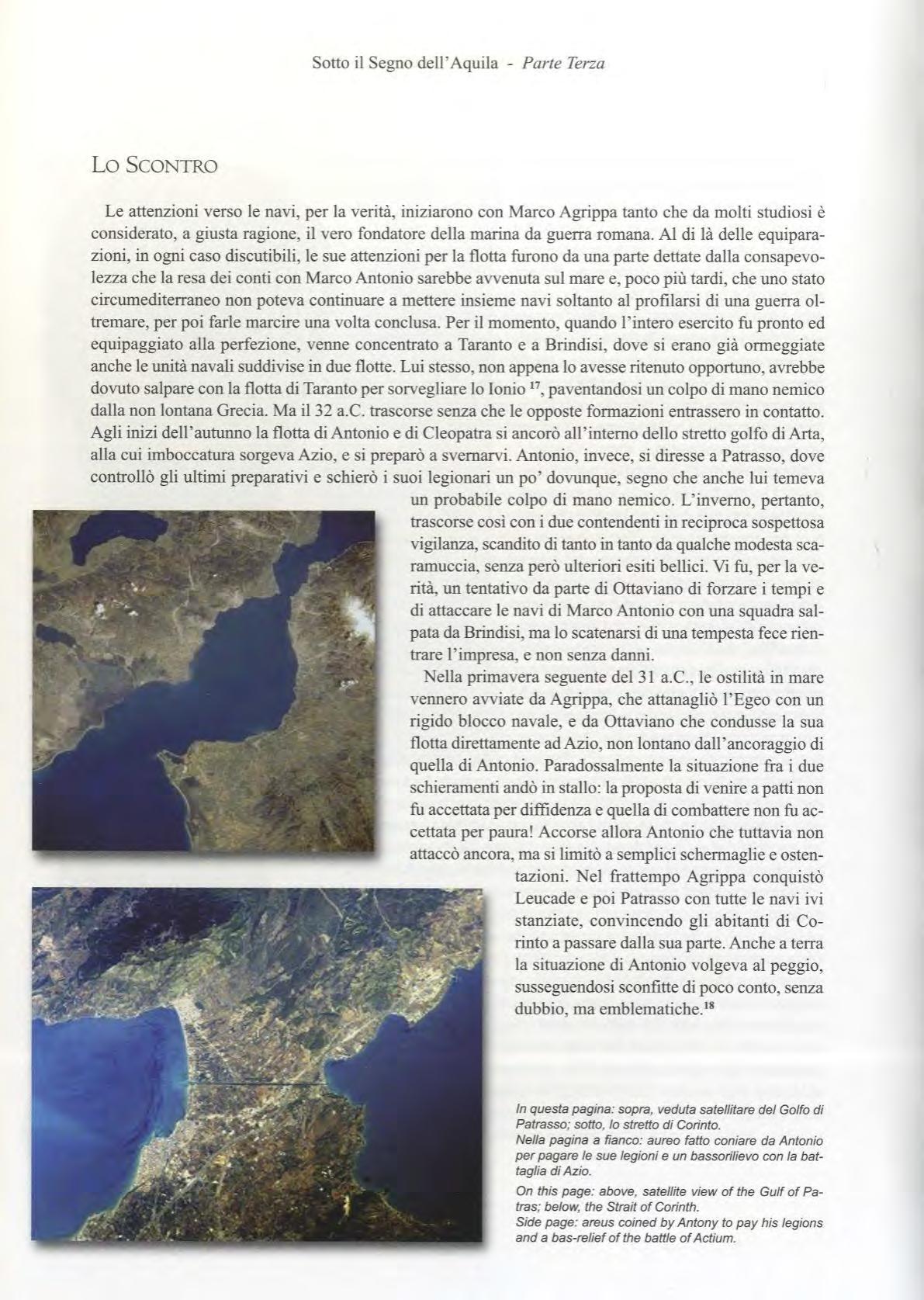
Sotto il Segno dell'Aqurla Porre
Terzo
Passò laprimavera e quindi, sul finire di agosto. si ebbe il primo scontro navale di una certa entità, sebbene fino a quel momento Agrippa avesse già catturato l30 navi di Antonio, affondandone molte altre ancora.Anche il suo blocco navale iniziò a dare i primi risultati: i viveri nel campo awerso presero a scarseggiare, incentivando le diserzioni che crebbero in modo vistoso, costringendoperciò Antonio ad indire un consiglio di guerra, La convinzione che ne trasse, non certo divulgata, fu quella di sganciarSi e di ri— parare inEgitto, essendo ancora ingrado di poterlo fare. Le navi nonnecessarie vennero bmciate, e sulle restanti si caricarono gli oggetti preziosi, fingendo però trattarsi dei preparativi per lo scontro finale.
Il 2 settembre la battaglia tanto attesa e temuta. finalmente ebbe luogo; Agrippa manovrando con straordinaria abilità stava ormai prevalendo sulla flotta nemica, quando la fuga delle navi di Cleopatra, seguita immediatamente da quelle di Antonio, gettò nella costernazione l’intera formazione. Tuttavia le unità continuarono a combattere con un certo valore. essendo pur sempre d'estrazione romana, senza però alcuna speranza di successo. Tramonti; il sole e soltanto al suo successivo sorgere, la vittoria di Ottaviano si stagliò netta. Rottami informi riempivano la superficie del mare: aggrappati ai maggiori si scorgevano i rari superstiti di tanti valorosi equipaggi; centinaia di navi, ridotte a pontoni fumanti, galleggiavano inerti con alle murate le ciurrne in attesa della sone. Per tutti Ottavianogaranti la vita e il perdono, ottenendone prontamente la deposizione delle armi. Anche i reparti terrestri, vistisi abbandonati, passarono in massa al vincitore."
IL Nuovo ESERCITO ROMANO
La forza militare di cui il giovane Ottaviano da quel momento si trovò a disporre, non vantava per entità alcun precedente storico, meno che mai romano. Una stima prudente la fa ascendere a circa 60-70 legioni, certamente non più complete negli organici e nein equipaggiamenti per le non irrilevanti perdite subite. ma pur sempre con un organico complessivo di oltre 250.000 uomini! Ammontare decisa» mente eccessivo e, in sostanza, superfluo anche per Roma. senza contare l’improbo onere del suo mantenimento economico. Ne d’altronde tornavapraticabile, senza paventare le prevedibili conseguenze, licenziare tutti quei legionari, molti dei quali di notevole esperienza e valore che mai più sarebbero stati recuperabili. Occorreva.pertanto, operare una selezione fia gli elementi posticci aggregati per far numero ed i veterani ingannati dallapolitica di Antonio, ma ora sicuramente e pienamente fedeli al nuovo imperator, del quale peraltro non mettevano minimamente in discussione né il diritto ne' tanto meno la legit»
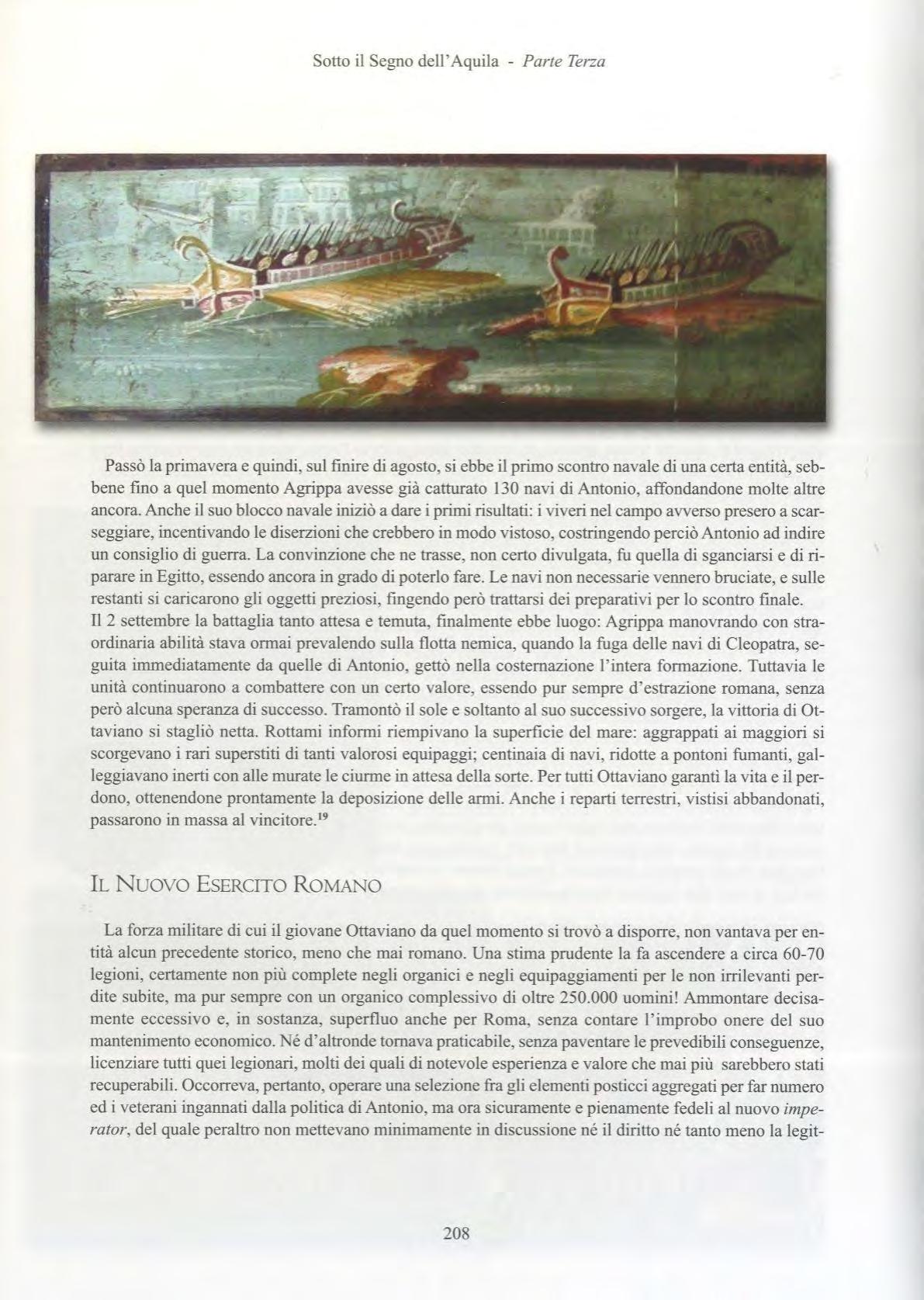
Sotto il Segno dell‘Aquila - Par-le Ter:a
208
timità di governare. La saggezza di Ottaviano escogitò, quale adeguata soluzione, una radicale riforma dell’intero esercito. Del resto persino dal punto di visto territoriale quell’intervento si imponeva già da tempo, dal momento che i confini di Roma correvano lontanissimi dalla città, con al loro interno grandi masse desiderose di ordine e prosperità.
Lo strumento militare che a quel punto sembrava imporsi era un esercito composto di uomini professionalrnente qualificati, capaci di combattere in guerra e, ancora di più, di saper gestire la pace, di civilizzare con l’esempio e l’attività quell‘immenso coacervo di etnie che doveva evolversi in una unica e coesa realtà statuale… Unesercito di guerrieri e di tecnici, capaci di aprire nuove strade, di condurre l‘acqua da centinaia di chilometri di distanza, di edificare intere città razionalmente, di amministrare la legge, di garantire la sicurezza dei territori di confine, dei mari e delle coste, perché se ormai non vi erano più nemici nella tradizionale accezione del termine, nonper questo non vi erano più minacce alla pubblica sicurezza. Unesercito di esperti ben pagati e relativamente poco numerosi costituiva la migliore garanzia al riguardo, tanto più chepotevano essere tratti agiusta ragione da moltissimi aspiranti. Pertantoz“il vittorioso Augusto "',si affrettò o ridurre I 'esercitoa venticinque, 0 ventisei, legioni (piu' aumentare o ventotto nel 25 a.C.) nell 'intentodi creare unaforza permanente di dimensionipiù convenienti. Questa nuovaforza legionari comprendeva unpo ’piùdi 150.000 uomini, numero apparentemente esiguo, in rapporto ullo vastità dell impero da difendere, ma basato su colcoli di opportunità militare epolitica,"“
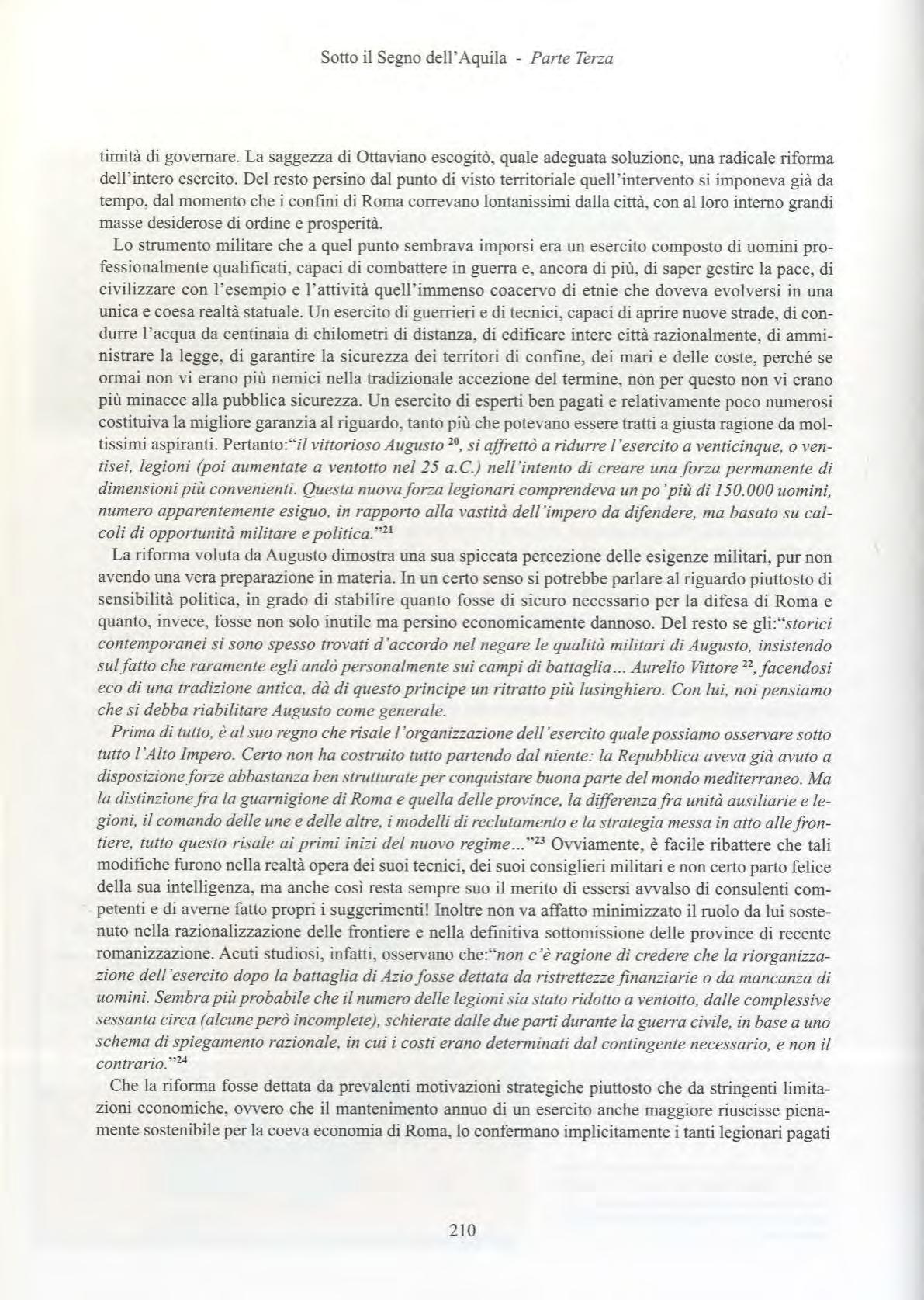
La riforma voluta daAugusto dimostra una sua spiccata percezione delle esigenze militari, pur non avendo una vera preparazione in materia. In un certo senso si potrebbe parlare al riguardo piuttosto di sensibilità politica, in grado di stabilire quanto fosse di sicuro necessario per la difesa di Roma e quanto, invece, fosse non solo inutile ma persino economicamente dannoso. Del resto se gli:“storici contemporanei si sono spesso trovati d ‘accordonel negare le qualità militari di Augusto, insistendo sulfatto che raramente egli andàpersonalmente sui campi di battaglia….Aurelio Vittore",facendosi eco di una tradizione antica, dà di questoprincipe un ritrattopiù lusinghiero, Con lui, noipensiamo che si debba riabilitare Augusto come generale.
Prima di tutto, è al suo regno cherisale [ 'orgaru'zzazionedel! ‘esercitoqualepossiamo osservare sotto tutto I ’AltoImpero. Certo non ha costruito tuttoponendo dal niente: la Repubblica aveva già avuto a disposizioneforze abbastanza benstrutturateper conquistare buonaparte del mondo mediterraneo. Ma la distinzionefra la guarnigione di Roma e quella delleprovince, la diflkrenzafi‘a unità ausiliarie e legioni, il comandodelle une e delle oltre, i modelli di reclutamento e la strategia messa in atto allefrom tiere, tuito questo risale ai primi inizi del nuovo regime…"u Ovviamente, è facile ribattere che tali modifiche furono nella realtà opera dei suoi tecnici, dei suoi consiglieri militari e non certo parto felice della sua intelligenza, ma anche così resta sempre suo il merito di essersi awalso di consulenti competenti e di averne fatto propri i suggerimenti! Inoltre non va affatto minimizzato il ruolo da lui soste« nuto nella razionalizzazione delle frontiere e nella definitiva sottomissione delle province di recente romanizzazione.Acuti studiosi, infatti, osservano che:“non c 'èragione di credere che la riorganizzazione dell 'esercitodopo la battaglia di Aziofosse dettata da ristrettezzefinanziarie :) da mancanza di uomini. Sembrapiù probabile che il numero delle legioni sia stato ridotto :: ventotto, dalle complessive sessanta circa (alcuneperò incomplete), schierare dalle dueparti durante loguerra civile, in base a uno schema di spiegamento razionale, in cui i costi erano determinati del contingente necessario, e non il contrario?“
Che la riforma fosse dettata da prevalenti motivazioni strategiche piuttosto che da stringenti limitazioni economiche, owero che il mantenimento annuo di un esercito anche maggiore riuscisse piena» mente sostenibile per la coeva economia di Roma, lo confermano implicitamente i tanti legionari pagati
Sotto il Segno dell'Aquila Porte Terza
210
da Augusto con le sue ricchezze, al momento del congedo. in pratica vigendo. magari in maniera molto discrezionale, la prassi di assegnare ai veterani all'uscita dall’esercito degli appezzamenti di terra, previa centuriazione, prassi malvista dal Senato per i suoi ingentissimi costi. di fatto il suo rispetto finiva per ricadere sulle capacità dei singoli generali. Ottaviano lo adottò per smobilirare l’eccedenza militare del dopo Azio. Per cui:“negli anni ” uu…e ivi ad Azio ‘ più di " rani, sistemandoli in una serie di colonie nuove e vecchie d 'Italiae delleprovznce. llfinanziamentoprov venne in massimaparte dalla suafortuna personale, confiscata all 'erart'ostatale egiziano nel 30 a.C.; e in seguito egli dichiarò di aver speso 600 milioni di sesterzi in Italia e 260 nelleprovince in acquisti di terreper i coloni (Res gestae, 16)“25 Difficile credere che quanto possibile ad un singolo, per facoltoso che fosse, riuscisse insostenibile per la Roma imperiale!
Sensata, quindi, l’osservazione che fosse relativamente più semplice sostenere le spese dell‘esercito che reclutame nuovi coscritti! Ma persino per questa difficoltà la lungimiranza di Ottaviano appare incontestabile, poiché quel prowedimento oltre a garantirgli la fedeltà dei congedati, agevolava indirettamente il re. ‘ dal che ogni recluta ,, ’ così l’entità e la natura della liquidazione finale su cui contare. E che non si trattasse di un mero espediente occasionale lo dimostra, di li a breve, la sua trasformazione inprassi istituzionale. infatti, sebbene a partire dal 13 dC. si fosse convenuto di sostituire le concessioni terriere con una indennita in denaro,pari a 3.000 denari dal 5 d.C.per ogni legionario, si tornò presto alla vecchiaprocedura… Sia gli imperatori che i veterani furono i fautori del ripristino delle assegnazioni: i primi perché le colonie erano, tradizionalmente,fedeli; i secondi perché preservavano cosi dall‘erosione dell’inflazione il loro capitale. In merito va ancoraprecisato che se l'indennità in denaro era sicuramente ben accetta dai veterani di estrazione urbana,ai quali l’appezzamento di terra non interessava gran che, e forse anche ad alcuni di estrazione agricola in quanto già detentori di piccoli poderi familiari, non lo era affatto ain occhi di tanti impera tori, Questi infatti vedevano nell’impianto delle nuove colonie una sorta di antemurale della civiltà romana, una sua difesa avanzata a costo zero, sulla quale poter fare sempre affidamento. il che favori il loro ciclico riproporsi, so— prattutto laddove la situazione geopolitica appariva meno stabile. Si ebbero perciò delle lamentazioni di veterani per gli asse— gnamenti di terre in regioni remote dell’Impero. per giunta di scarsissimo valore
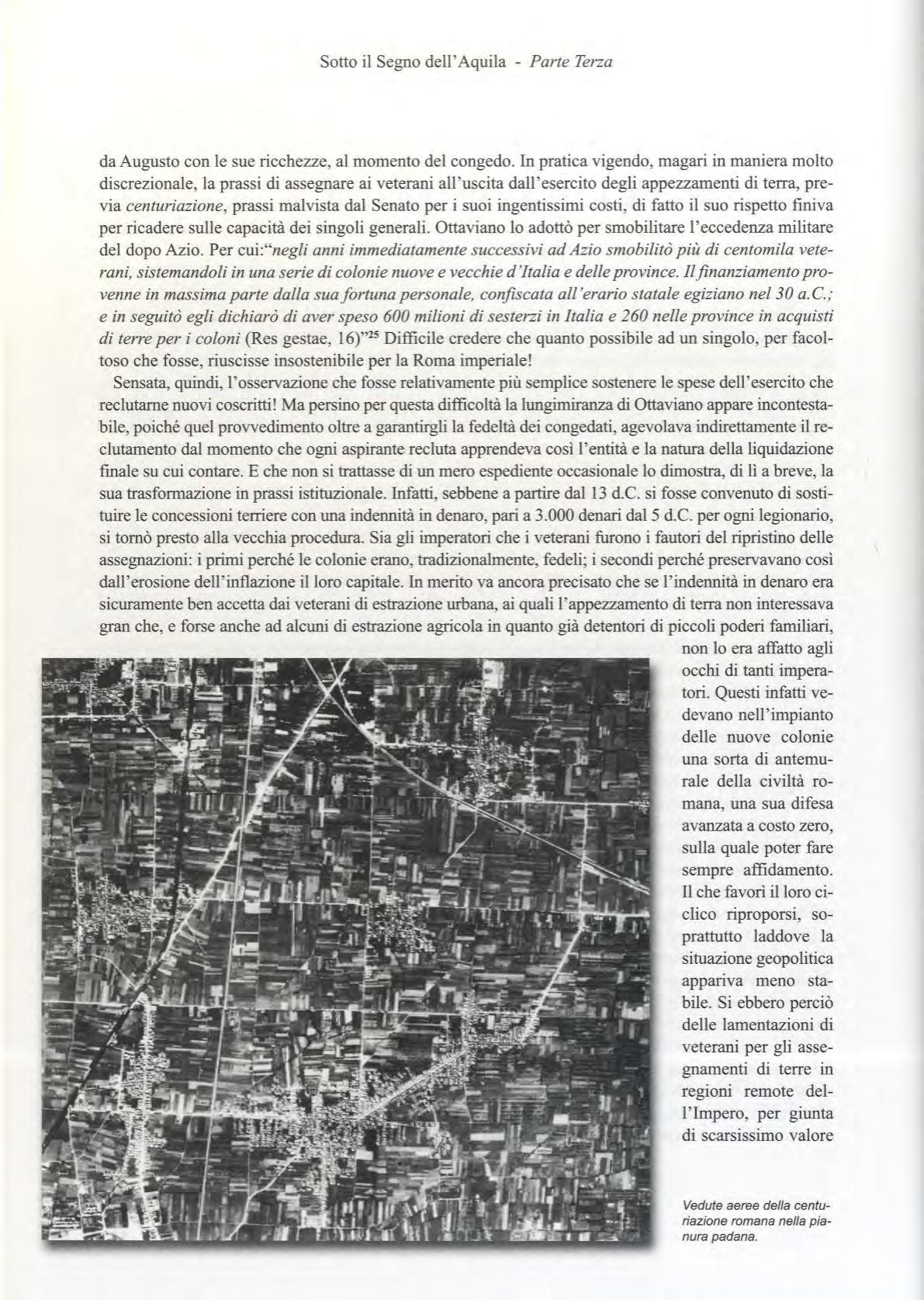
Sotto il
Segno dell'Aquila Parre Terza
L'l'
vete-
—.; .| ||| ,! "îtlt |\ ‘in
Veduteaeree della senta nazione roma/tanellaplsnurapadana.
commerciale e di infima rendita. Augusto sostenne a lungo questo gravoso onere, che solo dal 6 d.C. lo Stato si addosso, istituendo allo scopo un apposito erario militare, aerarium militare, al quale quasi a titolo di dote, diede uncontributo iniziale di ben 170 milioni di sestemi. Per garantirne il corretto funzionamento futuro, inoltre, promulgò un'imposta del 5% sulle successioni ed un altra dell‘ 1% sulle vendite all‘asta. Tanta cura nella gestione di quella antesignana previdenza sociale militare lascia intravedere una diversa percezione della istituzione, al contempo indispensabile supporto e infido strumento del potere, estremi opposto entro i quali tutti gli imperatori dovettero destreggiarsi.
Le ragioni del contenimento, quindi, oltre a quelle della razionalimzione delle forze [ringo lefrontiere, oltre a quelle del contenimento delle spese, erano anche, se non soprattutto, di tipo squisitamente politico. L’esercito doveva essere abbastanza consistente da difendere l’Impero, ma non tanto consistente da creare un pericolo per lo stesso oper l’imperatore; troppi uomini in una unicaprovincia erano unaminacciadi ribellione,una per un ,, ‘ pronto a ‘ ' unesercito di volontari professionisti ranrresmtava una garanzia di fedeltà, ma in mancanza di bottini che ne avessero integrato lo scarno stipendio, [evitava lapropensione all’ammutinamento. Del rem:“ilpericolo chepotevano costituite le ruppe consce della loro indisparsabilità era benpresente inAugusta (anchenei repartipiùfedeli, dopo Filippi, si erano avuteviolenterivendicazioni conrichiestadi congedoedipremi difine servizio).Egli aveva preferito promuovere tutta unapolitica dipace all interno edi buon vicinatocon ipopoli al di là dei confini epercio...dislocòlelegioni… tuttesui confini dei territori mi!itannartepiù esposti, trattenardoaRoma, come guardiapersonale, asostegnodelpotere centrale,solonovecoortidi legionariscelti, ipretoriani (gliaddetti alpraetorium, sede del comandomilitare nel castrum), unicocorpo di manovra edipronto impiego”16
ENTITÀ E DISLOCAZIONI DELLA FORZA ARMATA
Volendoin qualche modo stabilire l’entità e la suddivisione dell’intero apparato militare di Roma, se non all’indomani di Azio, almeno dopo la stabilizzazione delle riforme di Augusto nei primi decenni dell’Impero che,insostanza, coincidono conquelli della nostra era, abbiamo undettagliato resoconto di Tacito.Dunque, stando allo storico intorno al 23 d.C., allorquando Tiberioera ancora al potere, passò in rassegna il numero delle legioni e le province che avrebbero dovuto difendere conquesto risultato:“Due flotte, I ’unapresso il capo di Miseno. l’altra vicino a Ravenna,presidiavano !’Italianell ’unoe nell’al-
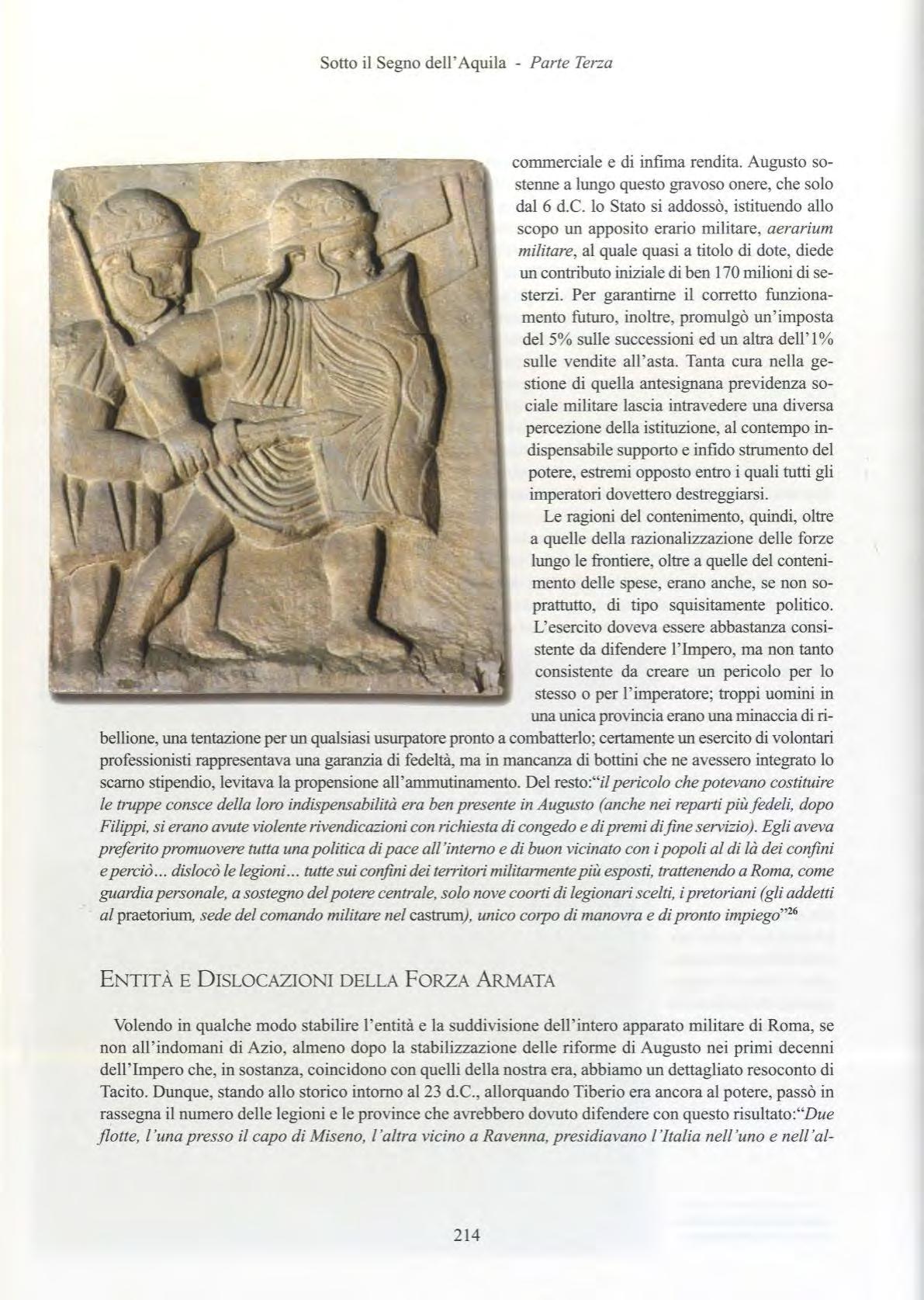
Sotto il Segno dell’Aquila -
Parte Terza
214
tra mare; accantopoi alle spiagge della Gol/ia. stavano le navi rortrote che. catturate nella bottoglio di Azio, Augusto con unforte equipaggio aveva mandato al Foro Giulia.27 [! nerbopiùforte del! 'esercitoera,per altro,presso il Reno: otto legioni che erano dipresidio contro Germani e contro Galli; la Spagna, invece, dapoco soggiogato, era occupata da tre legioni… Il re Giuba aveva accettato come dono del popolo romeno il dominio sui Mauri: mentre le altre regioni dell ’Africa e l 'Egittouvevano ilpresidio di due legioni, e da quattro legioni era sorvegliataper tutta lo ma vostilà il territorio doi confini della Siriafz'no alfiume Eufrate, col quale confinano gli Iberi, gli Albani ed altri regni, che la nostra potenza protegge controsignorie s!roniere... Due legioni in Pannonia e due in Merio tenevano le sponde del Danubio, mentre altrettante ve li 'eranoin Dalmazia, che,perla natura del luogo collocate a tergo di quelle sorebbero state rapidornente richiamote da luoghi non lontani, qualora in Italiafosse stato necessario un intervento improvviso,per quanto acBusto di CGS… canto a Roma viforsero di stanzo milizie specioli, tre coorti urbane, nove pretorie, Busto! Crassus quasi tutte arruolate nell 'Elruria e nell Umbria, 0 nell 'anticoLazio 0 nelle colonie fondate onticarnente dor Romani. Inoltre. nei luoghi più opportuni delle province vi erano le trirerni alleate, la cavalleria ele coorti ousiliarie,[one di importanzo non minore delle oltre.””
La rassegna consente di effettuare una considerazione di base: l'entità delle forze nonostante il lungo elenco non è molto abbondante, specie se relazionate all’imrnensità delle frontiere. Forse come già accennato 150.000uomini, al massimo 250.000, in ogni casoben poco a confronto dei quasi 10.000lun di frontiera da presidiare, E di ciò anche le massime gerarchie dell’esercito, a partire dallo stesso imperatore, erano perfettamente consapevoli. Si spiega forse cosi la disperazione di Augusto, il 9 d.C…. alla no— tizia dellaperdita di tre legioni nelle foresta di Teutoburgoche le ridusse da 28 a 25. La prima impressione sembrerebbe di teatrale ostentazione dal momento che nel 53 a.C. al Carrhae, presso Haran in Turchia, il massacro era risultato di gran lunga maggiore: delle sette od otto legioni arruolate da Crasso solo una decina di migliaia di uomini fecero ritorno!?9 Ma i caduti a Teutoburgo non erano reclute orientali prive di esperienza, arruolate a forza da un improvvisato duce di un raccogliticcio esercito, per una velleitario spedizione. Nella fattispecie si trattava di vere legioni dell'Impero, difiicili da reintegrare con nuove, non soltanto per gli uomini, che in qualche modo in un Impero di svariate decine di milioni di abitanti non doveva ” un, in … "‘ ma per l‘n, '' Questo, infatti, con i vigenti sistemi di produzione, per eflicienti che fossero, non risulmva né di facile ne' di rapido approntamento, anche dandoper scontata la disponibilità economica a sostenere tale sforzo, tutt’altro che scontata. Basti pensare al riguardo che, sul finire dello stesso secolo, la produzione degli elmi di bronzo avveniva ancora,proprio per la limitata produzione di quelli di ferro, dei quali una grossa fabbrica ne riusciva a produrre appena sei al mese!”
Come in apertura evidenziato, anche le istituzioni descrivono nel corso della loro esistenza le stesse due fasi distintive degli esseri viventi, anabolica o della crescita, che va dalla nascita al massimo sviluppo corporeo, e catabolica, o della decadenza, che va dal quest’ultimo alla morte. Fra le
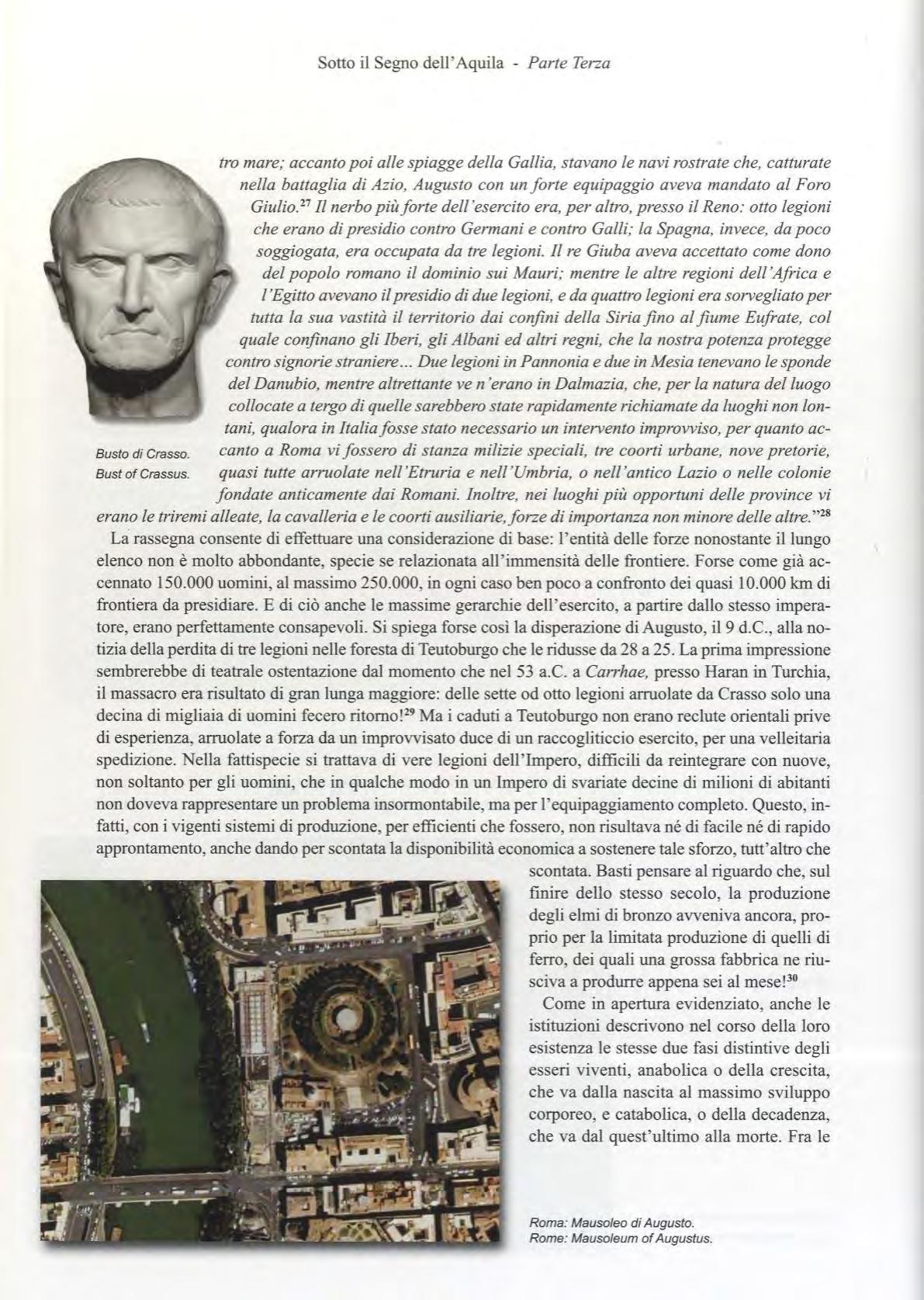
Roma: Mausoleo diAugusto
Rome: Mouse/eum ofAugusius.
Sotto
il Segno dell'Aquila - Parte Terza
duenon vige alcun intervallo sebbeneinpratica, si assisteadun intervallo durante il quale l’organismo sembraimmunealtempo.Questofuattintodall'ImperoromanoconAugustoesiprotrasseper circadue secoli abbondanti,durante i quali la politica militare adottatanon fupiù di tipo espansivoma difensivo, inmaniera semprepiù spiccata. ]prodromi del principiodella fine, infatti.sia pure larvati sicolgonogià conAugusto, tant’èche:“versoil9 d.C.tutteleenergiedel]'espansiontirmoaugusteoeranogiàstatespese, esieranoesauritenellefinis/redell'Il/irta edella Germania…Era impossibile nasconderequesta datadi fatto, tuttavia sipotevapresentare comeuna virtù quella cheera invece una necessita". QuandoAugusto mori, nel 14d.C., ilsuafiglt'arrro Tiberio (delladinastia Claudia, mentreAugustosiconsiderava appartenente a quella Giulia) amoreil comandodiun vasto impero, che ingranparte aveva contribuito lui stessoa conquistare, ma ricevetteanche Iingiunzionedinon espandereulteriormenteisuoiconfini.“"
La fasecatabolica,pertanto,ebbedapprimal'aspettodelcultodellapace,dellastabilizzazionedellefrontiereedellaprudenterinuncia aulteriori espansioni. Sivedrannoancoradellenuoveconquiste,ma queste soltantoinapparenzasembrerannoriproporrel’epocadelleconquiste,dell'iniziativaespansivadiRoma.In realtà,però, scaturirannodallastringentenecessità di fortificareilimes,portandoli adaderireagli ostacoli tattici naturali, quali ilcorsodeigrandi fiumioi deserti,per meglio garantire ladifendibilità.Non fu,perciò,un casol’edificazione a Roma dell‘AraPacis, il più tangibileriscontro della mutata concezione geopolitica, Ovviarnentez“in vita Augusto non era sempre statofedele a ciò che ingiunse nelfamoso ammonimentopostumoanonfareulterioriconquiste,cheTacitoriportaeandannandoloapertamente. Sotto lasuaguidafuronoinfatticombattuteguerrediconquistasu tuttiifioriti, cheportaronoall'annessionedi vastiterritori, tracuilefiztureprovincedellaMesia, dellaPannonia,delNoricoedellaRezia.oltrealle/{Ipi CozieeMarittime. Questeultimeannessionieranostateoriginarùzmentedellemisuredifensive,inteseafienaregliassaltipredatorideiSti/assicontroitrafl'ieialtraversoleAlpi. L ’opinionefinora accettata è che loscopodiAugusto, ancheprima dellegrandicrisi inllliria ein Germania nel6-9d,C.,fosse limitatoa creareunafrontiera ’sciennfica’sull’Elba,ovverounfronte ‘Amburgo-Praga- Viennai””
Secondoalcunetesipiùmoderne,nonprivediunacertasuggestione,Augustononposenessunlimitealle conquiste,tantopiùchelevigenticonoscenzegeografichedavanodelmondodelledimensioninotevolmente minori. Inaltreparole, avrebbecontemplatolamedesimautopia diAlessandroMagnorelativa all’unifica— zioneplanetaria.”L’ipotesi,però,apparescarsamenteconvincentedalmomentoche,proprioai suoigiorni, venne espostalaprima granderappresentazionegeograficaspaziantedall’oceanoAtlantico all’oceano In— diano,minuziosamentecompletadelledistanzefralevarielocalità.Eforsedaalcunireduci dellasconfitta di Carrhae,fortunosamenteritornatidopouna lunghissimaodisseainCina,sieranoappreseconmenoapprossimazione anchele immani distanzecontinentali,sconsiglimequalsiasiillusione al riguardo.

Sotto
il Segnodell'Aquila - Parte Terza

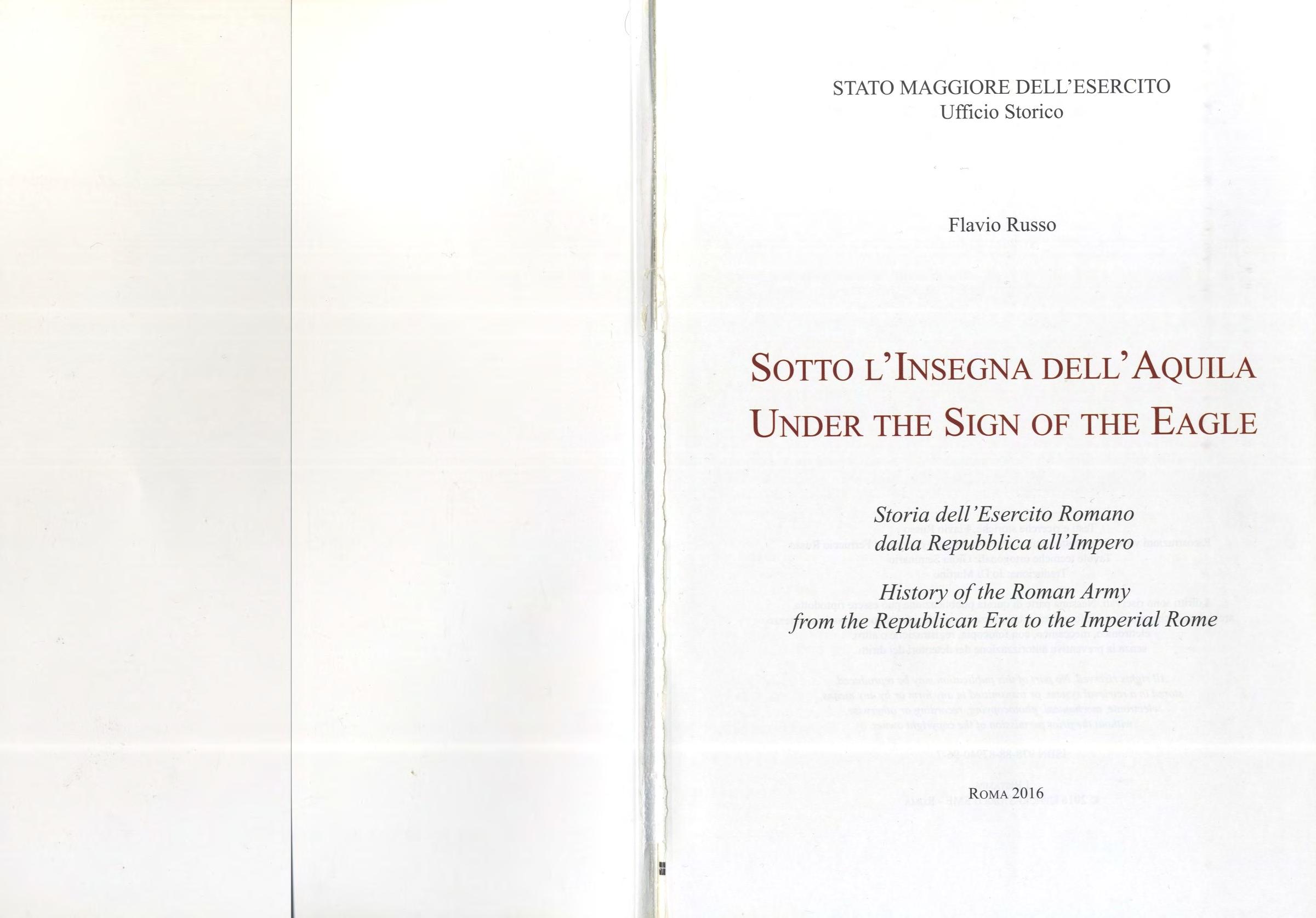
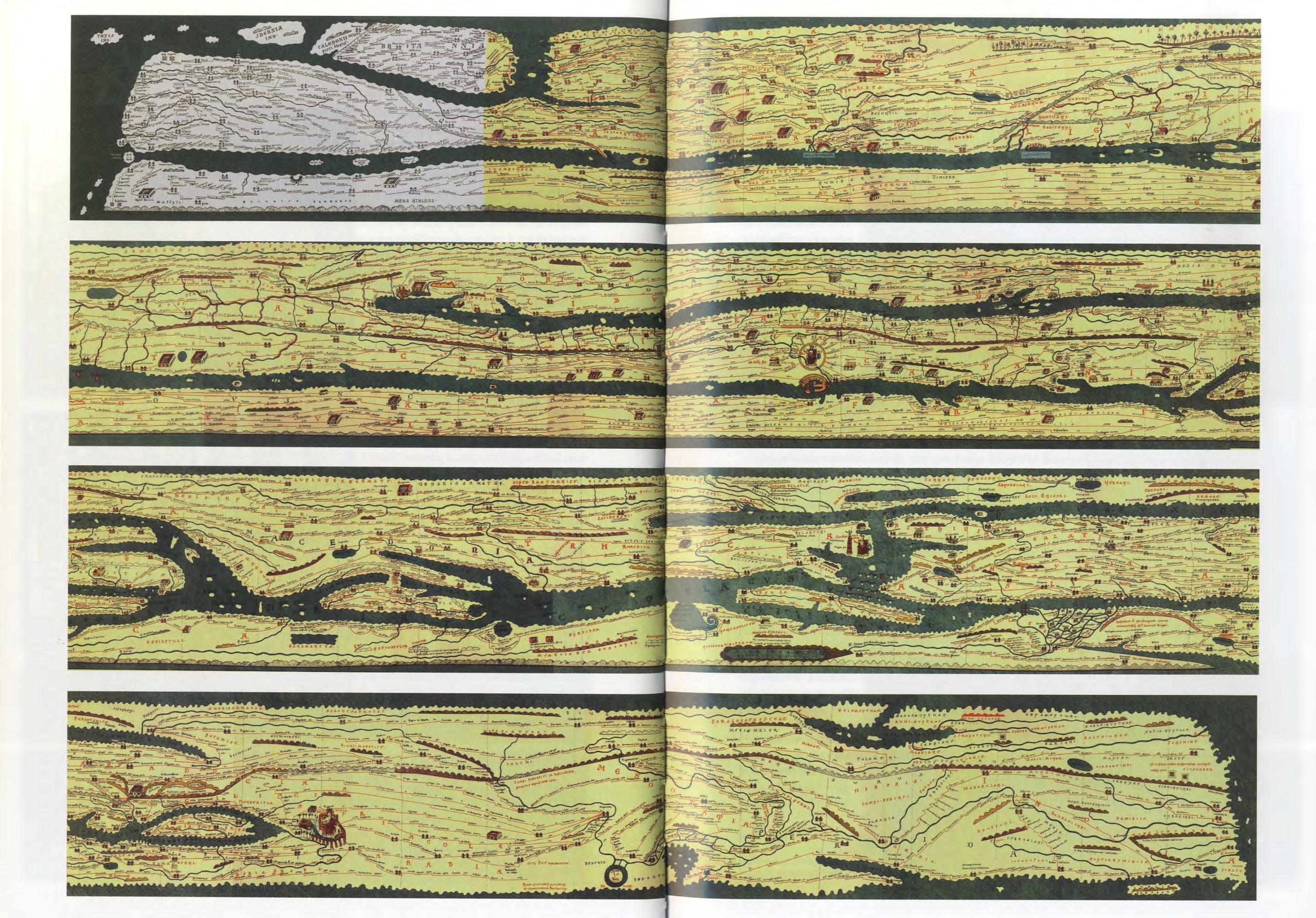
L'impero. quindi. già dal suo avvento sembra non manifestarepiùalcunaspinta espansionistica @ il suoenormeesercitosi muta da forza aggressiva in difensiva. con gli our cambiamenti di tattiche ed arma menti. Questa apparentemente modesta modifica, ealle spalle della trasformazione dellelegioniedeivari corpi annati. nel disperato tentativo di frenare il collassoe la dissoluzione sempre più incombente. Ciò
premesso,lavera grandiositàdell‘istituzionemilitareromana eranelnon avereancoradi fronteunnomico di forza ecapacità equivalenti. Se la ricostituzione di tre legioni per Roma eranoun problema. la costitu» zione di venticinqueper qualsiasi altro statodell‘epoca appari\anouna chimera assolutamenteirrealizzabile! Se mai restasse un qualche dubbio al riguardo lo fuga l‘impresa tentata da Augusto. nel 6 d.C.. di spingereildominiodelfimperofinoall'Elba.Nella circostanzadelleventottolegioni ancoradisponibiliben dodicipreseroparte all‘impresa. lasciandoperciòallerestanti l'oneredell‘interadifesa. E nonostante la ri— levante decurtazione non vi fu alcuna conseguenza.
Giustamenteestatorilevatoche:“lacaratteristicapit . iprentlentedelsistemadisicure: imperialedella dinastia Giulia»Clattdia è rappresentata dallasua "economiattifot:e'.Alla mortediAugusto, nel 14d.C.. [ territorisoggettialcontrolloimperiale.siadirettocheindiretta, comprendevanoleregionicostiereditutto il bacino del Mediterra— neo. l'interapenisola iberica. ]'entroterrtr continentale europeo fino al Reno eal Daf nubio, ]'Anatalta?.più lontano. il regno del Bosforosullecostesettentrionali del Mar Nero. Il controllo su tutto questo vasto terr ritorio era £_’_ ìt‘at'ementeesercitatoda un piccolo esercito, il cui contingente era stato
LaMuragliaCinese
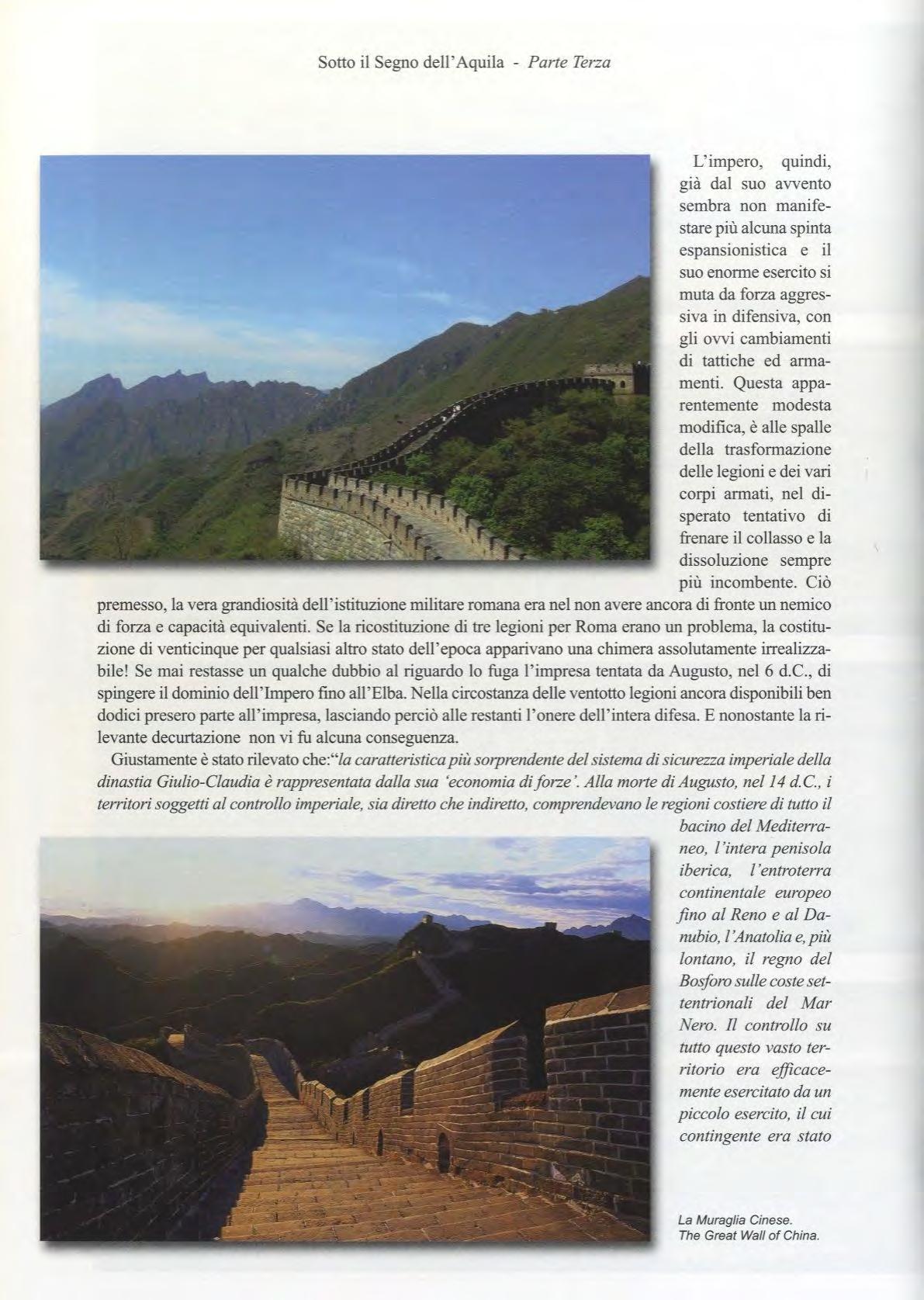
Sotto Il Segnodell'Aquila - Parte Terza
The Great Wall of China
ariginariarnentefissatoalliniziodelprincipatoesololeggermenteincrementata inseguito. Dopo ladisfatta di Varoeladistruzionedellesuetrelegioninel 9 d.C. rimasero, durante tuttoilregnoditiberio (14-37d.C.),soltantoventicinquelegioni. OttonuoveIegionifitrono costituitenelperiodofra !’ascesaalpoterediCaligola (nel37d.C.) elaguerraciviledel6970d.C,maquattrofiorinosoppresse,percuisono Vespasianoesistevanoventinovelegionief fettive.‘solouna inpiùrispettoalnumerooriginariamenteistituitadaAugusto.”“
Sebbenesulnumerocomplessivodellelegioni esullesuepiccoleoscillazioninonesi» stanodubbidisorta,nerestano,invece,sull’entitàdellalegioneall’epocadiAugustoenei periodi successivie,ancordipiù,suquelladelletruppeausiliarie,Alriguardo è necessariosubitounasommariaprecisazione:lalegionecheMarioavevafissatoa6.000fantie 120cavalierieridotta a5.000,distribuiti indiecicoorti,fermorestandol'organicodellacavalleria…Ilchegiàporterebbe adunadecurtazionecomplessivadicirca25.000uomini,pari al 10%deltotalepiùverosimile.

LEMANSIONIDELL’ESERCITOIMPERIALE
Lefunzionichevenneroafiidateall‘esercitoapartiredall‘avventodell’Imperofurono,perunverso, lasemplice continuazionedelletradizionali mansioni squisitamentemilitari, perun altro,delleattivitàradicalmente nuove,Questederiwvanoingranpartepropriodall‘immensarealtàterritorialeesocialedell’impero,cherendevacomplessoedarduoil mantenimentoal suointernodellalegalità,dell’ordinepubblico,dellariscossione deitributiedellagestionedeiwn'serviziprimari.Nonesistendoistituzionidifferenziateperlagestionediciascunafrmzione,nulladiequivalentecioèai nostri sistemigiudiziari,fiscali,amministrativi,sanitariedipubblicasicurezza,fuinevitabilechetuttequelleesigenzefinironoperricaderesull’esercito,l‘unicaforzanon solo armatamaancheorganizatarazionalmente.Inpocheparole l'insiemediquellemolteplicievariegateesigenze potrebberaggrupparsiinduebranche fondamentali:sicurezzaesternadello Statoedelsuoassettoterritoriale inognicontestogeogaficoe,alcontempo,sicurenainternadeicittadiniedeilorodirittifondamentali.Nederivò unnuovoesercito,nettamentediversononperle caratteristicheesteriori,per gli organigrammiel‘entità complessivachein sostanzarestaronopressappocoimmutati,maperi compitielecompetenze.Maiinepoca rqaubblicanaisuperstitidiunacittàconquistatasisarebberorivoltialcomandantedelcampolegionario,perchiederglil’interventodeisuoimcniciperlacostruzionediunacquedotto!Maineavrebberosollecitatoilpareregiuridiconelleloroquestioniinterne,omagaril’interventodeimedicidellasualegione!Nésarebberosorteintorno allostessocampodellevivacicittadine,&forteincrementodemografico!Ne', infine,ilegionaridistanzasisarebberodovutifarcaricodellabonificadalbrigantaggioodellarepressionedellalocalecriminalità!
Inultima analisi siconfigura,annodopoanno,una formannataimpegnatasempresudue fi-onti.Diessi il primo, inapparenzaprioritario sebbenediscontinuoepercircaduesecolifondamentalmentealeatorio,contemplava ilpresidiodeilimes,con l’eliminazioneol’allontanamentoattivodeinemiciedelleloro iniziative. Circailsecondo,chesoloperlanostraattualesocietàapparescontatomache,perl‘epoca,costituivaunaassolutanovità,abbracciaval’interagammadellefunzioniinnanziricordate,inclusapurelasorveglianzanavale per ' ‘ qualsiasi 4 ' e,persino,gli ’ ' interventi diprotezione civile.Prestazionequest’ultimacheebbeilsuodebuttouflicialeeterribilenellamissionecondottadalprefettoPlinioil Vecchio,conlenavidellaflottapretoriadiMiseno,insoccorsoallepopolazioni colpitedallacatastrofevesuvianadel79.Percui,più
indettaglio,dalmomentochelo:“Statoromanonon hamaiavutol’ideadiorganizzareilmantenimentodell'ordineall'interrrodellepropriefirmriere,sonoimilitariasvolgerefitnzionidipolizia.
Sottoil
Segnodell‘Aquila - Parte Terza
Monetaconl'effigiediVara. Coinwiththeefi‘7gyofVams.
224
La loroazione, vasottolineato.puòaverecaratterepreventivo. Ma inquestocaso, illororuolosilimitaa
operazionidispionaggioperteneresottocontrolloglieventualifomentatorididisardini. Stationariieburgariisorveglianolestradeeimercati, elamarina certadi prevenireiln'tomosemprepossibiledellapirateria.InGiudea.deidecurioni sonostanziatineivillaggi, edeicenturioninellecittà:altrigraduatiancora hannolaresponsabilitàdicontrollarequelchesidicenellescuole.
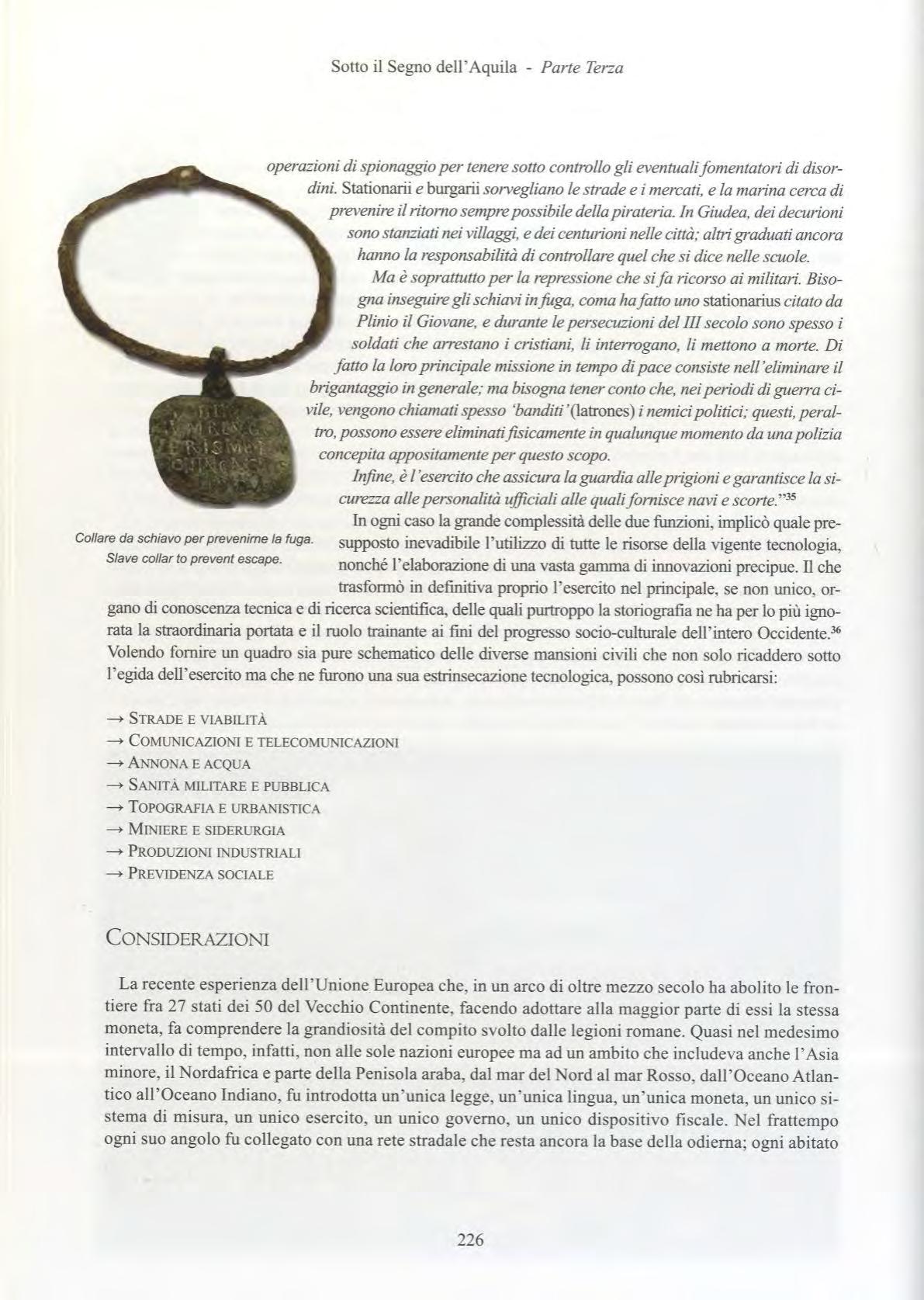
Ma èsoprattuttoperla repressionechesifi:ricorsoaimilitari. Bisof gnainseguireglischiaviinfuga,comahafilllDunosmtionariuscitatoda Plinio ilGiovane, edurantelepersecuzioni delIIIsecolosonospessoi soldatichearrestano i cristiani, li interrogano, li mettono a morte. Di fimolaloroprincipalemissionein tempodipace consistenelleliminareil brigantaggioingenerale;mabisogna tenercantoche,neiperiodidiguerracivile, venganachiamatispesso ’banditi'(latrones)inemicipolitici;questi,peraltro,possonoessereeliminatifisicamenteinqualunquemomentodaunapol'zr'a concepitaappositamenteperquestoscopo.
Infine, èI esercitocheassicuralaguardiaalleprigioniegarantiscelasi cumaallepersonalità ufiîeialiallequaliforniscenaviescorte…”35 lnognicasolagrandecomplessitàdelleduefunzioni.irnplicòqualepreC°”a’eda SC”ÌEV°P°'P'EVE”ÌMSlafuga. supposto inevadibile l’utilizzo di tutte lerisorse dellavigente tecnologia, sme°°”ar"’”’“V9m”ca’-’E' nonchél’elaboran'onediunavasta gammadi innovazioniprecipue. Ilche trasformò in definitiva proprio l‘esercitonel principale. senon unico. organodi conoscenzatecnicaediricerca scientifica,dellequalipurtroppolastoriografianehaperlopiù ignorata la straordinaria portata eil ruolo trainante ai fini del progresso socio—culturaledell’intero Occidente.“ Volendo fornire un quadro sia pure schematicodellediversemansioni civili chenon solo ricaddero sotto l’egidadell’esercitoma chene furonouna suaestrinsecazionetecnologica,possonocosirubricarsi:
% STRADEE VlABILITÀ
—> Comunrc:azromETELECOMUNICAZIONI
—> ANNONA EACQUA
—> SANITÀ MTL]TARE E PUBBLICA
—>ToroorrArm EURBANISTICA
—r MINIERE E SEDERURGIA
—>Paonuzrom mnusrrrmu
_. PREVIDENZAsocw.e
CONSIDERAZIONI
Larecente esperienzadell’UnioneEuropeache, inun arcodioltremezzo secoloha abolito le frontiere fra 27 stati dei 50del Vecchio Continente, facendo adottare allamaggior parte di essi la stessa moneta, facomprenderelagrandiositàdel compitosvoltodallelegioniromane. Quasi nel medesimo intervallo di tempo, infatti, non allesolenazioni europeema ad un ambitocheincludevaanchel’Asia minore, ilNordafrica epartedella Penisola araba,dal mar delNord al mar Rosso,dall’OceanoAtlantico all’OceanoIndiano,fu introdottaun’unica legge,un’unica lingua,un’unica moneta, un unico si— stema di misura, un unico esercito, un unico governo, un unico dispositivo fiscale. Nel frattempo ogni suoangolofucollegatocon unarete stradalecheresta ancora labasedella odierna;ogni abitato
Sottoil Segnodell’Aquila Parte Terza
226
ebbel‘acqua corrente,ancheseper por— tarla si dovettero costruire acquedotti lunghi fino a 150km;ogni cittàcostiera disposediun porto dovetutte lenavi, sicure dall‘insidia di qualsiasi pirata, potevano liberamente commerciare. E ciò accaddenonperun’obbedienza pedissequa a rigide norme imposte da una dittatura militare, ma per convincimento diretto, dimostrandosi anche ai più recalcitranti e renitenti la migliore delle situazioni auspicabili. Possiamo, soltanto oggi e per facili ragioni, capire quanto potesse essere complesso un sistemadiprevidenza socialeestesoanche solo alla classe militare, con liquidazioni ed indennitàvarie di congedo. Soluzione che supponevauna amministrazione economica oculatissima ed un valore monetario costante nel tempo. Di certo non si trattò di eventi fortui ,maesitodicompetenzecheimplicavanopadronanzetecnichein segiitoperseesistemi attuativi in seguitodimenticati.Ilchecostituìun saltoevolutivopermoltissime delleetniefagocitate dall’Impero, che vennero cosi portate allo stesso livello di Roma, senza alcuna preclusione ideologica orazziale. Realtà chea tutt‘oggi non ci sembrano né immediate né alla nostra portata.
Giustamente è statoevidenziatoche:“perquanto, inalcuneoccasioni, iRomaniabbianoinflittaduri castighi, deve essere ricordato che ipopoli, in queitempi, conducevano le loroguerre in modi che oggidefiniremmo inaccettabiliper una società civilizzato... Ingenerale, i vantaggiguadagnati con !’entratanelmondo romanoeranoenormi.Ilpiùgrandeincoraggiamentoallafelicità in tutta lastoria dell’uomo è stato,dopo tutto, laserenaaspettativadellagentecomunedipoter vivere lapropria vita, curarelapropria terra ecrescereiproprifigli, inpace. L ’esercitoromano ho creatocondizioni per cui, per interi secoli, un contadino ha potuto arare ipropri campi, certo che nessuno sarebbe giunto::depredarlodeifruttidelsuolavoroe,pergiunta, a ucciderlo oa rendereschiaviluielasua famiglia.
Nella PaxRomano, un uomopoteva viaggiareda Palmira, in Siria, a Eboramm, nella Britannia settentrionale, senza un passaporto esenza maisentirsicompletamente un estraneo. Ovunque sia giunto, Romaha riprodottouna versioneinminiatura dellacittàmadreconisimimercati, leterme, itemplietutte lealtrecomplessitàdellostiledivita romano. Ederadellacreazionediquestibeneficiedelmanenimento di quell’ordineche era direttamente responsabilel’esercitoromano...“”
Non a caso al centro di quasi tutte le principali cittàcircluneditenaneediantica fondazione, è facilericonoscereun incrocioortogonalediduestrade:sonoquelche restadelleviapraeton'a edellaviaprincipolis, le due strade che spartivano il campolegionarioin quattroquartieri!”
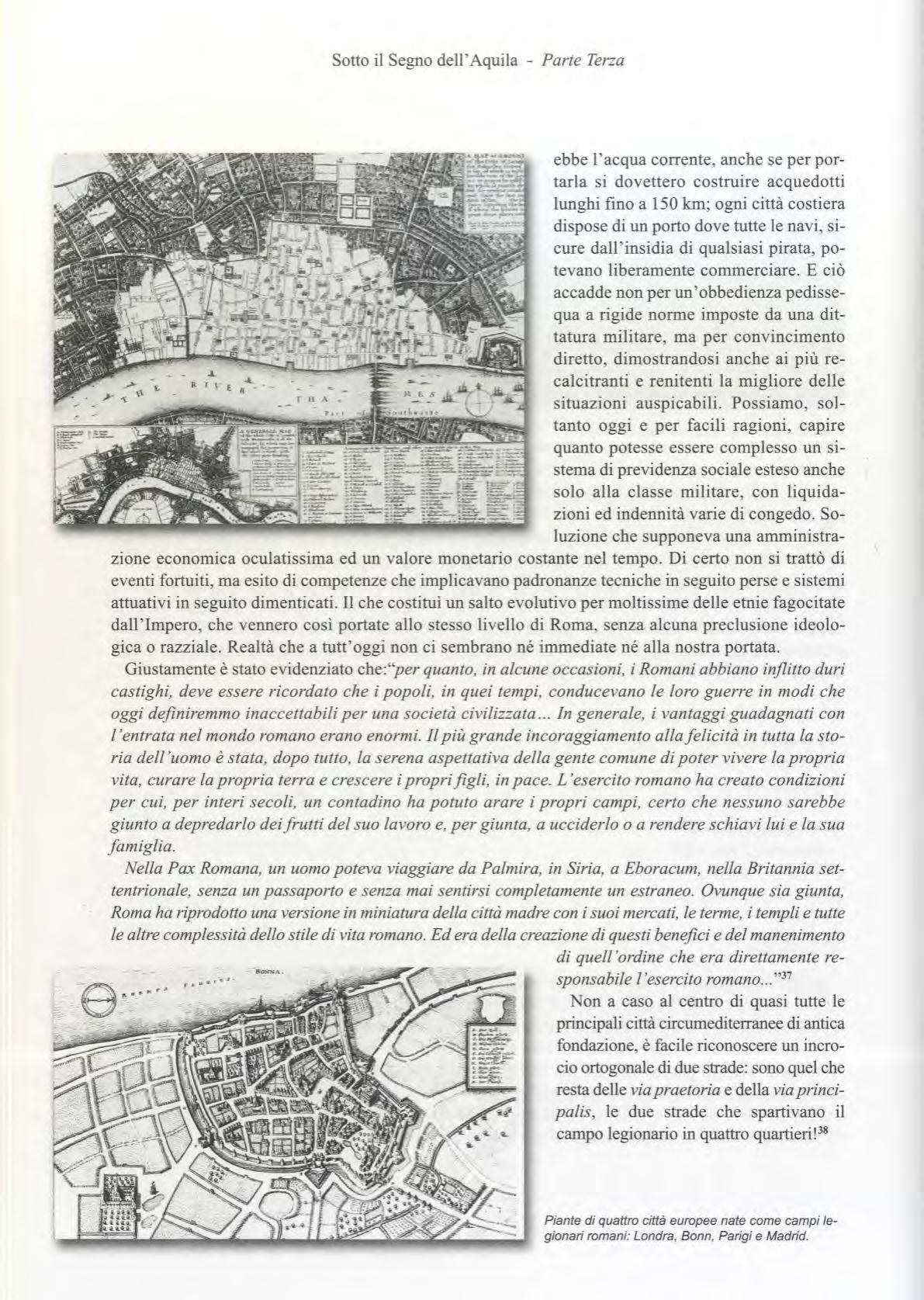
Sottoil Segnodell‘Aquila - Parte Terza
Piantediquamattaeuropeenatecomecampilegionan'romani:Landra.Bonn.ParigieMadrid.
ROM.-\:IL PRAETORIL'MDELL'IMPERO

Sebbenesottoilprofilo meramente formaleAugusto fossesoltantoil primo cittadino. ilprinceps. in pratica il suo volere si estendeva al controllo dela l‘elezione di tutte le magistraturee al comandodi tutte leforzearmate.Una sostanzialediversitàdi concezionenella nuova strutturapolitica o,più prof cisamente. ildoppiopotere.politico emilitare, concentratonellemani diun unico uomo a tempo indeterminato. comportò una modifica anche nella stessa definizione di Roma. Se il comandante supremo dell’esercito. l’ima peralorneerapure il sovrano.lacittàoltreadesserelasua capitaleela sede della sua reggia. era al contempo il suo quartier generale. propriamente definito il praetoriurn. Per alcuni storici il nome e l'origine delle coorti pretorie discendevanodallaristretta scortadi cui 51circonda\ano i magistrati repubblicani…meglio noticomepretori. quandopartivanoincampag1a.llvocaboloaveva.quindi,una chiaravalenza militare. derivandodalla voce verbalepine-ire. da cuiprae-irrìrem. ovverocolui che cammina avanti.colui che precede, cheva innanzi,cioèilducesupremodell‘esercito.Perovviaconseguenza,tutti i legionari scelti, preposti allasuadifesapersonale eschieratinel campointomo allasuatenda.ilpraetorium appunto,furono ben presto definitipretorianie GuardiaPietorrana.
Per altri studiosi.invece.ele due ipotesi potrebberocoincidere. il criterioinformatore sottesoalla istiruzione della Guardia Pretoriana e delle sue corti pretorie. deriva da una discussa e discutibile prassi adottatadaimaggiori generali roma '.Questi,sul finiredellaRepubblicaeranosolitifarsi scortareda una propria guardia del corpodi soldatisceltissimi.per lopiù d’origine germanica. Essendo il lorocompito primarioquellodipresidiare ilpraetorium.finirono denominatipretoriani. La preferenza accordata alle reclute di estrazione barbara. nascondeva la generalizzata difiidenza che ormai serpeggiava fra gli alti gradi dell’esercitoefra i politici di turno. sempre invischiati in congiure.
I CORPI DELL’ESERCITO IN ETÀ IMPERIALE
L’ampia massa diuomini arruolatinelle legioni che In qualchemodo finirono nella disponib 'tàdi Angusto.gliconsentìdiprocederedaunaparte aduna selezione.finoadalloraimpossibile.dal]'altraallacrea— zione di nuovi corpimilitari, dimostratisi necessari per le molteplici fimzioni civili emilitari che lanuova strutturastatualeavevaresoindispensabili. Il passaggiodallaconcezionedi uno Stato considerato una mera pertinenza territo rialedellacittàdi Roma.una sortadi periferia allargata,a un Impero che includeva fi'a letantecittàancheRoma comeaccennato, aveva evidenziato tutta una gamma diesigenzeediproblemi cheall‘epocasoltanto l'organizzazione militare poteva in qualche modo contribuire a risolvere. La stessa Roma, con il suomilioneepassa di abitanti…dimensione demografica urbana
Elementodlcondottaforzataevanodiunstfone … Sltoconconcezionesimilare.
Sectionofpressureconduitands/phon.ofsimi/al concopfion
Sotto il Segnodell'Aquila -
Pane Terza
senzaprecedenti fin quasial secoloscorsoinnessunapartedelmondo.comportavauna miriadediproblemi complicati daaffrontareecomplessidarisolvere.suiqualidifficilmente lastoriografiasiconcentra. L’approvvigionamento idrico. ad esempio,oquelloalimentare0, ancoraquelloenergetico, sistematicamente ignorato ma di certobasilare dal momento che l’unico combustibile usatoper riscaldare e cn— cinare era costituito dalla legna, ne emiro alcuni. Esistevano senza dubbio i grandi acquedotti che riversavano nella cittàverifiumi,ma qualepoteva esserelarete internadidistribuzione?APompeinessunacasadistavapiù di 50m da una fontana pubblica, emolteavevanol'allaccioallarete pubblica con tubidipiombodivaria sezione:ma perRoma sipuòipotizzarequalcosadisimile?Ogni abitantesideve presumerecheconsumasse almeno500g dipane al giorno,ma come siproduceva e soprattuttoquanta legnaoccorrevaper lasuacottura? Equantaancoraneservivaper ilriscaldamentoolacucinadellecase private? Problemi edifi'rcoltà che essendogià risolti per lanostra tecnologia inducono a credere che lo stessopotesse avvenireancheper i Romani,criterioassolutamentegratuito!
Ma ve ne eranoaltri ancora, non minori, come la pubblica sicurezza,vuoi comeprotezione dalla de— linquenza che dallecalamità naturali, come i frequenti straripamentidel Tevere, oaccidentali,come gli incendidi interiquartieri,persinopiù frequenti.Tuttesfideperuna amministrazionecheaccennavanelle suemani og‘ti aspettodella vita ciV|le echefiniva per poter contare soltanto sulleforzearmateper poterle espletare.Questo, in baseallefonti, l’interoorganigramma di tutto l'apparatomilitare eparamilitare cheprese l’avviodalleriformediAugusto.
LA GUARDIA PRETORIANA
Nel 27 o26 a.C., Augusto organiaòilgruppo dei suoipretoriani inun nuovo corpo, leCooniPretorio compostoperl’esattezzadi9coorti,di500uomini ciascuna.Essivenivanoarruolatitraimigliorilegionari italici,traendoli inparticolare dal Lazio,Etruria,Umbria,Piceno…Ancora nel Il secoloi trequarti deipretoriani proveniva dall’Italia centrale, mentre i restanti provenivano da province fortemente romanizzate. Lecoorti ebberounanumerazioneandantedal aIXecomeemblemaunoscorpione,il segnozodiacaledi TiberioenelloroinsiemecostituivanolaGuardiaPretoriana.Amp0diciascunacoorteun tribunoeseicen» turioniper l’inquadramento.lndettaglio:“questiultimi, nel!insieme,sonougualifialoro, adeccezionedel trecenarius, cheè ilprimaditutti, eilcuinomederivadalfattocheeglicomandai300speculatores(unal’ traguardia tie/principe), eadeccezioneanchedelsuosecondo, ilprinceps castrorum Le cortipretoriedette equitate, in quanto comprendonoalcuni cavalieri (1/5?) accantoa una maggioranza difiznti(4/5?).”39
Tiberio, dopo il 14d.C., ne affidò l’organizzazione a Lucio Elio Seiano chenefililpotenteprefetto…intornoal20-23prese l’ardirediinsediarlenella stessaRoma,perl’esattezzanovenella suaperiferia etreall'internodelsuo abitato…Ne derivòperquesteultimeladefinizionediCooniUrbane. La carrieradiSeiano,nonostantel‘immensoprestigioderivatoglidallafiduciadell‘imperatore,siconclusenel 31sulpatiboloperaltotradimento.Inognicaso, fit con lui cheuna intera grandeunità militare sistabili,per laprima volta, nella città,insediamentofinoadalloramai ipotizzatone' conosciuto senon nell’ambitodiun colpodistato.ARoma, infatti,peruna consuetudine antichissimanoneraconsentitoilsoggiornoaimilitariinarmi.Maitempierano ormai completamentediversiper cui,inbreve, non suscitòpiù risentimenti vederlicircolaredipattuglia,operordinesparso,comepure sfilareinparata sfatzosarnenteequipaggiati.Tuttavia.ondeevitareinutili tensioni erecipro—
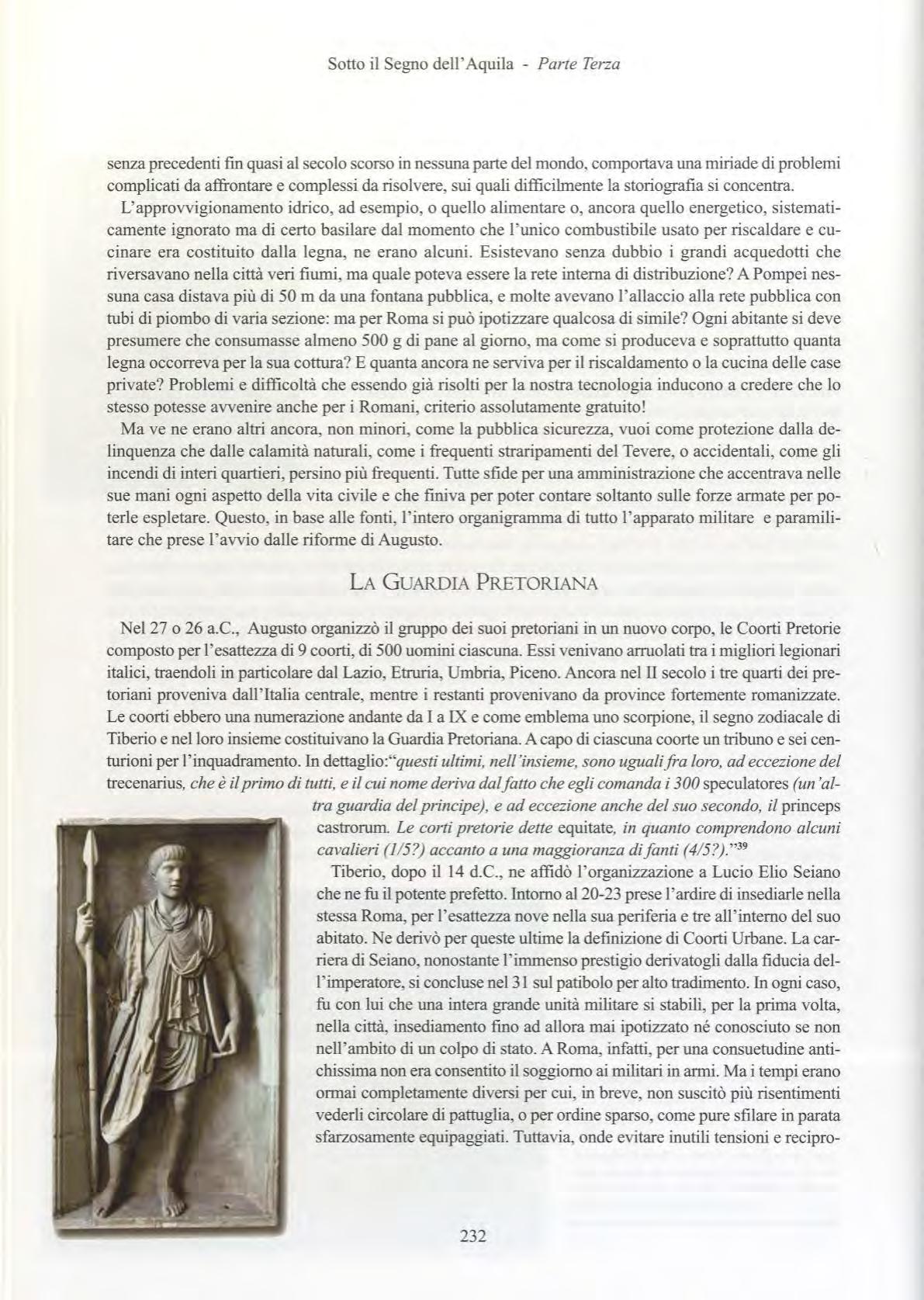
Sotto il Segnodell‘Aquila -
Parte Terza
232
cheintolleranzefraciviliemilitari.ancheipretonani ebbero unloroprecisoaccampamento. Definito, per ovvi motivi, CastroPretoria,fu ubicato tra ilViminaleel’Esquilino,dove ancorapermane intattalacinta e sostanzialmente immutata la destinazione militare. Le sue dimensioni, rn 440x380, per complessiviha 16.72,risultano leggermente minori di un campo legionario, oscillante fra i 18ed i 20 ha, difformità ulteriore che sembra volerne sottolinearelanon piena equiparazione militare. Ad onta Roma:vedutasatellitarede!CastroPraiano. dellaspregiudicatezzadi Seiano.i CastroPretoria sitrovanoaldilàdelle Rome:satelliteviewoftheCastroPretorio mura senriane, owero al di fuori, sia pure dipochissimo. della cerchia chedelimitava la cittàantica, Dettaglio datenere nella debitaconsiderazione,poichénon avendoRoma altremura fino a quelleAureliane, erette solotra il 271 e il 279, sottolineava il sostanzialerispettodeldivieto.
Anche l‘opzionedi limitare l’organicocomplessivodellaGuardiaPretoriana asolenovecoortienon le tradizionali diecidituttelelegioniuadiscelaripugnanzaataleequiparazionecheavrebbedi fattosignificatolapresenza aRoma diuna legione, ’ ‘ non “ ‘' dalla ‘ neppure in quel nuovo contesto. In seguitoil loronumero fu portato a 12da Caligola,poi a 16daVitellio e finalmente a 10da Domiziano: ma ormai nessuno si scandalizzavapiu di niente! Sottol’aspettomilitare la:“GuordiaPreloriana,compostadicittadiniromani, costituivalaguardiadelcorpodel]imperatore... [e sia] perevitareilpericolodicomplotti,eperchélapresenzadiunafinzocosinumerosonella capitalecon— trastava decisamente con letradizionirepubblicane, oRoma avevanostatua tre coorti soltanto; le altre erano dislocate in città vicine. Dapprima ciascuna coorte/il al comandodiun tribuno, mentreAugusto aveva ilcomandogenerale. Ma dal2a.C. ilcomandodellaguardiofuaffidatoaduepraefecti pretoriodi rangoequestre, equestoduplicecomandofuquasisempremantenuto.
]pretorianieranoselezionaticoncuraegodevanodinumerosiprivilegi infintodipaga edipromozioni, peresempio[pari]acenturionatilegionari. Lofenna,fissatoadodicianninel 13a.C.,fuaumentataasedicine] 5 a.C.In origine,sembrachelapagafossedi375denarii all'anno, ma allafinedelregno diAugustoessaerasalitoa 750, egiunsea 1.000denariisottoDomiziano.Eramoltopiù diquantoricevevano ilegionari, ecosì!indennitàdicongedo,fissata daAugusto in 5.000denarii.NelsuotestamentoAugusto lasciòaipretoriani 250denarii ciascuno, difronteai 75dellegionari]…Essendoun corpopreposto unicamenteallaprotezione dell'imperatoreedeisuoistretticollaboratori efamiliari,fini, inpratica,peroccuparsidituttociòcheriguardavalavitaaRoma,dallagestionedeglispettacoli,allariscossionedelleimposte, per finire anche adaiutarelecoortidei vigilesnellospegnimentodegli incendi!
Unabrevenotariguarda l’armamentodeipretoriani.agiustotitoloconsideratopiùdaparatachedacornbattimentopropriamente detto:riscontroemblematicol’elmo,spessodi foggiaattica,retaggio delperiodo arcaico. Tuttavia quandoprendevano parte a vere campagne militari il loro armamento non differiva da
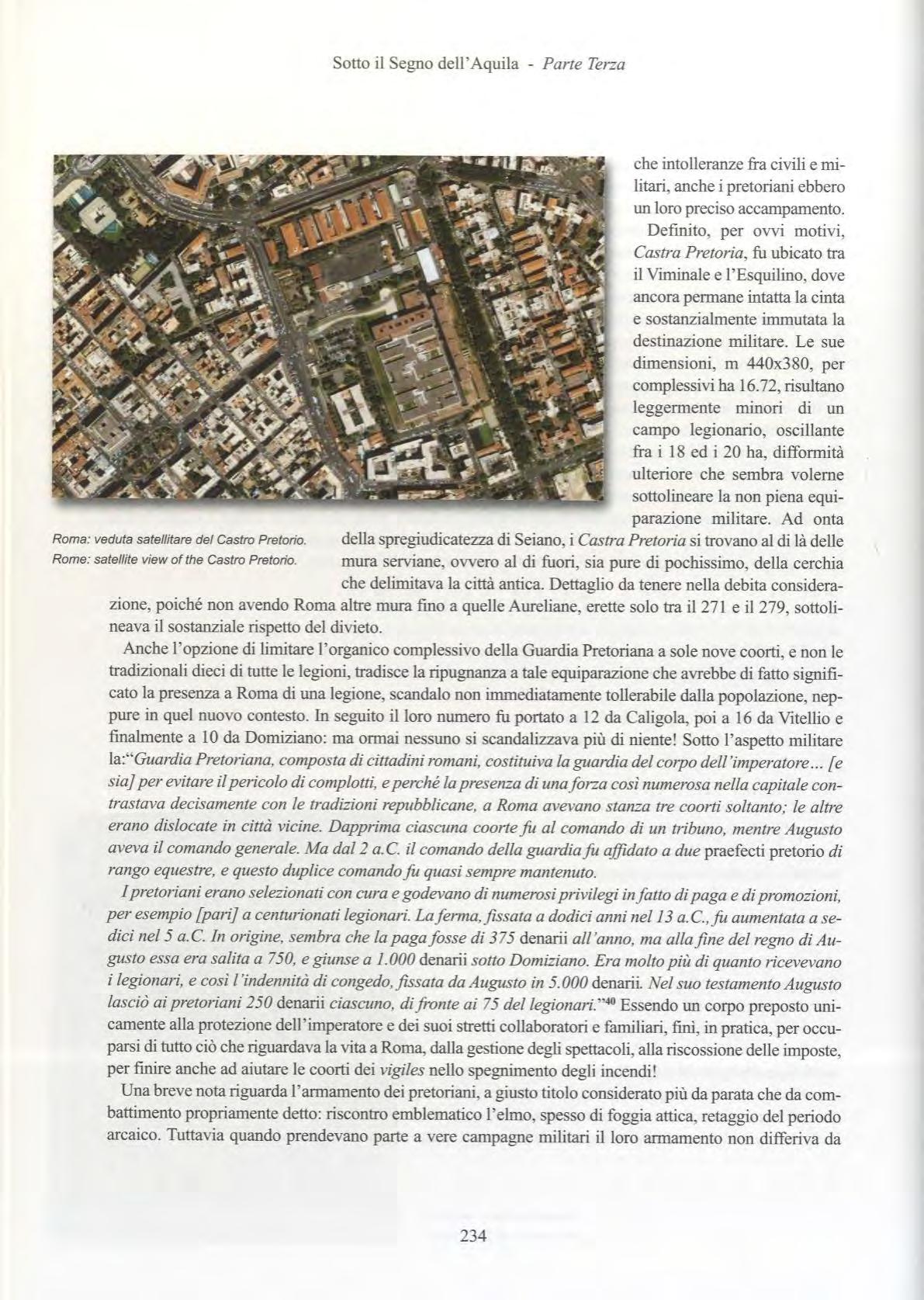
Sotto il Segnodell'Aquila
- Porte T€Iîa
234
quello d’ordinanza dei legionari. La Guardia Pretoriana, coinvolta sistematicamentenelle innumerevoli congiure dipalazzoenegli avvicendamenti degli imperatori,innescati in genereproprio dalla suacupidi— giaperdonativi straordinari…Atitolodiesempio,dopol’uccisionedi Caligola,Claudioascesoaltronoper l’acclamazionedeipretoriani,feceelargireaciascunodi loro 15.000sesterzi.Ilcorpo,dopounprimoscioglimentovoluto daVitellio nel 69,che insediòal loroposto sedicicoorti di legionari di stanza in Gennania, fudefinitivamentesoppressonel 312.
GL]SPECULATORES
GliSpeculotores,chetraevanoilnomedallavoceverbalelatinaspeculare,guardarsiattorno,osservarecon unatraduzioneliberasarebberodadefinirsiesploratori.Inrealtà,però,furonouncorpod’élite,selezionatoper giuntafia gli organicidiun altrocorpod’élite!Eranotratti, infatti,dallaGuardiaPretoriana, per l’esattezza dai suoireparti chefornivanolascortaravvicinata all’imperatore,1asuaguardiadelcorpochenonl’abbandonavamai, inqualsiasicircostanzaeconatoquotidiano…Pertantoi 300uomini dicuisicomponevailcorpo,avrebberodo» vuto rappresentare quantodi meglio, almeno sottoun determinatoprofilo,vifossenell’esercitoromano.Aco— mandarliprovvedeva un centurioneappositamentepresceltoedesignatocome CenturioSpeculatorum,ritenuto gerarchicamentepreminentefratuttiicomandantidelcampo, AureaconAgrippinaeClaudio. Essendo,insostanm,deipretorianiancheglispeculatoresalloggiavanoneiCastro AureuswithAgrippinaandclaudio; Pretorio,insiemequindialrestodellaGuardiaPretoriana Daunpuntodivista meramente operativodurantealcunecampagne,eprobabileche glispeculatoressvolgesseroanchefunzionidi esploratori avanzati…
LE CoormURBANE
Oltre allenove CoortiPretorie,Augustonel 13a.C.ne istituì anche altretre, definendoleCoorti Urbane, Corpodiimportanzanotevolmentepiùmodestadelprimo,sebbene,quasi&volerneevidenziareLacontiguità, neproseguisse lanumerazionedesignandosilesuddettecoorti X,)Ge)G].Costituivaormail’ultimaforza armatachedipendevaancoradirettamentedal Senato,dalmontatocheacomandarleprovvedevailPrefetto dell'Urbe,sceltofiaisenatori.E,nondirado,quandoleinterferenzeeleintimidazionideipretorianidivenivanopiùviolente,eranoproprioleCoortiUrbaneaschierarsiaprotezionedelSenato.Claudio,certamentememore di tali interventi,ne incrementò ilnumero asetteche,però, allafine delprimosecolofinirono sottoil comandodelprefettodel Pretorio…
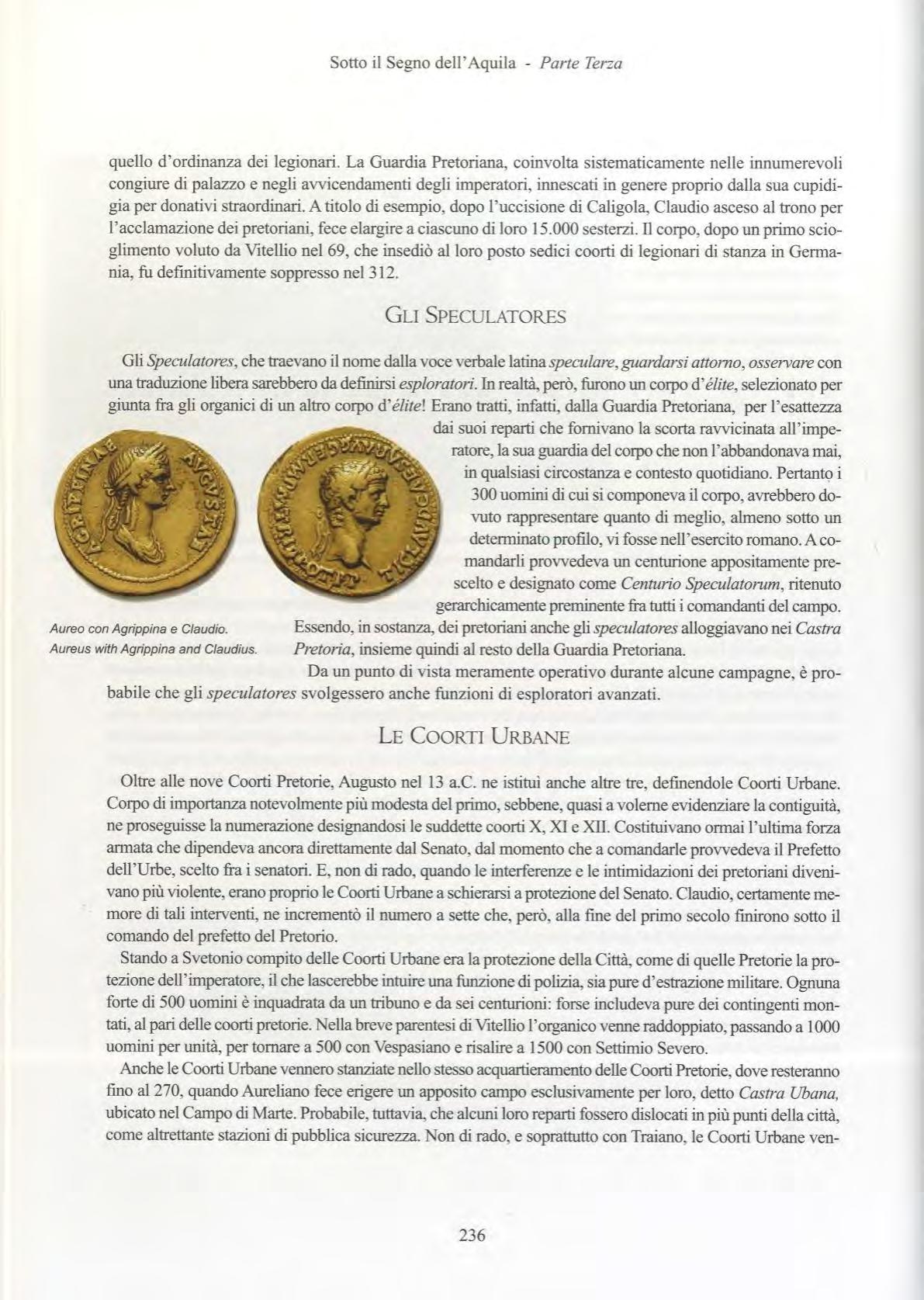
StandoaSvetoniocompitodelleCoortiUrbaneeralaprotezionedellaCittà,comediquellePretorielaprotezionedell’imperatore,ilchelascerebbeintuireunafunzionedipolizia,siapured’estrazionemilitare.Ognuna fortedi500uomini &inquadratadaun tribunoedaseicentra-ioni:forseincludevapuredeicontingentimontati,alparidellecoortipretorie.NellabreveparentesidiVrtelliol’organicovenneraddoppiato,passandoa 1000 uominiperunità,pertornarea500conVespasianoerisalirea 1500oonSettimioSevero.
AncheleCoortiUrbanevennerostanziatenellostessoacquartierameutodelleCoorttiPretorie,doveresteranno fino al270,quandoAurelianofeceerigereun appositocampoesclusivamenteper loro,dettoCastro Ubana, ubicatonelCampodiMarte.Probabile,tuttavia,chealcunilororepartifosserodislocatiinpiùpuntidellacittà, comealtrettanmstazionidipubblica sicurezza.Non dirado, esoprattuttoconTraiano,leCoort:iUrbaneven-
Sottoil Segnodell‘Aquila Porte Terza
236
nero impiegateanche in campagne militari.ma per lopiù intervenneroper stroncaree soffocarerivolte. Nel 312scamparonoallasoppressionedelleCoorti Pretorie. … nel corsodellostessosecolo.cessaronodi essere un corpomilitaretrasformandosi insezionidi impiegatial serviziodell‘arnminisn‘azione. Sisachealcune di taliunità vennerodistaccateanche fuori da Roma edinparticolarenei bacini minerari.pressoLione e Cartagine.Quantoalladotazione,armamentoedequipaggiamentoerauguale aquellodelleCoom'Pretorie.
GLI EQUITESSINGULARESAUGUST!
Si trattò diun corpo specialedi cavalleria romana, da cui il nome, in cui singularesva appuntointerpretato come speciale. Scanu-idalla constatazione della scarsa fedeltà della Guardia Pretorianaper cui si affermò, già al tempo diAuglsto, l‘abitudine di trarre un contingente di guardie del corpo, corporis eustodes, di entità compresa fra i 100ed i 500uomini, proprio tm i Germani e i Batavi, i più refrattari alletrame eal tradimento… Per ragioni facilmenteintuibili, tale formazione sidovette sciogliereall’indomani del disastrodi Teutoburgo,ma fu ricostruita meno di cinque anni dopo,quandoCaligola lamilitarizzò definitivamente. Altri scioglimenti ed altre ricostituzioni si avvicenderanno nelle epoche successive, aseconda dell’indole dell’imperatore di turno. La sua protezione ravvicinata, in ogni caso, veniva fornita soprattuttoda un corpodicavalleria di specialedistinzione, appunto gli equitessingular res, chevennero formativerosimilmentedaTraiano, in unità definitenumems, forsedi 500uomini iniziali ascesiben presto a 1000.Acomandarliprovvedevanodei decurionh quindiun decurioneprinceps, edun tribuno, a suavolta subordinatoaun prefetto del pretorio.
Iloroacquartieramentifurononeipressi delLateranoeduna caserma,edificatasulCelio,nelcorsodel [ secolo,alloggioduedistaccamenti con funzionicontigue. Di questi:“i ‘peregrim'‘servivanodapoliziapiù omenosegreta;eranoincaricatidiapplicaregliordinidel sovrano attraverso l'Impero; obbedivanoacenturionialoro volta sottoposti a un subpriceps e a un princeps. I fiumentari', costituiti in unità e alloggiati a Roma probabilmente ratto Traiano. al più tardi sotto Adriano, svolgevanofunzioni di corrieri; si assumevano, all’occorrenza, ['incarico di esecuzioni di‘ screle di oppositori del regime, eparsavanoperspie:in lorosisono voluti vedere gli antenatideitristementefimosi agentesinrebusdelBassoImpero. Ma il loro piccolo nur mero (/ìtnzianavanocomeun numerusdi 90-100 saldati)haprobabilmente limitatoiloromisfatti...”
Nelle province esistevano degli equitesring:/lorex, da non confondersiperò con i precedenti ma che forseneebberolamedesima definizioneper l‘analogiadel compiti.Erano, infatti,assegnati ai govemator-i provincialiper scorta emissioni varie,
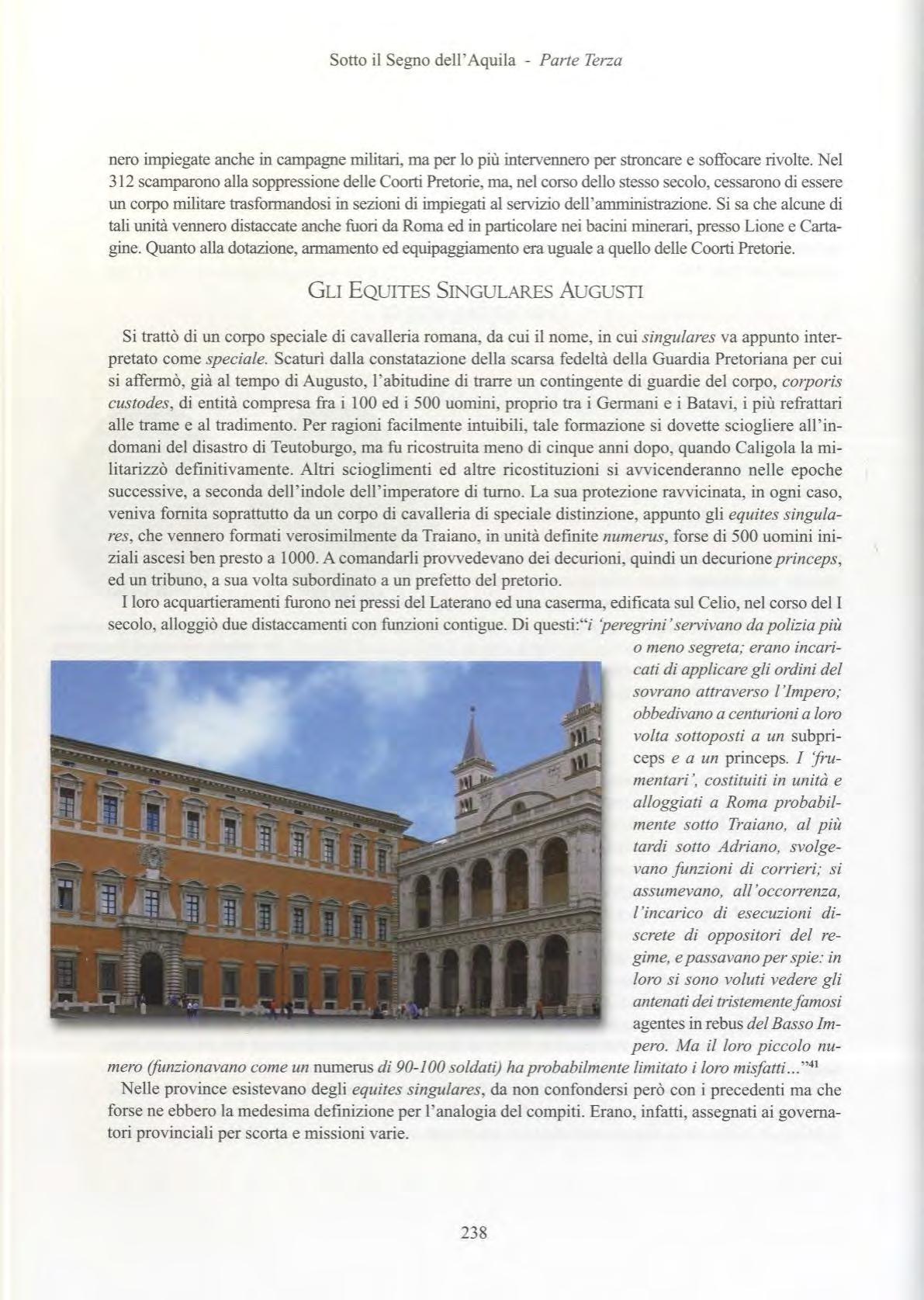
Sotto il Segnodell‘Aquila .Parte Terza
238
IVIGILI
Come in precedenza accennato. i Romani non ebberoun vero corpo di poliziadi Statosimileagli attuali edei quali dispongono,più omeno, tutte le nazioni. Le funzioni relative crane svolte dall‘esercito: questo almenonelle provrnce. In Roma però. quasi certamente qualv cosadel generevi dovette esseree sipuò riconoscere nelle setteCoonidei Vigili, Vennero istituitenel 6 a.C.daAugusto con due scopi: assicurare con ronde continue la \r'gilanza notturna della città. nonche' con adeguati mezzi la estinzione degli incendi. tragedia devastante quanto frequentenella città a causa delle sue costruzioni con molte parti lignee. Circa l’organico. inizialmente fu ap» pena di 600uomini.percuipiù chedi coorti sarebbecorretto parlare di centurie! Presto. però. fu accresciutoa settemila, raggiungendopertantoun organicomolto superiore.
La scelta di sette unità va relazionata alle quattordici re— gioni in cui era divisa la città. consentendo così di affidame a ciascuna coorte due comegiurisdizioned'intervento.Allo scopodi renderepiù rapidoed efficaceil servizio gli incendi infatti potevano essere contrastati tanto più validamente quanto p' im— mediato fosse stato l'intervento, nelle diverse regioni vennero insediate delle postazioni di vigili. Definite statia, stazioni o casermette, occupa vano deipunti baricentrici chene favorivano sia la prontezza di arrivo sul posto. sia la migliore ricezione degli allarmi lanciati da apposite guardiole dette excubiiorium. Alla via VII Caorle dei Vigili in Roma, sopravviveancora l'ingressodi una di tali stazioni.peraltro di discreta ricercatezza architettonica.
Per meglio valutare la difficoltà del loro compito va ricordato che gli edifici da sorvegliaree daproteggere in caso d’incendio ammontavano a circa 150.000.(! i in 423 quartieri. detti anche vici, nei quali alloggiava quasi un milione dipersone. Questa cifra chepuò sembrare eccessiva sca— turisce daun precisocalcolo,cosi dipanato:"c’èpoi ladichiarazionediAugusto. nellesueRes Gestae, quando... nel 5 a.C. «diedesessanta denari(: ognunodei320mila cittadini»checomponevanolapleberomana. Ora. secondoiterminiche I imperatorelia llSflîl meditatamente, taledistribuzione fueffettuatasoloagliadultimaschi…sicchénerestano escluseledonnee i ragazzi aldisotto degli undici anni, che con gli uominifacevanoparte dell'Urbs. Ne deriva… che lapopolazione romana… toccava i 675mila cives. A questibisogna aggiungerelaguarnigionediuna decinadimigliaia diuomini. cheabitava inRoma... lamoltitudinedeiforestieridomiciliati, non; chéquellainfinitamentepiù 'mpoi‘tante, deglisc/iiai Dimoda chenoisiamo por/ali dallostessoAugusto a valutare lapopolazione totaledi Roma sotto il suogovernoauna cifi‘aassaiprosrima,eforrepersinaSuperiore,almilione”2 Duplice la dotazione dei vigili: per il servizio di ronda notturno comprendevalanternc.perquelloantincendiooltre adasce,ramponi.palezappe.corde ecopertebagnateper soffocarelefiamme.comprendevaanchedegli appositi
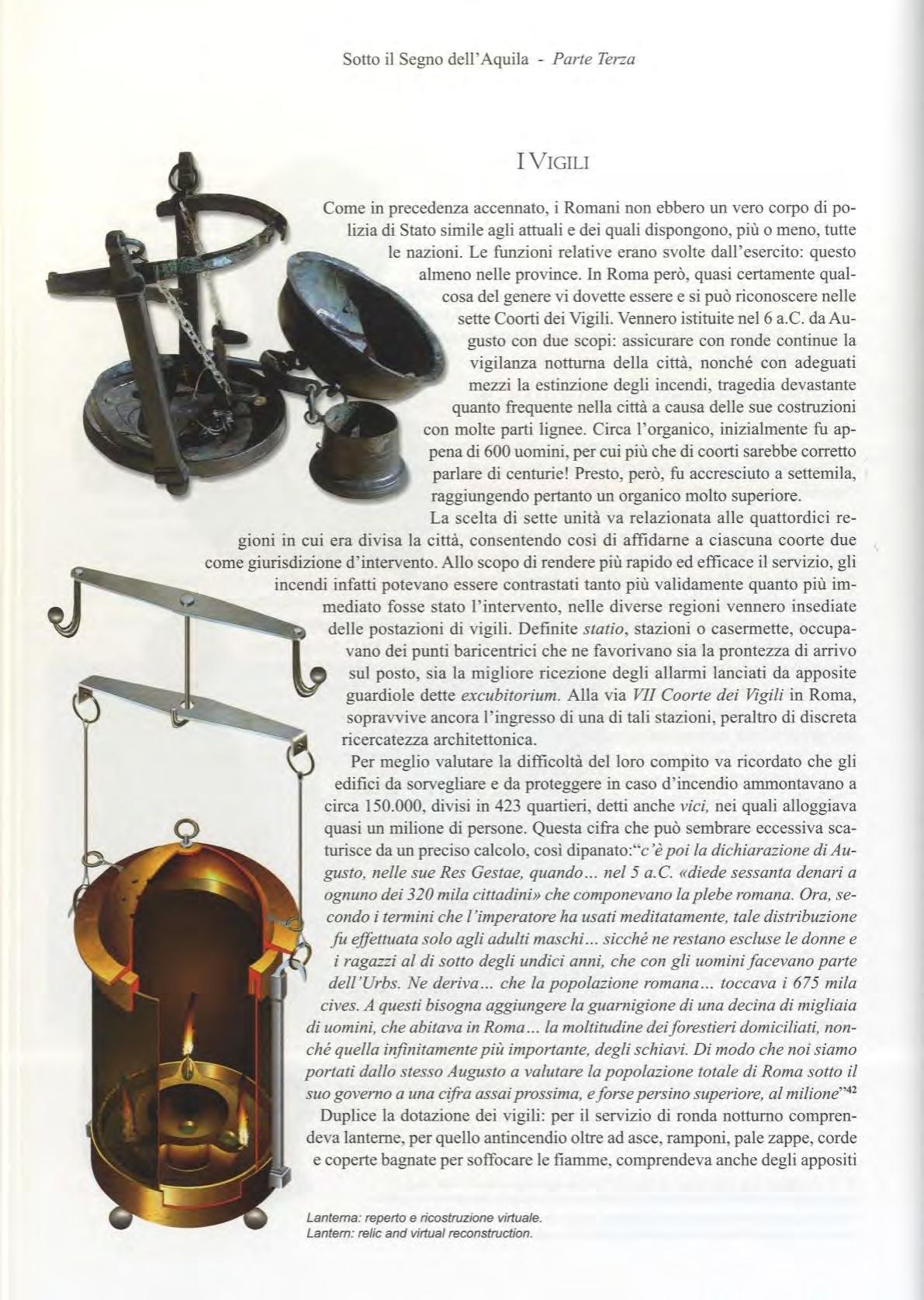
Sotto Il Segnodell'Aquila Parte Tetra
Lanterna:repertoencostruzlonevirtuale. Lantern“relicandvirtualreconstruction.
Ricostruzionedell'idrantesu canoin dotazioneaivigiliromani… Reconstructionofhydrantoncan usedbyRoman firemen.
canisifoni.Sitrattavadiveicoliprobabilmenteaquattroruote.con; tenenti una certa quantitàdi acqua,equipaggiati con idranti erubaturedi cuoioodi spessatela. L’idrantesideve supporrecostituitoda una pompa a doppio effetto, del tipo di Ctesibio “, che attingeva acquadalserbatoiodelcarro,apertosuperiormenteinmodo
di secchi.Lefontilascianoimmaginareche,inizialmente,il corponon fossenémilitarene'militarizzato, cosa che awerrà invece in seguito.
Al suo comando fu collocato allora un cavaliere col grado di prefetto dei vigili_ affiancato da un sottoprefetto. Nei ranghi, tuttavia, entravano uomini di infima estrazione,essendoun lavorovilequantorischioso, e Tiberio per incentivame l’arruolamento stabilì chefosseloroconcessalacittadinanzadopoappenaseiannidiservizio.Maanchecosì funecessarioridurrelafermaasolitreanni,per attrarrenuovereclute. Nonostante il disprezzoelariluttanza a farne parte, l‘operadel corpodei vigili ebbeuna indubbiavalidità, tant’è che Claudiovolle tre coortidivigili ancheaPozzuoli euna adOstia,non a casoimaggiori porti per i quali passava laquasitotalità dellemercidestinateaRoma, In seguitodivenutal’istituzionedeltutto militare nel [Ilsecolo,trovòadozioneinmoltissimealtrecittàdell’impero.
GLIAUSILIARI
Fra leprincipali innovazioniintrodotte daAugusto nell’ambito dell‘esercito,una delle maggiori fu la creazionedi numeroseunità ausiliarie.Non eradiper séuna novità, dalmomento che giàdasecolilelegionimarciavarroafi‘iancateda formazionidiminore importanza militare, Laveranovità, semai, consi» stevanellatrasformazionein unitàausiliari di quelleche,finoadallora,eranostatesemplicementeforze alleate.Inpraticacontaleriformaquesteultimeentravanoconcretamenteafarpane dell’esercitoromano enon più soltantocome subordinatidirango inferiore,ancorchédefiniti alleati. Certamentenon siebbe ' " tale ' ' madaquel la divenner 'vaedirreversibile. Volendoinqualchemodoattualizzarne laconcezioneleunitàausiliariepotrebberoparagonarsi adei modernireggimenti, i cui impieghisievolserodamerosupportoadazioni autonome, incuipotevano essere utilizmti ancheisolatamenteincombattimento.Illoroorganicoabitualecontava500o 1000uomini,dando perciò origine ad unità definite, rispettivamente, quingenarieomiliarie, Stando alle fontiAugustoz“organizzo'lesuefi)rzeausiliariein unità ditretipi:la cohorspeditata, la cohorsequitatae]’ala,In questo primoperiodotutte...avevanounafamadicirca500uomini; inognireggimentoilnumeroerabasatasu quelladiuna coortelegionaria.NelcorsodelI secalnfirmnocreatireggimentipiù numerosidituttietre itipi;fortinominalmentedi 1000uomini, questeunilrìfirronodettemillioria... Ilcambiamentoavvenne probabilmentenelregnodi Vespasiano, ipotesisuffragatadalpiùanticodocumentoepigraficodiun regi gimentomilliario, ancheseGiuseppeFlaviosegnalalapresenza diquesteunità nellafanteriadi Vespasianonella Guerra Giudaicagià nel67d.C.”“
Per l’esattezzarievocando la marcia di Tito fino a Tolemaide, dove si incontrò con il padre, precisa che:“‘alledue legionichestavanoaisuoiordini— eranolepiùfamose:la quinta ela decima —uni quella
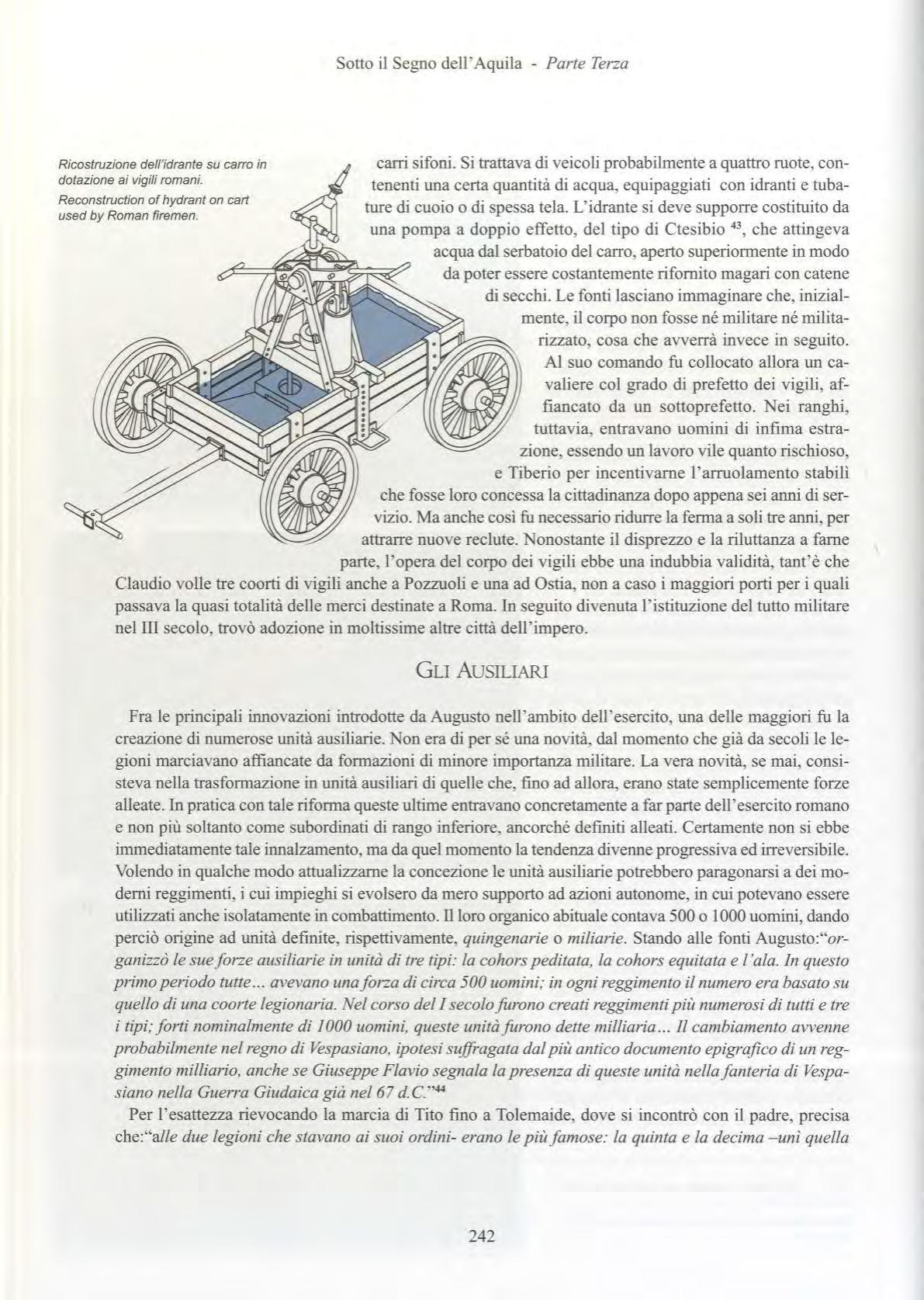
Sottoil Segnodell’Aquila - Parte
Terza
242
daluiCondotta, laquindicesima. Questetrelegionieranoafliancatedadiciottocoortiausiliarie;visiaggiunseropoi cinquecoortieun’aladicavalleriaprovenienti da Cesarea ealtrecinquealidicavalleria provenientidallaSiria.Dellecoorti,dieciavevanocircamilleuominiciascunamentrelealtretredicieuntavanociascunaseicentofizntiecentoventicavalieri.”Laprecisazione fugaognidubbioalriguardopoichénelbrano:“Giuseppesembrariportaredatiufiîciali, epertantoattendibiliancheneiparticolari, come ladivisionedelleventitrécoortiindiecimilliariae, cioèdi (nominali)millefanticiascuna.etrediciquingenariae,cioèdi(nominali)cinquecento/anti(questeultimeeranoequitatae,cioècomprendevanoun contingenteacavallodicentoventiuomini).…“
Comepertutte leunità definite inbase agli organici,ancheper lesuddettel’entitàrealesideve immaginare,siapure dipoco,mai esattamentecorrispondenteaquellateorica, per lopiù inferiore. Pertanto si ebbero quasi semprereparti meno fermo 4 chel’ (' 'vodegli ausiliaripresenti in unaprovincia ointerritoriosideve supporreagiustaragione equivalentea quella dei le— gionaripresenti negli stessi.Aldi ladelladiversa logicadi aggregazione dei reggimenti ausiliari, la loro vera peculiarità nelle ', che i Romani dal formarenelleloro legioni analoghireparti… Sidistinguevano,peresempio,unitàdiarcieri,altredifiombolieri,altredi cavalieri,capacitàcheperlaradicalizz‘iziouevoluta daAugusto,divenneperciascunauna distinzione stabile epermanente…
Standoaipiùaccuratistudi,ilnumerocomplessivodegliausiliaridevefarsiascenderea 150.000uomini, ovveroaduna entitàquasipari aquelladei legionari.Inpratica, adogni legionevenivanoassegnati vari reggimentiausiliari,chenondiradofinironodislocatiautonomamenteancheinsitiadiscretadistanzadalla base principale… In molteprovince, pertanto, le guarnigioni furono formate solo da ausiliari. Spesso le fontiledistinguonoinali,coortienumeri, il che lasciapresumere una suddivisionevagamente similea quelladellelegioni,nellaquale lealirappresentavanoirepartid'élite.Inpraticasitrattava digrossi squa» droni dicavalleria,suddivisialorovolta in 16Iurmeper leunità quingenarieein24perle miliarie.Tuttavia questa seconda formazionenon sembradisponibileprima dei Flavii.fermo restando chenel primo casoallalorotesta sitrova unprefettoenel secondounnibuno,conalledipendenzeun sottoprefetto,almenoagli inizi dell’Impero.
Quantoallecoortideireggimentiausiliari,sidevonosupporreformateda6centurieper quelliquinge» nari e di 10per quelli miliari, esattamentecomericordava Giuseppe Flavio. Non mancano fra le stesse anchealcunedi maggioreprestigio. segnoche sonoformatedacittadiniromani, confluì ’viper arruolamentovolontario: intal casogodonodellastessa stimadei legionari.A capodellecoortivi sonodeicenturioni, che a lorovolta sonoagliordinidiun centurioneprinceps, subordinatoadun prefettonelleunità quingenarie,oaduntribunoinquelledi cittadiniromanieinquellemiliari…Arenderelasituazioneunpo’ più complicatacontribuisconoalcunecoortiausiliariedefiniteequilate.Laqualificazionechenella accezionecorrentedevetradursiconmontate,oweroacavallo,nella fattispecie,invece,sottintendedelleunità miste, ovveroche comprendono6o 10centuriedi fantieda 3a 6turme di cavalieri, secondoche siano quingenarieomiliarie,ancoraunavolta inperfettoaccordoconlarievocazionediGimeppeFlavio.Resta dastabilireilruolotatticoeffettivodi questeformazionidicavalleria:per alcuni studiosii lorouominial momentodelcombattimentosmonhavanodacavalloperbattersi apiedi comeun qualsiasifante.Ilcavallo perciòcostituivaun semplicemezzoditrasportoperspostamenticeleri.Peraltri,invece,combattevanoa cavallocostituendopertanto unavera epropria cavalleria,ipotesi chetrova confortoinalquantibassorilievi,cheritraggonodeimiliti acavallointentiatrafiggerecon la lanciadeinemicialsuolo.
E’diun certointeressericordarechePlinioilVecchionella suagiovinezzascrisseunbrevetrattato,peraltromoltoapprezzatonell‘ambientemilitare,sultirodacavallo.‘7Argomentocheconfermasenon altro come anchei cavalieri romani si cimentassero in lanci in corsa,cioècombattendostandoa cavallo. Ov-
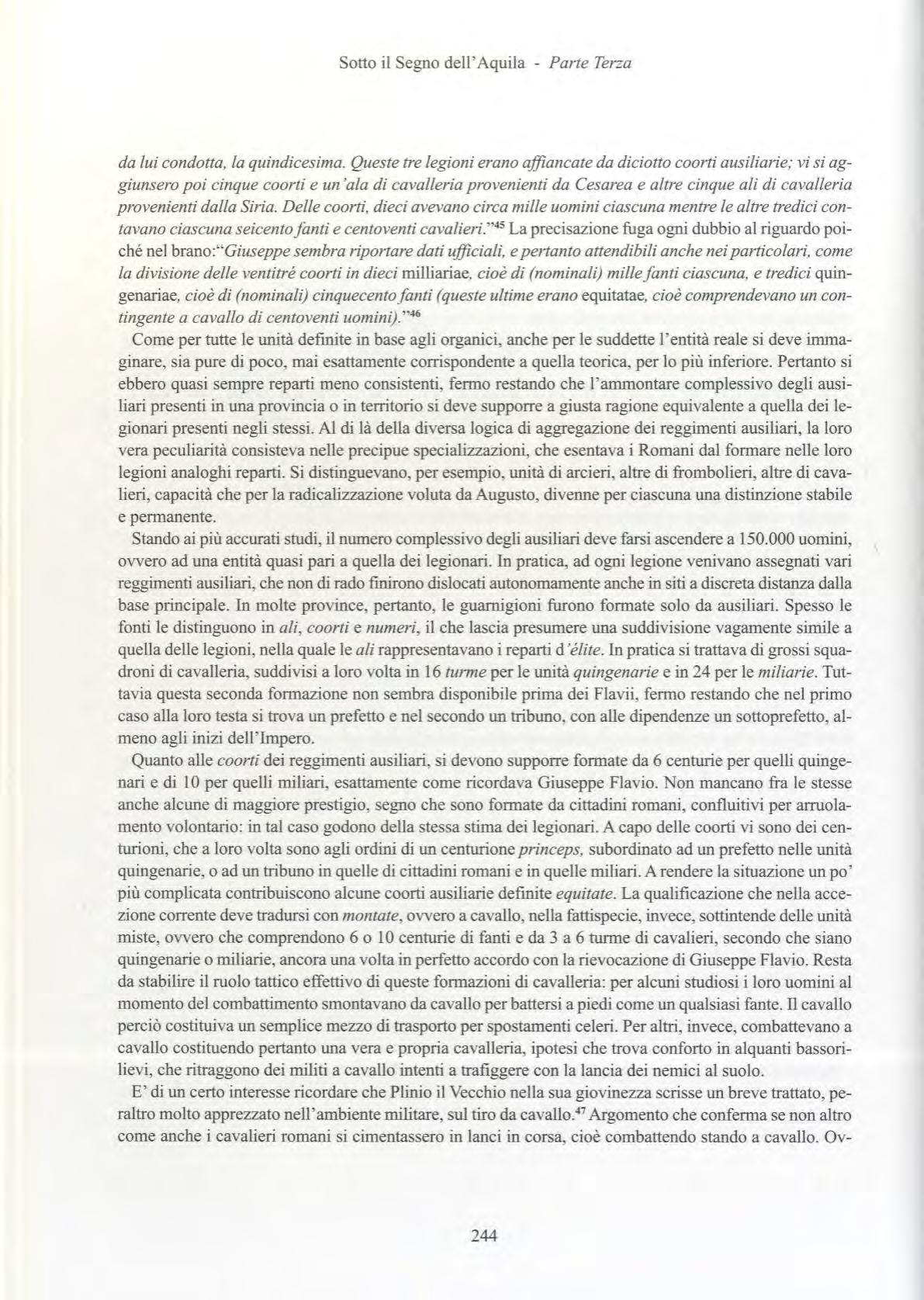
Sottoil Segnodell’Aquila - Parte Tena
244
viamente gli ausiliari lo facevano meglio, essendo proprio quella una loro precipua modalità di combattimento, Al riguardo e significativo il discorso pronunciato da Adrianonel corsodiuna suavisita all‘esercito di Numidia. nel 128d. ., ain uomini della Caliari V] Cannnagenorum equitara, con questeparole:“E'di/jieilechela cavalleria dellecow-rifacciobuona impressione diper .\‘é, eanchepiù di]]icilecheessa non deluda dopo le esercitazioni della cavalla ria ausiliaria.Quextadominameglio ilter» reno, ha un maggior numero diuomini che lanciano giove/lotti; ruota in ordine rerl'ato, lamanovra cantabrica è impeccabile; la bellezza dei cavalli e l’eleganza del— I'equipaggiamento è in armonia con il livello dipaga. Nondimeno, e nonostante il caldo, voiaveteevitatodiesteretediosi/àcendoprontamentequella(he('’emda’/are. Inoltre avete lanciatorossi con lefionde e combattutoconmissili…Avetecavalcatoaninrosatnente."“ Il giudizio espresso da Adriano circa l‘effettotedioso delle mano— vre di una coorte equitata, sembra confer— marne la sua inferiorità rispetto a quelle di un‘ala.peraltromeglio pagata.
W erano.infine,i numeri:taledefinizione sottoilprofilo militare indicavadelleunità che non disponevano degli organici né dei requisiti tecnici per potere essere conside— ratedellelegioni.delleali.oppuredelleco» orti. Potrebbero in generale considerarsi delle formazioni di consistenza molto va» riabile. mutevole secondo le circostanze. Secondouna diversa interpretazione i nur mera; sarebbero stati delleunità costituite da militi non romani, i quali non soltanto non avrebbero abbandonato le precipue connotazioni etniche.,ma anzi le avrebbero vistosamente esaltate specialmentequando fosserostatetattichedi combattimento.,modalità di armamentoefoggedi equipaggiamento.Tali furono.peresempio.i cavalieri Mauri chei Romani continuaronosemprea

Sotto il Segnodell‘Aquila - Parte Term
246
definirebarbari, senza rinunciare mai al lorovalido apporto. Volendo meglio precisare gli organici dei numeri, sappiamosoltantocheoscillainmodoarbitrario:alcuni sonodi 1000uomini,altri di 500,altriancora appena dipoche centinaia,Alla lorotesta sonocollocati, secondol’ordine decrescente, dei tribuni, deiprefetti odeipraepositi, cioèdei centurioni distaccati dalle legioni.
Ilprogressivoafflussodiuominiprovenienti daipopoli sottomessiedai cittadiniromanizzati, attratti dal soldoedallacarriera,accrebbe sulfiniredel Il secololadignitàdeinumeri, facendolipercepireaffini alletruppe ausiliarie del I secolo.Quanto alleprecipue designazioni delle diverseunità:“seguono lestesseregoledellelegioninella lorodenominazione:sidannoperlopiù treelementidibase, iltipo, ilnumeroeun nome(cohorsIAfrorumm,ala IAturum,numerusPalmyrenorurn; e‘un tipo difarmulazionecostruitasulmodellodilegio [Augusta,ecc.).Ilterzoelementodesignadisolitoilpopolodalcui internoisoldatisonostatiinizialmentereclutati.Mapuòesseretrattoanchedalla nomenclatura diun individuo:intalcasorinviaalpersonaggiocheperprima avevaavutol’onoredicomandarela truppa... Talvolta, dopoilnumerositrova indicato!imperatorecheha creatol'unita‘…In alcunicasiseguono ulterioriprecisazioni. distinzioni edepitetionorimi… titolidescrittivi… e!indicazione dellaprovi» cia diguarnigione?”
Aldi làdel soldoedellacan-iera,fattori senza dubbiofortementeato-attivi,laprincipale motivazione diognimiliteausiliario,cavaliereofantechefosse,fusempredi ottenerecon ilcongedolacittadinanza romana el’opportunitàditomate acasaconquestaprestigiosa ed ereditariadistinzione. Quantoal congedo, se ordinario,giungeva latermine di 25 anni di servizio, ed i privilegi a cui dava pieno diritto si estendevanoall’interafamigliadelcongedato.Vaosservatoalriguardochementreallegionarioromano, all‘atto del congedo, abitualmente non veniva rilasciato alcun diploma, ritenendosi inutile la sua attestazioneaifini delle sueeventualifutureattività,nelcasodegli ausiliarierainvecefondamentale.E’interessantericordare cheilterminediploma,derivavadal verbo grecodiplo'o,raddoppio, dacui il latino duplum,evenne adottatoper indicare la doppia lastrina di bronzo che i legionari egli ausiliari ricevevanoall’attodell’arruolamento.Ledueparti congiuntedarigidisigilli,contenevanoincisoal lorointerno legeneralità dellarecluta eladatad’iniziodel suoservizio.Una copiaautentica, esempresigillata,venivacustoditanell’archiviodelTabulariodiRoma:almomentodelcongedo,sirompevanoisigillidi errtrambe e se ne confrontavano le iscrizioni che, per essere valide dovevano risultare identiche.su Ne conseguiva la definizione di honesta missio e l’acquisizione dei privilegi civili connessi al congedo, primofratuttilacittadinanuelafacoltàdicontrarrematrimonio,conubium elalegittimazionedei figli, AncheimilitidelleCoortiPretorianeeUrbaneavevanoalterminedel loroservizioun diplomaanalogo, che li autorizzava soltantoapoter contrarrematrimonio.
Dalpuntodivista pratico il documento,del quale cene sonopervenuti moltissimi esemplari,constava di duepiastrine dibronzo,dicircaem 15x 12,pesanti circa200g,tenuteinsiemedaun filometallico sigillato.Alloro internouna sortadi fogliomatricolare del milite, che soltantoin casodinecessità poteva esseremostratorompendoilsigillo,inprecedenza appostoallapresenzadivaritestimoni.Quantoaltesto, indicava ilnomedell" , che ’ il L " ‘ quindi l’elencodelleunitàmilitari interessate,laprovincia diguarnigione,ilnomedel comandantedelreparto, i meritiacquisiti, i pri— vilegi concessi, nonché la data eil nome dei titolari del diploma edove era custodito il testo originale. Ampie le varianti ma sostanzialmentetutte simili fra loro.Nell’ambito della riorganizzazione dell’esercitoattuatadaVespasiano, sembraassodatocheairepartiausiliaridistintisi inbattaglia, venisseconcessa inblocco lacittadinanzapersinomoltoprimadelterminedellaferma.Ilchespiegherebbeasufiicienzala fortepropensione deireggimentiausiliari acombattereanchedasoli,comead esempionella battaglia di Mons Graupius,in Scozia,nell’84d.C.,quandosostennerol‘interoscontro,dinanzi allelegionischierate sulterrapieno, quasi comedegli spettatorisugli spalti… 248

Sotto il Segnodell‘Aquila Parte
Terza
Sottoil profilomeramente logistico. i Romani sembranoincrrisenatola massima diligenza anon fareal’ lontanarc sen ibilmentei reggimentiausiliaridal loroten'itoriodi reclutamento.destrnandoliperciòallebasi legionarie più vi inc. Si cercava di favorirecosì una maggiore tranquillità psicologica nellereclute, sopratf tutto lcpiù giovani.Non acasoquando.permotivazronr critiche…taleaccorgimentodovettecsscrctrascurato, non mancarono casi diribellioneepersinodi ammutinamento.di una certagravità inalmenoun paio di ciri costanze.Lavalidità el‘affidabilitàdeirepartiausiliari.purnonessendomaiassoluta.siincrementòcoltempo econ lamigliorespecializzazione.divenendoun apportoindispensabilesulcampodibattaglia e.soprattutto. nei trasferimentidelle legioni.faseritenuta pamcolarmenterischiosa in ogni circostanza.specialmentedopo latragediadiTeutoburgo.Cosi sempreGiuseppe Flatiodescn\elitrasferimento delle legioni diVespasiano versolaGalileaperilquale:“conrtrrrd6cheinterraavarrzasrerogliausiliaridilievearmaturaegliarcieriper respingere rmprowiri attacchinemiciedesplorareiboschi sospetti eadattiagliagguati;assieme((carraroproccdeva ancheun confine gentedisoldatiromaniarmatiallapesante.paneapiediepaneacavallo. Dietro a questi venivano dieci uomini ili ogni centuria. che portavano ilproprio equipaggiamento egli al!rez:iper la misura" nedell"accampamento.equindiigenieridellertradesiaperrad— dr reletortuosirà deipercorsi.rrapercolmareidislivelli.siaper abbatterelaveget "oneingombrante,affinche' I 'esercitonon avesse arojfiireidannidiunamarciadifficile.Dietroaquestidisposelerale marie sueedei comandantidipendenti,proteggendo/e con una numerorascortadicavalieri.Dranocavalcavaluiinpersona attorniata daifantiedaicavalierisceltiedailancieri. Venivapoi lacavalleria legionaria:centoventicavalieriper ogni legione. Seguivano i muli chetrainavanoleele/ralielealtremacchine. Dietroquartiilegatie iprefettidellecoorticon 1tribuni,scortatidasoldatiscelti:quindile insegnechecircondano]'aquila,laqualevieneportata intarta aogni legionedeiromani:è laregineeilpiùfortedituttigliuccelli. equindi rappresentaperlam ilsimbolodel]impero eun aus-pina di vittoria L'antro qualsiasi nemico. Dietro allesacre insegne venivanopui r tmnrbern'err'equindi ilgrossodellafanreria legionaria inca/annata suSei/ile. Dietroallafl/imlerr'a varrr'va ]insieme dei servi di cio’ Sarnolegione,portando ibagagli dei soldatirui muli esullebestie dasoma;allespalleditutte le legionilamarradeimercenari,prof rettidaunaretroguardiacomposta difanti leggeri epesanti e dipar Vecchia cavalleria“
Qualechefossel’entitàedi]va lore delle unità ausiliarie e degli altre forze armate il nucleo bash lare dell‘esercito romano. anche nei primi secoli dell‘Impero… ree staronosemprele legioni.
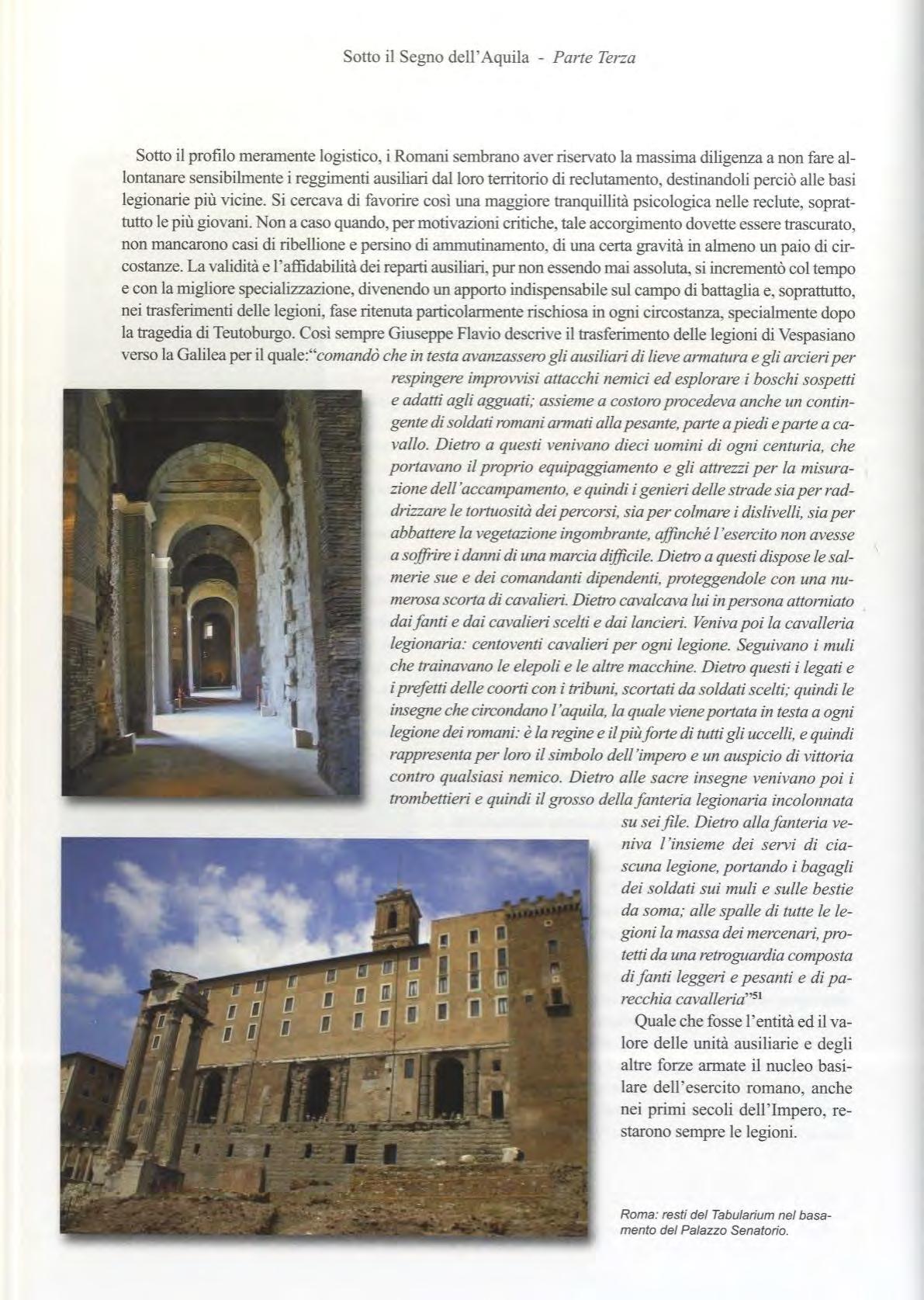
Sotto
il Segno dell‘Aquila Par-te l'orzo
Roma tesi!del Tabula/lum nel basa? mento delPalazzo Sanatoria
LE LEGIONI DI AUGUSTO
Le legioni cheAugusto trattenne in servizio erano numerare da I a XXI]. Non era, però, una corrispondenza biunivoca, poiché adalquantinumeri corrispondevanopiù unità.ambiguità che spiega la necessitàdi abbinateaciascunaunaparticolare definizione.quasiuna sortadicognomen.per differenziarla nettamente,Agiudizio di vari storicinella sceltada luioperata.sembra di scorgere una preferenza verso le legioni già appartenute ai:“suoi ex colleghi di triunvirato, MarcoAntonio e Marco Emilio Lepido; !’esercitodiquesto ultimopassò a Ottavianonel36a.C .. equattro numerisonoduplicati:IVMacedonia eIVSythica,VAlaudaeeV Macedonia,VI Fen-ameVI Victrix, X Gemina e X Fretensis; una è triplicato: lll Augusta, lll Cyrenaiea e III Gallica. Alcuni di questi nomi erano senza dubbio di origine ufiiciale, ma altriderivavanopresumibilmentedalnome dellaprovincia dove la legionesiera distinta… In qualche casa bastava un soprannome, comeper la V Alaudae (leallodole). una legione creata da Giulio Cesare. Più tardigli imperatoricrearononuove legioniopersostituirequelleperdute in batta— glia, oper accrescerelaforza legionaria, di solitoprima di una campagna opercontrastarequalche nuovopericolo. La nomenclatura diquestenuove legionipuò essere indicativa della loro origine:per esempiola [ItalicafuformatadaNerone con recluteitalicheela I, Il eIl]Panhicafuronocostituiteda SettimioSevero,per lecampagnein Oriente.La creazionedapartedi Traianodella XXX Ulpiavictrix filpensarechealmomentodellasuaformazioneesistesseroaltreventinovelegioni. Difattoneiprimidue secolidell'Imperoilnumerodellelegionirimaserelativamentestabile, aggirandosidisolitointornoalle ventotto originariamenteprevistedaAugusto.”51
Circa l’organicoogni legionez"eracompostadidiecicoorti.Designatea lorovolta daun numero d’ordine. questesiarticolavanoin seicenturie ciascuna, identificabiliper lopiù dalnome delcenturione in comando; I ‘anticaripartizionein hastati.princepsetrim-ii. itrescaglionidellafanteriapesantelegionaria, venne mantenuta-anchequandoognidistinzionetra essiera ormaicompletamentescomparsaper mereesigenzeamministrative, alloscopodiidentificareidiversirepartiedifissarelagerarchia interna deicenturioni. Ognicoorteera composta di480uomini. nannelaprima. chenecontava 800.
Ognilegione disponevapoidiunproprio contingentedicavalleria, 120uomini. divisiin tre turmae o squadroni;epressoognirepartoesisteva.neiprimisecolidellimpero. ilvexillum (termineche indicava qualsiasi unità senza organico fisso) dei veterani, soldati che conclusa laferma, restavanoper alcunianni in servizio ed erano destinatiacompitispeciali, Ogni legionepossedeva altresìunproprioparco d'artiglieria, compa siadaunasessantinatraballistae ed onagri, macchine da getto di vario tipo.”&
Pertanto, complessivamente: “compresigliuflîciali, ilpersonale amministrativo e un distacco mento di 120uomini chefungevana da sta/fetteeportaordini a cavallo, ['organicodiognilegione constavacirca 6.000uomini.
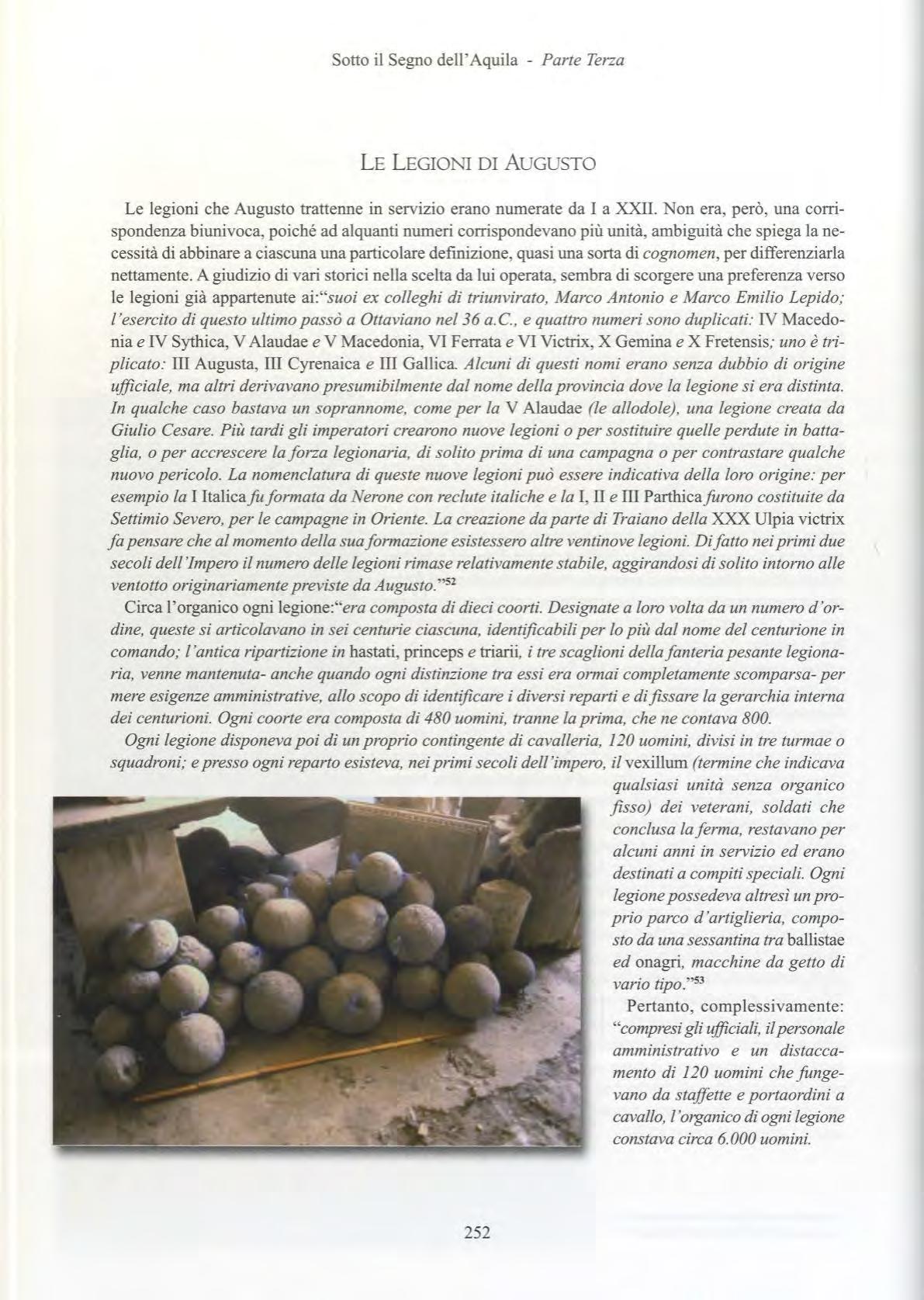
Sotto il Segnodell'Aquila - Parte Terza
252
SottoAugustoeisuoisuccessori, lastrutturadicomandodell'esercilodt]ferinotevolmentedaquellarepubblicana. Glieserciticonsolarieproconsolatidiun tempofiaonosottopostialcontrollodirettodelPRAV— cees, euna delleprime riforme augusteefu diassegnarea ciascuna legioneun unico comandante, che sostituìiltribunummilitum.giàinnumerodiseiperlegione,edesercitanoilcomandoacoppieperperiodi diduemesiallavolta.Ilnuovocomandantefudettolegatus legionis. Cesareavevausalo legatipercomandaresingolelegioni,ma titoloecaricafuronoinstauratistabilmentesolosottoAugusta.!legatisceltifragli uominidifiduciadell'imperatore, edapprimanellefiledegliex-questoriedegliex»pretori, ma versoliz/ine del!secolodisolitofraquestiultimi. Seilegaliservivanobene]imperatore,potevanosperaredidiventare inseguitoconsoliegovernatoridiprovince.
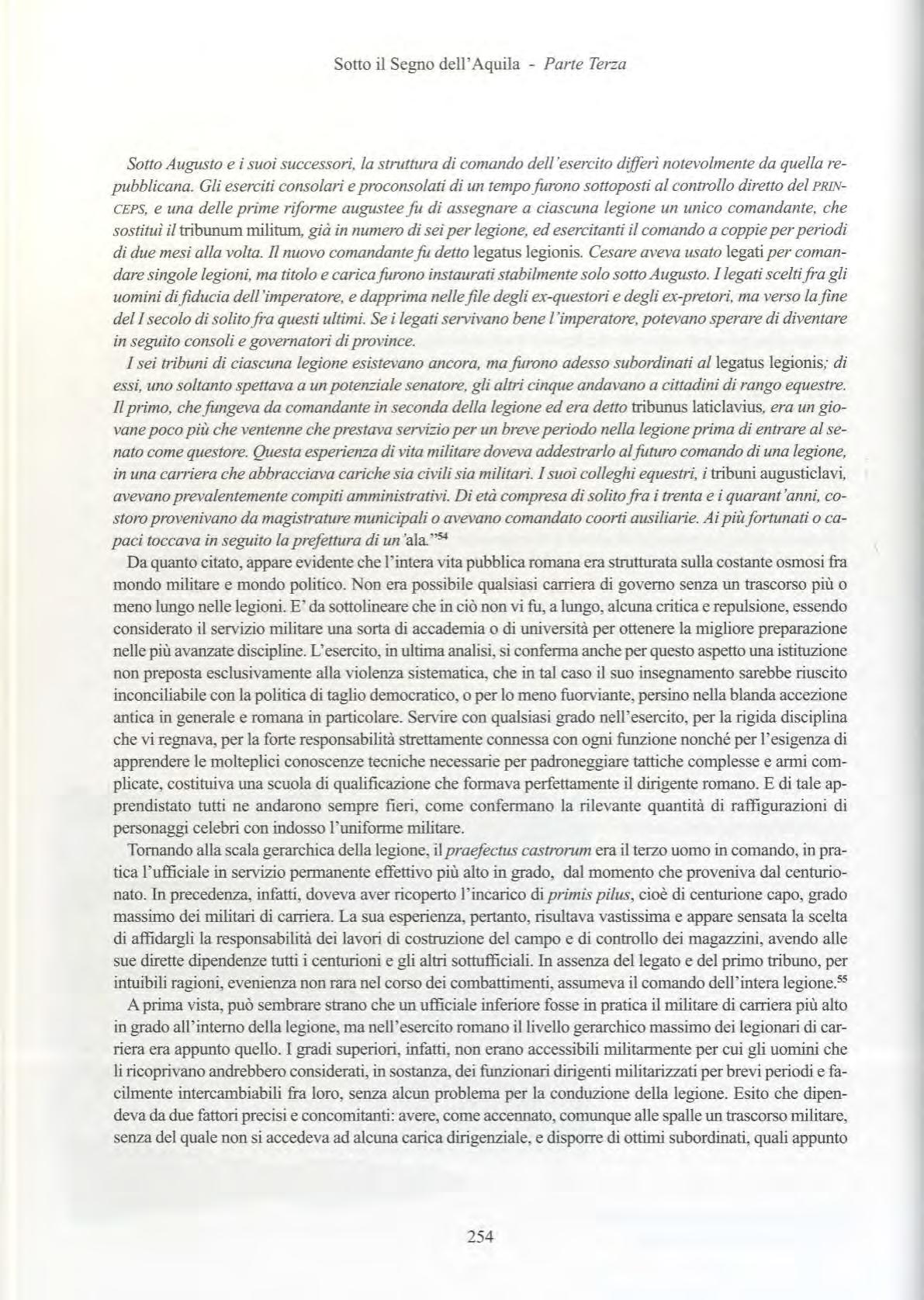
!seitribunidiciascuna legioneesistevanoancora, mafitronoadessosubordinatiallegatus legionis,‘di essi, unasoltantospettavaaunpotenzialesenatore,glialtricinqueandavanoacittadinidirangoequestre, Ilprimo, chefungevadacomandanteinsecondadellalegioneederadettotribunus laticlavius, Eraungiavanepocopiù cheventennecheprestavaservizioperun breveperiodonella legioneprima dientrarealsenatocomequestore. Questaesperienzadivitamilitaredovevaaddestrarloalfilturocomandodiunalegione, inunacarrieracheabbracciavacarichesiacivilisiamilitari.] suoicolleghiequestri, itribuniaugusticlavi, avevano, ' compiti '' ' '…DietàL ,, disolitofraitrenta eiquarant'anni, costoro ,, da " oavevano ’ coortiausiliarie.Aipiùfortunatiocapacitoccava inseguitolaprefetturadiun’ala”s‘
Daquantocitato,appareevidentechel’interavitapubblicaromanaerastrutturatasullacostanteosmosifia mondomilitare emondopolitico. Non erapossibile qualsiasi can-iandi governo senzaun trascorsopiù o menolungonellelegioni.E’dasottolinearecheinciònonvifis,alungo,alcunacriticaerepulsione,essendo consideratoil serviziomilitareuna sortadi accademiaodiuniversitàperottenere lamigliorepreparazione nellepiùavanzatediscipline.L‘esercito,inultimaanalisi,siconfermaancheperquestoaspettounaistituzione non preposta esclusivamenteallaviolenza sistematica,che in talcasoil suoinsegnamento sarebberiuscito inconciliabileconlapoliticaditagliodemocratico,operlomenofuorviante,persinonellablandaaccezione antica in generaleeromana inparticolare. Servireconqualsiasi gradonell’esercito, per larigida disciplina cheviregnava,perlaforte , Lilità conogni° ’ nonchèperl‘ ; di ,, le ’ tecniche tattiche eanni complicate. costituivauna scuoladiqualificazionecheformavaperfettamente ildirigenteromano, Editaleapprendistato tutti ne andarono sempre fieri, come confermano la rilevante quantità di raffigurazioni di personaggi celebriconindossol‘uniformemilitare…
Tornandoallascalagerarchicadellalegione,ilpraefectuscastrorumerailterzouomoincomando.inpratica l’uflicialeinserviziopermanenteelfettivopiù altoingrado, dalmomentocheproveniva dal centurionato.Inprecedenza, infatti,dovevaaverricoperto l'incaricodiprimispilus, cioè di centurionecapo.grado massimodeimilitaridicarriera.La suaesperienm,pertanto, risultava vastissima eappare sensatala scelta di afiìdargli laresponsabilità dei lavori di costruzionedel campoedi controllodei magazzini, avendoalle suedirettedipendenzetuttiicenturionieglialtrisottufficiali.Inassenzadellegatoedelprimotribuno,per intuibiliragioni.evenienzanonrara nel corsodeicombattimenti.assumevailcomandodell’interalegione.55 Aprimavista,puòsembrarestranocheun ufiicialeinferiorefosseinpratica ilmilitaredicarrierapiù alto ingradoall’internodellalegione,manell’esercitominanoil livellogerarchicomassimodeilegionaridica:riera eraappunto quello…Igradi superiori.infatti,non eranoaccessibilimilitarmenteper cuigliuomini che liricoprivanoandrebberoconsiderati,insostanza,deifunzionaridirigentimilitarizzatiperbreviperiodi efacilmente intercambiabili fra loro, senza alcunproblema per la conduzione della legione. Esito che dipendevadaduefattoriprecisi econcomitanti:avere,comeaccennato,comunqueallespalleuntrascorsomilitare, senzadelqualenonsiaccedevaadalcunacaricadirigenziale,edisporrediottimisubordinati,qualiappunto
Sottoil Segnodell‘Aquila - Parte Terza
254
Sotto il Sognodell‘Aquila Parte Terzo
i centurioni che garantivano la continuità comunque del comando. Non a caso eranoproprio i centurioni l’impalcatura dell'esercito.pur avendo in apparenza un modesto potere. persino inferiore a quello di un odierno capitano.Ai loro ordini. infatti. obbedixaf'una (‘Elllw'lil composta di ottanta uomini [centurioni diognicoortetranne laprima eranodesignati in ordinedigrado Comenell'eserr‘ttorepubblicano. ogni centurioneaveva iltitolo dioptioad spem ordims.

Sottoil L‘entitr'lonatnpossiamo distinguere in ogni cen/urto tre categoriemaggiori di soldati:principa— les. immunes emilites. E "dubbio.sequeste categoriefosseioriconosciutecometaliavantilaprima metà delI]secolo, ma lamaggiorpartedellemansionisvoltedui membridiciascuna CHIL’gOI‘H]risalgono, con certezza, a tempi moltoprecedenti… In sostan: doppiadiquellodellegionario {ilDLPt./('mi!s) 0pariauna volta e mezzo {ilsequiplicarius). Gli immunes, eranosoldati che riceve vano lapaga base, ma venivano esen/atida lavoripesantiperche' addettiocompitiparticolar' I militeseranoI comunilegionari, con tuttelemansioniordinarie. ‘“
principales eranosotngfiìcialichericevevano unapaga
1gradi sottostantiaquellodi centurioneedappartenenti aiprincipales. eranoin ordine gerarchico decrescente., il signifer.owero il portatoredell'insegna quindi l'optlo,chepon-ebberiguardarsicome il sostitutodel centurione quandoassente,eil tesseratins,preposto ai servizi di guardia e… in particolare. alla relativa parola d‘ordine quotidiana. Tutti i sottufficiali elencati avevano aspettative di care ricra complete.fino al ccnturionato,Va precisato. inoltre,chetanto Ilportatore dell'aquiladella legione.l'aquilrfer,comepure gli ima— giniferi. cheportatano le raffigurazioni dell'imperatore in carica e di qualche altro precedente già divinizzato, non appartenevano a questogrado.ma per la delicatafunzioneaffidata eranoassociati al personale di comando…sebbeneanch'essi siapurdipoco inferiorial centurionato.
Vi erano ancora. @ costituivano una peculiarità della legione romana, ben evidente sin dall'epoca repubblicana ma ultcriormcntc esaltatainetàimperiale.perl'evoluzionedellatecnologia militareun grannumerodi legionari tecnici.ovveroesperti di una vasta garrnna di attività professionali e artigiane. Fra loro. definiti immunes in quanto esentati dai lavori di approntamento del campo e manuali in genere. si riscontrano topografi. architetti.medici.ingef gneri. falce gnami.fabbri,fabbricantidilaterizi, idraulici. tagliapieth c boscaioli.57 Pertanto ogni legione riproduceva, in definit' uno spaccato auto— nome dell intera società civile, dimostrandosiperfertarnentc ingrado di aggregare e organizzare intorno
Rievocaztont'coninsegneleg/anatre. ColonnaTraiana leg/onanallevatoneiesth Marchilegionarisumattonielegale Reenactementswithleg/onna/retnstgrnas. Tra/anColum/i'legion/vaneswon<ingtothe fields.Legion/tanemarksonun…andtiles
Sotto
-
allasuabase,cittàconlestruttureeiservizi dell’epoca senza bisogno di alcun altro intervento. anche a livello puramentemateriale come,ad esempio,per la produzione dei mattoni, delle tegole o dei tubi di piombo.Atestimoniare in maniera inoppugnabiletalesingolarere— allasono i marchi che ciascuna legione imprirneva sui suoi manufatti, dai sin— golimattonietegole, aitubidipiombo, marchi che oltrea citare il suo numero ne rafiiguravano non di rado anche l‘emblema.
Considerando l‘ampia divaricazione territoriale degli stanziamenti delle le» gioni in epoca imperiale si comprende comepropriograzieallaloropresenmeallericordatelorocapacitàproduttive,ogniangolodell’imperofosse dalla ' ’ edalle ’ ' culturali.Dalla Britannia alNordafrica, dalla Spagnaall’Asia minore, vi erauna assolutastandardizzizionedeiprodotti tecnologici prodotti dalle fabbricheedalleofiicinedelle legioni,percui erapossibilemontareun pezzodirispettorealizzato dauna legionedi stanzainGermaniainuncongegnocostruitodaun’altradistanzainPalestina.Si è concluso,pertanto,cheimilitesimmunesfosseroadibitiallemassicceproduzioni industrialitragiugnoeottobre,quando per le avverse condizioni climatiche delleregioni del nord, vigeva l’assoluta stasidi qualsiasi operazione militare.Vi èancoradaaggiungerealriguardoche itecnicilegionari con competenzepiù evolute,quali gli architettieditopogmfivenivanorichiesti,spesso,anchedallecomunitàcivililimitrofe,perrisolvereproblemi esulantidallelorocapacità.Iltracciatodiunacquedottoedilrelativopianoquotato.adesempio,rappresentavanounodegliinterventipiù ambiti,dalmomentochesololastrumentazioneelacompetenzadeigeometri legionaripotevagarantirel’indispensabileprecisione.Analogoildiscorsoperlasanitàmilitarecheperlasua pregnanza materializzatadainospedalimilitari,detti valetudinari,obbligaaduna specificaesposizionenel prosieguo. Un altro,sia purbreve, approfondimentomerita pure ilpersonale amministrativodella legione, che andava a costituire il tabulan'um legionis,una sortadi archivioedal contempodi direzione contabile. Ne facevanoparte iIibrar1’i,analoghiadeicancellieri,egli exactiovveroi contabilipropriamente detti,co« ordinatida un comica/mins.
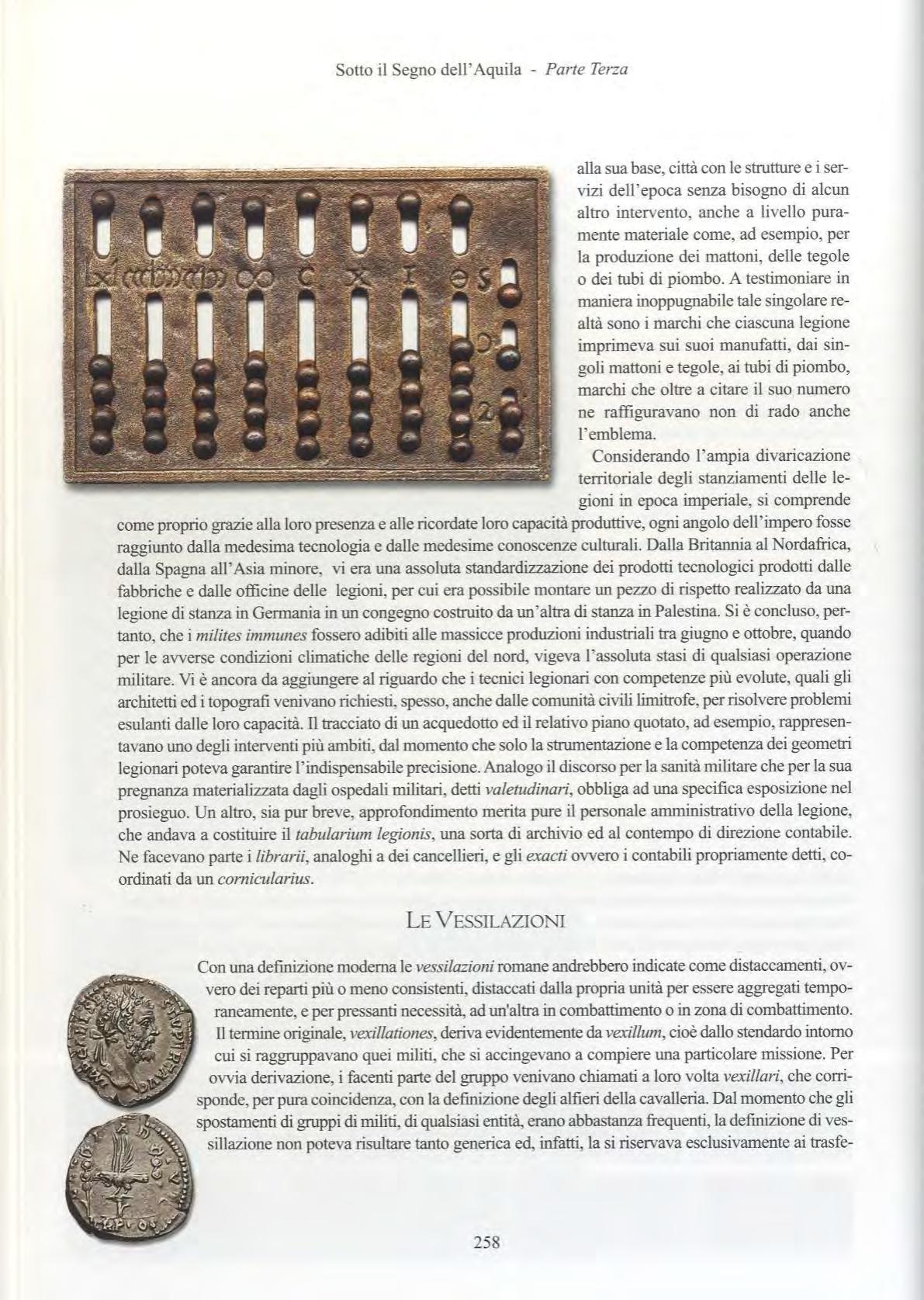
LEVESSILAZIONÎ
Conunadefinizionemodernalevessilazioniromaneandrebberoindicatecomedistaccamenti,ovverodeirepartipiùomenoconsistenti,distaccati dallapropriaunitàperessereaggregatitempo— raneamente,eperpressantinecessità,adun'altraincombattimentooinzonadicombattimento. Iltermineorig‘nale,vai11ariones,derivaevidentementedavai!/um,cioèdallostendardointomo cui siraggruppavanoquei militi, che siaccingevanoacompiereuna particola1emissione. Per owiaderivazione,ifacentipartedelgruppoveniwnochiamatialorovolta varillari, checorrisponde,perpuracoincidenza,conladefinizionedeglialfieridellacavalleria.Dalmomentochegli spostamentidigruppidimiliti,diqualsiasientità,etanoabbastanzafi'equenti,ladefinizionedivessillazionenon potevarisultaretantogenericaed,infatti,lasiriservavaesclusivamenteaitrasfe-
Il Segnodell’Aquila
Pane Ter-zzz
258
rimenti ufficialmentericonosciuti, conappositi ordini econ un verovarii/um: definizione, quindi,chesupponeunaprecisabase giuridicaancorprimachemilitare Effettuata lamanovra eraggiunta lanuova destinazione imiliti dellavessillazione passavano sottoil comandoivi vigente.Tentando di esemplificareun esercitoprovinciale,di stanzacioèinunaprovincia stabilmente,poteva inviareinzona di operazione, senon limitrofa neppure lontanissima. una intera legione oun semplice distaccamento, formato prelevando da ogni sua legione un numero di uomini, per entitàoscillanteha ledueolequattrocoorti.Lavessilazionecontava,perciò,dai 1000 ai2000militi,entitàeprocedura immutataanchequandoapplicataadunitàausiliarie.se Vaancoraprecisatochelaprassi diutilinareunavessillazionenoneracontemplatasolo dalle operazioni campali propriamente dette. In alcuni casi, infatti, se ne faceva ricorsoper lavoridi assolutaurgenza odi risaputa necessità,comeadesempiolaco» struzionediunforteodiunastrada.Quantoalcomandodellevessillazioni,sebbene in linea teorica dovessericadere soltantosu ufficiali di rango senatoriale, qualora nellastessavifosserostatideicittadiniromani,esuu.fiicialidirangoequestreseformata soltantodabarbari, nella realtà siebberonon rareeccezioni, inmodopartica larenel corsodel Isecolo,con l’affidamentoacenturioniprimipili.
Uncasoaséstantesiravvisaquandoildistaccamentonon hadirittoalvai!/um,ovvero non cadenelle norme giuridicheperessereritenuto tale, per lopiù per carenzediuomini: la suadefinizione alloraeraquelladinumeruscollana.Contaun organicovariabile, ma non lontano dal centinaio, costituitodi elementitratti dapiù campi odapiùunità, infunzionediuna precisamissione. Questa, tuttavia,proprioperlairrilevanzadelcontingente,lasciapresumerepiù cheunaesigenzabellicaunanecessitàditipotecnico,richiedendoperciòdeglispecialistiedegliespertiinprecisi settori,innessun altromodo disponibili.La suaduratapoteva divenireanchepermanente.
LA CAVALLERIA
Comepiù volte delineato in precedenza, per i Romani la cavalleria non rivestì una significativa rilevanza,menochemai comearma nel corsodel ‘ Lanon’ “ilitàdellastaffa edella ferranrradei cavalli,non acaso,contribuiva arendere l‘equitazionebellica più una capacitàper» sonalecheunadisciplina formativa.Difiicile,per ilprecario equilibriosullagroppadel cavalloesullapresa discutibiledei suoizoccoli,effettuarecaricheoinseguimenti.Ed èsignificativoche icavalieriromaniquandodovevanosuperaredellesaliteanche non particolarmente impervie, smontavano da cavallo e marciavano come un qualsiasi fante.Tutnavia con le riforme militari promosse daAugusto la cavalleriarecuperòunamaggioreimportanza.Ricomparverocosigliequiteslegionarii, che entrarono, come accennato, in numero di l20 nei ranghi di ogni legione. La loro suddivisione interna era fatta in base alla mmm, l’unità tattica minima, composta da soli trenta cavalieri. Con Adriano, poi, le tradizionali quattro ture maefi.rronoportate a 10,facendoascenderel'organicocomplessivodeicavalieri a300,Difficilecomunque,ancheinquestocontestostoricostabilirecome inre» altacombattesselacavalleria,ammessopure che lo facesse sistematicamente.
Per la verità, in precedenza sono state citate alcune steli funebri sulle quali stannoritratti, inbassorilievo, dei cavalieri chetrafiggono con una lunga lanciadei nemicial suolo, Il moltiplicarsidianalogheraffigurazioni, lungi dalconfermarequella
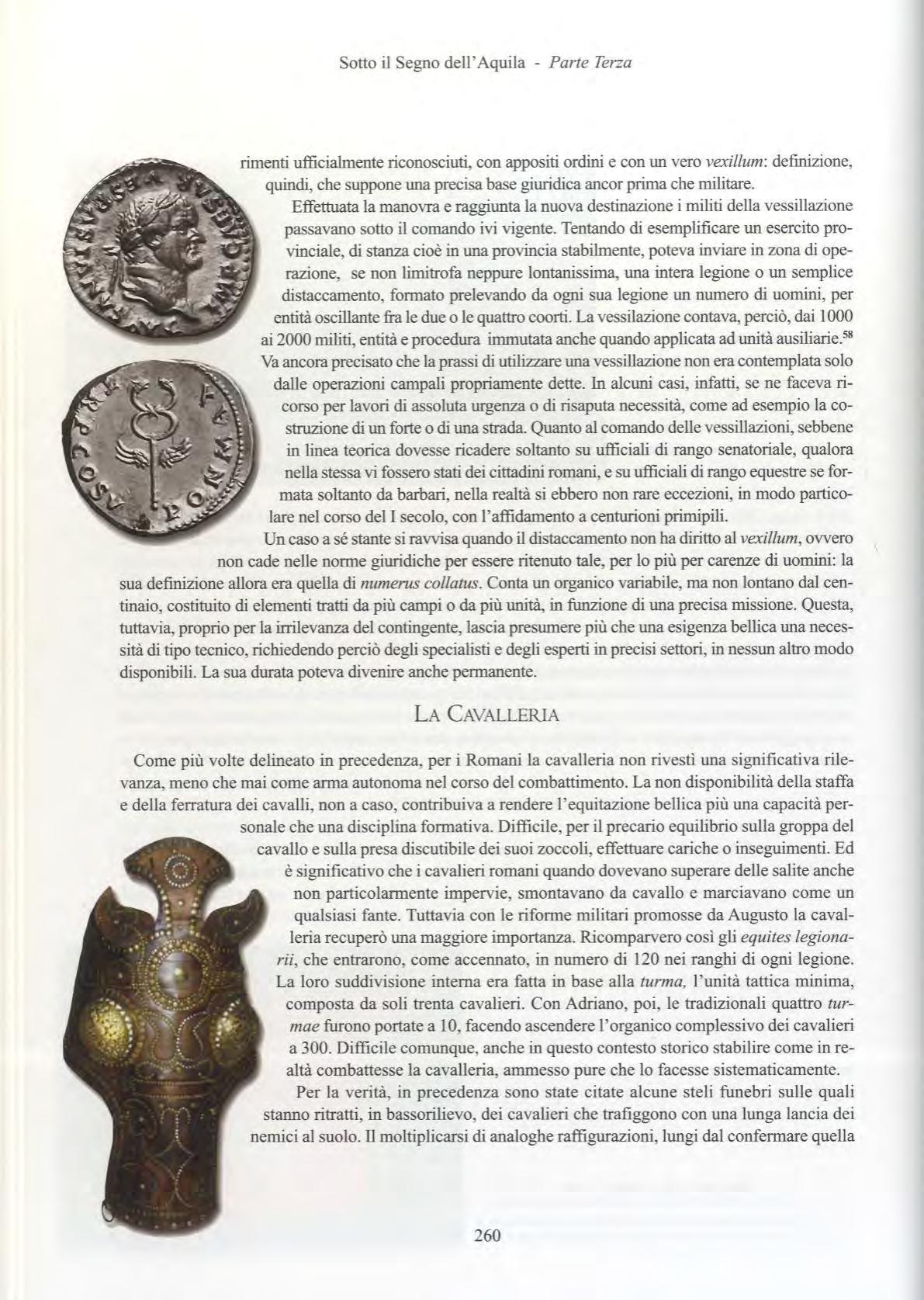
Sotto
il Segnodell‘Aquila Purte Terza
260
antesignana tattica medievale lascia propendere,invece,perl’affennarsi diuna suggestivavalenzaagiogafica. Sarebbe stata quella prestazione una sorta di 'deale a cui tendere, ma nella realtà ancora ben lontana dall’esserepraticata corrente— mente! 11che sembra trovare conferma nella predilezione accordata dai comandantiromaniall’impiegodellacavalleria ausiliaria, composta da elementi enricarnente addestrati al combattimento a cavallo, sia con la lancia che con l’arco, prestazioni impossibili da imitare con identica abilità.Traquestila:“migliorcavalleria cheoperava sono il comando romuno sulfinire del I sec. d.C. era nordafricana, inspeciequella maura. Non sappiamoquantafizssenumerosa questaformazioneacavallochefuimpegnata nelle operazioni in Dacia durante il regno di Traiano, siamo però 11 Nellapaginaafianco:bassorilievoconwvaliereecavalloincombattimento. ”"“”“Chei"‘“"ridiL’…"Quiet”Vi””l‘ Sidepage:bas—taliniwiflthorsemsnandhorseduringcombat. semun ruolonotevolissimo, innanzituttoperchélelorogestafirmnotramandatedairilievi della Colonna Traiana, in secondoluogoperche' le loroparticolari capacità militari vennero sfiuttate da Tfaianoanchenellesuccessiveguerre intrapresecontroiParthi.
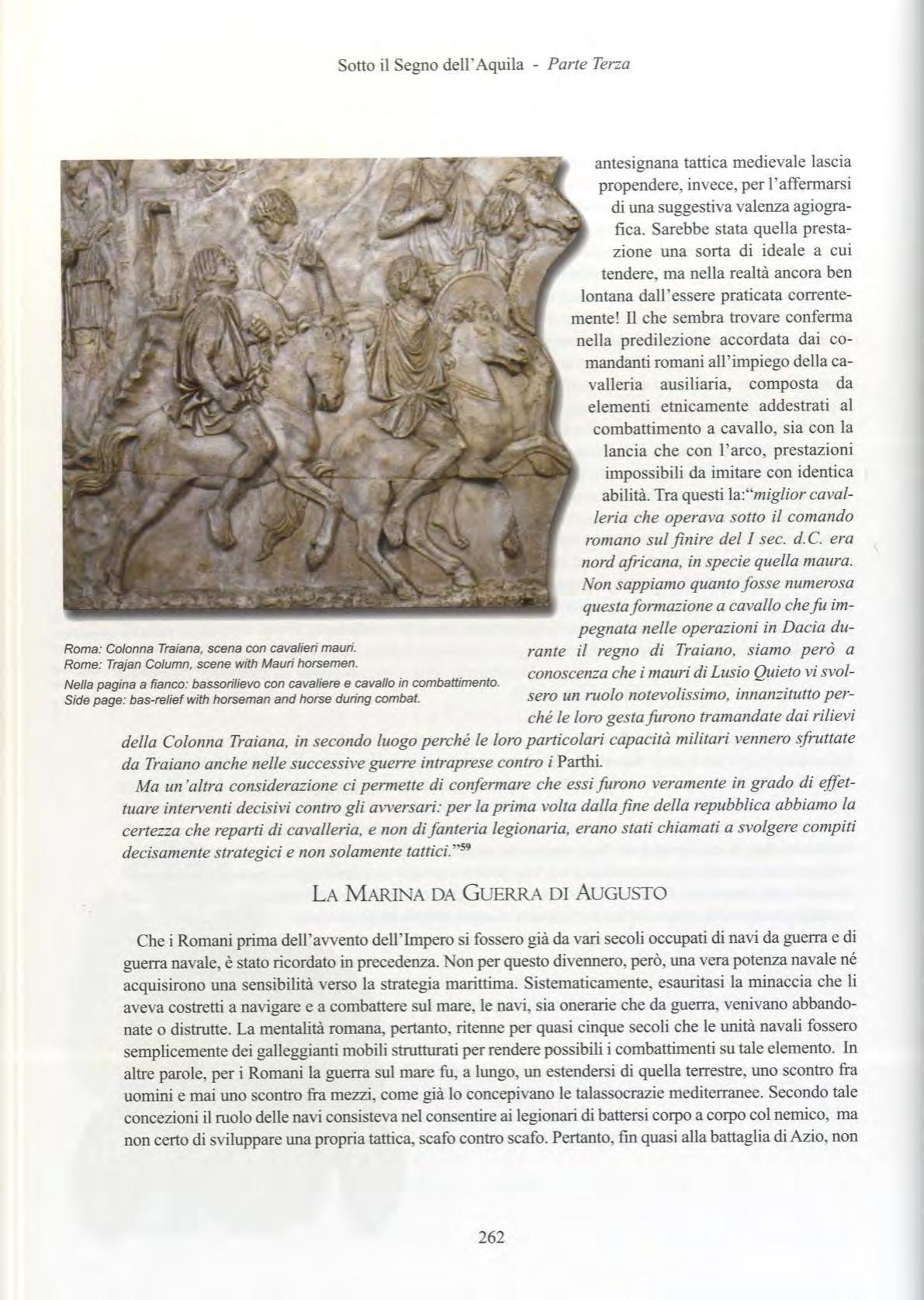
Ma un’altra considerazionecipermette di confermare che essifurono veramente in grado di effettuare interventidecisivicontrogliavversun':per 111prima volta dallafinedella repubblica abbiamola certezer cherepartidicavalleria, enon difiznteria legionaria, eranostatichiamatirz svolgerecompiti decisamentestrategicienon solamentetattici."sy
LA MARINA DA GUERRADI AUGUSTO
CheiRomaniprimadell’awentodell’Imperosifosserogiàdavarisecolioccupatidinavidaguerraedi guerranavale, è statoricordatoinprecedenza Nonperquestodivennero,però,una verapotenzanavalene' acquisirono una sensibilità verso la marittima. Si ‘ esanritasi la che li avevacostrettianavigareeacombatteresulmare, lenavi, sia onerarieche daguerra,venivano abbando— nate odistrutte.Lamentalità romana,penanto,ritenneperquasi cinque secoliche leunitànavali fossero semplicementedeigalleggiantimobilistrutturatiperrenderepossibili icombattimentisutaleelemento… In altreparole, per iRomani lagrenasulnrare fu,alungo,un estendersi di quellaterrestre, uno scontrofra uominiemaiunoscontroframezzi, comegiàloooncepivanoletalassocmziemediterranee. Secondotale concezioniilruolodellenaviconsistevanelconsentireailegionaridibattersicorpoacorpocolnemico, ma noncertodisviluppareunapropriatattica,scafocontroscafo.Pertanto,fin quaiallabattagliadiAzio,non
Sotto
il Segnodell’Aquila Parte Terza
Roma:Colonna Traiana, scenaconcavalierimauri. Rome: Traian Column. scenewith Maurihorsemen.
262
vennero neppure equiparateai cavalli.non dandoperciò origine ad una precipua anna. Dopo quella grandiosa vittona. forse proprio per il ruolo soste— nutovi dalle flotte contrapposte e dal controllo dei mari espletato da appositesquadre,laconcezioneconobbeunanettainversioneditendenza.
A farsenepromotore, non a caso. fu proprio Agrippa, il mitico artefice del trionfo di Augusto e suo volitivo braccio destro, oltre owiamente ad essere anche il suo migliore ammiraglio e. non ultimo, suo genero! In dettaglio:“…vebbeneglistoricinon ci dicanoquando vennero assunti iprovvedimenti chediedero una ristemaziunestabi1e alleflotte edun assettopermanente a quella che, con termine moderno, consideriamo/'efl”ettivaMarina imperialeromana, ciòchevenneflittoduranteil principatodiAugusto ha la chiara impronta della razionalità organizzativa edelle competenza navalediMarcaAgrippa. Ildisegnogeneraleva attribuita senz’altroa [al; 1arealizzazionepratica, inparte a lui ed in arteadAugurto, chelacompletò...”“’
E'paradossale che Roma giunse all’istituzione di una sorta di marinamilitare,quandononebbepiù nemici sulmare!Certamente lenavi tornavanoutili per il trasporto di contingenti dell’esercito a ridosso delle località dove si manifestavano le avvisaglie di rivolte eribellioni, ela rapidità dell’interventofavoriva il successo della repressione. Compitoquestoche con l‘andardel tempo s’istituzionalizzòeperfezionò.alpuntodaassurgere afunzioneprioritaria di quellacheagiustaragione sipuò considerare lamarina da guerra romana: una poderosa forza armata dell’Impero, capace di proiezioni in ogni angolodelbacino,nel girodipochissimi giorni!Quantoadorganico,lasuacomponentechecondefinizione moderna potrebbe definirsi fanteriadi marina 0 da sbarco,piuttosto chetruppetrasportate via mare. ammontava originariamentea due legioni. Unità che devono considerarsi dipronto impiego, in operazioni belliche di rinforzo in circostanze fortementecritiche:non a casofuronochiamate ]e IlAudiutrt'x. In seguitoentrambevennerotrasferiteedislocatealtrove.verosimilmentedopoesserestateawicendatedaequi— valentiunità informazione Del resto, concentrandosi l’esercito lungo|limes, furono!militi dellamarina adoversi farcaricodella degliulivi .' del fluvialelungoil Renoe il Danubio, dei commerci e, non ultimo, persino dei viaggi dell’imperatore. dal momento che le navi da guerrasieranodimostrateil mezzoditrasportopiùsicuroecomodoperraggiungerequalsiasidestinazione. Quest'ultimosingolareimpiego fornisceancheuna chiave di letturapervalumre i criteri operativi adottati in seguitodalla marina romana. Erende pure comprensibile la strettissimacontigiità dellebasi carnpane, Lucrino prima eMiseno poi, con il palazzo e le ville imperiali di Baia edi Capri.Tuttavia, quanto delineato,non minimizza affattoilsuocostanteimpegnoper lasicurezzanavale.Precisaalriguardoun celebre storicodel settoreche:“‘nonsicrea una marina, arma costosaetecnica.percompitidipolizia tene stre.Dal/atto cheuna truppa, organizzata eminentementeper un impiegobellico in un teatro esternosia. occasionalmente, utilizzataperristabilire ! 'ordineinternononsignificaaj”anchesiastataistituitaperque— stoscopo.vistochelasuafedeltànon è,apriori,piùcenadiquelladellelegioni,peraltropiù idoneeasimi1i impieghi. Questo è confondereincresciasamente lacausa e I ‘efletto.Se è verochela marina romana potetteessereunostrumentodelpoterepersonalenellemanidialcuniimperatori,dubitiamofortementeche siastataprevistaperquestoscopo.non dipiùalmeno,chelelegionideilimes,chegiocarononella vita inf tema del!'Urbeun ruolo ' ma lacui ' c_ 1 ’ non era quella dief-
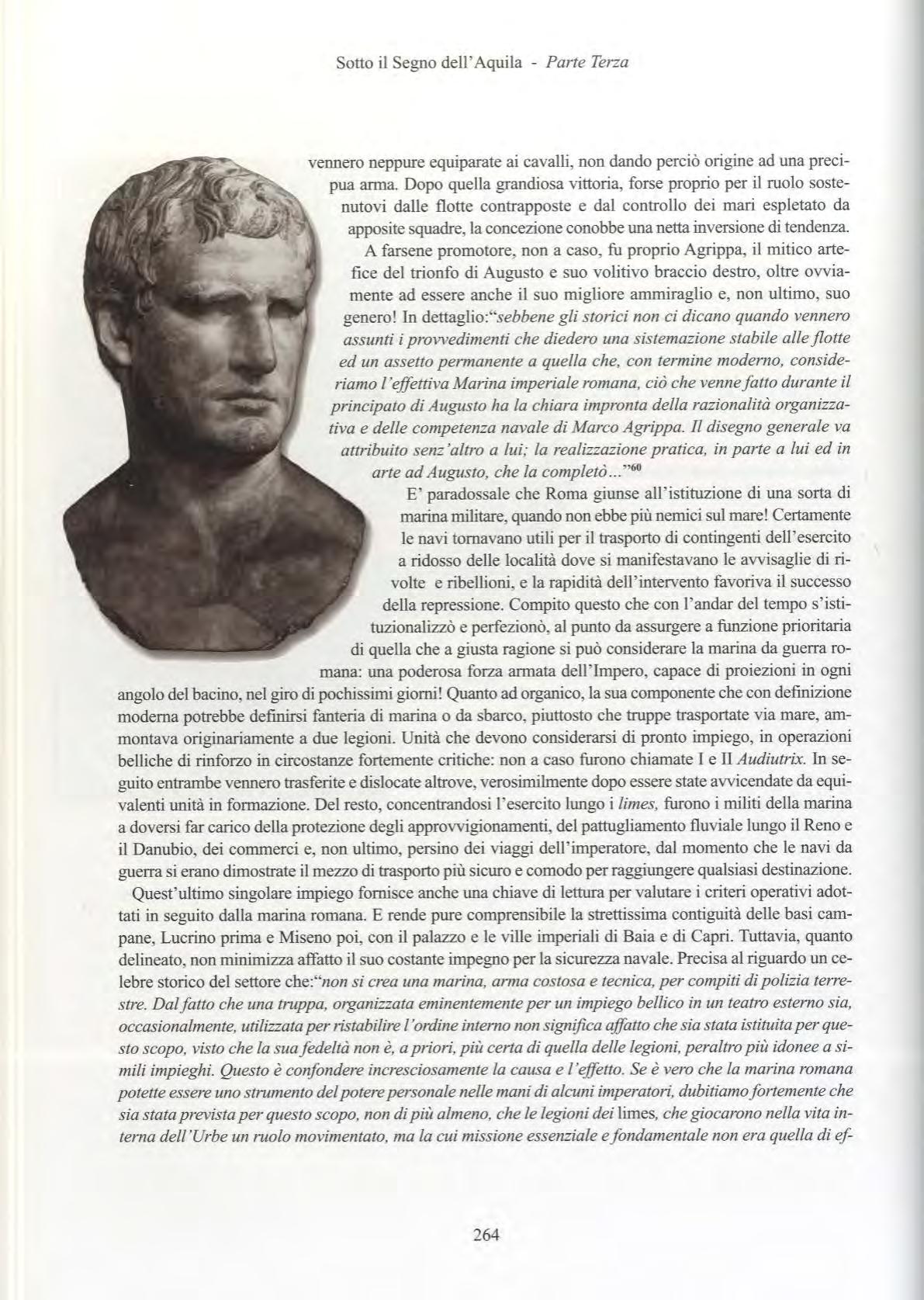
Sotto
il Segnodell'Aquila Parte ΀lîtl
264
fermarecolpidistato…L intervento della marina nella vita politica del]impero è statalimitataedoc— easionale.‘laflatta doveva adempiere ad altre funzioni piu' importanti““
Funzioni che per intuibili ragioni ormai non potevano essere quelleprecipue diuna marina da guerra propriamente detta, non esistendopiù in tutto il Mediter— rano un qualsiasi nemico! L’estendersidel dominiodi Roma al suo intero sviluppo costiero si completò con l’avvento dell‘Impero. Ne conseguì un capillare controllo dal grande porto alla Germania,Mainz:bassorilievoconnavemr'liiaremunitadiamglieriaeresl‘id‘ii'mbalmzianisimilari. minima cala, finendo cosi per Germany,Mainz…bas—reliefwithmilitaryshipcarryinganiiieryandremainsntsimiiarships. non concedere neppure un rcmoto anfratto, dove celarela sua barca, achiunqueavesseosatosfidareil suopotere navale! Eben presto il Mediterraneo divenne il lago centralediun imperoanulare,eperciò lasuamigliore via dicomunicazione.Lapiù rapida inquanto la piùdiretta,lapiùeconomica in quantopriva dipendenze, lapiùvalida inquantopriva di limiti di carico, la più vantaggiosa in quantopriva di limiti di sagoma, a patto però che fosseinnanzituttolapiù sicura, libera cioè da qualsiasi forma di pirateria. Fenomeno delinquenziale con alle spalle millenni di speri» mentate tattiche e noti proventi, radicato prima ancora che lungo i frastagliati arcipelaghi nelle mentalità di tante etnierivierasche. Estirpareradicalmente la parassitaria criminalità, perciò, non si dimostrò possibile inmaniera definitivaneppureperRoma, adontadiquantotrionfalmentepiù volteproclamato. Standoallepiù attendibili fontiromane, infatti, lapirateria erastatadrasticamente debellatagiànein ultimi annidellaRepubblica,percuinon esistendopiù nemici sulmarenéregolarinéirregolari,laflotta appariva inutile. Questo, appunto, secondo le ben note affermazioni della storiografia ufficiale chepur non essendo nella pienezza dell’accezione la propaganda di regime, lascia, però. notevoli perplessità. Perché manteneretantiuomini etantenavi perun compitocheormai avrebbedovutorisultareestremamentemarginalee discontinuocome lalottaaipirati?Seeffettivamenteestintiperche'continuareatenerein servizio centinaia diunità daguena,perfettamente armate ed equipaggiateper gli scontri sulmare, enon limitarsi aduna flottadisoleunitàdatrasporto?Qualicareneavrebberodovutosfondarequeimsn-i'!Larealtà,come risultadaindaginipiùaccorteedocumentate,eranettamentediversapercui,propriopermantenerelalibertà dinavigazioneelasicurezzalungolecoste,siimposenonlaformazioneel'eserciziod'unaflottamadidue addirittura! Tutto sembra confermare, infatti, che i suddetti predoni fossero di gran lunga meno sparuti, menodisorganizzatiemenoremotidiquantosbandierato:razziatorisenzadubbioinsidiosievili,nondegni certamente in quantotalidellaqualificadi nemici ma non per questomenopericolosi edirriducibili!
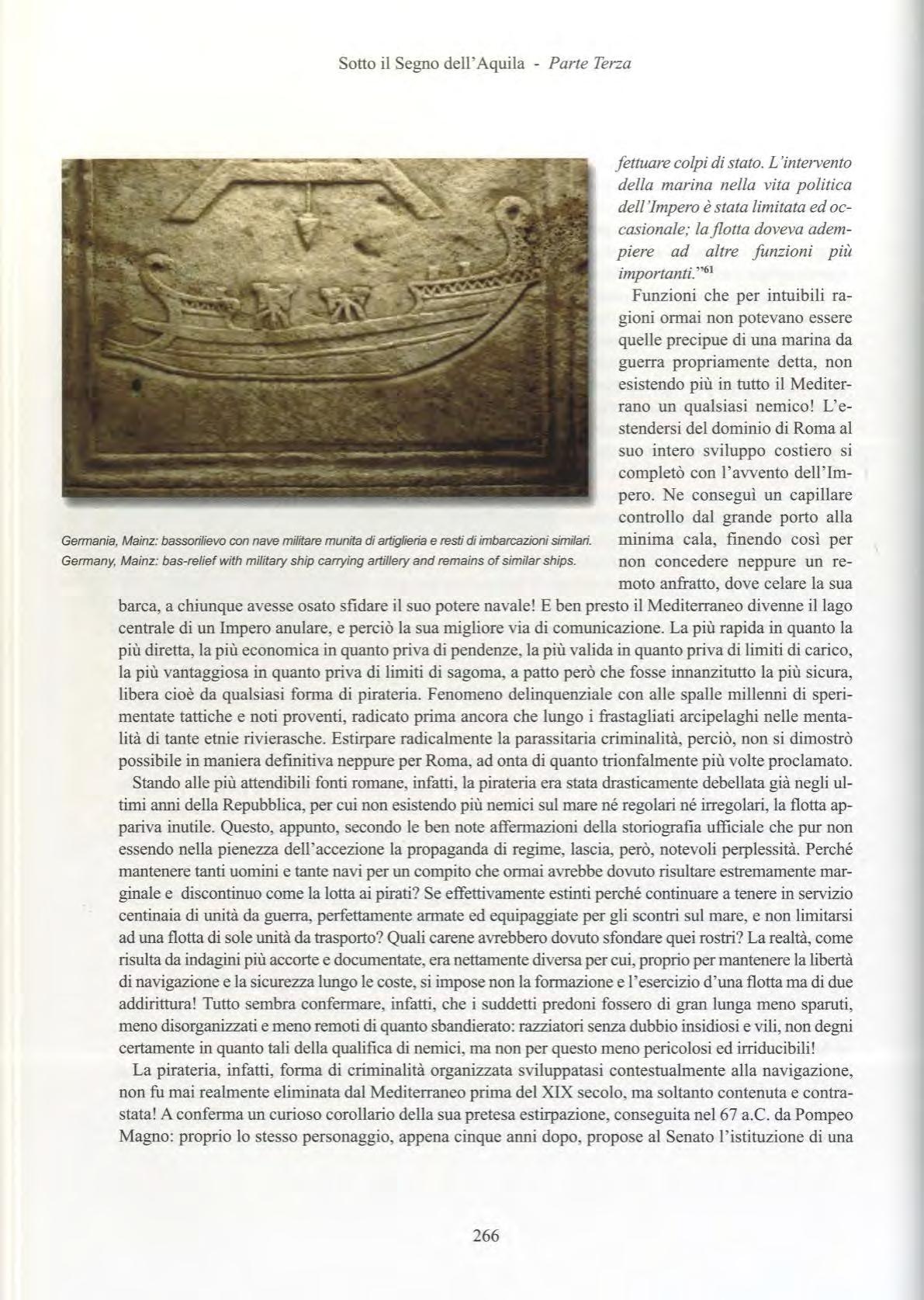
La pirateria, infatti forma di u " ‘ . ‘ alla '
non fumairealmenteeliminatadal Mediterraneoprima del XIX secolo.ma soltantocontenutaecontrastata!A confermauncuriosocorollariodellasuapretesa estirpazione,conseguitanel 67a.C.daPompeo Magno: proprio lo stessopersonaggio, appena cinque anni dopo.propose al Senato l’istituzione diuna
Sotto il Segnodell‘Aquila -
Par/e Terza
266
flotta permanente, al fine di rendere sicura la navigazionenel Mediterraneo. ui inItalia navigaret! E se quellapropostanonglisembròcontraddittoria,fusoltantoperchétutti sapevanoperfettamente che,innessun caso, l'eliminazione poteva considerarsi definitiva ed irreversibile! Ovvio quindi che la richiesta, comecertificaCicerone,non soltantofuprontamente accoltama persino finanziata con lacospicuaelargizionedi 4.300.000 sesterzi,destinandolaal maresuper-um et inferum, ovveroai futuriambiti di competenzadel.leflottediMisenoediClasse.Comepertuttigli stanziamentimilitari,però, ildenaropotrebbe essereandatoper l’approntamentodinuoveunità per il soldodipiù vasti organici oper lacostruzione dimaggiori infrastrutture, inavalr'a.Ma questaevenienza,che siconferma lapiù plausibile, lungi dallo la r ‘ larafforza basi navali che solorn vista di un impiego attivoavrebberogiustificatoquelle colossali spese.rIl cheporterebbe aretrodatare la genesi dellabase di Classediun trentennio, tantopiù cheproprionellasuagiurisdizionericadevano lecostedell’Illiria, dellaDalmaziaedell’Egeo.Una pletora di calette,fiordi edinsenature pullulanti da sempre di pirati, la cui virulenza ad onta dellereiterate repressioni funesterà il Mediterraneo centro orientale fin quasiallaetàcontemporanea.Edèemblematicochelanavedaguerraromanapiùveloce, la [ibm-na,era stata copiatadaquella cheusavano i più aggressivipirati, iLiburni!
Lamarina daguerraromana, quindi,purnon avendopiù sulmarenemici.dovette costantementeperlustrarlopertenereabada ipirati.La solapresenza dellesuenavi, inautonomacrociera oal seguitodei mercantili, bastava a garantire la libera navigazione. E Roma dipendeva sempre dipiù dal costante afflussodiderratevia mareper il suocostantel’approvvigionamentoalimentare:pertanto inetàimperiale il compito di polizia navale divenneprioritario, sia sul mare sia lungo le coste, rigenerandosi i pirati pochi anni dopoogni sconfitta. E seadAugusto venne riconosciuto il merito di aver liberatoi mari dai pirati,pacificmel’interoMeditenaneo,sitrattòinpraticadiunapace efiimeraeprecariadal momento chele fontici continuanoatramandare ancoraepisodidipirateria semprepiù frequenti.Per cui sideve parlarepiuttostodiunapacearmata,diuna sicurezzamaiacquisitaunavoltapertutte,madiun esitoguadagnatodallacostantepresenza in maredellapoderosa marina imperiale."
LA BASENAVALE DI MSENO
Per il ruolo cheapartire dall’età imperiale lamarina da guerraromana svolse, soprat— tuttonell’irrcessanteimpegnopermantenereliberalanavigazioneesicurelecoste,eindispensabileunadigressionesullesuebasi esullelorocaratteristiche.Delresto,alpari dellegrandibasi legionariolungoilimesorientali,eranoquesteleinfrastrutturemaggiori epiù complesse dell'esercito…Tutte le navi da guerraromane stanziate nei diversiporti del Mediterraneo,nell’ultimo quartodel I sec.aC.,come accennato, furono raggruppate e distinte in due flotte. Le rispettive basi navali vennero insediate presso Baia,a Miseno, e presso Ravenna, a Classe: allaprimasiafi-idòlagiurisdizionesulba» cino occidentale fino a Gibilterra, alla seconda sul bacino orientale.finoaiDardanelli.Pur fregiandosi, da Domiziano in poi, entrambe della designazione di Flatte Pretorie, quella tirrenica, nel cui ambito gravitavano Roma e le
Rosirodinavedaguerraromana. Rash-umofromanwarsmp.
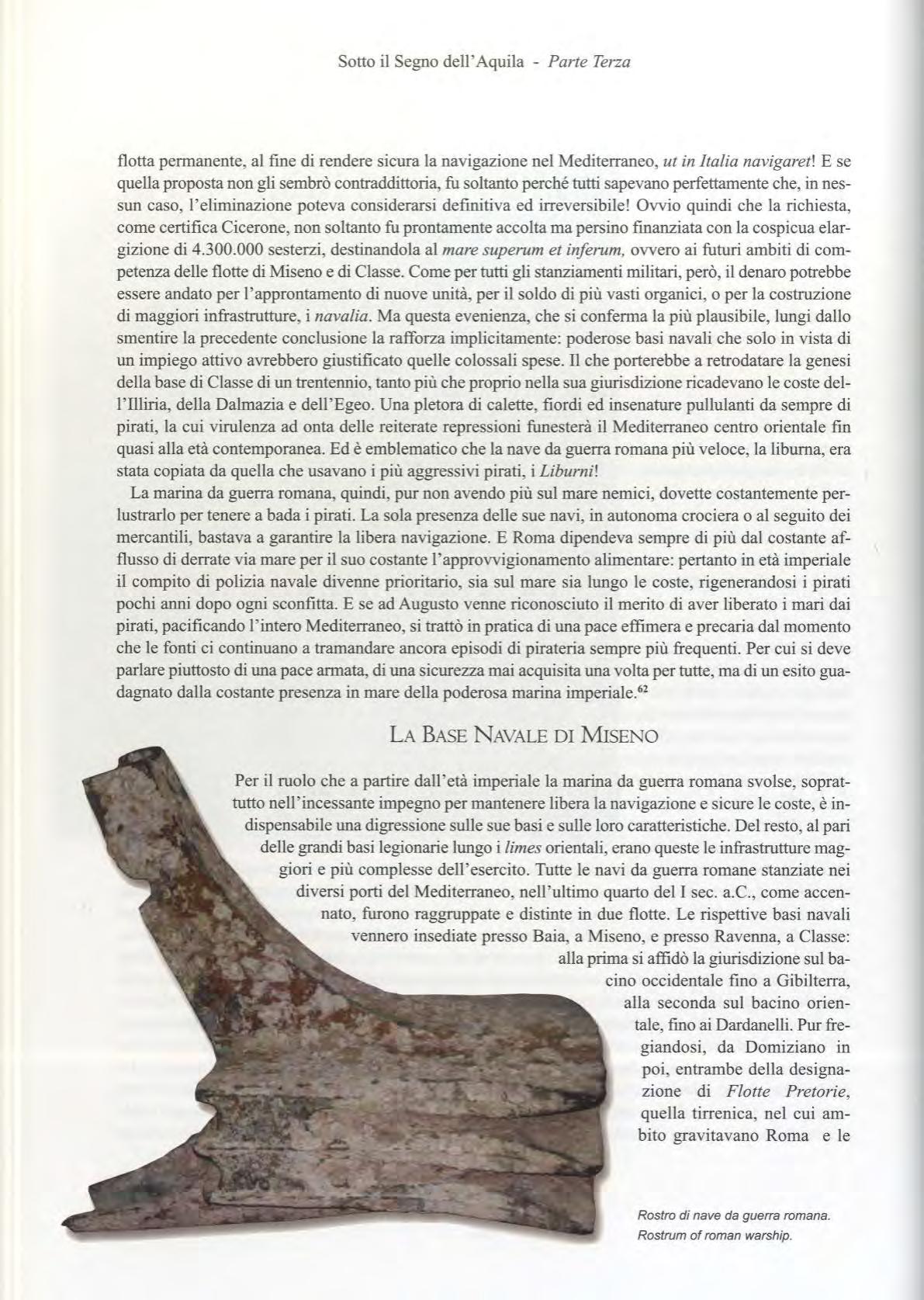
Sotto
il Segnodell'Aquila - Pane Terzo
maggiori città dell'Impero ebbe rango preminente.Per conseguenza il suocomandante potrebbe riguardarsi come l‘anicsignano capo di stato maggiore dellamarina imperiale.ovviamentecon tutte le limitazioni che la carica coeva contemplava.
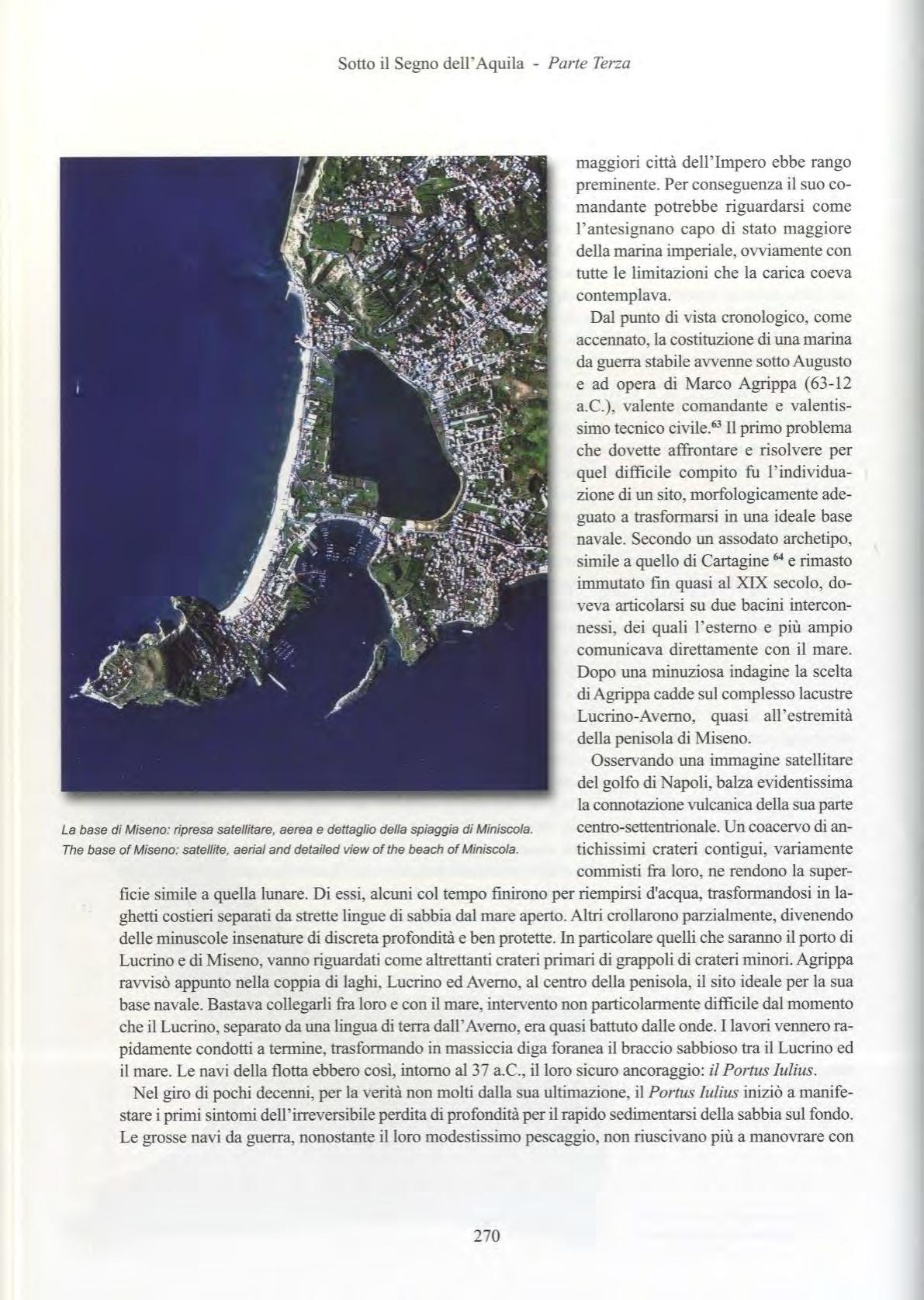
Dal punto di vista cronologico. come accennato.lacostituzmnediunamarina daguerrastabileavxenne sottoAugusto e ad opera di Marco Agrippa (63712 a.C.). valenie comandante e valentissimotecnico civile…EJIl primoproblema che dovette affrontare e risolvere per quel difficile compito Fu l‘individua— zione di un sito.morfologicamcntcadeguato a trasformarsi in una ideale base na\ale. Secondoun assodatoarchetipo, simileaquellodi Cartagine"‘erimasto immutato fin quasi al XIX secolo. dor teva articolarsi su due bacini interconnessi. dei quali l‘estemo e più ampio comunicava direttamente con il mare. Dopo una minuztosa indagine la scelta diAgrippa caddesulcomplessolacustre LucrinoAvemo. quasi all‘estremità della penisola di Miseno.
Osservando una immagine satellitare del golfodiNapoli, balza evidentissima laconnotazione\ulcanicadellasuaparte
centro-settentrionale.Un coacervodi aria
Thebase oiMrssna sale/irte,aerialanddetailedviewofthebeach ofMiriisco/a. tichissirni crateri contigui. variamente commisri fra loro, ne rendono la super ficie simileaquella lunare. Di essi. alcuni col tempo finirono per riempirsi d'acqua, trasformandosi in laghetti costieri separatidastrettelingue di sabbiadalmare aperto.Altri crollaronopanialmente, divenendo delleminuscoleinsenaturedi discretaprofondità eben protette…Inparticolare quellichesarannoilportodi Lucrinoedi Miseno,vannoriguardaticomealtrettanti crateriprimari di grappoli dicrateri minori.Agrippa rawisò appuntonella coppia di laghi. Lucrino edA\'emo. al centrodella penisola. il sitoideale per la sua basenavale.Bastava collegarli fia loroe con il mare.interventonon particolarmente difficiledal momento che il Lucrino, separatodauna linguaditerra dall'Axemo,eraquasibattutodalleonde.Ilavorivennerorapidamente condotti a termine.trmformando in massiccia d' foranca il braccio sabbiosotra il Lucrino ed il mare. Lenavi della flotta ebberocosi.intorno al 37a.C..il loro sicuroancoraggio:ilPar-tusIilIiur'.
Nel giro dipochi decenni.per la verità non molti dalla sua ultimazione. il Parlux lilli…iniziò amanifestareiprimi sintomidcl!‘irreversibileperditadiprofonditàperilrapidosedimentarsidella sabbiasulfondo, Le grosse navi da guerra. nonostante il loromodestissimo pescaggio.non riuscivano più a manovrare con
Sotto il
Segno dell‘Aquila - Parre Tei-:il
Labase diMiseno:npresa sale/mare.aereaedettagliodellaspiaggiadiMin/scola.
Sufficiente sicurezza. per cui nonostante l’ideale collocazione e funzionalità delle strutture accessorie e degli impianti navali il grande complessodovette essereabbandonato. Fu allorache si raWisò nella parte estrema dellapenisola. appena pochi chilometripiù ad ovest.un altrogruppo di crateri allagatiidonei allo scopo.Diessi ilprimo. giànaturalmenteapertosulmareetaprecedutodall'insenaturadi Miseno: la più vistosadifferenzacon il Porto Giulionella sua interezzasiran'isa nelledimensioni di gran lungaminori del nuovoPortodiMiseno.Ma ciò.nonostanteilsensibileincrementodellaflotta.non costituitauna gravedeficienza.essendonenel li‘attempomutato ilcriterioinformatore. Infatti. ormai non occorrevapiù unampio specchiod’acquaper l’addestramentodegliequipaggi…ma soloun buon ponoconun riparatoormeggioper le navi.euno spaziosufficienteper i cantieri.65 EMiseno era un buon porto già molti secoli prima, tant'è cheper i maggiori storici classici la potenza di Cuma fu donna proprio alla sua validità nautica: la deva-
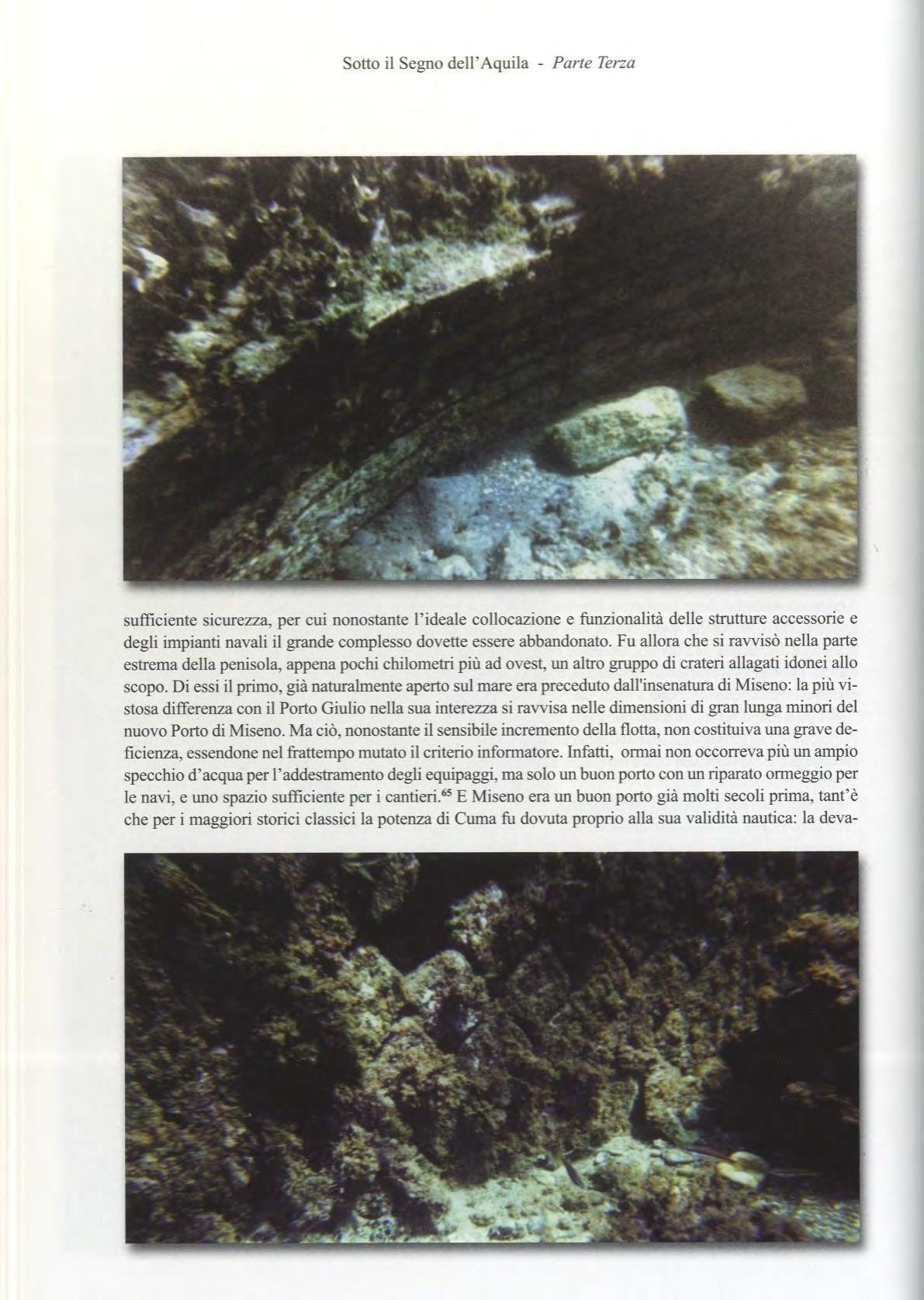
stazioneprovocata daAnnibalenel 214a.C.neconfermaindirettamentelarilevanza. Da alloraoccorsero quasiduesecoliperche'quellasplendidapenisola tornasse inauge,ricoprendosi divilledi svagodelpatriziato romano, Ilporto, invece,non tomò più alla suaantica rinomanza, essendotroppo distante daquello diNapoli, ilprincipale centroeconomico,eparadossalmentetroppovicino aquellodi Pozzuoli.

LatrasformazionediMisenoinprimabasenavaledell‘Imperonemodificòdrasticamente lecaratteristiche,persino dalpunto di vista giuridico.Le sueadiacenze, infatti,vennerodistaccate da Cumaformando unaentitàautonoma,unasortadienclaveextraterritoriale,nellaqualesiinsediòlanuovacoloniamarittima. Una seriedi deduzioni, suffragate da esigui rinvenimenti archeologici porta a concludere che la colonia venne impiantatadaAgrippa sullespondemeridionali delporto, doveesisteoggi l‘omonimo abitato,con un susseguirsidi edificidaMiniscola al monte diMisenum. Difficile stabilireoon precisione la data del» l‘eventoche,peranalogiaconlafondazionedialtrecolonie.estatasuppostaintornoal31a.C.,sebbenesem— briplausibileunadatapiùrecente.Inpochi anniilpiccolocentrodivenneunadinamicaepopolosacittadina militare,doveconverseroesistabilironoitantiufficiali editantissimimarinaidellaflotta,conlerispettive famiglie. Sotto questoaspettoanticipa la connotaz'one delle odierne grandi basi navali statunitensi, anch’essesimiliacittàautonomeinun contestostraniero.]lavoridellanuovabasenavalediMisenovennero avviatiintornoal 15a.C.,dicertofi‘a labattagliadiAziodel31a.C.elamortediAgrippa nel 12a.C.Nel medesimo scorciostorico,delresto, anchepressoRavenna siavviòlacostruzione della secondabasenavale.Attualmentequasinullaèrimastoditantecostruzionietantaattivitàesolonelnomedellaspiaggiadi Miniscola siconservaforsel’estremarimembranza dellamilitum scholn,ilcampod’addestrarnento,menzionatoappuntoscholaarmatura-um inuna epigrafedelIVsecoloivi rinvenutanei paraggi.66Per quanto possa sembrareincredibile,infatti,quasinulla è rimasto non solodellabase, ablazione chepuòattribuirsi al suoabbandono,ma persino dellastessacittà,lecuiultimenotizierisalgano al X secolo.Probabilmente più che leincursionisaracenelaprincipale concausadellaradicaledistruzioneva niwisataneibradisismi, dicuil'interazonafuvittima apartire dalladissoluzionedell’impero,
LA BASENAVALE DICLASSE
Aprimavistapuòsembrareun cinicodestinocheirestidiambeduemaggioribasinavali imperiali,siano staticancellatipropriodalmare.QuellidiMisenogiaccionoauna decinadimetrisottolasuasuperficiee quellidiClasseaqualchechilometrodallasuasponda!Semplicelaspiegazionedell’apparenteparadosso: una base navale ideale doveva dispone di un bacino interno di tipo lacustre ediun’insenatura esterna, molto raccolta: ormeggio sicuro dalletempeste l’una, ancoraggio stagionale l’altro. Una sorta di doppio specotangente, un bacinoa formadi 8,connotazionegeologicaiamquantoprecaria, esitodel degradodi sedimentivulcanicioalluvionali,formazionigeologichesempreinstabiliedeffimere.Poichélasceltascaturiva dall’indiscutibilecriteriomilitaredell’hince!nuc, l’evidenteipotecanon funeppurepresa inconsi— derazioneeperquasitre secoliqueibacini assolseroallalorofunzione,prima disvanire.
DalpuntodivistacronologicolatrasformazionediunapropagginediRavenna inbasenavaledeveesserecollocata all‘indomani della battaglia diAzio, intornoal 32 a.C.La grande flotta vittoriosa di VipsanioAgrippa,ulteriormenteincrementatadairesti di quelladiMarcantonio fusuddivisain duesezioni, una nei pressi di Baia,l‘altranei pressi di Ravenna. Riscontrata l’idoneità del sitoinbreve tempo i tecnici loadeguarcnoallemolteplici esigenzediuna grande flotta militare.dotandolodellerelative infiasîrutture.AncheaClassevenneroperciòcostruiticanalidiraccordo,cantieri,rampedialaggio,arsenali, depositi,magazzini,banchine,cisterneepersinoun grande faro.PliniomenzionalaFassaAugusta, ilcanalenavigabilecheuniva ClasseeRavenna allafocedel Po,edungrandefarosimile,asuodire,aquello d‘Alessandriad’Egitto…"
Sottoil
Segnodell'Aquila - Parte Terza
274
Sottoil Segnodell‘Aquila - Parte Terza

Tentareoggidistabilirel’urbanisticaegliimpiantidellabasediClasse e quasiimpossibile,perletantetrasformazionipolitiche successive alladissoluzionedell’Imperod’occidente.Delresto,siignora ptrre quandocon certezza Ravenna entròstabilmenteafar parte dello Statoromano: la forcella d’indeterminazione spazia fia il 295 ed il 170aC., oltreun secolo,e sembra concludersi nel 49 a.C. con laconcessione della cittadinanzaromana Maanchequestadata è discarsaattendibilità.,ricavata per analogia da quellaconcernente la Gallia Cisalpina,volutaappuntodaGiulioCesare.DicertofilpropriolostessoCesateatrarnandarciunaRavenna,similead una antaignanaVen.-a. Scriveva,infatti,che fraletante cittàsiuratefralepaludideldeltapadano,primeggiavaRavenna,costruitainteramenteinlegnoeattraversatadall‘acqua:visicircolavaperciòsuponti esubarche econl’alta mar-ea lacittàricevevaalsuointernoilflussodelmare.“
Aldilàdimrestasuggecfivacinàlacunare,qualefuinrealtàl’aqrdtodiClassenellapimezmdellasuaattività?Sembra plausibileuna strettaafiinitàcon Miseno,una sona di enclaveautonoma.multietnica,pullulantediuominiediattività,doveaitantimilitarisiaffiancavanoitantissirnicivili indispensabiliallasuagestione.Uncoacervodicaserme,di abitazioniprivate,dicantieri,ditaverne,dipostriboli,dibot» teQre,esullosfondocentinaiadinaviinanivoeinpartenm Scaricatorisullebanchine,marinaiinfranchigia,artigianial lavoroedovunquecommercietrafiici!Dalmomentochela vita media d‘unaunità navaleanticanon sembra eccedere pochedecined’anni,peraltrosupportatadacontinuamanutenzione,unaflotîadiuncentinaiodinavi daguena,che tale sembra essere stato l’organico massimo di quella di Classe,implicavaunindottosocialerilevante.Tantoper00minciareunaformmilitaredi940.000uomini,allaqualesi deveaggiungerequellarnerarnartenavale,pariasuavoltaad almenolS-20.000rematori;edancoratrnafolladiboscaioli, carrettieri.segaton.mastrid’ascia,calafati,cor-dai.fabbrifermi,tenditoriecarpentieri.Edovviamenteunacompaginedi pubbliciamministratori,addettiallemanutenzioniidrichee stradali,smerdotiemercanti.Tutticonlerispettivefamiglie, all’epocanumerose:quale l’entitàdemograficapiù proba- | bileperlacivims Chassis?Non simacollocandolainte-mo ai 40-50.000 abitanti, in buona sostanza coincidente con i quellaipotimtaperMisenonellastessaepocaechenondovettemutaregran chenel corsodei circatre secolidi esi- l stamidellabase
i
stessa.
StelefunerariadeltimoniereApelle, rinvenuta nell'area archeologica diClasse.
FuneralysteleoftheHeersmanApe/Ie, foundin (llearchaeological sileofClasse.
Note
1- Per un'ampia sintesi sugli awenimenti cheportarono alla istituzione dell’Imperoromano cfr. H.A, FISHER,Storiad'Europa,Milano 1964.pp. 119-140…
2 - Cfr.J.WACHER,IlmondodiRoma imperiale, Bari 1989,pp.70-78.
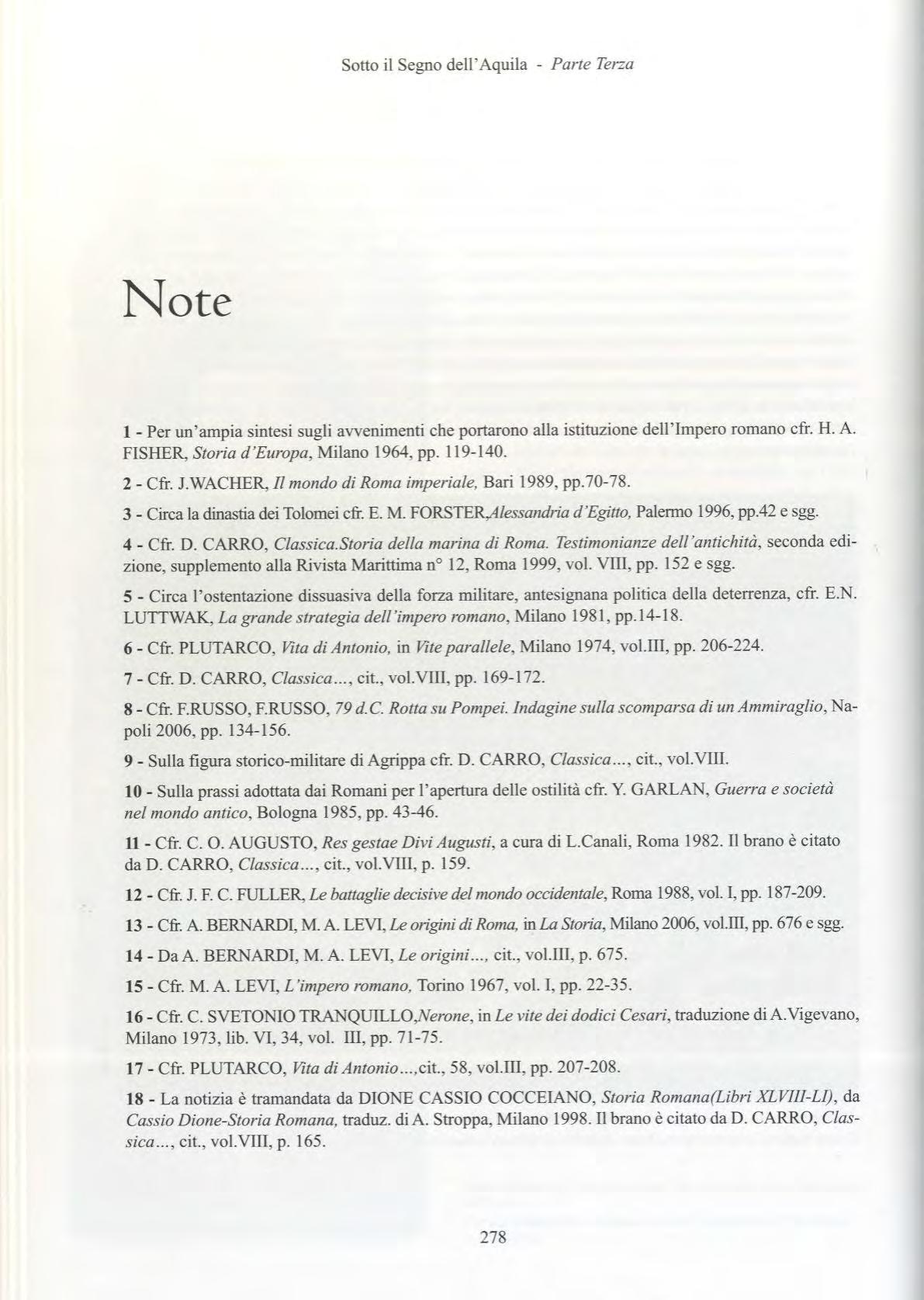
3-CircaladinastiadeiTolomeiefi:E.M.FORSTER,AI&YSMfi/zd’Egitto.Palermo 1996,pp.42 &:sgg.
4-Cfi'. D. CARRO, Clusxica.Smria della marina di Roma. Testimonianze dell’antichità,seconda edizione, supplementoallaRivista Marittiman° 12,Roma 1999,vol.VTII,pp. 152e sgg.
5 — Circa l’ostentazione dissuasiva della form militare, antesignanapolitica della deterrenza, cfr. E.N. LUIIWAK1Lagrandes!rulegia del!’imperoromano, Milano 1981,pp.]4-18.
6 - Cfr.PLUTARCO, Vita diAntonio, in Vueparallele, Milano 1974,VOLTI], pp. 206-224…
7-Cfr.D.CARRO,Classica.…cit.,vol.Vlll,pp. 169-172.
8-Cfr.F.RUSSO,F.RUSSO, 79d.C.RottasuPompei.IndaginesullascomparsadiunAmmiraglio,Na- poli2006,pp. l34-156.
9 - Sullafigura storico-militarediAgrippa cfr. D.CARRO, Classica.…cit….VDl.VIII.
10- Sullaprassi adottatadai Romaniper l’aperturadelle ostilitàcfr.Y. GARLAN, Guerra esocietà nelmondoantico, Bologna 1985,pp.43-46.
Il -Cfr.C.O.AUGUSTO, ResgestaeDivi/ingrati,acumdi L.Canali,Roma 1982.Ilbrano ècitato daD.CARRO, Classica.…cit.,vol.Vlll,p. 159.
12- Cfr.J.F.C.FULLER,Lebattagliedecisivedelmondooccidentale,Roma 1988,vol.I,pp. 187-209.
13-Cfr.A.BERNARDI,M.A.LEVI,Leorigiru'diRoma, inLaSror-ia.Milano2006,v01IH,pp.676esgg.
14-DaA. BERNARDI,M.A. LEVI,Leorigini..., cit.,vol.llI,p. 675.
15 Cfr.M.A.LEVI,L'impemromana, Torino 1967,vol. I,pp.22-35.
16— Cfr.C.SVETONIOTRANQUTLLOJVEIDIIZ,inLevitedeidodiciCesari,traduzionediA.Vigevano, Milano 1973,lib.VI, 34,vol. III,pp… 71-75.
17 Cfr.PLUTARCO, Vita diAntonia...,cit…, 58,vol.]"ll, pp.207-208.
18 - La notizia è tramandata da BIONE CASSIO COCCEIANO, SteriaRamana(LibriXLVIII-LI), da CassioDiane-StoriaRomana, traduz.diA.Strappa,Milano 1998.Ilbrano ècitatodaD, CARRO,Classic-a..., cit.,vol.VllI,p. 165.
Sottoil Segnodell‘Aquila Parte TEI°ZH
278
19- Cfr.M.A. LEVI,Limpero.... cit.. vol. I,pp, 9-97.
20 Per laverità il vincitore sichiamava ancorasoltantoOnaviano,poiché il titolo di Augustus gli sarà conferito dal Senatoil 13gennaiodel 27 a.C., assumendoda quel momento il nome ufficiale di Imperator CaesarDivifiliusAugustus.Quattroanni dopogli sarà riconosciuta pure latribuniciapotestas ed a vita l’imperiumproconsolare. Il suosarà lapiù lunga sovranità dell’intera storia imperiale, protraendosiperben 44 anni,fino al23 d.C. Cfr.M.A. LEVI,Limpera..., cit., vol… I,pp. 23-24.
21 - Cfr.].WACHER, 17mondo diRoma..., cit.,p.100.
22 - Cfr. S.A.VITTORE,Liberde Caesaribus,I, 1.
23 - DaY. LE BOHEC, L ’esercitoromano, Urbino 2001,p.244.
24 — Da E.N. LU'I’I'WAK1Lagrandestrategia cit.,Milano 1981,p. 30.
25 — Da J.WACHER,IlmondodiRoma…, cit.,p.101.
26 — DaA. BERNARDI,M.A.LEVI,Leorigini..., cit.,vol. 111,p. 679.
27 - Precisa C.MARCATO, coautrice del, Dizionario di toponomastica, Milano 1996, alla voce Friuli:"Regionestoricadell'Italianord—orientale,all’incircacoincidenteconleprovince diUdineePordenone;dalpuntodivista storicoincludevaancheilterritoriodi Portogruaro(oraprovincia diVenezia) el’altoemediobacinodel1‘lsonzo... IlnomeèlariduzionediForumIulii“forodiGiulio’(probabilmente dallagensIuliapiuttostochedaGiulioCesare)...”
28 — DaY.LE BOHEC,L'esenrr'toromano, Urbino 2001,p.27-28.
29 Tra i legionari cadutiprigionieri inquella disfatti,alcuni arruolati forsecome mercenari ed inviati sulconfineorientaledellaSogdiana,cadderonuovamenteprigionieri ma dell‘esercitocinesedelladinastiaHang, finendodeportati in Cina.Lì secondolatradizione fondaronouna cittàacui diederoil nome diRoma. Soloinpochiriuscironoatornare in Occidente…
30 - Cfr…M… SM(INS,L'esercitoromanodaAdriano a Costantino, Madrid 1999,p. 19.
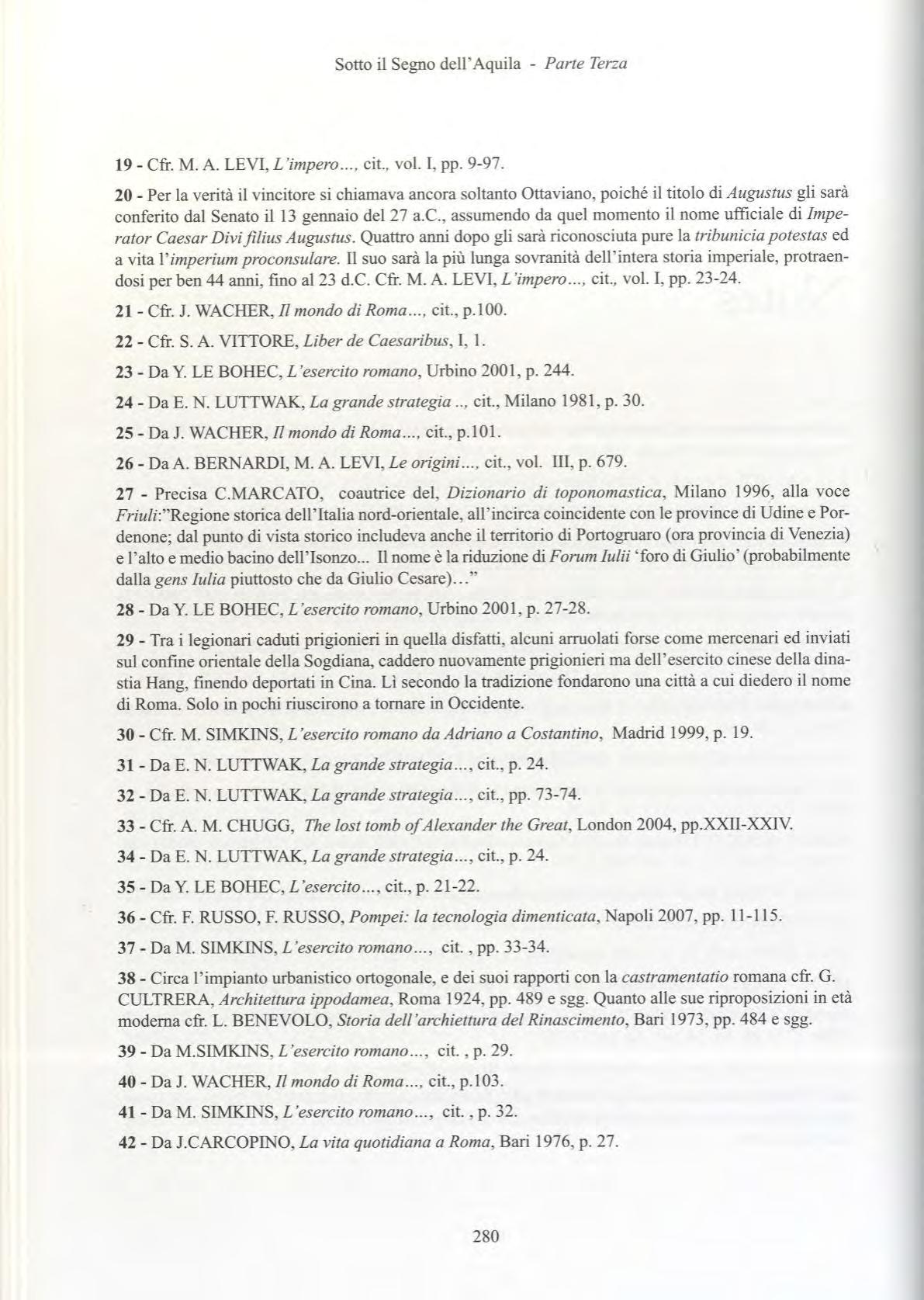
31 - Da E.N. LUTTWAK,Lagrandestrategia.…cit.,p.24.
32 — Da E.N. LUTTWAK,Lagrandestrutegia...,cit.,pp… 73-74.
33-Cfr.A.M.CHUGG, UrelosttombofAlexander the Great,London 2004,pp.XXIl—XXIV.
34-Da E…N. LU'I'I'WAK,Lagrandestrategia…cit.,p. 24.
35 DaY. LE BOHEC,L’esercito...,cit.,p.21-22.
36 - Cfr.F.RUSSO,F.RUSSO,Pompei:la tecnologia dimenticata,Napoli 2007,pp… 11—115.
37 — Da M. SIMKÎNS,L’esercito romano.… cit.,pp. 33-34.
38-Circa l’impiantourbanistico ortogonale,edei suoirapporti conlacastramentatioromana cfr… G… CULTRERA,Architettura ippodamea,Roma 1924,pp…489 esgg.Quantoalle sueriproposizioni inetà moderna di'.L.BENEVOLO, Storiadel!’archietturadelRinascimento,Bari 1973,pp.484 esgg.
39-Da M.SIMKINS,L’esercitoromano.… cit. ,p. 29.
40-Da J. WACHER,Ilmondo diRoma..., cit.,p.103.
41 Da M. SIMKINS,L’esercito romano.… cit.,p. 32.
42 - Da I.CARCOPINO,Lavita quotidiana a Roma,Bari 1976,p. 27. 280
Sottoil Segnodell'Aquila - Parre Terza
Sottoil Segnodell‘Aquila - Parte Terza
43 - Sullapompa di Ctesibiocfr. F.RUSSO,F.RUSSO,La tecnologia.... cit..pp. 208-211.
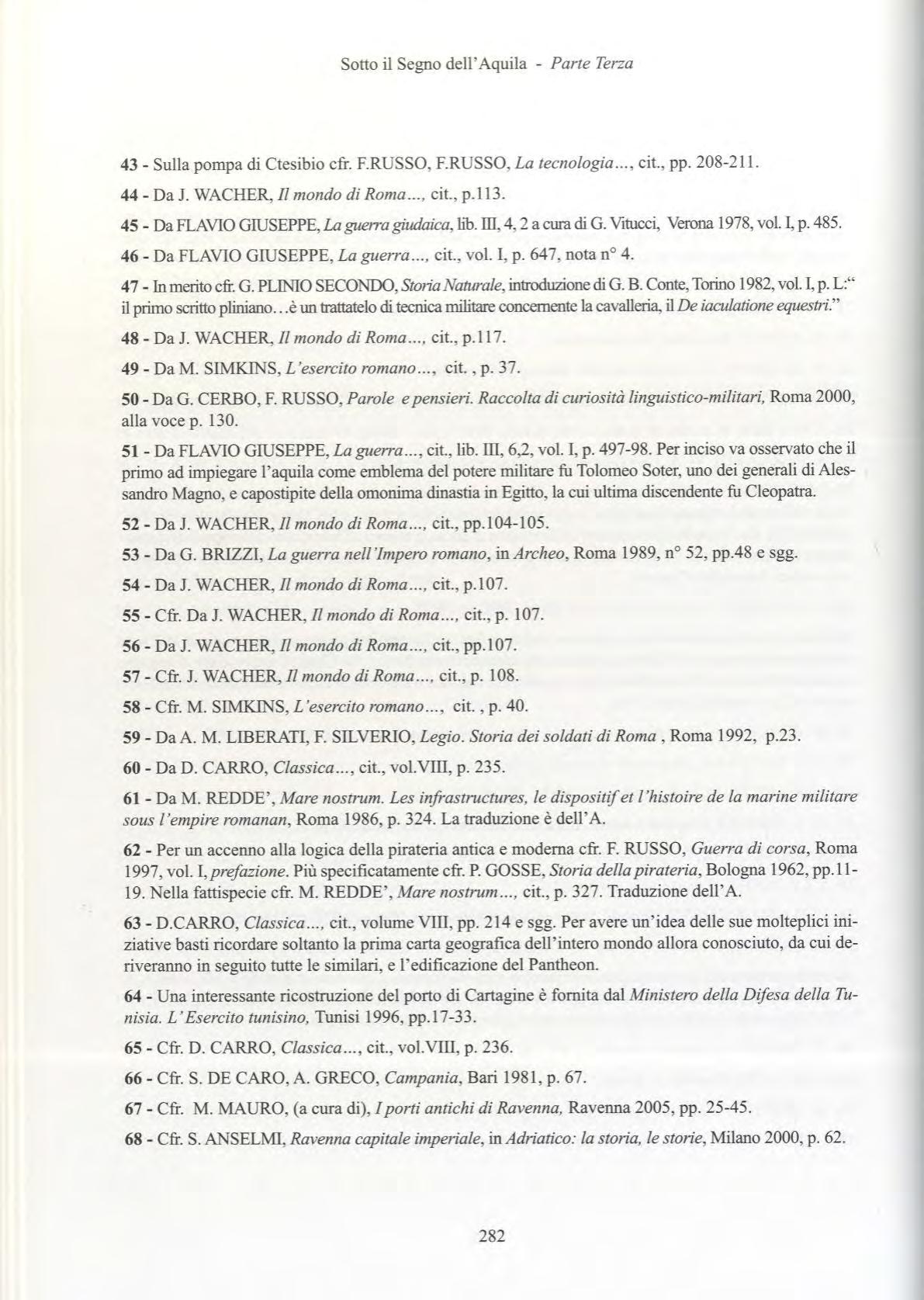
44 — Da].WACHER,Ilmondo diRoma...
cit.,p.113.
45 - DaFLAVIOGIUSEPPE,laguerragiudaica,lib.Il],4.2acuradiG.Vimcci, Verona 1978,vol.I.,p.485.
46 Da FLAVIO GIUSEPPE,Laguerra…. cit.,vol. 1,p. 647,nota n° 4.
47 — Inmeritocfi’.G.PLINIOSECONDO,StoriaNaturale,introduzionediG.B.Conte,Torino 1982,vol.I,p.L:“ ilprimoscrittopliniano. .èuntrattatelodimcnimmiliareconcernentelacavalleria,ilDethailationeequestri."
48 - Da].WACHER,IlmondodiRoma…, cit.,p.117.
49 — Da M. S]MKINS,L’esercitoromano.… cit.,p. 37.
50— DaG.CERRO,F.RUSSO,Parole epensieri.Raccoltadicuriositàlinguistico-militari, Roma2000, allavocep. 130.
51- DaFLAVIOGIUSEPPE,Laguerra...,cit.,lib. 11],6,2,vol.I,p.497-98.Per incisovaosservatocheil primoadimpiegarel’aquilacomeemblemadelpoteremilitareinTolomeo Soter,unodeigenerali diAlessandroMagno,ecapostipitedellaomonimadinastiainEgitto,lacuiultimadiscendentefuCleopatra.
52-Da .I.WACHER,IlmondodiRoma..., cit.,pp.104—105.
53 - Da G…BRIZZI,Laguerranell’Imperoromano, inArcheo,Roma 1989,n° 52,pp.48 esgg.
54 - Da J.WACHER,Ilmondo diRoma…, cit.,p.107.
55- Cfr.Da].WACHER,IlmondodiRoma..., cit.,p. 107.
56 — Da].WACHER,IlmondodiRoma..., cit.,pp.]07.
57 Cfr…J…WACHER,IlmondodiRoma… cit.,p. 108.
58 - Cfr.M. SIMKINS,L'esercitoromano.… cit.,p.40.
59 DaA.M.LIBERATI,F.SEVERIO,Legio.StoriadeisoldatidiRoma , Roma 1992, p.23.
60 - Da D.CARRO, Classico…cit.,vol.VlII,p.235.
61 - Da M… REDDE’,Marenostrum. Les infiastruetures, ledispositrfetI’histoiredela marinemilitare sousI'empireromanan, Roma 1986,p. 324.Latraduzioneèdell‘A.
62-Per un accennoallalogicadellapirateria anticaemoderna efi…F.RUSSO, Guerra dicorsa,Roma 1997,vol.I,prefazione.Più specificatamenteefi…P.GOSSE,Storiadellapirateria,Bologna 1962,pp.ll—
19.Nella fattispeciecfr.M.REDDE‘,Marenostrum... it.,p… 327.Traduzione dell’A.
63-D…CARRO, Classica.…cit.,volumeVIII, pp.214esgg.Per avereun’idea delle suemolteplici irriziativebastiricordare soltantolaprima cartageograficadell’interomondo alloraconosciuto,dacuideriveranno in seguitotutte le similari,el’edificazione del Pantheon.
64-Una interessantericostruzione delporto di Cartagine è fornitadalMinisterodella Difesa della Tunisia. L'Esercitotunisino, Tunisi 1996,pp.]7-33.
65 - Cfr.D.CARRO, Classica.…cit.,vol.VlU, p.236.
66-Cfr.S.DECARO,A.GRECO,Campania,Bari 1981,p.67.
67-Cfr. M.MAURO,(acuradi),Iporti antichidiRavenna, Ravenna 2005,pp. 25—45.
68— Cfi'. S.ANSELNH,Ravenna capitaleimperiale,inAdriatico:lastoria, lestorie,Milano2000,p. 62.
282
L'area sottoilcontrollodiRoma nel230d.C.
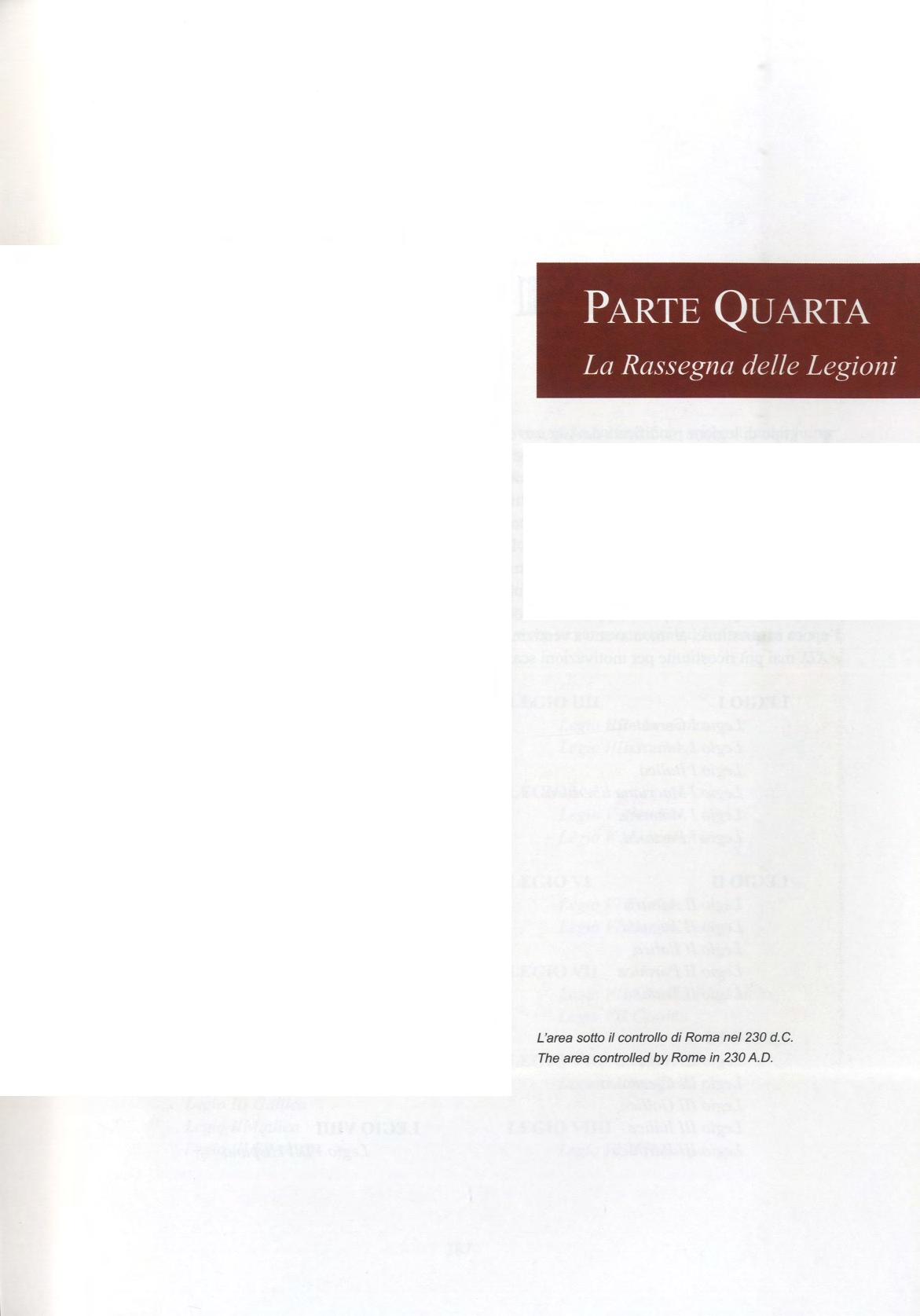
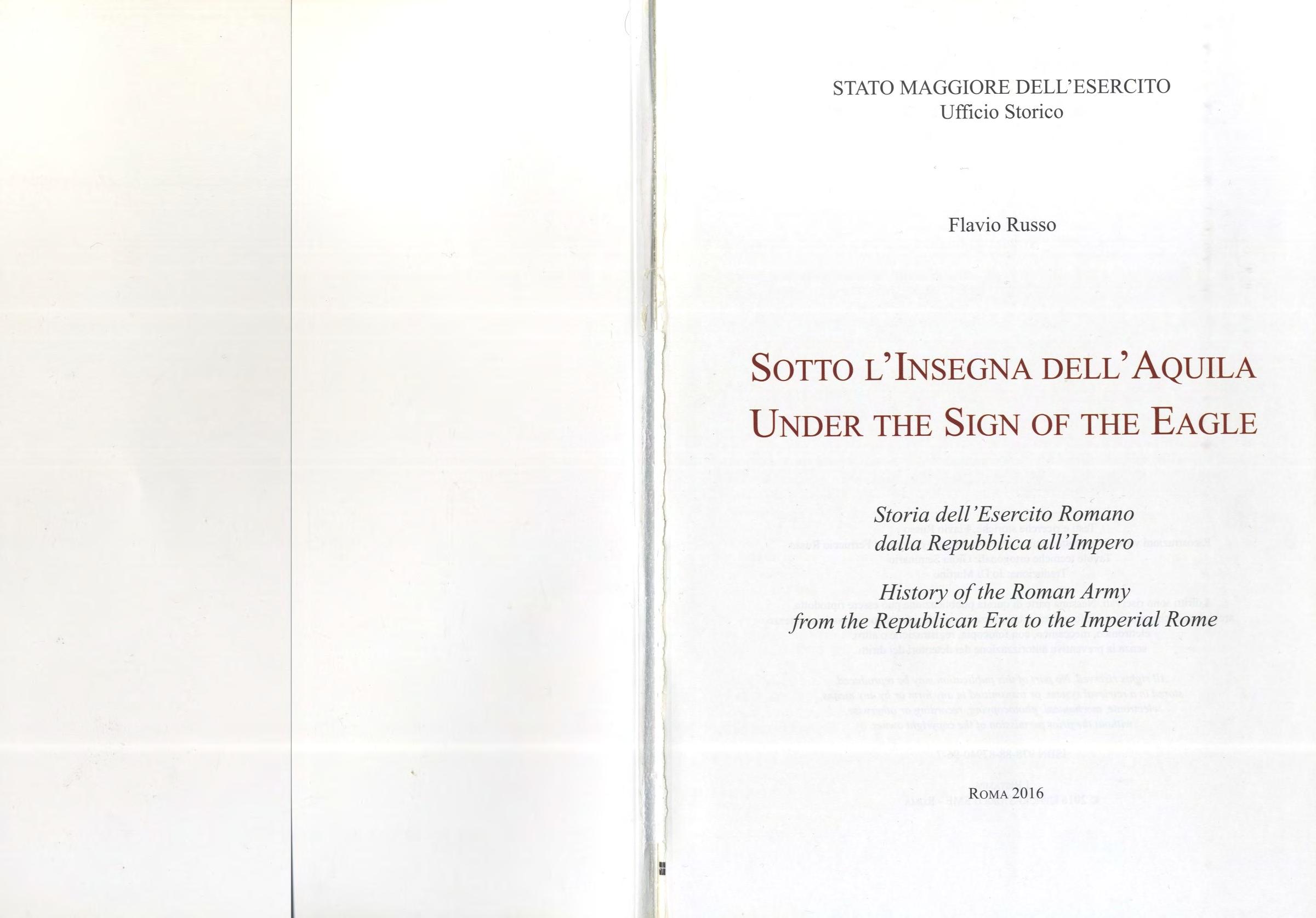
Theareacontrolledby Romein 230A.D.
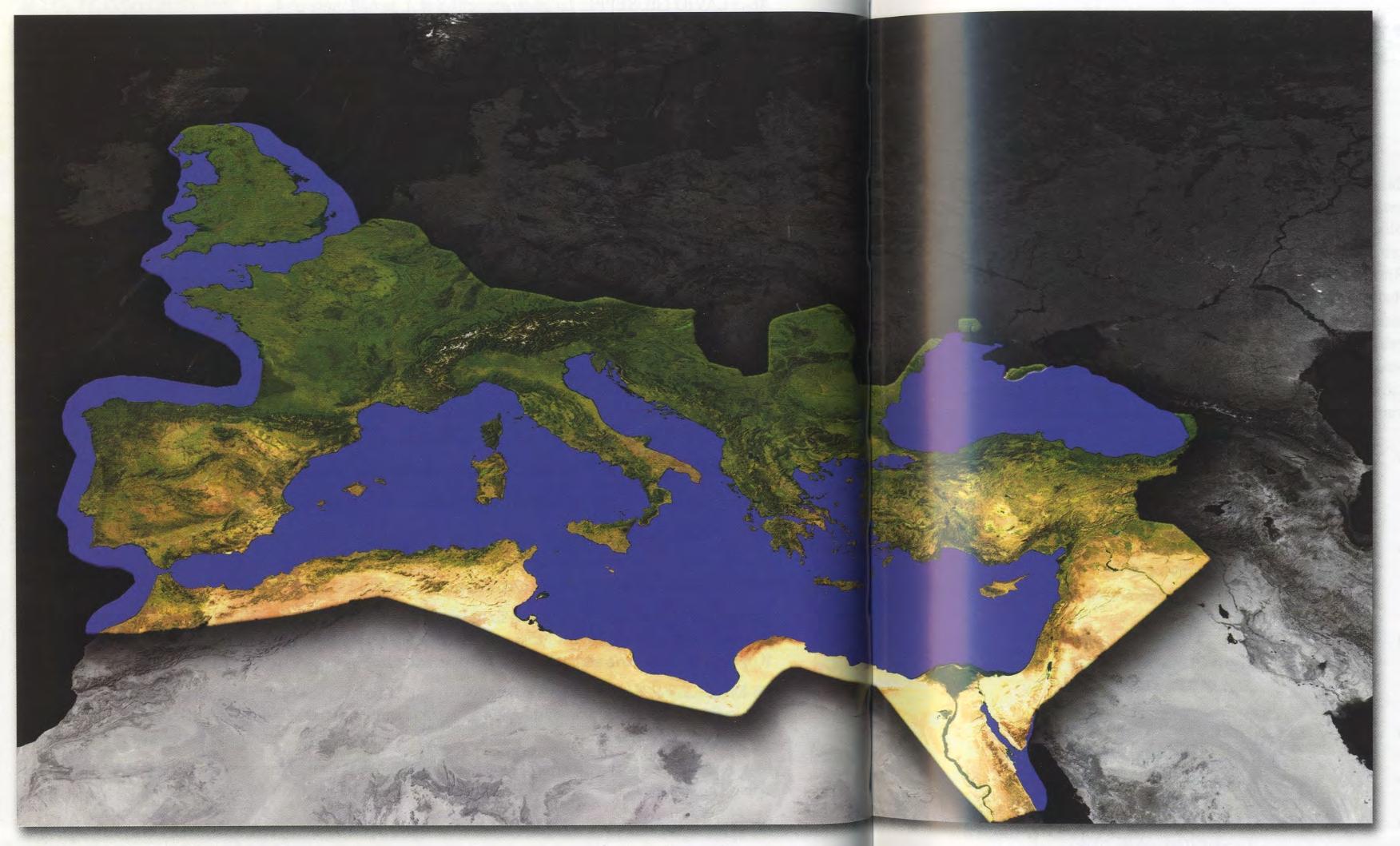
dcl/c' Legioni
PARTE QUARTA La Rasscgnu
Le Legioni dell’Impero
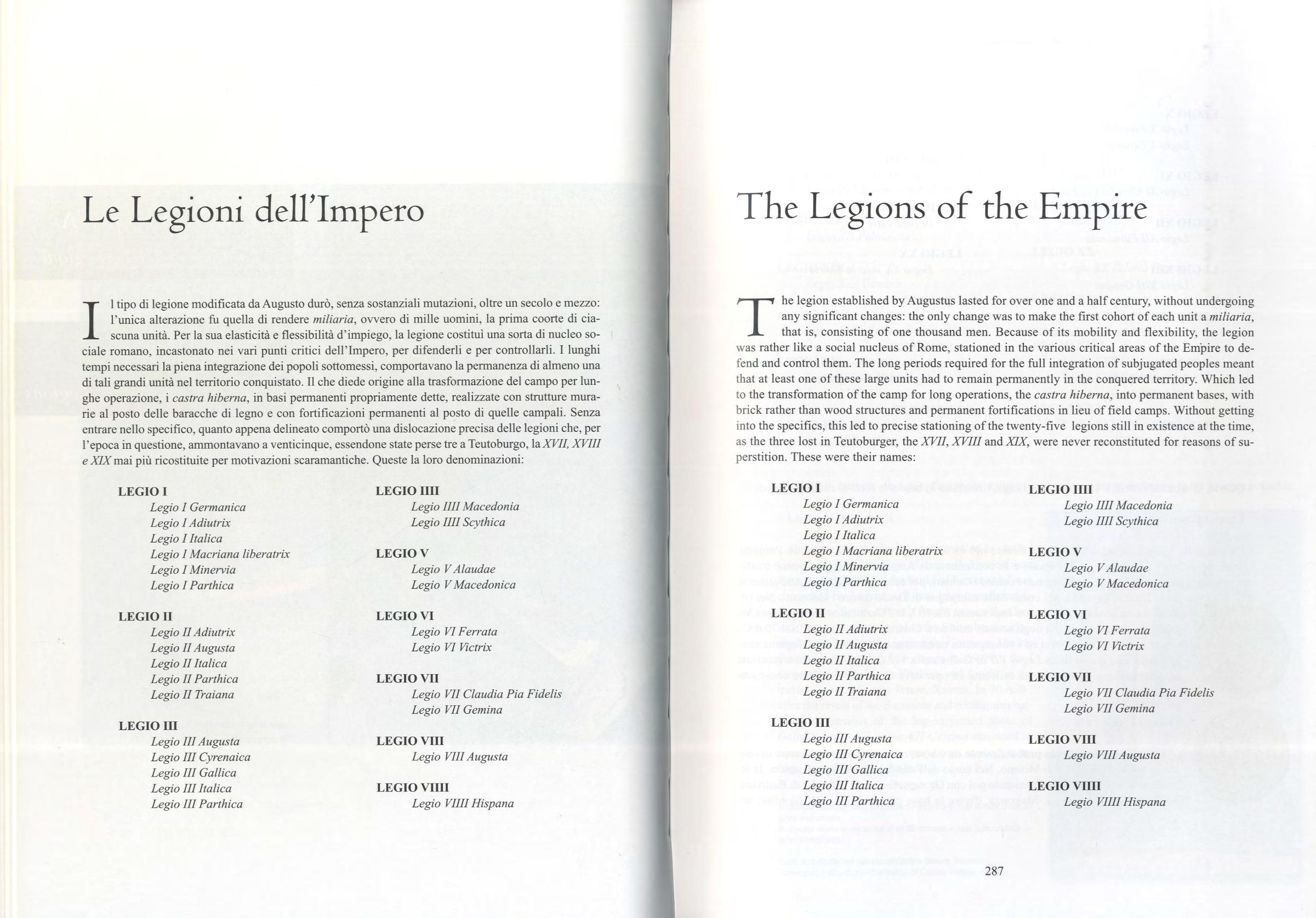
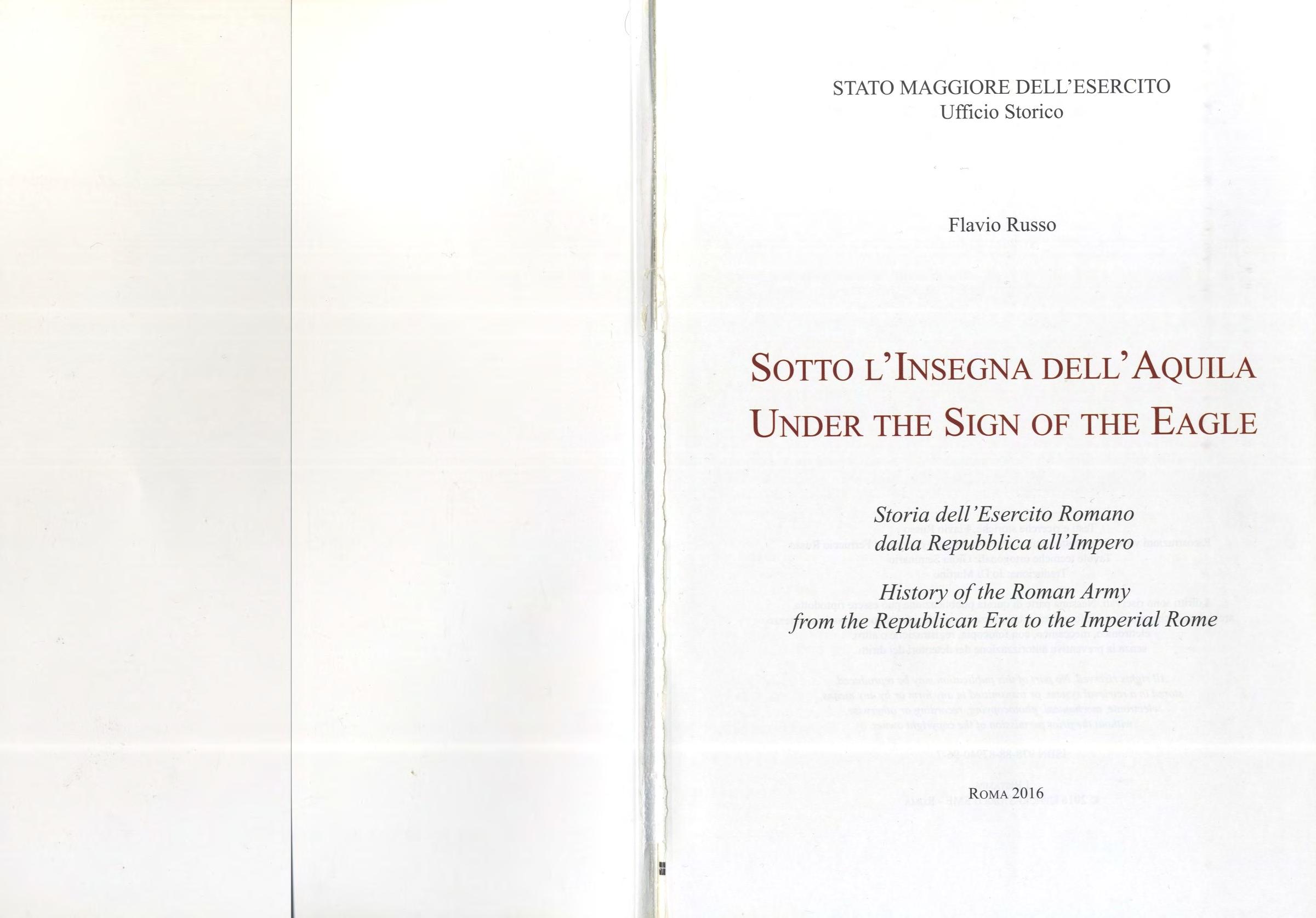
I1tipodi legionemodificatadaAugusto durò,senzasostanzialimutazioni,oltreun secoloemezzo:
l’unica alterazione fu quella direndere miliaria, ovvero di mille uomini, la prima coorte di ciascunaunità.Per la sua elasticità eflessibilità d’impiego,lalegione costituìuna sortadi nucleo so» ciale romano, incastonato nei vari punti critici dell’Impero, per difenderli e per controllarli. I lunghi tempinecessarilapienaintegrazionedeipopoli sottomessi,comportavanolapermanenza dialmenouna ditaligrandiunità nelterritorio conquistato. Ilchediedeorigine allatrasformazionedel campoper lun— ghe operazione, i castra hiberno, inbasi permanenti propriamente dette,realizzate con strutturemurarie alposto delle baracche di legno e con fortificazioni permanenti al posto di quelle campali. Senza entrarenello specifico,quantoappenadelineatocomportòunadislocazioneprecisa dellelegioniche,per l’epocainquestione,ammontavanoaventicinque, essendonestatepersetreaTeutoburgo,laXVII,XVIII eXIXmai più ricostituiteper motivazioni scaramantiche.Queste la lorodenominazioni:
LEGIO I
Legio]Germanico
Legio1Adiutrix
LegioIItalica
LegioIMacrianaliberater
LegioIMinervia
LegioIParthica
LEGIO[III
LegioIII]Macedonia
LegioIII]Scythica
LEGIOV
Legio VAlaudae
Legio VMocedonica
LEGIOIl LEGIOVI
LegioIIAdiutrix
Legio][Augusta
Legio]]Italica
LegioIlParthico
LegioIITraiana
LEGIOIII
Legio I]!Augusta
LegioIIICyrenaica
LegioIIIGallica
LegioIIIItalica
LegioIIIParthica
Legio VIFerrata
Legio VI Victrix
LEGIOVII
Legio VIIClaudia Pia Fidelis
Legio VIIGemina
LEGIOVIII
Legio VIIIAugusta
LEGIOVIIII
Legio VIII]Hispano
Sottoil Segnodell'Aquila Parte Quarta
LEGIOX LEGIOXVII
Legia )(Fretensir LegiaXVI]
LegioX Equestris
LEGIOXVII]
LEGIOXI LegiaXVIII
Legia)flClaudia Fia Fidelis
LEGIOXVIIII
LEGIOXII LegioXVIII]
LegioX?]Fulminala
LEGIOXX
LEGIOXIII LegiaXX Valeria Victrir
LegioXIIIGemina
LEGIOXXI
LEGIOXIII] Legio)O(]Rapax
LegioXIII]GeminaMartia Victrbr
LEGIOXXII
LEGIOXV Legio)O(]!Deiatoriana
LegiaXVApollinaris LegioJOG]Primigenia
LegiaXVPrimigenia
LEGIOXXX
LEGIOXVI LegioXXXUlpia Vict7'ix
LegiaXVIGallica
Questo,in estrema sintesi, il loro statodi servizio,ricostruito inbase alle fontidi cui disponiamo:
LactoI GERMANICA
Fu una delle legioni arruolate da Giulio Cesare nel 48 a.C. in vista dello scontro con Pompeo. L’unità prese parte alla battaglia di Farsalo e fu confermata da Augusto. In seguito venne trasferita nella SpagnaTarraconese,dovecombattécontro i Cantari,per esserepoi trasferita nuovamente lungo la frontiera renana, nel corsodellecampagne di Druso contro i Germani. Nel co» siddettotragicoannodeiquann;imperalori. 69-70‘.laIGermania:paneggiòper Vitellio esitrovò coinvoltanegli scontriintorno a Caslra Vetere, Xanten.Nel 70 d.C., dopola rivolta dei Batavi ed i conseguenti combattimenti, i resti della legione confluirono con quelli della Legia VIIdi Galba nella VII Gemina che venne stanziata in Spagna dove ancora risulta esistente ed operativa nel V secolo. Ebbe come emblema un toro.
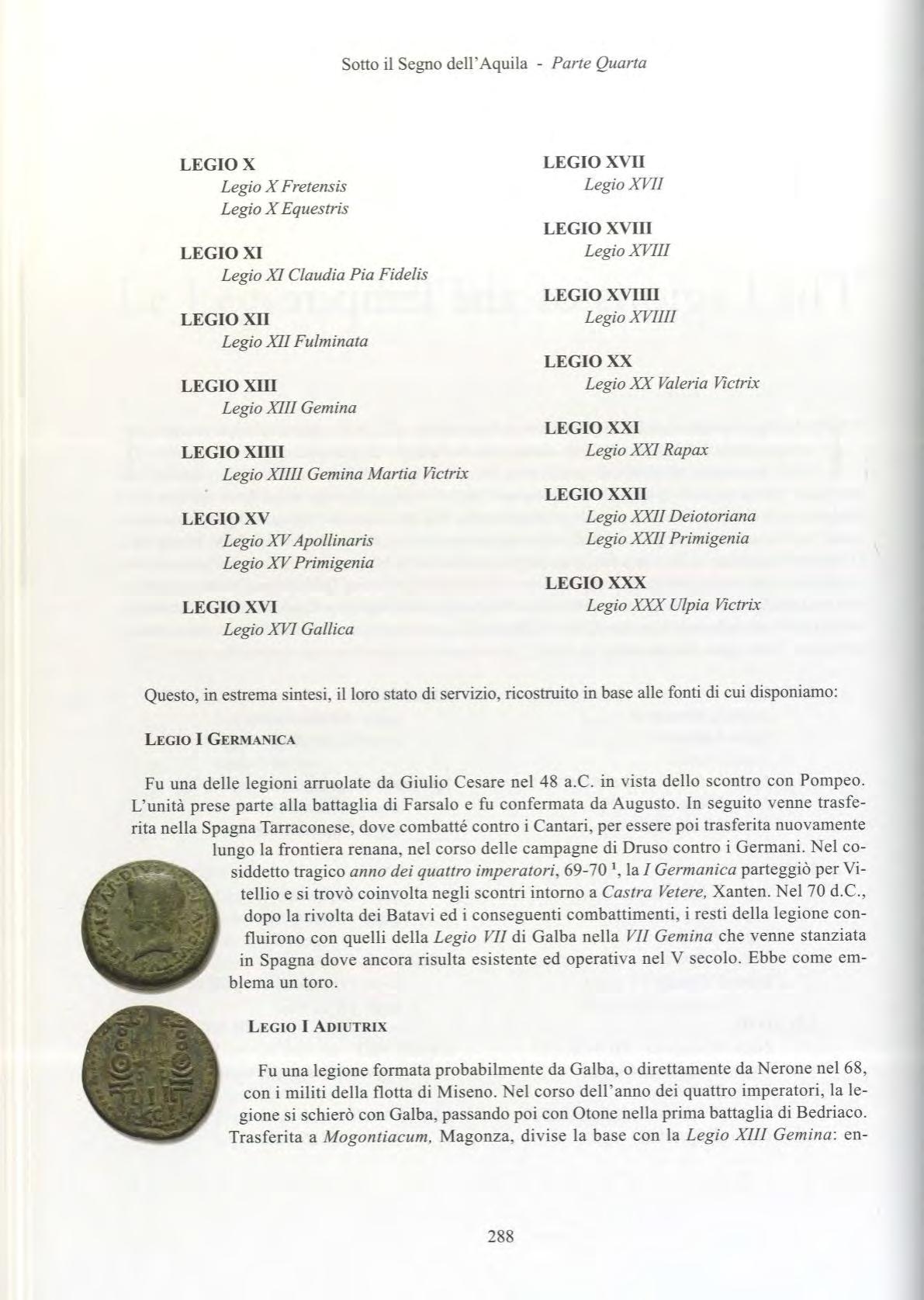
LEGIO I Amunux
Fuuna legione formataprobabilmente daGalba,odirettamente da Nerone nel 68, con i militi della flotta di Miseno. Nel corso dell’anno dei quattro imperatori, la legione si schieròconGalba,passando poi con Drone nella prima battaglia di Bedri3co. Trasferita a Magantiacum, Magonza, divise la base con la Legia XIII Gemina: en-
288
trambe le unità vennero impiegate nelle costruzioni di opere militari. In seguito combatté contro la tribù genna» nica dei Chatli,al di là del Reno,al comandodi Domiziano. Con la Legio[IIIFlavia Felix e la Legia XIII Gemina con— quistò la Dacia e ne occupò la nuova provincia. Per l’appoggio fornito nella circostanza a Traiano si meritò il cagnamen dipiafidelis. Rimasta sulla frontiera del Danubio, sostennel‘ascesa di Settimio Severoseguendolofino a Roma. Tornò. quindi, in Pannonia prendendo parte alle varie campagne contro i Parti. Durante il III secolo si meritò pure il cagnomen dipiufide/is bis e costans. Le ultime menzioni che la riguardanorimontanoal 444quandorisulta ancoradi stanza aBrigetio. Szonyin Ungheria, nella provincia della Pannonia. Come emblema ebbe il Capricorno e Pegaso, il cavallo alato.
Lacto [[nuca
La legione fu formata da Nerone nel 67,per una spedizionefia laMesia e l’Armenia. Sitrattava diun’unità d’élitedal momento cheper fameparte siselezionaronoreclute italiche altenon meno dim 1.76,statura ragguardevole per l‘epoca… Dissoltasi la spedizione, laIltalica fu mandata nella Gallia, con base a Lugdunum, Lione. Sostenne Vitellio nel 69-70 e si batté in suofavore, a Bedriaco controle legioni di Otone.SconfittadaVespasiano nella seconda battaglia di Bedriaco venne inviata nella Mesia inferiore, a Durostorum, Silistra in Bulgaria. Combatté in seguito nelle guerre dacicbeeprendendo parte alla conquista della Dacia con Traiano.z Fu quindi trasferita da Adriano a Name, Svitov in Bulgaria, da dove fu rimossa da Settimio Severoperla guerracontroi Parti. Le sueultime notizie si interrompono nel IV secolo,quando alcuni suoi reparti andarono a formare delle legioni comitatensi ed il resto degli uomini una legionedi limitanei,sempreintorno a Novae. Ebbe per emblema un toro edun cinghiale.
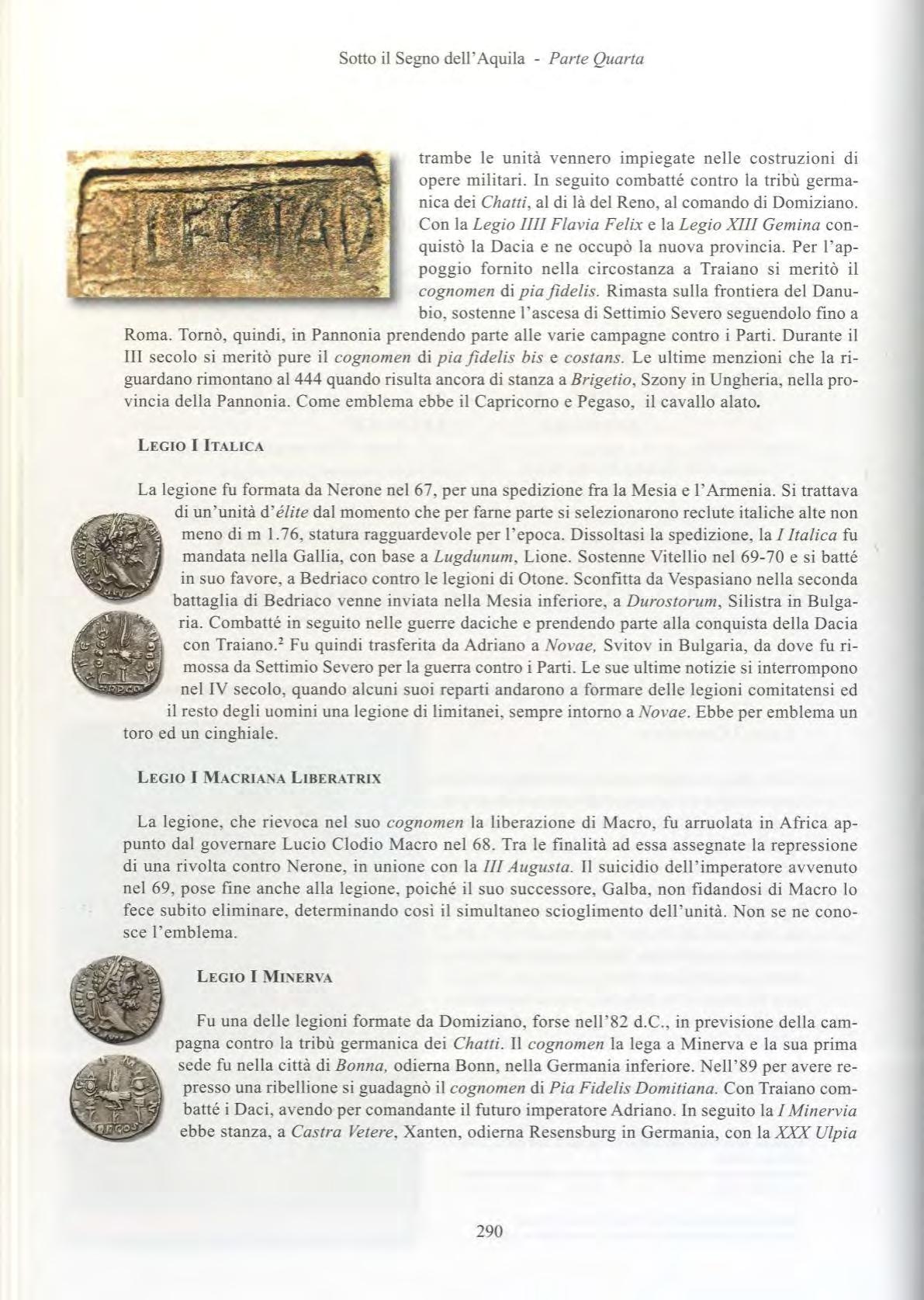
LactoI MACRIANA LIBERATRIX
La legione, che rievoca nel suo cagnomen la liberazione di Macro, fu arruolata in Africa appunto dal governare Lucio Clodio Macro nel 68. Tra le finalità ad essa assegnate la repressione di una rivolta contro Nerone, in unione con la IIIAugurla. Il suicidio dell’imperatore avvenuto nel 69,pose fine anche alla legione, poiché il suo successore, Galba, non fidandosi di Macro lo fece subito " ' e, de:-:- ’ cosi il ‘ " dell’unità, Non se ne conosce l’emblema.
LactoI MINERVA
Fu una delle legioni formate da Domiziano, forse nell’82 d.C., in previsione della campagna contro la tribù germanica dei Cha/ti. Il eagnomen la lega a Minerva e la sua prima sede fu nella città diBalma, odierna Bonn, nella Germania inferiore.Nell’89 per avere represso una ribellione siguadagnòil cognomen diPiaFidelisDamitiana. Con Traianocombatté i Daci, avendopercomandanteil futuro imperatoreAdriano. In seguito laIMinervia ebbe stanza,a Castra Vetere, Xanten, odierna Resensburg in Germania, con la…Ulpia
Sottoil
Segnodell'Aquila Parte Quarta
290
Victrix.Alcune sue vexilla!iortes presero parte a scontri in varie parti dell'Impero, Nel 353 i Frane chi travolsero e cancellarono la città di Bonn e da quel momento della ]Minervia s‘interrompe ognimenzione,pur non avendosi alcunacertezza sulla sua effettiva distruzione.Ebbe per emblema la dea Minerva.
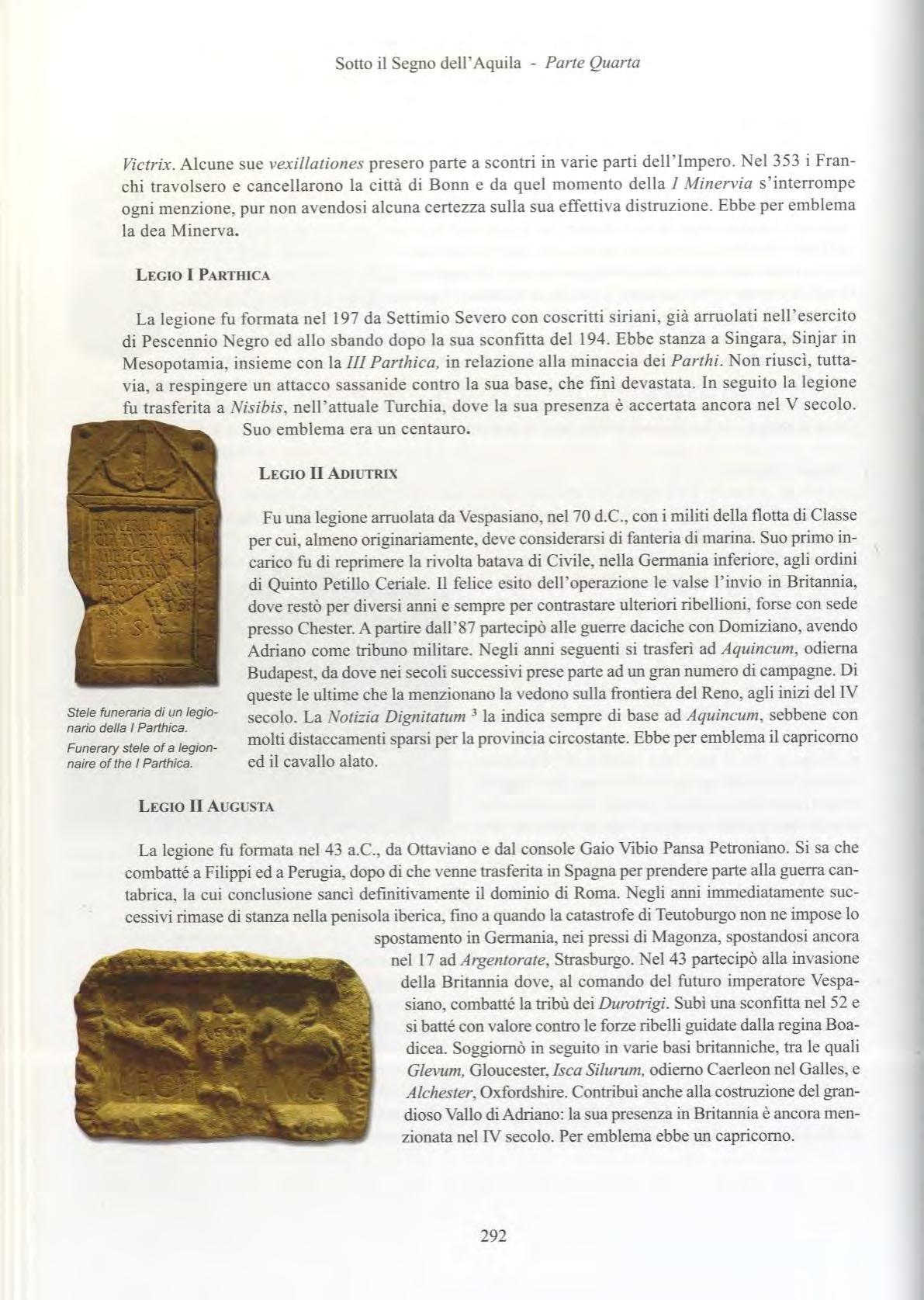
Lacto I PARTI-“CA
La legione fu formata nel 197da Settimio Severo con coscritti siriani,già arruolati nell‘esercito di Pescennio Negro ed allo sbandodopo la sua sconfitta del 194.Ebbe stanza a Singara. Sinjar in Mesopotamia, insieme con la [I]Parthica, in relazione alla minaccia dei Partiti. Non riusci, tutta» via, a respingere un attacco sassanide contro la sua base. che finì devastata. In seguito la legione
fu trasferita a Nisibis, nell’attuale Turchia. dove la sua presenza è accertata ancora nel V secolo. Suo emblema era un centauro.
LactoIlAntirme
Stelefunerariadiunlegio— nariodelle[Pa/litica.
Furiere/ysteleofalegion naireorme;Parthica.
Fuuna legionearruolatadaVespasiano, nel 70d.C.,conimiliti della flotta di Classe percui,abitenooriginariamente,deveconsiderarsidifanteriadi marina. Suoprimo in— carico fudireprimere la rivolta batava di Civile,nella Germania inferiore, agli ordini di Quinto Perillo Ceriale. Il feliceesito dell’operazione le valse l’invio in Britannia, doverestò per diversi anniesempreper contrastareulterioriribellioni, forseconsede presso Chester…Apartiredall’87partecipòalleguerredacichecon Domiziano,avendo Adriano come tribuno militare. Negli anni seguenti si trasferì adAquincum, odiema Budapest,dadoveneisecolisuccessivipreseparte ad un gran numerodicampagne.Di queste leultimechelamenzionanolavedono sullafrontieradelReno,agli inizi del IV secolo. La Notizia Dignitatam ’la indica sempre di base ad Aquincum, sebbene con moltidistaccamentisparsiper laprovinciacircostante.Ebbeperemblemailcapricorno ed il cavallo alato…
LactoIIAUGUSTA
La legione fu formata nel 43 a.C.,da Ottavianoe dal console GaioVibio Pansa Petroniano. Si sa che combattéaFilippiedaPerugia,dopodichevennetrasferita inSpagnaperprendereparte allaguerracarttabrica, la cui conclusione sancì definitivamente il dominiodiRoma. Negli anni immediatamente successivirimasedi stanzanellapenisola iberica,finoaquandolacatastrofediTeutoburgononneimpose lo spostamentoin Germania,neipressi diMagonza, spostandosi ancora nel 17adArgentorale, Strasburgo.Nel 43 partecipò allainvasione della Britannia dove, al comando del futuro imperatore Vespasiano,combatté latribù deiDamn-[gi Subìuna sconfittanel 52e sibatté convalorecontroleforzeribelliguidatedallaregina Boadicea. Soggiornò in seguitoin varie basi britanniche, tra le quali Glewm, Gloucester.IscaSilumm,odiernoCaerleonnel Galles,e Alchesler,Oxfordshire.ContribuìancheallacostruzionedelgrandiosoVallodiAdriano:lasuapresenza inBritanniaèancoramenzionatanel IVsecolo.Per emblemaebbeun capricorno.
Sottoil Segnodell‘Aquila Parte Quarta
292
Lacto"ITALICA
Fu una delle legioni formatedall‘imperatoreMarcoAurelio, tra il 165ed il 166.unitamenteallaLegia IIIItalica, mentre sicombatteva sia contro i Germani che i Parti. Per quantosene sa la sua prima base fortificata si trovava a Celeja, attuale Celje in Slovenia. istallata a difesa dei territori settentrionali e orientali dell’Italia.Inseguitovenne trasferita sullimesdanubiano.nelNorico, elasuabase fu insediata adAlbing inAustria, intorno al 183.Da li Comodolaspostòdi nuovoaLauriacum, odierrta Enns sempre inAustria,dadoveaccompagnòaRoma SettimioSeveronel 193.per garantirgliilpotere.Ebbeper« ciòil titolo di Fidelis,ecombattécontroi Parti. Siguadagni forsenella circostanza pure del cognamen di VIIPia VI]Fidelis, cioèsettevoltefedeleeleale. Le ultime suetracce rimontano alV secoloe sempre nelNorico. Ebbe per emblemauna lupacon i gemelliRomoloeRemo.
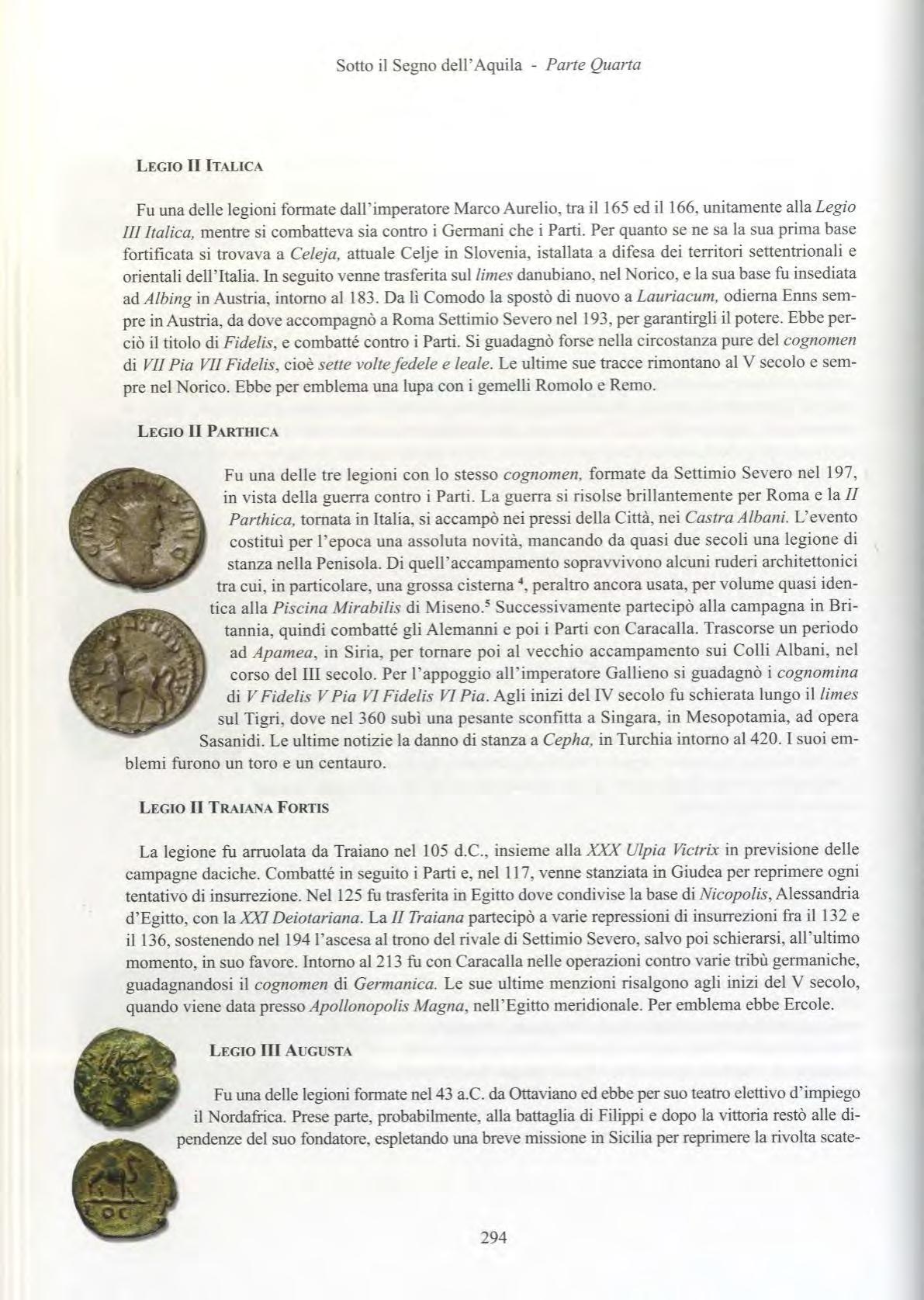
LactoII
PARTI-“CA
Fu una delle tre legioni con lo stesso cognomen, formate da Settimio Severonel 197, in vista della guerra contro i Parti. La guerra si risolsebrillantemente per Roma ela]] Parthica. tomata in Italia,siaccampòneipressi dellaCittà,nei CastroAlbani. L’evento costituìper l‘epoca una assoluta novità, mancando da quasi due secoli una legione di stanza nella Penisola. Di quell‘accampamentosoprawivonoalcunimderi architettonici tra cui,inparticolare,una grossacisterna‘,peraltroancorausata, pervolume quasi identica alla Piscina Mirabilis di Miseno.5Successivamentepartecipò alla campagna in Britannia, quindi combatté gli Alemanni epoi i Parti con Caracalla.Trascorseun periodo ad Apamea,111Siria,per tornare poi al vecchio accampamento sui Colli Albani, nel corso del III secolo Perl ,., ”' all’ ,. Gallieno si ‘ i di VFidelis VPia VIFidelis V]Pia.Agli inizi del IV secolo fu schierata lungo il limes sul Tigri, dovenel 360 subì una pesante sconfina a Singara, in Mesopotamia, ad opera Sasanidi.Le ultimenotizie ladannodi stanzaaCepha.inTurchia intorno al420.I suoi emblemi furonoun toro e un centauro…
LactoII TRAIANAForms
La legione fu arruolata da Traiano nel 105d.C., insieme alla …Ulpia Vietrix in previsione delle campagne daciche.Combattéin seguitoi Parti e,nel 117,venne stanziata in Giudea per reprimere ogni tentativo di insurrezione.Nel 125futrasferita in Egittodovecondivise labasediNicapalis,Alessandria d’Egitto,conlamDeiolariana. La!]Traianapartecipò avarierepressioni di insurrezioni fra il 132e il 136,sostenendonel 194l’ascesaaltronodel rivaledi SettimioSevero.salvopoi schierarsi,all’ultimo momento, insuofavore.lntomo al 213fuconCaracallanelleoperazionicontrovarietribù germaniche, gradagnandosi il cagnamen di Ger-manica. Le sue ultime menzioni risalgono agli inizi del V secolo, quandoviene datapressoApollonopolisMagna,nell‘Egitto meridionale.Per emblema ebbeErcole.
LactoIIIAUGUSTA
Fuunadellelegioni formatenel43a.C.daOttavianoedebbepersuoteatroelettivod’impiego il Nordafrica Preseparte,probabilmente, allabattaglia di Filippi edopo la vittoria restò alle di4 del suo una breve ' inSiciliaper reprimere larivolta scatev
Sotto il Segnodell’Aquila - Parte Quarta
294
Sottoi] Segnodell'Aquila - Furie Quarta
natavi da Sesto Pompeo. Ebbe poi stanza in Africa. forsea 77revertis,odiernaTebessainAlgeria, dovesioccupòspesso della costruzione di strutture a carattere militare e civile. Combatté i Mauri e i Numidi ed un suoreparto fini massacrato, forseper viltà dei commilitoni: di certotutta l‘unità subìladecimazione,penagravissimaedesuetanell’esercito, riservata aipeggiori crimini collettivi, quali appunto laviltà dinanzi al nemico.Nel 75 laIII/ingrata futrasferita aLam» buesis. inNumidia, odiernaLamhese inAlgeria,campofortificatoincuirimaseperi successividuesecoli,contrastando gliassaltidei Berberi.Alcunisuoirepartipreseroparteanche allecampagne di MarcoAurelio. Nel 193ebbe da Settimio Ruderidel retoriumdiLambaesis. [LambèseinNumidia.
NOMAMCE'; nenapagina Efianco feed…EemsMS,—…”_ SeverollcognnmendiP…Vindarper lafedeltamostratanel chen/ogiva. corso della guerra civile, successa alla morte di Pertinace. Agli inizi del 111secolo subì gravi attacchi dei Berberi, con perditetalidaricevererinforzidalla11!Gallica,scioltainquegli stessianni. Sofiocatanel 238larivolta di Gordoniano 1edi Gordoniano II,venne scioltaa suavolta daGordoniano 111chenedannòpure la memoria.Nel 252 furicostituita dall’imperatoreValeriano, conlariammissione dituttii legionari supersitistan, ziatinella Rezia enelNorico,ericollocata nellasuabase storica.Nellaoccasioneebbepure il cognome!:di it?/11mPiaitemm (finder,cioèdinuovamentefedeleevendiee.TralafinedelIVegliinizidelVsiperdono deltuttole suetracce.Peremblemaebbe il cavalloalatoPegasoeilcapricorno.
LaGto 111CYRENAICA
Fu,quasicertamente,unadellelegioniarruolatedaMarcoAntonionel 36a.C.,all’epocagovernatoredella Cirenaica.Debuttò,però,soltantonellaguerradiOttavianoperlaconquistadell’Egittonel30a.C.,doverimasedi stanzaalmenoper ilquinquenniosuccessivo.InseguitoebbepersuabaseAlessandria, insiemealla )OflDziotzzn‘ana,concompitidipacificazionelocale.Nei secolisuccessivipreseparte,sianellasuainterezza che condistaccamenti di varia consistenza,amoltecampagneinogni angolodell’Impero.Trasferita in localitàignotanelIl]secolo,lasiritrovamenzionataper l‘ultimavoltaagli inizidelV secoloneipressi diBostra,in Siria…1suoiestremi epigoni,dientitàdificiledaquantizzare,finironodistrutti dagliArabinel 634.
Laetolll GALLICA
FuunadellelegioniformatedaGiulioCesareintornoal49a.C.,verosimilmenteinprevisionedellaguerra civile.Dalsuocagnomen Gallica senearguisce l’originegallicadei suoilegionari, forsetrattidallaGallia Narbonense. L’unitàcombattéaFarsaloedalla mortediCesare,entrònell'esercitodiAntonio, trovando impiegonella sua campagnapartica. PurschierandosicontroOttaviano,gli siarrese aPerugianel41a.C.percui,dopolavittoria di Azio,laIIIGallicarestònelsuoesercito.Com» batté,quindi,nuovamenteiPartiperesserepoi stanziatanellaMesialungoilDanubio,dovenel 69riuscidapprimaaresisterequindiastroncare
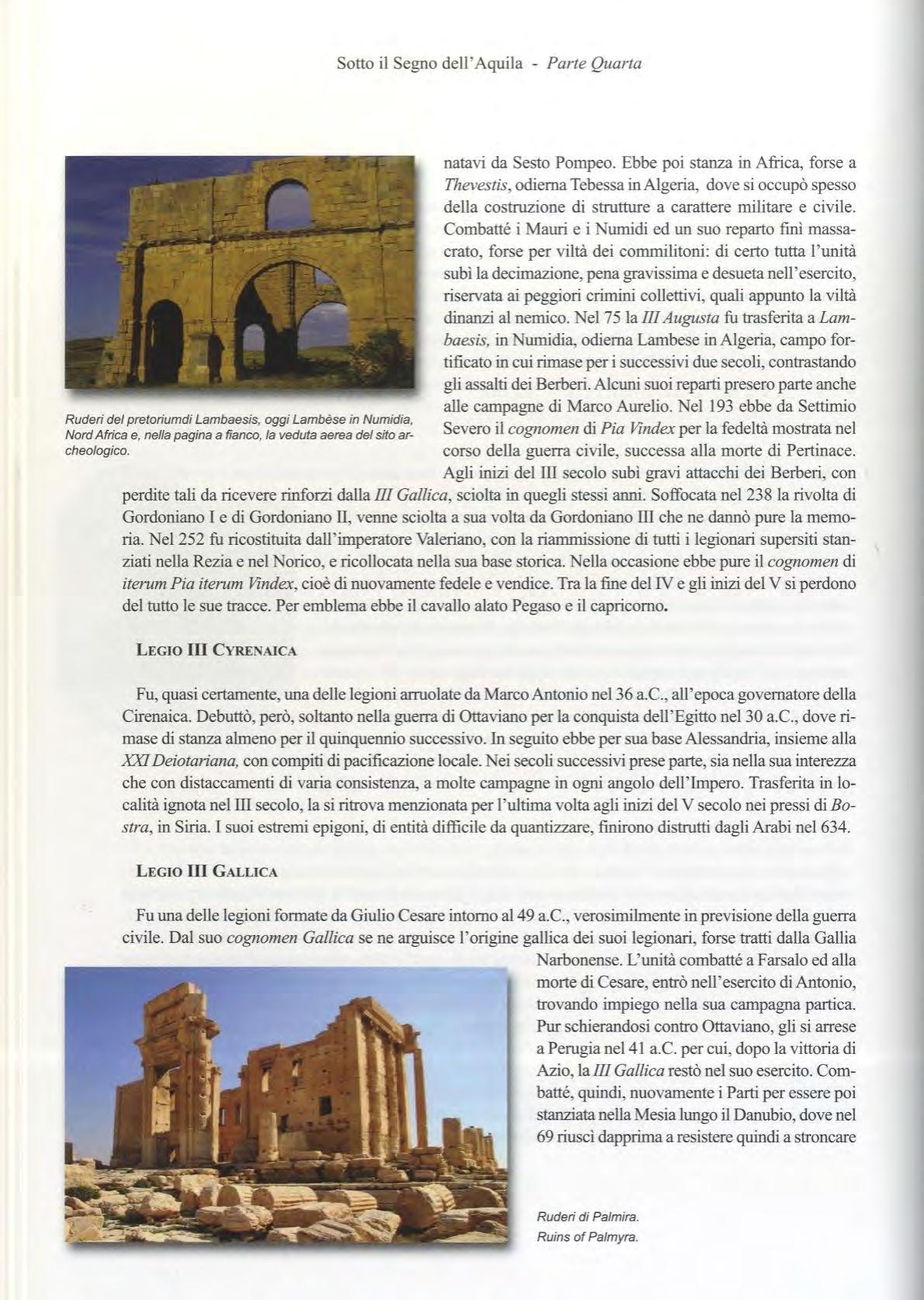
. .
Ruden diPalmira RuinsolPalmyra
Quarta una incursione di Sarmati Roxolani. Poco dopo si schierò a Bedriaco in favore di Vespasiano: proprio in quegli anni,militònei suoiranghiPlinioCelio Secondo,cometribunusmilitum.6insegrito la III Gallica andò in Siria per prendereparte allarepressionedellarivolta giudaica. Si stabilì quindi a Raphanea, semprein Siria,mentreun suo distaccamento venne dislocato nella Traconitide. presso il lago Tiberiade. Trasferita ag del Il]secolonella nuova provincia della SyriaPhoenice, nel 218 contribuì all‘acclarnazione di Eliogabalo. di appena 14anni, ad imperatore. La sua indocilità che sfociò nella rivolta del 219,costrinseroilgioVedutaaereadell'areaarcheologicadiPalmira.NellapaginaafiancolmderidiCte- vanissimosovranoadecretarne10scio— sifunteinunaforodel
glimento:il suonomevenneabrasodai monumenti ed una parte dei suoi legionari trasferita allaIIIAugusta. Alessandro Severo laricostituì, lasciandolasempreinSiria,pressoDamasco,colcompitodipresidiare lastradaperPalmira.Leultimi notizie relative alla[I]Gallica risalgonoal 323quandorisulta ancoraoperativa in Siria.Il suoemblemaeranodue torichetrainavanoun carrocon l'insegnadellalegione.
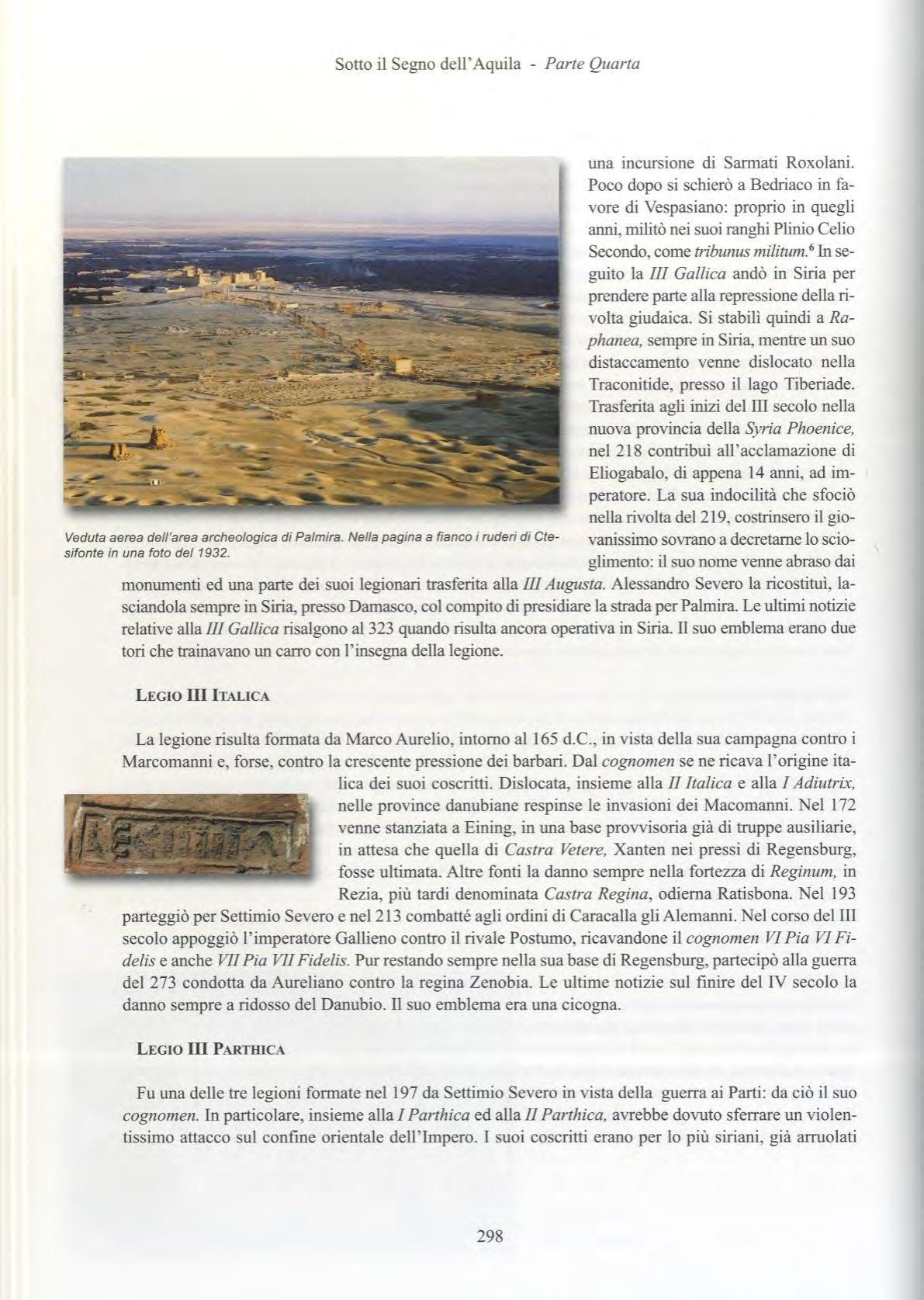
LacrolllITALICA
Lalegionerisulta formata da MarcoAurelio, intorno al 165d.C.,invista dellasuacampagna contro i Marcomanni e,forse,controlacrescentepressione deibarbari. Dalcognomen sene ricava l’origine italica dei suoi coscritti.Dislocam, insieme alla [IItalica e alla I Adiutrtlx, nelle province danubiane respinse le invasioni dei Macomanrri, Nel l72 venne stanziata a Eining, in una base provvisoria giàdi truppe ausiliarie, in attesa che quella di Castra Vetere, Xanten nei pressi di Regensburg, fosseultimata.Altre fonti la danno semprenella fortezza di Reginum, in Rezia, più tardi denominata Castra Regina, odierna Ratisbona. Nel 193 patteggiòper SettimioSeveroenel213combattéagliordinidi CaracallagliAlemanni.Nel corsodel III secoloappoggiòl’imperatoreGallienocontroil rivalePostumo,ricavandone il cognomen VIPia VIFideliseanche VIIPia VIIFidelis. Purrestandosemprenella suabasediRegensburg,partecipòallaguerra del 273 condotta daAureliano contro la regina Zenobia. Le ultime notizie sul finire del IV secolo la dannosemprearidossodelDanubio. Il suoemblema erauna cicogna.
LactoIII PARTHICA
Fuuna delletrelegioni formatenel 197da SettimioSeveroinvista della guerraaiParti:daciò il suo cognomen. Inparticolare, insiemealla!Parthica edalla[[Parthica, avrebbedovutosferrareun violentissimo attacco sul confine orientale dell’Impero. I suoi coscritti eranoper lo più siriani, già arruolati
Sottoil
-
Segrodell‘Aquila
Parte
1932.
298
Sottoil Segnodell‘Aquila - Parre Quarta
nell’esercitodi PescennioNigro. L'esitodellacampagna fupositivo eportòallaconquistadi Ctesifonte. LaIIIPanhica,tuttavia, rimasenella regionemesopotamica,nella basediResena,conil compitodias— sicurarelecomunicazionistradalidellaprovinciadagli assalti dei Sasinidi,con iquali.peraltro, nelcorso del 111secolosiscontròinnumerevoli volte.Un lorocontrattacconel230,costrinse lalegione aretroce— dere, salvopoi recuperare leprecedentiposizionipochi anni dopo.Combattéancora la vittoriosa battagliadiResena,intornoal 243.Agliinizi delV secololaII]Parthicarisulta sempreoperativanelle stesse regioni. Per emblemaaveva un loro.
LacroHH MACEDONKCA
Fu una delle legioni formate da Giulio Cesare nel 48 a.C., con coscritti tratti dall’Italia, per la sua guerracontroPompeo.Debuttòsulcamponello stessoannoaDunhachium.Durazzo,eaFaisalodove Pompeovennesconfitto.TerminatalaguerralaLegia 1111venne inviatainMacedonia,dacuitrasseilcognamen.Ottavianolaimpiegònellabattagliadi Filippinel42 a.C.edinquelladiAzionel 31a.C.Nella { ‘ '' la III '' ’ ' fu ’ ' alla SpagnaTerraconese, dove vi rimase anche dopo la fine dei lunghi combattimenti. Nel 43 partecipò alla conquista della Britannia, da dove vennepoi trasferita aMogantiacum,Magonza.nel campodella XIII] Gemina. Nel 69paneggiòper VitellioevennesconfinanellasecondabattagliadiBedriacodalletruppediVespasiano,chedivenutopoco dopoimperatore,nedecretòlo scioglimento.In seguitosaràricostituitacon il nomediLegioIII] Flavia Felix. Peremblemaebbeun toro eun capricorno.
Lacto[lllch1'mca
Fu una delle legioni arruolateda MarcoAntonio, per le sue campagnecontro i Parti, da cui l’unità trasseilcognomen. Seneignoral’originario stanziamentoma di certo, dopolavineria diAzio, futrasferitanella MesiadaAugusto. Suoicompitiprecipui la costruzione di nuove strade e la manutenzione di quelle esistenti. Il futuro imperatoreVespasianoprestòservizioneisuoiranghi… Con Corbulone combatté i Parti in Armenia e posta alledipendenzedelgovernatoredellaCappadocia, L. Cesennio Pete, subì nel 62, insieme alla HI Fulminato, una umiliante sconfitta a Rhandeia e fu costretm ad arrendersi. Trasferita con disonore a Zeugrna, sulla riva destra del— l’Eufrate,nell’attualeTurchia,vi rimaseper oltre un secolo. Nonostante il suo schierarsiper Vespasiano, nel 69, non ne ricavò significativi incarichi,reputandosi comunqueun’unità dibassa RuderidiZsugma,sullarivadestradell'Eufrate,nell’areaoggiprovin- levatura.F““‘Che 50011…“dagliEbreiinrivvlîa, ciadiGazìantep. riscattandosi però nelle successive vittoriose RuinsotZeugma,onMerighibankoftheEuphlates. Todaythisarea campagnecontroi Parti acuiprese sempreparte. rs intheprov/nce ofGaz/antep. . . . ,.
Ogm suo riferimento 5 mterrompe nel 219, per riaffiorare nuovamente agli inizi del V secolo, quando la legione viene ricordata in Siria. Ebbe per emblema un capricorno.
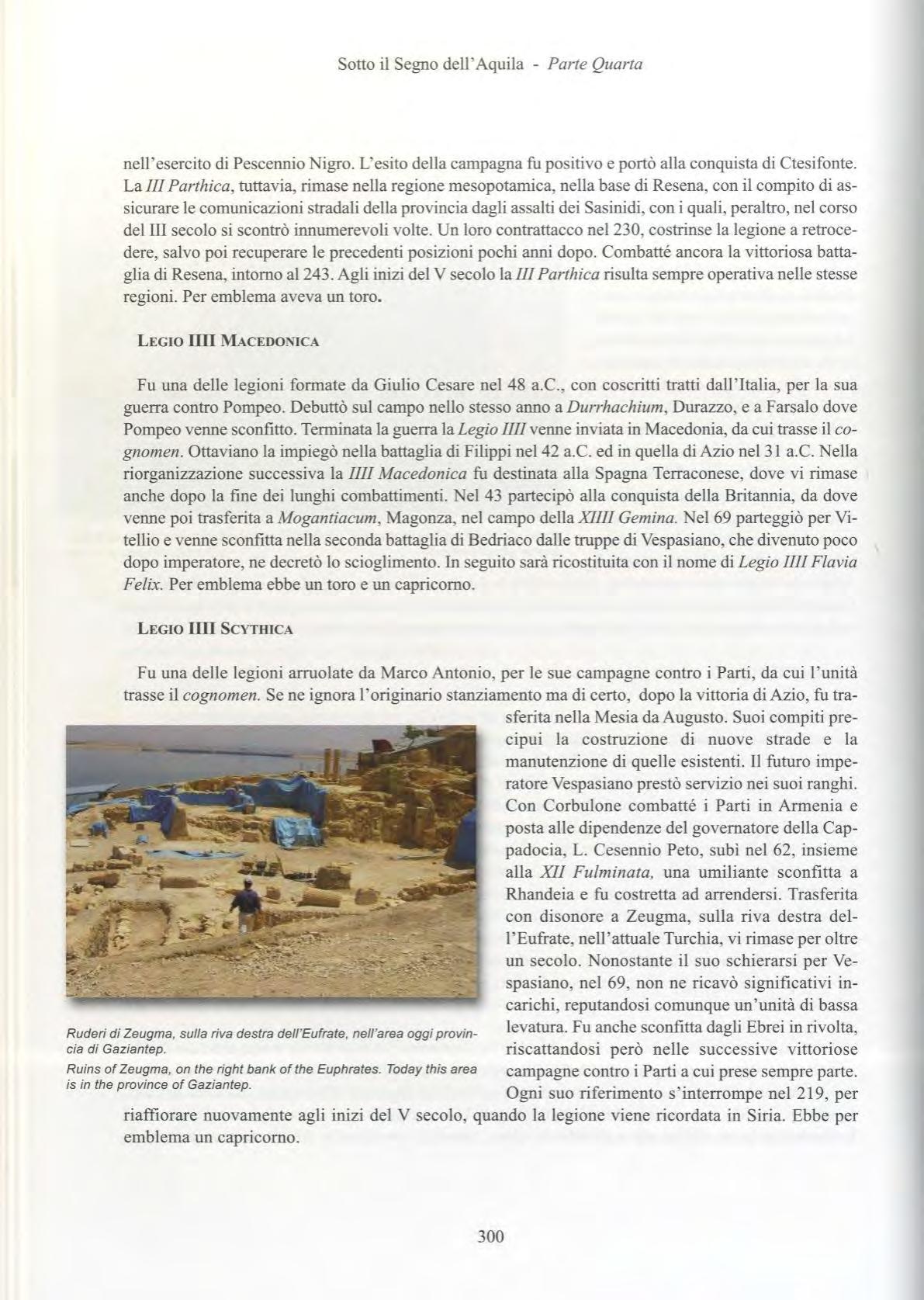
300
Lacto V ALAUDAE
Fuuna delle legioniformatadaGiulioCesarenel 52a.C..nota anchecome Gallica, essendoisuoico— scrittidellaGallia. Il suostranoL‘agnamenAlaudae.cioèleallodole,alludeprobabilmente allealtecrestepiumate,concuipropriotaliguerrieri eranosolitiomarsi.Purnon essendoinorigineunavera legione della Repubblica, lodivenne in secondo momento con il riconoscimento del Senato,che se ne assunse il mantenimento. Partecipò alla guerre galliche, dopodi chefini stanziata in Spagna intorno al 49 a.C. CombattéperMarcoAntoniotra il41edil 31a.C.eforsepartecipòallabattaglia diAzio:allasuamorte fucooptatanell’esercitodiAugusto.Non seneconoscelafineconcertenachemoltoprobabilmente avvenne nel corsodellarivolta batava nel 70.Ebbe per emblema un elefante.

LEGIOVMACEDONICA
LalegionerisultaarruolatadalconsoleGaioVibioPansa PetronianoedallostessoOttavianonel43a.C.,in vistadelconfrontocongliuocisoridiCesare.VerosimilmentepartecipòallabattagliadiAzioefecepartedelle ventottolegionicheAugusto Ebbecome ' ' ' la‘ ’ ' dacui il sebbene ilsuosoggiornosilimitasseapochianni.CombattéinseguitoiPartiinArmenia,conlaIl]Gallica,la VIFerr ramelaX Freteririlr,sottoCorbulone.PartecipòsottoVespasiano,nonancoraimpe1atore,allarepressionedella sommossagiudaicanel66,distinguendosipervalore.Nelcorsodeltragico69la VMacedonithrestòdistanza aEmmaus,dovepassòalledipendenzediTito,figliodiVespasiano,allorquandoquest‘ultimodivenneimperatore.ConclusalaguerragiudaicalalegionetornòinMesiaedebbenegliannisuccessivi,fiaisuoitribunum militum, anche il futuro imperatore Publio Elio TraianoAdriano.Agli inizi del II secolola VMacedonica vennedislocatainDacia,prendendoparteallevariecampagnediTraianocontroibarbari locali.Dal 107restò distanzaaTmesimus,presso lafocedelDanubio…Intervennesolonellefasiinizialinella campagnacontroi Parti del 161,per rientraresubitoaPoiana,oggiTurdainRomania.Con MarcoAureliotornòacombattere iMarcomanni,iSarmatieiQuadiriportandonealquantevittorie…Nel 185-87sconfisseun esercitodacico,da cui ilcognomen Pia Costans. Senzamutarelasuabase sostennealtrecampagneesiguadagnòaltri onori ed altrititoli.TornòadOescusnel274restandoadifesadellaprovincia Scomparvenel 636nelcorsodellabattagliadelYarmuk,un aflluentedelGiordanopressolealturedelGolan,controdiArabi.
LEGIO VÎ FERRATA
FuunadellelegioniformatedaGiulioCesarenella GalliaCisalpina,intornoal 53a.C.Nel 47a.C.combatténella battaglia dilela,oggiZileinTurchia,equindicontroipompeiani in Spagna.Parteggiòin se— guito per Marco Antonio, finendo ciò nonostante nell'esercito di Augusto, con base in Siria. Con CorbuloneinA.rmeniaaffrontòiPartieconlaXII] Fulmi'natzz, dal 58partecipò allaguerracontroi Giu— dei. Dopo dichevenne inviavanella Mesia doveriuscì aristabilire lasituazione,compromessadagli attacchi dei Daci… Rientrata nel 73 alla base, intervenne nella invasione di Commagene, piccolo regno ellenistico, già satrapia dell'Impero persiano prima della conquista diAlessandro Magno, che divenne parteintegrantedellaprovinciadiSyria.CoriAdrianomarciòcontroi Parti,conquistandonel 105la nuovaprovinciadell’ArabiaNabatea,collocatatra ilGiordanoed il marMorto.Pocodopovenne dislocatanella Palestina,per intervenire nella seconda guerra giudaica, che conclusasi nel 138 sancìlairreversibiledistruzionedelTempiodi Gerusalemme.Dopodi che,dichiaratasiper Settimio Severo,ebbei]cognomen diFidelisCanstans.Seneperdono letraccenel III secolo,forse in seguitoal suoscioglimento.Non sene conoscel'emblema.
Sotto il Segnodell‘Aquila - Parte Quarta
302
Lacto VIVteTrux
Fuunadella legioniformatedaOttavianonel41 a.C….evieneconsideratalagemelladellaI VFerrata. Siritienecheabbiaaccoltonei suoiranghi anchealcuniveterani diGiulioCesareedellastessa V1Ferrata. Debuttò all’assediodiPerugianello stesso41,poi combattécontroSestoPompeoperripristinareleforniture digranodalla Siciliada lui interrotte. Combatté, sempreconOttaviano, ancheadAzio e fu destinata in seguito alla SpagnaTarraconese. Vi rimase per circa un secolo,venendo quindi trasferita a Castro Vetere al tempodiNerone. Eproprio inquellabase acclamòGalbaimperatore al posto diNerone…Nel 119Adriano ladislocò in Britannia e li, dal 122,prese attivamenteparte alla co— struzionedelsuocelebreVallo.Nel 142,forseper l‘esperienzaacquisita,partecipòpure allacostruzione delVallodiAntonino,in seguitoabbandonato.Lescarsefontiladannopresentenell‘Isola ancoranelIV secolo…Ebbe per emblemaun toro, oforseVenere…
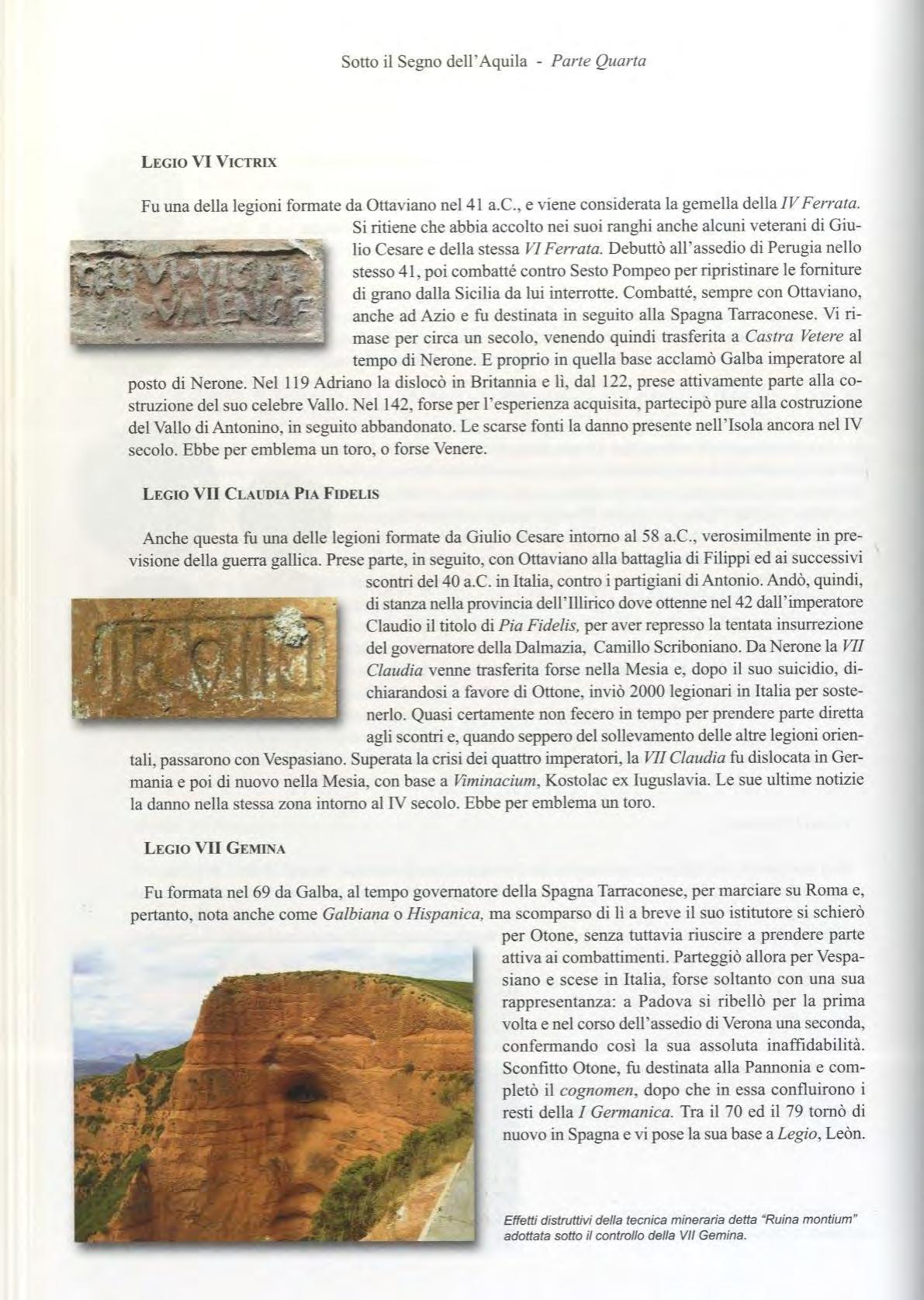
LactoVII CLAUDIA PIAFumus
Anchequesta fuuna delle legioni formatedaGiulioCesareintornoal 58a.C.,verosimilmente in previsionedellaguerragallica.Preseparte,inseguito,conOttavianoallabattagliadiFilippiedaisuccessivi scontridel40a.C.inItalia,controipartigiani diAntonio.Andò.quindi, distanzanellaprovinciadell’Illiricodoveottennenel42dall’imperatore ClaudioiltitolodiPiaFidelis,peraverrepressolatentata insurrezione delgovernatoredellaDalmazia, CamilloScriboniano.DaNerone la VII Claudia venne trasferita forsenella Mesia e, dopo il suo suicidio, dichiarandosi afavoredi Ottone,inviò2000 legionari inItaliaper sostenerlo… Quasicertamentenon fecerointempoper prendereparte diretta agliscontrie,quandosepperodelsollevamentodellealtrelegioniorientali,passaronoconVespasiano.Superatalacrisideiquattroimperatori,la VIIClaudiofudislocatainGermania epoi di nuovo nella Mesia,conbase a Wminacium, Kostolacex luguslavia. Le sueultimenotizie ladannonella stessazona intornoal IVsecolo.Ebbeper emblemauntoro.
LEGt0V].I GEMINA
Fu formatanel69daGalbo,al tempo governatoredellaSpagnaTatiaconese,permarciare su Roma e, pertanto, nota anchecome Galbiana oHispanico, ma scomparsodi li abreve il suoistitutore sischierò per Otone, se…tuttavia riuscire a prendere parte attivaaicombattimenti.ParteggiòalloraperVespasiano e scese in Italia, forse soltanto con una sua rappresentanza: a Padova si ribellò per la prima volta enelcorsodell’assediodiVeronaunaseconda, confermando così la sua assoluta inaffidabilità.
SconfittoOtone, fudestinata alla Pannonia e completò il cognome”, dopo che in essa confluirono i resti della I Germanico. Tra il 70 ed il 79 tornò di nuovoinSpagnaevipose lasuabaseaLegio,Leòn.
Sottoil Segnodell’Aquila - Parte Quartu
Effettidism1tfividella tecnica mineraria delia “Ruins montium" adottatasofiailDont/Ollodella VII Gemina.
Inscguitooperòcon \‘essillazioni anche in Britannia sottoAdrianoein Africa sottoAntonino. Dimostratasi favorevole. sia pure dopo qualche esitazione. a Settimio Severone ebbe in cambio la designazione di Pia Fidelis. con la conferma della sua sede in Spagna,dove ancora risulta operativa nel V secolo. Il suoemblemanon è noto.
LactoVlll AUGUSTA
Leo/i'Leoneinpietra conl’msegnadella VII Gemina;nella pagina a fiancoubustodiGallia.
Lean, Stonelionwith theinsigniaofthevuGemmaandsidepage,bust ofGallia.
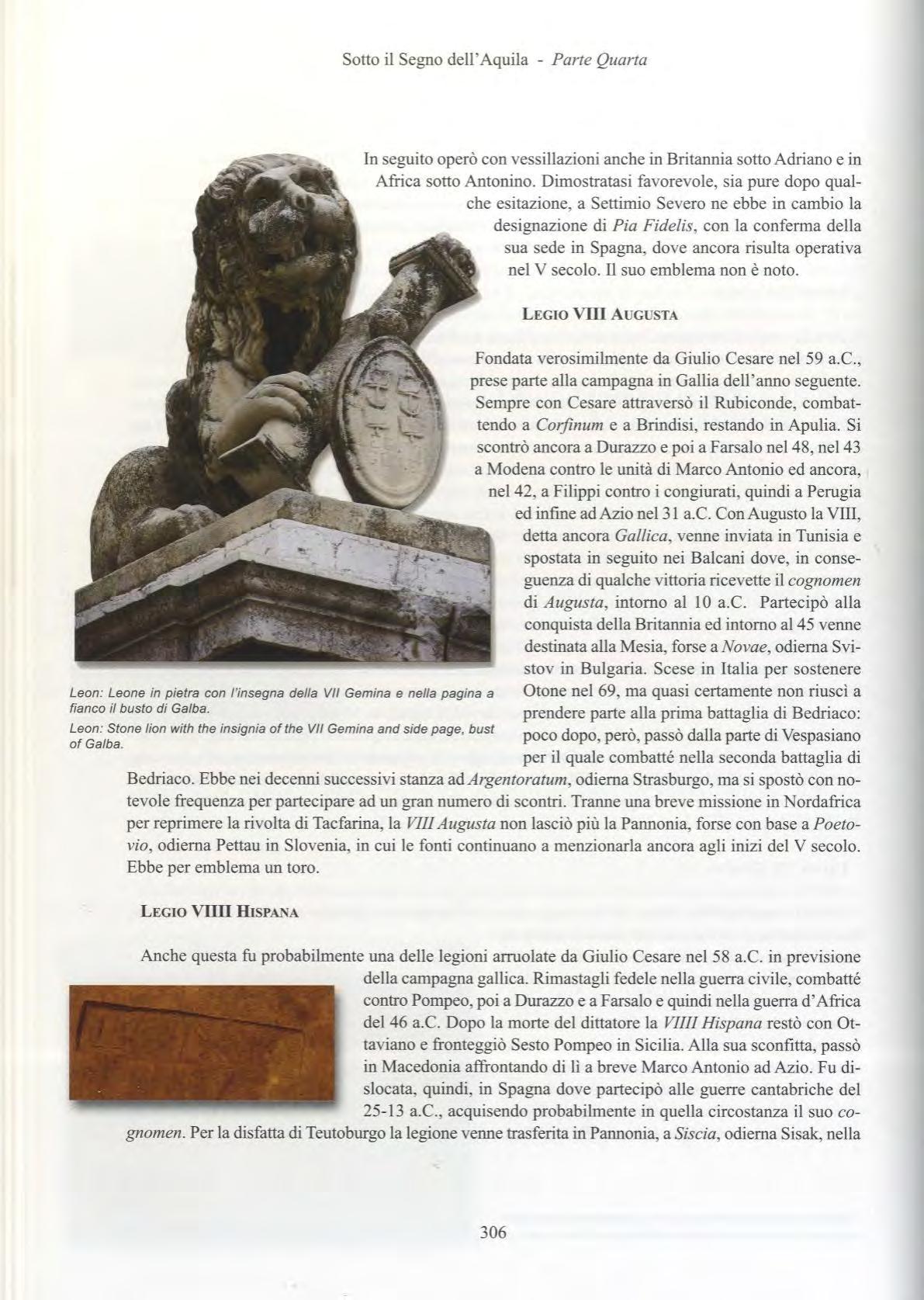
Fondata verosimilmente da Giulio Cesarenel 59 a.C., preseparte allacampagna in Galliadell'annosegiente. Sempre con Cesare attraversò il Rubiconde, combattendo a Corfinum e a Brindisi. restando inApulia. Si scontròancoraa Durazzo epoi a Farsalo nel 48,nel 43 a Modena controle unità di MarcoAntonio ed ancora, nel42.a Filippi controi congiurati. quindi a Perugia edinfineadAzionel 31a.C.ConAugnisto laVIII, dettaancora Gallica, venne inviata in Tunisia e spostata in segrito nei Balcani dove. in conseguenzadi qualchevittoriaricevette il cognomen di Augusta, intorno al 10 a.C. Partecipò alla conquistadella Britannia edintornoal45venne destinataallaMesia,forseaNovae, odiernaSvistov in Bulgaria. Scese in Italia per sostenere Otonenel 69.ma quasi certamentenon riuscì a prendere parte allaprima battaglia di Beddaco: pocodopo.però,passòdallaparte diVespasiano per il quale combatténella seconda battaglia di Bedriaco.Ebbe nei decennisuccessivistanzaadArgentaratum, odierna Strasburgo,ma sispostòconno» tevole frequenuperpartecipare adun gran numero di scontri.Tranneuna breve missione inNordafrica per reprimere larivolta diTacfarina,la VIIIAugusta non lasciòpiù la Pannonia. forsecon base aPoetavr'a. odierna Pettau in Slovenia. in cui le fonti continuanoa menzionarla ancora agli inizi del V secolo. Ebbe per emblemaun toro.
LactoVIII!HISPANA
Anche questa fu probabilmente una delle legioni arruolateda GiulioCesarenel 58a.C. inprevisione dellacampagnagallica. Rimastagli fedelenella guerracivile,combatté controPompeo,poi aDurazzoeaFarsan equindinella guerrad'Africa del 46 a.C. Dopo la morte del dittatore la VIII]Hispano restò con Ot» taviano efronteggiòSestoPompeo in Sicilia.Alla sua sconfitta,passò in Macedonia afirontandodi li abreve MarcoAntonio adAzio.Fu di» slocata, quindi, in Spagna dove partecipò alle guerre cantabriche del 25-13 a.C., acquisendoprobabilmente in quella circostanza il suo cor gnomen.Per ladisfattadiTeutoburgolalegionevennetrasferita inPannonia.aSiscia,odierna Sisak,nella
Sottoil
Segnodell‘Aquila Par-tc Quartu
306 i l l
regione orientale del Reno. Una breve parentesi nordafricatta e poi nuovamente schierata lungo il Da— nubio, da doveparti per la conquista della Britannia.al comando diAulo Plauzio. Subì una grave sconfitta nel 6061 ad opera delle forze della regina Bolli/it’ll… al punto da dover ricevere dei rincalzi dalla Germania. Le fonti ne danno le ultime notizie agli inizi del Il secolo.quandoricordano che costruì una fortezza presso York. Nel 117forse prese parte alla repressione di una rivolta tra le tribù dei Caledoni. Fu distruttaverosimilmentesottoMarcoAurelio:una curiosa menzionevuole chetra i suoiranghi vi fos» seronumerosi suonatoridi Zampogna.utrierilum. dai quali perciòderiverebbero le comamuse scozzesi! Forse ebbeper emblemaun toro
LEGIO X FRETEXSIS
Anche questa fuuna delle legioni formate da Ottaviano nel 4140 a.C. in Vista della guerra civile. Si ispiròperil suonumero alla mitica XLegu7 di Cesare: sibatté nel 36 a.C. contro SestoPompeo a Nauloco. nei pressi di Messina. All‘episodio si lega il suo cognomen. che ne ricorda il distretto marittimo. Combattéanche adAzio controMarcoAntonio. intervento che spiegherebbelapresenza di una trireme nel suoemblema, Fustanziatain seguitoinGiudea.poi aequartierata in Siriaapartire dal 6.insieme alla[I]Gul/ica, alla ”Ferrara edallaXÎIFHÎHIÎIIHÎIL Repressepure larivolta di ErodeArchelao e,altempodi Nerone. partecipò alleguerre controi Parti. Ebbeun ruolo fondamentalenella guerragiudaicadel 66-73,sono il comandodel Futuro imperatoreVespasiano.Conduzione che,dopo la suaascesa al trono. passò al figlio Tito. il quale conquistòdapprima (iamala eTaricaee spostando poi la suabase a Gerico…La ri\olta fu soffocata nel 70.tranne che a Gerusalemme e a Masada. Gerusalemme \enne perciò investita dalla V Macedonia. dalla XFulminam e dallaXVApa/Iinaris insieme allaXFrelensi's che si accampò sul Monte degli Ulivi.distinguendosi per le suemicidiali artiglierie.Nel 71 l‘assedio ebbetermine e nel 72 venne attaccata anche Masada la cui resistenza cesserà col suicidio di tutti i suoi difensori. dopo che Flavio Silva era musetto a costruire una grande rampa d'assalto. Nella seconda rivolta giudaica esplosa nel 132, la X Fre/emit- dopo feroci com— battimenti riconquistò Gerusalemme. Tra il 208 e il 211 dei suoi distaccamenti si spinsero in Britannia. sconv nandosi con i Caledont.Ebbe nel 268. forse per la sua azione di repressionedurante una molla. il cognomen di Pia Fidelis,elasidislocò.tra la fine del III secoloegli inizi del IV.adAlla. Elat in Israele. sul mar Rosso. Le suenotizie cessano tntomo alla metà del IV secolo.Ebbeperemblema una trireme edun toro.
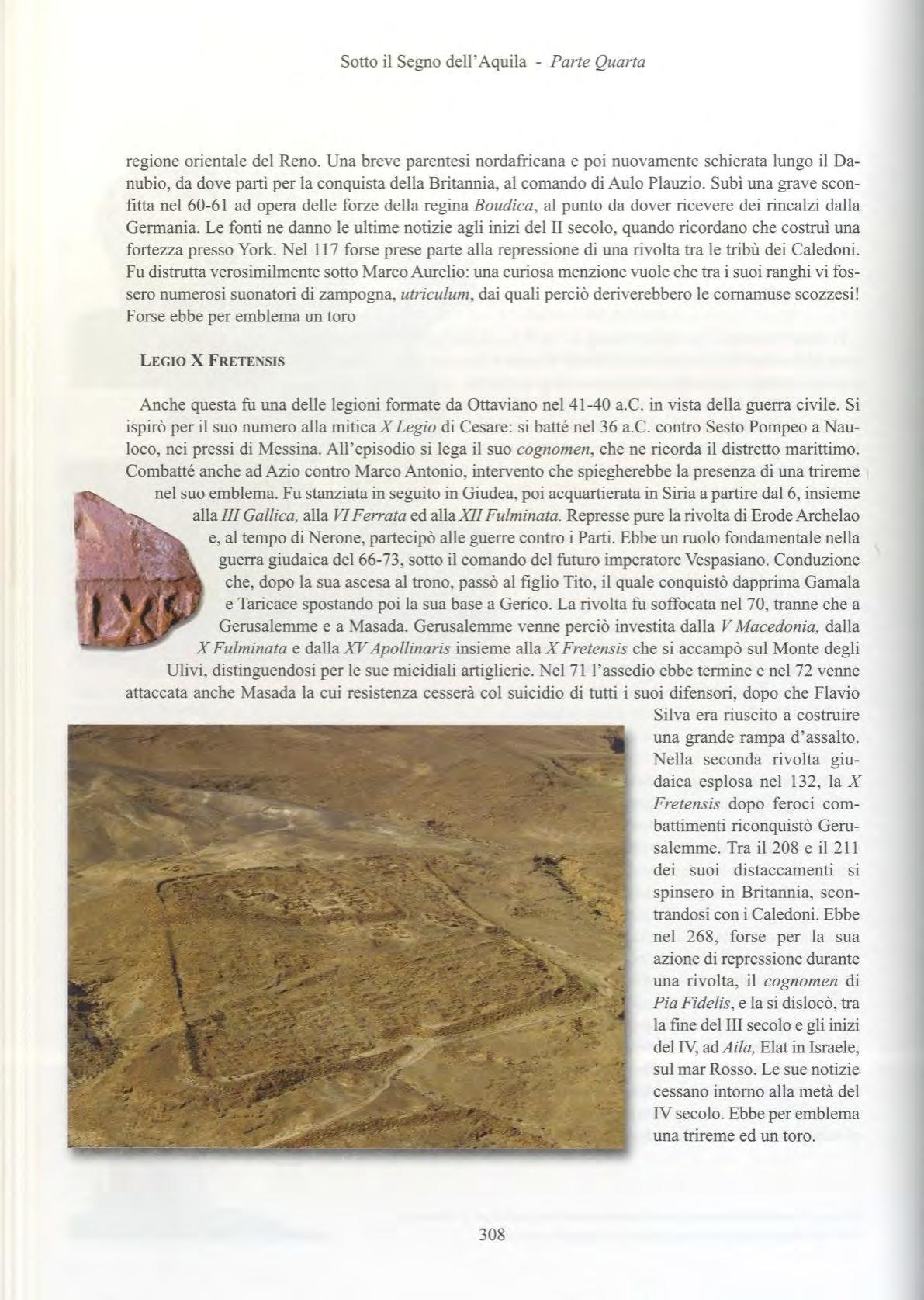
Sotto Il Segnodell'Aquila - Pur-re Qlllll‘lu
308
Lacto X EQUESTRIS
Fuunadellelegionidi cui siserviGiulioCesareperla conquistadellaGallianel 58a.C. Combattécon tale valoreche alcuni suoicontingentifuronodaluiprescelti comeguardiapersonale acavallo. dacui il cognamen dell’unità.Dopo la sua morte la legione fu ricostituita da Lepido eguerreggiòperi triumviri fino alla battaglia di Filippi. Passò,poi, conMarcoAntonio, dapprima inArmenia per battersi contro i Parti quindi anchecontroOttaviano.All‘indomani della disfatta di Azio. forseconsapevole del suovaloreAugusto la trattenne comunquenel suo esercitoma, quandogli si ribellò. fu privata del cognomen equestrisefattaconfluirenella Legio X Gemina.
Lacto Xl CLAUDIA PIA FIDELIS
Anche questa fu inorgineuna dellelegioni arruolatedaGiulioCesarenel 58 a.C. insiemealla XII, in previsione dellaguerracontrogliElvezi.LaX]Claudiapreseparte,quasi certamente,ancheall’assedio diAlesia, per battersi poi contro Pompeo a DurazzoeaFarsalo.Inseguitolalegionefuscioltaed i veterani collocati nel territorio di Bojano, Cam» pobasso. dandovita allaBat/iaan Undecumunorum. Ottaviano ricostituì l’unità nel 42 a.C. e la fececombattereaFilippieancoraadAzio,dopodi chel’x]Claudia fu inviata nei Balcani,peressere dislocata. subito dopo Teutoburgo, a Bumum, odierna ChistagneinDalmazia,dividendolabase conla VI]Paterna.Avendorepressouna ribellione durante l‘imperodi Claudio,venne fi'egiata dallo stessodel titolo diPia Fidelis. Durantel‘annodei quattro imperatori si scisse.paneggiando inparte per Otone e in parte per Vespasiano. Superata la crisieriunitasi,esauritauna seriedimodestecarn— pagne, venne stanziata nel 74 a Vindimissa, IlteatrodiPietmbbondanteneiplessidiBovianum.attualeBojano, …
odierna Windisch in Svizzera, allora già Genna"""°"sdicamwbsss°' nia superiore.Altri combattimenticontro i Chatti NellapaginaafiancoiruderidiVindanism,attualeVlfindischinSvizzera. equindi un altrotrasferimento ancora nel 101a Brigeti'o, odierna SzonyinUngheria, alloraPannonia inferiore. Partecipò alleguerre dacichedi Traiano enel 114vennetrasferitanellaMesia inferiore.Parteggiòper SettimioSeveroeforsepreseparte allaconquistadiCtesifonte.Alcuni suoiinterventirepressiviall’epocadell’imperatoreGallieno,lefruttaronoulteriori riconoscimenti.Nel corsodelV secolosiritrova schieratalungoilDanubio.Ilsuoemblemaforse fuun toto oNettuno 0anchei gemelli allattati dalla lupa.
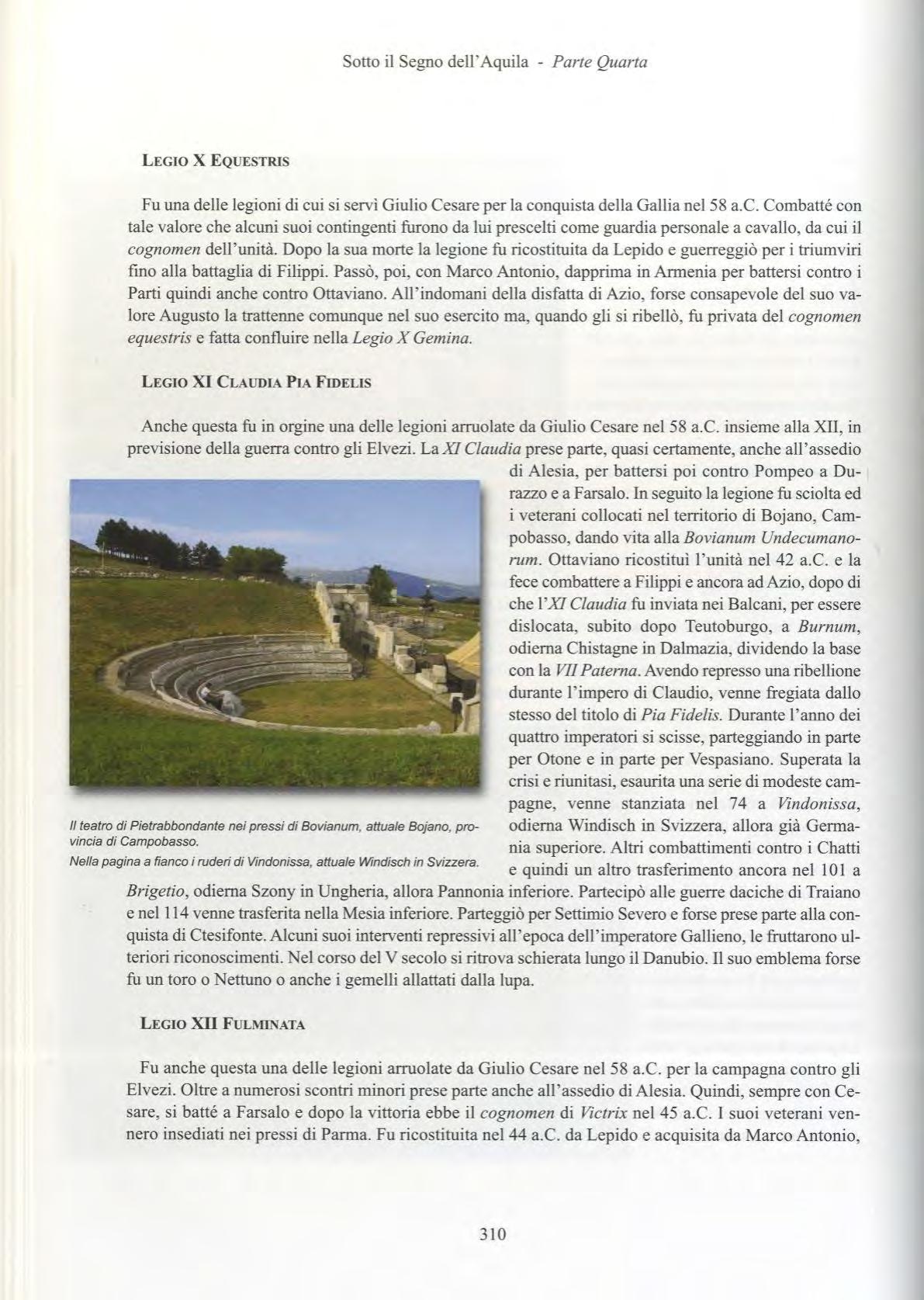
LactoXII FULMI.NATA
Fu anchequesta una dellelegioni arruolatedaGiulioCesarenel 58a.C.per lacampagna controgli Elvezi.Oltreanumerosi scontriminoripreseparte ancheall‘assediodiAlesia.Quindi,sempreconCesare, si batté a Farsan e dopo la vittoria ebbe il cognomen di Vic!rix nel 45 a.C. I suoi veterani vennero insediati nei pressi di Parma. Fu ricostituita nel 44a.C.da Lepido eacquisitadaMarcoAntonio,
Sotto il Segnodell‘Aquila - Parre Quarta
310
Sotto il Segnodell'Aquila Parra Qnm-m peril quale èprobabile che abbia combattuto zi Modena controOttaviano. e ancora con lui a Filippi. contro gli uecisori di Cesare. Recuperala daAugY stoebbe stanza a Ruphlllltl. in Siria. Subì una sconfittadisonorevolenella battaglia di lilium/ciu. in Cappadocia. nell‘anno (vl-63. Nel 66 tentò di recuperare la coinprome dignirà nel corso della prima guerra giudaica ma. per la sua fiacca combat…ità. fu rinviata alla base e nella marcia di rientro. incappata in una imboscata.perde pure le aquileoltre a 5.000 legionari e 380 caialieri' In seguito. tutta\ia. ebbe occasione di redimersi prendendopaneall'ultima fasedellaguerragiudaica. Più tardi sostenneTitoFlavioVespasiano nella sua ascesa al soglio imperiale e fu da questi destinata a Melitene. odierna Malata. in Turchia, dove ebbe l'incaricodi difendere la frontiera lungo l’Eufrate.Nel 75 si ritrota nel Caucaso.inviatavi da Domiziano.enel 114inArmenia conTraiano. MarcoAurelio laportòcon senella campagna contro i Quadi.durante le guerre inarcoinanniche. Ebbe in seguito anche il cognome" di Caria Corman; datole dallo stesso impera— tore quale riconoscimento per non essersi ribellata durante la ri» volta di Avidio Cassio. Verosimilmente rimasta in area mesopotamica partecipò a tutti i successivi e\enti bellici. anche se dalle fonti ben poco risulta. Di certo agli inizi del V secolo e ancora segnalata a Melitene. Ebbe per emblema il fulmine.
Lt:cto XIII Geniv.
E'ritenuta una delle legioni storicamentepiù celebri. Fomtata da Giulio Cesare nel 57 a.C. partecipò alle campagne di Gallia e.forse.anche all'assedio di Alesia. Passò per prima il Rubicone. nel gennaio del 49. dando inizio allaguerra controla fazionedein ottimati. Quindi si schieròcontro Pompeo, com» battendodaDurazzoa Farsalo.Richiamatanel46partecipò allabattaglia diTapso cquindi di Mundanel 45, dopodi che fu scioltada Cesarechericompensò i suoi veterani con elargizioni agricole.Nel 41 a.C. Ottavtano la ricostituì per stroncarelaribellione di SestoPompeo in Sicilia.Aequisì il rugiioiiien di Gemina dopolabattaglia diAzio.quandofureintegrata con i superstitidi altre legioni. VenneinviatadaAuf gusto inCroaziaenel 16trasferita a Eniunu.odierna Lubiana.nella Pannoni dove ebbea reprimerevarie rivoltelocali.DopoTeutoburgositrasferì a l'indonirrfl.nella Germania superiore.per fronteggiareeven tuali attacchi gennaniei.Claudiola spostò di nuovo in Pannonia ine torno al45.Nel 69paneggiòpritna per Otone e poi per Vitellio. en— trambi sconfitti: secondo la tradizione i suoi legionari furono costretti dopola resa acostruiregli anfiteatri di Cremonae di Bologna, prima di sere rinviati in l’annonia. Nella successiva crisi si schierò con Vespasiano e prese
Aerialnnniogiapn
 FotoaereadelIride/idel!anfiteatroromano diVindonissa
ofthemmsafaRoman amphitheatfe in Vindonissa.
FotoaereadelIride/idel!anfiteatroromano diVindonissa
ofthemmsafaRoman amphitheatfe in Vindonissa.
parte al saccheggiodi Cremona,per essere subitodopoinviata nelle Gallie,per tomare infine alla base di Viridoborra, odiernaVienna.Da quel‘ lungo i limes’ eda DomizianofustanziatainDacia.adApulum, AlbaIuliain Romania.perpresidiare laregione.Resasi necessatial’evacuazionedellaregionelaXIIIGemina siriposizionònella DaciaAureliano.Moltesuevessilazionipreseroparte aun grannumerodi campagne successive:di certostandoaduna fonteattendibile nel V secoloil grossodella legione stavaancora insediato in una fortezza a Babilonia d’Egitto, lungoil Nilo. Il suoemblema fu un leone.
LactoXIII GammaMAR‘I'lAVtc1'tux
Fuuna dellelegioniarruolatedaOttavianonel41 a.C.,forsefondendonedue.Intal casoil grossodel suoorganico sarebbe stato della Legio”IIIdi Cesarebattutasi adAlesia, da cui la scelta del numero. Quanto al cagnomen venne aggiunto da Nerone dopo la vittoria su Boudicca. Partecipò nel 43 alla invasionedellaBritanniaed.appunto,allaguerracontrolaregina Budicca conclusasinel 60—61.Nel 68fi.t stanziata nella Gallia Narbanensi's. Un episodiodi ribellione la vide protagonista nell‘89 ma fu presto soffocato. Nel 92 la legione fu mandata in Pannonia e pose la sua base a Wndobona, Vienna. Passò, quindi,a Camutum, oggi Petronell inAustria, dove stava la maggiore base della flotta fluviale del Danubio edoveverosimilmenterestòper i successivitre secoli.Dopo alcuneoperazioni,per lopiù dimatricepolitica,1aXIIIIGemina è sempresegnalahaagli inizidelVsecoloaCarnutum.Forsesisciolsenegli anni immediatamente successivi insieme alla cadutadell’intera frontiera del Danubio. Il suoemblema era il capricorno.
LEGIOXVAPOLLINARIS
AnchequestaquasicertamentevaconsiderataunadellelegioniformatedaGiulioCesareintornoal58 a.C.Fia quelle, infatti,proprio laLegioXVrisulta distruttaomolto malridotta inAfrica nel 49 a.C.Nel 40-41 a.C.,Ottavianolaricostituì oforsenecreòunacompletamentenuova che,però,nerievocava ilnumero,percombattereSestoPompeoin Sicilia.Dopolabattaglia diAzio laXVApollinarisvenneinviata nell'Illirico,dadovenel6partecipòconTiberioClaudioNerone allacampagna contro Maroboduo, non senza aver prima domato una rivolta nella regione boema, Fu trasferita, quindi,aPoeiovia,Pettau in Slovenia.Nel 50sispostòa Cnmum‘um dove restò fino al 63, quando dovette stanziarsi ad Alessandria d'Egittoepoi inGiudeatrail63edil 70,partecipandoallaprima guerragiudaica.Siritienecheebbeaccampamenti siaadAntiochia siaaGerusalemme, dove contribuì all’assedio sottoil comando di Tito. Rientrò a Camuntum al terminedellaguerraesottoDomizianocombattélungoilconfinedanubiano. ConTraianoalfrontòiPartidal 114,peresserestanziatastabilmenteinCappadocia nel 118.Alcune suevessilazioni intervenneronelleoperazioni di Marco Aurelio, cheper la fedeltà mostratagli, reprimendo un tentativo diusurpazione.lafregiòdeltitolodi CormonsPiaFidelir. Lesueultime menzionirisalgonoalVsecoloeladannosempreinCappadocia.dibase aSatu/a, odierrta Sadagh inArmenia, eAiicyra, Ankara. L’emblema è ignoto ma significando il suo cognomen fedele ad Apollo, si ritiene probabile che fosseproprio la suaraffigurazione.
Roma:statuaequestredlMarcoAurelio. Roms:oauesm'anstatusofMarcusAurel/us.

Sottoil Segnodell'Aquila Parte Quer!a
LEGIO XV PRI‘IIGl-XH
La legione fu formatadall'imperatoreCaligola nel 39.e dedicata.comerecita il suoCagno/nen,alladea Fortuna. In realtà l'unità di fortunane ebbepochissima sopravvivendoappena trent‘anni!Arruolata per la campagna germanica di Caligola si batté a Wiesbaden. non lontano da Magonza dove. terminati gli scontri, Caligola la insediò insieme con la XII]! Gemina. Dopo il 43 si spostò nella base di (astra Vc[ere. 'nsieme con la l’A/audae al posto della XXI Rapax. Partecipò nel 47 all'offensiva di Corbulone
ilcanalecostmitaInGerman/'adallaxvPrim/genre
Thecana!buminGermanybythexvanigen/‘a.
LEGIO XVI GALLICA
contro i Chatti. tatticamenie vittoriosa ma strategicamente sterile. essendo il vasto territorio conquistato indifendibilc. La XV Prirml genia nella circostanza si dedicò alla costruzione di un canale. che ancora esistetra Mari/v, Leida. cMimicipr'um Carrune/èm’um, Voor» burg. Sostenne Vitellio nel 69. ma scoppiata la rivolta batava finì insieme alla V 4qudae sconfina in battaglia e.dopo un breve assedio, a Cam-a Vetere. lidovette condividerne la resa nel 70.Anche due delle legioni inviate in loro soccorso furonobattute. prima che Vespasiano riuscisse a reprimere la rivolta.Tanto lafl'Prinzigenia che la l’A/umide non vennero più ricostituite. Ignoto il suo emblema. forsela raffiguraZione della dea Fortuna.
Fuunalegioneformataall‘epocadeitriumvin eperciò.almenoinizialmente.non ebbealcunragionieri.Nel 40—41 a.C.risulta arruolatada Ottaviano.standoalle ipotesi di alcuni studiosiper Cul,probabilmente. dopola vittoria diAziovennedallo stessostanziataaMagonza.Da 11futrasferita intorno al43.aAbr-nexium. odierna Neuss nellaGermaniainferiore.peravvicendarelaXX liz[en'a lien-Lr.inviataa suavolta inBritannia.Nel 69» 70seguiVitellio.mentrescoppiata lamolla dei Bata\i. lreparti ancorainsededellalegione siarresero,eonsegnandopersinol'aquilaalnemico…Recuperata lasituazioneVespasiano lasciolsenello stessoanno.Ebbeperemblemaforseun leone.
LEGIO XVII
Poche le notizie sicuresuquestadisgraziata legione.ad eccezrone di quella del 9.relati\a al suo massacro a Teutoburgonel corso del trasferimento guidato da Varo. Per motivi scaramantici non venne più ricostituita.
LEGIO XVIII
Anche di quest‘altra legione. distnitta con la precedente a Teuto— burgo emai più ricostituita.poche sono le notizre sicure.
Li;cro XVIII]
Terza legione ad esserecoinvolta nella strage di Teutoburgo fu la XVI/[].anchelei mai più ricostituita. La sua aquila fi.i ritrovata ere—
Soolcr'adellapaludeadiacentela folestadiTeutoburgo@afiancoIlmonumentoadAmri/ria SectionoftheSwampavd/acenttothe forestof Teutoburgandthemonument[oArmimus.
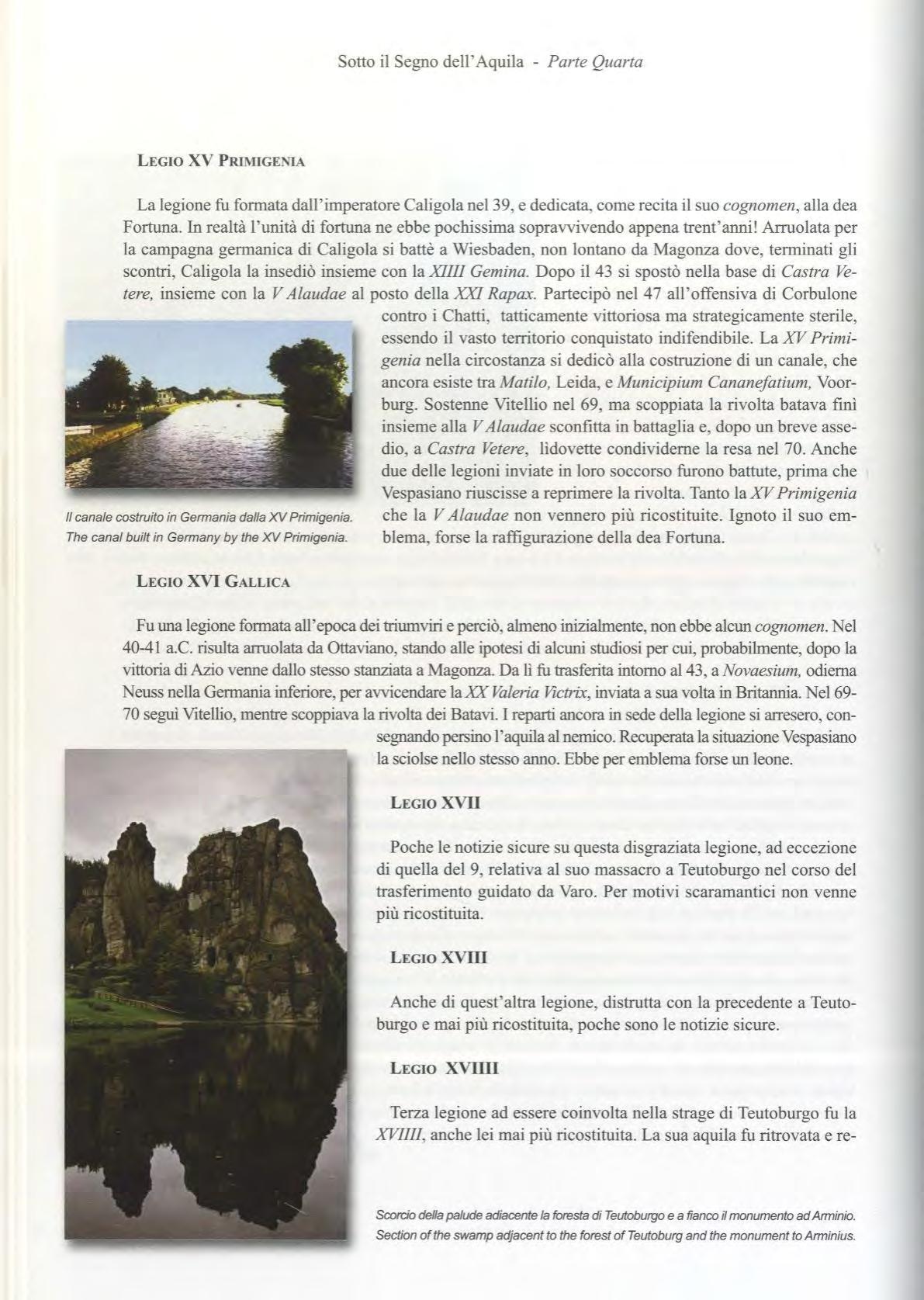
Sotto il Segno dell'Aquila - Pur-n:Quam:
Sottoil Segnodell’Aquila - Porte Quarta cupeiataben seiannidopo.duranteuna campagnadiGermanico mirante a riaffermare la sovranità di Roma negli stessi luoghi, pressounatribù di Bructer'i,Nella circostanzavennedata anche onoratasepolturaaitantissimi resti umani cheancoragiacevano sparsinella foresta…
LactoXX VALERIAVIC'I'RIX
Forse fit una dellelegioniarruolatedaOttaviano,dopoil 31 a.C. Di certoprestò servizio in Spagna,dove combatté i Cantari tra il 25 ed 13a.C. Venne quindi trasferita nell’Illirico, partecipando nel 6 alla campagna di Tiberio contro i Marcomanni.Dopo il disastrodi TeutoburgolaXX Valeria Vretrix si insediò nella Germania inferiore presso Colonia, ad Oppidum Ubiorum, per spostarsi poi aNavaesium, Neuss. Nel 43preseparte all’invasionedella Britannia,doverestò dibase a (‘ ’ ’ C ‘ L C ‘ ‘ contro " " e, nel 69 si schieròper Vitellio,non subendoperò sensibiliconseguenze.Combattéanchecon GneoGiulioAgricola in Scozia,dove stabili la sua base a Inchtuthil.Tomè quindi a CastroDecumz, Chester, dove restò per almeno due secoli. Partecipò alla costruzione del Vallo di Adriano e, forse, anche di quello diAntonino. Le sue ultime notizie risalgono al IV secolo, e la danno sempre in Britannia. Ebbe per emblema un cinghiale.
anroXXI RAPAX
Fuuna dellelegioni arruolatedaOttavianonel 31a.C.,forseconcoscritti giàinprecedenzamiliti in altre unità.Appena formata,venne inviata nella SpagnaTarraconese controi Cantari. Nel 15risulta stanziataaRegensburg,Ratisbona,nella nuovaprovincia dellaReziama, inseguitoaldisastrodiTeutoburgo,fuinviatanellaGermaniainferioreaXanten, dove divise labase conla VAlaudae…Nel 43vennespostata,verosimilmente per compensare i vuoti creati dall’invaione della Britannia, a Vîndo— m'ssa, Windisch,nellaGermaniasuperiore.Nell’anno 69appoggiò,ov— viamente, il suo comandante Vitellio e marciò per lui su Roma per assediarla: la vicenda, però, si concluse di li a breve con la sua uccisione.Nel 70fu destinata a domare la rivolta batava, al termine della quale tornò nella Germania superiore a Mogontiacum, Magonza, di stanzaconla)flVGemr'na. Dali,pocodopo,insorsecontroDomiziano,propriocon la)flVGemina.Ces. sata l’insurrezione le dueunità vennero separateelaXX!Rizan andòin Pannonia,dovefini annientata nel 92duranteuna rivolta dei Sarmati.Per emblema ebbeun capricorno.
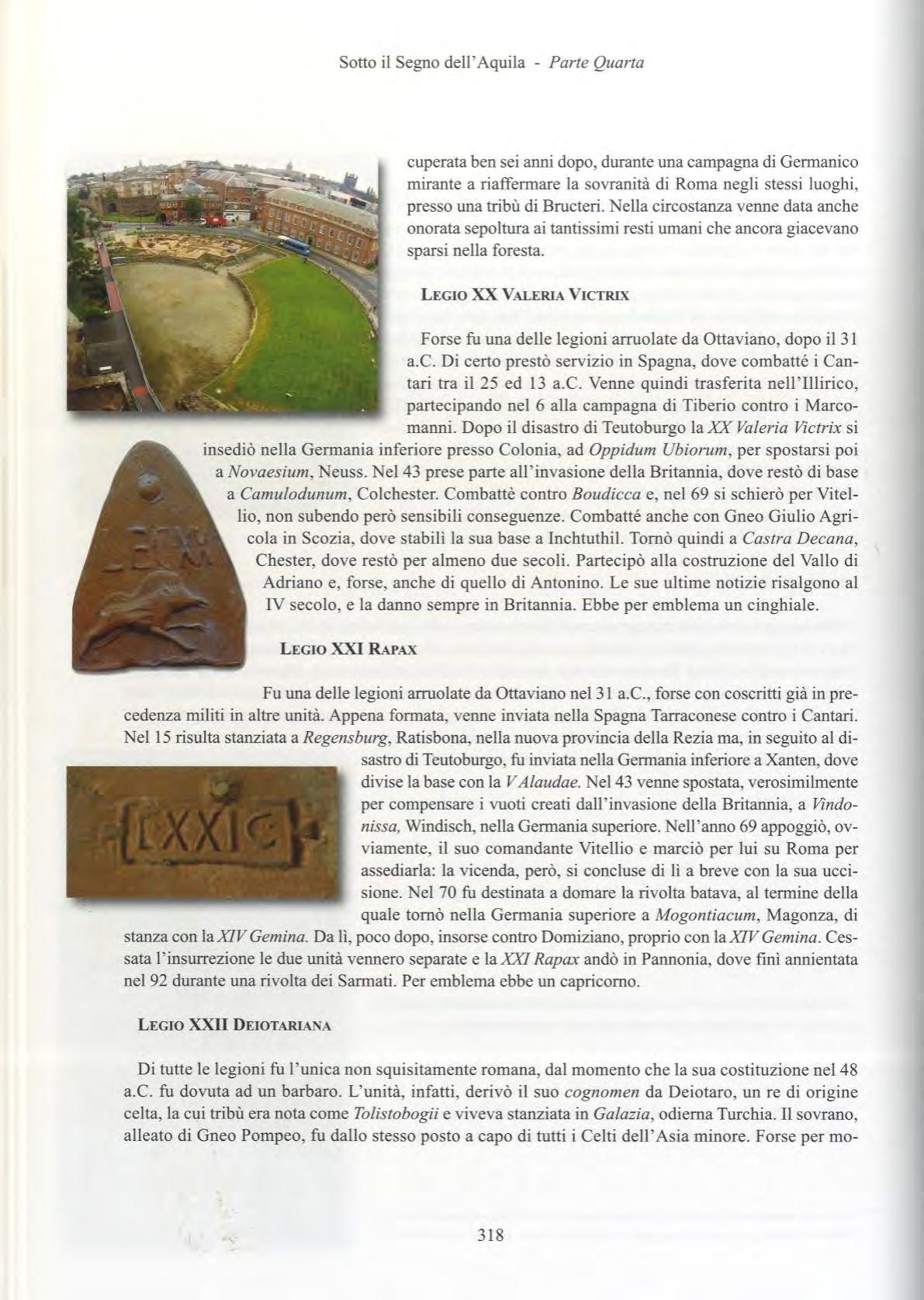
LactoXXII DEIOTARIANA
Ditutte le legioni fu l’unicanon squisitamenteromana, dal momento chelasuacostituzionenel48 a.C. fu dovuta ad un barbaro. L’unità, infatti, derivò il suo eogmnnen da Deiotaro, un re di origine celta, lacuitribù eranota come Talistabagir'eviveva stanziata in Galazia,odiernaTurchia.Ilsovrano, alleato di Gneo Pompeo, fu dallostessoposto a capodi tutti i Celti dell’Asia minore. Forse per mo-
318
strarsidegnodella fiducia, forse per smodata ambizione, Deiotaro assoldò un intera legione e la addestròa suespese, servendosiperòdi consiglieriromani, secondo letradizionali disposizioni.Per la verità lasuaunitàrisultava notevolmentepiù numerosa dellausuale, essendoformatada 12.000fanti e 2.000 cavalieri, con un organico suddiviso perciò in ben trenta coorti. In sostanza equivaleva a 3 legionipropriamente detteecontribuì, in modo determinante, alla vittoria romana nella terza guerra mitridatica. Ridotta ad una sola legione, l’unità fu a fianco di Giulio Cesarenella campagna contro il Ponto enella battaglia di lela 47 a.C.Annesso il regno galato la legione fu inclusa a tutti gli effettitra quelleromane, per la conformità del suoaddestramento eper il valore dimostrato.Dal momento chel’esercito contavaormaiventuno legioni, ne divenne la ventiduesima.Augusto la stanziò a Nicopoli in Egitto, nei pressi di Alessandria, nella stessa base della 111Cyremzica, a difesa del— l’Egitto.Andò nel26 a.C.con Elio Gallo in battaglia contro i regni diNubia, interrotta dalla epide» mie.Lalegione,daquel momento,restòdi stanzasemprein Egitto,finoallasuadistruzione avvenuta forse frail 132edil 135.Ne èigrotol’emblema…
LEGIOXXIIPRIMIGENIA
Fu l’altralegionevolutadaCaligolanel39,invistadiunacampagnainGermania,ededicataanch'essa alladeaFortuna.Al di làdeglischemidi Svetonio(7)lalegionevenneimpegnatainazionipernulla insignificantierisibili, dopoavervalicato leAlpi esuperatoilReno,comeadesempioil combattimento avvenuto aWiesbaden. LaJOG]Primigenia venne, quindi, stanziata a Magonza, a difesa del limes reniano,dividendoilcampoconlaH1Mueedonia,dadoveforsepartiperpartecipare alla fortunata campagnadiAuloGabinioSecondocontro i Chatti.Di certo sostenneVitellio nel 69, marciando su Roma,giungendo a far sfilare la sua aquila per la città. MaVespasiano,con lasecondabattagliadi Bedriaco, lasconfisserinviandolaallasua base, senza ulteriori punizioni, conferma implicita del suo valore. Sostenne gli at— tacchi deiribelli batavi, non riuscendo però adaverneragione efu spostata,perciò,a Vìndobona,Vienna,epoi aCasini Vetere.Perlafedeltàdimostratacontro ilribelleL.Antonio Saturnino,ebbedaDomiziano iltitolodiPia FidelisDomitiarra. InessamilitòcometribunoPublioElioTraianoAdrianonel97-98e DidioGiulianonel 170—171.Purnon lasciandomai ilcampo,alcunesuevessillazionicontribuironoallarealizzazionedelVallodiAdriano in Britannia e diAntonino in Scozia.Partecipò allacampagnadi Caracalla,nel 213 in Germania,ricavandoneiltitolodiAntonianaeallacampagnacontroiSasanidi,nel 233inPersia,conAlessandroSeveroricavandoneancorailtitolodiAlexandrizzmz.
Massimo,-,T…. L’imperatore,però, poco dopofinì linciatoproprio dai suoilegionari,che elessero
Maximumthemaman… al suoposto Massimino Trace. Il titoloPinFidelis loebbe inpiù occasioni dinon precisa collocazione storica. Si sa che combatté ancora contro i Goti nel 268. Le fonticessanodimenzionarlaagli inizi del IVsecolo,ma la suascomparsa sembrarisalire all’etàdi Co— stantino.Ebbeper emblemaun capricornoedErcole.
LEGIOXXX ULPIAVicnux
Fuuna legione arruolanel 105dall’imperatoreTraiano,del quale infatti ricordava lafamiglia Ulpius nel cognomen, invista dellesuecampagne inDacia.Ebbelasuaprima base inDacia,lungolafiontiera sulDanubio,edèprobabile chealcunisuoicontingentiabbianopresoparte allaspedizionecontroiParti.
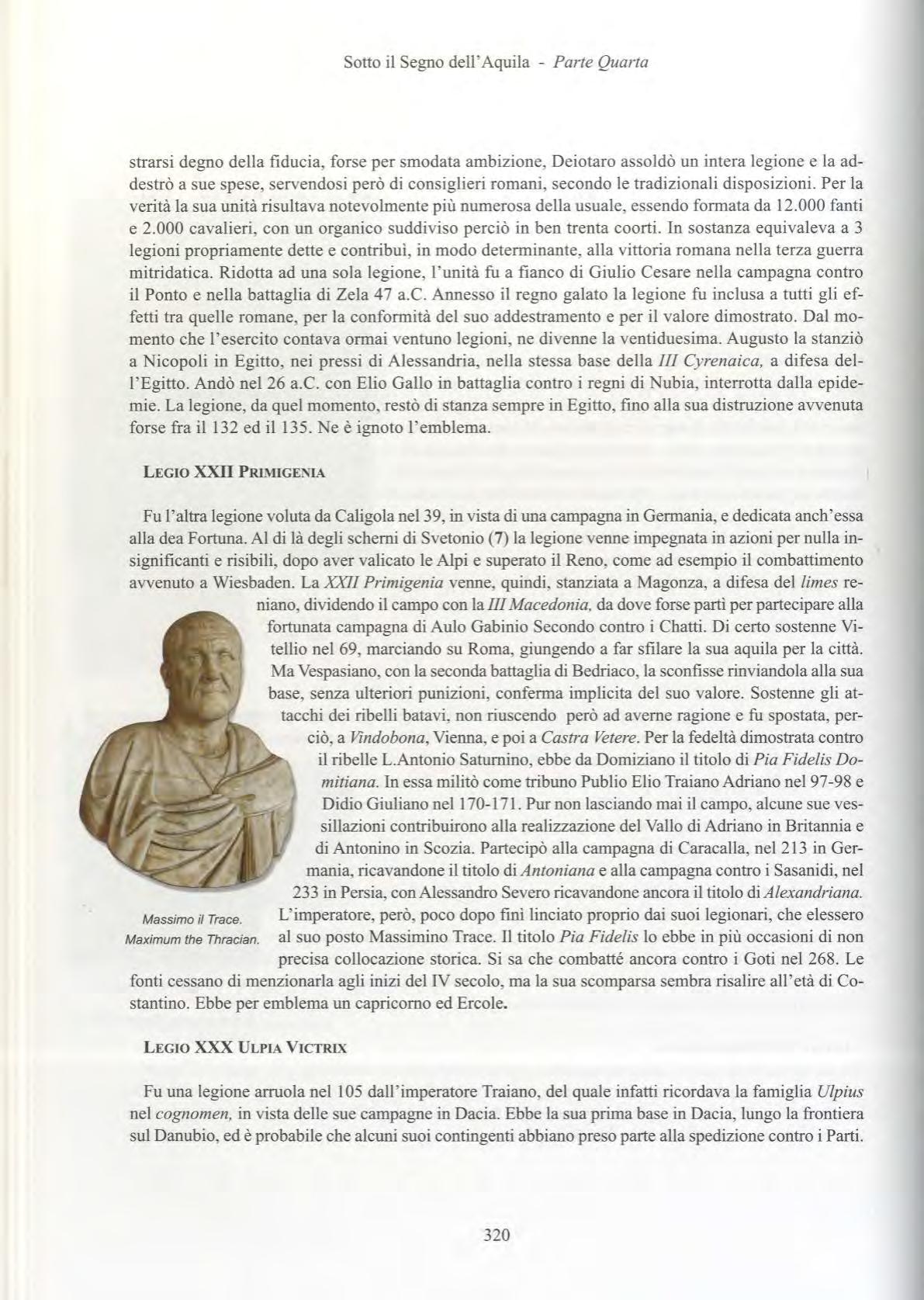
Sottoil Segnodell‘Aquila - Parte Quarta
320
Sottoil Segnodell’Aquila — Parte Quarta
Nel 122vennetrasferitaaColonia Ulpia Traiana,doverestònei secolisuccessivi…Sioccupòdaquelmo» mento soprattuttodicostruzioni edipolizia locale.Tralafinedel 11el’iniziodel [IlsecoloalcunisuoidismeamentivenneroinviatiinParikia, inGalliaeinMauretanianon ’ J sensibili r , ‘ ' la ’ ' in (‘ ' Avendo sostenuto l’imperatore SettimioSeveronella ribellione del 193,ne ebbeiltitolo diPiaFidelis.Combattéancoraconl‘imperatoreAlessandro Severocontroi Sasanidinel235.Lesueultimenotizienonvannooltreil V secolo,cessandoperciòcontestualmentealdissolversidel limesrenano. Suoiemblemi furonooltreal capricornogli deiGioveeNettuno.
Quadrod’insieme
Volendotracciareun quadroriassuntivo diquantofin qui espostocircal’esercitoromanonediscende il seguenteorganigramma,incui QsiaperquingenarieeMper miliari? :
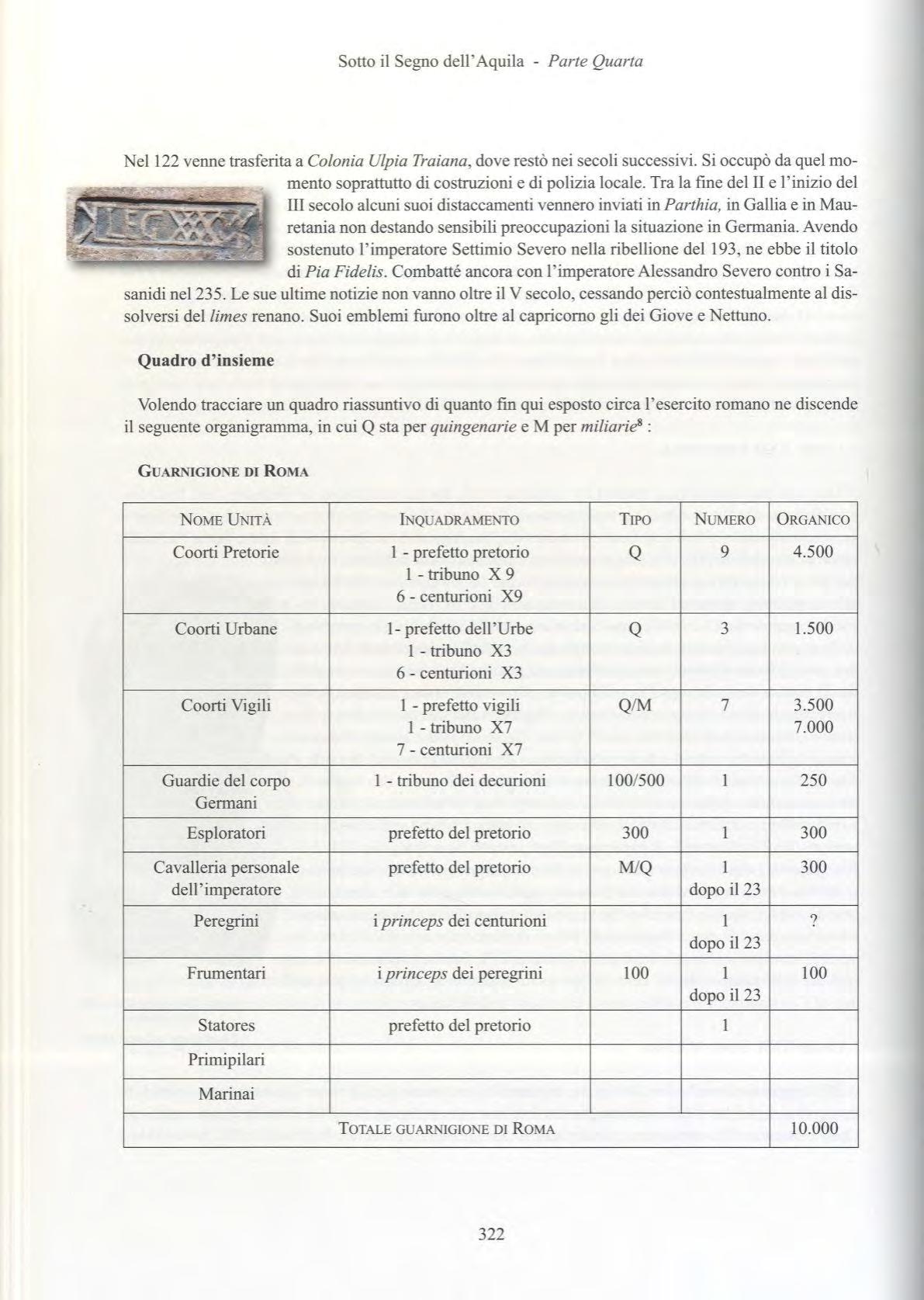
GUARMGIONEDr ROMA NOME UNlTÀ INQUADRAMENTO Tipo NUMERO ORGANICO CoortiPretorie 1»prefettopretorio Q 9 4.500 1 - tribuno X 9 6 - centurioni X9 CoortiUrbane l-prefetto dell‘Urbe Q 3 1.500 1 - tribuno X3 6 - centurioni XS CoortiVigili 1 -prefettovigili Q/M 7 3,500 1 tribuno X7 7000 7 - centurioni X7 Guardiedel corpo 1 - tribuno dei decurioni 100/500 1 250 Germani Esploratori prefettodel pretorio 300 1 300 Cavalleriapersonale prefettodelpretorio M/Q 1 300 dell’imperatore dopoil 23 Peregrini iprincepsdeicenturioni 1 ? dopoil 23 Frumentari iprincepsdeiperegrini 100 1 100 dopoil 23 Statores prefetto del pretorio 1 Primipilari Marinai TOTALE GUARNIGIONE DI ROMA 10.000 322

ESERchODELLE PROVINCE NOMEUN\TA INQUADRAMENTO ORGAN1CO NUMERO ORGANICO UNITARK) COMPLESSIVO 1- legatodi legione ] tribuno 5.000 1-prefetto del campo fanti Legioni 5 -tribuni 25 125.000 1- tribuno di6mesi 120 59centurioni cavalieri di cui 1primipilo Ausiliari Ali l prefetto D 250 125000 16- decurioni cavalieri Coorti l - prefetto D 6 - centurioni fanti Coorti ] - prefetto D miste 3- decurioni fantie 6 - cavalieri Numeri TOTALE ESERCITOALLE FRONT[ERE 250.000 FLOTn-z VARIE LUOGO NOME UNITÀ INQUADRAMENTO TIPOLOGIA ORGANICO COMPLESSIVO 1- prefetto Miseno per flotta marinai e flottepretorie detti 40.000 Ravenna navarchi militi centurioni trierarchi Provincie Bretagna Germania Pannonia ]»prefetto Mesia flotte per flotta Ponto Siria Alessandria TOTALE GENERALE 300.000
Sotto il Segnodell’Aquila - Parte Quarta FRONTIERE:
LE GRANDI BASI LEGIONARIE
GiuseppeFlavio "ci ha lasciato.quasi sicuramenteper esperienza diretta e personale. una dettagliata descrizionedi un accampamentoromanodi etàimperiale.conferrnandocicosi che.in sostanza.siaper concezione che per struttura ben poco era mutato rispetto a quelli dell‘epoca repubblicana. In dettaglio. scriveva: "i Romani non rie.rpongono …al11mi attaccodiSorpresa:quando invadono un territorio ostile. non impegnano battaglia priora di merloni/ir:an il loro accampamento... se il terreno è it7egolare. vieneprima spianato;paisimisura ilsitoper ['accamparnento. di» orma quadrata…
gen.
camente: in m
Linternodel]'acczzmpamenta (3diviso infileditende. Ilperimetro este/'no ho ['a.tpetlodiun muro, ed èprov» vista di torri a intervalli regolari; e negli spa:ifra le to: tonodispostebalitte. catapulte. lanciasusxieogni sortadimacchined'artiglieria, tuttepronteperl'uso.In questomuraperimetrale. .iiapronoquattroporte, abba» rtan:a alleperché viptLS‘SÌIID renza difficoltà bestie da soma.e«bbasta/1:11largheper [ero:-tilein corodiemerIlcampo è intersecatoda vie dispostesimmetri» () ci sono le tende degli ufficiali. e proprio nel centro c’è il quartiergenerale del comun» dame in capo. cheassomiglia {:unpia-an tempio... Se necessario, il campo è circondato da unfossato pro— fondoquattrocubilielarga altrettanto."…
Il campo temporaneo quadrato del I secolo descritto daGiuseppeFlavioripete senzasostanzialidifferenze il campodescrittoda Polibio nel il secoloa.C..fattesalve alcuni adeguamenti suggeriti. più che dall’evolversi dellelegioni.dal mutaredel loroimpiego.Inparticolare, sene coglie una maggiore attenzione alla connotazione difensiva.una sortadiprova preliminare diuna struttura destinata a un impiegopiù duraturo. in un contesto non necessariamente bellico. ma non per questo pacifico o pacificato. In altri termini una embrionale piazza forte, che51ritrova megliodelineatanel trattatoDemunitioni» buscast:-amm.attribuitoadunopseduo Iginoil Gromo» tico. composto in data imprecisata tra il 1 ed il 111 secolo." Questo schema di campo, che verosimilmente in quantotale è più ideale che reale. se non ebbe appli» i cazione nelle campagne lcgionarie, fu tuttavia l’archetipo sul quale siedificherannoapartire dal 111secolo,le grandi basi legionaricstabili.antesignane fortezze.Adif-
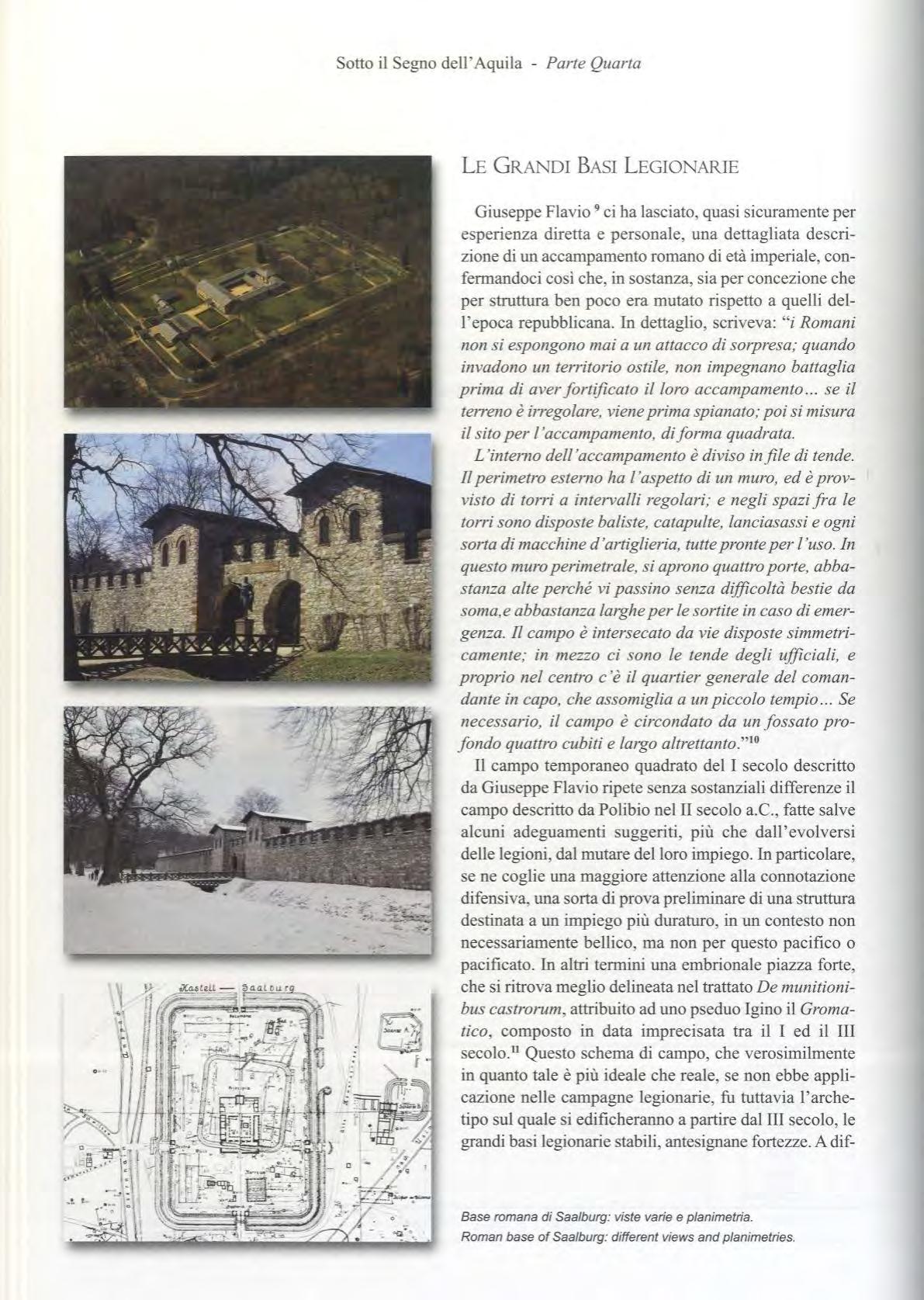
Sotto i]
Segnodell‘Aquila - Ptr/'le Qua/‘la
l i |
BaseromanadiSas/bulg'vistevarie&planimetria. Roman base of Ssa/Dung differentviewsandplantmetnes
ferenza del campo quadratodi Polibio e di GiuseppeFlavio, il campo di Igino è rettangolare con i lati lunghi 2.320 x 1.620 piedi romani, pari a m 700x 490 circa,quindi leggermentepiù grande. Infatti èdestinatoad oltre40.000 uomini. ovveroatre legioni.pretoriani. cavalleria e fanteria ausiliaria,esploratori e persino un intero reparto cammellato. Conseguente, perciò. la fortedensitàal suo internoela contrazionedi spazioadisposi» zione di ogni milite, circa un terzo di un campo tradizionale. Purtrattandosi,almenonelle intenzionidell’autore.diuncampo temporaneo, divenne inrealtà, comeaccennato,lo schemaplanimetrico tipo per i nuovi accampamenti legionari che si sta— ,,,g,essode,mne,egionafiodiKastettBificianap,esso vanotrasformando inbasi avanzate stabiliadottandoperciò non Wfliflenbufyi"EfiViefa 9. 5 nellaPagina & fianco Ptr più icanoni dellafortificazionecampalemadiquelli dellapermlissumi"Romania manente.Conl’estendersiinfatti delleguerreai:“territorilon-
tuttisiresenecessariocheletruppe, sulpostoper
estivifurono quindi integrati di quartieri invernali (hibema) costruiti in zone saldamente controllate dairomani. Questicastrahibema oflrivanoalloggiamentimeglio attrezzati, specieriguardoailocalidi magazzinaggio, ma non avevanoancora ilcaratterepermanentedeifi7rtilizidell'eta'imperiale. Ilpassaggioaquestiultimi avvennesottoAugusto, soprattuttoinseguitoallecampagnecontro i Germanidi là dalReno, Fra il 12a.C. eil 16d.C. ]‘esercitoromano condusseuna seriedi campagneal comando prima diDruso,poidi Tiberioeinfinedi Germanico.La vastità delterritorio di operazioni eilrigore dell'invemocentro-europeoportaronoallacostruzionediuna seriedigrandidepositidirifornimento e basi invernalisemipermanenti. Questatendenzasiaccentuòdopoladisfattadi Varo nella selva di Teu— toburgo (9d.C.), con laperdita ditre legioni. Iltraumaprovocato da questodisastrofu tale cheAugustoconsigliòalsuosuccessore Tiberiodinon estendereulteriormenteiconfinidel!'lmpero;sicchéalla morte diAugusto ilReno eilDanubio eranodiventatidifatto lefrontieresettentrionalidelmondo romano, Alla metà del[secololadistinzionefra la basepermanentee MIBERNA era chiaramentestabilita. Alcune diquesteprime basi legionarie ospitavanodue legioni,per esempioa Xanten (Vetem). nella bassa Germania; ma disolito solo una. Lefortezzedestinatead alloggiare una singola legione di 56.000uominieranoordinariamentedifannorettangolareeoccupavanoun 'areadicirca20ettari. L 'di» setto interno ricorda I 'accampamento temporaneo di Igino, apianta tripartita; i locali del comando (principia)adessoseparatidalla sededellegato (paretorium), eranosituatiallincrociofra la via principalìsela via praetoria."n L’accarupamento a quel punto aveva assuntolapiena connotazione di una antesignanafortezza,strutturadifensivachericomparirà,conidenticoimpianto,soltantoinetàmoderna!
FORTEZZELEGIONARIE
Oltre al grande campopermanente, infatti, in epoca imperiale si andaronosemprepiù diffondendofortezzedivarie dimensioniriservatea sezionistaccatedilegioni,avolte dientitàcomplessivapersino inferioreallacoorte.E’evidentechestrutturedelgenerenonavevanopiùunafunzionemeramenteresidenziale ‘‘ J protetta,ma acompiti '' difensivi,speciedove ilcontestosiconfermava fortementeostile. Sitrattava,allora,avoleressereprecisinonpiù diunasemplicemanifestazione,di unmanufatto variamentearticolatodell'architetturadifensiva,ma piuttostoil debuttodiunanuova branca dellastessa.Avoleresserepignoli, infatti,andrebbedefinitaarchitetturarepressiva, inquantoalsuointerno
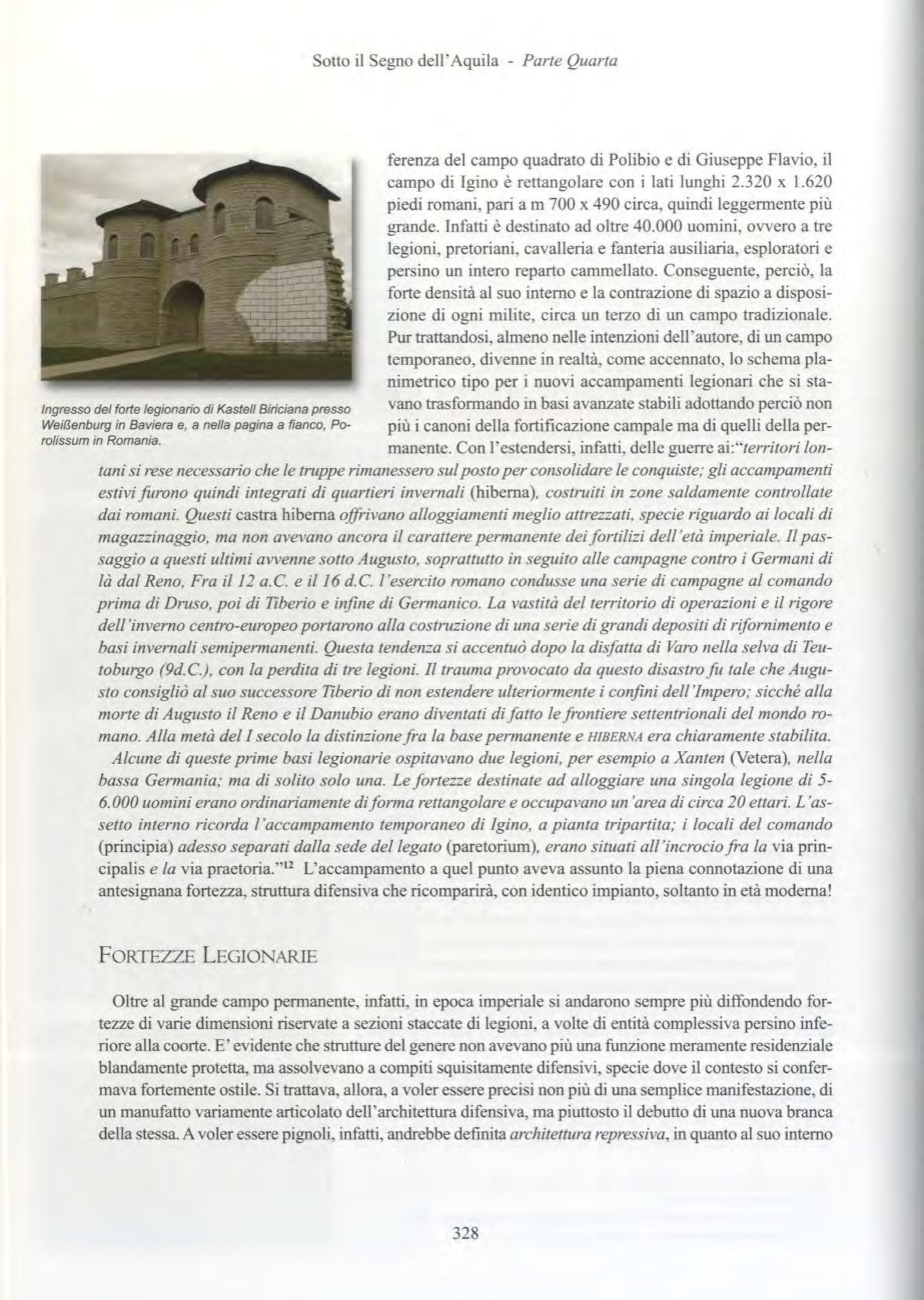
Sotto il Segnodell'Aquila - Parte Quarta
"’ le ‘in
328
non risiedeva ilpiù debole in assoluto.ma una cospicua guar nigione.anchedi dueotre legioni.destinataadominare lepopolazioni limitrofe. ostentando easi la sua inviolabilità ed al contempo garantire un confortevole soggiomo. La fortezza infatti.non dmerasemplicementeproteggere i suoioccupanti ma anchefavorirlinel tenere sottocontrollo il territorio circostante.incutendo il massimoterrorenein eventuali attaccanti, al puntodaindurli adesisteredalprovarci. Un prodottoditecnologia avanzaîa per ricavare il massimo effetto deterrente. Setivenaduranteil regno di Adriano.Arriano.dopouna ispezione eiîettuata intorno al Mar Nero:“llfurte (situato all'ingrexro del Faso). dove sono insediati quattrocento soldati scelti, mi èpartoper la natura dei luoghi, moltofortee moltoben collocatoperproteggerequellichenaviganoda questo lato. Due ampifi>ssati circondano la muraglia. In altritempi. ilmuroeraditerra. eletorri('ostmitevisopra dilegno:ma ora ilmuloeletorrisonoin mattonicotti, ? lefondamenta sonosolide. Sulmum sonostate istallate dellemacchine: in breve. esso è provvisto di tuttoperché nessun barbaropossa awicinaigli'5iemettere inpericolo di assedio quelli chelo custodiscono. Ma Siccomebird gnamcheilportofossesimmperlenavi. cosicometutta I‘aieache.aldifuoridelporto. è abitatadagliuominirif tiratisidalseni…to eda un certo numero di mercanti, ho credutodidove/ie.apartiredaldoppiofimvatochecircondalamuraglia, tracciare un altrofossato che \"a/lllù alfiume. che rac4 chiudeilporlo con tuttelecasefuoridelmuro"”
Volendotramedelleindicazioni è evidente.giàdallatriplicazione delfossato.ilricorsosemprepiù ampioai cmeridellafortificazione permanente. Quantoallapianta sidevepresumereditiporettangolare.costituitadaun recintomurario.dimattoniodipietra.contorri ] sporgenti ad intervalli regolari.pari ad un tiro utile di arco. Il:"ref cintoè normalmenteinterrottadaquattroporte, costruitecon cura perché rappresentano un punto debole in caso di attacco… Le lor-ri…costituiscono...un elementoimportantedelmurodifensivo. nonfoss'alm7perilruolodisupportochehannoper ipezzidiarr Ilglifl’ia.Leprimetorn d'angoloextei7iefiztzno,laloroapparizione, seconda.].Landen dopoleguerrecontroiMarcomanni, ma questomodellononsigenerali:…aprimadiunafareavanzata del[Ilsecolo… NelBZlYSDImpero...alonnnorio. leaggiunte alladifesasonoaddossateallafl1cciataavremo.Sichiamano ‘tetrarclnche'(dalnomedelsistemapoliticomessoinattoda Diocleziano)lefizrtez:ecomprendentibastionid'angoloquadra/i:difizttoquestotipohafiz/to lasuaapparizioneSiti/Va” niente/nima. durantelagrandecrisidel[I]secolo”“
Fossatimullrpll e lllum anlls!antl I grandifori!roman!
Multipletrenchesand [numin frontof thegreatRoman loris

Sono il Segnodell'Aquila
Porte Quar/a
- Porte Quarta in realtà. a \oler esserepig-noli. quel tipodi fortificazmne.un quadrato oun rettangolocon quattrotoniquadrateai \efliei.&moltopiù antico appanenendoal repertorio greco già desciitto da Filone di Bisanzio ne] il sec.a.(‘ col nomegenerico di Ten‘apir'gm Del resto la denominazione in latino. retrorelriuhe, od anchequot/ribuigum.non siriferisceaiquattro imperatori ma allequattrotorti!Ed e almeno emblematicochequello ste schema inizia acomparireeamoltiplicarsipurenellevillerustiche…che assumoeosi una parvenza di ante signano castello meclievale!‘S Quando allo sporgere sull'esternodi tali torri. ovvero del— l'aggettodalperimetrodicortina.deverelazionarsi alla necessità di intensificare la difesa di fiancheggiamento. e per la fre» quen7a degli assalti paventati e per la sua ottima cfiicaeia.esitosenza dubbiodellepiù avanzateartiglierie elastiche.comparseproprio in quegli stessianni.”
Il progressi\'o potenziarsi eattivarsi della difesadei campi permanenti. ha fattospessoimmaginare alle sue spalleun contestuale incrementarsi delle capacitàoffensivedeibarbari.soprattuttoinambitoossidionale.Inaltreparoledaun certomomentoin poivcr rosimilmenteapartiredallasecondametàdelIsecolo.ibarbari sarebberostaticapacidiespugnareletradizionali fortificazioni legionarieobbligandoperciò iRomaniaeostruirlesemprepiùsolideecomplesse.Appare.invece. di gan lunga più probabile esattamente il contrario! La tecnologia militare… come più in generale quella ci» vile:"ir_rfèrtti. non eunfenomenoindipendente, bensì un riflesso dellebasi culturale e economiche della società, e quella barbarica non avevaaffattosubitoconsiderevolicambia/tieni]…In realtà le testimonianze a noigiuntedimostranocheilprogressodellatecnologiabarbarica di(1538leebbeun ruolo solomarginalenel periadofla il I eil VI secolo…Sequestespiegazioni tattiche'deirivoluzionari L‘arribiarneritiawe/miinele [lire/riletturamilitareromanasonopocoplausibili.esisteinveceunachiarainterpreta:ione\‘ll'alegit‘tl. chepiu} essereapplicataatuttelestrategiedidi/èm 'inprofondità ‘.Lebasiromane/iavnu trasformateinrocche/orti non tanto[JE/"L‘hé[barbariavesseroarmor imparatoademoliredellesemplicimitra (ama chedevono & sere statisemprecapaci"difare), improprioperilfimochenon avm'anosviluppatodellenotevolicapacitàd‘di» sedia…[Pertanto]trovandosidi'/l’ontaadei barbaritroppomaleequipaggiatiperpoterdemoliredelleserie fortificazionidifesedaunnumeroadeguatodisoldati.chedisponevanodiampieris-enealimentari.questerue» altero/‘ti avrebberopotuto aspettare l’arrivodeirinforzi, CMI avrebberopoiofferto le loro variejnn:iarri di appoggio.“”
La sostanziale conferma del ragionamento è fornita proprio dalla fortificazione delle \ille rustiche. ritenuta nonostante la sua ovxia le re77a. sufficiente per respingeregliattacchialmenoperun altrosecolo.
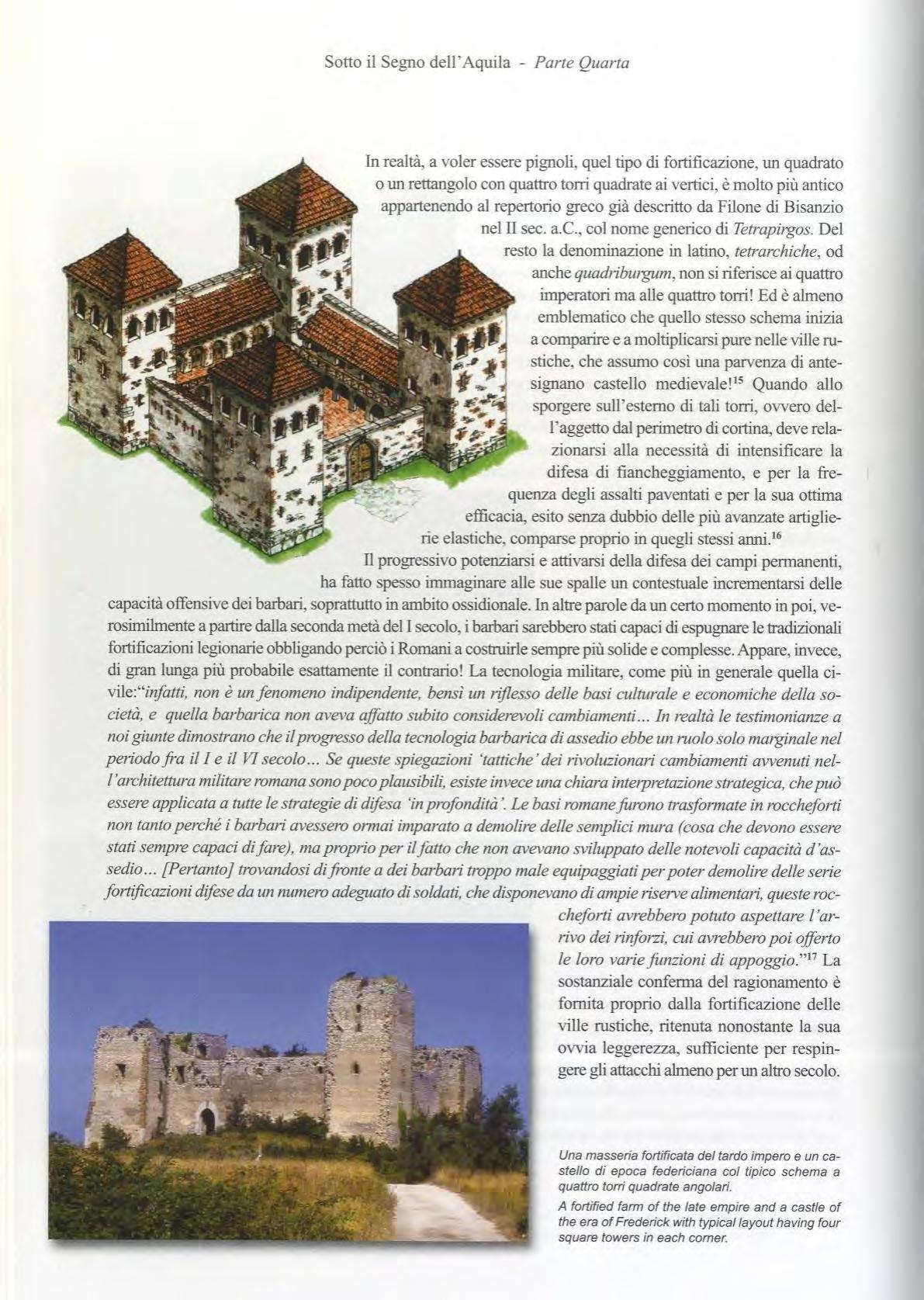
Urramasseriafortificatadeltardoimpera@uncaste/lo diepoca fedencrana coltipico schema a quattrotomquadrìieangolari
A lomfiedfarmorthelateempireand@cast/eof theeraoiFreden’ekwithtypicallayouthavingfour SONS/e towers rn each corner
Sottoil Segnodell’Aquila
COMUNICAZIONI ETELECOMUNICAZIONÎ
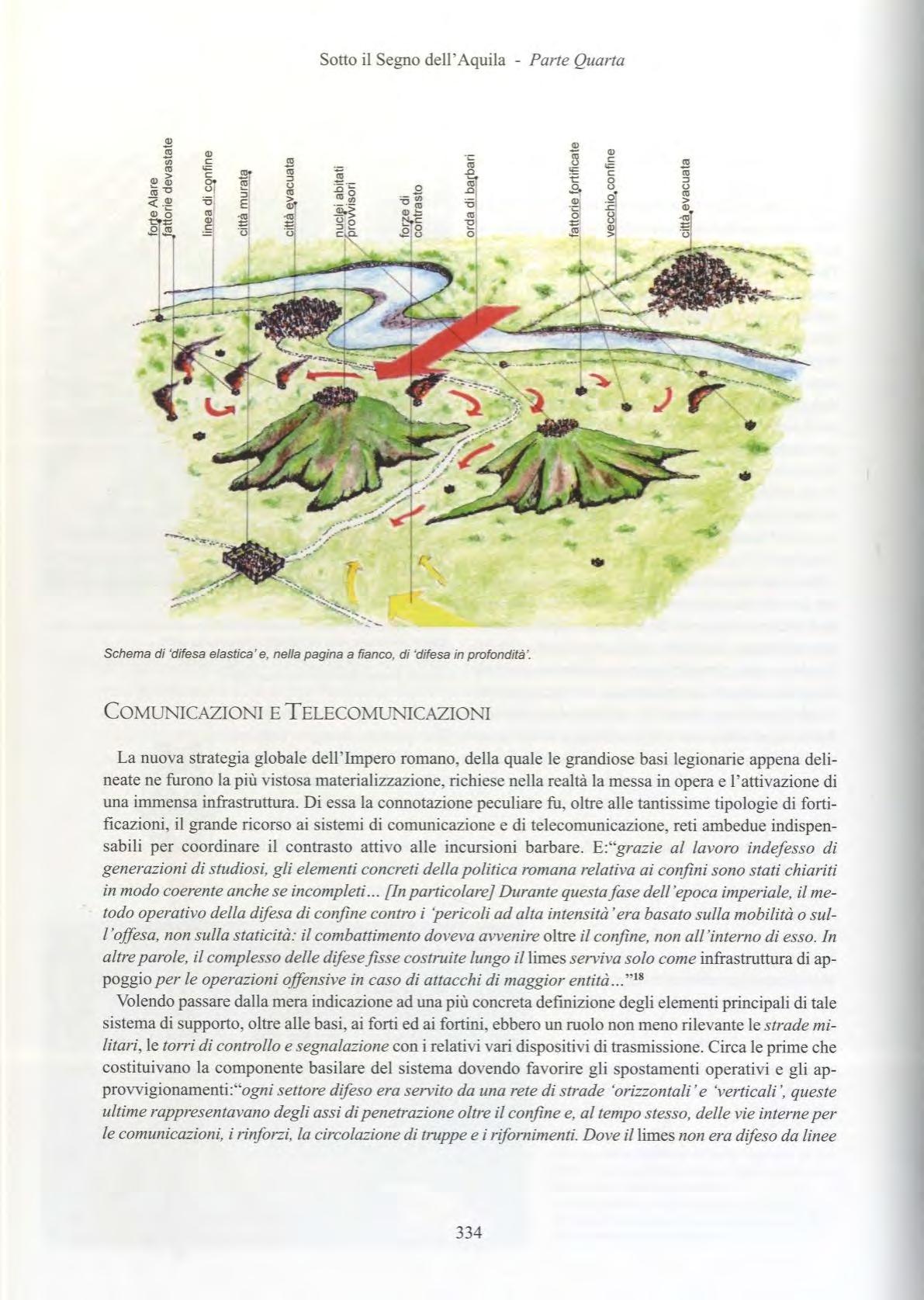
La nuova strategiaglobale dell’Imperoromano, della quale le grandiosebasi legionarie appena clelineatenefuronolapiùvistosa materializzazione,richiesenellarealtà lamessa inoperael’attivazionedi una immensainfrastruttura. Di essalaconnotazionepeculiare fu,oltre alletantissimetipologie di fortificazioni, il grandericorso ai sistemi di comunicazione edi telecomunieazione, reti ambedueindispensabili per coordinare il contrasto attivo alle incursioni barbare. E:“grazie al lavoro inde/esso di generazionidistudiosi,glielementiconcretidellapolitica romana relativa aiconfinisonostatichiariti inmodocoerenteancheseincompleti.[Inparticolare]Durantequestafasedell'epocaimperiale, ilmetodooperativodelladifesadiconfinecontroi pericoliadaltaintensità'embasatosullamobilità osul]'ofi”esa,non sullastaticità:ilcombattimentodovevaavvenireoltreilconfine, non all’internodiesso.In altreparole, ilcomplessodelledifesefissecoxm4itelungoillimesrervivasolocomeinfrastrutturadi appoggioperle operazioniafiensiveincasodiattacchidimaggior entità...""
Volendopassaredallamera indicazioneadunapiù concretadefinizionedeglielementiprincipali ditale sistemadisupporto,oltreallebasi,aifortiedaifortini.ebberoun ruolonon menorilevantelestrademilitari,letorridicontrolloesegnalazioneconirelativivaridispositividitrasmissione.Cimaleprime che costituivano la componente basilare del sistema dovendo favorire gli spostamenti operativi e gli approvvigionarnentiz“ognisettoredifesoeraservitodauna retedistrade ‘orizzontali‘e ‘verticali', queste ultimerappresentavanodegliassidipenetrazioneoltreilconfinee.altempostesso,dellevieinterneper lecomunicazioni, irinforzi, lacircolazioneditruppeeirifizrnimenti'. Doveillimesnon eradifesodalinee
Sottoil Segnodell‘Aquila - ParteQuarta % 2 fa E a .in 5 r.- : 'u 2— g 3 -Si 5 o o : …, *= .!
Schemadi'ditesaelastica'e,nellapaginaafianco,di‘difesainprofondita'.
334
difivnliera (lapiù importantecorreva lungolafiontiera della Siria), [e strade ‘orizzontali‘di confine servivano anche come strade di perlustrazione contro le infiltrazioni e le incursioni di scarsa enr tita. Quando il percorso esterno lungo i confini erapiù breve delle linee di comunicazione interne (come nel caso del limes della Rezia oltre il Danubio), le strade 'orizzontali'difiontieraservivano anche come vie di comunicazione interprovinciali. Basata com ’era sulla rapida concentrazione delle forze mobili, e chiaro che in questoperiodo dell ’impemladifesa di confine dipendeva in modo vitale dalla densità edalla quantità della retestradale. ”"
Appare senza dubbio interessante osservare che, proprio in questo scorcio storico, presero a La Pannonia nel II sec… ac.e,nellapagina afianco, laprovincia di Germanianel I sec. d.C. comparire nuove tipologie di carri destinati al trasporto persone e merci.Nella fattispecie eranousati dalla diligenza militare in trasferimento e dagli approvvigionamenti logistici… In un caso almeno, in un carro destinato ai viaggi notturni con cuccette, per rendere più con— fortevole l’avanzamentovenneroadottatepure delle sospensioni elastiche,destinate a trovare ampia adozione nel futuro.
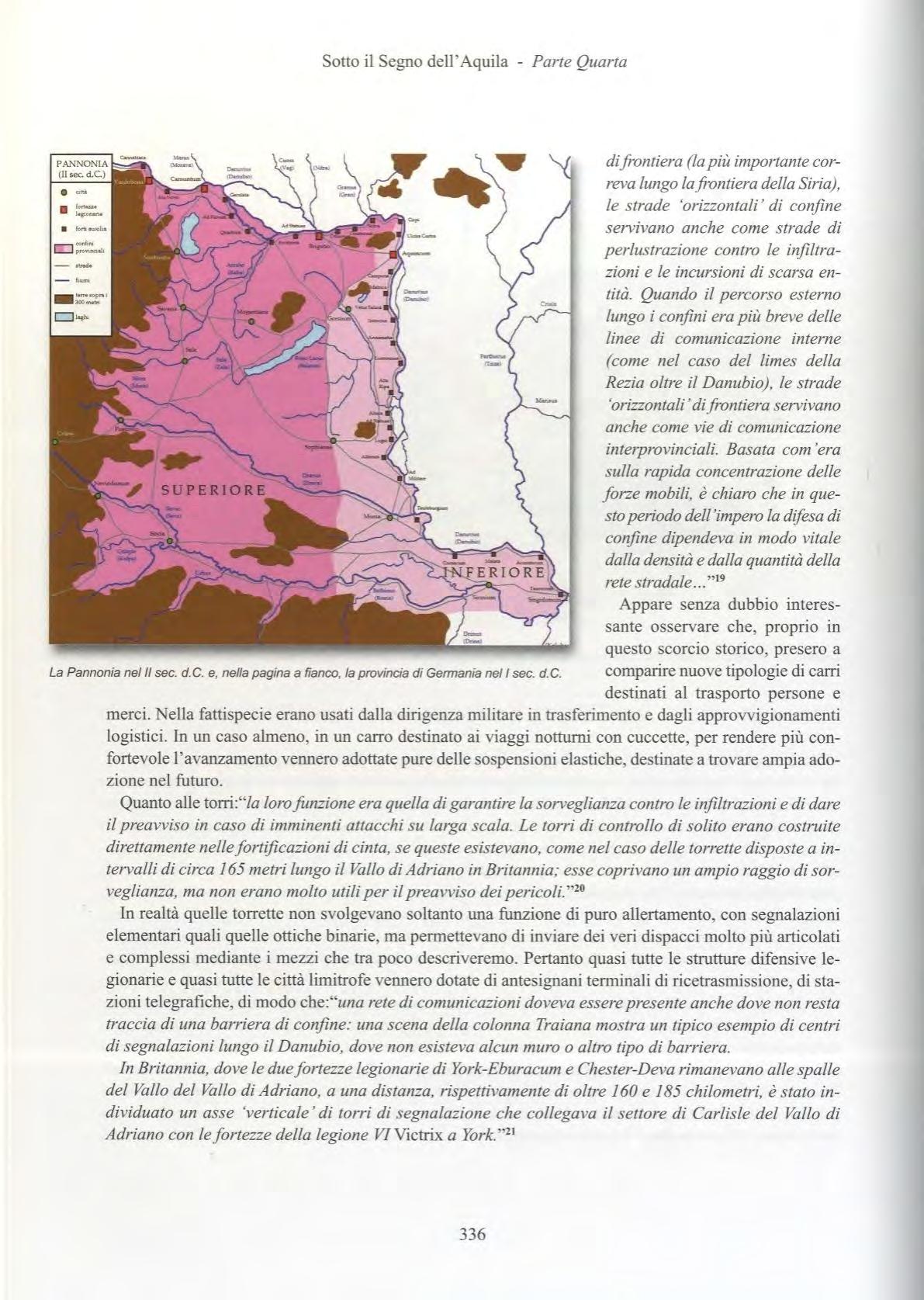
Quanto alle ton-i:“lalorofunzione eraquella digarantire lasorveglianza controle infiltrazioni e di dare ilpreavviso in caso di imminenti attacchi su larga scala. Le torri di controllo di solito erano costruite direttamente nellefortificazioni di cinta,se queste esistevano, come nel caso delle torrettedisposte a intervalli di circa 165metri lunga il VallodiAdriano inBritannia; esse coprivano un ampio raggio di sor» veglianza, ma non erano molto utiliper ilpreawiso deipericoli?“
In realtà quelle torrette non svolgevano soltanto una funzione di puro allenamento,con segnalazioni elementari quali quelle ottiche binarie,mapermettevano di inviare dei veri dispacci molto più articolati e complessi mediante i mezzi che tra poco descriveremo. Pertanto quasi tutte le strutture difensive legionario e quasi tutte lecittà limitrofevennerodotate di antesignani terminali di ricetrasmissione,di stazioni telegrafiche,di modo che:“una rete di comunicazionidoveva esserepresente anche dove non resta traccia di una barriera di confine: unascena della colonna Traianamostra un tipico esempio di centri di segnalazioni lungo il Danubio, dove non esisteva alcun muro o altro tipo di barriera.
In Britannia, dove leduefortaze legionariedi York-Eburacume Chester—Devarimanevanoalle spalle del Vallodel Vallodi Adriano, a una distanza, rispettivamente di oltre 160 e 185 chilometri, e stato in— dividuato un asse 'verticale’di torri di segnalazione che collegava il settore di Carlisle del Vallo di Adriano con lefortezze della legione VIVictrixa York"“
Sotto il Segno dell'Aquila Parte Quarta
336
Carrozzaunnzzaza dag/l am lara/onanm…:an Chenotused bysen/ar military Officers.
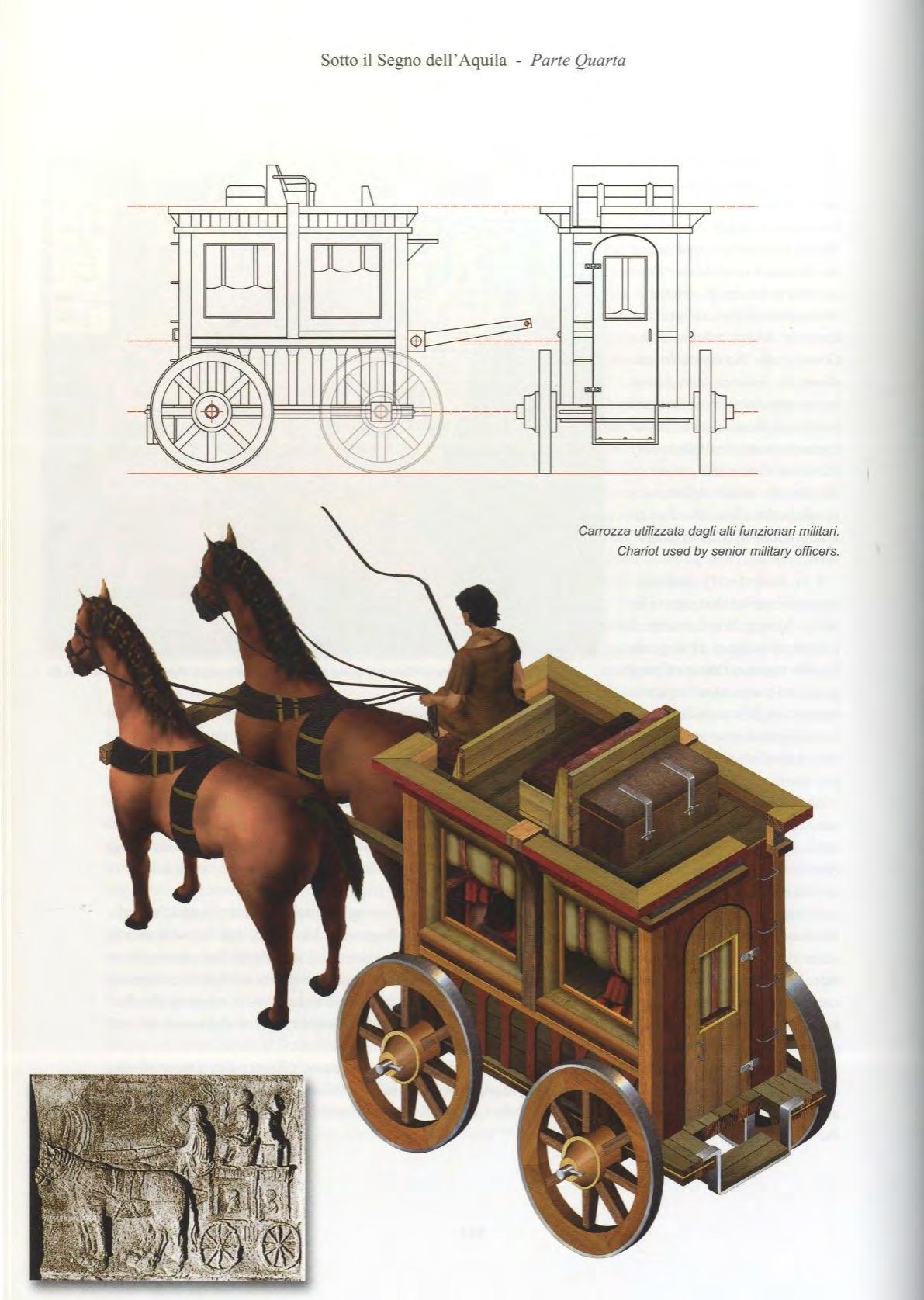
Solto ll Segno dell‘Aquila Par/e Qua/'la
I MEZZI DI TRASMI‘510NE
Augusto si prod ò affinche' lungo le strade militari fossero scaglionate, a brev tervalli,giovani staffette per recapitare con lamassima celeri i dispacci.Allo stesso scopo. per migliorare il servizio postale. introdusse in seguito veloci carri sui quali viaggiavano i corrieri, da unpunto all’altro dell‘impero. Implicito, pertanto. che lo stesso imperatore si dimostrasse fortemente interessato a qualsiasi innovazione, in grado di abbreviare i tempi morti delle comunicazioni a distanza. E' necessario ricordare. in merito a questo delicatissimo e vitale aspetto dell'apparato militare romano, che la saggistica storica è largamente deficitaria. Essendo. infatti.esito di approcci di tipo squisitamente umanistico, ha sistematicamente ignorato la variegata tecnologia vigente e disponibile. Le conclusioni appaiono. perciò, frequentemente assurde ed enigmatiche,pur nella stretta aderenza alle rievocazioni delle fonti. Unicaaltemativ .per delineare un ambito opera— tivo meno convenzionale… e compensare tale carenzafor-nendo approfondimenti tematici sui dispositivi e sui congegni sicuramente esistenti ed impiegati. Tantoper fornire un significativo esempio di quanto appena delineato.allorché il telegrafo Chappe comparve nel corso dellaRi— voluzione Francese, il mondo ne rimase stupito e meravigliato.In pochi anni, tutte le nazioni più evolute si dotarono di siffatto dispositivo. realizzando vaste reti. Loro tramite si poterono scambiare informazioni e notizie a distanze enormi, con celerità fino ad allora inconcepibili,premessa dell’odiema diffusione in tempo reale. Come credere. allora. che una così straordinaria e rivoluzionaria invenzione esistesse già all'epoca dei Romani. senza però suscitare il benché minimo stupore nei contemporanei? Eppure cosi la rievocava incidentalmente Renato Vegezio Flae vro “sulle torri dei castelli o delle città si collocano delle travi.J! 1 a volte ( , si comunica quanto accade." Ricordate come travi,furono in realtà delle leggere aste che risultavano visibili a diversi chilometri di distanzo,firrsefra i 5 ed i 10, in condizioni ideali e su sfondo omogeneo. Con una accorta manovra delle stesse, similiforse a vessilli o [altari di 576 m,piuttosto che a travi, mutandone ! inclina one di ciascuna di 45° per volta, si riusciva afar corri spondere ad ogni loropost 'oneuna lettera dell ‘allizbeto.Possibile percio‘ la trasmissione, con relativa rapidità. di un breve dispaccio.
L’estrema Iaconicità della citazione lascia motivatamente supporre che un telegrafo del generefosse da tempo impiegato, meritando la menzione soltantoperché utilizzato dall 'esercito.’Lo stesso Plinio nella sua monumentale Naturalis Historiae. affermava che: ”inAfiica e in Spagna, le torri diAnnibale...[ver-i] osservatoridi difesafitrono istif miti sotto la spinta del terroreper ipirati, e cosi cisi accorsepiù volte che ifitochi di allarme appia-ati alla sesta ora del giorno erano scorri alla terza ora notturna da chi si trovava nelpunto più arTetrato...“” Essendo lo sfasamento di circa 12 ore la linea si deve supporre di rilevante estensione.Interessante poi osservare che,nella generica de— finizione di turris Hannibalis, non si deve leggere l’inventore del sistema, di scarsa reputazione per la mentalità romana. ma il fruitore o il personaggio che ne aveva deciso
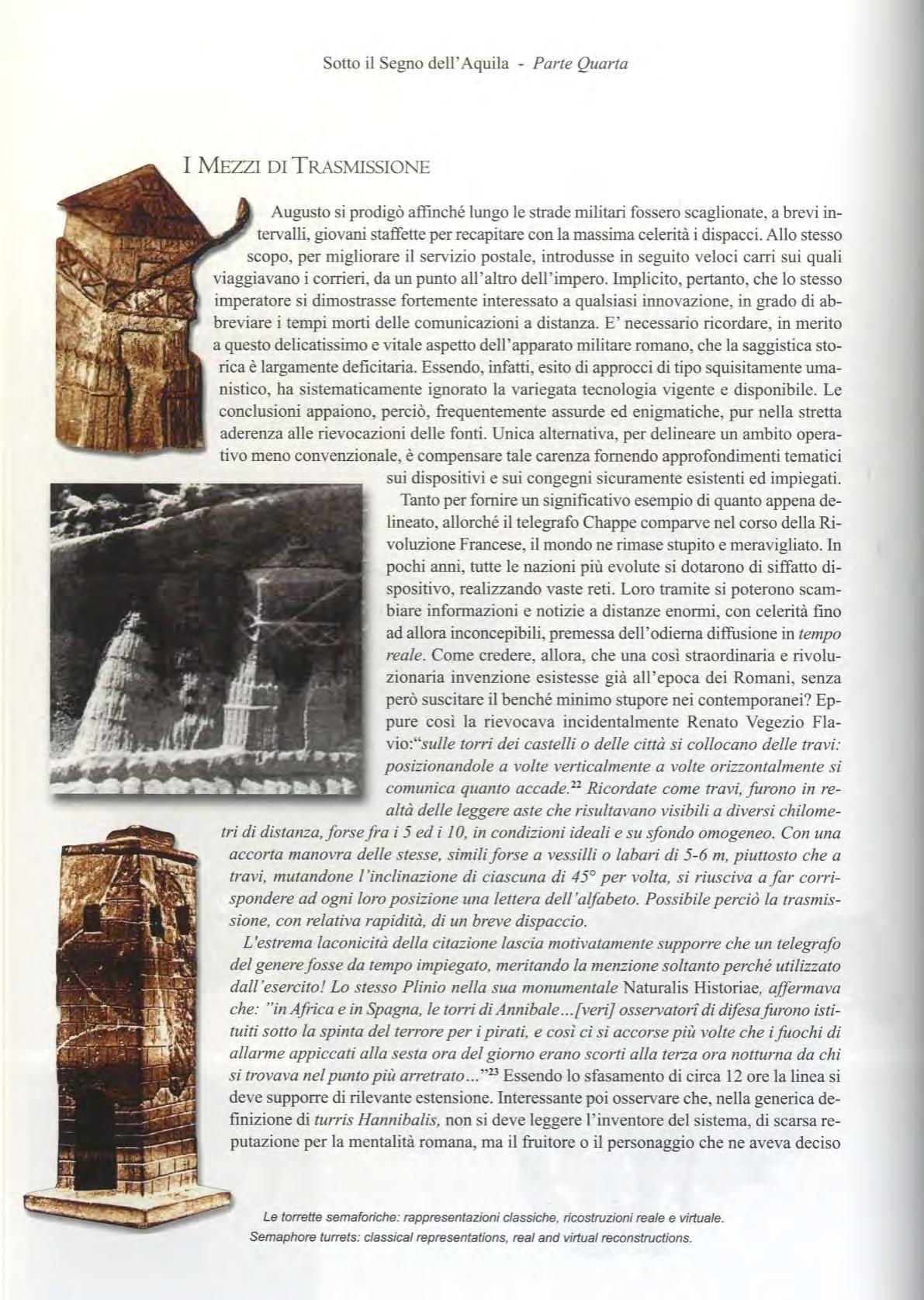
Sotto Il Segno dell‘Aquila — Porte Quarto
a volte ‘E!
Le torrette semaforlche: rappresentazioni classiche, "costruzionileale e writ/ale. Semaphore lunels,‘ Classicalfepresentations, real and virtual reconslmcl/ons.
l’impianto. Stupisce, inoltre,constatare come con mezzi estremamente elementari fossero conseguiti risultati che richiedono oggi strumenti di rilevante complessità. Le navi in crociera, ad esempio, per comunicare alla base ogni giomo la loro situazione liberavano semplicemente due o tre colombi viaggiatori, dei tanti che in ap« posite colombaie campali si erano portate a bordo, Alla velocità media di una sessantina di km/h, il volatile €: ca— pace di percorrere in una giornata anche 1000 km, orientandosi perfettamente in modo da rientrare alla sua abituale colombaia.In pratica ciò significava che tanto la flotta di Miseno quanto quella di Classe, potevano anche dai limiti dei rispettivi ambiti di giurisdizione navale, comunicare nell’arco della stessa giornata quanto accadeva!
Per passare dai segnali di fuoco e fumo ad un vero telegrafo ottico occorserovari secoli,vantandoforse all'origine i vividi lampi di luce proiettati dai lucidi scudi metallici.Dalla mera osservazione alla codificazione dei segnali ilpasso fu relativamente breve, tantopiù che alcuni fisici greci si dedicarono allo studio degli specchi. Tecnicamente un dispositivo capace d’impiegare la riflessione della luce solare per lanciare dei lampi convenzionali, in epoca moderna sarà definito eliografo. Strumento elementare Colombaia portatile: ricosrru- quanto efficace, che ancora trova vasto impiego nelle dotazioni di emergenza. Ma zione virtuale e reperto rinvs- il vero salto di qualità si realizzò quando si adibirono delle apposite torrette alla ri”“‘°a P°'"”°" cezione e al rilancio dei segnali ottici.Ovvio,pertanto, che i tecnici delle legioni,re» PMBME dwemte“ wma, re' sisi adroni del mezzo fossero in d d' ( tt ltr l' nal constmclion and relicfound in P « gra ° ‘ “Sme ere, ° 5 3‘ semp …seg 1 Pompe-ri… binari,anche interi messaggi alfabetici, organizzandoperciò lunghe catene telegrafiche, forse delle rudimentali reti, Plausibile supporre che il criterio informatore di tali linee non differisse da quello schematicamente rafiigurato sulla Colonna Traiana.Dunque,fu subito evidente che uno scudo di metallo lucido poteva senza dubbio trasmettere a grandi distanze e senza alcuna difficoltà, ma era del tutto inutile se… il sole. Qualche problema, per la verità, lo determinava anche il suo angolo rispetto al sole,per cui la trasmissione e l‘even» tualerisposta potevano avvenire soltanto secondo alcune direttrici ed in alcune ore della giornata Senza contare l'irrisoltoproblema della estrema modestia della quantità di informazione così trasferibile. Dopo alquanti tentativi si ottennero dei veri e propri eliografi anche notturni, simili ai fari e, non di rado, si adibirorio gli stessi fari ad eliogr'afi nonumi.Il sistema attinse cosi una rilevante funzionalità, ma nonper questo riusci a trasmettere qualcosa inpiù dei soliti semplici segnali binari.Fomì però il presupposto per rendere finalmente utile il trasmettitore a dispaccio fisso, o telegrafo ad acqua, meglio definibile telescrittore sincrono, inventato già da alcuni secoli dai soliti tecnicigreci, nella fattispecie Enea il Tattico."
:) in zo un In ’ " l’ " era molto ," , senza alcuna distinwvm- zione fia quello trasmittente e ricevente per cui lo stesso assolveva, a
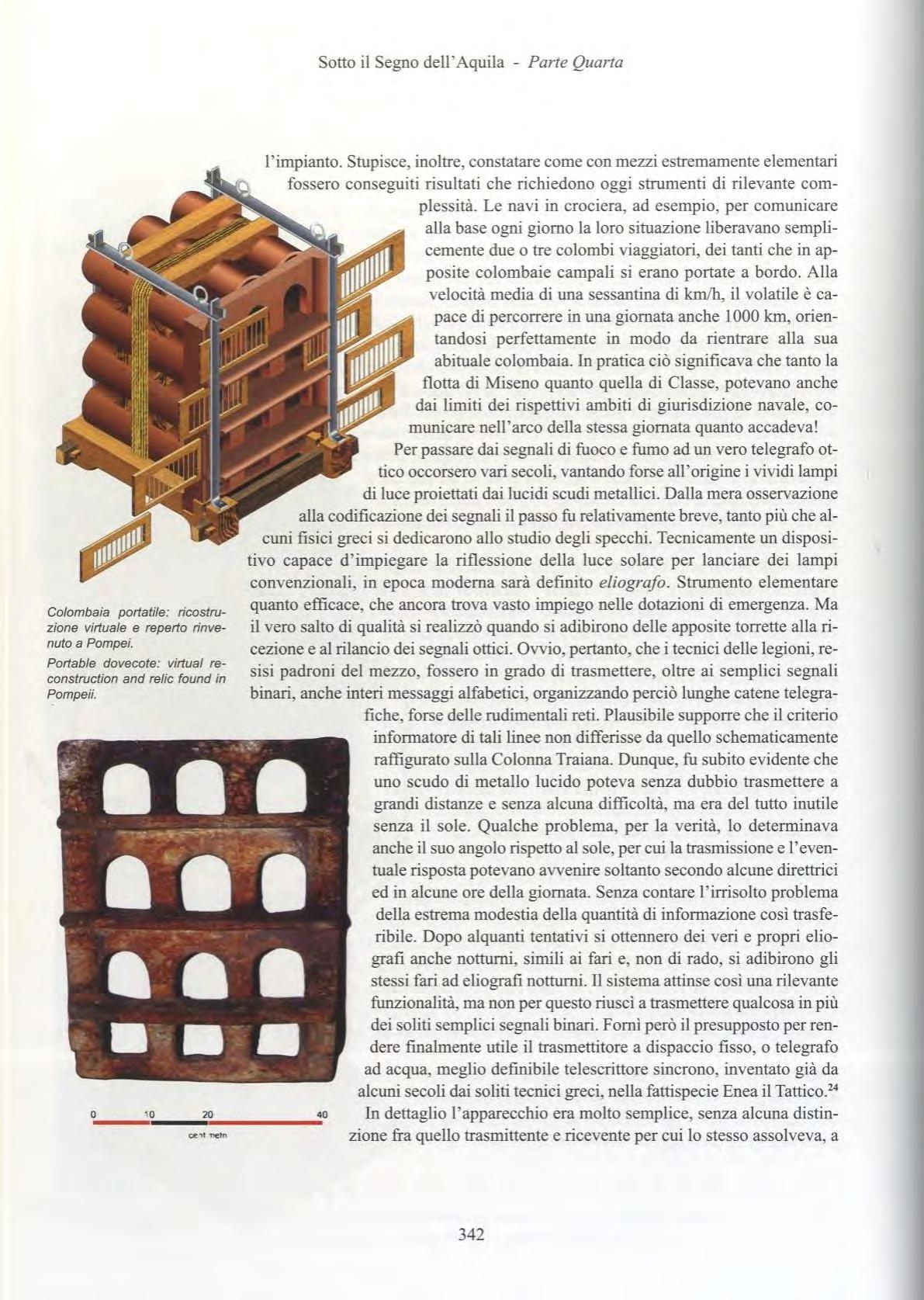
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte Quarta
342
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parre Quarta
fasi alterne, ambedue le finzioni. Volendopoteva anche servire come ripetitore intermedio consentendo trasmissioni di gran lunga maggiori del raggio dell'eliografo o dei fari. Consisteva in un contenitore cilindrico, conalla base unrubinetto e.all‘interno.ungalleggiante graduato: ad ogni sua tacca,contraddistintada unpreciso numero,corrispondevaun diverso messaggioprestabilito. Cosìper esempio,una sequenza di solo quattrodispacci:
] NULLA QUESTIO
11 AUXILIA NAVAL1A
III Mn.rras DEFICI'UNT
IV NON HABEMUS PANEM
Costruiti meticolosamente identici,per volume e per rubinetto, erano collocati unoper ogni stazione riempiti d’acquafino al livellomassimo,in smostm’bne Vmuale_ attesa di utilizzo. Per iniziare la trasmissione si lanciava al ricevente un Synchronous ,elewmen ”ficus ”mslm. lampo di luce,mediante uno specchio metallico o l’eclisse di una potente tionsand virtual reconstruction. emma.Ottenuta la conferma conun secondo identico lampo di risposta, conunterzo si ordinavalacontemporaneaapertura dei rubinetti. L’acqua iniziava così a definire dai contenitori, provocando in entrambi una sincrona discesa del galleggiante graduato, tacca dopo tacca.Allorquando nel trasmittente latacca numerata, corrispondente al dispaccio prescelto, giungeva a sfiorare il bordo superiore del cilindro,un ultimo lampo ordinava la chiusura dei rubinetti, consentendo di leggere sul ricevente il medesimo numero del trasmittente,ovvero il messaggio… Volendone scandire la sequenza operativa, supponiamo un contenitore di 30 cm di diametro per circa un metro di altezza, suddiviso in 10 tacche, unaogni 10 cm. Se munito di un rubinetto da 10 litri al secondo, l’avvicendamento di ogni tacca richiede circa 80 secondi, che portano a quasi 12 minuti il tempo necessarioper trasmettere l’ultima Sicché,per trasmettere il messaggio 111- MiLiri=.s DEFIClU'NT del nostro mbulato, ovvero che mancano i soldati, trascorrono tra il secondo e il terzo lampo soltanto 4 minuti!
Da un punto di vista strettamente tecnico si trattava di un an» sistema a simile per “ ad unodiernotelefax.Il dispaccio, infatti,non veniva trasmesso tra» mite una variazione analogica, quale che fosse, ma ricostruito per contemporaneità d’interventi tra la stazione trasmittente e ricevente. Dal che erano i "di apertura e L' relativi ad unpreciso apparecchio, qualora intercettati,non si ricavava alcun messaggio.L‘apparecchio appena de» lineato si dimostrò aflidabile e semplice da costruire a da impiegare… E’ probabile che con leggere modifiche del galleggiante, magari trasformato in un cilindro graduato appena più piccolo del contenitore, una sorta di gigantesca siringa per usomedico,si sia ottenutounapparecchio capace di funzionare anche su superfici instabili, quali le navi. Circa la sua portata massima, dipendeva, come accennato, soltanto
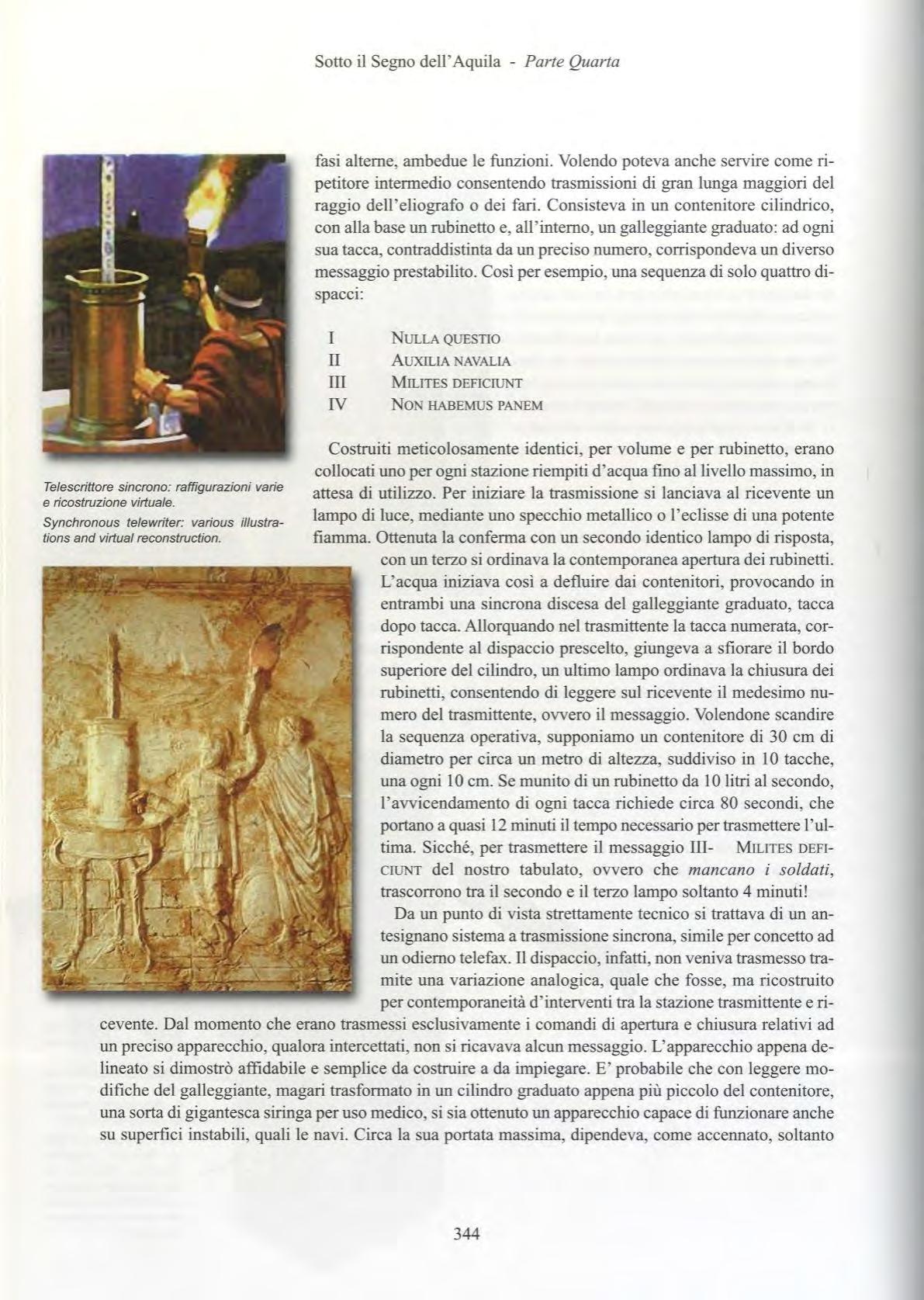
344
Telescrittale sincrona: raffigurazioni varie
dall'eliograt'o. oWero dalla visibilità del suo segnale luminoso. Sc questo. ad esempio.fosse stato lanciato dal faro di Alessandria il raggio di trasmissione avrebbe potuto raggiungere i 60 km, una quarantina per quello di Miseno. E' presumibile. però. che abitualmente non si superassero tratte di una trentinadi km. ricorrendo per le maggiori a ripetitori.
LE ARTIGLIERIE PALINTONE IMPERIALI'. RISCONTRITECNICI
Osservando la Colonna Traiana è facile scorgere in molte scene dei legionari intenti a brandeggiare deipiccoli pezzi d’artiglieria.del tuttodiversi sia dalle rarissime rafiigurazioni pervenuteci sia dalle pedanti descrizioni dei tecnici dell'antichità, In altre scene ancora compaiono altri pezzi, sostanzialmente similari,sebbene collocati su appositi cani adue ruote.Chepoi si tratti di artiglierie lodimostrapiù che laforma, l'ambito e l‘atteggiamento dei loro serventi intenti aprendere la mira: ma dal punto di vista tecnicoquei pezzi, vuoi dapiazza vuoi ippotrainati.non somigliano affatto a quelli inprecedenza descritti, in base ai ritrovamenti archeologici. E. dettaglio estremamente significativo, dei reperti di recente rinvenuti ed ascrivibili con certezza proprio ad artiglierie elastiche non sono anch‘essi compatibili inalcun modo con le suddette di epocarepubblicana. Ovvio,pertanto. concludere che unanuovagenerazione di artiglierie,nel frattempo. fosse stata messa apunto efosse stata data in dotazione dapprima ai reparti d’elite’.destinati alle campagne daciche ed alle operazioni speciali, epoi via via a tutte le fortezze legionarie prime fra tutte le più avanzate. Logico allora, cheproprio setacciando fra le macerie di una di esse. ubicata ad Hana, nei pressi del— l’odiema Al Hadr inIrak. siano affiorati i resti di una balista. la maggiore di tale rivoluzionaria concezione. Altri reperti relativi a più piccole catapulte di identica conce— zione, sono stati rinvenuti a Orsova e lungo il Danubio: tutti confermano l'adozione,tra il finire del I secolo e l’iniziodel Il. di artiglierie elastiche di diverso criterio propulsivo, nonché l‘esatta interpretazionedi unprezioso codice alto medievale. inerente alla loro costruzione. Volendosintetiz— zare la vicenda va ricordato che fino ad allora. l’unica maniera per potenziare leprestazioni delle artiglicrie elastiche consisteva nel— l’incrementare il diametro delle loro matasse nervine,unpo' come si farà con il calibrodelle artiglierie apolvere. Ma l’analogiafinisce qui poiché. a differenza di un cannone, una grande balistapoteva scagliare anche piccole palle. presumibilmente a distanze maggiori.
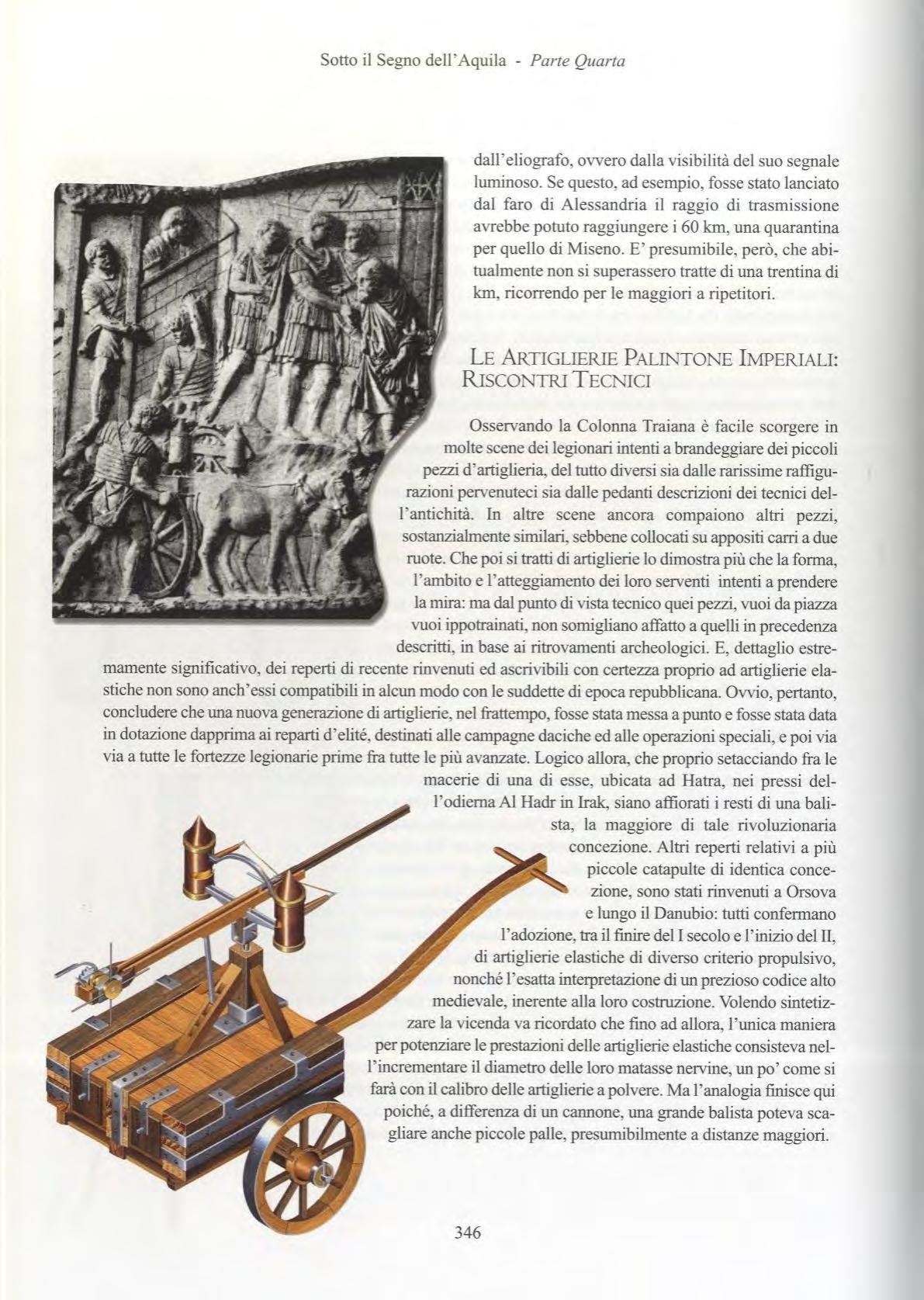
Sotto il Segno dell‘Aquila -
Parte Quartu
346
Di questa seconda potenzialità, tuttavia, lefonti nonfanno menzione forse perché ovvia o,forse paradossalmente,per il contrario.In altreparole una balista di un determinato modulo quando scagliava palle piccole non attingeva solo per questo bersagli più lontani.Essendo la velocità iniziale funzione della velocità di rotazione dei bracci, e non mutando questa per modesti scarti del peso del proietto. per variame la gittata occorreva intervenire proprio sull’elasticità delle matasse. si'ruttandola meglio. Di certo le artiglierie di epoca imperiale ostentavano, stando a molte fonti coeve, prestazioni alquanto superiori a quelle delle più antiche. Tantoper esemplificare,sappiamo daAmmiano Marcellino che la velocità iniziale dei dardi degli scorpioni doveva essere talmente rilevante da produrre scintille per lo sfregamento sul canale di lancio.Anche ammettendo lungo lo stesso un rivestimentometallico,che in effetti in alcuni reperti archeologici sembrapresente, unatalemanifestazionepoteva scaturire soltanto da velocità iniziali dell’ordine di un centinaio di metri al secondo,mentre le prove pratiche non hanno mai superato la ses— sanfina, come del resto i dati ricavati dai calcoli.
Similmente,analizzando il brano di Flavio Giuseppe,inerente al martellamento delle mura di Gerusalemme con le grosse baliste della X Legio, la velocità media delle loro palle si attesta intorno ai 70-80 m/sec, con un valore iniziale ovviamente superiore e non molto lontano dal precedente.25 Difi'icile supporre tali discordanze un semplice errore di calcolo o unaesagerazione dello storico: molto più sensato, invece,ravvisare in esse la testimonianza di propulsori radicahnente innovativi. In breve per incrementare la gittata sarebbe occorsa una spinta maggiore o più prolungata del proietto, come avviene nella canna del fucile rispetto a quella dellapistola. Il primo caso avrebbe richiesto l’allungamento dei bracci ma, come gli antichi sapevano ed i moderni facilmente avevano calcolato, questi non dovevano essere troppo corti e non potevano essere troppo lunghi.Discorso radicalmente diverso per Pain-a modalità che stranamente venne ignorata. Infatti quel ragionamento,apparentemente stringente,nonteneva conto che esistevano due modi alternativi per scagliare un oggetto. Come ben sanno quanti giocano al tennis, il colpo può essere impartito di dritto o di mvescio, con conseguenze dinamiche molto diverse! In modo analogo i bracci delle artiglierie elastiche potevano ruotare in due maniere opposte rispetto al telaio: verso l‘estemo, eso-rotanti, o verso l‘intemo endo-rotanti. Il che dava origine ad accelerazioni motrici ben diverse essendo prodotte da rotazioni rispettivamente di circa 60° e di oltre 160°.A riposo la corda arciera che nel primo caso stava sempre dietro al telaio,nel secondo stava sempre dinanzi,portandosi dietro quando posta in tensione…Il che faceva il sistema corda-bracci, da una configrrazione a riposo a M ad unaaV,convertice verso il tiratore a caricamento ultimato.La maggiore tensione,derivante dai quasi 100° di ulteriore torsione a cui venivano sottoposte le matasse, consentiva di immagazzinare una quantità di energiamolto superiore. Inoltre laprolungata corsadi ritornodella corda,quasi il doppio della configurazione più antica,somministrava al proietto la spinta più a lungo.La sommatoria dei due incrementi determinava gittate di gran lunga maggiori,forse eccedenti il 100%.Supponendo,per semplicità di approccio, pressoché lineare laresa energetica delle matasse nelle due configurazioni,che in realtà variava inmaniera esponenziale afavore della seconda, aparità di diametro le gittate sarebberopassate dai quasi 200 agli oltre 400 m, Dal punto di vistaformale esattamente come i comi dell‘arco composito che.liberati dalla corda.si piegavano in avanti, cioè alla rovescia, anche i bracci dei propulsori del secondo tipo infase di riposo stavano anteriom-rente al telaio. A ragione della configurazione inversa gli antichi definirono l’arco compositopalintone, cioè con la corda inversa,dapalin=inversa e tonaflorda,ed eutitone, cioè con cordagiusta, da eu=giusto, il tradizionale.Verosimilesupporre che lamedesima distinzione fosse adottatapure per i gruppi motopropulsori a secondo che i loro bracci fossero eso-rotanti,eutitani o endo-rotanti,palr'ntoni. Nel secondo caso il telaio avrebbe dovuto avere dimensioni trasversali non minori al doppio della lunghezza del braccio, quindi vistosamente più ampie di quelle dei telai tradizionali di
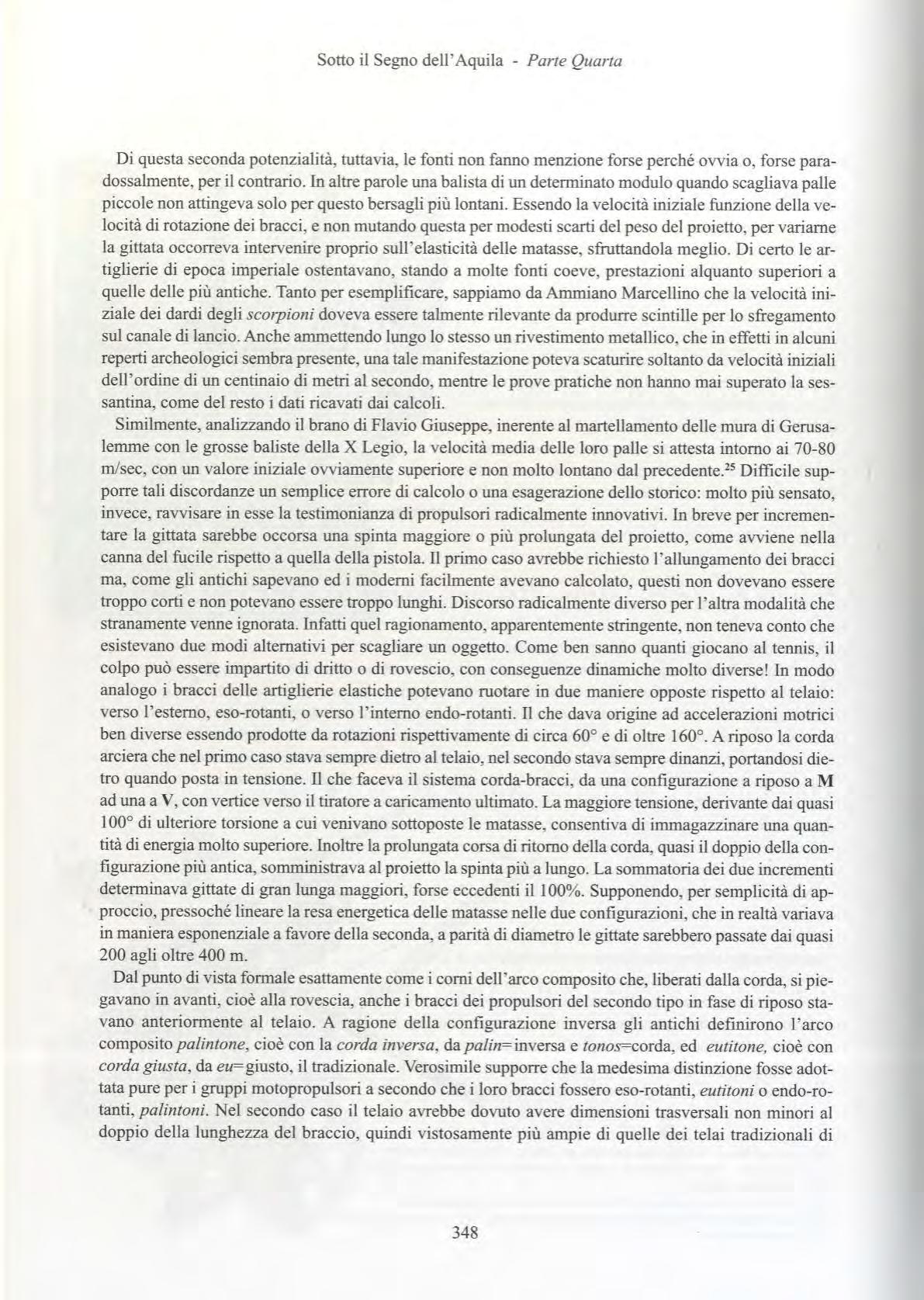
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte
Quarta
348
uguale calibro. Essendo assodato che ciascun braccio fosse lungo non più di sei moduli. la condizione di con» gruità per una macchina palintona implicava un inte— rasse tra le matasse appena superiore a 12 moduli. Per conseguenza fir accresciuto notevolmente lo spessore delle traverse orizzontali del telaio sia perché molto più lunghe sia perche' prive di montanti interni.
Forse fu proprio quest‘esigenza a suggerire di adotmre un telaio interamente metallico per i pezzi più piccoli. In esso le suddette traverse divennero delle snelle barre di accoppiamento fatte con quadre… di ferro fucinato munite di apposite forcelle, per l’innesto con i supporti delle matasse. Ne derivarono anni meno pe— santi ed ingombranti.agevoli da trasportare e più spedite da impiegare e da riparare, nonché più precise grazie alla migliore punteria consentita dalla sagoma arcuata della barra superiore. Con tutte le dovute riserve del caso, è significativo osservare che proprio quest’ultima componente.peraltro ben evidente nei bassorilievi della Colonna Traiana,ebbe la connotazione di un arco inseritofra due travi, soluzione architettonica squisitamente romana ideale anche per lapunteria di una catapulta.
LA BALISTA DI HATRA
Di certo l’adozione della configurazionepalintomz sulle grandi baliste.deve collocarsi all‘avvento dell’Impero,se non prima addirittura,essendonecessaria la loro enorme potenza per i tiri di interdizione difensiva che le nuove basi legionarie richiedevano. Difficile stabilire se tali armamenti furono dettati da queste esigenze opiuttosto non le consentirono! Di certo lamole maggiore di tali pezzi non era un limite dal momento che operavano in assetto statico su spalti. Per circostanze estremamente propizie, quanto rare, ci sono pervenuti i resti di un simile grosso calibro conservatosi al di sotto delle macerie delle for— tificazioni di Hatra, una delle basi legionarie più ad oriente nel deserto ir'akeno.2fi In dettaglio comprenv dono tutte le piastre di blindatura di bronzo. i mediali con le relative piste di rotazionc e bloccaggio sempre in bronzo, cinquepulegge ancora di bronzo ed in più un arpione di ferro, verosimilmente quello di scatto. Gli enormi modioli ostentano un diametro intento di circa 162 mm ed estemo di circa280 mm:
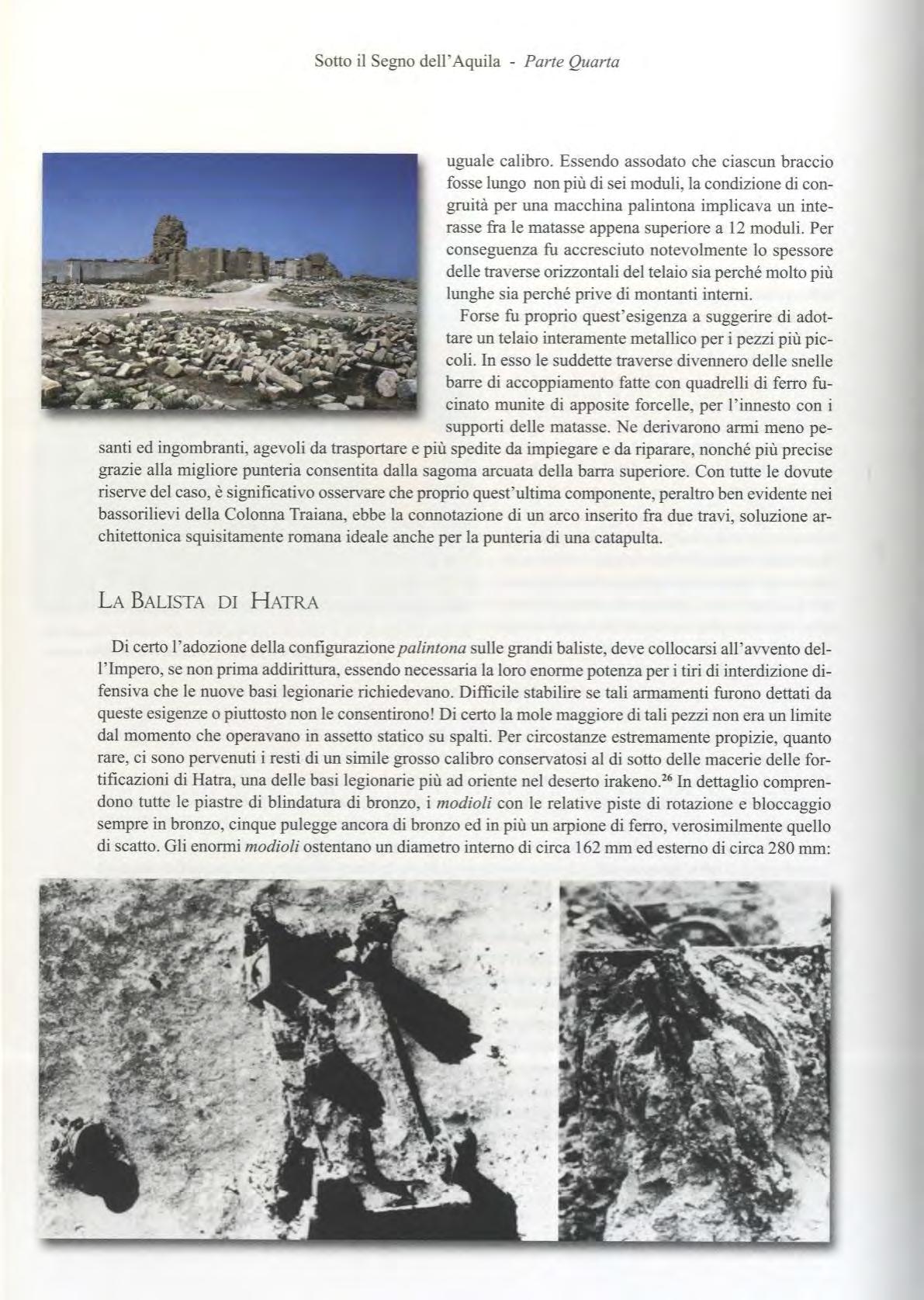
Sotto il Segno
dell‘Aquila - Parre Quarta
ruotavano su piastre di rilevante spessore. collocate all'estremità di un telaio lungo mm 2400, alto mm 650 e largo altrettanto. Ben evidente,da queste sole indicazioni metriche. il basso rapporto fra diametro ed altezza delle matasse, sinonimo di unesasperato sfruttamento della torsione,tantoda richiedere unparanco a cinque rinvii per il caricamento. La condizione di congruitàper la configurazionepalintona, che vuole l‘interasse maggiore della somma dei bracci, è soddisfatta poiché ridotta in formule risulta: 2x6x162=1944 mm totale inferiore ai 2000 mm dello stesso.
LE CATAPULTA DI ERONE
Per le artiglierie maneschepal.intone la conferma della loro esistenza,oltre ai rilievi della Colonna Tra- Î iana,si coglie in una singolare rielaborazione medievale di unpiù antico testo,concernente unapiccola ca— tapulta manesca, ricordata appunto come cheiroballistra da Erone, in latino letteralmente manuballista. Quattrocopie manoscritte sparse in altrettanti archivi europei, testo in greco e grafici, colorati e siglati, in assonometria .',5i' esplosa, tra le prime della storia! L‘eccezionale somiglianza
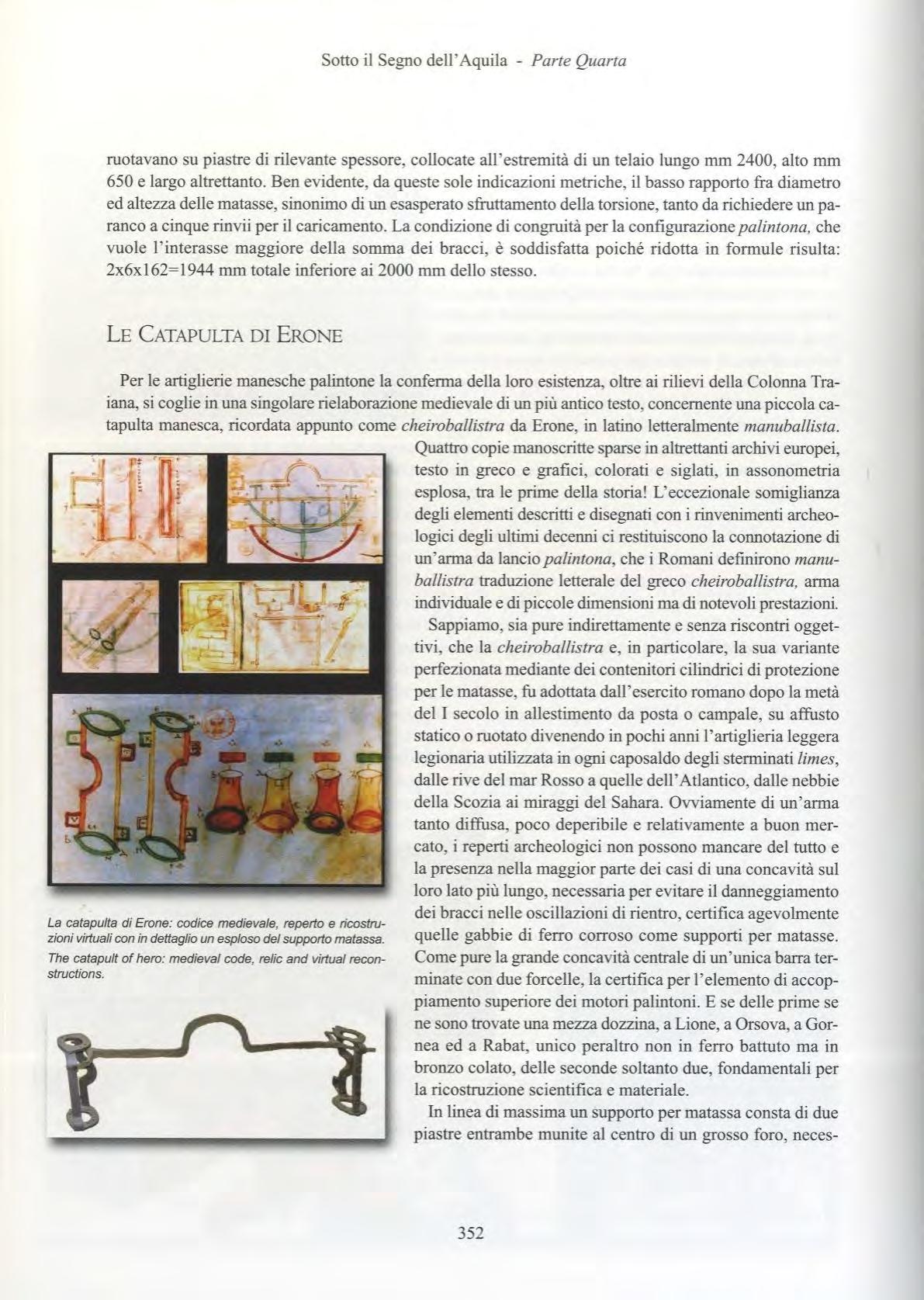
'
degli elementi descritti e disegnati con i rinvenimenti archeo-
% - logici degli ultimi decenni ci restituiscono laconnotazione di . ° un'arma da lanciopalintomz. che i Romani definirono manuballistm traduzione letterale del greco cheimballirtru, arma individualee dipiccole dimensioni ma di notevoli prestazioni.
Sappiamo, sia pure indirettamente e senza riscontri ogget» tivi. che la cheirobflllistra e. in particolare, la sua variante perfezionata mediante dei contenitori cilindrici di protezione per le matasse,fu adottata dall’esercito romano dopo la metà del I secolo in allestimento da posta o campale, su affusto statico o ruotato divenendo inpochi anni l’artiglieria leggera legionaria utilizzatainogni caposaldo degli sterminati limes, dalle rive del mar Rosso a quelle dell’Atlantico, dalle nebbie della Scozia ai miraggi del Sahara. Ovviamente di un’arma tanto diffirsa, poco deperibile e relativamente a buon mercato, i reperti archeologici non possono mancare del tutto e lapresenza nella maggior parte dei casi di una concavità sul loro latopiù lungo,necessariaper evitare il danneggiamento La catapulta diE/one: codice medievale, repetto e dei bracci nelle oscillazioni di rientro.certifica agevolmente z,bnfyfy…ajjwn ,,, deneg,;° ,… e…de,suppono …_ quelle gabbie di ferro corrose come supportr per matasse. The catspult ofhelu:medieval mde, relic and virtual …
Comepure lagrande concavità centrale di un’unicabarra ters"…"°”s° minate condue forcelle, lacertificaper l‘elemento di accop— piamento superiore dei motori palintoni. Ese delle prime se ne sono trovateuna mezza dozzina. a Lione. a Orsova,a Gornea ed a Rabat. unico peraltro non in ferro battuto ma in bronzo colato, delle seconde soltanto due,fondamentali per la ricostruzione scientifica e materiale.
In linea di massima un supporto per matassa consta di due piastre ' munite al centro di un grosso foro, neces-
Sotto il Segno dell‘Aquila — Parte
Quarta
e
‘.E‘i!",
=
352
sario per i] loro ancoraggio e precaricamento. Due regoli verticali. dei quali uno con la ricordata concavità centrale. Ie mantengono parallele e coassiali e sono dotati di due pa» righe di staffe simmetriche di forma rettangolare.inbasso la maggiore inalto la minore.
Nella inferiore si insenva lagrossa barra solidale al fusto ed in quella superiore labarra arenata, destinata ad irrigidire l‘insieme sopprimendone le oscillazioni… Sensato presumere che i tecnici romani volendo incrementare le prestazioni delle loro artiglierie leggere riuscissero ad adottare. dopo la metà del I secolo, anche sui pezzi minori la configurazionepalinrana. Forse si avvalsero della consulenza di Erone, forse ne copiarono i prototipi. Le piccole catapulte divennero così delle piccole baliste,ovvero delle baliste a mano, appunto delle manuballirte, denominazione che in breve diverrà soltanto bal/[rua e quindi balestra: ma a quel punto il Medioevo e gia iniziato.
Per giustificare tante trasformazioni e soprattutto il notevole incremento di peso da esse derivante. negativo per un’arma manesca, è verosimile reputate impressionanti le loro prestazioni. Credibili pertanto le gittate sbalorditive ricordate dai coevi; credibile il tiro al di là del Reno per coprime gli attraversamenti delle legioni; credibili pure gli sfondamenti delle corazze, da parte a parte. E soprattutto credibili enormi risparmi sulle fortificazioni chepotevano erigersi con un minor numero di toni,essendo possibile un interasse fra le stesse molto più ampio.
ARTIGLIERIA NAVALE
Se dal punto di vista cronologico non si scorge nessuna divaricazione fia l‘impiego in terra e quello in mare delle artiglierie elastiche,non cosi può dirsi per le rispettive connotazioni peculiari. Non esistendo sul mare le gravi "mitazioni imposte dal peso e dall’ingombro, le mac— chine da lancio navali furono sempre più grandi di quelle campali e forse di quelle da piazza. peculiarità non venuta meno neppure con le artiglierie a polvere. Ciò non esaurisce affatto le diversitàpoiche', anche in epocaromana,l‘impiego in ambitomarittimoper risultare affidabile e con prestazioni costanti, implicava la soluzione di alcune gravissime deficienze, non altrettanto penalizzanti a terra. In particolare le matasse elastiche,essendo formate con fibre fortemente igroscopiche al contatto con l’acquao con l‘umidità si allungavano,privando perciò i gruppi motori della indispensabile tensione. Da tale deficienza tecnica una fioritura di proposte tese alla sua eliminazione: di esse alcune si dimostrarono ridicole. altre velleitarie, altre insufficienti e pochissime risolventi, L’insieme costituisce comunque la testimonianza del problema e del suo superamento. Il tutto ha lasciato, si fa per dire, tracce archeologiche, riferimenti letterari e ulteriori derivazioni tecniche. La ricerca, quindi, di un motore elastico insensibile all’acqua ed al contempodipari potenza di quelloa torsione,divenne verosimilmente la sfida della tecnologia militare dell’età imperiale,portando a riscoprire e magari aperfezionare congegni ed intuizioni che già nel passato avevano dimostrato, se non altro, lapotenzialità di funzionare. Non occorreva, ad esempio, una grande fantasia a quanti avevano rapporto con le pompe a doppio effetto ricordare la lorofortissima resistenza elasticaquando se ne ostruiva lavalvola di scarico. Applicando quella semplice constamzione Ctesibioelaborò una balista ad aria compressa,che ebbe verosimilmente un discreto impiego navale.
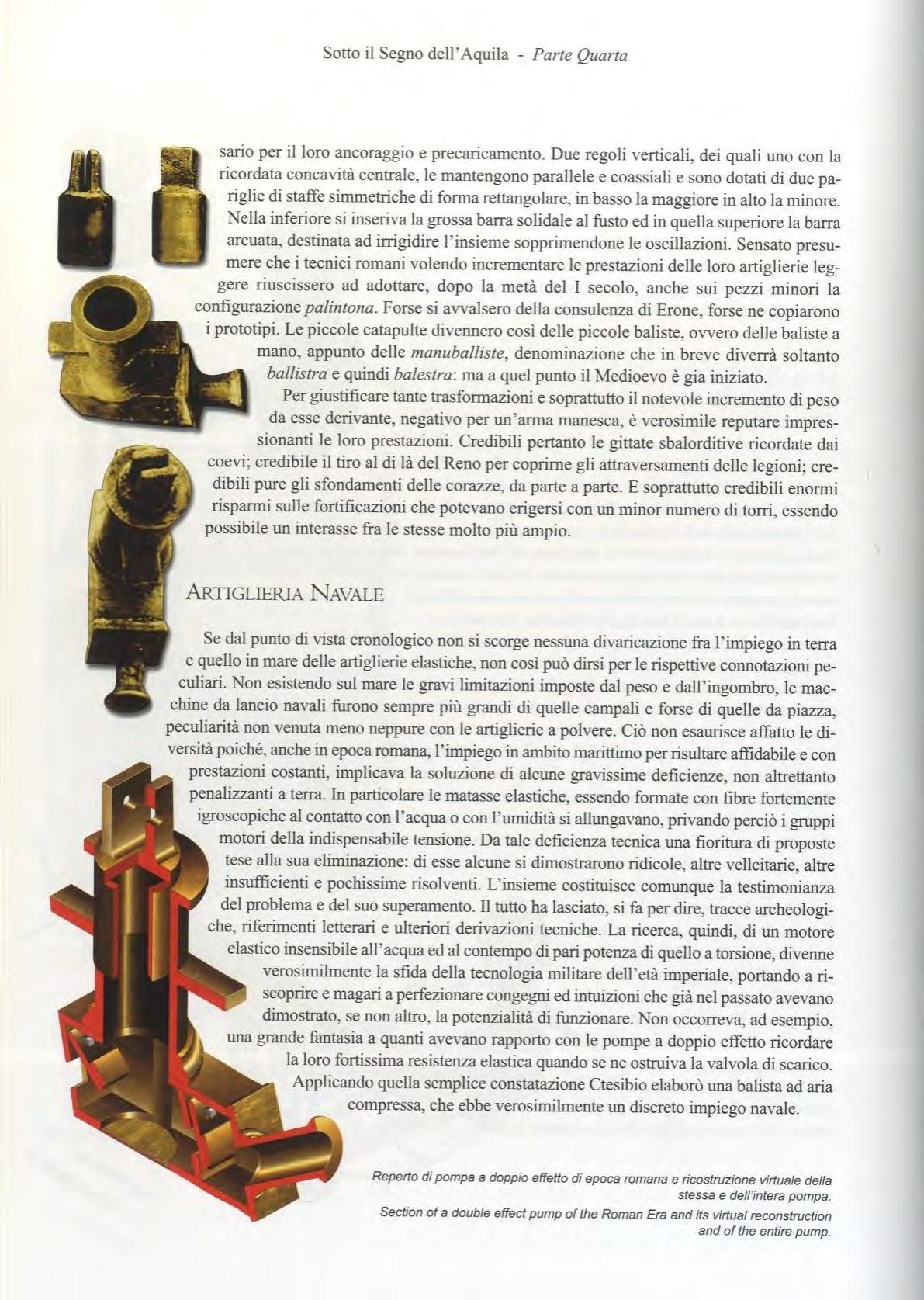
Sotto il Segno dell‘Aquila — Porte Quarta
Repetto dipompa adoppioeffettodi epoca romana e ricostruzione Virtua/edella stessa edell'interapompa. Sectionofa double eflectpump oftheRoman Era and itsvirtual reconstrucl/on and of ine ent/'lepump.
La sua arma, però, non era costruita per espellere con un vio— lento getto d’aria un proietto, come le attuali, ma piuttosto era un congegno che utilizzava la
n , dell’ariaper movi-
mentare i suoi organi propulsori, Per essere più precisi la sua connotazione non avrebbe dovuto discostarsi dall’architettura delle coeve baliste i cui due bracci erano fatti ruotare dalle matasse elastiche.La vera,quanto rivoluzionaria, differenzasarebbe consistita nel sostituire l’elasticità derivante dalla deformazione per torsione di lunghe fibre organiche con quella erogata dalla aria compressa.
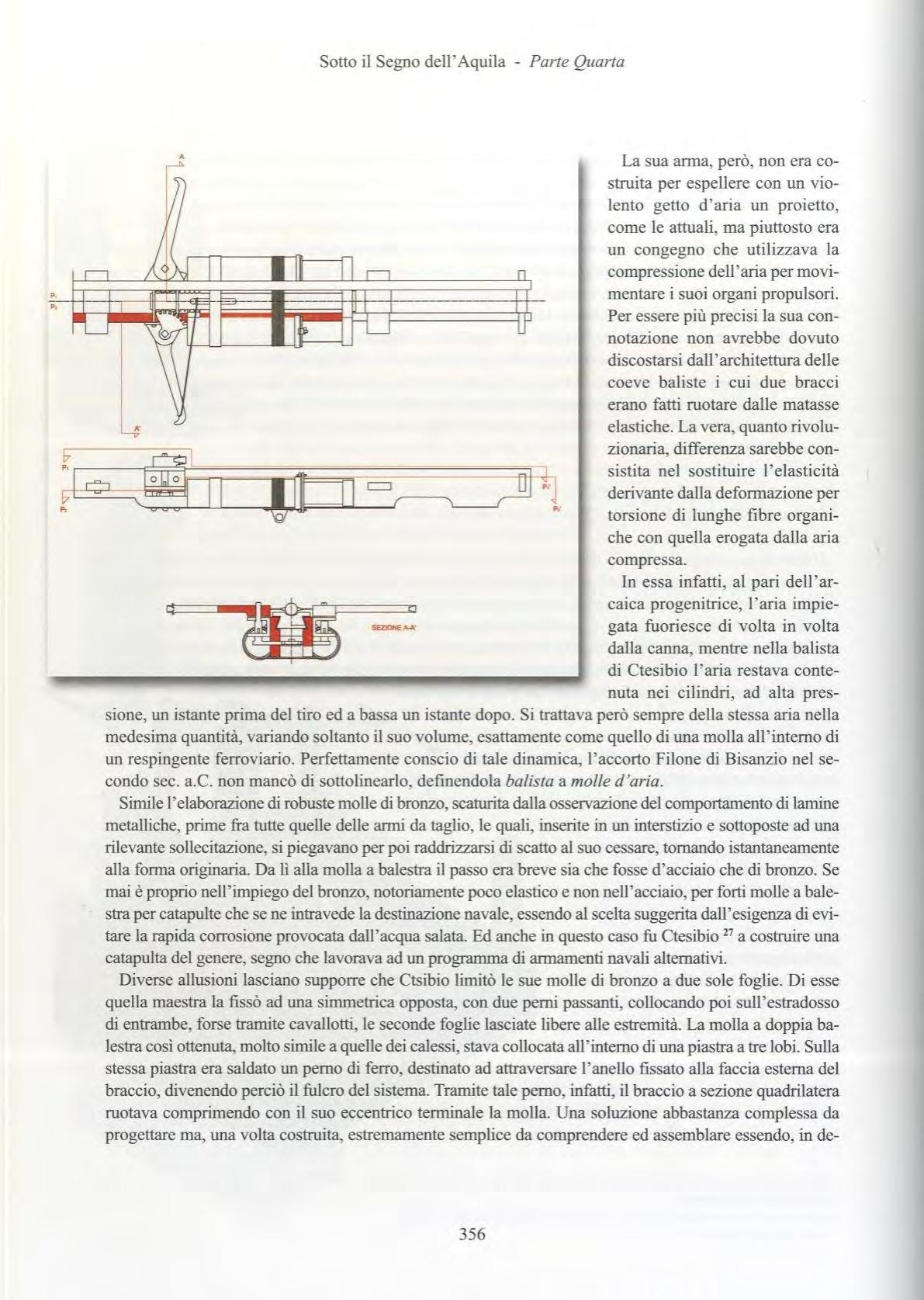
In essa infatti, al pari dell’arcaica progenitrice, l’aria impiegata fuoriesce di volta in volta dalla canna, mentre nella balista di Ctesibio l’aria restava contenuta nei cilindri, ad alta pressione,un istante prima del tiro ed a bassaun istante dopo. Si trattavaperò sempre della stessa aria nella medesima quantità,variando soltanto il suo volume,esattamente come quello di una molla all’interno di un respingente ferroviario. Perfettamente conscio di tale dinamica, l’accorto Filone di Bisanzio nel se— condo sec. a.C,non mancò di sottolinearlo, definendola balista a molle di 'arr'a.
Simile l’elaborazione di robuste molle di bronzo,scaturitadallaosservazione del comportamentodi lamine metalliche, prime fra tutte quelle delle anni da taglio,le quali, inserite in un interstizio e sottoposte ad una rilevante sollecitazione, si piegavano per poi raddrimrsi di scatto al suo cessare,tornando istantaneamente alla fon‘na originaria.Da li alla molla a balestra il passo erabreve sia che fosse d’acciaio che di bronzo, Se mai èproprio nell’impiego del bronzo,notoriamentepoco elastiooe non nell’acciaio,per forti molle abalestraper catapulte che se ne intravede ladestinazionenavale,essendoal scelta suggerita dall’esigenmdi evitare larapida corrosioneprovocata dall‘acqua salata Ed anche in questo casofix Ctesibio"a costruire una catapultadel genere, segno che lavoravaad unprogramma di armamenti nawli alternativi.
Diverse allusioni lasciano supptme che Ctsibio limitò le sue molle di bronzo a due sole foglie. Di esse quella maestra la fissò ad una simmetrica opposta,con due perni passanti, collocandopoi sull’estradosso di entrambe,forse tramite cavallotti, le seconde foglie lasciate libere alle estremità La molla a doppia balestracosì ottenuta,moltosimile a quelledei ealessi,stava collocata all’internodi unapiastra atre lobi,Sulla stessa piastra era saldato unperno di ferro, destinato ad attraversare l’anello fissato alla faccia esterna del braccio,divenendoperciò il fulcro del sistema. Tramite taleperno, infatti,il braccio a sezione quadrilatera ruotava comprimendo con il suo eccentrico terminale la molla Unasoluzione abbastanza complessa da progettare ma, una volta ' " da ’ ed ' essendo,in de-
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parre Quartu -s
|—| y—\
1 … || |n I | |
356
finitiva, quella tipica delle coeve catapulte e baliste,peraltro simili ad un moderno cavatappi a bracci moe bili.Messo apunto il congegno,owcroassemblate le sue componenti,tirando la corda arciera si irnprimeva una rotazione ai bracci che, a loro volta, tramite l’eccentrico comprimevano le molle a balestra… Quando ormai piatte la rotazione owiamente cessava e l’arma era carica,provvedendo una apposita ruota d’arresto ad arpioni abloccarla in sicurezza, come intutte lesimilari tradizionali.Sbloccato il ritegno lemolle riassumevano istantaneamente la loro curvatura spingendo con estrema violenza i bracci, la corda e il dardo, nella medesima maniera che avverrà oltre quindici secoli dopo nelle balestre medievali ad arco d’acciaio.
ARMI AUTOMATICHE
Sempre all’impiego navale va ricondotta l’esigenza di un rilevante volume di tiro dapiattaforma mobile, in particolare per bonificare le rive dei grandi fiumi dai tiratori nemici insidiosi, Le imbarcazioni fluviali, infatti,che senza interruzione pattugliavano il corso del Reno e del Danubio, costituivano una specialistica quanto nutrita tipologia di imbarcazioni.Al loro armamento erarichiesto di battere durante la navigazione bersagli a media distanza,scarsamente visibili e nonfortificati. Ideale l’impiego della catapulta a ripetizione,già inventata alcuni secoli prima, ma inutilizmtaper eccessivo consumo di munizioni e per l’insignificante brandeggio. Impiantata a prora avrebbero trasformato quei sottili battelli in antesignani pattugliatori fluviali. Circala congruità della definizione di arma automatica, occorre tuttavia unabreve precisazione.
Attualmente è definita automatica un’armache,dopo ilprimo colpo,continua a sparare senza ulteriori comandi.Mcccanicamente significa che lefasi di alimentazione,esplosione delle cartucce ed espulsione dei relativi bossoli,si susseguono inmaniera sequenziale, sino all’esaurimento del serbatoio senza alcun ausilio estraneo alla dinamica dell’arma.Perciò, servomotori elettrici,pneumatici o idraulici utilizzati per incrementare la cadenza di tiro,farebbero cadere la qualifica di automatica per l’arma d’appanenenza. Persifi’atte ', ‘ ' siconiòl’ ' ‘ diarrni ' ' odi ' " edi ' " trici meccaniche. Specificazione soloin apparenza pleonastica dal momento che evidenziava il basilare ausilio meccanico esterno,per lopiù erogato tramite unamanovella.In base a ciò le suddette mitragliere meccaniche dovrebbero solo mutare la definizione in serva-assistite. Paradossalmente, tale puntualizzazione, che sembra anagliarsi alle anni più aweniristiche,finisce per includere anche lacatapulta a ripetizione di Dionisio d’Alessandria!
Dal punto di vista storico lacatapulta a ripetizione nonha lascia“)nelle già laconichefonti labenché minima traccia, ad eccezione della dettagliata descrizione di Filone." Impossibile, perciò, stabilire con cenezzaquantoe quandofu impiegata,sebbene nulla contraddice la scelta dei tecnici di Mainz, di munire lalororicostruzione d’imbarcazionefluviale romana, peraltro ricavata dai relitti recuperati,di unacatapulta a ripetizione a prua, per molti aspetti estremamente
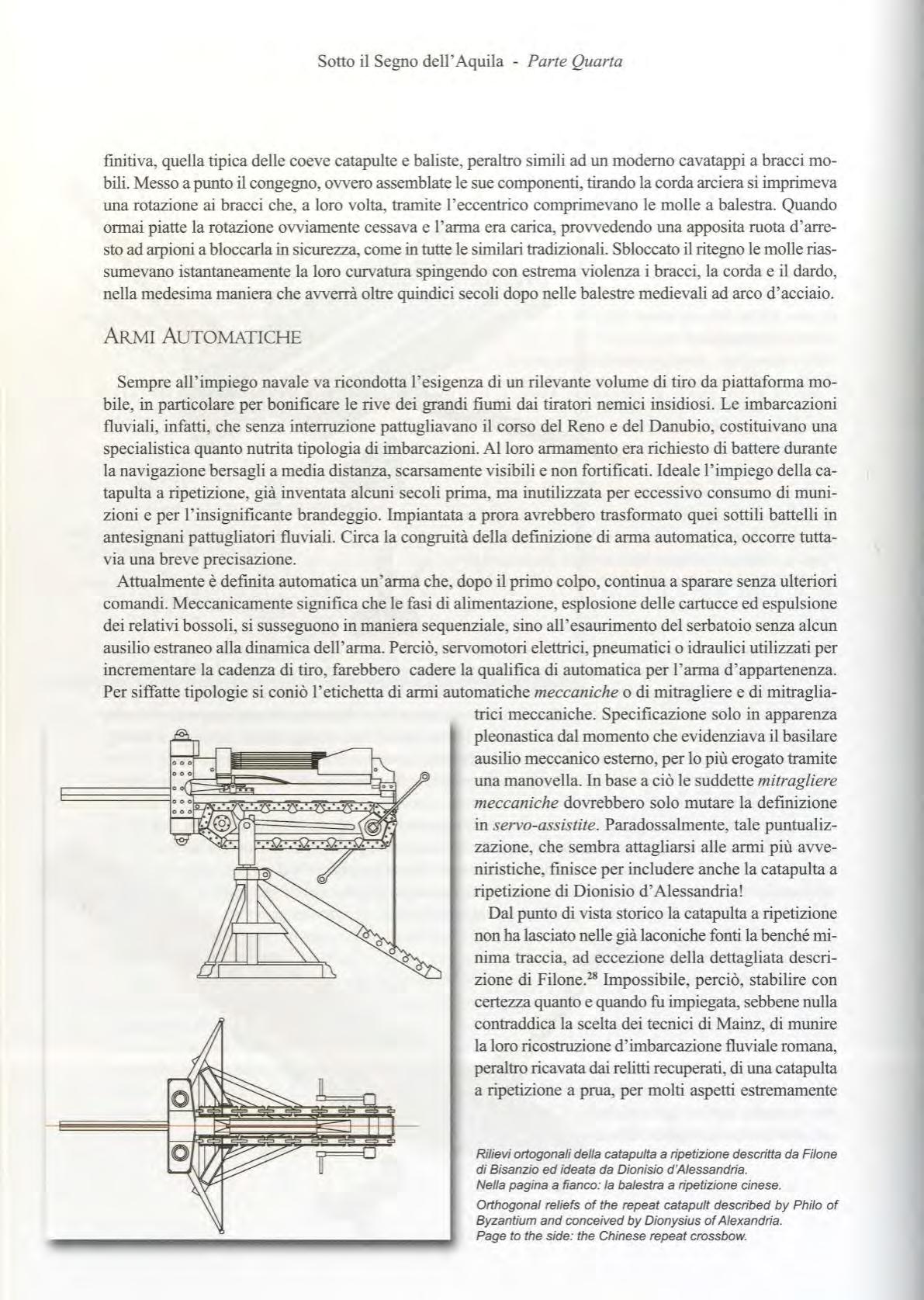
Nellapagina afianoo: labalestraaripetizione cinese.
Orthoganal mliefs of the repeat catapult described by Phi/a of Byzanlium and conceived byDionysius ofA/exandria.
Page to the Side: the Chinese repeat Crossbow
Sotto
il Segno dell‘Aquila - Parte Quarta
Rilievi ottagonali della catapulta aripetizione descritta daFi/one di Bisanzio ed ideata da Dionisio d'Alessandria.
sensata e razionale.Forse più che la sua meccanica fu il suo criterio informatore a divulgarsi maggiormente e a bucare i secoli: quel che è certoche i Cinesiarr» coranellaguerra del 1894»95 con i Giapponesi impiegarono delle balestre a ripetizione sulla cui efiìcacia bellica tutti i pareri sono lusinghieri. Il riarmo avveniva azionandounalevaad ogni colpo,soluzione che ricordava il fucile semiamomatiw Winchester.Ovvioconcludere che labalestra cinese sta alla caf tapulta di Dionisio come il Winchester alla mitragliera Gatling! Senza contare che tantoper la balestra quanto per il fircile, dovendosene ad ogni colpo mutare l‘assetto,era necessario riporla in punteria voltaper volta,perdendo cosi il tempo guadagnato nella ricarica! La catapultaa ripetizione,invece,non dovevasubire alcuno spostamento in fase di riarmo, potendo persino continuare a tirare mentre si riempiva nuovamente il serbatoio, La rievocazione di Filone tramanda un motore della catapulta a ripetizione non diverso dai tradizionali a torsione, avendo matasse compresefra i @Sl mm e i 0 78mm. Scagliava dardi di circa 50 cmche si devono immaginare rastremati verso la coda in modo che i governali, disposti a 120°fra loro,non firor-iuscivano dal diametro dell’asta, come nein attualiproietti di mortaio. Il serbatoio dei dardi eraa tramoggia,terminanteinbassoconunafessura lunga e largapoco più di un dardo,in modo dafame passare unoper volta nel cilindro alimentatore,che ruotando alternativamente di 180°lofaceva cadere dinanzi alla corda.Dopo il lancio continuando aruotare le levemotrici,laslitta tornava ad agganciare lacorda,che un apposito riscontrofaceva senare sull’arpione di sgancio, ed indietreggiando poneva in tensione la corda e l’armava,fin quando un secondo riscontro sbloccaw l’arpione determinando il tiro,Il ciclocontinuavaaripetersi inmaniera del tutto automatica e senza alcuna intenzione…”

Circail sistemausatoper lamovimentazione dell’anna,va osservato che lacatapultadi Dionisio non disponeva di un verricello di caricamento.Al suo posto un sofisticato congegno a catena, del tipo che in se— guito sarà definita regolarizzato,conmaglie identiche.In dettaglio constavadi due assi collocati intesta ed in coda del fusto, recanti alle estremità dei rocchetti, dei quali motore il posteriore e di rinvio l’anteriore. Quantoaitocchettisi trattavadi duepentagoni di legnorivestiti dipiastre di ferro, conuninterstiziofia loro. Le catene,formate da una teoria di blocchetti di quercia,rivestita di lamiera,lunghi quanto il lato dei pentagoni e la larghi come i relativi corpi.Le loropiccole piastre di raccordo, definitepinne, sporgendo verso il bassosi inserivanonell’intestizio impedmealle catene di fuoriuscime. La forza motrice venivafomita agendo su due ruote ad aspi poste all’estremità dell‘asse motore,
IL MORTAIO DELLE LEGIONI
In etàrepubblicana,come già ricordato,accenni di Filone e tracce a Pompei hanno fatto supporre l’esi— stenza di artiglierie mono—braccio.Circala cronologia di tali artiglierie lefonti sono ambigue: per alcune costituivano l’artiglieria principale delle legioni intorno al IV d.C. secolo, con il curioso nome di onagri; per altre non si trattadi unavera novitàma,appunto,di un significativo perfezionamento, Quale che fosse larealtà, l’onagrod’età imperiale constavadi un robusto telaio di forma rettangolare,abitualmente adagiato sul terreno ma non di rado munito di quattro rotelle ferrate. Questa ladescrizione dell’arma redatta daAmmiano Marcellinoz“lo scorpione, che aru chiamano {magro,possiede questa configurazione.
Sotto il Segno dell’Aquila Par/e Quartu
360
Due travi di legno di quercia, o in alternativa di leccio. vengonosagomate in modo taleda sembrare sollevarsi con una lieve gobba; quindi vengano congiunte nella stessa maniera del! 'attrezzoper segare e, praticati dei larghifori in entrambe le trovi,al loro internovisifannopassare delle robustefuni che rac— eordana la macchina e le impediscono di rompersi. Dal centro di queste [funi] si innalza obliquamente un braccio di legno, dritto come un rimane di cono, cosi avvinta nella matassa di nervi da riuscirepos— sibile sollevarlo o abbassarlo; allasua estremitàsuperiore sonofissati deiganci diferro, dai qualipende unafionda di corda o diferm.Dallaparte oppostadel braccio di legno viene collocato ungrosso sacco realizzato con ruvidi tessuti caprini, imbattendolo dipaglia sminuzzata, e quindi legato conforti nodi e' posto [insieme ail 'anna]sopra un rialzodizolle :)su di un cumulodi mattoni.Infatti una talemassaposizionata sopra un muro compatto dipietre losca/mette rapidamente e nonper ilsuopeso maper isuoi scuotimenti.
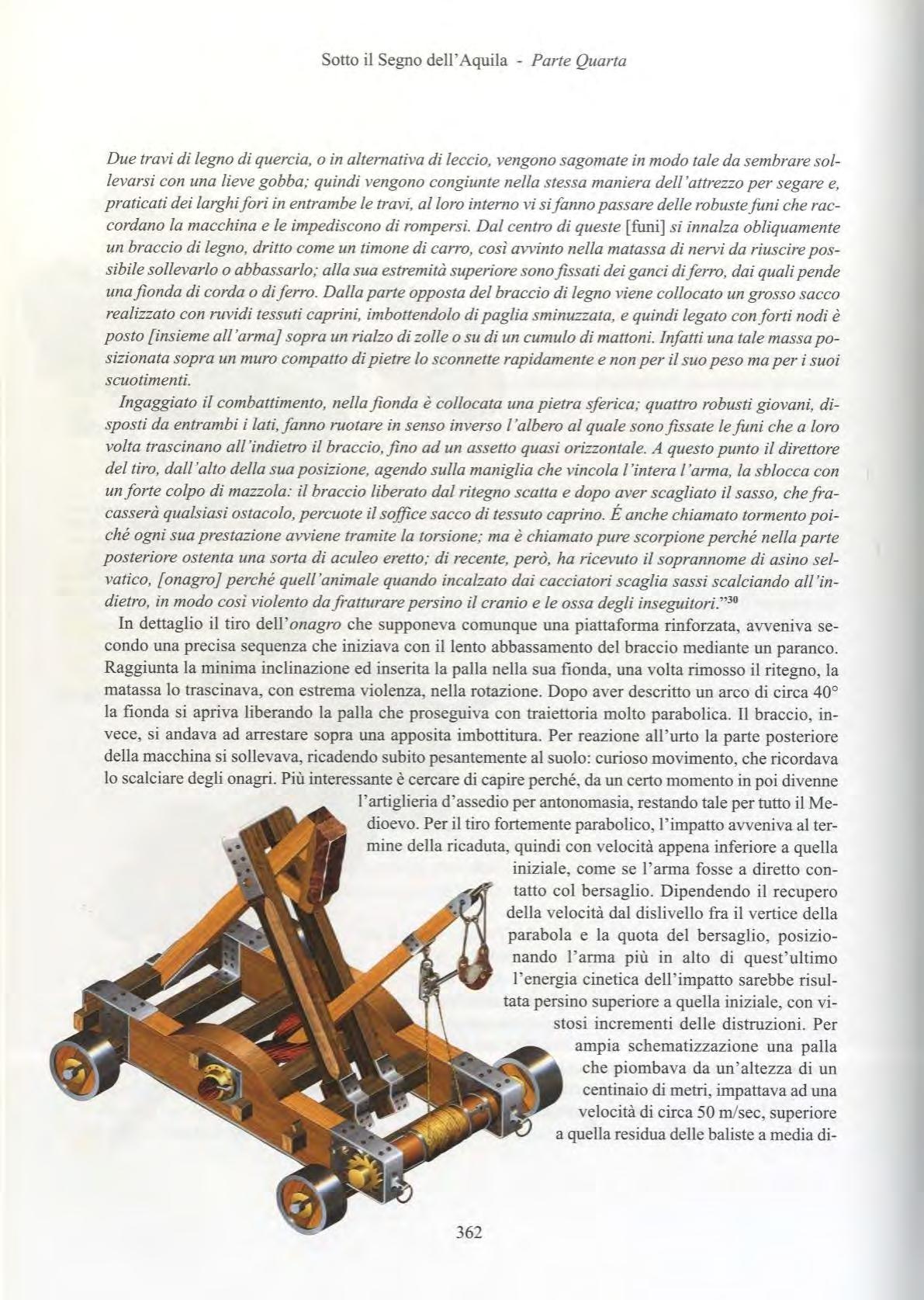
!ngaggiato il combattimento, nellafionda è collocata unapietra sferica; quattro robusti giovani, disposti da entrambi i lati,fanno ruotare in senso inverso [ ’alberoal quale sonofissate lefuni che o loro volta trascinano all indietro il braccio,fino ad un assetto quasi orizzontale.A questopunta il direttore del tiro,dall ’altodella suaposizione, agendosulla maniglia che vincola] intera l’arma, la sblocca con unforte colpo di mazzola: il braccio liberato dal ritegno scatta e dopo aver scagliato il sasso, chefra— casserè qualsiasi ostacolo,percuote il soffice sacco di tessuto caprino.È anche chiamato tormentopoiche' ogni suaprestazione avviene tramite la torsione; ma è chiamatopure scorpioneperche' nellaparte posteriore ostenta una sorta di aculeo eretto: di recente,però, ha ricevuto il soprannome di asino selvatico, [onagro]perché quel! ’animalequando incalzato dai cacciatori scaglia sassi scaleiando all 'in7 dietro, in modo cosi violento dafratturare persino il cranio e leossa degli inseguitori?“
In dettaglio il tiro dell’anagm che supponeva comunque una piattaforma rinforzata, avveniva secondo una precisa sequenza che iniziava con il lento abbassamento del braccio mediante un pannoc. Raggiunta la minima inclinazione ed inserita la palla nella sua fionda, una volta rimosso il ritegno, la matassa lo trascinava, con estrema violenza,nella rotazione… Dopo aver descritto un arco di circa 40° la fionda si apriva liberando la palla che proseguiva con traiettoria molto parabolica. Il braccio, invece, si andava ad arrestare sopra una apposita imbottitura… Per reazione all’urto la parte posteriore della macchina si sollevava,ricadendo subito pesantemente al suolo: curiosomovimento, che ricordava la scaldare degli onagri.Più interessante è cercare di capireperché, da un certo momento inpoi divenne l’artiglieria d’assedio per antonomasia,restando taleper tutto il Medioevo.Per il tirofortemente parabolico, l’impatto avveniva al termine della ricaduta, quindi con velocità appena inferiore a quella iniziale, come se l’arma fosse a diretto contatto col bersaglio. Dipendendo il recupero della velocità dal dislivello fra il venice della parabola e la quota del bersaglio, posizionando l’arma più in alto di quest’ultimo l'energia cinetica dell’impatto sarebbe risultatapersino superiore a quella iniziale,con vi» stesi incrementi delle distruzioni. Per ampia schematizzazione una palla che piombava da un’altezza di un centinaio di metri, impattavaad una velocità di circa 50 tri/sec,superiore a quella residua delle baliste a media di-
Sotto il Segno dell‘Aquila
Parte Quarta
stanza… Molto diverseperò le conseguenze,essendo l’angolo d’incidenza prossimo allaperpendicolare ed i bersagli battuti orizzontali,per lo più costituiti da impalcati lignei. In altre parole si scaricava la massima forza viva sulla minima resistenzastrutturale,con conseguenze facilmente intuibili. La palla, quindi, sfondava quei sottili diaframmi e piombava a] loro interno: spesso sfondava anche i solai dei piani inferiori delle case determinando crolli consegrenti. Senza contare gli effetti terrifici predoni da tiri del genere, specie quando condotti conproietti incendiari di notte. L’impiego dell’onag'ro non cessò con il dissolversi dell’Impero: mutata la fronda in una grossa cucchiaia si trasformò nella catapulta medievale, la catapulta per antonomasia!
L'ARMAMENTO DIFENSIVOINDIVIDUALE
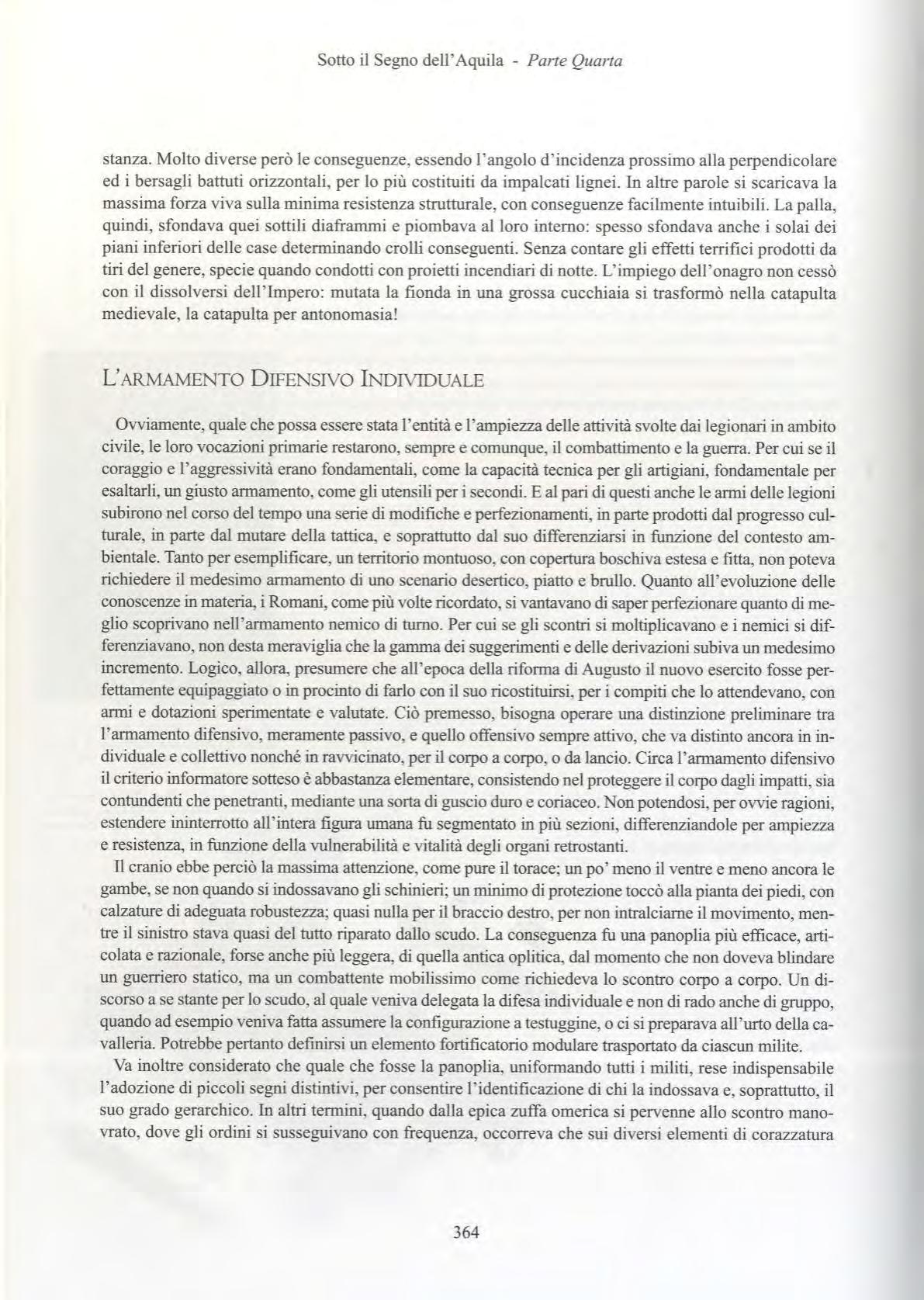
Ovviamente,quale che possa essere stata l’entitàe l’ampiezzadelle attivitàsvolte dai legionari in ambito civile,le loro primarie sempre e il ‘ ' e la guerra… Per cui se il coraggio e l’aggressività erano fondamentali, come la capacità tecnicaper gli artigiani,fondamentale per esaltarli,ungiusto armamento,come gli utensili per i secondi.Eal pari di questi anche le anni delle legioni subirono nel corso del tempouna serie di modifiche e perfezionamenti, inparte prodotti dal proyesso culturale, in parte dal mutare della tattica, e soprattutto dal suo differenziarsi in funzione del contesto ambientale.Tantoper esemplificare,unterritoriomontuoso,con coperturaboschiva estesa efitta, non poteva richiedere il medesimo armamento di uno scenario desertico,piatto e bmllo. Quanto all’evoluzione delle conoscenze inmateria,iRomani,comepiù volte ricordato,si vantavanodi saper perfezionare quantodi meglio scoprivano nell’armarnento nemico di turno. Per cui se gli scontri si moltiplicavano e i nemici si differenziavano, non desta meraviglia che lagamma dei suggerimenti e delle derivazioni subiva un medesimo incremento. Logico, allora,presumere che all‘epoca della riforma di Augusto il nuovo esercito fosse perfettamente equipaggiato o inprocinto di farlo con il suo ricostituirsi,per i compiti che lo attendevano,con anni e dotazioni sperimentate e valutate. Ciòpremesso, bisogna operare una distinzione preliminare na l’armamento difensivo, meramentepassivo, e quello offensivo sempre attivo,che va distinto ancora in individuale e collettivo nonché in ravvicinato,per il corpoa corpo,o da lancio…Circal’armamento difensivo il criterioinformatoresotteso è abbastanzaelementare,consistendonel proteggere il corpodain impatti,sia contundenti chepenetranti, mediante unasortadi guscio duro e coriaceo,Nonpotendosi, per ovvie ragioni, estendere ininterrotto all’intera figura umana fu segmentato inpiù sezioni, differenziandole per ampiezza e resistenza, infunzione della vulnerabilità e vitalità degli organi retrostanti… il cranio ebbe perciò la massima attenzione,comepure il torace;unpo’ meno il ventre e meno ancora le gambe, se non quando si indossavano gli scbinieri; unminimo di protezione toccòallapianta dei piedi, con calzature di adeguata robustezza; quasi nullaper il braccio destro,per non intralciame il movimento,mentre il sinistro stava quasi del tutto riparato dallo scudo. La conseguenza fu una panoplia più efficace,articolata e razionale,forse anche più leggera,di quella antica oplitica,dal momento che non doveva blindare un grerriero statico, ma un combattente mobilissimo come richiedeva lo scontro corpo a corpo… Undi— scorso ase stante per lo scudo,al quale veniva delegata ladifesa individualee nondi radoanche di gruppo, quandoad esempiovenivafatta assumere laconfigurazione a testuggine,o ci si preparava all’urto della ca— valleria.Potrebbe pertanto definirsi un elementofortificatorio modulare trasportato da ciascun milite.
Vainoltre considerato che quale che fosse lapanoplia, uniformando tutti i militi, rese indispensabile l’adozione di piccoli segni distintivi,per consentire l’idenfificazione di chi la indossavae,soprattutto, il suo grado gerarchico, In altri termini, quando dalla epica zuffa omerica si pervenne allo scontro mano— vrato, dove gli ordini si susseguivano con frequenza, occorreva che sui diversi elementi di corazzatura
Sotto il Segno
dell’Aquila - Parte Quarta
364
vi fossero delle modeste diversità convenzionali.Solo così.anche quando lapanoplia fosse ormai ridotta a pochi pezzi soltanto, tomava possibile discernere i comandanti per eseguime il volere. Essendo, per ovvie ragioni. l’elmo laparte più visibile della persona nella massa dei combattenti,proprio su di lui si concentrarono i suddetti distintivi. espediente ancora in vigore sebbene in maniera di gran lunga, e vo» lutarnente,meno vistosa.Al riguardo, inoltre,è interessante osservare che furono proprio i Romani a ridurne progressivamente lo sfarzo. avendone sperimentato sul campo di battaglia le controindicazioni d’una eccessivo risalto." ln linea di massima l’armamento difensivo di tarda età repubblicana che passò integralmente all’esercito imperiale, consisteva in tre elementi: il casco. la corazza e lo scudo.
ELMO
Il primo e fondamentale elemento dell’armamento difensivo fir senza dubbio il casco o,per meglio dire, l’elmo. l legionari lo indossavano in qualsiasi circostanza, spesso anche quando lontani dal com— battimento,come si desume da innumerevoli raffigurazioni. Essendo pure la protezione che sovrastava la figura riuscendo la più visibile,non stupisce il concentrarsi sullo stesso di ornamenti munifici, quali incisioni e sbalzati, di accessori terrifici,quali piume o pelli di animali feroci, e di distintivi gerarchici, per lopiù dati dalla disposizione delle creste e delle pene. Ma molti di tali orpelli riguardano piuttosto l’elmo daparata e non quello da combattimento.che erafrutto invecedi una assidua ricerca tecnica tesa ad accrescerne la solidità. l‘ottimale ergonomia e laportabilità.
Mentre in epoca repubblicana arcaica era stato spesso adottato il robusto elmo corin— zio di bronzo.ottimo nello scontro falangistico ma pericoloso nel combattimento individuale impedendo un adeguato campo visivo, sul suo finire si optò per un elmo molto diverso. Si trattava,infatti,di un casco,sempre di bronzo.ma munito di unpiccolo sporto posteriore per la difesa nuca, definitagronda, nonche' di due protezioni mobiliper gli zigomi, dette paragnatidi. In epoca mariana comparvero i primi elmi in bronzo, prodotti sicuramente in serie e di moderato costo, definiti dagli specialisti del settore modello Montefortino C. Si trattava di elmi crestati muniti di un pennacchio e di una coda di crine di cavallo su di un unico cimiero, che ricor— dano quelli degli odiemi corazzieri. Per quanto se ne sa restarono in dotazione fino al I secolo d.C.
In età augusteaz“feee la sua comparsa nell'esercito romano ilprima degli elmi Coolus. Questo modello seguiva maggiormente, nel Coppa, laforma naturale del teschio ed era dotato di una gronda più ampia di quella del Montefortino. ll coppa è di origine gallica e il campionepiù antico è stato ritrovato nella regione della Marna… La versione romana è certamente migliorata da un rinforzofrontale 0 reso, cheproteggeva laparte anterioredel teschio da colpi diretti. Iprimi caschi romani di tipo Cao/us,modello C non avevano cresta, al contrario di tutti i modellisuccessivi.””Nel modello E, ricavato da un reperto rinvenuto a Walbrook,oltre al cimiero centrale per la coda di cavallo,vi erano anche due tubicini laterali,per l’innesto delle penne. Non sappiamo se tali omamenti fossero anche un segno distintivo della unità o del grado. Nella prima metà del I secolo si amplia ulteriormente la gronda e si rinforza lo spessore. lnparttcolare:"i due caschiscoperti nel campodi Haltern sono stati utilizzati al] incirca tra il 9 a.C.fino al! ’abbandonodel sito verso il 9 della nostra era. 17primo, in bronzo, rappresenta l'evoluzione del casco italico (tipo repubblicano,poi di Buggenum): il copri-nuca [la gronda n.d.A.] è più svi-
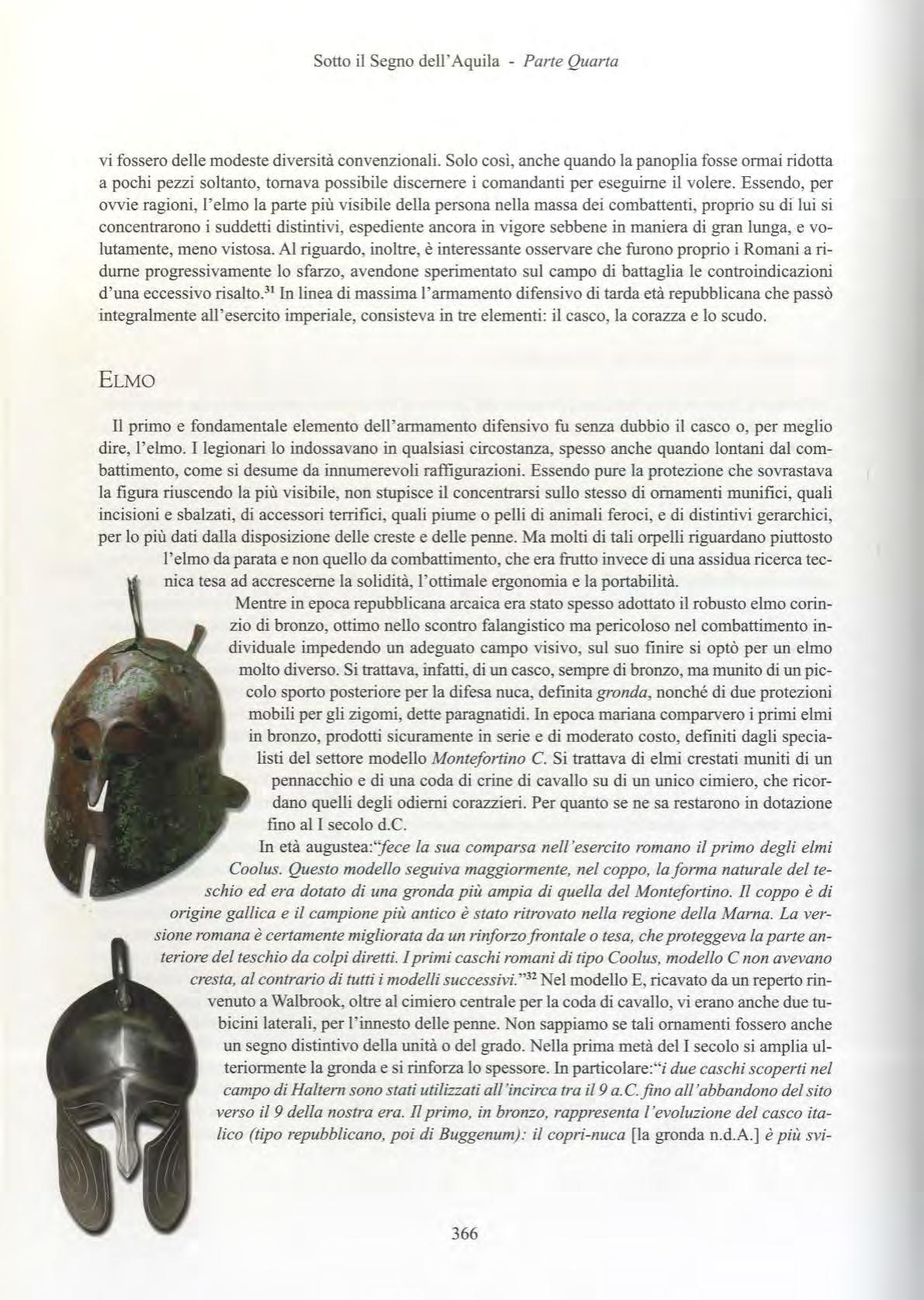
Sotto
il Segno dell‘Aquila Parte Quarta
366
luppolo che inprecede :a eforma con la calotta un angolo retto. Il bottone apicale, conico, non comparepiti in tuttigli esemplari della serie. Più importante sembra, in compenso, I aggiunta di un rinforzofmntale che serve a proteggere la calotta dai colpi direttamente inferti dall'alto in basso. Il casco eponimo di questa serie, scoperto a Drusenheim (basso Reno), è provvisto in altre di due tubi laterali che permettevano di innestareduepenne verticali, unaper lato.] copriguancia [paragnatidi n.d…A…], conv servati sul casco di Schaan {Svizzera). sono relativamente larghi e anteriormente muniti di due aperture semicircolari, unaper gli occhi e l'altraper la bocca. L 'altrocasco di Haltern. inferm, ma difarma moltosimile, anche se il materiale ha imposto qualche adattamento di dettaglio. Si ritrova una calotta molta sviluppata, quasi cilindrica alla base, e un copri-nucaperpendicolare (o. secondo i casi, leggermente inclinato).Da due a quattro scanalature, aforma di alette o di sopracigli, rinforzano la calotta anteriormente. Questiadattamenti tecnici. reseropossibile grazie alla maestria deifabbri ai quali si devono i caschi di questa serie, di non sostituire afi”atto il rinforzofrontale. esito che sembra essere stato costante . Alcuni esemplari precoci come il casco eponimo di Mainz- Weisenau o quello di Besancon, sonoprowisti di un decoro estremamente accurato: si sono utilizzati infatti tutti i contrasti di co— loreche derivano dall impiego di metalli e di materiali differenti (ferro,rame rosso, ottone, argento} Comepure smalto epersino dei coralli.”3
Di certo gli elmi di ferro non soppiantarono del tutto quelli di bronzo,forse ancheperché laproduzione di questi restò.ingenerale, sempre molto limitata. Sembra, da alcune fonti. che un fabbrica di una certa imponanza non riuscisse a produrne più di una mezza dozzina la mese! Unelmo di diversa foggia e fattura era quello della cavalv leria,cassis, che già Giulio Cesare non mancava di distinguere da quello dellafanteria, galea. Successivamente tali caschi si elaborarono ulteriormente per cui nel I sec. d.C. hanno tra le più curiose caratteristiche anche la calotta che riproduce a sbalzo la capigliatura umana,le orecchie e,non di rado.sulle paragnatidi anche la barba! Strutturalmente posseggono una gronda alquanto bassa ed innestata quasi ortogonalmente alla base posteriore dell'elmo.“
Comparvero sempre in età imperiale i primi elmi per cavaliere bimetallici, ovvero con struttura di ferro rivestita da lamina di bronzo o d’argento. Senza dubbio uno dei più begli esemplari della tipologiafil ritrovato nel 1986 in un banco di ghiaia presso Xanten ed attualmente è custodito nel Museo di Bonn: si tratta di un elmo di ferro ricoperto con una foglia d‘argento sbalzato,accuratamente lavorato eparzialmente dorato afuoco.35 Uncurioso complemento del casco da cavaliere, usato forse esclusivamente nelle parate, era la maschera di bronzo argentato che lo chiudeva anteriormente: ne sono state ritrovate alquanto, in ottimo stato di conservazione…
V1erano,inoltre,i caschi dellafanteria ausiliaria di gran lunga più semplici di quelli dei legionari, Venivanoprodotti con un singolare processo metallurgico, consistente nel sagomare, mediante una rilevante pressione, un disco di metallo, nella fattispecie di bronzo temprato, su di una matrice di legno duro, fatta ruotare tramite una macchina tipo tor— nio.“ E‘ indubbio che l‘energia necessaria alla sua movi-
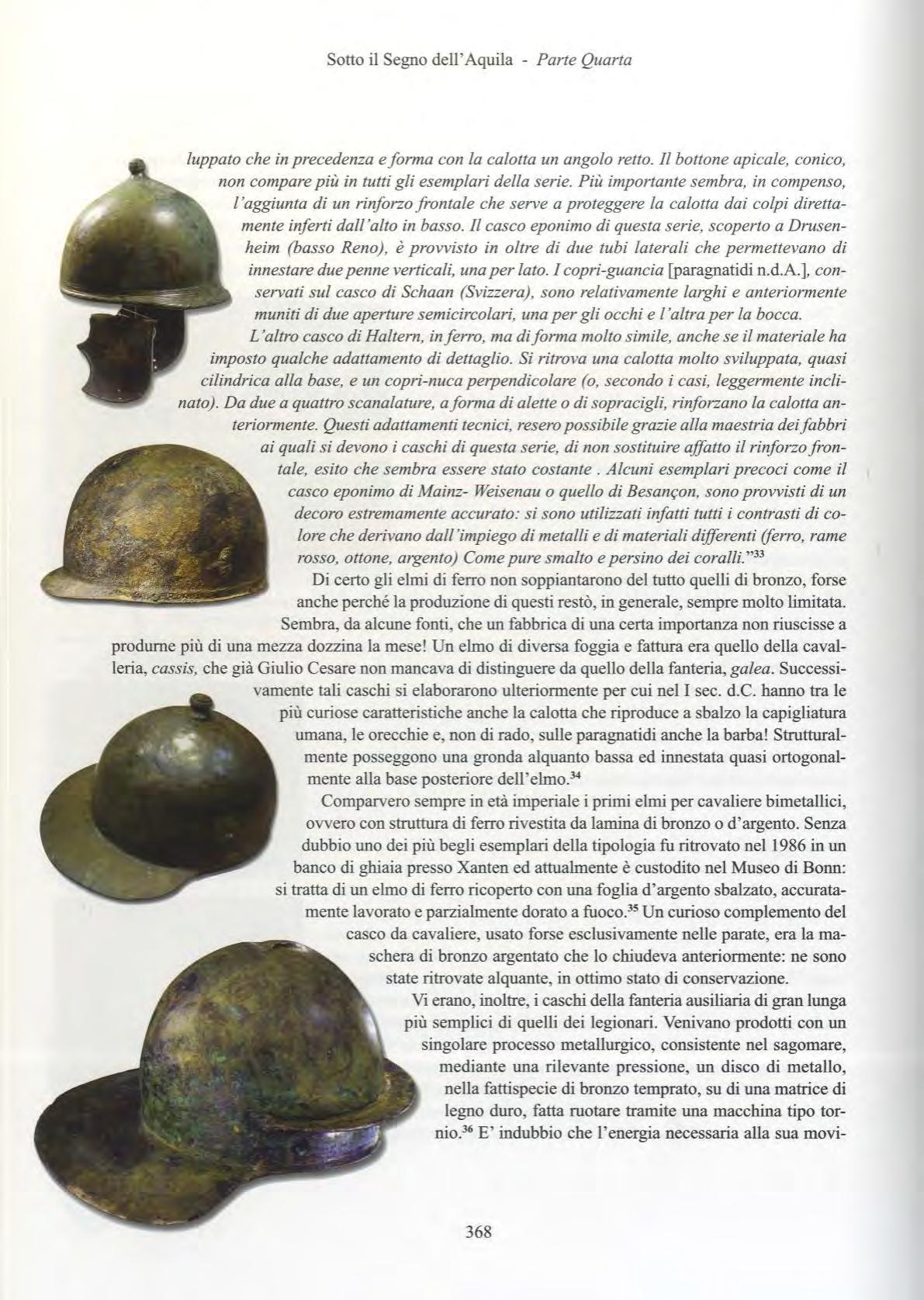
Sotto il Segno dell'Aquila - Parte Quarta
368
Legionari conelmo

Nellapagina afianco maschera da cavaliere eprotezioni Irontali &dorsaliper cavallo
Legtonnaires Withhelmet.
Sidepage. horsemen's mask andfront and backprotection.
meniazionc pOIC\ a pro\ enirc solo dalle grandi ruote idrauf liclie che I Romani da tempo. infatti,sfrutta\ ano nell’industria come stanno a confermare le grandi colonne realizzate al tomio. ole lastre di marmo tagliate con seghe idrauliche ricordate da Stazio nella sua Mosella.”
Pochissimi gli elmi posteriori a] I secolo sino a oggi rin\enuti: di essi con certezza se ne sono identificati infatti apr pena due… datati alla prima metà del [I secolo d.C. Sono entrambi di ferro. uno recuperato a Brigetio in Lnghcriti e l‘altro in una grotta di Hebron in lsraele,” Le riovità inaggiori del primo sono la gronda ulteriormente più larga e la presenza di borchie.anche sulle paragnatidi. i supporti della cresta appaiono del tutto assenti.forse per asportazione successi\a. E“ da notare tuttavia che forse a partire dal il secolo l‘antico ornamento della cresta a spazzola, con andamento antero-postcriorc peri legionari semplici e larerdlatcralc per i centurioni. era scomparso del tutto o in via di rapida eliminazione. Quanto al secondo elmo pur mostrando una lavorazione alquanto diversa. risulta di analoga qualità, in linea di massima dozzinale.JD
Relativamente al lll secolo. si conosce un interessante casco che \iene considerato una variante tardiva di quello di tipo Wiesenau.con calotta rinforzata da due strisce a croce. con cimiero apicale. robusta visiera. protezioni superiori per le orecchie. senza paragnatidi e con una lan ghissima gronda. con innesto a 45° al corpo cilindrico posteriore del casco. La presenza su quest'ultimo di ben Cinque nervature parallele rende eudente l‘esigenza di una maggiore rigidità dello stesso. dando all‘insieme una forte potenzialità difensiva. E l‘iinplicita testimo» nianza di una mutata modalità combattiva da parte dei barbari…forse con l'impiego di armi da lancio.“
Quello che l'archeologia non ci ha potuto restituire per la loro effimera durata sono i rivestimenti interni dei caschi. Questi… nella maggior parte dei casi. erano fatti di cuoio. tessuto o feltro applicato mediante ri\ettini.
Sotto il Segno dell'Aquila Porte Quartu
LA CORAZZA
Come e stato stigmatizzato da qualche puntiglioso esperto. le tante pellicole a soggetto militare romano,hannofinito per accreditare e rendere celebre sui legionari, una co» rana anatomica di cuoio, in realtà mai esistita. ll cuoio, infatti, trovò sicuro impiego solo negli ptemges, ovvero nelle strisce che scendevano dal corsetto di maglia o dalla cotta,di scaglie di bronzo o di piastre di ferro. Strisce che nel loro insiemeformavano quellasorta di gonnellino caratteristico dei legionari romani, dalla blandissima funzione protettiva… Altro impiego sistematico del cuoio si ebbe nelle calzature, meglio note come galigae, costituite da una robusta suola chiodata e da unacomplicata serie di cinghie e stringhe, che fasciavano il piede e la caviglia come dei moderni sandali alti. Scarpe aperte che garantivano una efiìcace circolazione dell’aria,una sana postura del piede e,al contempo.un‘ottima presa, persino sul ghiaccio, grazie alle chiodature.“
Tornando alla corazza propriamente detta, destina a proteggere il torace e le spalle, consta di numerosi modelli avvicendatisi nel tempo e, spesso, anche concomitanti.Più in dettaglio:“fizttasalva lacorazzasegmentato, le corazze utilizzate dall ’esercitoromano agli inizi delprincipato presentano solo evoluzioni marginali rispetto a quelle di epoca repubblicana. Gli uflicioli superiori continuano ad utilizzare lo corazza muscolata [anatomica], della quale i modellipiù decorati dovevano essereforgiati per occasioni ecceziono E 'Senzadubbio a tali corazze, ornate di oro e di argento che rinvia laNonna dignitatum nella Iixta dellafabbriche imperiuli del tardo Impero. E ‘signz'ficativorilevare che que sto modello, che è ilpiùfiequentemenle riprodotto nella statuaria risulta nella realtà ilpiù raro dal momento che nessun esemplare si è conservatofino ai nostri giorni““
Volendotracciare delle brevi descrizioni dei vari tipi di corazza laprima, più propriamente definita cotta,può essere considerata quella cosiddetta oscaglie che i Romani chiamavano lorica squamaza. In Oriente risulta impiegata già nell'età del Bronzo, ma mai dai Greci che ne fecero uso solo saltuariamente e in maniera sporadico. Ignota pure presso i Celti.venne adotta dalle unità ausiliarie romane agli inizi dell’età imperiale, come attestano molteplici ritrovamenti archeologici, databili tra i I ed il IV secolo. Ovviamente nessun
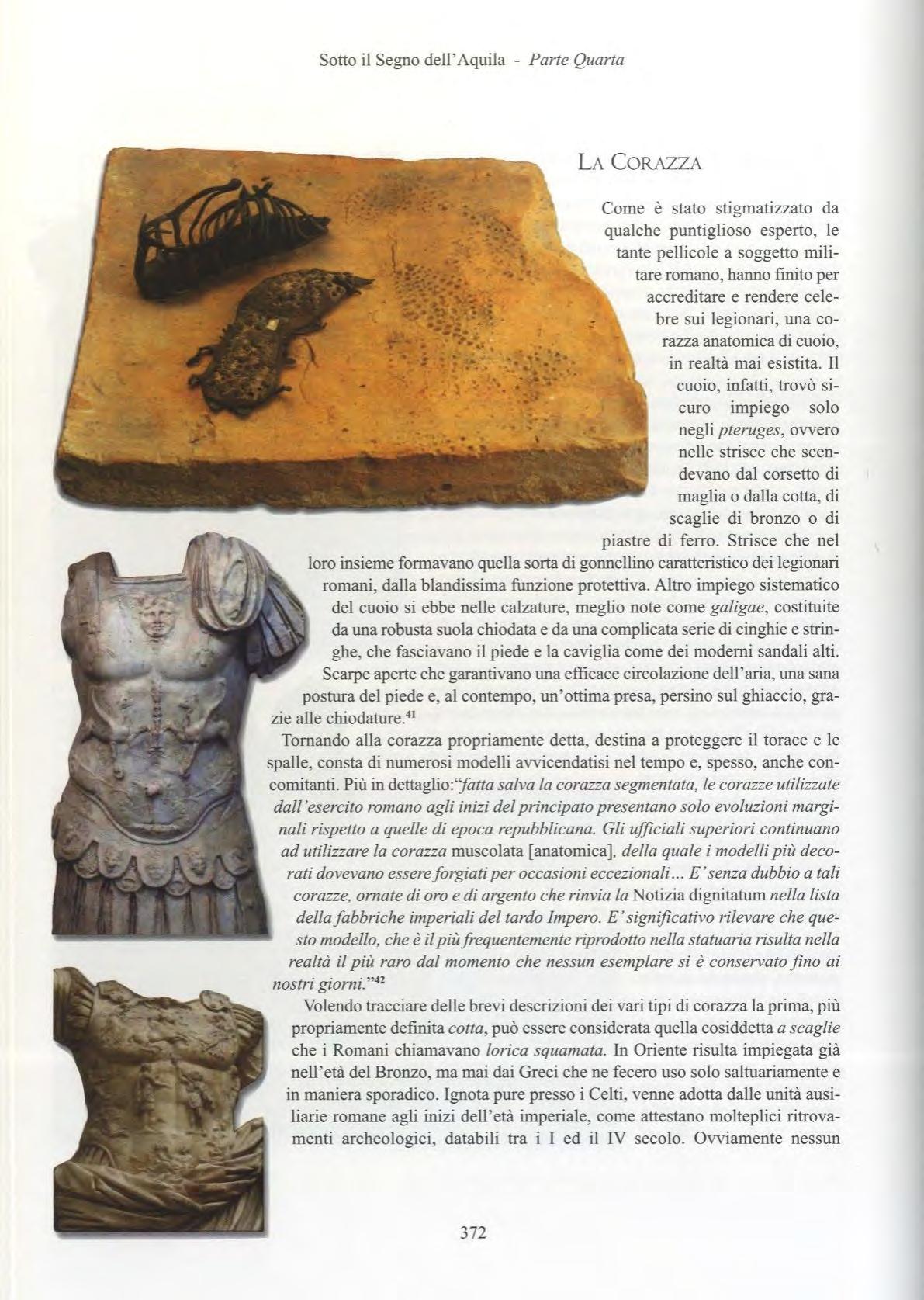
Sotto il Segno dell’Aquila - Parte Quarta
372
esemplare di tale corazza ci è pervenuto nella sua interezza, dal momento che la sua conscrvztzione Sl limitata unicamente alle scaglie. in numero più o meno consistente, Tuttavia l'osservzr zione anche di quei frammenti ne conferma la grande facilità di realizzazione e di riparazione quando danneggiate. non differ rendo in sostanza l'operazione.fatte salve le debite proporzioni. dalla messa in opera delle tegole. Le scaglie. logicamente.non finono tutte sempre di uguale formato. pur risultando all’incirca rettangolari. con dimensioni dell’ordine dei l-Z cm di larghezzaper 2-3 cm di altezza… con tre lati dritti e la base che sormonta quella sottostante, arrotondata. in diversi casi le scaglie, che sarebbe per molti aspetti più sensato chiamare squame.furono anche rese convesse.proprio come le tegole.
Per montarle allineate si usavano dei fili di bronzo.che venivanofatti passare nei due fori di ciascuna e poi ripiegati all’indietro. Ogni riga era così fissata su di un supporto di tessuto.verosimilmente una tela molto robusta forse quella perle vele o di leggerapelle scamosciata. Un altro metodo di montaggio consisteva nel bloccare la scaglie direttamente fra loro, senza alcun supporto sottostante, come alcuni reperti hanno rivelato, soluzione che ne riduceva di molto la mobilità. Stando ai bassorilievi.la fonte iconicapiù attendibile in materia. di corazze a scaglie ve ne erano due tipi. rispettivamente per i fanti e per i cavalieri.dei quali il secondo più lungo. In entrambi i casi la cotta a scaglie non sembra aver goduto significativi apprezzamenti essendo la protezione elargite di scarsa valenza. La sua maggiore prerogativa, infatti. era esclusivamente economica, non richie— dendo perla fabbricazione notevoli competenze e quindi l’impiego di mano d‘opera specializzata, Unaltro tipo di corazza era quella con la cotta di maglia di ferro, de» finita dai Romani humalo. La sua presenza sembra accertata già nel V secolo a.C. Stando ad alcune fonti i Romani la conobbero attraverso i Celti gallici. che non a caso vennero reputati i suoi inventori. Quale che ne sia stata l'origine e certo che venne adottata dai legionari intorno al II secolo a.C.. come si desume agevolmente da alcuni monumenti. In essi si nota addirittura un progressivo allungarsi del corpetto della cotta,conseguenza diretta del suo evolversi e dei sistemi adottati per calzarla sul busto. Sembra inoltre che i Romani adottassero due diversi rinforzi per le spalle.dei quali

Sotto il Segno dell'Aquila
Porro Quartu
Repem e noaslmflani della lonca Squamata Ruins and Ieconslructtans DI the Ionca Squamata
uno simile all‘imbottirure di lino per corazze dei Greci… e l‘altro simile ad un corto mantello, forse di origine celtica.‘3 Quest'ultimo. nella sua forma originaria. non richiedeva un supporto di cuoio.neces— sario invece per il modello greco., che altrimenti sarebbe consistito in un insieme di strisce inutili. Circa la fabbricazione risultava abbastanza complicata dovendosi realizzare gli anelli separatamente. uno alla volta,per poi giuntarli. Per avere un‘idea di quanto lavoro occorresse nella sua preparazione. va ricordato che si partiva da una barra resa lentamentepiù sottile mediante vari passaggi a caldo in unafiliera. Poi allorquando:"il_lila era sufficientemente lungo, veniva un‘alta intorno a imfiiso (’ le sue spire ragliare con una scalpello per 77cavare gli anelli che iljàbbricanre di Colle di maglia univapaifi-a loro… [Le loro] estremita' venivano quindi appiattiteper poterle spillare e ribattere. Per ultimo un Dperaio an:iano @ il capomastro li ipinavzr e ribatte…per rear lizzare le carte ('lIL’ renitha sagomate con cura secondo [afiguru umana.poiché. come tutte le armaturepersonali, anche lu corra di maglia diferro doveva «vestire» bene ed essere sufi?ci'entenierit€ comodaper CD]… che doveva indossarla in mw bullimento ““ Un leggero progresso si ottenne con lo stampaggio degli anelli. che comunque non evnava la legatura. Da recenti calcoli si è stabilito che il peso di una cotta del genere si aggirasse intorno ai 7-8 kg. con intuibile fatica per chi l'indossava.
Dal punto di vista difensivo. va osservato che tanto la cotta a scaglie e… ancor più quella ad anelli, senza dubbio efficaci per neutralizzare i fendenti e persino gli impatti delle frecce a bassa velocità.non garantivano minimamente dagli impatti di proietti contundenti, Corte del genere dal momento che erano flessibili. appunto come una maglia. non potevano neutralizzare gli impatti dei proietti delle fionde e delle baliste di piccolo calibro
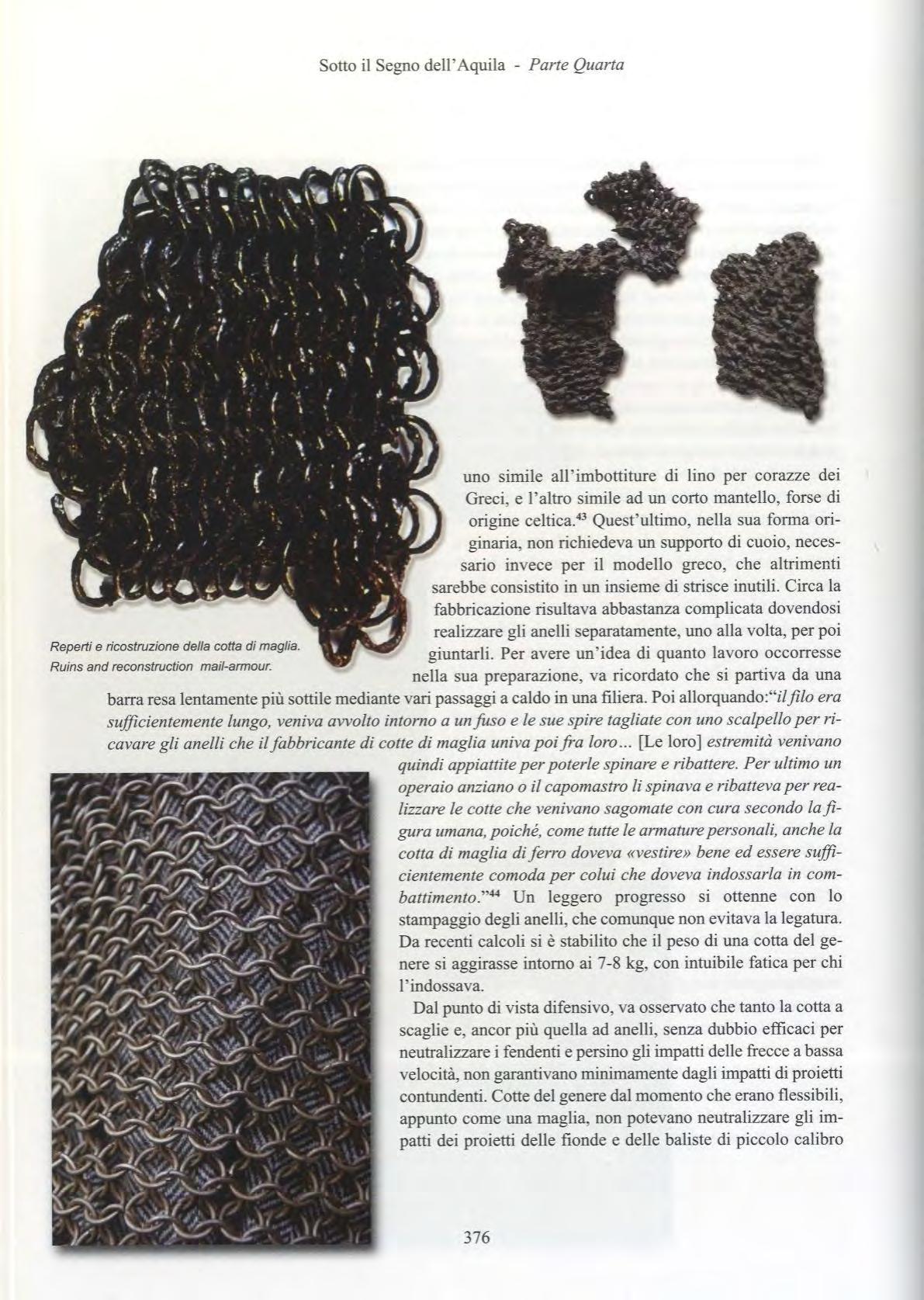
Sotto il Segno dell‘Aquila
Parre Quarta
Reperti & ncostruzione della carta di maglia. Ruins and reconslruction mailsrmouf.
che scaricavano perciò la loro energia letale sul corpo! Si spiega forse cosi lapreferenza ac— cordatadai Romani ad unacorazzacompostada variepiastre d’acciaio, di notevole ampiezza,
che fasciavano il busto e le spalle, veri elementi di blindatura. Il tipo di gran lungapiù usato, almeno nella prima età imperiale.fu la ben nota corazza ottenuta con la sovrapposizione di
varie piastre di ferro, detta anche lorica segmentato. Dal punto di vista cronologico il suo avvento coincide con il regno di Tiberioed è,per molti studiosi, una conseguenza della disfatta di Teutoburgo.A loro avviso, infatti,occorreva dar-mare un gran numero di legionari, in brevissimo tempo e con laminima spesa: lacorazza a lame rispondeva ad entrambe le esigenze. In realtà,pur essendo condivisibile lamotivazione dellafretta e dei costi del riarmo di alcune legioni dopo lagravissimaperdita, lanuova corazza aveva degli altri vantaggi, che forse proprio quella strage aveva fatto elaborare, consistenti in una protezione passiva di gran lunga superiore…Adifi”erenza della corazza & scaglie e della cotta di maglia, la corazza a lame,infatti,deve considerarsi un'invenzione squisitamente romana,che secondo un’ipotesi suggestiva, potrebbe essere derivata da quella usata dai gladiatori. Questi, da tempo, avrebbero usato unaprotezione apiastre, molto resistente sia ai colpi inferti da un’armape»
Comzzaa scaglie: reperto di epoca micena, raffigurazione sulla Colonna Traiana & repertidiepoca romana.
Plate cuirass: rel/i:from the Myeenaean Ere, representation on the ijan Co— lumn and relicsfrom the Roman Era.
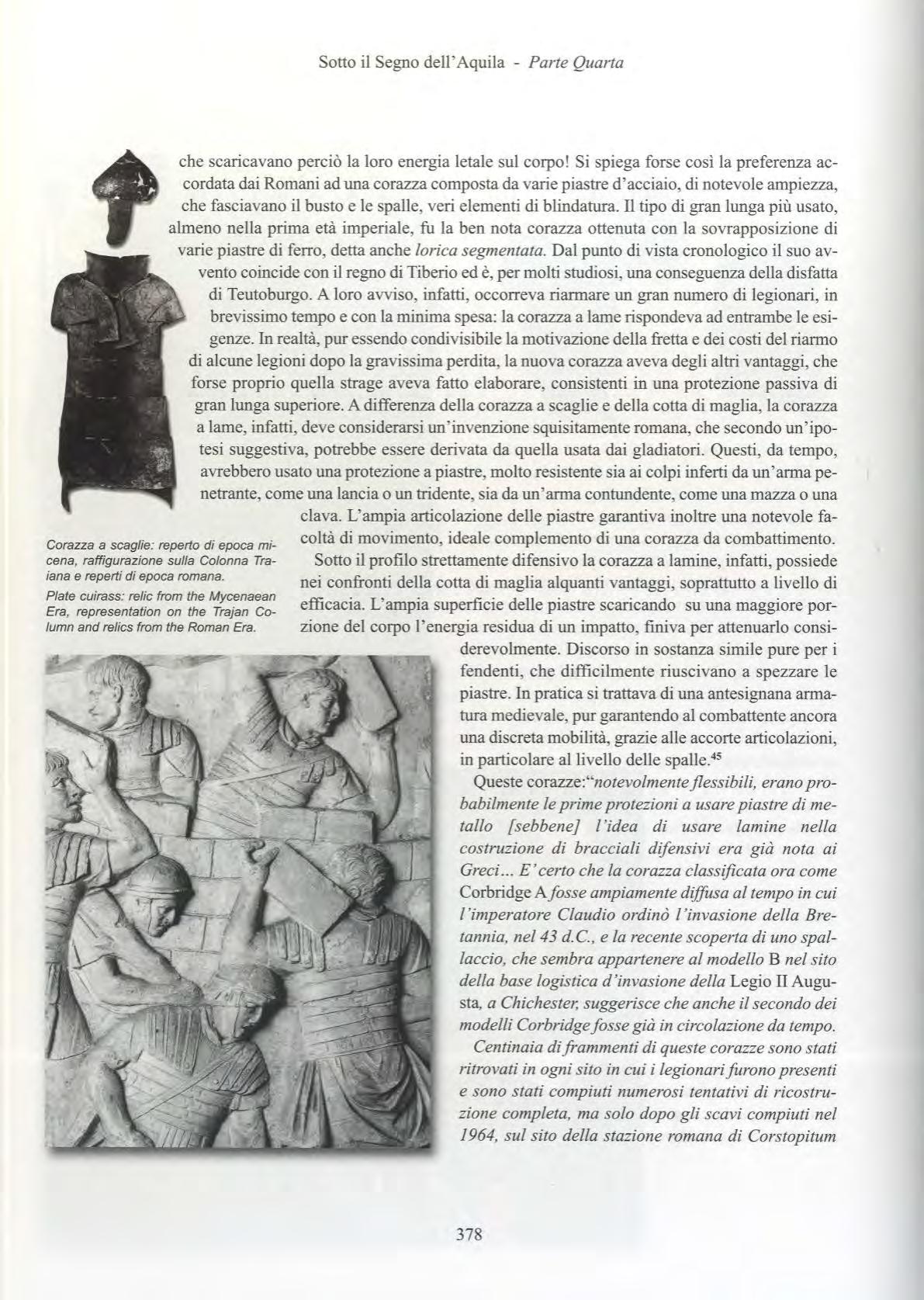
netrante,come una lancia ()un tridente,sia da un‘armacontundente,come una mazza o una clava… L'ampia articolazione delle piastre garantiva inoltre una notevole fa» coltà di movimento, ideale complemento di una corazza da combattimento. Sotto ilprofilo strettamente difensivo lacorazzaa lamine,infatti,possiede nei confi'onti della cotta di maglia alquanti vantaggi, soprattutto a livello di efficacia.L‘ampia superficie delle piastre scaricando su una maggiore porzione del corpo l’energia residua di un impatto,finiva per attenuarlo considerevolmente. Discorso in sostanza simile pure per i fendenti. che difficilmente riuscivano a spezzare le piastre. In pratica si trattavadi una antesignana amiatura medievale,pur garantendo al combattente ancora una discreta mobilità,grazie alle accorte articolazioni, inpanicolare al livello delle spalle.“
Questecorazzez“notevolmenreflessibili, eranoprobabilmente leprime protezioni a usarepiastre di me— tallo [sebbene] I 'idea di usare lamine nella costruzione di bracciali difensivi era già nota ai Greci...E 'certoche la corazza classificata ora come CorbridgeAfosse ampiamente diflusa al tempo in cui !'imperatore Claudio ordinò l’invasione della Bretannia, nel 43 d.C., ela recente scoperta di una spal— laccio, che sembra appartenere al modello B nel sito della base logistica d invasionedella Legio Il Augu» sta, :: Chichester;suggerisce che anche ilsecondo dei modelli Corbfidgefissegià in circolazione da tempo.
Centinaiadiframmenti di queste corazze sono stati ritrovati in ogni sito in cui i legionarifurono presenti e sono stati compiuti numerosi tentativi di ricostruzione eompleta, ma solo dopo gli scavi compiuti nel 1964, sul sito della stazione romana di Corstopitum
Sotto
Segno dell'Aquila -
il
Parte Quarta
378
(Cor-bridge), vicina al VallodiAdriano. il vero arpetto e [a struttura di queste corazze sono divenute notte"“
Nella circostanza, afiiorarono in una cesta ferrata, molte piastre di corazza. tra cui due interi sistemi risalenti al I-ll secolo d.C. Di gran lunga più semplici da costmire e meno pesanti di quasi un terzo delle cotte a scaglie o a maglia. le corazze a lama si imposero. nonostante gli inconvenienti connessi al gran numero di cinghie e legacci necessari per indossarle,Vierano.infatti,molte difficoltà che solo lentamente vennero superate, dovute alla fragilità dei legacci ed alla scadente qualità metallurgica della piastre e si deve attendere il finire del I secolo per giungere ad avere un prodotto di qualità media ottimale. Tuttavia alcuni di quei suoi difetti intrinseci derivanti dalla debolezza dei raccordi, dall’inevitabile deterioramento dei supporti di cuoio all’intemperie e dalla propensione ad arrugginirsi la resero co» munque d'improba manutenzione. E quanto fosse complicato il suo montaggio lo dimostra che. solo di recente, l’archeologia ne ha finalmente svelato tutte le fasi e le pe» culiarità. In particolare il frammento ritrovato nell’im» mediate adiacenze della for— tezza di Trimnontium. odierna Newstead. in Scozia, da cui appunto al definizione di modello Newstead, si è confermato robusto e perfettamente fiinzionale. Non a caso è il modello che compare con maggior frequenza proprio nella Co» lonna Traiana.‘7
LO SCUDO
E’ considerato l’elemento difensivo per antonomasia e, dalle riforme di Mario, se ne sviluppò un mo— dello, detto scutwn, rivestito interamente di cuoio ad eccezione di un foro centrale riservato all'umbone. Questo,per grandi linee,era una sorta di borchia bombata metallica, del diametro di unpalmo circa. convessa verso l’esternoe concavaall’interno,dove stava collocataunasbarra trasversale: l‘insieme servivaper

Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte
Quartu
380
consentire lapresa ergonomicaalla mano con assolutasicurezza efam. Diversi,tuttavia, i tipi di umboni,che potevano essere di ferro o di bronzo, di forma senriconica o semisferica, con o senza puntale, con flangia di raccordo più o meno ampia, ecc. Tanta varietà consente di riconoscere con accettabile approssimazione l‘epoca dello scudo e gli ambiti d‘impiego, sebbene nessun esemplare ci sia pervenuto intatto,o sostanzialmente inmtto, Per quanto se ne può dedurre dalle varie fonti letterarie ed iconiclrc, all‘epoca di Augusto compare un nuovo modello di scudo, che si diffuse in breve tempo all’intero esercito.La sua origine,ancora una volta.è forse celtica,dove risulta realizzatomediante ununico spesso strato di legno…Per quello romano.invece,gli strati sono diversi per cui: "Iintroduzionedi una curvatura laterale avrebbe necessitato del!introduzionedi unaprimitivaforma di compenf sato. Il tipo originario eracompostoda duestrati di legno incollati epoi coperti di tela e cuoio. mentre ledue ertremità,superiore e inferiore, erano anche bordate diferm. Gli scudi del tempo di Cesare eranoprobabilmente molto simili a quelloscoperto a Kasi: el Harit, in Egitto, noto come lo ‘Scutumdi Fayum ’. Questo esemplare, il solo del primo tipofinora scoperto, erafatto di tre strati distrisce dilegnoed eracopertodifeltro di lana... Comemoltiscudi ovali delperiodo, questocampione ha delle costolature o ‘spine'sulfionte, una caratteristica riscontrabile sui tipi romonifino allafine del I sec. a.C. Fuprobabilmente. durantelaseconda meta' diquel secolo che loscutum attraversòilprimo stadio dellasua evoluzione verso laforma semi-cllindrica.”“ Inpratica, gli vennero eliminate le curve superiore e inferiore,riducendone anche ilpeso complessivomediante l‘adozione di nervature e rinforzi interni.La forma dev finitiva e attinta intornoalla metàdellostesso secolo, restandopoi praticamente inalterato peri successive tre.Verosimilmenteoltre asiffatto modello,che si potrebbe definire quasi d’ordinanza,ne esi» stevano anche altri,soprattuttopresso i reparti ausiliari,di forma ovale,come cenifica inequivocabilmente la Colonna Traiana, Il fatto poi che nel tardo Impero sia stato adottato persino uno tondo, quasi un compro
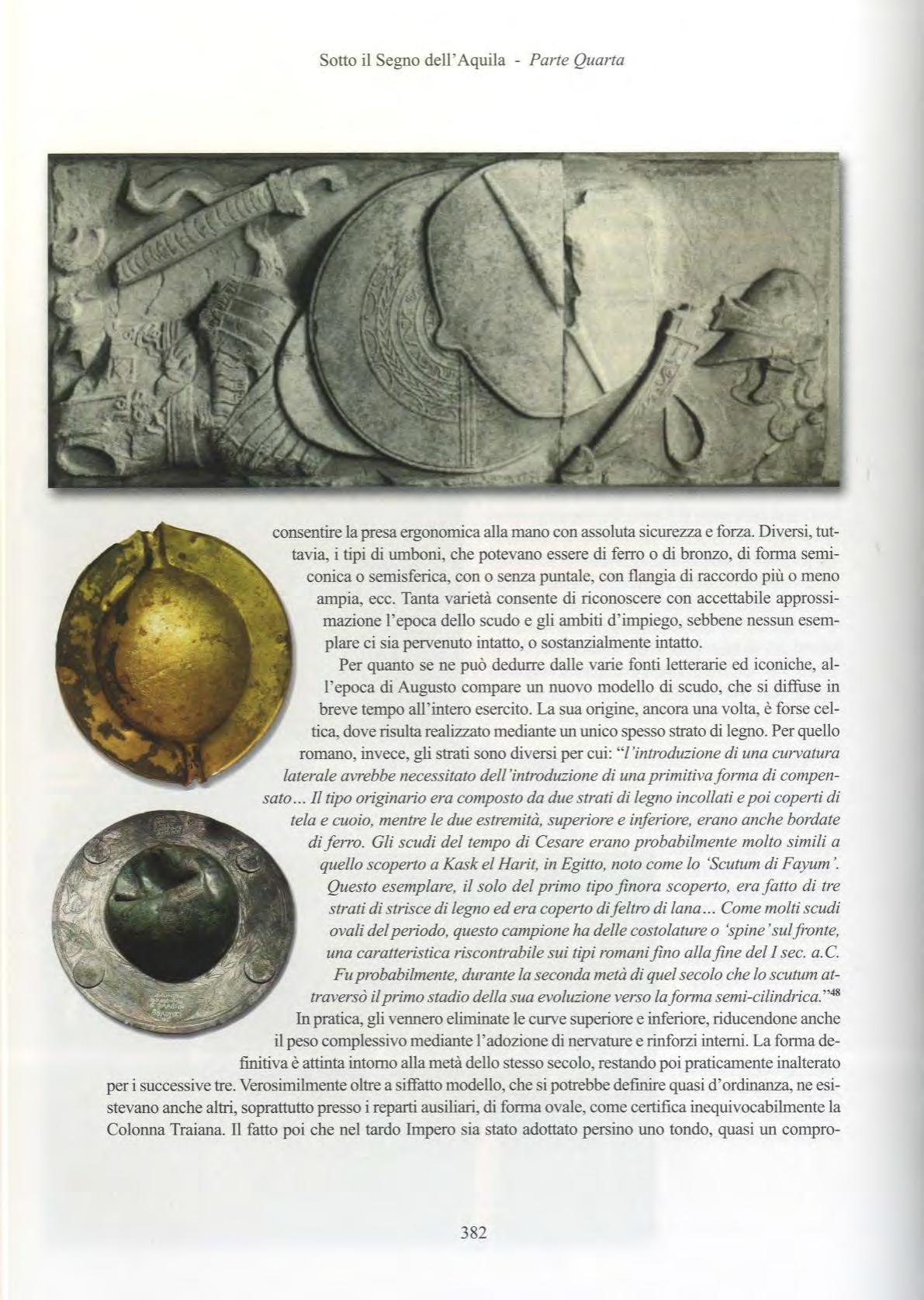
Sotto il Segno dell'Aquila - Parte Quarta
382
messo tra i due, sembra confermare che enn-ambipresentavano elementipositivi e nega— tivi da supemre. Pertanto:“quale che,/asse lo lorofot'nia.gli scudi al] 'in' 'odelprincipato firmw un largo impiegodi rinforzi metallici, a voltepcr legrande laterali eper laprotezione del] 'iinibone.Sullo scudo rettangolare questo pezzo centrale ha una forma semisferica, spessofissata su unapiastra di lamiera/atta aderire alla cun-amro dello scudo. L ‘esemplore più bello del genere, attualmente con— serrato presso il British Museum. è stato scoperto nelfiume Tyne; conserva [ ‘emblema (il loro) e ilnome incisodella Legio VIIIAu— gusta comepure il nome del suoproprieta’ rio... Gli uniboni degli scudi di questo tipo sono generalmenle più semplici, e qualche volta costituiti da una semplice gobbo semisferica fatta ade» rire; la curvaturapeculiare degli scudi legionari, in strati incol/ati in maniera inversa. permette perciò di distinguerli soltanto dal modello till/I.…..Hltî dagli a…iliari "49
Vainfine osservato che la superficie esterna degli scudi era coperta da uno spesso strato di pittura. formando delle raffigurazioni e delle scritte. variabili da reparto a reparto. Questa, chepotrebbe sembrare una mera concessione all'estetica.scaturiva invece.dalla necessità di proteggerli dalla acqua. Sottoposti.infatti.aforti piogge non solo i loro collanti cedevano, ma lo stesso legname si deformava.per giunta con unnotcvole incremento di peso. Nella foresta di Teutobirrgo.ad esempio i legionari di Varo.tlagellati da una micidiale tempesta d'acf qua… non potetiero più usarli. contribuendo così alla tragedia. In conclusione.si può generalizzare quanto appena delineato, ritenendo che lo scudo semicilindrico e stratificato fosse ti» pico dei legionari.mentre quello piatto ovale dei reparti ausiliari. Circa i rotondi. gli esagonali e di altre forme ancora, furono di pertinenza e d'impiego della cavalleria.
L’ARRHMENTO OFFENSIVO
L‘armamento offensivo rappresenta la componente primaria dell’equipaggiamento di ogni esercito. in qualsiasi contesto storico, essendo inultima analisi la ra— gion d‘essere. Come innanzi accennato,si può distinguere in armamento individuale e collettivo.per uso ravvicinato o da lancio,da punta, da taglio o contundenti.Ax endo già fornito una ampia descrizione delle anni collettive da lancio la gamma si riduce soltanto alle individuali, sia da lancio che per il combatti-
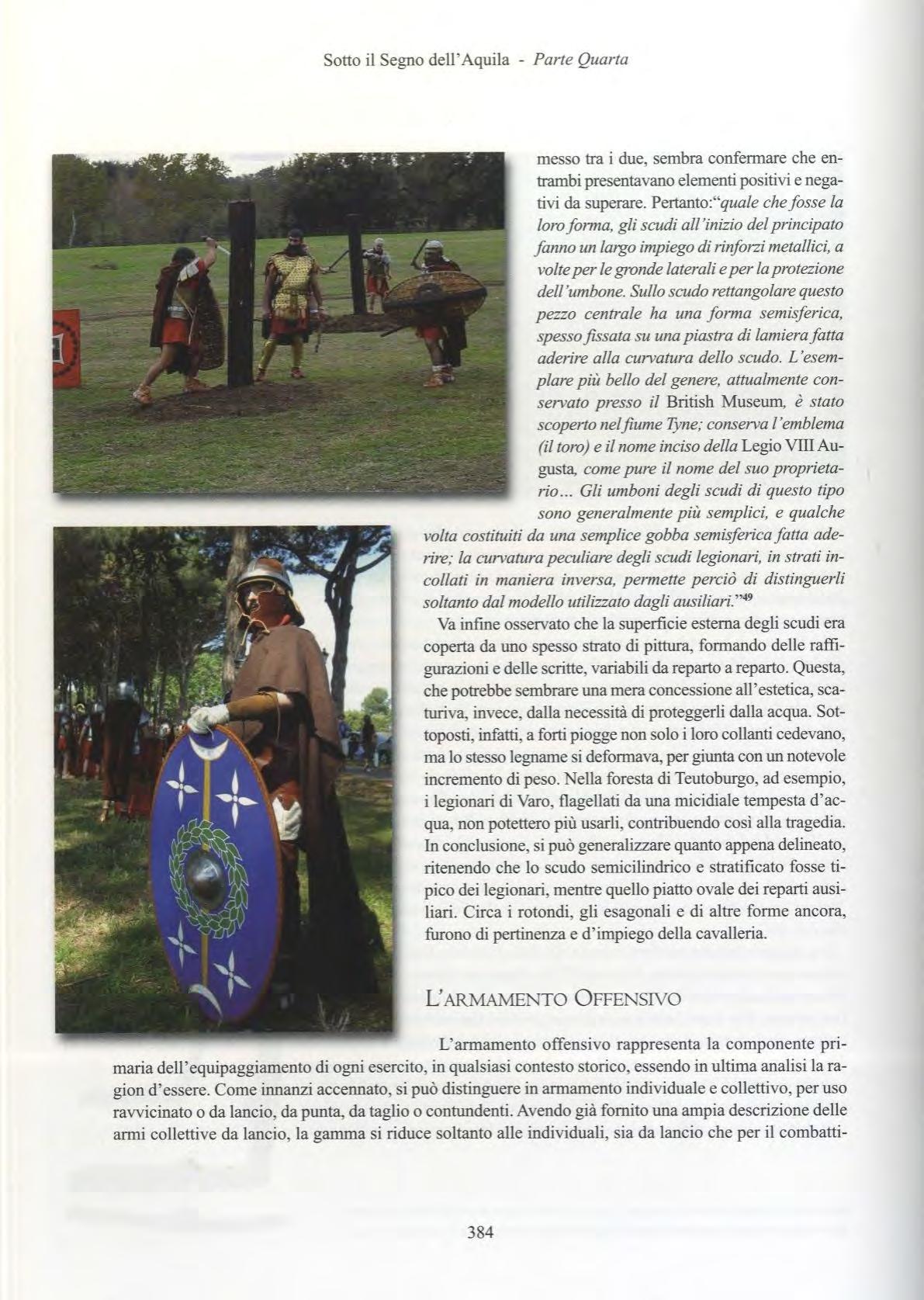
Sotto il Segno
dell'Aquila Par-tc Quarta
mento rawicinato, da punta o da taglio. Prendendo come criterio guida il loro raggio d'azione e ricordando che, sotto il profilo tecnico,per arma si intende quella che percuote direttamente l'avversario, cioè il proietto, e non già il suo propulsore. arco o cannone che sia,abbiamo il seguente ordine per quelle da lancio: giavellotto nei suoi diversi modelli. dardi. ghiande; e per quelle per scontro rawicinato: gladio. spada e pugnale. Poiche' del pilum come dell'harta ne sono già state tracciate delle dettagliate de— scrizioni, l’esposizione si riduce soltanto alle fionde ed agli archi.
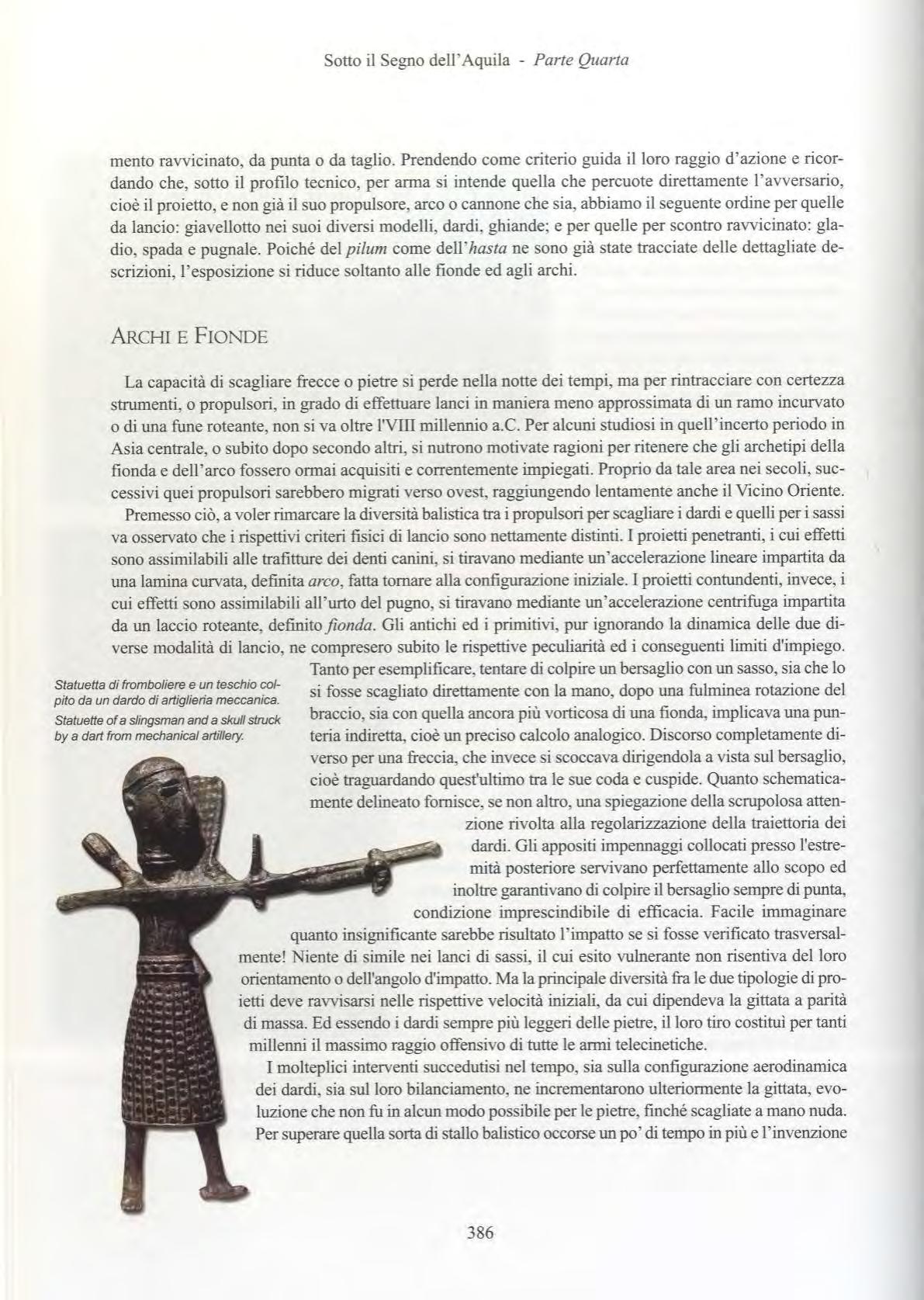
ARCHI EFIONDE
La capacinà di scagliare frecce o pietre si perde nella notte dei tempi.ma per rintracciare con certezza strumentiY o propulsori, ingrado di efi”ettuare lanci in maniera meno approssimata di un ramo incurvan o di unafune roteante, non si va oltre l'VIII millennio a.C.Per alcuni studiosi in quell’incerto periodo in Asia centrale, o subito dopo secondo altri,si nutrono motivate ragioni per ritenere che gli archetipi della fionda e dell’arcofossero ormai acquisiti e correntemente impiegati.Proprio da tale area nei secoli, successivi queipropulsori sarebbero migrati verso ovest.raggiungendo lentamente anche il VicinoOriente. Premesso ciò,a voler rimarcare ladiversità balistica traipropulsori per scagliare i dardi e quelli per i sassi va osservato che i rispettivi criteri fisici di lancio sono nettamente distinti. I proietti penetranti, i cui effetti sono assimilabili alle trafitture dei denti canini.si tiravano mediante un'accelerazione lineare impartita da una lamina curvata,definita arco,fatta tornare alla configurazione iniziale.I proietti contundenti, invece,i cui effetti sono assimilabili all’urto del pugno. si tiravano mediante un‘accelerazione centrifuga impartita da un laccio roteante, definitofionda. Gli antichi ed i primitivi. pur ignorando la dinamica delle due diverse modalità di lancio, ne compresero subito le rispettive peculiarità ed i conseguenti limiti d'impiego. Tantoper esemplificare,tentaredi colpire unbersaglioconun sasso,sia che lo Statuetta difmmbollere e un teschioDOIptto da un dardo diamg/leria meccanica Statuettaafsslingsmanandaskull … bya danimmmechanicalaru/lory…
si fosse scagliato direttamente con la mano, dopo una fulminea rotazione del braccio,sia con quella ancorapiù vorticosa di unafionda, implicavauna punteria indiretta.cioè unpreciso calcolo analogico.Discorso completamente diversoper unafreccia. che invece si scoccava dingendola a vistasul bersaglio. cioè traguardando quest‘ultimo tra le sue coda e cuspide. Quanto schematicamente delineatofornisce. se nonaltro.unaspiegazmne della sempolosa atten» zione rivolm alla regolarizzazione della traiettoria dei dardi. Gli appositi impennaggi collocati presso l'estre» mità posteriore servivano perfettamente allo scopo ed inoltregarantivano di colpire il bersaglio sempre dipunta. condizione imprescindibile di efficacia. Facile immaginare quanto insignificante sarebbe risultato l'impatto se si fosse verificato trasversal— mente! Niente di simile nei lanci di sassi, il cui esito vulnerante non risentiva del loro orientamentoodell'angolo d'impatto.Ma laprincipale diversitàfra le due tipologiedi pro» ietti deve ravvisarsi nelle rispettive velocità iniziali, da cui dipendeva la gittata a parità di massa. Ed essendo i dardi sempre più leggeri delle pietre. il loro tiro costituì per tanti millenni il massimo raggio offensivo di tutte le armi telecinetiche.
I molteplici interventi succedutisi nel tempo, sia sulla configurazione aerodinamica dei dardi. sia sul loro bilanciamento, ne incrementarono ulteriormente la gittata, evoluzione che nonfu inalcun modopossibile per le pietre, finche' scagliate a mano nuda, Per superare quellasorta di stallo balisticooccorseunpo‘ di tempo inpiù e l’invenzione
Sotto
il Segno dell‘Aquila - Parte Quarta
386
della fonda. Per cui. sebbene arco e fionda possano ritenersi in buona approssimazione coevi.ipotesi non suffragata da alcun riscontro materiale per l'assoluta degradabilità di qualsiasi loro esemplare… e siano ambedue capaci di scagliare unproietto di poche decine di grammi ad un centinaio di metri di distanza. il primo vantò cospicui perfezionamenti ed impieghi bellici preminenti rispetto allaseconda, la cui sola miglioria fu l'adozione di proietti di piombo a forma di mandorla, detti ghiande missili, sui quali non di rado era riponato il nome della legione che ne faceva uso.
Nonostante ciò i legionari Romani non si cimentarono mai direttamente né con il tiro con lafionda nè con quello con l'arco che l&ciarono ai reparti ausiliari specializzati, quali ad esempio i frombolieri delle Baleari o agli arcieri siriani. spesso con straordinari esiti tattici.
GLADIO
Anche il gladio. che può considerarsi l‘armaper antonomasia del legionario,ebbe una sua sensibile evo» luzione tra l’etàrepubblicana e quella imperiale…Curiosamentegli esemplari rinvenuti sono fin troppo rari. per una lamaprodotta incentinaiadimigliaia di esemplari e.oosaancor più significativa.nellepopolose città di Ercolano e di Pompei ne sono stati trovati appenaunpaio di esemplari.Le sue caratteristiche fondamentali possono sintetizzarsi con lalunghezzadella lama dell'ordine della sessantina di centimetri e la larghezza di circa V….conunapunta acuminata e duefili laterali discretamente taglienti.Anna, comunque,dapunta. come l’addestramento del legionari continuamente abitrrava e VegezioRenato Flavio continuava a ripetere, inquesti termini:“lereclute, inparticolare, venivanoaddestrate«colpire dipunta anziché di taglia, tecnica questa con la quale i Romani non solo sconfissero agevolmente i nemici. ma li dileggiavano.
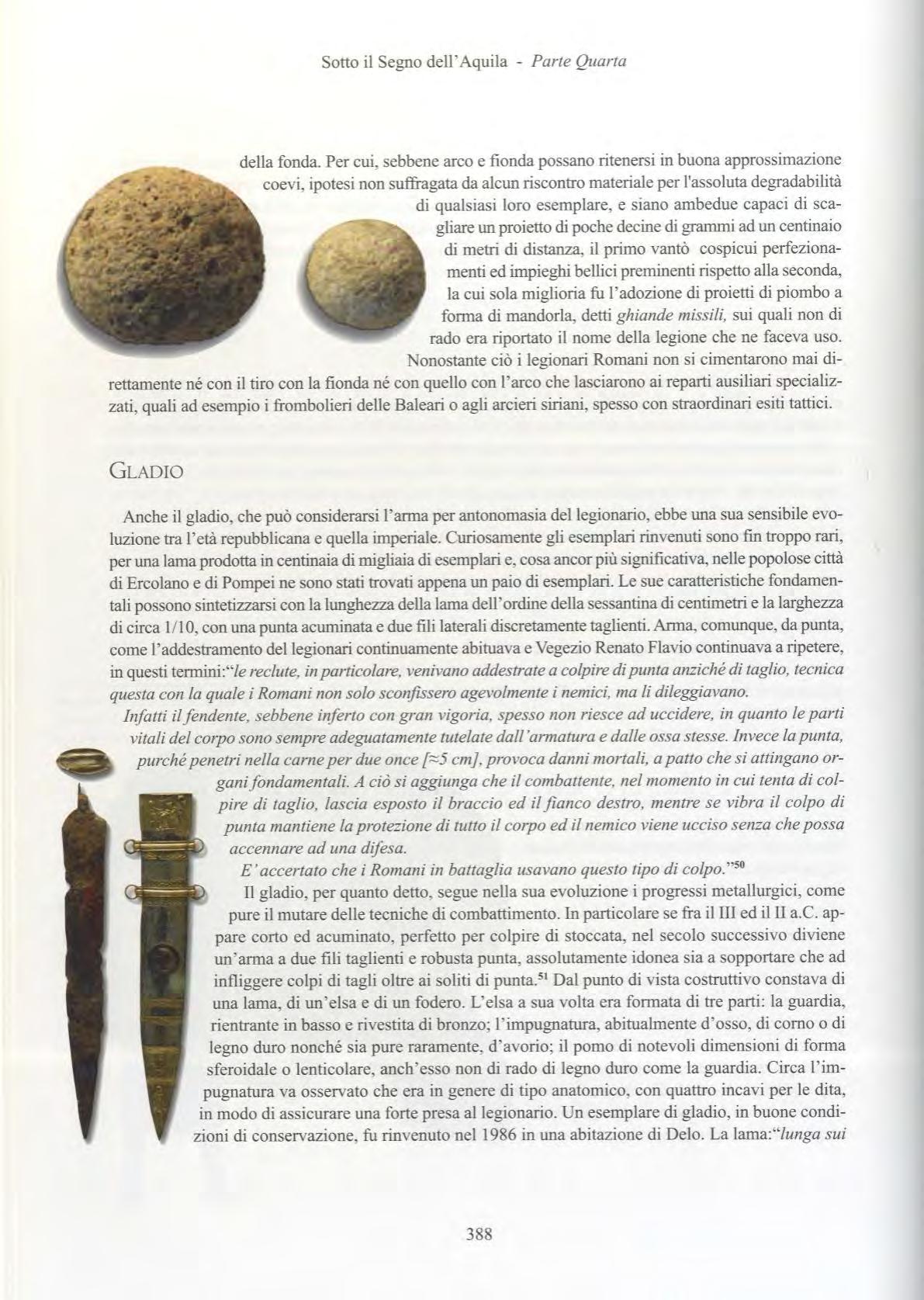
Infatti ilfendente, sebbene inferto con gran vigoi'i’a, spesso non riesce ad uccidere, in quanto leparti vitali del corposono sempre adeguatamente tutelatedal! 'annaturaedalle ossastesse. Invece lapunta, purche' penetri nella carneper due once [:5 cm].provoca danni mortali, ::patto che si attingana organi ’ " A ciòsi cheil L nel in cui tenta di col» pile di taglio. lascia esposto il braccio ed ilfianco destro, mentre se vibra il colpo di punta man/iene laprotezione di tutto il corpo ed il nemico viene ucciso senza chepossa accennare ad una difesa.
E 'accertaloche iRomani in battaglia usavano questo tipo di colpo.““
Il gladio, per quanto detto, segue nella sua evoluzione i progressi metallurgici, come pure il mutare delle tecnichedi combattimento. In particolare se fra il III ed il Il a.C, appare corto ed acuminato, perfetto per colpire di stoccata. nel secolo successivo diviene un’arma a due fili taglienti e robusta punta, assolutamente idonea sia a sopportare che ad infliggere colpi di tagli oltre ai soliti di punta}1 Dal punto di vista costruttivo constava di una lama,di un’elsa e di unfodero. L'elsa a sua volta era formata di tre parti: la guardia, rientrante in basso e rivestita di bronzo; l‘impugnatura.abitualmente d'osso, di como o di legno duro nonché sia pure raramente. d'avorio; il pomo di notevoli dimensioni di forma sferoidale o lenticolare, anch’esso non di rado di legno duro come la gnrardia, Circa l’impugnatura va osservato che era in genere di tipo anatomico. con quattro incavi per le dita, in modo di assicurare una forte presa al legionario. Unesemplare di gladio, in buone condi— zioni di conservazione.fu rinvenuto nel 1986 in una abitazione di Delo. La lamaz“lunga sui
Sotto
il Segno dell'Aquila - Parte Quarta
388 l
76 cm, appare tura/ler sata da una lungapunta acuminata @ [la tlttefi/i taglientiparalleli.‘ nulla resta del! impugnatura, senza dubbio di legno ('u/tte ilpoma, al] "innestadel quale si conservano ancora sette rivetti diferro. Questa spazio. al momento del suo abbandono, \'i trovava in nnfodero di cuoio teso tra due [tordini diferro arrotonda/t '.mantenuti a distanza da due barrette trasversa/t dijo/'r!) Pur non (" S€llll'05l trovato alcun clemenza di catenella. il sistenza di sospensione e sicuramente consentiti): tons s‘teva in quattro anellifissati sulle due barrette trasversali nellaparte superiore delfoderu.“51
Agli anelli facevano capo due cinghie biforcute.fissate al cinturone.detto propriamente eingulum nnlt'iare. Questo,che in origine servita per distribuire il peso della corazza sui fianchi. divenne il supporto della spada e del pugnale ma anche di un alrro elemento. dalle funzioni blandamente protettive: il cin; clarium. Si trattava di una sorta di frangia a strisce. ciascuna delle quali sorreggente un certo nutnero di dischetti metallici. La sua lunghezza non eccede\'a quella del gonnellino. quanto alla larghezza si limitava al massimo ad unpalmo.
Altre lame lunghe circa 76-75 cm sono state ritrovate negli ultimi anni. ma sempre in condizioni di con» servazione non ideali. confermando. in sostanza. le caratteristiche del gladio innanzi descritto. In conclusione il gladio si evolve dalla riforma di Mario all'età di Augusto accordandosi. con un progressivo ridursi della sua lunghezza e con una minore acutezza della punta.
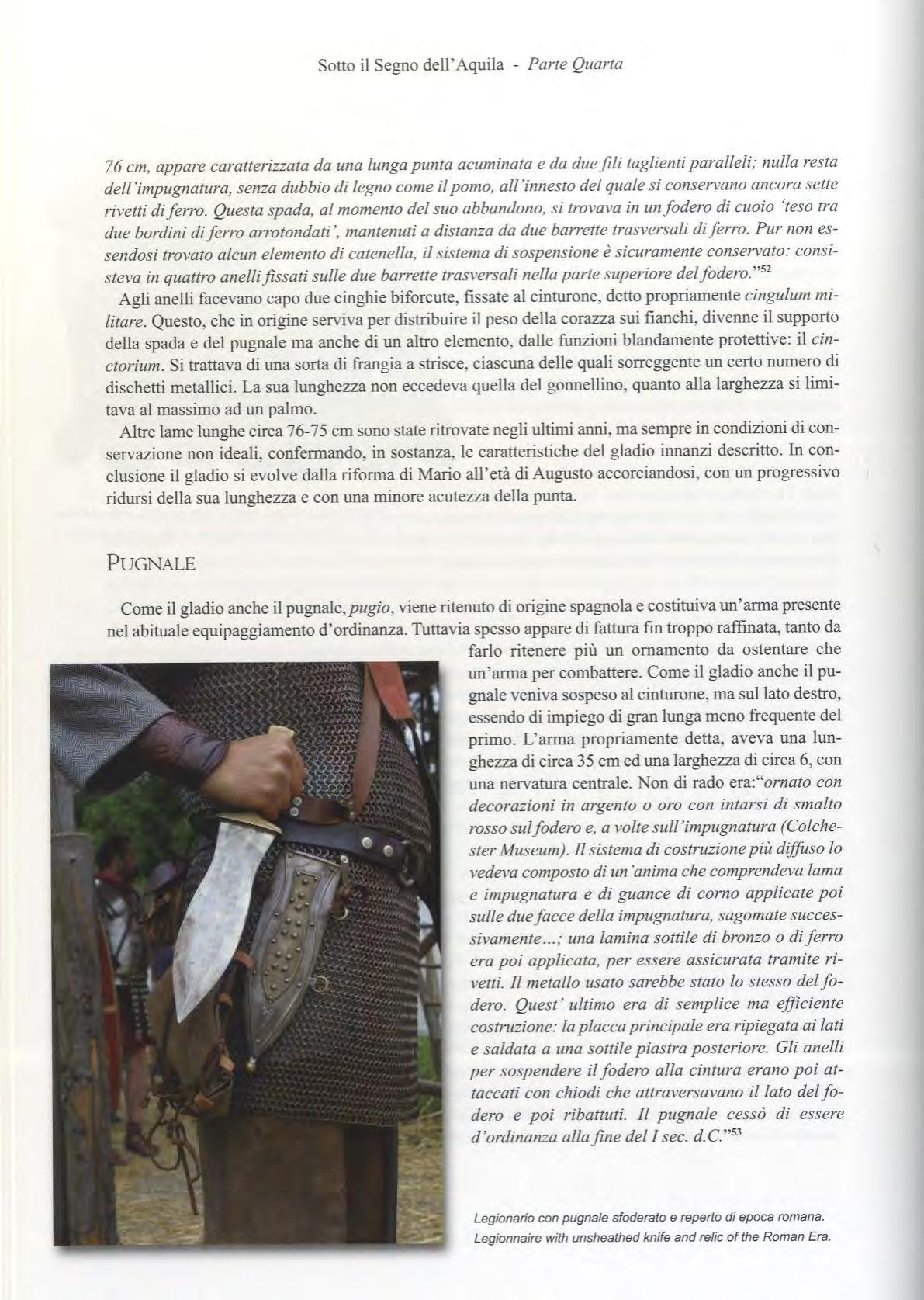
PUGNALE
Come il gladio anche il pugnale. pugiu. viene ritenuto di origine spagnola e costituivaun‘arma presente nel abituale equipaggiamento d‘ordinanza. Tuttavia spesso appare di fattura fm troppo raffinata. tanto da farlo ritenere più un ornamento da ostentare che un‘arma per combattere. Come il gladio anche il pu» gnale veniva sospeso al cinturone,ma sul lato destro, essendo di impiego di gran lunga meno frequente del primo. L'arma propriamente detta. aveva una lunghezza di circa 35 cm ed una larghezza di circa 6,con una nervatura centrale. Non di rado era:“ornata con decorazioni in argento o oro con intarsi di smalto l'ossoSUL/bdel‘n e, a volte sul! impugnatura (Co/chester Museum). !!sistema di costruzionepiù difliisu lo vedeva composta dt un 'animache comprendeva lama e impugnativa e di guance di Corna applicate poi sulle due/acea della impugnatura, sagomate successivamente...; una lamina sottile di bronzo a diferro era poi applicata, per essere assicurato tramite rivetti… ]] metallo usalo sarebbe stato la stessa delftr daro. Quest' ultima era di semplice ma efficiente castri ione: laplacca principale era ripiegata ai lati e saldata a una sottile piastra posteriore. Gli anelli per sospendere ilfodero alla cintura eranopai air Meran con chiodi che attraversavano il lato tic/fatiero e poi ribatttiti. Il pugnale cessò di essere d'ordinanza alla/ine del Isee. d.C."
Legionano conpugnale sfoderato e reperto w epoca romana. Legionnaife with unsneathed knile andfel”: of theRoman Era
Sotto Il Segno dell" Aquila Parte Qu…-ln
ARRUOLAMENTO E SELEZIONE
Le operazioni di leva che in epocaarcaica erano in sostanza automatiche.grazie anche al loroforte pre» stigio, in epoca imperiale iniziano ad essere subite con crescente repulsione. specialmente presso gli al» leati. La leva, che i Romani definirono dilectus, avveniva in ciascuna provincia tramite un apposito firnzionario, di alto livello gerarchico, inviatovi dall‘imperatore,detto a sua volta dilectatar, che in alcuni casi venne rimosso dal prestigioso compito per manifesta comrzione. In epoca più recente la mansione era svolta abitualmente dal governatore della stessa provincia, indipendentemente dal suo rango sia che fosse procuratore, legato imperiale,propretore o proconsole. Nel corso della missione una imponente scorta accompagnava il funzionario. sebbene accurate ricerche dimostrino che il contingente di reclute prelevato fosse abbastanza esiguo. Una legione, ad esempio, richiedeva un avvicendamento annuo di circa250 giovani che,tenendoconto del numero delle legioni.porta apoco più di 6.000 quelli da arruolare in tutto l’impero.Considerando,inoltre,che l‘entità degli ausiliari èpari a quella dei legionari,e quindi anche la loro ' di av v' ’ ‘ l‘entità ‘ '…sale al a 12.000: J tuale cifra anche con le coeve esigenze della guarnigione di Roma e della flotta. non si raggiungono i 20.000 uomini! Organicoda trarre dall’intero bacino del Mediterraneo, che verosimilmente all’epoca non era lontano dall’avere unapopolazione complessivadi uncentinaio di milioni di abitanti,base demografica tal— mente ampia da non dover creare alcuna difficoltà.
Più significativa,se mai, l‘insufficienmdei volontari.che,invece,avrebbero dovutofornire persino un gettito eccedente il bisogno,date lepotenzialità di carriera ed i crescenti compensi garantiti. Le motivazioni di tale ritrosia devono,pertanto, individuarsi in una altra caratteristica del sistema di leva romano: laforte selezione, effettuata dal consiglio di revisione,propriamente dettoprobatio.
In pratica all‘armolando,di età compresafra i 17 ed i 20 anni,è richiesta una sana e robusta costituzione, una discreta altezza, comunque non inferiore a tu 1.65 per i legionari e poco meno per gli ausiliari, e deve inoltre conoscere in maniera sia pure rudimentale, il latino,dimostrando in vari casi di saper leggere e scrivere. Niente di .. " io, ’ l’odiemo r o di v ‘ me ma considerando che in Italia, ancora nel 1861 , circa il 72%della popolazione maschile adulta e l’84% della femminile era analfabeta, con notevoli tare fisiche dovute a scarsa e scadente alimentazione. quelle richieste si confermano fortemente discriminanti… Viera,poi, un ulteriore vaglio costituito dall’origine sociale, che doveva essere non solo sicuramente libera, essendo punito con la morte lo schiavo che avesse tentato di arruolarsi, ma anche di discreto livello per i non romani. Il tutto finiva per ridurre a tal punto il gettito che non di rado già Augusto dovette far ricorso ad elementi non arruolabili in condizioni normali, come ad esempio i liberti. In dettaglio ciò avvennez“la prima volta, per proteggere le colonie vicine all ’Illirico,la seconda volta per proteggere la riva (sinistra) del Reno; erano schiavi chepersone ricche di ambo i sessi dave/terofornire, ma egli lifece affiancare sul campo e li dispose inprima linea, senza però mescolarli con i soldati di nascita libera e senza dar loro lestesse armi”“
Unavolta superata la selezione la recluta, detta tiro, non era considerata per questo un militare nella pienezza del temine.Per divenire tale a tutti gli effetti,doveva essere iscritta in una apposita lista,doveva ricevere il signaticum, una sorta di piastrina di riconoscimento formata da una lastrina di metallo che una fune manteneva intorno al collo,ed infine doveva prestare giuramento sugli dei e sull’imperatore di servire fedelmente. Unaprocedura di selezione più stringente riguardava l'arruolamento dei cen— turioni.e dei primipili inparticolare. La condizione che sembra determinante,almeno nell‘Alto Impero, e l’origine italica e quandonel Il secolo lasituazione muta afavore dell‘origine provinciale. ciò si ascrive ai vuoti lasciati nelle legioni dagli italici attratti in gran numero nella guarnigione di Roma. Del resto se
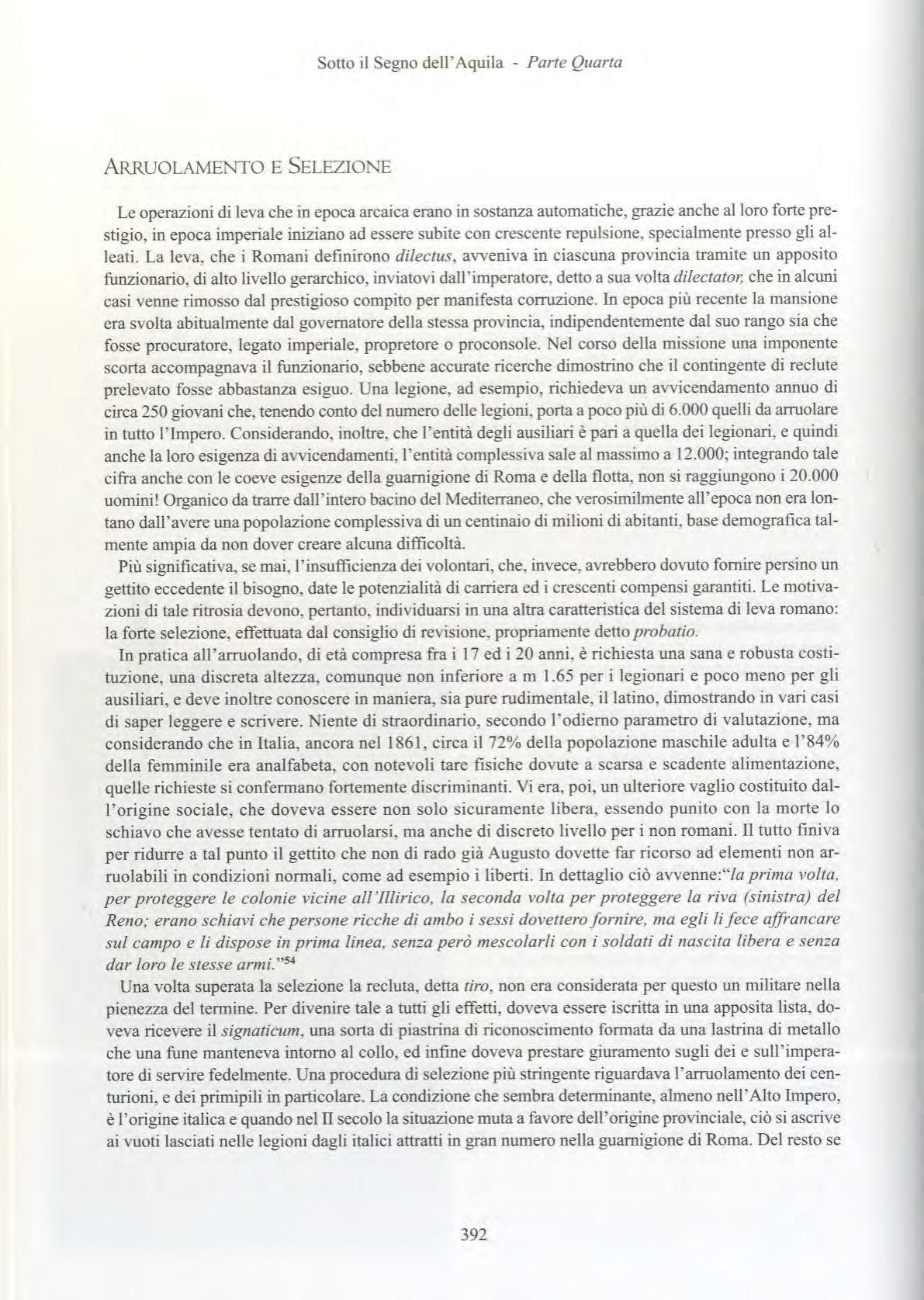
Sotto il Segno dell’Aquila - Parte
Quarta
392
in Occidente il I secolo vede preminente l‘entitàdei coscritti italici in Oriente vede. invece, ribaltarsi la situazione afavore di quelli di lingua greca, premessa e spinta verso il reclutamento locale.Pertanto sia che si parli di centurioni che di legionari ll secolo d.C… e quello degli stranieri? in generale, i reclutatori hanno d17"colta a trovare uomini;poche province si rivelano capaci di trovare nelleproprie/ile i propri difensori, e comunque sembra normale al potere politico procedere a un certo rimescolamento dellepopolazioni. Ma bisognafizre distinzionefra ledue metà del bacinodel Mediler1aneo. In Occidente, cioè nellaparte dell 'lrnperoin cui riparla latino,prevalgono gli Italici, salvo gli originari del Lazio, dell'Etruria, dell Umbriae delle vecchie colonie chepreferiscono armo/arsi nelle coortipretoriane e ur— bane… Nella parte orientale dell ’Impero,quella in cui la lingua della amministrazione è il greco, la rimozione è diversa: nel I secolo, i soldatiprovengano normalmente da questa metà del bacino mediterraneo;vengono indicati come ‘Drientali’.Eapartire da!!'epocadiAugusta- anchese raramente,per la verità -comincia ad esserepraticato il reclutamento locale/55
Vaosservato che il prevalere del gettito umano della parte orientale dell’Impero è strettamente connesso con la maggiore natalità che in essa si verifica, mentre per contro si assiste ad una progressiva contrazione della stessa in Occidente. Le ragioni ipotizzate per il vistoso squilibrio sembrano essere state molteplici,prima fra tutte il forte sviluppo della romanizzazione in alcune province periferiche, con una intensavoglia di entrare a pieno titolonell‘impero,potenzialità garantita pienamente dalla car» riera militare.
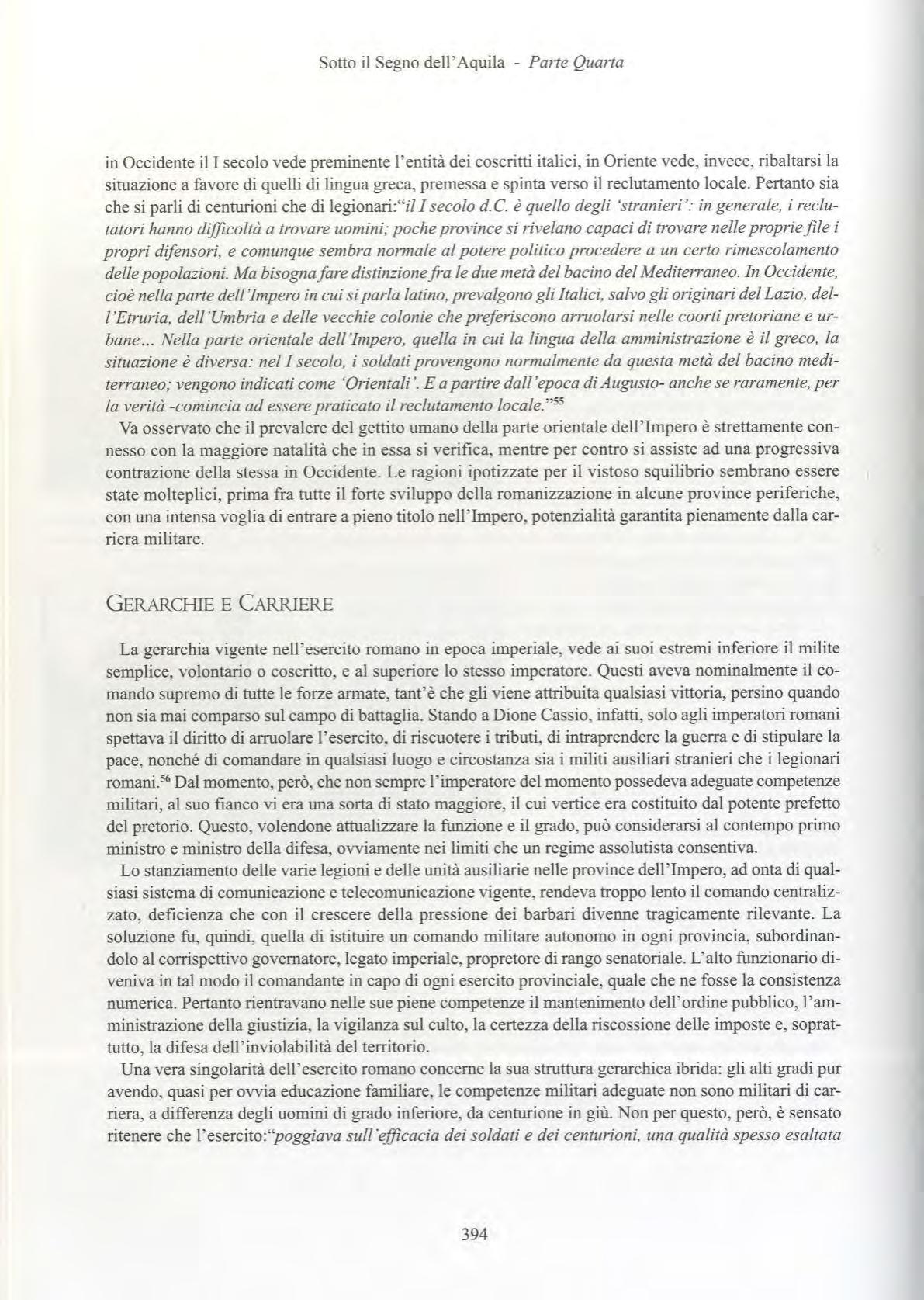
GERARCHIE ECARRIERE
La gerarchia vigente nell‘esercito romano in epoca imperiale, vede ai suoi estremi inferiore il milite semplice, volontario o coscritto, e al superiore lo stesso imperatore. Questi aveva nominalmente il comando supremo di tutte leforze armate, tant’è che gli viene attribuita qualsiasi vittoria,persiste quando non sia mai comparso sul campo di battaglia… Stando a Dione Cassio,infatti,solo agli imperatori romani spettava il diritto di arruolare l’esercito,di i' i tributi,di , la guerra e di ‘ la pace, nonché di comandarern qualsiasi luogo e circostanza sia i militi ausiliari stranieri chei legionari romani.“Dal momento,però, che non semprel' , del ’ militari, al suo fianco vi era una sortadi stato maggiore, il cui vertice era costituito dal potente prefetto del pretorio. Questo, ‘ 4 la e il grado, può " al r primo ministro e ministro della difesa, ovviamente nei limiti che un regime assolutista consentiva…
Lo stanziamento delle varie legioni e delle unitàausiliarie nelleprovince dell‘Impero,ad onta di qualsiasi sistema di comunicazione e telecomunicazionevigente,rendeva troppo lento il comando centralizzato, deficienza che con il crescere della pressione dei barbari divenne tragicamente rilevante. La soluzione fu, quindi, quella di istituire un comando militare autonomo in ogni provincia, subordinan» dolo al corrispettivo governatore, legato imperiale,propretore di rangosenatoriale.L’alto fimzionario diveniva in tal modo il comandante in capo di ogni esercitoprovinciale, quale che ne fosse la consistenza numerica.Pertanto rientravano nelle sue piene competenze il mantenimento dell'ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia, la vigilanza sul culto,la certezza della riscossione delle imposte e,soprattutto, la difesa dell’inviolabilità del territorio…
Unavera singolarità dell’esercito romano concerne la sua struttura gerarchica ibrida: gli alti gradi pur avendo, quasi per ovvia educazione familiare, le competenze militari adeguate non sono militari di carriera, a differenza degli uomini di grado inferiore,da centurione ingiù… Non per questo,però, è sensato ritenere che l‘esercitoz‘poggiwa sull 'efiìcaciadei soldati e dei centurioni, una qualita' spesso esaltata
Sotto il
Segno dell'Aquila - Parte Quarta
394
one alla mediocrità dei quadri superiori, che sarebbero stati invece dei dilettanti inf
in contrappo competenti; le Vittoriesarebbero state conseguite dalla truppa, in un certo senso nonostante lapresenza dei superiori. E'uncliché.questo. che in respinta. Ognifigliodi senatore a di cavalierepossedeva nella sua biblioteca trattati consacra/i all ‘ortedella guerra. e si dedicava regolarmente al! 'esercizio:queste letture e questa praticafizcevano parte dell 'educazione impartita a un giovane di buonafamiglia. Siccome la tecnica militare del tempo non presentava una complessità eccessiva,poche settimane di tirocinio nel comando effettivo bastavanoper assimilare !'essenziale ”
Più in basso. 'l comando di una singola legione era affidato ad un altro legato imperiale propretore, Legatus Legionis, posto agli ordini del govematore. Quando la legione era unica, le due cariche coin— cidevano nello stesso funzionario. Il titolo era stato utilizzato da Giulio Cesare per designare gli ufficiali posti a capo di ciascuna legione e solo sotto Augusto. divenne una carica riconosciuta dalle istruzioni e stabile nel tempo. Dal punto di vista pratico i legati erano scelti fra i fiduciari dell’imperatore e quindi fra le file degli ex questori. Una prestazione gadita al sovrano, costituiva una pre— messa per aspirare alla carica di console o governatore provinciale. L‘incarico di Legatus Legionis durava mediamente due otre anni e contemplava il buon andamento della vita della legione e delle re— lative unità ausiliarie. con una costante sorveglianza sulla disciplina e sulle esercitazioni.Allo scopo il funzionario godeva di una discreta autonomia economica e giudiziaria, ritagliata a similitudine di quella del suo diretto superiore. immediatamente a lui sottoposto, e secondo nella gerarchia della legione, risulta il Tribunus Latielavius. la cui strana denominazione gli deriva dalla larga fascia rossa che gli ornava il bordo della toga, in modo da ricordarne la dignità senatoriale. Al suo fianco una sorta di piccolo stato maggiore, che lo assisteva nel suo ruolo di consigliere. Disponeva di poteri militari e giudiziari e vigilava sull’espletazione delle esercitazioni,Abitualmente era molto giovane. intorno alla ventina d‘anni, ma non per questo veniva esentato dal ricoprire ruoli rilevanti in caso di mancanza del legato,assenza che non di rado andava ascritta alla sua perdita in combattimento: in tal caso assumeva il titolo di tribunusprolegoto.
Terzo nell'ordine gerarchico il prefetto del campo,Praefectus Castrorum, al quale era affidato il controllo delle .… ' ‘ ’dell' e,per ’ ' ‘ tecnica di la " degli investimenti ossidionali nel corsodelle campagne.Sempre alla sua responsabilità era delegata la scelta dei siti dove impiantare il campo,quale che ne fosse la tipologia, la sua fortificazione ed ancora la gestione dell‘ordine di marcia, dei carriaggi e delle artiglierie. che comandava pure in fase di scontro campale o di assedio. Per la rilevanza del grado era sempre presente alle decisioni dello stato maggiore del legato.Alle spalle di tale carica almeno tre tribunati a Roma e un trascorso di primipilo. distinzioni che per alcuni studiosi bastavano di fatto a garantire l’immissione all ’ordineequestre.
Segrivano cinque tribuni angusticlavi. Tribuni Angustielavi, denominazione tratta dalla stretta fascia rossa che omava il bordo della loro toga per ricordarne l’appartenenza all’ordine equestre,sebbene di rango inferiore.Da ciascun tribuno, durante labattaglia,dipendevano due cooni pari a circa 1000 uomini.Anche loro partecipavano alle riunioni dello stato maggiore legionario e presiedevano alle esercitazioni; controllavano inoltre gli approwigionamenti alimentari, amministravano la girmtizia e ispezionavano l’ospedale da campo. Oltre ai gradi suddetti le fonti ce ne hanno tramandati alcuni altri, meno usuali e duraturi la cui marginalità giustifica la non esposizione.
Affrescopompe/ano rafiîgurante :!tipica Volume/7deitrattati. Nellapagina afianco centurioneminanoed uninsegnacon l'immaginedell'imperatore Pompeianfresco depicting the typicalvolumenof treatises
Nextpage: Roman centurion and insigniawith theImage of theemparor
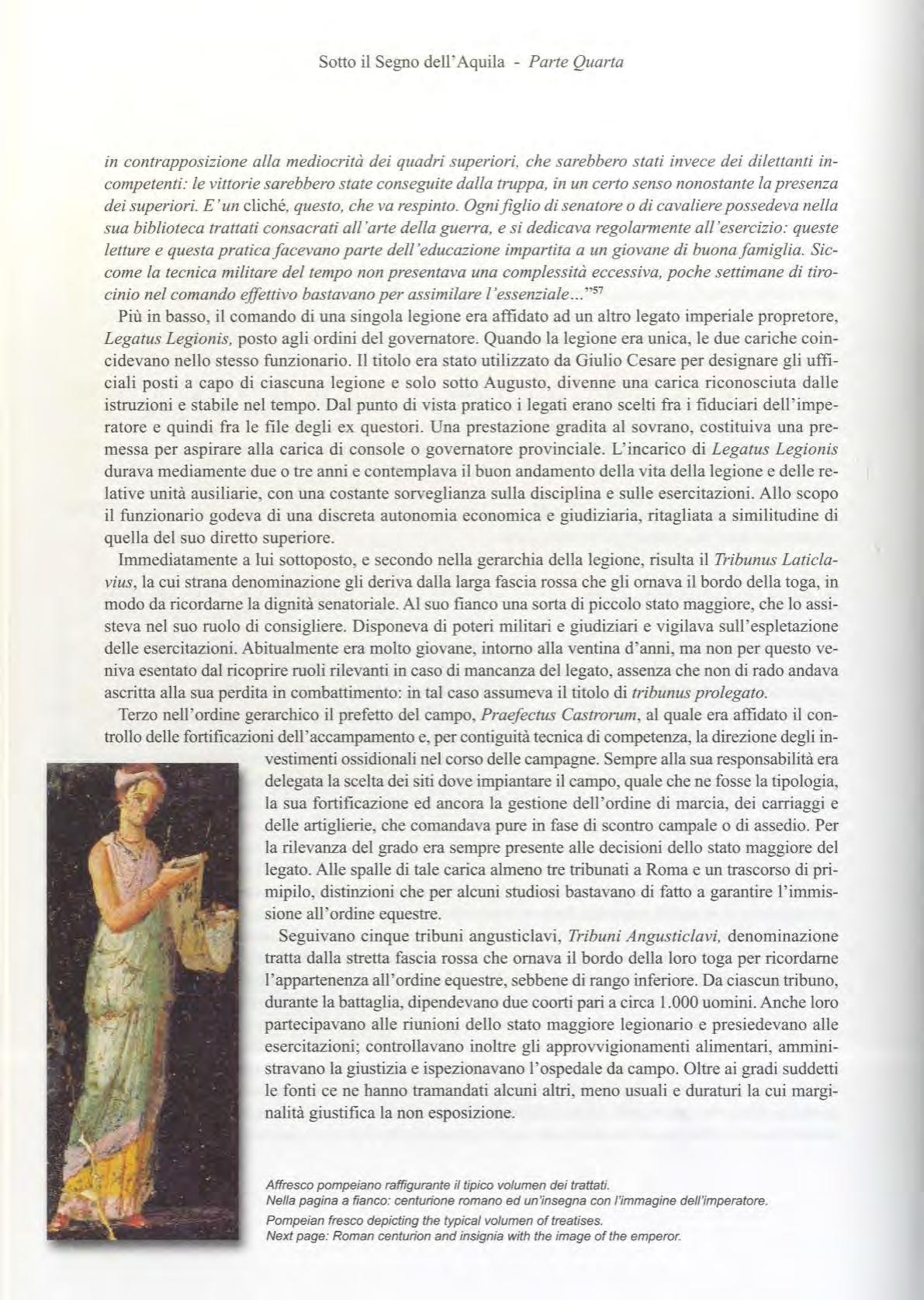
Sotto il Segno dell'Aquila
Parre Quarta
Quanto alle flotte pretorio, che di marina daguerra èper lomeno improprioparlare, erano subordinate ad altrettanti prefetti, di ordine equestre,dei quali quello di Miseno veniva ritenuto preminente. Percepivano ben 100.000sesterzi annui nel I secolo,portati a 200.000 nel successivo.Alle loro dipendenze un sottoprefetto e un capo arsenale, con 60.000 sesterzi annui. Quanto ai prefetti delle flotte in Germania, inBritannia e in altre province, ne percepivano soltanto la metà.
Venendoai militari di carriera propriamente detti, da nonconfondere con gli attuali sottufficiali, avevano come vertice gerarchico il grado di centurione.Ogni coorte,essendocompostadi sei centurie aveva perciò altrettanti centurioni mafra loro non vi era unapari rilevanza. La loro dignità, infatti, implicava nell’ordine ilpilus prior, princeps prior, hastalraprior; pilar posterior, princeps posterior; hostaMposteriar. Nella prima coorte che aveva organico doppio, al posto delpilus prior, si trova ilprimus pilar, che partecipava alle riunioni dello stato maggiore legionario,comandando oltre alla sua centuria anche l’intera coorte.
Ogni centurione,che nellapratica era coadiuvato da una sorta di assistente,optio, prestava servizio non meno di una ventina d’anni ed accedeva al grado o per evidente valore sul campo, o perche' già graduato e quindi secondo una sorta di avanzamento di carriera, comunque lento.Il vertice del centu— rionato, ilprimus pilar, apriva ampie possibilità ulteriori di criniera che andavano dalla prefettura del campo,al comandodi unaunità ausiliaria o,addirittura, di unaunitàdellaguarnigione di Roma. Quanto ai legionari, che a prima vista sembrano militi indistinti in quanto tutti di pari livello,avevano in realtà anche al loro interno una discreta diversificazione. Grazie a Vegeziodisponiamo di un puntuale spaccato della situazione durante l’Alto Impero, cosi delineataz“Gli oquiliferi egli immagint‘ferisono quelli cheportano le aquile ele ' ' "dell’" ,, , gli ' sono dei ' 'diuffivialipiù elevati, che se li associano con una specie di adozioneperché/Moiano le loro veci in caso di malattia o di assenza; iporta-insegne sono quelli cheportano le insegne e che oggi si chiamano droganori. Si chiamano tesserari quelli cheportano laparola o gli ordini alle camerate; quelli che combattono alla testa delle legioni sono chiamati anche campigeni,perche', per cosi dire,fanno nascere nel campo la disciplina e il valore e con !'esernpiache danno. Do meta, limite,prendono nome i memtores, quelli cheprecedono I ’esercitaper tracciare i confini del campo; bcneficiarii sono quelli
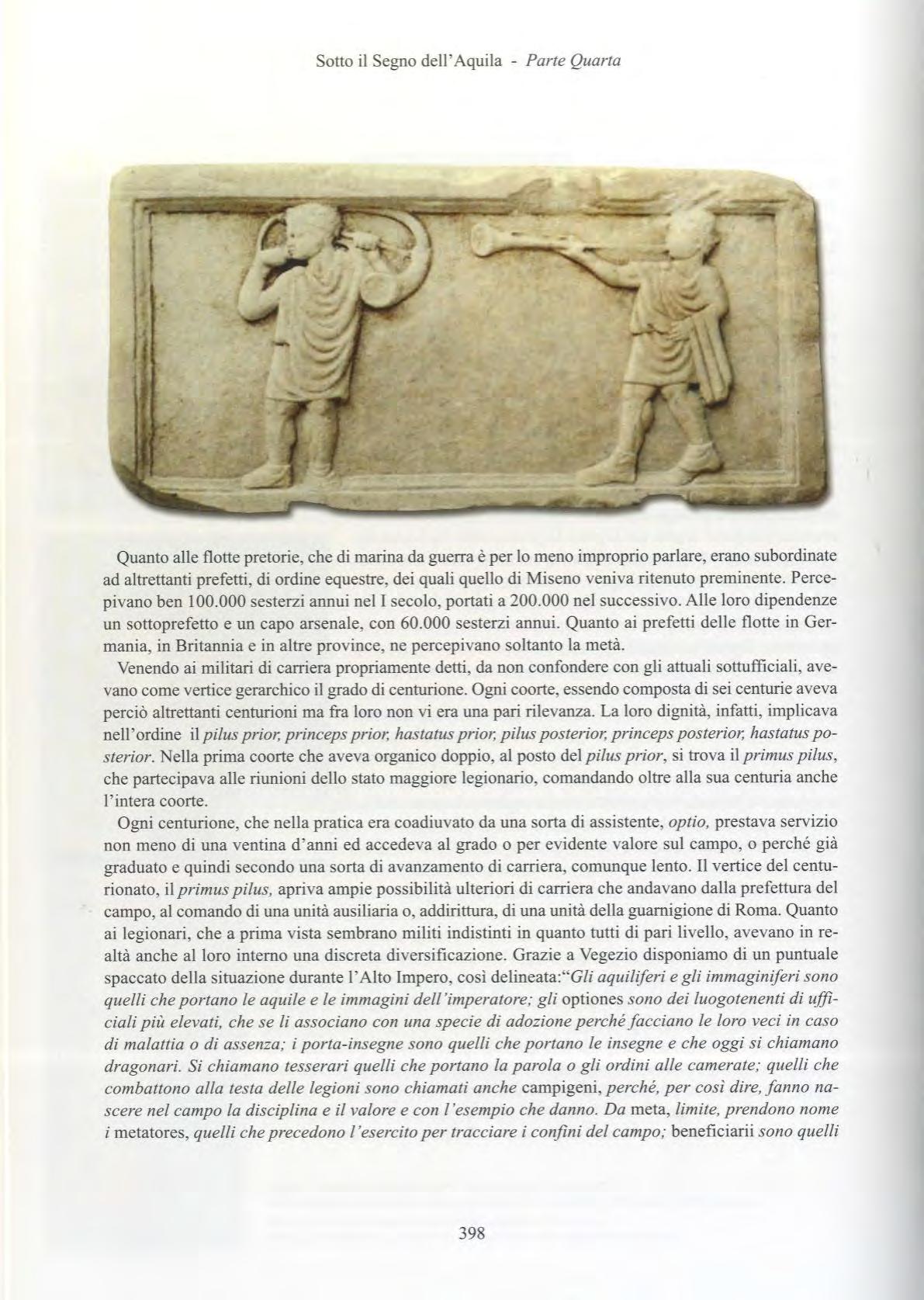
Sotto il Segno dell’Aquila - Parte Quarta
398
che salgono a questo grado per tlfavore dei tribuni; da liber.prete dono nome i librarìii, quelli che registrano tutti i dettagli che riguardano la legione; da tuba.tromba, da biccina (sic), corno, da comu. cornetta. prendono nome quelli che si servono di questi diversi sirmenti, tubicines. buecinatores (sie , comicincs. Si chiamano armaturae duplares, i soldati abili nella Scherma e che hanno due r 'oni,e armaturae simplares. quelli che ne hanno una sola: si chiamano mensores quelli che per ogni camerata misurano lo spazio destinato ad alzawz' la tenda, a segnano ]‘alloggiamentonelle città... C 'eranoanche. in rapporto alle razioni, candidati doppi e candidati Semplici: essi erano in attesa di avanzamento.
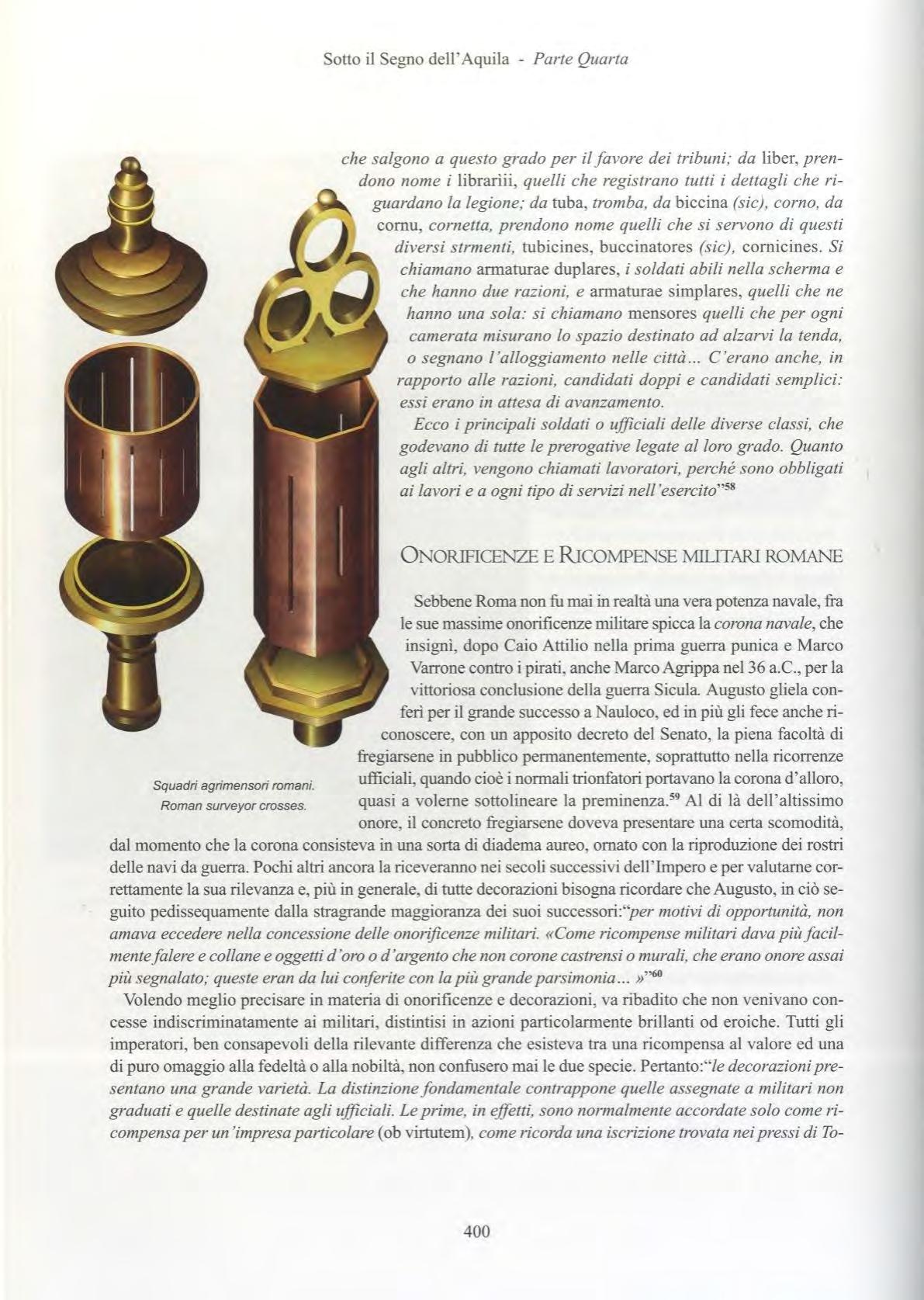
Ecco iprincipali saldati o ufficiali delle diverse cla. i, che godevano di tune leprerogative legate al loro grado. Quanto agli altri, vengono chiamati lavoratori,perché .rnnn obbligati ai lavori e a ogni tipo di Servizi nell 'e…rerciîo"ss
ONORIFICENZEERICOMPENSEMILITARI ROMANE
Sebbene Roma non fu mai in realtà unaverapotenza navale.fi'a lesue massime onorificenze militare spicca lacoronanavale,che insigni. dopo Caio Attilio nella prima guerra punica e Marco Varronecontro i pirati. anche Marco Agrippa nel 36 a.C.,per la vittoriosa conclusione della guerra Sicula Augisto gliela conferì per il grande successo a Nauloco, ed inpiù gli fece anche riconoscere, con un apposito decreto del Senato, la piena facoltà di fregiarsene inpubblico permanentemente. soprattutto nella ricorrenze Squad”.agfimensonroman" uflìcialic quandocioè i normali trionfatoriportavano lacoronad’alloro, Roma,,su,veyo,…ma. quasi a volerne sottolineare la preminenza,” A] di là dell’altissimo onore, il concreto fregiarsene doveva presentare una certa scomodità, dal momento che la corona consisteva in una sorta di diadema aureo. ornato con la riproduzione dei rostri delle navi daguerra. Pochi altri ancora lariceveranno nei secoli successivi dell‘impero e per valutarne correttamente la sua rilevanza e,più in generale. di tutte decorazioni bisogna ricordare che Augusto. in ciò seguito ’ , dalla ’ dei suoi 1. “permatin di opportunità, non amava eccedere nella concessione delle onorificenze militari. «Come ricompense militari davapiù facili mente./hier? e collane e oggetti d 'ma0d ’a:genioche non corone castrensi a murali, che erano onore assai più segnalato; queste eran da lui conferite con lapiù grandeparsimonia.…
Volendomeglio precisare in materia di onorificenze e decorazioni. va ribadito che non venivano concesse indiscriminatamente ai militari. distintisi in azioni particolarmente brillanti od eroiche. Tutti gli imperatori. ben consapevoli della rilevante differenza che esisteva tra una ricompensa al valore ed una di puro omaggio allafedeltà ()alla nobiltà,non confuseromai le due specie. Pertantoz“le decorazionipre» sentano una grande varietà. La distinzionefondamentale contrappone quelle assegnate a militari non graduati e quelle destinate agli ufficiali. Le prime, in effetti, sono normalmente accordate solo come rif compensaper un impresaparticolare (obvirtutem). come ricorda una iscrizione travata neipressi di To-
Sotto il Segno
dell'Aquila Parte Quarta
»"“’
400
rino e incisa in onore di «Lucio Celio,figlio di Quinto, decoratoper il suo coraggio (obvirtutes [sic])difalere, di collari e di braccialetti» (si chiamavanofalere delle placche abbastanza simili alle nostre medaglie moderne), Inoltre. isemplici saldati nonpossono ottenere che le tre ricompense elencate nella iscrizione appena citata In via ecc - nale,potevano ottenere delle distinzioni riservate in linea diprincipio apersonaggi di rangopiù alta, delle corone... Gliufficiali, invece, non sono nanna/mente ricompensati per il loro coraggio, ma semplice; mente per la loro partecipazione alla campagna (anche le guerre civili permettono loro,almeno in certi casi, di allenere delle decorazioni).Essi hanno di ritto a corone. a lancepure e a stendardi di cavalleria il cui numero, maifissato rigidamente, varia essenzialmente infunzione di trecriteri.Prima di lutto si tiene conto delposto del beneficiarionellagerarchia:più è in altoper rango,più onori o/lerra. Poi, sembra si possano distinguere due livelli.per ogni grado, e qui contaprobabilmente il meritopersonale. Infine bisogna stabilire delle distinzioni cronologiche,poiche' alcuni imperatori, come Traiana, eranopiù generosi di altri, come Marco Aurelio.”“
In ultima analisi, si può a ragione credere che.mentre le onorificenzefossero simili alle nostre decorazioni al valore,ed in quanto talipremiavano chi si eradistinto sul campo di battaglia, le ricompense,invece,fossero dei meri riconoscimenti di servizio, unpo’ come gli attuali nastrini da apporre sull’uniforme, Sebbene ambedue fossero apprezzate ed ambite, soltanto le prime notificavano un comportamento militare eroico,suscitando perciò stimaed ammirazione. Sappiamo che alcuni imperatori che ne vennero insigniti,con quanto merito è impossibile accertarlo,giunsero afarle riprodurre sui loro palazzi residenziali!
Del tutto diverse le seconde, prive di valenza militare ma per contro ricche di valore venale, trattandosi in genere di pesanti monili d‘oro e d'argento. Piastre d’oro,armille e catene d‘oro,di peso e costo estremamente variabili testimoniavano la generosità dell‘imperatore e la rilevanza sociale dell‘insignito. Questi, owiamente, le sfoggiava nelle cerimonie ufficiali nonche' in circostanze panico— lari,quando doveva ostentare tutto il suo potere.
Va,infine, ricordato che proprio per essere ricompense di valore economico pro» porzionale al rango e al grado di chi ne veniva insignitofinirono per equipararsi allo stesso o,addirittura,per indicarlo. Pertanto, vanità ai nostri occhi ipocritamente ridicola,gli altissimi ufficiali in grande uniforme sarebbero apparsi con intorno al collopiù giri di pesanti catene d’oro e con bracciali aforma di serpenti, sem» pre d’oro, awolti in più spire intorno ai polsi. Quanto agli anelli, almeno ufficiahnente,quelli d’oro,abbastanzapesanti e vistosi,costituivanounaprerogativa, quasi un segno di esclusivadistinzione della classe equestre! Unataleabbondanza di monili d’oro avrebbe fatto somigliare, a quanti non avessero dimestichezza con sifi"atte decorazioni ed onorificenze, i massimi gradi militari, spesso depilati ed imbellettati,a ridicole soubrette d‘avanspettacolo,giudizio quanto mai errato e superficiale! Probabile, infine,cheproprio da quegli aurei bracciali derivino le odierne fettucce dorate sulle maniche delle uniformi,come già dalle catene i tanti collari degli ordini cavallereschi, per non parlare degli anelli, tipici di alcune prestigiose accademie militari!
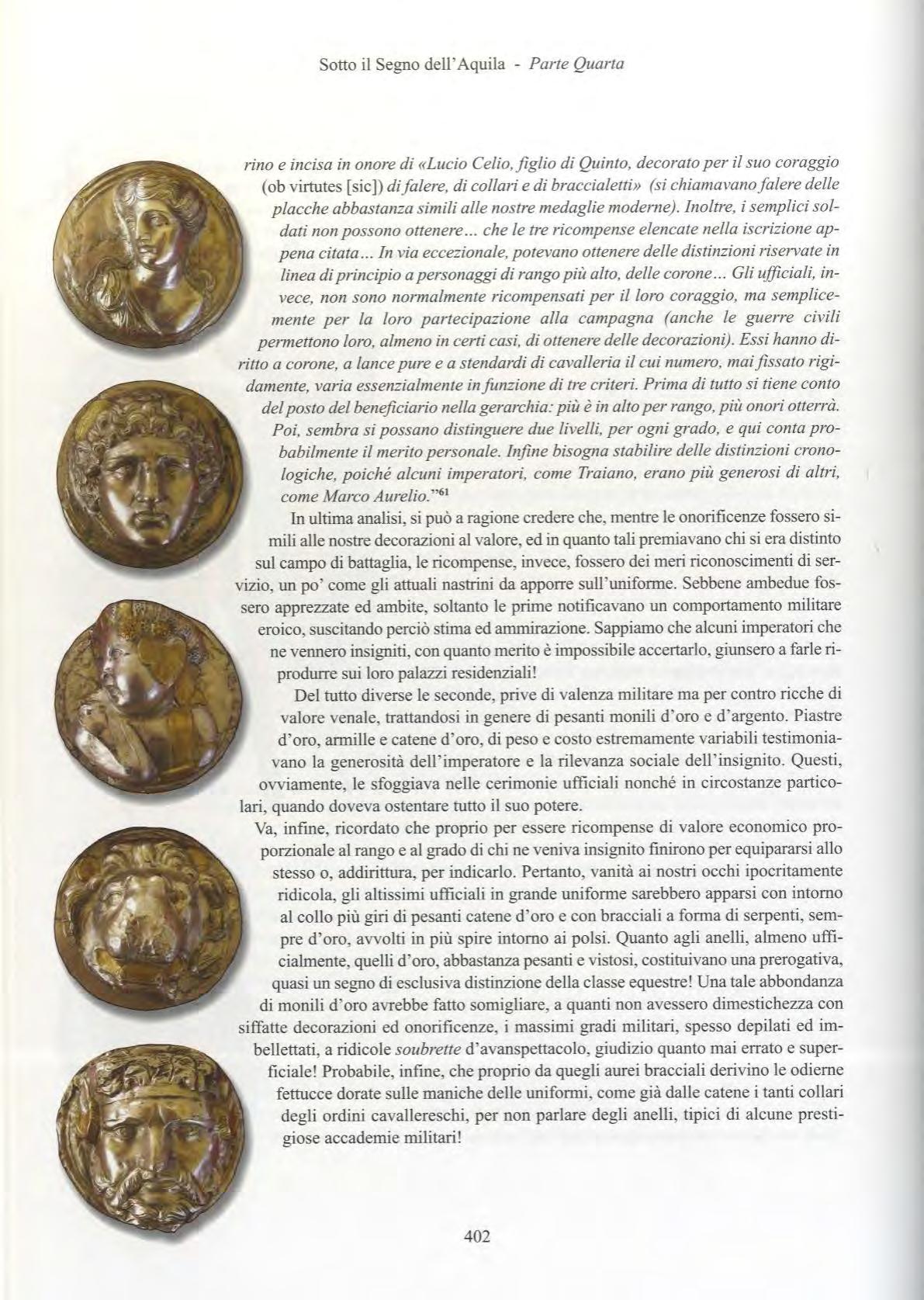
Sotto il Segno dell'Aquila - Parte Quarta
402
LE PUNIZIONI
Il corrispettivo delle onorificenze, sia personali che collettive,furono le punizioni, anch'esse per— sonali e collettive… Sebbene i legionari fossero sempre ritenuti, innanzitutto, cittadini romani, mantenendo perciò un’ampia disinvoltura nei riguardi dei loro superiori ed una certa autonomia persino nella tenuta,nel corso del combattimento e della marcia erano, invece,obbligati alla obbedienza più assoluta e senza esitazione: il venir meno a tale obbligo comportava pene draconiane, non di rado la morte. Lo stesso Augusto risulta al riguardo intransigente, al punto che, stando a Svetonio, allorquando:“laX Legione obbediva con un atteggiamento di insofferenza, egli lo licenziò con ignominia tutt 'interae cosìpure, siccome altri reclamavano il loro congedo con un insistenza eccessiva, li lascio‘ liberi senza dar loro le ricompense dovute ai loro servizi. Una volta che delle coorti eranofuggite, lefece decimare e poi lefece alimentare con orzo... [e quando] dei centurioni disertarono abbandonando il loroposto, lipunì con la morte, come semplici saldati, e,per altre mancanze, inflisse diversepene infamanti, condannandoliper esempio a rimanere per una intera giornata davanti alla tenda del generale, a volta vestiti con unasemplice lunica, senza cinturone, a volte tenendo in mano unapertica di diecipiedi opersino una zolla d ’erba.”62
Già da questa schematica memoria traspare l’ampia gamma di punizioni in uso nell’esercito romano,senza peraltro volere in alcun modo entrare nei dettagli né delineare neppure le principali che soltanto per categorie possono essere rubricate. Si andava da quelle personali, puramente etiche come, ad esempio, il raddoppio dei turni di guardia per un legionario reo di lievi mancanze. Vi era poi la condanna a trascorrere la notte fuori dal campo, che pur non grave di per sé in alcuni casi comportava il rischio di morte quando il nemicofosse stato nei paraggi. Altri castighi ancora, contemplavano una riduzione delle razioni, delle percosse con le verghe, che tutti i centurioni portavano e non si astenevano di usare,anche su quei particolari cittadini romani altrimenti immuni.Ne' mancavano le multe pecuniarie, attuate con la riduzione del soldo o con trattenute sulla paga e, neanche, degradazioni o trasferimenti ad unità ausiliarie… Vi era infine, non rara, la pena capitale sia individuale per vigliaccheria o diserzione, sia collettiva, quando a rendersi colpevole dei medesimi crimini era l’interaunità,sottoforma di decimazione.Nella fattispecie, dai legionari schierati veniva tratto un uomo ogni dieci, e passato per le armi.

LA SANITÀMILITARE
Se lavigliaccheria dinanzi al nemico implicava lapena capitale il comportamento eroico,testimoniato molto spesso daferite più omenogravi,provocava una serie di cure e di attenzioni volte asalvare lavita, almeno nei limiti delle vigenti conoscenze mediche… Non si trattava,owiamente, soltanto di unaforma di ovvio riconoscimento verso i meno fortunati che avevano fatto inpieno il proprio dovere, ma anche del risultato di un intelligente calcolo…All’epoca, situazione peraltro rimasta immutatafin quasi la metà del XIX secolo,ai massacri del combattimento facevano seguito nei giorni immediatamente successivi, stragi persino più numerose e tragichedi quanti eranorimasti feriti sul campo.Del tutto impossibile prestare loro il minimo soccorso,nonesistendo alcuna struttura preposta allo scopo ed essendo spesso il loro numero maggiore dei sopravissuti. La morte sopravveniva in quei terribili carnai lentamente,per disi’ ‘ o per " per ' ' o per " quando non inferta dallo sciacallaggio dei razziatori. Per cui è lecito affermare che la vera paura dei combattenti non era sicuramente la morte, ma laprospettiva di restare agonizmnti sul campo.
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte
Quarta
404
La disposizione di un servizio di sanità militare che si facesse carico di recuperare ife» riti e magari di curarli al meglio, esaltava perciò l‘aggressivitàper il combattimento riducendo quell’angosciante terrore. Se a ciò si aggiungano le conseguenze delle tante epidemie, contratte in zone e in contesti di scarsissima igiene e con avverse condizioni climatiche,capaci di porre temporaneamente fuori combattimento migliaia di uomini in uno stesso accampamento, si comprende il perché dell'importanza assegnata all’igiene generale e alla sanità medica in particolare e, soprattutto, la logica sottesa alla presenza
Plastlco ricostruttivo dl un valetudinano romana. di personale medico fra le legioni.
Solto: una cassettapermedlclne.
Dal mero punto di vista gerarchicoz“i medici Nellapagina afianco:/"94101 mll'tsnall'operasulla ColonnaTraiana.
Model olaRoman vsleludlnarla. erano equiparati a sottufficiali specialisti e dipen-
Below: Medicine kll. devanogerarchicamente dalpraefectus castrorum e sidepage:milìtsryphysicians alworkon the TraianColumn. da ,… med…, militare capo che, ad esempio, durante le guerre doriche,fu Critone, medicopersonale dell imperatore Traiano.
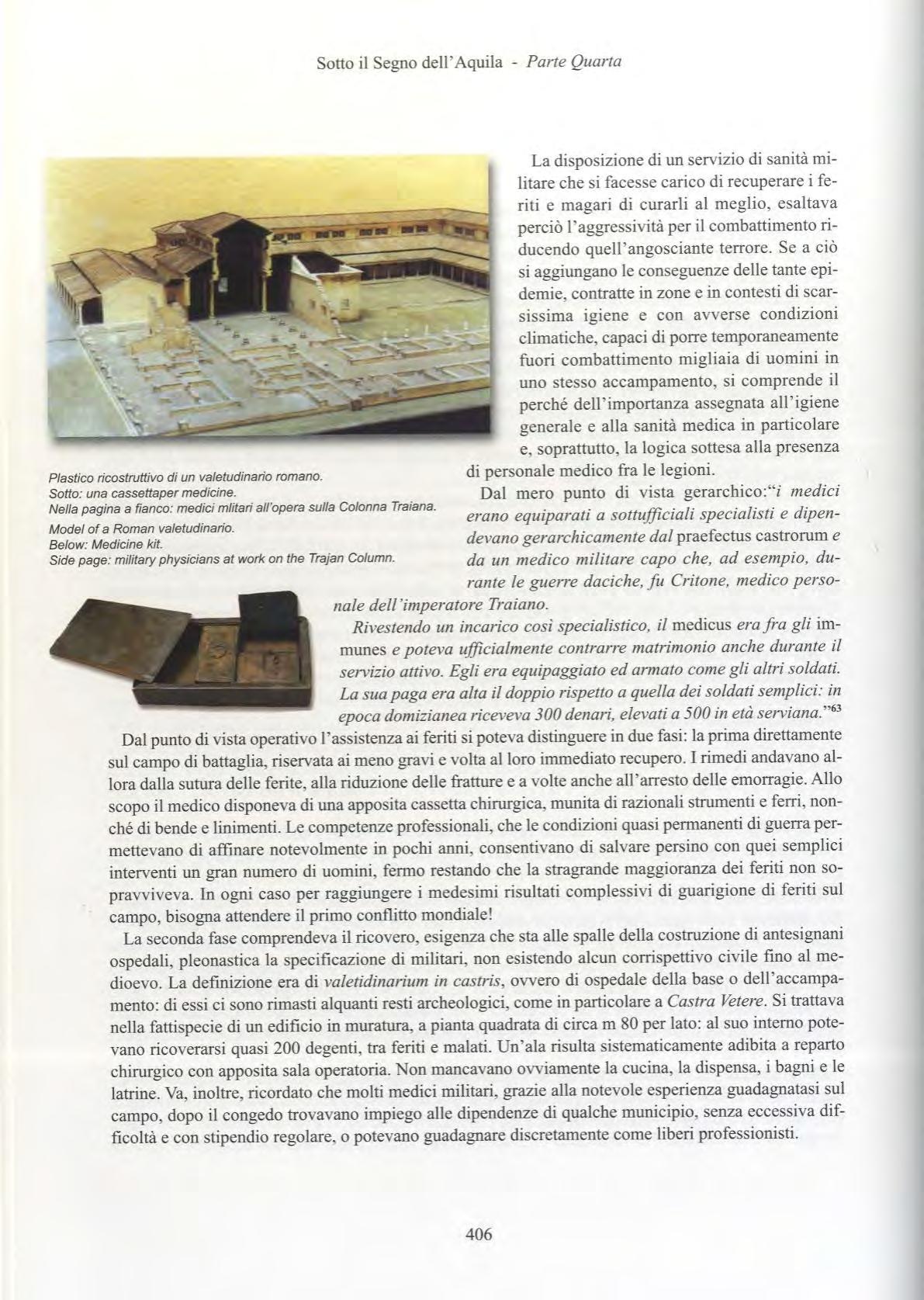
Rivestendo un incarico cosi specialistica, il medicus erafra gli immunes epoteva uflîcialmente contrarre matrimonio anche durante il servizio attivo. Egli era equipaggiato ed armato come gli altri soldati. La suapaga era alla il doppio rispetto a quella dei soldati semplici: in epoca domizianea riceveva 300denari, elevati a 500 in etàserviana.”63
Dal punto di vista operativo l’assistenzaai feriti si poteva distinguere in due fasi: laprima direttamente sul campo di battaglia, riservata ai meno gravi e volta al loro immediato recupero. ] rimedi andavano allora dalla sutura delle ferite, alla riduzione delle fratture e a volte anche all’arresto delle emorragie Allo scopo il medicodisponeva di una apposita cassetta chirurgica,munita di razionali strumenti e fer-ri, non« che di bende e‘ ' ' Le " che le " ' quasipermanenti di guerra permettevano di affinare notevolmentein pochi anni, consentivano di salvare persino con quei semplici interventi un gran numero di uomini, fermo restando che la stragrande maggioranza dei feriti non sopravviveva. In ogni caso per raggiungere i medesimi risultati complessivi di guarigione di feriti sul campo,bisogna attendere il primo conflitto mondiale!
La seconda fase comprendeva il ricovero, esigenza che sta alle spalle della costruzione di antesignani ospedali, pleonastica la specificazione di militari, non esistendo alcun corrispettivo civile fino al medioevo. La definizione era di valetidinarium in castris, ovvero di ospedale della base o dell’accampamento: di essi ci sono rimasti alquanti resti archeologici, come inparticolare a Castra Vetere.Si trattava nella fattispecie di un edificio in muratura, apianta quadrata di circa rn 80 per lato: al suo internopote— vano ricoverarsi quasi 200 degenti, tra feriti e malati. Un‘alarisulta sistematicamente adibita a reparto chirurgico con apposita sala operatoria.Non mancavano ovviamente la cucina, la dispensa, i bagni e le lattine.Va,inoltre,ricordato che molti medici militari,grazie alla notevole esperienza guadagnatasi sul campo,dopo il congedo trovavano impiego alle dipendenze di qualche municipio, senza eccessiva difficoltà e con stipendio regolare, o potevano guadagnare discretamente come liberi professionisti.
Sotto il Segno dell'Aquila Parte
Quarta
406
COSTO DELL'ESERCITO
Spesso,quandosi leggonoopere relative allacrisi ed alla dissoluzione dell’Impero romanod’occidente,si trovaesplicitamente ricordata,fra le sue principali concause,il gravame insostenibiledell’apparato militare. Situazione che iniziò a manifestare le prime avvisaglie già nell’Alto Impero. In realtà,però, non siamo in grado di stabilire, oltre ad una certa genericità, quanto concretamente influì su quel collasso il costo dell’istituzione militare. Di fatto:“! 'oflermazionediHeiclheim: «]’esercitoe laflotta, incluse lespeseper I ‘assistenza ai veterani, rappresentavanocertamente le voci di uscitapiù cospicua nel bilancio dellimpero. E ' appunto inquestosettore chesi sono tentatelevalutazionipiù attendibili», ètutt'altroche dimostrata, come osserva Pekàry. Unpasso della stessa CassioDione... sembrerebbe indicareche l’esercito non avrebbe effettivamente ripreso la metà di tutte le entrate; appuntoMao-ino nel 217,criticando lapoliticafinanziaria delsuopredecessore Caracalla,gli rimproverava diaverpagato al barbari untributoannuo equivalenteal] ’ammontaredel soldo annuale…Epoiché in molte altre occasioni Caracallasembra aver condotto unapoliticadi dissrpazione, lespese militariavrebberodovuto contribuire, come ritienePekàry,per meno del 50% ' anche il noto delsoldo, " da tale ' .,, ,per isoldati.“
La situazione, tuttavia,non è tantosemplice né,peraltro, tantostabile nel tempo.Alcuni tentativi di calcolo delle spese militari all’epoca di Augusto sono pervenuti ad un risultato complessivo di circa 100.000.000 di denali,pari & 400.000,000 di sesterzi,di cui 32.000.000 per il soldo dei legionari e circa 59,500.000 le restanti spese militari,tralequali oneri di approvvigionamento,di equipaggiamenti vari,di trasporti,di stipendi agli ufficiali,ecc.Posta inquesti tenniui laquestione,quanto delineato non sarebbe lontano dalla realtà,ma un’acuta tesi ha mutato i dati disponibili fornendo unadiversa lettura che,per molti aspetti, appare di gran lungapiù logicanelle conclusioni.Per cui:“una volta ammessa, essasignlficherebbe che, nella sostanza, le spese militari erano,all ’epocadi Tiberio,quasi uguali alle entrate statali ed in epoca vespasianea, abbon— dante/nentesuperiori alla metà dell'intembilanciodiprevisione, dellostato romano. Ciliindicherebbeanche a ben considerare che lo stato romano,già dall'età diAugusto. vivevapraticamente infinizione dell ’eser— cito e subordinava ad essaogni altrafilnzione dellostato..."“
Vrè,tuttavia,unaosservazione dafare relativamente aquestoruolototalizzante,almenoper il bilancio eco— nonrico, dell’esercito: sarebbe stata possibile la sopravvivenza e prima ancora la formazione dell’Impero senza di esso? E quanto degli introiti,anche al profilarsi della crisi,derivava in realtà dal bottino bellico e dalle varie operazioni rnilimri generiche? In altri termini nella scala costi benefici,il rapporto tende a modificarsi nel corso del tempo,magari incrementandosi,ma nonmuta nelle sue parti fondamentali!

Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte Quarta
408
Note
1 - Per l’esattezza si trattò di S. Sulpicio Galba, M. Salvia Otone,A. Vitellio,F.Vespasiano. L’intervallo di tempofra il prima e l'ultimo andò dall’estate del 68 a quella del 69…
2 — Unaeloquente rievocazione visiva della conquista della Dacia di Traiano e documentata nei 114 pannelli che si susseguono nelle spire della ColonnaTraiana In merito cfr, L. ROSSI, Rataealchi di pietra, Milano 1981,pp… 135-200…
3 — Cfr.G.CLEMENTE,La ‘NotitiaDignitatum '.in Saggi di storia e letteratura,n°4, Cagliari 1968.
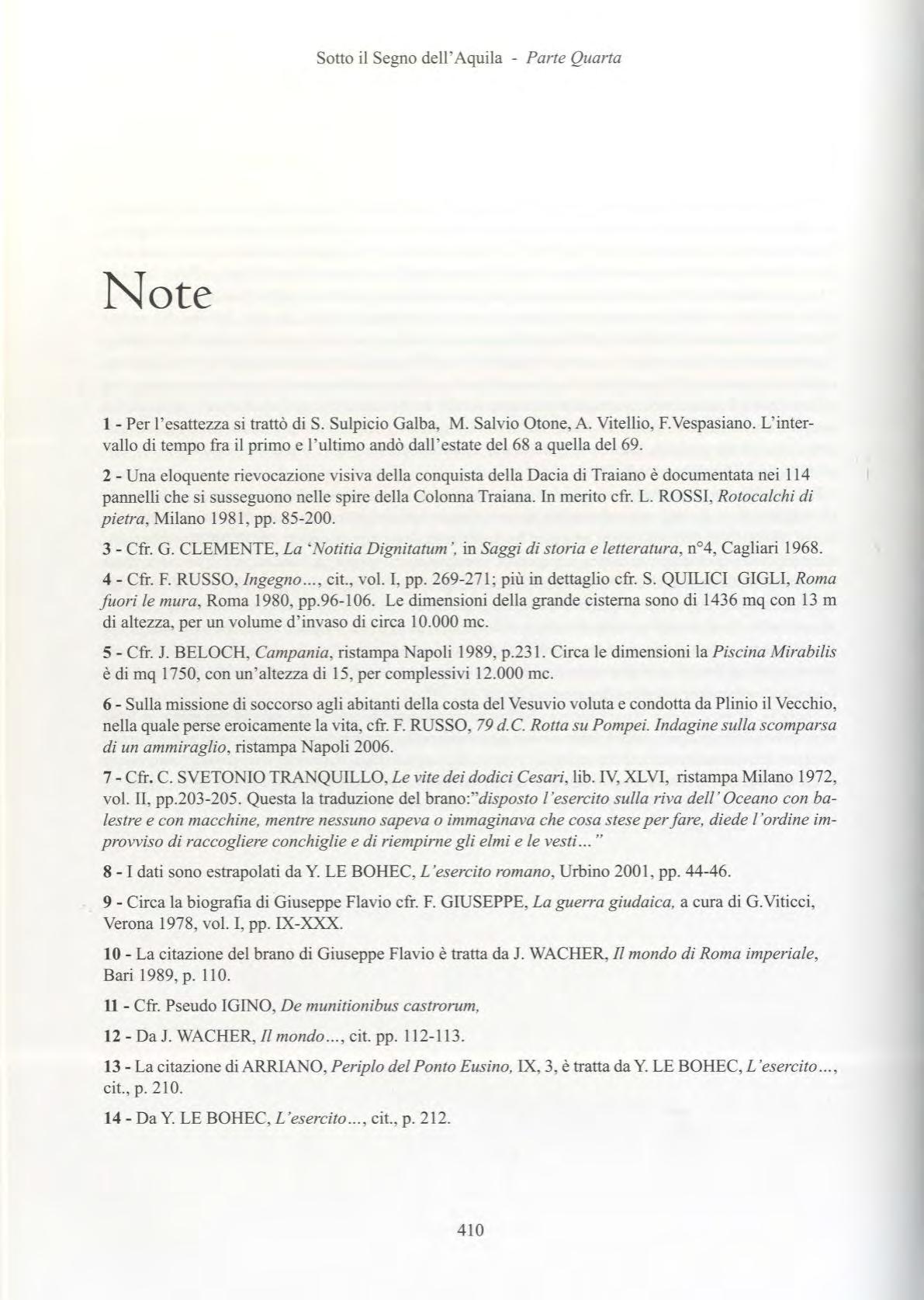
4- Cfr.F. RUSSO,Ingegno..., cit.,vol. I, pp. 269-271; più in dettaglio cfr… S. QUILICI GIGLI,Roma fuori le mura, Roma 1980,pp…96-106. Le dimensioni della grande cisterna sono di 1436 mq con 13 in di altezza,per un volume d’invaso di circa 10.000 mc.
5- Cfr.J. BELOCI-I, Campania,ristampaNapoli 1989,p.231. Circale dimensioni laPiscina Mirabilis e di mq 1750,con un’altezza di 15,per complessivi 12.000 me.
6- Sulla missione di soccorso agli abitanti della costadel Vesuviovoluta e condottada Plinio il Vecchio, nella qualeperse eroicamente lavita,cfr…F. RUSSO, 79d.C.Rotta su Pompei. Indagine sulla scomparsa di un ammiraglio, ristampa Napoli 2006.
7- Cfr.C…SVETONIO TRANQUILLO,Le vite dei dodici Cesari,lib.IV,XLVI, ristampaMilano 1972, vol. II, pp.203-205. Questa la traduzione del brano:”dispasto ] ’esercitosulla riva dell 'Oceano con balestre e con macchine. mentre nessuno sapeva o immaginava che cosasteseperfizre, diede ] ”ordineimprowiso di raccogliere conchiglie e di riempirne gli elmi e le vesti… "
8 — I dati sono estrapolati daY.LE BOHEC, L ’esercitoromana, Urbino2001,pp, 44—46,
9 — Circa la bioyafia di GiuseppeFlavio cfr.F. GIUSEPPE,La guerra giudaica. a cura di G.Viticci, Verona 1978,vol.I, pp. IX-XXX.
10 - La citazione del brano di Giuseppe Flavio è tratta da ]. WACHER,Il mondo di Roma imperiale, Bari 1989,p. 110.
11 - Cfr.Pseudo IGINO, De munitiartibus castromm.
12 - Da J. WACHER,Il mondo..., cit.pp… 112-113…
13 — La citazione di ARRIANO, Peripla del Ponto Eusino. IX, 3,è tratta da‘/… LE BOHEC,L'esercito… cit,p… 210…
14 - Da Y.LE BOHEC,L’esercita…, cit.,p. 212.
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte Quarta
15 - In merito cfr. F. RUSSO, La difesa delegata, Roma 1995,pp. 45-51.
16 - Cfr.F. RUSSO, Tormento. Ventisecoli di artiglieria meccanica.Roma 2002.vol. I,pp. 165-255.Più in particolare sotto il profilo tecnico, sempre dello stesso autore, L'artiglieria delle Legioni romane, Roma, 2004.
17 - Da E. N… LUTTWAK, La grande strategia dell impero romano, dal I al III secolo d.C., Milano 1981,p. 183.
18 - Da E. N, LUTTWAK, La grande strategia…, cit.,pp. 87 e sgg.
19 — Da E. N. LUTTWAK, La grande strategia…, cit.,p. 95.
20 - Da E. N. LUTTWAK, La grande strategia.… cit.,p. 93…
21 — Da E, N. LUTTWAK1 La grande strategia…, cit.,p. 94
22 - Da F. R,VEGEZIO, L 'anemilitare, lib. III, 5: così il testo: ”Aliquantiin castellorum, aut urbium turribus appendunt trabes: quibus aliquando erectis, aliquando depositis indicant quae geruntun ”
23 Da G.PLINIO SECONDO,StoriaNaturale, lib.Il, 73:"Multishoc cognitum experimentis inAfrica Hispaniaque turrium Hannibalis. inAsia veropropter piraticos terrores simili specularumpresidio excitato, in quispreanuntios ignes sexta hora diei accensos saepe compertum est tennia noctis a tergo ultimis visus. "
24 -AA.VV., Le trasmissioni dell Esercito, Roma 1995,pp. 5-14,Il brano relativo è di ENEA il TATTICO,Paliorketika, lib. X, 44.
25 — Circa la velocità dei proietti delle baliste cfi'. P. RUSSO, Tor-menta…cit.,pp. 253-255.
26 - Riguardo ad Hatra cfr…AMMIANO MARCELLINO, Storie, lib.XXIV, 4, 28, a cura di G.Vian— sino, Milano 2002,
27 - Per approfondimenti al riguardo cfr. F. RUSSO, F. RUSSO, Tor-menta navalia.Le artiglierie navali romane, supplemento Rivista Marittima n°6,giugno 2007,pp. 106-117.
28 - Il testo di Filone sulla balista pneumatica è contenuto nella sua Belopoica opera che è stata pubblicata e tradotta in inglese da E…W. MARSDEN, Greekand roman artillery… Technicallreatises,New York 1971,pp. 106 e sgg.
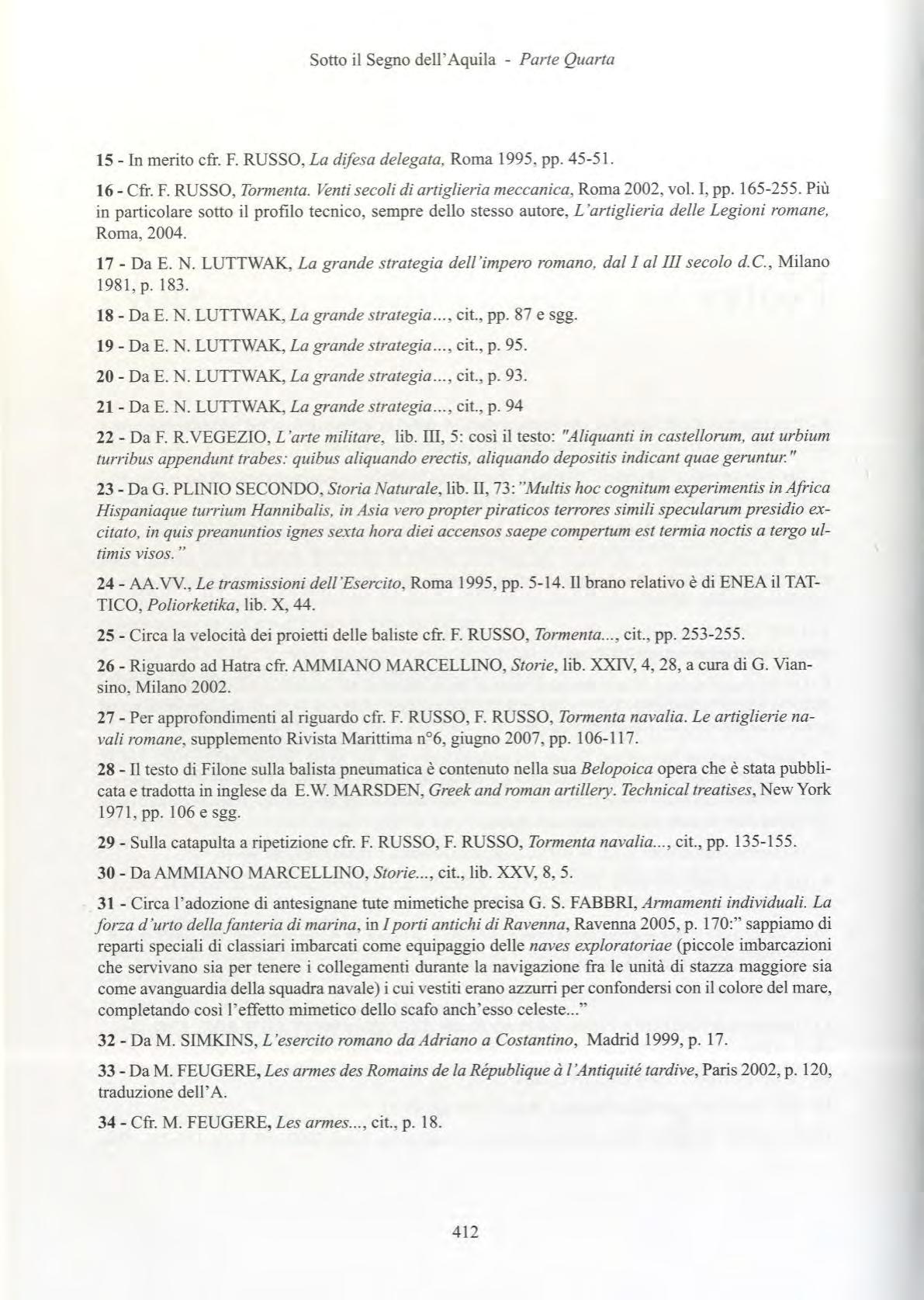
29 - Sulla catapulta a ripetizione cfr.F. RUSSO, F. RUSSO, Tormentanavalia..., cit.,pp. 135—155.
30 - Da AMMIANO MARCELLINO, Storie.… cit.,lib.XXV, 8, 5.
31 - Circa l’adozione di antesignano tute mimetiche precisa G.S. FABBRI,Armamenti individuali. La forza d’urto dellafanteria di marina, in [parti antichi di Ravenna, Ravenna 2005,p. 1702” sappiamo di reparti speciali di classiari imbarcati come equipaggio delle naves explaratoriae (piccole imbarcazioni che servivano sia per tenere i collegamenti durante la navigazione fra le unità di stazza maggiore sia come avanguardia della squadra navale) i cui vestiti erano azzurri per confondersi con il colore del mare, completando cosi l’effetto mimetico dello scafo anch’esso celeste…"
32 - Da M. SIMKINS,L 'esercitoromano daAdriano a Costantino, Madrid 1999,p. 17.
33 - Da M… FEUGERE,Les armes des Romains de laRépublique & l’Antiquité tardive,Paris 2002,p. 120, traduzione dell’A.
34 - Cfr,M. FEUGERE, Les armes...,cit.,p. 18.
412
Sotto
il Segno dell’Aquila - Parte Quarta
Sotto il Segno dell'Aquila - Parte Quarta
35 - Cfr.M. FEUGERE, Les armes...cit..p. 181.
36 - Cfr.M. SIMKINS,L ’esercitominano…cit.,p. 20.
37 - Da D. MAGNO AUSONIO, Mosella. Il poeta visse verosimilmente tra il 310 e il 395.
38 — Cfi'.M. FEUGERE, Les armes… cit.,p. 181 e sgg.
39 - Idem. 40 - Idem.
41 - Idem.
42 —Da M… FEUGERE,Les armes…cit.,p… 181,11ad.dell‘A.
43 Cfr.M. SIMKINS, L'esercito romano..., cit.,p. 14.
44 —Da W.RE1D, La scienza delle armi dall 'eta‘dellapietra ai nostrigiorni, Milano 1979,pp… 60» 62.
45 - Cfr.M. FEUGERE, Les armes…cit.,p. 129.
46 - Da… M… SIMKINS, L'esercito romana.…cit.,p. 15.
47 - Da. M. SIMKINS,L 'esercitoromano…, cit.,p. 16.
48 Da. M. SIMKINS,L'esercito romano…cit.,p. 22.
49 Da M. FEUGERE,Les armes...,cit.,p… 115,trad.dell‘A.
50 - Da A.ANGELINI, L ’artemilitare di Flavio Rena/o Vegezio,Roma 1984, lib. I, 12,p… 19.
51 Cfr.C.BLAIR,Enciclopedia ragionata delle anni, Verona 1979,p. 235 alla voce gladio,
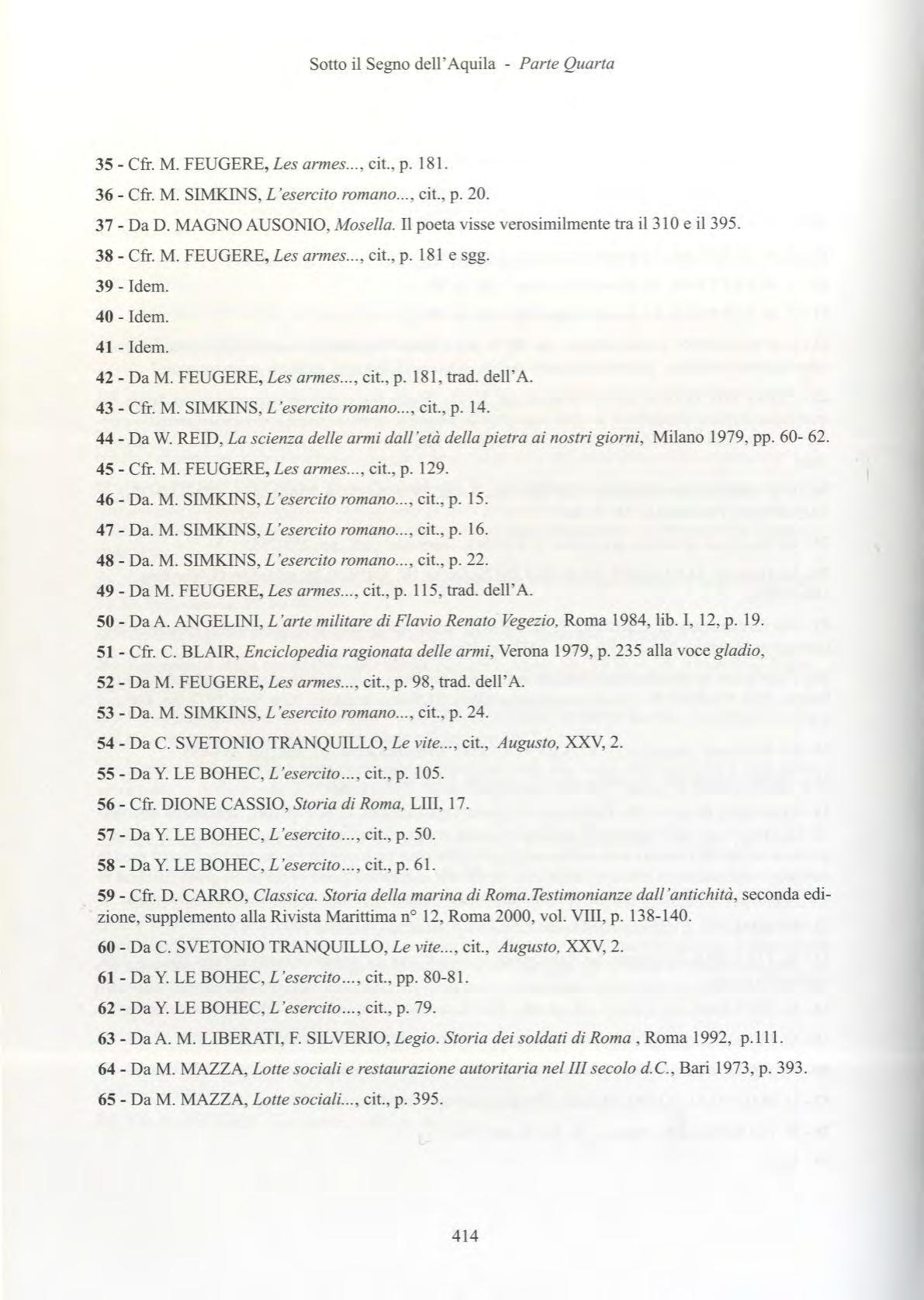
52 - Da M. FEUGERE,Les armes…cit.,p. 98,trad dell’A.
53 - Da. M. SIMKINS, L 'esercitoromano.... cit.,p. 24.
54 — Da C.SVETONIO TRANQUILLO,Le vite...,cit., Augusta, XXV, 2.
55 - Da Y.LE BOI-IEC, L’esercito… cit.,p. 105.
56 - Cfr.BIONE CASSIO,Storia di Roma, L…, 17.
57 — Da Y.LE BOHEC, L 'esercito...,cit.,p. 50.
58 - Da Y.LE BOI-IEC, L 'esercito...,cit.,p. 61.
59 - Cfr.D. CARRO,Classica.Storia della marina di Roma.Testimonianze dall ’antichità,seconda edizione, supplemento alla Rivista Marittima n° 12,Roma 2000, vol.VIII,p. 138-140.
60 - Da C.SVETONIO TRANQUILLO,Le vite...,cit., Augusto, XXV, 2.
61 — DaY. LE BOHEC,L 'esercito...,cit.,pp. 80-81.
62 — Da Y.LE BOHEC,L ’esercito...,cit.,p. 79.
63 - Da A. M. LIBERATI, F… SILVERIO,Legio. Storia dei soldati di Roma , Roma 1992, p. 111…
64 - Da M. MAZZA, Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.C.,Bari 1973,p. 393…
65 - Da M. MAZZA, Lotte socia/i..., cit.,p. 395.
414
PAR E QUINTA
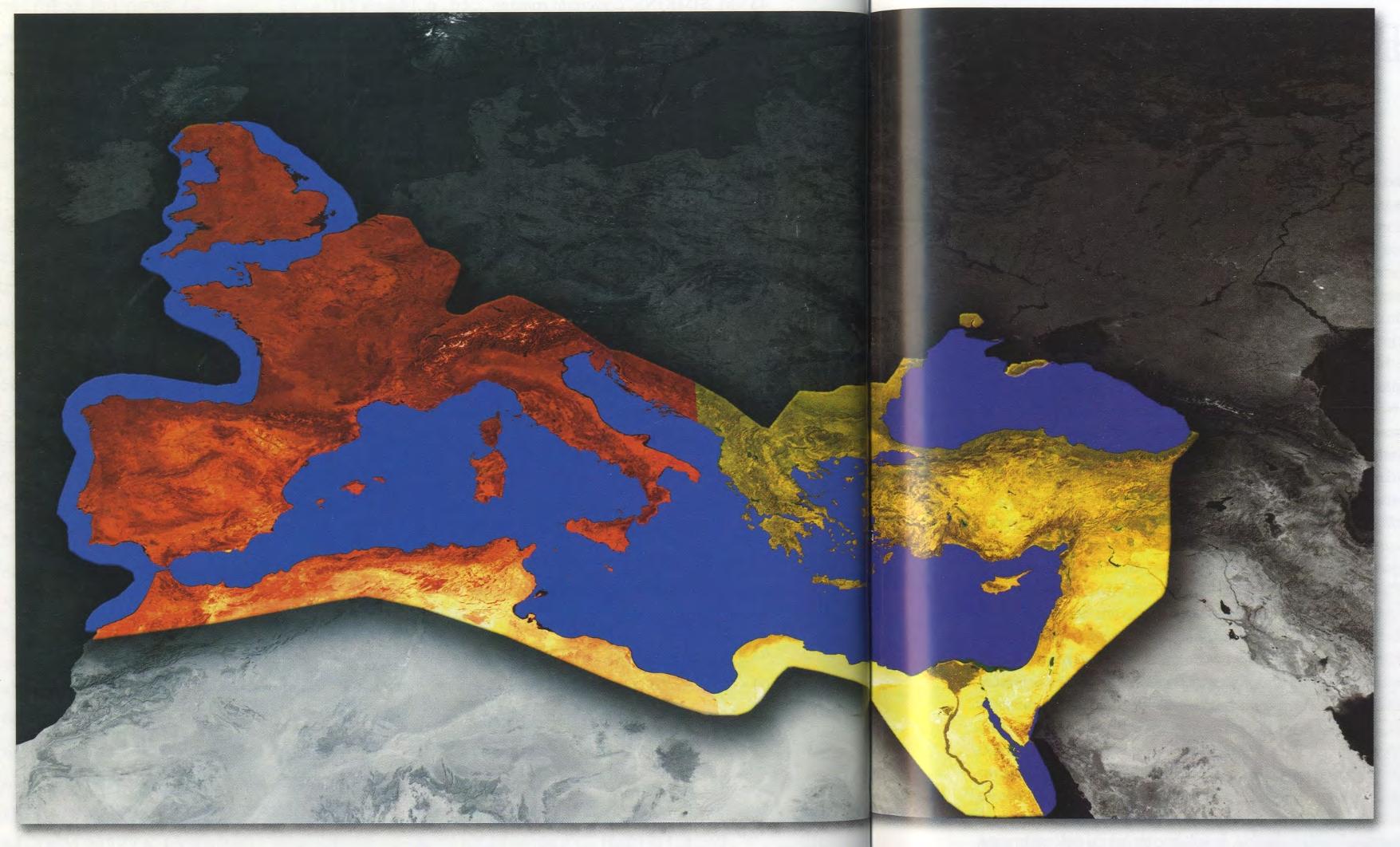
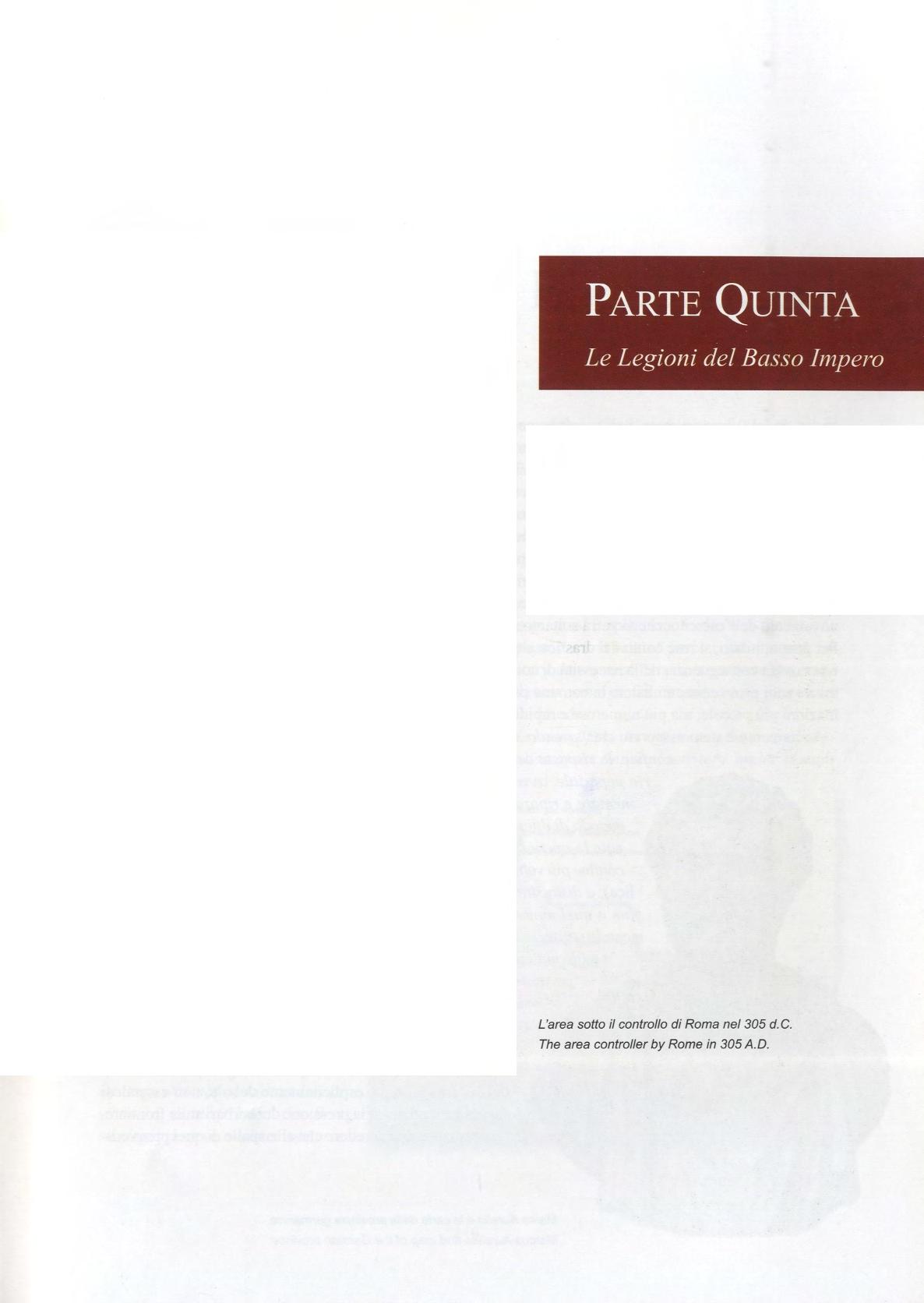
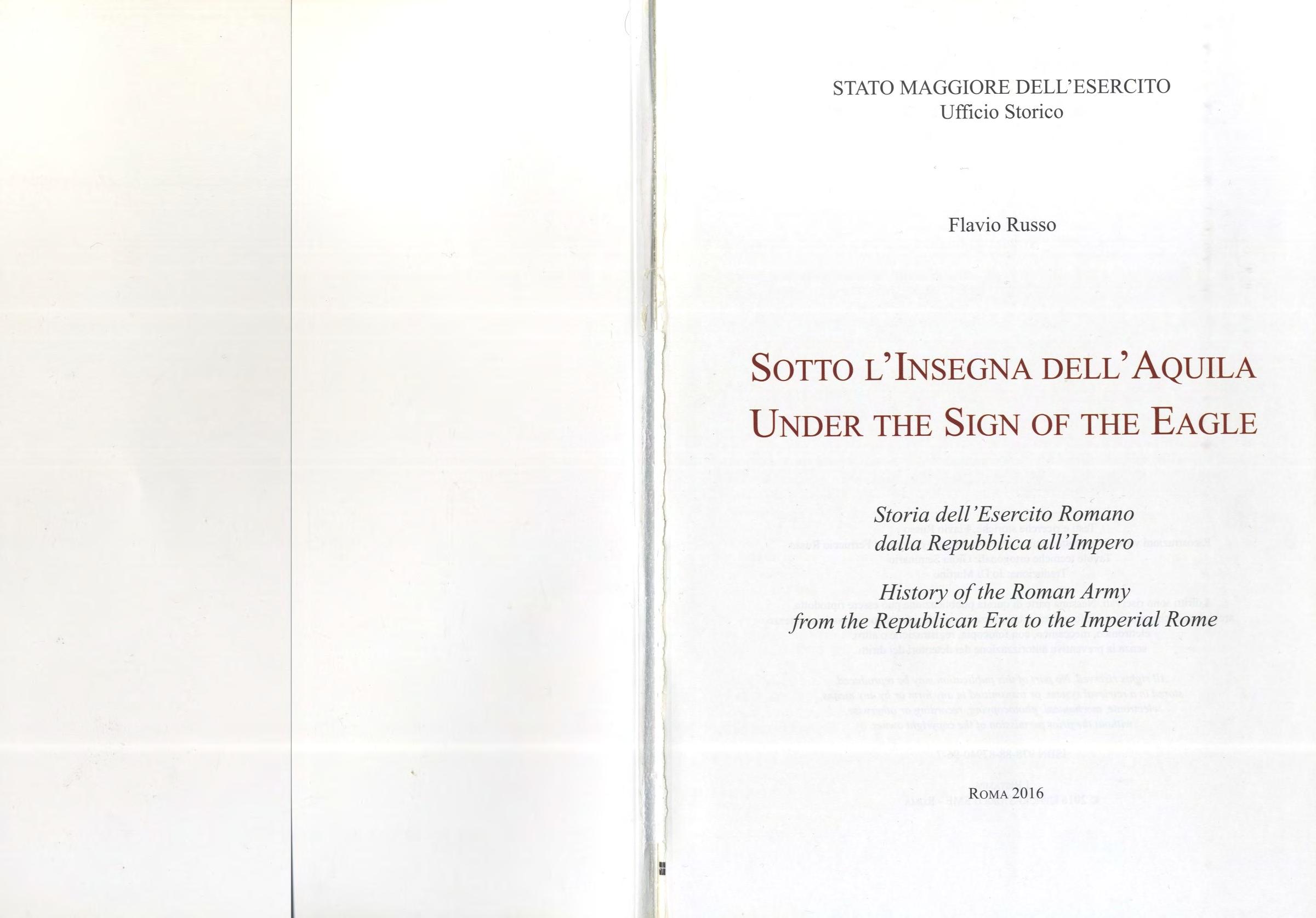
Legioni del Bu. ,) Imwa
La
controllo di
nel
d.C.
L'area sotto il
Roma
305
Dre area contro/ler by Roma in 305A.Dv
Le Legioni del Basso Impero
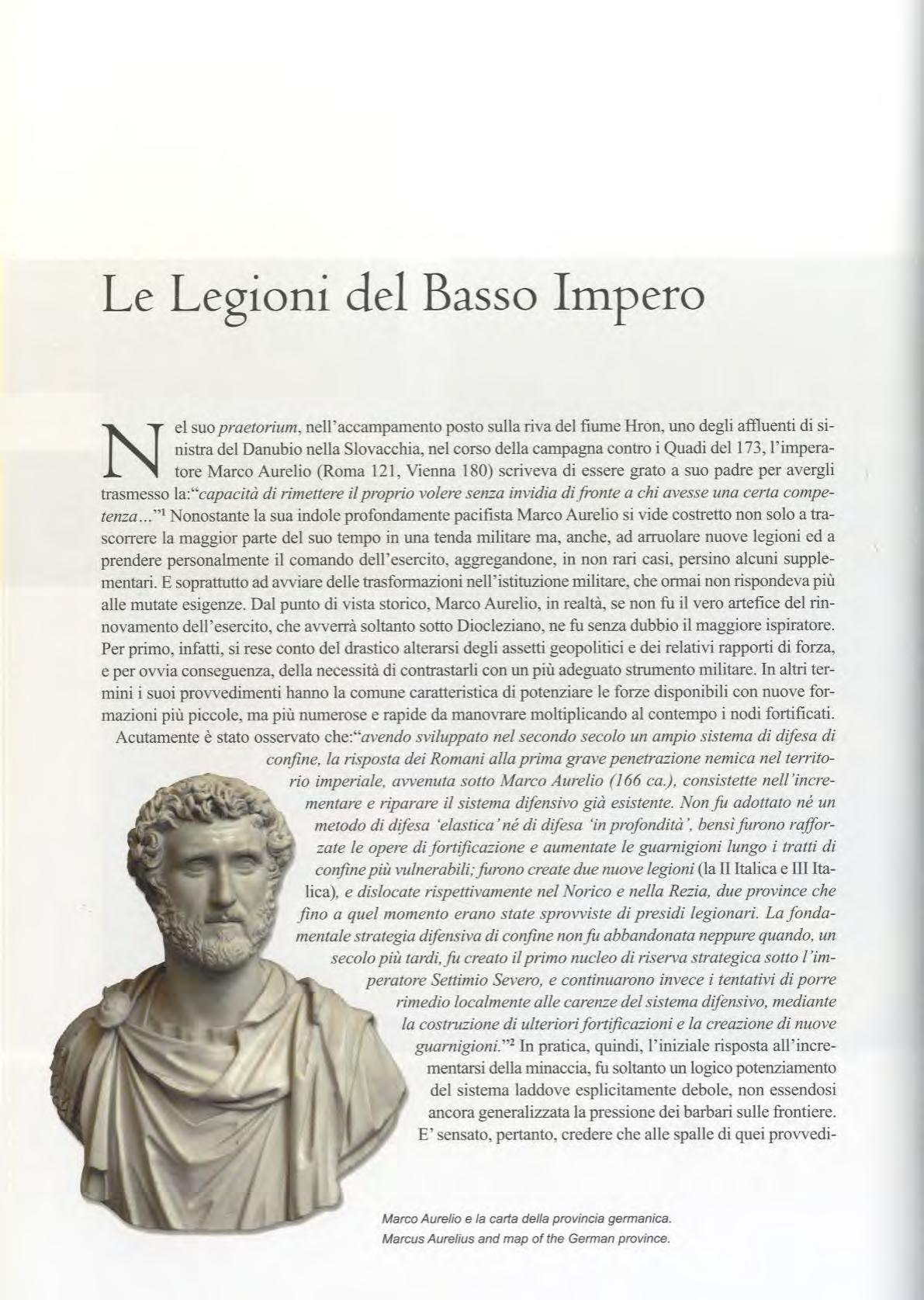
Nel suopraeton'um, nell’amampanrentoposto sulla riva del fiume Hron, unodegli afiluenti di si-
nistra del Danubio nella Slovacchia,nel corsodella campagnacontroi Quadi del 173,l’imperatore Marco Aurelio (Roma 121, Vienna 180) scriveva di essere grato a suo padre per avergli trasmesso la:“capacitti di rimettere ilproprio volere senza invidia difionte a chi avesse una certa competenza….”‘ Nonostante lasua indole profondamente pacifista Marco Aurelio si vide costrettonon solo a trascorrere la maggior parte del suo tempo in una tenda militare ma, anche, ad arruolare nuove legioni ed a r i] 1 dell’esercito ’ in non rari casi persino alcuni supplementari E soprattutto ad avviare delle trasformazioni nellistituzionemilitare,che ormai non rispondevapiù alle mutate esigenze.Dal punto di vista storico,Mamo Aurelio,|nrealtà, se non fu il vero artefice del rinnovamentodell'esercitoche awerràsoltanto sotto Diocleziano nefu senza dubbio il maggiore ispiratore Per primo, infatti,si rese conto del drastico alterarsi degli assetti geopolitici e dei relativi rapporti di forza,
eper ovvia della ‘ di li conunpiù ’ strumento militare.In altri termini i suoi prowedimenti hanno la comune caratteristica di potenziare leforze disponibili con nuove formazioni pìù piccole, ma più e rapide da ‘ ' " ’ al r i nodi fortificati. Acutamente è stato osservato che:“avenda sviluppato nel secondo secolo un ampio sistema di difesa di confine, la risposta dei Romani allaprima gravepenetrazione nemica nel territo— rio imperiale, avvenuta sotto Marco Aurelio (166 ca,), consistette nel! ’incrementare e riparare il sistema difensivo già esistente. Nonfit adottato né un metodo di difesa 'elastica’nédi difesa ‘inprofondità ',bensifixmno raflarzate le opere difizrttficazione e aumentate le guarnigioni lunga i tratti di confinepiù vulnerabili;film”!) createduenuove legioni (laIl Imlica eIII Italica), e dislocate rispettivamente nel Norico e nella Rezia, dueprovince che fino a quel momento erano state sprovviste dipresidi legionari. Lafondamentalestrategia difensiva di confine nonfit abbandonata neppure quando, un secolopiù tardi,fil creato ilprimo nucleodi riservastrategica sotto I ’imperatore Settimio Severo, e continuarono invece i tentativi diporre rimedio localmentealle carenzedel sistema difensivo, mediante lacostruzione di ulteriorifirr'tificazt'oni e la creazione di nuove guarnigioni.”z In pratica, quindi, l‘iniziale risposta all’incrementarsi della minaccia,fu soltanto unlogicopotenziamento del sistema laddove esplicitamente debole, non essendosi ancorageneralizuta lapressione dei barbari sulle frontiere, E’ sensato,pertanto, credere che alle spalle di quei provvedi-
MarcoAurelio elacartadellaplovtncta germamca. MarcusAure/ius andmapofthe Germanprovince.
menti vi fossero dei tecnici di provata esperienza.per cui. forse. quel riferimento di Marco Aurelio al suo sapersi avvalere delle altrui capacità.senza rancori ed invidie.si riferiva appunto ai consiglieri di cui dovette servirsi per intraprendere quel compito immane.in circostanze tanto critiche.
E che le circostanze fossero realmente critiche hanno anno modo di confermarlo numerosi studi che vedono. infatti,proprio nelle guerre marcomanniche sostenute da Marco Aurelio almeno perla fase iniziale. il tentativo di frustrare l‘avvento della minaccia germanica, ravvisata come ilprologo di un incubo. Della gravità della situazione fanno fede alcune:“contra misure daparte romana… Sperimentati comandantifurono mandati sul limes danubiana,‘ tra questi M ValeriusMarimianus... Marco Aurelio mise all "astaisuot' tesori,per arr-nolan>nuovisoldati e riempire imotiforman dallapeste. Due nuove legionifurono firmate... Furono rafiorzate leguarnigioni difiontiera...[e] da considerevole distanza vennero richiamatefonefresche. come 1a_farnosaLegio X Fretensis, da Gerusalemme (o almeno, un distaccamento) ed a quanto sembra… la Legio lll Augusta dall'Africa, da Larnbesi… Comeal tempodiAnnibale, si arruolaronoschiavi egladiatori,per riempire i moti delle unità alfionte... Furono messe in opera tutte leforze: allafine del 169 sipoté incominciar a scorgere qualche miglioramento:solamente allora] 'imperatorefiloso/bpoté mettersi in campagna. Era stato prima necessario una riorganizzazione… [e]fu solo nel I 7I che riuscirà aMarco Aurelio di concludere vittoriosamente laprimafase di questapenosa guerra.”3
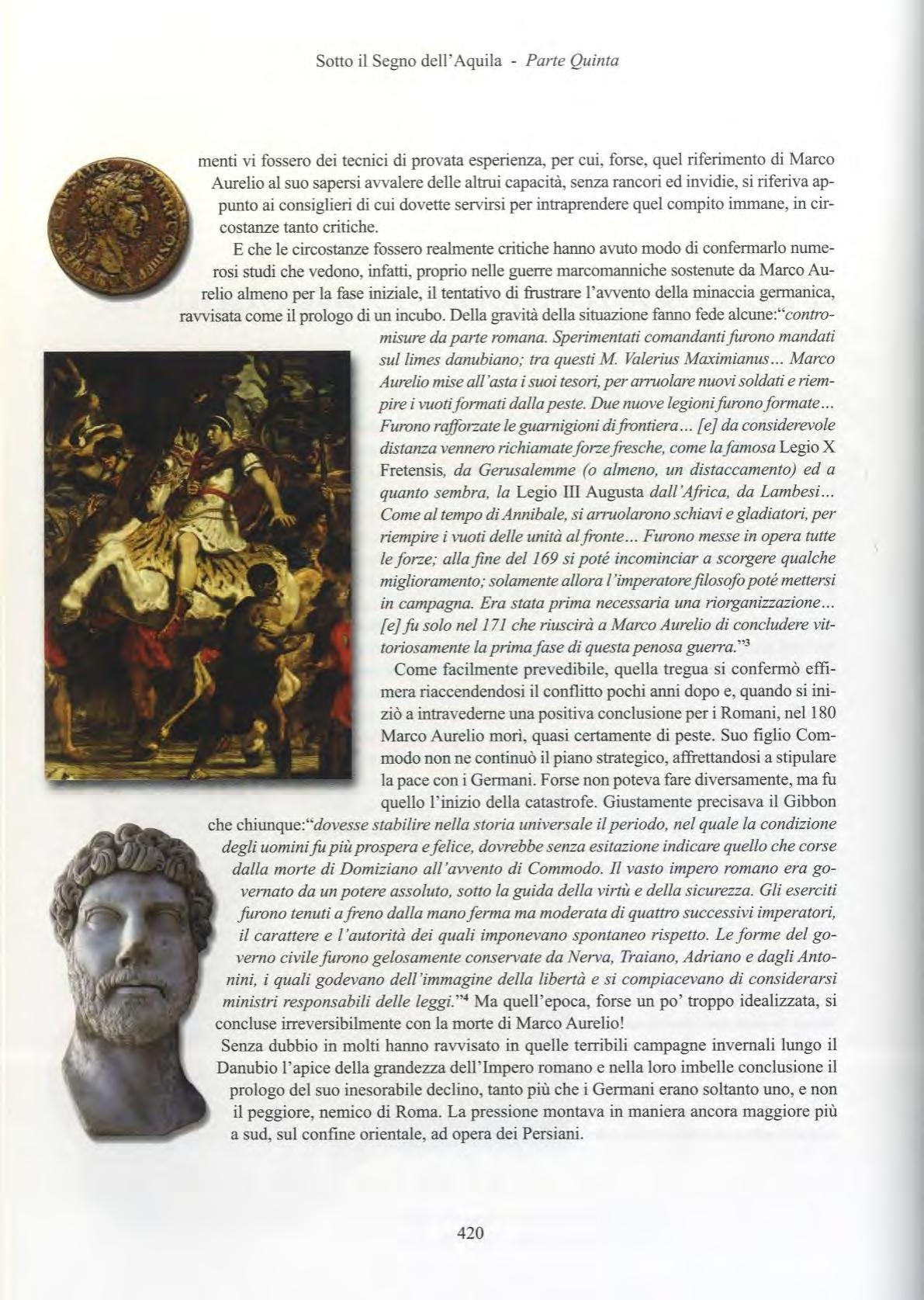
Come facilmente prevedibile. quella tregua si confermò effimera riaccendendosi il conflitto pochi anni dopo e,quando si iniziò a inuaveclemeuna positiva conclusione per i Romani, nel l80 Marco Aurelio mori, quasi certamente di peste, Suo figlio Commodononne continuò il piano strategico, alfrettandosi a stipulare lapace con i Germani.Forse non poteva fare diversamente,mafu quello l'inizio della catastrofe. Giustamente precisava il Gibbon che chiunque:“dovesse stabilire nella storia universale ilperiodo, nel quale la condizione degli uominifu più prospera efelice,dovrebbe senza esitazione indicarequello che corse dalla morte di Domiziano al! ’avventadi Commodo. ll vasto impero romano era governato da unpotere assoluto,sotto laguida della virtù e della sicurez-a. Gli eserciti furono tenuti afreno dalla manoferma ma moderata di quattrosuccessivi imperatori, il carattere e !'autan'tzi dei quali imponevano spontaneo rispetto. Leforme del go' verno civilefurono gelosamente conservate da Nerva, Traiano,Adriano e dagli Antonini, i quali godevano dell immagine della libertà e si compiaeevano di considerarsi ministri responsabili delle leggi.” Ma quell’epoca, forse un po’ troppo idealizzata, si concluse irreversibilmente con la morte di Marco Aurelio!
Senza dubbio in molti hanno ravvisato in quelle terribili campagne invernali lungo il Danubio l‘apice della grandezza dell‘Impero romano e nella loro imbelle conclusione il prologo del suo inesorabile declino, tantopiù che i Germani erano soltanto uno,e non il peggiore, nemico di Roma, La pressione montava in maniera ancora maggiore più a sud, sul confine orientale,ad opera dei Persiani, 420
Sotto il Segno dell’Aquila Par-te Quinta
L’ASCESA DI SETTIMIO SEVERO
Al pari di Marco Aurelio, anche Settimio Severo non aveva mai condotto operazioni belliche, prima della sua proclamazione. In compenso,tuttavia,possedeva una visione ancora più nitida delle esigenze dei militari, competenza che avrà una straordinaria rilevanza nella sua successiva azione di governo. Nato nel 146 a Leptis Magna, ad un centinaio di lon da Tripoli,sembra che,per volere di Marco Aure— lio, divenne senatore nel 172.Sotto Commodo ottenne il consolato ed il comando delle legioni in Pannonia, le stesse che lo vollero imperatore dopo l’uccisione di Pertinace nel 193, Ovviamente le legioni di Siria gli preferirono Pescennio Nigro e quelle di Britannia ClofioAlbino, senza contare la nomina di un quarto imperatore Didio Giuliano.Per liberarsi di tutti e tre quei rivali Settimio Severo impiegò quasi quattro anni,ma alla fine restò l’assoluto signore dell’Impero…
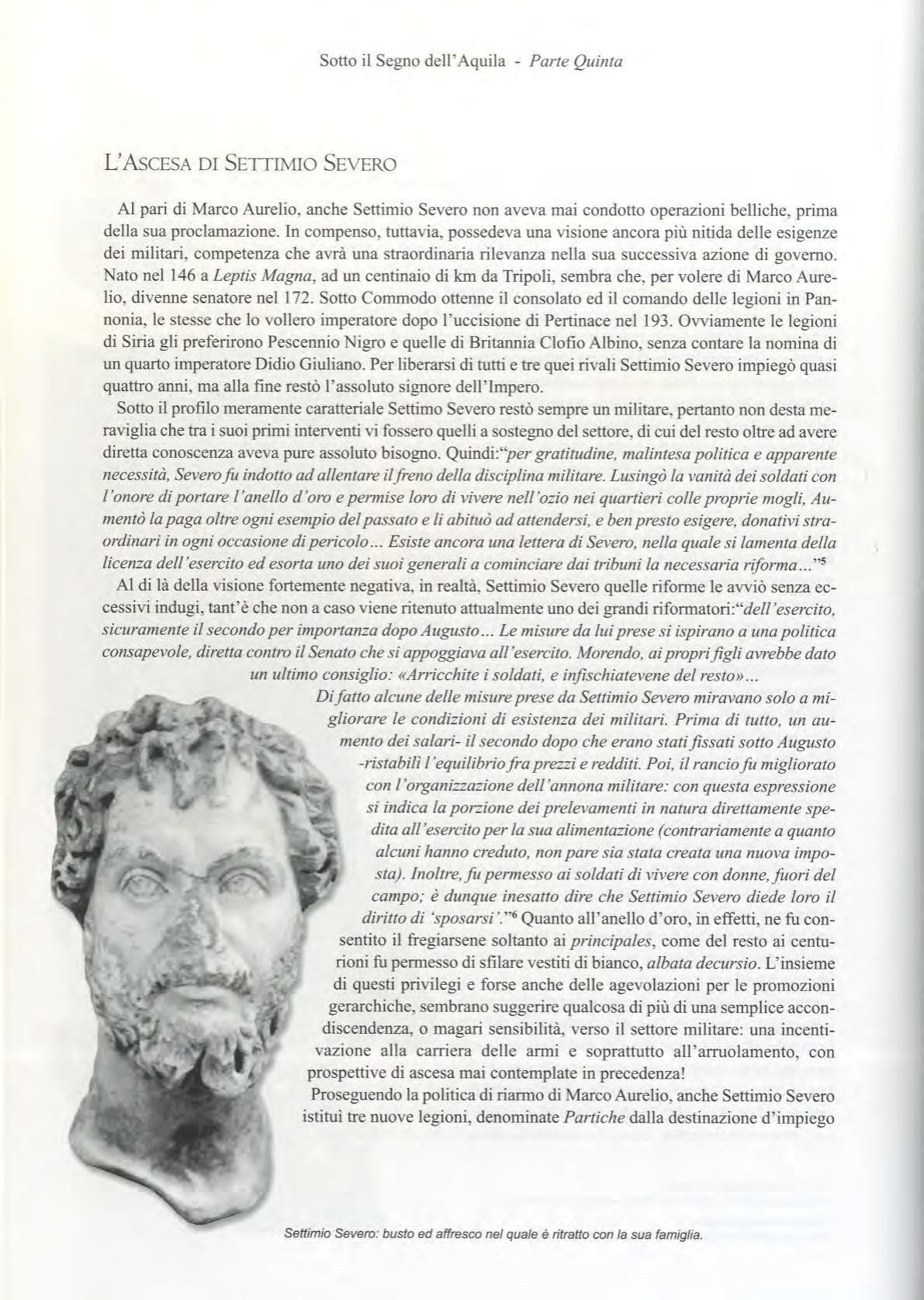
Sotto il profilo meramente caratteriale Settimo Severo restò sempre un militare,pertanto non desta meraviglia che trai suoi primi interventi vi fossero quelli a sostegno del settore,di cui del resto oltre ad avere diretta conoscenza aveva pure assoluto bisogno. Quindi:“pergratitudine, malintesopolitica e apparente necessità, Severo/ir indottoadallentare ilfreno della disciplina militare.Lusingo’ la vanità dei soldati con !'onoredipanare I ’anellod 'oroepermise loro di vivere nell'ozio nei quartieri colleproprie mogli, Aumentà lapaga oltreogni esempiodelpassato e li abitati adattendersi, e benpresto esigere,donativistraordinari in ogni occasione dipericolo... Esiste ancora una letteradi Severo, nella quale si lamenta della licenza dell ’esercitoed esorta una dei suoi generali a cominciare dai tribuni la necessaria riflrrma ”5
Al di là della visione fortemente negativa, in realtà, Settimio Severo quelle riforme le avviò senza eccessivi indugi,tant’è che non a caso viene ritenuto attualmente una dei grandi riformatoriz“dell ’esercito, sicuramente ilsecondoper importanzadopoAugusto... Le misure da luiprese si ispirano a unapolitica consapevole,diretta contro ilSenato che si appoggiava al]’esencito.Morendo, aiproprifigli avrebbe dato un ultimo consiglio: «Arricchite isoldati, e infischiatevene del resto»… Difi1tto alcune delle misureprese da Settimio Severo miravano solo a mi» gliorare le condizioni di esistenza dei militari. Prima di tutto, un aumento dei salari- il secondo dopo che erano statifissati sottoAugusto -ristabili !'equilibriofra prezzi e redditi.Poi, ilranciofu migliorato con I ’organizzazionedel! 'annonamilitare: con questa espressione si indica laporzione deiprelevamenti in natura direttamente spedita all ’esercitoper lasua alimentazione (contrariamentea quanto alcuni hanno creduto, nonpare sia stata creata una nuova imposta). Inoltre,fit permesso ai soldati di vivere con donne,fitori del campo; è dunque inesatto dire che Settimio Severo diede loro il dirittodi ‘sposarsi’.”‘Quanto all‘anello d’oro,ineffetti,ne fu consentito il fregiarsene soltanto ai principala, come del resto ai centurioni fu permesso di stilare vestiti di bianco,albata decursio.L’insieme di questi privilegi e forse anche delle agevolazioni per le promozioni gerarchiche, sembrano suggerire qualcosa di più di unasemplice accondiscendenza, o magari sensibilità, verso il settore militare: una incenti— vazione alla carriera delle armi e soprattutto all’arruolamento, con prospettive di ascesa mai contemplate inprecedenza!
Proseguendo lapolitica di riarmo di Marco Aurelio, anche Settimio Severo istituì tre nuove legioni,denominate Partiche dalla destinazione d’impiego
Sotto il Segno dell'Aquila - Parte Quinta
Settimio Severo: busto ed altresoo nel quale è riunito con la sua {army/ta.
prevista ed il cui organico complessivo corrispondeva ad unincrementopari al 10% dell’intero esercito. A capo delle stesse non pose dei legati di rango senatoria, come di prassi, ma dei prefetti equestri, opzione che sembra suggerire unaprecisa scelta politica, dal momento che i cavalieri furono sempre notoriamentepiù ligi all’imperatore. Senza contare che,afiidando il comandodelle vexillatianes,di crescente impiego,&duces epraepositi nani dai quadri delle legioni,si andava delineando unprogressivo distacco dei poteri civili e militari. Si trattava senza dubbio di novità foriera di vistose conseguenze successive come pure lo fu, per vari aspetti anche di più, la sua decisione di stanziare la [[ Portico ad Albano, nei pressi di Roma, dove ancora èpossibile scorgerne i resti del campo.Altra iniziativa rivoluzionariafu il congedo con igrominia della GuardiaPretoriana, con una umiliante cerimonia… In dettaglio stando alle fonti concentrati i suoi militi, completamente disarmati, in una pianura vicino alla Città, stretti fra le lance spianate di legionari scelti illiriei, dichiarati traditori,furono obbligati prima a cedere le loro lussuose uniformi e poi ad allontanarsi a non meno di cento miglia, mentre nel frattempo la loro caserma veniva , da un altro " per evitare , ‘‘ ' sorpresa. Circa l’entità delle unità che andarono a sostituire i pretoriani sono stimate in dieci coorti di organico doppio, pari a tre legioni,più un contingente di cavalleria tratto dai Mauri.
LA GRANDEINFLAZIONE
Delle riforme cosi incisive, supportate da incentivi e benefici tanto consistenti, unitamente alla crea» zione di nuove legioni,che sommandosi a quelle di Marco Aurelio ammontavano ad unquinto delle già esistenti, non potevano attuarsi senza disporre di una cospicua riserva economica. Ma questa era ben lontana dall’esserci nelle casse dello Stato, ne' si poteva sperare di reperirla mediante ulteriori imposte per cui,semprepiù pressato da improerastinabili esigenze,Settimio Severo ricorse ad una effettivatruffa '' ' n.L’ , ” fu, con la , alle “ ' la seconda,maforse più grave, concausa della dissoluzione dell’Impero. inpratica l’imperatoreautoriuò l‘adulterazione della moneta, variandone lapercentuale di oro e di argentoal suo interno: una sorta di falsificazione di Stato! Per la ve424
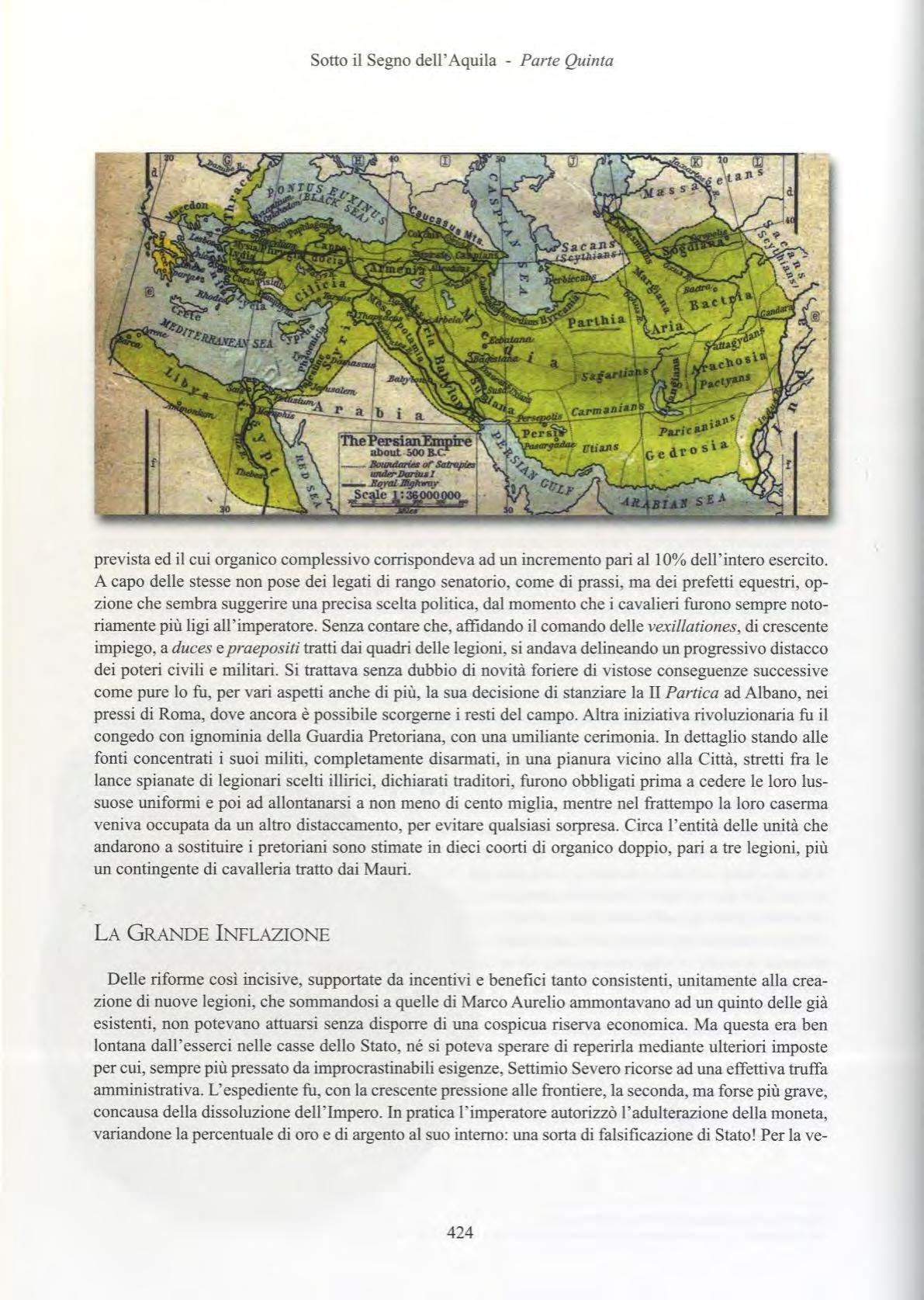
Sotto il Segno dell‘Aquila - Pane Quinto
rità, non si trattavaneppure per l’epoca di una novità assoluta, essendo un espediente tipico dei momenti di crisi,tant’è che:“una legislazionecon/lo ifalsari esistevagià in epoca repubblicana; leprime leggi sernbrono risalire a Mario: mofir soprattutto Silla, in questo come in altri campi, a lasciare una legislazione definita, Non a casoproprio agli inizi del Il] secolo, questo Lex Comeliaviene ripetutamente ricordato e citata,- essa era trattato da Ulpiano, nel suo libro de ofiicio prooonsolis e da Paolo. Esso è oggetto di particolare attenzione nelle Sententiae attribuite appunto a questo insignegiurista dell'età Saverione... La legislazione appare molto severa: essaprospetta la confisca dei beni e !'esilio,cioè la deportazione, aifillsari di origine ingenua, lamorteaquellidi origineservile; questepunizioni sono, in epocapiù tarda, addirittura inasprite (sotto Costantino,nel 321); CostanzoIl cammino addirittura lapena capitale anche aifalsori di origine non servile. L 'entitddellepene certifica della estensione delfenomeno ’”
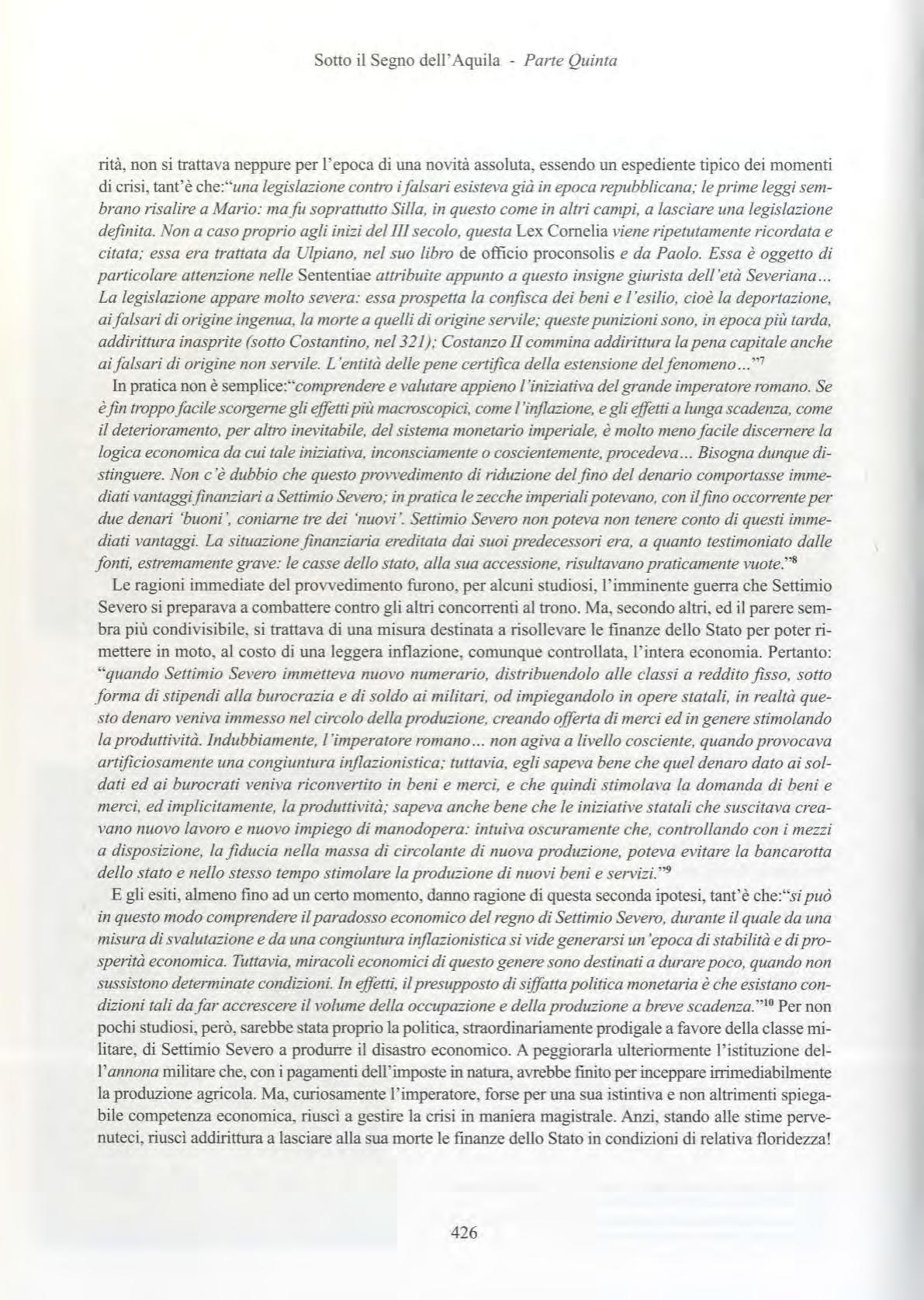
In pratica non èsemplice:“comprendere e valulare appieno I 'mi 'ativadelgrande imperatoreromano. Se èfn troppofacile scorgernegli qî'ettipiù macroscopici come ! ’in/lozione,egli efi'ettia lungascadenza, come il deterioramento,per altro inevitabile,del sistema monetario imperiale, è molto menofi1cde discernere la logica da cui tole' . o p: " Bisogna dunque distinguere, Non c 'èdubbio che questoprowedimento di riduzione delfina del denario comportasse imme» diati vontaggifinanziariaSettimio Severo: inpratica lezecche imperialipotevano, con ilfina occorrenteper due denari ‘buoni',coniarne tre dei 'nuovi',Settimio Severo nonpoteva non tenere conto di questi immediati vantaggi. La situazionefinanziaria ereditata dai suoipredecessori era, a quanto testimoniato dalle fonti, estremamentegrave: le casse dellostato, allasua occessione risultavanopraticamente vuote."
Le ragioni immediate del provvedimento tirreno,per alcuni studiosi,l’irruninente guerra che Settimio Severo si preparava a combattere contro gli altri concorrenti al trono.Ma, secondo altri. ed il parere sembra più condivisibile, si trattava di una misura destinata a risollevare le finanze dello Stato per poter ri— mettere in moto, al costo di una leggera inflazione,comunque controllata, l’intera economia, Pertanto: “quandoSettimio Severo immetteva nuovo numerario, distribuendolo alle classi a redditofisso, sotto forma di stipendi alla burocrazia e di saldo ai militari, od impiegandolo in opere statali, in realtà que» sto denaro venivo immesso nel circolodellaproduzione, creando offertodi merci ed ingenere stimolando laproduttività. Indubbiamente, l'imperatoreromano... non agiva a livello cosciente, quandoprovocava artificiosamente una congiuntura inflazionistico; tuttavia,eglisapeva bene che quel denaro dato ai soldati ed ai burocrati veniva riconvertito in beni e merci, e che quindi stimolava la domanda di beni e merci, ed implicitamente, laproduttività; sapeva anche bene che le iniziative statali che suscitava creavano nuova lavoro e nuovo impiego di manodopera: intuivo oscuramenle che, controllando con i mezzi a disposizione, lafiducia nella massa di circolante di nuova produzione, potevo evitare la bancarotta dello stato e nello stesso tempostimolare laproduzione di nuovi beni e servizi"”
E gli esiti,almenofino ad uncertomomento danno ragione di questaseconda ipotesi,tant’è che:“sipuò inquestomodo comprendereIlparadosso economicodel regnodiSettimio Severo, durante il quale da una misura di ' eda una si vide 'un'epocadistabilità e diprosperità economicaTuttavia,miracolieconomicidiquestogenere sonodestinatiadurarepoca, quando non “" ' In efi"etti,il, disiflhttapolitica monetaria eche esistanocondizioni tali dafar accrescere il volume della occupazione e dellaproduzione a breve scadenza?“ Per non pochi studiosi,però, sarebbe stataproprio lapolitica, straordinarianrente prodigale afavore della classe militare, di Settimio Severo a produrre il disastro economico.A peggiorarla ulteriormente l’istituzione dell'annonamilitare che,con ipagamenti dell’irnposte innatura,avrebbefinito per inceppare irrimediabilrnente laproduzione agricola.Ma, curiosamente l‘imperatore,forse per una sua istintivae non altrimenti spiegabile competenza economica,riusci a gestire la crisi in maniera magistrale. Anzi, stando alle stime perve— nuteci,riusci addirittura a lasciare alla sua morte le finanze dello Stato incondizioni di relativafloridezza!
Sotto il Segno dell'Aquila Parte
Quinta
426 l
Cassio Dione. che per primo volle studiame seriamente le disposizioni, non ebbe dubbi al riguardo affermando senza esitazione che:“alrnenodurante ilperiodo, non breve, del suo regno, Settimio Severo sembra sia riuscito afrenare la congiuntura, e ad invertirne la tendenza: la ’ ' politica , di uno _., epur prudente inter- sua ( e ventismostatale cheper parecchi aspettirassomiglia a quella… [di] Diocleziano... sembra es» sere riuscita nel tentativo di dominare lapericolante situazione…”
Ne derivò, in ultima analisi, una antesignano economia di guerra, certamente contrassegnata da fenomeni di inflazione e di svalutazione monetaria, ma anche da esiti complessivi non del tutto negativi,proprio per il basilare ruolosostenuto dall ’esercito.Dal momento che i militari rispetto alla media degli abitanti dell‘Impero,grazie al redditofisso di cui godevano, costitui— vano ormai unaclasse benestante,già la sola loropresenmz“creava un 'areadi ricchezza mobif liare;essi vigiocavano un ruolo motore, nelsenso concretodel termine,poiche' mettevano inmoto una macchina: da un lato, loStato attingeva daiprivati per pagare isoldati; dall 'altro,gli stessipri— vati recuperavanoquestodenaro con lespese cheiconsuma/ori appartenenti all 'esercitofizcevano.”12Quel particolare sistema economico,con laformazione delle grandi basi permanenti dell'Alto impero,divenute laprassi nei secoli successivi, ostentòunprogressivo incremento.Ogni grande campo,infatti, era al contempopure:“un mercato importante, e i civili ne eranoconsapevoli. L 'approvvigionamentodel campofil assicurato dapprima da una embrionale intendenza,poi dalla attivazione di quella che è stata chiamata ! ’armonamilitare...Le armirappresentavanoun 'altraspesa importanteper isoldati che dovevanofarsene carico, contrariamenteaquel cheaccadeneglieserciti moderni: neisecoli!e11ognimilitarepagava ilproprio equipaggiamento,nel [Ilsecolo inveceera loStato afornirlo, masi rifaceva effettuando un deduzione sullapaga. Cosìpure le unifimni, i vestiti ele tende non erano in dotazione daparte dello Stato. Inoltre I 'esercitoutilizzavaanimali da basto, buoi da aramrasuiprata… e cavalcature, cavalli e cammelli.Infine, isoldati si comportavano come ogni consumatore relativamente agiato... [che fa] acquisti diversi…"“
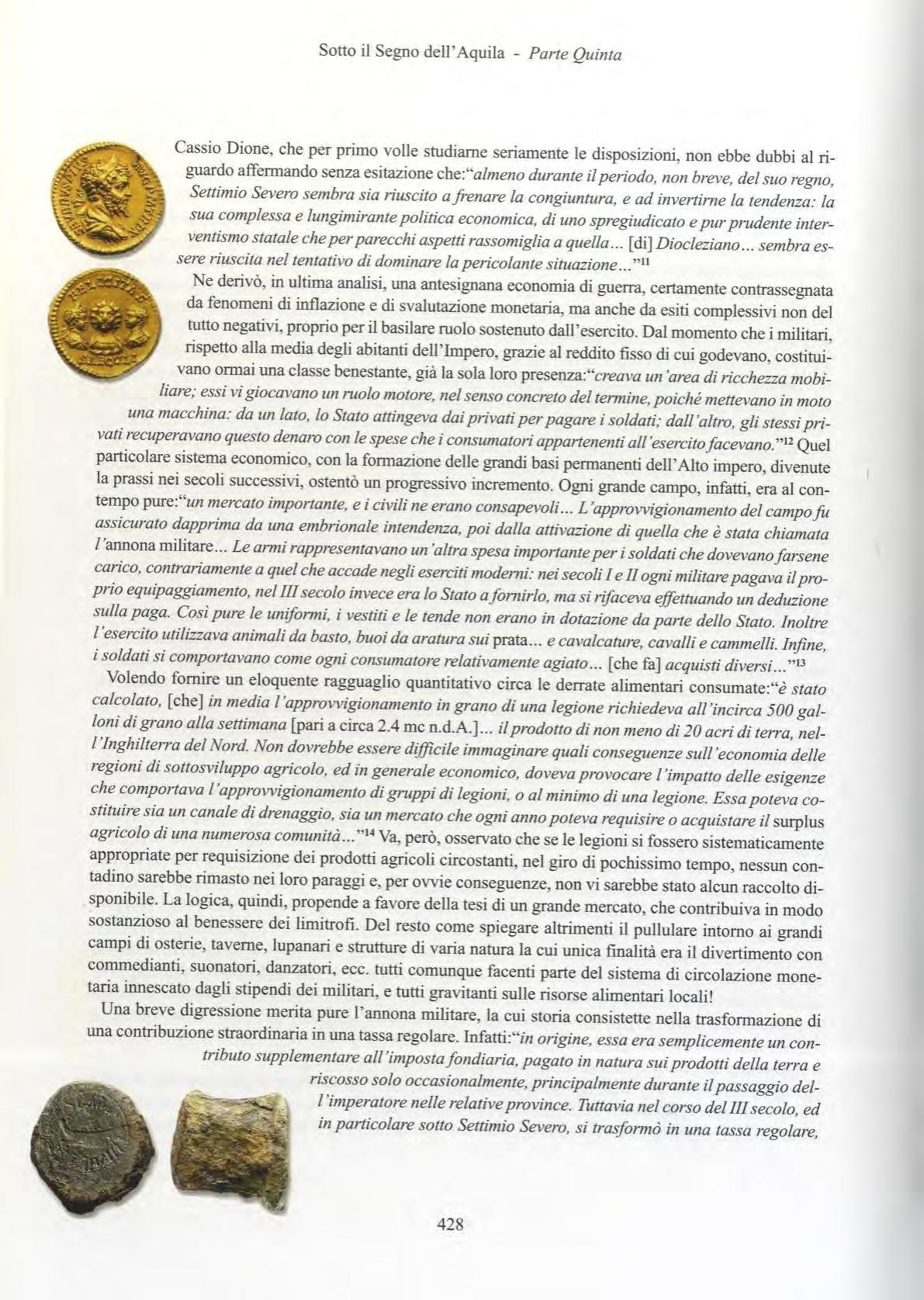
Volendofornire un eloquente raggnraglio quantitativo circa le derrate alimentari consumater“è stato calcolato, [che] in media 1'approvvigionamentoingrano di una legione richiedeva all incirca 500gal— Ioni digrano allasettimana [pari a circa2.4 mc n.d.A.]… ilprodotto di non meno di 20 acridi terra,nel!’]nghilterradel Nord. Non *' “ essere difi'icile ‘ quali sull ' delle regioni di sottosviluppo agricolo, ed ingenerale economico, dovevaprovocare I ’impattodelle esigenze che comportava I ’approvvigionamentodigruppi di legioni, o al minimo di una legione. Essapoteva costituire sia un canale di drenaggio,sia unmercato che ogni annopoteva requisire oacquistare il surplus agricolodi una numerosa comunità…"“Va,però, osservato che se le legioni si fossero sistematicamente appropriate per requisizione dei prodotti agricoli circostanti,nel giro di pochissimo tempo,nessun contadino sarebbe rimasto nei loroparaggi e,per ovvie conseguenze,nonvi sarebbe stato alcun raccolto disponibile. La logica,quindi,propende afavore della tesi di un grande mercato, che contribuiva in modo sostanzioso al benessere dei limitrofi. Del resto come spiegare altrimenti il pullulare intorno ai grandi campi di osterie,taverne, lupanari e strutture di varia nanna la cui unicafinalità era il divertimento con " i,’ i,ecc. tutti . facenti parte del sistema di circolazione monetaria innescato dagli stipendi dei militari, e tutti gravitanti sulle risorse alimentari locali!
Unabreve digressione merita pure l’annona militare, la cui storia consistette nella trasformazione di unacontribuzione straordinaria in unatassaregolare.Infatti:“in origine, essaerasemplicemente un contribqu supplementare allimpostafondiaria, pagato in natura suiprodotti della terra e riscossosolo occasionalmente,principalmente durante ilpassaggio de!!imperatorenelle relativeprovince. Tuttavianel corsodel[Ilsecolo, ed inparticolare sotto Smirnio Severo, si trasformò in una tassa regolare,
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte Quinta
428
LondraeParigiallafine delXVI sec.:evidenteI'lmpostazioneurbana originariadiaccampamentoromano. London andParisal theendof theXV! ceniuly:theoriginalurbanlayoutnia Romancampisevideni chefit riscossa in tutteleprovince con ] 'ausiliodi una apposita organizzazione; eccezionale ai suoi inizi, essa divennepermanente nel corso di una trasformazionechesiprecisò apartire dagli ultimi decenni del Ilsecolo…[poichéforse] esisteva unacertaorganizzazione del]’annonamilitaregià durantegli ultimi anni delregnodiMarco Aurelio; è tuttaviaassaiprobabile che,proprio apartire dalsoggiorno di Settimio Severo inEgitto (dicembre 199) edallasua concessionea questa regione delsistema municipale, taleorga— nizzazione diventassepermanente, eomepermanente era divenuto lo stato di guerra, e si unifimnosse al resto delle imposte… l 'annonasipuò consideraresu!pianofiscale «!immaginedella crisi economica che separa Iimpero degli Antonirni dall impero di Teodosio». In efletti la strutturazione dell’annonadipendeva dalle esigenze del! 'apparato militare e si era realiuata infinzione di queste; ma si spiega, preciv puarnente, sul terrenodella crisimonetaria chesconvolse I 'intperotrailIIedilIIIsecolo esulla base della praticasemprepi difiîuadeipagamenti innatura aisoldati edallaburocrazia dell impero,Per ilmomento 1'annonaapparirà a Settimio Severo comeun meropraticoperfarfronte allesue dificoltzìfinanziarie ed della spesa, LL " derivante dal! ' degli effettivi del! ‘armato…"‘5
un aspetto delle grandi basi meno noto e forse persino pi emblematico al riguardo: la loro produttivitàdi tipoproto industrialeo artigianale all‘ingrosso, Infatti inogni fortezza e grande base vi erano dei laboratori e delle ofiicine, in latinofabbrica. il cui compito consisteva nel produrre i materiali e le attrezzature di cui la legione e le sue varie pertinenze necessitava… lnparticolare venivano prodotti mat-
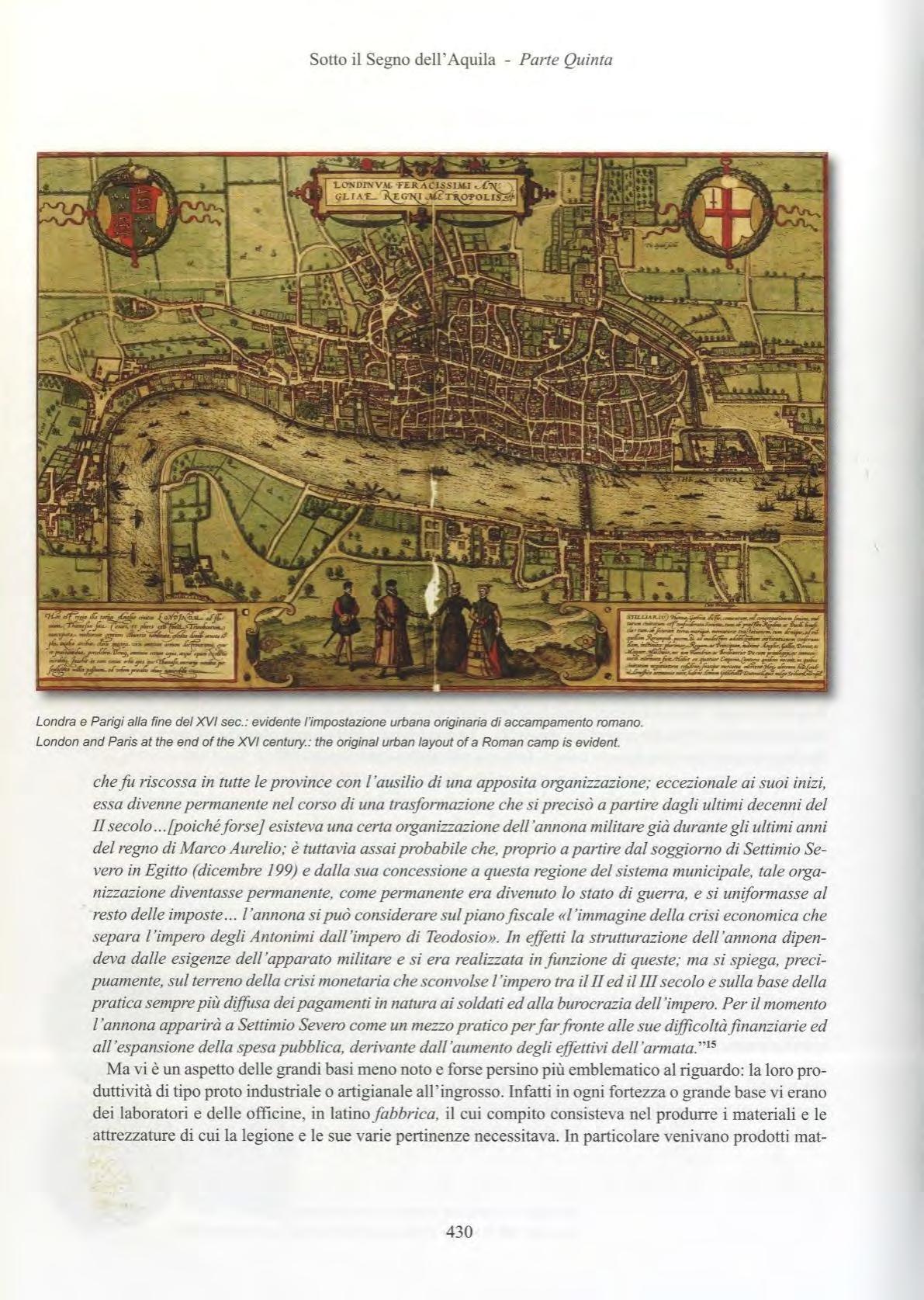
Sotto il Segno dell‘Aquila - Parte Quinta
430
toni e tegole, in apposite fornaci, come pure tubature di piombo e persino chiavi d‘arresto di bronzo. tutti marchiati col sigillo ed ilnumerale dell’unità. Probabile che talicomponenti non fossero soltanto de— stinati alle strette esigenze della base, ma trovassero sbocco sul mercato civile, tanto più che i militari erano esentati da un editto di Nerone dal pagamento delle imposte, Inoltre la stessa unità si faceva carico della coltivazione delle terre limitrofe, che non di rado destinava pure a pascolo per l’allevamento del bestiame.Almeno una iscrizione ci ha tramandato l’invio di un contingente per falciare il fieno, con queste parole: “ '” ' adfienurn ’ ”“Volendo’ " più …. questo aspetto, nelle fabbriche legionarie erano prodotti manufatti vari quali mattoni, tegole.
L’insieme di queste potenzialità che Settimio Severo seppe abilmente sfruttare con nuovi incentivi di carriera e nuove previdenze economiche, innescò un certo incremento degli arruolamenti con un notevole innalzamento dello spirito combattivo. Questo fu prontamente sfruttato nelle sue campagne orientali, che si uasforrnarono in grandi successi militari e, soprattutto per gli immensi bottini non a caso equiparati aduna sorta di fiume aureo, ingrandi apporti economici.ll cheforni unsalvifico aiuto allapoliticamonemria: a conferma laripresa della monetazione aurea nel 205, dopo laconquista di Ctesifonte nel 198,emissione già sospesa da tempo.
Il contributo,quindi, dell’impero di Settimio Severo fu, indefinitiva e nonostante tutto,quello di aver continuato sulla strada delle riforme militari, mettendo gli uomini al primo posto e di avere, in qualche modo, restituito a Romauna sia pur temporaneadeterrenza lungo le frontiere, con non trascurabiliricadute economiche… Non per questo, però, la situazione complessiva divenne meno critica, anche perché nel frattempo i barbari non certamente eranorimasti passivi a guardare ma, evento fino ad allora inconcepibile,iniziavano afederarsi fra loro,coalizzandosi contro l’Impero.La tradizionalepolitica del dividi et impera si poteva ormai reputare al tramonto,con tutte le tragiche conseguenze,
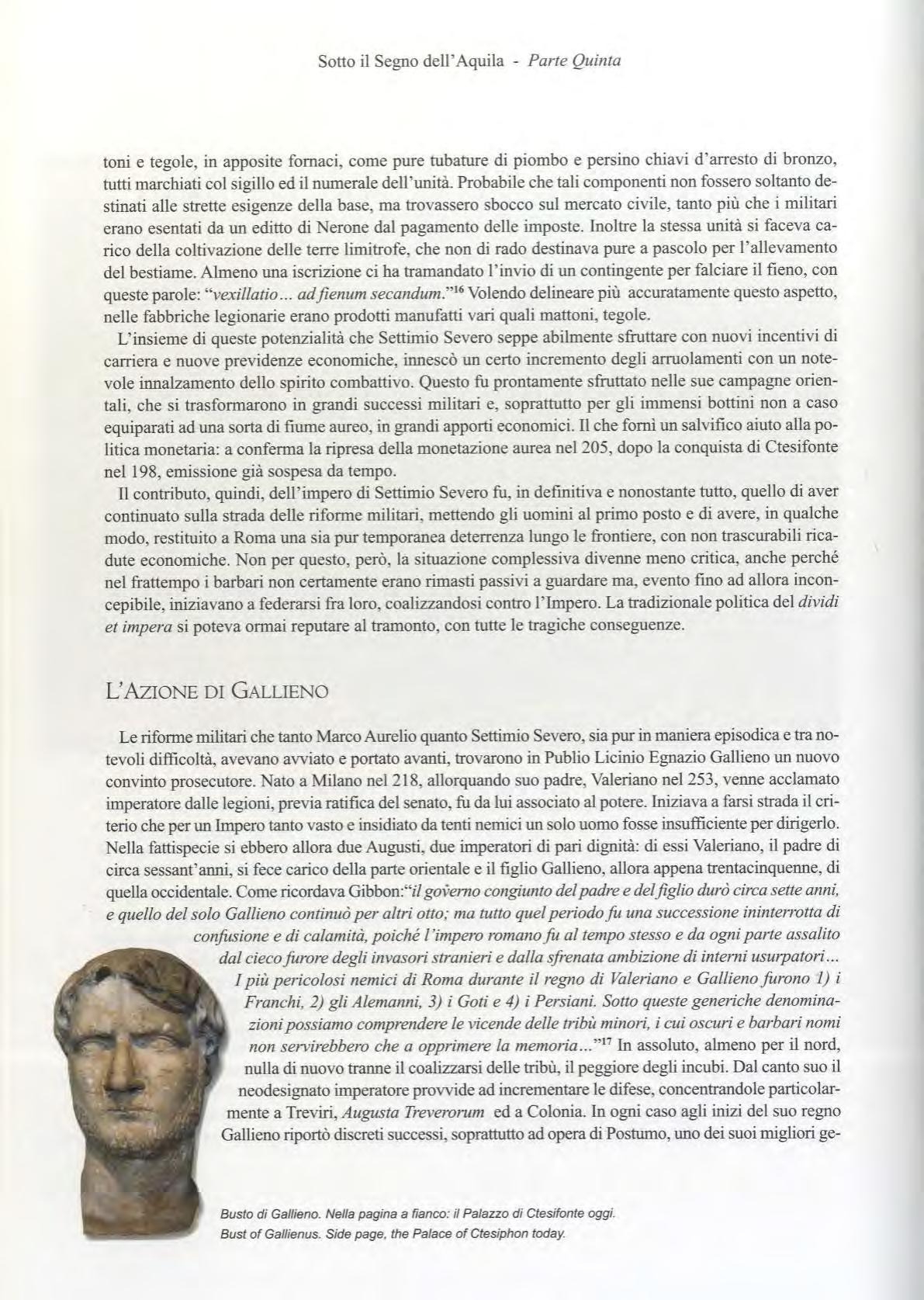
L'AZIONE DI GALLIENO
Le riformemilitari chetantoMarcoAurelio quanto Settimio Severo,siapur inmaniera episodicae tranotevoli difficoltà,avevano avviato e portato avanti, trovarono inPublio Licinio Egnazio Gallieno un nuovo convinto prosecutore. Nato a Milano nel 218, allorquando suo padre, Valerianonel 253, venne acclamato imperatoredalle legioni,previa ratificadel senato,fu da lui associato alpotere. Iniziavaafarsi strada ilcriteriocheper unImpero tantovastoe insidiatodatentinemici unsolo uomo fosse insufficienteper dirigerlo. Nella fattispecie si ebbero allora due Augusti, due imperatori di pari dignità: di essi Valeriano,il padre di circa sessant’anni, si fece carico della parte orientale e il figlio Gallieno, allora appenatrentacinquenne,di quellaoccidentale.ComericordavaGibbon:“ilgoùernocongiuntodelpadre edelfiglio durò circasette anni, equello delsolo Gallieno continuòper altri otto: ma tuttoquelperiodofix una successione ininterrotta di confusione edi calamita",poiché l'impero romanofi4 al tempostesso eda ogniparte assalito dalciecofurore degli invasoristranieri edallasfrenata ambizione di interni usurpatori I più pericolosi nemici di Roma durante il regno di Valeriano e Gallienofurono ]) i Franchi, 2) gli Alemanni, 3) i Goli e 4) i Persiani. Sotto queste generiche denomina zionipossiamo comprendere levicendedelle tribùminori, icui oscuri ebarbari nomi non servirebbero che a opprimere la memoria...”" ln assoluto, ahneno per il nord, nulladi nuovo tranne ilcoalizzatsi delle tribù,ilpeggiore degli incubi.Dal canto suo il ' ' , provvide ad ledifese, ’ ‘ particolarmente a Treviri,Augusta Trevemrurn ed a Colonia. In ogni caso agli inizi del suo regno Gallienoriportò discreti successi,soprattutto adoperadi Postumo,uno dei suoi migliori ge-
Sotto il Segno dell’Aquila -
Parte Quinta
Busto di (Sa/Irena.Nellapagina afianco: ilPalazzodi Ctesifonteoggi. BustalGallienus.Sidepage. mePalace ofCtesiphontoday
nerali. ma le terribili incursioni che si susseguirono nel biennio 2577258. cancellarono drasticamente ogni fin troppo sconsiderata euforia.
l Franchi, varcato il Reno, scorsero l’impero spingendosi fino alla Spagia, dove misero a sacco persino Tarragonaalpunto dadistruggerlaquasi. Equando non vi fu più nulla da razziarc presero lenavi ormeggiatenei porti epassarono adevastare laMauritania. GliAlamanni (alimentutti uomini) dal canto loro. traversate il Danubio e varcate le Alpi Retiche diressero. invece, su Milano proseguendo su Ravenna allavoltadi Roma. Un estremo sussulto d'orgoglio istigò il Se— nato a farsi carico della difesa, essendo i due imperatori impegnati in guerre lontanissime.Un esercito mccogliticcio bastò afugare nei barbari ogni facile illusioneper cui, stracarichi di bottino.rientrarono dadove eranopartiti. Più che di vittoria Sl trattòdi una non sconfina esolo qual— che tempodopo Gallieno riusci realmente abatterli presso Milano: ma se non sull’episodio, sulla sua etîettiva entitàpersistono fondati dubbi! In ogni caso per evitare il ripetersi di quelle funeste iniziative Gallieno strinse una singolare alleanza con ilre dei Marcomanni, sposandone lafiglia, matrimonio che gli altezzosi patrizi vollero sempre considerare soltanto alla stregua di un concubinaggio. Frequentissime le scorrerie dei Goti lungo ilDanubio, spinte avolte fino alla Macedonia ed all'Italia, sempre contiastate. magari in fase di rientro, dalle forze romane. Quando però l’obiettivo divenne l'Asia minore, bastò ladisponibilitàd’una piccola flotta per ilPonto e ‘ con bottino T “
Segui unaseconda spedizione gotica conesiti persino peggiori.con devastazioni dell’Asiaminore epoi della Grecia: adAtene per puro miracolo lagrandiosa biblioteca scampi) al rogo.
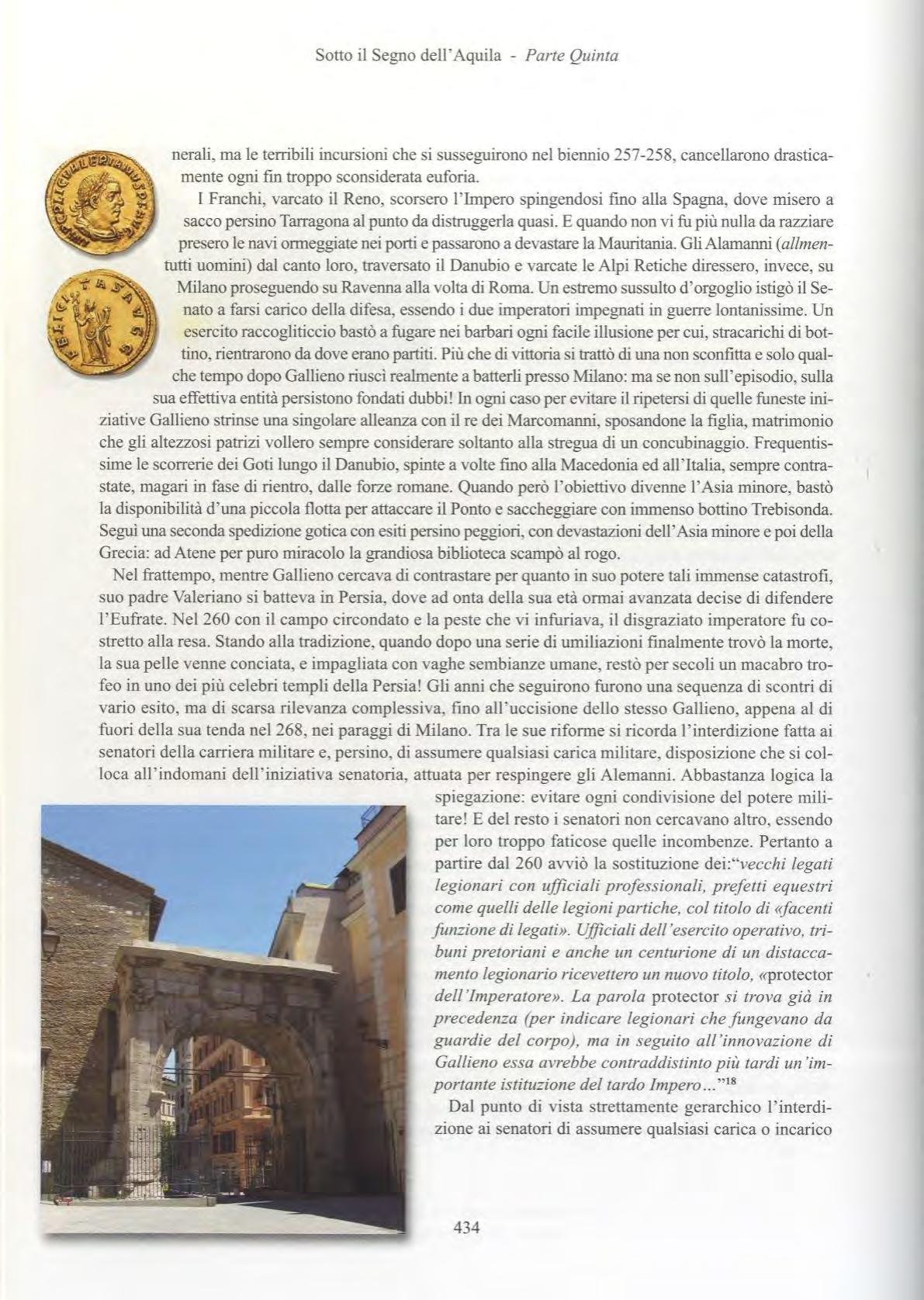
Nel frattempo, mentre Gallieno cercava di contrastare per quanto insuo potere tali immense catastrofi, suo padre Valeriano si batteva in Persia, dove ad onta della sua età ormai avanzata decise di difendere l’Eufrate. Nel 260 con il campo circondato e la peste che vi infuriava, il disgraziato imperatore fu costretto alla resa. Stando alla tradizione,quando dopo una serie di umiliazioni finalmente trovò lamorte, lasuapelle venne conciata, e impagliata con vaghe sembianze umane, restò per secoli un macabro trofeo in uno dei più celebri templi della Persia! Gli anni che seguirono furono una sequenza di scontri di vario esito, ma di scarsa rilevanza complessiva. fino all‘uccisione dello stesso Gallieno, appena al di fuori della sua tendanel 268,nei paraggi di Milano. Tra le sue riforme si ricorda l‘interdizione fatta ai senatori della carriera militare e,persino, di assumere qualsiasi carica militare, disposizione che si colloca all'indomani dell'iniziativa senatoria, attuata per respingere gli Alemanni Abbastanza logica la spiegazione: evitare ogni condiv ione del potere mili» tare! Edel resto i senatori non cercavano altro, essendo per loro troppo faticose quelle incombenze. Pertanto a partire dal 260 avviò la sostituzione dei:“vecchi legati legionari con ufficiali professionali, pre/tetti equestri come quelli delle legionipartie/te. col titolo di «facenti fitnzione di legati». Ufficialidell 'esel‘citooperativa, tribuni pretoriani e anche un centurione di un distaccomento [egionarlo ricevettero un nuovo titolo, «protector dell'Imperatore». La parola protector si trova già in precedenza (per indicare legionari che,/iingevano da guardie del corpo), ma in seguito al! innovazione di Gallieno essa avrebbe contraddistinto più tardi un 'im— portante istituzione del tardoImpero…“x
Dal punto di vista strettamente gerarchico l’interdiv zione ai senatori di assumere qualsiasi carica 0 incarico 434
Sotto il Segno dell'Aquila - Parte Quinta
militare, comportò, come delineato, la soppressione dei legati e dei tribuni laticlavi. Da quel momento i prefetti del campo, si ritrovarono di fatto acapo delle legioni,per lasimultanea scomparsa dei due gradi gerarchici superiori, ele stesse ebbero un inquadramento uniforme, sulla falsariga di quelle di stanza in Egitto 0 delle nuove tre Partiehe.Al contempo anche i governatori di province furono soppressi e sostituiti dapraesides, di rango equestre, ai quali rimasero sottoposti i prefetti di legione.
Gallieno, inoltre, per una sua improbabile competenza strategica () per una più verosimile sensibilità sviluppata in conseguenza della fine del padre, realizzò nitidamente che l'Impero ormai non potevaessere difeso daunafrontiera stabile erigida,un cordone omogeneamentepresidiato dalle legioni acquartierate nelle lorofortezze. Taleconcezione consiste:“nella distribuzione regolare delleforze difensive disponibili lungo tutta la linea di intercettamento, in modo da coprire uniformemente tutto il fronte. E 'senz’altrovero chequando ilnemico attacca una difesa ’acordone’hailvantaggio di un 'alla concentrazione diforze rispetto alle truppedifensive distribuite invece lungo tuttoilconfine (vantaggio che hanno tutte le colonne mobili che attaccanofronti tatticamente statici): in questo caso !'af» fensiva, pur essendo numericamente inferiore…può sempre ottenere unasuperiorità ‘disfondamento ’ localizzata nelpunto scelto per lapenetrazione.…” La difesa a cordone di sbarramento non era ormai nella concretezza delle possibilità, e per lacarenza delle forze difensive rispetto a quelle offensive, e per l’immensità della frontiera. Scelse perciò la soluzione che diverrà canonica in tutti i casi del genere: le forze di contrasto sarebbero state concentrate soltanto inalcuni punti, pronte a intervenire su precisa segnalazione nelle zone minacciate.Affinché una disposizione del genere riuscisse remunerativasotto il profilo difensivo, era indispensabile che le grandi basi fossero impiantate abbastanza arretrate, in modo da poter abbracciare una più ampia sezione di fronte. Il che, però, implicava che le unità destinate all‘intercettazione,fossero particolarmente celeri per accorrere in tempo utile e che la rete di sorveglianza e di allarme fosse capillare e ben collegata.
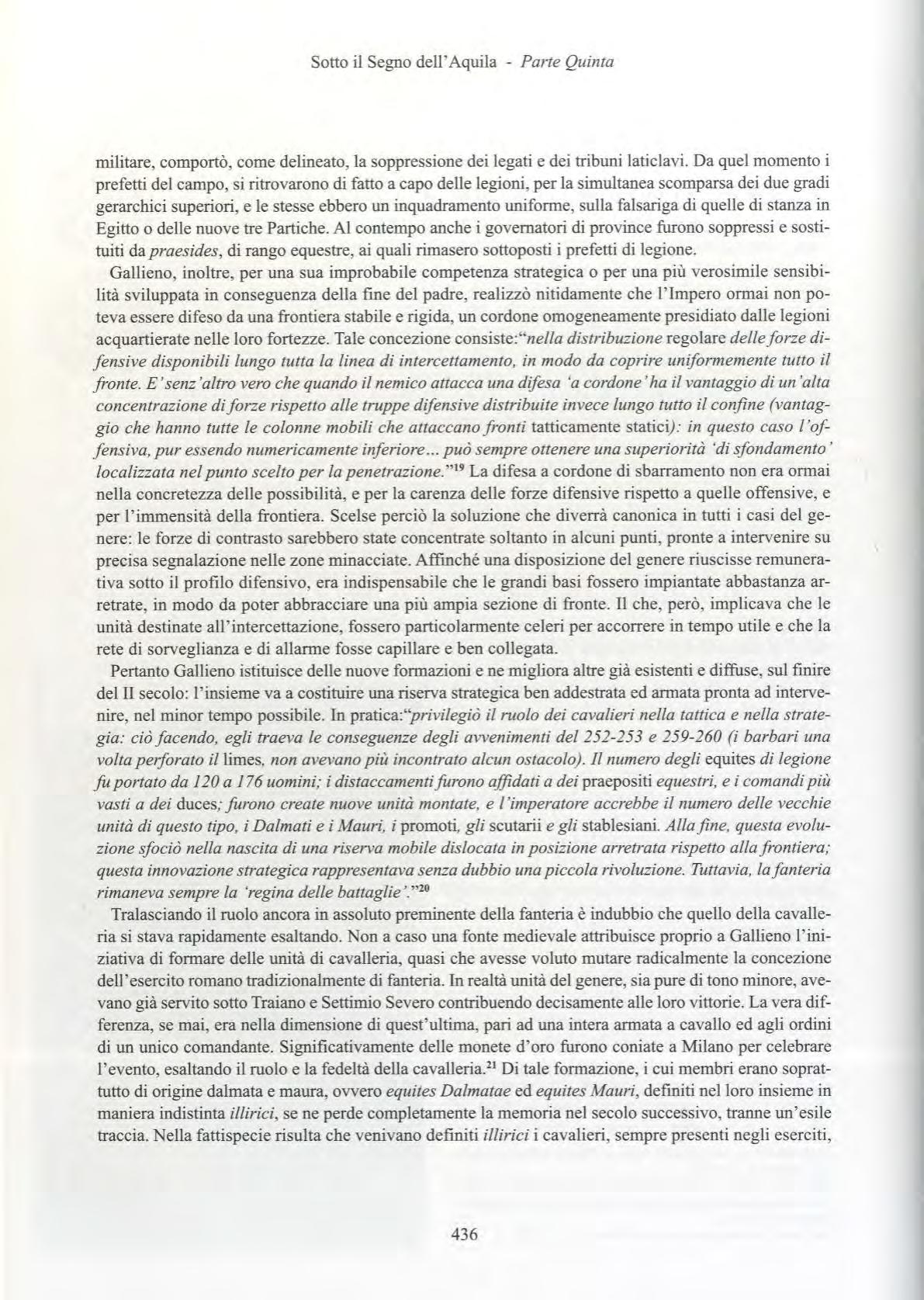
Pertanto Gallieno istituisce delle nuove formazioni e ne migliora altre già esistenti e diflilse, sul finire del [I secolo: l’insieme va a costituire unariserva strategica ben addestrata ed armatapronta ad intervenire, nel minor tempo possibile. In praticaz‘pn'vilegio' il ruolo dei cavalieri nella tattica e nella strategia: cidfacendo, egli traeva le conseguenze degli avvenimenti del 252-253 e 259-260 {i barbari una voltaperforato illimes, non avevanopiù incontrataalcun ostacola). Ilnumero degli equites di legione fixportato da 120a 176uomini; idistaccamentifirmno affidati a deipraepositi equestri, e i comandipiù vasti a dei duces;furono create nuove unità montate, e l'imperatore accrebbe ilnumero delle vecchie unità di questo tipo, iDalrnati e iMauri, ipromoti, gli scutarii egli stablesiani. Allafine, questa evoluzione sfocr'ò nella nascita di una riserva mobile dislocata inposizione arretrata rispetto allafrontiera; questa innovazionestrategica rappresentavasenza dubbio unapiccola rivoluzione. Tuttavia,lafanteria rimanevasempre la 'reginadellebaltaglie i“"
Tralasciando il ruolo ancora inassoluto preminente della fanteria è indubbio che quello della cavalle— ria si stava rapidamente esaltando. Non a caso una fonte medievale attribuisce proprio a Gallieno l’iniziativa di formare delle unità di cavalleria, quasi che avesse voluto mutare radicalmente la concezione dell’esercito romano tradizionalmentedi fanteria. In realtàunitàdel genere, siapure di tonominore, avevano già servito sotto Traianoe Settimio Severo contribuendo decisamente alle lorovittorie.La vera dif— ferenza, se mai, era nella dimensione di quest‘ultima, pari ad una intera armata a cavallo ed agli ordini di un unico comandante. Significativamente delle monete d'oro furono coniate a Milano per celebrare l’evento, esaltando il ruolo e la fedeltà dellacavalleria." Di tale formazione, i cui membri erano soprattuttodi origine dalmata e maura, ovvero equites Dalmatae ed equites Mauri, definiti nel loro insieme in maniera indistinta illirici, se ne perde completamente lamemoria nel secolo successivo, tranneun‘esile traccia.Nella fattispecie risulta che venivano definiti illirici i cavalieri, sempre presenti negli eserciti,
Sotto il Segno dell'Aquila - Parte
Quinta
436
stanziati a ridosso dei limesdel IV secolo lungo il Danubio e in Oriente. Con loroanche equites Pro— matr' ed equites Scularii, anch‘essi definiti illirir'i': owio allora ritenerli tutti derivanti da una unica originariaunitàdi cavalleria illirica,di notevoli dimensio i arruolataappuntotrai Dalmati e i Mauri, in cui eranopure confluiti elementi di cavalleria legionaria, detti appunto Frontali e di militi muniti di scutum, ovvero Scutarii. In breve queste diverseunità sarebbero state i resti residuali e frazionati della grande formazione a cavallo messa insieme da Gallienoedissoltasi dopo la sua morte. Quanto alle esigenze di rinforzi di fanteria lo stesso imperatore si regolò nella maniera solita. con distacca. menti evessilazioni tratte da legioni di frontiera.
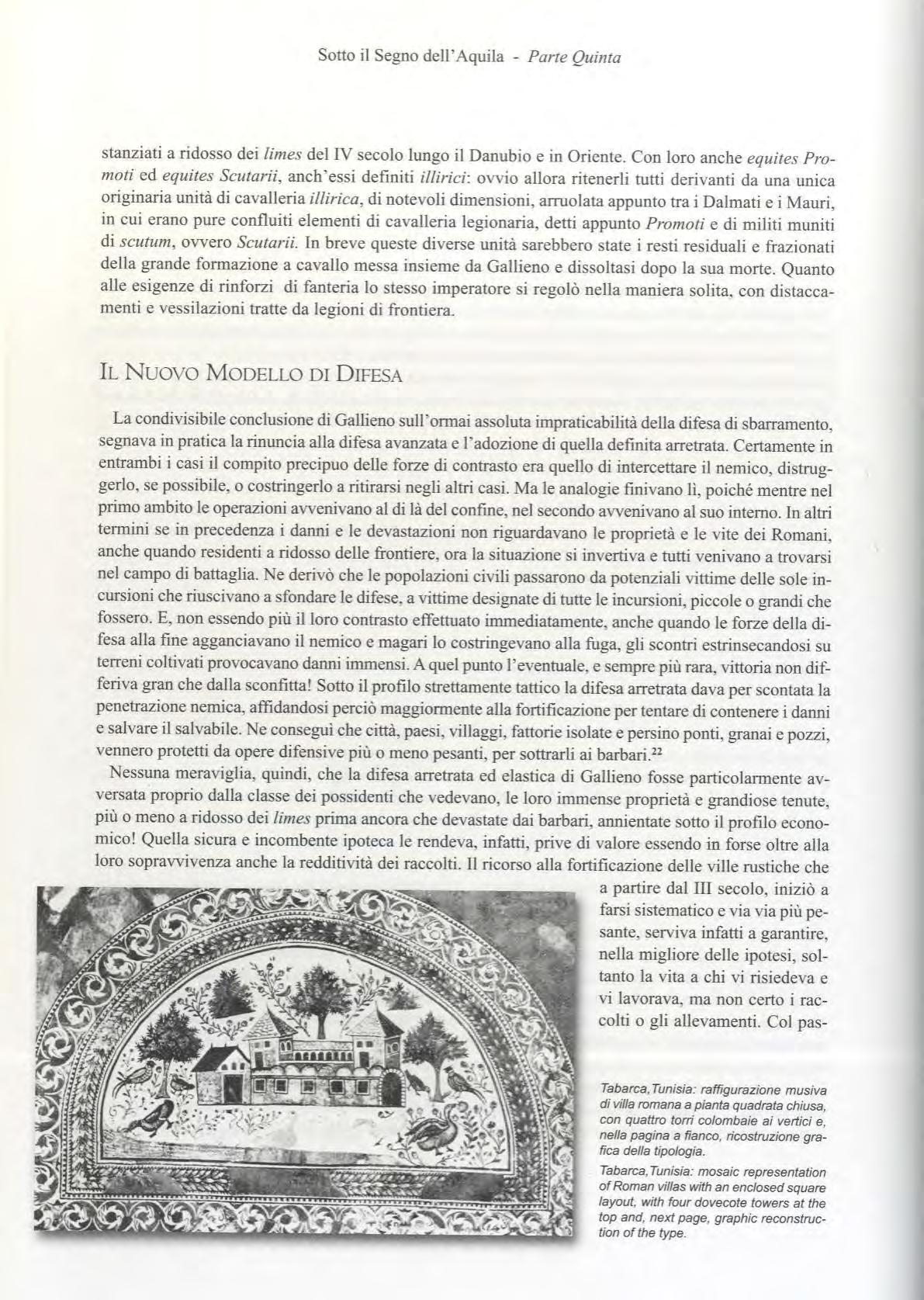
ILNUOVO MODELLODI DIFESA
La condivisibileconclusionediGallienosull’ormaiassoluwimpraticabilitàdelladifesadisbarramento, segnavainpratica larinuncia alladifesaavanzatael‘adozionedi quelladefinitaarretrata.Certamente in entrambi i casi il compitoprecipuo delle forzedi contrastoera quellodi intercettare il nemico. distrug— gerlo.sepossibile, ocostringerloaritirarsi neglialtricasi.Ma leanalogiefinivanolì,poiche'mentre nel primoambitoleoperazioniawenivanoaldi ladelconfine,nel secondoavvenivanoal suointemo. Inaltri termini se in ,, ’ i danni e le ’ ' ’ non -' ' leproprietà e le vite dei Romani, anchequandoresidenti a ridossodelle frontiere,orala situazionesiinvertivaetutti venivano a trovarsi nel campodibattaglia.Ne derivòche lepopolazioni civilipassaronodapotenziali vittimedelle solein— cursionicheriuscivanoasfondareledifese,avittimedesignateditutteleincursioni,piccoleograndiche fossero.E,non essendopiù il lorocontrastoeffettuatoimmediatamente,anchequandole forzedella difesaalla fineagganciavanoil nemicoemagari locostringevanoalla fuga,gli scontriestrinsecandosi su terrenicoltivatiprovocavanodanni immensi.Aquelpuntol’eventuale,esemprepiù rara,vineria non differiva granchedalla sconfitta!Sottoilprofilostrettamentetatticoladifesaarretratadavaper scontatala penetrazionenemica,affidandosiperciòmaggiormenteallafortificazionepertentaredicontenereidanni esalvareilsalvabile.Neconseguichecittà,paesi,villaggi, fattorieisolateepersinoponti, granai epozzi, venneroprotetti daopere difensivepiù omeno pesanti, per sottrarliaibarbari."
Nessuna meraviglia, quindi, che la difesa arretrata ed elastica di Gallieno fosse particolarmente av— versata proprio dalla classe deipossidenti chevedevano, le loroimmense proprietà egrandiose tenute, più omeno aridossodei limesprima ancorachedevastate daibarbari, annientate sotto il profilo econo— mico! Quella sicura e incombente ipoteca lerendeva, infatti,prive di valore essendo in forse oltre alla loro sopravvivenzaanchelaredditività deiraccolti. Il ricorso alla fortificazionedelleville rustiche che a partire dal III secolo, iniziò a farsi sistematicoeviavia piùpe— sante, servivainfatti a garantire, nella migliore delle ipotesi, soltanto la vita a chi vi risiedeva e vi lavorava, ma non certo i rac, colti o gli allevamenti. Colpas-
Tabama,Tunisfazraffigurazionemusiva divillaromanaapiantaquadratachiusa, conquattroionicolombai'eaiverticie, nellapaginaafianco,ricostnizi'onegis» ficadellaiipoiogia.
Taberna,Tunisia:Mosaicrepresentation ofRarnanvil/aswithaneno/usedsquare layout.withfourdoveeotetowersaithe topand,nextpage,graphicreconstnrctia/|oni-ietype
Sotto il Segnodell‘Aquila Parre Quinta
sar del tempo. la fortificazione civile divenne praticamente simileaquella militare e i lavora— tori simili a loro volta a dei militari. Quanti non si adegua rono alla mutazione dovettero ben presto abbandonare le loro aziende agricole e le loro ville rustiche.rifugiandosi nellecittà. Anche queste, nel frattempo, stavano assumendo una nuova livrea cheannodopoanno,dapprima soltanto per quelle a ridosso delle frontiere poi progressivamente anche per le altre.necaneellava laoriginaria architettura.Lacittàaperta,con \ ampie piazze. strade,teatri, anf fiteatri e basiliche divenne in Faicchio, Benevento:casa/e Tonenuova,latrama murena diepocaromana èancoraevidente breve un nostalgico ricordo. nellapartebassadell'attualemasseria.A fianco:dettagirodiunatonelta Come se …… bastasse. … Faicchio, Benevento:Torrenuovafarmhouse,themasonrystructureoftheRoman eraisstill svidentinthetowersectionotttrecurrentfarm.OnMeside detailoftunet.
quello stesso scorcio storico fece la sua ricomparsa, o forse divenne soltanto più temibile, la pirateria. segnoche anche l’azione repressiva delle forze navali im- ! l i periali sieraormainotevolmenteaffievolita.Un casoemblematicoin meritoèsegnalatosottoil regno di Probe: un gnrppodi Franchi,deportati sullerivedel Mar Nero, elusa la sorveglianzaerubate alcune barche, attraversarono lo strettodei Dardanelli enavigarono nel Mediterraneo, fermandosi di tanto in tanto per saccheggiareerifornirsi. In dettaglionel 275:"saccheggiateliz Grao-iu el'Asia, esorteggiati non senza danno rulli t' lidi del]Africa, presero infine Siracusa, un tempo rinomata perle vittore mrvalr'; quindi, dopo un lunghissimo viaggio, entrarononell'Oceanoladdoves’ingolftzfrala terra [alle Colonned’Ercole], dimostrando con [ofor-zum:di quel temerario cimenta, chenon vi alcuna terra inuceessibilealla disperazionedeipiruti [«pit-ativan], sevisiputìgiungerecon lenavi [«navigiis»]“” ,‘ Nel corso dell‘interminabile crociera nessuna nave da guerra romana. ne' orientale né occidentale, liintercettò o, forse, osò farlo.
LA NUOVAVESTE URBANA
Moltecittàromanedell’epocadiAugisto,oappenaposteriori,indipendentementedallalorodistanzadai limesebberolagraditaelargizionediuna cerchiaurbica.Cosi avvenne,adesempioaSaepi'irum,non lontano dalla mitica Bojanum dei Sanniti,a cavallodel tratturodellePuglie.A ridosso della nostra epoca fu racchiusa in una magnifica cerchiaturrita, gmziosamente regalataledaTiberio. Sebbenevada comunque ascritta alla architettura militare, la grande struttura non ebbe.almeno inizialmente, esplicite finalità di— fensive.Sitrattava,infatti.emolti aspetti stannoaconfermarlo.diun’operadestinata,come lastragande maggioranza delle consimili coeve, ad esaltare l‘orgoglio municipale, magari tenendo al contempo alla
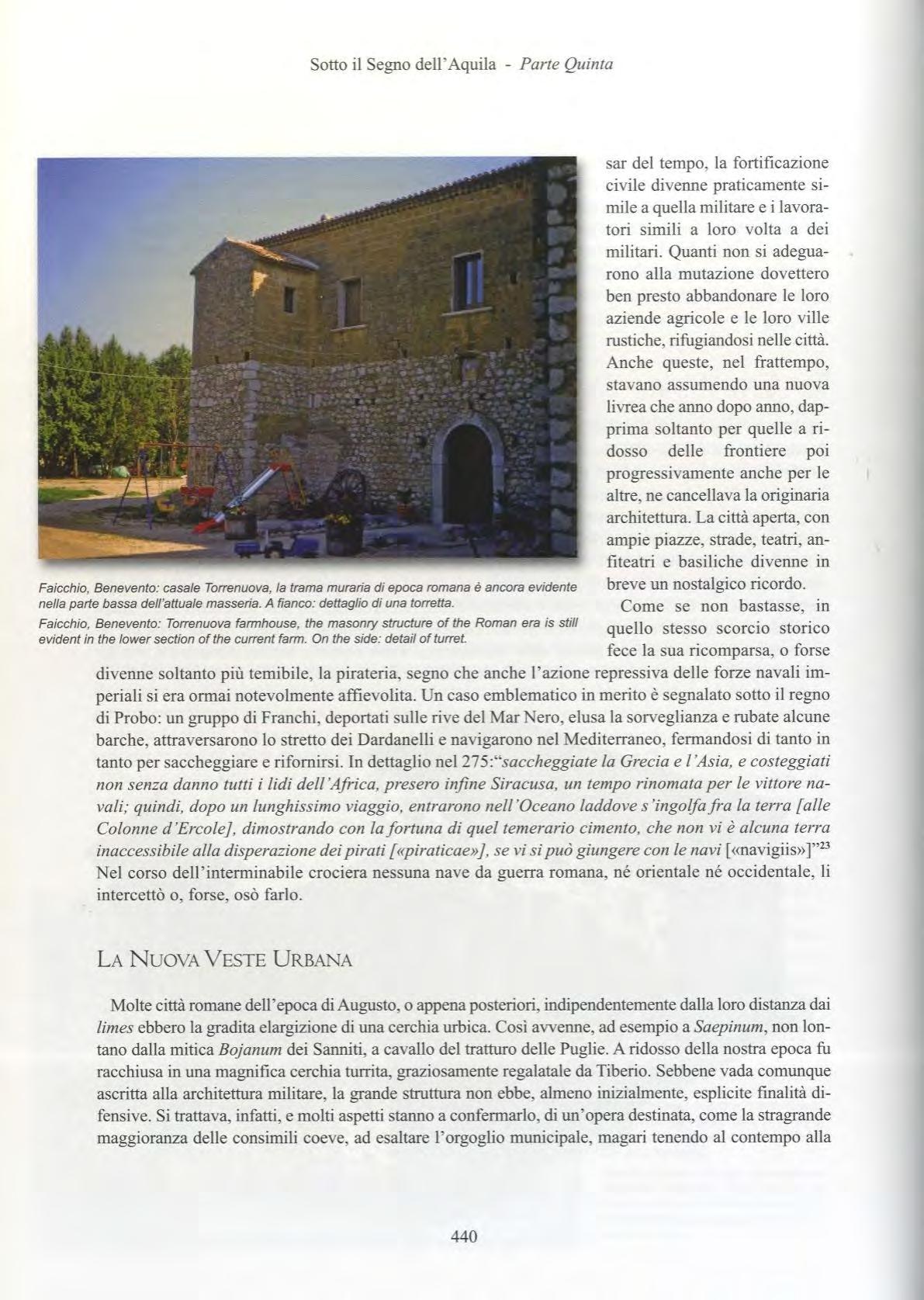
Sotto il Segnodell'Aquila
Parre Quinta
440
larga qualche banda di briganti, ' ma assolutamente inutileper resistere ad un imcstimento ossia dionale.ipotesi peraltrodel tutto irreale. Ben diverso, invece. il contesto rapidamente instauratosi dopolegrandi incursionidel III secolo e soprattutto… dopo l‘adozione della difesa arretrata nelle provincie a ridosso dei limes e, per ovvia conseguenza, leconnotazionitipologichedelle fortificazioniperimetrali daquel momento freneticamente erette intorno alle città.
Pertantoz"non appena [ cum fini [' ram/10dicostituiredelle €ffica 'difese “disbarramento', sipresentò la necessità di difendere. su scala locale econ/inre ]0L’flll. ibeni esitlentiin situ. Cama le stradefirrono resepiù fCHV'L’mediantelacoxrru:ionedi_on-iistradali.cosifir necessarioproteggeretutto ciòche avesseun certovalore, e chealtrimentisurethAlatri espostoal]intacca & olla dÎST7‘MZÌOI'IE due rante!’inevinrln'leinterwrllofrrr la penetrazione nemico e la vittoriosa intercetta-inne daparte della varie difese ’inprofondità Accanto allecittàpriredidifesedel]Occidente, la cuimancanza di cinto muraria eru testimonia… .almenofino alIIIsecolo, dellaprosperità edella .rir‘ur a che le caratteI va, eranosempreesistiteancheler'iflàfartifit‘llle.In Oriente. le difesemurarie erano di norma, dal momento che i'limes ernnu “aperti Ma anchein Occidente alcune città eranoefie!lit‘anterrtecircondateda mura già molto tempoprima che questesirendessero necessarie,“ Non si trattava però. come accennato. di mura difensive. che inquantotali sarebberostatedi ben scarsavalidità:troppo estese.troppo sottili e troppo elementari per garantire un minimo di interdizione attiva. Mura di circa un metro e mezzo scandite da torri di scarso fiancheggiamcnto, sormontatedarisicati spaltieprecedute dastriminziti fossati che costituivanoun ornamentoma non certoun deterrente, anche perla più scalcinata orda.
Quandolafortificazioneperimetraleurbana siconfermò imprescindibilepiuttostocheutileil suorepertoriofunetv tamentediverso.facendoassumere alle cittàlatetra livrea delle opere militari. Tanto per cominciare il massiccio anellodifensim andò a serrare un‘area notevolmente inferiore a quella urbanisticamente definita, per cui molti grandi edifici non potettero rientrarw. Teatri. anfiteatri. basilicheenon di rado persinoterme,restaronoperciò ale
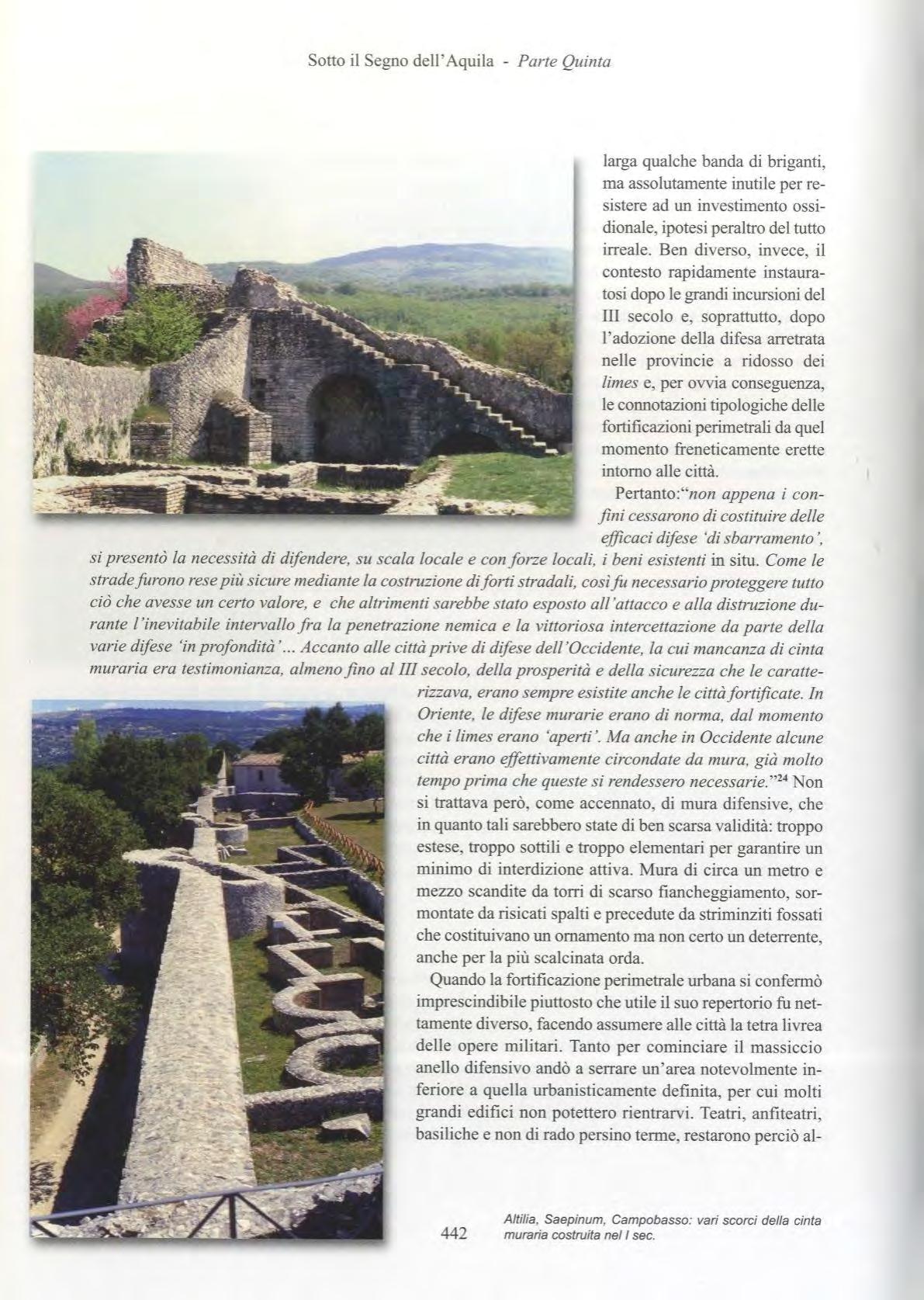
Sotto il S gnodell'Aquila Pur-n» Qltllllll
Altilia Saeprnum. Campobasso. vari sco/ct della curia 442 muro/lscostruitanei/ sec
l'esterno delle mura. triste re» miniscenza di un passato sicuro. In alcuni casi. per la stringente fretta di edificare le difese, di— vennero dellecavedipietra. assumendo allora il sinistro aspetto di ruderi. Lo spessore delle mura si accrebbe, spesso per raddoppio del circuito con un secondo anello concentrico, all‘internodel qualefinirono le macerie delle demolizioni. Nelle città più piccole lo sviluppoattintodallefortificazioni fu talmente predominante da trasformarle in pratica in vere fortezze, nelle quali la componente civile era scomparsa. Se si tiene conto che in molte fortezze legionarie vigeva, pur sempre,un minimo di vita civile per i familiari della guarnigione, si assiste ad un convergere fino all’identificazionedelleduestrutture.Similmente.comeaccennato,legrandimasserie.leaziendeagricole ele grandi ville ntstiche -unapr g ' a ' da castello " ‘
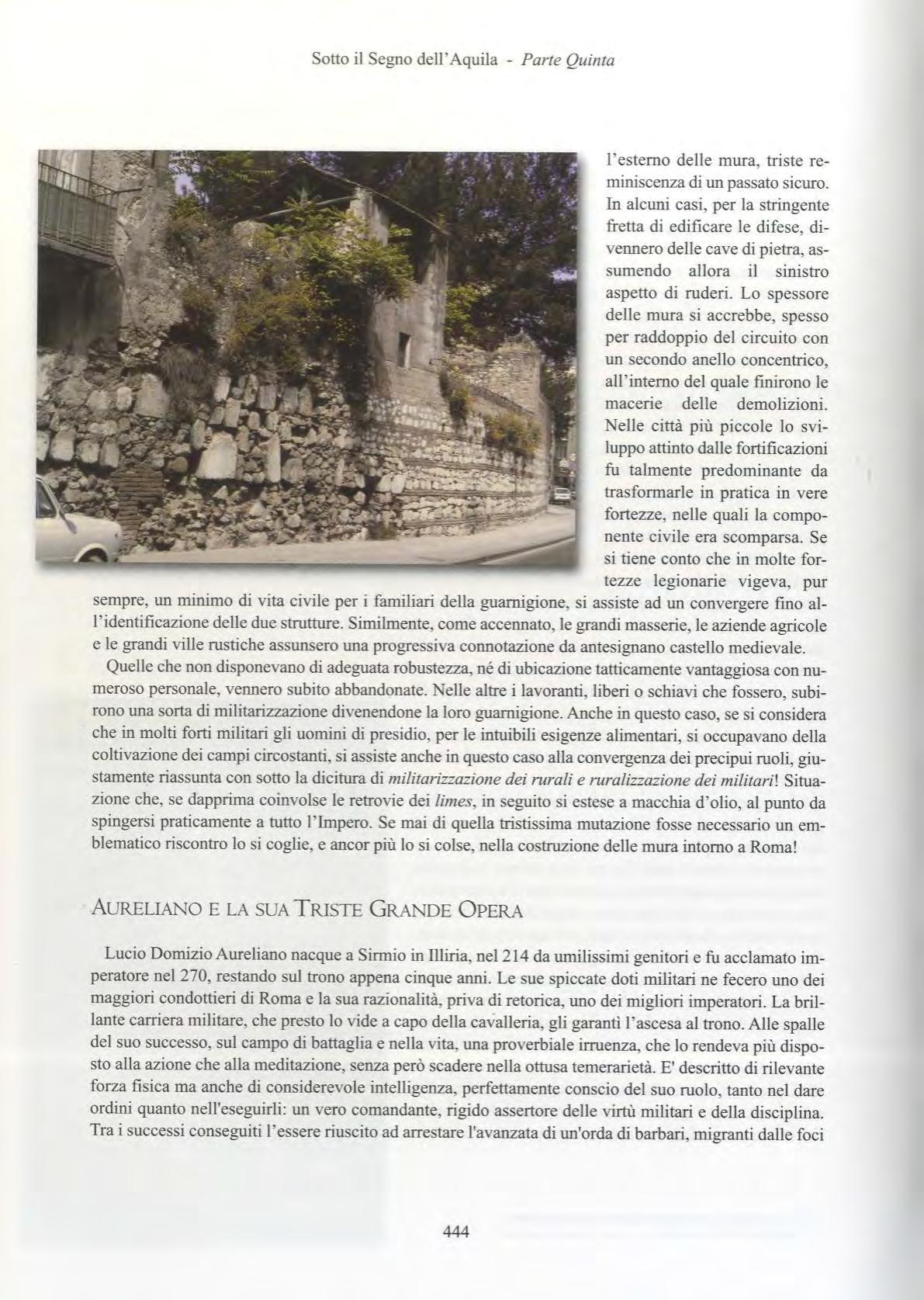
Quellechenon disponevanodiadeguatarobustezza.nédiubicazionetatticamentevantaggiosa connu» meroso personale. vennero subitoabbandonate.Nelle altrei lavoranti, liberi 0 schiavi che fossero, subironouna sortadimilitarizzazionedivenendone la loroguarnigione.Anche inquestocaso, sesiconsidera che inmolti forti militari gli uomini di presidio, per le intuibili esigenzealimentari, si occupavano della coltivazionedeicampicircostanti,siassisteancheinquestocasoallaconvergenzadeiprecipui ruoli, giustamenteriassunta con sottola dicitura di militarizzazionedeiruralieruralizzaziane deimilitari! Situazione che, se dapprima coinvolse leretrovie dei limes. in seguitosi estese a macchia d’olio, alpunto da spingersi praticamente a tutto l’impero. Semai di quella tristissima mutazione fosse necessario un em» blematico riscontro lo si coglie,eancorpiù lo sicolse.nella costruzionedellemura intorno aRoma!
AURELIANO ELA SUATRISTE GRANDE OPERA
LucioDomizioAureliano nacqueaSirmioin Illiiia.nel214daumilissimi genitori efuacclamatoim» peratore nel 270. restando sultrono appena cinque anni. Le suespiccatedoti militari ne fecerouno dei maggiori condottieri di Roma ela sua razionalità, priva diretorica, uno dei migliori imperatori. Labrillantecariiera militare, chepresto lovide ilcapodellacavalleria.gli garantì l‘ascesaal trono.Alle spalle del suosuccesso,sulcampodibattaglia enella vita. una proverbiale irruenza, chelorendeva più dispostoallaazioneche allameditazione, senzaperò scaderenella ottusatemerarietà.E' descrittodirilevante forza fisicama anche di considerevole intelligenza,perfettamente consciodel suoruolo. tanto nel dare ordini quanto nell’eseguir un vero comandante.rigido assertore delle virtù militari edella disciplina. Tra i successiconseguiti l’essereriuscitoadarrestarel‘avanzatadiun'orda dibarbari, migranti dallefoci
Sotto il Sognodell'Aquila . Pane Quinta
del Dniestcr verso occidente. formata di circa 320 mila uomini. per lo più Goti. Eriili e Sciti. Nella circostanza. a capo della cavalleria di Claudio il Gotico. li aveva battuti in Macedonia ed inseguiti nelle pia nure della Tracia e del basso Danubio.A seguito di tale stra— ordinaria vittoria fu insignito del consolato dall'imperatore Valeriano.venendo inoltreadottato daun consanguineodiTra— iano.dacui ebbepure inmoglie la figlia ed un cospicuo patrimonio.
Con simili trascorsi, si spiega la sua avversione per il gioco, per il bere e per la magia. rigidità che loportò anon tollerare nei suoiuomini laminima rilassatezza morale o materiale. né alcuna ingiustificata violenza o cupidigia,Nonpativaalcunaremoranelprenderedecisionimolto impopolari,comequandofeceevacuare dallaDaciatuttele forzeromane,abbandonandol‘interaprovincia aiGotied aiVandali:decisione estremamentedolorosa ma ormai improcrastinabile.Del restoquantograve fossedivenuta lasituazionelodimostrò, di li a breve. una ennesimascorreria degliAlamanni che.sbaragliatoun esercitoromano presso Piacenza, marciarono rapidamente alla volta di Roma. che soloper la prontezza di Aureliano riuscì ad evitare ladevastazione. Dissoltasi la minaccia.senza ripristinarsi la sicurezza, fu chiaro che l'unica maniera perevitareiltragico ripetersi di similieventi consisteva nel munirla, alpari di tutte le altrecittà,di massicce mura. Quelleche ancora.in parte, si scorgevanorisalbano all‘età monarchica. quasi settesecoliprima priveperciò della benché minima valenza difensiva. Si imponeva una nuova emoderna cerchia, la cui edificazioneper leresistenze dasupcraresiatecnicheche. soprattutto.psicologiche soltanto un imperatore volitivo e disincantato qualeAureliano poteva sperare di far accettare. Quella colossale operasidimostrò,paradossalmente.esaltanteeumiliantedal momentochetradiva ladebolezzadi Roma, confermando la sua grandezza!
Magistralmenterievocòquellostatod'animoilGibbonprecisando che:“ffu ll"grandema triste lavora, giacché lefortifica:iottidella capitale :velavana la decade della manarchia .“”Aconcretizzareulteriormente l‘angoscia fu la frenetica velocità con cui la cerchia venne portata avanti: meno di otto anni per uno sviluppo complessivo di circa 19km! Impossibile non scorgere in quell‘affannosa corsa una diretta conseguenza del deteriorarsi dellatenuba delle frontiere.Roma. inogni casoebbelc suemura e lorotramite un altrosecoloemezzodiindisturbata sopravvivenza.risultatogià straordinario.La cerchia aureliana consisteva in un circuitoin opera laterizia.di circa 4 rn di spessorecon una al-
Rania.scorcioefotoaereadlsegmentidellemuraaurelia/te. Manetaconl'effigiediAureliano.
Rome:viewandaerialphotograph(”sectionsurtheAurelia"walls ComwiththeemgyofAure/ius.
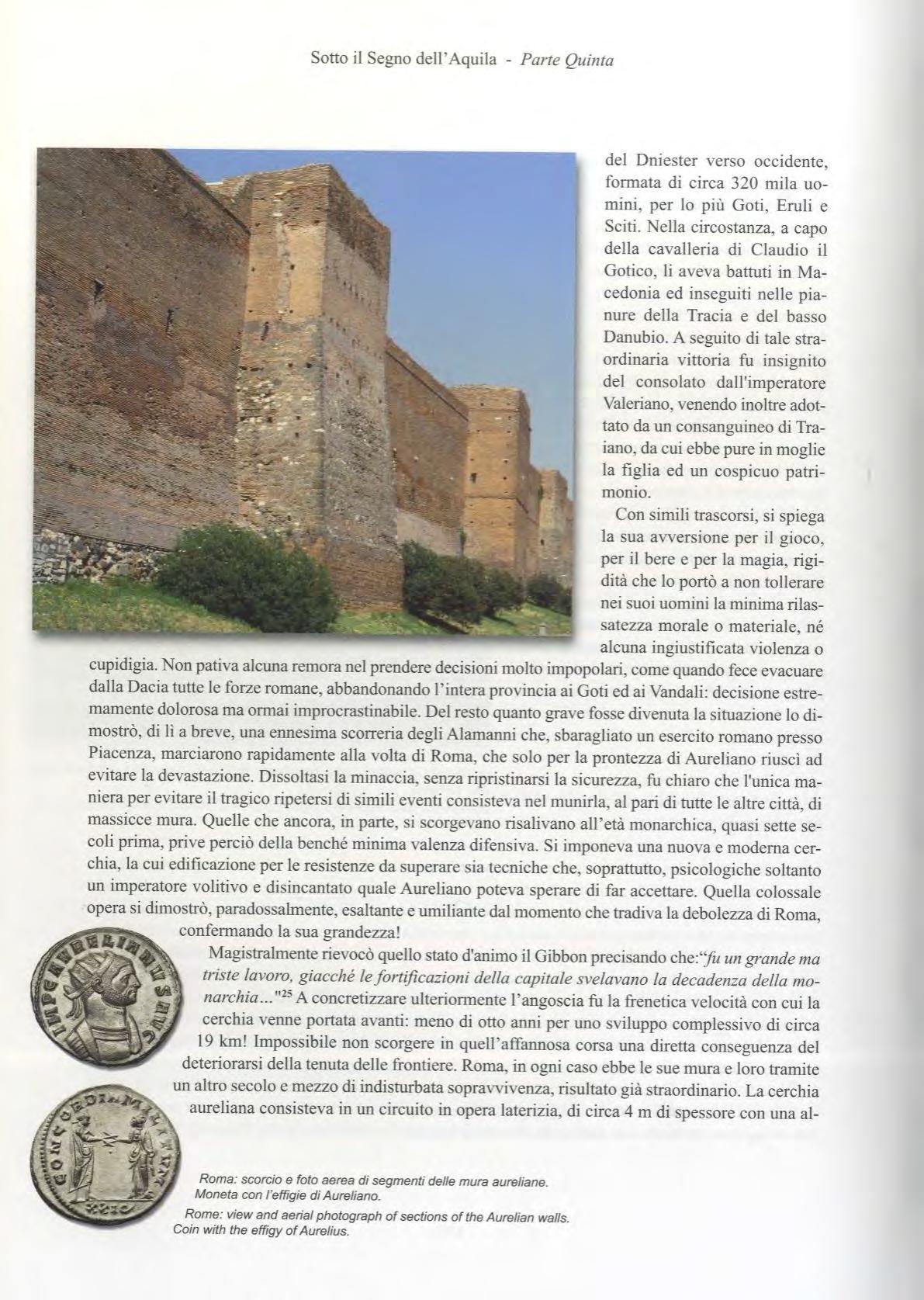
Sotto il Segno dell‘Aquila Parte Quinta
tezza media di 8 rn. insiv stente su una profonda fondazione. Più in detta gliole cortine furonorea» lizzate con paramento di mattoni.secondola tipica tecnica dei grandi edifici romani del III secolo.utilizzando mattoni di qualsiasi tipologia sia nuovi, che di recupero e persino di scatto.Ben 383toni ne scandivano lo sviluppo. con oltre 7000 merli lungo i camminamenti di ronda egli spalti;leporte erano 14eleposterle solo cinque; i posti di guardia 116edalmeno 2000le fe‘
ritoiedinotevoledimensioneper leartiglierie:innumerevoli leminori.Chel'interacostruzione fosseportata innanzi da una affannosa urgenza lo conferma la sua approssimata impostazione verticale, relativamentebassa esommariamentearticolata,fortemente stridentecon la grandiositàplanimetrica. In altreparole un cerchia chenella suaprima stesuraera certamente una grossa opera ma non una grande opera! Pertanto. superata la contingenza. con più ponderatezza emenoristrettezze. allemura vennero apportateuna tasta gammadi indispensabilimigliorie. innalzandole e coprendo il camminamento di ronda. Sebbene limitati “ima nella edificazione originaria.talecopertura.infatti.nel mezzo secolosuccessivo fini estesa all'intero circuito. tranne alcune modestesezioni.per 1aloroevidenteinvulnerabilttà. Ampio spaziofuriservatoalleartiglierie chevennero tenute neldebitocontosindallaprogettazione,come certificanolenumerosissimetorri innotevole aggetto dal filo delle cortine.
Originariamente il disimpegnoverticaledelletorri era garantitoda una unica scala interna in posizione centrale. Succcssivamente. dopo la soprelevazione. ne fuaggiuntauna seconda.ubicandola in un angolo. peraccedereai livelli superioriaggiunti durantel'imf pero di Onorio.Il tetto delletorri fil ottenuto con un padiglione a quattro falde. impermeabilizzato con uno strato di cocciopcsto. Ogni torre conteneva due
Roma.muraaule/rane.dettaglidelletomedellegallerieper leamg/rene
Rome.Aure/ran Walls detailsolthetowelsandgalle/tesfor theami/ery.
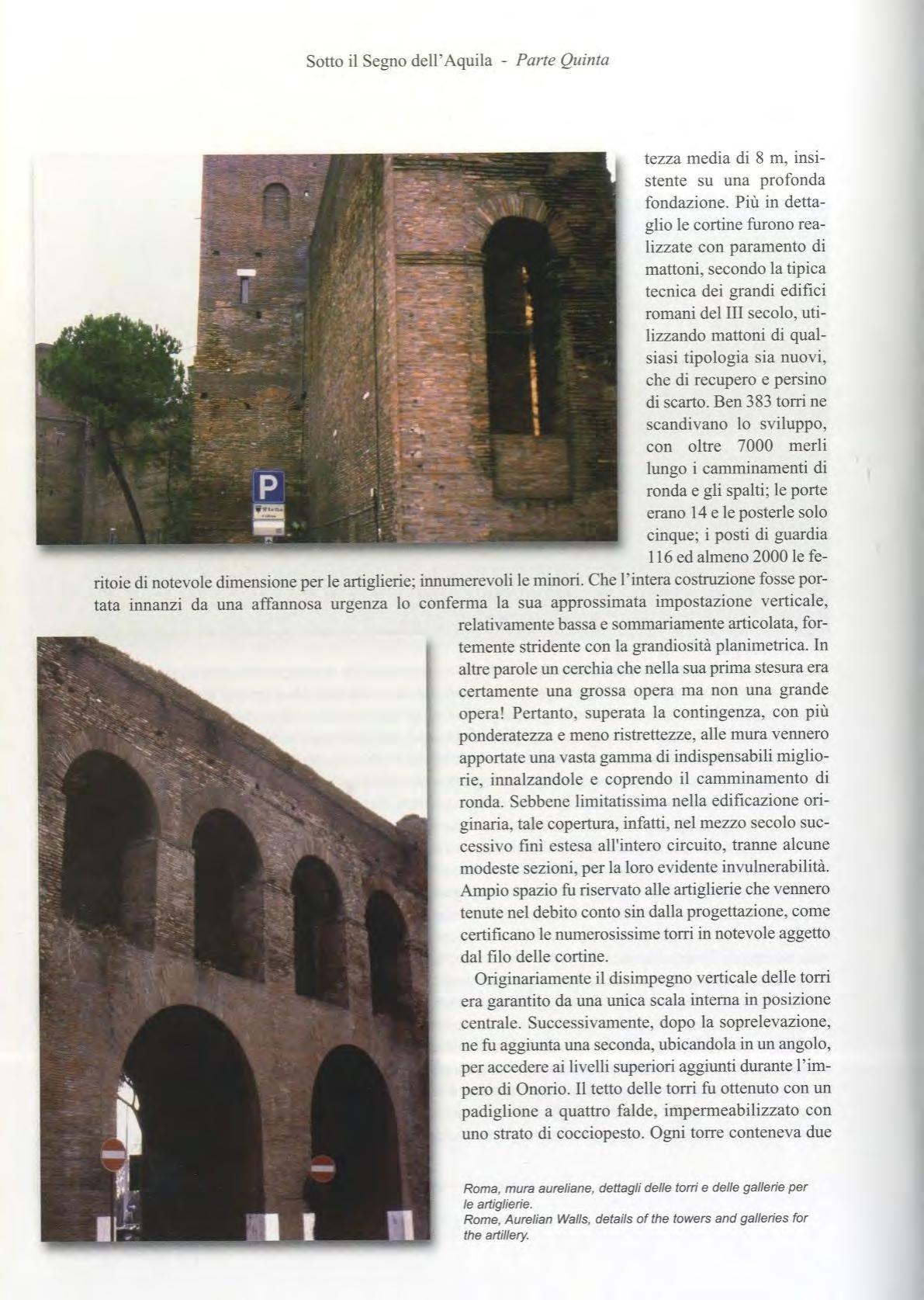
Sotto il Segnodell'Aquila Farm Qumm
Sotto il Segno dell'Aquila Parre Quinta grandi cameresovrapposte.dellequali lasuperioreerariservata alle artiglierieel’inferiore agli arcieri.Allo scopo lungo le sue muraperimetrali siapri\anoben dieci vaniarcuati.altitrepiedi: attoper battere il nemico edueper accedere al camminamento di destra e di sinistra. Dal momento che questi ultimi vani. in diretta comunicazione con la sommità della cerchia. creavano un pericoloso scadimentodell‘isolamentodella torre. edapre— sumere che fosserochiusi mediante robuste cancellate di ferro manovrabili soltantodall'interno. Schemachesitrova pedisse— quamente anticipatonelletorridellacerchiadi Pompei. Una monumentaleconcezione.non esentedi unaricercata si» curezza. fuapplicata all’impiantodelleporte, secondoi canoni tipici dell‘architettura militare romana. Tuttavia. è verosimile, come riscontrato per quelle di Trastevere, che gli abbellimenti ornamentaliegliampliamentidimensionali sianod’epocaposteriore. Nella versione iniziale. pertanto. si deve presumere che fosserotuttecon un unico fornice.connotazione.peraltro, conservataancoradallamaggioranza. Il criterioinformatoredifen— sivoadottatoera il solitoa doppioordinedi chiusura.conporta a saracinesca per il vano sull’esterno e a doppio battente su Pompei particolare dell’innestotam-cortina quellointerno.con un piccola cortedi sicurezza intermedia.
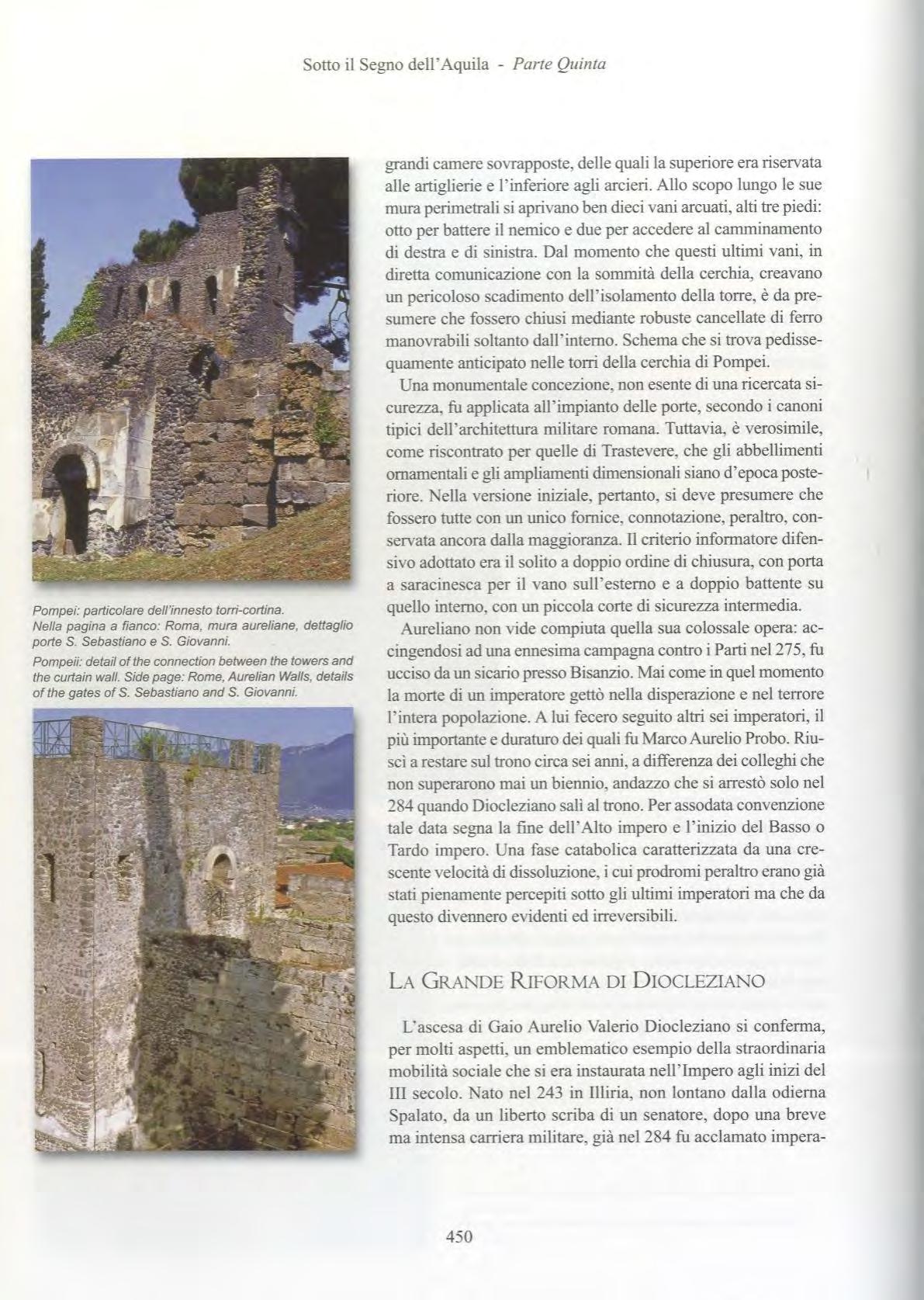
Ns“apagina 5 ,fianmi R°’"av ”"”3ame/"e’"?”"W”-" Aurelianonon vide compiutaquella suacolossaleopera:ac- poi1e s.Sebastianoes.Giovanni. .
Pompeil‘. ds,-Lai!oftheconnectionbetweenthetowersand cmgendosr “_“"? “mes……campagna ?°“"°'_Pam "51275"fu theeuiiainwall.Sidepage:Rome,Aure/ian Walls,details uccisodaun sicariopressoBisanzio.Maicomeinquelmomento °“"593‘“”'S'59553“3”°a””& GÌ°V5””Î- lamortediun imperatoregettònella disperazioneenel terrore ' i l'intera popolazione.A lui feceroseguitoaltri seiimperatori. il piùimportanteeduraturodeiquali fuMarcoAurelio Probo.Riu— sciarestaresultronocircaseianni.adifferenzadeicolleghiche non superaronomai un biennio. andazzoche si arrestòsolonel 284quandoDioclezianosalìalnono.Perassodataconvenzione tale data segna la fine dell‘Alto impero e l'inizio del Basso 0 Tardo impero. Una fase catabolica caratterizzata da una crea scemevelocità didissoluzione.icuiprodromiperaltroeranogià statipienamentepercepiti sottogliultimi imperatori ma che da questodivenneroevidenti ed irreversibili.
LA GRANDE RIFORMA DI DiOCLEZIANO
L‘ascesa di GaioAurelio Valerio Diocleziano si conferma. per molti aspetti.un emblematicoesempio della straordinaria mobilità socialeche siera instauratanell’Impero agli inizidel Il] secolo. Nato nel 243 in Illiria. non lontano dalla odierna Spalato. da un liberto scriba di un senatore, dopo una breve ma intensa carrieramilitare.già nel 284 fu acclamato impera-
tore. Per alcuni autoritanto suc cesso gli derivò dalle sue geniali capacità dirigenziali. che posero fineallasequenzadi improtvisazioni e di espedienti. più omenocorretti,nein ambiti economici e militari protrattasi per oltre mezzo secolo. Tanto per cominciare. Conscio della vastità dell'Impero. sdoppiò nuovamente la Carica imperiale fra Occidente ed Oriente nel 286. associando al suo potere. quindi con il rango diAugusta. Massimiano un suo valente ufficiale… «\le scaturì una diarchia chc.appenapochi anni dopo. si duplicò a sua volta. per facilitare le operazionimilitari.Diocleziano nominò suoCesareGalerioeMassimiano fecelo stessocon Co— stanzoCloro. Il ruolo dei Cesaripotrebbe definirsi di reggente.odi vicario plenipotenziario: in pratica, larisultante fuchementre Diocleziano govemava leprovince orientali e l‘Egitto. con capitaleNicomcv dia. Galerie govemava a sua volta le province balcaniche con capitale a Sirmio: in Occidente Massimiano governava Italia. Spagna eAfrica settentrionale con capitale a Milano. mentre Costanzo Cloro governava la Gallia e la Britannia. con capitale a Treviri. Ovviamente la suddivisionepolitica dell’Imperodovetteessereradicalmenteridefinita.con lacreaztonedi dodici circoscrizioni.denominatediaz-eri. in ragione di tre per ogni sovrano.ciascuna delle quali governata da un vicario e suddivisain 101pro— vince. Ne derivò una tetrarchia oper meglio dire una doppia diarchia. data la non identità di rango fra Augustie (era:i.sistema che garanti un ventenniostabile di regno. continuità che mancava dai tempi di Antonino Pio. Una perfetta rappresentazioneplastica di siffattacona cezione la si può osservare nel gruppo statuario dei TeIra/”Elli. dote mentre la mano destra di ciascun Augusto poggia sulla spalla del suo Cesare. in modo da suggerire la piena concordia. la sinistra di tutti stringel’elsa del parazonio “’per ribadire la natura militare dell'accordo…
La verifica del sistema sarebbe dovuta a\venire al mo— mento sempre critico della successione che si estrinsecò nel 305 allaabdicazione di Diocleziano edi Massimiano: i due Cesari divenneroAugusti… scegliendo altri due Cee rari. Un risultatosenzadubbioottimo.chetuttavia dipese piuttole dall‘essereavvenutocon i dueAugusti in vita, e soprattuttocon Diocleziano ancora in grado di esercitare una notevole autorità morale. piuttosto che dalla meccanica del dispositivo. Ed infatti. quando l'anno seguente mori Costanzo Cloro. l'automatismo si inceppi‘) misera-
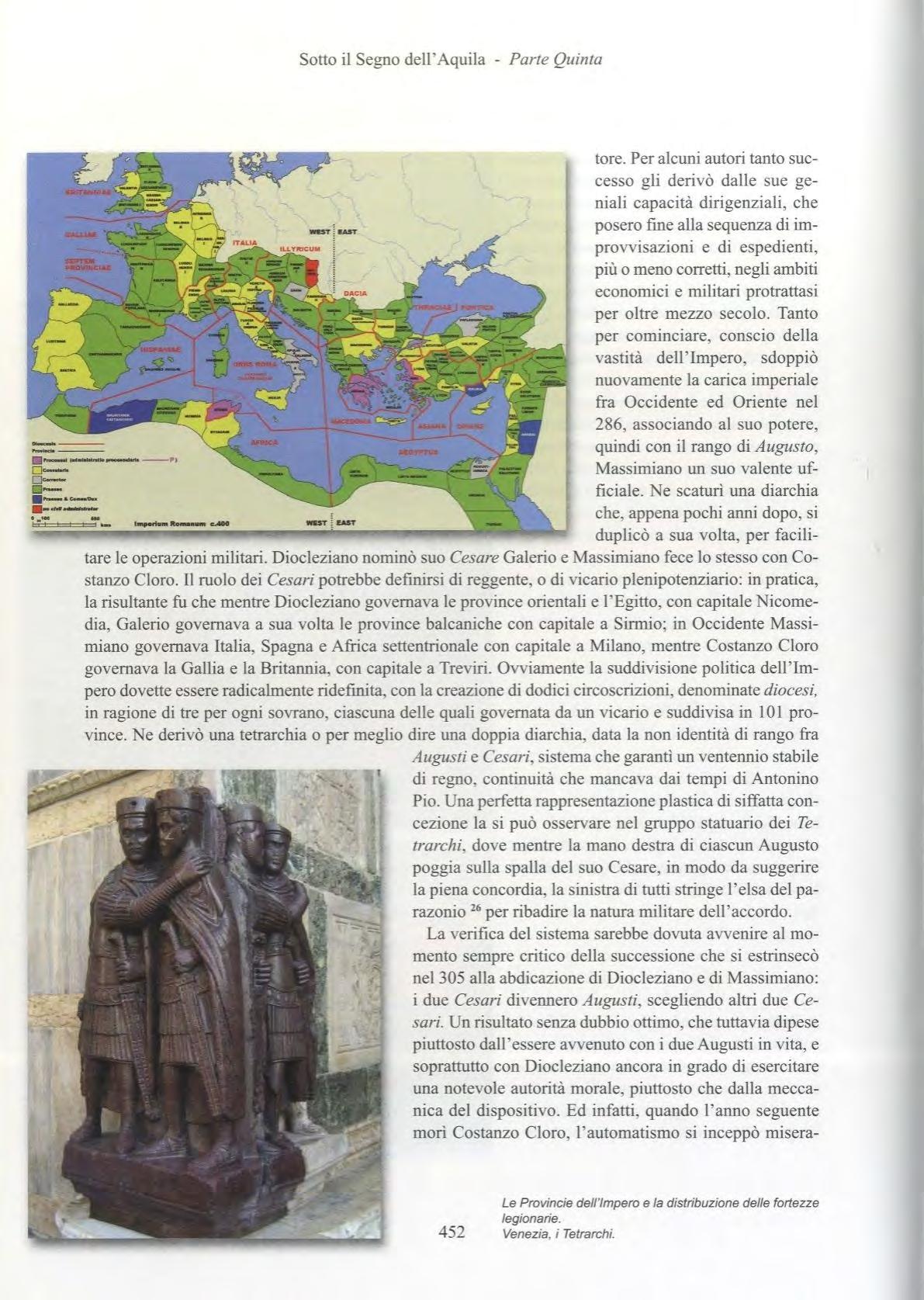
Sotto il Segnodell'Aquila -
Qililiia
Pam»
Le Provincie del/"Impero e la distribuzione delle fortezze . Iegloflsne 432 Venezia i Teliaieni
mente. Costantino… suo figlio illegittimo. fu acclamato Augusto dalle legioni locali. mentre a Roma i pretoriani acclamarono Mas— senzio, figlio di Massimiano. Lo scontro fra i due av— venne nei pressi di Ponte Milvionel312eCostantino. che nella circostanza im» piegò soltanto una frazione delle sue forze, come arcinotovinse,attribuendoastutamente il merito della vittoria al Dio dei cristiani, da lui scelto quale nuovo protettore celeste. Meno prosaicamente, monopolizzòunaineditaunità difanteria, l’auxilium, che avrebbe t‘omito le truppe d’assalto dell‘esercitoromanodelTardoimpero.Dopoil 324, avendo Theinsigniao,Constantine. eliminatotutti icontendenti,CostantinoconcentrerànuovaSidePage.“Rama.PanammicviewoftheWMOBfidgé- mente l'interopoterenelle mani diun unico imperatore. Aldi làdellatetrarchiaedel suodispositivolegale,ilvero ambito d‘azione di Diocleziano fu quellomilitare, con la riforma dell‘esercito. Tanto per cominciare, operòuna netta duplicazionedelle legioni cheraddoppiò letrentatré derivatedalpotenziamento attuato da Settimio SeveroDal momento che[organicocomplessivodell‘esercitonon sembra aver subito si@ificativi siritiene L‘ una decurtazionedellorganicodi ciascuna legione, forseaddiritturaun dimezzamentorispetto a quellodi epoca augustea.Di sicuro, stando allatradizione,quelle legionivenneroassegnateacoppie agli esercitiprovinciali. integratedareparti di cavalletia,trattiquasicertamentedallagrandearmataacavallodi Gallieno,definitaancheesercitoopeiativo. Per cui:“questi distaccamenti di cavalleria. o vexillationes. come sono detti con terminepoco chiaro, eranodigradosuperioreallestesselegioni etantopiù allealoeecoortisuperstiti,[sitrasformarono]in esercitidifrontiera comandatisemprepiù da soldatidimestiere. duces, anzichédagovernatori ,, ". Questa ’ ebbe , con (' cherese esc’ militari ociviliquasituttelecariche. Tuttavia/ÌJ mantenuto ilnucleodiun esercitomobile”27
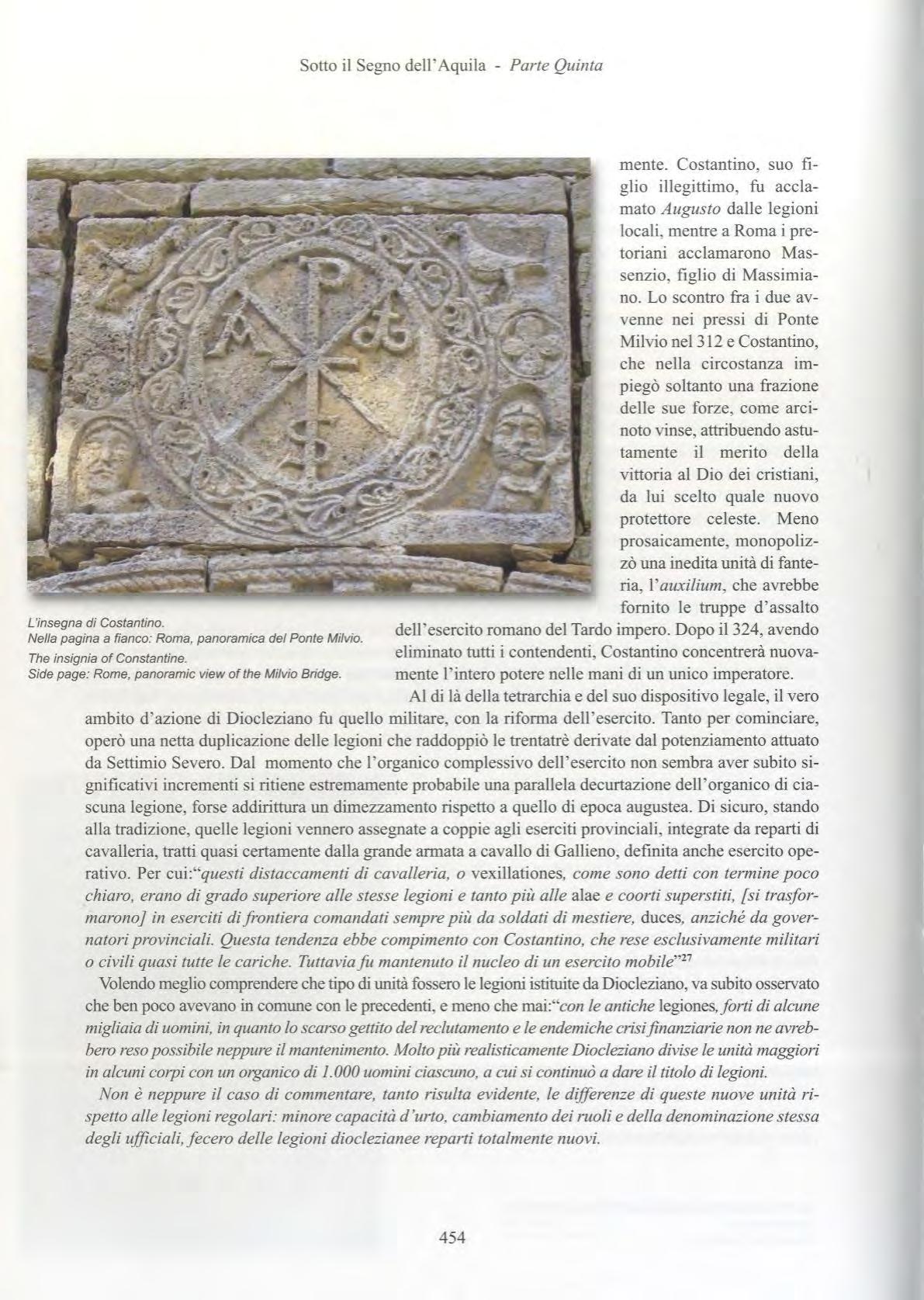
VolendomegliocomprenderechetipodiunitàfosserolelegioniistituitedaDiocleziano,vasubitoosservato chebenpocoavevanoincomunecon leprecedenti.emenochemai:“cun leantichelegiones.fortidialcune migliaiadiuomini, inquantoloscarsogettitodelreclutamentoeleendemichecrisifinanziarienonnedwebbem resopossibileneppureilmantenimento.Moltopiù realisticamenteDiaclm'anadiviseleunità maggiori inalcunicorpiconun organicodi 1.000uominiL‘ÌILS‘CHIID, acuisicontinuòadareiltitolodilegioni.
Non e‘ neppure il caso di commentare, tanto risulta evidente. le dijfkrenze di queste nuove unità rispettoallelegioniregolari:minorecapacita'd'una.cambiamentodeiruoliedelladenominazionestessa degliufficiali,fecerodelle legionidioclezianeerepartitotalmentenuovi.
L'insegna di Costantino. Nella pagina afianco:Roma, panoramica delPonteMilvio.
Sotto il Segnodell’Aquila - Parte Quinta
454
Accanto a questeunità legionarìeposedistaccamenti dicavalleria dedotti dagliesercitioperativi di Gallienoedisuoisuccessori.chiamatianch'essivexillationes— altradenominazionechenon conosciamo probabilmentedirangosuperioreallestesselegionielesuperstitialaeecohortesdegliausiliari.
Einnon abbandonòinoltreilconcettodiesercitomobileediriservagenerale.Purnella carenzadelle fonti, abbiamocognizionecheessoeracostituitoda unità dicavalleria, equitesPromoti edequitesComites, edarepartidifiznteria cosiindicati:nuovelegioniicuicomponentisonodenominatiIoviniedHer» culiani- dagli deiprotettori di Diocleziano, Giove. e di Massimiano. Ercole- e reparti denominati Solenses,MartenseseLanciarii. costituitiquest'ultimida legionariveteraniarmatidilancia. edinfine ilsacercomitatus,formatoevidentemenleanch’essoda elementisceltissimi."m
Per grande massima la suddivisione applicata all’esercito fia limitanei ecomitanei, consisteva nel ripartirlo inuna forzastaticaedinuna mobile.Volendo delineare ladifferenzafia limitaneiecomitatensis deveravvisarsinelfattocheisecondi,purpotendoformarsiunafamiglia,noneranodiguarnigioneinsedi fisse.Quandoinservizioattivovenivano insediati nellecittà,creandoper iprivilegi di cui godevanonon pochi attriticonicivilichedovevanoospitarli.E selacentralizzazionedelcomandovenneperseguita da Costantinochetrasferìl’autoritàmilitaredelPrefettodelPretorioaun MaestrodellaCavalleiia,magister equitum.eaun Maestro della Fanteria.magisterpeditum. lasciandoalprefetto la solaresponsabilità dei rifomime'nti,nulladel generesipoteva auspicareper i comitale/tres. Gli esercitimobili, ancheimaggiori come quelli dellaGallia,delleprovince danubiane ed’Oriente,eranocomandati dapropri Maestri della Cavalleria.Per leunitàminoriilcomandoeraafiìdatcadun altoufficialedefinito ‘conte’,comites,primo titologerarchicodell’incombenteMedioevo.Inpraticasipuòconcluderechelaveradifferenzatra l’esercitodelPrincipatoedelD èla " traesercito , ‘ " mobile ecostituitodacorpi sceltied ’’ ' edesercitodi " '' ‘
Inbreve:“l”interoapparatobellicovennesuddivisoinesercitodimanovra, organizzatoin unità dico— mitatenses, pseudocomitatensesepalatini einforzeconfinariedilimitanei.ripenses oriparienses.
Leforzelimitanee, cosidetteperche'dovevanosorvegliareilconfine,illimes. eranocostituitedaunità ditipodioclezianeo, legioni, aliecoonidi ausiliari, eda raggruppamentidiequitesdi cavalleria edi fanteria, denominatiper lopiù semplicementeauxiliares:;milites. L ’insiemedeirepartieracoordinato da un dux, tranne chenelleprovince a''Afi'ica ove Ieneva ilcomando un prepositus. il cuisuperiore, il comes, aveva aisuoiordiniancheun notevoleesercitomobile.
Lapartemobiledell'esercito i ' ' era '' daunità di ,… ' diverse. (‘ innanzi tutto, prelevà definitivamente dallelegioni cunfinariedelle vexillationes. che divennero autaname. Tale è il caso della legio II Italica Divitensium. il cui distaccamento venneprelevata da Divi! tia(Deuts. Germania), dei Tungrecani, cheprovenivano da Tungri (Tongeren, Belgio). della Quinta Macedonia, dalcastrumoriginariodi Oescus (nell'aitualeRomania).Altrirepartisonoricordatisolamentedainumerichelidistinguevano, comegliUndeeimania iPiimani
LaguardiadellimperatorenonsiidentificòpiùconipretorianichevenneroscioltisoprattuttoperessersibattutiperMassenzioalleportediRoma. I nuovireparticheneprestar;ilpostaechesivenivanoacostituirefacevanoparteintegrantedell’esercitodimanovra:lescolaedicavalleria, unitàd'e'litefizrridi500cavalliacuisi aggiungevanodistaccamentidicavalleriaodifanteriadipiùreameorigineefiznnatisempredasoldatiscelti.
Lesuetruppedirotturafirmnoinvececompostedanuoveunitàdiauxilia.arruolatesulfronterenano eprobabilmente costituiteda germani. Ricordiamo i Contati. i Bracchiati «coloro cheportavano il bracciale», gliInviiediVictores.
Ancheseper lungo temposi è ritenuto cheilimitaneifosseronull'altrochetruppe dicontadini-soldati, la lorofigura è stato recentemente rivalutata. Essi in efl“etti Erano contingenti ancora idonei al combattimentoesoprattuttoadattialcompitocuieranodestinati, ladifesadeiconfini.””

Sottoil
Segnodell’Aquila - Par/e Quinta
456 .» "««-MM…
Non acasoproprio suquestiultimi:“una importantediscussioneè attualmenteincorsotraglistudiosi dell'esercitodella TardaAntichità. Essa riguarda appunto ildifficileproblema delsignificatomilitare deisoldatilimitanei, creatidalleriformedioclezianee-costantinianechedeterminaronolenuovestrati ture dell’eseroitodel [Ve Vsecolo, edel loro rapporto con la terra. Due teorie, sostanzialmentecontrapposte, per quanto con sfumaturediverse tra di loro, tengono il campo. Laprima, che risale al Mommsen… considera i limitanei delIVseco/o come soldati{ontadiniancoratialla terra, la cuisedentarieta' è andataadetrimentodellelorocapacitàmilitari.Laseconda,difesabrillantementedalMazzarino ritiene che, almenoper ilIVsecolo, riguardo alrapporto con la terra non vifosse alcuna tra truppe " e " che non vi è alcunaprecisa prova che. nel corsodel[Vsecolo,ilimitaneicostituisserouna Bauemmilitz, echecoltivasseroleterrecuiera loroaf fidata la difesa; che essivenissero diconseguenzapagati diversamentedalletruppedimanovra comi— tatenses,’ che la loro eflîcienza militare non erapoi tanto scaduta, dal momento che inparecchi casi truppe limitaneefuronoinserite nell’esercitodimanovra: echesoltantocon l'iniziodel Vsecolo esolamenteinzonedellaparsOrientisèpossibileriscontrarelapresenzadisoldatilimitaneichepossiedono ecoltivanoterre…«L’errorenelladottrinacheparladeilimitaneicomedisoldati-coloniè nell‘averegeneralizzato edistituzionalizzato una situazionechenon saràstata ne'dappertuttodifiusa négiuridica— mentedefinitaedanzipiuttostoincertaedincontinuosvolgimentodal!'etàpostdiocleziana.Non tuttii limitaneisarannostatiagricoltori, ma chevifosserogià nelcorsodelIVseco/odeilimitanei checoltivano inproprio delle terre sembra difi‘icilenegare»… Tuttavia, che le unità difrontiera dalpunto di vista militaresianoandateprogressivamente decadendo, con ilprevaleredel]’esercitodimanovra del!’etàcostantiniana ecomeconseguenza della lorosedentarietà, edel!'essersiinparecchi casitrasformatiinformazionidisoldati-agricoltori, sembra un datodificileda controbattere...

Incerticasiilsoldatoromanopotédiventaredunqueun agricoltore. QuestoprocessosisvolgenelIII secolo;una deipuntidisvoltasembraessere,comepertantialtriaspettidellasocietàromana,!’eta‘diSettimioSeveroedeisuoifigli; un altro, l'etàdiGallienoediAureliano, l'epocadeirestitutores il!irici…"”
il singolareaspettodella ruralizzazionedei militari.che fadacontrappuntoalla militarizzazione deirurali, finoallaformazionediun’unica realtà indistinta,quelladellainterasocietàin anniaridossodei con— fini,prodromo del Medioevo,richiedetuttavia qualcheulteriore precisazione. Suilimeslalegionemolto fiequentementef‘sfiuttava inproprio…[la]terra;quellacheera venuta inpossessodellostatoperdiritto diconquistaedicuipoteva, teoricamente,disporre !imperatore. Ihloraineflettieraincameratadalfisco; mapoteva essereanchelasciataperattodigenerositàainativi, comepoteva essereafi'ittataoconcessain enfiteusiai0 Più spesso, era lasciata tuttavia aisoldati, costituendoilterritorium legionis, di cui, a quantosembra, ognicampoeraprovvisto, costituendoessa,percosidire, una dotazionedella legionein quantocorpo; allimite, essaavrebbepotuto coinciderecon lazonadellacuidifesa era incaricata la legione;inoltre,aquantosembra,partidiessapotevanoessere«subaflitate», adunità ausiliarie.Da questo privilegiopotevanascereunaltrosistemadirisolvere I ’eternoproblemadellasussistenza:diaffittareefare sfruttarequestoterritorium legionisaiCiv Sipoteva anchevenderlo;ma era indubbiamentepiù convenienteafittarloefarlofiuttare;lalegionesicircondavacosidiinsediamentiinpartecommerciali,inparte agricolichecontribuivanoaridurreilminimum dibisognidacuiessa eradipendente.”"
ALTRE MODIFICHE DI DIOCLEZIANO
In precedenza si è vista la formazionedi una annona militare, resa necessaria dall’influione conseguenteallasvalutazioneprovocatadaSettimioSevero.AnchedelsuomiglioramentoDioclezianosifece
Sono il Segnodell'Aquila - Parte Quinta
458
carico.impedendochel'esercitorequisisse.aprezzo di— screzionale ed arbitrario nonchè spesso senza neppure pagarlo concretamente. ciò di cui aveva bisogno dalle popolazioni limitrofe. La soluzioneda lui escogitata fu quella di trasformare la quantità di denarorelativa alle tasse… previste per una determinata regione, in generi vari,qualialimenti.materieprime.vestiario, armamenti ecc. Circa questi ultimi va osservato che non coincidendopiù loschieramentotatticodellenuoveunità con quellodi epocaprecedente. anchele armiprecipue ebbero a subire una modifica, Ilpilum considerato, per ovvieragioni.ormai inadeguatonegli scontricongrandi formazioni di cavalleria ocontronemici capaci di sviluppare un rilevante volume di tiri a grande distanza, venne sostituito da una robusta lancia,spiculum.eda una più piccola. veratum, Al gladiovenne preferita la lunga spada germanica. spatha. la quale implicava un diverso modo di combattimento ravvici» nato, chetuttavia non fecemutare l’elmo, lacorazzae lo scudo…
Diocleziano, come accennato, nel 305 abdicò e si ritirò nell’immenso palazzo fortificato che si era fatto costruire a Spalatoeche, in buona parte. ancora esiste… Dopo una breve parentesi turbolenta, che sconvolgeràquantoda lui dispostoper ladirigenzadell‘Impero,salirà al trono GaioFlavioValerioAul’elio Costantino,più noto comeCostantinoil Grande,nato aNaissus. attualeNis in Serbia.nel 274,destinatoadivenirunodeipiù importanti imperatoriromani. Fra lesuetantescelteepocaliquellaforsepiù nota fu l’avviodella sostanzialealleanzafra statoechiesacristiana.
LE RIFORME DI COSTANTINO
Al di là del noto episodio del monogramma XP, le prime due lettere della parola XPISTOS, Cristo, fatto dipingere sugli scudi dei suoi legionari da (‘ come già la vittoria su“ zio fu dovuta all’adozione di un nuovo dispositivo tattico destinato di lì a breve a trasformarsi in un corpod’elite'dell’esercitotardo imperiale,La suadenominazione inauxilium ed il debuttoawennecon elementi arruolati giàda Costanzooda Massimiano,i menzionati Camutio Cornuti,cioè «uomini con le coma», che sembrano raffigurati sull'ArcodiCostantino,eiBracchiati,«portatori del bracciale». Forse le coma dei primi ornavano l'elmo, come i bracciali lepam superioredellabraccia,ornamenti estranei alla tradizione militare romana, ma ben presenti in quella germanica. E non a caso:“più tarditroviamo costoro.e un 'altra coppia diunità ausiliarie scelte, gliloviieiVictores, lanciareungridodi guerragermanicoprima della carica. Ci
ilpalazzodiDioclezianoaSpalato:resti.plan/mem‘a encostruzwne.
A fianoa modems statuadi Costantinoa York, The Palace ofDiodetian m Split:mins. plan/metry andreconstruction. Dn side:modem statueof Constantinein York
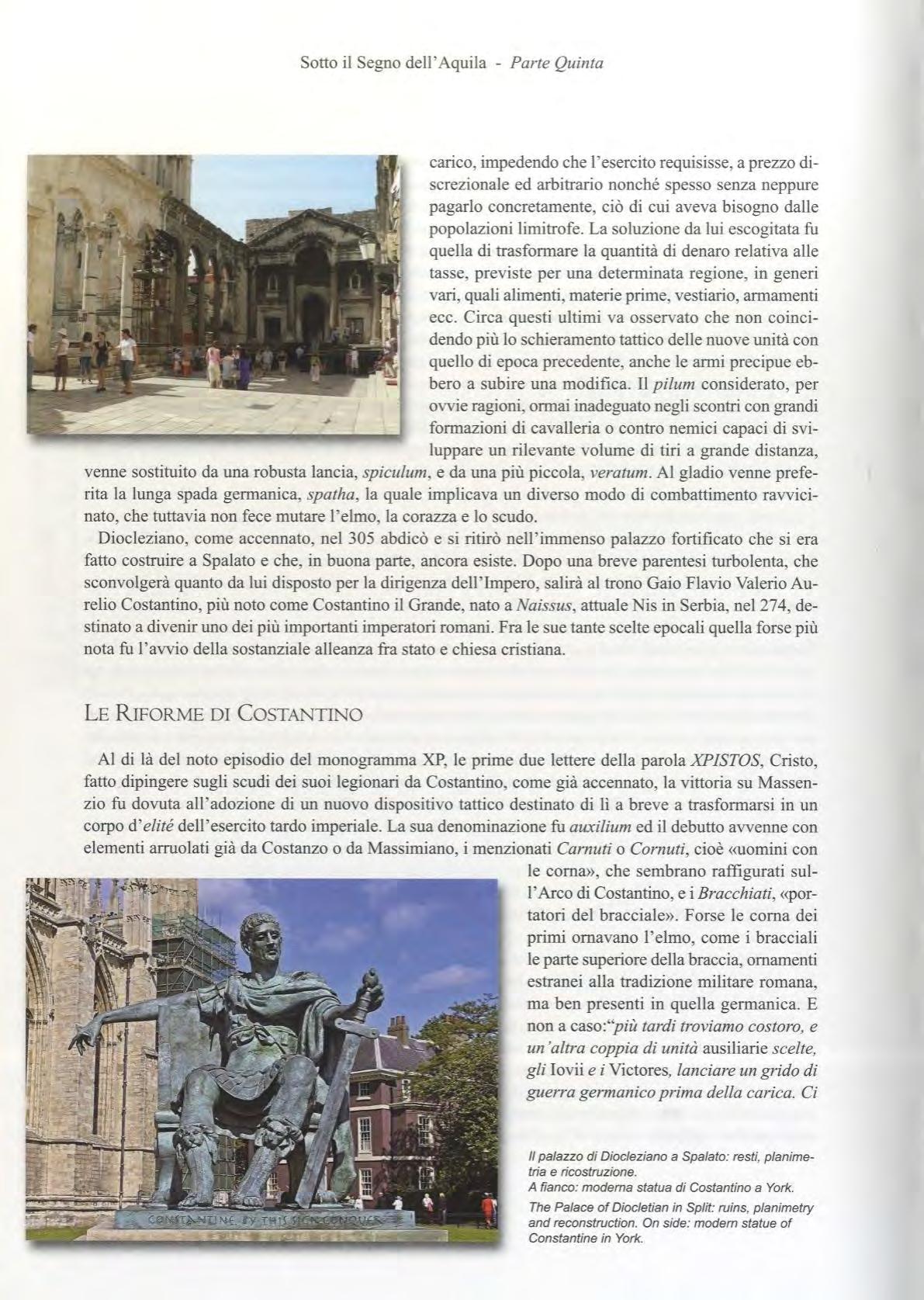
Sottoil SegnodellAquila Parte
Quinta
sonobuonimotivipersupporrecheinuoviformidabiliauxiliafosserorecIu/atifra i Germanidellazona renana, giovanip 'dailam, " "diGermani istituitida Diocleziano edai suoicolleghiin territoridisabitatidella Gallia."”Costantino. in seguito,arruolerànuove legioni organizzandone altreconuna diversa logicatattica.
L’ESERCITODEL IV SECOLO
Volendo descrivere sia pure per ampia schematizzazione le caratteristichedell'esercitodel IV secolo elesuesuddivisioniva ribaditocheormai sicomponevadiuna aliquotamobile, dettacampale,cdiuna pressocché equivalente. statica, detta territoriale.
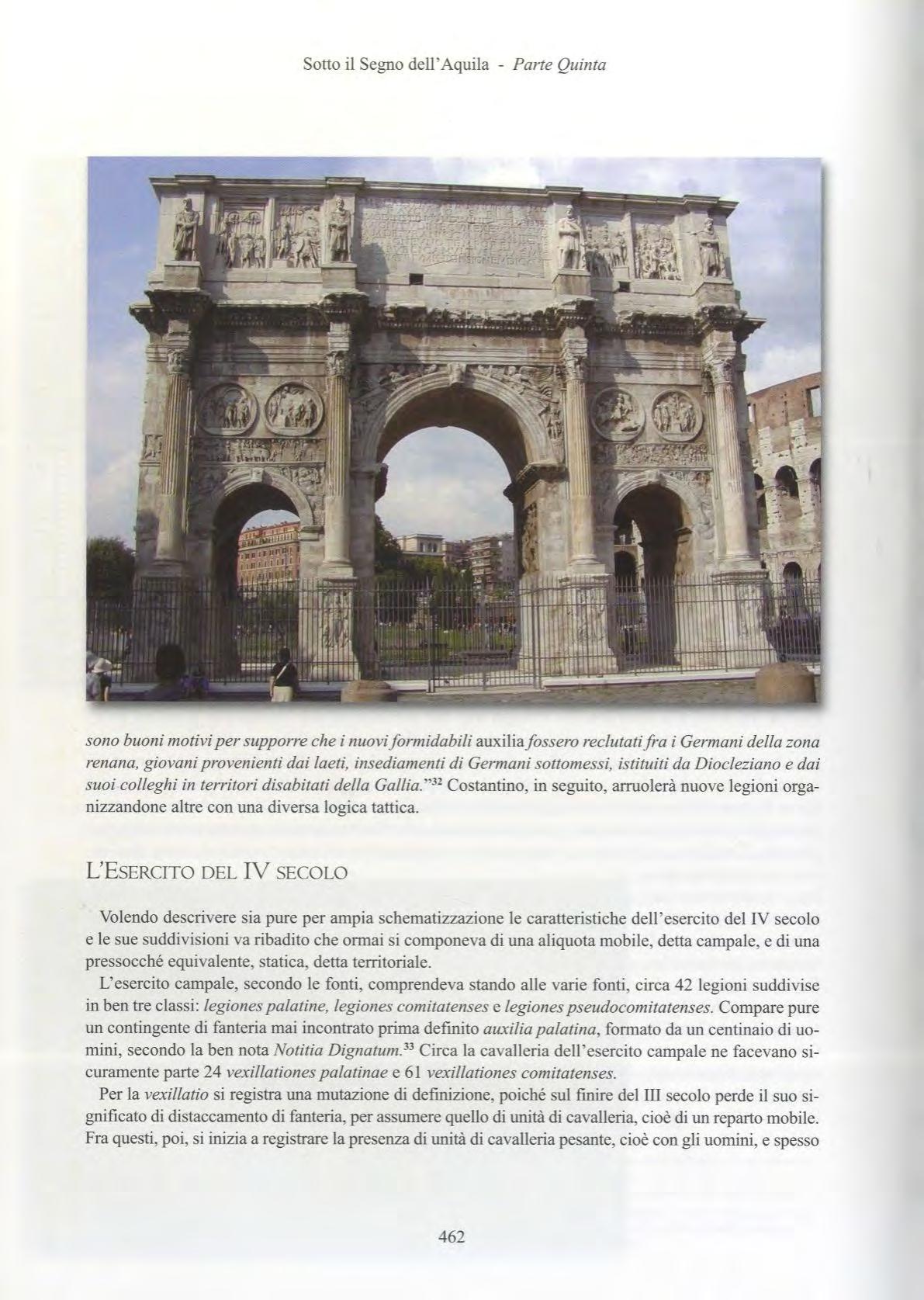
L’esercito campale, secondo le fonti.comprendeva stando alle varie fonti.circa 42 legioni suddivise in ben treclassi:legionespalatine, [regionescomitalenseselegione;pseudacomitatcnses. Comparepure un contingentedi fanteriamai incontratoprima definitoauxiliapalatina, formatodaun centinaiodi un— mini, secondo la ben nota Notitia Dignatum.” Circa la cavalleria dell’esercitocampalene facevano sicuramenteparte 24 vevillarianespalatinaee61vexillan'anescomi/atenses.
Per la vexillatia si registra una mutazione di definizione.poiché sul finire del [Ilsecoloperde il suosignificatodidistaccamentodifanteria.,perassumerequellodiunità dicavalleria.cioèdiun repartomobile. Fra questi,poi, si iniziaaregistrare lapresenza diunità di cavalleriapesante,cioècongliuomini, espesso
Sotto il Segnodell‘Aquila -
Parre Quinta
462
Sottoil Segnodell’Aquila - Parte Quinta pure icavalli,protetti dacorazze.definiteall’epoca dei catafratti,Diessi sitrova menzionenel seguentebranodiGiuliano,chenella imperantere— toricacoeva,elogiavaCostanzoII inquesti termini:“qualedegliimpera— toriprecedenti ha ideato e riprodotto una cavalleria e un armamento simile?Tuperprima ticiseiesercitato, etiseifimomaestroperglialtri diquestainvincibilepraticaguenesca,““
Lacavalleriacatali'atta,quindi,comparenelleprimametàdelIVsecolo: quanto alla suavera ideazione non può in alcunomodo ascriversi a Costanzo 11,dalmomento che la pratica di rivestire cavallo ecavaliere con un’armaturadiferro,pesanteeresistente,eraoriginariadell’Oriente.lRomani l’avevano appresa, infatti, dai Persiani che,a lorovolta, l’avevano trattadall’armamentodegliSciti.Cosi,inoltre,AmmianoMarcellorievoca CostanzoH:“generalecoscienzioso,mapocodotato, confamadivincere leguerreciviliediperderequelleestere.nell'attodelsuoingressosolenne aRoma,Procedevasoloinun carrodoratoscintillantedigioielli,constendardidisetapurpurea (:lestadiserpentechesibilavanoalventosoprail suocapo,Aiduelatimarciavartofantiinarmaturaeclibanarii, cavalieri cheparevanostatuesemoventi.”SS
Varilevatocheseletruppepalaline sonol’elitedelnuovoesercitocampaleelecomitatensipossonoconsiderarsiquelledilinea,lepseudocomitarensi sonoinvece l’esitodeltrasferimentodiinteri repartidall’esercito territorialealcampale,oonfermandocicosiancoraintaleepoca,ilpersisterediunacertaomogeneitàIniziacomunqueamanifestarsilastn)erioritàdeirepartidicavalleria,etuttol’esercitotendeadivenireinunaformcompletamentementata.Dalpuntodivistatatticolamutazioneoostitrriwunindubbiovantaggio,poichéspostandosi leformazionidicontrastoadunavelocitàmdiadi80chilometrialgiomo,illororaggiodiinterventorisulmva notevolmentepiùampio.Percontrosi ' " " la , ' cheaveva aiRomanidi un impero:la logisticadellalegionedifanteria. Leguardie dell’imperatorevennero divise in 12scolaepalatinae, dicui 5ad oveste 7ad est, che assolvonoaicompititradizionalideipretoriani. Sonoposteagliordini diunmagisterafi‘iciorum enon diunmagivtermilitum, W eranoancorai ProtectoresDomestici,chenelmentreassolvevanola fimzionedi guardia delcorpodell’imperatoresifacevanopure caricodell’addest'rar'nentodei futuriufficiali.Quantoall’esercito territorialelefontilotramandanocompostodicirca150legionie 118cohortesedancoradi 16numerievarie unitàminori,denominategenericamentemilitesenutri/iam…Lacavalleriaten-itorialeèdivisainaloe, cunei equitumoequites,nonché inunpaiodicohortesequitate.Compaionopurenumeroseunità dibalistarii,reparti forsearmaticonartiglierieleggereoppureipponairrate,comelecar-roballìstaeche svolgonofunzione disupponeall’esercitocampale.
Volendoprocedere adunaprimastimacomplessivadell’organicoditutteleunitàelencatevaricordato chenelle legioni del Basso Impero continua lavistosa contrazione dell’organicogià avviatada Diocleziono,percuisonodiganlungapiù scarnedelleprecedenti, forsenon più diun quintoodiun sestoaddirittura.Pertanto ciascunalegionedell’esercitocampaledeve stimarsidi BOO-1.200 uomini, mentre se difrontieradovrebbeancoracontame 3.000.Pergli auxiliapulmini le fonti ne collocanol’organicofra i 500egli 800effettivi.mentreperlacavalleria,vexillationes.alae, cuneiounità diequitesle rispettive entitàoscillanofra i 350-500uomini. Per lescolae,anch'esse in sostanzaunità di cavalleria,sitramandano500uomini.Pertantoassumendoilvaloreminoredellaforcellasiavrebbeunorganicocomplessivo perl’esercitodelTardoimperodi450.000militialmeno,chesalea650.000per il maggiore.Verosimile alloracollocare,masempresullacarta,l’entitàpresuntafraquestidueestremi,fermorestandoche laca-
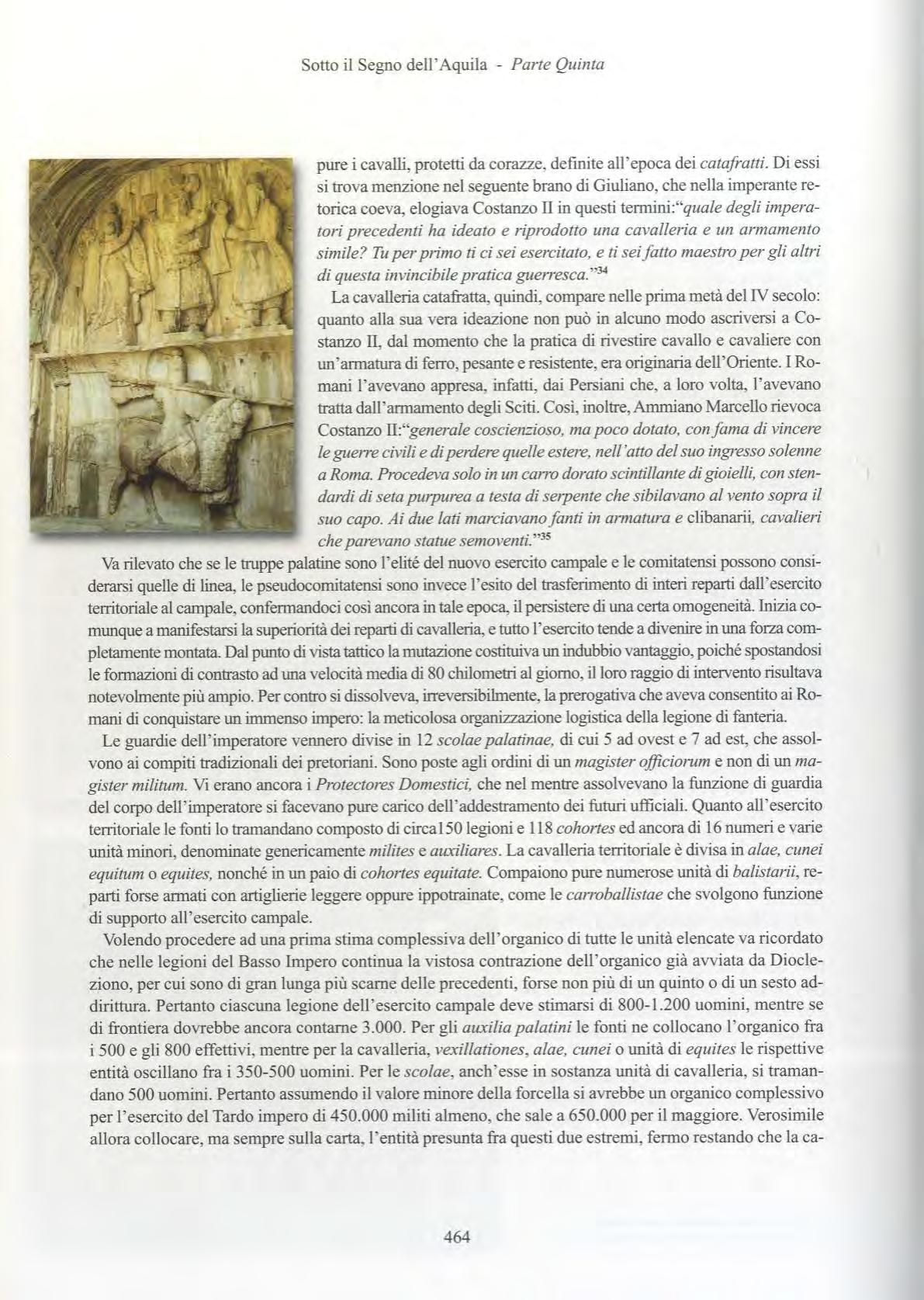
464
valleria rappresenta ormai un quartodelle forcedell’esercitocampale,eche questoa sua volta rappre» sentanella su interezza il 35—40%di tutti gli effettivi.
Dinotevolecomplessitàilquadrodeicomandi,percertiaspettimoltomoderno,ecomunquelontanissimo daquellodi epocaclassica.Perlaparte orientaleabbiamodueeserciti campalicentrali,ognunocomandato daun magistermilitumpraesentalis etreeserciti campaliregionali in Oriente,Tracia eIllirico,comandati ciascunodaun magistermilitum. Perlaparteoccidentalesitrovano, invece,dueeserciticampalicentralidi cuiunocomandatodaunmagisterequitumpraesentalt'sedaunmagisterpeditumpraesentalis,nonche'quat— troesercitiregionaliinGallia,Spagna,GranBretagnaeIlliricocomandatidacomitesadeccezionediquello dellaGalliacomandatodaunmagisterequitum.
Circal’esercitodifrontiera,prnnonavendosisicuririscontri,risultaprobabilecheicomitesediducesche licomandavafosseroall’occasione sottopostiaimagistridegli eserciti campali quandooperantinei loro settori,Da attenti studieffettuati sullefonti ilgettitoumanodi cuibisognaval’esercitodel IVsecoloeradi circa 30.000uomini l’anno,entitànonlontanainassolutodaquelladell‘Altoimpero,comenon lontanoera l‘organicocomplessivo.Perfarviflontesiricorrevaalreclutamentovolontario,alreclutarnenmereditarioed aquelloditipofiscale:laprevalenzadell’unoodell’altrodipendevasoltantodallacircostanmdelmomento.
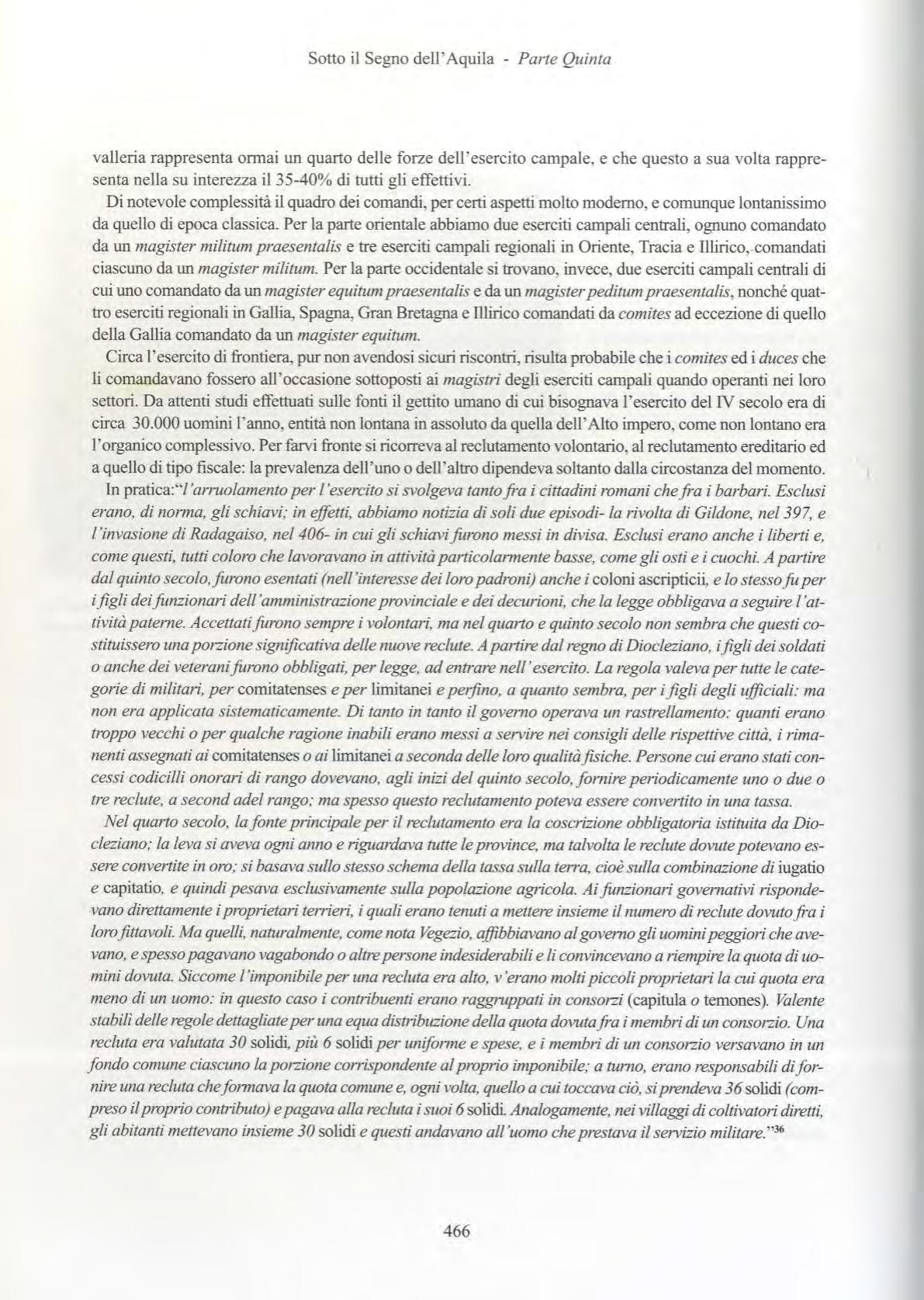
Inpratica:“!’arruolamentoper!'esercitosisvolgevatantofraicittadiniromanichefraibarbari, Esclusi erano, dinorma, glischiavi:inejetti, abbiamonotizia disolidueepisodi»larivolta di Gildone. nel397, e l’invasionediRadagar'so, nel406-incuiglischiavifitrortomessiin divisa.Esclusieranoancheilibertie, comequesti,tutticolorochelavoravanoinattivitàparticolarmentebasse, comeinostieicuochi.Apartire dalquintosecolo,fiorinoesentati(nel!interessedeiloropadroni)ancheicoloniascripticii,elostessofuper ifiglideifitnzionaridel!'amministrazioneprovincialeedeidecurioni,chelaleggeobbligavaaseguire1’attivitàpaterne.Accettatifirronosempreivolontari, ma nelquartoequintosecolononsembrachequestico— stituisserounaporzionesignificativadellenuovereclute.ApartiredalregnodiDioclaiano, ifiglideisoldati aanchedeiveteranifitronoobbligati,perlegge,adentrarenel]'esercita Laregolavalevapertuttelecategoriedimilitari,percomitatenseseper limitanei eperfino, a quantosembra,per ifiglidegliufiîciali:ma non era applicatasistematicamente.Ditanto in tanto ilgovernooperava un rastrellamento:quantierano troppo vecchioperqualcheragioneinabilieranomessiaservireneiconsiglidellerispettivecittà.irimanentiassegnatiaicornitalensesoailimitaneiasecondadelleloroqualitàfisiche…Personecuieranostaticoncessi codicillionoraridirangodovevano, agliinizidelquintosecolo,fornireperiodicamente una odueo trereclute, asecondade!rango;maspessoquestoreclutamentopoteva essereconvertitoin una tassa.
Nelquartosecolo, lafiznteprincipaleper ilreclutamentoera la coscrizioneobbligatoria istituitadaDiocle2iano'lalevasiavevaogniannoeriguardava tutteleprovince, ma talvolta lereclutedovutepotevanoessereconvertiteinoro,sibasavasullostessoschemadellatassasulkrterra, cioe'sullacombinazionediiugatio ecapitatio equindipesava ' sulla ,, ’ agricola Ai ' rispondevanodirettamenterproprietaritenieri, iqualieranotenutiamettereinsiemeilnumerodireclutedovutofra i lorofittrwoli.Maquelli,naturalmatte,comenota Vegaio,afi‘ìbbiavanoalgovernogliuominipeggioricheavevano, espessopagavanovagabondooaltrepersoneindesiderabilieliconvincevanoariempirelaquotadiuo— minidavum. Siccome]imponibileperuna recluta eraalto,v'eranomoltipiccoliproprietarilacuiquotaera menodiun uomo:in questocasoicontribuentieranoraggruppatiinconsorzi(capitulaotemones). Valente stabilidelleregoledettagliateperunaequadistribuzionedellaquotadovuta/"raimembridiunconsorzio Una recluta eravalutata 30solidi,più 6 solidipaunifirrmeespese, eimembridiun consorzioversavano in un fondocomune ' la , …,.', ’ alproprio , " " aturno, erano , L'’difor= nireunareclutachefirmavalaquotacomunee,ognivolta,quelloacuitoccavacià,siprendeva56solidi(compresoilpropriocontributo)epagavaallareclutaisuoi6solidiAnalogamente, neivillaggidicoltivatoridiretti, gliabitantimettevanoinsieme30solidiequestiandavanoal!'uomocheprestava ilserviziomilitare.…
Sotto il Segnodell‘Aquila -
Parte Quinta
466
ULTERIORI EVOLUZIONI
ApartiredalIVsecolol’insiemedell’esercitoromano,0permegliodiredegliesercitiromani,subisceun ulteriore, rapidoedinarrestabileprocessodiframmentazione,Una pletora diunità minori, per lopiù acavallo, edi distaccamenti di scarsoorganico, intasagli elenchi dandola sensazionediuna straordinariarilevanza numerica. Ma in realtà ognireparto diviene, giornodopo giorno, sempre meno consistente ed affidabile.Tantoperesemplificaresisadiun’ala dioclezianeadi appena 116uomini, comepure di 77cavalieri negli equitespromotidiuna legione,di 121in una unità diequitessagittari,edancoradi 164fanti nellacohorsXlChamavorum ecirca 1.000inalcunelegioni!Nel 359dueunità dicavalleriadanubianain servizioinMesopotamia contavanointotale700uomini, edall’iniziodelsecolosuccessivoun’altraunità di cavalleria, la Unnigardae, ne schierava appena40. L’elencopotrebbe agevolmente continuare,sempre conl’identicatragica inconsistenza,afrontediroboantidenominazioni emeticolose suddivisioni.
Unostudioattendibilecondottosuquellecheancorapomposatnentevenivanochiamatelegionisulfiniredel IVsecololasciaconcludereche:“1elegionialmenoeranosoloombre;laIIIItalicaperesempio,presidiavaquottrofirrtielasuavecchiafortezza,oltreafi)rnireuna«legione»perilpiùvicinoesercitomobile. Questaimpressionediunitàdipiccoledimensionie‘rtqfinzatadalcompiacimentodiGiulianoperaverpreso 1.000Germani prigionieri«induebattaglieeunassedio»:nell'assedioduratoduemai, 600Franchifitmnocostrettiperfarne ausciredaduefi7rt‘idovesierratonfilgiali, emandatiaCostanzoIIperservirenell”esercitod’Oriente.L ‘eser— citodiGiulianonel357eontavasolo13.000uomini;nel363,connatoI 'Impemacuiattingere,esenzaaltriimpegniguerresehi, isuoidueerertitiperl’invasionedellaPersiacomprendevanointotale65.000uomini?“
Sieraben lontani,comunque le sivoglia interpretare,dallecifreche sullacarta facevanoascendere a 390.000unità l’esercitodiDioclezianoeche,perun’altrastima,eragiàmolto inferioreaicirca645.000 del vecchio impero! Da dove scaturiva tanta diversità fra valutazioni teoriche ed entità concrete'.7 Una plausibile spiegazionepotrebberavvisarsinel sistemadigestioneeconomicaormaivigente,basatosulla fornitura delle razioni alimentari a ciascun milite, oltre ad una modesta paga in moneta spicciola, coniata in enormi quantitativi. Il numero complessivodellerazioni, infatti,per un’ovvia conclusione dovrebbe coincidere con il numero di uomini, seperò fossero statecorrisposte inragione diret1a enon di rilevanza:inpraticasalendodigradoaumentavano,percui seadunsemplicelegionarionevenivanocorrisposte setteallasettimana,per lo stessoperiodoun ufficialenepoteva avereancheunaventina ealtre ancoraperigradi superiori.Il totale, quindi,davaun organicoassolutamenteeccedenteil concreto.
Eppure nonostante i generosissimi emolumenti,reclutareuomini divennesemprepiù difficilee:“sembra chela coscrizionefossemoltoimpopolaretantofraiproprietarichefra icontadini.] primipreferivanoassolutamentepagareinmoneta, inmisuradi25o30solidiperrecluta, anzichéprivarsidiuomini. I secondi,una voltareclutati, eranomandatiallelorounitàsottostrettasorveglianzae, nonostantequesteprecauzioni, unagranquantitàdiessifitggivaduranteiltragitto.Nonpochi, inoltre,giungevanofino a tagliarsiilpollicerendendosicosiinabilialservizio. E difficiledirequantoestesefosseroquestepratiche.SecondoAmmiano, igallimaisitagliaronoilpollicecomefacevanogliitaliani, edèpmbabileche nelleprovincedi confine, comela Gallia. l'Illiricoela Tracia, doveilserviziomilitare era cosa ormai accettatadamolto tempo, non siincontrasserogravidiflîcoltà nelreperimento dinuovereclute]… Unaragionecherendevalaprospettivadelserviziomilitarebendiversasesieraabitantidelleprovince di confineodi quelle interne, non fu di cenol’assuefazione deiprimi e la pavidità dei secondi. Quelli cheabitavanoaridossodellimesvenivanodestinati,sianegliesercitidimanovrachestanziali,atruppe operantinon lontano dalle loro famiglie.Gli altri, invece, eranodestinati comunquea grandi distanze, quasi ad unperpetuo esilio.Talediversitàspiegapureilperché del maggiorgradimentodel servizionei limitaneirispettoaquellonei eomitatenses,nonostantelemaggioriretribuzionieprospettive dican-iera…
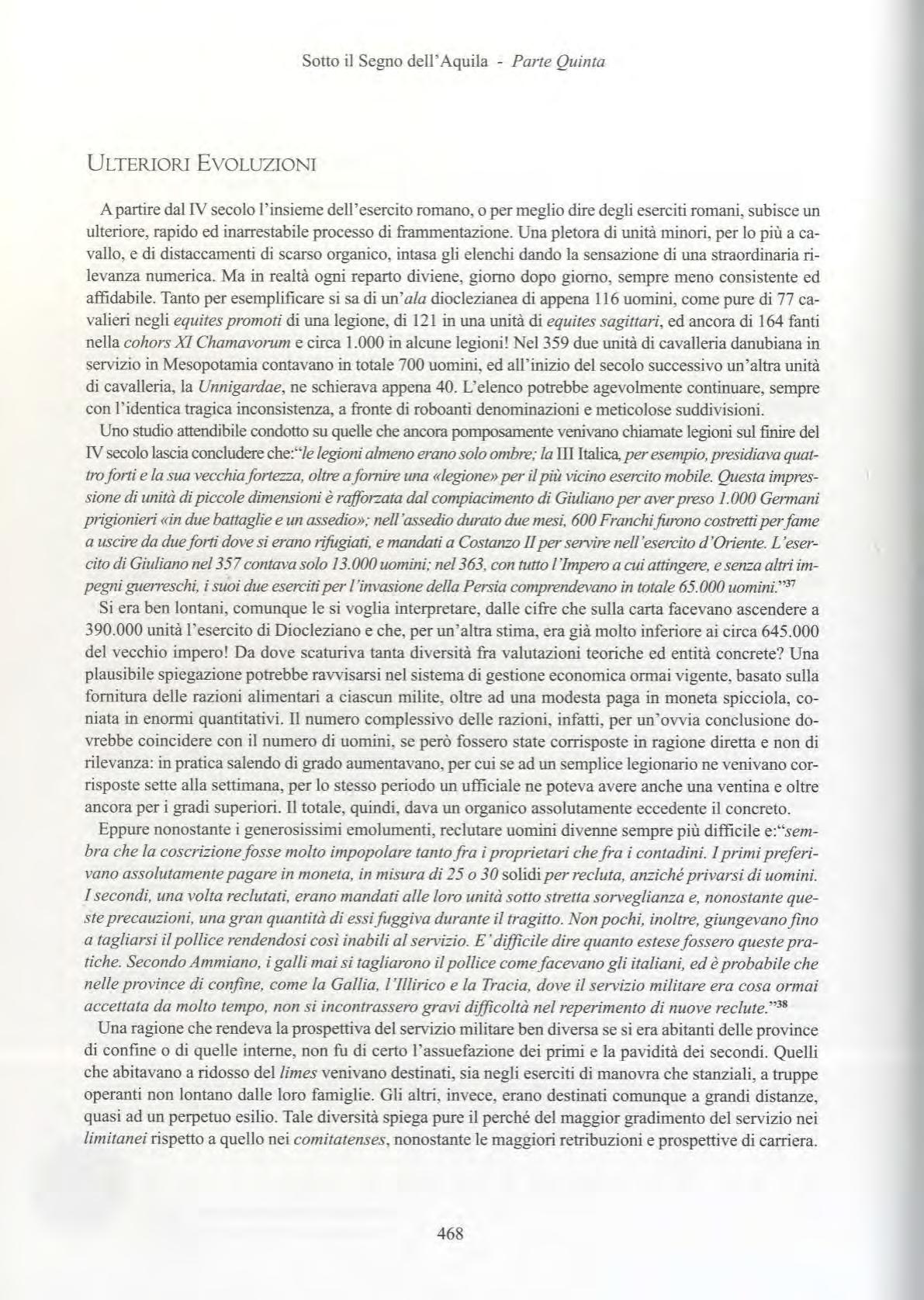
Sotto il Segnodell‘Aquila - Parte Quinto
468
La contrazione degli arruolamenti fucontrastata intutti i modi possibili, persino riducendo la statura minima richiesta, per giungere, alla fine, ad arruolareanche i barbari fatti prigionieri. Con il crescere del loro numero l’esito però fi.i catastro— fico:non avendo,infatti,ilbenchéminimosensodiappartenenzaetnicaogiuridica, finirono per ricattare le popolazioni che avrebbero dovuto difendere, estorcendo loropersinoterreedenaro,agli inizi del V secolo.
NOTmA DIGNITATUM
Per tentare di tracciare le suddivisionidell’esercitodel IVsecolo, intervallo che Fog/ivdelleNat/'na Dlgnftatum» intercorretra laconclusionedel regnodi Diocleziano nel 305elamorte di Teodo» sio il Grande nel 395, periodo particolarmente vivace del più vasto ambito del Basso Impero disponiamodiun singolaredocumento,di tanto in tanto già menzionato, definitoNotitia [" ‘ Inprima ' sitratta diun ’ cheelencatutti i dignitari del Tardoimpero,owerotuttelecariche civili emilitari, redattoper laparte occidentale,45libri,intorno al 400 eper quellaorientale,altri45, intorno al420. Il documentociègiuntotramiteuna copiadel IXsecolo,che oltre a ripropome il testo ne tramanda anchetutta la parte grafica relativa allediverse insegue di ogni singoloreparto, Di seguitole giurisdizioni risultanti dal documento:
OCCIDENS(PARTES IMPERII)
ProconsulatusAfrica
Lucania&Bruttii corrector
Africa meODSIIÌ Picenum suburbicarium consularis
Praet'ectura Italia praefectus praetorio s…… praeses
Diocesis Italia ? Sardinia praeses
Aemilia consularis Sicilia consularis
Alpescottia praeses Tuscia&Umbria consularis
Flam$oîaîiriiînum
consularis Valeria praeses
Liguria consularis Diocesis Hlyricurn
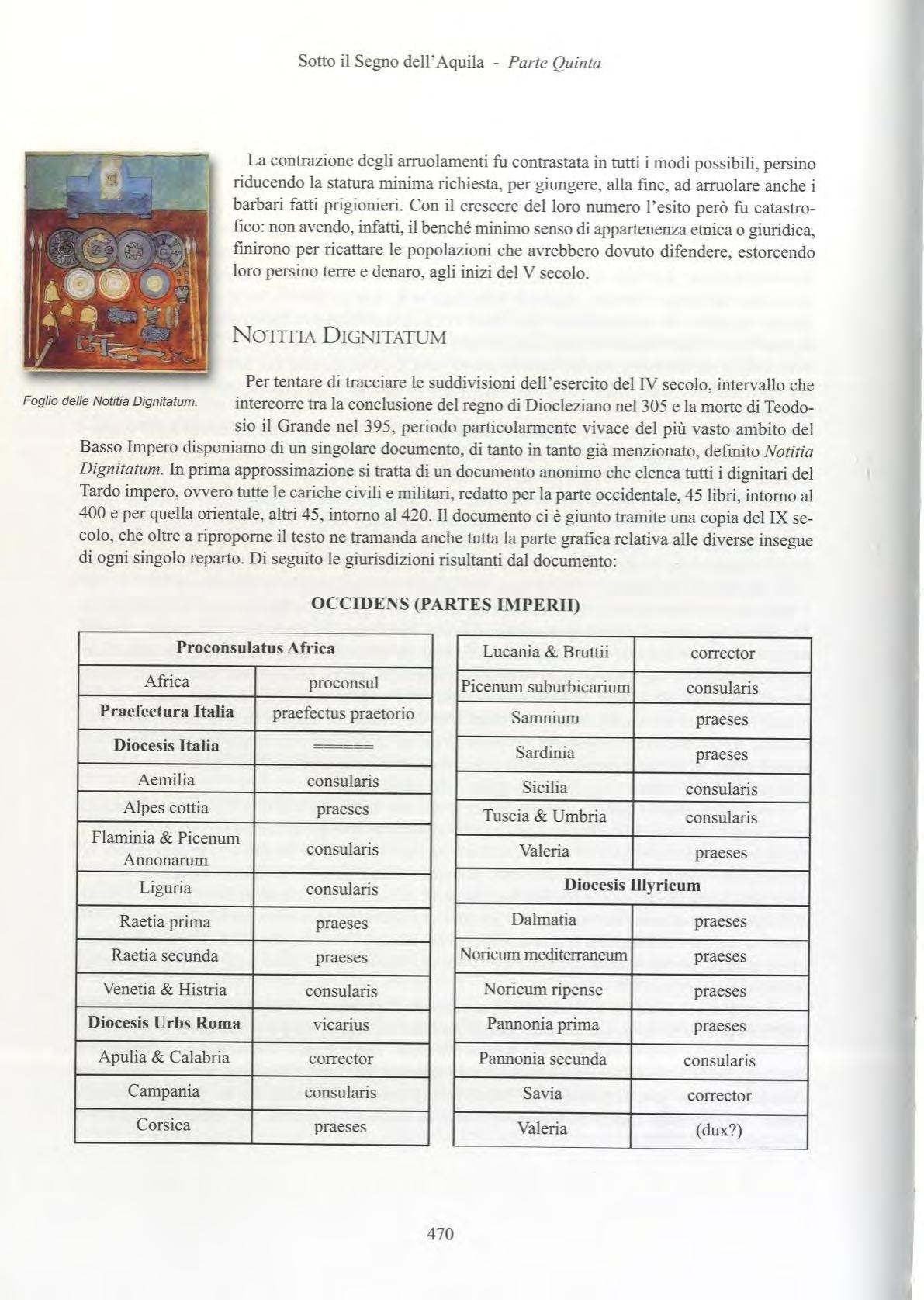
Raetiaprima praescs Dalmatia praeses
Raetia secunda praeses
Norianmediterraneum P‘35595
Venetia & Histria consularis Noricum ripense praeses
Diocesis Urbs Roma vicarius Pannoniaprima praeses
Apulia &Calabria corrector
Pannonia secunda consularis
Campania consularis Savia corrector
Corsica praeses Valeria (dux?)
Sotto il Segnodell‘Aquila - Parte Quinta
470 ...nn…»
DiocesisAfrica vicarius Narbonensis secunda praescs
Africa PIOCOUSUl Novempopuli praeses
Byzacium consularis Viennensis consularis
Mauretania caesariensis dux ctpraeses Dineesis Galliae
Mauretania sitifensis
praeses Alpespoeninae etgraiae praeses
Numidia consularis Belgicaprima consularis
Tripolitania piacses Belgica secunda consularis
Praefectura Galline praefectus pretorio Germania prima consularis
Diocesis Hispaniae vicarius Germania secunda consularis
Baetica consularis Lugdunensisprima consularis
Baleares insulae praeses Lugdunensis secunda praeses
Carthaginiensis praeses i Lugdunensis senonia praeses
Gallaecia consularis Lugdunensistenia praeses
Lusitania consularis Maxima sequanorum praeses
Tarraconis praeses Diocesis Britanniae vicarius
Tingitania praeses Britanniaprima praeses
Dioc. SeptemProv. vicarius Britannia secunda praeses
Alpes maritimae praeses Flavia caesariensis praeses
Aquitanica prima praeses Maxima caesariensis consularis
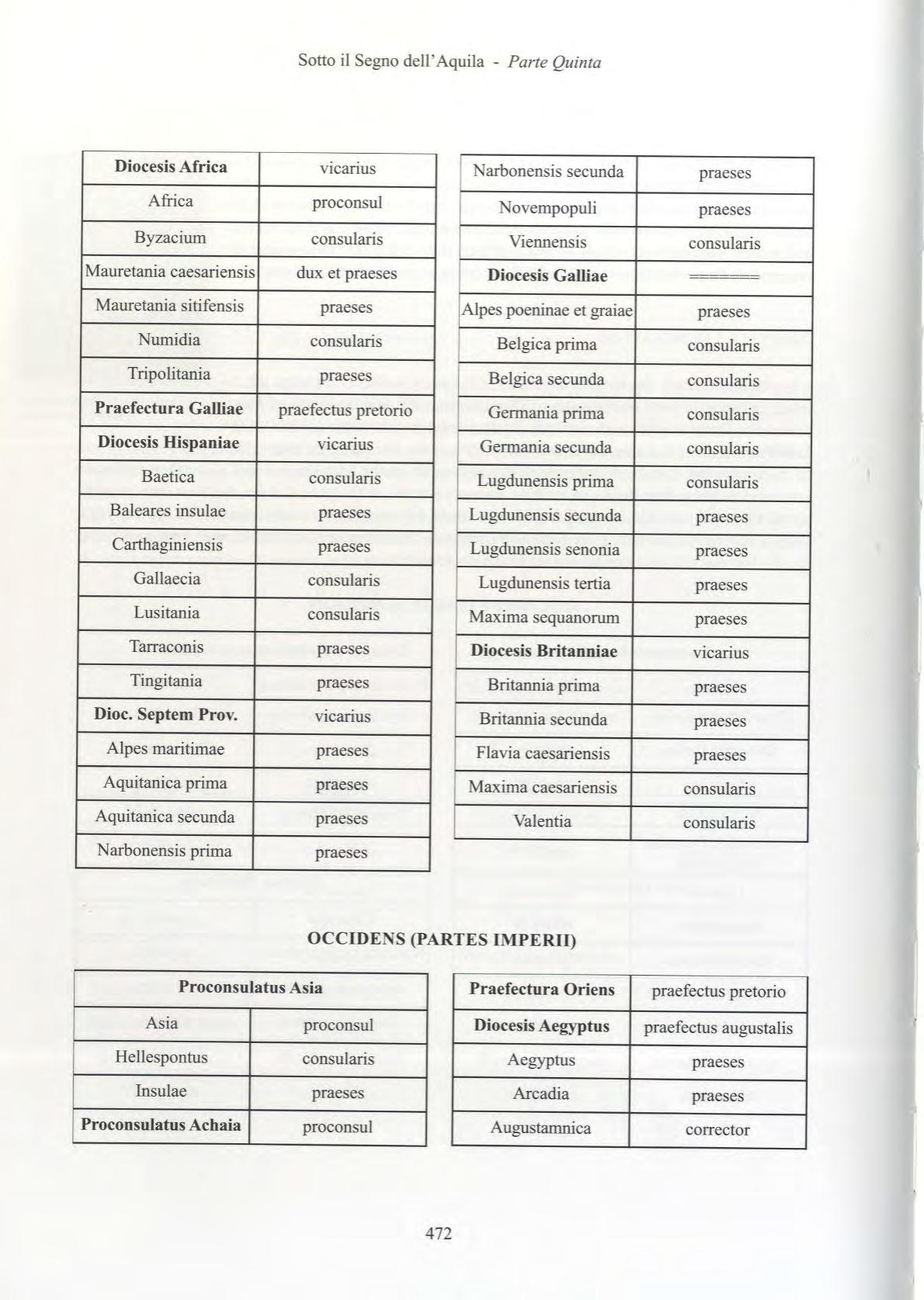
Aquitanica secunda praeses Valentia consularis
Narbonensis prima praeses
OCCIDENS (PARTES IMPERII)
ProcunsulatusAsia Praefectura Oriens praefectus pretorio
Asia proconsul DiocesisAegyptus praefectus augustalis
Hellespontus consularis Aegyptus praeses
lnsulae praeses Arcadia praeses
ProcunsulatusAchaia proconsul Augustamnica corrector
Sotto il Segnodell'Aquila » Parte Quinta
472
Libya inferior praeses Armenia prima praeses
Libya superior praeses Armenia secunda praeses
Thebais praeses Bithynia consularis
Diocesis Oriens comes Cappadociaprima praeses
Arabia dux erpraeses Cappadocia secunda praeses
Cilicia consularis Galatia consularis
Cilicia secunda praeses Galatia salutaris praeses
Cyprus consularis Helenopontus praeses
Euphratensis praeses Honorias praeses
Isauria comesetpraeses Paphlagonia corrector
Mesopotamia praeses Pontuspolemoniacus praeses
Osrhoena praeses Diocesis Thracia vicarius
Palaestina consularis Europa consularis
Palaestina salutaris praeses Haemimontus praeses
Palaestina secunda praeses Moesia secunda praeses
Phoenice consularis Rhodope praeses
PhoeniceLibanensis praeses ‘ Scythia praeses
Syria consularis Thracia consularis
Syriasalutaris praeses , Praefectura Îllyricum praefectuspretorio
DiocesisAsiana vicarius Diocesis Macedonia vicarius
Caria praeses Creta consularis
Hellespontus @roc.Asia) Epirus nova praeses
Insulae (proc,Asia) Epims Vetus praeses
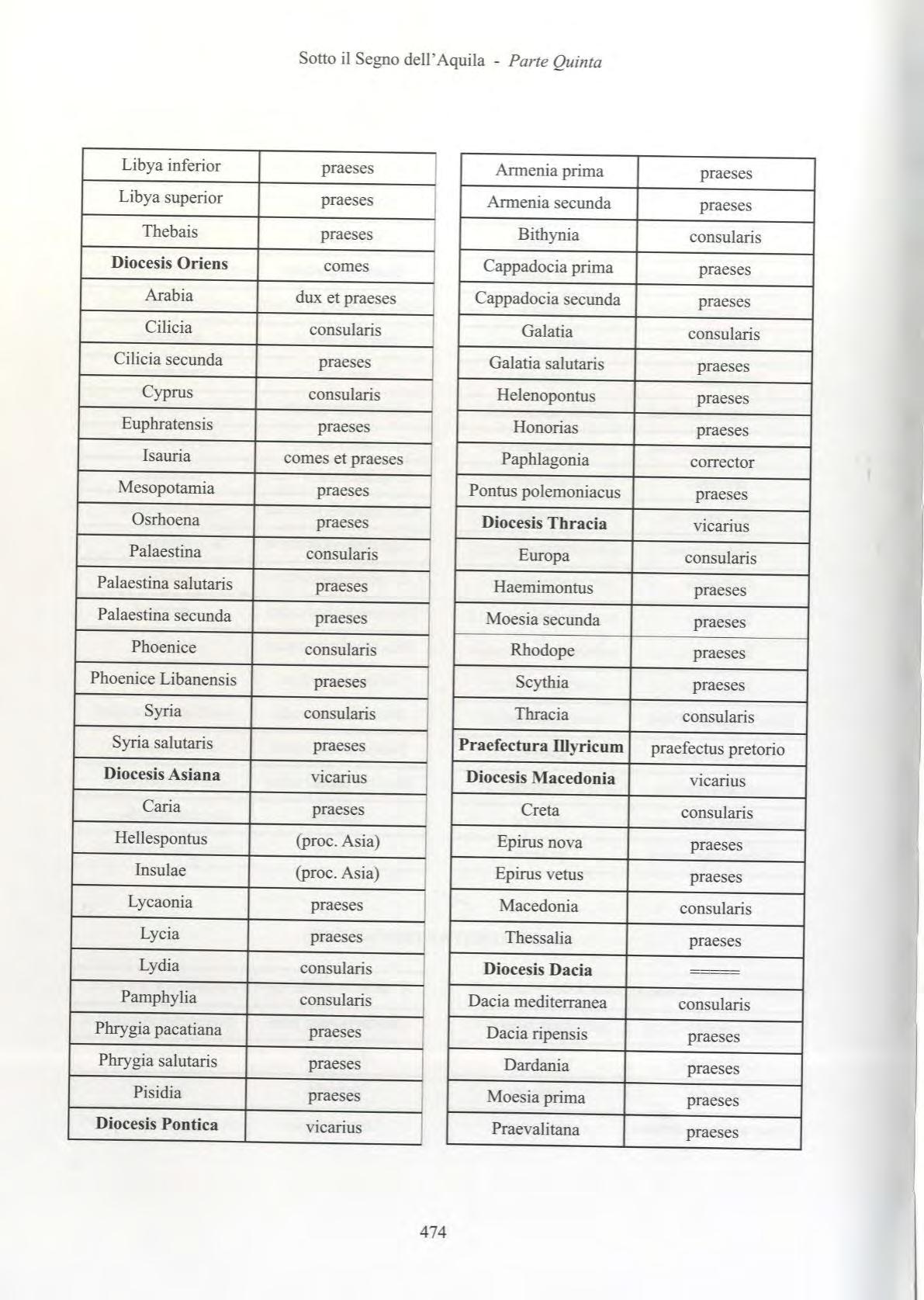
Lycaonia praeses Macedonia consularis
Lycia praeses Thessalia praeses
Lydia consularis DiocesisDacia
Parnphylia consularis Dacia mediterranea consularis
Phrygia pacatiana praeses Dacia ripensis praeses
Phrygia salutaris praeses Dardania praeses
Pisidia praeses Moesiaprima praeses
Diocesis Pontica vicarius Praevalitana praeses
Sotto il Segnodell‘Aquila - Parte
Quinta
474
Circa lelegioni che sipossonodesumere dallostessodocumentoe di cui seguel’elenco,sebbenefos— seroormai di entitàimprecisata,edimprecisabile.continuavanoafregiarsidel numero edel nome. Pro— babileche in determinatimomenti quellecomitatensi,chesipossonoconsiderareunità di linea regolari, quandodinuovaformazioneeranocompostedaun migliaiodiuomini.quandovecchie legioni imperiali anche da 6000. Le pseudocomitatensi, invece, eranounità di frontiera distaccatepresso l'esercitocampale in occasione di alcune campagne e spesso rimaste lì.Alcune legioni alto imperiali divennerounità pseudocamilatenses.
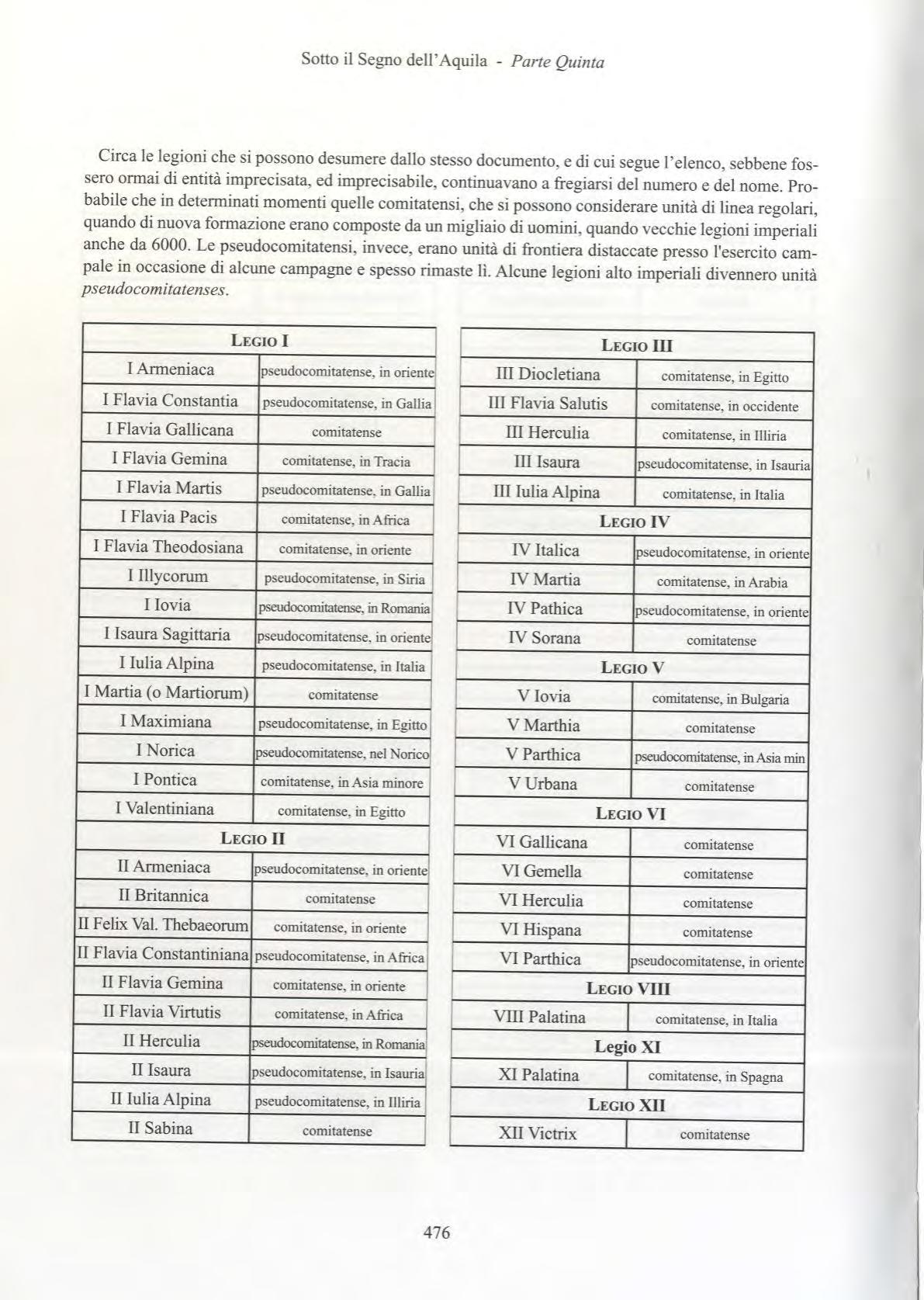
LomoI
LEGIOIII
IArmeniaca pseudocomitarense. inoriental IIIDiocletiana comitatensc.inEgitto
IFlavia Constantia pseudocomitaiense,In Galliai ? lll Flavia Salutis eomilaiense,inoccidente
I Flavia Gallicana comitatense III Herculia comitatense.inllliria
I Flavia Gemina corrutatense,inTracia ’ [IlIsaura in Isauria
l Flavia Martis pseudocomilatense. inGallia lll IuliaAlpina comitatense.in Italia
IFlaviaPacis …mi…ense … Africa “
LEGIOIV
I Flavia Theodosìana comitatense,inunente ‘ IV Italica ipSEudocomila!finse, inoriente ]lllycorum pseudocomitarense in Siriai i IVMartia comitatense,inArabia
I Iovia pseudocormtatense.inIlornania1 IVPad-rica
IpSeudocomitfltensi-r,inoriente
I Isaura Sagittaria pseudocornitatense. inorientei i IVSorana comiraiense
I IuliaAlpina pseudocornirarense,InItalia ‘—
LEGIO V
I Martia (oManiorum) comitatense V Invia comitatense.inBulgaria
I Maxin-riana pseudocomitatense. inEgitto, VMarthia comitatemse INorica nseudocomirarensenelNorico! ;' V Parthica mm….inAsiamin
I Pontica comitalense.inAsiaminore VUrbana comitatense
I Valentiniana comitatense.inEgitto ? LEGlOVI
LEGIOIl
VI Gallicana comitatense
IlArmeniaea ipseHducomitat6nse.inorientei l VIGemella comitalense
IIBritannica comitatense
LIFelixVal.Thebaeorurn comitatense,inoriente ‘ [
VIHerculia conutarense
VI Hispana cuminatense
Il Flavia Constantiuiana pseudocornitatense.inAfrica; VI Parthica Ipseud0Cùrtutatens€.inoriente
IIFlaviaGemina comitaleuse,inoriente \ Lec…VIII
Il Flavia Vututis comitatense,inAfrica ‘
11Herculia mm…-;…,inno…? ' LegioX]
Il Isaura pseudocomnatense.inIsauriaI
VIII Palatina | comitalense.inItalia
XI Palatina | comitatense,in Spagna
IlIuliaAlpina pseudocomitatensginm… { ’ LauroXII
II Sabina comitatense ] XII Victrix | comitatense
Sotto il Seguodell'Aquila Parre Quinta
LA CADUTADELLE AQUILE
L’esercitodel IVsecolo,incombattimentotentava diemularequellodellaprimaetàimperiale:ma sitrattavapiùdiformachedisomma.Quandobencomandato,tuttavia,riuscivaancoraabattersivalorosamente eariportareanche qualchevittoria, Dallepagine diAmmianotraspareancoraun indubbio spiritodicorpo, unconoorgoglioresidualechesostenevaqueinuomininellelunghemarce.neiguadideigrandi fiumi,nella difesadellelorosperdutepiazzeforti difrontiera.Pertanto:“icomitatensiseranodunquealmenoparagonabiliagliausiliaridelprimoImpero, isoldaticheavevanobattutoiCaledonialMonsGropius...Nel 378ad Adrianopoli, il 9agosto,lacavalleriasiaflennòdefinitivamentesullo/enteritieper I 'esercitoromanofix la peggioregiornatadellasuastar-io.””Cosìlarievocò,AmmianoMarcellinonel suo31°libro:
“)01- 10E sorseI 'ourorodel9 agosto[anno378],qualeèsegnatosulcalendario;cisimiseprestoinmarciamaitresolmerieebagaglivenivanolasciativicinoallemuradiAdrianopoliconunaconvenientesorveglianza operatadallelegioni(tesoroealtreinsegne[mantellodiporpora,dùzdema.scettro,globo,carroimperiale]della dignitàimperialeeranotenutientrolemuro, conilprefetto[alpretorio]emembridelConcistoro).
lI.Percorsitrattidistradadtfiie’ili,quandolagiornatatorridovolgevaumezzogiornoeccoCheaottomiglia[da Adn'anopoli]finalmentesiscorservicarrinemicidinrosti(secondolarelazionedeinesploratori)incircohrperfetto. Comed’uso,lamoltitudinebarbaricaululavo I 'urloferoceerattristante:eicomandantiromanidisposerola se" dibotuzgliaf" tlfiarrc "…” " " ',Iogmnpartedellafanteriorestavofarna
12.IIfiancosinistrodellacavalleriasitrovava (raccoltocongrandissimodifi‘icolto‘:moltissimicavalieri sitrovavanoancoresparpagliatiperlestrade)procedeva digrancorriera;mentrequestofiancosidispiegavoenessunovenivo<uncora> ::disturbarlo,ibarbarieranoatterritidal]’orrendofragoreprovocatodal <sibilare> dellearmidalancioedalbattereminaccioso[dellespadesugli]scudi;poichéunapartediloro (assiemeadAlotea eoSafrace)sitrovava lontanae,pur<riehiomata>, non<eraancoraarrivata>, mandaronoambasciatoriachiederelapace.
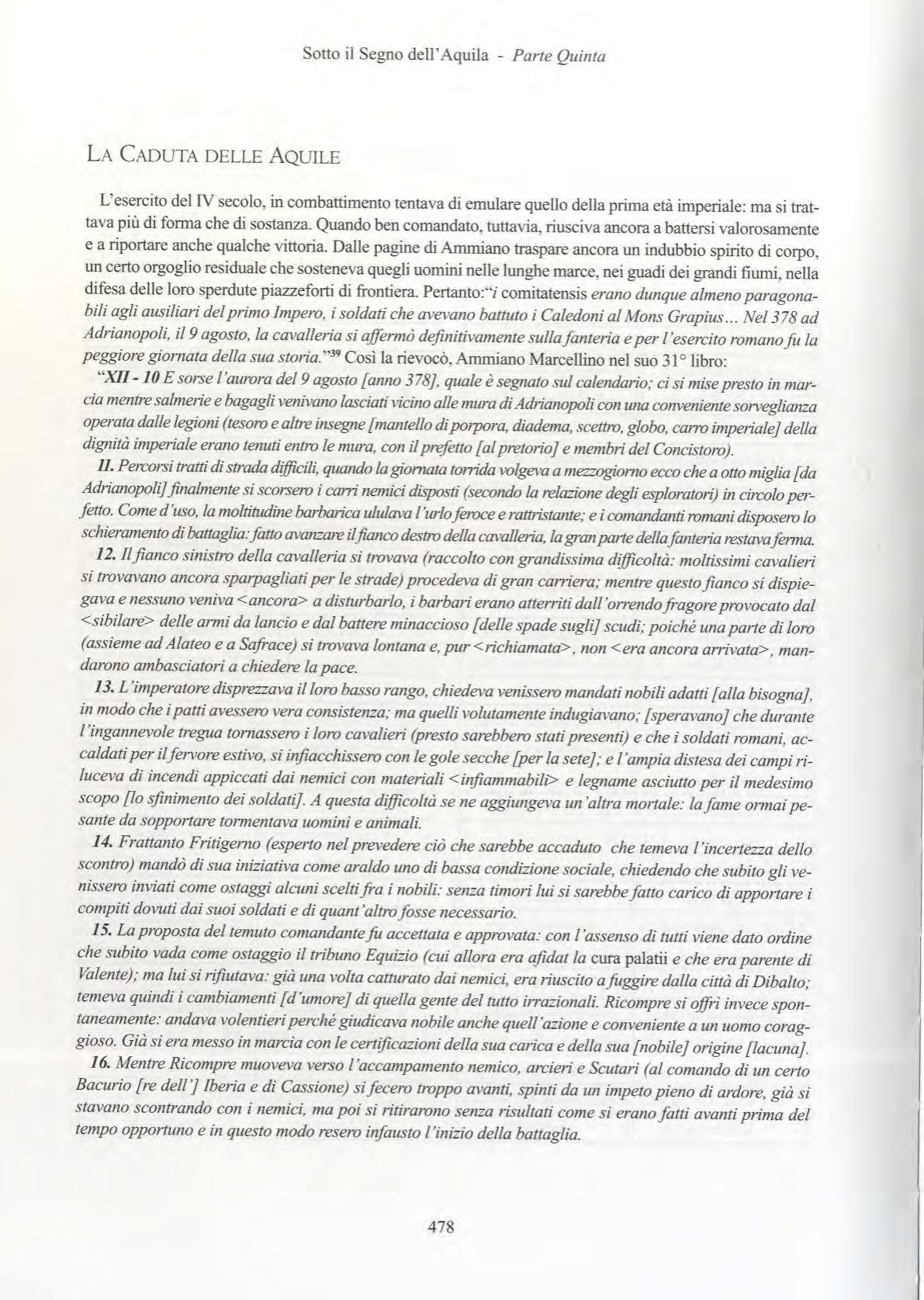
13.L imperatoredisprszillorobossorango, chiedevovenisseromandatinobiliadatti[ollabisogno]. inmodocheipntti vero moquelli ’ .[ ,, ]chedurante ]ingannevoletregua tornassero ilorocavalieri@restosarebberostatipresenti) echeisoldatiromani, accaldatiperilfervoreestivo,siinfiaeehisseroconlegolesecche[perlasete];e!'ampiadistesadeicampirif luceva di incendiappiccatidainemicicon materiali <infirzmmobilr> elegname asciuttoper ilmedesimo scopo[lasfinimentodeisoldati],A quartadifiîcoltàseneaggiungevaun 'altromortale:Infameormaipe— santedasopportaretormentdvouominieanimali.
14.FrottontoFritigerno (espertonelprevedere ciòchesarebbeaccaduto chetemeva I 'incertaza dello scontro)mandòdisuoiniziativacomearaldounodibassa condizionesociale,chiedendochesubitoglivenissero inviuticomeoslnggialcunisceltifia inobili:senza timoriluisisarebbefattocaricodiopportarei compitidovutidaisuoisoldatiediquant’altrofossenecessario.
15.La _., ,, deltemuto ’ [Il 2 r, .con I 'osserrsodituttivienedatoordine chesubitovada comeostaggioiltribunoEqui'zi0 (cuialloraeraafrdotla curapalatii echeeroparentedi Valente);ma luisirifiutava:giàuna voltocotturatodainemici, erariuscitoafirggiredallacittàdiDibalto: temeva quindiicambiamenti[d'urnore]diquellogentedeltuttoirrazionuli.Ricompresioflriinvecespontaneamente:andavavolentieriperche'giudicavanobileanchequel]hzioneeconvenienteoun uomocoraggioso. Giàsieramessoinmarciaconlecertificazionidellasuacaricaedellasua[nobile]origine[lacuna]… 16.MentreRicompremuoveva verso I ‘accznnpornentonemico, arcierieScutari(alcomandodiun certo Bacurio[redell]Iberia edi Castione)sifecerotroppo avanti, spintida un impetopieno diardore, giàsi stavanoscontrandocon inemici, ma poisiritiraronosenzorisultaticomesieranofoltiavantiprima del tempoopportunoein questomodoreseroinfizusto I 'iniziodellabattaglia.
Sotto il Segnodell‘Aquila - Parte Quinto
478
]7. Questotentativooperatoinmodointernpextivocostituìun disturbograve:laprontaza [concuisieraof» ferro]Ricomprefirresainutile(nonglifitinfattipermessodiandaredanessunaparte9;lacavalleriadeiGoti(tornataconAlateoeSafrace;esieraunitoancheunrepartodiAlani)ju simileaunfidminechesiscaricavicinoad altimonti:sconvolseconStragioperateintuttafrettaquantipotétrovareasévicinioperandounattaccoveloce.
XIII - I.Armi,frecceegiavellottivenivanomessiin motoda ogniparteaprovocarestragifra iRomani; epiùfuribondadelsolitoBellonasuonavaletrombeapportatn'cidimorte. I nostri, chesiritiravano, siarrestavanofra legrida dimolti; la battaglia <andava crescendo> come cresconolefiammeeatterrivagli animideisoldati(alcuniWMOstatidaproiettilirotean'edafiecce).
2. I dueschieramentipoisiscontraronocomenavimstratechecozzanounacontrol’altro:spingendosia vicendacomeleonde,venivzmo<agitatt> damotireciproci.Ilfiancosinistro[romano]siavvicinòadirittura aicarrieavrebbepotutoprocederealtresequalcunoavesseapportatoaiuti;fitinveceabbandonatodallarestantecavalleriaeincalzandololamassadeinemicifitschiacciatoeabbattutocomeglicrollasseaddossoun grandeterrapieno.Rimaserosaldiinpiediifantiprividipmtaione,a manipolicosìconcatenatifia loroche afizticaqualcunopotevasguainarelaspadaoppuretirareindietro&mano.Pal'ostocolocostituitodallapalverelevatasi, ilcielononsimostravaallavista,mar'irnbombavadiclamoriterrificanti;eiproiettili, chedappertuttovibravanomorte, cadevanoasegnoeferivano,datochenonsipotevanéprevederlinéscansarli.
3. Quandopoi ibarbari, spargardosiin schieresmisurate, calpestavnoanimalieuominieda nessuna partesiaprivaun luogooveritirarsi(ammucchiateeranoleschiereelaressacosiaddensatatoglievalapossibilitàdiuscirne), ecocheinostrisoldaticondisprazoestremodellamortesifizcevanoincontroalnemico e,ripreso!'usodellespade,massacravano[ibarbari]:reciprocicolpidiscurefianturnavanoscudiecorazze.
& Sipotevanovederebarbaririttinellalorobaldanza:conlemascellestrettedigrignantiperche'eranostati tagliatiiganettioperchélamanodestraerastataamputatada un colpodispada operaverricevuto un fianco trapassato, anchein vicinanza dellamortegiravanoattornogliocchitraci;per ilcrollo<a terra> reciprocodeicombattenti, icampieranocopertidicadaveri,siudivanocongrandepaura igemitideimoribondiedicolorocheeranostatiferitiinprofirndita‘,
5.Neltumultotantograndediunasituazionecosìconfina,ifanti(sfinitiperlafaticaeperipericolicorsi) poichéprogressivamente non avevanopiùforzefisichené capacità diprendere decisioni edovevanoace contentarsidi<sguainare> lespade<unavoltaspazatalamaggiorpartedeigiavellottipericontinuicolpi inflitti),siimmergevanonelletonneammucchiatedeinemicisenzapensareallapropriavitaevedendocome ognipossibilità diusciredilìerastataeliminata.
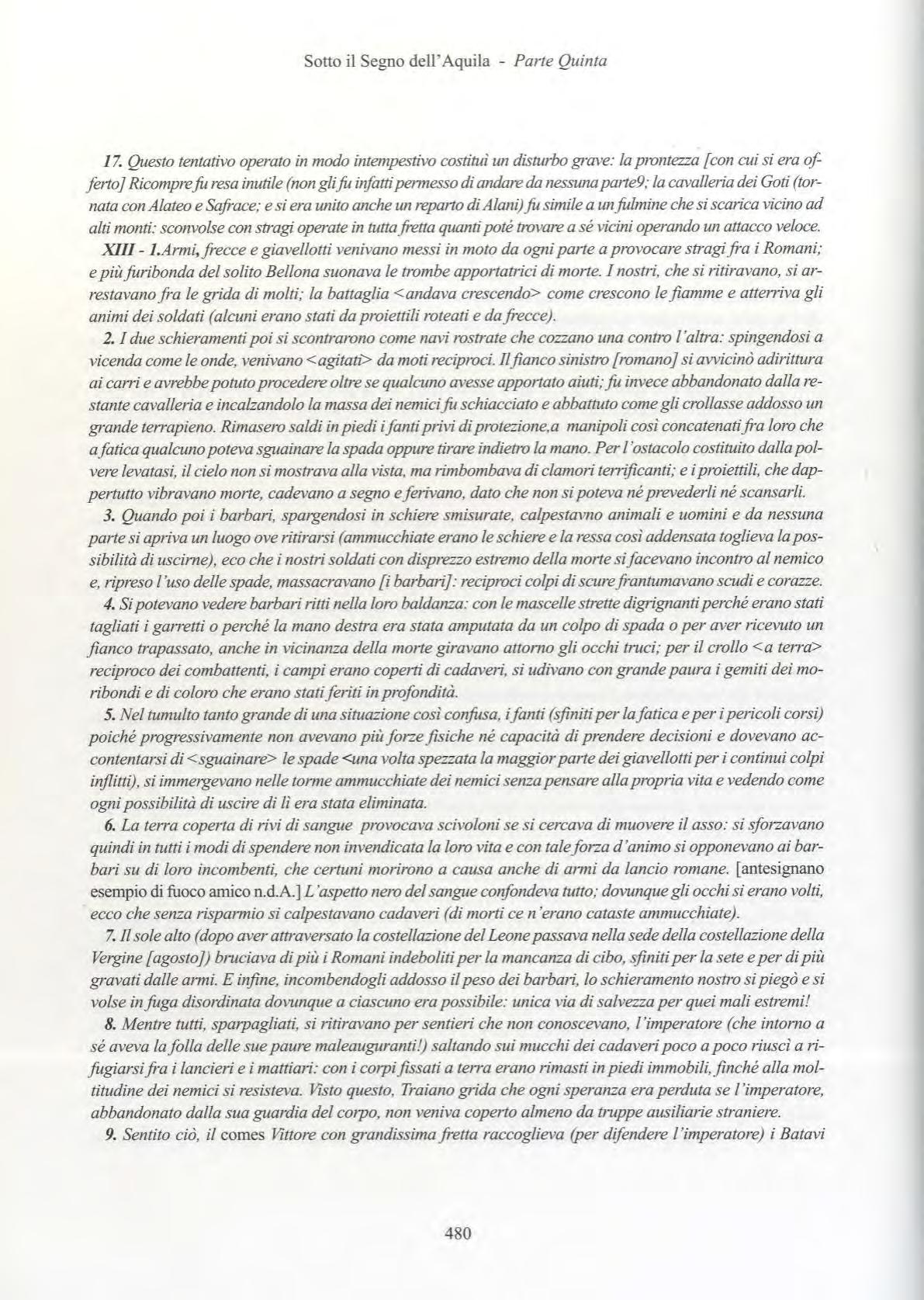
6.La terra copertadirividisangue provocava scivolonisesicercavadimuoverei!asso:sisforzavano quindiintuttiimodidispenderenon invendicatalalorovitaecontaleforzad'animosiopponevanoaibarbari su di loro incombenti, che certunimorirono a causa anchedi armida lancioromane. [antesignano esempiodi {Liceoamicou,d.A.]L aspettonerodelsangueconfirndevatutto;dovunquegliocchisieranovolti, eccochesenzar'uparrniosicalpestavanocadaveri(dimorticen'eranocatasteammucchiate).
7.Ilsolealta(dopoaverattraversatolacostellazionedelLeonepassavanellasededellacostellazionedella Vergine[agosto])bruciava dipiùiRomaniindebolitiperlamancanzadicibo,sfinitiperlaseteeperdipiù gravatidalleanni.E infine,incombendogliaddossoilpesodeibarbari, loschieramentonostrosipiegòesi volseinfirga disordinatadovunqueaciascunoerapossibile:unica viadisalvazaperqueimaliestremi!
8.Mentretutti, sparpagliati,siritiravanopersentieri chenon conoscevano, l”imperatore (cheintornoa séaveva lafolladellesuepauremaleauguranti.9saltandosuimucchideicadaveripocoapocoriusciarifirgiarsifi'a ilancierieimattian':conicorpifissatiaterraeranorimastiinpiediimmobili,finchéallamoltitudinedeinemicisiresisteva. Vistoquesto, Traianogrida cheognisperanzaeraperduta sel’imperatore, abbandonatodallasuaguardiadelcorpo, non variva copertoalmenodatruppeausiliariestraniere.
9. Sentita ciò, il comes Vittorecon5. " fieno r " (per ’f ’ l" ,, iBatavi
Sottoil Segnodell’Aquila -
Parte Quinta
480
schieratilivicinoinposizionediriserva, manongliriusciditrovarenessuno;quindi,ritiratosi, seneandò. AllostessomodosfirggironoalpericoloRicompreeSaturnino.
10.Mandandodagliocchilampidifurore, ibarbari inseguivanoinostri intorpiditiperche'ilcalore[del sangue]nellevenestavavenendomeno:alcunicadevanosenzasaperechiliavessecolpiti,altrischiacciati dalsolopesodichiliincalzava.altrisottoicolpideilorocompagni(noncisiritirava infattidifioriteachi spessotentava resistereenessunorisparmiava chisiritirava).
11.Inoltrelestradeeranoostruitedaimoltichevigiacevanomazomorti;assiemea questicoprivanoi campianchemoltimucchidicavalliuccisi. Interruppequestacatastrofe(cuimaisisarebbetrovatorimedio echetantocostòalloStatoromano!) lanottesenza luna.
12.Alprirnodistendersidelletenebre Iimperatore(eaquestovenivadatodipensare, nessunoafièrrnòin— fizttidiavervistooppurediesserestatopresente)caddefraisoldatisemplicicolpitoamorteda unafieccia; morisubitoenon vennetrovatodanessunaparte:poichéun ristrettonumerodinemicisiaggiròa lungoper queiluoghiperdepredareicadaveri.nessunfitggiascooabitantedellevicinanzeosòinfattirecarsili,
13.(Sappiamoche I imperatore [G,Messio Quinto Traiano]Decio combattendocon coragio contro i barbarimaridiuna mortesimile:buttatoaterrada!cavanscivolato—imbizzarrito.non ebbelaforzadirattenerlo— caddeinunapaludedacuinonglifupossibileuscireenonsipotétrovarlo).
14.AltridiconocheValentenon esalàl'anirnasua;assiemeacandidati[guardiedelcorpopersonali]eopachi eunuchifitportatoinunabaroccadicampagnailcuipùznosecondoerabmdifao:quimori,perche'curatoda maniinesperte.Circondatodanemicichenonsapevanochifosse,venneesentatodallavergognadellaprigionia.
15.I nemiciinseguitoritentaronosidisfondareleportesborrate,madallapartealtadellacasa venivano attaccaticon illanciodifrecce,pernonperderelapossibilità difarebottinoa causadiun indugio da cui sarebbestatoimpossibilevenireacapo.ammucchiaronopagliaelegnocuidetterofiancocosibruciando I 'edificioechivistavadentro,
16.Maunadeicandidatiriuscìafirgirecaldnosigiùattraversounafinestra;catturatodaibarbari, espose ciòcheera successoprovocando in lorograndeafilizione[perche'sivedevano]defiaudaridiuna gloria grande:non avercatturatovivoilcapodelloStatoromano!Questostessosoldatotornòpoidinascostofra inostrieraccontòcheifintisieranosvoltiinquestomodo...
18.FralemolteplicimortidimortidiuominiillustrisisegnalòquelladiTraianoediSebastiano;assieme aloromorironotrentacinquetribuni(senzaeconcomandomilitare). ValerianoedEquizia (addettoilprima alla cura dellestalle, ilsecondodelpalazzo). E anchePotenzio (tribunodeipromoti), checadenella sua primagiovinezza, ammiratodaognipersona dabbene,degnodistimaperimeritiproprieperquellidisuo padre Ursicino (un tempocomandanteditutteleforzearmate),

19.Sisa chesisalvòsoloun terzodell'esercito:nellastoriascrittonon sileggedinessuna disfatta cosi totaleaeccezionediquelladiCanne[216 a.C.]…‘““
LafanteriaaddestrataedequipaggiavaperdutaadAdrianopolinonpotettepiùessererimpiazzata:ilnuovo imperatore Teodosio, privo di sue forze militari adeguatefi:costrettoa impiegare quelle dei Goti, concedendolorolafacoltàdiinsediarsinell’Impero,nelleprovincedanubiane.Alla suamortenel 395 il lorornr)» vimentoversoovest ripreseenonvieranotmppesulficientiperfermarli.Stilicone,suogenerale,perqualche temporiuscìafrenarli,malasuareputazionecollassòinsiemeallefiondererenaneallafinedel406, sottola pressione degliAlemanniedeiFranchichedilagarrrnofinoallaGalliaedallaSpagna.
E’possibile, siapure con una certa approssimazione,tracciare le fasi del declino edella scomparsa del l’esercitoromanod’Occidente. SmndoaglielenchitrattidallaNotitiaDignitatim,cheforsevenneroaggiornatifinoalterminedellasovranitàdiOnorionel423,agliinizidel400,comeinprecedenzadelineatoindettaglio. l’e'ntità delle forze appare ancora imponente. In pratica, nell’esercito di stanza in Italia si 482
Sotto il Segnodell’Aquila - Parte Quinto
Sotto il Segnodell’Aquila - Parte Quinta
contanoz“quararitaquattroreggimenti e in quello della Gallia cinquantotto; gruppi minori del comitatus, inoltre,sonostazionatialcomandodelcomitesneil'Il/frico,inSpagna,inAfrica einBritannia.Insiemefirr» mano un totaledi circa 110.000 uomini… Ma idati chesitrovanosulla carta sono. alle volte, ingannevoli. L'esercitodistanzainAfrica e compostoquasiesclusivamentedilimitanei,promossiacomitatenses,eanche neglialtriesercitimoltedelleunitàsoriocompostedilimitanei.in Galliaalmenoventiseidellecinquantotta unità. Laproporzione dei limitaneisembroolla/ra le ouppedispostelungoI'altocorsodelDanubio (117 unita‘)einBritannia (46);altrove, inAfiica, GalliaeSpagna.troviamoriportatisoltantocinquantadueunità in tutto. ventidellequalidevonoesserestatecancellate, essendopassatealcomitatus.Iltotalegeneraledei limitaneiè,inteoria, dicirca 130.000 uomini;macisichiedeinqualmisuraessoesistevasoluzntosullacarta, L'esercito distanza inBritannia smisedifizrpartedelleforzedel!impero… durante l'ultimaparte del regnodi Valentiniano Il];quellodellÀfi‘icaprobabilmentesidispersequandoi vandalisiimpossessarono ditutta laregione, allamortedi Valentinianonel455; inSpagnaI ‘esercitacessòdie.ertare,sipensa, quando irevisigoticonquistaronolapenisola iberica,allamortediMaggiorano,nel457. L ’eserct'todella Galliasi disintegrànonmoltodopo;sembratuttaviaavercontinuatoadesisterenellaBelgica,finche'Clodoveosconfisseeucciseilsuoultimocomandante, Siagrio.nel 486. L ‘esercitodellaItalia, cheera tuttoquantorimanevaagliordinidegliultimiimperatoridel!Occidente,sembraessersiopacoapocoristrettapermancanza difinanziamentiedireclute.Neglieventicheportaronoallafinedel]'imperoinOccidente,nonsentiamoparlaredialtretruppeinItaliachenonfosserofedera
Nel410iVisigotiavevanoinvasol’ItaliaeperlaprimavoltasaccheggiatoRoma:lemuraAurelianenonerano stateingradodioattenerli.Altrosaccheggionel455operatodaiVandaliefinalmentenel476l‘ultimoimperatored’0ccidente,dalfatidiconomediRomoloAugustolo,fudepostoemandatoinesilioaNapoli,sull’isolotto diMegaride…Pochiannidopoanchegliultimirestidelgrandeesercitoromanoscomparverodefinitivamente.
Abbiamoalcunibrani checi tramandano leultimeunihàmilitari,nei loroultimi giorni di esistenza,prima delladissoluzioneirreversibile.SappiamocosichelaCohors[XBatavorum, diguarnigioneaPassau,mandò alcuni suoimilitiaritiraregli stipendiarretrati dell‘interaunità.Di loronon seneseppepiù nulla, finché il fiumenonnerestituì icadaveri.SappiamopurechequandoilmalconciofortediAbinneofiJevacuato,isuoi ultimi difensorialmomentodiallontanarsinechiuserolaportaachiave,disperdendwipoi fi'alapopolazione civile.Piùmesta ancoralafinediun‘altraunitàdiBatavi,forsel’ultimadistanzanel fortediFavianesulDanubio, intornoal 470—480, checivienerievocata daEugipponellaVitadiSanSeverino:
“Peridemtempus,quoRomanum constabatimperium.multorum militesoppidorumprocustodialimitis publicis stipendiis alebantur. Qua consuetudine desinente simul militares tunnae sunt deletae cum limite, Batavautcurnquenumeroperdurante. Ex quoper-rexerant quidamadItaliam exti'emum stipendium commilitonibusallattui,quosin itinereperemptosabarbarisnullus agnoverat.
Quando]imperoromanoeraancorainvita, isoldatieranomantenuticondanaropubblicoinmoltecittàper ladifesadeiconfini,maconlafinediquelsistemoleunitàmilitarifixronoeliminateinunsoltempocoiconfini?“
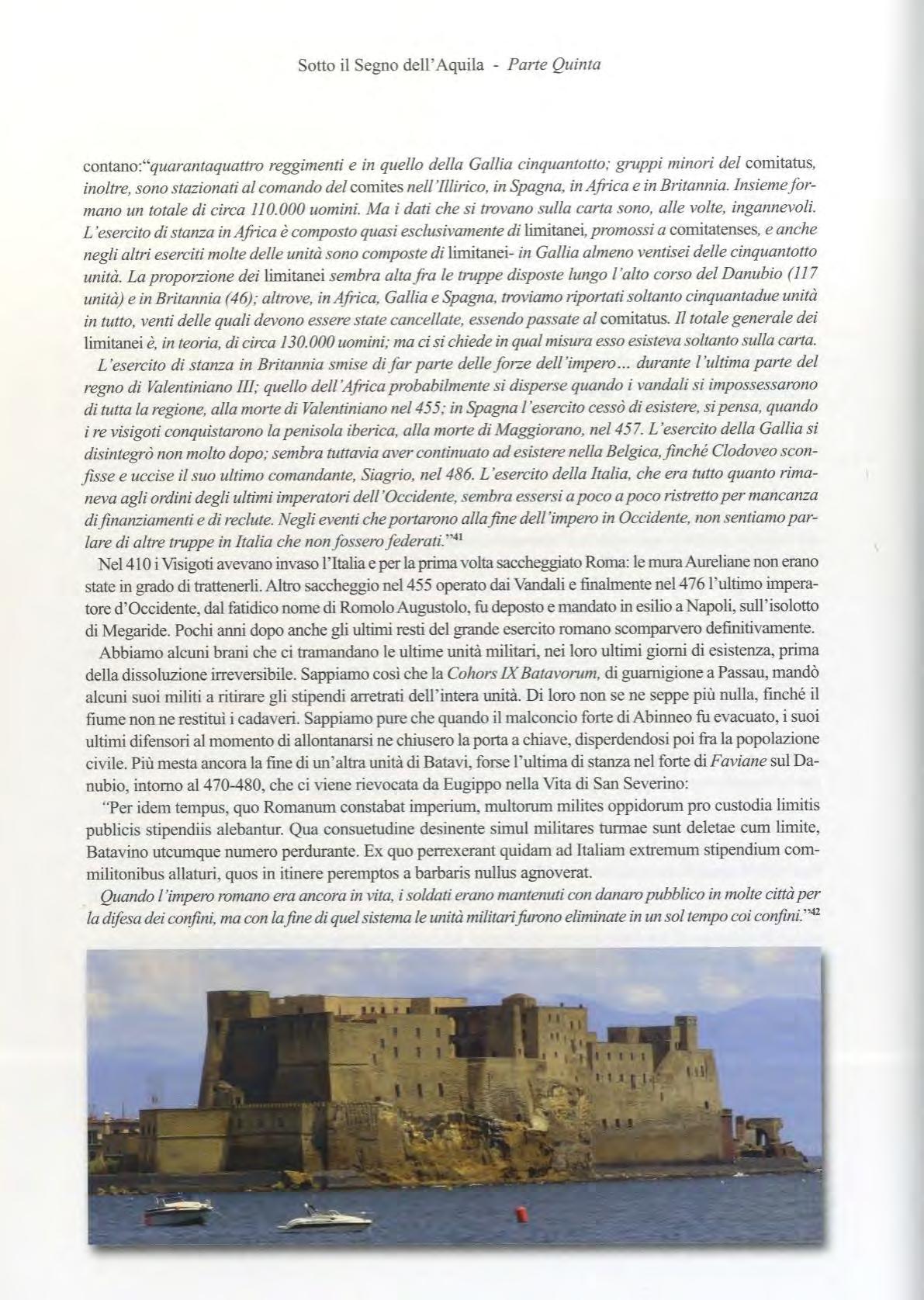
'."“
Note
1-Da MARCOAURELIOANTONINO, Ricordi,lib.I, 16,trad. E.Turolla, Milano 1980, p. 15,
2 -DaE.N.LI]l 1WAK,Lagrandestrategiadel!imperoromano,dallallllsecolod.C.,Milano 1981,p. 177.
3-Da M. MAZZA,Lottesocialierestaurazioneautoritarianel[Ilsecolod.C.,Bari 1973,pp.232-233.
4 - Da E. GIBBON, Storiadelladecadenza ecadutadell’Imperoromano, trad. G.Frizzi,Torino 1967, vol.I,pp.77-78.
5-Da E.GIBBON, Storiadelladecadenza…cit.,p. 117.
6 - Cfr.Y. LE BOHEC,L’esercitoromano, Urbino 2001,p.256.
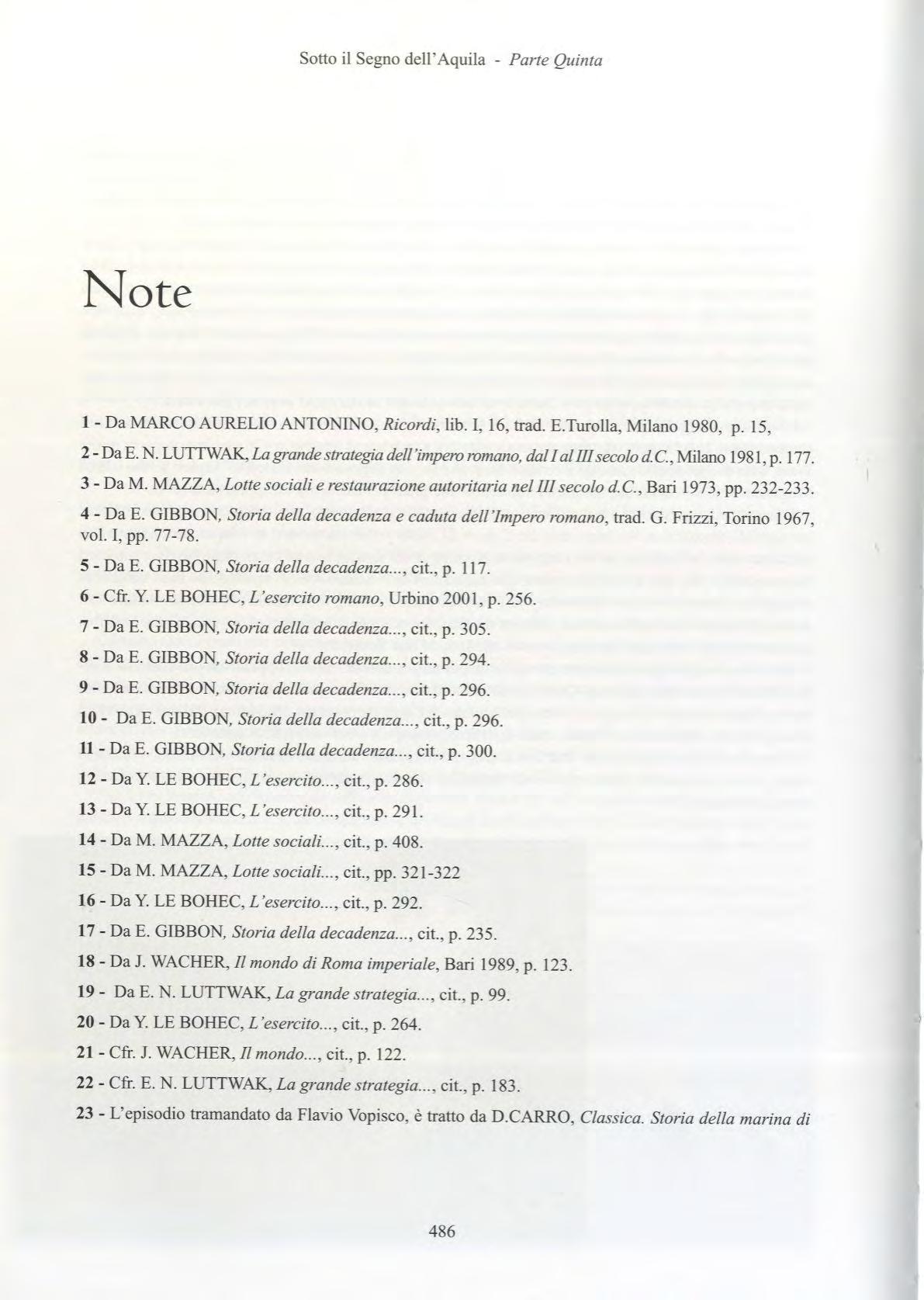
7 - Da E… GIBBON, Storiadelladecadenza....cit.,p.305.
8 - Da E.GIBBON, Storiadella decadenza…cit.,p. 294,
9-Da E. GIBBON, Storiadella decadenza…cit.,p. 296…
10 — Da E. GIBBON, Storiadella decadenza...,cit.,p… 296.
11 - Da E… GIBBON, Storiadelladecadenza.…cit.,p. 300.
12— Da Y.LE BOHEC, L 'esercito...,cit.,p. 286.
13-DaY.LEBOHEC,L’esercito...,cit.,p.291.
14- Da M. MAZZA,Lottesociali…cit.,p.408.
15-DaM.MAZZA,Lottesociali.…cit.,pp. 321-322
16 - DaY. LE BOHEC,L’esercito...,cit.,p.292,
17 - Da E.GIBBON, Storiadelladecadenza.…cit.,p. 235.
18- Da J. WACHER,IlmondodiRoma imperiale,Bari 1989,p. 123.
19- Da E.N. LUTTWAK,Lagrandestrategia…cit.,p. 99.
20-DaY.LEBOHEC,L’esercito...,cit.,p.264.
21-Cfr.J.WACHER,Ilmondo..., cit.,p. 122.
22 - Cfr.E.N… LU'1TWAK,Lagrandestrategia…cit.,p. 183.
23 - L’episodio tramandato da Flavio Vopisco, è tratto da D.CARRO, Classica. Storiadella marina di 486
Sottoil Segnodell'Aquila - Parte Quinta
Roma.Testirnonianzedall'antichità,secondaedizione,supplementoallaRivistaMarittiman° 12,Roma 2000, Vol. X, p. 25…
24 - Da E.N. LUTTWAK,Lagrandestrategia…cit.,p. 223.
25 — Da E.GIBBON, Storiadelladecadenza.…cit.,p. 273.
26 - Cfr. C.BLAIR,Enciclopedia ragionata dellearmi,Verona 1979,p.235allavoceparazonio.
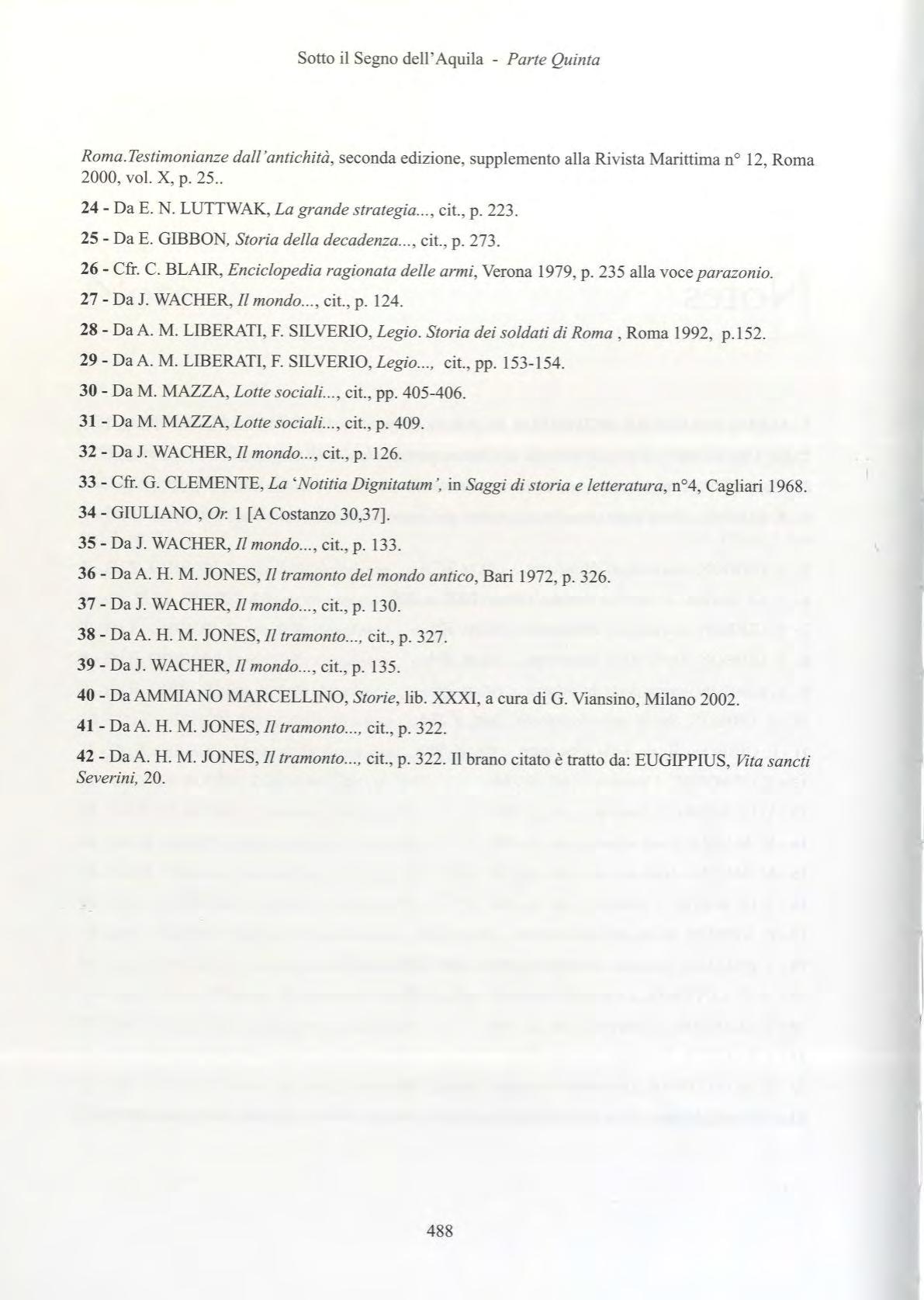
27 — Da J.WACHER,[[mondo..., cit.,p. 124.
28-DaA. M. LIBERATI,F. SILVERIO,Legio.StoriadeisoldatidiRoma , Roma 1992, p.152.
29 DaA.M.LIBERATI,F. SILVERIO,Legio..., cit.,pp. 153—154.
30 Da M.MAZZA,Lottesocia/i...,cit.,pp. 405-406…
31 — Da M. MAZZA,Lottesociali…cit.,p.409.
32 — Da J.WAC1-IER,Ilmondo..., cit.,p. 126.
33 — Cfr. G. CLEMENTE,La ‘NotitiaDignitatum ', inSaggidistoriaeletteratura,n°4, Cagliari 1968.
34 — GIULIANO, On 1[ACostanzo30,37].
35-Da ].WACHER,Ilmondo…, cit.,p. 133.
36-DaA.H,M.JONES,Iltramontodelmondo antico,Bari 1972,p. 326.
37 - Da J…WACHER,Ilmondo..., cit.,p. 130.
38 - DaA. H. M.JONES,Iltramonto.… cit.,p. 327…
39 - Da].WACHER,!!mondo..., cit.,p. 135…
40-DaAMMIANO MARCELLINO,Storie,lib.XXXI, acuradi G.Wansino, Milano 2002.
41 - DaA. H. M.JONES,Iltramonto.... cit.,p. 322…
42 - DaA. H. M. JONES,Iltramonto.… cit.,p. 322.Il branocitatoètrattoda:EUGII’PIUS, Vita sancti Severini,20.
Sotto il Segnodell’Aquila - Parte Quinta
488
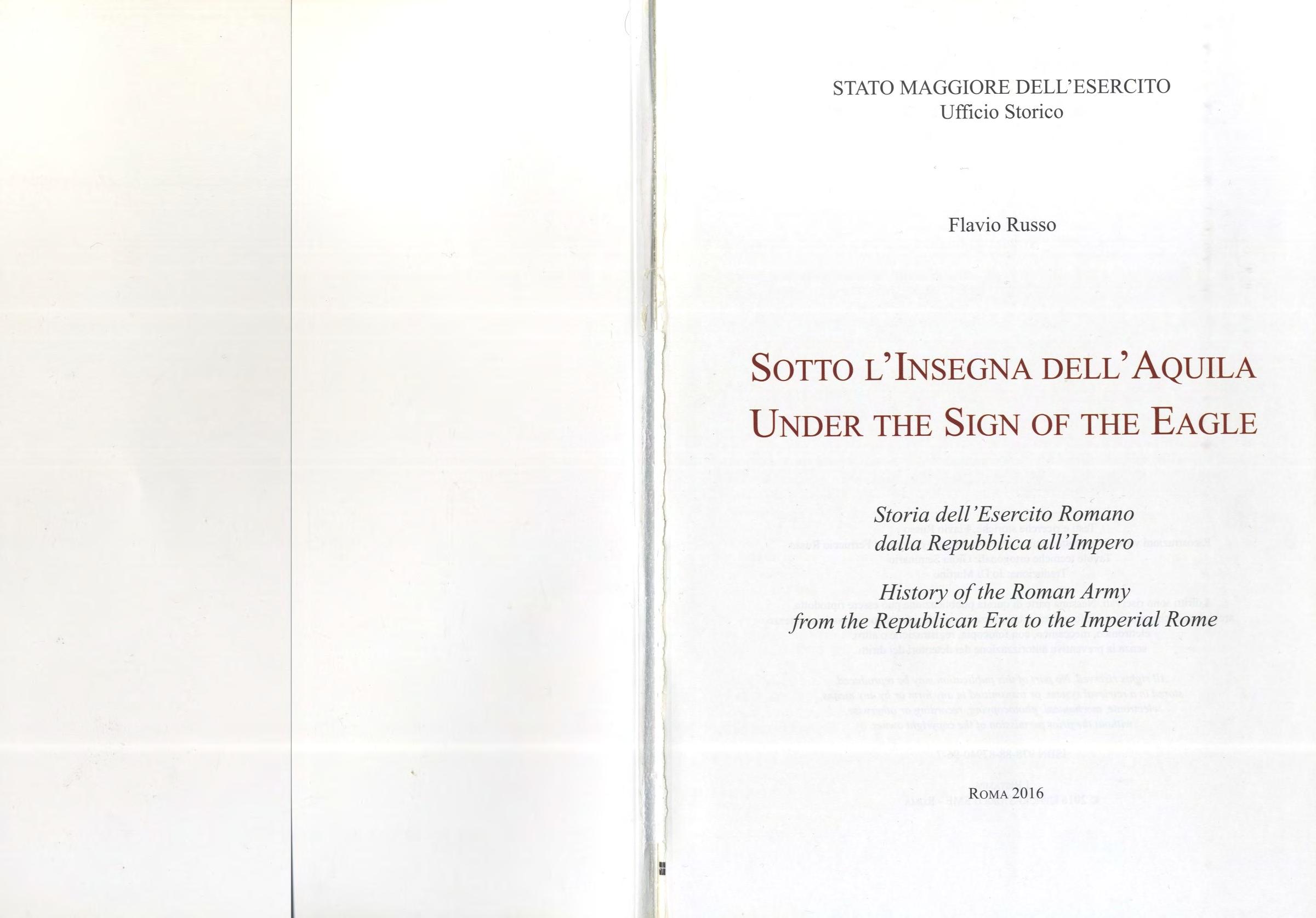
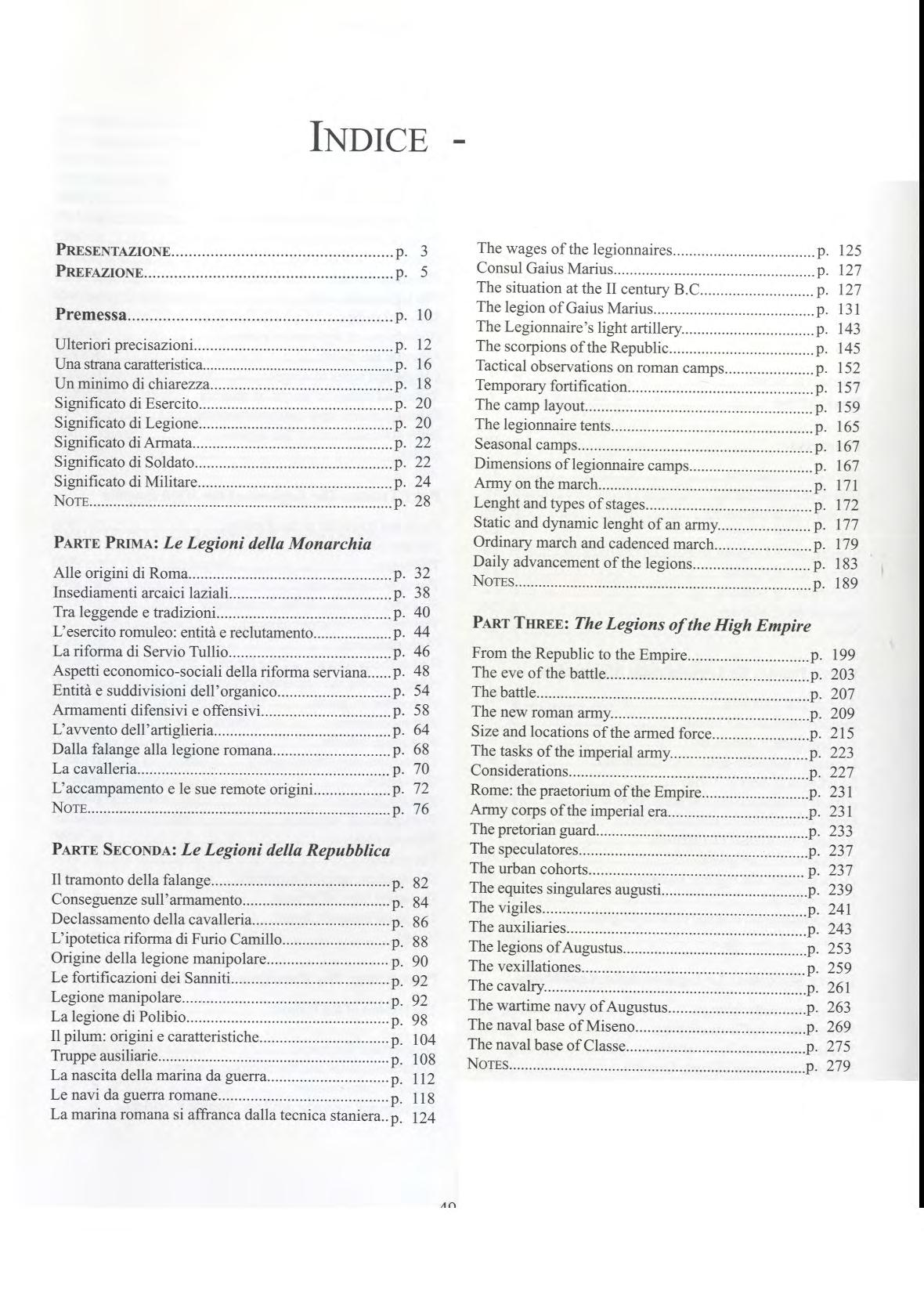
INDICEPRESENTAZIONE 3 PREFAZIOBE... . 5 Premessa... p 10 Ulteriori precisazio p. 12 Unastranacaratteristica p. 16 Un minimodi chiarezza p. 18 SignificatodiEsercito p. 20 SignificatodiLegione p. 20 SignificatodiArmata. p. 22 Significatodi Soldato. p. 22 SignificatodiMilitare p. 24 NOTE... p. 28 PARTE PRIMA: LeLegionidellaMonarchia Alleoriginidi Roma.. p. 32 Insediamenti arcaici lazial' p. 38 Traleggendeetradizion' p. 40 L'esercitoromuleo:entitàereclutamento p. 44 Lariformadi ServioTullio… p. 46 Aspetti economico—socialidellariforma serviana p. 48 Entità esuddivisionidell‘organico. p. 54 Armamenti difensivi e offensiv' p. 58 L’avventodell’artiglieria p. 64 Dalla falangealla legioneroman p. 68 La cavalleria. p. 70 L'accampamentoe le sueremoteorigini p. 72 NOTE... p. 76 PARTE SECONDA:LeLegionidellaRepubblica Il tramontodella falange... 82 Conseguenzesull’amtamento 84 Declassarnentodellacavalleria. 85 L‘ipoteticariformadiFurioCamillo 88 Origine della legionemanipolare 90 92 Lefortificazionidei Sannit' La legionedi Polibio Truppeausiliarie... La nascita dellamanna da guerra 112 Lenavi daguerraromane..... 118 Lamarinaromana siaFfrancadallatecnica staniera… 124 Thewagesofthe legionnaires. p. 125 ConsulGaiusMarius p. 127 The situation atthe II century B.C. p. 127 ThelegionofGaiusMarius… p. 131 TheLegionnaire’slightartillery p… 143 TheScorpionsoftheRepublic.. p. 145 Tacticalobservations onroman camp p. 152 Temporaryfortificatio p. 157 The camp layout… p. 159 Thelegionnairetent p. 165 Seasonalcamps.… p. 167 Dimensionsoflegionnairecamps. p. 167 Armyonthematch….. p. 171 Lenghtandtypesofstages. p. 172 Staticanddynamic lenght ofanarmy p. 177 Ordinarymatch andcadencedmarch. P. 179 Daily advancementofthe legions p. 183 NOTES… p. 189 PARTTHREE: TheLegionsoftheHighEmpire FromtheRepublictotheEmpire.... ..... P« 199 Theeve ofthebattle p. 203 Thebattle... . 207 Thenewroman arm . 209 Sizeandlocationsofthearmedforo . 215 Thetasksofthe imperia]arm 223 p. 227 Rome:thepraetoriumoftheEmpire. . 231 Army corpsoftheimperialem… 231 Thepretorian guard . 233 Thespeculatores . 237 Theurban cohorts. 237 Theequitessingularesangusti 239 Thevigiles.. 243 ThelegionsofAugustus 253 Thevexillationes... Thecavalry Thewanimenavy ofAugustu 263 Thenavalbase ofMiseno 269 ThenavalbaseofClass 275 NOTES... 279
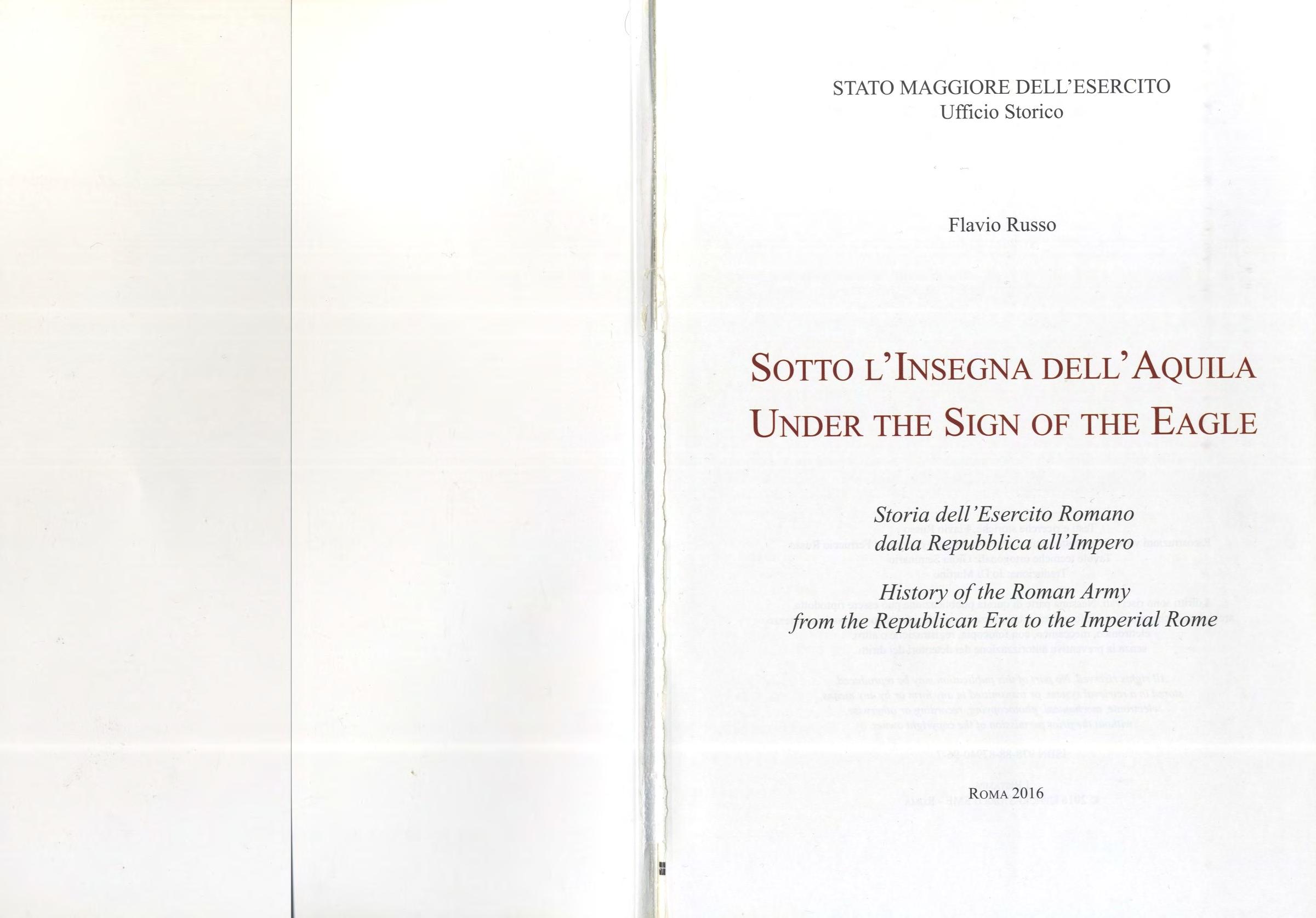
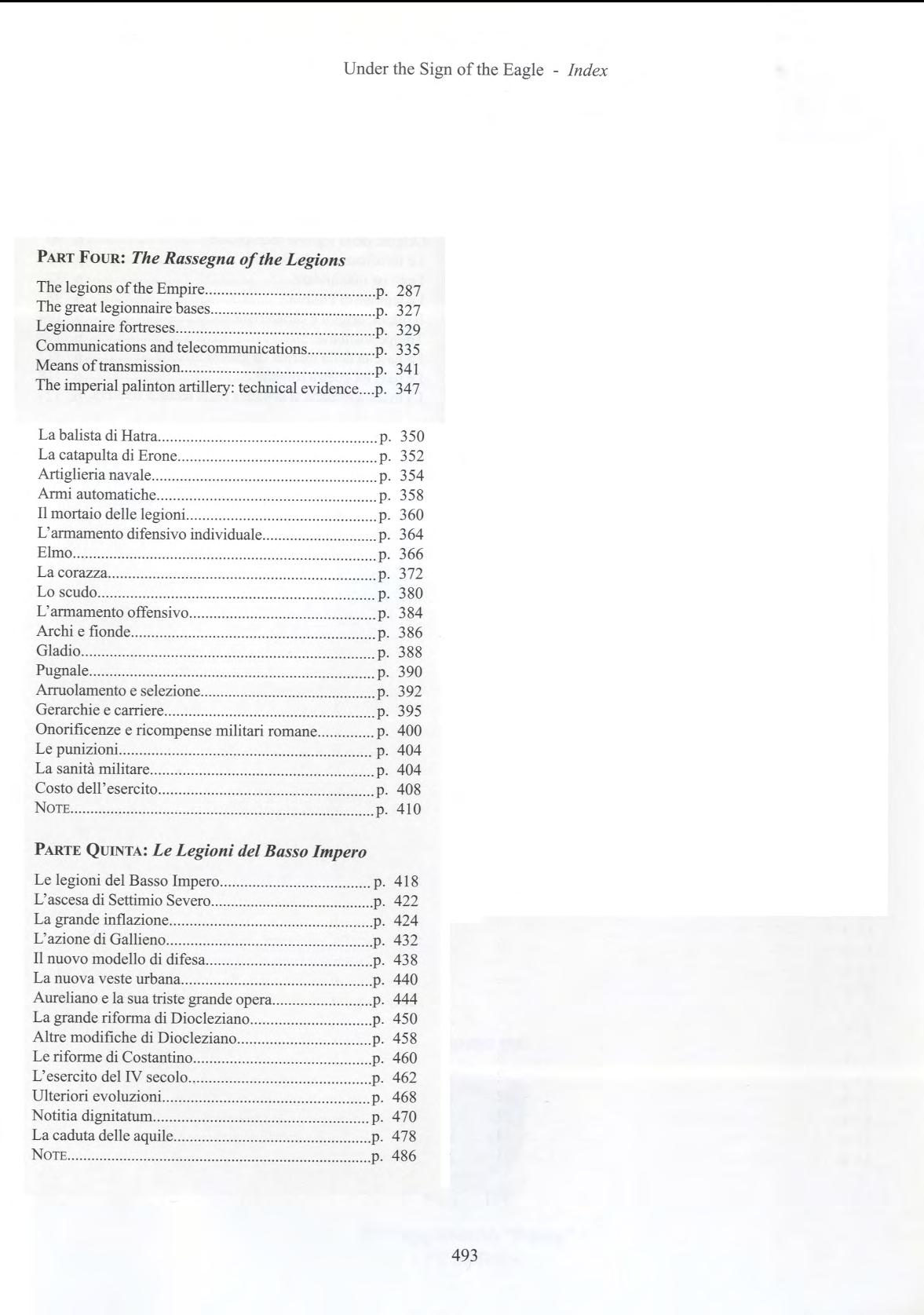
Under the Sign oftheEagle - Index PARTFOUR: TheRassegna oftheLegions ThelegionsoftheEmpire 287 Thegreatlegionriairebases. 327 Legionnairefomeses… 329 Communicationsandtelecomrnunications. 335 Meansoftransmission… 341 Theimperialpalintonamllery technical evidenc 347 LabalistadiHatra... P» 350 LacatapultadiEron P- 352 Artiglierianavale. P- 354 Armi automatiche... P- 358 Ilmortaiodellelegioni P— 360 L’armamentodifensivoind dual P- 354 Elmo... p. 366 Lacorazza. p. 372 Lo scudo.... p. 380 L’armamentooffensiv p. 384 p. 386 p. 388 p. 390 p. 392 Gerarchieecarriere ..... . 395 Onorificenze::ricompensem 'tariroman 400 Le punizioni.. 404 La sanitàmilitar Costodell’esercito NOTE… p. 408 410 PARTE QUINTA:LeLegionidelBassa Impero Le legionidelBassoImper L’ascesadiSettimioSevero Lagrande inflazione L’azionediGallieno. Ilnuovomodellodi difesa Lanuova vesteurbana. Aurelianoelasuatristegrandeopera LagranderiformadiDiocleziano. Alt-remodifichedi Diocleziano. LeriformediCostantino. L’esercitodelIVsecol Ulteriori evoluzioni.. '.470 Notitia dignitatum. Lacadutadelleaquile 478 NOT 486 493

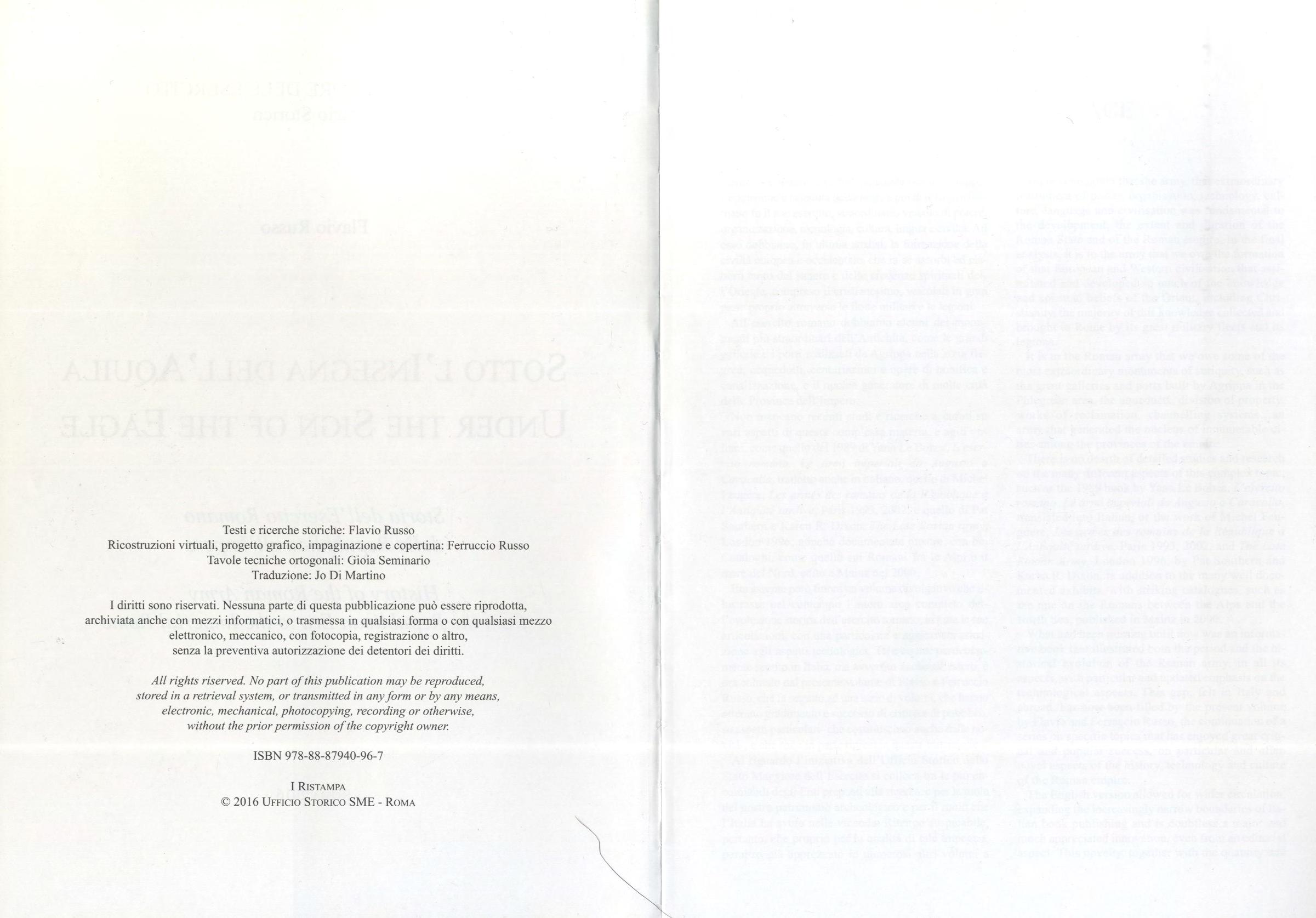
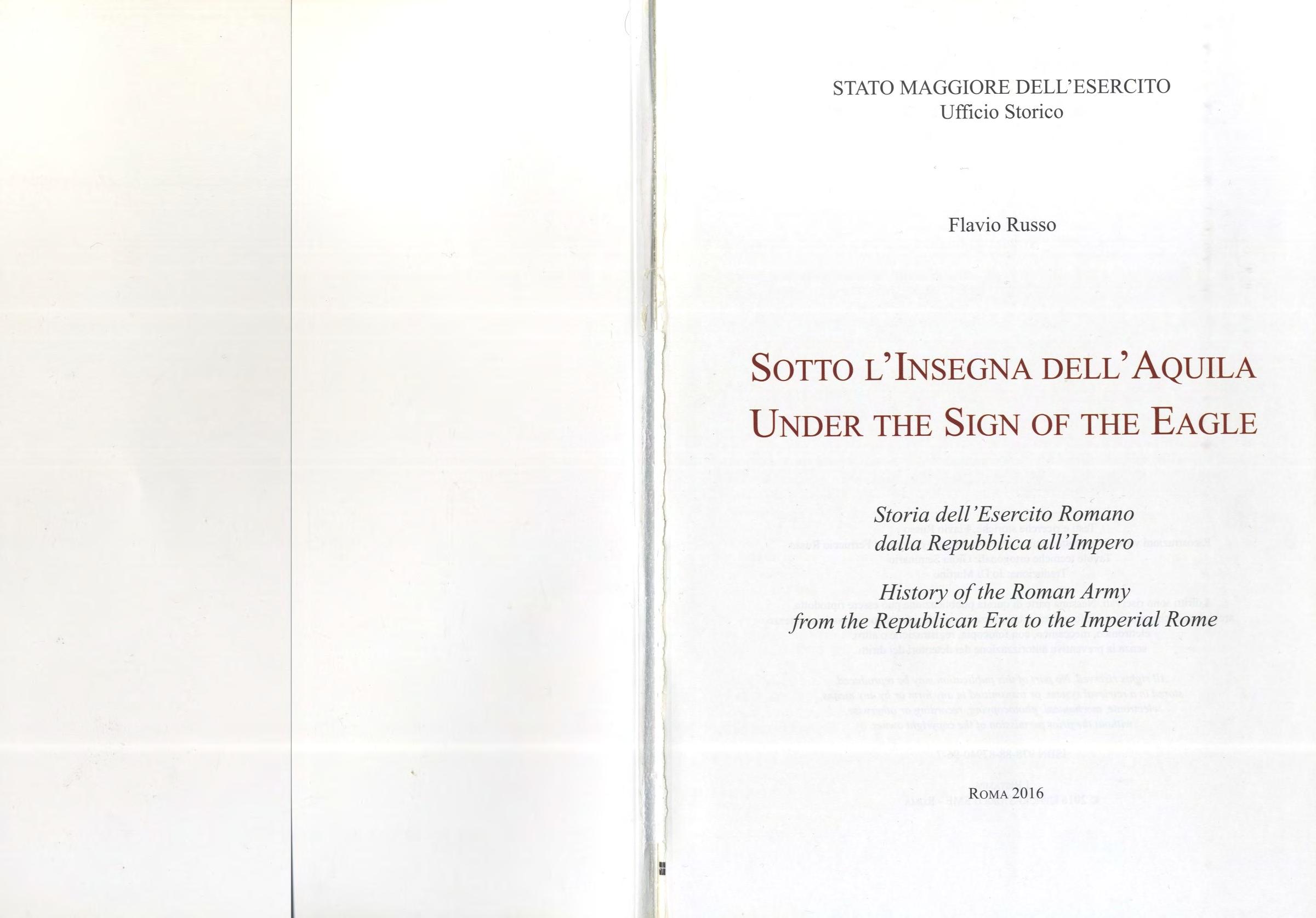

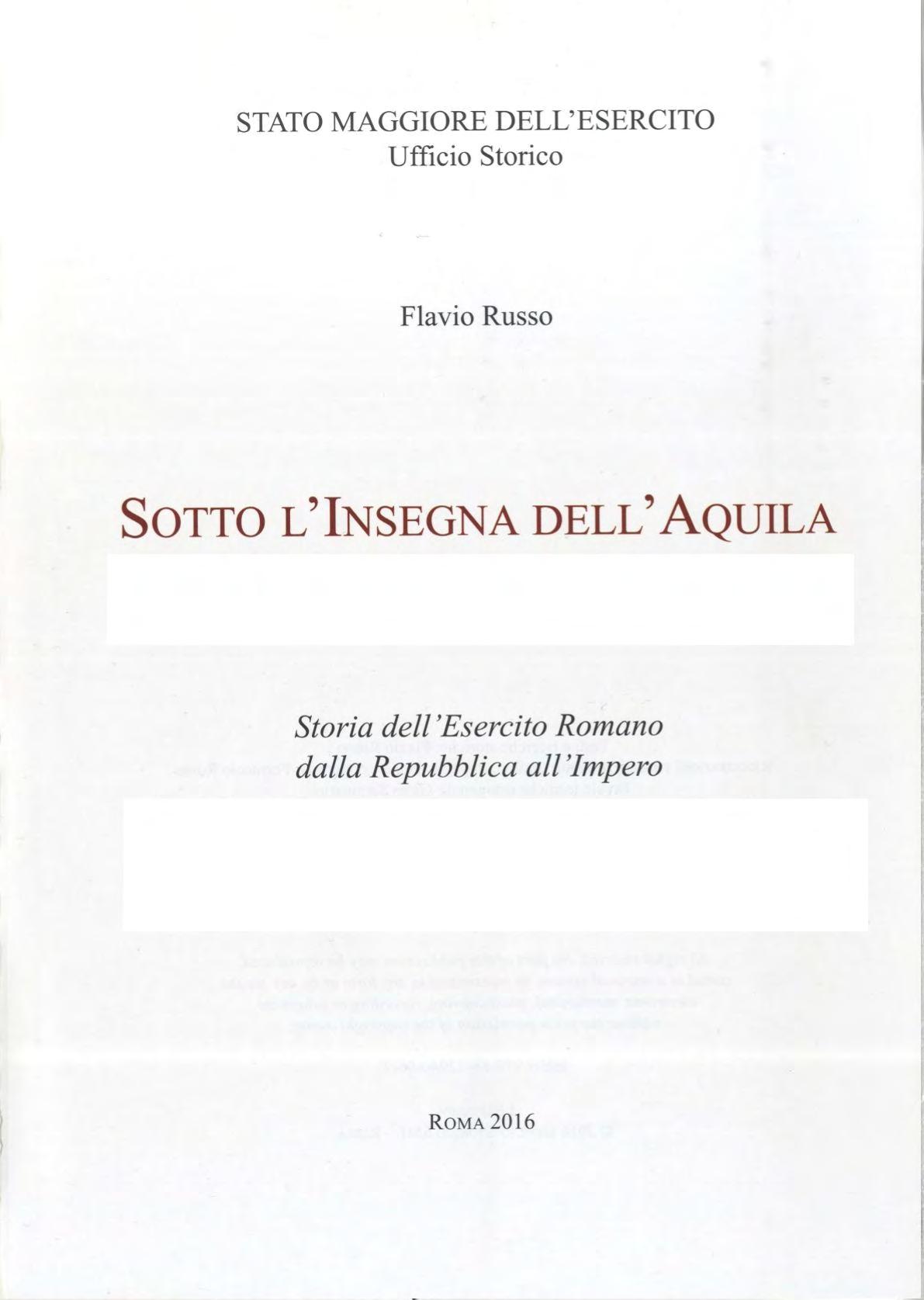
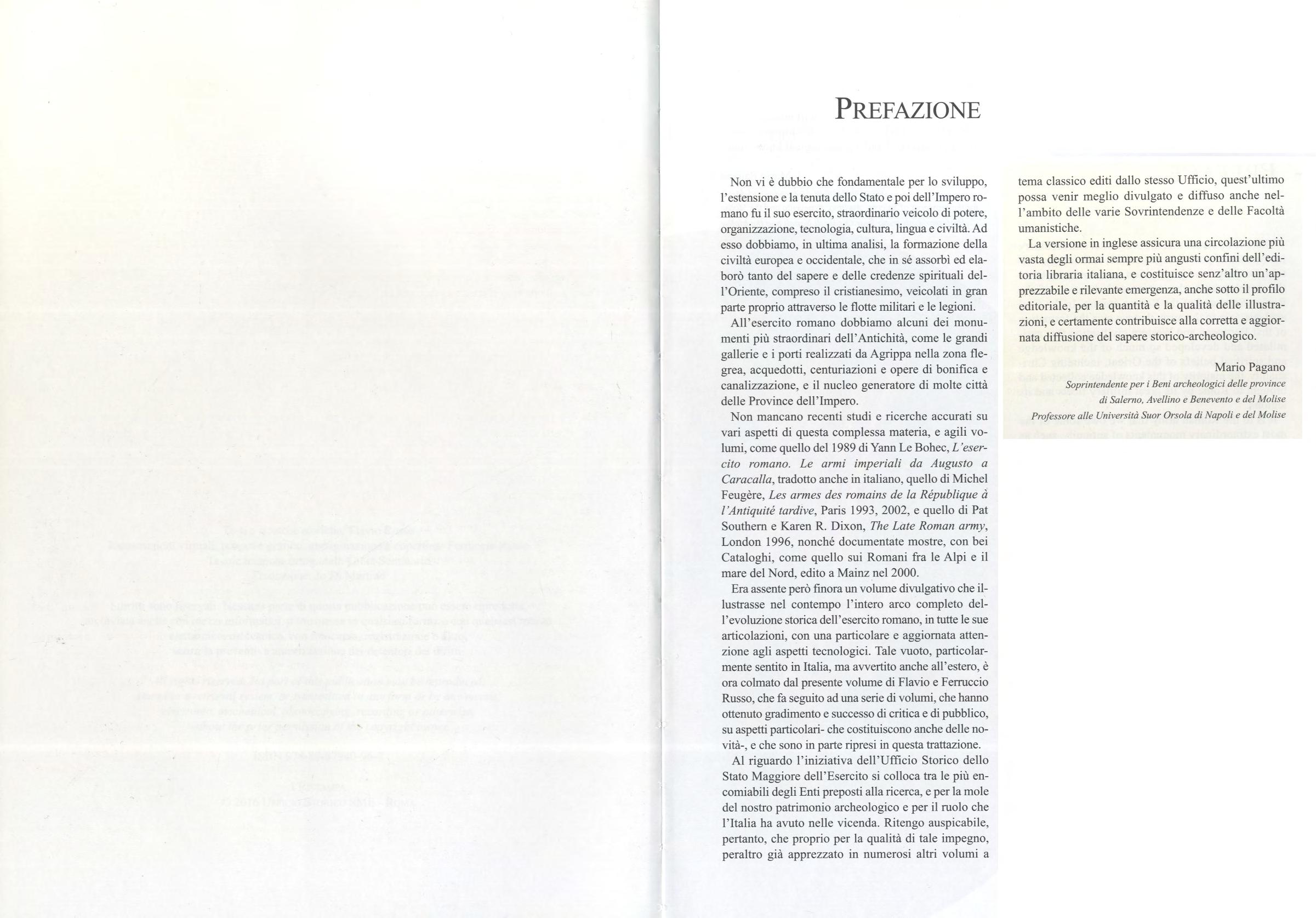
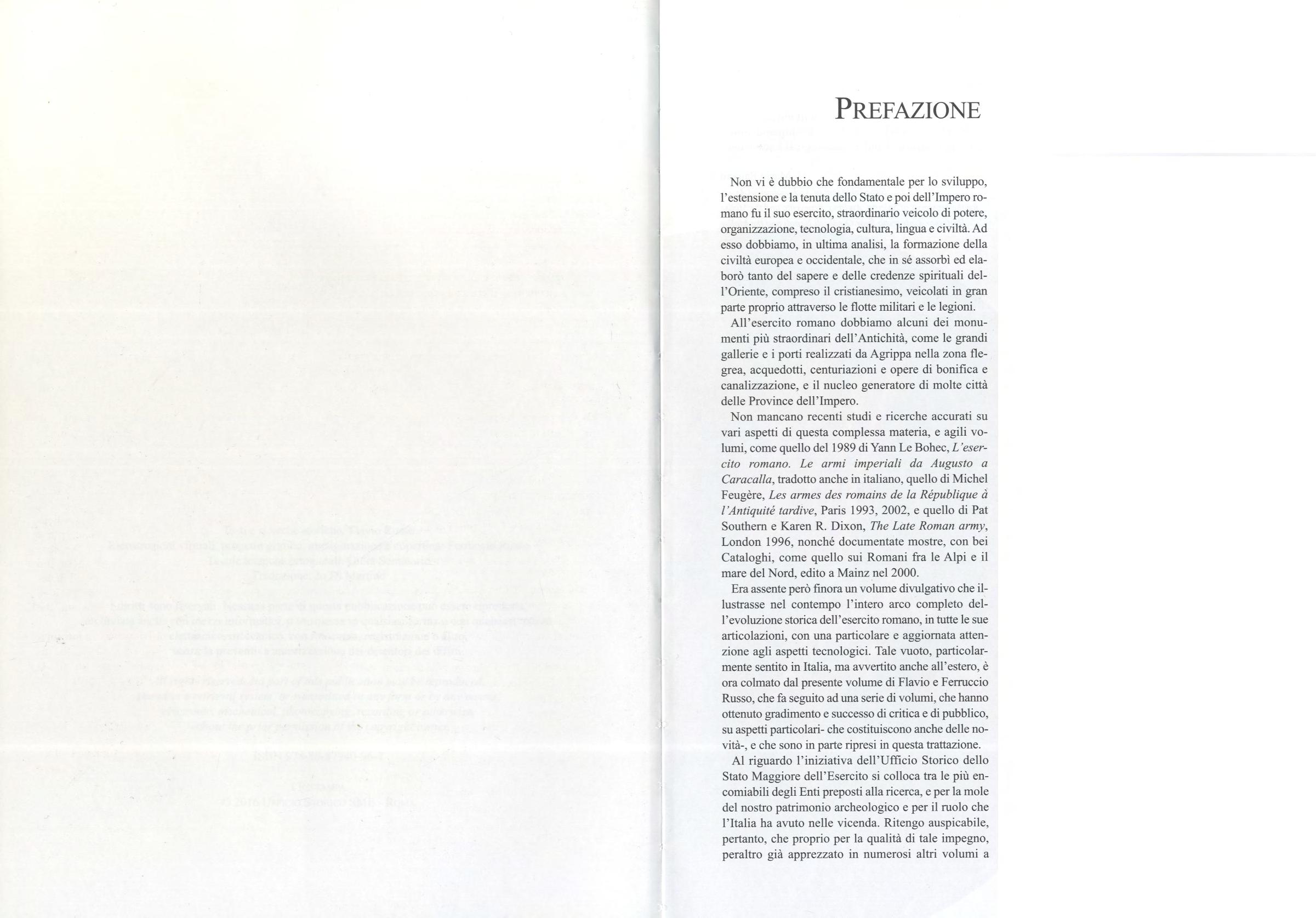

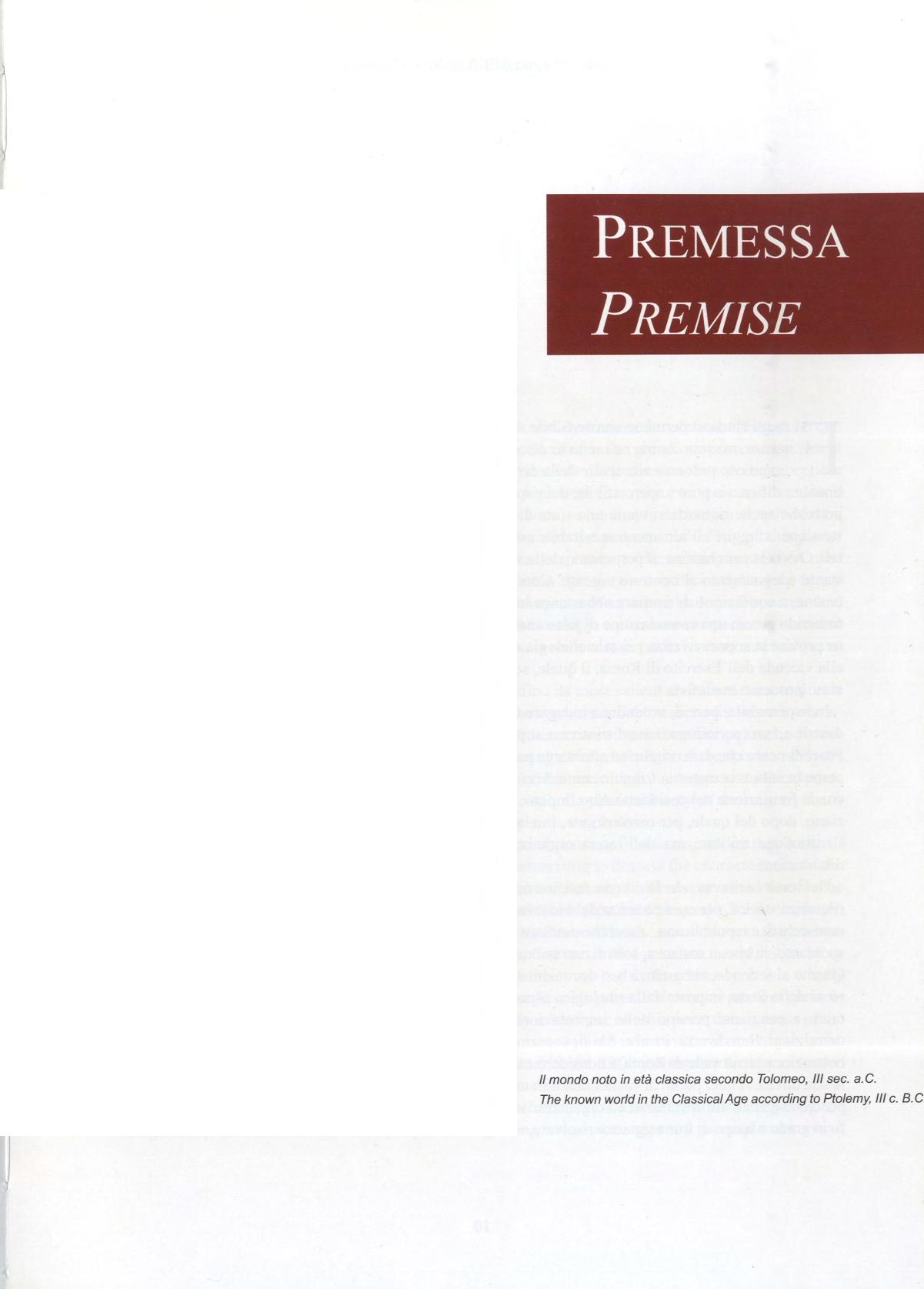

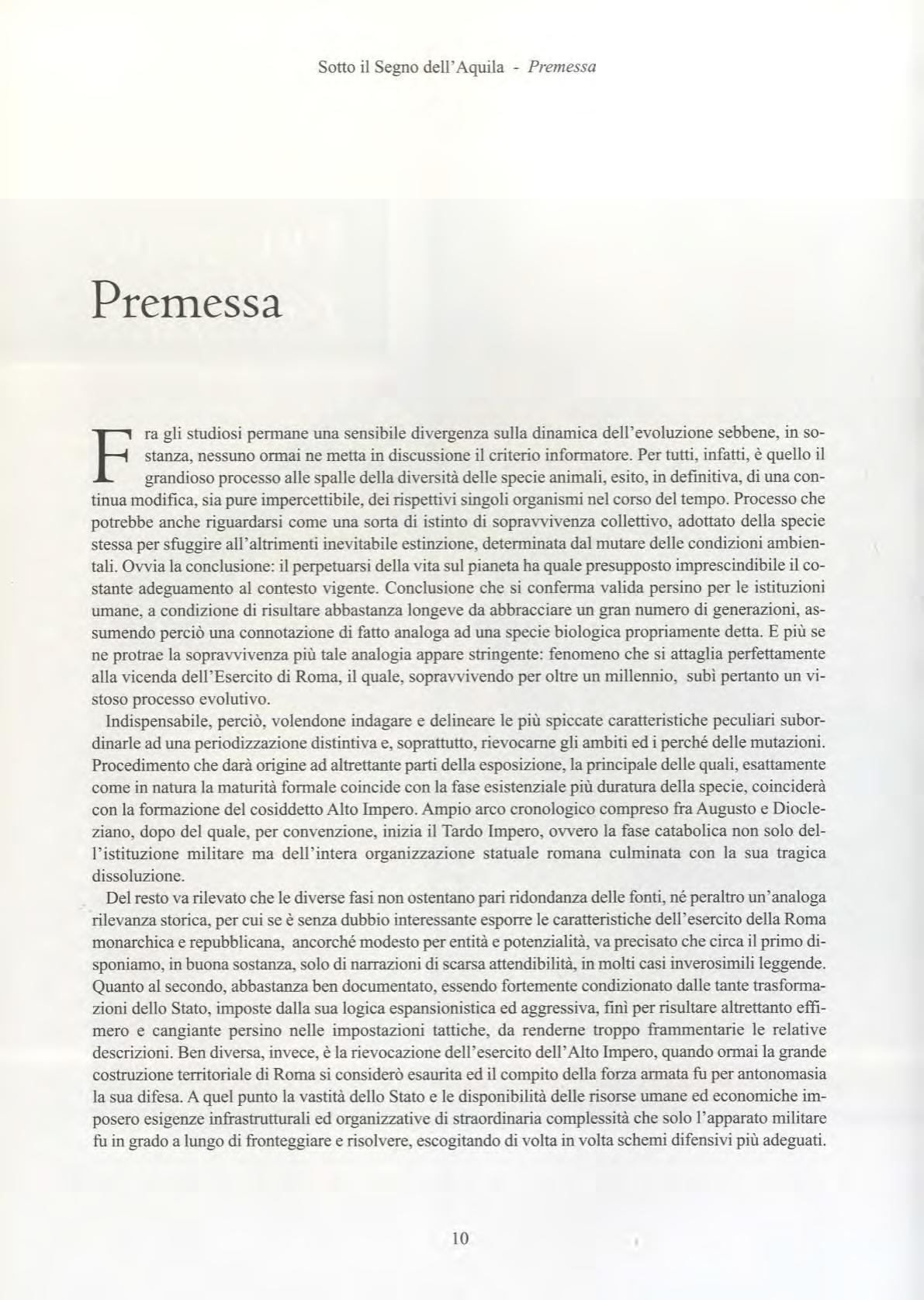
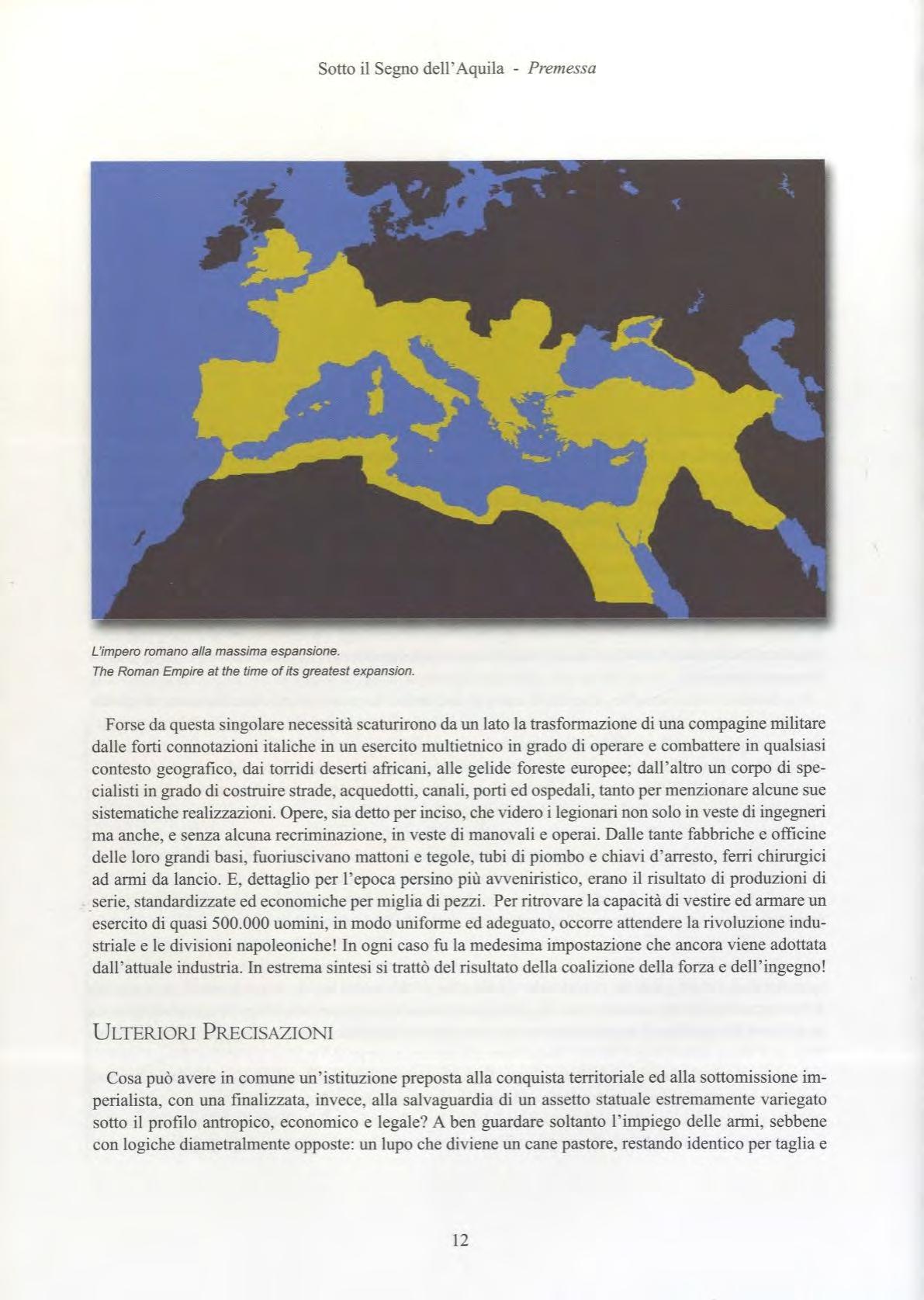
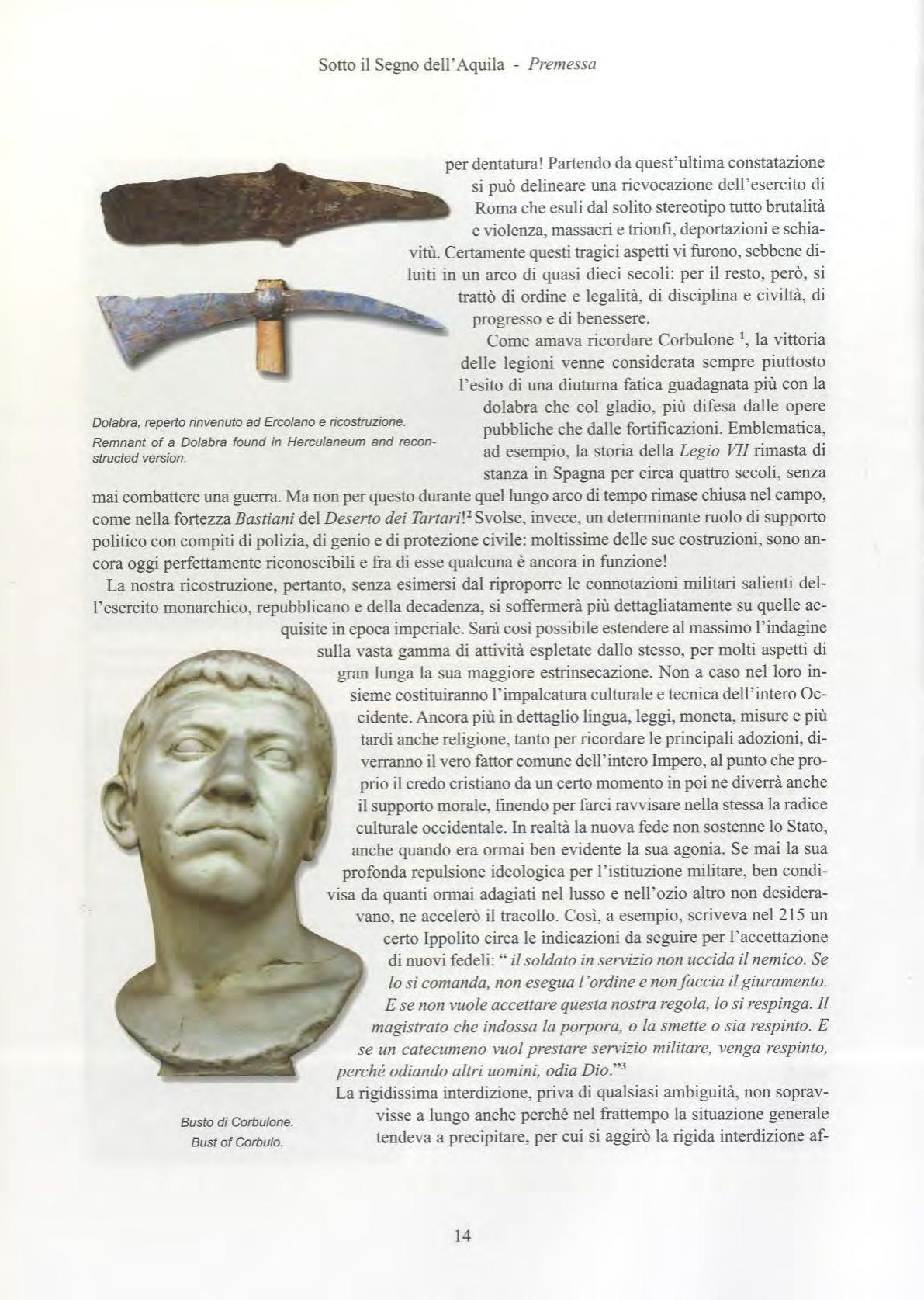

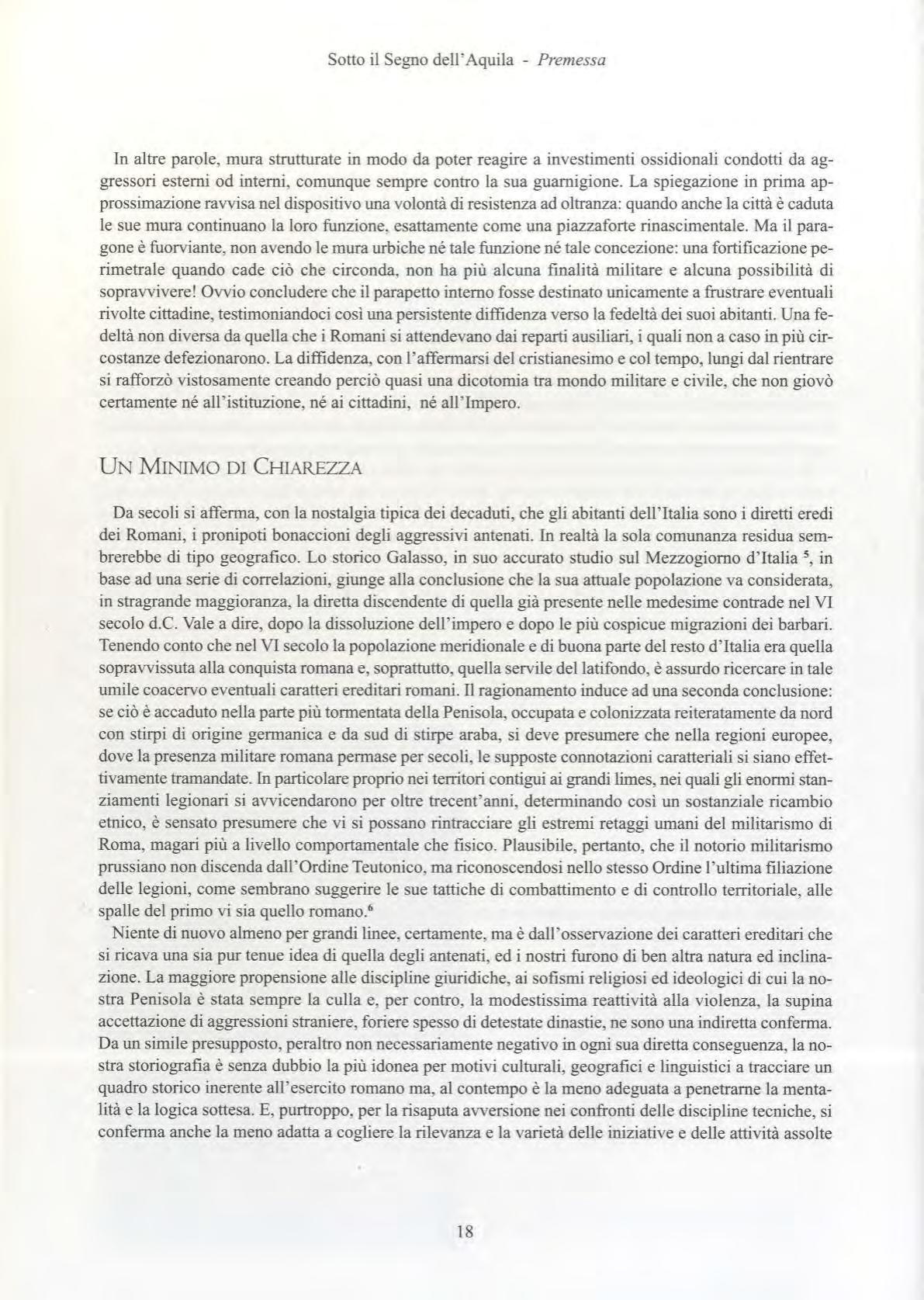
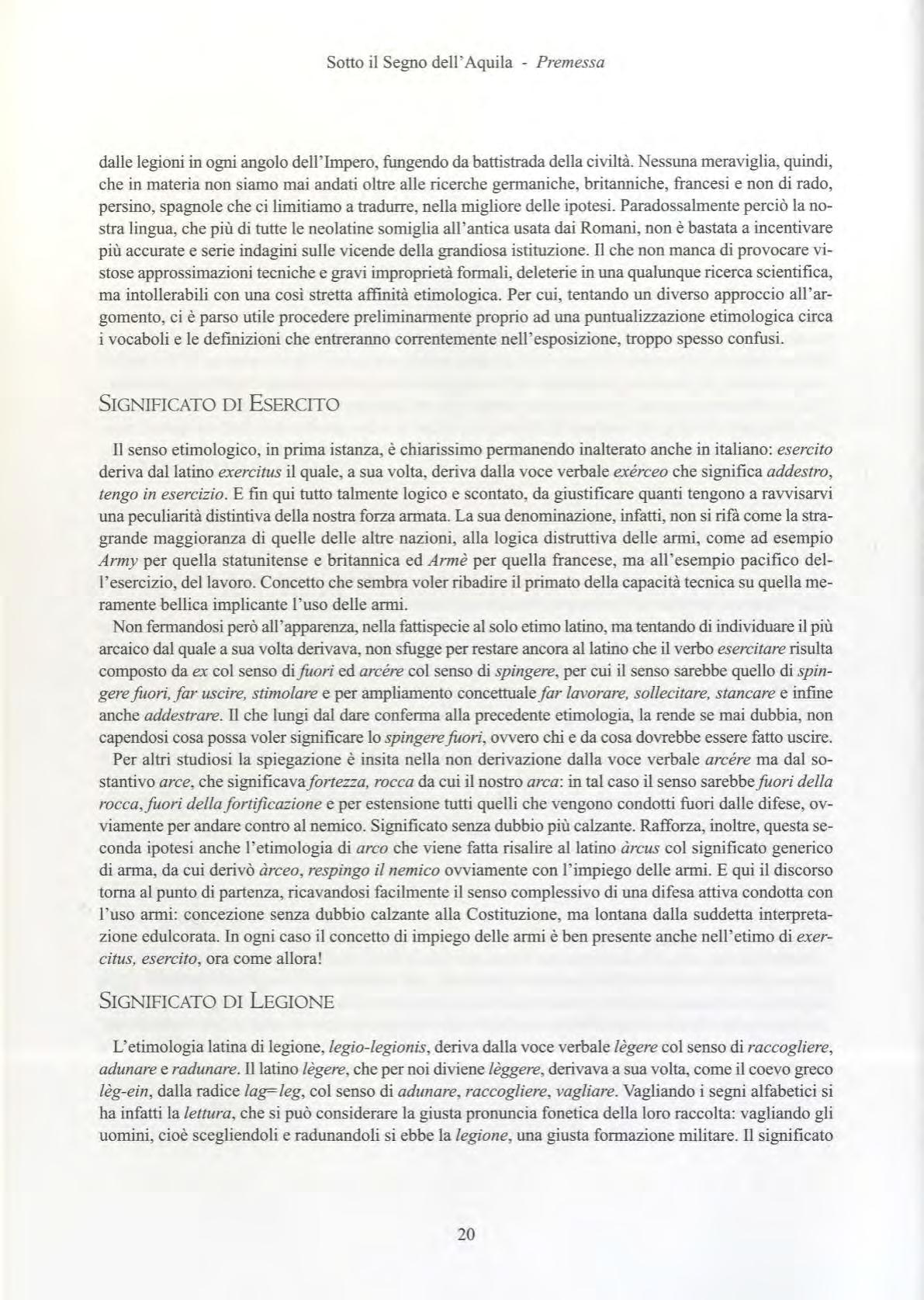
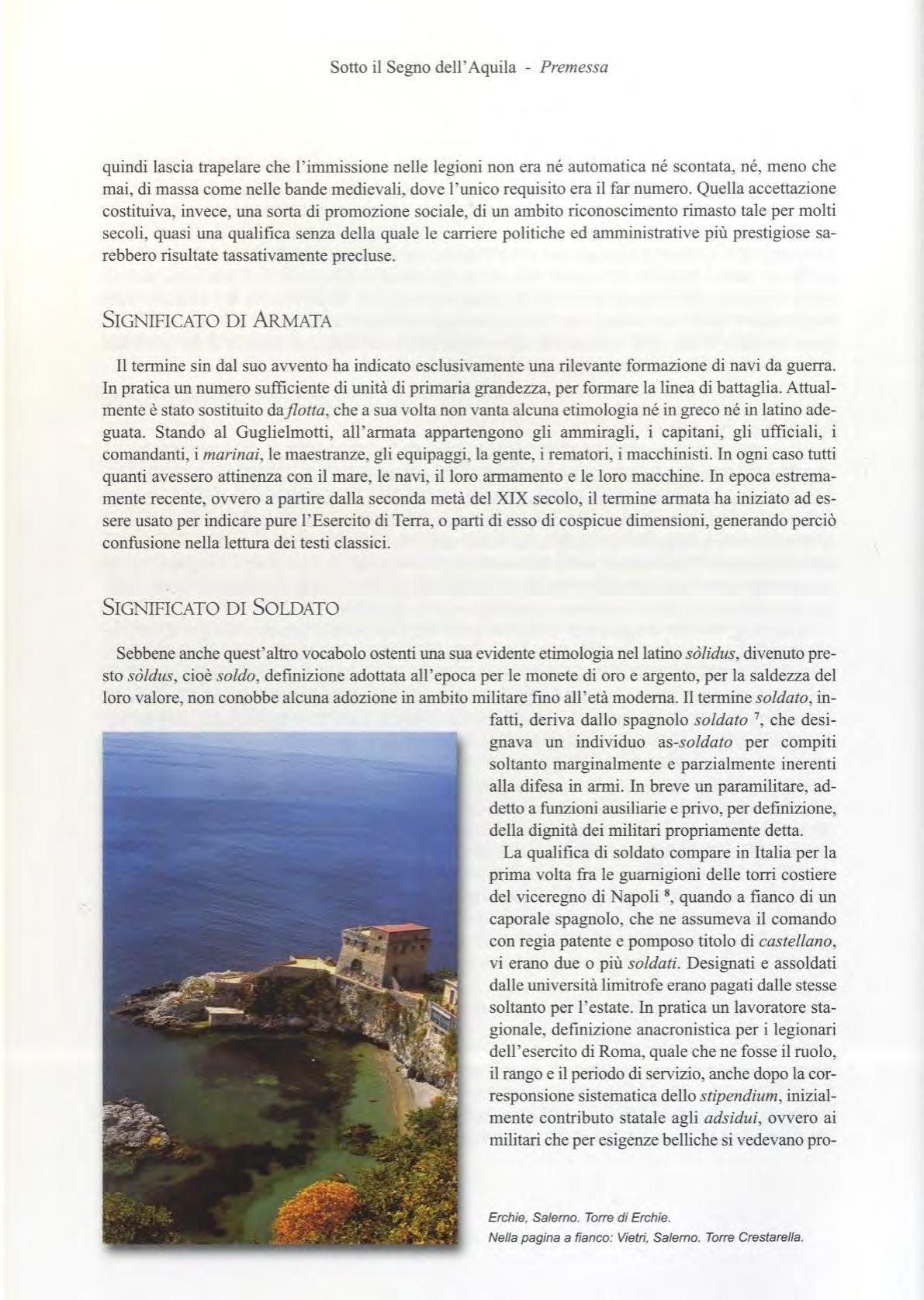
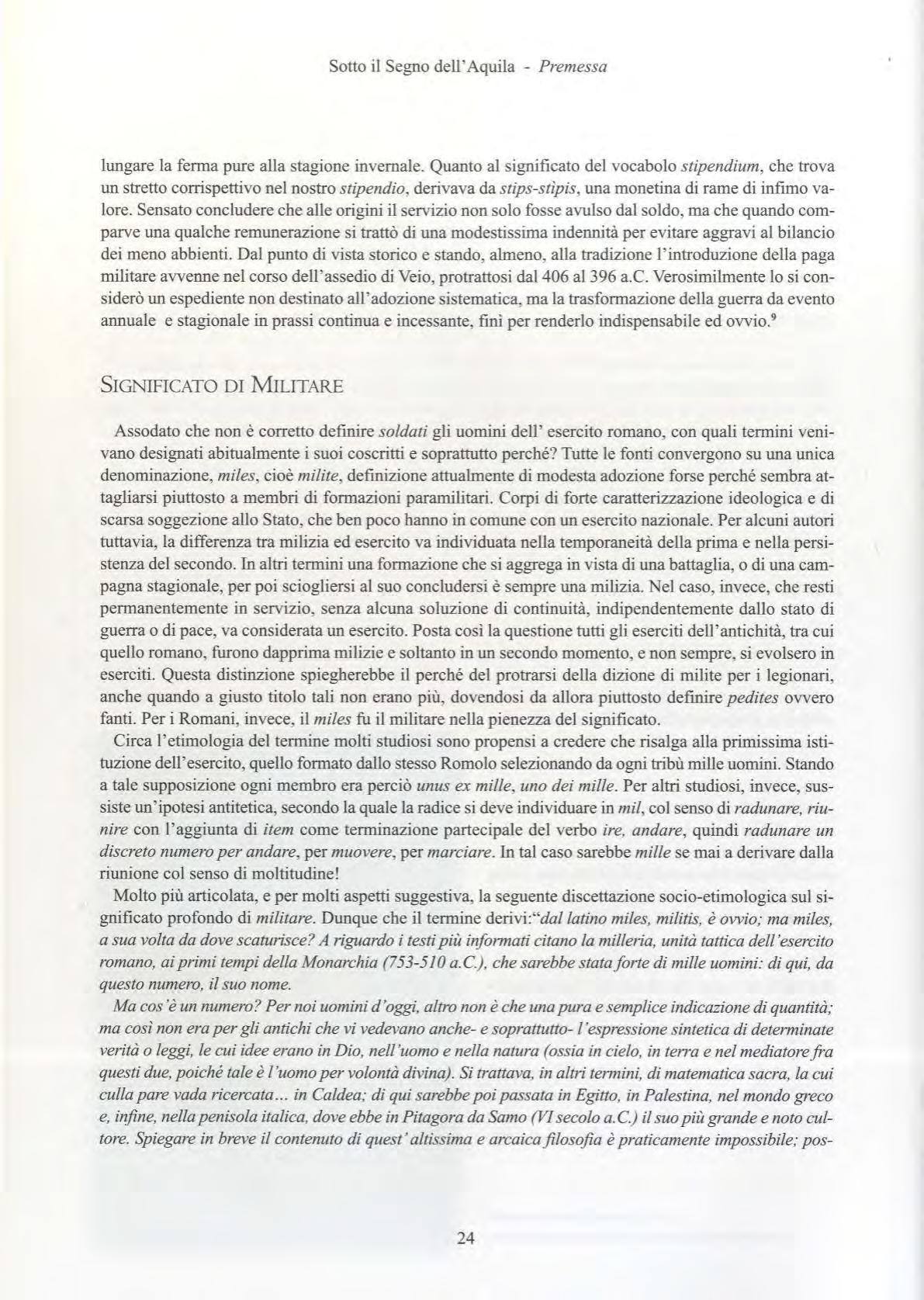
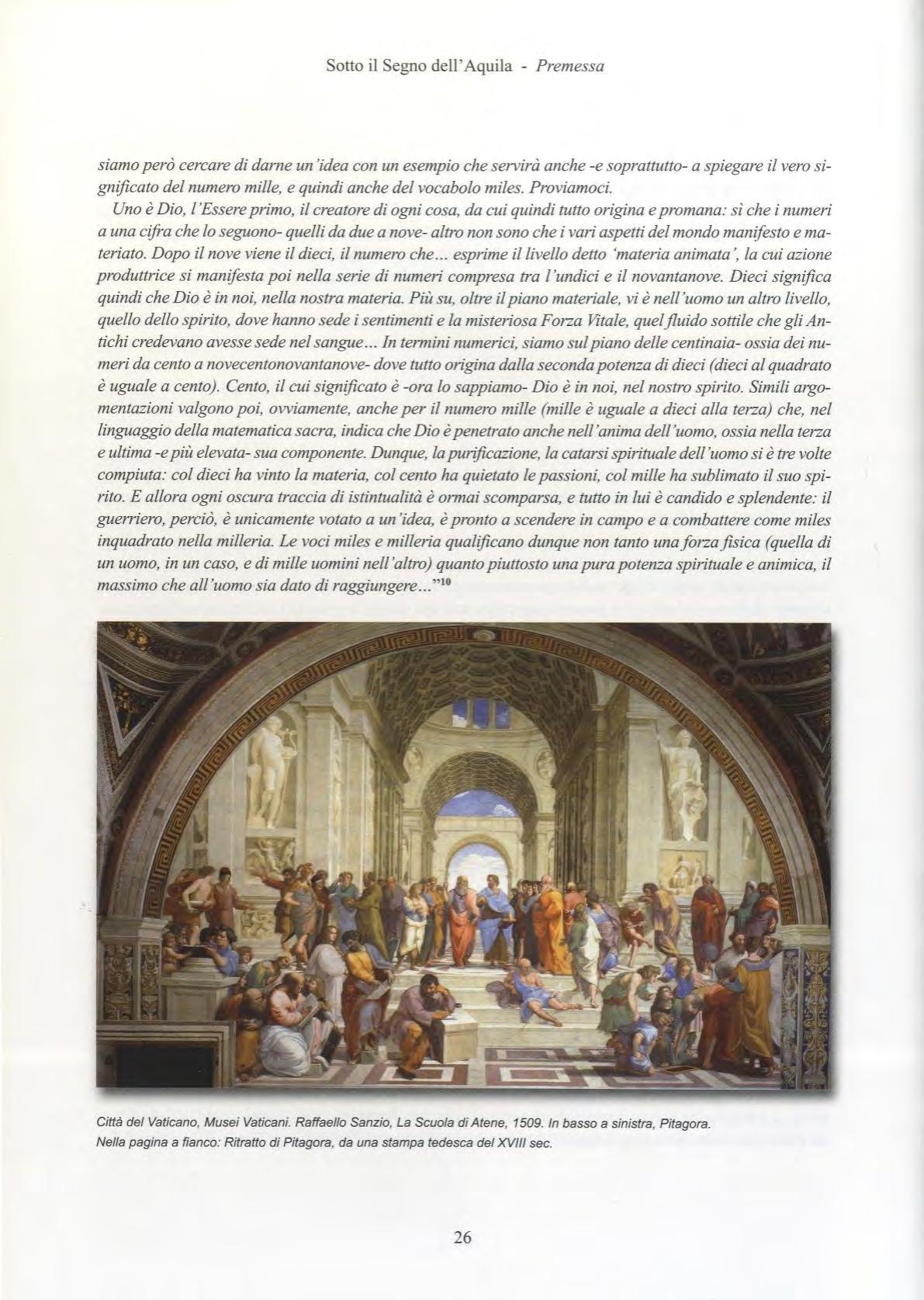
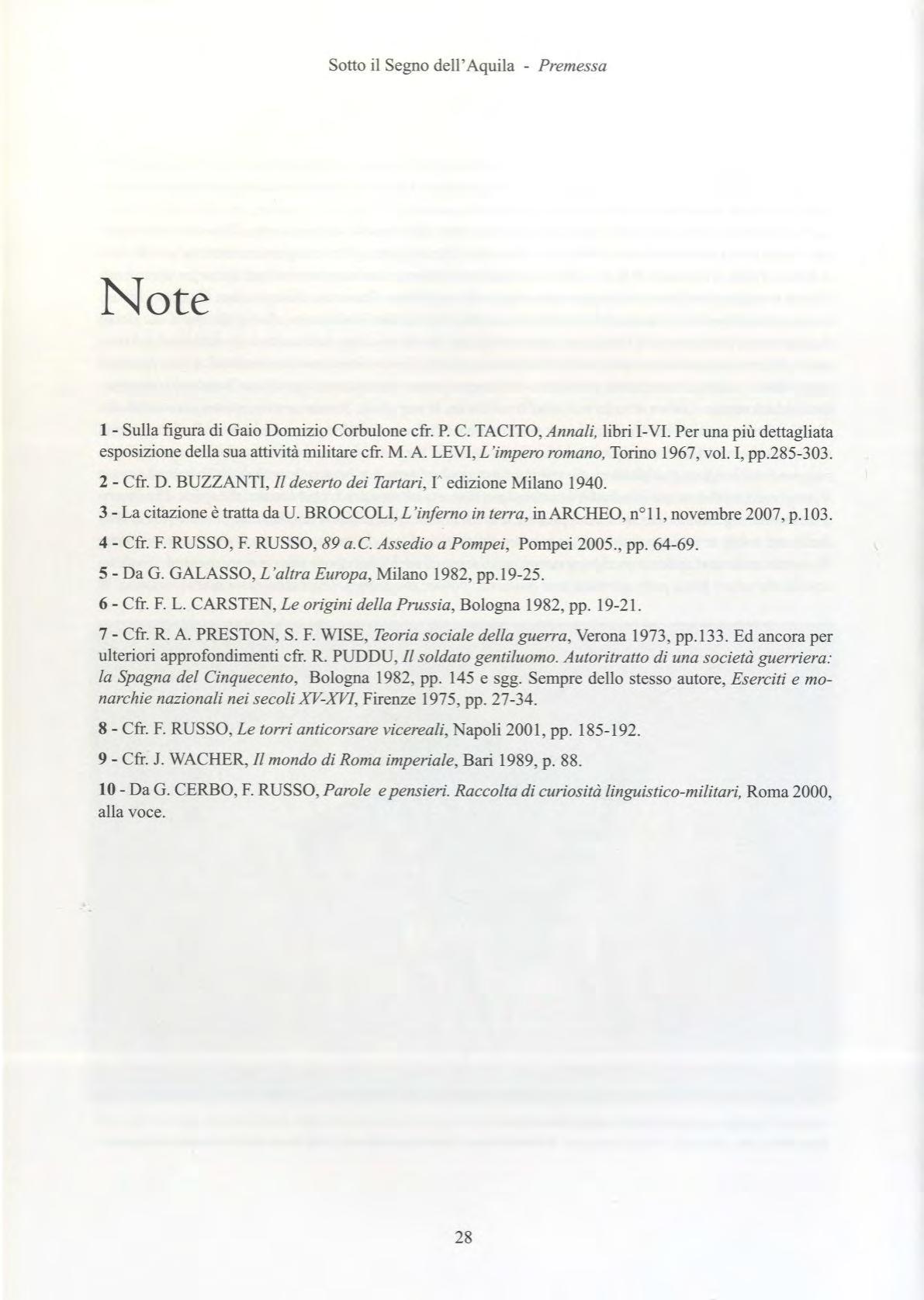
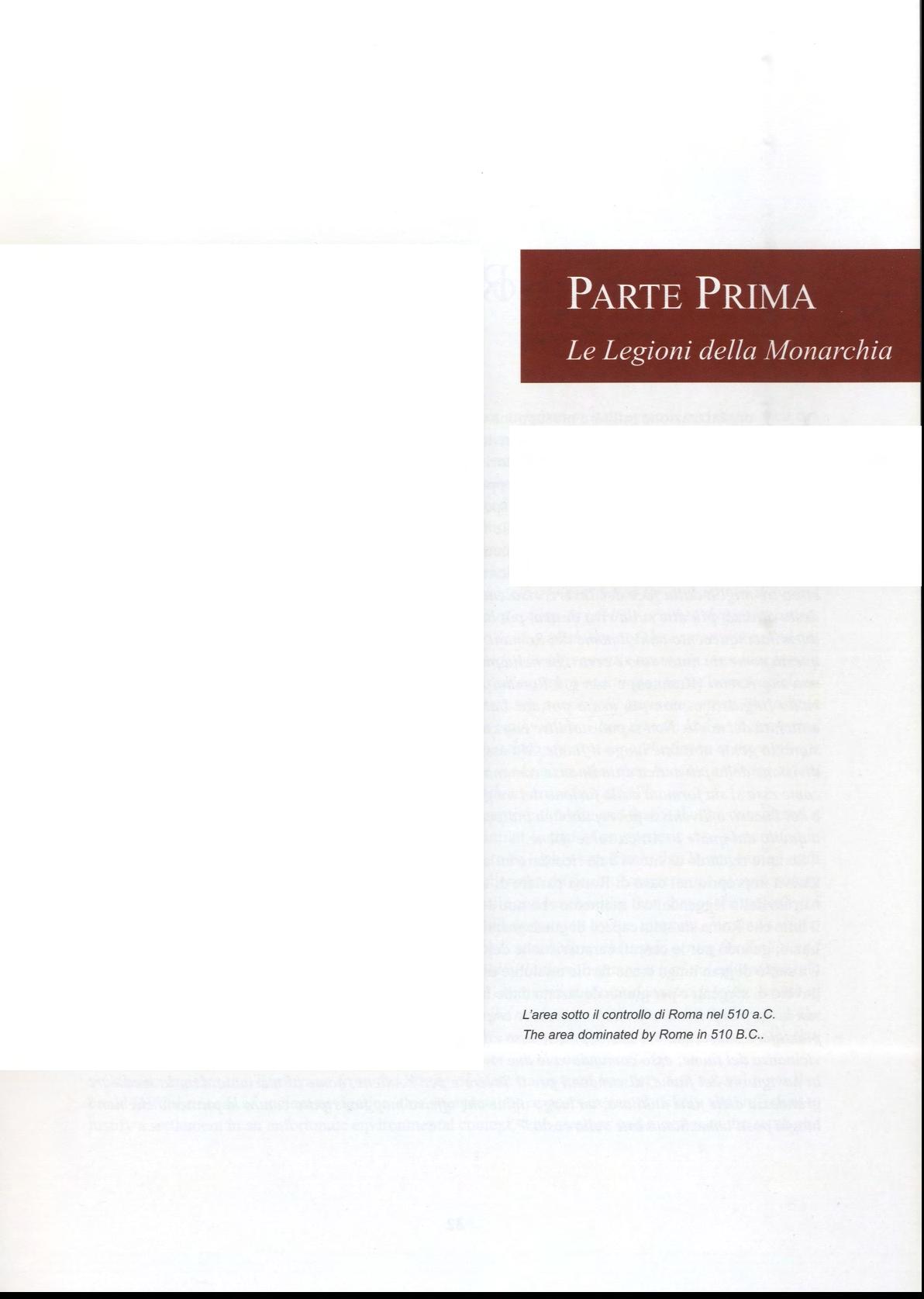
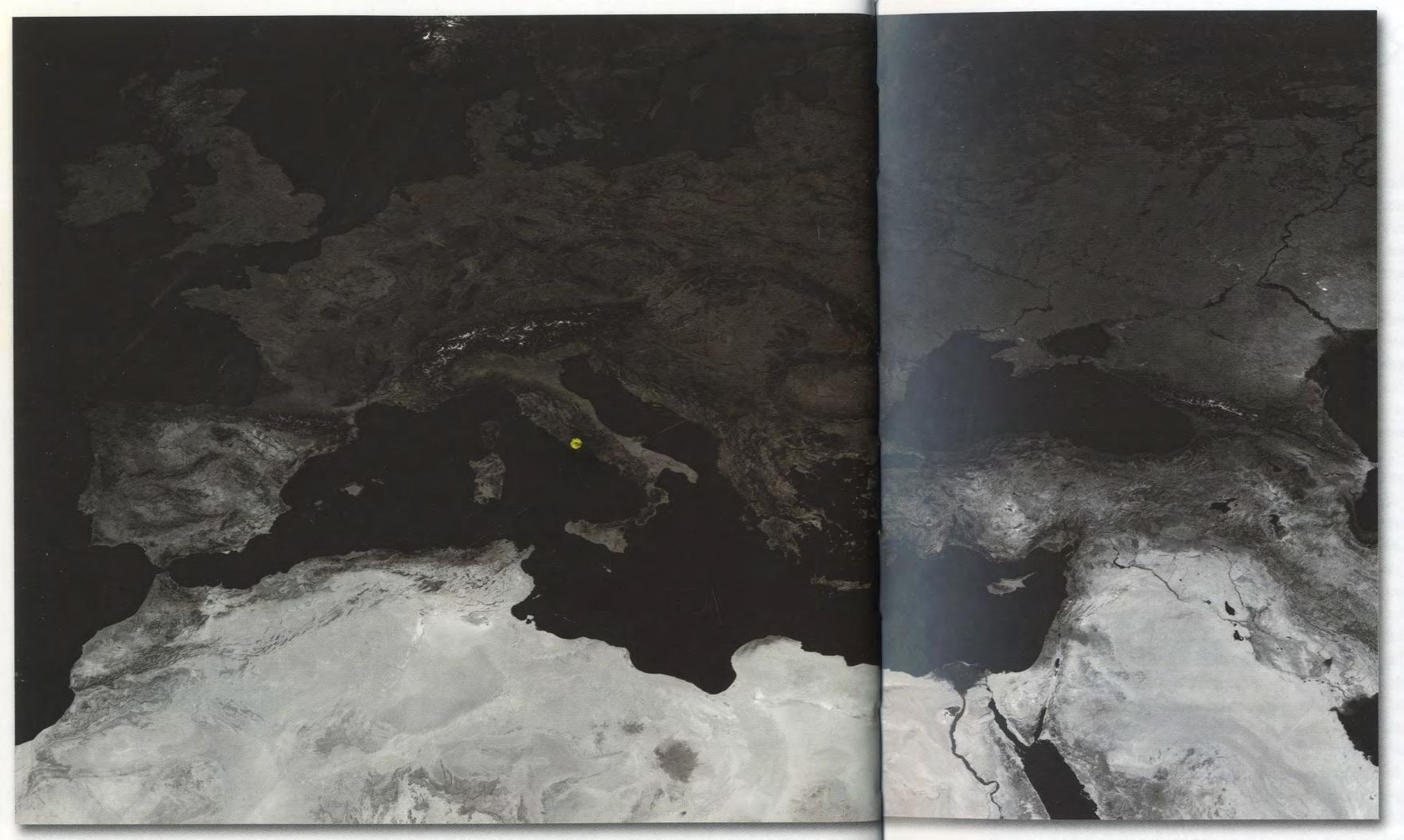
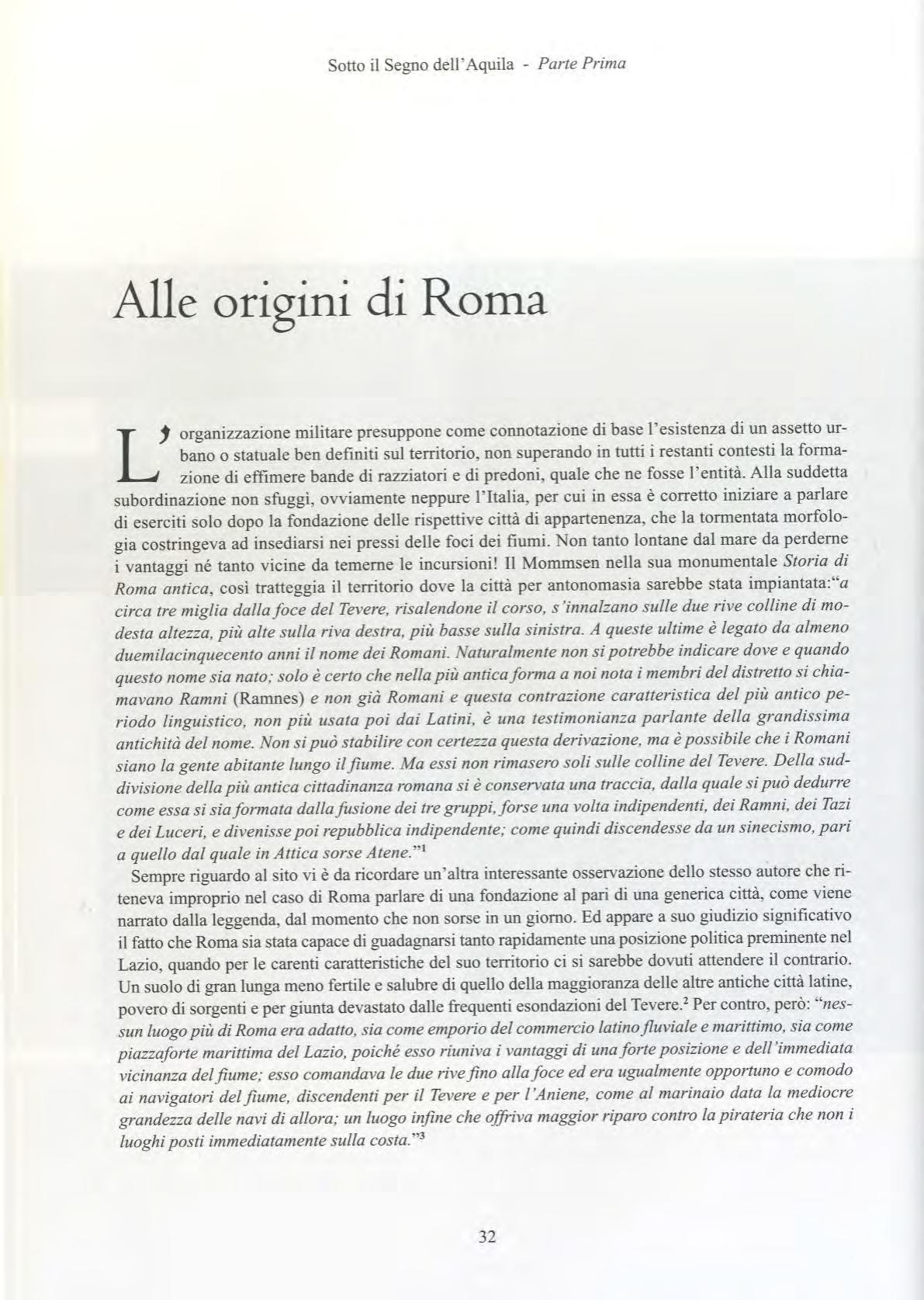
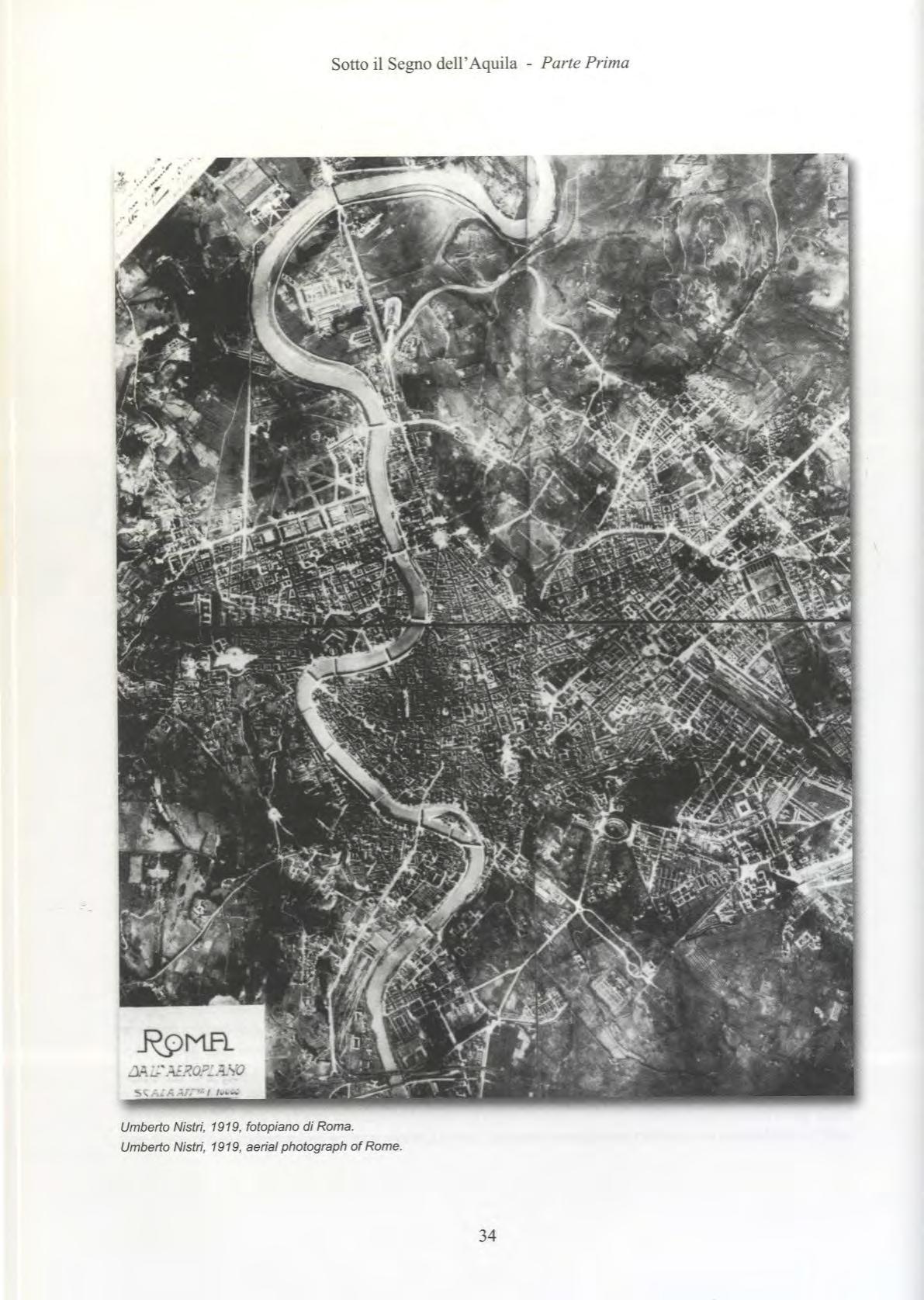
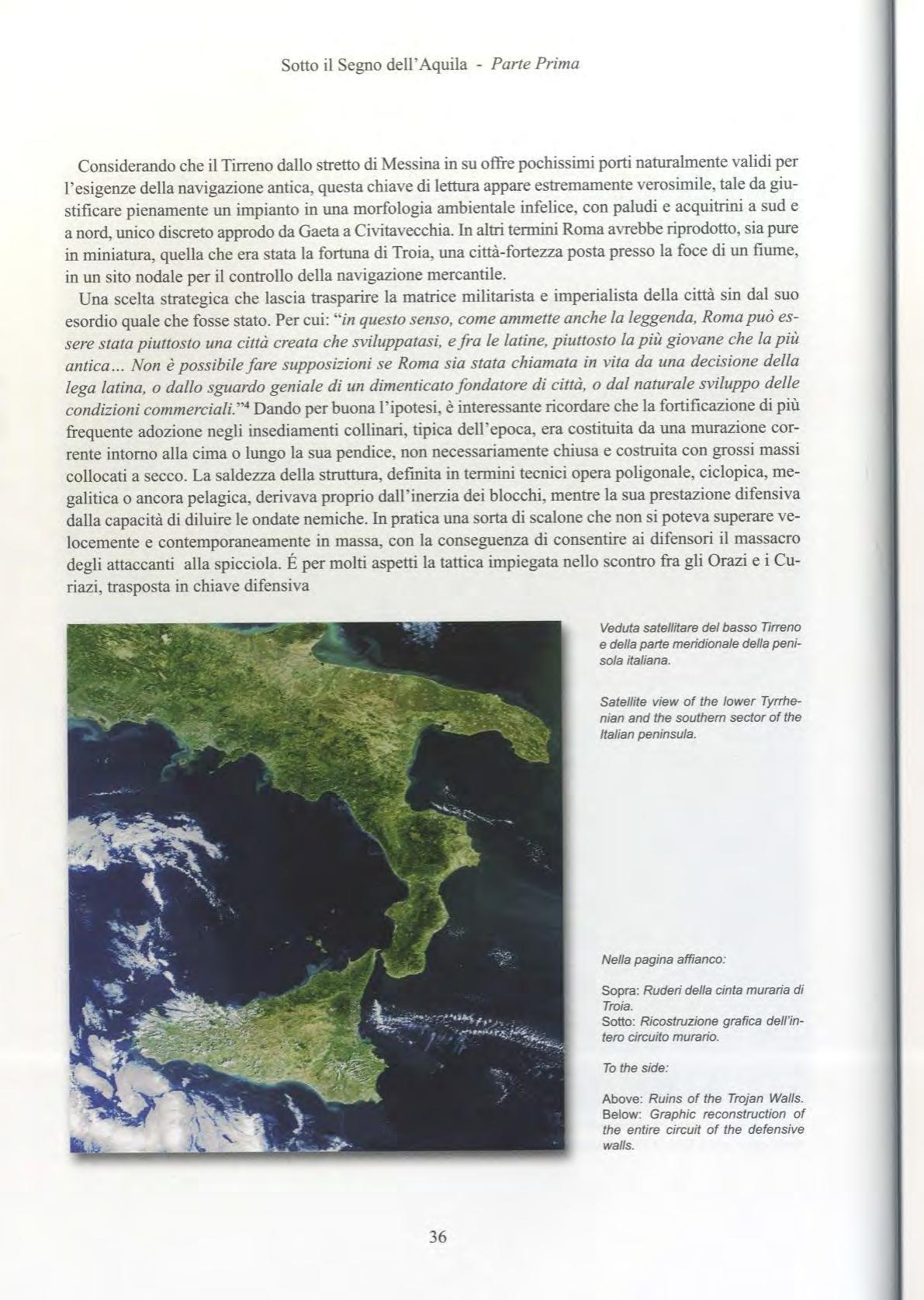
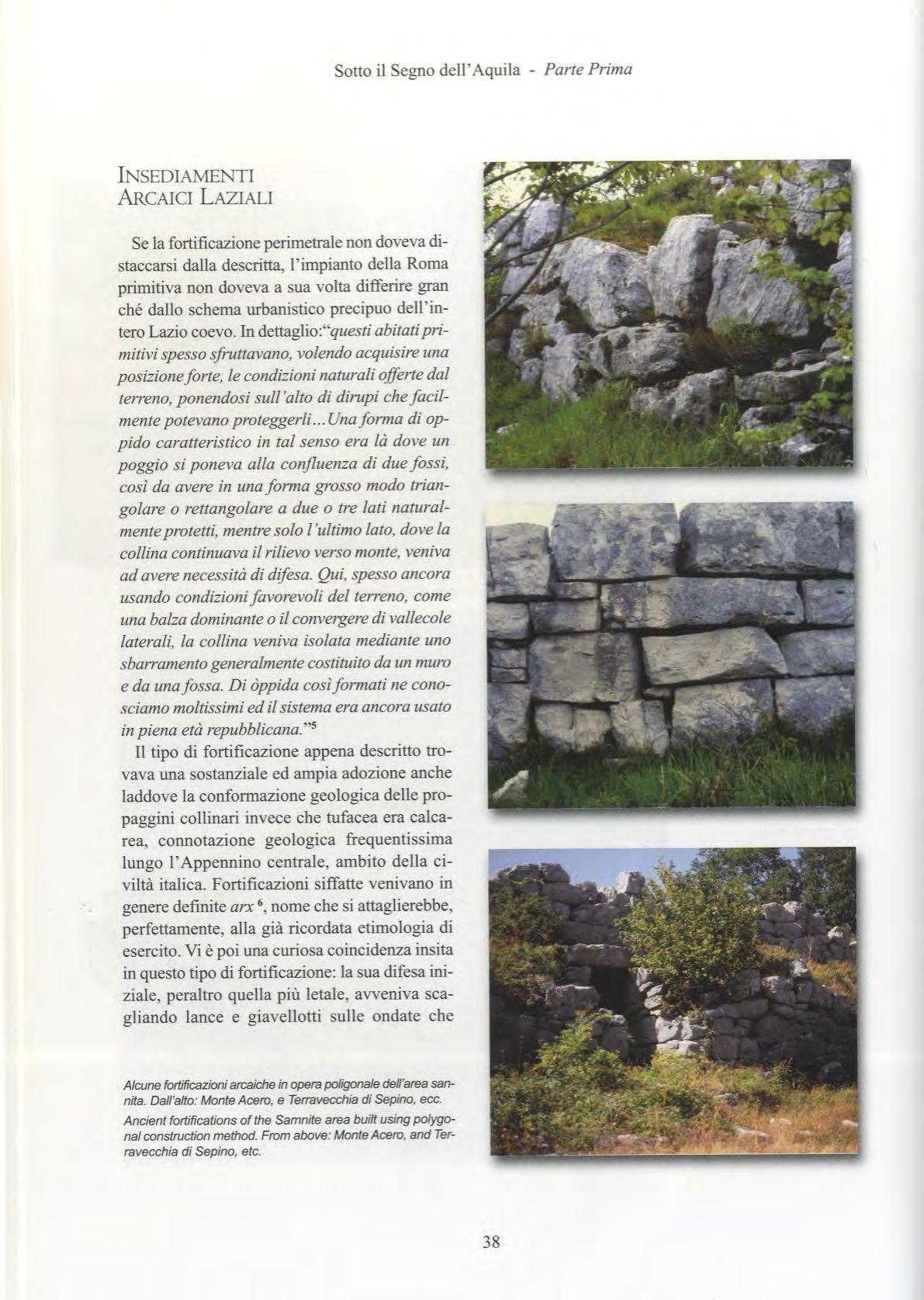

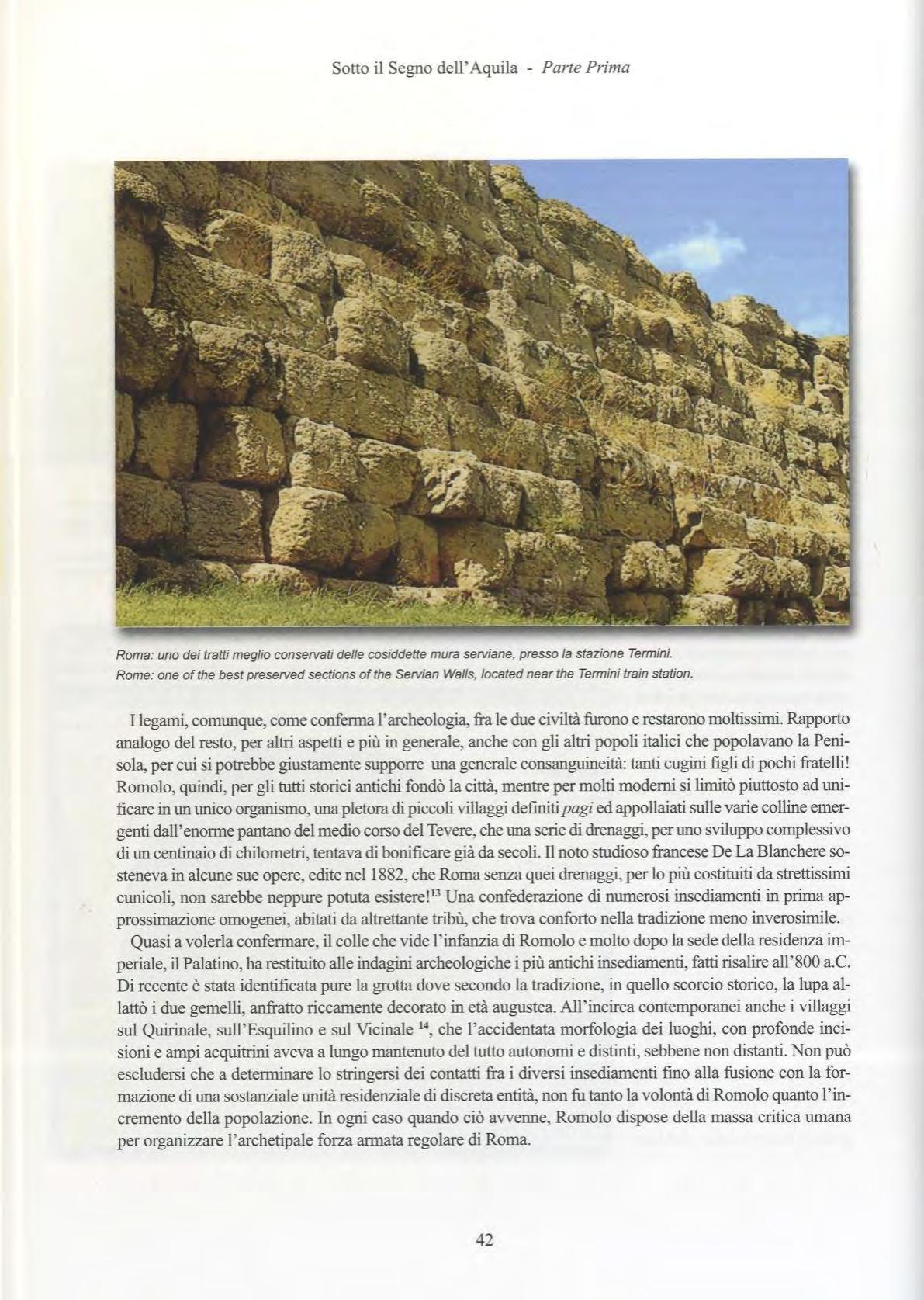
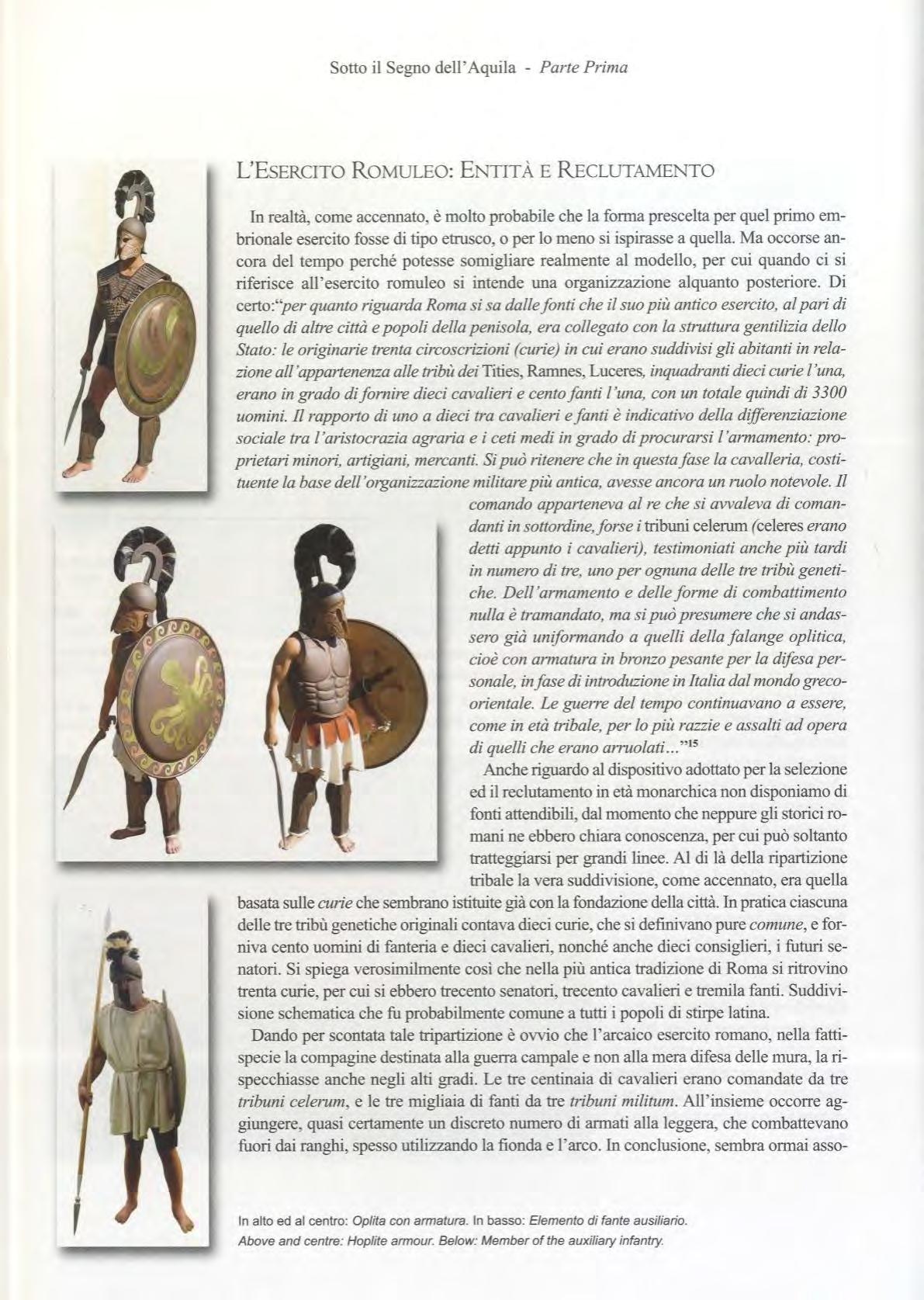
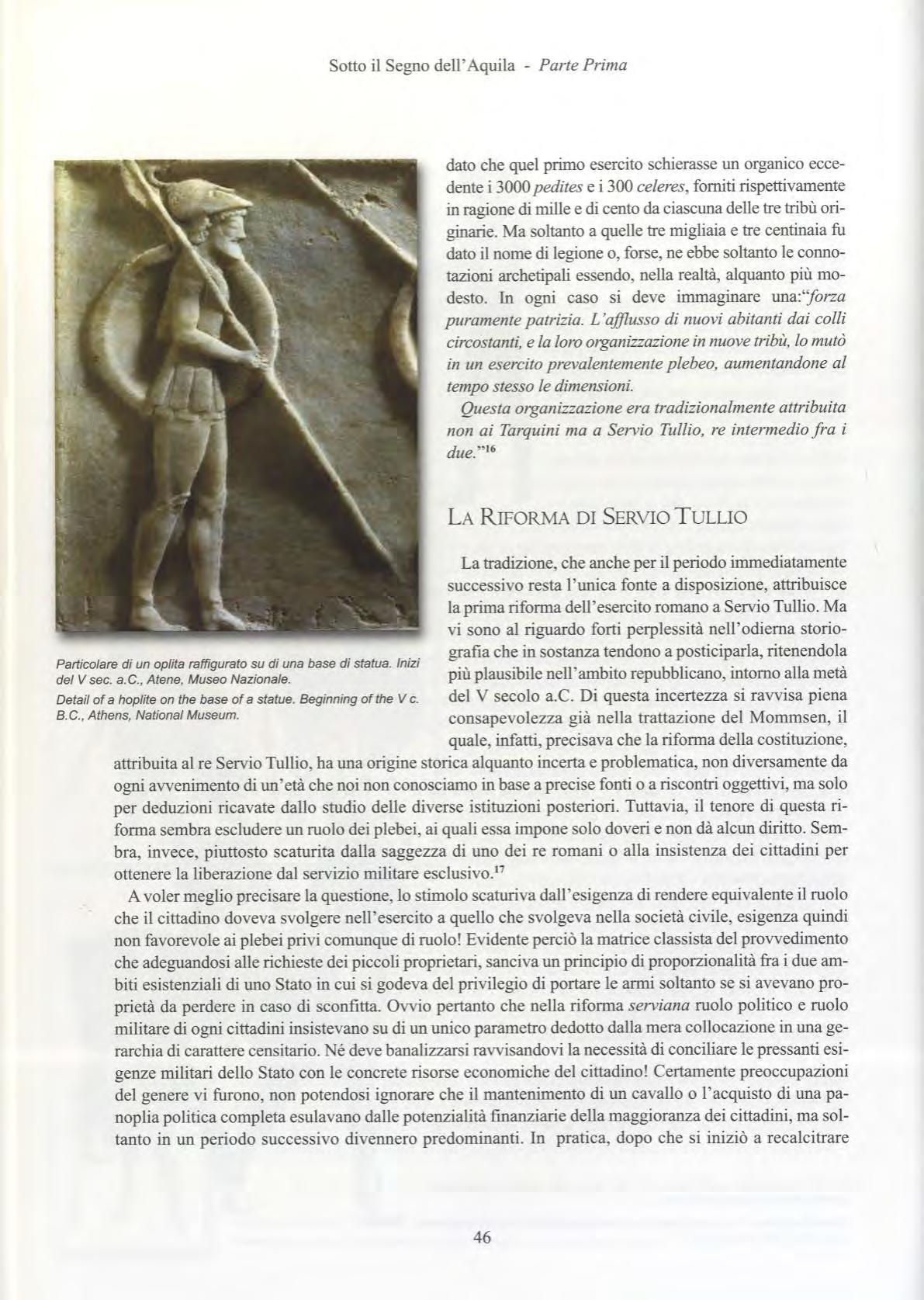


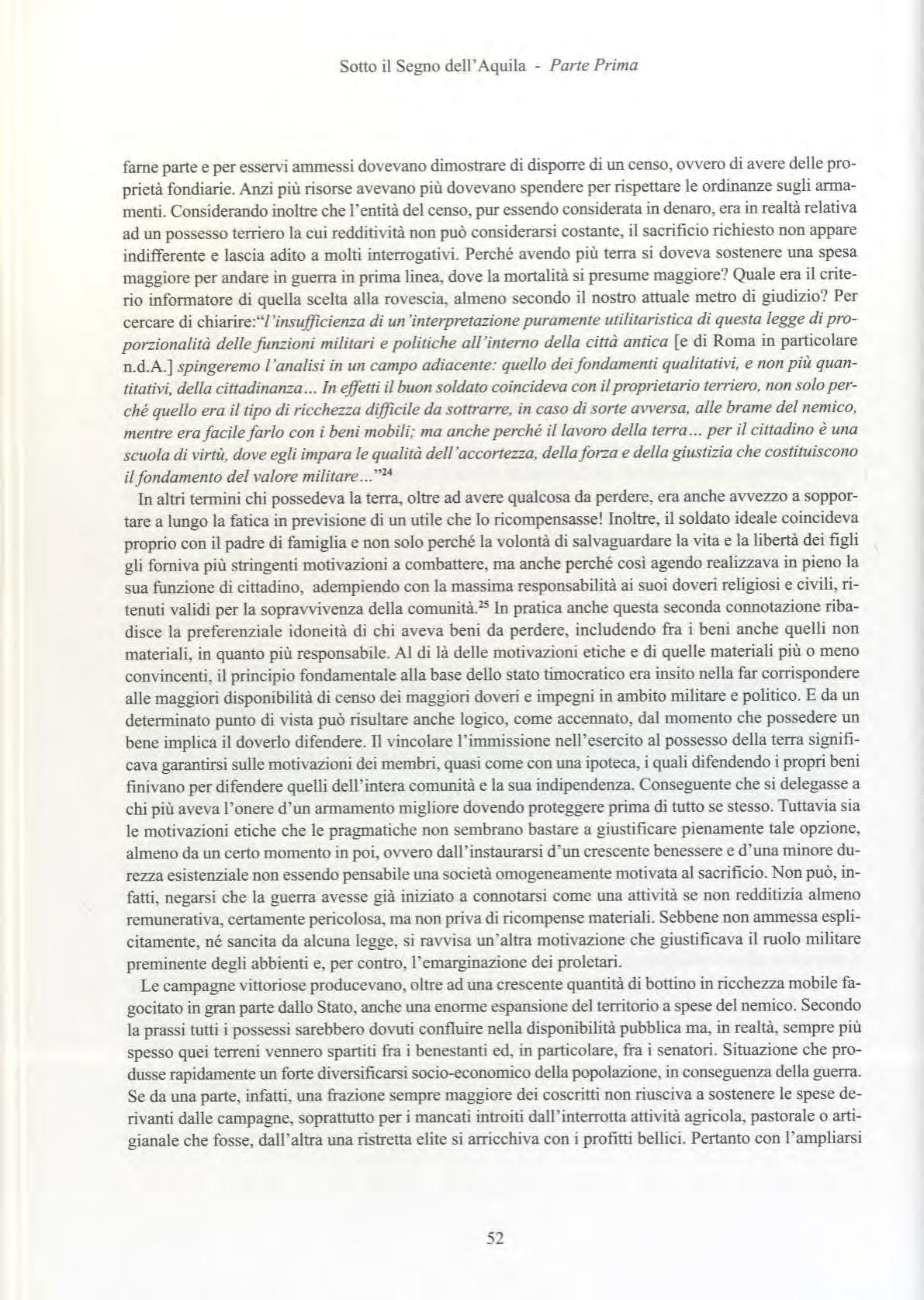

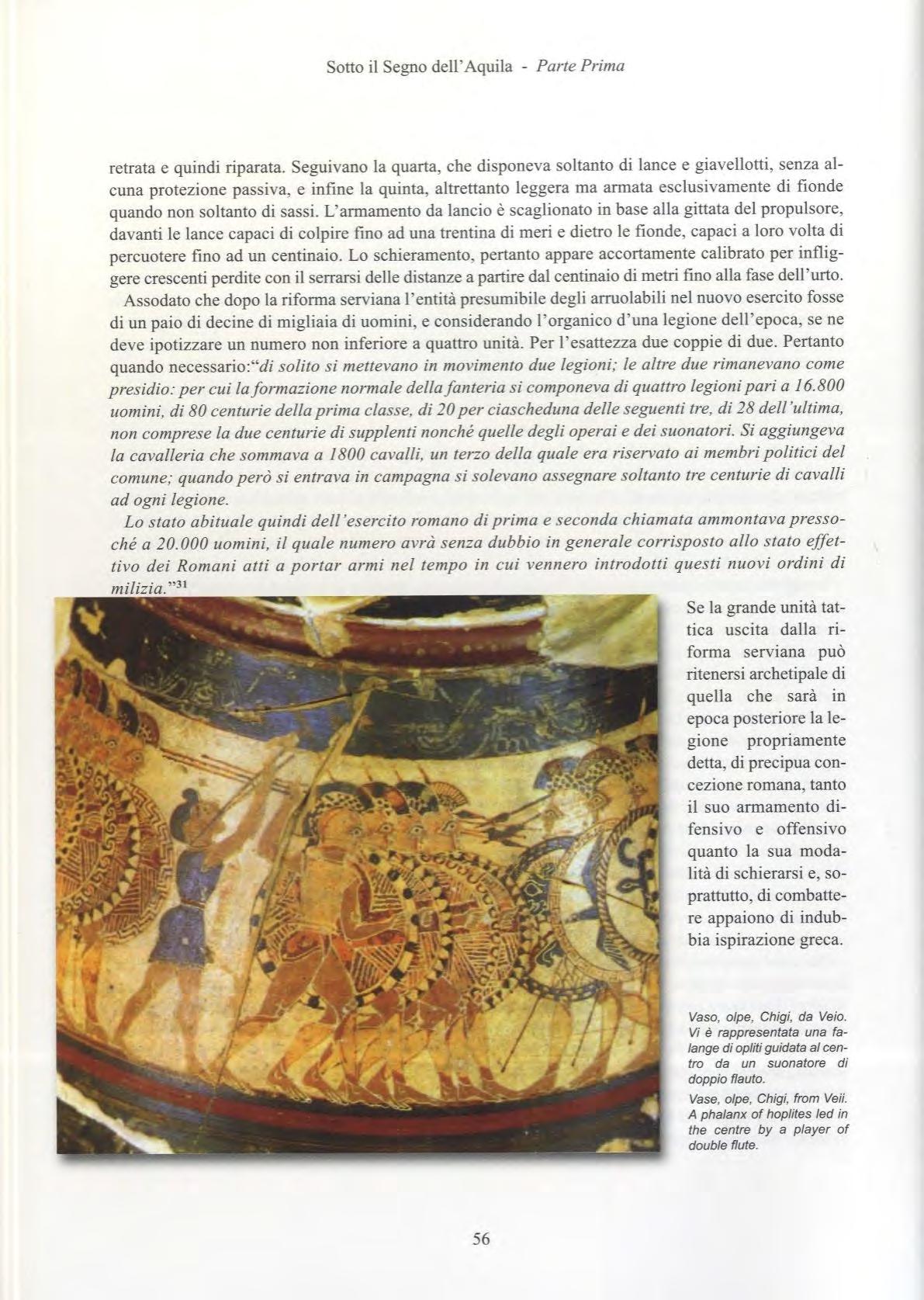

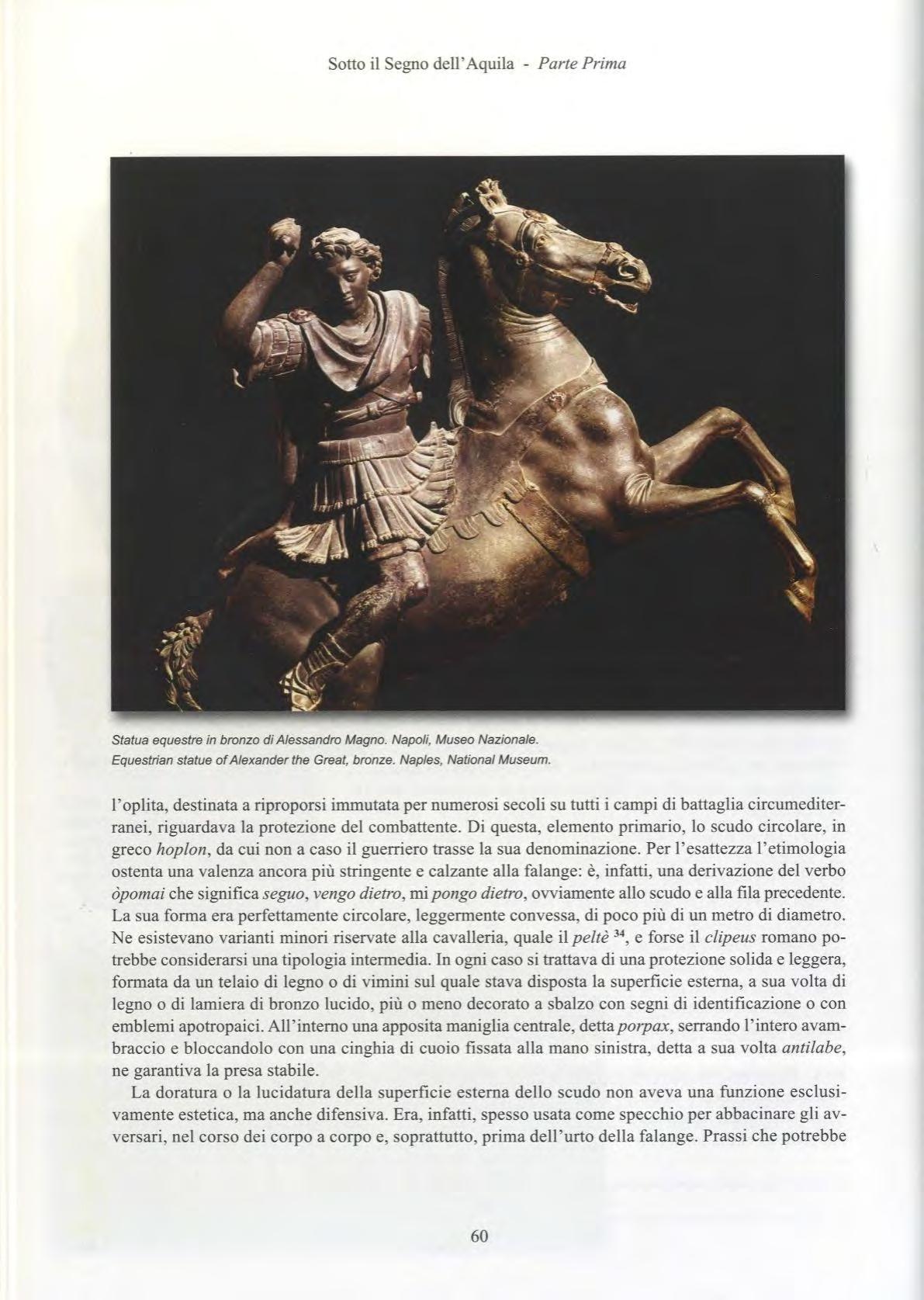
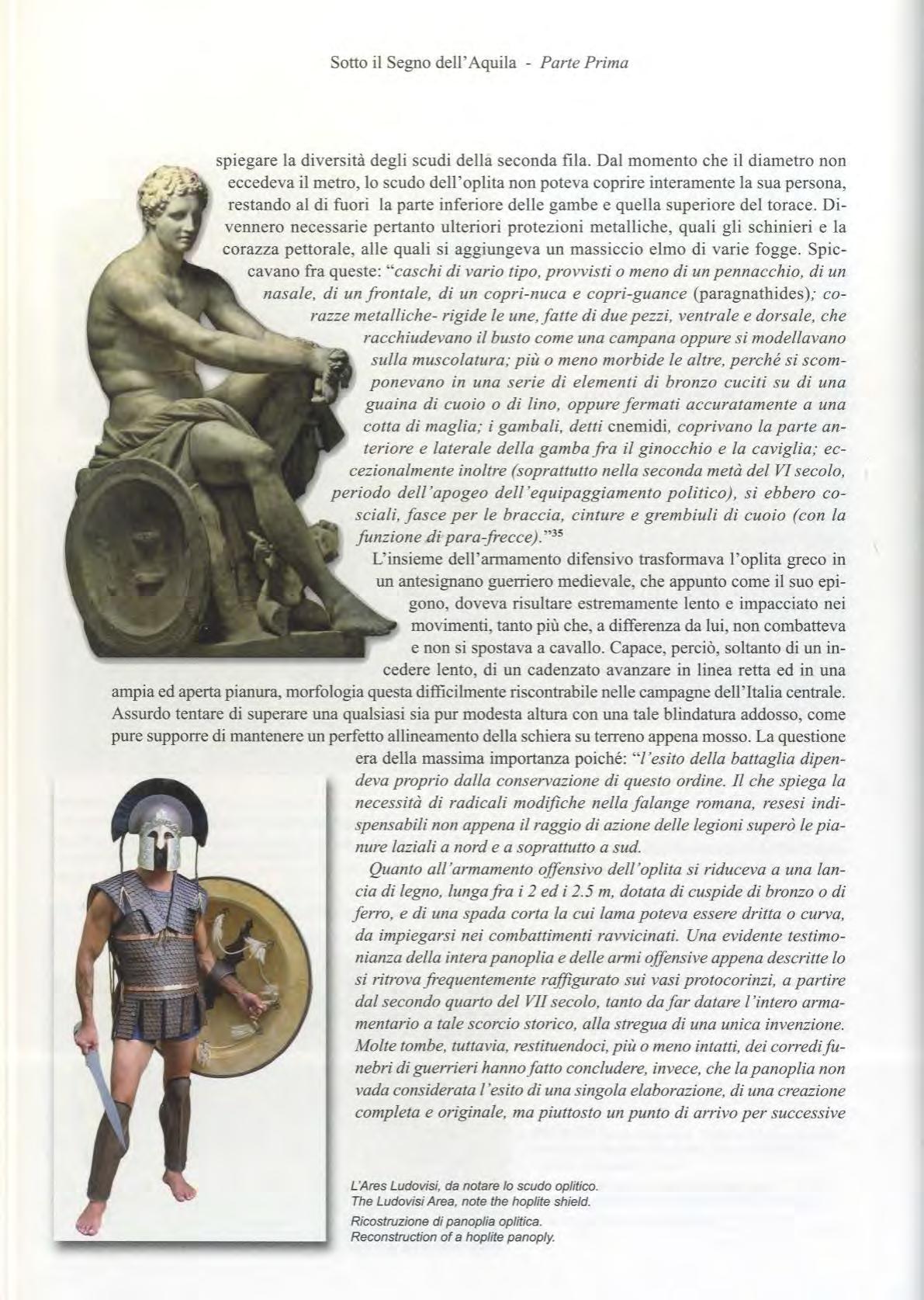
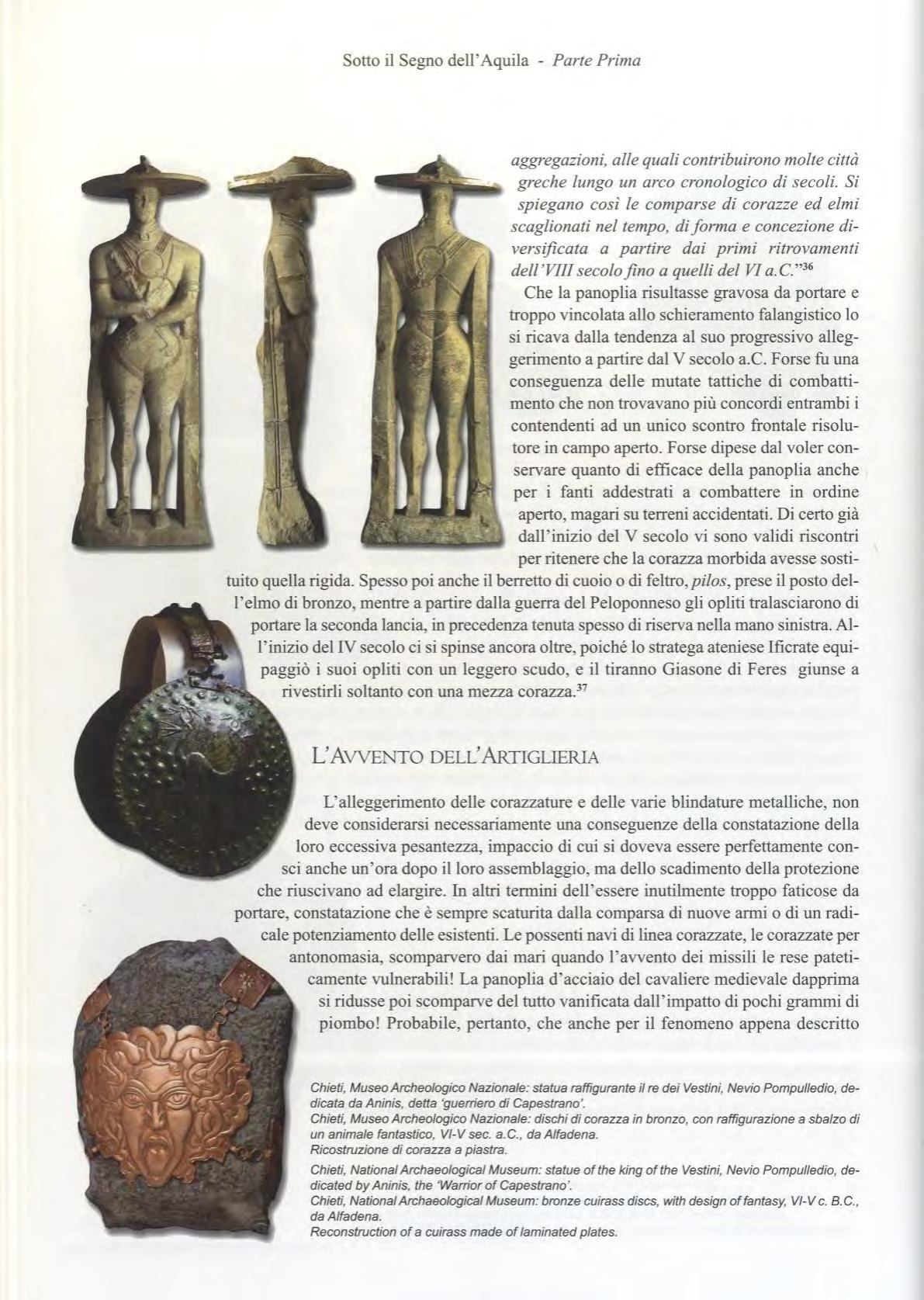

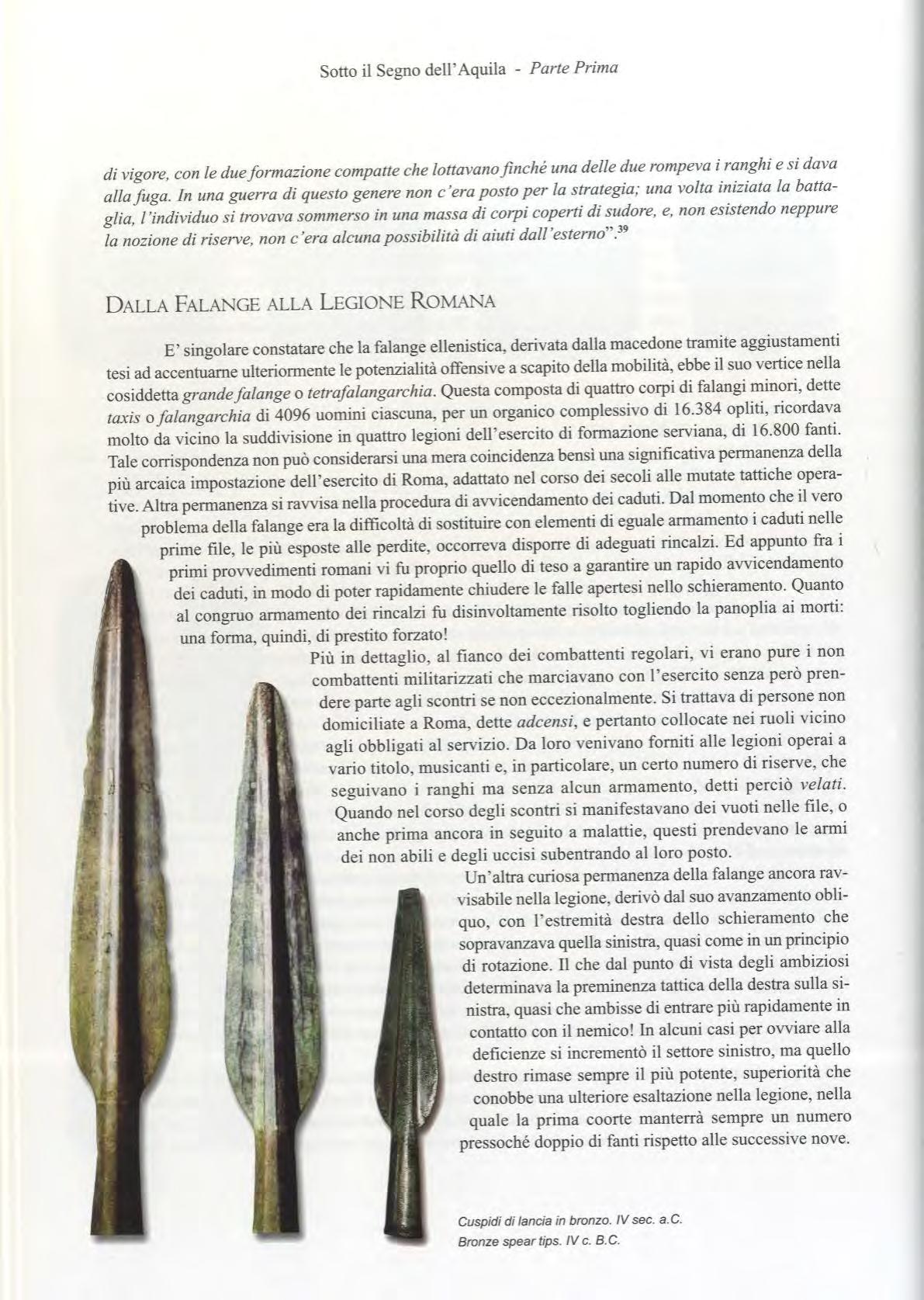
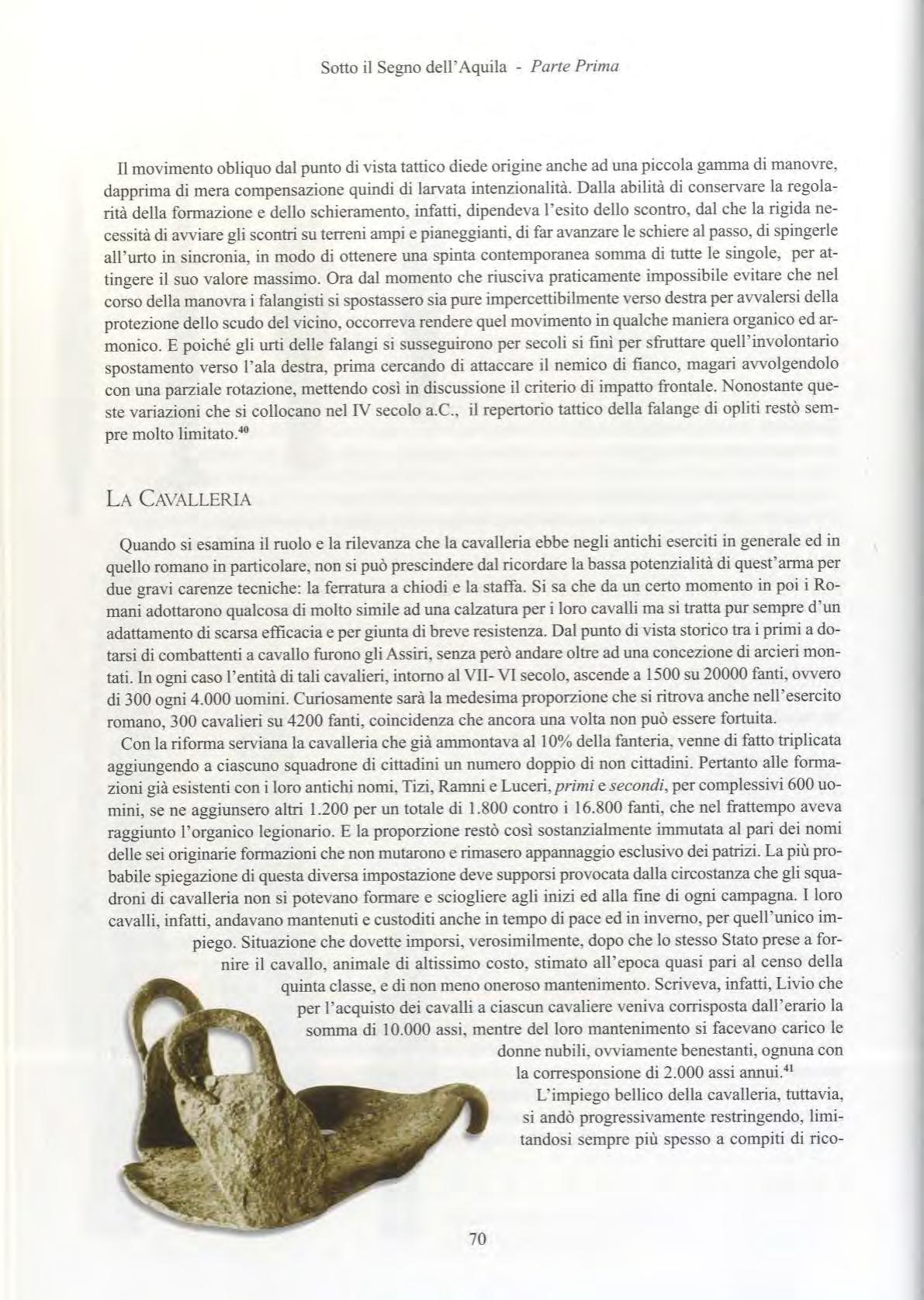
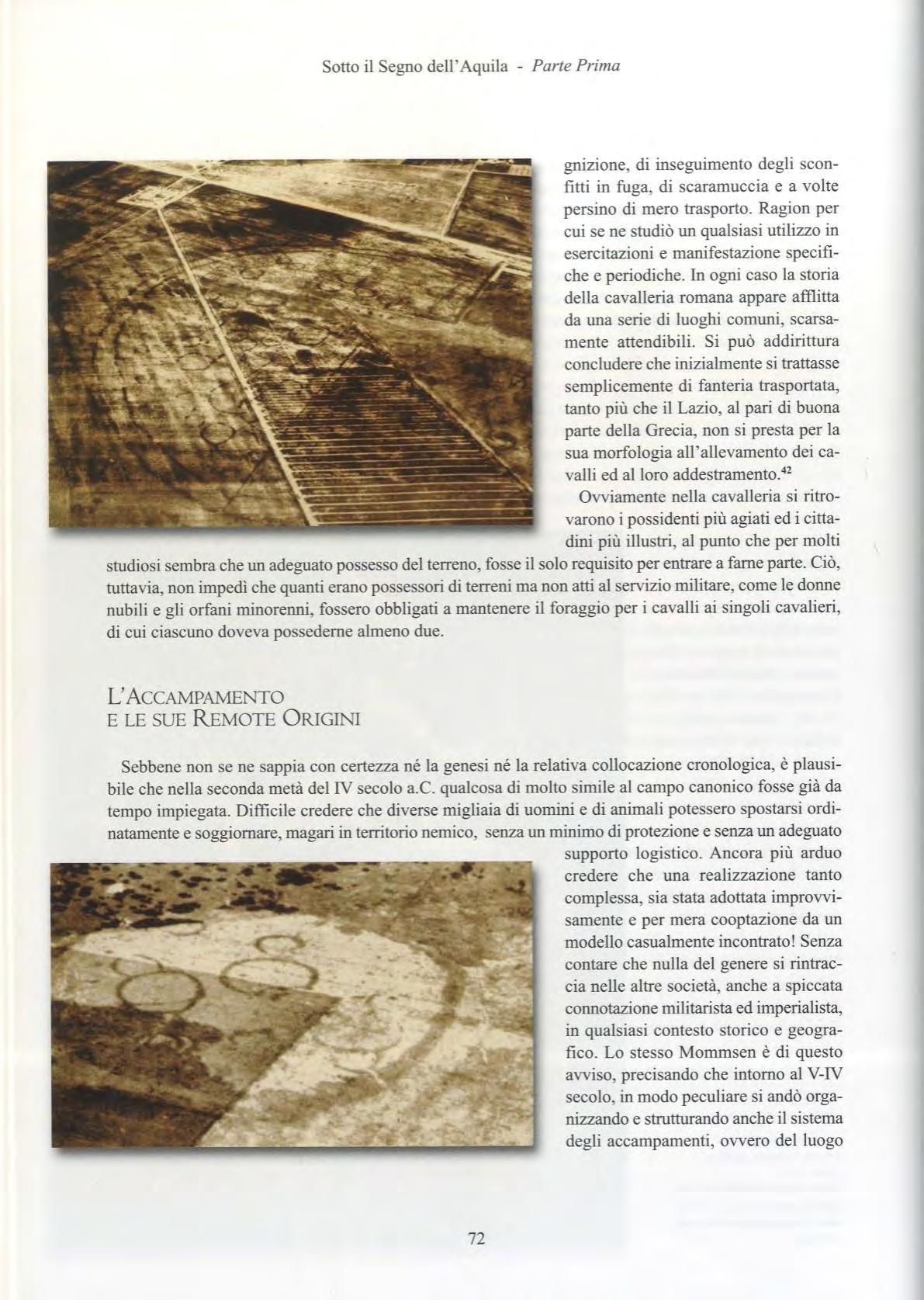
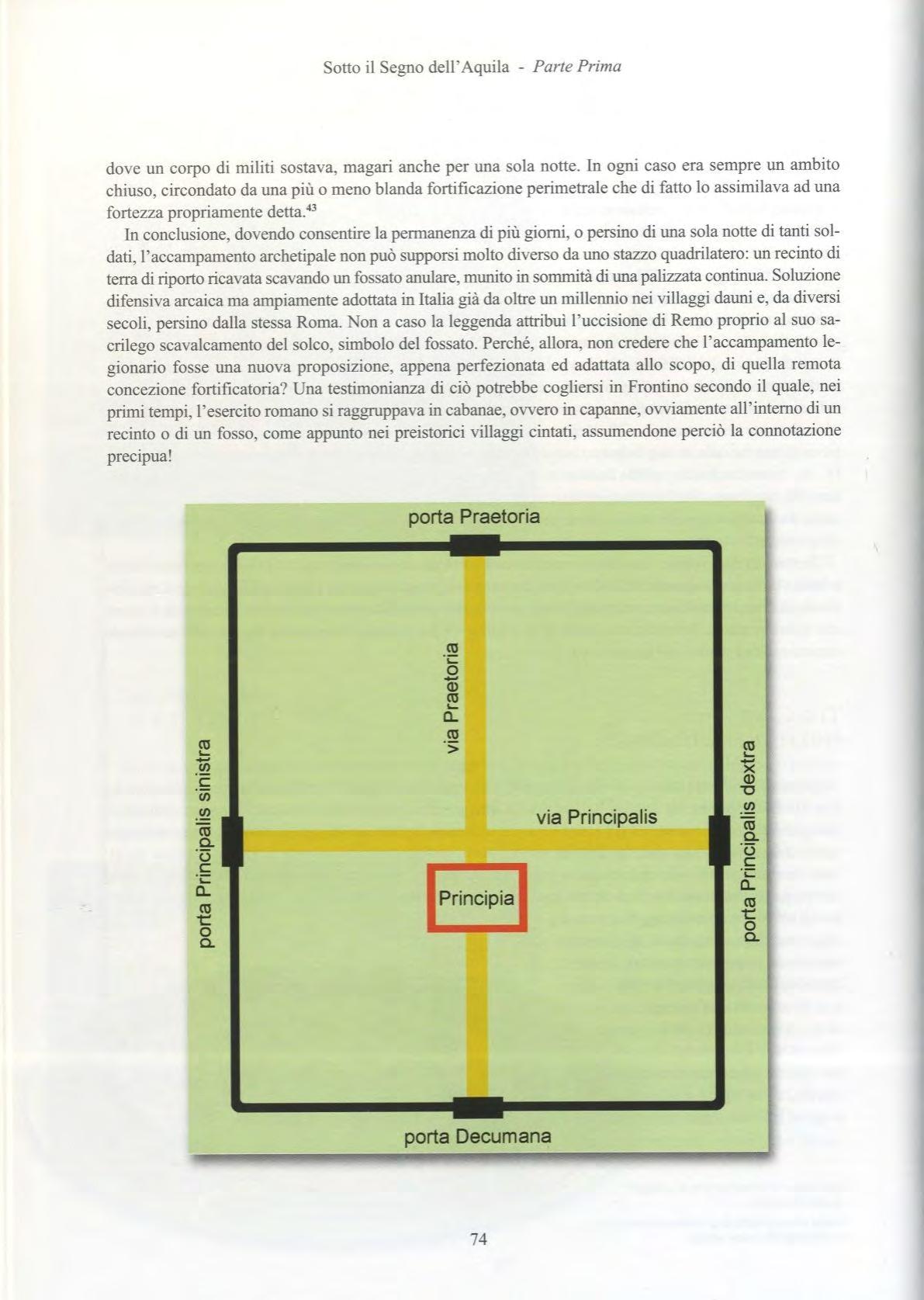
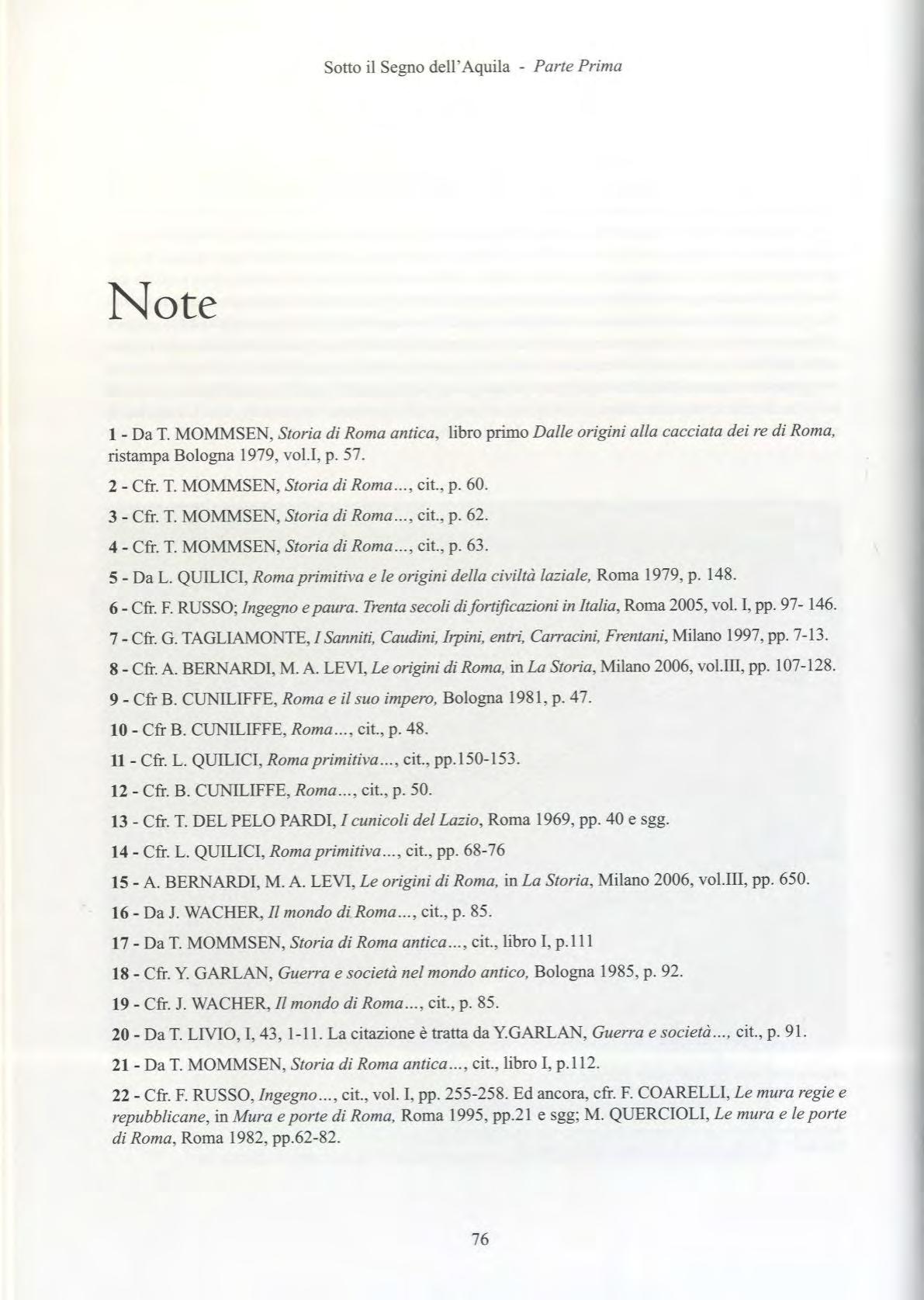
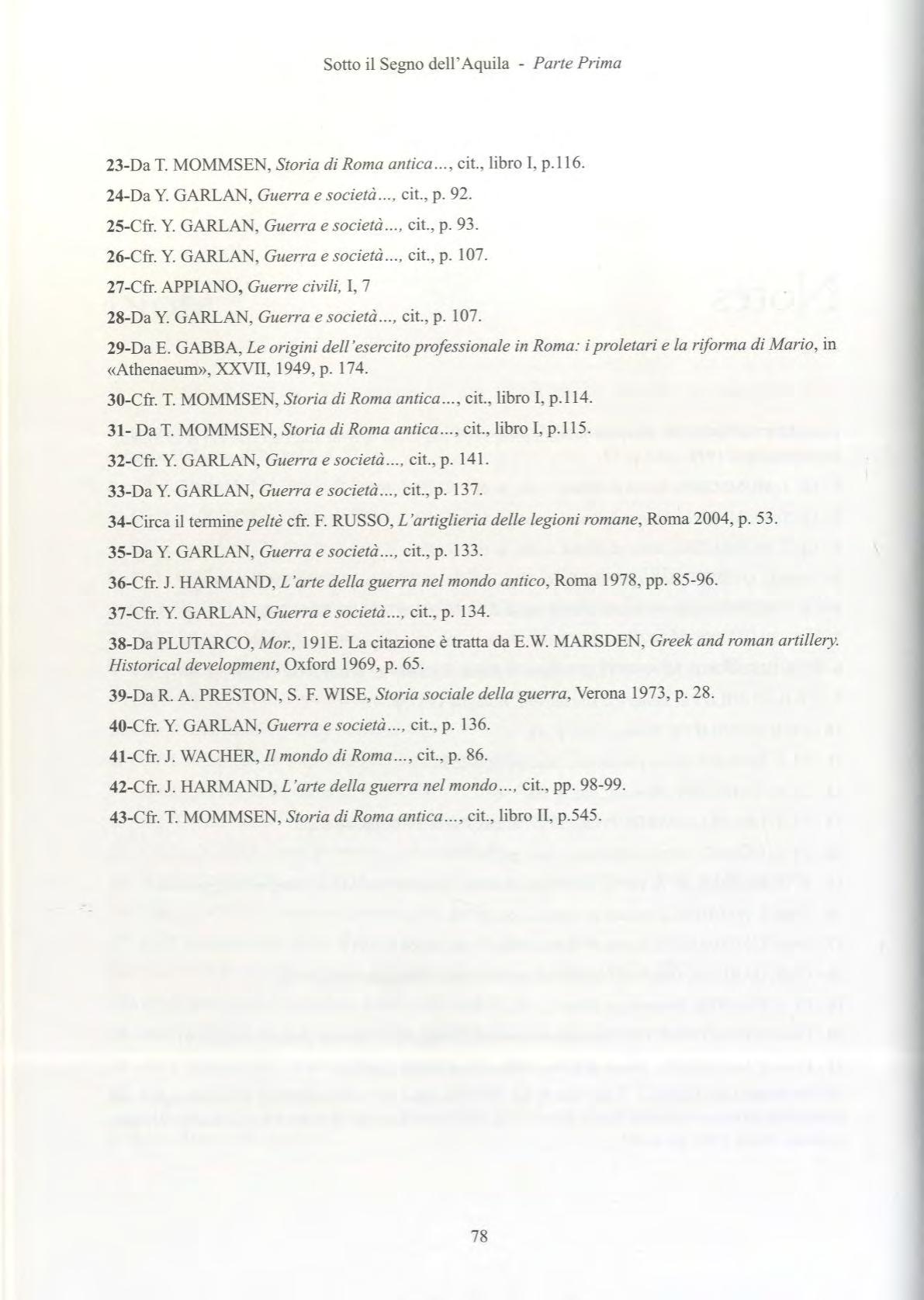
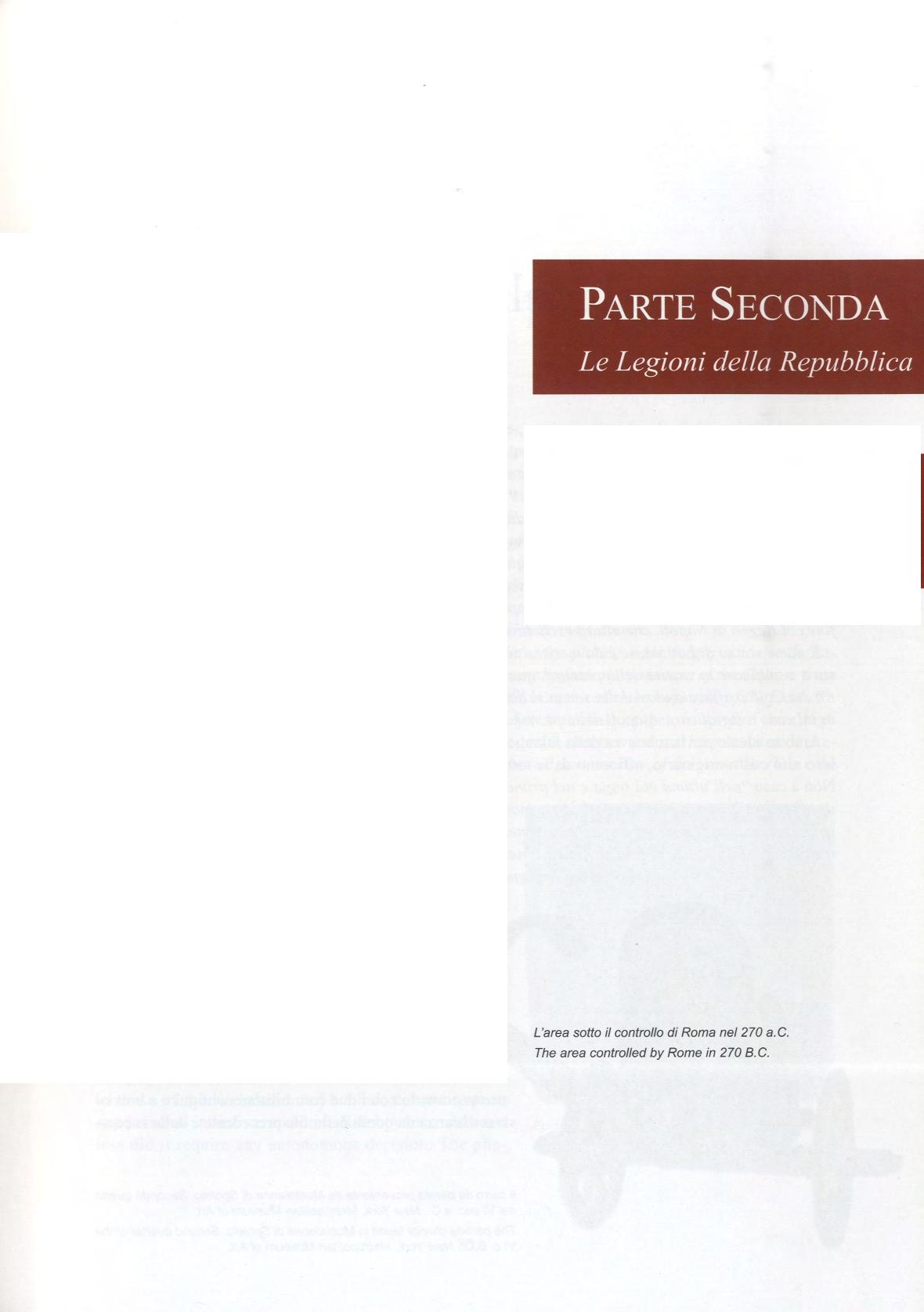
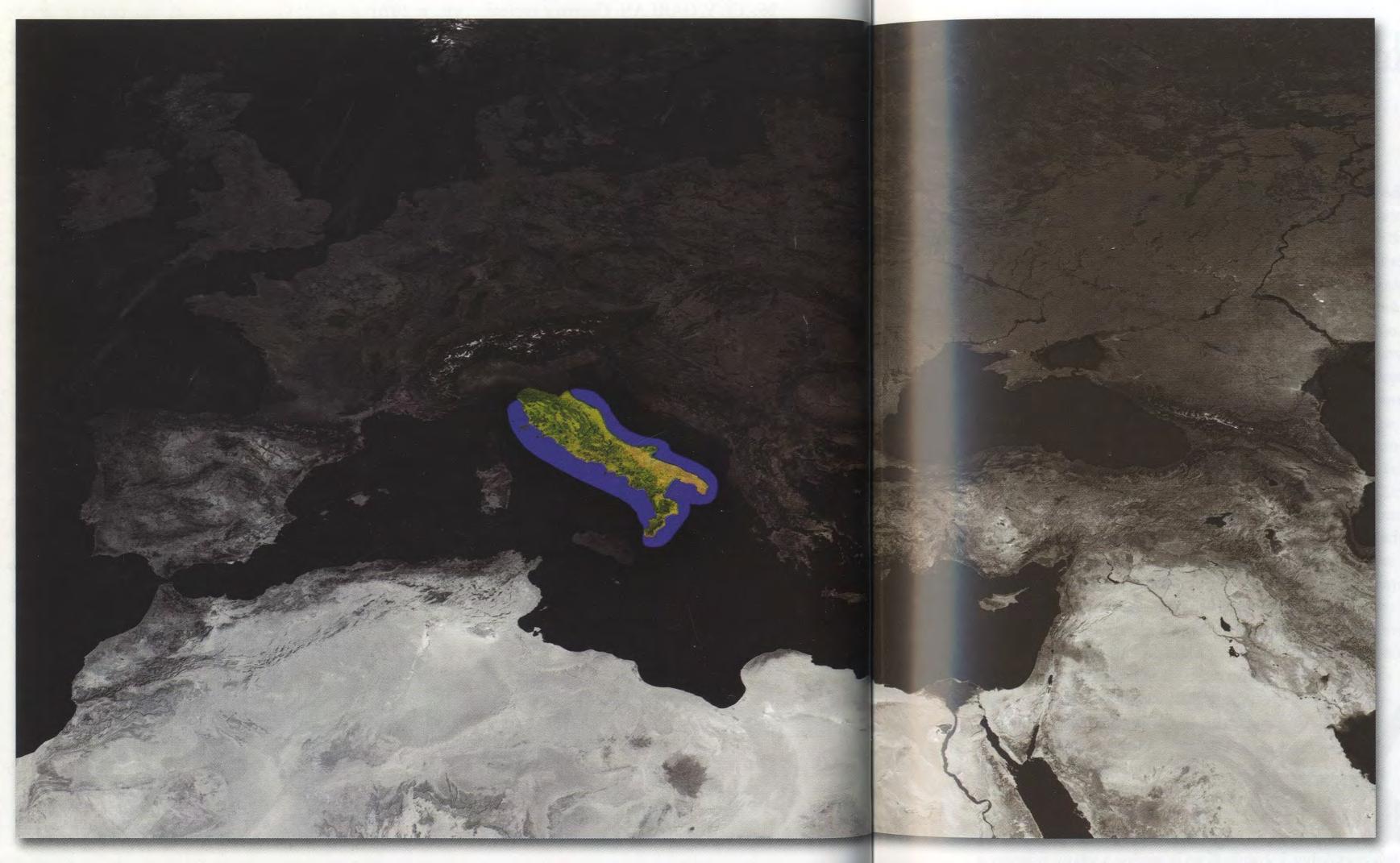
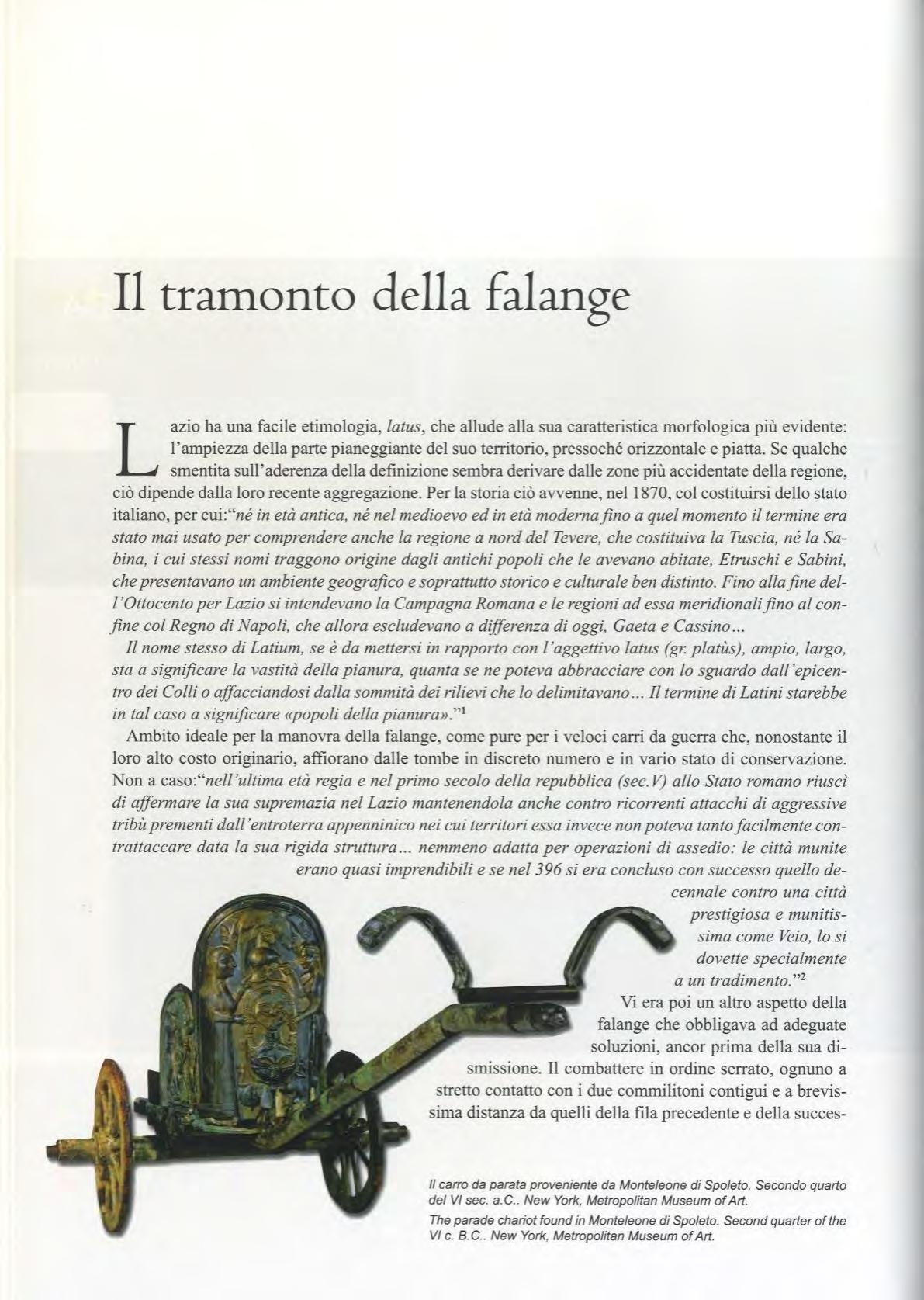
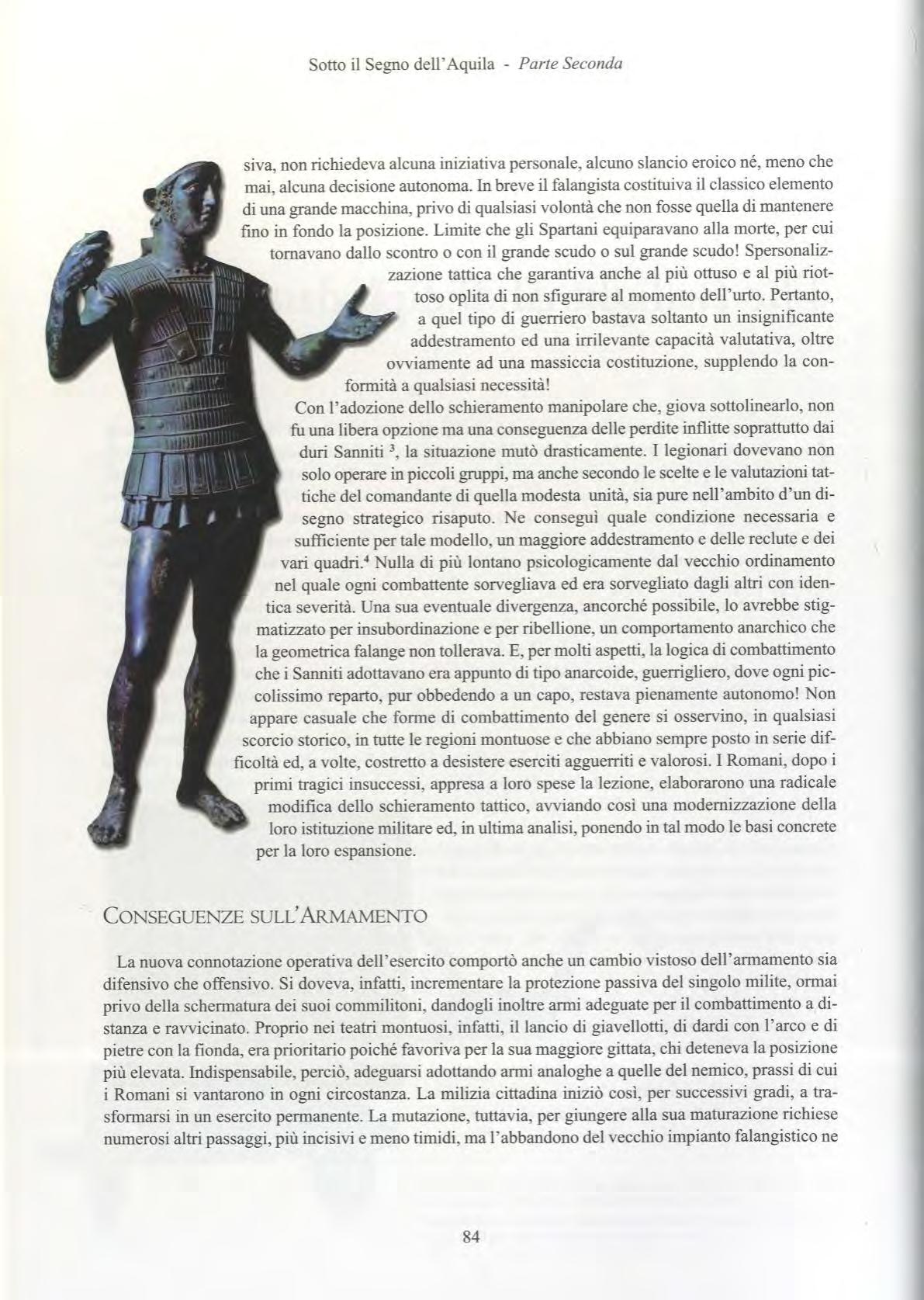
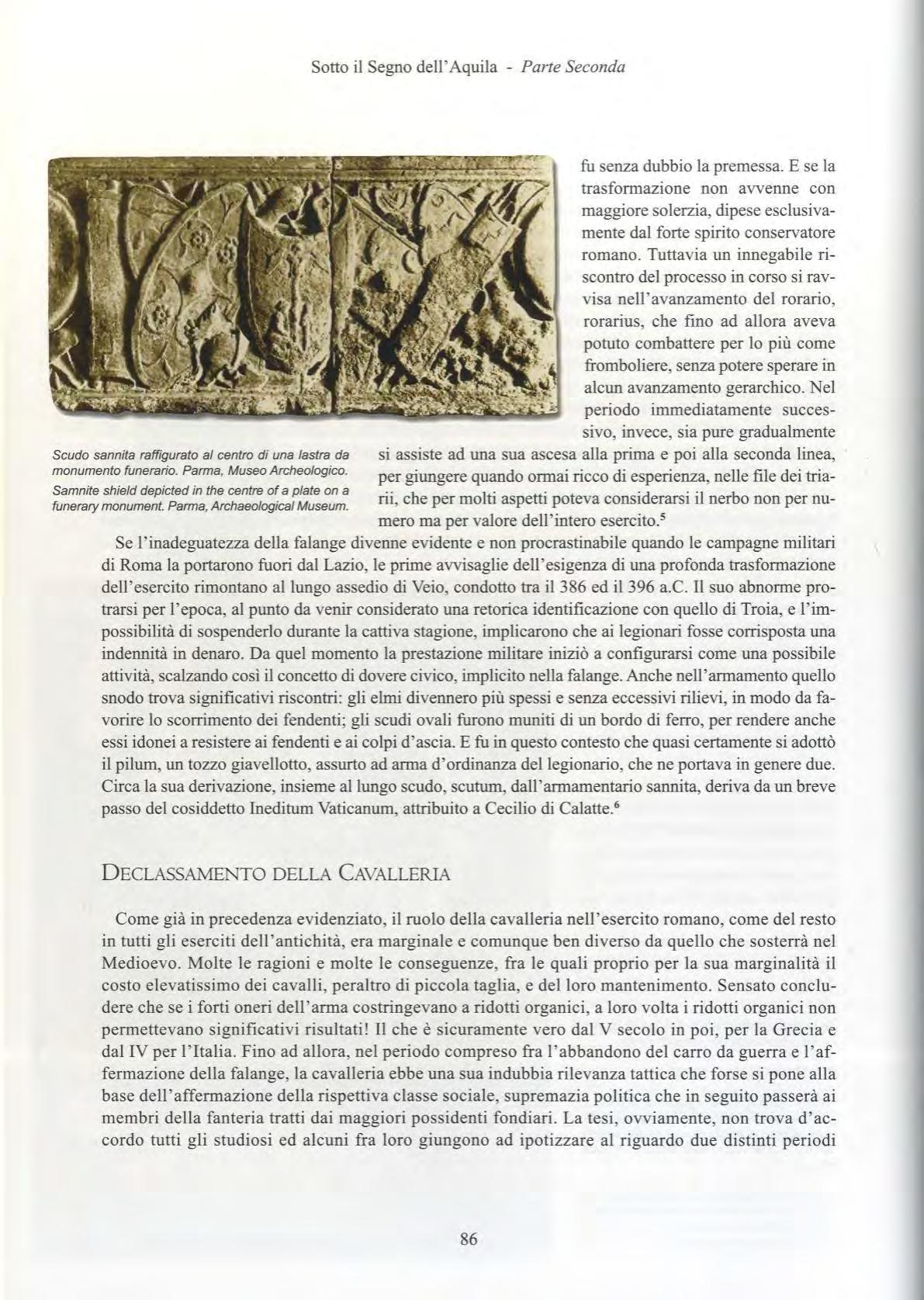
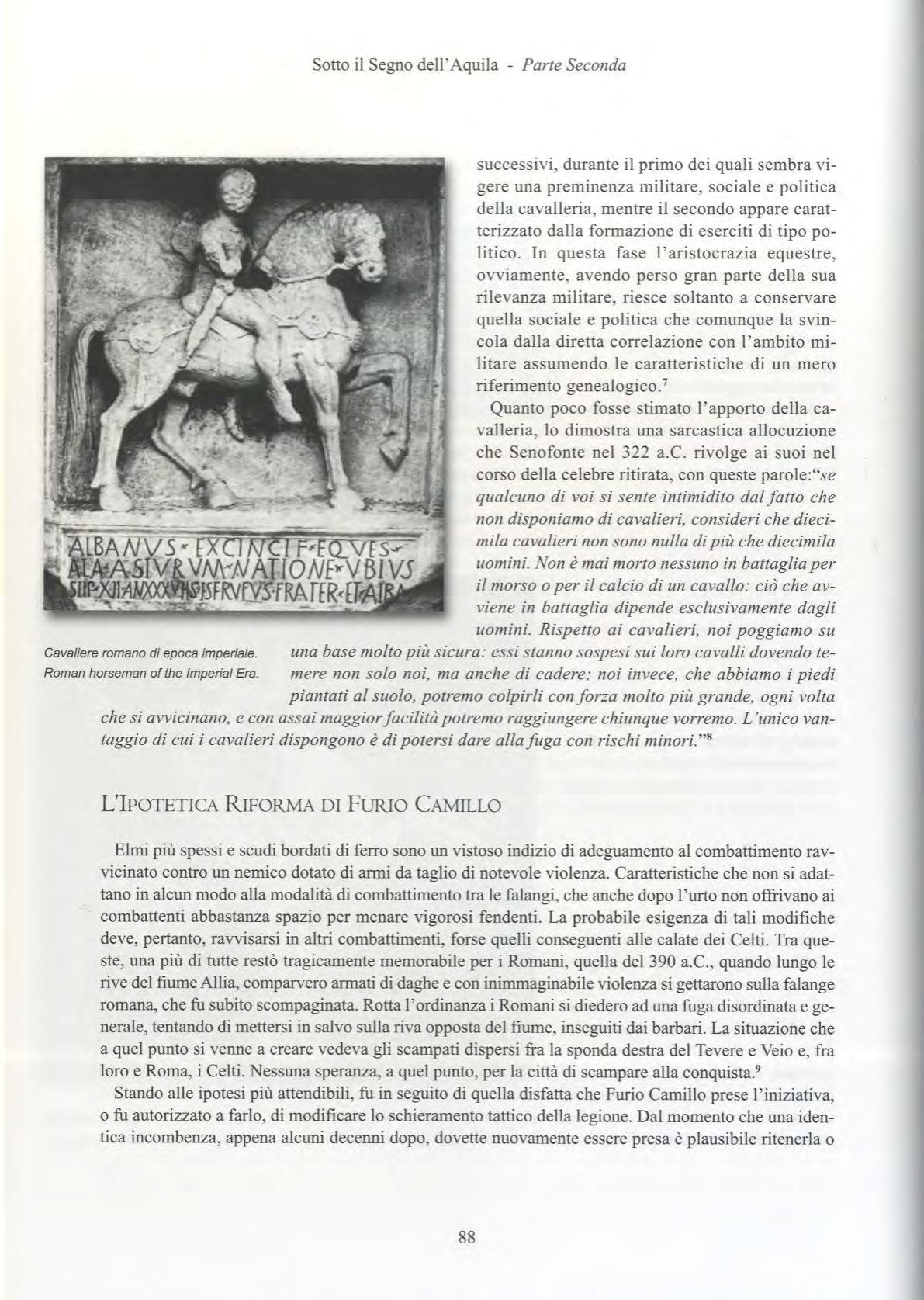
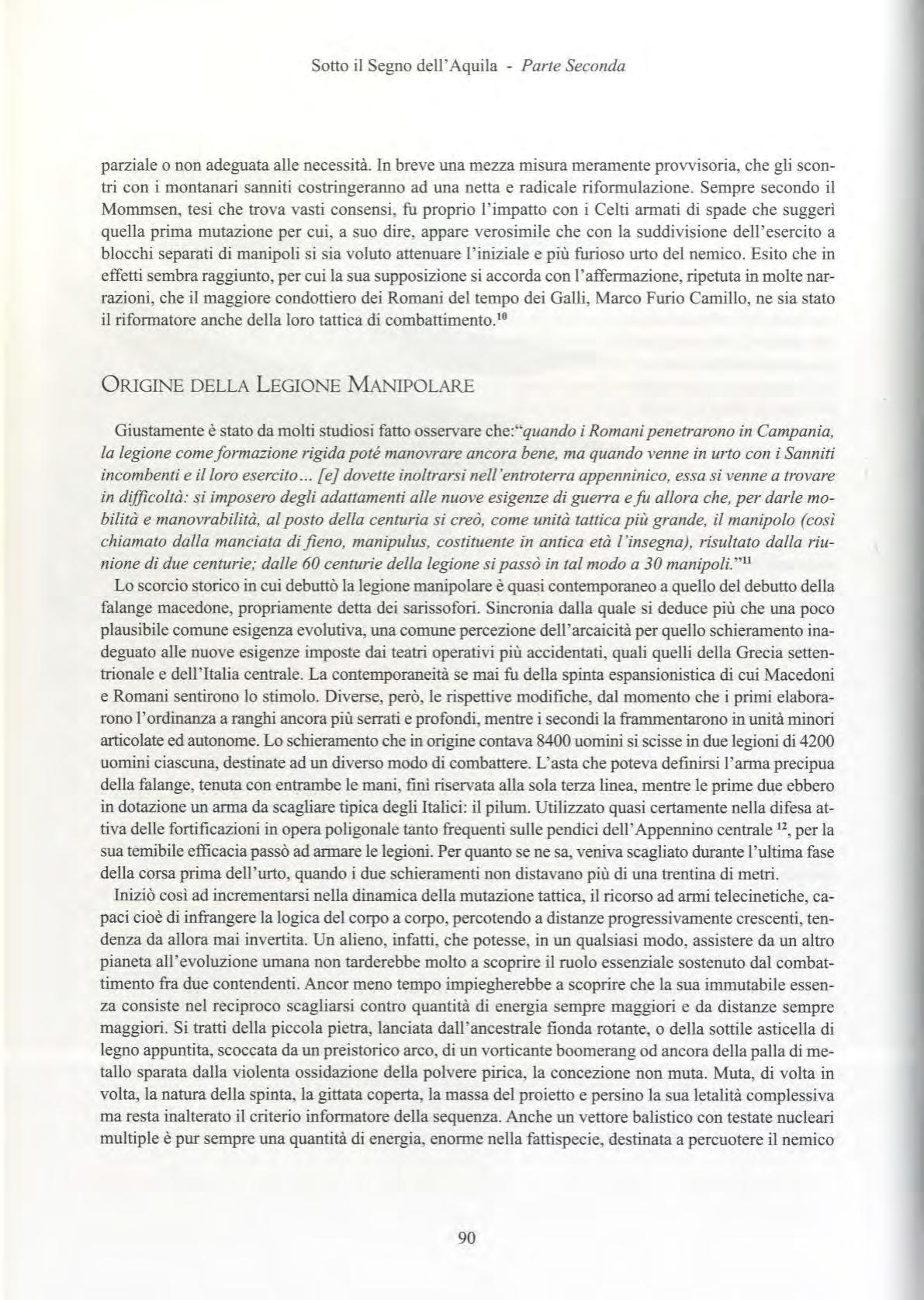
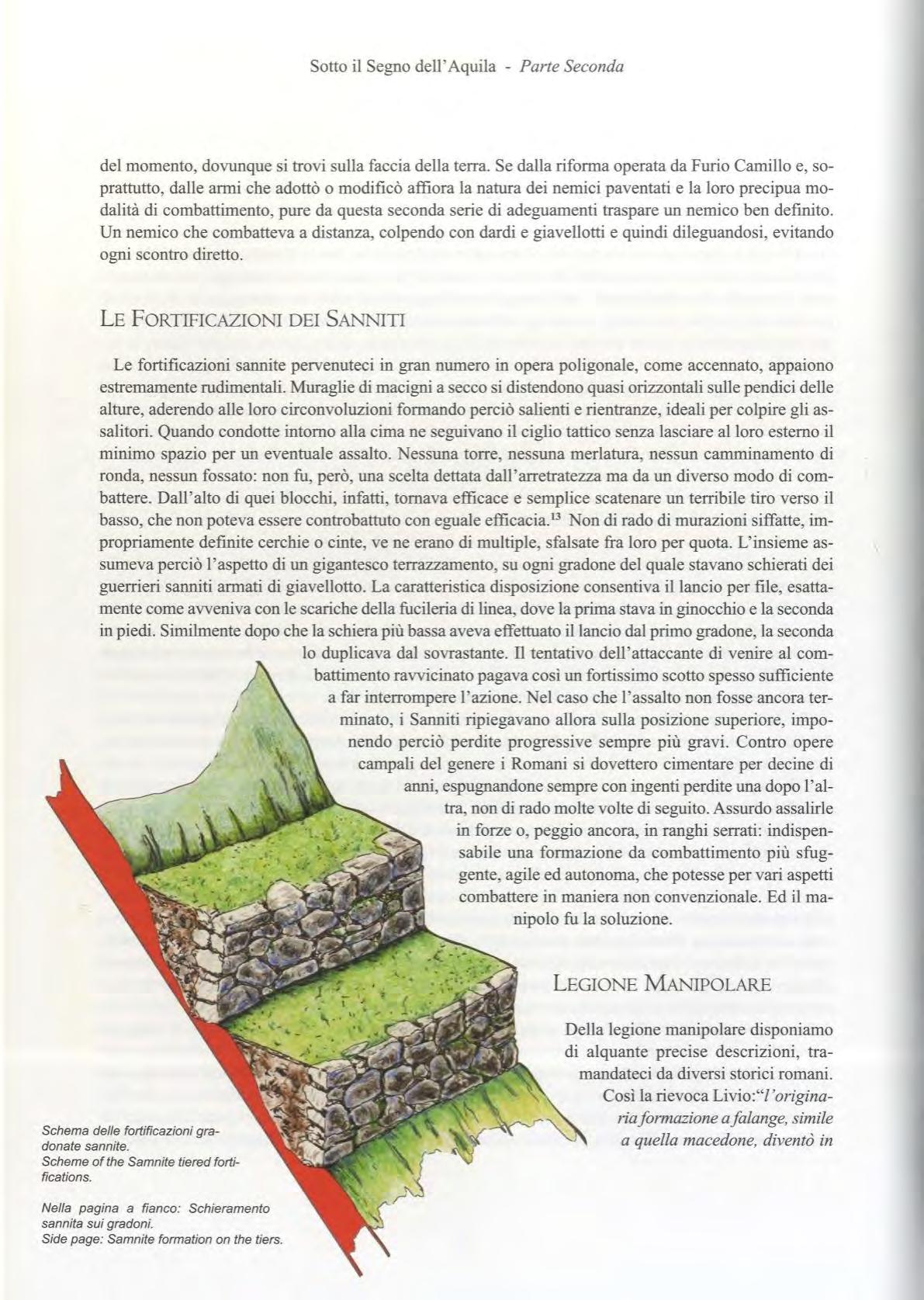
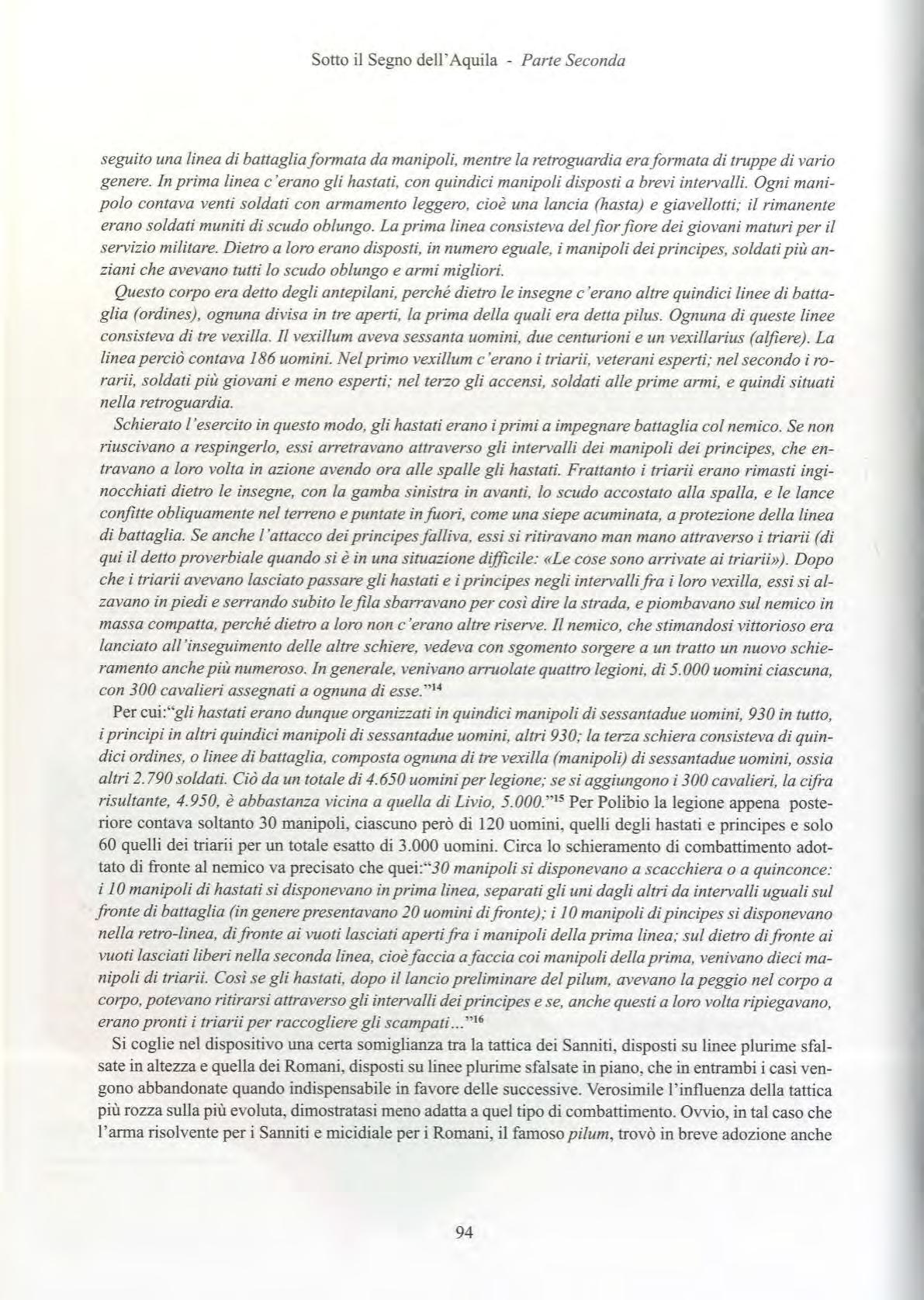
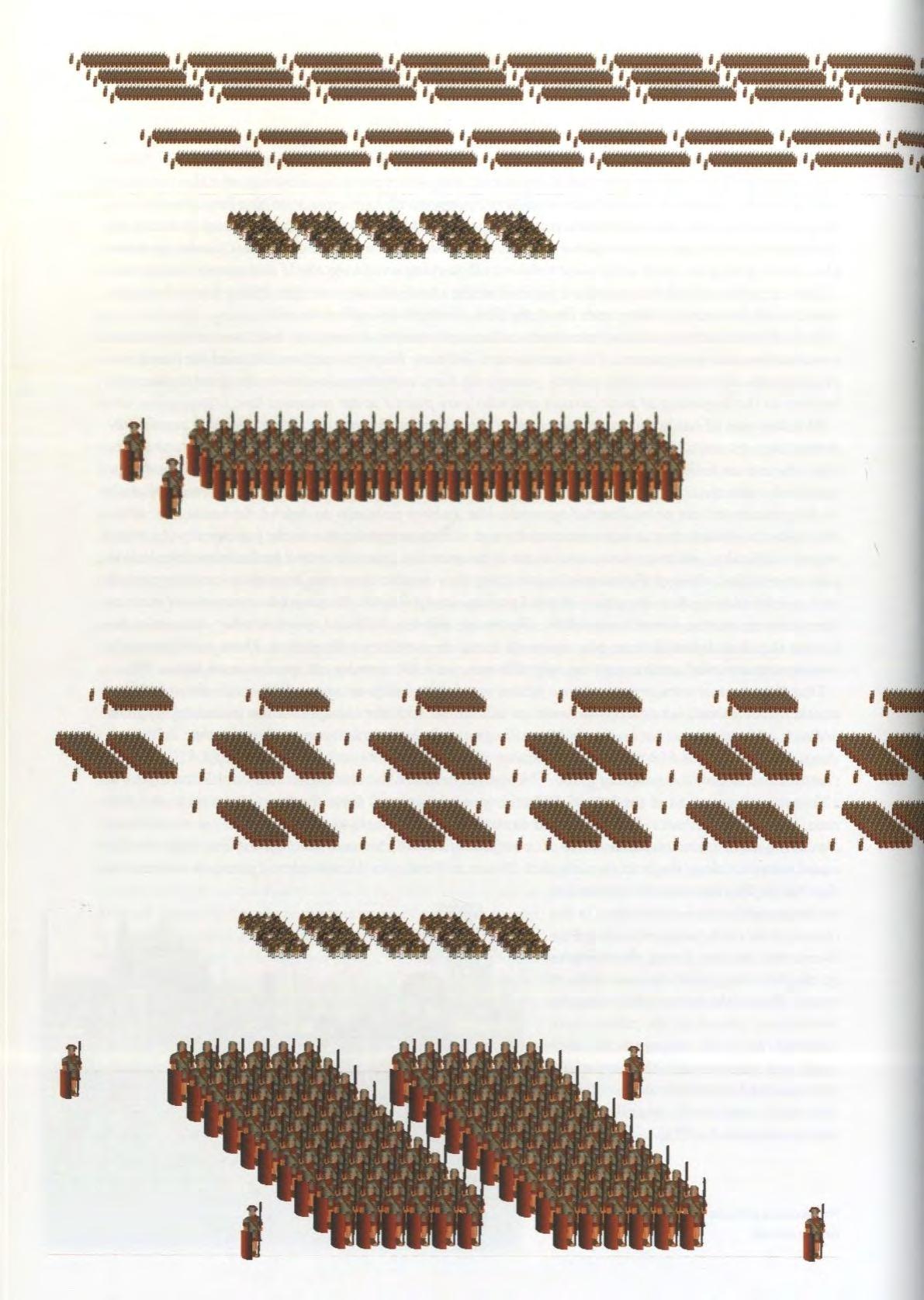
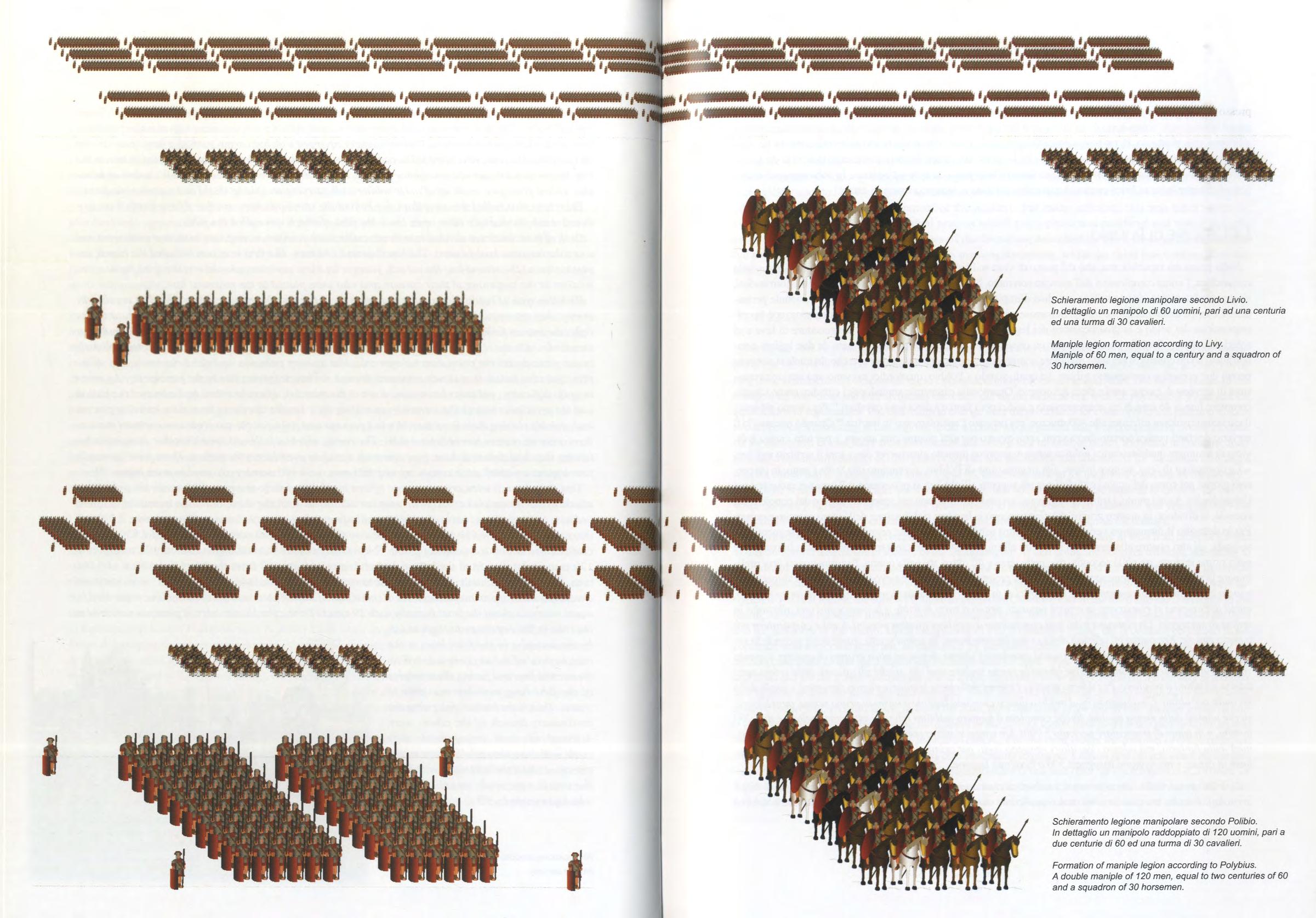

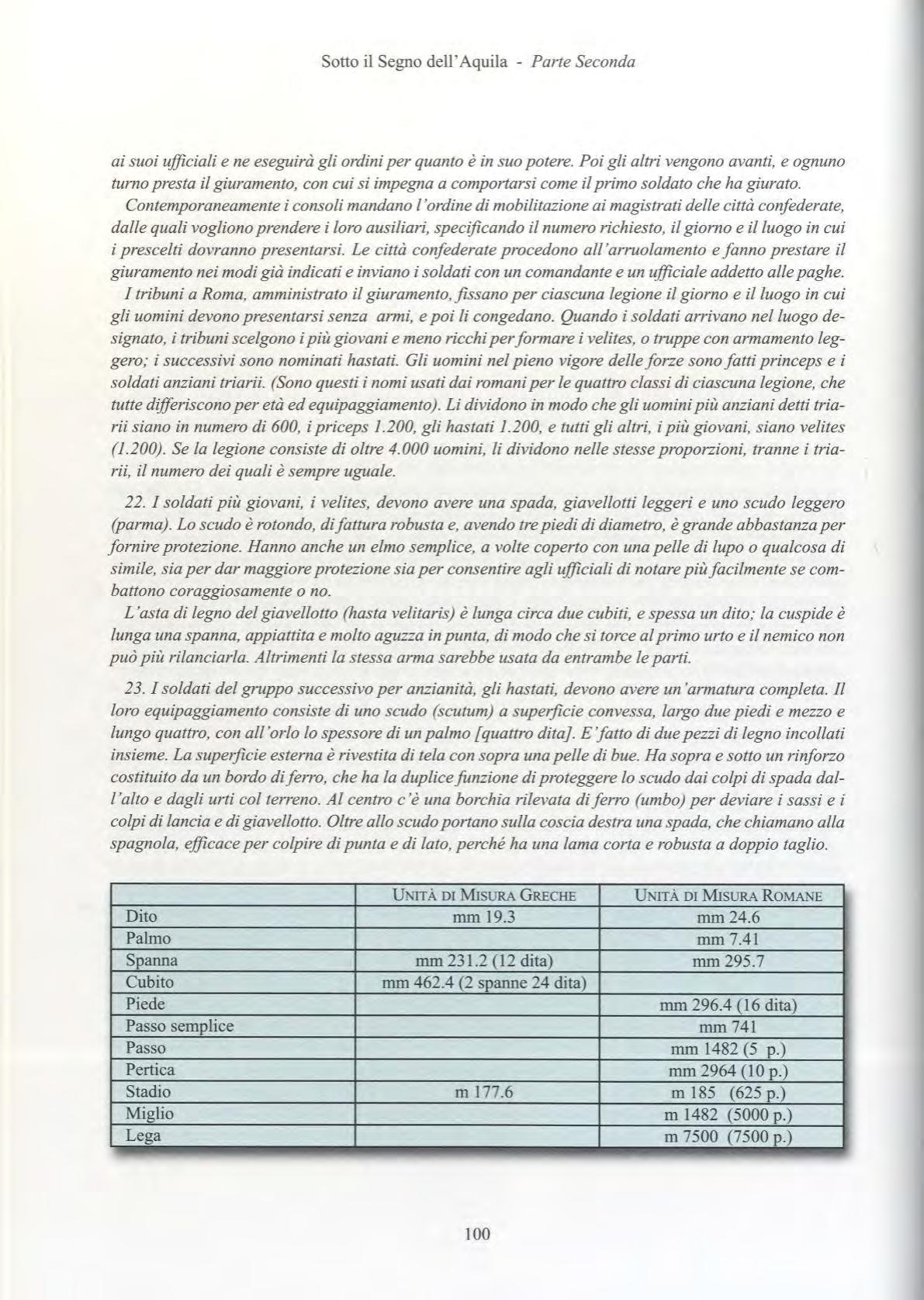
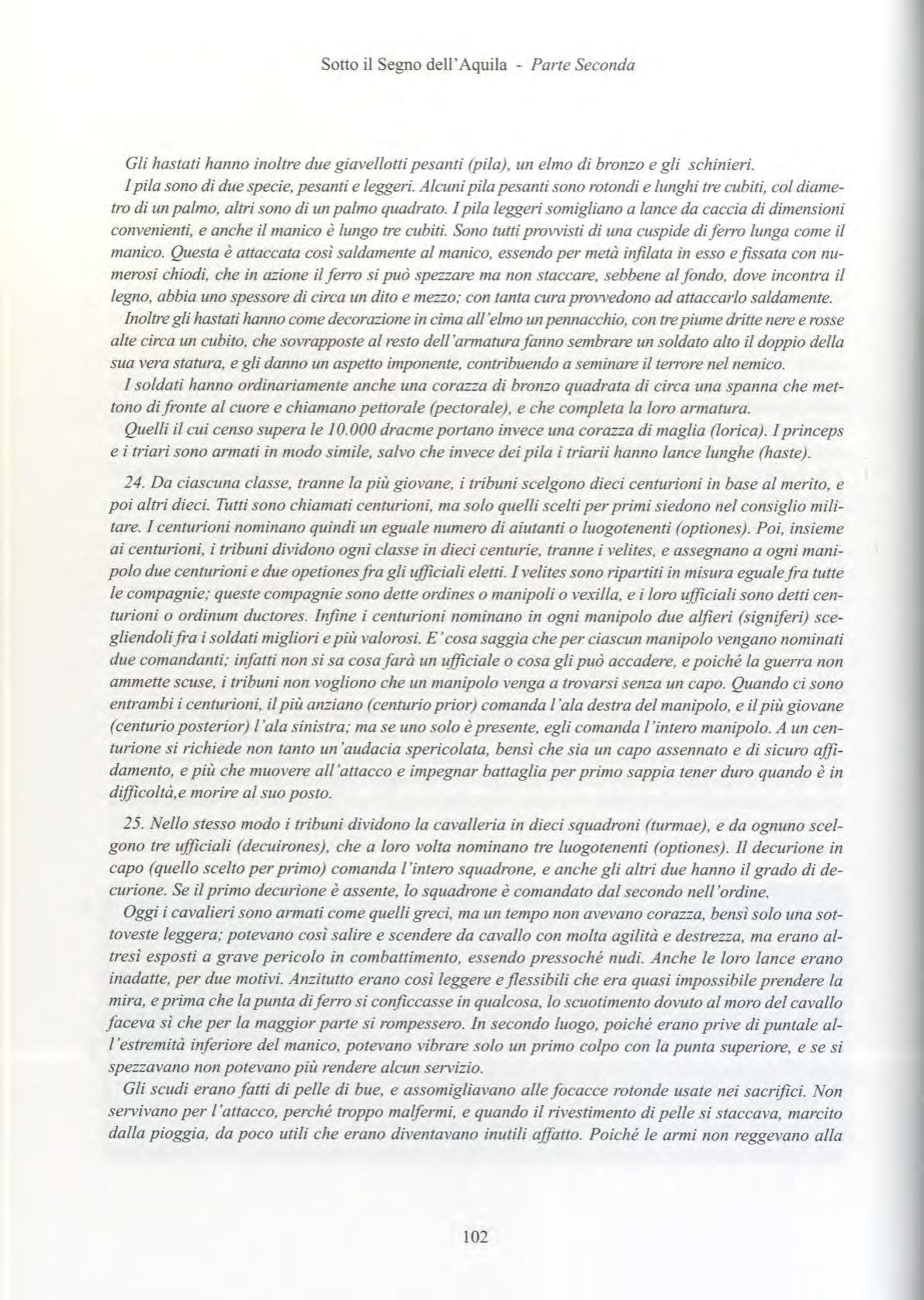

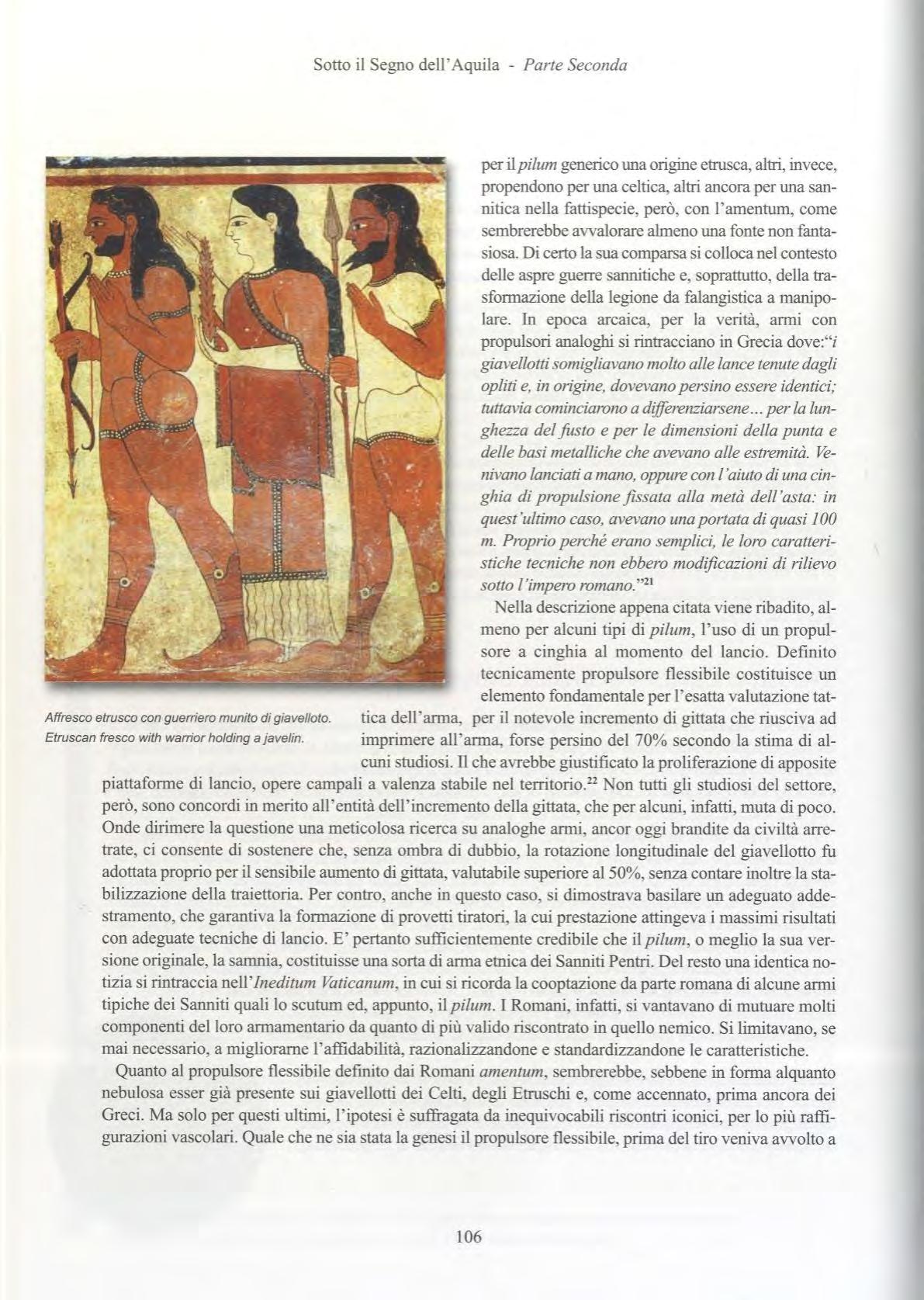
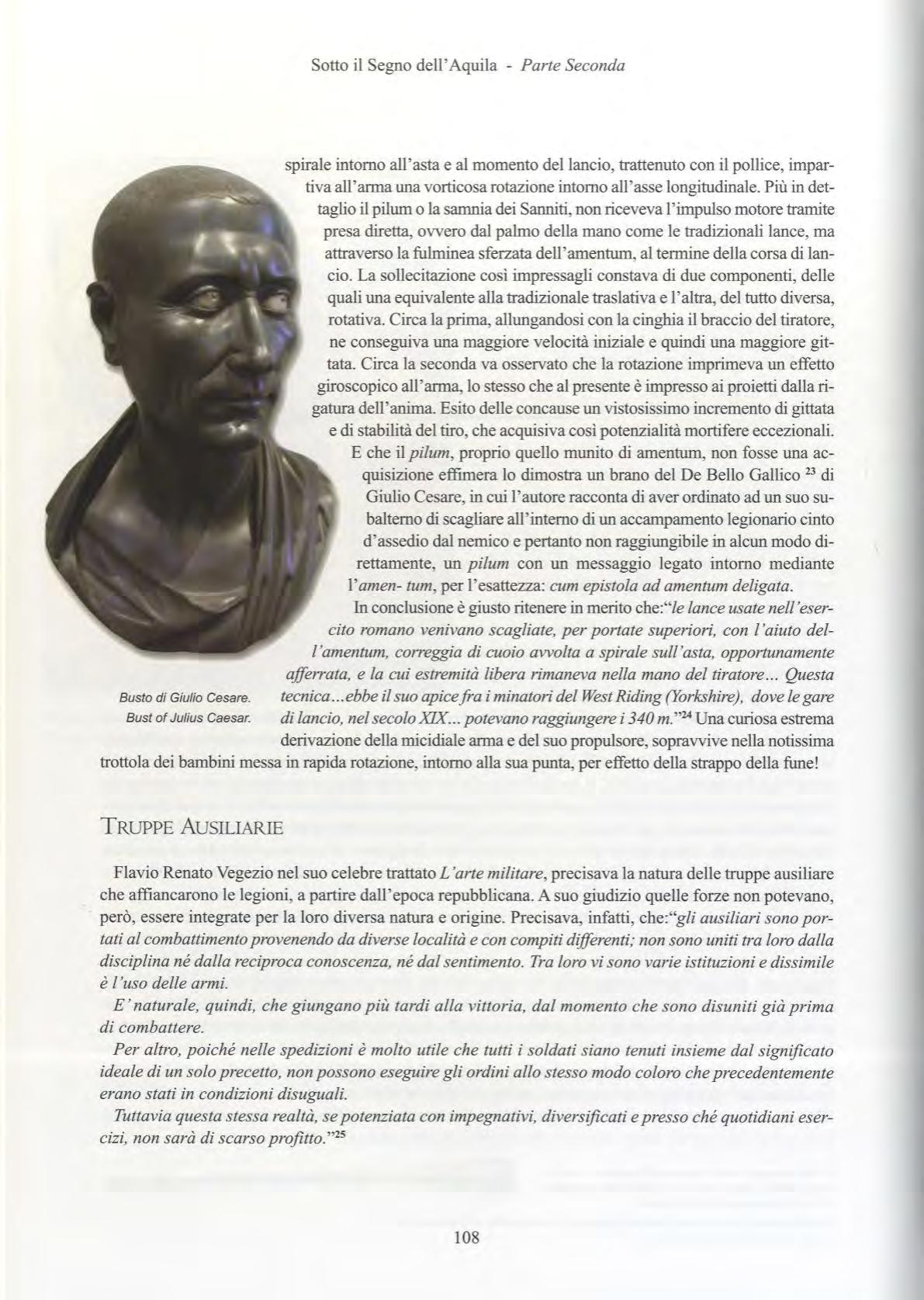

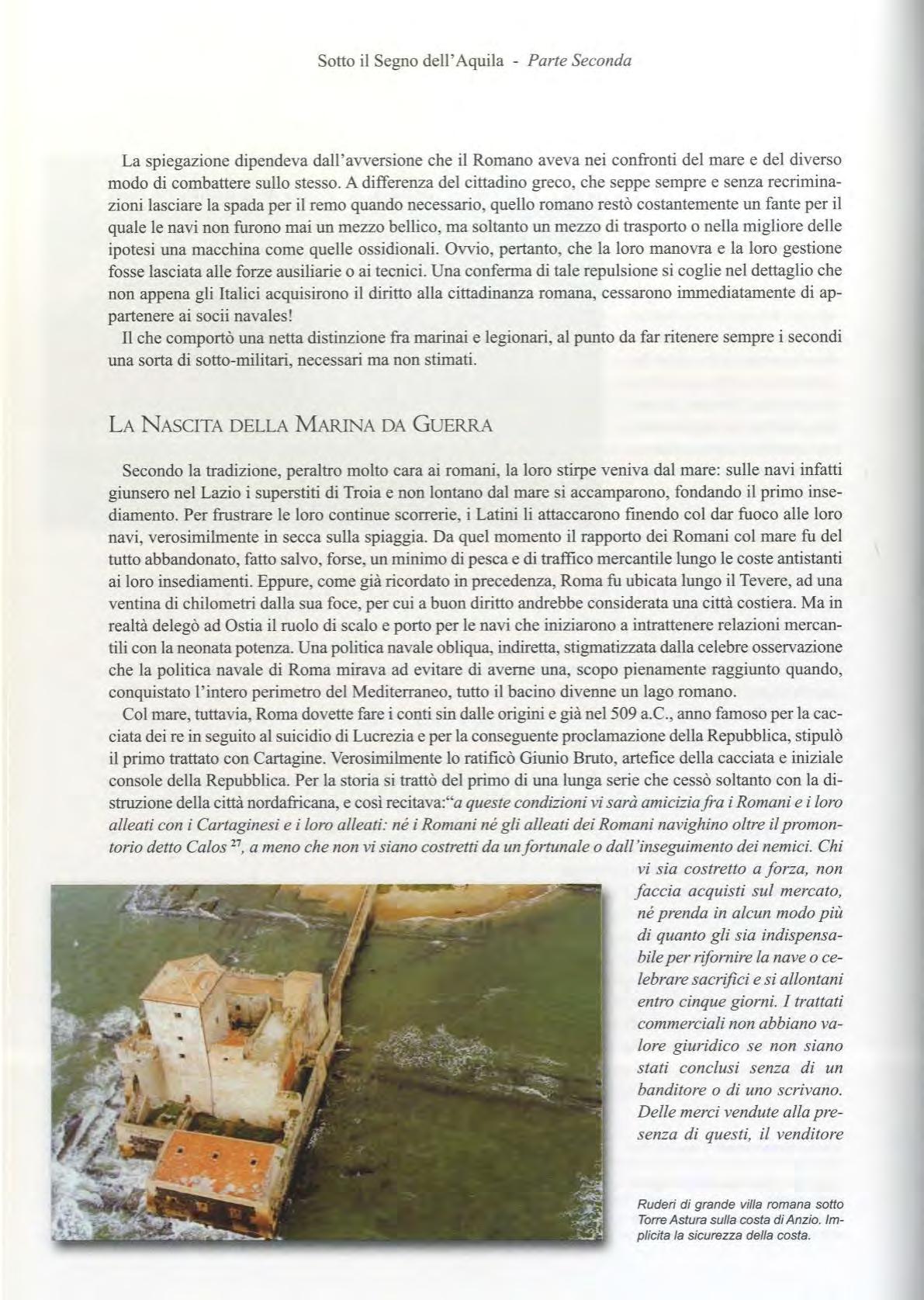
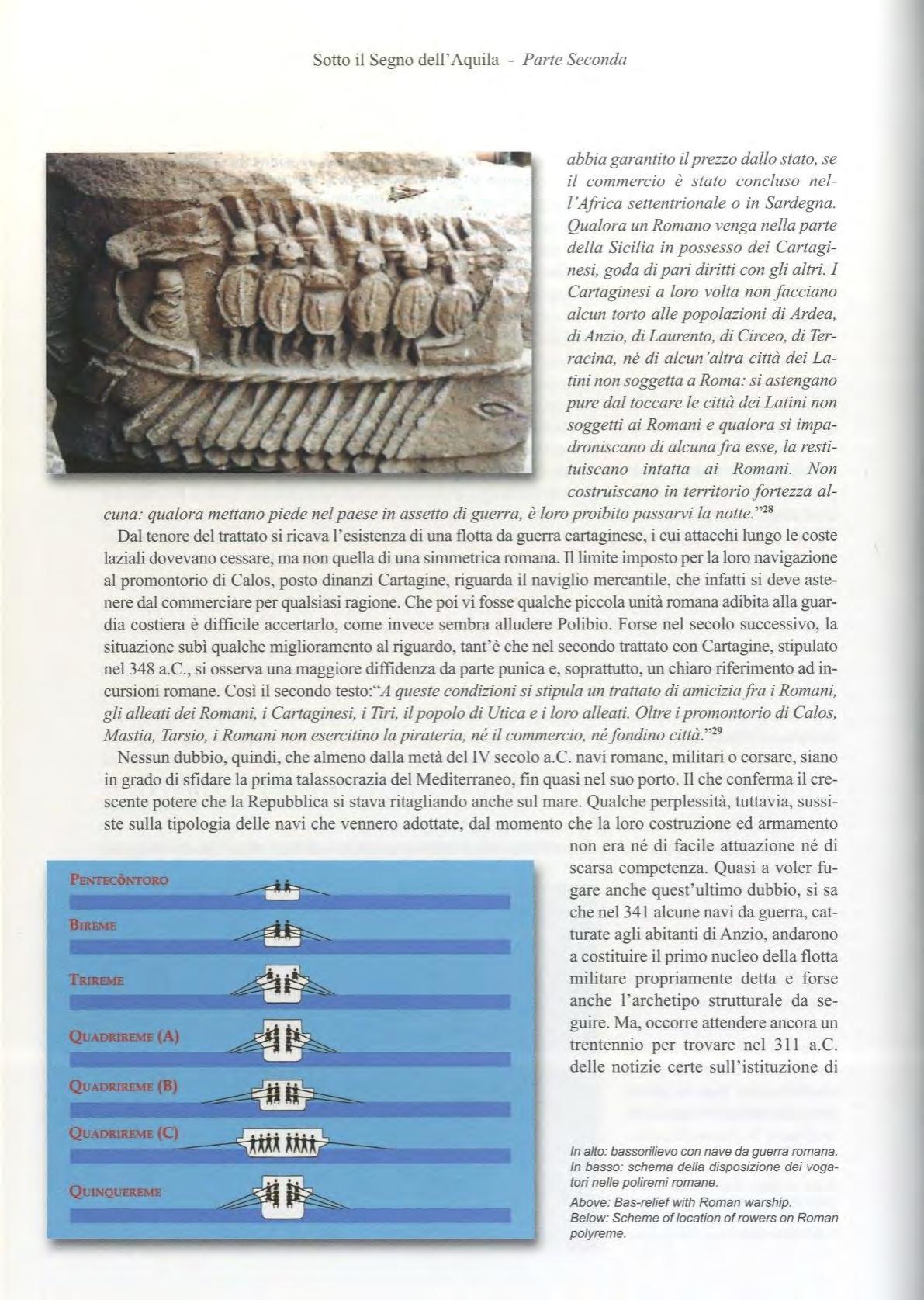
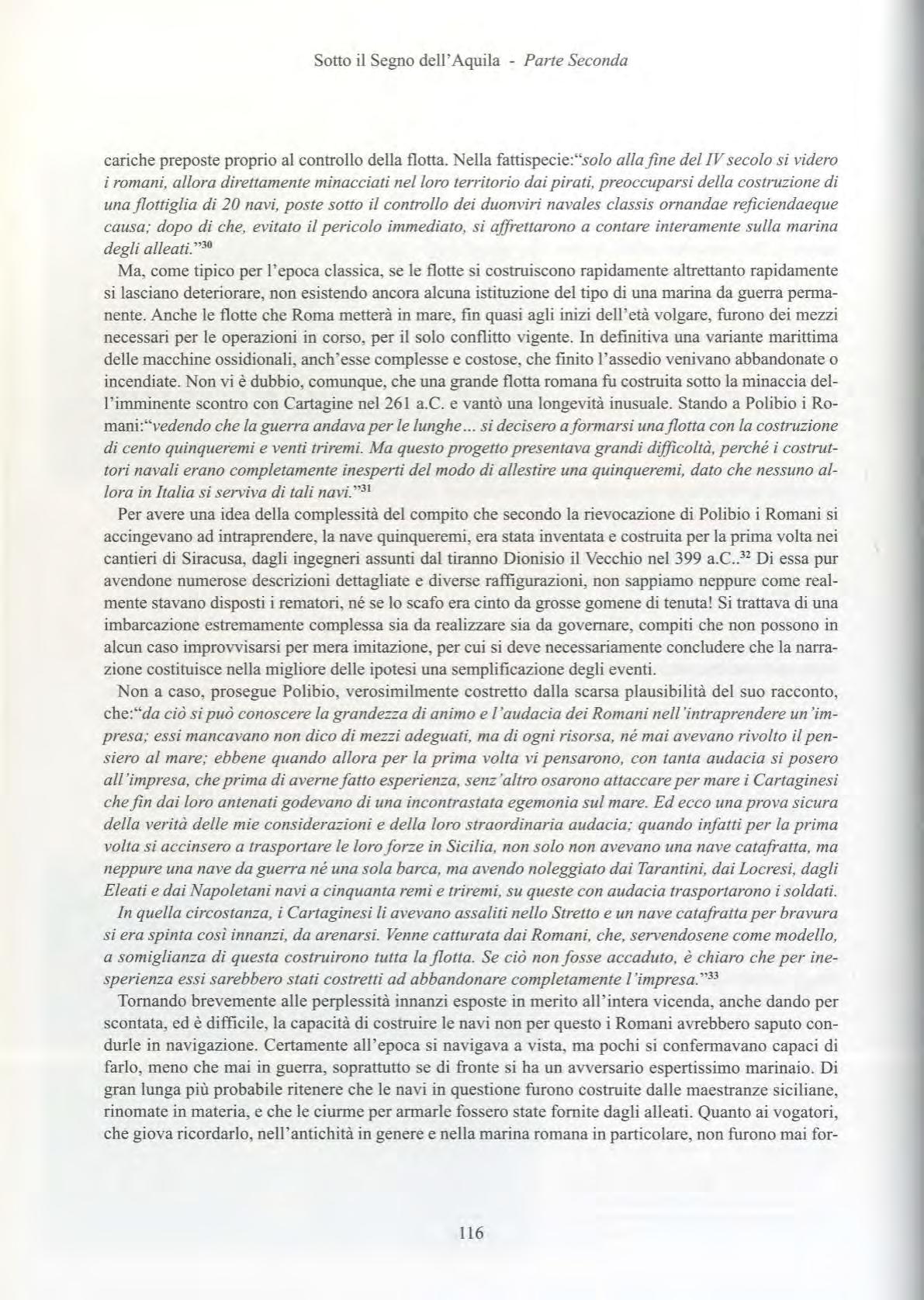

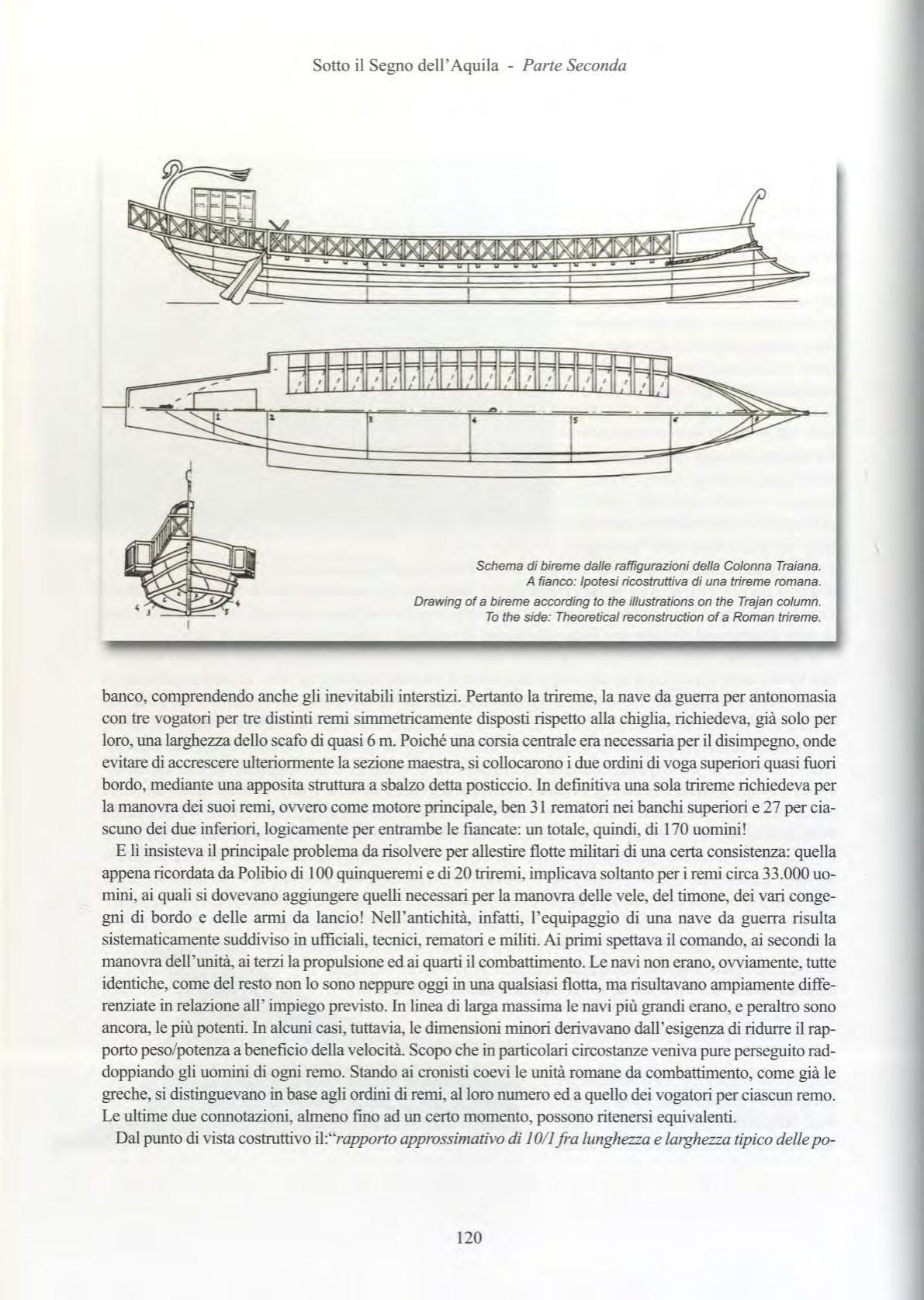
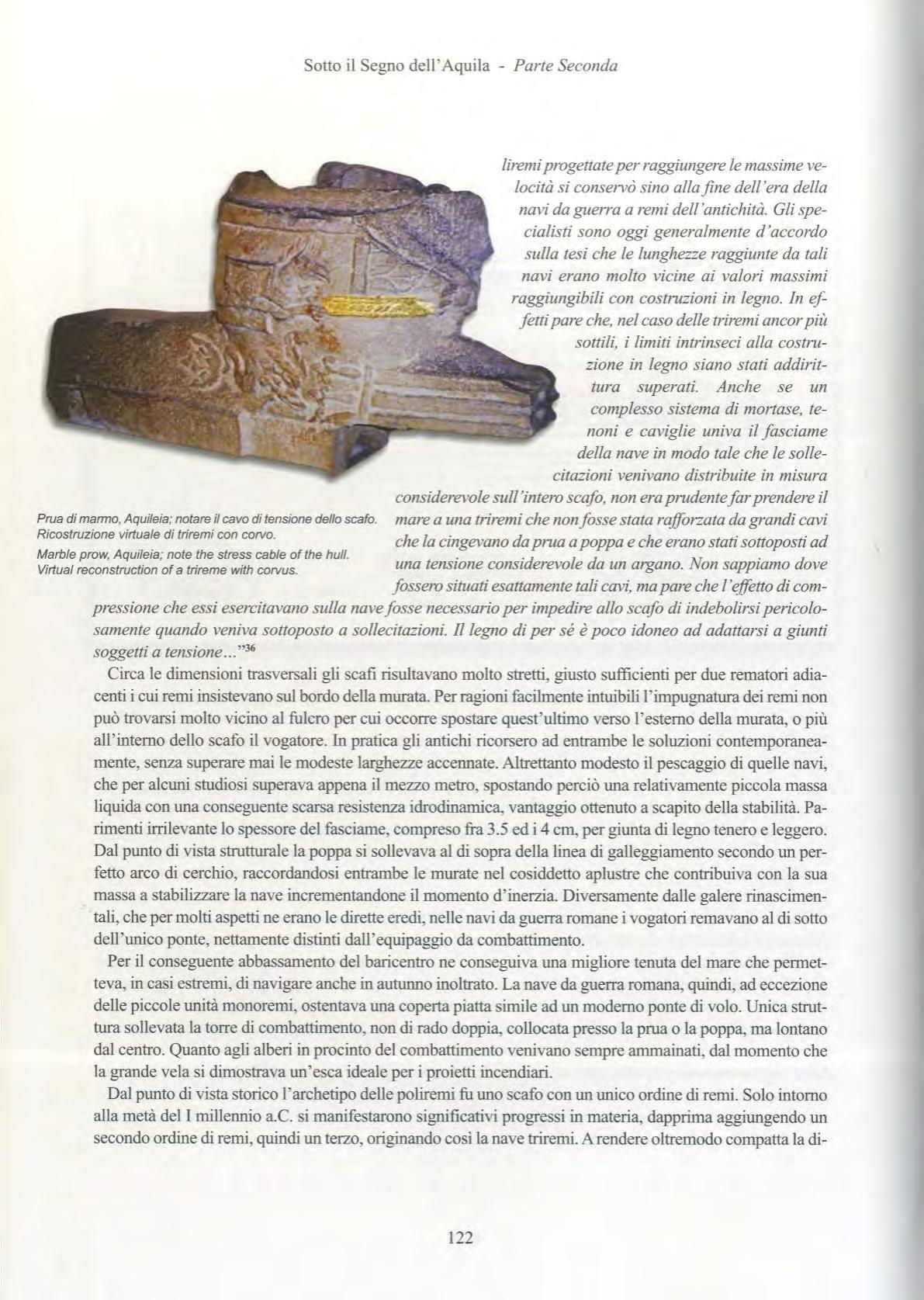
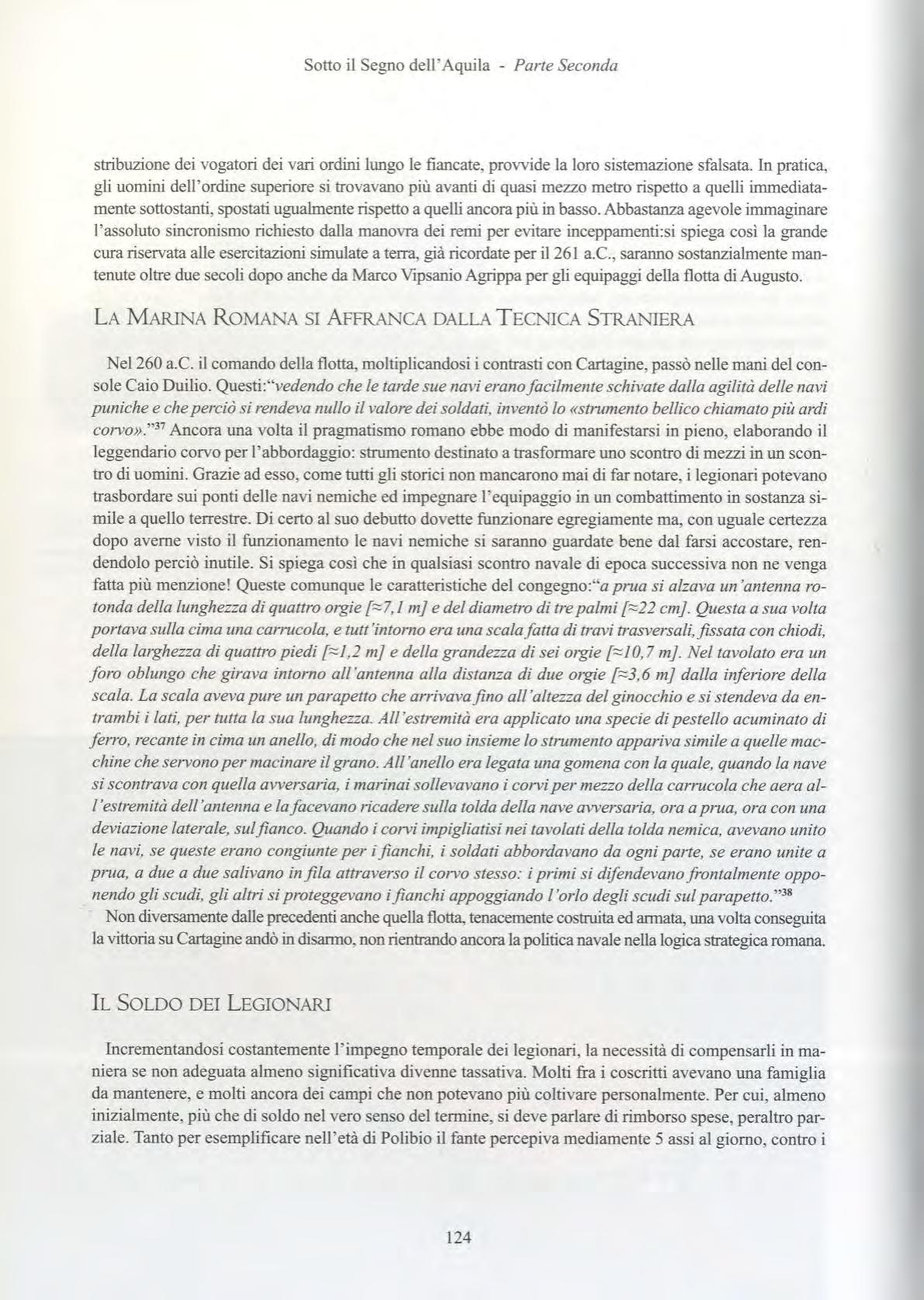
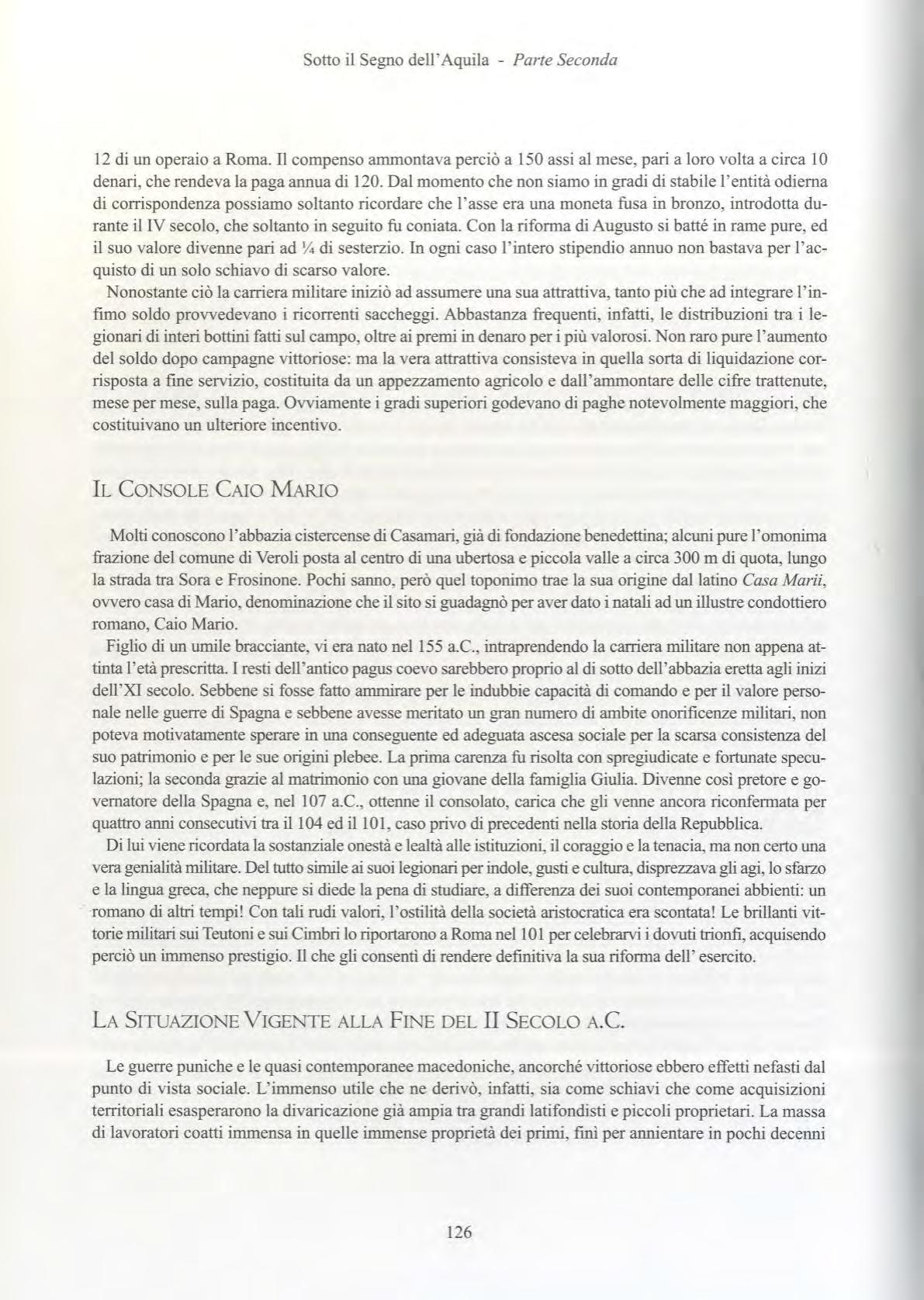

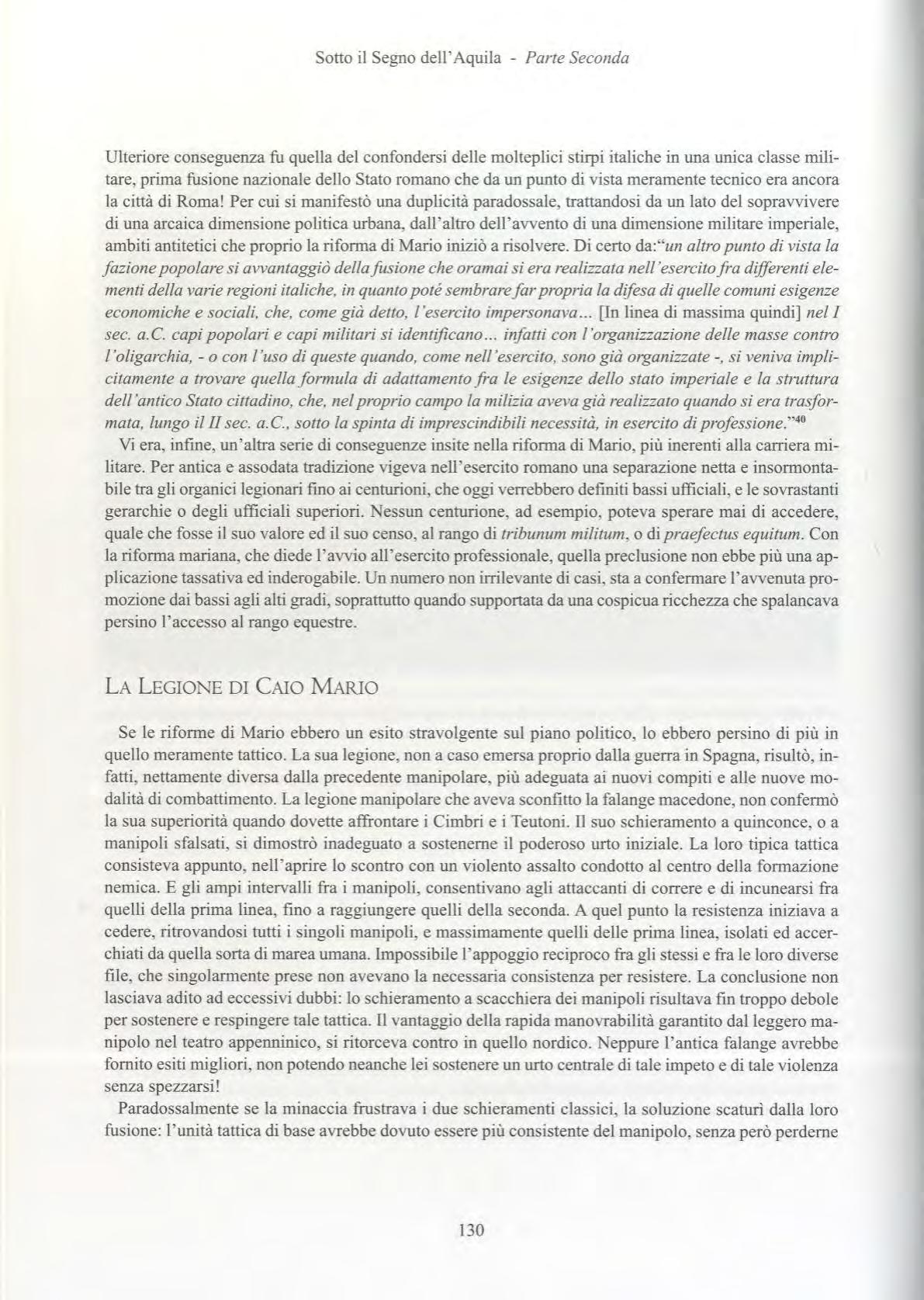
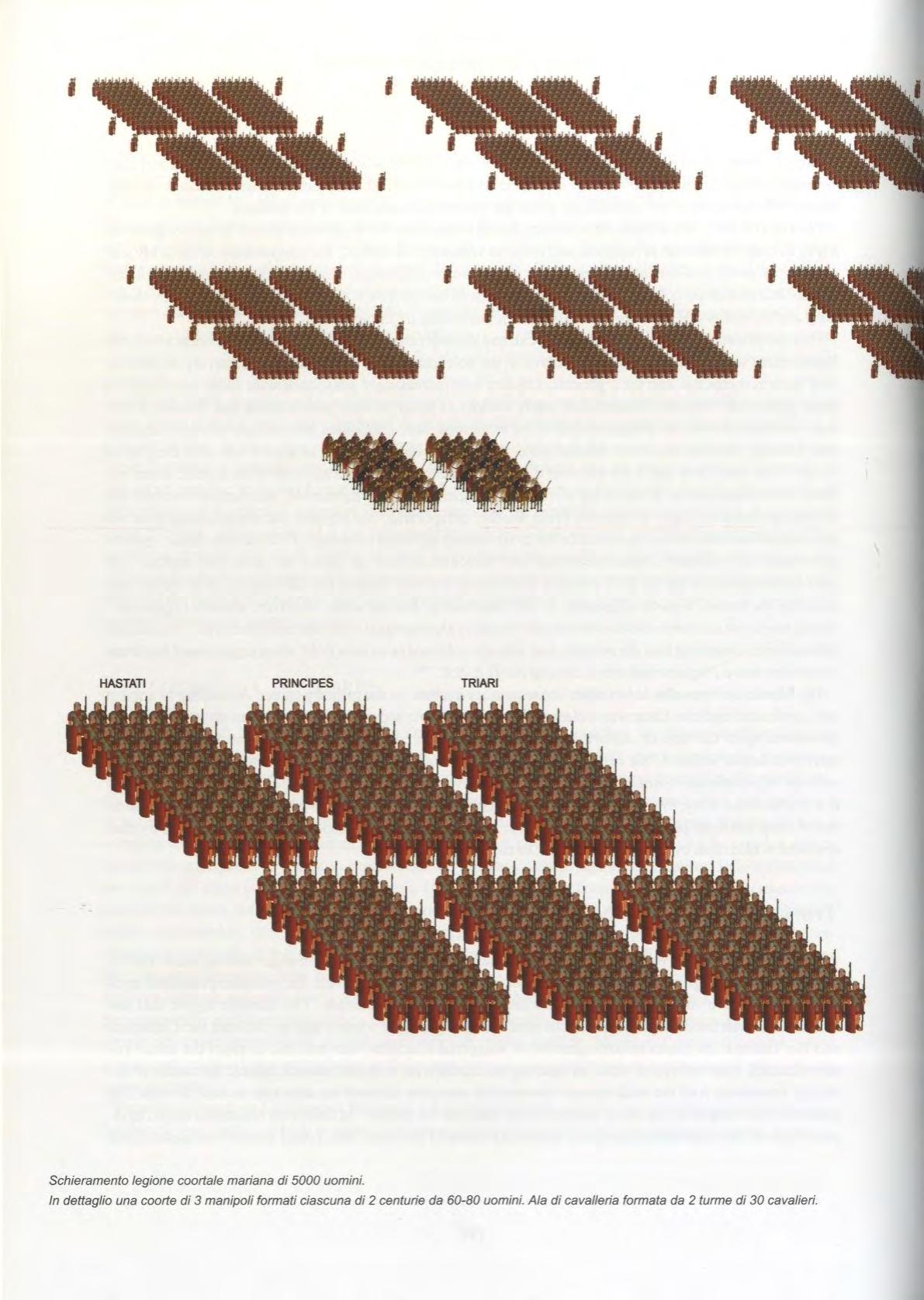 Ala dicavalleriafumata da 2 tumie di30cavalieri.
Ala dicavalleriafumata da 2 tumie di30cavalieri.
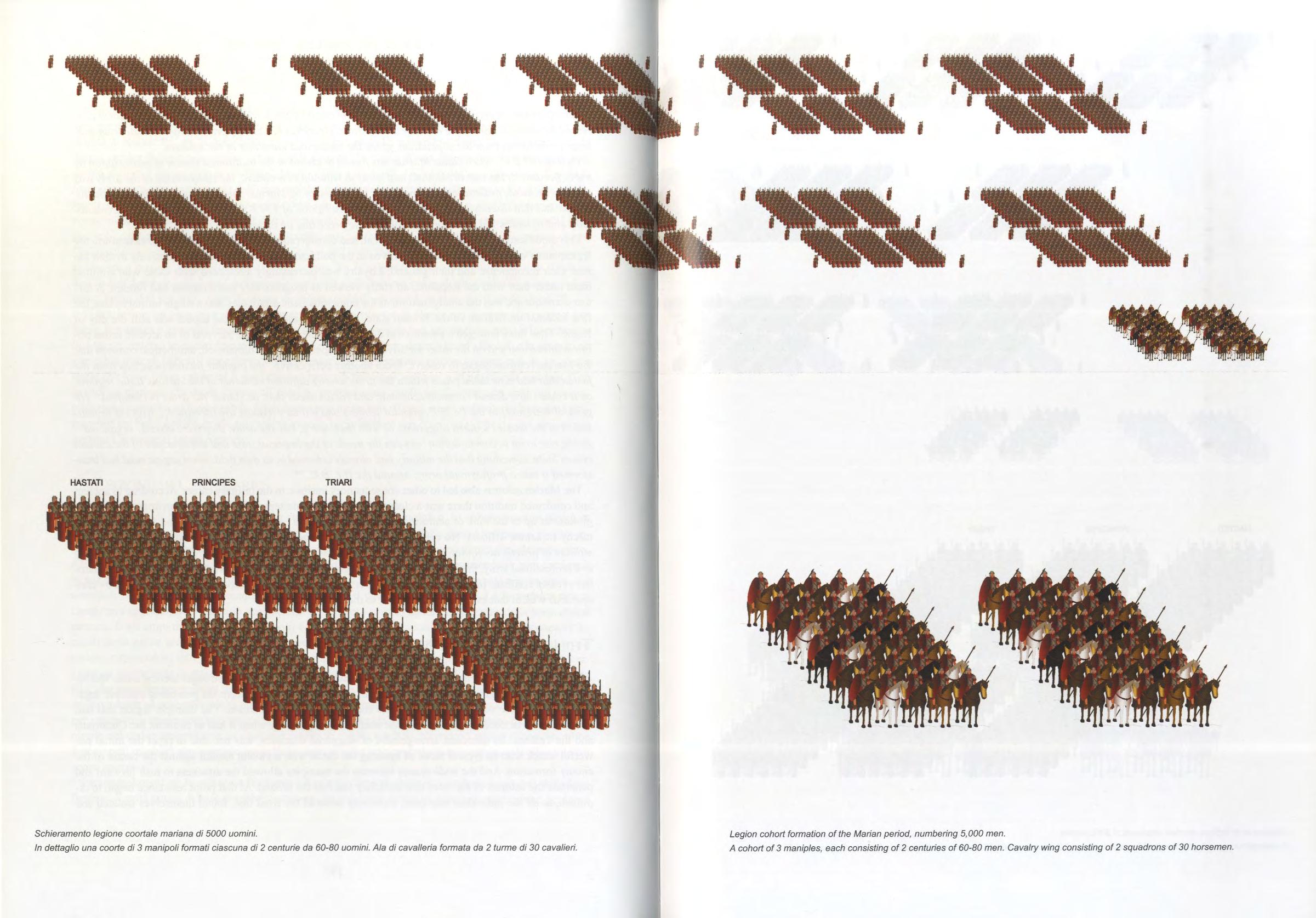
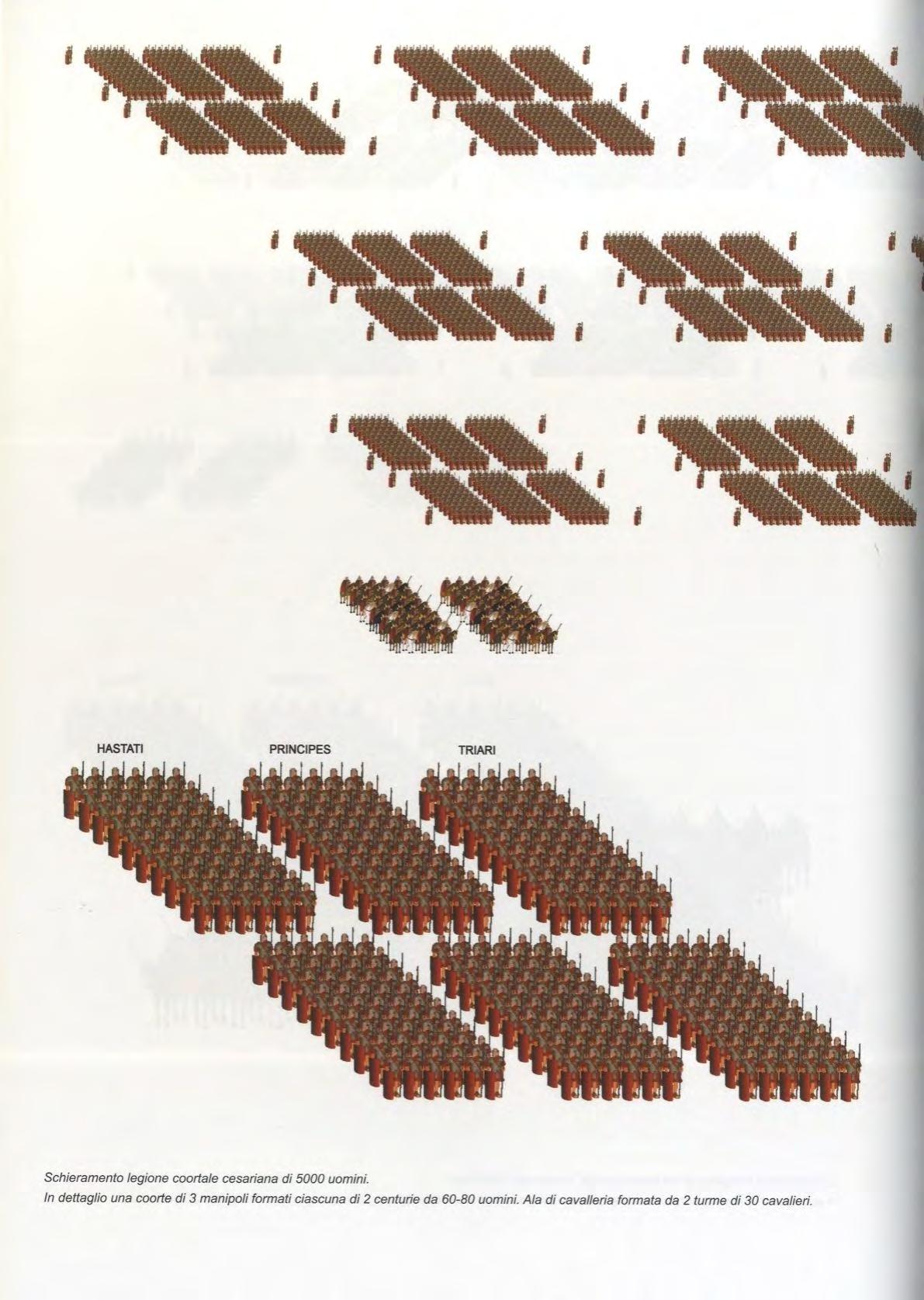
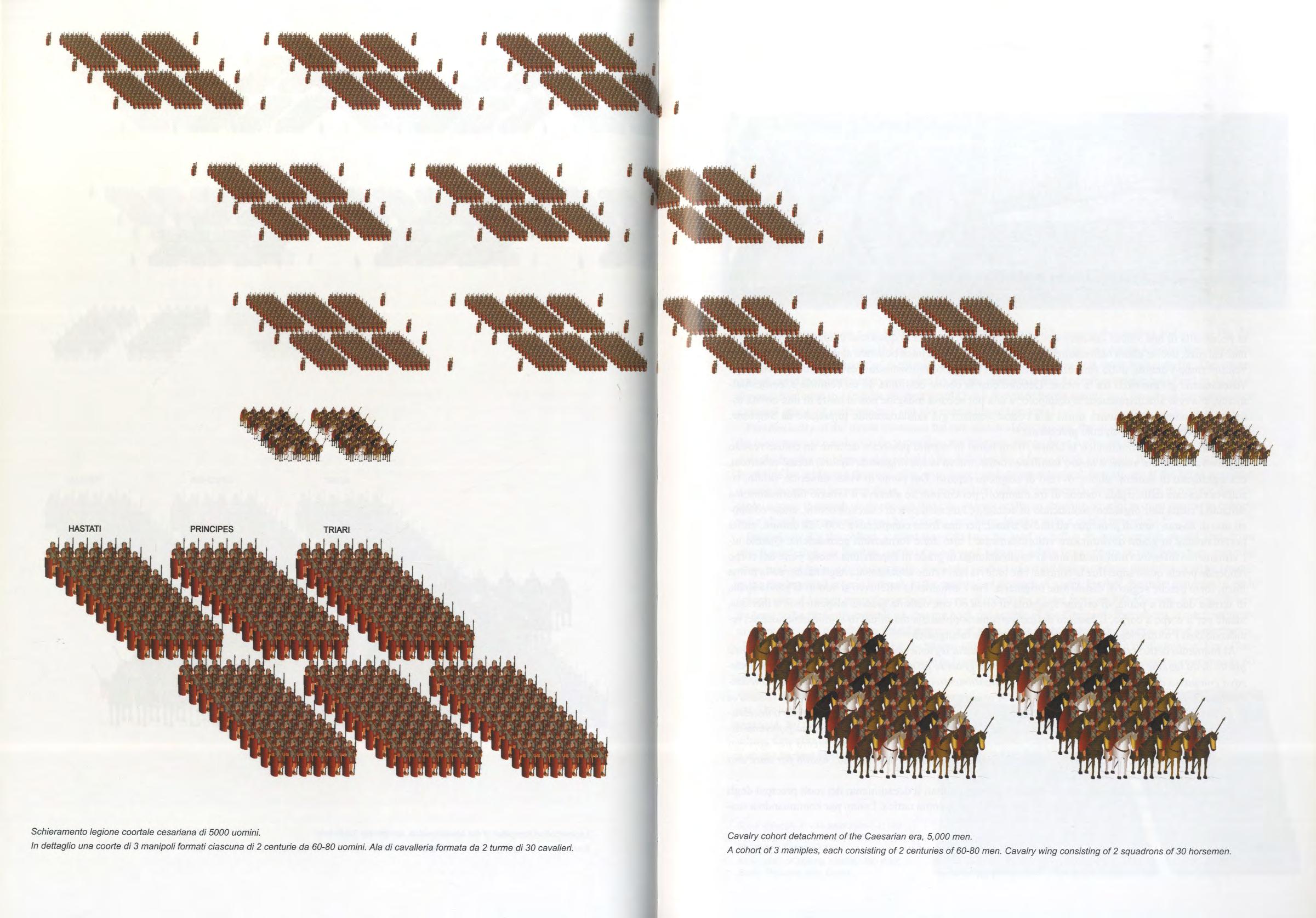
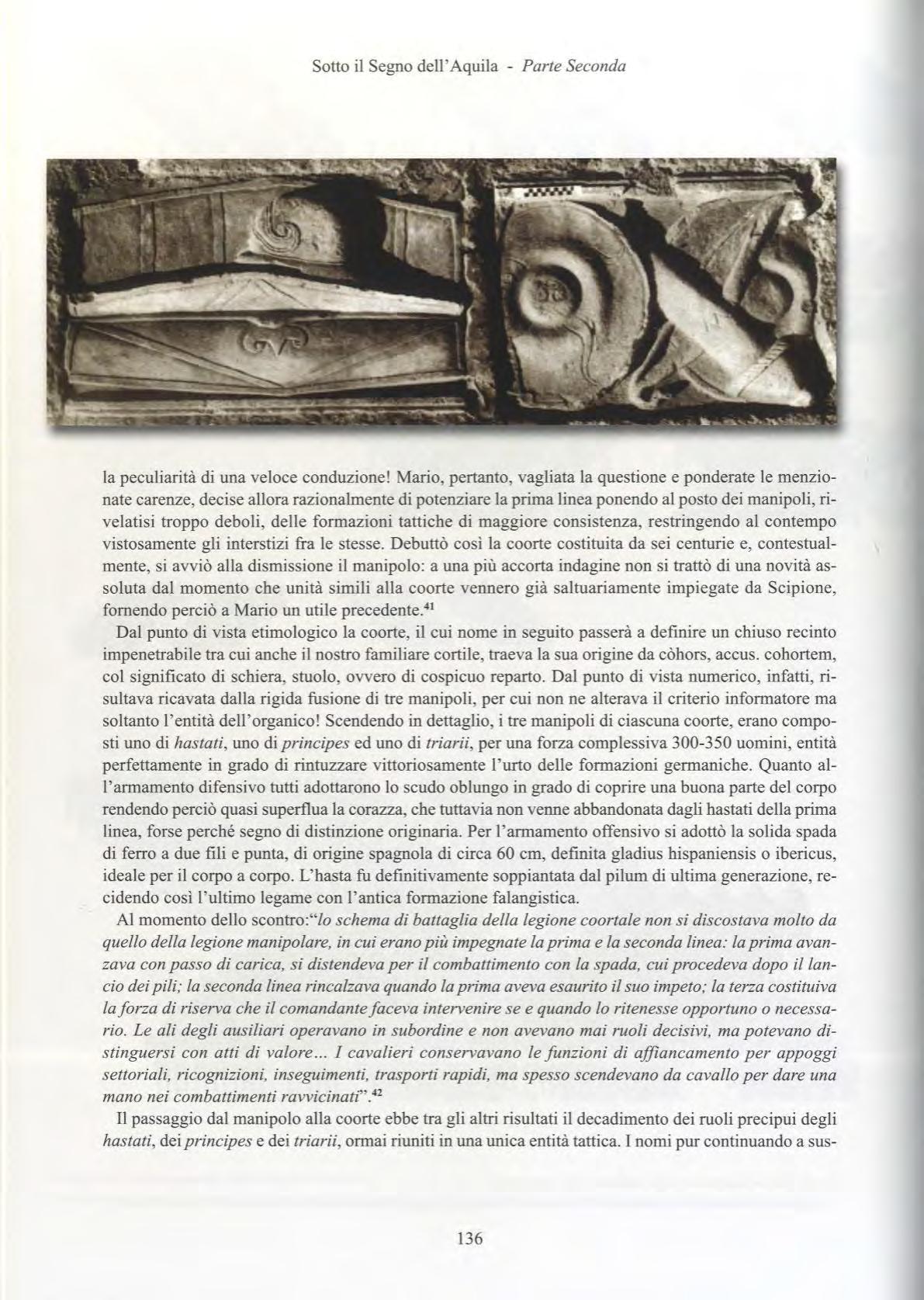
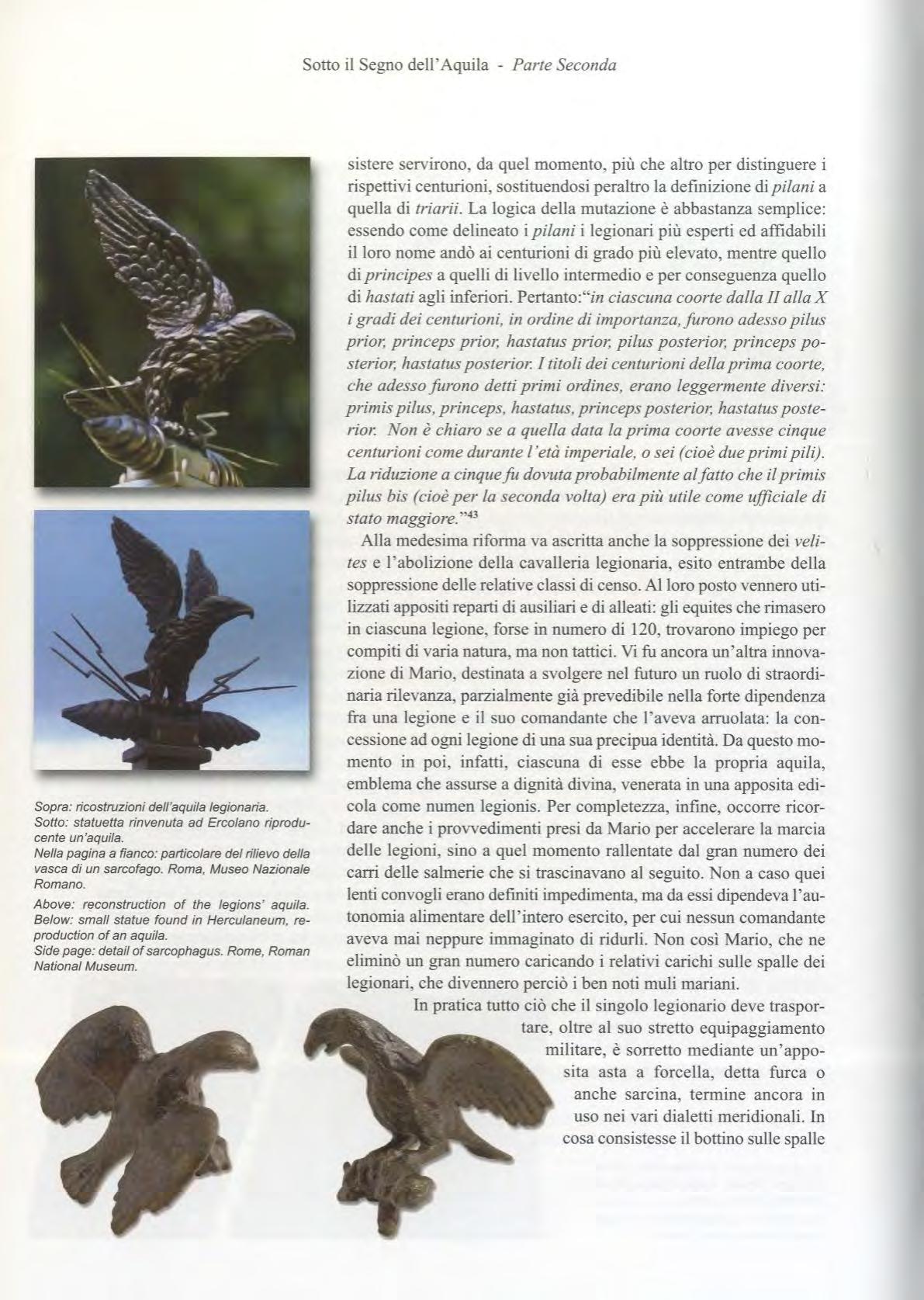

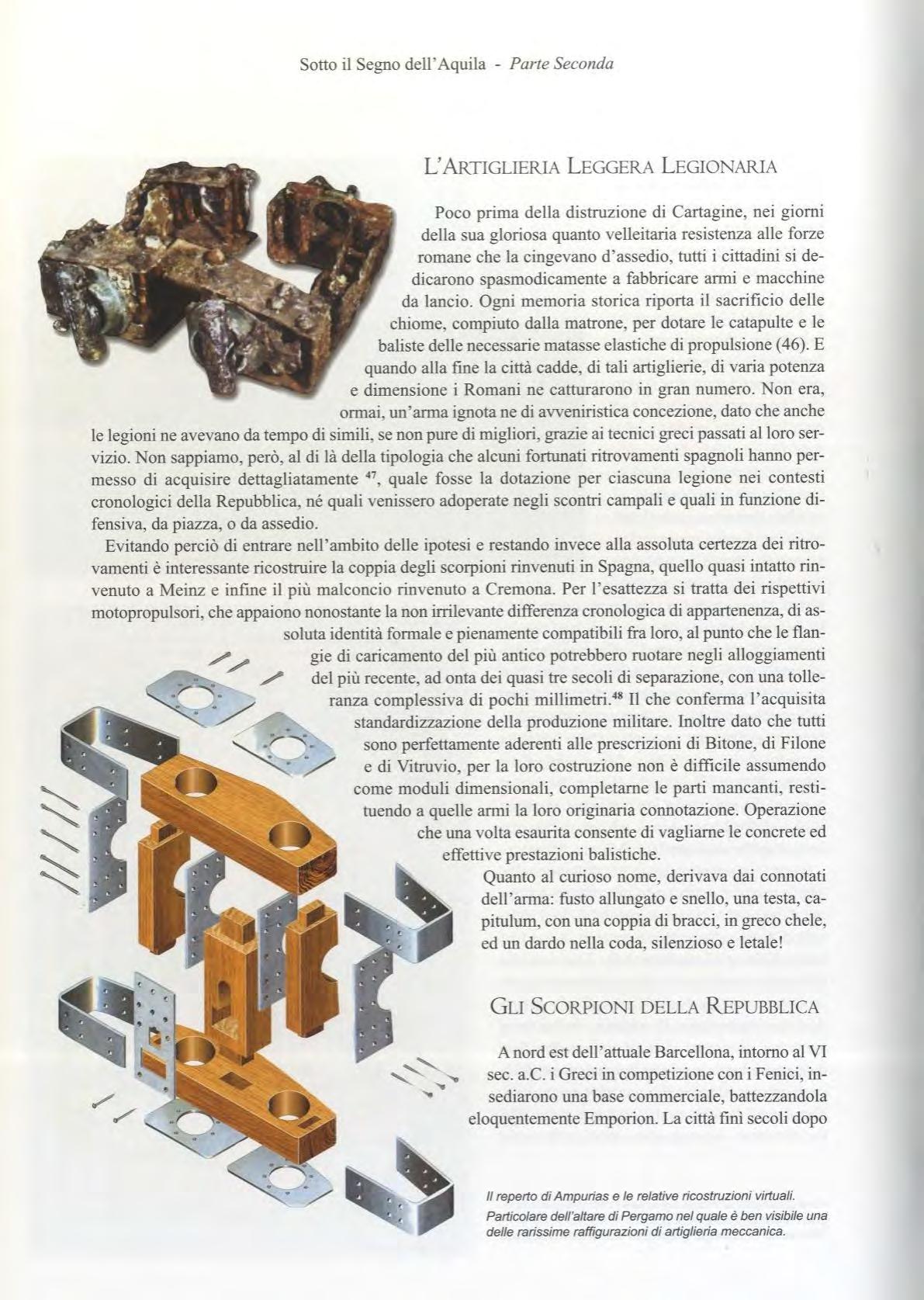
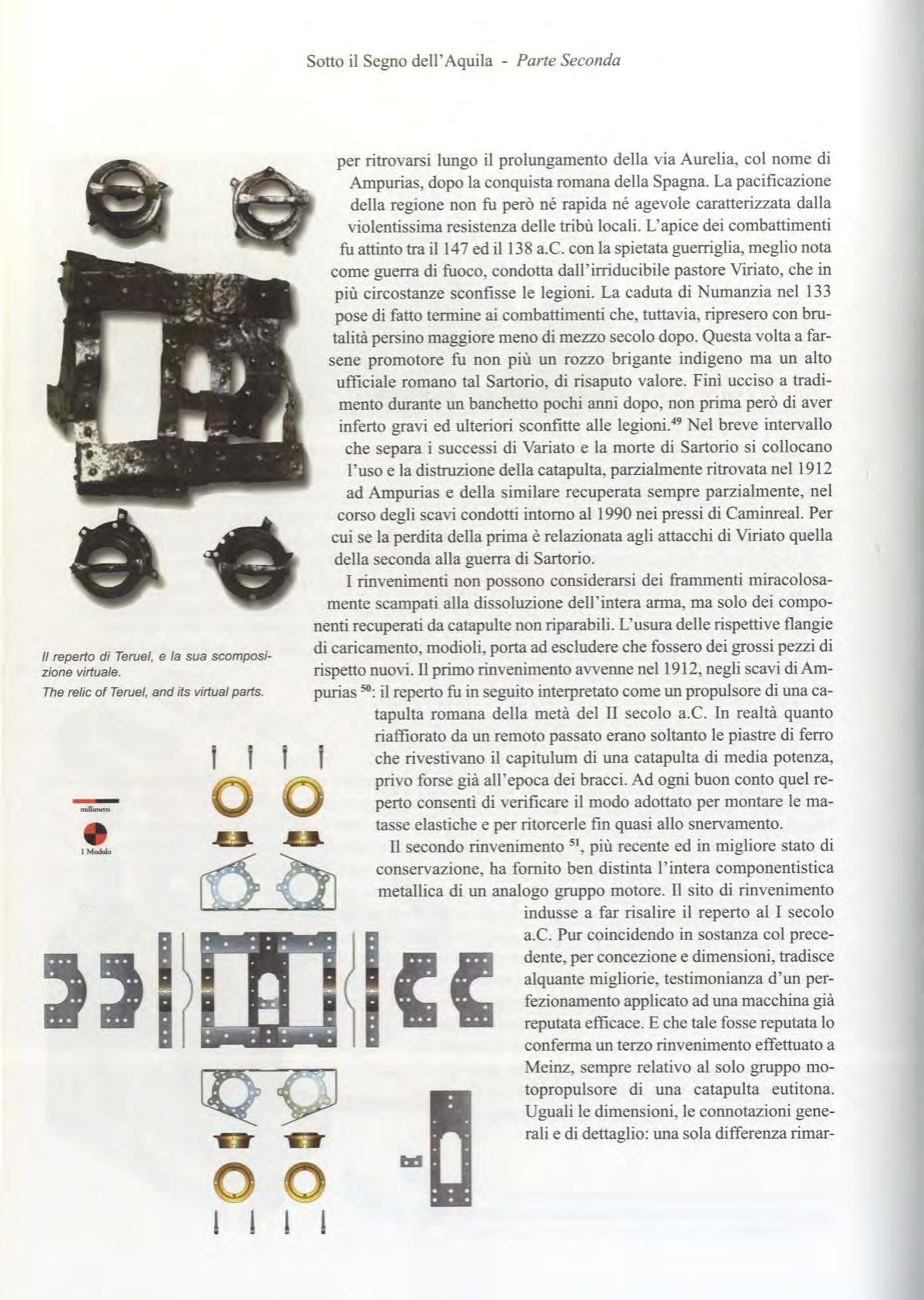

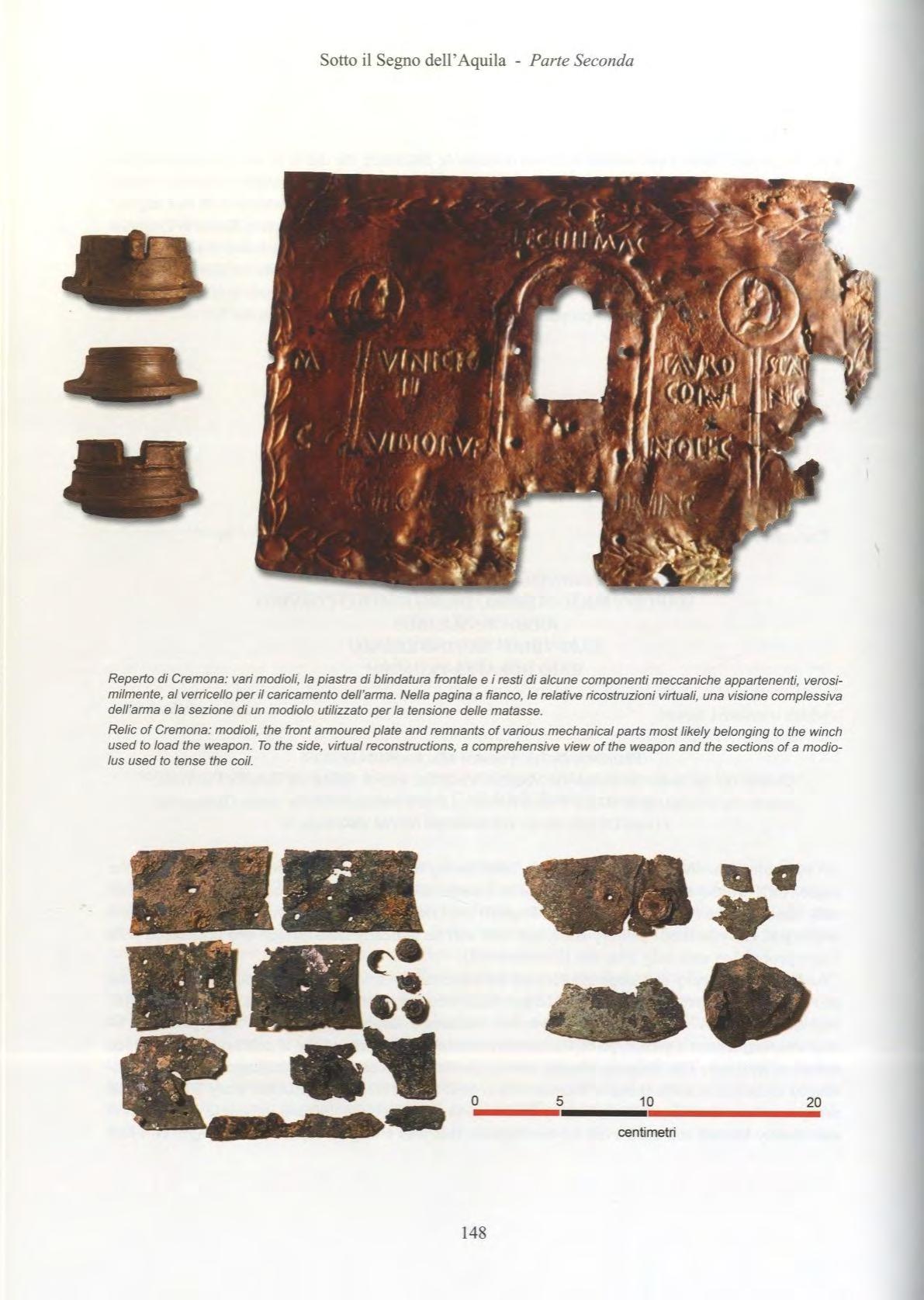


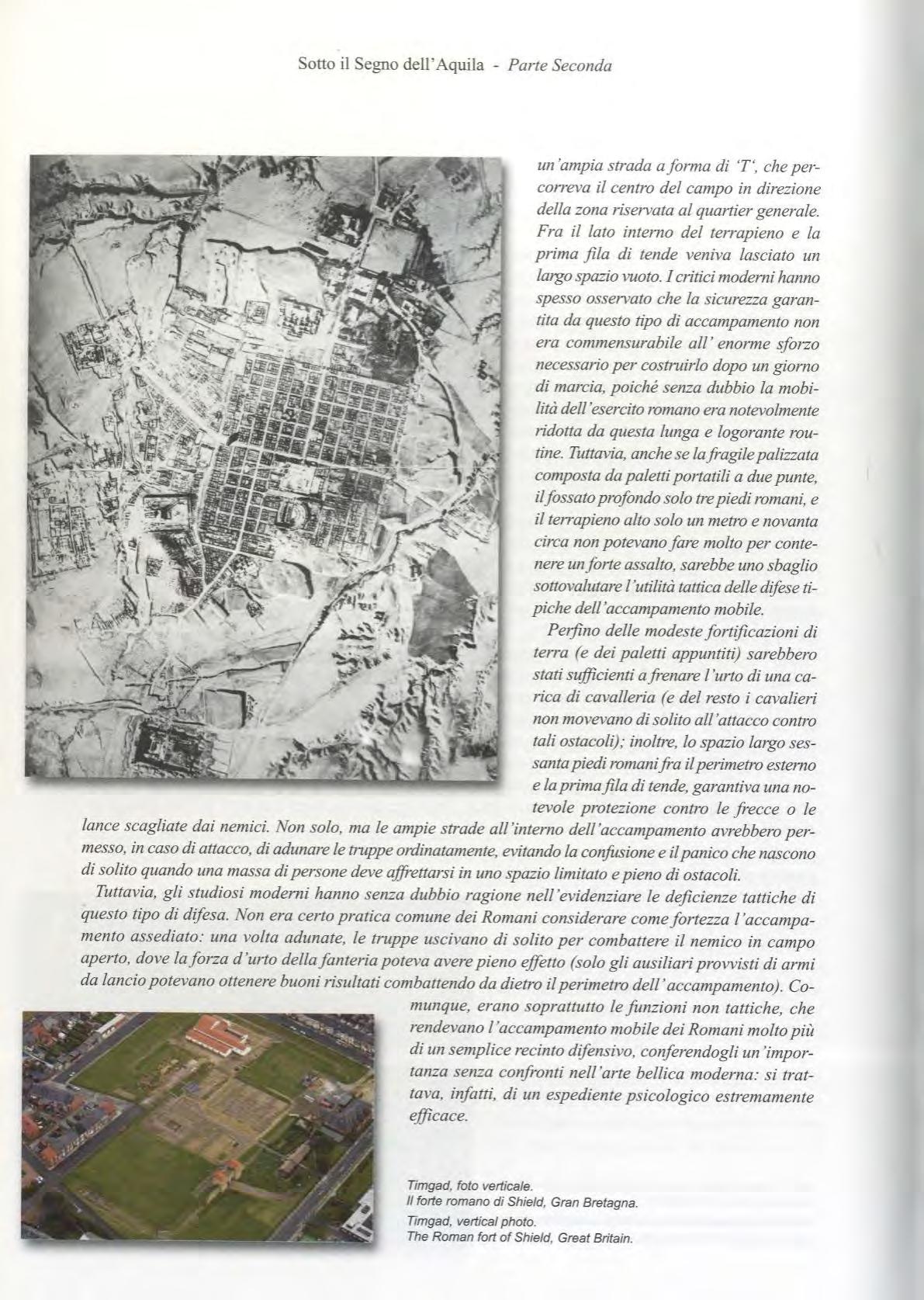
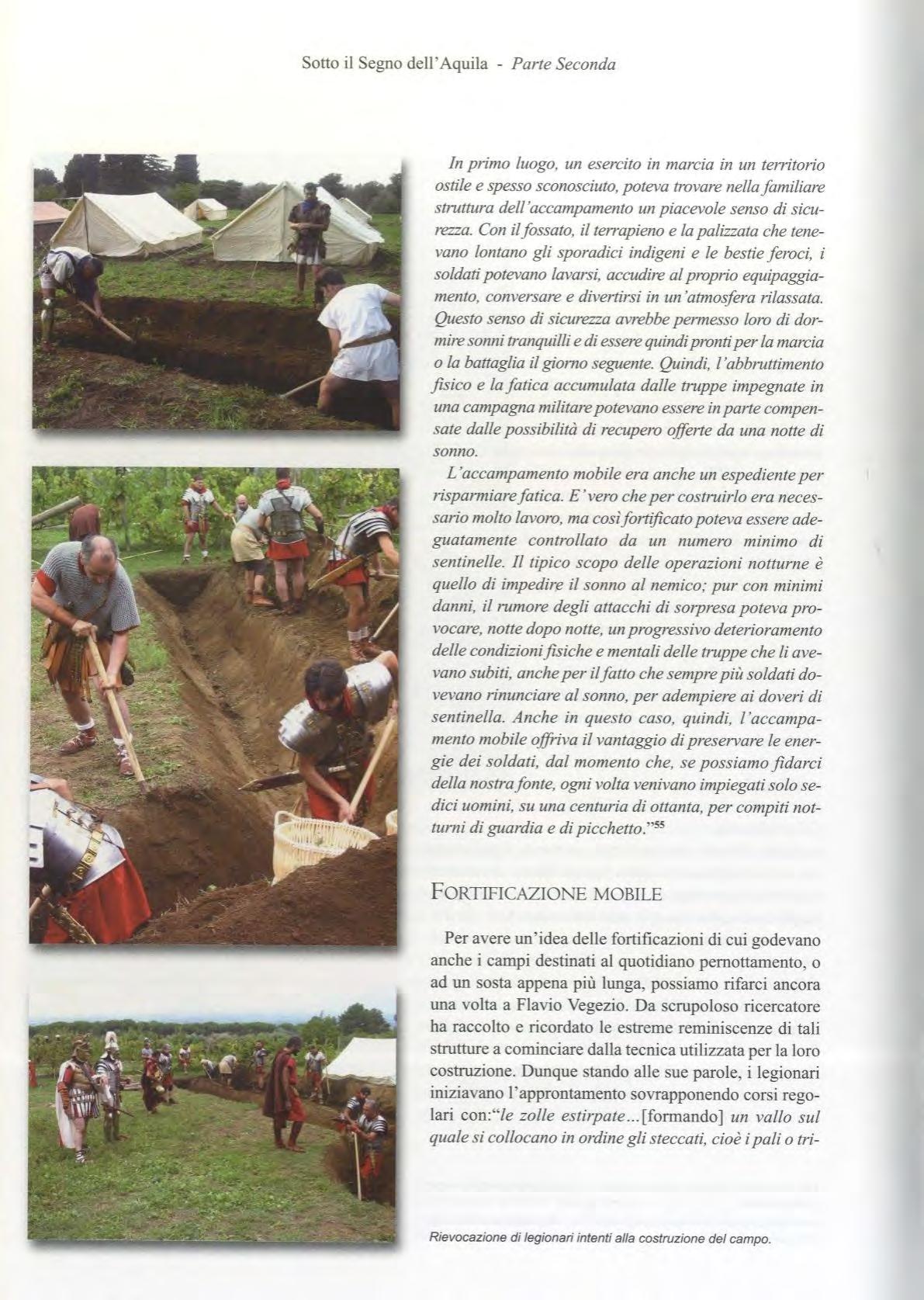
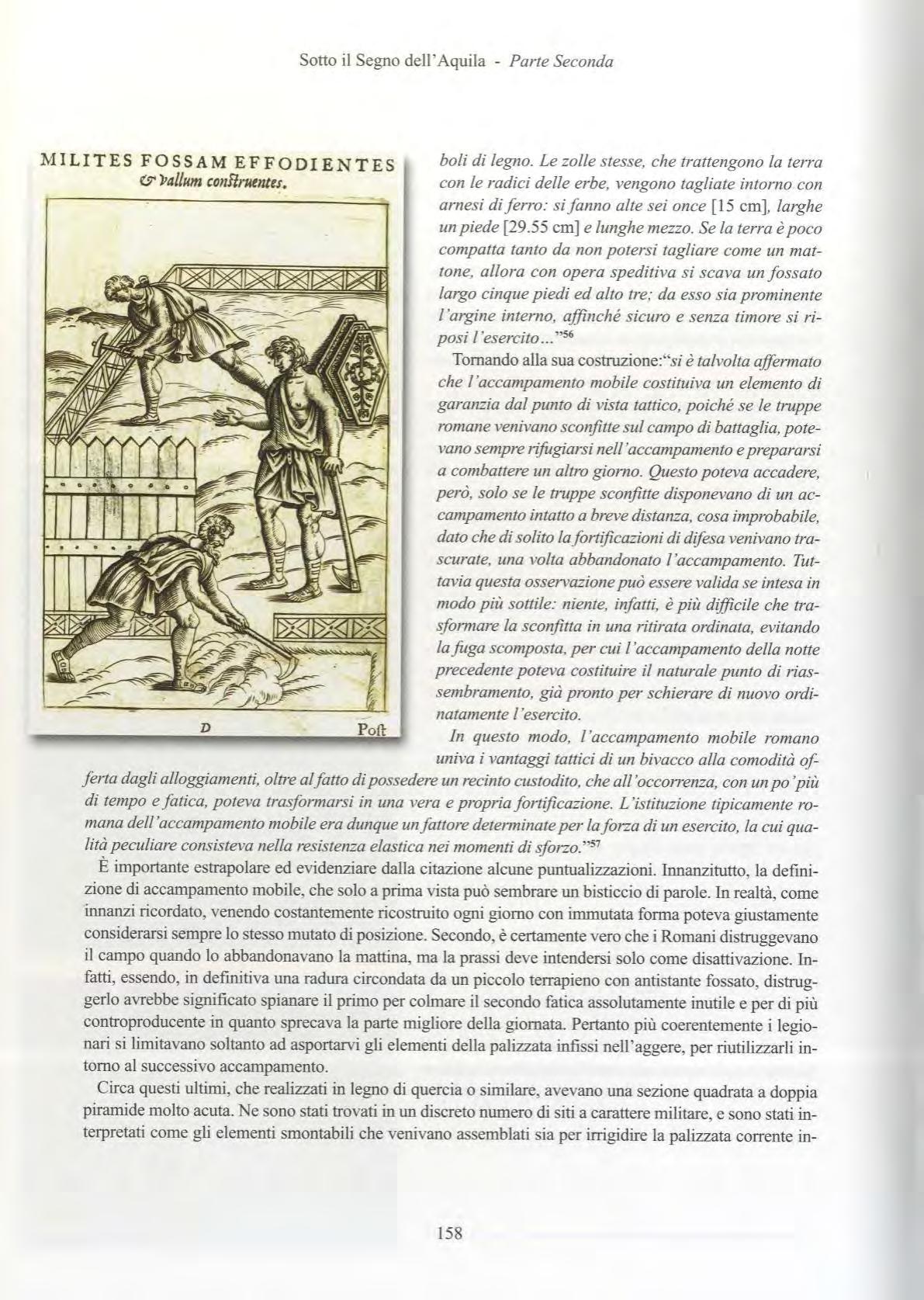
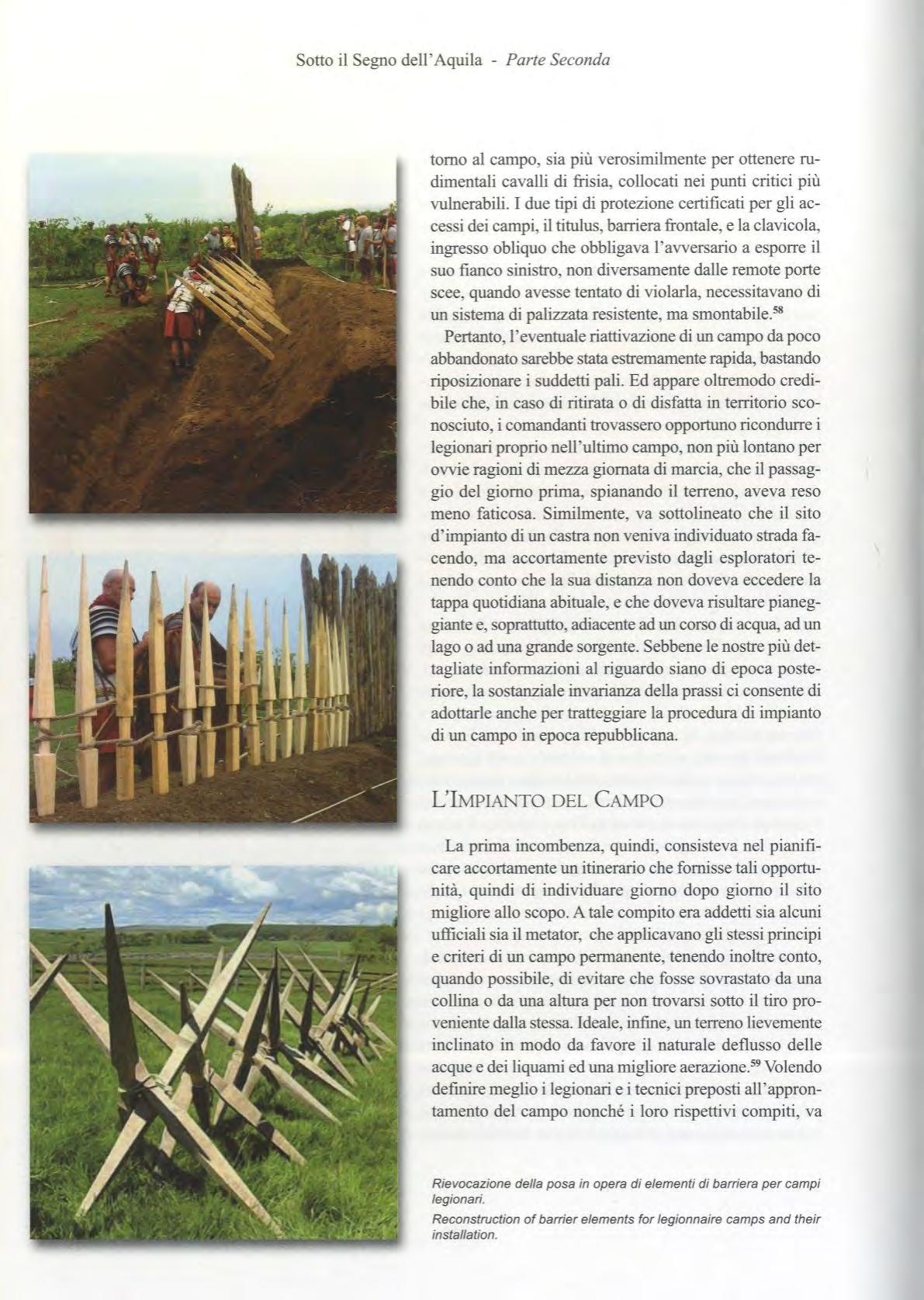
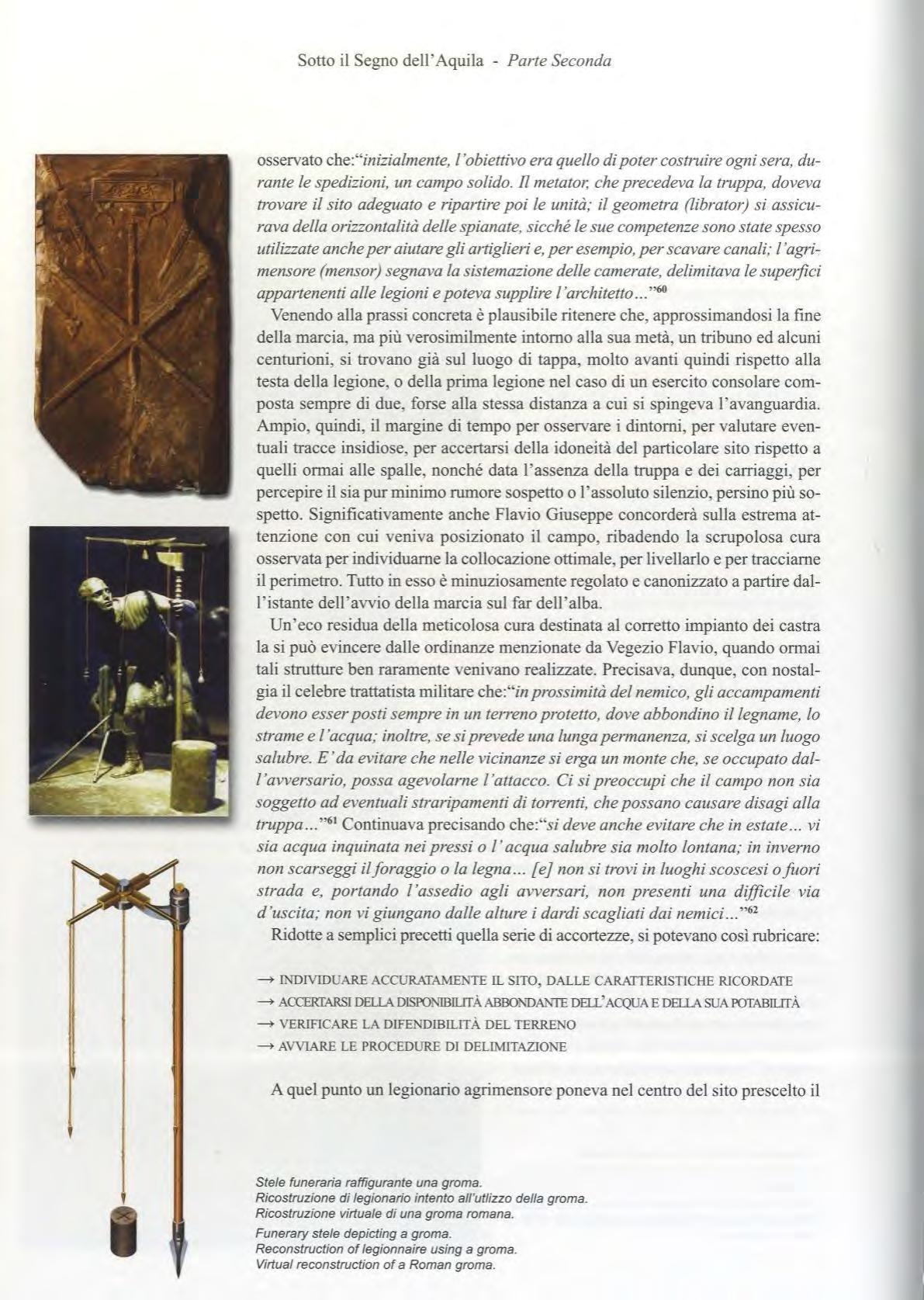
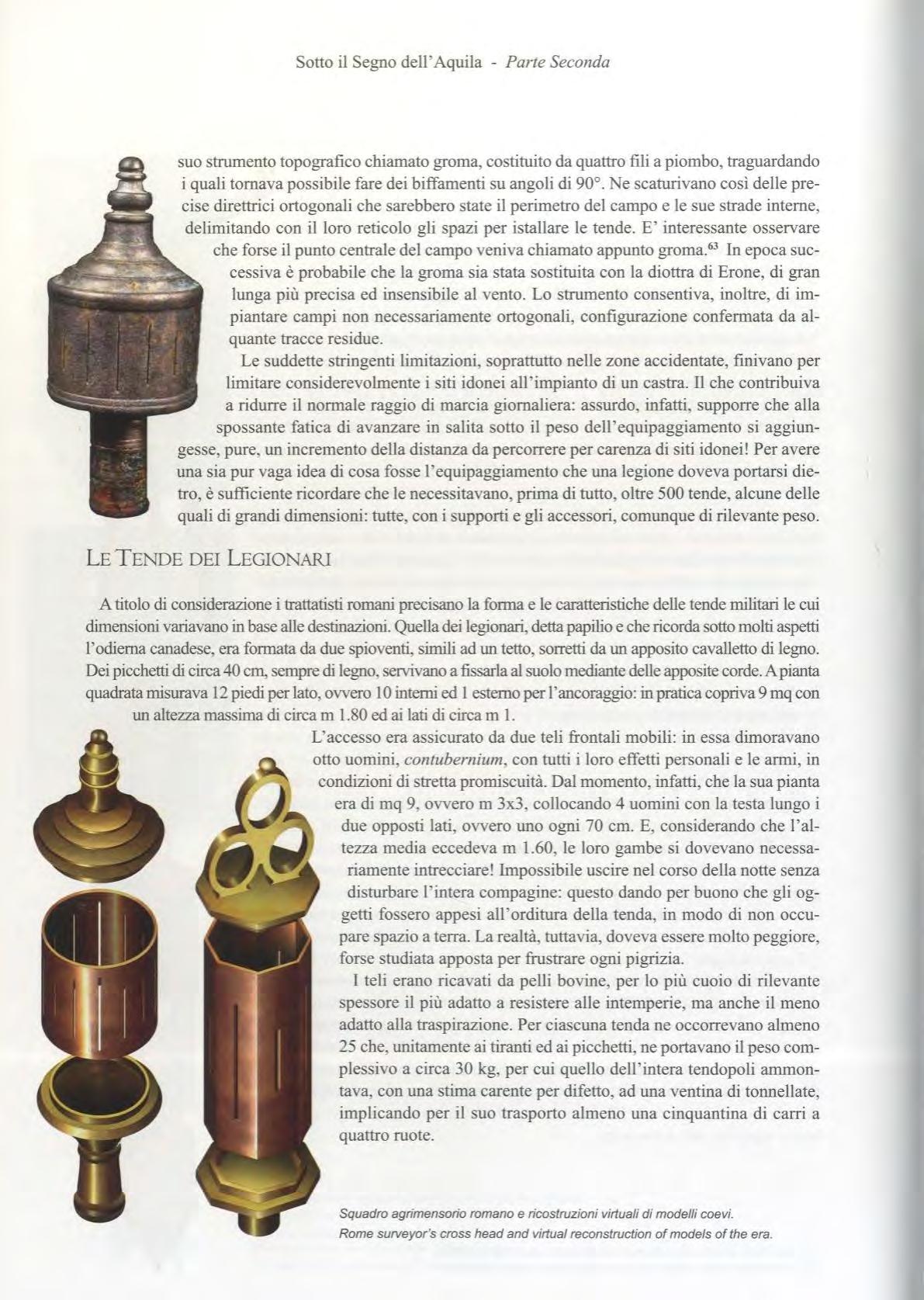

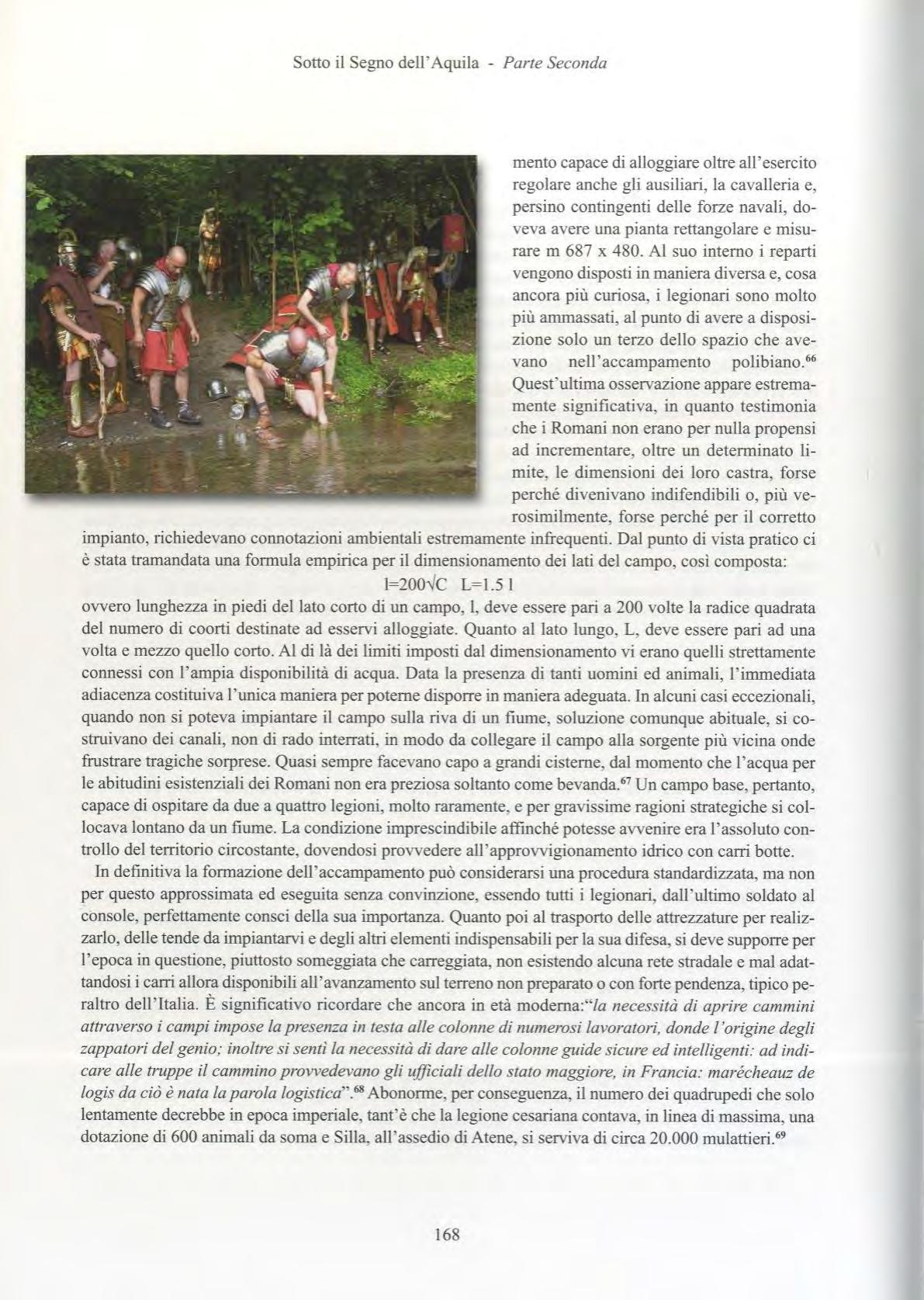
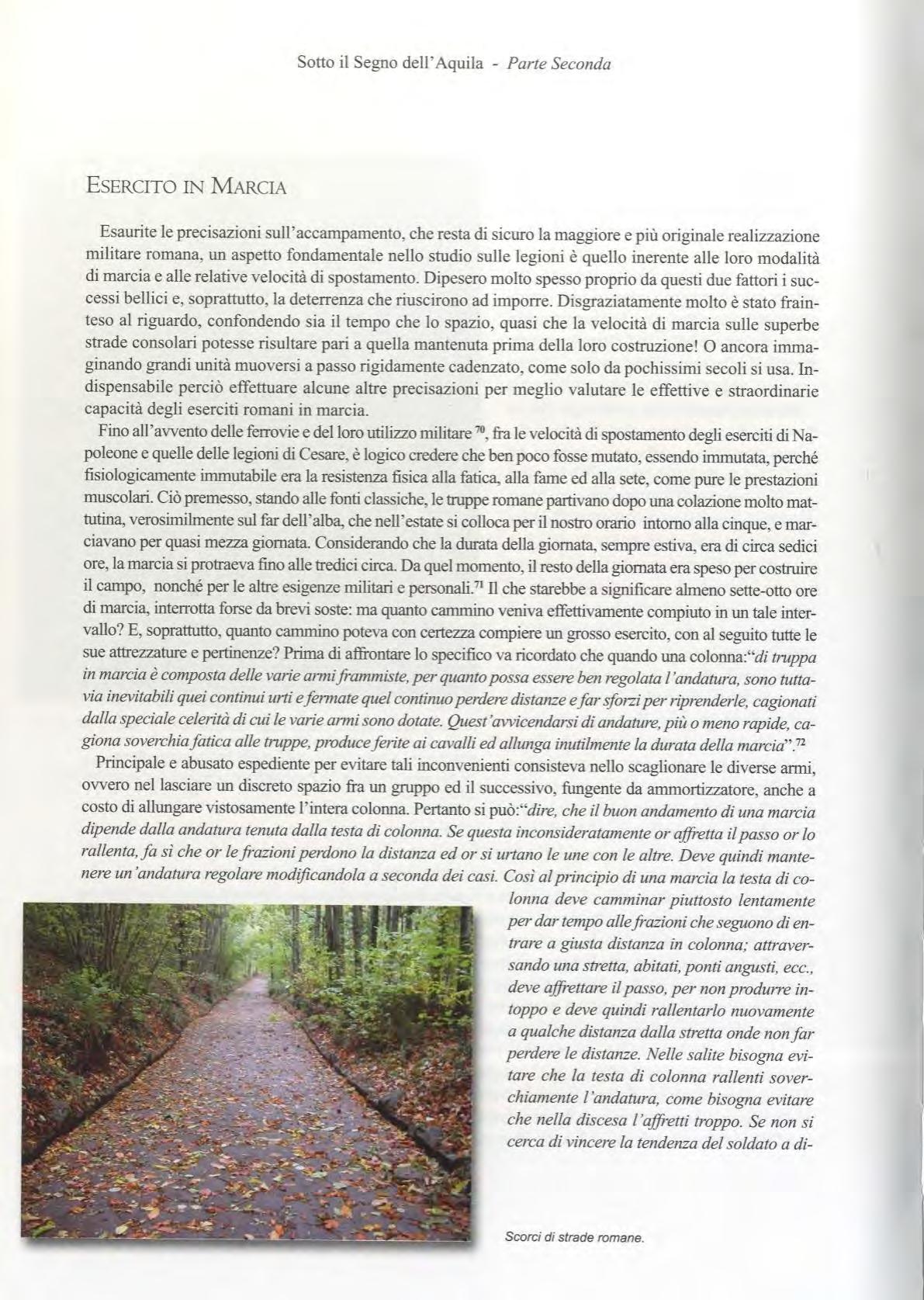
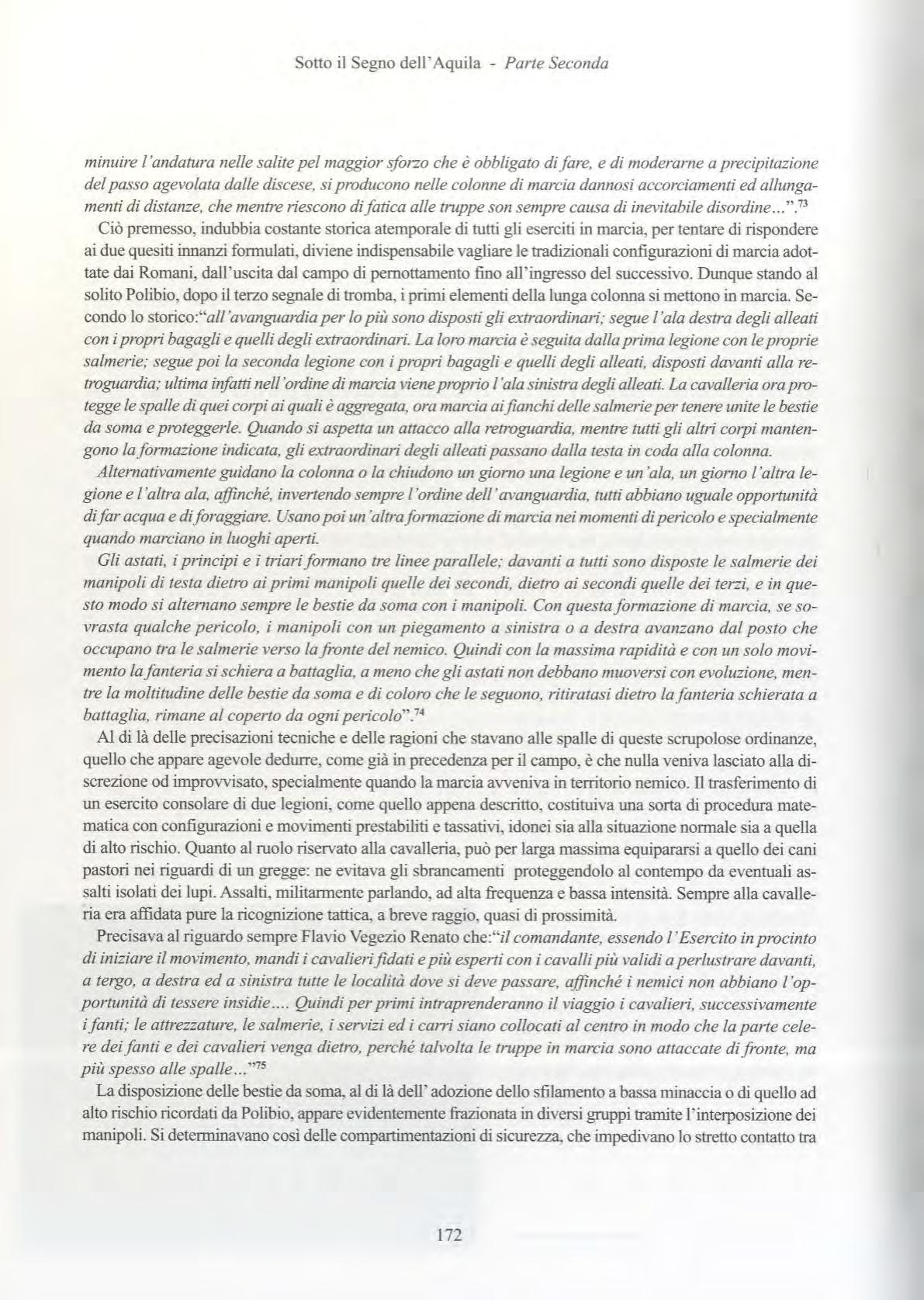
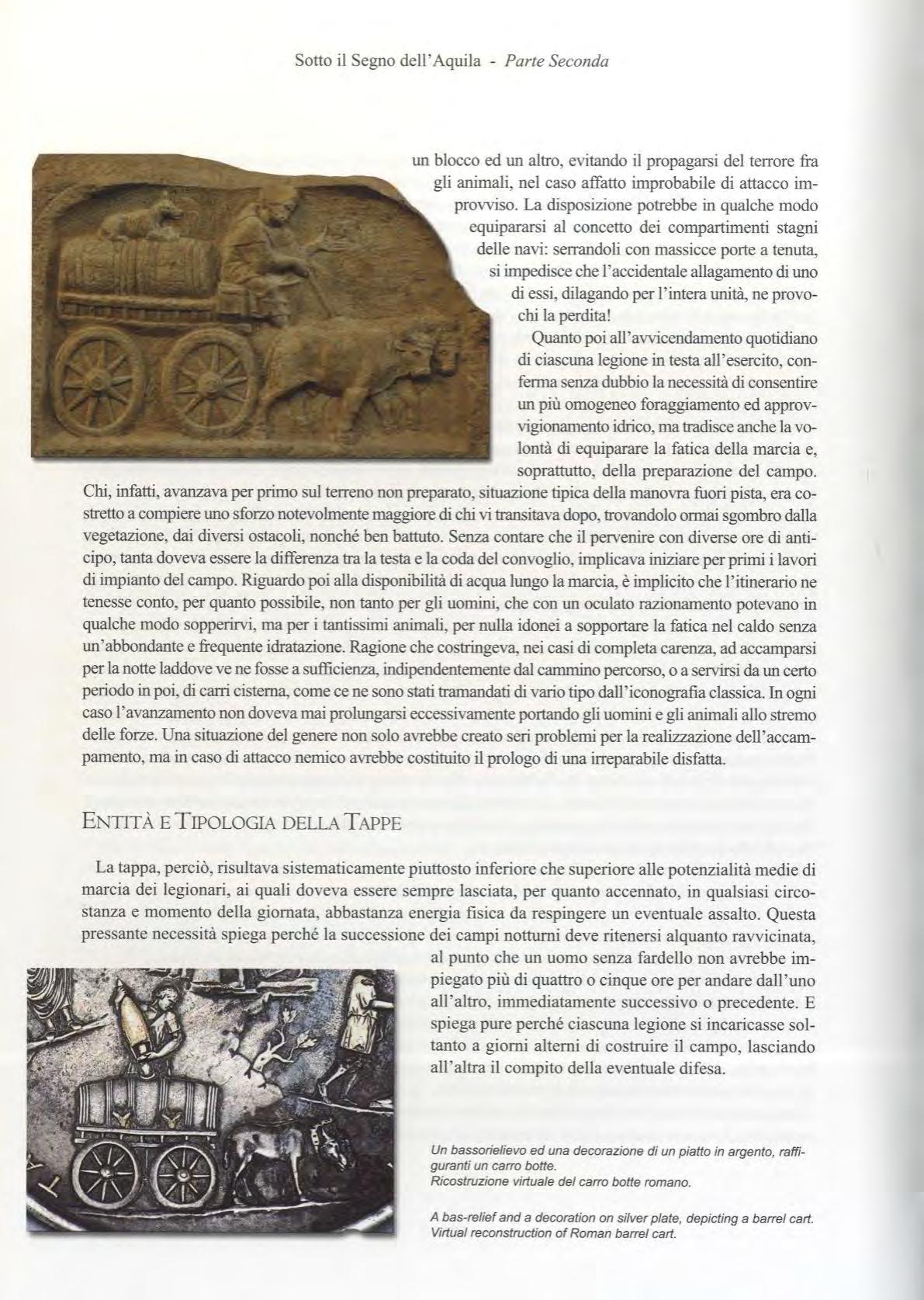
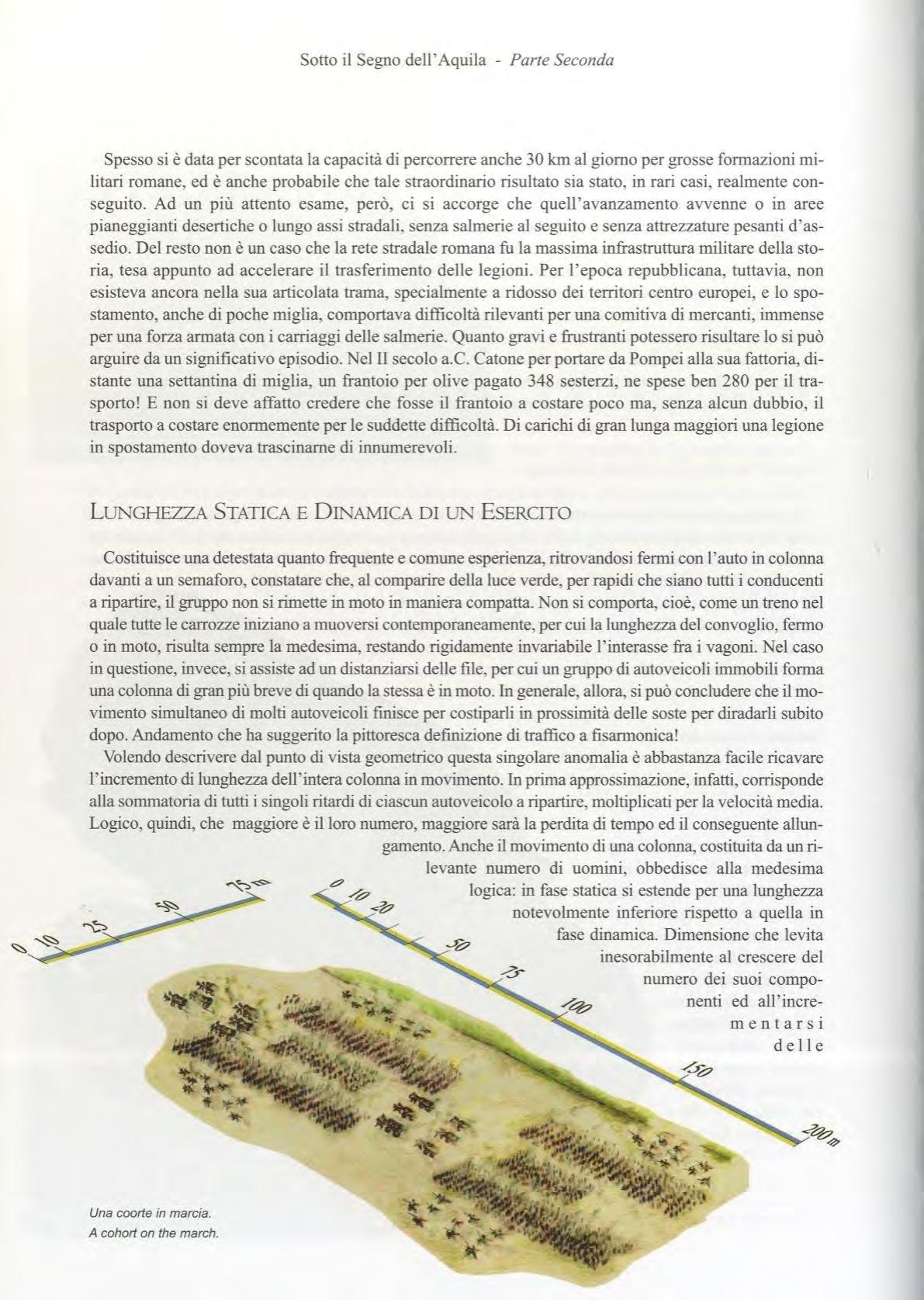
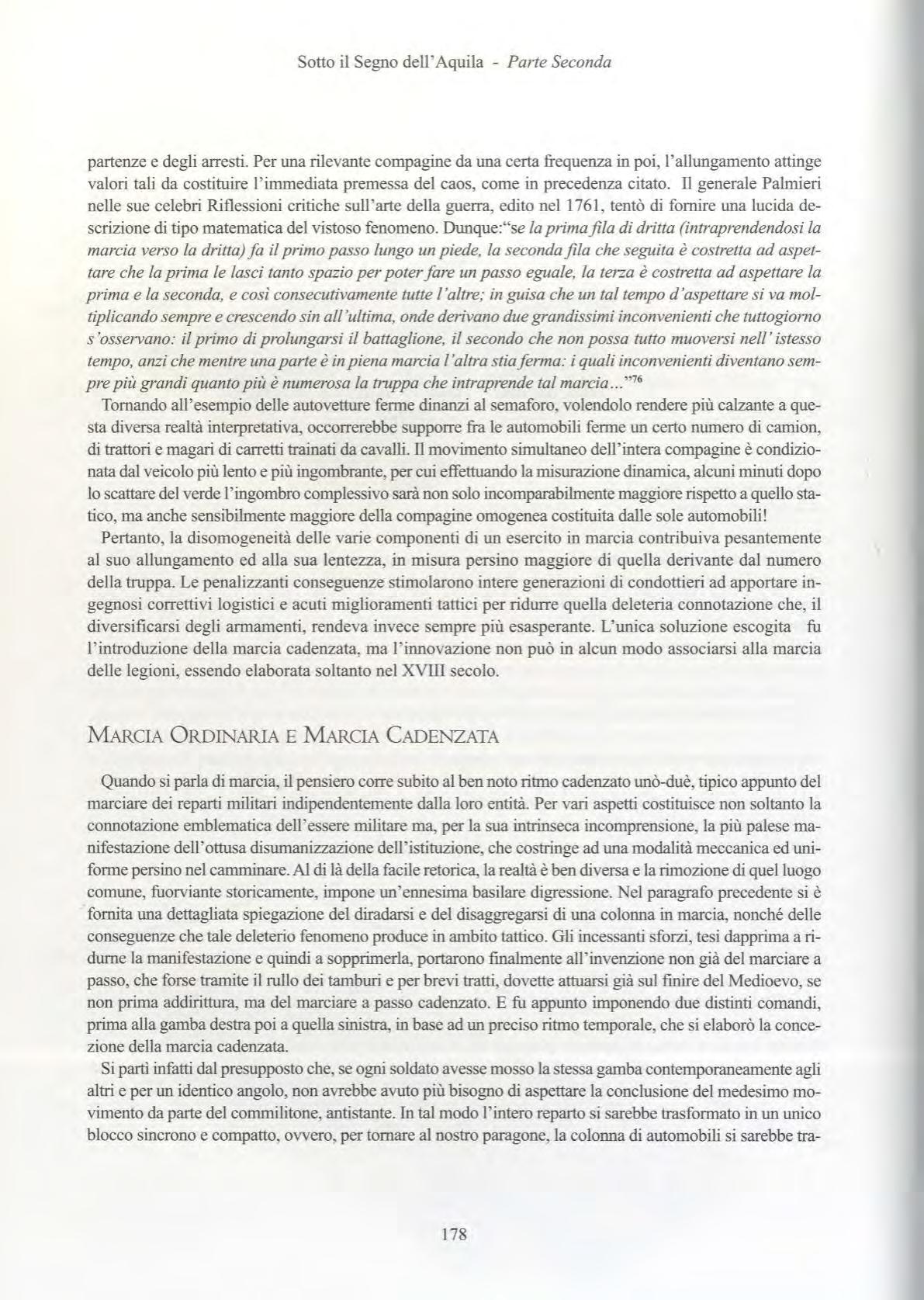
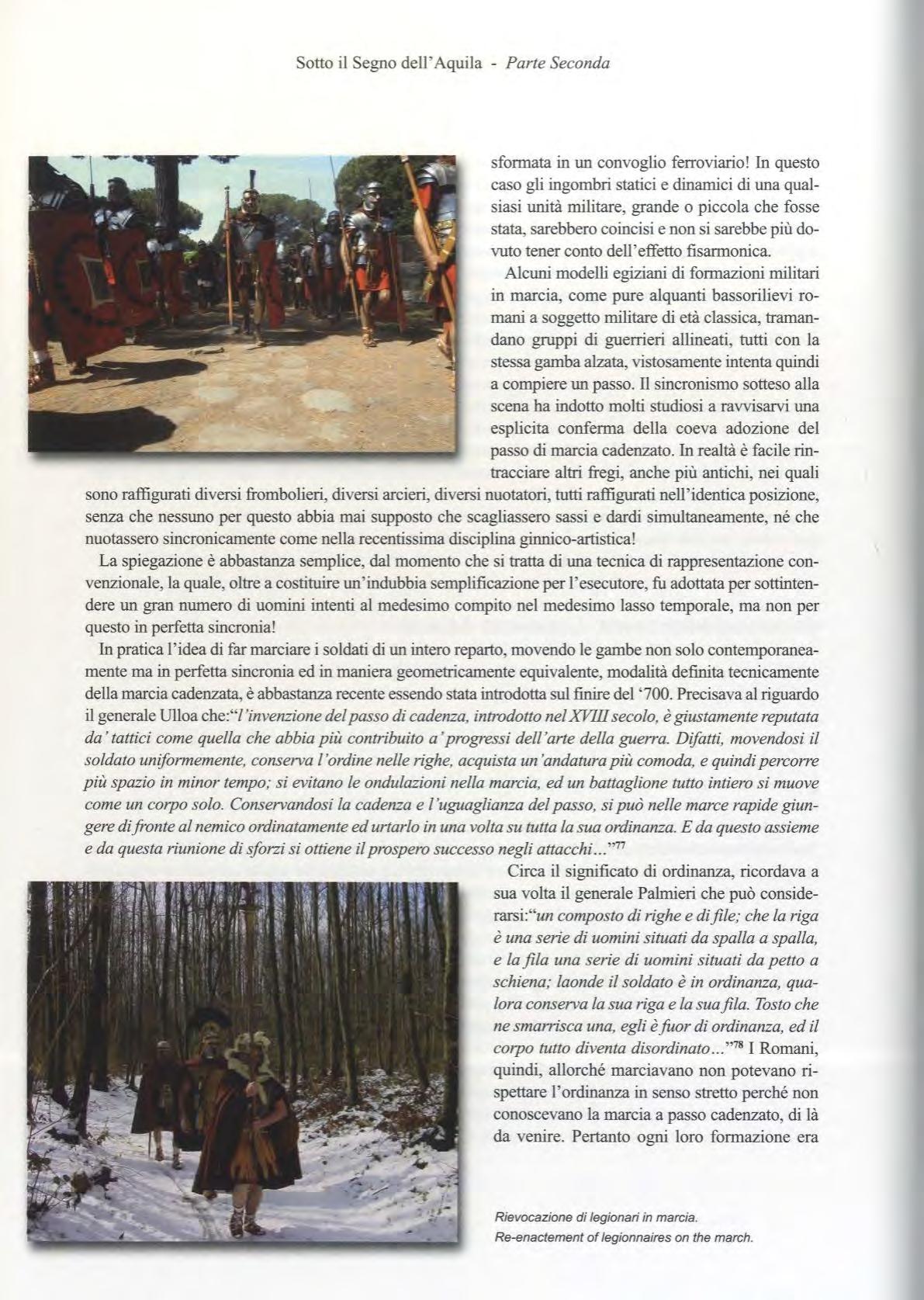

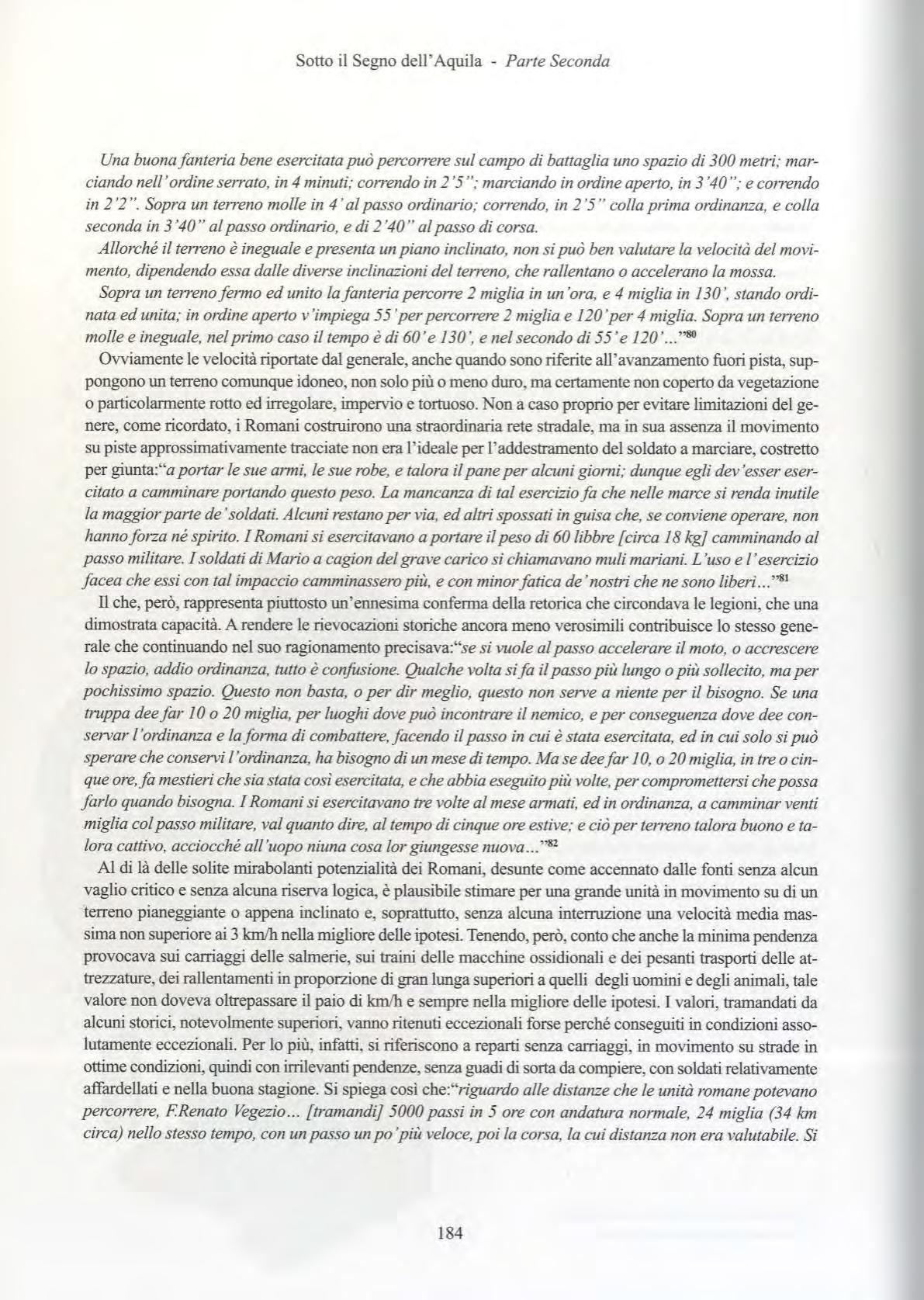
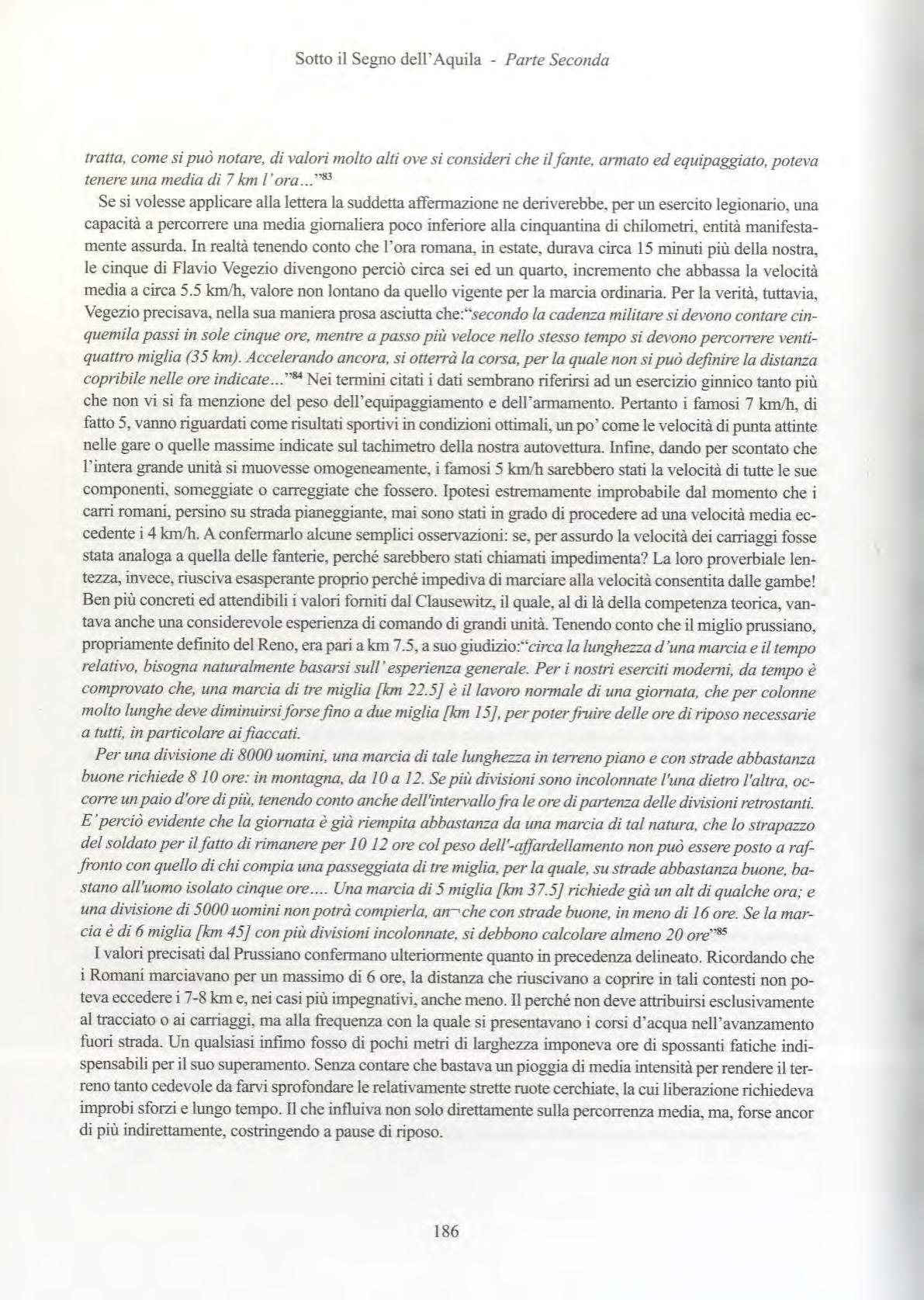
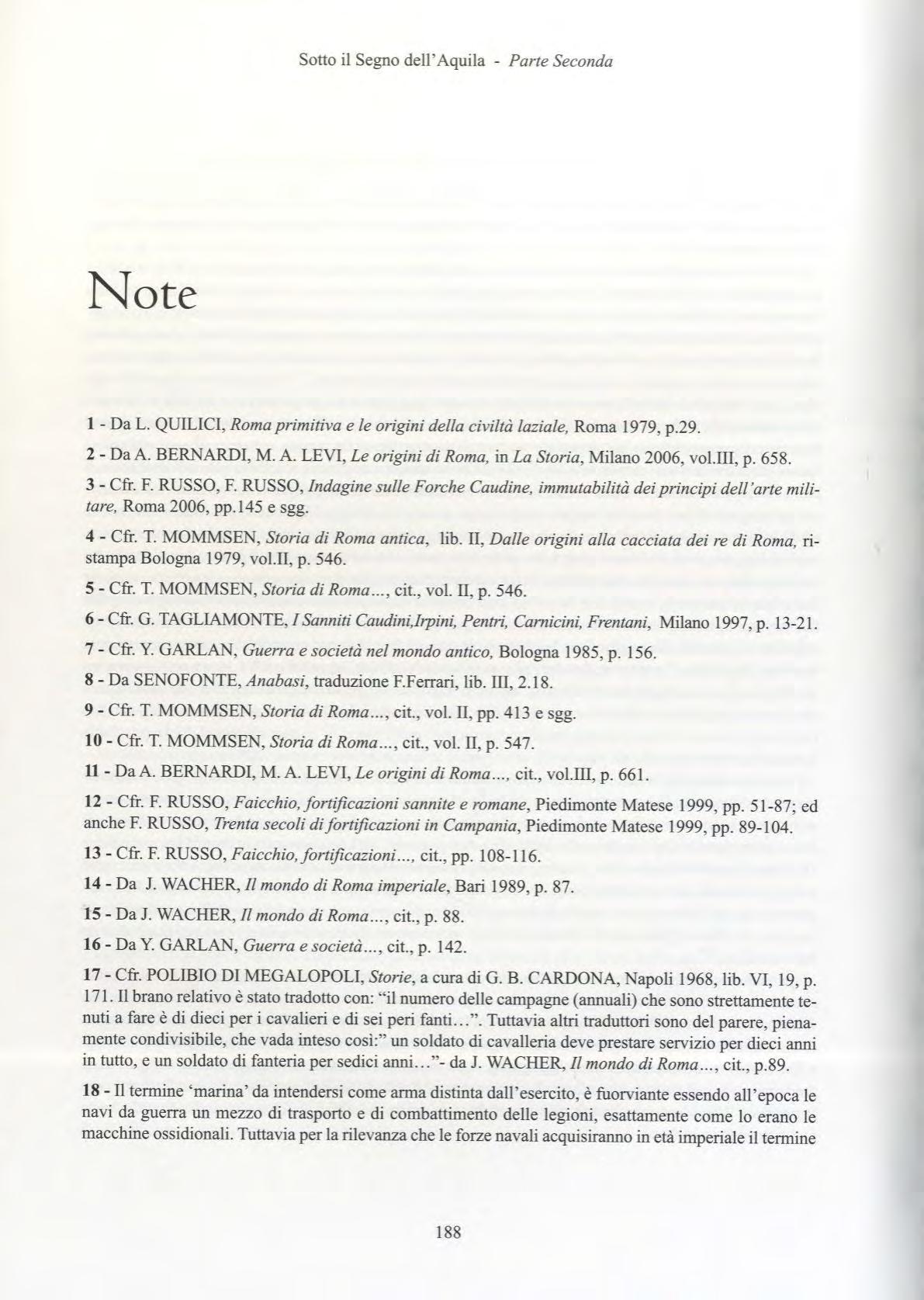
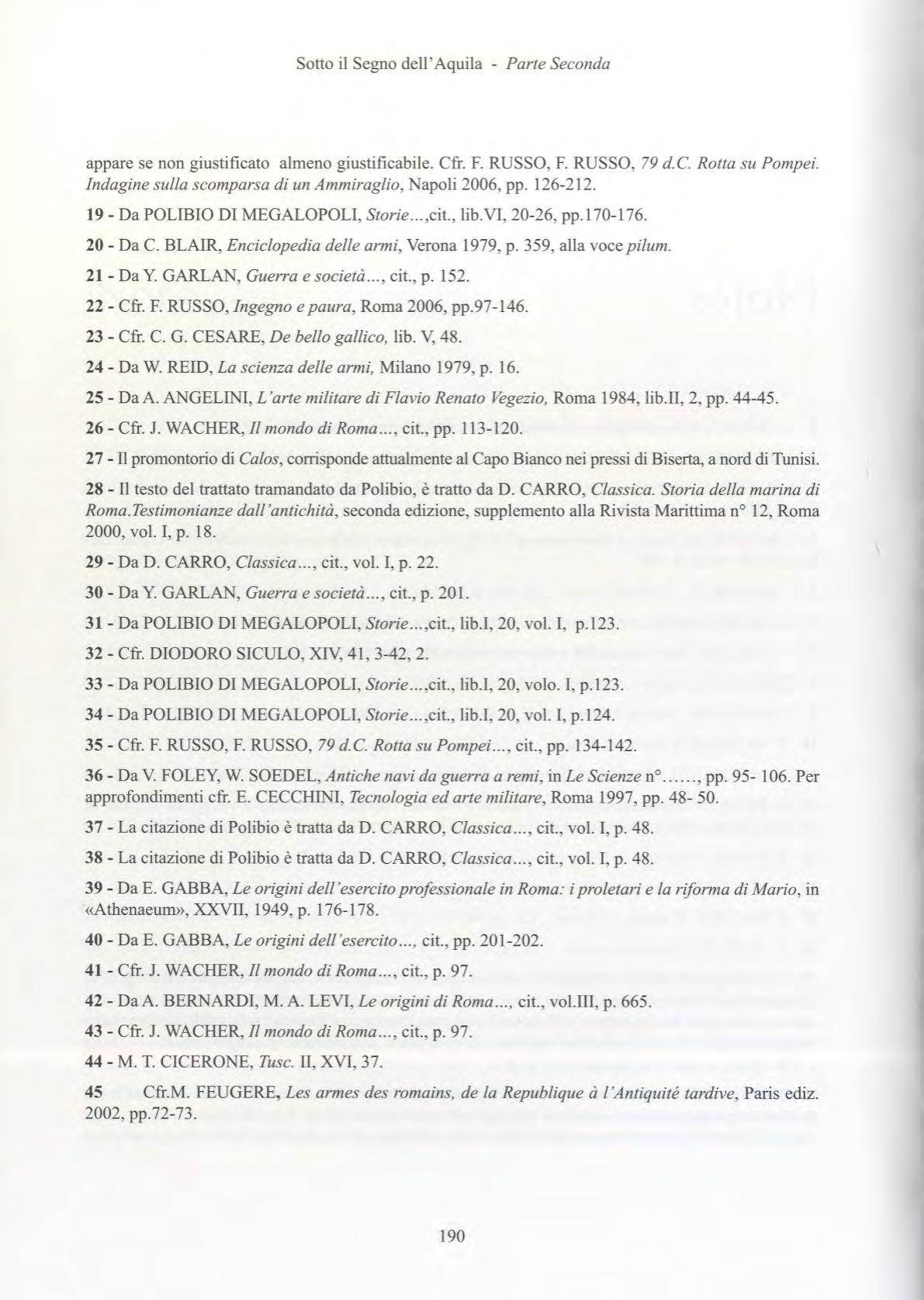
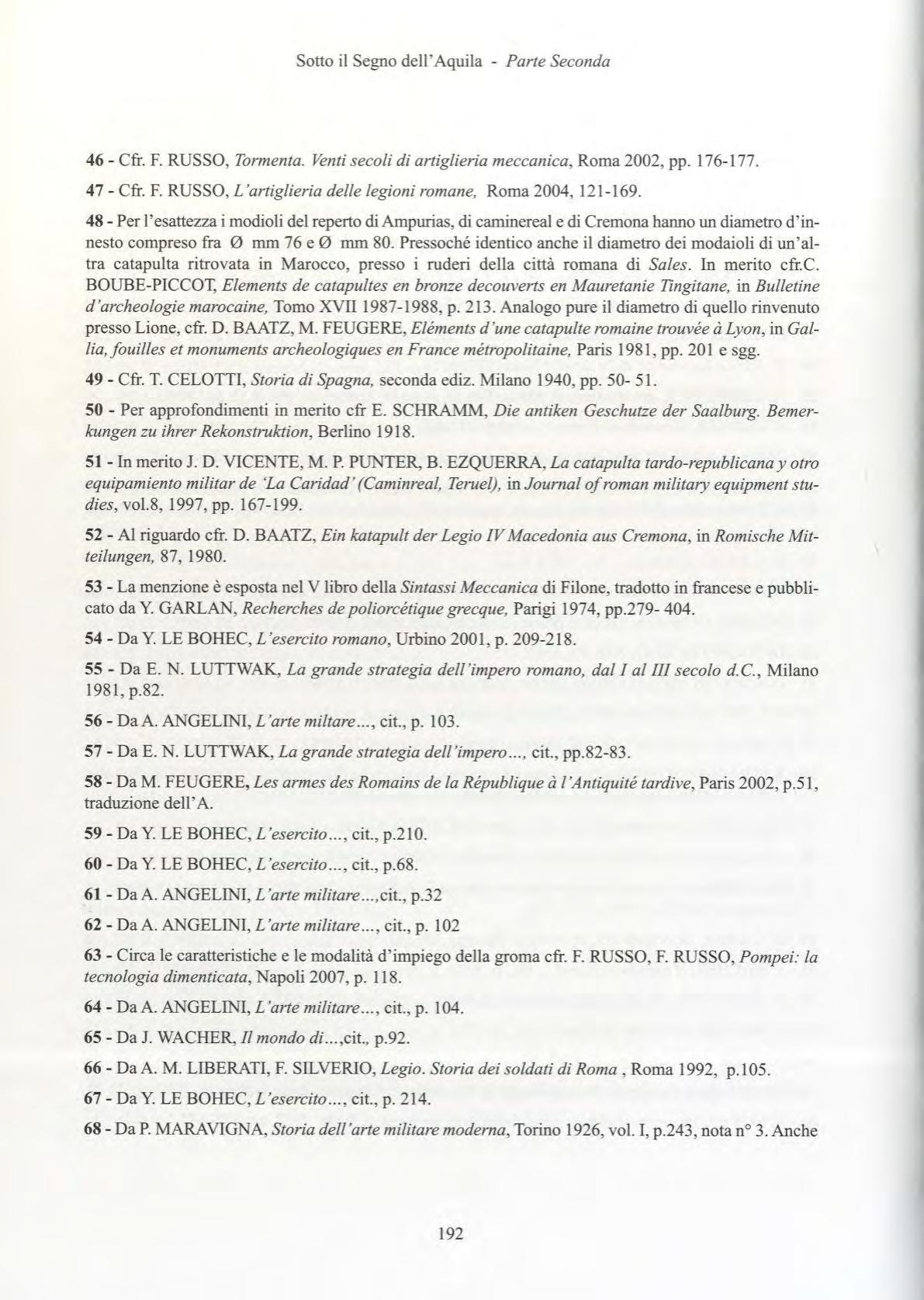

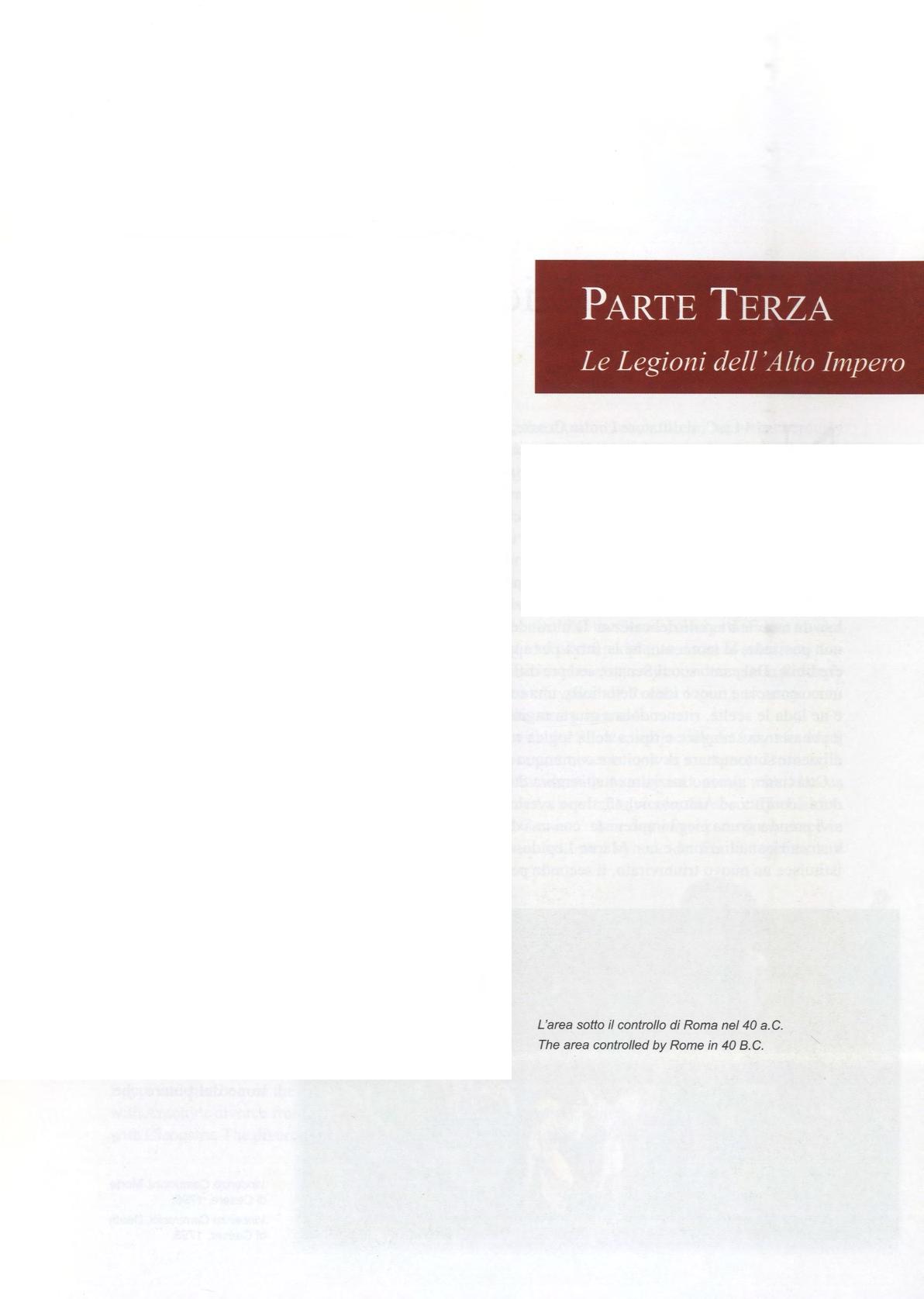
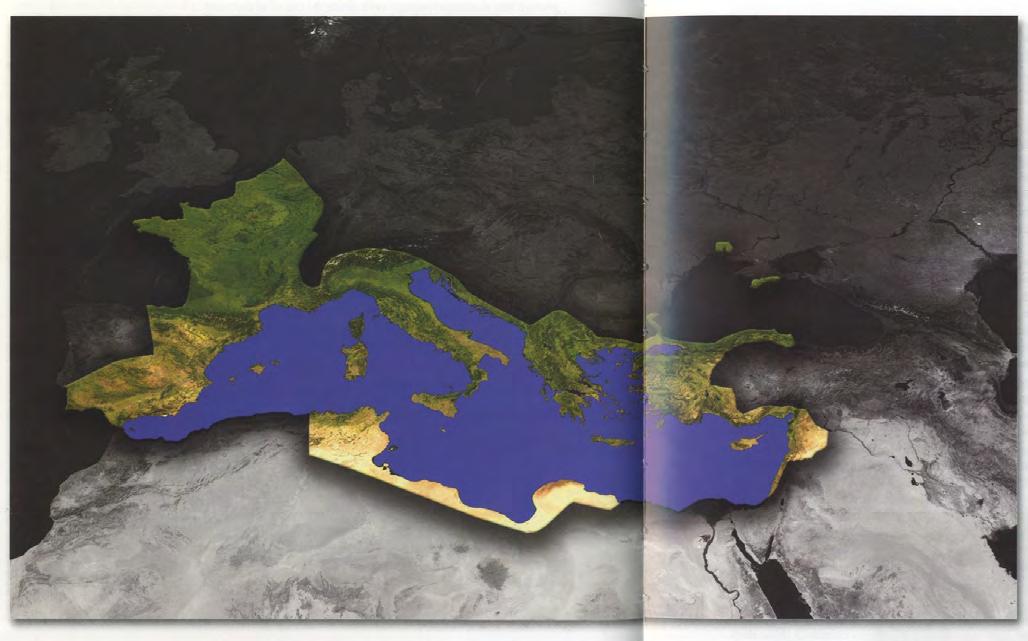
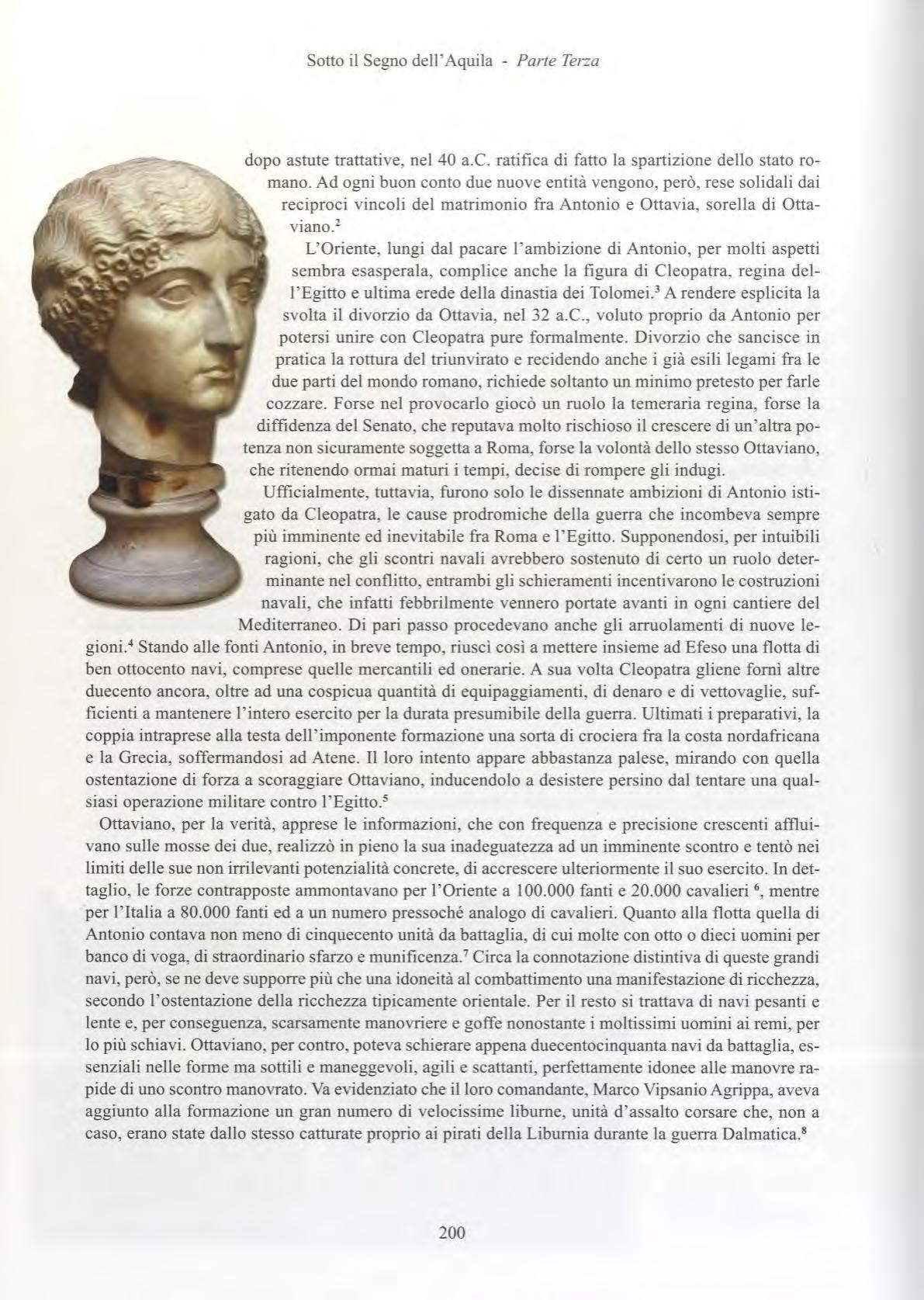
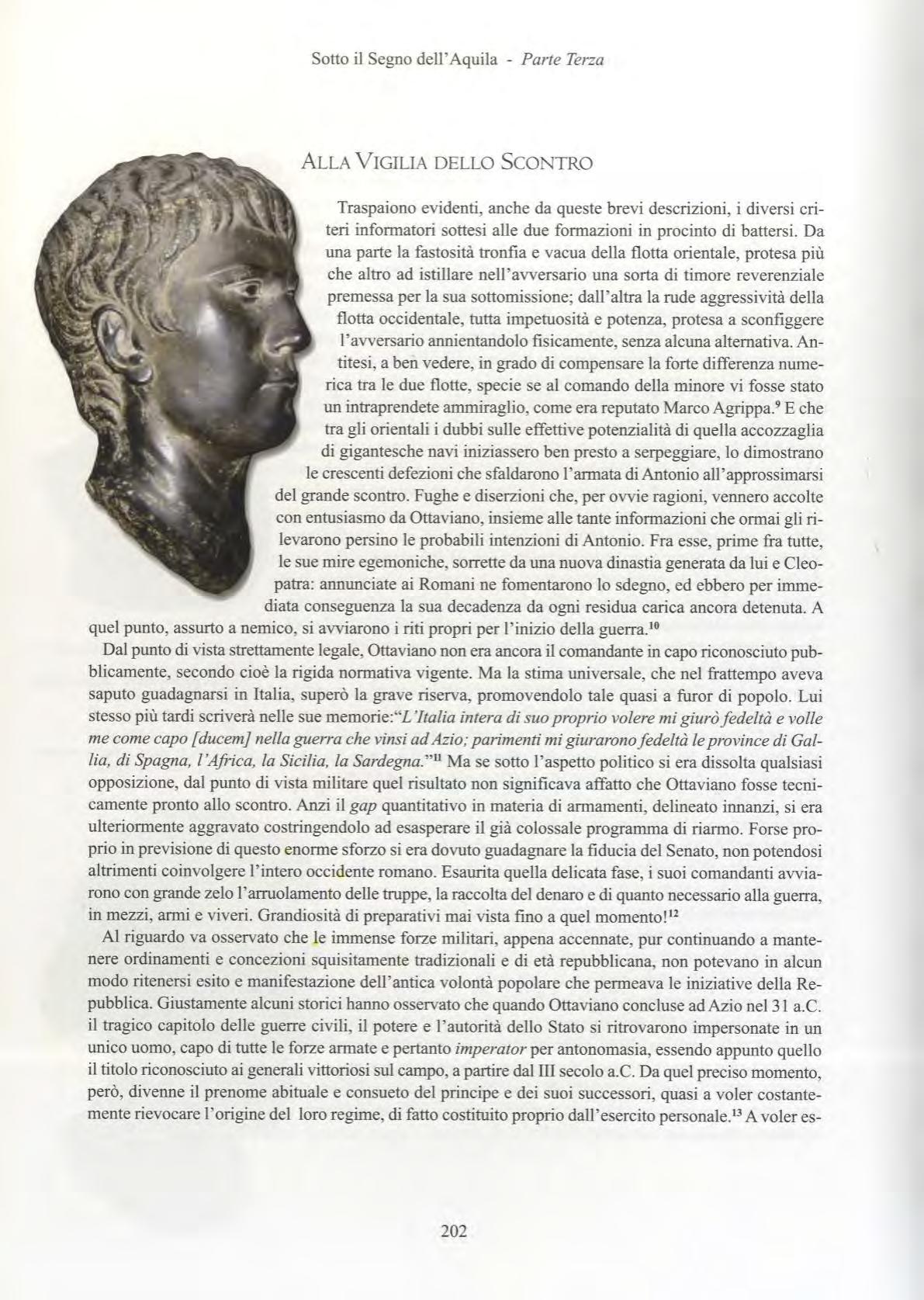
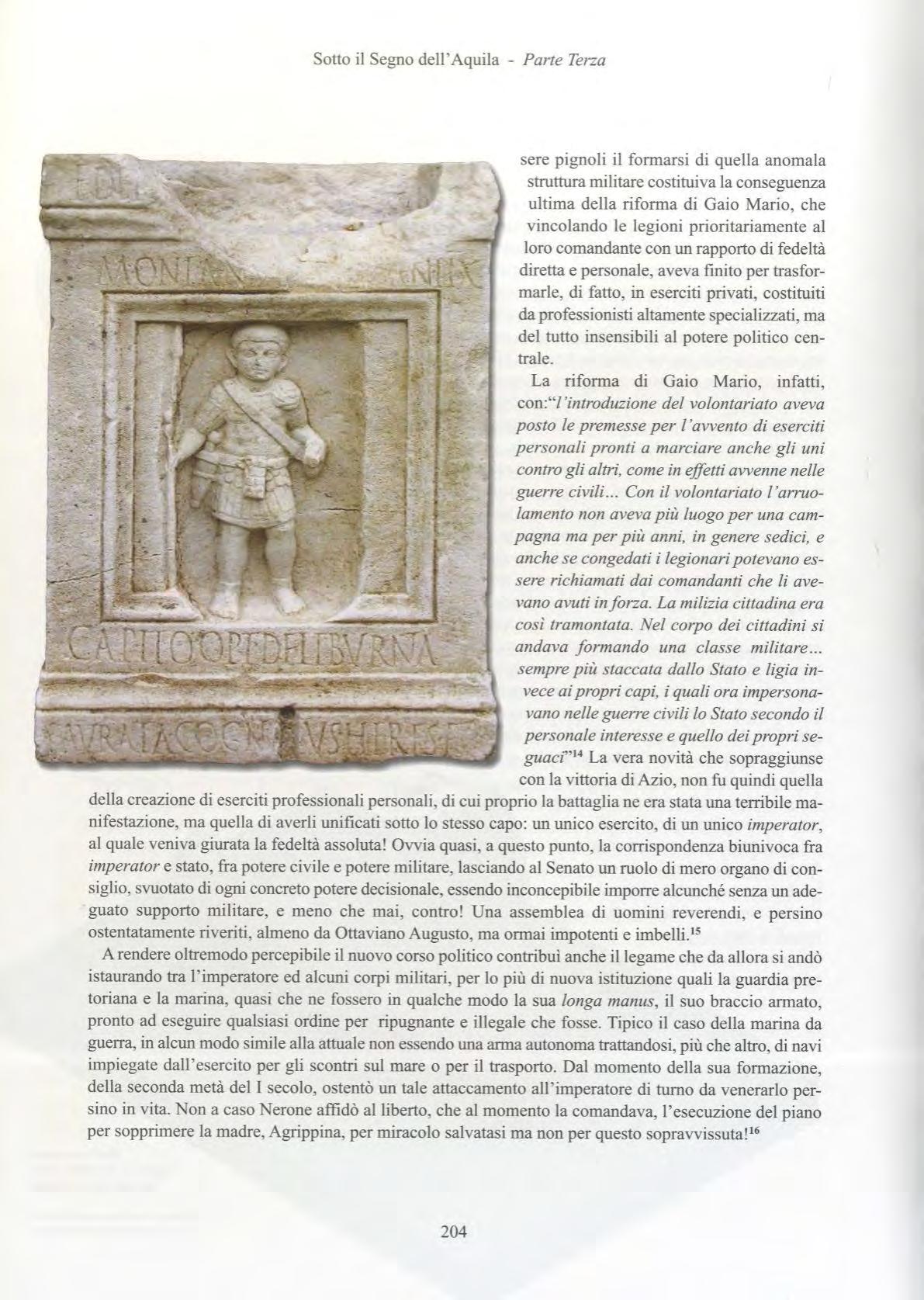
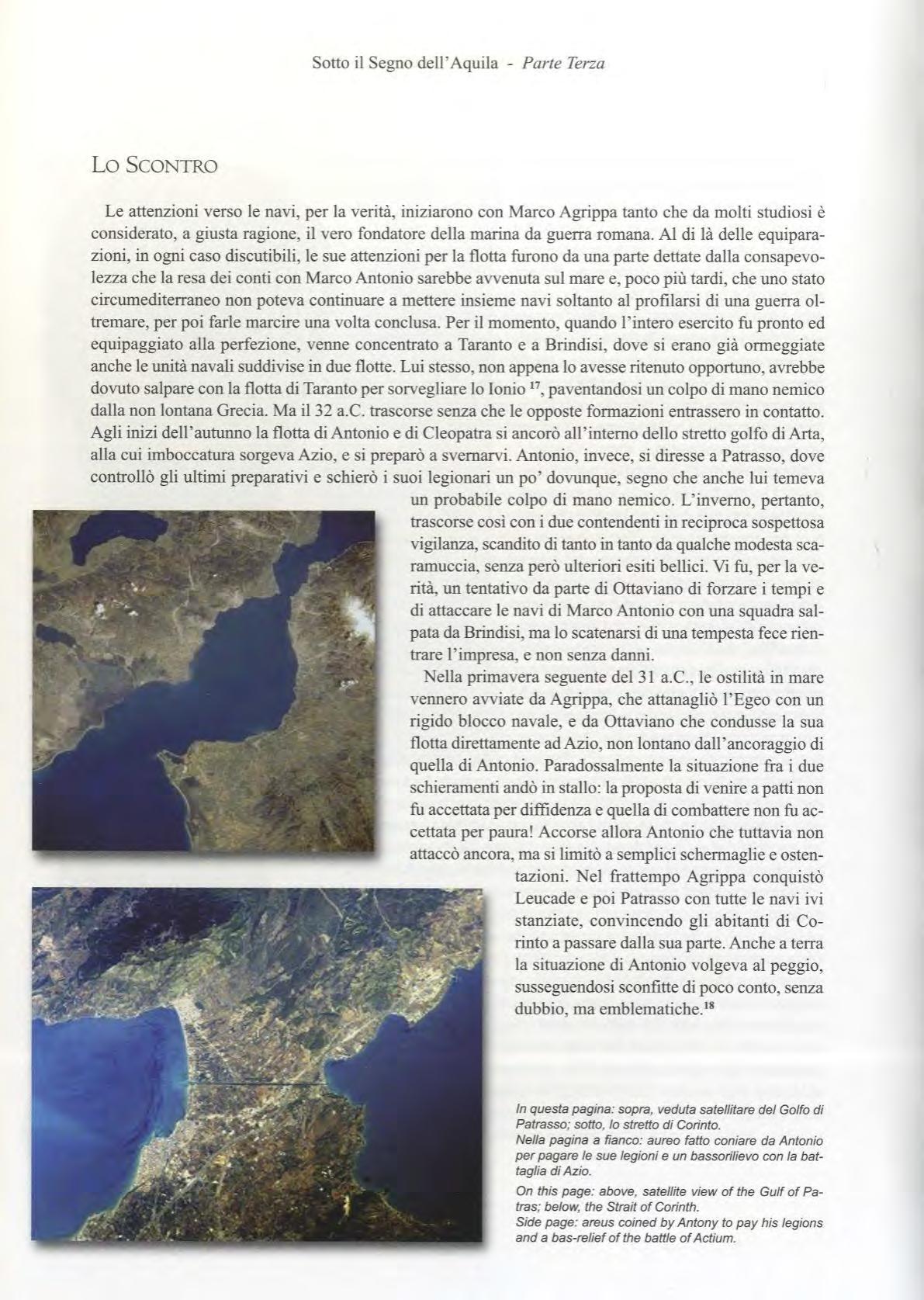
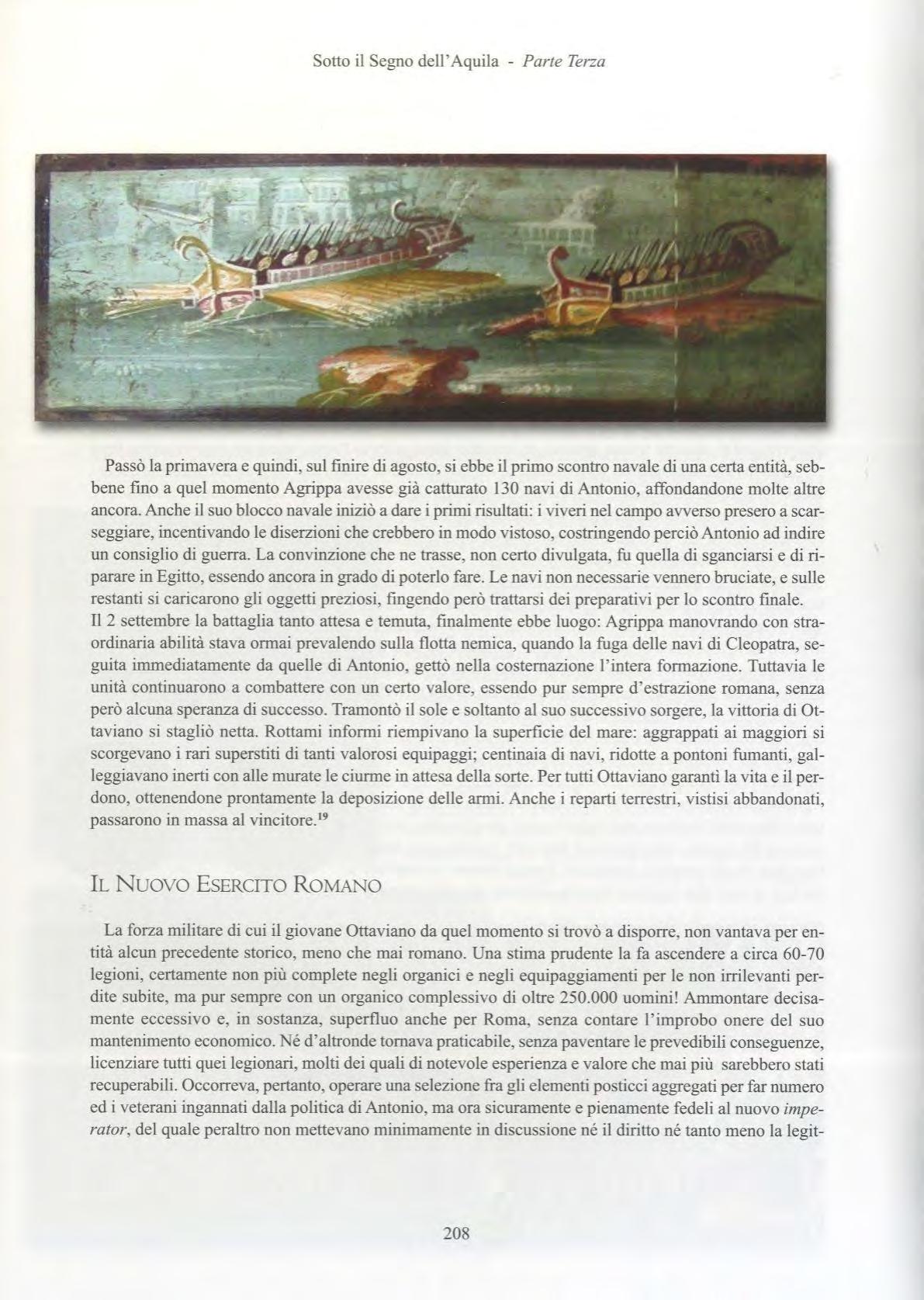
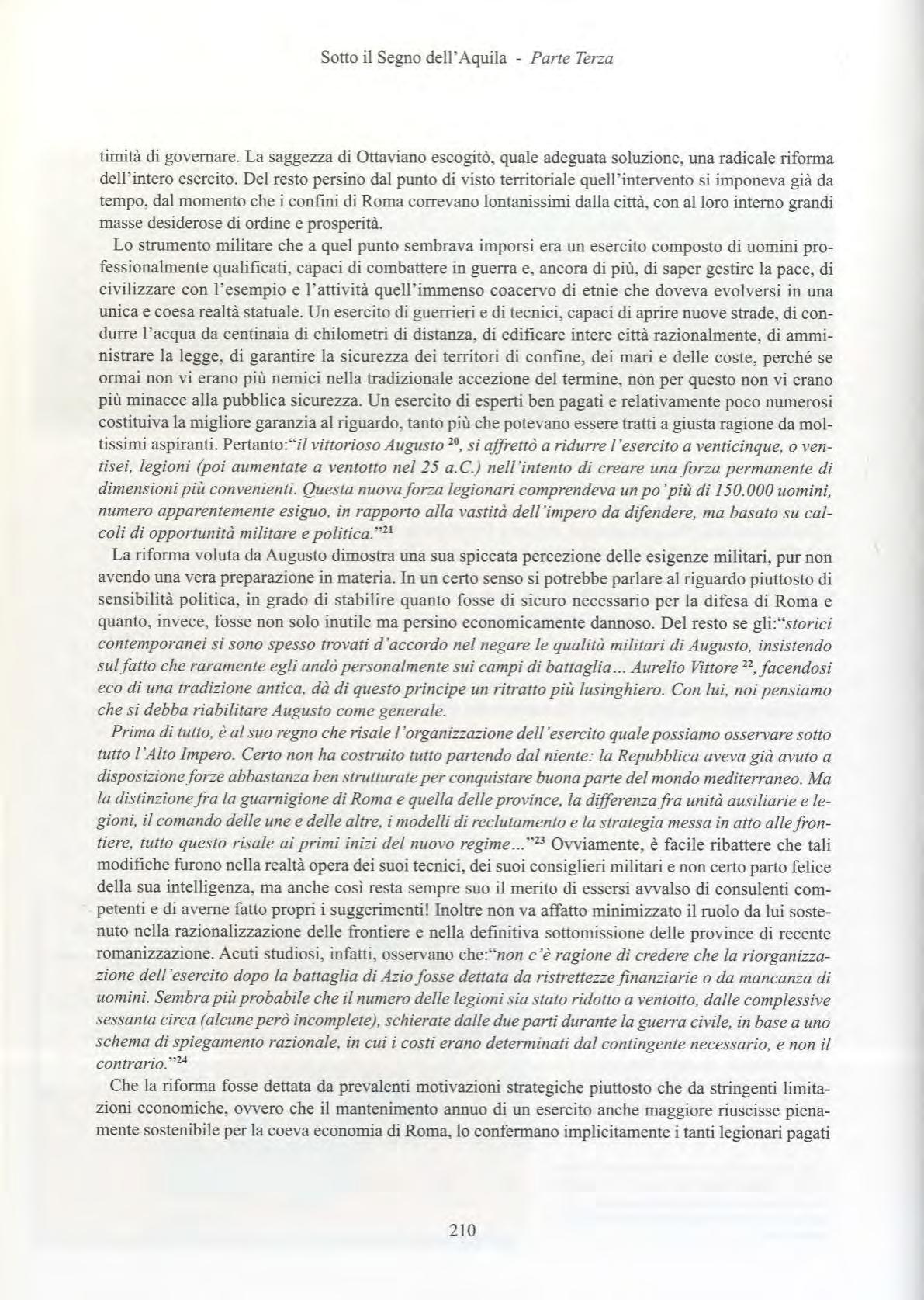
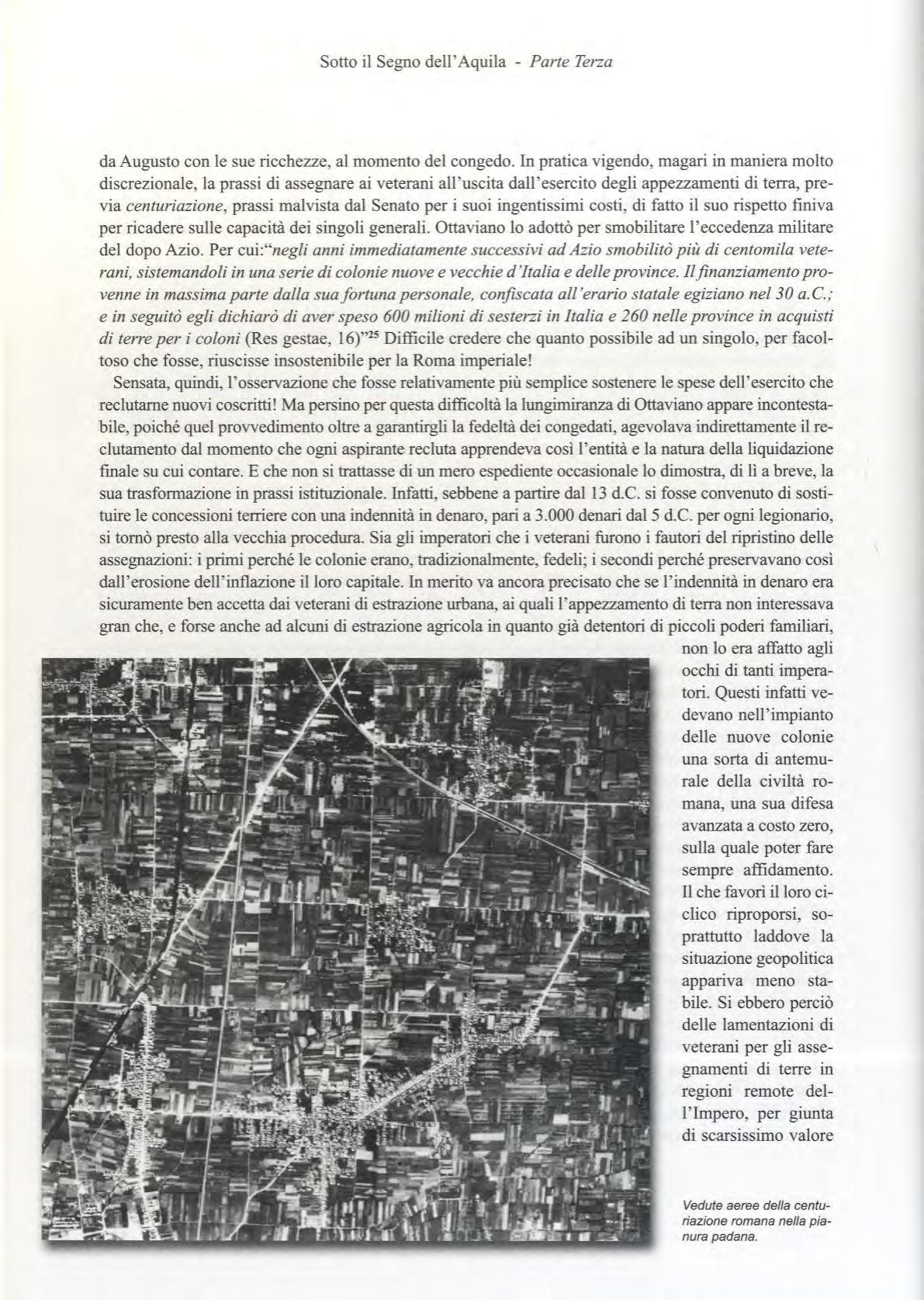
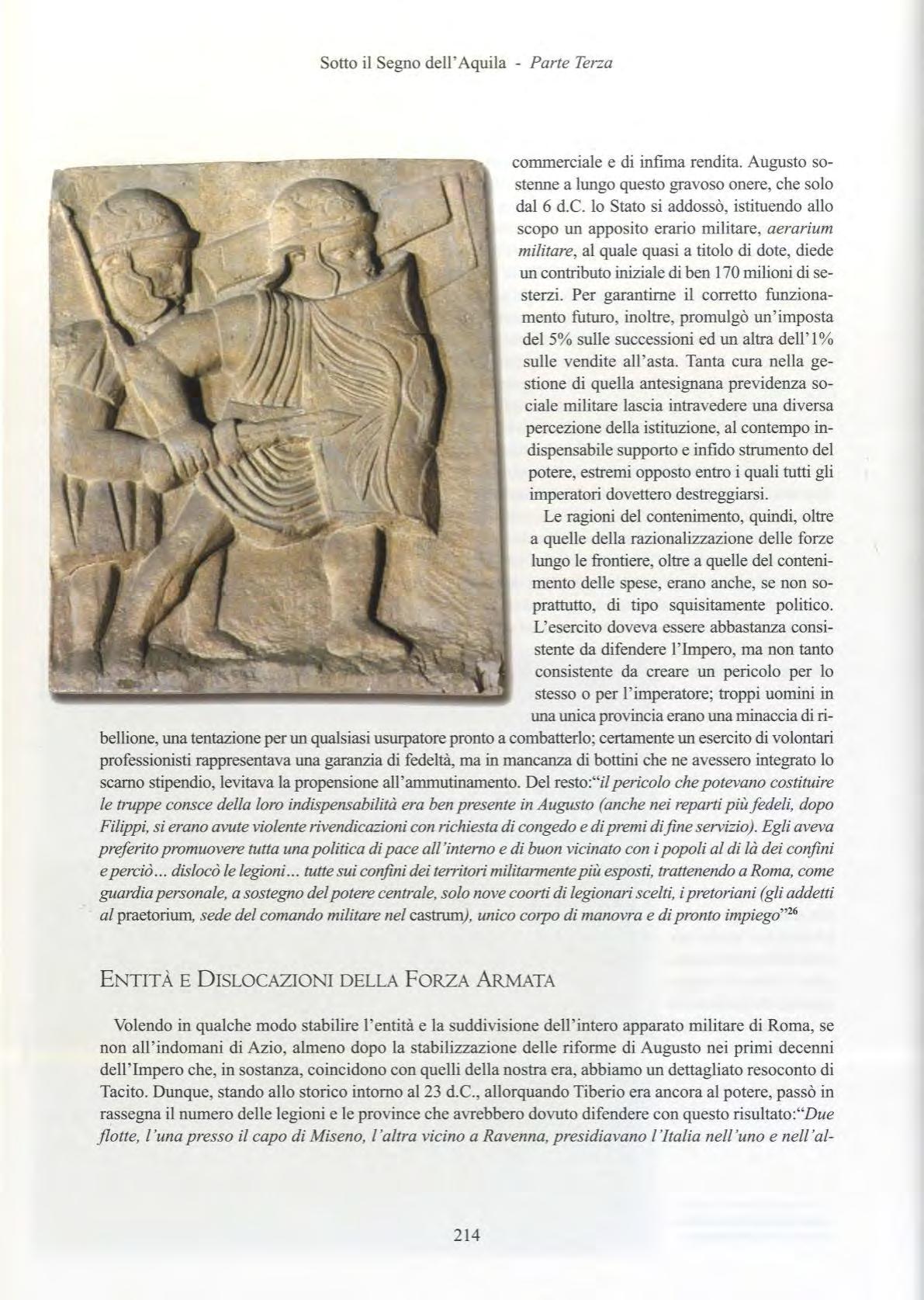
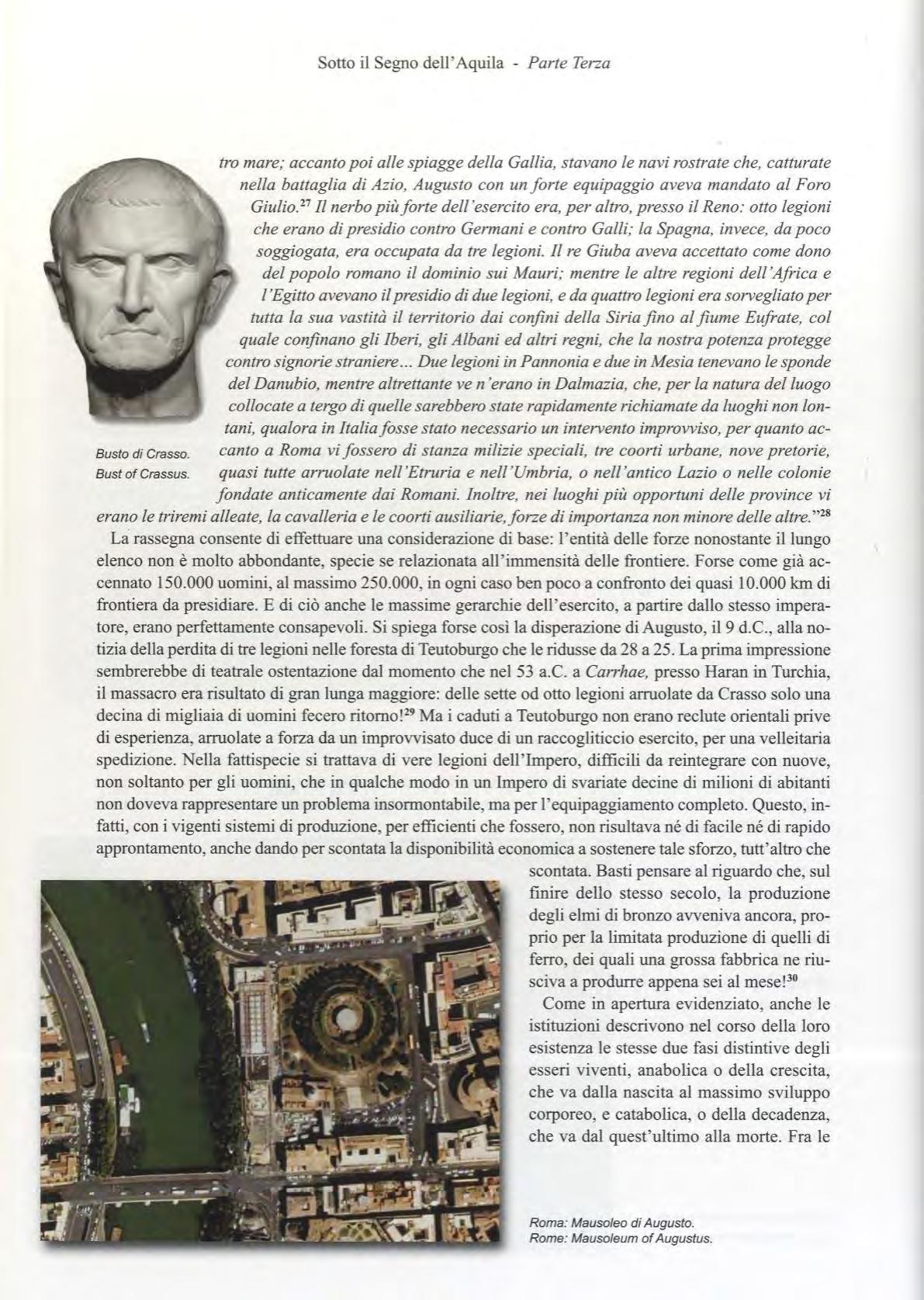


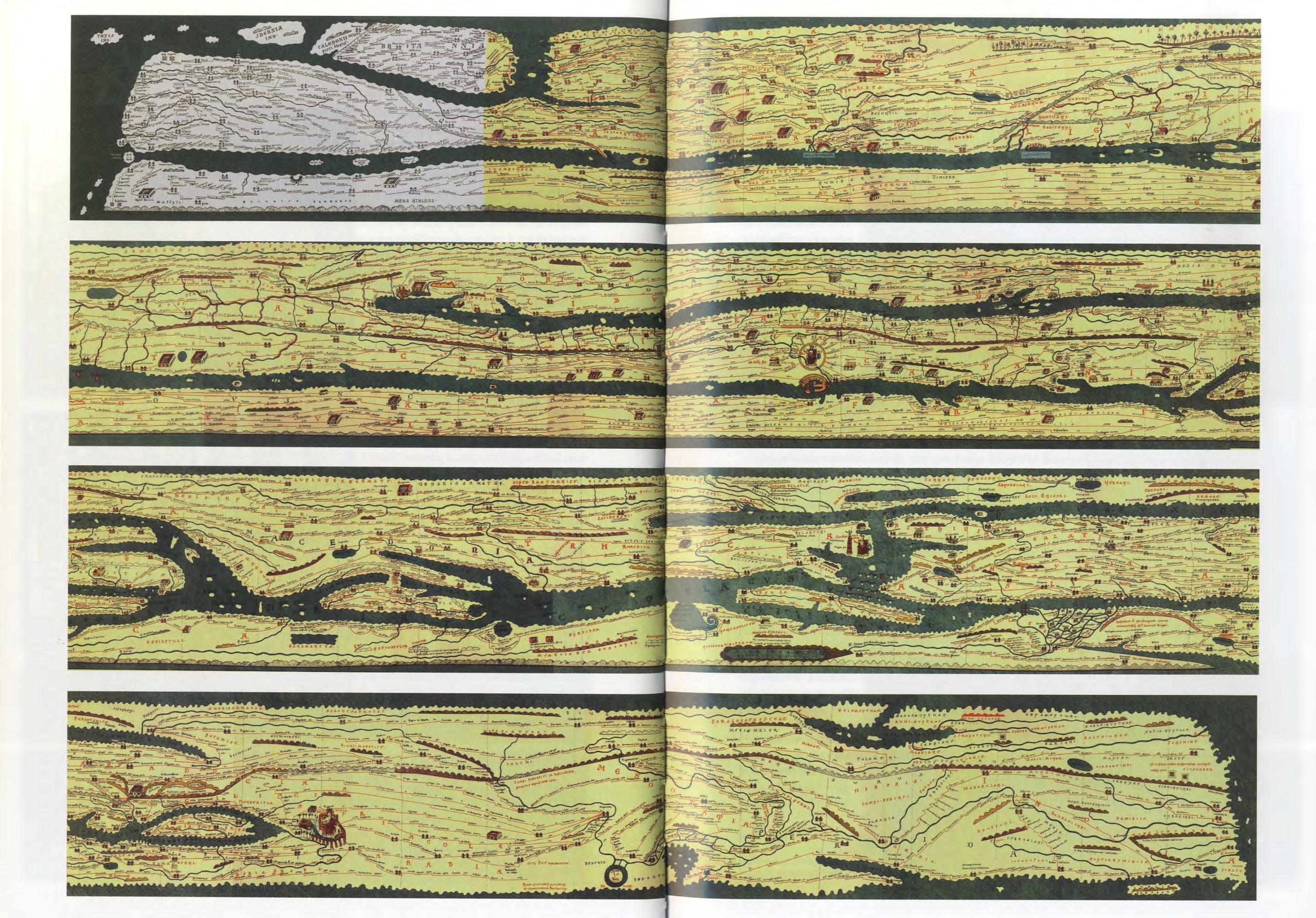
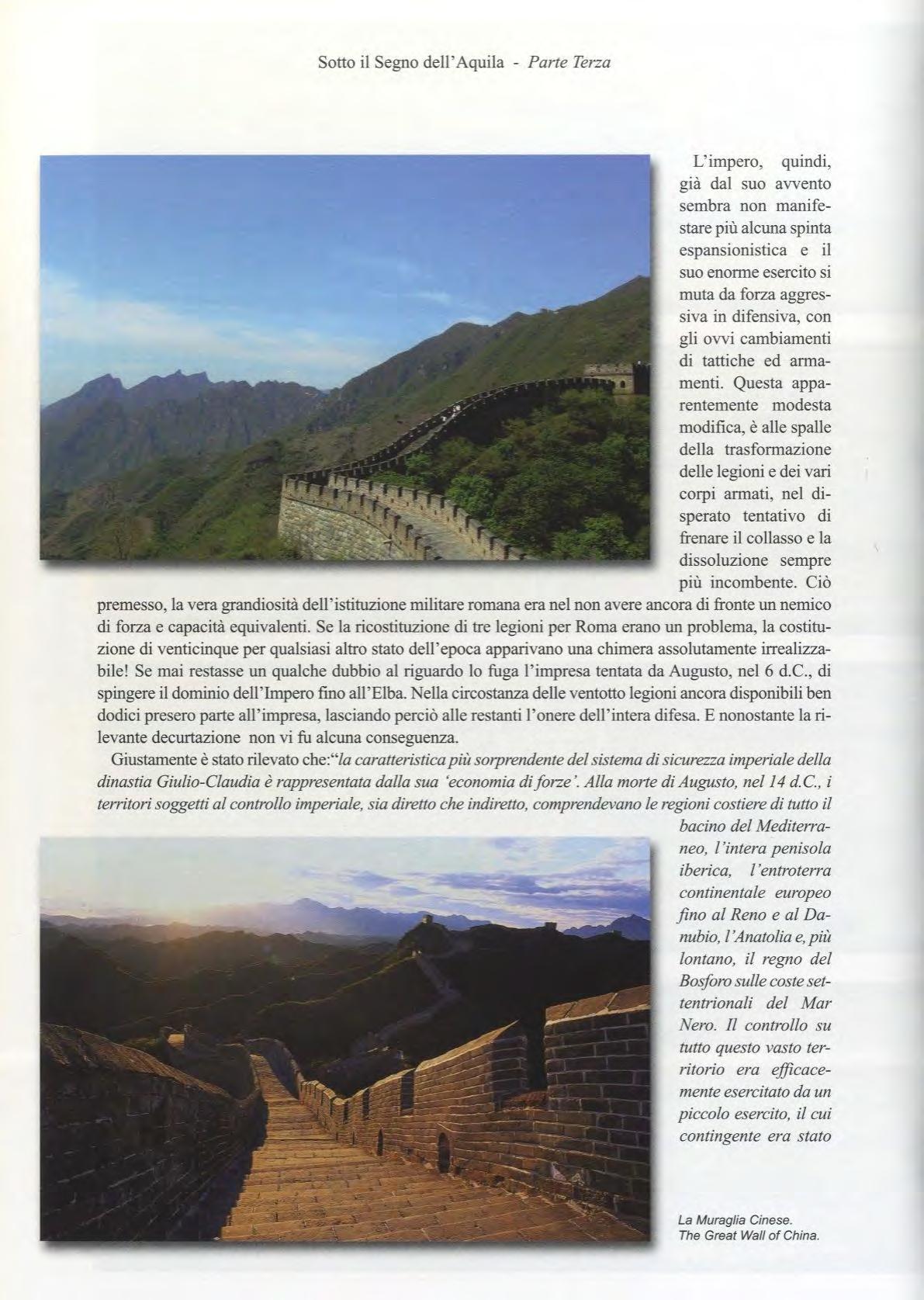

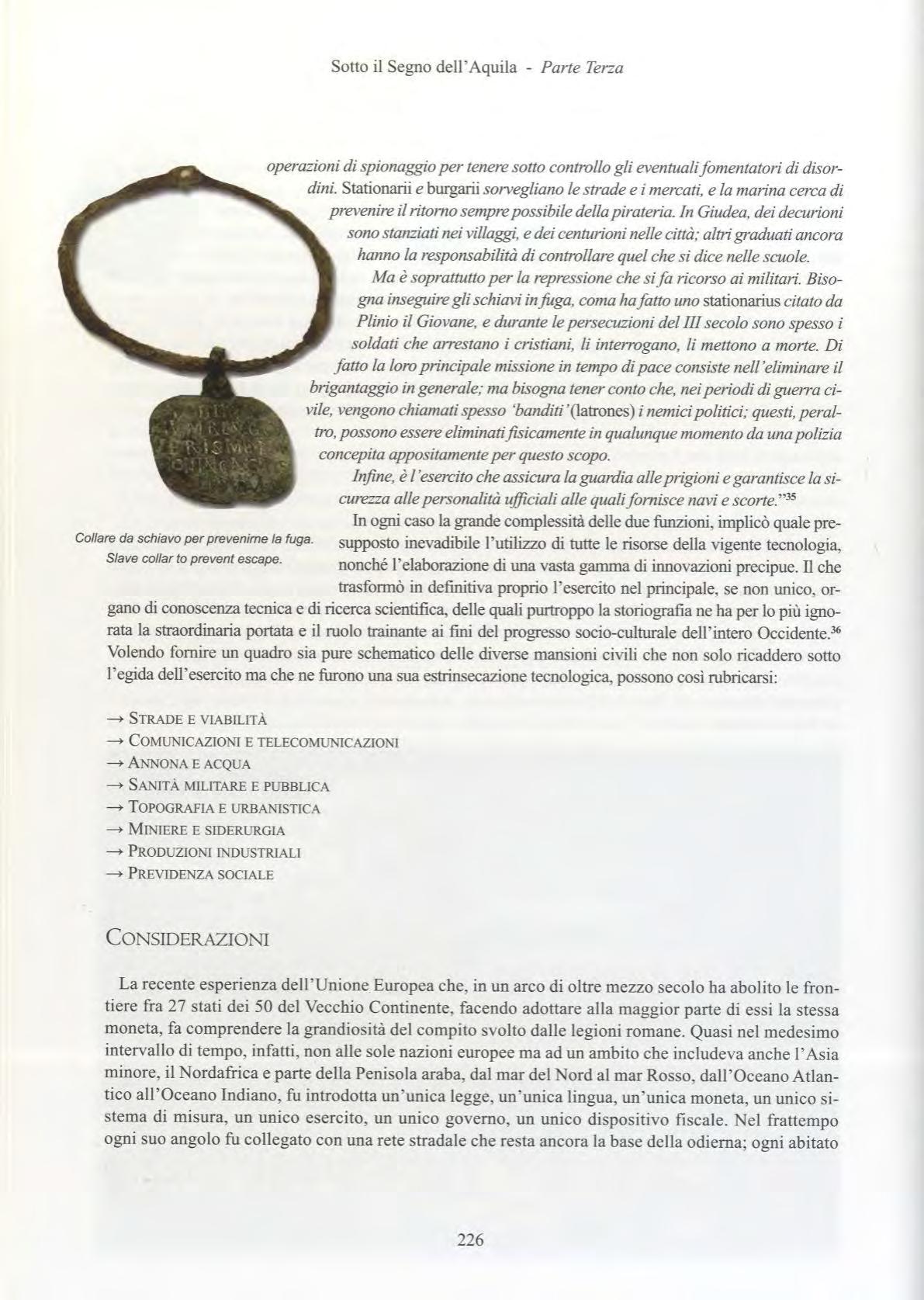
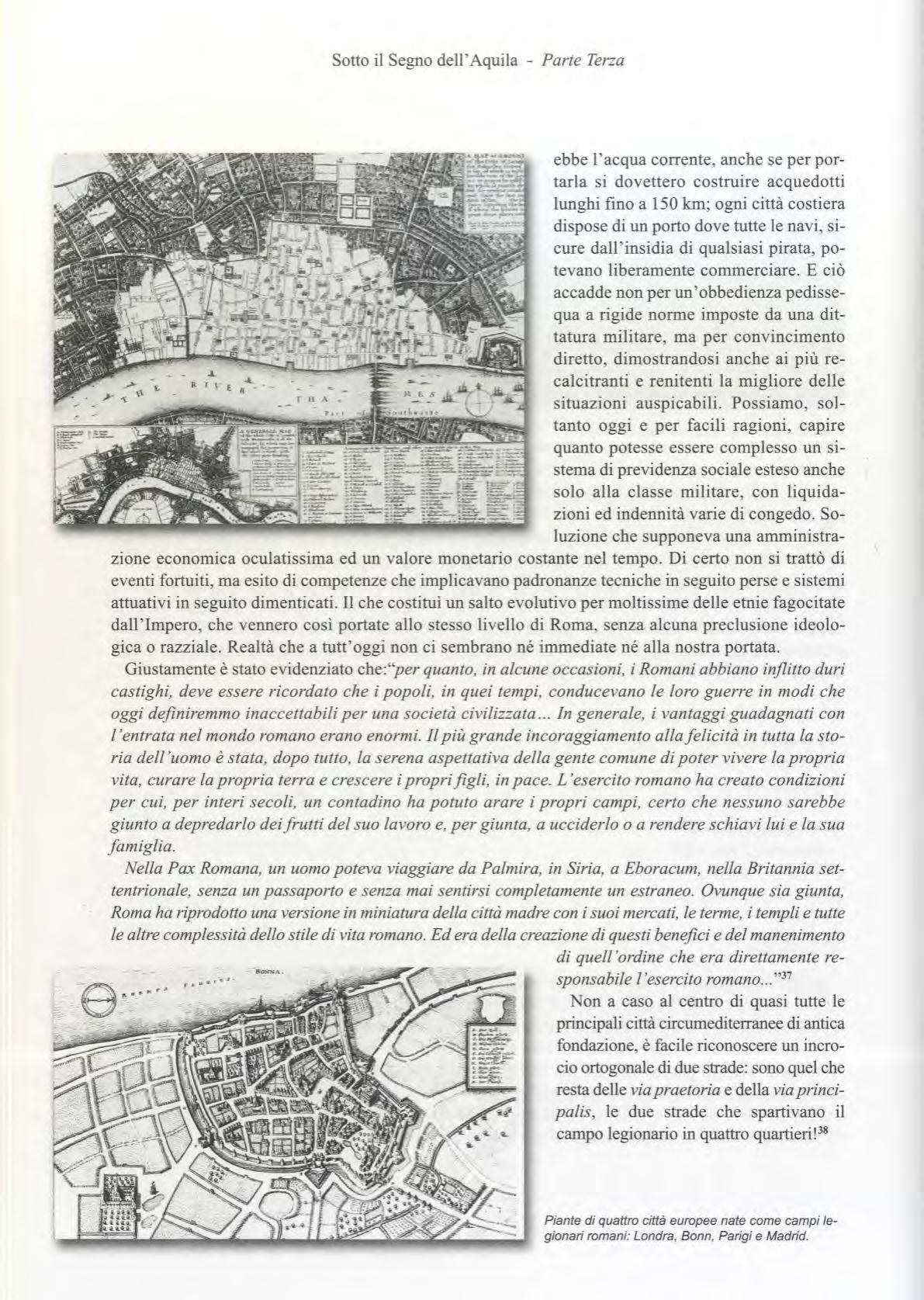

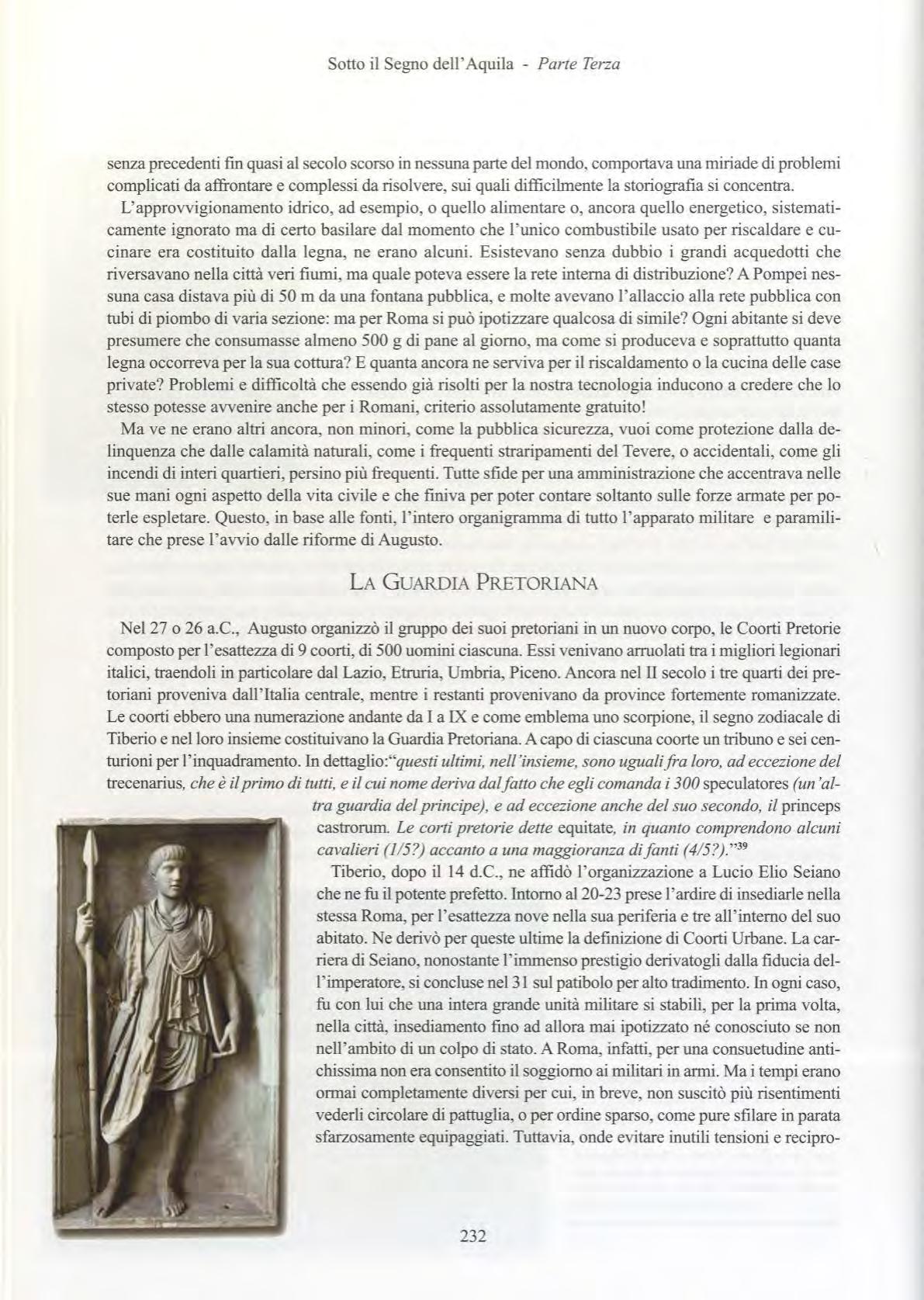
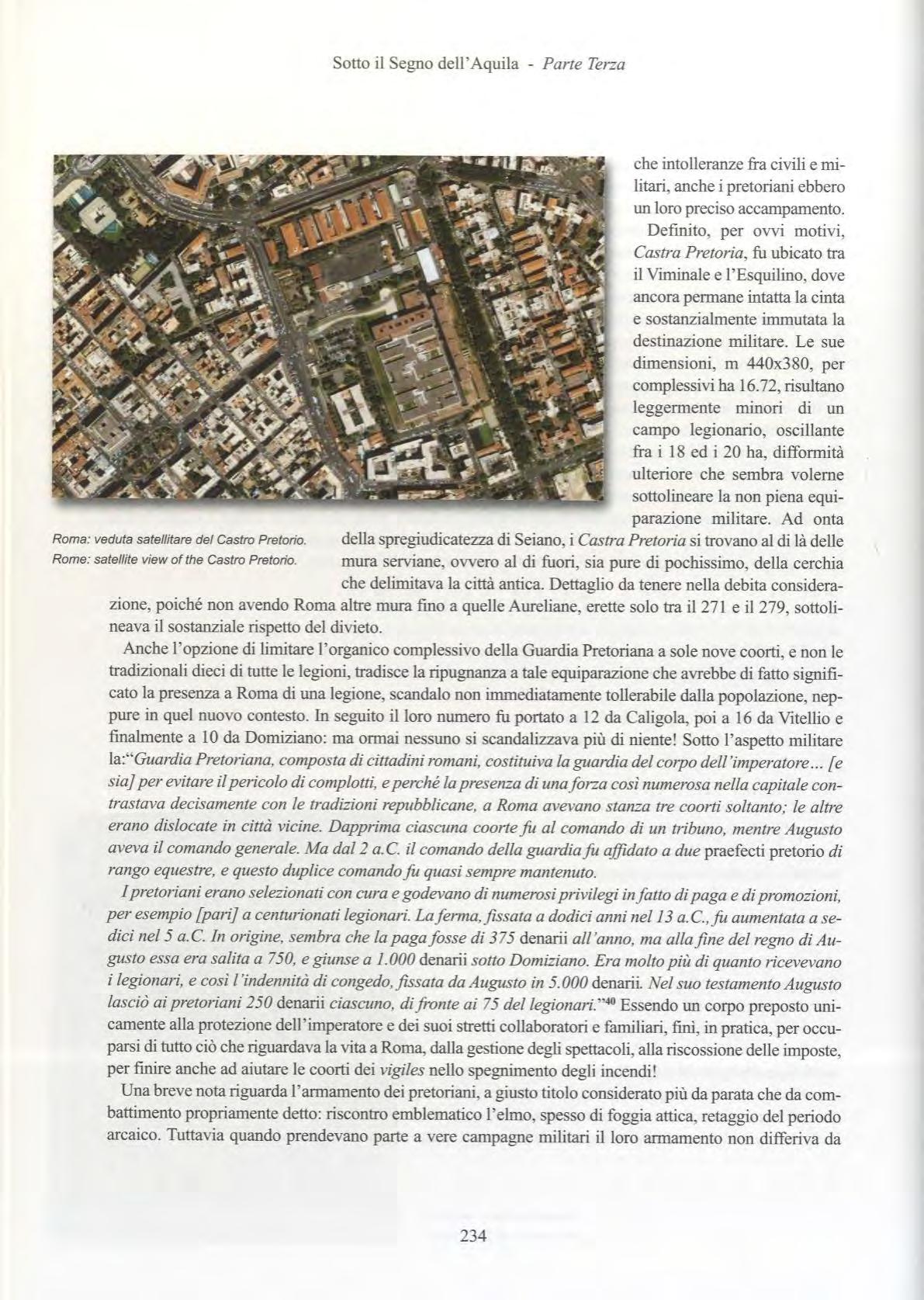
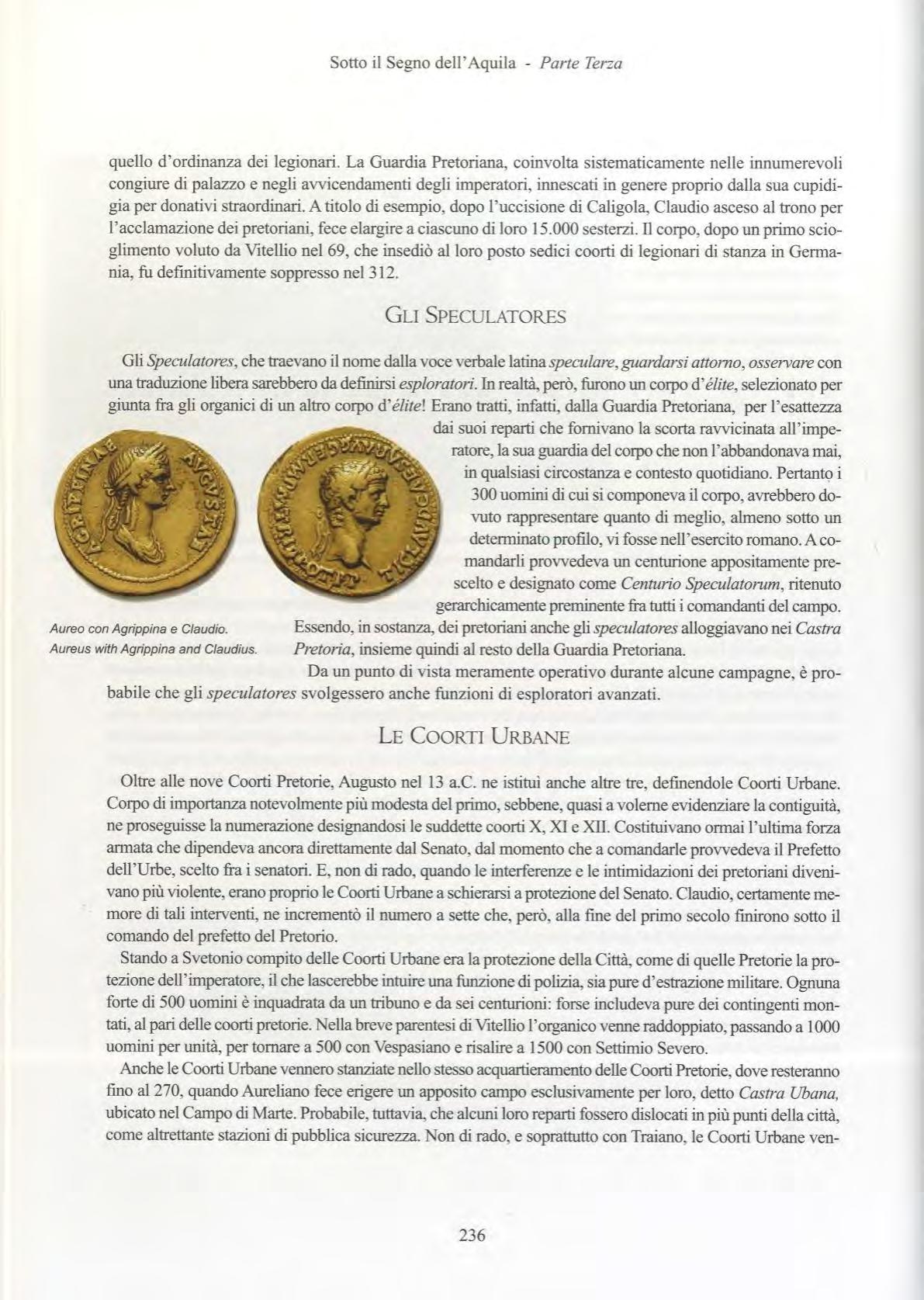
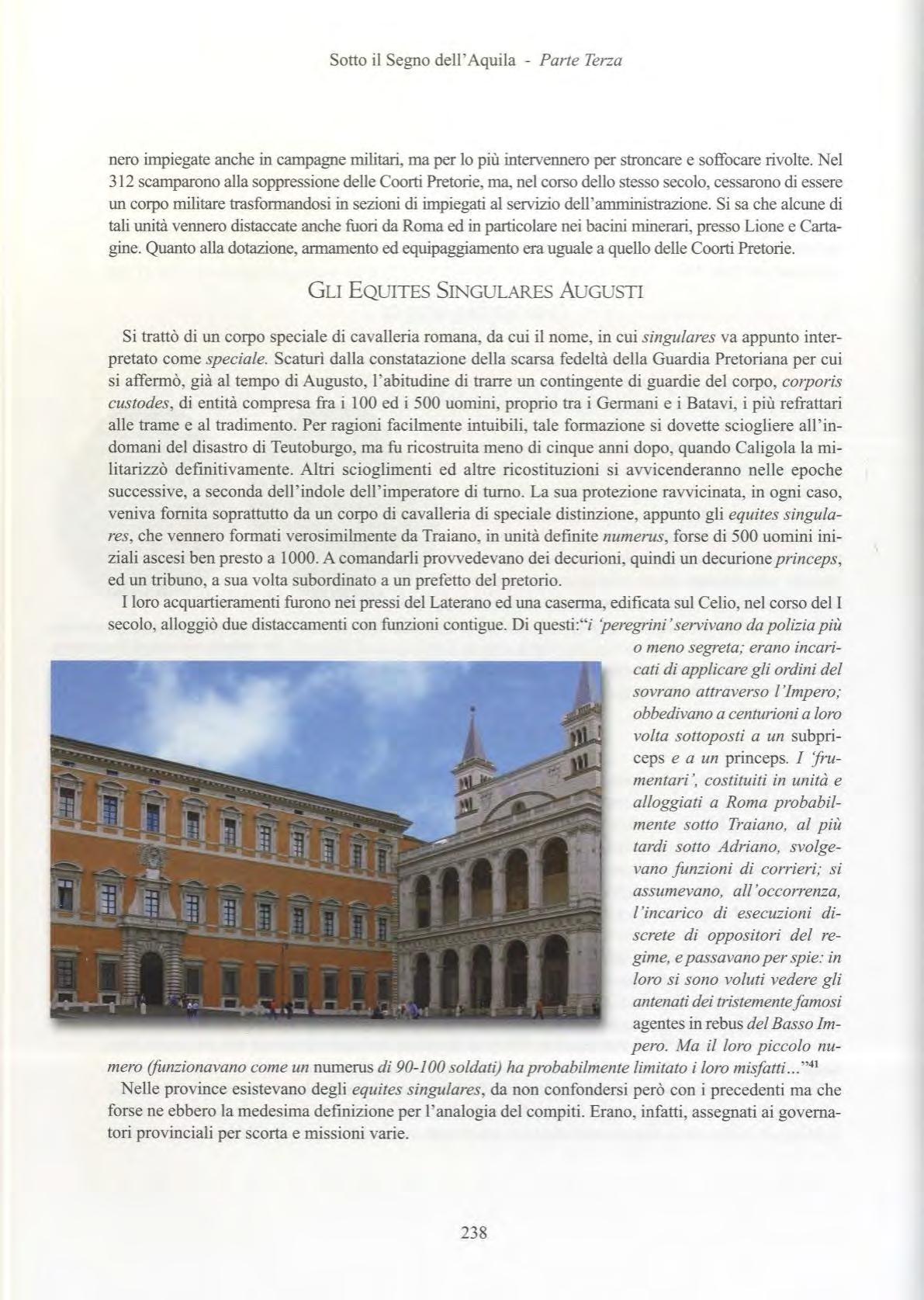
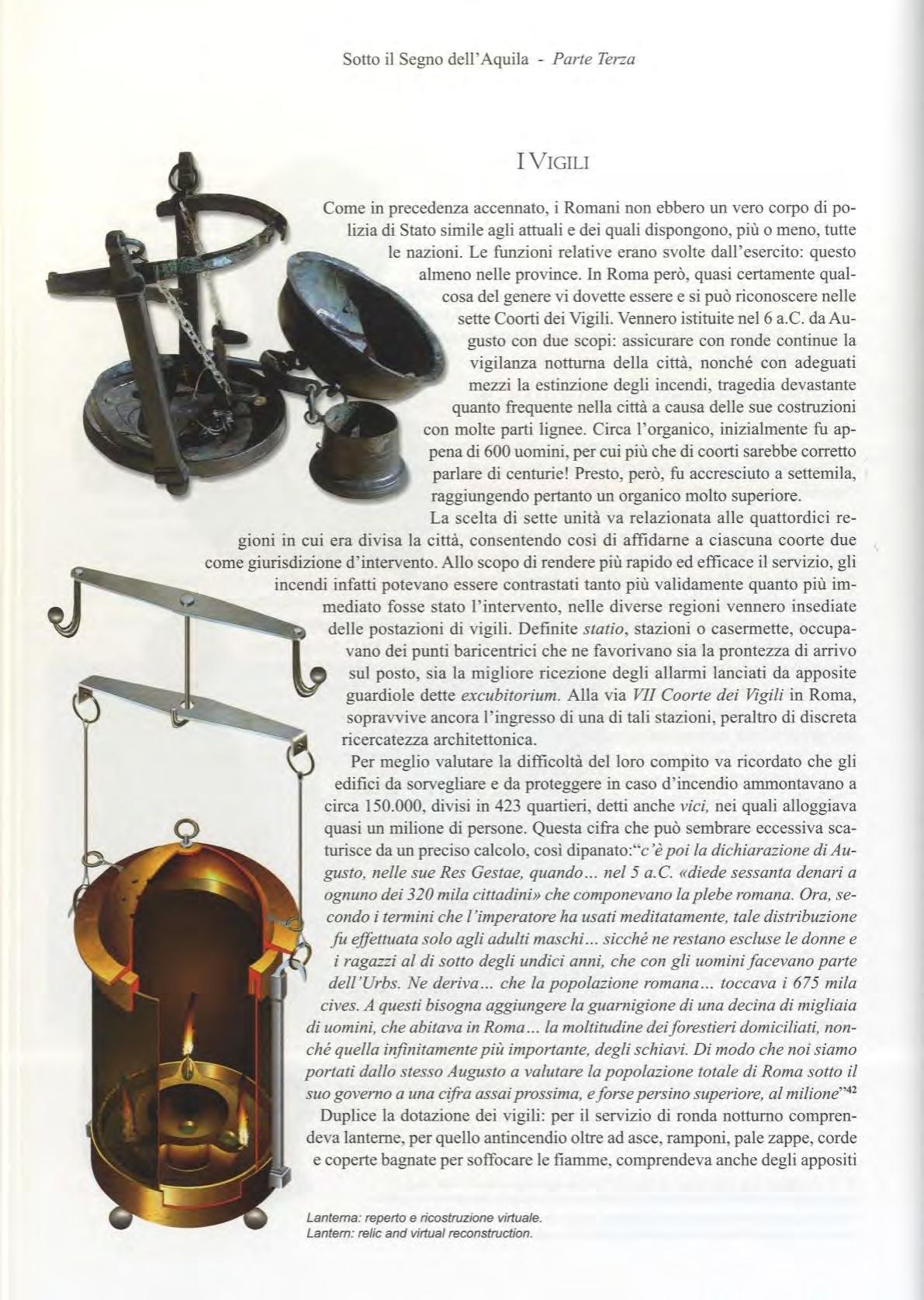
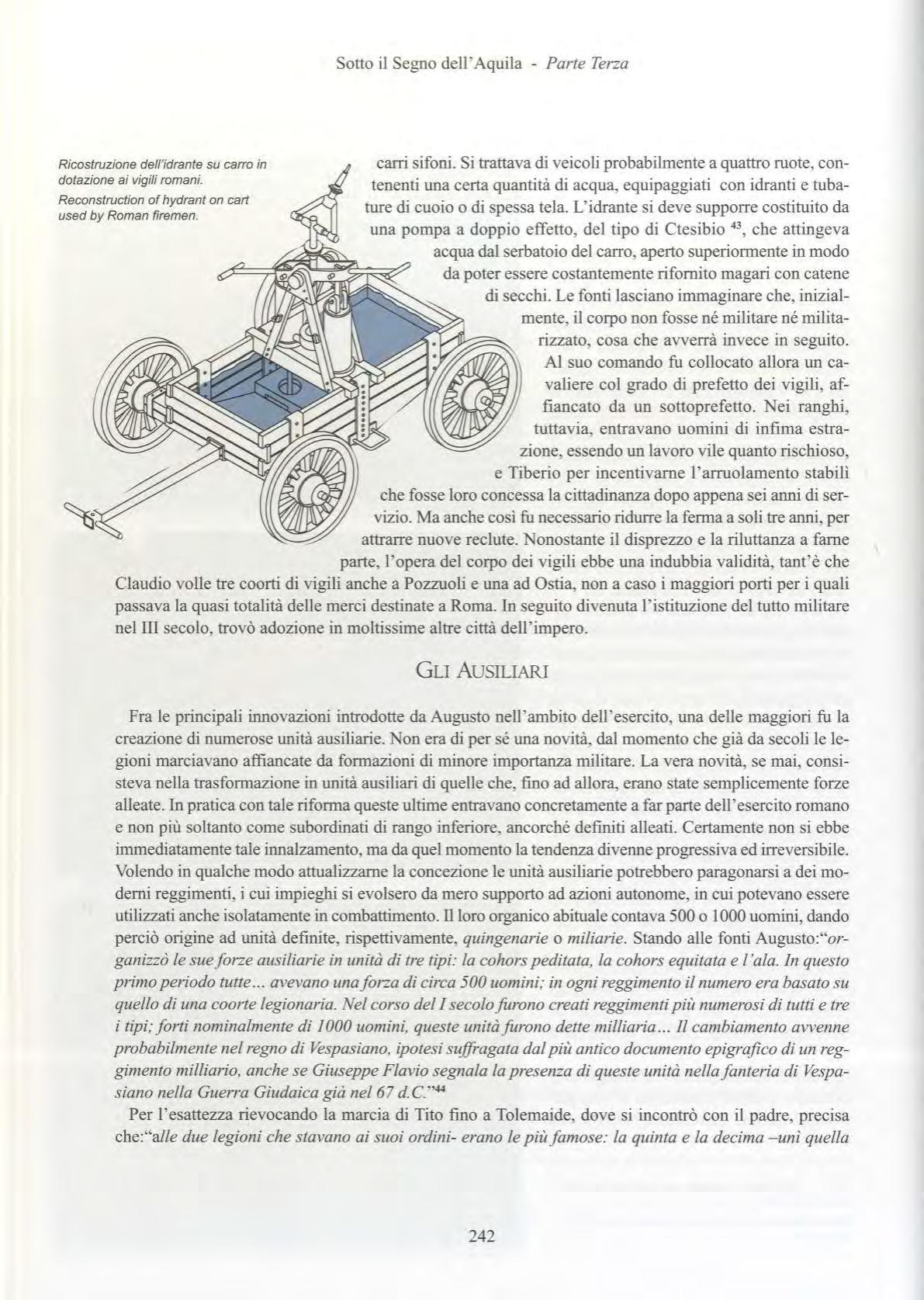
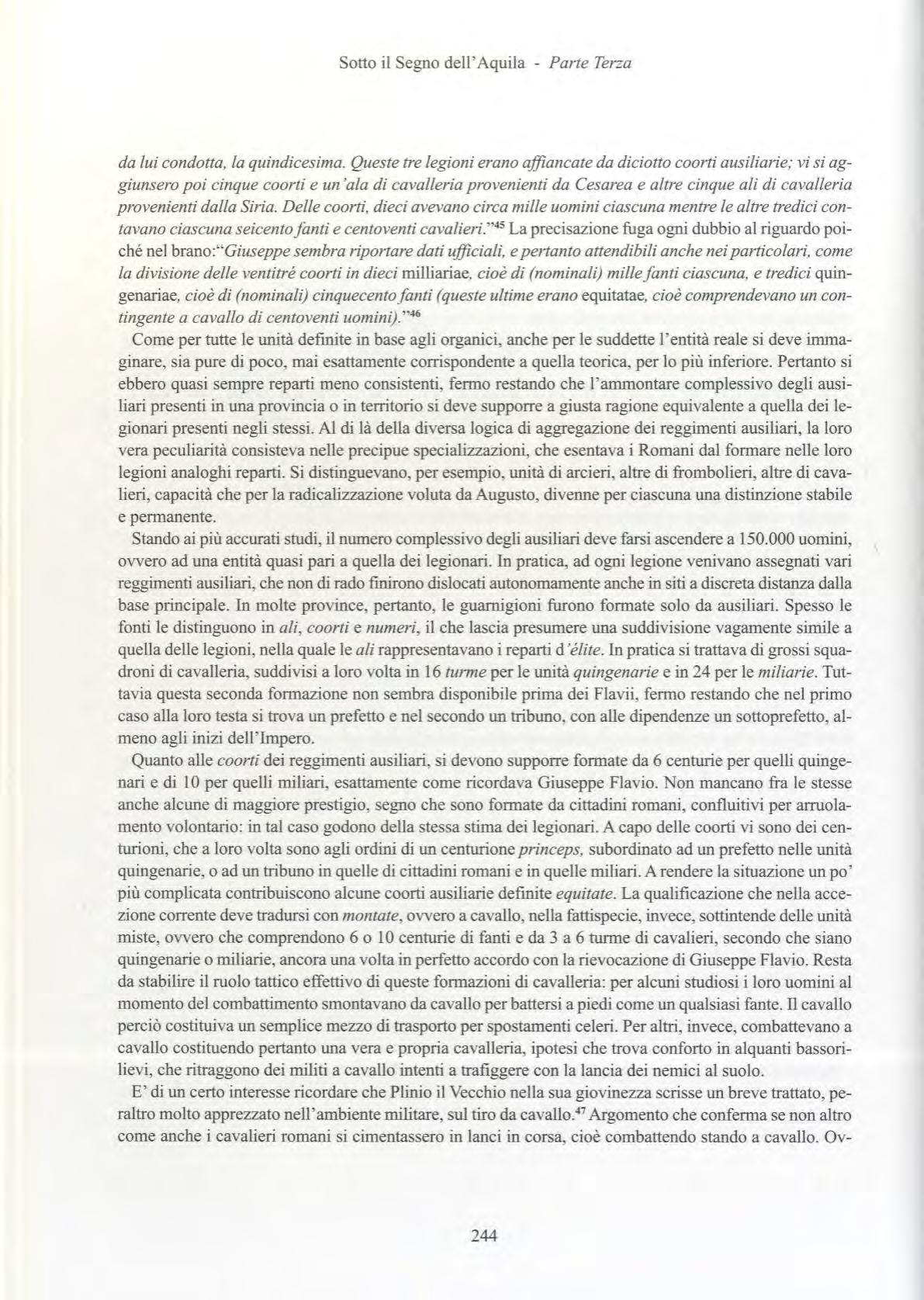


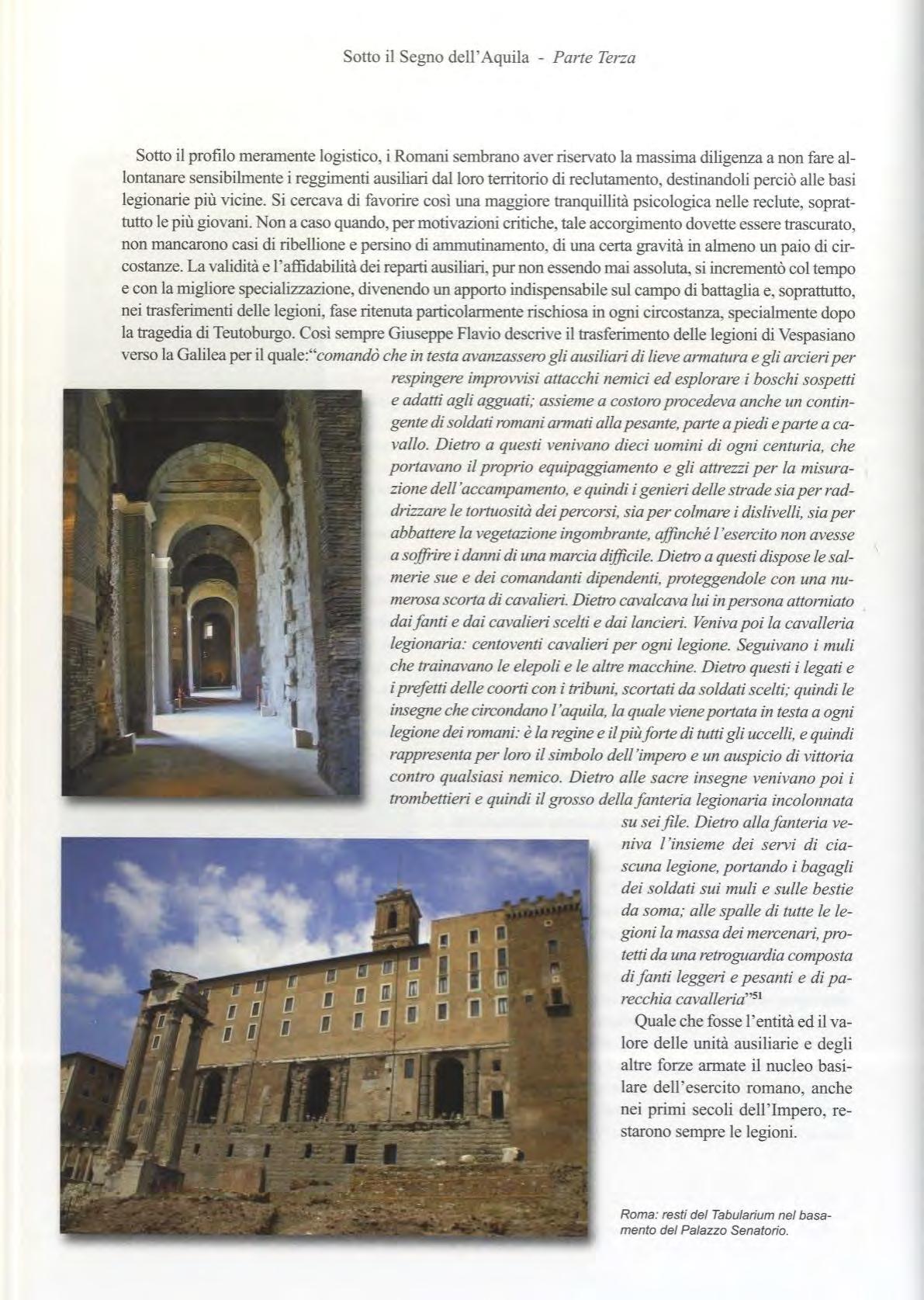
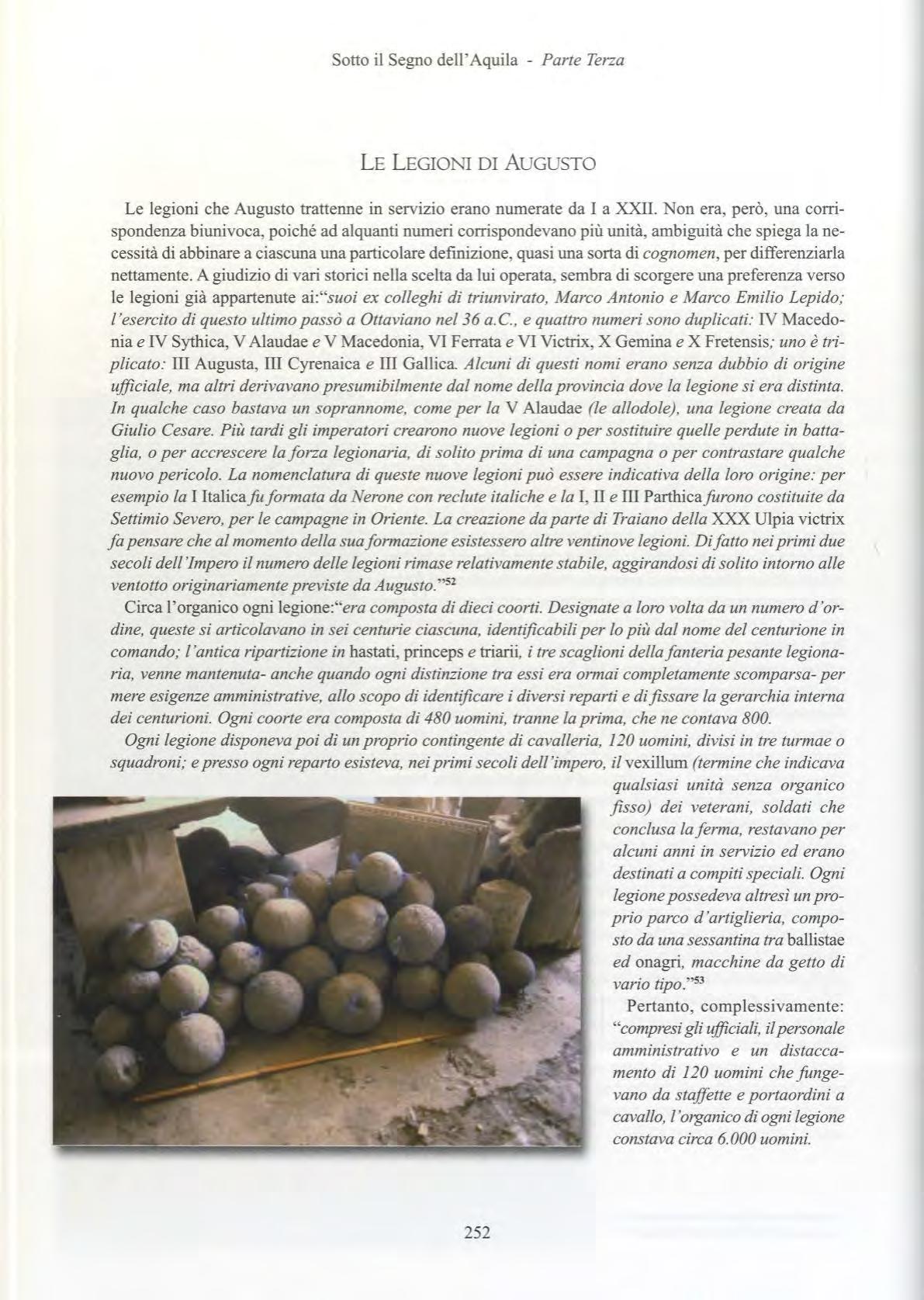
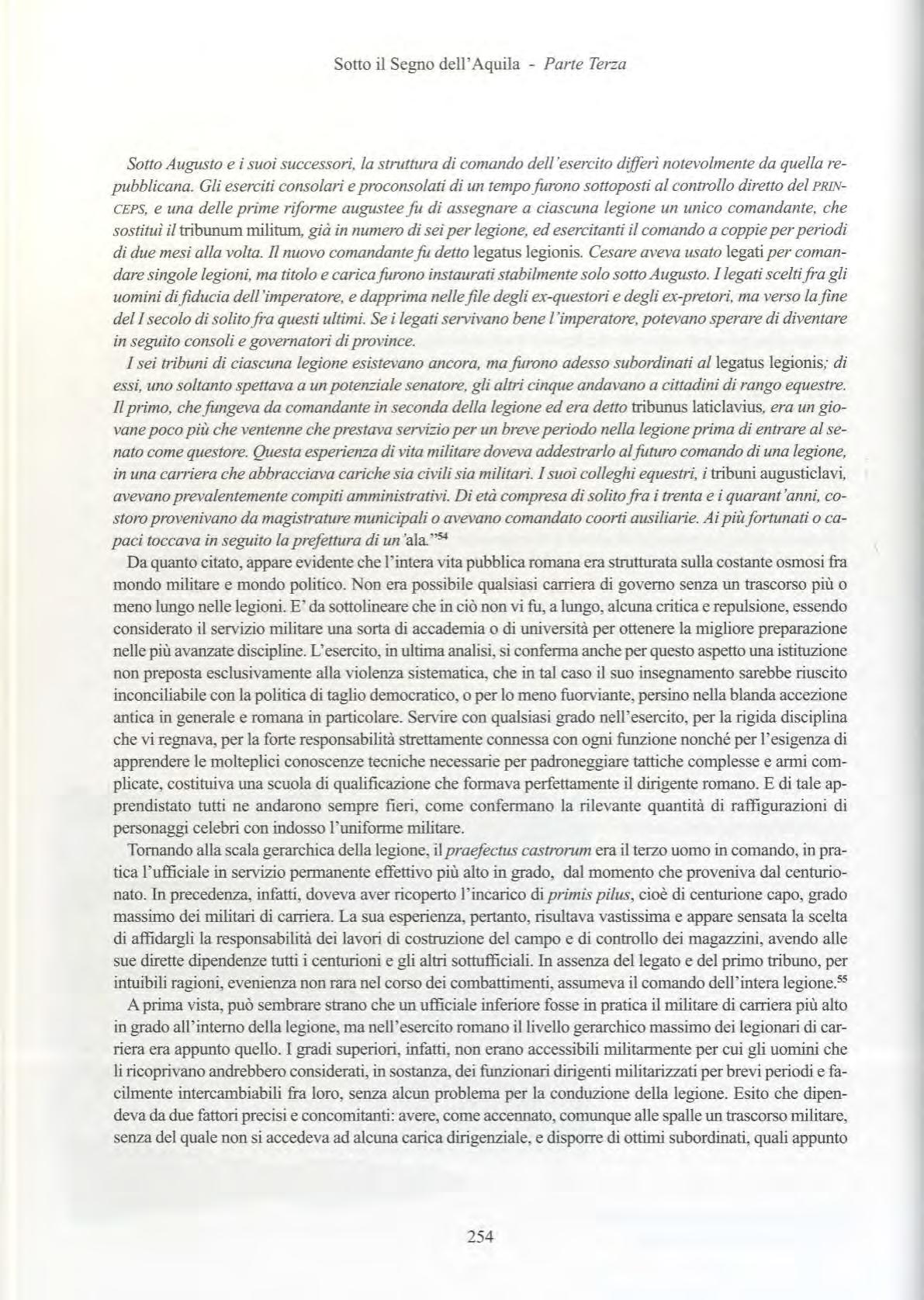

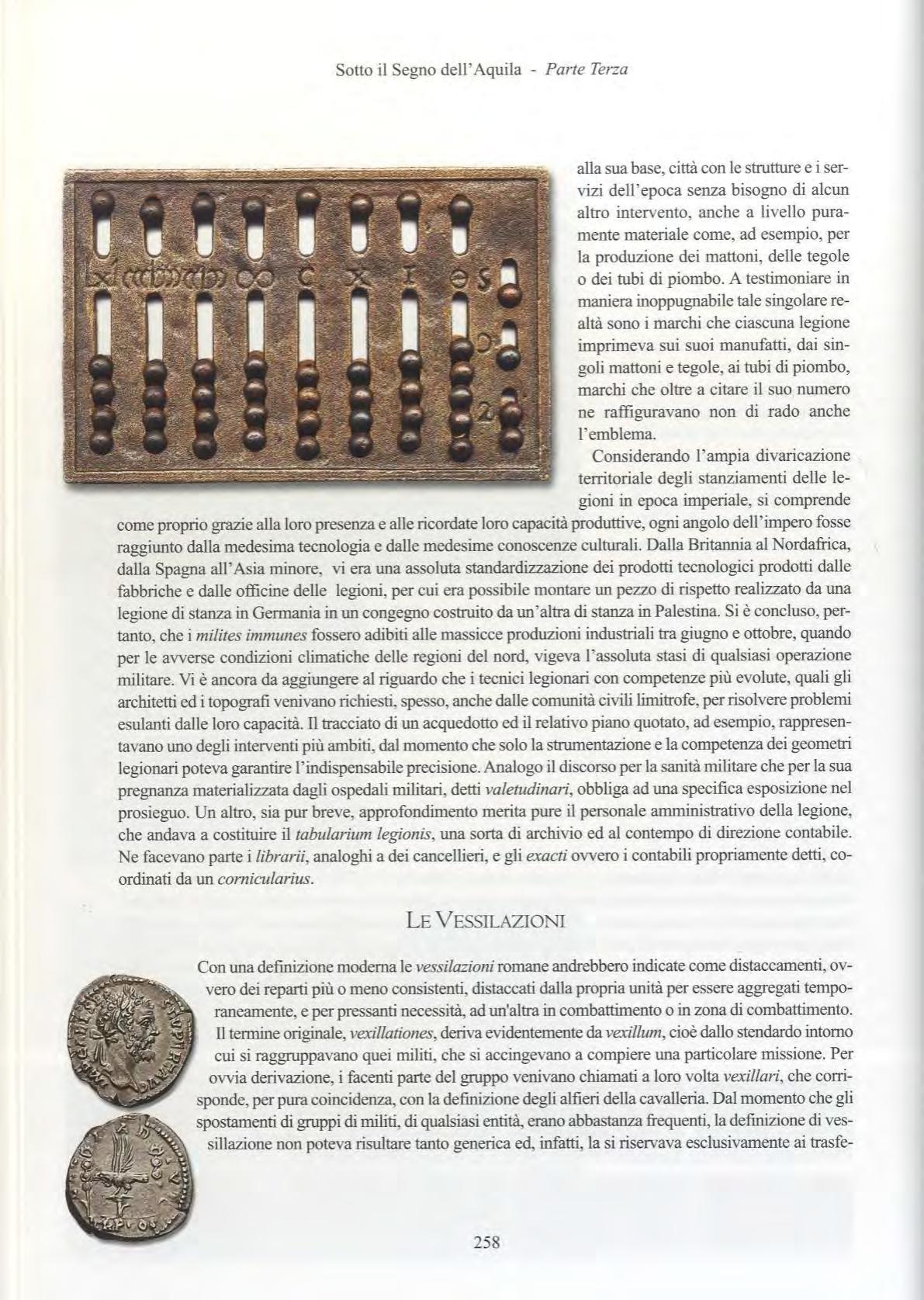
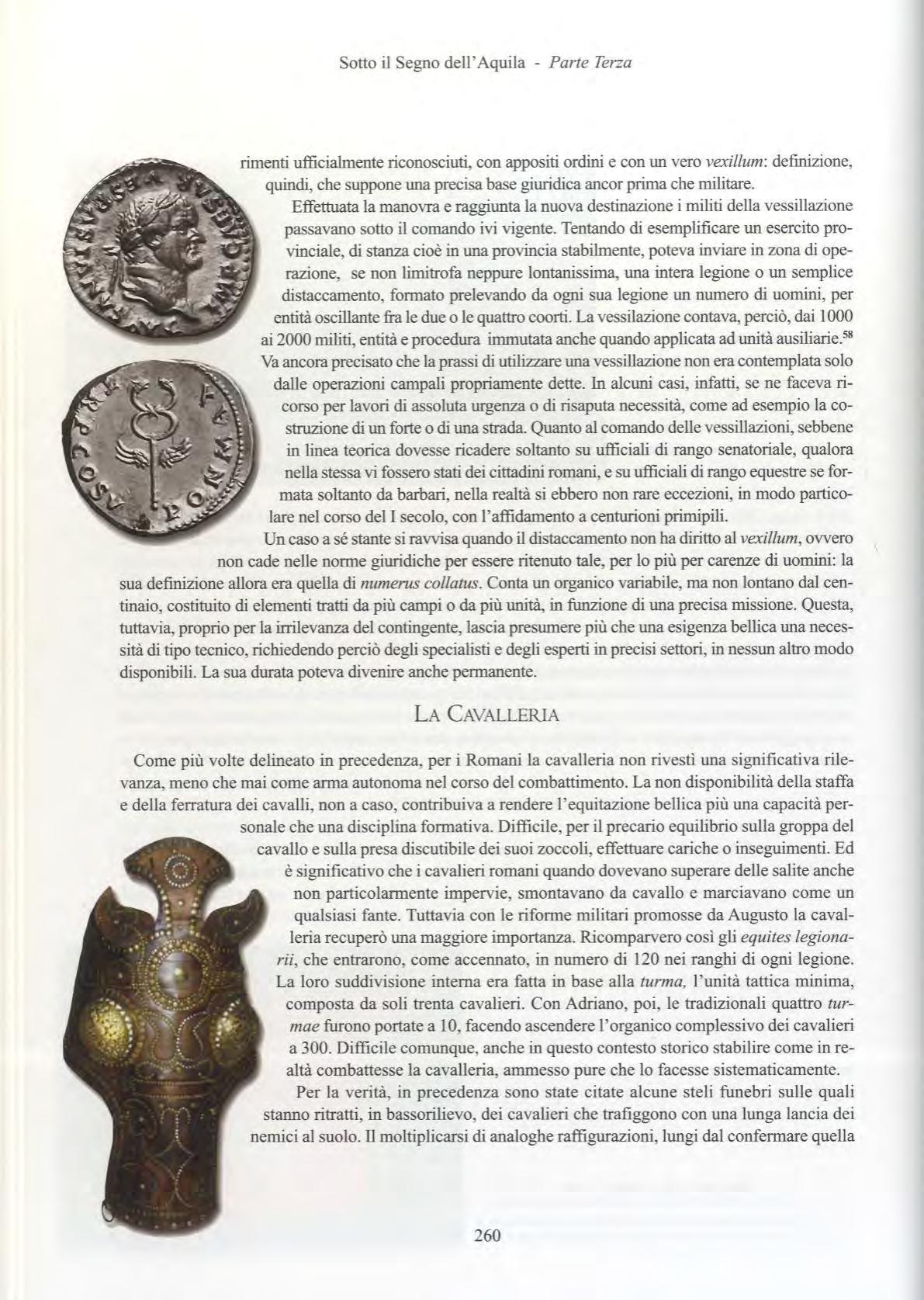
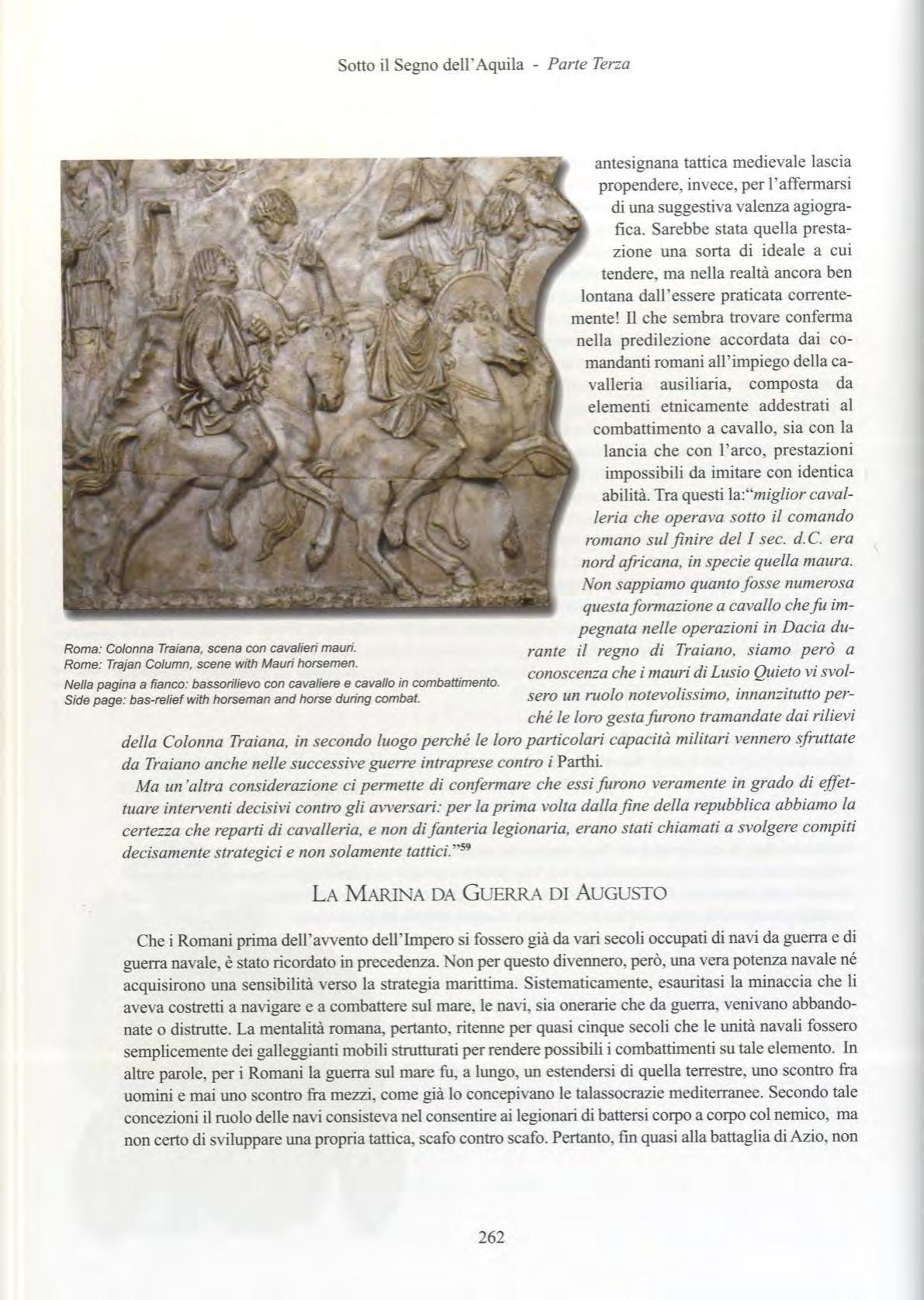
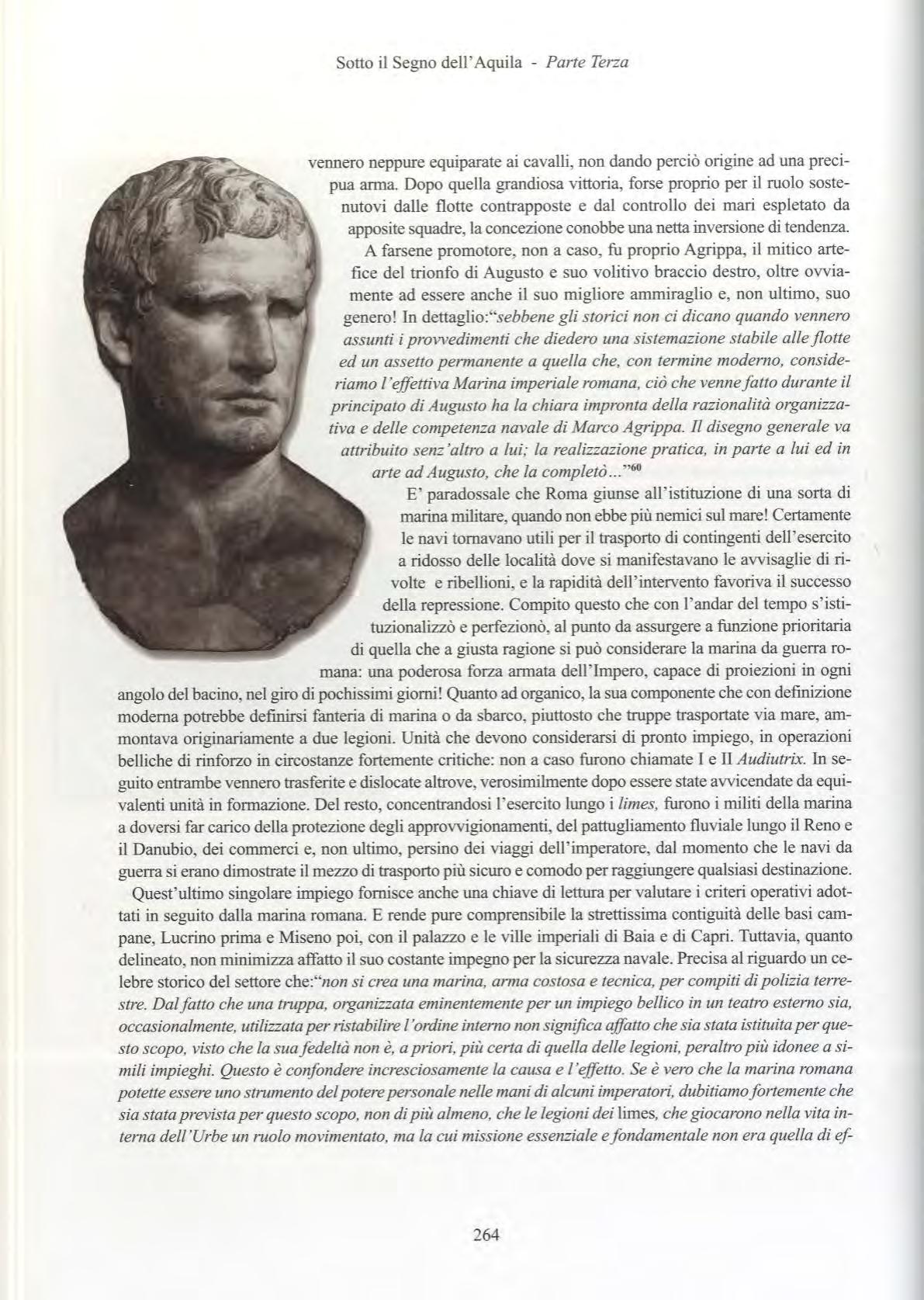
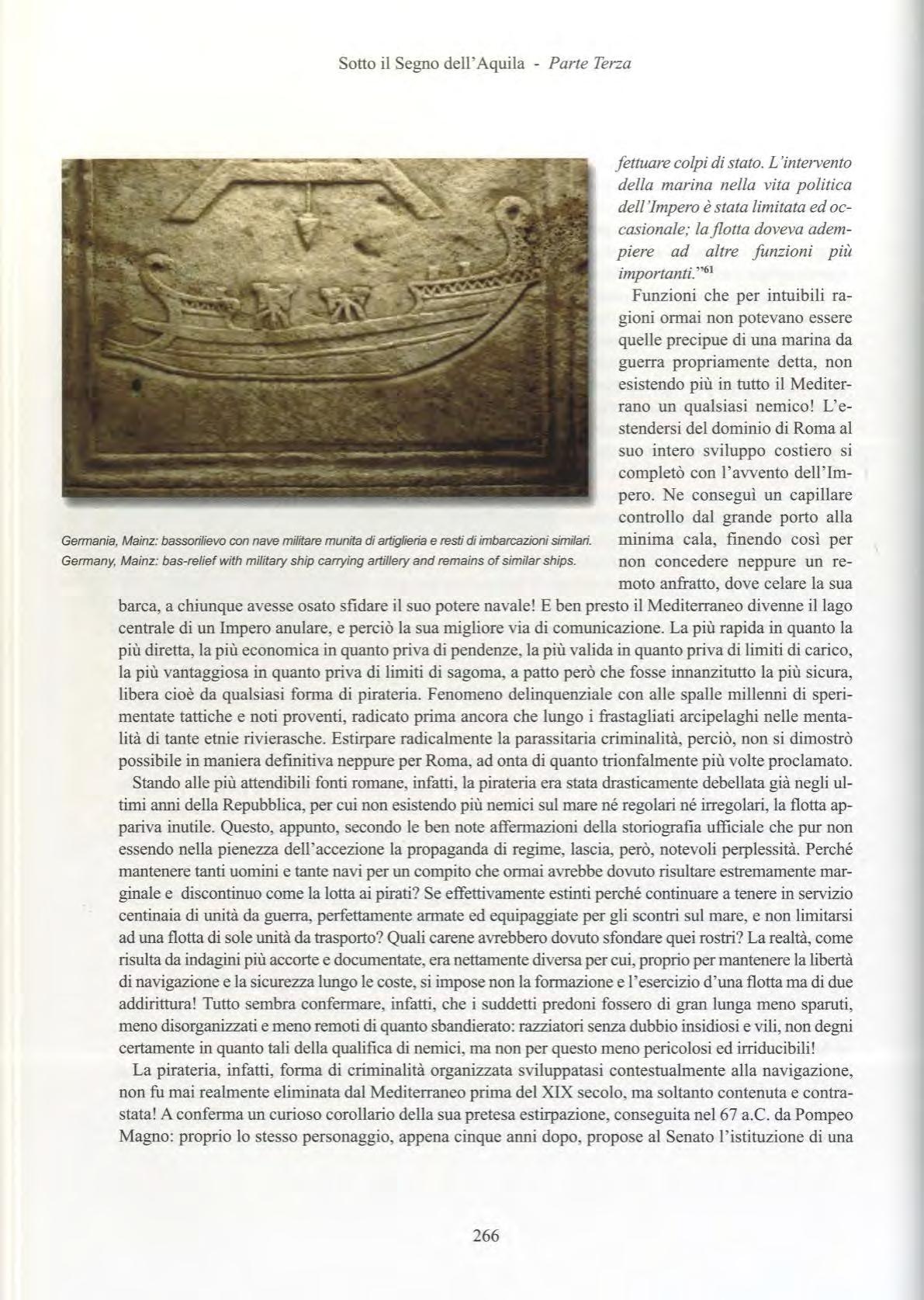
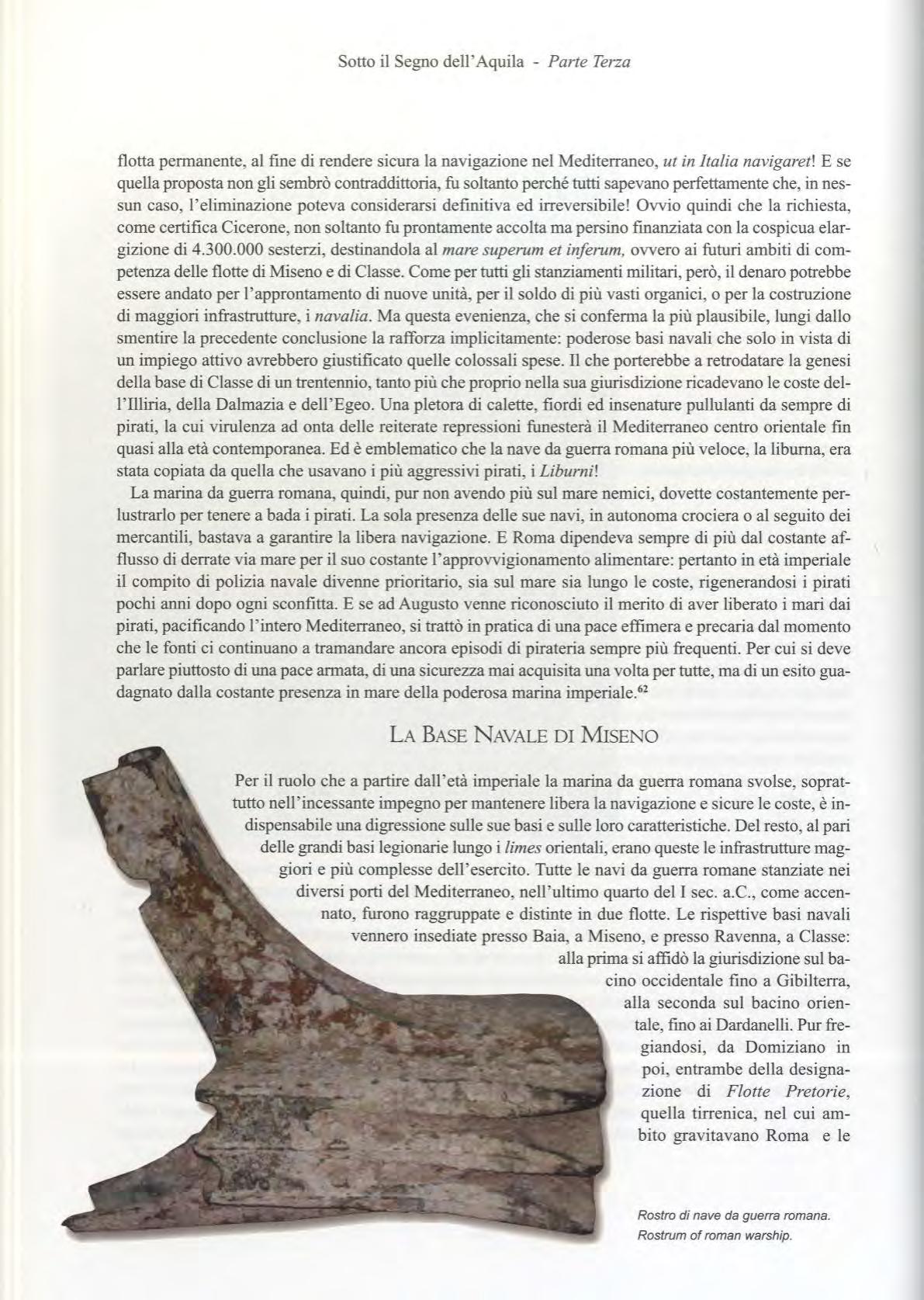
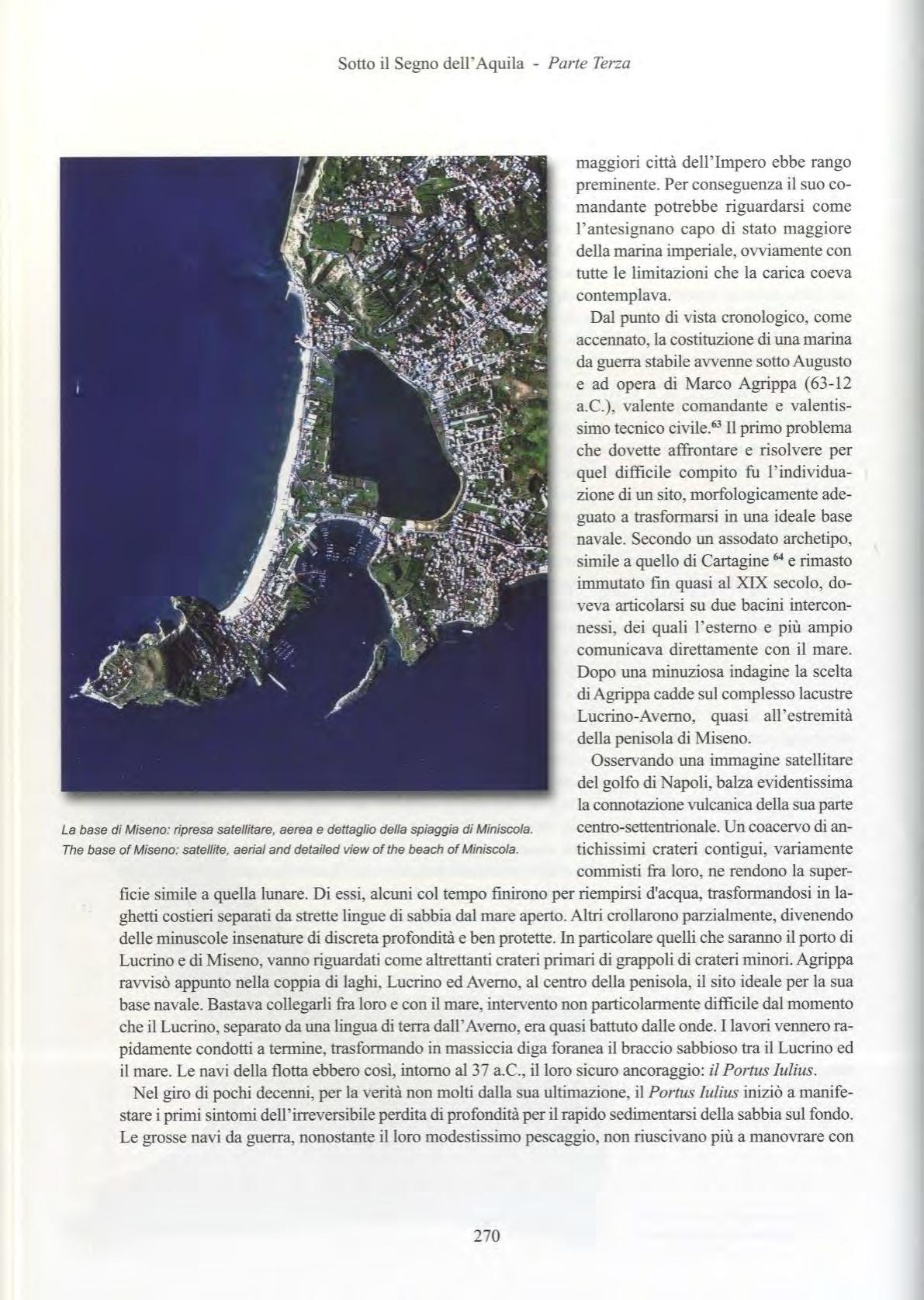
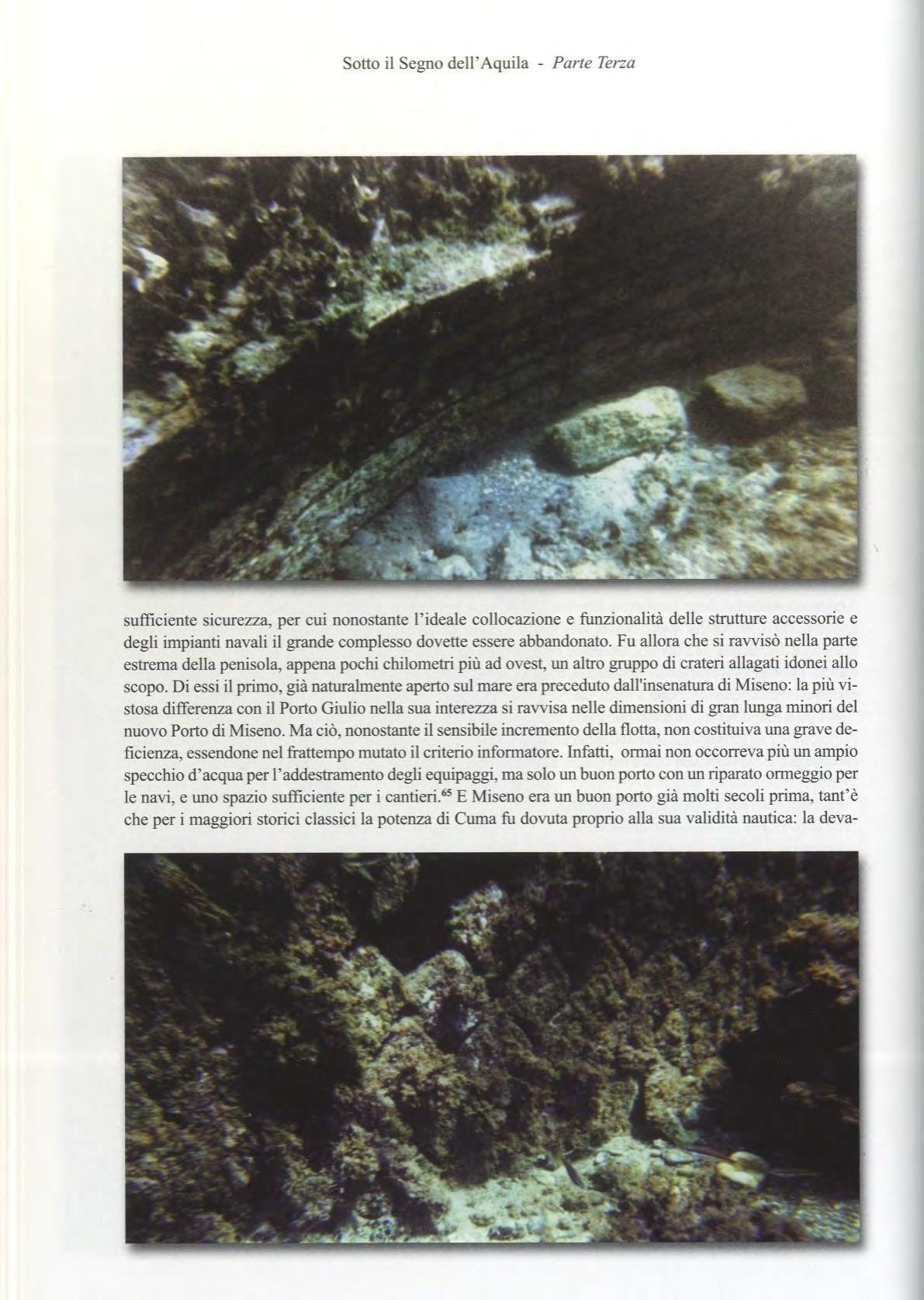


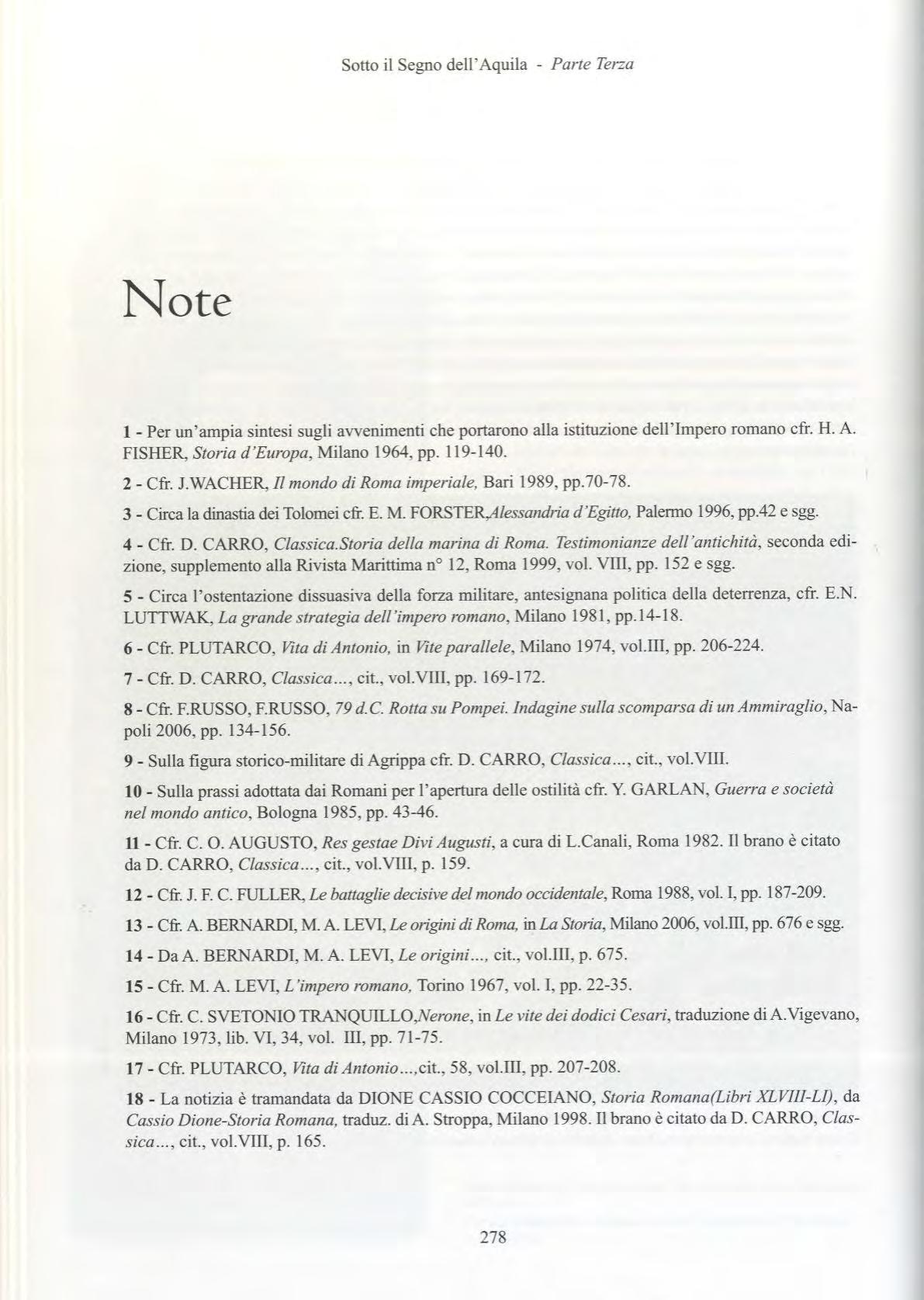
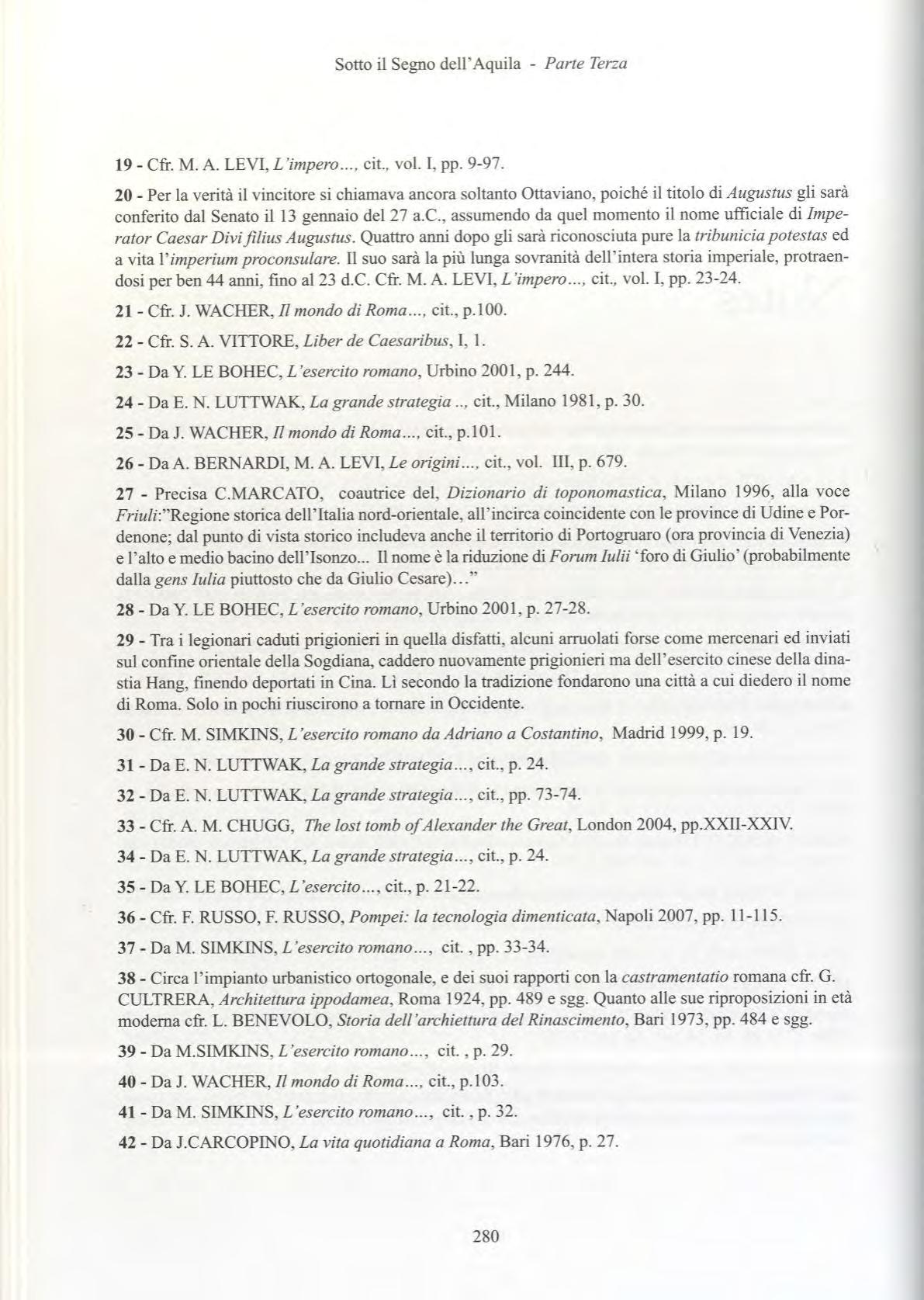
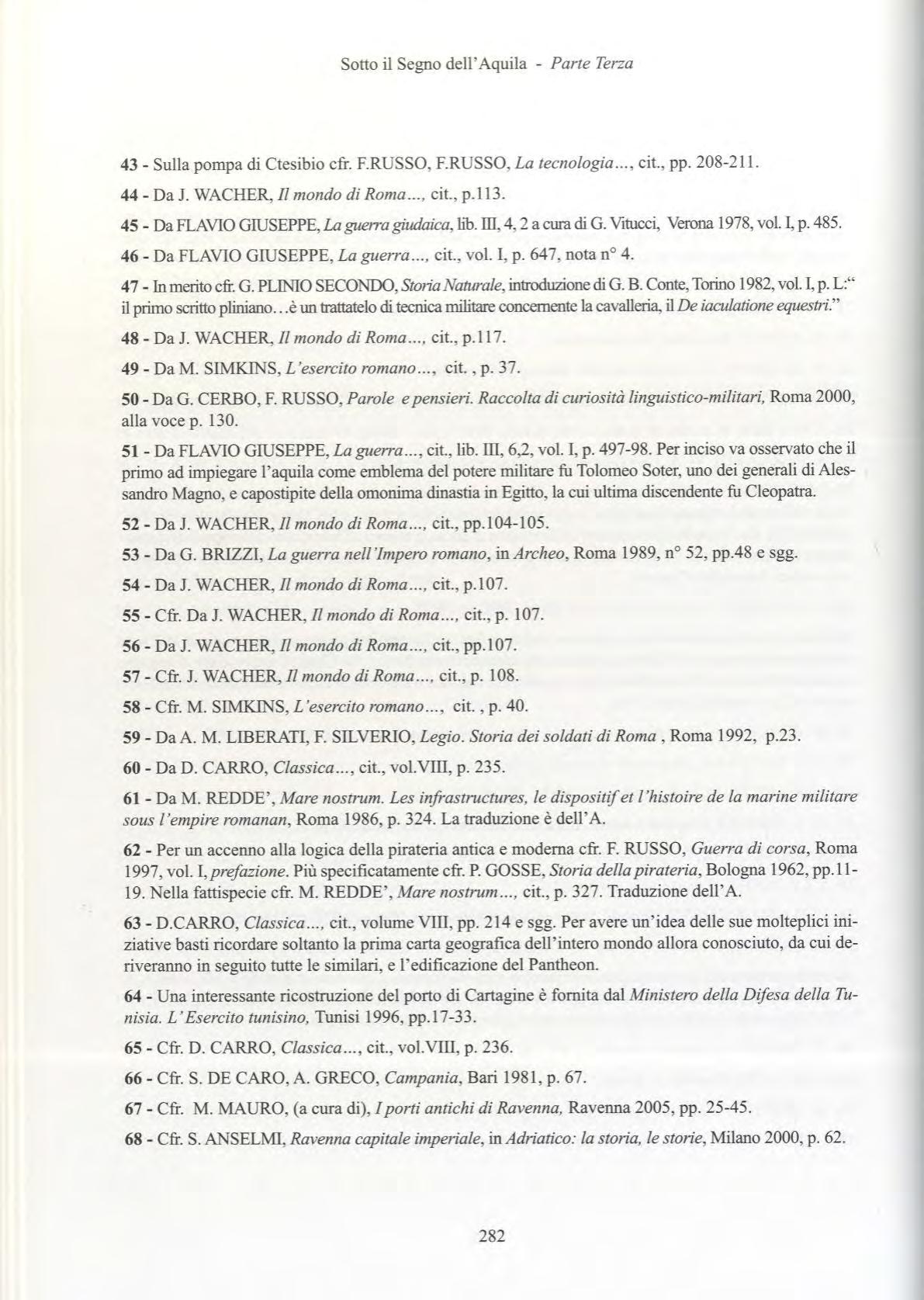
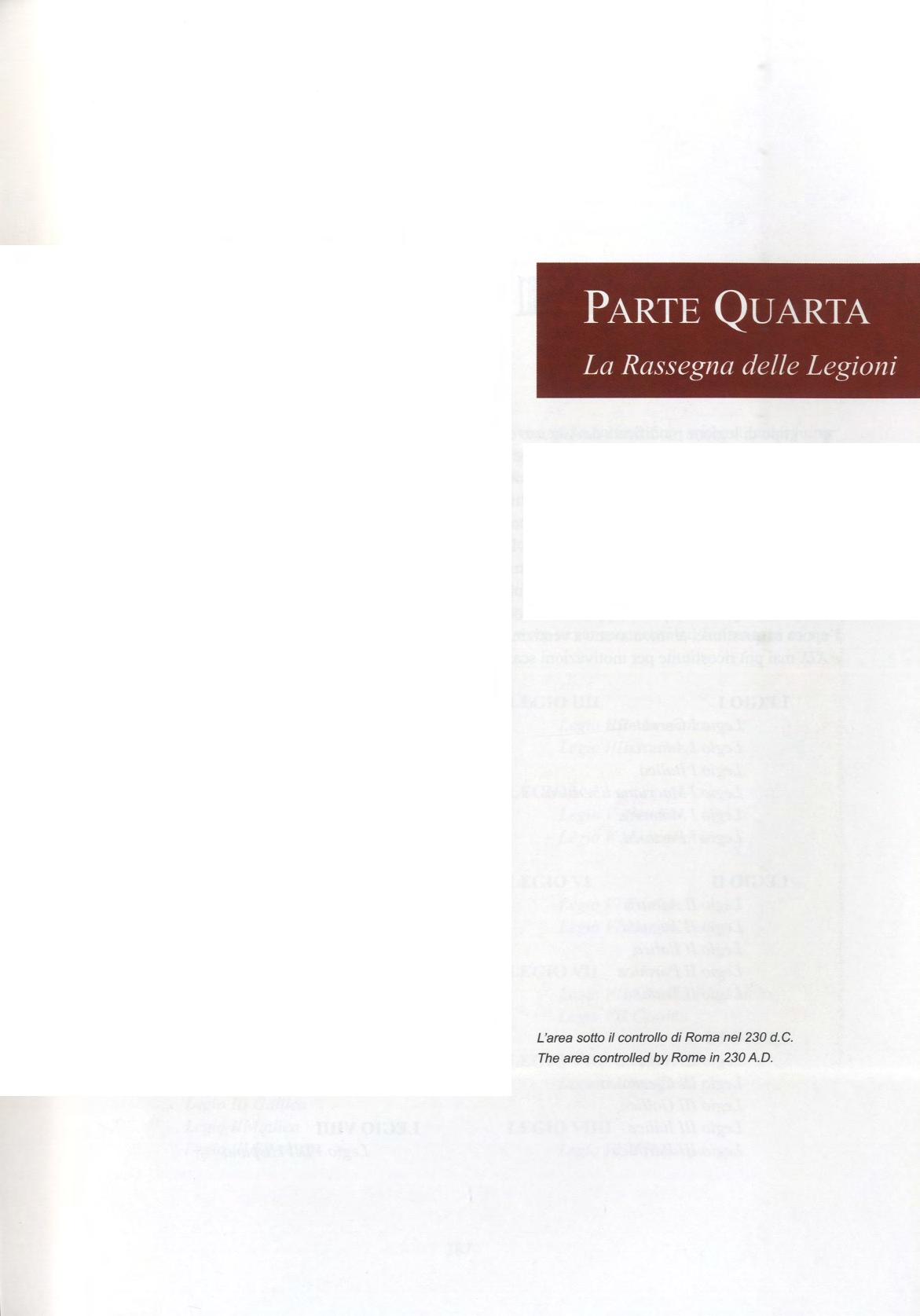
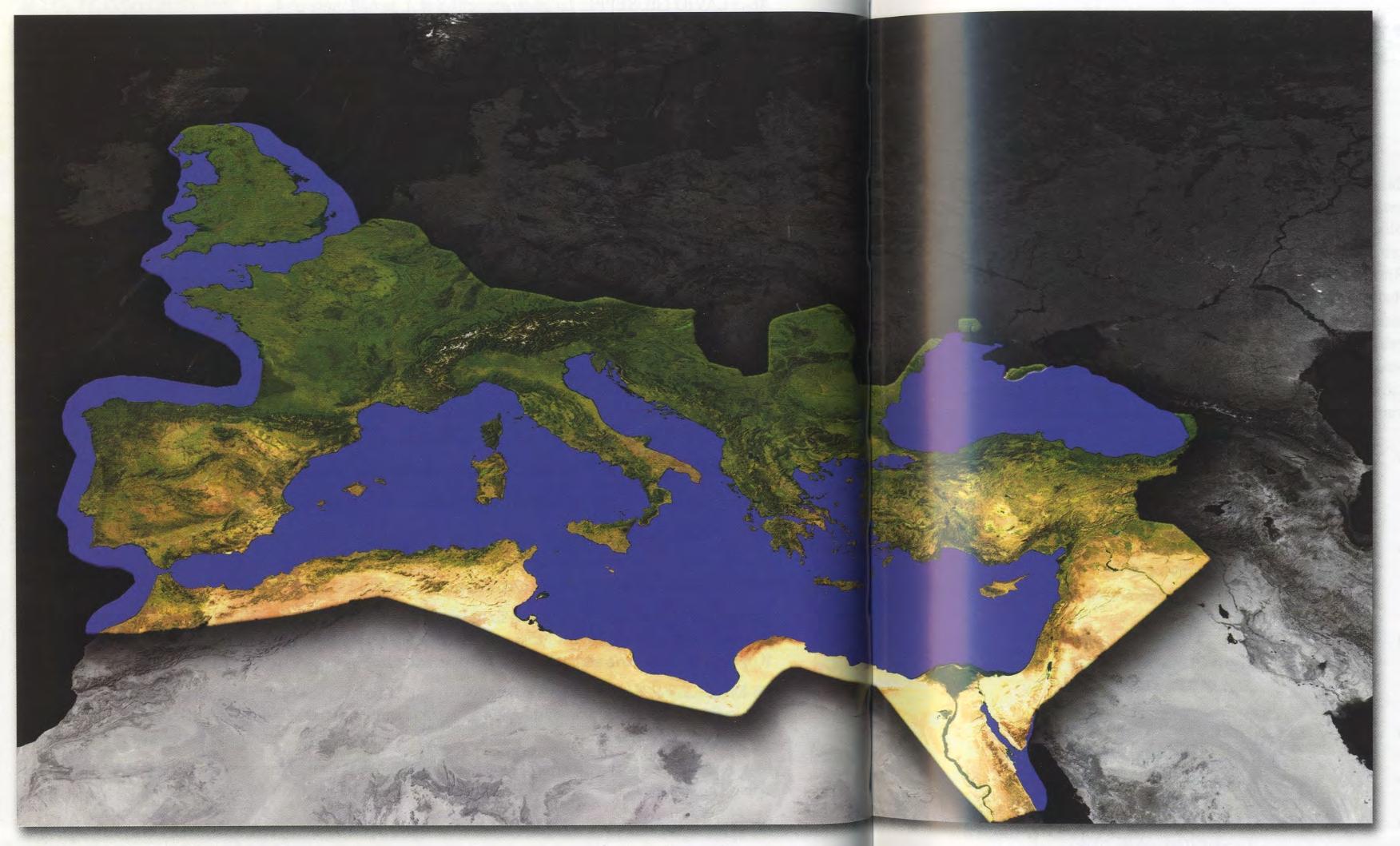
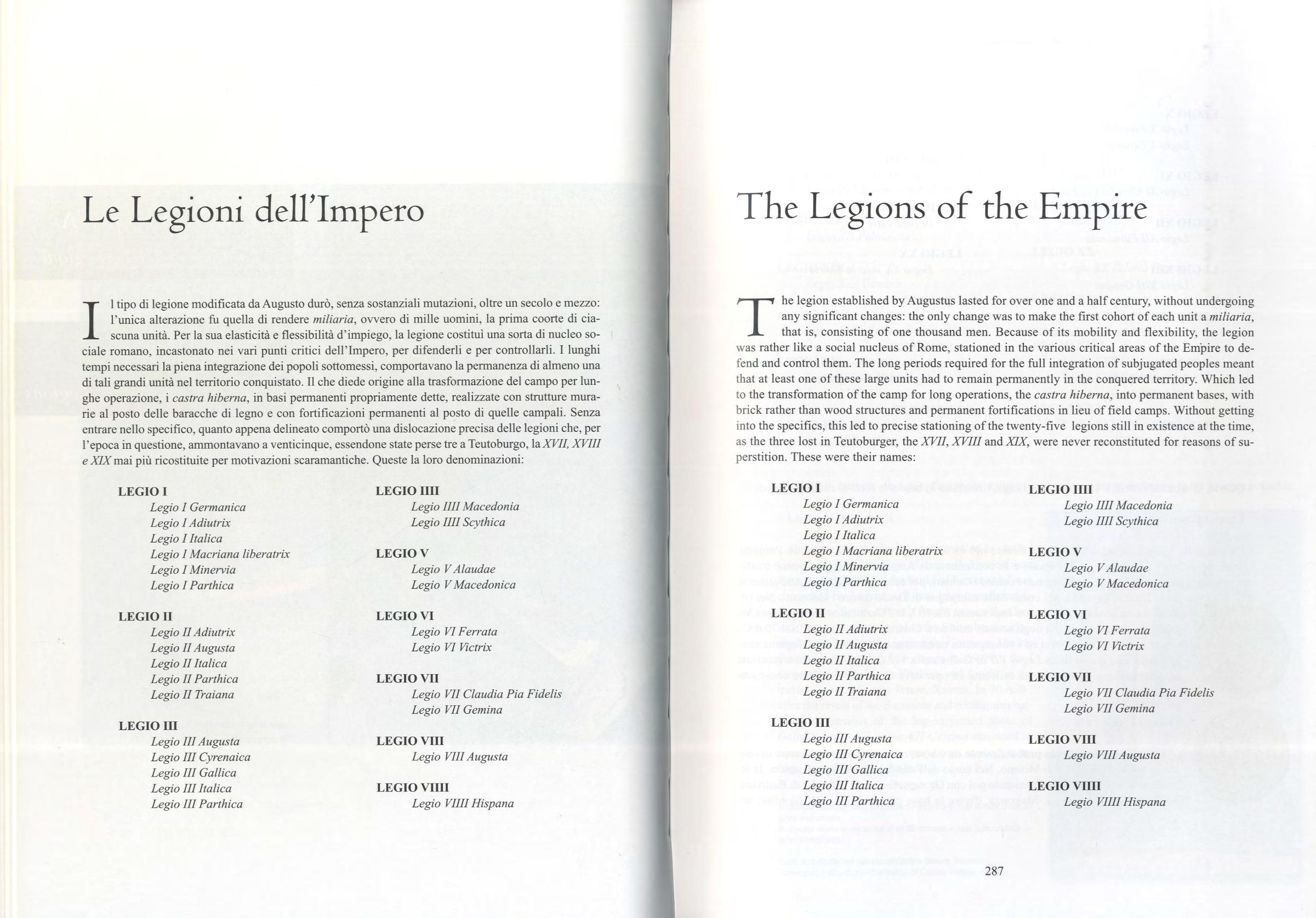
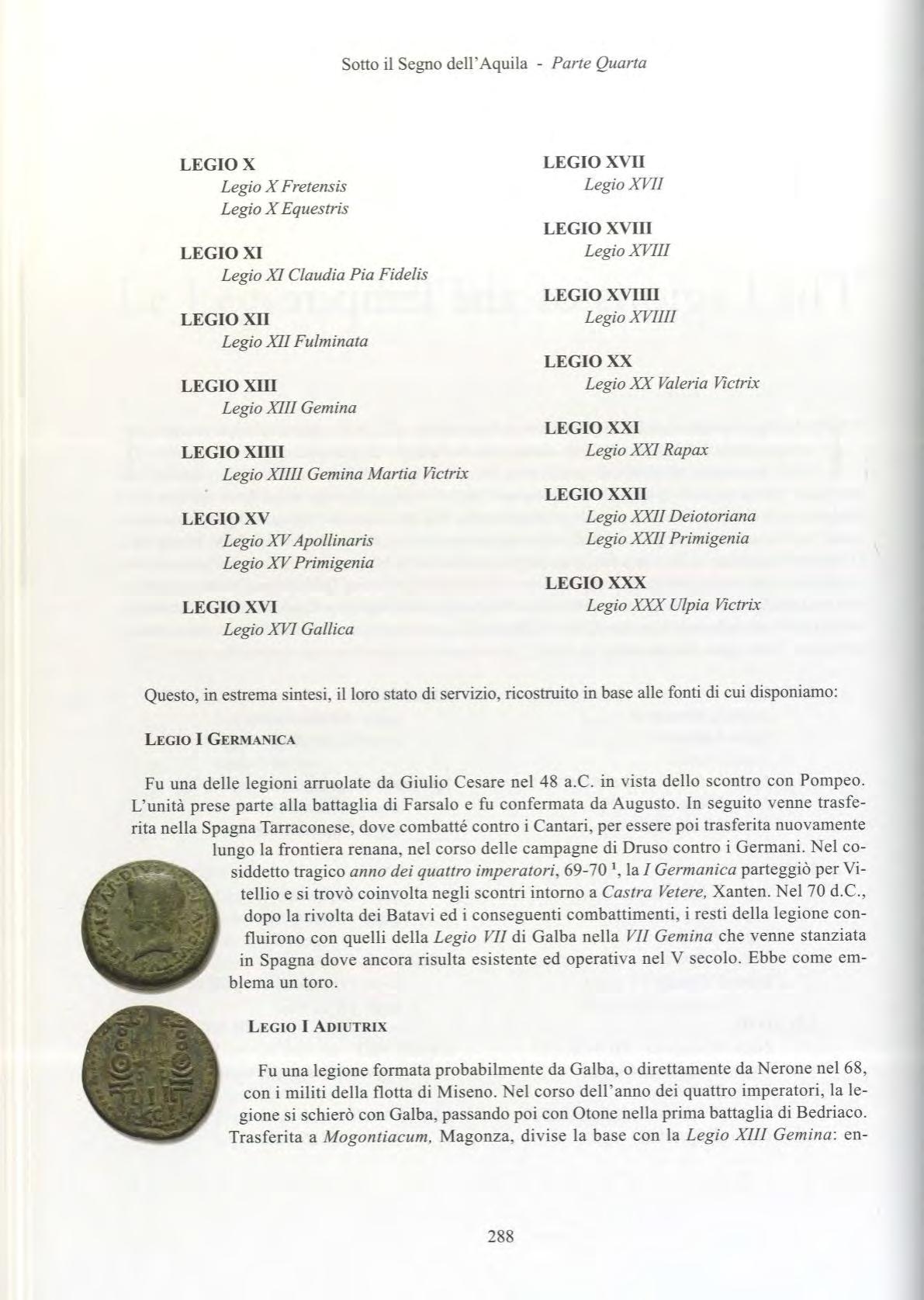
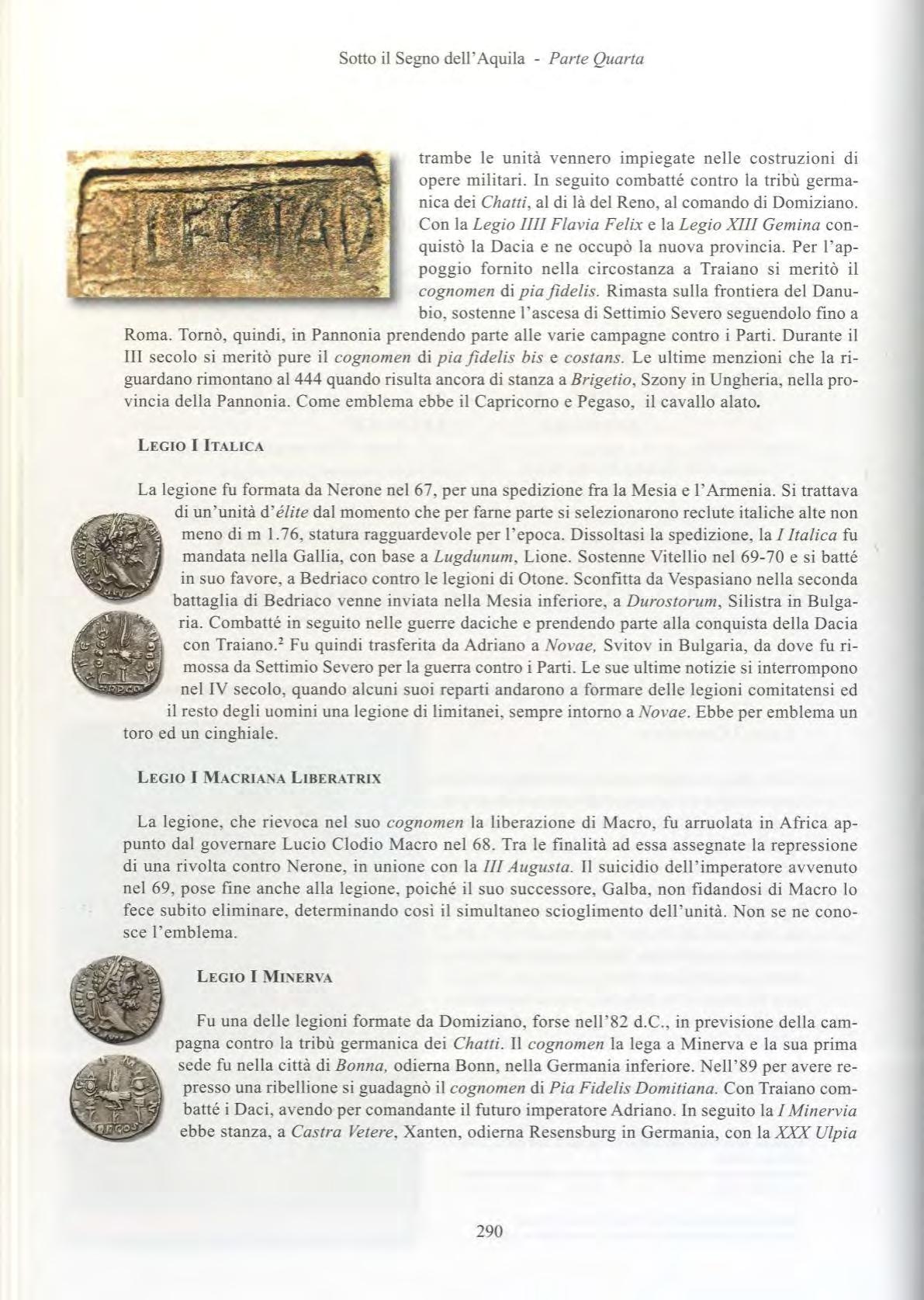
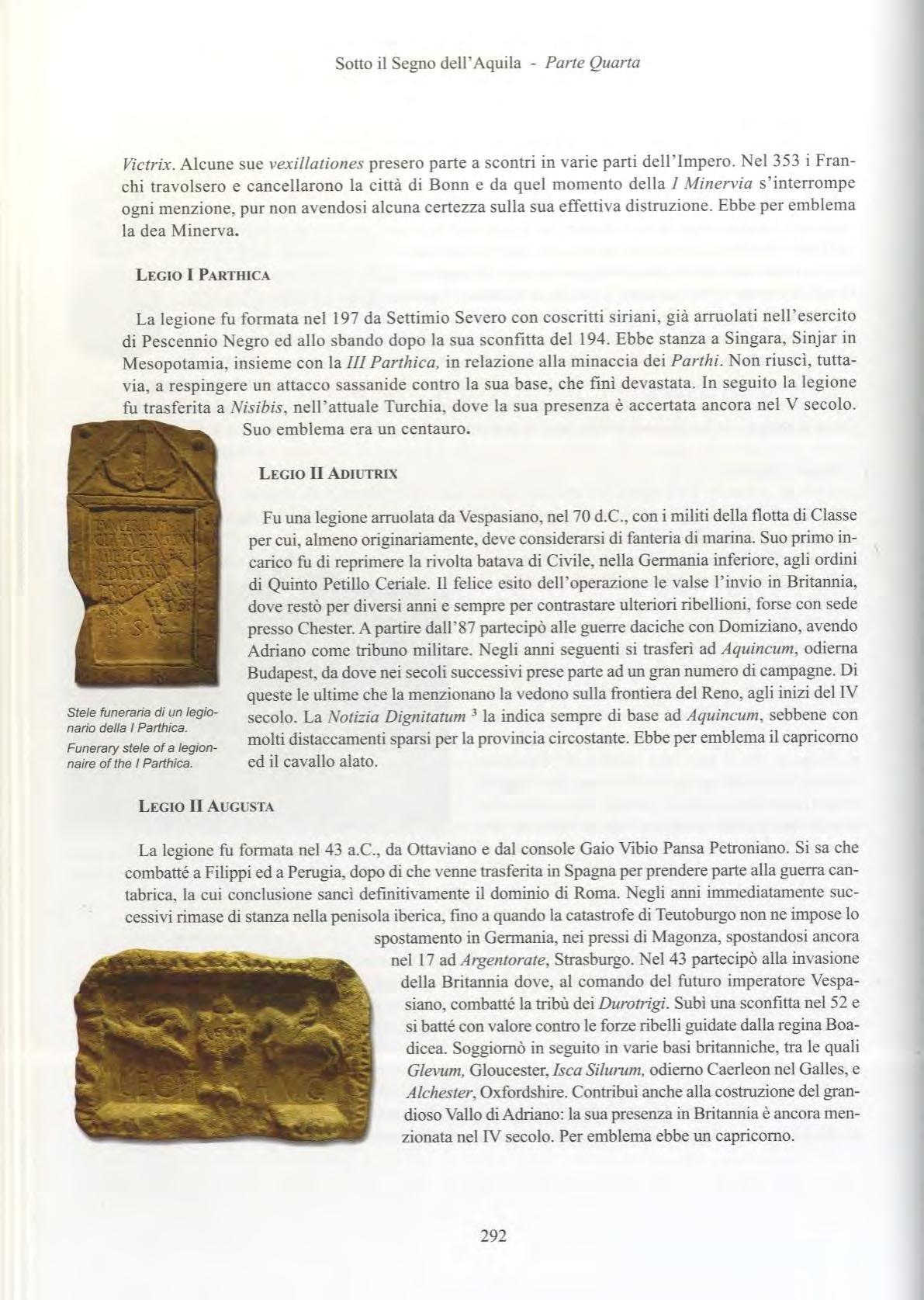
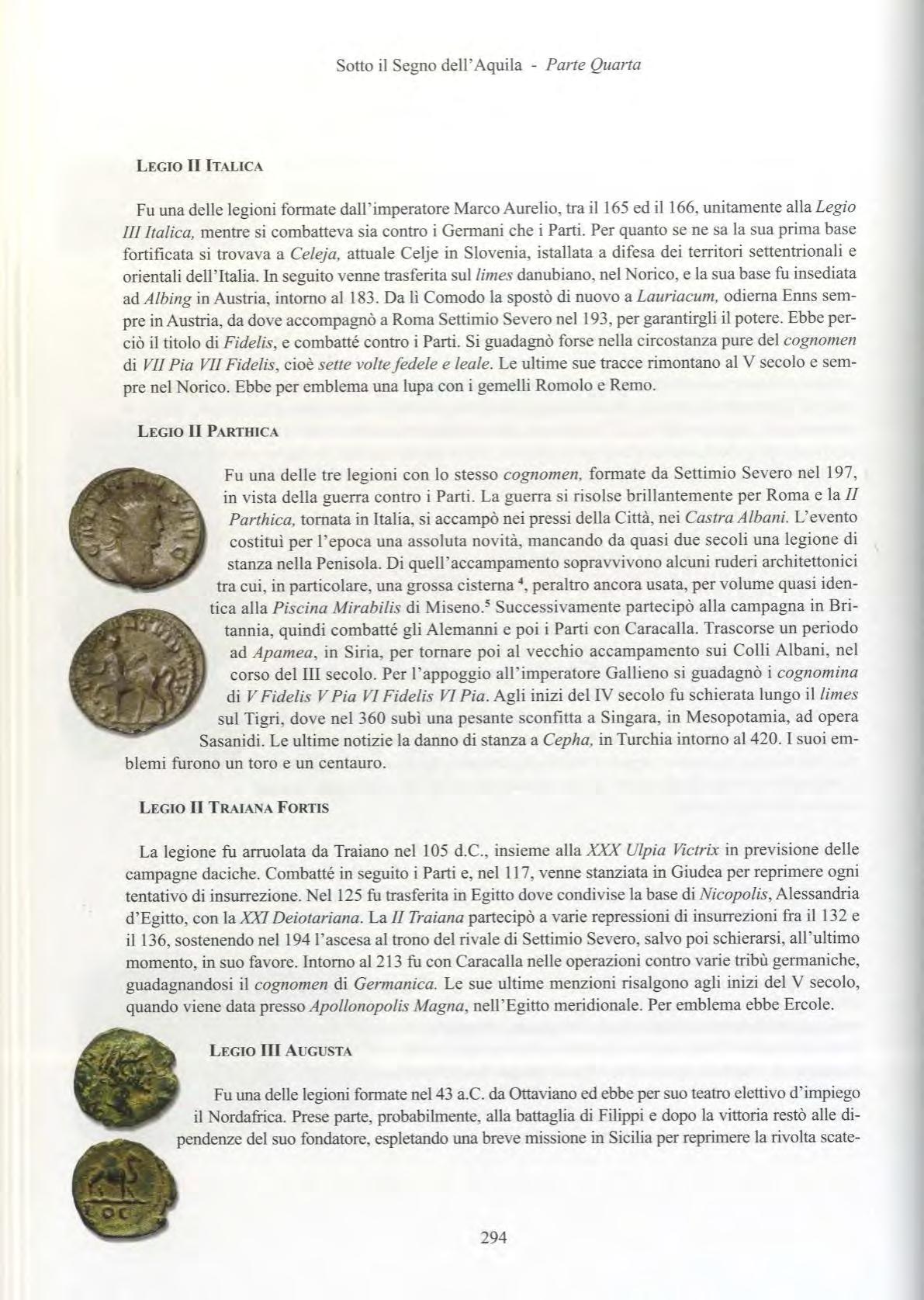
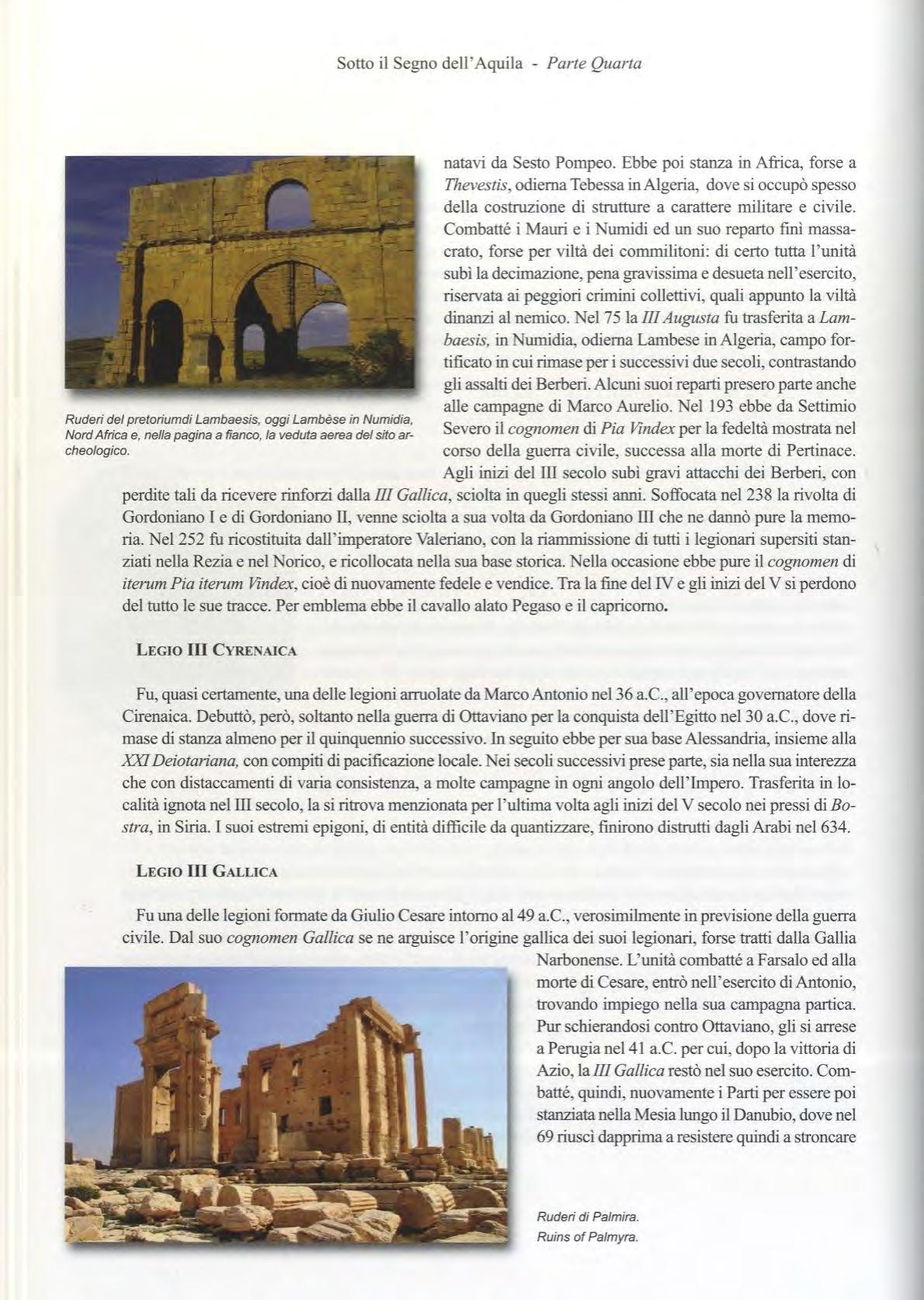
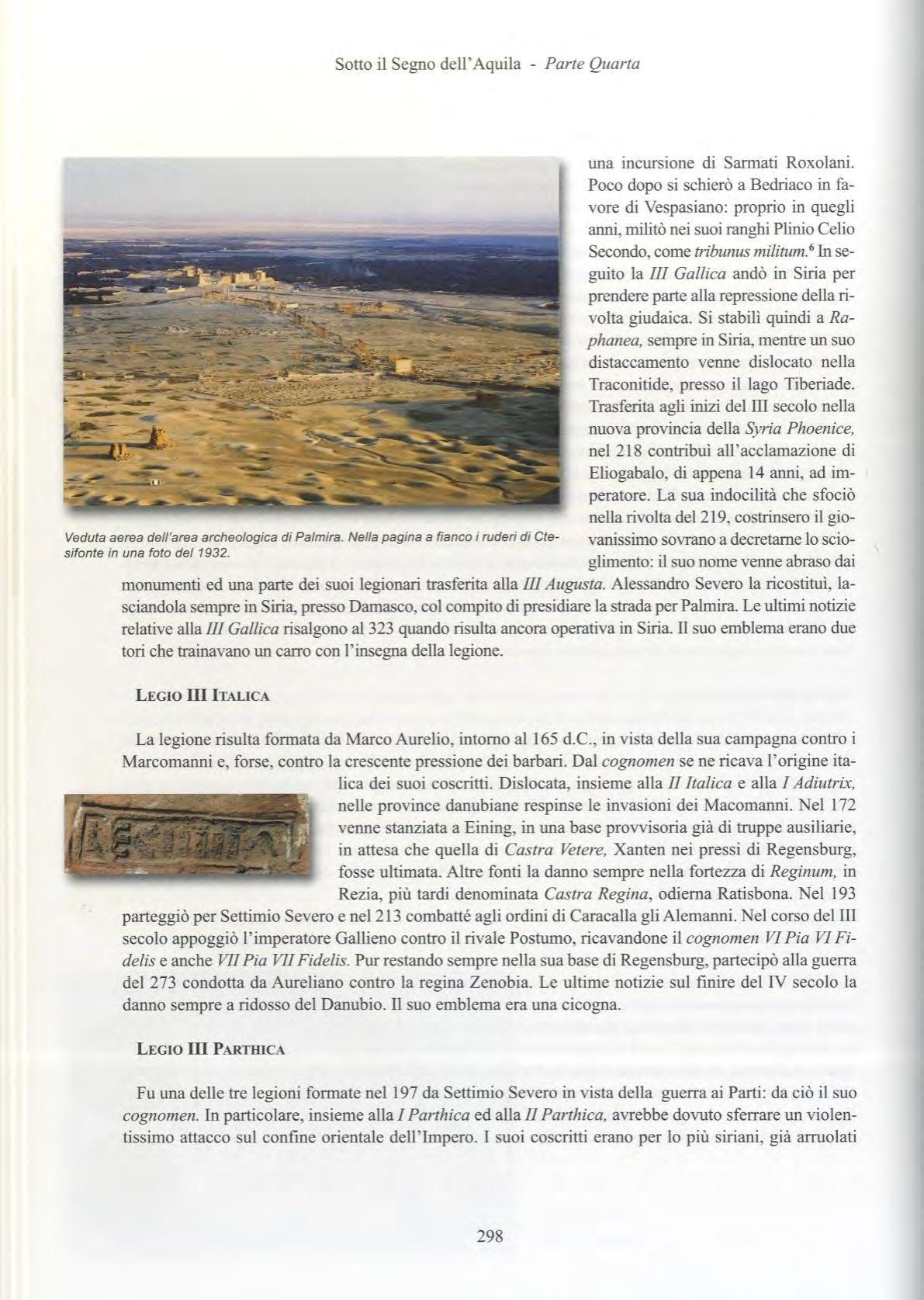
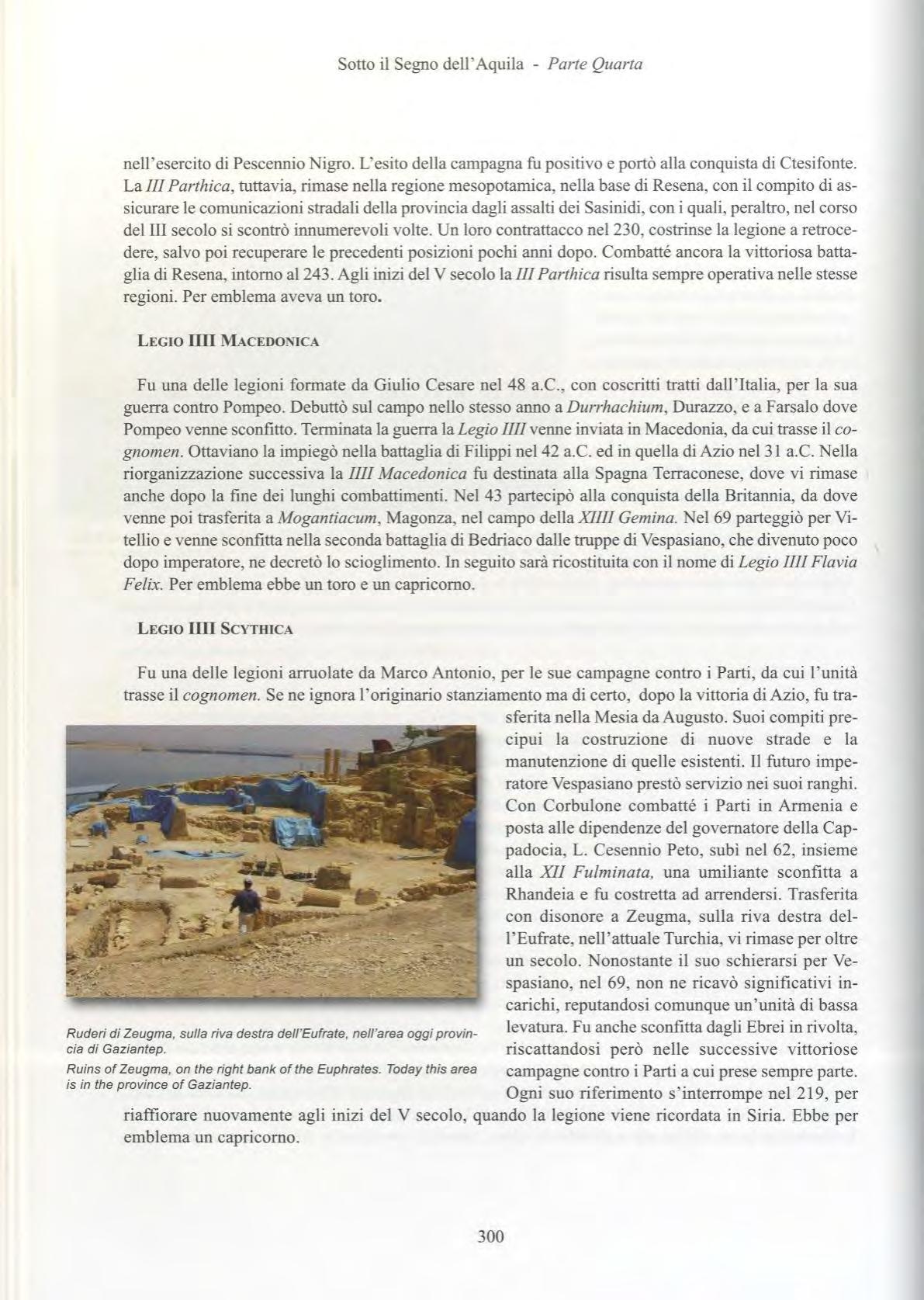

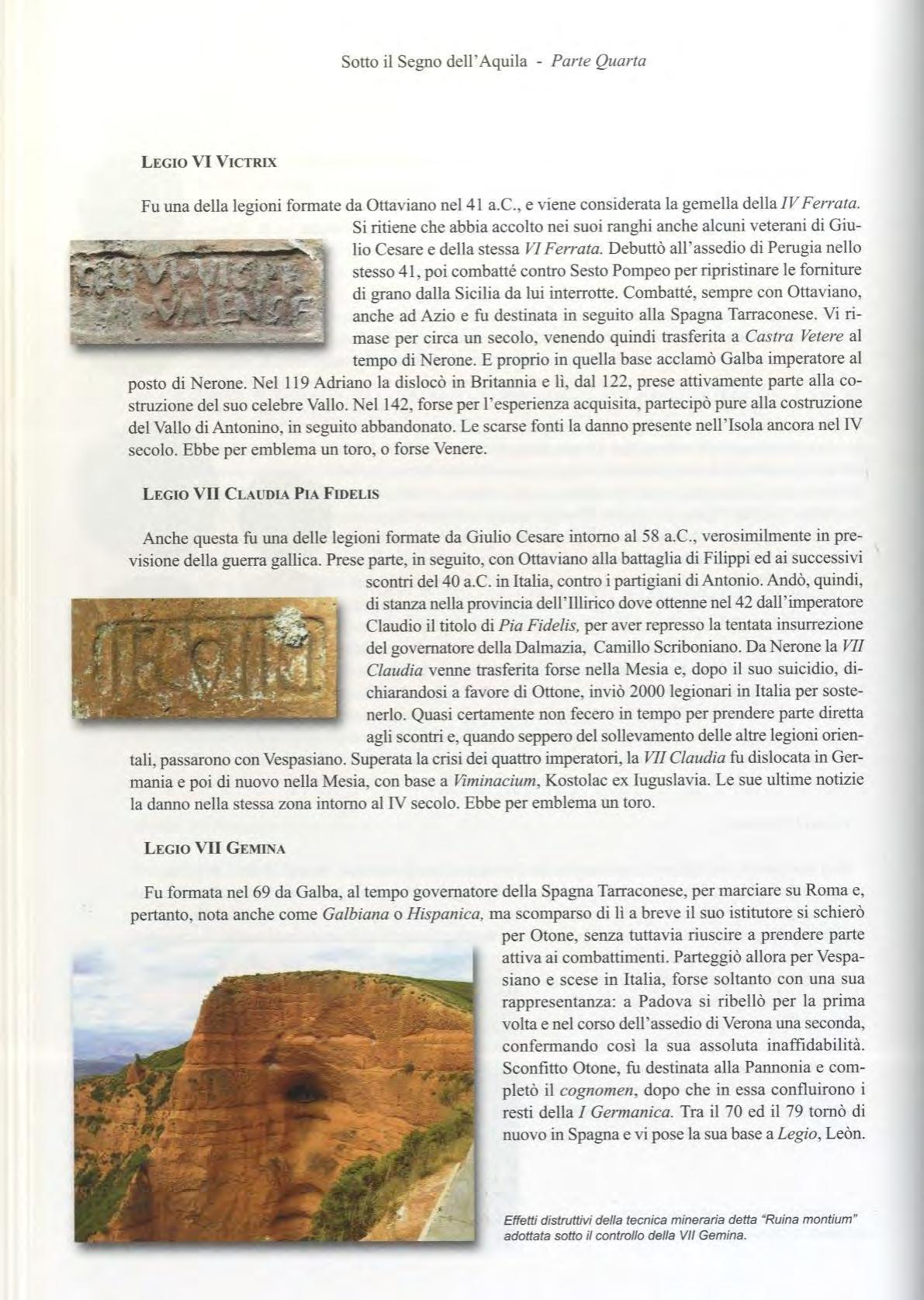
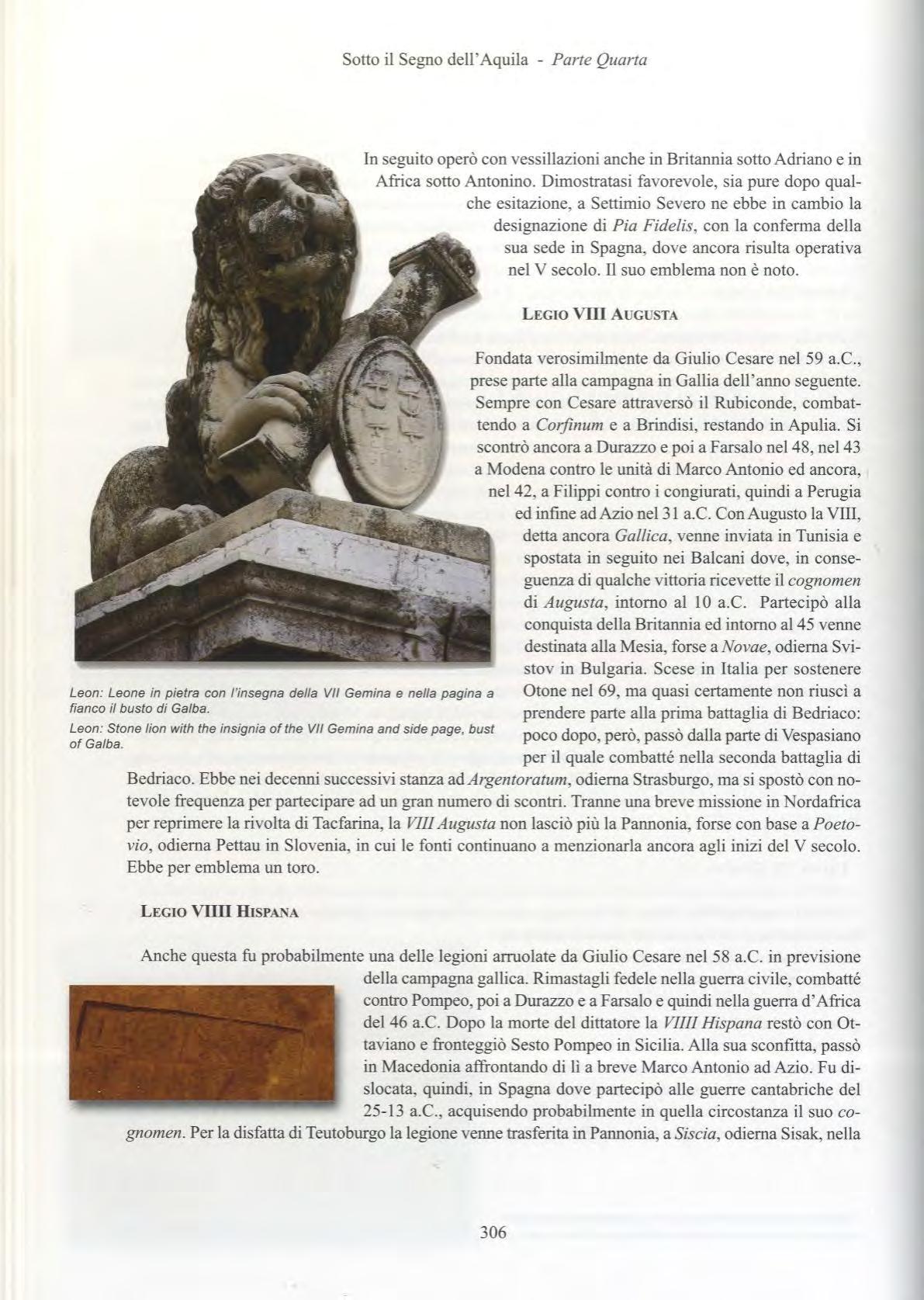
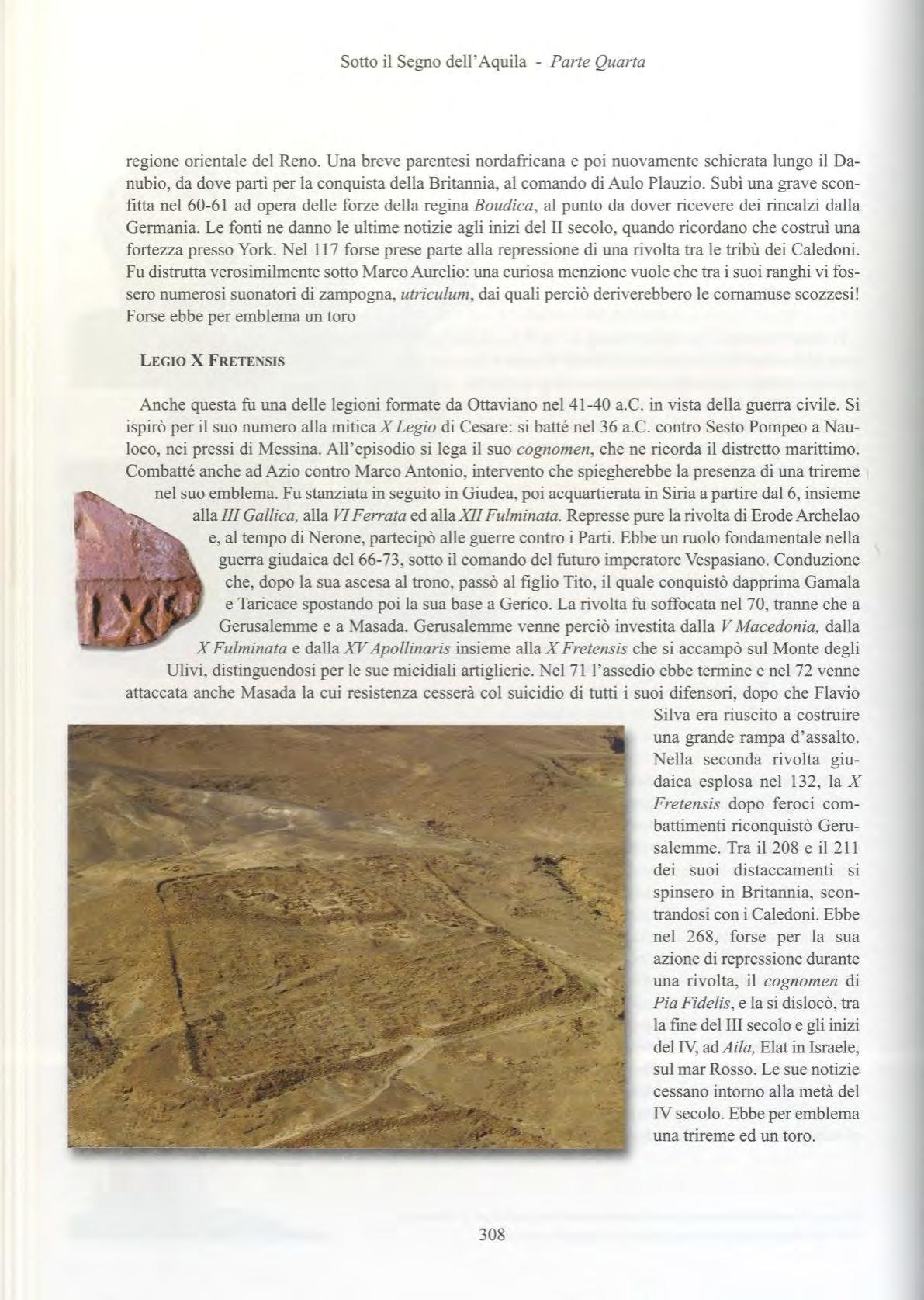
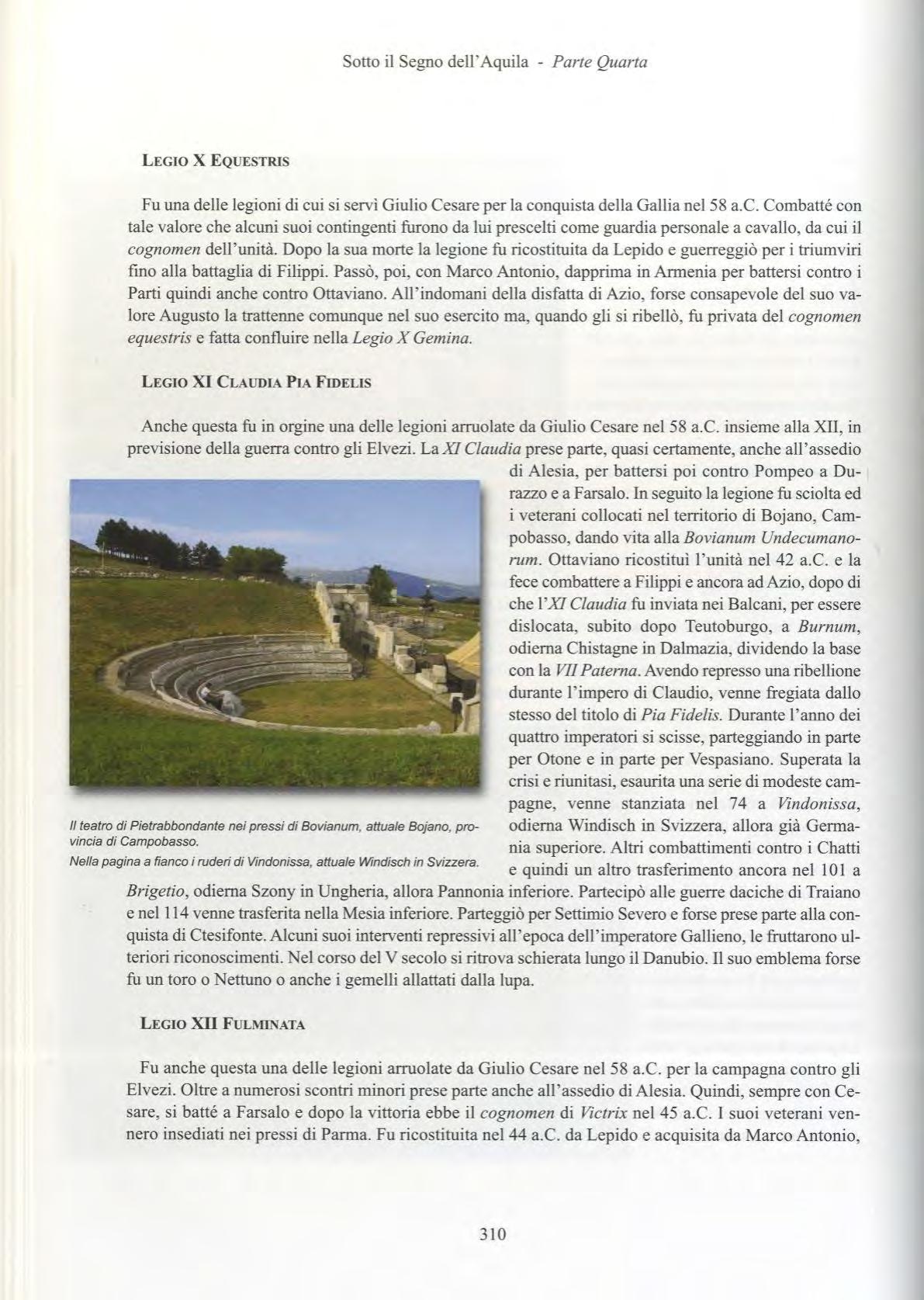
 FotoaereadelIride/idel!anfiteatroromano diVindonissa
ofthemmsafaRoman amphitheatfe in Vindonissa.
FotoaereadelIride/idel!anfiteatroromano diVindonissa
ofthemmsafaRoman amphitheatfe in Vindonissa.