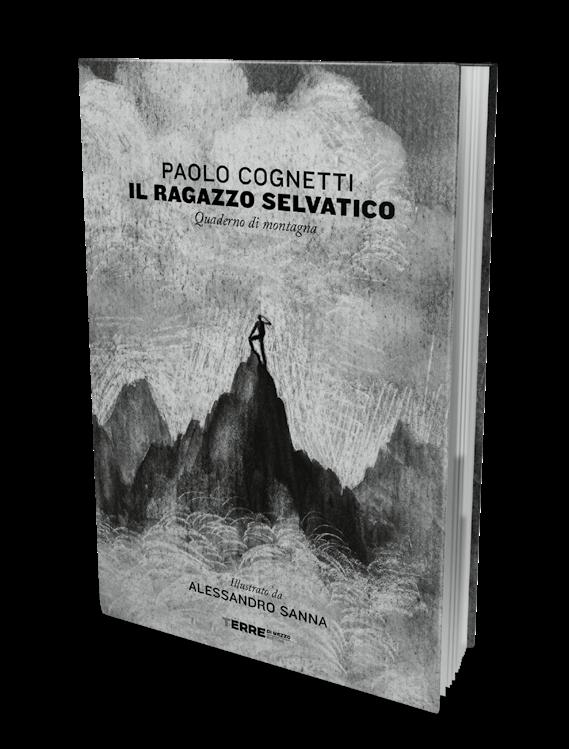© 2013 Cart’Armata edizioni Srl
Terre di mezzo Editore via Calatafimi 10, 20122 Milano Tel. 02-83.24.24.26 e-mail editore@terre.it terre.it
Direzione editoriale: Miriam Giovanzana
Coordinamento editoriale: Davide Musso
Copertina: Alessandro Sanna
Prima edizione: aprile 2013
Nuova edizione tascabile: giugno 2024
Stampato da Rotolito S.p.A, Pioltello (MI)
Paolo Cognetti
Il ragazzo selvatico
Quaderno di montagna
Questo libro è per Gabriele e Remigio, i miei maestri di montagna. E alla memoria di Chris McCandless, spirito guida.
Io fui nel giorno alto che vive oltre gli abeti, io camminai su campi e monti di luce –
Traversai laghi morti – ed un segreto canto mi sussurravano le onde prigioniere –passai su bianche rive, chiamando a nome le genziane sopite –
Io sognai nella neve di un’immensa città di fiori sepolta –io fui sui monti come un irto fiore –e guardavo le rocce, gli alti scogli per i mari del vento –e cantavo fra me di una remota estate, che coi suoi amari rododendri m’avvampava nel sangue –
Antonia Pozzi, Nevai
Inverno
Stagione del sonno
In città
Qualche anno fa ho avuto un inverno difficile. Ora non mi pare importante ricordare l’origine di quel male. Avevo trent’anni e mi sentivo senza forze, sperduto e sfiduciato come quando un’impresa in cui hai creduto finisce miseramente. In quel momento immaginare il futuro mi sembrava un’ipotesi remota quanto quella di mettersi in viaggio quando sei ammalato e fuori piove. Avevo dato molto, e dove stava la mia ricompensa?
Passavo il tempo tra librerie, negozi di ferramenta, il bar davanti a casa e il letto, a contemplare il cielo bianco di Milano dalla finestra. Soprattutto non scrivevo, che per me è come non dormire o non mangiare: era un vuoto che non avevo mai sperimentato. In quei mesi i romanzi mi respingevano, ma fui attratto da storie di persone che, per rifiuto del mondo, avevano cercato esperienze di solitudine nei boschi. Lessi Walden di Henry David Thoreau e Storia di una montagna di Élisée Reclus. Mi colpì specialmente il viaggio di Chris McCandless, raccontato da Jon Krakauer in Into the Wild. Forse perché Chris non era un filosofo dell’Ottocento ma un ragazzo della mia epoca,
11
che a ventidue anni aveva lasciato la città, la famiglia, gli studi, un futuro brillante concepito secondo i canoni della società occidentale, ed era partito per un vagabondaggio solitario che sarebbe terminato in Alaska, con la morte per fame. Quando la storia divenne nota molte persone giudicarono la sua scelta idealistica, una fuga dalla realtà se non proprio una pulsione suicida. Io sentivo di capirla e dentro di me la ammiravo. Chris non fece in tempo a scrivere un libro, forse non ne aveva nemmeno l’intenzione, ma amava Thoreau e ne aveva adottato il manifesto: “Andai nei boschi perché desideravo vivere in modo autentico, per affrontare soltanto i problemi essenziali della vita, per vedere se avrei imparato quanto essa aveva da insegnare, e per non scoprire, in punto di morte, di non aver vissuto. Non desideravo vivere quella che non era vita, vivere è così prezioso; non desideravo nemmeno praticare la rassegnazione, a meno che non fosse strettamente necessaria. Volevo vivere fino in fondo e succhiare tutto il midollo della vita, vivere in modo tanto solido e spartano da sradicare ciò che non fosse vita, falciare tutto intorno a filo d’erba, per mettere la vita in un angolo e ridurla ai minimi termini e poi, se si fosse rivelata misera, godere a pieno della sua miseria genuina e mostrarla al mondo; oppure se fosse apparsa sublime, farne esperienza per essere poi in grado di darne una vera descrizione nel resoconto di questo viaggio”.
Io non tornavo in montagna da dieci anni. Fino ai venti ci avevo trascorso tutte le mie estati. Da bambi-
12
no di città, allevato in appartamento, cresciuto in un quartiere in cui non era possibile scendere in cortile o per strada, la montagna aveva rappresentato per me l’idea più assoluta di libertà. Avevo imparato a muovermi lassù con un’iniziale brutalità e poi molta naturalezza, come altri bambini imparano a nuotare perché un adulto li butta in acqua: a otto o nove anni avevo cominciato a calpestare i ghiacciai e a mettere le mani sulla roccia, e presto ero stato molto più a mio agio sui sentieri che per le strade della mia città. Per dieci mesi all’anno mi sentivo costretto in abiti buoni, e in un sistema di autorità e di regole a cui obbedire; in montagna mi sbarazzavo di tutto e liberavo la mia natura. Era una libertà diversa da chi è libero di viaggiare e incontrare persone, o di passare la notte a bere, cantare e corteggiare le donne, o di trovarsi dei compagni con cui salpare per grandi imprese. Tutte libertà che apprezzo, tanto che a vent’anni mi sembrava importante esplorarle a fondo, ma a trenta avevo quasi dimenticato com’era stare da solo in un bosco, o immergermi in un torrente, o correre sul filo di una cresta dopo cui c’è soltanto cielo. Quelle cose le avevo fatte ed erano i miei ricordi più felici. Il giovane uomo urbano che ero diventato mi sembrava l’esatto contrario di quel ragazzo selvatico, così nacque in me il desiderio di andare a cercarlo. Non era tanto un bisogno di partire, quanto di tornare; non di scoprire una parte sconosciuta di me quanto di ritrovarne una antica e profonda, che sentivo di avere perduto.
13
Avevo messo da parte un po’ di soldi, il necessario per vivere qualche mese senza lavorare. Cercai una casa che fosse lontana dai centri abitati e il più in alto possibile. Non esistono grandi spazi selvaggi sulle Alpi, ma non serve l’Alaska per vivere l’esperienza che desideravo. In primavera trovai il posto giusto nella valle accanto a quella in cui ero cresciuto: una baita di legno e pietra a 1.900 metri d’altezza, dove gli ultimi boschi di conifere cedono il passo ai pascoli estivi. Un luogo in cui non ero mai stato ma un paesaggio che conoscevo bene, solo l’altro versante delle montagne che battevo da ragazzo. Si trovava a una decina di chilometri dal paese più vicino e a pochi minuti da un villaggio che si popolava d’estate e d’inverno, ma il 25 aprile, quando io ci arrivai, non c’era nessuno. I prati erano ancora in letargo, tinti dei colori bruni e ocra del disgelo; i versanti in ombra delle montagne ancora coperti di neve. Lasciai la macchina alla fine della strada asfaltata. Mi caricai lo zaino in spalla e mi incamminai per la mulattiera, salendo attraverso un bosco e poi un pascolo innevato fino a un gruppo di baite ormai in rovina, tranne quella rimessa a nuovo che avevo preso in affitto. Arrivato alla porta mi voltai: intorno non c’era niente se non il bosco, i prati e quei ruderi abbandonati; all’orizzonte le montagne che chiudono la Val d’Aosta a sud, verso il Gran Paradiso; e poi una fontana scavata in un tronco, i resti di un muretto a secco,
14 * * *
un torrente che gorgogliava. Sarebbe stato il mio mondo per un periodo che non avevo stabilito, perché non sapevo che cosa mi riservava. Quel giorno il cielo era di un grigio funereo, una mattina gelida e senza luce. Non avevo nessuna intenzione di sottopormi a una tortura: se avessi trovato qualcosa di buono lassù sarei rimasto, ma mi poteva anche succedere di piombare in una disperazione peggiore, e in quel caso ero pronto a scappare via. Mi ero portato libri e quaderni. Speravo di ricominciare a scrivere, con il tempo. Ma adesso avevo freddo, dovevo mettermi addosso un maglione e accendere il fuoco, così spinsi la porta ed entrai nella mia nuova casa.
15
Primavera
Stagione della solitudine e dell’osservazione
C’è una specie di commozione nell’aprire una baita a primavera. Spalancai stanze rimaste chiuse per mesi, con il gelo come unico padrone e i lucernari oscurati dalla neve. Passai un dito sul tavolo, la sedia, la mensola, su cui si era posato uno strato di polvere, come la cenere dimenticata nel camino. Avranno un modo, le case, per sentire il tempo che passa? O un inverno per loro vale come un istante? Pensai al giorno di dieci anni prima in cui ero uscito per l’ultima volta da quell’altra porta, dando una lunga occhiata a tutto. Adesso il senso del ritorno non era la vista ma l’olfatto, era il profumo di resina a rassicurarmi di essere di nuovo a casa. Le domandai: è stato molto duro l’inverno? La immaginai gemere e scricchiolare nelle notti di gennaio, quando lassù la temperatura scende a meno venti, e poi godere del pallido sole di marzo, i muri tiepidi, la neve che gocciola nelle grondaie. Se il fine di una casa è quello di essere abitata, pensai, forse provava una sua forma di felicità nel sentire di nuovo un uomo andare avanti e indietro con la legna, accendere la stufa, lavarsi le mani in cucina. Così quell’acqua fatta di neve e di
19
Case
roccia ricominciava a circolare nei muri come linfa in un albero, il fuoco come sangue in un corpo.
In un racconto che amo molto, intitolato Le mie quattro case, Mario Rigoni Stern ripercorreva le età della sua vita attraverso le case abitate. Non tutte erano case reali: si abita una casa anche immaginandola, o prendendola in prestito dalla memoria altrui. La prima era una casa perduta: la dimora storica degli Stern, vecchia di quattrocento anni e andata distrutta con la Grande Guerra. Mario, nato nel 1921, la conosceva grazie ai racconti dei vecchi: era il luogo in cui rimpiangeva di non essere nato, il legame tra la sua famiglia e la sua terra, il senso di patria che per i montanari non corrisponde alla nazione, ma a una lingua, ai nomi delle cose e dei luoghi, ai lavori stagionali, alla maniera giusta di farli. La seconda era una casa reale, quella dell’infanzia, piena di angoli segreti come sono le case in cui siamo stati bambini. La terza era una casa della mente: chiuso nel campo di prigionia, nel ’45, Mario aveva trovato un foglio e una matita e trascorso lunghi giorni di fame a progettare una baita. La immaginò in una radura di montagna dove avrebbe vissuto di caccia, libri e solitudine, a curarsi dalla guerra come il Nick Adams di Hemingway nel Grande fiume dai due cuori. Quel disegno lo protesse a lungo dalla disperazione. La quarta era la casa che costruì davvero, e in cui visse per cinquant’anni, con il bosco davanti alla finestra, le arnie delle api, i prati su cui pascolavano i caprioli,
20
l’orto e la legnaia, “con mia moglie, i miei libri, i miei quadri, il mio vino, i miei ricordi”.
Immagino che dia una grande pace, vivere in una casa fatta con le proprie mani. Io non avevo questo privilegio: la baita in cui abitavo era stata costruita dai montanari chissà quando, per ospitare bestie e uomini durante la stagione dell’alpeggio, e ristrutturata con tutte le comodità una decina d’anni prima. Era una casa di due sole stanze: di sotto, dove una volta c’era la stalla, ora avevo il bagno e la camera da letto con un armadio, un cassettone, la stufa; di sopra la cucina, il divano, un tavolo con due panche e una sedia. Ma i muri di pietra viva non erano cambiati dall’epoca della loro costruzione, e nel toccarli mi domandavo quante mani li avessero accarezzati, quanto fumo di legna, fiati di bestie, vapori di polenta e latte. A volte tra una pietra e l’altra c’era un grosso chiodo, o un paletto di legno mezzo carbonizzato. Che cosa appendevano qui, chi era l’uomo che l’ha piantato? Era una casa infestata dai fantasmi ma non faceva paura: mi sembrava un po’ di abitare insieme a tutti quei montanari, di conoscerli attraverso gli spazi e la forma delle cose, la fuliggine che ancora anneriva qualche pezzo di muro.
La casa in cui passavo le estati da bambino era stata costruita come albergo nel 1855, ma durante la mia infanzia era ormai in rovina. Sorgeva fuori dal paese, in cima a un viale di faggi, ai piedi di una cascata che diventava impetuosa durante le piogge di fine estate.
21
Sull’intonaco scrostato della facciata una targa ricordava il soggiorno della regina Margherita di Savoia, quando l’officina del meccanico era ancora la sala da ballo, e il suo tetto invaso dalle erbacce la terrazza in cui si serviva il tè nel pomeriggio. L’albergo aveva funzionato fino agli anni Trenta, ma era stato occupato dai tedeschi durante la guerra e poi venduto, e cinquant’anni dopo aveva ormai l’aspetto di un glorioso maniero diroccato: apparteneva a due anziane sorelle che l’avevano suddiviso in alloggi e ci guadagnavano qualcosa con gli affitti dell’estate, mentre negli altri mesi restava chiuso. Privo di manutenzione e riscaldamento, ogni inverno subiva nuovi danni. Le nevicate d’aprile del 1986 gli diedero il colpo di grazia: una valanga travolse una parte dell’edificio, e un’intera ala fu dichiarata pericolante. Sui muri rimasti in piedi, l’estate successiva erano comparse grosse crepe, e negli anni le ortiche prosperarono sulle macerie che nessuno aveva rimosso. Ma io, più che la rovina, ricordo lo stupore di trovare la neve all’inizio di luglio, così alta, ghiacciata e dura da diventare uno scivolo per gli slittini. Restò per sempre l’estate della valanga.
Arrivando dalla città mi sembrava di entrare in un’altra epoca. Un tempo in cui le cucine avevano il secchiaio di pietra, e i bagni vasche e catini in ferro smaltato. Sul soffitto, nella mansarda in cui dormivo, c’erano incisi due nomi di ragazza: Angela e Maddalena. Sapevo che una volta in quelle stanze alloggiava la servitù, così mi chiedevo se Angela e Maddalena fosse-
22
ro due cameriere d’inizio secolo, al servizio di qualche dama di corte, e immaginavo i loro discorsi della sera. Non so se le case abbiano un’anima ma io in quella ho lasciato un bel pezzo della mia: ci ho abitato per una ventina d’anni, due mesi all’anno, dal 1979 in poi. Con la fine del Novecento arrivò anche quella del vecchio albergo: venduto, demolito e ricostruito per farne un condominio. Così di quel luogo, come scriveva Mario Rigoni Stern, “sono rimaste ora solamente queste mie parole”.
Ripensai all’estate della valanga osservando le chiazze di neve nel pascolo di fronte alla baita. Benché protette dall’ombra del bosco ogni giorno si scioglievano un po’: rivoli d’acqua correvano giù per il prato scoprendo una terra nera e umida, un’erba come bruciata. Uccellini dal ventre bianco e il dorso scuro stavano lì a becchettare il terreno ai margini della neve. Avevo preso un libro per riconoscerli ed ero quasi sicuro che fossero fringuelli alpini: “cercano larve d’insetto”, c’era scritto, “nella terra intrisa d’acqua di fusione, e nidificano nelle cavità delle rocce o sui muri delle baite”.
Infatti due di loro avevano fatto il nido proprio sopra il trave di colmo della mia, in quel cantuccio riparato e buio tra il trave e il tetto. Volavano avanti e indietro tra il prato e il nido e mi tenevano compagnia mentre pranzavo, seduto al tavolo davanti alla finestra.
Nel pomeriggio si alzava una nebbia densa: la vedevo arrivare dal fondovalle, risalire i prati e i boschi e
23
infine avvolgere tutto. Restavo immerso in quella coltre bianca finché si faceva buio. Niente luna né stelle la sera, ma una pioggia mista a un po’ di neve che cominciava a cadere quando andavo a letto. Di notte stentavo ad addormentarmi. Non abituato all’altitudine, il cuore batteva più veloce del normale e mi sembrava di avere un tamburo nel petto. I suoni non sono come gli odori, c’è bisogno di tempo per lasciarsi cullare da loro, non sussultare a ogni rumore nuovo. Così con gli occhi spalancati fissavo il soffitto e pensavo: questa è la brace che si consuma e scricchiola nel camino. Questo è il motore del vecchio frigorifero che parte. Questa è la pioggia sul tetto di pietra. E questi passi fuori, verso le tre del mattino, che cosa sono? Giravano intorno alla casa, esitavano vicino alla porta, e in città sarebbe venuto istintivo il pensiero di un ladro. Lassù dovevo fare ricorso alla mia parte più razionale per convincermi che quel visitatore era solo un selvatico in cerca di cibo. Serviva a poco: non chiudevo occhio per il resto della notte, finché alle prime luci dell’alba mi rassegnavo ad alzarmi e mettere il caffè sul fuoco.
24
Topografia
Scrive Élisée Reclus, geografo anarchico dell’Ottocento, a lungo esiliato per le sue idee: “Da ogni punta, ogni burrone, ogni versante, il paesaggio di montagna si mostra sotto un nuovo rilievo, con un altro profilo. Il monte è, da solo, un intero gruppo di montagne; così in mezzo al mare ogni onda è irta di innumerevoli piccole onde irregolari. Per afferrare nel suo insieme l’architettura della montagna bisogna studiarla, percorrerla in tutti i sensi, inerpicarsi su ogni pendio, penetrare fin nella più piccola gola. Come ogni cosa, è un infinito per chi vuole conoscerla nel suo intero”.
Con questo spirito inaugurai le mie esplorazioni. Presi il sentiero che partiva dalla baita e cominciai a risalirlo per vedere dove andava. Attraversai un bosco di larici, i loro tronchi alti e spogli alternati ogni tanto al verde di un abete più giovane. Poco più in alto gli alberi si diradarono: sui pascoli esposti al sole spuntavano già i primi crochi, ma mi bastò cambiare versante, da sud a ovest, e la neve prese il posto del prato. L’acqua sgorgava ovunque, come se l’intera montagna ne fosse impregnata. Da un buco tra i sassi, dalle radici scoperte
25
di un larice, formando torrenti torbidi di fango. Dove il sentiero si incurvava verso nord affondai nella neve fino all’anca, così mi tirai fuori da quel buco e decisi di tornare indietro. Scesi a balzi urlando come uno yeti. Non avevo ancora cominciato a parlare da solo, però mi piaceva cantare a voce alta; canzoni d’amore, di montagna, di lotta, non vedevo anima viva da una settimana e mi tenevo compagnia così.
Avevo pensato che il senso di solitudine sarebbe aumentato con il tempo, invece accadde il contrario: dopo i primi giorni di spaesamento ero pieno di cose da fare.
Estendere la mappa della zona, catalogare animali e fiori, raccogliere legna nel bosco, fare esperimenti con la resina degli abeti, pulire il prato intorno alla baita.
La neve sciogliendosi regalava sorprese: il teschio di una marmotta, i carboni di un fuoco all’aperto, i solchi lasciati dalle ruote di un trattore. Il buco di un topolino appena uscito dal letargo mi diede coraggio: se ce l’ha fatta lui, pensai, sei mesi sotto la neve, la mia stagione sotto il sole sarà un gioco da ragazzi.
Quanto alla mappa, cominciava appena oltre la porta di casa e si allargava man mano che scoprivo cosa c’era intorno. Procedevo per esplorazioni, letture, ritrovamenti archeologici e incerte deduzioni. Il posto in cui abitavo era un minuscolo villaggio chiamato Fontane. Occupavo la prima di quattro baite in fila, la facciata rivolta a sud, sul colmo di una valletta percorsa da un ruscello senza nome. Un tempo, quando quegli alpeggi
26
erano ancora in funzione, una mulattiera arrivava fin lì dal paese abitato tutto l’anno. Era scavata nel terreno e delimitata da muretti a secco, perché le bestie che ci passavano non invadessero i pascoli. Adesso era ancora visibile in alcuni punti, una trincea larga un metro che costeggiava il bosco, affiancata ogni tanto da cumuli di pietre bianche, squadrate con mazza e scalpello dagli antichi pastori. Il ruscello là sotto, a cui si doveva l’esistenza del villaggio, non si era meritato un nome per via della sua brevità: lo misurai a passi e non ne contai che cento. Sgorgava da una sorgente in mezzo al pascolo e si gettava in un altro torrente poco più giù. Scorreva su una ghiaia fine, dai riflessi bianchi e azzurri, incredibilmente simile al letto di un fiume. Accanto al ruscello, in corrispondenza di ogni baita, c’era una piccola costruzione in pietra. Erano le cantine in cui veniva portato il latte dopo la mungitura: l’acqua corrente lo refrigerava facendo affiorare la panna, che poi sarebbe stata lavorata in burro. Ora nella mia cantina non avevo latte ma una pompa elettrica che prendeva l’acqua dal ruscello e me la mandava in casa. Benché io mi lavassi le mani e bevessi come qualunque uomo di città, cioè aprendo un rubinetto e dosando a mio piacere il caldo e il freddo, quando lo facevo mi ricordavo sempre che l’acqua veniva da lì, dalla ghiaia bianca e azzurra in mezzo all’erba, e nel suo sapore di notte mi sembrava di sentire la brina.
Da molti secoli il terreno che avevo intorno, ricco di sorgenti e ben esposto al sole, era stato disboscato,
27
liberato dai sassi e terrazzato dove necessario, prima per coltivare la segale e pascolare il bestiame, poi per fare piste da sci. Fino agli anni Cinquanta era difficile trovare un albero da quelle parti, così come un animale selvatico: ho visto vecchie foto in cui i campi coltivati si spingono ad altezze impensabili, e tutta la montagna ha l’aspetto di un prato ben curato. Poi, nel dopoguerra, era cominciato l’esodo dalle terre alte, e così il bosco aveva riconquistato terreno. Quello vicino alla baita era stato ripiantato una cinquantina d’anni prima: i larici erano piuttosto giovani, tutti delle stesse dimensioni, e diradati in modo che ai loro piedi continuasse a crescere l’erba. Infine, tra gli anni Settanta e Ottanta, una parte degli stessi alberi era stata abbattuta, per fare spazio alle piste che tagliavano i fianchi della montagna come scie di valanghe. Erano comparsi i piloni degli impianti e certi pendii accidentati erano stati spianati, e così il luogo aveva assunto le sembianze attuali.
Perché mi interessava tanto questa storia? Perché avevo bisogno di ripetermi una cosa molto semplice: che il paesaggio intorno a me, dall’aspetto così autentico e selvaggio, fatto di alberi, prati, torrenti, era in realtà il prodotto di molti secoli di lavoro umano, era un paesaggio artificiale tanto quanto quello di città. Senza l’uomo, niente lassù avrebbe avuto la forma che aveva. Nemmeno il ruscello né certi alberi maestosi. Perfino il pascolo in cui mi sdraiavo al sole sarebbe stato un bosco fitto, reso impenetrabile da tronchi e rami caduti, dai massi coperti di muschio e un sottobosco folto di
28
ginepro, mirtillo e radici intricate. Non esiste wilderness sulle Alpi ma una lunga storia di presenza umana, che oggi vive l’epoca dell’abbandono: alcuni ne soffrono come della morte di una civiltà, a me succedeva invece di gioire trovando un rudere inghiottito dal sottobosco, un albero che spuntava dove un tempo si era seminato il grano. Ma non era la mia storia a scomparire. Io che sognavo il ritorno dei lupi e degli orsi non avevo radici lassù, niente da perdere se la montagna si liberava finalmente dell’uomo.
Così le mie esplorazioni assunsero il carattere di un’indagine, il tentativo di leggere le storie scritte nel terreno. Meno poeticamente, raccoglievo rifiuti. Un vecchio secchio di legno marcio e mezzo sepolto nel letamaio, una serratura arrugginita. La storia che interessava a me era tutta umana: perché, per esempio, la baita dietro alla mia aveva quell’ampliamento su un lato? Forse le cose a un certo punto erano andate meglio, e l’allevatore aveva avuto bisogno di una stalla più spaziosa? Era la più grande di tutte, ma anche la più austera. Finestre minuscole, tre tavole sconnesse a fare da balcone. La terza baita aveva la pianta invertita, e la facciata rivolta a nord. Anche lì doveva esserci stato un buon motivo per rinunciare al sole: magari un litigio per questioni di confini? La quarta baita infine era la più curata, forse anche la più recente. Aveva un balconcino con qualche tentativo di decorazione, i vetri alle finestre e perfino l’intonaco sui muri esterni.
29
Un impasto grezzo, con qualche gobba qua e là, di un bianco sporco che mi piaceva molto. Fuori c’erano due recinti sbilenchi, per le galline o i conigli o qualche altro animale da cortile. Siccome il villaggio era disposto in leggera salita, la baita bianca dominava dall’alto quella girata all’incontrario, quella con la stalla grande e la mia, che in compenso godeva di un panorama senza ostacoli.
Osservandole a volte mi chiedevo: ci sarà stata davvero un’epoca in cui Fontane era un villaggio abitato? Facevo fatica a immaginarla, in montagna vedevo solo ruderi da quando ero bambino. Avevo l’impressione che il presente, lassù, da molto tempo fosse un mucchio di cocci che non era più possibile rimettere insieme. Potevi solo girarteli tra le mani e indovinare a cos’erano serviti, come mi capitava smuovendo una pietra e trovandoci sotto un manico di legno, un grosso chiodo ritorto, un groviglio di fil di ferro, una vanga arrugginita.
Anche se faceva un po’ ridere, ognuna delle quattro baite aveva il suo numero civico. A un certo punto qualche funzionario comunale doveva aver ricevuto il compito di registrare tutti gli edifici, e così anche i ruderi sparsi per la montagna possedevano una targhetta con il numero. Il mio era l’uno. Un giorno o l’altro, pensavo, scenderò in pianura e mi spedirò una cartolina, frazione Fontane numero uno, e poi tornerò qui ad aspettare il postino che arranca su per il sentiero. La
30
baita con la stalla grande aveva il numero due, quella girata all’incontrario il tre, quella intonacata di bianco il quattro. Ma lì abitavano solo i ghiri e i tassi che sentivo muoversi ogni tanto. Ero io la popolazione. Come Robinson sull’isola deserta “ero il signore assoluto del feudo, potevo chiamarmi re o imperatore di tutto il territorio che possedevo”. Rappresentavo, allo stesso tempo, l’abitante più in vista e quello caduto in rovina, il nobile possidente e il fedele guardiano, l’oste, l’ubriacone, il giudice, lo scemo del villaggio: avevo così tanti me tra i piedi che a volte la sera uscivo, e andavo a fare un giro nel bosco per stare un po’ da solo.
31
Una mattina di metà maggio mi svegliai sotto la neve. Nei prati stavano già fiorendo le violette, ma a mezzogiorno era tutto bianco intorno a me. Un temporale di lampi e tuoni, come d’estate, aveva riportato l’inverno da quelle parti. Restai in casa per tutto il giorno, la stufa accesa, leggendo e guardando fuori. Misuravo lo strato di neve che si accumulava sul balcone: cinque, dieci, quindici centimetri. Mi chiedevo che cosa ne fosse dei fiori, degli insetti e degli uccelli che avevo osservato, provando come un senso d’ingiustizia per la loro primavera interrotta. Trovai il racconto in cui Rigoni Stern classificava le nevicate tardive: neve della rondine a marzo, neve del cuculo ad aprile, e l’ultima era per lui la neve della quaglia. “Una nube che scende da nord, una ventata, un rapido abbassamento della temperatura, ed ecco la neve di maggio. Dura solo poche ore, ma sufficienti per far paura agli uccelli nel nido, dare morte alle api sorprese fuori dall’arnia e preoccupazione alle femmine di capriolo in attesa del parto.”
Verso le sette di sera il cielo si schiarì e quella distesa bianca diventò abbagliante, per via del sole spuntato
32
Neve
dalle nuvole poco prima del tramonto. Infilai giacca a vento e scarponi e uscii a fare un giro. Sulla neve trovai diverse tracce di selvatici: una lepre, una coppia di caprioli, moltissimi uccelli, altre impronte che non sapevo riconoscere. Mi colpì scoprire quel viavai mentre io, a casa, pensavo di essere tanto solo e ne soffrivo. Loro erano sempre stati lì, a scrutarmi, annusarmi, controllare i miei movimenti; io invece avevo occhi incapaci di vedere, e dalla finestra guardavo il bosco senza notare nulla. Mi chiesi se avrei imparato ad avvicinarli, con il tempo, o se loro piano piano si sarebbero fidati di me. Per il momento potevo solo seguire delle impronte, scelsi quelle della lepre per simpatia: erano orme a V che procedevano a balzi, partendo da un cespuglio di ginepro vicino alla mulattiera. Ne percorrevano un tratto e poi, con mio stupore, si dirigevano verso la baita. La lepre aveva fatto un giro intorno al vecchio larice, era andata a bere alla fontana, era perfino saltata sul tavolo che avevo nel prato. C’era un’unica impronta là sopra, le era bastato un balzo per salire e uno per scendere: la immaginai guardarsi attorno e leggere i segni della mia presenza, il fumo del camino, la roncola e la sega appese accanto alla legnaia, la coperta stesa sul balcone. Infine aveva scavalcato lo steccato, allontanandosi verso il torrente. Sopra le orme non era caduta altra neve: dunque, mentre io seguivo lei, la lepre era venuta a trovare me.
Durante la nevicata avevo sentito uno schianto forte, come un tuono molto vicino. Quando poi andai a con-
33
trollare nel bosco trovai un larice caduto. Il tronco si era spezzato ad altezza d’uomo, con una lunga frattura irregolare che saliva per un metro o due. Mi fece uno strano effetto osservare quell’albero disteso a terra, inerme ma ancora vivo. I rami coperti di germogli affondavano nella neve, e mi sembrava di sentirlo rantolare come un animale in agonia. Erano state proprio le sue foglie nuove a tradirlo, quelle cresciute nell’ultimo mese: in inverno il larice è spoglio, trattiene poca neve sui rami; ora invece quei fiocchi bagnati e pesanti si erano accumulati in grande quantità nel fitto dei suoi aghi. Così un albero sopravvissuto a un lungo gelo aveva ceduto all’ultima nevicata di maggio, imprevista e fatale.
Mentre gli giravo intorno vidi un uccellino nella neve. Faticava a muoversi e pensai che fosse caduto dal nido insieme all’albero morente. Quando lo raccolsi provò a sbattere le ali nella mia mano, poi si calmò o forse fu paralizzato dal terrore, non l’avrei saputo dire. Era la prima forma di vita con cui entravo in contatto da giorni, e ne fui commosso; non sapevo che mi stavo condannando a un lutto inevitabile. Sentivo il suo battito accelerato nel mio palmo, il solletico delle sue zampe sulla pelle. Va tutto bene, gli dissi, stai tranquillo, ci penso io a te. In casa stesi uno straccio sul fondo di una scatola da scarpe e lo adagiai lì dentro. Quale sarà stata la dieta di un uccellino così piccolo? Per la neve che c’era fuori, non potevo nemmeno cercargli qualche insetto o verme. Provai a dargli delle palline di pane, e vidi che le accettava; riuscì a ingoiarne un paio e poi si mise a
34
dormire. Ma la fame, il sonno, erano solo un’illusione di vitalità. Quando tornai a controllarlo era disteso su un fianco: respirava ancora, ma in una posizione del tutto innaturale, e non apriva più gli occhi. Prima che venisse buio era morto e andai a riportarlo vicino al larice caduto, dove magari, nella notte, sarebbe diventato il pasto di una volpe o di un corvo. Lasciarlo a loro mi sembrava più giusto che seppellirlo in un buco.
La mattina dopo pensavo ancora all’uccellino, bevendo il caffè e osservando la neve sciogliersi al primo sole, quando vidi un uomo salire dal sentiero. Mi affacciai sulla soglia ad accoglierlo, ma gli sarei anche corso incontro per l’eccitazione. È difficile descrivere l’effetto di una visita dopo un periodo di completa solitudine: per me erano state solo due settimane, eppure vedendo quell’uomo avvicinarsi il cuore cominciò a battermi veloce. Era Remigio, il mio padrone di casa. Era venuto a vedere se la nevicata mi aveva dato problemi, e se avevo abbastanza legna per scaldarmi. Non sapevo che idea si fosse fatto della mia presenza lassù: durante il nostro unico incontro gli avevo raccontato che scrivevo, e che ero venuto lì per lavorare. Lui non mi era sembrato particolarmente colpito. Senza tante parole mi aveva stretto la mano e consegnato le chiavi della baita, come non fosse nemmeno sua.
Quel giorno invece era più loquace. Lo invitai dentro per un caffè e parlammo un po’. Quando vide i libri che mi ero portato scoprii che era un buon lettore:
35
parlammo di Erri De Luca e di Mauro Corona, poi sfogliammo i miei manuali sugli animali selvatici e gli alberi del bosco, e infine gli prestai i racconti di Rigoni Stern a cui ero tanto legato, perché mi avevano aiutato a vedere e sentire nei primi giorni lassù. Remigio mi ascoltava con attenzione. Anche parlando sceglieva le parole con cura. Dimostrava una quarantina d’anni, ma la pelle abbronzata e i capelli grigi creavano uno strano contrasto, quello di un uomo giovane e vecchio allo stesso tempo. Conoscendolo avrei scoperto che era una buona definizione per lui.
Più tardi tornò con una motosega, e facemmo a pezzi il larice caduto. Della neve del giorno prima non restava che qualche chiazza all’ombra. Accatastammo i grossi ceppi contro il muro della baita che guardava a ovest: li avrei poi spaccati con calma e rimessi a seccare. Se l’estate farà il suo dovere, pensai guardandolo andare via, avrò legna buona da bruciare in settembre, e magari un amico con cui dividere il piacere del fuoco.
36
Dopo la scorta di legna c’era un altro lavoro che volevo fare. Era da un po’ che l’idea mi girava in testa, e l’incontro con Remigio mi diede la spinta decisiva. Una mattina di fine maggio, in attesa che lui arrivasse con gli attrezzi, costruii una panchina: tolsi due grosse pietre dai resti della mulattiera e ci appoggiai sopra una tavola trovata nel bosco, grigia per tutta la pioggia e il sole che aveva preso, le vene del legno in rilievo come quelle dei vecchi. Poi mi sedetti a leggere il capitolo di Walden sul campo di fagioli: “Cosa significasse questa piccola, erculea fatica, costante e orgogliosa, allora non lo sapevo. Presi ad amare i filari e i fagioli benché fossero molto più di quel che mi necessitava. Essi mi legavano alla terra e così ottenevo forza come Anteo. Ma perché avrei dovuto coltivarli? Solo il cielo lo sa. Fu il mio curioso lavoro per tutta l’estate, produrre fagioli da questa piccola parte della superficie terrestre che sino ad allora aveva prodotto solo pentafillo, more e simili dolci frutti e fiori selvaggi. Cosa dovrò imparare dai fagioli oppure loro da me? Li amo, li zappo
37
Orto
e al mattino e alla sera getto un occhio: questo è il mio lavoro giornaliero”.
Incantato dalle parole di Thoreau, studiai il pascolo che scendeva fino al torrente. Ne individuai un pezzetto appena sotto la fontana: era terra buona, concimata ogni anno dai pastori. Prendeva il sole dalle nove di mattina alle otto di sera, e l’acqua per irrigarla era lì a due passi. Mi sembrava già di vedere il rosso dei pomodori, il giallo dei fiori di zucchina. Ero impaziente di cominciare la mia vita da contadino.
Remigio spense subito i colori della mia fantasia. Lassù potevo dimenticarmi i frutti, mi spiegò, era già tanto che crescessero le foglie: lattuga, cavolo, erbette, spinaci, coste. Con un po’ di fortuna sarei riuscito a coltivare anche qualche carota stenta, ravanelli, broccoli, porri. Mi andava bene lo stesso? Io risposi che a me andava bene tutto. Poi avviai una motozappa per la prima volta in vita mia: è un piccolo aratro a motore, delle dimensioni di un tagliaerbe, la cui lama affonda nel terreno per qualche decina di centimetri, rivolta le zolle e grossolanamente le frantuma. Arammo in quel modo un rettangolo di quattro metri per sei.
Era solo l’inizio delle mie fatiche. Rotta la crosta, per il resto della giornata zappai e rastrellai la terra che c’era sotto. Tolsi pietre e strappai radici, scoprendo che quei fiori gentili avevano bulbi poderosi e inestirpabili, nascosti a grandi profondità per soprav-
38
vivere al gelo. Sbriciolai con le mani le zolle più compatte. Poi scesi in paese a comprare le piantine. Per proteggerle dai caprioli costruii perfino uno steccato con quattro paletti di larice. Ci avvolsi intorno una rete robusta, ed ero tutto contento di come stava venendo il mio orticello, ma quando alla fine mi sedetti ad ammirarlo la voce di Thoreau svanì, e al suo posto echeggiarono le note del Suonatore Jones di De André. Il pezzo in cui dice che nei campi coltivati dorme la libertà. Di colpo, quelle sei gobbe di terra smossa mi sembrarono tumuli sepolcrali. C’era la mia libertà seppellita lì sotto. E la libertà dei caprioli. E perfino la libertà del prato. Mi sentivo un po’ depresso, così misi via zappa e rastrello, presi il bastone e decisi di andare a camminare.
Salii più in alto di dove mi fossi mai spinto e a un certo punto abbandonai il sentiero, perché tutto il versante in ombra era ancora innevato. In giro non c’era nessuno: le nuvole basse, la minaccia di pioggia e il vento freddo avevano tenuto lontani gli escursionisti. Mi buttai giù per un boschetto di abeti con l’intenzione di attraversarlo e risalire la valle sul lato al sole, dove i pendii erano già sgombri dalla neve. Alla fine del bosco trovai un ponticello di legno, un villaggio di una decina di case sulla riva di un torrente. Avevano quasi tutte il tetto sfondato, la parete rivolta a monte deformata in quella grossa pancia che prelude al crollo. Superando il senso di abbandono entrai in una delle baite
39
rimaste in piedi. Nell’unica stanza trovai un lettino di legno, una panca, uno sgabello zoppo. Per terra segni più recenti: scatolette di carne e sardine, bottiglioni di vino, una camicia ridotta a stracci, i rifiuti di qualche pastore che si era accampato lì dentro senza cura. C’era un odore opprimente di muffa e tornai all’aria aperta con sollievo.
Risalendo il pendio raggiunsi la cima di un picco, e finalmente dall’altra parte vidi il lago di cui avevo sentito parlare. Era coperto da uno strato di ghiaccio e circondato dalla neve: solo qualche roccia spuntava ogni tanto sulle rive più scoscese. Avevo pensato di raggiungerlo, ma vederlo così, dall’alto, nel gelo di quella conca in ombra, mi fece cambiare idea. Allora mi sdraiai per terra e restai lassù, le mani sotto la nuca, a contemplare le nuvole gonfie di pioggia.
Tra una e l’altra si aprivano scorci di blu. Due aquile volteggiavano intorno a una cima, forse a caccia dei cuccioli di camoscio e stambecco che in maggio sono appena nati. I gracchi, meno nobili e più pietosi, sorvolavano gli alpeggi deserti, in cerca di rifiuti di cibo o di qualche carcassa di roditore che non aveva superato l’inverno.
Poi le due aquile si avvicinarono, scesero un po’ di quota e così mi accorsi che non erano una coppia, ma un’aquila adulta e un aquilotto. Quella a cui stavo assistendo sembrava una lezione di volo. L’adulto ripeteva una manovra molto elaborata: restava immobile a mezz’aria, sorretto da una corrente ascensionale, poi
40
di colpo raccoglieva le ali ed eseguiva un avvitamento sul corpo, in orizzontale, precipitando senza controllo. Sembrava il numero di un pilota acrobatico. Qualche metro più in basso spiegava le ali e frenava la caduta, quindi riprendeva la corrente e tornava alla quota iniziale. L’aquilotto osservava con attenzione e io pensai che presto sarebbe stato il suo turno. Mi chiesi se l’adulto fosse la madre o il padre.
Al ritorno ricominciò a piovere e la pioggia ridusse la neve in poltiglia. Giornata ideale per andarsene a spasso. Ma con i piedi inzuppati d’acqua, i capelli umidi e il vento che li ghiacciava, sentivo che stavo almeno recuperando il buonumore. Capitai in una radura popolata dalle marmotte, dove mi accolse una selva di fischi e un fuggi fuggi generale. Ce n’era una che sembrava più coraggiosa delle altre: mentre le sue compagne correvano a nascondersi nel primo buco disponibile, lei indugiava sulla soglia della tana e mi guardava. Allora mi avvicinai piano, cercando di non fare movimenti bruschi. Quando arrivai a tre metri di distanza lei sparì nel buco e io mi fermai, posai il bastone, mi sedetti lì accanto con cautela. Pensai di cantarle una canzone, e siccome mi girava in testa da tutto il giorno scelsi proprio De André.
Bastarono i primi due versi per vedere il suo muso rispuntare dalla tana: mi ascoltava, mi annusava, cercava di capire che razza di nemico ero. Io andai avanti a cantare. La marmotta ogni tanto tornava sotto, ma più
41
che altro stava lì e mi guardava. E questo chi è? Che cosa sta facendo?
Gliela cantai per tre volte di fila, e la marmotta le ascoltò tutte quante. Poi mi alzai e lei subito si nascose, presi il bastone e ricominciai a scendere verso il mio orticello.
42
Notte
Continuavo a non dormire bene. Nonostante fosse passato più di un mese, mi ritrovavo a svegliarmi nella notte con i sensi all’erta, gli occhi ciechi ma le orecchie vigili, attente a ogni scricchiolio del legno, ogni fruscio che arrivava da fuori. Non ho mai avuto un buon rapporto con il buio. Da bambino ne ero terrorizzato, passavo notti in preda a un senso di catastrofe imminente. In città mi tenevano compagnia le luci della strada: la mia finestra dava su un viale in cui il flusso di traffico non si esauriva mai, e per un gioco di specchi vedevo i fanali delle automobili scorrere sul soffitto, il giallo dei semafori lampeggiare, il blu delle ambulanze, il verde di una farmacia notturna. Ogni tanto risuonava un allarme o una sirena, versi acuti di uccelli sopra il mormorio continuo del fiume. Sentire la vita sotto di me mi tranquillizzava, i suoi rumori mi cullavano fino al sonno.
Nella baita precipitai di nuovo nelle paure infantili: quando la luna calava il buio era assoluto, e il silenzio così profondo da provocarmi dolore alle orecchie, tese per cogliere qualsiasi suono. Riuscivo a sentire l’acqua
43
scorrere nella fontana. Il vento che agitava le cime dei larici. Il verso di un capriolo nel bosco che non è come uno lo immagina, niente di simile a un belato: assomiglia piuttosto a un colpo di tosse rauco, l’abbaiare di un cane senza voce. Erano loro i selvatici e io il predatore, ma nel mio letto il buio invertiva i ruoli. Le prime luci verso le cinque erano un sollievo: gli uccelli cominciavano a cantare, la vita riprendeva a scorrere nel mondo e la mia vigilanza non era più richiesta. Allora, come una guardia che smonta dal turno di notte, mi assaliva un sonno sordo da cui mi risvegliavo intontito a metà mattina.
Così una sera mi infilai due maglioni, riempii una borraccia di vino, presi il sacco a pelo e decisi di bivaccare fuori. Era una specie di terapia d’urto. Verso le nove accesi un fuoco contro il muretto della mulattiera, feci la punta a qualche rametto di salice e con quegli spiedi infilzai pezzi di salsiccia da arrostire. Come pane avevo una piadina croccante, di quelle che cucinavo impastando acqua e farina. Lì fuori davanti al fuoco fu una cena da buongustai: quando la carne era pronta la sfilavo dallo spiedo con il pane e accompagnavo a ogni boccone un sorso di vino. Alle dieci, calato il buio, srotolai il sacco a pelo e ci entrai. Scoprii di non avere sonno. Allora mi misi seduto senza uscire dal sacco, alimentando il fuoco con la legna piccola che avevo raccolto nel bosco. Restai a finire il vino guardandola bruciare.
44
In quella notte strana me ne venne in mente un’altra di molte estati prima, cominciata in un bar di paese con mio padre e mio zio. Dopo cena mio padre raccontò di una montagna, lì nella zona, che una volta si saliva al buio per vedere l’alba dalla cima. Dal paese erano circa duemila metri di dislivello, quattro o cinque ore di cammino andando di buon passo. Be’, disse mio zio, e che ci vuole? Facciamolo. Loro erano ai giri di grappa, io avevo quattordici anni e un gran bisogno di dimostrare il mio coraggio. Andai con loro. A mezzanotte imboccammo il sentiero e passammo la prima ora di cammino a inciampare nelle radici e nei sassi, ridere, imprecare, farci luce a vicenda con l’unica pila che avevamo. Poi il bosco finì, ma finì anche l’effetto della grappa. I due fratelli non parlavano più, ora sbuffavano e basta. Avranno avuto gole riarse e gambe infiacchite dal bere, ma nessuno voleva essere il primo a proporre di tornare indietro. A poco più di metà strada, verso le tre, in mezzo ai pascoli ci sembrò di sentire il suono di un organo. Poi scorgemmo il bagliore di una finestrella. Chi stava suonando l’organo alle tre di notte, in una baita isolata a duemila metri d’altezza? Noi eravamo stanchi e infreddoliti. Per non spaventare il musicista mio padre e mio zio decisero di non bussare, ma di presentarsi cantando a squarciagola. Anche in quelle condizioni conservavano il loro spirito goliardico. Davanti alla porta della baita intonarono un coro alpino: nel giro di due strofe la musica si arrestò, si accese una luce al pianterreno e il padrone di casa venne ad aprirci.
45
Era un uomo sulla sessantina. Non sembrava per nulla contento di vederci. Era evidente che non gradiva la compagnia, ma si sforzò di essere ospitale: ci preparò un tè caldo, ci prestò altre due pile, declinò i tentativi di conversazione, ci augurò buon viaggio e ci accompagnò alla porta. Più avanti sul sentiero lo sentimmo ricominciare a suonare. Alla fine arrivammo davvero alla cima, ma non ricordo niente di quell’alba: chi era il musicista misterioso? Come aveva fatto a portare un organo lassù? Forse nemmeno lui aveva un buon rapporto con il buio. Allora mi sembrava un eccentrico, se non proprio un matto di montagna; invece adesso, davanti a quel fuoco, avrei voluto esser capace di suonare anch’io. Una chitarra o almeno un’armonica a bocca. Cantare da solo non era la stessa cosa.
Riaprii gli occhi dopo un sonno che non sapevo misurare. Mezz’ora, due, tre? In cielo si era alzata la luna, e del mio fuoco non restava che un mucchio di braci incandescenti. Sentivo odore di cenere e terra umida, in bocca il sapore aspro del vino, e sotto la schiena il sacco a pelo era fradicio di rugiada. Così mi alzai, andai a lavarmi la faccia alla fontana e l’acqua gelida della notte ebbe l’immediato effetto di svegliarmi. Ero incerto se andarmene a letto o riattizzare il fuoco e aspettare l’alba, che ormai non doveva essere lontana. Ancora quel vecchio bisogno di prove di virilità: ma se il nemico da combattere ero io, allora ritirarmi dalla gara e buttarmi sotto le coperte poteva essere l’autentica vittoria.
46
Mi ero seduto sui gradini della baita a decidere che cosa fare, quando colsi un movimento nel prato. Mi voltai verso il punto in cui avevo dormito e, vicino al sacco a pelo, vidi il profilo inconfondibile di una volpe. Il muso affilato, le orecchie dritte, la coda foltissima e lunga quanto il corpo. Non si era accorta di me: annusava il terreno intorno al fuoco in cerca dei resti della mia cena, e io restai immobile sperando di non essere visto ancora per un po’. La luna giù nel prato illuminava tutto di una luce fredda. La volpe smosse la terra vicino alle braci e leccò qualcosa, un pezzetto di carne che mi era scappato o solo il grasso rappreso. Poi da un momento all’altro, forse per una folata di vento che le aveva portato il mio odore, alzò la testa e mi vide. I suoi occhi riflettevano il bagliore delle braci. Io sarò stato solo una massa scura all’ombra della casa, e lei impiegò qualche istante a riconoscermi. Quello sguardo tra noi mi sembrò dilatarsi a dismisura. La volpe non ne fu impaurita: forse già da molte notti conosceva il mio odore. Si dileguò senza fretta, trotterellando via nel buio. Io andai a raccogliere il sacco a pelo, lo stesi sullo steccato ad asciugare e poi mi abbandonai al letto degli umani.
Scrive Thoreau: “Trovo che lo star soli la maggior parte del tempo sia utile e salutare. Anche la compagnia dei migliori presto annoia e consuma. A me piace star solo. Non ho mai trovato un compagno socievole quanto la solitudine. Io credo che siamo più facilmen-
47
te soli quando andiamo nel mondo, fra gli uomini, di quando stiamo nelle nostre stanze. Colui che pensa o lavora è sempre solo, lasciatelo stare dove vuole. La solitudine non si misura con le miglia che separano un uomo dai suoi simili.
In generale la compagnia è a buon mercato. Ci incontriamo in intervalli di spazio brevi, senza aver avuto il tempo di acquisire nuovi valori reciproci. Ci vediamo tre volte al giorno durante i pasti, dandoci l’un l’altro un assaggio di quel formaggio rancido che siamo. Abbiamo dovuto ricorrere a un accordo comune su certe regole, chiamate etichetta e cortesia, per poter rendere tollerabili questi incontri così frequenti e per non dichiararci guerra apertamente. C’incontriamo all’ufficio postale, nei ritrovi e ogni sera accanto al fuoco; viviamo in ambienti troppo affollati e c’ingombriamo il cammino e inciampiamo gli uni sugli altri, e in questo modo, credo, perdiamo il rispetto reciproco.
Ho sentito dire di un uomo perduto nei boschi e morto di fame e di fatica ai piedi d’un albero, la cui solitudine fu alleviata dalle visioni grottesche − dovute alla debolezza fisica − con cui la sua immaginazione malata lo circondava e che lui credeva vere. Allo stesso modo, grazie alla forza e alla salute del corpo e della mente possiamo essere ricreati di continuo da una compagnia simile, ma più normale e naturale, e così convincerci che non siamo mai soli”.
48
In giugno arrivarono i pastori, e la mia solitudine cambiò. Vennero in camion, grossi autocarri per il trasporto bestiame che comparvero un giorno alla fine della strada. Nervose per il viaggio, e forse eccitate da tutti quei prati fioriti, le mucche correvano giù dagli scivoli, si prendevano a cornate tra loro, ignoravano i confini dei pascoli e andavano a nascondersi nel fitto degli abeti. I pastori le lasciavano fare. Nonostante la transumanza a motore, i più anziani portavano ancora il gilet di velluto e il cappello di feltro, un costume a cui i giovani avevano sostituito lunghi grembiuli impermeabili. Tutti osservavano le montagne all’orizzonte come se avessero bisogno di riabituarsi al paesaggio. Era un trasloco in piena regola il loro: cambiavano casa per quattro mesi, trasferendo lassù animali e famiglie, passando a una vita più dura di quella invernale, eppure c’era un’allegria evidente nei loro gesti. Scambiandosi notizie in dialetto ridevano spesso. Mi sembrava che la felicità degli animali avesse contagiato gli uomini: che anche per loro salire in alpeggio significasse tornare a casa, forse ai luoghi della propria infanzia, o alle origini del proprio mestiere.
49
Vicini
Così ora avevo qualcosa da osservare, oltre alle nuvole che in quei giorni portavano piogge interminabili. Non lontano dalla baita, sull’altro versante della valletta in cui abitavo, c’era l’alpeggio che avevo creduto abbandonato, prima che arrivassero i proprietari: da quella parte all’inizio di giugno regnava il giallo del tarassaco, e se mi svegliavo presto la mattina potevo spiare il pastore anziano che spostava i confini del pascolo, avanzando i paletti di qualche metro al giorno in modo da razionare l’erba. Poco dopo il pastore giovane apriva il portone della stalla, e allora sette vitelli e una trentina di mucche adulte si precipitavano giù, verso la nuova striscia di erba alta. Erano quasi tutte pezzate castane, dominate da alcune mucche nere più agili e muscolose. A sera di quel prato non era rimasto nulla. Mentre mi preparavo la cena, dalla stalla si alzavano imperiosi muggiti: tre o quattro bidoni d’acciaio comparivano davanti al portone, e poco dopo un fuoristrada partiva per consegnarli al caseificio. Allora davvero la giornata era finita.
Ma il cambiamento più grande, nella mia vita quotidiana, fu provocato dai cani. Siccome mettevo via per loro le croste di formaggio, tornavano a trovarmi diverse volte al giorno (a dire il vero, anche se non è da montanaro, ogni tanto sostituivo alle croste qualche biscotto, di quelli che tra me chiamavo i biscotti degli amici). Avevano un campanello appeso al collo grazie
50 * * *
a cui li sentivo arrivare da lontano. Per qualche loro gerarchia interna uno dei tre restava sempre al pascolo, gli altri due invece erano liberi di gironzolare fino al momento di ricondurre le bestie nella stalla. Allora, richiamati dal pastore giovane, facevano gioco di squadra: accerchiavano la mandria abbaiando, mordevano ai fianchi le mucche più pigre e inseguivano quelle indisciplinate, le spingevano verso casa. Era uno spettacolo vederli all’opera.
Dalle grida del pastore scoprii che si chiamavano Black, Billy e Lampo. Black era il più vecchio, un gran mastino nero con sei dita nelle zampe posteriori e l’orecchio destro sbranato in chissà quale rissa. Per questo decisi di non chiamarlo Black, ma Mozzo. Si vedeva che era a fine carriera: alle mucche preferiva l’ombra degli abeti, o gli odori dei selvatici che seguiva pigramente nel sottobosco. Billy era un cane lupo e un lavoratore infaticabile, per questo io e lui ci incontravamo meno. Quando veniva da me sembrava sentirsi in colpa: prendeva una buccia di salame e subito scappava via, difficilmente si faceva accarezzare. Lampo era il più giovane, un border collie con una passione per i rametti di larice lanciati a grande distanza. Amava farsi grattare dietro le orecchie e mi lasciava un buon odore di stalla nelle mani. Stava imparando il mestiere, ma era alle prime armi e ogni tanto ne combinava una: una mattina, sotto il diluvio, i sette vitelli si ammutinarono e tutti insieme superarono il confine del pascolo, gettandosi nell’erba alta come su una tavola imbandita.
51
Allora il pastore giovane lanciò un gran fischio: Billy partì subito all’inseguimento, Lampo lo vide e gli corse dietro, Mozzo invece rimase a osservare dal mio balcone, all’erta ma defilato, come al suo solito, da vecchio capo. Io mi sedetti accanto a lui a godermi le operazioni. Nel pascolo Billy stava già riportando i fuggitivi in gruppo, ma poi Lampo se la prese troppo con uno dei vitelli, continuò a morderlo e abbaiargli addosso e così quello scappò di nuovo, e gli altri sei dietro. Billy corse a riprenderli, e la scena si ripeté uguale. Uno li riprendeva, l’altro li spaventava, e i vitelli confusi scalciavano e correvano dappertutto.
Billy a quel punto era fradicio di pioggia: guardò i vitelli, guardò Lampo, guardò il padrone che bestemmiava agitando il suo ombrello, poi entrò in sciopero e se ne andò verso il bosco. Il pastore giovane gridava: Billy! Ma Billy sparì tra i larici e non si vide più. Lampo scodinzolava lì vicino, per lui sarà stato un gioco. I vitelli banchettavano nell’erba che doveva essere il pasto dell’indomani. Veniva giù un’acqua da spazzarci via tutti, lavarci via dalla montagna come foglie secche, e sul mio balcone Mozzo finì il suo biscotto, si stiracchiò la schiena, brontolando si rassegnò all’idea che adesso toccava a lui.
La mattina dopo pioveva ancora, e avevo deciso di fare le tagliatelle verdi. Raccolsi foglie di ortiche e spinacio selvatico intorno alla baita, le feci appassire in padella, poi le tritai e mescolai a uova e farina. Avevo
52
cominciato a stendere la pasta con il mattarello quando sentii un frastuono di campanacci e le grida di un pastore. Mi affacciai alla finestra e feci in tempo a vedere due vitelli che scappavano in giù. Il pastore non era uno dei miei vicini, ma quello solitario e un po’ zoppo che ogni tanto passava col trattore: era l’unico a rivolgermi un cenno di saluto, benché non avessimo mai scambiato una parola. Per colpa della sua gamba non era riuscito a inseguire i fuggiaschi. Lo vedevo su in alto, in mezzo al prato, a sbracciarsi e imprecare. Allora mi slacciai il grembiule, spensi il fornello sotto l’acqua della pasta, presi il bastone e uscii, tutto infarinato com’ero. Trovai i vitelli poco più sotto, in una radura in mezzo al bosco. Pascolavano tranquilli. Non sapevo se mi avrebbero obbedito, l’avevo solo visto fare: girai intorno al primo e gli diedi un colpetto di bastone sul fianco, e piano piano, controvoglia, quello cominciò a risalire. Il secondo gli andava dietro. Tutto fiero di me li portai a Fontane e li chiusi in un angolo tra lo steccato e la baita, poi aspettai il pastore zoppo sperando che arrivasse presto. Comparve dopo pochi minuti su una moto da cross guidata da un suo amico. Legò i vitelli con una corda di canapa e mi chiese com’ero riuscito a catturarli: risposi che era stato facile, avevano fatto tutto loro. Lui rise, e vidi che gli mancavano gli incisivi. Disse che quasi quasi mi assumeva come guardiano. Si chiamava Gabriele. Aveva un’età tra i quaranta e i cinquanta, difficile stabilirlo per via delle mani enormi, il fisico da scaricatore, gli abiti laceri, la barba incolta e
53
la pelle bruciata. Da vicino zoppicava vistosamente: mi raccontò che l’anno prima al trattore era partito il freno a mano, lui c’era finito sotto mentre spaccava legna, e ora la sua gamba sinistra era tenuta insieme da una placca di metallo e un po’ di viti. Di me sapeva già tutto. A che ora accendevo la stufa al mattino, ogni quanto uscivo nell’orto a strappare le erbacce, e che quasi ogni giorno prendevo e me ne andavo a camminare. Mi vedeva dall’alto portando le mucche al pascolo: la sua baita si trovava poco più su della mia, a un quarto d’ora circa di sentiero, e grazie all’impresa di quel giorno mi guadagnai un invito a cena per la sera.
Non valevo granché come eremita: ero andato lassù per stare da solo, eppure non facevo altro che cercare compagnia. O forse era proprio la mia condizione a rendere ogni incontro così desiderato e prezioso. Dopo quasi due mesi nella baita, insieme alla primavera stava per finire la mia stagione di solitudine.
Alle sette passò Mozzo in cerca di biscotti, e mi scrutò mentre mettevo i jeans e la camicia a scacchi più elegante. Era abituato a vedermi con i calzoni corti e un maglione bucato, e non capiva. Che cos’hai da guardare?, gli chiesi. Non posso avere un invito a cena anch’io? Poi allacciai gli scarponi, presi la bottiglia di Nebbiolo che tenevo da parte per le occasioni speciali, diedi a Mozzo una grattata sulla testa e mi avviai per il sentiero verso il mio appuntamento.
54
Estate
Stagione dell’amicizia e dell’avventura
Pastore dove vai
E così sei un sovversivo, mi disse stappando il vino, quando provai a spiegargli che cos’ero andato a fare lassù. Gli avevo detto che non mi piacevano le regole e i padroni, e che in città mi sentivo chiuso in gabbia: se per vivere a modo mio dovevo stare da solo in mezzo a una montagna, be’, accettavo la solitudine in cambio della libertà che mi garantiva. Gabriele capì perfettamente il mio discorso. Solo quando ne feci una questione politica aggrottò le sopracciglia in una smorfia. Lui portava giacche militari, detestava gli stranieri pur avendone visti solo un paio in vita sua, e anche parlando di donne gli piaceva fare il duro. Eppure ero convinto che fosse molto più anarchico di me: lui che non aveva una famiglia né un lavoro fisso, né un televisore, un’automobile, un mutuo in banca; non aveva bisogno di soldi se non per comprarsi da mangiare e da bere; e non votava, non era rintracciabile in rete, non faceva numero in nessun sondaggio né indagine di mercato, non era nella media di niente. Un uomo così, che si era costruito un’esistenza ai margini e ci viveva a modo suo, era quanto di più sovversivo io riuscissi a imma-
57
ginare per la nostra epoca, però non trovavo le parole per dirglielo. Quando mi avventuravo in discorsi complicati lui mi guardava storto, e se usavo parole difficili smetteva di ascoltarmi. Così lo accontentai. Forse hai ragione tu, dissi. Mi sa proprio che sono un sovversivo.
Lui non diceva le mucche, diceva le baracche. O le baldracche quando lo facevano arrabbiare. Nemmeno quelle erano sue: gliele mandavano su dalla pianura per l’estate, a pascolare in montagna durante la stagione dell’alpeggio. Gabriele sfruttava così le sue uniche proprietà: una baita, un trattore, una stalla, un pascolo coperto di neve per sei mesi all’anno. D’inverno abitava in una stanzetta in paese e si adattava a fare l’operaio, lavorando alle piste da sci. Ma in fondovalle ci stava male, era troppo selvaggio per la vita urbana. Parlava solo gridando, come se si trovasse lontanissimo da chiunque. Non c’era niente che riuscisse a fare piano. Un dito dei suoi era grosso quanto due dei miei, e tutto diventava fragile nelle sue mani. Certe volte in paese lo assumevano a giornata per demolire un rudere o spaccare qualche quintale di legna, ma prima di sera col trattore tornava alla sua baita a duemila metri. Solo lassù aveva lo spazio che gli serviva: sembrava appartenere alla montagna quanto un masso erratico o un larice secolare, cresciuto in mezzo a un pascolo, al sole e al vento.
Mettiamo a nanna le baracche, diceva verso sera. Poi spalancava il portone della stalla, apriva un varco
58
nel filo elettrificato e con pazienza le chiamava. Vien, vien, vien. Una a una le bestie lo seguivano pigre. Per la mezz’ora successiva dalla stalla arrivavano insulti e sonori ceffoni: al momento di essere legate le mucche si ribellavano, mettendosi di traverso e scambiandosi di posto tra loro, così bisognava spingerle a spallate e tirarle per il collare in quel caldo opprimente, umido del loro fiato e sudore. Poi per fortuna Gabriele ne aveva da mungere un paio, e così ritrovava la calma. Era un gesto che lo rilassava molto. C’è chi munge con il pollice piegato dentro al pugno, mi spiegò, usando la nocca per stringere la mammella, ma a lui quel modo non piaceva perché era poco delicato. Preferiva usare il palmo della mano. Il secchio del latte poi lo lasciava ai vitelli e al cane, lui ne teneva soltanto un goccio per il caffè del mattino. A quel punto chiudevamo la stalla e finalmente ce ne andavamo a cena.
Casa sua era una stanza rivestita di legno, tre metri per tre, una branda, una stufa, un tavolo, niente acqua corrente, niente bagno. Intorno altri sei o sette ruderi cadenti, uno usato da lui come cantina, un altro come legnaia. La stanza all’interno era stipata di oggetti: alle pareti una collezione di campanacci e collari, le coppe vinte alla battaglia delle mucche, le ragazze nude sul calendario di un’azienda di trattori. Una vetrinetta di cristallo, un mobiletto anni Sessanta in truciolare (segato a metà in altezza perché non ci stava), un piccolo e molto più antico armadio a muro, solo due ante e un
59
fermo a chiudere una nicchia nella pietra. I piatti di legno, il paiolo di rame. Gli attrezzi per fare il formaggio appesi sopra la stufa.
A cena mi parlava spesso dei tempi andati. Era un uomo allegro per natura, ma l’abbandono gli metteva malinconia: si ricordava di quando andava lassù con la madre e le sorelle, adesso invece era rimasto solo. Tra le foto appese al muro ce n’era una con moglie e figli, ma temevo che quello fosse un tasto dolente e preferii non toccarlo. Chiesi piuttosto della foto con la mucca nera, dove lui sorrideva e l’abbracciava per il collo: quella era Morgana, la sua preferita, andata al macello ormai da molti anni. Le mancava solo la parola, mi disse. Adesso c’era Lupo a fargli compagnia, un cane pastore che lo seguiva ovunque: sveglio, riservato, affettuoso, il più intelligente che avesse mai avuto. Sentendosi chiamare Lupo drizzò le orecchie dal suo giaciglio vicino alla stufa, ci guardò, venne a prendersi una carezza e le croste della toma.
Nei racconti di Gabriele viveva un mondo perduto in cui, lassù nel villaggio, ogni casa era abitata e operosa. Uomini al lavoro nei campi e nelle stalle, ragazzini al pascolo, le donne a occuparsi degli animali da cortile. Due ore di mulattiera per arrivare dal paese, polenta e latte a pranzo e cena (per questo odiava la polenta, non la poteva più mangiare). Bastavano pochi giorni per dimenticarsi della civiltà, levarsi di dosso scarpe e vestiti e tornare allo stato selvatico. Eppure ci tenne a spiegarmi che il pastore - il berger - è quello delle
60
pecore, per chi ha le mucche c’è un’altra parola. Vacher. Non è una differenza da poco. Il pastore è un nomade, pascola e dorme dove capita, il vaccaro invece è un sedentario. Con campi suoi, una casa, una stalla.
Poi chiacchierando scoprii che quel mondo non l’aveva mai visto davvero. Quand’era bambino lui, il villaggio era già abbandonato. Nelle case vuote inventava i suoi giochi con qualche raro compagno di un alpeggio vicino. La montagna abitata non era un ricordo, ma una leggenda dell’età dell’oro con cui alimentare i sogni di felicità: gli sarebbe piaciuto venir su con i figli, che avevano diciannove e vent’anni e facevano i muratori, e poi galline, un asino, un paio di capre, un maiale da macellare in autunno. Parlava spesso di comprarsi quel po’ di bestiame sufficiente per vivere in autonomia. Invece aveva solo l’erba, con cui ingrassava le mucche degli altri, e sogni a occhi aperti per notti che non finivano mai.
Siccome a me piaceva cucinare e a lui no, ma a nessuno dei due dispiaceva cenare in compagnia, certe volte ci organizzavamo così: io salivo a casa sua verso le sette, prendevo la grossa chiave nascosta sotto una pietra, entravo e accendevo la stufa. Poi andavo a lavare i piatti alla fonte, dove Gabriele aveva sistemato una vasca da bagno da usare come tinozza per sé, i vestiti e le stoviglie. Lì trovavo il sapone, la spazzola, la paglietta metallica. Mi faceva uno strano effetto strofinare le padelle alla luce del tramonto, e usando acqua
61
gelida e niente detersivo c’era parecchio da grattare, ma dove avrei trovato un lavatoio migliore? Le marmotte mi scrutavano mentre riempivo la pentola della pasta. Dal bosco spuntava il muso di un capriolo. Quando tornavo in casa la stufa era già ben avviata e io accendevo la radio, mettevo l’acqua sul fuoco, mi sedevo a pelar patate. Spaghetti al pomodoro, patate bollite e formaggio, qualche volta un pezzo di salsiccia erano la nostra dieta quotidiana. Tornando dalla stalla Gabriele passava per la cantina, dove aveva quattro damigiane di Barbera che sarebbero durate per tutta l’estate, se poi una non l’avesse fracassata cercando di tapparla a pugni. Un’altra volta era toccato al parabrezza del trattore, che così era diventato un coupé. Queste erano le sue tipiche disavventure.
Quando invece era lui a venire giù da me si sedeva sempre nello stesso posto, sulla panca, le spalle al muro per osservare la casa. Tu sì che vivi bene, mi diceva guardandosi in giro, perché avevo una cucina vera, un frigorifero e perfino un divano, il bagno, l’acqua corrente, i muri dritti e il tetto tutto intero e non dovevo stendermi sotto al tavolo quando pioveva. Mi portava sempre un pezzo di formaggio e un bottiglione di vino. Una sera arrivò con un pollo arrosto che si era procurato chissà dove. Un’altra volta era andato a lavorare da un amico in pianura, e tornò con cinque chili di riso e un repertorio di racconti nuovi di zecca. La serata passata al night con le ragazze russe, la fila di trattori John Deere che aveva visto in cascina, il bambino che l’aveva
62
fatto ridere chiedendogli: come mai ti chiamano Rambo? È perché sei molto forte?
Alla fine aveva un modo elaborato di andar via. Era una specie di cerimonia, e impiegai un po’ di tempo a capire come funzionava. La prima volta disse: va bien, mi sa che adesso vado; così mi alzai per aprirgli la porta e salutarlo. Lui mi guardò strano e chiese: hai tanta fretta? Io no, risposi. Chiusi la porta e mi rimisi a sedere.
Quella sera scoprii che, prima di andarsene davvero, doveva dire adesso vado almeno cinque o sei volte, e poteva passare un’ora nel frattempo, un’altra storia, un’altra bottiglia di vino. E naturalmente imparai a fare altrettanto. Quando ero su da lui, a un certo punto della serata mi stiracchiavo la schiena, davo un’occhiata al buio fuori e dichiaravo: adesso vado.
Prendi un altro pezzo di formaggio, rispondeva Gabriele, ignorando le mie parole. Strizziamo un altro bottiglione?
Perché no, dicevo io (lassù anche il bere e il mangiare regrediscono allo stato selvatico: si trita una costina di maiale, si strizza una bottiglia di vino). E rimandavo la partenza di qualche altro bicchiere.
Il 29 giugno, San Pietro, patrono degli alpeggi, dopo cena salimmo insieme fino alla stalla. Gabriele aveva passato il pomeriggio a riempire il rimorchio di rami secchi, che ora stavano ammucchiati vicino a un grande masso. Ce n’era una catasta alta più di un metro. Verso
63
le dieci accese il falò nello stile dei montanari: ci versò sopra mezza tanica di benzina, strofinò un fiammifero e il fuoco divampò in un istante. Con quel gran silenzio intorno mi accorsi, per la prima volta, di come un incendio possa diventare assordante, il suo calore intollerabile anche a molti metri di distanza. Ci sedemmo nell’erba a osservare i profili scuri delle montagne, cercando altri fuochi come il nostro. Ne contammo tre, quattro, cinque, alcuni in posti di cui nemmeno sapevamo il nome. Quelle fiammelle gialle e tremolanti sembravano dire: io sono qui. E anch’io, anch’io, anch’io. Una costellazione di solitudini che brillò appena per qualche minuto: poi si fecero più flebili e si estinsero, una dopo l’altra. Anche il nostro fuoco ammutolì. Ricominciai a sentire il vento nell’erba, il gorgoglio del torrente, i sospiri delle mucche che ruminavano nella stalla.
Mi accorsi anche che faceva freddo, ora che mi ero abituato al calore del falò. Nel salutarmi Gabriele mi prestò un maglione e disse: passa pure dai prati. Era un grande onore quello che mi concedeva. Con il sentiero avrei dovuto fare un lungo giro, per i prati invece arrivavo giù dritto fino a Fontane: scesi al buio, allargando le braccia nel vento e sentendo le spighe solleticarmi i palmi delle mani. Lanciandosi il loro richiamo rauco i caprioli si inseguivano nel bosco.
64
Venne il mese di luglio. Quando l’erba raggiunse l’altezza dei fianchi e cominciò a ingiallire, ovunque nei prati spuntarono le falciatrici, i trattori, i rimorchi, le imballatrici. Ai fieni lavoravano tutti, dai vecchi ai ragazzini degli alpeggi: una mobilitazione collettiva davanti a cui era impossibile starsene con le mani in mano, così mi misi ad aiutare Remigio e sua madre. Non che mi mancasse tanto la famiglia che avevo lasciato in pianura. Lei quasi ottantenne, magrissima, infaticabile, ruvida come corteccia, io cittadino dalla buona volontà e la pelle delicata, formavamo una strana coppia dietro al trattore che suo figlio guidava. Imballavamo nel tardo pomeriggio, quando il sole aveva seccato il fieno falciato il giorno prima. Ormai valeva meno del lavoro che costava, ma vedevo dai gesti di quella donna quanto fosse stato prezioso: passava il rastrello dopo l’imballatrice e non lasciava nemmeno un filo d’erba, sgridandomi per quelli che io invece mi perdevo. Remigio dal volante sogghignava. Non gli dispiaceva che qualcun altro subisse il trattamento al posto suo. Sua madre all’inizio mi mostrò dove sbagliavo,
65
Fieni
poi concluse che non sapevo rastrellare e mi assegnò ai lavori pesanti, a caricare le balle sul rimorchio. Quel lavoro mi veniva meglio: ne prendevo due alla volta per gli spaghi che mi segavano le mani e le buttavo a bordo, poi salivo di corsa a impilarle per bene. Mi guadagnai un po’ di rispetto così, sudando e coprendomi di polvere, procurandomi i calli del manovale e il collo bruciato del contadino, la pelle irritata per il fieno che mi pungeva.
Tra un carico e l’altro alzavo la testa e guardavo i campi intorno a noi. Il bruno rossastro di quelli non ancora falciati, il biondo dove il fieno seccava al sole, il verde tenue che prendeva il suo posto alla fine. Era bello vedere la montagna curata come un giardino: con i crochi che spuntavano nell’erba nuova credendo che fosse tornata primavera. Solo che i crochi del disgelo erano bianchi come le nuvole di aprile, questi altri lilla e viola sotto il cielo di luglio, e ora non c’erano più le larve ma tutto un ronzio d’insetti nel gran caldo estivo. Ogni tanto la madre di Remigio andava a prendere qualcosa al bar per rinfrescarci: un’aranciata o una gazzosa per noi, un gelato per sé.
Non si può avere una birra?, protestava Remigio. Seduto su una balla di fieno, nel frinire delle cavallette, guardava la lattina come se non sapesse nemmeno da che parte aprirla.
Non vorrete mica ubriacarvi, rispondeva sua madre, dura. In quel voi finivo dentro anch’io, o forse chissà, gli uomini in generale.
66
C’era un colle davanti ai campi in cui lavoravamo, un valico ampio e basso per cui si andava a piedi nella valle accanto, che osservavo ogni tanto pensando a una persona. Doveva abitare ancora di là, e ancora faceva la guida alpina perché nessun altro mestiere riuscivo a immaginare per lui. Si chiamava Lorenzo, Renzo, dal santo di agosto e di molti villaggi, il mio maestro di montagna: il primo che mi aveva legato alla sua corda, mostrato dove mettere le mani sulla roccia, agganciato un paio di ramponi ai piedi perché lo seguissi sul ghiacciaio. Ma, da bambino, più che una scuola di attrezzi e tecniche l’alpinismo era stato per me un confronto con la paura, con la fatica e il freddo, con la distanza da casa. Con la sofferenza del corpo, anche, perché appena oltre i tremila metri cominciavo a stare male: la nausea mi rivoltava lo stomaco, gli occhi mi si appannavano e mi invadeva una grande nostalgia, come un senso di abbandono che era il mio vero mal di montagna. Renzo divideva con me quei momenti. Mentre piangevo e vomitavo, lui era la persona che mi parlava con dolcezza e mi convinceva ad andare avanti. Lo faceva talmente bene che l’avrei seguito ovunque. Poi il nostro rapporto aveva vissuto un’età gioiosa. A sedici anni il mal di montagna mi era passato e avevo cominciato a godermi le nostre avventure: ogni estate Renzo portava un gruppo di ragazzi in un rifugio d’alta quota, a fare scuola d’alpinismo per una settimana.
67 * * *
Arrampicavamo con piccozza e ramponi sui seracchi del Monte Rosa, ci calavamo nel profondo dei crepacci per simulare operazioni di soccorso, correvamo giù per il ghiacciaio trascinando un ferito immaginario su una slitta; e intanto ci passavano accanto quei seri collezionisti di cime. A noi le cime non interessavano. Erano più divertenti le pareti e le creste, e salirle come per gioco. Io adesso ero forte, sul ghiacciaio mi sentivo a casa, fantasticavo di diventare guida alpina anch’io. Tornati dal rifugio imitavo il mio maestro: provavo a parlare come lui (poco), camminare come lui (con leggerezza, quasi senza peso), avere il suo stesso atteggiamento di fronte al pericolo, tipo un temporale in parete (fischiettare). Avevo imparato così bene che una volta, quando si allenava per l’Himalaya, Renzo era venuto a chiamarmi per fare insieme una corsa fino ai quattromila metri e ritorno, in poche ore, noi due soltanto. Solo una corda, l’affiatamento dei passi, più nessun bisogno di chiedere o di dare istruzioni. Il Quattromila era facile, dopotutto. Eravamo entrati quasi subito nelle nuvole e non avevamo più visto nulla fino a sera, solo il bianco indistinto del ghiaccio e della nebbia, eppure era il ricordo più bello che conservavo di lui, la nostra privata Himalaya. Quella volta doveva esser stata l’ultima in cui eravamo andati in montagna insieme, poi credo di essere stato chiamato da altri luoghi, a farmi guidare da altri maestri. Nessuno come Renzo aveva più avuto la mia fiducia incondizionata. Erano passati quindici anni: chissà se si chiedeva dov’ero finito, e chissà cosa avreb-
68
be pensato a sapermi di là, oltre il colle, a fare l’eremita in una baita. In fondo se ero finito lassù uno dei colpevoli era lui.
Ora questi pensieri li dividevo con Remigio, con cui mi veniva facile parlare. Tra noi la confidenza si era stabilita fin dal primo incontro, il giorno dei libri e della neve, ed era cresciuta impolverandoci nel fieno. Andavamo avanti e indietro dai campi, lui alla guida del trattore e io seduto sul rimorchio traballante. Nel fienile ci lanciavamo le balle e le impilavamo in cumuli alti tre o quattro metri. Una sera dopo il lavoro mi invitò da lui per un bicchiere, di quelli che sua madre ci vietava, e in soggiorno fui sorpreso di trovare una macchina da scrivere. Era un vecchio modello ben conservato. Nel rullo c’era un foglio, e sul foglio un’unica riga: Chissà se riuscirò mai a scrivere come prima. La frase mi spiazzò: che cosa c’entrava quel montanaro con la scrittura? Poi mi turbò in modo più profondo perché di quel dubbio sapevo qualcosa anch’io, non scrivevo da mesi e temevo che non avrei scritto più. Quando gliene domandai il significato, Remigio mi spiegò che il foglio stava lì da vent’anni: era l’epoca della morte di suo padre, la macchina non l’aveva più toccata da allora. Mi misi in ascolto con il rispetto che si prova entrando nelle vite degli altri, lo stesso senso di soggezione. Il padre di Remigio era stato un cacciatore, un costruttore di case e un narratore di storie. Da bambino lo portava nei boschi a piazzare trappole per gli
69
animali da pelliccia, e sulla neve gli insegnava a riconoscere le tracce della volpe, della martora, dell’ermellino. Anni dopo l’aveva educato all’arte di tirare su i muri prendendolo come manovale nei cantieri. Erano stati molto legati - Remigio era figlio unico, e nel paese altri ragazzi non ce n’erano - finché il loro rapporto non era stato rovinato dall’alcol: quell’uomo affettuoso ed estroverso a un certo punto si era messo a bere forte, tanto da ammalarsi gravemente. Cambiò carattere, o forse era il figlio che, cresciuto, si era fatto chiuso e scontroso, e con quel padre sempre ubriaco litigava e basta. L’aveva visto consumarsi un po’ alla volta, accompagnato dentro e fuori dagli ospedali, e infine gli era toccato trovarlo nel campo in cui era andato a morire. Non si perdonava che le loro ultime parole fossero state di rabbia.
Ora di lui gli restavano i trofei di caccia, tetri custodi della stanza in cui parlavamo: le zampe di un camoscio usate per appendere le giacche, due corna di stambecco su una tavola di legno, esemplari imbalsamati di martora e d’ermellino. Le penne dell’aquila a cui suo padre aveva sparato per sfida, e che, moribonda, gli si era avvinghiata al braccio, finché Remigio non era corso a levargliela di dosso, usando tutte le sue forze per scardinarne gli artigli. Da allora di caccia gli era venuto il disgusto. La passione, come la chiamano i cacciatori, non gli era stata trasmessa insieme ai fucili.
Ma c’era un’altra eredità che conservava. Poco tempo prima di morire il padre gli aveva lasciato il rudere
70
di una baita in mezzo a un pascolo. Una piccola stalla di sotto, una stanza di sopra, il tetto in scandole di larice imbarcate e sbilenche, i muri anneriti di fumo e incrostati di letame. Non aveva aggiunto parole a quella donazione misteriosa. Poi era morto. Anni dopo Remigio aveva trovato da sé il significato, e per alleviare i suoi sensi di colpa aveva speso due lunghe estati a ristrutturare il rudere. Aveva deciso di lavorare da solo, senza operai né macchinari, scavando la terra a forza di piccone, issando i travi del tetto con uno scivolo di tavole, una fune e il trattore. Erano alberi che lui stesso aveva abbattuto nel bosco, scegliendoli con cura come tutto il resto: ogni legno, ogni chiodo, ogni pietra della casa, perché il lavoro fosse fatto a regola d’arte, come un padre muratore aveva insegnato.
Poi l’aveva finita, ci aveva passato un’unica notte, aveva capito che non ci avrebbe mai abitato. Troppe presenze tra quei quattro muri per dormire tranquilli. Così l’aveva messa in affitto. Meglio lasciare la casa stregata a qualcuno che non ne sapeva nulla. Dieci anni dopo ero arrivato io, in cerca di un posto per stare da solo, ed ecco la storia in cui mi ero cacciato sperando di ritrovare la scrittura.
71
In estate i selvatici erano spariti. Colpa di tutta la gente che cominciava a battere i sentieri, spingendoli in zone sempre più impervie. Di questi gruppi ne incontravo ogni giorno intorno a casa, e mi parevano sordi e ciechi al paesaggio che attraversavano, facevano tanto di quel rumore che li sentivo ancora prima di vederli. Perfino i loro profumi chimici mi colpivano a distanza. Sarò io, mi chiedevo, ad avere problemi col resto dell’umanità? O saranno loro a non saper passare sulla terra senza invaderla? Facevano irruzione nel bosco con violenza di odori, colori, suoni. E gli abitanti del bosco si proteggevano dileguandosi. Mi mancavano i miei vicini: la lepre, la volpe, i caprioli. Così una mattina mi alzai alle sei, buttai giù una tazza di caffè e uscii per un lungo giro. Niente zaino né borraccia né scarponi, solo il mio bastone e scarpe leggere come il vento. Dopo tre mesi lassù mi sentivo in gran forma: superai il bosco e i primi pascoli, la baita di Gabriele, le radure delle marmotte, i villaggi abbandonati e cadenti. Mi fermai al torrente per bere, poi superai in velocità anche i pascoli alti: alle sette avevo
72
Capre
davanti solo pietraie, i laghetti del disgelo e le ultime nevi. Respiravo l’aria intatta del mattino, appena prima che il sole spuntasse dalle creste e il giorno cominciasse davvero. Nessun altro sembrava avermi preceduto.
Sulla pietraia rallentai, badando a non smuovere sassi per non fare rumore. Arrivando sul crinale ebbi un colpo di fortuna: sarò stato controvento, oppure ormai puzzavo di capra anch’io, comunque giù nel vallone vidi due camosci su un piccolo nevaio. Li sorpresi nel bel mezzo di un loro gioco segreto. Tutt’intorno la pietraia si intiepidiva, la neve era ridotta a minuscole chiazze ghiacciate e luccicanti, e i camosci si rotolavano sulla pancia, la schiena e i fianchi, godendosi quel ricordo d’inverno. Scivolavano giù per un pezzo, poi si rimettevano in piedi e tornavano in cima al nevaio. Finché uno dei due sentì il pericolo, drizzò le orecchie, io mi nascosi tra le rocce e cercai di restare immobile, ma ormai qualcosa li aveva allarmati. Il più prudente partì per primo, l’altro esitò a seguirlo come rimpiangendo quel gioco interrotto; poi con pochi balzi eleganti sparirono nella pietraia.
Continuai a salire, ormai chi mi fermava più? Adesso ero in cresta tra le due valli della mia vita e camminavo su lastre di pietra rotte dal ghiaccio, e su quel muschio morbidissimo che si forma a tremila metri. Da un lato dello spartiacque, quello dell’età adulta, il cielo era limpido, di un azzurro così pieno che sembrava avere massa e volume. Dal lato dell’infanzia salivano sbuffi di nuvole che si arricciavano dissolvendosi
73
ai miei piedi. Di là avevo passato vent’anni, di qua gli ultimi mesi: due valli scavate da due fiumi, e due fiumi nati dalla stessa montagna. Era quella montagna, il Monte Rosa che adesso avevo davanti agli occhi, a unire il mio presente e il mio passato. Poi vidi alcune sagome scure, forme in movimento sulla roccia frastagliata. Era un piccolo branco di stambecchi maschi. Loro non sono prudenti come i camosci, non vengono cacciati da un secolo e hanno smesso di temere l’uomo. Stanno lassù, sulle creste e le vette, perché amano sorvegliare il loro regno dall’alto, nel vento e nella luce abbagliante. Il branco era composto da un adulto maestoso, adagiato in una cengia nella posa solenne del capo, quattro giovani stambecchi irrequieti che si provocavano tra loro, e un caprone così vecchio e stanco da muoversi a malapena. Aveva il manto spelacchiato e due corna di cui non reggeva più il peso, che lo costringevano ad arrancare a testa china. Appena fui avvistato, il capo stambecco si alzò e venne a mettersi tra me e il resto del branco. Mi fissava facendo un verso di battaglia, come una F prolungata e soffiata a pieni polmoni. Aveva corna lunghe un metro e muscoli poderosi a sostenerle, e gli sarebbe bastato poco per cacciarmi da casa sua, se non da questo mondo. Ma cercavo di fargli sapere che ero venuto in pace. I giovani saltarono su un sasso mettendosi al sicuro dietro di lui, mentre il vecchio per raggiungerli dovette fare un lungo giro. Io mi sedetti per terra e restai fermo per un minuto, finché il capo stambecco decise che
74
ero un nemico noioso, sbuffò un’ultima volta e si mise a rosicchiare il muschio tra le rocce. Due dei giovani cominciarono a prendersi a cornate, allenandosi per la stagione degli amori: si alzavano sulle zampe posteriori e si lasciavano cadere sul rivale, usando tutto il loro peso per dare forza al colpo e producendo con le corna uno schianto secco, come di pietre picchiate tra loro. Il vecchio ormai era l’unico che badava a me: mi si era accovacciato di fronte, a tre o quattro metri di distanza, e mi scrutava ruminando, e grattandosi ogni tanto la schiena con le corna. Di nodi ne contai una quindicina: quindici anni passati in giro per le montagne, senza nemici e senza mai scendere a valle. Che bella vita, pensai. Chissà se quella era la sua ultima estate o avrebbe superato gli acciacchi ancora per un altro inverno. Chissà che genere di domande si faceva lui su di me.
Poi guardai in giù nell’aria tersa delle otto di mattina. Riuscivo a vedere distintamente le strade del fondovalle, dove il sole non sarebbe arrivato ancora per qualche ora. Quel mondo all’ombra aveva l’aspetto di un pianeta alieno: con le auto che andavano e venivano tra i paesi cresciuti a dismisura, i quartieri di condomini e villette che si estendevano come periferie urbane. E poi le cave di sabbia e ghiaia sui fiumi, le piste da sci che tagliavano i boschi, i parcheggi alla base degli impianti, cantieri edili ovunque. Una specie operosa e infestante, tutta dedita a erodere, spianare, colonizzare: questo sembrava l’umanità dalle creste delle montagne,
75
dove per vivere ti bastava brucare un po’ d’erba e sdraiarti al sole. Osservai la casa in cui ero stato bambino, anzi il complesso di appartamenti che sorgeva al suo posto. Quella della mia infanzia non esisteva più da anni e mi sembrò una fortuna. Una gru stava piantata accanto a un silo del cemento in cortile, così mi chiesi che ne fosse del grande ciliegio selvatico che una volta era lì. Incrociai di nuovo lo sguardo del vecchio stambecco e adesso sentii chiaramente i suoi pensieri. Scusa, mi venne da rispondergli.
Scesi senza correre, quella mattina, insofferente verso il luogo a cui stavo tornando. La baita, le mie collezioni di reperti, i quaderni inutilizzati, i libri. Una stanzetta così piena di me, mentre fuori la montagna si offriva, inesplorata, in ogni direzione. A cosa mi serviva una casa? Mi sarebbe piaciuto fare come i pastori di un tempo, che vagabondavano da un pascolo all’altro e si fermavano a dormire nei ripari offerti dalle rocce. Ne incontravo ogni tanto durante le mie esplorazioni: massi sporgenti alla cui base il terreno era stato pulito, e a volte chiuso da muretti a secco. C’era un nome per loro, in dialetto, che avevo sentito pronunciare a Remigio mentre facevamo i fieni. Che cos’è una barma?, gli avevo chiesto. Una roccia per ripararsi quando piove, mi aveva risposto.
Giù alla baita era mezzogiorno, e una famigliola aveva steso una coperta sul prato davanti a casa. Due bambini giocavano a bagnarsi alla fontana, la madre
76
aveva tirato fuori buste e contenitori, il padre mi scrutò con quello sguardo torvo che si scambiano gli uomini quando c’è un territorio o una famiglia da difendere.
Può darsi che l’abbia guardato così anch’io.
Mi scusi, è proprietà privata?, mi chiese sua moglie, più gentile.
No no, dissi, è di tutti, state pure.
In casa tirai giù lo zaino dal chiodo a cui era appeso. Ci buttai dentro un po’ di vestiti, un telo impermeabile, il sacco a pelo, una borraccia di vino e le scatolette che avevo in cucina, l’accendino, il coltello, carta di giornale, una pila, due libri, la penna e il quaderno. Volevo spingermi più in là della zona che conoscevo, scoprire che cosa c’era a due o tre giorni di cammino. Partivo bello carico, eppure chiudendomi la porta alle spalle mi sembrò di liberarmi di un peso. Come sempre, il peso poteva essere la baita o la gente che ai miei occhi l’aveva profanata, ma era molto più probabile che fossi io. Da che altro scappiamo quando scappiamo da casa?
Addio, disse il ragazzo selvatico al domestico, poi gli girò le spalle e prese di nuovo il sentiero che saliva.
77
Giù per il pendio inghiottito dalla frana gli scarponi affondavano nella terra molle: una pasta grigiastra, vischiosa come malta fresca, che rendeva ogni passo una pena. Montai su un tronco sradicato e lo percorsi in equilibrio per superare quel caos di pietre smosse, rivoli d’acqua fangosa ed enormi zolle scaraventate intorno come da un’esplosione, appoggiate in bilico su un masso o incastrate in una crepa del terreno, e anche in quelle posizioni innaturali si ostinavano a fiorire. In alto un’ampia fascia scura segnava il punto in cui si era spaccata la montagna. Roccia umida e marcia, con le radici dei larici che sporgevano a metà parete e non riuscivano a tenerla insieme. Dei selvatici nessuna traccia: né un fischio d’allarme, né un rintanarsi improvviso al mio passaggio. Era come se fossero migrati in massa da quel disastro. Perfino gli uccelli tacevano, lasciando nell’aria soltanto il gorgoglio di una corrente sotterranea. Mi sentii sollevato quando alla fine superai gli ultimi detriti, ritrovai una traccia di sentiero che piegava a sinistra, mi lasciai la frana alle spalle e ricominciai a salire.
78
Bivacco
Avevo idea di passare la notte in riva a un lago, scaldandomi al fuoco e osservando le stelle d’agosto, ma non ci fu niente da fare: quella era l’estate della pioggia, e quando ormai ero arrivato sentii avvicinarsi il temporale. Saranno state le sette di sera. Un fronte di nuvole gonfie e scure tuonava qualche chilometro a valle, sul paese che avevo lasciato poche ore prima. Due pescatori si affannavano a montare una tendina canadese nel vento. Arrivava a folate rabbiose, increspando la superficie del lago e spingendo le nuvole verso di noi, così puntai un gruppo di ruderi nella speranza di trovare riparo. C’era una baita meno malmessa delle altre: i muri reggevano benché sbilenchi, sul tetto era stata posata una lamiera. Se qualcuno la usa ancora, pensai, avrà un lucchetto da qualche parte, o sarà chiusa a chiave. Ma non vidi nessuna serratura. La porta era tutta storta e incastrata a forza. Provai a spingerla con le mani, sentii che cedeva, poi le diedi una bella spallata spalancandola.
Gli occhi ci misero un po’ ad abituarsi al buio. Fuori la pioggia cominciava a picchiettare la lamiera. Dentro non c’erano finestre, ma una fessura tra le pareti e il tetto lasciava passare un po’ di luce. Il focolare stava al centro della stanza: quattro pietre piatte a delimitare il braciere, in un angolo il perno girevole per appendere il paiolo. Poi una mensola di legno con una lampada a olio, qualche bottiglia vuota, dei mozziconi di candela,
79 * * *
una pistola giocattolo. Che cosa ci faceva lì dentro una pistola giocattolo? Era l’imitazione di un revolver, tutta rotta e tenuta insieme dal nastro adesivo. Osservandola mi ricordai dei pastori bambini che da piccolo vedevo in montagna, sporchi, schivi, atteggiati ad adulti mentre sorvegliavano le loro mucche, e io cercavo di immaginarmi la vita che facevano quando non li vedeva nessuno. Trovai anche un pezzo di specchio e una ciotola sporca, due tazze di metallo, un materasso lurido e sventrato. Saranno stati i topi a dilaniarlo, pensai, perché il pavimento era cosparso di batuffoli di lana marcia, cocci di bottiglie rotte, paglia e chissà cos’altro. Per fortuna non c’era abbastanza luce da scoprirlo. Il temporale ora faceva un frastuono assordante: sgomberai alla meglio un tratto di pavimento per stendere il sacco a pelo, poi mi sedetti e aprii lo zaino. Un pezzo di pane nero, una scatoletta di carne, due pomodori e un po’ di vino sarebbero stati il menu della serata. Sotto tutta quell’acqua la cena era anche l’unico passatempo e così provai a prolungarla il più possibile, masticando a lungo il pane e bevendo il vino a piccoli sorsi. Invece poi il temporale si calmò. Trovai della legna secca in un angolo della stanza e accesi un fuoco, fuori, a qualche metro dalla baita, perché temevo di affumicarmi usando il focolare. Quando ricominciò a piovere era già un bel falò vivace. Seduto sulla soglia riuscivo a stare all’asciutto e avere un po’ di luce per leggere, così passai la serata in compagnia di un libro di Primo Levi, Il sistema periodico, che è un’autobiografia in forma di
80
racconti. Sopra di me incombeva il profilo del monte che avrei dovuto superare l’indomani: ogni tanto alzavo gli occhi per studiarmelo, fino a quando non fu troppo buio per fare qualunque cosa. Allora entrai e accesi quei mozziconi di candela, e andai avanti a leggere nel sacco a pelo. In Ferro, il quarto racconto del libro, Levi ricorda la sua amicizia con Sandro Delmastro, conosciuto nel 1938 alla facoltà di Chimica di Torino. Fu un incontro tra due emarginati: Primo lo era appena diventato per via delle leggi razziali (un figlio della borghesia torinese sconvolto e impaurito dalla diffidenza con cui i suoi compagni d’improvviso lo guardavano), Sandro lo era da sempre per le scarpe, i vestiti, le mani, il passo, la lingua e i modi che si portava giù dalla montagna d’Ivrea, da dove l’avevano mandato a studiare in città. Un ragazzo ebreo e un montanaro che si riconobbero e cominciarono ad aiutarsi. Primo aiutava Sandro con la chimica scritta dei libri, convinto che lì stesse la chiave per accedere al mistero della materia, e Sandro portava Primo a toccare la materia con le mani, e conoscere il suo mistero attraverso le rocce, i torrenti, il vento, la neve. In montagna, in quegli anni sempre più cupi che precedevano “la notte dell’Europa”, avevano stretto la loro amicizia e goduto degli ultimi momenti di libertà. “Mi trascinava in estenuanti cavalcate nella neve fresca, lontano da ogni traccia umana, seguendo itinerari che sembrava intuire come un selvaggio. D’estate, di rifugio in rifugio, a ubriacarci di sole, di fatica e di vento,
81
e a limarci la pelle dei polpastrelli su roccia mai prima toccata da mano d’uomo: ma non sulle cime famose, né alla ricerca dell’impresa memorabile; di questo non gli importava proprio niente. Gli importava conoscere i suoi limiti, misurarsi e migliorarsi; più oscuramente, sentiva il bisogno di prepararsi (e di prepararmi) per un avvenire di ferro, di mese in mese più vicino. Vedere Sandro in montagna riconciliava col mondo, e faceva dimenticare l’incubo che gravava sull’Europa. Era il suo luogo, quello per cui era fatto, come le marmotte di cui imitava il fischio e il grifo: in montagna diventava felice, di una felicità silenziosa e contagiosa, come una luce che si accenda. Suscitava in me una comunione nuova con la terra e il cielo, in cui confluivano il mio bisogno di libertà, la pienezza delle forze, e la fame di capire le cose che mi avevano spinto alla chimica.”
Durante la notte la pioggia cessò e riprese più volte. Anch’io mi addormentavo e risvegliavo di continuo. Per brevi momenti, in quell’accavallarsi confuso di stati della coscienza, sognai presenze muoversi intorno a me nella baita. Forse il fantasma di un pastorello solitario, o di due ragazzi che mi avevano preceduto di una settantina d’anni. Primo e Sandro potevano essere passati proprio di lì, in una delle loro scorribande: vagavo per le stesse montagne che avevano battuto loro. Un giorno avevano scelto la via sbagliata, si erano persi, Primo aveva proposto di tornare indietro ma Sandro era ir-
82
removibile, voleva proseguire. “Il peggio che ci possa capitare”, aveva commentato misterioso, “è di assaggiare la carne dell’orso”. Era venuta notte e i due amici si erano rassegnati a passarla all’aperto, stretti uno all’altro, battendo i denti, fissando la luna e un cielo “di nuvole stracciate”. Alle prime luci erano scesi verso il rifugio barcollando per il freddo e il sonno.
Anch’io mi alzai quando il cielo cominciò a impallidire. Saranno state le cinque di mattina. Non ne potevo più di stare lì a rigirarmi sul pavimento, evitando i cocci di vetro e l’acqua che veniva giù dal tetto e pensando a come il tempo riusciva a restringersi e dilatarsi, un anno intero poteva volare via in un baleno e una sola notte non finire mai. Avvolsi il sacco a pelo e rifeci lo zaino, mi allacciai gli scarponi e lasciai lì il giornale con cui avevo acceso il fuoco, pensando che qualcun altro poteva prima o poi averne bisogno. Infine salutai la baita che mi aveva offerto riparo, mi chiusi la porta alle spalle e respirai a pieni polmoni.
Fuori l’aria era umida e fredda. Mi sentivo tutto rotto e ancora più stanco della sera prima, ma sapevo che quella sensazione sarebbe svanita camminando. Cercai di non pensare alla parola caffè. Mi fermai in riva a un torrentello e mi lavai i denti, la faccia, il collo, finché fui del tutto sveglio. La mattina stava sorgendo limpida, con il lago ancora in ombra duecento metri sotto di me e la cima del monte mille metri più in alto, già illuminata dal sole. Chiazze di neve grigiastra langui-
83
vano sulla roccia nera, ma oltre a quella c’era un bianco nuovo, brillante e quasi d’argento, che striava le pareti, ne incideva bordi e pieghe come il segno di un gessetto. Pensai che in alto potesse aver nevicato, però non avevo mai visto la neve disegnare linee così nette. Avrei scoperto più tardi che si trattava di ghiaccio: la grandine che nella notte si era accumulata nelle fessure e sulle cenge, e alla luce del sole tracciava venature scintillanti. Mi aspettavano almeno due ore di pietraia sconnessa prima di arrivare lassù, a sgranare, meravigliato, il ghiaccio tra le dita. Così chinai la testa come un mulo, infilai i pollici nelle bretelle dello zaino e chiesi alle mie gambe fedeli di rimettersi al lavoro.
“E al locandiere, che ci chiedeva ridacchiando come ce l’eravamo passata, e intanto sogguardava i nostri visi stralunati, rispondemmo sfrontatamente che avevamo fatto un’ottima gita, pagammo il conto e ce ne andammo con dignità. Era questa, la carne dell’orso: ed ora, che sono passati molti anni, rimpiango di averne mangiata poca, poiché, di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha avuto, neppure alla lontana, il sapore di quella carne, che è il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare, e padroni del proprio destino.”
84
Rifugio
Per quanto mi svegliassi presto, in rifugio, c’era sempre qualcuno che si svegliava prima di me. La mia finestra era affacciata a est, su una catena di montagne nere da cui l’alba arrivava alle sei di mattina, illuminando il muro di fronte al letto e tingendo la stanza d’arancione e d’oro. Aprivo gli occhi in quella luce improvvisa, il sacco a pelo ridotto a un groviglio di sogni agitati. Era l’odore del fuoco a ricordarmi dov’ero. Legno di faggio, un profumo diverso da quello del larice che usavo a casa mia. La stufa andava avanti a bruciarlo per tutto il giorno, eppure riusciva a malapena a scaldare la cucina. In quell’agosto piovoso ci riunivamo sempre lì: sulla stufa facevamo il caffè, cucinavamo, stendevamo i panni ad asciugare, tostavamo i pistacchi che un giorno abbiamo trovato, umidi e vecchi di chissà quanto, in fondo a un armadio in dispensa. Era un rifugio antico, costruito nell’Ottocento per dare riparo agli emigranti che tornavano a casa d’inverno. Stava a 2.500 metri, sul passo di confine tra due valli - una precipitava a ovest, da dov’ero arrivato, l’altra si allungava più dolce verso est, e verso le cime e i
85
paesi sconosciuti che vedevo dalla mia stanza - lungo un antico sentiero per merci e uomini ormai in disuso. Estinta la civiltà del mulo il colle era fuori da tutte le rotte, circondato da montagne poco nobili per gli alpinisti e troppo impervie per i semplici camminatori. Perfette per me, invece, perché quel mondo era quanto di più selvaggio potessi desiderare: fatto di rocce rotte, creste, nevai, e senza nessuno intorno.
Mi ero fermato una notte a dormire, poi la mattina avevo avuto un’idea delle mie. Con tutta la faccia tosta di cui disponevo avevo chiesto ai due custodi se potevo fermarmi lì in cambio di lavoro, dato che ero stanco di girare, il posto mi piaceva ma non avevo soldi per pagarmi molti giorni di pensione. Loro mi avevano guardato strano. Ero l’unico ospite di quella notte e in effetti il rifugio non aveva l’aria di un’azienda fiorente.
Ma si erano consultati, forse avevano capito qualcosa di quello che non dicevo. Avevamo tutti trent’anni o giù di lì. Alla fine mi avevano risposto che di lavoro non ce n’era, però potevo fermarmi lo stesso con loro per tutto il tempo che volevo, senza pagare, se mi andava di condividere quella vita. Io non chiedevo di meglio.
Sullo spiazzo davanti al rifugio sventolava una bandiera italiana. Benché venisse sostituita ogni anno all’inizio di giugno, un po’ alla volta durante l’estate il vento la consumava, così la lunghezza di quella bandiera fu la clessidra del mio tempo lassù. Quando arrivai il rosso era quasi finito, se ne scorgeva appena una traccia sfilacciata contro il cielo. Quando me ne andai non
86
restava che metà del bianco, un moncone di patria che rappresentava bene lo spirito del colle, il nostro vivere su un confine.
Dei due custodi Andrea era quello mattiniero, con cui avrei legato di più. Quando scendevo lui aveva già acceso la stufa, messo su la colazione, lavato i piatti della sera prima, e ora stava fumando e guardando vecchi film sul portatile, o profili di ragazze in giro per la rete. Sedeva sempre dalla stessa parte del tavolo, accanto alla finestra umida di condensa. Verso le undici passava dal caffè al vino allungato con acqua, oppure acqua e Pernod oppure bianco e Campari, arrotolando sigarette di Golden Virginia, offrendo da bere anche a me e mostrandomi le turiste inglesi a cui d’inverno aveva insegnato a sciare. Adesso erano in spiaggia, pubblicavano foto in costume. Sembravano sirene in mari lontanissimi. Sopra le nostre teste pioveva ogni giorno e certe volte la pioggia diventava una poltiglia che era quasi neve, e quando non pioveva o nevicava tirava un vento gelido che mi respingeva appena mettevo il naso fuori dalla porta. L’unica ragazza in carne e ossa era un’atleta che si allenava nella corsa in montagna: la avvistavamo con il binocolo mentre saliva per il sentiero, ne commentavamo le forme, speravamo che almeno una volta si fermasse per un caffè. Invece lei raggiungeva il colle, toccava il muro del rifugio, girava i tacchi e tornava giù, fugace come ogni apparizione di bellezza. Le forme del ritorno erano altrettanto incantevoli, ma molto più malinconiche di quelle dell’andata.
87
Davide dormiva fino a tardi, scendeva per ultimo in cucina ma da quel momento era in moto perpetuo. Ogni due giorni impastava il pane che poi cuoceva nel forno della stufa. Teneva i conti, rispondeva al telefono ed era lui ad accogliere gli ospiti, dato che Andrea preferiva starsene in cucina, e parlare il meno possibile. Davide aveva sempre più idee di quelle che poi realizzava. Investimenti, feste, progetti per migliorare l’efficienza del rifugio. Se si ritrovava con le mani in mano afferrava una sgorbia dal davanzale e si metteva a intagliare il manico di un coltello. Diceva di non riuscire a disegnare forme simmetriche. Era convinto che ci fosse qualcosa, in lui, che faceva a pugni con la simmetria, forse per via dello zigomo che si era spaccato anni prima e che gli aveva segnato i lineamenti. Lì seduto nei giorni di pioggia parlava a ruota libera. Era come avere la radio accesa.
Io mi ero impossessato della cucina. Setacciando la dispensa avevo recuperato del riso, legumi secchi, farina, passata di pomodoro, scatolette di tonno, acciughe e olive. C’erano sacchi di cipolle e patate che dovevano durare fino a settembre. Il burro, le uova e il formaggio ce li procuravamo da un alpeggio poco più in basso, ed era tutto quello che avevo per inventarmi i pasti quotidiani.
A parte la povertà della dieta e la cronica mancanza di ragazze, il nostro problema principale era l’energia elettrica. Non c’era abbastanza sole per alimentare i
88
pannelli, la pala eolica era ancora un sogno nella testa di Davide e il gasolio andava centellinato. Così se arrivavano ospiti accendevamo il generatore, altrimenti il pomeriggio era un lento abituarsi al buio. Seduto a capotavola leggevo le poesie di Antonia Pozzi e un libro che avevo trovato in rifugio, la storia dell’ex soldato di Napoleone che per quarant’anni era stato lassù estate e inverno, con il compito di battere la traccia dopo ogni nevicata, suonare la campana nella nebbia, tenere la stufa accesa per chi arrivava. Un secolo e mezzo dopo non facevamo una vita poi tanto diversa. Verso le sei, solo spostandomi vicino alla finestra riuscivo a catturare sulle pagine un po’ di quel chiarore lattiginoso, appena sufficiente a distinguere le parole. Più tardi accendevamo una candela, e quando finiva anche quella era ora di andare a dormire.
Ero sorpreso che i ragazzi mi avessero accolto con tanta naturalezza, ma mi sembrava di averne capito anche il motivo. Eravamo stati spinti lassù dagli stessi bisogni, avevamo impiegato poco a riconoscerci. A letto mettevo due coperte sopra il sacco a pelo. Ci entravo nel buio più completo. Dormivo dentro vestiti che sapevano di zuppa di cipolla, stufato lasciato sul fuoco per ore, lana umida e fumo di legna - l’odore che avrei conservato a lungo come un profumo di casa.
Era facile perdere il conto dei giorni che passavano. Fuori dalle finestre regnava un bianco uniforme, sempre uguale fino a sera. Soltanto all’alba capitava di
89
vedere il mare di nuvole dall’alto, proprio come se il nostro mondo fosse separato da quello di sotto, uno lucente e limpido e l’altro piovoso e buio. Ma in poco tempo la marea montava inghiottendo i boschi, i pascoli, le pietraie, arrivava a lambire il pendio terminale e infine sommergeva anche noi. Chiusi in cucina ascoltavamo il cavo metallico della bandiera sbattere contro il pennone, e quel tintinnio era la musica del colle insieme ai fischi delle marmotte, ai gemiti delle imposte nel vento, allo scoppiettio della stufa, alla chitarra che ogni tanto Davide o Andrea imbracciavano, benché nessuno dei due la sapesse davvero suonare.
Certi giorni arrivava qualcuno. Soltanto un paio di persone alla volta, che avvistavamo dall’alto con il binocolo. Andrea li chiamava gli effimeri. Davide li accoglieva sulla porta, serviva un piatto di polenta e salsiccia e un bicchiere di vino, poi tornava in cucina con noi. Mantenevamo le distanze, non perché le visite non ci piacessero, ma perché quelle persone appartenevano al mondo di sotto e ci portavano sue notizie, notizie che non volevamo ricevere. Stavamo bene senza. Quando gli effimeri ripartivano li osservavamo allontanarsi, farsi sempre più piccoli e infine scomparire dietro una curva del sentiero, provando un senso di conforto nell’essere di nuovo soli.
90
Una buona bottiglia
Una mattina si aprì uno spiraglio tra le nuvole. Tra le cose del rifugio avevo trovato una canna da pesca, così domandai a Davide e Andrea dove potessi usarla.
Al lago che non c’è, mi dissero.
Perché si chiama così?
Perché a volte lo trovi e a volte no.
E trote ce ne sono?
Se trovi il lago, può essere che trovi anche le trote.
Mi indicarono una strada che passava sul filo dello spartiacque e poi attraversava a ovest, in mezzo alla pietraia, tenendosi sempre in quota. Che il lago ci fosse o no, dopo giorni al chiuso del rifugio avevo una gran voglia di far andare le gambe, così infilai la canna da pesca nello zaino e partii. Superai di buon passo la bandiera e raggiunsi la roccia dove Davide e Andrea avevano inciso le loro iniziali, insieme a quelle di un amico che non c’era più, sotto una piccola croce. In cresta stanai dei camosci e deviai dal sentiero per rincorrerli, finché li vidi sparire giù per la traccia ghiacciata di una slavina. Non pestavo più neve da settimane e decisi di buttarmi anch’io. Scivolai, caddi, mi rialzai,
91
risi da solo e mi abbandonai all’istinto di gridare. La ricordavo fin da ragazzino, questa trasformazione che la montagna mi provocava: questa gioia di avere un corpo, il senso di armonia che ritrovava muovendosi nel suo elemento, questa libertà di correre e saltare e arrampicarsi come se mani e piedi andassero da soli, e fosse proprio impossibile farsi male. Era anche un corpo senza età - non più lo stesso che da qualche inverno avevo sentito cominciare a invecchiare.
Il lago misterioso esisteva davvero. Capivo perché l’avessero chiamato così: infossato tra massi levigati dai ghiacciai, acqua nera dei 2.700 metri, potevi pure passare senza accorgerti di lui. Catturai qualche cavalletta nell’erba magra lì intorno e le misi in un barattolo per usarle come esche. Pescare, avevo pescato poche volte nella vita, però forse anche le trote del lago avevano visto pochi pescatori: ne presi tre di piccole, lunghe poco più di una spanna, gettando la mia lenza vicino alla riva. La quarta volta la gettai più in là: feci in tempo a intravedere una grossa ombra che passava, sentii tirare, tirai anch’io, e un momento dopo il lago mi aveva strappato tutto. Ecco il pesce che non c’era, pensai. Da principiante non mi ero portato materiale di riserva ma tanto il cielo si stava coprendo un’altra volta, e decisi di tornare.
Di nuovo in cresta ebbi una visione: ero in mezzo alle nuvole e uno scorcio di sole comparì all’improvviso alle mie spalle. Il sole proiettava sulle nuvole un arcobaleno circolare, e in mezzo a quel cerchio c’era l’ombra
92
di un uomo. Impiegai qualche secondo a capire che ero io. Ero alto e sottile, con gambe e braccia lunghissime che agitavo per salutare quell’altro me stesso, un alieno circonfuso di luce. Lo spettacolo durò poco, perché quasi subito il sole si oscurò e l’aria si fece elettrica. Mi dissi ecco, ora mi lavo. Dentro lo zaino avevo il bottino della battuta di pesca, e nella corsa di ritorno elencai tra me e me tutte le ricette che riuscivo a immaginare: trota al cartoccio, trota fritta nel lardo, filetti di trota in carpione, trota in padella con burro d’alpeggio e timo selvatico. Avevo voglia di preparare un bel pranzo per i miei amici. Quando la nostra mezza bandiera emerse dalla nebbia cadevano già le prime gocce: davanti al rifugio aprii il barattolo delle esche, e prima di rientrare liberai le cavallette rimaste.
Con Andrea dividevo le mattine e qualcosa di più. Ci assomigliavamo troppo per non saperlo e per non esserne un po’ turbati, come quando passi davanti a una vetrina che ti riflette e ti accorgi in leggero ritardo che quel tizio sei tu. Non era una somiglianza fisica, la nostra, ma di carattere, cioè del modo di sentire noi stessi e di stare con gli altri, una certa tendenza all’idealismo e una pelle troppo sottile per la durezza delle relazioni, il che ci portava entrambi a grandi slanci e grandi ritirate. Il silenzio e la solitudine erano un buon nascondiglio temporaneo. Anche il vino aiutava, finché non diventava un problema. Di me queste cose le sapevo già: era la prima volta che le vedevo così chiaramente in
93
un altro. Che succedesse lassù, dentro un vecchio rifugio, sulla linea di confine tra due valli, dava all’incontro l’aria di un appuntamento. Non poteva durare molto perché nessuno sopporterebbe a lungo la compagnia di un altro se stesso, o quanto meno non l’avremmo sopportata noi due.
Lui era figlio d’arte, cioè di un custode di rifugio alpino, e nipote di un montanaro con cui da bambino passava le estati in alpeggio. Da grande si era adeguato ai tempi: d’inverno faceva il maestro di sci in una località francese, con le discoteche e i pub ai piedi delle piste, e così si guadagnava da vivere per il resto dell’anno. Il rifugio non era un lavoro ma un modo per stare lontano dal paese, che lui aveva cominciato a sentire come pericoloso, e nascondersi in montagna, dove invece, almeno per un po’, sapeva di essere al sicuro. Quali fossero i pericoli del fondovalle non c’era bisogno di dirlo. Meglio tre mesi a custodire un rifugio da cui non passava nessuno.
Al sicuro, ma non felice. Quando fummo abbastanza amici da confidarci, mi disse che di montagna non ne poteva più. Ma come?, dissi io, convinto che nella quota elettiva fosse fondato il nostro legame. Confondevo le radici con la vocazione, o forse Andrea, che ci era nato, sentiva il mio stesso bisogno di scegliere da sé il proprio posto nel mondo: voleva andarsene al caldo, in Grecia o in Sicilia. Mi raccontò dei viaggi che faceva in autunno, tra la fine della stagione del rifugio e l’inizio di quella dello sci, in qualche spiaggia del sud con
94
il sole, il vino bianco, il pesce, i limoni. C’era di mezzo una ragazza in questi progetti di isola felice. Andrea aveva tutta l’intenzione di far fuori abbastanza soldi ai ricchi sciatori americani che lo assumevano d’inverno per comprarsi con lei una casetta sul mare, e dire addio al rifugio, alla neve e a tutto il resto. Qualcosa mi diceva che ci sarebbe riuscito.
C’era una vetta, lì vicino, che gli apparteneva così tanto da portare il nome della sua famiglia, e fu l’unica che salimmo insieme. Successe poco prima della mia partenza. La sera vennero altri amici dal paese, si fermarono a dormire, la mattina Davide appese un cartello con la scritta siamo in montagna, poi chiudemmo la porta del rifugio e prendemmo il solito sentiero. C’è a chi piace camminare in gruppo, chi quasi senza volerlo si ritrova subito da solo: a me attirava la cresta che avevo già cominciato a esplorare, e andai di lì. Vidi che anche Andrea partiva, di sotto, per una sua strada, scomparendo tra i massi tra cui si muoveva con leggerezza, e lasciammo il sentiero agli amici che camminavano in fila. Poco dopo, la cresta cominciò a richiedere la mia concentrazione. Superai la slavina ghiacciata da cui ero sceso la prima volta e il punto in cui potevo vedere dall’alto il lago che non c’era, intestardendomi a stare sul filo invece che prendere una delle tracce di camosci che partivano, più facili, su entrambi i versanti. In qualche punto mi toccò usare le mani, prima solo per appoggiarmi e poi per tirarmi su, finché mi ritrovai
95
a cavalcioni sulla roccia, due pareti lisce sotto i piedi, a chiedermi se non stessi facendo un’idiozia. Poi la salita tornò più facile, un ampio dorso di lastroni piatti e traballanti, quasi un gioco in cui scegliere su quale pietra saltare. C’era un ultimo intaglio sotto la cima e fu lì che incontrai di nuovo Andrea: saliva da solo lungo un canalone e capitammo insieme dove le due vie si incrociavano. Questo, anziché turbarci, ci fece sorridere, perché a distanza e senza guardarci avevamo tenuto lo stesso identico passo: una coincidenza rara di cui nessuno dei due sentì il bisogno di parlare.
Lui però aveva pensato a portare una bottiglia, io no. La estrasse dallo zaino e la stappò sulla cima che si chiamava come lui, mentre gli altri ci raggiungevano.
Ne avevamo divise parecchie, l’ultima fu la più buona: firmammo il libro di vetta con una data e i nostri nomi e fui contento che, in quel quadernetto nascosto a tremila metri, fossero scritti vicini. Non erano incisi sulla roccia, ma lassù per qualche anno la montagna li avrebbe conservati.
96
Nebbie. E il tonfo dei sassi dentro i canali. Voci d’acqua giù dai nevai nella notte.
Tu stendi una coperta per me sul pagliericcio: con le tue mani dure me l’avvolgi alle spalle, lievemente, che non mi prenda il freddo.
Io penso al grande mistero che vive in te, oltre il tuo piano gesto; al senso di questa nostra fratellanza umana senza parole, tra le immense rocce dei monti.
E forse ci sono più stelle e segreti e insondabili vie tra noi, nel silenzio, che in tutto il cielo disteso al di là della nebbia.
Antonia Pozzi, Rifugio
97
Era da un po’ che doveva succedere e alla fine, di tutti i posti infelici possibili, scoppiai a piangere proprio in mezzo a una pietraia di quelle che amavo tanto. Da quasi un’ora andavo sempre più piano: salivo di qualche passo, mi fermavo, mi piegavo a terra per respirare, guardavo in alto verso il filo del crinale e mi sembrava di non essere avanzato di un metro. Quanti ne avevo già scavalcati così? Cinque o sei muraglioni rocciosi da risalire indovinando la via, nella speranza che dall’altra parte ci fosse modo di scendere senza ammazzarsi. Non sempre mi era andata bene. Due volte ero arrivato su solo per ritrovarmi affacciato su un dirupo, e allora mi era toccato tornare indietro e provare a passare in un altro punto. Qualche ora prima avevo cominciato a sentirmi stanco, adesso ero decisamente esausto: con le cinghie dello zaino che mi segavano le spalle e una nausea da fatica, altitudine e sconforto che non sperimentavo dall’infanzia. In quello stato d’animo mi capitò un passaggio più difficile degli altri. Quando posai le mani sulla roccia e provai ad arrampicare, scoprii di avere perso tutta la mia agilità. Scivolai su un appoggio
98
Pianto
e caddi ritrovandomi più in basso, seduto senza volerlo sopra una grande pietra piatta. Il dolore arrivò poco dopo. Una fitta all’altezza dell’anca e una gamba mezza scorticata, però non mi pareva di avere niente di rotto. Mi sdraiai su quella stessa pietra usando lo zaino come schienale. Fu allora che sentii un groppo salirmi in gola, gli occhi che si appannavano. E piangi, pensai, non ti vede nessuno. Mi misi a singhiozzare sdraiato su quel sasso perché ero stanco, mi mancavano tutti quanti e non sapevo più dov’ero.
In pieno agosto, l’estate declinava già verso l’autunno precoce della montagna. Ero partito dal rifugio la mattina presto, ma non ero per nulla contento di andare via, così per il ritorno avevo deciso di cambiare strada. Sarebbe stato meno triste, pensavo, se avessi trasformato l’addio in un’avventura. C’era un villaggio, a una decina di chilometri da lì, di cui quel giorno si celebrava il patrono, e i pastori facevano festa con chi andava su. Per arrivarci seguendo la mappa avrei dovuto scendere di mille metri e poi risalire di altri mille in un vallone parallelo, ma mi ero convinto che si potesse restare in quota, trovando il modo di aggirare la montagna. Tipico modo di cacciarsi nei guai, quello di cercare scorciatoie. Così avevo cominciato ad attraversare una lunga scarpata detritica, solo con qualche ciuffo d’erba ogni tanto, qualche macchia di ginepro o rododendro, l’ultima neve ghiacciata nei canaloni. Il tempo era il solito enigma. Restavo a lungo
99
avvolto dalle nuvole, che ogni tanto si diradavano per lasciarmi studiare la via. Sulla mia destra avevo una catena di cime e da ognuna scendeva un contrafforte: solo che non sapevo quanti fossero né quali difficoltà nascondessero. Per capire dove passare spiavo i camosci. Scorgevo i loro movimenti dal basso, ne seguivo le orme sulle cenge e le brevi tracce battute: percorsi vertiginosi che tagliavano i fianchi della montagna come piste d’alta quota, e finivano di colpo dove i camosci si disperdevano. Così mi sfiancavo su per un pendio chiedendomi che cosa ci fosse di là, sperando in un pianoro o una conca; quando arrivavo in cresta scoprivo di avere di fronte solo un’altra discesa accidentata, un’altra pietraia sconnessa, un’altra risalita simile a quella che avevo appena compiuto. Era la pena per il mio peccato di presunzione. Ore dopo, sdraiato a singhiozzare su quel masso, ancora non ne vedevo la fine.
Adesso osservavo il cielo, invidiando le nuvole che correvano da una valle all’altra senza sforzo. Mi sentivo stupido, arrogante, trascinato fin lì da un gioco insulso: perdermi per vedere se ero in grado di ritrovare la strada, scappare lontano da tutti per scoprire se mancavo a qualcuno. Ero andato in montagna con l’idea che a un certo punto, resistendo abbastanza a lungo, mi sarei trasformato in qualcun altro, e la trasformazione sarebbe stata irreversibile: invece il mio vecchio io spuntava fuori ogni volta più forte di prima. Avevo imparato a spaccare la legna, ad accendere un fuoco sotto il tem-
100
porale, a zappare e seminare un orto, a cucinare con le erbe di montagna, a mungere una mucca e imballare il fieno; ma non avevo imparato a stare da solo, che è l’unico vero scopo di ogni eremitaggio. In questo mi sentivo come al primo giorno. La pelle delle mani si era fatta più spessa, il corpo più forte e resistente, ma non si era ispessito né rinforzato lo spirito, sempre gracile e malaticcio. Più che a una capanna nel bosco, la solitudine assomigliava a una casa degli specchi: dovunque guardassi trovavo la mia immagine riflessa, distorta, grottesca, moltiplicata infinite volte. Potevo liberarmi di tutto tranne che di lei. Per questo, sdraiato su quel sasso, decretai il fallimento della mia avventura.
Mentre stavo lì a compiangermi vidi un’aquila volteggiare sulla mia testa. Tracciava cerchi sempre più stretti, come se stesse puntando una preda, e mi venne istintivo il sospetto che la preda fossi io. Ero disteso immobile e per quanto ne sapeva l’aquila potevo pure essere morto. Se fossi stato morto, pensai, dopo un po’ avrebbe rotto gli indugi e sarebbe scesa a banchettare. Ne avevo trovati diversi, di camosci e stambecchi spolpati fino all’osso: i loro scheletri mi mettevano tristezza, però mi consolava il pensiero che fossero stati il cibo di qualcun altro. Potendo scegliere, mi sarebbe piaciuto fare quella fine anch’io.
Poi mi alzai. Subito l’aquila riprese quota e si allontanò. Mi aggiustai le bretelle dello zaino, chiusi la cinghia in vita. La botta che avevo preso non faceva
101
troppo male, e qualche energia sapevo di averla ancora. Aggirai il punto in cui ero caduto e ricominciai a salire con il ritmo di prima, due passi e una pausa, due passi e una pausa, senza più guardare in alto adesso, badando solo a dove mettevo i piedi. Non mi accorsi di essere in cima al crinale finché non ci fui davvero, e da lassù scorsi finalmente il villaggio che cercavo. Una decina di baite addossate, due o trecento metri sotto di me, con il bestiame che pascolava nei prati tutt’intorno. C’era un grande paiolo di rame su un fuoco all’aperto, un uomo che lo governava. Davanti a una cappelletta bianca si era radunata una piccola folla, da cui si alzava un canto che qualcuno accompagnava con la tromba. Credo di non essere mai stato tanto felice nel vedere una messa e sentire un canto di chiesa. Mi tolsi lo zaino, mi sdraiai di nuovo e chiusi gli occhi, questa volta per godermi la musica e il sole.
102
Autunno
Stagione della scrittura
Ritorno
Nel pomeriggio ero di nuovo alla baita. Da lontano si nascondeva tra gli alberi, così mi spuntò davanti come succede a volte con le persone, quando giri l’angolo e incontri qualcuno che era stato tuo amico e non lo è più, e non sai se abbracciarlo o passare abbassando lo sguardo. Provavo sentimenti simili per quella casa. Il teschio di stambecco che avevo trovato in giugno, e che chiamavo il dio di Fontane, ancora sorvegliava il suo regno dal davanzale. I prati erano solo un po’ più gialli, e la ciotola che usavo per i cani giaceva rovesciata nell’erba. A loro un po’ sarò mancato, pensai, e molto all’orticello: infestato dalle erbacce e devastato da qualche vitello in cerca d’insalata. C’erano ancora le sue impronte sulla terra morbida. Io più gentilmente mi tolsi gli scarponi sui gradini d’ingresso, posai il bastone accanto alla porta. In casa svuotai lo zaino nella lavatrice: avevo messo e rimesso gli stessi vestiti per settimane, senza nessun fastidio mentre vagabondavo per le montagne, ma adesso che ero a casa puzzavano terribilmente. Più tardi, mentre stendevo il bucato fuori, incontrai il pastore mio vicino, che era venuto a
105
scusarsi a nome del suo vitello. Era molto dispiaciuto, voleva perfino portarmi una cassetta di verdura come risarcimento, ma lo ringraziai e gli dissi di lasciar perdere. L’orto non era stato una buona idea fin dall’inizio. Non mi dispiaceva restituirlo al prato.
Quella sera davanti al fuoco cominciai a ripensare agli ultimi mesi. Contemplavo le tavole del tetto, i profili dei lupi, degli orsi e dei gufi disegnati dai nodi del legno; mi ricordavano la lunga primavera, li sentivo familiari come un paesaggio d’infanzia. Quante ore avevamo condiviso, la baita e io? Ero scappato da lei proprio perché mi conosceva così bene, e aveva visto le delusioni e le angosce della mia solitudine: adesso che ero tornato, ammaccato e un po’ intontito, dai vagabondaggi d’agosto come da una scorribanda notturna, sentivo che lì nella baita, di me, non mi dovevo vergognare. Mi accoglieva e mi invitava a riposarmi tra i suoi muri. O forse era solo l’autunno che cominciava.
La mattina andai a fare un giro nel bosco. Trovai bacche di ginepro e mirtilli da mettere nella grappa. Il sottobosco adesso era punteggiato da grossi laricini gialli, qualche mazza di tamburo nelle radure, qualche amanita muscaria; era come se la montagna, dopo una lunga incubazione, fosse finalmente entrata nella stagione del raccolto. Allora mi sedetti contro un larice e tirai fuori di tasca il mio quaderno. Restai lì con il naso in su a osservare le chiome degli alberi, il gioco del sole tra i rami, e ripensare all’Arboreto salvatico di
106
Rigoni Stern: io abitavo più in alto rispetto a lui, lassù non c’era traccia di faggi, frassini, querce, betulle, tutta la varietà del bosco intorno a casa sua. Gli alberi dei duemila metri sono solo quattro, gli ultimi a sopravvivere agli inverni dell’alta montagna, e a loro mi sentivo devoto come a santi protettori. Così decisi di inaugurare il mio quaderno con un ringraziamento al piccolo arboreto di Fontane:
Provo rispetto per l’abete rosso, come per l’abitante di un paese buio. Vive nei versanti umidi e nelle valli in ombra, dove l’uomo non costruisce né coltiva. L’umidità lo fa crescere in fretta: ha un legno leggero, spugnoso, adatto a isolare le case dal freddo. È un rispetto formale il mio, per un albero che non capirò mai fino in fondo. Mi turba la sua indifferenza alle stagioni, perché una pianta sempreverde è come un volto che non cambia espressione. Diffido della chioma dalla forma perfetta, che rende difficile distinguere un esemplare dall’altro.
Le grandi distese di abete rosso mi fanno pensare alle foreste del nord, ai laghi e ai fiordi, alla neve. Ma una volta, in agosto, sotto un abete mi sono protetto in un pomeriggio di pioggia, ho ringraziato il folto dei suoi aghi e il tappeto morbido, asciutto, di quell’albero che mi faceva da tana.
Ammiro il pino silvestre come un pioniere. È il primo albero ad alto fusto a colonizzare le pietraie, i canaloni spazzati dalle valanghe. La povertà del terreno ne fa un
107
albero dalla forma irregolare e bizzarra, un esemplare diverso dall’altro, tutti ricurvi e contorti come le ossa dei vecchi montanari. Impossibile ricavarne legname da costruzione. Non è adatto nemmeno alla stufa, perché i fumi della sua resina incrostano i tubi e finiscono per incendiarli. Ma la stessa resina dà profumo al bosco che si sveglia dal letargo. Quell’odore mi ricorda il sud e il mare: forse perché altri pini profumano la macchia mediterranea. Così il pino silvestre è un sogno di sole nel bosco sotto la neve.
Amo il larice come un fratello. Il larice è l’odore di casa e il fuoco del mio camino. Una fila di larici è ciò che vedo quando alzo gli occhi dal foglio e guardo fuori. Nei giorni di vento ondeggiano come spighe. Il larice trascorre lunghi mesi di sonno, prima di mettere le gemme in aprile, e poi cambia colore con l’avanzare dell’estate: dal verde pieno di giugno a quello sbiadito d’agosto, fino al giallo e al rosso di ottobre. Ama il sole, i versanti sud delle montagne, i terreni secchi, il vento. Cerca la luce spingendosi in alto, sopra i compagni che ha accanto: per questo i rami più bassi si seccano, come succede alle cose che ci lasciamo indietro nella vita, e basta poco a quel punto a spezzarli e liberarsene. Ma la fragilità dei rami garantisce la solidità del tronco: di larice sono i travi dei tetti delle case. Su quello di colmo i montanari usano incidere la data di costruzione: le case più imponenti di questa valle risalgono all’inizio del ’700. Io osservandole penso a quei larici vecchi di
108
quattro secoli, uno passato nel bosco e altri tre a sostenere una casa, e mi sembra il servizio più nobile che un albero possa rendere a un uomo.
Venero il pino cembro come un dio. Il bastone con cui cammino viene da lui: ha un legno bianco che non ingiallisce con il tempo, forte ed elastico nelle corse sui sentieri. Altrove vive in boschi, da queste parti invece è un albero solitario dalla crescita lentissima. Ha semi che gli uccelli nascondono nelle loro dispense segrete, le crepe delle rocce ad alta quota. Poi basta un po’ di terra, una vena d’acqua piovana: gli ultimi arbusti di pino cembro crescono lassù, sul ciglio dei dirupi, sulle creste. A volte assumono forme tormentate per le acrobazie che devono fare crescendo, per la neve che li torce e li flette, per il fulmine che li spezza. Ho trovato il più coraggioso degli alberi a 2.500 metri, un piccolo pino cembro cresciuto in una cengia che lo proteggeva dal vento e gli raccoglieva un po’ d’acqua dal cielo. Mi è sembrato di avere scoperto un tempio segreto, e devo aver detto qualcosa di simile a una preghiera.
109
Parole
Remigio leggeva di tutto, ma più di tutto i libri difficili. Quell’anno Sartre, Camus e Saramago. Era stupefacente camminare su un sentiero e sentirlo fare questi nomi, ricostruire le nostre storie opposte di lettori: io, liceale di città, avevo finito per rifiutare gli scrittori intellettuali e innamorarmi della narrativa americana, quella della frontiera e della strada; lui invece aveva la terza media, era cresciuto in un villaggio di montagna e a quarant’anni stava scoprendo i classici. Mi raccontò della sua infanzia solitaria, da figlio unico timido e senza amici. Molto presto aveva cominciato a fare il muratore con suo padre. Preferiva il lavoro alla scuola, ma aveva un carattere riflessivo e a un certo punto si era accorto di un grave limite: le parole che conosceva non gli bastavano per dire come stava. Mi fermai. Camminavamo nel bosco di fine agosto senza incontrare nessuno. In che senso?, gli chiesi incuriosito. Nel senso, mi spiegò Remigio, che aveva sempre parlato in dialetto, e il dialetto ha un lessico ricco e preciso per indicare i luoghi, gli attrezzi, i lavori, le parti della casa, le piante, gli animali, ma diventa improvvisamente
110
povero e vago se si tratta di sentimenti. Lo sai come si dice quando sei triste?, mi chiese. Si dice: mi sembra lungo. Cioè il tempo. È il tempo che quando sei triste non passa mai. Ma l’espressione va bene anche per quando soffri di nostalgia, quando ti senti solo, quando non ti piace più la vita che fai. Remigio a un certo punto aveva deciso che quelle tre parole non gli bastavano, gliene servivano di nuove per dire come stava, e si era messo a cercarle nei libri. Per questo era diventato un lettore così vorace. Cercava le parole che gli parlassero di sé.
Come tutti lassù, aveva un mestiere d’estate e un impiego d’inverno. D’estate metteva a posto le vecchie case. D’inverno manovrava il gatto delle nevi sulle piste da sci. I turni e il salario non gli si addicevano per nulla, il paesaggio sì: di notte, da solo, con un immenso spazio bianco intorno, le guglie di roccia dei tremila metri illuminate dai fari, un po’ di musica dentro l’abitacolo e il vento fuori, o la nebbia fitta, o il cielo stellato.
Una volta era quasi morto. Aveva venticinque anni e stava battendo una pista a bassa quota, proprio quella che passava accanto alla mia baita. A un certo punto aveva visto i larici piegarsi fino a terra, aveva fatto in tempo a sorprendersi per la forza del vento e poi lo spostamento d’aria aveva investito anche lui. Non era vento, era il fronte di una valanga. Era bastata l’aria a frantumargli il parabrezza. Remigio si era svegliato dopo chissà quanto, dentro al rottame del gatto delle nevi che si era andato a incagliare tra gli alberi. Gli faceva male tutto ma si era
111
tirato fuori da lì per trascinarsi a valle. Mi disse che il nemico peggiore, durante la discesa, non era stato il dolore ma la stanchezza, la tentazione di fermarsi a riposare. E che aveva scoperto una parte di sé ferocemente attaccata alla vita, ed era stata quella a riportarlo a casa. Dove era arrivato e aveva perso i sensi appena varcata la soglia.
Lui però non diceva casa. Benché per le case avesse un’ossessione, quando doveva indicare la sua ricorreva ai giri di parole. Andiamo da me, diceva. Oppure: dove abito. Mai una volta che l’abbia sentito dire: a casa mia. Mi chiedevo perché, io che invece cominciavo a chiamare casa qualunque posto dopo un po’ che ci abitavo. Se non si sentisse a casa da nessuna parte, o se una casa valesse l’altra perché tanto casa sua era la valle intera. Invidiavo questo in lui: l’appartenere a un luogo molto più vasto, appartenere ai boschi, ai torrenti, alla forma delle montagne, al pezzo di cielo che le montagne ritagliano, alle stagioni che transitano di lì.
Siccome non si era mai mosso dal suo paese, si innamorava delle persone che andavano e venivano. Gli succedeva fin da ragazzo. Erano i forestieri quelli con cui preferiva parlare: come un sasso che chiede a un uccello che cosa c’è dall’altra parte della montagna. Per ricambiare, quando faceva amicizia con qualcuno lo portava in un posto speciale, un grande lago cupo che assomigliava a lui, ed era lì che eravamo diretti quel giorno. Lungo il sentiero mi indicava i luoghi chiamandoli per nome, ma non erano villaggi o cime come sulle mappe ufficiali: la
112
sua mappa era composta da un bosco, una radura, una buca nel terreno, un masso erratico piantato in mezzo a un pascolo. Lo sai come si chiama qui?, mi diceva. Il pian des sardognes, il pra’ pera’, il sasc murel, la borna de’ grai. Quei toponimi non risultavano in nessun catasto. Ormai li ricordavano in pochi: avevano definito confini e proprietà, ma una volta abbandonata la montagna erano caduti nell’oblio. Così Remigio, che da ragazzo gioiva delle parole nuove, ora soffriva per le parole perdute, come per i ruderi che incontravamo salendo. Anche quelle case erano state battezzate ai loro tempi. Fontane, Champette, Brengatze, la Pelletzira, ogni casa un nome di cui a volte si capiva l’origine, altre volte era memoria di qualcosa o qualcuno che non si ricordavano più. Poi veniva giù il tetto, crollavano i muri, e l’ultimo pezzo a cadere era proprio il nome: sarebbero spariti uno dopo l’altro finché nessuno avrebbe più saputo dire come si chiamava il sasso, la radura, la buca, e la montagna si sarebbe liberata non solo dell’uomo, ma anche del suo bisogno di dare nomi alle cose. A volte Remigio ricordava un termine ma non il suo significato - era soltanto un suono sentito da bambino - e allora interrogava sua madre, che aveva settantadue anni, cinque mucche, due cani, e viveva fuori dal tempo insieme alle parole dimenticate. Nei ruderi mi guidava come un archeologo. Ristrutturava case da una vita e ne aveva visitate moltissime. Nelle cassapanche aveva trovato documenti di tre o quattrocento anni prima: testamenti, passaggi di proprietà, appalti di costruzione. Mi spiegò che, nei tempi
113
antichi, commissionando una casa non si disegnava la pianta, ma bastava elencare le stanze che avrebbe avuto, come da un catalogo immaginario: una stalla, un fienile, un locale per trebbiare la segale, uno per fare il formaggio, i balconi per seccare il fieno. I ruderi che visitavamo erano ancora più semplici. Remigio mi indicava i dettagli: il modo in cui era stato costruito il camino, o una nicchia nella parete, o l’arco delle finestre. Era da questi particolari che si capiva la data di costruzione. Mi spiegava le tecniche per filo e per segno mentre sulla porta scalpitavo, perché dentro era buio e fuori c’era il sole e a quei mucchi di pietre umide e alla loro aria di morte preferivo di gran lunga i prati e i boschi.
Avevamo scoperto che ci piaceva andare a camminare insieme. Partivamo nel tardo pomeriggio, quando i pochi escursionisti rimasti tornavano a valle: salivamo di corsa per un’ora o due, e al tramonto la montagna era tutta per noi. Ci fermavamo ai piedi di qualche pietraia, a inventarci ogni volta un percorso. Era sempre un torrente da risalire, o una traccia lungo un canalone. Andiamo su di lì?, ci dicevamo. Poi salendo incontravamo camosci che ci fissavano sorpresi, prima di dileguarsi in due o tre balzi: e voi che cosa ci fate quassù a quest’ora?, sembravano chiedere. Non ce l’avete una casa?
Remigio li fotografava. Questo gli era rimasto della passione di suo padre. Erano branchi di quindici, venti esemplari: la gioia delle nostre corse si compiva lì, non nelle croci di vetta o tra i tavoli di un rifugio, ma in
114
mezzo alle rocce al calare del sole, a guardarsi negli occhi con i camosci. Avremmo voluto dir loro di non scappare, tanto passavamo e basta. La paura che avevano di noi era l’unico limite invalicabile: potevamo farci il bagno in un lago, nutrirci di lamponi e mirtilli, dormire in un prato, ma i selvatici fuggivano al nostro passaggio e ci ricordavano che non eravamo come loro, non lo saremmo mai stati.
Io mi sentivo meglio sotto le cascate o sui torrenti, vicino all’acqua in movimento; Remigio preferiva l’acqua ferma. Il suo lago poi era particolarmente tetro. Da una parte la montagna era franata, e la pietraia scendeva fino all’acqua diventando scogliera. Sull’altra riva c’era un pendio colonizzato dal salice e dal rododendro, tagliato da un torrente che nasceva poco più in alto, e alimentava il lago. Aggrappate a mezza altezza, dove il pendio si addolciva in qualche pascolo, resistevano alcune baite. Una apparteneva a Remigio. Era stata costruita contro una parete di roccia, così bastavano tre muri anziché quattro e aveva un riparo naturale dalle valanghe. Lui me la indicò da sotto, accompagnandomi passo passo col dito lungo un sentiero immaginario. Alla fine mi sembrò di scorgere qualcosa davanti a una parete di roccia, dello stesso colore della roccia.
La vedi?, mi chiese.
Sì, risposi mentendo.
Andiamo su a vederla, ti va?
Ma sì, dissi, andiamo su.
115
Una visita alla baita
In settembre venne una persona a vedere come stavo. Non ci incontravamo da un po’. Restammo insieme due giorni che mi sembrarono lunghi, per la concentrazione che mi richiesero. Quando andò via, presi il mio quaderno e scrissi:
Ho visto una mano e un piede di mio padre sporgere dalle lenzuola stamattina. Com’era strano averlo lì, sul mio divano letto, ospite in casa mia. Mio padre è un uomo che non ha mai dormito molto. Pure questa mattina per terra c’erano un bicchiere vuoto e il Corriere di ieri, scompaginato come sono i giornali letti da cima a fondo. Doveva averlo studiato per tutta la notte, bevendo il whisky scozzese che ha portato per me, ed essersi addormentato che fuori era già chiaro. Per la luce che entrava dall’abbaino si era tirato le lenzuola sugli occhi, ed è così che l’ho trovato. Quante altre volte avrò visto mio padre in un letto? L’ultima dev’essere stata una domenica pomeriggio a Milano. Convocava mia sorella o me nella sua stanza quando i nostri litigi lo svegliavano. Nell’oscurità sta-
116
biliva il colpevole e chiamava il suo nome a voce alta, allora quello rabbrividiva, l’altro era salvo. Non dormiva nemmeno dopo, quando tornavo di notte e lo trovavo in cucina, con la sua grappa e il suo giornale, e avrei preferito che dicesse a parole quello che diceva con gli occhi, così avrei potuto rispondere senti, è la mia vita.
Anche adesso che la vita è mia, mio il divano dove lui dormiva, mio il bicchiere da cui aveva bevuto, e mio padre non era che un ospite nella mia casa, la sua mano a sessantaquattro anni era uguale alla sua mano a quaranta. Tormentata, scura, tutta nocche, con la fede nuziale che non viene più via. Il piede sporgente dalle lenzuola assomigliava alla mano, a parte l’unghia dell’alluce gialla e spessa, un’unghia d’osso rotta nelle corse giù per i sentieri. Mio padre non ha mai trovato uno scarpone giusto per il suo piede destro. Tra le canzoni che mi ha insegnato, la mia preferita parla proprio di questo. O con le scarpe, o senza scarpe, i miei alpini li voglio qua. Lui ha fatto il militare in montagna e da bambino mi cantava della Grande Guerra; le storie di scarpe, treni, morose e vino facevano parte di noi.
Allora ho immaginato di sollevare il lenzuolo e trovarlo così, barba e capelli nero carbone, occhi da diavolo, ho sentito di nuovo la pelle accapponarsi, ho messo su il caffè e sono uscito. Fuori mi sono lavato la faccia alla fontana e ho ritirato la scodella che i cani, nella notte, avevano ripulito dagli ossi. Quando sono tornato dentro mio padre non c’era già più.
117
Più tardi, dopo che lui è partito, su in alto nel bosco ho trovato un larice spogliato dal fulmine, a cui era successa una cosa molto strana. Un unico ramo vicino alla base era ancora in vita. Il fulmine aveva fatto male al tronco ma bene al ramo, che chissà come aveva cambiato direzione, cominciando a crescere in verticale, e ormai era quasi un secondo tronco. Così adesso di quel vecchio larice ce n’erano due: uno bruciato e spoglio, l’altro pieno di gemme. Per le cose successe in questi giorni, prima ho pensato che il tronco nuovo potevo essere io, e il tronco vecchio mio padre. Poi invece ho pensato di essere tutt’e due i tronchi, quello vecchio e quello nuovo, e il fulmine era proprio la cosa che stavo aspettando, il fuoco che uccide il tuo vecchio io perché ne cresca uno nuovo. In questo caso, mio padre era soltanto un altro albero del bosco. Di soprassalto mi sono voltato per affrontarlo.
118
Un cane fortunato
Se rinasco giuro che rinasco cane, diceva Gabriele, vedendo il cucciolo che aveva preso quell’estate coperto di baci e carezze dalle ragazze di passaggio. Qualcuno, non lui, l’aveva battezzato Lucky. Era nato in paese da madre border collie e padre ignoto, ed era stato portato in alpeggio perché imparasse da Lupo il lavoro di pastore, ma forse proprio quel padre amante dell’avventura gli aveva lasciato una vocazione, oltre che i colori invertiti: bianco con macchie nere, i fianchi magri di chi è nato per correre, un campanello al collo che sentivi andar via dietro a qualunque camminatore. Gabriele scuoteva la testa vedendolo allontanarsi. Le mucche a quel cane non interessavano, gli umani sì. Certe volte il camminatore ero io e per un po’ provavo a convincerlo: no, dai, non seguirmi, stai con il tuo padrone. Lucky scodinzolava. Se lo sgridavo e cercavo di scappare lo prendeva come un gioco e mi rincorreva sempre più lontano. Finché mi rassegnavo a portarlo con me, e metterne alla prova le qualità alpinistiche. I cani, che io sappia, non hanno l’indole di scalatori: lui si arrampicava sulle creste e
119
filava lungo le cenge come un cucciolo di camoscio, non aveva proprio niente di quei guardiani dall’aria torva, territoriale, che nei pascoli ringhiavano agli invasori. Ma da dove sei uscito tu?, gli chiedevo, mentre tutto fiero si issava su una roccia a scrutare le vallate, nella posa dello stambecco. Averlo tra i piedi mi metteva allegria. Giù da Gabriele c’era una catenella che penzolava da un muro, e a malincuore, al mio ritorno, lo legavo lì perché non mi seguisse fino a casa. Allora Lucky latrava al cielo tutta la sua tristezza - però senti che vocione, diceva Gabriele - mentre Lupo si avviava a riportare le mucche in stalla, fedele come se niente al mondo gli interessasse più di quel lavoro. Erano due fratellastri destinati a odiarsi, il figlio unico e l’adottivo, il sedentario e il nomade. Io scendendo a Fontane mi tappavo le orecchie per non sentire quegli ululati.
L’autunno era arrivato in piccoli segnali, non solo nel buio che calava ogni sera un po’ prima. Nella brina sul prato di casa, quando uscivo la mattina con la mia tazza di caffè. Nelle ombre dei larici che vedevo allungarsi a mezzogiorno. Nei selvatici che, spariti gli uomini, tornavano a mostrarsi: al tramonto i caprioli uscivano a brucare nei pascoli, la volpe si avvicinava in cerca di cibo. Il bosco vibrava di attività che percepivo andando a far legna - lo scatto di uno scoiattolo su un tronco, il balzo di una lepre nel ginepro, ombre in movimento. Mario Rigoni Stern diceva che, delle sta-
120
gioni, quella che gli piaceva meno era l’estate, perché la vita si nasconde all’uomo ed è come assente, mentre amava l’autunno che ci spinge di nuovo ad affinare lo sguardo, tendere l’orecchio e ascoltare. Però non parlava del sonno che sentivo avvolgere la montagna. Dei torrenti in secca, dell’erba bruciata dal gelo notturno, dei profumi che ogni giorno si affievolivano un po’: non più fieno, né resina, né muschio. Nell’aria cominciava a diffondersi l’odore delle stufe, e quello del letame che i pastori spargevano prima di partire. Dopo le notti di pioggia vedevo la neve imbiancare le cime delle montagne - abbassarsi a 2.500, 2.400, 2.300 metri - per poi sciogliersi in un pomeriggio di sole. Con il diradarsi della vegetazione i suoni arrivavano più lontano: così mi capitava di sentire un trattore e poi vederlo passare sulla strada un paio di chilometri a valle.
Al grido di motoseghe lontanissime si univano le voci delle raccoglitrici di patate, piegate negli orti a estrarre il frutto della terra. Ogni sera dall’alto sentivo: Lucky! Lucky! E a volte, ma non sempre, lo scampanellio che rispondeva al richiamo.
Hai visto Lucky?, venne a chiedermi Gabriele. No, non l’avevo visto. Era sparito da un giorno e non sapemmo più niente di lui fino al successivo. Poi chiamarono dal canile, dicendo che l’avevano trovato su un autobus al ritorno da scuola, dopo che tutti i ragazzi erano scesi e non restava che l’autista, a trenta chilometri da noi. Nessuno aveva idea di come ci fos-
121
se salito, ma certo le sue esplorazioni si erano spinte parecchio in là. Presto scoprimmo che, oltre ai sentieri di montagna, doveva avere un debole anche per la strada asfaltata, dato che saltava a bordo di qualsiasi mezzo vedesse aprirsi davanti a sé. Appena imparò a farlo i canili della zona si passarono il numero di Gabriele, e insieme alle telefonate cominciarono ad arrivare le multe.
È un cane beat, dicevo io.
Cosa?, chiedeva lui, poco in vena di letteratura. Era arrabbiato e si capiva: aveva preso Lucky per lavorare, invece gli toccava pagare le sue intemperanze. Da misura punitiva, la catena diventò un’abitudine. Io passavo di lì e lo vedevo legato e scalpitante, avevo il permesso di liberarlo per portarmelo a camminare, ma dopo le feste, le corse, gli inseguimenti di marmotte, agganciargli di nuovo il moschettone al collo mi faceva sentire più in colpa che mai.
Sai di qualcuno che vuole un cane?, cominciò a chiedermi Gabriele, con un distacco che dissimulava la malinconia. Gli si era disaffezionato, ma non del tutto. Io credo che gli piacesse quell’indole vagabonda. Lucky, Lucky, sembrava pensare, potevamo essere amici io e te, dandogli le ultime malinconiche carezze. Dal suo angolo Lupo osservava la scena con il muso a terra, denti semiscoperti, il fastidio contenuto a stento da un ringhio basso e privato.
* * *
122
Io un cane non lo volevo, non l’avevo mai voluto. Uno, mi avrebbe impedito di viaggiare. Due, mi avrebbe distratto dalla scrittura. Tre, quattro, cinque, mi avrebbe tolto libertà in modi che nemmeno sapevo immaginare. E poi, come avrei sopportato di esser chiamato padrone? Così quando varcai con Lucky la soglia della baita ero più preoccupato che contento. Pensai di preparare il pranzo, che era il mio modo di fare amicizia coi montanari: misi su una pastasciutta per due ma poi lui ebbe la sua e pure la mia, tanto era affamato. Finita quella, prese possesso del cantuccio in ombra sotto il tavolo. Allora mi tagliai un pezzo di pane e formaggio, mi sedetti a tavola e aprii il quaderno come ultimamente mi piaceva fare, scribacchiando mentre sbocconcellavo qualcosa. Con Lucky quel mio vezzo avrebbe avuto vita breve. Annusò la toma, si alzò, venne a mettermi il muso sulle gambe, mi sbavò i pantaloni. Ebbe le croste e qualcosa di più. Non avevo ancora posato la penna sul foglio che si stufò di stare là sotto e andò alla porta di casa. Fissava la maniglia, guardava me, scodinzolava, tornava sotto al tavolo a chiamarmi, andava di nuovo alla porta. Il campanello che aveva al collo era la voce della sua irrequietezza.
Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati, diceva Neal a Jack, e Lucky a me. Dove andiamo?, chiedevamo noi. Non lo so, ma dobbiamo andare. Pensai che quel campanello non serviva più a nien-
123
te e allora glielo tolsi insieme al collare di cuoio in cui era infilato, e appesi il collare a un chiodo che sporgeva dal muro. Fine della tua carriera da pastore, Lucky, gli dissi. Credevo che sarebbe stato contento di non avere più addosso quel ricordo di prigionia, ma lui era indifferente ai simboli, gli interessava solo l’azione. Così finalmente aprii la porta e andammo a camminare.
124
Desarpa Venne l’ultimo sabato di settembre, e dall’aria gelida che tirava avevo la sensazione che non me ne restassero ancora molti. Salendo per la mulattiera incrociai una lunga fila di mucche lente, cani e ragazzini intorno a badare che nessuna si attardasse, un uomo in testa al corteo e sua moglie in coda, alla guida di un trattore col rimorchio carico di roba. Era la desarpa. I pastori scendevano dagli alpeggi, non per il freddo ma perché l’erba era finita. Venivano giù silenziosi, senza bisogno di spronare le bestie né parlare tra loro, e non sapevo se quella che gli leggevo in faccia fosse stanchezza o malinconia. Qualcuno mi salutò perfino. È tuo il cane?, chiedevano. Sta con me, rispondevo imbarazzato, incapace di pensare o dire che Lucky fosse mio.
In alto facemmo un giro intorno agli alpeggi chiusi, dove fino a poco prima risuonavano i campanacci. Lucky annusava qua e là la vita che se n’era appena andata: porte e finestre sbarrate, letamai vuoti. I piccoli canali, che dai torrenti portavano acqua agli abbeveratoi e dentro le stalle, adesso erano in secca. Vasche da bagno arrugginite e rovesciate restavano a languire nei
125
pascoli. Per terra il letame secco, i segni delle ruote dei trattori, il paletto a cui era stato legato il cane. Sembravano cose lasciate indietro in un esodo precipitoso, come se fosse scoppiata una guerra o un’epidemia. Solo le ortiche erano ancora rigogliose, ma quelle crescono bene dove non c’è più nessuno, segnano l’abbandono.
Salendo oltre gli ultimi pascoli superai con un salto il torrente che in giugno avevo dovuto guadare togliendomi calze e scarpe: era ridotto a una serie di pozze in cui le trote stagnavano imprigionate, avrei potuto catturarle con le mani. L’acqua dei laghi era plumbea, quasi nera. Una crosta di neve ghiacciata velava le rive rivolte a nord. Lucky la leccava, la grattava via coi denti; qualcosa in lui era fatto per l’inverno e lo sentiva arrivare con eccitazione. Io invece ero fatto per l’estate, e fui sollevato nel correre giù e tornare a calpestare l’erba.
Arrivando da Gabriele pensai al mio amico che si scaldava con la sua tazza di caffè, burro d’alpeggio, zucchero e vino rosso, un intruglio infernale che un paio di volte, per questioni di ospitalità e d’orgoglio, avevo dovuto sorbirmi anch’io. Sperai che non mi toccasse di nuovo. Lo trovai davanti alla stalla, con cunei e mazza, a lavorarsi una catasta di legna alta più di lui. Lupo e Lucky, non più costretti a fingersi fratelli, erano già apertamente nemici: si girarono intorno con il pelo dritto e poi il vecchio ribaltò il giovane con una zampata, lo bloccò a terra, gli affondò i denti nella spalla. Lucky mugolò di dolore e spavento. Lupo!, gri-
126
dò Gabriele. Gli scagliò addosso un ciocco di legno e il cane mollò la presa, così Lucky scappò zoppicando verso casa e Lupo si allontanò offeso, come uno che aveva solo esercitato i suoi diritti. Io guardai Gabriele un po’ scosso dalla violenza della scena. Cani, disse lui scrollando le spalle. Presto ci avrei fatto l’abitudine anch’io.
Il vecchio larice doveva essere cresciuto ritorto, e non voleva saperne di diventare legna da ardere: per spaccarlo servivano tre o quattro cunei e molta più fatica del normale. A Gabriele non dispiacque posare la mazza e riprendere fiato. Quando gli chiesi se non fosse triste nel veder partire tutti quanti finse indifferenza, come se non gli cambiasse niente restare solo. Quanto a lui, alla desarpa non ci pensava proprio: spavaldo dichiarò che era solo questione di scorte, con la cantina piena avrebbe resistito lassù fino a Natale. Ma vedevo dai suoi occhi, dal modo in cui mi sfuggivano che quel ghigno era una posa, e che l’autunno, in realtà, opprimeva anche lui.
Oggi cos’è, sabato?, chiese. Che ne dici, andiamo in paese a riempirci il muso?
Risposi di no sottraendomi ai miei doveri di compagno di bevute. Sapevo di deluderlo, ma l’ultima volta che ci eravamo riempiti il muso avevo impiegato due giorni a rimettermi in sesto, e questa poi aveva l’aria di una sbronza triste e cattiva.
Trovai Lucky sul balcone della baita a leccarsi le ferite. Aveva un buco nella coscia che sanguinava. Avrai
127
capito di stare alla larga, gli dissi. Stagione crudele, l’autunno, che rendeva crudeli anche noi.
Il giorno dopo partirono anche i miei vicini. Più che per gli uomini, con cui non ero mai riuscito a legare, mi dispiaceva per i cani. Mi sarebbe mancato il suono della campanella che annunciava le loro visite. Siccome Mozzo arrivava al passo, Billy al trotto e Lampo al galoppo, avevo perfino imparato a riconoscerli dal tintinnio. Se ne andarono senza salutare, e io pensai: meglio così. Si sa che ai cani gli addii non piacciono per niente, e anch’io non sono portato per le cerimonie. Era un altro pezzo d’estate in meno, sfiorito, tramontato; quando della mia stagione non fosse restato più nulla avrei potuto chiudere la porta e partire.
Ma Mozzo, Billy e Lampo furono sostituiti da altri cani, e quelli non vennero scampanellando. Una mattina di ottobre fui svegliato dai loro latrati. Mi affacciai alla porta, tenendo Lucky perché non partisse a far rissa, e vidi una muta di bracchi correre avanti e indietro dal bosco, obbedendo ai richiami di due sconosciuti. Portavano binocoli al collo, tute mimetiche e fucili a tracolla. Non ci avevo mai pensato, che un giorno o l’altro sarebbe cominciata la stagione della caccia. I cani correvano isterici, eccitati dagli odori delle prede: da quella volta la scena si ripeté ogni mattina, e gli spari dei fucili cominciarono a rimbombare nelle ore intorno all’alba. Allora Lucky si rintanava sotto al letto, io pregavo il dio del bosco che i colpi fossero andati
128
a vuoto. Pensavo ai caprioli, ai camosci, ai cervi tanto ambiti. Durante la settimana, al tramonto, lo spiazzo alla fine della strada divenne un ritrovo di cacciatori: i cervi uscivano a quell’ora per brucare al margine dei pascoli, dove l’erba concimata è più grassa che nelle radure. Per sei giorni i cacciatori ne studiavano al binocolo movimenti e orari. Li contavano, li misuravano, li sceglievano perfino: sembravano dire quello è mio, lo prendo io, guai a chi me lo tocca. I cervi non sapevano che il settimo giorno sarebbe stato fatale, avrebbero dovuto starsene nascosti la domenica, santificare le feste.
C’era un vecchio cacciatore che passava dalla baita ogni mattina. Girava nel bosco lì intorno, forse perché non riusciva a fare più strada di così. Un giorno sentii due spari e poco dopo lo vidi andarsene con una lepre al fianco, appesa per le zampe posteriori, le lunghe orecchie grigie che pendevano fino a terra. Dentro di me fui sicuro che fosse la mia amica. La lepre di cui avevo avvistato le impronte in primavera, quando soffrivo di solitudine e quell’incontro era stato così prezioso; la stessa lepre che ogni sera mi scrutava da lontano, facendomi sperare che, con l’abitudine, prima o poi avrebbe trovato il coraggio di avvicinarsi. Adesso mi vergognai di quel paziente addomesticamento, era un tranello che le avevo teso: come poteva distinguere, la lepre, tra me e l’uomo col fucile? La sua morte mi sembrò un delitto intollerabile e odiai quel vecchio con tutto il cuore.
129
Ieri poi, nel pomeriggio, ha ricominciato a nevicare.
Neve secca, farinosa, invernale, che il vento faceva turbinare dappertutto, e arrivava a posarsi sulla soglia di casa e sulla legna accatastata contro il muro.
Ma questo cos’è, ottobre?, ho pensato.
Nemmeno i larici avevano fatto in tempo a liberarsi degli aghi. I loro rami pendevano bassi e qualche volta si spezzavano di schianto. Non ho più sentito il bramito del cervo né gli spari dei cacciatori.
Di sera sono rimasto vicino alla finestra, leggendo e guardando fuori. I fiocchi illuminati dalle luci di casa.
Un libro di Sylvain Tesson, Nelle foreste siberiane : lago Bajkal, sigari, vodka, pensieri di un fratello lontano.
Nevicava ancora, e avevo appena messo su la cena, quando è finita la bombola del gas. La fiammella azzurra è diventata gialla, ha tremolato e poi si è spenta.
Addio minestra, ho pensato.
Ho incartato quattro patate nella stagnola e le ho buttate tra le braci della stufa, e dopo un’ora le ho mangiate croccanti e bruciacchiate, intingendole nel sale, col vino rosso.
130
Nel bianco
Saranno state le nove quando mi ha abbandonato anche la luce. La lampadina sopra al tavolo si è spenta. La canzone alla radio si è interrotta a metà. Il frigorifero ha smesso di colpo di ronzare.
Tutta la casa è piombata nel buio e nel silenzio, a parte il crepitio del fuoco e il topo che da due giorni scorrazza nel mobile della cucina. La neve fuori non faceva nessun rumore.
Io mi sono rassegnato, che altro dovevo fare?
Ho tirato giù il divano, ho preparato il letto al bagliore della stufa, l’ho caricata per bene e me ne sono andato a dormire. Ascoltarla scoppiettare al buio mi faceva una bella compagnia.
Dopo un minuto ho sentito un cane che dal suo posto sotto il tavolo veniva a mettersi sul letto, cercando di non farsi sentire, come se potessi non accorgermi di lui.
Si è accovacciato giù in fondo e ci ho infilato i piedi sotto.
Nella notte devo aver sognato di scrivere un racconto su un uomo a cui finisce tutto, il gas, la luce, la penna, e la sua vita è ridotta di colpo ai minimi termini, mentre sopra di me, fuori, intorno, nevicava e nevicava.
Stamattina il mondo era una pagina bianca. Il cielo nitido, di quel blu reso più intenso dal contrasto coi boschi coperti di neve.
131 * * *
Ho fatto un giro per vedere quanta ne fosse caduta e appena oltre la porta di casa sono affondato fino al ginocchio.
Lucky aveva trovato il suo elemento: mi precedeva a balzi, si tuffava, si riempiva la bocca, si rotolava nella neve fresca. Forse sei stato un cane da slitta, gli dissi, non sei un ladro d’auto, sei un cercatore d’oro. I larici si liberavano senza preavviso al primo sole, scaricavano slavine e sotto erano verdi e gialli.
Se avessi avuto una macchina fotografica, avrei fatto foto in verticale perché mi piacevano gli alberi, la neve e il cielo. C’è una solennità in un larice innevato contro il mattino. Ho pensato a Pavese: “Io per me credo che un albero, un sasso profilati sul cielo, fossero dei, fin dall’inizio”.
A casa ho pulito un po’ di legna dal ghiaccio, ho acceso il fuoco, mi sono ricordato che non avevo più gas. Nemmeno la luce era ancora tornata. Allora ho fatto il caffè sulle braci, alla turca, e il pentolino si è tutto annerito sul fondo.
Quando mi sono seduto al tavolo il mio quaderno era lì che mi aspettava: fermo a ieri, a molti anni fa, proprio a quella riga, nel punto esatto in cui l’avevo lasciato prima che cominciasse a nevicare.
132
Ultima bevuta
“La fine è importante in tutte le cose”, dice l’Hagakure. E io trascorsi gli ultimi giorni lassù pensando a questo, che volevo finire bene. Di mattina Lucky mi svegliava leccandomi la faccia e andavamo insieme a controllare l’opera del gelo: spezzavo la lunga stalattite di ghiaccio che pendeva dalla fontana, la stringevo in mano finché non si incollava alla pelle, poi la lasciavo a galleggiare e sciogliersi tra gli aghi di larice. Se la notte era stata limpida, il termometro esterno segnava meno cinque gradi. In casa accendevo la stufa, preparavo il caffè, ricostruivo i percorsi del topo che mi teneva compagnia. Nella notte aveva esplorato il bancone della cucina, i fornelli, il lavandino, fatto un giro sulla mensola della pasta e del riso, scavato tra le assi del pavimento per estrarne briciole di pane. Non sapevo più cosa fare con lui: all’inizio era timido, usciva solo a notte fonda. Poi aveva capito di avere un padrone di casa tollerante, e aveva preso confidenza: ora me lo ritrovavo intorno perfino mentre cucinavo. Così non si può andare avanti, mi dicevo, pulendo la baita dalle tracce del suo passaggio. Avrei dovuto appellarmi al
133
rude montanaro che era in me, prendere la scopa ed eliminarlo. Il bastone l’avevo rotto da poco, attraversando un torrente. Il puntale di metallo si era incastrato tra due massi, avevo fatto leva per estrarlo e crac. Avevo deciso di non cercarmi un bastone nuovo, tanto non mi sarebbe servito. In compenso avevo conservato i pezzi di quello vecchio: quel cembro spellato con l’Opinel e seccato al sole, graffiato dai sassi delle pietraie e lucidato col sudore, compagno di scorribande di una lunga estate, sarebbe finito nel camino l’ultima sera. E dopo forse avrei smesso di affezionarmi ai topi, ai bastoni e alle scarpe, che ormai mi si disfacevano intorno ai piedi.
Gabriele continuava a sostenere che sarebbe sceso quando finiva il vino. Molto divertente, ma avevo imparato a riconoscere le sue battute. Le damigiane erano vuote da un pezzo, ci eravamo ridotti a comprare i cartoni del supermercato. La verità era che, senza consultarci, avevamo deciso di andar via tutt’e tre alla fine di ottobre, Gabriele, Remigio e io. Arrivava la neve, quella vera questa volta. Così uno aveva trovato una stanza in paese, la stava svuotando dei vecchi mobili per metterci dentro una stufa, una branda e un tavolo; l’altro si sarebbe spostato nella sua casa d’inverno, anche se nemmeno quella l’avrebbe mai chiamata casa; e io sarei tornato in città, a guardare le montagne dal finestrino, incolonnato in macchina sul ponte della Ghisolfa. Prima però avevo un ultimo progetto da realizzare. Da tanto tempo volevo passare una serata in-
134
sieme a loro due, ma avevano puntualmente schivato i miei inviti. Per qualche motivo, benché si conoscessero da sempre, non erano mai stati amici, e a me sembrava una cosa molto triste dato che volevo a entrambi così bene. Un giorno di ottobre affrontai la questione di petto e dissi sentite, io stasera cucino, voi portate da bere e niente scuse, prendetelo come un regalo che fate a me. E me lo fecero davvero. Con un po’ di imbarazzo, una bottiglia di vino a testa e il vestito buono si presentarono alla mia porta al calare del buio. “In casa avevo tre sedie”, scriveva Thoreau, “una per la solitudine, due per l’amicizia, tre per la compagnia”. Feci in tempo a sperimentarla anch’io, la nostra piccola società di montagna. Se ho combinato qualcosa di buono lassù, se devo sceglierne una di cui vado orgoglioso, è aver fatto sedere i miei amici allo stesso tavolo, essere stato bene con loro prima di andare via.
Passai l’ultimo giorno a preparare la baita per l’inverno. Nell’orto inselvatichito sparsi la cenere del camino. Non sarà stata granché come concime, ma mi sembrò giusto farlo: era come prendere quel larice caduto in primavera e restituirlo alla montagna. Coprii con qualche palata di terra la buca in cui accendevo il fuoco all’aperto, e ammucchiai la legna rimasta sotto al balcone. Portai in casa la sega, la roncola, la vanga e il rastrello. Poi mi lavai le mani alla fontana gelida e diedi un’occhiata in giro. Il posto era di nuovo come l’avevo trovato il primo giorno, solo Lucky che quel
135
giorno non c’era mi guardava e non capiva: sei pronto alla città, gli chiesi, cane sfortunato? In tutta la sua vita non aveva ancora visto un guinzaglio né un marciapiede. Dovremo volerci molto bene, io e te, gli dissi. Magari mi insegnerai a scappare sulla prima macchina che passa.
All’ora di pranzo venne Gabriele e disse: non sono molto pratico coi saluti. Nemmeno io, gli risposi. Allora ciao, disse lui. Le baracche non le aveva più, adesso lavorava già agli impianti di risalita. Smontavano i seggiolini, oliavano gli ingranaggi e stringevano i bulloni in vista della stagione dello sci. Si allontanò sul suo trattore, con Lupo che gli mordeva le ruote anteriori, come faceva sempre, abbaiando e mettendosi di traverso sulla strada, come a dire fermati, dove vai, torna indietro. Remigio invece mi cacciò di casa quando passai a salutarlo, finse di avere cose importanti da fare, e poco dopo mi scrisse un messaggio per scusarsi, perché era triste e non era stato capace di abbracciarmi. Capivo bene anche lui.
In alto non andavo da un po’, di mattina la montagna era coperta da una crosta di ghiaccio. Così approfittai di quel pomeriggio di sole, partii con Lucky subito dopo pranzo, salimmo veloci perché sapevo di avere poche ore prima del buio. Poi fu come registrare un nastro da portarsi via. Raggiungere il crinale e scoprire ancora, dopo tanti mesi, un versante sconosciuto, percorrere un sentiero mai preso. Scendere dall’altra parte fino a un pascolo bruciato dal gelo. Spiare dalla
136
finestra dentro un alpeggio chiuso: il tavolo, le sedie, i piatti impilati sulla mensola, i barattoli delle conserve, come se qualcuno fosse appena partito e avesse fatto un po’ d’ordine prima di uscire. Poi studiare la montagna e scegliere una linea bella, bella per chi conosce la bellezza di andare dove non c’è il sentiero, e attraversare in alto, lungo le vie dei camosci. Superare le tane deserte, i tronchi spezzati, i larici incendiati dall’autunno, attraversare una pietraia saltando da un masso all’altro tra i rododendri spogli. Bagnarsi le mani e la faccia in un torrente. Assaggiare i mirtilli d’ottobre, le piante ormai senza foglie ma ancora cariche di bacche, ghiacciate dal gelo notturno, avvizzite, scure, dolci come uva passa.
La facevo anche da bambino questa cosa, un ultimo giro per salutare la montagna. Scrivevo dei biglietti e li nascondevo nelle rocce spaccate, nelle fessure delle cortecce, così le mie parole sarebbero restate lì anche dopo di me.
Ora dobbiamo andare, dissi a Lucky. Era tempo di tornare giù. Conoscevo già tutti i sogni che avrei fatto d’inverno.
137
Le citazioni tratte dalle seguenti opere appaiono per gentile concessione dei rispettivi editori:
Daniel Defoe, Robinson Crusoe (traduzione di Riccardo Mainardi, © Garzanti Editore s.p.a., 1976, 1982, © 1999, Garzanti s.r.l., Milano)
Primo Levi, Il sistema periodico (Einaudi, 2005)
Cesare Pavese, Dialoghi con Leucò (Einaudi, 2014)
Élisée Reclus, Storia di una montagna (traduzione di Marcella Schmidt di Friedberg, prefazione di Mercedes Bresso, commento di Claude Raffestin, Tararà edizioni, 2008, ultima ristampa 2018)
Mario Rigoni Stern, Le vite dell’altipiano. Racconti di uomini, boschi e animali (Einaudi, 2013)
Henry David Thoreau, Walden ovvero Vita nei boschi (traduzione di Luca Lamberti, Einaudi, 2015)
Il ragazzo selvatico è disponibile anche in versione cartonata, con sedici preziose illustrazioni originali di Alessandro Sanna.
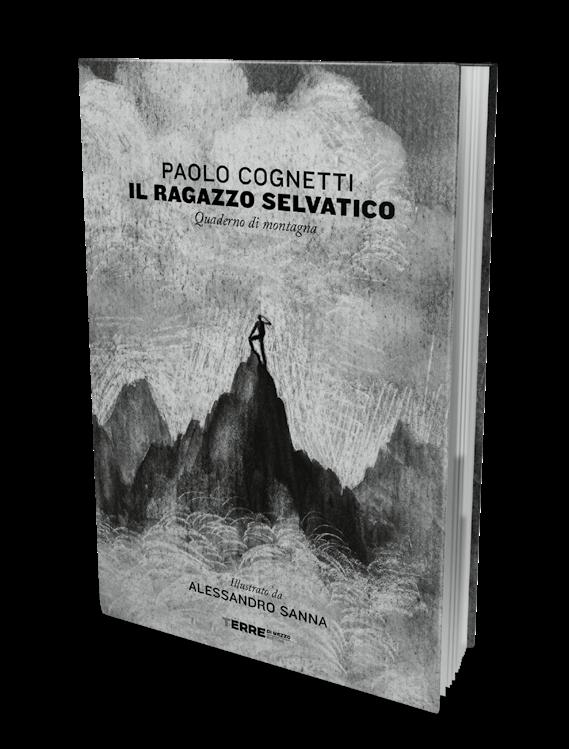
“Non
aspettatevi trame sofisticate o fuochi d’artificio. Cognetti preferisce le magie silenziose.”
– Tuttolibri