

Annuario
Caro Lettore,
apriamo l’edizione della nostra rivista inserendo il significato di una parola, tutt’altro che scontato. Cos’è un ecomuseo? Perché da molti anni la nostra associazione è L’ ecomuseo di Riva Valdobbia-Valle Vogna, riconosciuto dalla Regione Piemonte, ci sembra pertanto importante iniziare da qui...
Il Team
Finalità degli Ecomusei:
• favorire progetti di sviluppo sostenibile del territorio che mettano in relazione cultura, ambiente, cura del paesaggio, agricoltura, formazione, turismo e inclusione sociale attraverso la partecipazione di abitanti, associazioni, amministrazioni locali e istituzioni scolastiche;
• riservare particolare attenzione alle competenze tramandate oralmente a vantaggio delle nuove generazioni attraverso percorsi didattici ed educativi;

• valorizzare il patrimonio linguistico piemontese attraverso confronti intergenerazionali e interculturali;
• salvaguardare l’archeologia industriale attraverso il recupero, il ripristino funzionale e la nuova destinazione d’uso di fabbriche, opifici, mulini, officine, miniere, ecc.;
• favorire attività economiche sostenibili attivando laboratori tematici con lo scopo di recuperare le attività agrosilvopastorali e artigianali, mettendole in relazione con le industrie locali e le nuove tecnologie;
• favorire la conoscenza dei prodotti tipici locali, coinvolgendo produttori, operatori turistici, residenti e visitatori;
• adottare logiche di rete e processi partecipati, su ispirazione della Convenzione Europea del Paesaggio, della Convenzione di Faro e dei trattati internazionali dedicati alla salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e immateriali, attivando scambi di esperienze e favorendo progetti condivisi con altri ecomusei, musei e istituti culturali.
(dal sito della Regione Piemonte settore Ecomuseale)
Presmell
Presmell in collaborazione con il Palazzo dei Musei - Museo Calderini di Varallo presentano
DIGITALIZZAZIONE DELL’ERBARIO
Digitalizzazione dell’Erbario di Fanerogame dell’abate valsesiano Antonio Carestia, conservato al Museo Calderini di Varallo. L’erbario, organizzato in 15 cartelle, è costituito da 1.013 fogli; sono invece 1.391 le specie botaniche rappresentate, per un totale di 1.922 esemplari. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Presmell, Associazione Culturale Walser Ecomuseo Valle Vogna e Palazzo dei Musei di Varallo.

MOSTRA ITINERANTE


Troverete alcuni tra i campioni più interessanti dell’erbario digitalizzati esposti tra le vie di Riva Valdobbia
24 LUGLIO 2021 - ORE 16:30
TEATRO DI RIVA VALDOBBIA
“TI SALUTO ANCOR VALDOBBIA MIA”
Tavolo di lavoro sulle ricerche dell’Abate Carestia e presentazione dell’Annuario 2020 con la partecipazione straordinaria del biologo ed erpetologo svizzero, Philippe Golay. Intervengono: Massimo Bonola, Marta Coloberti, Sabrina Contini, Roberto Fantoni.
8 AGOSTO 2021 - ORE 10.00/12.00 - 14:30/16:30

TEATRO DI RIVA VALDOBBIA
COME SI REALIZZA UN ERBARIO
Laboratorio per bambini (6/14 anni) in collaborazione con il Museo Calderini di Varallo. Il Conservatore del Museo, Marta Coloberti, insegnerà come fare un erbario.
Prenotazione obbligatoria via email a associazione.presmell@gmail.com
Presmell Associazione Culturale Walser
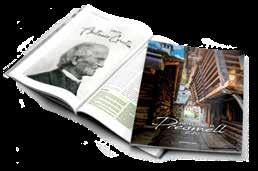

Ecomuseo della Valle Vogna - Alagna Valsesia www.vallevogna.eu

associazione.presmell@gmail.com
@associazione.presmell



ATTIVITÀ 2021
Siamo lieti di parlarvi della collaborazione che ha dato vita ad importanti iniziative in ambito di tutela del patrimonio culturale e della sua divulgazione. La partnership creata con il Museo Calderini di Varallo in nome della memoria dell’Abate Carestia e delle sue ricerche, ha aperto le attività del 2021.
Nella locandina a fianco il calendario delle iniziative svolte, durante le quali, per le vie di Riva Valdobbia, veniva esposta una piccola rappresentazione delle 1013 cartelle componenti l’erbario dell’Abate, conservato presso il Museo Calderini.
Ringraziamo Patrizia Cimberio per lo studio grafico e realizzazione.
La digitalizzazione dell’erbario rappresenta un’importante opera di salvaguardia che ha reso fruibile la collezione, altrimenti non visibile al pubblico.
A n e m o n e S u l f u r e a
Erbario Carestia

N. inv. I.2.2 Museo Calderini - Varallo
P u s a i l l a a l p n a ( L ) D e l a r b r e s s p a p i i f o a S c o p ) N y m a n A N E M O N E S U L F U R E A F a m R a n u n c o l a c e a e
D e s c r i z i o n e E s e m p l a r e r a c c o t o d a l A b a t e C a r e s t i a n e a p r m a v e r a d e 1 8 6 3 i n V a l l e V o g n a S p e c e p e r e n n e o s s c a c a r a t t e r i z z a t a d a c o o r g i a o n e n s o e d a u n ’ n f r u t e s c e n z a f o r m a t a d a a c h e n i c o n c o d a p i u m o s a l u n g a e v s t o s a , p e r s s t e n t e i n o a l n v e r n o p r e s e n t e s u t u t t o a r c o a l p i n o F i o r i s c e t r a m a g g i o e a g o s t o d a 1 5 0 0 a 2 5 0 0 m n V a l s e s a è d i f f u s a n t u t t a a v a l l e E t i m o l o g i a P u l s a t l a d a p u s o s c u o t e r e m u o v e r e , p e r a c o d a p i u m o s a d e l a c h e n i o c h e s i
RICHIEDICIILNOSTRO ANNUARIO2020 CONLARUBRICADEDICATA ALL’ABATECARESTIA
S c o p r i d o v è s t a t o r a c c o l t o q u e s t o f o r e !
C o n p a r o c n o u n o n e m o n a n a d e c o m u n d a v a s e a
C o m u n d a a g n a v a s e s a
II EDIZIONE
LOC. RIVA VALDOBBIA - ALAGNA VALSESIA
29-30-31 LUGLIO / 1 AGOSTO 2021
Spïnne, spïnne ds ganza spïnne...
PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA LANA E DELLA CANAPA LOCALI
nella splendida cornice del monte Rosa
GIORNI DI FORMAZIONE (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA VIA EMAIL - POSTI LIMITATI)
TEATRO DI RIVA VALDOBBIA
GIOVEDI 29 LUGLIO 2021 - ORE 14.30-17.30 - FELTRIRE

VENERDI 30 LUGLIO 2021 - ORE 14.30-17.30 - TESSERE
SABATO 31 LUGLIO 2021 - ORE 14.30-17.30 - FILARE
DOMENICA 01 AGOSTO 2021 - ORE 14.30-17.30 - TINTURA NATURALE

CONVEGNI
TEATRO DI RIVA VALDOBBIA
VENERDI 30 LUGLIO 2021 - ORE 17.30 - CONVEGNO “LANA DA RIFIUTO
A RISORSA E RIANNODARE IL FILO”
SABATO 31 LUGLIO 2021 - ORE 17.30 - CONVEGNO “LA FILIERA DELLA CANAPA
E L’IMPATTO SUL NOSTRO ECOSISTEMA: LE COLTURE DELLE ALTE TERRE”

PER BAMBINI (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA VIA EMAIL - POSTI LIMITATI)
TEATRO DI RIVA VALDOBBIA
DOMENICA 01 AGOSTO 2021 - ORE 10.00/12.00 - 14:30/16.30
LABORATORIO DI TESSITURA PER BAMBINI DAI 6 AI 14 ANNI



MERCATO (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ESPOSITORI VIA EMAIL)
TRA LE VIE DEL CENTRO DI RIVA VALDOBBIA
DOMENICA 01 AGOSTO 2021 - TUTTO IL GIORNO
APERTO A CHI LAVORA LE MATERIE PRIME LANA E CANAPA IN OGNI LORO VARIANTE CON CREATIVITÀ
E SAPER FARE. SECONDO IL PRINCIPIO DELL’USO
DI MATERIE PRIME LOCALI E NON INDUSTRIALI
Presmell Associazione Culturale Walser
Ecomuseo della Valle Vogna - Alagna Valsesia
www.vallevogna.eu
associazione.presmell@gmail.com
@associazione.presmell

29-30-31 luglio - 1 Agosto 2021
SPÏNNE, SPÏNNE DS GANZA SPÏNNE...
Riva Valdobbia - Giornata per la valorizzazione della lana e della canapa locali
Siamo giunti alla seconda edizione dell’evento Spinne… Spinne… Filare… Filare…
La lavorazione della lana e della canapa hanno caratterizzato per secoli i nostri territori e sono patrimonio storico del nostro saper fare tradizionale. Pensiamo che mantenere viva una tradizione non sia solo rispettoso ma interesse del territorio stesso e del suo mantenimento.
L’edizione del 2021 è stata ricca di partecipazioni e nuove amicizie. I corsi di formazioni alle arti artigiane hanno riscosso grande interesse: feltrire, tessere, filare e tingere ed i convegni introdotto ad interessanti argomentazioni in merito al mantenimento dell’ecosistema delle alte terre ed al racconto di diverse testimonianze di chi mantiene una tradizione facendone la propria attività lavorativa.
LOC. RIVA VALDOBBIA - ALAGNA VALSESIA 1 AGOSTO 2021
OCCASIONE DELLA FIERA SPÏNNE, SPÏNNE DS GANZA SPÏNNE...



Insieme per la Valsesia
PROGETTO
SOS-teniamoci
Le associazioni Circuito Viola OdV, Archimede Lavoratori Speciali APS ANffAS Valsesia onlus e Igea OdV hanno il piacere di presentare il Progetto SOS-teniamoci a sostegno di persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso il coinvolgimento, con attività e iniziative, della rete culturale, sociale, artistica e naturalistica del territorio. SOS-teniamoci è un progetto di aiuto e sostegno alle famiglie che conoscono la disabilità, con questo progetto ci poniamo obiettivo di offrire un opportunità di incontro di stimolo e di crescita con proposte di attività e iniziative sul territorio; creare spazi di accoglienza e di ascolto alle famiglie e favorire una cultura della condivisione e della sostenibilità sociale.

Il progetto è stato realizzato con il contributo di Fondazione CRV e con la collaborazione di Presmell Associazione Culturale Walser Ecomuseo della Valle Vogna e Fondazione
Valsesia Onlus
PRESMELL Associazione Culturale Walser Ecomuseo della Valle Vogna
Presmell opera da anni per la salvaguardia del patrimonio culturale locale, occupandosi di ricerca e divulgazione storico-culturale.
L’opportunità di condividere e costruire insieme ad altri enti locali percorsi virtuosi è per noi una grande opportunità.
Tutte le nostre attività dimostrano una fervida volontà di costruire reti solide che portino nostri progetti a risultati efficaci e costanza nel tempo.
Ringraziamo SOS-teniamoci e Fondazione CRV per aver accettato il nostro invito ed averci sostenuti.
25/26 settembre 2021
VISITA DELL’UFFICIO UNESCO – MINISTERO DELLA CULTURA
La Cultura Walser si candida a Patrimonio dell'umanità Unesco.
L'iniziativa è dell'Associazione Internazionale Walser, che ha riconosciuto nella Valsesia, in Piemonte, il punto di partenza di un progetto che coinvolge anche altre tre nazioni custodi del patrimonio dell'antica popolazione germanica dei Walser: Austria, Svizzera e Francia.



Il via ufficiale a Varallo Sesia, con il presidente dell'Associazione Internazionale Walser Paul Schnidrig, presente Elena Sinibaldi per l'ufficio Unesco del Ministero della Cultura.


Obiettivo, salvaguardare e rendere visibile il patrimonio culturale del popolo Walser: non solo monumenti e oggetti, ma anche linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, pratiche concernenti la natura e l'artigianato tradizionale. E' un patrimonio soprattutto immateriale, ritenuto fondamentale per il mantenimento della diversità culturale di fronte alla globalizzazione.
La candidatura, nasce dalla volontà di non ridurre questo patrimonio a delle coordinate geografiche, ma di estendere a più campi possibili e comunicare tramite mezzi innovativi questi preziosi e unici saperi.
Il ministero della cultura italiano ha aperto ufficialmente l’avvio della pratica mentre lo stesso processo avveniva in sede agli altri stati membri.
Il prossimo passaggio formale sarà il coordinamento dei ministeri della cultura per l’avvio della scrittura di una candidatura di carattere internazionale, la quale vaglierà le istanze congiunte di tutte le comunità partecipanti.
7 Agosto 2021 PRESENTAZIONE LETTERARIA

Corte della casa parrocchiale di Riva Valdobbia
LA CENA DEI COSCRITTI
SCRITTORE MICHELE MARZIANI
7 agosto 2021
Corte della casa parrocchiale di Riva Valdobbia
ore 17:30
Presentazione letteraria del libro “La cena dei coscritti” di Michele Marziani a cura dello scrittore Matteo Bertone
DOVE GHIACCIO ATTENDE
SCRITTORE MATTEO BERTONE
11
agosto 2021
Corte della casa parrocchiale di Riva Valdobbia
ore 17:30
Presentazione letteraria del libro “Dove ghiaccio attende” di Matteo Bertone a cura dello scrittore Michele Marziani

Presso la Corte della casa parrocchiale di Riva Valdobbia si è svolta la presentazione di due novità letterarie. Matteo Bertone e Michele Marziani, i due autori, ci hanno portato in viaggio in ambiente montano, seppur con modalità diverse.
25/26 settembre 2021
INTERNATIONALE VEREINIGUNG FUR WALSERTUM
Alagna Valsesia
Quest’anno ad accogliere l’assemblea annuale dell’Internationale Vereinigung fur Walsertum è stata Alagna.


L’associazione internazionale Walser con sede a Brig da più di 50 anni riunisce tutte le comunità Walser d’Europa ed è l’ente di coordinamento delle maggiori iniziative in seno alle comunità walser, in particolar modo il Walsertreffen che nel 2022 torna in Italia ad Ornavasso. L’associazione internazionale ogni anno vede i membri del direttivo generale riunirsi in una località diversa del panorama Walser. Il consiglio si è svolto nella mattinata di sabato 25 Settembre, mentre nel pomeriggio i numerosi partecipanti hanno potuto visitare Alagna e la Valle Vogna.

Sabato sera ospiti dell’amministrazione Comunale hanno consumato un impeccabile cena Valsesiana e domenica mattina hanno partecipato alla Santa Messa ed alla fiera di San Michele a Riva Valdobbia.
La pro loco di RivaValdobbia ed il Gruppo Folkloristico Walser Imland hanno organizzato un accogliente pranzo presso Unione Alagnese. Siamo certi che una visita così ricca di eventi rimarrà presente nella memoria degli amici Walser delle altre comunità.


viciniAmici, e lontani
Chiunque frequenti la Montagna sa che può essere fonte di ispirazione. Mondi intrisi di storie dalle radici profonde e dai paesaggi inebrianti.


Nuove esperienze di chi vuole ricominciare qui.. in montagna.

O di chi se ne andato ma ha lasciato qui un pezzo di cuore.
Amici, vicini e lontani... chi con passione documenta e ci racconta tratti distintivi delle Alte Terre.
Paesaggio, patrimonio culturale e tradizione racchiusi nelle loro parole.
Ricordo da Campello Monti
Di mia nonna Tensi Erminia, da tutti chiamata “Minia”, conservo un affettuoso e grato ricordo.
Era una donna piuttosto minuta che indossava abitualmente il costume tipico della Valle Strona, col foulard sulla testa e, ai piedi, le tipiche calzature che corredavano il costume (scufugn). Lei ed il nonno abitavano a S. Rita a Crusinallo.
La nonna Minia aveva uno sguardo dolce e sereno; ero il suo primo nipote, figlio del suo figliolo maggiore e forse per questo mi sentivo speciale per lei, come, del resto, lei era per me. Ogni anno, a primavera inoltrata, mia nonna si preparava per andare a Campello: nello zaino metteva poche cose indispensabili e nel gerlo sistemava due o tre galline ovaiole dopodiché si recava alla fermata della corriera che, a quel tempo, percorreva la tratta Omegna/Forno e ritorno con quotidiana regolarità; si trattava di un mezzo vetusto ma affidabile, con circa 25 posti a sedere. Da Forno la nonna raggiungeva a piedi Campello, dove possedeva la casa dov’era nata. Giunta lassù, sistemava in poco tempo quanto aveva portato con sé perché nella casa aveva tutto quanto le poteva servire, di mobili, stoviglie ecc. In quanto ai generi alimentari, a quel tempo a Campello era ancora attivo un negozietto di generi alimentari/tabaccheria. Le tre galline le garantivano le uova; di giorno sarebbero state libere di muoversi e di notte avrebbe provveduto a rinchiuderle in cantina per evitare loro i pericoli notturni. Il nonno l’avrebbe raggiunta più avanti e per breve tempo perché egli lavorava ancora, nella torneria Pianella di Omegna, situata in Via De Angeli, poco prima del Ponte sullo Strona. Quando le scuole chiudevano i battenti, anch’io mi preparavo per raggiungere la nonna lassù, nella verde cornice dei monti, fantastico mondo per i miei giochi di bambino, dove l’aria era frizzante, pulita, fragrante di quel vago sentore d’erbe e fiori.
La nonna Minia non si stancava di raccomandarmi di non avvicinarmi al fiume e tuttavia spesso non sapevo rinunciare a quella cordicella legata ad un bastoncino con cui mi improvvisavo pescatore. Quelle piccole e semplici felicità estive mi hanno accompagnato a lungo nella vita e peccato che allora non sapessi approfondire di più, con opportune domande, i ricordi di mia nonna.
In particolare ricordo l’estate del 1953; avevo circa nove anni e nell’anno scolastico appena concluso, ero passato, dalla precedente pluri-
classe di San Fermo, alla scuola di Crusinallo.
Lì la nuova Maestra ci leggeva settimanalmente dei brani dal libro “Cuore” di Edmondo De Amicis, non solo le pagine di diario ma, in specie, i racconti inseriti, particolarmente coinvolgenti per quasi tutti noi scolari. Avvenne così che, durante un pomeriggio in cui un temporale estivo mi aveva costretto in casa e mi ero rassegnato alla lettura ad alta vocegiusta raccomandazione dell’Insegnante per i compiti delle vacanze - qualche pagina del libro Cuore la nonna, seduta accanto a me ed affaccendata con il suo cestino da lavoro, prese a raccontarmi di suo padre, il mio bisnonno Tensi Giovanni, soprannominato Tossero. Di come fosse rimasto orfano, ancor bambi-
no, di entrambi i genitori ed affidato allo zio Tosseri Bartolomeo - da cui il soprannome “Tossero” che lo accompagnò per tutta la vita. La nonna Minia me lo descrisse come un padre intelligente, che aveva studiato il latino, dalla mentalità aperta al punto che, alla fine dell’800, mentre i figli davano del “voi” ai genitori, Giovanni Tensi affermava che “I figli a chi si devono rivolgere usando il “tu” se non ai genitori? Il rispetto che deve esserci tra genitori e figli non è certamente col “voi” che si estrinseca”. Era un genitore severo ma non accettava che altri alzassero le mani sui suoi figli. A quel tempo il parroco svolgeva anche la funzione di maestro elementare e, com’era normale allora, puniva gli scolari anche con qualche scapaccione. Giovanni Tensi non lo tollerava, tanto che diffidò pubblicamente il parroco dal picchiare i propri figli.
Gli anni sono passati ma, in quel pomeriggio di una lontana estate, un seme venne piantato nel mio cuore e più avanti, nella vita, germogliò. Campello per me divenne storia, divenne ricerca delle radici della memoria di coloro che, nel tempo, avevano partecipato ai cammini dell’evoluzione di quel piccolo paese in cima alla Valle Strona, ai collegamenti che Campello aveva intrattenuto con gli altri popoli walser.
Il bisnonno Tossero aveva fatto parte di quella storia; era nato e cresciuto lì, si era sposato ed aveva avuto diversi figli e nipoti ed uno di quei nipoti era mio padre, Raimondo Ballestroni, da tutti conosciuto come Vittorio.
Carcoforo, val d’Egua I riti del Natale e della tradizione religiosa
Della VedovaScrive Girolamo Lana nel 1840, nel capitolo dedicato a Carcoforo, nella sua “Guida ad una gita entro la Vallesesia”: “Non avvi, né può esservi altra industria di quella rivolta all’esercizio delle arti e mestieri al di fuori della patria. Secchionari e stuccatori sono la maggior parte di questi abitanti, che vanno in Lombardia e nella Francia a far valere le loro abilità. Parecchi si guadagnarono nome di bravi artisti e la famiglia Bertolini ebbe de’ valenti stuccatori e procacciossi una discreta fortuna”.
Come da tradizione gli uomini andavano a lavorare lontano, anche in Svizzera come l’arch. Bertolini, o in Germania come i Rappa, o in diversi paesi europei con i rimesi del marmo finto come Giuseppe Ragozzi e Amilcare Bagozzi; il paese era quindi in mano alle donne e ad alcuni anziani. Il periodo invernale, con i rigori della stagione fredda, era il momento del rientro a casa, con la riunione delle famiglie; quindi l’atmosfera di festa era ancora più sentita, e poi portavano le novità dai paesi dove lavoravano, e qualche omaggio come le sete e i velluti per i costumi, e durante
l’inverno si prodigavano in migliorie alle case e alle chiesette del paese. E infatti le feste del Natale e poi quelle dell’inverno, erano l’occasione per indossare i deliziosi costumi, gli abiti delle feste, che le donne si erano realizzati a mano, o che si tramandavano di generazione in generazione, e che venivano arricchiti con “nastri di seta”, spighette, ricami realizzati a mano, e con il mucareu di seta o di lana in testa, che in alcune occasioni arrivavano dalla Russia o dalla Francia.
Marta Dellavedova dice: “negli anni ’60 a Carcoforo si teneva la Novena di Natale in latino, ero piccola ma la ricordo con emozione, con gli uomini nel coro, le donne in platea che partecipavano al canto del “Tantum Ergo” e il “Regeventurum dominus”, alternandosi. Era una celebrazione con una certa solennità e mi stupiva quel rituale così partecipato rispetto alle funzioni normali in cui, anche allora, c’erano quasi solo donne, anziani, e pochi bambini, tanto che per anni ho fatto spesso il chierichetto perché non c’erano molti ragazzi. Altri canti erano il “Venite Adoremus” che si canta ancora oggi, la Novena ha continuato ad essere importante fino a pochi anni fa, … anche se quasi completamente in italiano. Ricordo i breviari sotto alle sedute riservate agli uomini”.
Ida Maria Pia Dellavedova si ricorda che quando arrivò a Carcoforo, nel 1955, la Messa
degli Angeli, quella a più voci, veniva cantata con una tonalità molto diversa rispetto a quella usuale… e così dovette impararla. Pia, per oltre 50 anni ha abbellito la chiesa con i fiori dei campi e del suo orto-giardino, ogni sabato ha dedicato a S. Croce: pulizie, cambio tovaglie, addobbi e confezionamento delle corbeilles di rami d’abete e fiori dei campi. In inverno usava rami di abete e fiori secchi. Ora le è succeduta Denise, per la chiesa grande, mentre altri seguono le altre chiese, cappelle e croci, ne parleremo in altre feste e incontri. A suo tempo in occasione della Novena, si suonava fisicamente sulle campane, andando direttamente sul campanile, Emma Dellavedova si ricorda che si diceva “numma a ciqùtee (o ciccòtee?)”, a suonare, Enrico Agnesetti dice che era Antonio Quazzola il maestro dei musicisti. Salivano vicino alle campane, lo raccontava Sergio Manetta, e ancora Leandrin Bertolini e Mario Sesone raccontano che: “vi erano delle tavolette di legno con delle corde che quando colpite provocavano il rintocco delle campane”, il gruppo delle campane veniva "portato in piedi e poi fatto ruotare, ed era anche un po’ pericoloso per il poco spazio”. Mario Sesone riporta che una volta si staccò il grosso battacchio della campana grande...per fortuna nulla di grave, ma fu un grosso spavento per i presenti! Un problema poi era costituito dal freddo, che a volte era “attanagliante” dovendo restare lassù a lungo… si premunivano di calde acqueviti alla “reis ‘d gentiana” (radice di genziana) per riuscire a resistere!”
La Chiesa principale è intitolata alla “Santa Croce”. La Parrocchia fu eretta nel 1618, quando si staccò da Rimasco. Maurilio Dellavedova aveva chiesto di scrivere che fin dal 1510 esisteva a Carcoforo una chiesetta dove venivano celebrati battesimi, matrimoni, funerali e sepolture (il vecchio cimitero venne poi spostato alla Madonna del Gabbio Grande o Beata Vergine della Neve. Il battistero lapideo elemento più antico della chiesa già esistente prima dell’arrivo dei vescovi post tridentini in Villa Carcoffori.
La prima visita pastorale documentata fu di Mons. Carlo Bascapè nel 1594. La reliquia di Santa Croce fu portata nel 1709 e fu collocata nell’altare di legno policromo decorato a finto marmo artificiale, realizzato da vari artisti
valsesiani, restaurato e celebrato nel maggio 2011. “La reliquia di Santa Croce veniva esposta, al suono delle campane, solo nelle solennità o per motivi eccezionali”.



Si narra che fu portata da Roma da tre carcoforesi tutti e tre di nome Giacomo: Ragozzi, Cacciauccelli e Bertolini) i quali, a missione compiuta, indugiarono sul sagrato della chiesa quasi che non fosse bastato il viaggio, a chiacchierare ancora a lungo tra loro. Nelle ricorrenze solenni alla luce delle candele risplendevano pregiatissimi reliquari lignei edi meravigliosi damaschi dei paramenti degli officianti (nelle immagini una pianeta “a giardino” stupenda).
Si legge nei documenti conservati nell’Archivio Storico della parrocchia di Carcoforo (ASPCa; Inventari) “la navata è di antichissima ed immemorabile costruzione”, ignorandogli l’epoca, con un culto molto singolare che viene indicato come: “Il titolare della Parrocchiale è l’Invenzione di Santa Croce”, dietro all’altare principale una grande ancona con tavola dipinta, che rappresenta la Crocefissione di Gesù, con una ricca cornice scultorea dorata, opera di artisti locali. “Il Presbiterio e Coro venne ricostrutto nell’anno 1729”.
“Il lampadario di mezzo è dono delle sorelle Maria e Maddalena Bertolini dette del Tetto Minocco, e comperato a Milano da Carlo Martinetti, (…). I lampadari laterali furono da me comperati a Milano nel negozio del Silva in Galleria e sono altresì un dono delle sorelle Catterina e Rosa Bertolini dette del Ponte. Le catene indorate eseguite a Novara dal signor Giuseppe Polizzi e sono dono di Margherita Cacciauccelli vedova (…). Il padiglione di seta antica da me comperato dalla Chiesa Parrocchiale di Galliate, e fatto tingere in rosso, essendo bianco, è dono di Domenica Dellavedova, la corona che lo sostiene è parimenti dono della stessa e fu eseguito a Galliate (…)”.

Il Parroco Tamiotti nei suoi registri è assai minuzioso nei dettagli, a quel tempo le famiglie pagavano la cera delle candele con prodotti come un coppo di sale, un carico di legna, lana, formaggio, burro (a volte anche un agnello) alla parrocchia e il parroco o il viceparroco aveva anche il compito di dare lezione ai “figli della parrocchia”, non essendoci un maestro in paese.
A Natale, e in tempo di avvento, ancora oggi si innalza un pesante tendone rosso carminio a coprire l’ancona con la crocefissione (essendo grande e pesantissimo occorre essere almeno in due per farlo salire in alto).
Sempre a Natale in paese molte sono le abitazioni con luci, presepi e addobbi natalizi e spesso la coreografia è completata dall’innevamento copioso, qualche fiocco
la notte di Natale completa la creazione di un’atmosfera speciale per i brindisi nei locali pubblici o a casa con gli amici e a volte anche in piazza della Chiesa dopo la Messa di Mezzanotte. Davanti al portico laterale di Santa Croce i più giovani realizzano un grande presepe con la base di fieno o di muschio e così si ricrea la magia della Natività a Betlemme e gli auguri tra i presenti rallegrano gli animi con sorrisi e tante buone parole, che fanno sempre bene. La comunità è da sempre molto religiosa e molto legata a uno stile “low profile”, rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni, non consumistico, che cerca di valorizzare il territorio e i suoi prodotti, oltre ai suoi riti. Nelle abitazioni davanti alle stufe e ai camini, con le calze di lana, realizzate a mano dalle
nonne, piene di dolcetti per i nipotini, si scambia qualche regalo: non è mai stato un paese consumista perché c’erano limitate possibilità di acquisto. La cultura del risparmio e del “farsi bastare” quel che si ha è sempre stata uno stile di vita: il pane fresco veniva prodotto in poche occasioni al forno del paese, dove veniva preparata la “farina verda söcca par i gnocheit”, raramente la carne, suppe, e il Natale era il periodo più importante, proprio per la possibilità di riunire le famiglie, dopo tanti mesi di assenza dei mariti e congiunti uomini. Tutti i giorni invece il pane era costituito dalle miacce (un tempo fatte con miglio o altri cereali ora con farina bianca) o dagli sparöi (con farina di meliga o mais).
Mi ricordo che decenni fa c’erano i pacchi dono dell’Ente Comunale d’Assistenza e a volte degli Alpini che organizzavano il “Natale Alpino”, così anche le famiglie meno abbienti avevano dei doni da scartare. Sui davanzali delle finestre alcuni ponevano una candela e qualche po’ di cibo per le anime lontane… quasi a voler rinsaldare un legame rassicurante con gli avi o con i poveri.
Il giorno seguente, il 26 dicembre Santo Stefano, si celebrava e si celebra ancora la festa del co-patrono, e negli ultimi tempi, qualche volta ha sostituito la S.S. Messa di Natale per motivi di maltempo. Al termine della funzione si tiene l’incanto delle offerte dei fedeli sempre presenti: prodotti del territorio: tome, oggetti in legno o puncetto e punto croce, uova, burro ecc. e di solito è seguito da un aperitivo delle associazioni locali e dei gestori di attività del luogo. E’ un momento di socialità, sotto il porticato, o sulla piazza della chiesa a seconda del clima meteorologico, in cui ci si svaga anche con risate e giochi al rialzo nelle offerte
per accaparrarsi i doni, similmente a quanto accade nelle feste estive.
Il pregevole organo del 1845 opera di Bartolomeo Gippa di Sabbia riempie la chiesa con il suo suono imponente, grazie a Valenti organisti come da tradizione, scendendo dalla sinuosa cantoria (Casimiro Debiaggi ha fatto notare “il singolare andamento flessuoso barocco e i dipinti con strumenti musicali” durante la visita guidata della Società valsesiana di Cultura del 8 agosto 2009, secondo quanto raccontato da Piera Mazzone) e armonizzando le voci nei canti.
Ricorda Emma Dellavedova: a Santo Stefano, sotto al portico viene distribuito alle donne un cero (bianco per le vedove e a fiori per le altre) in cambio di un'offerta. Il cero verrà restituito al termine della SS. Messa al momento del bacio al busto/ reliquia del Santo Martire. Fino a qualche anno fa si organizzava anche una sorta di lotteria che prevedeva come premi un foulard per le donne e un cappello per gli uomini, o un paio di scapin di pezza (il riciclo era la norma!)
Qualche anno fa, dice Marino Sesone: “a Santo Stefano abbiamo ripreso a tramandare l’antica tradizione che prevedeva “4 persone con una tunica blu/ azzurro (il Mons. Bascapè nella sua visita del 1594, aveva prescritto abiti “di colore celeste” per la stagione invernale per i rappresentanti della Compagnia del SS. Sacramento. (...per mancanza di confratelli), portanti 4 grossi ceri o meglio candelabbri storici di legno e metallo, che venivano posizionate ai lati dell’altare durante la Santa Messa”.

Dice Gian Dellavedova: “mi ricordo anch’io, dai racconti di Maurilio, in precedenza era anche prevista una breve processione tra le case, da piazza della Chiesa a piazza delle Mule fino a anciuma la Villa, all’ Oratorio della Pace, intorno a ca’ d’Iorio e rientro, con un baldacchino e i costumi color del cielo”. L’officiante ancora oggi indossa la pianeta di colore rosso guarnita con decori dorati. In occasione delle feste, alcune persone del paese, altri originari del borgo e villeggianti storici indossano, come un tempo, il costume della tradizione walser, che è realizzato ancora oggi utilizzando manufatti, come l’abito detto “patela” in lana, “le ghette “uose in lana di pecora”, i “ligaim” (nastri in lana e seta realizzati a telaio), le camicie con il puncetto anche detto punto saraceno: le tipiche trine che alcune
donne del paese ancora sanno produrre con maestria: Cornelia, Caterina, Orsolina, Emma, Piera e anche alcune che vengono da lontano come Giovanna. E per gli uomini un elegante abito con gilet, camicia e cravattino e cappello di mezzalana. “Nessuno che osasse togliersi la giacca o allentare il nodo alla cravatta”, racconta Ugo Cicardi nel suo filmato storico. “I balli si tenevano nel periodo natalizio per il rientro dei migranti. Verso sera la campana chiamava la novena (ndr: per 9 giorni) dava da lontano a
Creator”. Al termine il Te Deuss “(ASPCA: Relazione del parroco Tamiotti)
Sacerdote Luigi Tamiotti nel 1840 “in questa parrocchia avvi un solo fabbricere per ogni altare” (…) Un tempo c’era anche un particolare, che forse recupereremo nelle prossime manifestazioni, il Priore, di cui si conserva il quadro con l’elenco aggiornato a prima del covid. Il Priore entrava in Chiesa alla Festa di fine gennaio, con un mazzolino di fiori sul bastone della festa. E lo si vede ancora nelle foto ottocentesche, alle feste di matrimonio accanto agli sposi, e al Morgno e alla Morgna, le due figure familiari che si impegnavano a dare un supporto agli sposi novelli.
Un tempo facevano il pizzo detto “puncetto” per i costumi Caterina, Cecilia, Giulia, Elvira, Matilde, raccolte attorno al camino con i più piccoli o vicino al fornello di pietra ollare che scaldava tutta la “schtua”.
Oggi: Cornelia, Emma, Giovanna, Graziella, Orsolina, Piera.

O come gli “scapin”, le calzature realizzate a mano con il riutilizzo dei tessuti degli abiti usati, con tecniche antiche che ancora vengono tramandate dagli artigiani, come fa Piercarlo Francione con i corsi delle Botteghe operaie e dei commercianti delle contrade di Varallo.
Credenze e superstizioni popolari

chi tornava il saluto del paese natio. Nella casa al calore del camino o della tradizionale stufa in pietra della Gula (pietra ollare) la fidanzata e la sposa aspettavano, talvolta già al crepuscolo sorgeva la luna”.
Le ragazze da marito indossavano la camicia ottocentesca con il bordino rosso a ornare il collo di puncetto (che abbiamo ancora!), le donne in lutto tutte in nero, quelle in mezzo lutto in viola o marrone…e ci sono molte altre particolarità che sarebbe interessante approfondire.

“All’ingresso in chiesa si cantava l’inno “Veni
Grazie a tutti gli amici di Carcoforo, con i quali ci siamo sentiti, scritti o visti, che hanno accettato di contribuire con i loro preziosi ricordi e aneddoti: se ne avete altri inviateli, sono una testimonianza che condivideremo con i più giovani per non perdere la memoria collettiva: Ada Ragozzi, Agnese Ragozzi, Barbara Giulio, Denise Sesone, Cornelia Bertolini, Elena Lacroix, Emma Dellavedova, Enrico Agnesetti, Gianfranca Dellavedova, Gianmario Cantono, Giovanna Riva, Graziella Bertolini, Ida Maria Pia Frigiolini, Johnny Ragozzi, Leandro Bertolini, Luca Gamberoni, Luciana Agnisetti, Maurilio Dellavedova, Massimo Orlandi, Mariangela Provasi, Marino Sesone, Marta Dellavedova, Maria Pia Dellavedova, Mario Sesone, Massimo Orlandi, Orsolina Lana, Piera Mazzone, Piera Ragozzi, Remo Bertolini, Rita Bagozzi, Roberto Fantoni, Vittorio Bertolini
Dopo alcuni mesi di lavoro incessante e febbrile, ma con la mente serenamente diretta ad un alto segno, nel nome augusto della nostra graziosa Sovrana, alta e benigna protettrice di questa nostra società, tutta intenta a cose patrie, io do lieto principio all'opera meditata.” Così inizia il discorso inaugurale della Società Nazionale per le Tradizioni popolari italiane sotto l'alto patronato di S.M. la Regina Margherita, letto nell'Aula Magna del Collegio Romano il 20 novembre, genetliaco di S.M. la Regina. S.M. amante della cultura, svolse un ruolo fondamentale nel processo di unificazione culturale e identità nazionale. Al suo fianco, la marchesa Paola di Villamarina, sua dama d’onore, dama di palazzo, molto intelligente e istruita, nata a Torino nel 1834 e morta a Gressoney-Saint-Jean il 23 agosto 1914. Tra le varie iniziative, troviamo anche questa opera, datata 1° dicembre 1893, dove vengono raccolte le credenze e superstizioni della nostra valle, in particolare quelle di Riva Valdobbia, proprio raccolte dalla marchesa Paola, che in quell’anno accompagnò Sua Maestà sia sul Monte Rosa che al Colle di Valdobbia. Personalmente la immagino parlare con i residenti facendosi raccontare tutte le usanze della zona, come un moderno Poirot; grazie a lei queste tradizioni possiamo ancora leggerle e tramandarle, storie e credenze che risalgono alla notte dei tempi, a volte bizzarre, ma sempre seguite dai nostri avi, frutto di secoli di esperienze e incroci di popolazioni che si sono incontrate sul territorio, vuoi per passaggio, vuoi per immigrazione alla ricerca di lavoro. Facciamone tesoro, e tramandiamole: in fondo è la nostra storia, l’esperienza dei nostri vecchi, magari mettiamole anche alla prova, non si sa mai….








Ruolo fondamentale dell'agricoltura alpina tradizionale per il mantenimento degli ecosistemi
favoriscono l'agricoltura dei grandi numeri, che mancano di attenzione alle esigenze fondamentali; a considerazioni superficiali dovute alla profonda mancanza di conoscenza in ambito ambientale e scientifico.
Énecessario essere consapevoli che l'agricoltura tradizionale alpina e la conseguente presenza dell'uomo sono indispensabili al mantenimento duraturo e alla valorizzazione della straordinaria varietà degli ecosistemi alpini.
Dal punto di vista conservazionistico l'ambiente alpino riveste una grande importanza per la bellezza e la rarità degli elementi naturali e per il modo in cui l'uomo ha trasformato questi territori in una millenaria storia di insediamenti. Gli agricoltori di montagna oltre a produrre risorse alimentari di altissimo livello, conservano e curano diversi ecosistemi caratteristici di pascoli e prati, paesaggi culturali di alto pregio che si distinguono per l' eccezionale biodiversità floristica e faunistica.
L'abbandono della montagna continua in parte ancora oggi ed è dovuto a varie strategie che
La presenza di una popolazione che si dedica ad un'agricoltura compatibile con l'ambiente ed adatta alla montagna, oltre a produrre prodotti tipici e di qualità, cura indirettamente l'ambiente conservando il paesaggio, prevenendo rischi naturali, evitando la perdita di biodiversità, salvagurdando le basi stesse della vita. Il paesaggio alpino è un mondo culturale molto antico che si è consolidato con il passare dei secoli, documentato in epoca romana sia da Strabone che da Plinio il Vecchio, ha preso le sembianze attuali nel Basso Medioevo con l’invenzione della falce fienaria e con la sostituzione parziale dell'allevamento ovino e caprino con quello bovino.


Furono dapprima prescelti i versanti meglio esposti e le altitudini meno elevate; particolare fu, successivamente, l'insediamento Walser capace di creare realtà autartiche a quote estreme facendo riferimento a tecnologie ingegne-
ristiche specifiche e a forte senso comunitario.

L'uomo sulle Alpi si è da secoli inserito, diventando un anello insostituibile, in quel complesso di relazioni biologiche che si studia e si esplora cercando di cogliere la dimensione relazionale e dinamica per capire quali sono le interazioni e gli elementi che permettono la vita. Infatti il sistema vita è molto di più di una somma di componenti; presenta un altissimo valore aggiunto nelle relazioni: essenziale è il fitto e intricatissimo scambio di informazioni che assicura ai componenti: organizzazione, ordine, stabilità, capacità di sopravvivere e di reagire ai cambiamenti soprattutto in un ambiente difficile come quello di montagna. La cultura rurale compatibile con l'ambiente continua a fondarsi su strategie lente e di lunga portata, su progetti che prendono come riferimento di unità temporale l'arco di vita degli alberi, la naturale stabilità dei mercati primari legati, la costruzione di case destinate a resistere alle generazioni. Il tempo lungo ha consentito potenti e stabili trasformazioni.
La fatica induce un rispetto implicito per il la-
voro proprio, degli altri, di chi ci ha preceduto e induce a seguire regole il più possibile aderenti alle leggi cicliche della natura.
Per rendere sostenibile i processi l'agricoltura tradizionale sulle Alpi ha concentrato le risorse sull'impresa iniziale nella quale venivano incanalate risorse eccezionali, competenze straordinarie: muri a secco, mulattiere, spietramento dei pascoli, case e strutture di riparo destinate a durare.
Una cultura che ci insegna regole fondamentali nella relazione con il Pianeta: la sostenibilità deve essere un ingrediente fondamentale delle imprese produttive, i costi monetari e ambientali dell'energia, dell'acqua, dei prodotti devono ritornare sotto controllo.
La presenza dell'agricoltura alpina è multifunzionale, non deve produrre oltre il limite di sostenibilità dell'ambiente ma è importante che continui a produrre migliorando le condizioni ambientali e paesaggistiche del contesto.
Le strategie di sviluppo e di riqualificazione ambientale devono percorrere lo stesso itinerario: è un gioco di squadra che richiede persone molto preparate, capaci di affrontare le sfide con la ricerca, lo studio, il confronto.
Osservando la vegetazione alpina ci si rende subito conto che uno degli aspetti caratterizzanti e la grandissima varietà di ecosistemi e comunità che compongono un mosaico finemente articolato. A determinare questa struttura a mosaico sono gli aspetti pedoclimatici ed in particolare tre variabili: altimetria, acclività ed esposizione.
Quando l'uomo si insediò sulle Alpi solo le praterie naturali al di sopra della vegetazione arborea si prestavano ad un uso immediato come pascolo. I fondovalle erano paludosi e i versanti erano ricoperti da fitte ed impenetrabili foreste. Per creare condizioni vivibili l'uomo modificò l'ambiente attraverso un processo di arricchimento ecologico.
La fascia boreale inferiore venne utilizzata per colture: segale, orzo, grano saraceno, lino e canapa e, a partire dalla seconda metà del Diciottesimo Secolo, patate.
I prati si intersecarono con i pascoli e non di rado vennero utilizzati nella duplice modalità: taglio estivo seguito da pascolamento autunnale. Nei secoli si realizzò quel paesaggio agro-silvo-pastorale positivamente modificato dall'uomo: reso più bello, attraente, ospi-
tale. Un paesaggio culturale creato attraverso processi generazionali, testimonianza di una modalità di interazione intelligente e lungimirante con l'ambiente utilizzato con equilibrio e consapevolezza del valore delle risorse.
Gli studi ecologici hanno evidenziato che l'abbandono di prati e pascoli porta ad un impoverimento della biodiversità, la loro presenza rappresenta quindi un servizio ecosistemico in quanto, per assolvere alla sua funzione, il cotico erboso presenta un assortimento di specie a diversa funzionalità: mentre le specie a taglia elevata hanno una prevalente funzione foraggerea, le specie con apparati aereo e radicali fitti, portamento prostrato, habitus a rosetta hanno ruolo antierosivo, trattengono l'acqua in eccesso, pacciamano e imbrigliano il suolo che migliora di struttura e portanza. Le specie spinose e quelle velenose difendono il manto erboso dall'eccessivo pascolamento, specie aromatiche e con fiori appariscenti creano relazioni, prima fra tutte quella con gli insetti impollinatori.
Una montagna di storie (di persone) di montagna
Un volume di A. Pascariello in occasione del cento cinquantennale di fondazione del Corpo Guide di Alagna (1872)
di Massimo BonolaLa storia di Alagna è stata condizionata in modo determinante dalla presenza del massiccio del Monte Rosa, che ha costituito per lungo tempo, e costituisce tuttora, l’orizzonte a cui si sono rivolti gli alagnesi per trovare sostegno economico per la loro comunità. Tale ricerca si è tuttavia storicamente mossa, quasi in modo simbolico, lungo due opposte direttrici verticali. Da un lato, infatti, si sono scavate le viscere della montagna, mentre dall’altro si sono conquistate, percorse e attraversate le pareti
NOTE A MARGINE
e le vette del massiccio. Entrambe queste esperienze hanno dato vita a percorsi professionaliquello del minatore e quello della guida alpinache malgrado possano sembrare radicalmente differenti mostrano, ad uno sguardo più attento, tratti e caratteri molto simili. Ad accomunare le due professioni è soprattutto la componente del rischio, che è stata, ed ancora nel caso delle guide alpine, assai rilevante […] Il contesto alagnese però si è dimostrato particolarmente interessante, in quanto tale duplice riferimento si delinea
in modo inconsueto. La contemporanea presenza di due attività- entrambe estremamente pericolose- come la discesa in galleria e la salita in vetta, ha portato a sottolineare spesso… come ad Alagna si facesse del rischio un mestiere, anzi due: si rischiava andando “in giù” come minatore e andando “in sù” come guida alpina»1
Con questa interessante analisi, tratta da una recente ricerca antropologica e sociale su Macugnaga, e da me opportunamente modificata2 sostituendo in questo testo la località della valle Anzasca con quella della Valsesia, Roberta Clara Zanini introduceva in modo illuminante il tratto caratteristico dei “mestieri del rischio” come componenti essenziali della società alpina, almeno e soprattutto dall’inizio dell’età moderna e poi più significativamente a partire dalla fruizione alpinistica e turistica del territorio montano, considerati dalle popolazioni valligiane anche come alternativa, o attività sussidiaria, a quella agro-pastorale di antica tradizione. La sostituzione nominativa e toponomastica che mi sono permesso di introdurre mi è stata suggerita, tra le altre cose, proprio dal libro di Pascariello Una montagna di storie, nella convinzione che ci siamo più analogie che differenze nelle trasformazioni sociali ed economiche delle due località, e che proprio questo tema, quello delle guide alpine e del loro ruolo nell’evoluzione della società
locale, ne sia l’evidente dimostrazione. Il libro in questione, Una montagna di storie. Il Corpo Guide di Alagna Valsesia, pubblicato nel 2021 ad inaugurare l’anno di celebrazioni per il cento cinquantennale del sodalizio alpinistico alagnese, pur essendo stato propiziato da questa importante occasione, non può dirsi però soltanto un libro “d’occasione”, ovvero celebrativo o commemorativo di questa particolare ricorrenza. Al contrario la sua lettura, che può svolgersi opportunamente a più livelli ed è ricchissima di notizie altrove irreperibili, solleva questioni rilevanti di storia sociale, economica e culturale della realtà alagnese, suggerendo chiavi interpretative stimolanti per comprendere il suo sviluppo negli ultimi 150 anni, quelli appunto che corrispondono alla vita del suo Corpo Guide. Se è vero infatti che uomini e donne di Alagna, come di Macugnaga, si erano rivolti fin dall’epoca della colonizzazione al massiccio del Monte Rosa per trarne innanzitutto i mezzi di sussistenza, questo ha riguardato sostanzialmente per lungo tempo, direi per secoli, lo sfruttamento delle sue risorse ambientali, i suoi pascoli ricchissimi, le sue acque e i suoi giacimenti minera-
NOTE A MARGINE
ri, sotto un profilo che oggi diremmo materiale; ma non ha riguardato la montagna in sé stessa, in quanto luogo, ambiente e paesaggio, che per la sua attrattiva diventa “mestiere”, cioè sostentamento, per il solo fatto di saperci salire e saper quindi accompagnare chi, provenendo da più lontano, desidera salirci.
Questo passaggio fondamentale, dalla montagna come ricchezza di risorse alla montagna come avventura, sfida, piacere estetico e contemplazione, sul nostro territorio può risalire a quei pochi decenni che separano l’ascensione di don Gnifetti (1842) dalla fondazione del Club Alpino (1861) e della sua sezione di Varallo (1867), decenni nei quali si colloca, non a caso, anche la nascita dell’attività alberghiera di Alagna e Riva, come evidenziato in un recente almanacco alagnese3, a cui possiamo qui soltanto rinviare. Se si vuole poi ancora risalire oltre, la stagione precedente era stata caratterizzata dall’arrivo dei primi viaggiatori ed esploratori alpini, tedeschi4 e inglesi, che avevano iniziato le loro ascensioni sui contrafforti del Rosa, subito dopo la fine delle guerre napoleoniche (1816), proseguendo poi con fasi alterne fino agli anni quaranta. Ma costoro erano i cosiddetti Forschungsreisenden esploratori-scienziati stranieri spinti da esigenze di ricerca e propensi a muoversi senza guide, e ad incontrare la montagna come un immenso laboratorio scientifico, scevro di interesse economico e di necessità di sussistenza. Noi stiamo invece parlando della popolazione e società locale. Tuttavia, un effetto collaterale di quelle esplorazioni, e un suo riflesso sulla gente del luogo, era stato comunque far scoprire agli autoctoni la praticabilità dello spazio improduttivo oltre le “terre alte”, la possibilità di percorrere quelle “orride ghiacciaie”, creste e pareti, anche senza motivazioni scientifiche, ma semplicemente come esperienza umana, emozione sentimentale vissuta come gratificazione personale e fonte immediata di piacere.
Questa radicale mutamento di prospettiva nel modo di “vedere” la montagna rappresenta a mio avviso il vero evento iniziale che inaugura la stagione delle guide alpine, parallelamente alla scoperta del turismo d’élite come attività imprenditoriale che caratterizza quegli anni a cavallo dell’unità nazionale e nei quali gli stessi primi albergatori fungono da guide, o ne forni-
scono i clienti scegliendole tra i loro famigliari e nella società locale.
Questa specie di “rivoluzione copernicana”, che pone al centro la montagna in sé, è il segno di una trasformazione di mentalità, quindi di cultura, sulla quale occorre riflettere in modo approfondito. Si è trattato in sostanza di un passaggio dal materiale all’immateriale, in cui l’immaginario, poter vivere della propria personale passione per la montagna, diventava (almeno in parte) realtà.
Che la storia del Corpo Guide di Alagna fosse l’anello mancante di quell’analisi della società alagnese e valsesiana dell’Ottocento, su cui ci siamo trovati a riflettere ripetutamente negli ultimi decenni, è proprio il contributo rivelativo che il libro di Pascariello rappresenta, nel renderci consapevoli di una lacuna e di una problematicità che andava certo meglio focalizzata. Esso addirittura ci stimola a intraprendere un esperimento ambizioso, ma credo fecondo, che potrà concretizzarsi meglio nei prossimi anni: comprendere cioè alcuni aspetti di storia sociale e culturale alagnese attraverso il diaframma polivalente della nascita ed evoluzione del Corpo Guide in quella società, usando questo frammento di umanità, socialità e saperi per illuminare meglio il tutto, l’intera realtà del paese. Mi rendo conto che questa proposta, certamente ambiziosa e particolare, potrà apparire a qualche lettore esagerata; ma costui dovrebbe porsi e rispondere a questa semplice domanda:
“La società alagnese, almeno in quel secolo dopo la loro fondazione, sarebbe stata la stessa se non fosse esistito il Corpo Guide?”.
Credo che a questo quesito si possa dare concordemente solo una risposta negativa, e che da lì bisogna partire nella ricerca, per valutare lo sviluppo della compagnia delle guide come un elemento caratterizzante e “necessario” alla vita del paese; che deve quindi aver contribuito alla sua identità, cioè ai suoi caratteri peculiari. Questi caratteri distintivi sono stati ricercati già trent’anni fa a partire dallo studio di Farinetti e Viazzo (1992), opera ormai classica; mentre tralascerei qui, per ragioni di spazio e per la lunga deviazione che porterebbe al nostro tema il dibattito, suscitato soprattutto in area britannica e tedesca, sulla montagna “senza guide”, idea che fece proseliti autorevoli ma non in ambito
dell’attività alberghiera della località, nei suoi risvolti economici, sociali e culturali, rimane ancora tutta da scrivere.
4 Rinvio per ulteriori approfondimenti su questo tema alla mia ricerca Il Rosa di Alagna. La montagna dei tedeschi, ora in Il toro di Otro, Lions Club Valsesia, Sportello Linguistico del Comune di Alagna Valsesia, Società Valsesiana di Cultura, 2022, pp. 149-187.

5 Sulla fondazione del Corpo Guide di Alagna ed il dibattito relativo, una questione complessa sia in ambito alpinistico che associativo, oltre ovviamente al testo di Pascariello, rimando qui allo studio inedito di Riccardo Cerri, La “ Compagnia delle Guide Valsesiane” della sezione di Varallo del Club Alpino Italiano che mi è stato concesso di consultare per la cortesia dell’autore. Per la ricostruzione del quadro generale di evoluzione della sezione C.A.I. di Varallo rinvio invece al volume 150 anni della sezione di Varallo del Club Alpino Italiano a cura di C. Raiteri, Varallo 2017.
6 Cfr. Elisa FARINETTI, Pier Paolo VIAZZO, Giovanni Gnifetti e la conquista della Signalkuppe, Edizioni Zeisciu, Magenta 1992, p. 185 ss.
Mi riferisco qui all’almanacco-libro 2020 Gli alberghi storici di Alagna Valsesia, a cura di D. ed E. Farinetti, con interessante e inedite informazioni ed immagini; tuttavia la storia complessiva
valsesiano, scatenando qui invece una risposta polemica da parte di Orazio Spanna, proprio in occasione dell’investitura delle prime otto guide, il 1 settembre 1872.5
Il volume di Farinetti e Viazzo è stato infatti il primo a tentare l’inserimento dell’attività professionale delle guide alpine nel contesto sociale, economico e culturale delle comunità alpine come quella di Alagna6 dedicandovi un intero capitolo; ma, a distanza di anni, un significativo approfondimento, come dicevo all’inizio, è venuto dalle ricerche di Roberta Clara Zanini, svolte soprattutto a Macugnaga, che l’hanno condotta a caratterizzare quella esperienza lavorativa e umana come “mestiere del rischio”, la cui variabile oscilla tra i due estremi della verticalità, dalle gallerie più profonde delle miniere alle cime più alte del Monte Rosa.
Secondo l’autrice sarebbe di rilievo sociale riflettere sull’ identità di una “comunità del rischio” nella cui mentalità si inserisce e si accetta il rischio che il mestiere, ed i saperi ad esso connessi, siano sì un’azione di vita ma possano comportare anche la morte, o comunque un grave incidente, di colui che li intraprende.
Questa condizione di estrema fragilità, di esposizione al pericolo, al limite estremo della perdita della vita, che un proprio congiunto si trova a vivere, non riguarda lui solo ma trapassa dal
NOTE A MARGINE
singolo individuo alla famiglia, alla parentela, e poi all’intera società del paese, saldandosi insieme a quella di molti altri individui che vivono la stessa condizione, ai portatori e alle portatrici, agli albergatori stessi, i primi a voler reperire le guide per le escursioni dei loro clienti.
Se si pensa che, secondo i dati pubblicati da Farinetti e Viazzo, le guide alpine della Compagnia di Alagna, trent’anni dopo la loro fondazione, erano già state 32, in un paese che a inizio Novecento contava poco più di un centinaio di famiglie7 si comprende come fosse alta l’incidenza di persone coinvolte in questa “comunità del rischio” in rapporto alle modeste dimensioni demografiche del paese, a cui dovremmo sottrarre poi anche quei lavoratori che trascorrevano all’estero la maggior parte dell’anno.

Un altro indicatore di quanto fosse radicata questa “cultura del limite”, nella mentalità locale, lo possiamo cogliere inoltre laddove le figure parallele dei minatori e delle guide diventano addirittura coincidenti; e non soltanto in personalità di eccellenza come Mattia Zurbriggen o Ferdinand Imseng, citate dalla Zanini per Macugnaga8, ma anche ad Alagna, dove la doppia professione di minatore e guida ricorreva in diversi casi, poiché l’alternanza e integrazione di questi due mestieri permetteva di coprire l’intero anno lavorativo,
con il consenso dell’amministrazione mineraria che concedeva, a chi ne aveva le competenze e titoli necessari, di esercitare anche la professione di guida alpina in determinati periodi dell’anno.
L’insieme di queste riflessioni, come quelle da me avviate in altro contesto9, aprono un profilo ottico diverso attraverso cui studiare la storia alagnese oltre l’immagine della tradizionale comunità agropastorale, perché anche quella delle guide si caratterizza come un’esperienza di emancipazione dal lavoro agricolo, dall’emigrazione stagionale maschile, che ne era spesso il corollario, e quindi da quella dipendenza dalle risorse della montagna che si caratterizzavano come un “bene limitato”10, sempre troppo esiguo e quindi insufficiente per consentire sviluppo economico e demografico.
La lettura del volume di Adolfo non si limita tuttavia a suscitare queste importanti considerazioni storiche e sociali, su cui dovremo tornare a confrontarci in futuro, ma stimola inoltre utili riflessioni sul significato dell’esperienza delle guide alpine nella società odierna; un messaggio che viene immediatamente raccolto da Elena Sinibaldi, nella sua postfazione11
L’antropologa romana, considerando l’immenso valore immateriale di quel patrimonio di saperi di cui le guide sono portatrici, suggerisce di porre questa comune eredità a fondamento di un’azione educativa quanto mai necessaria oggi, quando la montagna è diventata un bene di consumo massificato, senza tuttavia che nel frattempo sia cresciuta la coscienza collettiva e la necessaria formazione all’incontro con il mondo alpino, la cui fruizione metaculturale rischia di trasformarsi in un semplice e frettoloso approccio consumistico, vanificando così il senso stesso di questa esperienza, la ragione per cui “andare in montagna”.
In questa prospettiva, concludendo, chi immagina che la grande stagione delle guide sia tramontata ed il loro compito sia ormai residuale nei nuovi scenari delle Alpi future ha frainteso sia la loro storia che il loro ruolo nel mondo attuale; la montagna di oggi e del futuro ne ha un bisogno enorme, forse diverso ma necessario all’intera collettività.
Per tutto questo ci vorranno un grande impegno e almeno altri… centocinquant’anni.
10 Per la definizione del concetto di limited good (risorsa limitata) si vedano le considerazioni di Sabrina CONTINI, Matrimoni e patrimoni in una valle alpina, Magenta, Zeisciu Centro Studi, 2011, p. 20 ss., con ulteriori riferimenti bibliografici, anche riferibili alle società alpine arcaiche.
PRESMELL
La nostra storia, la nostra cultura
Culture di confine, p.139.
9 Per lo sviluppo economico e sociale di Alagna oltre l’Alpwirtschaft rinvio alle conclusioni del mio saggio Alagna Valsesia: territorio e insediamenti dal XIV al XVII secolo, ora in Il toro di Otro op. cit. pp-17-43.
11 Cfr. Elena SINIBALDI, Fonti storiche e pratiche culturali per una rilettura dei sistemi socio-ecologici tradizionali, in Una montagna di storie. Il Corpo Guide Alpine di Alagna Valsesia, p. 279 ss.

Pe d’Alzarella
Un antico insediamento di Pietre Gemelle scomparso nella prima metà del Seicento
di Roberto FantoniRIVA TRA DUECENTO E TRECENTO Il giuramento di cittadinanza vercellese prestato dai capifamiglia valsesiani nel 12171 consente una ricostruzione approssimativa del limite tra aree con insediamenti permanenti ed aree occupate da alpeggi. Pur con le incertezze ed indeterminazioni dovute alla non obbligatoria coniugazione del nome a una località, alla omonimia di toponimi ed alla stessa variabilità temporale dei toponimi, l'elenco dei firmatari offre utili indicazioni sulla distribuzione degli insediamenti permanenti a monte di Varallo a inizio Duecento. L'ampiezza del campionamento (612 firmatari) permette il riconoscimento di una caratteristica generale del popolamento in Valsesia in questo periodo: l'elevata densità di firmatari nella bassa e media valle e la rarefazione (o l'assenza) nell'alta valle. Alla testata della val grande compare un solo firmatario, Guidetus filius Iohannis de Petris zumellis
Un secolo dopo, tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento sono attestate quasi tutte le frazioni di Riva ubicate lungo il corso del Sesia (fig. 1). Nel 1282 sono citate le frazioni Boccorio e Isolello2; nel 1316 compare il Gabbio3; la Balma è citata per la prima volta in un documento del 13194
PE D’ALZARELLA La frazione che compare più frequentemente in questi atti è Pe d’Alzarella (fig. 1) ubicata al centro della piana del Sesia dominata dalla maestosa parete valsesiana del Monte Rosa (fig. 2). Il toponimo denuncia chiaramente l’ubicazione dell'insediamento al piede dell’alpe Alzarella, collocata sul versante idrografico destro della Valsesia5. L’alpe appar-
NOTE A MARGINE
Alagna
Sesia
Balma 1319, 1347, 1393
Gabbio 1316, 1347
Piana Fuseria 1473
Casarolo 1401
Aput Alzarella vedova di Michele Anrigone di Pedemonte, che, con il figlio Pietro riceve da Zanino Anrigone, rispettivamente figlio e fratello, il denaro dovuto loro per la vendita di tutti i beni mobili ed immobili posseduti nel territorio di Pedemonte8
Nello stesso periodo, nella piana del Sesia attorno alla frazione, sono attestate le coltivazioni cerealicole9. In un documento del 30 gennaio 1345, che costituisce la più antica attestazione della coltivazione di cereali in Valsesia, a Piè d’Alzarella compare un appezzamento di terra colta et seminata cum sicali a cui confinano i beni di altri proprietari della frazione10, venduto da Iohannes dictus Revellus filius quondam Petri Ferrari de aput Alzarela11 a Matolo Montanario di Pietre Gemelle12
dovutogli per la vendita di un terreno a Piè d’Alzarella “ubi dicitur supra la pianella”16. La famiglia Bligari sembra essere la più consistente e importante della frazione. Nel 1483 Pietro compare come rappresentante della “squadra de aput alzarellam”17
Tra i testi di un atto del 1439 compaiono i rappresentanti di altre due famiglie: “Johannes fq Petri de Nicho” e “… Petri Jacobini”.In un documento del 1440 gli “heredes Jacobini”18 compaiono tra i confinanti di un prato “in territorio ubi dicitur apud alzarellam”19. In un documento del 30 novembre 1531 compare Zanolo Cazio di Piè d’Alzarella, che ricevette dal notaio Pietro Chiarini il denaro dovutogli per la vendita di un prato con alberi detto “ad pratum de la Gula20.
us, Formica (o Formigha), Cacia e Francesi sive Janzo
Quando l’espansione demografica raggiunse la capacità di carico del territorio alcuni coloni di Pe d’Alzarella, come di altre frazioni di Riva ubicate sul fondovalle del sesia, migrarono nella parte inferiore della val Vogna24. Nel 1475 si dichiarava “habitator ori vogne” Giacomo Giacobini di Pe d’Alzarella25, appartenente ad una famiglia già documentata in questa frazione nei primo decenni del secolo.
Riva 1217
Vogna di là
Pe d’Alzarella 1300, 1302, 1321, 1325, 1331, 1345, 1347
Isolello 1282, 1308, 1321
Boccorio 1282
A. Alzarella
AlpisAlzarelle
C.ma d’Alzarella
Buzzo
Varallo
Il 2 giugno 1347 il Milanus dictus Beligarius filius quondam Stande de apud alzarellam de Petris gemellis, citato nel documento precedente, risulta procuratore di molti abitanti di Pietre Gemelle13 nella richiesta che venga sospesa la sentenza di condanna per contumacia richiesta da Antonio Testa di Varallo14. Il soprannome si trasmise alla sua discendenza; in documenti del 1401, 1402, 1403 e 1412 compare, a fianco di altri rappresentanti della famiglia, un “Antonius fq Johannis Bligarii”15. Nel settembre 1502 Antonio Brigario di Piè d’Alzarella ricevette da Giacomo di Vogna il denaro
A fine Quattrocento alcuni abitanti di Pe d’Alzarella risultavano proprietari o affittuari di alpeggi valsesiani. Il 22 gennaio 1498 Giovanni Brigario di Pe d’Alzarella ricevette da Giacomo di Vogna il denaro dovutogli per la vendita di terreni all’Alpe Fornale21. Il 17 maggio dello stesso anno Lorenzo Filippa e Giovanni Magnani di Fobello concedono a titolo di enfiteusi perpetua a Zanolino Grandi di Pe d’Alzarella del terreno all’Alpe [Ononay]22
Nei registri parrocchiali, inaugurati nel 1553 con il Liber Baptizatorum, matrimoniorum et aliquorum mortuorum23, a Pe d’Alzarella compaiono rappresentanti delle famiglie Brughari-
In tutti i documenti tardo-medievali la frazione compare sempre come Pe de Alzarela (con la sua variante di Aput Alzarellam) de Petris Zumellis (o Gemellis) indicandone sempre l'appartenenza alla comunità costituita da diversi insediamenti sparsi identificata con il nome collettivo di Pietre Gemelle. Nella frazione era presente anche un edificio religioso dedicato a Sant’Antonio, citato in un documento del 15 marzo 1546 rogato a Piè d’Alzarella, in strata publica, apud capellam beati Sancti Antonii26
LA SCOMPARSA DELLA FRAZIONE Nei libri parrocchiali la frazione compare ripetutamente tra 1556 e 1630; da questi registri la frazione successivamente scompare e scompaiono anche i cognomi delle famiglie che vi abitavano (Brugarius, Formica, Francesi segmentazione del cogno-
teneva al vescovo di Novara; i suoi confini, citati in documenti d’inizio Quattrocento, erano costituiti dall’alpe Artogna, dalla comunità della Valsesia e dalla gulla rubea6
La prima attestazione documentaria della frazione risale al 18 aprile 1300 quando Maria filia quondam Iohannis de pe de Alzarela de
1 Mor C.G., Carte valsesiane fino al secolo XV, Torino, Biblioteca della Società Storica Subalpina, v. 124, 1933, dd. XXIX-XXX; Dessilani F., I giuramenti valsesiani di cittadinatico vercellese del 1217 secondo documenti originali ‘de valle Sicida’, a. XXVI, 2017, pp. 29-58.
2 Nel 1282 Miletus Imet Guilielmetius de supra Ripa de petris Zumellis riconosce un canone annuo da corrispondere a Berta figlia del fu Giovanni Arrio di Pietre Gemelle per un appezzamento di terra e un mulino a Bucorio ed un pascolo a Isolla (sASVa, MCa, m. 43, c. 2; Mor, 1993, d. LVIII). Isolello compare nuovamente in un docuemmto del 1308, quando Petrus filius quondam Milani del pont de l’Isolello vende al presbiter Gaspardo filius quondam Zaneti Lantie de Quarona, curatus et beneficialis ecclesie sancti Michaelis loci de Petris Zumellis, un campo canepale cum plantis ceresiis intus nel territorio di Isolello ubi dicitur apud tectum Dominici sive aput furnum (Mor, 1933, d. LXVIII).
Petris Gemellis ricevette da Pietro Ferrario anche lui di Pe d’Alzarella un mutuo di 20 soldi imperiali. Tra i testimoni all’atto compare un altro abitante della frazione, Zanolus de Pe de Alzarella7
In un altro documento, del 7 giugno 1331, compare Agnexola filia quondam Zanini de
Valente di Tonso di Varallo rilascia ad Albertolo de Gabio de Petris Zumellis quietanza di un suo credito (sASVa, MCa, m. 43, c. 7; Mor, 1933, d. LXXIII)
Rizzi E., Sulla fondazione di Alagna, Bollettino Storico Provincia di Novara, a.
LXXIV, n. 2, 1983, d. 8 (in parte non regestata ma citata nell’indice dei nomi).
L'analisi macro toponomastica mostra una forte connessione tra nomi degli insediamenti permanenti ed i nomi degli alpeggi entro cui furono fondati (Fantoni R., La percezione del territorio nella toponomastica dei fondatori, in Fantoni R., Cerri R., Carlesi P., Rivoira M. e Cusan F. (a cura di), “I nomi delle montagne prima di cartografi e alpinisti. Atti dei convegni e guida all’escursione (Varallo, 16 ottobre
- Milano, 24 ottobre - Val Vogna, 25 ottobre 2015”, Club Alpino Italiano sezione di Varallo Commissione scientifica ‘Pietro Calderini’, sezione di Milano Commissione scientifica ‘Giuseppe Nangeroni’; Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano, 2016, pp. 149-167). Alcune volte gli insediamenti ripresero lo stesso nome dell'alpe, come avvenne a Rimella (fondata nel 1256, Fornaseri G. (a cura di), Le pergamene di S. Giulio d’Orta dell’archivio di Stato di Torino Torino, Biblioteca della Società Storica
Subalpina., v. 180., 1958, d. C), Rima (fondata nel 1383; Fantoni e Fantoni, 1995, d. 16), Carcoforo (documentato dal 1462, d. 32) e Dorca (attestato come insediamento permanente dal 1442, d. 25). Ma la relazione toponomastica più comune è quella con la stazione inferiore d’alpeggio, specificata come piede (o aput) o campo. Al primo gruppo appartengono Piè di Rosso Aput rubeos, 1531, Fantoni e Fantoni, 1995, d. 67), Piè di Fagiolo e Piè di Moncucco (1531, Fantoni B. e Fantoni R., La colonizzazione tardomedioevale delle Valli Sermenza ed Egua (alta Valsesia), “de Valle Sicida”, a. VI, n. 1, 1995, d. 66), Pe d’Alzarella (Pe de Alzarela 1300, MOR, 1933, d. LXIII; aput Alzarellam 1347, d. XCV), Pe d'Otro, Pe d'Alagna (aput Alagnam, 1344, Rizzi, 1983, d. 18; Pe d’Alagna, 1387, d. 24), Pedemonte aput Mot, 1302, Mor, 1933, d. LXIV); al secondo Campo Ragozzi Campi Regoci, 1387, Rizzi, 1983, d. 24), Campertogno (ossia Campo Artogna; Campertenium, 1217, Mor, 1933, d. XXIX, Campartonium 1305, d. LXVI; Campartonium, 1335, d. LXXXV).
6 Fantoni B. e Fantoni R., 1995, dd. 6, 13.
7 sASVa, Mca, m. 43, c. 3; Briciole, p. 9; Mor, 1933, d. LXIII.
8 sASVa, MCa, m. 43, c. 11; Mor, 1933, d. LXXXIII; Rizzi, 1983, d. 15.
9 Fantoni R, Papale A, Regis A. e Sasso M., La sappa e la ranza. Produzione alimentare e alimentazione in una valle alpina tra Medio evo e nuovo millennio, in Fantoni R. et al. (a cura di), “La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione. Atti della XXI edizione degli Incontri tra/montani”. Incontri tra/montani, Gruppo walser Carcoforo, 2011, pp. 23-73.
10 Milanus filius Uberti Stande e un altro Uberto, figlio del contraente.
11 Citato nel documento del 1300.
12 sASVa, MCa, m. 43, c. 16; Briciole, p. 10; Mor, 1933, d. XCI. In un documento del 1523 compare un appezzamento di terra a prato e campo nella stessa comunità gravato dell’onere perpetuo di “starium unum sichali” da consegnare alla Carità di S. Spirito (Briciole, p. 185).
13 Tra loro compaiono anche altri abitanti di Pe d’Alzarella: Perolus filius quondam Zanoli, Iacobus flis quandam Mileti de Zanolo, Ubetinus et Iohannes fratelli e figli del fu Forendinus
14 sASVa, MCa, m. 43, c. 18; Briciole, p. 10; Mor, 1933, c. XCV.
15 Briciole, pp. 10, 28-30, 32, 40-41; Rizzi, 1983, dd. 29-30, 33.
16 sAVa, MCa, m. 43, c. 195.
17 Briciole, p. 14.
18 Briciole, p. 34.
19 Briciole, p. 42; Rizzi, 1983, d. 47.
20 sAVa, MCa, m. 43, c. 301.
21 sAVa, MCa, m. 43, c. 182.
22 Si tratta dell’alpe Nonai, ubicata in una valle laterale confluente nel Sermenza a S. Giuseppe; sAVa, MCa, m. 43, c. 183.
23 ASPRv.
24 Fantoni R., Riva, le frazioni di fondovalle e la Val Vogna. Insediamenti multietnici tardo-medievali sul versante meridionale del Monte Rosa Wohnen-Woona Vogna, 2017, pp. 16-21.
25 Briciole, pp. 46-47.
26 sAVa, MCa, m. 43, c. 335. documenti attestano l’esistenza tra Quattrocento e Cinquecento di cappelle in molte frazioni del territorio di Pietre Gemelle. Per il territorio di Alagna in un documento del 10 marzo 1443 viene citato un appezzamento di terra a prato con un edificio rurale ubicato nel territorio di Pedemonte ubi dicitur subtus capellam sancti Nicolay subtus viam (sASVa, MCa, m. 43, c. 84; Fantoni R., L’oratorio di San Nicolao a Pedemonte di Alagna. Il primo insediamento e il primo edificio religioso dei walser in Valsesia. Il Varallino, a. IV, n. 12, 2002, pp. 1-4). Pochi anni dopo, nel 1466, viene citata in un altro documento la cappella di S. Bartolomeo della frazione Giacomolo (Farinetti E. e Farinetti D., La frazione Giacomolo ad Alagna Valsesia e l’antico oratorio di san Bartolomeo, in “Uno scrigno prezioso: la Cappella di San Defendente in frazione Giacomolo ad Alagna Valsesia”, Sportello linguistico comune di Alagna Valsesia, 2018, pp. 90-91). La cappella di S. Maria Maddalena alla frazione Merletti fu consacra nel 1473 ad opera del vescovo Antonio Caccia. Per il territorio di Riva e della val Vogna in un documento del 1491 compare “in territorio de la petia subtus capellam S. Grati cui coheret ab una parte strata comunis ab alia strata antiqua” Briciole, p. 152). La cappella della Balma, documentata dal 1525, quando un contratto è steso coram capella beate Marie Virginis ac santorum Michaelis Archangeli et Iohanni Baptiste, era significativamente dedicata anche ai santi patroni di Riva e di Alagna (sASVa, MCa, b. 15, c. 280).
me Janzo). Nello stato d’anime del 1641, il più antico della parrocchia27, Pe d’Alzarella è rappresentata da una sola famiglia con tre persone appartenenti ad una famiglia Janzo (fig. 4). Nella casa del fu Francesco di Janzo abitavano ancora Pietro del fu Francesco (di 60 anni), sua moglie Costanza (di 50 anni)28 e Antonia Formica di 65 anni. Nei secoli successivi Pe d'Alzarella scomparirà completamente dai registri parrocchiali e dagli Stati d’anime.
La causa, o le cause, della scomparsa della frazione sono da ricercarsi in due eventi
27 ASPRv.
che caratterizzarono la vita di Riva nella prima metà del seicento: la peste del 1630 e l’alluvione del 1640.
La peste del 1630 colpì pesantemente Riva e la val Vogna29 provocando circa 200 vittime registrate negli Atti di morte e nella Memoria eorum qui mortui sunt ex peste in annis 1630 et 163130. Negli stessi atti di morte si trovano indicazioni sull’esistenza di un luogo destinato alla quarantena, ubicato nella piana del Sesia, a cui era deputato un custode, abitante a Pe d’Alzarella.
Pochi giorni dopo lo scoppio dell’epi-
28 Sposata probabilmente in seconde nozze, dopo la morte nel 1630 della prima moglie Maddalena Ema (ASPR, battesimo). Durante la peste del 1630 morirono anche figli avuti dalle prime nozze, Francesco, nato nel 1608) e Margherita (nata nel 1610), citati nella Memoria eorum qui mortui sunt ex peste in annis 1630 et 1631 (ASPRv, Briciole, pp.161-167; Fantoni R., Ferla A., Negro A. e Zanoletti E., Colle di Valdobbia: una via per la peste in Fantoni R. e Spotorno M. (a cura di), “La Montagna attraversata: pellegrini, soldati e mercanti. Atti del convegno di Bard 1617 settembre 2006”, Club Alpino Italiano Comitato Scientifico Ligure Piemontese, 2010, pp. 55-67.
29 Fantoni et al. 2010.
30 ASPRv; Briciole, pp.161-167.
31 ASPRv, Libro dei morti.
32 La prima sepoltura nel prato della quarantena risale a solo due giorni prima, il
demia, il 5 luglio 1630, nel prato apud ruggiam sessiate morì infatti Petrus filius quondam Clarini Formicae, di 61 anni, abitante a Pe d’Alzarella, definito nell’atto di morte custos quarantene; fu sepolto nel luogo che sarà indicato in altri atti come “prato della quarantena”.Nell’atto di mor te del 12 luglio di Graulio di 58 anni viene esplicitato il luo go di morte come Sessiete in quarantena
3 luglio. In altri atti (15 luglio) compare però anche Quarantena (il prato in località Scotto è ubicato presso la frazione Gabbio, sopra la mulattiera che costeggia il Sesia)
33 La roggia era ubicata presso il nuovo centro sportivo; attualmente è coperta ed in serita nel sistema fognario. Un tempo era alimentata dal torrente Otro, passava per Cascina Poio, alimentava alcuni mulini e raggiungeva il torrente Vogna. La località traeva nome da un ramo minore del Sesia.
34 L’edificio è successivamente scomparso.
35 Peco L., L’alluvione del 14 ottobre 1755 in Valsesia 1995.

36 Rizzi E., Storia della Valsesia, Fondazione Entico Monti – Studi alpini, 2012, p. 307.
37 Ragozza E., Comunità civile. Vita religiosa. Gente di Alagna Una comunità walser", pp. 15-56, 57-112, 113-160, 1983, p. 153.
38 Briciole, p. 185.
prato presso la roggia Sesietta morirono e furono sepolte anche altre sette persone registrate nel libro ordinario dei morti. La roggia identificata in questo ed in altri atti di morte scorreva nella località ancora oggi indicata come Sesietta, ubicata nella piana del Sesia immediatamente a valle di Riva in prossimità di Pe d’Alzarella.
Atti di morte del 1630
ra registrato negli Stati d’anime del 1641. Nel codicillo del 21 luglio 1630, redatto il giorno seguente quello della stesura del testamento, stabiliva di fabricare et dipingere nell’oratorio di sant’Antonio di Pe d’Alzarella quadrum unum factum ad olei cum imagine santissima vergine maria et eius filio et a parte dextra S.ti Antoni et a parte sinistra S.ti Rochi con i suoi ornamenti... con il detto testatore et Carolo suo figliolo inginocchiati nella parte sinistra. La famiglia di Pietro fu completamente decimata dall’epidemia. Sua figlia Maria, di 9 anni, era morta il 5 luglio e fu sepolta dietro l’oratorio di sant’Antonio. Altri due dei suoi figli morirono, in data imprecisata, dopo il 16 luglio (prima Giovanni, di 15 anni; poi Carlo, di 13). Il testamento fu probabilmente redatto a cavallo della morte dei due figli.


Un altro evento catastrofico interessò la comunità di Riva: l’alluvione del mese del 18-19 settembre 1640. Non sono noti i dettagli dell’inondazione, che fu comunque giudicata, almeno in alta valle, della stessa gravità di quella del 1755.La memoria dell’alluvione rimase nella comunità locale ed è ricordata in un libro di memorie dei fratelli Zanetti di Riva. Il torrente Vogna distrusse la vecchia chiesa parrocchiale di
Riva. In una nota nelle Briciole il Carestia annotava che il 21 settembre 1640 “l’acqua della Vogna ha atterrata la Chiesa di S. Michele alla Riva”.
CONCLUSIONI Uno dei più antichi e consistenti insediamenti di Pietre Gemelle, ampiamente documentato dalla sua fondazione tardo-medievale sino ai primi decenni del Seicento, scomparve sostanzialmente prima del 1641, anno in cui gli Stati d’anime attestano la presenza di un solo nucleo familiare.
Possiamo ipotizzare che la peste del 1630 decimò la popolazione della frazione e la successiva alluvione del 1640 atterrò le sue case e l’antico oratorio di Sant’Antonio, che non furono più ricostruiti. Nel corso dei quattro secoli successivi, si è persa anche la memoria storica dell’evento. La tradizione orale, seppur importante, da sola non è sufficiente per la ricostruzione della storia delle comunità valsesiane, che può essere affrontata solo attraverso l’analisi incrociata di diverse fonti documentarie.
RINGRAZIAMENTI Si ringraziano Adriano Negro, per le informazioni ricavate dai libri parrocchiali, e Attilio Ferla per la revisione critica della prima versione del manoscritto
RIFERIMENTI ARCHIVISTICI
Bricole Briciole di Storia Patria raccolte dall’Abate Carestia (fotocopie in Mca) ASRv Archivio Storico Parrocchia di Riva sASVa sezione di Archivio di Stato di Varallo
MCa Museo Calderini (in sASVa)
La pagina relativa a Pe d’Alzarella nello Stato d’anime del 1641
maggior controllo statale. In particolare, la legge del 1867 stabilì il non riconoscimento dei benefici ecclesiastici non curati, (cioè, senza annessa la cura d’anime), attribuendo ai patroni laicali la facoltà di rivendicarne i beni entro un anno, termine poi prorogato al 15 agosto 1869. La successiva legislazione, pur avendo un’impostazione più moderata, si propose comunque di imporre alla Chiesa la vendita dei propri beni immobili, favorendo la conversione del relativo ricavato in titoli del Debito Pubblico; così avvenne, ad esempio, per il Beneficio Bertolino.
Le leggi di eversione dell'asse ecclesiastico rimasero in vigore fino al 1929, anno dei Patti lateranensi; nel 1984, l’accordo di revisione del Concordato dispose che i benefici ecclesiastici fossero trasferiti agli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero.
IL BENEFICIO BERTOLINO I documenti conservati nell’archivio parrocchiale di Riva, ci permettono di conoscere nel dettaglio i contenuti e le vicende riguardanti il Beneficio Bertolino. Vediamo, innanzitutto, la puntuale ricostruzione fatta al riguardo da don Andrea Bignoli, arciprete di Riva Valdobbia dal 1924 al 1958.3
Il Beneficio Bertolino “di S. Maria e dei SS. Pietro e Paolo” e il Beneficio Morca “di S. Antonio”
di Attilio FerlaQuesto scritto intende presentare uno sguardo sulla Riva e la Valle Vogna dei secoli scorsi. Uno sguardo particolare, rivolto ad alcune vicende riguardanti i Benefici Bertolino e Morca, istituzioni che operarono in favore delle comunità locali, sotto diversi aspetti: religioso, civile e sociale, con una particolare attenzione nei confronti dei poveri.
I fondatori dei benefici, Pietro Bertolino e Michelangelo Morca, meritano dunque di essere ricordati, perché lasciarono un segno tangibile nella loro esistenza, fatto di attività caritative, svolte pensando a Dio.1
I BENEFICI ECCLESIASTICI - GENERALITÀ Il beneficio ecclesiastico, un istituto risalente

ai tempi del feudalesimo, viene così definito dal Codex Iuris Canonici del 1917: «Un ente giuridico costituito od eretto in perpetuo dall’autorità ecclesiastica, composto da un ufficio sacro e dal diritto di percepire i redditi della dote, spettanti all’ufficio» (canone 1409).
I benefici ecclesiastici si possono distinguere in differenti tipologie. In questa sede, ci preme sottolineare che i benefici possono essere semplici (sine cura) o comportare il peso della cura delle anime.
Il beneficio ecclesiastico può anche contemplare un diritto di patronato, ed essere costituito dal fondatore con atto notarile, con il quale si dispone che determinati beni stabili, in genere si tratta di fondi rustici,
siano legati al beneficio; ad essi viene eventualmente connesso un obbligo: ad esempio, la celebrazione di messe di suffragio.
L’atto notarile regolava, inoltre, la trasmissibilità dei suddetti beni e obblighi.
Il patronato era sovente laico, per cui il beneficio competeva non solo al patrono, ma altresì ai suoi eredi.2 Il nascente Regno d’Italia, con il Regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, di soppressione degli ordini e delle congregazioni religiose, e con la Legge 15 agosto 1867, n. 3848, che dispose la confisca dei beni degli enti religiosi, emanò due leggi che provocarono l’eversione dell’asse (del patrimonio) ecclesiastico. L’intento era quello di ridimensionare il potere economico della Chiesa cattolica e di sottoporla a un
to a favore dei fratelli Giov. Battista e Giacomo Chiesa, eredi Bertolini, ed a favore dei loro eredi, in linea mascolina, se essi avessero voluto accettare: nell’ipotesi negativa il diritto di patronato doveva passare, col consenso del parroco, alla locale Confraternita del SS. Sacramento.
Estinta la discendenza
L’origine del Beneficio di S. Maria e dei SS. Pietro e Paolo risale al 19 Maggio 1687, data del testamento di D. Pietro Bertolino, Parroco di Riva Valdobbia4, il quale, con tutti i suoi beni patrimoniali, istituiva un Beneficio Coadiutorale con l’onere al Beneficiato:
• 1° di celebrare quattro messe alla settimana nella Chiesa Parr.le
• 2° di celebrare una messa al mese nell’Oratorio di S. Rocco
• 3° di udire le confessioni in Chiesa e fuori presso gli infermi
• 4° d’insegnare la dottrina cristiana ai fanciulli.
Il decreto di erezione canonica del Beneficio Bertolino fu rilasciato il 26 ott. 1699 da Mons. Giovanni Battista Visconti, Vescovo di Novara. Il testatore Don Pietro Bertolini riservava la nomina ed il diritto di patrona-
NOTE A MARGINE
Chiesa nel 1847 subentrò infatti nel diritto di patronato del Beneficio Bertolini la soprannominata Confraternita. Nel 1908, per la morte dell’ultimo investito, Don Antonio Carestia, detto Beneficio rimase vacante, ed i confratelli, per non lasciarlo cadere sotto le leggi di soppressione, e valendosi del diritto di Patronato del Beneficio stesso loro conferito dal pio fondatore, chiesero all’Intendenza di Finanza di Novara lo svincolo di tutti i beni e censi costituenti la dote del Beneficio, con formale domanda in data 8 dicembre 1910.5
L’ultima parte dello scritto di don Bignoli ci ricorda che, avvenuta la concessione dello svincolo nel 1912 e ottenuta nel 1914 l’autorizzazione all’alienazione di alcuni fondi rustici, nel gennaio 1920 la Confraternita possedeva ancora i seguenti fondi: 1° Casa rustica (dove visse l’abate Carestia); 2° Alpe Camino; 3° Prato Comolo (frazione Balma); 4° Prato Rotondo; 5° Prato della Fiera; 6° Campo basso. La casa rustica e l’Alpe Camino furono venduti nel 1920. Il prato Comolo e il prato Rotondo furono venduti nel maggio 1922 e, nello stesso anno, del prato della Fiera furono venduti mq 464, destinati all’ampliamento del cimitero. Col provento di tali alienazioni, furono acqui-
1 Bertolino Pietro morì il 24 /01/1690, all'età di 61 anni (Archivio parrocchiale di Riva, registro morti n 84, anni 1618-1697); Morca Michelangelo morì il 20/02/1741, all'età di 83 anni (Archivio parrocchiale di Riva, registro morti n 10, 1698-1778). Si ringrazia il dott. Adriano Negro, per le notizie e le fotografie relative agli atti di morte sopra menzionati. L’istitutore dell’omonimo Beneficio viene sovente citato, nei vari documenti esaminati, con il cognome “Bertolini”. Alcune delle informazioni sul Beneficio Bertolino e sul Beneficio Morca, che compaiono nel presente articolo, sono pure rinvenibili in: Roberto Fantoni, L’abate Antonio Carestia. Archivi e sentieri di montagna giugno 2012.

2 Nei secoli scorsi molte famiglie facoltose desiderarono trasmettere ai posteri il nome e lo stemma del proprio casato, legando il loro patronato alla proprietà di un
stati dei certificati nominativi consolidati del Debito Pubblico del Regno d'Italia. Precedentemente al compimento degli atti sopra ricordati, dalla documentazione custodita in archivio parrocchiale risulta che il Beneficio vantava diritti di proprietà, o altri diritti, su terreni, case, boschi, adibiti o affittati per lo svolgimento di attività agropastorali, in Valle Vogna (Vogna sotto; Alpe Oro inferiore e Alpe Buzzo superiore; “regione al Sasso”) e nel Comune di Mollia (Alpe Valpiana).
La memoria di don Bignoli ci fa pure conoscere quali erano gli oneri a cui era tenuto il cappellano di S. Rocco; a questo proposito, in una lettera del 18 ottobre 1908, indirizzata al Vicario Generale della Diocesi di Novara, il parroco di Riva, don Eugenio
altare o di una cappella, che poteva fungere anche da luogo di sepoltura.
3 Arcipr. Andrea Bignoli, Pro Memoria – Beneficio Bertolini in Riva Valdobbia, Riva Valdobbia, 28 Giugno 1931.
Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) n. 149, volume 4, fascicolo 7“Istrumenti Bertolini”, carte novecentesche.
4 In realtà, Pietro Bertolino/i non figura nell’elenco, rinvenibile in archivio parrocchiale, dei parroci di Riva Valdobbia.
5 Arc. Francesco Merlino, Riva Valdobbia, 8 dicembre 1910 - Al Ricevitore Ufficio del Registro di Varallo. Oggetto: confratelli della Confraternita del SS. Sacramento chiedono lo svincolo dei beni costituenti la dote del Beneficio Bertolini. Archivio Parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) n. 149, volume 4, fascicolo 7 - “Istrumenti Bertolini”.
Mongini, precisava che il Beneficiato doveva celebrare (in parrocchiale) nelle domeniche dei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre la messa prima, “per comodo del popolo”.
LA SOPPRESSIONE DEL BENEFICIO Dalla lettura del promemoria di don Bignoli abbiamo appreso che Il Beneficio, eretto nell’ottobre 1699 e rimasto vacante in seguito alla morte del Carestia, non era “provvedibile” perché soggetto alla legge “eversiva” del 1899, e la richiesta di svincolo era diretta ad evitare la temuta soppressione. Dall’esame dei documenti presenti in archivio parrocchiale, si può conoscere nel dettaglio la controversa determinazione della vera natura del Beneficio Bertolino: ecclesiastica-coadiutoriale o meramente laicale (prevalse questa ultima qualificazione, che comportava la soppressione).
I tentativi di evitare la soppressione videro l’intervento di don Francesco Merlino6, parroco di Riva dal 1909 al 1924, e perfino del deputato valsesiano Carlo Rizzetti; entrambi sostenevano la natura ecclesiastica del Beneficio. Della controversia era già stato interessato don Eugenio Mongini, parroco di Riva dal 1907 al 1909. Scriveva don Merlino, il 24 gennaio 1910, al Ricevitore dell’Ufficio del Registro di Varallo, nei seguenti termini: «In alcune note esistenti nell’archivio parrocchiale e dal testamento
19 maggio 1687 di Pietro fu Antonio Bertolino fondatore del Beneficio di S. Maria di cui ultimo titolare fu l’Ab.te D. Antonio Carestia, mi risulta che detto Beneficio riveste la natura di Coadiutoria titolare poiché negli atti di fondazione vien fatto obbligo all’investito di coadiuvare il parroco nell’amministrazione dei sacramenti e nell’istruire i ragazzi e le ragazze nella dottrina cristiana».

Due giorni dopo vi fu la risposta, negativa, del Ricevitore (del Registro) di Varallo (26 gennaio 1910).
Le eccezioni fatte dalla LV.R.va e che sono
NOTE A MARGINE
quelle stesse già sottolineate dal def.o parroco D. Eugenio Mongini, sono già state risolute in senso negativo dalla Direzione Generale del Fondo Culto (1909…)
E’ risaputo che per aversi (l’indole) coadiutoriale deve l’investito prender parte alla Cura delle anime in modo principale e permanente, cosa che non puossi invocare in questo caso concreto, risultando dalle disposizioni testamentarie che secondario ed accessorio era l’obbligo dell’investito di udire le confessioni, d’insegnare il catechismo ai fanciulli, mentre la prima mansione era solo quella di celebrare la messa, come ha riconosciuto lo stesso parroco di Riva colla sua lettera 16 Dicembre 1908. Quindi il Beneficio di S.a Maria e dei SS. Pietro e Paolo, detto Bertolini, non è di natura ecclesiastica, ma soggetto alla legge 25 Maggio 1899.
Il Ricevitore, nel poscritto, suggerisce una via d’uscita: «Risulterebbe essere il Beneficio di patronato della Confraternita del SS. Sacramento, la quale potrebbe operarne lo svincolo, giusta quanto dissi in precedenza
6 Lettera del sacerdote Francesco Merlino, Riva Valdobbia, 24 gennaio 1910, indirizzata al Ricevitore dell’Ufficio del Registro di Varallo. Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) n. 149, volume 4, fascicolo 7 – “Istrumenti Bertolini”.
7 Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) n. 149, volume 4, fascicolo 7 – “Istrumenti Bertolini”.
8 Della documentazione relativa all’Oratorio di S. Rocco, ricordiamo ancora: la “Convenzione per costruire l’ancona”, 7 dicembre 1705; il “Disegno dell’oratorio di S. Rocco” (conservato in buono stato, s.d.). Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) n. 146, volume 2, fascicolo 2 – “Oratorio di S. Rocco”.
9 Nel terribile frangente della peste, le comunità invocarono la protezione divina, durante il contagio, e manifestarono il loro ringraziamento per lo scampa-
alla Confraternita stessa senza mai averne ricevuta risposta».
Dello stesso tenore di quelle di don Merlino, sono le ragioni sostenute dal Rizzetti, così come la risposta, negativa, del Direttore Generale del Fondo per il Culto (Roma, 9 aprile 1910), ricalca le argomentazioni sostenute dal Ricevitore del Registro di Varallo.7
L’ORATORIO DI S. ROCCO L’Abate Carestia fu, quindi, l’ultimo investito del Beneficio Bertolino “di S. Maria e dei SS. Pietro e Paolo” e, in quanto tale, cappellano dell’Oratorio di S. Rocco principiando dal 1848. Infatti, il 9 dicembre 1846, don Carlo Angelotti di Cavallirio rinunciava al suddetto Beneficio, che risultava ancora vacante nel 1848, quando il Carestia fu nominato sacerdote. La documentazione conservata in archivio permette di ricostruire le tappe dell’edificazione dell’Oratorio di S. Rocco, avvenuta tra il 1640 e il 1641, che vide il Bertolino come principale promotore. Il 14 maggio 1636 fu emanato il decreto per erigere l’oratorio; al 7 dicembre 1639 risale la supplica per benedire la prima pietra e al 26 marzo 1640 quella per lavorare nei giorni festivi.
L’8 maggio 1640 fu sottoscritta la convenzione per la costruzione dell’oratorio; l’anno successivo furono inoltrate le suppliche per poter celebrare e per benedire il nuovo oratorio, rispettivamente il 1° giugno 1641 e il 16 agosto 1641. Il 26 agosto 1641, si poteva infine procedere alla redazione dell’inventario del nuovo edificio.8
L’oratorio di S. Rocco sorse, quindi, in epoca immediatamente successiva alla peste che colpì duramente, nel 1630, l’alta Valsesia, in particolare la Valle Vogna e Riva Valdobbia. La facciata dell’oratorio presenta in affresco san Rocco con i santi Fabiano e Sebastiano ai lati, restaurati o ridipinti il 28 agosto 1830, secondo l’iscrizione che compare sotto l’architrave.
All’interno, è presente un altare barocco in legno dorato con le statue lignee della Vergine e dei santi Rocco e Sebastiano. Sull’ar-
to pericolo, dopo la sua scomparsa. I santi ricorrenti nelle intitolazione degli edifici e nelle opere pittoriche e statuarie sono quelli tradizionalmente invocati a protezione delle epidemie. Le figure ereditate dalla tradizione medievale (Sebastiano, spesso associato a Fabiano, e Defendente) sono spesso affiancate o addirittura sostituite da quella di S. Rocco, affermatosi nel corso del Cinquecento. segni di questa devozione sono distribuiti lungo la strada del colle Valdobbia, dalle frazioni alte della val Vogna al fondovalle del Sesia. Le notizie relative all’oratorio di S. Rocco, sul testo e in nota, sono state tratte da: Fantoni Roberto, Ferla Attilio, Negro Adriano, Zanoletti Enrico (2010) - 1630, Colle di Valdobbia: una via per la peste. In Fantoni R. e Spotorno M. (a cura di),
“La Montagna attraversata: pellegrini, soldati e mercanti. Atti del convegno di Bard 16-17 settembre 2006”, Club Alpino Italiano Comitato Scientifico Ligure Piemontese, pag. 64.
co sovrastante l’altare un motto latino ricorda il patronato del santo invocato contro la fame, la peste e la guerra (a peste fame et bello / preservans veneratur / in hoc sacello).9
LA CASA DELL’ABATE La Cappellania riconosceva al beneficiario il diritto di abitare la casa sita nei pressi dell’oratorio di S. Rocco, e di percepire una rendita annua. Il relativo atto di vendita, già ricordato da don Bignoli nel suo promemoria, ci descrive la suddetta abitazione, dove visse e morì l’Abate Carestia. Casa civile e rustica nel concentrico di Riva al numero 58 civico, in mappa Rabbini al numero 7909, con annesso giardino cintato – composta detta casa al sotterraneo di due cantine; al pianterreno di atrio d’entrata, piccola stalla, cucina e saletta con altra entrata secondaria e passaggio a notte; al primo piano di cinque stanze ed altra piccola stanzetta; al secondo piano di tre stanze e due piccoli locali con soprastante sottotetto. La casa è murata in pietre e calce, coperta a piode e ha lobbiali in legno a levante; fanno “...” a levante eredi Carmellino Michele e Matolo Maddalena Vedova Carmellino, a mezzodì fabbricali di eredi Carmellino Giovanni, a ponente e notte via e strada comunale per la frazione Gabbio.10
“IL PRATO DELLA FIERA”11 Diversi documenti attestano che il “prato della Fiera”, terreno appartenente al Beneficio Bertolino, si trovava nei pressi dell’attuale cimitero di Riva. Una parte del suddetto prato fu venduto al Comune (sindaco era allora Giacomini Giuseppe) per la costruzione del nuovo cimitero. Ne fa fede una quietanza per £ 360, del 1849, rilasciata dall’Abate Carestia, in qualità di Beneficiato e titolare della Cappellania Bertolino, a favore della Comunità di Riva.12
NOTE A MARGINE
In seguito, come ricordato dal promemoria di don Bignoli, fu venduta, nel 1915, un’altra porzione del “prato della Fiera”, destinata all’ampliamento del cimitero. A questo riguardo, negli anni precedenti la vendita fu oggetto di critica il valore di perizia attribuito, nell’ambito dei beni del Beneficio “di S. Maria e dei SS. Pietro e Paolo”, al prato della Fiera, ritenuto troppo elevato, per le seguenti ragioni.
Il prato della fiera sebbene vicino all’abitato non è in piano ma in terreno alquanto ripido e costituito vicino ai boschi a ponente d’una striscia di prato ove si fa un unico e magro taglio di fieno all’anno […] Non è area fabbricabile non solo per la vicinanza al cimitero ma anche perché soggetto
10 La casa dove visse l’abate fu venduta dalla Confraternita del SS. Sacramento della Parrocchia di Riva Valdobbia, Presidente don Francesco Merlino, arciprete di Riva Valdobbia, ai coniugi Andoli Vittoria e Giacomino Silvio. Atto di vendita, 8 luglio 1920, Notaio Mosè Valenti. Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) n. 149, volume 4, fascicolo 7 - “Istrumenti Bertolini”, carte novecentesche. Nella notte 31 dicembre 1922 - 1° gennaio 1923, mentre Riva festeggiava il Capodanno e si tenevano in paese tre distinti balli (si presume: uno in Società di Mutuo Soccorso, un altro presso l’Albergo delle Alpi), furono distrutte da un incendio doloso sette case che si trovavano attigue alla casa dell’Abate (quest’ultima rimase illesa), le quali, tranne due, non furono mai più ricostruite.
11 Ricordiamo che il giorno di San Michele (29 settembre), al termine della stagione d’alpeggio, si svolgeva a Riva, sin dal tardo medioevo, una fiera. La fiera di Riva era già riconosciuta da una concessione del duca Filippo Maria Visconti del 1424 agli uomini di Pietre Gemelle, comunità che in quel periodo riuniva gli insediamenti di Riva e di Alagna. Nel documento si precisa che la fiera era antica ed era già stata riconosciuta da Giovanni Galeazzo Visconti; risulta quindi antecedente al 1402, anno della morte del duca. Ma la sua origine
alla servitù gravosa della fiera e non immune dal pericolo di valanghe […] Aggiungesi che detto prato essendo attraversato dalla strada provinciale Varallo – Alagna va pure soggetto a non lieve danno pel passaggio e conseguente pascolo abusivo delle bovine in primavera ed autunno.
Il “prato della Fiera” viene citato anche in epoca più antica, in una memoria del 31 dicembre 1714: «Il “...” Sig. Pietro del fu Gioanni Chiarino hanno un prato alla Riva nominato il prato della fiera con il suo castello anesso confina verso matina la strada comune verso sera il croso della (larice) et la strada dei vicini verso mezzanotte Pietro Bertolino minore è pertiche 346. Quel prato è stato venduto [...] Quel prato adesso è del capelano».13
IL BENEFICIO MORCA Il Beneficio Morca, o “Beneficio di S. Antonio”, fu istituito con testamento Michelangelo Morca il 2 ottobre 1733, mentre il relativo atto di erezione canonica è del 18 Gennaio 1744. Il Beneficio seguì una sorte analoga al Beneficio Bertolino; la sua estinzione venne disposta «col Decreto Vescovile di unione del benefico coadiutoriale di San Antonio in Valle Vogna e cotesto Beneficio parrocchiale, in data 27 dicembre 1920, munito di R. Assenso con R.o Decreto 31 Agosto 1921».14

LA DOCUMENTAZIONE La parte più consistente della documentazione riguardante la Valle Vogna e le sue “squadre”, era custodita presso l’ex casa coadiutoriale di S. Antonio; purtroppo, è andata perduta sul finire del secolo scorso. Riguardo al Beneficio Morca, sono ancora conservati nell’archivio parrocchiale i seguenti, principali documenti:
è probabilmente più antica. Tratto da: Fantoni R. e Ferla A., La fiera di San Michele a Riva, in Fantoni R. et al. (a cura di), “La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione. Atti della XXI edizione degli Incontri tra/montani”. Incontri tra/montani, Gruppo walser Carcoforo, 2011, pagine 273-274. Lo scritto, con alcune revisioni, è stato successivamente pubblicato dagli stessi autori in: La Fiera di S. Michele a Riva, “Wohnen – Woona Vogna”, Annuario 2018, pag. 41, 2019. 12 Sala Parrocchiale di Mollia, 13 febbraio 1849. Presenti: don Giuseppe Gianoli, Parroco Vicario Foraneo, quale Delegato Vescovile; Regio Notaio Collegiato Giuseppe Carestia, Delegato della Regia Intendenza di Varallo. Testimoni: Amedeo Molino, di Campertogno, Pietro Janni, di Mollia. Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) n. 149, volume 4, fascicolo 7 – “Istrumenti Bertolini”.
13 Un altro documento settecentesco, tratta della “Misura del Prato della Fiera”, fatta l’anno 1774, il mese d’ottobre. “Note anonime (promemoria)”, Riva, 6 novembre 1912, scritto indirizzato all’Intendenza di Finanza di Novara. Entrambi documenti citati sono rinvenibili nell’Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) n. 149, volume 4, fascicolo 7 – “Istrumenti Bertolini”.
14 Regio Economato, Torino, 20 gennaio 1922. A Don Francesco Merlino, Parrocchia di S. Michele, Riva Valdobbia, Vendita stabili. Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) N. 149, Volume 4, Fascicolo 4 – “Beneficio Morca”.
“Accettazione dell’eredità di Morca Michelangelo”; “Istituzione della cappellania coadiutoriale di S. Antonio nella Valle Vogna”; “Supplica con relativo decreto”; “Ricorso e decreto per la celebrazione di messe”; a questi si aggiungono altre, varie carte, degli anni 1838-1924.
Di seguito, presentiamo in sintesi i principali temi che sono trattati nella documentazione consultata, limitandoci a segnalare, invece: le convenzioni con i terrieri; gli atti di vendita d’alcuni lotti.
EMOLUMENTI E ONERI DEL COADIUTORE In un documento, redatto dal «Rev. Coadiutore di questa valle di Vogna a norma della fondazione, e de’ venerati Decreti emanati 6 Agosto 1828 – e 1° Luglio 1831 da sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale

Giuseppe Morozzo Arcivescovo - Vescovo di Novara Delegato Apostolico», sono specificati gli Emolumenti e gli Oneri perpetui previsti in capo al coadiutore e cappellano del Beneficio Morca - “di S. Antonio”. Oltre alla dettagliata regolamentazione della celebrazione della S. Messa, sono contemplate delle opere di misericordia da praticare in favore degli abitanti della Valle Vogna.
1°. Il Coadiutore percepirà ogni anno dalla comunità di Vogna lire Milanesi seicento colla legna necessaria durante l’annata da portarsi a sua casa coadiutoriale per la celebrazione ed applicazione della S.a Messa in tutte e singole le Domeniche e feste di precetto dell’anno in questo ven.do oratorio di S. Antonio, e per l’adempimento pure dei seguenti Oneri. Si osserva che Egli potrà percepire pure integralmente il prenarrato emolumento, ove per malattia o per altre ben giuste cause da riconoscersi tutte le volte ed approvarsi dal Rev.do Curato locale tralasciasse annualmente di celebrare ed applicare messe festive quattro o cinque al più, con che però si supplisca colla celebrazione ed applicazione di altrettante messe in questo medesimo ven. do oratorio ed in giorni feriali di particolare devozione.
2°. Egli riceverà pure dalla pregata comunità l’annuo reddito superanti l’importo delle spese occorribili e le lire seicento sovra accennate, annuo reddito che dovrà convertire nella celebrazione ed applicazione di tante messe, alla limosina di lire una e cent.mi
NOTE A MARGINE
venticinque moneta nuova di Piemonte per ogni messa celebrata in questo stesso ven.do Oratorio, ed alla sola tassa sinodale per ogni messa celebrata fuori dal medesimo ven.do Oratorio.
3°. Egli dovrà all’aurora, o circa come nei giorni festivi celebrare la S.a Messa, ma però senz’applicazione, nel suddetto ven.do Oratorio ne’ giorni di particolare devozione, cioè alli 17 Gennaio – nel terzo giorno di Pasqua – alli 1. 4. 8. di Maggio – nel terzo giorno di Pentecoste – alli 15 e 24 di Giugno – alli 25 e 26 Luglio – alli 5, 10, 16, 24 di Agosto – alli 21 e 29 di Settembre – alli 28 di Ottobre – alli 30 di Novembre – alli 21, 27 e 28 di Dicembre ed annualmente.
4°. Dovrà anchesì il Rev.do Coadiutore non munito della facoltà di udire le confessioni fare scuola pel corso di mesi cinque d’ogni anno, ne’ mesi cioè di Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo a dodici poveri figli di questa valle per tali giudicati dal molto Rev.do Curato locale.
5°. E finalmente il Rev.do Coadiutore dovrà a norma della fondazione e delle sinodali prescrizioni recitare col popolo immediatamente dopo il Vangelo gli atti di fede, speranza, carità e di contrizione e quindi insegnare
su quattro colonne affrescate che terminano con capitelli a stucco si appoggia una bella cupola, mentre la volta dell’abside si presenta a spicchi di vela. Sul bell’altare di legno scolpito e dipinto con colonne ritorte, si trovava una tela raffigurante la Madonna con Bambino tra S. Michele e S. Antonio Abate; si segnalano, inoltre, il paliotto raffigurante S. Antonio e le tele originali portate da Rabernardo raffiguranti la Sacra Famiglia e S. Giovanni Battista. L’oratorio era anche ricco di ex voto.
La ex casa coadiutoriale, attualmente Rifugio comunale, è stata sede delle scuole elementari sino alla metà degli anni settanta del secolo scorso. Nell’edificio sono ancora conservate le tracce della antica residenza del cappellano, con due stufe in pietra ollare, un ritratto settecentesco e un armadio datato 1775, in cui erano archiviate le carte del Beneficio e della comunità della Val Vogna.16

le coadiutoria titolare”, in data 6 febbraio 1909, il funzionario del Regio Economato, dopo aver interpellato la Curia Vescovile, così risponde alla richiesta di chiarimenti proveniente da don Eugenio Mongini.
Ho esaminato il voluminoso atto di erezione canonica del Beneficio, in data 18 Gennaio 1744. Dall’inferta testamentaria disposizione del fu Michelangelo Morca 2 Ottobre 1733, risulta apposta la seguente condizione […]
Jachetti Carlo di Serveglio e Michele Carestia di Casa Janzo, cui successe Orso Pietro di Rabernardo e quindi Favro e Pajno, che seguitarono a tener l’amministrazione non essendosi mai saputa la morte del Sommi avvenuta fuori Diocesi».18
IL BENEFICIO MORCA E L’ABATE CARESTIA
la dottrina cristiana agli assistenti in tutte le Domeniche e feste di precetto; confessare gli uomini di questa valle, visitare gli infermi e sacramentarli, ed assistere ai moribondi della medesima valle.15
L’ORATORIO DI S. ANTONIO ABATE E LA CASA DEL CAPPELLANO Il Beneficio Morca prevedeva, come abbiamo visto, che l’investito assolvesse la funzione di cappellano dell’oratorio di S. Antonio Abate, posto nell’omonima frazione della Valle Vogna, a quota 1381 m.
L’oratorio di S. Antonio, di impianto seicentesco, fu ampliato a metà Ottocento e nuovamente benedetto il 10 ottobre 1851.
La chiesetta ha il tetto a capanna coperto a piode e campanile emergente da terra a pianta quadra, con porticina d’ingresso, loggia campanaria, orologio, meridiana e la data 1733. Il fronte è tipico valsesiano, con portale centrale e finestre ai lati; in alto, sopra il timpano a triangolo spezzato, il lunotto. Al centro della facciata, sopra il timpano, in finta nicchia, S. Antonio Abate e ai lati S. Michele e S. Bernardo sopra la trabeazione, la Madonna Immacolata. L’interno è a pianta rettangolare e nel transetto
15 Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) N. 149, Volume 4, Fascicolo 4 – “Beneficio Morca”. Giuseppe Morozzo fu Arcivescovo-Vescovo di Novara dal 1817 al 1842, anno della sua morte.
Ecco come la residenza risulta brevemente descritta, dopo aver specificato che gli abitanti della Valle Vogna erano allora circa 260, dall’arciprete di Riva, don Francesco Merlino, in una lettera del 23 maggio 1919, indirizzata al Vicario Generale: «La casa consta di un ampio locale per la scuola e di 2 cantine nel sotterraneo più 2 piccoli vani pel ripostiglio di legna; di 4 ambienti al pianterreno; di altri 4 ambienti al primo piano, e di sottotetto».17
AMMINISTRAZIONE DEL BENEFICIO Dalla lettura della corrispondenza, si rileva talvolta una vivace dialettica tra l’arciprete di Riva e la Curia novarese, da una parte, e i terrieri, rappresentanti della comunità della Valle Vogna e “patroni” del Beneficio, dall’altra. E’ il caso del primo semestre del 1909. Il 23 gennaio, emerge da una lettera del Regio Economato a don Eugenio Mongini, che i terrieri di Valle Vogna rivendicano i loro diritti in merito all’amministrazione delle rendite relative al Beneficio Morca. Sempre riguardo al diritto dei terrieri di Vogna di amministrare i beni della “loca-
Intanto i terrieri di Vogna patroni della coadiutoria hanno in virtù dell’atto di fondazione e di erezione della medesima il diritto di amministrare i beni, salvo l’obbligo di dare il conto della gestione al parroco di Riva Valdobbia cioè alla S.V. investita del Beneficio parrocchiale che perciò ha il mezzo di investigare che non accadano irregolarità e malversazione nell’amministrazione dell’ente, riferendone, occorrendo, a questo Economato per i provvedimenti opportuni.
Infine, Il 30 giugno 1909, don Giacomo Mongini, parroco di Riva dal 1867 al 1907, in una lettera scritta da Soriso ad un imprecisato cugino (si presume: don Eugenio Mongini, succeduto a Giacomo come parroco a Riva), precisa che, quando: «Il Sac. Sommi abbandonò la residenza senza rinunciare al Beneficio, fu allora che gli uomini di Vogna affidarono l’amministrazione a due di loro ed i primi furono
L’abate Carestia non fu mai investito del Beneficio Morca; quindi, non fu né cappellano dell’oratorio di S. Antonio in val Vogna, né maestro della scuola della stessa frazione. Vi fu un Carestia, don Giuseppe, che risulta dai documenti esaminati coadiutore e cappellano dal 1819 al 1849. D’altronde, l’Abate era già investito del Beneficio Bertolino, quindi era improbabile che potesse corrispondere anche agli oneri di altro Beneficio. Facendo riferimento al periodo in cui l’Abate Carestia era stabilmente a Riva, in qualità di cappellano di S. Rocco (1848 –1908), si possono fare le seguenti, ulteriori osservazioni.
1. Dal 1848 al 1862, il Beneficio Morca (“di S. Antonio”) era provvisto di un proprio cappellano titolare.
2. Dopo tale periodo, visto che don Sommi, ultimo titolare, abbandonò nel 1862 la residenza senza rinunciare formalmente al Beneficio, fu l’arciprete di Riva che surrogò di fatto, previe le debite, superiori autorizzazioni, il cappellano mancante, fin quando, nel 1920, col Decreto Vescovile di unione del beneficio coadiutoriale di San Antonio
NOTE A MARGINE
16 Notizie tratte da: Roberto Fantoni, Piero Carlesi e Attilio Ferla, Guida ad un’escursione in Val Vogna. L’eredità tardo-medievale: allevamento e cerealicoltura in una valle alpina, in Fantoni R. et al. (a cura di), “La cucina delle Alpi tra tradizione e rivoluzione. Atti della XXI edizione degli Incontri tra/montani”. Incontri tra/montani, Gruppo walser Carcoforo, 2011, pagine 237-238.
17 Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) N. 149, Volume
4, Fascicolo 4 – “Beneficio Morca”
18 Don Natale Sommi, citato da don Giacomo Mongini, abbandonò la residenza nel 1862, come vedremo più avanti. Il primo documento, del 23 gennaio 1909, lo troviamo nell’Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) n. 149, volume 4, fascicolo 7 – “Istrumenti Bertolini”; il secondo e il terzo documento, rispettivamente del 6 febbraio 1909 e del 30 giugno 1909, sono conservati nell’Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) N. 149, Volume 4, Fascicolo 4 – “Beneficio Morca”.
in Valle Vogna alla Parrocchia, venne a cessare la vacanza di detta coadiutoria.
3. L’arciprete di Riva poteva avvalersi (si ritiene, soprattutto a partire da fine ottocento), tramite atto di delega e sotto la sua vigilanza, di maestri di professione19 per l’insegnamento della religione; per quanto riguarda, invece, il primo periodo, posteriore al 1862, non è escluso che l’abate Carestia, ancora giovane, salisse una o due volte alla settimana, anche d’inverno, a insegnare ai fanciulli la dottrina cristiana e/o officiare delle messe, qualora ne fosse richiesto. D’altronde, egli, nella bella stagione, compiva sovente delle arborizzazioni nella Val Vogna; è probabile che alcune volte facesse tappa presso la casa coadiutoriale di S. Antonio, ideale punto di partenza per le sue ascensioni in alta quota. È vero, però, che anche le ipotesi ora accennate, non hanno trovato dei riscontri documentari. L’Arciprete Francesco Merlino di Riva, scrivendo al Vicario generale, il 10 giugno 1919, ci ricorda quali furono i beneficiari del Beneficio Morca “di S. Antonio”.
Osservo che dall’archivio Coad. Di V. Vogna furono dai procuratori di quel Beneficio durante le vacanze ed assenze dei titolari aspor-
NOTE A MARGINE
tati e smarriti diversi documenti per cui mi riesce impossibile dare un elenco preciso dei coadiutori e loro durata in possesso. Consultando l’archivio risulta che il primo coad. fu il sac. Michele Graulo investito del Beneficio nel 1744. Dal registro stato d’anime appare che dal 1760 al 1792 per lo meno era Coad.

D. (.)ieri Sca(..)nal della diocesi d’Aosta. Nel “… - …” V. Luigi Lirelli; nel 1813-1814 D. Franco Morini; dal 1815-1818 D. Gnifetti; dal 1819 al 20 Maggio 1849 D. Giuseppe Carestia; dal 1849-1850 D. Lagnini Antonio; dal 1852-1858 D. Prato; dal 1859- 1860 D. Antonio Ferraris; dal 1860-1862 D. Sommi Natale che abbandonò la residenza senza rinunciarvi.
Pertanto, dall’elencazione fatta da don Merlino, vi è la conferma che l’Abate Carestia non ricoprì l’incarico di cappellano titolare dell’oratorio di S. Antonio Abate. A complemento di questo articolo, si è ritenuto interessante illustrare, in sintesi, l’archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, che conserva una ricca documentazione, oltre a quella riguardante i Benefici.
RINGRAZIAMENTI Si ringraziano sentitamente don Carlo Elgo e don Marco Barontini.
19 Dall’Archivio Storico Comunale (F 112; U 435) risultano i: “Convocati comunità di Riva per la nomina del maestro”, a partire dal 1831; e le: “Nomine di insegnanti per le scuole elementari maschili e femminili di Riva e per quella di Vogna”, a partire dal 1871. Frascotti Maggiorina fu la maestra nominata nel 1886 espressamente per la “scuola di Vogna”. Un documento del 1920, trattando dell’insegnamento della religione a scuola, prevede l’affidamento alla Maestra, da parte del parroco di Riva, don Francesco Merlino, “ed alle di lui dipendenze e vigilanza”, dell’impegno, retribuito, di insegnare una volta alla settimana la religione ai fanciulli della Valle Vogna. Il 14 novembre del medesimo anno, i coadiutori, terrieri della valle Vogna, “chiedono che per l’insegnamento della religione ai fanciulli sia necessario richiedere il consenso ai loro genitori”. Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) N. 149, Volume 4, Fascicolo 4 – “Beneficio Morca”
20 Archivio parrocchiale di Riva Valdobbia, (faldone) N. 149, Volume
APPENDICE: L’ ARCHIVIO STORICO DELLA PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO IN RIVA VALDOBBIA
IMPORTANZA DELL’ARCHIVIO PARROCCHIALE L'archivio parrocchiale, oltre ad essere un’importante fonte per lo studio della storia religiosa e civile di una comunità, svolge delle essenziali funzioni di natura amministrativa e di natura pubblica. Una funzione pubblica, “notarile”, viene precipuamente svolta dal parroco riguardo agli atti contenuti nei registri dei battesimi, dei matrimoni, dei defunti, dello stato d'anime e delle cresime. A questo riguardo, precisiamo che l’obbligatorietà della compilazione dei registri parrocchiali dei Battesimi e dei Matrimoni fu decretata durante il Concilio Ecumenico di Trento (1545-1563), nel 1563. La norma fu poi estesa anche alle Morti e agli Stati delle anime, nel 1614. Nello “stato delle anime”, il parroco registrava i componenti dei “fuochi” famigliari, intesi come comprensivi anche delle persone che, per qualsiasi ragione, vivevano insieme alla famiglia naturale. Gli “stati d’anime” venivano redatti nel corso dell’annuale benedizione delle case, o in occasione delle visite pastorali.
L’ARCHIVIO PARROCCHIALE DI RIVA VALDOBBIA La Parrocchia di Riva Valdobbia, anticamente denominata Pietre Gemelle, fu costituita nel 1326, a seguito della separazione dalla “pieve” di Scopa. Da Riva si formò poi, nel 1475, la parrocchia di Alagna.
4, Fascicolo 4 – “Beneficio Morca”
21 I registri parrocchiali sono una fonte indispensabile di conoscenza per le epoche precedenti l’istituzione dell’anagrafe civile. Il Regno d'Italia istituì presso ogni Comune la prima anagrafe, non obbligatoria, con RD 31 dicembre 1864, n. 2105, rendendola obbligatoria con la legge 20 giugno 1871, n. 297.
22 Le informazioni sono tratte dalla introduzione all’inventario analitico dell’Archivio storico della Parrocchia di S. Michele di Riva Valdobbia, redatto dalla dottoressa Rossella Ratto.
23 E’ doveroso ricordare e ringraziare, anche in questa sede, il dr. Adriano Negro, per la sua importante ricerca anagrafica compiuta negli anni 2005-2006, sugli antichi registri parrocchiali di Riva. Il lungo, preciso e completo lavoro, indispensabile strumento per effettuare degli studi genealogici, è stato predisposto su base informatica, mentre un esemplare cartaceo è stato allora donato dal dr. Negro alla parrocchia, in occasione della tradizionale festa patronale di S. Michele Arcangelo.
La Parrocchiale di Riva è dedicata a San Michele Arcangelo, con Compatrona Maria SS. Assunta. Della Parrocchia, comprendente la Valle Vogna, fanno parte dieci oratori e una ventina di cappelle ad orandum. L’archivio della Parrocchia di Riva Valdobbia si trova presso la casa parrocchiale; è stato riordinato una ventina d’anni fa, a cura della dottoressa Rossella Ratto, archivista paleografa; all’epoca, era già arciprete don Carlo Elgo. Lo stato di conservazione del materiale documentario è generalmente buono; l’archivio si presentava già abbastanza ordinato al momento del succitato intervento. Il relativo inventario analitico consta di 193 numerazioni. Ciascun numero può riferirsi o al semplice registro-libro o al “volume”, (corrispondente a uno o due faldoni), composto da fascicoli a loro volta numerati; sono inoltre specificati l’oggetto e la data. La data è indicata per estremi cronologici nel caso si tratti di registri e raccolte. Quando sussiste, viene riportata nell’inventario anche la vecchia numerazione. Presentiamo ora brevemente i contenuti dell’archivio parrocchiale, partendo dalla “Anagrafe” (numeri 1-118), della quale segnaliamo: il Liber Baptizatorum, matrimoniorum et aliquorum mortuorum, che inizia le registrazioni già a partire dal 1553, dieci anni prima delle relative disposizioni tridentine di obbligatorietà; il primo Liber status animarum, degli anni 16411653; le prime registrazioni delle “confermazioni”, che prendono avvio dal 1698. La “Contabilità” (n. 119-143), si apre con il Liber missarum legatarum del 1641-1714.
Segnaliamo, inoltre: il Libro debitorum della chiesa parrocchiale, che parte dal 1597; il Libro “speso e ricevuto”, confessi e fatture, ecc. (fine sec. XVI in avanti).
Passando ai “volumi”, il primo (n. 144), è composto dai seguenti cinque fascicoli. F. 1, 1475 in avanti: atto di separazione da Alagna ed obblighi di questa, 17 giugno 1475; divisione dei territori di Riva e Alagna, diritti di Riva, compravendite terreni, ecc. F. 2 - Chiesa parrocchiale; convenzioni, suppliche, compravendite terreni, decime, dal 1594 in avanti. F. 3 – Campanile: convenzioni, accordi, suppliche, dal 1661 in avanti; segnaliamo la convenzione per
NOTE A MARGINE
la costruzione del campanile, quello più grande, del 20 febbraio 1661. F. 4 – Reliquie: autentiche, altro, dal 1660 in avanti. F. 5 – Lavori nella chiesa parrocchiale: erezione Via Crucis, 5 giugno 1746; altro. Il n. 145 contiene la documentazione relativa all’organo della parrocchiale: visita, collaudi, capitoli dei lavori, lite contro la ditta “Zali”, dal 1767 in avanti. Il secondo volume (n. 146) è composto da quattro fascicoli. F. 1 – Inventari, dal 1586 in avanti. F. 2 – Oratorio di S. Rocco: decreto per erezione, suppliche, convenzioni, ecc, dal 1621 in avanti. F. 3 – Oratorio S. Antonio da Padova, Vogna di là: suppliche, ecc, dal 1630 in avanti. F. 4 – Oratori e cappelle ad orandum: suppliche, ecc, dal 1594 in avanti. Inoltre, il volume contiene altre documentazioni, relative ai seguenti oratori. Carte dell’Oratorio di Isolello: benedizioni, suppliche, erezione cappellania, donazioni, compravendite, testamenti, ecc, a partire dalla benedizione dell’oratorio, dedicato all’Immacolata Concezione, avvenuta l’otto dicembre 1642. Carteggio Oratorio S. Croce al Buzzo: contenente lo stesso tipo di documentazione indicata per l’oratorio di Isolello, dal 1545 in avanti. La raccolta relativa al secondo volume prosegue nel n. 147, dove troviamo il fascicolo 5 – Compere e locazioni di beni della chiesa, dal 1595 in avanti; e il f. 6 – Atti di Visite Pastorali: visita di Mons. Bertone, 1760, altre visite. Del terzo “volume” (n. 148), viene prima riportato nell’inventario il contenuto relativo al fascicolo n. 4 –“Istrumenti di vari particolari dal 1483 al 1712” e seguenti; si tratta di atti giuridici di varia natura: vendite, obblighi, affitti, divisioni, confessi, ecc. Fanno eccezione, nell’ambito di questa raccolta, due documenti che riteniamo meritevoli di essere segnalati: “Convocato dell’intiera comunità di Riva”, 2 gennaio 1797; “Procura speciale delle due comuni unite di Riva e Vogna”, 2 marzo 1801. Sempre nel n. 148, V.3 f.4, troviamo alcuni interessanti documenti relativi all’Alpe Larecchio, un tempo appartenente alla Parrocchia di Riva: confini, cessione dell’alpe, affitti, ecc, dal 1722 in avanti.
Proseguiamo con gli altri fascicoli del ter-
24 Un tempo c’era una cappella anche alla frazione Gabbio, costruita negli anni 1733-1735, sotto il titolo della natività della Beata Vergine Maria e presumibilmente andata distrutta a causa dell’alluvione del Sesia, avvenuto intorno al 1817-1818. Nel 1819, in un documento, si
zo volume (sempre n. 148).
F. 1 – “Testamento di Zanolo Chiesa, istrumenti e pergamene di legati dal 1476 al 1734”.F. 2 – Collezione di diritti, ragioni, accordi, convenzioni, estimi e cambi (fine sec. XVI, in avanti); tra gli altri: “Copia del diploma del duca Francesco Sforza riguardo alla fiera di Riva”, 12 luglio 1451; copia del 1874. F. 3 - Quietanze e confessi (1542 in avanti).
Il “volume” quarto (n. 149) è composto da undici fascicoli. F. 1 – Legati e suppliche e decreti relativi. F. 2 – Norme riguardanti l’occupazione dei beni delle Opere Pie e della chiesa (documenti di nomina parroci, presa di possesso del beneficio e congrua), 1881 – 1960. F. 3 – Ospizio Valdobbia (pochi documenti, presenti anche nell’archivio storico comunale, tra i quali ricordiamo: “Estratto del testamento del canonico Nicolao Sottile”, 27 dicembre 1832). F 4. – Accettazione dell’eredità di Morca Michelangelo; istituzione della cappellania coadiutoriale di S. Antonio nella Valle Vogna; supplica con decreto relativo; ricorso e decreto per la celebrazione di messe, ecc. F. 5 – Fondazione della cappellania laicale Graulo (1792 in avanti). F. 6 – Testamento di Verno Giuseppe (1772 in avanti). F. 7 – “Istrumenti Bertolini”. Fascicoli 8, 9, 10, 11 – Testamenti di Caterina Graulo, Antonia Graulo, Antonia Perello, Anna M. Chiesa (1743 in avanti). Il “volume” quinto (n. 150) contiene tre fascicoli.
F. 1 – “Istrumenti Zolla” (1540 in avanti).
F. 2 - “Istrumenti Ianne” (1528 in avanti). F. 3 – “Legati” (1599 in avanti).
Il “volume” sesto (sempre n. 150) riguarda l’“Eredità Matolo” (sec. XIX). Infine, facciamo un cenno alle ultime numerazioni dell’inventario: (151- 160) – Confraternite (istituzione, amministrazione, ecc., 1640 in avanti); (161-179) – Oratori e cappelle (entrate, uscite, amministrazione, ecc.): S. Croce, Buzzo; S. Grato, Peccia; Madonna delle Pose; Madonna del Lancone; S. Antonio da Padova, Vogna di là; S. Rocco, Riva centro; oratorio scomparso del Gabbio; S. Pietro alla Balma; Visitazione della Madonna, Boccorio; Beneficio coadiutoriale di S. Antonio Abate, Val Vogna; (180-185) – Mutua (sec. XX); (186- 193) – Varie (sec. XX).
parla già della sua riedificazione, cosa in realtà mai avvenuta. Vedi: Ebe Bello Lanzavecchia, Riva Valdobbia (Ripa Petrarum Gemellarum), p.50, 1976. L’autrice trae le informazioni sulla ex cappella del Gabbio dal Libro di cui al n. 171 dell'Archivio Parrocchiale: “Libro del speso et ricevuto per la cappella ossia oratorio del Gabbio” (17331822).
Echi di ribeba in Val Vogna
di Alessandro ZoltLE ORIGINI E I PRIMI DOCUMENTI Non è una sorpresa che la Val Vogna, sbocco naturale della Valsesia sulla Valle del Lys attraverso il passo di Valdobbia (2480 m.), abbia svolto un ruolo centrale nella curiosa storia della produzione e del commercio della ribeba (ossia lo scacciapensieri), vicenda che vede protagonista varie frazioni soprattutto dell'alta valle, fra cui la più famosa è senz'ombra di dubbio Boccorio.

La produzione di ribebe in Valsesia si sviluppa almeno dalla seconda metà del XV secolo1 fino agli ultimi anni del XIX e, attraverso i primi documenti disponibili, risalenti al XVI-XVII secolo (contratti tra mercanti o tra mercanti e fabbri), risulta evidente come il canale commerciale principale in questa prima fase sia stato quello valdostano, con acquisti di grosse quantità di strumenti da parte di mercanti provenienti soprattutto da Brusson. Le casse che contenevano centinaia di ribebe hanno costantemente valicato a dorso di mulo il colle di Valdobbia per quasi tutta la durata della produzione, passando per la Val Vogna.
Lo stesso percorso veniva fatto nella dire-
NOTE A MARGINE
zione inversa per quanto riguarda le materie prime provenienti dalla Valle d'Aosta2 e necessarie alle officine: nell' “Elenco delle miniere, fonderie e fucine con martinetti esistenti in Valsesia”, redatto nel 1829, si riferisce che mentre il ferro “rottame” era fornito alle fucine valsesiane da “diversi particolari”, il “ferro nuovo” proveniva
“dalle fonderie di Campertogno e di Balmuccia in questa Provincia e da quelle di Grassonej Provincia d'Aosta, introducendolo dalla Valdobbia sull'Estate”3. Ancora nella memoria orale di Remo Carmellino (1922-1986), uno degli ultimi discendenti diretti delle famiglie coinvolte nella produzione, era vivo il ricordo del “acciaio di Cogne (Valle d'Aosta) trasportato a spalla attraverso la valle di Gressoney, il colle di Valdobbia e la Val Vogna, fino a Boccorio”4
Tutto questo particolare commercio non lasciò passivi gli abitanti della Val Vogna: almeno due documenti testimoniano come essi fossero al contrario ben coinvolti. In un contratto rogato il 21 agosto 15885, Antonius de Clarino de Super Ripa cede a Jacobo de Murcha de Vogna come pagamento grossarum decem zanforgnarum et
1 È famoso il primo documento che attesta la presenza della produzione in valle: un contratto notarile del 1524 in cui degli appezzamenti di terreno sono scambiati con sessanta dozzine di ribebe. Questo fa intendere che la produzione doveva già essere avviata durante il XV secolo. La manifattura di prodotti metallici in alta Valsesia era già fiorente in quel secolo come si capisce tra l'altro dal numero di fucine attestate in un estimo del 1487 di Campertogno (che all'epoca includeva anche Mollia) (F. Dessilani, Uomini e insediamento in Alta Valsesia alla fine del Medioevo. Campertogno e Mollia nel 1487, «De Valle Sicida», XXV, 2015, pp. 31-32). A questo si può aggiungere anche la presenza nel 1467 di donzene V zamporgnarum nella bottega milanese del mercante Antonio de Mozate. Si può supporre, senza forzare troppo la mano, che queste zamporgne provenissero dalla Valsesia, vista anche la posizione geografica di Mozzate (oggi in provincia di Como), paese situato verso occidente e in contatto con il Piemonte orientale su un'ipotetica strada che connette l'area
tromparum; ogni grossa era costituita da 12 dozzine, quindi si parla di 1440 strumenti! Il dettaglio forse più interessante di questo documento è il bilinguismo nella nomenclatura della merce: mentre nei contratti coevi tra “latini” viene spesso usata la doppia espressione zamporgnarum seu rubebarum oppure ciamporgnarum vulgo rubebe, riportando un nome più ufficiale per il latino o l'italiano basato sulla radice “zampogna”6 e di uno più locale e dialettale basato sulla radice “ribeba”, in questo caso

valsesiana con Milano (M. P. Zanoboni, Artigiani, imprenditori, mercanti. Organizzazione del lavoro e conflitti sociali nella Milano sforzesca (1450-1476), Firenze, La Nuova Italia, 1996, p. 112).
2 La Valle d'Aosta non era l'unica origine del ferro e dell'acciaio (quest'ultimo necessario per la fabbricazione della linguetta della ribeba, cuore sonoro dello strumento). Normalmente si prediligeva l'acciaio bergamasco ed infatti nel Quadro Statistico per l'anno 1835 nel comune di Riva si riporta che fabbri di ribebe, obbligati a ricorrere all'acciaio valdostano, si definivano “languenti” a causa della “proibizione d'entrata del ferro bergamasco”. Si imploravano dunque le autorità di provvedere a rimediare “una strada carrozzabile e il permesso dell'ingresso del ferro [bergamasco] senza dazio” (sASVc [da qui in poi per Archivio di Stato di Vercelli, Sezione di Varallo], Archivio della Viceintendenza della Valsesia, m. 172, Quadri statistici del comune di Riva).
3 sASVc, Archivio della Viceintendenza della Valsesia, m. 187.
4 A. Lovatto, Primi appunti sulla ribeba in Valsesia Bologna, Università degli Studi di Bologna, 1983, p. 11.
5 sASVc, Fondo Museo Calderini, Famiglia Chiarini, m.26.
che vedeva coinvolto un abitante della Val Vogna viene invece scritto il nome in lingua romanza da un lato e quello in lingua tedesca dall'altro. Ancora oggi infatti trumpa7 e trompo8 sono i nomi dello scacciapensieri nella lingua Walser rispettivamente ad Alagna Valsesia e a Gressoney, che a loro volta derivano da quelli usati nel tedesco svizzero (trümpi, trümmi, trimpi9). Questa curiosa premura del notaio è certamente da attribuire alla situazione multietnica presente nel vallone, risultato dell'insediamento a partire dall'inizio del XIV secolo da parte di coloni walser provenienti da Gressoney e coloni valsesiani provenienti da Riva10.
In un altro contratto, redatto il 30 maggio 161311, Antonius del Picco de Vogna paga a Giovanni Pietro Tosino, mercante di Ameno residente a Varallo, 176 lire im-
NOTE A MARGINE
6 A questo proposito è curiosa la presenza di una famiglia gressonara dal cognome Zamponali tra le prime ad abitare la frazione Peccia agli inizi del XIV secolo (R. Fantoni, La Val Vogna (Alta Valsesia). Un insediamento multietnico tardomedievale sul versante meridionale del Monte Rosa, «Augusta», 5, 2008, p. 59). La lieve assonanza con “zampogna” potrebbe portare a pensare ad un legame forse legato al commercio o alla manifattura dello scacciapensieri ma, stando ai dati finora disponibili, questo sembra poco probabile. Cognomi molto più chiaramente riferibili al termine sono presenti in altre aree del Piemonte già un secolo prima: Iacobus Champorgna da un documento redatto a Rivoli nel 1194, cognome che poi diventa Zamporgna in un altro documento del 1202 (I. Ruffino, Storia ospedaliera antoniana: Studi e ricerche sugli antichi ospedali di sant'Antonio abate, Cantalupa, Effatà Editrice, pp. 201-203 e 208-210). Il cognome Zamporgna compare anche a metà del XV secolo tra capi di casa di Locana, in Valle Orco (A. Bertolotti, Passeggiate nel Canavese Tomo VI, Ivrea, Tipografia Curbis, 1873, pp.192-193).
7 G. Giordani, La colonia tedesca di Alagna-Valsesia e il suo dialetto Varallo Sesia, Unione Tipografica Valsesiana, 1927, p. 184.
8 B. Salvadori, B. Favre, Walser Témoignage d'une civilisation, Aosta, Musumeci, 1979, p. 92.
periali per una quantità non specificata12 di scacciapensieri (tot rubebarum), che probabilmente il Tosino a sua volta acquistava all'ingrosso da fabbri alle sue dipendenze13. Una cifra in denaro considerevole che, come nel precedente caso, testimonia il ruolo degli abitanti della Val Vogna come intermediari commerciali tra Valsesia e Valle d'Aosta.
Ci si può rendere conto della vastità che un tale mercato abbia potuto raggiungere se si prende anche in considerazione il fatto che almeno fino al XVII secolo Gressoney era parte attiva di una rete commerciale che apriva queste impervie zone alpine ai principali mercati dell'Europa centrale e settentrionale, ed è facile immaginare che le ribebe facessero parte delle merci interessate dai viaggi degli abitanti della cosiddetta Krämertal (ossia la valle dei mercanti, come tradizionalmente era conosciuta la valle di Gressoney).
RIBEBE “MADE IN VAL VOGNA” Gli scacciapensieri non si limitarono semplicemente a transitare in Val Vogna: attraverso i documenti d'archivio è possibile infatti capire come nel corso del XIX secolo le ribebe vi venissero anche forgiate.
Nella Pubblica Denuncia delle Fucine avvenuta in Valsesia tra il 1827 e il 1828, sulle 14 risultanti nel territorio di Riva, una sola
NOTE A MARGINE
era presente e attiva, se non in Val Vogna quantomeno subito all'imbocco della valle: si trattava di una fucina dotata di due fornelli e due magli nella frazione al di là della Vogna (oggi Vogna di là) e in attività “da tempo immemoriale” dedita a “ridurre il ferro in utensili di casa e di campagna” per nove mesi all'anno14. Nessuna traccia di ribebe, fabbricate invece (ed esplicitamente dichiarate tra i prodotti nella rispettiva denuncia) nelle fucine di Isolello, Boccorio e Buzzo, per quanto riguarda le altre officine di Riva.
9 B. Bachmann-Geiser, Die Volksmusikinstrumente der Schweiz, Leipzig, VEB Deutscher Verlag für Musik, 1981, p. 38.
10 Fantoni 2008, p. 61.
11 sASVc, Fondo Notarile, Notaio Lassere Giovanni Battista, 10140 f. 131.
12 Doveva comunque trattarsi di un ragguardevole numero di strumenti. Per avere un'idea, ad esempio in un contratto del 1617 il fabbro Michele Negri di Buzzo Michael de Negris de Super Butio Vallis Sicide) promette di consegnare al mercante di Varallo Giovanni Fogliani nel corso dei due anni successivi 2500 dozzine di ribebe (una media di poco più di 100 al mese) vendendole a otto soldi imperiali alla dozzina (il soldo era un multiplo delle lire). sASVc, Fondo Notarile, Notaio Giovanni Battista Albertino di Varallo, 9483 c. 278.
13 Giovanni Pietro Tosino appare da coevi contratti notarili dell'epoca un importante mercante coinvolto nella vita economica della Valsesia: compare in numerose compravendite di terreni e bestiame ma sembra specialmente legato alle attività produttive legate ai metalli. Nel 1615 Domenico Miletti cede una fucina a Campertogno in pagamento al mercante Giovanni Pietro Tosino (sASVc, Fondo Notarile, Notaio Giovanni Battista Albertino di Varallo, 9482 c. 208), o ancora nel 1619 Andrea Pitto contrae un debito verso Giovanni Pietro Tosino per l’acquisto di ferro e azale, ossia acciaio (sASVc, Fondo Notarile, Notaio Lassere Giovanni Battista, 10140 f. 271). Il rifornimento di materie prime era un punto fisso dei contratti tra i fabbri di ribebe
Ma solamente una trentina di anni più tardi con il catasto Rabbini, elaborato nel territorio di Riva Valdobbia tra il 1861 e il 1862, risultano invece in Val Vogna 4 delle 17 fucine nel territorio del comune, rispettivamente nelle frazioni Selveglio, Ca Morca, Rabernardo e Piane15

Troviamo indizi della presenza in Val Vogna di fabbri che si dedicavano alla produzione di scacciapensieri dagli atti di morte del Comune di Riva Valdobbia: sono almeno quattro i zampognai16 che risultano residenti al momento della morte in Val Vogna, e almeno in un caso vi è sufficiente certezza sullo svolgimento di questa attività in loco. Abbiamo così testimonianza dei seguenti “fabbricatori di zampogne”17:
• Giacomo Carmellino, morto a cinquant'anni il 30 marzo 1855 nella sua casa situata genericamente a “Vogna”;
• Giovanni Antonio Gaudenzio Carmellino, morto a settantanove anni il 21 settembre 1867 nella sua casa alle Piane;
• Francesco Carmellino, morto a settantadue anni il 10 gennaio 1842 nella sua casa “al cantone Casa Vescovo”;
• Giovanni Evangelista Carmellino, figlio di quest'ultimo, morto a sessantacinque anni il 28 ottobre 1864 nella sua casa a Selveglio. Stando al già citato Catasto Rabbini, proprio a Selveglio un “Evangelista Carmellino fu Francesco” possedeva ancora poco prima
e grossisti, come poteva essere il Tosino: la fornitura mensile di un certo numero (spesso centinaia) di dozzine di ribebe veniva quasi sempre pagata parte in denaro e parte in grano, vino, ferro e acciaio.
14 sASVc, Archivio della Viceintendenza della Valsesia, Fucine e Fonderie, m. 187, Riva.
15 Non vi è invece più traccia della fucina a Vogna di là, probabilmente riconvertita in segheria o mulino. Le fucine in Val Vogna (di quella di Selveglio si dirà nel testo) appartenevano rispettivamente a (ASTo, Riunite, Catasti, Catasto Rabbini, Circondario di Varallo, Registri e atti diversi, Riva Valdobbia, Sommarione): Ca Morca (particella n. 5850), Carmellino Giovanni fu Pietro Anna; Rabernardo (particella n. 5161), Coletti Maria Catterina di Carlo maritata Vicario Giuseppe, Rosso Maria Antonia maritata Giacomino Michel'Angelo e Marianna maritata Jachetti Gaudenzio (queste ultime sorelle fu Giuseppe); Piane di Sotto (particella n. 4551), Carestia Don Antonio fu Giacomo Antonio e Carestia Vittorio, Maria e Pia (fratello e sorelle fu Pietro, minorenni in tutela della madre Rosso Agnese).
16 Negli atti dello Stato Civile, viene quasi sempre fatta menzione della professione, e (almeno per il XIX secolo) molto spesso vi è un certo grado di specificità della mansione: ad esempio nel caso dei fabbri viene sempre specificato se si trattava di un broccarolo (ossia produttore di chiodi, in dialetto brocche) o uno zampognaio (zampogna era ancora il termine più usato nell'italiano dell'epoca per indicare lo scacciapensieri).
17 sASVc, Stato Civile, Registro morti, Tribunale di Varallo, Registri dello Stato Civile dei comuni della Valsesia, 153 e 671.
della sua morte una fucina: un caseggiato isolato (particella n. 7042 nella mappa) situato in un'area poco distante dalla frazione, chiamata nel sommarione Prà di Creus, a metà strada tra la cappella di San Defendente e il torrente che scende al Vogna. Inoltre, circa vent'anni prima della sua scomparsa gli atti di morte di quattro delle sue figlie18, avvenute tutte nella “casa di suo padre a Silveglio”, testimoniano proprio come Evangelista fosse “di professione zampognaio e domiciliato in Riva a Silveglio” e sicuramente allora nel pieno della sua attività. Questa presenza della produzione di ribebe a Selveglio ha trovato ancora in tempi recenti un curioso riscontro nella tradizione orale: Rino Carmellino (1938-2015) riferiva come nella memoria della famiglia si sapeva che le ribebe venivano anticamente fabbricate a Selveglio addirittura prima ancora che a Boccorio, dove la produzione si spostò solo in seguito a causa di un incendio. Se da un lato i documenti sembrano per ora smentire questo primato di Selveglio su Boccorio, dall'altro la memoria della fabbricazione di ribebe in quella frazione della Val Vogna viene invece confermata. La produzione di scacciapensieri in Valsesia fu lontana dall'essere un'esclusiva di quel tratto di valle compreso tra Campertogno e Isolello: almeno fin dagli inizi del XVII secolo si ha traccia del tentativo di trasferire parte della produzione in Bassa Valsesia coinvol-
gendo luoghi come Roccapietra, Locarno e la stessa Varallo19. Questo spostamento era però probabilmente dovuto alle dinamiche e alle pressioni sempre maggiori del mercato, che tra il XVII e il XVIII secolo era all'apice del suo successo, cosa che portò i grossisti e i mercanti a desiderare le officine situate più a valle, di modo che il trasporto dei prodotti non fosse ostaggio delle strade non carrozzabili e delle intemperie, come tra l'altro testimoniato da varie lamentele in documenti dell'epoca. Sono invece sconosciute le ragioni che hanno portato nel corso del XIX secolo,
con la produzione ormai in declino, alcuni fabbri di ribebe a spostarsi in frazioni più isolate e lontane20
Non è comunque da escludere che già prima del XIX secolo questa manifattura avesse già coinvolto la Val Vogna, anche se al momento mancano purtroppo dati precisi sulle fucine prima di quel secolo: sotto alla frazione Rabernardo vi era un abitato chiamato Casa Ferrario e una lapide (oggi murata nel sagrato della chiesa parrocchiale di Riva) con data 1609 e la scritta ancora più eloquente La Casa del Feré dela Vogna ricorda la sua esistenza. Anche in questo caso, la memoria orale locale ricordava che nella fucina di questa frazione si producevano tra i vari prodotti anche le ribebe21

CIÒ CHE RIMANE... Di tutta questa storia che cosa rimane in Val Vogna? Gli scacciapensieri sicuramente oltre a transitare e venire forgiati, venivano “consumati” dagli abitanti del vallone e quindi usati per ballare, come accompagnamento al canto e per distrarsi nei momenti di pausa dal lavoro, ma delle melodie suonate in tutti quei secoli non ci rimane purtroppo più nulla.
Anche le ribebe stesse sono ormai rare nella stessa valle che le ha prodotte per così tanto tempo, ma è possibile ammirarne oggi un bellissimo esemplare presso il Museo Walser di Rabernardo, rinvenuto in Val Vogna dal Cav. Carlo Locca (vedi foto). Il caso vuole che a Gressoney siano ancora conservate in collezioni private alcune ribebe valsesiane che recano gli stessi marchi (un fiore e una S) di quella del museo di Rabernardo... Che siano tutte state forgiate da quel Giovanni Evangelista Carmellino nella sua fucina di Selveglio nel XIX secolo per poi finire da una parte e dall'altra del Colle di Valdobbia? Non ne avremo mai la certezza, ma forse ci piace immaginarlo!

NOTE A MARGINE
18 Si tratta rispettivamente di Maria Antonia Veronica, morta a tre mesi il 23 dicembre 1839; Maria Vittoria, morta a dieci anni il 21 gennaio 1842; Marianna, morta a un anno il 3 agosto 1842 e infine Anna Maria Gioconda, morta a un mese il 2 gennaio 1844 (ibidem, 153).
19 A. Lovatto, A. Zolt, La Ribeba in Valsesia nella storia europea dello scacciapensieri, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2019, pp 54-55.
In un contratto di lavoro del 1714 redatto dal fabbricante di ribebe Francesco Carmellino per assumere suo fratello Giuseppe come aiutante viene addirittura paventata la possibilità del trasferimento dell'attività da Varallo a Pogno, allora sotto la giurisdizione della Ri-
viera di San Giulio d'Orta e quindi propriamente all'estero (sASVc, Fondo Notarile, Notaio Francesco Antonio Tone di Varallo, 10095 f.241).
20 I fratelli Michele e Agostino Carmellino, gli ultimi storici produttori, scomparsi rispettivamente nel 1905 e nel 1911, al momento della morte avevano la loro fucina, ormai inutilizzata ed in rovina, non più a Boccorio ma nella frazione Balma, dove d'altronde entrambi vivevano, a poca distanza dall'oratorio di San Pietro (sASVc, Stato Civile, Registro morti, Tribunale di Varallo Registri dello Stato Civile dei comuni della Valsesia, 674 e 675).
21 A. Ferla, Sentieri dell'arte sui monti della Valsesia Val Vogna Alta via dei Walser, Varallo Sesia, CAI sezione di Varallo, s. d., p. IX.
L'avo ritrovato
Recenti ricerche condotte dai prof.ri Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa dell’Università statale di Milano in merito alla figura di Melchiorre d’Enrico e alla sua famiglia hanno condotto a risultati significativamente diversi, smentendo così alcune ipotesi prospettate dal presente articolo. Per un confronto critico e per un suo giudizio, rinviamo quindi il lettore al saggio d G. Agosti, J. Stoppa, Nel clan di Tanzio, in Gaudenzio Memorial, Milano, Officina Libraria, 2020, pp. 69-126. (NdR)
di Anna PapiniCome sappiamo Presmell è il territorio dell'alta Valsesia in cui nel 1300 circa si stabilì la colonia tedesca dei Walser provenienti dalla Valle del Rodano (il Vallese).
Ma chi erano i Walser e quali erano le loro principali attività?
Nei luoghi ad alta quota in cui essi vivevano conducevano una vita agricolo-pastorale con allevamento di bovini, ovini e pollame e coltivazione di segale, fieno e ordinatissimi orti.
Questo assicurava il sostentamento autonomo delle famiglie per tutto l'anno, anche quando il clima rigido invernale rendeva irraggiungibili i centri abitati ad altitudini inferiori.
L'autonomia di cui godevano era dovuta anche alla loro abilità artigianale (lavorazione del legno, della pietra e del ferro) che nei secoli si affinò al punto di diventare arte. Noi che amiamo Alagna dobbiamo avere una certa gratitudine per questo popolo che ci ha portato alla conoscenza delle loro usanze (come per esempio l'huszaiche, cioè il segno del casato impresso a fuoco sugli attrezzi di casa o a quelli del lavoro dei campi) ma soprattutto dal Vallese ci hanno portato il modello di quel piccolo gioiello di architettura semplice ma perfettamente funzionale che ben conosciamo: la baita!
Negli anni '80 del secolo scorso mio marito, figlio di Emma Grober, volendo realizzare un antico suo sogno, decise di ristrutturare una baita del 1700 da diversi anni disabitata e lasciata molto andare. Questa baita si trova ad Alagna alla frazione Resiga, dove già noi abitavamo.
Dopo due anni circa di lavoro potemmo entrare In una piacevole e comoda casa, in cui si stava bene sia d'estate che d'inverno. Purtroppo all'inizio di questo secolo, dopo quasi cinquant'anni di felice matrimonio rimasi sola. Da allora il mio rifugio preferito durante i mesi estivi è proprio questa baita con le sue belle lobbie e vicino un grande prato dove mi godo il silenzio o il cinguettio degli uccellini e l'aria buona del luogo.
Per dimostrare dunque la mia gratitudine al popolo dei Walser che per primi vennero a disboscare e rendere coltivabile questo territorio ho pensato di donare alla bella rivista "Presmell" (sperando di fare cosa gradita) una ricerca da me fatta nel corso di qualche anno che porterà i suoi lettori alla conoscenza di un pittore finora sconosciuto: Melchiorre Grober, vissuto nel 1500!
La famiglia Grober cui io appartengo, proveniente dalla Peccia della Val Vogna dette i natali a diversi personaggi degni di nota, soprattutto a partire dal 1700 in poi. Cristoforo Grober, bisnonno di mio marito, nel 1842 partecipò giovanissimo alla fortunata spedizione che partì da Alagna per arrivare alla Signal Kuppe (4559 mt) poi ribattezzata Punta Gnifetti in onore del capo spedizione Giovanni Gnifetti

Il nonno Antonio, figlio di Cristoforo, laureatosi in legge a Torino ed entrato a far parte dello studio Spanna, ma sempre molto legato alle sue amate montagne, fu nominato nel 1891 Presidente del Club Alpino Italiano, fondato da Quintino Sella nel 1863.
Le testimonianze dell'esistenza di un pittore alagnese del '500 nostro avo sono ormai tante che desidero scriverne per farle conoscere a chi interessa la pittura valsesiana che a quell'epoca era particolarmente fiorente. La prima e più valida testimonianza e' senza dubbio la pergamena tramandata è conservata nella nostra famiglia per secoli. Il primo di Gennaio del 1594 essa fu consegnata nel Castello di Morsperg in Alsazia ora completamente distrutto al maestro pittore di corte Melchiorre Enrico Grober come diploma di nobiltà " all’onesto e amato maestro per i fedeli e ubbidienti servigi che egli ha finora fornito e deve fornire in avvenire all'onorevolissima Casa d'Austria a noi e ai nostri eredi." La pergamena fu però dimenticata per parecchio tempo insieme ad altri documenti di famiglia finché un nostro nonno negli anni 1920-30 la prese in mano, la esamino', vide che era scritta in gotico tedesco, per cui la mando' ad una università' Svizzera, dove fu riscritta in caratteri non più gotici e quindi tradotta in italiano. Essa fu poi incorniciata ed appesa nella stanza più frequentata nella nostra casa avita di Alagna e guardata un po' distrattamente da noi discendenti nei periodi di vacanza in montagna.
Fino a che mio marito negli anni 2000 la riprese in mano, ne lesse la traduzione e finalmente la portò alla conoscenza del Prof. Casimiro Debiaggi, anch'egli valsesiano ma residente a Torino, noto per le sue ricerche sugli artisti della Valsesia e insieme alla pergamena ricomparve il nostro avo che fu finalmente preso in considerazione da noi discendenti. Occorre intanto sapere he il nome Grober deriva dalla frazione di Alagna sorta sul rio (Riale): in tedesco infatti Grabe o Grobe significa fossa o fossato. In questa stessa frazione viveva un'altra famiglia di origine germanica: i de Henriciis, anch'essi facenti parte della popolazione Walser, proveniente dal Vallese. La famiglia de Henriciis divenne molto nota nel secolo XVII per il pittore Antonio, famoso col nome di Tanzio da Varallo. Ad essa appartenevano anche altri artisti, soprattutto statuari e pittori, tra cui un Melchiorre, pittore ,nato nel 1574, a cui fu attribuito l'affresco del quale parlerò più avanti.
A differenza dei Grober, alcuni dei quali erano emigrati al Nord Europa, i de Henriciis non avevano mai lasciato l'Italia, anche perché intorno al 1600 era già in costruzione avanzata il Sacro Monte di Varallo che con le sue molte cappelle richiedeva il lavoro di architetti, affrescatori e statuari. La famiglia de Henriciis ave-
grandi al vero, nel qual lavoro si da' a conoscere compositore frescante pratico". A quel tempo qualcuno ha anche parlato di una firma quasi completamente rovinata dalle intemperie e dagli anni passati e quindi anche quasi illeggibile che pare fosse in basso a destra e che dicesse: "
Melchior E de Alania pinxit 1596"
Se si prende poi per buona la tradizione orale locale, secondo la quale l'uomo canuto con barba e baffi bianchi dipinto sul lato sinistro in basso sia l'auto ritratto dell'autore, e evidente che questi non possa essere il giovane Melchiorre d'Henriciis nato nel 1574 e tanto meno il Tanzio, nato nel 1580. Allora, non potendo il grandioso affresco essere stato dipinto da un principiante e non potendo questi ritrarsi come un vecchio, non sarebbe più verosimile attribuire il Giudizio Universale a un Melchiorre si', ma di cognome Grober, anziché d'Henriciis?
va tra i suoi componenti gli artisti richiesti dai fabbricieri per la grande opera , come si può anche rilevare da vari documenti del Sacro Monte che parlano di un Giovanni statuario, di un fratello lapicida scultore è così via.
Con tutta probabilità i de Henriciis avevano una bottega d'arte che misero in comune, quando fu necessario, con i Grober, abitanti come sappiamo nella stessa frazione Riale di Alagna. Tanto è vero che Alessandra Cesa nel suo scritto riguardante la " Dinastia dei de Henriciis " così scrive " sarà da rivedere la questione dell'esistenza di due famiglie di artisti nella frazione di Alagna con nome di battesimo comuni che si ripetono per generazioni, creando una certa confusione. Nel Dizionario Biografico degli Italiani della Treccani poi è detto che "Il contratto eventualmente firmato da un rappresentante del clan potesse essere poi soddisfatto da un altro membro del gruppo familiare allargato".
A noi Grober premerebbe approfondire l’argomento che ci interessa da vicino e che ci sta particolarmente a cuore. Si tratta dell'attribuzione del Giudizio Universale dipinto sulla facciata della piccola primitiva chiesa di Santa Maria nel paese poco distante da Alagna Riva Valdobbia, comunemente ritenuto opera di Melchiorre de Henriciis.
Il Bordiga che fu tra i primi a notare il grande affresco di cui fino ad allora nessuno aveva parlato, così ne scriveva nel 1830:"nella chiesa parrocchiale di detto luogo è osservabile un Giudizio Universale dipinto a fresco con figure

Gerolamo Lana nel 1840 riporta un'altra tradizione secondo cui il Tanzio avrebbe ritratto Melchiorre in una figura senile su d'una loggia (in una cappella del Sacro Monte) perché dessa somiglia a quella fisionomia disegnata da Melchiorre istesso nel Giudizio finale è che comunemente vien tenuto per suo ritratto." In più', riferendosi sempre all'affresco rivese, riferisce che " ai fianchi di due graziosi giovinetti (i figli?) si scorge un vecchio dalla barba bianca, aggiungendo però che per voce tramandata di generazione in generazione la figura più vicina a lui e' sua moglie, nativa del casale di Vogna".
Aggiungiamo noi che anche l'origine della moglie potrebbe essere una conferma che il pittore Melchiorre dell'affresco sia un Grober perché i suoi antenati (e quindi anche nostri) de Zanoltis (detti poi Grober quando si spostarono nella frazione alagnese) provenivano dalla Val Vogna e in particolare dalla località chiamata Peccia, come ci fa sapere un documento del 1325. Forse il nostro avo ha seguito il proverbio " moglie e buoi dei paesi tuoi?". Tornando alla pergamena essa ha tutta l'aria di essere un addio degli Ortemburg al loro pittore di corte, senza però abbandonare del tutto la speranza che in futuro possa tornare a lavorare anche per i loro eredi. Ma intanto lui la prende e se la porta in patria, dove può servirgli come attestazione di bravo affrescatore. Potrebbe anche essergli giunta la voce che i suoi compaesani volevano abbellire la loro piccola chiesa di S. Maria con un affresco sulla facciata. Riva Valdobbia godeva a quell'epoca di nuova ricchezza per l'arrivo di numerosi mercanti anche da valli lontane con popolazioni di lingua tedesca, attirati dalla grande fiera di bestiame e tanto altro che ci si svolgeva ogni anno il 29 di Settembre (ancora oggi esiste). Per questo volevano forse ornare la loro chie-
di un soldato in cui è ben visibile la scritta in stampatello MELCHIOR H (evidentemente Melchiorre de Henriciis)
suola con un grande affresco a colori vivaci che le desse più importanza. Essa cambiò perfino il nome: da allora fu dedicata a San Michele che le aveva portato fortuna e ricchezza.

Al ritorno in patria Melchiorre Grober si appoggiò sicuramente alla bottega d'arte dei suoi parenti d'Henriciis per poter anch'egli lavorare non solo a Riva Valdobbia, ma anche al Sacro Monte di Varallo.

Volendo poi fare chiarezza sui due pittori con lo stesso nome, originari della stessa frazione di Alagna, ma con formazione artistica diversa e anche di età diversa, scopriamo finalmente nella cappella dell'Ecce Homo del Sacro Monte la possibilità di districare la matassa. Qui risultano infatti che due Melchiorri vi avevano lavorato come pittori delle statue, distinti però dalle loro due firme: una sull'elmo della statua raffigurante un soldato che guarda verso l'alto su cui è scritto a chiare lettere in stampatello MELCHIORRE H (e quindi Henriciis) e sul copricapo di un'altra statua dipinta vi è invece la scritta in corsivo in colore verde Melch Graber. È questo è il nostro avo !
Siamo nel 1611: sono passati ben diciassette anni dal rilascio della pergamena e il nostro è ancora al lavoro, ma forse è da allora che uno fu chiamato M. il giovane e l'altro M. il vecchio".
In un documento dell'anno prima (1 dicembre 1610) si dice che i fabbricieri del Sacro Monte Lessere e Peterro concedono a Melchiorre Enrico del fu Giovanni l'uso di Casa Valgrana
nel periodo in cui sarà impegnato a dipingere le statue nella cappella dell'Ecce Homo, in assenza del pittore Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone che si allontanerà temporaneamente per finire un lavoro in altro Sacro Monte.
Di Melchiorre Grober ora sappiamo con certezza essere stato diversi anni in Germania dove la sua formazione artistica risenti' di un'influenza locale (riscontrabile in un certo carattere aspro , teutonico nel suo Giudizio di Riva) e dove è arrivato a essere Hofmaler presso gli Ortemburg. Altra cosa certa è la sua appartenenza al gruppo di artisti del Sacro Monte, dove molto probabilmente lavorava saltuariamente e in alcuni casi chiamato come aiuto. Siamo ormai vicini al1614, anno in cui scompare: da allora non se ne seppe più nulla. Prima di terminare, vorrei portare un' ultima testimonianza e ancora un'osservazione sulla facciata della parrocchia di Riva. Seguendo le orme dei critici d'arte Bordiga e Lana, che furono tra i primi a riconoscere il valore artistico dell'affresco rivese, vorrei accostare le due immagini dei supposti ritratti di Melchiorre ad una terza raffigurazione che si trova nella cappella XXXIII del Sacro Monte. Qui infatti Pier Francesco Mazzucchelli, detto il Morazzone (il quale oltre che collega si è rivelato amico del Melchiorre al quale addirittura concede temporaneamente la sua abitazione di Casa Valgrana al Sacro Monte) si serve, secondo me, di lui come modello. Nella cappella i cui si vede Barabba liberato dalla prigione compare alla sinistra del ladrone un soldato a figura intera molto prestante, anche se con capelli, baffi e barba bianchi. Le gambe muscolose infilate in bei calzari paiono avvezze a lunghe camminate è ovunque appartenenti ad un uomo ancora in età buona per essere un valido artista come affrescatore o pittore di statue. Ma soprattutto vedo una straordinaria rassomiglianza nella fisionomia del soldato con quella dei due ritratti, uno nella cappella dell'Ecce Homo e l'altro sulla facciata della parrocchiale di Riva.
Osservando quest'ultima non si può poi fare a meno di parlare della pittura sul vecchio campanile dove compare un gigantesco San Cristoforo eseguito diversi anni dopo il Giudizio è attribuito al Melchiorre de Henriciis: cosa del tutto verosimile dato che dopo il viaggio compiuto nel 1600 a Roma per il Giubileo insieme al fratello Tanzio, divenuto adulto e avendo acquistato una certa esperienza della pittura, era sicuramente in grado di intraprendere un'opera di una certa importanza. Forse però meno dotato dei suoi predecessori e fratelli.


Prendo qui l'occasione per esprimere la mia gratitudine al Prof. Casimiro Debiaggi che nel corso degli anni mi ha con benevolenza e sapere aiutato a proseguire nella mia piccola ricerca della verità .
Milano,23 Gennaio 2018
Nel periodo rinascimentale durante il quale ci fu la massima fioritura ovunque di grandi opere d'arte e di grandi artisti non soltanto in Italia ma anche in tutta l'Europa non fu da meno un piccolo, sperduto territorio nell'alta Valsesia, ai piedi della grande catena del Monte Rosa chiamato Pietre Gemelle.
In epoca remota due grandi massi erratici erano rotolati da un'erta montagna e si erano arrestati in un prato vicino al fiume. Da allora il territorio che parte dalla confluenza del fiume Sesia e il torrente Vogna in basso e l'incontro tra il fiume Sesia e il torrente Otro in alto fu chiamato " Pietre Gemelle ": i due massi erratici fermatisi del prato sono molto somiglianti tra loro per la forma e la dimensione, proprio come fossero fratelli gemelli. Due gruppi di coloni, appartenenti alla popolazione Walser, si spinsero dal Vallese attraverso i percorsi alpini intorno al 1300-1400 al sud del Monte Rosa alla ricerca di pascoli e clima migliori e si incontrarono e si fermarono proprio nel territorio di Pietre Gemelle. Abituati alla vita ad alta quota e per le esigenze climatiche abituati ad essere autonomi ed indipendenti, essi possedevano una particolare abilità' artigianale che nei secoli si affino' al punto da diventare arte. Questo fatto verso il 1500 spinse molti degli uomini facenti parte
del gruppo Walser a cercare lavoro nel periodo estivo all'estero, soprattutto in Svizzera, Francia e Germania. Molti di essi come gli Heinz,i Bodmer, i Ghiger e anche due Grober (Ulli e Yakub) vi si fermarono e divennero famosi soprattutto come costruttori ed architetti. In particolare poi pare che i Presmellesi fossero i soli capomastri che conoscessero e praticassero i misteri della costruzione di volte a crociera con dei costoloni, delle chiavi fino verso il1630.
Ed è questa la piccola storia che ci ha fatto nascere il desiderio di ritrovare il nostro antico avo.
Vorrei però ancora aggiungere che nella frazione Riale Inferiore (in tedesco Graber) prossima al territorio di Pietre Gemelle, vivevano due famiglie sempre di origine Walser: i de Henriciis che dettero i natali al famoso pittore Tanzio da Varallo e i de Zanoltis appellatur Graber, di cui noi siamo i discendenti. Sappiamo dai documenti raccolti dall'Abate Carestia che le due famiglie avevano un antichissimo rapporto di parentela. In uno di essi del mese di luglio del 1302 si dice che Anrigeto Alemanno detto Ursus de apud Mot cede a Pietro Gualcio de Petris Zumellis la quarta parte di tutti i suoi beni quale dote della propria figlia Imelda,ma con l'obbligo di fare parte della comunità familiare.
È' evidente che lo sposo dovrà sottostare a certi obblighi nei confronti della nuova parentela che gli potrà anche chiedere di prendere il cognome della sposa per avere certi diritti nella gestione dell'azienda familiare.
Il che ci confonde non poco le idee sui discendenti: i nuovi nati si chiameranno de Henriciis
IN ALTO: Cappella XXXIII parete destra: Barabba condotto a Pilato dipinto dal Morazzone. Il soldato a destra si suppone sia Melchiorre Grober che fa da modello al pittore amico e collega.
o de Zanoltis, appellatur Graber ? Tra vari documenti di anni successivi in nostro possesso troviamo atti di notai per la compravendita di erbatici, pascoli o quant'altro tra le due famiglie affini che per di più danno gli stessi nomi di battesimo sia in una famiglia che nell'altra. A dispetto di tutto questo forse noi abbiamo individuato l'antico avo.
Nel periodo rinascimentale a cavallo tra il XV e il XVI secolo, durante il quale ci fu la massima fioritura di grandi opere d'arte e di grandi artisti non soltanto in Italia ma anche in tutta l'Europa, non fu da meno un piccolo sperduto territorio nell'alta Valsesia ai piedi della grande catena del Monte Rosa chiamato Pietre Gemelle.
Cappella XXXIII dell'Ecce Homo: 'altra scritta è in corsivo di colore verde sul copricapo di un uomo che, in primo piano sulla sinistra della scena , invita i sua bambini ad osservare l'avvenimento principale in alto. La scritta è: Melch Graber e questo è il nostro antenato.
Queste sono le nostre supposizioni che col tempo sono divenute certezze ,ma a chi volesse approfondire tutta la questione consigliamo di leggere quanto scrive l'autorevole Prof. Debiaggi a questo proposito sul periodico " de Valle Siccida" del 1998 in cui con la sua professionalità ed esperienza da' una giusta e convincente lettura di tutto l'insieme della facciata della parrocchia di Riva.
Cappella XXXIII dell'Ecce Homo: particolare dell'altra scritta, in corsivo di colore verde sul copricapo di un uomo che invita i sua bambini ad osservare l'avvenimento principale in alto. La scritta è: Melch Graber e questo è il nostro antenato.
In epoca remota due grandi massi erratici erano rotolati da un'erta montagna e si erano arrestati in un prato vicino al fiume. Da allora il territorio che parte dalla confluenza del fiume Sesia e il torrente Vogna in basso e l'incontro tra il fiume Sesia e il torrente Otro in alto fu chiamato " Pietre Gemelle": i due massi fermatisi nel prato sono infatti molto somiglianti tra loro per forma e dimensione, proprio come fossero fratelli gemelli.
Due gruppi di coloni appartenenti alla popolazione Walser si spinsero dal Vallese attraverso i percorsi alpini intorno al 1300-1400' alla ricerca di pascoli e clima migliori e, dopo aver
accerchiato il Monte Rosa da due parti diverse si incontrarono proprio nel territorio di Pietre Gemelle dove presero dimora stabile. Abituati alla vita ad alta quota è costretti dalla rigidità dei lunghi mesi invernali che li isolava dal mondo ad essere autonomi ed indipendenti, essi possedevano una particolare abilità artigianale che nei secoli si affino' al punto da diventare arte.
Questo fatto verso il 1500 spinse molti degli uomini facenti parte del gruppo Walser a cercare lavoro nel periodo estivo all'estero, soprattutto in Svizzera,Francia e Germania. Molti di essi come gli Heinz, i Bodmer, i Ghiger e anche due Grober (Ulli e Jakub)vi si fermarono e divennero famosi soprattutto come costruttori ed architetti. In particolare poi pare che le maestranze Prismellesi fossero le uniche a conoscere i misteri delle volte a crociera con costoloni e chiavi fin verso il 1630.
È' questa la piccola storia che ha fatto nascere in noi il desiderio di ritrovare il nostro antico avo, anch'egli emigrato al Nord, dove aveva ricevuto il pieno riconoscimento delle sue doti artistiche e morali.
Desidero anche aggiungere che nella frazione alagnese Reale Inferiore (in tedesco Graber) prossima al territorio di Pietre Gemelle, vivevano due famiglie sempre di origine Walser: i de Henriciis che dettero i natali al famoso pittore Tanzio da Varallo e i de Zanoltis appellatur Graber, di cui noi siamo i discendenti. Sappiamo dai documenti raccolti dall'Abate Carestia che le due famiglie avevano un antichissimo rapporto di parentela.In uno di essi risalente al mese di luglio del 1302 si dice che un" Anrigeto Alemanno detto Ursus de apud Mot cede a Pietro Gualcio de Petris Zumellis la quarta parte di tutti i suoi beni quale dote della propria figlia Imelda, ma con l'obbligo di fare parte della comunità familiare". È' evidente che lo sposo dovra'sottostare a particolari obblighi
nei confronti della nuova parentela che in alcuni casi gli potrà anche chiedere di prendere il cognome della sposa per avere certi diritti nella gestione dell'azienda familiare. Il che ci confonde non poco le idee sui discendenti: i nuovi nati si chiameranno de Henriciis o de Zanoltis appellatur Graber ?
Tra i vari documenti di anni successivi in nostro possesso troviamo atti di notai per lo scambio o compravendita di erbatici, giacci , pascoli o quant'altro tra le due famiglie affini che per di più davano gli stessi nomi di battesimo sia in una famiglia che nell'altra.
A dispetto di tutto questo pensiamo proprio di avere individuato il nostro antenato.
4 aprile 2018
ARTE Nel periodo rinascimentale tra il XV e il XVI secolo, durante il quale ci fu la massima fioritura di grandi opere d'arte e di grandi artisti non soltanto in Italia ma anche in tutta l'Europa, non fu da meno un piccolo, sperduto territorio nell'alta Valsesia ai piedi della grande catena del Monte Rosa, chiamato Pietre Gemelle. In epoca remota due grandi massi erratici erano rotolati da un'erta montagna e si erano arrestati in un prato vicino al fiume. Da allora il territorio che parte dalla confluenza del fiume Sesia e il torrente Vogna in basso e l'incontro tra il fiume Sesia e il torrente Otro in alto fu chiamato " Pietre Gemelle".
I due massi fermatisi nel prato sono infatti molto somiglianti tra loro par forma e dimensione, proprio come due fratelli gemelli. In epoca medioevale poi,intorno al 1300-1400, due gruppi di coloni appartenenti alla popolazione Walser si erano
SOTTO: Cappella XXV - Supposti ritratti ( o autoritratti) di Tanzio da Varallo ( giovane sorridente con cappello piumato e Melchiorre Grober ( uomo con barba bianca e cappello). Non si sa se l'autore sia il Tanzio o il Grober.

spinti dal Vallese attraverso i percorsi alpini alla ricerca di pascoli e climi migliori verso Sud fino ad accerchiare il Monte Rosa da due parti diverse (Gressoney una e Macugnaga l'altra) per poi incontrarsi proprio nel territorio di Pietre Gemelle dove presero dimora stabile. Abituati alla vita ad alta quota è costretti dalla rigidità dei lunghi mesi invernali,che li isolava dal mondo, ad essere autonomi ed indipendenti, i coloni Walser erano arrivati ad avere una grande abilità artigianale che nei secoli si affino'al punto da diventare vera arte.
Queste loro doti,unite alle migliorate condizioni delle vie di comunicazione tra i vari paesi europei spinsero molti prismellesi a cercare lavoro all'estero, soprattutto in Svizzera Francia e Germania.
Molti di essi come gli Heinz, i Bodmer, i Ghiger e anche due Grober (Ulli e Jakub) vi si stabilirono definitivamente e divennero famosi soprattutto come costruttori ed architetti. In particolare poi pare che fino al 1600 le maestranze Prismellesi fossero le uniche a conoscere i segreti delle volte a crociera con costoloni e chiavi.
Tutto ciò ha fatto nascere in noi il desiderio di sapere qualcosa di più dell'antico avo, anch'egli emigrato al Nord,dove aveva ricevuto il pieno riconoscimento delle sue doti artistiche e morali.
A questo va aggiunto che nella frazione alagnese Reale Inferiore (in tedesco Graber) prossima al territorio di Pietre Gemelle vivevano due famiglie sempre di origine Walser: i de Henriciis che dettero i natali al famoso pittore detto Tanzio da Varallo e i de Zanoltis appellatur Graber, di cui noi siamo i discendenti. Dai documenti raccolti dall'Abate Carestia sappiamo che le due famiglie avevano un antichissimo rapporto di parentela.
In uno di essi infatti risalente al mese di luglio del 1302 si dice che " Anrigeto Alemanno detto Ursus de apud Mot cede a Pietro Gualcio de Petris Zumellis la quarta parte di tutti i suoi beni quale dote della propria figlia Imelda, ma con l'obbligo di fare parte della comunità familiare".
E'evidente che lo sposo dovrà sottostare a particolari obblighi nei confronti della nuova parentela che in alcuni casi gli potrà anche chiedere di prendere il cognome della sposa. Il che ci confonde non poco le idee sui discendenti: i nuovi nati si chiameranno de Henriciis o de Zanoltis appellatur Graber ?
Tra i vari documenti di anni successivi in nostro possesso troviamo atti di notai per lo scambio o compravendita di erbatici, giacci,pascoli o quant'altro tra le due famiglie affini che per di più davano gli stessi nomi di battesimo sia in una famiglia che nell'altra.
A dispetto di tutto questo pensiamo proprio di avere individuato il nostro antenato.
31 luglio 2018
Raccolta dati sui campi coltivati a
Riva Valdobbia anno 1840
DALL'ARCHIVIO STORICO DI RIVA VALDOBBIA
L a ricerca del Sig Ferraris, qui di seguito rappresentata, è un campione di un lunga e costante ricerca realizzata negli anni, di inventariazione. L'importante lavoro di raccolta dati, speriamo possa essere presto pubblicato in un libro che lo rappresenti.
di Pietro Ferraris DESCRIZIONE
MOTESO 43 58021,71
ALLA RIVA SOPRA LA FAIT 5 1602,01
AL PRATO DEI VITELLI 1 1141,82
NELL’ISOLA 1 457,56
SULLA BONDA 2 1075,46
SUI RIVETTI 1 458,60
NALLA TRAVERSAGNA 2 2510,87
ALLE GIAVINE MINOIA 1 2282,68
ALLE FORCHE 2 2284,85
AL CROSO GRANDE 1 1142,29
AL DI LA DEL PRATO GRANDE 6 9142,61
ALLE SCENINE SUPERIORE 3 7078,43
Totale m2 Campi 1.144681,70
Totale m2 Orti 27712,98
Totale complessivo m2 1.172394,68
Campi da 5000 a 6000 m2 n° 9
Campi da 4000 a 5000 m2 n° 22
Campi da 3000 a 4000 m2 n° 30
Campi da 2000 a 3000 m2 n° 126
Campi da 1000 a 2000 m2 n° 238
Campi da 500 a 1000 m2 n° 259
Campi da 0 a 500 m2 n° 420
Totale campi+ orti n° 1104
Il campo più grande è di m2 5617,38
Il campo più piccolo è di m2 1,30
PROPRIETARI CON PIÙ POSSESSORI DI CAMPI
Minoia Giò Battista fu Giacomo Antonio Campi 42
Carestia Giacomo Antonio fu Giò Pietro Campi 38
Graulo Giò Michele fu Giuseppe Campi 32
Graulo Giò Michele fu Michele di Riva Campi 31
Graulo Giò Giuseppe fu Giuseppe Campi 28
Verno Sacerdote Luigi fu notaio Giò Campi 28
Giacomo Raiga Giò Giacomo fu Giò Battista Campi 25
Bodmer Bernardo fu Giacomo Campi 23
Verno Maria Caterina ved. di Giò Michele Graulo fu Giacomo Antonio Campi 23
Matolo Giuseppe e Pietro frat, fu Giò Pietro di Riva Campi 22
Gabbio Giovanni fu Giacomo Antonio Campi 21
Graulo Giò Giuseppe detto Giacomino di Riva Campi 21
Verno Giacomo antonio fu Giacomo Claudio Campi 20
RIVA VALDOBBIA
Il dialetto locale
A cura di Roberta Locca Pubblichiamo le lettere da L a N dell’importante “vocabolario” dell’Abate. La traduzione è letterale.

DIALETTO TRADUZIONE APPROFONDIMENTO
Lazio spazio
Losch aggettivo che significa senza condimento
Loffia paura
Losne' lampeggiare
losna lampo
Lettigo solletico
Lozza sterco vaccino senza letame. Da Lotium voce latina
Larcot arnese pastorale dove si comprime la ricotta
Lutro senza battesimo
Louria Lontra
Lampa' ondata
Lis pallido
Lienda nenia. Dall'idioma iberico.
Lamma quantità d'acqua stagnante o quasi. Dal latino Lama che ha uguale significato
Lama uguale significato di Lamma
Lappe' lambire
Lappagion pacchione, parassita
Lobbia loggia, galleria in legno
Lesa slitta
Lam non ben stretto
Lavecc laveggio
Laugieu vaso di laveggio foggiato a pajuolo
Lancon, Lanche località da 1° in Riva, la 1° alla Rocca. Io suppongo che valgano luoghi acquitrinosi ai confini dell'Ossola. Vi è anche il Lancone a Ornavasso.
Livro ridotto agli estremi. Livro bagna': bagnato da capo a piedi.
Livrè
ultimare o metaforicamente ridursi. Così livrese (passivo) si applica a chi beve all'eccesso, a chi si sporca da capo a piedi a chi si danneggia gravemente. agli estremi.
Loppa escrescienza
Ladin leva
Lambogna corda non tesa
Lassa-si lascia essere. Vale moroso, lento nell'agire.
Luganiga specie di salsiccia, non da Lugano ma da Longanica, spagnolo.
Larion mortella ossia il frutto di Vaccinium Myrtillus
DIALETTO TRADUZIONE APPROFONDIMENTO
Larionera la pianta della mortella
Mastel quasi Verrocc
Meddro modello
Mauta calce impastata con sabbia
Moticcié sciupare
Masera leggo nel 1518 maxera o cumulo di sassi
Maugna finto, che non manifesta
Monel dispregiativo applicato ai preti
Monattè frugare
Monatton frugatore dispregiativo
Morché mangiare pare vocabolo di gergo
Meno agnellotto
Mesciota carne salata tenuta in salamoja
Meula falce mozzoria
Moje moine
Mantiga sacca di pelle da riporvi farina
Morgna donna che accompagna la sposa all'altare
Manzivé fare il lazzarone
Mocc, Moccia, Mocciaria pazzo, pazza, pazzia. E' forse voce spagnola
Mousa vacca dal tedesco
Masna ragazzo
Nizz , Nizzon livido, echimosi
Nidda
Neggia
Neggion
Nosna zaino degli scolaretti
Nolo scempio
Noutta niente
Nech mortificato. Dal Basco Nec senza spirito
Naiga il pezzo fra le natiche
nta , nte abbreviativo di onta
Ninna manina
Narfella moccio
Nast odorato, olfatto
Nast pianta Tasso. Taxus baccata
L’associazione ringrazia l’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, il Comune di Alagna Valsesia e tutti quanti ci sostengono.
Un ringraziamento particolare ad un generoso e riservato benefattore che ha permesso un primo intervento per salvare il mulino di Rabernardo.
PRESMELL - PIETRE GEMELLE. Annuale dell’Associazione Culturale Walser Presmell
Ecomuseo della Valle Vogna. Anno 2021. A cura del Comitato Direttivo.
Presidente: Roberta Locca; Vice Presidente: Donata Farinetti; Segretario: Gabriele Confortola
REALIZZAZIONE GRAFICA: NORDCAP STUDIO, Borgosesia - www.nordcapstudio.it

