Una montagna di risparmi
Inizia il nuovo anno con interessanti riduzioni.




































Inizia il nuovo anno con interessanti riduzioni.



































Entriamo piuttosto guardinghi nell’anno appena nato, come gatti acciambellati sugli zerbini e tuttavia vigili: sempre pronti a spiccare il balzo salvifico un istante prima di essere sorpresi da un rottweiler o investiti da un motorino. Se chiedete in che cosa possiamo sperare per l’anno venturo, mi vengono in mente solo i felini, la loro studiata prudenza, la capacità di tenere la posizione fino all’ultimo e l’istinto animale per la sopravvivenza.
Non sarà il massimo delle ambizioni, ma se proviamo ad osservare il 2022 dallo specchietto retrovisore della storia vediamo un’umanità che pensava di essere scampata al morbo neo-medievale del coronavirus e si è trovata immersa in una sporca guerra sul pianerottolo di casa, la malandata casa europea – abbruttita sul finire dell’anno passato da uno scandalo tangentaro. Un deprimente spettacolo che ci travolge con i suoi drammi annessi e connessi, tipo la traballante situazione energetica. D’altra parte è così quando, per scaldare il salotto occidentale, si stipulano contratti con democrazie notoriamente
finte, dalla Russia ai torbidi regimi petroliferi. O l’inflazione e il conseguente aumento del costo di tutto (comunque più contenuto in Svizzera rispetto all’Eurozona).
Almeno, nei già pochissimo brillanti anni della pandemia l’ingegno umano aveva partorito i vaccini che, volenti o nolenti, hanno evitato una decimazione (a dir poco) della popolazione mondiale, checché ne dicano i critici. Ma qui, tra autocrati guerrafondai, regimi come quello talebano che tornano a impedire alle donne di studiare all’università o come quello iraniano che appronta patiboli per soffocare dentro un cappio il grido di protesta delle piazze, il vaccino dov’è?
Chi può fabbricare, oggi, il vaccino della pace?
Dove si nasconde la sua ricetta? Che fine hanno fatto le speranze della nuova era di armonia e prosperità che sembrava essersi spalancata sul mondo dopo il crollo del Muro di Berlino?
E che cosa abbiamo fatto dell’eredità etica della Seconda guerra mondiale, dei suoi solenni «mai più» all’orrore e alla violenza, della convinta costruzione di un’umanità pacifica e pacificata?
Guardandoci intorno la situazione è desolante, ma dobbiamo ammettere che sul nostro zerbino le cose non poi vanno tanto male. Perché un conto è avere meno potere d’acquisto e restare sgomenti leggendo i giornali ma trascorrendo le feste più o meno come prima, tra panettoni, spumanti e maratone Netflix, dentro una casa che non è minacciata da una pioggia di missili, e un conto è sperare che non ti crolli il soffitto in testa o che tuo figlio, tuo marito o tuo padre non muoiano, là al fronte. Sono quasi tutte giovani le vittime del conflitto russo-ucraino (su tutti e due i fronti) ed è vergognoso che non se ne parli, che delle loro vite e delle loro morti non resti quasi traccia, qui nei tg e nelle nostre coscienze.

Felinamente acciambellati nelle nostre confortevoli tane, non possiamo e non dobbiamo consolarci pensando di stare meglio di chi sta peggio, sarebbe meschino e poco lungimirante. Ci deve consolare e dare speranza, invece, credere che dopo ciò che è successo negli scorsi mesi, dovremmo avere acquisito qualche anticorpo al
male. Come minimo l’intelligenza dei gatti che attivando le vibrisse fiutano in tempo le minacce nell’aria. E, soprattutto, sanno togliersi dagli impicci prima di essere travolti.
Ce ne sono fin troppe di minacce che non abbiamo saputo o voluto vedere – dalla crisi ambientale, al terrorismo, alle guerre dormienti, agli squilibri economici – e abbiamo imparato, o avremmo dovuto imparare, che di fronte a queste sfide o ci si salva tutti o non si salva nessuno. Mentre attendiamo se non un vaccino alla tragedia, almeno un palliativo – che so, un accordo di pace o uno straccio di armistizio, per restare alla crisi russo-ucraina – ci auguriamo che il 2023 sia un balzo verso la saggezza, uno scatto dell’intelligenza collettiva, della nostra responsabilità nei confronti della famiglia umana e dell’intero pianeta. Ce la possiamo fare, nel corso della storia l’umanità è uscita da crisi orripilanti come le secolari pestilenze e i conflitti mondiali. Sì, ce la possiamo fare: i gatti hanno sette vite. Riusciremo a non sprecarle tutte?
Il boom delle auto elettriche
Entro il 2050 la metà del parco veicoli in Svizzera sarà elettrico, ma i problemi di mobilità si risolveranno solo limitando gli spostamenti
Pagina 7
Una malattia ereditaria
Diversi tipi di tumore hanno a che fare con una mutazione genetica che oggi può essere diagnosticata preventivamente
Pagina 8
Groenlandia dell’Est
Grande è la voglia di riscatto che la gente di queste terre ha quando si mette in fuga da un vivere incerto e intriso di solitudine
Pagina 9
Bambini e migrazione ◆ La Svizzera ha accolto finora quasi 70mila profughi ucraini, tra cui molte famiglie con figli piccoli. Isabella Cassina, esperta in materia di sostegno psicosociale, propone un intervento terapeutico per curare le ferite invisibili del conflitto ancora in corso
La questione migratoria è tornata d’attualità dopo che per quasi due anni era finita in secondo piano. Con l’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia, i flussi migratori sono ripresi. Inoltre, la guerra in Ucraina ha provocato in Europa la più grande crisi umanitaria dalla Seconda guerra mondiale. Dallo scoppio del conflitto gli sfollati interni sono più di 7 milioni e oltre 13 milioni di persone hanno trovato rifugio nei Paesi limitrofi. La Svizzera ha accolto finora 67mila ucraini (dati di inizio novembre) che hanno ottenuto lo statuto di protezione S.
«Ai genitori fuggiti dall’Ucraina consiglio di creare da subito uno spazio e un tempo dove il bambino possa giocare»
Sono soprattutto donne con bambini e giovani in età scolastica. Anche se ora sono al sicuro, sul treno diretto a ovest si sono portati la sofferenza di una separazione forzata dai propri cari e dalla loro terra. Sono ferite invisibili che vanno riconosciute e curate. Ed è proprio ciò che fa Isabella Cassina. L’assistente sociale sta svolgendo un dottorato di ricerca sull’applicazione del gioco e delle arti espressive come terapia nei contesti di crisi. Di recente ha dato alle stampe una pubblicazione in cui illustra il concetto di «recuperare il tempo di gioco perduto», approccio terapeutico volto a fornire supporto a bambini affetti da una serie di disturbi psicosociali causati dallo sfollamento.

Signora Cassina, la sua prima esperienza sul campo nell’ambito del sostegno psicosociale risale al 2009, quando ha assistito gli sfollati interni a Belgrado. Cosa ricorda di quella esperienza in Serbia?
Le persone fuggite dal Kosovo più di dieci anni prima vivevano ancora in baracche nei centri di prima accoglienza ai margini della città. In questa situazione di emergenza erano nati i loro figli che parlavano del conflitto come se l’avessero vissuto sulla loro pelle perché quell’esperienza traumatica era stata trasmessa loro dai genitori. Nonostante fosse finita da anni, la guerra era quindi ancora molto presente nella quotidianità, anche in quella dei più piccoli. Possiamo parlare di trauma intergenerazionale. È stata per me un’esperienza illuminante che ha avuto un ruolo decisivo nel mio percorso professio-
nale. Lì ho capito che volevo saperne di più sulle strategie per aiutare i bambini.
E una di queste strategie si basa proprio sul gioco. Di che cosa si tratta?
Il gioco è un istinto naturale dell’essere umano che ci accompagna per tutta la vita. Bambini e adulti hanno bisogno di giocare, lo fanno in modalità differenti e per soddisfare necessità diverse. Per i bambini il gioco è fondamentale per comprendere il mondo che li circonda, esprimere ed elaborare episodi di vita ed emozioni forti, sviluppare abilità essenziali. Per questo motivo, è importante che un bambino venga messo rapidamente nelle condizioni di giocare se è stato privato di questa possibilità, ad esempio durante una migrazione forzata o in una situazione di emergenza. Nel libro parlo proprio di «recuperare il tempo di gioco perdu-
to» affinché i bambini possano fare esperienze riparatorie fondamentali per il loro benessere psicosociale e lo sviluppo cognitivo.
Come si articola l’intervento terapeutico attraverso l’uso del gioco?
Il nostro è di solito un intervento a 3 livelli di forma piramidale. Nella prima fase vengono coinvolte possibilmente tutte le persone che ruotano attorno ai bambini: genitori, familiari, operatori sociali, insegnanti. Attraverso il gioco si crea un contesto senza troppo regole, in cui ci si può divertire e stare bene insieme in un ambiente accogliente e rilassato. In questo contesto si individuano i bambini che hanno bisogno di un sostegno psicosociale più mirato. In seguito, il gioco viene usato come terapia e si inizia un percorso parallelo con la singola famiglia. Si cambia il setting, ad esempio da uno spazio che può accogliere una ventina di perso-
ne si passa ad una stanza di terapia in cui viene fatto un lavoro individuale basato sui bisogni del bambino, sul suo livello di sviluppo e durante il quale vengono coinvolti quanto più possibile i genitori.
Anche se hanno raggiunto il Paese d’accoglienza dove i genitori hanno chiesto asilo, i bambini ucraini continuano a vivere una condizione di stress post-traumatico e sono confrontati con grandi difficoltà. Che tipo di intervento dovrebbe essere promosso in Svizzera?
La migrazione è un processo che consiste in un prima, un viaggio e un dopo. Quando il bambino arriva in Svizzera ha vissuto esperienze complesse e potenzialmente traumatiche che possono creare una situazione di grande disagio, soprattutto se non vengono individuate in fretta. È importante quindi intervenire tempestivamente e per poterlo
fare bisogna essere preparati e sapere chi contattare per fornire il supporto necessario. In linea generale, a un genitore proveniente dall’Ucraina consiglierei di creare da subito uno spazio e un tempo dove il bambino possa giocare. Sembra una banalità, ma studi scientifici hanno dimostrato che il gioco è il più naturale ed efficace processo di autoguarigione per i bambini. Grazie al gioco riescono ad esprimere attivamente le proprie emozioni, a rielaborarle e con il tempo a sentirsi a proprio agio in una nuova realtà. Inoltre, le scuole hanno un ruolo fondamentale. Sono il nostro punto di riferimento in tutti i progetti e interventi in qualsiasi parte del mondo. È così che riusciamo ad arrivare ai genitori. Ma è importante occuparsi anche del corpo docente, confrontato con una situazione inattesa, come ad esempio l’arrivo di nuovi bambini che possono alterare le dinamiche di classe.
Devono il loro nome ai cavalieri del passato, le cui nobili e coraggiose gesta erano svolte nell’intento di salvare delle vite, gli odierni «Cavalieri del cuore», espressione usata per designare quei comuni cittadini che sono prontamente intervenuti in una situazione di arresto cardiaco, dando prova di grande umanità.
L’iniziativa «Cavaliere del cuore» – promossa dalla Fondazione Ticino Cuore – è un momento di festa e celebrazione, giunto alla tredicesima edizione, voluto per rendere omaggio alle oltre 600 persone che negli ultimi tre anni si sono prodigate nella pratica della rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’arrivo dei sanitari. La cruciale importanza di questa fase di intervento immediato è oggi una cosa nota. Un’efficace presa a carico dell’arresto cardiaco – che solo in Ticino interessa ogni anno tra le 300 e le 350 persone – assume infatti la forma di una catena, ogni anello della quale è essenziale per il successo del seguente. La difficoltà, lungo questa catena, sta nel fatto che i differenti elementi terapeutici devono essere eseguiti in maniera coordinata ed estremamente rapida. Difficoltà sulla quale grava ulteriormente il fatto che i primi anelli sono spesso nelle mani di non professionisti.
I primissimi momenti di soccorso sono fondamentali per salvare le vite di chi è colpito da un arresto cardiaco. I corsi per volontari laici sono un’arma fondamentale per aiutare le vittime (foto Keystone). Nella foto piccola: il direttore di Ticino Cuore, Claudio Benvenuti.
ne al tema di cui ci stiamo occupando, che ha permesso al nostro Cantone di ottenere un tasso di successo nella rianimazione cardiopolmonare ineguagliato a livello svizzero.
Sensibilità e solidarietà sono testimoniate anche dalle gesta dei 600 Cavalieri del cuore di cui parlavamo in apertura. Fra questi, vi sono dei First Responder come più in generale delle persone che appartengono ai servizi partner degli enti di soccorso, come polizia, pompieri, guardie di confine, ma pure dei cittadini comuni, che non hanno necessariamente seguito una formazione.
I primissimi interventi di soccorso dipendono spesso da non professionisti chiamati a praticare la rianimazione
«Se i primi tre anelli non sono stati gestiti in maniera corretta, nessuna struttura sanitaria sarà in grado di recuperare», commenta Claudio Benvenuti, direttore della Fondazione Ticino Cuore, costituita nel 2005 su iniziativa della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA) e del Cardiocentro Ticino, con lo scopo di aumentare la sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso. Che la Fondazione si stia muovendo nella giusta direzione, lo testimonia il fatto che nel nostro Cantone tale sopravvivenza sia triplicata dall’anno della sua costituzione. Ad oggi, infatti, la sopravvivenza globale in caso di arresto cardiorespiratorio si aggira attorno al 14% ed aumenta fino al 55% in caso di fibrillazione ventricolare. «Si tratta di un risultato molto importante che colloca il nostro Cantone tra le migliori regioni a livello internazionale», aggiunge Benvenuti.

Questo eccellente risultato si deve al concetto ticinese di presa a carico dell’arresto cardiaco. «Il modello
Settimanale edito da Migros Ticino Fondato nel 1938
Abbonamenti e cambio indirizzi tel +41 91 850 82 31 lu–ve 9.00 –11.00 / 14.00 –16.00 fax 091 850 83 75
registro.soci@migrosticino.ch
Costi di abbonamento annuo Svizzera Fr. 48.– / Estero a partire da Fr. 70.–
ticinese si compone di un insieme di azioni. Da un lato vi è la sensibilizzazione e la formazione della popolazione perché l’idea che sta alla base dell’aumento della sopravvivenza è che la rianimazione vada cominciata al più presto possibile», spiega il direttore di Ticino Cuore. Dalla segnalazione dell’arresto, il tempo medio d’intervento è nel nostro Cantone di 10-12 minuti. Un intervallo rapido, che non cambia però il fatto che ogni minuto passato, la probabilità di successo della rianimazione si riduce del 7-10%. Da qui la convinzione del ruolo chiave dell’intervento dei soccorritori volontari. «Chi è presente deve attivarsi e farlo nel modo corretto: riconoscere l’evento, allarmare il 144
e iniziare subito il massaggio cardiaco. Per far sì che ciò sia possibile, c’è stata un’attività importante, come si diceva, di sensibilizzazione e formazione, che ha fatto in modo che in 15 anni quasi 120mila persone siano state formate a questi temi; detto in altri termini, un ticinese su tre almeno una volta nella vita ha seguito un corso di rianimazione – afferma Benvenuti – altro elemento importante è la messa a disposizione di apparecchi defibrillatori, i quali aiutano, in alcuni casi in maniera molto significativa, il paziente ad avere una prognosi positiva». «Negli arresti cardiaci la fibrillazione è frequente nei primi 7-10 minuti; un ulteriore motivo per il quale è imperativo intervenire precocemente», continua. Attualmente sul territorio sono distribuiti 1400 defibrillatori. «Se sono in presenza di una persona che sta avendo un arresto cardiaco, l’operatore del 144 mi dirà dove si trova il defibrillatore a me più vicino. La stessa cartina usata a tale scopo dal 144 si trova sul nostro sito Internet e sulla nostra applicazione per smartphone – spiega Claudio Benvenuti –se invece, per esempio, lavoro in una banca oppure faccio l’allenatore in un centro sportivo che dispongono di un tale apparecchio, devo essere a conoscenza di dove esso si trovi».
Per garantire una risposta adeguata a questa patologia che colpisce spesso senza preavviso, è quindi importante che la popolazione impari ad allarmare correttamente, riani-
mare ed usare il defibrillatore. Detto ciò, e restando in tema di non professionisti della sanità, c’è da parlare del successivo step della rete d’intervento e soccorso che ha contribuito a rendere il nostro territorio una delle zone più cardioprotette d’Europa. Stiamo parlando della rete First Responder (FR) – un modello organizzativo innovativo ideato dalla Fondazione Ticino Cuore e dalla FCTSA – costituita da un insieme di persone e istituzioni (polizia, pompieri, guardie di confine, samaritani, …) che, su base volontaria, danno la propria disponibilità ad essere allarmati da Ticino Soccorso 144. «Praticamente, al verificarsi di un arresto cardiaco, Ticino Soccorso attiva la rete di FR indicando il luogo dell’intervento e i minuti necessari all’ambulanza per arrivare sul posto. Se un First Responder può raggiungere il paziente in minor tempo, risponde alla chiamata attivandosi immediatamente – spiega Benvenuti – la possibilità che una persona formata possa iniziare la rianimazione sul posto, con defibrillatore e massaggio cardiaco, prima dell’arrivo dei soccorsi è un ulteriore elemento che fa sì che il paziente possa beneficiare del massimo delle chances per riprendersi». Per essere un First Responder basta essere maggiorenni, aver seguito un corso per la rianimazione ed avere il relativo certificato valido. Oggi la rete di FR conta più di 5000 persone, a testimonianza della sensibilità e solidarietà esistenti in Ticino in relazio-

«Il Cavaliere del cuore è un evento che abbiamo voluto per ringraziare tutti i laici che si sono attivati spontaneamente per salvare qualcuno. Vogliamo valorizzare questo bellissimo gesto di altruismo, anche nel caso in cui, purtroppo, l’esito è stato sfavorevole», afferma il direttore di Ticino Cuore. Alla cerimonia prendono parte alcuni ex pazienti, che consegnano di persona il riconoscimento ai loro salvatori. «Spesso si tratta del primo momento che essi hanno per incontrare le persone che si sono prodigate nelle prime misure di rianimazione e questo è molto bello e toccante», continua.
Non tutti, trovandosi in una situazione come quella in cui intervengono i «Cavalieri del cuore» avrebbero il coraggio di agire; quali sono effettivamente i rischi che si corrono? «Innanzitutto, la prima cosa da fare è chiamare il 144 e seguire le indicazioni fornite dall’operatore», spiega Benvenuti, tornando su un elemento che già di per sé è rassicurante. «Detto ciò, bisogna essere consapevoli del fatto che se non si fa nulla, il paziente morirà; quindi, ogni cosa che si fa prima dell’arrivo dei soccorsi è meglio dell’immobilismo», continua il direttore della Fondazione, la quale, per promuovere ulteriormente la sensibilizzazione su questo tema che nel nostro Cantone è già buona – basti pensare che all’anno sono mediamente 8mila le persone che seguono un corso di rianimazione – punta sulle giovani generazioni: «Riteniamo questo aspetto molto importante perché genera un cambiamento culturale. Di fatto ogni anno proponiamo la formazione ai ragazzi di quarta media, iniziativa alla quale attualmente aderiscono circa due terzi delle sedi –conclude Claudio Benvenuti – in ogni caso, chiunque fosse interessato può rivolgersi ai Servizi di autoambulanza locali, alle Sezioni samaritani oppure alle Società di salvataggio, che offrono regolarmente dei corsi di rianimazione cardiopolmonare certificati e riconosciuti». azione
Sede Via Pretorio 11 CH-6900 Lugano (TI)
Telefono tel + 41 91 922 77 40 fax + 41 91 923 18 89
Indirizzo postale Redazione Azione CP 1055 CH-6901 Lugano
Posta elettronica info@azione.ch societa@azione.ch tempolibero@azione.ch attualita@azione.ch cultura@azione.ch
Pubblicità Migros Ticino Reparto pubblicità CH-6592 S. Antonino tel +41 91 850 82 91 fax +41 91 850 84 00 pubblicita@migrosticino.ch
Editore e amministrazione Cooperativa Migros Ticino CP, 6592 S. Antonino tel +41 91 850 81 11
Stampa Centro Stampa Ticino SA Via Industria – 6933 Muzzano
Tiratura 101’177 copie
Attualità ◆ Puntualmente, come in ogni Epifania che si rispetti, ritorna la deliziosa torta dei Re Magi, sfornata freschissima dal panificio della Migros

confezionata, 420 g Fr. 4.10
Impossibile resistere alla torta dei Re Magi, non solo per il suo gusto unico, ma anche per l’irrefrenabile desiderio di riuscire finalmente a trovare al suo interno la famosa statuina di plastica a forma di re che dà diritto al fortunato di regnare per un giorno intero, indossando l’immancabile coroncina acclusa alla confezione. Questo soffice dolce di pasta lievitata viene prodotto fresco dal panificio della Migros seguendo la ricetta tradizionale che venne rilanciata in Svizzera negli anni Cinquanta. Che si tratti della variante classica con uva sultanina nell’impasto e granella di zucche-

ro e mandorle a scaglie in superficie, di quella con ingredienti al 100% di origine biologica oppure ancora della versione con golosissimi pezzetti di cioccolato nascosti nella pasta, ognuno troverà il suo dolcetto preferito per celebrare come si conviene la festa dei Re Magi. La specialità è preparata con passione dalle panettiere e dai panettieri del panificio Migros, come pure nelle due panetterie della casa di S. Antonino e Serfontana, utilizzando ingredienti di elevata qualità. Bisognerà però affrettarsi a procurarsela, perché sarà disponibile fino a giovedì 5 gennaio.
A tavola ◆ Grazie alla sua versatilità, questo tipo di carne permette di approntare portate prelibate e mai banali
•
Ingredienti
•
•
•
•
• Sale, pepe
•
•
•
La carne di tacchino, analogamente a quella di pollo, è un alimento prezioso perché apporta al nostro organismo importanti sostanze quali proteine, sali minerali e vitamine e, rispetto ad altre carni, è povera di grassi. Inoltre, grazie alla sua tenerezza, succosità e all’aroma delicato, il tacchino si presta bene per la preparazione di un’infinità di ricette, dalle più semplici a quelle più raffinate dei giorni di festa. Se il tacchino intero arriva sulle tavole soprattutto durante le occasio-

ni speciali per accontentare numerosi commensali, gli altri tagli si gustano tutto l’anno per preparare invitanti ricette sempre diverse e particolarmente economiche rispetto ad altre tipologie di carne. Le fettine sono per esempio molto gettonate quando si tratta di soddisfare i gusti di tutti, anche dei buongustai più piccoli. Sono ricavate dal petto dell’animale e risultano molto tenere e facilmente digeribili. Si possono utilizzare alla stregua delle fettine di maiale o vitello, al natura-

le, con una salsina o impanate, sia arrostite, grigliate, stufate o come ripieno. Come il pollame in generale, anche il tacchino deve essere servito sempre ben cotto onde evitare disturbi alla salute. Idealmente, la carne dovrebbe avere una temperatura al cuore di almeno 75°C per distruggere tutti i batteri, pur mantenendo la sua bella succosità. Infine, se siete a corto di idee in fatto di ricette, qui a lato trovate una proposta super croccante che non deluderà nessuno.
•
Taglia i pomodori a dadini. Trita finemente la cipolla e il prezzemolo. Mescola i pomodori con la cipolla e la metà del prezzemolo. Condisci con il Condimento bianco, sale e pepe.
Sbatti le uova e mescolale con il prezzemolo rimasto e il parmigiano. Condisci le fettine con sale e pepe. Passale prima nella farina poi nell’uovo. Rosola la carne a fuoco medio per ca. 10 minuti nel burro per arrostire. Servi la piccata con la salsa fredda di pomodori.
Lo scorso settembre l’Accademia della mobilità, una società del Touring Club Svizzero che si qualifica come una «cellula di riflessione e di azione» dedita allo studio e alla promozione delle conoscenze sulle trasformazioni del settore dei trasporti, ha dedicato ai veicoli elettrici una giornata della sua «Arena della mobilità», una manifestazione che ogni anno riunisce esperti provenienti da tutta l’Europa. Il motore elettrico non è un’invenzione degli ultimi anni. Era già conosciuto a fine Ottocento. Ma è solo nell’ultimo decennio, a fronte dei problemi ambientali e climatici e delle incognite riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento in carburanti fossili, che la spinta verso la mobilità elettrica si è fatta irresistibile. L’industria automobilistica ha avviato una profonda riconversione, ben illustrata dalla crescente offerta di modelli ibridi ed elettrici; la maggior parte dei produttori intende passare esclusivamente all’elettrico al più tardi entro il 2035. La via è dunque tracciata. Una serie di ostacoli sono stati superati o sono in procinto di esserlo. Alcune riserve, o miti come li ha definiti Martin Bolliger, responsabile del servizio di consulenza sulla mobilità del TCS, sono caduti.

C’è chi pretendeva che l’automobile elettrica non fosse sostenibile dal punto di vista ambientale. Oggi risulta invece che, considerato l’intero
processo dalla fabbricazione, alla produzione di energia, all’uso e all’eliminazione e al riciclaggio, essa presenta un profilo migliore rispetto al motore termico, purché l’elettricità provenga da fonti rigenerabili. Infatti, a seconda del modello, le emissioni di CO2 sono inferiori a partire da una percorrenza di grosso modo 30’000 km.




C’è chi temeva che non si disponesse dell’energia per alimentare un parco veicoli convertito alla nuova trazione elettrica. Giova ricordare a tal proposito che oggi circa un terzo dell’energia finale è consumata in Svizzera dal settore dei trasporti e di questo terzo il 95% è di origine fossile. Con la diffusione della trazione elettrica viene progressivamente a diminuire l’uso dei carburanti fossili. L’energia elettrica per le automobili è per contro destinata ad aumentare. Entro il 2050 la sua incidenza sul totale passerà dall’attuale 0,4% ad un previsto 15-20%. Si tratta di un incremento importante ma gestibile nell’ambito della strategia energetica elvetica, che, accanto all’obiettivo di una maggiore efficienza e quindi riduzione dei consumi, postula la sostituzione delle energie fossili con la produzione di energia elettrica da fonti indigene e rigenerabili. L’uso dell’auto elettrica non è ancora del tutto privo di condizionamenti. Sono tuttavia in fase di superamento. Lo sviluppo delle batterie per assicurare una maggio-
re autonomia è in corso, la diffusione dell’uso sta riducendo i costi, la rete per la ricarica si amplia velocemente. La guida di un’auto elettrica si sta anche rivelando piacevole, silenziosa e confortevole. A quando un parco veicoli completamente elettrico?
Nel 2021 il parco delle automobili ha raggiunto in Svizzera 4,7 milioni di unità. I veicoli completamente elettrici erano 70’223, ossia l’1,5%. Se consideriamo anche gli ibridi plug-in (43’223) arriviamo a una quota del 2,5%. Nelle nuove immatricolazioni il numero delle auto elettriche è in forte ascesa. La Confederazione, nello scenario di riferimento dell’ottobre 2021, valuta che nel 2050 la metà del parco automobili sarà elettrico. Per essere in linea con la strategia energetica e climatica perseguita questa quota dovrebbe essere ben superiore e fissarsi all’80%.

Per questo motivo la stessa Confederazione, tramite Svizzeraenergia, ha stabilito una Roadmap Elettromobilità 2025 che, con il coinvolgimento di 59 organizzazioni pubbliche e private, punta a far sì che entro questa data la metà delle nuove immatricolazioni sia costituito da modelli elettrici o ibridi plug-in (oggi il 22,2%), disporre di 20’000 stazioni di ricarica accessibili a tutti (stato agosto 2022: 8588) e promuovere la ricarica a casa e sul posto di lavoro. Le misure per incentivare questo cammino vanno dall’informazione capillare e dalla puntuale consu-

lenza alla definizione di standard per gli allacciamenti elettrici e alla realizzazione di stazioni di rifornimento. In diversi Cantoni sono previsti contributi per l’acquisto dei veicoli e/o per le stazioni di ricarica, la Confederazione ha rinunciato all’imposizione fiscale dei veicoli elettrici, prevede contributi per stazioni di ricarica e intende inasprire le norme per le emissioni dei motori termici. La riconversione del parco veicoli all’elettricità costituisce in definitiva una delle maggiori sfide politiche, tecnologiche ed economiche mai sinora affrontate. Gli economisti mettono in guardia da due possibili controtendenze. Da un lato la cresci-
ta demografica tende inevitabilmente a ridurre i vantaggi ottenuti a seguito dell’incremento dei consumatori. Dall’altro, in economia il minor costo grazie alla maggiore efficienza tende a ridurre il consumo di risorse solo in parte, poiché automaticamente può generare nuovi bisogni e quindi spingere il consumo a un nuovo rialzo. Le soluzioni ai problemi della mobilità e della sua sostenibilità vanno quindi inserite in una strategia più ampia nella quale devono trovare spazio anche misure per evitare gli spostamenti, per condividerli usando uno stesso veicolo, e per incoraggiare quelli a piedi, in bicicletta e con i trasporti pubblici.


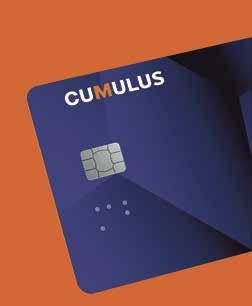
Medicina ◆ Oggi si può individuare la predisposizione a sviluppare più facilmente un tumore rispetto alla popolazione generale
Maria Grazia BulettiLa modella italiana trentottenne Bianca Balti, di recente, si è sottoposta a una mastectomia preventiva. Lo ha annunciato lei stessa: quando ha scoperto di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1 (dall’inglese Breast Cancer gene 1), ha scelto di sottoporsi all’intervento per ridurre il rischio di contrarre un tumore al seno. Nel 2013 la stessa diagnosi era toccata ad Angelina Jolie che raccontò di aver ereditato la mutazione genetica dalla madre, morta di cancro alle ovaie a 56 anni. Aveva fatto scalpore la decisione della nota attrice quando optò per una scelta preventiva radicale, sottoponendosi alla mastectomia bilaterale e all’asportazione di tube e ovaie. Entrambe hanno preso questa decisione in seguito al test genetico BRCA raccomandato nei pazienti con un rischio famigliare elevato e documentato da un’accurata consulenza genetica.
Filippini: «Per il tumore al seno e all’ovaio, una quota tra il 5 e il 10% dei casi è attribuibile alla forma ereditaria»
«La doppia mastectomia preventiva non è raccomandata per tutte: in ogni caso deve trattarsi di una decisione informata e consapevole». Così la dottoressa Francesca Borzani, specialista in oncologia alla Clinica Sant’Anna di Sorengo, introduce il tema dell’oncologia genetica e della consulenza oncogenetica che oggi permette di individuare nel DNA le mutazioni dei geni in presenza di diverse tipologie di tumori.
Dal canto suo, la specialista FMH in genetica medica Giuditta Filippini chiarisce che «tra quelli ereditari più frequenti ci sono il tumore al seno, il tumore all’ovaio, il tumore del colon , il melanoma, il tumore al pancreas e quello alla prostata; mentre ve ne sono altri più raramente ereditari come, ad esempio, i tumori onco-ematologici».
La pertinenza della genetica oncologica è supportata da chiari dati statistici: «Per il tumore al seno e all’ovaio, per esempio, una quota tra il 5 e il 10% dei casi è attribuibile alla forma ereditaria (ndr : quando la sua insorgenza è dovuta a una mutazione genetica trasmessa dai genitori)», prosegue la genetista che puntualizza: «Le mutazioni presenti nei genitori hanno il 50% di probabilità di essere trasmesse ai figli che, sia chiaro, non ereditano la neoplasia dovuta a quell’alterazione ma, eventualmente, la predisposizione a sviluppare più frequentemente quel tumore rispetto alla popolazione generale».
Ciò spiega come la consulenza oncogenetica è parte integrante di un processo il cui obiettivo guarda alla gestione globale di tutte le persone a rischio o affette, provenienti da famiglie predisposte a forme ereditarie o famigliari di cancro. «I criteri d’accesso ai test oncogenetici e al relativo diritto alla richiesta di rimborso da parte delle casse malati si possono
consultare sul sito della Società svizzera di oncologia (www.sakk.ch)», spiega la dottoressa Borzani, invitando poi ad approfondire: «In caso di famigliarità, o di forte sospetto di tumore ereditario, è importante affidarsi allo specialista che sarà in grado di valutare la necessità di eseguire o no i relativi test genetici».

L’oncologa ricorda che la consulenza genetica oncologica è rivolta a persone con sospetta predisposizione ereditaria allo sviluppo di tumori e soprattutto deve essere effettuata da un gruppo multidisciplinare che comprende un genetista, un oncologo (eventualmente un esperto specialista della patologia in esame) e uno psicologo. Quest’ultimo mira a garantire un adeguato supporto e a favorire un’autonomia decisionale, considerata la complessità degli argomenti trattati, della scelta di sottoporsi al test e/o di intraprendere in seguito specifici percorsi di sorveglianza o riduzione del rischio: «Il paziente che vi si sottopone è invitato
a fornire dati sulla sua famiglia di appartenenza, sulla sua malattia e quella dei suoi famigliari; dopo la stesura dell’albero genealogico e un’esaustiva analisi dei dati anamnestici, il genetista verifica la presenza o meno dei criteri di accesso al test genetico».
Esame che si effettua tramite un campione di sangue da cui si estrae il DNA per leggerne le sequenze dei geni interessati dal tumore in questione, chiarisce Filippini: «In sede di consulenza vengono date tutte le informazioni disponibili sulla malattia e sul rischio di svilupparla, sull’indagine genetica e i suoi limiti, sul rischio di malattia associato al risultato del test e sulle possibilità preventive e/o terapeutiche disponibili».
Dal test genetico è quindi possibile ottenere «un risultato chiaramente informativo – spiega Filippini – in quanto viene individuata la mutazione famigliare predisponente, oppure un risultato in cui questa non viene identificata perché non è presente nella persona testata, o perché
si trova su altri geni non noti o non identificabili dall’analisi attualmente disponibile».
Scoprire il reale rischio di sviluppare un tumore, ad esempio del seno o dell’ovaio, permette di attuare un’adeguata strategia difensiva adatta alla situazione specifica personale, afferma Barzani: «La persona può decidere di partecipare a programmi di sorveglianza ad alto rischio, godendo di una possibilità di controllo maggiore rispetto agli screening esistenti per la popolazione in generale; può inoltre fornire ai propri famigliari informazioni importanti; infine può decidere in tutta autonomia e coscienza per una scelta più radicale come ad esempio hanno fatto la Jolie e la Balti per le quali il test genetico BRCA è risultato positivo, con le relative scelte che ne sono conseguite».
La genetista illustra l’esempio riportato: «I geni BRCA1 e BRCA2 producono proteine in grado di correggere eventuali errori a livello del DNA, prima della replicazione cellulare. Quando queste sono mutate, cioè difettose, il DNA non viene riparato correttamente e le mutazioni aumentano fino a indurre le cellule a dividersi in modo incontrollato, dando così vita a una massa tumorale. Una mutazione di questo tipo, ereditata da un genitore, determina quindi la predisposizione a sviluppare il tumore più frequentemente rispetto alla popolazione in generale: queste mutazioni aumentano l’insorgenza di tumori, con un rischio di cancro al seno che varia dal 60 all’80%, e un rischio tra il 15 e il 60% di contrarre un tumore all’ovaio, secondo il tipo di mutazione e la storia famigliare».
La popolarità delle due persone che hanno divulgato la propria scelta permette di sensibilizzare i lettori sull’importanza dei test oncogenetici laddove la storia famigliare è predisponente per lo sviluppo di un tumore, e apre la strada a un’eventuale monitoraggio di prevenzione del tutto individuale.
Migros Impegno ◆ A partire dal 9 gennaio sarà possibile votare le migliori iniziative svizzere per un buon vicinato –I progetti saranno sostenuti con un importo fino a 50’000 franchi
Chi non ne ha può dirsi fortunato. Oppure no. Ci riferiamo agli amati/ odiati vicini di casa, ossia coloro che vivono accanto e intorno a noi, e con cui a volte siamo costretti a condividere spazi comuni come lavanderie, solai e garage, oppure siepi e muri. Che la nostra vita si svolga in città, in piccoli centri, in una comunità abitativa o in una casa unifamiliare, alla maggior parte di noi capita di doversi confrontare, per un motivo o per l’altro, con i vicini di casa. E per questo sarebbe importante coltivare buoni rapporti con chi ci abita vicino, anche alla luce del fatto che negli ultimi anni la popolazione svizzera si è allontanata nei rapporti interpersonali, sia in termini di spazio sia di socialità.
Vista e considerata l’importanza di questo ambito relazionale, nel corso del 2022 Impegno Migros ha deciso di chinarsi su diversi aspetti a esso correlati. Nel corso dell’estate sono stati resi pubblici su scala nazionale i risultati del primo studio empiri-
A questo importante studio, che ha permesso di evidenziare le aspet-
tative e i desideri di cittadine e cittadini, Migros Impegno ha deciso di affiancare anche una serie di iniziative collaterali atte a incrementare e migliorare, quando addirittura non a creare, un buon rapporto di vicinato. È stato dunque lanciato il progetto
#iniziativadivicinato, volto a sostenere attivamente grandi o piccoli progetti di comunità nel vicinato.
Durante la prima fase dell’#iniziativadivicinato sono stati estratti a sorte 500 contributi da 500 franchi ciascuno per progetti di comunità nel vicinato, e nel mese di ottobre 2022 Migros Impegno ha indetto un concorso per la presentazione di idee di progetti volti a promuovere in modo duraturo la buona convivenza tra vicini. I progetti, che si potranno votare dal 9 gennaio, saranno sostenuti con un importo fino a 50’000 franchi. Fra quelli in lizza ve ne sono anche tre ticinesi.
L’Associazione «Il Circolo di Bedigliora» intende ridare vita al villaggio, da cui negli anni sono spariti sia il negozietto sia il bar, creando un luogo aggregativo in cui leggere, giocare a carte, fare musica, il tutto in nome di uno spirito aggregativo intergenerazionale.

L’associazione «Amélie» di Pre-
gassona, che dal 2021 offre attività e corsi per la socializzazione e l’integrazione, riuscendo a coinvolgere ben 500 persone, tra cui 200 giovani, desidera estendere la propria offerta, in modo da favorire uno sviluppo sociale anche a livello regionale.
Infine, l’Associazione «COSCOL» di Beride, che da oltre vent’anni offre letture, concerti e incontri culinari in una vecchia stalla salvata dalla demolizione, vorrebbe intensificare la propria offerta, permettendo ai partecipanti di riunirsi con maggiore regolarità e soprattutto indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.
Come votare
A partire dal 9 gennaio 2023 sarà possibile votare il proprio progetto di vicinato preferito cliccando su https://www.migrosengagement.ch/it/vicinato
Tasiilaq, Groenlandia Orientale, 65°37'N 37°38'W, primi di dicembre, 2022. Dalla finestra, ore 16.15, buio completo: le montagne dall’altra parte del Kong Oscars Havn svettano sotto l’aurora boreale, mentre il mare si accende di verde. Di giorno, il villaggio di piccole case colorate nelle quattro ore di luce si veste di cieli rosa pallido, pervinca, azzurro carta da zucchero, viola, porpora, oro. Nell’aria i corvi e in lontananza l’ululato dei cani.



Il fiordo di fronte all’abitato più popoloso (2500 anime) della costa est della seconda isola più grande al mondo è totalmente libero dal ghiaccio. Le temperature di questi giorni sono insolitamente alte. Le montagne sono appena imbiancate e le tempeste delle ultime settimane hanno portato più acqua che neve. Parlando con la gente del luogo c’è un misto di preoccupazione e inquieta euforia.
Gli anziani sono perplessi: il mare gela sempre più tardi e le previsioni meteo sono sempre meno regolari. Caja, che da ragazza, correvano gli anni Novanta, nell’ambito di un programma di scambi interculturali all’estero, studiò per un anno in Ghana, sorride e mi conferma che lei preferisce così. Da bambina doveva uscire in slitta ad aiutare i cacciatori della sua famiglia e ha avuto un paio di incidenti, due brutte cadute che le hanno lasciato degli strascichi, e i dolori si sentono di più quando il freddo morde. Aggiunge però che suo padre, da che ha memoria, non si ricorda di un clima così mite in questa stagione. In genere a inizio dicembre la gente del posto ha già tirato in rada o a terra le piccole imbarcazioni, prima che il mare ghiacci. Una volta che il fiordo sarà solidamente stretto nella morsa del gelo, lo si potrà attraversare a piedi o con le slitte trainate dai cani.
Fino a 150 anni or sono la costa orientale della Groenlandia era una delle zone più remote del pianeta: lo stretto di mare che la separa dall’Islanda, infatti, era infestato da distese di ghiaccio che la Transpolar Drift
Stream trascina da nord (dalle coste della Siberia) verso l’oceano Atlantico. I primi tentativi di esplorazione condotti dai fiordi occidentali islandesi prevedevano una finestra temporale incerta tra giugno e agosto, per tentare di arrivare dall’altra parte. Le barche all’epoca erano di dimensioni ridotte e in legno. Mare agitato, iceberg e condizioni meteo spesso proibitive fecero naufragare diverse spedizioni. Furono in molti a partire senza mai fare ritorno, interi equipaggi inghiottiti dal mare, di cui non si seppe più nulla. La popolazione Inuit locale, arrivata su questa costa si stima 2000 anni prima di Cristo, rimase legata alle tradizioni e a uno stile di vita nomadico fino all’arrivo dei danesi che fondarono nel 1894 l’insediamento di Ammassalik (Tasiilaq).
Le esplorazioni delle regioni polari ci hanno regalato pagine memorabili colme di imprese e uomini che hanno sfidato la natura più avversa per amore dell’avventura e della scienza. Capitani coraggiosi, ricercatori indomiti, visionari abbagliati da queste distese di ghiaccio e mare, che hanno cercato di spingere sempre un po’ più in là il confine tra noto e ignoto. I loro racconti hanno contribuito alla nascita e all’espansione del nostro immaginario su queste terre estreme che anche ai giorni nostri continuano a esercitare un fascino magnetico. Ancora oggi c’è chi va in Groenlandia, in cerca di extreme expedition, convinto di trovare gli eschimesi vestiti di pelle di foca, che vivono negli igloo e si strofinano il naso per salutarsi.
Quello che spesso manca in questa narrazione è il prezzo pagato dalla popolazione locale, gli Inuit, per essere stata civilizzata e salvata dal paganesimo. Oggi si parla praticamente solo di quanto questi indigeni (che qui non sono una minoranza etnica, ma più dell’80% della popolazione) siano preda di alcolismo, depressione (la Groenlandia, 55mila persone, è il Paese al mondo in cui ci si suicida di più), indolenza. Le case «in sti-
le europeo» costruite dal governo danese, sono colorate, ma senza acqua corrente. Il sistema fognario inesistente. A scuola si insegna il danese e il groenlandese dell’ovest: il dialetto dell’est resta solo parlato a casa. Se a casa è rimasto qualcuno che lo parla. Molti cercano lavoro altrove, a Nuuk (la capitale), dove si fa business, o negli insediamenti a sud, che sono verdi e ci si possono persino allevare le pecore. I figli, li si lascia a casa, da qualche parente.
I ragazzi che hanno voglia di studiare vanno comunque a ovest, dove c’è più movimento e si concentrano gli investimenti economici, o in Danimarca. Molti tornano dopo poco, perché soprattutto nelle città europee restano frastornati. Troppo rumore, troppo traffico. Ansia. Pressione. Del resto, come ha sintetizzato bene Barry Lopez, nel suo magistrale Arctic Dreams, «Per alcune persone, ciò che sono non finisce con la loro pelle, ma arriva dove i sensi toccano la terra. Se la terra viene sommariamente sfigurata o riorganizzata, questo provoca loro dolore psicologico».
Sbircio di nuovo dalla mia finestra: questa notte è nevicato. Finalmente. Tutto è bianco, tranne i corvi. Non si vedono più le lattine vuote, abbandonate a decine per strada, gli elettrodomestici guasti che nessuno sa riparare, le gomme bucate, la barca guasta, arenata a riva. Per un attimo torna tutto perfetto. Anche i cani sembrano felici, l’odore della neve vuol dire che si torna presto a correre. Finalmente.
Quando il ghiaccio sarà abbastanza spesso e solido, i pescatori risaliranno la costa e praticheranno fori per pescare. I cacciatori più esperti usciranno in cerca di uccelli e foche, che nell’alimentazione tradizionale hanno lo stesso posto che polli, suini e bovini hanno per noi. È l’unica fonte di proteine fresche. Non ci sono allevamenti qui sulla costa est, il cibo arriva congelato sulle navi cargo da Danimarca e Islanda. E i cani non sono
abituati a scatolette e crocchini. Hanno bisogno di mangiare bene: presto correranno anche per i turisti in arrivo nella stagione invernale.
La gente a Tasiilaq sorride sempre, quando la incroci per strada. Un saluto non si nega a nessuno. Per millenni si sono spostati seguendo la linea del mare gelata e i suoi capricci. Vivevano in campi invernali, costruiti con ghiaccio e neve in inverno, in abitazioni fatte di roccia, erba e torba in estate. Sono arrivati quasi allo stermi-
nio nei periodi più freddi, hanno conosciuto abbondanza in quelli più miti e stabili. Oggi continuano a vivere una vita resa difficile da regole imposte da una cultura non loro e un clima che cambia troppo in fretta, ma sempre eroicamente aggrappati a queste latitudini, come le loro case sulle rocce di Tasiilaq.
Informazioni Su www.azione.ch, si trova una più ampia galleria fotografica.
Fu per distinguersi dalla plebe che cambiarono i gusti dei consumatori nobili nel nord Europa verso la fine del XVII secolo
Pagina 12
La storia della carne: come e quando dalla tavola dei ricchi è arrivata nei piatti dell’intera popolazione
Pagina 13
Una Befana che nasconde dolcetti
Al posto delle tradizionali calze appese ai camini, per la festa dell’Epifania possiamo creare uno scrigno segreto speciale
Pagina 14
La nostalgia ◆ Tuffarsi nel passato attraverso melodie, film o libri è un’esperienza che caratterizza il nostro tempo libero
Sebastiano CaroniPuò capitare, a volte, di ascoltare una canzone che ha marcato la nostra vita, che associamo a un momento, a una persona, a un’esperienza importante; ed è un po’ come se quella melodia, in modo quasi impercettibile, ci trascinasse in un doppio movimento: il presente viene risucchiato dal passato, e il passato torna a visitare il presente. Accade cioè che la nostra memoria riattiva esperienze vissute nel passato che, sospinte in avanti, si ripresentano al cospetto del nostro presente.
Può succedere con una melodia, presenza eterea per eccellenza, alleata del vento. Ma può capitare anche con un film, che scegliamo per allietare il nostro tempo libero. Magari è un film che immortala il decennio in cui abbiamo vissuto i momenti più formativi della nostra gioventù, e in maniera vicaria ci restituisce qualcosa di quell’epoca: sapori, suoni e sensazioni che credevamo sepolti ma che improvvisamente riaffiorano. E per chi ama leggere, allora anche un libro può regalarci l’ebrezza di quel doppio movimento. E quando un libro viene riletto, un film rivisto, o una canzone riascoltata, quel libro, quel film e quella musica diventano a loro volta parte integrante del presente.
In certi momenti è praticamente impossibile non avvertire un fremito, lieve o marcato, di nostalgia, per il semplice motivo che la nostalgia è
una delle cifre più rappresentative del nostro tempo: è quel retrogusto agrodolce che pervade e accompagna il presente. Rivisitare in chiave inedita il passato è una tendenza che caratterizza in maniera importante anche il nostro tempo libero, tanto che molti prodotti culturali destinati all’intrattenimento, dalla musica al cinema passando per l’abbigliamento e i prodotti di bellezza, fanno leva proprio sul sentimento della nostalgia.
Chi non è mai incappato in qualche serata musicale dedicata agli anni Ottanta o Novanta? Anche la televisione, del resto, sfrutta in modo strategico l’appeal di questi due decenni, proponendo trasmissioni e cicli di film nell’intento di riproporre il mood di quegli anni. La moda, da parte sua, non può essere da meno, con le sue continue rivisitazioni di stili che credevamo sorpassati.
Il blogger Mark Fisher rileva come nella musica contemporanea, prettamente digitale, spesso vengano riprodotti ad arte effetti analogici che ci riportano a stili e tendenze del passato. Basta veramente poco: una registrazione digitale che incorpora l’inconfondibile suono – perfetto nella sua imperfezione – della puntina del giradischi raggiunge, potenzialmente, il massimo effetto con un semplice dettaglio. E che dire delle numerose cover band che, attingendo a brani che
hanno fatto la storia, ci fanno rivivere i bei tempi andati?
In un presente in cui le innovazioni tecnologiche si susseguono troppo rapidamente e si perdono in un vortice di sterile autoreferenzialità, viviamo all’insegna della retrotopia, termine coniato dal sociologo Zygmunt Bauman per descrivere la contemporaneità: «abbiamo invertito la rotta e navighiamo a ritroso» afferma Bauman. «Il futuro è finito alla gogna e il passato è stato spostato tra i crediti, rivalutato, a torto o a ragione, come spazio in cui le speranze non sono ancora screditate».
Ma che cosa è, dunque, la nostalgia, e perché è una sfumatura importante dell’esperienza del nostro tempo libero? In un interessante saggio pubblicato negli anni Novanta – poi riedito e ampliato in due occasioni – dal titolo Nostalgia. Storia di un sentimento, il critico letterario e poeta Antonio Prete ricostruisce la storia della parola, affermando che il neologismo, coniato alla fine del XVII secolo dallo studente in medicina Johannes Hofer designava, in origine, «la malattia che colpiva i soldati svizzeri in servizio presso guarnigioni straniere»: la lontananza, si racconta, innescava in questi soldati l’irrefrenabile desiderio del ritorno in patria.
Jean-Jacques Rousseau, il secolo successivo, avrà modo di interrogarsi
su cosa esattamente mancasse a questi mercenari, arrivando alla seguente conclusione: «C’è in Svizzera una celebre aria popolare di montagna che i pastori suonano coi loro corni facendo risuonare tutt’intorno le montagne. Questo motivo, che in sé è poca cosa, ma che fa venire in mente agli svizzeri mille pensieri relativi al paese natio, fa versare fiumi di lacrime quando si ascolta in terra straniera».
Se la parola nostalgia – che risulta dalla convergenza fra i termini greci nostos (ritorno) e algos (dolore) – ha, perlomeno all’inizio, una connotazione prettamente medico-patologica, con il tempo si diffonde in altri ambiti e assume nuove sfumature di senso. Fintanto che la parola rimaneva in ambito medico, inoltre, veniva usata con un’accezione marcatamente negativa. Oggi, invece, le cose sono cambiate, e alla nostalgia si riconosce una duplice valenza: non solo negativa, dunque, ma anche positiva.
Come afferma Tiffany Watt Smith in Atlante delle emozioni umane (UTET, 2017), all’inizio del Novecento, «il significato del termine nostalgia iniziò a cambiare: non era più tanto in relazione al malessere provato quanto ci si trovava lontani da casa, ma una forma di desiderio per le cose passate». Sempre Watt Smith, a tal proposito, rileva come «un sorprendente numero di ricerche recenti

hanno messo in evidenza i vantaggi del concedersi qualche riflessione nostalgica, suggerendo che questo genere di riflessione aumenta il nostro senso dei legami sociali e del significato della vita». La stessa autrice poi, in maniera sintetica, ne conclude che la nostalgia «in meno di un secolo, da malattia mortale è diventata un salutare tuffo nel passato: neanche la nostalgia è più quella di una volta».
E se qualcuno, malauguratamente, si ritrovasse impantanato sul versante meno edificante della nostalgia, possiamo comunque ricordare le raccomandazioni che l’illustre medico Philippe Pinel, redigendo la voce «Nostalgia» dell’Encyclopédie Méthodique del 1821, elargiva ai suoi lettori: «Distrarre i malati con il gioco, i divertimenti, gli spettacoli, con occupazioni piacevoli». Oggi si direbbe, semplicemente, con il tempo libero.
Ai nostri lettori desiderosi di approfondire il tema, consigliamo invece due pubblicazioni recenti. La prima è Yesterday. Filosofia della nostalgia (Salani, 2022) della filosofa Lucrezia Ercoli, e la seconda è La luce delle stelle morte (Feltrinelli, 2022) dello psicanalista Massimo Recalcati. In entrambi questi libri troviamo un’analisi attenta e sensibile della profonda ambiguità che fa della nostalgia un pharmacon – al tempo stesso malattia e rimedio – dei tempi moderni.
Il filosofo olandese Erasmo da Rotterdam scriveva: «Il reciproco amore fra chi apprende e chi insegna è il primo e più importante gradino verso la conoscenza». Ed è grande davvero, l’amore di Luis Humberto Soriano Bohórquez verso i suoi alunni e l’insegnamento. Cinquantenne, laureato in letteratura spagnola, Luis Soriano è un maestro della zona rurale della Magdalena, nel Nord Ovest della Colombia. Ha sempre conosciuto, fin da quando era piccolo, la difficoltà di avere libri in casa per chi vive in questa regione.
Quella della Magdalena è una zona che vive di agricoltura, un’area di contadini, dove la violenza della guerra civile tra Farc, esercito e paramilitari, ha lasciato dietro di sé molte vittime. Come molti sono i bambini e i ragazzi che vivono in fattorie isolate, tanto che per andare a scuola devono fare anche più di dieci chilometri e, spesso, si ritrovano a dover rinunciarci, dopo i primi anni di studio.
Tali difficili condizioni di vita portarono Luis Soriano – circa 25 anni or sono (poco dopo essere diventato maestro) – a prendere un’importante decisione: avrebbe contribuito alla cultura del suo popolo. Aveva capito che non era sufficiente garantire una possibilità ai giovani di andare a scuola, era invece importante stimolare la conoscenza dei ragazzi, portare a casa loro quello che mancava: i libri.
Luis trasformò questo suo desiderio in realtà creando la biblioburro, ovvero si inventò una biblioteca itinerante trasportata da due asini (burro in spagnolo vuol dire asino), che si chiamano Alpha e Beto: «Così che le due parole, lette di seguito danno la parola Alfabeto». Sorride Luis Soriano, sotto al suo cappello di paglia, gli occhiali che scivolano sul naso a causa del sudore, il viso tondo e l’andatura claudicante a causa di una caduta dall’asino. «È successo tempo fa, sono caduto dal mulo e mi sono rotto il ginocchio. E da allora zoppico. Ma non importa. Riesco ad arrivare comunque in tutte le fattorie sperdute della zona».


Racconta la sua vita, Luis Soriano, mentre cammina all’interno della biblioteca che ha creato a La Gloria grazie alle donazioni, e che ora contiene più di 5mila libri: «Ce ne sono di tutti i tipi, continua Luis Soriano, dalle favole ai romanzi ai libri di storia e geografia». Intanto, davanti a casa, la moglie ha portato i due fedeli

quadrupedi, Alpha e Beto, già pronti con le loro selle speciali per trasportare la cultura a dorso di mulo, nelle fincas della regione.

Sono viaggi a volte brevi, di due o tre ore, e a volte lunghi, che impegnano il nostro maestro anche per due giorni lontano da casa. Caricati circa 70 libri, Luis Soriano si mette in viaggio seduto sulla groppa di Alpha, tirando dietro Beto. Il sole batte forte mentre la ristretta carovana attraversa le campagne della Colombia caraibica puntando verso la modesta fattoria La Fortuna, che dista tre ore a piedi. A poco dall’arrivo, un nugolo di bambini, appena vede arrivare da lontano il maestro, si prepara per accoglierlo con grida di allegria e sorrisi.
Ci si raduna all’ombra di un albero e subito inizia l’assalto ai libri. Luis Soriano si siede circondato dai bambini. C’è chi legge Pinocchio, chi invece rimane affascinato dal libro delle Storie dell’Abuelo, (il nonno in spagnolo), mentre altri si fanno trasportare dalle vicende degli Inca. Il maestro con pazienza spiega le storie, la morale dietro alle favole, illustra i disegni, risponde alle domande originali e curiose dei bambini e ragazzi. È attento a ogni loro richiesta, sorride felice quando vede lo stupore sui loro volti. Agita le mani e le braccia mentre tiene la sua lezione all’aria aperta.
«Il mio modo di vedere l’insegnamento è molto basico», mi dice mentre si asciuga la fronte e sia appoggia all’albero. «Io non devo solo insegnare le materie scolastiche, ma devo anche trasmettere il valore della vita. Perché qui da noi se sei povero e ignorante, sei povero due volte. Qui le famiglie non possono permettersi di mandare tutti i figli a scuola (anche se è obbligatorio) o di acquistare dei libri. E allora cerco di aiutarle io». Un modo di fare che ricorda in parte la Teologia della Liberazione, un pensiero cattolico nato proprio in seno alla chiesa sudamericana e dichiarato qui in Colombia nel 1968. Un pensiero che mette al centro i valori di emancipazione sociale della gente più povera. Ma che pure, una volta, gli ha fatto rischiare la vita: fermato dai paramilitari, durante la guerra civile, Luis Soriano venne preso in ostaggio e accusato sia di essere uno degli organizzatori dei contadini locali, sia di trasportare armi, «ma fortunatamente dopo un paio di giorni si resero conto che l’unica arma che avevo erano i
miei libri per i ragazzi: mi lasciarono andare insieme ai miei due asini».
Si riparte di primo pomeriggio per raggiungere un’altra fattoria a un’ora di cammino. Luis Soriano lascia alcuni libri ai ragazzi per finire di leggerli, li riprenderà la prossima volta che torna e ricorda loro che devono tenerli con cura. In Colombia le statistiche dicono che il tasso di alfabetizzazione è del 95% «ma questo solo nelle grandi
città. Qui nelle campagne – mi spiega il maestro – è molto più basso».
I due docili asini seguono il sentiero tracciato tra l’erba che accarezza le caviglie, e appena passata la piccola collina si vede in lontananza il tetto della fattoria. Anche qui il benvenuto alla biblioteca itinerante, al suo maestro, ad Alpha e Beto è caloroso. Tutto è pronto per il pomeriggio di lezione e lettura: alcuni adolescenti sanno
già che libri prendere dalla groppa degli asini, mentre altri si tuffano su nuove copertine e disegni. Un anziano che sta tornando dal campo, un paio di ciabatte ai piedi e le mani rugose e sporche di terra, si ferma e abbraccia Luis Soriano, ringraziandolo per quello che sta facendo: «Io non sono mai andato a scuola, so appena leggere e far di conto. Ma ho sempre voluto per mia figlia una vita diversa dalla mia. Ed oggi grazie a lui – dice indicando Luis Soriano – lavora come bibliotecaria nella biblioteca del maestro, giù al distretto di La Gloria».
L’anziano riprende il suo cammino verso casa mentre intorno i bambini e le bambine sono attratti dalla lettura e dalle spiegazioni di Luis Soriano. Alpha e Beto riposano all’ombra, miti e silenziosi. Protagonisti involontari ma principali di questa storia. Discendenti, forse, di Platero, l’altro asino protagonista del romanzo Platero e Yo di Juan Ramon Jimenez, Premio Nobel per la letteratura.
Informazioni
Su www.azione.ch, si trova una più ampia galleria fotografica.




Vino nella storia ◆ Verso la fine del XVII secolo, le classi al potere cercano un vino nuovo e costoso per distinguersi dal popolo
Davide ComoliTra la seconda metà del XVII secolo e la prima metà del XVIII in Europa occidentale si verifica una vera rivoluzione del gusto in materia di vino. E, tanto per cambiare, incomincia tutto dall’Inghilterra. È appunto a metà del XVII secolo – dopo i moti civili tra re Carlo I e il Parlamento (1642), e la rivoluzione inglese, quando viene deposto re Giacomo (1688) – che l’aristocrazia britannica si consola assumendo una forma di snobismo con cui vuole distinguersi, non solo con i vestiti indossati, ma anche con i piaceri che può concedersi, compreso quello del bere: birra, Sack, vini bianchi dolci, Clairet, diventano bevande troppo comuni. Nasce da queste circostanze l’assoluto bisogno di un nuovo tipo di vino.
A tale scopo, i viticoltori si ingegnano elevando di fatto i costi con innovazioni che modificheranno le caratteristiche dei vini noti fino a quel momento: si parla di diversa produzione, dell’introduzione delle bottiglie di vetro e quella dei tappi di sughero modellati nella forma voluta, nonché d’invecchiamento in cantine asciutte dentro la sabbia. Alla fine, i mercanti ottengono una tipologia di bordolesi chiamati vins noirs, vini di lunga fermentazione (più rari e più cari), che convincono la clientela inglese, per la durezza dei tannini che fa pensare a vini più alcolici rispetto ai famosi French claret


Il 10 aprile 1663 Samuel Pepys scrive sul proprio diario: «Usciti dalla Borsa con sir J. Cutler e Mr. Grant, siamo andati alla Royal Oake Taverne a Lumbard Street dove abbiamo trovato A. Broome, il poeta, un uomo allegro e intelligente credo, se non fosse un po’ troppo presuntuoso. Lì abbiamo bevuto un tipo di vino francese di nome Ho Bryan, dal sapore buono e particolare mai bevuto prima». Il vino in questione è quello che viene prodotto nella proprietà di Haut-Brion da Arnaud III de Pontac, primo presidente del Parlamento di Bordeaux, nella sua tenuta situata nella regione del Graves.
Nel 1666 il de Pontac apre per il figlio a Londra una drogheria, un ristorante e una taverna chiamati «The Sign of Pontac’s Head», dove vengono presentati all’esigente élite dell’alta società britannica i vini della tenuta, venduti tre volte più cari dei vini provenienti dal sud della Spagna. È fatta!
A differenza di altri vini importati, de Pontac produce il suo vino su un vigneto dalla superficie di 38 ettari, il terreno dell’Haut Brion costituito da una collina il cui suolo è stato drenato dalle ghiaie ( graves) sulla sponda sinistra del fiume Garonna. I vitigni usati per la produzione del vino a quell’epoca sono: il Malbec (Noir de Pressac), e il Petit Verdot al quale erano associati i due Cabernet (Sauvignon – Franc) chiamati all’epoca «Grande e
petite vidure ». Questi nuovi vin noir sono certamente migliori dei Claret, troppo leggeri, acidi e poco stabili, di facile deperimento.















Nonostante il successo dei vini della Graves nell’alta società londinese, lo scoppio della guerra tra Francia e Inghilterra (1660-1670), la proibizione d’importare qualsiasi merce sull’isola, e l’imposizione di tasse doganali (1678) molto pesanti sui vini francesi, portano a una crisi nel bordolese.
Viene dunque abbandonata la produzione di vini dalla scarsa qualità, per investire nella produzione di vini d’alta gamma. Nel frattempo sopravviene il famoso inverno del 1709 che
impone una totale ricostruzione dei vigneti, soprattutto nel Medoc e nelle Graves. Si preparano i terreni, bonificando le zone paludose con buona terra e ghiaia. È chiaro che solo le grandi famiglie proprietarie terriere possono investire denari in queste opere, troviamo così: i Pontac, i d’Avlède (Margaux), la famiglia Ségur (proprietario di Lafite, 50 ettari, e Latour, 36 ettari), considerata nel XVIII secolo come «il principe delle vigne». Cominciamo a trovare anche i nomi di ricchi commercianti bordolesi come Moytié a Saint-Julien, Rauzan a Pauillac, Kanon a Saint-Emilion, Fontenmoing a Pomerol e alcuni commercianti ingle-
si come Lynch, Barton, Johnstone e molti altri.
A metà del XVII secolo alcuni mercanti olandesi prendono la cittadinanza di Bordeaux, in modo da poter beneficiare di esenzioni fiscali per il loro commercio. Oltre che dell’esportazione dei vini di Gaillac e Cahors, si occupano anche di esportare vini dolci, per questo le vendemmie vengono ritardate in modo da ottenere uve dal contenuto zuccherino più alto, usate anche per la distillazione.
Già nel 1670 questa operazione è fatta a Sauternes e, a fine secolo, anche un po’ più a est, a Monbazillac. Gli olandesi intuiscono la potenzialità delle uve Sémillon che, lasciate in pianta più a lungo, possono raggiungere un alto grado zuccherino, perché attaccate da quella che veniva chiamata «pourriture noble », muffa nobile che, più tardi, sarà identificata come Botrytis cinerea; la dolcezza unica dei vini prodotti in questo modo, raggiungerà presto prezzi elevati tra gli amanti di questa tipologia di vini speciali.
Nel 1713 con la pace di Utrecht, Filippo V re riconosciuto di Spagna deve cedere i Paesi Bassi, l’Inghilterra ottiene Gibilterra e alcuni territori francesi d’oltremare. Ristabilita la pace il commercio tra Francia e Inghilterra riprende con più regolarità e vigoria, il mondo di allora incomincia a conoscere i grandi crus bordolesi.

La carne, per secoli, è sempre stata un lusso, cioè, una pietanza che poteva essere accessibile solo ai ricchi, o ai molto ricchi. Il resto della popolazione si nutriva di cereali, nella forma sia di polenta sia di pane, e il consumo era, ancora a metà Ottocento, di un chilo di pane a testa al giorno! Abbastanza per sopravvivere, non per essere in salute, data la scarsità di proteine e vitamine. Nonostante venisse arricchito ogni tanto con legumi (la carne dei poveri); ma davvero solo ogni tanto, ché a cuocere i legumi secchi ci voleva tanto combustibile, da sempre caro. La carne incomincia ad essere alla portata di molti, non di tutti, dopo la Prima Guerra Mondiale, per trasformarsi in un grande boom dagli anni Cinquanta in avanti. Non comunque nella ricettazione classica, ricca e complessa, ma in una versione nuova, più semplice, alla portata di ogni palato e portamonete.
Una ricetta si impone, le scaloppine. Non si sa con precisione quando siano nate, si sa però che – nei libri del tempo – i saltimbocca (ovvero le scaloppine arricchite) facevano parte delle «ricette di importazione», sebbene nessuno specifichi da dove. Sono quindi un patrimonio condiviso. Definiamole. Si tratta di un piatto composto da fettine di carne di vitello (o maiale, ma anche pollo e tacchino) ricavate dalla fesa o dalla noce, appiattite con il batticarne allo spessore di cinque millimetri per intenerirle, cotte in un grasso, aromatizzandole con «un qualcosa». Questa è la versione che ho conosciuto nella mia infanzia. Nella capitale italiana prese poi piede una versione locale, appunto i saltimbocca, anzi i salt’in bocca alla romana, dove venivano e vengono proposte coperte con una fettina di prosciutto crudo e salvia, fissati con uno stecchino, come fosse uno spillo. Altrove, altre versioni locali.
Sono sempre state considerate «cibo per bambini», e giustamente. Perché sono di fatto tenere – hai voglia, se batti una carne prima o poi diventa tenera –; perché veloci da fare; perché non hanno l’orrido bianco del grasso – allora odiato anche da me, mentre oggi se una carne non ha tanto saporito grasso non la considero –; e perché «moderne».
Erano considerate un piatto casalingo che di più non si può, anche se ovviamente moltissime trattorie lo proponevano, con successo.
Il grasso di cottura? Qui iniziano i problemi. A casa si utilizzava una forte tradizione lombarda: burro mescolato con olio d’oliva, quello base, non certo l’extravergine che peraltro allora non esisteva del tutto. Nel resto del paese, solo strutto od olio di oliva.
Altra questione importante da considerare è in quale modo arricchirle per ottenere un sughetto col quale poi fare scarpetta. Il canone era doppio. Ovviamente dovevano essere passate nella farina, altrimenti il sughetto non si addensava. Prevaleva la versione più classica, col solo succo di limone, anche se così guarnendo si doveva utilizzare più grasso. L’altra versione era con i piselli: un mix di proteine animali e vegetali davvero vincente. A volte si facevano con il Marsala: d’accordo eravamo bambini, ma allora si diceva che un po’ di alcol facesse bene. Di fatto, tenuto conto dell’evaporazione della parte alcolica del Marsala in cottura – l’alcol evapora prima della parte acquosa dei vini, che è poco meno del 90 per cento del vino – restava un piatto adatto anche ai più piccoli.
Molto raramente si faceva invece la cosiddetta versione bolognese. Con le scaloppine passate nell’uovo sbattuto, fritte, ricoperte con prosciutto e formaggio e finite in forno.
Due ricette di scaloppine, la prima classica la seconda nuova. Saltimbocca alla romana (ingredienti per 4 persone): 800 g di fesa di vitello, prosciutto crudo a fettine, 1 dl di vino bianco secco, salvia, olio evo,


pe. Togliete gli stecchini e servite i saltimbocca nappati con la salsa. Scaloppine con cavoletti di Bruxelles (per 4 persone): 800 g di fesa di vitello, 16 cavoletti di Bruxelles, prezzemolo tritato, farina bianca, olio evo, sale, pepe. Sbollentate 16 cavoletti per 5’, scolateli e frullateli con poca acqua. Tagliate la fesa a fettine sottili, battetele e infarinatele. Scaldate un filo d’olio in una padella antiaderente e rosolate le fettine 1 minuto per lato poi levatele e tenetele in caldo. Unite i cavoletti e fate addensare. Rimettete le fettine, fatele insaporire 30 secondi per lato. Regolate di sale, di pepe e di prezzemolo tritato. ●
sale, pepe. Tagliate a fettine sottili la fesa, appiattitele con il batticarne e incidetene i bordi con qualche taglietto per evitare che si arriccino durante la cottura. Appoggiate sopra ogni fettina 1 fettina di prosciutto crudo e 1 foglia di salvia poi fermate con uno stecchino, infilandolo come fosse uno spillo. In una padella fate scaldare 1 filo di olio, deponeteci le fettine con il prosciutto sotto e fatele rosolare 3 minuti, poi giratele e rosolatele per 2 minuti. Scolate e tenete in caldo. Deglassate con il vino, unite 4 cucchiai di soffritto di cipolla ed emulsionate unendo 1 filo di olio fino ad avere una salsa abbastanza densa. Regolate di sale e pe-

Tagliate la carne a dadi uguali di 3 cm per lato e marinateli con olio, 1 bicchiere di vino, gli aromi, pepe pestato e 1 foglia di alloro per 1 ora, a temperatura ambiente. Scolate i cubetti dalla marinata e infilzateli in 8 spiedini di legno che avrete bagnato con acqua. Alternate ai cubetti falde sottili di cipolla. Appoggiare gli spiedini su una griglia e infornare a 250°C. Cuoceteli per 10 minuti, girandoli 4 volte in modo che tutte le facce dei dadi siano egualmente cotte. Salate solo dopo averli sfornati.

Lavate le salsicce e asciugatele. Tagliatele a metà e apritele. Appoggiatele dalla parte del budello su una griglia che inserirete nella placca del forno. Cuocete le salsicce per 10 minuti a 220°C, poi giratele, irroratele con il vino e proseguite la cottura per altri 10 minuti. Sfornate le salamelle e chiudetele in alluminio. Lasciate riposare per 10 minuti nel forno spento. Nel frattempo, appoggiate i panini aperti sulla griglia e scaldateli nel forno ancora caldo ma non acceso. Servite le salsicce nei pani caldi spalmati con poca senape e insaporiti con sale (tenendo in
già
delle salsicce) e pepe.
Con l’arrivo del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si chiude il periodo festivo e si entra nella routine del nuovo anno. Vediamo allora come concludere in bellezza questo periodo così magico, creando con i bambini di casa una simpatica Befana, vera protagonista di questa festa tanto amata dai più piccini.
Una volta finita potrà nascondere qualche dolcetto, frutta secca o un piccolo dono. Prima di prendere la sua scopa e spazzar via tutte le festività!
Ricavate dalle confezioni delle uova i piccoli coni centrali. Dipingeteli in nero o viola; saran-

Forse non tutti sanno che la bandiera più antica del mondo è… Scopri il resto della frase leggendo a soluzione ultimata le lettere evidenziate. (Frase: 6, 5, 9)

no il corpo e il cappello della vostra befana.
Con un pennarello fine nero disegnate con pochi tratti un viso sulla parte convessa dei cucchiaini. Potete arricchire questo volto con la tecnica che preferite. Inserite il cucchiaino nel cono che avete scelto come base. Se il manico fuoriesce, tagliatelo.
Mettendo qualche punto di colla direttamente sul cucchiaino, create la capigliatura della vostra befana con una piccola matassa spettinata di lana cardata, (in questo caso è stata utilizzata la lana cardata della Pro Verzasca).


Avvolgete metà pulisci pipa attorno al collo della vostra figura e andate così a creare delle braccia che potete arricchire con due piccole perle in legno o con dei piccoli pomelli di cartone ricavati anch’essi dal cartone delle uova e dipinti dello stesso colore del vestito. Incollate il cappello.
A piacere aggiungete dettagli. Un vecchio calzino di nylon avvolto intorno al corpo o al cappello renderanno la vostra befana più completa e vissuta.
Volete che per l’Epifania la befana porti un piccolo dono?
Inserite un sacchetto di frutta secca o qualche dolcetto nei vasetti per culture. Chiudete il fondo con della carta crespa e un elastico o con un calzino di nylon (in fondo la befa-
• Alcune confezioni vuote delle uova
• Pittura acrilica nera e viola, pennelli

• Pulisci pipa neri
• Cucchiaini da caffè in legno

• L ana cardata arancia
• Vasetti
• Pennarello fine nero
• Pistola colla a caldo
(I materiali li potete trovare presso la vostra filiale Migros con reparto Bricolage o Migros do-it)

na ha un sacco di calze rotte nel cassetto!) e posizionateci sopra la vostra simpatica vecchietta. Buona Epifania!
Tutorial completo azione.ch/tempo-libero/passatempi
Regolamento per i concorsi a premi pubblicati su «Azione» e sul sito web www.azione.ch I premi, tre carte regalo Migros del valore di 50 franchi, saranno sorteggiati tra i partecipanti che avranno fatto pervenire la soluzione corretta entro il venerdì seguente la pubblicazione del gioco. Partecipazione online: inserire la soluzione del cruciverba o del sudoku nell’apposito formulario pubblicato sulla pagina del sito. Partecipazione postale: la lettera o la cartolina postale che riporti la soluzione, corredata da nome, cognome, indirizzo del partecipante deve essere spedita a «Redazione Azione, Concorsi, C.P. 1055, 6901 Lugano». Non si intratterrà corrispondenza sui concorsi. Le vie legali sono escluse. Non è possibile un pagamento in contanti dei premi. I vincitori saranno avvertiti per iscritto. Partecipazione riservata esclusivamente a lettori che risiedono in Svizzera.
Prima di addentrarci nel nuovo anno, vogliamo provare a ricapitolare cos’è successo d’interessante negli ultimi sei mesi nel campo dei viaggi e del turismo?
Per cominciare si è molto sgonfiato il tanto atteso revenge tourism, ovvero un nuovo, fortissimo desiderio di viaggiare per rifarsi del tempo perduto durante l’isolamento. Gli entusiasmi hanno dovuto misurarsi con qualche ritorno di fiamma del virus e soprattutto con la guerra infinita in Ucraina, oltre a inflazione e costi aumentati, rinvii, cancellazioni e caos generale (soprattutto nei cieli). Nel frattempo diverse destinazioni, nonostante vengano da anni difficili, hanno mostrato chiaramente di non voler tornare al passato. Apripista è Amsterdam: non solo la città olandese da tempo non si promuove più sui mercati internazionali, ora ha anche cominciato a scoraggiare attiva-
mente (Stay away! ) quei turisti molesti, soprattutto inglesi, interessati solo ad alcool, droga e prostituzione. E, nel loro piccolo, due villaggi catalani, Rupit i Pruit e Siurana, a sorpresa hanno rifiutato di essere inclusi tra i borghi più belli di Spagna, nel timore di veder arrivare troppi visitatori.
La ripartenza in grande stile del turismo è stata frenata anche da giustissime preoccupazioni ambientali, sottolineate da un’estate insolitamente torrida e prolungata. Ecco perché treni e autobus ‒ decisamente più sostenibili ‒ hanno cominciato a erodere gli spazi di mercato dell’aviazione, che per parte sua non riesce ancora a superare la crisi degli ultimi due anni.
Altre conseguenze? A quanto sembra il grande caldo fa desiderare il grande freddo e dunque è sempre più forte l’interesse per i Paesi nordici.

L’Islanda è senza dubbio in cima alla lista dei desideri. Nel 2014 l’italianista Claudio Giunta intitolò il suo libro di viaggio in quel Paese Tutta la solitudine che meritate (non proprio uno slogan turistico). Ma oggi essere soli a quelle latitudini non è facile.

L’Islanda non ha neppure bisogno di promettere troppo e infatti in un divertente video prende in giro i turisti spaziali: se cercate paesaggi infiniti, deserti rocciosi, vulcani, basta venire in Islanda (o andare in Groenlandia, v. pag. 9). Aggiungete che oltre metà della popolazione terrestre, secondo un recente sondaggio, preferirebbe investire nel nostro pianeta i soldi destinati al turismo spaziale, considerato non senza ragioni uno spreco di risorse.
Anche le isole Faroe sono richieste. Il locale ente turistico offre vitto e alloggio gratis in cambio di tre giorni di lavoro, prendendosi cura dei
Una signora elegantissima di una certa età, entrata in scena con cappotto blu notte e foulard a pois, appena arriva il gipfeli su un piattino, all’istante, gli stacca l’estremità con le dita. Intanto, la boiserie in ciliegio del tea-room al primo piano della confiserie Schiesser a Basilea (253 m), incomincia ad accordarsi, tra i milioni di fotorecettori della mia retina un mattino d’inizio inverno, al verde larice dell’imbottitura delle panche e sedie. Dove su una di queste, in stile caffè viennese, è seduta la signora del gipfeli: taglio a caschetto lungo, capelli grigi striati di nero, naso aquilino, orecchini a forma di cuore. L’ultima estremità, a sorpresa, la inzuppa nell’espresso e poi, roba mai vista, con il cucchiaino raccoglie ogni minima briciola rimasta in giro. Un gesto inatteso che la dice lunga sulla bontà dei gipfeli (o kifer come si dice in Ticino) di Schiesser.
Forse la vera specialità insospettabile di questa pasticceria al diciannove della Marktplatz da centocinquantadue anni. La sciura del gipfeli, con i polpastrelli, continua a cercare, tastando, le briciole. Senza ordinarne un secondo come faccio ora, seduto a uno dei ventuno tavolini in marmo di questo tea-room anni Trenta, le cui tende ricamate, sono color rosa salmone. Dalle finestre si vedono passare via i tram verdi, l’albero di Natale sulla piazza dove ci sono, come sempre, le bancarelle del mercato. Diversi, tra gli avventori, sono turisti venuti a visitare l’eccentrico municipio rosso mattone in faccia. Molti gli habitué, riconoscibili dal trinomio «Basler Zeitung» – caffè-kifer Laila mi porta il kifer dorato, la cui piega è basilare e l’aspetto graziosamente irregolare. Azzannandolo, ecco che arriva Stephan Schiesser, pasticcere di quarta generazione,
con un vassoio di foreste nere che vuole sistemare nella vetrinetta. Bisnipote di Rudolf Schiesser (18501905), il fondatore glaronese venuto a Basilea da Diesbach, villaggio di duecento anime sulla sponda destra della Linth. Alla fine ci pensa Laila, la cui visione dello spazio è più acuita. Le cameriere di Schiesser vengono un po’ da tutto il mondo: dalle Filippine come Laila, dalla Spagna come la storica Adelina qui da una vita al pari di Chantal l’alsaziana, poi Messico, Brasile, Italia, Germania, Pakistan.
Degno di nota, l’arco ligneo degli specchi: nuvolesco come gli stucchi sul soffitto color meringa, ma soprattutto che riprende, con esattezza, il rilievo delle decorazioni scolpite sul portale della facciata in arenaria – lungo la Sattelgasse – dell’edificio opera di Heinrich Flügel (18691947). Architetto basilese artefice del
sentieri. In quei giorni d’aprile 2023 l’arcipelago sarà «chiuso per manutenzione» e i cento volontari previsti avranno le diciotto isole tutte per loro. Unica difficoltà: pronunciare correttamente il nome Slættaratindur, la vetta più alta delle Faroe, dove sono previsti gli interventi del prossimo anno.
Altri si spingono sino all’Artico, attratti dalla vastità degli spazi, i fiordi, la neve, il ghiaccio, i silenzi, l’aurora boreale, il sole di mezzanotte.
Inoltre – i puristi devono farsene una ragione – queste terre sono anche molto instagrammable e funzionano benissimo nel tempo dei social. Anche per questo nelle regioni più settentrionali di Finlandia, Norvegia e Svezia i numeri sono già quelli del 2019, come se nulla fosse accaduto nel frattempo. Lentamente anche i voli diretti e le strutture per l’accoglienza stanno migliorando. Semmai
manca il personale: se appena sapete guidare una slitta trainata dai cani, avete un posto di lavoro assicurato. E se volete lasciarvi tutto il mondo a sud, per la prossima estate ci sono cento posti disponibili a bordo della nave rompighiaccio più grande del mondo, la 50 Let Pobedy, (il nome significa «50 anni di vittoria» in russo e si riferisce al trionfo dell’Unione sovietica nella Seconda guerra mondiale). Il suo scafo rosso è lungo quasi 160 metri; da Murmansk naviga a 20 km all’ora attraverso l’Oceano artico in direzione della Terra di Francesco Giuseppe, l’arcipelago più settentrionale d’Europa. Spinto da una coppia di reattori nucleari da 171 megawatt, il colosso si fa strada fragorosamente rompendo una lastra di ghiaccio spessa tre metri. Lo spettacolo è grandioso e di certo questa è l’unica forma di nucleare russo che vorremmo vedere all’opera nel 2023.
bovindo stratificato come una torta e rallegrato in cima da tre misteriose figure di pietra: un pellicano, un molosso, un gufo. Nonché all’origine dei sorrisi strappati al passante dall’occhio attento, prima di entrare nella confiserie qui dal 1870. Sul portale, scolpiti, ci sono un bambino con un’alzatina portadolci strapiena e un cane goloso ai suoi piedi. Dall’altra parte, una bambina con una bambola a penzoloni, aspetta di ricevere un dolce. Delicata scena-preludio che raffigura le aspettative di chi entra da Schiesser dove si trova un po’ di tutto: dai läckerli ai paté in crosta, passando per praliné, frutta e verdura di marzapane, biscotti natalizi o cos’altro ancora fino ai pastéis de nata portoghesi. Però, secondo i conoscitori, oltre ai sorprendenti super gipfeli, il cavallo di battaglia – a parte simboleggiare involontariamente l’iniziale della confiserie, presente,
Quando si è confrontati con un periodo difficile della propria esistenza o quando si ha la percezione che l’umanità intera stia viaggiando su un percorso insidioso, si tende a cercare conforto nei cosiddetti beni-rifugio. Mi pare fuori di dubbio che, dal punto di vista della collettività, stiamo vivendo una serie inquietante di situazioni che induce più al pessimismo che alla speranza: pandemia, guerra, crisi climatica, crisi energetica, ampliamento delle disuguaglianze tra chi è ricchissimo e chi poverissimo. Credo siano sufficienti per iniettare, quantomeno una considerevole dose di inquietudine in chi non è invitato al banchetto. Che fare? Andare sulle barricate? Comporterebbe molti rischi, non è da tutti, e non offrirebbe a priori garanzie di miglioramento. Si potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di abbandonarsi al primo rassicurante bene-rifugio: la nostalgia di un passa-
to che, complice a volte una memoria birichina, ricordiamo come migliore del presente.
I cambiamenti ci spaventano. La caduta della Swissair, quella del segreto bancario, la consapevolezza di non più poter iniziare una professione a 18 anni e poterla esercitare serenamente fino alla pensione – per citare solo alcuni esempi – sono elementi di disequilibrio. L’idea che alcune istituzioni, come le chiese e i suoi sacerdoti, su su fino al Papa, i politici, gli scienziati, gli educatori, la polizia e le autorità in genere, possano finire sotto l’artiglieria delle critiche indiscriminate, è stata tranquillamente sdoganata. Tutti possono permettersi di mettere alla berlina tutti. Senza documentarsi, senza aver analizzato in profondità situazioni e temi. La facoltà, conferitaci dai social media, di dare impunemente la caccia ai presunti responsabili di tutto quanto non fun-
ziona sul pianeta, è falsa democrazia, poiché, come detto, rarissimamente è suffragata da una soppesata analisi dei vari fenomeni.

Ciò nonostante, rifugiarsi nel passato aiuterebbe a reggere un presente e un futuro che ci inquietano? In questo magma di paure, incertezze e fragilità, l’unico bene immutabile, granitico e salvifico sono le icone dello sport. Leo Messi e compagni non avevano ancora alzato al cielo la Coppa, che già il pensiero di molti commentatori correva al popolo argentino che da tempo se la passa male dal punto di vista socio-economico, e che ora, grazie alle magie della Pulce atomica e dei suoi altrettanto eroici compagni, potrà risollevare la testa. Ma quando mai! I ragazzi della Albiceleste hanno semplicemente dispensato bellezza ed emozioni. Sono stati un balsamo per lo spirito. Hanno contribuito per qualche ora a lenire il dolore interio-
re. Sono riusciti, per poco tempo, a ricompattare la popolazione sotto la sacralità della bandiera. Tuttavia, lunedì 19 dicembre, l’Argentina e gli Argentini si sono svegliati con gli stessi problemi del giorno precedente, senza la prospettiva che inflazione, disoccupazione e tutto quanto incute paura, possano essere cancellati con un calcio di rigore.
Lo stesso vale per l’Africa, che per la prima volta è approdata alle semifinali della Coppa del Mondo. L’esaltante percorso della Nazionale marocchina ha regalato gioia ai suoi cittadini, ma non modificherà di una virgola gli equilibri sociali del Paese e dell’intero continente. Men che meno lo farà il successo ottenuto in apertura di torneo dall’Arabia Saudita, proprio contro coloro che sarebbero diventati Campioni del Mondo. È solo sport. Niente di più. È un fenomeno che pensiamo di conoscere bene, ma il più
goticizzante, in bronzo, sulla porta d’entrata – sono le Schoggi-S: le esse di cioccolato. Per dovere di cronaca ne provo una, niente male, a metà strada tra la meringa e la mousse di cioccolato.
Indaffarata e spesso al telefono, gironzola anche Rosalba, la moglie di Stephan Schiesser con la quale gestisce la pasticceria di famiglia. Orfano di Frau Kifer, m’immagino, seduto a un tavolino un pomeriggio di decenni fa, Hermann Kesten (19001996). Scrittore tedesco frequentatore abituale, nell’ultimo periodo della sua vita, di questa sala da tè ed esperto del tema. «Ho passato una buona parte della mia vita nei caffè e non me ne pento. Il caffè è la sala d’attesa della poesia» scrive in Dichter im Café (1959). Cedo alla tentazione di un mandarin givré. Mi tocca però aspettare che si sciolga. Allora, in attesa, leggo il giornale.
delle volte cadiamo vittima dei suoi incantesimi e dei suoi sortilegi.
Col passare dei giorni – la Coppa del Mondo che si è conclusa 15 giorni fa in Qatar – questa manifestazione è stata sempre più abile nell’avviluppare le masse nella sua zuccherosa melassa fatta di lustrini, lusinghe e magie. Di tutte le gravi e grevi situazioni che si sono verificate prima del 2 dicembre del 2010, giorno dell’assegnazione della CDM al Qatar, e il 20 novembre del 2022, giorno del calcio d’inizio, si è parlato sempre meno. Quindi, attenti. Se in futuro si vorrà porre l’etica davanti all’economia, alla finanza, alle lotte di potere, ci si dovrà attivare subito. Per analizzare, riflettere, capire, mettere in discussione e, se necessario, contestare e boicottare. In modo da poter naufragare nel dolce mare del calcio, e dello sport in genere, senza complessi di colpa, senza se e senza ma.
























La risposta decisa di fronte alla guerra in Ucraina e la tenuta dei Democratici alle recenti elezioni consolidano la posizione di Joe Biden
Pagina 19
Scoperte un centinaio di stazioni di polizia cinese illegali in Occidente. La Cina smentisce, ma intanto le ha chiuse tutte
Pagina 21
Una nota battuta di spirito, di solito erroneamente attribuita ad Albert Einstein, afferma che «la follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi». Se questo è vero, qualcuno avrebbe dovuto scriverlo a lettere maiuscole nella stanza in cui sono stati firmati i famigerati accordi di Doha tra Stati Uniti e talebani. Molti hanno cercato di dare consigli o di lanciare almeno un allarme, ma nessuno ha ascoltato. Le priorità erano altre e, da un punto di vista politico, anche se molto ristretto e miope, è persino comprensibile. Quello che non è comprensibile è come, riportando i talebani al potere, gli Stati Uniti e tutti gli alleati della Nato si aspettassero un risultato diverso e, soprattutto, un regime totalmente diverso da quello precedente. Considerando anche che i talebani non hanno mai fatto mistero del fatto che il Paese sarebbe stato governato secondo la Sharia. O meglio, secondo la loro particolare interpretazione della Sharia. Quello che ne è seguito, fino a non molto tempo fa, è stato un imbarazzante co-
ro di «date ai talebani una possibilità», tenendo metaforicamente in mano una candela o un accendino come adolescenti a un concerto pop.
I talebani 2.0 erano dappertutto, volavano su jet privati in tutta Europa e sedevano con gente come l’ex diplomatico norvegese Kei Aide che ha twittato lo scorso gennaio: «Orgoglioso che il governo norvegese abbia invitato il governo afghano, la società civile e i Paesi chiave a Oslo». E molti come lui, a partire dal controverso Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, si sono uniti al gruppo di cheerleader dei nuovi padroni dell’Afghanistan. Nel frattempo, per concentrarci sulle donne, dopo aver imposto l’hijab integrale e la chiusura delle scuole, nel settembre 2021 i talebani hanno annunciato che le signore potevano frequentare solo le università, con ingressi e aule rigorosamente separate per genere. Nel marzo 2022 il codice dell’hijab è stato rafforzato, così come il divieto di frequentare le scuole. Alle donne è stato vietato di viaggiare senza una scor-
ta maschile. A novembre, alle donne è stato vietato di entrare in giardini, parchi di divertimento, palestre e bagni pubblici. All’inizio di dicembre, i talebani hanno ricominciato a fustigare i loro cittadini negli stadi e nelle piazze, a cominciare dalle donne. Poi è arrivato il divieto totale di accesso alle università per le ragazze, e la proibizione per le signore di lavorare nelle Ong.
Tutto questo era atteso, a dire il vero, visto che Nida Mohammad Nadim, un ecclesiastico della linea dura, era stato nominato in ottobre ministro dell’istruzione superiore e che in novembre il premier Hasan Akhund aveva dichiarato: «Finché vivrò, bambine e ragazze non varcheranno la soglia di quei centri di corruzione che sono le scuole». A quel punto, l’invisibile leader supremo Haibatullah Akhundzada aveva già ordinato ai giudici afghani di applicare la Sharia in tutto il suo illuminato splendore: mani mozzate per i ladri, fustigazione o lapidazione per le adultere e altre amenità del genere. Sarebbe quindi divertente, se non
Gli alti costi diretti e indiretti derivanti dalla nascita dei figli sono un elemento che spiega il basso tasso di natalità, ma non l’unico
Pagina 22
fosse tragico, lo «sdegno» di quell’entità fantasma chiamata «comunità internazionale» per l’ultima mossa della loro nuova versione di talebani, carini e coccolini, quei «nuovi» talebani tanto amati e lodati dalla stampa mondiale e intervistati, con i capelli debitamente coperti se i conduttori erano donne, su ogni piattaforma disponibile. Dopo tutto hanno «rotto le catene della schiavitù», come diceva l’ex primo ministro pakistano Imran Khan nell’agosto del 2021, e hanno il diritto di fare ciò che vogliono con la loro nuova libertà: anche affamare metà del Paese, nominare i professori in base al «numero di bombe che hanno fatto esplodere», perseguitare e uccidere i giornalisti, gestire i campi terroristici come prima. E l’elenco è molto più lungo. E, tanto per aggiungere la beffa al danno, a giugno il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha affermato che il suo governo ha soddisfatto «tutti i requisiti» per ottenere il riconoscimento diplomatico del resto del mondo. Non ne ha ancora ottenuto uno formale, ma
informalmente diversi governi, a partire da Pakistan e Cina, fanno allegramente affari con Kabul.
Il punto è: gli Stati Uniti e la Nato sono stati ingannati dai talebani e dal Pakistan che li manovra, o hanno fatto ciò che hanno fatto sapendo perfettamente cosa sarebbe successo? E davvero il Segretario di Stato americano Anthony Blinken, che dichiara «i talebani non possono aspettarsi di essere un membro legittimo della comunità internazionale finché non rispetteranno i diritti di tutti in Afghanistan. Questa decisione avrà delle conseguenze», pensa che a qualcuno nel governo di Kabul importi qualcosa delle sue fumose «conseguenze»? Meglio smettere di fingere, tutti noi, e dire chiaramente che il popolo afghano, a partire dalle donne, è stato solo un danno collaterale in una guerra strategica geopoliticamente insensata e miope. Sapendo che, col tempo, tutti noi ne affronteremo le conseguenze. Ciò che accade in Afghanistan, la storia insegna, non rimane mai a lungo in Afghanistan.

Afghanistan ◆ Dopo la presa del potere nell’estate del 2021, i fondamentalisti islamici hanno progressivamente annullato le libertà di cui godevano le donne e reintrodotto le punizioni corporali previste dalla Sharia









































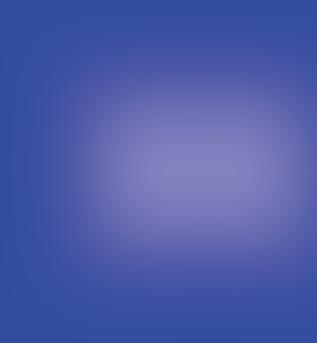



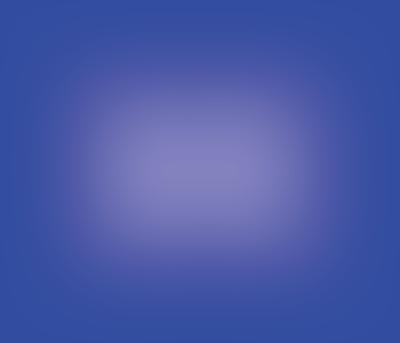




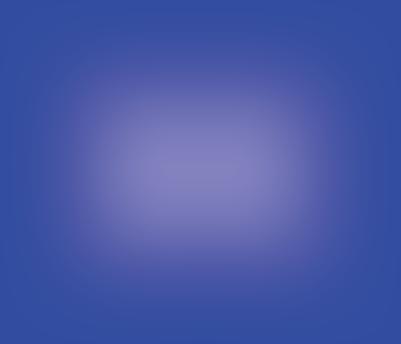







A Washington il 2022 cominciò con una miscela di lucidità e pavidità geopolitica. L’intelligence americana fu la prima a capire che la Russia avrebbe invaso l’Ucraina. La Casa Bianca avvisò gli europei, inutilmente: non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Però lo stesso Biden offrì a Zelensky di evacuarlo in Polonia: un gesto che equivaleva a dire a Putin «accomodati pure». Con un presidente in esilio l’Ucraina avrebbe resistito poco. Gli Stati Uniti all’inizio hanno sottovalutato la capacità di resistenza ucraina. Poi hanno corretto l’errore, sia pure restando al di qua di una linea rossa: Biden ha rifiutato una no-fly zone della NATO che avrebbe limitato la terribile pioggia di missili sul popolo ucraino. Il meglio di sé Biden lo ha dato con la politica delle alleanze. Ha costruito il fronte della condanna all’aggressione russa, ha mobilitato gli aiuti militari a Kiev, ha tenuto insieme l’Europa superando le esitazioni di Germania Francia e Italia. Nelle sanzioni ha ottenuto adesioni preziose in Estremo Oriente, da Giappone e Corea del Sud. Mancano all’appello tanti Paesi asiatici, africani e latinoamericani. Però non era scontato che la NATO fosse così compatta. Se si aggiunge la domanda di adesione di Svezia e Finlandia all’Alleanza atlantica, il bilancio geopolitico del 2022 si chiude con un guadagno per l’America che rinsalda il suo ruolo di guida delle liberaldemocrazie.
All’interno, il presidente più anziano nella storia degli Stati Uniti ha superato un test delicato. I pronostici indicavano una débacle per il partito democratico alle elezioni di novembre per il rinnovo del Congresso. In soccorso della sinistra è arrivato Donald Trump che ha imposto molti candidati repubblicani estremisti e scadenti. I democratici se la sono cavata perdendo la Camera ma conservando un’esigua maggioranza al Senato, un risultato che ha premiato l’ottimismo di Biden. Il precoce annuncio di Trump sulla sua ricandidatura nel 2024 fa sperare ai democratici un nuovo miracolo. Se ottiene la nomination repubblicana, Trump dovrebbe essere facile da battere. Se viene scartato dal Grand Old Party potrebbe presentarsi come indipendente, un altro disastro per i repubblicani. Restano le perplessità sul bis di Biden, vista l’età.
Per il momento possiamo archiviare gli allarmi sulla salute della democrazia americana? È un brutto vizio quello di descriverla moribonda solo quando si perdono le elezioni. La liberaldemocrazia più antica del mondo – nata nel 1787 – offre spesso uno spettacolo sgangherato e caotico, rissoso e brutale; e non solo nell’agghiacciante giornata del 6 gennaio 2021. Nessuna fazione è immune dal malcostume di demonizzare l’avversario, di descriverlo come un

pericolo per la nazione, di delegittimarne le opinioni. Ma l’annuncio dei funerali della democrazia americana è prematuro.
Nel suo status globale, l’America gode di vantaggi ineguagliati: il dollaro è la moneta universale, l’economia resta la più forte al mondo, lo Stato di diritto rassicura gli investitori mondiali
Nel suo status globale l’America continua a godere di vantaggi ineguagliati. È l’unica potenza a possedere il «triangolo magico» degli imperi. Il dollaro è la moneta universale, perché ha dietro di sé l’economia più forte (il sorpasso cinese è rinviato) ma anche uno Stato di diritto che rassicura gli investitori. L’America gode inoltre dell’autosufficienza energetica, preziosa più che mai. Infine mantiene per adesso una superiorità tecnologica, che include le tecnologie militari; l’embargo di Biden sulle forniture hi-tech alla Cina cercherà di prolungare il più possibile questo terzo elemento di forza.
Meno visibili all’estero, ci sono
altri due successi che la Casa Bianca ha incassato nel 2022. È riuscita a far passare al Congresso due manovre cruciali di politica economica. Una riguarda l’energia: 370 miliardi alle fonti rinnovabili, all’auto elettrica, più qualche sostegno alle energie fossili che resteranno essenziali per decenni di transizione verso la de-carbonizzazione. L’altra manovra, da 280 miliardi, rilancia la ricerca scientifica e dà aiuti di Stato per riportare sul territorio nazionale un’industria strategica come i semiconduttori, per ridurre la dipendenza dall’Asia. Nella gara con la Cina come nel sostegno alla reindustrializzazione, non mancano gli elementi di continuità con il Make America Great Again di Trump. Il filo comune è lo scenario della nuova guerra fredda. I bilanci su questo terreno si fanno nel lungo periodo. La prima guerra fredda durò 42 anni.

Un episodio minore ma emblematico ha chiuso il 2022: uno scambio di prigionieri con la Russia. Putin ha ottenuto la liberazione di un grosso mercante d’armi legato all’intelligence russa. Biden aveva la possibilità di far liberare un ex marine. Ha preferito scambiare il «mercante della morte» russo con una celebrity sportiva, una campionessa di basket: donna,
nera, lesbica dichiarata, militante anti-razzista e spesso in feroce polemica contro il proprio Paese. La scelta è stata approvata o criticata, è comunque un segnale del clima culturale e delle nuove priorità. Questa America non pratica l’ethos guerriero e spartano in voga a Mosca e a Pechino.
I suoi avversari però hanno conosciuto un 2022 più difficile. Gli errori strategici di Putin sono stati marchiani, Xi Jinping ha gestito male la pandemia e la sua economia soffre. In Iran la parte più avanzata della società civile combatte un regime brutale e chiede diritti di tipo occidentale. Poiché i bilanci sono relativi, quello di Washington è uno dei migliori.
Il 2023 comincia in salita, con la banca centrale decisa ad alzare il costo del denaro finché non avrà domato l’inflazione. Storicamente molte strette monetarie hanno «curato» il carovita fabbricando recessioni. I due terzi degli americani si dicono pessimisti sul futuro del Paese.
ni, soprattutto quelli della West Coast, sopraffatti dalla ripresa dei traffici e della domanda di prodotti asiatici. Le navi facevano la coda, «in rada», perché il troppo traffico non poteva essere smaltito dai porti, e al largo di Los Angeles-Long Beach quel tratto dell’Oceano Pacifico era trasformato in un gigantesco parcheggio. I noli marittimi, sia per le navi che per i container, erano schizzati alle stelle contribuendo all’inflazione. Le consegne si allungavano, i ritardi negli approvvigionamenti si ripercuotevano a cascata su tutta la catena dalla fabbrica al consumatore. Scarsità, ingorghi, rincari, erano i temi dominanti. Uno dei settori più colpiti erano i semiconduttori, memorie e cervello di ogni prodotto elettronico. La produzione di microchip non riusciva a stare al passo con la domanda e questo creava altre scarsità fino a colpire l’industria dell’automobile, perché oggi una vettura è piena di semiconduttori.
Sono bastati dodici mesi ed eccoci in un mondo al contrario. Le code di navi sono sparite, al loro posto è già subentrata la situazione opposta: molti cargo portacontainer viaggiano semivuoti, gli armatori cancellano alcune rotte per mancanza di clienti. 3
Tornare indietro con la memoria al dicembre 2021 dà le vertigini. Un anno fa a quest’epoca un tema dominante dell’economia globale era l’intasamento della logistica a tutti i livelli, e le penurie conseguenti. Si notava il tremendo ingorgo dei porti america-













































Rivelazioni ◆ La Cina ha aperto illegalmente un centinaio di posti di polizia in Occidente per sorvegliare i propri cittadini all’estero –Pechino nega, ma intanto ha chiuso gli uffici
Giulia PompiliSarebbero più di cento le stazioni di polizia cinese all’estero. Di queste, la maggior parte sarebbe stata aperta nel corso degli ultimi anni senza dare alcuna comunicazione alle autorità dei Paesi ospitanti. Oggi si trovano nelle principali città dei Paesi occidentali, ma soprattutto in Europa, dalla Spagna alla Grecia – l’unico Paese dove non sono state individuate è la Svizzera. È una rete estesa ed efficace, quella che Pechino ha costruito fuori dai suoi confini nazionali, il cui scopo principale è controllare (e spesso intimidire) la comunità cinese all’estero. Secondo quanto scoperto nelle ultime settimane dai media internazionali e dalla ong spagnola Safeguard Defenders, sono le associazioni di cittadini cinesi residenti all’estero ad inaugurare queste «stazioni». E del resto si tratta ufficialmente di centri di servizi, promossi come luoghi dove poter svolgere pratiche amministrative quali rinnovo patenti e documenti senza doversi rivolgere al consolato. Eppure, dalle immagini online di promozione degli uffici, e pure dalle dichiarazioni ufficiali del ministero della Sicurezza di Pechino, si capisce perfettamente quale sia il vero scopo di queste stazioni: collegare direttamente i cittadini cinesi all’estero con le Forze dell’ordine cinesi in Cina. Una delle priorità della leadership del Partito comunista cinese è infatti il controllo della sua diaspora, perché resti fedele al potere
centrale ma anche per evitare che proprio dall’estero possano nascere movimenti di protesta o dissenso.
Pechino nega di aver violato le leggi internazionali, anche se nel frattempo, dall’Italia alla Francia, dall’Olanda alla Spagna, gran parte di questi uffici nel giro di poco tempo è stata chiusa. Ma c’è un problema di fondo, che riguarda i rapporti dei governi occidentali con Pechino. L’opacità del sistema autoritario cinese rende difficile capire quale sia il confine tra le legittime attività di un Paese, anche nel fornire assistenza ai propri cittadini all’estero, e la sua capacità invece di muoversi nel cono d’ombra dell’illegalità attraverso tecniche di coercizione, repressione e controllo. Accordi siglati con il ministero della Sicurezza cinese tre, quattro anni fa, alla luce di quello che è diventato di dominio pubblico, mettono in imbarazzo i governi occidentali.
Lo scopo di queste stazioni di polizia è il controllo della diaspora, affinché resti fedele al potere centrale

L’operazione «Fox Hunt» è stata lanciata dal governo di Pechino nel 2014 come una «campagna anticorruzione», ma solo di recente, tramite studi e inchieste giornalistiche, abbia-
mo capito esattamente che cosa fosse. Dietro al pretesto della corruzione c’è in realtà una più sofisticata operazione per controllare la diaspora cinese e per riportare in patria dissidenti o critici della leadership in Cina. A volte le richieste d’arresto internazionali che Pechino fa all’Interpol vengono bocciate (per esempio, se si nota la natura politica e non giudiziaria del mandato d’arresto), oppure gli accordi di estradizione con altri Paesi sono burocratici e lunghi. E allora, secondo le ricostruzioni di vittime, testimoni e indagini, la Cina passa ad altri metodi. A volte è sufficiente l’intimidazione: le autorità cinesi individuano un eventuale fuggitivo all’estero e lo costringono a tornare in Cina. Molti uiguri, la minoranza islamica e turcofona che vive nella regione cinese dello Xinjiang, sarebbero scomparsi così. Diverse vittime hanno raccontato di ricatti e intimidazioni, e addirittura di minacce contro i familiari rimasti in Cina. E sembra che nessu-
no sia al sicuro: nel 2018 il funzionario cinese Meng Hongwei era a capo dell’Interpol, il cui quartier generale si trova in Francia. Sparì all’improvviso, dopo essere tornato in Cina per un viaggio di lavoro. Riapparve qualche tempo dopo agli arresti, indagato per corruzione.
È anche per questi motivi che l’apertura di opache stazioni di polizia cinesi all’estero ha messo in allarme i governi occidentali e il mese scorso almeno quattordici Paesi, tra cui Gran Bretagna, Canada e Germania, hanno aperto delle inchieste sulla vicenda. Anche l’FBI in America sta indagando. Durante un’audizione della commissione per la Sicurezza nazionale del Senato, il direttore Christopher Wray, ha detto: «Devo essere cauto a parlare del nostro lavoro investigativo, ma per me è scandaloso pensare che la polizia cinese tenti di aprire un ufficio a New York, per esempio, senza un adeguato coordinamento». L’operazione cinese «vio-
È ora disponibile anche in italiano un’autobiografia di Chelsea Manning, l’addetto dei servizi segreti che nel pieno della guerra in Iraq rivelò informazioni altamente compromettenti sull’azione delle forze americane. Contiene un elemento nuovo che, se non distorce la narrazione, almeno pesantemente la influenza: la «autorivelazione» della vera identità sessuale dell’autore. Scritta nel 2007, al tempo di un impegno fortissimamente criticato anche dalle nostre opinioni pubbliche, l’aspetto politico-militare avrebbe certamente prevalso, il problema personale sarebbe rimasto in penombra. Oggi, il (come dirlo?) fatto nuovo di un maschio che si scopre donna e che a poco a poco invade la narrazione si pone almeno in parallelo con la dimensione politica. Sarà accettato? Non piacerà? Secondo me, almeno il rispetto è dovuto al drammatico concatenarsi dei due elementi.

Le vicende familiari dell’autrice –tipiche di quell’America profonda così diversa per usi e costumi dalla vecchia Europa – occupano la prima parte del libro. Nella carriera scolastica del/della giovane Manning influisce la sempre più capillare diffusione delle nuove tecniche informatiche. È bravo (è brava!) a scuola, vive le esperienze ti-
piche di una gioventù disinibita benché incerta sui valori, entra finalmente al servizio degli uffici segreti delle forze armate e come tale viene a conoscenza di molte informazioni non partecipate all’opinione pubblica attraverso i mass media. È su questo punto critico (la domanda: «perché la gente non dovrebbe sapere?») che Chelsea Manning si mette alla prova, quando, mandata in Iraq dove infuria la guerra, ne vede, come ognuno può immaginare, di cotte e di crude. Perché non si dovrebbe sapere? Non siamo il Paese della libertà? Per esempio, dello scempio che l’equipaggio di un elicottero Apache fa di civili innocenti e di due giornalisti della Reuter, nel luglio del 2007? I mass media non sono forse un asse portante della civitas americana? «Le mie azioni erano state guidate dal desiderio che i cittadini americani sapessero cosa veniva commesso nel loro nome».
Scoperto il suo contatto con WikiLeaks di Julian Assange e con altri mezzi d’informazione, la polizia dell’esercito e i servizi segreti la mettono sotto pressione – in condizioni inumane di detenzione e di interrogatorio, descritte nei particolari. Si arriva al processo davanti alle corti militari e alla sentenza: 35 an-
ni di detenzione, fino a che il presidente Obama (ma la guerra in Iraq a questo punto ha cambiato obiettivi…) la fa beneficiare di un provvedimento di grazia: dal 2017 Chelsea Manning è libera. «Non so perché Obama abbia deciso di commutare la mia pena. Quando un giornalista glielo domandò, lui riconobbe che mi ero assunta la responsabilità di ciò che avevo fatto e che avevo già scontato una pena piuttosto dura di carcere». E ribadisce: «Ciò che ho fatto quando ero nell’esercito è stato un atto di ribellione, di
resistenza, di disobbedienza civile. Un gesto che si inserisce in una tradizione importante della nostra storia». Come leggere questa vicenda? Certamente con rispetto, e non solo per il cambiamento antropologico vissuto dalla protagonista insieme con l’acuirsi della sua coscienza civica. Con un poco di indulgenza, direi pure, per il rapporto che ella instaura, e che definirei un poco disinvolto, rispetto alle regole di riservatezza «normali» per ogni esercito (per molto meno, durante la seconda guer-
la la sovranità e aggira i normali processi di cooperazione giudiziaria e di applicazione della legge», ha spiegato Wray. A ottobre, subito dopo il Congresso del Partito comunista cinese che ha consegnato il terzo mandato a Xi Jinping, il Dipartimento di Giustizia americano ha annunciato una vasta operazione giudiziaria che ha portato all’incriminazione di tredici cittadini cinesi con varie accuse, dallo spionaggio alla violenza privata contro altri connazionali. Sette persone sono state accusate di aver sorvegliato e molestato la famiglia di un cittadino cinese in America, detto «John Doe-1», nell’ambito di una missione per costringerlo al rimpatrio in Cina. Solo tre mesi prima, il procuratore di New York Jacquelyn Kasulis aveva incriminato nove cittadini cinesi, tra cui un giudice, per aver fatto lo stesso contro un loro connazionale residente in America e la sua famiglia, sempre nell’ambito della cosiddetta operazione «Fox Hunt».
ra mondiale, soldati svizzeri furono processati e condannati a morte). Ma è vero che negli Stati Uniti i mass media godono di una libertà unica al mondo: «Il Congresso non farà leggi restrittive della libertà di stampa» recita la Costituzione. È punito chi divulga informazioni riservate, ma non sono puniti i media che le diffondono. In Svizzera, per il «caso Jagmetti» – la relazione dell’ambasciatore negli Stati Uniti sui rapporti con i circoli ebraici americani –, il «Tages-Anzeiger» fu condannato a una multa, confermata addirittura dalla Corte di Strasburgo, benché fosse evidente l’interesse pubblico delle informazioni pubblicate.
La situazione dei whistleblower da noi è tuttora irrisolta: sono ammesse le denunce interne che concernono la pubblica amministrazione, in misura minima quelle che riguardano le aziende private. Dovrebbe essere il contrario.
La conoscenza del dibattito che sottotraccia continua ad animare la politica americana ci potrebbe servire da lezione.
Chelsea Manning, Readme.txt.
La mia storia, Rizzoli, Milano, 2022, pp. 317.

Statistiche ◆ Le spese incidono molto sul bilancio delle famiglie con reddito medio. Ma questo è solo uno degli argomenti per rinunciare alla maternità
 Iganzio Bonoli
Iganzio Bonoli
I tassi di natalità in Svizzera, come in molti Paesi europei, sono da tempo a livelli bassissimi. Il numero di figli per donna in grado di procreare è di 1,46. I sociologi citano due fattori determinanti: la maggiore istruzione delle donne e, quindi, la precedenza agli studi e alla carriera lavorativa, inoltre la tendenza ad avere il primo figlio in età più avanzata (in Svizzera in media 30,9 anni). Per contro, un tasso di natalità che permetta il rinnovo generazionale non deve essere inferiore a 2,1 figli.
Vi sono però anche altri motivi importanti: la scarsità di asili-nido e il loro costo, nonché congedi per maternità (o anche paternità) molto brevi. Accanto a questi motivi si potrebbe anche considerare il costo di un figlio dalla nascita al diciottesimo anno. I dati sono quelli forniti dall’Ufficio federale di statistica, da uno studio dell’Associazione delle banche cantonali svizzere e dall’Ufficio della gioventù di Zurigo. Secondo quest’ultimo, un figlio costa da 1200 a 1800 franchi al mese, secondo l’età. Se consideriamo che il salario mediano in Svizzera è di 6500 franchi mensili, l’incidenza del costo di un figlio va dal 18 al 27% del salario mediano. Secondo lo studio delle banche cantonali, un figlio di 18 anni sarà costato 330’000 franchi alla famiglia. Si tratta di costi diretti, che non comprendono eventuali costi di affidamento a terzi. Vi sono poi costi indiretti,
come per esempio una riduzione delle ore di lavoro o un’interruzione della carriera, una riduzione delle prestazioni di vecchiaia, o un ritorno all’attività lavorativa con salario inferiore, dopo una pausa.
Tenendo conto di tutti questi fattori si potrebbe accettare la sentenza un po’ retorica secondo cui «un figlio costa un milione!». Ovviamente l’aggravio dei costi varia molto da famiglia a famiglia e anche da situazione a situazione (città/campagna, tipo di abitazione, presenza di famigliari, ecc.). Secondo un’esperta di previdenza dell’UBS, una famiglia media con due figli, al momento del pensionamento, si troverà con un milione di franchi in meno rispetto a una coppia senza figli.
Paradossalmente si può anche pensare che più il reddito famigliare aumenta, più i figli costano. Questo dipende dal fatto che un reddito disponibile maggiore incita a spendere di più anche per i figli da un lato, dall’altro perché solo le famiglie con redditi bassi godono di sostegni da parte dello Stato (Cantone, Comune). Di conseguenza, per genitori con redditi molto bassi, il costo di un milione può ridursi a meno di mezzo milione. Al contrario, per genitori con redditi elevati, ma anche spese elevate per le cure esterne e lunghi periodi di formazione per i figli, il costo potrebbe salire anche sopra i 2,5 milioni di franchi.
Questo può spiegare in parte perché la tendenza a non avere figli si manifesta in misura maggiore in famiglie benestanti in cui i due genitori lavorano.
I costi diretti sono generalmente inferiori nei primi anni di vita dei figli. Secondo la tabella dell’Ufficio giovani di Zurigo un figlio fino ai quattro anni d’età costa in media, nel canton Zurigo, 1320 franchi al mese: cifra che copre i costi per l’alimentazione, l’abbigliamento, le cure della salute e il tempo libero. Costi che aumentano di pari passo con l’età. Tra i cinque e i dodici anni si calcolano in media 1465 franchi al mese, tra i tredici e i diciotto anni 1790 franchi, che si estendono a spese di trasporto, acquisti come la
bicicletta, il computer o il telefonino, nonché per qualche hobby. Costi che diminuiscono per il secondo o terzo figlio. Uno studio dell’Ufficio federale di statistica, realizzato nel 2021, dice che le famiglie spendono in media 838 franchi al mese per il cibo; per trasporto e comunicazione 1313 franchi; per altre spese (abbigliamento, corsi, abbonamenti) 638 franchi. E questo in famiglie con due genitori, per le quali due figli costano 1405 franchi al mese, tre figli o più costano 1’783 franchi.
Le spese per le cure esterne dei figli, sempre secondo l’UFS, variano a seconda degli istituti e dei comuni di residenza. In media si possono calcolare 619 franchi al mese per famiglia
con un reddito medio. Ciò significa il 4,4% di questo reddito. Vi sono però casi, per esempio nel canton Zurigo, in cui il costo per una sorveglianza di tre giorni a settimana può salire fino a 1580 franchi al mese. Spese che si riducono fortemente al momento dell’inizio della scuola dell’infanzia.



Per i costi indiretti gli aumenti possono essere anche più incisivi. Per esempio se uno dei componenti della famiglia (o anche entrambi) riduce il tempo di lavoro. L’aggravio è più alto se lo stipendio dei due coniugi è alto. Tuttavia, molte coppie con redditi inferiori alla media non possono permettersi un lavoro a tempo parziale. Questo potrebbe ripercuotersi più tardi anche sull’entità della pensione. Sempre secondo l’UFS, il 17% delle famiglie con figli dicono di avere difficoltà finanziarie quando possono disporre di un solo reddito. Le difficoltà sono più marcate nel caso di famiglie monoparentali o con tre o più figli. C’è chi conclude che, in Svizzera, il fatto di avere figli è il maggiore dei rischi di povertà.
Lo Stato interviene a sostegno di queste famiglie, ma questi interventi coprono spesso soltanto una parte dei costi. In conclusione, per migliorare il tasso di natalità, oggi sostenuto soprattutto dalle donne straniere, sarebbero necessari migliori incentivi per la riduzione dell’aggravio del costo dei figli sul budget famigliare.

Quando un cambiamento diventa inevitabile il comportamento più saggio è quello di accettarlo e di adattarvisi. Nel mondo di oggi sono almeno due i mutamenti di lungo termine ai quali, lo si voglia o no, dovremo adattarci. Il primo è rappresentato dal cambiamento climatico. Per lungo tempo – parliamo degli ultimi decenni del secolo scorso – ci cullammo nell’illusione che era possibile contenere l’aumento della temperatura entro un grado. Oggi stiamo invece accorgendoci che non saremo in grado, con tutte le misure, già adottate e ancora previste per combattere questa tendenza, di contenere il riscaldamento sotto il limite del grado e mezzo degli accordi di Parigi di qualche anno fa. L’altro cambiamento importante che non saremo in grado di combattere è costituito dalla tendenza all’invecchiamento della popolazione. È oramai acquisito che, tra qualche anno, almeno un terzo della popolazione dei

Paesi dell’Europa occidentale avrà superato i 65 anni. E allora? Allora, ci dicono gli studiosi del problema, è venuto il momento di considerare che cosa sia questo fenomeno che accompagnerà l’evoluzione demografica in questa regione del mondo almeno per altri 50 anni.
Partiamo dalla situazione attuale. Oggi, in forza dei limiti di età previsti dalle assicurazioni statali, si diventa vecchi al momento del pensionamento ossia, in Europa, in una fascia di età situata tra i 60 e i 67 anni.
Quando la maggior parte dei sistemi pensionistici statali furono concepiti, ossia più di 70 anni fa, all’uscita della Seconda guerra mondiale, con speranze di vita che superavano di poco i 60 anni, una persona che aveva raggiunto quella età poteva veramente essere dichiarata vecchia. Diciamo che allora, appunto perché la speranza di vita non era elevata, poter arrivare all’età del pensionamento era un

La resistenza ucraina contro l’aggressione di Vladimir Putin è un esempio per tutti. Non sapevamo niente di questo popolo quando il presidente russo ha lanciato il suo attacco, nel febbraio scorso, non sapevamo che sapesse combattere, difendersi, ricacciare indietro l’invasore; non sapevamo che avesse eletto un presidente come Volodymyr Zelensky, che alla prima offerta di mettersi in salvo ha detto: ho bisogno di munizioni, non di un passaggio, e non ha più smesso di chiedere aiuto e di rimanere fermo dov’era, a incoraggiare gli ucraini tutti i giorni, per dieci e più mesi; non sapevamo che il carattere ucraino fosse fatto di forza, determinazione, coraggio, ironia, perseveranza, solidarietà.
Avevamo lasciato l’Ucraina alla prima invasione russa, all’annessione illegale della Crimea, alla propaganda del Cremlino sul popolo ucraino
che si sentiva molto russo, all’impunità di quella prima aggressione: abbiamo scoperto giorno dopo giorno che era cambiato tutto – nemmeno lo stesso Putin se n’era accorto, o forse i suoi collaboratori non gliel’avevano detto, ma in ogni caso la scommessa della capitolazione rapida dell’Ucraina è stata perduta subito, nel fango di marzo, nella riscossa dell’estate, nella liberazione dell’autunno fino a quella più recente, quando la bandiera ucraina è tornata a sventolare nella città di Kherson, assieme a quella europea. Putin ha cambiato strategia, quel che non riesce a conquistare via terra lo distrugge dal cielo, bombardando indefesso tutto il Paese, tutti i momenti, portando morte, freddo, buio, devastazione. E Zelensky trova nuove parole per rassicurare gli ucraini, è andato sul fronte della guerra, a Bakhmut, nel Donbass, e ha parlato di vittoria e di luce; è andato a Wa-
Mondiali di calcio in Qatar archiviati. Inizio polemico e gran bel finale, anche televisivamente. Da noi cori di ringraziamento conclusivi alla RSI… con smontaggio della tenda della trasmissione N’DOHA nem. Andando con ordine: proverò a dimenticare il calcio e i suoi protagonisti, mettendo a fuoco il fortunato «post partita» notturno della nostra televisione. Lo spunto mi arriva la sera prima della finale: un’ospite, tornato dal Qatar dopo un mese da inviato come esperto, loda in diretta l’unicità della trasmissione e chiede di clonare il format. Giustifica la sua richiesta non tanto con l’interesse e i riscontri positivi di N’DOHA nem (vissuti in streaming anche in Qatar), ma piuttosto con il bisogno di più frequenti momenti televisivi permeati di intrattenimento leggero. Bella pensata, ma, diciamo subito, realizzazione improbabile. Sono più di trent’an-
ni che il popolo ticinese rimpiange la Palmita e avverte il magone appena accerta che nessuno dei «promessi comici» è in grado di ereditarne il successo. Esperimenti molti, pochi durano. Alla lunga si scopre sempre che per far ridere non basta ridere forte! Di sicuro dopo il successo di N’DOHA nem – come dopo il dirompente «Russo ma non dormo» trasmissione legata ai mondiali del 2018 in Russia – a Comano qualcuno si chinerà sull’interrogativo. Ma dal San Bernardo e dalla Torre di Redde non tarderanno a muoversi truppe cammellate (alcune avanguardie già si sono palesate) per un posto sul carro dei vincitori o su futuri rimorchi. E poi, e poi… Il 2023 non è forse anno di votazioni cantonali e federali? Coincidenze anche queste poco propizie. Così l’ombra della Palmita rischia di allungarsi ancora di più. Per rievocare ai pochi che non l’hanno

po’ come vincere alla lotteria. La probabilità di morire prima di arrivarci era veramente ancora molto concreta. Oggi la situazione è molto diversa. Grazie ai progressi della medicina e all’aumento generale del benessere la speranza di vita, non solo in Svizzera ma in quasi tutti i Paesi europei supera, attualmente, gli ottant’anni, per le donne come per gli uomini. Non solo, ma dappertutto si constata che per una larga parte della popolazione nella fascia d’età tra i 65 e gli 80 le condizioni di salute sono buone, per non dire eccellenti. Sono quelle persone che oggi formano la domanda crescente dei viaggi in crociera. È ancora giusto parlare di vecchiaia per queste persone che riempiono le sale di ginnastica e i fitness studio e, non di rado, si incontrano nelle gite in montagna anche ad altezze sopra i 2000 metri? I medici dicono che il processo di invecchiamento è un processo individuale. Accertato – come ci suggeri-
scono i neurologi – che si incomincia a invecchiare a 27 anni, il modo con il quale si invecchia è diverso per ogni individuo, indipendentemente dalle creme anti-aging o dalle cure specifiche che lo stesso potrà usare, o alle alle quali potrà sottoporsi, per rimandare l’apparizione dei segni della vecchiaia. Non soltanto, ma il continuo aumentare della speranza di vita fa sì che per un numero sempre crescente di persone il limite biblico dei 120 anni appare più che raggiungibile. Un autore come Rutger Bregman afferma addirittura che è già nato il cittadino del mondo che raggiungerà i 1000 anni di età. L’invecchiamento della popolazione è dunque più che palpabile. Per esempio in Ticino, nel corso degli ultimi 50 anni, la percentuale delle persone con più di 90 anni si è moltiplicata per sette e oggi supera l’1% del totale della popolazione. A questo punto ci sono esperti di geriatria che rimettono in discussione la triparti-
zione così comune della vita in tre fasi: la gioventù, l’età matura e la vecchiaia. La società del futuro sarà una società di giovani (per un periodo di tempo relativamente breve) e di vecchi (per un lunghissimo spazio temporale). Questo comporterà sicuramente non solo una rivalutazione della vecchiaia in quanto tale. Una delle conseguenze di questo mutamento sarà, per molti, di prolungare la vita attiva oltre l’età convenzionale del pensionamento. Così uno dei problemi più importanti del mercato del lavoro del futuro non sarà probabilmente la disoccupazione giovanile ma la necessità di trovare una risposta, praticabile e soddisfacente, alle richieste di occupazione da parte di lavoratori e lavoratrici anziani che hanno superato l’età del pensionamento. Perché non è il riposo e la quiete che ci tiene vivi ma la possibilità di continuare ad essere attivi all’insegna del motto: Sono vecchio ma non sono ancora morto!
shington, in visita alla Casa Bianca e al Congresso, e ha parlato di vittoria e di luce, senza lamentarsi, ringraziando il suo popolo e i suoi alleati, ricordando che questa guerra si vince tutti assieme o si perde tutti assieme, non è data una via alternativa. Ci vuole il sostegno degli alleati, sempre, deve essere deciso e, ha detto Zelensky nel suo discorso splendido a Washington in cui ha parlato delle mille luci negli occhi degli ucraini, «non è beneficenza»: è salvezza, per tutti. Il presidente ucraino ribadisce questa sua fiducia nella sconfitta dei russi e nella luce che hanno dentro gli ucraini, anche se il costo umano è tutto su di lui e sull’Ucraina: il prezzo del gas in Occidente è tornato ai livelli pre guerra di Putin, un livello alto ma non la catastrofe energetica di cui si è discusso a lungo prendendo in considerazione anche la possibilità di una resa degli ucraini: nonostante le tante dimo-
strazioni offerte rischiando e perdendo la vita, c’è ancora chi pensa che gli ucraini non ce la possano fare, che il prezzo della loro forza sia troppo alto per noi che pure non muoriamo sotto le bombe e che le luci di Natale le abbiamo accese eccome.
Il coraggio ucraino è un esempio per tutti. Se prima della resistenza ucraina i regimi totalitari pensavano che l’Occidente fosse in crisi e disunito, che non avesse più la forza fisica e morale per difendersi (l’idea è stata molto alimentata anche dalla nostra parte di mondo, dagli intellettuali declinisti: si sbagliavano), ora hanno scoperto che non è così: questo non li fermerà nelle loro mire espansionistiche, ma certo li costringe a rivedere calcoli e tempi, oltre che la convenienza a lungo termine di mettersi di traverso rispetto all’ordine liberale del mondo. Ma l’esempio ucraino riguarda soprattutto le persone, gli al-
tri popoli che vivono sotto l’oppressione di governi illiberali: gli iraniani, in particolare, vedono che resistere è possibile. Il regime della Repubblica islamica è forte e ben impiantato, ha strumenti di repressione brutali e spesso poco visibili, come dimostrano le quasi ventimila persone incarcerate (il carcere in questo Iran vuol dire: torture, stupri, istigazione al suicidio), ma per la prima volta da quaranta e più anni teme per la propria sopravvivenza. S’è invertito il corso della paura: da più di cento giorni gli iraniani protestano sfidando i cecchini e le torture, hanno più paura che le cose ritornino come erano prima che di morire, mentre il regime s’arrocca, mostra qualche crepa, studia come conservarsi. Gli ucraini hanno mostrato al mondo che resistere alla violenza di un regime si può, gli iraniani li hanno guardati e ora ci credono anche loro, fortissimo.
frequentata, la trasmissione N’Doha nem, seguita non solo nella Svizzera italiana, ma anche da tanti italofoni d’oltre Gottardo e «aficionados» della vicina Repubblica (WhatsApp docet), posso tentare di spiegare che era un programma in cui ogni sera due bravi e infaticabili condottieri – un Andrea Mangia talvolta un po’ troppo baudesco e una Serena Bergomi invece fin troppo timida – completavano un puzzle di attualità e tematiche non solo sportive con contributi portati da ospiti, interviste, rievocazioni, collegamenti esterni, occhiate ai social media e bella musica. In breve: un «patchwork» multimediale confezionato con professionalità lungo tutte le oltre 30 puntate. Basterebbe questa inusuale continuità a configurare la mole di impegno e di creatività che, con la regìa di Giampaolo Giannoni, ogni sera il pubblico trovava in tenda.
Così, a corollario delle intense giornate calcistiche dei mondiali in Qatar – raccontate da cronisti ed esperti di un livello professionale perlomeno pari a quello di nazioni e media con mezzi e credenziali infinitamente superiori a quelli della RSI – per tutta la mesata N’DOHA nem ha funzionato come intrigante invito ad avvolgersi nella coperta di un Linus televisivo, coccolati ma tenuti svegli da un «ciciarém» permeato di un sempre strisciante umorismo e di spot musicali di artisti rigorosamente dal vivo. Credo che anche l’imprevedibilità abbia contribuito a rendere speciale la trasmissione e che proprio questo contesto abbia favorito la crescita di una godibilissima serie di doppi appuntamenti in diretta con Nicolò Casolini, reporter legato al giornalismo sportivo, paracadutato in Qatar con un compito difficilissimo: riproporre
l’esilarante comicità inanellata quattro anni fa durante il già citato «Russo ma non dormo». Chi ha seguito sera dopo sera il suo ciondolare alla ricerca di spunti e ospiti, immerso in vocianti sciami di tifosi, duellando con rigorosi servizi di sicurezza o sfidando limiti imposti dai costumi locali, ha avuto conferma delle doti straordinarie di questo personaggio televisivo: grazie a lui N’DOHA nem ha dispensato lunghi momenti di genuina comicità, oscillante tra esilaranti espressioni idiomatiche (spesso riconducibili al Mendrisiotto) e zaffate di vera poesia surreale. Di sicuro il Nicolò Casolini della visita a un figaro del Bangladesh in un sobborgo di Doha merita un posto accanto al mitico Cito Steiger delle «Nuvitads da Coira» di trent’anni fa. E torno a chiedermi: riuscirà stavolta la RSI a far lievitare la sua vis comica anche oltre l’ambito sportivo?
Per 1 pezzo da 800 g


• 5 00 g di farina
• 1½ cucchiaini di sale
• 20 g di lievito fresco
• ½ cucchiaio di zucchero
• 6 0 g di margarina vegana
• ca. 3,25 dl di bevanda all’avena, tiepida

• 2 cucchiai crema di soia da montare
1. Versa in una scodella la farina e il sale, mescolali e disponili a fontana. Mescola il lievito con lo zucchero e versali al centro della fontana. Unisci la margarina e il drink all’avena, poi impasta tutto fino a ottenere una massa liscia e omogenea. Copri l’impasto con un panno umido e lascialo lievitare a temperatura ambiente finché raddoppia di volume.
2. Dividi l’impasto in 5 pezzi e forma dei filoni della stessa lunghezza sulla superficie di lavoro leggermente infarinata. Accomodali uno accanto all’altro. Unisci i filoni all’estremità superiore. Sistema 2 filoni a sinistra e 3 filoni a destra, in modo che al centro ci sia uno spazio vuoto. Prendi il filone esterno a destra e posalo nello spazio vuoto al lato del filone sinistro interno – mantieni sempre uno spazio vuoto al centro. Prendi il filone esterno a sinistra e accomodalo nello spazio vuoto accanto al filone interno di destra. Continua così fino alla fine dell’intreccio, premi insieme le estremità e ripiegale sotto la treccia.
3. Posa la treccia su una teglia foderata con carta da forno e spennellala con la crema di soia. Accendi il forno statico a 220 °C, infila la treccia al centro del forno e cuocila per ca. 35 minuti mentre la temperatura aumenta. Sforna e lascia raffreddare completamente su una griglia



A gennaio nessun piatto di origine animale? Nessun problema, con questi prodotti e ricette vi assicurate un veganuary super gustoso

Con dei pomodori passati e delle polpettine di verdure potete preparare velocemente una zuppa di pomodori come piccolo pasto.
Ricetta su migusto.ch
Con gli aromatici straccetti Plant-based Delicious Pieces arrostiti nessuno rimpiangerà la carne nella Caesar Salad.

Ricetta su migusto.ch

Piatto principale per 4 persone
• 3 00 g di cicoria pan di zucchero o di cavolo cinese
• 1 mela
• 6 cucchiai d’aceto
• 1 cucchiaio di sciroppo d’agave

• sale
• 4 cucchiai di grasso vegetale

• 4 scaloppine vegane, ad es. scaloppine Plant-Based V-Love, di 85 g ciascuna


• 4 cucchiai di salsa maionese alla sriracha
• 20 g di microgreen o di germogli

1. Taglia la cicoria pan di zucchero a striscioline. Dividi la mela in quattro, privala del torsolo poi tagliala finemente. Mescola la mela e la cicoria con l’aceto e lo sciroppo di agave poi condisci con sale.
2. Scalda il grasso in una padella antiaderente e rosola le scaloppine da entrambi i lati per ca. 5 minuti. Servi le scaloppine con l’insalata di cicoria e mela. Irrora con la maionese alla sriracha e guarnisci con i microgreen. Ideale con un contorno di riso.
Il nuovo romanzo di Orhan Pamuk Le notti della peste è ambientato sull’isola di Mingher, luogo immaginario nel Mediterraneo orientale
Pagina 28
Il responsabile dell’etichetta ticinese spiega storie e sfide della casa discografica ticinese che resiste in un mercato sempre più competitivo
Pagina 29
Ricordando Rudolph Nureev
Sergio Trombetta, giornalista e critico di danza, tratteggia un ritratto appassionato del ballerino russo, ricordandolo nella vita e sulla scena
Pagina 30
Oltre al fatto che è unanimemente riconosciuto come uno degli artisti più importanti e influenti del nostro tempo, tra le molteplici ragioni per non perdere la mostra che l’Hangar Bicocca di Milano dedica a Bruce Nauman, vi è anche la possibilità di godere di un’opportunità piuttosto rara: quella di essere per un’ora intera gli unici a poter fruire in maniera esclusiva di una sua opera. L’opera in questione è Kassel Corridor. Elliptical Space, una grande installazione ambientale che Nauman ha realizzato per la più dirompente tra le edizioni della Documenta, quella del 1972 diretta da Harald Szeemann.
I curatori della retrospettiva milanese hanno deciso di focalizzarsi sulle opere dell’artista americano che indagano la dimensione spaziale e architettonica
Secondo quanto stabilito dall’artista, l’installazione dev’essere resa accessibile a una sola persona alla volta per la durata di un’ora. Per poter usufruire di questa possibilità occorre prenotare all’ingresso del museo una delle fasce orarie disponibili. All’orario per il quale si è prenotato, lo spettatore riceve la chiave della porta ritagliata in maniera quasi impercettibile su un lato della struttura e può così accedere allo spazio che si cela al suo interno. Per tutta la durata in cui le chiavi sono in suo possesso il visitatore è libero di fare ciò che preferisce, salvo cedere il proprio posto a qualcun altro. Può quindi entrare o uscire a piacimento dalla struttura oppure, sempre che non soffra di claustrofobia, decidere di rimanere per tutto il tempo all’interno dallo spazio angusto delimitato dalle due alte pareti realizzate con pannelli in legno.
Caratterizzato da una doppia curvatura ellittica, lo spazio interno ha una larghezza al centro, in corrispondenza della porta, di circa 50 centimetri per poi restringersi rapidamente sui due lati, fino ad arrivare a una larghezza massima di una decina di centimetri. Alle due estremità vi sono delle strette aperture, così che chi si trova all’esterno può sbirciare all’interno della struttura e quindi anche osservare i comportamenti del suo temporaneo inquilino, mentre per chi è all’interno vi è solo la possibilità di avere uno spaccato molto limitato di ciò che avviene fuori, visto che a causa dell’angustia dello spazio non si può avvicinare a queste aperture. Questa minuscola enclave all’interno dello spazio espositivo diventa così il fulcro di un campo estremamente concentrato di forze da cui scaturisce un’intensa relazione dinamica che coinvol-
ge non solo la percezione del tempo e dello spazio, ma anche il rapporto tra osservatore e osservato, tra pubblico e privato.
Nati come semplici apparati scenografici all’interno dei quali ambientare performance realizzate in prima persona nello studio e riprese con la videocamera, come nel caso di Walk with Contrapposto del 1968, i «corridoi» sono stati rapidamente trasformati da Nauman, anche su suggerimento della curatrice e storica dell’arte Marcia Tucker, in vere e proprie installazioni ambientali che si attivano attraverso la presenza degli spettatori e i cui antecedenti possono essere rintracciati in Passageway del 1961 di Robert Mor-
ris o in alcuni degli ambienti spaziali che Lucio Fontana ha realizzato tra il 1949 e il 1968. Ambienti, questi ultimi, come forse molti ricorderanno, al centro di una memorabile mostra proposta sempre dall’Hangar Bicocca nel 2018.
Pur includendo anche alcune celebri sculture al neon, come One Hundred Live and Die (nella foto) o The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths, oltre ad alcune installazioni video, i curatori della retrospettiva milanese hanno deciso di focalizzarsi sulle opere dell’artista americano che indagano la dimensione spaziale e architettonica. Una dimensione sulla quale l’attenzione di Nauman si è concentrata in modo

particolare tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli anni Settanta, ma sulla quale ha continuato a riflettere anche nei decenni successivi, come documenta bene la mostra.
Stretti al punto da costringere gli spettatori ad attraversarli camminando di lato, privi di uscita così da accentuare i sentimenti claustrofobici, inondati da disturbanti luci al neon verdi o gialle, convergenti verso un unico punto cieco, popolati di specchi, telecamere e monitor, animati da registrazioni vocali, delimitati da gabbie di metallo inserite l’una nell’altra, i numerosi «corridoi» realizzati da Nauman hanno la forza di sottrarci agli automatismi percettivi della quotidianità e alla distratta
assimilazione di ciò che ci circonda. Nelle strutture anonime ma cariche di tensione di questi corridoi che richiamano nella loro astratta neutralità le architetture dentro cui si svolgono le nostre vite, Nauman spinge lo spettatore a un’acuità percettiva dello spazio, del tempo e della sua relazione con gli altri, che inevitabilmente assume una valenza filosofica. Sono, in altre parole, installazioni ambientali in cui l’essere umano è costretto a confrontarsi con l’enigma della propria presenza corporea e con le domande essenziali che essa pone.
A dispetto del look da cowboy che mostra spesso nei ritratti fotografici realizzati dopo il 1979, anno in cui ha deciso di lasciare Los Angeles per andare a vivere in una fattoria isolata del New Mexico, Bruce Nauman è un artista estremamente colto, un artista la cui opera si nutre profondamente di quelle letture che, come ha raccontato lui stesso in un’intervista, costituiscono una delle sue occupazioni principali durante le lunghe ore trascorse nello studio.
Tra gli autori che più di altri hanno influenzato il suo lavoro vi sono fin dagli inizi soprattutto Samuel Beckett e Ludwig Wittgenstein. Proprio l’interesse per il linguaggio che caratterizza il pensiero del filosofo austriaco e la sua teoria dei giochi linguistici sono uno degli elementi essenziali della ricerca di Nauman, che nelle sue opere ha fatto spessissimo uso delle parole. Nel caso delle opere ambientali questo significa soprattutto registrazioni sonore di voci che si sovrappongono e modellano la nostra percezione dello spazio, come nel caso della beckettiana Get Out of my Mind. Get Out of This Room del 1968, che trasforma uno spazio vuoto illuminato unicamente da una lampadina che penzola dal soffitto in uno spazio mentale, o come nella grande installazione sonora pensata nel 2004 per la Turbine Hall della Tate Modern, che qui viene riproposta all’esterno come una sorta di lungo corridoio immateriale, delimitato sui due lati da 21 registrazioni audio provenienti da lavori precedenti dell’artista. Un corridoio impalpabile che con il suo ritmo sincopato, ci accompagna come una lunga dissolvenza all’uscita.
Eppure, siamo certi che anche dopo essere usciti dall’Hangar Bicocca, la voce di Bruce Nauman continuerà a riecheggiare nella testa di molti e per qualcuno sarà difficile levarsela dalla mente.
Dove e quando Bruce Nauman. Neons, Corridors and Rooms, Pirelli Hangar Bicocca Via Chiese 2, Milano, fino al 26 febbraio. Gio-do 10.30-20.30. www.pirellihangarbicocca.org
Artigiano, architetto, illusionista, poeta, Olafur Eliasson nella sua ultima mostra ha trasformato Palazzo Strozzi in una sorta di scatola magica che agli occhi dei visitatori può rivelarsi piena di sorprese e suggestioni, o anche spoglia e quasi vuota, in un’alchimia che viene suggerita dal titolo stesso: Olafur Eliasson: Nel tuo tempo, perché sta ad ognuno di noi scoprirla, completarla, riempirla a nostro piacimento e con i nostri ritmi.

L’artista danese di origini islandesi, presentando questa mostra alla stampa, ad oggi la più grande e completa a lui dedicata in Italia, aveva spiegato: «Mi piace pensare che l’opera d’arte consiste in realtà nella qualità dell’esperienza di chi la guarda, che visitandola contribuisce con il suo percorso e il suo vissuto, insieme allo spazio e alla storia di questo spazio, alla creazione dell’opera d’arte». Non deve stupire quindi che Eliasson parli sempre di «lavori esposti» e mai di opere d’arte, e che il percorso della mostra sia una sorta di «galassia» allo stesso tempo antologica, personale e spettacolare, in cui trovano posto i suoi lavori passati che s’inseriscono perfettamente nella nuova visione suggeritagli dal Rinascimento e dall’umanesimo che impregnano Palazzo Strozzi.
L’esposizione inizia dal cortile con un’opera site specific, una grande struttura ellittica di undici metri, sospesa a otto metri di altezza tra le snelle colonne del porticato, dal titolo: Under the weather, un enorme pannello di tessuto stampato che grazie «all’effetto moiré» popola il «cielo» dell’elegante architettura di piccole onde che sembrano muoversi quando ci si passa sotto e trasformarsi in gorghi di nuvole, o di vento a seconda della luce del giorno. Perché in effetti è la luce il fil
rouge della mostra che si dipana in un ammiccante gioco a rimpiattino tra quella naturale e quella ricreata, alterata, spettacolarizzata attraverso le più moderne tecnologie, con migliaia di lampade, con colori abbaglianti, o crepuscolari e che ci guida attraverso tutto il piano nobile del Palazzo.
Triple seeing survey (2022) Tomorrow (2022), Just before now (2022) sono i lavori delle prime sale, dove inizia un suggestivo dialogo tra l’architettura di Palazzo Strozzi e l’artista che, attraverso faretti, schermi, superfici specchiate e proiezioni, ingrandisce le antiche finestre piombate, le colora, le sdoppia, aprendone altre sui muri candidi; raccontandone le imperfezioni dei vetri spessi che sembrano percorsi da gocce di pioggia, o da minuscole bollicine di ghiaccio e ci riporta alla fine del 1400 all’epoca della creazione del palazzo. In un’altra sala How do we live together (2019), un grande arco metallico invade in diagonale lo spazio e il soffitto, dove grazie ad uno specchio l’arco diventa una sorta di anello e, in un effetto trompe l’oeil, la sala sembra percorribile in tutti i sensi e in tutti i lati, e, se non siete soli, ma insieme ad un consistente numero di persone, specchiandovi capovolti nel soffitto e nei riflessi, vi sentirete quasi accerchiati da una calca asfissiante.
In questa mostra a poco a poco, si ha l’impressione di essere al centro di un puzzle sofisticato e sfuggente, ma il cui lirismo non lascia mai indifferenti, come in Beauty (1993), dove, nella sala buia, fasci di luce colorata brillano in una cortina di nebbia creata dalle minuscole gocce d’acqua di una leggera cascata di vapore e, passandoci attraverso lo spettatore, scorge improvvisamente un arcobaleno: una visione sorprendente che appare
e scompare solo grazie ad un minimo movimento. Più avanti in un’altra sala, attraverso un caleidoscopio esagonale Colour spectrum kaleidoscope (2003), si può osservare l’ambiente che ci circonda e gli altri visitatori riflessi in una miriade di colori e sfaccettature; e subito dopo in Room for one colour (1997) dove una miriade di luci in monofrequenza emettono una gamma di luce gialla, ci si ritrova immersi in una sorta di abbagliante deserto in cui percepiamo solo le tonalità del giallo e del nero. Gli effetti delle luci colorate, del calore, quelli della luce notturna, le lame di luce nel
buio, le immagini capovolte e miniaturizzate che sembrano gemme incastonate in lucide sfere d’acciaio, tutto nel percorso di questa mostra ci sollecita, ci incuriosisce, ci rende ricettivi e allo stesso tempo coscienti di come le nostre emozioni possano essere evocate, manipolate, falsate, in un susseguirsi di atmosfere abilmente ricreate dove, per goderne appieno, è necessario mettersi in gioco e lasciar fluire liberamente sensazioni, ricordi e pensieri. Con questa consapevolezza si continua il viaggio negli spazi ipogei della Strozzina dove Your view matter (2022), nuovo lavoro di realtà virtuale
nella quale perdersi.
Dove e quando Olafur Eliasson: Nel suo tempo, Fondazione Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi, Firenze, fino al 22 gennaio. Aperto tutti i giorni 10.00-20.00, gio. fino alle 23.00. www.palazzostrozzi.org
Tommaso DonatiDa qualche tempo si sente molto parlare di Wednesday, la prima stagione della serie incentrata su Mercoledì, enigmatico personaggio, che su Netflix ci porta nel mondo de La famiglia Addams. Un universo che affascina giovani e non sin dal 1938, anno in cui il fumettista Charles Addams diede vita a una serie di figure che formavano una ricca famiglia fuori dal comune, che si dilettava nel macabro. Grazie all’aiuto dei creatori Alfred Gough e Miles Millar, Tim Burton è riuscito a riunire i suoi simboli; non mancano dunque un’estetica gotica, un umorismo macabro e le musiche di Danny Elfman. Il tutto però realizzato tenendo il freno a mano tirato con la sensazione che la sua creatività non riesca davvero a sprigionarsi. Il risultato è una serie, che si potrebbe definire una

commedia horror, forse troppo moderata, che rientra perfettamente negli standard di Netflix.
In questa nuova versione Mercoledì, ereditiera dark interpretata dalla giovane attrice Jenna Ortega, è una quindicenne che viene espulsa dal suo liceo e trasferita dai genitori Gomez e Morticia Addams (Louis Guzman e Catherine Zeta-Jones) nel collegio esclusivo di Nevermore. Nell’Academy riservata ai «reietti», ragazzi che si trasformano in lupi mannari, sirene, vampiri e altri strani personaggi dotati di particolari superpoteri, Mercoledì dimostra di essere un genio in tutto ciò che affronta e nel mentre scopre di avere delle visioni psichiche. La protagonista rifiuta la sua contemporaneità, viene vista come un personaggio oscuro e si ritrova, inizialmente,
ad essere la pecora nera del gruppo. Poi, motivata a far luce su una serie di misteriose uccisioni nel bosco che separa la Nevermore Academy dalla cittadina di Jericho, riuscirà ad ambientarsi. Il suo è un personaggio dal tono sarcastico, che insieme al suo viso pallido, incarnano alla perfezione quell’essenza gotica tanto cara a Burton. Del cast fa parte anche Christina Ricci, che ha interpretato Mercoledì nella famosa serie degli anni ’90 e Victor Dorobantu, che interpreta in maniera divertente un personaggio che non poteva mancare, Mano.
Il caotico vuoto della nostra società porta lo spettatore a cercare una luce nell'irrealtà, a rifugiarsi in un universo inventato che può essere paragonato ai mondi paralleli dei social media. Mercoledì salta continuamente dal
passato al presente, da adolescente si confronta con le problematiche sociali e relazionali attuali. L'impressione però è che gli autori abbiano forzato la mano, togliendo quel tocco di leggerezza ed ironia connaturato a La famiglia Addams Wednesday è una serie che non vuole essere ambiziosa, mira semplicemente a raccontare storie dal sapore fantastico, storie di adolescenti che lottano per la loro identità e sopravvivenza, in una società ostile a chi è fuori dagli schemi (outcast è il termine inglese usato nella serie).
Tra le scene che compongono la prima stagione è di particolare effetto quella in cui Mercoledì si lascia andare ad un ballo mostruosamente cool sulle note di Goo goo muck dei Cramps durante la festa organizzata dalla scuola.

Pubblicazione/1 ◆ Il romanzo storico allegorico di Orhan Pamuk è ambientato nel Novecento ma ricorda i giorni nostri
Quanta parte della straripante offerta narrativa (o poetica) contemporanea merita la qualifica di letteratura? Come riconoscere alla prima lettura gli autori che si faranno largo nel canone letterario? Difficile rispondere. Forse impossibile, perché il concetto stesso di canone – imperfetto quanto inevitabile – si definisce soltanto in rapporto al continuo lavorìo di selezione ad opera del tempo. Proprio per questo, però, il patrimonio depositatosi nel passato ci offre qualche indizio, oserei dire discriminante. Nell’avvicendarsi di epoche e generi, la letteratura degna di questo nome ha sempre mostrato anzitutto la capacità di creare mondi: di spalancare agli occhi del pubblico universi di possibilità, che prendono forma e vita grazie alle doti mimetiche e icastiche della scrittura.
Non credo che Orhan Pamuk entri di diritto nel canone in quanto Premio Nobel, ma ritengo sia un candidato con ottime credenziali perché interpreta il mestiere del letterato all’insegna del compito di inventare orizzonti umani perfettamente delineati nel loro complesso e in ogni loro dettaglio. Si pensi al romanzo Il museo dell’innocenza (2008), il cui effetto di realtà è stato tale da portare all’istituzione, a Istanbul, di un «museo letterario» che espone i reperti materiali, gli oggetti iconici di una vicenda di invenzione. Tra reale e immaginario, l’ultimo lavoro, Le notti della peste (2021), raccoglie allora lo stimolo pungente della contemporaneità per dare corpo ad una nuova trasfigurazione narrativa del dramma senza tempo delle epidemie e della fragilità mortale dell’umanità di ieri e di og-
gi. Senza mai interrompere il dialogo con la tradizione precedente (in esergo è posta, non a caso, anche una riflessione manzoniana sulla peste milanese del Seicento), Pamuk si concede quindi la libertà di prendersi settecento pagine per raccontare come la morsa della pestilenza abbia attanagliato all’aprirsi del Novecento la fittizia isola di Mingher, gioiello d’immaginazione del Mediterraneo orientale. E lo fa adattando alle proprie esigenze il modello del romanzo storico, forgiato per penetrare i risvolti intimi e i particolari minuti della storia che si sottraggono all’analisi storiografica, perché le vicende terribili di quel tempo «non potevano essere comprese solo con il metodo storico, ma richiedevano l’arte del romanzo» (come scrive un’immaginaria studiosa della civiltà mingheriana nella Prefazione al libro).
Si potrebbe obiettare che le settecento pagine siano anche troppe. O meglio, eccessive in rapporto alla densità di eventi e personaggi. Certo, il racconto ripercorre le fasi progressive dell’epidemia e il precipitato di iniziative individuali e reazioni collettive che, sull’onda del caos pestilenziale, inducono Mingher a dichiarare la propria indipendenza dall’Impero ottomano e ad affrontare un complesso percorso di consolidamento dell’identità nazionale. Ma tutto questo non basta a giustificare la mole del romanzo, né il passo lentissimo della narrazione. Le misure adottate da Pamuk servono, piuttosto, a introdurre il lettore nella realtà di Mingher e a confinarcelo più o meno forzatamente, come accade agli appestati in quarantena. Soltanto così si arriva a percepire l’isola co-
me spazio irrimediabilmente chiuso, che si è condannati a percorrere e ripercorrere in ogni suo quartiere e anfratto (con tanto di piantina offerta in apertura del libro), ad amarla per la sensualità accattivante delle bellezze naturali e la vivacità della popolazione, a odiarne l’orizzonte angusto, le contraddizioni e le violenze intestine. Soltanto così Mingher può diventare, almeno per il tempo della lettura, un mondo intero.
Ma, si sa, quando la letteratura genera mondi alternativi agisce soprattutto per volontà di comprendere l’unico mondo che ci sia dato. Non tanto crea, ma ricrea; inventa nel significa-
to etimologico del verbo, cioè trova, o più precisamente ritrova qualcosa di nostro. Nelle notti oscure della peste di Mingher si può riconoscere facilmente come nostra tutta l’irrazionalità alimentata dalla paura del contagio e dall’insofferenza nei confronti delle misure restrittive; comuni e ricorrenti sono gli attacchi (anche mortali) a quanti si adoperano per arginare il male o ai cronisti che tentano di darne notizia, così come le ambiguità e i compromessi cui si piegano i personaggi che di volta in volta si trovano ad esercitare il potere (dal governatore ottomano al giovane militare nazionalista fino ai leader religiosi).
Le torture perpetrare nelle carceri rispecchiano le vicende seicentesche ritratte da Manzoni nella Storia della colonna infame, e la soppressione del diritto di cronaca somiglia da vicino alla quotidianità della Turchia di Pamuk. Perché in fondo – scrive ancora la fantomatica prefatrice – «l’arte del romanzo si basa sulla capacità di raccontare le nostre storie come se appartenessero ad altri, e di raccontare le storie degli altri come se fossero le nostre».
Bibliografia Orhan Pamuk, Le notti della peste, Einaudi, Torino, 2022.
Pubblicazione/2 ◆ La sfilata come opera d’arte, il nuovo saggio di Claudio Calò, riflette sul rapporto inquieto tra haute couture e arte
Emanuela BurgazzoliLa grande mostra a Parigi che qualche mese fa ha visto gli abiti di YSL disseminati in alcuni grandi musei della capitale francese per celebrare il sessantesimo anniversario della prima collezione sfilata a suo nome, ha segnato da una parte la definitiva consacrazione dello stilista, dall’altra ha riportato l’attenzione sullo statuto della moda come arte, un intreccio che affonda le sue radici nelle Avanguardie storiche, dai balletti russi di Diaghilev con i costumi realizzati da artisti fino agli abiti «antineutrali» dei futuristi che dovevano essere aggressivi, dinamici, semplici e asimmetrici. Non è la prima volta che gli abiti di grandi stilisti (nella foto) entrano nei musei d’arte; è toccato a Issey Miyake, a Gianni Versace e allo stesso Yves Saint-Laurent, che negli anni Sessanta aveva firmato una collezione di abiti ispirati al geometrismo di Mondrian. A lui l’onore nel 1983 al Metropolitan di New York della prima mostra consacrata a uno stilista vivente; un punto di svolta preannunciato nel 1982 da una storica copertina di ArtForum che ritraeva l’immagine di una modella in un abito Miyake. Una scelta che innescò un vivace dibattito, con gli scettici che si affrettarono a sottolineare la natura commerciale della moda, che doveva restare un prodotto industriale. Del resto nel 2000 la retrospettiva su

Armani al Guggenheim di New York sollevatò critiche per il suo carattere commerciale, con un allestimento che rendeva le sale simili a una boutique. Ma ormai si erano aperte nuove possibilità che vedevano nel rapporto tra arte e moda un potenziale di creatività che trascende dal genere espressivo per produrre quello che Germano Celant definisce «un vortice iconoclasta»; il celebre critico aveva curato nel 1996 per la Biennale di Firenze un evento dal titolo Il tempo e la moda che includeva sette progetti realizzati da coppie di artisti e stilisti (Damien Hirst-Miuccia Prada, Tony Cragg-Karl Lagerfeld, Mario MerzJil Sander, ecc).
Claudio Calò ne La sfilata di moda come opera d’arte aggiunge un nuovo tassello a questa lunga storia, analizzando l’evoluzione di «quel grande spettacolo funzionale al marketing e strumento di vendita» che è la sfilata di moda, divenuta a un certo punto vera e propria opera d’arte; «fantasia celebrativa» che con il duo olandese Viktor e Rolf raggiunge nuove potenzialità: negli anni Novanta i due stilisti trasformano la sfilata in una vera esposizione d’arte, dove i corpi delle modelle sono avvolti nei quadri, che vengono alla fine smontati e allestiti dai due designer. Sul fronte dell’arte l’americana Vanessa Beecroft compie, si potrebbe dire, un’operazione
speculare, con installazioni composte da modelle nude. Se la moda è una riflessione sul corpo, la sfilata ne è il momento culminante: uno dei padri della svolta pop della moda, con l’avvento delle supermodelle, è stato Gianni Versace nel 1991. Al genio di Versace si può accostare Galliano, uno «dei sommi alchimisti della moda», divenuto famoso per la mise en scène delle sue sfilate dove c’è un continuo gioco di citazioni, in vero spirito postmoderno: poteva accostare la belle époque alle donne Masai, l’antico Egitto al modernismo di Avedon.
La moda in questo senso è un «business cannibale», in grado di assorbire tutto ciò che la circonda per rinnovarsi. E la pandemia, osserva Calò, ha determinato un’accelerazione verso ciò che viene chiamata la «transmoda», che esplora ormai tutti i formati disponibili, dotata di un’intelligenza orizzontale, tipica di una cultura visiva degli anni Duemila; una cultura che per Jean Baudrillard «produce immagini in cui non c’è niente da vedere», mentre altri individuano nel medium della moda una possibilità di individuare scorciatoie per raggiungere il proprio linguaggio visivo, sovvertendo consuetudini grazie anche alle nuove tecnologie. Oggi la moda è sempre più «veloce e atomizzata», «insofferente verso le gerarchie», distrugge appunto mode e marchi in modo quasi istantaneo ed è caratterizzata da una creatività che Calò definisce «diffusa, permutativa, remota e autoportante».
Un esempio emblematico di questa nuova era sono i marchi «che si aprono a pratiche di hackeraggi», includendo nelle proprie collezioni ufficiali i falsificatori, come nel caso di Gucci che ha prodotto dei veri-falsi-veri, ma anche condivisioni e metamorfosi con Balenciaga, tanto da far comparire in una sfilata «fantasma» una borsa deturpata dalla scritta «This is not a Gucci Bag», con un evidente richia-
mo a un celebre dipinto di Magritte.
E se la moda a volte può parlare senza mostrare abiti, anche l’arte oggi può esistere al di là della dimensione fisica, come avviene per l’arte digitale, venduta oggi sottoforma di NFT. La modalità digital-virtuale si è trasformata nell’unico mezzo a disposizione per comunicare, tanto che il video (della sfilata) è ormai l’intero evento, non più soltanto la ripresa di un evento fisico, che però in un certo senso riduce la libertà di scelta dello spettatore. Nel suo saggio Calò non risolve la questione se la moda «sia da iscriversi tra le arti, le arti applicate o il puro business», ma fornisce una dettagliata ricognizione dell’evoluzione della moda «come creatrice di nuovi formati che riflettono la cultura e il modo di comunicare delle diverse età».
E come accade per l’arte, anche nella moda una delle sfide future risiede nella dicotomia digitale-fisico, nella tensione tra questi due poli, attorno ai quali si giocherà la partita estetica (ed economica). In questo processo la sfilata, che ha assunto forme molto diverse nella storia, oggi è diventata «un catalizzatore dalla natura liquida e vischiosa che sublima e si mimetizza nei generi».
Jazz ◆ Intervista a Dimitri Loringett, responsabile della casa discografica ticinese che l’anno prossimo festeggia 30 anni
 Alessandro Zanoli
Alessandro Zanoli
La monumentale e imprescindibile Storia del jazz svizzero di Bruno Spoerri, l’ha fissata nelle sue pagine, a futura memoria, con queste parole: «Fin dagli inizi degli anni 90 l'etichetta ticinese Altrisuoni documenta non soltanto la scena musicale a cavallo del confine tra Svizzera del Sud e Italia del Nord. Il responsabile dell'etichetta (e flautista jazz) Christian Gilardi ha saputo costruire infatti continuamente ponti verso la Romandia e la Svizzera tedesca. Il programma editoriale persegue chiaramente il primato della qualità, ma oltre a questo Altrisuoni propone anche quantità: il numero delle loro produzioni è molto più alto di quello delle altre tre etichette svizzere (Intakt Records, For 4 Ears, Unit Records)».
Insieme ai suoi compagni di avventura Romano Nardelli e Stefano Franchini, Gilardi aveva messo in movimento un meccanismo dinamico e propositivo, capace di attirare l’attenzione doppia del pubblico e dei musicisti, in un circuito virtuoso che ha portato in effetti il numero delle produzioni ad aumentare in modo davvero notevole. Altrisuoni è stato indubbiamente un acceleratore della passione per il jazz alle nostre latitudini, tanto quanto lo sono stati Estival Jazz o JazzAscona. Oltre alla sua attività di editrice, la casa discografica, in una dimensione più di nicchia, si era fatta promotrice di piccoli ma interessanti festival in Ticino. Aveva portato i propri artisti a contatto con il pubblico e aveva contribuito a far conoscere anche qui da noi le migliori proposte nazionali. Oltre a questo, si è data fin dall’inizio il compito di promuovere la musica dei nostri esecutori e compositori ticinesi, in vari generi musicali, un obiettivo sicuramente unico e meritevole.
Oggi, nel pieno delle trasformazioni che hanno rivoluzionato il mondo della riproduzione musicale e della sua fruizione, che opportunità ci sono per Altrisuoni? Ne abbiamo parlato con Dimitri Loringett, responsabile dell’etichetta (nella foto).
A guardare le cose con occhio critico oggi non è proprio un momento favorevole per le case discografiche…



Sì, lo streaming ha modificato completamente le abitudini di ascolto. L’avvento dell’editoria digitale rende molto difficile riuscire a coprire le spese di produzione. A pensarci oggi, però, possiamo dire di essere stati i primi in Svizzera a intuire la direzione in cui stavano andando le cose; già nel 2006 abbiamo iniziato a collaborare con una casa di distribuzione digitale che si chiamava Big Fish Media (poi BFM Digital). Era stata fondata da appassionati di jazz e quindi alla fine avevamo un campo di interesse comune. Abbiamo firmato il contratto e dal 2007 abbiamo cominciato a distribuire il nostro catalogo in formato digitale. All’epoca non c’era ancora lo streaming, c’era il download; chi lo voleva scaricava il brano a pagamento. E man mano abbiamo messo quasi tutto il catalogo. Siamo stati tra i primissimi, forse tra i primi in Europa e comunque primi in Svizzera.
Alla fine degli anni 2000 poi c’era la fila per andare da loro, tutti vole-
vano vedere online i loro brani perché il digitale stava davvero prendendo piede. Noi abbiamo vissuto in pieno questo periodo, che andava in parallelo col calo delle vendite di CD. Poi nel 2009 è arrivata la crisi finanziaria e c’è stata un’accelerazione del digitale e, con l’avvento dello streaming, soprattutto una decrescita quasi esponenziale del fisico. Il periodo peggiore è stato tra il 2010 e il 2013, quando il nostro distributore fisico iniziò a farci pagare una «fee» (tassa base) per mettere in distribuzione le nostre nuove pubblicazioni. Per finire, la società chiuse i battenti, per fortuna avevamo già iniziato a lavorare con la romanda PBR Record, che ancora distribuiva il fisico e con cui poi abbiamo continuato a collaborare.







Sul mercato oggi possono sopravvivere solo i grandi distributori, pare… Si chiamano «aggregator»: sono distributori in formato digitale. Tu gli mandi il contenuto (i file dei singoli brani), la copertina e loro distribuiscono sulle piattaforme. In pratica quello che faceva il distributore discografico loro lo fanno nel corrispettivo digitale. Noi ci siamo adattati: abbiamo cominciato a pubblicare dischi ma su richiesta dei gruppi. Una volta creato il disco, era poi compito degli artisti distribuirlo e venderlo. Certo, noi lo mettiamo in distribuzione, in catalogo, facciamo la pubblicità. Però oggi è principalmente l’artista che vende il CD, tipicamente ai concerti. Di fatto è cambiata la logica della distribuzione, completamente.
Da parte vostra c’è stata anche una modifica aziendale. Altrisuoni, nel 2015 è stata ceduta alla società con la quale facciamo la distribuzione, PBR Record citata prima, oggi forse l’unico distributore fisico rimasto in Svizzera, che rifornisce i negozi, quei pochi che sono rimasti. PBR ha rilevato il catalogo, le edizioni e tutto quanto. E quindi si pubblica ancora, sempre come Altrisuoni. Le tirature, rispetto al passato, sono però limitate a 200-300 copie.
Voi comunque avete musicisti che vi cercano per fare i dischi.
Sicuro, la richiesta non è calata, anzi calcola che negli ultimi anni siamo a circa dieci-dodici album che vengono pubblicati all’anno. E ce ne sono sempre di più solo in digitale, nel senso che non c’è la stampa del cd, ma l’interesse è per l’etichetta. Perché se vai su iTunes o su Spotify e si vede che sei sotto Altrisuoni ispiri più fiducia.
Altrisuoni nel ’93 era nata come etichetta che dava spazio alle giovani leve: oggi?
C’erano allora, ci sono oggi. A essere cambiato in realtà è l’output, il risultato di questa passione. Molti sono consapevoli del fatto che i dischi non si vendono tramite le etichette, ma servono per avere quel minimo di credito per iniziare, e quindi fanno questo investimento perché torna loro utile, sanno che devono suonare per uscire e guadagnare. In Svizzera Altrisuoni (e tanti me lo dicono) è ancora l’unica in cui se chiami al telefono c’è qualcuno come me o come Bruno Pepe (il tito-

lare di PBR Record) che ti risponde. Le altre non alzano nemmeno la cornetta.


Oltre ai giovani avete avuto anche grossi nomi.
Diciamo che il vero colpo di fortuna è arrivato agli inizi con il compianto Fredi Lüscher. Lui era un pianista abbastanza conosciuto nella scena più d’avanguardia svizzera. Il fatto che avesse deciso di venire con noi
ha fatto rumore: il mercato discografico svizzero era abbastanza ingessato, c’erano tre-quattro etichette discografiche e quindi per molti artisti era difficile fare un disco perché non ti davano retta. Credo che Lüscher fosse un po’ stufo di questo sistema. Ha fatto un primo album e poi ha continuato sempre con noi: altri musicisti hanno cominciato a parlarne, così si è diffuso il nostro nome.
All’inizio vi siete identificati fortemente col jazz. Ma il jazz esiste ancora?
Si, decisamente. In Svizzera ci sono delle buone scuole e buoni musicisti che vogliono incidere.
In Ticino penso a Pianca e Romerio, a Borzacchiello, a Pezzoli, a Boggini e a Granati, di cui pubblicheremo prossimamente un nuovo disco. D’altro canto, è vero che non tutto va sull’etichetta, perché tanti giovani magari si arrangiano diversamente, vanno direttamente sul digitale, mettono in piedi la propria etichetta, fanno un po’ quello che facevamo noi all’inizio. Adesso i mezzi tecnologici sono alla portata di tutti. Dal punto di vista economico produrre un CD costa poco.
Una delle tue esperienze importanti è stata la produzione dell’album di Lewis Porter per la quale sei andato a New York…
Sono cose bellissime, ma costano parecchio. Lì ho toccato con mano cosa significa produrre un album di livello internazionale. Abbiamo pagato lo studio e i musicisti, gente di altissimo valore come John Patitucci e Terri Lynn Carrington. C’è un video su YouTube di qualche momento della produzione. Alla fine, è funzionato tutto. Ma non sono cose che si possono fare tutti i giorni.

Se dopo «un secolo di incontrastato regno della ballerina» grazie a Vaclav F. Nižinskij nel Novecento si vide apparire «un modello di maschio assolutamente inedito nei teatri di danza», possiamo dire che con Rudolf Nureev (Lago Baikal-Irkutsk, 1938 – Parigi, 6 gennaio 1993) tale ruolo si consolidò appieno. Figura tragica, dalle origini dolorose, segnata dal peso dell’epoca e da un privato estremamente duro, com’è risaputo Nureev era di carattere non facile e sulla sua schiacciante personalità sovente si è chiacchierato a lungo. Ciò, come sempre capita in questi casi, mette in ombra l’autentico valore dell’artista e crea, al contempo, una sorta di alone mitico-maledetto attorno al suo personaggio. Più interessante oggi, nel trentennale della scomparsa del celebrato danzatore e coreografo, interrogarsi invece sulle ragioni della sua importanza così come sul decisivo contesto storico in cui la sua figura si impose; non va infatti dimenticato che se gli albori del secolo videro fiorire e sfiorire Nižinskij mentre il sogno dell’impero russo andava man mano sgretolandosi, gli anni della Cortina di ferro sono quelli in cui l’espatriato Nureev affermò con veemenza la sua arte.
A ricordarlo con noi c’è Sergio Trombetta, giornalista e critico di danza laureato in lingua e letterature russe.
Per prima cosa vorrei chiederle cosa ha caratterizzato il Nureev danzatore e cosa il coreografo. Se con Nijinsky la faccenda appare più chiara – l’imporsi dell’androginia sulla scena, l’irrompere di forme barbare e non aggraziate, l’uso asimmetrico dello spazio – con Nureev la questione sembra diversa.
Rispetto a Nijinsky, dal punto di vista coreografico Nureev non è stato un innovatore. Nijinsky aveva di fronte un terreno fertile e tutto ciò che faceva rappresentava una novità. Nureev si è invece mosso su un sentiero di danza classica e contemporanea già fortemente consolidato. Per un ballerino col suo tipo di formazione sarebbe stato difficile fare altrimenti. Al di là delle sue doti, la sua importanza è stata quella di creare un’immagine greater than life: è stato un personaggio importante dal punto di vista mediatico. La sua vita è stata un film, un balletto. Egli è entrato da protagonista nella storia della danza. La sua celebre fuga del 1961 – quando, ricordiamolo, lasciò la compagnia Kirov stabilendosi in Occidente – fu in nome della libertà di danzare, poiché era ben conscio che rimanendo a Leningrado non avrebbe potuto mettersi alla prova coi più grandi coreografi come poi avrebbe fatto.
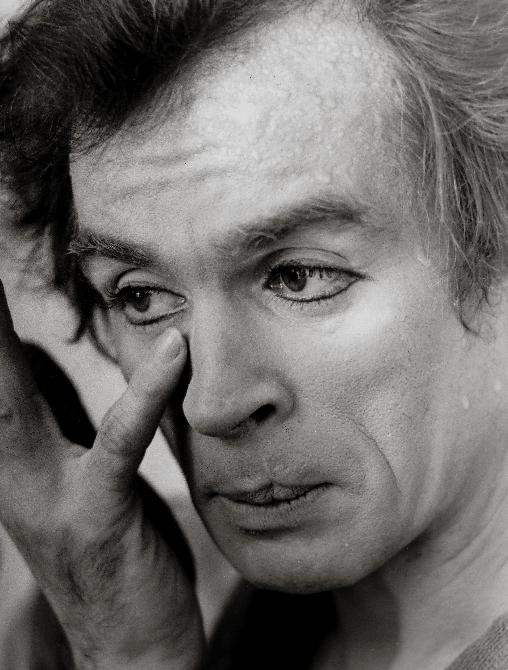
Quale fu a suo avviso la creazione in cui Nureev espresse al massimo i suoi mezzi, la sua identità e la sua storia?
Ho visto danzare Nureev al Teatro Regio di Torino, al Teatro Smeraldo di Milano quando già non aveva più l’energia e la freschezza che gli avevano dato fama. Ma esistono moltissimi materiali video che testimoniano della sua bravura, del suo appeal e della sua presenza scenica: come ad esempio quelli che immortalano la sua variazione de Il corsaro di Adolph Adam.
La vita di Nureev è stata, come quella di altri artisti di epoca sovietica, difficile e segnata dall’esilio. Tratteggiamola per sommi capi. Per quanto riguarda l’esilio, difficile pensare che la sua scelta di abbandonare il Paese fosse veramente politica, anche se all’epoca fu facile interpretarla così. Era nato su un treno sul quale la madre viaggiava per raggiungere il marito. Si avvicinò tardi alla danza. Ebbe un’insegnante a Ufa, che successivamente lasciò per andare a Leningrado, dove la leggenda vuole passò una notte all’addiaccio prima di essere accolto alla scuola del Teatro Mariinskij. Una vita difficile, sì, ma soprattutto perché sentiva di non poter danzare come avrebbe voluto. Da qui la sopraccitata fuga del ’61, che lo vide rimanere fra gli amici parigini ai quali si era legato durante la tournée (fra questi, tra l’altro, c’era Pierre Lacotte e l’immagine di Nureev che salta la barriera fa più parte della mitologia che della realtà: semplicemente al momento di imbarcarsi prese un’altra strada). Poi iniziarono i suoi esperimenti, le sue prove con un repertorio a lui sconosciuto
e il suo amore apertamente vissuto con Erik Bruhn, danzatore-étoile del Royal Danish Ballet. Fu un successo dopo l’altro, un perenne muoversi fra le capitali europee. Ci fu la partnership con Margot Fonteyn, la direzione del Balletto dell’Opéra di Parigi e, successivamente, il mettersi alla prova come direttore d’orchestra – con scarso successo – e come coreografo. E se le sue coreografie non passeranno alla storia, certamente il loro ruolo fu quello di far conoscere in Occidente titoli come La Bayadère o Raymonda, opere che oggi fanno parte del patrimonio di tutte le grandi compagnie di danza classica. Una piccola nota: nel bel film di Cédric Klapisch La vita è una danza – in originale En corps – a un certo punto la protagonista ha una visione: vede apparire le ombre delle bayadères nella periferia di Parigi. Senza l’opera di Nureev queste ombre non avrebbero potuto essere citate.
Con la guerra in Ucraina la patria di questi giganti del passato è nuovamente isolata, il mondo della danza come vive tutto questo? Oggi il potere russo è molto simile a quello repressivo dell’Unione Sovietica, ma è anche più «furbo». Per esempio Svetlana Zacharova ha danzato parecchio in Occidente – dove, va ricordato, non è persona grata per il suo endorsement a Putin – ed è sempre tornata a danzare a Mosca. Esempi di danzatori perseguitati non mi pare che ce ne siano, al momento. Esule, ma senza gesti clamorosi, è sicuramente Ol’ga Smirnova, che ha deciso di lasciare il Bolshoi per il Balletto nazionale olandese. Più difficile da definire la posizione di Jacopo Tissi, a cavallo fra il Bolshoi e la Scala di Milano.





 Carlo Piccardi
Carlo Piccardi
Non so esattamente a quando risalga il primo concorso di esecuzione musicale, ma è un fatto che i concorsi in genere hanno condizionato l’intera vita musicale del Novecento. Il principio del concorso, nel suo far appello alla competitività, sottende un concetto di tipo «sportivo» ed è naturale che si sia imposto come abitudine nella stessa epoca che ha inventato le olimpiadi e le World Series. Non che una certa dimensione «agonistica» non esista da sempre nella musica, ma è evidente che il concorso musicale, con tanto di giuria, punteggi e premi, è un fenomeno tipicamente moderno.
Nei secoli passati tutt’al più potremmo costatare l’occasionalità dei confronti a due, correnti in musica tanto quanto nelle altre discipline del sapere che nelle antiche università cercavano lo stimolo suscitando diatribe tra dotti messi direttamente a confronto su di uno stesso specifico argomento. A tutti è noto il caso di Johann Sebastian Bach invitato a Dresda nel 1717 per un confronto all’organo con Louis Marchand, confronto che in verità non ci fu, avendo preferito il celebre organista francese svignarsela di notte anziché affrontare il temibile tedesco. Sulla stessa linea di tradizione si pone un altro celebre confronto, organizzato a Parigi nel 1837 tra Sigismund Thalberg e il giovane Franz Liszt, occasione che consacrò definitivamente la fama e la supremazia di quest’ultimo. E di episodi simili ne potremmo elencare molti a dimostrazione di una dimensione comunicativa della musica rimasta sempre viva nella ricerca della grandezza o addirittura del culto di una personalità. Diversi e anche stravaganti furono tutti questi episodi, ma tutti furono simili nella loro funzione di consacrazione di valori che in fondo erano già conosciuti.
Ben altra è la situazione dei moderni concorsi. I concorsi di oggi, si sa, riguardano i debuttanti: schiere vastissime di allievi di conservatorio ai quali sempre più si tende a insegnare che il concorso e solo il concorso sia l’unico canale per ottenere l’affermazione come concertista. Affermazione forse un tantino rozza ma senz’altro vera nella misura in cui i concorsi assi-
stono di anno in anno a un aumento progressivo dei candidati e nella misura in cui ogni anno, per motivi vari e per lo più extramusicali, sorgono nuovi concorsi per il fatto di poter contare sull’immancabile materia prima. Non è più quindi con il principio della qualità che abbiamo a che fare, ma con uno strano compromesso tra qualità e quantità che, nel modo in cui sono concepite tali organizzazioni, è inevitabile. Il giudizio espresso infatti, che nel caso citato di Liszt e di Thalberg evidentemente non si limitava a quel concerto memorabile ma coinvolgeva tutta l’attività precedente dei due «mostri sacri», è oggi nettamente inficiato dalla nozione quantitativa che pretende il giudizio determinato da «quella» esecuzione regolamentata in un quarto d’ora, da «quello» e non da un altro «brano d’obbligo», ecc.; il tutto in un anonimato ovviamente inevitabile, ma che tende a spogliare il candidato della sua «storia».

Detto questo il lettore potrà già immaginarsi il mio parere sui concorsi musicali. A smussare le punte del giudizio negativo occorre però dire che i concorsi svolgono una funzione democratizzante permettendo costantemente a forze nuove che provengono dal basso di inserirsi in una situazione che altrimenti rischierebbe di essere monopolizzata da un’oligarchia artistica. Accetterei questa considerazione se tale passaggio della musica a «sport di massa» non nascondesse preoccupanti risvolti. Primo fra tutti la rincorsa del successo a tutti i costi che vede iscritti ai concorsi decine per non dire centurie di illusi e di futuri disadattati.
V’è poi l’aspetto della priorità abusivamente data al concorso nel predisporre il curriculum del concertista, priorità che oggi condiziona il tipo stesso di formazione musicale di molti giovani, spinti dal condizionamento non già ad approfondire il proprio ruolo professionale ma a prepararsi in funzione delle severe selezioni delle giurie di esperti, che a conti fatti non possiamo non paragonare alle rassegne sportive internazionali che oggi si possono vantare di tenere incollati ai televisori milioni di persone in tutto il mondo.
























































































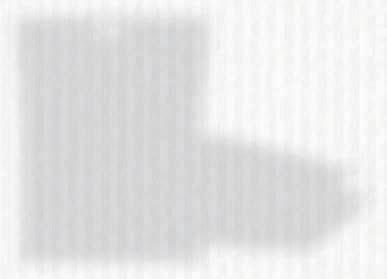

















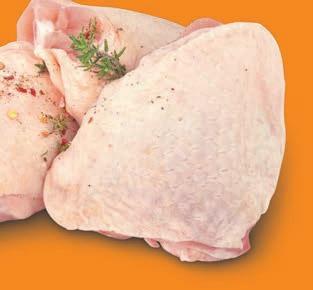

























































































































































La prima ricetta Blévita entrava sul mercato svizzero nel 1969. L’obiettivo era di creare un prodotto conservabile a base di pane. Oggi si produce annualmente più di mezzo miliardo di cracker singoli in 40 varietà Blévita. I top seller sono Gruyère, Timo/Sale marino e Sesamo. Prima che nasca una nuova ricetta ci vogliono diversi tentativi.

20%
Tutti i dessert in coppetta refrigerati (prodotti Daily esclusi), per es. coppetta svedese, 100 g, 2.– invece di 2.50

20%
Fagottini di spelta alle pere, bastoncini alle nocciole o fagottini alle pere bio per es. fagottini di spelta alle pere bio, 3 pezzi, 225 g, 2.70 invece di 3.40, confezionato
20%
Tutti i salatini da aperitivo Party per es. cracker salati, 210 g, 1.45 invece di 1.85


20%
a partire da 2 pezzi –.60 di riduzione
Tutto l'assortimento Blévita per es. al sesamo, 295 g, 2.70 invece di 3.30



invece di 4.90
Original o alla paprica, in conf. speciale, 200 g








































































































































































































































































































































