POLITICA
Fratelli coltelli d’Italia. Con Meloni al governo il partito litiga e sbanda

Fratelli coltelli d’Italia. Con Meloni al governo il partito litiga e sbanda
Non è speculazione. Tasse altissime. Troppi piccoli distributori. Raffinerie vecchie e obsolete.
Dietro il caro benzina c’è un mercato che non funziona

ECONOMIA

Licenziamenti in massa nelle Big Tech. Con modalità spesso brutali

CULTURA
Dai talent show a Youtube, tutte le strade portano a Sanremo

SCOPRI LA NUOVA JEEP ® AVENGER 1ST EDITION.
Il futuro è nelle tue mani. La nuova Avenger 1st edition è puro DNA Jeep®. Lasciati conquistare dal suo design audace e scopri la sua sorprendente combinazione di affidabilità e versatilità.

Immagini indicative, a puro scopo illustrativo, veicolo non ancora disponibile. La commercializzazione nei paesi europei è attesa approssimativamente alla fine del 2022, anche con motorizzazione turbo benzina. Consumo di energia elettrica di Jeep® Avenger per kWh/100 km: 15,9; emissione di CO2 g/km: 0. Valori definiti in base al ciclo combinato WLTP, misurati dal costruttore in prove di pre-approvazione e che possono essere soggetti a modifiche dopo l’omologazione finale. I valori indicati servono a fini comparativi. Importante: i valori effettivi del consumo di energia elettrica possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori quali: optional, frequenza di ricarica elettrica per chilometri percorsi, temperatura ambiente, stile di guida, velocità, peso totale, uso di determinati sistemi (aria condizionata, riscaldamento, radio, navigazione, luci, ecc.), tipi e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, condizioni climatiche esterne, ecc. Autonomia Jeep® Avenger full-electric: 392-390 km. Valori definiti in base al ciclo combinato WLTP, misurati dal costruttore nelle prove di pre-approvazione e che possono essere soggetti a modifiche dopo l’omologazione finale. Importante: l’autonomia effettiva può essere fortemente diversa e può variare in base a: optional, condizioni di utilizzo dell’auto (stile di guida, velocità, peso totale, ecc.), uso di alcune attrezzature (aria condizionata, riscaldamento, ecc.), tipi di pneumatici, condizioni stradali, condizioni climatiche esterne. Per ulteriori informazioni, specifiche e dettagliate sull’autonomia elettrica di Jeep® Avenger e i vari fattori che influenzano tale autonomia elettrica saranno forniti non appena il veicolo sarà omologato e disponibile per la vendita.
Consumo di carburante di Jeep® Avenger Autonomia benzina l/100 km: 5,6; emissioni CO2 g/km: 127-126. Valori definiti in base al ciclo combinato WLTP, misurati dal costruttore nelle prove di pre-approvazione e che possono essere soggetti a modifiche dopo l’omologazione finale. Importante: il consumo effettivo di carburante e i valori delle emissioni di CO2possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni d’uso e di vari fattori quali: equipaggiamenti opzionali, temperatura ambiente, stile di guida, velocità, peso totale del veicolo, uso di sistemi del veicolo, aria condizionata, riscaldamento, radio, navigazione, luci, tipi e condizioni di pneumatici, condizioni stradali, condizioni climatiche esterne, ecc. Jeep® è un marchio registrato di FCA US LLC.
www.jeep-official.it
Alessandro Mauro Rossiera una volta la borghesia. Rappresentava l’Italia laboriosa, che sapeva occuparsi di politica, che aveva una visione, dei propri interessi, certo, ma anche del Paese e del futuro. Accanto alla famiglia Agnelli, «borghesi di sangue blu», c’erano tanti altri Grandi Borghesi, soprattutto industriali, da Adriano Olivetti a Giovanni Battista Pirelli, che hanno gettato le basi di questo Paese. C’era addirittura una scuola del pensiero laico e borghese come l’ufficio studi della Banca Commerciale Italiana da cui sono uscite menti eccelse del ’900. Ma questa è storia. Veniamo ai tempi nostri. C’era una vol-
ta la borghesia e c’è ancora come racconta Gianfrancesco Turano. Però è cambiata, quella industriale di una volta non c’è più. Pochissimi figli hanno seguito le orme dei padri e dei nonni, affogando nelle paludi di un’Italia dove, più che la borghesia, sono scomparse le classi dirigenti: è un Paese che vive nella mediocrità. D’altra parte, se anche la politica deve andare a cercare Mario Monti o Mario Draghi qualcosa vorrà pur dire, cioè che la politica non sa più esprimere leader veri in grado non solo di governare l’Italia con lungimiranza e competenza ma anche soltanto di tenere insieme le maggioranze. Oggi non comanda più l’industria ma comandano i servizi. E i servizi sono sempre più globali, ci si occupa meno del Paese e più dei mercati internazionali. Quello che è peggio, è che è cambiato il mondo del lavoro. Sono cresciuti i precari, i lavori sottopagati, il lavoro nero.
Oggi per un giovane comprarsi una casa è un miraggio, prima era un obiettivo sacrosanto. Si stava meglio quando si stava peggio? Non si può dire. Ogni tempo ha le sue caratteristiche. Ma la classe lavoratrice così come siamo stati abituati a concepirla nel ’900 è destinata ad assottigliarsi fin quasi a scomparire. Sono cambiate anche le classi sociali e il rapporto tra loro: prima padroni/proletari; poi produttori/consumatori; ora sempre più distributori di servizi/utenti.
Ma anche nel mondo dei servizi non c’è da stare troppo allegri, per chi lavora. Come scrive Matteo Novarini, «l’ondata di tagli all’occupazione nei servizi più innovativi non ha risparmiato l’Italia. Meta ha scelto di tagliare 22 dei circa 130 dipendenti degli uffici di Milano. Amazon ha rinunciato a un nuovo polo della logistica che avrebbe impiegato 100 persone a Cuneo. Un disimpegno che fa preoccupare i 3.500 dipendenti degli altri stabilimenti del Piemonte e i 17 mila di tutto il Paese. Uno dei tagli più massicci è arrivato a luglio, quando l’app di consegne tedesche Gorillas ha deciso di uscire dal mercato italiano e di lasciare a casa 540 persone. Le ha informate con una videoconferenza». Ci saranno sempre più tante braccia in libera uscita, ma anche tante intelligenze (programmatori, ingegneri, esperti in sostenibilità, ecc.) che avranno più occasioni per ricollocarsi nel mercato del lavoro. Destinato però inevitabilmente a cambiare.
Secondo il professor Domenico De Masi, chi svolge lavori creativi come artisti, calciatori, musicisti, visionari, diventerà sempre più importante, quasi insostituibile in un mercato chiuso o comunque poco aperto; saranno loro i veri padroni dell’immaginario e quindi domineranno la società, supportati dall’intelligenza artificiale e dalla robotica.
E l’uomo che fine farà? Possibile che abbia programmato di sconfiggere sé stesso?

Il tramonto della borghesia e del lavoro come li abbiamo conosciuti.
E gli interrogativi sul progresso










Sarà materia di forte scontro tra governo e opposizioni. Ogni cambiamento tocca interessi forti
uando il governo Draghi annunciò l’intenzione di riformare il fisco, previdi che non ci sarebbe riuscito perché sarebbe stato impossibile per una coalizione tanto variegata trovare un accordo su un tema così politico come le tasse. Ci avevo visto giusto. Per una riforma fiscale serve un governo politico come quello che abbiamo ora. La legge delega per la riforma fiscale dovrebbe arrivare in Parlamento fra un mesetto. Sarà un’area di forte scontro con le opposizioni, soprattutto per l’Irpef, l’imposta sui redditi personali.
Vediamo perché.
Un primo terreno di scontro sarà la sem-
via della ritenuta alla fonte, mentre gli autonomi evadono due terzi delle imposte (non lo dico io: lo dice il rapporto sull’evasione che questo stesso governo ha pubblicato in ottobre). Un’apparente maggiore equità orizzontale, senza ridurre l’evasione, porterebbe allora paradossalmente a una ancora maggiore differenza nel grado effettivo di tassazione. Le opposizioni daranno battaglia a difesa dei dipendenti.
C’è poi il tema della progressività dell’imposta sul reddito. Quanto dovrebbe differire il livello di imposizione tra persone con redditi diversi? La Costituzione richiede che il nostro fisco sia progressivo, ma quanto debba essere progressivo è una scelta politica. Probabilmente il governo riproporrà la tassa piatta, che è inaccettabile per tutte le opposizioni, alcune delle quali vorrebbero anzi aumentare il grado di progressività.
plificazione dell’Irpef. Su questa tutti dovrebbero essere d’accordo. Anche quest’anno le istruzioni per il modulo 730 saranno di 400 pagine! Ma semplificare è difficile perché la complessità è frutto dell’accumularsi di leggi, leggine, regolamenti introdotti per far piacere a qualcuno. Semplificare allora vuol dire andare a toccare gli interessi di fasce particolari della popolazione che fanno riferimento a gruppi politici diversi.
Altro terreno di scontro sarà quello dell’equità orizzontale, il che significa che, a parità di reddito, l’imposta dovrebbe essere la stessa indipendentemente dal lavoro che uno fa. Al momento, invece, gli autonomi sono tassati di più soprattutto a livelli di reddito medio bassi. Il governo vuole eliminare questo svantaggio. Potrebbe sembrare desiderabile a tutti. Ma l’evasione da parte dei dipendenti è quasi zero, per
Infine c’è la questione di come il sistema fiscale debba incentivare certi comportamenti. In quest’area un tema delicatissimo è quello del “quoziente familiare” che il governo vorrebbe introdurre per favorire chi ha più figli. Col quoziente familiare la tassazione passerebbe da individuale a familiare, con la divisione del reddito complessivo per il numero di membri della famiglia. Questo sistema però disincentiva l’entrata nel mondo del lavoro delle donne perché con esso una donna che inizia a lavorare ricevendo come spesso accade un reddito più basso di quello del marito pagherebbe un’aliquota di tassazione più alta di quella applicata con la tassazione individuale. Anche qui lo scontro con l’opposizione sarà forte, anche perché si potrebbe facilitare chi ha figli in altri modi, per esempio aumentando l’assegno unico corrispondente.
Insomma, le aree di scontro sono tante e anche tali forse da creare, per la prima volta dalle elezioni, un fronte unito di tutte le opposizioni. Incredibile a dirsi.

 Francesca Barra
Francesca Barra
entosessanta ore in mezzo al mare. Centosessanta ore schiacciato fra bambini cullati da mamme disperate, fra anziani, esseri umani infreddoliti che pregavano ognuno il proprio Dio, mentre il pericolo di non farcela allontanava sempre di più la speranza di raggiungere illesi una terra libera.
Remon Karam ha solo quattordici anni quando abbandona il suo Paese, l’Egitto, il 6 luglio 2013. Suo cugino era stato ammazzato davanti alla Chiesa dove pregava, sua madre era stata colpita con delle pietre lanciate per intimorirla, i suoi insegnanti lo picchiavano perché non riusciva a impa-
rare a memoria il Corano. E così, lui, cristiano copto, per poter professare la sua fede, per poter studiare e realizzare i suoi sogni, decide di accodarsi a un gruppo di migranti e fuggire. Per cinque giorni viene sequestrato dagli scafisti in attesa di un riscatto da parte della famiglia che, in quel momento, pur di non farlo morire, vende velocemente tutto ciò che possiede.
«In barca per dissetarci ci davano piccoli sorsi di acqua, razionandola nei tappi di plastica sporchi di benzina. Era così nauseante che non ci veniva voglia di bere. Il riso veniva cotto con l’acqua salata del mare e ho trascorso le prime notti bagnato dalle onde gelide del mare».
Remon riesce ad arrivare in Italia, a Portopalo di Capo Passero, ma qui diventa solo un numero: il novantadue. Resta tale per molto tempo nel centro di accoglienza travolto da liti, fughe, impossibilità di comu-
È arrivato in Italia dall’Egitto a 14 anni. Oggi ne ha 23, si è laureato e vuole fare l’ambasciatore
nicare fra culture e lingue differenti. Una sola volta, dopo un mese, un ragazzo somalo gli presta un telefono cellulare con cui chiama sua madre per avvisarla di essere vivo, ma quella telefonata è solo uno scambio di lacrime e singhiozzi.
Poi accade un miracolo quando incontra una coppia italiana: Marilena e Carmelo che per quindici anni avevano provato ad adottare un bambino italiano, senza riuscirci. Non ci pensano troppo quando lo conoscono: «Eravamo destinati a lui». Carmelo, per fargli imparare l’italiano velocemente e poterlo iscrivere a scuola, ricopre i mobili e gli oggetti di casa con foglietti adesivi con la traduzione in italiano (e in siciliano per farlo divertire). Remon è sveglio, impara in fretta e si sente amato come un figlio, non importa se di sangue o di cuore. «Qualche volta, di notte, immagino il mio ritorno in Egitto. Immagino di fare una sorpresa ai miei genitori, bussare alla loro porta, anzi fischiare e scoprire che mia madre sa ancora distinguere il fischio di suo figlio, come quando ero bambino, e dire: ce l’ho fatta! Sono diventato l’uomo che sognavate?»

Oggi Remon ha 23 anni, ha realizzato il suo sogno. Si è laureato in Lingue e culture moderne all’Università Kore di Enna, dove è anche rappresentante degli studenti al consiglio dei Garanti, e ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale ha dedicato il suo amore per l’Italia e l’università. Sogna di diventare ambasciatore e di «rappresentare i diritti degli ultimi».
«Sogno un’Italia che non sia ferita dall’individualismo, spaventata da chi sembra diverso. Capace di accogliere chi la ama, indipendentemente dal colore della pelle o dall’orientamento sessuale e libera da ogni pregiudizio. Ma soprattutto sogno un mondo dove non si debba più fuggire dal proprio Paese per trovare una vita migliore e vivere da esseri umani liberi».
Il successo è qualcosa di molto personale e dipende dalla sicurezza con cui si affronta la propria strada, qualunque essa sia, chiunque noi siamo.
Mettiamocelo bene in testa.
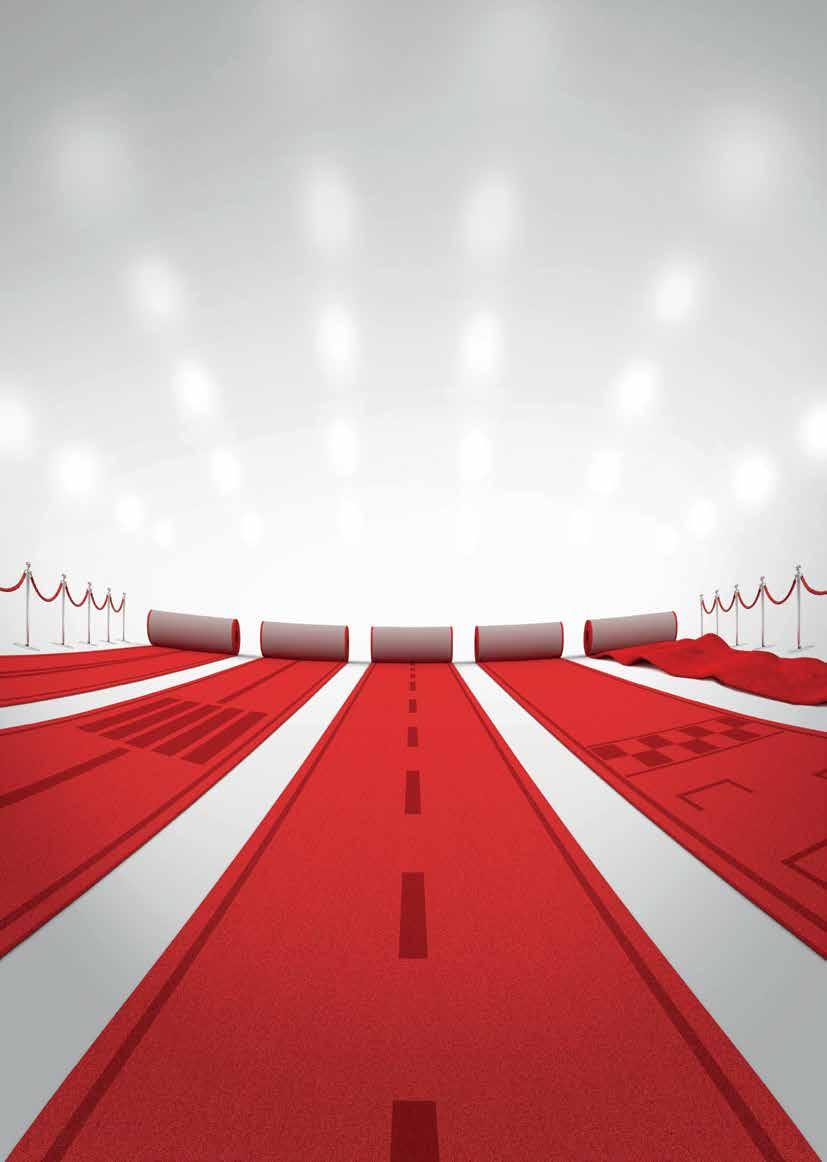

Questa settimana è veramente una passeggiata tra notizie singolari. Ad esempio, leggo che i maschi gelosi inietterebbero nelle femmine una sostanza soporifera per impedire i tradimenti. Lo studio è stato fatto sugli insetti. Il moscerino della frutta di sesso maschile sembra essere geloso, lo hanno scoperto alcuni ricercatori argentini che hanno condotto uno studio sull’insetto e sui suoi comportamenti durante la stagione dell’amore. Ed è lì che hanno scoperto, per l’appunto, che i moscerini maschi quando si accoppiano con le femmine iniettano loro un particolare liquido che le farebbe ad-
dormentare subito dopo l’accoppiamento. In questo modo la femmina non si unirebbe ad altri moscerini interessati. Chissà per quale motivo i moscerini maschi sono stati spesso oggetto di studio. Leggo infatti che alcuni anni fa fu scoperto che i suddetti, subito dopo l’accoppiamento, lasciavano attaccata alla femmina una sostanza che l’avrebbe resa meno attraente agli occhi di altri pretendenti. Sarà questione di moscerini, ma se ci pensate somiglia anche al comportamento di umani maschi e femmine.
Una riflessione va fatta: si è soliti ripetere, scrivere e diffondere notizie sulla scarsa fedeltà delle donne e degli uomini e su come tra maschi e femmine succeda tutto e di più. Poi scopriamo all’improvviso che le leonesse, nel periodo fertile, si accoppiano anche cento volte con più maschi. È un modo, si dice, per evitare che uccidano
Le notizie curiose abbondano. E riguardano uomini e animali. La morale è: non esagerare
i futuri cuccioli dato che potrebbero essere loro figli. Peraltro, alcuni esperti sostengono che, anche tra certe razze di uccelli, le femmine volano via dal nido per accoppiarsi con altri esemplari pur di irrobustire la specie. A leggere queste notizie si evidenzia come tra gli animali non esistano la gelosia, la ripicca, la rivalsa che tanti guai provocano agli umani. Dirazzano un po’ i moscerini che sembra siano gelosi. Ma il problema è che un moscerino incazzato fa paura solo ad altri esemplari della specie e a nessun altro.
L’importante dopo aver letto un po’ di queste notizie è: umani e animali non devono esagerare. C’è una frase emblematica: «Se non ve la sentite, restate a casa: il divano non ha mai ucciso nessuno». Questa notizia fa da corollario a quella di cronaca dove si racconta di due escursionisti che hanno chiamato il Soccorso Alpino per farsi venire a recuperare. Perché? Perché erano troppo stanchi. L’elisoccorso ha infatti aiutato un 41enne e una 32enne che non riuscivano neanche a scendere a valle. Però non si spiega per quale motivo, sentendosi stanchi, avessero organizzato e realizzato una gita in alta montagna. Questa notizia è veramente singolare e pensavamo che non l’avremmo mai letta. Un autista Cotral, ovvero dipendente della concessionaria del servizio di trasporto pubblico extraurbano del Lazio, è stato scoperto mentre, nel tragitto fra Palombara Sabina e Monterotondo, si masturbava. La scena è stata ripresa con un telefonino da due adolescenti che si trovavano a bordo di quell’autobus. Pare che sia molto difficile risalire al conducente del mezzo. Noi avremmo dei suggerimenti in proposito ma non vogliamo mettere in difficoltà il supereccitato autista Cotral. Vi ricordate gli anni Cinquanta quando si fece un gran parlare per le automobili che avevano i sedili ribaltabili e lì si consumavano tradimenti a ogni ora della giornata?

Allo scoccare del novantesimo giorno di sciopero della fame un detenuto nel carcere di Sassari, l’anarchico Alfredo Cospito, aveva perso 38 chili. A maggio 2022, al suo decimo anno di carcere, Cospito è stato rinchiuso in una cella di un metro e 52 centimetri di larghezza per due metri e 52 centimetri di lunghezza, cioè uno spazio occupato quasi tutto dal letto.

Cospito, sepolto, come altri 749 detenuti in Italia (2021), in un sarcofago di cemento armato, è sotto regime di 41 bis. Nel 2022, il reato di Cospito è passato da strage comune a strage politica, reato
non applicato neanche per Capaci o Piazza Fontana. Il 41 bis, nella sua fondazione giuridica, ha una ratio non punitiva, ma di prevenzione: è infatti per esempio applicato indistintamente a persone condannate o in attesa di giudizio.
Lo scopo dell’isolamento, o quasi isolamento, è quella di impedire che il detenuto possa comunicare con altri soggetti, sia all’interno che all’esterno del carcere, per proseguire le attività criminose. Da misura emergenziale, nel 2002, questo regime detentivo è diventato cardine del sistema a tempo indeterminato ed è stato applicato, da lì in poi, anche ai reati di terrorismo. Il 41 bis nella sua formulazione giuridica, non si identifica necessariamente con il “carcere duro”; lo scopo della norma è quello di recidere i rapporti con l’organizzazione criminale di riferimento.
Il 41 bis dunque, quando applicato fuori dal suo scopo fondante, ovvero quello di tagliare i ponti con la struttura mafiosa, è un carcere che si potrebbe definire “illegittimo”, perché persegue concretamente e produce conseguenze diverse dalla norma, dalla sua finalità, dalla sua ratio. Ha un intento afflittivo e persecutorio, nega l’identità, depriva i sensi, non lascia spazio alla rieducazione a cui il carcere dovrebbe mirare.
Così vi è l’assenza della natura rieducativa e umana dell’istituzione carceraria, e, ancor più che agli anarchici, il carcere duro deve far paura a chi crede e protegge uno Stato di diritto. Il carcere duro e il 41 bis sono l’epitome di un’istituzione che condanna, in ogni caso, alla marginalità sociale e all’illegalità, di fatto la istituzionalizza. È una struttura intrinsecamente criminogena e patogena, ovvero reitera, anzi rafforza, le distorsioni di una società che di fatto non sa emancipare l’individuo dalle proprie condizioni materiali. Il carcere deve redimere, deve socializzare, deve assurdamente correggere devianze che sono le devianze di Stato: la precarietà, la marginalizzazione. Chiaramente l’ambiente sovversivo, quello che spazia dalle azioni dimostrative e simboliche, alla non-violenza, all’azione diretta e quant’altro, teme il carcere duro, perché la sua applicazione richiede necessariamente, da parte di chi esercita il diritto, l’identificazione di una categoria politica criminosa, non di un fatto. È la torsione del diritto, l’apice d’offensiva dello Stato: sugli anarchici si sperimenta la tortura e la repressione, parte di una strategia che viene allargata poi a chiunque pratichi il conflitto sociale, anche in forme lievi. Non è un caso infatti, che anche strumenti come la sorveglianza speciale, derivino dal codice Rocco. Ma cosa c’entrano i boss mafiosi con chi pratica il conflitto sociale?
Fuori dallo scopo di tagliare i ponti con la struttura mafiosa è un carcere “illegittimo”
Diletta Bellotti

Alle 7.30 suona la sveglia del cellulare, controllo se ho nuovi like su Facebook, no, allora insulto qualcuno su Twitter, ci leggo qualche opinione, mi indigno un po’, fuori è un brutto mondo, controllo il meteo, forse pioverà, controllo lee-mail, magari c’è una proposta che mi cambia la vita, ma no, non c’è, non c’è mai, e ormai mi sento vecchio, così guardo un balletto su TikTok, poi un altro, che gran figa ‘sta qui che twerka, per me fuori portata, allora guardo se una bionda mi ha rispostosuInstagram,no,nientemessaggi,allora guardo un video su Pornhub, poi un altro, poi un altro, magari intanto la bionda ha risposto, niente

da fare, allora insulto un giornalista su Twitter, lui mi risponde, io gli rispondo, lui dice che mi denuncia, io sparisco e controllo l’home banking, per ogni evenienza, magari mi è arrivato un pagamento, no, guardo LinkedIn, forse mi è arrivata un’offerta di lavoro, no, ma mi ha

scritto un mio compagno delle medie, proprio lì su LinkedIn, è sempre stato un secchione, vuole sapere come va, la sua foto profilo è una scrivania, lo cerco su Facebook per vedere se è ingrassato, anche lì la sua foto profilo è una scrivania, per guardare le altre foto dovrei chiedergli

l’amicizia, non vorrei che poi mi proponesse di incontrarci, vedo che la mia ex è una nostra amicizia in comune, controllo sul profilo della mia ex se sta ancora col maestro di yoga per cui mi ha lasciato, a quanto

pare no, non pubblica foto insieme a lui da 4 mesi e 12 giorni, adesso potrei finalmente iscrivermi a un corso di yoga, confronto i pacchetti di lezioni che trovo su Google, tutti troppo cari, potrei partire da un tutorial


su YouTube, apro l’app, che mi suggerisce una vecchia canzone, giro il link ai vecchi amici su Whatsapp, uno risponde con la foto di un culo, un altro col ralenti di un gol, un altro condivide un articolo contro

i politici, torno su Twitter, insulto un politico, il mio commento riceve sette like, prendo coraggio, scrivo alla bionda di Instagram: “ma perché non mi rispondi più?”, subito lei risponde: “scusa, stavo cucinando, e io detesto cucinare”, le invio la foto di un’anitra laccata trovata su Google Images, le scrivo che è il mio piatto forte e che potrei cucinare io per lei, non mi risponde più, aggiorno la pagina, ancora, ancora, ma niente, torno su Twitter, insulto un’attrice, però vedo che ha recitato in un film



che mi incuriosisce, vado su Netflix, in alto mi appaiono ititolidel momento , interessanti, in fondo chi se ne frega del film di quell’ attricetta del cazzo, inizio a guardare la prima puntata di una serie sui lottatori di sumo, non riesco a concentrarmi, inizio un documentario sui marsupiali, non riesco a concentrarmi, inizio un film sul genocidio degli armeni, che palle, però armeniha un bel suono, qualche mese fa stavo leggendo un eBook su Armani, lo apro, non mi ci raccapezzo più, ormai ho un gran sonno, anche oggi sono riuscito ad arrivare alla notte senza mai pensare alla morte.
 Enrico Dal Buono
Enrico Dal Buono
Dal Getty di Los Angeles al Met di New York. Così opere e reperti di età grecoromana trafugati finivano nei musei più famosi

Agnelli, Benetton, Berlusconi. Le grandi famiglie contano sempre meno. E i nuovi ultraricchi sono lontani dal potere
Inquadra il Qrcode e ricevi la rivista a casa tua per un anno a 5,00 euro al mese (spese di spedizione incluse)

Rampelli commissariato. Donzelli elevato. La sorella Arianna domina. Con Meloni al governo il partito più votato resta senza guida

numero 4 - anno 69 - 29 gennaio 2023




Filtri e App dettano canoni estetici falsi, che non ammettono imperfezioni. E per i più giovani lo specchio è lo sguardo dei social
Per approfondire o commentare gli articoli o inviare segnalazioni scrivete a dilloallespresso@lespresso.it I nostri giornalisti vi risponderanno e pubblicheremo sul sito gli interventi più interessanti


Tasse altissime. Troppi impianti piccoli. Raffinerie vecchie e inefficienti. Mentre il governo accusa gli speculatori, un mercato che non funziona aspetta da anni una riforma
 VITTORIO MALAGUTTI illustrazione di Ivan Canu
VITTORIO MALAGUTTI illustrazione di Ivan Canu
Su il sipario: va in scena la commedia della benzina. Una commedia all’italiana, naturalmente. Primo atto: il prezzo aumenta. Parte la caccia ai colpevoli, agli speculatori. Chi siano di preciso non si sa, ma basta la parola per far scattare le proteste di innumerevoli associazioni di consumatori. E siamo al secondo atto, con il governo che scende in campo, a parole. Terzo tempo: l’Antitrust monitora e la Guardia di Finanza indaga. Risultati? Si vedrà. Fine della storia. È un copione collaudato. L’ultima replica risale a pochi giorni fa, con lo sciopero proclamato dai sindacati dei benzinai, presunti colpevoli della recente impennata del listino dei carburanti.
DISTRIBUZIONE
Una raffineria. Sopra: rifornimento in autostrada. Nell’altra pagina: Ia fornitura alla pompa. Tutta la catena produttiva e distributiva italiana è altamente inefficiente
«Noi non c’entriamo», sostengono gestori e padroncini delle stazioni di servizio, tornati sulle barricate come è già successo più volte in questi anni. Già ai tempi del decreto “Salva Italia”, quello varato a fine 2011 dall’allora premier Mario Monti, la categoria si mobilitò per protesta contro alcune misure di legge per liberalizzare distribuzione e vendita dei prodotti petroliferi. Poca cosa, in realtà, ma le nuove norme vennero spiegate come il primo passo di una riforma complessiva del settore. Obiettivo finale: favorire il ribasso dei prezzi, che in Italia viaggiano da sempre su livelli ben superiori a quasi tutti i Paesi europei. Da allora, nell’arco di un decennio, i benzinai hanno più volte minacciato la serrata e, in un paio di occasioni, hanno anche chiuso i battenti per un paio di giorni, com’è successo tra martedì 24 gennaio e giovedì 26.
La macchina delle accuse e delle polemiche si è messa in moto anche la scorsa primavera, quando il mercato prese il volo per via - si disse - dell’invasione russa dell’Ucraina. Nel giro di poche settimane, complice la riduzione delle accise decisa dall’esecutivo di Mario Draghi, la tempesta si placò. Adesso siamo daccapo. La benzina venduta in Italia resta tra le più care d’Europa. Colpa della speculazione, ripetono i governi. A marzo dell’anno scorso fecero scalpore le parole di Roberto Cingolani. «È una colossale truffa a spese delle imprese e dei cittadini», tuo-
nò l’allora ministro della Transizione Ecologica commentando l’ennesimo aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia in genere. A molti mesi di distanza da quelle dichiarazioni, nessuno ha ancora individuato i colpevoli del reato evocato da Cingolani. In compenso, il mercato dei prodotti petroliferi resta ingabbiato tra distorsioni e inefficienze che finiscono per scaricarsi sul consumatore finale.

Partiamo dalle grandi imprese petrolifere, da sempre sospettate di tirare le fila di una speculazione che amplifica ogni movimento al rialzo del greggio sui mercati internazionali. Difficile negare che le violente oscillazioni delle quotazioni del prezzo dell’oro nero abbiano garantito profitti straordinari alle aziende del settore. «Ma i margini di raffinazione (cioè i guadagni dei petrolieri, ndr) sono influenzati soprattutto dal fatto che gli impianti faticano a soddisfare la domanda di mercato», sostiene Claudio Spinaci, presidente di Unem, l’as-

In Italia ci sono oltre 21 mila distributori. Che vendono in media 1,3 milioni di litri.
Mentre in Germania, Francia e Spagna si superano ampiamente i tre milioni
sociazione di categoria dei petrolieri. In sostanza, le raffinerie sono poche e obsolete. Una situazione comune a tutti i Paesi occidentali, dall’Europa agli Stati Uniti. E così, se la materia prima scarseggia o i consumi aumentano, le ripercussioni sui prezzi diventano sempre più ampie.

In Italia, però, come segnalano i portavoce delle aziende di big oil, il costo industriale di benzina e gasolio è tra i più bassi d’Europa. Inferiore, per esempio, a quello tedesco e spagnolo. Poi ci sono le tasse. Il prelievo del fisco di Roma (accise e Iva) non ha eguali negli altri Paesi della Ue. Questo non basta, però, a spiegare la differenza di prezzo che pesa sugli automobilisti italiani. E allora, per capire meglio, conviene guardare anche altrove. Un dato su tutti: 1,3 milioni litri. È la quantità di carburante veduta in media da ognuno dei 21.700 distributori disseminati sulle nostre strade. In Germania, Francia e Spagna si superano ampiamente i tre milioni di litri, per-


ché le stazioni di servizio sono molto meno numerose. Oltreconfine gli impianti sono più grandi ed efficienti e questo, ovviamente, finisce per influenzare anche il prezzo. Questione di centesimi, certo, perché i margini di guadagno lordi dei singoli gestori, da cui vanno poi dedotti i costi d’impresa, sono di solito compresi tra il 10 e il 20 per cento per cento di quanto incassato. Secondo del Figisc-Confcommercio, una delle associazioni di categoria più rappresentative, si va dai 17 centesimi al litro dei self-service ai 31 centesimi circa per il “servito”. A conti fatti, però, l’estremo frazionamento del mercato, con una miriade di impianti piccoli o piccolissimi, contribuisce a spiegare i rincari, perché i gestori devono fare i salti mortali per far quadrare i conti e quindi, per evitare il crack, tendono a ritoccare all’insù il prezzo.
In passato, l’Antitrust ha più volte segnalato l’inefficienza complessiva del sistema invitando i governi che si sono via via
DISTRIBUTORI Confronto tra il numero di impianti in Italia e in alcuni Paesi europei
PER CENTO
L’aumento dei consumi di benzina e gasolio nei primi 11 mesi del 2022 rispetto al 2021

PER CENTO
Le tasse sul prezzo della benzina, le più alte d’Europa
PER CENTO

La diminuzione delle vendite di carburanti in autostrada tra il 2008 e il 2021
Per la quarta volta in un anno, con sempre maggiore enfasi mediatica, si sono tenute le cerimonie per onorare l’amicizia di convenienza fra Italia e Algeria. Due visite di Mario Draghi (aprile e luglio), una a domicilio del presidente Abdelmadjid Tebboune (maggio), una recente di Giorgia Meloni (addirittura due giorni) e altre assidue frequentazioni informali e ufficiali agevolate dalla trasferta di Sergio Mattarella nel novembre 2021. Certo, il gas. A fiotti. Anche troppo a leggere i resoconti. I soliti giochi di prestigio. Roma ha bisogno del metano algerino per sganciarsi definitivamente dai ricatti russi e per riaffermare la sua influenza nel mare Mediterraneo. Invece Algeri ha bisogno del sostegno italiano per elevarsi a forza industriale e soprattutto militare, a potenza regionale in grado di reggere il confronto con gli odiati vicini marocchini per
succeduti ad avviare una riforma che favorisse la ristrutturazione della rete. Secondo l’Autorità per la concorrenza i punti vendita andrebbero drasticamente ridotti, per migliorare l’efficienza complessiva del sistema e quindi favorire una riduzione dei prezzi. Sulla stessa linea si sono schierati anche i sindacati dei gestori. Ecco la loro idea: tagliare almeno 10 mila impianti, in pratica la metà del totale, finanziando gli interventi con un apposito fondo gestito dallo Stato. La proposta risale a un paio di anni fa. Da allora, però, si è fatto ben poco, quasi nulla. E così la benzina italiana resta tra le più care d’Europa, con una sorta di tassa supplementare a carico degli automobilisti, frutto dell’inefficienza del mercato. C’è di peggio. Le statistiche più aggiornate rivelano che migliaia di stazioni di servizio, almeno 5 mila, non arrivano a vendere 300 mila litri di carburante all’anno. Un giro d’affari troppo magro per garantire un profitto, anche minimo, ai
titolari degli impianti. E allora, per sbarcare il lunario, resta una sola strada: evadere il fisco.
Numerose indagini della magistratura hanno dimostrato che il trafficodi prodotti petroliferi è diventato uno dei business più redditizi per la criminalità organizzata. I proventi illeciti realizzati grazie all’evasione dell’Iva e delle accise, vengono reinvestiti «nell’acquisizione di depositi di stoccaggio e di impianti di distribuzione stradale», come ha ricordato il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, durante un’audizione della commissione parlamentare antimafia del maggio 2021.
Il virus dell’illegalità si è diffuso soprattutto tra le cosiddette pompe bianche, cioè i distributori, circa 8 mila in tutta Italia, che non sono affiliati alle grandi compagnie petrolifere. Secondo i sindacati dei
la disputa sui territori contesi del Sahara Occidentale. Lo scambio più interessante, che viene sottovalutato o persino omesso dalle cronache, è fra forniture di energia algerina e materiale bellico italiano che coinvolge le migliori aziende di Stato (Leonardo e sorelle).
Ciascuno può trarre vantaggi da posizioni di evidente debolezza. Per una sorta di impostazione storica che risale alla guerra di indipendenza, gli algerini tendono a differenziare le relazioni diplomatiche proprio per non sottomettersi a nessuno. Hanno radici antiche i rapporti con i russi, sin dai tempi sovietici, e anche con i cinesi. La coppia di grandi paesi che ha consentito ad Algeri di sopportare il crescente isolamento/distacco rispetto ai dirimpettai europei: per ragioni di orgoglio nazionale con la Francia, per questioni marocchine con la Spagna (amico del mio nemico), per profonda indifferenza con la Germania. Non rimane che l’Italia. Nell’ultimo decennio, dopo la violenta caduta del regime libico di Muammar Gheddafi e l’irrisolta instabilità politica, Roma non ha più un solido legame con Tripoli e ha perduto il suo ruolo decisivo nelle vicende in-
terne, se non per la presenza ancora strategica di Eni. Algeri può offrire al mondo le sue risorse naturali, e nient’altro, perciò lo fa con estrema prudenza e pure con molta fatica. La pace sociale algerina si basa sul gas, che viene garantito alle famiglie e alle fabbriche. La multinazionale Eni è stata la chiave di accesso per l’Italia e la sua collaborazione e i suoi progetti con la Sonatrach sono essenziali per aumentare le esportazioni attraverso i tubi del vecchio Transmed che approdano a Mazara del Vallo, per migliorare in fretta le estrazioni nonché per l’immancabile transizione ecologica (la settimana scorsa le delegazioni hanno annunciato un gasdotto per l’idrogeno). Oltre la consueta retorica, ci sono i numeri di Nomisma, dicono che nel 2022 l’Italia ha ricevuto col Transmed 23,7 miliardi di metri cubi di gas (Eni ha dichiarato 25) contro i 21,2 del 2021 e dunque con un modesto 12 per cento in più. Già al momento l’Algeria copre quasi un terzo del fabbisogno nazionale, che era di 76 miliardi di metri cubi nel 2021 e di 69,9 nel 2022 complice il tepore autunnale e la stangata dei prezzi. In sostanza i nordafrica-
Tra il 2008 e il 2021 la vendita di carburanti sulle autostrade
è crollata del 68 per cento. Gli esperti concordano: le stazioni di servizio, 370 in tutto, una ogni 30 chilometri, sono troppe
gestori, le perdite per le casse pubbliche ammontano ad almeno 13 miliardi l’anno, sotto forma di mancati incassi per l’Erario. D’altra parte, i benzinai legati alle organizzazioni criminali si riforniscono di carburante esentasse, per poi rivenderlo a prezzi molto inferiori rispetto a quelli dei concorrenti che rispettano le regole. I margini di guadagno per i boss di quella che è stata definita “petromafia” sono potenzialmente amplissimi, visto che il 58 per cento del totale degli incassi andrebbe versato allo Stato sotto forma di Iva e accise.
Un caso a parte è quello delle stazioni di servizio sulle autostrade. Qui i titolari degli impianti devono pagare ricche royalty ai gestori della rete. Secondo le rilevazioni più recenti dell’Autorità di regolazione dei trasporti, queste royalty ammontano in media a circa 6 centesimi per litro di carburante venduto. Va poi ricordato che ogni impianto autostradale deve per legge rispettare uno stan-
Accordi
strategici
dard di servizio che comprende, per esempio, il presidio del punto vendita 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno. Ecco perché il costo del rifornimento in questi particolari distributori è sempre molto più caro della media.
Non è una sorpresa, allora, che tra il 2008 e il 2021 la vendita di carburanti sulle autostrade sia crollata del 68 per cento. Gli esperti concordano: le stazioni di servizio, 370 in tutto, una ogni 30 chilometri, sono troppe. Il sistema delle concessioni andrebbe ripensato. Servirebbero nuove norme, una riforma attesa da anni. Invano. La politica preferisce inseguire i fantasmi degli speculatori. Per qualche voto in più.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il residente algerino Abdelmadjid Tebboune nel recente incontro ad Algeri
Per approfondire o commentare questo articolo o inviare segnalazioni scrivete a dilloallespresso@lespresso.it I nostri giornalisti vi risponderanno e pubblicheremo sul sito gli interventi più interessanti
ni hanno sostituito in minima parte la Russia, che è crollata da 29,1 a 11,2 miliardi di metri cubi. Poiché i siti di stoccaggio sono abbastanza saturi per affrontare quest’inverno, la paura di restare a secco incombe sul prossimo. Anche se, va precisato, la geopolitica adottata da Draghi, e non rinnegata da Meloni, permette all’Italia di non aver più un unico venditore di energia.
Però l’Algeria è necessaria, va blandita, persuasa, coccolata, e le commesse belliche da realizzare sono uno strumento formidabile. La premessa è che i nordafricani hanno molti soldi da investire perché gli idrocarburi sono richiesti e quindi assai cari, difatti l’ultimo bilancio ha portato a circa 20 miliardi di euro la dotazione complessiva per la Difesa.
Algeri è un abituale cliente di Mosca, possiede suoi elicotteri da trasporto e da attacco, mezzi anfibi, caccia bombardieri e, secondo una rivista specializzata americana e il senatore repubblicano Mark Rubio, un anno fa avrebbe comprato armi per 7 miliardi di dollari. Un evento concreto di segno opposto, non motivato, si è verificato nelle ultime settimane di novembre, quando
Il traffico di prodotti petroliferi è diventato uno dei business più redditizi per la criminalità organizzata.
C’è poi l’evasione di Iva e accise di pompe senza marca che arriva a 13 miliardi
di giovani algerini, costruzione di elicotteri per il mercato del continente.

I generali nordafricani hanno intensificato i contatti con diverse aziende italiane partecipate dallo Stato come Fincantieri (cantieristica navale civile e militare), Vitrociset (aerospazio e comunicazioni), Mbda Italia (tecnologia e missili) e hanno assistito alla presentazione (e al volo) del nuovo elicottero da combattimento chiamato AW-249 di proprietà di Leonardo. È molto probabile che quest’esemplare finisca nella lista della spesa. Con Fincantieri c’è l’idea di un programma congiunto da eseguire nel cantiere di Mers el Kébir. A Mbda hanno chiesto un lotto di missili (otto pezzi) Aster, ma l’azienda ha proposto i moderni Cammer-er. Ridurre le distanze tra l’Algeria e l’Europa e, di riflesso, smorzare la sintonia tra l’Algeria e la Cina e in particolare la guerrafondaia Russia, è un piano che può soddisfare gli alleati a Bruxelles e Washington. È un’occasione per l’Italia, capita nel Mediterraneo, appare non ripetibile. Andrà perduta se la politica ricade nel vizio dei proclami e dei titoli facili.
Luciano Canovaul ruolo e sul taglio delle accise sono state dette e scritte tante cose. A me preme sottolinearne due che sono legate a un modo di ragionare strettamente economico: la funzione di segnale del prezzo da un lato e, dall’altro, il costo opportunità di una scelta.
Le accise contribuiscono al prezzo della benzina e veniamo al primo punto: il ruolo di segnale dei prezzi. I prezzi contengono informazioni: se uno non capisce niente di vino, può ragionevolmente supporre che una bottiglia che costa di più contenga vino di maggiore qualità.
La scelta, prima del governo Draghi e poi del governo Meloni fino a dicembre 2022, di calmierare il prezzo della benzina scontando le accise, ha dunque distorto il segnale informativo contenuto nel prezzo. È legittimo farlo, in momenti di emergenza che richiedono un intervento a favore delle famiglie. Ma è anche legittimo fermarsi se si rischia di togliere a quel segnale di prezzo la sua funzione. Pensiamo per un attimo all’obiettivo di incentivare la mobilità elettrica e sostenibile, di consumare meno carburanti anche per una questione ambientale: come fare se il prezzo della benzina continua a essere sgonfiato artificialmente da un intervento governativo? Senza considerare un altro dato: le accise sono imposte regressive, che pesano di più su chi ha di meno e uno sconto su di esse avvantaggia, dunque, più l’autista della Porsche Cayenne che quello della Panda. È una questione di opportunità ed eccoci, dunque, al secondo punto: il costo opportunità.
Quando si prende una decisione, si soppesano costi e benefici delle varie opzioni disponibili e il costo opportunità definisce il valore più alto tra le opzioni scartate. La Germania è intervenuta pure alla voce “trasporti”, ma lo ha fatto rendendo più attraente l’alternativa all’auto come modalità di trasporto: l’abbonamento ai mezzi pubblici (treni, bus, metropolitane) è stato scontato in modo molto favorevole per gli utenti. Risultato: minore domanda di carburante e spostamenti più sostenibili sulla rete. In Italia per tutto l’anno passato, sono stati spesi 7 miliardi di euro per scontare il prezzo della benzina. E se quei 7 miliardi fossero destinati, invece, al miglioramento dell’infrastruttura di trasporto pubblico?
IN SIMBIOSI
Arianna Meloni, sorella di Giorgia e coordinatrice di fatto
della campagna elettorale per le Regionali del Lazio

Rampelli commissariato. Donzelli elevato. La sorella Arianna che domina sullo sfondo. Con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi il partito più votato resta senza una guida. E comincia a sbandare
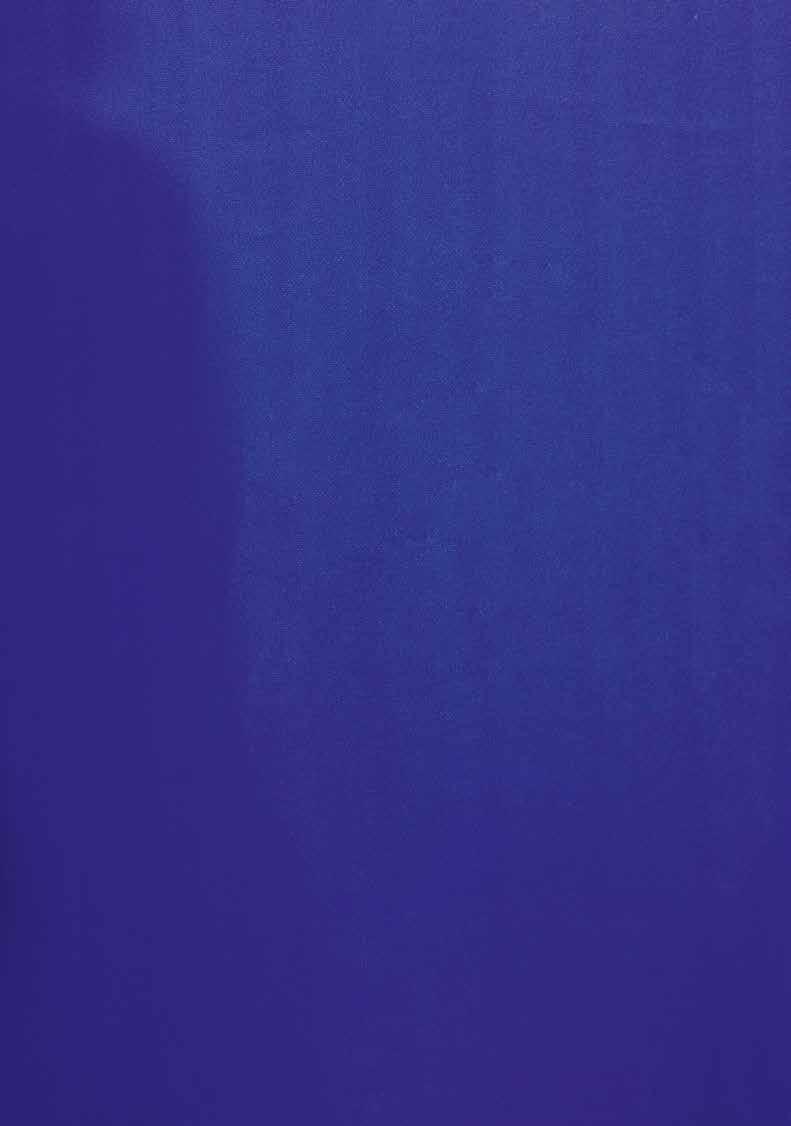
ino a una settimana fa la situazione era abbastanza ordinata, almeno all'apparenza: c'era un candidato, l'ex presidente della Croce Rossa Francesco Rocca, in corsa per il centrodestra alla Regione Lazio. C'era una sorella in ascesa, Arianna Meloni, coordinatrice informale e per lo più telefonica della sua campagna. C'era un partito, Fratelli d'Italia, avviato verso la sua prima competizione elettorale post vittoria politica. Pochi giorni e tutto è cambiato: Rocca ha disertato lunedì 23 senza preavviso il primo confronto tv, la parte politica del suo comitato si è inabissata e il partito si è rivelato, più che una falange, una pentola a pressione. Soprattutto a Roma, dove FdI è da sempre più forte che nel resto d'Italia - prendeva il 20 per cento anche quando a livello nazionale non superava il 4 - e dove dopo un lungo ribollire è infine scoppiata, proprio mentre la premier era in Algeria, la contesa con la componente che fa capo all'ex mentore di Meloni, Fabio Rampelli, per una storia di iniziative di corrente assai simbolica e rivelatrice di un andazzo generale.
Come se non bastasse, in mezzo tra l'apparente quiete e l'esplosione della vicenda romana, si è consumata anche la rocambolesca caduta di Giuseppe Valentino, penalista, presidente della Fondazione An cioè di una delle casse di Fratelli d'Italia, candidato laico al Csm indicato da FdI come vicepresidente, ritiratosi il 17 gennaio nel bel mezzo della votazione perché era saltato fuori che era indagato per reato connesso nel processo Gotha, quello contro il direttorio della 'ndrangheta: l'avevano tirato in ballo nel 2021, ma nulla di formale era emerso dai controlli di Fratelli d'Italia, effettuati da Ignazio La Russa in persona. «È specchiatissimo, non facciamo la figura dei peracottari», protestava infatti il presidente del Senato, e presidente dell'Assemblea Nazionale di Fratelli d'Italia, in Transatlantico anche quando Meloni aveva già silurato l'ex sottosegretario.
Il caso Rampelli. Il caso Valentino. Il commissariamento dell'unica minoranza di Fdi. La malagestione delle nomine. Gli inciampi della comunicazione. Ed ecco, appena passati i cento giorni di governo, affio-
rare il tallone d'Achille di una premier e di una leader, Giorgia Meloni, che non si fida di nessuno, se non della famiglia. Che non delega a nessuno, se non singole questioni a pochi fedelissimi, a briglia corta. Basti dire quanto sia difficile per Meloni delegare, anche a livello di comunicazione: allo stato la premier - che a parte quella rituale di fine anno ha dismesso la pratica delle conferenze stampa, l'ultima risale al 22 novembrenon ha un capo ufficio stampa («alla prima imprecisione lo ucciderebbe», sussurrano), la sua storica portavoce Giovanna Ianniello è inquadrata come «coordinatore della comunicazione istituzionale» e il suo responsabile dell'ufficio stampa, già portavoce di Fini, Fabrizio Alfano, formalmente è solo un vice (il capo risulta «non nominato»).
La sorella d'Italia decide tutto. E ha messo in piedi, sussurrano in sintesi, una gestione mediorientale del partito, quasi «alla Gheddafi», o anche alla «partito comunista cinese», ora difficile a proseguirsi. Chi comanda a via della Scrofa ora che Giorgia sta a Palazzo Chigi? Questa incertezza ha consumato già qualsiasi ammortizzatore degli ingranaggi del partito. Al punto che tut-

Passati i cento giorni ecco affiorare il tallone d’Achille di una leader che non delega a nessuno, se non alla famiglia. Una gestione quasi mediorientale, “alla Gheddafi” o alla “comunisti cinesi”LA FRONDA Fabio Rampelli a capo della corrente dei gabbiani di FdI. A destra, Giorgia Meloni
to è esploso in una reazione spropositata proprio contro l'unica opposizione nel monolite di FdI, quella che fa capo ai gabbiani di Rampelli dove Meloni in origine militò: il commissariamento del coordinatore di Roma, Massimo Milani, accusato sostanzialmente di mescolare il suo ruolo formale con la sua appartenenza di corrente (i gabbiani di Rampelli appunto). Una durezza di reazione, per la vicenda romana, che non ci fu neanche ai tempi di Fanpage e dell'inchiesta sulla Lobby nera: quando la Procura aprì l'inchiesta, di cui ora ha chiesto l'archiviazione, indagando otto persone per un presunto giro di fondi illeciti e riciclaggio, nessuno pensò, per dire, di commissariare la federazione milanese guidata da Stefano Maullo (area Santanché).
Tutto nasce da un dato: nel partito di Giorgia Meloni comanda soltanto lei, sempre di più. Anche Roma, via Donzelli «per garantire terzietà». L'ultimo congresso di FdI risale al 2017, le cariche dell'esecutivo non sono state toccate ora che quasi tutti siedono al governo, come si evince anche dal sito del partito, trasformato in un organo di propaganda dell'esecutivo (si consiglia

in proposito la sezione: Gazzetta tricolore). Insomma modello Renzi, dice chi ricorda come il Rottamatore amministrò il Pd da Palazzo Chigi.
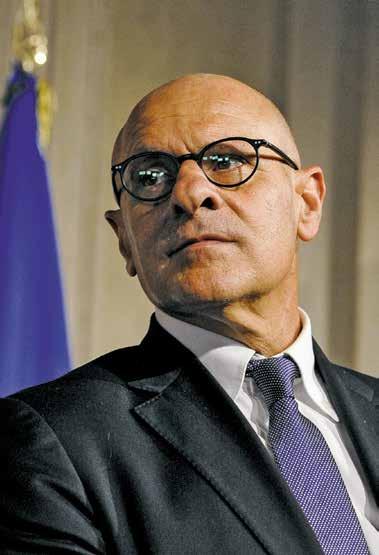
È l'opposto, questo, del modo democristiano di gestire il potere, secondo una suddivisione accurata: se al governo c'è Aldo Moro, al partito c'è Mariano Rumor; se c'è Giulio Andreotti, al partito c'è Arnaldo Forlani. Ecco, invece qui c'è solo Meloni: al governo e al partito. La destra del resto non è avvezza alla problematica. Mai fino ad oggi aveva espresso un presidente del Consiglio, e solo una volta ha dovuto confrontarsi con la compresenza di incarichi di governo e di partito: con Gianfranco Fini, che da leader di An, ministro e vicepremier aveva delegato tante questioni a una specie di direttorio, ai colonnelli, ai capicorrente: La Russa, Gasparri, Matteoli, Urso. Ecco, nell'era di Giorgia Meloni colonnelli non ve ne sono.
Nel partito iper-personalizzato ci sono uomini di fiducia, come il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, l'eurodeputato Carlo Fidanza, il responsabile dell'organizzazione Giovanni Donzelli. E qualche donna, come Chiara Colosimo (anche lei una
ex gabbiana, pare che quel disegno tribale che ha sull'anulare sinistro una volta fosse appunto un gabbiano). Personaggi che seguono Meloni sin dai tempi in cui divenne capa dei giovani di An nel 2004, ma che non sono titolari di quote rilevanti di voti.

E poi ci sono i parenti. Qui bisogna aprire un capitolo a parte, perché la funzione della parentela è particolare, nel caso Meloni. In questi mesi molto si è capito circa il ruolo di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, detto il cognato, ma di fatto anche più che un braccio destro: nel senso che «Lollo» come lo chiamano tutti è davvero un emissario del melonimondo. Fedeltà alla capa, sì, ma anche legame di sangue. Le due cose si mescolano in una maniera mai vista: di norma, infatti, nel campo da gioco della politica italiana il parente è colui che il potente colloca arbitrariamente in un qualche posto quando acquista sufficiente potere per farlo, anche a prescindere dalle sue competenze. Modello Berlusconi. Qui c'è un elemento diverso - peraltro comune in una destra dove spesso si condivide impegno politico, parentele, legami - nel senso che Lollobrigida in effetti ha una compe-

tenza politica fatta di quasi trent'anni anni di militanza, spalla a spalla con Giorgia Meloni. Che conobbe quando lei aveva 18 anni e non era nessuno, mentre lui iniziava a uscire con la sorella.
È proprio Arianna, «l'altra Meloni» come la chiamò Simone Canettieri nella sua prima intervista, l’elemento da tenere d'occhio nella vicenda di FdI. Dacché Giorgia è entrata a Palazzo Chigi, infatti, Arianna ha visto accrescere il suo potere. Nulla di formale, almeno per ora. Però con la fine del 2022 Arianna ha chiuso il suo ventennio di contratti a termine con la Regione Lazio (non ha mai cercato l'assunzione volendo evitare polemiche, era in ultimo responsabile della segreteria di Chiara Colosimo). Da allora per lei si è ventilato prima l'incarico di responsabile del tesseramento, poi di coordinatrice della campagna di Rocca. Un incarico che in parte svolge, nel consueto guazzabuglio che già si vide un anno fa con le Comunali per Roma, e anzi con una differenza: mentre per Enrico Michetti c'erano fin troppi referenti politici - da Lollobrigida al coordinatore regionale Paolo Trancassini, fino a Rampelli - adesso per impegni o per lesa maestà,
LA COPPIA
Arianna e Giorgia Meloni: sopra, in abito da sera per gli auguri sui social per il nuovo anno. In alto, Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e marito di Arianna
nessuno sta seguendo la pratica. L'unica appunto è Arianna, che però agisce con discrezione: al telefono appunto.

Fu lei, del resto, già un anno fa a spingere per la candidatura di Michetti, che sentiva a Radio radio. Non è un segreto poi che Arianna faccia politica «sin da ragazza», come ha rivendicato più volte. È tutt'uno con la sorella «i nostri dna sono sovrapponibili, come quelli di due gemelle omozigote», ha raccontato. È la sua prima consigliera e sempre più spesso è proprio lei la terminale di tante informazioni. «Ho parlato con Arianna» è diventato come «parla con Lollobrigida», racconta il Foglio. Per toccare con mano questa simbiosi, basta dare un'occhiata ai profili social di Arianna. Pieni di messaggi politici del-
Tra i più recenti giochi di società per malati di politica, frequentatori di Palazzi e di salotti, aspiranti frequentatori, gente che cerca invano di disintossicarsene: individuare chi siano i segretissimi confidenti intervistati ne “L'Inquilino. Da Monti a Meloni, indagine sulla crisi del sistema politico”, il volume di ben 592 pagine (Feltrinelli) ma che appunto gli addicted divorano tipo romanzo di Stephen King, col quale Lucia Annunziata, editorialista e conduttrice di “Mezz'ora in più”, analizza e racconta dieci anni di potere italiano, dalla caduta di Silvio Berlusconi fino a quella di Mario Draghi. Un viaggio dentro a un decennio di «disordine istituzionale» e di premier tecnici, di sfiducia nei partiti, svuotamento del Parlamento e di crisi del Pd (inevitabile), nel quale fra l'altro parlano una serie di interlocutori privilegiati, che restano anonimi (le conversazioni, registrate, sono depositate presso l'editore). Ecco il punto: gole profonde che chiacchierano in un normale dialogo, nel libro, offrendo particolari che ingolosiscono, dettagli da giallo, sciarade per solutori esperti. Ad esempio, si ricostruisce nel dettaglio come nacque il governo Conte due, che poi tanti lutti addusse ai dem. Con riunioni riservate, mattina o pomeriggio, a casa di Luigi Zanda, per non farsi scoprire da Renzi. I partecipanti? «Zanda, Zingaretti, Franceschini, Gentiloni, Martina, Paola De Micheli, Piero Fassino, io, Andrea Orlando e poi potevano aggiungersi alcune variabili a seconda della riunione», dice l'anonimo. È ovvio che gli ospiti di Zanda sappiano chi sia l'«io» che parla: chi altro saprebbe indovinarlo?

Negli organigrammi interni non si è mosso nulla. E a Palazzo Chigi non esiste un capo ufficio stampa. Ma la prima consigliera è Arianna. Che non lavora più alla Regione Lazio
A palazzo si gioca a “Indovina chi?”
Festa per Casini, ma che dolore allo stadio. Presenti Giuliano Amato, Mario Monti, Ignazio La Russa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Matteo Piantedosi, Raffaele Fitto, Clemente Mastella, Roberto Speranza, Pier Luigi Bersani, Nicola Zingaretti, Lorenzo Guerini e tanti altri per festeggiare Pier Ferdinando Casini e il suo libro “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano”, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Folto il gruppo dei bolognesi, concittadini di Casini: in cima alla lista Gianfranco Fini, Piero Gnudi e Gian Luca Galletti. In sala, nel settore dell’economia e della finanza, si parlava del fratello di Pier Ferdinando, Federico Casini, uno dei massimi esperti di assicurazione e brokeraggio, ex presidente Aon, ora scelto come ceo di Howden Italia. E somigliantissimo al fratello. Curiosità: a poche centinaia di metri di distanza, allo stadio Olimpico, c’era in campo la Lazio contro il Bologna, per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Ma lì la squadra felsinea ha perso: 1-0 per i biancazzurri. E pensare che Casini nella sua casa romana conserva la tuta della squadra di calcio del Bologna: un vero feticcio.
la sorella, foto della sorella, foto con la sorella, anche qualche capovolta sugli anelli come faceva anche la sorella quando aveva più tempo. Messaggi sulla sorella: «Ti accompagnerò sul monte Fato, sapendo che non è la mia storia che verrà raccontata, ma la tua», scrisse il 24 settembre. È ancora più simbolico il post di fine anno, dove compaiono le due sorelle d'Italia in abito da sera. E gli auguri: «A chi ha creduto, a chi non l'ha fatto ma si sta ricredendo, auguri anche ai rosiconi che non si ricrederanno mai per puntiglio. Auguri ai nostri amici e ai nostri nemici», «sarà un grande anno perché questo è il nostro vero augurio». Con tutti questi «nostro», viene in mente un verso del poeta Kavafis: il mio, il tuo, queste fredde parole tra noi mai pronunciate. Varrà anche per il partito?
CANDIDATO
Francesco Rocca, avvocato, già presidente della Croce Rossa è in corsa per il centrodestra alla guida della Regione Lazio

Lo scherzo della Lollo alla Cardinale. È stato l’ultimo scherzo di Gina Lollobrigida ai danni di un’altra grande del cinema, Claudia Cardinale. Nello stesso giorno della cerimonia di addio alla “Bersagliera” nella basilica di Santa Maria in Montesanto, nota al grande pubblico come la “chiesa degli Artisti di piazza del Popolo”, celebrante don Walter Insero (il suo storico soprannome? George Clooney), al cinema Barberini erano in programma la presentazione del volume “Claudia Cardinale. L’indomabile”, edito da Cinecittà ed Electa, e la visione del film “La ragazza di Bube”, restaurato, per omaggiare la carriera dell’attrice. Per evitare sovrapposizioni, all’ultimo minuto disponibile, l’evento dedicato alla Cardinale è stato rinviato al giorno successivo. Ed è stata pure rimandata, ma è stata recuperata il 26 gennaio, la prevista audizione dell’ad di Cinecittà Nicola Maccanico di fronte alla commissione Cultura della Camera dei Deputati, che doveva svolgersi sempre nel fatidico giovedì “terremotato” dalla Lollo. Le risposte ai parlamentari sul tema del Pnrr possono attendere.
Per approfondire o commentare questo articolo o inviare segnalazioni scrivete a dilloallespresso@lespresso.it I nostri giornalisti vi risponderanno e pubblicheremo sul sito gli interventi più interessanti



Ma è Guadagnino o Ingroia? Successo assicurato, con tanto di premio, per il regista Luca Guadagnino al Sundance Film Festival, la kermesse fondata da Robert Redford a Park City e tornata, finalmente, “in presenza”. Le sue ultime fotografie però hanno creato il panico nelle redazioni: «Ma è Guadagnino o l’ex magistrato Antonio Ingroia? Sono uguali». In effetti…
Scrivete a laboccadellaverità@lespresso.it

Al quarto governo di fila che si mette d’impegno per disintegrarla, è giunta l’ora di porre una domanda: che fine ha fatto l’Autorità nazionale Anticorruzione? Perché l’Anac non c’è più. Adesso assomiglia di nuovo alla sonnecchiosa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che nel 2014 Raffaele Cantone aveva trasformato in cane da guardia degli appalti e della trasparenza.
Ultimo segnale, il codice dei contratti pubblici. L’Anac non tocca palla: il testo è confezionato in esclusiva dal Consiglio di Stato. E a Giuseppe Busia, il presidente che nel settembre 2020 ha sostituito Cantone, non rimane altro che protestare flebilmente — a un convegno dell’Ance — contro i soprusi: «L’eliminazione di controlli con l’uso indiscriminato dell’in-house, l’innalzamento della soglia degli appalti a 500 mila euro, la soppressione delle verifiche sul conflitto d’interessi…», elenca. Ma è come abbaiare alla Luna.
Sulla carta l’Anac conserva pur sempre poteri consistenti. Sono però quelli tipici della defunta authority da cui è nata. È sparito, invece, per dirne una, quello di impartire le tanto discusse «linee guida» degli appalti pubblici. Per non parlare di certe oscenità spuntate nel testo con la scusa della semplificazione, come la possibilità di evitare moltissime gare con assegnamenti diretti o stratagemmi simili: lo scoglio di una authority dotata di robusta spina dorsale sarebbe stato insormontabile.
La storia del codice segue quella di un decreto dell’ex ministro Renato Brunetta, mai entusiasta dell’Anac, che alleg-
gerisce il suo ruolo nei piani delle pubbliche amministrazioni contro la corruzione. E nel frattempo ha pure successo un ricorso del sindacato di destra Ugl che demolisce la riforma dell’authority pensata da Cantone.
Lo stillicidio prosegue senza opposizioni, anche perché l’autorevolezza dell’Anac è ormai roba del passato. Parla chiaro il profilo della nuova commissione, ma non sono estranei alcuni fatti. Tipo la nomina a segretario generale di un dirigente di Palazzo Chigi, Renato Catalano, presidente della Consip in scadenza. Peccato che la Consip sia la centrale degli acquisti dello Stato. Dunque vigilata dall’Anac, che non le ha nemmeno risparmiato pesanti rilievi sulla gestione delle aste. La nomina è ri-

Mal sopportata dagli ultimi governi, svuotata di poteri e colonizzata dalla politica.
L’Autorità nazionale Anticorruzione non è più il cane da guardia dei contratti pubblici
tenuta non incompatibile perché alla Consip il presidente non ha deleghe gestionali. Giustificazione incredibile, la quale rafforza il sospetto che il problema fosse solo quello di dare un altro incarico, qualsiasi, a Catalano. Il quale, peraltro, ha già mollato: al suo posto Maurizio Ivagnes, dirigente interno dall’epoca precedente alla rivoluzione di Cantone.
Lo scivolone segue l’imbarazzante infortunio della scelta del portavoce, caduta a gennaio 2021 sul giornalista Francesco Paravati, incidentalmente genero dell’ex governatore calabrese Agazio Loiero. Salvo poi scoprire, solo dopo averne ufficializzato la nomina, che gli manca un requisito previsto dal bando. Con il risultato che Paravati si dimette dopo appena dieci giorni.
Il cortile interno della Galleria Sciarra, a Roma, dove ha sede l’Autorità nazionale Anticorruzione

Cantone lascia nel 2019, in anticipo di qualche mese sulla scadenza del mandato da presidente. C’è il governo gialloverde. «Sento che un ciclo si è definitivamente concluso, anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell’Anac e del suo ruolo», mette a verbale. Traduzione: è chiaro che vi stiamo sullo stomaco, quindi tolgo il disturbo. Nel Palazzo pochi sono costernati. Cantone ha troppo potere, troppa influenza, troppa indipendenza. Sistema gli appalti dell’Expo 2015, facendo risparmiare mezzo miliardo. Commissaria il Mose. Fa risarcire le vittime dei crac bancari. Per ogni problema si bussa alla sua porta. E poi, perfino ricevuto alla Casa Bianca da Barack Obama. Scherziamo?
La verità è che la sua authority va di traverso a tutti. Da subito. Perfino chi l’ha istituita prova a toglierle i soldi, senza successo. Finché arriva il Nuovo che avanza. E si fa dura. Per nove mesi in attesa del repulisti tengono l’Anac a bagnomaria. Poi scatta la restaurazione partitica. Giuseppe Conte adesso governa con il Pd. Ed ecco Laura Valli, funzionaria della Banca Mondiale in quota grillina. Ecco Luca Forteleoni, magistrato sponsorizzato dal suo collega e deputato di Italia Viva, Cosimo Ferri. Ecco l’avvocata Consuelo del Balzo, collaboratrice del sito meloniano La Voce del Patriota. Ecco l’avvocato Paolo Giacomazzo, che ha lavorato con il legale principe di Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini. Ecco infine il presidente Busia, amico del pre-
mier: Conte vorrebbe farlo segretario generale di Palazzo Chigi; poi addirittura sottosegretario alla presidenza. Ma ogni volta il nome di Busia viene bloccato. All’Anac, però, non trova opposizione. Anzi. Il Pd accetta di buon grado, come fosse uno dei suoi, anche perché ha sempre orbitato nell’area della Margherita. Fa il segretario generale della Privacy con l’ex deputato Antonello Soro. Ma l’ha fatto anche nell’Autorità sugli appalti, prima dell’arrivo di Cantone. E finalmente si volta pagina, per la tranquillità del Palazzo.
P.s. Siamo ancora in attesa del regolamento sulla pubblicazione dei patrimoni dei dirigenti pubblici (cui Busia è allergico). Da quattro anni.


La comunicazione è sempre più lo strumento determinante per indirizzare successi o débâcle di un governo, di un partito o più in generale di un brand aziendale, soprattutto nell’epoca in cui ogni elemento, anche della vita privata, diventa preda dei social e di pubblici influenti.
In questa cornice, sono diversi i nuovi comunicatori che negli anni si sono distinti per aver inciso positivamente sull’immagine dei propri leader. Talvolta, instaurando un network di contatti imponente dal punto di vista strategico e relazionale. Tra questi ci sono indubbiamente Augusto Rubei e Paola Ansuini. Il primo, classe ’85 e già portavoce del ministero della Difesa e del ministero degli Affari Esteri, è forse l’unico under 40 in Italia ad aver saputo coniugare una profonda esperienza ai più alti livelli dello Stato, del giornalismo, della comunicazione politica/istituzionale e del management. Considerato un giornalista autonomo e indipendente, è salito alle cronache per aver ricostruito da zero l’immagine internazionale di Luigi Di Maio alla Farnesina dopo i disastri dei suoi predecessori, oggi è in forza alle relazioni internazionali di Leonardo Spa. La seconda, condivide altrettanto una profonda esperienza professionale a metà tra la politica e il management. Cresciuta infatti in Banca d’Italia fin dal 1988 dove ha poi ricoperto la carica di responsabile della comunicazione, viene chiamata nel 2021 da Mario Draghi ai vertici dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi. Soprannominata, con ironia, la “portasilenzio” per i suoi modi sobri e cauti di gestire l’esposizione mediatica dell’ex premier, in passato - sempre per Bankitalia - ha ricoperto i ruoli di vicecapo della de-
legazione a Bruxelles a ha curato la comunicazione per il cosiddetto Financial Stability Board. Restando tra le file governative, oggi spiccano l’attuale e storica portavoce della premier Giorgia Meloni, Giovanna Ianniello e il suo braccio destro Tommaso Longobardi, che ha esportato dalle parti di via della Scrofa le tecniche apprese alla scuola di Caseleggio, contribuendo alla modernizzazione e all’impennata dei social di Fdi. La Ianniello, in particolare, si è fatta notare in occasione della campagna elettorale che ha trascinato Giorgia Meloni alla vittoria. Donna di partito, da sempre legata al centrodestra, iniziò la sua collaborazione con Giorgia ai tempi di Azione giovani. Dal 2008 al 2013 è stata impegnata nella giunta di Gianni Alemanno quando questi ha ricoperto il ruolo di sindaco di Roma. Luca Morisi e Matteo Pandini per la Lega incarnano invece il momento forse di maggior successo della Lega. Non a caso il primo Governo
Dagli “istituzionali”
Ansuini e Rubei agli spin doctor di partito. Chi sono le donne e gli uomini che governano strategie decisive per il successo o la sconfitta dei leader politici
gialloverde fu pesantemente condizionato dalla strategia aggressiva di Matteo Salvini, che fagocitò prima sui media e poi nelle urne il Movimento Cinque Stelle. Il vero direttore d’orchestra fu proprio Morisi, che allora con La Bestia disegnò indubbiamente la nuova linea politica del partito e contribuì a costruire il successo delle Europee del 2019. Non è forse un caso che l’erosione dei voti del Carroccio abbia coinciso con la scelta obbligata da parte di Morisi di defilarsi. Pandini del canto suo continua a ricoprire il ruolo di portavoce del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Già a capo della comunicazione di Salvini quando sedeva al Viminale, ha un trascorso storico nel Carroccio. Per il M5S sarebbe impossibile non considerare il social media manager di Giuseppe Conte, Dario Adamo, vero artefice del successo del nuovo capo politico grillino insieme a Rocco Casalino, che alle ultime elezioni ha saputo dimostrare
Palazzi girevoli

L’idea di spacchettare in due la direzione generale del Tesoro è sempre più vicina: da una parte la finanza pubblica e i rapporti internazionali in mano a Riccardo Barbieri Hermitte, dall’altra la gestione delle partecipate al presidente di Ita Airways Antonino Turicchi, che sta facendo un ottimo lavoro in azienda coadiuvato anche da una buona dirigenza. Per chi parla di incompatibilità? Draghi fu direttore del Tesoro e contemporaneamente presidente di Sace. ***
Siamo pronti a scommettere che le foto del Ministro Urso in compagnia del Presidente Zelensky abbiano dato a Giorgia Meloni molto fastidio. Possiamo immaginare che la Presidente avrebbe voluto essere la prima ad incontrare il Presidente ucraino in rappresentanza del Governo italiano, dopo aver reiterato più volte l’intoccabile sostegno militare ed economico a Kiev nonché dopo aver preannunciato un suo viaggio in occasione della conferenza stampa di fine anno. La smania di visibilità e protagonismo può giocare brutti scherzi alla coesione complessiva della squadra.
ancora un’ottima visione strategica per il successo del nuovo Movimento.
Infine il Partito Democratico, con Monica Nardi e Laura Cremolini. Quest’ultima capo ufficio stampa con l’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando e subito dopo portavoce del Ministro del Sud Giuseppe Provenzano, oggi cura i rapporti con i media per la vicepresidente del Senato Anna Rossomando. Monica Nardi prosegue nel suo compito di portavoce di Enrico Letta, al fianco di Tiziana Ragni come capo ufficio stampa Dem.



Ieri e oggi, donne e uomini che operano nella comunicazione sono gestori, riferimenti, suggeritori, costruttori di contenuti e ingegneri di strategie. L’evoluzione di un mestiere che oggi sembra essersi ritagliato un nuovo vestito su misura, cercando di vincere la sfida di non snaturarsi. Perché vecchio e nuovo possono coesistere senza confliggere.
PARTITI E NON SOLO
Da sinistra in senso orario: Augusto Rubei, Giovanna Ianniello, Tommaso Longobardi, Matteo Pandini, Monica Nardi, Paola Ansuini, Laura Cremolini, Luca Morisi

 Goffredo Bettini
Goffredo Bettini
La triste vicenda circa la corruzione di alcuni parlamentari e assistenti nel Parlamento Europeo, appartenenti al gruppo socialista, ha riproposto il tema della questione morale. Le singole persone e le loro responsabilità vanno indagate dalla magistratura, individualmente e nel pieno rispetto delle loro garanzie.
Siamo di fronte a reati colti in flagranza. A confessioni, come nel caso di Antonio Panzeri, per la volontà di collaborare con la giustizia. Alcuni, invece, sono ancora in una fase di accuse generiche o di un coinvolgimento per sentito dire. Mi auguro che al più presto si arrivi a dare certezze

ai presunti rei e a cancellare l’inquietudine dell’opinione pubblica, soprattutto di sinistra. L’aumento di comportamenti scorretti, o persino criminali, va riferito a due processi politico-istituzionali e culturali che ci stanno investendo con rinnovata forza. La questione morale è tutt’uno con la questione democratica. Lo osservò per primo Enrico Berlinguer nel 1981 in una memorabile intervista concessa sull’argomento a Eugenio Scalfari. Quando si allenta il vincolo della rappresentanza e le decisioni si assumono nell’ambito di istituzioni lontane e poco trasparenti, aumenta il pericolo dell’autoreferenzialità, della discrezionalità, della irresponsabilità.
L’Occidente parla della necessità di esportare la democrazia in tutto il mondo. Ma quale democrazia? È dagli anni ’70 (ricordate la Trilateral?) che il pensiero neoliberista invoca una restrizione della de-
mocrazia, una riduzione della domanda, un accentramento del potere esecutivo. La coda avvelenata di questo lungo percorso che ha ribaltato le speranze suscitate dalle costituzioni emancipative del dopoguerra, ha portato all’oggi: una condizione nella quale mai è stato così fragile e confuso il rapporto tra il potere democratico e i cittadini. Ma oltre a questo c’è qualcosa, persino, di più basico. Si potrebbe dire di antropologico. Anche nella politica, che avrebbe il compito di promuovere ed educare il popolo, si sono insediati i miti peggiori di questa nostra modernità, per molti aspetti malata. Se comandano esclusivamente i valori del mercato, del profitto, della competizione persino spietata, dell’indifferenza di fronte al dolore degli altri è evidente che la classe dirigente (se non è in grado di resistervi e di coltivare un esempio di sobrietà alternativa) ne rimane vittima. Si adegua. Perde l’anima e il senso della sua missione. Anche a sinistra.
Nella discussione congressuale del Pd i temi che investono l’etica pubblica, vanno affrontati come una vera e propria sfida per il rinnovamento del partito. Che fare? L’interesse particolare e del tutto subalterno alla mondanità, va superato con uno sforzo, assente ormai da decenni, di pensiero, di elaborazione, di sapienza, di valorizzazione di tutte le energie ideali e intellettuali. Le correnti interne al Pd debbono concentrarsi su questo.
Sull’elaborazione e la proposta. Piuttosto che sull’organizzazione povera di catene di comando. E alla base, se si vogliono davvero mescolare le culture e le tradizioni costitutive del Pd, va dato un potere non solo di partecipazione ma di deliberazione agli iscritti, i quali attorno ai temi fondamentali in discussione possono determinare maggioranze diverse. Basta con le deleghe in bianco, occorre una democrazia dal basso consapevole e verificabile in procedure chiare.
Il congresso del Pd deve pronunciarsi. Conferendo un vero potere agli iscritti
La loro foto ha fatto il giro del mondo, ma dietro c’è una storia. Impressionante quanto quell’immagine». Chi parla è una delle operatrici della Commissione spagnola per l’assistenza ai rifugiati (Cear) di Las Palmas, la Ong che ha prestato assistenza ai tre nigeriani arrivati a Gran Canaria a inizio dicembre. Nascosti dietro il timone di una petroliera, hanno navigato per 11 giorni. Erano partiti da Lagos il 17 novembre e si erano sistemati nell’ incavo sul retro del gigantesco timone della petroliera Alithini II, 180 metri di lunghezza, salpata verso una meta per loro ignota. Ma qualunque posto sarebbe stato migliore, hanno detto quando sono stati ritrovati al porto di Las Palamas dal Salvamento Marítimo. Vivi, tra lo stupore degli operatori sanitari, anche se molto provati. «Disidratati, denutriti, con sintomi di congelamento. Eppure felici, perché ce l’avevano fatta, piangevano e tremavano», racconta l’operatrice. In ospedale, trattenuti come clandestini, hanno chiesto invano la protezione internazionale. Quando due di loro sono stati dimessi, le autorità spagnole li hanno rispediti a bordo in attesa del terzo: per legge toccava al comandante della petroliera riportarli a Lagos. Ma a quel punto sono intervenuti la Ong Caminando fronteras e il Segretariato per le migrazioni del vescovado delle Canarie.
«È un caso molto delicato», spiega Marìa Vieiyra, una degli avvocati, che sta seguendo Harry, 42 anni. È stato lui il primo a nascondersi nel vano del timone. Gli altri che non lo conoscevano l’hanno seguito: avevano avuto l’imbeccata dallo stesso pescatore. «Non avevamo idea di dove andassimo – racconta Harry attraverso il legale - Avevamo delle bottiglie d’acqua e qualche scorta di cibo. Io avevo preso anche delle spranghe, così da battere contro le paratie e richiamare l’attenzione dell’equipaggio. Il sacchetto con l’acqua è caduto in mare appena dopo qual-
che ora di navigazione. Ma eravamo lì e non restava altro da fare se non rimanerci, cercando di non morire. I giorni successivi sono stati tremendi, cercavamo di dormire a turno, così da non rischiare di cadere in acqua e non avevamo più nulla da mangiare. Sapevamo che un’onda più alta avrebbe inondato la cavità e ci avrebbe fatto annegare come topi in trappola. Perciò, al buio, abbiamo trascorso le ore pregando o cantando. Ma più i giorni passavano, più la nostra disperazione aumentava». Nessuna certezza, solo la voglia di resistere. «Senza sapere quanto tempo dovrai ancora patire la fame, la sete e il freddo, l’attesa diventa insopportabile. Ho detto agli altri di non bere l’acqua di mare, ma lo hanno fatto ed è stato peggio perché poi hanno avuto anche i crampi».
Per Harry era il secondo tentativo. Aveva già provato a fuggire dalla Nigeria nel 2020 su una petroliera diretta in Norvegia. Ma all’arrivo è stato respinto e riportato a Lagos. «Lì, la mia vita non ha senso, per questo ci ho riprovato. Io e la mia famiglia abbiamo subito le violenze della guerra, del terrorismo, le minacce di morte, la povertà. Come possiamo vivere senza speranza di futuro?», chiede Harry. Il suo piano prevedeva di chiedere asilo e poi farsi raggiungere da moglie e figlio. «Ho studiato da meccanico, posso lavorare sodo, perché
La sua foto e quelle di altri due migranti arrivati a Las Palmas nel vano timone di una petroliera fece il giro del mondo. Siamo andati a raccogliere la loro storia. Dormire o annegare
non ho diritto divivere? Perché sono nato nella parte sbagliata del mondo?». Neppure la legale Marìa Vieiyra può rispondergli, almeno fino alla decisione del ministro dell’Interno di Madrid Fernando Grande-Marlaska. La prima richiesta di asilo è stata respinta ma le pressioni del Cear, del Segretariato per le migrazioni del vescovado delle Canarie hanno indotto il governo a considerare la possibilità di accogliere i tre. Del caso si sta occupando anche David Melian Castellano, l’avvocato che assiste i compagni di Harry: «Dopo che il ministero ha ordinato l’espulsione immediata abbiamo coinvolto l’Acnur, la Agencia de la Onu para los Refugiados (l’Unhcr, ndr) che ci ha subito appoggiati. È stato un lavoro di squadra e ora per questi ragazzi si profila una possibilità».
LO SCATTO
I tre migranti nigeriani arrivati a Las Palmas dopo 11 giorni di navigazione nascosti nell’ incavo del gigantesco timone della petroliera Alithini II

questo va gestito con molto riserbo, almeno fin quando non verrà presa una decisione definitiva». Per ora, dunque, i ragazzi sono in Spagna, la loro richiesta d’asilo è ancora pendente e tocca alle autorità riconsiderarla. Serviranno almeno sei mesi. Durante i quali i tre provano a riprendersi dalle conseguenze del viaggio. Sono ancora abbastanza scossi, accusano i sintomi di stress post traumatico e sono seguiti da una psicologa.
L’agenzia spagnola per i rifugiati ufficialmente non si pronuncia ma conferma che il caso, anche grazie al clamore suscitato, potrebbe costituire un precedente importante per le politiche migratorie in Spagna. «La vicenda – rivela una fonte anonima – ha attirato l’attenzione. La stampa non ha seguito quasi nessuno dei 30mila disperati arrivati nel 2022, mentre in questo caso, l’interesse è stato forte, nel bene e nel male. Per
Due di loro hanno difficoltà a dormire, dopo che per undici giorni chiudere gli occhi poteva significare sparire tra le onde. Come per migliaia di altri migranti diretti in Spagna. Sono 11.286, secondo il più recente report di Caminando fronteras. Ovvero sei al giorno. Una strage i cui numeri potrebbero persino non essere precisi, al ribasso. Sempre secondo i dati, infatti, sono 241 le imbarcazioni che durante la traversata in mare sono sparite dai radar e mai più ritrovate.
GLORIA RIVA
e potesse tornare indietro, lo rifarebbe?
SAdriano De Gasperis, 54 anni ha gli occhi lividi di chi ha passato troppe notti in bianco. Lo incontriamo nello studio milanese del suo avvocato: «Nella Giustizia, nei giudici, ci credo ancora. Ma persone irrispettose delle leggi mi hanno distrutto la vita. Quindi no, non lo rifarei, resterei al mio posto». Nel momento in cui ci si indigna per l’omertà siciliana che ha permesso a Matteo Messina Denaro di vivere indisturbato tra Palermo e Campobello di Mazara, la piccola storia di ingiustizia subìta da De Gasperis, un civil servant milanese che ha denunciato una truffa di svariate migliaia di euro (e forse più) ai danni dei cittadini e del comune, dovrebbe almeno far riflettere.
Dal ’99 De Gasperis lavora in Atm, l’azienda del trasporto pubblico milanese, dove si occupa di audit e sicurezza. Nel 2012 inizia a sospettare che qualcosa nel sistema di bigliettazione non funziona a dovere, fa una serie di verifiche, riceve confidenze e scopre una falla nel sistema. Quell’anno e poi ancora nel 2015 segnala ai suoi superiori che parte dei ticket di bus e metro venduti ai passeggeri non vengono rendicontati nelle casse di Atm, generando un grave ammanco per le casse del Comune di Milano, che detiene la proprietà di Atm. A parole, i vertici dicono di aver effettuato tutte le verifiche del caso, ma in entrambi i casi le indagini interne non portano a nulla. Tutto in regola, insomma. Nel novembre 2017 il ligio impiegato decide di andare a fondo, invia una segnalazione al sindaco Giuseppe Sala, mettendo in copia il presidente di Atm Luca Bianchi e il direttore generale dell'azienda Arrigo Giana, e allega documenti «da cui deriva un ingente danno
erariale. Le chiedo audizione anche per esporre alcune situazioni da verificare, di dubbia moralità che per anni hanno dilapidato risorse», scrive De Gasperis. Ripartono le indagini interne e si scopre che il dipendente aveva ragione: ci sono degli ammanchi. L’impiegato, a quel punto, dovrebbe diventare l’eroe dei milanesi, capace di mettere al riparo Atm dai furfanti. Le cose vanno diversamente: la reazione dell’azienda è impetuosa, fatta di quattro procedimenti disciplinari, due sospensioni, due denunce penali, fino alla soluzione finale: tre licenziamenti, il primo dei quali adottato dal consiglio di disciplina di Atm a marzo 2019, a distanza di poco più di un anno dalla segnalazione del whistleblower. Già perché De Gasperis è a tutti gli effetti un whistleblower, «un dipendente pubblico che ha segnalato illeciti di interesse generale e che come tale andrebbe protetto». Al contrario, De Gasperis è costretto a difendersi da solo - affiancato dagli avvocati Domenico Tambasco e Gennaro Colangelo - in due processi penali avviati contro di lui dai vertici di Atm, che lo accusano di aver utilizzato una falsa identità per fare segnalazioni scomode, e di aver minacciato di morte i suoi superiori: tutte bugie, come sostiene il Tribunale di Milano che con due sentenze definitive scagiona De Gasperis, giudicando la prima accusa priva di prove valide e la seconda infondata perché il fatto non sussiste.
A inizio febbraio 2022 il Tribunale meneghino ordina il reintegro in azienda di De Gasperis. E cosa fa
“Non lo rifarei”, dice Adriano De Gasperis. Per aver denunciato una truffa ai danni della sua azienda, la milanese Atm, è stato cacciato e ha subìto due processi. Ecco la sua storia
MILANO
La fermata Loreto sulla linea Verde della Metropolitana di Milano

l’azienda? Passa una settimana e il direttore generale, Arrigo Giana, scrive all’ex dipendente dicendo che sì, può tornare al lavoro perché lo ha imposto il giudice, ma dal momento che dei quattro procedimenti disciplinari avviati nel 2019, solo due sono stati messi fuori uso dalle sentenze di assoluzione, Atm lo sospende nuovamente perché intende riattivare i restanti due richiami rimasti in sospeso che, ad aprile sfocano in altrettanti licenziamenti. Gli avvocati Tambasco e Colangelo si oppongono e fanno appello al consiglio di disciplina interno, che tuttavia per colpa di alcune mancanze da parte del Comune, non viene convocato da dieci mesi. A febbraio i legali dell'impiegato presenteranno reclamo anche in appello rispetto alla prima sentenza di reintegro al lavoro, per chiedere la piena applicazione della legge sui whistleblower: «A De Gasperis è stato riconosciuto solo il ruolo di whistleblower, non la protezione che dovrebbe essere garantita per legge», dice Tambasco, che sintetizza la vicenda così: «È abnorme quello che è stato fatto a questa persona, considerato che si tratta di un dipendente che ha fatto gli interessi dell’azienda». Perché accanirsi tanto contro una persona che ha sventato un raggiro a danno dell’azienda? Solo in seguito alle segnalazioni inviate al sindaco di Milano i vertici di Atm avviano l’ennesima indagine interna, e solo a quel punto il capo della sezione informati-
ca, analizzando alcuni database, nota delle anomalie e individua i colpevoli: la responsabile degli Atm Point e altri dieci dipendenti, ma «nessun dirigente o quadro viene coinvolto o individuato», come scrive la giudice Sara Moglia nell’ordinanza di reintegro al lavoro, citando la denuncia di De Gasperis. Lo stesso consulente tecnico del Tribunale sostiene che l’indagine interna svolta dagli informatici di Atm non ha alcun valore legale, perché si tratta di una serie di documenti stampati ed estratti da un foglio excel, dal quale non è possibile risalire alla fonte perché i dati sono stati cancellati dal server di Atm: svaniti nel nulla. La sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha creduto a quel documento, corroborato da alcuni testimoni e dalla buona fede degli informatici che lo hanno realizzato, e per questo ha licenziato le persone coinvolte. Ma a breve al Tribunale di Milano si aprirà il processo penale al quale parteciperanno i colpevoli (o presunti tali) della truffa, alcuni dei quali non hanno mai confessato di aver intascato quelle poche centinaia di euro, in un caso si parla di 477 euro, e ritengono il licenziamento una totale ingiustizia. Il processo penale, quindi, potrebbe riservare dei colpi di scena.
Prima di tutto voglio dire che quanto sto per raccontare è per il bene di mio marito». Inizia così l’intervista ad Oksana, vedova di guerra e vittima di torture ripetute da parte di alcuni soldati russi durante l’occupazione di Kherson. Suo marito, Oleksiy, era un militare ucraino caduto in combattimento nelle prime ore del 24 febbraio, il giorno dell’invasione, e da quel momento per la donna è iniziato un vero e proprio inferno durato mesi che l’ha portata in più occasioni a desiderare di morire.
«Il 24 Oleksiy mi ha chiamato di mattina presto e mi ha detto: tesoro, è iniziata la guerra. Raccogli tutte le mie cose, gli ordini, le medaglie, i certificati… tutto ciò che trovi e portalo via da casa perché potrebbe essere molto pericoloso se il nemico entra in città e non dovessimo avere il tempo di fuggire. Poco dopo, alle 3 del pomeriggio, abbiamo avuto la nostra ultima conversazione e alle 6 ho iniziato a cercarlo».
«Mi sono vestita e ho camminato fino al ponte Antonivskiy». Dal centro di Kherson, il ponte dista circa 10 chilometri e oggi è ancora una delle zone più pericolose della regione nonostante abbia perso ogni utilità strategica. «Sono arrivata alle 2 circa. C’era l’inferno, c’era l’orrore», qui si ferma e guarda in basso, come se quelle immagini terribili fossero ancora davanti a lei e inizia a martoriarsi le mani, «molte persone uccise, corpi straziati sulla strada, sul ponte. Ero disperata, confusa, non sapevo cosa fare». Ora sappiamo che sulla riva est, dove i russi erano già riusciti a sfondare,
«ci sono stati molti… molti morti. Ho visto i militari russi farsi strada gettando corpi nel fiume».
I soldati ucraini tranquillizzano Oksana, le dicono che il marito sta bene e la convincono a tornare a casa. Tuttavia, «alle 8 del mattino del 25 febbraio un militare mi ha chiamato per dirmi che Oleksiy era stato trovato morto sul ponte». La donna si ferma, continua a muovere nervosamente le mani stringendosi spesso l’indice della destra nell’altra mano, la voce le si spezza per il pianto e chiede una pausa. «Il suo corpo era stato fatto a pezzi e i medici l’avevano ricucito insieme, si vedevano tutti i segni». In ogni caso Oksana decide di seppellirlo «ma eravamo già in piena occupazione, non si poteva neanche uscire».
«Il 3 marzo, dopo 8 giorni, mi ha chiamato una donna che non conoscevo. Ha detto che potevo seppellire mio mari-
Il marito ucciso il primo giornodi guerra, la furia del nemico nell’inferno di Kherson. Oksana ha subito sevizie e un supplizio psicologico. Un chirurgo estetico le ha ricostruito il viso
AL CIMITERO
Oksana davanti alla
tomba di suo marito
Olekseiy morto all'inizio della guerra

to, ma che avevo solo un’ora di tempo». Mentre stavamo celebrando il funerale, tre soldati russi si sono avvicinati. Hanno guardato la cerimonia, si sono girati e se ne sono andati». Malauguratamente Oksana, si trattiene di fronte alla bara più del dovuto. «Quando sono rientrata a casa, ho pensato: finalmente questo giorno è finito. Ma era appena iniziato. A notte fonda ho sentito bussare alla porta. Erano i militari russi. Mi hanno prelevato di forza e portato al cimitero, proprio davanti alla tomba di mio marito, e mi ci hanno lasciato mentre si allontanavano a passo lento. All’improvviso, senza avvertirmi, hanno iniziato a sparare. Ero atterrita e non riuscivo a muovermi. Intorno era tutto buio, non si vedeva nulla, pensavo che sarei morta in quel momento». Oksana racconta di aver sentito delle risate e di essere rimasta immobile per molto tempo. Solo quando si è resa conto del freddo che la faceva tremare ha notato che i soldati russi se ne erano andati e si è incamminata verso casa «piangendo e tremando».
«La volta successiva, alle 2 del mattino del 13 marzo, dei soldati si sono presentati di nuovo a casa mia. Mi hanno detto che avevano ricevuto una lista dove c’era scritto che mio marito era un militare e lo cercavano. Ho risposto che era morto, sepolto ma non si sono fidati e hanno iniziato a perquisire tutta la casa. Purtroppo in camera da letto hanno trovato alcuni indumenti dell’uniforme di Oleksiy ai quali non avevo fatto caso». La situazione a quel punto precipita, «hanno iniziato a urlare che ero la moglie di un nazista e mi hanno minacciato di farmi qualsiasi cosa». Dalle parole sono passati subito ai fatti. «Mi hanno messo un sacchetto in testa, mi hanno legato le mani e mi hanno caricato su una macchina. Una volta arrivati, mi hanno ordinato di spogliarmi fino alla biancheria intima perché avevano visto un tatuaggio sulla mia schiena; poi mi hanno portato nella stanza adiacente dove c’erano dei giovani. Penso fossero partigiani o attivisti ucraini ar-
Un edificio pubblico sventrato da un razzo a Kherson. A destra, vigili del fuoco dentro a un palazzo colpito

restati ma non ne sono sicura perché nessuno parlava. In ogni caso ero l’unica mezza nuda. Uno degli agenti russi ha aperto la finestra e ricordo che tremavo, a marzo qui fa freddo come in inverno. Non mi importava cosa mi avrebbero fatto dopo, volevo solo morire in quel momento, il prima possibile».
«Poco dopo gli agenti sono tornati e hanno chiesto: Kherson è russa?. I ragazzi hanno risposto: Kherson è Ucraina. Mettetevi in ginocchio, hanno detto gli agenti ma i ragazzi si sono alzati e i soldati li hanno colpiti alle ginocchia uno per uno. I militari sono tornati da me e mi hanno detto che se non avessi rivelato dov’era mio marito mi avrebbero fatto la stessa cosa». Oksana era terrorizzata, non parlava. «Mi hanno riportato nella prima stanza dove mi hanno fatto sedere, mi hanno legato i polsi ai braccioli della sedia e mi hanno coperto di nuovo la testa con un sacchetto prima di iniziare a picchiarmi. Poiché non sapevo cos’altro dire se non

che mio marito era morto si sono arrabbiati e hanno iniziato a strapparmi le unghie; a tratti mi sembrava di svenire, ma loro nel frattempo continuavano a picchiarmi. Ho chiesto mentalmente a Oleksiy di portarmi via da quel posto, di proteggermi. Quando mi hanno buttato fuori dall’auto nella strada sotto casa mia, era già l’alba. Mi hanno scaricato a terra e hanno aspettato che qualcuno venisse ad aiutarmi perché non avevo la forza di muovermi».
In seguito i soldati sono tornati a casa di Oksana 9 volte, «mi hanno picchiato, minacciato, insultato, torturato con l’acqua bollente… hanno picchiato anche il mio cagnolino». Le chiedo se ha mai subito violenze sessuali durante quelle visite.
«Ero molto preoccupata che mi violentassero la prima volta, quando sono stata spogliata nella prigione. Ma mi avevano picchiato talmente tanto che ero ridotta a un ammasso di carne maciullata, qualcuno mi ha anche detto che gli facevo schifo», quasi le viene da ridere e le pesanti labbra rifatte gonfiano gli zigomi, anch’essi con i segni della chirurgia estetica.
A causa delle violente percosse subite il 13 marzo, Oksana ha avuto bisogno di un’operazione chirurgica. «I muscoli vicino all’occhio si erano strappati durante la tortura» e non riusciva a vedere bene, «sembravo un mostro». Prende il cellulare per cercare delle foto e mostra delle immagini che non so come ha il coraggio di conservare. Si vede il suo volto tumefatto, gli occhi gonfi e neri e i segni su tutto il viso. «Mi vergognavo anche di uscire». Finalmente il 14 luglio è riuscita a operarsi «ho avuto un medico molto bravo, grazie a Dio, nonostante fosse russo; mi ha anche consigliato di uscire e parlare con qualcuno, di non restare isolata. Ma io non volevo vedere nessuno, tra i vicini c’era chi aveva iniziato a chiamarmi Lady Frankenstein».
Oggi Oksana vive a Kherson, in una casa che la maggior parte del tempo è senza corrente a causa dei bombardamenti costanti. Attualmente è «in fase di riabilitazione» ed è seguita da uno psicologo, «ma ho molte questioni in sospeso». Nel suo appartamento ospita soldati del reggimento di suo marito di passaggio e si occupa di raccogliere cibo e beni di prima necessità che poi distribuisce al fronte. Dice che ha scritto più volte a Zelensky e al governo per chiedere un riconoscimento per Oleksiy ma non le hanno mai risposto, «hanno nominato “eroi dell’Ucraina” persone che non hanno mai combattuto, gente che non si è mai mossa da Kiev, di Oleksiy e di tanti come lui non gli interessa». Anche per questo resta a Kherson, oltre che per il volontariato: «Aiutare questi soldati è un modo per tenere viva la memoria di mio marito».

Dopo avermi massacrata ero ridotta a un ammasso di carne maciullata. Per questo non mi hanno stuprata.
Sono ancora in terapia, ho molte questioni in sospeso

Dal Getty di Los Angeles
al Met di New York. Così opere e reperti di età greco-romana
trafugati finivano nelle sale espositive più famose del mondo. Grazie a una rete di predoni. Anche italiani

MERCANTE SICILIANO
Giovanni Franco Becchina, detto Gianfranco, classe 1939. Imprenditore di Castelvetrano, qui ritratto nella sua biblioteca
Castelvetrano, 1985. Jiri Frel, già curatore del museo Getty di Los Angeles, entra nella casa di un mercante d’arte siciliano. Lo studioso di origine cecoslovacca non sa nulla di mafia, ignora di trovarsi in un centro storico dominato da una delle più potenti famiglie di Cosa nostra. A riceverlo è Giovanni Franco Becchina, detto Gianfranco, classe 1939. Frel lo conosce solo come valido fornitore di pezzi d’arte antica, con clienti dalla Svizzera agli Stati Uniti, che ha già venduto al Getty più di cinquanta preziosi reperti classici. New York, 2022. L’agente speciale Robert Mancene fa irruzione nella residenza di una ricca vedova americana, Shelby White. Il poliziotto sventola un decreto di perquisizione, firmato il 27 aprile dal giudice Ruth Pickolz, e sequestra 18 antichità greche e romane, che valgono almeno 24 milioni di dollari. Il blitz giudiziario in quell’appartamento di One Sutton Place South fa scandalo nell’alta società: la signora è una nota mecenate e con il marito Leon Levy, un magnate di Wall Street morto nel 2003, aveva donato venti milioni al Metropolitan Museum per ampliare un’ala da dedicare proprio all’arte greca e romana. Entrando così nel consiglio direttivo del Met, il museo più importante degli Stati Uniti. A collegare Castelvetrano a New York, a unire gli affari siciliani di quarant’anni fa con le indagini odierne negli Usa è una serie di personaggi al confine tra due mondi in apparenza lontani: criminalità e arte. Il più chiacchierato, oggi, è proprio Becchina. In questi anni l’imprenditore di Castelvetrano ha rivendicato più volte di non essere stato mai condannato per alcun reato. Nel 2018, però, la Commissione Antimafia presieduta da Rosy Bindi lo ha bollato come «vicino sia alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara sia a quella di Castelvetrano», che è risultata «attiva anche nel commercio illecito di reperti archeologici provenienti da scavi clandestini nell’area di Selinunte», con «interessi facenti capo a Matteo Messina Denaro e, prima ancora, a suo padre Francesco».
Nel decreto della primavera scorsa, il giudice americano spiega che ci sono «ragionevoli motivi» per ritenere che la vedova White fosse entrata in possesso di «opere rubate». Dei 18 reperti sequestrati, almeno otto sono passati dalle mani di Becchina, come ha confermato un portavoce del Met all’International Consortium of Investigative Journalists (Icij), con cui L’Espresso collabora da anni. La nostra inchiesta giornalistica ha cercato di ricostruire come quelle opere siano potute finire nel patrimonio della mecenate di New York. E in che modo molti altri tesori d’arte antica siano stati rivenduti, dopo vari passaggi e mediazioni internazionali, a grandi musei europei e americani.
Tra i maggiori intermediari, oltre a Becchina, spicca un altro italiano, Giacomo Medici, condannato a Roma, nel 2011, a otto anni con sentenza definitiva. Nelle carte di New York compaiono anche un mercante inglese, Robin Symes, e un collezionista americano, Robert “Bob” Hecht, coinvol-

Nelle indagini Usa spuntano personaggi al confine tra mafia e mecenatismo.
Il principale mediatore è Gianfranco Becchina, di Castelvetrano.
Avrebbe legami con Matteo Messina Denaro
to a Roma in un processo (parallelo a quello contro Giacomo Medici) assieme a Marion True, ex curatrice del Getty, subentrata a Jiri Frel. Entrambi sono stati salvati dalla prescrizione, come del resto lo stesso Gianfranco Becchina.
Per ricostruire la provenienza e il turbinio di trasferimenti delle opere poi finite a Shelby White, L’Espresso ha chiesto l’aiuto di tre esperti: il docente greco Christos Tsirogiannis, professore alla Ionian University e consulente della procura di New York; e gli archeologi italiani Maurizio Pellegrini e Daniela Rizzo, che hanno collaborato con i magistrati di Roma nel processo a Giacomo Medici. I tre studiosi hanno fatto un lavoro certosino: ricerche sui cataloghi dei musei, confronti con le foto sequestrate, analisi del patrimonio dei coniugi Levy-White, che nel 1990 esposero al Met duecento opere di loro proprietà in una mostra dal titolo “Glories of the Past”. Becchina aveva agganciato Levy e White nel 1987, vendendo loro varie ceramiche, an-
che etrusche. All’epoca il mercante siciliano era al culmine della carriera. Aveva già piazzato altre antichità in Europa, in particolare al Louvre e al museo statale di Monaco di Baviera. Il legame con il Getty risale almeno al 1976. Nel 1983 c’è un grosso guaio: Becchina offre al museo californiano, al prezzo di 10 milioni di dollari, un kouros greco, ovvero una statua in marmo di un giovane nudo. L’affare sfuma perché un famoso critico italiano, Federico Zeri, consulente del Getty, etichetta l’opera come «un falso». Becchina però resta in auge. E due anni dopo, a Castelvetrano, incontra Frel, appena rimosso dalla carica di curatore del Getty con l’accusa di aver fatto troppi acquisti a prezzi gonfiati. Con pezzi di dubbia origine, probabilmente trafugati. Tra il 2005 e il 2010 il museo californiano restituisce all’Italia i primi 43 reperti etruschi e greco-romani, mentre lo scandalo si allarga: il Boston Museum ne rimpatria 13, il Met di New York altri 20.
Questa svolta ha la sua genesi in una se-

rie di inchieste avviate in Italia su Medici e sullo stesso Becchina, che nel 2001 viene indagato a Roma per ricettazione ed esportazione illegale di opere d’arte. Nel maggio 2002 gli inquirenti svizzeri, su richiesta italiana, perquisiscono la sua galleria d’arte antica, chiamata Palladion e da lui fondata con la moglie Ursula a Basilea, dove aveva messo radici dagli anni ’70. Da lì e da altri depositi emerge un catalogo enorme, ribattezzato «archivio Becchina»: a quello ufficiale, con 13 mila documenti e quattromila fotografie, se ne aggiunge uno «riservato», con immagini di altri 3.164 reperti. Molti provengono dalla Puglia. E oltre il 90 per cento dei «vasi apuli» risulta avere un’unica fonte: Raffaele Monticelli, poi condannato come «tombarolo», annotano gli inquirenti di New York.
A Roma, intanto, il processo è lentissimo: Becchina approfitta delle leggi italiane e ottiene la prescrizione per tutti i reati, già nel 2011. Il giudice Rosalba Liso gli nega però l’assoluzione, scrivendo nella sentenza che «la copiosa documentazione acquisita attesta che quegli oggetti provengono da scavi clandestini: qualsiasi provenienza legittima è da escludere».
Il professor Tsirogiannis conosce bene l’archivio Becchina. È stato lui a identificare le opere sequestrate a New York, orientando le indagini guidate dal viceprocuratore Matthew Bogdanos, un ex colonnello dei Marines. Lo studioso greco chiarisce che sono arrivate alla vedova White «tramite una catena di rivenditori». E precisa a L’Espresso di aver riconosciuto almeno otto reperti provenienti dall’archivio Becchina: fibule in bronzo, argento e oro di oltre duemila anni fa, piatti decorati da antichi pittori greci e «un’anfora a figure nere» del sesto secolo avanti Cristo, attribuita al celebre ceramista Nicostene, che vale da sola almeno 250 mila dollari.
Gli archeologi Pellegrini e Rizzo aggiungono altri dettagli cruciali. Nell’archivio sequestrato a Becchina, ad esempio, c’è una vecchia Polaroid con la scritta: «Foto già in-
viata al signor Levy», proprio il marito di Shelby White. Il quale salda con un assegno di 28 mila dollari la fattura emessa dal mercante di Castelvetrano il 28 agosto 1987. Stessi passaggi per un «guttus», un «vaso apulo a figure rosse» del 330 avanti Cristo che il signor Levy ha acquistato il 15 marzo 1988, a New York. L’archivio svizzero di Becchina, con la sua miniera di vecchie Polaroid, è citato anche in un secondo decreto di sequestro, firmato l’11 luglio 2022 da un altro giudice di New York. È sempre l’agente speciale Mancene a presentarsi, questa volta, nella sede del Metropolitan Museum, al 1000 di Fifth Avenue, per prelevare altre 21 opere che valgono più di 11 milioni di dollari. Anche in questo caso ci sono «ragionevoli motivi» di credere che siano state «saccheggiate». E proprio in questi giorni le autorità americane stanno cominciando a restituirle all’I-

Alcuni oggetti sottratti ai siti archeologici e venduti Oltreoceano sono stati sequestrati a una ricca vedova di Manhattan. Le autorità americane procedono con le restituzioni al nostro Paese
Sopra e a sinistra: alcune delle opere e dei reperti fotografati nell’archivio di Gianfranco Becchina e finiti al centro delle indagini americane sul traffico d’arte al Met e al Getty. A destra: l’arresto di Matteo Messina Denaro. Sul sito de L’Espresso, l’inchiesta integrale con il consorzio Icij e tutte le foto dei reperti che verranno restituiti all’Italia
talia, come ha confermato pubblicamente il viceprocuratore di New York.
Gli studiosi italiani Pellegrini e Rizzo hanno identificato molte altre opere dell’archivio Becchina, come un vaso d’argento del sesto secolo avanti Cristo, valutato 300 mila dollari; uno in vetro con manici d’argento da 400 mila; tre elmi corinzi da mezzo milione; una «testa in marmo di uomo con barba» da 350 mila dollari; una «statuetta in bronzo di Giove» che ne vale altrettanti.

La procura di New York collega a Becchina, definendolo «noto trafficante», anche un «gruppo di sculture in terracotta» quasi a grandezza naturale, chiamato «Poets and Sirens» (in italiano, Orfeo e le sirene), del valore di otto milioni di dollari. Secondo gli inquirenti americani, il mercante di Castelvetrano lo comprò da ladri italiani, che l’avevano estratto da una tomba vicino a Taranto. Poi l’ha «contrabbandato» in Svizzera, dove l’ha fatto ripulire e restaurare, per offrirlo a un banchiere elvetico che

nel 1976 ha gestito come broker la cessione finale al museo Getty.
Con l’arte e l’archeologia Gianfranco Becchina è diventato ricchissimo. In Sicilia ha comprato tenute agricole, aziende, immobili, perfino una parte del castello di Castelvetrano. Unico errore, un’impresa edilizia con un socio mafioso. Sei anni fa, i suoi legami siciliani gli sono costati una confisca. Nella motivazione, riportata da Lirio Abbate nel libro-inchiesta “U Siccu” su Matteo Messina Denaro, il tribunale di Trapani spiega che «pur non avendo riportato condanne per associazione mafiosa, le sue frequentazioni, i suoi traffici e i rapporti diretti con gli ambienti della criminalità organizzata di tipo mafioso castelvetranese rendono attuale e rilevante il suo grado di pericolosità qualificata». Quando la Dia, il 15 novembre 2017, gli ha notificato la confisca, non ha trovato nessun archivio: la biblioteca del palazzo di Becchina, con tutte le sue carte, è bruciata proprio quel giorno per un misterioso incendio.


























































































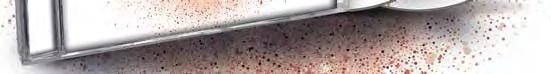







 Virman Cusenza
Virman Cusenza

Un fantasma si aggira per il Parlamento: le commissioni bicamerali. Nella scorsa legislatura erano addirittura 18. Ma, a oltre tre mesi dal debutto, ancora – con l’eccezione del Copasir – non ce n’è traccia. Per le commissioni di inchiesta, poi, un problema in più: serve una legge, da rifare per ogni legislatura. Perché? «Nel caso dell’Antimafia altrimenti sarebbe come istituzionalizzare la mafia», è la battuta che circola nel Palazzo. Risultato: al momento dell’arresto di Matteo Messina Denaro, il Parlamento non ha potuto fare tempestivamente il suo mestiere, scavando lo scavabile con i poteri
che avrebbe. I più ottimisti prevedono che i 25 deputati e gli altrettanti senatori non si insedieranno prima di fine marzo, se va bene. È l’andazzo delle ultime legislature. L’Antimafia del Parlamento eletto a febbraio 2013 cominciò i lavori solo il 21 ottobre (8 mesi dopo). Quella della legislatura cominciata a marzo 2018 si insediò il 14 novembre. Se la mafia è un’emergenza, perché il Parlamento non si mobilita con un automatismo a ogni legislatura per non farsi cogliere impreparato?
Un terzo delle confische resta al palo È una piaga nella piaga. Prima il sequestro, poi la confisca, ma alla fine poco o nulla. Nel 2021 il 33 per cento dei 19.255 beni requisiti alle organizzazioni criminali non ha trovato destinazione. Il risultato sconsolante arriva dal report dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la desti-
La legislatura è iniziata da oltre tre mesi, ma mancano le commissioni d’inchiesta. Una prassi consolidata
nazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La sequenza virtuosa si inceppa proprio nel chilometro finale. Una bella fetta dei beni resta sul groppone dello Stato, costi e oneri di gestione compresi. Sono ben 6.486 gli immobili, i terreni e le imprese in attesa di destinazione. Molte aste vanno deserte. Il meccanismo non funziona, lo dimostrano i beni assegnati a fine 2021: l’82 per cento agli enti locali, il 13 resta nella disponibilità dello Stato, solo il 4 per cento degli edifici venduto e appena l’1 reintegrato nel patrimonio aziendale. Catturare il Padrino e confiscarne il patrimonio non basta.
Corsa alle onorificenze: 3.500 l’anno «Una croce da cavaliere e un mezzo toscano non si negano a nessuno». Folclore a parte, il motto di Vittorio Emanuele II ha subito in 160 anni interpretazioni più restrittive. Dal 1951 il tetto massimo alle cariche onorifiche viene fissato con un decreto del presidente della Repubblica su proposta del premier. Nel Cdm del 12 gennaio scorso si è deciso di lasciarlo a quota 3.500 titoli. Non sono pochi, il numero è costante negli ultimi anni. Così ripartito: 20 cavalieri di Gran Croce; 80 grandi ufficiali; 300 commendatori; 500 ufficiali e ben 2.600 cavalieri. La legge sull’Ordine al merito della Repubblica è chiara: il capo dello Stato può assegnarne per sua iniziativa un quindicesimo del totale, ovvero 233. Una piccola quota destinata a valorizzare casi simbolici, per merito sociale, per chi si è distinto nella lotta al Covid-19 o per meriti sportivi. Tocca poi a Palazzo Chigi stabilire la ripartizione con i ministeri: queste onorificenze “ordinarie” sono firmate per la Festa della Repubblica (2 giugno) e della Costituzione (27 dicembre). Insomma, almeno sul fronte dei titoli onorifici, niente strappi. Destra, sinistra e governi tecnici marciano alla stessa velocità, sotto l’occhio vigile del Colle.
Agnelli, Benetton, Berlusconi. Le grandi famiglie imprenditoriali contano meno che in passato. I nuovi ultraricchi sono lontani dal potere. Mentre prosperano le imprese pubbliche
PROTAGONISTI
In senso orario: Luciano Benetton, Gianni Agnelli, Adriano Olivetti e Raul Gardini




SCANDALO
A destra: Ernesto Bertarelli (farmaceutica).
Vent’anni senza l’Avvocato. Vent’anni di estinzione, neppure troppo lenta, di quella che fu la grande borghesia imprenditoriale. La morte di Giovanni Agnelli, il 24 gennaio 2003, per chi cerca simboli, rappresenta l’inizio di una decadenza che oggi si pesa e non si conta, per usare l’espressione di Enrico Cuccia, l’ultimo architetto di un potere tramontato. Se ci si limita a confrontare le cifre, non si possono avere dubbi. L’ultimo ventennio ha visto crescere la ricchezza dei ricchi a ritmi senza precedenti nella storia. Nella classifica dei miliardari pubblicata da Forbes, l’italiano più ricco anno Domini 2003 era l’allora presidente del Consiglio in carica, Silvio Berlusconi, ultimo profeta del magico accordo potere più grana. Il premier forzista aveva un patrimonio stimato in 5,9 miliardi di dollari ed era il numero 45 al mondo. Oggi è accreditato di 7,1 miliardi, praticamente un aggiornamento Istat, ed è retrocesso al quarto posto fra gli italiani negli asset e al quinto nel consenso elettorale, persino dietro al neopauperista Giuseppe Conte.

Nella classifica dei ricchissimi 2023, il Cavaliere è surclassato dal numero uno Giovanni Ferrero (36,2 miliardi di dollari): figlio dell’inventore della Nutella, Michele, morto a Montecarlo nel 2015, che vent’anni fa era al quarto posto in Italia e numero 94 al mondo, con 3,5 miliardi, ossia un decimo di quello che l’erede ha in mano adesso.
Dal 2003 ha resistito, anzi, ha prosperato l’impero EssilorLuxottica creato da Leonardo Del Vecchio, morto a giugno dello scorso anno. L’impero mondiale degli occhiali ha conservato la seconda posizione di vent’anni fa e ha quintuplicato la ricchezza da 5,6 a 27,3 miliardi. Terzo è Giorgio Armani, 88 anni, con asset per 7,8 miliardi, deciso a difendere il baluardo del made in Italy insieme ai coniugi Patrizio Bertelli-Miuccia Prada, nono e decima rispettivamente fra i miliardari 2022. Nella top ten di oggi, a parte Berlusconi, 86 anni, non ci sono figure pesanti nel senso che Cuccia avrebbe dato all’aggettivo. Cibo, moda, Ferrari, le cucine De’Longhi e la Menarini farmaceutica di Massimiliana Landini Aleotti, prima delle
Sotto: Andrea Agnelli, che ha lasciato gli incarichi dopo lo scandalo Juventus

Nella classifica dei patrimoni in testa c’è
Giovanni Ferrero. Il Cavaliere è sceso al quarto posto.
John Elkann, primo della sua famiglia, è ventiseiesimo
miliardarie e al quinto posto generale. Tanti soldi certamente. Ma la capacità di agire sui meccanismi del potere con il gianduia e le montature Ray-Ban è trascurabile.
Per trovare il primo erede dell’Avvocato, maestro nei rapporti con il Palazzo romano fino allo schiaffo delle visite in Mercedes di Berlusconi, bisogna scendere alla ventiseiesima piazza con John Elkann. Poco sopra ci sono i fratelli Luciano e Giuliana Benetton. Quarantesimo è il petroliere Massimo Moratti, comproprietario della Saras con gli eredi del fratello maggiore Gianmarco, scomparso a febbraio del 2018. Nella migliore delle ipotesi l’alta borghesia imprenditoriale italiana ha un potere soft. Nella peggiore cerca di badare a sé stessa temendo, o sperando, di finire in mano al capitale straniero com’è successo a Tim e a Pirelli, a Versace e a Valentino. L’ultimo rapporto Kpmg su fusioni e acquisizioni afferma che su 1.184 operazioni per un totale di 80 miliardi di euro in Italia, quelle dei fondi esteri sono state 131 per 19 miliardi contro 12,1 miliardi del 2021. È solo l’inizio.
Non si sarebbe potuto immaginare un periodo più grigio per la famiglia che da un secolo è sinonimo di potere in Italia. Andrea Agnelli, ultimo maschio della dinastia a portare il cognome del fondatore della Fiat, il senatore Giovanni nonno dell’Avvocato, è appena uscito dai consigli di amministrazione della holding di diritto olandese Exor, della partecipata Stellantis e dell’amatissima Juventus, già presieduta dal padre Umberto e dallo zio Gianni, in coda a uno scandalo sportivo-finanziario che ha portato quindici punti di penalizzazione ai bianconeri, mentre si attende la seconda e più pericolosa inchiesta sugli ingaggi dei calciatori. Andrea è rimasto nel cda dell’accomandita di famiglia, anch’essa emigrata verso la sede dei Paesi Bassi nel 2016 e nella sua società di investimento, la Lamse.


Dal lato del cugino John Elkann, socio di maggioranza nell’accomandita a monte di Stellantis, il panorama è rattristato dalla lite familiare con la madre Margherita sull’asse ereditario che si trascina a ondate dalla morte dell’Avvocato.
Sotto il profilo industriale, l’azienda che ha dominato l’automotive italiano dagli inizi è sempre meno italiana e sempre più dei francesi che guidano il cda con sei consiglieri su undici. Il marchio di fabbrica del fondatore è stato accantonato e sopravvive come brand dopo la fusione Fca-Psa del 2020. Le fabbriche italiane di Stellantis sembrano costantemente sub judice, se non in via di chiusura come lo stabilimento Maserati di Grugliasco. Dopo la fine dei contratti di solidarietà nella fabbrica di Pomigliano d’Arco pochi giorni fa, mentre Melfi ha registrato una contrazione nonostante il traino della Panda, il primo appuntamento con il nuovo governo è stato fissato il 14 febbraio al Mise guidato da Adolfo Urso.
La filiera della componentistica, che soprattutto nel Nordest dell’Italia era stata protagonista di un boom di medie e piccole imprese, ha dovuto fare i conti con la
Foto: Fabio Ferrari/LaPresse, Sbastien Agnetti / 13 Photo / Contrasto Fotonuova realtà di un committente che non riesce più a lavorare a piena capacità. Chi non ce l’ha fatta ha chiuso. Fra chi ha resistito molti sono passati al servizio dei colossi tedeschi come Mercedes Benz e Bmw, 168 e 111 miliardi di ricavi 2021 rispettivamente contro i 152 di una Stellantis a conduzione transalpina.
La catastrofe del viadotto Morandi a Genova, il 14 agosto 2018, ha segnato la storia di un gruppo che si vantava di affidare la guida operativa a manager esterni. Il potere di Giovanni Castellucci in Autostrade-Aeroporti di Roma-Atlantia ha sempre più condizionato le scelte della direzione strategica formata da Gilberto Benetton e Gianni Mion. Oggi, i processi penali che hanno travolto la prima linea del manager marchigiano, la scomparsa di Gilberto due mesi dopo il crollo del Morandi e
la chiacchierata cessione di Autostrade a Cdp-Macquarie-Blackstone per 8,2 miliardi di euro hanno riportato la holding Edizione nelle mani di Alessandro, 58 anni, figlio di Luciano, 87 anni.

Con la leadership che gli riconoscono gli altri rami della famiglia, Alessandro sta elaborando i nuovi confini del gruppo che si era adagiato sugli automatismi dorati delle concessioni.

L’operazione con Dufry, ideata dall’ad di Autogrill Gianmario Tondato Da Ruos che lascerà la carica il 6 febbraio per diventare presidente delle attività Usa, è un’integrazione sul modello di quella tra Fca e Psa. Autogrill andrà verso il delisting e Dufry cambierà nome. L’obiettivo dell’operazione è passare da un mercato globale di 25 miliardi di dollari a un mercato da 130 miliardi, attraverso un ritorno alla diversificazione che era stato bocciato nel 2015, quando il gruppo macinava profitti dalnell’età postindustriale, dove i beni principali prodotti diventano immateriali. Sono servizi, informazioni, simboli, valori, estetica. Col mutare delle principali fonti di guadagno, cambiano anche i soggetti che le possiedono, cioè quella che chiamiamo borghesia (con qualche approssimazione). Quindi oggi chi conta non sono più le famiglie titolari di grandi fabbriche, ma sono i proprietari di aziende di trasporti, tv, internet, moda. Il fatto che la Apple sia un’azienda più ricca della Exxon, spiega la gerarchia di oggi».
on credo che la borghesia sia sparita. È cambiata. È diversa da quella delle grandi famiglie industriali dei decenni passati, ma denaro e potere continuano a essere strettamente legati». Domenico De Masi, sociologo celebre, è professore emerito alla Sapienza di Roma dove è stato anche preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, sulla società postindustriale ha concentrato parecchi dei suoi studi. Rispetto al passato e guardando il futuro vede mutamenti importanti, anche nelle gerarchie sociali. Professore, esiste ancora la borghesia?
«Borghesia è un termine un po’ vago, che si riferisce a una realtà molto ampia. Proviamo a tracciare un perimetro. Dalla rivoluzione francese a oggi molto è cambiato. Dalla borghesia delle professioni si è passati, nei secoli a quella industriale. Da tempo siamo però
Non è significativo che molti grandi gruppi italiani siano passati in mani straniere?
«Oggi dire che un’azienda è italiana o francese significa poco. Le imprese in realtà sono in mano alla finanza, che per definizione è globale. Quindi, se chiamiamo borghesia la classe che ha il potere, è una classe che opera su scala globale. Del resto, anche il potere politico non agisce più nella dimensione nazionale. A contare politicamente sono Stati Uniti, Cina. Gli altri si accodano».
Ma si può ancora parlare di classe? E di lotta di classe?
AL VERTICE
Sopra: Alessandro Benetton. Guida il gruppo di famiglia. A sinistra: Giovanni Ferrero, primo nella classifica degli italiani più ricchi: a destra: Domenico De Masi


«Già Marx sosteneva, distinguendo tra classe “in sé” e classe “per sé”, che la classe non è un fatto “oggettivo”. ci vuole anche la coscienza di esserlo. Allora ci si organizza per difendere i propri interessi, con un sindacato o un partito. I movimenti nascono dal basso, a volte riescono a “istituzionalizzarsi” e diventano partiti, a volte riescono, a volte no. Per esempio. I Cinque Stelle ci stanno riuscendo, le Sardine no. Quanto alla lotta di classe, lo ha spiegato bene il famoso finanziere americano Warren Buffett: “C'è una lotta di classe, è vero, ma è la mia classe, la classe ricca, che sta facendo la guerra, e stiamo vincendo”. Dopo i trent’anni keynesiani e del welfare, dagli anni ’80 hanno prevalso le politiche neoliberiste. Il risultato è la gigantesca disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza che oggi abbiamo di fronte. Nel 2017, secondo Forbes, le otto persone più ricche del mondo mettono insieme quanto 3,6 miliardi di persone, cioè metà dell’umanità. E il processo si è accelerato negli ultimi anni. In Italia nel 2007 le 10 famiglie più ricche aveva-
le autostrade con una stretta sempre più soffocante sugli affitti per il food&oil, passati dal 7 al 17 per cento e soprattutto grazie all’accordo sull’adeguamento automatico dei pedaggi strappato dai lobbisti di Castellucci nel 2008. Oggi il rapporto con la politica è gestito dal presidente di Edizione, Enrico Laghi, uomo dai mille incarichi (Pirelli, Tim, Fendi, Finnat, Unicredit, Alitalia, Ilva) capace di entrare in sintonia con ogni tipo di governo.
QUEI PULLMAN VERSO IL BRIANTEO
L’età passa per tutti. Ma Silvio Berlusconi ormai sembra accontentarsi di miracoli minori. Chi lo ha visto alla festa del Monza, diventata virale per il video in cui l’ex premier prometteva ai calciatori un pullman carico di sex workers, per così dire, notava con tristezza l’appello rivolto dal fonda-
no una ricchezza pari a quella di 3,5 milioni di poveri. Oggi le stesse dieci famiglie possiedono quanto sei milioni di poveri». Come si ripercuote tutto questo sul mondo del lavoro?
«Le trasformazioni sono enormi. Non solo sono diminuiti gli operai e aumentati gli addetti ai servizi. Ma si lavora molto meno, molto del lavoro è compiuto dalle macchine. Due dati: nel 1901 gli italiani erano 40 milioni e lavoravano per 70 miliardi di ore all’anno. Oggi siamo 60 milioni e le ore lavorate sono 40 miliardi. Si diffondono lavori sottopagati, cresce il rischio di disoccupazione. Operai e impiegati alla lunga scompariranno. Forse con l’intelligenza artificiale e la robotica scompariranno perfino i chirurghi! Diventerà invece sempre più importante chi svolge un lavoro creativo. Quelli sono insostituibili, almeno per quanto possiamo vedere ora. Artisti, calciatori, musicisti ecc. saranno i veri padroni dell’immaginario e quindi domineranno la società. I creativi supportati dall’I.A. saranno i padroni del mondo di domani».

In un anno le operazioni di fondi esteri in Italia sono passate da 12 a 19 miliardi. I gruppi nazionali che sono rimasti anche centri di potere si contano sulle dita di una mano
Pier Silvio Berlusconi. È amministratore delegato di Mediaset, che fa registrare dati finanziari in calo
tore di Forza Italia alle decine di piccoli e piccolissimi imprenditori presenti perché si tassassero di qualche migliaio di euro in favore del club brianzolo portato dalla Lega Pro alla serie A in quattro anni. Berlusconi e la sua holding Fininvest stentano a pensare in grande. Delle tre teste del gruppo (Mediaset, Mondadori, Mediolanum) la più efficiente è la banca guidata da Ennio Doris fino alla morte nel novembre 2021 e passata ora al figlio Massimo. Mediolanum ha incassato 713 milioni di profitti netti nel 2021 e nei primi nove mesi del 2022 è a quota 371 milioni, in leggero calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La Mondadori della primogenita Marina Berlusconi è tornata al dividendo nel 2021 dopo dieci anni mentre Mediaset, dove il fratello Pier Silvio è sempre in cerca di partnership europee dopo il trasferimento di sede in Olanda, presenta dati fi-
nanziari in calo. I primi nove mesi dell’anno scorso registrano un utile di 78 milioni, pari a -71 per cento del periodo precedente. Per il solo Monza Silvio e il suo braccio destro esecutivo Adriano Galliani hanno speso oltre 120 milioni di euro. Dai trionfi del Milan a San Siro allo stadio Brianteo il declino è nei fatti.
ALLA FINE, VINCE LO STATO
Alla fine nell’isolotto del potere politico-finanziario italiano, sempre più sommerso dall’acqua alta, i gruppi nazionali che sono rimasti anche centri di potere si contano sulle dita di una mano. Nella finanza ci sono Intesa San Paolo e Generali con 42 e 28 miliardi di capitalizzazione di mercato. Francesco Gaetano Caltagirone veleggia all’undicesimo posto tra i ricchissimi con un patrimonio stimato di 3,9 miliardi di dollari. Altri tre miliardari da top ten sfuggono alla lista italiana perché hanno sede all’estero. Sono l’armatore Gianluigi Aponte di Msc (14,6 miliardi) e i due imprenditori farmaceutici Stefano Pessina (9,4 miliardi) ed Ernesto Bertarelli (8,5 miliardi).
Sempre più centrale è l’Eni, che da sola vale tre o quattro ministeri, Farnesina inclusa, ed è sotto controllo pubblico (30 per cento). Il gruppo amministrato da Claudio Descalzi ha dalla sua risultati mostruosi agevolati dalla crisi energetica: 101 miliardi di fatturato nei primi nove mesi del 2022 contro 49,8 dei primi tre trimestri del 2021 e utile netto quintuplicato a oltre 13 miliardi. Certo ci sono elementi eccezionali in questa contabilità, guerra in primis. Ma una holding a guida pubblica che si avvia a scavalcare Generali ed Enel, altra società in capo al Tesoro, in testa alla classifica dei ricavi dice che nell’impresa italiana comanda ancora lo Stato. Come ai tempi dell’Iri.
Per approfondire o commentare questo articolo o inviare segnalazioni scrivete a dilloallespresso@lespresso.it I nostri giornalisti vi risponderanno e pubblicheremo sul sito gli interventi più interessanti
L’Eni, da solo vale tre o quattro ministeri, Farnesina inclusa.
Grazie alla crisi energetica ha più che raddoppiato il fatturato e quintuplicato gli utili nei primi nove mesi dell’anno scorso


La minaccia aleggia, si fa sottile, lascia aperta la porta al dialogo. Una fessura, attraverso la quale passano speranze che diventano illusioni. Fino alla scossa. Scuote gli ingenui e non sorprende i complici. Vince così la mafia in trasferta. Vince facile su un terreno favorevole e quasi sempre porta a casa, la casa madre, il risultato. Succede con la ’ndrangheta che ha messo radici e non da ora anche in Australia, figuriamoci in Nord e Centro Italia. Cosche, le chiamano “locali”, ovunque (25 in Lombardia, 14 in Piemonte, secondo la Dia) e un’unica obbedienza. Perché puoi girare il mondo ma «se sei fermo per la Calabria, sei fermo per tutti». Ricordava un vecchio padrino: «Il mondo si divide in due, quello che è Calabria e quello che lo diventerà». Così due trafficanti promettevano di «mettere in piedi San Luca a Milano». Ovvero la Calabria sotto alla Madonnina. Erano legati alla locale di Mariano Comense guidata da Giuseppe Morabito. E un imprenditore suo amico ha finito per mettere nei guai l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani e il sindaco di Seregno, Edoardo Mazza.
In nome degli affari alcune regole, all’occorrenza, diventano duttili. Anche le donne assurgono al ruolo di capi come Caterina Giancotti, 45 anni, «più spietata degli
uomini» nel recupero crediti, ha detto di lei il procuratore aggiunto di Milano Alessandra Dolci. Gestiva i traffici della locale di Rho per conto di Cristian Bandiera, rampollo di Gaetano che frattanto si industriava per uscire dal carcere dandosi malato. «Vuoi che divento cattiva? E io divento cattiva», ammoniva, mentre l’anziano boss, ormai libero, proclamava: «La legge è tornata, la ’ndrangheta è tornata a Rho». E c’era gente in fila alla sua porta, anche solo per dirimere una lite di condominio.
A Reggio Emilia, per i giudici, il legame dei calabresi con la casa madre si era allentato ma era la famiglia di Cutro, il clan Grande Aracri, a operare in città e nelle province di Parma e Piacenza. Per le mafie, per tutte le mafie, vale il principio dell’adattarsi. Nicolino, Mano di Gomma, il patriarca dei Grande Aracri, tentò di accreditarsi come pentito pur di sminare i processi. Ma agli amici di
Grandi opportunità su tessuti economici permeabili. Schiere di professionisti disponibili e politici pronti a scambiare voti e favori. Così quello che era un contagio diventa radicamento
giù corse a dire che si trattava di «una farsa». A Brescello, set di don Camillo e Peppone, il Comune era stato sciolto per mafia. La famiglia Grande Aracri, Francesco, il fratello di Nicolino, con i figli Paolo e Salvatore, ne aveva fatto il proprio quartier generale. Per espandersi, giocando in grande, nel mondo dell’impresa in collegamento con i centri di spesa. Quelli pubblici, del resto, sono l’eldorado, il luogo di incontro tra mafia e politica. A Milano con la Perego strade, eterodiretta dal boss Salvatore Strangio, si tentò l’assalto a Expo 2015. Soldi e voti vanno sempre a braccetto. Giuseppe “Pino” Neri, studio da tributarista ma considerato il capo della ’ndrangheta in Lombardia, nel 2009, si dava da fare per accreditarsi durante la competizione elettorale per il sindaco di Pavia. In città a tenere insieme ’ndrine e politica, del resto, provvedeva l'ex direttore della Asl, Carlo Chiriaco. Un sistema di mutua assi-
stenza come quello instaurato dall’ex assessore regionale Domenico Zambetti che non disdegnava un pacchetto di voti dei Mancuso di Limbadi.
Clan integrati ma con il paese sempre nel cuore. Accumulano, mandano le briciole in Calabria e appostano la ricchezza dove mimetizzarsi è più semplice. Ma alla «mamma» hanno la necessità di rapportarsi. Il contrario della Camorra che un’organizzazione unitaria non riesce a darsela.
A Roma i gruppi criminali sono obbligati a coesistere in perenne fragile equilibrio. «È il re di Roma che viene qua, io entro dalla porta principale...», diceva di sé stesso Massimo Carminati, il boss nero che l’accusa di 416 bis però è riuscito a scrollarsela.
Perché vedere mafia fuori dai territori di origine resta per molti versi ancora un percorso impervio. Clan vecchi e nuovi, gruppi emergenti e colletti bianchi, soprattut-
Un sequestro di beni mafiosi frutto di investimento dei clan
 LE FORTUNE
LE FORTUNE
to loro, possono ancora farla franca. Le segnalazioni di operazioni sospette languono e i reati spia (turbativa d’asta, traffico di influenze, riciclaggio, corruzione e concussione) restano circoscritti. Privi del bollo di mafiosità sembrano poca cosa agli occhi del pubblico che ancora dieci anni fa plaudiva rassicurato a chi gli raccontava di un Nord e di un Centro immuni per diritto divino dalla malapianta. E invece se la ritrovano comoda tanto nelle curve degli stadi quanto nei cda.
Il circolo di Paderno Dugnano con la foto di Falcone e Borsellino dove nel 2009 si tenne il summit delle ’ndrine per decidere il capo della Lombardia. A destra, due boss a Milano. Nell’altra pagina, Mario Draghi

spera di sterilizzare la concorrenza. Da chi spalanca i capannoni a soci munifici e si ritrova per strada. Dai professionisti e dalle banche.
L’intimidazione quasi scolora nella minaccia ambientale, di sistema.
La predizione sciasciana sulla linea della palma è diventata la metafora di quello che chiamano contagio. «E invece è radicamento», ha ribattuto il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. Come ha ricordato lo studioso Rocco Sciarrone, non era alla palma che bisognava guardare ma alla linea. Al paradigma mafioso che si faceva largo, diventando consuetudine del potere. Mafia che si impone ma viene cercata, invocata, blandita, coccolata e protetta. Dagli imprenditori in crisi di liquidità, da chi con la protezione
Ci sono gli investimenti del denaro della droga, la ristorazione - il clan del camorrista Angelo Moccia controllava 14 locali della capitale – il turismo, l’agroalimentare e l’immobiliare. E la Lombardia è quarta per fabbricati confiscati e quinta per numero di aziende. Ma ci sono anche i traffici diretti: i rifiuti - l’ultimo affare in Toscana sullo smaltimento in odore di ’ndrangheta - le guardianie, i subappalti e le girandole delle società cartiere. Servono a frodare il fisco ma sono anche il formidabile passe-partout per entrare nelle aziende e impadronirsene.
Anche il grimaldello del recupero crediti si attiva a richiesta. A rivolgersi al vecchio padrino di Brancaccio, il medico boss Giuseppe Guttadauro che con un’intercettazione aveva spedito in carcere il presidente

della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro, era stata una nobildonna dell’aristocrazia capitolina che pretendeva 16 milioni da Unicredit.Lacommissioneperil disturbo era pari al 5 per cento. Dopotutto di mediazione si trattava. I modi spicci erano messi nel conto e le potenziali vittime già inquadrate. “Il dottore” aveva pure messo in mezzo il figlio Carlo al quale raccomandava un personalissimo senso della modernità mafiosa: «Ti devi evolvere, hai capito? Il problema è rimanere con quella testa, ma l'evoluzione…». Adattarsi, cambiare pelle, pensare mafioso e agire nel business.


Raccontano le carte giudiziarie che un gruppo autonomo di camorristi napoletani chiese il permesso e pagò una tassa ai Casalesi doc per potere spendere, qua-
si fosse un franchising, il nome della ditta per accreditarsi in Veneto. Lì dove avrebbe investito l’ex imprendibile Matteo Messina Denaro e prima di lui il boss palermitano Salvatore Lo Piccolo.
Tra tutti i territori il Veneto è il più appetibile. Ha un tessuto di piccole imprese, cresce più del resto del Paese ma vede aumentare vertiginosamente i comuni interessati da sequestri e confische di beni. Indice di una presenza mafiosa con numeri record, come accertato da uno studio di Antonio Parbonetti, economista dell’università di Padova (L’Espresso, n°23 del 12 giugno 2022), relegato a dossier clandestino da un imbarazzato governo regionale. Racconta di ventimila aziende infiltrate dalle cosche. Troppe per parlare di contaminazione. «Sono venuto qui per imparare», sintetizzò l’ex camorrista Nunzio Perrella, specialista in traffico di rifiuti («La monnezza è oro»), per spiegare che il territorio si prestava all’espansione. Più di recente Mario Crisci, 33 anni da Castel Volturno, un padrino autocostruitosi, con base a Selvazzano, in provincia di Padova, ha raccontato da pentito al pm Roberto Terzo: «Siamo venuti qui perché qui sono disonesti. Più disonesti di noi. Io sono un esperto di elusione fiscale. Qui la gente non ha voglia di pagare le tasse, peggio che da noi. Molti, grazie a me, hanno mandato i capitali all'estero e i loro professionisti erano presenti alle trattative». Centoventi imprese nella rete, in un impasto di convenienze, minacce e ricatti. Un solo testimone. Meridionale.
A Eraclea, l’imprenditore edile casalese Luciano Donadio, da vent’anni in Veneto, avrebbe portato in dote al sindaco i voti necessari a vincere e così il primo cittadino e l’ex sono finiti coinvolti nell’inchiesta per mafia. A Verona, l’indagine sul calabrese Ruggiero Giardino, figlio di Antonio detto “Totareddu” vicino alla cosca degli Arena Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, – interessi edilizi anche in Toscana - è arrivata fin dentro la municipalizzata dei rifiu-
Ai boss, ormai ripulitisi, si rivolgono imprenditori stretti dalla crisi o illusi di sterilizzare la concorrenza con la protezione. Chiedono
fatture false, prestiti o recupero crediti
Un sequestro di armi in Lombardia ai danni due famiglie della ’ndrangheta

ti scaligera, sfiorando l’ex sindaco Flavio Tosi, risultato estraneo. Alla corte dei Giardino studiava Nicola Toffanin veneto che più veneto non si può, detto l’avvocato. Studiava con mire da capo. Veneti i funzionari di banca, i commercialisti amici, le teste di legno messe alla guida delle società della grande lavanderia.
Anche così le mafie lavorano a tutto spiano. Quaranta miliardi di fatturato, due punti di Pil, stima la Cgia di Mestre, escludendo i proventi dell’economia legale che da quei capitali è inquinata. Così l’ordine di grandezze potrebbe crescere fino a 140 miliardi. Un mondo parallelo intorno al quale il Paese orbita. Sono 220 i miliardi attesi con il Pnrr, 31,5 per infrastrutture e gli allarmi si moltiplicano.
«Bisogna proteggerli da una criminalità non solo organizzata ma globalizzata, ormai multinazionale ed essenzialmente finanziaria», ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi a maggio 2022 al trentennale della Dia. E poi ci sono i grandi eventi come le Olimpiadi invernali. Ovunque i mafiosi hanno imparato la lezione. Menano e sparano alla bisogna ma gli affari prosperano se c’è pace. Un mediatore della Piana calabrese, spedito nel Lazio a far da paciere, teorizzava di tene-
re distinte le «ragioni economiche e le ragioni d’onore», le uniche per le quali valga la pena di mettere mano alla fondina. L’indice di penetrazione mafiosa di Transcrime è l’algoritmo da sbattere in faccia a un Paese che preferisce il folklore dell’ultimo Padrino alla sostanza del dramma. È lo stesso ministero dell’Interno ad avvertire che già nove cittadine del Nord pesantemente infiltrate segnano un trend in crescita. Disegnano una rete di compromissione con i politici, certo, e un contorno di funzionari e professionisti proni a mafie che si sono fatte potere. «Per essere mafiosi bisogna essere potenti imprenditori», raccomandava un padrino. Le origini si smacchiano e le indagini, spesso ostacolate appena sfiorano i piani alti, sono esposte ai venti cangianti di una legislazione ondivaga e di una giurisprudenza altalenante.
«La mafia ormai sta nelle maggiori città italiane dove ha fatto grossi investimenti edilizi, o commerciali e magari industriali. A me interessa conoscere questa "accumulazione primitiva" del capitale mafioso, questa fase di riciclaggio del denaro sporco, queste lire rubate, estorte che architetti o grafici di chiara fama hanno trasformato in case moderne o alberghi e ristoranti à la page. Ma mi interessa ancora di più la rete mafiosa di controllo, che grazie a quelle case, a quelle imprese, a quei commerci magari passati a mani insospettabili, corrette, sta nei punti chiave, assicura i rifugi, procura le vie di riciclaggio, controlla il potere».
Lui era Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il generale prefetto mandato a morire a Palermo il 3 settembre del 1982. Parlava così al taccuino di Giorgio Bocca (Repubblica, 10 agosto 1982) pochi giorni prima di essere ammazzato con la moglie Emanuela e il poliziotto Domenico Russo. La mafia non era ancora nel codice penale. Ci sarebbe entrata solo dieci giorni dopo con la legge che porta il nome di Pio La Torre, il segretario regionale del Pci ucciso con Rosario Di Salvo il 30 aprile precedente. Non esisteva eppure vinceva. In casa e fuori.
Una stima prudente indica in 40 miliardi il fatturato delle organizzazioni, ma non tiene conto dell’enorme flusso di soldi che inquinano l’economia legale, falsando le regole del mercato
Era domenica quel 19 luglio 1992 e io, rientrando in auto dal meraviglioso weekend in Cilento, ero incolonnato al casello autostradale. La strage di via d’Amelio avvenne alle 16.58 e passò pochissimo tempo per la diffusione capillare della notizia. La appresi dalla radio, che interruppe quella musica domenicale adatta a conciliare l’ozio e il rientro da giornate estive. Fu subito rabbia. E sgomento, perché non c’era stato nemmeno il tempo di capire cosa fosse accaduto due mesi prima a Giovanni Falcone.
Ero appena laureato e, come per tanti giovani di allora, questi episodi criminali sono

stati determinanti per scegliere da che parte stare per tutto il resto della vita.
L’anno dopo Matteo Messina Denaro, che era stato tra i mandanti di quei maledetti delitti contro lo Stato, si dava alla latitanza e solo due settimane fa (a distanza cioè di trent’anni) è stato arrestato dai carabinieri del Ros.
Spetterà agli inquirenti ricostruire i lunghissimi anni di latitanza, gli spostamenti, le connivenze, i rapporti con quanti hanno reso possibile tutto ciò. E sarà, ancora una volta, una gioia vedere che assicurati alla giustizia saranno quanti hanno consentito che u’ siccu potesse girare liberamente nei luoghi della sua giovinezza durante la quale ha germogliato, nella sua anima malata, il seme della criminalità.
A noi interessa tutto il resto, affinché ognuno di noi sia chiamato a fare la sua parte. Noi siamo la società civile che non può più
Messina Denaro è stato assicurato alla giustizia. Ma la società civile combatta le infiltrazioni criminali
assistere in silenzio alla pervasività delle infiltrazioni criminali, le quali, sempre più frequentemente, occupano lo spazio che prima era della Politica. Perché purtroppo sempre più concreta è quella compenetrazione tra la criminalità e il tessuto sociale, là dove l’assenza dello Stato genera ideali di appartenenza a sodalizi criminali che fanno intravedere vana speranza e incerto futuro. Nel piccolo centro abitato dal boss nessuno ha visto e sentito e forse nessuno ha avuto il coraggio di vedere e di sentire. Ora lì, come in tanti luoghi della Sicilia e non solo, la gente è scesa in piazza come in un giorno di festa ed è stato bello vedere tanti striscioni tra le mani di giovanissimi studenti. Diceva Giovanni Falcone che la conoscenza del fenomeno mafioso deve essere alla base della coscienza civile delle nuove generazioni. Così ho visto i giovani anche negli occhi impauriti ma felici dei carabinieri che stringevano le braccia dell’ultimo latitante stragista. Avevano le spalle dritte e fiere come vele al vento della Legalità.
«Te l’ho già detto. Sono Matteo Messina Denaro», disse il boss con voce fioca e dimessa, mentre abbassava lo sguardo non potendo incrociare gli occhi verdi del carabiniere che lo aveva fermato.
«Sono lo Stato», gli rispose lui: «Quello Stato che a volte tarda a venire, ma che c’è e ci sarà sempre contro chi ha provato a minare la Democrazia, a volte piegandole le gambe dal dolore per quegli Uomini e quelle Donne che hanno perso la vita».
«Siamo lo Stato», continuò: «Io con la mia divisa e il mio orgoglio quotidiano, i miei figli che studiano per diventare uomini onesti, i ragazzi che credono nella Bellezza della Libertà».
Tacque. Gli misero la mano sulla testa per farlo sedere nel blindato che lo porterà ancora una volta in carcere. Sì, ancora una volta! Perché è per tutta la vita in carcere chi fugge dai suoi inseguitori, chi vive nascondendosi, chi ruba agli altri la Libertà.
Se Palazzo Chigi non avesse ancora incaricato una società di pubbliche relazioni per ricostruire il rapporto con l’Unione Europea, dovrebbe farlo in fretta. Mes, balneari, Pnrr, giustizia, etichette su vino e alimentari, tassi della Bce: il “cahier des doléances” delle polemiche aperte dal governo italiano con Bruxelles (e Francoforte) si allunga ogni giorno. Eppure l’Italia, non si stanca di ricordare il presidente Sergio Mattarella, dovrebbe essere parte e non controparte dell’Europa. Ma ora l’imperativo diventa categorico perché è partito il negoziato per il nuovo Patto di Stabilità, il più importante documento finanziario dell’Ue. Sospeso per il Covid, sarà riattivato dal 1° gennaio 2024, e entro l’estate il lavoro preparatorio sarà completato. La commissione ha delineato le basi: verranno confermati, perché scritti nei trattati, i vincoli del 3% sul deficit/Pil e del 60% per il debito/Pil. Vista però la distanza dalla realtà odierna (debito/Pil al 149% in Italia), scompare la regola-capestro per cui si doveva ridurre di un ventesimo il debito ogni anno per la quota eccedente il 60%, l’equivalente di una manovra da 40 miliardi l’anno. Non a caso questa regola non è stata mai attuata. Ora niente schemi fissi, ma una trattativa caso per caso in cui si concorda con la commissione, viste le condizioni oggettive di ogni Paese, il timing per il rientro dal debito nonché, sulla base delle specifiche esigenze, gli investimenti da fare e quali eventualmente stornare dal computo. Per recuperare credibilità, la commissione imporrà pesanti penalità per i trasgressori, reputazionali e patrimoniali: si potrà arrivare allo stop ai fondi europei compresi quelli del Pnrr. Insomma è fondamentale arrivare alla fase finale del negoziato con un buon “feeling” con l’Unione, minacciato da tutti gli episodi prima citati: un banco di prova cruciale per il governo.
Va detto che, ferma restando l’opportunità di buoni rapporti, diversi prestigio-
si economisti indipendenti sono perplessi sulle nuove modalità del Patto. «È la trasformazione di una procedura che doveva salvaguardare l’Ue da comportamenti devianti, in una misura di governo economico centralizzato che mette nelle mani della Commissione poteri senza precedenti di controllo delle politiche nazionali», obietta Stefano Micossi della Luiss. Il modello è quello dei Pnrr: «Ma lì i Paesi hanno accettato di legarsi le mani in cambio di generosi fondi. Qui si chiede a quanti sono indebitati un nuovo assetto». C’è comunque chi conta sul “ravvedimento” del governo Meloni, dopo i fuochi d’artificio anti-europei iniziali: «Alla fine il Mes è stato approvato, la manovra di fine anno ha rispettato i saldi di bilancio ed è stata licenziata senza problemi da Bruxelles, per il Pnrr siamo riusciti a rispettare le scadenze», riflette Ferdinando Nelli Feroci, ambasciatore ed ex commissario all’Industria. «Si può ragionevolmente sperare che il negoziato sul nuovo Patto avvenga su una base di reciproca fiducia».
La questione è complicata da un fattore strettamente connesso, gli aiuti di Stato: anche il divieto ai Paesi membri di ricorrervi è stato sospeso per il Covid, e sta per essere ripristinato perché è previsto anch’esso dai trattati costitutivi dell’Unione. Ma non mancano le polemiche, coincidenti con l’inaspetta-
Con il nuovo Patto di Stabilità il rientro di deficit e debito andrà negoziato. Fondamentale aver buoni rapporti con Bruxelles. Al governo di destra conviene cambiare atteggiamento
ta concorrenza americana sul terreno degli interventi pubblici. È difficile tornare indietro: nel 2022 Bruxelles ha autorizzato 170 richieste di aiuti per 540 miliardi. Metà è stata versata alle proprie imprese dalla Germania, il 30% dalla Francia e gli altri 25 mercati si sono dovuti spartire il restante 20%. L’Italia ha avuto l’autorizzazione per aiuti straordinari per il 4,7% del totale. Ma ancora una volta il nostro Paese è al centro dell’attenzione: deve decidere se appoggiare l’asse franco-tedesco che chiede il “liberi tutti” sugli aiuti di Stato visto che può permetterselo, e l’eterogenea compagine dei Paesi minori (Danimara, Finlandia, Polonia e così via) che di tale disponibilità di bilancio sono privi. C’è il pericolo che i due “soci forti” dell’Europa prendano buona nota dell’atteggiamento di Roma e immaginino eventuali ritorsioni in sede di rinnovo del Patto di Stabilità.
È come una partita a scacchi. Che non sia fantapolitica lo prova un precedente: nel 2003 l’intervento italiano scongiurò la procedura d’infrazione contro Francia e Germania perché, proprio loro, avevano violato il Patto sforando il deficit. Nel 2012 Parigi e Berlino, memori dell’episodio (e grazie ai buoni uffici di Mario Monti), ci restituirono la cortesia avallando la
politica monetaria “accomodante” della Bce che salvò l’Italia (e l’euro). Alla Bce, peraltro, si rivolgerebbero di nuovo i Paesi che dovessero finire in crisi per il mancato rispetto del nuovo Patto. Però è un’“altra” Bce: chiusa l’era del quantitative easing è iniziata quella dei rialzi dei tassi nonché dello smobilizzo delle posizioni accumulate. Si hanno, è vero, nuovi strumenti per fronteggiare le emergenze come il Tpi (Transmission protection instrument), un programma di acquisto di titoli “personalizzato” (rivolto solo a un Paese): però per accedevi va superato lo scrutinio di Bruxelles e della stessa Bce. Ecco che ancora una volta contano le buone relazioni coltivate da ogni governo. Il Tpi si aggiunge, con modalità simili, al Mes e alle Omt (Outright monetary transactions), le protagoniste del “whatever it takes”: alle Omt si riferiva Draghi quando nel 2012 annunciò che la Bce avrebbe fatto tutto il necessario per salvare l’euro. Non sono servite, almeno finora.

MATTEO NOVARINI
imanshu Verma, un ingegnere del software indiano, si è trasferito in Canada per lavorare a Meta all’inizio di novembre. Due giorni dopo è diventato uno degli undicimila dipendenti licenziati da Mark Zuckerberg. Tra loro c’era anche Xiaohui Huang, una ragazza cinese che ha raccontato su LinkedIn di avere quattro mesi di tempo per trovare un lavoro e non perdere il visto. E poi Aaron Doran, irlandese con una figlia di pochi mesi, che ha rivissuto il licenziamento del padre all’epoca del crac di Lehman Brothers. Tre storie fra quelle delle 154.186 persone (calcolo del sito specializzato layoffs.fyi) lasciate a casa nel 2022 da un migliaio di aziende del settore tecnologico.

Pochi giorni prima dei tagli di Zuckerberg, Elon Musk si era presentato a Twitter dimezzando il personale. Cisco ha previsto più di quattromila licenziamenti, Shopify, Snap e Stripe un migliaio. I più resistenti, come Apple, si sono limitati a congelare le assunzioni. Il 2023 è cominciato allo stesso modo: Amazon ha annunciato 18 mila esuberi, Alphabet/Google 12 mila, Microsoft diecimila, Salesforce quasi ottomila, Spotify circa 600.
L’ondata ha riguardato soprattutto gli Usa, ma non ha risparmiato l’Europa e l’Italia. Meta ha scelto di tagliare 22 dei circa 130 dipendenti di Milano. Amazon ha rinuncia-
to a un nuovo polo della logistica che avrebbe impiegato 100 persone a Cuneo. Un disimpegno che fa preoccupare gli altri 3.500 dipendenti del Piemonte e i 17 mila di tutto il Paese. A luglio l’app di consegne tedesca Gorillas ha deciso di uscire dal mercato italiano e di lasciare a casa 540 persone. «Avevo un contratto a tempo determinato, come altri 480 lavoratori, ma rientravo nella metà che l’azienda si era impegnata ad assumere a tempo indeterminato», racconta Alex Deiana, 30 anni, ex operatore di magazzino a Roma: «L’amministratore delegato ha organizzato una videoconferenza con tutti i dipendenti. Ci ha fatto sapere che la società aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo e che i contratti in scadenza non sarebbero stati rinnovati». Prima di andarsene, i dipendenti hanno vissuto settimane di ritmi folli. «L’azienda ha applicato il 70 per cento di sconto sulle merci per liberare i magazzini. Gli ordini erano tanti ed enormi, le persone sempre meno. Alla fine c’erano ragazzi che pedalavano per Roma con 25
2022 le grandi aziende tecnologiche hanno licenziato 154.186 persone. Per compensare le troppe assunzioni dei due anni di pandemia.
chili sulla schiena». Secondo la Cisl, che si è occupata di molti ricollocamenti, casi come questo dimostrano «l’urgenza di affrontare in modo organico le tematiche che riguardano il lavoro su piattaforma digitale».
Di sicuro le società tecnologiche devono affrontare problemi comuni a tutta l’economia: inflazione, incertezza geopolitica, caro energia, forniture difficili. Anche aziende di altri settori hanno tagliato. Ma questo è un caso speciale. Se l’S&P 500, il più importante indice di Wall Street, è sceso del 19 per cento nel 2022, le cosiddette big tech hanno fatto peggio della media: Apple e Microsoft hanno perso poco meno del 30 per cento, Alphabet il 40, Amazon quasi il 50, Meta addirittura il 64.
In parte i licenziamenti compensano le assunzioni dei due anni più intensi della pandemia. Quando le persone si sono spostate in massa online, le aziende tecnologiche hanno visto lievitare i ricavi e hanno ampliato il personale. Qualcuno ha esagerato. Lo ha ammesso anche Zuckerberg che ha
SPERANZE DELUSE
Dipendenti di Facebook al lavoro nel campus di Menlo Park, in California, nel 2011

assunto circa la metà dei suoi dipendenti tra il 2020 e il 2022. Secondo Andrea Rangone, cofondatore degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, «non siamo di fronte alla fine di un’era. Molte aziende continuano a realizzare utili enormi. Sono in difficoltà quelle che non hanno ancora raggiunto un equilibrio economico-finanziario e devono consumare soldi per andare avanti. Ora che il costo del denaro è salito, gli investitori le penalizzano».
Nella Silicon Valley, i più ottimisti pensano addirittura che l’ondata di tagli darà origine a una nuova generazione di startup. L’agenzia Reuters ha raccontato la storia di Nic Szerman, un ragazzo di 24 anni che, dopo aver perso il lavoro a Meta, ha iniziato a cercare finanziamenti per la sua società di pagamenti basati sulla blockchain. «Ho incassato quattro mensilità e ora ho il tempo di concentrarmi sul mio progetto», ha raccontato. Il fondo Day One Ventures ha lanciato un’iniziativa per finanziare startup dallo slogan «Finanziati, non licenziati». Più di mille aziende si sono candidate per uno dei 20 assegni da 100 mila dollari. Molte grandi imprese tecnologiche, in effetti, sono nate in periodi di crisi. Microsoft è stata fondata nel 1975, in coda alla stagnazione. LinkedIn nel 2002, dopo lo scoppio della bolla delle dot-com. Airbnb nel 2008, pochi giorni prima dell’inizio ufficiale della Grande Recessione. «Ci sono molti talenti a disposizione. Ma chi esce da grandi aziende percepisce stipendi e benefit che poche aziende giovani si possono permettere. In più la pandemia
ha portato molti a riconsiderare l’equilibrio tra vita privata e professionale. Non è detto che tale sensibilità sia considerata nella Silicon Valley», dice Nicoletta Corrocher, docente del dipartimento di Management e Tecnologia alla Bocconi.
«Le aziende hanno assunto con leggerezza. E con la stessa leggerezza licenziano. Non per errore di pianificazione, ma per scarsa considerazione del lavoro», dice Ivana Pais, professoressa di Sociologia economica alla Cattolica. Una visione che si riflette anche nelle modalità: «All’epoca delle dot-com si seppe che un dirigente di un’azienda italiana convocava i lavoratori e li licenziava con la formula del Grande Fratello: “Sei stato nominato”. Fu uno scandalo. Oggi la superficialità è la stessa, ma non ci si indigna più».




 Bruschini
Bruschini
singolare come il governo si affanni a mettere sul tappeto questioni che esulano dal cuore del problema che tormenta il Paese: l’inflazione che falcidia i redditi da lavoro e da pensione, i margini di sussistenza delle imprese e gli interventi del settore pubblico allargato.
È difficile capire il senso della drammaticità che si vorrebbe instillare nell’opinione pubblica sugli sbarchi, e sulle ong, che rappresentano il 10 per cento dell’immigrazione irregolare. Allo stesso tempo rimane incomprensibile l’esigenza di voler presentare, senza indugio, all’attenzione del Parlamento la riforma presidenziale della Costituzione e il
varo dell’Autonomia differenziata. Forse è un espediente per distrarre dai veri problemi. Le questioni, infatti, sono ben altre. È lo stesso governo che lo sostiene, nel momento in cui sia la presidente del Consiglio sia il ministro dell’Economia ripetono a ogni piè sospinto che per le accise non si poteva fare di più perché la «coperta era corta». Sarebbe bene che il governo convocasse un tavolo interministeriale per valutare come reperire le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare i bisogni di famiglie e imprese per il pagamento delle bollette a partire da aprile e per attutire i pesanti problemi che gravano sulla società nel suo complesso. Una cosa appare certa, con i tassi di interesse che aumentano, cresce di più di 10 miliardi di euro la spesa annua per il servizio del debito dello Stato. La spesa pubblica in deficit diventa di conseguenza impercorribile. Il governo — se vuole trovare una sponda

nell’Ue per mettere a terra i progetti del Pnrr, condizionati dall’aumento dei prezzi — non può interporre altro tempo per ratificare la riforma del salva-Stati, finalizzata a prevenire rischi di contagio connessi a crisi bancarie (bank stop) e approvata da tutti gli altri membri dell’Eurozona. Non gli gioca a favore demandare la decisione al Parlamento. La preoccupazione per una ripresa del Covid-19, nonché per la cronica carenza di personale specializzato e di infermieri (sostituito da personale medico delle cooperative), oltre che per le inaccettabili attese per le visite specialistiche e le terapie complesse hanno riacceso i riflettori sul sistema sanitario nazionale. Che si sta sgretolando a causa del disinteresse verso la politica sanitaria da più vent’anni.
Nello stato in cui si trova il sistema sanitario nazionale, il Mes va ratificato senza se e senza ma. Perché consente di attingere a 37 miliardi di euro di finanziamenti del Mes sanitario, che consta di 240 miliardi di euro ed è stato costruito appositamente in era Covid-19, a un tasso di interesse pari a un terzo del costo delle emissioni del Btp decennale, intorno al 4 per cento. Si tratta di finanziamenti a basso costo, con l’unica condizionalità di essere usati a esclusivo sostegno del sistema sanitario, che l’Ue ha predisposto proprio per ammodernare e migliorare i sistemi sanitari nazionali che con la pandemia hanno evidenziato carenze insospettabili, non solo in Italia.
È una scelta che il governo non può non perseguire, considerati anche gli allarmi sull’indilazionabile necessità di riforma e di potenziamento dei sistemi sanitari regionali su cui si concentra l’attenzione in vista delle elezioni regionali di Lombardia e Lazio. Queste risorse saranno spese bene se il ministero della Salute saprà attivare una programmazione capace di livellare gli squilibri esistenti tra Nord e Sud, affinché la “Nazione” non sia vestita da Arlecchino anche nel campo della salute.
Per realizzare i progetti del Pnrr, condizionati dall’inflazione, è urgente ratificare il salva-Stati
Alberto
Filtri e App dettano canoni estetici falsi e conformisti, che non ammettono imperfezioni. E per i più giovani lo specchio
è lo sguardo dei social
Un selfie non è mai una posa a perdere. Non ci si fotografa mai tristi, in disordine, non filtrati. È la regola per pesare nell’impero del piacere. Un impero che tutti abitiamo e che ha inevitabilmente finito per modellare il concetto stesso di bellezza. Gli studiosi da tempo osservano il fenomeno che ha raggiunto il suo apice durante la pandemia tra riunioni online via Zoom, videochiamate e dirette Instagram, l’immagine dei nostri corpi è diventata un riflesso costante, lo specchio è lo sguardo degli altri. La spia è anche l’aumento delle procedure mediche cosmetiche e degli interventi di chirurgia plastica, che hanno registrato un trend in crescita costante nel mondo e anche in Italia. Utilizzando i dati forniti dall’International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) nell’anno 2021, si evidenzia che il nostro è il quinto Paese al mondo per numero di procedure di chirurgia estetica. Negli Stati Uniti si parla di “Zoom-boom”, dal nome della popolare app di videocall. Direttamente legato alla voglia di vedersi più belli di fronte allo schermo: «Quasi 700mila sono le prestazioni mediche in Italia. Il totale delle procedure non chirurgiche è 385mila, quelle chirurgiche sono 238mila», spiega a L’Espresso il professor Francesco Stagno d’Alcontres, presidente della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed estetica (SICPRE): «Si interviene su testa e viso, in chirurgia palpebrale e blefaroplastica e per il miglioramento delle labbra. La rinoplastica è il terzo intervento più richiesto dai giovani». Sono proprio i ragazzi e le ragazze i nuovi pazienti che si sottopongono a interventi di chirurgia estetica, quelli della Generazione Z (nati tra il 1995 e il 2010). Se un tempo le pazienti entravano nello studio medico con in mano le foto delle top model, oggi la richiesta si allinea allo spirito del tempo: per le ragazze il riferimento è spesso quella che gli americani chiamano “rich girl face” (faccia da ragazza ricca), ben promossa dalla famiglia Kardashian come Kim e Kyle Jenner, zigomi pronunciati e labbra gonfie. Ma spesso, come racconta il presidente del Si-
cpre, moltissimi giovani si presentano dal chirurgo con un selfie a cui hanno applicato filtri di bellezza. I filtri dei social diventano il modo in cui vediamo noi stessi o il modo in cui vogliamo vederci.
Una vera e propria ossessione per la perfezione che ci porta a vedere imperfezioni anche dove non ci sono e che, nelle situazioni più gravi, può portare a un disturbo: la dismorfofobia o dismorfismo corporeo, catalogato dal manuale DSM-5 tra i disturbi ossessivo-compulsivi. «Una patologia sempre più diffusa», conferma Stagno d’Alcontre: «Non ci si accontenta mai. Perciò è importante che lo specialista sappia dire di no e porre un freno. Ci sono ragazze che non hanno bisogno di aumentare il volume delle labbra a 24 anni e invece le vogliono ingrandire con acido ialuronico in maniera eccessiva, fino a raggiungere misure irragionevoli. L’eccesso è quello che preoccupa, soprattutto nelle giovanissime».
Il selfie è stato catalogato dall’Apa (Associazione Americana di Psichiatria) come nuovo disturbo mentale. L’Apa ha conside-

È “Zoom-boom”: la crescita di interventi di chirurgia plastica anche tra giovanissimi.
Molti di loro arrivano con il loro autoscatto elaborato da applicazioni
rato la dipendenza da selfie come una conseguenza della dismorfofobia (paura di essere brutto o deforme): due terzi dei pazienti che soffrono di dismorfofobia coltivano regolarmente la pratica del selfie.
In Italia non abbiamo ancora ricerche specifiche sul tema ma possiamo guardare agli studi anglosassoni in materia: nel 2020, l’associazione inglese “Girlguiding” ha condotto un sondaggio proprio sull’uso dei “filtri di bellezza”, rilevando che il 34 per cento delle utenti intervistate tra gli 11 e i 21 anni non posta mai immagini di sé senza ricorrere a questi strumenti di alterazione artificiale. Mentre la rivista “MIT Technology Review” del Massachusetts Institute of Tecnology ha pubblicato uno studio sull’impatto dei filtri facciali su giovani e giovanissimi.
Claire Pescott, ricercatrice dell’Università del Galles, ha studiato il comportamento dei preadolescenti sui social media. Nei focus group, ha osservato una differenza di genere quando si tratta di filtri: i ragazzi li definiscono divertenti. Le ragazze li vedono come uno strumento per sentirsi più
a bellezza è architettura, politica, etica. Non solo estetica fisica. Quella che vediamo condivisa non è bellezza ma conformismo. È un problema socio-politico, ci si conforma a tutto ciò che è più facile, comodo e quindi stupido. Dovessi declinare la parola bellezza direi che non è una regola, non è un sistema, non è un diktat: è libertà. C’è un rapporto molto forte tra etica ed estetica e quando le due cose si incontrano nasce la bellezza.
LUOGHI DA SELFIE
A destra: Supercandy! Pop-Up Museum di Colonia, che rimbalza nei selfie di molti adolescenti
Ho scattato decine di migliaia di volti nel mondo per il progetto “Razza Umana”. Non esiste una persona brutta. La bellezza si legge nell'espressività, nella vitalità, nel sentirsi bene. Sapete perché i bambini vengono sempre bene in foto? Perché sono quello che sono: con le orecchie a sventola e senza denti. Appena prendono coscienza di dover sembrare quello che gli dicono di essere diventano brutti. Guardate chi si sottopone a interventi chirurgici? Sono l’esempio di chi non si vuole bene. Chi si rifà non si accetta. È una cessione di libertà all’ordine cosmetico che altri hanno deciso per loro. Siamo vittime dell’estetica dell’eterna giovinezza, convinti che quella sia la bellezza: è un inganno. Colpa del mondo adulto: l’educazione, la famiglia, la scuola, la religione. In particolare gli uomini. Il modello alimentato dai social si rivolge a chi consuma, numeri. Una forma di capitalismo anche questo. Mentre cogliere il rapporto tra estetica e etica è straordinario. La vita mi ha insegnato a farlo: per conoscere una persona mi basta uno sguardo, e questo, lo confesso, mi imbarazza. Bellezza è accettarsi. È molto semplice.

L Liberi come i bambini
Oliviero Toscani
belle: «Dicevano tutte cose del tipo: “Ho messo questo filtro perché ho una pelle perfetta. Mi toglie cicatrici e macchie”. In realtà, si trattava di bambine di 10 e 11 anni. Alla domanda sulle caratteristiche perfette di un volto Instagram hanno risposto: naso piccolo, occhi grandi, pelle liscia, labbra carnose». Come racconta Veronica, 19 anni: «Quando uso un filtro è perché ci sono cose di me che voglio cambiare. Se non mi sono truccata o penso di non essere al massimo, il “filtro bellezza” ti permette di correggere alcune parti di te». Veronica ha iniziato a usare i filtri per modificare le proprie foto quando aveva 14 anni. Le conseguenze sono serie. La funzione social non rischia di filtrare solo una foto, ma inghiotte la percezione della realtà, fino a farla perdere. Specie nella fase delicata della scoperta di sé.
«A partire dal mito, il narcisismo dovrebbe coltivare la nostra unicità. Oggi molti adolescenti sembrano coltivare la loro repli-
GENERAZIONE Z
Cellulare in mano, i teenager sperimentano di continuo la rappresentazione di sé
bbiamo chiesto a Vittorio Lingiardi cosa ci porta, oggi più di ieri, a rivolgere sguardo e obiettivo verso noi stessi.
«Per non dilungarmi fino a risalire alla fortunata formula di Christopher Lasch, che alla fine degli anni Settanta inaugurò il concetto di “cultura del narcisismo”, oggi potremmo parlare di “cultura del video-narcisismo”, che peraltro evoca l’immagine archetipica del autorispecchiamento. Narciso si specchiava in una sorgente d’acqua, oggi la sorgente è lo schermo di uno smartphone. La nostra crescente “narcisizzazione”, confermata dalla ricerca sul campo, è in gran parte riconducibile alla trasformazione delle strutture della comunicazione e dei rapporti sociali. Viviamo in un’epoca che facilita lo sviluppo di immagini di sé fragili che si traducono in paura dei rapporti duratu-
cabilità, il conformarsi a una regola dell’immagine per essere accettati, che è comunque è un tema tipico dell’adolescenza», racconta a L’Espresso lo psicoanalista e psichiatra Vittorio Lingiardi, autore di “Arcipelago N. Variazioni sul narcisismo” (Einaudi):
«La credenza alla base dei selfie non è “mi vedo dunque sono”, ma “sarò visto dunque sono”. La tragedia dei selfie è di ritrarsi e ri-
ri, superficializzazione/virtualizzazione delle relazioni, stigma per ciò che è considerato brutto, orrore dell’invecchiamento, rimozione della vulnerabilità, ricerca di apprezzamento a buon mercato (i like) e presenzialismo iterativo (i selfie). Non che sia un male coltivare sé stessi. Il vero problema, e qui è lo spartiacque tra narcisismo temperato dell’ambizione e dell’assertività e quello patologico della grandiosità e dell’insensibilità, è se questa ricerca è fatta con gli altri o a loro discapito. Vedo un indebolirsi dei legami di solidarietà e un irrobustirsi di egolatrie fatte di ossessioni identitarie, economiche, estetico-chirurgiche. Il narcisismo ha catturato l’attenzione dei media ed è entrato in politica. Ricondurrei il narcisismo sociale dentro cui galleggiamo a tre dinamiche principali: mistificazione della politica, mistificazione del corpo, mistificazione delle relazioni. In un’ottica clinica, aumentano le diagnosi di “disturbo di personalità narcisistica”. Però attenzione: ogni disturbo della personalità è l’esito di un modello bio-psico-sociale, per cui quello “sociale” è solo un terzo del problema. Vanno considerati anche il tem-

peramento e la storia delle relazioni familiari». Sullo sfondo c’è la dismorfofobia diffusa. Spesso questa generazione non riesce neanche a postare un selfie “senza filtri”.
«La “mistificazione” del corpo serve a negarne la caducità. Penso all’esponenziale ricorso alla chirurgia estetica, all’ossessione per la forma fisica, all’inseguimento della magrezza o della muscolatura (tatuata), alla proliferazione di laboratori per la cura delle unghie, dove si lima la parte perché è difficile occuparsi dell’intero. Negli Stati Uniti, prima degli anni Duemila, pochissimi ricorrevano all’intervento di sbiancamento dei denti; negli ultimi vent’anni, avere denti scintillanti è diventato un obbligo. La lista degli interventi cosmetici è infinita: dalla demandorlizzazione degli occhi in Corea agli impianti dei glutei in Brasile, un’epidemia globale di ritocchi ci aiuta a tollerare ciò che di noi riteniamo impresentabile».

Se la reputazione (chi sono io per gli altri)
toccarsi per riprodursi in migliaia di sé, da far rimbalzare sui social. Il bisogno di riconoscimento: per molti è proprio fame. Non di guardarsi, ma di essere guardati da migliaia di occhi. Dietro ogni fenomeno narcisistico c’è la speranza di essere notati, forse per essere amati. Dalla società, ma anche dalla famiglia. Molti adolescenti catturati dalle dinamiche narcisistiche portano sulle spalle il peso delle aspettative genitoriali. La tirannia narcisistica dell’essere notati ci costringe a comportarci come fossimo aquile. Per la paura di essere scambiati per passeri». Esistiamo solo se sognati, diceva Danilo Dolci. La Generazione Z, tra selfie e video, chiede di meno: solo se filtrati.
Per approfondire o commentare questo articolo o inviare segnalazioni scrivete a dilloallespresso@lespresso.it I nostri giornalisti vi risponderanno e pubblicheremo sul sito gli interventi più interessanti

prende il posto dell’identità (cosa vedo io di me), che effetti produce?
«Reputazione e identità sono cruciali nella personalità narcisistica. Si intrecciano con il tema della vergogna. Uno dei criteri per individuare fragilità narcisistiche dice: «Tende a trattare gli altri come un pubblico che deve testimoniare la sua importanza, il suo ingegno, la sua bellezza». Altri criteri dicono: «Tende a sentirsi inadeguato, inferiore o fallito» e «Tende a provare vergogna o imbarazzo». È importante differenziare la vergogna dalla colpa: nel caso della colpa i sentimenti negativi sono suscitati da riprovazione interna per aver violato i propri standard morali; nel caso della vergogna nascono dal sentire che la riprovazione arriva dallo sguardo dell’altro. Il punto di vista depressivo della colpa è interno, quello della vergogna è esterno: è lo sguardo del mondo sulla nostra insufficienza. La colpa è la convinzione di essere sbagliati, la vergogna è di essere considerati tali». S. A.
Più che la loro preziosa unicità, molti adolescenti, per essere accettati, sembrano oggi coltivare la loro replicabilità.
Il riprodursi in migliaia di sé, da far rimbalzare sulla rete sociale
La strada che porta a Sanremo passa dai talent televisivi, si sa. Ma, chiederebbe il Nanni Moretti di “Ecce Bombo”, mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Nel senso che il talent show musicale - che sia Amici, saldamente ancorato a Maria De Filippi, o X Factor che cambia giudici ogni anno - se si guarda il curriculum dei finalisti di questa edizione del Festival di Sanremo sembra un jolly che ognuno gioca a modo suo. Per ottenere il risulta-
to migliore in quella che dopo alti e bassi è tornata ad essere, per usare le parole di un decano dell’industria discografica come Lucio Salvini, «la notte che può cambiarti la vita». Questo era vero almeno finché «si vendevano milioni di dischi e un Sanremo ben fatto poteva cambiare il bilancio di una casa discografica», continua Salvini, che è stato per 17 anni ai vertici della Ricordi e nove alla Fonit Cetra. «Ma ora tutto è diverso perché i dischi non si vendono più». Però proprio quest’anno, risponde Michele Canova, produttore di diversi artisti che sono passati dal festival, «i guadagni fatti con lo streaming sono tornati ai livelli di quando la musica era solo in cd». Da
quando la vendita di dischi è crollata, però, il grosso degli incassi si fa con i concerti: in questi giorni vengono annunciati i live dei protagonisti del festival. «Cantare dal vivo è il massimo per un artista», commenta Tosca, che a Sanremo ha vinto un’edizione e partecipato altre volte «e sempre con grande divertimento. Il live è fondamentale», continua, «perché ogni cantante è innamorato del pubblico, e ogni concerto è come un appuntamento con la persona che ami».
Tornando al ruolo dei talent come trampolino per una carriera, a Sanremo dal 7 all’11 febbraio ci saranno Marco Mengoni, lanciato nel 2009 dalla vittoria a X Factor, e gIANMARIA che nel 2021 è arrivato secondo (lo stesso piazzamento degli ormai mitici Måneskin). È arrivata seconda ad Amici Elodie, che a X Factor era stata eliminata in corso d’opera. Sono usciti presto anche Will e Ariete, ma la figura più clamorosa l’ha fatta Mr Rain, che si è ritirato da X Factor subito dopo essere stato selezionato. Levante al talent di Sky c’è arrivata direttamente come giudi-

Vincere un talent o farsi eliminare. Studiare in conservatorio o lanciarsi su Youtube. Da Milano a Udine, da Amici a X Factor, tutte le strade che portano al festival
ce, Madame come ospite. Tananai invece ha partecipato a Top Dj, selezione per disk-jockey, ma del resto la sua strada per Sanremo ha seguito un percorso originale: è passato anche al Politecnico di Milano, dove ha studiato architettura. Inusuale anche il curriculum di Rosa Chemical: pittore di murales e modello per Gucci, ha già cantato a Sanremo l’anno scorso proprio con Tananai. Per Leo Gassman e LDA, invece, la gara televisiva è servita a rafforzare un’immagine schiacciata sul ruolo di “figlio di papà”. Dai genitori, Alessandro Gassman e Sabrina Knaflitz, entrambi attori, Leo ha ereditato una presenza scenica fuori dal comune. LDA invece deve al padre, Gigi d’Alessio, il debutto nel disco “Buongiorno”, ma la carriera l’ha consolidata grazie ad Amici. Mara Sattei non è “figlia di”, ma sorella: al fratello, Tha Supreme, deve l’inizio di un successo dovuto anche al talent di Mediaset.


«Giorgia e io abbiamo iniziato a cantare insieme nei club: lei cantava in inglese, io in portoghese», ricorda Tosca. Che paral-

lelamente alla sua carriera internazionale, da otto anni è impegnata nella direzione di un Laboratorio di alta formazione artistica della Regione Lazio. «Ai ragazzi di Officina Pasolini consiglio di capire bene chi sono prima di intraprendere una strada, a saper dire di no, di non lasciarsi plasmare. Se si è se stessi, si può andare ovunque, anche a Sanremo. Il miraggio non è partecipare, ma far conoscere il proprio lavoro. In un’industria che oggi vuole prodotti, non progetti, che dà a un giovane solo pochi giorni per giudicare se la canzone che ha inciso funziona oppure no, è molto difficile». Il caso più famoso di metamorfosi ad uso del mercato lo ha vissuto Caparezza: difficile immaginare il rapper dai ricci selvaggi nelle vesti di Mikimix, cantante pop minimalista atterrato a Sanremo nel 1997. «Io c’ero, me lo ricordo bene», dice Canova. «Però cambiare la personalità di un artista è difficile, e soprattutto non funziona: la cosa giusta è esaltare le sue qualità vincenti. E questo oggi l’industria musicale lo sa fare meglio di vent’anni fa, quando
Alcuni dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2023. In senso orario: Ariete; Shari; Colla Zio; Rosa Chemical; i Coma Cose; Olly



si mandavano allo sbaraglio venti cantanti a Sanremo Giovani sperando che almeno uno funzionasse».
Sanremo Giovani è sempre di più la vetrina del festival: sei finalisti di quest’anno vengono da lì. A Colla Zio, gIANMARIA, Sethu, Shari, Olly e Will è affidata una “mission impossible”: attrarre il pubblico più giovane verso una kermesse che ha 73 anni e fino a pochi anni fa era fuori moda. Sono stati i giovani a decretare la clamorosa vittoria del Måneskin: ma era il 2020, e i ventenni chiusi in casa per il Covid si sono concentrati su Sanremo
con una dedizione irripetibile. «Sanremo l’hanno rovinata gli anni Ottanta, quando si cantava in playback», racconta Canova. «Poi nel Duemila, quando alcuni giovani cantanti italiani hanno sfondato a livello internazionale, è diventato una vetrina per artisti già affermati in un genere che veniva sentito come vecchio. Le cose sono cambiate con Pippo Baudo e Amadeus, che hanno fatto un grandissimo lavoro di scouting». Tra i due c’è stato Claudio BaTra i big
RITORNI

L’ultima volta a Sanremo, tre anni fa, Levante se la ricorda bene. “Tikibombom”, la canzone che accarezza gli “animali stanchi” della diversità, i freak, gli strani che non seguono il ritmo degli altri, restò per settimane in cima alle classifiche. Disco di platino, il singolo festivaliero che ha avuto vita più lunga, in pieno lockdown. Ora Claudia Lagona, 35 anni, autrice di canzoni e romanzi (il terzo, “E questo cuore non mente”, è uscito nel 2021 per Rizzoli), capelli non più castani ma biondi, torna al Festival in gara tra i big come la sua grande amica Elodie. Porta “Vivo”, «una canzone che parla di un momento buio della mia vita, la crisi post-parto». Alla vigilia dell’uscita del nuovo album
“Opera Futura” (Warner Music), il 17 febbraio.
Levante, lei è diventata mamma di Alma Futura un anno fa, il 13 febbraio. Non la spaventa parlare di uno stato d’animo così personale?
«Quando ho scritto questo brano, il 4 marzo dell’anno
scorso, sapevo che avrei affrontato un argomento molto difficile. Oscillavo tra stati d’animo opposti, desideravo ritrovare un equilibrio nonostante la depressione. Al centro della canzone c’è l’ambizione di riprendere possesso della propria vita, riappropriarsi di mente e corpo, sentirsi vivi».
Veniamo a Sanremo. Quest’anno è tra i big, e pensare che fino all’altroieri un certo mondo indie, di cui lei fa parte, snobbava il Teatro Ariston. Cosa è successo? «Fino a qualche anno fa Sanremo non era un palco ambito. La direzione artistica ha dato una svolta: oggi finalmente il Festival ha fatto luce su un genere musicale che esiste, riempie i club, fa concerti, ascoltatori e sta anche in classifica. Finalmente Sanremo guarda alla musica indipendente, l’ha messa allo stesso livello dell’Olimpo della musica italiana. È stato un gesto intelligente e quindi oggi tutta quella fetta di artisti che mai avrebbe partecipato è felice di farlo».
Lei si è sempre schierata contro omofobia e discriminazione di genere. Qualche mese fa, in un post su Instagram ha menzionato una frase di Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd: “C’è molta differenza tra leadership femminili e leadership femministe”. Di re-
“L’universo indie finalmente sul palco”
glioni, che a Sanremo (caso più unico che raro) non ha mai gareggiato ma lo ha diretto nel 2018 e 2019: e con la sua immagine da “cantautore non impegnato” ha fatto molto per richiamare i giovani autori pop che hanno svecchiato la lista dei partecipanti. Hanno un pedigree da cantautori Colapesce e Dimartino, protagonisti di un duo che l’anno scorso ha conquistato critica e pubblico: il primo ha in curriculum una Targa Tenco, il secondo un premio al Meeting delle etichette indipendenti di Faenza. I Coma Cose invece erano sconosciuti quando furono chiamati a cantare al concerto del Primo Maggio nel 2019. I Colla Zio si sono fatti le ossa nei festival milanesi, e vent’anni fa anche Kekko Silvestre dei Modà ha fatto esperienza direttamente davanti al pubblico, in locali del Nord. Silvestre poi ha consolidato
la carriera firmando successi di altri come “Non è l’inferno”, con cui ha vinto Sanremo Emma, che quando non partecipa al festival è sempre una dei “king maker”: concorrente di Amici e giudice di X Factor, conosce tutti e ha contribuito a lanciare, tra gli altri, Elodie. Altro kingmaker ancora determinante è Claudio Cecchetto: Paola e Chiara erano coriste degli 883, fortunata creatura del produttore e dj. Lanciarsi nel mondo del web è come gettare in mare un messaggio in bottiglia: solo Will deve gli inizi della sua carriera ai video che ha caricato su Youtube, mentre Sethu ha debuttato sul canale Trash Gang. Più facile trovare buoni contatti attraverso le scuole di musica: Gianluca Grignani
cente Schlein ha confessato di fare il tifo per lei e Elodie a Sanremo. È ancora attuale l’impegno da parte di un cantautore?
«Lo trovo necessario e attuale, ma solo se sincero. Purtroppo oggi si rischia di sembrare retorici o prendere posizione per convenienza. Personalmente non mi sono mai sentita obbligata a parlare di politica o indignarmi per qualcosa. Quando lo faccio scelgo l’approccio da cittadino, da essere umano, come se discorressi delle cose che non vanno con gli amici in salotto».
La decisione di tingersi i capelli di biondo ha fatto molto discutere i suoi fan. Perché questo cambio di look?
«Anche la scelta del biondo fa parte del post-parto. Mi vedevo brutta, tuttora non mi vedo chissà che (ride). Dentro di me sono sempre stata bionda, mi sono detta “voglio fare questo colore folle”. Non si capisce che colore ho, lo chiameremo pesca. Tornerò mora, ovviamente, ma mi stupisce come la gente l’abbia presa sul personale. Con le mie sopracciglia nere, i capelli neri, sono stata talmente iconica che le persone si sono sentite tradite. Non resterò a lungo bionda, anche perché la ricrescita è uno “sbattone” totale. Ma è bello cambiare, osare. La vita è una sola».

“Negli anni Ottanta si cantava in playback, nel Duemila era una vetrina per artisti affermati.
Poi Pippo Baudo e Amadeus hanno fatto un grande lavoro di scouting”
è andato a Milano alla Cpm di Franco Mussida, uno dei fondatori della Premiata Forneria Marconi, Shari invece alla Groove Factory di Udine. Pochi hanno messo piede in un conservatorio: Leo Gassman ha studiato chitarra, Olly canto, Lazza pianoforte. Ma il giovane rapper più che il conservatorio lo sostiene la scena musicale milanese, una catena umana che va da Ghali a Ernia, da Gué a Dargen D’Amico.
AL TIMONE
Amadeus, conduttore e direttore artistico dal 2020, durante il festival dell’anno scorso
Ha iniziato in conservatorio anche l’artista che ha il record di concerti da tutto esaurito e che ha collezionato due bocciature nei talent, sia a X Factor che ad Amici. Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, torna a Sanremo dopo il doloroso testa a testa nel 2019 quando la vittoria andò a Mahmood. Ultimo può contare sui fan che si piazzeranno davanti alla tv, pronti a votarlo anche a scatola chiusa. Quattro anni fa aveva avuto l’endorsement di Matteo Salvini, allora ministro dell’Interno, e questo non lo aveva aiutato: chissà se questa volta il suo ingombrante fan riuscirà a stare zitto…
on c’è due senza quattro. La fabbrica del consenso a guida Amadeus è pronta a ripartire con stile secondo un’inoppugnabile strategia: la compagnia dei numeri pari. In un crescendo di colpi al cerchio e alle relative botti, la rassicurante scenografia di Castelli accoglierà giovanissimi e vecchie glorie e se nella sterminata lista dei big si azzardano nomi contemporanei, la serata vintage con l’inedito trio Al Bano, Ranieri e Morandi distenderà i volti di coloro che si stanno ancora chiedendo «Lazza chi?». Due i figli d’arte, due le sorelle e quattro le (magnifiche) co-conduttrici, giustamente divise in quote. Paola Egonu, la campionessa vittima di ignobile razzismo, Francesca Fagnani, la sontuosa Belva all’attacco, Chiara Francini che considera il mondo gay la sua famiglia e Chiara Ferragni l’influencer benefica che devolve il suo compenso contro la violenza sulle donne. Il tormentone resta immutato, ovvero “Niente gender a Sanremo!” come tuonano flebili vocine. Così per par condicio festivaliera le famiglie tradizionali non si dividono e anche Fedez marito fedele sbarca serenamente in Rai dopo il Primo Maggio della censura, portandosi dietro il suo podcast con risate annesse. I Pooh invece si erano lasciati, ma si rimettono insieme per l’occasione, recuperando in corsa anche Riccardo Fogli. C’è chi ha vinto e torna in gara, come Giorgia, chi ha vinto ma a rientrare proprio non ci riesce, come i Jalisse, scartati per la 26esima volta e chi rifiuta nel disappunto generale come Beppe Vessicchio, che al Festival quest’anno ha detto no. Neanche Fiorello si è lasciato convincere, ma alla fine gli spoiler sono rimasti nel suo microfono, tranne quello di Zelensky, che la guerra è una cosa seria e spetta a Bruno Vespa. Infine dopo le baruffe sul plagio, i Cugini di Campagna si incroceranno la stessa sera con i Maneskin. E probabilmente saranno tutti vestiti uguali.



Febbraio è in arrivo e passeggiare per Bologna vuol dire percepire, più che altrove, una forza rigeneratrice che attraversa cose ed esseri viventi, un flusso di energia riconducibile all’acqua che circolava e circola nei vecchi canali di medievale e rinascimentale memoria, offrendo uno scambio continuo tra il dentro e il fuori, tra ciò che resta e si conserva della vecchiaurbeeilmondoesterno.Unintrecciodiincontri,interessi e scambi presto protagonista di Arte Fiera, «una 46esima edizione organizzata in soli cinque mesi e caratterizzata dal forte spirito di rinnovamento», spiega Simone Menegoi, alla sua quarta direzione artistica. «Se Torino con Artissima e Milano con Miart competono per chi sia più internazionale, Bologna punta a essere un riferimento per l’arte italiana», aggiunge. Tornando nei padiglioni 24 e 25 di Bologna Fiere, si avrà la percezione di tutto questo con un’offerta di oltre 140 espositori presenti nella Main Section ricca di opere che spaziano dal Moderno all’arte post-bellica fino al contemporaneo di ricerca, seguendo un itinerario che collega alcuni stand secondo un criterio tematico. Se Pittura XXI, a cura di Davide Ferri, è una panoramica che coinvolge talenti emergenti e artisti mid-career, la sezione Fotografia e immagini in movimento, a cura di Giangavino Pazzola, arrivato dal Centro Camera di Torino, conferma il suo essere un punto di riferimento per collezionisti e appassionati di fotografia, mentre Multipli - a cura di Lisa Andreani e Simona Squadrito, fondatrici di Replica-Archivio italiano del libro d’artista - sarà dedicata alle opere in edizione di ogni genere, a cominciare dai libri.
Ad Alberto Garutti, che a Bologna ha tenuto la cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti, spetterà la commissione di un importante lavoro inedito negli spazi della fiera (Opus novum), mentre la Fondazione Furla e la sua direttrice Bruna Roccasalva presenteranno un intervento del collettivo israeliano Public Movement, protagonista di un progetto che coniuga installazione, performance e co-
CROMATISMI
A sinistra: l’opera di Jerry Zeniuk, Untitled n. 371, realizzata nel 2020
reografia. Al fianco di Menegoi ci sarà un grande collezionista come Enea Righi nella veste di managing director, «per portare la sua sensibilità e competenza alla definizione e realizzazione di un’accoglienza piacevole per i cittadini, turisti, galleristi e altri collezionisti in un’Arte Fiera inclusiva e attenta alle trasformazioni sociali e ambientali», spiega il direttore.
Una fiera che dimostra di avere un ruolo cruciale per le gallerie e per un pubblico eterogeneo che nei tre giorni – dal 3 al 5 febbraio – si avvicina incuriosendosi e si confronta scoprendo, apprezzando e acquistando. L’installazione di Yuri Ancarani sul maxischermo in Piazza della Costituzione, prima Led Wall Commission, vi darà il benvenuto e se amate il videomaker e regista originario di Ravenna, andate a vedere Atlantide 2017-2023, la personale che gli dedica il MAMbo (Museo
Torna a Bologna Arte Fiera. L’appuntamento con il moderno e il contemporaneo che trasforma l’intera città in un palcoscenico di performance e visioni d’artista
dell’Arte Moderna di Bologna) a due passi dalla stazione. Nella Sala delle Ciminiere, il curatore Lorenzo Balbi fa esplodere in un museo quello che è stato l’omonimo film di Ancarani, presentato due anni fa nella sezione Orizzonti alla Mostra del Cinema di Venezia, una rappresentazione onirica e reale di quel mondo a sé che è l’isola di Sant’Erasmo, in laguna, dove un gruppo di ragazzi vive di espedienti spostandosi con i loro barchini che trasformano in bolidi da competizione.
Ognuno immagina e sogna la propria isola che non c’è, ma quella raccontata da Ancarani esiste e mette al centro, pur a Bologna, Venezia, protagonista di questa mostra visitabile dal primo febbraio al 7 maggio, «simbolo e rappresentazione ideale della decadenza del capitalismo», parole dell’artista, «luogo esemplare per raffigurare un problema globale».
Dal 28 marzo, sarà la volta del PAC (Padiglione d’Arte Contemporanea) di Milano che gli dedicherà una mostra a cura di Diego Sileo e Iolanda Ratti, per sottolineare il dialogo e la connessione tra le due esposizioni. Sempre a Bologna, affamata d’arte ma mai bulimica, a pochi minuti a piedi dal MAMbo, avete tempo fino al 28 marzo per visitare al Cassero di Porta San Donato, sull’omonima piazza, Intra-ground, l’installazione composta da un trittico di sculture del neozelandese Guy Lydster e di tre grandi fotografie di Andrea Abati, fondatore dello spazio no-profit Dryphoto di Prato. Jago, Banksy e TvBoy la fanno da protagonisti (fino al 7 maggio) a Palazzo Albergati (via Sara-
Bologna chiama
Dall’alto in senso orario, alcune delle opere in mostra a Arte Fiera dal 3 al 5 febbraio: installazione di Hans Kotter; Bride and Groom di Arthur Tress; Hourglass, Our Time di Lucrezia Roda; Hicham Gardaf. In basso, a destra: il Centro Servizi dell’Artefiera realizzato da Mario Cucinella Architetti


gozza 28), una tripla monografica Controcorrente sin dal titolo, con le loro opere più significative: dalle ormai super inflazionate Girl with Baloon e Bomb Love di Banksy a Memoria di sé di Jago e agli eroi di TvBoy.
Imperdibile Giovanni Fattori con la sua umanità tradotta in pittura a Palazzo Fava (via Manzoni 2, fino al primo maggio), selezione di oltre 70 opere del maestro della macchia, scelte da tre studiose del precursore della modernità: Claudia Fulgheri, Elisabetta Matteucci e Francesca Panconi. La gravità, intesa come forza a cui la forma si assoggetta e cede fino al suo azzeramento, è al centro dei lavori della tedesca Bettina Buck per Finding Form a Palazzo De’ Toschi (piazza Minghetti 4/D), tra gli appuntamenti più interessanti di Art City. Tra questi, anche Guarda Caso di
Foto pagine 98-99: Foto per gentile concessione di: ABC-ARTE GallerySiamo tutti già cyborg, ci ricordano alcune opere.
Automi, ma con eccezionali e inesauribili risorse fisiche e mentali, pronti a trasformarci e rigenerarci
Eva Marisaldi al LabOratorio degli Angeli (via degli Angeli 31) e Apoptosi di Anne e Patrick Poirier alla Galleria Studio G7 (via Val D’Aposa 4/A).

Ultimo l’appuntamento alla Fondazione Mast con le opere dei cinque finalisti della settima edizione del concorso MAST Photography Grant on Industry and Work, protagonisti di una mostra curata da Urs Stahel, anima di questo spazio speciale, insieme ai lavori dei finalisti delle precedenti edizioni. Parteciperanno al concorso le foto di Farah Al Qasimi (Sorelle), Hicham Gardaf (Laaroussi, a dir poco incantevole), Lebohang Kganye (Donna nel cuore della notte), Maria Mavropoulou (un luminosissimo Senza Titolo) e Salvatore Vitale che ci ricorda che Siamo già dei Cyborg: automi, ma dalle inesauribili risorse.




In un posto a sé, in periferia ma al centro dei palazzi del quartiere Santa Viola, c’è la Fondazione Mast, istituzione internazionale, culturale e filantropica, basata sulla tecnologia, l’arte e l’innovazione. Mast, albero maestro delle navi in lingua inglese, sta infatti a sottolineare lo stretto rapporto con la manifattura di arti, sperimentazione e tecnologia. Reach, la scultura curva e a specchio di Kapoor è visibile nel giardino.
All’interno del museo, mostre temporanee e tante sorprese a partire da “Photography Grant on Industry and Work 2023”, dal 25 gennaio fino al primo maggio 2023 (a ingresso gratuito). Interessante e fitto è anche il calendario di appuntamenti e di riflessioni sull’etica con relatori come Lella Costa, Alessandra Viola, Dacia Maraini e Vito Mancuso (dal 30 gennaio al 13 marzo).
Articolati e ricchi sono pure i percorsi educativi pensati per scuole e famiglie. Tutte le informazioni su www.mast.org
Marco Montemagno è un “diversamente giovane”, come ama definirsi lui. Ha cinquantuno anni e uno stile di vita da generazione Z. Di mestiere fa l’influencer. In realtà sarebbe più corretto dire che fa il divulgatore, ma ormai questa parola è sorpassata. «Mi appassiona tutto il mondo del digitale, della comunicazione e dell’imprenditoria», esordisce: «Intendo l’imprenditoria moderna, quella abilitata dalle nuove tecnologie digitali che nascono ogni due minuti. Così da vent’anni faccio due cose: startup digitali e comunicazione».

Ha studiato Legge ed è stato un campione di ping pong, ma la storia moderna di Montemagno è partita con il boom di Internet e della new economy. Dall’inizio degli anni Duemila ha lanciato diversi progetti, senza grande successo per sua stessa ammissione. Finché nel 2005 è arrivata l’idea di Blogosfere, un network di blog professionali che invece si è affermato sempre di più, fino ad essere comprato da Il Sole 24 Ore. Negli stessi anni si è consolidata la sua carriera di divulgatore, con la conduzione della trasmissione “Pianeta Internet” su Sky Tg24, per sette anni. È stato anche il protagonista di un format itinerante nei teatri e nelle piazze italiane dal nome “Codice Internet” e nel 2009 è uscito il suo primo libro, “Alla conquista del web”, a cui ne sono seguiti altri tre, l’ultimo nel 2021 col titolo “Tutto Montemagno” (Mondadori Electa).
Finita l’esperienza di Sky, è arrivato un cambiamento di vita. Con la “sua dolce metà”, come è abituato a chiamare sua moglie anche nei video pubblici, si è trasferito a Brighton, in Inghilterra, terra di ori-
gine di lei. «Quando sono arrivato ho fatto un provino alla Bbc, convinto che avrei potuto fare una trasmissione tv tech simile a quella che avevo condotto per sette anni in Italia. E invece mi hanno scartato. Con il passare del tempo, mi mancava la diretta, l’appuntamento con il pubblico. Così ho iniziato a fare video su YouTube». L’idea era buona: di fatto all’epoca nessuno faceva filmati di qualità che parlassero di digital, di business e di marketing, ma il pubblico non ha risposto subito secondo le attese. La vera svolta arriva quando Facebook lancia i primi video. «Il mio primo video ha avuto subito un successo incredibile, virale. Da lì ho iniziato a pubblicare con regolarità: un video al giorno. Sono stato fra i primi a espormi su tutte le nuove piattaforme che iniziavano a includere filmati». I suoi post sono di varia natura, negli ultimi anni si è affermata la sua formula del “Quattro chiacchiere con”, in cui intervista personaggi con i tempi veloci del web.
Ad oggi, considerando tutti i social me-
Da vent’anni si occupa di divulgare temi legati alla cultura digitale. E sui social ha tre milioni e mezzo di follower. Che
lo seguono anche per i suoi consigli e incoraggiamenti
li. Non c’è nessuna aspirazione speculativa, è realmente il modo più moderno per gestire una community ristretta».
Quello di Montemagno è un pubblico molto pregiato e profilato per piattaforma, che a lui si rivolge come a un fratello maggiore da cui ricevere un consiglio per l’indirizzo di studio, un parere sulle nuove tecnologie o un incoraggiamento a inventarsi un nuovo lavoro. Pubblico che lo segue anche offline ogni volta che è ospite in un evento e ancor di più se lo gestisce. Così è normale che aziende e istituzioni collaborino volentieri con lui per raggiungere facilmente la sua community.
dia su cui è presente, Montemagno ha un pubblico di quasi tre milioni e mezzo di follower. È naturale che gran parte del suo tempo sia dedicato a curare e a crescere questa community, alla quale ha dedicato anche il suo ultimo progetto imprenditoriale: 4Books. Una piattaforma dove è possibile leggere o ascoltare centinaia di sintesi di libri da tutto il mondo sui temi cari al divulgatore. Il suo spirito imprenditoriale viene fuori anche nella gestione della propria community, ha addirittura una specie di programma fedeltà basato su NFT: i Crazy Fury. Chi possiede uno di questi “digital collectible”, oggetti digitali collezionabili, può accedere a contenuti riservati, eventi live e altro. Per chi proprio vuole essere intimo con Marco, deve acquistare almeno dieci Crazy Fury entrando nella Hall of fame, così può anche incontrarlo per aperitivi e cene, come per esempio è successo lo scorso Natale. L’influencer spiega: «I Crazy Fury di fatto sono una membership, una password moderna per accedere a contenuti ed eventi specia-
Marco Montemagno, 51 anni, è influencer, youtuber, imprenditore, giornalista e scrittore
Proprio in questi mesi è nel vivo Edufin 3.0, progetto di educazione finanziaria di Banca Generali e altri grandi partner che lo vede coinvolto in prima persona. «Sono anni che la mia community mi chiede approfondimenti sul tema dell’educazione finanziaria, ancor di più sull’educazione digitale», racconta: «Dopo aver trovato una squadra di partner perfetta, sono davvero contento di poter aprire le porte dei miei canali social a questo progetto. Il palinsesto spazia a 360 gradi sul tema finanza con 52 interviste a esperti, il mio classico format “Quattro chiacchiere con”, volte a diffondere una cultura positiva verso il mondo degli investimenti e rivolta a un pubblico trasversale, di generazioni diverse». È ben noto che l’Italia non eccelle affatto per quanto riguarda la competenza finanziaria. Questo perché la scuola non la include tra i propri programmi e anche perché in qualche modo rimane ancora un tabù. Certamente non c’è da auspicarsi una società basata su finanza e ricchezza, ma neppure si può pensare di continuare ad avere una popolazione incompetente e alla mercè di truffe e imbonitori. E, come dice Montemagno, «la divulgazione non può prescindere dai social: basti pensare che la generazione Z trascorre più di tre ore al giorno online». Però questo pubblico vuole contenuti veri, non spot promozionali, per questo il format è basato su interviste a esperti di qualità per fornire strumenti grazie ai quali ognuno possa crearsi una propria cultura e idea sul tema. «È stato fondamentale incontrare Gian Maria Mossa, ad di Banca Generali», conclude Montemagno: «Anche lui voleva un vero progetto di educazione finanziaria, non vendere prodotti».

A38 anni appena compiuti il regista e sceneggiatore Damien Chazelle ha vinto già un Oscar, due Golden Globe e un Bafta per il suo “La La Land”. Che cosa ne ha fatto di questi prestigiosi riconoscimenti? «Non mi hanno cambiato la vita, ma mi hanno aperto delle porte importanti: grazie a loro ho potuto trovare i finanziamenti per realizzare un film che avevo nel cassetto da 15 anni». Sta parlando di “Babylon”, in questi giorni al cinema, un film iperbolico e faraonico che attraverso performance di divi cari allo star system di oggi come Brad Pitt e Margot Robbie mira a raccontare la cultura degli eccessi agli albori di Hollywood.
In America oggi c’è un clima culturale e politico che possa consentire un cinema veramente libero?
«No. Lo dico senza mezzi termini. Hollywood oggi è completamente governata dalla paura e da un certo moralismo puritano.
Tutt’altro rispetto agli anni Venti che racconto nel film, in cui si respirava un’aria di maggiore libertà artistica in cui c’era spazio per l’eccesso e la trasgressione».
Intende dire che Hollywood negli anni è diventata bigotta?
«Penso faccia parte del suo processo naturale di evoluzione, fatto di continui aggiustamenti, modifiche, progressi e regressioni, per tendere all’ideale di una perfezione evidentemente irraggiungibile. La Hol-
REGISTA DA OSCAR
Damien Chazelle, 38 anni, ha vinto già una statuetta, due Golden Globe e un Bafta per il suo film “La La Land”
lywood di oggi, fatta di regole e conformismo, è ben diversa da quella libera e selvaggia che ho voluto raccontare in “Babylon”.
Non il mito della vecchia Hollywood patinata, ma la costruzione di una città e un’industria nel bel mezzo del nulla ad opera dei reietti della società».

Vale a dire?
«Gli esclusi, gli emarginati, i rifiutati altrove. È ai poveri, agli immigrati, persino ai criminali che si deve la nascita di una nuova Babilonia. E al loro desiderio di arricchirsi attraverso un mezzo allora considerato sporco, volgare, peccaminoso al limite del pornografico, senza prestigio e senza futuro, cioè il cinema».
Ha dichiarato di essersi ispirato a maestri del cinema italiano come Fellini, eppure il suo “Babylon” fa pensare molto a certe opere di Pasolini.
«È il cineasta che più di tutti ha saputo trasgredire, senza alcun timore di sfidare o
colloquio con DAMIEN CHAZELLE di CLAUDIA CATALLIscioccare il pubblico, eppure – o forse proprio per questo - ancora è celebrato e riconosciuto in tutto il mondo. Anche i suoi film più estremi e controversi sono considerati di valore. Lo ammiro molto e penso che la storia del cinema l’abbiano fatta, la facciano e la faranno i provocatori».
Chi sarebbero oggi i provocatori?
«Quelli che provano a fare qualcosa che esca dai binari prestabiliti, dalle regole e dalle convenzioni. Solo così il cinema può sopravvivere, grazie al lavoro di autori veramente liberi, in grado di rivendicare e usare questa loro libertà».

Per Pasolini il cinema era un modo per esprimere anche la propria visione politica. Per lei?
«Penso che avesse ragione lui, qualsiasi opera è politica. Da autore non puoi separare il cinema che fai dalla persona che sei, anche se involontario il gesto politico c’è sempre. Credo sia importante però per i registi non confondere l’intento politico con il didascalismo, la pedagogia, il volere a tutti i costi mandare un messaggio. Anche la sola provocazione è un gesto politico, per me forse il più alto, perché punta a scuotere lo spettatore, a porgli delle domande senza la pretesa di dare risposte. Anche perché chi diavolo le ha queste risposte? Contano solo le domande: spero che “Babylon” sollevi quesiti mai sollevati prima dai film precedenti, mostrando a viso aperto com’era, nel bene e soprattutto nel male, Hollywood quan-
Gli anni Venti, la cultura degli eccessi, gli albori del cinema. Il nuovo film del regista di “La La Land” guarda a “La dolce vita” di Fellini e all’intellettuale italiano. “Hollywood? È governata dal moralismo”
do era totalmente libera, selvaggia e sregolata».
Come libera, selvaggia e sregolata è Margot Robbie nel suo film, nei panni dell’aspirante attrice Nellie LaRoy. Già solo nella prima mezz’ora del film la vediamo fare praticamente di tutto: imbucarsi ad una festa, sniffare cocaina, ballare scatenata, mostrare un seno, piangere da un occhio solo e molto altro ancora.
«Margot Robbie è una forza della natura, un’attrice straordinaria con un talento e un coraggio rari. Ogni ruolo risveglia in lei una belva selvatica diversa, sul set può osare qualsiasi cosa, compreso piangere da un occhio solo. Sa unire all’istinto naturale una grande disciplina e questa combinazione tra selvaggia irrazionalità e virtuosismo tecnico è vincente. Per dirigerla ho dovuto solamente crearle intorno un’atmosfera di supporto e massimo comfort in cui potesse essere pienamente libera di sperimentare e improvvisare qualsiasi cosa volesse».
Parliamo dell’accoglienza che è stata riservata al suo film. “Babylon” sta dividendo molto pubblico e critica, si aspettava reazioni tanto controverse?
«Sapevo che avrebbe suscitato reazioni negative e infastidite, ci tenevo a fare un film controcorrente, contropelo, difficile da digerire. Come difficile è stato convincere i produttori a realizzarlo, sapevo fin dal principio che sarebbe stato scioccante nel suo
intento di sollevare il tappeto e mostrare il marcio della vecchia Hollywood. Se vedendolo trovate certe cose eccessive vuol dire che ho centrato il mio obiettivo: non volevo un film che scivolasse silenzioso nell’anonimato, ma che facesse rumore. Ecco perché, nel realizzarlo, non ho voluto ammorbidire né attenuare nulla».
“Babylon” si apre con un elefante che sta per essere trasportato alla festa dell’anno, un party esagerato in cui vediamo accadere veramente di tutto…
«È lì che ho pensato a Fellini, nessuno sapeva girare le feste come lui, pensiamo alla Dolce Vita che ha fatto implodere ogni convenzione stilistica dell’epoca. Fellini ha insegnato al mondo a filmare il sogno e ad esplorare il confine tra sogno e realtà, arte e vita, bellezza e grottesco. Vorrei che si guardassero i miei film come tutti abbiamo guardato i suoi, lasciandoci trasportare in un viaggio incredibile».
Il cinema, come arte, è immortale?
«È un quesito che lo accompagna fin dai tempi dei fratelli Lumière. In camera ho appeso una copertina di Paris Match con Marilyn Monroe in cui ci si chiedeva se il cinema stesse morendo, erano gli anni Cinquanta. Se qualcosa è morto è forse il sistema degli studios, ma è stato sostituito dal sistema delle piattaforme, la cui coesistenza con le sale non è facile. Per fortuna però il cinema continua a sfornare nuovi mezzi per intrattenere il pubblico. Ieri con l’avvento del sonoro e del cinemascope, oggi con il 3D». Una tecnica interessante, se maneggiata da chi è in grado di usarla al meglio come James Cameron».

“Nel film racconto i poveri, gli immigrati, i criminali che hanno dato vita a una nuova Babilonia.
E la loro voglia di arricchirsi attraverso un mezzo allora considerato sporco: il cinema”
SUL SET
Il regista americano Damien Chazelle durante le riprese del film “Babylon”

La guerra, la Resistenza, l’orrore nazista visti dalla Maremma, da Le Case anzi, “un niente sperduto nel niente delle croste con l’unico vantaggio di guardare dall’alto la fogna delle paludi”. Una guerra dei poveri “con un circo di animali strani” tra i quali spiccano René, il modesto, solitario ciabattino del paese. E una donna, Anna, alla quale la guerra ha tolto il figlio, cioè tutto, e che per sopravvivere si dà uno scopo. Due amici che potevano essere qualcosa di più.
La memoria del Male nel romanzo di Sacha Naspini. I versi nostalgici di Warsan Shire. Gli spiriti ribelli di Manchester. E un podcast
Quando Beyoncé, folgorata dai versi della prima raccolta, le chiese di scrivere alcune poesie per il videoclip di “Lemonade”, in pochi conoscevano questa poetessa nata in Kenya da famiglia somala in fuga, ma cresciuta a Londra. Da allora la sua esistenza è cambiata ma la sua voce potente a difesa delle ragazze afrodiscendenti ha acquistato ancora più forza e carisma. Perché si nasce “con una ninna nanna che lamenta la melanina”, ma con orgoglio si vive.
BENEDICI LA FIGLIA CRESCIUTA DA UNA VOCE NELLA TESTA
Warsan Shire, Fandango, pp. 155, € 16

Una passeggiata per la città inglese tra le lamiere e i mattoni, gli echi di rivolte operaie e i suoi luoghi più simbolici, sulla scia di alcune delle band più interessanti dagli anni Settanta a oggi: Joy Division, The Fall, Oasis, The Stone Roses e, appunto, i mitici Smiths. Tra angoli, indirizzi, ponti, club e citazioni di canzoni, la biografia musicale di una città, accogliente come quel vento che penetra ovunque.
VILLA DEL SEMINARIO
Sacha Naspini Edizioni e/o, pp. 204, € 17,50
Nei giorni in cui la senatrice Liliana Segre, intervenendo sulla proposta di un fondo per favorire i viaggi della memoria, ricorda che ad Auschwitz non si va per fare selfie ma a testa bassa e magari avendo saltato la colazione, il grossetano Sacha Naspini ripropone una storia intrisa di fame, freddo, paura: “Villa del seminario” (Edizioni e/o). Un romanzo ispirato a una vicenda vera, accaduta a Roccatederighi tra il 1943 e il 1944, quando la diocesi affitta un seminario a un gerarca fascista che vuole farne un campo di internamento. La ricerca storica conferma: dall’ex residenza estiva del vescovo si partiva per Fossoli, da dove i vagoni proseguivano per Auschwitz. René è un uomo che è sempre stato a guardare. Rinchiuso nella sua onestà senza mai colpi di testa, dedito a un lavoro simbolicamente prossimo al camminare dei resistenti, ha rinunciato a ogni passione.
Finché rapito da una possibilità di amore e di riscatto, precipita nella battaglia, “rinomina il mondo che lo circonda. E se stesso”. Perché è questa la sfida che muove la storia e che penetra tagliente nel lettore, insieme col freddo delle nevicate, il profumo di castagne rubate quando anche le briciole sono preziose, il dolore di corpi rattoppati con ago e filo, tra partigiani affamati di giustizia: spezzare il silenzio. Denunciare le complicità. Coltivare l’indignazione come arma deflagrante. “È una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”, scandisce una frase sull’Olocausto attribuita a Primo Levi. Naspini ne imprime uno, importante e toccante, su quella strada, Via del Seminario, “che la gente continua a percorrere con la leggerezza di chi raccoglie papaveri”.
A MANCHESTER CON GLI SMITHS Giuseppina Borghese

Giulio Perrone editore, pp. 155, € 15

In contemporanea al lancio di un gruppo Telegram, dedicato alla saga da appassionati cultori che Beat Edizioni pubblica in sei volumi (“La piena”, il primo), un podcast invita alla scoperta di questo horror uscito in America negli anni Ottanta e scritto da Michael McDowell, amico di Stephen King. Per lasciarsi conquistare dall’atmosfera di un paesino di un migliaio di abitanti, nell’Alabama di inizio ’900, e dai suoi infiniti misteri.
BLACKWATER
Michael McDowell, Neri Pozza Podcast Su Spreaker e Spotify

























Se c’è un artista che a teatro non ha paura di rompere tutti gli schemi è Antonio Rezza. In coppia da anni con Flavia Mastrella ha imboccato una strada ben precisa: raccontare il nostro mondo, la nostra società, le nostre relazioni costruendo spettacoli pungenti (come la sua inconfondibile sadica vocina), totalmente anarchici, semplicemente assurdi. Sia chiaro: non troverete niente di simile nel teatro italiano.
Ricordo che rimasi sconvolta quando andai a vedere uno dei suoi primi spettacoli (“Fotofinish”). Pescava persone in mezzo al pubblico e le scaraventava sul palcoscenico, fingendo che i loro corpi fossero i morti di una guerra contro l’universo. Intanto girava tutto nudo in lungo e in largo. Ma non è solo l'imprevedibilità a caratterizzare il suo teatro, piuttosto è la capacità di esprimere un pensiero nella totale assenza di regole. Ci vuole talento. Non a caso nel 2018 è arrivato il Leone d'oro alla carriera della Biennale Teatro di Venezia (a proposito, lo hanno appena assegnato ad Armando Punzo, evviva!). Cosa è successo rispetto ai primi spettacoli visti? Sempre dissacrante e folle, Rezza ha portato avanti un piccolo esperimento: moltiplicare la presenza
Evviva Caryl Churchill. I testi della drammaturga inglese non passano certo inosservati. Parlano di femminismo, guerre o del rapporto che ha la donna con il potere, come “Top girls”, che è in scena al Teatro Due di Parma fino al 5 febbraio, con la regia di Monica Nappo e un supercast esclusivamente al femminile.
Ma perché è così difficile vedere certi spettacoli nei nostri teatri? Più sono belli, prima spariscono. Solo tre repliche milanesi sono state previste per “Fraternité, conte fantastique” di Caroline Guiela Nguyen, artista associata del Piccolo di Milano e nuova direttrice del Teatro di Strasburgo. Un vero peccato.

Imprevedibile e senza regole, Antonio Rezza trascina il pubblico in un labirinto di personaggi surreali. Senza timore di “Hybris”
degli attori e spogliare la scena. Una scelta che salta subito all’occhio nel nuovo lavoro, “Hybris” (produzione RezzaMastrella, Teatro Vascello, Teatro di Sardegna). In un percorso labirintico la porta con il suo telaio sostituisce i morbidi tessuti colorati creati nei lavori precedenti da Flavia Mastrella e diventa il dentro/fuori di relazioni, collettività, pensieri. Sentiamo sbattere la porta decine di volte e noi ridiamo del nostro stesso smarrimento, trascinati da una giostra di personaggi che Rezza dirige e muove al ritmo velocissimo di un film muto. In questo assurdo dentro/ fuori fra infiniti mondi tutto è messo in crisi, a partire dal concetto di famiglia, fino alla presunta potenza dell’io (ecco la tracotanza dei greci a cui allude il titolo). Il “coro” è formato da otto attori - fra cui Maria Grazia Sughi (la madre), Chiara Perrini (la fidanzata) e Ivan Bellavista (uomo in nero e storica presenza nei lavori precedenti) - che ci regalano la scena più irresistibile quando arriva il momento delle presentazioni fra le famiglie. Da ridere, fino a star male. Ma il grande pregio di Antonio Rezza è uno: quello di essere libero, sempre, perfino di illuderci che chi sta oltre la porta non siamo noi, ma gli altri.

“Hybris” di Antonio Rezza e Flavia Mastrella
Ascoli, Teatro Ventidio Basso, 3 febbraio
Genova, Teatro della Tosse, 17 e 18 marzo
Arezzo, Teatro Petrarca, 23 marzo

Una ex fabbrica a Milano. Dove è nato l’ICA italiano. Che ospita artisti emergenti e superstar come Michael Stipe, in arrivo a fine anno
Un’immagine dell’installazione “Morestalgia” di Riccardo Benassi all’ICA, Milano

Era il 1947 quando una pattuglia di intellettuali, poeti e artisti dava vita a Londra all’Institute of Contemporary Arts, fondato perché creativi di ogni ambito avessero uno spazio espositivo e di confronto in grado di reggere fuori dai frugali canoni della istituzionalissima Royal Academy of Arts. Ed è proprio a quel modello che il critico Alberto Salvadori pensava quando ha deciso di avviare l’ICA anche in Italia: un’istituzione slegata dalle istituzioni. E allora è andato alla ricerca di uno spazio sui generis, che non avessevetrine su strada ma ricordasse un luogo di lavoro, interno a un complesso. Arriva un’ex fabbrica (completamente abbandonata), a Milano, che fino a qualche anno fa ospitava una carrozzeria e che è rimasta com’era: pavimenti, porte, vetrate, muri. Tutto fermo a quando si aggiustavano auto e furgoni. L’idea era quella di un posto che gli artisti potessero usare senza impedimenti, senza la paura di rovinare la struttura. E tutto questo suona ancora più strano a pensare che a 400 metri c’è il colosso Fondazione Prada, un’architettura preziosa, raffinata, elegante. ICA ha aperto nel 2019 e da allora sono state realizzate oltre venti mostre e se c’è posto sia per le superstar, sia per giovani agli inizi, sembra però che Salvadori abbia rivolto un’attenzione particolare agli “artisti che piacciono agli artisti”: una categoria di professionisti che hanno esposto in grandi musei e che nella stretta cerchia dell’arte contemporanea sono conosciutissimi, ma hanno magari faticato a fare il salto verso il grande pubblico. A fine anno arriverà il leader dei Rem Michael Stipe (dopo corteggiamenti di spazi con curriculum ben più ampio), che ha scelto proprio ICA per la sua prima mostra che lo vedrà cimentarsi in sculture e ritratti basati su foto. Fino al 18 marzo, però, è il turno di Riccardo Benassi e Chemutai Ng’ok.
Il primo, quarantenne italiano con una felice carriera in corso, installerà un grande led penetrabile dal corpo umano: il titolo è “Morestalgia” ed è riferito alla nostalgia tipica di questa epoca, che cerchiamo di sostituire con le esperienze digitali, creando invece un circolo vizioso di malinconia amara. La seconda, keniota classe 1989, porterà in mostra 15 disegni di un tratto evanescente come uno spirito. Quelle opere sembrano ambientate in un sogno carico di tensione, che forse è ciò che si prova a crescere in una megalopoli africana, con
tutte le sue complicazioni e l’inseguimento del modello occidentale.
La formula ICA dunque ha portato a Milano un esempio nuovo, partecipativo, reso possibile anche grazie al fatto che grandi professionisti, come lo stesso direttore Salvadori, l’ufficio stampa e comunicazione di Paola Manfredi, lo studio dell’architetto Luciano Giorgi, l’avvocato Ivan Frioni, il commercialista Franco Broccardi e altri si sono messi a disposizione gratuitamente. Attenzione però, questo approccio è molto lontano dalla concezione che la cultura non deve pagare, perché è invece la consapevolezza di chi ha avuto un meritorio e fortunato successo nel mondo dell’arte di dover restituire qualcosa a questa disciplina e alla collettività. Ovviamente addetti a curatela e produzione sono invece assunti (con contratto a tempo indeterminato, tutti). A finanziarlo sono i membri del board presieduto da Lorenzo Sassoli de Bianchi e altri fondi che si trovano di volta in volta. La Fondazione Apple ha deciso per esempio di premiare questa esperienza con 50mila euro come riferimento in Italia per la cultura. A breve uscirà anche la tessera member, ma in stile ICA: niente gold, silver, premium o roba del genere. Semplicemente, chi ci sta è dentro.






Welcome to the party, bitches!... così, tanto per riscaldare gli animi e ricordare che la prima e più autorevole delle cattive ragazze è pur sempre lei. Ha annunciato così la data che ha fatto scalpore: 23 novembre 2023, otto anni dopo l’ultima presenza in Italia, Madonna sarà al Forum di Assago, e la notizia ha fatto rumore anche per un’altra ragione, meno edificante. Il miglior biglietto per la serata è a 350 euro, per poi scalare fino a un beffardo 46 euro per il “sesto settore numerato visione laterale limitata”, come dire che si può pagare anche “solo” quasi cinquanta euro per vedere maluccio, di sguincio, e farsi raccontare quello che succede sul palco da qualcuno che ha pagato di più. Tanto, troppo, anche per un concerto così atteso e che Madonna ha annunciato con un video in cui è circondata da vip suoi amici e l’attrice Amy Schumer la sfida a portare in scena i suoi successi. Madonna non si fa pregare più di tanto e annuncia il tour mondiale, insieme a un nuovo singolo, “Back that up to the beat”, firmato con Pharrell Williams. Dunque nel tour si celebreranno i suoi 40 anni di carriera ed è verosimile immaginare che per la gioia degli idolatri sarà tutto un ripercorrere le sue fasi, i suoi celebri look, come quello della virginale sposa
Drake nel bel mezzo del suo spettacolo al leggendario Apollo Theatre di Harlem ha interrotto il concerto quando gli hanno riferito che uno spettatore era caduto dal loggione in platea, e non ha ricominciato finché non gli hanno assicurato che lo spettatore stava bene e non aveva subito danni.
Dolly Parton ha annunciato che sta per pubblicare per la prima volta in vita sua, a 77 anni, un disco di rock’n’roll e per l’occasione, tra le tante collaborazioni, ha inciso un duetto con Paul McCatney, 80 anni, sulla canzone “Let it be” che di anni ne ha 52. Ce n’era davvero bisogno?
La prima delle cattive ragazze torna in Italia. Con un concerto in cui ripercorrerà 40 anni di carriera. Ma i biglietti costano fino a 350 euro
Madonna parla sul palco degli MTV Video Music Awards, nel 2021

degli inizi, l’egitto-romana inventata per il Super Bowl del 2012, il reggiseno a forma di cono firmato da Gaultier, Marilyn, e tanto altro, verosimilmente con gli stessi vestiti di allora.
A incuriosire è una semplice domanda: come sarà davvero questo spettacolo? In questi ultimi tempi Madonna è enormemente cambiata, ha 64 anni, ha radicalmente mutato il suo approccio alla comunicazione, spudorata, senza veli, a tratti perfino sguaiata, anche se di recente ha ripulito tutto quello che c’era su Instagram, per ripartire da zero. Da qualche tempo stava lavorando anche a un biopic su se stessa, praticamente un gigantesco selfie, che nel frattempo, però, è stato congelato per dare priorità al tour. Il biopic, comunque, sarebbe stato — secondo la star — «un attacco preventivo, perché molte persone stavano cercando di fare film su di me. Perlopiù uomini misogini. Così ho detto: “Nessuno racconterà la mia storia tranne me”».
E a proposito del concerto ha aggiunto che non vede l’ora di poter avere un momento con ognuno di voi. È quello che fanno i grandi, ti danno l’impressione che quello che stanno facendo non lo stanno facendo per una platea gigantesca e generica, lo stanno facendo solo ed esclusivamente per voi, per ognuno di voi, a patto di pagare un misero obolo che va dai 50 (vedendo male) ai 350 euro.
 Foto: J.
Shearer
Foto: J.
Shearer
Èbene dirlo subito, per togliersi il pensiero: “Call My Agent” è uno dei prodotti seriali migliori in circolazione. Perché fa molto ridere, è fatto con estrema cura ed è persino assai bene interpretato. Così giusto per mettere a tacere tutti coloro che avevano messo avanti mani piedi e nasi storti al debutto dei sei episodi su Sky Serie. Perché si sa, la forma nervosa da remake è uno di quei disturbi diffusi di cui il nostro Paese si ritrova assai spesso vittima con scarse probabilità di successo. Solo per non fare nomi e cognomi, basti pensare a “Noi”, la versione polpettone di un capolavoro come “This is Us”, o ancor peggio per certi versi, alla trasposizione italica di “Your Honor”, letteralmente tradotto come “Vostro onore” che si sa, dire giudice (o presidente della Corte) sembrava troppo provinciale. Generalmente, al di là della colpevole incapacità di essere credibili, le trasposizioni vengono affrontate come i dettati delle elementari che furono, perché definirlo copia incolla regala quel senso di modernità eccessivo. Se la storia funziona anche da noi, bene. Altrimenti pazienza, si fa sempre in tempo a dire che l’idea è di Stefano Accorsi. Per cui lo stupore davanti alla traduzione riuscita di quella vaporosa meraviglia francese chiamata “Dix pour cent” è palpabile. La trama è presa di peso ma riesce, nonostante la tendenza ostinata alla cartolina romana, a essere plausibile, come la sabbia che si
La versione italiana di “Dix pour cent” è diretta da Luca Ribuoli e scritta da Lisa Nur Sultan
In ”Call my agent” (Sky) il cast funziona, le risate abbondano e l’adattamento italiano una volta tanto non lascia delusi

adegua alla formina. Chi ha già visto l’originale (e guai a chi non l’avesse ancora recuperato su Netflix) soffrirà ovviamente quel senso di già raccontato. Ma la sorpresa si nasconde nei dettagli, nel cast degli agenti che regala finalmente a Sara Lazzaro un ruolo nevroticamente motivato, in quel gusto del tutto inedito degli attori per l’autoironia, nel desiderio di mostrare i vizi più che le virtù. Così mentre si gongola per la nuova coppia comica Corrado Guzzanti (una certezza imperitura) ed Emanuela Fanelli (una certezza capace di consolidarsi a ogni apparizione), quel che colpisce è proprio Accorsi che cita malignamente se stesso, a partire dallo spot del gelato Maxibon. E poi Pif e l’insicurezza riassunta nei baffi fuori scala, Favino che nei panni di Che Guevara dialoga con Minà, Matilda De Angelis e l’insofferenza social, Paola Cortellesi che prende lezioni di etrusco da Alberto Angela. Sino a Paolo Sorrentino che in un gioiello gigione si rivolge a un suo parigrado: «Ho scritto: Dio, occupati tu dell’istruzione. Non dei figli, ma dei genitori». Insomma, alla fine quel che resta è che è vero che i macaron sono assai buoni, ma anche le ciambelle, quando hanno il buco, non sono niente male.
The Voice senior è quello strano programma in cui all’apparenza è tutto già visto: la selezione, la gara, la giuria, le canzoni. Eppure, quei ragazzi irresistibili che prima di scatenarsi sul palco raccontano la loro lunga vita ad Antonella Clerici, regalano un’inedita tenerezza. È la loro seconda volta, ma dolce come la prima.
Nella scuola di Amici scoppia lo scandalo del Capodanno condito dalla noce moscata. I ragazzi colpevoli di malefatte per amor d’euforia vengono trattati come discoli in diretta, sgridati in malo modo, bullizzati via social, tolti i cellulari e tutti a letto presto. La tv educativa di Maria De Filippi, altro che libro Cuore.

L’ultimo erede di Hitchcock si chiama Park Chan-wook, è coreano, ha al suo attivo film molto diversi e molto premiati, ma stavolta guarda addirittura a “Vertigo - La donna che visse due volte”, da cui riprende la struttura bipartita e il dubbio che tortura il protagonista per l’intero film. La malinconica Seo-rae, immigrata cinese dal coreano imperfetto, cosa che la rende ancora più indecifrabile (e affascinante), è un’assassina manipolatrice, la donna del destino – o magari le due cose insieme?
Il resto è stile, ricercatissimo ma mai vistoso, perché un film naturalmente non è solo ciò che mostra, è anche ciò che tace o nasconde, lasciando allo spettatore il compito (e il piacere) di capire cosa è accaduto fra una scena e l’altra. Ovvero cosa passa nella mente, nel cuore e sotto la pelle dei protagonisti, l’impeccabile e sposatissimo ispettore Hae-joon (Park Hae-il) e quella giovane badante con un marito troppo vecchio per lei, morto cadendo da una montagna, che in Corea è arrivata su un barcone e potrebbe già avere sulle spalle altri delitti.
Anche se più gli indizi si accumulano (indizi e false piste, Park Chan-wook e la

C’è un po’ d’Italia fra i candidati all’Oscar, “Le pupille” di Alice Rohrwacher, in gara come miglior corto. Un piccolo grande film, basato su una lettera di Elsa Morante all’amico Goffredo Fofi, che celebra “il desiderio, la libertà e lo spirito anarchico che può irrompere nelle menti di alcune allieve di un collegio religioso”. Visibile su Disney +

E vabbè, sarà anche eccessivo, squilibrato, ridondante, un po’ pulp, ma è mai possibile che il coraggioso e personalissimo “Babylon” totalizzi appena 3 candidature agli Oscar (scene, costumi, musiche) mentre il roboante “Top Gun: Maverick”, per dire, ne colleziona ben 6 fra cui miglior film, adattamento ed effetti speciali?
Il regista di “Old Boy” e “Mademoiselle” reinventa “La donna che visse due volte” e coniuga azione e sentimento
co-sceneggiatrice Chung Seo-kyung sono maestri delle sottotrame), più il detective, oggetto anche di ire e gelosie professionali, cade preda di un sentimento irresistibile. Espresso con un’eleganza e un pudore che possono evocare il Wong Kar-wai di “In the mood for love” ma sono in realtà frutto di un gusto per l’allusione sorprendente nel regista sfrenato di “Old Boy” e “Mademoiselle”. Una frase ricorrente, uno sguardo sospeso, un dettaglio che si riaffaccia, ed eccoci sprofondare negli abissi della passione o nei tormenti del dubbio. E dell’insonnia che lo accompagna: l’unica scena “di letto” che ci viene concessa è quella, bellissima, in cui Seo-rae rilassa l’amante inquieto invitandolo a scendere nelle profondità marine “come una medusa che non ha occhi, né naso, né pensieri”.
Gli elementi della Natura sono del resto fondamentali in questo film che coniuga Hithcock e Confucio, thriller e melodramma, azione vertiginosa (è il caso di dire) e vampate d’ironia. Ma soprattutto esalta la bellezza, il mistero, insomma la bravura davvero superlativa di Tang Wei (già protagonista di “Lussuria” di Ang Lee). Premio per la regia a Cannes, già nella shortlist dell’Oscar al miglior film straniero, Park-Chan-wook ritrova il gusto dello spettacolo - e dei sentimenti - con sottigliezza insolita, oggi che si tende a dire e mostrare tutto. E tanto più necessaria.
DECISION TO LEAVE di Park Chan-wook Corea, 138’












Il benessere del cane di razza passa anche attraverso il pedigree. Pochi sanno cosa sia questo pezzo di carta e quale sia il suo valore. E su questo, giocano molti “scucciolatori” senza scrupoli che poco hanno a cuore il benessere dei propri cani e dei cuccioli che venderanno al primo che abbocca. Le razze più richieste sono quelle di taglia piccola e da compagnia. Prendiamo ad esempio il barboncino. Un cane delizioso e con alte capacità associative, non perde il pelo, non puzza ed è affettuoso. Un barboncino nano o toy quindi, di piccolissima taglia, costa tanto. Poi ci sono i colori che vanno di moda e quelli più rari da trovare. Alla fine un cucciolo di barbone viene a costare sul mercato tra i 1.500 e i 3.500 euro. L’incauto acquirente comincerà a cercare su Google e troverà un’infinità di proposte. Dagli allevatori con affisso riconosciuto (titolo dell’allevamento, ndr), a privati, fino a furbi commercianti di malcapitati cani. L’incauto acquirente si rivolgerà a quello che offre il miglior prezzo, e con 1.500 euro si porterà a casa un cucciolino delizioso senza il famoso pedigree. Dietro a quel cucciolo ci sono storie di sofferenze e maltrattamenti. Femmine che arrivano dall’est Europa con il traffico clandestino, dedicate alla riproduzione fino allo sfinimento e poi gettate chissà dove, nessun controllo sulle malattie genetiche ereditarie, vaccinazioni assenti, nessuna sverminazione, cuccioli che vengono tolti alle mamme dopo poche setti-

Un barboncino in un prato
Il benessere del cane di razza passa anche dal certificato genealogico. Ma pochi sanno qual è il suo valore. E rischiano di essere ingannati
Se desideriamo un cane, ma pagarlo non fa parte dei nostri piani, dovremo rivolgerci ad un canile o ad un’associazione per adottare un meticcio.

Non acquistate mai un cane di “razza” senza il pedigree. Un consiglio che do per due motivi: non solo il cane non sarà di razza, ma meticcio, ma dietro a quel cucciolo si nasconde un maltrattamento.
mane senza pensare al loro benessere. Da quel momento, nove volte su dieci, comincia il calvario. Piano, piano, vengono fuori malattie che, per essere tenute almeno sotto controllo, hanno costi elevatissimi. Qualche allevatore poco serio fa lo sconto se non vogliamo il pedigree. È bene sapere che questo documento vidimato dal ministero (Masaf), costa circa venti euro al nuovo proprietario. Non si tratta quindi del costo intrinseco del pezzo di carta, ma del lavoro che c’è dietro: testimonia l’albero genealogico, i test sulle malattie ereditarie, le vittorie sul campo di genitori nonni e bisnonni. Titoli, dietro ai quali, c’è un grande lavoro con costi elevati. Cosa dice la legge. Secondo il decreto legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992, in Italia è vietato vendere cani senza pedigree spacciandoli per cani di razza. Se anche le sembianze sono ad esempio quelle del barbone, senza il pedigree e la registrazione nell’anagrafe dei cani di razza, sarà solo un meticcio. L’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana www.enci.it, prevede che gli allevatori firmino un codice etico di allevamento, in cui viene, ad esempio, stabilita l’età delle femmine per partorire: minima diciotto mesi, massima otto anni, e tutta un’altra serie di vincoli sul benessere degli animali. Se proprio vogliamo un cane di razza, mettiamoci in testa che il pedigree è un documento fondamentale. Va preteso.

Parampampoli, Caffè valdostano e le diverse versioni della nota bevanda calda a base di rum, limone e miele. Per affrontare la stagione fredda
fè Valdostano è una bevanda fiammeggiante ottenuta da una miscela di caffè, grappa locale, genepì (infuso di piante aromatiche del tipo Artemisia), zucchero, scorze di limone e di arancia.
Anche nelle bevande calde invernali spesso e volentieri l’intuizione ha giocato un ruolo fondamentale. Pensiamo, ad esempio, al Parampampoli. Siamo in Val Sugana, dove sorge un piacevole e accogliente punto di ristoro, il Rifugio del Crucolo, il cui proprietario Giordano Purin inventò una miscela liquorosa a base di caffè, vino, grappa e altri ingredienti tenuti custoditi segretamente, da servire alla fiamma ai clienti infreddoliti. Il successo fu tale che si pensò di confezionarlo già dosato con tutti gli ingredienti in bottiglia, non restando altro da fare che farlo bollire sul fuoco e servirlo alla fiamma nelle tipiche e massicce tazze di ceramica. Ci spostiamo dal Trentino alla Val d’Aosta per il cosiddetto Caffè alla Valdostana sorseggiato direttamente dalla “Coppa dell’amicizia” o dalla “Grolla”. Si tratta - pur nelle loro differenze: una più piatta una più alta, simile a un calice - di recipienti di legno intarsiato. La Coppa ha una forma larga e bassa, con il coperchio, provvisto dei caratteristici beccucci per bere “à la ronde”, cioè passandosi la coppa sorso via sorso, commensale via commensale. Si racconta che i pellegrini in transito in Valle d’Aosta e provenienti dalla Borgogna portassero con sé una coppa con coperchio per bere in compagnia. Coppa che richiamava il Sacro Graal e con il tempo per renderlo accessibile al popolo fu lavorato in legno da utilizzare nei momenti di festa lasciandolo poi in eredità ai figli. Il Caf-
Una tazza di grog. Vin brulé in bicchieri di ceramica con mandarini, rosmarino fresco, timo, cannella e stelle di anice
Passiamo quindi a un’altra bevanda temprante ma questa volta estera: il Grog facendo un salto nel XVIII secolo quando l’ammiraglio della Royal Navy Edward Vernon decretò nel 1756 che ogni marinaio avesse diritto a una dose quotidiana di una mezza pinta di Rum allungata con un quarto di pinta di acqua, da somministrare in due momenti della giornata. Pare che i marinai, che ovviamente amavano il Rum senza tante diluizioni iniziarono a chiamare “grog” questo beverone, desumendo la voce dal soprannome dell’ammiraglio Vernon, definito “Old Grog”, a causa di un cappotto di “grogram” o “grosgrain” (cioè stoffa grossa) che era solito portare. Quando poi si scoprì che la vitamina C preveniva lo scorbuto, si cominciò ad aggiungere al grog del succo di limone o di lime e zucchero di canna. Con gli anni, comparvero varie ricette di grog. La preparazione si avvia facendo scaldare sul fuoco in un pentolino, una porzione di Rum scuro, poco più di acqua, succo di limone e un cucchiaino di miele. Senza gli agrumi, con solo Rum, acqua, zucchero e noce moscata si prepara la variante chiamata “Bumboo”.

HIBRID MIX
Nel mondo automobilistico i crossover sono diventati un must. Ora anche in cucina le ibridazioni stanno prendendo piede ed ecco che sfilano i Cronuts (croissants-donuts), i baissants (bagels-croissants), i duffins (donuts-muffins).
LO YUZU
Che questo agrume giapponese sia ottimosorta di mix succoso tra limone, pompelmo e mandarino – è assodato ma che in una certa ristorazione esista solo questo agrume ci pare davvero eccessivo.
Elvio Cogno è una di quelle rare aziende vinicole capaci di vedere oltre il qui e ora e anticipare, con successo, gli scenari futuri. Attestata come proprietaria-produttrice fin dalla fine del ’700, in zona Novello, la storia recente inizia negli anni ’60, quando Elvio decide di vinificare i cru Brunate e La Serra a La Morra, insieme al socio, il notaio Marcarini. È il periodo in cui si posano i primi mattoni della mitologia moderna del Barolo e in cui la neonata cantina già usa, profeticamente, i nomi delle vigne in etichetta. Negli anni ’90 Elvio rientra a Novello, affidando la struttura alla figlia Nadia e al marito Valter, che impostano fin da subito un lavoro di grande lungimiranza.
In cantina si abbandonano datate interpretazioni iperconcentrate preferendo fermentazioni lunghe, anche di 40 giorni, con la classica tecnica del cappello sommerso (parte con grappolo intero) e affinamento in botte grande e bottiglia, alla ricerca soprattutto della raffinatezza. Poi molti dei segreti sono custoditi in campagna, in cui da 10 anni si sono aboliti diserbi, chimica di sintesi e trattamenti massivi, e ora, dopo un periodo in cui si è valutata la reazione di terreno e vite, l’azienda approderà alla certificazione bio.
Tra i prodotti il Barolo Ravera, innanzitutto, che arriva in etichetta già nel 1991, ponendo le basi per l’omonima MGA (Menzione Geografica Aggiuntiva), indubbiamente la più feconda di Novello. Ma c’è tanto altro, come il bellissimo progetto dedicato alla Nascetta o la Barbera d’Alba DOC Pre-Phylloxera, una bottiglia unica, prodotto di uno dei pochissimi vigneti a piede franco superstiti, vecchi di 120 anni. L’etichetta su cui si è investito di più, invece, è il Barolo DOCG Ravera Riserva Vigna Elena. Da clone Nebbiolo Rosé in purezza, rappresenta una rilettura magistrale dei classici delle Langhe, con note di nespola, fragoline di sottobosco, peonia e anice stellato, al gusto salato, con sfumature di cappero di Pantelleria e ritorno balsamico-floreale.
I classici del territorio magistralmente riletti. Come il caparbio Barolo Docg Ravera. E altre raffinate sorprese Elvio Cogno
Veduta dell’azienda agricola Cogno con i suoi vigneti. A destra: Nadia Cogno con il marito Valter.

BAROLO DOCG RAVERA 2019


PUNTEGGIO 100/100
Prodotto nel territorio della MGA Ravera, un Barolo di inimitabile tempra e carattere. Olfazione di freschezza, che parte con note di lampone, poi sfumature di nettarina, tocchi officinali di alloro ed eucalipto, noce moscata in chiusura. Palato con sensazioni di arancia sanguinella, salino, teso-croccante, con ritorno fruttato. Ideale l’abbinamento con una guancia di manzo brasata al vino rosso, magari proprio a base di Nebbiolo.
ELVIO COGNO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.

Località Ravera, 2
12060 Novello (CN)
Tel. 0173 744006
elviocogno@elviocogno.com
Cara Rossini, con la presuntuosa attenuante del «les grands esprits se rencontrent toujours», conceda questo timido lamento iniziando -come si usa oracon il disinvolto «salve!». L'uso confidenziale del tu dilaga tra persone che non si sono mai viste, né conosciute. Se lo posso ignorare nei supermercati, in considerazione della cultura merceologica, non lo accetto da banche, assicurazioni e enti vari addirittura nelle loro comunicazioni riservate e personali. Ritengo che la questione meriti un ricordo. Il 15 febbraio 1938 ci fu l'abolizione del “lei”, provvedimento così giustificato: il lei è sradicamento e abolizione di un uso che non solamente urta contro la legge grammaticale e logica, ma è testimonianza di una terminologia importata e servile, non appartenente alla tradizione linguistica latina, in luogo del lei si deve usare il tu! Contemporaneamente si fissavano altre norme, come il saluto romano al posto della stretta di mano. Queste norme furono abolite già nel luglio 1943, alla caduta del fascismo, e confermate definitivamente il 25 aprile 1945. Esattamente trent’anni dopo nascevo io. E se con la mia cara tata ci scambiavamo un affettuoso tu, in seguito alla nostra preziosa (da 25 anni) collaboratrice domestica mi rivolgo doverosamente
DIRETTORE RESPONSABILE:
Alessandro Mauro Rossi
CAPOREDATTORI CENTRALI:
Leopoldo Fabiani (responsabile), Enrico Bellavia (vicario)
CAPOREDATTORE: Lirio Abbate
UFFICIO CENTRALE:
Beatrice Dondi (vicecaporedattrice), Sabina Minardi (vicecaporedattrice)
Anna Dichiarante
REDAZIONE: Federica Bianchi, Paolo Biondani (inviato), Angiola
Codacci-Pisanelli (caposervizio), Emanuele Coen (vicecaposervizio), Vittorio Malagutti (inviato), Antonia Matarrese, Mauro Munafò (caposervizio web), Gloria Riva, Carlo Tecce (inviato), Gianfrancesco Turano (inviato), Susanna Turco
ART DIRECTOR:
Stefano Cipolla (caporedattore)
UFFICIO GRAFICO: Martina Cozzi (caposervizio), Alessio Melandri, Emiliano Rapiti (collaboratore)
PHOTOEDITOR:
Tiziana Faraoni (vicecaporedattrice)
RICERCA FOTOGRAFICA: Giorgia
Coccia, Mauro Pelella, Elena Turrini
SEGRETERIA DI REDAZIONE:
Valeria Esposito (coordinamento), Sante Calvaresi, Rosangela D’Onofrio

CONTROLLO DI QUALITÀ: Fausto Raso
OPINIONI: Ray Banhoff, Fabrizio Barca, Francesca Barra, Alberto Bruschini, Massimo Cacciari, Lucio Caracciolo, Franco Corleone, Maurizio Costanzo, Carlo Cottarelli, Virman Cusenza, Donatella Di Cesare, Roberto Esposito, Luciano Floridi, Enrico Giovannini, Nicola Graziano, Bernard Guetta, Sandro Magister, Bruno Manfellotto, Ignazio Marino, Ezio Mauro, Claudia Sorlini, Oliviero Toscani, Sofia Ventura, Luigi Vicinanza
COLLABORATORI: Simone Alliva, Erika Antonelli, Viola Ardone, Nicolas Ballario, Giuliano
col meritato “lei”. Convinto che «se sbaglio mi corrigerete», la saluto.
Gaetano Maria CavalliNon lacorreggo, signor Cavalli, madevo avvertirlache la sua è una battaglia persa. L'abitudine di darsi del tu tra estranei ha superato da tempo i confini delle differenze anagrafiche, sociali e culturali. Nasce, come sosteneva già anni fa Tullio De Mauro, da una spinta egualitaria senza uguaglianza.Tutti amici quindi tutti uguali. E non importa se a dare del tu è la giovane commessa che sta servendo un canuto signore. Lui, pure se perplesso, non si opporrà, pena l'espulsione dal ring dell'uguaglianza fasulla. Naturalmente le differenze restano, e possono essere percepite da un orecchio attento. Il tu dall’alto al basso è ovvio e tranquillo, come tra i militari di grado diverso. Quello dal basso in alto è spesso incerto, come in attesa di una smentita, che però in genere non arriva perché nessuno oggi interromperebbe l'interlocutore con la battuta tagliente di Togliatti: «Caro compagno, dammi pure del lei». Tutti uguali e tutti amici anche dell'ennesimo venditore telefonico che esordisce con un sonoro «ciao!». Del resto mandarlo a quel paese sarebbe inutile visto che la voce è registrata.
Battiston, Marta Bellingreri, Marco Belpoliti, Caterina Bonvicini, Ivan Canu, Viola Carignani, Gino Castaldo, Giuseppe Catozzella, Manuela Cavalieri, Stefano Del Re, Francesca De Sanctis, Cesare de Seta, Roberto Di Caro, Paolo Di Paolo, Fabio Ferzetti, Alberto Flores d’Arcais, Marcello Fois, Luca Gardini, Wlodek Goldkorn, Marco Grieco, Andrea Grignaffini, Luciana Grosso, Helena Janeczek, Gaia Manzini, Piero Melati, Donatella Mulvoni, Matteo Nucci, Eugenio Occorsio, Massimiliano Panarari, Simone Pieranni, Sabrina Pisu, Laura Pugno, Marisa Ranieri Panetta, Mario Ricciardi, Gigi Riva, Stefania Rossini, Evelina Santangelo, Elvira Seminara, Chiara Sgreccia, Francesca Sironi, Leo Sisti, Elena Testi, Chiara Valerio, Stefano Vastano
PROGETTO GRAFICO:
Stefano Cipolla e Alessio Melandri I font Espresso Serif e Espresso Sans sono stati disegnati da Zetafonts
L’Espresso Media SPA Via Melchiorre Gioia, 55
20124 Milano
P. IVA 12262740967 Iscr. Reg. Imprese n. 12546800017
N. REA MI - 2649954
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE: Denis Masetti
AMMINISTRATORE DELEGATO:
Marco Forlani
DIRETTORE GENERALE:
Mirko Bertucci
CONSIGLIERI: Maurizio Milan, Massimiliano Muneghina, Margherita Revelli Caracciolo, Alessandro Mauro Rossi
DIREZIONE E REDAZIONE ROMA:
Via in Lucina, 17 - 00186 Roma
Tel. 06 86774111
E-mail: espresso@lespresso.it
REDAZIONE DI MILANO: Via Luigi
Galvani, 24 – 20124 Milano
Un numero: € 4,00
copie arretrate il doppio
PUBBLICITÀ: BFC Media spa info@bfcmedia.com - Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano
ABBONAMENTI: Tel. 0864 256266 Fax 02 26681991 abbonamenti@gedidistribuzione.it Per sottoscrizioni www.ilmioabbonamento.it
SERVIZIO GRANDI CLIENTI: Tel. 0864 256266
DISTRIBUZIONE:
GEDI Distribuzione S.p.A. via Ferrante Aporti 8 - 20125 Milano Arretrati e prodotti multimediali: Tel. 0864 256266 arretrati@gedidistribuzione.it
STAMPA E ALLESTIMENTO: Rotolito S.p.A Via Sondrio, 3 - 20096 Pioltello (MI)
TITOLARE TRATTAMENTO DATI (REG. UE 2016/679): L’Espresso Media SPA info@lespresso.it Soggetto autorizzato al trattamento dati (Reg. UE 2016/679):
Alessandro Mauro Rossi
Registrazione Tribunale di Roma n. 4822 / 55 TIRATURA COPIE 179.300
lettere e commenti su lespresso.it

he sia un fake o no la storia della bidella pendolare da Napoli a Milano, il punto è un altro: perché invece di farvi schifo almeno inizialmente vi ha commosso?
Più che la parabola di un’eroina nazionale tutta dedita al sacrificio quello della Giugliano doveva essere percepito come il racconto di incubo scritto da Verga e sceneggiato da Stephen King. Cioè: se per guadagnare 1.165 euro al mese devi stare dieci ore al giorno in un treno italiano, allora faresti bene a non lavorare. O ti opponi a una vita così oppure vai in qualche Paese subtropicale del Terzo Mondo, gua-
dagni lo stesso, ma almeno c’è il sole. La parte giornalisticamente forte della storia era quella in cui si denunciava il caro affitti di Milano, una bolla ormai fuori controllo, che non si capisce come mai non sia risolvibile. Su quella avrebbero dovuto vertere il dibattito e la nostra indignazione. Stiamo lì a preoccuparci del fact-checking, ma sul fatto sbagliato.
In un Paese in cui tutto è tassato e sottoposto a normativa è normale che non ci sia un tetto ai costi degli affitti? È normale chiedere 1.200 euro per vivere in 30 metri quadrati perché siamo a Milano? Che poi fossero case normali, sono incubi architettonici di Escher al limite dell’abitabile, infiocchettati da descrizioni come «soppalchini mansardati», «contesto signorile», «spese escluse». Se non vi fidate di me andate su Instagram e guardate i video di @mangiapregasbatty, ovvero Noemi Ma-
Yorkriani, che recensisce gli annunci di case in vendita e in affitto. Fa morire dal ridere ma il bello è che non si inventa niente, quella è proprio la realtà. Abitare dentro la circonvallazione di Milano ormai è elitarismo puro. Come New York ma senza essere New York, manco per cinque minuti e manco per sbaglio. Milano città notturna. Quando mai? La sera alle 21 solo un turista chiederebbe un piatto al ristorante perché tutti sanno che «le cucine stanno per chiudere» e, tolti i ritrovi molesti della movida tipo sui Navigli o “in Isola”, per il resto la capitale morale è un grande dormitorio silenzioso in cui non c’è niente fuori dagli orari d’ufficio. Trovi da pippare h24 e brutti localini coi cocktail annacquati più cari d’Italia, ma un bar prima delle sei del mattino è quasi impossibile. Milano città del lavoro? Sì, nel senso che il lavoro diventa tutta la tua vita, non fai altro.
Quando cerchi casa capisci che c’è qualcosa di malato. Dopo quella con la vasca in cucina, ho vissuto nella «casamera», la casa-camera, ribattezzata così dalla mia migliore amica. Diciotto metri quadrati (credo non fosse del tutto a uso abitativo) dietro corso Genova. Mi sentivo mezzo ricco. Facevo colazione da Cucchi e nel mio palazzo abitava Bianca Balti, ma avevo un frigo tipo minibar da nave e una piastra singola a induzione. Pavimento come nei campi di basket in lattice nero, il termosifone non c’era, però c’era un «coso», un sifone a ventola strano e rumoroso. All’epoca spendevo solo 550 euro, roba che oggi nemmeno per il box per il motorino. Il concetto che tu debba lavorare per spendere quasi tutto il tuo stipendio nell’affitto e nel costo della vita è un incubo. Chi pensa sia vero, normale o lecito attraversare mezza Italia per mille euro al mese si renda conto che nemmeno George Orwell in “1984” era arrivato a immaginare un mondo del genere.

Affittare una casa nella capitale morale d’Italia è elitarismo puro. Neanche fosse New






