


























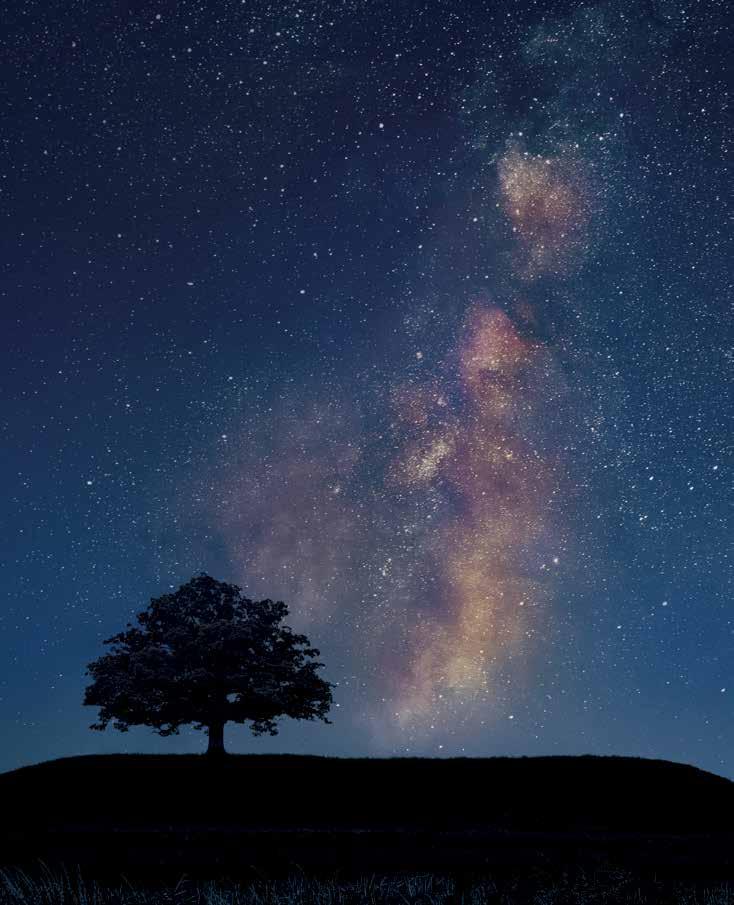
I




























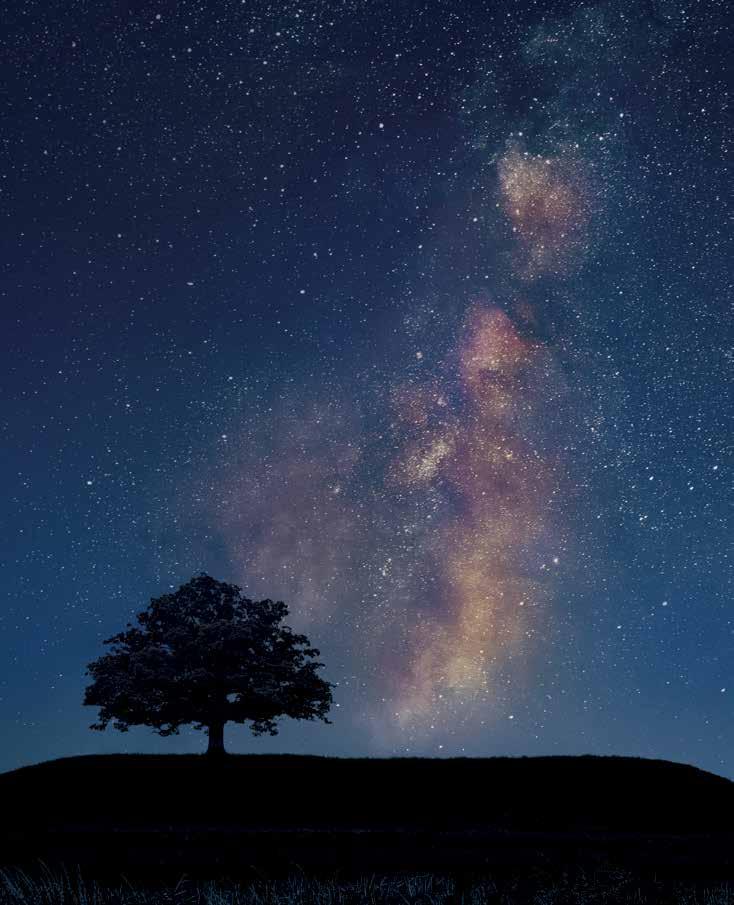
I
Gabriele Cruciata 14 “Boss delle triadi”, processo a rilento Sara Lucaroni 18 Intese sul denaro, mai sui diritti umani colloquio con Riccardo Noury di Antonio Fraschilla 20 La rivolta inconsapevole dei cinesi prigionieri in casa Federica Bianchi 23 Quei femminicidi invisibili Luana De Francisco 24 Una legge contro i clienti, i sex worker dicono no Simone Alliva 26 Nuovo cinema Meloni Susanna Turco 28 Calamita Cuffaro, vuol rifare la Dc Antonio Fraschilla 32 Contrordine, si torna al carbone Vittorio Malagutti 34 In lotta per risarcire le malattie da inquinamento Angiola Codacci Pisanelli 38 Le cure negate ai bimbi del Sud Marco Grieco 40 Con la riforma Calderoli, Sanità basata sull’iniquità Ivan Cavicchi 43 A mani nude contro i veleni Anna Dichiarante 44


L’Ilva fa gola. Se paga lo Stato Gloria Riva 48 Quelle lacrime inaccettabili Paolo Pileri 54 Abbiamo occupato la scuola rivendicando responsabilità Edoardo Graziuso 56 La finta resa dei Casalesi Rosaria Capacchione 58 Tre proposte per evitare l’Apocalisse nelle carceri Franco Corleone 61 Una premier contro Macron Camille Vigogne Le Coat 66 Crisi di coppia Frank Baasner 68 L’azzardo scozzese Luciana Grosso 70 Guantanamo non chiude mai Gloria Riva 72 Piegare Kiev per negoziare la tregua Sabato Angieri 76 In classe sull’attenti Giuseppe Agliastro 78 Porta aperta sul retro dell’Ue Elena Kaniadakis 80 Non c’è pace tra gli ulivi Stefano Lorusso 84


Noi, campi di battaglia colloquio con Agnieszka Graff di Wlodek Goldkorn 88 Oriente magico Marisa Ranieri Panetta 94 L’arte è top secret Paola Caridi 98 Giovani con la febbre a 41 colloquio con Valeria Bruni Tedeschi di Claudia Catalli 100 Crane sull’altare Marcello Fois 102 Casa è libertà Valeria Verbaro 104


Così l’astrofisica Díaz-Merced traduce in suoni l’universo Roberto Orlando 106 Nella “ballroom” italiana dove si esprime la propria identità Natasha Caragnano 110 Influencer e top model virtuali, i grandi marchi se le accaparrano Maurizio Di Fazio 114

Un sentimento potente si va insinuando nella confusione di una scena pubblica affollata di idee deboli e proposte incerte: la nostalgia. È un sentimento che ha tante facce: nostalgia di casa per i milioni di persone che hanno lasciato la loro terra in cerca di una vita migliore; nostalgia di sicurezza per coloro che proprio da questi si sentono minacciati; nostalgia di un progresso economico che si immaginava garantito a tutti, ma anche, e forse soprattutto, nostalgia di una politica in cui credere e riconoscersi. Si sente crescere la fatica di vivere e si pensa che tornare indietro sarebbe il modo migliore per andare avanti. Vengono rimpianti, così, uomini e idee di tempi conclusi: Moro, Berlinguer, persino Craxi e Andreotti, con l’utile dimenticanza di scandali e ombre per non compromettere apologie tardive. E si guardano i nuovi politici con la diffidenza che in verità si meritano, soprattutto quelli che, a lungo nostalgici di un’epo-
ca tragica, cercano oggi di mostrarsi liberi dall’imprinting del fascismo. Esercizio inutile, perché la nostalgia ai nostri giorni è un impulso scomposto che invade la comunicazione, inondando la Rete di parole pronunciate nel passato o anche strumento di personaggi come Trump che l’hanno sfruttata per vendere un passato mai esistito. È quindi un sollievo che la nostalgia sia centrale anche nelle arti, con grandi film del passato come “Nuovo Cinema Paradiso” o il recentissimo “Nostalgia” di Martone, e che si sia sottoposta per secoli al trattamento di poeti e scrittori, diventando rimembranza per Leopardi, spleen per Baudelaire, nostalgia del futuro per Musil. Tra il passato idealizzato e il futuro minaccioso manca, però, un protagonista centrale: il presente. Non piace a nessuno perché ha annientato il vecchio e l’ha sostituito con il peggio. Anche se forse è proprio quella del presente la nostalgia più dolorosa.





Com’è possibile che in Italia ci siano decine di uffici investigativi cinesi camuffati da centri per i servizi che hanno lo scopo di rintracciare nel nostro Paese i dissidenti del regime e rimpatriarli? Formalmente gli uomini di Xi Jinping distribuiti in diverse città non “rapiscono” delle persone da loro “ricercate” che vogliono riportare in Cina. Se queste avessero commesso un reato, con una regolare procedura di estradizione si potrebbe procedere al rimpatrio. Questo invece non viene fatto secondo le normali procedure giudiziarie e così i cinesi hanno purtroppo perfezionato gli errori del passato commessi dagli occidentali nella lotta al terrorismo islamico, vedi la vicenda di Abu Omar. In questo caso non si tratta di “extraordinary rendition”, ma dell’accompagnamento dall’Italia a Pechino o a Hong Kong del ricercato che è stato “convinto” con una serie di operazioni violente effettuate in patria, come minacce ai parenti e torture, a lasciare “volontariamente” il nostro Paese. Di queste persone è poi complicato conoscere che fine facciano una volta messo piede in Cina.
Tre anni fa in centinaia di migliaia sono scesi in piazza per protestare contro una proposta di legge che consentiva l’estradizione di sospetti criminali nella Cina continentale, dove i tribunali sono controllati dal Partito Comunista. Ma tutto ciò non è bastato. Adesso un’inchiesta giornalistica internazionale a cui ha partecipato L’Espresso con la Cnn e Le Monde, mette in luce quello che avviene anche nel nostro Paese.
I cinesi l’hanno chiamata operazione “caccia alla volpe”. Di tutti i fuggitivi che rientrano in Cina, come svela Gabriele Cruciata nelle pagine successive, solamente una percentuale compresa tra l’uno e il sette per cento usa vie ufficiali. Lo affermano i dati forniti dalla Commissione centrale per l’ispezione disciplinare, il più alto organismo di indagine interno al Partito Comunista Cinese che gestisce la «campagna contro la corruzione», utilizzata dal segretario Xi Jinping per le purghe sia interne al Partito sia a livello internazionale. Gli altri «fuggitivi» sono stati illegalmente «persuasi a tornare», per usare le parole delle stesse autorità cinesi.
L’inchiesta spiega che la preferenza del regime per la “persuasione” è legata alla ritrosia dei Paesi occidentali a rimpatriare i ricercati per metterli nelle mani di Paesi in cui i diritti umani di cittadini ordinari e oppositori politici sono sistematicamente calpestati, come ha affermato di recente la Corte europea per i diritti dell’uomo. Nei docu-
menti pubblici, che pubblichiamo online a corredo dell’inchiesta giornalistica, per concretizzare il desiderio di riportare i fuggitivi in Cina, si legge che l’operazione “Caccia alla volpe” ha avuto inizio nel 2014 e fino allo scorso mese le forze di polizia cinesi hanno condotto più di undicimila operazioni riguardanti talvolta singoli individui e talvolta interi gruppi familiari. Decine di migliaia di persone fuggite nei Paesi occidentali e di cui si sono poi perse le tracce al rientro in Cina.
Visto che in Italia abbiamo scoperto stazioni di polizia cinesi camuffate, ci si chiede se e come è possibile che questo accada, e come sia stato consentito a persone vicine al regime di Xi di lavorare indisturbate e senza autorizzazioni nel nostro Paese seguendo le indicazioni ufficiali della Ccdi (Commissione centrale per l’ispezione disciplinare) applicando la «persuasione al ritorno» (ritorsioni contro i familiari rimasti in Cina), di agenti sotto copertura, di spie, di sistemi di tortura e addirittura di rapimenti come «metodo legale» per convincere i fuggitivi a tornare. Sono domande che abbiamo posto alla Farnesina e al Viminale, che però hanno preferito non rispondere.
In molti Paesi la questione finisce nelle indagini delle Unità antiterrorismo o per la sicurezza nazionale, mentre negli Stati Uniti il direttore dell’Fbi ha dichiarato dinanzi al Congresso di essere molto preoccupato per delle attività così gravi «che violano il principio di sovranità e aggirano gli standard internazionali di cooperazione tra forze di polizia». Sul tema delle stazioni di polizia d’oltremare e la repressione transnazionale, la Commissione speciale sulle interferenze straniere del Parlamento Europeo udirà l’8 dicembre la ong Safeguard defenders che si occupa di monitorare le sparizioni in Cina. Ci piacerebbe sapere come il nuovo governo di Giorgia Meloni vuole affrontare questa questione di diritti civili, ma soprattutto di incursioni di spie cinesi nel nostro Paese.
Uffici investigativi cinesi truccati da agenzie di servizi. Agiscono nel nostro Paese per “convincere” al ritorno chi è contro il regime con procedure illegali e violazioni dei diritti umani. Viminale e Farnesina tacciono

Forze dell’ordine fuori dal Congresso Nazionale del Popolo, a Pechino

W. J. è un cittadino cinese giunto a Prato nel 2002. Arrivato illegalmente in Italia, per anni ha dovuto lavorare in nero con paghe intorno ai 700 euro mensili a fronte di turni massacranti da 15 ore al giorno in fabbrica. Pensava di essersi costruito una vita lontana dal regime cinese. L’illusione è durata fino all’agosto del 2015, quando è stato contattato dai suoi familiari rimasti in Cina, a loro volta contattati da ufficiali del regime.
Lo chiamavano per suggerirgli caldamente di ritornare in Cina e consegnarsi alle autorità cinesi, che da anni lo ricercavano perché accusato di appropriazione indebita. Dopo solo una settimana W. J. è rientrato in Cina, e da quel momento di lui non si è più avuta notizia.
Le autorità del regime hanno preferito minacciare W. J. e i suoi familiari e convincerlo a tornare in patria anziché usare le vie ufficiali, come ad esempio una richiesta di estradizione.
possano tornare in un territorio in cui i diritti umani di cittadini ordinari e oppositori politici sono sistematicamente calpestati, come anche affermato di recente dalla Corte europea per i diritti dell’uomo.

Di tutti i cosiddetti fuggitivi che rientrano in Cina solamente una percentuale compresa tra l’1 e il 7 per cento lo fa usando vie ufficiali. Lo affermano i dati forniti dallo stesso Ccdi (Commissione centrale per l’ispezione disciplinare), il più alto organismo di indagine interno al Partito comunista cinese che gestisce la «campagna contro la corruzione», utilizzata dal segretario Xi Jinping per le purghe sia interne al Partito che a livello internazionale. Gli altri «fuggitivi» sono stati illegalmente «persuasi a tornare», per usare le parole delle stesse autorità cinesi.
La preferenza del regime per la persuasione è legata alla ritrosia dei Paesi occidentali a che dei ricercati
Come si legge in alcuni documenti pubblici, per concretizzare il desiderio di riportare i fuggitivi in Cina, nel 2014 Pechino ha lanciato l’operazione “Fox Hunt” - Caccia alla volpecon cui da inizio 2014 a ottobre 2022 le forze di polizia cinesi hanno condotto con successo più di 11mila operazioni riguardanti talvolta singoli individui e talvolta interi gruppi familiari. Decine di migliaia di persone fuggite nei Paesi occidentali e di cui si sono poi perse le tracce al rientro in Cina. Alcune di queste sono state trovate in Italia e da qui fatte rientrare forzatamente in Cina usando mezzi come la ritorsione sui familiari e la tortura.

Per superare il grande limite della distanza fisica, in tempi più recenti alcune strutture provinciali della polizia cinese hanno avviato operazioni in stretta collaborazione con il Dipartimento del fronte unito (Ufwd) e la sua rete internazionale di associazioni, tutte impegnate in operazioni di influenza politica. L’obiettivo delle operazioni era aprire stazioni di polizia camuffate da uffici di servizi in
IL SISTEMA MESSO A PUNTO PER LA PRIMA VOLTA QUI DA NOI NON HA TROVATO OSTACOLI. ED È STATO POI SPERIMENTATO IN ALTRI STATI. EPPURE
territorio straniero. Le attività erano supervisionate dal Ministero nazionale della Pubblica sicurezza (Mps).
Queste stazioni sono state aperte in molti Paesi occidentali tra cui l’Italia, e hanno consentito a persone vicine al regime di lavorare indisturbate e senza autorizzazioni sul suolo straniero seguendo le indicazioni ufficiali del Ccdi sulla «persuasione al ritor-

Il presidente Xi Jinping all'Assemblea nazionale del popolo.A sinistra, il manager accusato di corruzione Ren Biao, sbarca da un aereo sotto la scorta della polizia a Pechino

no», che includono anche l’impiego di familiari rimasti in Cina, di agenti sotto copertura, di spie, di sistemi di tortura e addirittura di rapimenti come «metodo legale» per convincere i fuggitivi a tornare.
Formalmente gli uffici rinnovano patenti, passaporti e altri documenti cinesi e funzionano come dei Caf pensati per aiutare la comunità cinese a esplicare pratiche a di-

stanza nel proprio Paese d’origine. Inoltre agirebbero come uffici consolari paralleli. E questo in violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Essa prevede che tali strutture siano indicate come tali alle autorità ospitanti. In realtà, però, lo stesso governo cinese definisce gli uffici come «stazioni di polizia d’oltreoceano» in cui il personale lavora affinché la comunità cinese locale venga monitorata e vengano intercettati eventuali fuggitivi, come confermano decine di storie personali verificate da L’Espresso.
L’esistenza di queste stazioni era già stata denunciatadaunreportpubblicatoasettembre da Safeguard defenders, Ong spagnola dedita alla difesa dei diritti umani, e ripreso da alcuni articoli di giornale apparsi in Italia soprattuttosuIlFoglio.MaL’Espressooraèin grado di rivelare in esclusiva nazionale dettagli nuovi che dimostrano il ruolo cruciale giocato dall’Italia nelle attività transfrontaliere del regime cinese.
In un nuovo report di Safeguard defenders pubblicato domenica 4 dicembre e che L’Espresso ha visionato in anteprima viene mappata una situazione ben più grave di quella iniziale. Le stazioni di polizia cinese d’oltreoceano in Italia non sarebbero più
Due giovani cinesi fatti a pezzi in un ristorante, un regolamento di conti con un machete come arma. Era il 2010 e da quel duplice omicidio partì “China Truck”, l’inchiesta che secondo la Dda di Firenze e la Squadra mobile di Prato, non solo smantella una delle principali organizzazioni mafiose cinesi in Europa la cui base era nella cittadina toscana, ma ne svela forse per la prima volta meccanismi, peso, caratteristiche. E soprattutto nomi, come quello del «capo dei capi», Zhang Naizhong, «l’uomo nero», artefice di una pax fra bande criminali la cui guerra aveva già fatto una quarantina di morti, e ritenuto la mente di quel sodalizio. Se questo sia stato di «stampo mafioso», lo decideranno i giudici di Prato, in un processo che però non riesce a partire per cavilli legali, difficoltà di traduzioni, reperibilità degli imputati: lo scorso 11 novembre, per difetti di notifica ad alcuni di loro, per la terza


Agenti della polizia impegnati nell’operazione contro la mafia cinese denominata “China Truck” a Prato. A sinistra, il pattugliamento congiunto di agenti cinesi con la polizia italiana

quattro come affermato inizialmente, ma almeno dieci. Oltre a Prato, Firenze, Milano e Roma, ora spuntano anche nuove aree tra cui Bolzano, Venezia e la Sicilia.
A questo punto l’Italia è il Paese con la più alta presenza al mondo di stazioni di polizia d’oltreoceano. Ma c’è di più. In alcuni documenti delle autorità cinesi, che L’Espresso ha messo a disposizione dei lettori online sulla piattaforma Pinpoint, accessibile dal sito lespresso.it, si parla delle stazioni di Milano e Roma come di «progetti pilota». Cioè la Cina avrebbe utilizzato l’Italia come esperimento per capire come aprire stazioni di polizia
volta l’udienza è stata rinviata. In quella del 23 settembre invece non si trovavano i 56 faldoni che costituiscono il fascicolo penale, mentre il 16 febbraio, data di inizio del processo, il rinvio era dipeso dall’accoglimento delle istanze di impedimento presentate da alcuni difensori. Le indagini nel gennaio 2018 culminarono con 70 indagati e 33 arresti, tra cui Naizhong, ritenuto il boss delle triadi in Italia con l’accusa di controllare la logistica merci delle aziende cinesi pratesi e di altre città italiane da e verso mezza Europa imponendo le ditte di trasporto. Attività corroborata da estorsione, usura, riciclaggio, sfruttamento della prostituzione, spaccio, gioco d’azzardo, reati ora contestati a vario titolo a 55 imputati. Tutto rimandato al 10 marzo 2023, col rischio concreto che molti reati finiscano in prescrizione. L’aggravante mafiosa, contestata a 38 di loro tra cui il presunto boss, è il cuore del colossale lavoro di indagine della Squadra mobile di Prato, allora diretta da Francesco Nannucci, ora capo centro della Dia di Firenze: «Chi comanda a Prato, comanda in Europa», spiegò dopo gli arresti, annullati venti giorni dopo dal Tribunale del Riesame di Firenze che non rilevò «gravi indizi» di colpevolezza tali da contestare l’esistenza di un sodalizio mafioso. Sentenza che la Cassazione confermò in due pronunciamenti, fino alla decisione nel 2021 del Gup di Firenze di portare invece alla sbarra per la prima volta proprio la «mafia cinese». Le 5.000 pagine di informativa ricostruiscono circostanze, metodi, potenza economica, timori
e omertà non sul territorio ma dentro le comunità, i legami verticistici in Cina, e l’ascesa e gli affari milionari di Naizhong. Per il 62enne originario del Zhejiang, il 19 settembre è però arrivata la prima assoluzione, sempre a Prato, nel processo stralcio di “China Truck”. Erano a giudizio sei dei 55 imputati, quelli ancora destinatari della misura cautelare, non per l’aggravante mafiosa ma per i soli reati satellite: due sono stati condannati a otto e sei anni di reclusione. Naizhong, accusato di un episodio di usura risalente al 2011, è stato assolto perché «il fatto non sussiste». L’uomo che nelle intercettazioni si autoproclama «boss dei boss» ufficialmente è un imprenditore nel settore logistico. Stando alle carte, le società risultano affidate a prestanome e sempre lui sarebbe beneficiario finale dei proventi di sale da gioco illegali, estorsioni, droga, prostituzione e riciclaggio. Giri milionari: nei camion dell’organizzazione, oltre alle merci, viaggiavano anche scatole di banconote da 500 euro. Residente a Roma, ma temuto e riverito nelle più grandi comunità cinesi italiane ed europee, a Prato la polizia lo riprende mentre all’interno un ristorante riceve «l’inchino» di decine di connazionali arrivati in auto di lusso per omaggiarlo. Lusso che sfoggia anche al matrimonio del figlio nel 2013: all’hotel Hilton di Roma gli invitati li aveva fatti arrivare a bordo di Ferrari e Lamborghini noleggiate, 500 gli ospiti giunti anche da Francia e Cina, 80 mila euro di conto saldato in contanti.
Secondo il portavoce di Amnesty international in Italia Riccardo Noury le autorità della Cina hanno spesso tentato di fare pressioni su componenti delle loro comunità all’estero e con metodi che vanno contro il rispetto del diritto internazionale. «Sugli uiguri abbiamo segnalato un caso anche in Italia. Ma il vero tema, che le nostre istituzioni non considerano, è che dietro accordi commerciali con la Cina si chiudono gli occhi sulla richiesta del rispetto dei diritti umani nei Paesi occidentali come nel territorio cinese».
Noury, avete segnalato casi di interferenze delle autorità cinesi nei Paesi esteri e in particolare in Europa?
«Sì, ci siamo occupati più volte a livello internazionale della mano lunga delle istituzioni diplomatiche cinesi all’estero. In particolare in relazione alla questione delle famiglie di esuli uiguri, la popolazione che vive nel nord-
su territorio straniero che sono state poi effettivamente impiantate in numerosi Paesi occidentali.
Ma perché il regime di Pechino ha trovato nell’Italia la porta d’ingresso al mondo occidentale? Secondo l’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua, le stazioni di polizia d’oltreoceano sono «una delle importanti realizzazioni dei pattugliamenti congiunti di polizia sino-italiani». Il 27 aprile del 2015 infatti l’allora ministro degli Esteri Paolo Gentiloni firma un accordo con cui si dà il via a delle operazioni congiunte di pattugliamento del territorio tra forze dell’ordine italiane e cinesi. La prima stazione «pilota» viene aperta a Milano nel 2016 proprio durante lo svolgimento dei pattugliamenti congiunti.
Ma non finisce qui: il 24 luglio 2017 l’allora viceministro dell’Interno Filippo Bubbico firma un accordo per rafforzare i pattugliamenti congiunti. I contenuti dell’accordo rimangono tuttora ignoti, ma è noto che in occasione del rinnovo il ministero della Pubblica sicurezza cinese affida le missioni in quattro città italiane al Dipartimento provinciale di Pubblica sicurezza dello Zhejiang, lo stesso a cui sono legate le stazioni dello Qingtian presenti a Roma, Milano e Firenze, aperte nel 2018.
ovest della Cina, nella regione autonoma dello Xinjiang. Queste comunità sono in diversi Paesi esteri sotto ricatto dalla polizia cinese e dalle autorità di Xi Jinping».
In che modo sono sotto ricatto, e quali metodi utilizzano le autorità cinesi per farli tornare in patria?
«Cercano in ogni modo di riportarli in Cina con la scusa di dover rinnovare un documento, per esempio, oppure avvisandoli che ci sono problemi con le loro famiglie rimaste nella madrepatria. Sappiamo per certo che, accolta la richiesta delle autorità e ritornati in Cina, moltissimi finiscono nei campi di rieducazione. Ma c’è di più: chi inizialmente si rifiuta di tornare in patria, e mantiene magari rapporti epistolari con la famiglia, mette a rischio i componenti di quest’ultima, che vengono magari arrestati. Si spezzano così sentimenti e rapporti familiari in maniera profonda e drammatica.

Ma la situazione più grave di tutti, e che denunciamo a livello internazionale, è quella dei campi di rieducazione dove sono finite oltre un milione di persone. E oggi preoccupa non solo la situazione a Pechino o nell’area della Xinjiang , ma anche quello che si sta vivendo ad Hong Kong: qui è stata appena chiusa anche la sede di Amnesty international». Avete segnalato casi di pressioni da parte di esponenti del governo o dello stato cinese avvenute nelle comunità in Italia alle nostre autorità? E che risposta avete ricevuto?
«In Italia abbiamo seguito una storia di ricongiungimento familiare. I genitori vivono in Italia ma non riescono a far arrivare dalla Cina i loro tre figli. Dobbiamo dire che in questo caso le autorità italiane ci stanno aiutando, con tutte le difficoltà del caso. Comunque anche da parte nostra è difficile ricevere segnalazioni dall’interno di queste comunità, che sono spesso molto chiuse. In generale ci scontriamo con un Paese che non considera il rispetto dei diritti umani come un elemento fondante dello Stato. In Cina inoltre c’è una continua repressione

del dissenso, soprattutto di avvocati che hanno provato a chiedere riforme e che invece vengono perseguiti: in diverse centinaia sono così finiti in carcere con l’accusa di aver seminato disordine e malcontento».
I governi italiani negli ultimi anni hanno fatto diversi accordi commerciali con la Cina. Che risposte avete ricevuto sull’inserimento del rispetto dei diritti umani, in entrambi i Paesi, per la comunità cinese? «Nessuna. E abbiamo sempre sollevato questo tema: in ogni accordo che viene preso con le autorità cinesi non c’è nulla sul rispetto dei diritti umani. A esempio sulla famosa intesa della “Via della seta”: questi accordi, al contrario, sono basati sullo sfruttamento del lavoro in grandi aree della Cina. E non parliamo solo dei marchi del lusso, dove ci sono decine di denunce. I rapporti tra Cina e Occidente, inclusi i rapporti tra Cina e Italia, sono basati evidentemente sul denaro e non sul rispetto dei diritti».

Un’imprenditrice sventola la bandiera cinese nei giorni del festeggiamento del capodanno cinese nella zona industriale di Prato.
In alto Riccardo Noury portavoce di Amnesty international in Italia.
Esistono inoltre delle fotografie e dei video riportate su Formiche che immortalano l’inaugurazione della stazione di polizia d’oltreoceano all’Esquilino, storicamente punto nevralgico della comunità cinese nella capitale. All’inaugurazione, tenutasi nel luglio del 2018, è presente Giuseppe Moschitta, in quel momento capo del Commissariato Esquilino. Presenti anche Feng Sibo, alto rappresentante della polizia cinese, e il console cinese.
L’Espresso ha interpellato il ministero dell’Interno e Giuseppe Moschitta per capire cosa sapessero le autorità italiane in quel momento e la Farnesina per capire com’è possibile che l’ambasciata italiana a Pechino - all’epoca retta da Ettore Francesco Sequi - fosse all’oscuro del fatto che questi accordi venivano presi con l’Mps, ministero cinese ben noto per le attività di repressione condotte a danno dei dissi-
denti e delle minoranze etniche-religiose nel Paese. Anche perché i documenti in questione consultati da L’Espresso erano e sono tuttora pubblici.
Dopo più di una settimana né la Farnesina né il Viminale hanno mai risposto.
Tra le storie personali verificate da L’Espresso spicca quella di Z., in Italia per 17 anni e persuaso al ritorno in soli sette giorni dopo che le autorità cinesi avevano trovato la sua figlia minore ad Hangzhou. Secondo Laura Harth, campaign director di Safeguard defenders, «non solo operazioni e storie individuali simili hanno riguardato cittadini cinesi in almeno 120 Paesi del mondo, ma ci sono le prove dirette dalle stesse autorità cinesi che le stazioni di polizia d’oltremare sono coinvolte nelle operazioni».
In molti Paesi la questione viene investigata dalle Unità antiterrorismo o per la sicurezza nazionale, mentre negli Stati Uniti il direttoredell’FbihadichiaratodinanzialCongresso di essere molto preoccupato per delle attività così gravi «che violano il principio di sovranità e aggirano gli standard internazionali di cooperazione tra forze di polizia». Sul tema delle stazioni di polizia d’oltremare e la repressione transnazionale, la Commissione speciale sulle interferenze straniere del Parla-
Una donna si avvia verso l'ingresso del centro culturale cinese in via Sarpi, la Chinatown di Milano

mento Europeo udirà Safeguard defenders il prossimo 8 dicembre.
«L’Italia è l’unico Paese europeo in cui la reazione alla nostra indagine è stata molto fredda», ha detto Laura Harth citando in particolare l’ex ministra degli Interni Luciana Lamorgese (all’epoca della pubblicazione a fine mandato), che parlando della stazione di polizia di Prato disse al Foglio che «non destava particolare preoccupazione» e che nel complesso si trattava solo di uffici amministrativi che niente avevano a che fare con attività di polizia.
«Sarebbe il caso che il nuovo governo italiano mostrasse la ferma volontà di cambiare passo e investigare seriamente la questione, ivi inclusa l’esposizione complessiva del Paese alle interferenze di Pechino, visto che è proprio dall’Italia che è partito tutto», conclude Harth.

Èstata la protesta del foglio bianco. Bianco come la tuta degli uomini che da due anni impediscono ai cittadini di uscire di casa per contenere l’epidemia del Covid-19. Bianco come il vuoto pneumatico in cui finisce ogni richiesta. Bianco come il lenzuolo in cui sono ricoperti i cadaveri dei protestanti torturati a morte. Il bianco in Cina equivale al nostro nero: è il colore della morte. Fisica e civile.
La scintilla è stato l’incendio scoppiato in una palazzina di Urumqi, capitale della martoriata regione dello Xinjiang, dove a una decina di persone in fuga le barricate poste per arginare il Covid-19 hanno tolto la vita. Ma, a differenza delle decine di proteste locali, le fiamme responsabili di quelle morti hanno attraversato valli e colline, lambendo le città della costa orientale, Pechino, Shanghai, Hong Kong e l’ormai mitica Wuhan, epicentro dell’epidemia. E hanno riattizzato profondi e nascosti rancori, dolori, rimostranze per cui non c’è più nessuno spazio nella Cina sterilizzata e iper-controllata di Xi Jinping. Dopo 32 anni, anche se solo per qualche giorno, le proteste di pochi sono diventate quelle di tanti, in tutto il Paese, unendo contadini, impiegati e studenti. Un’eventualità ritenuta impensabile in uno Stato dove i cittadini sono scrupolo-
samente sorvegliati, ma chiaro indice del malessere diffuso da tempo, almeno da quando Xi Jinping ha preso il potere dieci anni fa, trasformandolo da oligarchia in monarchia assoluta. Un potere che non lascia spazio nemmeno alla concertazione interna tra i membri del Politburo, come esemplificato dalla brutale cacciata pubblica dell’ex presidente Hu Jintao, critico di Xi, durante la quinquennale riunione del Congresso del Partito lo scorso ottobre. Un potere che anziché allentare i lacciuoli della dittatura, come stava avvenendo nei primi anni del nuovo millennio, li ha stretti sempre più forte, coadiuvato dalle moderne tecnologie e da una propaganda radicale che ha culturalmente isolato la popolazione dal resto del mondo e ora rischia di toglierle il respiro.
Le nuove generazioni di cinesi, cresciute in questa realtà sotto vuotosenza accesso a nessuno strumento non cinese di informazione - non hanno memoria di nulla: non solo del massacro di piazza Tiananmen del 1989 ma nemmeno della rivoluzione tibetana del marzo 2008, delle proteste pro democrazia del 2011, della rivolta del 2013, della rivoluzione di Hong Kong, dei paladini della giustizia sociale come Liu Xiaobo, premio Nobel per la pace, ucciso in prigione. Non sanno che ogni anno sono in au-
mento le sommosse locali. Non sanno che sono metodicamente e violentemente represse proprio da quel governo che ha per obiettivo «servire il popolo», come recita la scritta fuori dai palazzi del potere. Ed è forse per questo che tanti giovani sono scesi inconsapevoli in strada con i loro cartelli inneggianti sia alla fine dei lockdown sia alla fine di Xi. «Non avranno il coraggio di farci del male», gridavano i leader, increduli quando sono stati brutalmente sbattuti nelle auto e portati via. C’è chi è però riuscito a gridare, prima di scomparire, «libertà o morte». Con un coraggio pari alla sua ingenuità. Frutto della sterilizzazione della conoscenza voluta da Xi.
Il Covid-19 è stato per questo novello Mao la prima grande sfida ai suoi metodi di dominio. Pensava di risolverla con vaccini “nazionalisti”, poi risultati inefficaci, e con la chiusura della popolazione in casa per mesi, poi anni, sottoponendola ad ogni tipo di obbligo. A sorpresa, la resilienza della pandemia ha puntato il faro sui limiti di un governo antidemocratico e ultranazionalista. Che ora, per salvarsi, utilizzerà una combinazione di bastone e carota, eliminando i capi delle rivolte e allentando alcune restrizioni pandemiche.
Ma la corazza del dittatore Xi è ormai scalfita in tutto il Paese: chissà se, per distrarre il pathos comune, non cercherà di indirizzarlo velocemente al di fuori dei confini, contro un nemico esterno. Taiwan è ancora una volta avvertita.
La resilienza della pandemia ha puntato il faro sui limiti di un governo antidemocratico e ultranazionalista che per salvarsi le tenterà tutte

Ci sono stati periodi in cui la percentuale delle prostitute vittime di omicidio ha rappresentato quasi un quarto del totale delle donne uccise. Eppure, di quella porzione di delitti, laddove ne sia stato dato conto, si è parlato in termini e con enfasi diversi dai toni usati per il resto dei femminicidi. Quasi si trattasse di un segmento dell’universo femminile confinato ai margini di una società che, nel rifiutarle, ha scelto anche di ignorarne i diritti e le sorti. Compresa la morte per mano violenta. È uno spaccato che trova conferma ogni volta in cui la cronaca nera faccia irruzione nelle vite anonime delle sex workers quello che il Numero verde nazionale antitratta descrive nelle mappature che semestralmente aggiorna con i dati raccolti dalle unità di contatto e di strada attive in tutta Italia. Una fotografia tornata di estrema attualità anche dopo i fatti di Roma e che rispecchia l’analisi condotta dal suo coordinatore, Gianfranco Della Valle, e da Paola Degani, dell’università di Padova, nel primo e finora unico studio espressamente dedicato ai femminicidi di prostitute.
Un numero su tutti: dal 1970 a oggi, i casi sono stati 897. Un’autentica strage, che ha cancellato dall’anagrafe - sempre che vi fossero registrate - 765 donne e 132
transessuali (tutte mtf, ossia male to female). L’anno nero si ebbe nel 1998, quando le prostitute trucidate furono 37. Ma poco cambia se, come nel 1992 e nel 1996, le vittime furono 34, o se negli anni Settanta si era rimasti in un range compreso tra 10 e 19, o se, ancora, nel terzo millennio si è toccato il picco nel 2000, con quota 29. Restano comunque dati sconcertanti e, probabilmente, impensati anche in Lombardia, che svetta con 202 casi. Fanno storia a sé regioni più piccole come il Friuli Venezia Giulia, pure nella parte alta della classifica, visto che almeno 13 dei 27 femminicidi sono attribuiti all’ignota mano del “mostro di Udine”, e il Trentino Alto Adige, dove fu invece il “mostro di Bolzano”, pure rimasto senza nome, a colpire 5 delle 10 prostitute complessivamente ammazzate sul territorio. Il periodo approfondito nel report è più ristretto: si va dal 1988 al 2018, perché è a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta che la prostituzione di strada cambia volto, passando da prevalentemente autoctona a prevalentemente migrante. Oggi - si legge - meno del 3% delle donne che lavora in strada è italiana. Al sorpasso, tuttavia, non ha corrisposto un maggiore riparo ai rischi del


mestiere: con 421 vittime, la nazionalità più penalizzata è proprio quella italiana. Seguita dalle altre due nel frattempo imposte sul mercato del sesso a pagamento dalle rispettive tribù criminali: quella nigeriana (90) e quella albanese (66). «Donne - ricordano gli studiosi - accomunate da debolezza individuale e sociale e da scarsa autodeterminazione del loro progetto migratorio». E che «pagano con la propria vita le faide legate a logiche di accaparramento del profitto».

Il triplice femminicidio di Roma, con la montagna di stereotipi sfoderati per relegarlo nella categoria dei delitti a sfondo sessuale, peraltro per mano di un presunto folle, ha dimostrato ancora una volta quanto poco interesse ci sia a sollevare la tendina su un mondo criminale che di quelle e altre violenze rappresenta la cornice. Elemento, questo dello sfruttamento e delle vessazioni quotidiane subite dalle sex workers, che non a caso lo studio evidenzia, osservando tuttavia come siano le condizioni stesse dell’attività svolta a disincentivare qualsiasi forma di denuncia. Vittime due volte, quindi: in quanto «schiacciate tra organizzazioni criminali tra loro rivali e la patologica affermazione di potere dei clienti» e in quanto “prive di regolari titoli di soggiorno e spaventate tanto all’idea di non essere credute, quanto dalla certezza delle ritorsioni” che chi le controlla farà loro patire.
Da qui, la preziosità del lavoro svolto dagli operatori e dai mediatori linguistici e culturali. Tanto più in questi ultimi anni di profondo mutamento delle modalità di prostituzione, con il progressivo calo delle presenze in strada, in atto dal 2017 - già prima, quindi, dei divieti e delle restrizioni imposti dalla pandemia da Covid 19 -, anche quale conseguenza delle ordinanze emesse da questo o quel Comune per questioni di “decoro pubblico”, e il parallelo incremento dell’offerta indoor. Una transizione tutt’altro che vantaggiosa, a sentire gli esperti, e non soltanto per la maggiore difficoltà di mapparne il variegato universo. «Il rischio, ora più che mai, è rappresentato dall’invisibilità - spiega Della Valle -. A differenza della prostituzione autonoma e negoziata, che negli appartamenti può trovare situazioni di maggiore comfort, chi vive sotto lo scacco del-
lo sfruttamento e dell’assoggettamento vede aggravata la propria posizione di vulnerabilità». E torniamo all’esempio di Roma: quanto tempo c’è voluto per risalire all’identità delle due vittime cinesi? Essere ostaggi di quattro mura equivale a non esistere agli occhi del mondo che le circonda. «Finché sono in strada, le prostitute possono essere avvicinate dai nostri operatori e, pur con tutte le paure e resistenze che comprensibilmente manifestano, cominciare ad aprirsi - continua -. Tutto sta a conquistarne la fiducia: oggi sorseggiando una tazza di tè caldo insieme, domani chiacchierando in una pausa dal lavoro». La tutela sanitaria, che è l’obiettivo primario del Numero verde contro la tratta, si costruisce così. «Il meccanismo di prevenzione, con la distribuzione di preservativi e l’accompagnamento alle visite mediche - ricorda il suo coordinatore -, è rivolto a chi si prostituisce, ma vale poi anche per i clienti e per i loro par-
Foto:F. Fotia / Agf
Sommerso da stratificazioni del costume, della morale e della legalità il dibattito pubblico sulla prostituzione da sempre oscilla tra proibizionismo e legalizzazione. Sull’opportunità di legalizzare o meno il lavoro sessuale la società è divisa, così come i movimenti femministi, tra chi considera la prostituzione una forma di oppressione e chi, come “Non una di meno”, chiede invece di «attuare sforzi culturali per distinguere sex worker e prostituzione forzata, denunciando e combattendo lo stigma nel primo caso e la violenza patriarcale nel secondo» e di riconoscere i diritti di questi lavoratori. Incerta è la politica che aveva fatto riemergere il tema nel mese di giugno, a 64 anni di distanza dall’approvazione della legge Merlin che nel 1958 decretò l’abolizione della regolamentazione della prostituzione e quindi anche delle cosiddette “case chiuse”. La miccia che ha innescato per mesi discussioni tra le associazioni per i diritti civili è stata il disegno di legge presentato a Palazzo Madama dalla senatrice Cinquestelle Alessandra Maiorino, che puntava a criminalizzare i clienti
tner, presenti o futuri». Non meno centrale la necessità di favorire, attraverso il filo diretto con le unità di contatto, l’emersione dei risvolti criminali del fenomeno. A differenziare gli omicidi di prostitute dagli altri, cosiddetti, di genere, oltre all’età media più bassa delle vittime (35,8 anni le italiane, 26 le nigeriane e 24,3 le albanesi), è proprio la frequenza con cui non si perviene all’identificazione del colpevole. «Si tratta di donne “disumanizzate”, di cui si minimizza anche la morte - scrivono gli autori -. Le prostitute risultano spesso “disperse mancanti”: persone scomparse mai segnalate alle forze dell’ordine. Indagare non è facile quando mancano interesse pubblico e testimoni credibili, colleghe e clienti si dimostrano riluttanti a collaborare e le stesse prove del Dna appaiono confuse e riferibili a più soggetti. Lo stile di vita e l’assenza di relazioni interpersonali, inoltre, rendono improbabile che familiari e amici conoscano gli spo-

delle prostitute, seguendo l’approccio «neo-abolizionista» introdotto in Svezia nel 1999 e oggi in vigore anche in Francia. Modello, afferma la prima firmataria, riconfermata al Senato con le ultime elezioni, che ha portato ad una diminuzione del fenomeno del 65 per cento. Oggi quel ddl torna, sulla scia del dibattito scatenatosi sui delitti di Roma. «La scintilla iniziale- spiega la senatrice a L’Espresso - era scattata già a marzo 2019. Sui giornali Salvini chiedeva di riaprire le case chiuse. Ho approfondito la questione, avviato un’indagine conoscitiva di due anni. Il mio disegno di legge non colpisce chi è in prostituzione ma chi, utilizzando il denaro, pensa di poter comprare l’accesso al corpo di un altro essere umano. Senza sapere che quel gesto mette in moto tutto il sistema di tratta». Va ricordato che nell’ordinamento attuale, non è vietata la prostituzione in sé e per sé, ma solo l’intermediazione di terzi, sia in termini di promozione sia di sfruttamento. La novità introdotta dal ddl Maiorino sarebbe la possibilità di perseguire legalmente i clienti, tramite sanzioni pecuniarie e, in casi estremi, anche pene detentive. Lo scopo è colpire la domanda. La legge potrebbe convincere Fratelli d’Italia, già nel 2018 la leader Giorgia Meloni e attuale Presidente del Consiglio dichiarava: «Non ha senso colpire le prostitute che sono solo delle vittime. Probabilmente la via che può portare a dei risultati più efficaci è quella adottata dalle nazioni del nord Europa che punta a disincentivare la domanda. Un tentativo che vale la pena fare». Un tentativo che stona con le uscite del leader della Lega
stamenti quotidiani della vittima». Condotte con il contributo di 65 tra enti (soprattutto Comuni) e associazioni, le rilevazioni rappresentano una bussola di come, dove e quanto la criminalità organizzata punti sul business della prostituzione. L’ultima, aggiornata al 20 ottobre scorso, attesta un’ulteriore inversione di marcia, con il gruppo africano (quasi soltanto nigeriane) al 19,7% delle presenze, molte di meno rispetto al passato e al 70,8 del gruppo europeo, rappresentato per oltre il 45% da rumene, quasi il 30 da albanesi e il 5 da bulgare. In termini assoluti, le prostitute osservate sono state 1.440: con la prima mappatura nazionale, nel 2017, se ne erano contate 3.709. Allora come oggi, si tratta comunque di numeri per difetto: istantanea delle presenze complessive in una determinata sera e, poche o tante che siano, anche dello schiavismo dell’epoca contemporanea.
Matteo Salvini da anni favorevole alla riapertura delle case chiuse. «Oggi in Italia questo mercato lo gestisce la criminalità. E riguarda 80 mila persone. In Austria, Svizzera, Germania si mettono le regole, si danno garanzie. È un lavoro come un altro che si fa per scelta ed è sanitariamente tutelato e tassato. Io al governo voglio un Paese con delle regole».
E il Pd? Naviga a vista. «Non ne abbiamo ancora discusso», fanno sapere. Tuttavia, per la senatrice Valeria Valente «potrebbe esserci una maggioranza del partito favorevole a una legge che punisca i clienti».
Dentro questo dibattito muta sembra la voce delle e dei sex worker. «Cavalcando le notizie delle terribili uccisioni di sex worker a Roma si propone ancora il modello abolizionista nordico osteggiato dalle e dai sex worker la cui vita è resa più fragile proprio dalla criminalizzazione dei loro clienti», sottolinea Pia Covre, presidente del Comitato per i diritti civili delle prostitute.
La politica sul tema semplifica la complessità, dimentica che la realtà è fatta di pieghe e non di linee rette, fanno sapere da Ombre Rosse collettivo femminista di sex worker e attivisti: «Togliere il reddito alle lavoratrici vuol dire cancellare la complessità delle loro vite. Il cliente per non farsi multare potrebbe attirare le lavoratrici fuori da uno spazio sicuro. La maggior parte del lavoro sessuale è indoor, esistono dei meccanismi tra lavoratrici di mutua tutela. Il ddl aggrava e non risolve».
desso la verve teatrale è appena appena soffocata dalla veste istituzionale, cova sotto la cenere e sale a galla non appena si presenti l’occasione. Ma certo Giorgia Meloni, anche da premier, sul punto non è cambiata: «Siete stati così coraggiosi in altre situazioni», ha sibilato sottovoce, sarcastica, con gli occhi all’orizzonte e come parlando tra sé e sé, quando in sala stampa a Palazzo Chigi i giornalisti le contestavano avesse lasciato troppo poco spazio alle domande sulla manovra. Vestita di rosso, quella volta. Anche se non più urlante come nei comizi di Vox. Una Giovanna d’Arco social, come sostiene sulla rete chi gioca sulla data di nascita forse coincidente della pulzella d’Orleans, una politica subito capace di stare al centro dell’agone, del teatro della politica. Come quella volta a Milano, conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, in cui stette in silenzio sul palco per ben 54 secondi - in quel contesto è un’eternità - per significare quanto fosse assurdo che le si chiedesse ancora conto della maglietta nera piuttosto che delle sue proposte. Una tea-
tralità spiccata, naturale, che ai militanti di FdI ricorda Giorgio Almirante: «Da Giorgio a Giorgia», c’è chi ha sospirato quella volta a Milano. Si sa che Almirante veniva da una famiglia di artisti e teatranti girovaghi: il padre Mario era regista e doppiatore, gli zii Ernesto, Giacomo e Luigi erano attori.
Ma a chi risale la presenza scenica meloniana? Qualche giorno fa, su Repubblica, Filippo Ceccarelli nel cercare un modello espressivo primigenio ha azzardato un paragone tra Giorgia Meloni e una grandissima del passato, Bice Valori. Compagna di Paolo Panelli, attrice versatile da teatro alto e rivista, doppiaggio, musicarelli e intrattenimento tv. Molto in comune con Meloni: «Stessa statura da piccoletta, stessa verve femminile, ironica e popolaresca, stessa risposta pronta e schietta, stessa risata allegra o, se necessario, sprezzante. Impressionante è la voce che nel crescendo acquista una inconfondibile cadenza romanesca».
C’è un’altra attrice, con caratteristiche analoghe,


cui Meloni somiglia ancora di più. Il suo nome è Zoe Incrocci. Caratterista romana, una delle più note negli anni Cinquanta, attrice di teatro, cinema , televisione. Ha recitato in “Totò cerca moglie”, in “Brutti sporchi e cattivi” di Ettore Scola. Tanto doppiaggio: era la voce stridula di Lina Lamont (Jean Hagen) in “Cantando sotto la pioggia”, della servetta lamentosa Prissy (Butterfly McQueen) in “Via col vento”, di Marilyn Monroe in “Eva contro Eva”, di nonna Salice in “Pocahontas”. Tanti ruoli in televisione, da “Piccole donne”, “La cittadella”, fino a “Don Matteo”, “Il maresciallo Rocca” e “La dottoressa Giò”. Nel 1991 Incrocci vinse il David di Donatello, attrice non protagonista, per “Verso sera” di Francesca Archibugi. La somiglianza con Giorgia Meloni è spiccata. Impressionante. Quasi vertiginosa. Cosa c’entra Giorgia Meloni?


Un link è spuntato tra fine settembre e inizio ottobre. Quando i media spagnoli hanno cominciato a scrivere della vita canaria di Francesco Meloni detto Franco, il padre di Giorgia Meloni (che se ne andò di casa quando lei aveva un paio d’anni, e che lei non ha mai più visto dal 1988), una vita da film tra isole, trasferimenti in barca, un ristorante chiamato Marques de Oristano probabilmente ispirandosi alle origini sarde, la condanna a nove anni di galera per narcotraffico e due candidature alle elezioni locali: ebbene i giornali come El Mundo, ma anche nella Gazzetta ufficiale Spagnola (Boe) lo hanno indicato come Francesco Meloni Incrocci. In Spagna si utilizza nei documenti ufficiali anche il nome della madre - riforma che per ironia della sorte in Italia non ha mai attecchito, fra l’altro con l’argomento (maschilista) che avrebbe rovinato gli alberi genealogici.
Ecco dunque spuntare un altro ramo: Incrocci. Nel 1937, Zoe Incrocci, appena ventenne, sposò a Roma Giovanni Meloni detto Nino, nato a Ghilarza in provincia di Oristano, vent’anni più di lei, personaggio di primissimo piano nel mondo dello spettacolo di quegli anni. All’epoca lui dirigeva il teatro universitario di Roma dei Guf, avrebbe avuto un ruolo sempre più importante dal dopoguerra in poi. Regista radiofonico,
punto di riferimento per prosa, rivista e teatro in radio. Premiatissimo, cercatissimo, ebbe la Maschera d’argento nel 1954 (nello stesso giorno Gina Lollobrigida presentava “La Romana” alla Mostra del cinema di Venezia) lavorava con Garinei e Giovannini e altri pezzi grossi, perfettamente inserito nell’universo favoloso e interconnesso che si stendeva tra via Veneto e Cinecittà, passando per la Rai-Eiar.

Un personaggio che ne metteva in contatto altri, da questo punto di vista somigliante aVittorioVeltroni.MelonieVeltroni,entrambi premiati con il Microfono d’argento in quegli anni, si conoscevano peraltro abbastanza bene. Alighiero Noschese raccontando i propri esordi, avrebbe spiegato che era stato proprio il padre di Walter Veltroni, all’epoca direttore del giornale radio, a dirottarlo sullo spettacolo: da redattore della radio, infatti, ogni volta che tornava dalle assemblee parlamentari dilettava i colleghi, più che con le cronache, con le imitazioni di De Gasperi, Togliatti, Nenni, Parri. Raccontò Noschese al Corriere d’Informazione, il 3 marzo del 1978: «Un giorno Veltroni mi consigliò a un regista radiofonico, Nino Meloni. “Sei più tagliato perfarelarivistacheilgiornalista”,midisse».
Intuizione corretta: Noschese finì nella commedia “Caccia al Tesoro” di Garinei e Giovannini e non tornò più indietro.

Nino Meloni, per suo conto, è personaggio chiave di tante carriere. Anche Nino Manfredi, nel 1987, avrebbe raccontato che nei primi anni di carriera, tra gli stenti, aveva svoltato così: «Grazie a Nino Meloni scoprii la radio, via Asiago. E il doppiaggio. Se no, come andavo avanti? Il cinema non mi voleva».
Era la stagione in cui l’Italia, dall’elenco mussoliniano scolpito all’Eur sul Colosseo Quadrato che la descriveva come un «popolo di poeti, artisti, eroi, di santi, pensatori, scienziati, navigatori, di trasmigratori» diventava anche un popolo rutilante e ruspante di arricchiti, di cinematografari, di attori, di scrittori, di cialtroni. Di inventori di mondi. Il popolo insomma della commedia all’italiana, magnificamente messo in scena, in quegli anni, da una coppia regale di sceneggiatori: Age e Scarpelli. Gli autori di cosette come “I soliti ignoti”, “L’armata Brancaleone”, “La grande guerra”, “I mostri”, “C’eravamo tanto amati”, “La terrazza”, “Romanzo popolare”, “In nome del popolo italiano”, “Straziami ma di baci sazia-
Il leader di Azione Carlo Calenda. Sopra, il nonno Luigi Comencini nel 1987 a New York

mi” e di almeno un altro centinaio di pellicole fondamentali nella storia del cinema italiano. Che c’entrano i due? Age era Agenore Incrocci, fratello minore di Zoe, che era nata a Roma due anni prima di lui.

Una vita non sempre fortunatissima, quella di Zoe. Sarebbe rimasta vedova nel 1960, il marito Meloni stroncato da un infarto mentre leggeva un copione coi suoi collaboratori in casa, proprio nel giorno in cui Fanfani inaugurava il tratto Firenze-Bologna dell’Autostrada del Sole. «Zoe Incrocci ferita in un incidente d’auto», riportano le cronache nell’agosto di quell’anno: era in vacanza in Spagna, con quattro dei suoi figli. Ma madre alla fine di sette: «Gemma, Paolo, Franco, Mario, Guido, Lellina e Raffaele», così come compaiono insieme con «le nuore e tutti i nipoti» su La Repubblica, nel necrologio che il 7 novembre 2003 ne annunciava il funerale nella chiesa di Santa Chiara a piazza dei Giuochi Delfici, la parrocchia della Camilluccia dove Giorgia Meloni ha passato i suoi primissimi anni di vita. Prima di trasferirsi, dopo l’incendio della casa a Roma nord che ha più volte raccontato, nel quartiere della Garbatella con la madre e la sorella. E di rompere con tutto il mondo della famiglia paterna, a un punto che si fatica persino a immaginarli parenti.
Zoe Incrocci avrebbe continuato tutta la vita a recitare: ha una parte iconica anche in “Pinocchio”, dove recita Lumachina, accanto alla fata Turchina Gina Lollobrigida, zia di quarto grado di Francesco Lollobrigida, oggi ministro della Sovranità alimentare nel governoMeloni.RegistadiquellaserieeraLuigi Comencini, che con Age e Scarpelli aveva fatto “Tutti a casa” e “La donna della domenica”, e che come si sa è il nonno di Carlo Calenda.
Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare. In alto, la zia di quarto grado Gina Lollobrigida nel 1965
Martedì scorso, dopo due ore di colloquio con la premier, uscendo da Palazzo Chigi il leader di Azione ha raccontato alla Stampa: «Sento il fascino della storia di Giorgia Meloni. È quella che lei ha raccontato più volte: una donna che nasce in una famiglia non privilegiata, con una vita difficile e che ce la fa da sola. La chiami “chimica” se vuole». La storia di una «underdog», come Meloni ama definirsi. Con mezza storia del cinema italiano ad aleggiare fantasmaticamente sulla testa, però. Un po’ di chimica è il minimo, in effetti.
Foto: M. Mencarini –Rosebud2, A. Serranò –Agf, Keystone France –Gamma Rapho / GettyImages, C. Minichiello –Agf
Dicono i loro fan: sono i soli a fare ancora politica. Con molta spregiudicatezza. A cominciare dalla temerarietà con la quale si dividono sulla scena. Qui si parla, l’avrete capito, di Calenda & Renzi, profeti del Grande Centro che forse verrà, e del loro fitto dialogo con il governo Meloni che già fa gridareLetta indignato di qua, Berlusconi preoccupato di là - a nuove maggioranze, a generose stampelle, ad aiuti parlamentari e nomine concordate. Del resto c’è l’illustre precedente dell’ascesa di Ignazio La Russa, no? E sì, ma andiamo con ordine.
I due, così diversi tra loro ma noti entrambi per essersi rumorosamente disfatti del Pd, incuriosiscono la destra da tempo. Marcello Pera, per esempio, ex berlusconiano di ferro ora senatore di Fratelli d’Italia, si appellò un anno fa a Meloni perché lanciasse Calenda nella corsa a sindaco di Roma: «È una candidatura d’eccellenza». In quanto a Renzi, l’ex Cavaliere lo considera un figlioccio. Poi è arrivato il ciclone Giorgia e le cose a destra si sono complicate.
Il primo passo l’ha fatto Renzi, sempre il più svelto di tutti, che si è
offerto come presidente di una commissione d’inchiesta su Covid-19 e lockdown. E come dimenticare l’elogio della premier - «Ammazza, bravo!» - mentre al Senato lo ascolta condannare «il no a prescindere su presidenzialismo, giustizia e rigassificatori» e dichiararsi «lealmente contro, lealmente pronto a dare una mano». Dopo un po’ ecco anche Calenda, comprensivo: «La manovra economica non funziona e la premier è nuova: va aiutata, non solo contestata». Poverina.
I due sono bravi a dividersi i ruoli. Mentre Calenda si fa ricevere a Palazzo Chigi per parlare di manovra e del contestatissimo Mes, il meccanismo europeo nato per dare assistenza ai Paesi in difficoltà finanziarie, Renzi va a rassicurare Berlusconi su abuso d’ufficio e tv. Meloni assiste con interesse: un aiuto potrebbe servire, al Senato la maggioranza è stretta e Forza Italia fa mille obiezioni su pensioni, superbonus, reddito di cittadinanza. Il Cav. invece è molto agitato per l’intrusione. Commenta il fedelissimo Giorgio Mulè: «Ho il sospetto che i due si muovano come un cavallo di Troia per fare breccia nella maggioranza e scombinare gli equilibri».
Rosicchiare elettori a Forza Italia e Pd in vista delle Europee. Chiedere posti al prossimo giro di nomine. Una tattica spregiudicata che però apre grandi spazi a sinistra
È proprio così? E perché? Intanto al Terzo Polo, all’asciutto nel giro grosso delle nomine, serve un po’ di concreta gestione del potere: hanno trattato su Copasir, vigilanza Rai, commissione Covid-19; poi verranno Eni, Enel, Poste, Leonardo… Ma dietroc’èancheunprogettopiùampio. Calenda continua ad agitarsi nella speranza di strappare al Pd militanti e consensi; Renzi sonda Berlusconi convinto che questi, in caso di difficoltà con Meloni, non si affiderebbe certo a Salvini, ma a lui. E Calenda e Renzi insieme scommettono che alle Europee del ’24 (è vicina un’altra campagna elettorale!) conquisteranno un pacchetto di votiadoppiacifra«parlandoailiberalinonsovranistieairiformistiche non vogliono morire populisti». E i giochi si riaprirebbero.
Alcuni sondaggisti dicono che questi progetti danno più fastidio al Pd che alla destra, e tutto sembra confermarlo, dall’alleanza per le politiche annunciata e poi cancellata, a quelle per Lombardia e Lazio fino al dialogo in corso. I terzopolisti pensano che spingere il Pd verso Conte aprirebbe praterie per le loro scorrerie. Ora però la stampella di Renzi e Calenda a Meloni cambia le cose e forse sposta il dibattito dentro il Pd: la questione non è più scegliere tra Calenda e Conte, ma valutare quanto sia opportuno dialogare con il M5S e a quali condizioni. Scombinare gli equilibri, non subirli. E magari riflettere sulla propria identità.
Il grande salto è pronto e a chi lo guarda con scetticismo e un po’ di puzza sotto il naso per i suoi atteggiamenti folcloristici rimasti immutati, si consiglia caldamente di «non sottovalutarlo». L’ex governatore siciliano Salvatore Cuffaro, dopo il ritorno in politica nella sua Sicilia con le insegne della nuova Democrazia Cristiana, e fresco di riabilitazione dalla condanna per favoreggiamento, sta tessendo una rete nazionale per rilanciare lo scudocrociato e tornare in giro e in televisione. I volti sui quali Totò sta puntando sono due: l’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, e l’esuberante eurodeputata no vax Francesca Donato. Ma non solo: nella rete di Totò saranno coinvolti nomi noti della Dc dei tempi che fu. Ma andiamo per ordine.
Cuffaro e il progetto di rilanciare la Democrazia Cristiana in salsa siciliana non sono stati minimamente scalfiti dalle polemiche per aver lanciato, assieme a Marcello Dell’Utri, altro condannato, per concorso esterno, e tentato dal ritorno in politica, la candidatura a sindaco di Palermo dell’ex rettore Roberto Lagalla e per aver sostenuto la candidatura
di Renato Schifani a presidente della Regione.
Totò, senza fare molto clamore, ha nel frattempo incassato il ritorno di potere che voleva con queste due operazioni. Piazzando assessori nella giunta comunale e soprattutto in quella regionale, e sempre in ruoli chiave e in storiche camere del consenso. Al Comune di Palermo in quota Dc è entrato in giunta Giuliano Forzinetti, figlio d’arte appena trentenne, che ha preso la delega importante alle Attività produttive: uno dei ruoli più ambiti in giunta, perché significa avere a che fare con tutte le attività commerciali della città e anche con i lasciapassare per aprire nuovi negozi.
Ma è nella giunta regionale di Schifani che Cuffaro è tornato in grande stile, prendendo anche qui deleghe pesanti per la sua Democrazia Cristiana: la delega alla Famiglia e al lavoro per l’ex medico legale Nuccia Albano, forte di un bacino di consensi radicato soprattutto in provincia di Palermo, e la delega agli Enti locali per Dario Messina, politico conosciuto
L’ex governatore della Sicilia Salvatore Cuffaro impegnato in un incontro durante la campagna elettorale per le regionali

alle falde dell’Etna. Per essere chiari: su queste deleghe nella storia della politica siciliana sono state lanciate carriere formidabili. Tanto per citare alcuni nomi: Raffaele Lombardo giovane democristiano negli anni Ottanta le ha avute, come le hanno avute ras del voto di Forza Italia negli anni d’oro berlusconiani come mister ventimila voti Francesco Scoma. Non c’è sindaco o amministratore siciliano che non debba avere a che fare con l’assessorato alle Autonomie locali, non c’è famiglia indigente o precario nella regione tra le più povere d’Europa che invece non abbia mai bussato alle porte dell’assessorato alla Famiglia e al lavoro: tanto che Albano ha appena ricevuto una delegazione di percettori del reddito di cittadinanza che temono di perdere l’assegno per le scelte del governo Meloni.
Cuffaro però guarda avanti. E lavora a una proiezione nazionale, anche perché è fresco di riabilitazione dalle condanne subite in carriera. Il tribunale di sorveglianza di Palermo il mese scorso gli ha concesso la riabilitazione dalle due condanne rimediate: una negli anni Novanta, per diffa-

mazione nei confronti di un magistrato, Francesco Taurisano, l’altra per favoreggiamento aggravato per aver agevolato Cosa nostra. Cuffaro puntava anche all’eliminazione dell’interdizione dai pubblici uffici, che di fatto non gli consente di candidarsi alle elezioni. I giudici hanno applicato una norma della legge spazzacorrotti che impedisce al leader della nuova Dc di scendere in campo in prima persona.
Lui comunque lavora alacremente a rilanciare adesso sul territorio nazionale la sua Dc. Il primo contatto che ha avuto per trovare sponde al Nord è stato quello di Roberto Formigoni. L’ex governatore della Lombardia scalpita per tornare sulle scena politica, scontata la condanna per corruzione: «Lasciando il Senato ho detto che non mi sarei ricandidato, ma ho detto che avrei continuato a occuparmi di politica scegliendo il ruolo di insegnante», ha assicurato in una intervista al sito online Open. Ma adesso Cuffaro lo tenta, in virtù di una vecchia amicizia
che li lega fin dai tempi dei giovani della Dc e poi nella rampante Udc di Pier Ferdinando Casini. Cuffaro e Formigoni hanno poi altre reti, diciamo così, in comune: come quelle della sanità privata, che a entrambi sono costate care in termini di guai giudiziari. Ma i rapporti e le amicizie restano, come quella con Angelino Alfano, oggi alla guida di un colosso della sanità come il gruppo San Donato (appena sbarcato in Sicilia con una convenzione d’oro per creare un mini-reparto di cardiochirurgia pediatrica all’ospedale Civico di Palermo).

In ogni caso la rete degli ex Dc si sta muovendo per salire sul carro cuffariano. Due i nomi sul taccuino dell’ex governatore siciliano: Luigi Baruffi, ex componente di spicco della Dc milanese nella corrente andreottiana e Renzo Gubert, ex parlamentare del Cdu, oggi leader di una formazione autonomista in Trentino. Ma anche Mario Tassone, già calamita del voto in Calabria, è un nome presente sull’agenda di Cuffaro.
Il colpo mediatico vero è però quello che a breve incasserà con l’adesione ufficiale alla Dc dell’eurodeputata Francesca Donato. Il marito si è già candidato alle Regionali nella lista con lo scudocrociato, ma Totò vuole lei, la moglie che negli anni della pandemia è stata quasi ogni giorno in televisione, spesso con tesi a dir poco discutibili sui vaccini e sulle restrizioni imposte dal Covid-19: ma si sa, i volti conosciuti nel bene o nel male attirano attenzione e la Dc, se vuole fare il salto nazionale, ha bisogno dei riflettori addosso.
Cuffaro vuole utilizzare questi anni per provare a schierare la sua Dc alle prossime elezioni politiche e, perché no, se le cose vanno bene, anche subito; al Nord, magari alle Regionali in programma tra qualche mese in Lombardia, o alle prossime Europee, come lui ha annunciato a un sito locale molto vicino alla destra dell’isola: «Vogliamo rico-
minciare a tessere la tela dei moderati interrotta da Giorgia Meloni. La Dc non è di Cuffaro ma è degli elettori e di chi ci crede. Mi impegno da dirigente politico in Sicilia ma stiamo prendendo contatti e lavorando in questo senso anche in altre regioni come Lombardia, Piemonte, Veneto, Sardegna, Campania. Sono il tessitore di questa idea e chissà se ancora una volta, dalla Sicilia, la Democrazia Cristiana, risorgerà ancora». Amici e detrattori confermano: mai sottovalutare Totò.

Il deposito di carbone della centrale elettrica Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, di proprietà dell’Enel

on è il gas, e neppure il petrolio, la minaccia più grave per il clima. Se il mondo vuole mettere un freno alle emissioni di CO2, e quindi anche al riscaldamento globale, deve liberarsi in fretta del carbone, la fonte di energia di gran lunga più dannosa per l’ambiente. È questo l’obiettivo da anni al centro delle discussioni di scienziati e politici, ma come dimostra l’esito deludente dell’ultima conferenza dell’Onu sul clima, la Cop 27 chiusa due settimane fa a Sharm el-Sheikh, il traguardo appare ancora molto lontano. L’ultimo allarme sugli effetti nefasti del carbone arriva da un rapporto appena pubblicato dalla Iea, l’Agenzia Internazionale dell’Energia. L’uso del più inquinante tra i combustibili fossili dovrà essere ridotto del 90 per cento entro il 2050 per rispettare la tabella di marcia che permetterebbe di limitare l’aumento della temperatura globale intorno a 1,5 gradi entro la fine del secolo, come fissato dall’Accordo di Parigi del 2015. Questa, in sintesi, la conclusione dell’Agenzia. Difficile negare che, alla luce della situazione attuale, l’obiettivo di decarbonizzazione fissato nel report sembra a dir poco irrealistico. Per mettere un freno al surriscaldamento del pianeta, entro il 2040 dovrebbero essere infatti dismesse le 9 mila centrali a carbone ora in funzione in tutto il mondo, per due terzi situate in Cina e in Paesi via di sviluppo dell’Africa e dell’Asia.
Il rapporto traccia un quadro per nulla rassicurante della situazione. Secondo gli analisti dell’Agenzia, è probabile che nel 2022 la produzione di energia con il carbone toccherà il suo massimo storico. A trainare la crescita sarà l’India, che vale il 12,5 per cento del consumo globale. Più di metà del minerale estratto nel mondo vie-

ne invece assorbito dalla Cina, dove però il rallentamento della crescita economica previsto per quest’anno dovrebbe finire per stabilizzare anche il ricorso al carbone come fonte di energia. Bastano questi dati per intuire come mai i due giganti asiatici, anche nella recente Cop 27, abbiano preso solo impegni generici sulla riduzione delle emissioni da combustibili fossili. Il governo di Nuova Delhi, in particolare, avrebbe voluto che la dichiarazione finale della conferenza non citasse espressamente il carbone, ma la richiesta è stata respinta. Nel testo però si parla di graduale riduzione (“phase down”) e non di eliminazione (”phase out”).
D’altra parte, va considerato che per Paesi come India e Cina il carbone è di gran lunga la fonte più importante per la produzione di energia elettrica: vale tra il 60 e il 70 per cento del totale. Una quota dieci volte superiore rispetto all’Unione Europea, dove le miniere locali (soprattutto Polonia e Germania) insieme all’import da altri continenti, forniscono materia prima per meno del 6 per cento dell’energia. Quest’anno, però, il taglio delle forniture di gas da parte della Russia ha spinto i governi a rimettere in funzione decine di centrali con combustibili ben più inquinanti del metano.
«Si va a carbone con le centrali che sono ancora operative, per un periodo transitorio che serve per risparmiare, mentre sostituiamo il gas russo con il gas nuovo», ha minimizzato nel giugno scorso l’allora ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani. A settembre, lo stesso Cingolani ha firmato un atto di indirizzo che
Andamento emissioni di CO2 in milioni di tonnellate nella Ue per la produzione di energia e altri impianti fortemente inquinanti, come acciaierie, raffinerie, cementifici
consente alle centrali a carbone italiane di riprendere a marciare a pieno regime. Il provvedimento riguarda in massima parte Enel, che possiede quattro dei cinque impianti ancora attivi nel nostro Paese. Il più grande è a Brindisi, gli altri tre a Civitavecchia, a Fusina (vicino a Venezia) e nel Sulcis, in Sardegna. Una seconda centrale sarda si trova nel nord dell’isola ed è controllata dal gruppo Eph del miliardario ceco Daniel Křetínský, azionista, tra l’altro, del quotidiano parigino Le Monde.
Già nel marzo scorso, pochi giorni dopo l’attacco russo all’Ucraina, il governo Draghi aveva dato luce verde al ritorno al carbone. Il piano di risparmi concordato da Roma con la Ue per far fronte allo stop delle forniture di gas da Mosca prevede da agosto un taglio dei consumi fino a 8 miliardi di metri cubi (su 74 miliardi complessivi all’anno) da raggiungere entro il marzo prossimo. Secondo Cingolani, un contributo complessivo di 1,8 miliardi potrebbe arrivare dai vecchi impianti dell’Enel e da quello targato Eph. Indietro tutta, quindi. Le centrali del gruppo pubblico, tutte in via di smantellamento o di riconversione a gas, hanno di nuovo riacceso i motori al massimo. «L’impatto ambientale
Nella prima foto da sinistra: l’impianto a carbone di Belchatow, in Polonia. Al centro: la miniera carbonifera nella stessa località. A destra: la miniera di lignite di Piniowek, sempre in Polonia, uno dei Paesi europei che fa maggiore ricorso al carbone

sarà piccolissimo - ha garantito il ministro - largamente compensato dalla crescita molto forte delle rinnovabili».
È ancora presto per fare un bilancio dell’anno, ma i dati relativi a questi ultimi mesi sembrano smentire le previsioni rassicuranti di Cingolani. Già nel primo trimestre del 2022, con il prezzo del gas volato ai massimi storici, le emissioni sono aumentate dell’8 per cento sullo stesso periodo del 2021 per effetto del «maggior consumo di fonti fossili concentrato su carbone e petrolio», come rilevato a suo tempo dall’Enea, l’Agenzia pubblica per l’energia e lo sviluppo sostenibile. Tra settembre e ottobre, segnalano le stime più recenti, il tasso di crescita della CO2 in atmosfera è un po’ calato, ma la buona notizia si spiega più che altro con il rallenta-
mento del sistema industriale accompagnato da un clima insolitamente mite nelle prime settimane d’autunno. Di conseguenza, insieme alla domanda di energia per le aziende e per il riscaldamento, sono diminuite anche le emissioni. A ottobre, per dire, l’Italia ha consumato il 6,6 per cento di elettricità in meno rispetto allo stesso mese del 2021. Il trend, però, potrebbe invertirsi quanto prima, con l’arrivo dell’inverno e il calo delle temperature.

E le rinnovabili? Qui le previsioni di Cingolani non hanno retto alla prova dei fatti, almeno finora. Abbiamo consumato più carbone, certo, ma anche meno energia da fonti pulite, perché nei primi dieci mesi dell’anno il sistema ha dovuto fare i conti il crollo della produzione idroelettrica, meno 37,6 per cento, dovuto a un’eccezionale
siccità che prosegue ormai da più di un anno. A conti fatti, quindi, la crescita di fotovoltaico (circa 2 mila gigawattora in più) e quella, molto più ridotta, dell’eolico (circa 500 gigawattora) non hanno affatto compensato l’aumento dell’energia elettrica prodotta nelle centrali a carbone, pari a circa 7 mila gigawattora in più rispetto ai primi dieci mesi del 2021, un incremento del 71 per cento. Secondo le rilevazioni di Terna, l’elettricità prodotta grazie al carbone ha così raggiunto il 6,7 per cento del totale, quasi il doppio del 3,7 per cento fatto segnare tra gennaio e ottobre del 2021. Le emissioni di CO2 sono aumentate di conseguenza, come segnala Enel. Le centrali gestite dal gruppo pubblico hanno prodotto nel primo semestre dell’anno 237 grammi di CO2 per kilowattora contro i 207 grammi registrati nello stesso periodo del 2021, un dato che nei documenti ufficiali dell’azienda viene spiegato con «l’aumento della produzione termoelettrica a carbone».
Il riavvio delle quattro centrali che da tempo funzionavano a mezzo servizio ha costretto Enel a fare scorta di minerale proprio mentre i prezzi si impennavano al rialzo. Da gennaio a luglio le quotazioni


del carbone sui mercati internazionali sono più che raddoppiate e il calo estivo ha ridimensionato solo in parte il rialzo dei mesi precedenti. Come se non bastasse, la società italiana, al pari degli altri concorrenti europei, ha dovuto fare a meno anche della materia prima proveniente da un importante fornitore come la Russia, colpita dalle sanzioni occidentali. Adesso Enel importa carbone soprattutto da Sudafrica, Indonesia e Colombia. Tutto combustibile che serve a compensare almeno in parte il taglio del gas di Mosca.
Il risparmio, però, ha un costo in termini di maggiori emissioni di CO2. Senza contare che la ripartenza delle centrali più inquinanti ha interrotto un processo virtuoso di decarbonizzazione che avrebbe dovuto portare alla chiusura o alla riconversione di tutti gli impianti a carbone entro il 2025. È questo, infatti, l’obiettivo dichiarato dal Piano nazionale integrato per energia e clima (Pniec) varato dal secondo governo Conte nel dicembre 2019. A tre anni di distanza, le buone intenzioni devono fare i conti con la più grave crisi energetica di sempre, innescata dall’attacco russo all’Ucraina. Le rinnovabili, per quanto in forte crescita, per molto tempo ancora non saranno in grado di prendere il posto del gas naturale come principale fonte energetica del Paese.
Difficile fare previsioni per il futuro prossimo. L’Europa corre il rischio di arrivare alla prossima primavera con gli stoccaggi di metano ridotti a zero e la corsa a riempirli in vista della successiva stagione invernale farebbe ripartire la corsa dei prezzi. Rinunciare al carbone diventa quindi molto difficile. Le centrali italiane continueranno a marciare a pieno ritmo e le emissioni di CO2 sono quindi destinate ad aumentare, come anche le polveri sottili nelle zone circostanti gli impianti, che pure sono dotati di filtri di ultima generazione per ridurre l’inquinamento. Certo l’Italia non è la Polonia dove gli impianti a carbone soddisfano il 70 per cento del fabbisogno di elettricità, mentre in Germania siamo al 25 per cento circa. Enel conferma che i suoi piani non cambiano: dal 2025 solo rinnovabili e centrali a gas naturale. Un impegno solenne che si perde in un orizzonte più incerto che mai, oscurato dalla guerra e dalla crisi climatica.
È un anniversario che nessuno vuole ricordare. Il 5 dicembre di settant’anni fa il cielo di Londra fu oscurato da una nuvola di smog più velenosa del solito. Quando si diradò, cinque giorni più tardi, aveva provocato tra cinquemila e 12 mila morti. La forbice tra queste due cifre mostra quanto sia difficile attribuire malattie e decessi all’inquinamento atmosferico. In Italia, secondo i dati più recenti, ogni anno muoiono per colpa dell’aria inquinata 53 mila persone. O forse 80 mila. Il problema è che legare all’inquinamento il singolo caso è praticamente impossibile. Può sembrare un paradosso, visto che da sempre i medici consigliano “aria buona” a chi ha malattie respiratorie: «Ma non lo è», risponde Roberto Romizi, presidente dell’associazione Medici per l’Ambiente. «Il rapporto causa-effetto tra inquinamento e aumento della frequenza di numerose malattie respiratorie è stato ampiamente dimostrato. Quello che non si riesce a fare è imputare il singolo caso (attacco di asma, bronchite, tumore del polmone...) accaduto tra le persone esposte all'inquinamento, perché ve ne sono (seppure con frequenza inferiore) anche tra i non esposti». Si spiega così che solo una volta una richiesta di danni in questo senso è stata accettata da un tribunale. È successo a Londra nel 2020, quando i genitori di una bambina morta di asma hanno ottenuto un risarcimento che ha fatto storia. Sperano di scrivere un pezzo di storia anche i due torinesi, appoggiati dagli ambientalisti di Torino Respira e di ClientEarth, che hanno deciso di portare in tribunale la Regione Piemonte perché il loro figlio di sei anni soffre di bronchite cronica. Per colpa dell’aria avvelenata che ha respirato quasi ogni giorno della sua vita, e quindi della Regione, che non ha fatto rispettare i limiti di legge sull’inquinamento atmosferico. In effetti dall’inizio di quest’anno, ha calcolato MeteoExpert, i cittadini di Torino, Milano e Venezia hanno respirato per due mesi interi aria inquinata (soprattutto dalle polveri sottili, le famigerate PM10 e PM2,5). E non è un problema solo delle metropoli: all’inizio del 2021, secondo fonti dello Health Effects Institute di Boston e della rivista Lancet, la Pianura Padana era il luogo in Europa in cui si moriva di più di inquinamento. In particolare, tra le venti città a più alta concentrazione di MP2,5 si contavano Brescia, Bergamo, Vicenza, Saronno, Verona, Treviso, Milano, Padova, Como, Cremona, Busto Arsizio… Al ventunesimo posto c’era Pavia, poco oltre Torino.
Gli allarmi si ripetono, le misure d’emergenza scandiscono gli inverni. Chi cerca le previsioni del tempo si vede segnalare per prima cosa la qualità dell’aria: molte città della Pianura Padana collezionano una quantità di “inquinata”, “mediocre”, “scadente” (e ci si chiede a che serve saperlo: se piove prendo l’ombrello ma se l’aria è sporca che faccio, respiro di meno?). Un numero crescente di cittadini sceglie comportamenti virtuosi: i ciclisti aumentano anche se i medici sconsigliano lo sport all’aperto, i trasporti pubblici svuotati dal Covid-19 sono di nuovo affollati, l’aumento dei vegani mira a ridurre gli allevamenti, il caro-gas si allea con l’ecologia per far abbassare i riscaldamenti. Ma la buona volontà dei singoli non basta. Quando L’Economist ha pubblicato una piantina dell’Europa che sanciva il record negativo della Pianura Padana, le cause erano attribuite ad «agricultural waste, factory emissions and car exhausts». Allevamenti, fabbriche e motori: la seconda voce però compare a stento nel dibattito sulle misure per ripulire l’aria. Come se tutti avessero introiettato in anticipo la filosofia del nostro presidente del Consiglio: «Non disturbare chi produce». Romizi (che è di Arezzo) invece elenca tra le cause «l’industrializzazione e l’alta densità di popolazione, oltre a traffico su strada, termovalorizzatori, riscaldamento a legna e allevamenti intensivi». Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, conferma che «le misure prioritarie devono riguardare la limitazione del traffico, automobilistico e commerciale, sapendo che i risultati più incisivi derivano dal superamento della motorizzazione diesel. L'altro pilastro su cui occorre lavorare è la riduzione delle emissioni agricole di ammoniaca, che in Pianura Padana sono la fonte più rilevante, e fino ad oggi fortemente sottovalutata, di particolato secondario». Chi si aspettava richieste più

stringenti, in una delle zone più martoriate al mondo dal Covid, sarà rimasto deluso: ma il rapporto tra pandemia e aria avvelenata «non è stato dimostrato in modo definitivo», continua Meggetto. «Sicuramente l'inquinamento è un fattore debilitante della salute respiratoria e cardio-circolatoria. Ma sembra da escludere che ci sia un ruolo delle particelle sottili come agenti in grado di facilitare il contagio».
I ricercatori intanto allargano il campo della ricerca. «Negli ultimi quindici anni», spiega Romizi, «sono emerse, a livello sia sperimentale che epidemiologico, relazioni ben definite anche con malattie metaboliche, neurologiche, endocrinologiche, gastroenterologiche e persino psichiatriche. Per non dimenticare le neoplasie maligne». I danni colpiscono anche prima della nascita: «Una volta si riteneva che il sacco amniotico fosse in grado di “schermare” molte sostanze potenzialmente tossiche, ma ora si sa che non è così: particolato e microplastiche sono stati ritrovati nella placenta». E la situazione è destinata a peggiorare: «Le modificazioni climatiche in corso ci ricordano che non abbiamo più tempo per indecisioni o per rischiose “transizioni”. Abbiamo la urgente necessità non solo di un rapido e completo abbandono delle fonti fossili a beneficio di energie rinnovabili e sostenibili ma anche di un completo ripensamento di modelli alimentari e produttivi che si sono dimostrati nocivi per ambiente, animali ed esseri umani». Una spinta all’azione la danno le multe previste per il superamento dei limiti stabiliti dalle leggi europee, che diventano sempre più restrittivi: «Per rientrare nei limiti previsti dalla nuova direttiva», osserva Meggetto, «che più o meno dimezza i valori-soglia ammessi, occorre lavorare per togliere auto nelle città, ridurre le velocità, far viaggiare le merci sui treni e le persone in bici o sul trasporto collettivo. Ridurre il numero degli animali allevati. E rendere più efficienti gli edifici» Difficile chiedere di più in una regione in cui l’assessore all’ambiente, Raffaele Cattaneo, ha dichiarato che rispettare i nuovi limiti europei non sarebbe stato possibile nemmeno «deportando tutti i lombardi», e ha festeggiato la pioggia che ha interrotto il primo blocco del traffico di stagione a Milano notando che «la qualità dell’aria risente molto di più delle condizioni meteo-climatiche» che delle misure antismog. Il problema insomma non è l’inquinamento ma il clima. Sembra di risentire la battuta chiave di “Johnny Stecchino”: «Palermo ha un grosso problema. La mafia? No: il traffico!» Ma come nel film di Roberto Begnini, anche questa volta si ride amaro.

Ibambini non sanno cos’è la morte, alla fine delle loro favole il drago viene sempre sconfitto. Eppure ogni anno per oltre 2mila di loro, il drago irrompe nella vita vera con nomi impronunciabili: leucemia, linfoma, neuroblastoma. Secondo l’Associazione italiana registro tumori, ne sono affetti 1.400 bambini fino ai 14 anni e 900 adolescenti dai 15 ai 19 anni. Una diagnosi di cancro diventa, così, una storia da un finale incerto, perché se è vero che per le leucemie e i linfomi gli avanzamenti della ricerca oggi garantiscono un tasso di sopravvivenza dell’80 per cento, spesso le difficoltà sono lungo un cammino che può snodarsi per centinaia di chilometri.
È la cosiddetta mobilità sanitaria, garantita nel nostro Paese a tutela di un diritto costituzionale (art. 32) e ribadita dall’art.24 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e adolescenza, ma che rende lo stivale una vera e propria corsia d’emergenza. Secondo la Fondazione Gimbe, infatti, nelle regioni del centro-nord emigra l’85,9 per cento dei pazienti sotto i 14 anni. Lo conferma anche l’Istat: nel 2019 nel centro-nord sono stati ricoverati 38.462 su oltre 44mila pazienti provenienti dal meridione. È quello che i tecnici chiamano indice di fuga, cioè la propensione dei pazienti a ricercare un servizio sanitario fuori regione e che economicamente diventa una voce di debito. Cinque anni fa, soltanto sei regioni hanno generato debiti per oltre 300 milioni di euro: in testa Lazio e Campania. Secondo la ri-
cerca Pediatric interregional healthcare mobility di De Curtis, Bortolan, Diliberto e Villani, nel 2019 la mobilità passiva è costata al meridione oltre 90 milioni di euro. Ma i propositi e i piani di rientro regionali non bastano se, come spiega il rapporto Disuguaglianze nella mortalità infantile in Italia a cura di De Curtis, Frova e Simone, il tasso di mortalità neonatale al sud è maggiore del 40 per cento rispetto al nord a causa della carente fornitura di servizi pubblici di prevenzione e assistenza sanitaria.
Così, per molte famiglie, la prima risposta a una diagnosi nefasta è una corsa contro il tempo in centri di cura spesso lontani, che richiedono di mettere in stand-by le proprie vite. Come Anna, che in 24 ore ha racchiuso la vita sua in un trolley ed ha la-

sciato Catanzaro perché la figlia di 5 anni iniziasse un percorso di cura presso il Policlinico San Matteo di Pavia, fiore all’occhiello dell’oncoematologia pediatrica italiana. La nuova vita di Anna e di sua figlia non è solo iniziata con la diagnosi nefasta di leucemia, ma anche con la porta aperta di Casa Mirabello, la struttura dell’associazione Agal, nata 40 anni per assistere i bambini leucemici in cura al San Matteo e le loro famiglie: «Se non avessi trovato Agal, non so cosa avrei fatto. Grazie a loro ho potuto concentrarmi su mia figlia». Dal 2014, anno di inaugurazione della struttura alle porte di Pavia, sono state ospitate 2.500 famiglie, in larga parte dal meridione: «Non può esserci cura senza accoglienza», spiega la presidente Clara Baggi, che nei suoi oc-
chi di nonna ricorda ancora gli anni in cui l’associazione ospitava le famiglie in appartamenti dislocati nella città: «Fu allora che, assieme a mio marito Pietro, abbiamo pensato che Agal avesse bisogno di una struttura. Così, nel 2011 abbiamo visto questa casa diroccata piena di topi e, partecipando a un bando del Comune, siamo riusciti a ristrutturarla e inaugurarla nel 2014».
Oggi, a due passi dall’antica residenza di caccia dei Visconti, le dieci camere e gli spazi comuni di Casa Mirabello sono un’oasi di ordine nel caos di vite sconvolte, dove un disegno appeso con la calamita sul frigo o i vapori dei piatti regionali cucinati insieme nella grande cucina comune rubano speranza dove regna la disperazione scandita da anamnesi e referti. Per i genitori, che in una manciata di ore hanno smesso di leggere i libri di fiabe per incomprensibili cartelle cliniche, la vita si tratteggia nei gesti semplici dei loro figli: una risata, un catetere

rimosso, una breve corsa in cortile: «Sono i bambini che, non conoscendo né la morte né il rischio, danno a noi la forza», spiega Baggi. Come già sottolineava la dottoressa Francesca Baldo, presidente dell’associazione Respirando, nata per sostenere le famiglie dei bambini medicalmente complessi, per un genitore assistere un bambino malato significa convivere con un continuo senso d’emergenza: si tratta, cioè, di un vero e proprio disturbo da stress-post traumatico. «Da noi festeggiamo quando un bambino toglie un catetere e vediamo la felicità in chi, come Gaspare, è contento perché potrà festeggiare il compleanno con i suoi amici in Sicilia», aggiunge Stefano Lucato, consigliere di Agal.
Ma queste case di accoglienza e cura, figlie del terzo settore, aiutano anche a supplire le spese che una famiglia si trova a dover sostenere quando uno dei due genitori – se non entrambi – è costretto a lasciare il lavoro o gli altri figli.
Marisa Barracano Fasanelli e suo marito – primario radiologo - hanno vissuto queste difficoltà di persona negli anni Novanta, cercando una cura all’estero: «Mi sono trasferita con mio figlio Emanuele in Minnesota, al Children’s hospital di Minneapolis. Eravamo soli e preoccupati perché, quando la stanza d’ospedale ti costa migliaia di dollari al giorno e devi darli in anticipo, cogli la drammaticità della situazione» spiega. Emanuele morirà molti anni dopo: «Mio figlio si è ammalato che era un bambino delle medie ed è morto che era laureando in Fisica», spiega Marisa, ma il suo lascito è l’Associazione Peter Pan, nata nel cuore di Roma per accogliere le famiglie con i loro bambini in cura presso l’ospedale Bambino Gesù. A fare da spalla alla presidente di Peter Pan c’è Giovanna Lea, che ha perso sua figlia Maura dopo tre anni di sofferenze: «È stata lei che, su un letto d’ospedale, mi ha ricordato quanto fossimo fortunati: nel suo stesso reparto, un bambino da Cagliari era entrato vivo e ne era uscito salma senza aver potuto salutare né il papà né i fratelli né i nonni. Quelle parole dette da mia figlia in preda alle sofferenze mi hanno segnato. In fondo, io e Marisa ereditiamo il lascito dei nostri figli».
Davanti al nosocomio pediatrico, Gianna e Marisa hanno visto spesso famiglie barattare la speranza con un panino masticato
per strada, il sonno consumato in auto, l’igiene personale affidata alle fontanelle del Gianicolo: «Così, quando ancora non ci credeva nessuno, sono andata alla ricerca di una casa che potesse accogliere anche loro perché fossero vicino ai loro figli». Ispirata dalle case della Fondazione McDonald’s che la ospitarono a Minneapolis, Marisa trova su via della Lungara una vecchia scuola che oggi è la Casa di Peter Pan, prima di due strutture che possono ospitare 30 nuclei familiari e preservare il legame con i loro figli, come da statuto. È una realtà ancora oggi possibile grazie ai volontari e donatori: «Non dimenticherò mai la colletta organizzata dai detenuti del vicino carcere del Regina Coeli nel 2000. Li ringraziai perché loro, privati della libertà, hanno cer-
cato di lenire la prigione dei bambini malati di cancro e delle loro famiglie», ricorda commossa Marisa.
Dopo i mesi difficili del lockdown e con la crisi energetica in corso, Casa Mirabello, Casa Peter Pan e altre strutture analoghe affrontano nuove difficoltà: «Il terzo settore è in sofferenza e dopo il Covid abbiamo adempimenti più costosi, dal revisore contabile al caro bollette», spiega Clara Baggi. A centinaia di chilometri, le fa eco Marisa Barracano Fasanelli: «Le spese e le difficoltà non mancano. In fondo il sogno dei nostri bambini e il nostro resta lo stesso: che di case come questa non vi sarà più bisogno un giorno». È il lieto fine su cui da anni lavora la ricerca, ma che richiede l’impegno delle istituzioni affinché per sempre meno famiglie salvare la vita del proprio figlio non costi perdere la propria, lavoro compreso. Perché, oltre le rendicontazioni, i debiti e le donazioni, in fondo tutti, bambini e adulti, sognano lo stesso finale della storia: che il drago possa essere sconfitto, una volta per tutte.

Non è difficile dire cosa succederà alla Sanità nel nostro Paese se la proposta “autentica” di regionalismo differenziato sarà approvata in Parlamento. Quello che è difficile dire è se la proposta “autentica” resterà tale o cambierà per opera degli inevitabili pasticci legislativi. Il testo autentico, che, sia chiaro, ancora nessuno ha scritto, neanche il ministro Calderoli (la sua bozza è nulla di più di un ballon d’essai), si può desumere mettendo insieme la dissennata controriforma decisa dal Pd (titolo V) nel 2001, le pre-intese fatte con i governi dalle principali regioni interessate a una autonomia speciale (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) e infine la “terza via al federalismo” teorizzata da Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria Pd.
Il nodo centrale della faccenda è principalmente uno solo: come si finanzia la sanità e quindi i Lep (Livelli Essenziali di Prestazioni)?
Se la Sanità continuerà a essere finanziata secondo i principi dell’articolo 32 della Costituzione e della legge 833 del 1978, il sistema sanitario, pur con le sue innumerevoli magagne, non cambierà. Resterà decadente certo, ancora diseguale, ma fondamentalmente universalistico e solidale, e i malati con i Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) saranno considerati giuridicamente uguali al Nord e al Sud. Se invece la Sanità sarà finanziata secondo i principi del federalismo fiscale che ispirano il regionalismo differenziato, quindi secondo il reddito prodotto dalla regione, il Sistema Sanitario Nazionale
sarà radicalmente controriformato.
Pur restando un sistema prevalentemente pubblico diventerà un insieme di regioni autarchiche nel quale il diritto alla salute dipenderà interamente dalla volontà della singola regione e i malati avranno prestazioni diverse da regione a regione e pure, probabilmente, professioni diverse cioè formate con sistemi formativi diversi.
I principi su cui si basa il regionalismo differenziato sono così antimoderni e così anticostituzionali, ma anche così socialmente immorali, che per il governo Meloni la questione è sicuramente un enorme trappolone politico e per l’Italia la rinuncia a essere un Paese civile. Per decidere di fare delle diseguaglianze addirittura il “valore” portante di una controriforma così radicale prima di tutto bisogna essere cattivi, non solo ingiusti.
Ma distinguendo i problemi in termini istituzionali e funzionali vediamo cosa significherebbe passare da un sistema sanitario imperniato sul diritto a un sistema sanitario imperniato sul reddito, cioè da un finanziamento basato sulla fiscalizzazione (DL 56 2000) a un finanziamento basato sul regionalismo fiscale (residui fiscali):
l’art. 32 della costituzione sarebbe di fatto abolito e di conseguenza tutte le leggichehannoistituitosinoadorala sanità pubblica (L833, L502, L299);
il Ssn sarebbe superato come sistema di tutela nazionale e con esso quel sistema di governo definito “decentramento amministrativo”; si affermerebbe un sistema regionale
di fatto autarchico (non autonomo, l’autonomia a certe condizioni è una necessità)
Passando ai problemi funzionali: le diseguaglianze le ingiustizie le discriminazioni che già oggi dividono il Nord e il Sud si radicalizzerebbero; la dipendenza medico-sanitaria ma anche finanziaria del Sud nei confronti del Nord diventerebbe cronica e irreversibile per cui si continuerebbero a spostare malati e risorse dal Sud al Nord (già oggi la mobilità sanitaria ha un valore di circa 5 miliardi); lo sfruttamento delle carenze sanitarie del Sud per le regioni del Nord diventerebbe un secondo business (già ora i saldi attivi della mobilità sanitaria di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna sono spaventosi, quelli negativi delle regioni del Sud altrettanto); la qualità già piuttosto carente dei servizi al Sud ne sarebbe ulteriormente compromessa, in particolare ospedali e assistenza territoriale; la decadenza dei servizi pubblici accentuerebbe il fenomeno della migrazione delle professioni verso il Nord e il Sud si troverebbe a gestire i servizi maancheareeimportanticomelasalute mentale con sempre meno operatori; con la decadenza dei servizi pubblici la privatizzazione del sistema non incontrerebbe più ostacoli. E tutto questo perché? Perché tanti anni fa il centrosinistra nel 2001 pensò la sua “vaccata” politica peggiore: la controriforma del titolo V. L’idea cioè, di fronteggiare l’avanzata della Lega diventando Lega a sua volta: similia similibus curantur.
Zaporizhzhia, in Ucraina, i bombardamenti cadono a pochi metri dalla centrale nucleare. E riportano l’Europa all’incubo di Chernobyl. Mentre l’Agenzia internazionale per l’energia atomica avverte che intorno a quei reattori si gioca con il fuoco, la Russia accusa Kiev di voler utilizzare ordigni con materiale radioattivo. In questo clima di tensione, dallo scorso febbraio, gli esperti del Centro antiveleni di Pavia lavorano senza sosta proprio per essere pronti ad affrontare eventuali emergenze di tipo nucleare o radioattivo. Pur facendo i conti con un organico ridotto all’osso e con storture ataviche della sanità nostrana.
«Ci confrontiamo quotidianamente con le istituzioni governative e amministrative per prepararci a intervenire, qualora si verificassero davvero incidenti o attacchi», spiega Carlo Locatelli, direttore del cosiddetto Cav dal 1992. In pratica, sin dalla fondazione di questo polo d’eccellenza ospitato dagli Istituti clinici scientifici Maugeri. Un unicum. «In Italia esistono altre nove realtà analoghe, ma nessuna si occupa di questioni legate alla minaccia nucleare, al terrorismo, alle armi chimiche, ai disastri industriali e alle nuove droghe», continua il professore: «Noi siamo il riferimento sanitario per crisi del genere. E fungiamo da Centro nazionale d’informazione tossicologica; cioè da collettore di ogni aspetto relativo a diagnostica, cura, prevenzione e sperimentazione nell’ambito delle intossicazioni».
Così la squadra di Locatelli affina la capacità di risposta agli scenari peggiori che la guerra in Ucraina evoca, sia per ciò che riguarda il nostro Paese sia per le misure necessarie a livello continentale: «Saremmo allertati nell’immediato. Fondamentale è comprendere che cosa sia successo, quante persone siano coinvolte e dove. Saremmo in grado di capire quali sostanze pericolose siano state diffuse e con qua-
li conseguenze. Procederemmo con le analisi chimico-cliniche, con le diagnosi e, se opportuno, avremmo anche la possibilità di trasferire i pazienti dalla zona colpita alla nostra o ad altre strutture. Per partire con i trattamenti più urgenti».
Perciò il Cav pavese collabora con il ministero della Salute, in materia di difesa civile, e con la presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare con i dipartimenti delle Politiche antidroga e della Protezione civile. È il solo, poi, a essere inserito in un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

come Maugeri: tra i suoi compiti, per definizione, rientra la ricerca. «A Pavia, nel 1967, sono nate la prima scuola di specializzazione in Tossicologia e la Società italiana di tossicologia», ricorda Locatelli: «C’erano le condizioni ideali per creare anche un Centro antiveleni, che via via ha sviluppato competenze specifiche. La principale consiste nel saper mettere a sistema le risorse, gestendo i rapporti e muovendosi sull’intero territorio nazionale. Un ruolo gravoso, sommato all’attività di routine».

Il telefono del Cav, infatti, squilla 24 ore su 24. Chiama chi ha mangiato tonno avariato, chi ha maneggiato pesticidi nocivi, chi soccorre bambini che hanno ingerito sostanze stupefacenti lasciate incustodite. Un modello rodato di telemedicina. «Negli anni Cinquanta, l’Organizzazione mondiale della sanità ha classificato le intossicazioni come problema di salute pubblica non gestibile nei singoli ospedali e ha dettato linee guida per istituire servizi specialistici a distanza», racconta il
direttore: «Pur non essendo presenti fisicamente all’esame dei loro pazienti, supportiamo i colleghi che ci contattano da tutta Italia. Le patologie riscontrate sono complesse, gli agenti che le causano sono infiniti e variabili. Il nostro personale deve essere altamente qualificato ed efficientissimo. Il servizio, dunque, ha costi notevoli. Motivo per cui nei Paesi meno ricchi stenta ad affermarsi».
In parallelo vengono garantite le prestazioni ospedaliere, con gli ambulatori e i posti letto, così come le attività d’insegnamento in diverse università, quelle dei laboratori e della centrale operativa. Una cabina di regia «delicata e protetta», sottolinea Locatelli, perché custodisce un patrimonio di conoscenze strategiche. «Nel 2021 abbiamo effettuato più di 92 mila consulenze; in media, riceviamo 200 richieste al giorno. Rappresentiamo un osservatorio epidemiologico straordinario sul piano nazionale. Siamo fonte di una casistica sterminata: raccogliamo, compariamo e forniamo dati agli enti regionali e statali, studiamo i trend delle intossicazioni per segnalare alle autorità di vigilanza situazioni di rischio». Quali? Dal dilagare tra i giovani di tentativi di suicidio con

determinate sostanze al commercio di cibo contaminato. La squadra che il professore dirige, però, è formata da 22 persone tra medici, chimici, biologi, farmacisti, tecnici: «Sono inclusi gli specializzandi, preziosi per la mole di lavoro che si sobbarcano. Dovremmo essere molti di più. Come altri comparti sanitari, soffriamo per la carenza di organico e per la difficoltà nel reclutare forze fresche. Se è vero che s’impara sul campo, è altrettanto innegabile che per resistere ai ritmi del Centro antiveleni servano doti non comuni: preparazione specifica, rapidità nel reagire e nel prendere decisioni, attitudine alla sintesi e nervi saldi. Spesso fronteggiamo circostanze ignote in emergenza».
Non solo. Secondo Locatelli, il fatto che si seguano tanti casi in poco tempo e che si sia responsabili assieme ai colleghi che si trovano sul posto comporta un’elevata esposizione ad azioni legali: «Ci vuole grande spirito di sacrificio, anche perché occorre essere sempre reperibili. La retribuzione è la stessa che viene riconosciuta per servizi ben più tranquilli. Non è corretto, occorre ripagare la fatica di ciascuno in misura equa laddove il carico sia più impegnativo».
C’è un ulteriore tasto dolente: «Non sono ancora correttamente accreditate nel Servizio sanitario nazionale le funzioni svolte dai Cav in generale. E il nostro risulta ancora più penalizzato perché, essendo interno a una struttura privata,
non riceve neanche il finanziamento per il personale medico, che è invece corrisposto a quelli presenti negli ospedali pubblici. Eppure la nostra funzione è di sanità pubblica, unica e di riferimento nazionale. In pratica, per svolgerla siamo costretti a sostenerci con i fondi ottenuti attraverso i progetti di ricerca». Ricerca che costituisce vanto e onere. Il team pavese si concentra sulla tossicologia clinica, sperimentale e analitica; allo studio, per esempio, ci sono le intossicazioni alimentari e ambientali, oppure generate da farmaci, prodotti per uso domestico, alcolici, metalli rilasciati da protesi, morsi di vipera e persino da errori terapeutici.

Al Cav, inoltre, fa capo il sistema nazionale di allerta precoce per le droghe. Si monitora la diffusione di nuove sostanze d’abuso, di cui non si conoscono tossicità ed effetti, per individuare i trattamenti e i meccanismi di prevenzione. Come avverte Locatelli, «si tratta di una piaga seria tra ragazze e ragazzi, per cui condividiamo a livello sia nazionale sia europeo le informazioni raccolte». Le quali, peraltro, confluiscono in uno dei quattro database implementati dal Centro.
Oltre ai due con gli elenchi dei casi identificati e degli esami tossicologici, il più significativo tra questi è la banca dati nazionale degli antidoti. Aggiornata di continuo, consente di fare una ricognizione in tempo reale degli antidoti dislocati sul territorio e di movimentarli dal luogo più vicino all’ospedale che li richiede. Una rete telematica, a cui le strutture aderiscono in modo volontario e gratuito condividendo i dati. E il Cav di Pavia coordina pure la Scorta nazionale antidoti. In parte sono disponibili nella sua sede: «Li inviamo con l’elisoccorso o con i mezzi delle forze dell’ordine e diamo indicazioni su come somministrarli. Sono distribuiti ovunque. Con urgenza, giorno e notte, in Italia e all’estero. Siamo gli unici, per esempio, a disporre di immunoglobulina antirabbica», prosegue il direttore: «Per certi farmaci rari, invece, si è raggiunto un accordo con importanti aziende a rilevante rischio d’incidente, come il petrolchimico, le quali conservano scorte nei loro depositi e con cui cooperiamo per attività specifiche. È un modello senza pari al mondo».
Nonostante gli ostacoli, Locatelli resta «innamorato di questo mestiere eccitante. Affrontiamo cose talvolta strambe e talvolta drammatiche, ma possiamo dirci soddisfatti. Cito il fronte del terrorismo: abbiamo calibrato la nostra operatività sull’ipotesi di molteplici attacchi in città diverse e lontane; siamo più avanti di altri Paesi». Il Cav pavese, quindi, va preservato: «Innanzitutto, per le peculiarità del servizio, non è pensabile porre in discussione l’assetto nazionale. Le divisioni regionali non hanno senso per talune problematiche. E vorrei concludere con un monito. Se chiudessimo, si impiegherebbero oltre vent’anni per ricostruire l’esperienza accumulata finora. E si priverebbero i pazienti dell’ultima spiaggia, dell’ultimo presidio che può salvare le loro vite in caso di intossicazioni di difficile diagnosi e trattamento».
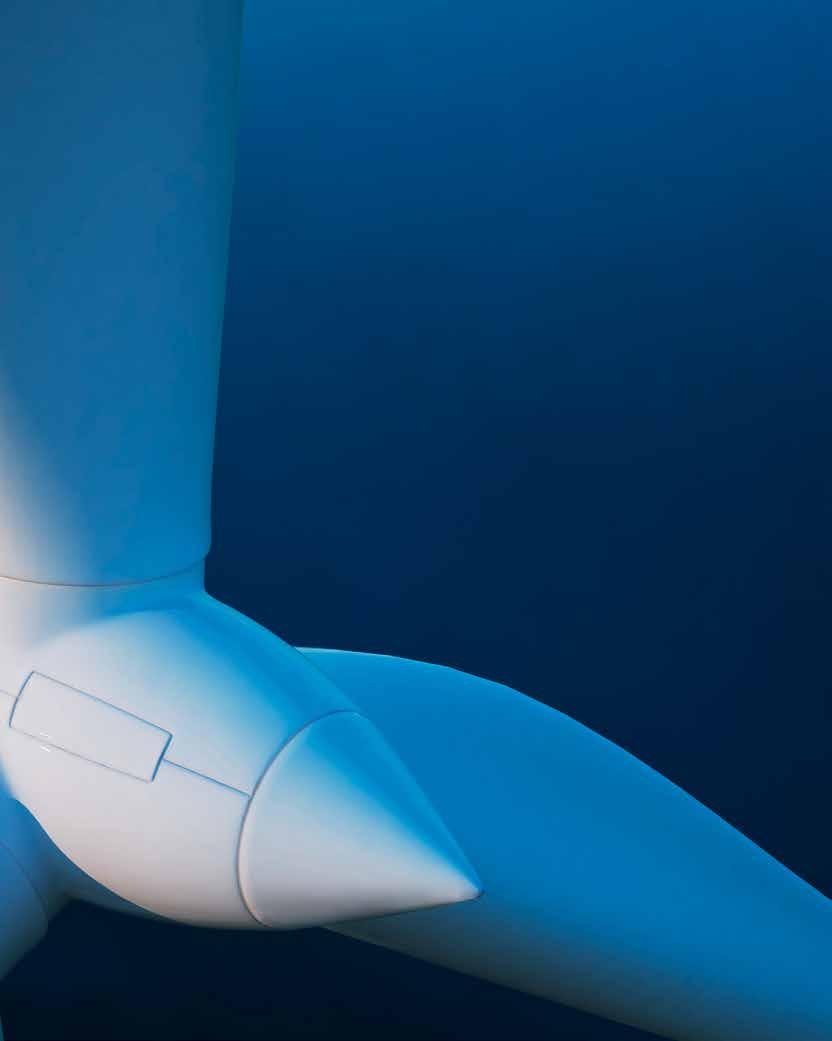

due si sono sposati troppo in fretta. Senza neppure conoscersi bene. Del resto si è trattato di un matrimonio riparatore: c’era da salvare l’Ilva, che alla fine del 2020 era sull’orlo della chiusura. Ci hanno provato l’azionista privato, ArcelorMittal, e quello pubblico, lo Stato attraverso Invitalia, ad andare d’accordo. Ma neppure il tentativo dell’attuale presidente di Acciaierie d'Italia Holding, Franco Bernabè, di far marciare entrambi verso il risanamento finanziario e ambientale ha sortito l’effetto sperato. Insomma, la resa dei conti è vicina. Alla finestra attendono due pretendenti, due gruppi siderurgici del Nord: la cremonese Arvedi, che è in grande crescita, e la mantovana Marcegaglia, storico cliente Ilva. Entrambe stanno analizzando il dossier molto da vicino ed è probabile stiano dando qualche consiglio al ministro dello Sviluppo economico, Adolfo Urso. Una volta risanata dai debiti e dagli eventuali contenziosi con i tanti, troppi, fornitori in attesa di essere pagati, uno dei due potrebbe decidere di versare una quota – circa 400 milioni di euro — per far ripartire non solo l’acciaieria tarantina ma anche, e soprattutto, gli impianti di laminazione di

Novi Ligure e Genova: due fiori all’occhiello al servizio delle principali imprese siderurgiche del Paese, che da parecchio tempo vengono mortificate dalle logiche strategiche di Acciaierie d’Italia, con un costante ricorso alla cassa integrazione, mentre i competitor fanno affari d’oro.
Per capire il motivo di tanta diffidenza tra lo Stato e ArcelorMittal bisogna riavvolgere il nastro all’autunno 2020, quando in fretta e furia il governo Conte compra l’Ilva a scatola chiusa, impegnandosi a pagare un miliardo senza disporre di un’analisi approfondita e completa dei conti della società, gestita dal 2018 da ArcelorMittal. Qualche mese dopo è il nuovo governo Draghi a versare una prima tranche da 400 milioni in Acciaierie d’Italia per sigillare l’accordo: il
denaro, però, termina nel giro di poche settimane e viene utilizzato dall’amministratrice delegata Lucia Morselli (in quota ArcelorMittal) per coprire le spese correnti e in parte i debiti. Da lì si apre una situazione di stallo, con ArcelorMittal socio di maggioranza al 68 per cento e lo Stato socio di minoranza al 32 per cento. In base agli accordi presi, tutto dovrebbe restare così, congelato, almeno fino all’aprile del 2024, per lasciare il tempo di completare il piano ambientale che, a cascata, consentirebbe alla magistratura di dissequestrare gli impianti per metterli a rogito e venderli allo Stato. Solo a quel punto il governo verserà il resto dei quattrini. Quindi: lo Stato sostiene di non poter versare il miliardo di euro promesso e salire in maggioranza perché, fin-
Una veduta dello stabilimento dell’ex Ilva di Taranto. Il polo è stato, per quasi tutto il XX secolo, il più grande produttore di acciaio in Italia e uno tra i maggiori in Europa
ché non saranno fatte le opere di ambientalizzazione, gli impianti sono in mano alla magistratura e non c'è proprio nulla da comprare. Anche la promessa dei 700 milioni di euro di garanzie da parte di Sace, la società di Cassa Depositi e Prestiti che rilascia coperture assicurative, è congelata, perché la situazione debitoria di Acciaierie d’Italia è troppo pesante: di conseguenza, le linee di credito che Unicredit e Banco Bpm si erano impegnate a concedere sono bloccate. Sul fronte opposto, ArcelorMittal è convinta che lo Stato possa e debba versare al più presto in Ilva i due miliardi promessi senza però cambiare la governance. Per quello, sostiene Arcelor, c’è tempo fino al 2024. Del resto il gruppo franco-indiano dice di aver già sganciato 1,3 miliardi di

euro e che ora tocca allo Stato. Ma il governo non si fida di versare tutti quei soldi senza poter decidere come spenderli, tanto più che il partner privato, quando è stato siglato l’accordo a fine 2020, non aveva fornito tutte le informazioni alla società di consulenza Kpmg per effettuare una corretta valutazione di Ilva. E mesi dopo ha preso corpo il sospetto che la multinazionale ArcelorMittal sfruttasse a proprio favore il posizionamento strategico dell’ex Ilva per conquistare quote di mercato in Italia, dubbi che i sindacalisti continuano a nutrire. Di vero c’è il nuovo record di fatturato di ArcelorMittal, che ha annunciato di aver registrato nel secondo trimestre di quest’anno vendite per 22,14 miliardi di dollari, in crescita dell’1,4 per cento su base trimestrale e del 14,5 su base annua, grazie agli elevati prezzi dell’acciaio.
E l’Ilva? In base al cronoprogramma dovrebbe produrre sei milioni di tonnellate d’acciaio, invece ne fa la metà. Dopo un 2021 chiuso non troppo male (4 tonnellate di acciaio; 3,3 miliardi di fatturato; utile netto a 300 milioni, contro una perdita di 266 milioni nel 2020) la produzione in Ilva sta ora registrando una battuta d’arresto a causa del caro energia, del crollo dei prezzi dei coils, cioè i nastri laminati d’acciaio, ma soprattutto per via del rinvio al 2024 delle decisioni sulla struttura societaria tra azionista pubblico e privato. La crisi di liquidità dell’Ilva è confermata da una bolletta da 300 milioni di euro che la società tarantina non riesce a pagare a Eni e una fonte vicina al dossier parla di oltre un miliardo di debiti commerciali nei confronti dei fornitori, che sono 2.100, di cui 320 pugliesi. L’amministratrice delegata, Lucia Morselli, ha sospeso l’attività dei 145 fornitori del gruppo, adducendo vaghe motivazioni. Di fatto il blocco delle forniture, la sospensione degli ordini e l’assenza delle materie prime in magazzino stanno paralizzando l’attività dell’impianto siderurgico. Secondo ArcelorMittal, l’Ilva ha bisogno subito di un’iniezione di liquidità, ma il problema è chi ci mette i soldi e per fare cosa. Il ministro Adolfo Urso si è detto disposto ad anticipare l’incremento della partecipazione pubblica dal 32 al 60 per cento già l’anno prossimo (nonostante fosse previsto solo al 2024 e in seguito al dissequestro degli impianti). Solo una volta salito in maggioranza, il go-
Il ministro dello Sviluppo economico vuole riportare subito l’Ilva in mano pubblica
verno verserebbe in Ilva le risorse a disposizione: ovvero i circa due miliardi che provengono dal Pnrr e dal previsto aumento di capitale, così come indicato nel decreto Aiuti bis firmato da Mario Draghi. Al contrario, il governo non è disposto a investire quel denaro in una società che non controlla, tanto più che lo scorso 17 novembre l’amministratrice delegata Morselli ha prima disertato l’incontro convocato al Mise dal ministro Urso e poche ore dopo ha sospeso l’attività dei fornitori, andando quindi allo scontro.

Il governo non ha intenzione di farsi intimidire e ha in mente un piano b: un fallimento pilotato attraverso la revoca del contratto che permette ad Acciaierie d’Italia di utilizzare gli impianti. Visto che anche ArcelorMittal non vuole sborsare ulteriori quattrini in una società priva di patrimonio tangibile (perché l’ex Ilva ha solo debiti e nessuna proprietà sugli impianti), la soluzione – la peggiore per i fornitori e la migliore per coinvolgere nuovi azionisti – è il fallimento pilotato, dando però il tempo ai fornitori di cartolarizzare i propri debiti e incassare una frazione degli stessi, per poi portare in liquidazione Acciaierie d’Italia e ripartire con una nuova società.
È il presidente di Acciaierie d’Italia Holding, nominato dall’ex premier Draghi
LUCIA MORSELLI È amministratrice dell’ex Ilva, chiede soldi pubblici e invarianza della governance

Solo a quel punto si aprirebbe la strada a una delle due società del Nord. Da un lato c’è il gruppo Marcegaglia, diretto da Antonio Marcegaglia, fratello dell’ex presidente di Confindustria, Emma, con un giro d’affari di sei miliardi: già nel 2017 sostenne ArcelorMittal in Ilva, ma fu obbligata dall’Antitrust Ue a uscire dalla cordata. Più concreto l’interesse di Giovanni Arvedi, 85 anni, che negli ultimi anni si è distinto sia per la capacità di realizzare acciaio a impatto zero, sfruttando nuove tecnologie fra cui l’idrogeno, sia per la crescita dimensionale del suo gruppo: l’ultima espansione è l’acquisizione della Ast, Acciai Speciali Terni, da ThyssenKrupp, al punto che Arvedi si candida a diventare il primo gruppo siderurgico italiano, con un potenziale fatturato da 7,5 miliardi e oltre 6.600 dipendenti. Giovanni Arvedi aveva già presentato un’offerta per Ilva nel 2017 e ora potrebbe tornare in campo, mettendo a disposizione le proprie competenze soprattutto sul fronte dell’ambientalizzazione e della conversione verde dell’acciaieria tarantina.



Nuove rivelazioni sugli abusi edilizi in Italia. Secondo clamorose indiscrezioni una intera vallata veneta, la Val Farlocca, sarebbe abusiva. Non solo gli edifici, anche la valle stessa: è stata costruita con terra di riporto durante i week-end dalla industriosa popolazione. «Prima qui eravamo in pianura - spiega il sindaco, Bepi Tomaia - ma siccome fabbrichiamo scarponi da sci, abbiamo pensato di trasformarci in una valle alpina per poterli collaudare meglio». La Val Farlocca è già stata condonata da sette governi. Il suo capoluogo, Smottola, è stato travolto altrettante volte dalle frane, ma gli abitanti, con una tenacia straordinaria, lo hanno ricostruito ogni volta identico e nello stesso posto.
L’esempio Non solo neve artificiale, anche montagne artificiali: l’esempio della Val Farlocca potrebbe fare scuola. Il progetto “montagna a chilometro zero” permetterebbe a chiunque di erigere una catena montuosa nei pressi della propria abitazione. Le piste da sci sarebbero raggiungibili a piedi, con grande giovamento per il traffico e la qualità dell’aria. Il materiale migliore, per costruire montagne, è il calcestruzzo. In via di studio anche montagne gonfiabili, che in estate possono essere riposte in un capannone dismesso.
Ischia Gli abitanti delle case non abusive di Ischia sono sotto accusa. Avrebbero accatastato regolarmente le loro abitazioni solo allo scopo di mettere in cattiva luce i vicini, e di farsi belli con gli inviati della Rai. «Qui ci sono delle tradizioni da rispettare - spiega il leader degli abusivi campani, Calogero Iuorno, eurodeputato - e da un governo che si richiama ai valori tradizionali ci aspettiamo collaborazione». Iuorno è un caso unico: è stato eletto, con centinaia di migliaia di preferenze, in cinque liste diverse, e a Strasburgo occupa, oltre alla sua, altre quattro poltrone, e fa parte di ben tre gruppi parlamentari. Ha voluto erigere, con l’aiuto di alcuni parenti, un bilocale a pochi chilometri dall’Europarlamento, allacciandolo personalmente alla rete elettrica.
Il settore è in crisi, dopo i recenti disastri, e va rilanciato.
In Veneto la Val Farlocca è completamente irregolare. Ma è stata condonata già da sette governi
La polemica L’idea che molte case meridionali siano abusive è comunque messa in discussione da molti osservatori. «Quasi tutte le nostre case hanno la benedizione della Vergine - spiega per esempio lo storico locale Gennaro Gnagnariello - ed è una certificazione che vale molto di più di quella di un geometra comunale: a meno di credere che la parola di un geometra conti più di quella della Madonna». A riprova della sua teoria, Gnagnariello ha pubblicato uno studio secondo il quale in quasi tutte le case travolte da frane e alluvioni c’era una statua della Vergine. Di quali irregolarità si parla, dunque?
Il Vesuvio Fittamente edificate, le pendici del Vesuvio costituiscono uno straordinario esperimento. «L’idea - spiega l’urbanista abusivo Cirillo Zolfanelli - è arrivare a una densità abitativa impenetrabile dalla lava, che non troverebbe più sfogo e sarebbe costretta a fare ritorno nel vulcano». Con lo stesso spirito, un gruppo di geometri abusivi ha presentato in Regione un piano per la copertura abusiva del Vesuvio. La sommità, cementificata, potrebbe ospitare migliaia di villette a schiera, con una vista impareggiabile sul Golfo di Napoli.
La politica Estendere il 110 per cento anche al settore dell’abusivismo edilizio, che dopo le recenti sciagure idrogeologiche necessita di un forte rilancio. È la proposta della Lega, da sempre vicina all’economia spontanea. I Cinque Stelle, per sveltire gli iter e dare la parola direttamente ai cittadini, chiedono di mettere ai voti sulla piattaforma Rousseau le piantine dei singoli progetti edilizi, con possibilità per ogni iscritto di apporre le sue correzioni, vano per vano. La presidente Meloni cerca di allungare lo sguardo anche sul futuro, e dunque esprime cordoglio non solo per le vittime di Ischia, ma anche per quelle delle future frane e alluvioni. Il Pd dirà la sua posizione dopo il congresso, ma fonti interne fanno sapere che il partito è contrario alle catastrofi.


Il 5 dicembre è la Giornata mondiale del suolo. Dovremmo spegnere le betoniere e fare il punto sulla sua salute e sulla sua tutela. Facciamolo partendo da alcuni numeri che riguardano dei suoli particolarmente fragili, quelli franosi: +345,6 ettari; +311 ettari; +286 ettari; +371 ettari: sono le aree franose follemente urbanizzate dal 2017 al 2021 in Italia. 1.313,6 ettari asfaltati in soli cinque anni. Tra il 22 e il 32 per cento sono cementificazioni in aree a elevata/molto elevata franosità, dove sono matematici il disastro, le vittime, i danni a cose e case e l’aumento di spesa pubblica. Numeri che sono la prova delle irresponsabilità urbanistica e politica qua e là in tutto il paese, non solo a Ischia. Sono un grido che denuncia la miopia di chi governa il territorio a tutti i livelli. Sono numeri dai quali non si scappa e che non è ammesso ignorare: chi lo fa è colpevole, ancor più se ha un ruolo di amministratore pubblico. Quei dati non sono segreti, ma sono parte dei rapporti sul consumo di suolo pubblicati dall’Istituto superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (Ispra) e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Snpa). Quindi sono accessibili a tutti e gratuitamente. Ispra è un’agenzia del Governo italiano che opera con rigore scientifico e per supportare governi,
politici e sindaci nella loro azione decisionale. Ma proprio qui arriva una nota dolorosa: quei rapporti sono poco o per nulla letti da chi dovrebbe leggerli. Una indifferenza che certo non è una medicina per il cambiamento. Ignorare tutto, diciamolo, equivale ad assumersi precise responsabilità e precise aggravanti. Sono ricevibili le lacrime dei sindaci che piangono i fatti delle tante Casamicciola diffuse in Italia, ma che mai hanno sfogliato quei dati? È ammissibile l’ignoranza dei politici e dei loro staff tecnici? Hanno mai indetto riunioni politiche per diffondere quegli indicatori e capire che fare? Ne hanno parlato in campagna elettorale? E le alte cariche dello Stato? Il suolo italico, caro a Luigi Einaudi, fa ancora parte dei discorsi pubblici, delle preoccupazioni dei nostri tanti presidenti?
Nessuna legge per fermare il consumo di suolo è stata approvata in Parlamento nelle
ultime tre legislature. Un cocktail al fulmicotone di ignoranza e indifferenza tecnica e politica continua a tollerare un’urbanistica fuori controllo: siamo nelle prime posizioni in Europa per consumo di suolo; siamo lontano da tutti i traguardi minimi di sostenibilità; l’Agenda2030 è disattesa; le Olimpiadi del ’26 consumeranno suolo, nessun politico prende le difese del suolo quando un cantante dà dell’econazista a chi tenta di dire che una spiaggia è un ambiente naturale e non una pista da ballo. Poi arrivano Casamicciola, Sarno e Quindici (1998), Giampilieri (2009), Val Canale (2003), Borca di Cadore (2009), Cinque Terre e Lunigiana (2011), Alta Val d’Isarco (2012), San Vito di Cadore (2015), Madonna del Monte (2019), Chiesa in Valmalenco (2020), Cavallerizzo di Cerzeto (2005), Montaguto (2010), Capriglio di Tizzano (2013)… E puntuali arrivano le lacrime di coccodrillo delle istituzioni e dei loro governatori cheahinoi - non portano da nessuna parte e si asciugano pre-

sto, non innescando alcun cambiamento. È tempo di finirla. La latitanza da tutte le evidenze scientifiche che aiuterebbero a decidere meglio è un problema grave che riguarda il modo con cui si fa politica nel nostro Paese e il modo con cui si fa urbanistica e governo del territorio non solo a Ischia. Tutti gli urbanisti, tutti i sindaci, tutti i politici hanno la responsabilità pubblica di fare qualcosa e capire per bene la questione ecologica e climatica che stanno evidenziando l’insostenibilità del governo del territorio. La configurazione amministrativa spezza i territori in migliaia di comuni quando la questione ambientale è una sola. Troppi comuni e con troppe competenze ambientali esclusive che non conoscono e non possono gestire, a partire dall’uso del suolo che non sanno essere un ecosistema fragile. L’urbani-
stica è ancora inadeguata a raccogliere la sfida climatica. Ma lo è anche il Pnrr sul fronte della prevenzione al dissesto idrogeologico (8 miliardi per 6 anni quando ce ne vorrebbero sei volte tanti) che ancor pensa di combattere a colpi di cemento e grandi opere anziché guardare all’ingegneria naturalistica, figlio dell’ossessionante teorema secondo cui bisogna sempre aggiungere e mai togliere. Matilde Casa, sindaco di Lauriano (TO), nel 2010 invece tolse l’urbanizzabilità a un’area a vincolo idrogeologico perché è così che si deve fare se non vuoi morti e danni sulla coscienza e vuoi salvare il suolo. Ma - assurdo - per questo atto fu spedita dai magistrati ad affrontare un processo penale. Dopo alcuni anni ne uscì illesa processualmente, ma ferita a morte politicamente. Nessun collega, nessuna istituzione, nessuna urbanistica, nessuna alta carica dello Stato hanno mai preso la storia di Matilde per farne una bandiera della sostenibilità e della messa in sicurezza del territorio, provando a cambiare le cose. Nessuno. Ma torniamo a Ischia e al disordine urbanistico ambientale che non è solo campano ma italiano anche se non possiamo nascondere che in Campania la situazione è particolarmente grave. Hanno urbanizzato 77 ettari in aree franose tra il 2020 e il 2021. Altre 37 tra il 2019 e il 2020. Altre 50 tra il 2018 e il 2019 e 81 tra il 2017 e il 2018 (Ispra, 2022). Sono i primi in Italia in questa terrificante classifica di abuso di suolo e di suoli in aree franose. Ma anche da qui possono nascere fiori e vogliamo sognare uno scatto di orgoglio pensando che la miglior politica di questa regione martoriata si intesti una battaglia per cambiare le cose, per togliere urbanizzabilità, per chiedere una legge che fermi il consumo di suolo ovunque, perché il problema non è solo campano. Le frane censite nell’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia sono oltre 625.000 e interessano un’area di quasi 24.000 km2, pari al 7,9 per cento del territorio nazionale (Ispra, 2021). Davanti a tutto questo è vietato stare zitti, a meno di voler essere complici di questo maledetto stato di cose che fa dell’insostenibilità
la norma. Non abbiamo ricette se non quella di investire tanto in cultura ecologica e di mettere in piedi un’agenda pubblica senza più compromessi. Si può fare, va fatto. *Docente di Pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano. Il suo ultimo libro è “L’intelligenza del suolo” (Altraeconomia)

Noi studentesse e studenti del liceo Torquato Tasso di Roma abbiamo occupato il nostro istituto. Le ragioni, le critiche, la nostra idea di società e di scuola sono qui di seguito estratte dal manifesto e dalla lettera aperta che abbiamo scritto perché vorremmo vivere istituzioni scolastiche democratiche, egualitarie, in cui gli studenti si sentissero apprezzati. Luoghi che insegnino ad amare il vivere in società e che si preoccupino di sviluppare una nuova eticità.
Perché siamo noi che dobbiamo costruire una società senza ipocrisie, che innovi. Una società libera da pregiudizi, inclusiva, aperta, progressista. Non crediamoci eredi del futuro, dobbiamo essere i protagonisti del presente. E l’istituzione promotrice di questa consapevolezza deve essere la scuola.

logica e fisica degli studenti. Anche il ruolo del docente deve essere rivalutato, tenendo conto dell’enorme potere sociale di cui dispone. L’assenza di un’istituzione scolastica moderna è una delle cause dell’impoverimento culturale di questo Paese. Intervenire significa vederne gli effetti tra almeno dieci anni. È una scelta di democrazia che dobbiamo fare ora.
Ci rivolgiamo anche a chi pensa all’occupazione come un atto contro il diritto all’istruzione. Sul piano giuridico non c’è nulla che possa difenderci ma il modello attuale di scuola manca di un reale valore sociale. Probabilmente a noi che frequentiamo uno dei migliori licei di Roma permetterà di realizzare le nostre aspirazioni, ma saremo in grado di avviare
Abbiamo assistito a riforme che hanno parzialmente smantellato la scuola pubblica, i governi non hanno mai specificato quale compito sociale spettasse all’istruzione. Fatta eccezione per la valutazione sulla base del merito che evidenzia l’incapacità o la non-volontà dei partiti di proporre un’idea di Paese fondata sull’uguaglianza: il merito elitarizza, eleva i migliori, cioè i più facoltosi, e lascia indietro la maggioranza.
La scuola, invece, dovrebbe massificare, stimolare il pensiero critico, e non basarsi sulla sola valutazione delle nozioni. L’aziendalizzazione degli istituti va nella direzione contraria. Contro un sistema classista chiediamo gratuità dei libri di testo per i redditi più bassi, il miglioramento del trasporto pubblico e massicci investimenti, una riforma dell’esame di maturità che valorizzi il ragazzo e il suo percorso di studi, un ripensamento dei programmi perché è impensabile non studiare la storia del Novecento o, in letteratura, importanti autori che trattano la contemporaneità.
Nelle scuole devono esserci programmi che abbattano i tabù sessuali e che salvaguardino la salute psico-
una rivoluzione culturale se educati a divenire parte del sistema che vogliamo stravolgere? È antidemocratico disinteressarci della maggioranza delle realtà scolastiche che sono inadatte a coinvolgere gli studenti, a rendere le future generazioni libere di fare della vita una loro scelta.
Concludiamo, quindi, con una domanda: è così grave che per una settimana gli spazi del liceo Tasso vengano gestiti da studenti che si fanno carico di responsabilità di cui mai ci avete reso protagonisti? Che la didattica frontale sia sostituita da corsi organizzati dagli alunni? È così grave avere, per una settimana, la possibilità di aggregarci e socializzare come mai ci è permesso da questa compulsiva quotidianità?
* Collettivo politico Tasso – Roma



Aforisma 341. «Questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo». Nella stessa sequenza e successione, con gli stessi nomi e le stesse facce, gli stessi interessi e le stesse armi. È la teoria dell’eterno ritorno di Friedrich Nietzsche, è il clan dei Casalesi secondo Anna Carrino, compagna e madre di boss, collaboratrice di giustizia; Gianluca Bidognetti, suo figlio, e Ivanhoe Schiavone, figlio di capoclan e fratello di un pentito. È attraverso le loro parole che è possibile ricostruire la struttura dell’organizzazione, unitaria come non accadeva da trentacinque anni, che ha tatticamente deposto le armi, ma solo finché serve. Che si nutre di ricatti, minacce, estorsioni e – la sola novità – di spaccio di droga, che un tempo era stato subappaltato alla mafia nigeriana. A quasi quindici anni dalle stragi terroristiche del 2008, a tredici dagli ergastoli definitivi del processo Spartacus, a una decina
dagli arresti in massa e dalla cattura dei grandi latitanti, l’inchiesta della Dda di Napoli e dei carabinieri di Caserta, che nei giorni scorsi ha portato a una quarantina di arresti, disegna strategie, alleanze e interessi economici del mai sconfitto cartello mafioso del Casertano. Ci sono, negli atti, i fatti-reato che saranno oggetto di processo. Ma c’è, soprattutto, la strategia a lungo termine: la ricostituzione della cassa comune, lo stipendio agli affiliati e ai capiclan detenuti (anche a Vincenzo Zagaria, capozona a Casapesenna fino al suo arresto nell’aprile 1996), l’attesa per la scarcerazione di Emanuele Schiavone, il più piccolo dei figli maschi del boss chiamato Sandokan e testa pazza che ha visto rinviare più volte la liberazione a causa delle sue ripetute intemperanze.
Anna Carrino lo aveva anticipato il 12 febbraio scorso, in una lunga intervista rilasciata a Roberto Saviano nel programma “Insider”, che il clan sarebbe tornato. E ha detto anche di non essersi «pentita» della sua vita da donna del boss («mi dovrei pentire davanti a un prete»), ma di aver fatto un patto di reciproca convenienza con lo Stato. Così come, in effetti, prevede laicamente la legge. E un’eco dello stesso concetto è nelle parole di Ivanhoe Schiavone, quarto figlio maschio del boss ergastolano, di recente rinviato a giudizio per trasferimento fraudolento di beni. «Io non giudico nemmeno mio fratello Nicola – dice al genero di Francesco Bidognetti – e non giudico nemmeno a Raffaele (figlio di Bidognetti, ndr) o qualche altro cristiano. Non perché è capitato ora nella famiglia mia. Conoscendo i retroscena di tutto quello che poi è successo, di come si sono evolute le cose, tutti i cristiani che hanno fatto asso pigliatutto, di tutte le cose che sono scomparse, di tutte le male azioni che uno ha subito, quello dopo dieci anni di galera ha fatto bene». La collaborazione con la giustizia, dunque, come una qualunque altra strategia processuale, cancellato lo stigma sui “pentiti” e i loro familiari. Questione di realpolitik. Con un nuovo obiettivo da perseguire: colpire coloro che si sono arricchiti grazie al clan e che l’hanno fatta franca. Ed è per questo che pure Anna Carrino è ammessa alle conversazioni con i parenti. A febbraio aveva detto di non aver più parlato con i figli dalla data del suo pentimento, nell’autunno del 2007. Negli atti dell’inchiesta ci sono invece conversazioni con il genero precedenti di qualche mese. E un regalo importante alla nipote: una ricarica (su PayPal, verosimilmente) di 500 euro.
Tutti insieme come una volta, dicono nelle ambientali. Superando le divisioni tra sottofamiglie che tante morti avevano provocato tra il 1988 e il 2010: alcune centinaia di vittime delle faide che si sono succedute dalla misteriosa scomparsa di Antonio Bardellino all’arresto del primogenito di Francesco Schiavone, Nicola, condannato all’ergastolo e poi diventato collaboratore di giustizia. Cassa comune, escludendo solo il gruppo di Antonio Iovine e la sua famiglia, perché «si sono pentiti tutti» e sono, quindi, fuori dal giro. Ripresa delle attività, dalla piccola usura (prestiti anche da


Poliziotti a Casal di Principe, in provincia di Caserta
mille euro, ma con interessi del 20 per cento al mese) al gioco d’azzardo, dalle estorsioni alla droga. Con un occhio, come sempre, ai grandi affari: welfare e sanità durante la pandemia, traffici internazionali su traiettorie temporali più lunghe. L’attività dei carabinieri ha documentato, tra le altre cose, il lungo lavorio di uomini del gruppo Schiavone con personaggi che, sostanzialmente impuniti, da quarant’anni gravitano nell’orbita del clan nel ruolo di broker: da Milano a Roma, da Caserta a Salerno e a Bari, sempre le stesse persone che compaiono in decine di inchieste nel ruolo di procacciatori di droga, di tecnologie per la bonifica di siti inquinati, di carburanti, di immobili e di società decotte e poi svuotate prima di finire nelle aste fallimentari di mezza Italia. La solita compagnia di giro per le solite attività.

Maria Capua Vetere, sottraendogli la competenza sui territori del clan dei Casalesi, spacchettando quelli della Terra dei fuochi e caricando tutto su Napoli Nord. Che ha sede ad Aversa e sul quale gravitano anche tutti i Comuni a Nord di Napoli: da Caivano a Frattamaggiore, da Marano ad Arzano, da Giugliano a Villaricca. In complesso, un milione di abitanti e statistiche criminali da orrore. In compenso, niente aule, organici sottodimensionati, carichi di lavoro impossibili. «Il Tribunale di Napoli Nord ha competenza su ben 38 Comuni, 19 della provincia di Caserta e 19 della provincia di Napoli, alcuni dei quali saliti agli onori della cronaca per vicende gravissime di malaffare: i fenomeni camorristici, il degrado ambientale e urbano associato di riflesso all’espressione “Terra dei fuochi”», spiega Picardi: «Con un bacino di utenza che vanta un dato complessivo di popolazione di gran lunga superiore a quello di altri tribunali del distretto, cioè Santa Maria Capua Vetere, Nola, Torre Annunziata, Benevento e Avellino, dotati di numeri di magistrati e di personale amministrativo, in assoluto e in percentuale, notevolmente superiori a quelli di Napoli Nord, che, per popolazione, è tra i primi cinque d’Italia. È entrato in funzione a carico zero, cioè senza pendenze. Oggi la situazione è questa: per ogni magistrato in pianta organica a Napoli Nord sono arrivati, nel 2021, 444 fascicoli. In concreto, ben 180 più che a Napoli e 150 più che a Santa Maria Capua Vetere. La situazione del penale è
Aspettando il ritorno di Emanuele Schiavone e l’immancabile riassetto, il vecchio clan dei Casalesi si è riorganizzato, riammettendo anche i vecchi nemici e i loro nipotini, non ancora nati quando furono ammazzati i nonni, dei quali pure hanno preso i soprannomi. Non si sa che passo avranno i Casalesi 3.0, né quanto tempo dureranno. Gli apparati investigativi sono mille volte più efficienti dei tempi delle origini, le denunce non sono più merce rara. La macchina giudiziaria, invece, non è adeguata alle necessità del territorio. Il Tribunale di Napoli Nord, inaugurato nel 2013, avrebbe dovuto causare un forte effetto deflattivo sui carichi di lavori di Procura ordinaria e aule di giustizia. I dati forniti dal suo presidente, Luigi Picardi, sono di tutt’altro segno. E sono drammatici. I processi monocratici vengono fissati a quattro anni. Oggi, cioè, si chiude un’inchiesta che arriverà in aula a dicembre del 2026. Tutta colpa, dice Picardi, di una scellerata applicazione della riforma della geografia giudiziaria, che ha sostanzialmente alleggerito di molto il Tribunale di Santa
particolarmente drammatica. Al 30 giugno scorso erano di fatto pendenti circa 25 mila processi».
Disastrosa la situazione delle strutture: «Non tutte le aule penali hanno camere di consiglio e quelle presenti sono comunque palesemente inidonee. L’edificio che avrebbe dovuto ospitare cinque aule è stato assegnato al tribunale nove anni fa. A oggi, i lavori sono bloccati dalla Sovrintendenza a seguito del ritrovamento di due archi borbonici. Sono stati assegnati al tribunale due edifici in attesa di adeguamento. Per effettuare interrogatori i giudici devono spostarsi a Napoli. Ma in organico ci sono solo quattro autisti e in dotazione due auto, la più nuova delle quali ha già percorso 130 mila chilometri. Oltre al danno, la beffa: ci è stato anche sottratto un autista per destinarlo a un altro ufficio giudiziario». In queste condizioni, assicurare giustizia è poco più di una speranza. E si spiana, così, la strada ai progetti egemonici dei nuovi Casalesi.
Il sistema carcerario è incompatibile con la rieducazione, perché troppo brutale. Le sue strutture edilizie e le condizioni inumane sono al limite della tolleranza, sono una vergogna della nostra pretesa giuridica».
«La stessa prigione è una forma di pena da rivedere profondamente. Rispetto a qualche anno fa, qualcosa si è fatto, ma è ancora troppo poco di fronte alle emergenze note a tutti, di cui quella più esplosiva è il numero dei detenuti».
Ho scelto due frasi di Carlo Nordio, contenute nel dialogo con Giuliano Pisapia sulle riforme possibili, pubblicato nel 2010 nel volume “In attesa di giustizia”. Il confronto tra un politico di sinistra e un magistrato liberale e moderato trovava motivo nell’aver entrambi presieduto commissioni per la riforma del codice penale (rispettivamente nel 2004 e 2006) e nell’aver individuato soluzioni simili, ma con lo stesso destino delle precedenti commissioni Pagliaro (1988) e Grosso (2000). Quest’ultima improntata al diritto penale minimo, con la pregevole indicazione di cambiamento del sistema delle pene attraverso il superamento della centralità del carcere e il favore sia verso il principio di riserva di codice sia verso quello di offensività.
La presenza di Nordio nel governo Meloni rappresenta una vera contraddizione: dipenderà da lui che questa si riveli una contraddizione felice, e realizzi l’obiettivo dichiarato ripetutamente di cancellare il codice Rocco e di approvare un codice
repubblicano dopo 90 anni, anziché un tradimento delle sue idee.
La tragedia di 79 suicidi nelle carceri italiane fino a novembre scorso rischia di costituire un alibi per versare lacrime di coccodrillo, ma non fare nulla per cambiare. Cosa andrebbe fatto lo sappiamo almeno dal 1949: lo indicava già Ernesto Rossi a Piero Calamandrei, direttore della rivista “Il Ponte” e promotore della commissione parlamentare d’inchiesta sulle carceri e sulla tortura nel 1948.
La prima verifica sulle buone intenzioni di Nordio si manifesterà entro la fine di dicembre con la definizione del decreto-legge sull’ergastolo ostativo, sui rave party e sulla riforma Cartabia. E, ancora prima, con la scelta della persona a cui affidare la delega del carcere, al viceministro Sisto o a uno dei sottosegretari, e soprattutto con la nomina del capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con la conferma dell’ottimo Carlo Renoldi o la preferenza per un
magistrato giustizialista. Certo non è un buon segno la delega per la politica antidroga affidata da Giorgia Meloni ad Alfredo Mantovano, esponente del proibizionismo moralistico e carcerocentrico, ispiratore della nefanda legge Fini-Giovanardi.

Per parte mia suggerisco tre misure indifferibili: 1) liberare i 15.000 detenuti classificati come tossicodipendenti e da affidare a programmi alternativi territoriali o comunitari; 2) istituire case di reintegrazione sociale per i soggetti (7.000) con pene inflitte fino a tre anni e quelli con pene residue fino a tre anni (altri 13.000), con la direzione affidata ai sindaci e con personale educativo, del volontariato e del terzo settore per incarnare l’articolo 27 della Costituzione; 3) approvare una legge intelligente sul numero chiuso per limitare gli ingressi in carcere. È sicuro che, senza misure deflattive, l’Apocalisse alla fine verrà.

















































Secondo un recente studio dell’Istituto Demoskopika, nel 2022 una famiglia italiana spenderà per luce e gas in media 1.516 euro in più rispetto all’anno precedente: 2.771 euro quest’anno, contro i 1.255 del 2021 per un aumento complessivo del 120,8%. Ammonterà a oltre 38 miliardi di euro la spesa aggiuntiva degli italiani per i consumi di energia elettrica e gas: 15,4 miliardi di euro per la luce e poco più di 23 miliardi di euro per il gas. La crisi energetica, quindi, è ancora lontana dall’essere superata e il tema delle bollette resta una priorità per privati e aziende. A fronte dell’aumento globale dei costi dell’energia, diventa sempre più importante per le aziende che forniscono luce e gas orientarsi in questo mercato variabile, intercettandone gli spostamenti e prevedendo i prezzi di elettricità e gas per offrire ai clienti le condizioni più vantaggiose. Oggi, infatti, la competitività di un’impresa che fornisce servizi di vendita e distribuzione di energia è legata alla capacità di gestire un corretto approvvigionamento della materia prima, prendendo decisioni in modo da coprire il rischio di carenze di materiale o ulteriori aumenti di prezzo. Le aziende del settore energy che adottano soluzioni di Intelligenza Artificiale possono prevedere disponibilità e costi di gas e luce, riuscendo a proporre offerte sempre aggiornate e restare competitive sul mercato. AtalescopoVedrai,gruppochesviluppasoluzionidiIntelligenza ArtificialeperlePMI,metteadisposizioneBecky,agentevirtua-
le che supporta il responsabile acquisti nei processi decisionali analizzando grandi quantità di dati relativi alle materie prime. In primo luogo, l’AI esamina i dati storici sulla disponibilità, l’andamento dei prezzi della commodity prescelta negli ultimi 10-15 anni e i principali indicatori di mercato (Stocastico, MACD, RSI). A seguire il team di market analyst di Vedrai analizza i cosiddetti “regressori”, cioè le notizie macroeconomiche o gli eventi che possono influenzare l’andamento sul mercato, selezionando quelli che possono avere un impatto sulla materia prima su cui si sta lavorando e li inseriscono nella piattaforma; un esempio di regressore in fatto di energia è un evento straordinario come l’attuale crisi geopolitica. Incrociando questi dati, Becky è in grado di fornire delle previsioni su disponibilità e andamento dei prezzi delle materie prime: nel caso specifico dell’energia, monitora il PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’elettricità e il PSV (Punto Scambio Virtuale) per il gas, facendo risparmiare mediamente alle aziende il 4,58% sul costo di acquisto. Questo risparmio per le imprese ha un impatto positivo anche sull’utente finale: riducendo i costi, infatti, queste possono aumentare i margini e proporre dei prezzi più convenienti ai propri clienti. In questo momento di congiuntura sfavorevole, quindi, l’Intelligenza Artificiale di Vedrai è uno strumento in grado di alleggerire le aziende del comparto energy dagli effetti negativi della crisi, offrendo soluzioni concrete a un settore che, oggi, è sempre più chiamato a orientarsi con lungimiranza nel mercato globale.


C’è una frase, spesso pronunciata in questi giorni, che nelle intenzioni di chi la dice dovrebbe suonare bellissima, nobile, etica: «Il calcio deve restare fuori dalla politica». O la variante: «La politica deve restare fuori dal calcio». Ma quando arriva alle orecchie di un uditorio planetario, in tempo di Mondiali, risulta falsa, ipocrita, farisaica.
Si poteva sperare che l’epoca di Sepp Blatter fosse il punto più basso toccato dalla Fifa, il massimo organismo del calcio mondiale. Con il suo successore, l’italo-svizzero Gianni Infantino, da un anno residente in Qatar con la famiglia, si è ripreso a scavare.
Per cercare di buttare la palla in tribuna e allontanare i sospetti di invasione di campo tra sport, business e politica, Infantino si è esibito nel famoso discorso degno di un rapper: «Oggi mi sento qatarino, oggi mi sento arabo, oggi mi sento africano, oggi mi sento gay, oggi mi sento lavoratore migrante».
Fosse davvero gay passerebbe qualche guaio nel luogo dove si svolgono i Mondiali. Fosse lavoratore migrante avrebbe avuto buone possibilità di morire nei cantieri degli stadi. Fosse davvero così interessato alle minoranze, ai diritti degli ultimi, eleverebbe qualche protesta presso gli emiri quando i loro zelanti poliziotti sequestrano le magliette di Mahsa Amini, la ragazza uccisa in Iran per una ciocca di capelli. Fosse contro la censura non avrebbe vietato di portare la fascia arcobaleno ai capitani delle squadre, pena un’ammonizione. Cartellino giallo alla libertà.
La Fifa fa politica da sempre. L’aveva
fatta quando aveva deciso di assegnare i Mondiali in sequenza alla Russia e agli Usa per bilanciare i favori alle due grandi potenze (ce ne sarebbe una terza,laCina). L’hafattaamaggiorragione quando tra i due appuntamenti ha intrufolato il Qatar per il volere di un presidente francese, Nicolas Sarkozy, che giocava una geopolitica tutta sua per i denari del Golfo. L’ha fatta con la scusa di mostrare la supposta modernità di un Paese e aiutarlo nel progresso verso la conquista dei diritti per tutti non solo per i famigli della casa regnante. La modernità sono lo shopping delle bellezze di Francia (e d’Italia), quanto al progresso lo si vede in questi giorni. È semmai la Fifa ad essere regredita e ad aver rinunciato, per cinque miliardi di euro di buoni motivi, ai valori che in teoria dovrebbe propagandare: fair play, uguaglianza, difesa delle minoranze vessate.
Implacabile arriva, a questo punto di ogni discussione, l’obiezione del rispetto verso la cultura altrui. Non meno ipocrita della precedente. Forse
che allora si doveva andare in un luogo dove il regime decide quale t-shirt si può usare e quale no? Forse che per rispetto dell’ospite bisogna imbavagliare i calciatori e impedire loro di dire quello che pensano e se sono discoli come i tedeschi si oscurano le immagini della loro protesta? Forse che si arriva al grottesco di mandare un guardalinee a controllare la fascia del portiere tedesco Neuer nel caso, sia mai, fosse colorata?

Esiste, poi, l’ipocrisia di segno opposto. Sognare che davvero lo sport possa essere scisso dalla politica quando è il più grande palcoscenico planetario e dunque da sempre abituato agli assalti di chi vuole veicolare messaggi, difendere una causa, promuovere un’idea.
Dunque si rassegni Infantino. Non per colpa sua il calcio è politica, la sua continuazione con altri mezzi. Talvolta è addirittura utile per difendere delle buone cause. Lui, però, ha scelto la causa sbagliata.

In Francia, la tradizione vuole, sin dal 1978, che ciascun primo ministro pianti un albero nel parco dell’Hotel di Matignon, uno dei più grandi e bei giardini di Parigi. Un modo per lasciare una traccia del proprio passaggio: se i presidenti sono eletti per cinque anni, i primi ministri conoscono spesso un’esistenza molto più breve. Lunedì 28 novembre, Elisabeth Borne ha scelto la sua pianta: una quercia verde, un albero sempreverde. «Una scelta ecologica e rispettosa dell’ambiente», si è compiaciuto il gabinetto del primo ministro. Un modo di ricordare che il capo di governo è anche ufficialmente in carico della «pianificazione ecologica» voluta da Emmanuel Macron. Una formula che il presidente francese ha preso in prestito alla sinistra e a Jean-Luc Mélenchon, quando era ancora in campagna elettorale, per convincere di voler veramente agire sulla
questione ambientale.
Sei mesi dopo la sua nomina, è ancora qua, Elisabeth Borne, i piedi ben piantati per terra. Dopo avere puntato su un fallimento veloce, la stampa francese è oggi vittima di una sindrome inaspettata di “Bornemania”: “L’Odissea di una resistente” (Les Echos), “La trasformazione politica di Elisabeth Borne” (Le Point)... Prima dell’estate, nessuno avrebbe scommesso su una tale resilienza per la sessantunenne.
Troppo rigida, troppo tecnica, troppo fredda… Laureata al Politecnico - la più prestigiosa scuola di ingegneria francese - questa alta funzionaria non era mai stata eletta, né candidata a un’elezione. Il capo dello Stato aveva dapprima offerto il posto a una donna di destra, il sindaco di Reims Catherine Vautrin, conoscenza di Nicolas Sarkozy, ex ministro sotto la presidenza di Jacques Chirac. Ma Macron ha cambiato idea sotto la pressione della sua cerchia ristretta, preoccupata di questa ennesima svolta a destra. Ed è stato allora che Elisabeth Borne è entrata in scena: nel passato, è stata consigliere dei socialisti Lionel Jo-
spin e Ségolène Royal, e rivendica, ancora oggi, una sensibilità di sinistra. Membro del governo durante l’intero quinquennio precedente, ha già occupato diversi posti strategici: trasporti, ecologia, lavoro… Ma senza riuscire mai a imporsi come personaggio politico di prim’ordine.
Al di là del suo profilo, è soprattutto la situazione politica che sembrava dover condannare il Premier a un contratto a breve termine. A giugno, le elezioni legislative hanno regalato una brutta sorpresa a Emmanuel Macron: una maggioranza relativa all’Assemblea nazionale. Per la prima volta dal 1988, l’Eliseo non può più contare su un gruppo di deputati che obbediscono come un esercito di soldati alla volontà del Presidente. Ormai, ogni legge deve essere discussa con i gruppi di opposizione, fino ad ottenere un compromesso. In alcuni paesi, si chiama democrazia. Nel contesto della Quinta Repubblica francese, tutta incentrata sul presidenzialismo, si definisce instabilità. Da qui in avanti, l’ipotesi di uno scioglimento del Parlamento per provocare nuove elezioni legislative, prerogativa che il presidente può attivare quando vuole, sembrava l’unico orizzonte a medio termine. Ma anche su questo punto, il timore sembra scemare. Numerosi testi sono stati votati, anche se non senza difficoltà. Un succes-

so che nessuno si aspettava. E se la ragione si chiamasse Elisabeth Borne?
Il Premier ha dimostrato la serietà del suo metodo: concertazione, dialogo con le opposizioni e le parti sociali. Quelli che la pensavano trasparente e in disparte sono stati delusi: l’appassionata di running può anche alterarsi quando lo ritiene necessario, la sigaretta elettronica sempre in mano con gesto nervoso. All’interno del governo, ha dato prova di leadership, nei confronti di quelli che sognano di rubarle la poltrona, o che vogliono quella di Emmanuel Macron, dal 2027. Una puntualizzazione fatta in privato - i ministri devono giocare da collettivoera dediacata soprattutto agli ambiziosi ministri Bruno Le Maire (Economia), o Gérald Darmanin (Interno).
Lo “stile” Borne - efficace e discreto - sembra funzionare. Negli ultimi sondaggi, il primo ministro è più popolare di Emmanuel Macron. Piccoli segnali che possono avere grandi conseguenze. Edouard Philippe ne sa qualcosa, congedato perché più apprezzato nei sondaggi del Presidente. Tra l’attuale inquilino dell’Eliseo e quello di
Matignon, i potenziali screzi esistono già. Emmanuel Macron sta cercando un accordo con la destra; Elisabeth Borne afferma che così si correrebbe il rischio di perdere a sinistra i voti trovati a destra. Il Presidente fa sapere che vuole imporre rapidamente la sua riforma delle pensioni; il Premier insiste sulla necessità «di lavorare più a lungo» sull’argomento… E mentre Elisabeth Borne è ufficialmente incaricata del delicato tema dell’ecologia, è Emmanuel Macron stesso che decide di riprendere il dossier in mano, e si occupa di nuove riforme di trasporti pubblici, convinto che sul tema della transizione ecologica non si vada abbastanza veloci.
Per Elisabeth Borne, il più difficile deve quindi ancora venire. Al parlamento, si aspetta per il 2023 l’ennesima legge sull’immigrazione, tema sempre difficile per una maggioranza divisa. La riforma delle pensioni, che dovrebbe essere sul tavolo in primavera, rischia di essere esplosiva. Nel frattempo, Elisabeth Borne deve continuare ad occuparsi di una crisi energetica senza precedenti, e di numerose critiche sulla gestione statale, in particolare per quanto riguarda la questione del nucleare. L’equazione sembra irrisolvibile: come promuovere la costruzione di sei nuovi reattori (Epr) - come ha promesso Emmanuel Macron nel suo programma - quando il dispositivo attuale funziona già così male, con il 41 per cento del parco nucleare spento per motivi tecnici? Quando il governo chiederà ai francesi di ridurre il riscaldamento quest’inverno, di rinunciare a far funzionare la lavatrice, o di accettare delle interruzioni di corrente per due ore, Elisabeth Borne si ritroverà da sola in conferenza stam-

pa, per spiegar loro tali misure. Una mossa sbagliata potrebbe danneggiare una popolarità basata soprattutto sull’immagine e non ancora su fatti concreti.
Le sfide sono talmente numerose che nessuno parla più del fatto che una donna occupa la poltrona di Primo Ministro. «Dedico questa nomina a tutte le bambine», aveva dichiarato con emozione l’interessata nel suo primo grande discorso. Una cosa purtroppo eccezionale nella storia politica francese: era avvenuto solo una volta, tra il 1991 e il 1992, per un periodo di undici mesi, con Edith Cresson. Questo è senza dubbio il più bel tour de force di Elisabeth Borne.
Attività frenetica tra Berlino e Parigi - la prima ministra francese Elisabeth Borne e il cancelliere Olaf Scholz dichiarano, dieci giorni fa, che i rapporti tra i due paesi non sono mai stati così buoni e stretti. Poco prima il presidente Emmanuel Macron riceve la ministra degli Affari Esteri Annalena Baerbock, poi il Ministro delle Finanze Christian Lindner e quello dell’Economia Robert Habeck. Tutti invitati alla sede della presidenza francese, il sontuoso Palazzo dell’Elysée, un onore normalmente riservato ai capi di stato o di governo di Paesi partner della Francia. Raramente si sono visti tanti viaggi diplomatici e una tale esibizione di unità tra i due paesi. Borne e Scholz hanno pure firmato un accordo di solidarietà reciproca nell’approvvigionamento energetico, un accordo messo in scena davanti alla stampa internazionale, anche se in verità già da parecchio tempo i tedeschi forniscono elettricità alla Francia e la Francia trasporta gas verso la Germania. Gli osservatori non credono ai loro occhi, perché solo un mese fa una crisi importante minava la stabilità di quella che spesso viene chiamata la “coppia franco-tedesca”. Macron aveva deciso di annullare all’ultimo momento il vertice dei due governi previsto per il 23 ottobre, perché il partner tedesco non gli sembrava sufficientemente motivato per trovare compromessi su questioni urgenti a livello europeo e bilaterale.
Un conflitto aperto di tale portata non si vedeva da tempo. Un’irritazione crescente e una mossa politica nazionale dopo l’altra che, accumulandosi, alla fine hanno fatto traboccare il vaso. Come ha dimostrato Michel Derdevet tre settimane fa in queste pagine, la crisi è profonda perché riguarda non solo progetti concreti, nell’industria degli armamenti ad esempio, ma anche concezioni divergenti sulla strategia dell’Ue nei suoi rapporti con gli Stati Uniti e la Cina. Le reazioni dei media europei più importanti sono state dettate da una grande preoccupazione. Jacques Attali, ex-consigliere di François Mitterrand, in un contributo sulle pagine di Les Echos, non escludeva neppure una nuova guerra tra Germania e Francia prima della fine del secolo.

Come spiegare questo rapporto complicato e fragile malgrado la lunga esperienza nella cooperazione bilaterale, e il gran numero
attività diplomatica per ricucire i rapporti tra Francia e Germania, difficili come mai da anni. Oltre alle divergenze politiche pesano anche antichi pregiudizi
L’AUTORE
Nato nel 1957, Frank Baasner ha vissuto e lavorato in vari paesi europei. È cattedratico alla facoltà di lettere dell’Università di Mannheim, e dal 2001 è direttore dell’Istituto Franco-Tedesco di Ludwigsburg. Per più di 25 anni ha lavorato come consulente per la cooperazione tra Francia, Germania e Italia sia nel settore privato, sia in quello pubblico. È autore di libri e saggi sui rapporti tra paesi europei
di rapporti istituzionalizzati a tutti i livelli, politici, economici e sociali? Germania e Francia sembrano Paesi talmente antitetici che un’intesa spontanea pare esclusa. Storicamente il loro antagonismo nasce molto tempo prima delle guerre devastanti tra il 1870 e il 1945: fin dagli esordi del movimento liberal-nazionale tedesco negli anni 1800, la costruzione di un’identità filosofica e anche politica della Germania era orientata contro la Francia. Fichte, nei suoi famosi “Discorsi alla nazione tedesca”, combatteva l’idea chiave della Rivoluzione francese che vedeva nell’individuo, considerato il “citoyen”, l’attore principale dello Stato moderno, sottolineando invece l’importanza dell’appartenenza a una comunità (germanica) quasi tribale. Wilhelm von Humboldt, nella sua grande riforma del sistema pedagogico e universitario tedesco, spazzava via la tradizione dell’educazione gesuita, mettendo al suo posto il concetto di “Bildung”, una visione quasi organica dell’educazione secondo cui, invece di inculcare sapere, il ruolo del professore è quello di accompagnare lo sviluppo di un potenziale che il giovane ha, in nuce, già dentro di sé. E per dare un terzo esempio, la poetica della letteratura di lingua tedesca di quell’epoca si opponeva radicalmente alle regole del classi-
cismo francese per mettere in risalto il “genio”, ispirato da forze divine e per niente sottoposto alle norme dell’Académie française.
Questo richiamo storico, che si potrebbe prolungare citando Clausewitz e la sua replica anti-napoleonica sull’arte della guerra e la serie di umiliazioni reciproche durante le tre guerre, dal 1870 al 1940, dimostra quanto è difficile, anche tra Paesi amici, guardarsi in faccia senza avere in testa, consapevolmente o meno, delle idee preesistenti.
Proprio in momenti di tensione, come quelli che stiamo vivendo in questi ultimi mesi se non anni, gli stereotipi che tutti noi abbiamo rispetto ad altri Paesi, hanno il loro peso. Pochi sarebbero in grado di spiegarne le origini storiche, ma è proprio questo che complica la nostra collaborazione. Raramente siamo coscienti che spesso riproduciamo vecchi modelli anche se in veste più contemporanea. I tedeschi visti dai francesi? Egoisti e fissati sul loro modello economico con la dipendenza energetica dalla Russia e quella commerciale dalla Cina. I francesi visti dai tedeschi? Troppo protezionisti, antiamericani e vanitosi malgrado la debolezza della loro industria, sempre pronti ad imporre la loro visione universalista del mondo “alla francese”. Alcuni di questi giudizi preconfezionati
IL TEMA
Attività frenetica e tanti viaggi diplomatici tra Berlino e Parigi per ristabilire i rapporti tra i due Paesi, minacciati da varie crisi politiche negli ultimi mesi. Il rapporto, storicamente complicato, è stato messo a dura prova e la coppia rischia di ricadere in vecchi stereotipi invece di portare avanti la cooperazione bilaterale necessaria per il futuro europeo
riposano sicuramente su delle osservazioni giuste: in ogni stereotipo c’è un pizzico di verità. Al limite ci si può anche ridere sopra, come nelle barzellette del tipo: «Il paradiso è dove i tedeschi sono gli organizzatori, i francesi i cuochi, gli svizzeri i banchieri, gli inglesi sono i poliziotti e gli italiani sono gli amanti», mentre: «L’inferno è dove i tedeschi sono i poliziotti, gli italiani sono gli organizzatori, i francesi sono i banchieri, gli inglesi sono i cuochi e gli svizzeri sono gli amanti».
Purtroppo non basta farsi una risata, anche se può aiutare a sbloccare la situazione. Gli scambi tra i grandi Paesi sono troppo importanti per l’Europa per lasciare la cooperazione al caso. Le percezioni schematiche che tutti abbiamo in testa ci conducono troppo spesso a giudizi prematuri, prima di aver ascoltato l’altro, prima di aver cambiato prospettiva. La cooperazione - e quello che vale per la Francia e la Germania vale per tutti i paesi dell’Ue - richiede un’attenzione particolare, la capacità di ascolto e di autocritica. Il motto dell’Ue “unita nella diversità”, se vuole essere più di una formula vuota, richiede tanto il rispetto delle particolarità quanto lo sforzo nella ricerca di interessi comuni.
Traduzione di Amanda Morelli


In fondo alla strada più antica e bella di Edimburgo, il Royal Mile, dopo una lunga discesa, c’è un palazzo: si chiama Holyrood, ed è il luogo in cui risiede il sovrano d’Inghilterra quando si reca a Edimburgo. Proprio di fronte al palazzo reale, sorge un altro edificio, quello del Parlamento scozzese, istituito nel 1999 per dare alla Scozia l’autonomia che con tanto vigore chiedeva. In quel Parlamento autonomo, da anni e in modo esplicito, si discute apertamente di indipendenza dal Regno Unito, un regno del quale la Scozia fa parte dal 1707, ma con il quale si accapiglia più o meno dal XII secolo.
La questione dell’indipendenza e dell’insofferenza scozzese verso l’Inghilterra e verso il Regno Unito è da sempre sostrato di ogni trattativa tra Edimburgo e Londra, ma di recente quest’ultima ha preso a farsi più
aspra, tanto che nelle ultime settimane si è preso a parlare di nuovo di un referendum (dopo la sconfitta di quello del 2014) e di indipendenza.
In realtà, a quanto sembra, non ci sarà nessun IndyRef 2, nessun nuovo referendum sull’indipendenza e anzi, la posizione caparbia (al limite dello stolido) della premier scozzese Nicola Sturgeon, sembra indebolirsi e farsi più fragile ogni volta che alza la voce e che rinvigorisce le sue richieste di autonomia.
Una situazione paradossale nella quale la Scozia appare in stallo, finita in un vicolo cieco, e divisa tra chi chiede l’indipendenza e chi, invece, si accontenterebbe di un minimo di senso di realtà.
La ragione di questo stallo è che la premier scozzese Sturgeon, come il suo partito, lo Scottish national party, ha costruito gran parte del proprio consenso sul nazionalismo e sull’indipendentismo dal Regno Unito. Se dovessimo riassumere in una parola le posizioni dell’Snp, che pure si colloca vagamente a sinistra, la parola che useremmo sarebbe nazionalista. Nel 2007 il partito vinse le elezioni del Parlamento autonomo scozzese proprio schiacciando sul
Una manifestazione dei sostenitori dell’indipendenza scozzese fuori dal Parlamento di Edimburgo, il 23 novembre scorso

pedale dell’autonomia da Londra; nel 2011, poi, le stravinse con la promessa di organizzare un referendum per l’indipendenza. A questo punto, dopo che il governo autonomo scozzese era riuscito, con una lunga trattativa, a ottenere dal Parlamento britannico l’autorizzazione a tenere un referendum su una materia che, in teoria, non gli competeva il referendum per l’indipendenza si è tenuto davvero. E, nel 2014, gli indipendentisti, dopo una campagna elettorale a tappeto, a sorpresa, lo persero. E nemmeno di poco: 44 a 55 per cento.
Da quel voto in poi, la faccenda dell’indipendenza invece di chiudersi si è inasprita. Per almeno due ragioni. La prima è che, due anni dopo la decisione scozzese di rimanere nel Regno Unito, è arrivata Brexit. In Scozia il Remain, cioè la parte di quelli che volevano continuare a far parte dell’Ue, aveva stravinto con percentuali anche superiori al 60 per cento. Non solo: ma nel 2014, molti di quelli che avevano votato affinché la Scozia non divenisse indipendente dal Regno Unito, lo avevano fatto proprio per poter rimanere nell’Ue, cosa che una neonata repubblica scozzese non avrebbe potuto fare. La somma di questi due voti divergenti ha così creato una profonda ferita nell’animo e nella politica degli scozzesi che oggi si
trovavano in una posizione molto diversa da quella che avrebbero voluto: legati a un Regno Unito che non hanno mai digerito fino in fondo e, allo stesso tempo, espulsi da un’Unione Europea di cui invece volevano essere parte.
A questa prima frattura si è sommata quella della necessità di sopravvivenza politica del partito Snp. Il partito è da tempo in affanno. Anche se, secondo i sondaggi è ancora il primo partito, il suo consenso è in forte diminuzione (dal 47 per cento a circa il 38 per cento).
E dunque, per un partito che dell’indipendenza dal Regno Unito ha sempre fatto la sua bandiera, non c’è altro modo di riprendere vigore che tornare ad agitarla, quella bandiera. E il modo per farlo è alzare la posta ogni volta che la strada si fa impervia o addirittura sbarrata.
Così, pochi giorni fa, dopo che i giudici della Corte Suprema britannica hanno stabilito che il Parlamento scozzese non ha il potere di indire un referendum sull’indipendenza a meno che non sia il Parlamento della Gran Bretagna a concederlo (cosa che Westminster a questo giro non ha nessuna intenzione di fare), la premier Sturgeon ha rilan-

ciato e ha detto che saranno le prossime elezioni a decidere sull’indipendenza, diventando un referendum de facto. Tradotto in soldoni significa che se il suo partito, la cui proposta principale è l’indipendenza, dovesse avere più del 50 per cento dei voti, allora la partita si riaprirebbe.
Una scommessa audace, di quelle che se si perdono si perde tutto. E soprattutto una scommessa che al momento non sembra avere possibilità di essere vinta, anche perché nel farla Sturgeon sembra essersi dimenticata di tenere conto di vari fattori in gioco.
Il primo sono i sondaggi di opinione, che dicono che per quanto il consenso verso l’indipendenza sia cresciuto negli ultimi anni, è ancora al di sotto della magica soglia del 50 per cento (anche se di pochissimo: 49 per cento circa). Questo perché, secondo molti scozzesi, l’indipendenza sarebbe un salto nel vuoto troppo audace e per giunta con il rischio che la sola Scozia, che pure è ricca, non lo sia abbastanza da reggersi autonomamente.
La seconda è l’Europa: non sta scritto da nessuna parte che, nel momento in cui la Scozia facesse il bel gesto di lasciare il Regno Unito per correre verso l’Ue questa sia disposta ad accoglierla. Anzi. Un’ipotetica Scozia indipendente dovrebbe essere sottoposta, come tutti i Paesi che fanno richiesta di adesione, ad un lungo processo che, nella migliore delle ipotesi, durerebbe 10 anni. In questi dieci anni la Scozia si ritroverebbe inevitabilmente al di fuori da qualsiasi rapporto commerciale e politico, sia con la Gran Bretagna che con l’Ue. Anzi: ci sarebbe il serio pericolo che l’adesione della Scozia all’Ue finisca come merce di scambio nel risiko diplomatico che da anni vede Ue e Regno Unito impegnati a gestire Brexit.
Un rischio che nessuno si sente davvero di correre.
Non solo. La Scozia, per quanto rispetti molti dei requisiti richiesti dall’Ue, in realtà manca anche di infrastrutture legislative e istituzionali che, sino ad ora, ha delegato al Regno Unito (banalmente, non c’è un capo di Stato).
Infine, quello di cui Sturgeon sembra non tenere conto, è la stanchezza degli elettori che, probabilmente, dopo anni di dibattito avvitato sulla faccenda referendum sì, referendum no, e dopo un voto già compiuto, potrebbero voler iniziare a parlare d’altro. E soprattutto potrebbero non considerare allettante la promessa elettorale di un salto nel vuoto.
L’ONDA INDIPENDENTISTA FA I CONTI CON LA REALTÀ DI UN PAESE CHE FUORI DALLA GRAN BRETAGNA RESTEREBBE IN PANCHINA NELL’UE. E LA PREMIER STURGEON SI GIOCA IL TUTTO PER TUTTO


Il cappuccio nero calato sulla testa. Le catene ai piedi. Le tute arancioni. I corpi ripiegati su se stessi, stesi su brevi fazzoletti di ghiaia, a respirare quel poco d'aria concessa ai carcerati. Le immagini del carcere militare di Guantanamo, ex base navale cubana, sono indelebili. E perché mai quell’orrore dovrebbe essere archiviato fra i brutti ricordi, se a vent’anni e undici mesi dall'apertura di Guantanamo, quella prigione non è ancora stata chiusa? Persino i campi di sterminio nazisti sono stati serrati e i responsabili puniti. Invece Guantanamo, il buco nero dei diritti umani, dove è vietato guardare, dove le regole non valgono mai e dove qualsiasi pratica - specie la tortura - è lecita, continua a esistere. Addirittura nel 2018 l'allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciava che Guantanamo non sarebbe mai stata chiusa e che era stato un errore rilasciare
centinaia di pericolosi terroristi «per ritrovarli di nuovo nel campo di battaglia».
Delle 780 persone internate al Camp X-Ray, oggi restano 36 detenuti, pochi nel raffronto con il passato, ma sono comunque persone in attesa di un processo che probabilmente non arriverà mai: sono infatti quattordici i trattenuti a tempo indefinito che non hanno avuto alcun contatto con una qualsivoglia forma di organo giudiziario. Questo perché la giurisdizione di Guantanamo è affidata al Tribunale di guerra delle commissioni militari essendo i prigionieri definiti “enemy combatant”, cioè nemici combattenti: si tratta di persone ritenute vicine al terrorismo, catturate in Afghanistan e in Pakistan, incarcerate e fatte confessare a qualsiasi
Giornalistacosto e con qualsiasi mezzo. Per via del livello di brutalità applicato ai detenuti, confermato da Amnesty e da molti ex prigionieri rilasciati, si è fatta strada la richiesta da parte della società civile di chiudere il gulag cubano. Qualche promessa in tal senso è stata fatta, ma non è mai stata mantenuta. Su tutti il tentativo dell'ex presidente Barack Obama, che nella sua prima campagna elettorale promise di mettere fine a Guantanamo. Ma andò diversamente: «È una questione molto complessa», racconta l’avvocato tedesco per i diritti umani Bernard Docke, che continua: «Obama non agì abbastanza prontamente. Se lo avesse fatto subito, dopo le elezioni, cogliendo lo slancio entusiastico successivo alla sua nomina, probabilmente ce l’avrebbe fatta. Invece ha lasciato passare il tempo e dalle elezioni di midterm è uscita una maggioranza repubblicana del Congresso, che ha fatto opposizione e ha bloccato tutta una
serie di provvedimenti di stampo riformista e pacifista, fra cui anche la chiusura del campo di prigionia X-Ray. Il piano di Obama è stato poi definitivamente accantonato all'indomani di una nuova escalation di attacchi terroristici e della conseguente inversione di rotta dell'opinione pubblica. D’altra parte Obama stava portando avanti alcuni progetti di politica interna, fra cui la riforma sanitaria, che gli stavano a cuore e per i quali aveva bisogno dell’approvazione dei repubblicani, per cui alcune questioni, fra cui quella di Guantanamo, sono scivolate in secondo piano e questo purtroppo è vero ancora oggi, con il presidente Biden, alle prese con una maggioranza risicata e parecchie tensioni interne soprattutto per il sostegno alla guerra in Ucraina». Joe Biden sta evitando di affrontare il problema, forse più preoccupato dalle divisioni interne - addirittura il dipartimento di Giustizia ha deciso di istituire una nuova unità per contrastare il terrorismo interno, una minaccia in ascesa dopo il violento assalto a Capitol Hill - e dall’effetto che una decisione su Guantanamo potrebbe avere sul risicato sostegno di cui gode al Congresso.
L’avvocato Bernhard Docke si occupa di Guantanamo dal 2002, cioè dalla sua creazione, e per cinque anni ha lottato contro l’amministrazione di George W. Bush nel tentativo di liberare il suo assistito, l’allora diciannovenne Murat Kurnaz, nato in Turchia ma cresciuto in Germania, nella periferia di Brema. Murat nell'ottobre del 2001 volò da Francoforte al Pakistan perché voleva frequentare le scuole del Corano e rafforzare la sua fede musulmana, proprio mentre gli americani invadevano l’Afghanistan per combattere i talebani all'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle. Sebbene non fosse accusato di alcun crimine, Murat venne arrestato in Pakistan e venduto per tremila dollari alle forze armate statunitensi, che lo imprigionarono a Guantanamo, un carcere dove si trova «il peggio del peggio», così definì i detenuti sull’isola l’allora vicepresidente Dick Cheney, che aggiunse: «L’unica alternativa alla creazione di Guantanamo Bay sarebbe stata uccidere direttamente i sospetti terroristi». L’edificazione di Guantanamo, a distanza di vent'anni, ha finito per intrappolare la stessa America: «I trentasei prigionieri che ancora oggi si trovano lì pongono un altro tipo di problema: loro per primi non vogliono tornare nel loro Paese d’origine dove spesso vige la pena di morte e quindi un loro rimpatrio significherebbe subire ulteriori torture, se non la morte. Dall’altra parte questi prigionieri sono considerati troppo pericolosi per essere rilasciati e troppo difficili da condannare. Ovvero, da un lato, se fossero liberati sarebbero una minaccia per l’America se non altro perché potrebbero cercare una rivincita rispetto ai torti subiti in carcere; d'altro lato, le loro confessioni,


CI SONO ANCORA DECINE DI DETENUTI NEL CARCERE DELLE TORTURE.
AUTORITÀ AMERICANE NON POSSONO PROCESSARLI E NON VOGLIONO LIBERARLI. UNO SCANDALO INFINITO
“Una mamma contro G.W. Bush” del regista Andreas Dresen, al cinema dal 24 novembre, è una commedia basata su uno dei maggiori scandali giudiziari legati alla guerra al terrore proclamata dal presidente degli Stati Uniti Bush nel 2001.


essendo state estorte con la tortura, non avrebbero alcun valore legale di fronte a un tribunale e sarebbero di fatto annullate: i carcerati verrebbero quindi liberati, ma gli Stati Uniti non possono permetterselo perché, come dicevamo, si tratta di persone troppo pericolose. In qualche modo Guantanamo è una trappola che l’America si è costruita da sola», spiega l’avvocato Bernhard Docke, che in questi giorni si trova in Italia per la presentazione del film “Una mamma contro G.W. Bush” del regista Andreas Dresen, che ha conquistato due Orsi d'argento alla Berlinale 2022. Il film, una commedia divertente, nonostante la complessità del tema, racconta i cinque anni e mezzo di lotta di Rabiye Kurnaz, la madre di Murat, per liberare suo figlio da Guantanamo, dove ha subito torture: dall'essere costretto a ingoiare acqua fino al limite del soffocamento, all'elettroshock, a restare appeso per giorni al soffitto, al restare giorno e notte sempre con la luce accesa. Per liberarlo la madre Rabiye ha intentato una causa contro Bush davanti alla Corte Suprema. Unendosi a una class action di altri genitori di giovani incarcerati a Guantanamo e sfruttando le apparizioni televisive, Rabiye è riuscita a fare pressione sulla politica e sulla magistratura statunitensi per garantire ai prigionieri di Guantanamo il diritto di
avviare un'azione legale contro la loro detenzione. La Corte Suprema si pronuncia a favore dei detenuti presentatisi in giudizio contro il governo Bush. «Eppure Guantanamo non è ancora stato chiuso. È un pensiero che mi assilla, ripenso continuamente alle persone rinchiuse e torturate, che ricevono un trattamento disumano», dice Rabiye e racconta anche il difficile percorso di riabilitazione di Murat che solo dopo molto tempo è riuscito a tornare a una vita normale. Anche la documentarista Laura Silvia Battaglia ha incontrato Murat, così come altri ex carcerati di Guantanamo: «Molti convivono con problemi di post traumatic stress disorder e dicono di dover convivere

quotidianamente con l'incubo di quel lager».
La mancata chiusura di quel carcere e l’assenza di alcun pentimento da parte degli Stati Uniti rispetto all’esplicita violazione del diritto internazionale e alla privazione del diritto di “habeas corpus” ha provocato un generale declassamento dello stato del diritto in generale: «Se in Ucraina la Russia si permette di oltrepassare qualsiasi regola minima del diritto umanitario e se le norme della Convenzione di Ginevra vengono sistematicamente ignorate è anche perché G.W. Bush, dopo l’11 settembre, ha aggredito in modo così esplicito il diritto internazionale da averlo praticamente annientato ed è oggi ipocrita chiedere un qualsiasi rispetto del diritto in Ucraina, quando gli Stati Uniti continuano a violarli mantenendo aperto il carcere di Guantanamo», commenta l’avvocato Docke.
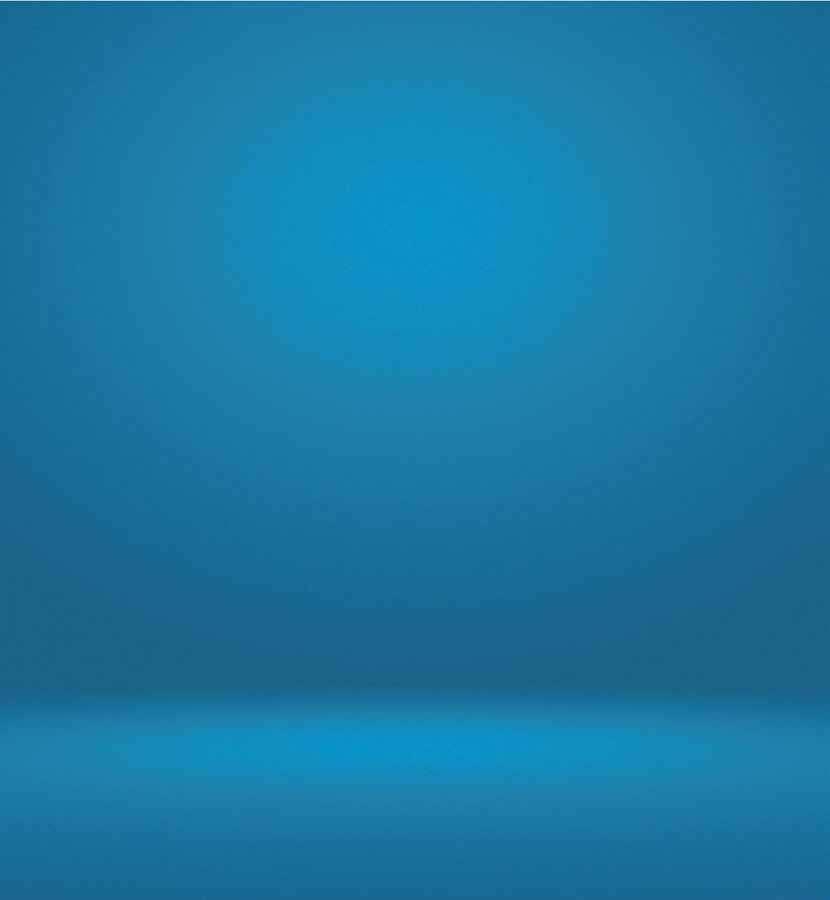



Fare dell’Ucraina un grande Donbass. Sembra essere questo l’obiettivo della strategia russa in vista dei mesi invernali. E finora le preoccupazioni del governo di Kiev e dei suoi alleati confermano che le mosse del generale Surovikin, il comandante in capo delle forze armate russe in Ucraina, stanno ottenendo dei risultati. Certo, quando si tratta di guerra i risultati rimano con l’indebolimento e la morte dei nemici e, tuttavia, non si può fare a meno di parlarne. I recenti attacchi alle infrastrutture energetiche del Paese hanno seriamente minato le capacità del sistema ucraino di mantenere le città nelle retrovie a un livello minimo di normalità. L’apparato industriale soffre in maniera evidente per i continui bombardamenti e le aziende in chiusura, anche nei settori strategici, aumentano giorno dopo giorno. La sede di ArcelorMittal di Kryvyi Rih, ad esempio, ha sospeso la maggior parte dei processi produttivi a causa del massiccio attacco missilistico russo alle infrastrutture energetiche del 23 novembre. Secondo i vertici dell’azienda, «la quantità di elettricità disponibile è insufficiente per sostenere la produzione anche al 20 per cento della capacità produttiva». Il che è molto significativo se si considera che si trattava della più grande azienda siderurgica ucraina. Il metallo, infatti, in una guerra è fondamentale sia per riparare le infrastrutture civili sia per costruire i pezzi di ricambio per i mezzi corazzati e per l’industria bellica. Chissà se il governo ucraino deciderà di agire come ha fatto a inizio novembre, ovvero espropriando e nazionalizzando alcune industrie considerate «strategiche». Si tratta delle compagnie di idrocarburi Ukrnafta e Ukrtatnafta, della fabbrica di camion AvtoKraz, del produttore di trasformatori industriali Zaporizhtransformator e della fabbrica di motori per aerei Motor Sich. In quell’occasione, il ministro della Difesa Oleksii Danilov aveva annunciato che gli espropri erano anche dovuti alla proprietà delle ditte, gli oligarchi Kostyantyn Zhevago, Igor Kolomoisky e Konstantin Grigorishin. Ma non si può non considerare che le aziende in questione operano tutte in settori strategici, vitali per la resistenza dell’Ucraina soprattutto in virtù del possibile stallo invernale. Il presidente Zelensky aveva dichiarato che «le complesse mansioni di queste aziende possono essere svolte solo attraverso una gestione di tipo militare-statale» aggiungendo anche che non escludeva «deci-

sioni simili» in futuro. In altri termini, il governo ucraino si preparava a gestire un’emergenza che aveva visto chiaramente arrivare rispetto all’approvvigionamento energetico e alla logistica, accentrando tutto nelle mani dello Stato. La legge marziale, prolungata fino al 19 febbraio 2023, permette anche questo, con buona pace degli uomini d’affari e degli industriali ucraini che hanno provato timidamente a protestare.
Tuttavia, queste decisioni non sono sufficienti a risolvere i problemi contingenti della popolazione civile. Il presidente ucraino ha pubblicizzato molto la costituzione degli invincible points (i punti dell’invincibilità, ndr), ovvero dei tendoni dotati di generatori autonomi e beni di primo conforto dove ricaricare i dispositivi mobili e ottenere aiuti umanitari. Si tratta di un palliativo, è evidente, dato che la stessa compagnia energetica nazionale Ukrenergo ha dichiarato che le forniture di energia nel Paese al momento sono ridotte al 30 per cento della capacità totale a causa dell’arresto di emer-
lo stesso peso di quelli di Kiev o di Odessa sul governo centrale. Quando si sentiva qualcuno di loro dire che «l’unica cosa importante è che la guerra finisca, non importa sotto quale bandiera» ci si scandalizzava perché la dissonanza con le dichiarazioni dei residenti di Leopoli o di Kiev era troppo palese. La resistenza «fino alla vittoria» sembrava l’unica versione ammessa, a costo di bollare chiunque si esprimesse diversamente come un «filorusso» o, peggio, come un traditore. Se consideriamo i vertici militari e politici di Kiev tale censura è comprensibile: l’Ucraina è in guerra e il morale deve restare alto, pena il disfacimento della narrativa così faticosamente costruita dal 24 febbraio a oggi e, soprattutto, la sconfitta. Per alcune parti delle opinioni pubbliche occidentali, invece, sembra che alcuni non siano mai riusciti a capire che la cosiddetta difesa dei valori democratici non è qualcosa di astratto ma passa attraverso morte e devastazione. Non solo nell’immediato, ma negli anni a venire, la cancrena dell’attuale conflitto in Ucraina è già evidente a chi non ha i paraocchi. Orfani che odieranno chi gli ha portato via i genitori, famiglie spezzate, invalidi di guerra, traumi psicologici, povertà, chiusura culturale e violenza. Chi vive in Donbass ne sa qualcosa, otto anni di guerra intermittente sfociata nell’invasione su larga scala di inizio anno e poi mesi e mesi di sofferenze in una terra di confine.
genza delle unità di diverse centrali elettriche dopo i bombardamenti del 28 novembre. L’operatore energetico ha inoltre aggiunto che il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha portato a un aumento del consumo di energia. In altri termini, fa più freddo e le persone vorrebbero riscaldarsi ma l’energia non c’è.

Ed è proprio questo il punto. Nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare spesso dell’imminente arrivo del «generale inverno», i media di tutto il mondo si sono profusi in analisi sui possibili risvolti militari e sociali per l’Ucraina e su quanto i russi puntino sul freddo come una sorta di alleato. L’obiettivo primario del Cremlino sarebbe quello di fiaccare il morale dei civili nelle retrovie, di obbligarli in qualche modo a fare pressioni sul governo affinché si intavoli un negoziato a partire dalla situazione attuale. Si ricordi che in Donbass ci sono migliaia di persone che vivono senza gas da giugno e che dalla fine dell’estate non hanno neanche acqua corrente ed elettricità. Ma i civili dell’est forse non hanno
Ora il Cremlino sembra essere deciso a distruggere l’Ucraina non solo con le bombe ma nell’animo, a lasciare solo macerie al posto dello Stato che ha osato opporsi ai suoi progetti espansionistici. Il problema, reale come la morte che si respira vicino alle linee del fronte, è che questa non è una vendetta di Putin ma una strategia militare. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno già dichiarato che aiuteranno Kiev in ogni modo possibile, ma sembra difficile che i generatori possano riuscire a sostituire la rete elettrica e intanto il freddo aumenta.


La propaganda di guerra del regime di Putin ha cominciato a fare irruzione nelle scuole della Russia nello stesso istante in cui i carri armati del Cremlino hanno cominciato a irrompere prepotenti in Ucraina. Ma adesso, assieme al militarismo più spinto, negli istituti scolastici russi potrebbero presto fare capolino persino elementi di preparazione alla guerra da propinare a bambini e ragazzi.
A dare la notizia è stato il ministro della Pubblica Istruzione Sergey Kravtsov, annunciando che dal prossimo settembre nelle scuole russe si svolgeranno dei corsi di «preparazione militare di base». Si tratta ancora di un progetto e la confusione non manca. Il ministro prima ha assicurato che le lezioni saranno obbligatorie per tutti, a partire dalla quinta classe. Poi ha fatto marcia indietro dicendo che saranno «extracurriculari» e che il loro inserimento nel piano di studi dipenderà da insegnanti e genitori. Non è neppure chiaro in cosa consisteranno queste lezioni, perché il programma non è stato delineato. Stando a Ria Novosti, però, «gli studenti impareranno l’esecuzione dei comandi, studieranno i dispositivi di protezione individuale e di primo soccorso, le armi e come maneggiarle, le basi del tiro, l’uso e la composizione delle bombe a mano». Ma non è finita. Sempre secondo l’agenzia di stampa statale, «gli studenti degli ultimi anni impareranno inoltre come operare in un moderno combattimento, studieranno la composizione e l’armamento di una squadra di fucilieri motorizzati su un veicolo da combattimento di fanteria, l’equipaggiamento ingegneristico della postazione di un soldato e impareranno cos’è una trincea singola». La Tass — altra agenzia statale — sostiene che «gli alunni del 10° e dell’11° anno» impareranno anche «a maneggiare un kalashnikov» e «fornire primo soccorso in combattimento»; poi, «studieranno i principi di funzionamento delle granate F1 e Rgd-5».
Preparazione militare, quindi preparazione alla guerra. E sicuramente non è un caso che queste lezioni vengano pensate proprio ora, nel pieno dell’invasione dell’Ucraina ordinata da Putin. Lo ha confermato indirettamente la stessa presidente della commissione Istruzione della Duma, Olga Kazakova: «Per una qualche ragione, molti genitori rifiutavano la parola “militare”. Tuttavia, sullo sfondo dell’operazione militare speciale, tutti hanno sentito l’importanza di questo corso a scuola», ha detto la deputata al quotidiano Vedomosti. «Operazione militare speciale» è il modo in cui le autorità russe pretendono che si chiami il conflitto in Ucraina: il Cremlino vieta, infatti, di chiamare la guerra col suo vero nome. «Crediamo che nelle attuali condizioni molto difficili, ogni giovane dovrebbe essere in grado di maneggiare le armi e sottoporsi a una preparazione militare di base», ha dichiarato, secondo No-

vaya Gazeta Europa, il leader del partito Russia Giusta, Sergey Mironov.
A marzo, quando la crudele guerra scatenata dal Cremlino era iniziata da poche settimane, la famigerata “Z” simbolo dell’offensiva delle truppe russe in Ucraina era spuntata già sulle finestre di diverse scuole. Alcuni istituti sembravano fare a gara nel dimostrare il loro appoggio all’invasione dell’Ucraina. In più di una scuola, bambini e ragazzi sono stati fatti schierare nei cortili o nelle aule e sono stati messi in fila in modo da formare una “Z”. Già la scorsa primavera c’era notizia di lezioni in cui si ripetevano agli studenti le menzogne sulla guerra diffuse dal Cremlino: ovvero che l’invasione sarebbe in realtà un atto di difesa della Russia con l’obiettivo di «denazificare» l’Ucraina. Da quest’anno, inoltre, nelle scuole sono stati introdotti alzabandiera e inno nazionale (da eseguire ogni settimana) e, soprattutto, le co-
siddette «conversazioni su cose importanti», considerate vere e proprie lezioni di propaganda. Non tutti sono stati zitti, ci sono state anche lamentele, sia di genitori sia di insegnanti, ma a Mosca sembrano intenzionati a continuare su questa strada. E i corsi di «preparazione militare di base» proposti sono purtroppo la conferma del crescente livello di militarismo che il Cremlino vorrebbe imporre alla società russa e persino ai più giovani.
Le nuove lezioni dovrebbero impegnare gli studenti per 35 ore nel corso di cinque giornate e il loro contenuto, per quanto sia noto solo per sommi capi, ricorda a molti quello della preparazione militare di epoca sovietica, quando a scuola s’imparava a reagire ad attacchi nucleari o chimici, prestare primo soccorso e maneggiare armi da fuoco. Secondo il quotidiano filogovernativo Izvestia, il capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov avrebbe accolto con favore l’iniziativa così come l’idea di includere eventualmente i veterani di guerra tra gli insegnanti di queste lezioni militari. Inoltre, sempre secondo il giornale, vorrebbe che i corsi durassero addirittura 140 ore in due anni per gli studenti della decima e dell’undicesima classe.

La Russia di Putin non è arrivata a questo punto da un giorno all’altro. Sono anni ormai che le scuole e la tv divulgano una visione edulcorata e idealizzata della storia nazionale. Ed è già dal 2016 che in Russia esiste un gruppo paramilitare per bambini o poco più: la YunArmiya, che ha l’obiettivo di diffondere il culto della patria anche tra i più piccoli. I ragazzini in uniforme — basco rosso e divisa beige — hanno tra gli otto e i 17 anni. Gli adolescenti sfilano regolarmente nelle parate dell’esercito russo, inclusa quella colossale sulla Piazza Rossa che si svolge ogni anno il 9 maggio per celebrare la vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale, ma che serve al Cremlino anche per gonfiare i muscoli davanti al mondo mettendo in bella mostra carri armati e missili balistici. A differen-
za di quanto succedeva in epoca sovietica col corpo dei Pionieri, non è obbligatorio per i ragazzini far parte della YunArmiya, ma le loro scelte sono inevitabilmente influenzate da insegnanti e genitori. Stando ai dati ufficiali, ora, i bambini e gli adolescenti col berretto rosso sarebbero più di un milione. Alcuni attivisti si sono schierati contro questa militarizzazione denunciando che viola i diritti dei minori. Purtroppo, sono rimasti inascoltati.

Quando Tibor Szabó ha notato un kalashnikov nascosto nel suo campo di grano, non si è spaventato: ha fatto una fotografia, che mostra sullo schermo del suo cellulare, e non ha toccato l’arma, convinto che presto sarebbe scomparsa. «Non sono il primo contadino della zona a cui è capitata una cosa del genere, né sarò l’ultimo», spiega appoggiato allo steccato della sua casa di campagna mentre un gruppo di galline razzola attorno ai suoi piedi. Lui e la moglie, racconta, stanno cercando di abituarsi ai colpi di arma da fuoco che di tanto in tanto riecheggiano nella notte e ai passi furtivi nei campi quando cala il buio. A pochi chilometri dal suo terreno, nella regione serba della Voivodina, dove un decimo degli abitanti parla ungherese, si stende la doppia recinzione, alta quattro metri e costellata di filo spinato e telecamere, fatta costruire da Viktor Orbán nel 2017 per impedire l’ingresso ai migranti diretti dalla Serbia in Ungheria.
Nell’estate scorsa, non lontano dalla casa di Tibor, una sparatoria tra bande di trafficanti ha provocato una vittima: «Sono nervosi, quest’anno il carico di lavoro è aumentato», commenta il contadino, fissando un punto indistinto in direzione del confine. Dalla casa la recinzione non si vede, nascosta dalla boscaglia, ma in questa zona di frontiera tutti si sono abituati alla sua presenza. Secondo i dati di Frontex, il numero dei migranti in cammino per entrare nell’Unione Europea sulla cosiddetta rotta dei Balcani occidentali è aumentato del 170 per cento quest’anno, e nei primi nove mesi sono stati registrati 106mila ingressi irregolari. Un aumento favorito, a detta di Bruxelles, dal governo di Belgrado: la Serbia, infatti, non chiede il visto ai viaggiatori provenienti da Stati che non riconoscono l’indipendenza del Kosovo, tra cui India, Turchia e Marocco. Per i cittadini di questi Paesi che desiderano vivere in Europa lo Stato balcanico rappresenta la prima tappa, raggiungibile con un biglietto aereo, di un viaggio che li conduce fino alle porte dell’Ungheria, dove tentano di entrare clandestinamente. Si tratta di «una porta di accesso dal retro che va chiusa», ha affermato il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas. «I nostri amici serbi pensavano forse che non avremmo notato come gli indiani oggi figurano tra le prime dieci nazionalità di richiedenti asilo?», ha commentato il politico greco, mentre la commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha annunciato «un piano d’azione» per la rotta balcanica pronto prima del vertice “Ue-Balcani occidentali” del 6 dicembre a Tirana.
Nel luglio scorso, l’Austria ha registrato il più alto numero di domande di protezione internazionale dalla crisi migratoria del 2015; i primi, per nazionalità, sono stati proprio i cittadini indiani, ma nessuno di loro, si è affrettata a chiarire Vienna, ha ottenuto l’asilo. Un mese dopo, ad agosto, l’Ue ha registrato un inedito, anche se contenuto, picco di domande da parte di migranti turchi e marocchini per un totale di 6mila richieste. Così, su pressione di Bruxelles, la Serbia, candidata ufficialmente a entrare nell’Unione, ha promesso di uniformare la propria politica di ingresso a quella degli Stati europei e ha, per ora, imposto l’obbligo di visto ai viaggiatori provenienti dalla Tunisia e dal Burundi, Stato africano tra i più poveri al mondo.

Seduto in mezzo a un campo di patate nei pressi del confine con l’Ungheria, Jaskaran prova a scaldarsi con i raggi del sole autunnale; accanto a lui il suo compagno di viaggio, con il capo avvolto in un turbante nero, taglia una cipolla da mangiare con un pezzo di pane. Entrambi raccontano di essere emigrati dalla regione indiana del Punjab, dopo avere scoperto l’esistenza della rotta balcanica tramite Internet: «Lavoravamo nei campi, ma ci siamo indebitati a causa delle frequenti alluvioni e vogliamo trovare lavoro in Svizzera». Ogni tanto tossiscono, perché il mulino abbandonato in cui hanno passato la notte è molto umido, raccontano: dopo essere arrivati in aereo a Belgrado, hanno depositato 5mila euro in un fast food vicino alla sta-

zione ferroviaria, che funge da base per i trafficanti, e ora sono in attesa delle indicazioni per sapere quando varcare il confine a nord della città di Subotica.
Con i suoi edifici in stile Art Nouveau e i colori accesi delle facciate dei palazzi, la città di Subotica racconta un’altra storia di frontiera. L’elegante sede del municipio, il teatro e la sinagoga testimoniano l’antica ricchezza di un crocevia commerciale conteso tra gli Ottomani e gli Asburgo. Oggi sui giornali stampati in lingua magiara che si leggono nelle piazze fanno spesso capolino titoli contro i profughi, accusati di avere reso la città una terra di conquista dei trafficanti.
Snodo di contrabbando di armi durante le guerre jugoslave e di cannabis ed eroina ancora oggi, la regione intorno a Subotica ha infatti scoperto un nuovo business: il traffico di migranti. Secondo il centro di ricerca svizzero Global Initiative questo giro di affari al confine tra la Serbia e Ungheria frutterebbe ai trafficanti più di 8 milioni all’anno. Radoš Durović, della ong serba Asylum protection center, si è abituato a leggere delle sparatorie fuori dalla città tra gruppi rivali: «I criminali locali arruolano i migranti che si sono indebitati durante il viaggio per utilizzarli come traduttori. Ma anche i cittadini del posto, spesso in difficoltà economica, si offrono come autisti o mettono a disposizione i loro appartamenti».

Fuori dal centro di accoglienza nei pressi della città di Sombor, a pochi chilometri dal confine con la Croazia e l’Ungheria, una lunga fila di taxi staziona sotto agli alberi. «Accompagniamo i migranti in città per acquistare il cibo, oppure li avviciniamo al confine: ma cosa fanno lì bisogna chiederlo ai trafficanti, senza di loro qui non puoi fare nulla», commenta un tassista. Progettato per ospitare un centinaio di persone, il centro di accoglienza di Sombor ne accoglie oggi circa 800. Tutti, al suo interno, conoscono la logica del profitto dei trafficanti che regola le modalità di attraversamento. La percentuale di successo è molto alta, se ci si può permettere di pagare 10mila euro per corrompere i funzionari dei varchi ufficiali, mentre i più poveri versano 300 euro per noleggiare una scala con cui provare a scavalcare, di notte, il muro di filo spinato. Oltre la barriera, però, l’ostacolo più grande rimane quello della polizia ungherese.
«In ogni accampamento che visitiamo, tra i boschi o negli edifici abbandonati, ci sono persone con lesioni e arti spezza-
ti», racconta Vuk Vuckovic, della ong serba klikActiv, impegnata a offrire sostegno umanitario ai migranti lungo il confine. «L’Unione Europea ha mostrato interesse solo per la questione dei visti che hanno un’influenza minima: il 70 per cento dei migranti in transito oggi in Serbia è rappresentato da afghani e siriani, e tutti, a prescindere dalla nazionalità, subiscono soprusi terrificanti per mano della polizia». Secondo klikActiv, sono centinaia le persone respinte ogni giorno in Serbia dopo avere attraversato la frontiera con l’Ungheria. In un rapporto pubblicato lo scorso agosto, Medici senza frontiere ha elencato gli abusi documentati in questa terra di confine: percosse con cinture e manganelli, calci, pugni, uso di spray al peperoncino e gas lacrimogeni, e poi umiliazioni come quella di «funzionari di frontiera che durante i rastrellamenti hanno urinato addosso ai migranti svestiti».
A fine ottobre, il governo ungherese ha annunciato di volere aumentare l’altezza del muro, che si estende anche al confine con la Croazia, e ha rimproverato l’Unione di non avere rimborsato la spesa di oltre 800 milioni di euro necessaria a costruirlo. «Bruxelles è convinta che i respingimenti illegali e le barriere fungano da deterrente: ma finora hanno solo favorito gli affari dei trafficanti», sostiene Durović. «Molti rifugiati stanno abbandonano la Turchia, dove hanno vissuto per anni, a causa della crisi economica e dell’ostilità della popolazione, e con l’avvicinarsi delle elezioni nel Paese la situazione peggiorerà».
La risposta dell’Unione europea non sembra destinata a farsi attendere: «Frontex deve essere impiegata lungo tutta la rotta balcanica», ha chiarito il vicecommissario Schinas, e Belgrado ha accettato di ospitare le truppe di pattugliamento dell’agenzia europea al confine meridionale con la Macedonia del nord. Il ministro dell’Interno serbo, Aleksandar Vulin, ha chiarito la posizione del governo durante una visita istituzionale in Grecia, quando ha alluso al conflitto secolare con l’Impero ottomano: «Non è la prima volta che la Serbia protegge l’Europa da un’invasione: ogni migrante fermato al confine serbo è un migrante in meno a Vienna o a Berlino». Intanto, nel campo al confine con l’Ungheria, assieme a migliaia di altre persone, Jaskaran attende le indicazioni dei trafficanti. E si augura di non essere lui, quel migrante.








Una donna palestinese protesta per il taglio dei suoi ulivi nel villaggio di Burin

Robert Abuied ha fatto tutto quello che ha potuto quest’anno per mantenere in salute i suoi ulivi nei 50 dunam (12 acri) di terreno della sua famiglia, nella municipalità di al-Walaja, a nord-ovest di Betlemme. Ma un gennaio più caldo del solito ha ritardato la fruttificazione degli alberi. «Il mese di gennaio, in genere il più freddo e decisivo per la fioritura, è stato mite, seguito da alcune gelate notturne a febbraio. Di conseguenza le olive sono più piccole e questo si ripercuote sui miei guadagni. Ho perso almeno 15.000 shekels (4.220 euro) rispetto all’anno scorso e produco la metà rispetto a 10 anni fa», spiega l’agricoltore sessantacinquenne e proprietario della Cooperative association for olive pressing, il più antico frantoio di Betlemme.
Robert Abuied è uno dei tanti agricoltori palestinesi che ha visto i suoi redditi diminuire per gli effetti combinati del cambiamento climatico e dell’occupazione israeliana. 16 (4 acri) dei suoi 50 dunam di terreni agricoli si trovano nella Seam Zone, una enclave di terre intrappolate tra la Linea Verde - il confine dell’accordo di armistizio del 1949 - e il Muro di separazione, cui i contadini palestinesi non possono accedere senza un permesso concesso dalle autorità israeliane.
Quest’anno Robert non l’ha ottenuto, in linea con le politiche restrittive dello stato ebraico che secondo i dati dell’ong israeliana HaMoked ha ridotto il tasso di approvazione dal 71 per cento nel 2014 al 27 per cento nel 2020, affermando che i Palestinesi si servirebbero di questo strumento per entrare illegalmente in Israele e cercarvi un impiego.
L’assegnazione limitata dei permessi impedisce le attività agricole essenziali come l’aratura, la potatura, la concimazione o la gestione dei parassiti durante l’anno, impattando negativamente la produttività e la qualità delle olive. «In poche settimane il raccolto di un intero campo infestato dalla mosca dell’olivo, le cui larve si nutrono della drupa del frutto può andare perso, senza intervento umano», spiega Thaer Fakhoury, esperto nell’accompagnamento dei contadini dell’Arab centre for agricultural development. Nel 2020 in Cisgiordania sono stati prodotti circa 13.000 metri cubi d’olio d’oliva, mentre nel 2014 la produzione era di circa 25.000 metri cubi, quasi il doppio.
Un colpo duro da incassare per le 100.000 famiglie palestinesi che secondo l’Onu aspettano i proventi della raccolta per rafforzare i propri redditi, in un settore, quello dell’olio, che vale tra i 160 e 190 milioni di dollari secondo il Palestine trade center.
Negli ultimi dieci anni i raccolti di olive in Cisgiordania, ma anche quelli degli alberi da frutto, sono diminuiti non solo a causa della riduzione dei permessi, ma anche per l’effetto del riscaldamento globale che danneggia la fruttificazione degli alberi. «In primavera le alte temperature e gli
sbalzi termici notturni interrompono e danneggiano le fasi di fioritura e allegagione dell’ulivo. Di conseguenza il fiore si essicca e cade», spiega Abeer Butmeh, coordinatrice del Palestinian environmental Ngos network. «L’irregolarità delle piogge e la siccità impediscono all’acqua di raggiungere le radici dell’albero, che pur essendo resistente, deve andare a cercare il nutrimento in un suolo sempre più secco», continua l’ingegnere ambientale oggi a capo di una rete di 15 organizzazioni ambientaliste.
La diseguale distribuzione dell’acqua poi peggiora il quadro. L’80 per cento delle risorse idriche in Cisgiordania è controllato da Israele che la incanala verso le colonie, illegali secondo il diritto internazionale. Lo sa bene Rizak Qaraq, contadino di sessantadue anni, le cui viti, ad un centinaio di metri dalla colonia di Neve Daniel, a sud di Gerusalemme, si sono essiccate: «Mi hanno tagliato l’acqua. Non sono riuscito a salvare le piante con il concime», spiega l’agricoltore, cui l’ordine militare n. 158 dello stato d’Israele vieta di scavare un pozzo.
La stagione della raccolta delle olive, tra ottobre e novembre, è uno dei momenti più importanti dell’anno per le
famiglie e gli agricoltori palestinesi, non solo per la sua rilevanza economica. La raccolta contribuisce a costruire un senso di comunità familiare e di appartenenza alla terra e alle tradizioni palestinesi. Un sentimento che si tramuta in numeri. Negli oltre 900.000 dunam (222.395 acri) di terre arabili in Cisgiordania sarebbero piantati circa 10 milioni di ulivi, secondo il programma di sviluppo dell’Onu.
La loro produttività non è minacciata soltanto dal cambiamento climatico, ma anche dagli attacchi dei coloni che si fanno più intensi durante la raccolta delle olive. L’ong israeliana Yesh Din ne ha documentati 42 tra l’ottobre e il novembre 2021. Quest’anno, tra l’11 e il 24 ottobre, ce ne sono stati 22 secondo l’Onu, risultati in oltre 800 ulivi distrutti. Ma non solo. Il 19 ottobre scorso a Kisa, nel sud di Betlemme, un’attivista israeliana di 70 anni è stata ricoverata con un polmone perforato da un bastone di ferro scagliatole contro da un colone di Ma’ale Amos. Due giorni più tardi a Burin, a sud-ovest di Nablus, un agricoltore di 22 anni, colpito da una pietra lanciata dai coloni di Yitzhar, ha perso un occhio.
Proprio a Burin, la mattina del 7 no-

vembre scorso, Doha Asous, contadina di 60 anni, ha avuto, dopo più di un anno, finalmente accesso al suo oliveto. Ma non si aspettava di trovare 35 dei suoi ulivi in pezzi, piantati in terra come mozziconi di sigarette spenti, tagliati con la motosega dagli abitanti della colonia di Yitzhar. «Sono rimasta congelata e congelate erano anche le mie lacrime. Quegli ulivi avevano più di 70 anni», racconta la contadina, sessant’anni, mostrando le foto dei tronchi mozzati.
Il villaggio di Burin, poco più di 2.500 abitanti, è situato tra Yitzhar e Har Bracha, due colonie conosciute per la violenza dei loro abitanti. «L’esercito israeliano ha assistito all’attacco senza intervenire. Poi mi ha allontanata dai campi. Non posso permettermi di star ferma. Se lo faccio il dolore prende il sopravvento», denuncia la contadina, i cui terreni agricoli si trovano in zona C, sotto controllo amministrativo e militare israeliano, come l’80 per cento del territorio di Burin. In zona C è vietato coltivare, salvo ottenimento di uno speciale permesso da parte dell’Amministrazione civile israeliana, braccio del governo israeliano in Cisgiordania. Quest’anno a Doha sono stati concessi due soli giorni per raccogliere le olive nei suoi 8 dunam (2 acri) di terreno. «Li denuncerò alla polizia israeliana, ma so già che gli autori non subiranno conseguenze», sospira Doha. Nel 2021 i coloni hanno distrutto più di 9.300 ulivi secondo la Croce Rossa, mentre dal 2005, su 1.395 fascicoli d’indagine riguardanti le aggressioni dei coloni, il 92 per cento è stato archiviato senza la formulazione di un’accusa.
Le minacce psicologiche e le violenze mirano a scoraggiare l’accesso alle terre per i Palestinesi e rinforzare il principio su cui si fonda il diritto fondiario israeliano ereditato dall’e-
poca ottomana, per cui un campo lasciato incolto per almeno tre anni consecutivi diventa di proprietà dello stato di Israele. Una strategia che sarebbe utilizzata dai coloni per impaurire i contadini palestinesi e accaparrarsi nuove terre. «Rivendicare la proprietà di un campo di ulivi, soprattutto se antichi, o piantare un ulivo, è un gesto politico. L’atto di bruciarli poi statuisce chi ha il potere di cambiare lo status quo

e dettare chi è chi e chi è cosa», analizza Dani Brodski, dell’ong israeliana Rabbis for human rights, che ogni anno si reca nei villaggi palestinesi a rischio per supportare le operazioni di raccolta con un gruppo di volontari israeliani.
«La raccolta delle olive è sempre stata un periodo di festa per la mia famiglia. Voglio che continui ad esserlo nonostante tutto», dice sorridendo Doha Asous, mentre raccoglie le olive cadute fuori dai grandi teli di nylon neri distesi alla base dei tronchi. «Mi piace raccogliere le olive che scappano», dice con lo sguardo sfuggente, mentre il caffè aromatizzato al cardamomo bolle sul fuoco da campo. L’olio d’oliva, spremuto la sera prima nel frantoio di Burin, è pronto per essere mischiato allo Za’tar (miscela di maggiorana, timo e origano) e spalmato sul pane caldo.













Perché oggi la libertà delle donne è diventata in tutto il mondo così centrale. E perché questo non piace alle destre populiste. Parla la pioniera del pensiero femminista in Polonia
 colloquio con Agnieszka Graff di Wlodek Goldkorn illustrazione di Ambra Garlaschelli
colloquio con Agnieszka Graff di Wlodek Goldkorn illustrazione di Ambra Garlaschelli

l palcoscenico è un caffè, un po’ hipster, affollato più da donne che da uomini fra i trenta e cinquant’anni, nel rione Saska Kepa, sulla riva destra della Vistola a Varsavia: viali alberati, villette d’anteguerra e ampi spazi verdi. La protagonista è Agnieszka Graff, cinquantadue anni, storica di letteratura anglosassone, dottorato di ricerca su James Joyce, curriculum universitario fra Amherst College, Oxford e ora professoressa all’Università di Varsavia. Graff è una delle pioniere del pensiero femminista in Polonia, introdotto un quarto di secolo fa: un modo di percepire il mondo che trasformò le donne polacche in protagoniste e guide dei movimenti di protesta e delle iniziative della società civile, dalla difesa della Costituzione all’aiuto ai profughi dall’Ucraina, per non parlare della questione dell’aborto. Con lei abbiamo parlato del perché la libertà delle donne sia diventata centrale nel nostro immaginario e per quali motivi le destre populiste considerano quello che loro chiamano “l’ideologia gender” come nemico da combattere. Tutto questo dal punto di vista di un’intellettuale di quella che in Italia viene spesso chiamata “l’Europa dell’Est”, una definizione che, paradossalmente e polemicamente, Graff fa sua.
Si comincia con l’attualità, l’Iran. «La rivoluzione è iniziata quando una ragazza, Mahsa Amini, è stata uccisa dalla polizia per aver indossato l’hijab in modo non conforme alle regole. La domanda è: è stato un pretesto, un fattore scatenante, o si tratta davvero dell’hijab? La risposta è: si è trattato di entrambe le cose. Garantire che il velo sia indossato correttamente è diventato un simbolo di potere. Dall’altra parte, togliersi le sciarpe e bruciarle in piazza è diventato segno di ribellione. L’Iran è un caso estremo, ma per qualsiasi potere il controllo sui corpi delle donne è cruciale: come dovrebbero vestirsi, se hanno il diritto di muoversi liberamente, chi controlla la fertilità. È analogo, seppur diverso, il caso dell’aborto in Polonia: il corpo della donna è un campo di battaglia. L’atteggiamento nei confronti dei diritti delle donne e della sessualità fa la differenza fra sistemi autoritari e democratici, liberali e anti-liberali». Ci torneremo. Intanto, il fatto stesso che il corpo delle donne sia oggetto di battaglia (in Polonia comunque stiamo indisturbati in una città dove chiunque può vestirsi come vuole e la
nostra interlocutrice vive in un legame con un’altra donna), una battaglia cui partecipano pure i maschi è la testimonianza del fatto che il femminismo ha cambiato il nostro sguardo sull’universo e sia vincente. Graff prende tempo, poi dice: «Merito del nostro attivismo, di generazioni di donne in molti Paesi, ma anche dell’atmosfera spirituale e culturale in cui viviamo e che ha le sue radici nel pensiero illuminista. La persona umana è sempre più al centro dell’attenzione». Sorride: «Però, dire che il femminismo abbia cambiato il modo di percepire il mondo anche dei maschi mi sembra un’affermazione azzardata. Di alcuni sì, di altri no. E comunque, il femminismo è un’idea semplice: le donne sono esseri umani». Chiarisce: «Dal momento che ripetiamo il credo illuministico e liberale per cui tutti gli uomini sono stati creati uguali e tutti hanno diritto alla felicità, parole della Dichiarazione d’Indipendenza americana, si pone la domanda: solo gli uomini?». Aggiunge: «Per me la storia del femminismo è una serie di moniti per cui la democrazia ha dimenticato le donne. Sembra che tutti i diritti che abbiamo oggi ce li siamo conquistati con le nostre lotte e la capacità di rivolta. Ma c’erano pure necessità storiche. In conseguenza delle guerre mondiali le donne sono entrate massicciamente nel mercato



del lavoro. Ecco: il femminismo può essere raccontato come la causa di cambiamenti radicali oppure come il sintomo dei cambiamenti. Penso che ambedue le narrazioni siano vere. Però». Però? «È pure cambiato il paradigma del pensiero liberale».



Spiegazione: «È entrata a farne parte la psicanalisi, la cultura della terapia». Si ferma. Guarda l’interlocutore e chiede: «Ha presente Eva Illouz?». L’abbiamo presente, è una studiosa franco israeliana nata in Marocco e l’abbiamo intervistata per questo settimanale. «Adoro i suoi libri», dice Graff: «La sua tesi è la seguente: la psicanalisi come forza culturale è in forte connessione con il femminismo. Certo, il femminismo trattava Freud da nemico. Lo psicoterapeuta era la persona che normalizzava le donne e le riportava fra le mura domestiche dicendo: la tua rivolta è solo sintomo della tua nevrosi. Ma possiamo raccontare il femminismo partendo dai gruppi di autocoscienza degli anni Sessanta e Settanta, come terapia psicanalitica trasformata da un processo politico e sociale in corso. In breve: il femminismo è anche una specie di terapia della civiltà mediante la conversazione, un po’ come la psicanalisi».
Terapia è anche Riparazione - un concetto che nella tradizione ebraica si chiama “Tikkun” - la Riparazione del mondo o, for-
scrittrice e attivista per i diritti delle donne. Sopra: manifestazione femminista a Varsavia; sempre a Varsavia, il 6 novembre, commemorazione di Iza, giovane donna morta per il divieto di abortire

se, l’attuazione della grande promessa della modernità per cui tutti gli esseri umani sono liberi di scegliere l’appartenenza, il genere, i modi con cui amare l’altro.
E così si torna all’attualità. La domanda è perché in un Paese considerato spesso periferico e arretrato, la Polonia, il femminismo, punta avanzata del pensiero occidentale, è fondamentale? Graff risponde: «Perché la Chiesa ha scelto di allearsi con il partito Diritto e giustizia (Pis). E così il femminismo si è liberato dall’impasse in cui si trovava fin dall’inizio del processo della transizione dal comunismo alla democrazia». Spiega: «Ci veniva detto: state zitte, non svegliate i demoni del cattolicesimo polacco; noi liberali abbiamo bisogno della Chiesa perché la Polonia entri e resti nell’Unione europea». E infatti la Chiesa si proclamava favorevole all’Europa: «Ma dal momento in cui quel contratto è stato stracciato dai vescovi, noi femministe
 Agnieszka Graff,
Agnieszka Graff,
“Lo sguardo sul mondo oggi è femminile. Ma il potere è nelle mani dei maschi. E la storia dell’umanità non è una storia delle idee, ma di chi ha soldi e potere”
da sovversive, guardate con sospetto o ridicolizzate dagli stessi liberali, siamo diventate le difensore principali della democrazia. Un cambio epocale nella storia polacca». Allarga: «Non si tratta di sola Polonia. In molti Paesi il populismo di destra mette in questione la democrazia liberale e ovunque la questione di genere è cruciale. C’è un’alleanza fra le destre populiste e radicali e l’ala ultraconservatrice della Chiesa o forse al plurale delle Chiese: negli Stati Uniti, come in Spagna o in Italia, e basti pensare alle conferenze del Congresso mondiale delle Famiglie». Uno di questi si era tenuto a Verona nel 2019 fra le manifestazioni di protesta delle femministe, un altro a Budapest. Però, per quanto riguarda l’Italia, le destre promettono che la legge 194 sull’aborto non si tocca. Risposta: «Certo. Si usano vari registri di retorica a seconda del Paese. In Polonia si promette qualunque cosa, dalla proibizione totale dell’aborto allo stop alla “Sodoma e Gomorra” . In Francia sono nel miri-
no i matrimoni dello stesso sesso». In Russia ci sono leggi che vietano la propaganda Lgbt. «La narrazione è sempre la stessa», dice Graff: «Il liberalismo ci ha portato a una situazione in cui è in pericolo la famiglia e noi vi difenderemo da questo obbrobrio». Riflette: «È senso comune pensare che il populismo anti-gender sia una reazione al femminismo. Io invece credo che sia al contrario. Il risveglio del femminismo è una reazione all’ondata di misoginia».
Una pausa nel colloquio. Graff risponde al telefono al figlio adolescente. Poi riprende: «In Occidente viviamo in un periodo che sa di tramonto e di paura. Da quando Putin ha spiegato che la sua “operazione speciale” non riguarda soltanto l’Ucraina quanto “l’Occidente collettivo”, il gender, la questione dei gay e delle lesbiche è oggetto di una guerra vera, combattuta. Ecco, il femminismo è così importante perché è diventato parte di una partita che non riguarda più e
Il linguaggio della lotta Donne protagoniste alla Fiera nazionale della Piccola e media editoria di Roma (7-11 dicembre). E tanti libri che muovono dalle loro lotte. Come “Aborto senza frontiere” di Alessandro Ajres (Rosenberg & Sellier), dedicato proprio alle donne polacche. O “Il mito della bellezza” (Tlon) di Naomi Wolf; “Le Lupe di Pompei” con Elodie Harper (Fazi). E “Donne, diritti e libertà”: il titolo dell’incontro con l’iraniana Azar Nafisi, con Michela Murgia.
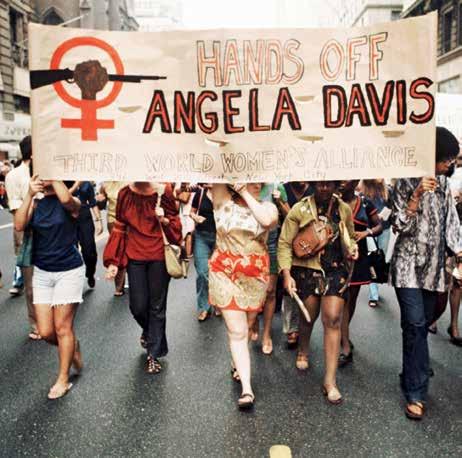
non solo i costumi. La guerra non è più su chi lava i piatti nelle coppie eterosessuali ma ha come oggetto la questione di chi governerà il mondo». Sorride: «Ciò detto, chi lava i piatti resta comunque importante».
Obiezione. Al tramonto siamo noi maschi, non il mondo. Lei ride e racconta un episodio. Mentre portava i suoi cani al guinzaglio un uomo con una postura molto da macho la redarguì e le intimò di liberare gli animali. «Ma era poco convinto della sua superiorità e anch’io non mi sono arrabbiata come invece sarebbe successo dieci anni fa». Insistiamo. Perché le donne hanno vinto. Nella sfera della cultura le cose più importanti le creano loro. Risposta: «Lo sguardo sul mondo oggi è delle donne. Ma il potere è nelle mani dei maschi. La storia dell’umanità non è storia delle idee ma prima di tutto di chi ha i soldi e il potere. E da questo punto di vista il potere maschile è in crescita. Siamo in un momento storico in cui il femminismo potrebbe diventare patrimonio generale dell’umanità ma potrebbe anche diventare storia, passato».
Silenzio, poi dice: «Secondo alcuni studiosi, lungo tutto il Novecento e fino a oggi le destre radicali hanno avuto un’ossessione per la questione della purezza, dell’identità certa e univoca. Le forme di questa ossessione cambiano, si trasformano con l’evoluzio-

“Siamo in un delicatissimo momento in cui il femminismo potrebbe diventare patrimonio universale. Ma potrebbe anche diventare di colpo storia, passato”
ne della cultura e della società. Oggi, al centro, ripeto, è l’esaltazione della famiglia tradizionale». Ha detto tradizionale.

La guerra in Ucraina ha riportato i ruoli tradizionali. I maschi combattono, le donne aspettano a casa, oppure: «Oppure vengono stuprate. Ho l’impressione che molte fra le femministe occidentali non si rendano conto di quanto gli stupri sistematici siano un’arma di guerra». Tace e poi: «Questa guerra ha riportato la divisione fra un’Europa occidentale e una orientale, in un modo doloroso. Per noi, in Polonia è evidente quanto non siamo percepite come parte con pari diritti dell’Unione europea ma come una propaggine del Continente. Comunque, abbiamo scoperto la comunanza con la nostre sorelle dei Paesi dell’Est e dell’Ucraina e questa è stata una piacevole sorpresa».

Spiegazione (nostra ): è solo nei Paesi della “vecchia Europa”, in particolare in Italia, che è comune la convinzione per cui al di là del Muro di Berlino si sia sviluppata una specie di “cultura comune”, diversa dall’Occidente; non allo stesso modo la pensano i diretti interessati. E restituiamo la parola a Graff: «Poco tempo fa a Breslavia si è svolta l’assemblea annuale di Kongres Kobiet (il congresso delle donne, l’organizzazione che unisce varie istanze femministe e femminili). Finora abbiamo sempre invitato le sorelle
italiane, olandesi, tedesche, per sottolineare la nostra appartenenza all’Occidente, i nostri “standard europei”. Quest’anno invece c’erano molte ucraine o donne che aiutano le ucraine. La guerra ha cambiato la nostra identità. Non dobbiamo cadere nella trappola del nazionalismo di nessun tipo (certamente non quello polacco e neanche ucraino) ma il tema dell’Ucraina è per il nostro femminismo centrale. Riguarda la nostra sicurezza, la nostra identità. Ma anche il nostro sguardo sulle sorelle occidentali. Abbiamo l’impressione che una parte del femminismo occidentale usi una mappa obsoleta dell’Europa e una retorica della pace che non dice niente. Hanno tanto criticato da sinistra la democrazia liberale da non aver percepito il montare delle destre radicali». Infine: «Non ho le energie per occuparmi di tutto questo. Ho già tanto da fare nel cercare case e lavoro alle ucraine rifugiate da noi». E alla domanda finale sul perché dalla periferia si vede l’Europa meglio che dal centro risponde così: «Sono americanista, ho studiato gli scritti di W.E.B. Du Bois (teorico del riscatto degli afroamericani). Parlava dell’importanza della voce degli ultimi per vedere meglio la natura del potere e del razzismo. Parafrasando dico: da qui, dall’Est, vediamo quel che succede prima delle altre» .

Gioielli, monete, mosaici, icone. Al Museo archeologico di Napoli va in scena l’età d’oro di Istanbul. Quella Bisanzio, ponte tra civiltà. E ultimo baluardo dell’impero romano
 di Marisa Ranieri Panetta
di Marisa Ranieri Panetta
Foto per gentile concessione di: G. Sannino
onte strategico fra Oriente e Occidente, l’antica Anatolia, oggi Turchia, ha visto fiorire e decadere civiltà diverse sul suo territorio, dal regno ittita alla leggendaria Troia. Erano però tutte greche le principali città sulla costa, quando Alessandro Magno le liberò dal giogo persiano. Ed era greca Bisanzio, affacciata sul Bosforo, dove Costantino “il Grande” trasferì la sua residenza nel 330.
Da lui prese il nome di Costantinopoli, sebbene, con i suoi sette colli e con un Senato, alla denominazione ufficiale di Nuova Roma rispondessero i fatti; il latino restava la lingua amministrativa e militare, mentre il Cristianesimo si diffondeva sempre di più, fino a diventare, sotto Teodosio, religione di Stato. Stava cambiando il mondo.
L’impero fu suddiviso in seguito tra Oriente e Occidente, ma la sede del massimo potere rimase Costantinopoli, che continuò ad arricchirsi di monumenti, chiese e palazzi. Lì risiedeva l’imperatore d’Oriente, rimasto solo nella nuova capitale a reggere lo scettro della romanità dopo che il “barbaro” Odoacre depose l’ultimo regnante occidentale nel 476. Dunque, fu impero romano (e “romei” erano detti gli abitanti) lo Stato che per tanti secoli ne proseguì l’esistenza, fino alla conquista turca del 1453. Eppure, a cominciare dal Seicento fu definito “bizantino” dal più antico nome di Costantinopoli, per la prevalenza della lingua greca e l’assetto teocratico dell’impero. A questo lungo tratto di storia è dedicata una mostra a Napoli, nel Museo archeologico nazionale (Mann): “Bizantini. Luoghi, simboli e comunità di un impero millenario”.


Promossa da Paolo Giulierini, direttore del museo, curata scientificamente dall’archeologo Federico Marazzi e organizzata da Villaggio Globale International, la mostra entra, attraverso quindici sezioni e quasi 500 reperti, in ogni aspetto di quanto si irradiò dal Bosforo in Italia e nel Mediterraneo: amministrazione, esercito, espressioni artistiche, vita di corte, monetazione, commercio (dal 21 dicembre 2022 al 13 feb-
braio 2023, guida breve e catalogo Electa).
Ma perché il racconto è stato allestito proprio a Napoli, luogo più legato ai regni angioino, aragonese, delle due Sicilie? «Riguarda un aspetto importante e poco conosciuto della storia di questa città», spiega Marazzi, docente all’Università Suor Orsola Benincasa, partner dell’evento: «Napoli, come ducato all’interno dell’impero, conobbe per secoli autonomia e prosperità; inoltre, il suo porto ben attrezzato offriva maggiore sicurezza ai vivaci traffici commerciali con il cuore dell’impero e il mondo islamico. La sezione d’apertura della mostra è riservata proprio alla Campania e a Napoli, vero Stargate verso l’Oriente».
Se “bizantino” e “bizantinismo” sono rimasti termini relativi a norme cavillose, discorsi tanto retorici quanto difficili da comprendere, non rimangono dubbi sul nome dell’imperatore che fece raggiungere il massimo splendore al regno: Giustiniano (527-565). Promotore del codice che riordinava, adattandole ai tempi nuovi, le leggi romane (Codex Iuris civilis), ricostruì la famosa chiesa di Santa Sofia (ora moschea); con i suoi eserciti riuscì a conquistare i territori italici sotto il dominio gotico e gran parte del Mediterraneo, mentre continuò — come i predecessori – a essere arbitro di contese religiose, quale garante dell’ordine costituito. Di più: sentiva la sua figura pervasa da una missione ultraterrena, interprete di una sinergia tra imperatore e divinità. E di questa col laborazione Santa Sofia era l’esempio più fulgido. Talmente maestosa, rilucente d’oro nei mosaici, ricca di colonne e ornamenti di vari colori da lasciare abbagliato chi vi entrava.
La liturgia aveva il suo peso: il complica to cerimoniale tra suoni, canti, gesti, pro fumi intensi rendeva il culto un grande spettacolo. La stessa Costantinopoli si offriva agli occhi dei sudditi e dei visitatori alla stregua di un palcoscenico, con processioni e sfilate interminabili all’insegna del fasto lungo la via Mesa, larga 25 metri e fiancheggiata da portici. Arrivava fino al Gran Palazzo, sede principale dei sovrani, adiacente all’Ippodromo, il più importante luogo di raduno
Tesori in mostra a Napoli. Sopra: formella in avorio con Dormitio. Sotto: evangelario miniato, dalla Biblioteca medicea laurenziana di Firenze. Al centro: orecchino con perle. Nella pagina accanto: veduta di Istanbul con la Moschea di Solimano

della città dove l’imperatore appariva dall’alto di una loggia.
Nella rassegna napoletana una statua in marmo (dalla Centrale Montemartini di Roma) rappresenta un giovane magistrato: nella mano destra stringe una specie di fazzoletto che serviva, agitandolo, a dare inizio alle corse equestri. Era il momento più atteso dalle migliaia di persone stipate sulle gradinate e, anche se la scultura si riferisce al Circo Massimo, lo stesso rituale doveva svolgersi a Costantinopoli.
All’interno del percorso espositivo, ingrandimenti dei reperti più minuti e gigantografie di personaggi reali fanno da sfondo alle vetrine e potremo vedere Giustiniano, con sua moglie Teodora e alcuni dignitari, come appaiono nei mosaici della basilica di San Vitale a Ravenna. Colpiscono i gioielli che li ornano: per l’imperatrice, una corona-turbante di pietre preziose, perle à gogo, pendenti che terminano con diamanti. Ma l’imperatore non è da meno, sfoggiando la ricca corona e la vistosa spilla che trattiene il mantello su una spalla.

Sono molte le donne di potere che caratterizzarono i secoli bizantini, iniziando da Elena, madre di Costantino, poi le regnanti: Irene alla fine dell’VIII secolo, unica ad assumere il titolo imperiale al maschile (basileus), che pose fine alla guerra con gli arabi, e Zoe, che salì e scese più volte dal trono tre secoli più tardi; ma la moglie di Giustiniano rimane la più famosa (da non perdere la biografia “Teodora. Ascesa di un’imperatrice” di Paolo Cesaretti, Bolis Edizioni) perché è stata la prima a incidere nella storia del suo tempo e per la vita dissoluta condotta prima del matrimonio, raccontata dallo storico Procopio di Cesarea.

A Napoli si vedranno altri gioielli, indicativi del lusso delle dinastie che si sono avvicendate, accompagnati da vasi invetriati, croci con gemme, le stesse monete auree
che ritraggono i sovrani. Due posti a sé spettano ai sigilli e ai testi scritti. In particolare, va segnalato l’evangelario greco in caratteri d’oro che faceva parte della biblioteca di Lorenzo il Magnifico.

L’erezione di chiese e monasteri è stata considerevole ovunque, anche per l’impulso di donne aristocratiche, e pertanto a prevalere nella mostra sono mosaici, ornamenti architettonici, icone, affreschi religiosi provenienti da 57 musei, in gran parte greci. Ma per illustrare il mondo cristiano-bizantino in alcune postazioni scorreranno immagini di manufatti e luoghi significativi.
In tutta Italia, da Venezia a Cagliari, dalla Puglia alla Sicilia, passando per Roma, si trovano edifici di culto e fortificazioni. Custode di particolari bellezze è la Calabria che per cinque secoli fu un concentrato d’Oriente e di grecità. Sono lì a documentarlo i resti del castello di Santo Niceto, la Cattolica di Stilo, chiesa a croce greca su pianta quadrata con le sue cinque cupole intatte; e ben conservati sono anche il battistero di Santa Severina, il complesso monastico basiliano di Santa Maria del Patire a Rossano, città che conserva il Codice purpureo, patrimonio Unesco: 188 fogli miniati di pergamena rossa con i vangeli di Marco e Matteo, risalenti al VI secolo. «La rassegna che sta per iniziare si presenta come specchio di una comunicazione culturale, religiosa, amministrativa durata secoli tra le diverse sponde del Mediterraneo e, grazie a un impero che ha tenuto insieme popoli profondamente diversi fra loro, si offre come occasione per riflettere in chiave di conciliazione internazionale tra luoghi, oggi contrapposti, permeati di questa eredità», sottolinea il direttore Giulierini.
Pure Istanbul, l’attuale Nuova Roma, conserva testimonianze e ha inviato un bellissimo video con la ricostruzione virtuale di Costantinopoli al suo apogeo. Il silenzio delle immagini è interrotto dal rumore dell’acqua che zampilla in fontane e terme, scende lungo ninfei, scorre negli acquedotti. Sembra una musica leggera, senza tempo.
Foto per gentile concessione di: G. Sannino













Dovremmo parlare più di oblio, e meno della memoria. Abbiamo parlato poco, pochissimo,diunastrategiadel potere in senso largo che va avanti da molto tempo (forse da sempre?): narrare solo parti della storia, e nascondere le altre. Dobbiamo riflettere sull’oblio, sull’uso dell’oblio da parte del potere. Non è la richiesta che viene dal mondo degli storici, bensì da un’artista. Un’artista visuale cilena, Voluspa Jarpa, che da almeno quindici anni conduce il suo processo artistico dentro gli archivi diplomatici e dell’intelligence, soprattutto quelli statunitensi, e nelle carte dei magistrati latino-americani.
La sua ultima mostra, allestita nello spazio Zac dei Cantieri Culturali della Zisa, a Palermo, dove la Fondazione Merz opera già da oltre un anno, è l’imponente descrizione di quello che non sappiamo. Che non ci viene detto, o meglio, ci viene nascosto, fino a che le autorità deputate non decidono di declassificare, di mostrare un documento. Con i segni della censura, spesso: tratti pesanti di pennarello nero coprono parole, frasi, nomi. Fino al paradosso di cancellare, in questo modo, intere pagine: gli interi documenti desecretati.

È una cascata di strisce srotolate quella che accoglie chi visita, all’interno della mostra “Isolitudine”, l’installazione dell’artista cilena intitolata “False flag”, “Falsi Bersagli”, e curata da Beatrice Merz. Le strisce composte proprio da quelle pagine ricordano, a prima vista e in versione
gigantesca, i distruggi-documenti in uso quando la carta era ancora essenziale, per chi doveva gestire un archivio e anche per chi, al contrario, voleva distruggere prove. E in effetti, è un elenco infinito di documenti diplomatici declassificati quelli che Jarpa ha messo insieme.

La Storia, in effetti, ha fatto irruzione nella vita di Jarpa quando l’artista aveva due anni. L’11 settembre 1973, Salvador Allende viene assassinato. Una morte che fa precipitare il Cile nell’abisso della dittatura di Augusto Pinochet, sostenuto dagli Stati Uniti. La Cia, in quegli anni, interviene con tutta la sua potenza per cambiare il corso politico deciso dai cittadini di molti Paesi dell’America Latina. Sono gli anni bui, in cui la scelta è tra una vita sotto la dittatura o, invece, l’esilio.
Affascinante e intenso è il modo in cui prende la Storia e ne fa un campo di indagine artistica. «Mi sembrava interessante vedere il potere, guardare in faccia il potere, anche in questa azione di declassificare i documenti», dice l’artista: «Ci si può chiedere: ma perché gli Usa declassificano i loro se-
Documenti da 007.
Atti diplomatici. Informazioni riservate che hanno cambiato la storia. L’artista cilena Voluspa Jarpa trasforma in opere il potere della censura
greti? Credo che lo facciano per dirci: questo è il potere, è nelle nostre mani, e dunque, proprio per questo, possiamo manipolare quello che si sa e quello che, al contrario, non si sa. È diverso, insomma, leggere un documento di Wikileaks e, dall’altra parte, osservare un documento che il proprio sistema di potere ha reso accessibile, e che contiene tutti i segni, le impronte di come questo sistema di potere continua a pensare alla relazione tra potere e informazione. È importante vedere, leggere, sapere ciò che questi documenti dicono, e allo stesso tempo ciò che dicono le stesse cancellazioni. La censura. In quello che è cancellato con un pennarello nero, c’è la dimostrazione del potere». Il segno nero sui documenti desecretati ma comunque censurati rappresenta, insomma, l’uso deliberato dell’oblio. Ciò che non è stato raccontato deve continuare a essere coperto, censurato, perché altrimenti cambierebbe la stessa memoria degli eventi storici.
Le ricadute di questa narrazione della storia sono evidenti nel popolo, in chi dovrebbe conoscere la propria
storia e, invece, riesce solo episodicamente a intuire qualcosa. Jarpa cita le riflessioni di Naomi Klein, secondo la quale un popolo che non conosce il suo racconto, la sua narrazione, è un popolo che vive in uno stato di shock. «Non sa quello che gli è successo, ed è per questo che non sa quello che gli stasuccedendo»,spiegal’artista:«Perde il suo racconto, perde la possibilità di comprendersi. Negli ultimi venti anni abbiamo messo molta enfasi sulla memoria, molta meno sull’oblio. Io credo che una parte della incoscienza storica del popolo abbia a che fare con operazioni attraverso le quali si sceglie cosa dimenticare e cosa far dimenticare, perché non comprendano quello che hanno vissuto».
L’esempio che fa Jarpa non è in America Latina. Riguarda invece l’Europa. L’Italia. «Quello che mi fa impressione è quanto poco la gente sappia dell’Operazione Gladio, e dell’importanza che ha avuto nel determinare il divenire politico dei Paesi europei tra gli anni Sessanta e Ottanta», sottolinea l’artista: «E mentre in America Latina ci sono stati colpi di stato vio-

lenti attraverso i quali i militari hanno preso il potere, in Europa si è utilizzata una strategia adatta a una società traumatizzata dalla guerra per cui, attraverso piccoli attentati, si riviveva proprio l’orrore e il terrore della guerra». Una lettura straniante, e allo stesso tempo un’ipotesi su cui ragionare: la strategia della tensione poteva essere legata alla memoria della guerra, visto che la generazione che rappresentava la rete connettiva del Paese era quella che aveva vissuto sulla sua pelle il secondo conflitto mondiale?
L’ipotesi è affascinante, e al tempo stesso pone una domanda sulla differenza tra un’indagine artistica e lo scavo dei documenti condotto da una storica. Dove ci si può incontrare? «Ci si incontra sul metodo, talvolta, sul modo in cui si indaga il documento. Per me, come artista, sono però importanti due elementi. Non cerco solo informazioni, cerco il simbolo. Non cerco solo la storia, mi interessa anche il livello simbolico di quella storia».
C’è dunque anche una dimensione etica, in ballo. Come passare tutto questo a chi vede, in una mostra, la storia occultata e poi solo parzialmente svelata dal potere. «Il segreto ha prodotto in noi una sorta di infantilizzazione, per la quale vogliamo ascoltare solo storie belle e a lieto fine», conclude l’artista: «Quello che, invece, ci dice questa storia è che dobbiamo essere più adulti. Dobbiamo essere capaci di guardare il potere, altrimenti resteremo sempre cittadini in attesa di empatia».

Tengo ad esprimere, innanzitutto, il mio grande rispetto per la libertà di parola delle donne e il mio profondo attaccamento al fatto che possano essere ascoltate. Sono stata io stessa vittima di abusi durante la mia infanzia e conosco il dolore di non essere presa sul serio. Ciò non mi impedisce, tuttavia, di essere sbalordita nel vedere il trattamento riservato a un giovane uomo oggetto di un’indagine penale in corso, senza alcun rispetto per le persone che stanno lavorando su questa indagine, né per il principio di presunzione di innocenza. Ad oggi, è chiaro a tutti che non è stato ancora giudicato, e questa scelta editoriale non è altro che un puro linciaggio mediatico». Sono parole scritte e lette a Roma dall'attrice e regista Valeria Bruni Tedeschi sull'attore Sofiane Bennacer, suo attuale partner e protagonista maschile del suo film “Forever Young“, denunciato per stupri e violenze. È ora nelle sale il film, fortemente applaudito a Cannes, storia di passioni incandescenti e amore smodato per il teatro, in cui Bruni Tedeschi sceglie di portare in scena la gioventù ribelle del Théâtre Nanterre-Amandiers degli an-
ni Ottanta che ha frequentato in prima persona.
Le sono voluti lunghi mesi di casting per trovare gli attori giusti e poi settimane di prove prima delle riprese. Com’è andata?
«Abbiamo fatto insieme un lavoro molto teatrale, ho provato un grande piacere a dirigerli, sono tutti talenti formidabili. Il lavoro del regista è come quello di una madre egoista. Occuparsi dei figli, e non unicamente di sé, dà molta gioia: più che una regista generosa mi ritengo una regista fortunata».
La protagonista Nadia Tereskiewicz nel film si chiama Stella, ma è chiaramente il suo alter ego.
«Non l’ho filmata pensando di filmare me, non volevo realizzare un film nostalgico sui miei ricordi. Le ho parlato molto della mia vita e di situazioni che non conosceva, le ho fatto indossare i miei vestiti di allora, ma abbiamo lavorato soprattutto sul ritmo, perché abbiamo un ritmo interiore molto diverso. Nadia si è messa a mia completa disposizione, ha accettato la possibilità di perdere il controllo e lasciarsi portare per acquisire il mio respiro, mai per imitarmi. È stato molto bravo anche Sofiane Bennacer, che ho forte-
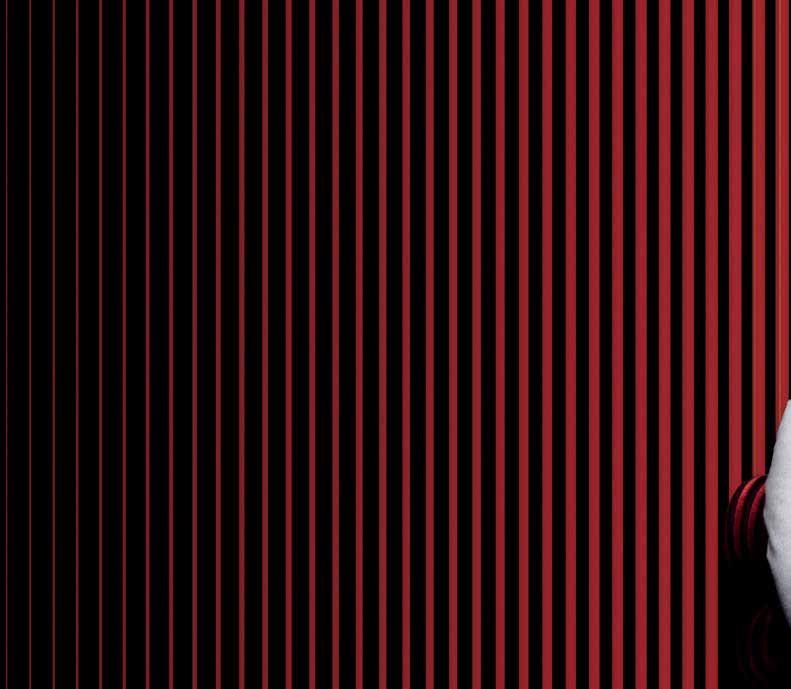
Se dovesse dare un consiglio alla Valeria ventenne con l’esperienza di vita e di carriera che ha oggi?
«Le suggerirei di volersi più bene. Ai giovani attori, tutti, direi di non aver paura di fare psicanalisi, che non toglie il talento, ma offre la chance di essere più forti in un mestiere che fragilizza molto. E di circondarsi di persone care, perché è un mestiere che può rendere molto soli».
I giovani che vediamo nel film amano e vivono pericolosamente insieme.
«Volevo andare in profondità nelle emozioni come si va in profondità a vent’anni, un’epoca in cui volevamo
Un gruppo di aspiranti attori nella Parigi degli anni Ottanta. Tra amori, voglia di vita, l’Aids. È “Forever Young”, dell’attrice e regista italo-francese. Che sulle accuse al partner chiede rispetto
divorare la vita. Eravamo tutti arsi dalla passione, dal desiderio di fare gli attori e di vivere in modo intenso. Dovevamo alzare la temperatura della nostra vita affinché fosse alta poi sul palcoscenico o davanti alla cinepresa. Per questo agli attori ripetevo: “Alzate la temperatura, dovete avere 41 di febbre, quasi morire di gioia e di dolore”. Senza isterie, però». Ha saputo tenere alto l’equilibrio anche nell'affrontare il tema della malattia dell’Hiv che ha conosciuto da vicino con suo fratello Virginio,

«Ho cercato di raccontare cosa fosse quella malattia a giovani che per loro fortuna non la conoscono più così tanto. Ho mostrato loro dei film, abbiamo parlato a lungo di come l’Hiv ci accompagnasse nel quotidiano: i risultati dei test e lo spavento facevano parte della nostra vita, così come la morte. Eravamo in balia di eros e thanatos, due forze che nel film si attraggono continuamente».

Il suo è un film incandescente, fatto di arte, sesso, droga, malattia e anime capaci di osare, che spicca nel panorama italiano: trova che il nostro cinema si sia “imborghesito”? «Si parla tanto di libertà di parola, a
me sembra ci sia qualcosa di tirannico e terrorizzante nell’aria che influisce sul modo in cui ci muoviamo: c’è una paura costante di non fare o non dire la cosa giusta, di non essere politicamente corretti. Più che imborghesito il cinema, come la società, mi sembra spaventato. Allora avevamo paura anche noi, ma della morte, di certo non della vita. Vivevamo pericolosamente, abitavamo con la morte ma non ci fermavamo, l’Es freudiano era più presente. Oggi governa il super-Io».
Ha affidato a Louis Garrel il ruolo di Patrice Chéreau che aveva un pensiero politico preciso. Ritiene che Forever Young sia anche un film politico?
«Chéreau era un uomo di sinistra che non aveva paura di avere un pensiero scorretto sulla sinistra stessa, era veramente libero. Quando gli proposero un teatro in piena Parigi disse che preferiva il teatro di una periferia di sinistra a Nanterre, Les Amandiers appunto. Fu un gesto politico. Per noi studenti era come un dio dell’Olimpo, è stato il primo regista a valorizzare la diversità e lavorare con attori di origini e provenienze diverse, e a mettere in scena i testi di Koltès. Arte, politica, pensiero intellettuale si mescolavano in lui e anch’io ho voluto mischiarli dentro il mio film, raccontando come l’incontro tra mondi diversi possa generare un grande amore».
Teme un governo di destra?
«Mi preoccupa molto, ma lo prendo come una specie di delirio. La collettività ha avuto un colpo di follia, speriamo sia solo un momento passeggero. Anche perché è un disastro per l’ecologia, che non riguarda solo l’aria pura ma la visione politica del mondo in cui c’è rispetto per ogni essere vivente e, ovviamente, per ogni essere umano, a partire dal più debole. Avere cura dei più deboli è un pensiero di sinistra, però. Tutto questo mi fa pensare a “Tutti dicono I love you” di Woody Allen, in cui il figlio di due democratici che fa discorsi di destra si scopre avere un serio problema al cervello, risolto il quale torna ad essere normale».
Non credo che esista, a memoria d’uomo, un omaggio tributato da uno scrittore a un altro scrittore, che sia, anche lontanamente, simile al lavoro di riesumazione, direi quasi di resurrezione, che Paul Auster ha fatto nei confronti di Stephen Crane. E l’ha fatto con un volume di oltre mille pagine, edito in Italia da Einaudi, dal titolo “Ragazzo in fiamme”. Un volume di oltre mille pagine, si diceva, per raccontare ventotto anni di vita. Tanto è il tempo trascorso dall’autore de “Il segno rosso del coraggio” su questa terra. È evidente che il destino di certi artisti è di avere tantissime cose da dire e pochissimo tempo per dirle.
L’omaggio di Auster, sontuoso come la piramide di Cheope o come il Taj Mahal, si concentra proprio sulle tantissime cose anziché sul pochissimo tempo. Certo può apparire azzardato accostare un’opera letteraria ad un monumento che è anche un sepolcro, ma nel caso del “Ragazzo in fiamme” è assolutamente calzante. Innanzitutto per l’ubicazione dell’edificio: Auster posiziona Crane, senza mezzi termini, nel Sancta Sanctorum della letteratura americana. Alla base di questo possente lavoro c’è infatti un evidente intento di sistemazione, e forse di risarcimento. Auster si è chiaramente assunto il compito di far accomodare questo gigante, mai diventato adulto, sullo scranno che gli spetta nella stanza dei padri americani: Poe, Melville, Withman, Conrad, Faulkner, Hemingway, Salinger. Ma non solo: esiste anche una precisa volontà di comprendere questo “monumento” in quello che si potrebbe definire un Grand Tour mondiale delle opere capitali della modernità. La lista di Auster a
questo proposito è asciutta e chiarissima: “Il segno rosso del coraggio”, “Fame”, “Alla ricerca del tempo perduto”, “Gita al faro”, “Ulisse”, “Mentre morivo”. È evidente che quando si decide di tracciare un canone della modernità ci si assume l’onere delle proprie scelte, tuttavia questa lista non è affatto gratuita, ma risiede in un pensiero piuttosto coerente come è quello di inserire il defilato Crane, e il rovello adolescenziale del soldato Henry Fleming, protagonista della sua opera principale, nella lista di coloro che hanno inaugurato la tendenza a costruire storie basate su un’interiorità appassionata. Secondo questa coerente visione l’edificio Crane è come una costruzione troppo avanti per i suoi tempi, di quelle che solo pochi illuminati possono apprezzare, ma è proprio questa caratteristica a determinarne l’importanza e, soprattutto, la durata.
Nella letteratura americana, e dunque mondiale, Stephen Crane corrisponderebbe a quello che in architettura ha rappresentato la “Casa sulla cascata” di Wright, trentanove anni esatti dopo la sua prematura morte. Infatti Paul Auster dedica ogni singola riga di queste straordinarie mille pagine a dimostrare, punto per punto, quanto questo autore anarchico, precoce, sprecone, sotto molti aspetti in-
dolente, sia stato fondamentale per individuare in tempi non sospetti, e imporre a rilascio lento, un punto di vista letterario “organico” che a molti, troppi, oggi, appare scontato. Esiste poi il peso romanzesco della vita breve di questo intemerato e perenne adolescente, tanto da far sembrare “Ragazzo in fiamme” un’opera di finzione dove, al contrario, è una biografia documentatissima, con tanto di contributi fotografici: fogli manoscritti, immagini private, disegni, appunti, corrispondenze, testimonianze, eccetera. L’idea cioè che, raccontata a posteriori e da una penna sopraffina, ogni esistenza possa apparire assolutamente straordinaria. Tuttavia la vita breve di Stephen Crane straordinaria lo è stata davvero, avventurosa come quella di Jack London, errabonda come quella di Hemingway, scandalosa come quella di Henry Miller, ma enormemente più concentrata. Non a caso questo ragazzo, che non fa in tempo a diventare uomo, è definito in fiamme. Ha tendenze monogamiche, Cora Taylor resterà il suo grande amore, ma consuma compulsivamente sesso mercenario. Deve correre, bruciare le tappe, sperimentare i propri talenti e fare il poeta, il narratore, il giornalista, spesso contemporaneamente. Prima che la vampa dell’esistenza lo divori deve subire lo smacco dell’insuccesso e poi
Con un libro di oltre mille pagine Paul Auster rende omaggio allo scrittore americano scomparso a soli 28 anni. Anarchico, precoce, avventuroso,
quello del successo come Mozart, Basquiat, Jim Morrison, Alain Fournier.
Deve spostarsi da New York al Messico a Cuba in Grecia come inviato di guerra. Deve capire che cosa significhi vivere nella propria carne la frustrazione del fallimento, il morso della fame, ma anche il soffio dell’entusiasmo, il privilegio, o la maledizione, di possedere un talento strepitoso con le parole. E deve fare tutto in fretta, con una velocità che possa raddoppiare quel poco tempo che ha a disposizione. Di questa attitudine fulminea, di questo capacità performatica racconta Auster nell’esposizione incommensurabile, monografica e universale, che è “Ragazzo in fiamme”.
Stephen Crane è una falena, e come ogni falena ha la passione della fiam-


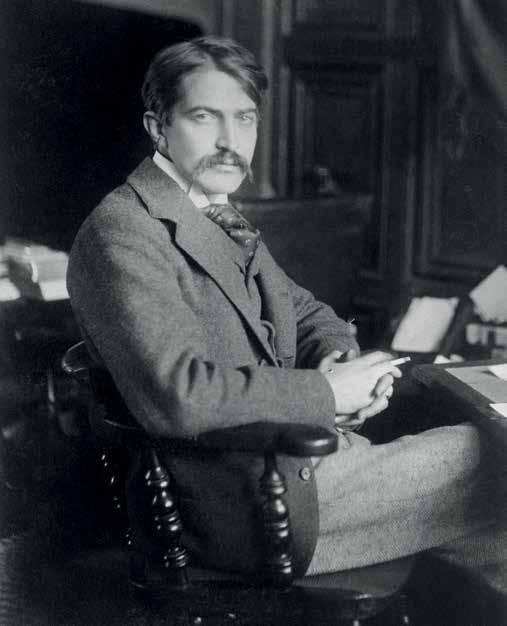
ma, ci gira intorno: scrive per vivere e vive per scrivere. Rompe gli schemi, e spesso sbaglia, perché sa di non avere abbastanza agio per muoversi con destrezza. Scrive con l’efficacia di un velocista naturalmente costruito per bruciareiltraguardonelpiùbrevetempo possibile, secondi, decimi di secondo: cinque romanzi, Tra cui “Maggie”, “Il mostro”, “Il segno rosso del coraggio”; due volumi di poesie, tra cui “Cavalieri oscuri”; centinaia di articoli giornalistici, interi volumi di reportage bellici in quattro anni. Asciutto, nervoso, non alto, in ogni ritratto che lo immortali Stephen Crane guarda dritto in camera con una sfacciataggine che non appartiene al suo tempo rappresentato dalla sussiegosa prossemica della Gilded Age.
Spesso sporco e trascurato nel vestire si scolla dalla carta moschicida delle convenzioni. Ma l’uomo e l’artista non sono la stessa cosa anche se abitano lo stesso corpo. Almeno due enormi scandali investono Crane entro il compimento dei ventiquattro anni: uno che riguarda un articolo sui sindacati e mette nei guai Whitelaw Reid, proprietario del Tribune, il giornale che gliel’ha commissionato, tanto che Reid stesso deve rinunciare alla candidatura di vice presidente degli Stati Uniti; l’altro quando, nel settembre del 1896, si inimica la già da allora potente polizia di New York presentandosi, come teste a favore, in una sala di tribunale dove si discuteva la causa di una prostituta che aveva denunciato un agente. E tutto questo vissuto in senso letterale e letterario come un’anticipazione, una premonizione in terra di quel Paradiso della scrittura che gli spetta e sta precocemente per raggiungere. Perché, per dirla con Menandro, muor giovane chi agli Dei è caro. E, nonostante il tempo breve, Stephen Crane un po’ caro agli Dei, magari a quelli della scrittura, doveva essere stato se è vero che l’ultimo Natale della sua vita, quello del 1899, sei mesi prima di morire di tubercolosi, lo trascorrerà in compagnia di Joseph Conrad, quello di “Linea d’ombra”, Herbert Georges Wells, quello de “La macchina del tempo”, Henry James, quello di “Giro di vite”.
Una concentrazione spaventosa che è bello considerare come una specie di ultima luminosissima fiammata prima dell’estinzione fisica. L’intensità senza limiti di uno scrittore che si consuma molto più velocemente dell’universo narrativo che ha generato. Il corpo mortale di un genio immortale.
romanzo,
 di Valeria Verbaro
di Valeria Verbaro
Alcune storie si tramandano silenziose in famiglia, scorrono nel sangue, nel colore dell’iride o dei capelli. All’improvviso trovano il modo di tornare in superficie, da un ricordo, da una parola in più sfuggita ai propri nonni o ai genitori. Ci si chiede allora, chi erano queste persone prima di noi? Da quali sogni, quali difficili cambi di direzione sono state guidate. E da quali pensieri.
Chissà se è questo ciò che è successo ad Alberta Riccardi quando ha iniziato a scrivere “Café Ida”, il suo primo romanzo (pubblicato da Piemme). Nei ringraziamenti finali ci sono le tracce di un processo di riscoperta di luoghi che nella memoria storica e affettiva l’hanno portata altrove, a una terra cui non sapeva di appartenere.
Dalla Ciociaria alla Scozia e ritorno, “Café Ida” vuole essere una saga familiare, di quelle che come i cent’anni di solitudine di García Márquez riserva una pagina solo all’albero genealogico, alle vite che nel corso di tre decenni si saldano fra loro. I Montefosco da una parte, i Datti di Lanza dall’altra. Servi e padroni. Il destino però rimescola i ruoli e l’amore, spesso, li disin-
“Café Ida” di Alberta Riccardi (Piemme, pp. 446, € 19,90). Sopra: Clydesdale, Scozia, un ragazzino nel 1931

tegra. Al di là della Manica e ancora più a Nord, dove «la lingua stringe le vocali per non disperdere il calore e il sole quando si affaccia pensa di aver sbagliato strada e se ne va», Nevio e Giovanni ricostruiscono le loro esistenze da zero, più e più volte. Il figlio del fattore e l’erede, che nulla hanno in comune, si ritrovano ancora bambini a fare i conti con il muro di diffidenza che la loro pelle scura e i loro forti accenti alimentano già a prima vista. Nel dramma di famiglie che si spezzano, in cerca di fortuna o di una nuova libertà, Riccardi racconta una ferita condivisa da molti italiani. Prova a immaginare come quei due bambini diventano adulti e crea le forze invisibili che continuano a riportarli sulla medesima strada, mai tanto lontani da perdersi del tutto. La loro amicizia nasce tra gli alberi di Roccasecca, Frosinone, poco prima che il “secolo bre-
ve” li trasformi rapidamente in uomini. Nevio salva Giovanni da una spaventosa scarica di pioggia e fulmini, lasciandogli addosso un odore «di selvatico e fumo di camino» che da quel momento diventa odore di casa. Umiliazioni, traguardi, gioie e lutti si susseguono senza badare gli uni agli altri, perché la vita, semplicemente, accade. Più di quanto ne siano consapevoli, però, Nevio e Giovanni si cercano in ognuna delle loro esperienze. Desiderano dividerne il peso, anche quando questo diventa imperdonabile. Si riconoscono a prima vista, in nuovi corpi, in nuove voci, come fossero uno il riflesso dell’altro. Sullo sfondo rimangono immagini vive di una Scozia che Alberta Riccardi ricostruisce come si farebbe con una vecchia parente, cercando di scorgerne il carattere dai pochi indizi rimasti nella memoria familiare. Con lo stesso spirito di Giovanni, Riccardi crea il suo «presepe» di personaggi. Li muove di continuo su una scena che è sempre fissa, ma si trasforma velocemente. E scopre se «spostandone uno si scombussola tutto. Se cambiando una regola si infrangono tutte le altre».
Un
tra la Ciociaria e la Scozia, incrocia i destini di due amici diversissimi. In una storia di famiglie spezzate, in cerca di fortuna, comune a molti italiani

Una figlia petite, che suscita disagio. E la lezione di chi è allenato alla rinuncia. È il romanzo di Carmen Verde
Può la felicità consistere nell’avere qualche centimetro in più? O è sempre e solo l’amore - cercato, spiato, inseguito, bramato - il fulcro intorno al quale vortichiamo, come falene alla fiamma? Per Anna, che piccola è davvero, col suo corpo alto un metro e venti centimetri soltanto, il dilemma è più che lecito (“Tremenda fortuna essere alti. Avere la fisica impressione di tutto il proprio essere. Noi piccoli dobbiamo sempre integrare, col pensiero, ciò che di concreto manca al nostro corpo”). Tanto più se hai una madre bella, elegante, sfuggente, che con i suoi non detti, con un’aria furtiva, nel tentativo di proteggerti, involontariamente accentua la tua diversità. È arrivata una voce nuova, forte, cristallina nella narrativa italiana, di quelle esercitate a sottrarre anziché a ridondare. A puntare dritta sulle immagini – poche, squadernate, come le fotografie che la storia passa in rassegna – per raccontare una, due, tre vite, una famiglia intera.
Carmen Verde ha scritto un romanzo che mette al centro il rapporto tra una madre e una figlia: il loro dialogo senza parole, le carezze negate dell’una, l’amore mendicato dell’altra. “La mia missione era meritare finalmente la sua attenzione”, dice la bambina: “Mamma non mi guardava mai, ma la sua indifferenza non faceva che accrescere il mio amore già
Il racconto di una città diversa da tutte le altre. Un luogo che non è solo geografico ma l’espressione di un preciso perimetro dello spirito. Culla di democrazia, certo, di filosofia, di teatro. Ma soprattutto di ideali: luogo simbolo per eccellenza di bellezza, di miti eterni. Da un docente di Letteratura greca che a lungo ha scandagliato il dramma e la mitologia delle origini, l’avventura di Atene attraverso quei luoghi più simbolici dove la storia reclama una sosta.
“ATENE.

Giorgio Ieranò
Einaudi, pp. 228, € 21


smisurato”. Nel quadro familiare c’è un marito solo e smarrito, che invecchia di colpo. E una nonna pazza, Adelina, con le sue gonne di taffetà oro e Dio e i santi ogni giorno convocati per assistere alla sua disperazione. E c’è una domestica inquietante e dispotica, che esercita la sua tirannia contro la padrona di casa, quella madre sempre sul punto di scivolare, un bicchiere di cognac per stordirsi, una poltrona su cui sprofondare. “La vita non è meno della letteratura”, nota con acutezza la protagonista: “Bisognerebbe studiare a scuola l’infelicità delle nostre madri”. Ed è l’infelicità che tiene insieme questa famiglia, la consapevolezza che la vita non è uno scherzo e che la gioia non è una promessa. Senza drammi, però: “Non è indispensabile essere felici”. E un corpo così piccolo può insegnare ad accontentarti di quel poco che hai. Quel poco, che è tutto. E che basta.
La storia della Marvel attraverso la vicenda biografica di uno dei più leggendari creativi: amato, controverso, scandita da quei supereroi che sono parte dell’immaginario globale: da SpiderMan agli Avengers, dagli X-Men a Hulk e Iron Man. Scavando in un’esistenza piena di ombre, intuizioni imprenditoriali, dispute con gli autori, un’indagine nella vita di un uomo che è stato quintessenza della vita americana. Un sogno dove più che il talento ha contato l’ambizione.
“STAN

Abraham Riesman (trad. Enrico Zigoni) Rizzoli Lizard, pp. 496, € 25
“Il posto della guerra e il costo della libertà” è il titolo completo di questo saggio che enuncia subito la sostanziale correlazione tra conflitti e pace: è solo nella libertà che può esistere la pace. Naturale diventa perciò domandarsi il prezzo che siamo disposti a pagare per garantire l’armonia tra i popoli. L’invasione russa dell’Ucraina ce lo ricorda, costringendoci a ripensare l’idea della guerra e il posto che occupa nella cultura politica democratica.
“IL
Vittorio Emanuele Parsi Bompiani, pp. 211, € 17
perso la vista anni fa. Ma ha sviluppato un metodo per avere una percezione rigorosa dei dati cosmici, pur senza usare gli occhi. Diventando leader mondiale della “sonificazione”. E realizzando un sogno
Sul maxischermo alle sue spalle compare la straordinaria immagine di una delle galassie intercettate dal telescopio spaziale Hubble. Wanda Díaz-Merced muove un piccolo strumento sul monitor del suo notebook, dove è riprodotta la stessa immagine, e comincia a descriverla al pubblico del Festival della Scienza di Genova, nel salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, con una precisione minuziosa: le sue forme, i suoi colori, le sfumature più delicate, il nucleo bianco e le sue eliche. In sala si sente un brusio di stupore: il fatto è che Wanda ha perso la vista molti anni fa e, ciononostante, ora può scoprire i segreti delle stelle grazie al sistema che ha creato per tradurre in suoni le immagini, i segnali, i raggi, le onde che arrivano dall’universo. Per questo Wanda Díaz-Merced è diventata l’astrofisica leader mondiale della “sonificazione” dei dati astronomici e ha consentito a studenti non vedenti o ipovedenti di tutto il mondo di realizzare un sogno che sembrava destinato a restare tale: avere una percezione scientifica del cosmo anche senza vederlo. Non solo. Ascoltare la voce delle stelle, dei pianeti, delle galassie si è rivelato uno strumento utilissimo anche per i ricercatori che, invece, lo spazio lo vedono molto bene.
Wanda oggi dice di non ricordare più quando fu l’ultima volta che riuscì ad ammirare la bellezza di un cielo
stellato. Però ricorda quanto sia stata dura la strada per «uscire a riveder le stelle», per dirla con Dante alla fine dell’Inferno.
La letteratura quasi romantica che racconta sul Web il percorso dell’astrofisica portoricana fissa un momento preciso in cui ebbe inizio la sua avventura umana e scientifica. Risale a quando, da bambina, si trova una sera a pescare su una spiaggia della sua isola con i genitori e rimane colpita da una scia luminosa che attraversa il cielo stellato. Il padre le spiega che è un meteorite, ma in realtà è la scintilla che accende in lei la passione per la scienza. Un amore che la porterà a iscriversi alla facoltà di Fisica dell’Università di Porto Rico, a Río Piedras. Per
assurdo è questo il momento in cui il suo sogno rischia d’infrangersi, a causa di una retinopatia genetica degenerativa che a vent’anni la priverà della vista. Lei non si arrende alla malattia, è tenace e si laurea nonostante tutto. Ed è proprio negli anni degli studi universitari che un amico le mostra il funzionamento di un ricevitore audio collegato a un radiotelescopio: è così che lei avverte le potenzialità del suono per studiare l’universo.
«Ma il mio lavoro – spiega Wanda Díaz-Merced – non è frutto di un’intuizione e nemmeno d’immaginazione. Ho fatto esperimenti, ho ottenuto risultati e sono andata avanti facendo analisi dei dati, progettando un prototipo per ascoltare i dati che arrivano dallo spazio, e ho testato il sistema durante tutto il mio dottorato». Con una sensazione di fondo, poi smentita dai fatti: «Mi aspettavo che non funzionasse, che il suono fosse inutile per l’esplorazione dei dati. Ma dopo aver dimostrato che è utile, eccome, ho pensato di progettare metodi che permettessero alle persone cieche o ipovedenti di fare ricerca».
Un percorso tracciato a partire dal 2005, quando Wanda partecipa a uno stage della Nasa per persone con disturbi della vista. Gli studi della scienziata portoricana proseguono poi con un dottorato in Computer Sciences all’Università di Glasgow e quindi

Rappresentazione artistica di un buco nero. Nella pagina a sinistra, Wanda Díaz-Merced nel 2016 alla Casa Bianca
all’Harvard Smithsonian Center per l’Astrofisica. Nel 2016 il presidente Barack Obama la invita alla Casa Bianca, alla conferenza “Frontiers”, e lei prepara un intervento il cui titolo è la sintesi della sua mission di ricercatrice: “Rendere l’esplorazione della scienza accessibile a tutti”. Oggi lei ribadisce così il principio: «Viviamo in tempi di inclusione, equità e parità. Scoprire che non era complicato per le persone con disabilità sensoriali partecipare a tutte le attività di ricerca che sono naturali in campo astronomico mi ha fatto inizialmente sentire molto delusa. Se non era complicato, perché non era stato fatto prima?».
Nell’ultimo anno Wanda Díaz-Merced ha continuato i suoi studi a Cascina,
in provincia di Pisa, presso Ego: cioè il consorzio italo-francese costituito nel 2000 dal Centre national de la Recherche scientifique e dall’Istituto nazionale di Fisica nucleare con lo scopo di realizzare e poi garantire il funzionamento e il miglioramento del più grande rivelatore di onde gravitazionali d’Europa. Si chiama Virgo — dal nome di un ammasso di 1.500 galassie a 50 milioni di anni luce dalla Terra — ed è un gigantesco interferometro laser costituito da due bracci lunghi tre chilometri che si estendono nella campagna tra Pisa e Cascina. Le onde gravitazionali, teorizzate da Albert Einstein nel 1915, sono ondulazioni della trama spazio-tempo che si propagano alla velocità della luce e si ve-
rificano quando grandi masse vengono accelerate o deformate: accade, per esempio, quando esplode una supernova o in caso di interazioni tra buchi neri o stelle di neutroni. Ed è qui che il metodo ideato da Wanda Díaz-Merced ha un ruolo decisivo, perché le onde gravitazionali sono molto diverse dalla luce, principale strumento utilizzato finora per intercettare i messaggi dell’universo. La prima rivelazione diretta delle onde gravitazionali risale solo al settembre 2015, un secolo dopo la teoria di Einstein. Il motivo di tanta difficoltà sta nella natura stessa delle onde gravitazionali, che attraversano lo spazio-tempo deformandolo e producendo movimenti impercettibili. Per effetto dei quali anche i corpi

materiali vengono deformati e le distanze si allungano e si accorciano alternativamente. Queste variazioni sono difficili anche solo da immaginare: se un’onda attraversa Virgo, si stima che la lunghezza dei suoi bracci di tre chilometri vari di un miliardesimo di miliardesimo di metro. Un “quasi niente”, insomma, che, a dispetto delle sue dimensioni infinitesimali, racconta un portentoso evento astrofisico avvenuto a migliaia di anni-luce dalla Terra.
Durante i suoi studi a Cascina, Wanda Díaz-Merced ha raggiunto altri importanti risultati grazie ai quali, per esempio, è stato «progettato e pubblicato sulla pagina web di Ego un training per usare il suono». Sonificazione, ma non solo: anche il tatto ora si può utilizzare per “vedere” l’universo. Spie-
ga la scienziata: «Ho creato una versione della sequenza principale delle stelle in forma audio-tattile e realizzato il concept di un rilevatore di luce basato sul tatto in tempo reale».
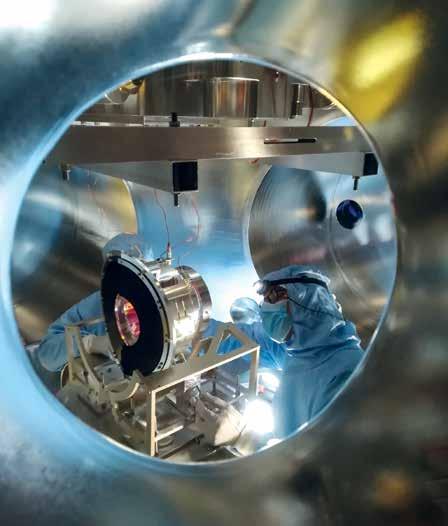
Il primo tentativo risale all’eclissi solare del 2017. Ricorda Wanda: «Assistevo un mio conoscente mentre lavorava a un rilevatore di luce collegato al movimento. In pratica, con un fascio di luce puntato su di me, impiegando strumenti a ultrasuoni e un Raspberry Pi (cioè una scheda madre per la programmazione di hardware molto usata in robotica, ndr), il movimento del mio corpo generava un segnale acustico. Questo semplice concetto creato da Steve Marks mi ha fatto pensare che avremmo potuto usare un sensore più piccolo, più semplice, più economico e
più potente per far sentire dagli Usa ai miei studenti in Sudafrica l’eclissi solare del 2017. Ho elaborato un concept e ne ho parlato con diversi scienziati che, però, si sono dimostrati scettici. Ne ho discusso poi con Allyson Bieryla, manager del centro di astrofisica di Harvard, la quale, invece, in meno di tre mesi ha prodotto un rilevatore per sentire l’intensità della luce solare durante l’eclissi. Lo conservo ancora oggi come un tesoro! Quel giorno i miei studenti in Sudafrica hanno potuto ascoltare l’eclissi in tempo reale. La loro felicità, lo stupore in quell’aula mi rimarranno sempre impressi...».
Ma i metodi di Wanda non solo hanno agevolato gli allievi non vedenti a studiare le stelle. Hanno anche rivoluzionato la ricerca astronomica. Spiega: «In realtà non so se sia davvero così. È stato difficile per l’astronomia prendere sul serio la sonificazione. Mi viene sempre chiesto di fare divulgazione e non ricerca. La divulgazione è importante, certo, ma è necessario lavorare ancora sulla sonificazione come strumento di analisi dei dati. Ora invece viene spesso considerata un intrattenimento e pertanto è difficile che sia rispettata come metodo di ricerca. A volte succedono cose paradossali: ad esempio che mi siano concessi solo sei mesi per scrivere una relazione in cui documentare come la sonificazione abbia raggiunto lo stesso livello di sviluppo delle tecniche visive. Le quali, però, hanno richiesto ben più di sei mesi di sviluppo per arrivare allo stadio attuale».
Suoni, percezioni tattili...magari un giorno potremo sentire anche gli odori e i sapori del cosmo, ammesso che abbia un senso a fini scientifici. Wanda Díaz-Merced non lo esclude: «Chissà se accadrà, ma so per certo che gli esseri umani si adattano e innovano costantemente. Chi avrebbe detto 20 anni fa che oggi avrei usato la mia voce e il mio udito per inviare un’e-mail o che le persone avrebbero scritto su un telefono con il pollice?».








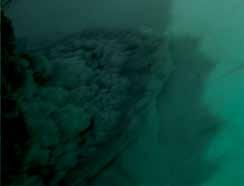






Negli anni ’70 la comunità queer di New York inizia a incontrarsi in sale dove ci si sfida a colpi di travestimenti. Per sovvertire le categorie di genere. Una scena che s’è diffusa oltre i confini Usa. Grazie alla House of Ninja
Stivali di vernice bianca e una grande valigia blu seguono la fila che entra nel District 272. Nello storico locale milanese in via Padova, la gente è intenta a prepararsi per esprimere al meglio il tema che caratterizza la serata: c’è chi trasforma il proprio corpo in una tela pop art e chi dà vita ai famosi murales di Banksy per mostrare il lato più scandaloso e controverso del mondo dell’arte posando, sfilando o ballando. Le luci colorate illuminano la passerella quando i partecipanti la percorrono. «La categoria è…», la frase che ogni volta porta dentro un mondo nuovo, pieno di vita e libertà.
«Quando entri in una “ball” tutte le strutture su cui la nostra società si fonda si spaccano. Resta uno spazio sicuro in cui poter esprimere se stessi e accettarsi, anche quando il resto del mondo non riesce a farlo». Una sensazione che Barbara Pedrazzi, in arte La B. Fujiko, prova ogni volta che si esibisce e che l’ha spinta a portare in Italia la Ballroom scene, sottocultura nata a New York negli anni ’70.
All’epoca delle prime lotte e rivendicazioni dei diritti Lgbtq+, la comunità queer afroamericana e latinoamericana si incontrava in sale segrete. Spazi clandestini in cui persone emarginate per l’identità e l’orientamento sessuale, o la provenienza, si sfidavano in categorie che sovvertivano l’ideale di genere e classe sociale.
Su queste passerelle ogni gesto, trucco o abito era parte di un complesso processo di identità e liberazione. «In quelle sale da ballo urlavano: “Io ci sono, esisto”», spiega La B. Fujiko, delineando una necessità ancora oggi sentita dalla comunità Lgbtq+ e non solo.
Incornicia il volto attraverso il movimento frenetico e angolare delle sue mani, mentre percorre la passerella. Intorno a lei, a seguire le sue mosse, gli applausi a tempo. Ci sono più di 700 persone, un numero che conferma come la “Scandalous Ball” organizzata dalla performer modenese sia ormai diventata l’evento più atteso e importante della scena Ballroom italiana. Dal pubblico si leva subito un coro: «Ninja!», scandiscono ogni lettera mentre seguono i passi della madre dell’iconica House of Ninja in Italia.
Agli inizi della scena Ballroom newyorchese una “madre” o un “padre” garantivano protezione, e spesso un tetto, a ragazzi rinnegati dalla propria famiglia e costretti a sopravvivere per strada prostituendosi o spacciando droga. «La House oggi è uno spazio di crescita in cui esprimersi e confrontarsi», spiega La B. circondata dai “kids” della sua casa, di cui è punto di riferimento dal 2012. Indossano i colori blu e verde, usati per rendere riconoscibili i membri di una casa in competizioni grandi come questa, e
seguono, ballando o saltando, il pubblico che esulta per loro.
L’House of Ninja, fondata nel 1982 da Willi Ninja, è tra le più famose perché è stata la prima a portare la Ballroom scene all’estero in un periodo in cui elementi iniziavano a diffondersi oltre gli Stati Uniti. In Italia, per esempio, l’idea di ball è stata per anni legata soprattutto al voguing, uno stile di danza che imita i gesti angolari e fluidi delle modelle sulle riviste. È a New York, nel 2008, che La B. Fujiko comprende cosa c’è dietro a questa parola, grazie all’incontro con membri storici della House of Ninja come Archie Burnett, Benny e Javier Ninja.
All’inizio la scena italiana resta incastrata nel voguing e, di conseguenza, legata alle scuole di danza. Negli anni, però, la scena inizia a prendere forma integrando regole e valori della sottocultura. Nel 2014 La B. Fujiko e Dolores Ninja organizzano la prima vera ball italiana: “The Italian Spring Ball”, ispirata alla rinascita. «Nello stesso anno ho fondato BBallroom, organizzazione che si occupa delle ball in Italia e di eventi legati alla scena. All’inizio eravamo in pochi a partecipare». Alla “Scandalous” di quest’anno, invece, la gente fa a gara per cercare il posto migliore da cui vedere le facce dei giudici mentre esaminano la performance.
Negli ultimi due anni è aumentata molto la curiosità verso le ball in

Il premio del vincitore della categoria Lip Sync, in cui i partecipanti scelgono e interpretano una canzone alla manifestazione di Milano

Italia, grazie anche all’influenza di serie tv come “Pose”. Quando è uscita su Netflix, nel 2019, la “Scandalous Ball” ha raggiunto numeri incredibili e La B. Fujiko Ninja è stata proclamata “pioneer” e “legend”: «Titoli che riconoscono il lavoro che ho fatto per la scena italiana e la responsabilità di portare avanti i valori da cui è nata».
La scena Ballroom in Italia è molto legata alla sua storia. «All’inizio abbiamo cercato informazioni, oggi stiamo cercando di capire chi siamo», spiega La B. D’altronde anche per Jack Mizrahi, icona della scena newyorchese, la ball è una celebrazione del cambiamento. «La scena italiana sta crescendo molto in espressione artistica e fiducia in sé stessa», commenta a fine serata. Il mondo, e le ball, sono in continua
evoluzione e cercano spazi nuovi in cui tutti possano riconoscersi, come quello per Gender Non-Conforming da cui in molti partecipano alla “Scandalous” di quest’anno.
Da quando tra le categorie La B. Fujiko ha aggiunto “Runway with a twist”, Sofia Chellini non deve più scegliere chi essere. In uno smoking nero che ricorda la donna delle pulizie del murales “Spazzalo sotto il tappeto” di Banksy, tema della categoria, Nemesi Ninja sfila con la testa dritta in una camminata mascolina. Ma al twist del commentatore l’espressione del volto cambia e i movimenti si fanno più morbidi e femminili. «La scena Ballroom nasce per butch queen, uomini gay, e femme queen, transgender. Le donne all’inizio erano molto poche e le categorie
pensate per loro rispecchiavano l’ideale di bellezza e femminilità imposto dalla società», racconta la 25enne toscana che per anni ha cercato di abbracciare questa idea.
Ma quando ha deciso di lanciarsi in categorie storicamente poco partecipate dalle donne ha iniziato a comprendere meglio sé stessa. «Le ball mi hanno aiutata a rompere la mia insicurezza», spiega Nemesi Ninja. Prima di far vedere cosa sai fare, devi avere qualcosa da dire e sapere chi sei, le ripeteva Benny Ninja agli inizi del suo percorso. Oggi basta incrociare il suo sguardo sulla passerella per capire che sa bene chi vuole essere e che non ha paura di raccontarlo.
Chellini, in quanto parte del direttivo di Arcigay Toscana, cerca di legare la scena Ballroom della sua regione all’attivismo Lgbtq+ per aiutare gli altri a sprigionare la propria luce. «Le ball possono aiutare le persone con disforia di genere a trovare punti di riferimento diversi in cui rispecchiarsi», racconta prima di tornare a fare il tifo per quelli che per lei sono amici, famiglia e compagni di squadra. Nemesi Ninja, da brava godmother della House, segue i passi di tutti i ninja sulla passerella.
«La prossima categoria è Vogue Fem», urla il commentatore. Danilo D’Aprile, o meglio Yunikon Ninja, cammina a tempo di musica con le gambe leggermente piegate e facendo movimenti vorticosi con le mani. Passi costruiti negli anni sul pavimento

liscio della Galleria Umberto I di Napoli, che ogni fine settimana diventava il suo studio di danza.
«Nella mia città c’è un legame molto forte tra Ballroom scene e la strada», racconta il 23enne che viveva in un piccolo monolocale con sua madre quando ha incontrato il voguing attraverso i video di due coreografe giapponesi, Aya Sato e Bambi, e poi di Lasseindra Ninja, madre europea della House che porterà Danilo nella famiglia. «Sono un ragazzo intersessuale e ho avuto difficoltà a capire come funzionava il mio corpo, come approcciarlo a una sessualità prettamente binaria». Dall’energia che sprigionasulpalcoèderivatoilsoprannome “dinamite”: piccolo, ma pronto a esplodere sulla passerella.
«Partecipare a una ball ti lascia ad-
dosso una sensazione di grandiosità, ma quando esci da qui la gente continua a insultarti e aggredirti. Questo dimostra come ci sia ancora tanto da fare in materia di diritti per la nostra comunità». Forse, secondo Yunikon Ninja, portar fuori l’essenza della ball potrebbe aiutare gli altri a far propri valori fondamentali per la nostra società. «Nelle ball c’è una libertà di espressione, accettazione e condivisione che fuori non c’è. E spero che i valori che condividiamo in questo spazio possano in futuro far parte della nostra quotidianità»: il messaggio di La B. Fujiko Ninja vale per tutti, perché ogni ball, attraverso la sua storia, si allarga fino a diventare uno spazio in cui celebrare la persona in qualunque suo aspetto e forma.

Nefele, come la ninfa plasmata da Zeus da una nuvola, ha i capelli corti dalla tonalità cangiante. Mostra un approccio anticonformista e gender fluid. Il suo corpo è punteggiato da lentiggini, il suo motto «l’imperfezione è bellezza». Vive su Instagram, dove pubblica immagini sbarazzine e intriganti: lei mentre cucina, fa windsurf, scherza col cagnolino, è in vacanza nel deserto, si gode un tramonto in riva al mare. Si definisce, la definiscono la «prima influencer virtuale imperfetta» made in Italy: lontana al quadrato, quindi, dagli stereotipi e dalle convenzioni di categoria. Già, perché Nefele, nonostante le sembianze e le movenze, le espressioni
e i comportamenti, non avrebbe nulla a che fare con l’evoluzione darwiniana della nostra specie. O almeno per ora. È un prodotto della computer grafica: l’hanno concepita tre ragazzi torinesi, Filippo Boschero, Laura Elicona e Luca Facchinetti. «Prova emozioni e sogna di creare un universo più inclusivo, facendo leva sul lato umano della tecnologia - ci spiegano -. Dove ci si senta liberi di essere ciò che si vuole, senza paure e pregiudizi». E senza l’ossessione del bellissimo a tutti i costi, naturale o innaturale che sia. «Il suo pubblico? Per lo più giovani donne, tra i 18 e i 35 anni». Sono chiamati influencer virtuali e in Asia polarizzano l’attenzione già da qualche anno. Il loro debutto in
Giappone nella sottocultura otaku, tra anime e manga. La capostipite assoluta era stata Hatsune Miku, nel remoto 2007, punta di diamante dell’era del vocaloid (un sintetizzatore vocale). Ne ha macinata poi di strada quel software beta. L’esplosione di massa è avvenuta nel triennio 2018-2021: ormai tra Sol Levante, Cina e Corea del Sud sono star strapagate, recitano in film e collezionano pienoni in cyber-concerti fantasmagorici. In seguito è toccato all’America e adesso è la volta dello sbarco in Europa e nella penisola. Sono avatar, all’apparenza, autosufficienti, porte girevoli tra il vecchio mondo fisico e il Metaverso che incombe. Frutto dell’intelligenza artificiale, luccicano


sempre più numerosi su Instagram e Twitch, TikTok, Facebook e Twitter. Post e streaming, interazioni con i followers: tutti protocolli che eseguono come, e meglio, dei loro omologhi in carne e ossa. E dire che sarebbero solo dei modelli in 2 o 3D, animazioni dal design ultra-antropomorfo pilotate da fotocamere e sensori di movimento. Yuniiho è una V-Tuber (virtual youtuber) tutta italiana. Sfoggia capelli rosa e due enormi occhi verdi da cartone anni Ottanta. Con una foglia di basilico sulla cima del cappello che manda in visibilio la sua rigogliosa community su Twitch, decine di migliaia di persone con sangue e muscoli. L’hanno ideata i tre misteriosi fondatori di VCorp. Loro stessi si fanno rappresentare da avatar perché «in un pianeta sempre più connesso e con l’aumentare dello scambio di informazioni questo permette di separare vita privata e pubblica, senza sacrificare l’identità - raccontano a L’Espresso -. Ci rivolgiamo principalmente a una clientela giovane, lavoriamo
parecchio con l’estero». Alle spalle di Zaira, aria eterea e pop, un occhio verde e uno blu, arrivata in primavera e già con quasi 80 mila followers su Instagram, opera un team di professionisti tricolori del settore, tra cui un autore di serie tv. A lanciarla nei nuovi mondi è stata la compagnia Buzzoole. «Rappresenterà la generazione Z e parlerà più lingue. Sarà la Virgilio del Metaverso» assicurano. A meno di improvvise riprogrammazioni, Eli e Sofi sono due gemelle virtuali venticinquenni nate in Sicilia durante il primo lockdown, con un capitale di 47 mila seguaci Instagram. Capigliatura rossa «perché rare», dalla loro biografia fittizia scopriamo che amano la natura, il make-up e ovviamente i romanzi fantasy. Combattono il razzismo, il bullismo e le discriminazioni in genere: alla base c’è sempre uno storytelling sensibile ai temi imprescindibili del presente. E preferiscono, chissà perché, i viaggi astratti e «immersivi, senza mezzi di trasporto inquinanti». Eccole coltivare in una

delle loro stories un ricordo elegiaco della terra dei loro nonni, con selfie panoramico ma di Gucci vestite e con tanto di hashtag della maison. Trascendono il tempo e lo spazio, sono più economiche di una Chiara Ferragni e non si sono ancora ribellate ai loro demiurghi mortali: schiere di ingegneri, filosofi e sceneggiatori freelance. Anche Daisy è una connazionale di nascita, ma è stata realizzata dal gigante dell’e-commerce Yoox ed è ricalcata sulle fattezze dell’attrice canadese Hannah Gross. Pure lei non disdegna affatto gli abiti griffati, lo shopping free, anzi, ben retribuito dai grandi brand. L’alta moda e le multinazionali dell’abbigliamento, della bellezza, del lifestyle, dell’intrattenimento, del turismo, dei videogiochi, del food e dell’high-tech ricorrono infatti in maniera esponenziale ai servigi degli influencer virtuali. Sarà che come ambasciatori commerciali rasentano, in termini tecnici e cinici, la perfezione: instancabili e malleabili, veramente interattivi e dotati, volendo, del dono

Yuniiho

dell’ubiquità. Quando tutto era fermo per pandemia loro potevano muoversi dove volevano, alla velocità della luce. E non hanno bisogno di maquillage o filtri ingegnosi: non invecchiano mai. Valentino ha scelto, per esempio, la blasonata orientale Kizuna Ai; Louis Vuitton si è affidata all’elegante modella di colore “all pixel” Shudu Gram. Un’altra acclamata top model elettronica è Lil Miquela, un’eterna diciannovenne californiana con la frangetta irresistibile alla Amélie: l’hanno cooptata, tra gli altri, Calvin Klein, Chanel e Samsung. Adidas si è rivolta a Lu Do Magalu, una webstar brasiliana precipitata dal futuro. Vanta addirittura 6 milioni di followers su Instagram: sono rinomati i video in cui recensisce prodotti e app. Vegana e bandiera dell’empowerment femminile, la tecno-musa Noonoouri ha sfilato, da par suo, per Versace e Dior ed è amica di Kim Kardashian. Tra le senatrici fashion del gruppo spicca Imma da Tokyo, una sgargiante e iperattiva mannequin con caschetto pink
e Sofi sono due
shocking e connotati incredibilmente realistici. È stata testimonial, per dirne qualcuno, di Ikea e Porsche e appoggia le campagne di sensibilizzazione sull’ambiente e sui diritti della comunità LGBTQ+. I giovanissimi la adorano. Uno dei pochi protagonisti maschili è Knox Forst, un ventenne robotico from Atlanta, Georgia. È apparso sulle copertine di Forbes e Fortune e durante l’emergenza Covid-19 ha dato una mano nientemeno che all’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità.
Il10novembresiètenutaaMilanola prima edizione dell’Influence Day, un evento organizzato da Flu, tra le principali realtà in materia. Tra gli ospiti Cameron-James Wilson, ceo di The diigitals, la prima agenzia planetaria di virtual top model. Nel Belpaese «il comparto dell’influencer marketing vale oggi quasi 300 milioni di euro», dice Giancarlo Sampietro, fondatore di Flu. E prendono quota “i virtuali”: pochi margini di rischio con questi nostri
indistinguibili simulacri, nessuna gaffe o caduta di stile dietro l’angolo. Anzi, la loro capacità di coinvolgimento è tre volte superiore alla norma come dimostrano studi recenti. Nutriamo una fiducia istintiva verso queste interfacce sempre più evolute e senzienti, o pseudo-tali. Doppi di noi, sfrondati però di tutti quei difetti intrinseci alle nostre virtù. Pesano tuttavia sullo sfondo problemi di ordine etico e giuridico: chi risponde dei contenuti che condividono sui social? E qual è il confine tra libertà d’espressione e sponsorizzazioni più o meno manifeste? La legislazione e la consapevolezza, al riguardo, sono ancora agli albori. Sta di fatto che se e quando cominceremo ad abitare a miliardi l’inquietante e sfavillante Metaverso, avatar e ologrammi definitivi di noi stessi, avremo la medesima codifica grafica degli odierni influencer virtuali. E il cielo in una stanza, la vita da remoto. Più nativi digitali di così. Restiamo umani, virtualmente umani.


Nella striscia di Rai Tre persone belle che pensano al bene del Paese. Anche se non fanno gol

Sventurata è la Terra che ha bisogno di eroi, diceva qualcuno. Ma sono passati decenni e il signor Brecht non se ne avrebbe a male se ritrovasse la sua celebre frase aggiornata alle barbare modalità del suolo italico. Che potrebbe suonare più o meno con un: «Sventurato è il
Paese che prende gli eroi, li mastica e li butta via, senza imparare granché». Certo un po’ brutale, ma sicuramente onesta. Perché altrimenti l’effetto stupore che provoca la striscia quotidiana di Rai Tre dedicata a quelle persone che guardano al di là del loro naso per il bene comune non avrebbe ragion d’essere. Si intitola “Nuovi Eroi” l’intermezzo televisivo ormai alla sua quarta stagione, in cui rimbombano voci fortissime, a tratti assordanti persino nel silenzio. Storie quotidiane della cosiddetta Italia migliore, inedite foto di un Paese civile, in cui cittadine e cittadini si lasciano andare a gesti che diventano enormi. Non ci sono le grida di entusiasmo di Adani a sottolineare le azioni belle della vita, ma la voce sabbiosa di Veronica Pivetti che diventa
filo rosso, mentre scorrono i racconti di chi posa mattoni di esempi da seguire. Chi non si è arreso alla mafia, chi ha cercato di costruire un futuro diverso per sé e i suoi compagni, chi ha sacrificato forza, privato e denari per offrire un’alternativa a chi soffre, l’impegno di chi non si è arreso al dolore per la morte di un figlio operaio e ha reso quel lutto una battaglia senza fine per tutte le vittime. Azioni potenti di cittadine e cittadini che sarebbe naturale come l’acqua senza bolle che diventassero esempio da seguire. Eppure tra interviste e repertorio, sera dopo sera, viene spontaneo pensare come il concetto di eroismo del nostro buffo Paese sia perlopiù circoscritto all’urlo di Tardelli, solitario esempio di condivisione universale. Senza gol non restano né Achille né Ettore, i medici diventati “angeli” del Covid si dimenticano nei talk come mascherine usate e persino una figura delle dimensioni di Liliana Segre diventa bersaglio della schiuma di risulta di un Paese che la memoria non sa neppure cosa sia. Così, mentre il cuore si gonfia di orgoglio per Giovannella, Giovanni, Mauro, Valentina, Marco, donne e uomini che ogni anno vengono premiati per la loro etica dal presidente Mattarella, torna alla mente l’estrema sintesi dell’eroe firmata Stan Lee: «Non credevo che l'Uomo Ragno sarebbe diventato un'icona mondiale. Io speravo solo che il fumetto vendesse così da potermi tenere il lavoro».

In questi giorni mi è capitato di riscoprire un eccezionale trio femminile di stile folk rock di cui si è persa la memoria. Sono The Roches, tre sorelle americane che negli anni Ottanta e Novanta hanno inciso dischi deliziosi, per nulla ruffiani, con armonie vocali molto originali, e ingiustamente cancellate dalla memoria. Ma potrebbe non essere un fatto accidentale. Per essere definita da una parola così sontuosamente femminile, la musica è uno dei mondi più schifosamente maschili, se non addirittura maschilisti, che ci siano. Peggio di altri proprio perché teoricamente sarebbe per eccellenza il mondo dei sogni, dell’uguaglianza, della pace, dell’accettazione, dell’amore. E invece no, per una serie di leggi non scritte, eppure incredibilmente efficaci, alle donne in musica è in sostanza concesso quasi esclusivamente di cantare. Fateci caso, di voci ne possiamo trovare in quantità, dovunque, in ogni genere musicale, ma appena usciamo dal ruolo c’è il deserto, pressoché assoluto. La percentuale di donne che suonano uno strumento, che scrivono canzoni, che producono, compongono, arrangiano, o che dirigono case discografiche è incredibilmente bassa. Con alcune circostanze aggravanti. A essere efferatamente maschile, ai limiti dello sciovinismo, è proprio il rock, la musica che dagli anni Sessanta ha avuto la presunzione di raccontare la rivoluzione, l’emancipazione, la liberazione sessuale. Eppure, voci a parte, di gruppi rock femminili ce ne sono stati, ma pochi, pochissimi, a fronte di una marea sconfinata di maschi, di gruppi sempre e solo maschili, stabilendo quello che alla fine risulta un cliché sonoro e visivo incrollabile, roccioso. Ma anche i
singoli ruoli strumentali sono quasi sempre nettamente col segno maschile. Per una Victoria che suona il basso nel gruppo rock più famoso del momento ci sono migliaia di suonatori uomini. E se cambiamo genere le cose non vanno granché meglio. Ve lo immaginate un gruppo jazz composto esclusivamente da donne? Ce ne sono, per carità, ma all’estrema periferia dell’orizzonte. Ci sono stati maschi illuminati come Prince, che faceva di tutto per esaltare ruoli femminili al suo fianco, ma di solito ai musicisti piace creare club esclusivi e inaccessibili al mondo femminile. Il motivo per cui le donne sono autorizzate di fatto quasi solo a cantare è legato a ragioni ancestrali, alle serenate che le mamme per lenire il pianto cantavano ai piccoli. In tutte le civiltà antiche ci sono immagini di donne che cantano, diciamo pure che le donne hanno sempre cantato e continuano a farlo. Ma non basta, la disparità in tutti gli altri ruoli è offensiva, ingiustificata. C’è una intera cultura che blocca questi processi, e che dovrebbe mutare profondamente al seguito della rivoluzione in atto. Tutto è cambiato, ma la presenza di donne rimane incredibilmente scarsa. E la musica oggi non può più permetterselo.

Un vecchio contadino della Sabina costretto a correre a Bruxelles. Il film di Vicari carico di emozioni

Il nuovo film del regista di “Diaz” sembra un po’ fuori dal tempo, come il suo protagonista. Un vecchio contadino che lascia i monti della Sabina per scapicollarsi nella gelida Bruxelles, dove il figlio che non vedeva da secoli è morto all’improvviso. Soldi cuciti nella giacca, aria impaurita e insieme sprezzante (Michele Placido è superlativo), il taciturno Orlando è come un nobile castagno trapiantato a tradimento nella metropoli (rubiamo l’immagine al regista). Ma tutta questa distanza non fa che renderlo ancora più contemporaneo. Un estraneo, come molti tra noi. Uno sradicato, anzi un individuo dalle radici pesanti in un mondo tutto fluidità e velocità (“Velocità massima” era il titolo del potente esordio di Vicari). Un naufrago venuto da un luogo e un tempo lontani, che sa estrarre meraviglie dalla fisarmonica ma è del tutto inadeguato all’insidioso tesoro che gli tocca in sorte. Una nipote belga di nome Lyse (la sorprendente Angelica Kazankova). Una ragazzina dai lunghi capelli biondi che non ha mai conosciuto la madre ma chiamava il padre per nome. E guarda quel nonno ignoto come un reperto, un alieno, un enigma. Forse una promessa. O una minaccia. Il seguito ha un passo a tratti meno sicuro. Se l’impatto reciproco, lo sperdimento nell’ostile capitale d’Europa, l’arcaica fierezza con cui il vecchio Orlando si rimbocca le maniche per mantenere Lyse e il suo misterioso stile di vita, scorrono come acqua dalla sorgente, il lento avvicinamento di
quei due mondi suona a tratti un poco premeditato. Quasi che Vicari e il suo sceneggiatore Andrea Cedrola, come il loro protagonista, non lasciassero Lyse essere ciò che è fino in fondo con tutte le sue ambiguità, le sue ferite, i suoi egoismi.
Anche se questa difficoltà - questo do-
lore - sono parte del gioco e iscrivono l’ispirato “Orlando” nel vasto registro dei film dominati da un personaggio così potente da fare ombra a tutto il resto (riecco l’albero), malgrado comprimari eccellenti come la barista del paese (Daniela Giordano), l’assistente sociale Fabrizio Rongione o suo padre Federico Pacifici, a sua volta un emigrato italiano. Poco importa del resto. In un cinema accecato dalle mode e sempre più incapace di interrogare la memoria - dunque la modernità - il viaggio a ritroso di “Orlando” rappresenta una felice eccezione. Teniamocelo stretto.
“ORLANDO” di Daniele Vicari Italia-Belgio, 122’

CAPOREDATTORI CENTRALI: Leopoldo Fabiani (responsabile), Enrico Bellavia (vicario)
UFFICIO CENTRALE: Beatrice Dondi (vicecaporedattrice), Sabina Minardi (vicecaporedattrice), Anna Dichiarante
REDAZIONE: Federica Bianchi, Paolo Biondani (inviato), Angiola Codacci-Pisanelli (caposervizio), Emanuele Coen (vicecaposervizio), Antonio Fraschilla, Vittorio Malagutti (inviato), Antonia Matarrese, Mauro Munafò (caposervizio web), Gloria Riva, Carlo Tecce (inviato), Gianfrancesco Turano (inviato), Susanna Turco
ART DIRECTOR: Stefano Cipolla (caporedattore)
UFFICIO GRAFICO: Martina Cozzi (caposervizio), Alessio Melandri, Emiliano Rapiti (collaboratore)
PHOTOEDITOR: Tiziana Faraoni (vicecaporedattrice)
RICERCA FOTOGRAFICA: Giorgia Coccia, Mauro Pelella, Elena Turrini
SEGRETERIA DI REDAZIONE: Valeria Esposito (coordinamento), Sante Calvaresi, Rosangela D’Onofrio
CONTROLLO DI QUALITÀ: Fausto Raso
OPINIONI: Barbara Alberti, Altan, Mauro Biani, Massimo Cacciari, Lucio Caracciolo, Franco Corleone, Donatella Di Cesare, Roberto Esposito, Luciano Floridi, Bernard Guetta, Sandro Magister, Marco Dambrosio Makkox, Bruno Manfellotto, Ignazio Marino, Ezio Mauro, Michela Murgia, Denise Pardo, Massimo Riva, Pier Aldo Rovatti, Giorgio Ruffolo, Michele Serra, Raffaele Simone, Bernardo Valli, Gianni Vattimo, Sofia Ventura, Luigi Vicinanza, Luigi Zoja
COLLABORATORI: Simone Alliva, Erika Antonelli, Viola Ardone, Silvia Barbagallo, Giuliano Battiston, Marta Bellingreri, Marco Belpoliti, Caterina Bonvicini, Ivan Canu, Gino Castaldo, Giuseppe Catozzella, Manuela Cavalieri, Rita Cirio, Stefano Del Re, Alberto Dentice, Francesca De Sanctis, Cesare de Seta, Roberto Di Caro, Paolo Di Paolo, Fabio Ferzetti, Alberto Flores d’Arcais, Marcello Fois, Antonio Funiciello, Giuseppe Genna, Wlodek Goldkorn, Marco Grieco, Luciana Grosso, Helena Janeczek, Stefano Liberti, Claudio Lindner, Francesca Mannocchi, Gaia Manzini, Piero Melati, Luca Molinari, Donatella Mulvoni, Matteo Nucci, Eugenio Occorsio, Marco Pacini, Massimiliano Panarari, Gianni Perrelli, Simone Pieranni, Paola Pilati, Sabrina Pisu, Laura Pugno, Marisa Ranieri Panetta, Mario Ricciardi, Gigi Riva, Stefania Rossini, Evelina Santangelo, Elvira Seminara, Caterina Serra, Chiara Sgreccia, Francesca Sironi, Leo Sisti, Elena Testi, Chiara Valentini, Chiara Valerio, Stefano Vastano

PROGETTO GRAFICO: Stefano Cipolla e Daniele Zendroni
Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano P. IVA 12262740967 - Iscr. Reg. Imprese n. 12546800017 - N. REA MI - 2649954
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE: Denis Masetti
AMMINISTRATORE DELEGATO: Marco Forlani
DIRETTORE GENERALE: Mirko Bertucci
CONSIGLIERI: Maurizio Milan, Massimiliano Muneghina, Margherita Revelli Caracciolo, Alessandro Mauro Rossi
DIREZIONE E REDAZIONE ROMA: Via in Lucina, 17 - 00186 Roma - Tel. 06 86774111 E-mail: espresso@espressoedit.it
REDAZIONE DI MILANO: Via Luigi Galvani, 24 – 20124 Milano Registrazione Tribunale di Roma n. 4822 / 55 Un numero: € 4,00; copie arretrate il doppio
PUBBLICITÀ: BFC MEDIA SPA info@bfcmedia.com - Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano ABBONAMENTI: Tel. 0864 256266 - Fax 02 26681991

E-mail:abbonamenti@gedidistribuzione.it Per sottoscrizioni www.ilmioabbonamento.it Servizio grandi clienti: Tel. 0864 256266
DISTRIBUZIONE: GEDI Distribuzione S.p.A. - Via Nervesa, 21 - 20139 Milano Arretrati e prodotti multimediali: Tel. 0864 256266 - Fax 02 26688669 - arretrati@gedidistribuzione.it
STAMPA E ALLESTIMENTO: Stabilimento Effe Printing S.r.l. - località Miole Le Campore-Oricola (L’Aquila); Puntoweb (copertina) - via Variante di Cancelliera snc Ariccia (Rm).
Titolare trattamento dati (Reg. UE 2016/679): L’Espresso Media Srl - info@lespresso.it - Soggetto autorizzato al trattamento dati (Reg. UE 2016/679): Lirio Abbate
Cara Rossini, sono un neolaureato e mi voglio raccontare. Sono stato uno studente appassionato e ho concluso sia la laurea breve che quella magistrale col massimo dei voti lo scorso autunno. Durante il biennio ho frequentato uno studio professionale dove ho lavorato gratuitamente per due anni per “imparare il mestiere” di agronomo. Ho svolto una tesi sperimentale sull’utilizzo di un materiale d’impianto che potrebbe innovare la viticoltura siciliana, ma dal giorno della laurea a oggi ho incontrato solo porte sbarrate. L’ultima ieri, dopo due colloqui andati bene l’azienda mi ha chiesto di attendere un mese per poi liquidarmi dicendomi che la posizione è stata occupata da un’altra persona. Quello che le scrivo non contiene nessuna eccezionalità, è la vicenda comune di molti giovani che dopo il periodo di studio si scontrano con un Paese che sembra non aver bisogno di loro. Per me - fortunatamente - è la storia di qualche mese da disoccupato, ma ci vuole un grande ottimismo per credere che non passerò altri lunghissimi mesi così, impegnandomi a una continua e inutile ricerca, vivendo giornate tutte uguali e svilenti, senza quel lavoro che l’articolo 4 della Costituzione menziona come dovere di tutti i cittadini volto a concorrere il progresso materiale o spirituale della società. Io, Rossini, vorrei non avere vergogna di questa mia condizione, ma vado perdendo le speranze e mi sento come una clessidra che più passa il tempo più si esaurisce.
Claudio MirabellaEccole le umiliazioni, cocenti, ripetute e avvilenti. Non certo utili, come ha detto imprudentemente il ministro dell’Istruzione e del Merito, apprezzandole come «un fattore fondamentale della crescita», anche se ho il sospetto che Valditara abbia confuso un termine con un altro. È probabile che intendesse parlare di frustrazioni, termine solo apparentemente simile, che fu introdotto da Freud per indicare lo stato psicologico provocato dal mancato appagamento di un bisogno e che la moderna psicologia infantile ha sviluppato fino a considerare le frustrazioni un prezioso allenamento alla maturazione emotiva del bambino, il quale, imparando a tollerare i rifiuti e i tanto celebrati “no” dei genitori (più tardi degli insegnanti e degli altri adulti), si allena a stare al modo. L’umiliazione è invece violenza, dominio dell’altro e produce avvilimento, senso di impotenza e spesso rabbia. Proprio i sentimenti che sta provando il nostro giovane lettore, agronomo per passione e competenza, che dopo studi brillanti pensava di essere accettato con facilità nell’ambiente professionale dove aveva già dato ottime prove. Era un pensiero giusto, ma non qui, non in Italia, in un mondo del lavoro che accetta il merito come bandierina di propaganda ma spesso non sa riconoscerlo né premiarlo. Per fortuna Claudio è abbastanza saggio da avere la consapevolezza del proprio valore e si dice da solo che prima o poi ce la farà. Ne siamo certi anche noi.






Chiesi a Wauna dove fossero finiti gli uomini. Rispose “Non ne ho mai sentito parlare. Dev’essere un animale estinto”
Forse al nostro risveglio di donne manca l’atto rivoluzionario per eccellenza. L’utopia, il gesto, il sogno. Mi è parso di ritrovarlo in un libro dell’800, “Mizora” di Mary Bradley Lane (ed. 1000 e una notte, 2018), anche se si è rivelato una trappola. A Cincinnati, nel 1880, esplode uno scandalo: sul Cincinnati commercial news sta uscendo a puntate “Mizora”, un romanzo anonimo. Racconta un popolo di sole donne, che senza il maschio hanno raggiunto la civiltà perfetta. Il Cincinnati vende,

vende, vende. Nessuno sa chi sia l’autore, nemmeno il direttore. Le puntate arrivano per posta. I cittadini si rivoltano. Telegrammi furiosi, minacce, un redattore viene picchiato. A una cena di notabili, dall’avvocato Burt Lane e sua moglie Mary Ellen, non si parla d’altro. Il sindaco inveisce contro “Mizora”. «Uno scritto immorale, sedizioso! Tutti i maschi sono spariti dal mondo, e per questo non ci sono più omicidi, fame, guerre. Aberrante». Mary Ellen, quieta, risponde: «Una visione speculare a quella di Tolstoj. Lui pensa che l’assenza delle donne sanerebbe ogni male del mondo. Il suo “Sonata a Kreutzer” è un manuale per la necessaria soppressione della femmina». Discutono dell’autore misterioso, ma in una cosa sono tutti d’accordo: “Mizora” lo ha scritto un uomo. Le donne non hanno immaginazione. Se fosse vero ci saremmo estinte da un pezzo, pensa Mary Ellen. Coglie lo sguardo del marito all’amante in carica. Ma anche lei ha un segreto. Un’altra vita. Partiti gli ospiti si chiude a chiave e tira fuori il suo libro, “Mizora”: è lei l’autore misterioso. Si sfila la livrea da moglie, e scrive la nuova puntata. Protagonista è Vera, nata per l’avventura, che si imbarca su un veliero, fa naufragio e sprofonda in mare. Ma invece di morire si ritrova
Nella Cincinnati di fine Ottocento spopola un romanzo, “Mizora”,
nel mondo ideale. In fondo all’Oceano, in una zona asciutta e fertile, le donne hanno creato Mizora, la repubblica perfetta. Il luogo della bellezza, musica, scienza, libertà, giustizia. L’amica Wauna le rivela che senza gli uomini da servire sono diventate onniscienti. Non hanno un dio, ma il sapere è sacro. La cultura è di tutti, come il benessere. I maschi non servono più nemmeno come schiavi, meglio le macchine. Superflui anche per la riproduzione. Nel segreto della notte, Mary Ellen sogna la partenogenesi. Grazie alle diete le donne vivono a lungo, lucidissime, a 200 anni studiano ancora. A Mizora si muore serenamente, senza paradiso o inferno. Il paradiso è aver bene operato. Nella sua stanzetta Mary Ellen rifonda il mondo. Risolve la sanità, l’inquinamento, i rifiuti. Tutto è trasformato in risorsa. Questa Jules Verne ragazza immagina le invenzioni future. Robot, videotelefoni, automobili… Mentre a Cincinnati le donne soffocano nei busti, le mizoriane fluttuano in sete lievi. Mizora è il sogno di un’esteta, economista di genio. Finché Vera chiede: «Ma… dove li avete messi i maschi?». «Si sono estinti». «Lo so. Ma come?». E viene fuori che quelle donne perfette hanno alle spalle il più grande genocidio della storia. I maschi li hanno fatti
fuori. Tutti. Per questo provvedimento estremo c’erano delle buone ragioni. Quelli sapevano solo torturare e distruggere. Incivilizzabili. Mizora è monda dal mal seme di Adamo. A Vera ciò sembra già molto sinistro. Poi nota che le mizoriane sono tutte bianche e bionde. Solo lei ha i capelli neri. Domanda a Wauna: «E le genti di pelle scura dove le avete messe?». «Anche loro erano perverse». Mary Ellen scrive, scrive, la sua creatura le scappa di mano, le sue donne divine sono anche delle razziste assassine, non sa più da che parte stare. Estranea alla società di Cincinnati, anche nel regno di Utopia Mary Ellen resta un’aliena. La sua utopia è distopica. Burt, il marito, morì vecchio e felice, senza mai sospettare che l’anonimo di “Mizora” fosse sua moglie.
di autore ignoto. Ma il sogno di un mondo tutto al femminile alla fine si rivela un incubo






