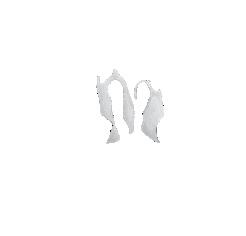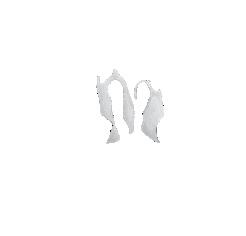Prefazione
La ferita
Una costante dei romanzi di Irène Némirovsky è la condizione di orfano che caratterizza uno o più personaggi: orfano come condi zione oggettiva di chi ha perduto uno o entrambi i genitori e orfano come stato d’animo di chi è stato privato della casa, della patria, di un patrimonio, di un affetto, della salute, della soddisfazione di un bisogno essenziale per vivere e della vita stessa.
Lo stato della perdita, che condiziona e motiva le azioni, i pensie ri e l’intera esistenza di chi ne è portatore o portatrice, è presente in ogni romanzo: indagare e narrare questa materia in modo originale da parte di Némirovsky, fin dagli Anni Venti del secolo scorso, non è certo una posizione comoda, anche se la scrittrice trova esempi e sostegno nelle fiabe, nella biografia di tante persone realmente esi stite, sconosciute o anche note, come Dante, Leonardo, Caravaggio e tanti altri artisti rimasti orfani fin da piccoli, oltre che nella lettera tura greca, russa, francese, tedesca e inglese, che Némirovsky legge e studia in lingua originale fin da piccola.
Potrebbe correre il rischio di ripetersi, invece inventa un pensie ro e uno stile narrativo tutto suo, anticipando l’elaborazione femmi nista e le scoperte dei nostri giorni sul funzionamento del cervello,
9
sulle attività neurologiche e sui bisogni primari dell’essere umano, a partire dal concepimento. La motivazione di fondo che agita il pensiero, il sentire e lo scrivere di Irène Némirovsky, secondo me, è la cognizione del dolore, secondo il racconto gaddiano: dolore come sostanza dell’essere in questo mondo; Buddha lo definisce «dukkh, una nobile verità»; Agostino si domanda: «Unde malum?» come Va silij Grossman che, lo stesso, si chiede: «Forse è la vita il male?»1 Il Cristianesimo trova la risposta nella croce.
Simone Weil lo chiama “le malheur” , mentre Cristina Campo esprime in forma di interrogativo retorico una sua convinzione sul nostro tempo, considerato «civiltà della perdita: a che cosa si riduce ormai l’esame della condizione dell’uomo, se non all’enumerazione, stoica o atterrita, delle sue perdite?»2
Hannah Arendt pensa che «il male non è mai “radicale” ma sol tanto estremo e che non possegga né profondità né una dimensione demoniaca. Esso può invadere e devastare il mondo intero, perché si espande sulla sua superficie come un fungo. Esso “sfida”… il pen siero, perché il pensiero cerca di raggiungere la profondità, di anda re alle radici e nel momento in cui cerca il male è frustrato, perché non trova nulla. Questa è la sua banalità. Solo il bene è profondo e può essere radicale».3 Per Arendt, quindi, il male è mancanza e assenza di pensiero, che si manifesta come «una temporanea mani festazione di un bene ancora nascosto».4
I pensieri non sono elucubrazioni astratte, sono fatti di carne, come hanno dimostrato gli studi più recenti sul cervello, attraverso
1
V. Grossman, Vita e destino, Adelphi, Milano, 2013, p. 385.
2 C. Campo, Gli imperdonabili, Adelphi, Milano, 1987, p. 113.
3 H. Arendt, Ebraismo e modernità, Feltrinelli, Milano, 1993, p. 22.
4 H. Arendt, Sulla violenza, Guanda, Parma, 1996, p. 52.
10
Cara Irène
tecniche come la tomografia a emissione di positroni (PET) e la ri sonanza magnetica funzionale per immagini (fMRI); oggi si può e si deve affermare che «il principio alla base della nuova scienza della mente è che tutti i processi mentali sono biologici, che tutti dipen dono da molecole organiche e processi cellulari».5 Questi studi, avvalendosi delle tecniche, hanno “fotografato”, ad esempio, come «il sistema dell’attaccamento, innato, istintivo o motivazionale, simile alla fame o alla sete… organizza i processi mnemmonici del bambino e lo induce a cercare una prossimità e una comunicazione con la ma dre»,6 rafforzando la probabilità di sopravvivenza, base dell’intera esistenza e della possibilità di interagire col mondo da parte di ogni individuo. Sono “fotografie” del cervello in attività non di poco con to, capaci di scardinare i muri, che vogliono separare le conoscenze scientifiche da quelle umanistiche; conoscenze che, invece, sono par ti di un solo campo, la scienza, ognuna con la sua specifica ricerca. In continuità con quanto sopra, Melanie Klein sottolinea «l’im portanza fondamentale della prima relazione oggettuale del bam bino, il rapporto con il seno materno e con la madre, aggiungendo di essere giunta alla conclusione che se questo oggetto primario, il quale viene introiettato, mette nell’io radici abbastanza salde, viene posta una base solida per uno sviluppo soddisfacente».7 La studiosa analizza la conflittualità di questo rapporto, perché chi nasce perde «quel sentimento di unità e sicurezza, tipico dello stadio prenata le, provando un’intensa angoscia persecutoria messa in moto dalla nascita», che rafforza il «conflitto innato tra amore e odio, cioè tra pulsioni di vita e di morte». Il mantenimento dello stato prenatale
5 E. R. Kandel, Alla ricerca della memoria. La storia di una nuova scienza della mente, Codice Edizioni, Torino, 2017, p. 342.
6 Ivi, p. 347.
7 M. Klein, Invidia e gratitudine, Giunti, Firenze, 2012, p. 11.
11
Prefazione
è possibile anche dopo essere venuto al mondo, ma dipende dal le «condizioni psicologiche e fisiche della madre e da fattori non esplorati, presenti nel bambino prima della nascita».8 Nei primissimi stadi dell’infanzia la madre è il primo e unico oggetto per il neonato, che desidera da lei non solo il cibo dal seno «ma anche la liberazione dagli impulsi distruttivi e dalle angosce persecutorie».9 Invidia, rabbia, avidità, confusione sono gli impulsi distruttivi, “il seno cattivo”, che danneggia il rapporto con “il seno buono” della madre. «(In contrapposizione al bambino invidioso) il bambino che possiede una grande capacità di amore e gratitudine stabilisce un rapporto ben radicato con l’oggetto buono ed è in grado di superare senza grave danno quegli stati di invidia, di odio e di dolore tempo ranei, da cui non sono esenti neppure i bambini amati e ben curati dalla madre».10 In questi primissimi stadi di vita il rapporto con la madre è determinante, perché i neonati da soli non sono in grado di affrontare la lotta tra le pulsioni di vita e di morte, lotta necessaria, ché costituisce l’attività iniziale dell’io appena nato. Nella creatura, se è abbandonata all’angoscia persecutoria e al “seno cattivo”, se condo la teoria della studiosa, prevarranno «meccanismi paranoidi e schizoidi che… costituiscono la base della schizofrenia»11 e di tanti altri meccanismi di difesa (sensi di colpa, idealizzazione…) che im pediscono l’equilibrio, l’integrazione, il sentimento di gratitudine e la capacità di amare se stessi e gli altri. «Il primo felice rapporto con la madre durante tutta la vita mitiga l’odio e l’angoscia… e anche in vecchiaia continua a dare appoggio e appagamento».12
8
Ivi, p. 12.
9
Ivi, p. 13.
10
Ivi, p. 26.
11
Ivi, p. 35.
12
Ivi, p. 54.
12 Cara Irène
Questi recenti studi hanno dimostrato come il cervello conservi la memoria del nostro esserci; una memoria sintetizzata anche da Hegel con l’espressione: «Non verrà fuori nient’altro che quello che c’era già»; idea poi ripresa da Marx: «Ogni società contiene i semi di quella successiva allo stesso modo che ogni organismo vivente porta i semi dei suoi discendenti»13. Tanto più negli esseri umani, per i quali è importante, soprattutto, il tipo di relazione che si stabilisce tra la madre e la sua creatura. Ne era convinta anche Maria Mon tessori, molto amata dalla madre Renilde, donna positiva, allegra, elegante, piena di ammirazione per questa figlia, che, da medico, già agli inizi del Novecento, rivoluziona la cura e il recupero dei bimbi chiusi nel manicomio di Roma, anticipando la riforma Basaglia, di ventata Legge 180 nel 1978. Maria Montessori, poi, segue la forma zione dei bimbi svantaggiati socialmente presso la Casa dei Bambini nella stessa città, inventando Il Metodo, che ancor oggi viene appli cato nelle scuole del mondo intero per gli straordinari risultati a vari livelli: terapeutico, educativo e formativo. Durante e dopo la Prima guerra mondiale, Montessori trasforma alcune Case dei Bambini in centri per ricevere i figli dei profughi e degli sfollati e propone an che l’istituzione di una Croce Bianca Internazionale a difesa dell’in fanzia; è convinta che solo tutelando i bambini e fornendo loro gli strumenti, questi possano prendere coscienza del trauma vissuto, risvegliare la pace interiore, stimolare le risorse, seguire una terapia per il dolore e l’ansia e diventare così dei cittadini capaci di rispetto per sé, per gli altri e per il pianeta.
Irène Némirovsky con la sua narrazione non vuole certo imi tare Maria Montessori, né farsi portavoce di una teoria o mettersi in competizione con la psicanalisi, la neurologia e le altre scienze,
13 H. Arendt, Sulla violenza, cit., p. 26.
13
Prefazione
però, condivide con la scienza contemporanea e con Montessori la passione per l’infanzia e per questi “cittadini dimenticati”; la sua attività di scrittrice è la narrazione della loro sofferenza e alla fine raggiunge obiettivi identici alla pedagogista, obiettivi che Montes sori sintetizza nel suo libro Il segreto dell’infanzia: «penetrare nei recessi misteriosi dell’anima infantile… chiave capace di aprire tesori nascosti». Se la narrazione di Irène Némirovsky non vuol essere una autobiografia, per piangersi addosso, nel fare letteratura, con il suo mestiere e la sua arte, comunica a chi legge una ontologia, un nuovo sapere sull’essere, che in superficie non si vede, un senso dell’essere che accomuna tutte le persone di questo mondo. «Il termine senso è qui da intendere non in prospettiva teoretica, cioè come sinonimo di significato, ma in prospettiva terapeutica e dinamica, cioè come dimensione di marcia, sentiero, via d’uscita».14
Se l’esistenza e il problema del male accompagnano l’essere uma no dal tempo dei tempi e se non si danno pensiero filosofico o reli gione senza una riflessione sul male, Némirovsky con il suo lavoro sembra dare connotati precisi a questa sostanza dell’essere: il male è la perdita e l’abbandono; l’origine di ogni male, la ferita inguari bile e il male più male di tutti è l’abbandono sofferto nell’infanzia. Questa è la mancanza per eccellenza, la ferita inguaribile. La storia di ognuno dipende da come il soggetto si rapporta e si comporta nei confronti della sua ferita. Una storia di singoli che diventa la Storia. La scrittrice narra e, con le parole che crea, stabilisce un rap porto tra quello che c’è e quello che non si vede, spinta da bisogni essenziali, comuni agli esseri umani, pur se ognuno ha un individua le, diverso e irripetibile modo di vivere la sua storia. In uno stato di assenza e di mancanza, la libertà del desiderio e della soddisfazione
14 V. Mancuso, I quattro maestri, Garzanti, Milano, 2020, p. 180.
14 Cara
Irène
dei bisogni fa paura, come nella prima infanzia, quando si dipende totalmente dalla mamma e si ha paura che muoia, rimanendo soli, in balia della violenza e della morte stessa. Per tutti, ma per la bimba in modo particolare la relazione con la madre è fondante la propria identità e il suo stesso futuro di madre, impossibile per il maschio; per la bimba invece la relazione con la madre è la sua vita, “un copia e incolla”, secondo la dottoressa Paula Paulin, a cominciare da Lilith e da Eva, la moglie “cattiva” e quella “buona” di Adamo, le due lab bra della stessa ferita. «Nascere donna vuol dire nascere predisposta allo sbilanciamento del centro di gravità che si sposta in altro, fuori di sé. Predisposizione non di natura metafisica o fisiologica; provie ne dal rapporto con la madre. Nascere dello stesso sesso della madre è un privilegio grande ma costoso: la possibilità di essere (madre), che è un di più, la imprime come un meno, come una carenza che permane».15 La carenza è l’amore, come spiega Muraro: «La que stione dell’amore… è fermarsi alla carenza e starci lo stesso, vivere nello squilibrio del meno e del più perché sia in rapporto con l’altro, andare e venire fra la gioia della presenza e il dolore dell’assenza, perché l’amore soltanto sa quando viene e quando se ne va».16 La studiosa sostiene che anche il rapporto maschile con la madre può prevedere lo “sbilanciamento”, ma che è più frequente che un uomo si consideri “il termine, lo scopo e l’inizio” di tutta la faccenda. Solo la madre comprende le lallazioni e la strana lingua della figlia, che corrisponde al segreto che le lega; è la lingua di uno stato relazione e di un mondo d’amore, dove vengono detti il dicibile e l’indicibile. Némirovsky anticipa queste conquiste del sapere, narrando storie dove è prevista questa materia, storie reali più della realtà, dove tut
15 L. Muraro, Il Dio delle donne, Marietti, Bologna, 2020, p. 131.
16 Ivi, p. 133.
15
Prefazione
to avviene alla luce del sole, dove ogni gesto è descritto in modo chiaro, eppure sono storie con i verbi all’imperfetto, come il “c’era una volta” delle fiabe e come accade nelle allegorie: «L’allegoria è un nascondiglio: dell’invisibile e dell’indicibile… dà visibilità all’invisi bile nascondendolo e mettendoci sulle sue tracce».17
I personaggi dei romanzi di Némirovsky sono esuli, orfani, fug giaschi, persone esperte nella perdita di tutto, anche dell’essenziale; persone che si trovano a vivere situazioni di estraneità, abbandono, malattia, cadute improvvise, arricchimenti altrettanto imprevisti, di fronte e in mezzo al rischio, a volte evitato, altre affrontato con l’at teggiamento del soldato, in lotta con se stesso e i demoni del suo destino. Sono ebrei, levantini, francesi, americani, europei, russi, persone accomunate da una stessa ferita, quella dell’umanità orfana, descritta così da María Zambrano: «Non avere un posto nel mondo, né geografico, né sociale, né politico, né… ontologico. Non essere nessuno, nemmeno un mendico… non essere nulla».18
Irène Némirovsky narra con la precisione dello storico nella ri costruzione temporale dei fatti e scrive con l’atteggiamento della scienziata nell’analisi antropologica, geografica, botanica, economi ca, finanziaria e sociale delle diverse situazioni che racconta; non è mai vaga nella narrazione: città, vie, piazze, stagioni, ore, menu, flora, fauna, abbigliamento, tutto ha il suo nome preciso e avviene in un’ora determinata, sotto un cielo ben descritto e in una natura cantata. I personaggi sono inseriti nel contesto in modo così appro priato, che qualche pagina sembra una fotografia o un documento storico, perché la scrittrice racconta fatti che conosce bene, che ha studiato a lungo, su cui ha meditato, le città e i Paesi dove ha abitato,
17 Ivi, pp. 69-71.
18 M. Zambrano, I beati, SE, Milano, 2010, p. 35.
16 Cara
Irène
le strade che ha attraversato, i caffè dove si è fermata, le spiagge che ha frequentato e le persone che ha incontrato.
Come i grandi scrittori – Primo Levi, solo per citare un nome –il suo scopo è entrare dentro l’umanità, a cui appartiene anche chi legge, e narrare fatti quotidiani che odorano di vita, come se stessero accadendo proprio in quel momento. Come nelle opere di Caravag gio, le cui figure sembrano prendere vita uscendo dal buio che le circonda, un buio nero e denso come il sangue rappreso di una ferita. Anche se le storie narrate in questo libro si svolgono nel decennio successivo alla Prima guerra mondiale, le tematiche sollevate sono quanto mai vicine alla contemporaneità e si riannodano al bi sogno primario del bene dell’essere umano, il più delle volte tradito, cominciando dal concepimento, dalla nascita e dalla relazione pri maria con la madre, i genitori, l’intera storia familiare. Una relazio ne uguale a una ferita sanguinante, presente fin dalle prime pagine della Bibbia, che si aprono con il sangue di Abele, per l’appunto, pagine, però, che in Esodo 13 avvertono come il sangue della stessa ferita di esuli può trasformarsi in occasione di liberazione: «il san gue sulle case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore». Una visione del sangue confermata dall’esperienza di Gesù nelle pa gine dei Vangeli. L’intera opera di Némirovsky è la narrazione di questo bisogno dell’umanità, dall’infanzia alla vecchiaia, raccontato nelle situazioni in cui è oltraggiato e strozzato da altri bisogni. Ogni storia narra le conseguenze che questo oltraggio determina nell’individuo, una volta diventato adulto. È questa “la ferita” ed è questo il sangue che accomuna tutti i personaggi, che rappresentano l’intera umanità. Ogni individuo, però, vive la stessa ferita in modo personale: chi la accetta e la riconosce, costruisce un’altra realtà, immagina un altro mondo, si appassiona e magari crea, come artista, o da mercante,
17
Prefazione
oppure da finanziere, comunque lotta e risorge, passando ad altri un testimone, vitale da continuare; trasforma la ferita in un’apertura, una possibilità, una feritoia; non si ferma davanti al muro ma intravede una soglia, la sua soglia, il suo passaggio; agisce per conquistare la libertà. «L’uomo non può essere libero se non sa di essere soggetto alla necessità, perché la sua libertà è sempre guadagnata nei suoi tentativi mai pienamente riusciti di liberarsi dalla necessità».19
Chi vive la crisi, grida, alza le mani, le apre e non le chiude in un pugno, anzi, morendo consegna il suo messaggio a un altro, giova ne come è stato lui, come fa David Golder. «Il difetto cambiato in profitto» dice Jacopone da Todi nella sua Laude. Hannah Arendt afferma che questa azione umana somiglia a un miracolo, perché «se lasciate a se stesse, le faccende umane possono solo seguire la legge della mortalità, che è la più certa e implacabile legge di una vita spesa tra la nascita e la morte».20 Agendo, secondo Arendt, gli esseri umani cominciano qualcosa di nuovo e questa loro facoltà «ricorda in permanenza che gli uomini, anche se devono morire, non sono nati per morire, ma per incominciare».21 Un riuscito “radicamento” lo considera Simone Weil, contemporanea di Némirovsky, secondo la profezia di Isaia (53,2): «È cresciuto come un virgulto davanti lui / e come una radice in terra arida». Una radice che, se manca, diventa “sradicamento”22 in chi, invece, nega la ferita, non riconosce quel sangue, non lo cura, non lo trasforma in parole, canto, grido. Fissandosi in una falsa immagine di sé, costui diventa un nemico di se stesso, distrugge e si distrugge portando il suo destino verso
19 H. Arendt, Vita activa, Bompiani, Milano, 1994, p. 86.
20 Ivi, p. 182.
21 Ibidem.
22 S. Weil, La prima radice, SE, Milano, 1990.
18 Cara
Irène
la morte, come fa Christophe Bhun. Il sangue di questa ferita è un fiume che scorre all’interno dell’essere, attraversa tutti i luoghi, mo difica percorsi, portata, paesaggi e alimenta l’umanità e la sua storia: è il suo segreto. Segreto legato alla «sacralità del nascosto, cioè alla nascita e alla morte… una sfera che deve rimanere nascosta… segreta, perché l’uomo non sa dove va dal momento in cui nasce e dove va quando muore».23
Questo spirito governa l’anima nascosta dell’opera di Némirovsky ed emerge allo scoperto, come scrive Albert Camus nella premessa alla riedizione di Il rovescio e il diritto: «In fondo a se stesso ogni artista custodisce in tal modo un’unica sorgente che nel corso del la vita alimenta quel ch’egli è e quello che dice».24 Una sorgente sotterranea che Némirovsky porta allo scoperto attraverso la scrit tura di storie, dove sono rintracciabili i dati storici e biografici del personaggio: quando, dove e come è nato; chi sono la madre, il pa dre, gli avi e la qualità dei rapporti che li legano; il periodo storico, l’ambiente sociale e l’educazione ricevuta. Dati necessari per tessere un racconto il più possibile concreto e pulsante di vita, nato dalle domande di fondo sul male, la vita, la morte, l’amore e il dolore, do mande senza risposta, materia vivente, sanguinante, da vivere, anche se non si può capire.
Le storie narrate sono creature che nascono da questo sangue, come quelle della Bibbia e di tutte le opere d’arte, tanto che non sembra assurda, vista con occhi laici, la storia di Gesù, l’Ecce homo, che eccelle in consapevolezza e in amore. Egli non chiede il sangue di nessuno, anzi versa il suo sangue, paga con la sua vita la fede in un Regno di Dio: terra nuova, cieli nuovi, in continuità con ogni pagina
23 H. Arendt, Vita activa, cit., p. 46.
24 A. Camus, Il rovescio e il diritto, Milano, Bompiani, 1958.
19
Prefazione
dei Vangeli: «L’immenso, l’incessante invito all’ultima liberazione che è oblio totale di sé».25
Sua madre, Maria di Nazareth, che l’ha partorito, non può essere che ai piedi della croce, non tanto per la “contiguità donna-san gue”, quanto per rovesciare quella tradizione, come afferma Cettina Militello: «Ai piedi della croce Maria è testimone alle nozze di san gue che, rovesciando il simbolo culturale, vedono lo sposo rovesciare il sangue».26
Simone Weil individua una relazione tra questa decisione e quel la che prende Antigone: «Ben lungi dall’avere qualcosa in comune con un qualche diritto o con qualcosa di naturale, non era altro che l’amore estremo, assurdo che ha spinto Cristo sulla croce».27
Etty Hillesum fa lo stesso nel campo di concentramento, dove è rinchiusa e dove morirà, quando scrive: «Dio non è responsabile verso di noi, siamo noi a esserlo verso di lui… Se Dio non mi aiuterà più, allora sarò io ad aiutare Dio… aiutare Dio il più possibile e se questo mi riuscirà bene, allora vuol dire che saprò esserci anche per gli altri».28
Irène Némirovsky è una scrittrice forte, coraggiosa, profonda, capace di leggerezza e di tenerezza; si pone davanti e dentro la vita e i suoi inspiegabili segreti senza paura, senza riserve, senza dimen ticare niente e nessuno; racconta il mondo che si vede e intuisce l’invisibile in tutti gli aspetti, dai più teneri a quelli terribili, usando il linguaggio e lo stile più adatto, dall’ironico al lirico, dal sarcastico al comico, dal realistico al sognante, laico, eppure spirituale; non
25
C. Campo, Gli imperdonabili, cit., p. 110.
26
C. Militello, Maria con occhi di donna, San Paolo, Milano, 2019, p.73.
27
S. Weil, La persona e il sacro. Morale e letteratura, ETS edizioni, Pisa, 1990, p. 50.
28
E. Hillesum, Diario 1941-43, Adelphi, Milano, 1996, p. 134.
20
Cara Irène
indietreggia davanti al peggio dell’esistenza ma lo attraversa per po terlo narrare con onestà, senza giudicare. E consegna questa materia viva, pulsante come il sangue, al lettore, rendendolo libero di provare tutta la gamma emotiva e riflessiva dell’esperienza umana, dove la pietà e la compassione occupano il primo posto.
Certo la sua ricerca è stata interrotta, contro la sua volontà, nel luglio 1942 quando, in quanto apolide,29 è stata deportata dai nazisti ad Auschwitz, dove è morta nel mese di agosto. Non ha potuto ter minare la sua Commedia, come invece ha potuto fare Dante, che ha conosciuto l’inferno, ma ha cantato anche il paradiso. Sicuramen te Némirovsky avrebbe desiderato narrare la risalita dall’inferno, come si comprende da alcuni personaggi (Rachele, la figlia del dro ghiere in Il bambino prodigio, Tat’jana Ivanovna in Come le mosche d’autunno, la domestica Clemence in La moglie di don Giovanni, Marianne e Antoine in Due, Ada in I cani e i lupi, Agnès e Pierre in I doni della vita, la signora Pain in I falò d’autunno, i coniugi Michaud in Suite francese…) che dimostrano la possibilità della risalita nella quotidianità, senza essere riconosciuti eroi e senza cancellare la feri ta dell’essere e dell’esistere.
La scrittrice aveva in progetto una trilogia, di cui abbiamo solo il primo volume, Suite francese, una trilogia che forse voleva fare il verso alla Commedia, oppure a Shahrazad, che con le sue Mille e una notte è riuscita a rimandare la morte, convertire il nemico e rovesciare il destino. Infatti, si domanda Cristina Campo: «A chi va nelle fiabe la sorte meravigliosa? A colui che senza speranza si affida all’insperabile. Vince nella fiaba il folle che ragiona a rove
29 Scrive Hannah Arendt: «Gli esperti di diritto approntarono leggi per rendere apolidi le vittime, il che era molto importante per due ragioni: nessun paese poteva indagare sul loro destino, e lo Stato in cui risiedevano poteva confiscare i loro beni» Cfr. H. Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, Milano, 1992, p. 123.
21
Prefazione
scio. Crede, costui, come il santo, al cammino sulle acque, alle mura traversate da uno spirito ardente. Crede come il poeta, alla parola: crea dunque con essa, ne trae concreti prodigi… Al termine della sua discesa agli inferi, della sua salita al Carmelo lo attende la misura traboccante, il mondo per soprammercato».30
Anche se Némirovsky, vittima dei nazisti, la cui folle ideologia ha distrutto le migliori menti del tempo, non è riuscita a portare a termine il suo lavoro, ci ha lasciato i suoi scritti, la sua parola, ric ca di sapere e di un sapore narrativo «di intensità quasi straziante: che forse unisce in sé quello dell’ultima, tiepida acqua prenatale, già mischiata alla cruda aria del mondo, e quello stranamente ferale dell’acqua dolce che diviene salata all’estuario».31
Ogni pagina di Némirovsky è simile a un tappeto speciale di «un’orditura incessante di tali attimi inafferrabili, fissati al loro mas simo splendore»;32 l’autrice vi racconta l’oggi, lo ieri e il per sem pre: un «ritmo eterno proprio della fiaba come di tutti quegli scritti spirituali che prestano e riprendono di continuo alla fiaba le sue esatte iperboli, i suoi precisi impossibili».33 Una pagina, quella di Némirovsky, che racconta solo a chi ha occhi per vedere «affinchè dalla vista si sollevi alla percezione. Percepire è riconoscere ciò che soltanto ha valore, ciò che soltanto esiste veramente. E che altro veramente esiste in questo mondo se non ciò che non è di questo mondo?»34 Nella pagina di Némirovsky, come in un tappeto si uni ficano «i diversi piani della vita, per farne una miniatura squisita mente completa… che nessuna cosa esclude purché sia contemplata
30
C. Campo, Gli imperdonabili, cit., p. 41.
31 Ivi, p. 23.
32 Ivi, p. 21.
33 Ibidem. 34 C. Campo, Gli imperdonabili, cit., p. 10.
22
Cara Irène
al suo massimo di purezza stilistica»;35 «un sempre in un microsco pico spazio… che non tratta ostinatamente che del reale e soltanto in virtù del reale tocca le geometrie dello spirito, le matematiche contemplative… sensi e oltresensi… e in essi ciascuno… leggerà il messaggio destinato a lui e a nessun altro».36
L’invisibile nella scrittura di Némirovsky compare in ogni ro manzo e lascia qualche traccia nelle pagine, come i sassolini che l’e roe delle fiabe butta per terra per non perdersi, attraverso il colore rosso. Colore mutevole, che va dal rosa vivace al blu scuro, fino al nero; colore del sangue, delle ferite, della violenza, del potere, della ribellione, della rivoluzione, della morte e della resurrezione. Simbolo della vita. La pagina di Némirovsky, scritta con la massima attenzione creativa nei confronti della realtà e della vita, come quel tappeto, alla fine chiede e risveglia in chi legge quel che è indicato già nel Talmud come l’essenziale: «Egli chiede agli uomini il cuo re».37 Lo stesso sostiene la contemplazione bizantina: «discendere dentro il proprio cuore, riportare la mente nel cuore, ricondurre l’attenzione della mente nel cuore, perché là dentro dimora Iddio e là dentro bisogna incontrarlo».38
Uno stile ardente
I romanzi di Irène Némirovsky costituiscono una pietra miliare nella letteratura, prima di tutto, per lo stile: un concentrato di intel
35 Ivi, p. 63
36 Ivi, pp. 64-65.
37 J. G. Langer, Eros nella Cabbalà. Il mistero dell’amore: mistica e psicologia del profondo, La parola, Roma, 2007, p. 195.
38 C. Campo, Gli imperdonabili, cit., p. 229.
23
Prefazione
ligenza, mestiere, competenza, passione, arte. La scrittrice rispetta il suo lavoro e chi lo legge, vi si dedica con la massima attenzione, come chi costruisce una casa, cercando di soddisfare tutti i bisogni di chi l’abiterà, senza tradire, anzi, esaltando le proprie capacità ar tistiche, perché l’attenzione è una «lettura su molteplici piani della realtà intorno a noi che è verità in figure»39 e l’artista «che scioglie e ricompone quelle figure, è anch’egli un mediatore: tra l’uomo e il dio, tra l’uomo e l’altro uomo, tra l’uomo e le regole segrete della natura».40
Lo stile della scrittura di Némirovsky, perciò, non somiglia a una casa qualunque, né a un appartamento, bensì rimanda a una di quelle costruzioni solide, antiche, più simili a un palazzetto, pensato per durare anni, secoli, magari per sempre. Una casa di diversi pia ni, non solo quelli abitati di giorno e quelli per la notte, ma anche quelli destinati alle cantine, alle stalle, ai ripostigli, alle soffitte e alle dispense; ogni stanza ha una funzione autonoma, una vita a sé, ma, nello stesso tempo, è parte integrante e integrata all’intera costruzio ne. È una casa per molte persone: i proprietari e, di più, quelle che li aiutano nelle tante attività quotidiane all’interno e fuori; uno spazio che brulica di voci umane e animali: cani e gatti, tanti uccelli, inset ti e animali da cortile, nel giardino e nell’orto; gli ambienti interni sono arredati con pochi mobili di legno buono e di fattura maestra, dove si ripongono stoviglie e corredi di materiali nobili; colpisce l’abbondanza e la ricchezza essenziale degli utensili in cucina, nei ripostigli, nelle soffitte e in cantina. È una casa per diverse gene razioni, dai bisnonni ai nipoti e in giardino, coltivato anche a orto, crescono grandi cespugli di lillà e di rose profumate, fra gli alberi da
39 Ivi, p. 166. 40 Ibidem.
24 Cara
Irène
frutto. Lo stile di Némirovsky fa pensare a una casa così e, chi legge i suoi romanzi, ha l’impressione di poter entrare con grande libertà nei luoghi di questa dimora, come se Irène non ci fosse, come se nessuna porta fosse chiusa, come se lo stile della scrittrice costituis se una chiave speciale, capace di aprire ogni uscio per le proprietà della parola, come una bacchetta magica: apriti sesamo! Chi legge si sente presente e invisibile, può entrare ovunque senza essere visto: può ascoltare i dialoghi che vi si intrecciano, percepire i pensieri na scosti nella mente e nel cuore di tutti quelli che vi abitano o vi hanno abitato, osservare i comportamenti di chi si sente solo e libero di fare quello che desidera, trovarsi a tu per tu con il bene e con male, le gioie e le sofferenze, le meschinità e le virtù; può guardare dentro gli armadi, osservare quello che succede fuori, attraversare muri, provare lo stupore e la meraviglia di chi conosce il fare quotidiano e segreto di ogni vivente; arriva persino a immaginare che quegli spazi determinati e quel tempo storico, diversi dal presente di chi legge, siano una sintesi di vita umana e che rappresentino anche la propria. Quel palazzetto è la casa della vita. Mentre vanno avanti nella lettura, quella lettrice e quel lettore, pur lasciati liberi, in com pagnia solo delle cose, degli animali, dell’ambiente naturale e delle persone, che agiscono nelle pagine senza nessuna presenza da parte della scrittrice, avvertono crescere calore nel cuore, come davanti a un fuoco nel focolare, che arde con fiamme vive, luminose, costanti, sicure, dai colori decisi, come il rosso con tutte le sue sfumature: lo stile ardente di Némirovsky.
Chi legge e rilegge i suoi romanzi, si rende conto che lo stile è uno e che si basa su cinque colonne portanti: l’invisibilità di chi scri ve, la tecnica del dialogo, la funzione del primo capitolo, l’autono mia di ogni capitolo e la descrizione del paesaggio. L’autrice, nello scrivere un romanzo, sembra tesa, più di tutto, a scomparire: narra
25
Prefazione
senza esserci, con una presenza che è uguale all’assenza. «Assenza, assenza, più acuta presenza» canta Attilio Bertolucci. E Némirovsky sa come rimanere invisibile, possiede l’arte della dissolvenza e della spoliazione, della privazione e della perdita, quasi la sua vocazione fosse procedere all’indietro, come un passo di danza che crea spazio e vuoto, come se il suo destino di scrittrice si realizzasse fuggendo nel deserto e nel silenzio, dove si può percepire anche il più leggero soffio d’aria, simile a un tenero alito, come insegna il profeta Elia nella Bibbia. La narrazione, poi, procede attraverso i dialoghi dei personaggi tra loro e di ognuno con se stesso, come se la storia venisse raccontata dai suoi protagonisti. Le frasi del dialogo sono brevi, secche, decisive, formulate con parole appropriate al conte sto, al linguaggio e al carattere del personaggio, per cui chi legge comprende con immediatezza tanto la situazione quanto la persona.
In ogni romanzo, comunque, la prima pagina e il primo capitolo hanno la funzione generale di introdurre la storia, quasi costituissero l’ingresso del palazzetto prima descritto, ma, nello stesso tempo con tengono gli elementi di una sintesi dell’intero romanzo, tanto che, leggendo attentamente, si possono prevedere l’argomento centrale e i suoi personaggi principali. Come quando si entra in una casa con rispetto e attenzione dei particolari e si ha una prima impressione sull’intera abitazione, impressione che verrà confermata dalla visita di tutte le altre stanze. Questo accade perché la nostra autrice non vuole attrarre il lettore con un linguaggio imbellettato, dilatato, in concludente, lasciando l’essenziale al dopo o al mai, proprio di ogni procedimento seduttivo, ma, al contrario, usa espressioni sintetiche, animata da sincera attenzione, che quando è vera «non conduce, come potrebbe sembrare, all’analisi, ma alla sintesi che la risolve al simbolo e alla figura, in una parola al destino… L’attenzione è il solo cammino verso l’inesprimibile, la sola strada al mistero. Infatti è so
26
Cara Irène
lidamente ancorata al reale e soltanto per allusioni celate nel reale si manifesta il mistero. L’attenzione sollecita e prepara: come il paraful mine il fulmine, come la preghiera il miracolo, come la ricerca di una rima l’ispirazione che proprio da quella rima potrà sgorgare… Opera una scomposizione e una composizione del mondo».41
Con questo atteggiamento Irène Némirovsky, fin dalla prima pagina, mette in chiaro, sinteticamente, il fulcro principale della storia, quasi stabilisse dei patti chiari con chi legge, mettendolo a conoscenza del tema, della mappa e dei compagni di un viaggio, che arriverà di sicuro a qualche destinazione, solo se chi scrive e chi leg ge procedono insieme: «Quale misteriosa confidenza lega il grande scrittore al suo lettore e quale abisso lo separa da lui».42
La terza colonna dello stile di Némirovsky è l’autonomia di ogni singolo capitolo, all’interno dell’intero romanzo, oppure di una par te. Chi legge prova doppia soddisfazione al termine di ogni capitolo, perché da un lato si è arricchito di nuovi particolari, necessari per la trama di una storia, che rendono chi legge più consapevole, aumen tando il livello di conoscenza e il suo desiderio di continuare la lettu ra; ma la lettrice o il lettore, per un altro verso, sono presi anche dal desiderio di fermarsi e di assaporare quella soddisfazione; è una sorta di tentazione di una pausa, la stessa che si prova dopo aver letto una novella o un breve racconto, che in poche pagine riescono a dare un sentire compiuto, procurando una forma di pienezza. Una maestria tutta propria della nostra scrittrice, maturata, forse, dalle tante let ture dei grandi della letteratura, Čechov in primis. Ma, guardando la cosa dal punto di vista della lettrice o del lettore, si comprende che nel leggere un intero romanzo o più opere della stessa autrice, o
41 Ivi, pp. 167-168.
42 Ivi, p. 153.
27
Prefazione
addirittura tutta la sua opera, quella lettrice o quel lettore fanno nu merose esperienze di queste pause di doppia soddisfazione, pause valide per se stesse, ma anche per quelle innumerevoli possibilità di riflessioni e pensieri conseguenti, provocati nel segreto di chi legge, capaci di aiutare ad accettare la realtà, per quello che è, e utili, nello stesso tempo, a immaginare qualcosa che superi la legge di necessità e le forze che governano il mondo. Contribuisce ad arricchire queste pause, l’ultima colonna dello stile della nostra autrice, ultima delle quattro elencate, ma identica per importanza alle altre: la descrizione del paesaggio. Anche questo elemento, così presente nei romanzi in generale, in Némirovsky acquista un rilievo particolare perché è, per lo più, affidato al punto di vista del personaggio e può accadere che una strada di Parigi, una piazza di Nizza, i festeggiamenti per la festa della Repubblica, un porto ucraino, un ponte o un palazzo di Pietroburgo, le spiagge di Biarritz, di Hendaye o di Wimereux, il bosco de La Coudre a Saint-Elme in Normandia e tutti i giardini raccontati, vengano descritti in modo diverso, se visti con lo sguar do di un bambino, oppure quello di una ragazza esule, o quello di una borghese parigina, pur se il luogo è lo stesso. La descrizione del paesaggio, come le pagine dedicate al ballo, al sogno e alla presenza dello specchio, hanno una funzione di pausa narrativa, all’interno del racconto, denso di dialoghi spesso conflittuali o di monologhi altrettanto complessi, sull’esistenza in generale, partendo da quella individuale del personaggio. In quei luoghi il tempo e gli accadi menti della storia sembrano interrompersi, intrappolati nel tempo lungo delle fronde, dei profumi, dello scorrere dell’acqua, dell’erba alta, dei riflessi di uno specchio, del fango di una pozzanghera, in mezzo a un’estensione inimmaginabile, lungo sentieri senza fine, in una luce troppo accesa o improvvisamente spenta, in mezzo a mille altre atmosfere, che uno sguardo sa percepire nell’ambiente in cui si
28 Cara
Irène
viene a trovare. La molteplicità dei punti di vista, però, non rompe la compattezza della narrazione, perché chi legge ha l’impressione di essere davanti a una descrizione del paesaggio, che appartiene comunque alla scrittrice, anche se è attribuita al personaggio del momento e del romanzo. La funzione di pausa, che acquista ogni descrizione all’interno di ciascun romanzo, è dovuta alla circolarità che rappresenta: una situazione viene descritta dal personaggio che la vive, secondo le modalità creative della scrittrice. Una circolari tà sulla pagina, come quella di una piazzetta, dove chi legge viene invitato a fermarsi, insieme al personaggio, che si esprime con la guida maestra della scrittrice. Chi legge prova un sentire pieno in quello che fa: conosce un ambiente, come lo guarda il personaggio, la visione nascosta della scrittrice e, contemporaneamente, ritrova in sé particolari che lo riguardano nel suo rapporto personale con l’ambiente esterno. Un momento di pausa, appunto, un incontro coinvolgente e, solo dopo, scrittrice, personaggio e lettore o lettri ce riprenderanno il cammino della storia con maggiore energia e consapevolezza, ciascuno nel suo ruolo. È evidente che le descrizio ni del paesaggio non compaiono a caso, ma sono posizionate dalla scrittrice nel momento più strategico, ai fini della narrazione, mo mento che sempre coincide con il normale fare delle persone, degli animali, delle cose e della vita. È questa l’arte di Némirovsky.
Definire le fondamenta nascoste dello stile della nostra autri ce, capirne e delinearne tutti gli ingredienti, che lo fanno ardente, non è dato conoscere a una comune lettrice, come la sottoscritta; si può tentare, però, di invadere l’intimità dell’intuizione creativa della scrittrice, con l’aiuto dell’autrice stessa, attraverso il libro, da lei dedicato alla vita e alle opere di Čechov,43 in cui Némirovsky
43
29
Prefazione
Irène Némirovsky, La vita di Čechov, Castelvecchi, Roma, 2012.
sembra specchiarsi. Anton Čechov infatti, suo conterraneo, appar tiene come lei alla schiera degli autori che hanno avuto una infanzia infelice, alla Dickens, ma diversamente dall’autore inglese, la nostra autrice sottolinea come il piccolo Anton cerca e trova dappertutto briciole di felicità… si divertiva a guardare la gente, ad ascoltarla.44 Questo comportamento infantile diventa di fatto l’atteggiamento alla base del tono tra il piacevole e il triste45 di ogni scritto di Čechov, a cominciare dalle lettere ai familiari e agli amici, fino ai racconti e alle opere che lo hanno reso famoso. Questo tono caratterizza anche gli scritti di Némirovsky, per cui chi legge ha l’impressione di entrare dentro una realtà quotidiana con il passo leggero della normalità, osservando particolari che aprono anche il sorriso nello sguardo, lontano da qualsiasi pregiu dizio o giudizio. Nel libro su Čechov, poi, l’autrice riporta, da una lettera, una frase della madre dello scrittore, ancora studente: Solo lui ha pietà di me;46 frase che può essere letta come un indizio per individuare il sentimento nascosto, ma prevalente, che accompagna la scrittura di Némirovsky e che le permette di mantenere l’equili brio tra la distanza e la partecipazione nei confronti della materia narrativa: la pietà per i viventi.
Descrivendo la Russia degli ultimi anni dell’Ottocento vissuti da Čechov, Irène Némirovsky ritrae con precisione quella società e adopera espressioni valide anche al suo tempo, gli Anni Venti-Tren ta del Novecento, fino a noi, gente del Duemila: tutto era meschino, gretto, compenetrato di mediocrità. Si era in attesa dello scrittore che avrebbe parlato di quella mediocrità senza collera, senza disgusto, ma
44 Ivi, p. 24.
45 Ivi, p. 49.
46 Ivi, p. 50.
30 Cara
Irène
con la pietà che meritava.47 Se Čechov è quello scrittore atteso a fine Ottocento, la scrittrice capace di dare voce a quella mediocrità senza collera, senza disgusto, ma con pietà nei confronti dell’umanità, nei primi decenni del Novecento, è Irène Némirovsky. La strada mae stra, tracciata dallo scrittore russo, per riuscire in questo impegno è la stessa percorsa dalla nostra: quel segreto: scegliere il quotidiano dei giorni, l’ordinario e non l’eccezionale.48
Sì, Némirosky è presente nelle strade, come nei viottoli più re conditi della realtà che narra, a partire dal basso e dal nascosto, come un mollusco, come una chiocciola, invisibile agli occhi dei più, che assume sul suo guscio il peso dell’ordinarietà della vita e che comunica col mondo attraverso le sue piccole antenne. Certo, non basta l’istinto, alla scrittrice serve la parola, e per conoscere il crite rio di scelta delle sue espressioni, è utile l’osservazione sullo stile di Čechov, che semplicità, concisione, pudore, ecco quello che importava prima di tutto. Suggerire e non spiegare. Condurre la narrazione con schiettezza e lentezza.49 Poche righe dense, che esprimono la materia, propria delle colonne portanti dello stile, tanto di lui che di lei: scrit tura come disegno artistico; arte che richiede meditazione continua, riflessione, volontà, determinazione, virtù forti e amiche dell’istinto, per arrivare a elaborare e scrivere un testo semplice, costruito con frasi brevi, che suggeriscono, senza dare lunghe spiegazioni, frasi comprensibili da qualsiasi lettore tanto sono chiare, in modo che chiunque possa avvertire la schiettezza, che le sostiene. Uno stile che si affida anche a particolari tecniche di scrittura, ma che nasce da motivazioni interne, da un lavorio spirituale, da una
47 Ivi, p. 73.
48 Ivi, pp. 125-126.
49 Ivi, pp. 128-129.
31
Prefazione
ricerca dal di dentro e da esigenze personali. Può scrivere così solo chi, lungamente, lavora su se stesso e con se stesso, pulendo l’inutile e il dannoso, tenendosi stretto al timone del pudore nei confronti della propria esistenza, dell’essere a questo mondo e dell’altro da sé.
Solo da una meditazione continua e da una esperienza vissuta deriva uno scritto, le cui pagine sono esseri viventi.50
Lo stile di Némirovsky ha un’anima musicale, musica, che se condo María Zambrano, è un’arte del movimento per eccellenza, in quanto «è il sogno organizzato, il sogno che, senza cessare di esserlo, è passato per il tempo e ha imparato dal tempo, ha messo a frutto il tempo».51
Quest’eco musicale risuona in chi legge le pagine di Némirovsky: la sua intelligenza narrativa è più vicina a quella di un composito re come Vivaldi, di uno scultore come Michelangelo, di un pittore come Caravaggio e di una poetessa come Amelia Rosselli, che con il loro lavoro danno forma e voce a una storia e a chi la vive, cercan do di tenere presenti tutti gli elementi e di rappresentarli come si muovono nelle quotidiane esistenze, con l’aggiunta di un personale punto di vista artistico, capace di sconvolgere quegli elementi e di disporli in modo inedito, tanto che il profano che guarda, ascolta o legge, scopre una ricchezza di pensieri, azioni, sentimenti, anche in se stesso, fino ad allora non previsti nella sua esperienza.
Leggere i romanzi di Némirovsky è come ascoltare Le quattro sta gioni, come guardare La Pietà Rondanini e insieme cantare La libel lula; rileggere arricchisce: la sua arte stimola, inquieta e, inspiegabil mente, nello stesso tempo dà pace, perché il suo stile rivela e lenisce: esprime anche il lato oscuro di pochi personaggi, fino al dramma e
50 Ivi, p. 125.
51 M. Zambrano, I beati, cit., p. 115.
32
Cara Irène
alla tragedia, ma quei pochi rappresentano tutti; sono le figure della condizione umana. Le sue storie presentano una molteplicità di si tuazioni, per lo più conflittuali, in vari Paesi e con persone diverse per età e per ambiente, che conducono chi legge entro dinamiche psicologiche, sociali, economiche e storiche, proprie dell’esistenza di altri esseri umani; una lettura che, invece di aiutare il lettore a dimenticare i suoi problemi, lo spingono verso domande, a partire dal testo, verso il senso dell’essere e dell’esistere, e lo avviano a una comprensione migliore di se stesso e della condizione umana. Con il procedere delle letture e, quindi, della familiarità, della conoscenza (mai abitudine), nei confronti dello stile narrativo di Némirovsky, quello che all’inizio poteva sembrare un limite stilisti co, come il ripetuto uso degli aggettivi o del lemma “sangue”, poi di venta ricchezza espressiva: gli aggettivi, così appropriati, contribui scono a dare valore alla narrazione e, nello stesso tempo dimostrano l’intensità e la profondità del sentire dell’autrice. Come in Leopar di. Che cosa sarebbero gli “spazi”, i “silenzi” e la “quiete”, cantati ne L’infinito, senza i relativi aggettivi: “interminati”, “sovrumani”, “profondissima”?! Sono proprio questi ultimi a qualificare la mate ria poetica, corrispondente al sentire del poeta, che dal punto di vi sta filosofico giudica “matrigna” quella natura, che canta con tanta passione. Una contraddizione? Leggendo i romanzi di Némirovsky si comprende che contraddizione non c’è; i suoi lavori non cedono mai al sentimentalismo, non concedono niente al passatempo, sono duri e tesi a raccontare le cose come stanno, fuori e dentro: serrati, documentati, come per avvertire quanto e come la vita sia difficile, dolorosa, amara, cattiva, a cominciare dall’infanzia, fino alla vec chiaia. Eppure l’autrice racconta come chi ama al massimo questa vita, di una passione ardente, calda come il sangue di una ferita, che motiva la scelta di uno stile narrativo altrettanto ardente. Un amore
33
Prefazione
Cara Irène
che è insieme eros, philia e agape, come testimonia la sua stessa esi stenza, finita in un campo di concentramento; un amore tutto uma no, così tanto umano da diventare sacro: un fatto di vita così laico da diventare religioso. La parola sangue, che si incontra quasi in ogni pagina, costituisce un avvertimento per chi legge: spinge a riflettere sui molteplici significati che la parola acquista in base ai personaggi e alle situazioni; non è mai scritta per caso.
Il lavoro di Irène Némirovsky è accompagnato da commenti molto contraddittori da parte dei suoi contemporanei: chi, francese, la giudica con sospetto in quanto è un’ebrea russa che scrive in fran cese; chi, ebreo, la rimprovera di rappresentare gli ebrei secondo stereotipi antigiudaici, per compiacere anche i lettori francesi anti semiti; e chi la legge per curiosità, come una scrittrice tra tante, per trovare nelle sue trame un che d’esotico e d’orientaleggiante.
L’autrice, quindi, se pubblica, vende e guadagna tanto da mante nere la sua famiglia, soffre incomprensioni e fraintendimenti, come si legge nelle pagine della documentata biografia a lei dedicata da Olivier Philipponnat e Patrick Lienhardt52. L’ingiustizia più grande è la mancata cittadinanza francese a una scrittrice che ha dato lustro alla letteratura in questa lingua; forse, se avesse ottenuto quel rico noscimento i tedeschi avrebbero ritardato la decisione dell’interna mento e lei avrebbe avuto il tempo di fuggire e salvarsi. Leggere i suoi lavori è un modo per tenerla in vita, come scrive Luisa Muraro: «Un libro non è mai finito finchè continua a essere letto».53 Non solo il libro, anche chi l’ha scritto. Irène Némirovsky ha il grande potere di mettere chi legge di fronte al dolore del mondo, portando a provare nello stesso tempo la meraviglia del miracolo e della cono
52 O. Philipponnat, P. Lienhardt, La vita di Irène Némirovsky, Adelphi, Milano, 2009.
53 L. Muraro, Il Dio…, cit., p. 27.
34
scenza, come se la prosa nascondesse versi pensati da una sensibilità acuta, ardente, mistica, profetica.
Come insegna Francesco d’Assisi nel Cantico delle Creature, scritto dopo una notte di cecità, di dolore e di tormento agli occhi: la lode per tutte le creature, il sole, la terra, la luna, le stelle, il vento, l’aria, il cielo, l’acqua, il fuoco, l’essere umano e la morte. Francesco canta e loda Dio per coloro che “sostengono infirmitate e tribulazione in pace”, come dice la seconda parte del suo Cantico, importan te per capire come il dolore possa mutarsi in canto. Per Francesco «ogni cosa è creatura, parola composta da creo (da cui cresco) e un suffisso latino che indica un’azione che sta per accadere: la creatura non è “creata” una volta per tutte, ma “sta per esserlo” continua mente e in ogni istante».54
Anche Némirovsky racconta una storia senza mai dimenticare nessun elemento delle varie situazioni: natura animale, minerale, ve getale e umana; questa disponibilità nei confronti di ogni elemento, nella narrazione come nella vita, deriva dal suo amore appassionato per il nostro esistere, compreso il dolore, raccontato nella sua nar razione, non fissato, ma liberato, come se l’autrice volesse aprire la storia per darle un futuro, attraverso la creazione narrativa.
Leggere i romanzi di Némirovsky è importante, perché orienta no nel luogo e nel tempo di una situazione che somiglia a quella di trovarsi su un ponte tra passato, presente e futuro; sembra di entrare dentro uno spirito letterario, dalla Bibbia ai giorni nostri, dalla tra dizione orale a quella scritta e di godere della sintesi delle letterature e dei modi di dire di tanti Paesi: culture diverse, colte e popolari, rappresentate e rinnovate da uno spirito nuovo, capace di animare la classicità, integrare l’Oriente e l’Occidente, la fiaba infantile, la
54 A. D’Avenia, La notte di Francesco, in “Il Corriere della sera”, 14 ottobre 2019.
35
Prefazione
saggistica più matura e le suggestioni delle varie forme artistiche, in un tutto alimentato da nuove sensibilità e da un sapere inedito, vali do fino ai giorni nostri, utile a meditare sulle problematiche odierne. La scrittura di Némirovsky è colta perché riesce a inventare un linguaggio che aderisce a ogni personaggio, senza provocare squilibri narrativi; ogni personaggio si racconta da sé, esprimendo il suo punto di vista, secondo il suo modo di pensare, di fare e di parlare, all’interno di una struttura dialogica essenziale, tanto che la lettrice o il lettore si sentono coinvolti e non vogliono perdere una battuta, per capire il più possibile del detto e del non detto. Come in tea tro. In più, nei romanzi della scrittrice attraggono le descrizioni del paesaggio, delle stagioni e delle manifestazioni atmosferiche, insie me alle citazioni letterarie, ai proverbi, ai detti popolari e alle com parazioni, che movimentano i dialoghi e stabiliscono una continuità tra l’agire e il pensare umano con quello animale e con eventi na turali. Come se la scrittrice riconoscesse l’unità intrinseca di tutto ciò che è, convinta dell’appartenenza alla natura da parte dell’essere umano e come se scrivere per lei significasse ricercare nel linguaggio e nelle parole i sentieri più nascosti della conoscenza, attraverso i quali avvicinarsi alle leggi principali di quella unica natura.
In tempi di gravi preoccupazioni per i cambiamenti climatici e, soprattutto, per la pandemia da Covid, come quelli che stiamo vivendo, l’atteggiamento artistico di Némirovsky diventa profetico e suggerisce come e quanto gli esseri umani possano contribuire a migliorare o a distruggere questo mondo.
Per esprimere un pensiero, a chiusura di un discorso intorno allo stile di Irène Némirovsky, è d’aiuto il concetto di “sprezzatura”, che Cristina Campo considera una caratteristica dei più grandi artisti, dei santi e dello stesso Gesù Cristo: «La sprezzatura è un ritmo mo rale, è la musica di una grazia interiore, è il tempo… nel quale si
36 Cara
Irène
manifesta la compiuta libertà di un destino, inflessibilmente misura ta, tuttavia, su un’ascesi coperta… è briosa, gentile impenetrabilità all’altrui violenza e bassezza… profonda riverenza per il più alto che sé e per le forme impalpabili, ardimentose, indicibilmente prezio se, che quaggiù ne siano figura – la bellezza, innanzitutto, interiore prima che visibile, l’animo grande che ne è radice e l’umor lieto».55
55 C. Campo, Gli imperdonabili, cit., p. 100.
37
Prefazione
Stampato per conto di Carlo Gallucci editore srl presso Rotolito spa (Pioltello, MI) nel mese di novembre 2022
Marilena Menicucci è nata e ha studiato a Perugia, dove è stata allieva di Aldo Capi tini. Collaboratrice negli anni del “Corriere della Sera”, “Il Messaggero”, “Paese Sera”, ha scritto poesie, saggi e raccolte di testi monianze, con una particolare attenzione all’universo femminile. Con Gallucci ha pubblicato La do menica delle donne e Kalekalè. Storia di un’adozione (in ver sione ePub), il manuale di stile Presi per i capelli e le raccolte di poesie Senza punto , Fare il verso , A Trieste .

UN RITRATTO LETTERARIO DELLA PIÙ GRANDE SCRITTRICE UCRAINA
Concepito come una lettera indirizzata direttamente a Irène Némirovsky, Cara Irène è un dialogo intimo con le parole dell’au trice, scomparsa ad Auschwitz nel 1942. Intuizioni interpretative e suggestioni personali si mescolano per comporre l’omaggio di una lettrice all’opera ammirata, frequentata, meditata della scrittrice ucraina naturalizzata francese. Temi e trame dei romanzi sono ri vissuti e osservati sotto la lente delle emozioni, in uno straordina rio diario di lettura. “I personaggi dei romanzi di Némirovsky sono esuli, orfani, fuggiaschi, persone esperte nella perdita di tutto, anche dell’essenziale; persone che si tro vano a vivere situazioni di estraneità, abbandono, cadute improvvise, arricchimenti altrettanto impre visti. Sono persone accomunate da una stessa ferita, quella dell’umanità orfana”.