Dakota Jones
L’uomo del destino immortalato in una foto, la prima ultramaratona a soli 18 anni e l’incredibile carriera tra successi e passione.
Colorado Ultrarunning
Un viaggio nel cuore del Colorado, tra ferrovie, città fantasma, miniere e praterie alla scoperta di come l’ultrarunning ha cambiato il West.

Queen Jasmin Paris
100 miglia, 59 ore, 58 minuti e 21 secondi. La leggendaria Barkley Marathons ha incoronato finalmente la sua regina.
ISSN 83167269 9HRSDLG*hcgaag+[E\K\K\G\G Aprile €7.00 2024 BIMESTRALE P.I. 18 APRILE 2024


EDITO
BY DAVIDE FIORASO PHOTO JORDAN MANOUKIAN

Questo editoriale mi ha fatto riscoprire il piacere della scrittura lenta, di quel rapporto privilegiato e diretto tra mano e mente che permette di tradurre qualunque variazione di pensiero o stato d’animo. Da quanto tempo non mi capitava. Sono rannicchiato su una scomoda poltroncina dell’aeroporto di Arrecife, mentre un monitor annuncia impietosamente “Delayed” nel volo che mi riporterà a casa. Sono nel luogo dell’attesa per antonomasia, uno spazio che più di ogni altro riesce a dare consistenza al passare del tempo. In queste zone di transito ci comportiamo tutti allo stesso modo: lo sguardo che non riesce a evitare l’orologio, la ricerca instancabile di nuove distrazioni che possano alleviare il peso dei minuti, e che spesso ci vengono offerte senza nemmeno chiederle. Facciamo di tutto, in sostanza, per trasformare i luoghi dell’attesa nel loro opposto: luoghi di svago, intrattenimento, o perché no, di lavoro, negando così la loro funzione principale. Siamo del tutto incapaci di aspettare e basta. A
pensarci ho preferito anch’io fuggire l’attesa con la ricerca di un antidoto, invece che viverla. Volevo basare le mie parole su questo e, invece, carta e penna mi hanno sollecitato l’immaginario. Mi hanno stimolato a farvi conoscere una persona: Cesar Manrique, una grande mente creativa che riesce ogni volta a plasmare i miei ritorni su questa isola. Manrique ha ricentrato in maniera emblematica alcuni dei contenuti fondativi dell’architettura, tracciando una mappa che ha contribuito a definire l’identità inconfondibile di Lanzarote. Lo ha fatto in anticipo sui tempi, praticando concetti che, attualmente, sono entrati nella retorica più diffusa. Nel 1966 Juan Ramírez Cerdá, allora presidente del Cabildo, la massima istituzione politica dell’isola, lo chiamò per elaborare strategie finalizzate ad arginare le incalzanti pressioni speculative del turismo globalizzato. Fu la decisione giusta. Grazie all’avvedutezza di questa scelta, i criteri estetici ed ecologici prevalsero su quelli economici. Azioni e interventi finaliz-
zati a risaltare il valore del paesaggio e delle bellezze naturali, dando vita alla proiezione internazionale dell’isola con un adattamento consapevole all’economia del turismo.
In venticinque anni Lanzarote divenne la sua tela: un’opera totale, in cui la conservazione della natura originaria del luogo correva in parallelo con la trasformazione; interventi che nascono sempre dalla lettura del paesaggio e con il paesaggio si amalgamano. “Di ritorno da New York, sono arrivato con l’intenzione di trasformare la mia isola natia in uno dei posti più belli del pianeta”. Manrique incide nuove rotte tra le curve dei vulcani, flirta con il litorale, si inabissa nel fitto reticolo di grotte che corre sotto l’isola. Oggi molte architetture contemporanee potrebbero essere ovunque, appartengono all’etere di un mondo globalizzato. Quelle di Manrique no: le sue opere possono essere solo a Lanzarote, ritagliate nello spessore del suolo vulcanico, negli anfratti, nelle caldere, dentro
2
ALL FUN, NO EDGE.

Istinto. Contatto con la roccia. Arrampicata naturale. Con No-Edge® il tuo piede si spalma su ogni appoggio con maggiore sensibilità, grazie a una costruzione della punta a spessori ridotti e senza spigoli, per una scalata più naturale, libera, dinamica. Semplicemente più divertente. Scopri Mandala su lasportiva.com
#citizensofthemountain
Elias Iagnemma , Fountainbleau.
EDITO
BY DAVIDE FIORASO PHOTO JORDAN MANOUKIAN

il vento, davanti all’oceano: coincidono con il luogo, con la sua materia. Le sue opere insegnano che la natura è sempre una risorsa e che è necessario osservarla per capire come abitarla. Dentro l’isola dei vulcani e degli alisei, in un ambiente in cui ciò che sovrasta la nostra fragile specie si mostra con una potenza incontrollabile, la natura è anche riparo, guscio che protegge; e ciò che deriva da una catastrofe può trasformarsi in una nuova quiete e in un rinnovato patto di alleanza. Da artista totale spazia dalla pittura, alla scultura, alla grafica. Per le sue opere non bastano gli occhi. Servono le orecchie, le mani, il gusto, il naso. I suoi spazi sono
esperienze contemporaneamente cinetiche e contemplative, fisiche e mentali: esistono in rapporto a chi li abita.
Per Manrique il paesaggio è un rapporto d’amore e di consapevolezza che diventa attribuzione di valore, sguardo profondo ed esteso; perché non riguarda solo i punti notevoli, ma un insieme di singoli episodi che dialogano in una rete di relazioni. Con lui le rocce, il vento, i licheni, i cactus, acquisiscono agli occhi di tutti un valore identitario che prima non avevano. E fu lui ad affermare che l’architettura rurale fatta di volumi semplici, bianchi, bassi, di pochi e preziosi serramenti in legno
fosse la depositaria della tradizione da mantenere per confermare l’identità locale evitando l’introduzione di edifici a più piani, materiali assortiti, cromie casuali, cartelloni pubblicitari. Creò così una nuova ideologia estetica, vincolata all’industria turistica, ai quali donò una funzionalità economica e sociale inedita anticipando concetti chiave di sostenibilità quando “sostenibilità” era un termine che ancora non esisteva. Come Ernst Haeckel e Alexander von Humboldt credeva nella relazione indissolubile tra arte e natura. Manrique professava queste idee e le difendeva con la stessa convinzione con la quale respingeva il pensiero materialista che concepisce la natura come una fonte di risorse passibili di essere sfruttate.
L’orrore che mi porto a casa da questo ultimo viaggio sono file di costruzioni a ridosso del Parco Naturale di Los Ajaches, dove fino a quattro anni fa c’era solo terra deserta. In 30 anni ho visto questa isola trasformarsi lentamente, cedere sempre più spazio al capitalismo incalzante, alla crescita indiscriminata di costruzioni senza senso. Ho visto la sua identità scricchiolare e perdere pezzi. Manrique temeva lo spegnersi di questa fiamma; conseguenza, a suo parere, degli attacchi commessi contro l’integrità e che egli riteneva vere e proprie profanazioni. E, poiché la nozione del profano implica la nozione del sacro, è evidente che egli attribuiva questo valore allo spazio insulare. Non per niente, quando veniva a sapere che qualcuno osava profanare il tempio della natura, del quale si sentiva sommo sacerdote, niente e nessuno poteva contenere la sua santa ira.
Prima di andarmene sono andato nel piccolo cimitero di Haria, a visitare la sua modesta tomba. A chiedere perdono per quello che sta succedendo, perché niente e nessuno sembra in grado di mantenere a lungo la sua eredità.
4
 THE SALEWA TREKKING COLLECTION IS ENGINEERED IN THE DOLOMITES, CRAFTED FROM NATURAL FIBERS, AT HOME IN NATURE. ANYTIME, ANYWHERE.
THE SALEWA TREKKING COLLECTION IS ENGINEERED IN THE DOLOMITES, CRAFTED FROM NATURAL FIBERS, AT HOME IN NATURE. ANYTIME, ANYWHERE.
THE CREW

PRODUCTION
The Pill Agency | www.thepillagency.com
EDITOR IN CHIEF
Denis Piccolo | denis@thepillagency.com
EDITORIAL COORDINATOR
Lisa Misconel | lisa@thepillagency.com
Elena Benassi | elena@thepillagency.com
EDITING & TRANSLATIONS
Silvia Galliani
ART DIRECTION
George Boutall | Evergreen Design House
Niccolò Galeotti, Francesca Pagliaro
THEPILLOUTDOOR.COM
hello@thepillagency.com
PHOTOGRAPHERS & FILMERS
Giorgia Archetti, Chiara Guglielmina, Matteo Pavana, Jacob Zocherman, Mountain legacy project, Jourdan Manoukia, Elisa Bessega, Denis Piccolo, Mattia Davare, Jerome Tanon, Photos Perly
COLLABORATORS
Filippo Caon, Chiara Beretta, Chiara Guglielmina, Davide Fioraso, Matteo Pavana, Lisa Misconel, Elena Benassi, Simone Luciani, Elisa Bessega, Luca Albrisi, Andrea Passerini, Sara Mariotta
SHOP & SUBSCRIPTIONS
www.thepilloutdoorshop.com
SHOP MAGAZINE MAP
www.thepilloutdoor.com/magazine-finder
COMPANY
EDITOR
Hand Communication, Piazza XX Settembre 17, Saluzzo CN 12037, Italy hello@thepillagency.com
COVER
Jordan Manoukian
PRINT
L'artistica Savigliano, Savigliano - Cuneo - Italy, lartisavi.it
DISTRIBUTION
25.000 copies distribuited in 1100 shops in Italy, Switzerland, Austria, Germany, France, Belgium, Spain, England & The Netherlands
ADVERTISING
hello@thepillagency.com | +39 333.7741506
FOLLOW US
www.thepilloutdoor.com
www.facebook.com/thepilloutdoor
Instagram.com/thepilloutdoor
The Pill rivista bimestrale registrata al tribunale di Milano il 29/02/2016 al numero 73

6
PHOTO JORDAN MANOUKIAN
THE WEIGHT IS OVER.


BLIZZARD-TECNICA.COM LIVE THE MOMENT
TECNICA ZERO G TOUR PRO
P.10
P.14
P.18
P.22
P.26
P.28
P.30
P.32
P.34
P.38
P.40
P.42
P.44
P.49
P.52
THE DAILY PILL
BEST MADE
KILLER COLLABS
ECO SEVEN
NIRMAL "NIMSDAI" PURJA
VANS ULTRA RANGE NEO VR3
CRAFT X VITTORIA
SCOTT KINABALU 3
LUCIA CAPOVILLA
CLIMB WORLD TOUR
GARMIN FENIX 7 PRO
LA MUNT CREW
SALEWA
DOLOMITE SAXIFRAGA
TECNICA WOMEN2WOMEN

P.56
P.60
P.64
P.71
P.77
P.80
P.88
P.94
P.100
P.108
P.116
P.124
P.132
P.142
P.160
FRESH FOAM X HIERRO 8
ROBERT HAJNAL
DAKOTA JONES
AKU VEGAN AS POSSIBLE
OMAR DI FELICE
MILLET CAMP DE BASE CHAMONIX
VICTOR DAVIET
UNASTORIA VERA
ALTERED DOLOMIA
AMORE CHE VIENI AMORE CHE VAI
BARKLEY MARATHONS
TRANSGRANCANARIA
THE SPEED PROJECT
ULTRAWEST
LAST WORD
8
ISSUE 66
PHOTO JORDAN MANOUKIAN
Cinque giorni. Quattro notti. Una prima.
"Avevo adocchiato questa linea da molto tempo, ne ero attratto! Ne ho parlato a Clovis e poi a Symon. È così che è nato il nostro trio. Non si tratta solo di un mix di abilità alpinistiche. Prima di tutto è una storia di amicizia e di passione condivisa"

 GRANDES JORASSESPRIMA INVERNALE Parete NordDirettissima alla punta Walker Charles Dubouloz, Symon Welfringer, Clovis Paulin
GRANDES JORASSESPRIMA INVERNALE Parete NordDirettissima alla punta Walker Charles Dubouloz, Symon Welfringer, Clovis Paulin
©M.Dumas_M.Daviet
Charles Dubouloz





THE DAILY PILL
BY SARA MARIOTTA
LA SPORTIVA NO-EDGE: UPGRADE E NEW ENTRY
La Sportiva rinnova No-Edge, tecnologia per tutti gli appassionati di arrampicata che vogliono vivere l’esperienza verticale nel modo più fluido e naturale possibile. Una proposta che soddisfa la sensibilità dei climber più esigenti e che vogliono avere un contatto ancora più intimo con la parete, grazie a una sensibilità aumentata e una percezione precisa dei punti di appoggio anche più complessi.
LA VETTA DELLA VITA: NUOVO LIBRO DI DELLA BORDELLA
L’alpinista Ragno di Lecco Matteo Della Bordella torna in libreria con “La vetta della vita”, un libro che nasce da una delle sue più grandi imprese: l’apertura di una nuova via sul Cerro Torre. Il libro ripercorre gli ultimi anni della sua vita, dalla sua storia da alpinista alla nascita del figlio, ripercorrendo le pareti più difficili accompagnate da inserti fotografici che trasportano il lettore fin sulla vetta del Cerro Torre.
LA SPORTIVA:
SECONDA EDIZIONE DEL CLIMB WORLD TOUR
Martedì 16 aprile: 13 palestre in 5 continenti hanno preso vita attraverso workshop, incontri con gli atleti e test prodotto. Climb World Tour è concepito per mettere in connessione La Sportiva e le comunità di arrampicata di tutto il mondo, promuovendo il divertimento e la condivisione nelle palestre più celebri del globo. Il tour ha permesso ad appassionati e principianti di partecipare a sessioni di arrampicata con leggende del settore.
MARC RADUA 1° POSTO MILLET TOUR DU RUTOR EXTREME
L’atleta spagnolo Marc Radua del team Millet si è classificato al primo posto nella categoria U23 del Millet Tour Du Rutor Extreme, una delle gare di scialpinismo più spettacolari al mondo di cui Millet è partner dal 2009. La gara si è conclusa domenica 24 marzo sulle montagne valdostane e ha visto il giovane Marc Radua gareggiare insieme al francese Noé Rogier, altro atleta del team Millet.
FJÄLLRÄVEN: IL BRAND PIÙ SOSTENIBILE
Per il quinto anno consecutivo, Fjällräven è stato eletto dai consumatori svedesi come il marchio più sostenibile del Paese nella categoria “abbigliamento e moda”, nel Sustainable Brand Index 2024. Questo indice, basato sui feedback di circa 80.000 consumatori provenienti da otto Paesi, valuta la percezione della sostenibilità di quasi 1.600 marchi tramite un’analisi annuale.
10

dolomite.it/saxifraga-capsule





THE DAILY PILL
BY SARA MARIOTTA
BEYOND BEGINS TODAY:
NUOVI TESSUTI POLARTEC
Polartec presenta Polartec Power Shield, membrana realizzata con materiali in poliestere riciclato, Polartec 200 e Micro Series, pile riciclati dotati della tecnologia Polartec Shed Less. Un nuovo step nel processo di riduzione dell’impatto sul pianeta, favorendo processi circolari e sostenibili a livello ambientale, senza sacrificare caratteristiche quali impermeabilità, proprietà antivento e traspirabilità.
DEUTER: TOGTHER WE CARE
La sostenibilità è al centro della filosofia aziendale Deuter, che comprende la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti e un servizio di riparazione a vita dei prodotti. Dal 2015, ad esempio, il brand usa esclusivamente piume di alta qualità certificate RDS, standard che garantisce il benessere animale in tutta la catena di produzione. “Togheter we care”, come suggerisce lo slogan.
FERRINO: MONTAGNA PER LE DONNE PAKISTANE
Ferrino annuncia una partnership con il corso di montagna dedicato alle donne nella regione dello Swat in Pakistan, promosso dall’Asian Desk di Mountain Wilderness, dal Club Alpino Accademico Italiano (CAAI) e dall’Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente (ISMEO). Anna Ferrino sottolinea l’importanza dell’iniziativa per la promozione delle comunità montane e dell’empowerment femminile.
PATAGONIA APRE NUOVO STORE AD AMSTERDAM
Patagonia apre il suo primo punto vendita nei Paesi Bassi ad Amsterdam, progettato per essere non solo uno store ma anche uno spazio dedicato ad attivisti locali e comunità sportive. Lo store, collocato nella storica location Singel 465467, offre una vasta gamma di prodotti per gli sport outdoor e ospiterà periodicamente eventi dedicati alla community di riferimento, come workshop sulle riparazioni, proiezioni e talk.
ASICS NIMBUS MIRAI
ASICS presenta Nimbus Mirai, nuova scarpa da corsa progettata per essere circolare, senza compromettere le prestazioni e la qualità del prodotto. “Mirai” in giapponese significa “Futuro”, riflettendo l’impegno per un impatto positivo sulle prossime generazioni di sportivi. Nimbus Mirai rientra in un programma di recupero pensato per incoraggiare i runner a restituire le scarpe alla fine del loro utilizzo, sostenendo un percorso di riciclo.
12



‹‹‹CUSHIONINGANDGRIP›››



1 0 W GET O GET E


1. NEW BALANCE
FUELCELL VENYM
Destinata a corridori veloci e tecnici, la New Balance FuelCell Venym arricchisce il catalogo di scarpe fuori strada del marchio di Boston. Ideali sia per la strada che per la montagna, queste scarpe offrono leggerezza, eccellente ammortizzazione e reattività, rendendole l'opzione ideale per chi cerca prestazioni elevate.
4.LA SPORTIVA
M ANDALA
U ltima nata nella famiglia No Edge, Mandala è una scarpetta dedicata allo scalatore moderno, dove ogni dettaglio è pensato per massimizzare la prestazione: precisione in fase di tallonaggio, ampia copertura ultra aderente sul puntale per facilitare gli agganci, spessori limitati per garantire elevata sensibilità.
BEST MADE
BY DAVIDE FIORASO




2.SALEWA
P UEZ 40+5L
Uno zaino dal design contemporaneo, studiato appositamente per adattarsi a un’ampia serie di attività. L’apertura roll-top mette a disposizione 5 litri di spazio aggiuntivo, mentre la zip infinity con doppio cursore consente un rapido accesso allo scomparto principale. Tutta la struttura ruota attorno al collaudato sistema di trasporto Dry Back.
5.SPACE
A CACIA TENT
Sistema 3-in-1 composto da una tenda spaziosa e moderna, robusto pavimento gonfiabile brevettato e l'innovativo tettuccio canopy in Oxford 300D con protezione solare e regolazione della temperatura. Due le versioni disponibili: standard o XL per ospitare fino a sei persone. 8 finestre laterali e 4 sopraelevate offrono una ventilazione ottimale.
3. THE NORTH FACE
SUMMIT SERIES PAPSURA
FUTURELIGHT JACKET
Guscio in Futurelight a tre strati impermeabile e traspirante, già vincitore dell’ISPO Award 2023. Così chiamato in onore della vetta a est del ghiacciaio Tosh, nella parte orientale dell'Himalaya indiano. Design minimalista, cappuccio regolabile, assenza di cuciture sulle spalle. Si ripiega nella sua tasca destra.
6.ARC’TERYX
KRAGG
Un nuovo concetto di calzatura da approach in grado di garantire comfort e libertà dopo la scalata. La tomaia è costituita da un unico strato di Spacermesh traspirante ed elastico. TPU e gomma Vibram forniscono protezione sulla punta e nelle aree soggette ad usura. Durante le soste o in fase di sicura il tallone si piega per creare l’effetto ciabatta.
14 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Step Outside Adventure Awaits
outdoor since
Contemporary
1870


8.SUUNTO
S ONIC
Cuffie sportive a conduzione ossea con tecnologia open-ear per ascoltare la musica senza smettere di sentire l'ambiente circostante. Diversamente dalle tradizionali cuffie, aderiscono all’osso mascellare lasciando libero il canale uditivo. Resistenti all’acqua e al sudore; autonomia fino a 10 ore con una ricarica da 60 minuti.
10.HYPERLIGHT
MOUNTAIN GEAR VICE VERSA
Ci sono elementi essenziali e poi c’è l’essenziale dell’essenziale. Il marsupio Vice Versa da 1.3L trasporta i tuoi oggetti più importanti nei brevi viaggi o nelle escursioni. Come il suo fratello maggiore, è realizzato con tessuti compositi Dyneema resistenti e impermeabili al 100% per un peso, appena percettibile, di 76 g.
BEST MADE
BY DAVIDE FIORASO



8.GREATER GOODS
STEM BAG 1L
Progettata per contenere i tuoi oggetti essenziali mentre sei sulla bici. Base e corpo in tessuto X-Pac ad alte prestazioni, top espandibile in nylon ripstop riciclato, strisce di velcro per diverse configurazioni il fissaggio. Tasca laterale in Dyneema per contenere facilmente telefono e portafoglio, clip in alluminio.
11.BOTA
TEA BOTTLE
La preparazione del tè, in ogni momento. Un’elegante bottiglia 4-in-1 con camera di macerazione/infusione separata e controllo preciso della temperatura; preparazione in soli 5 minuti e isolamento a doppia parete per mantenere la bevanda calda per 12 ore. Design ergonomico a prova di perdita e tazza incorporata.

9.LA MUNT
ALBERTA REMOCA PAD HYBRID
JACKET WM’S
Comoda, calda e altamente traspirante, beneficia dell'isolamento ReMOCA Pad realizzato con i ritagli delle pelli da sci alpinismo Pomoca uniti a poliestere e cotone riciclato. Il pile tecnico elasticizzato sulle maniche, sugli inserti laterali e sulla parte inferiore della schiena assicura ampia libertà di movimento.
12.MILLET
WANAKA BOA WM’S
Calzatura da fast hiking contraddistinta da un sistema BOA con fasce laterali che avvolgono il piede con estrema precisione. Un modello tecnico destinato al trekking estivo con tomaia in TPU altamente traspirante e suola Michelin della famiglia Traction con battistrada appositamente studiato per una trazione progressiva.
16 7. 8. 9. 10. 11. 12.





1.STUDIO TEMP X RAYON
VERT X DOLOMITE
SAXIFRAGA 3L JACKET
Esplorare nuovi codici estetici e comunicativi per vivere l’outdoor a 360°. Saxifraga è la capsule collection Dolomite nata in collaborazione con Studio Temp e Rayon Vert. Parte del progetto From Dawn ‘till Dusk questa giacca a tre strati traspirante, antivento e resistente 20.000 mm colonne d’acqua.
4.RAY ZAHAB X NORDA
001 RZ MAGMA
Costruita con la prima tomaia al mondo in Bio-Dyneema senza cuciture, e l'esclusiva intersuola Vibram, la 001 è una scarpa che non ha bisogno di presentazioni. Questa versione esclusiva è frutto della collaborazione con l'atleta Ray Zahab per sostenere i programmi della sua organizzazione benefica impossibile2possible (i2p).
KILLER COLLABS
BY DAVIDE FIORASO



2.CHARLES DUBOULOZ X MILLET
OFF_LINE MIXT 25L BACKPACK
Zaino tecnico che si adatta a molteplici attività in montagna, dalle rapide ascensioni su roccia allo sci alpinismo, dall’arrampicata al trekking. Progettato in collaborazione con Charles Dubouloz nell’ambito della vasta collezione Off_Line, interamente confezionata a partire da scarti ed eccedenze di produzione.
5.GRAMICCI X AND WANDER
PATCHWORK WIND PANT
Estetica e funzionalità si fondono nella collezione SS 2024 dei due lungimiranti brand. Ispirati ai classici Voyager di Gramicci, questi pantaloni da arrampicata sono realizzati con un divertente patchwork di ripstop e nylon ad alta densità. Tasche su fianchi e cosce, coulisse alle caviglie ed un iconico logo collaborativo.

3.PATTA X MARSHALL
EMBERTON II PORTABLE SPEAKER
Per celebrare la sua prima collaborazione con Patta, Marshall ha creato questa edizione limitata dello speaker Emberton II che trae ispirazione dalla cultura del sound system caraibico. Arancio fluo e stampa OSB si scontrano per creare qualcosa di unico. L’eredità del Suriname di Patta è intrinsecamente intrecciata nella griglia multicolore.
6.HIGHSNOBIETY X MERREL
1TRL JUNGLE MOC BREEZE TOPAZ
Highsnobiety, media brand fondato nel 2005 da David Fischer (e acquistato dal colosso tedesco Zalando nel 2022) presenta la sua prima collaborazione con Merrell 1 TRL. L’offerta prevede una nuova interpretazione dell'iconica sneaker slip-on Jungle Moc con pannelli su misura e colorazione esclusiva peyote/brezza/topazio.
18 1. 2. 3. 5. 4. 6.

ADERENZA.LEGGEREZZA.CARATTERE.
Questo è il trail running con le nuove Timp 5. Lo stesso comfort di sempre, con una struttura ancora più leggera e, grazie alla suola Vibram ® Megagrip, un’aderenza impareggiabile su superfici asciutte e bagnate.
MUOVITI NATURALMENTE
La nuova Timp 5 ti offre un puntale spazioso e zero drop per consentirti un movimento naturale.
ALTRARUNNING.EU

KILLER COLLABS
BY DAVIDE FIORASO


7.OSTRYA X ROA
KATHARINA
Il piccolo brand di abbigliamento da alpinismo con sede a Montréal firma questa edizione di Katharina, pezzo forte del marchio italiano ROA. Ibrido con una classica scarpa da avvicinamento, combina una tomaia in pelle scamosciata che trae ispirazione dal sole primaverile. Foxing in gomma con logo riflettente Ostrya.
10.CLESSTE X PLUS PHENIX
CITY WADING JACKET
Quella tra Clesste, brand fondato a Tokyo da Ryo Takashima e +Phenix, progetto urban-lifestyle dello storico marchio di abbigliamento da sci, è una rivisitazione moderna della giacca da pesca SST, capolavoro Patagonia degli anni '90. Realizzata in tessuto Windstopper by Gore-Tex Labs è caratterizzata da un taglio ridotto e ampio.

8.JEAN-MICHEL BASQUIAT X ROARK RUN AMOK
SECONDWIND ANORAK JACKET
A quasi 40 anni dalla sua morte, l’eredità artistica di Jean-Michel Basquiat continua a tenere banco. Il suo neoespressionismo si ritrova oggi in una collezione targata Run Amok by Roark di cui fa parte la giacca tecnica Secondwind 3.0, ultraleggera e comprimibile nella sua tasca. Stampe e logo riflettenti.
11.PORTER X CITIZEN
PROMASTER GMT WORLD TIME
Dopo un'uscita speciale con G-Shock, il marchio di borse e accessori Porter Yoshida svela un'altra entusiasmante partnership, quella sulla serie Promaster di Citizen. La reinterpretazione del modello GMT World Time, con movimento Eco-Drive, presenta co-branding sul quadrante, lancette personalizzate e cinturino bicolore in caucciù e tessuto.
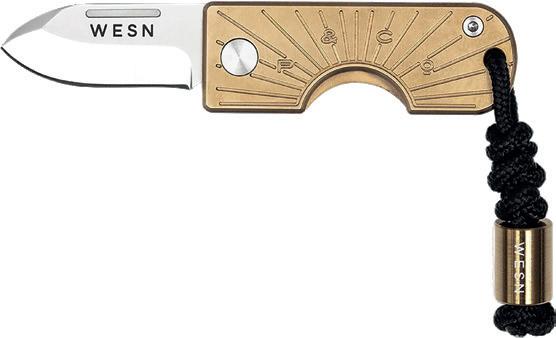

9.P&CO X WESN
SLIPJOINT MICROBLADE
Da Birmingham a Detroit, una collaborazione che si insegue dal 2022, fedele al patrimonio di entrambi i marchi. Slipjoint Microblade è un coltello a microlama in acciaio D2 semi inossidabile con manico in ottone inciso destinato a sviluppare una bellissima patina nel tempo. 5,9 cm da chiuso per un peso di soli 51 g.
12.END CLOTHING X HOKA
OVERLAND MAFATE SPEED 2
Rivisitazione di uno dei classici trail titans di Hoka, l’edizione Overland di Mafate Speed 2 è parte della collezione di debutto con END, rinomato retailer britannico specializzato nello streetwear. Una capsule in due pezzi che celebra i popolari viaggi avventura e l’amore condiviso per i grandi spazi aperti.
20 7. 8. 9. 10. 12.
11.


ECO SEVEN
BY DAVIDE FIORASO & SILVIA GALLIANI

N ATURA, SOSTENIBILITÀ E COMFORT: SALEWA INTRODUCE LA CANAPA NELLA COLLEZIONE ESTIVA
Grazie alle sue proprietà e al basso impatto ambientale, negli ultimi anni si è assistito ad una rinascita della filiera tessile della canapa ed è in questo contesto che Salewa ha deciso di farsi strada, utilizzandola come materiale principale in alcune delle sue collezioni. “Il grande potenziale sostenibile della canapa industriale risiede nella pianta stessa, nella coltivazione e nella sua capacità di carbon storage. La canapa non richiede irrigazione e pesticidi, protegge la biodiversità e rigenera il terreno” - Christine Ladstaetter, Innovation & Special Projects Manager,Salewa

MICROPLASTICHE SUI GHIACCIAI ITALIANI: ORTOVOX ANNUNCIA IL SUO SOSTEGNO ALLA RICERCA
Ortovox ha annunciato il suo sostegno, tramite la fornitura di materiale e abbigliamento tecnico, allo studio condotto dal Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università di Milano, in collaborazione con Greenpeace Italia, riguardante la presenza di microplastiche sui ghiacciai alpini. I risultati hanno finora mostrato che la contaminazione interessa l’80% dei campioni prelevati sul Ghiacciaio dei Forni e il 60% di quelli raccolti sul Ghiacciaio del Miage. Tra le microplastiche individuate, le fibre rappresentano oltre il 70% dell’impronta di contaminazione.

PATAGONIA PRESENTA A SALMON NATION, U N DOCUMENTARIO SULL’IMPATTO DEGLI
A LLEVAMENTI IN MARE APERTO
Patagonia ha lanciato Laxaþjóð – A Salmon Nation, il suo nuovo film sulla lotta per proteggere le acque incontaminate e i salmoni selvatici islandesi dagli allevamenti industriali in reti aperte. Sotto la superficie dei fiordi islandesi, i metodi di allevamento industriali dei salmoni minacciano uno degli ultimi luoghi selvaggi d’Europa. Il documentario di 27 minuti racconta la storia di una nazione unita dalle sue terre e dalle sue acque. Ma non solo: anche del potere di una community di proteggere i propri spazi selvaggi e gli animali che l’hanno aiutata a forgiare la propria identità.
22

MOUNTAIN ME-TIME
Abbigliamento da montagna premium creato da donne per donne
LaMunt.com
ECO SEVEN
BY DAVIDE FIORASO

P OLARTEC PRESENTA NUOVI TESSUTI AD ALTE PRESTAZIONI CON VANTAGGI SOSTENIBILI
Con l’intento di intensificare il proprio impegno verso il pianeta, Polartec ha presentato Power Shield RPM, un tessuto in poliestere riciclato al 100% che rivoluziona la protezione dagli agenti atmosferici garantendo al contempo elevata libertà di movimento. Tra le novità anche la tecnologia Polartec Shed Less, un processo innovativo che, ottimizzando la costruzione del filato e la lavorazione a maglia, riduce la perdita di frammenti di fibre durante il lavaggio domestico fino all'85%. Meno spargimenti di microfibre che finiscono nei corsi d’acqua e più anni di utilizzo di morbidi tessuti in pile.

B LOOM SUSTAINABLE MATERIALS:
T HE CLEAN WATER CHALLENGE
Spostare i marchi e i loro prodotti verso un’economia riparativa e circolare. È questo l’obiettivo di Bloom, che ha lanciato una sfida ai brand partner (Adidas, Rip Curl, Merrell, Redwing, Icebug, Chaco, Igloo per citarne alcuni) per implementare cambiamenti sostanziali nel modo in cui creano i loro prodotti. Bloom sfrutta gli attributi positivi delle alghe, una risorsa rinnovabile che cresce naturalmente.. L’innovativo processo prevede la loro spremitura in una pasta che, una volta essiccata, viene ridotta in miscele di polvere verde da convertire in schiume e gomme.
L A RIVOLUZIONARIA APP LODESTAR SEMPLIFICA
LA PIANIFICAZIONE DI VIAGGI SOSTENIBILI
Lodestar ha celebrato la Giornata internazionale della donna svelando la sua innovativa app, una piattaforma tuttofare per programmare le proprie avventure all'aria aperta. Progettata per consentire agli utenti di avere un impatto positivo sui luoghi e sulle comunità, stabilisce un nuovo standard di responsabilità offrendo una gamma completa di funzionalità che coprono tutti gli aspetti della pianificazione del viaggio sostenibile: piani, percorsi, mappe, prenotazioni di campeggi, calcolo dell'impronta di carbonio e contatti con la crescente rete di organizzazioni no-profit locali.

OUTDOOR ALLIANCE CELEBRA 10 ANNI DI SUCCESSI CON UN VIDEO CHE RIPERCORRE LE SUE TAPPE
Costituita per rappresentare gli interessi politici di 10 distinti gruppi membri, che rappresentano altrettante attività ricreative all'aperto, negli ultimi 10 anni Outdoor Alliance ha aiutato la comunità outdoor a diventare una forza in grado di proteggere oltre 40 milioni di acri di terra, assicurando 5,1 miliardi di $ di finanziamenti a favore di territori e acque pubbliche. “L’impatto della Outdoor Alliance nel mondo delle politiche e della difesa degli spazi aperti non può essere sopravvalutato”, ha affermato Ryan Gellert, CEO di Patagonia. “L’esperienza del loro team ha modellato la legislazione per proteggere le terre e le acque pubbliche e garantire un accesso equo agli spazi esterni”.

24


 BY ANDREA PASSERINI
BY ANDREA PASSERINI
Nirmal “Nimsdai” Purja Solidarietà
e ispirazione
oltre i record
Nirmal “Nimsdai” Purja, un nome che non ha bisogno di presentazioni. Le sue straordinarie imprese e record parlano per lui e lo accompagnano in ogni suo passo. Quando SCARPA, ha annunciato che sarebbe stato lui l’ospite speciale della rassegna “ Courmayeur Feeling Mountain”, l’evento è andato subito sold out, neanche il tempo di allacciarsi gli scarponi. Abbiamo a disposizione solo pochi minuti insieme a lui per scoprire cosa c’è dietro l’uomo dei record.
Ciao Nims! Penso che quello che stai facendo per il tuo paese sia qualcosa di semplicemente fantastico, Ma prima di tutto, qual’ è la tua ispirazione nella vita e nello sport? Partiamo con una facile. La mia ispirazione è ispirare gli altri. Credo che ci saranno e ci siano persone molto talentuose, tra le generazioni più giovani. A volte quello di cui hanno bisogno è solo di qualcuno che li supporti, per permetter loro di ottenere anche molto di più di quello che ho ottenuto io. Con la fondazione Nimsdai, in questo momento stiamo costruendo la Porter House e solo l'anno scorso abbiamo sponsorizzato più di una dozzina di atleti. Allo stesso modo, quando c'è stata l'alluvione in Pakistan, siamo stati i primi a rispondere. Abbiamo sostenuto più di 10.000 famiglie. Questo è ciò che mi dà la motivazione per andare avanti.

Nella tua vita c'è stato un evento particolare che ti ha cambiato e ti ha spinto a fare ciò che stai perseguendo? Non credo di aver vissuto eventi straordinari o simili. La mia storia è unica, nasce da un contesto estremamente umile: a volte non avevo nemmeno il minimo indispensabile per sfamarmi. La mia è la vicenda di un ragazzo che ha osato sognare in grande. Il primo passo fu unirmi ai Gurkha, così da poter sostentare mia madre e i miei genitori. Da quel momento, ho realizzato che c'erano orizzonti più ampi e questa consapevolezza mi ha spinto a tentare l'ingresso nelle forze speciali, diventando il primo nepalese a riuscirci. Successivamente, ho trovato uno scopo nella vita: con il "Project Possible", mi sono prefisso di elevare il prestigio della comunità nepalese, dimostrando al mondo che non esistono limiti al raggiungimento dei propri obiettivi.
Pensi che il turismo di massa in montagna possa coesistere con la sostenibilità ambientale? Voglio fare una considerazione: si tende a criticare gli alpinisti, e certo, è innegabile che possiamo sempre migliorare in ogni aspetto delle nostre azioni. Ma pensiamoci: quante persone visitano New York ogni anno? Parliamo di milioni di individui. E allora, perché dovremmo scandalizzarci per 50.000 persone che scelgono il Nepal come meta in un anno? In confronto al flusso turistico globale, il settore dell'alpinismo in Nepal appare minimo eppure, è proprio la nostra comunità, quella montana, che spesso si trova in difficoltà.C'è chi critica senza considerare l'altra faccia della medaglia. Ora, però, stiamo facendo passi avanti per migliorare la gestione dei rifiuti grazie al “Big Mountain Cleanup”, progetto a cui tengo moltissimo e stiamo cercando di realizzare in più luoghi possibile.
26
PILL INTERVIEW
THE




 BY ELENA BENASSI
BY ELENA BENASSI
Vans Ultrarange Neo VR3
Innovazione e versatilità
Immaginate l'ebbrezza di cavalcare un'onda al tramonto, il sole che tinge d'oro l'orizzonte mentre le onde si infrangono con forza lungo la costa. Pensate alla sensazione di libertà nell'eseguire un trick con lo skateboard, sfidando la gravità e danzando con il vento negli spot cittadini. In questi momenti, dove l'adrenalina incontra la pura gioia, nasce un'ispirazione senza tempo. Da questa fusione di emozioni, stimolata dal prezioso feedback degli atleti del team Vans Surf, nasce la nuova collezione Vans Ultrarange Neo VR3. Queste calzature rappresentano ben più di un semplice accessorio; sono il culmine di un viaggio creativo che fonde le radici autentiche di Vans con le più audaci innovazioni tecnologiche.
La Vans Ultrarange Neo VR3 apre un nuovo capitolo con l'introduzione di due nuove varianti cromatiche: "Light Green/Black" e "Yellow/Multi". Queste nuove tonalità non solo arricchiscono l'estetica del modello ma mantengono e amplificano tutte le caratteristiche più apprezzate della versione precedente.
Uno degli aspetti più innovativi delle Ultrarange Neo VR3 è la sua rinnovata forma che garantisce una calzata migliorata e un profilo ottimizzato, preservando allo stesso tempo l'iconica estetica "Off The Wall" di Vans. Inoltre, la calzatura è stata dotata di una culla dell'arco plantare aggiornata, per offrire un sostegno senza pre -

cedenti ai piedi degli avventurieri di ogni giorno.
Ma le novità non si fermano alla forma e al colore. Vans ha lavorato sodo per integrare nella Ultrarange Neo VR3 elementi sostenibili senza compromettere le prestazioni. La scarpa fa parte della linea Vans Checkerboard Globe, che segue standard rigorosi per quanto riguarda l'uso di materiali sostenibili. Le tomaie sono fabbricate interamente in PET riciclato, mentre le intersuole sono realizzate con almeno il 50% di schiuma EVA derivata da fonti biobased. Le suole, che reinterpretano la tradizionale trazione waffle di Vans, sono composte per almeno il 60% da gomma naturale rigenerata.
Accanto alle innovative calzature, Vans introduce una linea di abbigliamento versatile e all'avanguardia, perfettamente abbinabile alle nuove Ultrarange Neo VR3. La collezione comprende pezzi come il gilet reversibile Rosewood, un set composto da mock neck e shorts a doppia maglia, un pantaloncino da arrampicata, un berretto da campeggio, una t-shirt a manica corta e una canotta in cotone.
Questo modello è destinato a diventare un punto di riferimento per chi cerca una calzatura capace di affrontare ogni avventura mantenendo un occhio di riguardo per l’ambiente e ancora una volta, Vans insegna, che è possibile coniugare performance e stile in un unico prodotto di alta qualità.
28 THE PILL PRODUCTS
THE PILL PRODUCTS
BY ELENA BENASSI

29
BY LISA MISCONEL
Craft Xplor x Vittoria
Quando si parla di gravel, ci si riferisce generalmente al mondo bike.
Una formula che unisce strada e sterrato per variegare il campo di gioco di quei ciclisti che puntano a velocità e dinamicità ma cercano di allontanarsi dalla strada. Questa transizione la ritroviamo anche nel mondo running, basti pensare all’enorme crescita del trail. Se però nella bici i concetti di strada, gravel e MTB sono abbastanza definiti, nel running la distinzione è ancora ferma a strada e trail. Posizionato come ponte fra ciò che è la corsa su strada ed il trail running su terreni tecnici, il gravel è tutto ciò che comprende asfalto, strade bianche, strade sterrate e forestali che non presentano difficoltà tecniche ma permettono di lavorare sulla velocità in piano, salita e discesa che devono avere una pendenza moderata.
Craft x Vittoria
Parliamo di gravel, corsa, bike... e di una partnership innovativa. Uno dei sodalizi sportivi più frequenti ed efficienti è quello di bici-corsa. Se ci pensiamo, il recupero di un ciclista si traduce quasi sempre con una corsa lenta laddove il recupero di un corridore è spesso sulle due ruote. Questo connubio vincente è stato riproposto da Craft e Vittoria nella loro ultima novità chiamata Xplor. “Più che una collaborazione, la nostra è una comunione di intenti” tiene ad evidenziare Bruno Tecci, global marketing director di Vittoria, brand leader mondiale nei copertoni tecnici e accessori per biciclette; i due brand puntano infatti alla nascita di un nuovo modo di interpretare la corsa.

Un battistrada rivoluzionario
Highlight principale della scarpa è dunque il battistrada: una tassellatura a freccia ripresa dal copertone da gravel di Vittoria Terreno Mix si accosta all’incisione a squame ripresa dal Terreno Dry. Terreno Mix è pensato per dare il massimo su tutto ciò che è off-road garantendo massima presa e sicurezza, mentre Terreno Dry garantisce massime prestazioni su asfalto e bagnato.
Gravel Relay Race @Vittoria Park
Dalla Parigi-Roubaix alle Fiandre, dal terriccio ai sassi, all’erba bagnata fino alle radici: se c’è un posto dove poter testare delle suole, quello è il Vittoria Park di Brembate. Con circa 50 000 mq di superficie, è un paradiso per gli ap-
passionati ma anche campo di ricerca per lo sviluppo dei prodotti Vittoria. Quale luogo migliore di questo per testare le nuove Xplor con una gara a staffetta su un circuito di 1km tracciato per l’occasione? Saliscendi, curve e terreni misti per il test di Craft Xplor al culmine di una serata inaugurata da un talk con interventi di Bruno Tecci, global marketing director di Vittoria e Alex Baldaccini, atleta Craft. Dopo una giornata di pioggia il Vittoria Park ha dato il meglio di sé nella sua prima serata dedicata al running, dove staffettisti agguerriti e nerd di prodotto hanno potuto testare il nuovo battistrada al meglio. La reattività su asfalto ha permesso di spingere nei tratti pianeggianti, mentre le parti in Terreno Dry hanno dato il giusto supporto in discese e curve sconnesse.
30
THE PILL EVENTS


31 BY
PILL EVENTS
LISA MISCONEL THE
BY LISA MISCONEL
Scott Kinabalu 3 come non l’abbiamo mai vista
Quando una cifra accompagna il nome di una scarpa significa che la stessa è in circolazione da un bel po’, anno dopo anno, sempre migliore. È il caso di Kinabalu 3... presentata al pubblico a febbraio 2024 in un setup completamente riprogettato. Siamo davanti ad una scarpa best-seller, apprezzata per la sua grande versatilità che le permette di performare su diversi tipi di terreno ed assecondare i bisogni di diversi tipi di runner. Introdotta all’interno della collezione trail running di Scott dal 2016, il nome Kinabalu comprende una collezione di diversi modelli di scarpe che vanno dall’allenamento alle gare.
Novità ed upgrade
Kinabalu 3 è il risultato di un grande lavoro di miglioramento che rivede completamente la versione precedente per migliorarne comfort, protezione ed efficienza. Possiamo identificare le novità di questa terza edizione in due punti specifici che si trovano nella parte inferiore di Kinabalu 3. Si nota fin da un primo sguardo il rocker accentuato: grazie alla tecnologia Evolved Rocker2 (ER2), viene favorita una posizione della corsa più dinamica, capace di ridurre gli impatti sul tallone ed ottimizzare l’efficienza. Questa tecnologia è il risultato di 10 anni di ricerca e sviluppo del marchio basati su principi biomeccanici. L’altra novità sta nell’intersuola, dove la normale schiuma EVA è stata sostituita da Kinetic Foam, una


schiuma leggera e molto reattiva a doppia densità in grado di restituire il 14% di energia in più rispetto alla precedente. Questi due miglioramenti sono volti ad una corsa più veloce e per periodi prolungati con il minimo dispendio di energia.
Kinabalu 3 in numeri
Come sempre, nel mondo running e trail running ci vuole anche qualche numero per identificare una calza-
tura. Innanzitutto il peso: si parla di 300g che si traducono in una scarpa la cui caratteristica principale non è la leggerezza ma che giustifica ogni grammo con feature più importanti quando si parla di sentieri. Il drop è di 7mm, mentre lo stack è di 29,5mm sul tallone e 22,5mm sull’avampiede. La suola Versatile Traction di Scott permette di performare su ogni tipo di terreno.
32
PILL PRODUCTS
THE
BY LISA MISCONEL

33
PILL PRODUCTS
THE
THE PILL HEROES
BY ELENA BENASSI
Leggera: la Storia di Lucia Capovilla
Nel mondo dello sport, dove la fisicità sembra regnare sovrana, emergono storie che riscrivono le regole, ispirano e trasformano. La storia di Lucia Capovilla è una di queste, una narrazione che non solo eleva lo spirito umano ma ridefinisce il concetto di possibilità. Il suo racconto, splendidamente catturato nel film “Leggera" prodotto da Mammut è una testimonianza di resilienza, determinazione e pura passione per l’arrampicata.
Nata senza il braccio sinistro, Lucia non ha mai permesso che questa sua caratteristica la definisse o limitasse. La sua storia inizia nella tranquillità di una casa dove l'amore per le sfide si respirava quotidianamente. Sua nonna, una figura chiave nella sua vita, ha trasformato la curiosità e l'ingegnosità in una missione, creando soluzioni personalizzate per permettere a Lucia di arrampicare senza compromettere la sua sicurezza o il suo comfort Questa ricerca congiunta di adattamento e superamento degli ostacoli è diventata il fulcro della sua avventura nell’arrampicata.
Il paraclimbing, la disciplina che Lucia ha scelto di conquistare, era un tempo relegato ai margini dello sport mondiale. Tuttavia, attraverso gli

sforzi e i trionfi di atleti come Lucia, il paraclimbing ha guadagnato il suo meritato riconoscimento. Il suo secondo posto ai Campionati mondiali di arrampicata IFSC a Berna non è solo un tributo alle sue abilità atletiche, ma anche un simbolo dell'evoluzione dello sport stesso.
"Aveva 20 anni quando ha iniziato ad arrampicare. Da allora è stata la sua libertà”.
Le parole della nonna risuonano come un eco di questa libertà conquistata, un promemoria del potere dell'inizio, indipendentemente dall'età o dalle circostanze. La sua arrampicata, più che un'espressione di resistenza fisica, è diventata una danza di strategia mentale e determinazione, portando alla luce il vero significato del motto "The mind is the limit".
Oggi, Lucia non solo scala le vette fisiche ma anche quelle metaforiche, fungendo da faro di ispirazione per molti. La sua carriera come infermiera e oratrice motivazionale le permette di condividere la sua storia, incoraggiando gli altri a superare i propri limiti e a riscoprire il potere della volontà umana.
"Leggera" non è solo un film sulla vita di una paraclimber di successo; è un inno alla forza interiore, un'esplorazione della resilienza umana e un promemoria che, nelle sfide della vita, la determinazione è tanto importante quanto la prestazione fisica. La storia di Lucia Capovilla dimostra che, con la giusta dose di coraggio e perseveranza, le vette più alte possono essere raggiunte, un passo alla volta.
34
THE PILL HEROES
BY ELENA BENASSI

35
THE PILL HEROES
BY ELENA BENASSI


36
THE PILL HEROES
BY ELENA BENASSI

37
BY ELENA BENASSI
Climb World Tour La Sportiva Ascendere Insieme
Da sempre La Sportiva ha intrecciato strettamente il proprio destino con quello della comunità di arrampicatori, costruendo non solo attrezzature ma anche relazioni, legami e una rete globale di appassionati. Il Climb World Tour rappresenta l'apice di questo impegno, un evento che si estende oltre i confini geografici per toccare le vite degli arrampicatori su quattro continenti.
Abbiamo incontrato Fabio Parisi, Sports Marketing & Events Team leader, per farci raccontare la genesi di questo ambizioso progetto a pochi giorni dal kick off della sua seconda edizione.
Raccontaci l’idea al principio di questa iniziativa Il Climb World Tour rappresenta sicuramente uno dei progetti fondamentali all'interno delle nostre attività nelle palestre di arrampicata, con l'obiettivo principale di integrarsi nelle comunità locali e di consolidare il rapporto con chi ci segue. Questa iniziativa ha origine circa 15 anni fa, dove siamo stati pionieri nel testare le scarpette direttamente nelle palestre. Tutto è nato per volontà di Pietro Dal Pra, che con il suo furgone ha viaggiato in giro per l’Europa presentando le scarpette. All’inizio erano solo 5-6 palestre, oggi il progetto si è notevolmente espanso, prevedendo di raggiungere 150-200 palestre entro fine anno.
Da evento locale a globale… Partirà contemporaneamente in 13 città diverse, da Tokyo, a Boulder, da Pechino a Vienna. Il kick off è fissato per il 16 apri-

le dai 4 continenti, per poi continuare con tour nazionali fino a fine novembre. Quindi, fondamentalmente, questo evento è un evento di rete. Cerchiamo di entrare in contatto e di mettere sulla stessa piattaforma cose che accadono in luoghi non così vicini tra loro. Il successo dell'evento dipende dall'impegno di ciascun distributore locale nella sua organizzazione. Il nostro ruolo principale è coordinare gli sforzi, assicurando uniformità nel progetto, nella visione e nella qualità della presentazione degli eventi.
Quale sarà il tema principale di quest’anno? Il tema centrale sarà la tecnologia No Edge, che riflette l'identità e l'innovazione della nostra azienda e fa parte del nostro DNA da circa un decennio. No Edge rappresenta una scommessa sul futuro dell'arrampicata, distinguendosi per l'approccio innovativo rispetto alle tradizionali scarpette da arrampicata con punta. Quest'anno, abbiamo previsto il rinnovamento di tutti e quattro i modelli No Edge, aggiornandone tre e introducendone uno nuovo. L'obiettivo è arricchire la nostra
offerta con una capsule collection No Edge che soddisfi un ampio spettro di esigenze, dal modello Mantra, meno strutturato, al Genius, decisamente più definito e adatto per l'uso esterno.
Non solo test ma anche laboratori e incontri con gli atleti I nostri prodotti, notevolmente tecnici e performanti, sono progettati per durare. In tal modo, anche un articolo risuolato può offrire prestazioni paragonabili, se non superiori, a un prodotto nuovo, mantenendo la personalizzazione della calzata. Ecco perché abbiamo introdotto il concetto di rigenerazione nel mondo dell'arrampicata, promuovendolo nei nostri eventi e presso le comunità locali. La presenza degli atleti non è solo simbolica ma rappresenta un ponte tra il passato, il presente e il futuro dello sport. L'arrampicata libera, con le sue innovazioni e la sua evoluzione, deve molto alla comunità degli atleti, i quali hanno contribuito a definirne l'identità e la crescita. Durante il Tour, gli atleti condividono le loro esperienze e il loro percorso con il pubblico, arricchendo l'evento con la loro prospettiva unica.
38
THE PILL EVENT
THE PILL EVENT
BY ELENA BENASSI

39
BY ELENA BENASSI
Garmin fēnix
7 Pro Oltre i sentieri battuti
Garmin fa un ulteriore passo incontro agli atleti e a noi appassionati delle sfide impossibili. La serie fēnix 7 Pro è stata appositamente progettata per soddisfare le esigenze di trail e ultra runner, offrendo strumenti di allenamento specifici, una navigazione migliorata e un monitoraggio dettagliato della condizione fisica, garantendo un supporto costante e un'analisi precisa dei parametri fisici in ogni momento.
Guardiamo nuovo fenix 7 nei dettagli. fenix 7 Pro mette sul piatto una durata della batteria ancora più ampia: la tecnologia di ricarica solare è estesa ora a tutti i modelli della gamma, sia nelle versioni Power Sapphire con vetro zaffiro che nelle versioni Power Glass. Grazie a questa imponente dotazione tecnologica, l’autonomia è estesa fino a 37 giorni in modalità smartwatch e fino a 139 ore con GPS attivato in Expedition Mode: una durata incredibile che dilata ulteriormente il tempo tra una ricarica e l’altra. (la durata della batteria varia

a seconda del modello e delle prestazioni)
Il display MIP di nuova generazione migliora notevolmente la leggibilità in diverse condizioni di illuminazione, grazie a pixel riprogettati, maggiore contrasto e saturazione del nero, retroilluminazione ottimizzata e un pannello solare più efficiente. Queste migliorie assicurano una visibilità superiore senza compromettere la qualità di visualizzazione anche sotto intensa luce solare.
La torcia Led, ora standard su tutti i modelli, offre diverse modalità di intermittenza, un Led rosso per la sicurezza e una modalità stroboscopica, migliorando la visibilità e la sicurezza durante le attività notturne.
Il sensore Cardio Gen5 porta il monitoraggio delle prestazioni a un nuovo livello, grazie a sensori ottici avanzati, algoritmi sport-specifici e una migliore disposizione dei sensori, che rendono il monitoraggio dell'attività fisica più accurato e affidabile.
40
THE PILL PRODUCTS
BY ELENA BENASSI

Particolarmente degne di nota sono le funzioni dedicate alla corsa in montagna, tra cui l'Endurance Score, che valuta la resistenza su lunghe distanze e ad alta intensità, e l'Hill Score, che misura la capacità di corsa in salita, offrendo una valutazione basata sulla potenza generata e sui progressi nel tempo.
La corsa in salita è un'attività che richiede più energia e potenza rispetto alla corsa su terreno pianeggiante, poiché comporta la spinta del proprio peso corporeo in avanti e verso l'alto contro la forza di gravità. Questo tipo di cor-
sa utilizza una percentuale maggiore di muscolatura e presenta differenze biomeccaniche significative, come velocità del passo più elevate e una maggiore potenza necessaria a livello delle articolazioni. L'Hill Score sottolinea l'importanza di allenarsi in salita per migliorare le capacità complessive di corsa, evidenziando come un allenamento specifico possa trasformare le salite in un vantaggio competitivo.
L'Endurance Score, infine, fornisce una valutazione dinamica della capacità di sostenere prestazioni elevate per pe-
riodi prolungati, riflettendo l'influenza di vari adattamenti fisiologici all’allenamento. Il solo tracciamento del VO2 max non è sufficiente infatti a stabilire le reali condizioni fisiche dell’atleta: uno stesso valore può portare a prestazioni diverse tra gli atleti a causa di vari adattamenti fisiologici (metabolici, neurali e muscolari) indotti dall’allenamento. Il tracciamento del VO2 max, in combinazione con il monitoraggio delle attività, offre un quadro completo della resistenza fisica e motiva a migliorare continuamente, rendendo visibili i frutti del duro lavoro.
41
THE PILL PRODUCTS
THE PILL WOMEN
BY ELENA BENASSI
LaMunt: una storia di donne, montagna e Me-Time
In un mondo che spesso si muove a ritmi frenetici, esiste un luogo dove le voci femminili risuonano con forza e chiarezza, intrecciando storie di passione, innovazione e autenticità. Questo luogo non ha coordinate geografiche, ma si trova ovunque ci sia il desiderio di esplorare, di superare limiti e di abbracciare la maestosità della montagna con spirito e cuore aperti. È qui che nasce e prende forma LaMunt, non solo come un brand, ma come un manifesto vivente del "By women for women”.
La magia di La Munt non si esaurisce nei sentieri percorsi o nelle vette conquistate, ma si rinnova e si intensifica nei LaMunt Crew Events, dove il tempo si trasforma in #MountainMe-Time, un tempo di qualità per condividere, sperimentare e crescere insieme. Ogni membro della Crew, community eterogenea tutta al femminile, può con la sua storia essere fonte di ispirazione e per questo motivo abbiamo deciso di raccontavi le storie di Tiziana, Lisa e Dagmar.
Quando la montagna è la prima cosa che vedi aprendo la porta, fin da quando ne hai memoria, è inevitabile instaurarvi un rapporto unico e speciale. Tiziana, nata e cresciuta in Val Camonica, ha sperimentato proprio questo. La sua natura dinamica rispecchia quello che studia: i ghiacciai. La loro trasformazione continua la affascina a tal punto che ha scelto di coniugare la passione per la montagna con il suo lavoro di ricerca, studiando l’effetto del cambiamento climatico sui ghiacciai e

cercando di comprendere come salvaguardare il luogo in cui si sente più a casa. «Vivere la natura è un'occasione per conoscermi meglio, senza filtri, per connettermi con me stessa e con le mie radici» spiega con passione. «Quando sono in montagna, riesco davvero a dare valore al percorso, più che alla meta. E questo è un grande insegnamento che cerco di mettere in pratica nella vita di tutti i giorni, riuscendo ad apprezzare di più l’impegno che metto in quello che faccio».
Lisa e Dagmar entrambe sudtirolesi, sono circondate da sempre dalle montagne e con questo ambiente hanno sviluppato una relazione unica. Lisa è la terza figlia di una famiglia molto sportiva e fin da piccola è stata abituata ai mountain sports: per lei pensare una vita senza attività in montagna non è possibile. “Il Mountain Me-Time per me significa prendermi una pausa dalla vita di tutti i giorni, per me stessa o condividendo questi momenti con gli
altri, godersi il silenzio, il panorama e più in generale il qui ed ora, ritrovando serenità e completezza.” Dagmar, ha invece scoperto una passione per il mondo degli sport outdoor spostandosi dai luoghi in cui è cresciuta, spinta dall’entusiasmo contagioso di amici e colleghi. È proprio durante il soggiorno ad Innsbruck - durante il suo primo lavoro - che nasce la sua passione per lo sci alpinismo e le escursioni in montagna. “Vivere la montagna è sinonimo di tempo di qualità, stacchi dalla quotidianità e torni ad apprezzare il silenzio ma anche a superare i tuoi limiti. Che sia durante la fatica della salita sugli sci, nella quiete dell’arrivo in cima, o ancora nel brivido di libertà della discesa; che sia in solitudine ed intimità, nella gioia scoppiettante di un gruppo di amici, oppure nella complicità di un’uscita in coppia, l’essenza della montagna è una, e trovare il contatto con essa è un viaggio da assaporare e godersi, ognuno al proprio ritmo.”
42
THE PILL WOMEN
BY ELENA BENASSI

43
BY ELENA BENASSI
Salewa We_ar* Nature Vivere la natura ovunque
Nel mondo dell'outdoor, l'evoluzione continua a ritmo serrato. Oggi, più che mai, assistiamo a una trasformazione nelle esigenze e negli stili di vita di coloro che amano avventurarsi tra le cime e i sentieri. È in questo contesto in continua mutazione che Salewa presenta la sua ultima creazione: la linea Salewa Puez SS24. Si distingue per essere un'interpretazione fresca e innovativa dell'abbigliamento outdoor, perfettamente adattata alle esigenze di una generazione più giovane, desiderosa di coniugare l'avventura in montagna con uno stile di vita moderno e cosmopolita. Questa generazione non è solo attratta dalla montagna per la sua bellezza selvaggia, ma la vive come un ambiente dinamico e multifunzionale, dove l'avventura si fonde con lo stile di vita quotidiano. È qui che questa collezione trova la sua ragione d'essere, offrendo un guardaroba versatile che si adatta a ogni situazione, dalla città alle cime più alte. In questa intervista, ripercorriamo il processo creativo e di realizzazione di questa nuova collezione insieme a Leonardo Fumagalli, Designer Coordinator Salewa.
Raccontaci il processo creativo per la realizzazione di questi nuovi prodotti Il primo passo è stato proprio quello di guardare al consumatore e studiare le esigenze dei giovani

di oggi che, insieme naturalmente ai nostri consumatori tradizionali, sono proprio il target di questa campagna. Con il cambiamento generazionale in atto, abbiamo notato un approccio diverso nei confronti dello sport, con una maggiore enfasi sull’esperienza legata appunto al vivere la compagnia, vivere la natura, vivere la montagna e meno sull'aspetto puramente sportivo. Questo cambiamento potrebbe essere stato influenzato anche dalla pandemia, con molti giovani che hanno riscoperto la natura dopo essere stati chiusi per tanto tempo e soprattutto si sono avvicinati a questo mondo senza
seguire le regole, chiamiamole, più classiche legate alla prestazione sportiva e al raggiungimento di obiettivi prefissati. Adesso, secondo me, questi aspetti per molti giovani sono passati un po' in secondo piano focalizzandosi maggiormente sul voler vivere un’esperienza; quindi, voler magari andare semplicemente con degli amici o comunque con delle persone con cui hanno un rapporto. Vogliono uscire un po' da quella che è la quotidianità, quotidianità lavorativa o quotidianità semplicemente della città, degli studi, vogliono vivere questo outdoor in un modo un po' diverso.
44 THE PILL INTERVIEW

45 ITW TO LEONARDO FUMAGALLI THE PILL INTERVIEW
BY ELENA BENASSI

Come questa analisi si è concretizzata nella realizzazione dei nuovi prodotti? Il nostro prodotto si posiziona come elemento lifestyle, rispondendo alla domanda di stile e vestibilità urbana. L'influenza del "Gorpcore", movimento che fonde semplicità e dettagli tecnici come piumini fluo, ha orientato questa percezione. La funzionalità, spesso secondaria nel lifestyle ma cruciale nello sportivo, si integra ora con l'ispirazione dall'outdoor. La nostra collezione segue questa linea, proponendo capi urbani, confortevoli e dai colori naturali, in linea con le aspettative di un pubblico giovane che desidera versatilità. L'ispirazione viene anche dall'Oriente, specialmente da Giappone e Corea, dove lo stile è essenziale anche nell'outdoor. Questa fusione tra Gorpcore, elementi
orientali e l'approccio al design funzionale caratterizza la nostra offerta, rendendola ideale per uno stile di vita dinamico, pur mantenendo le qualità tecniche dell'abbigliamento outdoor.
Come pensate che questa nuova direzione verrà percepita dai puristi dell’outdoor? Ci sarà sicuramente una certa dose di scetticismo da parte dei puristi dell'outdoor, ma crediamo che ci siano anche vantaggi per loro. I prodotti offrono comunque le prestazioni tecniche richieste per le attività outdoor, ma con un'estetica più urbana e versatile. Siamo convinti che questa nuova direzione renderà i nostri prodotti accessibili a una gamma più ampia di consumatori, mantenendo comunque la qualità e l'integrità di Salewa.
Il claim scelto per la campagna, "WE_AR* NATURE. We are nature, and we wear it", è molto suggestivo Il claim è frutto di un super lavoro del nostro reparto marketing. Qui in Salewa siamo molto fortunati ad avere persone che da questo punto di vista sono davvero competenti e che riescono a valorizzare il prodotto e a farne capire l’essenza.
“We Are Nature” rappresenta il desiderio dei consumatori di immergersi completamente nella natura durante le attività outdoor e di vivere l’esperienza a 360°.
“Wear Nature”, invece, si riferisce al fatto che noi questa forte componente naturalistica l'abbiamo voluta portare nel prodotto, perché le tecnologie principali che ritroviamo in questi capi sono la canapa, l’Alpine Hemp e la lana merino.La lana merino si è affermata come un'opzione ampiamente accettata nel mondo dell'outdoor, grazie ai suoi notevoli vantaggi ormai universalmente riconosciuti. Salewa ha deciso di adottare la lana merino nei suoi primi strati di abbigliamento, inclusi t-shirt e fleece, per via delle sue eccellenti proprietà termiche, antiodore e antibatteriche, che consentono il suo utilizzo prolungato senza necessità di lavaggio frequente. D'altra parte, la canapa, sebbene meno diffusa e nonostante sia stata meno utilizzata a causa delle restrizioni legate alla cannabis, sta guadagnando terreno. Negli ultimi anni, diversi marchi, inclusi quelli più orientati al lifestyle, hanno iniziato a utilizzarla, seguendo il percorso tracciato da Salewa tre anni fa. Le caratteristiche della canapa sono innegabili: è resistente, gestisce bene l'umidità e richiede meno acqua per la coltivazione rispetto ad altre fibre. È importante che i consumatori apprezzino il suo valore, poiché rappresenta un'alternativa sostenibile e di lunga durata rispetto ai materiali sintetici, con un impatto ambientale inferiore.
46 THE PILL INTERVIEW


47 THE PILL INTERVIEW ITW TO LEONARDO FUMAGALLI

Saxifraga
La
nuova capsule collection di
Dolomite
BY LISA MISCONEL
L’inverno volge ormai al termine, la neve inizia a sciogliersi lasciando il posto a colori e profumi di primavera. Il giallo dei mesi rigidi lascia spazio a nuovi germogli, e fra le rocce si fa spazio la Saxifraga. Dal latino saxum, roccia e frangere, rompere si tratta di una pianta dai petali delicati capace di resistere ai venti di alta quota ed infrangere la roccia per insediarsi nelle fessure. Bianco e rosso rosato sono le tonalità che si accostano alla roccia grigia tipica dei territori alpini la cui saturazione diminuisce al calare della sera ed all’arrivo dei primi raggi del mattino.
Saxifraga: è così che Dolomite, brand italiano con oltre un secolo di esperienza nello sviluppo e produzione di calzature ed abbigliamento per la montagna, ha chiamato la nuova capsule collection creata in collaborazione con gli studi di Design Temp Studio e Rayon Vert. Un rifiorire nella nuova stagione con una chiave stilistica all’avanguardia e l’utilizzo della natura come tema centrale. La continua innovazione ed esplorazione di nuovi codici estetici e comunicativi è ciò che permette ai brand di rimanere al passo con i tempi, ed accostare
questo ad una tradizione secolare è sicuramente un gesto coraggioso da parte di Dolomite. La resilienza della Saxifraga è accompagnata dal tema del dualismo che si ritrova in “From Dawn till Dusk”. Colori chiari e caldi per l’inizio di una nuova giornata per poi scurirsi verso i toni del muschio con l’avvicinarsi al tramonto. Questi colori, insieme al rosso Saxifraga sono i protagonisti dei pezzi della collezione: una giacca 3-layer in big ripstop waterproof, due t-shirt in cotone organico drirelease, shorts 4-way stretch con tasche e calzini tecnici.
49



50

Saxifraga GTX è la scarpa che caratterizza il lato footwear: pensata per il fast hiking e tutte le caratteristiche che richiede, dalla suola Vibram con Traction Lug Technology alla membrana Gore-Tex Invisible Fit. Grande ricerca e prestazioni elevate in una scarpa in grado di garantire massimo comfort durante l’attività ma rimanere adatta ad accompagnare i look urban della vita di tutti i giorni potendo scegliere fra due diverse colorazioni.
Questo progetto è sostenuto da Rayon Vert, un'agenzia europea specializzata in consulenza e design nel settore dell'abbigliamento outdoor, che si distingue per l'elevato standard dei test sui prodotti. Terzo player nella capsu-
le Saxifraga è Temp, studio di progettazione grafica con sede a Bergamo che segue la parte di identità visiva, direzione creativa, identità digitali e siti web. Il risultato è un concetto di comunicazione molto interessante, con immagini di altissima qualità ed ottimo equilibrio fra narrazione del tema e del prodotto. Un tipo di contenuto e prodotto che inizia ad essere sempre più apprezzato dai giovani frequentatori dei sentieri.
La barriera fra vita quotidiana e giornate in montagna viene man mano eliminata ed attività all’aria aperta diventano sempre di più facile approccio a nuovi utenti da ogni tipo di background.
51
Women2Women
Un bel progetto di Blizzard-Tecnica
BY LISA MISCONEL

Lagazuoi. 24 ore da tramonto a tramonto nel cuore delle Dolomiti ed un gruppo di donne provenienti da ambienti, professioni e luoghi diversi. Lo scopo? Sciare. Il vero scopo? Ricominciare con un nuovo focus group italiano per il programma globale di Blizzard-Tecnica Women2Women. Infatti, le origini di questo progetto si trovano nel 2015, quando nacquero i primi focus group in USA ed Europa che misero per la prima volta in contatto donne con background ed interessi diversi che condividevano la medesima passione per sci, libertà e montagna. Trascorrere del tempo insieme aiuta la creazione di sinergie, dove la timidezza lascia il posto all’empatia ed alla condivisione di pensieri e racconti di vita. La pandemia ha purtroppo interrotto gli incontri italiani e così, nel marzo 2024 grazie al lavoro della Community Manager Elisa “Sisa” Vottero, supportata da Giulia Pintarelli, Digital Content Coordinator di Blizzard-Tecnica, la storia è ricominciata. A partecipare alla nascita del nuovo focus group è volata dal Vermont anche Leslie BakerBrown, Global Leader del programma W2W.
52

53
Fra ex sciatrici, allenatrici, maestre, ma anche appassionate che lavorano in campi diversi da quello dello sci, c’ero anche io. Le pieghe forse non sono il mio pane quotidiano, ma sulla neve ci so stare e raccontare le storie è qualcosa che mi riesce, o perlomeno mi piace fare. La solidarietà fra donne è una tematica della quale si sottolinea l’importanza un po’ troppo di rado: siamo un genere molto critico, insicuro ed è spesso più facile cercare il conflitto più che il supporto. Questa è una delle cose che mi sono portata a casa dai due giorni in Dolomiti: avere punti di riferimento simili a noi, lavorare con chi ha i nostri stessi obiettivi e parlare con chi ha le stesse paure sono cose che ci rafforzano e motivano, ed è questo ciò che si propone il programma Women2Women. Non si parla solo di prodotto, ganci e comfort di calzata. Infatti, sedute intorno al tavolo con la luce soffusa delle lampade del rifugio Lagazuoi e la luna alta fuori dalle piccole finestre, Leslie ci ha parlato dei quattro pilastri del programma: product, education, inspiration, community building.
Col Gallina. Il prodotto
Ore 7:00, rifugio Lagazuoi. Inizia qui la parte dedicata al test del prodotto: protagonisti Phoenix e Black Pearl di diverse larghezze abbinati a Cochise e Mach. Le piste del comprensorio di Dolomiti Superski sono in condizioni perfette dopo la notte fredda e iniziano le prime curve sulle piste immacolate ai piedi delle imponenti cattedrali di roccia, prima di finire sulla pista di Col Gallina riservata per i test. Come qui, anche ad Aspen, Portillo, Kaprun, Mittersill, Lech, Alta Badia e Jackson Hole si testano e si valutano i prodotti di punta in commercio e si fa brainstorming per quelli futuri. Innovazioni come il CAS Cuff Adapt, le scarpette riscaldate Thermic-IC, le fibre Celliant per mantenere i piedi delle sciatrici più caldi più a lungo sono solo alcuni dei risultati di queste giornate. L'ultimo traguardo del programma W2W è il nuovo Black Pearl, testato più volte dai team W2W di tutto il mondo prima che fosse definita la versione finale che oggi conta 8-10 000 di paia vendute solo negli Stati Uniti e ad oggi singolo modello più
venduto. Le piste perfettamente tirate delle prime ore del mattino sono il terreno perfetto soprattutto per i Phoenix, che brillano del contrasto nero/rosa ad ogni curva. Poche ore dopo è dove Black Pearl inizia il suo momento, riuscendo a regalare grande divertimento in pista.
Rifugio Averau. La community
Tutto ciò che viene prima e dopo i momenti di sci, è ciò che chiamiamo community. Un gruppo di diciassette donne quasi sconosciute che a distanza di 24 ore si saluta come un gruppo di amiche che si stimano e supportano. Sembrano frasi fatte (e chissà quanto potrà durare questo idillio vista la naturale inclinazione di noi ragazze a piccoli drammi quotidiani), ma che importa. Ci sono donne di marketing, di sport, di comunicazione e ci sono mamme, neo mamme e non mamme. Infondo, come dice Sisa prima di lanciarsi nell’ultima discesa di giornata sotto una copiosa nevicata, “non c’è forza più grande che il supporto le une delle altre”, in grado di combattere ogni tipo di invidia. Che importa se sei una maestra di sci o un’influencer, se pubblichi ogni momento della tua vita o preferisci la modalità aereo? Non siamo uguali quando ci blocchiamo alla finestra davanti a una nevicata? O quando ci guardano storto se parliamo di rocker e sciancrature non permettendo che vengano prese decisioni al posto nostro?
Sui tornanti che scendono dal passo Falzarego penso che io in realtà non so bene regolarmi gli attacchi degli sci, e non so neanche cosa rispondere quando mi chiedono se sono una buona sciatrice. Sicuramente però so che il timore che avevo quando quei tornanti li salivo ed il senso di inadeguatezza del non essere una “sciatrice vera” sono spariti lasciando spazio a nomi a cui poter collegare un volto amico, l’idea di un nuovo viaggio insieme e sì, ovviamente anche delle curve da paura. Women2Women Italia si chiama Sisa, Giulia, Camilla x3, Anna, Baba, Annachiara, Daniela, Silvia, Maria, Viola, Valeria, Valentina, Ludovica, Sara ed il viaggio è appena ri-cominciato.
54


55
New Balance Fresh Foam X Hierro 8
Dal tramonto all’alba
BY STEFANO LIONETTI
Una chiacchierata con Riccardo Borgialli sugli obiettivi dell’anno, sulle gare UTMB, sul suo ingresso nel New Balance Trail Team e sulle nuove Fresh Foam X Hierro 8.
Era parecchio che non facevo quattro chiacchiere con Riccardo. Ci incontriamo sempre alle gare ma poi siamo entrambi di fretta e lui – ovviamente – è già a casa a mangiarsi una pizza quando io finisco. Avevo in mano la nuova NB Hierro 8 da qualche giorno e dopo averla testata per qualche chilometro mi faceva piacere confrontarmi sulle sensazioni con qualcuno che avesse una gamba decisamente più svelta della mia. Ma in fondo era una scusa per parlare un po’ di tutto.
Allora, come sta andando questo trail camp di New Balance? Bene, mi sto divertendo, si fa anche un po’ di gruppo con gli altri atleti.
Siete in Liguria giusto? Sì, vicino a Spotorno. Per me è perfetto perché mi posso allenare già sui sentieri di Mare Montana, con Davide [Cheraz] ci siamo fatti delle belle salite ieri.
Giusto, allora leviamoci subito le domanda sulla stagione 2024, quindi primo obiettivo Mare Montana? Esatto, di solito la prima gara è quella di selezione per il campionato italiano, in questo caso selezione per gli europei. Sarà una bella occasione per buttarsi nella mischia e per
testare la mia condizione in vista della LUT120 e UTMB. La classica accoppiata estiva che vorrei provare a interpretare al meglio.
Sono gare in cui ti senti a tuo agio? Sono molto carico. Sai in queste gare la differenza la fa la notte. Quando arriva l'alba in un modo o nell’altro la porti a casa: può essere a Cimabanche, come a La Fouly. Secondo me è come in un film di Quentin Tarantino: bisogna stringere i denti dal tramonto all'alba e poi quando vedi il sole sorgere è andata, nel bene o nel male.
Gare lunghe o gare corte il momento di difficoltà c'è sempre, ma saper tenere duro è proprio quello che contraddistingue un runner da un altro.
Il bello delle gare lunghe però è che puoi anche toccare il fondo ma hai modo di risalire. Io l'ho vissuto sulla mia pelle la prima volta che ho fatto una 100 chilometri – la CCC di tre anni fa – davvero non pensavo mai di poter risorgere. Dopo Champex-Lac, quando mi si era spenta la luce, la prima cosa che ho pensato è stata “adesso mi trascino fino alla fine perché voglio portarla a termine”. Invece mi è bastata una salita e una discesa e sono tornato a correre come se fossi partito mezz'ora prima.
Raccontami dell’ultima gara in Chianti (Ultra Trail). Chianti bene, son conten-
56

to. In realtà più per la gestione che in termini di performance. Diciamo che è stata la gara che avevo programmato: una gara costante e negli ultimi km in crescendo in cui lavorare sull'approccio, lavorare sull'alimentazione, per mettere a punto alcune cose che a Transgrancanaria non erano andate proprio nel verso giusto.
Quanto hai avvertito la presenza di UTMB? Beh, il parterre di partecipazione era di un altro livello con atleti di élite in cerca di Running Stones e ticket per entrare in gara nelle finali per qualificazione diretta. Su tutte le distante hanno abbassato il record, ma non soltanto il primo: io sono arrivato sesto ed ero comunque sotto il record precedente di una decina di minuti. È giusto così, è lo sport che cresce.
La tua esperienza con il Trail Team New Balance è iniziata da poco. Che differenze vedi rispetto al Team Salomon nel quale sei stato per molti anni? Con New Balance, a differenza del periodo in Salomon in cui facevo parte del team locale, l’approccio è più internazionale. Abbiamo solo il team europeo e puoi confrontarti con tutti atleti internazionali. Il Trail Camp include workshop di sviluppo prodotto: ci alleniamo al mattino e nel pomeriggio collaboriamo con il team di Boston per discutere bisogni, pro e contro, e miglioramenti dei prodotti testati, dalle scarpe all'abbigliamento, adeguati alle distanze che corriamo. La differenza di approccio si sente nelle piccole cose, nella voglia e nella possibilità di sperimentare. Qui hai la sensazione di essere utile a costruire qualcosa, oltre che semplicemente come atleta con le tue prestazioni. Quello che percepisco è il fatto che sia un processo di crescita comune. Atleti e scarpe di pari passo.
Con che scarpe hai corso in Chianti? Ho usato le FuelCell SuperComp Trail,
quelle con la piastra in carbonio. Era comunque una gara veloce e io mi ci trovo molto bene, quindi ho usato un approccio stile maratona: se faccio meno fatica e vado abbastanza veloce, sono più efficiente. È ovvio che se avessi avuto in mente di metterci 10 ore avrei dovuto pensare a un’altra strategia e a un'altra scarpa, come la Hierro 8.
Eccoci qua. Io le ho usate per una decina di giorni e ho sentito parecchia differenza rispetto al modello precedente, sono curioso di sapere cosa ne pensi tu da atleta professionista. Per le prime gare dell’anno ho usato le Hierro 7, scarpe con cui mi sono trovato bene perché erano molto stabili anche su terreni dissestati come a Gran Canaria. Perfetta per un misto un po’ tecnico. La Hierro nuova secondo me ha più propulsione, ti aiuta di più nella corsa veloce in termini di stack e rullata. Inoltre la schiuma Fresh Foam X è molto morbida è molto confortevole e fa la differenza quando le ore e i chilometri sulle gambe aumentano.
Potrebbe essere la scarpa per fare Lavaredo Ultra Trail? È sicuramente tra quelle che sto valutando, insieme alle FuelCell Venym che però sono fatte per spingere e lì torniamo al discorso di quante ore pensi di stare sulle gambe.
Potresti pensare di cambiarle a metà gara, è una cosa che sei abituato a fare? Di solito no, ma su una distanza del genere potrebbe anche avere senso. Dipende anche da come sta andando la gara, cambiare le scarpe ti fa perdere comunque un paio di minuti, magari ne vale la pena e hai comunque 60 chilometri per recuperarli. Mi piace, è una buona idea.
Ci sentiamo presto per un’altra chiacchierata? Volentieri, ma almeno davanti a una pizza
58



60
L’umidità di Cimabanche, i canyons di Western States e Robert Hajnal
BY FILIPPO CAON
Cimabanche deve essere certamente uno dei luoghi più umidi del pianeta. Il ristoro si trova lungo la strada statale che porta a Dobbiaco, sotto a un grande tendone di quelli delle feste di paese, stile balera. Non possiamo entrare e così ce ne restiamo fuori, in quattro su due seggiole da campeggio, coperti di rugiada, a contare i minuti che ci separano dal sole, fissando come una meridiana la parete est della Croda Rossa già illuminata. Siamo vestiti troppo leggeri, come ogni anno. Quando iniziano ad arrivare i primi corridori riusciamo a rivitalizzarci applaudendo il loro arrivo. Tra l’uno e l’altro passa qualche minuto, abbastanza per rivedere il nostro statement per cui Cimabanche è ormai senza più dubbi il luogo più umido del pianeta. Poi arriva un terzo corridore. Da lontano è vestito di bianco e di rosso tipici di Altra e capiamo che è Robert. Corre in t-shirt o forse in canotta, gronda di sudore e una volta giunto al ristoro trangugia una borraccia d’acqua versandosene metà sui capelli. Un brivido freddo ci
attraversa la schiena e così decidiamo di riniziare ad applaudire. Lascia il tendone e si avvia sul sentiero verso Ra Stua. Robert sembra proprio un bel tipo.
Hai preso il golden ticket per partecipare a Western States in Thailandia, ma senza arrivare primo alla gara. Eri lì per quello? Com’è andata? Mentirei se dicessi che non volevo il ticket, che veniva assegnato ai primi due. Prima della gara avevo chiesto a Gediminas Grinius, che poi sarebbe arrivato secondo, se nel caso avesse vinto il ticket lo avrebbe accettato. Mi disse di no e così mi sono detto che mi bastava arrivare terzo, nel caso lui fosse arrivato davanti a me, perché il ticket veniva assegnato ai primi due, o al terzo se uno dei due lo avesse rifiutato. Alla fine, sono arrivato quarto: Grinius secondo e Marmissole terzo, ma anche lui ha rifiutato il ticket e così l’ho preso io.
La prima volta che ti ho visto è stato a Cortina. Qual è il tuo rapporto con LUT e perché sei tornato così
tante volte? Lo fai per l’esperienza? Per il risultato? Per migliorare il tempo? È un’ossessione? LUT è stato il mio primo risultato buono in una gara importante. L’ho corsa la prima volta nel 2016 e arrivai quinto. Quando ho iniziato a correre nel 2012 e dopo aver partecipato alla mia prima ultra, una 100k in Romania, che vinsi, iniziai a chiedermi quale fosse la gara più importante al mondo, e cosa dovessi fare per arrivare al podio. Così il mio obiettivo diventò fare un grande risultato a UTMB. Poi scoprii che c’era un intero circuito di gare attorno a UTMB, che all’epoca era l’Ultra-Trail World Tour. Così corsi Transgrancanaria, Cape Town, e ovviamente anche LUT. Cortina è molto comoda arrivando dalla Romania: voli su Venezia e poi prendi l’autobus fino alle Dolomiti. Le montagne sono stupende ed è stato abbastanza naturale partecipare alla gara. La prima volta finii quinto, ma vidi che primi tre ricevevano una grande bottiglia di prosecco. Sarei tornato per quella, e così tante altre volte.
61

62
Nel 2017 hai fatto secondo a UTMB dietro a Thevenard, un risultato che vale una carriera. Non hai mai pensato di essere a posto, con questa gara, e che quello potesse essere il miglior risultato che potessi fare? Vorrei arrivare a finire dieci volte UTMB. Per il resto, non penso mai al fallimento o al DNF. Ho finito UTMB tre volte, e mi sono ritirato altre tre volte, sempre nello stesso punto, a Trient. Penso che la gara sia il punto culminante di una preparazione di tanti mesi, e che il grande risultato sia la preparazione. È come se la gara fosse la punta dell’iceberg. Ritirandomi, magari perdo la gara, ma posso usare quella preparazione per altri appuntamenti. Poi mi piace incontrare le persone, visitare i posti, è tempo ben speso indipendentemente dal risultato, e questo compensa in qualche modo le possibili delusioni.
Ogni gara ha i suoi punti iconici. Alla LUT è Cimabanche, all'UMTB Chamonix sono Courmayeur e Champex-Lac o Trient nel tuo caso. A Western States è Forest Hill. Come affronti questi luoghi durante la gara? Western States è la gara di cui ho letto di più. Soprattutto in Eat&Run di Jurek, dove parla molto della gara e di questi posti: Forest Hill, Rucky Chucky, Robinson Flat. Ma sono solo dei nomi per me al momento, non ho ricordi di questi posti, e non ho sensazioni legate ad essi. Ho una sensazione per Courmayeur, ho una sensazione per Cimabanche, che porto con me, ma non ho una sensazione per Western ancora, e questo è il motivo per cui voglio andare là un mese prima, per vedere il percorso, per iniziare a immaginarmi lì, durante la gara. E per associare delle emozioni a quei nomi.
Forse è anche la cosa bella di correre gare così leggendarie. Durante la preparazione ci immaginiamo correre attraverso questi luoghi iconici. Per gli amatori
forse è la cosa più bella, non so se sia così anche per i professionisti. Penso che per l’80 per cento sia uguale, in termini di emozioni.
Mi interessa capire come un professionista viva questo genere di cose. Cosa si provi alla sesta o settima volta che partecipi a una gara con l’obiettivo di correre forte. Penso che ogni gara sia unica. Per questo ne scelgo tre all’anno e cerco di concentrarmi su quelle, cercando di correrle bene e di assorbire la cultura che c’è dietro alla gara, e la visione degli organizzatori. Poi sì, voglio correre più velocemente possibile, ma è più tutto quello che ci sta attorno.
Perché Western? Perché è difficile entrare. Avevo provato con la lotteria negli ultimi tre anni. Poi scrissi un messaggio su un gruppo di atleti che alleno e gli consigliai di mettere il nome nella lotteria. Uno di loro fu preso e fu il primo romeno a finire la gara. Non potevo più essere il primo, ma volevo essere il primo romeno a vincere un golden ticket, e magari fare una top-10. A parte questo, voglio vedere cosa posso imparare dalla gara e dalla sua tradizione.
Com’è la scena della corsa in Romania? Noi abbiamo i Carpazi, che sono molto diversi tra loro, e abbiamo gare in tutto il paese. Devo dire che adesso è diventato uno sport popolare, gli sponsor iniziano ad arrivare, e in generale abbiamo dei buoni ambassador.
Pensi di aver avuto un ruolo nella crescita dello sport nel tuo paese? Penso di sì in realtà, questo perché ho provato a gareggiare al livello degli altri atleti professionisti a livello internazionale. Da noi c’è un po’ la tendenza di rimanere nel proprio paese, soprattutto per gli atleti elite. Manca un po’ il desiderio di correre fuori, anche se abbiamo grandi atleti. Penso che guardare di più verso l’esterno aiuterà le proprie generazioni di corridori.
Cimabanche deve essere certamente uno dei luoghi più umidi del pianeta. Il ristoro si trova lungo la strada statale che porta a Dobbiaco, sotto a un grande tendone di quelli delle feste di paese, stile balera.
63

Dakota Jones
L’aria inquinata, la panchina di Chamonix
Dunque c’è questa foto, ripubblicata su Instagram mesi fa, che ho salvato nella certezza che un giorno sarebbe tornata utile. Si vedono tre persone su una panchina, a Chamonix Mont-Blanc, lungo la pista ciclabile. Si chiamano Scott Jurek, Goeff Roes e Dakota Jones, e tutti e tre si sono appena ritirati dall’Ultra-Trail du Mont Blanc 2011.
Sono seduti su quella panchina ad aspettare di vedere Kilian Jornet vincere il suo terzo UTMB. Sono giovani—uno di loro lo è ancora oggi, mentre gli altri due appartengono già all’Olimpo dell’ultrarunning. Ripostando la foto, qualche giorno dopo aver fatto podio a CCC, nel 2023, Jones aveva scritto: “In my recent post I mentioned sitting on a bench in Chamonix after dropping out of UTMB 2011. Scott Jurek sent me the photo! This is from that day! I can’t remember who these two
BY FILIPPO CAON
other people are. They probably aren’t important to the history of trail running… I look such an idiot on this picture”.
Tra quella panchina e noi ci passano tredici anni, ere geologiche e generazioni di corridori, ma c’è chi è riuscito ad attraversarle indenne, arrivando dall’altra parte meglio di come era partito. Non molti, a dire il vero, e dei tre in quella foto uno soltanto. Nel frattempo, Jurek è diventato una divinità, Roes è stato semidimenticato (forse perché vive ad Anchorage, Alaska, ai confini del mondo conosciuto), ma solo Jones ha continuato a correre ad altissimi livelli, e forse più alti di allora—questo e altri sono i vantaggi di iniziare a correre ultramaratone a 18 anni. Ne riportiamo brevemente la carriera, testimoniata nelle agiografie e consultabile su UltraSignup: Jones corse la sua prima
50 chilometri nel 2008 a Moab, la cittadina dello Utah in cui è nato. Il maggio successivo corse la sua prima 50 miglia, mentre nel 2010 la prima 100 miglia, Bear 100, chiudendo in settima posizione in 22 ore e 15 minuti e vincendo la Bear 50 miglia dieci giorni dopo. Il giorno della foto sulla panchina a Chamonix Jones non ha ancora 21 anni e ha da poco corso la sua prima Hardrock 100 (secondo in 27h10’). Da lì in poi ha corso ogni gara che qualunque corridore coscienzioso sognerebbe di correre, e, oggi, dà l’impressione di essere in questo sport da sempre, pur avendo a malapena 34 anni e avendo appena raggiunto la fase migliore della sua carriera. Si spiega anche solo così, almeno per chi è sensibile a questo genere di cose, perché sia avvolto da un certo fascino. Tocca contare e ricontare aiutandosi
64


con le dita per convincersi che siano passati solo tredici anni, tanto sono cambiati questo sport e il suo sapore.
Flash-forward. È un pomeriggio di febbraio, da qualche giorno #inquinamentopianurapadana ha preso il posto di #palestina nei trend di X e di Instagram.
Da una settimana vengono pubblicate ovunque cartine geografiche molto colorate, anche se tutte un po’ diverse tra loro. Dati indecifrabili ai più, ma con un significato chiaro a tutti. Per gli empiristi e i dubbiosi, da qualche giorno dalla collina est di Trento si distingue un denso strato di foschia che copre il fondo valle anche nelle giornate limpide. C’è dunque un’altra foto, destinata a restare negli annali del Trento Running Club: c’è Martina Valmassoi in piedi su una panchina panoramica della Marzola, al tramonto, con un cielo giallo e azzurro e le classiche nuvole estive di fine inverno, e sotto, sulla valle, quella lingua di polveri sottili che copre migliaia di persone. Noi otto—io, Pass, Micky, Martino, Tommy, Mario (il di lui cane),
Martina e Dakota—siamo dall’altro lato della fotocamera, a 900 metri e in maniche corte (Mario no, è un cane). Dakota sta imparando l’italiano e ha ben chiara una frase: “giovedì, merda”. È nota l’affezione dell’italiano per la perifrasi, ma quella è fin troppo chiara, così approfittiamo dell’ultimo giorno di bel tempo per portarli sulla Marzola, al di sopra della malaticcia foschia che adombra la valle.
Avevo visto Dakota Jones per la prima volta in mezzo al deserto, mentre mi superava a un metro e mezzo da terra al terzo giro di Javelina Jundred. La seconda, a Chamonix, a qualche metro dall’ormai proverbiale panchina, aspettando il suo passaggio all’ultimo chilometro di CCC; in compagnia, io, di uno scatenato Francesco Puppi e di un commosso Dylan Bowman, per amore del gesto atletico il primo e per patriottismo il secondo. Anche Martina—già notissima ai più assidui frequentatori di questa rivista, ma mica solo a loro—l’avevo incontrata soltanto di sfuggita. Escluse queste fugaci apparizioni, il primo surreale incontro con entrambi doveva eviden-
temente avvenire qui, in un parcheggio della Marzola, sopra a Trento, in un anodino pomeriggio di febbraio. La scusa, una serata a cui li abbiamo invitati circa un mese prima con un prosaico messaggio su Whatsapp, per venire a raccontare le loro storie ai corridori di Trento, davanti a una birra, schiacciati in una saletta troppo piccola e con due telecamere in faccia e un registratore sulle ginocchia. Perché le epifanie vanno registrate e tramandate, e riascoltate in loop, anche in forma di aforisma, come un reel, che una volta che finisce ricomincia daccapo. È ancora questa, nonostante tutto, una delle ultime cose che ci illude di vivere ancora uno sport di nicchia, rievocato da quella foto sulla panchina: invitare un atleta a raccontare delle cose a caso a gente a caso in una birreria a caso, e a correre un giorno a caso in un boschetto a caso. E senza sponsor, o senza nominare, nemmeno per sbaglio, le scuderie degli atleti. Questo è il motivo per cui quell’amalgama di individui che chiamiamo comunità (inciso: comunità fisica, non mediatica), individui ancora troppo poco adulti per ab-
66


bandonare il pronome plurale (chi ce lo dirà, tra vent’anni, che quel noi era solo un’illusione?), continuerà a essere grata e devota.
“Ma la cosa che conta di più è lo sforzo, il viaggio che facciamo allenandoci ogni giorno, la routine, e soprattutto condividere questo viaggio con persone che capiscono, persone come voi. Questo è il modo per abbracciare questa comunità. Non stiamo facendo uno sport individuale, anche se tecnicamente quando corriamo siamo da soli, ma facciamo gare per stare con altre persone e perché così possiamo condividere i nostri obiettivi e la nostra passione con altre persone. Ed è una cosa che non capisco del tutto, è una specie di domanda senza risposta: perché significa così tanto per me? Ma essere in grado di viaggiare per migliaia di chilometri e incontrare un gruppo di persone come voi, che probabilmente sentono la stessa cosa che sento io per questo sport, è qualcosa di potente.”
Una banda di matti. Questo, almeno, deve aver pensato chi passava fuori dal locale e vedeva attraverso le vetrate quella piccola folla ascoltare queste
parole. Tutti matti, idealisti e sognatori, che poi in fondo sono la stessa cosa.
C’è questa scena bella e violenta, che in pochi minuti spazza via ogni sogno adolescenziale con un colpo di spugna, qualunque sogno, mio e vostro; è il momento in cui diventiamo adulti, in cui scopriamo che tutto quello in cui credevamo non era che un gioco. È l’ultima scena di Quadrophenia, di Franc Roddamm (1979), che, come tanti film che parlano di queste cose, è diventato il manifesto di un movimento pure facendolo a pezzi. C’è quindi questo Jimmy, sulle scogliere di Dover, che dopo aver trovato nella controcultura mod—ma metteteci quello che volete—il senso della sua vita di adolescente disadattato, e dopo aver fatto a pezzi lavoro e famiglia in nome di quello stile di vita, vede i suoi pilastri crollargli addosso a uno a uno, scoprendo che per tutti gli altri—i suoi amici, i mod—era solo un gioco: un modo di vestire, un modo di comportarsi: niente di esistenziale.
Così Jimmy torna a Brighton, il luogo in cui per la prima volta aveva sentito di appartenere a qualcosa, e in cui aveva creduto, nel modo più alto, di essere
nato per quello. Qui scopre che il suo idolo ribelle, Ace Face, fa il facchino in un hotel, e deluso ruba la sua Lambretta e gettandola dalle scogliere.
La fine del noi.
Tutti abbiamo la nostra Brighton, e prima o poi Brighton muore. Però c’è qualcosa che di volta in volta si rinnova, qualcosa di cui continuiamo a portare l’illusione, un noi, che sono poi persone con nomi e cognomi, non certo entità astratte, con cui condividiamo il processo, o se non altro dei momenti, momenti che magari non hanno nessun significato, parole al vento che tra vent’anni nemmeno ricorderemo, ma che sono comunque momenti reali. E siamo disposti a fare a pezzi le nostre vite in nome di questo, e a sacrificare il nostro tempo, il nostro denaro, i nostri dolori, e in una certa misura anche alcuni pezzi della nostra felicità. Chiunque corra le 100 miglia è disposto a farlo, almeno in parte, è una forma di privazione. Una gabbia di matti. Sono modi per sopravvivere, tutti insieme, e per dare un senso a qualcosa che non ce l’ha.
Maschere, forse, e allora datecene un’altra, un’altra maschera ancora.
68


Vegan as… Possible
Mi guardo intorno un po’ spaesato come spesso mi sento in queste situazioni. Gente, mormorio, luci. La cassa in sottofondo che manda musica orecchiabile che non riconosco. L’evento sembra ben riuscito e probabilmente, anzi sicuramente, il limite è mio che ormai non “riesco più” in certe situazioni urbane. È come se mi mancasse un orizzonte da rincorrere con lo sguardo, anche solo per un secondo. Una piccola via di fuga che mi faccia sentire più al sicuro, guardando oltre.
Partecipo abbastanza spesso a eventi, incontri, proiezioni, ma a volte mi capita di subire questa “sindrome da mancanza di scappatoia naturale” dovuta a contesti troppo di pianura per quelle che sono ormai le mie abitudini. Così mi soffermo sulla location che ospita l’evento, il Vibram Connection Lab, che devo ammettere essere davvero interessante per il senso di rivisitazione e interpretazione creativa che mi trasmette. Osservo le persone e i dettagli di ognuna di esse cercando dei punti di contatto negli sguardi, negli atteggiamenti nelle parole anche se solo di circostanza. Bevo un sorso di birra dal calice che mi è stato imposto (il calice, non la birra)
in modo molto gentile dal ragazzo al bar “tutto in calice stasera” mi ha detto sorridendo. Mi guardo intorno in cerca di qualcuno di conosciuto per scambiare due chiacchiere.
Nada, tutti già impegnati in conversazioni.
Così decido di avvicinarmi a una delle attrazioni della serata: una scarpa posizionata in modo creativo ed esteticamente impeccabile su un piedistallo. È sezionata in più parti così da rendere esplicita la cura, la ricerca e il processo che sta alla base dello sviluppo di ogni sua parte. Personalmente faccio fatica a provare entusiasmo per delle “novità” riguar-
danti prodotti tecnici, a meno che non siano davvero rivoluzionarie o che siano funzionali a trasmettere valori specifici e ben definiti. Trovo che purtroppo, nella maggior parte dei casi, il concetto di “novità” si perda in un vortice consumistico per cui dover lanciare qualcosa di nuovo venga prima della stessa necessità di sviluppare un prodotto nuovo. Questo nel mercato outdoor come su qualunque altro mercato. Resto qualche minuto di fronte a questa scarpa blu (una Aku Conero GTX Limited Edition con suola Vibram Fuorà, per i più curiosi) edizione limitata di un modello arrivato al trentesimo anno di presenza nella collezione dell’azienda di Montebelluna che, proprio per questa ragione, ha deciso di festeggiarla con una limited edition in tre versioni (una blu dedicata al rispetto per l’ambiente, una marrone dedicata alla salvaguardia della tradizione manifatturiera e una gialla dedicata alla competenza tecnica nella collaborazione con Vibram).
Osservando questa scarpa la mia mente vaga riflettendo in modo più ampio su quanto sarebbe bello trovare un reale equilibrio tra tradizione e
71
TEXT LUCA ALBRISI PHOTOS ELISA BESSEGA


innovazione. Penso alla necessità impellente di immaginare e realizzare prodotti realmente sostenibili in questo piccolo, ma ormai grande, mondo outdoor. E poi, come mi capita spesso quando fantastico su prodotti “ideali”, penso alle mie personali e costanti difficoltà di ambassador, praticante, outdoorer, insomma essere umano e consumatore, che ormai da anni ha optato per uno stile di vita vegano.
Vegano non per salutismo, atletismo, radicalchicchismo ma per avvicinarmi, per quanto possibile, a un’esistenza “Cruelty Free”. E se già trovare prodotti vegani validi e durevoli è molto difficile, all’interno del mercato outdoor risulta ancora più complicato soprattutto per quanto riguarda le calzature. Già di per sé non è sempre facile trovare la scarpa giusta per le nostre caratteristiche, figuriamoci poi se si inserisce la variabile vegan.
E quindi me ne sto qui, imbambolato davanti a quella che è ormai diventata un’indistinta macchia blu che fluttua tra i miei occhi e i miei pensieri,
quando un tipo mi si avvicina e con tono gentile mi dice “se hai qualche domanda dimmi pure eh…”
Cerco di scrollarmi tutto quell’idealismo di dosso per dare una risposta decente ma mi accorgo di osservarlo con lo sguardo ancora rivolto ai miei pensieri. “Ah, sì grazie… Grazie mille.” È più una risposta automatica la mia, infatti raramente mi intrattengo a parlare di materiali anche perché solitamente, appena esplicito la mia scelta vegana, lo sguardo della persona che ho di fronte inizia a mostrare titubanza e spaesamento, vuoi per poca preparazione sul tema, vuoi perché pensano di avere di fronte qualcuno che li sta giudicando in modo spietato (tanto per la cronaca, non giudico le scelte di nessuno anche se credo che chi ricopre certi ruoli aziendali dovrebbe perlomeno masticare un minimo l’argomento).
Così, per evitare inutili imbarazzi, mi sono abituato a evitare il tema a priori. Ma il tipo gentilmente aggiunge:
“La versione blu l’abbiamo immaginata e sviluppata come rappresentativa del futuro. Futuro inteso come futuro del pianeta, dell’andare in montagna e della nostra azienda.”
Ok, ci siamo, a questo punto non posso più esimermi dall’approfondimento: “Mmm, dimmi di più…” e sorridendo timidamente aggiungo “ma ti avviso che hai di fronte un vegano.”
“Curioso” dice lui, “perché questa versione particolare della nostra scarpa non presenta alcuna componente in pelle. Tutto quello che vedi simile alla pelle è in realtà microfibra.”
“Ah” rispondo io un po’ basito “ma davvero? Ok, adesso hai tutta la mia attenzione” aggiungo sorridendo più che compiaciuto da quell’informazione.
Così lui procede aggiungendo “la nostra azienda ha una storicità manifatturiera legata alla pelle perché la pelle è un materiale dalle caratteristiche che si prestano perfettamente all’uso in montagna. Un uso storicamente legato ai lavori delle terre alte prima,
73
SPECIAL EDITION
YEARS
PRESSO IL MUSE DI TRENTO
PAGINA SX AKU CONERO 30 GTX
30TH
CHIARA FREDIGOTTI ECOLOGA

e all’andare in montagna per hobby poi, uso per il quale la scarpa doveva proteggere e durare. Se ti prendi cura di una scarpa in pelle” conclude, “può durare tranquillamente quindici o venti anni e questo per noi è un enorme valore.”
“E qual è stato lo stimolo per sperimentare oltre la pelle?” chiedo io.
“Negli anni abbiamo intrapreso alcuni percorsi (tra cui l’E.P.D. - Environmental Product Declaration) per capire effettivamente quale fosse l’impatto ambientale produttivo delle calzature Aku nelle diverse fasi di produzione delle materie prime, di loro trasformazione nella componentistica che compone una scarpa e, come ultimo, nel loro fine vita. Il risultato è che l’80-85% dell’impatto deriva dalla produzione delle materie prime e questo ci ha dato un obiettivo di lavoro chiaro per ridurre il nostro impatto, cioè lavorare sulle materie prime impiegate nelle nostre calzature.”
Inizio a capire rapidamente che chi mi sta parlando ha una chiara consapevolezza di quello che dice, nelle sue parole non c’è quella “superficialità green” che caratterizza la maggior parte dei discorsi attuali, tutt’altro, distinguo chiaramente la consapevolezza di un lucido percorso che si districa tra le contraddizioni ambientali del nostro tempo. Mi piace ascoltare persone che dimostrano di aver riflettuto sui passi già compiuti per capire come compiere scelte sempre meno imperfette. Così, sempre più incuriosito e stimolato da questo fortunato incontro lo invito a continuare.
“Approfondendo l’impatto di ogni passaggio produttivo abbiamo scoperto che in termini di emissioni di CO2 la produzione della pelle ha un
peso molto alto perché comprende tutta la fase di allevamento del bestiame (che come sappiamo è una delle filiere più inquinanti sul nostro pianeta), questo ci ha portato a sperimentare l’uso di altri materiali anche con la sviluppata consapevolezza che quelli riciclati abbattono ulteriormente l’impatto di produzione. Abbiamo quindi trovato una microfibra riciclata per più del 50% con la quale abbiamo creato dei prototipi e, dopo più di un anno di test ai piedi di camminatori, abbiamo raccolto risultati molto soddisfacenti riscontrando prestazioni del tutto simili a quelle dello scamosciato.
Da questa sperimentazione è nata la linea V-Light (composta da tre modelli: tempo libero, hiking e backpaking) dove “light” indica la leggerezza a livello di impatto ambientale ma anche a livello di peso poiché la microfibra è più leggera della pelle e quindi il prodotto in sé, risulta più leggero. La “V” puntava invece a rappresentare la sua caratteristica vegana poiché avevamo escluso totalmente l’uso di pellame in qualunque componente della scarpa. Purtroppo però, tramite ulteriori indagini, abbiamo scoperto che alcuni additivi presenti nelle membrane e in alcune gomme non erano certificabili come vegan. Per questo, almeno per ora, ci limitiamo a dire che in questa linea non usiamo pelle mentre siamo alla ricerca di fornitori che possano darci alternative vegan alle poche componenti che ci mancano per chiudere il cerchio.”
Mi rendo conto che, probabilmente per la prima volta in questo settore, mi trovo di fronte a una persona che non si rivolge a me come consumatore ma come un utilizzatore consapevole di un determinato prodotto e che cer-
ca di mettermi di fronte al maggior numero di informazioni possibili perché io possa effettuare una scelta sulla base dei miei personali criteri.
L’essere vegano, vegetariano o sensibile a tematiche ambientali passa necessariamente per una serie di contraddizioni riguardo a scelte che compiamo ogni giorno, un atteggiamento di trasparenza (e di misurazioni scientifiche) da parte di un’azienda, outdoor o no, rappresenta un importantissimo mezzo per compiere scelte il più possibile in linea con i nostri principi.
“Comunque piacere, Luca” dico al mio interlocutore porgendogli la mano con estremo ritardo. “Piacere mio, sono Giulio Piccin.” (product& CSR Manager Aku ndr.)
Mentre mi allontano abbasso lo sguardo verso le mie vecchissime scarpe da approach in canva risuolate ormai troppe volte dal mio calzolaio di fiducia in valle. Non ho idea se in queste colle o in queste gomme ci siano derivati animali, anche perché quando le acquistai, ormai più di dieci anni fa, non ero ancora vegano e tantomeno ero ferrato sull’argomento come ora. Avevo deciso semplicemente di comprare delle scarpe senza pelle, e cominciare a sperimentare.
E forse è proprio questo il vero valore che sta alla base del cambiamento che porta a reali “novità”, nella nostra vita come in quella delle aziende: il coraggio di sperimentare ricordando da dove si viene ma senza aver paura di cercare una nuova strada forse un po’ meno imperfetta.
Passo dopo passo. E passo dopo passo finisco la mia birra in calice, riporto il vuoto al cameriere sorridente, lo ringrazio e torno in cerca di montagne.
75

Oltre i confini dell’ignoto insieme Omar Di Felice
BY ELENA BENASSI
Nel panorama del ciclismo, Omar Di Felice non è solo un nome, ma un simbolo di resistenza, avventura e superamento dei limiti umani. Conosciuto come il titano dell'Ultracycling, Omar ha pedalato attraverso le terre più remote e spietate del pianeta, trasformando ogni rotazione dei suoi pedali in una narrazione di coraggio e scoperta. Dall'aspro freddo dell'Antartide alle aride distese del deserto, le sue imprese non sono solo sfide fisiche, ma viaggi nell'animo umano, dove ogni chilometro percorso è una storia di determinazione e passione
Siamo riusciti a fare due chiacchiere transoceaniche insieme a Omar, qualche giorno prima dei nastri di nastri di partenza della Indian Pacific Wheel Ride, gara estrema di 5500 chilometri e oltre 30.000 metri di dislivello nel continente australiano.
Ciao Omar, come stai? Certo che non se ne parla proprio di restare a casa tranquillo? No, assolutamente ormai per me è una necessità, un richiamo che è impossibile ignorare. C’è da dire poi che dopo 748 km nel freddo più totale per l’Antartica ∞ Unlimited un po’ di caldo ci stava…
(Ridiamo entrambi)
Il tuo amore per le temperature sotto zero ormai è cosa nota, qual’è stato il viaggio che ti ha segnato? Ho sempre avuto una predilezione per il freddo, fin dalla mia infanzia a Roma, trovandolo affascinante rispetto al clima tipicamente mite della città. Questo interesse si è intensificato con l'inizio della mia passione per l'ultracycling, spingendomi verso avventure in ambienti freddi e atipici. Il mio primo grande viaggio in queste condizioni è stato a Capo Nord nel 2014, durante l'inverno, un periodo in cui l'idea di affrontare il freddo estremo in bicicletta era quasi inesplorata. Le difficoltà erano molteplici, dalle gomme chiodate, reperibili solo nei paesi scandinavi, alla lotta contro il freddo pungente tipico del ciclismo, fino alla sfida della stabilità sul ghiaccio. Nonostante le fat bike fossero un'opzione, la loro limitata autonomia sulle lunghe distanze, le rendeva poco adatte rispetto alla mia scelta di una bicicletta da corsa con ruote da ciclocross. Questa esperienza iniziale ha rafforzato il mio amore per le sfide in condizioni gelide e gli obiettivi impossibili poi il Il progresso tecnico e tecnologico ha facilitato l'evoluzione del ciclismo in climi freddi, permettendomi di esplorare le regioni artiche più estreme.
77

Veniamo all’’Antartica ∞ Unlimited. Com’è nata l’idea di questa spedizione? L'Antartide ha sempre esercitato un fascino particolare su di me, un luogo mitico e magico che popolava la mia immaginazione fin dall'infanzia. Questa terra estrema ha ispirato la mia passione per le avventure insieme alla letteratura esplorativa, da Shackleton a Messner. Crescendo e diventando un ultracyclist, l'idea di un'avventura antartica si è trasformata da sogno a progetto concreto. Organizzare un viaggio del genere ha comportato sfide immense, dalla ricerca di sponsor alla preparazione tecnica e fisica, fino alla gestione dell'equipaggiamento in condizioni estreme. La mia prima spedizione in Antartide è stata un'esperienza profondamente formativa, interrotta dopo una settimana per motivi personali, ma ricca di insegnamenti. Il ritorno, dopo un anno di ulteriori preparativi e riflessioni, mi ha visto più consapevole e pronto ad
affrontare l'immensità e l'isolamento di questo ambiente estremo. Niente è come l’Antartide e non parlo solo di temperature: qui il concetto di distanza e il raggiungimento di un obiettivo fisico passano in secondo piano di fronte alla vastità della natura e alla lotta per la sopravvivenza e l’adattamento. Qui ho imparato che il successo non si misura in chilometri percorsi o traguardi geografici raggiunti, ma nella capacità di resistere, adattarsi e trovare un equilibrio dentro di te e con l'ambiente circostante.
Rispetto alla prima spedizione è cambiato qualcosa a livello di equipaggiamento?
La mia bicicletta è rimasta sostanzialmente invariata, essendo già adeguata alle condizioni estreme. La modifica più significativa riguardava la slitta: ho optato per un modello più pesante e strutturato, in grado di offrire una migliore gestione del carico e una mag-
78

giore stabilità. Questa scelta è stata dettata dall'esperienza dell'anno precedente, durante il quale la slitta leggera, sebbene specifica per l'uso con biciclette, si era rivelata poco adatta alle sfide antartiche.
Un altro importante cambiamento ha riguardato la tenda. Quest’anno ho deciso di portare con me il modello Blizzard 2. Questa tenda era progettata per essere più leggera, favorendo così un minor peso sulla slitta, e più resistente al vento. La scelta è stata influenzata anche dai ricordi dei giorni trascorsi bloccato dalla tempesta durante la mia prima avventura, spingendomi a privilegiare una soluzione che offrisse maggiore sicurezza e confort in caso di condizioni meteorologiche avverse. Avere accanto un brand come Ferrino con cui lavorare insieme per migliorare il mio equipaggiamento è stato fondamentale.
Ferrino che ormai ti accompagna da di -
versi anni… La collaborazione con Ferrino è iniziata nel 2020, durante il mio viaggio in Mongolia, e da allora il rapporto è cresciuto costantemente. Inizialmente, la partnership è stata una scommessa per il brand, dato che il mio profilo di ciclista non rientrava esattamente nel target tradizionale di Ferrino. Tuttavia, con l'espansione del mercato del bikepacking, il supporto di Ferrino per le mie avventure è aumentato. La condivisione di valori, la lealtà e l’affetto reciproco hanno poi consolidato il nostro rapporto. Collaborare con Ferrino mi ha anche offerto l'opportunità di promuovere il ciclismo e il viaggio in bicicletta a un pubblico più ampio, non necessariamente limitato agli appassionati di ciclismo. Questo aspetto è particolarmente gratificante, poiché riuscire a coinvolgere e appassionare nuove persone al mondo del bikepacking rappresenta un successo aggiuntivo e una soddisfazione personale.
79

Millet Camp de Base Chamonix
Alpinismo, Innovazione e Impegno Ambientale nel Cuore delle Alpi francesi
BY ELISA BESSEGA

Originario di Annecy, nel cuore delle Alpi francesi, il marchio Millet accompagna da oltre un secolo alpinisti ed esploratori: nel 2024, ha dato il via a un nuovo progetto che promette di lasciare il segno per almeno altri cento anni, mettendosi al servizio dell’ambiente montano e di chi lo frequenta e celebrando il suo storico legame con Chamonix, capitale mondiale dell’Alpinismo.
L’iconica cittadina alle pendici del Bianco è stata infatti scelta come sede del “Camp de Base Chamonix”, svoltosi dal 19 febbraio al 21 febbraio per offrire occasione di confronto e formazione sul tema della montagna che cambia.
Il raduno è stato occasione per presentare, insieme alla nuova collezione, la sua nuova brand identity: il nuovo logo è una chiara dichiarazione di intenti nel voler rivolgere lo sguardo sempre a nuove sfide e al futuro mantenendo il proprio Dna e l’eredità storica, con un design raffinato che ne riafferma l'unicità.
La salvaguardia del futuro è stato l’altro grande protagonista dell’evento: da diversi anni Millet si impegna a ridurre al minimo il suo impatto negativo ottimizzando contemporaneamente il suo contributo positivo per la società e il pianeta. Da questa visione è nata la “Roadmap to 2030” programma di 5 punti che guideranno il brand nel suo percorso.
“Oggi siamo impegnati nella sfida di adattarci costantemente ad un ambiente in rapida evoluzione, con l’obiettivo della neutralità della nostra impronta carbonica.” afferma in apertura del raduno Romain Millet, Direttore Generale e pronipote del fondatore del marchio.
Autenticità, presa di coscienza e adattamento al cambiamento sembrano essere le parole chiave per definire la direzione che l’azienda intende seguire per il proprio sviluppo futuro. Alla conferenza inaugurale dell’evento, tenutasi allo Spazio Michel Croz, a due passi dalla teleferica dell’Aiguille du Midi, è riunito l'intero ecosistema alpino, con una variegata presenza di giornalisti specializzati, media, professionisti del settore, semplici appassionati, ambassador e atleti.
Su un lato del palco, illuminati dai riflettori, i manichini mostrano i nuovi prodotti Trilogy, gamma più avanzata e più tecnica della collezione. Beneficiando della collaborazione e del sostegno di una rete di esperti e delle principali compagnie di guide alpine - la Compagnia delle Guide di Chamonix, la Società delle Guide del Cervino e la Compagnia delle Guide di Grindelwald - Millet ha sempre canalizzato la propria esperienza nel creare prodotti affidabili destinati a soddisfare gli utenti più esigenti. Il vero valore aggiunto sembra essere proprio il know-how acquisito grazie ad una storica e ben radicata presenza nel settore.
“L’evoluzione delle nostre montagne con l’arretramento dei ghiacciai e lo scioglimento del permafrost ci spingono ad adattare le nostre pratiche e i nostri prodotti, a studiarne di nuovi. Di conseguenza anche la pratica cambia, si evolve. Avvicinamento a basse emissioni di anidride carbonica a piedi, in sci- alpinismo, in parapendio o in bicicletta per accedere ai piedi delle vie; ascensioni più rapide, fast & light, discese lungo pendii sempre più ripidi.”.
82



“Abbiamo sempre sostenuto coloro che hanno scritto la storia dell'alpinismo. Nel 2024, continuiamo a sostenere i progetti dei nostri atleti e riaffermiamo il nostro attaccamento a Chamonix, la patria dei loro più grandi successi e dell'alpinismo mondiale” – afferma Frederic Fages, Millet Global Brand Manager – “Un luogo emblematico dove godiamo di un ecosistema di partner appassionati e impegnati, come la prestigiosa Compagnie des Guides e il Groupe Militaire de Haute Montagne. Partner animati da uno spirito di cordata così familiare agli alpinisti, che ci ispira ogni giorno nella nostra ricerca dell’ignoto”, proprio come recita il motto “Knowledge for the Unknown".
Componente essenziale del Trilogy Alpine Kit è la nuova tuta Trilogy Jorasse Goro-Tex Pro 3L Suit dedicata ad un uso specifico in alpinismo, parete nord e spedizione in condizioni estreme; a questa si affianca un innovativo primo strato integrale in lana e poliestere, la Trilogy Jorasse Wool Suit e un caldissimo piumino altamente tecnico e comprimibile, Il
Trilogy Jorasses Dyneema Down Hoodie. Il fulcro della serata si concentra però sugli ospiti, figure chiave dell’entourage del brand e portavoce della visione innovativa dell'azienda. Tra di loro, François Damiano, consulente tecnico ed alpinista lui stesso; Olivier Greber, presidente della Compagnia delle Guide di Chamonix; Jean Baptiste Bosson, membro del Consiglio Nazionale Francese per la Protezione della Natura; Aurélien Vaissière, guida alpina; e infine Charles Dubouloz e Simon Welfringer, alpinisti del team Millet, fra i più celebri atleti francesi della loro generazione. Questi ultimi, invitati a presentare il trailer di "Deep Freeze", un documentario prodotto da Millet che racconta la loro recente impresa sulla Direttissima Walker, prima ripetizione in invernale di una via storica sulla parete nord delle Grandes Jorasses.
Per il resto, gli argomenti trattati riguardano l’impegno del brand per la sopra menzionata “Roadmap to 2030” e i suoi cinque pilastri: prodotti circolari, risorse rinnovabili, catena di

produzione responsabile, essere umano al centro delle attività e cooperazione con le comunità montane. Questi i capisaldi che ispireranno le policy degli anni a venire, principi che - in concreto - Millet ha applicato annunciando la creazione di un fondo di dotazione per sostenere piani educativi, turistici, sociali, ambientali e di innovazione. Queste iniziative includono borse di studio per giovani, sostegno ai rifugi e alla biodiversità, e il finanziamento di progetti come Ice & Life.
È Jean Baptiste Bosson che, durante la serata, si occupa di presentare al pubblico quest’innovativa iniziativa a cavallo fra scienza e conservazione della natura, volta ad esplorare una delle più grandi metamorfosi attuali del nostro pianeta: lo scioglimento dei ghiacciai. L’approfondimento della conoscenza dell’ambiente glaciale e delle sue evoluzioni legate alla crisi climatica sarà il filo conduttore di tutte le attività a venire. Il giorno successivo il campo base si sposta in quota, con una risalita dell’iconica teleferica che dal centro di Chamonix, in 20 minuti, trasporta visitatori ed alpinisti a 3842 metri d’altezza, sulla cima dell’Aiguille du Midi, punto di partenza per l’esplorazione del massiccio del Bianco.
Ai partecipanti è stata offerta l'opportunità di visitare il Glacier du Géant insieme a Ludovic Ravanel, geomorfologo e guida alpina di Chamonix, per osservare da vicino i cambiamenti che l’alta quota sta subendo con l’aumento delle temperature. Ci fermiamo a qualche centinaio di metri dalla stazione a monte della teleferica, al centro del ghiacciaio, dove alcune centraline ne rilevano lo stato. "La velocità con cui stiamo perdendo i ghiacciai alpini è senza precedenti nella storia umana", ha dichiarato Ravanel. "Il riscaldamento globale sta provocando un rapido scioglimento di ghiaccio e permafrost, con conseguenze disastrose per
gli ecosistemi montani e per le comunità che dipendono da essi.”
Dopo una suggestiva escursione in cordata fino alle pendici dell’imponente Triangle du Tacul insieme agli atleti Symon Welfringer e Charles Dubouloz, la giornata si conclude al Refuge des Cosmiques, a 3100 mt, il più grande e secondo più alto rifugio di tutta la Francia, dal 1942 punto di riferimento dei personaggi che hanno fatto la storia dell’alpinismo. La struttura del rifugio è essa stessa testimone delle complicazioni legate al riscaldamento globale: nel 1998, 600 metri cubi di roccia sono franati proprio sotto alle fondamenta dell’edificio, rimasto miracolosamente in bilico fra i pinnacoli di granito e successivamente messo in sicurezza con rinforzi e puntelli.
L’approfondimento di Ravanel prosegue nella sala comune, nella calda atmosfera da rifugio d’alta quota, e si apre proprio con il racconto di quel crollo. Così come il Cosmiques, nel corso degli ultimi anni numerose altre strutture in alta quota hanno subito la stessa sorte - se non peggiore. I crolli del Periades nel 2019, de La Fourche e il bivacco Sberna nel 2022 e del bivacco Meneghello nel 2023 sono testimonianze di una montagna destinata a cambiare completamente il suo volto nel corso dei prossimi anni. Per dare una misura concreta all’entità del mutamento, si stima che solo una minima percentuale delle storiche vie che percorrono le guglie dei più alti massicci delle alpi resterà percorribile o uguale al passato.
Millet ha scelto dunque di fornire ai partecipanti al Camp de Base Chamonix 2024 elementi concreti e facilmente comprensibili per misurare l’entità del cambiamento senza trascurare di approfondire possibili strategie per prevenire e - dove non possibile - adattarsi, tanto a livello di azione collettiva che individuale.
86


Quando lo snowboard ti salva la vita Victor Daviet
BY LISA MISCONEL
PHOTOS PERLY, JEROME TANON
Nel mondo degli sport di adrenalina, tutto o quasi gira intorno a pochi semplici elementi: estetica, complessità dell’impresa, editing. La musica, la linea giusta, l’impresa impossibile. Di questo tipo di sport non c’è molto da dire, si spiega e racconta attraverso immagini e suoni, più che parole. È per questo che non è mai facile parlare di rider e freerider, ritrarli per la loro unicità e comunicare qualcosa di speciale. Non è però questo il caso di Victor Daviet, snowboarder new entry del team Arc’teryx.
Dopo un passato nelle competizioni a livello mondiale e una decina di anni nel contesto del filming, il nome di Vitctor è ben posizionato nello scenario dello snowboard. Le gare non sono il suo habitat e i video di nicchia bloccano la sua necessità di arrivare a comunicare con un
pubblico più ampio. Inizia così il suo percorso dedicato alle web series: Trip Roulette, una fra queste. “Con Trip Roulette avevamo la possibilità di raccontare tutto ciò che sta dietro ad un video, un viaggio, un’impresa. Potevamo usare lo snowboard come scusa per viaggiare il mondo, conoscere nuove persone, metterci alla prova anche con sfide di ecologia.” Parliamo di Trip Roulette - format che prevede l’estrazione casuale di una location, un mezzo ecologico, e dei compagni per portare a termine un progetto di snowboard - perché ha un ruolo nelle storie che voglio raccontare oggi. Dopo aver fornito un piccolo background, probabilmente comune a molti suoi colleghi, voglio che questo articolo giri intorno a due specifici temi: il suo ruolo nell’educazione alla sicurezza, il modo in cui da questo è iniziata una storia incredibile di vita.
88
PHOTO

89

Safety Shred Days – un nuovo modo di educare alla sicurezza
Nella vita di un rider, il pericolo è una costante. Dopo un traumatico episodio in cui Victor si è ritrovato a dover salvare in prima persona i suoi amici, si è acceso in lui il bisogno di dare priorità alla sicurezza. È da qui che è iniziata la storia di Safety Shred Days, un evento di formazione alla sicurezza in montagna che parla agli snowboarder con il linguaggio e lo stile che appartiene alla community. “Mi piaceva l’idea di rendere la sicurezza una cosa cool, volevo creare un evento per snowboarder giovani e squattrinati. Infatti, Safety Shred Days costa pochissimo ed include skipass, pasti ed esercitazioni. Per non parlare delle feste la sera: la community è riunita e si possono incontrare pro rider, professionisti del settore, giovani appassionati e condividere momenti indelebili! (...) Ho la sensazione di essere stato molto più utile con questo evento che in tutti i decenni passati a girare video per ispirare i rider.”
Trip Roulette 3 – Verso il Pakistan in sella ai muli
“Un giorno mi è stato proposto di partecipare ad un progetto dell’organizzazione no profit Zom Connection, con l’obbiettivo di raccogliere quanti più snowboard
possibile e portarli in una piccola valle del Pakistan dove esiste l’unica comunità di sciatori e snowboarder della nazione. Qui ho anche avuto l’opportunità di organizzare la prima edizione di Safety Shred Days Pakistan.” È iniziato così il viaggio di Victor nella valle di Chitral, nel nord del Pakistan, precisamente a Madaklasht. Un piccolo resort, l’unico in tutto il Pakistan dove si conta una community di sciatori e snowboarder di circa 2000 anime, dove sorge un solo piccolo skilift e gli sci sono per lo più di legno. “Quando ho conosciuto i ragazzi del villaggio è nato subito in me il desiderio di portarli in un’avventura. Abbiamo deciso di spingerci il più lontano possibile nella valle, dove non fossero mai stati con i loro snowboard. Volevo far vivere loro ciò che viviamo noi nelle Alpi, scendere da pendii in neve fresca, arrivare in posti inesplorati e scendere creando linee che dipingiamo noi per primi. Siamo partiti in sella a dei muli, per poi passare sulle nostre gambe e raggiungere il rifugio per la notte. Per scaldarci abbiamo acceso un falò e passato la notte tutti insieme chiacchierando e ballando. Il giorno dopo lo abbiamo passato a salire e scendere con le split: i ragazzi erano esausti, non avevano mai fatto snowboard in quel modo.
90


91
(...) Molti non sanno l’inglese ma una volta che sali sulla tavola non importa che lingua parli, siamo entrati in sintonia divertendoci sulla neve. Per la parte sulla sicurezza con Safety Shred Days, un local che conosceva bene l’inglese ci ha fatto da interprete per assicurarci che tutti potessero ascoltare, imparare ed allenarsi con i dispositivi che abbiamo fornito. Non potevo portare loro a scoprire il backcountry senza insegnare tutti i rischi che porta con sé!”
Afghan Snowboard Team: incontri che cambiano la vita
Prima di arrivare a Madaklasht, il team francese di Zom Connection fa uno stop a Malam Jabba, per partecipare ai campionati nazionali pakistani. Lì, oltre a rider nazionali, c’era anche l’Afghan Snowboard Team. Non esistono resort in Afghanistan, ma i ragazzi si allenavano a bordo strada sui passi montani dove scendeva un po’ di neve, e sulle dune del deserto durante l’estate. In tutta la nazione c’erano sì e no 15 tavole, ed erano loro a possederle! “Un po’ quello che ricevo io per una singola stagione...” ride Victor. Come spesso nella vita, è la curiosità che fa scattare l’inizio di nuove storie, e questa curiosità portò i ragazzi a bussare alla stanza d’hotel di Victor, che durante il giorno aveva dato spettacolo con trick ed evoluzioni mai visti da quelle parti. Da lì è nata un’amicizia e un fortissimo interesse e curiosità da entrambe le parti, e Victor aveva già deciso di viaggiare in Afghanistan per raccontare di loro. Poco tempo dopo però, arriva una telefonata dal presidente della federazione di snowboard afghana: con il dominio dei talebani, i ragazzi sono in serio pericolo per il solo fatto di essere snowboarder. “Mi trovavo a Parigi quando ho ricevuto questa chiamata d’aiuto. Ero pieno di speranza e buona volontà e molto ingenuo, e così ho preso il mio skateboard e sono andato all’ambasciata afghana. Non mi ero reso conto che il problema fosse di portata nazionale, che in pericolo c’erano altre centinaia di persone. Facevo di tutto per aiutare i miei amici, raccontavo a tutti che erano specia-
li in quanto snowboarder e dovevano essere aiutati.” Erano così simili a lui e allo stesso tempo all’interno di una storia così assurda. Morire perché si ama uno sport è un concetto normalmente astratto, ma in quel caso, più vero che mai. Grazie all’enorme condivisione dei media e su social, giornali e blog, la questione è diventata di interesse comune al punto di dare vita ad un vero e proprio team di professionisti volenterosi di salvare i 15 ragazzi afghani sotto l'egida dell'organizzazione no-profit Snowboarders Of Solidarity. Grazie a numerose raccolte fondi in poco tempo alcuni ragazzi sono stati trasferiti dappertutto (Germania, Stati Uniti, Canada) mentre gli altri hanno trascorso un periodo di stallo in Pakistan prima di arrivare in Francia. La loro vita è stata salvata ed è cambiata. Lontani dal pericolo ma anche dalla loro vita, hanno ricominciato da capo chi nelle Alpi, chi oltreoceano, partendo da un’unica sicurezza: lo sport. “Alcuni vivono qui in città, sono come una famiglia. Ho passato il Natale con loro e proprio qualche giorno fa siamo stati a pranzo. (...) L’anno scorso (2022. ndr) li abbiamo portati in un lussuoso resort, sono rimasti a bocca aperta. Mi hanno confessato di aver fatto più snowboard in quell’unico weekend che in tutta la loro vita”.
Possiamo parlare di trick, linee e gradi di pendenza. Possiamo mettere la musica più adrenalinica al video più impressionante che riusciamo a realizzare. Ma quando salvi delle vite, lì è un’altra storia. La storia di Victor e di ciò che gli è successo solo dal 2021 ad oggi iniziata da un semplice viaggio per una causa benefica è sicuramente una di quelle che vale la pena raccontare, e a dire la verità non è neanche difficile sentirla raccontare da lui in persona, basta partecipare a una delle tappe di Safety Shred Days! Ci fa ricordare come le nostre passioni possano fare da veicolo per esperienze che vanno ben oltre il singolo tema della neve, che possono riempirsi di mille significati e portarci su percorsi che mai avremmo intrapreso e chissà, magari salvare delle vite.
92


93
 BY CHIARA GUGLIELMINA
BY CHIARA GUGLIELMINA
Una storia vera
Premessa: le fotografie sono state scattate sulle Alpi Pennine di confine, nell’unica nevicata degna di nota della stagione in corso, nel mese di marzo 2024.
Era il 5 marzo. Linda fu la prima ad aprire gli occhi. Una lieve luce rosa illuminava la stanza mentre fuori, il sole, dormiva dietro le montagne. Nelle brande a fianco, lo Smilzo e Formica erano immobili a pancia sotto, uno dei due rantolava. La polvere si levava dal vecchio pavimento, restando sospesa in una nevicata inversa. Linda si alzò per aggiungere un ciocco di legno al focolare. I tre ragazzi vivevano in quella casa da ormai dieci anni, convivendo l’unica stanza. E la stufa, “Fiammetta”, era l’unica fonte di calore. Il bagno era una capanna fatta di tavole di legno segnate dal gelo. Il tetto era collassato sotto il peso della neve e la porta d’ingresso era sbarrata da un chiavistello arrugginito. Una volta con le chiappe sulla tavoletta, la vista sulla nord del Corno Bianco era impareggiabile. Eri però a cinquanta metri dal rifugio, e durante l’inverno dovevi spalare la neve per due ore prima di raggiungerlo. Lassù, in quel mondo lontano, il silenzio era rotto soltanto dal vento tra i larici e dal crepitio di Fiammetta.
Formica era il più piccolo, nessuno ricordava il suo vero nome. Forse Niccolò, o Nicola. Per l’intero villaggio, mille metri di quota più in basso, era sempre stato “Formica”. Si caricava sulle spalle zaini più grandi di lui, non si lamentava mai e a sciare era il migliore. Lo Smilzo, invece, probabilmente superava i cento chili. Era grosso, non grasso. Mangiava polenta tutti i giorni e quando finiva il mais camminava oltre quattro ore per scendere in paese a fare scorta. Era il più forte del gruppo e conosceva ogni angolo del Monte Rosa.
Linda era l’unica donna, con due perle di ghiaccio al posto degli occhi e una lunga treccia bionda sulla schiena. Era lei ad occuparsi della cucina e delle galline, mentre gli uomini si occupavano della legna e delle vacche: Bella e Daisy, due pezzate rosse con un latte dolce e grasso.
Linda, Formica e lo Smilzo parlavano poco, avevano poche cose e detestavano ogni forma di spreco. Per loro ogni giorno rappresentava una nuova opportunità
95

per essere creativi. Trovarono soluzioni sostenibili per tutto. La legna, raccolta nella foresta, non era solo il combustibile per la stufa che li riscaldava, ma un modo per preparare un pasto nutriente con ingredienti semplici. Patate, cavoli, cipolle. L’acqua calda per le docce e la lavanderia non proveniva da nessuna fonte esterna, ma da una caldaia alimentata a legna. E anche leggere un libro dopo il tramonto era possibile grazie alla “Lucciola”, la lampada a olio sempre alimentata dalla legna. La legna era usata per tutto lassù. Per loro avere meno non aveva nulla a che vedere con la povertà. In quelle umili giornate trovavano una pace sconosciuta al villaggio di sotto. E non l’avrebbero mai abbandonata. Linda mise la moka sulla stufa e svegliò gli amici con due tazze di caffè fumante. Aveva nevicato senza tregua per sedici ore, ma ora il primo sole illuminava le cime. Bisognava andare fuori. Il freddo mordeva le guance, mentre gli sci tagliavano la neve fresca. Le lame affilate erano morbidi pennelli su una tela bianca. Ogni movimento dei corpi era libero, come se il mondo si fosse rimpicciolito sotto i loro piedi. E le sole cose rimaste erano il vento tra i rami e l’aria che risveglia i polmoni. Erano tre punti insignificanti in una montagna di neve, tre giovani creature nella natura selvaggia. Sciarono le valli e le creste, immersi nella crudele bellezza di un paesaggio incantevole, ma effimero. Per un attimo, dimenticarono ogni cosa. Qual era il loro nome? Da dove venivano? Erano parte della montagna, ora. Erano vivi nel presente e capaci di sentire un’idea di eterno.
Non nevicava così da cinque anni ormai e anche quella stagione, fatta eccezione per quelle sedici ore, non si era visto un fiocco per l’intero inverno. A pochi giorni dalla sciata, infatti, il sole sciolse ogni cosa. I prati tornarono verdi e gli sci asciutti, deposti nel rifugio. Soltanto in alto, oltre i 3.000 metri, qualcosa resisteva.
Lo smilzo, che era stato l’idraulico del villaggio, propose l’idea di utilizzare l’acqua di fusione del ghiacciaio per creare energia. Formica, che un tempo era il fabbro più conosciuto del paese, cominciò a tracciare disegni e schemi progettando un impianto visionario; capace di sfruttare quella risorsa in modo unico e sostenibile. Dopo settimane di duro lavoro, tentativi e fallimenti, i tre amici completarono il progetto. Era nata una manovia a impatto zero. Un impianto che, utilizzando l’acqua che sgorgava feroce dai seracchi del Ghiacciaio, li avrebbe portati fino alle vette più alte, dove la neve resisteva. Dove lo sci sopravviveva. E la libertà li aspettava.
La voce si sparse come l’eco di un sussurro nei vicoli del villaggio, a valle. Quella piccola scintilla di genio divenne il principale argomento di conversazione al bar e sotto i portici. Nacque come un segreto sussurrato tra intimi fino a spargersi a gran voce su tutte le Alpi. L’idea nata lassù, in mezzo alla natura, divenne un successo. Di Linda, Formica e Lo Smilzo non furono apprezzati soltanto il coraggio e l’ingegno, quanto piuttosto la perseveranza nel cercare soluzioni innovative ai problemi ambientali che minacciano la loro montagna. La montagna di tutti.
97

Da quel giorno la vita dei tre ragazzi non cambiò di una virgola. Continuarono a esplorare le montagne affrontando le sfide con forza e speranza. I tre giovani dimostrarono al mondo che è sacrosanto affrontare gli ostacoli con serietà. Ma è inutile focalizzarsi sul problema senza cercare una soluzione. Ogni idea diventa possibile, se smetti di crederla impossibile.
Questa non è una storia vera. Quello che è vero è che il Monte Rosa è una delle principali catene montuose delle Alpi e che lo scioglimento accelerato dei suoi ghiacciai minaccia la stabilità della riserva idrica che nutre queste terre. Avremo più sete e meno acqua. E quando la sete diventa più grande dell’acqua si capisce quanto precario sia l’equilibrio in montagna. Come alpinisti sulla cresta del Lyskamm, in un giorno di vento forte.
Quello che è vero è che i ghiacciai stanno perdendo massa a un ritmo accelerato in molte parti del mondo a causa del riscaldamento globale. È vero anche che il Ghiacciaio di Indren, sul Monte Rosa, è arretrato di 60 metri in due anni. Così come è vero che laddove fino a 25 anni fa si sciava, esiste oggi un deserto di roccia. Un’altra storia vera è quella legata all’andamento temporale nei tassi di perdita di massa dei ghiacciai. E al loro aumento spropositato negli ultimi decenni. I dati
raccolti da satelliti, sonde e misurazioni sul campo indicano una tendenza alla diminuzione della massa glaciale in molte parti del mondo, comprese le Alpi, le Ande, l’Himalaya e l’Artico. Quest’altra storia vera non fa che evidenziare l’impatto del cambiamento climatico sulle risorse di ghiaccio della nostra Terra.
Infine, la storia più vera di tutte è quella che preferiremmo non sapere. Il ghiaccio che si scioglie come un gelato in agosto, sparendo grammo dopo grammo, rappresenta un’ulteriore sfida per il nostro pianeta. La Terra sta sudando, cerca di liberarsi del peso che la opprime. Come quando a 4.000 metri, a luglio, vorremmo strapparci via la pelle. I nostri occhi possono vedere solo una parte di questa ennesima storia vera. Ma la testa riesce a comprendere la gravità della situazione.
E ora magari volete sapere del futuro. Vi chiedete come finirà questa storia vera? Siamo di fronte a un bivio e una scelta è necessaria. Possiamo continuare a raccontarcela parlando di ere, di cicli e di normalità. Credendo alle storie non vere e ignorando il pericoloso cambiamento. O possiamo alzare la testa, affrontare tutte queste storie vere e cercare soluzioni che possano salvare il nostro pianeta dalla rovina. E le nostre sciate dalla fine. Perché questa, pensateci, sarebbe la storia vera più triste da raccontare ai nostri nipoti.
Vi chiedete come finirà questa storia vera? Siamo di fronte a un bivio e una scelta è necessaria. Possiamo continuare a raccontarcela parlando di ere, di cicli e di normalità. Credendo alle storie non vere e ignorando il pericoloso cambiamento. O possiamo alzare la testa, affrontare tutte queste storie vere e cercare soluzioni che possano salvare il nostro pianeta dalla rovina.
99

100

Altered Dolomia
Quando i riflettori si spengono
BY CHIARA BERETTA PHOTOS GIORGIA ARCHETTI
Tralicci, piloni di cemento, cabine elettriche, impianti di risalita, infrastrutture più o meno decadenti. Siamo così abituati alla loro presenza che quasi non ci facciamo più caso, eppure queste costruzioni restano una nota terribilmente stonata nel paesaggio montano che le circonda. A documentare l’impronta indelebile dell’essere umano sulle Dolomiti è il progetto Altered Dolomia della fotografa Giorgia Archetti, classe 2000: una serie di scatti che portano l’attenzione su quello che resta tra le cime patrimonio Unesco quando l’alta stagione finisce e la folla si dilegua.
101

102

Ciao Giorgia, come ti sei avvicinata alla fotografia e come è nata l’idea di Altered Dolomia? Sono originaria della provincia di Brescia e inizialmente i miei studi sono stati di natura scientifica: la passione per la fotografia è arrivata solo verso la fine delle scuole superiori. Ho poi deciso di studiare fotografia allo IED a Milano, scegliendo il corso internazionale così da poter entrare in contatto con punti di vista stimolanti e più lontani dal mio. Durante il mio percorso di studi triennale ho avuto modo di sperimentare vari tipi di fotografia, ma mi sono trovata molto bene con la fotografia paesaggistica e di architettura, due aspetti che non a caso si combinano in Altered Dolomia, che è stato il mio lavoro di tesi.
Perché hai scelto proprio le Dolomiti? Sono zone che ho frequentato molto fin da quando ero bambina: lì ho imparato a sciare, ho fatto passeggiate in estate... È una terra che sento molto vicina. Crescendo e continuano a frequentarla, però, è cambiata la mia percezione dell’ambiente e del turismo di massa. Ho iniziato a notare il modo in cui abbiamo modificato la montagna per permettere al maggior numero di persone possibile di viverla: la mia vuole dunque essere un’analisi, una documentazione dell’impatto antropico sul territorio.
In tutte le immagini ho voluto bilanciare la componente architettonica con quella paesaggistica, facendo sembrare integrato nel paesaggio qualcosa che evidentemente non lo è e non dovrebbe trovarsi lì.
Il progetto è concluso o stai continuando ad ampliarlo? Al momento è in sospeso, ma certamente vorrei ampliarlo. Per presentare Altered Dolomia, infatti, non ho creato un libro, ma un sito (www.altereddolomia.com). Questo mi permette di avere un archivio fotografico consultabile online, con anche una mappa interattiva, che può essere sempre aggiornato, modificato e reso più dinamico. In futuro, ad esempio, vorrei esplorare la zona più a est, verso il Friuli, dove il turismo è forse meno sviluppato rispetto ad altre zone delle Dolomiti.
Un aspetto interessante delle fotografie di Altered Dolomia è che non ci sono mai persone: le infrastrutture sono abbandonate oppure chiuse, ma comunque deserte. Il risultato è alienante, quasi post apocalittico. Le località turistiche in bassa stagione diventano quasi città fantasma, con le infrastrutture prevalentemente rivolte al turismo completamente ferme. Molti impianti non sono aperti nemmeno in estate, tra l’altro;
103

104

105
dunque, restano davvero attivi solo per tre o quattro mesi all’anno. Altre strutture che ho fotografato sono invece completamente abbandonate, come gli impianti sportivi di Cortina, dove adesso si parla della costruzione della nuova pista da bob.
In effetti il tema dell’impatto antropico sulla montagna è molto attuale: se ne scrive, se ne parla, lo si mette in discussione. Cosa aggiunge al dibattito un progetto fotografico come il tuo? La fotografia permette di avere una percezione visiva del problema. Ha un impatto molto più diretto e istantaneo rispetto ai dati e al testo scritto, specialmente su chi non conosce bene la montagna. La fotografia ti costringe a guardare, pone attenzione su ciò che di norma viene trascurato o nascosto nel momento in cui si vuole promuovere un territorio. Le pubblicità delle località montane ovviamente mostrano gli impianti di risalita, ma in funzione turistica, e i paesaggi incontaminati. Che esistono, certamente, ma ci sono anche interventi pesanti sul territorio.
Come hai trovato o come hai scelto i luoghi da fotografare? A maggio 2022 mi sono trasferita per un mesetto nella zona delle Dolomiti, in provincia di Belluno. Avendo base nei pressi del Col di Lana, ogni giorno facevo dei lunghi giri in auto. A volte sceglievo solo quali itinerari fare in macchina e poi, guardandomi intorno e girando un po’, trovavo cosa fotografare. Altre volte partivo con un obiettivo preciso che avevo individuato facendo ricerche: ad esempio, è stato così per la pista olimpica abbandonata di Cortina.
Durante il tuo soggiorno hai avuto modo di confrontati con i residenti sul tema, magari anche per farti suggerire qualche luogo da fotografare? In realtà no. Qualche mese prima avevo avuto modo di parlare con un ragazzo di Bolzano che si era lamentato di come i sentieri nei boschi fossero stati modificati per adattarsi alle e-bike, diventando abbastanza anomali:
questo spunto mi aveva aiutato a sviluppare l’idea del progetto. Poi però durante il mio soggiorno è stato davvero come abitare e attraversare dei paesi fantasma, o quasi: ho visto pochissime persone ed era strano guidare magari per un’ora senza incontrare quasi nessuna altra macchina... A Cortina, località che di solito ci immaginiamo iper-affollata, ho dovuto camminare mezz’ora prima di trovare l’unico bar aperto e riuscire a mangiare un toast. Il solo posto in cui nonostante la bassa stagione ho trovato turisti è stato il Lago di Braies, che tra l’altro era terribilmente asciutto.
C'è uno scatto che per qualche ragione ti è rimasto impresso o che ti piace particolarmente? Mi piace particolarmente una foto che ho fatto a Nova Levante, è una delle mie preferite: ritrae una parte di bosco, con alberi giganteschi, e la “zampa” di una torre della nuova cabinovia di Tires. Rende bene la scala, la differenza di dimensioni: la torre non si vede nemmeno tutta, ma si percepisce quanto è più grande. Ho letto che i pali della cabinovia sono stati progettati apposta così alti per evitare di abbattere una zona maggiore di foresta. È uno scatto che secondo me traduce bene l’intento di bilanciare il paesaggio e l’impatto umano, che in questo caso è molto recente visto che la cabinovia era all’epoca in costruzione e non ancora aperta. Altre strutture sono più datate, come la stazione di arrivo della cabinovia del Sass Pordoi, che ha aperto negli anni Sessanta: nella foto che la ritrae la si vede “appollaiata” in cima a una maestosa parete di roccia.
La fotografia ti costringe a guardare, pone attenzione su ciò che di norma viene trascurato o nascosto nel momento in cui si vuole promuovere un territorio.

106

107
Amore che vieni, amore che vai
BY MATTEO PAVANA
È spiegazzato, ricurvo, ruvido. Sono aggettivi che sicuramente non rimandano ai canoni di un concorso di bellezza; nemmeno tra piante. Il ginepro non ha davvero niente di brutto. Il suo essere spiegazzato, ruvido e ricurvo rappresenta appieno la sua anima irremovibile. Un’invincibile bellezza. Di sospensione. Infatti, se il ginepro ha un’anima, è verticale e sa di vento. E se il suo legno venisse scolpito, diverrebbe scalatore.
Ho sentito dire che un bravo scultore è colui che sa modellare la coerenza che ogni particolare legno esige, che sa rispettare lo spirito racchiuso in un fusto. Ho sentito dire anche che la betulla, per esempio, armoniosa, candida e slanciata qual è, è ideale per raffigurare ballerine, belle donne, acrobati; non si presta a incidere contadini che faticano. Per quello esiste il carpino. E così la maternità dimora nel pino cembro, i solai nel larice, i neonati nel ciliegio, la Madonna nell’acero. Pensate all’ulivo, invece, a come grida dolore solo a guardarlo, con quel tronco mesto e i rami slanciati nel gesto di una somma disperazione; sono braccia al cielo.
Si, mi piace credere che, se il ginepro venisse mai scolpito, sarebbe scalatore.
Nell’intaglio di questo balcone calcareo, è proprio da questo ginepro a cui non riesco
togliere gli occhi di dosso. Sono passati almeno cinque minuti. Fotoni salmastri lo investono, conferendogli, nel contrasto di un cielo terso, tersissimo, la silhouette di una fiamma nera zigzagante su sfondo blu. Col pensiero, stendo i chilometri di chilometri orari di vento che ha dovuto lasciar correre su di sé questo rudere immortale; per poter essere una raffigurazione così reale di un’idea alquanto astratta come la vita. Penso anche alle persone a cui voglio bene. Penso all’Ale, al Pierin, all’Aldo, al Paco, al Filo, al Tullio. E poi alla mamma, alla Sarin. Sono felice. Non è nostalgia verso di loro. Sono solo felice.
In primo piano, a bordo parete, ci sono Fede, Andre e Micky. Sullo sfondo, invece, due punti neri rimbalzano a colpi di termiche sul Maestrale del Tirreno, incuranti o ignoranti del concetto di gravità. Beate
108

loro, le aquile. Una gratitudine in formato cartolina. Pura e naturale meraviglia.
“Bisogna proteggere quello che rimane.” Mi aveva detto pressappoco il Pierin, prima di partire.
E aveva aggiunto anche: “L’arrampicata, oggigiorno, ha solo bisogno di persone che abbiano voglia di scalare; di ascoltare l’arrampicata. E basta.”
Solo da quassù riesco a comprendere appieno quanto questo luogo vada protetto, in un qualche modo. In primis dalla stessa arrampicata, quella di questi tempi; è l’epoca in cui bisogna comunicare tutto, mostrare tutto. Non è il periodo storico del silenzio e dell’anonimato, questo è certo. È al contempo strano e difficile parlare e scrivere di montagna ultimamente, di arrampicata soprattutto. L’arrampicata è divenuta una geometria senza forma, è una brutta poesia di frenetica confusione, è lo sguardo vuoto di una mucca che rumina dinanzi allo sfrecciare della TAV in un pascolo rigoglioso.
Io non ho di certo scoperto l’arrampicata in tempi migliori; non l’ho conosciuta per necessità mia personale. Il Lux mi portava ai Bindesi, fuori città, e mi faceva assaporare quello che c’era di appagante nell’arte dell’artigliare la roccia; o almeno ci provavamo. Solo dopo, dopo tanti anni, ho cominciato a vivere la montagna nel quotidiano, grazie al lavoro di fotografo di montagna - il termine fotografo outdoor lo odio come il coriandolo -. Ai tempi c’era già chi, del fotografo di montagna, ne aveva fatta una professione. I vari Levati, Felderer, Gimenez, Chin; tanto per citarne alcuni. La capitalizzazione del marcato outdoor (e ridaje) coincideva con il primo segmento di una curva in tendente ascesa, quando ancora la Ferragni ne capiva quanto me di Instagram e Honnod aveva vinto solamente l’Oscar per “quello che sicuramente finirà con l’ammazzarsi”. Erano i tempi di Progression, i vari Dosage, Pilgramage. Gli arrampicatori scalavano (inteso che gli atleti facevano gli atleti) e
di Influencer nessuna traccia. Ispirati dai fotografi citati poco fa, io e alcuni altri abbiamo cercato di ritagliarci uno piccolo angolo di mondo in cui vivere grazie alle nostre fotografie, alle nostre storie. È stato un bellissimo periodo di rivincita personale, dopo quella che ho archiviato per sempre come “una carriera universitaria poco soddisfacente”. Ma se fino a dieci anni fa questo stile di vita era una beguine su brano di Bocelli in versione spagnoleggiante, ora posso dire di viverla come, citando Tesson, una “felpata su uova fabergè”. Essere promotore dell’immaginario della montagna e della scalata è sempre più, per me, una questione delicata. Quasi uno stile di non vita.
“Ma secondo te, quel tipo di arrampicata, quella che ha vissuto tu, io potrò riviverla?”. Avevo chiesto sempre al Pierin, in quella che non era più una chiamata al telefono, bensì una vera e propria crisi esistenziale.
“Mi dispiace dirtelo Pavi, ma io credo proprio di no.” La risposta la conoscevo già.
Di arrampicata basta aver letto qualche racconto e visto qualche vecchia immagine in qualche rivista - altrettanto vecchia - per intuire e comprendere che qualcosa è cambiato. Ed è cambiato per sempre. Che le cose cambino è storia già scritta, una condizione d’esistenza. Non sono le vesti del vecchiodimmerda quelle che voglio indossare, per carità. Però è sul come cambiano che varrebbe sempre la pena avvalersi del beneficio del dubbio.
Me lo domando: “Cos’ha di così speciale, l’arrampicata?”
L’intuizione ultraterrena travestita da meccanismo biologico, la vibrazione del grido nel vuoto; questo significa per me arrampicare. Niente a che vedere con quello che viene propinato o venduto ora. Nei tempi che corrono l’arrampicata viene vista ed etichettata al pari di un’attività insulsa come il paddle. Cioè, ma davvero? Cosa hanno di vagamente simile la traduzione in danza del concetto di precario equilibrio, e lo smottamento corporeo del-
110


112

Finché rimarrà la scalata fine a se stessa sarò salvo, sarò felice; devo ricordarmelo. Poco importa poi se sarò spiegazzato, ricurvo, ruvido. Sarò stato, per lo meno, libero per davvero.
la dignità a colpi di racchettoni? Spoiler alert: niente. L’arrampicata ha solo molto di più da perdere: messa alla mercé della massa, privata della sua storia, snaturata della sua identità. La sua cultura? Ignorata. Ahimè, la storia del Mondo. Credo che la vera arrampicata si nasconda ancora negli anfratti e nelle pieghe delle montagne. E confido che abiti nel cuore dei ribelli: persone curiose che non si accontentano. Saranno i ribelli a salvare la montagna, perché sono gli unici che, in un mondo in cui tutto ha un’etichetta e un prezzo, si aggrapperanno al vero e unico Concetto; ciò che non è ancora possibile comprare (non del tutto, non per il momento).
Parlo della libertà. Io ho concepito il significato di libertà dopo la morte di mio padre, dopo aver interiorizzato che il tempo è “l’aria che respiro finché la respiro”. Perché si sa che la morte è una suggestione invisibile, un’orchestrina malandrina in trepidante attesa. Dopodiché il vuoto. Il Niente.
Osservo questo ginepro, ancora una volta. Solo adesso sento soffiare, come la termica a bordo parete, questa dannata malinconia. Una volta tornato a casa, avrò il compito di raccontarvi tutto questo: un’esperienza di viaggio, l’apertura di una nuova via, l’amicizia; arricchire il tutto, stando attento di trasmettervi quanto sia figo scalare, dormire in furgone, bere vino la sera, stare insieme e bla bla bla. Temo davvero che questa volta verrò meno a tutti i miei obblighi.
Io vorrei davvero potervi parlare di come io sia stato qui, di quello che ho imparato, delle persone che ho incontrato. Di quello che abbiamo fatto e di come lo abbiamo
fatto. Di quanto la roccia fosse tanto corallinica agli occhi quanto primitiva al tatto (pura goduria). Di quello che ci siamo detti la Fede, l’Andre il Micky ed io. Di quanta vitale energia ci fosse in ogni tacca, smagnesata, urlo o fotografia che fosse.
Ma che senso avrebbe così, senza raccontarvelo di persona? Vorrei parlarvene a quattrocchi, osservando la luce fioca di un bar di paese illuminarvi le pupille, e le pupille inghiottire quella stessa luce. Sarebbe bello. Vi dirò che è stato vero. Talmente vero da volerci tornare presto per vivere altri ricordi e lasciarli termicare lontano. Io non so quello che passa per la mente dei miei compagni ora, ma per me il fatto che un ricordo rimanga lì, dove dovrebbe stare un ricordo, mi sta insegnando a vivere meglio, ad apprezzare quello che c’è, a immaginare cosa sia possibile migliorare in una realtà che non mi soddisfa.
Spero mi venga concesso, almeno per una volta, di non raccontarvi o mostrarvi tutto. È per riflettere su quello di cui ha bisogno l’arrampicata adesso; c’è qualcosa di noi stessi che dobbiamo assolutamente correggere. Lo vorrei fare solo per questa volta.
Ancora l’ultimo respiro prima di cominciare le doppie. La nostalgia è lassù, con le aquile.
Finché rimarrà la scalata fine a se stessa sarò salvo, sarò felice; devo ricordarmelo. Poco importa poi se sarò spiegazzato, ricurvo, ruvido. Sarò stato, per lo meno, libero per davvero.
Com’è già che cantava De André?
114



La Barkley ha la sua regina
TEXT SIMONE LUCIANI
PHOTOS JACOB ZOCHERMAN
Il mio viaggio verso il cuore del Tennessee nasceva da un'ambizione precisa: documentare la terza impresa di Harvey Lewis alla Barkley Marathons, una leggenda vivente nell'universo degli ultrarunner con il fresco record del mondo in Backyard e due volte vincitore di Badwater 135. In questa missione, anticipavo di incrociare la traiettoria di un atleta eccezionale, di scrutare i confini estremi dello sforzo umano, ma mai avrei pensato di documentare la nascita di una nuova regina della Barkley.
All'interno del Frozen Head State Park, il varco verso una realtà dove la natura impone le sue regole e le sfide umane raggiungono livelli epici si apre davanti ai miei occhi. La Barkley Marathons si rivela ben più di una semplice ultramaratona; è una prova di resistenza mentale e fisica, un pellegrinaggio per anime audaci provenienti da ogni angolo della Terra, pronte a sfidare se stesse e l'ambiente circostante.
La Barkley è una invenzione di Gary Cantrell, in arte Lazarus Lake, definito un sadico da molti, ma dopo averlo conosciuto posso dire che è un visionario che ha costruito un vero e proprio parco giochi per chi è alla ricerca profonda dei limiti umani, creando qualcosa di eccezionale senza eguali al mondo.
La Barkley Marathons è caratterizzata da un percorso di oltre 100 miglia di terreno selvaggio, rivelato solo il giorno prima dell'evento attraverso la Mappa “Madre” su cui gli atleti potranno copiare la propria.
Ogni anno partono 40 partecipanti, che per entrare in questa gara hanno dovuto passare una rigorosa selezione “segreta”, architettata da Lazarus. In pochi sanno come entrare in questa selezione e il segre-
to rimane custodito dall’inizio di questo progetto.
La Barkley si distingue per essere per due terzi fuori sentiero con una difficoltà quasi disumana, ma anche per il suo dislivello che supera i 20.000 metri. Questa non è solo una corsa; è un duello contro l'inesplorato, dove i concorrenti si affidano a mappa, compasso e bussola per orientarsi. Il clima è quasi sempre impervio, tranne quest’anno, dove gli Dei di Barkley sono stati clementi. In quasi 40 anni di storia, ci sono stati ad oggi solo 17 atleti capaci di completare i 5 giri previsti, nessuna donna. Per diversi anni, la gara ha visto nessuno terminare i giri previsti nel tempo limite di 60 ore.
Il rito d'inizio, segnalato da una conchiglia usata come strumento musicale a soffio, alle 4:17 del mattino, annuncia che l'avventura sta per cominciare in meno di un'ora. Questo momento, imprevedibile fino all'ultimo, sottolinea la natura unica della Barkley. L'emozione e la tensione crescono, mentre gli atleti si preparano per una partenza misteriosa.
La competizione inizia sotto il simbolo della Barkley: l'accensione di una sigaretta da parte di Lazarus Lake.
Senza tecnologie moderne, i 40 partecipanti affrontano la natura con strumenti di navigazione tradizionali e un orologio in dotazione da 10 dollari, cercando pagine di libri disseminate lungo il percorso come prova del loro passaggio.Quest’anno sono 15, da ritrovare in ognuno dei 5 giri, corsi in sensi inversi ogni volta. Dovranno strappare la pagina con il numero del proprio pettorale. Il pettorale verrà cambiato ad ogni giro.
118





Il mio ruolo di testimone mi ha permesso di immergermi in un evento dove l'endurance incontra avventura e mistero, in un contesto di rispetto reciproco tra atleti, organizzatori e natura.
Tra le sfide e le sorprese, emerge la storia di Jasmin Paris, atleta britannica di fama internazionale nell'ultra trail, che ha infranto ogni record precedente, diventando la prima donna a completare la Barkley, con appena 99 secondi di margine sul tempo limite.
La competizione in passato ha visto partecipare talenti eccezionali come Courtney Dauwalter, ma nessuno aveva mai terminato la Barkley. Il suo ultimo giro è stato addirittura più veloce del penultimo, una testimonianza eloquente della sua inesauribile forza di volontà.
Durante il passaggio alla Torre, l'unico punto accessibile ai media lungo il percorso, le speranze di vederla concludere entro il limite di tempo sembravano svanire: Jasmin aveva davanti a sé il 40% del giro ancora da completare in un tempo che avrebbe richiesto prestazioni da record. Tuttavia, nel breve momento al punto di rifornimento d’acqua, l'intensità della sua determinazione brillava nei suoi occhi, sfidando ogni previsione. La convinzione generale nel suo fallimento iniziava a vacillare, e quello che sembrava improbabile iniziò a trasformarsi in una storica realtà dell'ultra trail.
Jasmin ha tagliato il traguardo nei tempi previsti, esanime, crollando a terra subito dopo, suscitando un silenzio carico di apprensione tra gli spettatori. Quel silenzio si è poi trasformato in un fragoroso boato di approvazione e festa quando è stata effettuata la conta delle pagine e, al suo rialzarsi, abbiamo assistito non solo alla sua
ripresa fisica ma anche alla nascita di una leggenda.
Questa edizione ha anche visto brillare Ihor Verys, un debuttante Ucraino / Canadese che ha attraversato per primo il leggendario cancello giallo, segnando l'inizio di una serie di successi. Accanto a lui, veterani come John Kelly (USA), al suo terzo traguardo, e Jared Campbell (USA), che con il suo quarto finish ha stabilito un record storico, dimostrano l'incrollabile spirito Barkley. Ha concluso la gara anche Greig Hamilton (Nuova Zelanda), portando il numero totale di finisher a 5, record mai visto.
La comunità Barkley si è unita in uno spirito di mutuo sostegno e rispetto per la natura, con concorrenti che hanno affrontato uno dei percorsi più ardui al mondo. Queste storie di tenacia e trionfo personale trasmettono un messaggio di ispirazione universale, ricordandoci che, nonostante le difficoltà, la determinazione può portarci oltre ogni ostacolo.
Mentre osservavo la gara, ho raccolto momenti di sconfitta e realizzazione, testimoniando come corpo e spirito possano superare confini inimmaginabili. In particolare, l'atto di generosità di Jared Campbell, che ha concesso a Jasmin Paris la scelta della direzione nell'ultimo giro, è un esempio luminoso di camaraderia.
Sicuramente ti chiederai, c’erano italiani tra i partecipanti? Purtroppo no e ne abbiamo avuto solo uno nella storia ad oggi.
La Barkley Marathons si conferma molto più di una gara: è un insegnamento sulla capacità umana di affrontare e superare l'impossibile, invitandoci a riflettere sul vero significato di sfida, comunità, vittoria e sconfitta.
122



Dentro una bolla Transgrancanaria
BY FILIPPO CAON
Allora c’è questo nuovo circuito di gare, un altro ancora, annunciato il 13 novembre dell’anno scorso e partito ufficialmente a Hong Kong il 18 gennaio scorso. In coro, il primo pensiero, come un rumore di fondo: un altro?! Questo circuito si chiama World Trail Majors ed è stato voluto e pensato da alcuni organizzatori di gare con il dichiarato intento di unire in un’unica serie dieci gare di tutto il mondo, cinque delle quali provenienti dal defunto Ultra-Trail World Tour; e chi sa che tra un anno o due non useremo lo stesso aggettivo anche per questo ennesimo tentativo di universalizzazione di uno sport che trova nell’eclettismo la sua identità.
Le dieci gare: Hong Kong 100, Black Canyon, Mt. Fuji 100, Swiss Canyon Trail (qualunque cosa sia), South Downs Way 100, Quebec Mega Trail (eh?), Grand Raid Des Pyrénées, Ultra-Trail Cape Town e Transgrancanaria. Il nome World Trail Majors ammicca alle World Marathon Majors, che raccolgono le migliori maratone al mondo per livello, storia, bellez-
za e importanza; denotando la necessità—ma di chi? ma quando?—di avere un corrispettivo nel trail running (c’è questa cosa di sognare un trail che assomigli più all’atletica leggera che a sé stesso, al che ci si chiede se non varrebbe la pena darsi direttamente ai salti).
La differenza principale con le Marathon Majors, però, è che le Trail Majors sono nate con la volontà di contrastare il monopolio di UTMB, e quindi già in partenza orfane di gare che meriterebbero del tutto il titolo di “major”, ma che hanno l’unico difetto di appartenere alla squadra dei cattivi. Questa pretesa di universalità va quindi a farsi benedire ancora prima di nascere, in nome di idealismi ben più pedestri, dovuti alla frustrazione di ottimi organizzatori di gare che vedono il loro sport cambiare alla velocità della luce dietro al faro sbagliato. Il risultato è che tra queste dieci gare alcune giustificano lo sforzo, le altre fanno da ripiego. Ma quelle che meritano il titolo, lo meritano davvero (la seconda gara del circuito, Black Canyon
125

100k, organizzata da Aravaipa in Arizona, è stata definita l’ultramaratona americana più competitiva di sempre), e Transgrancanaria lo ha dimostrato. Delle tre grandi corse insulari sull’oceano Atlantico, con Transvulcania e Madeira Island Ultra Trail, Transgrancanaria è la più storica e viene organizzata ogni anno dal 2003, che è parecchio tempo per la scena trail europea. L’evento prevede gare di diverse distanze ma le principali sono la Classic da 126 chilometri, la Advanced da 84 e la Maraton da 46. Negli ultimi anni la community dello sport si è affezionata sempre di più a Transgrancanaria, riconfermandola uno degli eventi più importanti della prima parte dell’anno.
Le gare. Cosa dovete sapere per avere argomenti di conversazione durante le corse con gli amici. Partiamo dalle foto. Ci sono diverse scene immortalate dai fotografi sul percorso e diventate virali nei giorni seguenti (virali, vabbè, ci siamo capiti), fra queste: Zach Miller in carrozzina dopo l’arrivo, devastato, dopo aver
chiuso la gara in settima posizione; l’abbraccio tra Miller e Jiasheng Shen all’arrivo, resta da appurare se prima o dopo la scena sulla carrozzina; infine, un video questa volta, di Miller e Shen che corrono lungo una strada asfaltata nel cuore della notte in mezzo a una bufera di pioggia e di vento.
Nessuno dei due ha corso la gara in grande forma, a dimostrazione che Transgrancanaria
Delle tre grandi corse insulari sull’oceano Atlantico, con Transvulcania e Madeira Island Ultra Trail, Transgrancanaria è la più storica e viene organizzata ogni anno dal 2003, che è parecchio tempo per la scena trail europea.
126


128


sia troppo dura e lunga per essere corsa come allenamento per l’estate—premiando chi la prepara al caldo. Gara maschile vinta da Raul Butaci, mentre la gara femminile (parliamo della Classic) è stata vinta da Courtney Dauwalter, che l’ha preparata sugli sci da fondo nel gelido inverno di Leadville, Colorado—cosa dicevamo di chi si allena al sole? Non ha battuto il suo stesso record, ma ha corso sempre in testa, per lo più da sola. Durante la stessa settimana The North Face, title sponsor di Transgrancanaria, ha organizzato un camp per i suoi atleti sull’isola, invitandoli a partecipare alle gare e aumentando il livello medio del parterre (ecco Miller, Shen, e Katie Schide). Ultime considerazioni random su Transgrancanaria. C’è questa cosa, che non richiede un piedistallo per essere osservata. Di anno in anno è come se avvenissero dei pellegrinaggi che cambiano meta di volta in volta. Non si sa perché, ma stando a Instagram è come se che un giorno tutti si sve -
gliassero e decidessero, senza mettersi d’accordo, di andare tutti a fare quella cosa. Accade con le montagne—c’è l’anno in cui tutti fanno il Breithorn, e poi l’anno del Gran Paradiso, e poi l’anno del Cervino—e accade con le gare.
Questa cosa ci ricorda che viviamo tutti in delle bolle, che quella del trail è una bolla, ed è una bolla talmente piccola che in un anno possiamo conoscere dieci o quindi persone che non si conoscono tra loro e che vanno tutte a correre la stessa gara, magari dall’altra parte del mondo, e però non conosci nessuno che la settimana prossima vada a fare la gara dietro casa tua. È un fenomeno curioso, non so come si chiami, deve avere in parte a che fare con la statistica, o con i sei gradi di separazione, che ne so. Fatto sta che l’anno scorso erano tutti a Madeira e per una settimana il mio cellulare è stato invaso da fotografie di spiagge nere. L’anno di Transgrancanaria? Fatto anche questo, metti la spunta. E chi ci va l’anno prossimo è uno sfigato.

130



James, where are you?
The Speed Project Atacama
BY LISA MISCONEL PHOTOS JORDAN MANOUKIAN


Questo è un articolo che gira intorno ad un soggetto ed un complemento oggetto. Un chi ed una cosa. Il chi è l’ultrarunner londinese James Poole, il cosa, The Speed Project Atacama.
Se siete come me e non vi basta un solo articolo per saziare la vostra curiosità, potrete prepararvi alla lettura oppure concluderla cercando di capire meglio chi è James e cosa è The Speed Project e per farlo vi basterà guardare Solis, il film che racconta del primo The Speed Project Solo corso da James da Los Angeles a Las Vegas. Dico che potrete conoscere James perché in tutti i film e docufilm che mi capita di guardare, è raro trovarne uno in cui il protagonista vi parla per tutta la durata del video, raccontando e raccontandosi. E mentre le immagini vi mostrano i luoghi del cosa, James vi racconta a parole un po’ anche del cosa, ma soprattutto del chi.
L’ultrarunning è uno sport che in Europa si è espanso raggiungendo numeri incredibili, se pensiamo che si basa sul correre una distanza almeno superiore ad una maratona, ma che molto più comunemente supera i 100km. Le competizioni sono aumentate a dismisura in ogni angolo del pianeta in stili diversi, più o meno eccentrici e con più o meno partecipazione. Le polemiche che seguono la commercializzazione di questo sport attraverso delle competizioni dove brand, numeri e media sono posti al centro, non sono poche e sempre più sono i corridori che decidono di prendere le distanze da questa scena. Uno fra questi Niels Arend, che un giorno ha deciso insieme ai suoi amici di buttarsi in un’avventura e correre da Los Angeles a Las Vegas per il puro gusto di farlo lontano da classifiche,
spettatori, pubblicità. Questa esperienza è stata così impattate per i ragazzi che sentirono il bisogno di condividerlo con altri appassionati non solo tramite foto, video e racconti, ma portandoli a viverlo in prima persona. Così ha origine The Speed Project, una corsa di circa 500km da Santa Monica al cartellone di Las Vegas dove non ci sono regole, né un sito ufficiale. Una regola anzi c’è, è quella di correre da un punto all’altro, scegliendo il percorso che più si preferisce. Non ci sono ristori, pronto soccorso, security. Si corre originariamente in staffette formate da 6 corridori, ma c’è anche chi lo fa da solo.
“Ho sempre sognato di correre TSP (The Speed Project), e quando mi si è presentata l’occasione di provare a ipotizzarne uno in stile DIY a casa mia in Cile, non ci ho pensato due volte. Sarebbe stata la prova che mi avrebbe fatto capire se TSP faceva per me o no. Abbiamo provato quindi una versione cilena di TSP attraverso il deserto di Atacama e solo dopo siamo volati a Los Angeles per prendere parte a quello originale. Lì abbiamo conosciuto Niels ed è iniziata la storia di TSP Atacama.” Racconta Max Keith, ultrarunner cileno fra le menti che hanno dato origine alla prima edizione delocalizzata di TSP. Il deserto dell’Atacama in Cile è noto come il luogo più arido della Terra, e tocca in altezza i 3600mslm. Come succede per ogni TSP che si rispetti, non ci sono iscrizioni né ripescaggi, un messaggio Whatsapp ai 7 solo runner ed ai 15 team
135

è bastato a farli volare in sudamerica per affrontare il selvaggio, duro, caldo, arido ed hardcore deserto dell’Atacama. La partenza è fissata per il 20 novembre 2023, ora locale, 4am ora locale presso lo skate park di Iquique dove non ci sono striscioni né tifo nè musica. Fra i sette corridori che attraverseranno i 500km in solitario oltre a Max Keith ovviamente, c’è anche James Poole. Lo vediamo in un frammento di video scovato nei reel dell’unico canale di comunicazione dell’evento, il loro profilo Instagram. “Non vedo l’ora di correre nel deserto più profondo, lontano da tutto dove non c’è niente a parte miglia e miglia di sabbia e paesaggi incredibili. Voglio essere lì e vivere qualsiasi cosa mi capiterà, questo è il bello di TSP. Il principio è molto semplice: io, il mio zaino e 500km da correre.” Dopo esattamente quattro minuti i sette ragazzi partono dallo skate park in direzione San Pedro de Atacama.
A documentare l’intero svolgersi della corsa è un simpatico host statunitense che con uno slang ed un look tipicamente americano racconta giorno per giorno i progressi dei runner. Vi ricordate la regola del “correre da un punto all’altro, scegliendo il percorso che più si preferisce?” e vi ricordate la voglia di James di essere nel più profondo del deserto lontano da tutto? Ecco. Lui, a differenza degli altri sei runner che hanno scelto di seguire la strada statale, ha percorso quasi tutti i 500km off road. Come ha fatto? Ci è ancora oscuro. Ricordo l’host che commenta un errore di percorso di una delle runner così: “Non tutti i sentieri verso San Pedro de Atacama sono chiari, se ti allontani dalla strada potresti cadere in qualche buca e non uscirne mai più.” Già dal primo giorno la frase ricorrente per tutti coloro che seguono la gara è: “James, where are you?”
James nel frattempo correva in mezzo alle dune, lontano da truck e rumori, ma anche dalla sua crew. “Ci sono state un paio di occasioni in cui il terreno era decisamente troppo sconnesso per permettere al veicolo di seguirmi. Correre per sette o otto ore da solo senza ombra solo con acqua ed un po’ di cibo è stato tosto – il tutto amplificato dal non sapere se e quando avrei potuto riconnettermi con la crew. Diciamo che quando li ho ritrovati ero abbastanza disidratato.” scriverà lui stesso qualche tempo dopo. Sabbia, dune, caldo, anche qualche impronta di puma. Le ore passano e i chilometri che separano dalla meta diminuiscono insieme alle energie.
Nel frattempo la cronaca della gara prosegue più o meno così: “Lucy in quinta posizione si è persa per un piccolo tratto questa mattina. Alberto in sesta posizione trova ancora le forze per ballare di tanto in tanto. James...non sono sicuro se James sia ora in quarta posizione oppure in prima... o se sia su un volo per tornare in UK. Non abbiamo notizie di lui se non il segnale del suo GPS che si muove. Dove sei fratello?”
“Non vedo l’ora di correre nel deserto più profondo, lontano da tutto dove non c’è niente a parte miglia e miglia di sabbia e paesaggi incredibili. Voglio essere lì e vivere qualsiasi cosa mi capiterà, questo è il bello di TSP.
137


139

James intanto correva, insieme al suo supporter Nicki. Un concetto di cui parla riferendosi al TSP americano e che ritornerà nel racconto cileno è il quello dei momenti up e dei momenti down. Infatti, dice lui, in ogni esperienza così lunga ed intensa ci saranno sempre una serie di low, e sono una parte importante del processo. Per poter vivere e godere a pieno i momenti belli, è necessario accettare e passare anche i momenti più brutti, più down. “Mi chiedo sempre se i momenti belli sarebbero stati così speciali se quelli brutti non avessero fatto così schifo. C’è sicuramente un equilibrio fra i due.”
Siamo quasi alla fine, siamo all’inizio del quarto giorno, e come ormai d’abitudine, l’host racconta sulla live di Instagram la situazione della classifica. “Alex, Max e Lucy per il quinto, quarto e terzo posto sono a dieci minuti di distanza l’uno dall’altro. Il secondo, crediamo sia il londinese James Poole. James mi ha inviato un messaggio recentemente e crediamo sia secondo, ma non abbiamo notizie di lui.” La giornata volge al termine e 87 ore dopo quella partenza allo skate park di Iquique, Rob Perez arriva a San Pedro de Atacama. Si parla ovviamente di record, essendo il primo finisher della storia di TSP Atacama, ed il tempo è comunque impressionante. Tuttavia, James non è molto lontano. Si trova a 30km dall’arrivo quando il suo supporter Nicki riesce per
la prima volta a collegarsi in live con il canale Instagram @thespeedproject. James fa la sua prima apparizione dopo tre giorni e mezzo dall’inizio della sua avventura per fare le congratulazioni a Rob. “You shamshed it!” Lo vediamo per la prima volta vicino ad una strada, stanco ma non troppo. “Questi ragazzi sono completamente pazzi. Correre tutti i 500km vicino a questi truck... io non ho visto l’ombra di un veicolo per giorni prima di arrivare qui. Come vorrei tornare in mezzo alle dune, a quei 300km di Powerline in mezzo al deserto. Ora mi godo questi ultimi 30km, tanto ormai Rob ha vinto. Arriverò prima di mezzanotte.” L’host fa i complimenti per la sportività, ma la realtà è che, risponde James, non si tratta di una gara ma di uno stile di vita, è un’esperienza incredibile che non si basa su chi arriva primo all’arrivo ma di come si vive il viaggio, l’avventura.
93 ore e 48 minuti. James arriva a San Pedro de Atacama dopo aver percorso quasi la totalità della corsa su sterrati lontano dalle strade. Un’avventura vera che racconta bene la natura selvaggia ed indomata di TSP Atacama che si sposa perfettamente con la sua. Ed è per questo che le foto che raccontano della sua corsa non hanno niente in comune con quelle che vedrete degli altri concorrenti. Atacama – What a (wild) ride.
In ogni esperienza così lunga ed intensa ci saranno sempre una serie di low, e sono una parte importante del processo. Per poter vivere e godere a pieno i momenti belli, è necessario accettare e passare anche i momenti più brutti, più down.
141

TEXT FILIPPO CAON PHOTOS ELISA BESSEGA REPORTAGE TRATTO DA "ULTRAWEST" IN COLLAB WITH RUNTRENTO
sparate al
Non
pianista


«Before it was a dream, now it’s a memory, which is almost the same feeling»
– Jim Walmsley
Poche ore dopo siamo al Tomichi Creek Trading Post, su Sargents, nella Gunnison National Forest. È una stazione di servizio nel mezzo di una prateria, in mezzo alle montagne. Una pompa di gasolio, un emporio e una tavola calda: da queste parti è già molto. Nel west americano i Trading Post erano originariamente empori e luoghi di baratto per i primi pionieri occidentali, nonché gli unici luoghi di commercio per centinaia di miglia sulle piste verso l’ovest. Oggi sono luoghi di passaggio per i camionisti, gli ultimi cowboy americani, in cui trovare un piatto di fagioli e fare rifornimento al camion.
Tomichi Creek si trova sul Continental Divide Trail ed è diventato una tappa fondamentale anche per i thråu-hikers
che affrontano il sentiero a piedi. Servono un ottimo caffè, e i migliori huevos rancheros nel raggio di cento chilometri, o gli unici, e sul retro dell’emporio, vicino al fiume, si può parcheggiare la macchina per passare la notte e fare una doccia calda. Ricorda un campeggio europeo, ma ci si trova molto di più e ci si ferma molto meno. All’emporio c’è un’intera linea di merchandise a tema Tomichi Creek: magliette, felpe, adesivi, calamite. Gli lascio giù 40 dollari per un cappellino da baseball e un sapone di Marsiglia.
In un certo senso i luoghi come questo hanno mantenuto la loro funzione originale: il mondo a qualche chilometro è cambiato, così come le persone che ci arrivano e i motivi per cui lo fanno, ma quello che cercano e quello che possono trovarci non sono poi così diversi da un secolo fa. A modo suo, Tomichi Creek è un luogo eterogeneo, in cui ci finiscono camionisti, escursionisti, famiglie in vacanza, e poi noi, forse i più strani di tutti.
Le ombre lunghe della prateria avvolgono ogni cosa di un soffice sapore estivo. L’aria della mattina è fredda e sembrerebbe che il sole possa restare piantato lì a mezzaria in eterno, mentre una nuvola di vapore si alza dal fiume e risale la strada fino alla pompa di benzina. L’emporio ha tre larghe finestre che danno su un porticato con due sedie a dondolo e un distributore di Coca-Cola. Di fronte ci sono parcheggiati due pick-up, oltre, la US 50 e poi la prateria. Alle pareti del ristorante sono appesi un paio di sci di legno, un fucile, alcune fotografie dell’emporio a fine Ottocento e una bandiera americana, piegata a lutto e riposta in una cornice di legno triangolare.
Ci fermiamo a Tomichi Creek per quindici ore senza alcuna apparente ragione. Alle otto di mattina la tavola calda inizia a essere affollata e al tavolo a fianco al nostro si siedono due mandriani sulla settantina, uno porta un paio di jeans infilati dentro agli stivali in gomma, t-shirt e cappellino in rete
144

col frontino. Ha la faccia paonazza e farebbe meglio a ordinare un’insalata; invece mangia uova e pancetta e beve una tazza di latte freddo, fissando il vuoto poco oltre la spalla del suo compagno. Si sentono il rumore dei camion che scorrono lungo la Highway e il dondolio della porta della cucina, a ventola, come nei saloon, che oscilla ogni volta che la cameriera porta il caffè.
Non so per quale ragione la vita mi abbia portato in qui, a Tomichi Creek, o in Colorado più in generale, fatto sta che quando ci sono capitato ci sono rimasto invischiato e ho finito per tornarci. Il Colorado è il west. Lo è geograficamente e lo è culturalmente. È il sogno del west, è dove quel sogno si è infranto e fallito, e dove rivive, tra le strade di una cittadina di montagna, in una miniera abbandonata o in una stazione di servizio come questa. È allo stesso tempo il mito e la realtà, con tutte le sue ambivalenze.
Se non avete confidenza con la geografia dello stato disegnate un grande
rettangolo coi lati lunghi in orizzontale e poi dividete il rettangolo in due tracciando una linea verticale al centro. Chiamate il rettangolo Colorado e la linea Interstate 25: a destra di quella linea ci sono le Grandi Pianure, che si estendono verso est fino al fiume Mississippi, mentre a sinistra ci sono le montagne, le Colorado Rockies. A distanza regolare, sulla Interstate 25, ci sono le città di Fort Collins, Boulder, Denver, Colorado Springs e Pueblo, tutte in fila, da nord a sud, sulla pedemontana che divide le pianure dalle montagne.
Così come le pianure del Colorado sono solo una piccola parte delle Grandi Pianure americane, le montagne del Colorado sono solo una piccola parte delle Rocky Mountains, che si estendono dal Canada al New Mexico. Le Rocky Mountains che si trovano in Colorado sono chiamate Colorado Rockies, e sono ciò di cui parleremo. Le Rocky Mountains dividono i due principali bacini idrografici del continente: quello dell’Atlantico e quello del Pacifico. Il
che significa che tutta l’acqua che cade e che scorre a est di queste montagne finisce nell’Oceano Atlantico, mentre tutta l’acqua che cade e scorre a ovest delle montagne finisce nell’Oceano Pacifico. La linea immaginaria che divide questi due bacini si chiama Continental Divide.
A loro volta, le Colorado Rockies sono divise in sottogruppi, chiamati Front Range, Mosquito Range, Sawatch Range, Sangre de Cristo, Elk Mountains, Tenmile Range e San Juan Mountains. Ma al contrario delle Alpi, dove i settori sono contigui, i gruppi delle Colorado Rockies distano anche diverse ore di auto l’uno dall’altro, e in mezzo vi si possono incontrare colline, praterie e deserti. La catena di montagne che si affaccia sulle Grandi Pianure, e sulle città di Boulder e Denver, è chiamata Front Range, e comprende Pikes Peak, Mount Evans e Longs Peak. Il Sawatch Range è una catena disposta da nord a sud, ed è la seconda fila di montagne rispetto alle pianure, oltre il Front Range,
145

146
e include le cime più alte della catena. Il gruppo più remoto invece è il San Juan, che si trova nell’angolo sudovest del Colorado, a circa cinque ore di macchina da Denver e poco distante dagli stati dello Utah, dell’Arizona e del New Mexico.
La storia del Colorado inizia nel 1858 con la corsa all’oro di Pikes Peak, dieci anni dopo la prima grande corsa all’oro, quella della California del 1848, che aveva portato alla fondazione di città come San Francisco e che diede inizio alla grande migrazione verso ovest. Tuttavia, sebbene fossero state ormai conquistate le due estremità del continente, ciò che si trovava in mezzo era ancora un territorio ostile e inesplorato. Le prime città del Front Range vennero fondate subito dopo la scoperta dell’oro in Colorado, all’ora Territorio del Kansas; ma il grande boom arrivò solo negli anni Sessanta, dopo la Guerra di Secessione, quando il Governo americano iniziò a promuovere il west come terra di salvezza e redenzione cercando di togliere pressione interna agli ex stati confederati e iniziando la costruzione di quello che poi divenne il mito del vecchio e selvaggio west.
Parlare dell’ultrarunning in Colorado, delle sue gare e dei suoi atleti, significa muoversi tra i rimasugli di ferrovie abbandonate, città fantasma, miniere e praterie. Leadville, Silverton, Manitou Springs, Boulder, sono tutti luoghi che sono diventati il simbolo di una scena sportiva e culturale, e che condividono la stessa storia: si tratta di ex città minerarie della frontiera del west, ricche e selvagge, che a un certo punto di questa storia hanno iniziato a spegnersi, così come si stava spegnendo quella civiltà, e poco prima di scomparire del tutto hanno iniziato a rinascere, grazie a una nuova civiltà di gente che andava in bicicletta e correva a piedi 100 miglia in un giorno.
Sono tornato per risalire alle origini di quella storia e per capire che relazione ci sia tra questi due mondi. E per farlo sono finito sugli stessi sentieri (davvero quelli) che centocinquant’anni fa ve-
nivano battuti con una piccozza sulla schiena e un mulo carico di pietre, da chi fra queste montagne cercava qualcosa di molto diverso da quello che cerco io. Così ho preso un aereo e sono tornato dove me ne ero andato un anno prima: a Denver, Colorado.
Dopo una notte in un Motel 6 sgarrupato fuori dal Denver National Airport, con un infarto e mezzo e alle spalle e tutto il margine del nostro viaggio andato in una GMC gigante che per dieci giorni sarebbe diventata la nostra casa, ci lasciamo alle spalle quella distesa di monofamiliari e guidiamo fino a Boulder. Io ed Elisa, questa volta, che mi ha seguito per dare un’immagine a queste parole, e per girare quello che nelle nostre intenzioni dovrebbe essere il primo documentario italiano sull’ultrarunning americano – anche se, e questo lo sappiamo soltanto io e lei, di ultrarunning avremmo parlato gran poco. In realtà, quella della corsa è soprattutto una montatura: noi volevamo girare un western, con pochissimi soldi, e così siamo finiti qui.
Passiamo la notte in un campground nei pressi di West Magnolia, nella Roosevelt National Forest, sul Front Range. L’ultima volta c’era la neve e le betulle erano arancioni. Il campground si trova in mezzo a una foresta di bassi pini gialli e, poco distante, lungo la strada, tre alci fanno colazione accanto a un pick-up schiantato contro un albero. La mattina successiva cerchiamo una fetta di crostata a Nederland, in un diner ricavato da tre vagoni di un treno costruito dalla Union Pacific nel 1872. Sul lato lungo c’è un affresco che recita The Big Show of the World. The Buffalo Bill’s Wild West. Circus & Train Owned by the Publishers of the Denver Post 1906, e che fa riferimento a uno spettacolo teatrale mobile rappresentato tra il 1870 e il 1920 che metteva in scena il mito del west attraverso fatti storici, stereotipi e cliché della frontiera americana. Era il west che metteva in scena il west nel west per la gente del west: una matriosca narrativa sotto forma di convoglio ferroviario trasformato in un diner di
ciambelle fritte: il primo segno di ciò che stavamo cercando.
Le poche ore a Boulder avevano distolto Elisa dai nostri scopi. Del west, tolti gli edifici in stile vittoriano su Pearl Street, non aveva visto granché, e quella romantica cittadina universitaria popolata da hipster e artisti di strada, le era apparsa abbastanza diversa dai paesaggi lontani e sperduti con cui l’avevo ammorbata. Insomma, era più che altro il posto per lei. Ma dopo una colazione a Nederland e il terzo paio di stivali da cowboy, anche lei aveva iniziato a comprendere tutta quella storia del west. E forse, solo ora, dopo aver smarrito e ritrovato il passaporto in un tavolino di Chipotle a Denver, e insieme a quello qualcosa di ancora più importante e che non riporteremo qui per rispetto di noi stessi, forse solo ora – ho perso il filo. Comunque, eravamo pronti, ed era tutto quello che importava, ancora una volta.
Per calarci del tutto nella nostra avventura western, risaliamo in auto con un bicchiere di caffè, mettiamo i Grateful Dead alla radio e partiamo, verso l’occidente. Ci lasciamo alle spalle le foreste del Front Range e riscendiamo sulle grandi pianure, verso sud, rientrando nei sobborghi di Denver. Da lì, decidiamo di prendere l’unica strada che avesse senso prendere: la US 285 segue la prima pista aperta dagli occidentali, e che dal Colorado più civilizzato si addentra verso ovest, tra i pascoli dei bisonti Arapaho, fino alle montagne e oltre, fino all’angolo più remoto dello stato, il San Juan Triangle. Da Denver, l’autostrada porta al South Park attraverso Kenosha Pass, sul percorso dell’antica ferrovia che collegava Denver a Fairplay, da dove i cercatori d’oro partivano per inoltrarsi a piedi o a cavallo fino alle sperdute valli dell’Arkansas River. Oggi la Highway attraversa paesi fantasma e ranch sperduti in una prateria talmente grande da scoraggiare chiunque ad attraversarla, ma non abbastanza da tirarsi davvero indietro. A Kenosha Pass l’autostrada interseca il Colorado Trail, un sentiero che percorre
147

500 miglia da South Denver a Durango, attraverso le montagne più alte dello stato. Poi, la 285 continua verso sud fino a Buena Vista, aprendosi sulla valle dell’Arkansas e sui Collegiate Peaks: Mount Yale, Princeton, Antero. Piramidi di roccia di più di 4200 metri, grigie e immense, che cadono a picco sulle praterie della valle. In effetti non sono molto più grandi di tante montagne italiane, ma incutono timore. Il cielo è grigio e incombe un temporale, e niente invoglierebbe a scalarle.
Chissà quante di queste cime si potrebbero collegare in 100 miglia. Lo chiese Fred Vance a Jim Nolan nel 1991. Vance aveva corso la sua prima 100 miglia, Wasatch 100, l’anno precedente, e Nolan aveva già scalato tutte le 54 cime più alte di 14 mila piedi del Colorado, in America chiamate fourteeners e che corrispondono grossomodo ai nostri ‘quattromila’ – anche se, a voler essere pedanti, 14 mila piedi corrispondono a 4267 metri. Negli anni Novanta, negli Stati Uniti si era creato un intero
movimento escursionistico attorno ai fourteeners, e questi cacciatori di cime, o peakbagger, iniziarono a registrare una serie di record informali dei loro concatenamenti, che solo in un secondo momento presero il nome di fastest known time. Alcuni di questi percorsi divennero noti a livello nazionale, come il New Hampshire 4000 Footers, l’Adirondack 46 High Peaks o il Catskill High Peaks e i Colorado Fourteeners. Qualche giorno dopo, Nolan tornò da Vance con una risposta: quattordici. Il percorso di Nolan partiva dal Fish Hatchery Campground, sul percorso di Leadville 100, saliva Mount Massive e arrivava a Mount Shavano, sul limite meridionale del Sawatch Range, concatenando tutti i Collegiate Peaks in one push. Di lì a poco Fred Vance si trasferì in California e accantonò il progetto fino al 1998, quando propose a Blake Wood e a Charlie Thorn di organizzare un primo tentativo l’estate successiva. La prima gara autooganizzata sul Nolan’s 14 (così venne chiamata) si
svolse tra il 24 e il 27 agosto del 1999. Le regole erano poche: niente pacer o accompagnatori, senso di percorrenza alternato ogni anno, cutoff finale di 60 ore; inoltre, chi non completava il concatenamento non veniva considerato come ritirato, ma veniva registrato col numero di cime salite in 60 ore o fino al momento dell’abbandono. Quel primo anno nessuno riuscì a completare il concatenamento.
Le prime edizioni del Nolan’s 14 erano eventi informali e privi di autorizzazioni, così, quando nel 2003 il Forest Service Department scoprì l’esistenza della gara, Vance fu costretto a cancellarlo. Il Nolan’s 14 cadde nel dimenticatoio e tra il 2004 e il 2011 registrò soltanto pochi tentativi solitari. Poi, nel 2012, Jared Campbell e Matt Hart tornarono sul percorso completandolo in 58 ore e 58 minuti e stabilendo il nuovo record di percorrenza. Da allora il Nolan’s è tornato negli annali dell’ultrarunning americano, diventando uno degli FKT più ambiti al mondo.1
148

Dalla sua fondazione nel 1999, le statistiche del Nolan’s 14 sono tenute da Matt Mahoney nel suo blog personale, orgogliosamente in stile html – roba da paleo-informatica per nerd dell’ultrarunning. Ciononostante, l’identità originale del Nolan’s 14 come evento ristretto e collettivo si è persa e ha assunto sempre più l’identità di un FKT tradizionale, a causa anche della progressiva crescita del sito fastestknowntime.com. Il blog di Mahoney, come tanti altri della scena ultra degli anni Duemila, è rimasto appannaggio di una nicchia di corridori che non si è mai ingrandita, di contro a uno sport che invece ha continuato a svilupparsi. Forse, dell’ultrarunning di quegli anni, il Nolan’s è uno dei pochi percorsi che ha mantenuto l’aura pionieristica delle origini, al contrario di Barkley, Hardrock o Western States, che nonostante la loro dimensione ancora familiare e ristretta, hanno acquisito sempre più attenzione mediatica. E se negli ultimi anni sempre più atleti europei si stanno
muovendo verso gli Stati Uniti, anche a causa di un ruolo sempre più centrale dei media americani che aumentano la visibilità di eventi un tempo sconosciuti in Europa, il Nolan’s e tantopiù la sua storia continuano ad essere sconosciuti ai più. E osservando queste montagne dal basso della valle dell’Arkansas si riesce a coglierne le ragioni: esse incutono timore e fanno da testimoni delle forze telluriche che le hanno formate, 70 milioni di anni fa.
Ci lasciamo South Park alle spalle e da Buena Vista proseguiamo verso sud, costeggiando i Collegiate Peaks fino a Salida, per poi prendere la US 50 verso Monarch Pass. Monarch Pass si trova a un’altezza di 3448 metri e circa a metà del Continental Divide. La strada venne costruita negli anni Trenta per collegare Salida a Gunnison attraverso una valle costellata di miniere. In cima al passo c’è un diner un po’ troppo grande e decadente, la struttura è davvero brutta ma la vista è the best of the United States, o almeno è quello che è scrit-
to sul muro del ristorante; io d’altronde non posso smentirlo. Poco prima del passo, lungo la statale, un’antica strada sterrata si addentra in un bosco rado di Ponderosa Pine risalendo qualche metro di dislivello fino all’Old Monarch Pass, il valico antico. Sul passo c’è un cartello in legno che divide le foreste di San Isabel National Forest e di Gunnison National Forest, oltre che, più sensazionalisticamente, i bacini idrografici dell’Atlantico e del Pacifico.
Noi non ci pensiamo. Non siamo abituati a pensare che il Brennero divide il Mediterraneo dal Mar Nero, e che una goccia che cade in Austria bagnerà le coste della Russia mentre quella che cade qualche metro più in qua bagnerà quelle del Marocco. Ma gli americani tendono a dare peso a queste cose tanto da farle diventare motivo di orgoglio locale e attrazione turistica. Il Continental Divide, la linea immaginaria che divide i due bacini idrografici del continente, è percorso dal Continental Divide Trail, un sentiero di 5000 chilometri
149

150
che collega i confini del Canada e del Messico. Insieme all’Appalachian Trail e al Pacific Crest Trail, il Continental Divide Trail fa parte della Triple Crown of Hiking, il trittico di grandi cammini americani, di cui esso è il più lungo e difficile, oltre che il meno frequentato. Non c’è una vera ragione della sua sfortuna, ad eccezione della sua scoraggiante lunghezza. Ciononostante, il CDT diventa una costante del nostro viaggio in Colorado, e ritorna inatteso, giorno dopo giorno, dietro a una curva o nel cuore della notte, a centinaia di chilometri di distanza dall’ultima volta in cui lo avevamo incontrato: una scritta su uno scudetto bianco appeso di tanto in tanto al tronco di un albero, che riflette la luce della frontale.
Come le altre strade che attraversano il Sawatch Range, la strada per Monarch Pass venne costruita negli anni Trenta per unire i diversi centri minerari della regione. Lungo la strada si incontrano cave abbandonate e strutture fatiscenti, testimoni di un mondo perduto che non ha lasciato il posto a nient’altro. A chi o a cosa servano oggi queste montagne è difficile dirlo. Tolto qualche raro resort sciistico e qualche sentiero semideserto, qui, a metà strada da tutto, sembra che la defunzionalizzazione abbia avverato il sogno del più semplicistico ambientalismo. La natura sembra essersi ripresa i suoi spazi e al contrario delle Alpi, dove lo spopolamento è diventato sinonimo di abbandono sciatto e incontrollato, qua si ha l’impressione che le montagne siano tornate a una pace primordiale, smarrita per un secolo tra il fragore della dinamite e delle strade ferrate. Le Rocky Mountains oggi sono molto più silenziose di un tempo, e attraversarle a piedi, soprattutto per uno dell’est, lascia inermi.
Il sentiero che collega Old Monarch a Monarch Pass attraversa una rada foresta di pini gialli in cui la luce del tramonto penetra facilmente. Le cime circostanti sono battute dal vento e un temporale incalza da est sulle cime di Aetna e Taylor Mountain. A ovest, le nuvole e la terra creano una fessura
stretta e profondissima che pare pronta a chiudersi da un momento all’altro. Io sono in alto, dove l’aria è rarefatta, e la valle sotto è bassa e si perde all’orizzonte chiuso da un lontano e bluastro profilo di montagne: quello è il San Juan, ai confini dello stato, dove stiamo andando. Le ultime montagne del west, prima del deserto.
Quanto dista il purgatorio da Silverton Colorado? È uno dei primi risultati digitando su Google il nome della città. Purtroppo, Purgatory è solo il nome di un resort a metà strada con Durango, ma a me il dubbio resta: se non è il purgatorio questo, non può essere molto lontano. A Silverton vi conducono due strade: una da nord, la Million Dollar Highway, senza dubbio la strada col nome più altisonante che abbia mai sentito; e una più accessibile, da sud, che conduce a Durango, fino al deserto. Nei negozi di souvenir locali, accanto alle calamite di Bigfoot, è piuttosto frequente trovare merchandise che recita «I Survived the Million Dollar Highway». In realtà la strada non ha niente di eroico, è anzi piuttosto larga e sale a malapena, ma loro ci credono molto ed è bello lasciarglielo fare. Inutile dirlo, anche questa deve la sua esistenza alle miniere, e in particolare al Red Mountain Mining District, uno dei più importanti siti minerari del San Juan Triangle e il più gustoso da visitare. Va anche detto che dopo quindici ore di praterie, ranch e montagne è difficile stupirsi ancora per una baracca abbandonata, ma arrivando da Denver sembra che ogni miglio verso ovest sia più western di quello appena passato, ed essendo il giro di boa del nostro viaggio, questo è l’apice del climax.
Quando nevica, che qui significa buona parte dell’anno, la Million Dollar Highway viene chiusa, e l’unico accesso alla città resta via Durango. Davanti a una birra da Big Mountain, a Chamonix, Bryon Powell mi racconta che qualche anno fa una frana bloccò l’uscita di una galleria sulla strada per tutto l’inverno, isolando completamente la città fino alla primavera successiva. In
posti come Silverton le persone tendono ad avere priorità diverse che altrove, e i flatlanders, come nelle Rockies chiamano chi nasce al livello del mare, hanno poco tempo per adattarsi. Un anno dopo quella birra mi trovo nel portico di casa sua a Reese Street. Lui è in Alaska, ma c’è Meghan. Meghan Hicks è direttrice editoriale di iRunFar, è anche una forte ultrarunner e membro del board di Hardrock 100 Endurance Run. Insieme a suo marito Bryon si è trasferita a Silverton nel 2019, e ora trascorre qui buona parte dell’anno. In due, Meghan e Bryon hanno otto fibbie di Hardrock 100, equamente divise e conservate, mio malgrado, nella loro baita in Utah. La loro casa di Silverton è del 1985, ha le pareti esterne azzurre e gli infissi rossi, e i cornicioni bianchi e un porticato con due sedie a dondolo e una catasta di legna per il camino. La facciata dà a nord ovest, sulla collina del Christ of the Mines Shrine da cui si vede tutta la città.
«Là, dove inizia la collina – racconta Meghan – sono public lands e non si potrà mai costruirci nulla, il che è una buona cosa perché quelle terre saranno protette per sempre. In America ci sono vari livelli di protezione delle public lands, in alcune di queste può essere estratto petrolio e possono essere usate per il pascolo del bestiame, mentre in altre non è possibile fare nulla, nemmeno mantenere una rete sentieristica».
Silverton si trova in un punto in cui la valle si apre e spiana, chiusa da tutti i lati da alte montagne grigie. Da queste parti gli alberi danno l’impressione di avere poca clorofilla e ogni cosa è spenta, ad eccezione di qualche fiore viola e dei torrenti color ruggine.
La città fa 600 abitanti quando è piena e si sviluppa su quattro strade principali di cui soltanto una è asfaltata. Greene Street vanta un discreto numero di attività economiche, sebbene sempre le solite: la birreria artigianale, il negozio di merchandise, la caffetteria hipster, eccetera. Ma è la seconda fila di case ad essere davvero fascinosa – non che quella principale sia patinata, non c’è
151

la soprintendenza dei Beni Culturali da queste parti, non è preconfezionata, anzi, è così perché è sempre stata così e semplicemente ha continuato ad esserlo – ma la seconda fila, con le case di cartapesta, la bandiera appesa al portico e la motoslitta parcheggiata in giardino, quella seconda fila racconta che questo posto vivrà anche di turismo, ma non si è mai piegato ad esso, le case sono ancora prime case e le persone ci abitano davvero.
Per capire qualcosa di Silverton e della sua storia, e per capire perché l’ultrarunning qui è diventato ciò che è diventato, la vicenda della Kendall Mountain Ski Area ci racconta parecchio. Kendall Mountain è l’unica area sciistica della città e inizia appena oltre il fiume, a un chilometro dalla via principale. L’impianto venne costruito dal Grand Imperial Hotel nel 1963 e per un paio di decenni mantenne il turismo invernale di Silverton, poi, tra primi anni Ottanta e fine anni Novanta l’impianto venne chiuso a causa di alcuni permes-
si mancanti e quando venne riaperto la città si ritrovò con un impianto obsoleto e con una seggiovia a due posti in grado di muovere un numero molto contenuto di persone. Per molti anni, la stessa Kendall Mountain Ski Area si autopromosse come «The cheapest ski area in the West», trasformandosi in un comprensorio rivolto a famiglie e a sciatori senza pretese. Poi, nel 2017 un fondo d’investimento che possedeva già Purgatory e altri resort della regione avviò una ricerca per analizzare l’interesse d’espansione dell’area di Kendall Mountain e un possibile rinnovo degli impianti: in un primo momento il progetto sembrò realizzabile, ma presto incontrò la resistenza della popolazione locale, che covava grossi dubbi sugli effetti che l’ingrandimento della zona avrebbe portato. Tra le dichiarazioni rilasciate al Durango Herald nell’inverno del 2022 dal consiglio comunale di Silverton:
«La città sta valutando opzioni di espansione che mettano al primo po-
sto i cittadini. Questo sforzo è volto a migliorare la qualità della vita degli abitanti di Silverton, di qualsiasi estrazione socio-economica, piuttosto che a rendere la città attraente come destinazione per una seconda casa o come opportunità di investimento. La comunità è stata chiara nel dire che non vuole un resort, né lo sviluppo immobiliare su larga scala e la perdita di carattere che spesso ne consegue».2
Se questa idea di territorio e di sviluppo lento si è diffusa in diverse città di montagna del Colorado, come anche a Ouray e a Leadville, non bisogna pensare che sia avvenuto dappertutto: il Colorado conta decine dei resort sciistici più ricchi di tutto il paese, come Aspen, Vail, Copper Mountain, Glenwood Springs, Winter Park, Steamboat Springs e Telluride, ma vanta anche casi opposti, come Silverton appunto. Insomma, sembra che in Colorado si siano seguiti due modelli di svi-
152

luppo turistici diversi: uno di stampo alpino, se vogliamo, e uno che ha cercato sport e motivi di sviluppo alternativi, e questo non è avvenuto sulla spinta di tendenze o di movimenti ambientalisti che si sono contrapposti all’espansione turistica dei grandi fondi di finanziamento negli ultimi anni, ma è partito dagli abitanti stessi, e in un’epoca in cui il concetto stesso di turismo alternativo doveva ancora nascere e doveva ancora arrivare, ossia gli anni Ottanta e Novanta. Silverton e altri posti del Colorado sono diventati le mecche di sport come il freeride, lo snowboard e la mountain bike, che, sebbene sia nata, guarda caso, in California, si è sviluppata sulle montagne attorno a Silverton – e non è un caso se uno degli storici modelli furistrada del brand Specialized si chiama proprio Hardrock.
Di contro, Silverton è diventato un luogo altrettanto celebre anche per attività poco ecologiche come il fuoristrada e il quad, che rappresentano uno dei principali indotti della città. Ma una volta
steso un velo pietoso su questo, è grazie al modello di sviluppo alternativo e un pensiero disallineato rispetto ai normali modelli di sviluppo turistico che nacque, nel 1993, quella che era destinata a diventare una delle gare di ultrarunning più importanti al mondo, e il motivo per cui abbiamo percorso così tanti chilometri per arrivare fin qui.
«Hardrock è una 100 miglia a piedi che si tiene ogni anno nel San Juan Range, delle montagne che si trovano nell’angolo sud ovest del Colorado. La gara venne fondata da un gruppo di persone ormai trent’anni fa con l’obiettivo di collegare tre diverse aree della storia mineraria della regione e le quattro città del San Juan Triangle, cioè Silverton, Lake City, Ouray e Telluride. Così presero una mappa e provarono a collegare questi posti attraverso sentieri minerari in un anello che fosse sensato.
«La gara è chiusa a 140 partecipanti. È un numero piccolo e resterà sempre così perché le public lands vietano l’or-
ganizzazione di grandi eventi in questo territorio, ma a parte per questo, il motivo principale è che Hardrock vuole mantenere il suo senso di comunità e gli organizzatori vogliono conoscere personalmente ogni corridore che partecipa alla gara, incoraggiandoli a tornare non per forza per correre, ma anche per fare da volontario, assistenza o pacer a qualche altro atleta.
«Ogni gara ha i suoi propositi, e quelli di Hardrock sono le persone: creare una comunità che abbia voglia di tornare qui anno dopo anno, per tramandare la storia di Hardrock 100».3
Ogni cosa, a Silverton, lascia trasparire la consapevolezza che i boom troppo rapidi e feroci tendano a esaurirsi in fretta. L’orgoglio locale qui non si traduce in diffidenza, ma in senso di ospitalità, e questo è il senso della gara: un evento a numero limitatissimo, con standard e requisiti di accesso alti, ma con una dimensione familiare, locale, a misura d’uomo, e in questo molto inclusiva. Le
153


154
grandi voci dell’ultrarunning americano di oggi come Dylan Bowman di Freetrail e Finn Melanson di Singletrack Podcast, diventate quasi le voci di una generazione di atleti, sognano negli Stati Uniti un evento importante, internazionale e professionalizzato come i grandi eventi europei. Ma vedendo un posto come questo ci si rende conto che quel sogno non si realizzerà mai: sebbene l’ultrarunning americano stia raggiungendo livelli di professionalizzazione molto più avanzati rispetto a quelli europei, la sua natura non ha niente a che fare con la crescita e con la commercializzazione, ma con un senso di comunità e di appartenenza che va oltre Silverton, che va oltre le Colorado Rockies, ma che ha a che fare con uno spirito che difficilmente verrà cancellato e che difficilmente riuscirà ad integrarsi con una visione dello sport circense e mediatica come quella europea. Hardrock 100 Endurance Run e il lavoro fatto dai suoi organizzatori in questi anni è la dimostrazione di come la crescita smisurata di questo sport possa essere arginata col disinteresse. Disinteresse per la crescita, disinteresse per la sua mitizzazione, disinteresse per la sua visibilità. Il motivo per cui Hardrock è diventata la gara che è oggi sta nel suo sviluppo organico, naturale e non nella ricerca di attenzione né tantomeno di partecipazione. Chi deve arrivare a Silverton, in qualche modo, ci arriva sempre, e chi non ce la fa significa che non doveva farlo.
In città la gara si ritrova dappertutto: nelle fotografie appese nei locali, e lungo la strada principale, in un parchetto pubblico, dove viene conservata l’iconica roccia che gli atleti baciano all’arrivo, e che durante l’anno viene lasciata in un parchetto pubblico su Greene Street, a fianco a un truck food, per poi essere spostata poco più in là nei giorni della gara, di fronte alla scuola, sulla linea d’arrivo. Bryon e Meghan abitano un centinaio di metri dalla linea di partenza. La gara si ritrova anche a Kendall Mountain, poco fuori dalla città, dove partiva la prima edizione e dove oggi è conservata la vecchia roccia di Har-
drock, utilizzata fino al 2011, riposta sotto a una pensilina a una decina di metri dalla seggiovia. L’avvento dell’ultrarunning, a Silverton, ha plasmato la comunità attorno alla città, e viceversa la città ha plasmato l’identità di questo sport.
Il mito del west lo troviamo sul tergicristallo a Ouray. L’ufficio di Polizia si trova poco più in là, nello stesso edificio della biblioteca pubblica. I tre che ci stanno dentro fanno brutto e tengono il giubbotto antiproiettile anche per stare al computer.
«In Italia potete parcheggiare di fronte agli idranti?»
«In Italia non abbiamo gli idranti razza di bifolco, noi gli idranti li interriamo. Esci dal ghetto cazzo».
La multa non ce la tolgono e per pagarla dobbiamo andare in tribunale. È un edificio in legno di tre piani con una torre dell’orologio al centro. È anche la sede dello sceriffo e per entrare dobbiamo passare gli oggetti personali nel metal detector. Lo sceriffo, o chiunque sia il tipo con la stella appuntata al petto, ha una livrea più allegra dei suoi colleghi della biblioteca e l’atmosfera al tribunale ricorda più quella di un ufficio postale italiano. Accanto al metal detector, in entrata, c’è un cartonato 1:1 di John Wayne nei panni del Grinta. Un cartonato. John Wayne. In tribunale.
«Cosa dicevi a proposito del western?»
Nel west l’unico modo per saldare i propri conti con la legge è in contanti, e i bancomat non vi sono ancora giunti. La signora parecchio incinta che troviamo allo sportello del tribunale ci confida sottovoce che gli uffici pubblici in Colorado sono rimasti nel paleolitico, e la cosa in fondo ci rallegra o quantomeno ci sgrava per un momento dall’onnipresente senso di inadeguatezza che portiamo con noi.
Viaggiando per il paese in auto, come noi, senza un posto preciso in cui dormire e il portafoglio troppo leggero per una camera di motel, passiamo le notti nel bagagliaio dell’auto. È una GMC
Terrain enorme, ma comunque di gran lunga più piccola di qualunque altra macchina in autostrada. In Colorado, come nel resto degli Stati Uniti, è vietato dormire in macchina ad eccezione di alcune aree prestabilite chiamate campgrounds. Nella maggior parte dei casi si tratta di aree gratuite e non custodite in cui vige il principio first come best serve, chi prima arriva meglio alloggia. Queste aree sono semplici parcheggi, quasi sempre in luoghi ameni, tanto che certa gente ci passa le vacanze. Così, durante la settimana di Ferragosto le autostrade americane si riempiono di enormi pick-up che trainano roulotte altrettanto grandi. Agli occhi di un sobrio visitatore europeo non sembrano altro che l’ennesima prova del gigantismo americano, e d’altronde lo sono, ma negli Stati Uniti il concetto di campeggio è parecchio distante dal nostro: le aree di sosta non sono servite e possono passare molti chilometri, in alcuni casi persino giorni, tra un’area e l’altra. Così quelli per non sbagliare si portano dietro tutto. Non solo: il concetto di outdoor è qualcosa di molto radicato, e non ha necessariamente a che fare col correre ultramaratone in montagna o scalare montagne inviolate; nella maggior parte dei casi, outdoor può voler dire preparare una pizza all’aria aperta, motivo per cui è piuttosto frequente trovare gente che viaggia con un forno a legna nel cassone del pick-up. Insomma, se in Europa il concetto di outdoor ha un significato quasi prettamente sportivo, negli Stati Uniti è più che altro uno stile di vita, limitato nella maggior parte dei casi a un periodo specifico dell’anno, le vacanze. E il campeggio è la quintessenza della vacanza on the road americana, con tutti i comfort e le facilities necessarie. Avendo fatto del viaggio il loro credo, ed essendo passati per il trauma secolare della conquista del west, gli americani sembrano aver deciso congiuntamente che, almeno a casa loro, nessun viaggio avrebbe mai più dovuto riservare incognite. Così hanno creato da zero un paese in cui si potesse mangiare ogni sera lo stesso hamburger, dormire ogni
155

notte nello stesso letto, e svegliarsi il giorno dopo mangiando la stessa fetta di torta, anche se a mille chilometri di distanza da quella del giorno prima. L’unica cosa a cui è concesso cambiare, insomma, è il paesaggio fuori dal finestrino. A noi sembrerà stupido, e pure un po’ noioso, ma chiunque abbia viaggiato negli Stati Uniti sa che questa cosa dà anche un certo senso di tranquillità. Questo senso di sicurezza e di prevedibilità si traduce in ogni aspetto della vita americana: ogni Walmart ha le stesse aspirapolveri, ogni squadra di baseball ha lo stesso cappellino e ogni città ha gli stessi ristoranti. Poi ci sono anche quelli locali, ma se non hai voglia di rischiare, se ti viene il dubbio che quella pizzeria abbia le blatte, c’è sempre uno Starbucks dietro l’angolo e nel peggiore dei casi un caffè lo troverai sempre. E questo spirito è talmente radicato che se lo portano dietro anche in campeggio: bella la roulotte e la vita all’aria aperta, ma quando sei da solo in mezzo al deserto o nelle foreste del
Colorado, sapere di poter contare sullo stesso forno che usi a casa, per fare la pizza, non è una cosa da sottovalutare.
Questo ha anche dei risvolti positivi: tantissimi americani trascorrono le ferie in campeggio, e tantissimi americani trascorrono i fine settimana in campeggio. Solo nel 2021 si stima che 50 milioni di americani abbiano trascorso le ferie in campeggio e la tendenza è in crescita.4 E questo ha un impatto anche sul loro modo di vivere gli sport di montagna, che nel tempo hanno assunto una connotazione sempre meno legata alla performance e sempre di più al life style: è così nell’arrampicata, nella mountain bike, nel freeride e nell’ultrarunning. Si tratta di una generalizzazione, ma non è indebita. E sebbene le cose negli ultimi anni stiano cambiando e il livello di professionalizzazione raggiunto in molti di questi sport sia per certi versi superiore rispetto a quello europeo, queste attività mantengono nella maggior parte dei casi ancora un’identità molto low key. Certo, in città
come Boulder questo life style è diventato per versi stucchevole, ma lontano dal Front Range si traduce ancora e soltanto come un modo di vivere molto comunitario, e in città come Silverton si riesce ancora a passare del tempo senza avere l’impressione di essere soltanto uno fra tanti, e senza sentirsi risucchiati da una comunità troppo grande da diventare spersonalizzata.
Tanto questa civiltà outdoorsy ha imposto i propri status symbol in città come Bend, Flagstaff e Asheville, che pure loro hanno iniziato ad accorgersene. L’homo outdoorsy è diventato lo stereotipo di se stesso, e su Instagram c’è pure chi ha iniziato a impersonarlo: Every person who wears Rope Hats, Every person who goes Bikepacking, Every person with a Lightweight puffy jacket, Every Person at a Folk Concert, Every Person who climbs Colorado 14ers, Every person who moves to San Francisco, e il mio preferito, Your new roommate at Colorado University in Boulder (@mattslyon).
156

Forse è il suo essere isolata, circondata da montagne che hanno poco di estetico e tanto di aggressivo, il suo essere lontana da aeroporti internazionali. Forse è il suo essere cruda e dannatamente alta: la gentrificazione sta lentamente arrivando anche qui, i prezzi delle case stanno aumentando e una birra da Avalanche costa comunque troppo. Ma vivere a 3000 metri sarà comunque sempre un deterrente, e luoghi come Silverton saranno sempre abbastanza vicini per passarci un weekend ma troppo lontani per andarci a vivere. Insomma, per quanto hipster possano essere le sue caffetterie, i suoi inverni sono comunque troppo freddi per un californiano.
Sul Front Range era già estate inoltrata e le Grandi Pianure venivano battute dal sole; mentre qui, a ovest, sulle montagne, le betulle del Boulevard avevano appena iniziato a gemmare. La sera prima aveva piovuto, faceva freddo e non tirava un alito di vento. Così, per ripararsi, aveva steso il sacco a pelo sotto a
un capanno degli attrezzi, uno di quelli con la tettoia ondulata, in fibra di vetro. Lesse qualche pagina di Infinite Jest ascoltando il ticchettio della pioggia sul tettuccio del suo giaciglio improvvisato. Poi andò a dormire.
La mattina successiva, Harrison Street era ancora deserta, e gli edifici vittoriani, con le facciate dipinte e gli infissi in legno bianco e i cornicioni stuccati e le grandi vetrate. Al 508 di Harrison si trovava un palazzo verde su due piani. L’insegna recitava City on a Hill e sembrava il luogo giusto dove rifugiarsi in una fresca mattina di inizio estate, in cui trovare una fetta di torta di ciliege e l’unico caffè potabile da lì a Salida.
Entrò e si sedette al bancone che dava sulla strada. Appoggiò il libro sul tavolo e lo zaino ai piedi dello sgabello, poi abbassò il cappuccio della felpa e si strofinò le braccia con le mani. Si rialzò e andò al bancone e chiese alla signora coi capelli bianchi che vi lavorava dietro un breakfast burrito e un caffè. Nell’an-
golo opposto del locale, coperto a metà dalla pagina dell’Herald Democrat, un tipo sulla sessantina sfogliava il giornale scrutando gli avventori del locale. Indossava due camicie una sopra l’altra, un cappellino di rete e un paio di Levi’s. Restò seduto per un po’, con un gomito appoggiato al tavolo e lo sguardo a metà tra la pagina e il locale. La signora dietro al bancone porse una tazza al ragazzo e gli indicò il thermos da cui servirsi il caffè. Si trovava a Leadville ormai da cinque settimane. A mezzogiorno si allacciò le scarpe e si diresse a ovest. Il sole era alto e il vento aveva ripreso a soffiare. Era freddo e caldo allo stesso tempo e Mount Massive era coperto da un sottile strato di nevischio caduto la sera prima. Percorse il Boulevard fino alla ferrovia e poi attraversò il fiume Arkansas. Poi si inoltrò nella prateria. Quando il vento soffiava da est, si poteva sentire il rumore della Highway, ma ora soffiava da sud ovest e gli unici suoni che si sentivano erano il fiato dei cavalli
157

158

bradi e il ricordo svanito dei bisonti. Arrivò sulla cima della montagna a metà pomeriggio: tirava ancora vento ma la neve ormai si era sciolta. Rimase sulla cima per qualche istante a guardare la valle sottostante e poi imboccò un canale roccioso e selvaggio. Scese fino alla linea degli alberi e poi continuò a scendere nel bosco di betulle fino al sentiero e tornò in città. Passò le due notti successive al Matchless Campground. L’ultima notte, il parcheggio si era riempito e il campground si era trasformato in un luogo particolarmente febbricitante. Impostò la sveglia dell’orologio alle 2 e 30 e andò a dormire.Il mattino seguente risalì la County road fino alla città e parcheggiò al liceo. La città era avvolta dall’oscurità e dal silenzio e a mano a mano l’incrocio tra Harrison e la Sesta iniziò a popolarsi di persone in pantaloncini da corsa. Appena oltre alle transenne della partenza, un tale aveva acceso un fuoco sul marciapiede di fronte a casa e si mise seduto lì accanto su una sedia a dondolo, con un plaid sulle gambe a sorseggiare una tazza di caffè caldo. Per scaldarsi il ragazzo prese un caffè alla gelateria messicana su
Harrison, poi si sedette sul marciapiede ad aspettare la partenza.Un colpo di fucile. Il primo miglio scendeva lungo la Sesta verso ovest e da lì proseguiva fino al Boulevard. Era una strada bianca che attraversava un bosco di pini gialli avvolta nell’oscurità, illuminata soltanto da una fila di frontali che si allungava fino a Turquoise Lake. Corse lungo il lago con una fila di luci che ne segnavano le sponde. L’aurora iniziava a illuminare i boschi e lui continuò a salire fino al passo a cui conduceva il sentiero. Arrivò in cima quando i raggi del sole iniziavano a penetrare in controluce gli aghi dei pini, tingendo di rosso la cima di Mount Elbert e lasciando in ombra la prateria sottostante. Corse sotto la linea dell’alta tensione che friggeva la fredda del mattino fino a Fish Hatchery e poi lungo la strada dell’Hunt Gulch. La aid station sorgeva in mezzo alla prateria recintata da un lungo filo spinato, e una bassa nuvola di polvere alzata dalle auto copriva la linea dell’orizzonte, lasciando spuntare le cime delle montagne sul fondo. La pianura si perdeva in quella luce tiepida e l’umidità del fiume avvolgeva ogni cosa di un sapore mistico.
La foresta era verde e umida e un ruscello scorreva lungo la valle al bordo del sentiero che si inerpicava oltre la linea degli alberi. Lì si schiuse una conca erbosa circondata dalle cime grige e pietrose del Sawatch Range. La cima di Hope Pass era ventosa a quell’ora e, dietro di lui, la Arkansas Valley era ormai battuta dal sole di mezzogiorno e i due specchi turchesi dei Twin Lakes squarciavano la prateria gialla e secca. Scese ancora. Arrivò in cima di buon’ora, discese dall’altra parte e tornò indietro. Gli restavano ormai quaranta miglia da percorrere e in quel momento non gli sembrarono poi così tante.
Ormai il sole stava tramontando incendiando le cime del Mosquito, sopra a Leadville, dall’altro lato della prateria. Questa era rossa e il bosco era giallo e le montagne erano arancioni e ogni cosa sembrava avere cambiato colore. La barba e i capelli erano sporchi di polvere e l’aria del tramonto aveva iniziato ad asciugargli il sudore. Corse con la faccia ramata dal sole nel vento rosso che soffiava da ovest. Poi scese la notte.
Continua nel prossimo numero
159
LAST WORD
BY DAVIDE FIORASO PHOTO JORDAN MANOUKIAN

Abbiamo una chiave per il cancello. Abbiamo una chiave per il portone d’ingresso e una per la porta di casa. Abbiamo una chiave per il garage, una chiave per l’auto e pure una chiave per la bicicletta. C’è una chiave per l’ufficio e un badge per l’ingresso. C’è un pin, un puk, un codice di sicurezza, un
ID e una password per tutto. A questo mondo abbiamo più cose per tenerci fuori che cose per farci entrare. La rete è una tecnologia nata per ridurre le distanze, eppure, siamo sempre più soli e distanti. Ma allora la domanda è: ci siamo chiusi dentro o è il mondo intero ad averci chiusi fuori?
160








72. SOCI PATROCINI MEMBER OF MAIN SPONSOR Iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo - Ministero della Cultura
TRENTO 26 APRILE - 5 MAGGIO 2024
Artwork by Clorophilla Studio
 Fresh Foam X Hierro v8
Fresh Foam X Hierro v8







 THE SALEWA TREKKING COLLECTION IS ENGINEERED IN THE DOLOMITES, CRAFTED FROM NATURAL FIBERS, AT HOME IN NATURE. ANYTIME, ANYWHERE.
THE SALEWA TREKKING COLLECTION IS ENGINEERED IN THE DOLOMITES, CRAFTED FROM NATURAL FIBERS, AT HOME IN NATURE. ANYTIME, ANYWHERE.






 GRANDES JORASSESPRIMA INVERNALE Parete NordDirettissima alla punta Walker Charles Dubouloz, Symon Welfringer, Clovis Paulin
GRANDES JORASSESPRIMA INVERNALE Parete NordDirettissima alla punta Walker Charles Dubouloz, Symon Welfringer, Clovis Paulin












































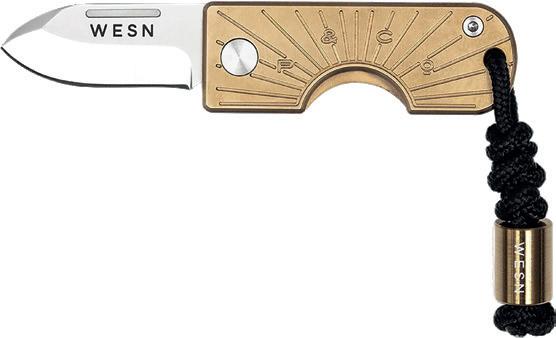













 BY ANDREA PASSERINI
BY ANDREA PASSERINI





 BY ELENA BENASSI
BY ELENA BENASSI

































































 BY CHIARA GUGLIELMINA
BY CHIARA GUGLIELMINA

































































 Fresh Foam X Hierro v8
Fresh Foam X Hierro v8