

Nella
realtà
DIRITTO ED ECONOMIA
Nella realtà è un corso di Diritto ed Economia per il primo biennio, articolato in 10 Moduli, ciascuno dei quali suddiviso in Unità.
Il Modulo si apre con una mappa che ne anticipa a colpo d’occhio i contenuti.
Il Modulo in mappe / i miei appunti
Accedendo al QR code è possibile scaricare:
• tutte le mappe in PowerPoint per poterle modificare e personalizzare durante lo studio;
• schede preimpostate per prendere appunti guidati per ogni unità e alla fine del modulo.
All’inizio del percorso sono presenti consigli di metodo per redigere appunti efficaci.

Ai blocchi di partenza apre ogni unità con un video su temi attuali e veloci attività didattiche per un dinamico avvio allo studio e uno spunto per lezioni in flipped classroom.
Il testo è piacevolmente narrato, con spiegazioni semplici e lineari.
Lo studio è coadiuvato da mappe utili per una rapida visualizzazione degli argomenti nei loro rapporti gerarchici.
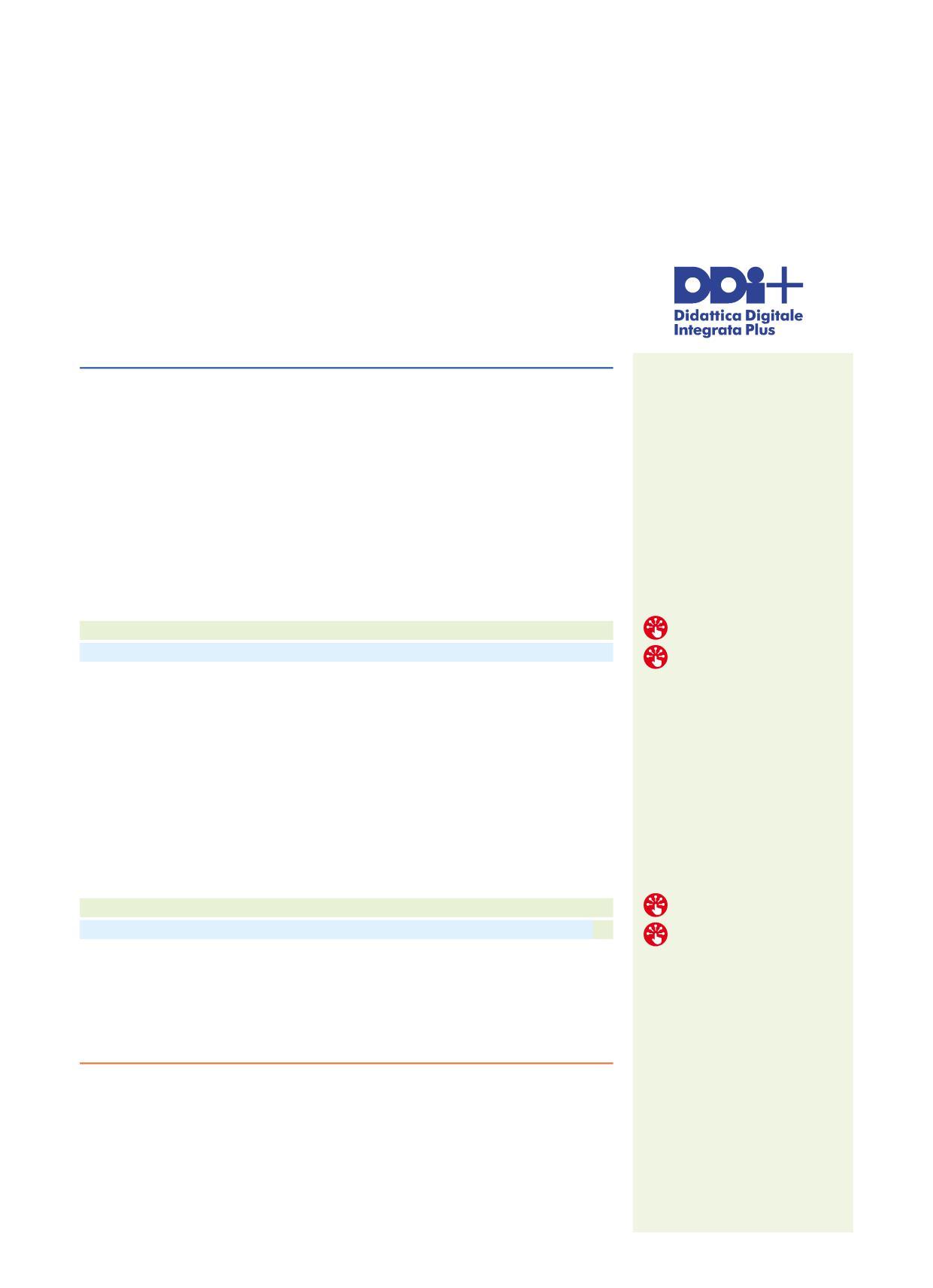
LEZIONE DIGITALE:
AUDIO MAPPE
HUB TEST

giuridica
LEZIONE DIGITALE:
Le fonti del diritto
AUDIO MAPPE
HUB TEST
LEZIONE DIGITALE:
Il rapporto giuridico
HUB TEST
LEZIONE DIGITALE:
Gli elementi dello Stato
AUDIO MAPPE
HUB TEST
MODULO
3 LA COSTITUZIONE

VIDE d’AUTORE
CHE COS’È L’EGUAGLIANZA?
PAG. 119
AI BLOCCHI DI PARTENZA
per studiare anche in modalità Flipped classroom
CITTADINANZA DIGITALE
per diventare cittadini e cittadine consapevoli delle potenzialità e dei rischi degli strumenti digitali
LEZIONE DIGITALE
per ripassare i concetti fondanti o svolgerli in maniera agile ed esercitarsi
AUDIO MAPPA
per rielaborare e ripassare con la mappa dell’unità modificabile e l’audio di spiegazione
HUB TEST per metterti alla prova e consolidare quanto studiato con tanti test autocorrettivi
CHE COSA STAI PER STUDIARE?
Che cos’è la COSTITUZIONE?

Insieme dei principi (PRINCIPI FONDAMENTALI) e delle regole su cui si fonda il nostro Stato
Che cosa prevede?
DIRITTI INDIVIDUALI, della singola persona (per es. il diritto alla libertà)
Diritti dei cittadini
Quali sono?
DIRITTI COLLETTIVI, riconosciuti ai gruppi di persone (per es. la libertà di riunione)
CONOSCENZE
• Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri.
ABILITÀ
• Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con la norma giuridica.
• Distinguere le differenti fonti normative, con particolare riferimento alla Costituzione italiana.
DIRITTI SOCIALI, riconosciuti dallo Stato per permettere ai cittadini di vivere dignitosamente (per es. il diritto alla salute)
Doveri dei cittadini
Che cosa sono?
Sono DOVERI COSTITUZIONALI richiesti ai cittadini per garantire un buon funzionamento dello Stato (per es. il dovere di pagare i tributi)
COMPETENZE
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione.
IL MODULO IN MAPPE / I miei appunti
Inquadra il QR code e scarica:
• le mappe di tutte le unità del modulo per modificarle e annotarle mentre studi
• le schede per organizzare i tuoi appunti
1 U à I principi costituzionali


1 Completo
a Le anime della Costituzione corrispondono ai che in essa sono affermati.
b L’art. 1 Cost. afferma il principio
c La democrazia esige nei modi di esercizio del potere.
AI BLOCCHI DI PARTENZA
Guarda il video
Il video mostra la firma della Costituzione, entrata in vigore nel 1948, a un secolo esatto dall’approvazione dello Statuto albertino.
• Viene messo in luce il rigore e la frugalità dell’evento: lo immaginavi così il momento dell’approvazione della Costituzione?
• Che cosa vuol dire che dalle cartelle di cuoio la Costituzione entra “nelle forme e nello spirito della vita nazionale”?
Usa gli strumenti del libro
• Tenendo a mente il video, vai ai paragrafi 3 e 5 e leggi il contenuto, individuandone i concetti principali
• Verifica di aver capito i contenuti del paragrafo 3 svolgendo l’esercizio “Completo”
1 Le anime della Costituzione
Ha un’anima la Costituzione italiana?
Ne ha tante, come ciascuno di noi. Può succederci di essere timidi nei rapporti individuali con gli amici o con i compagni di classe, ma al tempo stesso fin troppo sicuri delle nostre opinioni, al punto da apparire presuntuosi quelle poche volte che le dichiariamo in pubblico. Per stare in pace con noi stessi, per raggiungere la felicità, dobbiamo riuscire a creare un’armonia fra le nostre diverse anime. Lo stesso vale per la Costituzione.
Le “anime” della Costituzione sono costituite dai principi che si ricavano dalla lettura del testo costituzionale e la “felicità costituzionale” consiste in un equilibrio fra principi che, presi uno per uno, spingerebbero in direzioni contrapposte. Di seguito esamineremo i più importanti principi della nostra Costituzione. Ne tralasceremo solo due, il principio di autonomia e quello internazionalista, di cui tratteremo più avanti.
2 Il principio democratico
Quando esci con gli amici e scegliete che film vedere o in che pizzeria trovarvi, sei parte di una piccola comunità e, proprio per questo, puoi dare il tuo contributo per arrivare alle decisioni da prendere in comune. Succede perché “appartieni” al gruppo e ne sei una parte attiva, quindi hai anche una parte di potere nel decidere.
Il principio democratico è la prima e anche la più importante fra le anime che distinguono la Costituzione italiana e fa proprio riferimento a questo principio di appartenenza.
Il principio democratico afferma, infatti, che «la sovranità appartiene al popolo» (art. 1 Cost.).
Come abbiamo già avuto modo di ricordare, “democrazia” significa “governo del popolo”, e proprio per questo motivo il principio democratico richiede che il potere politico si fondi sulla volontà popolare.
La democrazia può assumere diverse forme: rappresentativa, diretta o partecipativa. C’è un elemento, tuttavia, che le congiunge: la pubblicità, la trasparenza nei modi di esercizio del potere.
Come ha detto uno dei massimi giuristi del secolo scorso, Norberto Bobbio, «La democrazia è il potere del pubblico in pubblico».
3 Il principio personalista
Crescendo, ti accorgi che hai una tua specificità, qualcosa che ti distingue dagli altri. Inizia allora una ricerca che ti porta a interrogarti su qual è la tua personalità, chi sei veramente.
Questa ricerca è molto lunga, occupa gran parte della vita e si svolge non da soli ma insieme agli altri (i genitori, i professori, i compagni di classe, gli amici ecc.).
La Costituzione valorizza questa ricerca, garantendoti i diritti che la rendono possibile.
Il secondo tratto distintivo della Costituzione italiana, il principio personalista, parla proprio del ruolo dell’individuo come centro dell’universo giuridico: la persona umana è al centro del sistema e viene prima dello Stato, non il contrario.
Nella Costituzione italiana la più chiara enunciazione del principio personalista si legge nell’articolo 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]».
In questo articolo va notato innanzitutto l’uso del verbo “riconosce”, con cui si vuole indicare che i diritti umani preesistono allo Stato, sicché lo Stato non può che prenderne atto. Ciò viene peraltro confermato dall’aggettivo inviolabili, ripreso anche dall’articolo 13 e dagli articoli seguenti per caratterizzare le libertà dei cittadini, che nemmeno il legislatore ha il potere di cancellare. La tutela dei diritti inviolabili è quindi una caratteristica essenziale della natura democratica della Repubblica. Lo Stato non solo deve difendere i cittadini da possibili violazioni dei diritti ma si deve fare parte attiva, attraverso le istituzioni, per soddisfare i bisogni e garantire il pieno sviluppo di ogni individuo. La Costituzione usa il verbo “riconosce” e si riferisce indistintamente a tutte le persone: non solo ammette l’esistenza di questi speciali diritti ma si impegna a garantirne il godimento a tutti, e quindi non solo ai cittadini italiani ma a tutti gli esseri umani.
La trasparenza in Comune
Ti sei mai chiesto come funziona il tuo Comune?
Per legge, tranne in alcuni casi, le sedute dei Consigli comunali sono pubbliche e aperte a tutti, in modo da garantire la trasparenza dell’operato di chi esercita il potere.
Indaga
• Visita il sito web del tuo Comune e guarda che informazioni rende disponibili per i cittadini. Nella pagina principale troverai sicuramente un link denominato “Amministrazione trasparente”: che tipo di informazioni vengono fornite in questa sezione? Che cosa significa “amministrazione trasparente”?

1 Completo
a Il principio personalista considera la al centro del sistema.
b Il principio personalista afferma che l’uomo viene prima dello
c I diritti preesistono allo Stato, che si impegna a garantirne il godimento a tutti.
• Nel QR code leggi i principi che il decreto legislativo n. 33/2013 prevede in materia di trasparenza e svolgi le attività proposte.
1 Scelgo
L’articolo 37 della Costituzione:
a prevede una serie di garanzie in caso di malattia del lavoratore
b prevede una tutela speciale per il lavoro minorile
c tutela il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione adeguata
d individua il lavoro non come un diritto, ma come un dovere per l’uomo
4 Il principio lavorista
Quando ti confronti con i tuoi amici sul vostro futuro, uno degli argomenti di cui può capitare di parlare è il lavoro che ognuno desidera fare e in cui si proiettano talenti e inclinazioni personali. Il lavoro è talmente importante nella vita di ogni individuo che anche quando si incontra per la prima volta una persona o si inizia una conversazione per conoscersi meglio, una delle prime domande che poni è: “che cosa fai nella vita?”.
Anche nella nostra Costituzione il lavoro è un elemento fondamentale su cui si sviluppano tutti gli altri aspetti, tant’è che lo troviamo citato sin dall’art. 1.
Il principio lavorista afferma la centralità del lavoro nell’ordinamento della Repubblica e nella vita dei singoli individui: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», dice l’articolo 1 della nostra Costituzione.
Ma che cos’è il lavoro? È allo stesso tempo una fatica che ci permette di mantenerci, ma pure l’occasione di realizzarci.
Anche per questo l’articolo 4 della Costituzione attribuisce allo Stato un compito importante ma difficile: quello di garantire il diritto al lavoro dei suoi cittadini.
In base all’articolo 4 della Costituzione, «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto».
Il lavoro è anche un servizio che rendiamo al nostro prossimo, è il contributo che diamo alla società nel suo complesso, perché nessuno di noi può bastare a se stesso, ciascuno dipende un po’ da tutti gli altri. E infatti lo stesso articolo 4 definisce il lavoro come «un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società»: non solo un diritto dunque, ma anche un dovere
La Costituzione tutela il lavoro e la sua centralità mediante apposite garanzie, come il diritto a una retribuzione adeguata, al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite (art. 36).
Lo scopo di tali norme della Costituzione è quello di tutelare la dignità e la libertà del lavoratore e il riconoscimento di queste tutele parte dal presupposto che il rapporto tra il datore di lavoro e i lavoratori possa essere anche di conflitto e veda, in questo caso, i lavoratori come la parte debole.
Una tutela speciale è poi prevista per il lavoro minorile (art. 37), per la disoccupazione involontaria e per i casi di malattia del lavoratore (art. 38).

La retribuzione dei minori
Vanessa ha 16 anni e, per dare un piccolo aiuto alla famiglia, nelle ore libere dagli impegni scolastici fa la cameriera in un bar insieme all’amica Marta, che ha 3 anni più di lei.
Le due amiche lavorano per lo stesso numero di ore, hanno la stessa esperienza, le stesse competenze e svolgono la stessa mansione ma, al momento di ricevere la retribuzione, il datore di lavoro versa a Vanessa una somma inferiore del 20% rispetto a quella corrisposta a Marta.
Risolvi il caso
Consulta l’articolo 37 della Costituzione e rispondi: il datore di lavoro ha agito in modo conforme al testo costituzionale?
5 Il principio di eguaglianza
Immagina di accompagnare uno dei tuoi genitori in un ufficio pubblico e di essere in fila in attesa del vostro turno. Come ti sentiresti se a un certo punto arrivasse qualcuno, saltasse la fila e l’impiegato dell’ufficio lo facesse passare senza nessun problema? Sicuramente ti darebbe molto fastidio e ti sembrerebbe una vera e propria ingiustizia, perché dovremmo essere trattati tutti allo stesso modo senza favoritismi e, in generale, senza distinzioni. Ed è giusto così, ecco perché il principio di eguaglianza si pone a fondamento della nostra società e del nostro ordinamento giuridico.
Il cuore della nostra Costituzione, l’articolo 3, scolpisce un’idea, un’aspirazione, una speranza antica quanto l’uomo: l’eguaglianza.
Ma che cos’è l’eguaglianza? Non è forse vero che siamo tutti diversi? Siamo diversi per aspetto esteriore e per inclinazioni, per genere e per età: nessuno al mondo è la fotocopia di un altro. Tutte queste sono diseguaglianze naturali, contrapposte alle diseguaglianze sociali, che invece distinguono le persone per ricchezza, posizione sociale, reputazione, in una parola per il potere che ciascuno esercita sugli altri.
Il diritto può cercare di evitare entrambi i tipi di diseguaglianza in due modi opposti: stabilendone l’irrilevanza, e quindi vietando ogni forma di discriminazione basata sulle differenze naturali o sociali (eguaglianza formale), oppure applicando un particolare trattamento giuridico a chi, a causa di tali differenze, viene a trovarsi in una posizione di svantaggio (eguaglianza sostanziale).
Ci sono situazioni, infatti, che richiedono necessariamente un trattamento differenziato tra le persone.
Per esempio se sei all’ingresso di un pronto soccorso, in attesa del tuo turno da tempo, ma arriva all’improvviso una persona con una grave patologia che richiede un intervento urgente, non ci sarebbe alcuna violazione del principio di eguaglianza nel suo passare davanti a tutti gli altri in attesa. Il principio di eguaglianza a volte richiede che sia previsto un trattamento differenziato nei confronti di chi si trova in una condizione di maggiore difficoltà.
L’eguaglianza formale | Come abbiamo visto, l’eguaglianza è una medaglia a due facce, che corrispondono ai due commi dell’articolo 3 e nell’insieme esprimono il senso di giustizia che anima la nostra Carta costituzionale.
In base al principio di eguaglianza formale, «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (art. 3 Cost., comma 1).
Il principio di eguaglianza formale è riflesso nella scritta che compare in ogni Tribunale: «La legge è uguale per tutti». Questo significa che nessuno è al di sopra della legge, ma
L’eguaglianza nei parcheggi
La foto mostra alcuni parcheggi riservati a una particolare categoria di persone.
Applica
• Di quali persone si tratta?
• La disposizione in base alla quale sono stati creati questi posti riservati è contraria al principio costituzionale di eguaglianza? Perché?

1 Vero o falso?
a Il principio di eguaglianza è un principio cuore della nostra Costituzione. VF
b Le diseguaglianze naturali sono contrapposte alle diseguaglianze sociali. VF c Il principio di eguaglianza serve a mettere in evidenza le diseguaglianze naturali. VF
2 Completo
a L’ è una medaglia a due facce, entrambe espresse nell’art.
3 Cost.
b Il principio di eguaglianza mira a contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

anche che nessuno è al di sotto della legge, nessuno può subire discriminazioni per le sue idee politiche, per la sua fede religiosa, l’orientamento sessuale o per i suoi tratti somatici.
L’eguaglianza sostanziale | L’eguaglianza puramente formale non tiene conto delle diseguaglianze di fatto che ci dividono e da qui, perciò, nasce la spinta a rendere effettiva l’eguaglianza, altrimenti destinata a rimanere sulla carta. Ecco allora spiegata l’importanza del secondo comma dell’articolo 3.
In base al principio di eguaglianza sostanziale, «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3 Cost., comma 2).
Lo Stato, insomma, deve intervenire attivamente per rimuovere le diseguaglianze presenti nella società e garantire a tutti i cittadini di esercitare pari diritti. In sostanza l’eguaglianza:
Ӷ in senso formale, garantisce che tutti abbiano pari opportunità e che le caratteristiche personali non siano fonte di discriminazione in negativo;
Ӷ in senso sostanziale, può giustificare discriminazioni in senso positivo, correzioni per rimediare a una condizione sfavorevole in cui alcune persone si trovano.
Con riferimento all’ultimo punto, vengono allora in gioco le azioni positive, come nel caso dell’introduzione delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche, così da rendere ogni edificio, compresa la tua scuola, accessibile a tutti.
Per esempio immagina due studenti molto bravi e con la stessa media che superano gli esami con eguale profitto, ma uno con le possibilità economiche per studiare e uno, invece, proveniente da una famiglia con disagi economici. Il principio di eguaglianza sostanziale impone allo Stato di rimuovere un ostacolo (in questo caso di tipo economico, esentando il secondo studente dal pagamento delle tasse) che impedisce allo studente con difficoltà economiche di proseguire liberamente gli studi e di costruirsi un futuro.
c Il principio di eguaglianza mira ad assicurare pari opportunità per tutti. formale
EGUAGLIANZA distinta in
NELLA REALTÀsi tutela
sostanziale si tutela
Una selezione tutta al maschile
Ti è mai capitato che il tuo genere di appartenenza potesse essere un ostacolo o un motivo di discriminazione per aspirare a qualcosa, che fosse un posto in una squadra sportiva o in un gruppo di studio?
Un’azienda sta selezionando del personale da impiegare nel suo reparto informatico. Carlotta si presenta alle selezioni ma il capo del personale le dice che la ricerca è limitata a lavoratori di sesso maschile.
Risolvi il caso
Ritieni che in questo caso il principio dell’eguaglianza formale sia stato rispettato? Motiva la tua risposta.
con eguaglianza davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali
rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale
Le tutele per le donne lavoratrici
La legislazione italiana prevede particolari tutele a favore delle donne lavoratrici, in particolar modo in caso di maternità. A questo proposito, l’articolo 37 della Costituzione afferma: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».
Indaga
Pensi che sia giusto offrire protezioni speciali alla donna che lavora, in quanto madre, e al bambino? Motiva la tua risposta e discutine in classe.
6 Il principio di solidarietà
Se pensi alla tua famiglia, ai tuoi amici e ai tuoi compagni di scuola, ti rendi subito conto che i rapporti tra di voi sono legati da responsabilità reciproche, come quelle dei genitori nei confronti dei figli oppure dei fratelli e sorelle o degli amici tra loro.
Il principio di solidarietà afferma infatti che ogni cittadino ha una responsabilità personale nei confronti degli altri, verso la comunità di cui fa parte.
La solidarietà che dovrebbe legarci gli uni agli altri discende dal fatto che la nostra esistenza si consuma all’interno di una società civile, e nessuna società può sopravvivere se fra le persone che la compongono prevalgono gli istinti egoistici o le sopraffazioni.
Il principio di solidarietà affonda le sue radici nell’articolo 2 della Costituzione, dove i diritti inviolabili si coniugano all’adempimento dei «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», anche con il fine di tendere all’eguaglianza sostanziale fra cittadini. Il principio di solidarietà emerge anche dal catalogo dei doveri costituzionali:
Ӷ il dovere di svolgere un’attività lavorativa (art. 4);
Ӷ il dovere di mantenere i figli (art. 30);
Ӷ il diritto-dovere di voto (art. 48);
Ӷ il dovere di difendere la Patria (art. 52) e di fedeltà alla Repubblica (art. 54);
Ӷ il dovere di concorrere alle spese pubbliche attraverso l’imposizione tributaria (art. 53).
CITTADINANZA DIGITALE

L1 Scelgo
Il dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche è espressione del principio:
a personalista
b di eguaglianza
c di solidarietà d lavorista
Hate speech e parole ostili in Rete
o sviluppo di Internet ha incrementato notevolmente le possibilità di interagire con gli altri, di condividere contenuti e opinioni personali in modo aperto e libero, ma a volte questa libertà di espressione è usata in modo improprio da quanti, protetti dall’anonimato, diffondono pregiudizi o incitano e giustificano l’intolleranza e l’odio verso altre persone. Donne, immigrati, omosessuali sono categorie spesso bersagliate sul web, vittime di frasi e commenti offensivi e discriminatori.
Per contrastare le varie forme di intolleranza che inquinano il web e minacciano le stesse basi della democrazia, il Consiglio d’Europa ha lanciato una campagna tesa a promuovere una corretta educazione all’uso dei media e di Internet e a coinvolgere i giovani nella difesa dei diritti umani, nel mondo digitale così come in quello materiale. Tra le varie iniziative, c’è anche la creazione di un movimento, il No Hate Speech Movement, il cui scopo è individuare e contrastare “discorsi di odio” e intolleranza in Rete, promuovendo attivamente fra i giovani una cultura fondata sul rispetto reciproco.
Vorresti dare un tuo personale contributo alla causa del No Hate Speech Movement?
1 Vai sul sito del movimento No Hate Speech e, con l’aiuto dell’insegnante di inglese, naviga nelle pagine in lingua inglese. Se lo desideri, avrai la possibilità di partecipare attivamente al progetto del Consiglio europeo.
2 Hai mai sentito parlare del Manifesto della comunicazione non ostile, riportato qui sotto?
Manifesto della comunicazione non ostile
1. Virtuale è reale
2. Si è ciò che si comunica
3. Le parole danno forma al pensiero
4. Prima di parlare bisogna ascoltare
5. Le parole sono un ponte
6. Le parole hanno conseguenze
7. Condividere è una responsabilità
8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare
9. Gli insulti non sono argomenti
10. Anche il silenzio comunica
Svolgi le attività proposte nel QR code per saperne di più e riflettere sulla comunicazione in Rete.
1 Vero o falso?
a Lo Stato italiano si definisce uno stato confessionale. VF
b Secondo l’art. 7
Cost. lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani. VF
c In base al principio di laicità tutte le confessioni sono egualmente libere per legge. VF
7 Il principio di laicità
L’Italia è un Paese in cui la maggior parte delle persone religiose sono cattoliche, ma i cattolici non sono gli unici a vivere sul nostro territorio nazionale. Probabilmente nella tua quotidianità hai modo di incrociare qualcuno di fede diversa o non credente. Per noi è la normalità perché l’ordinamento italiano si basa sul principio di laicità, ma non in tutto il mondo è concessa questa varietà di credo sul territorio.
In base al principio di laicità lo Stato italiano garantisce la libertà di religione, ma non si interessa degli affari religiosi e non ne è condizionato.
L’aggettivo “laico” si contrappone a “confessionale”, che a sua volta evoca l’appartenenza a una confessione religiosa; laicità significa quindi indipendenza rispetto alle scelte della Chiesa cattolica (a cui lo Stato repubblicano riconosce una posizione speciale per ragioni storiche) o delle altre religioni.
Così, l’articolo 7 afferma che «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani»; e l’8 aggiunge: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano».
Lo strumento normativo che regola i rapporti fra autorità statali e i fedeli delle diverse religioni è un accordo recepito dalla legge, che può essere un concordato o un’intesa, a seconda che la stipula avvenga con un culto cattolico o non cattolico.
Lo Stato può raggiungere intese solo con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. L’esercizio della libertà religiosa viene comunque garantito a tutte le confessioni religiose, anche a quelle non riconosciute.
PRINCIPIO DI LAICITÀ
garantisce

indipendenza dello Stato dalla Chiesa
Il crocifisso a scuola
Secondo un’indagine dell’ufficio regionale scolastico (URS) dell’Emilia-Romagna, a seguito di una richiesta di chiarimenti di diversi dirigenti scolastici, in Italia sono vigenti delle disposizioni che prevedono l’affissione del crocifisso nelle aule e tale affissione non deve ritenersi lesiva del principio di libertà religiosa.
Rifletti
• Secondo te, l’esposizione di simboli religiosi nelle scuole pubbliche italiane potrebbe essere giudicata in contrasto con il principio costituzionale di laicità? Perché?
• Discutine in classe con i tuoi compagni e l’insegnante.
libertà di religione
8 Il principio di legalità
Quante volte ti sarà capitato di dover rispettare una norma (portare il casco, pagare il biglietto dell’autobus ecc.) e di chiederti: perché devo comportarmi proprio in questo modo?
Ogni norma che impone un certo comportamento deve trovare fondamento in una legge dello Stato.
Dice l’articolo 23 della Costituzione: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge». Ciò significa che nessuna imposizione può provenire da autorità diverse dallo Stato e dalle sue leggi.
Per esempio serve una legge per imporre il servizio militare (ossia una prestazione “personale”), per obbligare al pagamento di una tassa (prestazione “patrimoniale”), per comprimere le libertà degli individui secondo quanto stabiliscono gli articoli 13 e seguenti.
In queste norme si riflette il principio di legalità, cardine dello Stato di diritto, che è sottoposto al dominio della legge e che ha due varianti diverse.
La prima forma di legalità è la legalità formale, in cui la legge attribuisce i poteri di compiere atti alle amministrazioni (come attribuire al Comune la facoltà di emettere una determinata ordinanza in materia di viabilità sulle strade). La seconda forma di legalità è la legalità sostanziale, in cui la legge non solo descrive tali poteri attribuiti per la creazione di atti e provvedimenti, ma lo fa con un livello di precisione in più, specificando il contenuto e lo scopo dei singoli atti che le amministrazioni possono compiere.
PRINCIPIO DI LEGALITÀ
che si distingue in

I1 Completo
a Per il principio di il potere non può essere esercitato in modo arbitrario.
b Ogni Stato di diritto è sottoposto al dominio della
c Il principio di legalità si esprime in due forme: legalità e legalità
legalità formale
CITTADINANZA DIGITALE
legalità sostanziale
Internet, un diritto umano a rischio
diritti dell’essere umano valgono anche quando si è connessi al web. Impedire o limitare l’accesso alla Rete equivale a negare libertà e diritti ritenuti inviolabili dalle Costituzioni democratiche, come la libertà di espressione, il diritto all’informazione, all’istruzione, all’eguaglianza, tutte componenti indispensabili per il pieno sviluppo della persona umana. A stabilirlo è una risoluzione dell’ONU del 2016, Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on Internet (“Promozione, protezione e godimento dei diritti umani su Internet”), che afferma chiaramente come la natura globale e aperta di Internet deve essere riconosciuta quale forza trainante dello sviluppo sociale, culturale, economico e politico della comunità internazionale.
Il mondo, però, è spaccato in due: i Paesi più ricchi godono di tutte le opportunità offerte dal web, mentre i Paesi più poveri restano inesorabilmente indietro. Se questo “divario digitale” (digital divide) non viene colmato, le più elementari forme di esercizio della cittadinanza online resteranno un privilegio per pochi.
Venendo a un ambito più ristretto, anche in Italia c’è il problema del digital divide. A questo proposito un progetto governativo, il Piano strategico banda ultralarga, mira a estendere e ad ammodernare le reti di telecomunicazione così da favorire la crescita dell’intero “sistema Paese”.
1 Quali sono gli obiettivi di copertura progressivi previsti per la tua Regione dal Piano strategico banda ultralarga? Perché questa scheda si intitola “Internet, un diritto umano a rischio”?
Scoprilo nel QR code e procedi con le attività proposte per approfondire il tema di Internet, diritti umani e digital divide
2 Debate in classe
“Impedire o limitare l’accesso alla Rete equivale a negare libertà e diritti fondamentali”.
Dividetevi in due gruppi: il primo gruppo argomenterà per sostenere l’affermazione, il secondo per confutarla.
CLIL
Eguaglianza: equality Democrazia: democracy

1 Completo a L’art. 11 Cost. afferma il principio
b I padri costituenti hanno fatto della un bene supremo da proteggere.
c Il della guerra ha permesso all’Italia di aderire alle Nazioni Unite.
9 Il principio pacifista
Non è sempre possibile andare d’accordo con tutti, lo sai bene: in famiglia, a scuola, tra amici, è normale che ci siano momenti di disaccordi, magari anche di litigate. Quello che è importante, in quei momenti, è ricordarsi di risolvere il conflitto in modo civile, mai con la violenza fisica o con aggressioni verbali violente e dolorose. Perfino la Costituzione si esprime rispetto ai conflitti che possono sorgere con altri Stati.
L’articolo 11 proclama con forza il ripudio nei confronti della guerra sia come strumento di offesa sia come strumento per risolvere le controversie con gli altri Paesi: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».
L’articolo 11 fu pensato perché i nostri padri costituenti avevano ben presente che cosa volesse dire vivere una situazione di conflitto a livello internazionale. L’Assemblea costituente ha, infatti, introdotto un vero e proprio principio pacifista per tenere lontana quella guerra da cui l’Italia era uscita distrutta e nei cui confronti tutte le forze politiche fecero fronte comune. Non solo questo principio serviva per ribadire la chiara volontà di non ripetere gli errori del passato ma si poneva come base per stringere relazioni costruttive con le organizzazioni internazionali che avevano come scopo la pace e la giustizia tra i Paesi. L’articolo 11 favorì infatti l’adesione dell’Italia alle Nazioni Unite che richiedevano come condizione di ammissione l’essere “amante della pace”.
Nello scenario storico del secondo dopoguerra si inserisce anche l’inclusione tra i principi fondamentali della Costituzione dell’art. 12: «La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni».
Nelle intenzioni dei costituenti, infatti, il motivo alla base della descrizione del tricolore italiano all’interno della carta costituzionale era il voler impedire che qualche forza politica potesse, peraltro con una legge ordinaria, modificare la bandiera nazionale introducendo i simboli delle proprie ideologie.
unificazione nazionale tricolore italiano ripudio della guerra
Il tricolore
Durante le competizioni sportive, le manifestazioni e tutte le volte in cui le persone si sentono di esprimere la propria appartenenza alla società italiana, il nostro tricolore viene sbandierato con gioia e orgoglio.
Indaga
Con una ricerca in Rete, scopri le origini della nostra bandiera e le modifiche che ha subito nel tempo.
Oltre alla bandiera, c’è un’altra cosa che ci unisce tutti e che cantiamo nelle occasioni più diverse: l’inno nazionale. Il nostro inno, l’Inno di Mameli, non trova un chiaro
riconoscimento nella Costituzione, ma è stato reso ufficialmente inno nazionale nel 2017 con una legge dedicata.
Indaga
• Con una ricerca in Rete scopri il testo integrale dell’inno e la storia della sua creazione.
• Confrontati con i tuoi compagni: capite tutto il testo?
E lo ricordate già a memoria?
VIDE d’AUTORE

Che cos’è l’eguaglianza?
Hai studiato che l’essere umano, per stare bene nella società, ha bisogno di un diritto che garantisca pace sociale, libertà ed eguaglianza. Per questo motivo, uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione è quello di eguaglianza, contenuto nell’art. 3.
L’eguaglianza è un ideale, una situazione che si vuole si realizzi, non è un dato di realtà; nella realtà, infatti, ci sono grandi differenze tra gli uomini, alcune sono create dalla natura, altre sono originate dalla società. Il diritto vuole modificare la realtà e lo fa sia con punizioni sia con premi. Il diritto infatti ha due “anime”: quella del diritto tradizionale, che scoraggia i comportamenti indesiderati castigandoli con una punizione, e quella del diritto premiale, che incoraggia i comportamenti virtuosi, gratificando con una ricompensa chi li tiene.
Quale eguaglianza
vuole realizzare la Costituzione?
Per contrastare le diseguaglianze la Costituzione stabilisce due regole:
1. nessuno è al di sopra della legge (ma neppure al di sotto);
2. bisogna combattere le diseguaglianze di fatto. Per combattere le diseguaglianza di fatto, il legislatore deve livellare le situazioni dei diversi cittadini, ma questo livellamento non può essere totale: la legge deve trattare in modo eguale situazioni eguali e deve trattare in maniera diversa situazioni diverse. Questo significa che la legge deve combattere solo le diseguaglianze ingiuste in modo da assicurare l’eguaglianza dei punti di partenza. I punti di arrivo possono essere anche molto diversi, l’importante è che le differenze dipendano dal merito.
ASCOLTA quello che l’Autore ha da dire in merito e poi FAI IL PUNTO.
▶ Che cosa sono le azioni positive in materia di eguaglianza? Sai fare qualche esempio?
▶ Un insegnante quando adopera la logica del diritto punitivo e quella del diritto premiale nei confronti dei suoi studenti?
▶ Che cosa significa eguaglianza dei punti di partenza?
▶ Quali sono, secondo te, le diseguaglianze ingiuste?
▶ Quali sono, secondo te, le diseguaglianze irrilevanti, su cui la legge non deve intervenire?
▶ In classe, confrontate le vostre risposte alle domande e raccogliete in una tabella con due colonne i casi di diseguaglianze ingiuste e diseguaglianze irrilevanti.
FAI IL PUNTO

LEZIONE DIGITALE
1 Ripassa i temi fondanti con la lezione digitale “Struttura e fondamenti della Costituzione”.
2 Leggi e completa questa pagina.
ô Qual è il significato del principio democratico?
Il principio democratico è contenuto nel articolo della Costituzione che richiede che il potere politico si fondi sulla popolare («la sovranità appartiene al popolo»).
ô In quale modo il principio personalistico e quello lavorista rappresentano i tratti distintivi, insieme al principio democratico, della nostra Costituzione?
L’art. 2 descrive il principio personalistico, affermando che la Repubblica riconosce e garantisce i , preesistenti allo Stato, di ogni singolo essere umano sia in chiave («come singolo») sia in chiave («nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»). L’individuo è quindi il centro del sistema giuridico, anche prima dello Stato. Il lavoro assume un’importanza primaria rispetto alla vita dei singoli individui: il principio lavorista afferma proprio la centralità del lavoro nell’ordinamento della Repubblica come strumento di , realizzazione e contributo alla società nel suo complesso. La Costituzione riconosce un vero e proprio diritto al lavoro, sancito dall’articolo 4 e tutelato da numerose norme in materia di , settimanale, tutela del lavoro minorile, e malattia del lavoratore.
ô Quali sono le due dimensioni del principio di eguaglianza?
L’art. 3 contiene due commi a cui corrispondono i due volti dell’eguaglianza:
ôeguaglianza in forza della quale tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge senza distinzione, e quindi senza alcuna possibile discriminazione, con riferimento alla lingua, alla religione e a ogni caratteristica personale;
ôeguaglianza sostanziale che mira a eliminare le diseguaglianze di fatto di cui l’eguaglianza formale non tiene conto, per cercare di rendere effettiva l’eguaglianza per tutti attraverso la degli ostacoli di ordine economico e sociale di cui parla l’art. 3, comma 2.
ô A che cosa si riferisce il principio di solidarietà?
Il principio di solidarietà afferma che ogni cittadino ha una nei confronti degli altri, cioè verso la comunità di cui fa parte. Le norme che contengono questo principio sono l’art. 2 che parla dei doveri inderogabili di politica, economica e sociale tra i cittadini e la lunga lista dei doveri costituzionali presenti nella Costituzione.
ô Qual è il contenuto del principio di laicità?
L’ordinamento italiano si basa sul principio di laicità: lo Stato la libertà di religione, ma non si interessa né è condizionato dagli affari religiosi. Lo Stato rimane in sostanza rispetto alle questioni religiose.
PRINCIPI COSTITUZIONALI
L’UNITÀ IN AUDIO MAPPE
Per ripassare, guarda le mappe, ascoltando le sintesi audio dell’unità

Principio democratico
Principio personalista
Principio di eguaglianza
Principio lavorista
Principio di laicità
Principio di legalità
Principio pacifista
secondo cui secondo cui
che si articola in
secondo cui
secondo cui secondo cui
secondo cui
art. 1 «la sovranità appartiene al popolo»
Aart. 3, c.1 Uguaglianza formale: «Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge»
art. 2
«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»
La persona è al centro del sistema e viene prima dello Stato
che riconosce anche
Principio di solidarietà parlando di
art. 2
«[…] doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale»
art. 3, c. 2 Uguaglianza sostanziale: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini»
art. 4
art. 7 «Lo Stato e la Chiesa sono […] indipendenti e sovrani»
«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto»
prevedendo anche
garanzie per
• retribuzione adeguata
• ferie
• malattia
• parità di trattamento
• lavoro minorile
• casi di disoccupazione
art. 8 «Tutte le confessioni sono egualmente libere davanti alla legge»
art. 11
«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali»
art. 23 «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»
si articola in due forme
legalità formale: la legge deve attribuire alle amministrazioni il potere di compiere atti
legalità sostanziale: la legge deve specificare contenuto e scopo degli atti
VERIFICO CONOSCENZE E ABILITÀ
VERO O FALSO?
1 I rapporti tra lo Stato e i culti religiosi non sono regolati, perché lo Stato è indipendente. VF
2 L’Italia ripudia le guerre di aggressione. VF
3 Il riconoscimento dei diritti inviolabili c’è solo a seguito dell’adempimento dei doveri inderogabili. VF
4 Le azioni positive mirano a ristabilire condizioni di equità in nome del principio di eguaglianza sostanziale. VF
5 Ogni imposizione deve trovare fondamento in una legge dello Stato. VF
6 Secondo il principio personalista, l’uomo è titolare di diritti “inviolabili” che solo lo Stato può eliminare. VF
7 La religione cattolica è l’unica religione di Stato. VF
8 L’eguaglianza sostanziale impone un trattamento identico per tutti gli individui. VF
9 In base al principio di laicità lo Stato si astiene dall’intervenire nelle questioni strettamente religiose. VF
10 I diritti inviolabili preesistono allo Stato. VF
11 Le donne, in quanto tali, non possono esercitare la professione di magistrato. VF
12 Il dovere di educare e mantenere i figli risponde al principio di legalità.
13 Il tricolore italiano è descritto precisamente all’interno del testo costituzionale: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
SCELGO
1 In base al principio democratico:
a il potere politico è fondato sulla volontà popolare b il potere giuridico deve prevedere sanzioni per la violazione delle norme
c il potere giuridico è esercitato illimitatamente dal popolo
VF
VF

d il potere politico è fondato sulla volontà del Capo di Stato eletto dal popolo
2 L’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici rappresenta:
a un’azione positiva che esprime l’eguaglianza sostanziale
b un’azione positiva che esprime l’eguaglianza formale
c una misura positiva a sostegno del principio personalista d il principio per cui “la legge è uguale per tutti”
3 La Costituzione prevede che il lavoro:
a sia un diritto ma non anche un dovere
b sia un diritto e un obbligo
c sia un diritto e un dovere
d sia un diritto e un servizio, oltre che un obbligo
HUB TEST
Allenati con ulteriori test autocorrettivi su HUB Test
COMPLETO (attenzione ai distrattori)
confessionale / formale / individui / intese / inviolabili / lavoro / legge / naturali / personalità giuridica / principi / sociali / solidarietà / sostanziale / storiche / trasparenza / persone
1 In base alla nostra Costituzione, i diritti dell’uomo sono riconosciuti non solo ai cittadini, ma a tutte le
2 “La legge è uguale per tutti” è la classica affermazione del principio di eguaglianza , tuttavia l’impegno dello Stato non si esaurisce così e grazie all’eguaglianza può intervenire applicando un trattamento giuridico differenziato a chi, a causa di tali differenze, si trova in una posizione di svantaggio.
3 Per ragioni lo Stato riconosce una posizione speciale alla Chiesa cattolica, ma non si può definire uno Stato e resta indipendente nei confronti di tutte le confessioni religiose.
4 Il principio lavorista afferma la centralità del per la Repubblica e nella vita dei singoli , come servizio per il progresso della società e occasione di realizzazione e di sostentamento del singolo.
5 Per regolare i rapporti con le confessioni religiose lo Stato raggiunge , tuttavia può farlo solo con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della
6 Per imporre una nuova tassa o ristabilire l’obbligo del servizio militare serve necessariamente una
7 Il principio di è correlato al dovere costituzionale di concorrere alle spese pubbliche attraverso l’imposizione tributaria.
8 Il rispetto del principio democratico non si esaurisce nella sovranità del popolo, ma comporta la nei modi di esercizio del potere politico.
9 Le diseguaglianze sono le differenze che ci distinguono gli uni dagli altri per genere, età ecc., mentre quelle per il potere che ciascuno esercita sugli altri.
COLLEGO (Fai attenzione a riempire tutti i campi)
1 Principio personalista
□ Art. 3, c. 2
2 Principio democratico □ Art. 11
3 Principio di eguaglianza formale □ Art. 23
4 Principio di eguaglianza sostanziale □ Art. 7
5 Principio lavorista
6 Principio di solidarietà
7 Principio di laicità
8 Principio di legalità
9 Principio pacifista
□ Art. 3, c. 1
□ Art. 2
□ Art. 1, art. 4
□ Art. 2
□ Art. 1
SVILUPPO COMPETENZE
ANALIZZO
1 Come viene configurato il lavoro nella Carta costituzionale?

2 Che cosa hanno in comune il principio personalista e il principio di solidarietà?
RISOLVO IL CASO
1 Giuditta è stata convocata per un colloquio di lavoro nell’azienda dei suoi sogni, ma è rimasta sorpresa da come è andato l’incontro. Il responsabile delle risorse umane le ha spiegato che si è liberato un posto di lavoro, perché Daniela è stata licenziata non appena è rimasta incinta. Durante il colloquio le sono state poste molte domande personali, piuttosto che professionali, relativamente alle sue opinioni religiose e sui futuri “progetti di famiglia”. Queste domande, a detta del responsabile, servivano per inquadrarla meglio nelle sue mansioni e nella retribuzione. a Sapresti riconoscere se sono state compiute delle discriminazioni?
b In quale delle sue forme è stato violato il principio di eguaglianza?
3 Che cosa tutela il principio di legalità?
4 Come viene tutelata la pace nel nostro ordinamento?
COSTRUISCO UNA MAPPA
1 Nel corso di questa unità hai imparato nuove parole relative ai Principi fondamentali alla base della nostra Costituzione. Con le parole per te più significative, prova a costruire una mappa su quanto appreso.
2 A fronte di una grave crisi economica, le nostre autorità hanno deciso di intervenire tempestivamente evitando i tempi troppo lunghi richiesti dall’iter legislativo inviando piuttosto una lettera a tutti i cittadini in cui sono descritte le misure che hanno programmato a sostegno dell’economia, ma in cambio dichiarano di aver introdotto una nuova tassa, la “TIRIAMOCI SU!”, che tutti i cittadini hanno l’obbligo di pagare entro 7 giorni. Viene chiesta anche la disponibilità da parte di tutti i cittadini a preferire il consumo dei prodotti italiani, per favorire la crescita economica.
a Ti sembra legittimo il comportamento delle autorità italiane e la disponibilità richiesta ai cittadini? Perché?
ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARE
1 Lo studio delle “anime” della Costituzione ha fatto emergere le solide fondamenta su cui è stata costruita la nostra Repubblica, i nostri principi fondamentali. Questi principi però non hanno avuto sempre lo stesso riconoscimento. Nell’antico Egitto o nell’antica Roma, per esempio, era normale ci fossero gli schiavi. Come puoi mettere in relazione quanto hai studiato qui con quello che hai studiato in storia in merito ai periodi citati? Che principi venivano riconosciuti e come o a favore di chi venivano applicati?
ENGLISH CORNER
1 Choose the answer that best matches the given definition. Principle of the Italian Constitution according to which the People are the source of the authority of government.
a Principle of secularism
b Principle of equality
c Principle of solidarity
d Principle of democracy


I diritti individuali
Guarda il video
Nel video proposto sono intervistati alcuni ragazzi che partecipano a una delle giornate chiamate Fridays For Future.
• Su quali argomenti in particolare i manifestanti pongono l’attenzione?
• Secondo te sono utili iniziative come queste in cui i cittadini possano esprimere e confrontare le proprie idee e opinioni?
Usa gli strumenti del libro
• Tenendo a mente il contenuto del video, vai al paragrafo 1 e al paragrafo 5 e leggi il contenuto, individuandone i concetti principali
• Verifica di aver capito i contenuti dei paragrafi letti svolgendo l’esercizio “Scelgo”
• Per metterti alla prova svolgi la consegna n. 1 di Cittadinanza digitale – Il diritto a essere dimenticati
1 I diritti e i doveri nella Costituzione
Abbiamo detto che la Costituzione italiana, in armonia con i principi che la animano, «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2).
La Costituzione dedica l’intera Parte I ai Diritti e doveri dei cittadini, facendo una distinzione fra quelli relativi ai Rapporti civili (artt. 13-28), ai Rapporti etico-sociali (artt. 29-34), ai Rapporti economici (artt. 35-47) e ai Rapporti politici (artt. 48-54).
In questa unità e nelle seguenti esamineremo i più importanti diritti e doveri costituzionali, quelli che incidono più profondamente nelle nostre vite. Iniziamo dai diritti
I diritti costituzionali possono essere suddivisi in:
• diritti individuali, attribuiti al singolo, che può esercitarli autonomamente;
• diritti collettivi, assegnati sempre al singolo, che però li può esercitare solo insieme ad altri;
• diritti sociali, attraverso i quali lo Stato mira a realizzare l’eguaglianza sostanziale. In questa unità analizzeremo i principali diritti costituzionali individuali, nelle successive due quelli collettivi e sociali e i doveri che la Costituzione riconosce, anche se in posizione meno centrale rispetto ai diritti, in capo ai cittadini.

2 La libertà personale
Immagina di andare allo stadio a vedere una partita di calcio. All’uscita alcuni ragazzi prendono a sassate le vetrine dei negozi della città. Tuo malgrado ti ritrovi in mezzo ai tafferugli, così le forze dell’ordine, arrestando i responsabili, fermano anche te e ti trattengono in caserma per tutta la notte. Questo è un esempio classico di limitazione della libertà personale. Quali strumenti hai per tutelare la tua libertà personale, intesa come piena disponibilità del tuo corpo, e per impedire interferenze o limitazioni da parte di altri? In che modo la legge difende il tuo diritto di dimostrare che tu non sei colpevole e di tornare al più presto in libertà? La garanzia della libertà personale è una questione fondamentale di ogni ordinamento giuridico perché riguarda la sfera più importante della propria libertà.
Proprio per questo motivo la libertà personale è il primo e più importante fra i diritti costituzionali individuali perché costituisce il presupposto senza il quale non è possibile godere degli altri diritti di libertà.
La prima cosa da capire è che per libertà personale non si intendono tutte le libertà genericamente riconosciute alla persona, bensì una specifica forma di libertà.
La libertà personale è la libertà di disporre del proprio corpo, quindi il diritto di non subire coercizioni materiali come l’essere legati, bloccati, ammanettati, l’essere ispezionati o perquisiti, l’essere ristretti in una cella.
Secondo il primo comma dell’articolo 13 della Costituzione, «La libertà personale è inviolabile».
L’attributo di inviolabilità che la Costituzione assegna a questa libertà consiste anzitutto nel fatto che è illegale, per chiunque, imporre simili coercizioni a un altro essere umano: il Codice penale prevede infatti una serie di reati che ledono la libertà personale, come il sequestro di persona (art. 605), l’arresto illegale (art. 606), la violenza sessuale (art. 609-bis) o la riduzione in schiavitù (art. 600). Inoltre, il carattere di inviolabilità implica che non è possibile abrogare questa libertà nemmeno attraverso un procedimento di revisione costituzionale perché, se lo si facesse, verrebbero negati valori supremi della Costituzione, come la dignità umana.
I limiti | Le persone possono essere legalmente perquisite, arrestate e tenute in carcere se risulta necessario limitare la libertà personale per proteggere la collettività.
Così, l’articolo 13 della Costituzione, al secondo comma, dopo avere riaffermato la regola generale («Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale [...]»), prevede una deroga, un unico modo legittimo per arrestare, ispezionare ( per esempio prelevando le impronte digitali) o perquisire una persona: «[...] se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».
L’infanzia negata
Capita spesso di vedere per strada bambini obbligati da persone adulte a chiedere l’elemosina.
Indaga
Secondo te, in questo fenomeno si può ravvisare una violazione della libertà personale dei bambini?
• Motiva la tua risposta e, con l’aiuto dell’insegnante, discutine in classe con i compagni e le compagne.
LE PAROLE DEL DIRITTO
Ordinanza di custodia cautelare: atto dell’autorità giudiziaria che comporta la restrizione della libertà personale di un soggetto prima che questi sia condannato.

1 Completo
a La libertà personale è il primo e più importante diritto
b Secondo l’articolo 13, primo comma, Cost.: «La libertà personale è ».
c Nessuno può essere privato della libertà personale, salvo nei casi previsti dalla
Esiste quindi un procedimento ordinario che permette agli organi dello Stato di limitare la libertà personale, ma nel rispetto di due fondamentali garanzie, che servono a prevenire gli abusi e gli arbitri da parte delle forze dell’ordine o dei magistrati:
Ӷ una riserva di legge prevista dall’articolo 13, secondo comma, che afferma che solo una legge approvata dal Parlamento o un atto con forza di legge (decreto legislativo o decreto legge) possono stabilire in via generale e astratta limiti alla libertà personale. Per esempio il legislatore stabilisce i casi in cui si può arrestare una persona prima che sia condannata con sentenza definitiva se esistono gravi indizi di colpevolezza per un reato in caso di pericolo di fuga dell’indagato visto che la riserva di legge riguarda, innanzitutto, la determinazione dei comportamenti da considerare come reati;
Ӷ una riserva di giurisdizione per la quale solo un giudice, attraverso un atto obbligatoriamente motivato, può applicare in concreto la legge stabilendo che qualcuno debba essere sottoposto a limitazione della libertà personale ( per esempio nei casi di ispezione).
Esistono però situazioni straordinarie nelle quali non è possibile attendere che il giudice emetta l’atto. Per esempio pensa a un rapinatore che stia fuggendo da una banca subito dopo aver sottratto del denaro: se il poliziotto che interviene dovesse prima recarsi in Tribunale per ottenere dal magistrato l’ordinanza di custodia cautelare, che gli consente di privare l’imputato della libertà prima della sentenza di condanna, il suo intervento sarebbe inutile.
Per affrontare queste situazioni particolari, il terzo comma dell’articolo 13 prevede un procedimento straordinario: «In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto».
In casi eccezionali previsti dalla legge, quindi, le forze dell’ordine possono limitare temporaneamente la libertà personale.
Il giudice dovrà valutare se le forze dell’ordine hanno agito in modo legittimo ed eventualmente convalidare l’arresto o la perquisizione. Nel nostro esempio, quindi, il poliziotto potrà arrestare subito la persona colta sul fatto, in flagranza di reato, ma entro 48 ore dovrà informare il magistrato il quale, nelle successive 48 ore, deciderà se confermare l’arresto o rimettere in libertà il presunto rapinatore.
È da notare che anche in questa ipotesi entrambe le garanzie costituzionali rimangono in vigore: nulla cambia per la riserva di legge e l’intervento del giudice (richiesto dalla riserva di giurisdizione) è comunque necessario, benché dopo l’arresto.
Ora sei in grado di rispondere alle domande che erano state poste all’inizio del paragrafo, nell’esempio dell’arresto dopo una partita di calcio. La Costituzione garantisce la tua libertà personale prevedendo che quel provvedimento di arresto, preso dalle forze
In arresto o in libertà
La mattina del 5 maggio alcuni agenti di polizia in borghese arrestano uno spacciatore che incautamente ha offerto loro della droga ritenendoli dei normali passanti. Nel pomeriggio danno notizia dell’arresto al magistrato competente che, a causa di una serie di impegni, riesce a convalidarlo solo due giorni dopo.
Risolvi il caso
Lo spacciatore resterà in stato di fermo o sarà rimesso in libertà? Motiva la tua risposta.
dell’ordine per fermare i tafferugli, sia convalidato da un magistrato il quale valuterà in maniera indipendente, oggettiva e in tempi brevissimi tutti gli elementi a disposizione per verificare se effettivamente ti eri trovato in quella situazione per caso e senza alcuna responsabilità da parte tua.
La libertà di domicilio
Di fronte a persone che, con un pretesto qualsiasi, chiedono di entrare in casa tua, tu hai il diritto di non farli entrare. Questo perché la Costituzione tutela la libertà di domicilio, ossia il luogo nel quale ciascuno vive e svolge le proprie attività, al pari della libertà personale, quasi come se ne fosse una estensione.
Secondo la nostra Costituzione, «Il domicilio è inviolabile» (art. 14, comma 1), intendendo per domicilio non solo la propria casa bensì qualsiasi luogo in cui ci si possa isolare dall’esterno, come una tenda da campeggio o una camera d’albergo. Persino le forze dell’ordine non possono violare questa libertà se non rispettando le regole che abbiamo già visto per la libertà personale.
Lo stesso articolo 14, infatti, impone il divieto di «eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge» e secondo le stesse garanzie previste per la tutela della libertà personale (art. 14, comma 2). Ci sono dei casi, previsti comunque dalla legge, in cui a specifici organi della pubblica amministrazione è consentito l’accesso per verifiche e controlli per motivi di sanità o di incolumità pubblica senza le garanzie previste per l’attività di polizia: per esempio, pensa ai controlli fatti per verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o dei requisiti igienici dei luoghi aperti al pubblico (art. 14, comma 3).
3 La libertà di circolazione e soggiorno
Quando decidi di fare una passeggiata al parco, di visitare un museo o di trascorrere una giornata al mare tu non fai altro che godere di un diritto ormai sancito dalla nostra Costituzione ma che ha una storia molto lunga di lotte e rivendicazioni. Durante l’emergenza Covid-19 hai potuto sperimentare in maniera molto diretta che cosa significhi limitare questa libertà: infatti non era consentito uscire di casa se non per fare la spesa o per esigenze improrogabili di salute o di lavoro.
La libertà di circolazione e soggiorno difende l’individuo dalle limitazioni e dalle interferenze che possano impedirgli di spostarsi liberamente da un posto all’altro o di decidere dove andare ad abitare e lavorare.
Il divieto di trasferta
Una limitazione alla libertà di circolazione molto discussa riguarda le trasferte dei tifosi delle squadre di calcio, che i Questori possono decidere di vietare.
Indaga
• Secondo te, in quali circostanze questo divieto è legittimo?
• Nel QR code leggi la normativa contro la violenza negli stadi e svolgi le attività proposte.

LE PAROLE DEL DIRITTO
Sequestro: provvedimento dell’autorità giudiziaria che rende indisponibile un bene a chi lo detiene.
1 Vero o falso?
a La libertà di domicilio è un’estensione della libertà personale. VF
b La parola “domicilio” nell’art. 14 Cost. è da interpretare in senso ampio. VF
c Le forze dell’ordine non possono violare la libertà di domicilio. VF
1 Scelgo
A garanzia della libertà di circolazione e soggiorno la Costituzione ha previsto:
a un divieto generale per le limitazioni fondate sulla religione
b una riserva di giurisdizione
c sia una riserva di giurisdizione, sia una riserva di legge
d una riserva di legge rinforzata

Secondo la nostra Costituzione, «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche» (art. 16, comma 1); «Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge» (art. 16, comma 2). È da notare che, mentre la libertà personale e quella di domicilio valgono per tutte le persone, la libertà di circolazione e soggiorno è un diritto riconosciuto espressamente solo ai cittadini italiani, e dunque può venire disciplinato in modo più severo nei confronti degli stranieri.
In base al principio di eguaglianza formale, però, ciò può avvenire solo se il diverso trattamento previsto per il cittadino straniero è “ragionevole” rispetto a quello stabilito per l’italiano.
I limiti | A differenza della libertà personale, per le limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno è prevista solo una riserva di legge, che in questo caso però è “rinforzata” dal fatto che la Costituzione consente alla legge di stabilire limitazioni alla libertà solo «in via generale» (la limitazione deve cioè riguardare tutti o una particolare categoria di persone, e non singoli individui) e solo per motivi di sanità o di sicurezza.
Per esempio in caso di una grave epidemia virale, come è accaduto nel nostro Paese e in tutto il mondo con la pandemia da Covid-19, i cittadini possono subire limiti negli spostamenti sul territorio nazionale e i malati possono essere messi in isolamento per evitare che il virus si propaghi.
A completare questa disciplina, l’articolo 16 della Costituzione vieta espressamente qualunque restrizione basata su ragioni politiche. Qui si coglie il riferimento storico al confino praticato in epoca fascista, una misura di “prevenzione” attraverso la quale gli oppositori del Regime venivano obbligati, senza processo, a soggiornare in zone isolate del territorio nazionale, così da impedirgli di partecipare alla vita sociale del Paese.
4 La libertà e la segretezza delle comunicazioni
Se ci pensi, nel mondo che ci circonda la libertà di comunicare e di condividere le idee ha conosciuto negli ultimi tempi, grazie anche ai social media, un enorme sviluppo. Ogni giorno tu stesso invii e ricevi tantissimi messaggi e condividi contenuti e opinioni con molte altre persone. Ma quanto è importante che quei messaggi restino riservati tra te e chi li riceve? Quali garanzie sono previste per evitare che questi messaggi diventino pubblici?
NELLA REALTÀComunicazione o manifestazione del pensiero?
Si avvicinano le elezioni: uno dei candidati a Sindaco del tuo Comune partecipa a una trasmissione televisiva locale per presentare il proprio progetto politico. Successivamente, il candidato telefona ad amici e conoscenti per chiedere il loro voto. Applica
• In quale occasione il candidato Sindaco ha comunicato il suo pensiero?
• In quale, invece, l’ha manifestato?
La Costituzione prevede anche libertà che riguardano questa dimensione spirituale e intellettuale della persona e che rientrano nella generale “libertà di espressione” dell’individuo. Si tratta della libertà e segretezza delle comunicazioni (art. 15), della libertà di religione (art. 19), della libertà di manifestare il pensiero (art. 21), della libertà dell’arte e della scienza (art. 33).
Prima di esaminare quanto la Costituzione italiana stabilisce per ciascuna di queste libertà, è opportuno chiarire una distinzione fondamentale: quella tra comunicazione e manifestazione del pensiero.
Differenza tra comunicazione e manifestazione del pensiero | Partiamo da alcuni esempi: telefonare, scrivere un sms, spedire una cartolina o un’e-mail sono forme di comunicazione, mentre pubblicare un video su Internet, fare un discorso in un’assemblea, scrivere un articolo su un giornale o parlare in televisione sono forme di manifestazione del pensiero. In entrambi i casi si tratta di attività attraverso cui ci esprimiamo, ossia trasmettiamo agli altri informazioni di varia natura: notizie su di noi, sugli altri, su fatti presenti o futuri, opinioni e impressioni. Per esprimerci possiamo usare qualunque mezzo: la voce, la carta, il telefono, Internet.
Se esaminiamo le diverse attività che abbiamo elencato, ci accorgiamo di alcune differenze: Ӷ nelle comunicazioni le informazioni sono dirette a persone ben determinate, l’intenzione è quella di comunicare in modo privato e riservato, e in modo reciproco con il mio destinatario ( per esempio pensiamo a una telefonata con un amico o a una email spedita a un compagno di classe);
Ӷ nelle manifestazioni del pensiero le informazioni sono dirette a una generalità di persone per diffondere un pensiero in modo unilaterale ( per esempio come nel caso di un commento pubblicato su Facebook o di un intervento fatto durante un’assemblea studentesca).
Le norme costituzionali sulla comunicazione del pensiero
In base all’articolo 15 della Costituzione, «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili» (comma 1); la loro limitazione può avvenire solo sulla base di un atto motivato di un giudice e comunque sempre nel rispetto delle garanzie stabilite dalla legge (comma 2).
Esaminiamo queste disposizioni:
Ӷ la libertà in questione viene riconosciuta a tutte le persone, non solo ai cittadini italiani;
Ӷ il diritto cui si fa riferimento consiste non solo nella possibilità di comunicare con gli altri attraverso qualsiasi strumento, ma anche nell’interesse giuridicamente tutelato a mantenere il segreto sulla comunicazione e sul suo contenuto.
Ogni giorno inviamo e riceviamo molti messaggi attraverso strumenti diversi. Lo scambio di messaggi personali su WhatsApp, per esempio, è una forma di comunicazione del pensiero.
Applica
• I tuoi genitori possono pretendere di leggere i messaggi che scrivi e ricevi?
• Prova a rispondere e, con l’aiuto dell’insegnante, discutine in classe con i compagni e le compagne.

1 Completo
a La Costituzione tutela molte libertà di espressione dell’individuo, nella sua dimensione spirituale e
b Si parla di
del pensiero quando le informazioni sono dirette a una generalità di persone.
c Si parla di comunicazione del pensiero quando le informazioni sono scambiate in modo
LE PAROLE DEL DIRITTO
Censura: attività di controllo ideologico e morale esercitata da un’autorità politica o religiosa al fine di limitare o sopprimere la libertà di espressione.

1 Scelgo
L’articolo 21 della Costituzione tutela:
a la manifestazione di tutte le notizie, anche quelle riservate o segretate
b le opere d’arte solo se in linea con il buon costume
c l’interesse generale all’informazione d il diritto assoluto di divulgare immagini altrui senza consenso
5 La libertà di manifestare il pensiero
Al giorno d’oggi e nel nostro Paese quando pubblichi contenuti e messaggi su Instagram o intervieni a un’assemblea studentesca, pensi sia normale poter esprimere liberamente la tua opinione ma non sempre è stato così e anche oggi non lo è per tutti. A volte ciò che diciamo può apparire una verità scomoda per gli altri oppure non è un’opinione condivisa da tutti e il rischio è che qualcuno possa impedire la libera espressione del pensiero.
Questo è un motivo in più per capire l’importanza della nostra Costituzione che all’articolo 21, primo comma, afferma che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
Mentre l’articolo 15 tutela la comunicazione privata fra persone, qui viene garantita a ogni individuo, e non solo ai cittadini, la libertà di esprimere pubblicamente le proprie idee e opinioni.
Non a caso il resto dell’articolo è dedicato alla libertà di stampa: viene stabilito che gli organi di stampa non possono essere soggetti ad autorizzazioni o censure e che il sequestro dei giornali può avvenire soltanto per atto motivato del giudice, nel caso di reati per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi espressamente.
L’articolo 21 tutela così l’interesse generale all’informazione. Infatti la libertà di manifestare il pensiero, oltre a essere un diritto individuale, garantisce la circolazione di opinioni e informazioni all’interno della società, e quindi rappresenta un presupposto fondamentale della nostra democrazia.
I limiti | Un aspetto molto delicato della libertà di manifestare il pensiero è rappresentato dai limiti che essa incontra.
L’articolo 21 prevede un limite esplicito ove afferma espressamente il divieto delle pubblicazioni a stampa, degli spettacoli e di tutte le altre manifestazioni contrarie al “buon costume”. Con questa disposizione si intende impedire che l’esercizio della libertà possa ferire il comune sentimento del pudore: il Codice penale infatti punisce la vendita e la pubblica diffusione di scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie. Il limite del buon costume non riguarda le opere d’arte e di scienza, perché esse godono di una tutela privilegiata stabilita dall’articolo 33 della Costituzione: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». L’arte e la scienza sono forme di manifestazione del pensiero caratterizzate dal particolare tipo di informazione che trasmettono. In passato hanno subito pesanti limitazioni a opera del potere politico e di quello religioso e i costituenti, con questa disposizione, hanno voluto impedire che ciò si ripetesse.
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
libertà e segretezza delle comunicazioni art. 15
si distingue in che consiste in che consiste in
informazioni dirette a persone ben determinate
libertà di manifestazione del pensiero art. 21
informazioni dirette a una generalità di persone
L’ordinamento giuridico pone inoltre una serie di limiti impliciti alla libertà di manifestazione del pensiero: in particolare, chiunque si esprima pubblicamente non deve offendere la reputazione né violare la riservatezza di altre persone, non deve ostacolare il funzionamento della giustizia né mettere a repentaglio la sicurezza nazionale. Per esempio si possono riscontrare limiti simili in relazione alla pubblicazione di contenuti e immagini sul web: navigare su Internet richiede responsabilità proprio perché l’uso inconsapevole della Rete può portare a commettere illeciti, cioè azioni non consentite e punite dalla legge, come la diffamazione di una persona o la divulgazione non autorizzata di immagini altrui.
6 La libertà di religione
Ti sarà capitato di conoscere ragazzi della tua età che hanno tradizioni culturali e religiose diverse dalla tua: la ricchezza di una società passa anche attraverso questa possibilità di confronto. Un altro aspetto molto importante della generale libertà di espressione e di opinione è proprio la libertà in materia di religione.
L’articolo 19 della Costituzione della Repubblica italiana afferma che «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume».
Si tratta di un diritto che viene riconosciuto a tutte le persone, non solo ai cittadini italiani, e che comprende tre distinte facoltà:
Ӷ professare la propria credenza religiosa, il proprio agnosticismo o il proprio ateismo sia in modo individuale (parlando, scrivendo ma anche indossando abiti e simboli che esprimono le proprie convinzioni), sia attraverso organizzazioni e associazioni di tipo religioso;
Ӷ fare propaganda della propria convinzione, cercando nuovi proseliti e adoperandosi per diffondere la propria visione religiosa del mondo e della vita;
Ӷ esercitare la libertà di culto, cioè il diritto di manifestare in privato o in pubblico la propria fede celebrando o partecipando ai riti religiosi.
Solo rispetto a quest’ultima facoltà la Costituzione prevede il limite del buon costume, ossia il divieto di compiere riti osceni o comunque lesivi del comune sentimento del pudore.
CITTADINANZA DIGITALE

NLE PAROLE DEL DIRITTO
Diffamazione: reato che ha come oggetto l’offesa della reputazione di una persona non presente, che quindi non è in grado di percepire l’offesa, attraverso la comunicazione con altre persone.
1 Completo
a L’art. 19 Cost. garantisce la libertà
b La libertà di religione non è assicurata solo ai , bensì a tutte le
c La libertà di culto ha come limite il rispetto del buon
LE PAROLE DEL DIRITTO
Agnosticismo: atteggiamento di chi sospende il proprio giudizio rispetto a una situazione o un problema perché non se ne può avere una sufficiente conoscenza.
CLIL
Libertà personale: individual liberty
Libertà di espressione: freedom of expression
Manifestare il pensiero su Internet
el mondo ci sono molti Stati che, a differenza dell’Italia, non riconoscono né tutelano la libertà di manifestazione del pensiero. Per chi vive in questi Paesi, Internet può essere un mezzo fondamentale per esercitare la libertà di espressione e denunciare gli abusi osservati o subiti. Infatti, esistono strumenti e tecnologie che permettono agli utenti di agire su Internet in forma anonima, cioè di postare contenuti e far circolare informazioni celando la propria identità. Blogger “dissidenti”, giornalisti e attivisti usano quotidianamente tali sistemi al fine di aggirare controlli e censure.
In Italia, per fortuna, non abbiamo di questi problemi, ma l’anonimato in Rete può comunque servire sia per esercitare le libertà civili e politiche senza timore di subire qualche forma di discriminazione, sia per sfuggire al monitoraggio delle nostre attività online da parte di estranei.
Quali rischi e “fastidi” possiamo evitare mantenendo l’anonimato in Rete e in che modo possiamo proteggere le nostre informazioni personali?
Per approfondire questo tema puoi consultare alcune guide che trovi su Internet e che descrivono che cosa accade ogni volta che si visualizza una pagina web, e quali sono le informazioni che il sito visitato acquisirà (per esempio l’indirizzo IP, l’indirizzo del sito di partenza, il nome del browser usato e il tempo trascorso sul sito).
1 Sapevi dell’esistenza di questi aspetti legati alla navigazione sul web? Ritieni che si tratti di una violazione della tua privacy? C’è differenza fra le informazioni che consapevolmente inseriamo in Rete e quelle che, invece, lasciamo senza rendercene conto?
2 Svolgi le attività proposte nel QR code per saperne di più.
Libertà personale (art. 13)
Libertà di domicilio (art. 14)
Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16)
Libertà e segretezza delle
comunicazioni (art. 15)
Libertà di manifestare il pensiero (art. 21)

Libertà di religione (art. 19)
Diritti
Diritto a disporre del proprio corpo
LE LIBERTÀ COSTITUZIONALI: QUADRO RIASSUNTIVO
ApplicazioneLimiti e garanzie
Tutti
Diritto all’inviolabilità del luogo in cui si svolgono le proprie attività private
Diritto a muoversi nel territorio nazionale, a uscire dai confini nazionali, a rientrarvi e a stabilirsi in qualsiasi luogo
Diritto di comunicare con gli altri attraverso qualsiasi strumento e all’inviolabilità del contenuto di ogni forma di comunicazione
Diritto di esprimere il proprio pensiero con qualsiasi mezzo, di informare e di essere informati
Tutti
Cittadini italiani
Tutti
• Procedimento ordinario: limitazione «per atto motivato dell’autorità giudiziaria» (riserva di giurisdizione) e «nei soli casi e modi previsti dalla legge» (riserva di legge)
• Procedimento straordinario: limitazione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» (riserva di legge), convalidata dall’autorità giudiziaria
• Procedimento ordinario: vedi la regola sulla libertà personale
• Procedimento straordinario: vedi la regola sulla libertà personale
• Limitazione stabilita dalla legge in via generale per motivi di sanità o di sicurezza (riserva di legge rafforzata). Nessuna limitazione può avvenire per ragioni politiche e il diverso trattamento previsto per il cittadino straniero deve essere “ragionevole” rispetto a quello stabilito per l’italiano
• Procedimento ordinario: vedi la regola sulla libertà personale
Diritto a professare la propria fede religiosa, a fare propaganda della propria fede religiosa e alla libertà di culto
CITTADINANZA DIGITALE
HTutti
• Procedimento ordinario: vedi la regola sulla libertà personale
• Procedimento straordinario: sequestro da parte dell’autorità di pubblica sicurezza in casi eccezionali, allo scopo di reprimere rapidamente un delitto previsto dalla legge sulla stampa (riserva di legge), con conseguente eventuale convalida dell’autorità giudiziaria
• Gli organi di stampa non possono essere soggetti ad autorizzazioni o censure
• Divieto delle pubblicazioni a stampa, degli spettacoli e di tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume, non applicabile alle opere d’arte e di scienza
• Limiti impliciti: divieto di pubblicazione di notizie diffamatorie, di diffusione non autorizzata di informazioni personali, di divulgazione di notizie coperte da segreto istruttorio, militare o di Stato
Tutti • Limite del buon costume applicabile alla sola libertà di culto
Il diritto a essere dimenticati
ai mai sentito parlare di “diritto all’oblio”? Si tratta del diritto di ciascun individuo di “essere dimenticato”, cioè di richiedere la rimozione di informazioni presenti in Rete che danneggiano la propria persona e non più rilevanti per l’opinione pubblica. A stabilirlo è stata la Corte di giustizia europea che nel 2014, in una sentenza che ha fatto da apripista, si è espressa sul caso di un cittadino spagnolo stanco di vedere sul web il suo nome associato a una vicenda giudiziaria del passato. A seguito della sentenza, i responsabili di Google hanno dovuto “de-indicizzare”, cioè eliminare dai risultati restituiti dal motore di ricerca, tutti i link che rinviavano a pagine in cui si parlava di quella vicenda. A partire da tale data, Google è stata inondata di richieste di rimozione, di cui ha dovuto valutare la legittimità caso per caso. Abbiamo dunque tutti il diritto di far cancellare dalla Rete ciò che non ci piace? In verità no, perché il diritto alla riservatezza del singolo deve essere bilanciato con il diritto di cronaca e con quello degli utenti a essere informati: in altre parole,
i giudici europei hanno evidenziato che i link “scomodi” non vanno toccati se esiste un interesse pubblico che ne giustifichi la visualizzazione. Su questa scia si sono mossi anche alcuni giudici italiani che hanno respinto richieste di oblio avanzate da personaggi che rivestivano un ruolo pubblico o riguardanti episodi che non sarebbe stato giusto cancellare dalla memoria collettiva.
1 Nel QR code consulta il “Rapporto sulla trasparenza” di Google, in cui l’azienda fornisce i dati sulle richieste di rimozione ricevute a livello europeo e gli esiti delle valutazioni effettuate su alcuni casi. Tra quelli riportati si legge per esempio: «Un attivista politico che è stato pugnalato durante una protesta ci ha chiesto di rimuovere un link che rimandava a un articolo relativo al fatto. Abbiamo rimosso la pagina dai risultati di ricerca relativi al nome della vittima». Ti sembra che in questo caso Google abbia agito correttamente?
Per approfondire il tema, svolgi le attività proposte.
EDUCAZIONE CIVICA
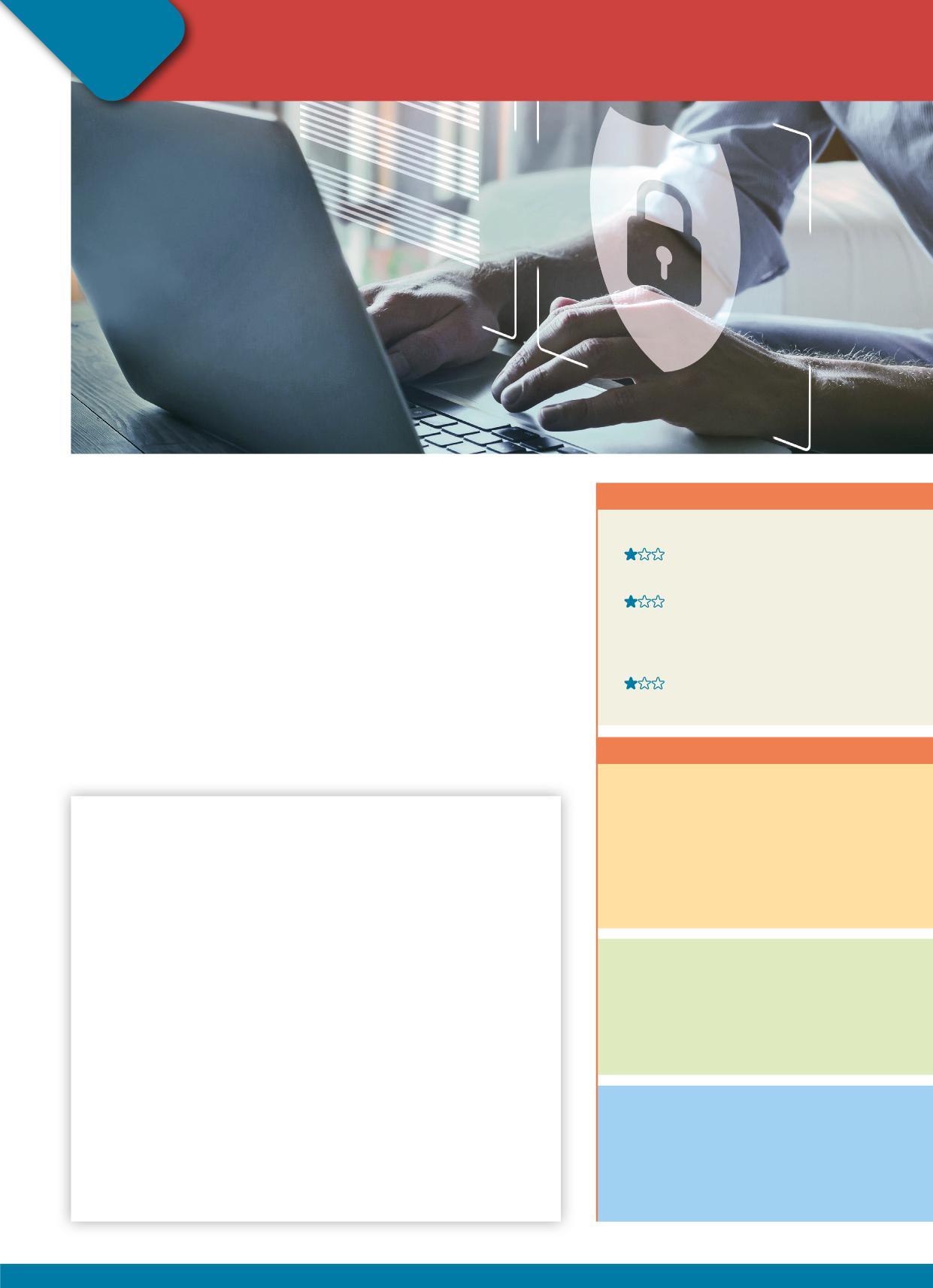
Il diritto alla privacy in Europa
Proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea enuncia i diritti civili, politici, economici e sociali fondamentali di tutte le persone che vivono sul territorio dell’Ue. Il documento si compone di un preambolo introduttivo e di 54 articoli suddivisi in sei titoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia.
Di seguito riportiamo il testo dei primi articoli del titolo II, relativo alla libertà.
PERCORSO DISCIPLINARE
Leggi con attenzione il testo e rispondi.
�1 Che cosa si intende per libertà e sicurezza?
�2 Perché, secondo te, dopo il diritto alla libertà e alla sicurezza la Carta prende in considerazione il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali?
�3 Qual è il contenuto dell’articolo 8?
PERCORSO PLURIDISCIPLINARE
STORIA
Titolo II – Libertà
● Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
● Articolo 7 – Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.
● Articolo 8 – Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
Il rispetto per la riservatezza non è sempre stato un diritto rispettato e protetto: prova ne è stata l’emanazione delle leggi fascistissime negli anni venti in Italia. Fai una ricerca sulla censura e i controlli attuati sulla corrispondenza in quegli anni e confrontalo con quanto previsto dalla nostra Costituzione sul tema.
INFORMATICA
Si parla di sicurezza informatica come di un baluardo essenziale ormai per le aziende ma anche per i privati. Prova a cercare qualche notizia di violazioni della sicurezza informatica avvenute in Italia e nel mondo negli ultimi anni.
LETTERE
Dopo aver visto in classe, con l’aiuto dell’insegnante, il film Le vite degli altri di Florian Henckel discutete in classe del tema della riservatezza e dei suoi limiti nel mondo moderno.
FAI IL PUNTO

LEZIONE DIGITALE
1 Ripassa i temi fondanti con la lezione digitale “I diritti individuali”.
2 Leggi e completa questa pagina.
ô Che cosa si intende per diritti e doveri costituzionali?
La Costituzione dedica l’intera Parte I ai Diritti e doveri dei cittadini, distinguendo fra quelli relativi ai Rapporti civili, ai Rapporti etico-sociali, ai Rapporti economici e ai Rapporti politici.
I diritti costituzionali possono quindi essere suddivisi in:
ôdiritti individuali, attribuiti al singolo, che può esercitarli ; ôdiritti , assegnati sempre al singolo, che però li può esercitare solo insieme ad altri;
ôdiritti , attraverso i quali lo Stato mira a realizzare l’eguaglianza sostanziale.
La Costituzione prevede anche alcuni in capo ai cittadini.
ô In che cosa consiste la libertà personale di cui parla l’art. 13 della Costituzione?
La libertà personale è la libertà di del proprio corpo, il diritto di non subire limitazioni materiali come l’essere legati, ispezionati o perquisiti, l’essere messi in una cella.
ô Qual è il contenuto della libertà di circolazione e di soggiorno riconosciuta in Costituzione?
La libertà di circolazione e soggiorno tutela l’individuo dalle limitazioni che possano impedirgli di spostarsi da un posto all’altro o di decidere dove andare ad abitare e lavorare. Questa libertà può subire solo in via e per motivi di o di sicurezza.
ô Che cosa prevede l’art. 21 della Costituzione in materia di libertà di manifestazione del pensiero?
L’articolo 21 della Costituzione afferma che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». La tutela riguarda la sfera delle persone ma anche l’ come interesse generale e prevede un limite esplicito (il ) e un limite implicito (il rispetto della e della delle altre persone).
ô Che cosa prevede la Costituzione in materia di libertà religiosa?
L’articolo 19 della Costituzione afferma che «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di e di in privato o in pubblico il , purché non si tratti di riti contrari al ».
3 Ripassa l’unità con le audio mappe contenute nel QR code della pagina accanto.
Rapporti civili (artt. 13-28)

L’UNITÀ IN AUDIO MAPPE
Per ripassare, guarda le mappe, ascoltando le sintesi audio dell’unità
PARTE I
DELLA COSTITUZIONE
contiene
libertà personale
art. 13: «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione […] né qualsiasi altra restrizione alla libertà personale […] e nei soli casi e modi previsti dalla legge» non si può abrogare la libertà perché verrebbero negati valori supremi come la dignità umana
libertà di domicilio
art. 14: «Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale» per domicilio si intende non solo la propria abitazione ma qualsiasi luogo in cui ci si possa isolare dall’esterno
Diritti dei cittadini
Doveri dei cittadini
Diritti costituzionali individuali
Rapporti etico-sociali (artt. 29-34)
libertà di circolazione e soggiorno
art. 16: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza»
libertà e segretezza delle comunicazioni
art. 15: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili»
Rapporti economici (artt. 35-47)
Rapporti politici (artt. 48-54)
libertà di manifestare il pensiero
art. 21: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»
libertà di religione
questa libertà difende l’individuo dalle limitazioni o interferenze che possano impedirgli di spostarsi da un posto all’altro
si tratta di una libertà riconosciuta a tutti, non solo ai cittadini ed eventuali limitazioni devono essere garantite dalla legge
la norma garantisce a tutti la libertà di esprimere idee e opinioni e tutela l’interesse generale all’informazione
art. 19: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma […] di farne propaganda e di esercitarne ([…] il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume» anche in questo caso la libertà di religione è riconosciuta a tutti, e non solo ai cittadini italiani
VERIFICO CONOSCENZE E ABILITÀ
VERO O FALSO?
1 In Costituzione, il concetto giuridico di “buon costume” rappresenta il comune sentimento del pudore.
2 La libertà di manifestazione del pensiero non ammette limitazioni.
3 La libertà di circolazione e soggiorno tutela il diritto dell’uomo di spostarsi liberamente in tutto il mondo, potendosi stabilire dovunque per lavorare.
4 In Italia, a livello costituzionale, non soltanto è garantita la libertà religiosa, ma anche il diritto di non credere che un Dio esista.

VF
VF
VF
VF
5 La libertà personale può essere abrogata soltanto con procedimento di revisione costituzionale. VF
6 La comunicazione del pensiero è uno scambio di informazioni che avviene pubblicamente. VF
7 Diffamare una persona sul web non costituisce illecito, perché difficilmente si viene scoperti. VF
8 In ipotesi straordinarie previste dalla legge, le forze dell’ordine possono limitare temporaneamente la libertà personale. VF
9 La libertà di corrispondenza comprende ogni forma di comunicazione, da quella epistolare a quella telefonica.
10 Per ragioni politiche, motivi di sanità o di sicurezza sono ammesse alcune restrizioni alla circolazione sul territorio nazionale.
11 A livello costituzionale la libertà di domicilio è riconosciuta a tutti, mentre la libertà di circolazione soltanto ai cittadini.
SCELGO
1 L’art. 13 Cost. tutela:
a la libertà di domicilio
b la libertà di religione
c la libertà di comunicazione d la libertà personale
2 Il proselitismo è:
a un’attività vietata dalla Costituzione
VF
VF
VF
COMPLETO (attenzione ai distrattori)
21 / 24 / 48 / buon costume / censura / coercizioni / comunicazione / confino / culto / destinatario / domicilio / giurisdizione / interesse generale / inviolabile / legge / limitazione / manifestazione / personale / politica / sequestro / supremi
1 Esprimere pubblicamente le proprie opinioni costituisce un diritto individuale per il singolo e, allo stesso tempo, una garanzia per tutta la società, a tutela dell’ all’informazione.
2 L’affermazione del carattere dei più importanti diritti di libertà significa che non è ammessa la loro abrogazione, in quanto valori per l’ordinamento italiano.
3 La differenza fondamentale tra comunicazione e manifestazione del pensiero consiste nel dell’informazione: nella libertà di si tratta di individui ben determinati, nella libertà di della generalità delle persone.
4 Il limite del è previsto espressamente sia nell’art. 19 Cost. con riguardo alle ipotesi di svolgimento in forma pubblica del , sia nell’art. 21 Cost.
5 Ai sensi dell’art. 14 Cost., qualsiasi luogo in cui ci si possa isolare dall’esterno, anche una tenda da campeggio o il proprio ufficio, è considerato
6 L’autorità di pubblica sicurezza deve comunicare entro ore all’autorità giudiziaria l’arresto di una persona colta in flagranza di reato.
7 La libertà garantisce tutti gli esseri umani dalle illegittime materiali al proprio corpo: è il presupposto senza il quale sarebbe impossibile godere delle altre libertà costituzionali.
8 La “riserva di ” è una garanzia prevista dalla Costituzione per alcuni diritti di libertà e consiste nello stabilire che solo una legge del Parlamento o un atto con forza di legge possono stabilire in via generale e astratta i casi e i modi di di tali libertà.
COLLEGO
1 Prevede una riserva di legge “rinforzata”
b una delle tre facoltà contenute nella libertà religiosa
c la propaganda del proprio culto, sottoposta al limite del buon costume
d la ricerca di nuovi proseliti, facoltà concessa in esclusiva ai cittadini italiani
3 Il principio per il quale solo l’autorità giudiziaria può porre restrizioni alla libertà personale nei casi previsti dalla legge prende il nome di:
a flagranza di reato
b riserva di legge
c riserva di giurisdizione
d limite del buon costume
2 Comprende anche l’interesse a mantenere la segretezza del suo contenuto.
3 È garantita con riserva di legge e di giurisdizione
4 Impone un chiaro divieto della censura
5 È il primo e più importante tra i diritti individuali
6 Riguarda anche il diritto all’agnosticismo
1.
a Libertà personale
b Libertà di stampa
c Libertà religiosa
d Libertà di comunicazione del pensiero
e Libertà di circolazione e soggiorno
f Libertà di domicilio
SVILUPPO COMPETENZE
ANALIZZO
1 Perché la garanzia della libertà personale è una questione fondamentale per ogni ordinamento giuridico?

2 Qual è la differenza tra riserva di legge e riserva di giurisdizione?
APPLICO IL PROBLEM SOLVING
1 Parte 1. Roberto, appena laureato in Scienze Biotecnologiche a Firenze ha vinto una borsa di studio come ricercatore a Milano, che però secondo alcuni studi ha una qualità della vita non particolarmente alta. Secondo un famoso quotidiano nazionale nel 2019 Milano è al primo posto tra le città italiane dove sono stati commessi il numero maggiore di reati. Inoltre, in un post su Facebook si dice che il Sindaco, per controllare la crescente criminalità, abbia imposto agli italiani che vengono da altre Regioni di ottenere un permesso molto particolare per risiedere nella città. Roberto rassicura la mamma dicendole che si tratta di fake news e che Milano è una città sempre più verde e sempre più smart, dove si vive benissimo. Dentro di sé, poi, Roberto si chiede se certe informazioni, che possono provocare paura nelle persone, possano essere censurate.
a Quali diritti costituzionali individuali sono coinvolti in questa vicenda?
b La tutela prevista dalla Costituzione per i diritti in questione ti sembra sia stata rispettata?
3 Chi può godere della libertà di circolazione e soggiorno?
4 Com’è garantita la libertà e segretezza delle comunicazioni?
COSTRUISCO UNA MAPPA
1 Nel corso di questa unità hai imparato nuove parole relative ai diritti individuali costituzionali con cui si apre la Parte I della Costituzione sui diritti e doveri dei cittadini. Con le parole per te più significative, prova a costruire una mappa su quanto appreso.
Parte 2. Roberto, amareggiato dalla situazione, si sfoga con il suo migliore amico Giovanni e in un vocale su WhatsApp gli racconta che sua madre sta soffrendo ancora molto a causa della morte del padre avvenuta circa un anno prima e non vorrebbe che il suo trasferimento la rattristasse ancora di più. Per questo motivo non partirà più per Milano. Il giorno dopo, Giovanni incontra la madre di Roberto per strada e per tranquillizzarla decide di farle ascoltare il vocale del figlio.
c Quale diritto costituzionale individuale è coinvolto in questa vicenda? È stato rispettato?
ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARE
1 Hai studiato il valore altissimo che la Costituzione attribuisce alla libertà di espressione e la forza con cui il nostro testo costituzionale afferma che la stampa non può essere soggetta a censura. Così facendo, i padri costituenti hanno cercato in modo molto chiaro di impedire la possibilità che opinioni, idee, informazioni, fossero sottoposte ai rigidi controlli del potere politico e di quello religioso, come era avvenuto in passato. Pensa a quello che hai studiato finora nelle altre materie. Indica altre censure importanti, anche nel campo scientifico o artistico.
ENGLISH CORNER
1 Choose the right answer to complete the following sentence.
Article 21 of the Italian Constitution guarantees the:
a right to travel or sojourn freely in any part of the national territory
b right to profess freely a religious faith
c right to express oneself freely
d inviolability of personal liberty
Le donne e il Parlamento europeo
Leggete il seguente testo, tratto dal Portale europeo per i giovani dell’Unione europea, che presenta la strategia della Commissione europea per la parità di genere.
L’atteggiamento verso l’eguaglianza sta evolvendo, ma nemmeno la generazione più giovane attuale è immune dagli stereotipi e dalle disparità di genere. Oggi permangono diseguaglianze tra donne e uomini, in particolare nel mercato del lavoro. La parità tra donne e uomini è uno dei principi fondanti dell’Unione europea. Negli ultimi decenni l’UE ha compiuto notevoli progressi per quanto riguarda la parità di genere. Tuttavia le disparità persistono e nel mercato del lavoro le donne continuano a essere sovrarappresentate nei settori peggio retribuiti e sottorappresentate nei livelli decisionali. La Commissione europea ha posto la parità di genere in cima alla sua agenda politica e ha recentemente adottato un’ambiziosa strategia per la parità di genere (2020-2025) volta a raggiungere un’Europa in cui la parità di genere sia la regola. Ecco alcune delle sfide che le donne si trovano ad affrontare, ma ovviamente ne esistono ancora altre.
Qual è la situazione e che cosa fa l’UE in proposito?
L’azione dell’UE a favore della parità di genere è integrata in vari settori politici e mira a garantire pari diritti, quali l’eguaglianza nel processo decisionale, l’eliminazione della violenza di genere
e del divario retributivo di genere. Ecco alcune statistiche essenziali sulla situazione e le relative azioni dell’UE.
Parità retributiva
Nell’Unione europea (UE-27) le donne guadagnano in media il 16% in meno rispetto agli uomini, con differenze significative tra i vari Paesi. L’UE fa opera di sensibilizzazione sulla situazione con la campagna annuale della Commissione europea (la Giornata europea della parità retributiva), che si celebra il 4 novembre, e adotta varie leggi, come quella sul diritto nell’UE all’equilibrio tra vita professionale e vita privata.
Istruzione e ricerca
Le diseguaglianze di genere nell’istruzione persistono, per esempio in termini di preferenze di studio. Le donne hanno maggiori probabilità di avere un diploma di istruzione superiore, ma continuano a essere sovrarappresentate in settori di studio legati a ruoli femminili tradizionali, come quelli connessi all’assistenza, e sottorappresentate in quelli della scienza e dell’ingegneria. Ecco perché l’UE ha istituito il premio dell’UE per le donne innovatrici e sostiene la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Quello del genere è anche un tema trasversale nell’ambito di Orizzonte 2020,

il programma di finanziamento dell’UE per la ricerca e l’innovazione.
Violenza
Il 33% delle donne nell’UE ha subito violenze fisiche e/o sessuali. L’UE mira a combattere la violenza di genere attraverso la legislazione e le misure pratiche sui diritti delle vittime in linea con la convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
Leadership
Infine, le donne sono meno rappresentate nelle posizioni direttive in diversi settori: politica, economia, scienza e ricerca. Solo il 7,5% dei presidenti dei consigli di amministrazione e il 7,7% degli amministratori delegati sono donne (si veda la scheda informativa sulla strategia dell’UE per la parità di genere 2020-2025).
La Commissione europea si è impegnata a svolgere un ruolo guida. Guidato da Ursula von der Leyen, la prima donna presidente della Commissione, il collegio dei commissari dell’UE è, per la prima volta nella storia, vicino a raggiungere la parità di genere.
[…]
COMPRENDO
�1 Qual è la fonte di questi documenti?
�2 Quale tematica viene affrontata?

ANALIZZO
�1 In quali ambiti l’Unione europea sostiene la parità di genere e la partecipazione femminile?
LAVORO DI GRUPPO
�1 Dopo esservi divisi in gruppi, scegliete uno dei punti analizzati nel documento riportato (parità retributiva, istruzione e ricerca, violenza e leadership) e cercate dati e informazioni sulla situazione italiana.
�2 Realizzate una presentazione ed esponete ai compagni i risultati della vostra ricerca.
DEBATE
�1 Dopo aver ascoltato, attraverso i risultati delle ricerche presentate, qual è la situazione in Italia, ritieni che esista un problema di parità di genere? Se sì quali sono i motivi? E quali le possibili soluzioni?
�2 Sei d’accordo sull’importanza della presenza femminile in politica, in economia, nella ricerca e in qualsiasi altra situazione?
�3 Confronta le tue risposte con quelle dei tuoi compagni di classe.
�2 Attraverso quali strumenti? Quali problematiche ti sembrano più urgenti?
AUTOVALUTAZIONE
�1 Ho capito il testo letto?
�2 Ho individuato le informazioni adeguate alle richieste che mi sono state fatte?
�3 Ho sintetizzato/esposto le informazioni in modo adeguato?
�4 Ho partecipato adeguatamente al lavoro di gruppo?
�5 Ho collaborato con i compagni?
�6 In che cosa ho riscontrato le maggiori difficoltà?
�7 Perché?
SÌ NO IN�PARTE
SÌ NO IN�PARTE
SÌ NO IN�PARTE
SÌ NO IN�PARTE
SÌ NO IN�PARTE
COME FUNZIONA L’ECONOMIA 6

AI BLOCCHI DI PARTENZA per studiare anche in modalità Flipped classroom
CITTADINANZA DIGITALE per diventare cittadini e cittadine consapevoli delle potenzialità e dei rischi degli strumenti digitali
LEZIONE DIGITALE per ripassare i concetti fondanti o svolgerli in maniera agile ed esercitarsi
AUDIO MAPPA per rielaborare e ripassare con la mappa dell’unità modificabile e l’audio di spiegazione
HUB TEST per metterti alla prova e consolidare quanto studiato con tanti test autocorrettivi
CHE COSA STAI PER STUDIARE?
CHE COS’È L’ECONOMIA?

Lo studio di come soddisfiamo molti BISOGNI attraverso l’acquisto di BENI ECONOMICI
agendo in un
SISTEMA ECONOMICO con degli OPERATORI che agiscono al suo interno
Un insieme di dinamiche che nei secoli sono cambiate
perché ci sono
SISTEMI ECONOMICI diversi NELLA STORIA
CONOSCENZE
• Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri.
ABILITÀ
• Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica.
• Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia, con particolare riferimento alla Costituzione italiana e alla sua struttura.
COMPETENZE
• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
IL MODULO IN MAPPE / I miei appunti
Inquadra il QR code e scarica:
• le mappe di tutte le unità del modulo per modificarle e annotarle mentre studi
• le schede per organizzare i tuoi appunti

1

I
I bisogni e i beni economici
AI BLOCCHI DI PARTENZA
Guarda il video
Nei primi 3 minuti del video vengono illustrati settori economici che corrispondono ad altrettanti bisogni e, quindi, beni.
• Il video fa riferimenti a settori che già conoscevi?
• Partendo dai beni prodotti in ciascun settore, quali ulteriori settori ti vengono in mente per integrare questo elenco?
Usa gli strumenti del libro
• Tenendo a mente il contenuto del video, vai al paragrafo 2 e leggi il contenuto, individuandone i concetti principali
• Verifica di aver capito i contenuti del paragrafo 2 svolgendo gli esercizi “Scelgo”, “Completo” e “Vero o falso?”
• Per metterti alla prova svolgi la consegna del box Nella realtà – I diversi tipi di bene
1 I bisogni
Come abbiamo visto nell’unità 0, ognuno di noi è spinto a fare delle scelte in quanto avverte determinati bisogni.
Il bisogno è la sensazione che provi quando hai delle esigenze da soddisfare e che ti spingono a fare uso dei mezzi utili per soddisfarle.
I bisogni che ciascuno di noi può avere sono così diversi che è opportuno catalogarli in qualche modo, così da comprendere meglio le loro caratteristiche; un primo criterio di classificazione riguarda la loro urgenza; un altro li distingue a seconda del modo in cui sorgono e sono soddisfatti; un terzo modo li classifica a seconda della loro natura (bisogni economici e non).
I bisogni in base all’urgenza | Da questo punto di vista possiamo classificare i bisogni in due tipologie fondamentali:
Ӷ i bisogni primari (o urgenti) sono i più importanti, quelli che riguardano esigenze fondamentali per la stessa sopravvivenza, come nutrirsi, dissetarsi, ripararsi dal freddo, curarsi quando si è malati;
Ӷ i bisogni secondari (o voluttuari) sono collegati a esigenze meno impellenti, come andare in vacanza, navigare in Internet, ascoltare la musica o seguire il calcio in tv.
Per esempio quando compri un panino da mangiare a ricreazione soddisfi un bisogno primario, quando compri un fumetto o una rivista soddisfi un bisogno secondario.
Le nuove tecnologie e i bisogni
Dai pc fissi a quelli portatili, fino agli smartphone e ai tablet: il progresso tecnologico ha alimentato e rinnovato i bisogni di ciascuno di noi, indipendentemente dall’età.
Per esempio, fino a qualche anno fa nessuno sentiva l’esigenza di navigare in mobilità, ovvero di collegarsi a Internet fuori da casa e lontano dal pc, mentre oggi in pochi rinuncerebbero a questo servizio.
Rifletti
• Pensando alla tua esperienza, sapresti fare alcuni esempi di bisogni che sono sorti con l’evoluzione delle tecnologie digitali?
• Inquadra il QR code e scopri i dati del Global digital report 2019 sui tempi di navigazione delle persone nei vari Paesi del mondo. Individualmente o con i tuoi compagni, svolgi le attività proposte.
I bisogni in base alla loro origine e alla loro soddisfazione | In base a questa distinzione, possiamo distinguere:
Ӷ i bisogni individuali, che sono percepiti dal singolo, che deve anche provvedere a soddisfarli, come quando ho fame e vado in cucina a cercare qualcosa da mangiare;
Ӷ i bisogni collettivi, avvertiti sempre dal singolo ma in quanto membro di una comunità.
Per esempio il tuo bisogno di sicurezza c’è perché sei parte di una collettività.
Se hai una bicicletta, vivendo in società non puoi escludere che ci sia qualcuno che te la voglia rubare e questa paura genera in te uno stato di insoddisfazione; tale bisogno non può essere soddisfatto autonomamente da te, altrimenti la società si dissolverebbe per i continui conflitti.
I bisogni si distinguono in base all’intensità in primari e secondari, e in base a come nascono e vengono soddisfatti in individuali e collettivi.
I bisogni economici e i bisogni non economici | A seconda della loro natura, i bisogni possono essere economici o non economici.
Tu hai bisogno di mangiare ma anche di stare con gli amici.
Ӷ Il primo è un bisogno economico perché può essere soddisfatto attraverso un bene materiale, in cambio del quale pagare un prezzo.
Ӷ Il secondo è un bisogno non economico perché non può essere soddisfatto pagando gli amici, il loro affetto non può essere comprato.
L’economia politica studia solo i bisogni economici, cioè quelli che possono essere soddisfatti attraverso l’impiego di un bene per ottenere il quale occorre pagare un prezzo.
La caratteristica fondamentale dei bisogni economici è che essi sono tantissimi e, soprattutto, appena se ne soddisfa uno ecco che ne sorge immediatamente un altro.
I beni economici possono quindi essere considerati: saziabili (si possono soddisfare), risorgenti (ritornano), soggettivi (cambiano da persona a persona), variabili nel tempo.
Per esempio quando compro la pizza soddisfo il bisogno di mangiare. Subito dopo, con la pancia piena, mi accorgo che mi andrebbe di andare al cinema, oppure di comprare un nuovo videogioco.
I bisogni economici sono illimitati

1 Scelgo
I bisogni economici sono:
a tutte quelle esigenze che sentiamo di dover soddisfare nella vita
b saziabili, risorgenti, soggettivi, variabili, illimitati
c primari, secondari o terziari, a seconda della loro urgenza d piuttosto stabili nell’arco della vita di un uomo
1 Scelgo
La lezione di economia cui stai partecipando:
a è un bene
b è un servizio
c non è né un bene né un servizio
d non soddisfa nessun bisogno
2 I beni e i servizi
Per soddisfare il bisogno di mangiare, scegli di mangiarti una pizza; quest’ultima, quindi, è il mezzo che utilizzi per soddisfare il bisogno e poiché ti fa stare bene lo chiamiamo, appunto, bene.
I beni sono i mezzi materiali, le cose che servono a soddisfare i bisogni.
In questo senso, anche l’acqua che sgorga da una fonte naturale e la luce del sole possono essere considerate dei beni, perché possono soddisfare il bisogno di dissetarsi e di vedere quello che ci circonda. Perché un bene possa essere definito economico, quindi, deve avere qualche caratteristica in più.
Un bene si dice economico se, oltre a essere utile per soddisfare un bisogno, è scarso, ossia disponibile in quantità limitata, e ha un prezzo, per cui potremo procurarcelo solo pagando una somma di denaro.
Per esempio l’acqua che bevi da una sorgente in montagna o la luce del sole non sono beni economici pur essendo beni che soddisfano il tuo bisogno di sete e di illuminazione; sono beni economici invece la bottiglietta d’acqua che compri e l’elettricità che consumate in casa e che i tuoi genitori pagano alla società che la fornisce.
I beni non sono l’unico mezzo per soddisfare i bisogni. Ci sono infatti alcuni bisogni che possono essere appagati attraverso la fruizione di servizi, vale a dire attività – una visita medica, una consulenza legale, un servizio di trasporto – che possono essere svolte tanto da soggetti privati (servizi privati) quanto da enti pubblici (servizi pubblici).
Per esempio il fattorino che ti porta la pizza a casa fornisce un servizio privato, mentre la scuola fornisce un servizio pubblico per il quale si paga poco (la tassa di iscrizione) perché tutte le altre spese (stipendi degli insegnanti, materiali…) sono pagate dallo Stato. I bisogni possono essere soddisfatti, oltre che da beni, anche da servizi, cioè da prestazioni fornite da soggetti privati dietro pagamento di un prezzo oppure da enti pubblici.
Beni di consumo e beni strumentali | I beni sono talmente tanti che occorre distinguerli in modo da capire meglio quali tipi di bisogno soddisfano. La distinzione fondamentale è quella tra beni di consumo e beni strumentali. Ci sono beni, infatti, che utilizziamo per soddisfare direttamente un bisogno. Ci sono anche beni che non soddisfano direttamente un bisogno ma servono per produrre altri beni che saranno utilizzati per soddisfare un bisogno.
Per esempio le scarpe prodotte in un calzaturificio sono beni di consumo, mentre i macchinari, gli strumenti e i materiali utilizzati per produrle sono beni strumentali. Grazie ai macchinari, infatti, si possono produrre scarpe utilizzate per soddisfare un bisogno.
I beni economici si distinguono in beni di consumo, utilizzati direttamente per soddisfare un bisogno, e beni strumentali, impiegati per produrre altri beni.
NELLA REALTÀ
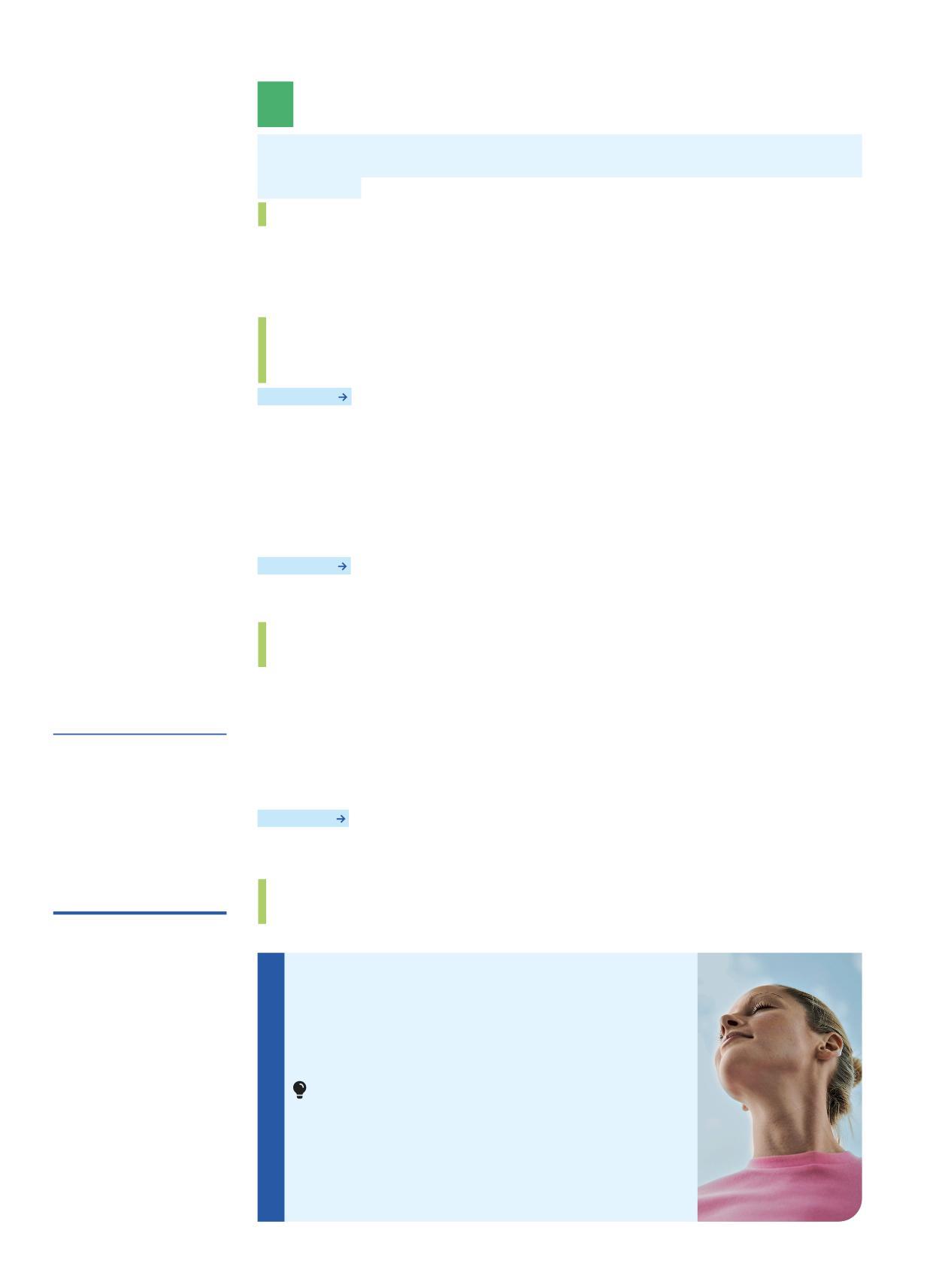
Da non economico a economico
L’ossigeno è un bene determinante per la nostra vita. Senza di esso possiamo resistere alcuni secondi, come ti sarai accorto andando sott’acqua, ma ben presto i nostri polmoni cominciano a reclamarne di più.
Risolvi il caso
• Perché l’ossigeno non è un bene economico pur essendo così importante per la nostra sopravvivenza?
• Ci possono essere situazioni in cui l’ossigeno diventa un bene economico?
• Che cosa succede quando un bene non economico diventa economico?
Il fioraio da cui va a lavorare un ragazzo per avere un salario utilizza forbici, spillatrice e taniche per l’acqua: questi sono i suoi beni strumentali, necessari per produrre mazzi di fiori. Nella serra dove sono coltivati i fiori, sono usate zappe, vanghe, forbici: anche questi sono beni strumentali.
A loro volta, i beni di consumo possono essere classificati in vari modi.
Innanzitutto, in base alla durata si distinguono:
Ӷ beni non durevoli, la cui utilità viene meno dopo un singolo atto di consumo (come gli alimenti);
Ӷ beni durevoli, che possono essere utilizzati ripetutamente senza che si deteriorino (come gli elettrodomestici).
In secondo luogo, si distinguono in base all’uso che se ne fa:
Ӷ alcuni beni che devono essere usati insieme per poter soddisfare un unico bisogno (come la macchina e la benzina che la fa andare) e per questo sono detti complementari, nel senso che si completano a vicenda;
Ӷ altri beni possono essere utilizzati l’uno al posto dell’altro per soddisfare uno stesso bisogno (come l’olio di oliva e l’olio di semi, entrambi utilizzabili per cucinare); tali beni si definiscono sostituti (o succedanei)
I beni di consumo si distinguono: in base alla durata, in non durevoli e durevoli; in base all’uso congiunto o meno per la soddisfazione di uno stesso bisogno, in complementari e sostituti.
BISOGNI
soddisfatti da
beni servizi

strumentali
di consumo
durevoli non durevoli complementari sostituti
I diversi tipi di bene
Come hai visto, il concetto di “bene” è articolato.
Risolvi il caso
Qui di seguito sono indicati alcuni beni di consumo; stabilisci se sono beni complementari, beni sostituti, oppure se tra i beni non c’è alcun legame.
1. Penne nere e penne blu
2 Vero o falso?
a I beni sono mezzi materiali, mentre i servizi sono attività. VF
b I beni di consumo sono utilizzati per produrre altri beni. VF
c Come i bisogni, anche i beni economici sono illimitati. VF
3 Completo
a Un bene si dice economico se, oltre a essere utile per soddisfare un bisogno, ha un ed è
b I beni di consumo utilizzabili più volte, senza esaurirsi dopo il primo utilizzo, sono detti
c I beni si distinguono in complementari e , in base all’uso congiunto o meno per la soddisfazione di uno stesso bisogno.
2. Inchiostro e penna stilografica
3. Margarina e burro
4. Farina e lievito
5. Libro e occhiali da sole
6. Automobile e tram
7. Zappa e cestino di vimini
CLIL
Bisogno: want/need
Bene: good
Servizio: services
Patrimonio: asset/patrimony
Reddito: revenue

1 Scelgo
Costituisce una forma di reddito:
a l’insieme dei terreni
di proprietà di una famiglia
b il palazzo di un miliardario
c lo stipendio di un impiegato
d il giardino del vicino di casa
3 Patrimonio e reddito
Una famiglia ha due appartamenti, diversi mobili, un’automobile, del denaro e due biciclette: questa è la ricchezza che la famiglia possiede in un determinato momento e viene indicata con il termine patrimonio.
Il patrimonio è l’insieme dei beni che possiede una famiglia o un’impresa in un certo momento.
Nello stesso tempo, nell’arco di un anno, nella famiglia entra denaro perché mamma e papà lavorano e guadagnano dei soldi; inoltre, poiché il secondo appartamento è dato in affitto, ottengono anche un affitto mensile. L’insieme di queste entrate rappresenta il reddito della famiglia.
Il reddito è il totale delle entrate che un individuo ha nel corso di un certo periodo di tempo.
Quello di patrimonio è un concetto cosiddetto di stock, perché descrive una quantità di ricchezza statica, misurata cioè in un determinato istante.
Per esempio anche tu hai un patrimonio, ed è costituito da tutti i beni che possiedi, indipendentemente da chi te li ha comprati. Pensa a quante cose hai nella tua stanza, ai vestiti, alla bicicletta e a tutto ciò che è tuo; quello è il tuo patrimonio in questo preciso momento.
Diversamente dal patrimonio, il reddito non rappresenta uno stock ma un flusso, ossia un valore dinamico, generato in un certo arco temporale
Per esempio una persona che lavora e che riceve uno stipendio fisso o dei compensi per la propria opera ha un reddito che, in un anno, ammonta a una certa cifra. In un certo senso, anche tu hai un reddito se consideriamo un’eventuale paghetta data dai tuoi genitori. Con quel reddito, se vuoi, puoi scegliere che cosa comprarti (un monopattino, dei vestiti, la cover per il cellulare) e andare così ad accrescere il tuo patrimonio.
CITTADINANZA DIGITALE
La pubblicità comportamentale
Ti è mai capitato di cercare su Internet offerte vantaggiose relative a un paio di scarpe sportive e, nei giorni successivi, diventare bersaglio (per esempio su Instagram) di promozioni riguardanti capi di abbigliamento o accessori dello stesso genere? Benvenuto/a nel mondo del behavioral targeting, o pubblicità comportamentale, una tecnica pubblicitaria, utilizzata in particolare sul web, che consiste nel mostrare suggerimenti commerciali tagliati sugli interessi e i bisogni di chi li visualizza.
Come è possibile tutto ciò? Tutte le nostre attività online (le ricerche che facciamo, i siti che visitiamo, i messaggi, le foto e i video che postiamo, le app che scarichiamo ecc.) possono essere tracciate da fornitori di pubblicità comportamentale che poi sfruttano le informazioni raccolte per offrire alle imprese annunci sempre più mirati ed efficaci. Il tracciamento avviene soprattutto grazie ai cookies, piccoli file di testo che vengono memorizzati sui nostri dispositivi non appena accediamo a un sito.
1 Vuoi scoprire di più sull’argomento e magari imparare a navigare in maniera più consapevole?
Inquadra il QR code e scopri alcuni consigli per rendere più riservate le tue attività online e prestare attenzione alla privacy del tuo dispositivo. Individualmente o con i tuoi compagni, svolgi le attività proposte.
EDUCAZIONE CIVICA

Beni durevoli che non durano
L’aspirapolvere ti si è rotto proprio appena dopo la fine della garanzia o la batteria del cellulare ti ha abbandonano proprio quando sul mercato sta per uscire il nuovo modello? Sembrano casualità ma potrebbe esserci anche lo zampino dei produttori.
Spesso si ha la sensazione che gli elettrodomestici e gli apparecchi elettronici durino sempre meno e si rompano sempre prima. Scegliere il prodotto giusto, quello con la migliore qualità, potrebbe servire ad allungare questi tempi.
Tuttavia a molti sarà capitato che il ferro da stiro abbia smesso di funzionare proprio qualche settimana dopo la fine del periodo di garanzia e di sentirsi dire dal tecnico che forse sarebbe stato più economico cambiarlo invece di ripararlo. Una situazione che, con ogni probabilità, non è solo sfortuna. Esiste un trucco, una strategia di produzione che prende il nome di “obsolescenza programmata” e consiste nel costruire prodotti sempre meno resistenti in modo da spingere il consumatore a cambiarli con più frequenza. Certo non fa il gioco delle aziende un prodotto indistruttibile, ma è innegabile la percezione che da qualche tempo a questa parte la vita di elettrodomestici e dispositivi elettronici si è ridotta drasticamente.
PERCORSO DISCIPLINARE
Leggi attentamente il testo e rispondi alle domande.
�1 A quale tipologia di beni si fa riferimento? Quali caratteristiche dei beni vengono prese in considerazione?
�2 Che cosa si intende per “obsolescenza programmata”? A quale categoria di bisogni si riferisce?
�3 Uno degli esempi di obsolescenza programmata più evidenti è quella di alcuni smartphone di ultima generazione. Ti sei mai trovato in una situazione di questo tipo?
4 Prova a fare una ricerca online digitando “obsolescenza programmata smartphone” e seleziona tra i risultati le pagine che danno indicazioni su come difendersi.
5 Prepara poi una breve guida tramite ppt da condividere con i tuoi compagni.
GEOGRAFIA
I nostri cellulari, insieme a migliaia di altri oggetti tecnologici, una volta buttati via, fanno un lungo viaggio e finiscono in un quartiere di Accra, capitale del Ghana, nella più grande discarica del mondo che in sé ha molte delle caratteristiche peggiori derivanti dall’inquinamento moderno: plastiche bruciate che esalano sostanze tossiche per i lavoratori e terreni inquinati dove pascola il bestiame. Dopo aver fatto una breve ricerca sulla discarica di Accra, fai una lista delle conseguenze negative per chi lavora e vive in questo angolo d’Africa e proponi una o più alternative per arginare questa situazione.
SCIENZE
Negli ultimi anni si è diffuso un modo diverso per bere il caffè, utilizzando capsule e cialde monouso: a fronte di un miliardo di capsule utilizzate in Italia ogni anno il risultato sono 12 mila tonnellate di rifiuti difficili da riciclare. Fai una ricerca sulle possibili soluzioni che si stanno ipotizzando, anche grazie a nuove tecniche di smaltimento, e discutine con i tuoi compagni di classe.
FAI IL PUNTO

LEZIONE DIGITALE
1 Ripassa i temi fondanti con la lezione digitale “Bisogni, beni e servizi”.
2 Leggi e completa questa pagina.
ô Che cos’è un bisogno?
Un è la sensazione che si prova quando ci sono delle esigenze precise che devono essere soddisfatte. Il bisogno può essere , se riguarda esigenze legate alla sopravvivenza (mangiare, bere, dormire…) oppure , se è collegato a esigenze meno impellenti.
ô Che caratteristiche ha un bisogno?
Un bisogno può essere , quando è percepito da una singola persona, oppure , quando è percepito dal singolo in quanto membro di una comunità.
Un bisogno può essere , quando può essere soddisfatto pagando del denaro, o , quando non può essere soddisfatto con il denaro.
ô Che cosa serve per soddisfare un bisogno?
Un bisogno può essere soddisfatto da:
ôun , che è un mezzo materiale;
ôda un , che è una prestazione fornita da alcuni soggetti dietro pagamento di un prezzo.
ô Come possono essere classificati i beni?
Un bene è classificato come bene economico quando è scarso, cioè disponibile in quantità limitata.
Un bene può essere distinto in bene di consumo o in bene strumentale:
ô se soddisfa direttamente il bisogno;
ô se è utile per produrre altri beni.
I beni di consumo, a loro volta, si distinguono in base alla loro durata:
ô quando dopo un singolo consumo diventano inutili;
ô quando possono essere utilizzati ripetutamente.
I beni di consumo possono distinguersi anche in base all’uso che se ne fa:
ô quando devono essere utilizzati insieme;
ô quando possono essere usati al posto di altri.
ô Che cosa formano i beni che si posseggono?
I beni posseduti da una persona o da una famiglia o da un’impresa ne formano il . Oltre al patrimonio, la persona, la famiglia o l’impresa può possedere però anche del denaro, e quindi oltre al patrimonio avrà anche un
L’UNITÀ IN AUDIO MAPPE
Per ripassare, guarda le mappe, ascoltando le sintesi audio dell’unità
I BISOGNI

SERVIZI
sono attraverso
si distinguono
esigenze da soddisfare
in base all’urgenza
in base alla natura
primari economici
secondari non economici collettivi
in base all’origine
individuali
ovvero attività che possono essere svolte da soggetti privati o pubblici
BENI
che si distinguono in
strumentali se servono per produrre altri beni
di consumo per soddisfare direttamente un bisogno
ovvero mezzi materiali che servono a soddisfare i bisogni
durevoli
possono essere usati più volte
il loro insieme forma il patrimonio
possono essere classificati come
non durevoli
possono essere usati una volta
complementari
che si completano a vicenda
sostituiti
che si possono usare uno al posto dell’altro
VERIFICO CONOSCENZE E ABILITÀ
VERO O FALSO?
1 Reddito e patrimonio sono due grandezze fondamentali per valutare la situazione economica complessiva di un soggetto economico. VF
2 I beni di consumo sono tutti non durevoli. VF
3 Avere degli amici è un bisogno economico primario. VF
4 I bisogni economici sono saziabili e risorgenti. VF
5 I bisogni si distinguono in base all’intensità in individuali, collettivi e pubblici. VF
6 Il patrimonio è un concetto di flusso e descrive una quantità di ricchezza dinamica. VF
7 L’automobile di proprietà di una famiglia rappresenta un elemento del suo patrimonio. VF
8 I servizi sono attività che possono essere svolte tanto da soggetti privati (cd. servizi privati), quanto da enti pubblici (cd. servizi pubblici). VF
9 I bisogni variano nel tempo e da persona a persona. VF
10 La luce del sole non è un bene economico. VF
11 Il canone d’affitto incassato rappresenta un’entrata monetaria che fa parte del reddito di un individuo.
SCELGO
1 I bisogni economici sono molteplici perché:
a variano da persona a persona
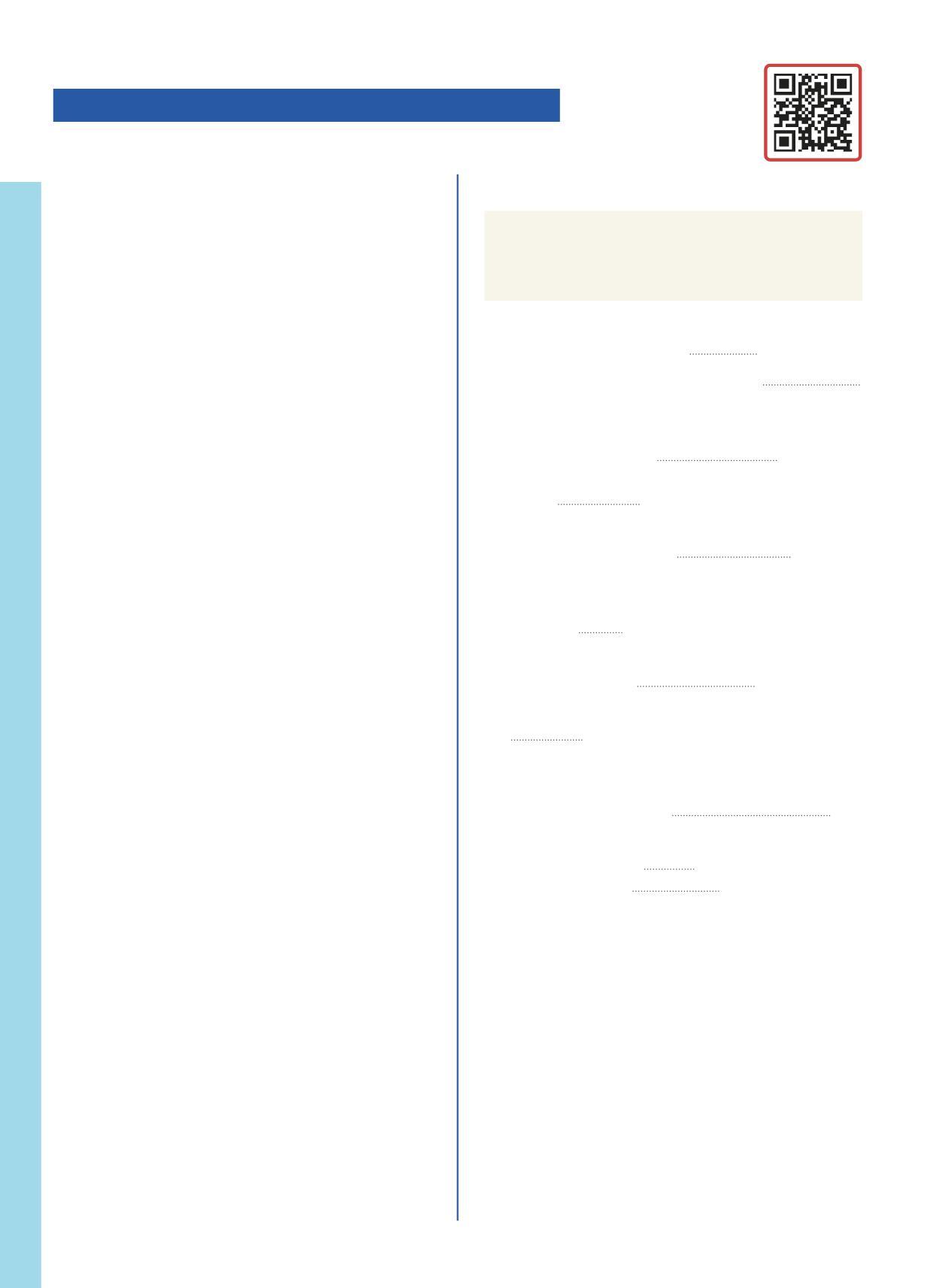
VF
b non si presentano isolatamente, ma insieme ad altri
c possiamo confrontarli tra loro e classificarli in ordine di importanza
d dopo essere stati soddisfatti si ripresentano nuovamente
2 Il tostapane è:
a un servizio
b un bene semidurevole
c un bene durevole
d un bene non durevole
3 Una lezione di pianoforte è:
a un bene non durevole
b un bene superfluo
c un servizio
d un bene immateriale
4 I bisogni primari sono quelli che:
a vengono sollecitati attraverso le campagne pubblicitarie
b riguardano tutte le esigenze dell’uomo, più o meno impellenti
c vengono chiamati anche voluttuari
d riguardano le esigenze fondamentali per la nostra stessa sopravvivenza
COMPLETO (attenzione ai distrattori)
beni / collettivo / complementari / consumo / inutilizzabili / limitata / illimitata / patrimonio / prezzo / primari / reddito / risorgenti / servizi / succedanei / utili / voluttuari
1 I bisogni economici sono quelli che possono essere soddisfatti mediante il pagamento di un
2 I beni economici si distinguono in beni di , utilizzati direttamente per soddisfare un bisogno, e beni strumentali, impiegati per produrre altri beni.
3 In economia, il termine descrive una quantità di ricchezza statica, misurata cioè in un determinato istante; il , invece, è un valore dinamico, generato in un certo arco temporale.
4 I bisogni economici si dicono perché, una volta appagati, si ripresentano nuovamente dopo un periodo di tempo più o meno lungo.
5 Si chiamano i mezzi materiali, ossia le cose che permettono di soddisfare i bisogni.
6 Un bisogno è definito se è avvertito dal singolo in quanto membro di una comunità di persone.
7 I sono attività immateriali che soddisfano i bisogni.
8 I beni che devono essere usati insieme per poter soddisfare un unico bisogno sono detti .
9 I beni e i servizi si dicono economici quando hanno le seguenti caratteristiche: sono per soddisfare un bisogno, disponibili in quantità e hanno un prezzo.
INDIVIDUO
1 Indica nell’elenco di seguito, se si tratta di un bisogno di tipo primario (P) o secondario (S):
a Bere acqua potabile P S
b Navigare in Internet P S
c Andare in pizzeria il sabato sera P S
d Disporre di un’abitazione in cui vivere P S
e Acquistare un piumino per l’inverno P S
f Viaggiare P S
g Acquistare le medicine per l’influenza P S
h Acquistare vestiti di alta moda P S
SVILUPPO COMPETENZE
ANALIZZO
1 Che cosa si intende per bisogno? I bisogni come possono essere classificati?
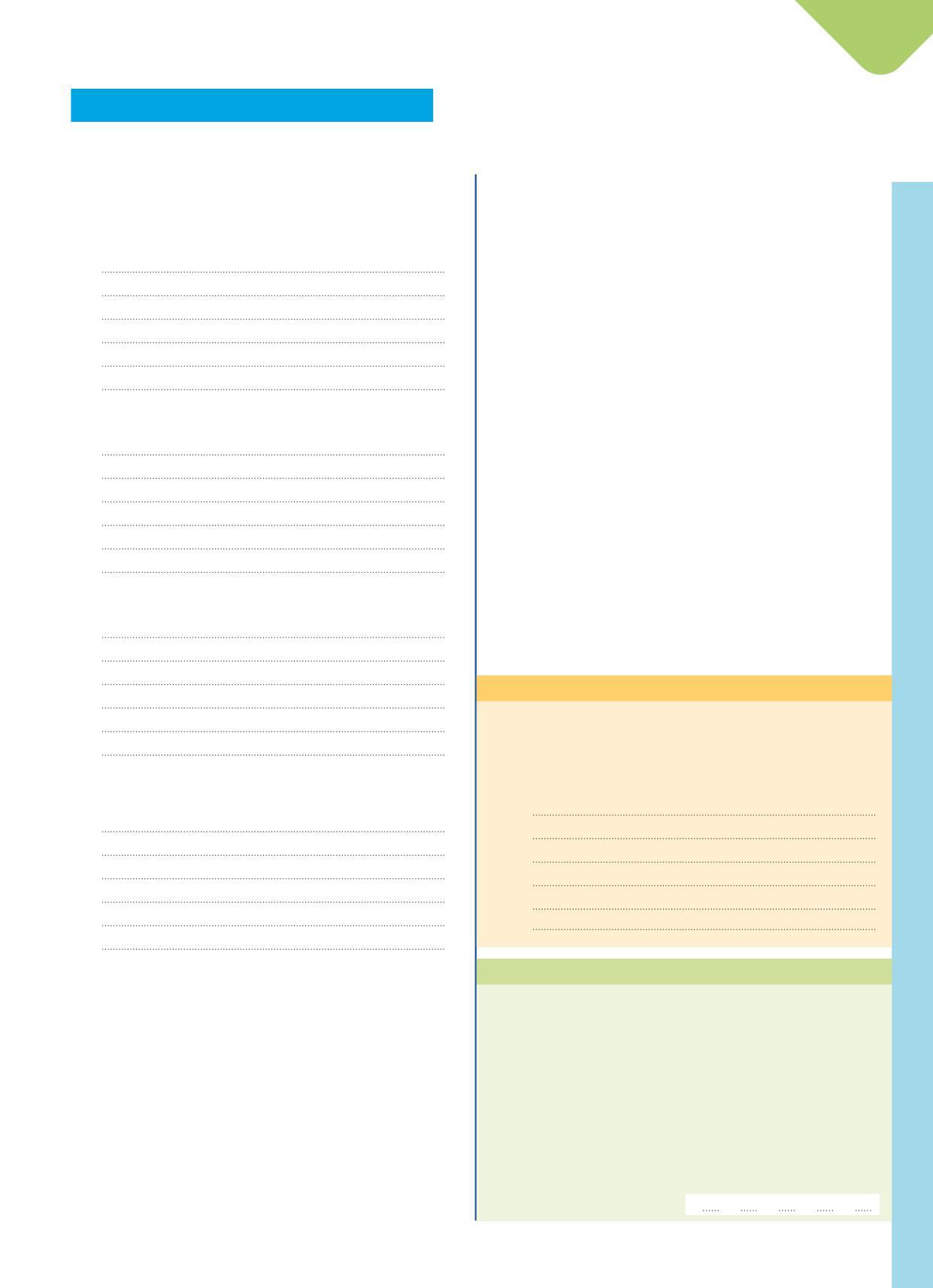
2 Quando un bene viene considerato un bene economico?
LAVORO SUI DATI
Un recente studio della Confcommercio ha calcolato che nel 2019 oltre il 75% dei consumatori percepisce la tredicesima. Di questi:
• il 25,9% la utilizzerà in spese per la casa e la famiglia;
• il 20,4% la metterà da parte;
• il 19,5% la utilizzerà per pagare tasse e bollette.
La quota destinata all’acquisto dei regali di Natale è pari al 17,8%. Circa la spesa pro capite per i doni di Natale, l’Ufficio studi Confcommercio ha rilevato una leggera diminuzione rispetto agli scorsi anni: la spesa media nel 2019 risulta pari a 169 euro, contro i 171 euro del 2018 e i 166 euro del 2017.
1 Dopo aver cercato sul dizionario l’esatta definizione di “tredicesima”, rispondi alle seguenti domande.
a Le tredicesime costituiscono reddito o patrimonio?
b I doni natalizi sono beni di consumo o beni strumentali?
c Considerata la percentuale di consumatori che percepiscono la tredicesima, com’è stata utilizzata in prevalenza la tredicesima relativa al dicembre 2019?
3 Come si distinguono i beni economici?
d Qual è la quota destinata all’acquisto dei regali di Natale?
e Com’è cambiata negli anni la spesa pro capite per i doni natalizi?
ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARE
1 Pensa a quello che hai studiato finora in storia. Nelle epoche storiche passate che hai approfondito in classe, ti risulta che il concetto di bisogno economico sia mutato, oppure i bisogni primari e secondari sono sempre stati gli stessi per l’uomo?
4 Qual è la differenza tra patrimonio e reddito?
INDAGO E RISOLVO
1 Il signor Rossi ha avuto oggi una giornata intensa. Di prima mattina ha accompagnato il figlioletto all’asilo nido comunale; poi, prima di recarsi al lavoro, si è sottoposto ad analisi mediche presso un presidio ospedaliero regionale. Nel pomeriggio, dopo aver telefonato alla moglie per comunicarle il ritardo, si è fermato in un bar per festeggiare con un aperitivo il compleanno di un collega. Solo verso sera si è infine diretto verso l’autobus di linea che l’ha ricondotto verso casa.
Di quali servizi ha goduto? Distinguili in servizi pubblici e privati.
ENGLISH CORNER
1 Try to match the words in English with their translation in Italian:
1 Durable goods a Beni di consumo
2 Substitute goods b Beni strumentali
3 Capital goods c Beni succedanei
4 Complementary goods d Beni complementari
5 Consumer goods e Beni durevoli

2

I
Il sistema economico e i suoi operatori
AI BLOCCHI DI PARTENZA
Guarda il video
Nel video proposto sono descritti i tre settori economici che contribuiscono a soddisfare i bisogni dei singoli e della collettività.
• Secondo te in Italia il settore primario è sviluppato? Perché?
• Elenca tre attività concrete, cui corrispondono altrettante professioni, del settore terziario Usa gli strumenti del libro
• Tenendo a mente il contenuto del video, vai al paragrafo 1 e al paragrafo 4 e leggi il contenuto, individuandone i concetti principali
• Verifica di aver capito i contenuti dei paragrafi 1 e 4 svolgendo gli esercizi “Vero o falso?” e “Scelgo”
• Per metterti alla prova svolgi la consegna del box Nella realtà – Le attività attorno a te
1 Il sistema economico
Nell’unità di economia del Modulo 0 hai immaginato che compravi una pizza, lavoravi per un fioraio per ottenere un salario, utilizzavi il risparmio per comprare uno smartphone. Eri quindi parte di una fitta rete di relazioni che coinvolge tutta la società. Per mettere ordine in questa intrecciata rete possiamo classificare le attività economiche che in ogni società devono essere svolte per sopravvivere e crescere nel tempo. Ogni gruppo sociale deve provvedere a produrre i beni necessari, distribuirli tra i membri e utilizzarli. Per esempio in un paesino di montagna isolato, se si interrompono i collegamenti con altri territori, i cittadini dovranno produrre i beni necessari a sopravvivere e distribuirli, lasciando poi ai singoli la scelta su come impiegarli.
Le attività economiche necessarie in ogni gruppo sociale si dividono in tre categorie:
1) produzione di beni e servizi;
2) distribuzione del reddito;
3) impiego di beni e servizi.
1) La produzione di beni e servizi consiste nella realizzazione dei beni utilizzati per soddisfare i bisogni. I beni necessari, oggi, non sono prodotti all’interno delle famiglie ma sono realizzati da apposite organizzazioni chiamate imprese. La pizzeria, per esempio, è un’impresa, ossia un’organizzazione che ha come scopo quello di produrre pizze, venderle e garantire al proprietario un reddito.
Le attività intorno a te
Nel quartiere o nel paese in cui vivi ci sono sicuramente molte attività produttive.
Indaga
• Su un tabellone o un poster elencate le categorie in cui si dividono le attività economiche.
• Tracciate una riga e, di fianco alle categorie, elencate le principali attività economiche che vengono svolte dagli abitanti del vostro quartiere o paese.
• A quali categorie appartengono queste attività economiche? Collegate le attività alle categorie.
2) Il reddito prodotto dalle imprese attraverso la vendita di beni deve essere distribuito tra coloro che hanno contribuito a generarlo (distribuzione del reddito). Così, in cambio della loro attività, gli imprenditori percepiscono un profitto e i lavoratori un salario; profitto e salario sono rispettivamente il reddito dell’imprenditore e quello del lavoratore, la quota di reddito creata che spetta all’uno e all’altro.
3) L’impiego di beni e servizi non è altro che l’utilizzo di ciò che è stato prodotto. Nulla di complicato, dunque: ognuno di noi utilizza beni e servizi che qualcun altro ha realizzato. Come? Attraverso quelli che in economia vengono chiamati consumi e investimenti.
Per esempio sono attività di consumo una cena in pizzeria, un viaggio in treno, una visita dentistica. Non tutti i beni e i servizi prodotti, però, vengono destinati al consumo: alcuni di essi, come i macchinari e gli attrezzi da lavoro, sono utilizzati per produrre altri beni o servizi, cioè per compiere degli investimenti.
Un sistema economico è un gruppo sociale che provvede alla produzione dei beni, li distribuisce e li impiega.
Solitamente, si identifica un sistema economico con un Paese: avremo così un sistema economico italiano, un sistema economico tedesco ecc.
2 I soggetti economici
I soggetti che operano all’interno di un sistema economico possono essere raggruppati in quattro categorie principali: famiglie, imprese, Stato, resto del mondo.
Le famiglie
Cominciamo parlando delle famiglie, che all’interno del sistema hanno un duplice ruolo.
Ӷ Da un lato, le famiglie sono proprietarie dei mezzi necessari per effettuare la produzione. Questi mezzi sono chiamati fattori della produzione e sono il lavoro, la terra e il capitale. Un’ipotetica famiglia può mettere a disposizione delle imprese:
• il lavoro del padre e della madre;
• un secondo appartamento dato in affitto. La famiglia fornisce così alle imprese i locali per svolgere l’attività produttiva. Possiamo chiamare, genericamente, terra un bene immobile che viene utilizzato per produrre;
• poiché ha risparmiato nel corso degli anni, ha da parte un capitale di 10.000 euro che presta alle imprese affinché possano acquistare materie prime e beni strumentali.
Le famiglie sono proprietarie dei fattori della produzione richiesti dalle imprese. I fattori della produzione sono il lavoro, la terra e il capitale.
Unità di consumo
Dal punto di vista economico, il tuo nucleo familiare è certamente una famiglia, ma in economia si considera famiglia anche qualsiasi soggetto, individuale o collettivo, che si comporta come un’“unità di consumo”. Per esempio, anche un single è una famiglia.
Indaga
Con l’aiuto dell’insegnante, prova a fare altri esempi di soggetti che, pur non costituendo una famiglia nel senso comune del termine, sono tali per gli economisti.

1 Vero o falso?
a Ogni gruppo sociale per sopravvivere e crescere nel tempo si sviluppa attraverso tre diverse attività economiche: produrre, distribuire, impiegare. VF
b La distribuzione del reddito è una delle tre attività economiche caratterizzanti il sistema economico. VF
c La produzione di beni e servizi è realizzata direttamente dalle famiglie. VF
Unità 2 Il sistema economico e i suoi operatori
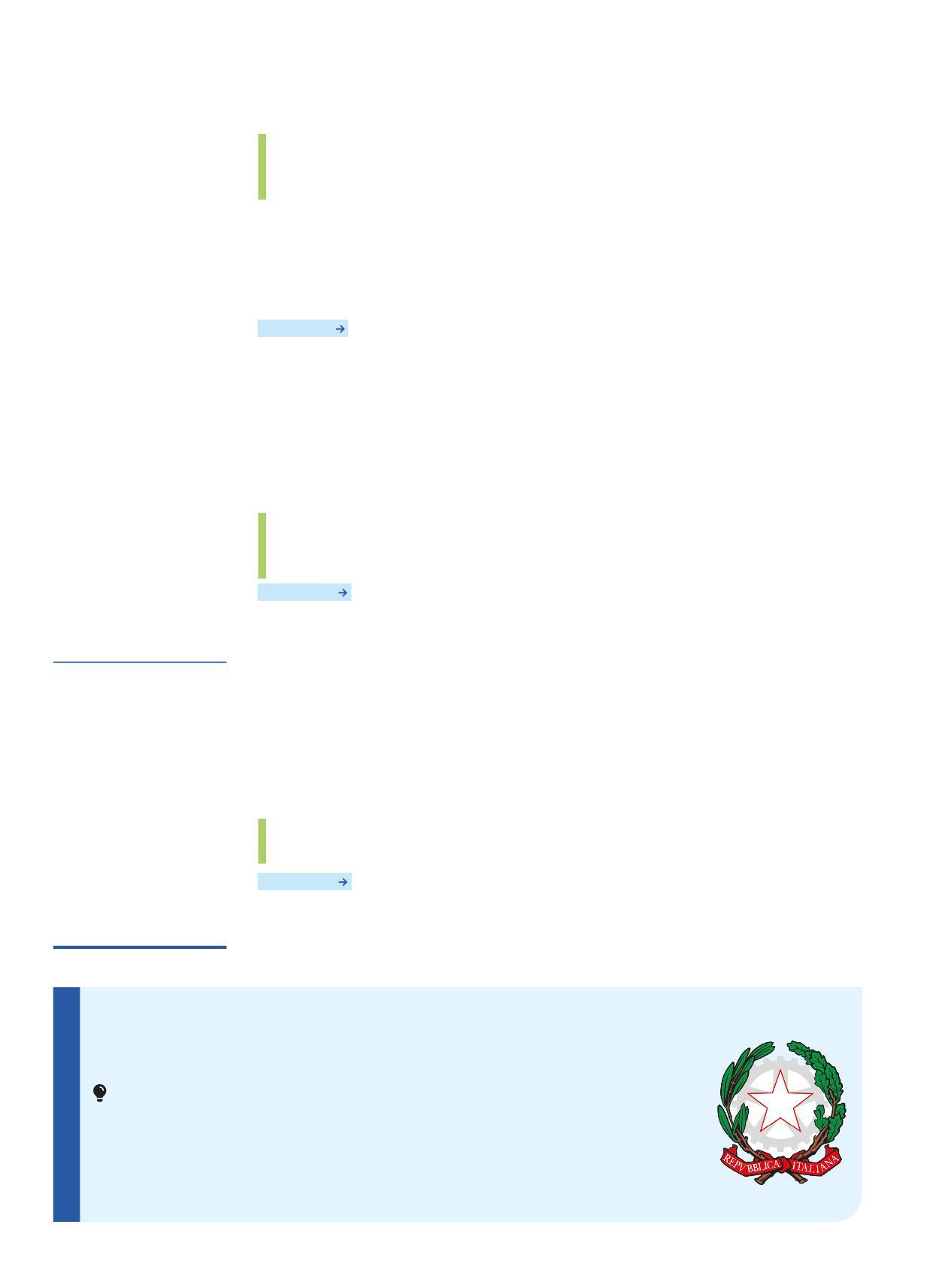
1 Vero o falso?
a I soggetti economici si raggruppano in quattro categorie: famiglie, imprese, Stato e resto del mondo. VF
b Le famiglie sono proprietarie dei fattori della produzione e allo stesso tempo consumatori. VF
c L’attività delle imprese è orientata al soddisfacimento dell’interesse collettivo e non al raggiungimento di un profitto. VF
Ӷ Dall’altro lato, le famiglie sono anche consumatori, ossia chiedono beni e servizi alle imprese.
Le famiglie sono i soggetti economici che danno alle imprese i fattori della produzione e usano i propri redditi per il consumo, cioè per acquistare beni e servizi utili per soddisfare i loro bisogni.
Le famiglie spesso conservano una parte di reddito per far fronte a necessità future. Per indicare queste diverse destinazioni del reddito, in economia si usa la formula
Y = C + S dove Y indica il reddito complessivo della famiglia, C la parte di reddito usata per il consumo e S (saving) il risparmio.
Per esempio se la famiglia di Marzia, cedendo alle imprese i fattori della produzione, ottiene in cambio un reddito di 30.000 euro all’anno, e ne consuma 25.000, il suo risparmio è di 5000 euro. Reddito (30.000) = Consumo (25.000) + Risparmio (5000)
Le imprese
I beni e servizi domandati dalle famiglie sono forniti dalle imprese, che utilizzano i fattori produttivi (terra, lavoro, capitale) per ottenere i prodotti da offrire sul mercato e trarne un profitto. Il profitto è la differenza tra ciò che le imprese ottengono dalla vendita dei beni (ricavi) e le spese che sostengono per effettuare la produzione (costi).
Le imprese sono i soggetti economici che svolgono l’attività produttiva utilizzando i fattori della produzione terra, lavoro e capitale al fine di ottenere un profitto (ricavi – costi).
Per esempio Maria acquista farina e lievito con cui produce pane. La spesa per l’acquisto ammonta a 300 euro al giorno (costi); il pane lo vende per 350 euro al giorno (ricavi). Il profitto giornaliero di Maria è perciò di 50 euro (Profitto = Ricavi – costi = 350 – 300 = 50).
Lo Stato
Un operatore economico del tutto particolare è poi lo Stato. La sua attività si distingue da quella degli altri soggetti economici in quanto è orientata al soddisfacimento dell’interesse collettivo. A differenza delle imprese, quindi, lo Stato non opera con l’obiettivo di ottenere un profitto, ma con finalità di benessere generale, e a tale scopo fornisce servizi pubblici (sanità, istruzione, giustizia ecc.) chiedendo ai cittadini, in cambio, il pagamento di tasse e imposte.
Lo Stato è il soggetto economico che garantisce i servizi pubblici nell’interesse della collettività. Per finanziare tali spese, richiede ai cittadini il pagamento di tasse e imposte. Per esempio Roberto frequenta una scuola superiore. I professori, il dirigente, i bidelli, il riscaldamento sono tutti costi dello Stato (spesa pubblica). Per frequentare la scuola Roberto paga una tassa di iscrizione; la sua famiglia poi paga una serie di imposte che servono, tra l’altro, a coprire la spesa pubblica derivante dall’attività scolastica.
Alcune attività dello Stato
Ci sono attività dello Stato che riguardano direttamente te e la tua famiglia.
Risolvi il caso
Chiedi ai tuoi genitori quali sono le attività dello Stato che vi riguardano. Per aiutarti, qui di fianco troverai un elenco di possibili attività: togli quelle che non riguardano la tua famiglia e aggiungi quelle che, invece, mancano.
1. Pagamento delle imposte
2. Istruzione
3. Assistenza medica
4. Sicurezza pubblica
5. Difesa del territorio nazionale
6. Aiuti alle imprese
7. Sussidi di disoccupazione
8. Raccolta dei rifiuti
9. Pulizia delle strade
10. Manutenzione delle strade
Il resto del mondo
L’ultimo operatore economico ha un nome un po’ strano: resto del mondo. Questa denominazione si spiega con il fatto che un sistema economico non è un’entità isolata ma è in relazione con ciò che è al di fuori di esso. Così, i soggetti economici di un Paese hanno continui rapporti con soggetti economici di altri Stati, cioè, per l’appunto, con il resto del mondo.
Il resto del mondo è costituito dall’insieme dei soggetti economici che operano all’esterno del sistema considerato, ma intrattengono con esso delle relazioni economiche.
Tali relazioni sono rappresentate prevalentemente dalle importazioni e dalle esportazioni, che sono movimenti internazionali di beni e servizi: nel primo caso in entrata (acquisto dall’estero), nel secondo caso in uscita (vendita all’estero).
Per esempio l’Italia vende vino nel resto del mondo (esportazione) e acquista da altri Paesi materie prime come il petrolio (importazione).
3 Il circuito economico
Dopo aver messo a fuoco quali sono i soggetti economici e quali le loro attività, possiamo analizzare meglio il funzionamento complessivo del sistema economico.
Le relazioni che intercorrono tra i vari soggetti economici comportano due tipi di flussi: un flusso reale e un flusso monetario.
Il flusso reale consiste in un movimento di beni, servizi e lavoro; il flusso monetario in un trasferimento di denaro.
Il flusso reale è alimentato dai beni e dai servizi forniti dalle imprese e dallo Stato, dal lavoro prestato dalle famiglie, dai beni e servizi importati ed esportati.
Il flusso monetario è formato da: il reddito che le famiglie percepiscono per l’attività lavorativa svolta, il prezzo che le famiglie e lo Stato pagano alle imprese per l’acquisto dei prodotti, le tasse e le imposte che famiglie e imprese versano allo Stato, i movimenti di valuta (euro, dollaro, sterlina ecc.) collegati alle importazioni e alle esportazioni.
L’insieme dei flussi reali e dei flussi monetari che si creano in un determinato sistema economico si definisce circuito economico.
1 Completo
a Il sistema economico è caratterizzato da due tipi di flussi, monetario e reale, che insieme danno vita al cd.
b Il flusso reale è costituito da: , e
c I movimenti di valuta legati alle importazioni e alle esportazioni sono elementi del flusso

FLUSSO REALE
FLUSSO MONETARIO
BENI
CLIL
Sistema economico: economic system
Famiglia: private owner
Stato: government agency
Impresa: industrial council
Settore economico: economic sector

1 Scelgo
Le attività delle industrie di base rientrano nel settore:
a primario
b secondario
c terziario
d terziario avanzato
2 Vero o falso?
a Tradizionalmente i settori produttivi si distinguono in quattro categorie: primario, secondario, terziario e terziario avanzato. VF
b Le attività artigiane rientrano nel settore terziario. VF
c Nelle economie più avanzate il settore terziario ha un’incidenza maggiore sul reddito degli Stati. VF
4 I settori economici
Dopo aver descritto i soggetti che operano nei sistemi economici, esaminiamo meglio le attività economiche e chiariamo come contribuiscono al soddisfacimento dei bisogni dei singoli e della collettività.
Le attività economiche possono essere classificate distinguendo tre settori produttivi:
• primario (agricoltura, allevamento, pesca e attività forestali);
• secondario (industria e artigianato);
• terziario (commercio e servizi).
Il settore primario è quello più tradizionale e storicamente è stato il primo ad affermarsi in quanto legato agli stadi iniziali della civiltà umana.
Il settore secondario comprende innanzitutto le imprese industriali, che trasformano le materie prime in prodotti finiti attraverso l’impiego di macchinari e lavoratori. In questo settore rientrano sia le industrie di base (siderurgica, metallurgica, meccanica e chimica), sia quelle di trasformazione (tessile, alimentare, automobilistica ecc.), sia quelle avanzate (elettronica, informatica ecc.). Nel settore secondario rientrano anche le attività artigianali, in cui l’uso delle macchine è limitato e la maggior parte del lavoro è manuale. Il settore terziario comprende attività economiche molto diverse tra loro, sia pubbliche sia private, che vanno dal commercio al trasporto, dalla ricerca scientifica alla sanità, dal turismo ai servizi bancari. Oggi, poi, hanno grandissima importanza i servizi legati all’informatica e al digitale, per i quali spesso si parla di terziario avanzato. Tutte queste attività si sono sviluppate particolarmente negli ultimi decenni, dando luogo alla terziarizzazione dell’economia, cioè a un vistoso sbilanciamento del sistema economico verso il settore terziario. Pensa che attualmente i tre quarti di tutta la ricchezza prodotta in Italia provengono proprio da questo settore.
Per esempio Melissa è proprietaria di un terreno che coltiva insieme al marito e ai figli (settore primario); Roberta compra tessuti e produce abiti sartoriali per uomo (settore secondario); Camilla è una commercialista che si occupa della contabilità di alcune aziende (settore terziario).
CITTADINANZA DIGITALELa digital economy
Con digital economy si indica l’insieme delle attività economiche che si basano sull’utilizzo di Internet. Le possibilità offerte dalla Rete sono incredibili: permettono di mettere in contatto compratori e venditori di ogni parte del mondo e di far muovere beni e denaro a livello locale, nazionale e mondiale. L’Italia, nonostante l’appartenenza a una realtà occidentale sviluppata, è sempre stata tra gli ultimi Paesi in Europa in quanto a digitalizzazione dell’economia e della società.
Nel 2020 la diffusione del Covid19 ha messo ancora più in evidenza le nostre mancanze, ma allo stesso tempo ha costretto tante aziende a fare i conti con la necessità di guardare al futuro con occhi nuovi, valorizzando le potenzialità della digital economy. Molte attività, grandi o piccole che fossero, hanno infatti implementato una serie di servizi attraverso il web per poter raggiungere la propria clientela anche a porte chiuse.
Si tratta di un cambiamento epocale che continuerà a portare frutti anche in futuro, e sarà interessante e stimolante tenere d’occhio l’evoluzione del nostro Paese in questo ambito.
1 Vuoi sapere di più sullo stato di digitalizzazione dell’economia italiana? Guarda il QR Code e, con l’aiuto dell’insegnante di inglese, confronta i dati sull’Integration of Digital Technology del nostro Paese con quelli degli altri Stati UE. Quale giudizio daresti alla digital economy italiana nelle due componenti dell’indicatore (business digitization ed e-commerce)?
EDUCAZIONE CIVICA

L’agroalimentare
Il settore agroalimentare comprende l’insieme di attività orientate alla produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari.
Competenze
Il settore agroalimentare ha una filiera produttiva molto ampia e diversificata che va dall’agricoltore che lavora la terra, passando per l’operaio che utilizza macchinari per la lavorazione, la trasformazione e il confezionamento alimentare per arrivare, infine, al distributore finale del prodotto
Settori affini
Il sistema della produzione agroalimentare così com’è ora strutturato prevede il trasporto di grandi quantità di merci (spesso in tempi relativamente brevi) per permettere la commercializzazione dei beni prodotti: per questo motivo il settore agroalimentare è strettamente connesso al settore del commercio e al settore dei trasporti.
adattato da www.cittadeimestieri.it/settori-professionali/agroalimentare.html
PERCORSO DISCIPLINARE
Leggi attentamente il testo.
�1 A quali soggetti del sistema economico fa riferimento? Quali settori sono coinvolti?
�2 Prova a specificare il ruolo di ciascun settore all’interno del cosiddetto “agroalimentare”.
�3 Con quale dei soggetti descritti, tu e la tua famiglia entrate in contatto?
�4 Hai mai sentito parlare del “mercato a kilometro zero”?
5 Prova a fare una ricerca online digitando “mercato a km 0” e raccogli informazioni su che cosa sono e in quali zone sono presenti.
6 Ne hai trovati vicino a te?
• A quale settore appartengono?
• Quali vantaggi presentano?
7 Prova infine a costruire uno schema con i flussi reali e monetari tra i soggetti economici coinvolti.
GEOGRAFIA
Nei nostri territori si sta diffondendo l’offerta di prodotti a km 0, cioè acquistati nello stesso luogo in cui sono prodotti, senza intermediazione tra chi coltiva e chi consuma. Approfondisci l’argomento e fai una lista di vantaggi ed eventuali svantaggi di questa agricoltura “a filiera corta” presente nelle regioni italiane.
SCIENZE
Quando si parla di agricoltura biologica si fa riferimento a metodi di coltivazione che utilizzano le risorse naturali in modo responsabile, rispettano il terreno e il benessere degli animali. La Commissione europea mantiene un sistema di controlli rigoroso sui metodi biologici per garantire piena fiducia ai consumatori che scelgono il biologico.
Approfondisci l’argomento e rifletti sui modi in cui l’agricoltura biologica rispetti la sostenibilità a livello di ambiente ed esseri viventi.
FAI IL PUNTO

LEZIONE DIGITALE
1 Ripassa i temi fondanti con la lezione digitale “Il circuito economico”.
2 Leggi e completa questa pagina.
ô Che cos’è un sistema economico?
Un sistema economico è un insieme di soggetti che formano un gruppo sociale che:
ô , cioè realizza i beni necessari per rispondere ai bisogni del gruppo;
ô il ottenuto attraverso la vendita dei beni prodotti tra tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo;
ôutilizza e prodotti attraverso consumi e investimenti.
ô Quali sono i soggetti che fanno parte di un sistema economico?
1) Le famiglie: soggetto con ruolo.
Le famiglie infatti:
ôpossiedono i (lavoro, terra, capitale); ôsono soggetti .
2) Le : soggetti economici che svolgono l’attività produttiva usando i fattori della produzione delle famiglie per ottenere un profitto.
3) Lo Stato: soggetto economico che garantisce l’interesse della fornendo servizi pubblici, finanziati attraverso le tasse e le
4) Il : insieme di soggetti economici che operano all’esterno del sistema considerato e che con esso hanno relazioni economiche.
ô Che cos’è il circuito economico?
Il circuito economico è l’insieme delle relazioni tra i vari soggetti economici. Queste relazioni comportano due tipi di flussi;
ô (movimento di beni, servizi, lavoro);
ô (movimento di denaro).
ô Come possono essere classificate le attività svolte dai soggetti economici?
Le attività svolte dai soggetti economici all’interno del circuito possono essere classificate in base al settore produttivo di appartenenza:
ô (agricoltura, allevamento, pesca e attività forestali);
ô (industria e artigianato);
ô (commercio e servizi).
Ripassa l’unità con le audio mappe contenute nel QR code della pagina accanto.
SISTEMA ECONOMICO
gruppo sociale che svolge attività economiche
L’UNITÀ IN AUDIO MAPPE
Per ripassare, guarda le mappe, ascoltando le sintesi audio dell’unità

produzione
nei di
• settore primario (agricoltura, allevamento, pesca e attività forestali)
• settore secondario (industria e artigianato)
• settore terziario (commercio e servizi)
distribuzione profitti e salari
soggetti economici
impiego consumo o investimento
in
imprese
che sono che svolgono
proprietari dei fattori della produzione e consumatori
attività produttiva usando i fattori della produzione
corrisponde a tra questi soggetti ci sono
formato da
resto del mondo famiglia
movimenti di denaro (reddito, prezzo, tasse e i movimenti di valuta)
flusso monetario
Stato servizi pubblici finanziati attraverso tasse e imposte
che fornisce che opera che grazie alle relazioni tra i vari soggetti economici formano il
CIRCUITO ECONOMICO
movimenti di beni, servizi, lavoro
flusso reale
all’esterno del sistema economico ma con esso ha relazioni attraverso importazioni ed esportazioni
VERIFICO CONOSCENZE E ABILITÀ
VERO O FALSO?
1 Le famiglie spendono tutto il loro reddito per gli acquisti.
2 Un sistema economico è un gruppo sociale che si occupa della produzione di beni e servizi, della distribuzione del reddito e dell’impiego dei beni e servizi prodotti.
3 Lo Stato opera con il solo obiettivo di ottenere un profitto.
4 Il settore secondario è stato il primo ad affermarsi in quanto legato agli stadi iniziali della civiltà umana.
5 Per i servizi legati all’informatica e al digitale si parla di terziario avanzato.
6 Per l’economia una famiglia può essere anche una persona che vive da sola.
7 Le imprese per ottenere i prodotti da offrire sul mercato richiedono ai cittadini il pagamento di tasse.
8 Il flusso reale consiste in un trasferimento di denaro che avviene tra due o più soggetti economici.
9 Il reddito accantonato dalle famiglie è denominato risparmio.
10 I tre quarti di tutta la ricchezza prodotta in Italia provengono dal settore terziario.
SCELGO
1 I flussi economici:
a si distinguono in reali e nominali b sul mercato li generano solamente le famiglie e le imprese
c sono scambi che determinano trasferimenti reali o monetari tra i vari soggetti economici d nessuna delle precedenti
2 Le famiglie:
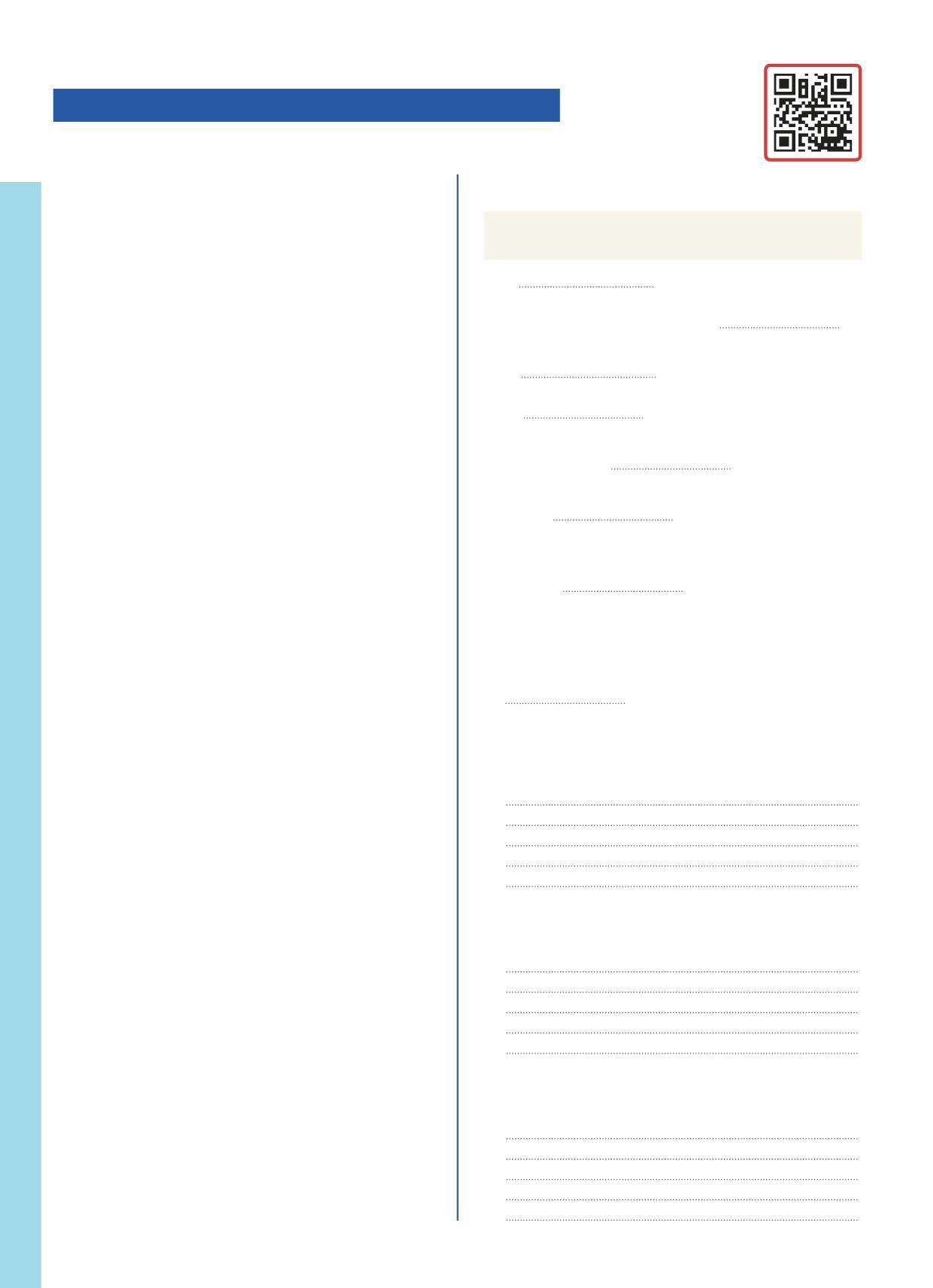
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
VF
COMPLETO (attenzione ai distrattori)
petrolio / consumo / pane / primario / produzione / vino / reale / importazioni / esportazioni / secondario
1 Le si verificano quando i nostri operatori economici vendono beni o servizi in altri Stati. Un classico esempio per l’Italia è la vendita del nel mondo.
2 Le sono movimenti internazionali di beni e servizi in entrata, come avviene in Italia con l’acquisto del di altri Stati.
3 Un sistema economico contiene un insieme di attività e relazioni riguardanti la , lo scambio e il consumo di beni e servizi.
4 Il flusso è alimentato dai beni e servizi forniti dalle imprese e dallo Stato, dal lavoro prestato dalle famiglie, dai beni e servizi importati ed esportati.
5 Il settore comprende le imprese industriali che trasformano le materie prime in prodotti finiti attraverso l’impiego di macchinari e lavoratori.
6 Dal punto di vista economico non interessa la natura giuridica della famiglia, quanto piuttosto il ruolo di unità di che essa ricopre nel sistema.
CORREGGO L’ERRORE
1 In economia si usa la formula: Y= C – S, per indicare le diverse destinazioni del reddito delle famiglie.
2 Il quarto soggetto economico si chiama “resto del mondo”: questa denominazione particolare sta a significare che ogni sistema economico è un’entità isolata, chiusa in se stessa.
a utilizzano i redditi provenienti dall’attività lavorativa per il consumo
b svolgono l’attività produttiva
c garantiscono i servizi pubblici nell’interesse della collettività
d importano ed esportano indifferentemente sia beni sia servizi
3 La pesca è un’attività economica del settore:
a primario
b secondario
c terziario
d terziario avanzato
3 Il reddito prodotto dalle imprese deve essere distribuito tra coloro che hanno contribuito a generarlo: gli imprenditori percepiscono il salario e i lavoratori il profitto.
SVILUPPO COMPETENZE
RISPONDO ALLE DOMANDE
1 Da che cosa è costituito un sistema economico?
RISOLVO IL CASO
1 Alessandro, pescatore da tutta la vita, ha avviato una sua piccola impresa per la vendita diretta del pescato. Ogni giorno all’alba con la sua imbarcazione e Alberto, suo dipendente, prende il largo alla ricerca di buon pesce da vendere al mercato. Nell’anno in corso dalla sua attività ha già ricavato 20.000 euro.
a In quale categoria di soggetti economici può essere inquadrato Alessandro?

2 Che cos’è una famiglia dal punto di vista economico?
3 Che cosa indica la formula Y = C + S?
4 Quali sono le maggiori componenti del flusso monetario?
5 Che cosa si intende per terziarizzazione dell’economia?
COSTRUISCO UNA MAPPA
1 Nel corso dell’unità hai imparato nuovi concetti sul sistema economico e sui suoi flussi economici. Concentrandoci adesso sui flussi reali e monetari che vengono originati ogni giorno da famiglie e imprese, prova a fare degli esempi concreti di questi flussi, riportali qui sotto e poi rappresentali graficamente.
b In quale settore produttivo opera?
c Il ricavato di questa attività corrisponde interamente al profitto? Nella sua attività, quali sono i costi che secondo te Alessandro dovrà sostenere?
d In che cosa consiste maggiormente il flusso monetario della sua attività?
2 La famiglia di Elisabetta è composta da quattro persone: Elisabetta è impiegata presso un’azienda informatica, guadagna 1200 euro al mese, proprio come il fratello Luca che è stato appena assunto come infermiere presso una RSA privata, mentre il padre è insegnante e guadagna 1600 euro al mese. La madre è collezionatrice d’arte per passione, ma non percepisce nessuna retribuzione. È lei che gestisce le spese mensili della famiglia, che ammontano a: 500 euro per la spesa mensile in beni alimentari, 500 euro per le spese in trasporti di tutta la famiglia e 1000 euro per tutti gli altri consumi, e a depositare l’importo restante presso un deposito bancario. La famiglia sta riflettendo sulla possibilità di acquistare un camper da utilizzare per viaggi di famiglia.
a A quanto ammonta il reddito complessivo mensile della famiglia di Elisabetta?
b A quanto ammontano i consumi mensili?
c Qual è lo scopo dell’importo depositato in banca? A quanto ammonta ogni mese?
ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARE
1 In questa unità abbiamo parlato di importazioni ed esportazioni, ossia di scambi internazionali di beni e servizi che l’Italia intrattiene con altri Stati.
Pensa a quello che hai studiato in geografia e immagina quali sono le maggiori risorse che l’Italia esporterà nel mondo e quali invece possono essere i beni che sarà costretta a domandare ad altri.
Fai ulteriori collegamenti con ciò che hai studiato finora in altre materie.
ENGLISH CORNER
1 Choose the answer that best matches the given definition. Economic agents who use the income derived from their work to buy goods and services.
a Government
b Households
c Rest of the world
d Firms
Lo sviluppo economico capitalistico
Come hai studiato in questa unità, il sistema economico capitalistico, che regola le attività economiche della maggior parte dei Paesi moderni, è il risultato di un lungo processo storico. Pensa, per esempio, alla lunga strada che ha portato dal sistema agricolo dei tempi antichi alla Rivoluzione industriale, che ha segnato l’ingresso nella modernità.
Questa linea del tempo ti condurrà per mano attraverso il lungo viaggio dello sviluppo economico capitalistico, ma naturalmente l’argomento non si esaurisce qui: basti pensare agli altri sistemi economici che si sono sviluppati nel corso della storia e in Paesi lontani rispetto al mondo occidentale.
I sistemi economici, infatti, nel loro sviluppo hanno dovuto rispondere a esigenze diverse e a fattori storici, geografici, tecnologici e ambientali. Per scoprirne di più, inquadra il QR code qui a fianco. Sarà un viaggio interessante.

Fu il primo sistema economico della storia, nell’antica Roma e in Grecia, incentrato sulla coltivazione della terra e sull’allevamento.
La borghesia fu protagonista dei fiorenti scambi delle città e delle grandi scoperte geografiche dell’epoca che aprirono il commercio a nuovi mondi.

L’ CO OM N A STO d le
Inquadra il QR code e scopri le tappe evolutive dell’economia dall’antichità a oggi.
Per ogni tappa percorsa, dopo aver letto con attenzione, rispondi alle domande e verifica le tue risposte nella sezione di fine percorso.
Rivoluzione industriale (dal 1870)
I grandi capitali accumulati dalla borghesia favorirono un’epoca di forti sviluppi che sfociò nella Rivoluzione industriale, in grado di introdurre nuove tecnologie, processi produttivi e modi di distribuire il reddito.
1. Le società primitive
2. Le società nel mondo antico
3. Il modo di produzione feudale
4. La transizione dal feudalesimo al capitalismo
5. Il modo di produzione capitalistico
6. Dal capitalismo industriale al sistema postindustriale
Sistema economico pianificato (dal 1917)
Lo Stato è l’unico decisore in campo economico e le attività economiche sono prestabilite e descritte all’interno di programmi pluriennali detti “piani”.
Sistema economico capitalistico (fine Ottocento)
Sistema economico capitalistico misto ovvero quello italiano (dal 1900)
Le caratteristiche fondamentali del sistema economico capitalistico sono la proprietà privata dei beni che vengono scambiati liberamente nel mercato, la proprietà privata degli strumenti di produzione e la libertà di iniziativa economica.
