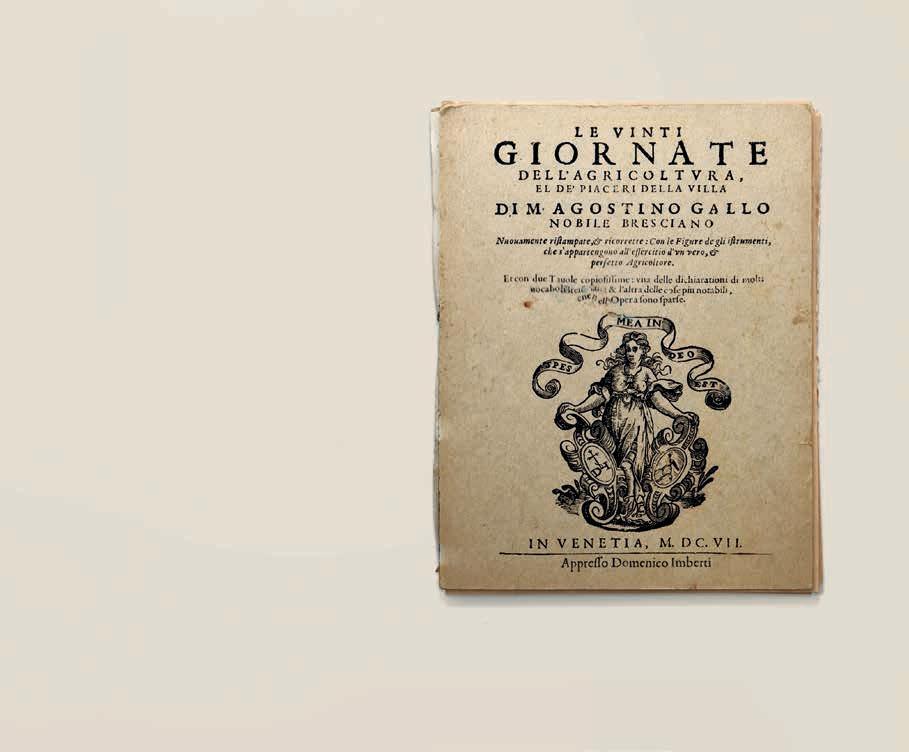
18 minute read
Storia lattiero-casearia
Il malghese Scaltrito di Agostino Gallo
L’agronomo Agostino Gallo ne “Le vinti giornate dell’agricoltura, el de’ piaceri della villa” descrive lo stato dell’arte lattiero-casearia nel XVI secolo, attraverso i dialoghi dei Messeri Avogadro e Maggio con il malghese Scaltrito
VINCENZO BOZZETTI
Il Nobile Agostino Gallo nasce qualche giorno prima del 14 maggio del 1499 a Cadignano, oggi frazione di Verolanuova in provincia di Brescia [Benzoni G., 1998] e stabilisce il suo “buen retiro” a Borgo Poncarale, dove possiede venti ettari di terra “aradora, prativa, adacquadora”. Appassionato studioso di agricoltura scrive un impegnativo trattato agronomico, diviso in “giornate” e concepito sotto forma di dialogo tra i suoi ospiti. Già nel 1558 circolano le prime copie scritte a mano, quindi, nel 1564, viene stampata la prima edizione bresciana di G.B. Bozzola con il titolo Le dieci giornate della vera agricoltura, e piaceri della villa. Alla prima versione, purtroppo, seguono alcune “veneziane pirata”, sino a che lo stesso Gallo, nel 1569, si convince ad aggiungere altre tre giornate per lo stampatore lagunare G. Percaccino. Lo stesso editore dà alle stampe la definitiva versione intitolata Le vinti giornate dell’agricoltura et de’ piaceri della villa. Il testo in consultazione, invece, è stato stampato sempre a Venezia nel 1607 da Domenico Imberti [Gallo A., 1607]. L’Autore presenta i suoi dialoganti ospiti nell’incipit della Prima Giornata: “Nella quale ragionano i Nobili M. Gio. Battista Avogadro, e M. Vincenzo Maggio della qualità de terreni, che si deb-
bono comprare e del modo d’ordinarli, e coltivarli”; in rapida successione il trattato agronomico esamina anche le diverse culture agricole nonché i diversi allevamenti animali. La tematica del latte bovino viene trattata all’“Undecima Giornata” che verte: “Intorno alle vacche, vitelli, giovenchi, e buoi”, allorquando nei ragionamenti interviene il malghese Scaltrito, “nome comunemente à i pari suoi: poiché generalmente sono i più astuti d’ogni altra qualità e professione di persone.”
INTORNO AL LATTE DI VACCA
Dopo le riflessioni intorno alla gestione dell’allevamento bovino Messer Vincenzo Maggio approfondisce il tema della produzione del latte. Vinc.: Dapoichè voi malghesi mandate le vacche di Maggio a pascer nelle nostre campagne, e di Giugno poi in monte, acciocchè pascano in quelle erbe fresche, e morbide fin che le ritornate anco nelle campagne dopo San Bartolomeo, ovvero alle cascine avendo tolto i fieni, vorrei saper da voi quando le pascete di fieno, s’è cosa buona à tener le ben calde nelle stalle al tempo del freddo, e massimamente essendo eccessivo? Scal.: Solamente gli uomini ignoranti e avari le tengono talmente rinchiuse nel caldo a quel tempo, che le povere vacche non mangiano la metà del fieno che mangerebbero quando fossero tenute al caldo mezzano, come fanno i liberali che tendono alla utilità maggiore; perciochè per esperientia veggono, che quanto più mangiato buon fieno, tanto maggior copia di latte producono. Vinc.: Poi che tenete le vostre vacche morbidamente, vi prego che mi diciate anco quanti pesi di latte vi danno all’anno, oltre il lattar dei vitelli, e vitelle? Scal.: Avenga che ordinariamente molti di noi si contentano quando (computando l’una vacca con l’altra) fa cento pesi di latte: nondimeno io non mi contenterei se le mie non passassero i centoventi e centotrenta: perciò che ve ne sono quasi il terzo, che giungono, sino a centoquaranta per ciascuna. E questo ci fa vedere (come ho detto) quanto importa a pascerle bene, e non a sparagnare il lor mangiare, come vien fatto da molti che non hanno giudizio.
I pesi bresciani durante la Repubblica di Venezia
Tratto da Enciclopedia Bresciana, Fappani A., 1991 Nel sistema dodicesimale che fu in vigore fino al secolo XIX, quando venne adottato il “decimale”, le misure ebbero denominazioni diverse in multipli e sottomultipli, inerenti al sistema. Per la determinazione dei pesi era usata la libbra la quale si divideva in 12 once, la oncia in 16 dramme, la dramma in 4 quarti, 25 libbre fanno un peso, 100 pesi fanno un carro…
Segnaliamo le antiche denominazioni con le rispettive valutazioni di peso: il quarto è pari a gr. 0,418 il denaro è pari a gr. 0,139 la dramma è pari a gr. 1,670 la oncia è pari a gr. 26,734 la libbra piccola, di 12 once, è pari a gr. 320,808 la libbra grossa, di 30 once, è pari a gr. 802,02 il peso o rubbo è pari a kg. 8,02 la soma, di 16 pesi, è pari a kg. 128,32 il carro, di 100 pesi, è pari a ql. 8,02
Inoltre esisteva anche una misura di peso per i fieni e cioè: il carro pari a ql.8; un fasso pari a kg. 80 e il peso kg. 8.
INTORNO AL FORMAGGIO
Vinc.: Quanti pesi di buon latte vi vuole a fare un formaggio bello di due pesi ben salato e ben ordinato? Scal.: Non ci vuole manco di pesi ventiquattro, o venticinque di latte fresco per fare un formaggio ben ordinato, il quale si trovi, due pesi in capo dell’anno, secondo l’usanza nostra. Vinc.: Per qual cagione non fate voi malghesi i formaggi di quattro, o di sei pesi l’uno, e anco di più, come fanno gli altri Piacentini e Lodesani, i quali (per farsene grandissima copia) vanno per tutto’l mondo? Scal.: […] E qui il nostro Scaltrito diventa maggiormente dettagliato, mentre noi per ragioni di spazio, dobbiamo sintetizzare: quindi il malghese-casaro ribadisce che i suoi formaggi sono migliori e sono venduti a Roma, a Venezia ed in Alemagna; che non diventano verdi, perché sono alti quattro di-
ta, mentre i Piacentini e Lodesani, alti un palmo, non si salano bene nel mezzo. Poi lo Scaltrito spiega come il latte debba essere scremato diversamente nelle diverse stagioni e, che non si deve ricavare più di due-due e mezza, libre di burro (1,6-2 kg) per dieci pesi di latte (80 kg). Torniamo ora ai dialoganti per la descrizione della caseificazione. Gio.Bat.: Voi mi avete pur detto, che a non cavare il butiro quel formaggio è molto dubbioso di guastarsi? Scal.: Confirmarei ciò che voi dite, quando si mancasse a romper benissimo la giuncata. Et però ogni malghese ben pratico di questo non pur la rompe talmente col bastone, che fa parer che non ve ne fusse mai, ma ancora com’ella è ridutta al fondo, le da un po più fuoco del solito, acciocchè quel formaggio

Ritratto di Agostino Gallo, Agostino Galeazzi (1523-1576) morbido non si guastasse, come facilmente farebbe quando non fusse alquanto più cotto dell’altro. Posti adunque vinti, e vinticinque pesi di buon latte colato nella caldara al fuoco fin che tanto caldo, che si possa sofferire col braccio nudo, vi si pone un’oncia di buon caggio ben sminuzzato con l’acqua in un piatto, e volendo che’l formaggio resti con bel colore, vi si metta anco dentro tanto zaffarano pesto, quanto starebbe sopra un quattrino; e com’è ben caggiato il latte si rompe col bastone tondo, e ben bianco fin che si vede esser bisogno: onde essendo ridotta la gioncata rotta al fondo della caldara, il malghese polito con panni di bugato, caccia le mani, e braccia ben nette sin’al fondo, volgendo e rivolgendo quella massa, sin ch’ei conosce essere ugualmente cotta, e alquanto soda e tonda: di maniera che la si levi fuori, cacciandovi sotto un pane ben bianco, ò più tosto un mastello, e la pone nella fascia di legno sopra del pressore alquanto pendente, acciòcchè esca tutto il brodo del latte superfluo: la quale, cinta, e stretta quanto vi conviene la copre con un’asse tonda: mettendovi sopra delle pietre di sofficiente peso, e altro non vi fa fino al mattino seguente, la qual massa, per essersi ridotta in bel formaggio asciutto, lo porta nella cascina a terreno, e ordinata a simili formaggi con le assi sopra le scalere di mano in mano. Lo Scaltrito spiega poi: la salatura a mano, con le sue variazioni stagionali; la pulizia e i rivoltamenti in stagionatura (dove muffe e acari non mancavano); i trattamenti a base di olio d’oliva, lino o burro e, “per darli più bel colore, che ha alquanto del vermiglio”… La stagionatura media era di un anno, mentre problematico era il suo prolungamento.

INTORNO AL LATTE DI PECORA
Vinc.: Non avete voi per migliore il formaggio accompagnato col latte di pecora (com’è tutto quel che fate voi) che non è il puro fatto quasi da tutti gli altri malghesi?
Scal.: Nò è dubbio alcuno, che la lunga esperientia mi ha fatto veder che ’l mio formaggio riesce sempre più saporito, più delicato, e si mantiene con maggior peso, e però non è meraviglia se io persevero a tenere ottanta, e cento pecore appresso alle 35 e 40 vacche, e se vendo il mio ogni anno no solo quattro, e cinque soldi il peso di più, che nò fanno quei malghesi che ne fanno quella medesima somma che faccio io, ma ancora le pecore mi rendono (a tanto per tanto) maggior utile, che nò cavo dalle vacche. Vero è che questa sorte di formaggio resta alquanto bianco, ma dandolo quel poco di zaffarano (come faccio) resta colorito.
INTORNO ALLA RICOTTA
Vinc.: Non avete parimenti per migliori le ricotte salate, e bene ordinate di questi dui latti mescolati, che non son le pure di quel di vacca? Scal.: Non solamente sono più saporite quelle de’ detti dui latti, e più le pure di pecora, ma sono ancora più delicate quell’altre fatte di latte di capra, e medesimamente sono questi latti, cioè si come quel di pecora è migliore, e più grasso di quel di vacca: cosi in queste due cose avanza tutti quel di capra.
INTORNO AL LATTEMELE
Vinc.: Che modo tenete voi nel fare si delicato il lattemele? Scal.: Posta la panna co acqua rosa in una bacia, o altro vaso comodo, si sbatte, e si rivolve con le bacchettine legate per quanto si tengono in mano, e le cime ben sparse, riducendola in schiuma, la quale si va levando col mescolo forato di mano in mano, secondo che i fa (ponendovi sopra del zucchero ben spolverizato) e si mette nei piatti, seguitando pure a rivolgere; sin che finita di ridurre in schiuma.
INTORNO AL CAGLIO E ALL’AGRA
Vinc.: Come fate voi malghesi questo caggio? Scal.: Non lo facciamo altramente, ma lo pigliamo da gl’interiori de’ vitelli maschi, e femmine, il qual è tanto migliore, quanto che questi animali si trovano ben grassi, e 224 che l’abbiamo spiccato dalle budella, lo saliamo, e chiudiamo la pelle con uno stecco acuto ( come se fosse la borsa de’ testicoli) e poi l’attacchiamo sotto sotto al camino dove si fa fuoco, acciocchè venga secco. Vinc.: Vorrei saper ancor, à che modo fate l’agra, che voialtri adoperate nel fare, che’l fiorito divenga poina, o ricotta? Scal.: Ordinariamente abbiamo il vascello, del quale ogni giorno caviamo quell’agra che ci bisogna, e altrotanto brodo vi ritorniamo subito tolto fuori dalla caldara tutta la ricotta, acciocche ella non manchi mai. Ma se qualcuno ne vuol fare di novella, e massimamente in un vascello nuovo, lo piglia (per l’ordinario) d’una brenta: facendovi il buco donde si cava l’agra non appresso al fondo, ma alto da quello circa quattro dita, acciocchè vi resti la fece, e si cavi solamente quella, che fa di mestiero. Et però tolto il vascello concio (come ho detto) e posto dentro il detto brodo puro, e netto, vi si mette un pane di lievito rotto in più pezzi, e una man piena di sale, e anche delle ortiche; et a questo modo si fa l’agra perfetta in tre, o quattro giorni che non si guasta mai.
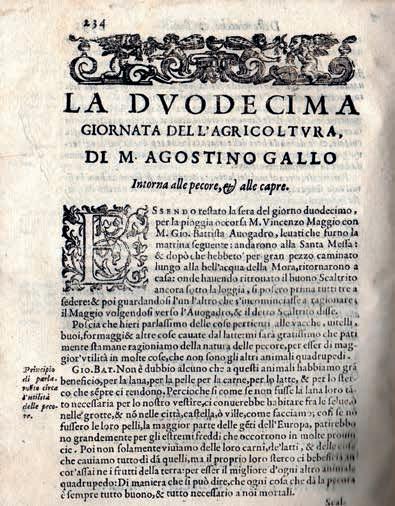

INTORNO AL LATTE DI CAPRA
Nelle pagine della “Duodecima Giornata” i discorsi girano “Intorno alla pecore e alle capre”: prima in merito all’utilità di allevare ovini, alle razze del territorio bresciano, alla gestione dei montoni, all’allattamento degli agnelli e quindi al latte di capra. Vinc.: Perché vi dissi innanzi desinare che il parlamento nostro sarebbe solamente intorno alle capre, però mi sarà grato che me ne ragionate quel tanto che ne sapete. Scal.: Ancora ch’io non abbia tenuto capre, da poi ch’io era giovane sotto alla obedientia di mio padre, nella villa di Agnosceno di Val di Sabbio, e ch’elle non rendano in tutto quella utilità di buon formaggio, e manco di lana come fanno le pecore, non di meno è cosa buona à tenerne, e massime ne i siti sterili, come sono i moti, i colli, le valli e le campagne deserte, perciò che danno maggior copia di latte, e migliore, e più sano che nò fanno le pecore, e anco la ricotta loro è più delicata. Et però si dice per proverbio. Butiro di vacca, formaggio di pecora, e ricotta di capra, sono i migliori frutti che rendono questi animali. Poi le capre sono di poca ispesa, conciòsia che nò si da loro fieno, se nò quando partoriscono,… Vinc.: Per quanto tempo si mungono le capre, e quanto latte possono dare al giorno? Scal.: Si mungono mesi quattro sin cinque; dando ordinariamente la mattina con la sera libbre tre, sin quattro di latte, il quale avanza (quanto a bontà e sanità) quello di vacca e di pecora. Vinc.: Non vuole à questo latte quel caggio istesso, e quell’agra che si adoperano à quel di vacca, e di pecora? Scal.: Certo è che non si farebbe il formaggio di capra senza buon caggio, ma non già con l’agra; perché non venirebbe buona la ricotta; e però à farla delicata, vi s’aggiunge altro tanto acqua, come si farebbe d’agra quando vi bisognasse.
Pala “La Carità di San Lucio”, Francesco Paglia ( 1636-1714 ), commissionata dal Paraticum Formaggiorum, associazione di mestiere, che ottenne l’altare da dedicare al proprio Santo nel 1675, Chiesa di San Giuseppe, Brescia [Foto Ed. La Scuola, Brescia]. La punta di formaggio in mano al Santo, potrebbe essere similare al formaggio prodotto dallo Scaltrito (2 pesi, ovvero 16 kg, scalzo 10-11 cm, diametro 45-46 cm)
IN CONCLUSIONE
In futuro il “malghese Scaltrito” sarà sostituito dal “casaro Scientrito”, che forse farà il formaggio con l’intelligenza artificiale e il metodo predittivo; ma intanto noi cerchiamo di essere più vicini al primo o al secondo?
Riferimenti bibliografici
Benzoni G., Dizionario Biografico degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1998. Fappani A., Enciclopedia Bresciana, Edizioni “La Voce del Popolo”, Brescia, 1991. Gallo A., Le vinti giornate dell’agricoltura, el de’ piaceri della villa, Appresso Domenico Imberti, Venezia, 1607.
Revisione del sistema delle IG
Nelle giornate del 25-26 novembre la Commissione Europea ha organizzato una conferenza con lo scopo di iniziare il processo di revisione del sistema delle Indicazioni Geografiche in riferimento alla strategia Farm to Fork. La revisione è prevista per la fine del 2021-inizio 2022 e si suddivide in quattro punti: • consolidamento; • attrattività; • sostenibilità; • importanza dei “Gruppi”/Consorzi.
La Commissione Europea ritiene che molti degli argomenti sostenuti da oriGIn EU contenuti nel rapporto OCM del Parlamento Europeo (Andrieu report), come ripartizione del valore e maggiore tutela, dovranno essere riconsiderati e non andrebbero inseriti nella riforma PAC in corso. Dal punto di vista della CE è troppo presto per introdurre tali elementi, dal momento che il settore IG deve essere consultato in modo approfondito e la Commissione deve effettuare uno studio d’impatto per valutare la necessità di una legislazione europea in questo campo. Commissione Europea ed EUIPO hanno colto l’occasione della conferenza per presentare il nuovo database delle IG denominato GIview, che fornisce informazioni dettagliate sulle Indicazioni Geografiche protette a livello UE, comprese quelle provenienti dai Paesi Terzi.


Farm to Fork: dal produttore al consumatore
al Parlamento Europeo è stato trovato un accordo fra COMAGRI (relatore Herbert Dorfmann) e COMENVI (relatrice Anja HAZEKAMP). È necessario, però, attendere i pareri di diverse altre commissioni parlamentari. Il calendario dei lavori è abbastanza lungo e prevede per il 25-26 gennaio 2021 un esame della bozza del testo AGRI-ENVI (oriGIn Eu ha inviato un proprio parere ai relatori); la scadenza per presentare gli emendamenti è il 28 gennaio, mentre il voto finale nelle commissioni congiunte AGRI-ENVI è previsto per fine aprile.

Accordo sul quadro finanziario pluriennale
Èstato raggiunto un accordo interistituzionale tra il QFP 2021-2027 e il NextGenerationEU (Recovery Fund Covid-19). Con un ammontare di 1.8 trilioni di euro sarà il più grande impegno mai finanziato dal bilancio UE. Per l’agricoltura, sarà accelerato lo stanziamento di 8.07 miliardi di euro di sussidi attraverso i programmi di sviluppo rurale. I negoziatori hanno convenuto di anticipare i pagamenti al 2021 e 2022, mentre la Commissione Europea aveva proposto un periodo fra il 2022 e il 2024. Circa il 30% degli 8.07 miliardi verrà dunque reso disponibile nel 2021 (2.4 miliardi), mentre i restanti 5.6 miliardi verranno resi disponibili nel 2022. Il 37% del fondo dovrebbe essere destinato ad agricoltura biologica, benessere animale, azioni ambientali e per il clima. Mentre almeno il 55% sarà destinato all’inserimento dei giovani agricoltori e agli investimenti nelle aziende agricole che contribuiscono ad azioni durature. Sarà accordata maggiore flessibilità agli Stati Membri per investire il restante 8% in azioni di sviluppo sostenibile.
Etichettatura d’origine per le carni
Nel mese di novembre è stato pubblicato lo Studio CE sull’etichettatura obbligatoria per alcune tipologie di carne, le cui conclusioni principali sono le seguenti: le norme UE sull’indicazione d’origine di alcuni tipi di carne si sono dimostrate affidabili e utili per i consumatori; non risulta che le normative abbiano avuto un impatto sugli scambi commerciali nel mercato unico, sebbene appaiano alcuni cambiamenti nei flussi per alcuni casi specifici. Monitorando il mercato si rileva un crescente interesse dei consumatori sulle informazioni relative all’origine della carne. Tali conclusioni riguardano anche le varie tipologie di tagli venduti nel settore Horeca/food service e dovrebbero superare le normative o le iniziative volontarie assunte in alcuni Stati Membri. La valutazione sull’etichettatura di origine per alcune tipologie di carni si concluderà con la pubblicazione di un rapporto della Commissione a inizio 2021.


Notizie dal mondo
Cina Dal 1 febbraio 2021 entra in vigore l’accordo sulle IG
Con l’adozione da parte del Consiglio Europeo, avvenuta il 23 novembre, dell’accordo bilaterale UE-Cina sulle IG, entreranno in vigore: • le nuove normative che prevedono la tutela di 200 denominazioni (100 UE e 100 cinesi); • la lista delle IG europee protette in Cina; • la lista delle IG cinesi protette nella UE.
USA Pubblicazione dei dazi doganali sulle esportazioni verso la UE
Nel quadro del contenzioso Airbus/Boeing, i ministri del commercio UE hanno autorizzato la CE a imporre dei dazi aggiuntivi sull’importazione di prodotti USA. Si tratta di dazi aggiuntivi del 15% sugli aerei e del 25% su di una serie di prodotti agricoli e industriali, quali, per esempio, vini e distillati, ketchup, cheddar, arachidi, cotone, patate. Il nuovo Commissario UE al commercio, il lettone Valdis Dombrovskis ha invitato gli USA affinché le due parti rinuncino con effetto immediato all’applicazione di tali dazi aggiuntivi all’import, in modo da porre fine al contenzioso. Dopo l’elezione di Joe Biden, la Commissione Europea spera anche nel miglioramento generale delle relazioni con gli USA.
Nuova Zelanda e Australia Accordi sulle IG
Sono stati completati 8 round negoziali. Al termine dei quali permangono ancora controversie su alcune denominazioni IG, per prodotti quali formaggi e vini. Le discussioni sono inerenti anche al testo generale di un accordo per le Indicazioni Geografiche, che dipenderà probabilmenti sui temi di accesso al mercato, soprattutto per i lattiero-caseari. I negoziati continueranno di certo anche nel 2021.
Un nuovo piano per la proprietà intellettuale
Su indicazione del Consiglio dei Ministri UE, la Commissione ha presentato delle proposte sulla evoluzione della politica UE in materia di proprietà intellettuale. Questo “piano d’azione” mira a permettere alle imprese europee di rimanere fra i leader mondiali. In particolare vengono definite delle misure chiave per migliorare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, diffonderne la conoscenza e l’uso da parte delle piccole e medie imprese, lottare contro le imitazioni e contraffazioni, promuovere le condizioni di equa concorrenza a livello mondiale. Il piano mira a rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche agricole, valutando nel contempo la fattibilità di un sistema di protezione delle IG per i prodotti non agricoli a livello europeo. La Commissione avvia inoltre un dialogo con l’industria sull’impatto delle nuove tecnologie (quali IA e blockchain) sul sistema della proprietà intellettuale. Per garantire che le imprese abbiano accesso a strumenti di protezione rapidi, efficaci e a prezzi accessibili, riducendo così la frammentazione e la complessità persistenti dell’attuale sistema. Il piano d’azione invita gli Stati membri a introdurre rapidamente il sistema brevettuale unitario al fine di creare uno sportello unico per la protezione e l’applicazione dei brevetti in tutta l’UE. La CE renderà inoltre più energica la risposta dell’UE alle pratiche sleali, come lo spionaggio industriale o i tentativi di appropriazione indebita della PI nel contesto della cooperazione in materia di R&S.

Etichettatura nutrizionale
il Consiglio dei Ministri Agricoli ha adottato le conclusioni della presidenza tedesca, ma con l’opposizione di Italia, Grecia e Repubblica Ceca. Molto dura la presa di posizione dell’ex Ministro Teresa Bellanova, che si è opposta con veemenza alla proposta di una etichettatura nutrizionale definita come una “classificazione semplicistica” rappresentata da codici colore applicati a indicazioni nutrizionali. Il Ministro greco ha obiettato che il testo della Presidenza non esclude dalla Front of pack nutrition labelling (FOPNL) i prodotti di alta qualità come le Indicazioni Geografiche ottenuti con metodi tradizionali che non possono essere riformulati. Anche per la delegazione Ceca la proposta è troppo semplicistica, mentre occorre maggiore educazione e accrescere le conoscenze dei consumatori sul valore nutrizionale di certi alimenti. Il dibattito è molto acceso anche in ambito produttivo industriale. Per qualcuno, la Front of pack nutrition labelling potrebbe diventare uno stratagemma per finalità di marketing.

Con il supporto incondizionato di

SAVE THE DATE
L I V E W E B I N A R
8 aprile dalle ore 16.30 alle 18:00
Colture starter per il settore lattiero-caseario
Introduzione a cura di Vincenzo Bozzetti
Direttore tecnico di Scienza e Tecnica Lattiero-Casearia
Relatore Prof. Vittorio Zambrini
Professore a contratto, Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza
P ar L ere M o D i :
generalità sugli innesti batterici e sui batteri lattici colture acidificanti colture ancillari colture probiotiche
PreNoTa
IL TUO POSTO




