
19 minute read
MEDICA187
le alterazioni palolop:iche del reumatismo articolare cronico sono un prodotto di questi germi.
I bacilli sono corti, grossi, con uno strozzamento centrale poco profonJo e due corpuscoli polari. Si colorano bene coi comuni colot·i Ji anilina e si :!ecolorano anche facilm ente; nel m'glior modo si colorano con la fucsina carbolica. Le colture ~i sviluppano bene alla temperatura dì 20° C., devono però. essere mollo riparate dalla luce e son o assai durevoli; anc he dopo 10-12 mesi le co!lul'e secche sono inoculabili.
Advertisement
THORNER. - Sull'uso della. t u bercolin a. i n casi avanza ti d i tube rc olos i. - (Cenrralblatt fùr Bakteriologie uncl Par:isitenk u ncle, voi. XIV, N. 18, 1893). (Sunto di Kiibler di Berlino) .
Il relatore è di parere che la tubercolina, Jopo le prime entusiastiche accoglienw e i buoni risultati riferiti, sia caduta in clis~redito per l'applicazione inesatta che molte volte alcuni medici ne hanno fatto. Egli stesso reputa sempre la tubercolina anche ora un rimedio molto efficace e nella tubercolosi incipiente con l'uso di essa ha osservllto nella sua pratica, sospensione di tutti i fenomeni morbosi, anche nel polmone, cessazione della tosse, dell'espettorato, scomparsa dei bacilli . aumento grandissimo di forze, miglioramento dell'aspetto e grande aumento del peso del corpo. Se il rimedio e usato nei casi avanzati, allora non ne segue più la guarigione della malattia, ma la sospensione d~ll'emottisi; cessano o diminuiscono assai la tosse e l'espettorato, i sudori notturni e la febbre etica. Le tube r colosi della laringe migliorano in modo e$senziale.
Nell'uso della tubercolina il relatore si regola in questo modo: le inoculazioni hanno principio con dose di 1/i. di milligl'ammo ed ogn i 48 ore questa dose è aumentata di un ventesimo di milligrammo. Dopo tre settimane di cura, se il malato è giunto alla dose di 1/1 milligrammo, allora le dosi nelle
Rivista I
5 inoculazioni successive sono aumentate ogni volta di , · di ·11· . 10 m1 1grammo d1 modo che il malato dopo circa 4 settimane ne riceve un milligrammo. Se la febbre non é ancora cessata, allora la dose é aumentata; in certi casi la dose é aumentata di f/, milligrammo (allora ogni sett.imana n0n si fanno che due iuiezioni), finché dopo una cura di 9 1/i settimane la dose giunge a 5 milligrammi. In modo analogo il rdaLore aumenta la dose sino a 5 centigrammi, se duranl'3 il decorso della malattia non avvengono considerevoli disturbi. Se invectl durante la cura s i manifestano grande inappetenza, anemia 0 febbre, allora la tubercolina é sospesa o per lo mèno non aumentata nella sua dose.
C.S. ..
HowARD. - Endocardite ulcerativa acuta prodotta dal bacillo dlfter~co. - (Sunto di Escherich - Centralblatt fiir Bakteriologie und Parasitenkunde, volume XIV, ~.19, 1893).
U~ lavoratore di 44 ~nni, già sano, a mmalò con brivido, vom~to, debolezza e palpitazione di Cjorc e sette giorni dopo entro all'ospedale. Durante i 17 giorni, in cui egli rimase là in cura, ebbe febbre irregolare, il pÒJso in principio era assai pieno, 90 pulsazioni al minuto, in appre$so divenne debole e frequente . L ' infer mo morì in collasso.
All'autopsia si trovò il cuore dila tato. Il miocardio duro piuttosto pallido. La va lvola mitrale, veduta dall'alto, era cn~ perta d~ un tromb? voluminoso bianco rossastro, della spessezza d1 0,2, 1 cm., 11 quale comio c iava alla base della valvola la cuopriva del tutto ed aderiva fortemente ad essa. Sulla su: perficie inferiore della valva posteriore si trovarono solamente piccole ulceri, le quali erano pure coperte con eguali masse fibrinose. I:'endocardio delle valve, dopo allontana·te le masse del trombo. appariva ruvido, ulcerato, sparso di emorrag·e. Inoltre sulle superficie ventricolari delle valvole ao r tiche si trovavano alcune vegetazioni simili . II fegato ,fra grosso ed iperemico, la milza molto ingrossata e disseminata
~IEDICA
d' infarti. In ambedue i reni sì scorgevano i segni di un11 nefrite àcula e nello stesso tempo numerosi infarti. Nei pr~parati batterioscopici fatti tanto con la massa del fro-mbo, quanto <.:On Ja sostanza della mi lza e dei reni si trovaron0 i bacilli difterici Gli stess1 bacilli, in coltura pura, si ottennero dal polmone, dal fegato, dalla milza, dai reni e dai tessuti della valvola mitrale.
Le colture ottenute rassomigliavano in tutto a quelle del bacillo della difterite, ma non erano patogene per le cavie e i conigli.
Le sezioni microscopiche della val vola malata dimostrarono, che là, ove aveva sede il trombo, le fibre mu::;colari erano d ~generate, l'epitelio mancava ed esisteva reazione infiamma toria del tessuto. Il processo infiammativo in alcuni luoghi era progredito sino alla formazione di focolai purulenti. La superficie era costituita da un essudato fibrinoso, in cui erano contenuti bacilli in numero considerevole. Il trombo era costituito da pt.recchi strati; sulla superficie, uno strato spesso, formato esclusivamente di ba cilli, quindi uno strato di fibrina, povero di cellule e disseminato di cumuli di bacilli disposti a nastri.
Il prof. \Velch è di avviso, che in ' questo caso, nonost~nte Ja mancanza di virulenza, si tratti del vero bacillo di Loeffier e che questo sia il primo esempio di pura endocardite difterica.
c. s.
ROTHMANN - Snll'enterltb membra.na.cea. - (Berliner klinisc/1(3 Wochenschrift,. N. 49, 1893).
La conoscenza dell'enteritis membranacea di frequente osservata, nella quale masse membranose sono emesse con le deiezioni, è stata fino a.d ora incompleta, poichè, per cagione della natura lieve della malattia, non fu possibile intraprendere esatte ricerche analomo- patologiche. Soltanto Corni! nella pseudo enterite del porco, malattia affine all'enterite membranosa, trovò i cosiddetti tappi tìbrinosi negli otricoli glandolari e nelle cellule ulricolari. Il relatore in ·un , caso di cancro della base del cranio, combinato con eriterite rne~branosa riuscì a studiare istolog'icamente questa malatt.ia . Per mezzo della colorazione d~I \':eigert ed anche meglio deUa colorazione con la tionina di Ehrlich Hoyer, che colora in modo specifico il muco, ottenne colorazioni doppie, dalle quali fu possibile riconoscere la presenza di grosse masse di muco irnlla superficie dell'intestino grosso, 'negli stessi otricoli glandolari ed anche nelle c ellu le glandolari.
Conclusioni. - i. L'enteritis membranacea o megJio colica mucosa (Nothnagel) é una malattia del colon.
2. Essa é costitui4). da un'aumentata secrezione delle cellule glandolari in seguito a durevole costipazione .
3. La leggera infiammazione. della mucosa è da considerare come secondaria.
4. Le ::nasse secrete sono formate da muco.
Roux e VAJLLA.RO. - Contribuzione a.Ilo studio del tetano.
- (A nnal <: s de l' fnstitut Pasteur, fascicolo 2', 1893).
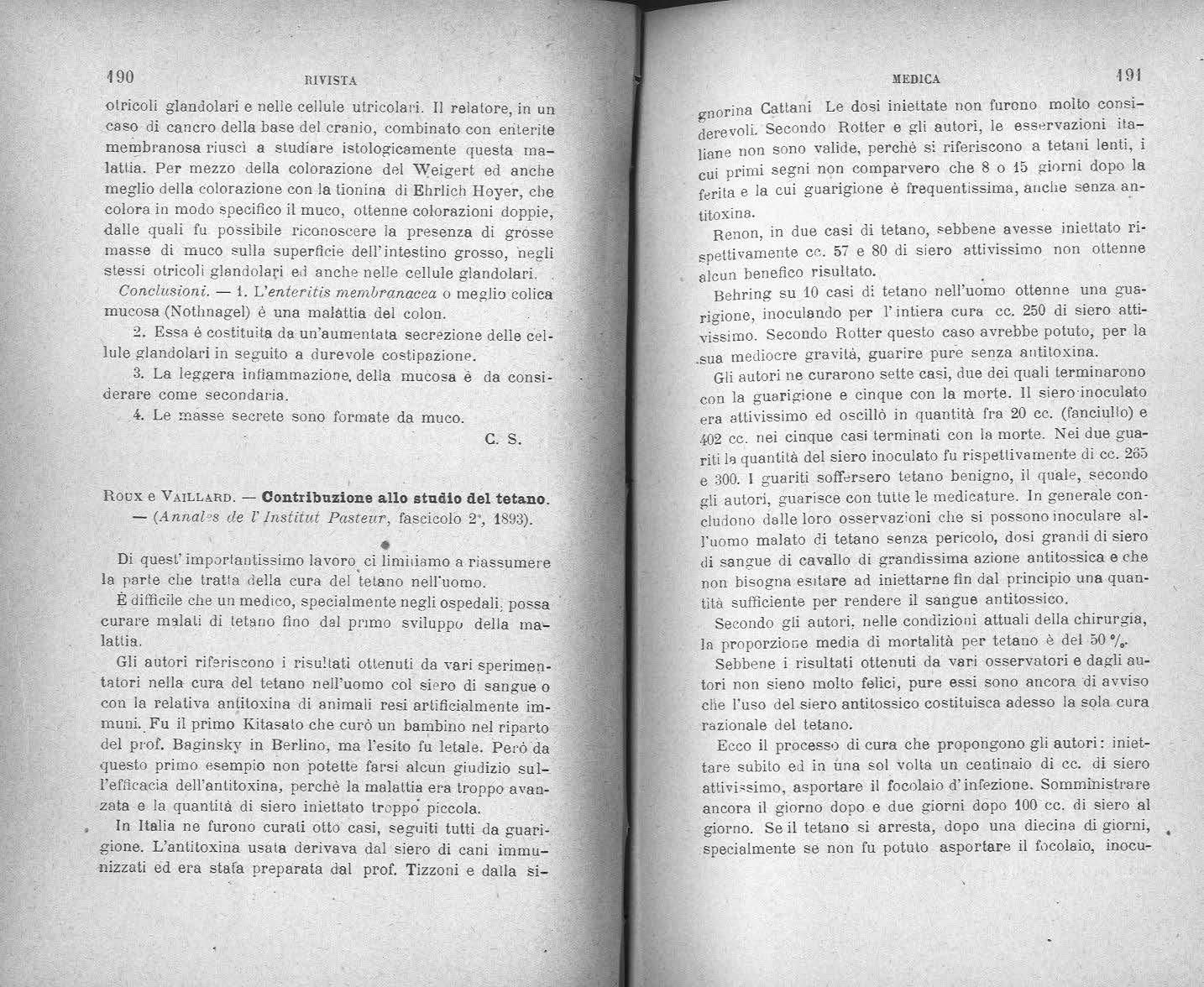
Di quesl' imp.::>rlantissimo lavoro ci Jimi,iamo a riassumere la parte che tratta della cura del 'teta no nell'uomo. difficile che un medico, specialmente negli ospedali ; possa curare malati di tet~no fino dal primo sviluppc, della malattia.
Gli autori rif9riscono i risultati ottenuti da Yari sperirneptatori nella cura del tetano nell'uomo col siero di sangue o con la relativa an(itoxina di animali resi artificialmente immuni.. Fu il primo Kitasalo che curò un bambino nel riparto del prof. Baginsky in Berlino, ma l'esito fu letale. Però da questo primo esempio non potette farsi alcun giudizio su ll'efficacia dell'anlitoxina, perchè la malattia era troppo avanzata e ]a quantità di siero iniettato troppo piccola.
In Italia ne fu ro no curali otto casi, seguiti tulti da gua r igione. L'antitoxina usala derivava dal siero di cani immunizzati ed era stafa preparata dal prof. T izzoni e dalla si-
MEDICA •191
oorina Cattani Le dosi in iettate non furono rnoito consi:erevoli. Secondo Rotter e gli autori, le esservazi?ni i~a -: liane non sono valide, perché si riferiscono a tetani lenti, 1 cui primi segni non comparvero che 8 o i5 l!i0rni dopo la ferita e la cui guarigione è frequ ent issima, auche senza a.ntitoxiua.
Renon, in due casi di tetano, ~ebbene avesse iniettato rispettivamente cc. 57 e 80 di siero attivis!.'imo non ottenn e alcun benefico risnllato. ·
Behring su 10 casi d: tetano nell'uomo ottenne una gu arigione, inoculando per l' intiera cura cc. 250 di siero attivLssimo. Secondo Rotter questo caso avrebbe potuto, per la .sua mediocre gravità, guarire pure senza a11tiloxina.
Gli autori ne curarono sette casi, due dei quali terminarono con Ja guari~ione e cinque con la morte . Il siero ·inoculato e ra altivissimo ed oscillò in quantità fra 20 cc. (fanciullo) e 402 cc. nei cinqu e casi terminati con la morte. Nei due guariti 1~ quantità del siero inoculato fu rispettivamente di cc. 265 e 300. I guariti sofl'tirsero tetano benigno, il quale, !:'econdo gli autori, guarisce con tutte le medicature In generale con· eludono dalle loro osservazioni che si possono inoculare all'uomo malato di tetano senza pericolo, dosi grand i di siero ~ <l i sangue di cavallo di grandissima azione antitossica e eh.e non bisogna esitare ad ini ettarne fin dal principio una quantità sufficiente per rendere il sangue antitossico.
Secondo gli autori, nelle condizioni attuali della chirurgia, In proporzior.e media di mortalità per tetano è del 50 o;..
Sebbene i risultati ottenuti da vari osservatori e dagli autori non sieoo mollo felici, pur e essi sono ancora di avviso clie l'uso del si ero antitossico costituisca adesso la sola cura razionale del tetano.
Ecco il process•) di cur a che propongono gli autori: iniettare subilo ed in i.ma sol volta un centinaio di cc. di siero atlivi,:sirno, aspo r tare il focolaio d'infezione. Somministrare ancora il giorno dopo e due giorni dopo 100 cc. di siero a l giorno. Se il tetano si arresta, dopo una diecina di giorni, specialmente se non fu potuto asportare il focolaio, inocu-
RIVISTA lare ancora del siero per prevenire il ritorno possibile del tetano. c. s.
Gli autori da ultimo emettono il parere che sarebbe utilissimo, specialmente, in circostanze di guerra, d'iniettare l'antitoxina in casi di lesioni sospette a solo scopo preventivo. In questi casi, il rimedio è efficacissimo e non ne occorrono che piccole dosi per ottenere l'intento.
RIVIS TA CHlR URGIC A
Gli aneurismi dlflusl complicanti le fratture della gamba.. - MouRRET. - (Journal de· médecine et de chirf!,rgie, agosto, 1893).
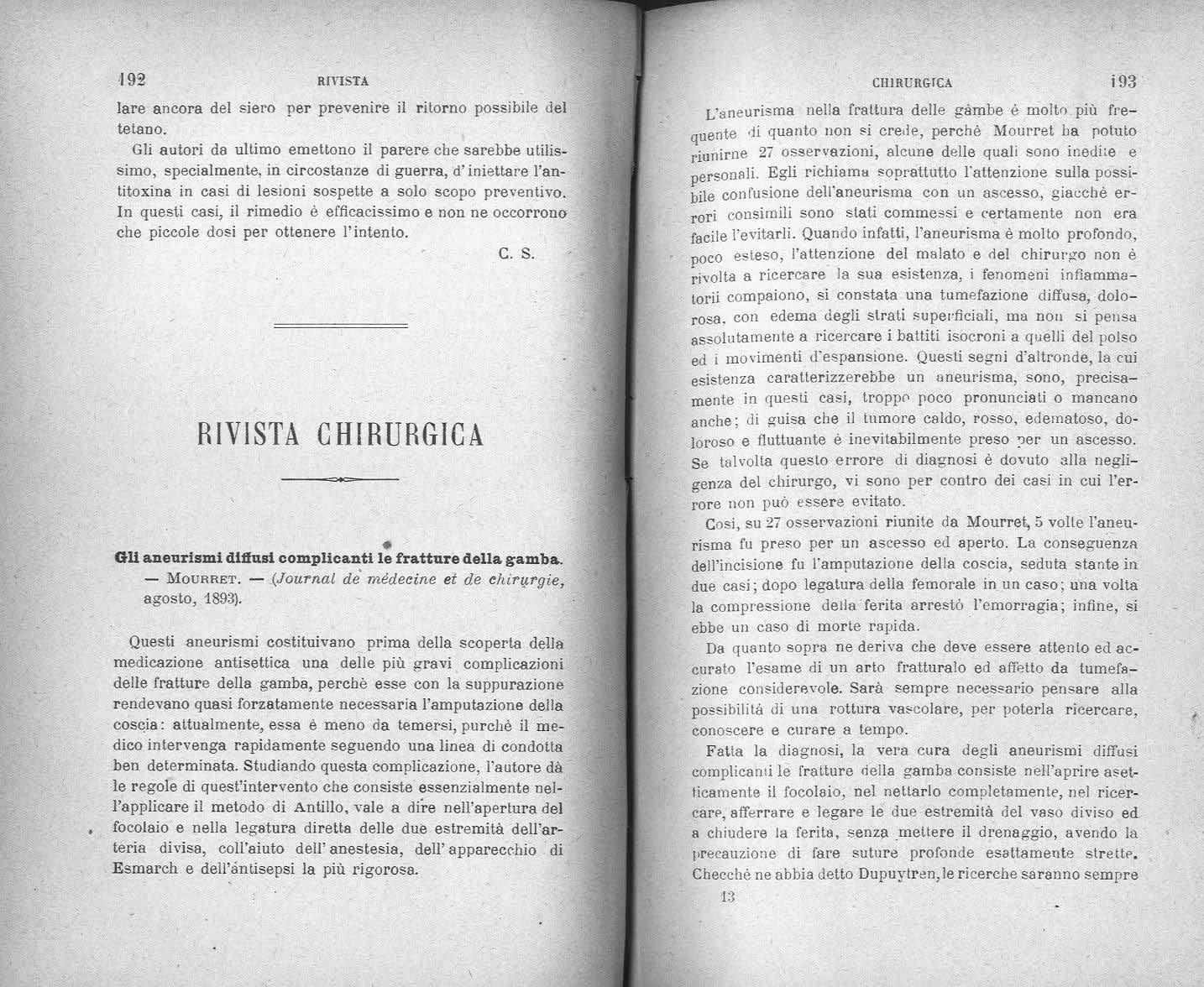
Questi aneurismi costituivano prima della scoperta della medicazione antisettica una delle più gravi complicazioni delle fratture della gamba, perché esse con la suppurazione rendevano quasi forzatamente necessaria l'amputaz ione de lla cos<;ia: attualmente, essa è meno da temersi, purché il medico intervenga rapidamente seguendo una linea di condotta ben determinata. Studiando questa complicazione, l'autore dà le r egole di quest'intervento che consiste essenzialmente nell'applicare il metodo di Antillo, vale a dire nell'aper tu r a del focolaio e nella legatura diretta delle due estremità dell'a rteria divisa, coll'aiuto dell'anes tesia, dell' appa r ecc.hio di Esmarch e dell'antis eps i la più rigorosa.
CHIRURGTCA i93
L'aneurisma nella frattura delle gambe è molti) più freuente di quanto non $i crede, perché Mourret ba rotulo ~iunirne 27 osservazioni, alcune delle quali sono inedite e ersonali. Egli richiarn~ soprattutto l'attenzione sulla possi~ile confw:;ione dell'aneurisma con un ascesso, giacchè errori consimili sono stati commessi e certamente non era facile !"evitarli. Quando infatti, l'aneurisma è molto profondo, poco esteso, l'attenzione del_ malato _e <lei chi~u'.'1<0 non è rivolta a ricercare la sua esistenza, 1 fenomem 1nfiammatorii compaiono, si constata una tumefazione diffusa, dolorosa. con edema degli strati superficiali, ma 0011 si pensa assolutamente a ricerca r e i battiti isocroni a quelli del polso ed i movimenti d"espansione. Questi segni d'altronde, la cui esisten za caratterizzerebbe un aneurisma, sono, precisamente in questi casi, tropp0 poco pronunciati o mancano anche; di guisa che il tumore caldo, rosso, edematoso, doloroso e fluttuante è inevitabil mente preso ::ier un ascesso. se talvolta questo errore di diagnosi è dovuto alla negligenza del chirurgo, vi sono per contro dei casi in cui l'errore non può essere eYitato.
Cosi, su 27 osservazioni riunite da Mourret, 5 volle l'aneur isma fu preso per un ascesso ed aperto . La conseguenza dell'incisione fu l'amputazione della coscia, seduta stante in due casi; dopo legatura della femorale in un caso; una volta la compressione della· ferita a r restò l'emorragia; infine, si ebbe un caso di morte rapida.
Da quanto sopra ne deriva che deve essere attento ed ac• curato l'esame di un a r to fratturalo ed affl'llto da tumefazione consid erflYole. Sarà sempre neces$ario pensare alla possibilita di una rottura va~colare, per poterla ricercare, conoscere e curare a tempo.
Fatta la diagnosi, la vera cura degli aneurismi diffusi com plicami le fratture della gamba consiste nell'aprire asetticamente il focolaio, nel nettarlo completamente, nel ricercarE>, afferrare e legare le due estremità del vaso diviso ed a chiudere la ferita, senz!l _meltere il drenaggio, avendo la precauzione di fare suture profonde esattamente stretti> , Checchè ne abbia detto Dupuylren,Ie ricerche saranno sempre 1:3 abbastanza facili per un chirurgo alquanto esperto nell'anatomia, e tanto più facili quanto più esse SAranno fatte subilo dopo l'accidente. Sussiste, è vero, quest"obbiezione: non si hanno mai dati certi sull'arteria ferita. Ma si può rispondere che in generale, la sede esatta non è necessaria; basta conoscere se l'aneurisma si è for mato nella loggia anteriore o nella loggia posteriore della gamba, e ciò è in generale abbastanz& facile ad essere ric~nosciuto, la sede dell a raccolta l'indica. E se, per caso, come in un'osservazione c itata da Mourret, esistono due raccolte, la più grande deve corrispondere alla r egione dell'arteria ferita.
Se l'aneurisma è anteriore, si dovrà legare l'arteria tibiale anteriore. Se è posteriore, fa1·à d'uopo fa re le ricerche, sia sull'arteria peronea, sia sul tronco tibio- peroneo, sia infine sulla tibiale posteriore, ed, in quest'ultimo caso, l'assenza o l'indebolimento dei battiti dietro il malleolo interno indicheranno una ferita -di questo vaso.
Di guisà che oggidì si può nel modo seguente formulare il trattamento degli aneurismi complicanti le fratture della gamba: incidere il focolaio, ricercare l'arteria ferita, torcerla o legarla, e chiudere la ferita in modo da s0pprimere qualun'lue cavità, per piccola che sia, a4,ondizione di adoperare la più rigorosa asepsi.
La legatura col metodo di Anelio-Hunter e l'amputazione devo110 riservar~ i ai casi, in cui qualche grave complicazione (:rnppu razione, gangrena) rende la legatura delle due estremità inutile ed impossibi le.
CHIRl:RGICA
.snni fa, aveva contralto sifilide, gli fu prescritto l'joduro di potassio . Al !:'econdo esame si ottenne lo stesso risultato. 11 relatore pensò che qu~lla roas~a fosse un proiettile, e ,d i fatt o, doµo essersene bene accertato, lo estrasse. . Dopo l'operazione il relatore potette osservare, da c1ca-t ice ancora esistente, che il proiettile era disceso dal cer• ::elio nel naso . 11 malato non presentava sensibili disturbi motori o psichici.
F. ÙPPENHEn!ER. - Estrazione di un proiettile dalla. oa.vltà. n asal e. - (Berliner klinische Wochensehrift, num ero 1, 1893).
L'auto re estras;:;e dal na~o un proiettile ad un paziente, che 12 anni prima aveva c0rso pericolo di vita per un colpo d'arma da fuoco sul capo. Il malato si latrÌentàva di una secrezione fetidissima del naso. All'esame diretto si riscontrò una massa grigio verdastra, friabile. Poiché il paziente, 12
Si ritiene comunemente che la terminazione dei casi veri ,di rottura splenica sia costantemente la mortf:. una sola con.dizione potrebbe motivare un pronostico non assolutamente ,mortale, cioé la preseilza di aderenze perispleniche capaci -<li impedire lo spandimento del ssngue nel peritoneo. Que~to f!iudizio del Collin dato più <li rruarant'anni fà non venne ancora mod ificato: lo spoglio delle letterature mediche dei vAri paesi dà un numero abbastanza considerevole di casi, .quasi tutti colla medesima terminazione fatale; appena si tro-vano alcune osservazioni date come casi di guarigione e an.eora nessuna ammessibile alla critica come caso di indiscu-tibi\e lacerazione splenica .
Un esame delle statistiche pubblicate su questa lesione mostra la propo rzione enorme della mortalità , qua si cost.ante: ,i casi di guarigione sono pochissimi, e giova r ipeterlo, non tutti indiscutibili; asserzioni provate dalrautore colle rela.ziooi dimostrative di parecchi dei casi indicati di cui una personale.
Ma devesi assolutamente ammettere che la guàrigione co~tituisca un esit~ tanto eccezionale nelle lacerazioni .della milza?. Alcuni dei fatti citati mostrano la guarigio11-e possibile e specialmente l'osservazione dell'autore in cui, eon ipertrofia splenica i,i un individuo ajfetio da cachessia mala rica si el.Jbe rottura del oisce re in seguito a una caduta .. sopraooioenza con uno spandimento sanguiyno considereoole nell'addome, laparotomia consecutioa e guarigione .
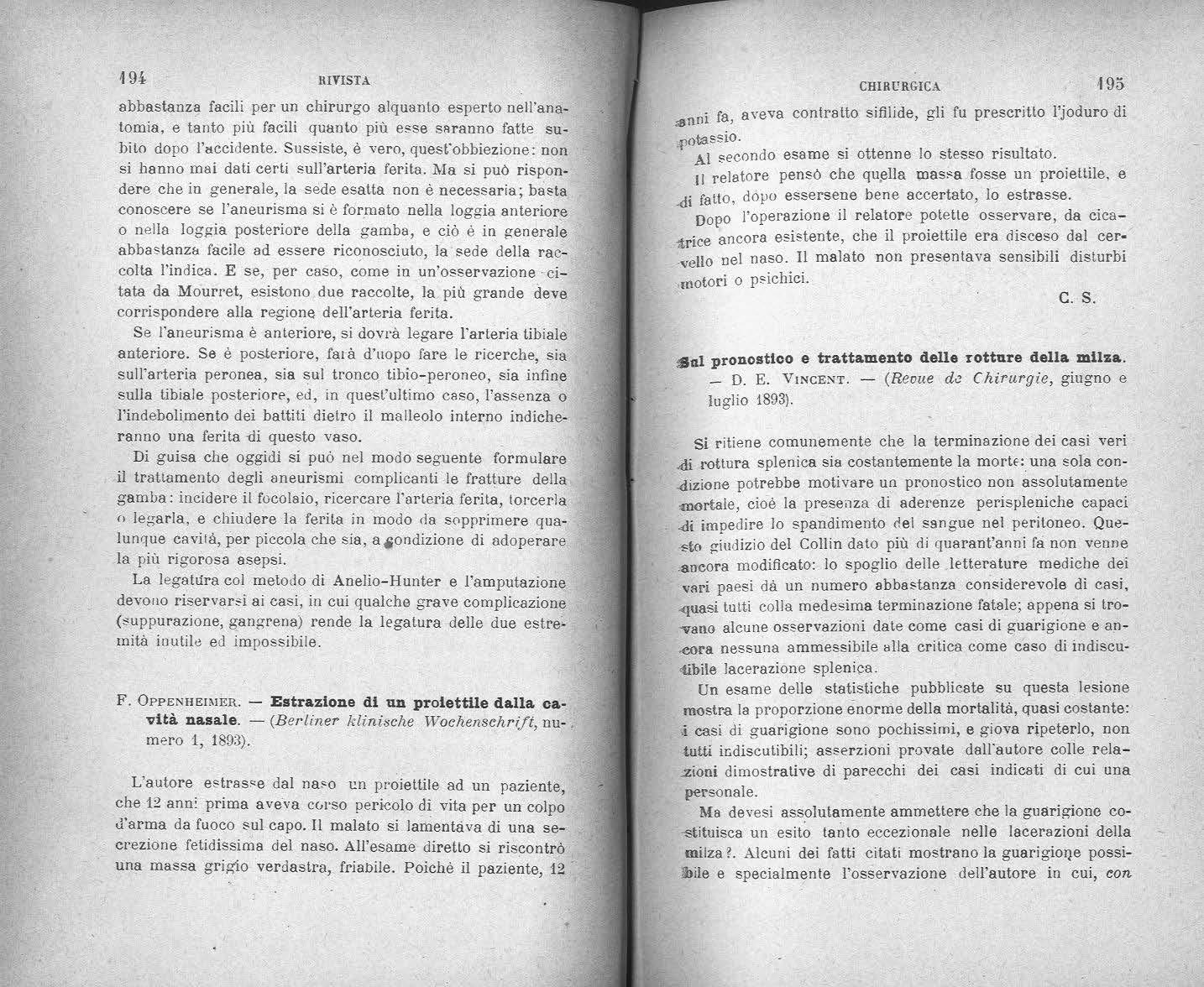
In alcuni cttsi di guarigione si po;,e in dubbio la realtà della lacerazione splenica: tale in certezza dipende da ciò che· la diagnosi è difficile assai a stabilirsi sul vivo, e non si ritiene µer certo il fatto che allorquando è reso evide_nte all'autopsia. Da ciò ne deriva la conseguenza che dei casi di lacerazione della m1b:a seguiti da guarigione possono rima-nere sconosciuti perché non venne fatta la diagnosi di questa lesione Con parecchie osservazioni i·iportate o riassun te da var:i autori e specialmente df'.l Collin viene d imo~:trata la possibilità di rotture superficiali della milza assai leggiere., senza lacerazione di grossi vasi, senza grandi spandimenti sanguigni, limitate alla sola capsuta, perfino senza emorragia.
Nelle rotture superficiali si forma e si depone alla loro superficie un essudato di linfa plastica che contribuisce ad arrestare lo scolo sanguigno ed a produrre il_ lavoro di cicatrizzazione : ma anche nelle lacerazioni più profonde si conslalaoo modifkazioui curatrici.analoghe, la formazio ne· di coaguli fibrinosi resistenti, in via di organizzarsi, qualol'a la sopravivveoza sia sufficiente a permetterne lo sviluppo~ Con un altro meccanismo può ancora prodursi l'emostasia io queste rotture, a condizione che la quantità di sangue· versato nel peritoneo non ~ia così forte da produrr e rapidamente la morte, e sarebbe l'interposizione fra le labbra della lacerazione, di una piega di épiploon che vi si applichi come un , turacciolo e vi contragga aderenze: anche q uesta eventualità vien dimostrata possibile da qualche or:;servazione, di fatti constatati.
Per .quanto poco numerosi i falli constatati di rotture spleniche suscettibili di guarigione, pure e;sistono e sono innegabili e l'autore a confermare meglio la sua tesi riferisce un'altra storia personale di un caso di lapa r otomia praticata per errore di _diagnosi, ed in cui prodotta accidentalmenteuna lacerazione della milza enormemente ipel'trofica .presa
CHlRURGICA -197
d operata per una cisti ovarica, ottenne non solo la cica.e · zazione della lacerazione, ma anche la scomparsa del trJZ · · d. more splenico in seguito all'intervento. La spanz1one 1 ,,u . . -taluni neoplasm i in seguito all'apertura del ventre e .oggi bene conosciuta, ma è ))ur sempre un fenomeno che eccita la sorpresa e che non riceve finora spiegazione.
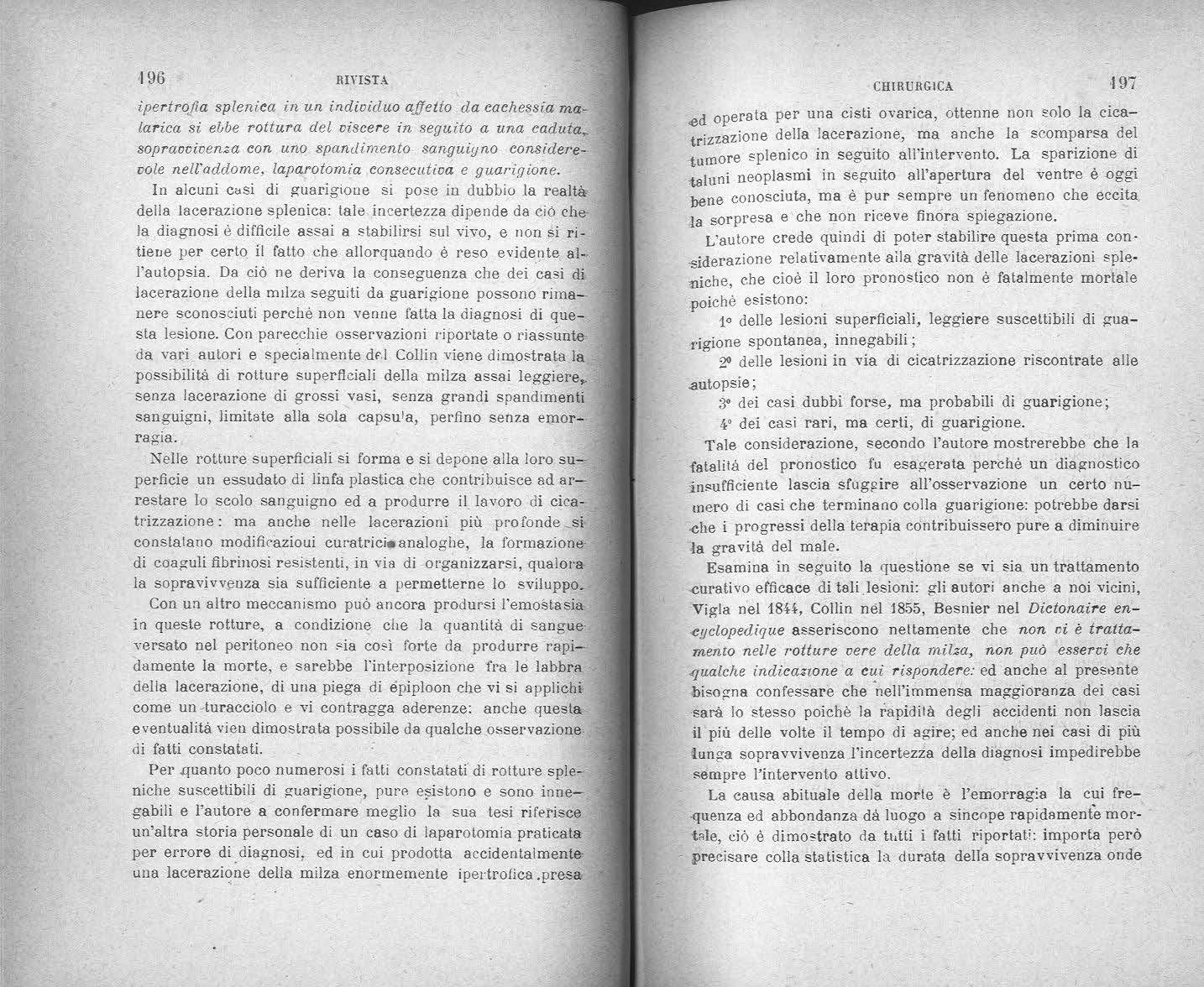
L'autore crede quindi di poter stabilire questa prima con· -siderazione relativamente aìla gravità deJle lacerazioni spie· niche, che cioè il loro pronostico non è fatalmente mortale poiché esistono:
10 delle lesiorii superficiali, leggiere suscettibili di guarigione spontanea, innegabili;
20 delle lesioni in via di cicatrizzazione riscontrate alle .autopsie;
3° dei casi dubbi forse, ma probabili di guarigione;
4° dei casi rari, ma certi, di guarigione.
Tale considerazione, secondo l'autore mostrerebbe che la fatalità del pronostico fu esagerata perché un diai;rnostico :insufficiente lascia sfuggire all'osservazione un certo numero di casi che terminano colla guarigione: potrebbe darsi -che i progressi della terapia contribuissero pure a diminuire la gravità del male.
Esamina in seguito la questione se vi sia un trattamento -curativo efficace di tali)esioni: gli autori anche a noi vicini, Vigla nel 18H, Collio nel 1855, Besnier nel Dictonaire en~uclopedique asseriscono nettamente che non ni è trattamenco nelle ,·alture oere della milza, non può esseroi che .qualche indit:azwne a c~i rispondere: ed anche al pres~nte bisogna confessare èhe nell'immensa maggioranza dei casi sarà lo stesso poiché la rapidità degli accidenti non lascia il piu delle volte il tempo di agire; ed anche nei casi di più lunga sopravvivenza l'incertezza della diagnosi impedirebbe ~empre l'intervento allivo.
La causa abituale della morie è l'emorragia la cui fre.quenza ed abbondanza dà luogo a sincope rap ida mente mort;ile, ciò è dimos trato da h,tti i fatti riportati: importa però precisare colla statistica la durata della sopravvivenza onde stabilire se essa sia abbastanza lunga da permettere l'intervento. Sopra 77 casi di rottura della milza, con' indicazionedella sopravvivenza, si hanno 41 malati vissuti al massimodue ore; il 54 p. cento; 17, vissero da 2 a 2i ore, il 22 p. cento, e 19, cioè il 24- per cento sopravvissero oltre le 24 ore..
Queste cifre dimostrano in qual ristretto numero di casi sia possibile l'intervento, notando ancora che pure in questo ristretto numero le difficoltà della diagnosi si aggiungono a ridurlo sempre più a proporzioni esigue.
Parec<!hi processi razionali esistono per combattere gli; accidenti che si determinan0 in seguito alle lacerazioni spleniche: nei casi seguiti da peritonite il trattamento non djfferenzia da quello delle peritoniti, larga apertura, e lavatura, con o sen1.a drenaggi0 della sierosa: negli spandimenti sanguigni si può usare per l'emostasia la compressione generale dell'addome, e la laparotomia che permette di agire direttamente sul. focolaio della rottura, seguita o non dallasplenecLomia: tutti mezzi però che dobbiamo riconoscere non fondali che su indicazioni teoriche, ma il cui valore non èdimostrato da documenti.
La compressione contribuisce nel favorire l'emostasi accrescendo la tensione della cavi~ addominale. Masler propose d'injettare parecchi litri d'acqua fredda nel co.lon nella speranza di comprimere la milza dai basso in alto, ma il liquido injeU.ato non resterebbe nel grpsso intestino ma supererebbe la valvola ileo-cecale, e se anche vi r1manesse, sarebbe impossibile distendere l'intestino ad un grado tale da poter comprimera la milza. L'autore propone di fare Ja, compressione elastica e forte su tutta la parete addominale·anteriore mediante varii r,trati di cotone e fasciatura molto, tesa,. senza produrre scosse per non aumentare le lacerazioni, e facilitata da preventiva injezione di morfina all'ipocondrio sinistro. Questo processo dovrebbe essere sovratutto efficace nelle rotture di milze ipertrofiche senza rammollimento troppo accentualo. ,
La laparotomia pare dovrebbe essere il trattamento indicato per frenare le emorragie spleniche, ma di fatto rara-
Chirurgica 199
onte si potrà ap.plicare e non costituirà che il primo tempo : una operazione, il cui secondo tempo consisterà o nella mpressione diretta colla garsa jodoformica, o nella sutura d .. tt· d · maro'ini della lacerazione, nella a.llacciatura t>I vasi ro 1, o , nella cauterizzazione col termo-cauterio, o ne"la splenectomia.
La compressione diretta non è fattibile che ,nelle lacera·oni della faccia C'onvessa di grosse milze e pare in tali casi Zl bb' ossa riuscire, come fu efficace a Dalloo, Micheaux e La e pn casi analoghi di lacerazioni o ferite del fegato. I • . • Poco affidamento dovrà farsi sulla sutura dei margini, er la poco resistenza del tessuto splenico che si lascia la~erare dai fili, massime se già alterato, eccetlcchè si trattasse di milze scler0sale, con capsula ispessita da perispleniti pregresse.
L'allacciatura dei vasi non sarà applicabile che nella rottura di grosse vene snperficiali; ma allora il sangue ne sorte con tanta rapidità che sopraggiunge la morte prima che s1 abbia il tempo d'intervenire.
For:.:e la cauterizzazione col termo- cauterio sarebbe più efficace, almeno su lacerazioni superficiali e ristrette ed in una milza sana; di effetto più dubbio in milze alterate.
La splenectomia è il vero mezzo radicale per soppr~mer~ l'emorragia, ma anche questa potrà raramente pralicars1 p ~r molteplici condizioni sfavorevoli : l'ind_eboli~ento rapido ed eccessivo delle forze pel' l'emorragia; li cattivo slato generale per cachessia palustre dell'infermo; l'abituale ipertrofia cospicua di tali milze che complica per se stessa n~tevolmente la loro operaziune. I casi in cui la splenectomia sarà più indicala sono quelli di rotture traumaliche di milze sane e normali io persone sane, e allora, se praticata abbastanza in tempo essa darà buoni risultati. Ma della splenectomia come degli altri processi non dobbiamo farci troppe illusioni: il loro campo d'applicazione sarà sempre molto ristretto e limitato.
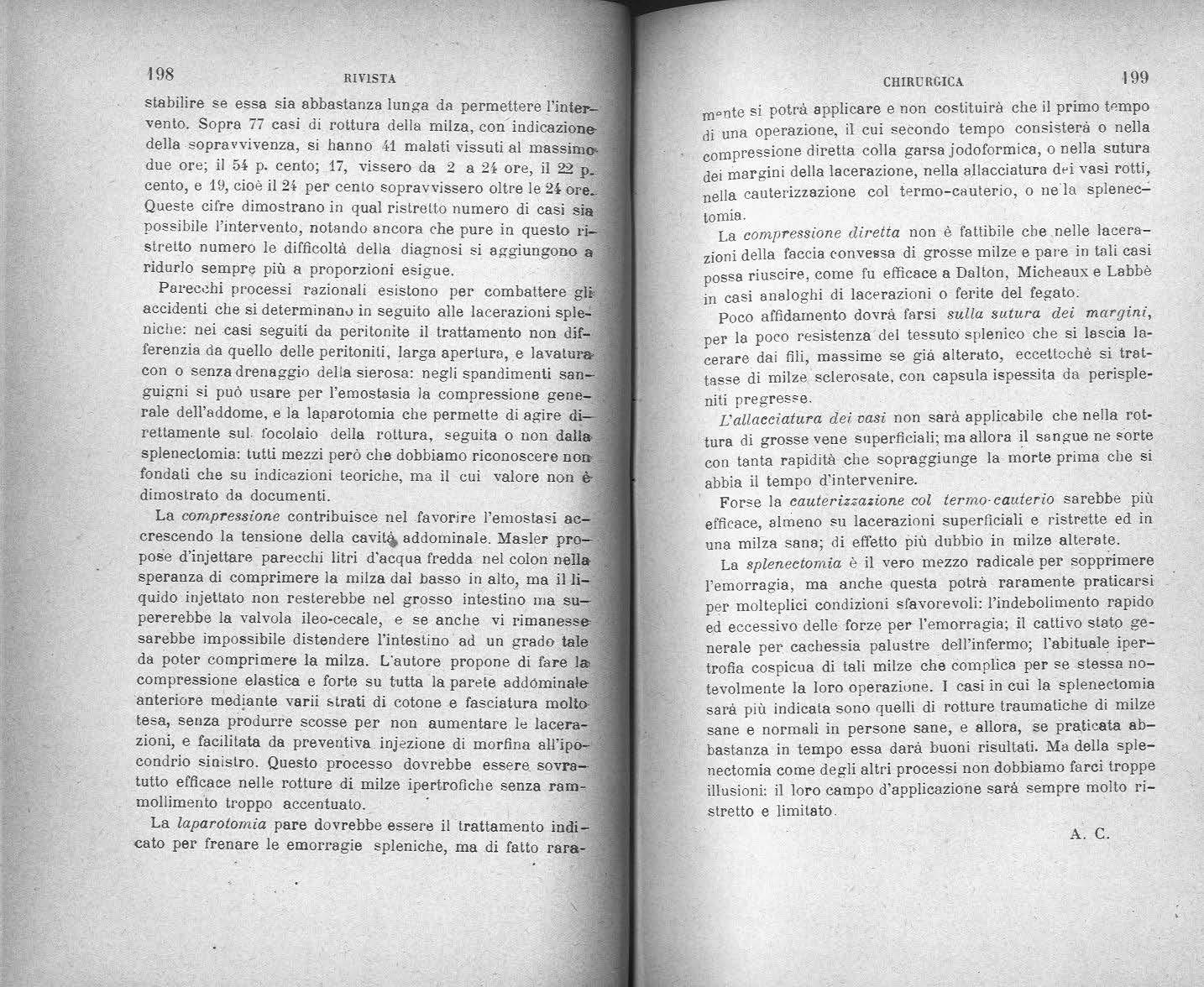
200 111\'JSTA
Elettrolisi nelle anchilosi fibrose . - GwYER - (Brit. }ferl Journ . , 2 settembre 1893).
Il dott. Gwyer (A.nn . of surg. agosto 1893) richiama l'atteo. zione dei chi rurghi sulla grande efficacia della corrente galvanica per distruggere le aderenze fibrose di nuova formazion e.
Egli usa ordinari11mente un grande elellrodo piano e uno a spugne con manico. Il f?raude elettrodo é io comunicazione col polo negativo e dev'essere applicalo sulle aderenze ; il piccolo sul lato opposto. Entrambi gli elettrodi debbono essere bagnati in una soluzione salina e la più efficace si è mostrata quella di cloruro ammonico. La corrente é roYesciata ed aumentata fìnché il paziente nor. può più tollerarla. Più antiche sono le arlerenze, più forte dev'essere la corrente e Gwyer ha più fiducia in una corrente forte usata poco tempo che in una debole usata più a lungo. La corrente dev'essere applicata da lO a 30 minuti ad intervalli da 1 a 5 giorni.
G. G.
Nuovo metodo per fissare I frammenti dl fratture composte e non consolidate - SENN - (Brit. Med,. Journ., 2 settembre 1803).
Il prof. Senn (A nn. of surg. agosto 11393) fa una ser:a difesa a favorè del metodo di ricurrere più frequentem ente a mezzi diretti per fissa r e i frammenti di fr atlure composte e non consolidate.

A preferenza dell e suture. dei chiodi, delle ,·iti, dei cilindri d'a\·0111to e dei elamps, Senn raccomanda, a guisa di ferule interossee riassorbibili , dei cilrndri ossei acuti e perforati iotrodolti nella cavità midollare i quali non ostacolano la formazione del callo e sono più rapidamente riassorbiti che i cilindri d'avorio o metallici. ·Ma il più sicuro e efficace mezzo di fissare di r ettamente i frammenti d'una frattura obliqua si è l'usare una ferula ossea applicata in modo da ci r cònda re entrambi i frammenti. Tale assicella
CHIRURGICA 101 circolare previene alla perfezione gli spostamenti laterali e longitudinali: la rotazione del membro sottostante alla frat · tura e rangolarità del focolaio di essa dovrà essere prevenuta da un'a;,sicella al gesso Senn ha usato questo metodo tre volte e con eccellenti risultati.
G. G.
Una nuova siringa intratlmpanloa.. - MILLIGA'.\t - (Bri!. J1ed. Journ. del 9 settembre 1893).
Il doll . William ~1illigam di Manchester dice che la prima condizione da soddisfare nei casi di affezioni suppurative dell'orecchio medio é quella di pulire completamente e scrupolosamente la mucosa timpanica dimodochè le a pplic~· ziooi topiche possano agire direttamente sulla superficie ammalata. Le difficoltà di ciò eseguire sono alcune volte mollo grandi. Questo é il caso quand0 la coesistente perforazione è molto piccola o situata troppo in alto sulla superficif' c!ella membrana del timpa.no, p. e. quando la perfora• . zione è nella membra na flaccida di Sbrappell.ln simili ctrcostanz~ il ro~todo ordinario di siringare lungo il condotto auditivo estern o é insufficiente. Pochissimo li<Juido trova passaggio attraverso la piccola perforazione per penetrare nella ca, ità dell'orecchio medio e cosi nettare la membrana mucosa affetta. In molli casi le lavande dell'orecchio medio per la via della tromba d'Eustachio sono senza dubbio soddisfacenti, ma sfortunatamente molti pazienti ::;offrono pel passa~gio della sonda. Va r i otoiatri hanno inventato delle siringhe intratimpaniche atte ad essere introdotte nell'orecchio m edio pel meato auditivo altraverM-ndo la perforazione del timpano; tra le altre quelle di Hartmann, Blake, Politzer e Pritchard han reso e rendono buoni servizi. Esse per tanto sono un po· difficili a maneggiarsi e, per la po· sizione in cui debbono essere tenute, impediscono parzialmente di vedere le parti dell'orecchio profondamente situate. Oltre a ciò è difficile lener fermo lo strumento mentre. al tempo stesso, devesi compiere l'atto del siringar e Queste difficoltà sono in certa guisa sormontate usando una $Ìringa
RIVISTA CHIRURGlCA
intratimpanica alimentata da un serbaloio situato in posizione elevata. I vantaggi di questa forma di siringa sono: 10) essa può essere tenuta perfettamente ferma quando il liquido fluisce dal serbatoio ne ll'orecchio medio; 2·) che durarite tutto il tempo dell'atto operativo il punto della siringa è costantemente tenuto d'occhio; 3·) che modificando l'altezza del serbatoio la pressione del liquido può essere reqolata a seconda delle speciali indicazioni d'ogni singolo caso.
G. G.










