
8 minute read
I DISTURBI VISIVI DEGLI KPil,ETT!Cl
Sonno e sogni. - Dormiva bene. Sognava qualche volta, ma non sèrbava ricordo dei sogni cbe faceva.
L'esame oftalmoscopico negatirn ei:cludeva i morbi oculari per spiegare la cecità di Riz., e la persistenza del riflesso pupillare allontanava l'idea Ji qualsiasi lesione ai gangli onici encefalici, perchè fimpegno di essi è seguito da immobilità della pupilla allo stimolo luminoso (Basevi , 30); tnentre se la lesione è dietro i tubercoli quadrigemini, l'arco riflesso, andando dalla retina all'iride, rimane intatto, e la rec1zione pupillare è conservata (Leyden, 31).
Advertisement
Intrapresa l'applicazione della corrente continua, si notò subito la differente intensità necessaria per eccitare l'uno o l'altro bulbo oculare , e per l'occhio destro la corrente doveva essere più forte. Dopo qualche sed uta si cercò di persuadere l'infermo come la visione cominciasse a ripristinarsi, ed egli infatti convenne che con l'occhio sinistro gli pareva di discernere la fiamma del fanale a gas che illuminava il reparto, che anzi la luce del sole gli recava molestia nello stesso occhio. Lo si provvide di occhiali da sole.
Consecutivamente a,endo forzato l'infermo ad esercizi di scrittura, si ebbe agio di osservare, come continuando a dettargli i numeri o !è aste da scrivere, egli verso l'orlo del foglio andasse sèmpre restringendo la spazio fra i se~oi, riuscisse a incrociare le aste ·tra loro, e spesso in forma di croce esatln, con giungesse bene i tratti del 4 scritto in più tempi. (Vedi figure da V a VIII).
C.onviolo lo stesso in(ermo della tornata visione all'occhio . sinistro, se ne esaminò il C. V., risultò ristretto per il bianco, ma non per i colori foodìimeotali rosso, bleù e verde. Saggiata la percezione per gli altri colori, si mostrò ritornnta . Valutala l'acutezza visiva con la scala metrica di De Wecker, risultò ridotta ad ' / ~. Tutto questo per l'occhio
-.sinistro, e intanto si continuava la cura elettrica, assicu-rando l'infermo che anche nll'occhio destro sarebbe ritornata la vista.
Esperimenti di sorpresa con la camera catottrica di Flees, .con lo stereoscopio e con il prismn di GriiJe conv.-ilidarono la previsione, sicchè l'infermo si decise a vedere anche con rocchio destro, del quale si potè misurare l'ampiezza del .visus e l'acute.zza: quella risultò ristrella per il bianco, questa àiminuita alla scala indicata .
Riz. ha poi confessalo che il ritorno della Yisione è av-venuto nel modo seguente: per l'occhio sinistro prima nel ::Segmento temporale e poi io quello nasale, per l'occhio de· -stro prima nel segmento nasale e poi io quello temporale. Quando riformato Riz. lasciò l'ospedale era in queste -condizioni: lieve restringimento concentrico del C. V. per ,il bianco solo nell'occhio destro. Acutezza visiva normale in entrambi gli occhi. P ercezione dei colori regolare. Persi:Stenza dell'analgesia cutanea.
La concomitanza di disturbi nella sensibilità (analgesia), e la precedenza di a~certati accessi convulsivi esclusero la -simulnzione nell'ambliopia presentala da Riz., anzi la convalidarono quale stimmata di una nevrosi, essendo mancato .ogni reperto oftalmoscopico alto a spiegarla, ed essendosi s,oi dileguata con l'applicazione della corrente continua.
Non mancammo di ricerrare se per avventura l'infermo .avesse zone isterogene; ma non fu dato trovarne, mentre -si sa essere tali zone frequenti nell'isteri smo maschile, nel ,quale è ovvio riscontrarsi la ipersensibilità dei testicoli, la ~ui pressione può modificare l'accesso: di 1,1 casi d'iste.-ismo maschile raccolti da S~obbo (32j nel nostro esercito, 4i presentavano iperalgesia testi.colare.
Frustranei riuscirono in Riz. i tentativi d'ipnotismo.
Con ogni probabiliLà l'ambliopia del Riz. doveue durar& solamente breve tempo dopo l'ultimo accesso convulsivo che la produsse , e ben presto si dovellero stabilire nella visione le condizioni confessate da lui in ultimo, cioè abolizione parziale della vista e propriamente nel segmento temporale dell'occhio destro , e nel segmento nasale dell' occhio sini stro , emianopsia lateral e destra , ammette ndo la semidecussaziooe dei nervi ottici, come ora generalmente si ritiene Del Monte (33). Schmidt-Rimpler (3i).
Da ricerche istituite sopra ind ividui alfeui da nevrosi il dotl. Schiele di Berne (35) aveva riconosciuto fin dal 188& che i fenomeni, compresi sotto il nome di rifioimento o di irritabilità anormale della retina, devono essere consideratr come una manifestazione della fati ca della corteccia dei lobi occipitali, e possono essere osservati in tntti i casi inclusi nella rubrica d'anestesia e ipereste.:;ia della retina, tanto nelle alterazioni puramente funzionali (isteria, ipocondria, nevrastenia), quanto nelle lesioni organiche dei centri nervosi, nelle alter;izioni psichiche transitorie, e anche negli individui sani.
E nel seguente '87 .Nothnagel (36) potè affermare essere incontestabile che le lesioni della corteccia cerebrale so no in relazione con j turbamenti della vista (emianopsia, cecità intellettuale, allucina:;ioni ~ella 1Jista, daltoni smo isolato o associato a cecità intellettuale); non essere assodato che una lesione unilaterale possa p,:odurre alterazioni morbose unicamente nelYocchio del lato opposto; doversi le ind ica te alterazioni connettere esclusirnmente a lesioni del lobo occipitale, nè a tutta la superficie di t'lsso, ma più propriamente a quella del cuneus e della I• circonvoluzione occi_ pitale, e dipendere dalla diversa profondità della lesiooe il prodursi~ora l'emianopsia, ora la cecità intellettuale.
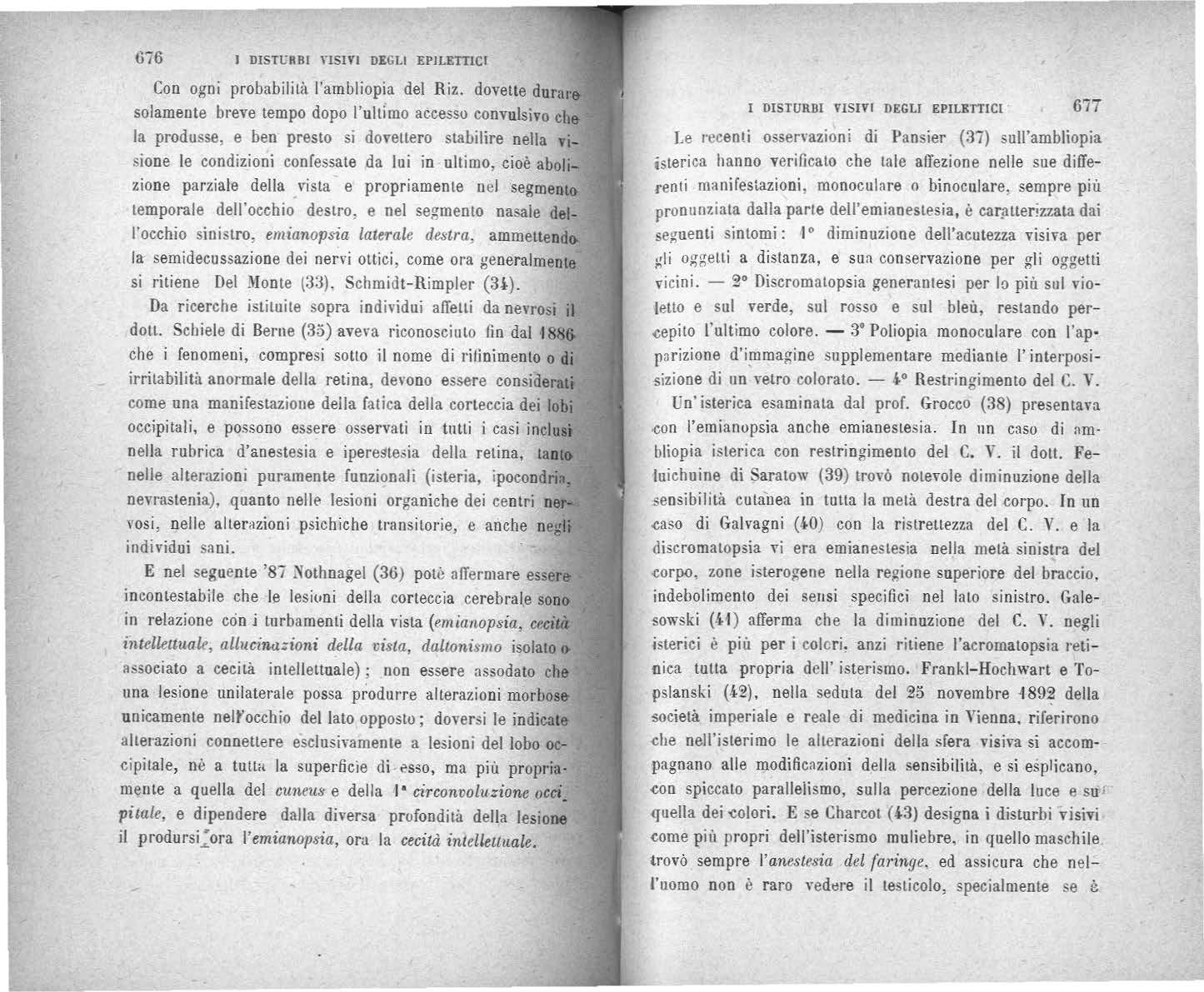
I Disturbi Visivi Degli Epilettici 677
Le recenti osservazioni di Pansier (37) sull'ambliopia isterica hanno verifrcato che tale affezione nelle sue differenti manifestazioni, monoculare o binoculare, sempre più pronunz iata dalla parte dell'emiaoestesia, è carptterizzata dai seguenti sintomi : IO diminuzione dell'acutezza visiva per gli oggetti a distanza, e sua conservazione per gli oggetti vi cini. - 2° Discromatopsia generantesi per lo più sul violetto e sul verde, sul rosso e sul bleù, restando per.cepito l'ultimo colore. - 3° Poliopia monoc ulare con l'ap · parizione d'immagine supplementare mediante I' ioterposisiziooe di un vetro colorato. - 4° Restringimento del C. V. Un'isterica esaminata dal prof. Grocco (38) presentava .con l'emianopsia anche emianestesia. In nn caso di :imbliopia isterica con restringimento del C. V. il dolt. Feiuichuine di Saratow (39) trovò notevole diminuzione della sensibilità cutaì1ea in tulla la metà destra del corpo. In un .caso di Galvagni (40) con la ristrettezza del C. V. e la discromatopsia vi era emianestesia nella metà sinistra del .corpo, zone isterogeue nella regione superiore del braccio, indebolimento dei sensi specifici nel lato sinistro. Galesowski (41) afferma che la diminuzione del C. V. negli tsterici è più per i col ori, anzi ritiene l'acromatopsia retinica tutta propria dell' isterismo. Frankl- Hochwart e Topslanski (4.2), nella seduta del 25 novembre 489~ della società imperiale e reale di medicina in Vienna. riferirono .che nell'isterimo le alterazioni della sfera visiva si accoro- . pagnano alle modificazioni della sensibilità, e si esplicano, .con spiccato parallelismo, sulla percezione della luce e su <Juella dei -colori. E se Charcot (4.3) designa i disturbi visivi .come più propri dell'isterismo muliebre, in quello maschile trovò sempre l'anestesia del faringe, ed assicura che nell'uomo non è raro vedere il testicolo, specialmente se è sede di anomalie di posizione o di sviluppo, rappresentarela parte di zona i~terogena, o anche il prepuzio, dove fa sensibilità è squisita (!4.), In molti casi esso Charcot trovò, acromatopsia ftal lato anestesico, allucinazioni ipnogogicbe,. e con frequenza l'arco di cerchio e le attitudini passio-nati (4.5). li non essersi accompagnata all'emianopsia anche la discromatopsia, J' essersi limitato esclusivamente al bianco i• restringimento del C. V., l' essersi circoscritta l'anestesia quasi solo all'anal~esia, rispetLaodo l'ugola, e più specialmente il faringe (sede prediletta di preziosa stimmata isterica), spiega in Riz. l'assenza di zone isterogene, sapendosi come nell'isterismo le turbe visive alterino ;i.oche la. percP-zione dei colori, e i disturbi sensitivi sieno più completi invadendo anche le altre sensibilità (tattile. topografica .. barica, termica) . Quindi neÙ'accesso convulsivo di Riz. non l'arco di cerchio caratteristico degli isterici e degli isteroepilettici, non "le attitudini passionali, non le allucinazion~ ipnogogiche.
E se tutto questo per l'isterismo, è da notare da altraparte come l'ottusità sensoria in massa sia frequ ente negli, epilettici. Anzi Ton nini (4) crede che nessuno pari ali'epilettico possa dirsi olluso nella sensibilità, neppure l'isterica, la quale porta nella somma dclte cifre il comp.enso delleiperestesie sulle emianestesie, mentre nell'epilettico prevalesempre l'ottusità.
Oggi poi è risaputo che gli accessi di rabbia senza motivo, le scappàte insensate, e altre azioni colpevoli sono esplosìoni puramente epilettiche; e, quando seguite da amnesia del fatto occorso, depongonl) per uno stato di sonnambulismo epilettico, come recentemente ba opinato Mobius (46).
I DISTURBl VISIVI DEGLI EPILETTICI 6i\)
Mentre Tonnini (4. 1 , come già notammo, vorrebbe atti· rare l'isterismo nell'orbita dell'epilessia, Mobius, pur ammettendo in rari casi la coesistenza delle due infermità, ne nega la fusione, e dice: « il vocabolo istero·epiles$ia « è un'espressione per l'isterismo grave che più non do(( vrebbe usarsi » (pag. '176).
li aiudizio diagno;;tico dunque non poté lasciarsi trasci· o .. nare da parve nze d'isterismo non resistenti alla critica, e bisoooò riconoscere in Riz. un epilettico senso-motorio . . Tale· lo desi,rnarono a\i accessi inconscienti e automatica· o o . . mente impulsivi, i caratteri di degenerazione raccolti net ripetuti esami, le tur be visive acustiche sofferte, la p~r~i· stente analgesia, la quale trovò forse terreno reso prop1z10 da delinquenza atavica (padre irascibile).
Lo studio delle localizzazioni cerebrali, confortato oggi anche dal controllo della clinica, ha assegnato ai lobi occipitali il centro della vista (sfera visiv~ di Munk): si am· • mette anche che a tali lobi pervengono direuamente fibre di senso del fascio esterno del peduncolo ; sicchè nelle fat· tispecie non è improbabile supporre, che la zona epilellooena si trovi nelll corteccia di essi lobi oecipitali, ove !') • risiederebbero, secondo la brillante espressione di Jackson, le cellule torpedini, pronte ad esplodere il loro fulminato lisiologico.

Elenco Delle Opere Citate
(1) ARETEO DI CAPPAOOCl~. - Delle cause, de' Se(Jni e della cura delle malattie acute e croniche. - Libri ott0, volgarizzati da Francesco Puccinotti. Napoli, 1858, pag. 381.
(2) F. V1zrou - Epilessia. - Nell'Enc[clopedia medica italiana.
(3) ADOLFO STRÙ~fPELL. - Trattato di patologia speciale medica e terapia. - Terza edizione italiana sulla quarta tedesca. - Vallardi.
(4) S1Lv10 TONNtNI. - Le Epilessie in rapporto aUa degent!ra:.ione, T orino, 1891.
I DISTGRBC VISIVI DEGLI RPlLETTICl 681
(15) PARISOTTI. - Studio comparatioo del campo oisioo di neuropatici e psicopatici, citato da Ott.olenghi (14).
(16) PARISOTTI. - Del campo oisioo nei neuropatici e psicopatici. - (Comunicazione ratta all'accademia di medicina di di Roma, nella seduta del 27 novembre 1892). - Gauetta degli ospedali, i892.
(17) NoTHNAGEL. - Epilessia, nella patolo[Jia e te rap ia di Z iemssen .
(18) BECllTEREW. - Sulla circola:.ione sanouigna del cercello durante gli accessi epilettici. - Rioista sperimentale di/reniatria e medicina legale, 1892.
(19) A. MAsuccr. - Su di un caso di vertigine epilettica. - Giornale medico del R. esercito e della R. marina, 1891 .
( l20) BALDO ZAKIBO.NI. - Valore semeiotico dell:esame periometrico nella diagnosi d'iste r ismo. - Osservazioni cliniche. - Archioio italiano di clinica medica, 1892.
5) LANOON C.rnLER GRA Y. - Il calore didgnostico di una pupilla dilatata e mobile negli epilettici, citato da Musso (,).
(6) MARIE. - Nota sullo stato della pupill~ degli epilettici juori dell'accesso, citato da Vizioli (2).
(7) GIUSEPPE Musso. - Le oariaiioni del diamet ro pupillare negli epilettici - Rioista sperimentale di freniat ria e medil ina legale, 1884.
(8) K. E. BASSE. - Trattato delle malatie del sistlma nervoso, traduzione di Clodomiro Bonfigli . - Milano, 1875.
(9) CESARE AGOST1N1. - Sulle oariazioni della sensibilità generale, sensoriale e riflessa nel peri-Odo interparossi.stico e dopo le conoulsioni. :- Rioista sperimentale di .freniatria e medicina legale, 1890.
(10) D' Aeu~Do. - Ricerche cliniche sui disturbi oisioi nell'epilessia. - La psichiatria, 1884, citato da Agostini (9) e da Tonnini ({).
(11) ÙTTOLENGet. Anomalie del campo cisico nei psicopatici e nei criminali, Torino, 1891.
(1.2) ÙTTOLE.NGHI e CARRARA. - Perioptometria e psicometria di uomini geniali, T orino, 1892.
(13) S. 0TTOLENGH1. - Nuooe osseroazioni sul campo oisioo in rapporto alla medicina legale e alla psichiatria.Gazzetta d.Jgli ospedali, 1892.
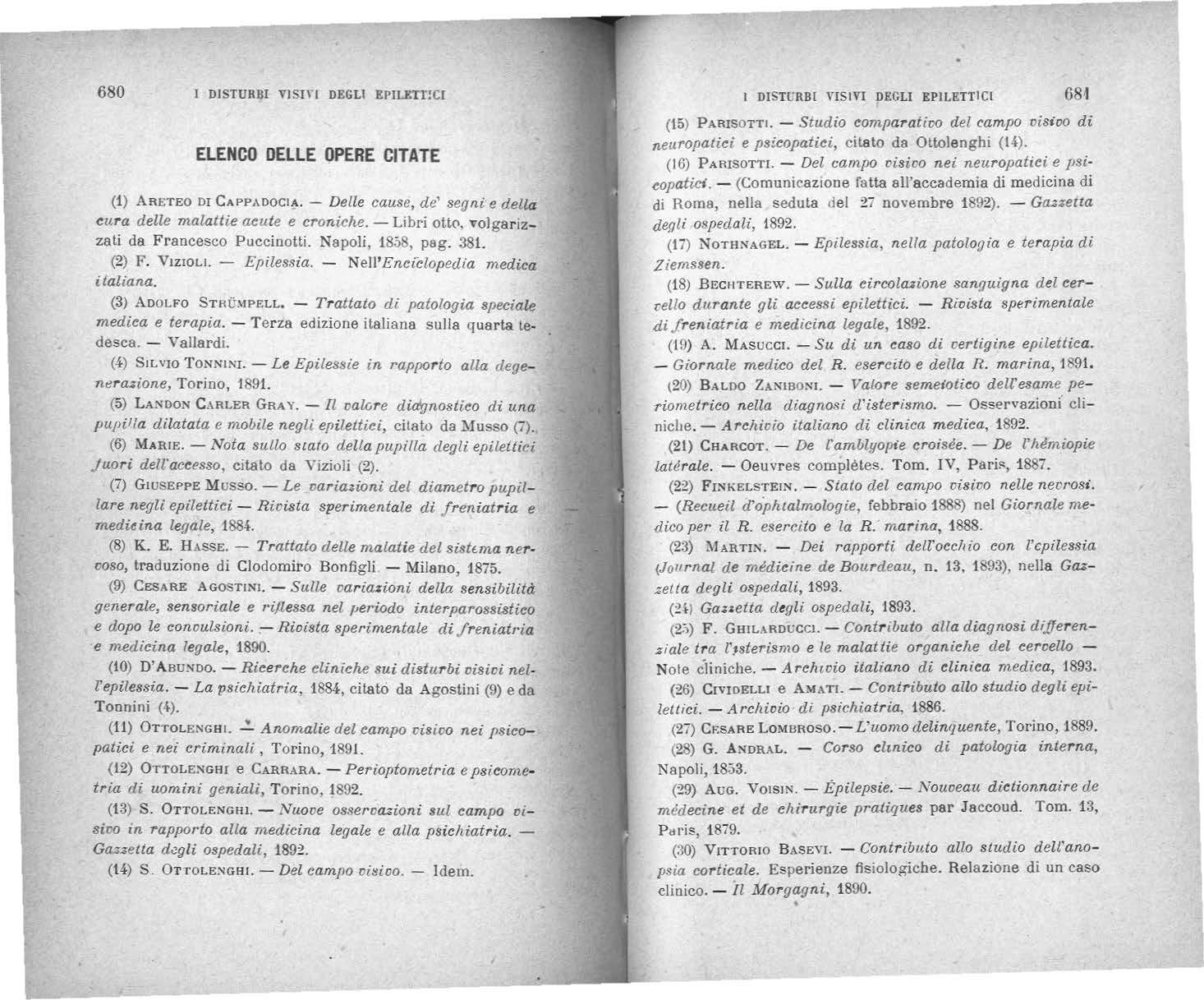
(14) S. 0TTOLENGHr. - Del campo oùsioo. - Idem.
(21) CHARCOT. - De l'amblgopie croisée. - De l:hémiopie latérale - Oeuvres complètes. T om. IV, Pàri!\ 1887.
(22) FINKELSTEtN. - Stato del campo oisioo nelle necrosi. - (Recueil d'ophlalmologie, febbraio 1888) nel Giornale medico per il R . esercito e la R. ma rina, 1888
(23) MARTIN. - Dei rapporti delfocchio con l'epilessia (Journal de médicine de Bourdeau, n. 13, 1893), nella Gazzetta degli ospedali, 1893.
(:H) Ganetta d egli ospedali, 1893.
(2=>) F. GHILARDucc1. - Cont r ibuto alla diagnosi diffe r enziale tra r,sterismo e le malattie organiche del ceroelloNote éliniche. - Archioio italiano di clinica medica, 1893.
(26) C1v1 0ELLt e AMATI. - Contributo allo studio degli epilettici. - Archioio di psichiatria, 1886.
(27) CF.SARELOMBRoso. - L'uomodelinquente, Torino, 1889.
(28) G. A:-ioRAL. - Corso clinico di patologia interna, Napoli, 1853.
(29) AuG. Vo1s1N. - Épilepsie. - Nouoeau dictionnaire de médecine et de chirurgie prati,ques par Jaccoud. Tom. 13, P1:1ris, 1879.
(:lO) VITTORIO BASEVJ. - Contributo allo studio dell'anopsia corticale. Esperienze fisiologiche. Relazione di un caso clinico. - il Morgagni, 1890.
,










