
117 minute read
Piccole e grandi guerre per gestire le risorse Franco Fracassi
Franco Fracassi Piccole e grandi guerre per gestire le risorse
Biskek, Kirghizia. 24 marzo 2005. Il centro della città è attraversato da quindicimila manifestanti, tutti con una sciarpa rosa al collo e un tulipano giallo in mano. Solo undici giorni prima si son tenute le elezioni parlamentari. La folla protesta contro il presidente Askar Akajev, accusato di averle truccate. Il giovane Edil Baisalov marcia alla testa del corteo. È felice. Edil ha studiato negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio concessa dal Governo di Washington. Adesso lavora per il National Democratic Institute, presieduto dall’ex segretario di Stato Madaleine Albright. Ufficialmente Edil aveva il compito di reclutare osservatori indipendenti per monitorare le elezioni. In realtà reclutava giovani per la rivoluzione. Una rivoluzione pacifica, ma pur sempre la rivoluzione. La storia politica di Edil è cominciata nel dicembre dell’anno prima. Baisalov era stato inviato in Ucraina per seguire i retroscena della rivoluzione arancione ed imparare. Delle sei settimane passate a Kiev ha conservato un ricordo stupendo. «Sono stato laggiù un mese e mezzo per conto del National Democratic Institute. Dagli ucraini ho imparato tantissimo. Erano veramente organizzati. Questa è una sciarpa arancione, poi c’è il cappelletto, la maglietta, e perfino l’impermeabile e l’ombrello. Avevano veramente pensato a tutto. Ed è quello che faremo pure noi. Questa volta il colore è il rosa», aveva raccontato Edil appena tornato dall’Ucraina. La rivoluzione vincerà. Il 4 aprile Akajev si dimetterà, lasciando dopo quindici anni il potere. Tre episodi sono sufficienti a spiegare che cosa è accaduto in questo remoto Paese, che si estende all’estremità settentrionale della catena himalayana, tra Cina e Kazakistan. 13 gennaio, periferia settentrionale di Biskek. Sede della Coalizione per la democrazia. Edil tiene un discorso davanti a una quarantina di ragazzi: «Il Presidente americano Bush ha detto: “Tutti coloro che vivono oppressi dalla tirannia non saranno mai dimenticati dagli Stati Uniti”. L’America è dalla nostra parte». Al termine del discorso viene proiettato un filmato, gentilmente donato da «un simpatizzante americano», dal titolo “Come rovesciare un dittatore”, ovvero la storia del movimento serbo Otpor, quello che ha costretto alle dimissioni il Presidente serbo Slobodan Milosevic. Subito dopo prende la parola una ragazza. Mentre parla viene distribuito un manuale. Sulla copertina c’è scritto “Dalla dittatura alla democrazia”. Il libro è edito dalla Freedom House, un’associazione con sede a New York che si occupa di libertà e democrazia nel mondo. «Questa è un’arma potentissima. Spiega come si fa a rovesciare un regime dittatoriale senza violenza», racconta. 14 marzo. Quindici chilometri a Sud di Biskek. Ai piedi del monte Tian Shan, che raggiunge i 4.800 metri, oltre una palizzata verde sorge un campo di golf a nove buche. La sede del club è costituita da una casa di legno, stile baita di montagna spartana. Al centro della stanza principale un tavolo rotondo, intorno al quale sono riunite tre persone: Mike Stone, 52 anni, ex giornalista ora a capo della Freedom House kirghiza; Brian Kemple, 48 anni, in Kighizia da quindici, gestisce l’ufficio locale di Usaid, l’agenzia statunitense per lo sviluppo; David Greer, avvocato, 42 anni, è qui per insegnare ai Kirghizi i pro e i contro dell’economia di mercato. I tre rappresentano le principali organizzazioni statunitensi che operano in questo Paese. La discussione è animata. Pare che il Governo abbia tagliato l’elettricità alla tipografia gestita da Stone, dove vengono stampati i manuali distribuiti nel corso della riunione della Coalizione per la democrazia. Le elezioni si sono
Advertisement
concluse la sera prima, con l’ennesima affermazione plebiscitaria di Akajev. Kemple e Greer hanno paura che il Presidente si getti tra le braccia di Mosca. La guerra in Afghanistan è cominciata cinque mesi prima, e Washington non si può permettere di perdere il controllo della Kirghizia. La sera stessa Stone sarà al ministero degli Esteri kirghizo (terzo episodio). Ad attenderlo all’entrata il ministro Askar Aimatov. Stone, Aimatov e tutti gli altri presenti sono in attesa di una telefonata da Washington, che non tarda ad arrivare. «Buon giorno da Washington. Sono John McCain. Sono indignato della chiusura forzata dell’unica tipografia indipendente del Paese, Questo controllo dell’informazione è un residuo della vecchia società sovietica, e non ha ragione di esistere in una società libera». Segue ramanzina di oltre un’ora. Dieci giorni dopo gli studenti, con il loro manuale “Dalla dittatura alla democrazia” in tasca, assaltano il palazzo presidenziale, costringendo Akajev e il suo Governo alle dimissioni. Gli Stati Uniti, da soli, consumano il 30% delle risorse energetiche mondiali. Se si considera l’Occidente nel suo complesso, la cifra sale fino al 60%. La fine della guerra fredda ha segnato la supremazia politica, militare ed economica degli Stati Uniti sul resto del mondo. Supremazia che però ha bisogno di costante rifornimento energetico. Le risorse energetiche primarie, ovvero petrolio, gas e uranio, stanno raggiungendo o hanno già raggiunto il picco di produzione. In altre parole, l’offerta si sta restringendo. Inoltre, va considerato anche lo sviluppo economico dell’Europa dell’Est, della Russia, e soprattutto di India e Cina. Sviluppo che riduce la fetta di energia disponibile per Washington. A partire dagli anni Novanta l’energia è quindi diventata il terreno di scontro principale tra le grandi potenze economiche e politiche del pianeta. Da una parte Stati Uniti e Gran Bretagna, dall’altra la Cina, e ultimamente anche l’India. In mezzo, Europa e Russia, che fino al crollo del


Muro di Berlino controllavano direttamente o indirettamente i due terzi delle risorse energetiche mondiali. Due le direttive di questa guerra: strappare alla concorrenza Paesi ricchi di risorse oppure prendere il controllo di quegli Stati e di quelle aree che rappresentano il futuro energetico. Una guerra combattuta senza quartiere, per procura o in prima persona, anche con l’utilizzo del terrorismo. È la guerra che vi stiamo raccontando. È la vera guerra di al-Qaeda. L’Asia è sconvolta da piccole e grandi guerre e da frequenti azioni di gruppi terroristi. Per capire quello che sta accadendo bisogna capire quali sono gli interessi in gioco. Ci sono le potenze mondiali (Usa, Russia e Cina), quelle regionali (India, Pakistan e Indonesia, Iran) e i poteri nazionali (Birmania, Filippine, Uzbekistan, Thailandia). Ciascuno di questi soggetti si batte per acquisire maggior potere, muovendo delle pedine più piccole. In mezzo oltre tre miliardi e settecento milioni di persone inermi (quattro volte e mezzo la popolazione europea). Vittime di una violenza spesso incomprensibile e spesso attribuita a dispute etniche o contrasti religiosi. Un grande gioco, nel quale i servizi segreti di troppi Paesi la fanno da padrone. E che i media, per loro colpa, non raccontano o raccontano male.


Situazione attuale e ultimi sviluppi
Droga
L’invasione dell’Afghanistan da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati ha fatto del Paese asiatico il maggior esportatore di droga al mondo. In base all’ultimo rapporto dell’agenzia delle Nazioni Unite per la lotta alla droga (Unodc), in Afghanistan viene coltivato il 92% dell’oppio mondiale. Inoltre, il Paese è anche divenuto il principale esportatore di hashish, superando il Marocco. Grazie a una politica repressiva dei talebani, nel 2001 la produzione di oppio aveva raggiunto il suo minimo storico. Due anni dopo l’invasione la produzione ha ricominciato a crescere. In più, in Afghanistan per la prima volta si è iniziato a raffinare l’oppio in eroina. Oggi il 60% della droga trafficata nel mondo viene dall’Afghanistan. Più di 4700 morti fra i soldati della coalizione in nove anni di guerra, 31 dei quali italiani: gli ultimi sono stati nell’ottobre del 2010 4 alpini che scortavano un convoglio. La guerra in Afghanistan resta un grande “buco nero”, capace di divorare eserciti, senza mai dare la vittoria. Così, l’attualità del conflitto iniziato nel 2001 per volontà del Presidente statunitense George W. Bush all’indomani degli attentati alle Torri gemelle di New York, è identica alla storia: una guerra simile ad un pantano. Se ne è accorto l’attuale Presidente nordamericano, Obama, che ha annunciato il ritiro delle truppe a partire dall’estate del 2011. Se la strategia sarà confermata, torneranno nei loro paesi ben 160mila uomini - 100mila più o meno sono statunitensi - lasciando al Governo afghano il compito di modernizzare il Paese. La realtà, è che la missione appare impossibile. Il Presidente afghano Karzai, recentemente rieletto, ma inseguito dalle accuse di brogli, controlla di fatto solo le aree delle grandi città: Kabul, Kandahar, Herat. I Talebani, che nel 2001 governavano il Paese ed inizialmente furono costretti ad arretrate lungo il confine con il Pakistan dall’offensiva occidentale, non si sono mai arresi e anzi hanno riguadagnato terreno. Negli ultimi dodici mesi, poi, l’annuncio del ritiro delle truppe alleate li ha rafforzati. Sanno di dover semplicemente resistere sino a quando l’ultimo soldato straniero avrà lasciato l’Afghanistan e così hanno ripreso a dettare legge e condizioni. Il primo effetto politico di questa situazione è nel riavvicinamento di molti signori della guerra, cioè capi clan, che controllano il loro territorio e stanno scegliendo di allearsi con i talebani per il futuro, isolando sempre più il Governo centrale. Per questa ragione, a dispetto dell’annunciato ritiro, la scelta strategica delle Forze Nato è di una offensiva costante contro i Talebani. I combattimenti sono quotidiani nelle Province di Paktia, Khost e Nangarhar, a Oriente, oltre a quelle di Ghazni, Zabul e Uruzgan. Si combatte anche nei distretti di Helmand, Kandahar, Farah


Generalità
Nome completo: Repubblica Islamica dell’Afghanistan Bandiera
Lingue principali: Il pashto e il persiano (dari) sono le lingue ufficiali. C’è inoltre una grande varietà di lingue, la maggior parte di origine persiana o altaica: hazaragi, turcomanno, uzbeco, aimaq e altri Capitale: Kabul Popolazione: 32.254.372 Area: 652.090 Kmq Religioni: Musulmana (99%) (74% sunnita, 15% sciita e 10% altro). Moneta: Nuovo Afghani Principali Smeraldi, uranio, altri esportazioni: minerali, oppio PIL pro capite: Us 1.310
ed Herat. In quest’ultima Provincia è stanziato il contingente italiano, formato da quattro corpi operativi delle forze speciali, che intervengono in battaglia a fianco delle truppe statunitensi e da una compagnia di fanteria, che opera nel pattugliamento a lungo raggio.
Le cose vanno distinte, in questo Paese. Molti - signori della guerra, talebani, le truppe di Karzai - combattano, ognuno a modo loro semplicemente, per mantenere il controllo - a dispetto degli altri - del territorio, cioè per governare casa loro. Gli eserciti stranieri, invece, sono lì per ragioni differenti e spesso poco nobili. L’Afghanistan è da sempre ambito dalle potenze militari, per la posizione chiave dal punto di vista geografico: chi controlla l’Afghanistan, controlla l’Asia. Il riferimento, oggi, è ai gasdotti che lo attraversano e alle vie commerciali - sottoforma di strade e ferrovie - che attraversandolo collegano tutta Terra di passaggio in Asia, luogo di controllo delle grandi vie di comunicazione: è la posizione geografica ad aver fatto dell’Afghanistan un Paese in guerra permanente. A questo, cioè al dato geografico, si aggiunge la storia di un popolo sempre diviso fra clan. Così, l’Afghanistan è stato nelle mire dei grandi imperi da sempre, non ultimo quello inglese, che nel XIX secolo tentò, senza successo, di sottometterlo. È sempre stato terra indipendente, che però alla fine della seconda guerra mondiale deve cercare una strada per rimanere in equilibrio fra Usa e Unione Sovietica. Un equilibrismo che fallisce dinnanzi alle scelte internazionali. L’appoggio sempre più pieno degli Usa al vicino Pakistan, convince la dirigenza afghana ad avvicinarsi all’Urss, inviando sempre più afghani a studiare a Mosca. Una serie di golpe e contro golpe, negli anni ’60 e ’70, portano a spodestare il re Zahir - nel 1973 - e a creare una Repubblica sempre più filosovietica. L’ennesimo colpo di stato, nel dicembre del 1979, porta all’invasione del Paese da parte dell’Armata Rossa di Mosca. Inizia una durissima guerra fra le truppe sovietiche e governative da un lato e mujaheddin - combattenti per la l’Asia Centrale al Pakistan e all’India. Detto questo, non mancano le risorse minerarie. Recentemente sono stati scoperti buoni giacimenti di uranio ed è da sempre una buona riserva di smeraldi. Da non dimenticare, poi, che l’Afghanistan è il maggior produttore mondiale di oppio e anche se nessuno lo ammetterà, è un mercato - questo - che fa gola a molti. Poi, ci sono osservatori che sostengono che in Afghanistan, oggi, si combattono contemporaneamente molte guerre, per coprire gli interessi di potenze più o meno grandi. Una specie di gi-
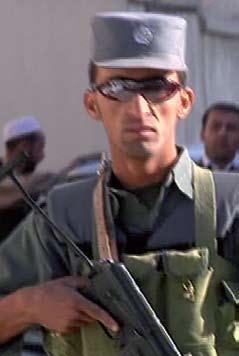
gantesco ring, che serve a far sfogare tutti.

fede - dall’altro, appoggiati da musulmani fondamentalisti di tutto il mondo. Nel gennaio 1987 arriva un primo cessate il fuoco. Sei anni dopo il ritiro delle truppe sovietiche. È una disfatta, che spinge l’Urss sull’orlo del collasso. Nel Paese inizia un lungo periodo di scontro fra fazioni armate, fondamentalmente fra mujaheddin tagiki, uzbeki, hazari, pashtun. Nel 1995 nasce il gruppo armato dei Taliban (“studiosi del Corano”) nel Sud dell’Afghanistan, appoggiati da Pakistan, Arabia Saudita e Stati Uniti. Nel 1996 i Taliban entrano a Kabul. Mohammed Omar Akhunzada - il Mullah Omar - è il loro capo, nominato “comandante dei credenti” (amir ol-momumin). Nel Nord tentano di resistere, creando nel 1997 il Fronte Islamico Nazionale Unito per la Salvezza dell’Afghanistan, conosciuto come Alleanza del Nord (An) o Fronte Unico. Lo formano uzbechi, hazari e tagichi. I Taliban, intanto, cambiano il Paese: le donne spariscono dalla scena pubblica e dalle scuole. Musica, teatro, canto, tutto viene vietato. Nel 2001, l’11 settembre, c’è l’attacco alle Torri Gemelle, a New York e al Pentagono. Gli Stati Uniti accusano subito al-Qaeda, organizzazio-
Quadro generale

Ahmad Shah Massoud (9 gennaio 1953 - 9 settembre 2001)
Ahmad Shah Massoud in Afghanistan è un eroe nazionale. Le gigantografie dei suoi ritratti campeggiano nelle principali piazze di Kabul. Massud è l’uomo che ha battuto l’Armata Rossa, Massud è l’uomo che ha resistito da solo all’orda talebana. Massud è il martire dell’11 settembre. Massud nasce nell’alta valle del Panshir. Il padre di etnia tagika è un alto ufficiale dell’esercito. Il giovane Ahmad può quindi permettersi di frequentare il liceo francese a Kabul e successivamente la facoltà di architettura. Nella seconda metà degli anni Settanta, quando i comunisti prendono il potere, Massud si trasferisce in Pakistan, da dove tornerà nel 1978 per dare vita alla guerriglia prima anticomunista e poi antisovietica. La conoscenza delle tattiche di guerriglia e l’aiuto militare della Cia fanno del “Leone del Panshir” un guerrigliero invincibile. Battuti i sovietici e i comunisti scatena insieme al nemico Gulbuddin Hekmatyar una guerra civile che devasta Kabul. Nel 1996 l’invasione dei talebani lo costringe a ritirarsi nella valle del Panshir. Massud muore il 9 settembre 2001 (all’età di 48 anni) per mano di due estremisti islamici fattisi passare per giornalisti televisivi.

Le mine Quattromila anni: è il tempo stimato dagli esperti per bonificare completamente l’Afghanistan dalle mine. Un vero flagello quello degli ordigni anti uomo lasciati in ricordo dalle troppe guerre degli ultimi 30 anni. Per la Ong Halo Trust, della Gran Bretagna, l’invasione sovietica sparpagliò almeno 640mila mine. Sono sostanzialmente ordigni anti uomo e anticarro. A queste si sono aggiunti tutti gli ordigni, come le cluster bomb, sganciate dagli Usa appena iniziata la guerra contro il regime taliban: solo nel periodo 2001 - 2002 pare ne siano state sganciate 250mila. Il risultato è che in trent’anni, 400mila afgani - quasi tutti civili sono rimasti uccisi o mutilati dalle mine.
ne terroristica guidata dal saudita Osama bin Laden, ex mujaheddin che vive in Afghanistan con i suoi uomini, protetto dai Taliban. Il Consiglio degli anziani, da Kabul chiede a bin Laden di andarsene volontariamente e annuncia, però, la Guerra Santa (jihad) in caso di attacco americano. Attacco che inizia il 7 ottobre 2001, con bombardamenti aerei. La campagna viene chiamata dal presidente George W. Bush prima “Giustizia Infinita”, poi “Libertà Duratura”. Si forma una coalizione internazionale con Regno Unito, Australia e Canada, appoggiata dalla Unione Europea e della Nato (inclusa la Turchia), Cina, Russia, Israele, India, Arabia Saudita e Pakistan, ex alleato dei taliban. L’azione dei bombardieri consente all’Alleanza del Nord di recuperare due terzi del Paese e di entrare a Kabul il 13 novembre 2001. Mentre i Taliban sono in rotta, a Bonn viene convocata la Conferenza Interafghana. Viene creata una amministrazione, con a capo il pashtun filomonarchico Hamid Karzai. Si formano una Loya Jirga (Assemblea) d’Emergenza, una Autorità di transizione e una Loya Jirga Costituzionale, assistite da una Forza di sicurezza internazionale dell’Onu, il tutto per preparare - entro due anni e mezzo - le elezioni generali. Il 22 dicembre assume il potere Karzai. Gli scontri nel Paese continuano, con parte del territorio controllato da potenti signori della guerra sostenuti dagli Stati Uniti e la resistenza Taliban che non demorde. Nell’agosto del 2003 la Nato lancia una missione di pace. È la prima volta che l’Alleanza Atlantica varca i confini europei. Il 3 novembre 2004 Karzai vince con il 55% dei voti le prime elezioni presidenziali, ma i problemi continuano. A combattere contro il Governo dl presidente Karzai e la coalizione che lo sostiene è un arcipelago composito. Si tratta, nei fatti, di una da alleanza formata da ex combattenti del Jihad antisovietico come lo Jamiat Jaishal Muslemeen (Jjm, guidato da Maulwi Muhamad Ishaq Manzoora o lo Hizb-e Islami di Gulbudin Hekmatyar. Ci sono poi i Taliban del Mullah Omar, diverse frazioni e gruppi che hanno come referenti al-Qaeda, ex comandanti mujihaidin autonomi come Sayyed Muhammad Akbar Agha da Kandahar. Un mondo in lotta, che restringe il potere di Karzai sempre più alle sole grandi città. Il Presidente, per altro, viene rieletto nel 2009, nonostante da più parti si avanzino dubbi sulla regolarità del voto. E l’anno dopo, il Presidente statunitense Obama annuncia il ritiro delle truppe entro l’estate del 2011.

La zona dell’India indicata con questa colorazione indica la parte riconducibile alla Regione del Tibet a cui questa scheda è dedicata.
Situazione attuale e ultimi sviluppi
Il cuore dell’Asia
È fondamentale conoscere il Tibet dal punto di vista geografico, per comprendere le ragioni dello scontro con la Cina. Comunemente conosciuto come “il Tetto del Mondo”, il Tibet è davvero il cuore dell’Asia. È a Nord dell’India, del Nepal, del Buthan e della Birmania, a Ovest della Cina e a Sud del Turkestan orientale. Ha una superficie di 2.5milioni di chilometri quadrati, come due terzi dell’India. Ha un’altitudine media di 3650 metri sopra il livello del mare e molte delle sue montagne - tra cui l’Everest - superano gli 8000 metri. L’altopiano tibetano è il più alto e il più esteso del mondo. Gli fanno corona a Sud la catena dell’Himalaya e a Nord le montagne dell’Altyn Tagh e del Gangkar Chogley Namgyal. A occidente si fonde con le cime del Karakorum mentre a oriente scende in modo graduale verso le vette del Minyak Gangkar e del Khawakarpo. Sono arrivati in trecento, da tutto il mondo, a Bylakuppe. Laggiù, nello stato indiano del Karnataka, dal 26 al 30 agosto del 2010 i delegati del popolo tibetano in esilio hanno partecipato alla prima Assemblea Generale Tibetana. A organizzarla il Parlamento Tibetano in esilio, in agenda temi fondamentali come la riforma della linea politica del Governo Tibetano, la salvaguardia della democrazia, la promozione dell’istruzione e della cultura, soprattutto tra le nuove generazioni, il sostentamento economico degli insediamenti e lo status dei tibetani residenti all’estero. Tutti temi essenziali, mentre resta alta la tensione con la Cina e la richiesta di maggiore autonomia - tramontata per ora l’ipotesi di indipendenza - rimane lettera morta. La linea politica resta quella di un confronto senza violenza con le forze di occupazione. Il Presidente del Parlamento Tibetano, Pempa Tsering, ha confermato che i delegati si sono espressi a larga maggioranza a favore della Via di Mezzo formulata dal Dalai Lama. L’assemblea, all’unanimità, ha espresso la sua totale fiducia nel leader tibetano al quale ha chiesto di non abbandonare la carica ma di continuare a svolgere il ruolo di guida spirituale e temporale. In realtà, il Dalai Lama ha di fatto annunciato il proprio ritiro. “Verrà il momento in cui lascerò ogni responsabilità di Governo” - ha dichiarato -, “nella nostra democrazia, la mia presenza non è indispensabile”. Tenzin Gyatso ha spiegato anche che è già uno stato di fatto il trasferimento dei suoi poteri e delle responsabilità di Governo al primo Ministro. Ha ricordato ogni decisione viene presa con il Kalon Tripa - è il titolo del premier - e che d’ora in avanti i documenti più importanti del Governo Tibetano saranno firmati dal primo Ministro. Un cambiamento profondo, che vuole avvicinare regole e usi dei tibetani alle democrazie occidentale. Un adeguamento solo teorico, dato che il Tibet resta un territorio occupato dalla Cina, che non ammette trattative sull’indipendenza. Il pellegrinare nel mondo del Dalai Lama è l’unico

CINA TIBET

Generalità
Nome completo: Repubblica Popolare Cinese Bandiera
Lingue principali: Cinese mandarino Capitale: Pechino Popolazione: 1.330.503.000 Area: 9.596.960 Kmq Religioni: Confuciana, taoista, buddista (95%), cristiana (3,5%), musulmana (1,5%) Moneta: Renminbi Principali Praticamente tutto esportazioni: nel manifatturiero, più frumento, riso, patate PIL pro capite: Us 5.963
modo per ricordare l’occupazione. La situazione in Tibet, non cambia. C’è - dicono gli osservatori - una maggiore rassegnazione proprio da parte dei tibetani, diventati minoranza in casa loro. I cinesi hanno fatto del Tibet un territorio loro, portando milioni di Han a vivere là. Non si sentono più minacciati e sembrano quindi più tolleranti verso alcune necessità dei tibetani, permettendo scritte bilingue sui cartelli stradali e consentendo una maggiore libertà di culto.
Si fondono interessi strategici e una rivendicazione storica nello scontro fra Tibet e Cina. I cinesi da secoli rivendicano quel territorio e lo considerano essenziale dal punto di vista militare. Grazie al Tibet si presidia meglio la frontiera con l’India. Dal punto di vista economico, dalla regione si controllano enormi riserve d’acqua che vengono dai tanti fiumi e vi sono buone risorse minerarie. Queste esigenze cinesi - simile a quelle che nei secoli hanno tentato di controllare l’area - si scontrano naturalmente con la voglia di indipendenza dei tibetani, che forti di una cultura politico-religiosa radicata e delle tradizioni “È solo un problema interno”. Hanno pensato a questo le cancellerie di Stati Uniti ed Europa la mattina del 7 ottobre del 1950, leggendo sulle agenzie stampa o sui dispacci dei servizi segreti che quarantamila soldati dell’Esercito cinese avevano attraversato il fiume Yangtze e occupato tutto il Tibet orientale e il Kham - che ora è parte di tre province cinesi - uccidendo ottomila soldati tibetani male armati. Solo sette giorni dopo l’attuale Dalai Lama, Tenzin Gyatso diventò sovrano del Tibet Il cuore della controversa questione tibetana è tutto il quella frase: è un problema interno. Nessuno lo ricorda più, ma nessun Paese occidentale ha mai riconosciuto il Tibet come uno Stato sovrano indipendente. E non uno dei tanti governi europei o Nord americani che si sono succeduti in 59 anni di occupazione del territorio, dichiarando sempre quanto fosse giusta la fine della militarizzazione del Tibet da parte cinese, ha mai mosso un passo verso il riconoscimento della sovranità. Quindi, in punta di diritto internazionale, Pechino ha ragione nel definire la questione un “pro-

rivendicano il loro diritto ad essere uno Stato libero e autonomo. La scelta del Dalai Lama di trovare una soluzione attraverso il dialogo non convince tutti i tibetani. L’ala più radicale del movimento indipendentista chiede all’opinione pubblica mondiale un intervento più duro nei confronti della Cina, da loro considerata Paese occupante. Idea, questa, che si scontra con la realtà politica internazionale: molti Paesi, al di là delle dichiarazioni di principio, non hanno mai riconosciuto il Tibet come Stato sovrano e, quindi, continuano a considerare la vicenda come un problema interno alla Cina. blema interno”. I cinesi - coerenti con questa visione - avevano pianificato tutto. Soprattutto avevano saputo cogliere il momento adatto. Il mondo guardava solo alla guerra in Corea, scoppiata all’alba di domenica 25 giugno 1950, con un attacco della Corea del Nord di Kim Il Sung alla Corea del Sud. Gli Stati Uniti intervennero militarmente, subito, chiedendo e ottenendo l’ombrello politico delle Nazioni Unite. In questo clima, l’attacco al Tibet, pianificato da tempo, passò in secondo piano. Formalmente il Tibet era in una posizione di stallo, nata dall’abbandono dell’India da parte della Gran Bretagna nel 1947. Storicamente, la regione era stata a lungo indipendente, poi era caduta sotto l’influenza della Cina imperiale, prima di essere messa sotto tiro dalla Russia zarista e dal Regno Unito, che intervenne militarmente nel 1904. Da sempre, però, cultura e autonomia politica erano rimaste salde, tanto da definire una identità nazionale, che aveva nel Dalai Lama il capo di Governo e spirituale. La Cina aveva annunciato l’attacco. Mao, al potere dal 1949, aveva
Discarica nucleare
L’esistenza di scorie nucleari in Tibet è stata denunciata dal Dalai Lama nel 1992. Recentemente la Cina ne ha ammesso l’esistenza. Il 19 luglio 1995, l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua ha infatti dichiarato che, nella Prefettura autonoma tibetana di Haibei, vicino alle rive del lago Kokonor, il più grande lago dell’altopiano tibetano, vi è “una discarica di venti metri quadrati utilizzata per il deposito di materiale radioattivo”. In quell’area si troverebbe anche un centro nucleare segreto, chiamato Fabbrica 211. Una dottoressa dell’ospedale di Chabcha, Tashi Dolma, ha recentemente denunciato la morte per cancro di sette giovani nomadi che pascolavano il bestiame nella zona: si sono ammalati e i loro globuli bianchi erano aumentati a
livelli incontrollabili.
Quadro generale

Gedhun Choekyi Nyima (Maggio 1989)
Gedhun Choekyi Nyima, 11° Panchen Lama del Tibet, ha compiuto 21 anni nel maggio del 2010. È stato rapito dalle autorità cinesi, assieme ai suoi genitori, il 14 maggio 1995, a sei anni. A nulla sono valse le proteste di organizzazioni e governi, negli anni: è sempre prigioniero. Perché? La spiegazione è nella figura del Panchen Lama. Il nome si può tradurre come “grande erudito”. Come il Dalai Lama è considerato una reincarnazione del Buddha ed è subordinato solo al Dalai Lama. Non esercitava mai alcun potere civile. Questo permise al 10° Panchen Lama di continuare a vivere in Tibet e di esercitare la propria funzione dopo l’occupazione cinese e la fuga del Dalai. Alla morte, il successore è stato però rapito e suo posto, le autorità della Repubblica Popolare Cinese hanno designato un altro ragazzo, Gyaltsen Norbu, che cresce e studia a Pechino sotto lo sguardo vigile degli organi del partito.

I dati dell’occupazione Secondo dati degli osservatori internazionali, oltre un milione di tibetani sono morti a causa dell’occupazione del 1950. Il 90% del patrimonio artistico e architettonico tibetano, inclusi circa seimila monumenti tra templi, monasteri e stupa, è stato distrutto. La Cina ha poi canalizzato verso Pechino le enormi ricchezze naturali del Tibet, favorendo solo la classe dirigente e gli imprenditori cinesi. Lo scarico dei rifiuti nucleari e la massiccia deforestazione hanno compromesso l’ambiente e il fragile ecosistema del Paese. In Tibet sono di stanza 500.000 soldati della Repubblica Popolare.
più volte spiegato che voleva un Cina riunita in tutti i suoi territori e questo significava anche il Tibet. Il 1° gennaio 1950 Radio Pechino annunciò che presto il Tibet sarebbe stato liberato dal giogo straniero. Così, l’occupazione avvenne senza quasi proteste, messa ulteriormente in secondo piano dal fatto che i cinesi il 19 ottobre del 1950 intervennero pesantemente nella guerra di Corea appoggiando il Nord con milioni di uomini e mettendo in grave difficoltà gli Stati Uniti. Il 23 maggio 1951 il Dalai Lama firmò il “Trattato di liberazione pacifica” e diventò vice presidente del comitato permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo. Il documento permise alla Cina di iniziare la colonizzazione del Tibet. Prima militarizzandolo, poi spingendo i cinesi ad andare nella nuova regione. Il Tibet intanto rinunciava ad avere una politica estera autonoma, a batter moneta, a stampare francobolli. Le terre venivano ridistribuite, soprattutto nelle zone del Kham orientale e nell’Amdo, per non rompere i rapporti con l’aristocrazia. Da quel momento fu tutto un susseguirsi di ribellioni, avvicinamenti pacifici e rotture, spesso alimentate dall’esterno, da altri Paesi. Nel 1959 la prima grande rivolta. Il 10 marzo 1959 il movimento di resistenza tibetano guidò una protesta contro i cinesi. Per reprimerla, Pechino schierò 150.000 uomini e di unità aeree. Morirono in migliaia nelle strade di Lhasa e in altre città. Il 17 marzo, il Dalai Lama abbandonò la capitale e chiese asilo politico in India, assieme ad almeno 80mila profughi. I morti pare furono 65mila. Nel 1965 il Tibet venne dichiarato Regione Autonoma, con una annessione di fatto alla Cina. Nel 1968 la Rivoluzione Culturale portò alla distruzione dei monasteri, almeno 6mila e all’uccisione di molti monaci. La resistenza tibetana però non mollava. Nel 1977 e nel 1980 vi furono altre due sollevazioni, anche queste represse duramente da Pechino. Dal 1976, Pechino ha riavviato l’opera di colonizzazione, tanto che in Tibet sono arrivati 7milioni di cinesi, contro i 6milioni di tibetani che ci vivono. L’obiettivo di Pechino, denuncia la resistenza, è cancellare la cultura e l’identità tibetane. Il Dalai Lama, con il suo Governo in esilio in India, ha nel frattempo tentato la via della mediazione, rinunciando a reclamare l’indipendenza, puntando all’autodeterminazione per salvare la cultura del Paese e salvaguardare i diritti umani. Un mediazione proposta nel 1987 tramite gli Stati Uniti è fallita. E come sempre, dopo ogni fallimento, sono ricominciati gli scontri.

Situazione attuale e ultimi sviluppi
Un arcipelago per tanti popoli
Sono davvero molti i popoli che vivono nelle Filippine, differenziati spesso solo dalla lingua. La differenza religiosa, infatti, riguarda esclusivamente la minoranza mussulmana nell’isola di Mindanao. Notevole anche la presenza di diversi gruppi tribali, tutti numericamente poco significativi, che si caratterizzano per non aver subito l’influenza della cultura cristiana né musulmana. E da segnalare la massiccia presenza di meticci, cioè discendenti dagli spagnoli e di cinesi. Ecco comunque i dieci gruppi etnici più numerosi Bisaya (20.160.000) Tagalog (13.928.000) Ilocani (9.527.000) Hiliganon (8.068.000) Bicolani (3.504.000) Waray-Waray (3.426.000) Kapampangan (2.667.000) Ispanofilippini (2.575.000) Albay Bicolani (2.155.000) Panggasinan (1.637.000) Il doppio fronte della guerra interna alla Filippine è sempre aperto. Da un lato lo scontro con gli indipendentisti del Fronte Islamico di Liberazione Moro (Milf), dall’altro la guerra con il Nuovo Esercito del Popolo (Npa) di matrice comunista, continuano a far pagar prezzi alti in termini di vite umane. Nell’autunno dello scorso anno, Il Npa è tornato all’offensiva, con almeno 21 morti nella capitale Manila in vari attentati durante l’anno. In aprile in un agguato un gruppo di ribelli aveva aperto il fuoco e fatto esplodere una mina al passaggio di un veicolo della polizia ad Est della capitale Manila, uccidendo quattro agenti e ferendone cinque. Da quel momento è stato un continuo seguirsi di attentati, attacchi e azioni di polizia. Nei confronti del Milf e degli indipendentisti islamici c’è invece un doppio binario. Il neo presidente Benigni Aquino III - eletto in giugno - ha fatto ripartire le trattative di pace con risultati scadenti, così sono continuate le offensive militari. Per le trattative, il ministro degli Esteri della Malaysia è stato chiamato a fare da mediatore, senza risultato. Il Milf vuole trattare solo sulla base della cosiddetta “sovranità condivisa”, che prevede un unico stato con un Governo autonomo nel Sud islamico. Una ipotesi che può diventare realtà solo con una revisione della Costituzione e quindi con l’intervento del Parlamento filippino, poco disponibile ad una decisione di questo tipo. Così il Milf e il gruppo Abu Sayyaf - legato ad al-Qaeda - continuano a lottare per arrivare a creare uno stato islamico indipendente a Mindanao e nelle isole meridionali delle Filippine. Finito il Ramadan, la offensiva del Governo si è concentrata sull’arcipelago di Sulu, con l’impiego della marina militare per stanare i ribelli.

Generalità
Nome completo: Repubblica delle Filippine Bandiera

Lingue principali: Filippino, Inglese, Spagnolo, Arabo Capitale: Manila Popolazione: 93.000.000 Area: 300.000 Kmq Religioni: Cristiana (91%), musulmana (5%), altre (4%) Moneta: Peso Filippino Principali Prodotti agricoli, abbiesportazioni: gliamento e idraulica PIL pro capite: Us 4.923
Nel mirino soprattutto gli uomini di Abu Sayaff, gruppo nato negli anni Novanta per creare uno stato islamico nell’arcipelago del Pacifico e, dicono gli osservatori, degenerato poi diventando un normale gruppo criminale, dedito soprattutto ai rapimenti e alle estorsioni. A comandare la missione del Governo è il generale Benjamin Mohammad Dolorfino, comandate del distaccamento militare di Mindanao Ovest, che ha dichiarato che concentrerà le forze contro il gruppo di Sulu, forte di circa 200 uomini e contro quello di Basilau, che ne conta solo cento.
Lo scontro principale, nelle Filippine, è tra maggioranza cristiana e minoranza mussulmana, che reclama l’indipendenza. E nel fondo di tutto questo c’è la pessima distribuzione della ricchezza, in termini sociali e territoriali. Il Nord e il Centro dell’Arcipelago sono, appunto, le aree a maggioranza cristiana e sono le zone più ricche rispetto al Sud, a prevalenza mussulmana. Gli islamici - che sono il 5% della popolazione L’elezione di un altro Aquino alla presidenza, Benigno, figlio dell’icona della democrazia Filippina, Cory Aquino, ha portato speranze nel Paese asiatico, ma la situazione resta difficile e complessa, come è la storia delle Filippine, passate attraverso una lunga colonizzazione e una altrettanto lunga dittatura. Prima colonia della Spagna, poi degli Usa, dopo l’indipendenza il Paese è stato guidato con mano dittatoriale da Marcos sino al 1986, anno in cui inizia la vita democratica delle Filippine, con l’elezione della presidente Cory Aquino. L’arrivo della nuova Presidente portò ad un accordo con i movimenti separatisti musulmani di Mindanao, attivi nel Sud del Paese sin dagli anni ‘50. Venne concessa loro ampia autonomia amministrativa. Questo fermò il conflitto armato con i separatisti. Continuò invece la guerra con il Nuovo Esercito del Popolo: nel 1990, la guerriglia riprese, dopo la denuncia della scomparsa di attivisti politici e sindacali della sinistra. Il 26 novembre 1991 un altro pezzo del passato coloniale se ne andò: gli Usa si ritirarono dalla base di Clark - una delle due esistenti nelle Filippine, l’altra è Subic Bay -, ritirando 6mila effettivi americani. Nel maggio dell’anno dopo venne eletto alla presidenza Fidel Ramos, ex ministro della Difesa. Venne lanciata una campagna contro il crimine che portò al licen-

complessiva - da sempre accusano la maggioranza cristiana di non aver fatto abbastanza per distribuire le risorse equamente. Lo stesso, ma in senso non religioso e con obiettivi differenti, fanno i gruppi di origine marxista. Una cattiva distribuzione che è ben rappresentata dalla diffusione della popolazione sul territorio: il 60% degli 85milioni di Filippini, infatti, vive in una sola isola, Luzon, dove c’è la capitale. ziamento del 2% dei poliziotti e alla denuncia per associazione a delinquere di un altro 5%. Contemporaneamente, la guerriglia comunista del Npa perdeva forza a causa delle divisioni interne e di un’amnistia accordata ai suoi membri dal Governo. Nel 1996 parve risolto anche il problema con i separatisti islamici. Il 30 settembre venne firmato un accordo di pace e Nul Misauri, capo del Fronte di Liberazione Nazionale Moro, diventò governatore di Mindanao, regione autonoma enorme. Fu una pace di breve durata. Già nel 2000 i musulmani chiedevano un referendum per l’autodeterminazione, mentre la maggioranza cattolica protestava contro l’accordo non accettandolo. Intanto una serie di scandali per tangenti e corruzione travolgeva la politica. Nell’aprile del 2002 a General Santos, nel Sud del Mindanao, venne dichiarato la stato d’allerta, per l’esplosione di parecchie bombe, con 14 morti, a opera del Milf, il Fronte Islamico di Liberazione Moro. È la ripresa ella guerra. In giugno gli Usa accusarono i leader del gruppo Abu Sayyaf, legato ad al-Qaeda di aver rapito e ucciso due statunitensi. In ottobre, il gruppo mette a segno una serie di attentati contro grandi magazzini e una chiesa, con 8 morti e 170 feriti. L’obiettivo dichiarato è creare uno stato musulmano. Lo scontro con i gruppi isla-
In nome del Re
Interessante scoprire da dove viene il nome Filippine. Deriva dal nome del re Filippo II di Spagna. Durante i suoi viaggi esplorativi lungo l’arcipelago, l’esploratore e navigatore spagnolo Ruy Lopez de Villalobos le chiamò la prima volta chiamandole las Islas Filipinas, cioè le Isole Filippine. Inizialmente il suo riferimento geografico era solo alle isole di Leyte e Samar, mentre il resto le altre isole avevano nomi differenti. Solo più tardi, il termine Filipinas arrivò ad identificare l’intero arcipelago. Durante la rivoluzione filippina, il Paese si chiamò República Filipina (Repubblica Filippina). Poi, dopo la guerra ispano - americana del 1898 e con l’arrivo degli Stati Uniti la denominazione Filippine iniziò ad apparire sempre più spesso e venne utilizzata come nome
ufficiale.
Quadro generale

Benigno Simeon “Noynoy” Cojuangco Aquino III , è il 15mo Presidente delle Filippine. Soprattutto, però, è il figlio della donna che ha rappresentato la nascita della democrazia nell’arcipelago asiatico, cioè Corazon Aquino, morta nel 2009 a 76 anni. Alla ribalta il 50enne benigno è salito la prima volta proprio durante la presidenza della madre, nel 1987. Rimase, infatti, coinvolto in un tentativo di golpe di alcuni militari. Venne ferito da cinque proiettili e uno gli è rimasto nel collo, come ricordo del fatto. Laureato in economia, dal 1988 fa parte del Partito Liberale, di cui è stato anche segretario. Prima della elezione, è stato uno dei maggiori oppositori della presidente Gloria Macapagal - Arroyo, che ha accusato di violazione dei diritti umani. Ha accettato la candidatura alla presidenza nel 2009, 40 giorni dopo la morte della madre dichiarando di “accettare le istruzioni dei miei genitori e di voler proseguire la lotta per il bene del Paese”. Ha vinto battendo largamente gli avversari e appena insediato ha tentato di aprire una trattativa di pace con gli indipendentisti islamici del Sud. Finora senza risultati.

La guerra dei nomi In Asia, come nel resto del mondo, le rivalità geografiche, le rivendicazioni di possesso passano anche attraverso i nomi. Ad esempio, quello che per Pechino è il mar Cinese Meridionale, per Hanoi è il Mare Orientale, le Paracel sono le Hoang Sa per Hanoi e le Xisha per Pechino, le Spratly vengono chiamate Truong Sa dal Vietnam e Nansha dalla Cina. Proprio queste isole sono rivendicate anche dalle Filippine, che hanno compiuto passi formali presso il Governo cinese e l’Onu. L’arcipelago è formato da circa 600 fra atolli corallini e isole, La maggiore è Itu Aba, di appena 0,36 chilometri quadrati di superficie. Nessuna delle isole è abitata in modo permanente. Nel sottosuolo, però, ci sono petrolio e gas naturale, in più l’arcipelago è giusto sulle rotte di navigazione più importanti dell’area. Dal gennaio la Repubblica Popolare di Cina occupa le Paracel, che i francesi avevano annesso all’Indocina nel ’32, e non vuole mollarle. Il Vietnam resta la rivale più agguerrita, nonostante i proclami di amicizia e gli accordi sul confine di terra siglati nel 2009 con Pechino. La nuova assertività, anche marittima, di Pechino pesa. Ma i sei sottomarini che, in base a un accordo di dicembre 2009, Hanoi ha comperato dalla Russia, fanno pensare che il Vietnam non voglia proprio lasciar perdere.
mici divenne sempre più duro, ma restava alta la tensione anche i gruppi guerriglieri di origine marxista. Nel gennaio 2003, il partito comunista si assunse la responsabilità dell’omicidio di un suo ex dirigente, Romulo Kintanar, attribuendolo al suo braccio armato, il Nuovo Esercito del Popolo (Npa). Nel 2003, Amnesty International denunciò l’uso della tortura su prigionieri politici, membri di gruppi armati e criminali comuni. Accusa che venne respinta dal Governo. Nel marzo del 2004, venne sventato un attentato simile a quello che aveva colpito Madrid l’11 marzo. Vennero arrestati quattro membri di Abu Sayyaf con 36 chili di esplosivo confiscati. Uno di loro si dichiarò responsabile dell’attentato che il 27 febbraio di quell’anno costò la vita a 100 persone sul SuperFerry 14. Gli arrestati svelarono di essere stati addestrati dalla rete terroristica Jemaah Islamiah, legata ad al-Qaeda, progettavano attentati contro treni e negozi a Manila, città con dieci milioni di abitanti. Nel 2004, la Norvegia mediò un accordo fra Nuovo Esercito del Popolo e Governo. L’anno successivo, dopo negoziati di pace in Malaysia, indipendentisti musulmani e Governo annunciarono un accordo sulle terre ancestrali di cui i ribelli rivendicavano la proprietà da trent’anni. Tregue che non durarono. Un nuovo tentativo di tregua è saltata nel 2010 e sono ripresi i combattimenti. Si calcola che dal 1971 a oggi siano stati più di 150mila i filippini morti tra Mindanao e l’arcipelago di Sulu, nello scontro per l’indipendenza e oltre 50mila gli sfollati. Il conflitto con la guerriglia del Npa, invece, avrebbe procurato almeno 40mila morti, a partire dal 1969.
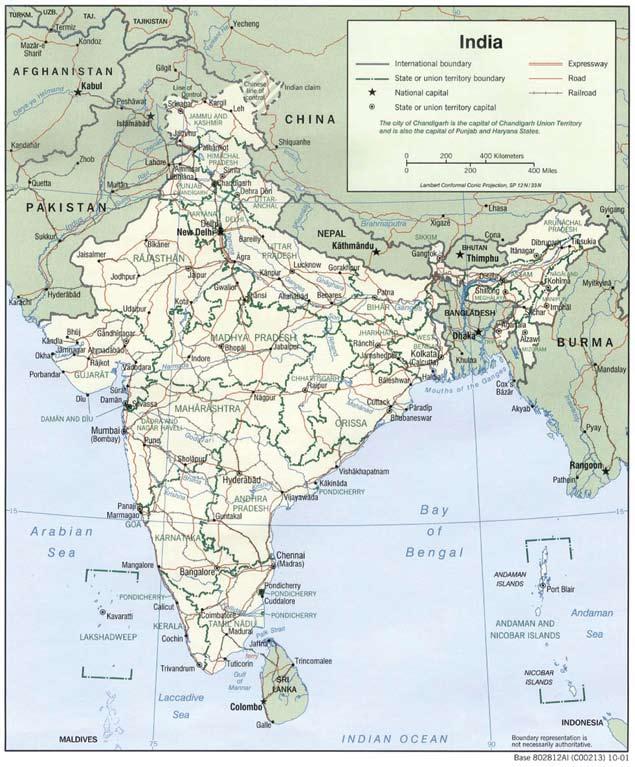
Situazione attuale e ultimi sviluppi
Danni economici
La guerriglia naxalita arreca molti danni all’economia indiana. La cosiddetta area naxalita occupa circa il 40% del Paese e un terzo della popolazione indiana. Inoltre, in quelll’area si trovano ricche miniere di ferro e di carbone. Come se non bastasse, la guerriglia naxalita attacca in continuazione le linee ferroviarie, le centrali elettriche e le principali vie di comunicazione. Negli ultimi anni sono tante le aziende che straniere che hanno abbandonato l’area e ancora di più i possibili investimenti persi. L’India è un Paese in piena espansione economica. E se l’economia non ha ancora raggiunto livelli di sviluppo paragonabili a quella cinese è dovuto soprattutto alle tre regioni interne in cui è in corso una guerriglia (Kashmir, Nord-Est ed Est), e in particolare le zone dove operano i naxaliti, che abbiamo visto essere dal punto di vista economico strategicamente più importanti delle altre. L’India è la più popolosa democrazia del pianeta. Una democrazia impregnata di nazionalismi di ogni tipo, a partire da quello indù. Una democrazia dove la violenza è all’ordine del giorno, sia nei confronti delle minoranze religiose (musulmani in Kashmir), sia di quelle etniche (popoli che vivono nel Nord-Est del Paese), sia nei confronti dei poveri contadini delle regioni centro-Sud orientali (naxaliti). In questo momento all’interno del territorio sono in corso tre guerre, combattute da una parte con lo strumento della guerriglia e del terrorismo, dall’altra con la repressione dell’esercito. Negli ultimi due anni la guerriglia maoista naxalita ha deciso di giocare la carta delle pubbliche relazioni e dell’opinione pubblica. L’autorevole centro studi geostrategici con base in Texas, Stratfor, sostiene che i naxaliti “hanno trovato la strada per mettere in difficoltà il Governo di Nuova Delhi”. Il potere nazionalista indù ha grosse difficoltà a contenere movimenti di opinione e campagne mediatiche. E così, “i naxaliti hanno fatto nascere diverse organizzazioni universitarie a Nuova Delhi e nelle altre capitali regionali, il cui scopo è accattivarsi le simpatie degli studenti e mostrare un volto non violento del movimento”. A quanto pare la mossa ha avuto successo, perché il giornali indiani hanno cominciato a parlare di loro in termini non sempre ostili. I naxalisti sono un movimento marxista maoista, diviso in una settantina di gruppi e organizzazioni diverse, che si batte (a loro detta) per ottenere una riforma agraria e per dare maggiori diritti ai contadini. Nel Nord-Est, invece, ogni anno è uguale all’altro. Una legge dello Stato indiano autorizza ad applicare nei sette Stati che si trovano incastrati tra Bhutan, Bangladesh, Myanmar e Cina “l’uso indiscriminato della forza e arresti senza mandato” in nome del mantenimento dell’ordine pubblico. “Nessun processo o altre azioni


Generalità
Nome completo: Repubblica dell’India Bandiera
Lingue principali: Hindi, inglese e altre 21 lingue Capitale: Nuova Delhi Popolazione: 1.147.995.904 Area: 3.287.594 Kmq Religioni: Induista (80,45%), musulmana (13,43%), cristiana (2,34%), sikh (1,87%), buddista (0,77%) Moneta: Rupia Principali Tessuti, gioielli, proesportazioni: dotti dell’ingegneria e software PIL pro capite: Us 2.563[5]
legali contro le forze di sicurezza” macchiatesi di reati “possono essere intraprese senza il permesso del Governo”. E tutto questo avviene quotidianamente fin dal 1971 negli Stati di Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Negaland, Tripura e Assam. In quest’area le minoranze etniche buddhiste, che lottano per l’indipendenza, vengono discriminate, anche nella professione della loro religione.
Il movimento naxalita ha una grossa spinta ideologica e sociale. Ma come avviene in tante altri parti del mondo viene appoggiato da forze esterne al movimento che sono mosse da altri interessi. I naxaliti possiedono un esercito di circa 7.000 soldati ben equipaggiati, oltre a una serie di piccole organizzazioni terroriste. Tutto questo è reso possibile dagli aiuti che arrivano dall’estero. In particolare dal partito maoista nepalese (che porta avanti una guerriglia da oltre trent’anni), il partito maoista bhutanese, quello dello Sri Lanka e la Cina (che peraltro è il principale sostenitore anche dei maoisti nepalesi e bhutanesi). La Cina ha bisogno di allargare il suo controllo sui territori che si affacciano sull’Oceano Indiano per pure ragioni commerciali, visto che il Paese si affaccia solo sull’Oceano Pacifico e che la maggior parte del commercio arriva via mare da Africa, Medio Oriente ed Europa. Inoltre, la Cina è un Paese prima nemico e oggi concorrente dell’India (anche se negli ultimi anni le relazioni tra i due Stati sono molto migliorate). In altre parole, Pechino ha bisogno di porti sicuro per le sue merci e per le risorse energetiche di cui ha bisogno. La guerriglia nel Nord-Est del Paese, invece, combatte per l’indipendenza di quegli Stati dell’Unione indiana e delle etnie che ci abitano. Anche in questo caso, però, c’è dietro la mano della Cina. Le ragioni sono le stesse che per i naxaliti. In questo caso, però, ci sono altri due Paesi che finanziano la guerriglia: il Bangladesh e Myanmar. Entrambi strettissimi alleati della Cina.


Il movimento naxalita indiano e la relativa guerriglia e la guerriglia del Nord-Est hanno origini lontane. Nascono difatti quando gli inglesi lasciarono l’India, e gli Stati del Nord-Est rifiutarono l’invito dell’allora Presidente indiano Nehru ad entrare nell’Unione indiana. La guerriglia è stata in origine particolarmente attiva in Assam, Nagaland, Manipur e Mizoram dove, alleati del gruppo indipendentista di Angami Zapu Phizo, agiva come squadra di guastatori per la Naga Army secondo il motto: “Il potere politico scaturisce dalla canna del fucile”. Finanziati e addestrati prima dal Pakistan orientale (l’attuale Bangladesh) e poi dalla Cina, col tempo hanno cambiato di segno per diventare ufficialmente i difensori dei diritti dei poveri e delle caste basse nelle zone rurali. La rivoluzione armata naxalita aveva però registrato una forte battuta sotto la presidenza di Indira Gandhi, quando il Governo mise al bando i gruppi rivoluzionari e ne ordinò l’eliminazione. Il movimento di ispirazione maoista, sconfitto ma non morto, si riorganizzò ai principi degli anni Ottanta nella cittadina di Naxalbari, nel lo Stato di Darjeeling. La cittadina da cui il movi-
Quadro generale
Muppala Lakshman Rao
Muppala Lakshman Rao, detto Ganapathi è il segretario generale del Partito comunista maoista indiano. La sua leadership è stata ufficializzata nel congresso di rifondazione del partito, il 14 ottobre 2004, con la fusione di due tronconi del movimento dei naxaliti, il Maoist Communist Centre of India (Mcc) e il Communist Party of India People’s War (anche conosciuto come People’s War Group e spesso abbreviato in Pwg). Ganapathi intende portare l’India verso una nuova rivoluzione democratica “contro l’imperialismo, il feudalesimo e il capitalismo burocratico”. Nato nel villaggio di Beerpur, nello Stato dell’Andhra Pradesh, Ganapathi ha lavorato come insegnante liceale, finché non ha incontrato il leader maoista Nalla Adi Reddy. Incontro che lo ha spinto ad entrare nel movimento naxalita. Egli ha dichiarato nel corso di un’intervista: “Mi piacerebbe riuscire a fare qualcosa di simile alla Lunga marcia di Mao anche qui in India. Sono certo che un’impresa del genere porterebbe questo Paese a cambiare. Non ne possiamo più del neocolonialismo dell’Occidente, e nemmeno del sistema parlamentare, che, i fatti dimostrano, essere un sistema fallimentare”.

Gurkha Una delle etnie che più si battono contro il Governo centrale di Nuova Delhi è quella Gurkha, un’etnia di origine nepalese che vive nello Stato di Assam. Il popolo Gurkha è famoso in tutto il mondo per aver costituito un corpo speciale all’interno delle forze armate britanniche: il Royal Gurkha Riflemen. I Gurkha sono considerati grandi guerrieri. Li si potrebbe quasi definire i “samurai” del Nord-Est indiano, abilissimi nell’uso del pugnale. Cominciarono ad arruolarsi come volontari nell’esercito della Compagnia britannica delle Indie orientali a partire alla conclusione della guerra anglo-nepalese (1812-1815). La repressione in Assam ha portato alla nascita del Gtf (Forza delle Tigri Gurkha), che conduce da anni una sanguinosa guerriglia contro le forze di occupazione hindu. Una guerriglia letale quella dei Gurkha, abilissimi nelle imboscate, nei colpi di mano e nella lotta corpo a corpo.
mento prende nome e in cui troneggia ancora un busto di Charu Mazumdar, padre ideologico dei moderni guerriglieri maoisti e filosofo “dell’annientamento selettivo”. I naxaliti si proponevano di instaurare il Governo del popolo e fornirono appoggio alle rivendicazioni dei contadini e dei gruppi tribali degli Stati in cui operano. In pochi anni, complici povertà e privilegi dei ricchi duri a morire nelle zone rurali, presero piede un po’ dappertutto. Soprattutto nel misero Stato di Bihar, dove i naxaliti contrastarono efficacemente i temibili eserciti dei latifondisti e si batterono contro i privilegi di casta. Arrivarono a fondare un Governo parallelo che in pochi anni, con azioni armate e con i suoi “tribunali istantanei”, eliminò qualche migliaio di “sfruttatori della classe contadina”. Altrettanto accadde ai movimenti naxaliti in Orissa e nel confinante Madhya Pradesh. Nel 2004 il salto di qualità. Il Maoist Communist Centre of India (Mcc) e il Communist Party of India People’s War (noto anche come People’s Guerriglia Group o Pwg) si sono uniti dando vita al Communist Party of India-Maoist (Cpi-M), superando divisioni ideologiche e conflitti interni. La nuova formazione, di cui è stato eletto segretario generale Muppala Laxman Rao, detto Ganapathi, ha pubblicato un manifesto ideologico contenuto in cinque punti. Negli Stati del Nord-Est, invece, agiscono prevalentemente due organizzazioni armate: il Fronte unito di liberazione dell’Assam (Ulfa) e il Fronte democratico nazionale del Bodoland (Ndfb). La guerriglia iniziò nel 1971, in seguito alla separazione tra il Pakistan occidentale e il Pakistan orientale. Il nuovo Bangladesh abbandonò al suo destino le etnie non indù delle regioni indiane circostanti. E queste per trovare sicurezza si affidarono alla neonata guerriglia. Da allora nulla è cambiato. Anche se a partire dal 2004 il Nord-Est ha il suo martire, in nome del quale combattere. Una trentaduenne del Manipur (Thangjam Manorama Devi) venne accusata senza prove di aver appoggiato i separatisti. In carcere Manorama venne stuprata e poi uccisa durante l’interrogatorio. La terribile vicenda di Manorama fece scendere in strada migliaia di contadini e studenti per chiedere delle leggi razziali. Da allora il movimento separatista ha ripreso vigore.
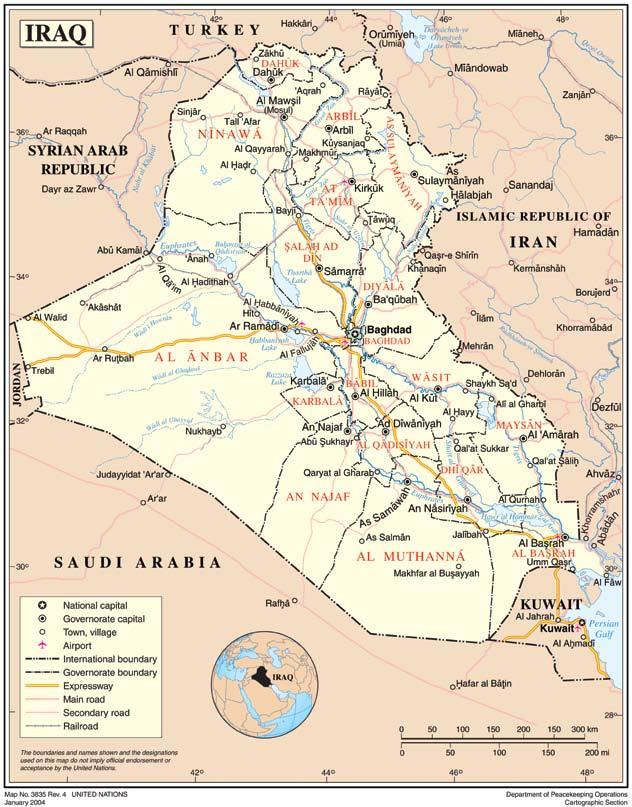
Situazione attuale e ultimi sviluppi
Il petrolio
Sono una dozzina i contratti firmati finora dal Governo di Baghdad con diverse compagnie petrolifere internazionali (fra queste l’Eni) per lo sviluppo di altrettanti giacimenti, situati per lo più nel Sud, dove è concentrato il grosso della ricchezza. L’obiettivo, ambizioso secondo diversi esperti, è aumentare la produzione di greggio da 2,4milioni di barili al giorno a 12milioni entro il 2017. Sono contratti “di servizio”, dove la compagnia straniera viene pagata per il lavoro fatto, e non partecipa agli utili della produzione, e hanno una durata di 20 anni. A operare saranno joint venture in cui l’Iraq mantiene una quota di minoranza. Fra le compagnie che hanno concluso gli accordi solo una è americana: la ExxonMobil. A fare la parte del leone sono state la malese Petronas, e i cinesi di Cnpc. Il 14 dicembre 2008, dopo molti mesi di faticosi negoziati, Iraq e Stati Uniti firmano lo Status of Forces Agreement (Sofa), che stabilisce il ritiro delle truppe Usa dalle città e dai centri abitati entro il 30 giugno 2009 e il loro ritiro totale entro fine 2011. Nel febbraio 2009, il nuovo Presidente Usa Barack Obama annuncia che le operazioni “da combattimento” in Iraq si concluderanno entro il 31 agosto 2010. La scadenza viene rispettata. Nel Paese rimangono circa 50mila soldati statunitensi, con compiti prevalenti di addestramento delle forze di sicurezza irachene. Fino al ritiro totale entro il 2011. Ma la stabilità in Iraq è ancora lontana. Se la violenza è diminuita (relativamente), in campo politico i progressi sono davvero pochi. Le elezioni legislative che si sono tenute il 7 marzo 2010 hanno visto vincere di strettissima misura Iraqiya, alle-


Generalità
Nome completo: Repubblica Irachena Bandiera
Lingue principali: Arabo, curdo Capitale: Baghdad Popolazione: 27.102.912 Area: 437.072 Kmq Religioni: Musulmana Moneta: Dinar iracheno Principali Petrolio esportazioni: PIL pro capite: Us 3.400

anza di forze nazionaliste guidata dall’ex primo Ministro Iyad Allawi. Ma a oltre cinque mesi dal voto, non c’è ancora un Governo. Nessuna delle maggiori formazioni politiche ha da sola i 163 seggi che occorrono per votare la fiducia in Parlamento, e i negoziati per le alleanze segnano il passo. Maliki, il premier uscente, la cui coalizione ha solo due seggi in meno della lista di Allawi, vuole a tutti i costi un secondo mandato. Iraqiya insiste sul proprio “diritto elettorale e costituzionale” a formare il Governo. E l’impasse nella quale si trova il Paese fa temere per il suo futuro.
L’invasione dell’Iraq del marzo 2003 e il rovesciamento del regime di Saddam Hussein, con la successiva occupazione guidata dagli Stati Uniti, hanno messo in moto una serie di dinamiche che hanno destabilizzato il Paese. Il controllo delle sue ricchezze, in particolare quella petrolifera, e la questione di una decentralizzazione estrema (definita federalismo) che oppone i kurdi al Governo centrale di Baghdad, L’Iraq, Paese di storia e cultura millenarie, è oggi noto soprattutto per le sue vicende recenti. Un tempo parte dell’Impero Ottomano, diventa, nel 1920, uno Stato - una monarchia sotto mandato britannico, per decisione della Società delle Nazioni, finita la Prima Guerra Mondiale. Nel 1932 l’indipendenza. Il 14 luglio 1958 un colpo di Stato nazionalista rovescia la monarchia. Ma il Governo di Abdul Karim Qasim durerà poco. Nel 1963, l’8 febbraio, un altro golpe - guidato dal Ba’ath, partito nazionalista arabo, secondo alcune fonti con l’appoggio della Cia. Qasim viene ucciso, e si scatena una repressione sanguinosa, in particolare contro i comunisti. Abdul Salam Arif, Presidente della Repubblica, presto estromette i ba’athisti e diventa primo Ministro. Il 17 luglio 1968 il Ba’ath torna al potere - con un altro colpo di Stato, che instaura il regime del partito unico. Inizia l’ascesa di Saddam Hussein, numero due del generale Ahmad Hasan al Bakr, di cui prende il posto, il 16 luglio 1979, diventando Presidente dell’Iraq. Nel febbraio dello stesso anno (1979), in Iran la Rivoluzione Islamica guidata dall’Ayatollah Ruhollah Khomeini rovescia il regime dello Scià. L’Occidente, e gli Stati Uniti in particolare, perdono un alleato strategico nell’area, ma gli eventi inquietano anche il vicino Iraq, dove il regime laico, dominato dai sunniti, ne teme la

restano nodi irrisolti - strettamente legati - che potrebbero deflagrare in un conflitto. Lo scontro, tuttora in atto, è fra quelle forze politiche che vogliono un forte Governo centrale, che gestisca anche le risorse del Paese a cominciare dal petrolio, e quelle che perseguono un progetto che mira a dare i poteri alle Regioni federali. possibile influenza, visto che nel Paese gli sciiti sono maggioranza, come in Iran. Il 22 settembre 1980 Saddam attacca l’Iran. Inizia una guerra sanguinosa che si concluderà con un cessate il fuoco il 20 agosto 1988 - senza vincitori né vinti, e con centinaia di migliaia di morti: le stime vanno da 500.000 a un milione (cifre precise non ce ne sono), di cui almeno 300.000 iraniani. L’Occidente - Stati Uniti in testa - si schiera con Baghdad. Finita la guerra, l’Iraq è in una situazione economica disastrosa, con un debito enorme (fra 60 e 80 miliardi di dollari) verso i Paesi arabi del Golfo, che ne hanno finanziato l’avventura militare. Nel luglio 1990, Saddam accusa il Kuwait di abbassare il prezzo del petrolio per indebolire l’economia irachena. Il 2 agosto invade l’emirato. Il 6 agosto le Nazioni Unite impongono un embargo che metterà in ginocchio il Paese: l’obiettivo iniziale è costringere Baghdad a ritirarsi dal Kuwait. Ma incombe anche l’azione militare, in base al Capitolo VII della Carta dell’Onu, che autorizza l’uso della forza per le minacce alla pace internazionale. L’Operazione Desert Storm inizia il 17 gennaio 1991: l’Iraq viene attaccato da una coalizione di 34 Paesi. Il 3 marzo 1991 Baghdad accetta il cessate il fuoco. Le sanzioni vengono mantenute, nonostante il ritiro dal Kuwait. Perché vengano tolte l’Iraq dovrà dimostrare di non
Il Sofa
Firmato a fine 2008 dal governo di Baghdad con l’amministrazione di George W. Bush, dopo mesi di negoziati, lo Status of Forces Agreement (SOFA) è un accordo bilaterale sulla presenza militare statunitense in Iraq, sulla falsariga dei numerosi accordi con i Paesi stranieri in cui gli Stati Uniti tengono loro truppe. E’ importante soprattutto per il calendario del ritiro delle forze Usa, sostanzialmente imposto ai negoziatori statunitensi dal governo di Baghdad. Due le date: 30 giugno 2009, ritiro dai centri abitati, e 31 dicembre 2011 - quando tutti i soldati statunitensi dovranno aver lasciato l’Iraq. A queste, per decisione del nuovo presidente Usa Barack Obama, si è aggiunta il 31 agosto 2010, fine delle operazioni “di combattimento”. In Iraq restano fino al 2011 meno di
50.000 soldati americani.
Quadro generale

Muqtada al Sadr (Najaf, 12 agosto 1973)
Muqtada al Sadr torna a essere l’ago della bilancia nella politica irachena. Giovane esponente religioso sciita senza particolari credenziali, deve il suo prestigio al fatto di venire da una famiglia influente - che ha avuto due “martiri” sotto il regime ba’athista. Il padre, Mohammed Sadiq al Sadr, fu assassinato a Najaf nel febbraio 1999 da alcuni sicari, mentre un parente, Muhammad Baqir al Sadr, era stato giustiziato nel 1980. Dopo l’invasione dell’Iraq del 2003, Muqtada è stato coerente nel suo atteggiamento contro l’occupazione, con cui ha sempre rifiutato di collaborare. Il suo Esercito del Mahdi, accusato di violenze contro gli arabi sunniti fra il 2006 e il 2007, è stato sciolto e sostituito da un’organizzazione a carattere sociale sul modello degli Hezbollah libanesi. Sadr, che da qualche anno vive in Iran dove studia per diventare ayatollah, è tuttavia anche un politico accorto e pragmatico, con un movimento che ha una vera base popolare fra gli sciiti iracheni. Forte dei 40 seggi conquistati in Parlamento alle elezioni del 7 marzo 2010, il suo appoggio al premier Nuri al Maliki, che vuole a tutti i costi un secondo mandato, si è rivelato decisivo, come già era avvenuto nel 2006.

possedere più “armi di distruzione di massa” (nucleari, chimiche, biologiche). Inizia un regime di ispezioni internazionali, sotto il controllo delle Nazioni Unite. L’embargo devasta il Paese, già distrutto da una guerra, colpendo in particolare donne, bambini, e anziani. E di fatto rafforza il regime. Il programma dell’Onu “Oil for Food”, che dal 1997 tenta di alleviare la drammatica crisi umanitaria, si rivela del tutto inadeguato. Ma fra Iraq e Stati Uniti il braccio di ferro continua: obiettivo di Washington è il “cambio di regime”. Dopo l’11 settembre 2001, il presidente George W. Bush decide di rovesciare Saddam, con il pretesto delle “armi di distruzione di massa”. Agli ispettori dell’Onu viene impedito di completare il loro lavoro di verifica. Pur in assenza di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che autorizzi l’azione militare (Francia, Russia, e Cina, tre dei membri permanenti, sono contrari), Stati Uniti e Gran Bretagna decidono di invadere il Paese. Il 20 marzo 2003 inizia l’Operazione Iraqi Freedom. Il 9 aprile i carri armati americani entrano a Baghdad. Deposto il regime di Saddam, il 1° maggio 2003, Bush jr, a bordo della portaerei Abramo Lincoln, sotto uno striscione che dice “Missione compiuta”, dichiara concluse le “operazioni di combattimento”. In Iraq si insedia un’amministrazione civile di occupazione a guida statunitense-britannica - la Coalition Provisional Authority. Che presto tuttavia deve fare i conti con una guerriglia efficace e variegata, che la cattura di Saddam (14 dicembre 2003) non scalfisce minimamente. Il rapido precipitare degli eventi convince Washington ad accelerare il “passaggio di consegne” agli iracheni. A fine giugno 2004 la Cpa viene sciolta, e l’Iraq riacquista la sua “sovranità”. Con un Governo a interim guidato da Iyad Allawi (fra i leader dell’opposizione in esilio), in attesa di elezioni. L’Iraq di fatto è ancora un Paese occupato: a legittimare la presenza delle truppe straniere (dal luglio 2003 c’è anche un contingente italiano) è una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, poi prorogata annualmente, che autorizza la cosiddetta “Forza multinazionale” - sotto comando statunitense. Le prime elezioni si tengono il 30 gennaio 2005: un “Governo di Transizione” ha il compito di redigere la nuova Costituzione. Che viene approvata, di stretta misura, in un referendum popolare il 15 ottobre 2005. Il 15 dicembre 2005 gli iracheni tornano a votare. Ma per il Governo bisognerà aspettare il maggio 2006: il nuovo esecutivo guidato da Nuri al Maliki è una coalizione fra partiti sciiti (religiosi) e kurdi - i due gruppi perseguitati dal regime di Saddam. L’ex Presidente iracheno, condannato a morte da un Tribunale speciale, viene giustiziato il 30 dicembre 2006. Il 22 febbraio 2006 un attentato contro la moschea al Askariya di Samarra (luogo assai venerato dagli sciiti) innesca un ciclo sanguinoso di violenze confessionali fra sunniti e sciiti. Migliaia di iracheni di entrambe le confessioni sono costretti a lasciare le proprie case per salvarsi la vita. Molti diventano sfollati interni, molti altri se ne vanno, soprattutto in Siria e in Giordania. Fra loro, moltissimi sunniti e cristiani, in gran parte della classe media professionale. Gli americani non sanno più che fare. Dal gennaio 2007 il presidente Bush jr. avvia una nuova strategia irachena: la cosiddetta “surge”, basata sull’aumento della presenza militare, che raggiungerà un picco di quasi 170mila uomini. Ma il fattore decisivo per la diminuzione della violenza (che pur resta elevata) sono i cosiddetti “Consigli del Risveglio”: formazioni tribali sunnite alleatesi con le truppe Usa per combattere “al-Qaeda in Iraq”.

Come leggere le Mappe
Nella Mappa Onu, qui sopra, troverete solamente indicato lo Jammu and Kashmir poichè si tratta dell’antico nome dell’intera area contesa da India, Pakistan e Cina. La Mappa, qui a destra, indica invece la spartizione di fatto dei territori da parte dei suddetti Stati, con diversa denominazione, mai riconosciuta a livello internazionale.

Situazione attuale e ultimi sviluppi
Terrorismo in India
18 dicembre 2001, un commando di estremisti islamici irrompe nel parlamento indiano a Nuova Delhi. Il bilancio è di 13 morti. L’attacco è rivendicato da una sedicente sigla terrorista che combatte per l’indipendenza del Kashmir. 25 novembre 2008, un commando di terroristi pachistani attacca l’hotel Taj Mahal e il centro ebraico di Mumbai, in India. Dopo 62 ore di battaglia i morti sono 195. Nuova Delhi accusa i servizi segreti pachistani di aver progettato l’operazione. Tra questi due attacchi in India sono avvenute centinaia di azioni del terrorismo islamico. Tutti attacchi rivendicati in nome dell’indipendenza del Kashmir. Per raccontare di cosa accade in Kashmir dobbiamo spostarci altrove. A Kabul, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2010. Un commando paramilitare irrompe nel City Center. Il bilancio è di nove morti (tra cui un agente dei servizi segreti italiani) e ventinove feriti. Qualche anno prima, a Herat, in Afghanistan occidentale, il 7 maggio 2006. Una bomba esplode davanti a un caffé: due morti. In entrambi i casi la colpa viene attribuita ai talebani. In realtà, l’inchiesta sull’attentato del 2006 scoprirà che a piazzare l’ordigno è stato un agente dell’Isi (il servizio segreto pachistano), il cui scopo fallito era far saltare in aria il consolato indiano che si trova a pochi metri dal caffé. Emergerà anche che ad aprire il fuoco nell’edificio della capitale nel 2010 era stata una squadra militare pachistana, con lo scopo di colpire una centrale di spionaggio indiana. Questo attacco non è altro che l’ultimo di una serie infinita di operazioni militari contro bersagli indiani in Afghanistan. E sì, perché la guerra tra India e Pakistan per il controllo della regione del Kashmir si sta oggi combattendo in Afghanistan, in territorio neutrale. Nuova Delhi cerca di prendere il controllo del Paese per stringere il Pakistan in una morsa, il Pakistan cerca di opporsi a questo disegno, anche perché considera l’Afghanistan alla stregua di una colonia. “La guerra in Kashmir sta all’Asia Meridionale come il conflitto arabo-israeliano sta al Medio Oriente”. Una sintesi perfetta. A pronunciare la frase, un agente dei servizi segreti russi esperto di India. Stesso più o meno l’anno di inizio del conflitto (1947 il Kashmir, 1948 l’arabo-israeliano), stessa la religione di una delle due parti in causa (l’islam), stesso il potenziale destabilizzante per l’intera regione e anche per il pianeta intero, stessa la complessità della rete di attori protagonisti del conflitto, stessa la presenza
Generalità
Nome completo: Jammu e Kashmir Bandiera
Lingue principali: Hindi, Inglese Capitale: Jammu e Srinagar (rispettivamente capitali invernale ed estiva dello Jammu e Kashmere) Popolazione: 11.729.000 Area: 101.387 Kmq Religioni: Musulmana ma nella regione Jammu prevale la hindu e in quella del Ladakh quella buddhista Moneta: Rupia Principali Non disponibili esportazioni: PIL pro capite: n.d.

Generalità
Nome completo: Azad Kashmir Bandiera
Lingue principali: Kashmiri, Urdu, Hindko, Mirpuri, Pahari, Gojri Capitale: Muzaffarabad Popolazione: 3.965.999 Area: 13.297 Kmq Religioni: Buddista, musulmana, induista, sikh Moneta: Rupia Principali Non disponibili esportazioni: PIL pro capite: n.d.
del terrorismo. Una guerra, dunque, che alterna scontri tra eserciti, pogrom nei confronti della religione del nemico e campagne di terrorismo. Ed è proprio quest’ultimo punto ad essere il più controverso. Le organizzazioni terroristiche in Pakistan sono tutte di carattere religioso e al tempo stesso controllate da una parte del potere attraverso una parte delle forze armate e una parte dell’Isi. Questi gruppi organizzano attentati in India, ma anche in Pakistan, contro il loro stesso governo. Pratica, questa degli auto attentati, adottata talvolta anche dai servizi segreti indiani.
Il Kashmir è una regione montagnosa che si divide tra tre Paesi: India, Pakistan e Cina. Non ha particolari risorse minerarie, né agricole, non vi sorgono complessi industriali significativi. Insomma, al contrario di quanto solitamente avviene, la guerra non ha nulla a che fare con l’economia o il controllo delle risorse. È probabilmente l’unico vero conflitto politico, etnico e religioso. In quel triangolo di Himalaya ai piedi del K2 si combatte in nome di Allah o di Shiva, si combatte perché l’esercito indiano è troppo repressivo o per far cessare le bombe ai mercati piazzate da fanatici islamici, si combatte perché il Pakistan lo si combatte da oltre sessant’anni o perché l’India è un nemico da sconfiggere, si combatte perché si ha paura che l’avversario usi prima o poi la bomba atomica in suo possesso, si combatte perché è l’Arabia Saudita che te lo chiede o perché la Russia ha paura dell’espansionismo pachistano e la Cina di quello indiano, si combatte per tenere a bada il crescente nazionalismo interno ai due Paesi, si combatte perché si è sempre fatto così, perché ben quattro generazioni sono nate e cresciute in questa guerra e la guerra e l’odio sono lo stato naturale delle cose.

Una posizione strategica che rende la Regione appetibile per troppi Paesi. Poi, scontri di tipo religioso e culturale fra gruppi differenti. Sono queste le ragioni che portano il Kashmir ad essere teatro di una sanguinosa guerra da decenni. Non a caso, il territorio è stato spartito negli anni dai tre grandi Paesi vicini: India, Pakistan e Cina. Di fatto si tratta di un’area amministrata da tre diversi Governi: l’India si è impossessata dei territori dello Jammu, della Vallata del Kashmir e del Ladakh (tutti e tre questi territori prendono l’unico nome di “Jammu e Kashmir” e hanno un’estensione pari a 81.954 kmq); il Pakistan dell’Azad Kashmir e dei Territori del Nord, cioè il Gilgit ed il Baltistan (97.547 kmq); la Cina dell’Aksai Chin e del Shaksgam (42.735 kmq). Si tratta di suddivisioni che non hanno mai ottenuto un riconoscimento ufficiale, elemento che aggrava ulteriormente la situazione e che alimenta la guerra per il controllo del Kashmir. A combatterla sono soprattutto
UNHCR/B.Baloc
Quadro generale

Syed Ali Shah Geelani (Zoorimunz, 29 settembre 1929)
Syed Ali Shah Geelani è il più importante leader politico del movimento indipendentista del Jammmu e Kashmir. Egli è fondatore e presidente del partito Jamaat-e-Islami Jammu and Kashmir. Geelani pensa che la questione del Kashmir si possa risolvere in maniera pacifica, e non attraverso la guerra e il terrorismo. È anche convinto che non potrà mai esserci una pacifica soluzione del conflitto finché l’India non fermerà le violazioni dei diritti umani nella regione. La sua è una visione politica pragmatica. Geelani si rende conto che il Kashmir non sarà mai uno Stato autonomo. “Ammesso che India e Pakistan accettassero una soluzione del genere, la Cina non darà mai il benestare”, ha sostenuto più volte nel corso di interviste. Egli quindi lotta perché il Jammu e Kashmir diventi uno Stato federato pachistano. Nemico giurato dell’ex Presidente Pervez Musharraf, Geelani ha instaurato buoni rapporti con l’attuale Presidente Asif Ali Zardari. Geelani ha 81 anni ed è malato di cancro ai reni. Bisognoso di cure all’estero, il visto gli è stato rifiutato dagli Stati Uniti, mentre l’India ha permesso che si curasse a Mumbai.
UNHCR/B.Baloch

Il ruolo della Cina La Cina gioca un ruolo fondamentale nei delicati equilibri tra India e Pakistan per il Kashmir. Da una parte Pechino appoggia Islamabad perché combatte il comune avversario indiano, dall’altra ha paura di fomentare troppo l’irredentismo islamico. La popolazione della regione autonoma del Sinkiang, al confine occidentale della Cina, è musulmana. Gli Uiguri (così si chiama quel popolo) hanno fatto nascere un vero e proprio movimento indipendentista, aiutati dai gruppi terroristi pachistani che combattono in Kashmir. La Cina, dunque, negli ultimi anni si sta avvicinando all’India, sia con scambi commerciali, sia militari che d’intelligence. Inoltre, Pechino riceve buona parte dei suoi fabbisogni petroliferi dall’Iran. Petrolio che attualmente arriva in Cina via mare, mentre sarebbe molto più economico e rapido farlo arrivare via terra, attraverso il Pakistan. Evidente, quindi, la doppia partita diplomatica giocata dalla potente Cina, che confina per oltre 500 chilometri con il Kashmir.
India e Pakistan dato che rivendicano la sovranità sull’intera Regione mentre la Cina si “accontenta”solo della porzione che occupa attualmente. È nel 1947 che si gettarono le basi per lo scontro. Dopo la dissoluzione dell’India britannica, si scatenarono violenti scontri, soprattutto nello Jammu, che portarono al massacro di migliaia di musulmani. Nei distretto di Gilgit scoppiarono rivolte per ottenere l’annessione al Pakistan, alla quale però si oppose il maragià Hari Singh che, preoccupato dall’avanzare dei combattenti islamici, chiese la protezione dell’India, con cui firmò un trattato di adesione. L’intervento indiano portò al conflitto con il Pakistan. La guerra si concluse nel 1949, grazie alla mediazione delle Nazioni Unite, che decisero di creare un confine provvisorio chiamato “linea di controllo”. Nello stesso anno l’Azad Kashmir si conferì una Costituzione e creò un Parlamento; al suo Governo, legato a quello Pakistano, venne affidata l’amministrazione di Gilgit, del Baltistan e dei Territori del Nord. Nel 1954 il Jammu e Kashmir vennero annessi all’India, ma i contrasti tra induisti e musulmani continuarono cruenti. Annessioni coatte e scontri religiosi portarono, nel 1965, allo scoppio di una nuova guerra con il Pakistan, terminata un anno dopo con un nulla di fatto, dato che i due eserciti si ritirarono verso le posizioni che occupavano prima dei combattimenti. Nel 1974 il Pakistan non riconobbe l’accordo con il quale il Jammu e Kashmir veniva inserito nell’Unione Indiana. La conseguenza fu che le tensioni tra la comunità induista e musulmana si impennarono. La componente islamica iniziò a rivendicare il diritto alla separazione, con durissimi scontri con l’esercito indiano. La situazione peggiorò ulteriormente nel 1999, quando l’India annunciò la ripresa degli esperimenti nucleari e il Pakistan rispose con i suoi primi test atomici. Il Pakistan invase i territori indiani, scatenando la breve ma intensa guerra del Kargil, terminata grazie alla mediazione degli Usa.

Situazione attuale e ultimi sviluppi
Venti di guerra
I venti di guerra che partono dalla valle di Fergana soffiano anche in Tagikistan. Il 19 settembre 2010 una ventina di soldati dell’esercito regolare tagiko sono stati uccisi nell’Est del Paese, nel corso di violenti scontri con i guerriglieri islamici capitanati dal comandante Mullo Abdullo Rakhimov, legato al MIU. Nell’area interessata, la valle di Rasht, l’esercito era impegnato da settimane nel tentativo di catturare 25 militanti di al-Qaeda fuggiti a fine agosto dalla prigione centrale di Dushambé. Non è la prima volta che il fondamentalismo islamico mette piede in Tagikistan. Già negli anni ’70 operava in clandestinità il Partito Islamico di Rinascita, che fomentò diverse ribellioni contro il regime sovietico. E alla data dell’Indipendenza, nel 1991, dopo lo scioglimento dell’Urss, il Tagikistan è teatro di una vera e propria guerra civile fra i gruppi islamici ed il regime del nuovo presidente, Emomali Rahmonov. Questo conflitto provocherà decine di migliaia di morti e durerà fino al 1997, quando viene firmato un Trattato di Pace. In realtà, molti guerriglieri non fecero altro che traslocare nel confinante Afghanistan, da dove però sono rientrati nel 2009, pronti a riprendere la jihad con l’intento dichiarato di rovesciare il Governo di Rahmonov.
UNHCR/ S.Schulman Il 6 e 7 aprile 2010 le strade di Biskek, la capitale del Kirghizistan, si sono riempite di manifestanti reclamanti a gran voce le dimissioni del presidente Kurmanbesh Bakiyev, in carica dal 2005, accusato di autoritarismo. I violenti scontri con le forze dell’ordine hanno fatto almeno 80 morti e un migliaio di feriti. Dopo una settimana di caos, con l’assalto al Parlamento, alla presidenza e alla tv di stato, un golpe bianco ha portato al potere una donna, l’ex ministro degli Esteri divenuto leader dell’opposizione, Roza Otunbayeva, che ha subito promesso di avviare una transizione pacifica alla democrazia. Il 27 giugno si è tenuto un referendum, che ha sancito la trasformazione del Kirghizistan in una Repubblica parlamentare e non più presidenziale. La Otunbayeva ha giurato come Presidente della Repubblica il 13 luglio e in qualità di capo del Governo ad interim si è impegnata ad indire nuove elezioni per il mese di ottobre 2011. A tutti questi avvenimenti è stato appioppata, un po’ troppo sbrigativamente, l’etichetta di “rivoluzione kirghiza”. Sarebbe la terza rivoluzione nel giro di 20 anni, considerando la rivoluzione di seta che portò il Kirghizistan all’indipendenza, nel 1991, dopo la dissoluzione dell’Urss, e la rivoluzione dei tulipani, che nel 2005 sancì definitivamente il passaggio all’epoca post-comunista, con le dimissioni del presidente Akayev e l’ascesa al potere di Bakiyev. In realtà, i moti di piazza dell’aprile 2010 e i drastici mutamenti politici che ad essi sono seguiti sono solo il capitolo più recente nel lungo processo di destabilizzazione subito dal Kirghizistan alla fine della Guerra Fredda. La prova sta nei violenti scontri interetnici fra kirghizi e uzbeki che hanno funestato il Sud del Paese e in particolare la regione di Osh fra l’11 e il 15 giugno 2010, con un bilancio stimato in almeno 2000 morti e un flusso di 100mila profughi spinti oltre frontiera, in Uzbekistan. È vero infatti che in questi scontri ha giocato certamente un ruolo il clan dell’ex-presidente Bakiyev, deposto due mesi prima, rifugiatosi poi in Kazakistan e smanioso di rientrare nel gioco politico. Ma è vero anche che la contrapposizione fra la maggioranza kirghiza

Kirghizistan
Generalità
Nome completo: Repubblica del Kirghizistan Bandiera

Lingue principali: Kirghizo, russo Capitale: Bishkek Popolazione: 5.000.000 circa Area: 198.500 Kmq Religioni: Musulmana sunnnita, minoranze cristiane Moneta: Som kirghizo Principali Gas naturale, oro, esportazioni: mercurio, uranio, carni, lana , cotone PIL pro capite: Us 2.184
(che rappresenta il 65% della popolazione) e la minoranza uzbeka (15%) è un problema politico che si trascina da tempo. Ancor più preoccupante è il fatto che nessuna delle due potenze che si contendono l’egemonia in Asia centrale, Russia e Stati Uniti, si sia decisa ad intervenire per evitare questo ultimo bagno di sangue, con l’invio di una forza multinazionale di interposizione. Il risultato è che nel Sud la convivenza fra kirghizi e uzbeki permane assai difficile, con la possibilità (non così remota) che le violenze si allarghino anche alla minoranza degli uiguri, che rappresentano attualmente il 5% della popolazione.
Russia e Stati Uniti da anni si contendono il Kirghizistan a suon di dollari camuffati da aiuti economici, per motivi squisitamente geopolitici. Gli Stati Uniti, infatti, fin dal 2002 hanno ottenuto il permesso di stanziare 2000 soldati nella base militare di Ganci, vicino Biskek, che è diventata con gli anni un importante centro di transito per le operazioni della Nato in Afghanistan. La Russia dal canto suo, che pure mantiene una sua base militare non lontana, a Kant - residuato dell’epoca sovietica - non ha mai nascosto di essere ostile a quella che giudica una sfacciata ingerenza americana nel proprio spazio d’influenza. E aveva promesso al presidente Bakiyev aiuti economici per più di due miliardi di dollari se la base di Ganci fosse stata chiusa. Immediato è stato il “rilancio” degli Usa, con una escalation di promesse economiche e di intrighi diplomatici che hanno finito per minare la stabilità del Governo, fino a diventare una concausa nella caduta precipitosa del regime di Bakiyev. Secondo alcuni analisti, la nomina a Presidente ad interim di Roza Otunbayeva - che è stata per tre anni ambasciatore negli Usa e poi in Gran Bretagna - va interpretata come una vittoria sia pur temporanea degli americani nel complicato Great Game che si combatte in Asia Centrale. Ma la partita è ancora aperta. Anche la contrapposizione fra kirghizi e uzbeki ha radici politiche, e ben poco o nulla di etnico. La sua spiegazione va cercata infatti nella scelta fatta da Stalin negli anni ‘30 di smembrare il vecchio Turkestan e creare dal nulla cinque nuove Repubbliche in Asia Centrale - Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Kazakhistan - cercando poi di dotarle di una certa omogeneità, fondata su criteri prevalentemente etnici. Tale scelta avrebbe anche avuto una sua logica se si fosse riuscito a distribuire la popolazione di conseguenza, superando cioè la compresenza e il meticciato etnico che contraddistingueva, ieri come oggi, diverse aree geografiche e in particolare la Valle di Fergana, che è stata divisa fra Uzbekistan e Kirghizistan. Il risultato invece è stato che 700mila uzbeki si sono ritrovati a essere cittadini del Kirghizistan, con l’aggravante che in alcune città del Sud rappresentano il gruppo etnico più numeroso: ad Osh sono il 49% della popolazione, contro il 39% rappresentato dai kirghizi; a Jalalabad sono il 43% e nel distretto di Aravan addirittura il 59%. Più che su basi etniche, la vera contrapposizione in Kirghizistan si è creata fra il Sud agricolo e il Nord industriale: il primo saldamente in mano agli uzbeki, grandi commercianti, il secondo in mano invece ai kirghizi e ai russi, che detenevano le leve dell’amministrazione pubblica e quindi il potere. La convivenza non è mai stata pacifica, ma almeno in apparenza si è mantenuta nei binari dell’ordine pubblico, senza violenti scontri di piazza, fino al 1989-1990, quando la crisi dell’Urss è apparsa irreversibile ed è cominciato a profilarsi la possibilità di un cambio di regime. È all’epoca che si segnalano le prime manifestazioni di piazza della minoranza uzbeka, capeggiata da un proprio movimento nazionalista, e i primi scontri con la maggioranza kirghiza, fedele al presidente Askar Akayev, intellettuale di prestigio ed esponente di spicco della corrente liberal del Partito comunista locale, saldamente al potere.

Eppure, all’inizio degli anni ‘90 fa il Kirghizistan passava per essere “la Svizzera” dell’Asia Centrale. Grazie all’abilità del suo carismatico Presidente, Akayev, era riuscito infatti a superare senza spargimenti di sangue la difficile transizione che in breve tempo aveva portato sia alla dissoluzione dell’Urss che alla proclamazione dell’indipendenza, il 31 agosto 1991. Le riforme economiche ed istituzionali promosse da Akayev avevano inoltre contribuito a creare un quadro di promettente democrazia, che non aveva paragoni nella regione, se si considera che sia in Uzbekistan che in Tagikistan la fine dell’Urss non aveva comportato alcun cambiamento sostanziale nello status quo, lasciando il potere saldamente nelle mani della nomenklatura. E invece, nel giro di qualche anno, anche il Kirghizistan subisce la classica involuzione autoritaria tipica dei regimi presidenziali. Con una serie di revisioni costituzionali poi approvate con dei referendum farsa - nel 1993, nel 1996 e nel 2003 - Akayev accentua infatti il centralismo amministrativo, rafforzando i poteri del capo dello Stato. Allo stesso tempo viene imposta una forte restrizione delle libertà politiche, parlamentari e personali, al punto che sia la scelta dei candidati alle elezioni che dei giudici e degli alti funzionari pubblici diventa una delle tante prerogative del Presidente (e del suo clan). Non è perciò casuale se le elezioni locali
UNHCR / S. Schulman
Quadro generale

Movimento islamico dell’Uzbekistan
Si chiama Miu, Movimento islamico dell’Uzbekistan (di cui Tohir Yo’Idosh è uno dei fondatori) ed è diventato lo spauracchio di molti governi centro-asiatici, costretti a confrontarsi con il pericolo dell’islam più radicale, quello che predica la Jihad armata e sogna l’instaurazione di un nuovo califfato. Fondato nel 1997 nella valle di Fergana, il Miu ha costruito la sua popolarità sulla feroce repressione subita. Per anni, infatti, come testimoniano Amnesty International e Human Rights Watch, l’unica risposta del regime uzbeko alla sfida lanciata dal Miu è stata la repressione brutale, che ha portato alla chiusura di centinaia di moschee e all’arresto (con torture) di decine di migliaia di cittadini colpevoli solo di essere musulmani. L’attentato dell’11 settembre alle Twin Towers ha finito inoltre per dare una “copertura” politica alla repressione di Karimov, garantendogli la benedizione e l’appoggio degli Usa. Il risultato è che gli abitanti della valle di Fergana hanno aderito in massa al Miu Ed oggi i militanti del Miu combattono in Afghanistan, Pakistan, Cecenia, addirittura in Yemen. Cellule del Miu sono nate poi in Tagikistan e in Kirghizistan, sfruttando il malcontento della minoranza uzbeka.

La valle di Fergana Il cuore economico, culturale e sociale dell’Asia Centrale batte certamente nell’antica valle di Fergana: un’oasi di verde pianeggiante coltivata a cotone, attraversata dal fiume Syr Darya e incassata fra le steppe desertiche e le montagne. Solo qui c’è acqua in abbondanza e una terra fertile; col risultato che da secoli la valle di Fergana vanta una densità abitativa inusuale per questa regione e una ricchezza di vita che non ha pari. “Chi controlla la valle di Fergana - si diceva non a caso nei secoli del Great Game - controlla tutta l’Asia Centrale”. Un insegnamento che Stalin pensò bene di non sottovalutare, quando decise di smembrare l’antico Turkestan, creando dal nulla cinque nuove repubbliche in Asia Centrale. La valle di Fergana finì così per essere orrendamente smembrata fra Uzbekistan, Tagikistan e Kirghizistan, senza alcun rispetto per la continuità territoriale e con l’unica logica di affidarne il controllo a più guardiani. Il che non ha impedito al radicalismo islamico di attecchire da queste parti e di crescere con forza, fino a diventare un punto di riferimento per la regione.
del 2002 verranno fortemente contestate, per via dei brogli evidenti, con la dura repressione delle proteste popolari. Ancora più contestate saranno le elezioni parlamentari del marzo 2005, e in questo caso le proteste sono talmente violente da spingere il presidente Akayev a fuggire in Russia e subito dopo a rassegnare le dimissioni. È la cosiddetta “rivoluzione dei tulipani”, che a dispetto dell’entusiasmo con cui è stata accolta in Occidente - al pari delle altre rivoluzioni soft che si sono verificate negli stessi anni avvenute in Georgia e Ucraina - in realtà è stata solo l’occasione per un avvicendamento interno allo stesso gruppo di potere. Con l’unica differenza che mentre Akayev, originario del Nord, rappresentava soprattutto gli interessi della maggioranza kirghiza, il suo successore Bakiyev, originario del Sud, ha avuto il sostegno della minoranza uzbeka, in cerca di riscatto sociale. È difficile capire se la transizione alla democrazia avviata dal nuovo presidente Otunbayeva potrà ora compiersi fino in fondo e, soprattutto, se i nuovi assetti politici e istituzionali che il Kirghizistan si darà riusciranno a convogliare su binari pacifici le rivalità etniche ormai esacerbate fra maggioranza kirghiza e minoranza uzbeka. Molto dipende dagli esiti del complicato Great Game che Russia e Stati Uniti stanno giocando in tutta l’Asia Centrale. C’è innanzitutto da vedere come evolverà la situazione in Afghanistan, soprattutto in caso di partenza delle truppe Usa e della Nato. E non bisogna poi dimenticare la stretta interdipendenza che ancora oggi, per motivi etnici e non solo, lega il destino del Kirghizistan a quello dell’Uzbekistan e al Tagikistan: col risultato che anche un battito di farfalla dall’altra parte della frontiera rischia, da queste parti, di provocare un terremoto.
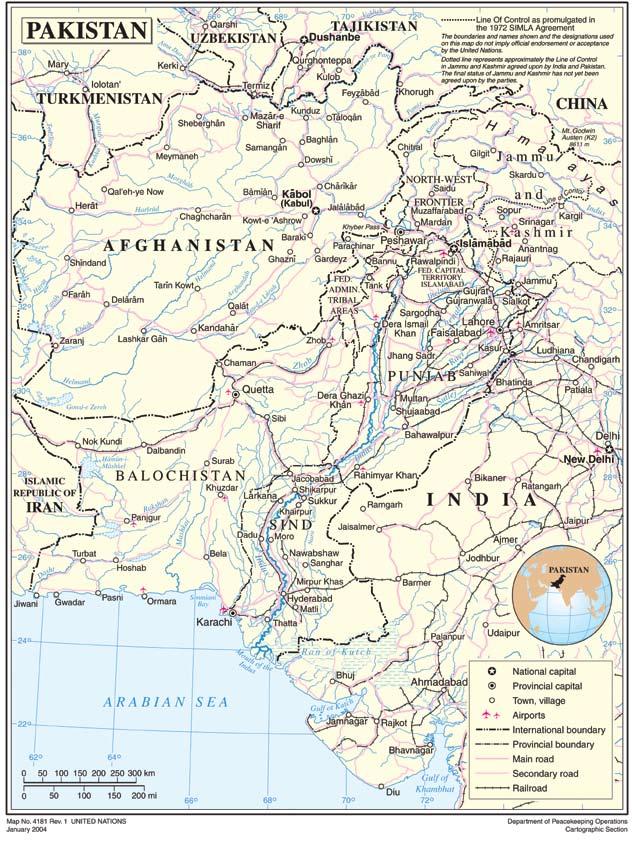
Situazione attuale e ultimi sviluppi
Terrorismo in Pakistan
In Pakistan ci sono 43 gruppi di terroristi islamici. Alcuni di questi si battono per l’indipendenza del Kashmir dall’India, altri per l’indipendenza delle aree tribali (al confine con l’Afghanistan) dal Pakistan, altri ancora per l’indipendenza del Beluchistan sempre dal Pakistan, una nutrita pattuglia di sigle, invece, lotta per avere uno Stato confessionale islamico. Il gruppo più influente è l’Esercito dei Giusti (Lashkar-e-Taiba o Let). Molto influenti anche Jamaatud-Dawa (JuD), Sipah-e-Sahaba, Jaish-e-Muhammad, Harkatul Jihad al-Islami, Harkatul Mujahideen, Hizbut Tahrir e Lashkar-e-Jhangvi.
UNHCR/B.Baloch “Gli Stati Uniti stanno facendo un gioco al massacro con il Pakistan. Vogliono ripetere l’esperienza jugoslava e irachena. In altre parole, Washington vuole disintegrare il Pakistan in tanti piccoli Stati. È il loro modo per neutralizzare un Paese pericoloso per i loro interessi”. L’agente della National Security Agency (Nsa), che ha rilasciato questa dichiarazione a chi scrive, per anni si è occupato dello spionaggio in Asia Meridionale. “È vero, il Pakistan sta deflagrando. Se nessuno aiuterà Islamabad il Paese esploderà il mille pezzi”, ha confermato il generale Alain Lamballe, responsabile del Pakistan per conto dei servizi segreti francesi. Il Pakistan è sull’orlo della guerra civile. Il Governo contro se stesso, l’esercito contro se stesso, i servizi segreti (Inter Services Intelligence o Isi) contro se stessi. Gli unici che combattono contro un nemico diverso sono i terroristi. Gli attentati si susseguono a un ritmo di uno a settimana. Il Governo ha paura di prendere posizione. Gli stessi Paesi amici una volta si schierano a fianco del presidente Asif Ali Zardari, la volta successiva utilizzano l’organizzazione terrorista di turno per propri fini strategici. Le forze armate e i servizi segreti cercano di reprimere come possono il terrorismo e l’estremismo islamico, mentre alcuni loro colleghi aiutano le stesse forze per cercare di ottenere il controllo dell’Afghanistan, considerato da Islamabad né più né che una colonia. A tutto questo va aggiunta la presenza di una numerosissima comunità sciita, la seconda nel mondo con oltre trenta milioni di fedeli. Gli estremisti sciiti e sunniti si odiano più di quanto questi odino gli infedeli cristiani. Dietro gli sciiti c’è l’Iran, che vorrebbe approfittare della dissoluzione del Pakistan per annettersi l’enorme Stato (a maggioranza sciita) del Baluchistan. Se il Pakistan vuole sopravvivere devono accadere due cose: il Governo deve decidere da che parte stare e devono finire le lotte intestine. In altre parole, o il Pakistan appoggia totalmente la


Generalità
Nome completo: Repubblica Islamica del Pakistan Bandiera
Lingue principali: Inglese, urdu, punjabi, sindi, pashto, baluchi Capitale: Islamabad Popolazione: 155.694.740 Area: 803.940 Kmq Religioni: Musulmana (95%), in maggioranza sunniti; cristiana (2%), indù (1,6%) Moneta: Rupia pakistana Principali Tessuti, cotone, pesce, esportazioni: frutta PIL pro capite: Us 2.653
linea dell’estremismo islamico oppure si schiera realmente con l’Occidente e cerca di trovare una soluzione negoziale con l’India, con cui è da sessantatre anni in guerra permanente. L’ex candidata alla Presidenza Benazir Bhutto aveva scelto di combattere l’ala militare ed estremista del potere. Non a caso è stata assassinata. Oggi Presidente è il vedovo della Bhutto, Asif Ali Zardari, che ha dichiarato di voler seguire le orme della sua defunta consorte.
Il Pakistan è un Paese chiave per il commercio internazionale e per l’industria petrolifera. Eccetto l’Iran e l’unico Paese che confina con l’Asia centrale che si affaccia sull’Oceano Indiano. Nel sottosuolo di Turkmenistan, Kazakistan e Uzbekistan si trovano le più vaste riserve al mondo di gas e ricchissimi giacimenti di petrolio. Per far uscire gli oleodotti dalla regione ci sono tre strade possibili: il Caucaso a Ovest, la Russia a Nord, l’Oceano Indiano a Sud. Il Caucaso è scosso da continui conflitti, quindi poco sicuro. La Russia è antagonista di quell’Occidente che sta cercando di sottrargli proprio le risorse dell’Asia centrale. Per accedere all’Oceano Indiano bisogna passare o attraverso l’odiato Iran oppure via Afghanistan e Pakistan. Ovviamente l’Occidente sceglie quest’ultima strada. Il Pakistan è anche importante per le rotte commerciali a causa della sua posizione geografica strategica. Nel Baluchistan si sta finendo di ultimare il porto di Gwadar, il più grande dell’Oceano Indiano. È qui che scaricherebbero il loro greggio le petroliere provenienti dal Golfo Persico, è qui che scaricherebbero i loro container le navi provenienti dall’Africa, e dall’Europa. Il Governo pachistano sta ultimando la costru-

zione di un’autostrada e di una ferrovia che portano a Nord, verso la catena montuosa del Karakoam (Himalaya), oltre la quale c’è la Cina. In altre parole, il Pakistan sta diventando il porto commerciale dell’alleata Cina, e questo dà fastidio a molti. Infine c’è l’elemento religioso. Il Pakistan è a maggioranza musulmano sunnita, ma nel Paese vive anche una minoranza sciita di trenta milioni di fedeli, che fanno del Pakistan il seconda Paese sciita al mondo dopo l’Iran. La guerra religiosa in atto nel Paese vede da una parte i sunniti appoggiati dall’Arabia Saudita e gli altri Paesi del Golfo dall’altra gli sciiti appoggiati, appunto, dall’Iran. Entrambi fanno leva sul vicino conflitto afgano, entrambi usano le moschee come arma di propaganda, entrambi usano il terrorismo come arma, entrambi puntano alla dissoluzione del Paese, entrambi gli schieramenti sono appoggiati da una parte del Governo pachistano, da una parte delle forze armate e da una parte dei servizi segreti. Contro i due contendenti il resto del Governo, delle forze armate e dei servizi segreti, ovvero quelli che vogliono un Pakistan unito, e possibilmente laico.
I talebani
I talebani sono gli studenti delle scuole coraniche che i wahhabiti (il credo religioso islamico praticato in Arabia Saudita) hanno edificato e finanziato in Pakistan. Inoltre, i talebani appartengono all’etnia pashtun, presente nel Pakistan occidentale e meridionale e nell’Afghanistan meridionale, orientale e centrale. Il pensiero dei talebani, estremamente rigido ed arcaico, è stato descritto come “un’innovativa combinazione di shari’a e pashtunwali”, il codice d’onore dei pashtun, ispirandosi all’interpretazione dell’islam dell’estremismo sunnita indiano deobandi, che enfatizza la solidarietà, l’austerità e la famiglia (saldamente gestita dagli uomini). Oltre a voler riconquistare l’Afghanistan, i talebani compiono azioni militari all’interno del Pakistan per destabilizzare il Paese e portare all’indipendenza delle regioni del Waziristan e del Beluchistan.
È un vero e proprio terremoto politico e sociale quello che oggi attraversa il Pakistan, la “Terra dei puri”. Generalmente trascurato dalle cronache giornalistiche, questo Paese, alle prese con una profonda instabilità interna che ha radici molto antiche, è invece uno dei protagonisti assoluti del moderno scacchiere politico internazionale. Situato nel cuore dell’Asia meridionale, il Pakistan nasce ufficialmente il 14 agosto 1947. Fino ad allora aveva fatto parte dell’India britannica poi divisa in due diversi Stati: il Pakistan, a maggioranza musulmana, e l’India, a maggioranza indù. Dall’indipendenza, il Pakistan è sempre stato in conflitto con l’India per il controllo del territorio del Kashmir ma questa non è l’unica causa di destabilizzazione per il Paese. La sua stessa struttura di federazione, suddivisa in 4 Province, 2 Territori e 107 Distretti con una composizione etnica estremamente frastagliata, ne fanno un territorio di difficile gestione, dove convivono una parte meridionale organizzata in modo più moderno ed una settentrionale profondamente tribale e attraversata da
UNHCR / H. Caux
Quadro generale
Benazir Bhutto (Karachi, 21 giugno 1953 - Rawalpindi, 27 dicembre 2007)
È stata l’unica donna a ricoprire la carica di primo ministro in un Paese islamico. Figlia del premier che ha cercato di affrancare il Pakistan dagli Stati Uniti prima di essere deposto da un colpo di Stato, e nipote di una delle figure chiave del movimento indipendentista pachistano, Benazir Bhutto è stata per anni il punto di riferimento di quanti si battono per un Pakistan non allineato e laico. Ha studiato ad Harvard e Oxford. Dopo l’esecuzione del padre da parte del dittatore Muhammad Zia-ul-Haq, è prima agli arresti domiciliari e poi in esilio nel Regno Unito, dove diviene leader del Partito del popolo pachistano (Ppp), già presieduto dal padre. Morto Zia torna in patria, dove sarà premier dal 1988 al 1990 e dal 1993 al 1996. Costretta all’esilio in seguito al colpo di Stato del generale Pervez Musharraf, la Bhutto ritorna in Pakistan nel 2007. Il giorno del suo arrivo a Karachi (18 ottobre) un camion situato lungo il percorso del suo corteo esplode, causando 138, ma lei resta illesa. Lei accusa dell’attentato Musharraf, che la mette agli arresti domiciliari. Liberata grazie alle pressioni Usa, Benazir Bhutto viene assassinata da un attacco suicida lanciato durante un suo comizio il 27 dicembre dello stesso anno, all’età di 54 anni.
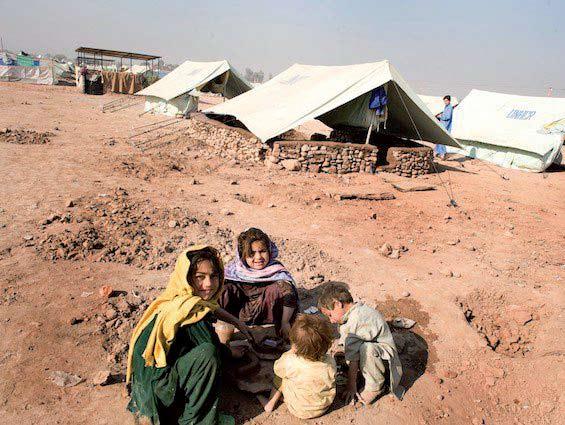
antiche spinte indipendentiste. Epicentro della crisi interna che sta portando al collasso il Pakistan è il territorio di frontiera con l’Afghanistan e l’Iran, da Nord a Sud. L’area più instabile è quella della Provincia del Belucistan, nel Pakistan occidentale, abitata dai beluci, popolazioni tribali, dedite alla pastorizia e alla coltivazione della terra che vivono anche nell’Ovest dell’Iran e nell’estremo Sud dell’Afghanistan. Nel Belucistan dagli anni ‘70 imperversa la guerriglia indipendentista di gruppi ribelli che si battono per l’autonomia della Regione, ricchissima di risorse naturali e per questo annessa con la forza nel 1947 al territorio pakistano. Il conflitto è iniziato già negli anni ’50 ma il picco più violento è stato nel 1973 con un’insurrezione delle tribù beluci più agguerrite, Marri e Bugtì. Gli scontri infuriarono per quattro anni e la rivolta fu soffocata nel sangue dall’esercito pakistano, anche grazie all’utilizzo di armi fornite dal confinante Iran. Negli anni ’80 e ’90 il Movimento Beluci, stremato dalla repressione pakistana ha interrotto la lotta armata per imboccare, senza risultati, la strada della lotta politica. Nel 2000 alcuni gruppi di beluci hanno dato vita all’Esercito di liberazione del Balucistan, e ripreso la guerriglia a cui il Governo pakistano ha risposto con l’utilizzo massiccio di esercito e aviazione. Una repressione divenuta ancora più vio-
UNHCR/ M. Pearson
lenta dopo gli attacchi alle torri gemelle del 2001. Con l’inizio della campagna militare nel vicino Afghanistan la guerra contro gli indipendentisti del Belucistan è finita col mescolarsi a quella contro i terroristi islamici di al-Qaeda nascosti nell’Afghanistan meridionale. Nel 2004 l’allora Presidente del Pakistan, il generale Musharraf diede il via libera alla formazione di un comitato parlamentare che avrebbe dovuto rappresentare le istanze dei beluci, ma il gesto fu soltanto formale e il conflitto fra esercito e guerriglieri non si interruppe. Tra il 2005 e il 2006 la repressione dell’esercito pakistano si è concentrata nei distretti di Dera Bugti e Kholu, considerati i più ribelli. I militari pakistani sono riusciti ad assestare un colpo durissimo alla guerriglia beluci uccidendo, nell’agosto 2006, il capo dei guerriglieri, l’ottantenne Nawab Akbar Bugti. Un altro fronte interno di conflitto per il Pakistan è quello del distretto del Waziristan, una zona impervia e montuosa del Nord Ovest del Pakistan, divisa in 2 parti: Nord Waziristan e Sud Waziristan. Regione di frontiera a cavallo con il tumultuoso Afghanistan, il Waziristan è dal 2004 nel mirino dell’esercito pakistano - perché nascondiglio prediletto per i Taliban in fuga dall’Afghanistan - anche sulla spinta delle pressioni americane che chiedono a Islamabad un maggiore controllo della Regione. Dal 2004 sotto i bombardamenti dell’esercito pachistano e statunitense sono morti migliaia di waziri, sia guerriglieri che civili.

Situazione attuale e ultimi sviluppi
Povero il Re
Bhumibol Adulyadej, re della Thailandia, è il sovrano più ricco del mondo. Una riconferma la sua, dato che per la rivista statunitense “Forbes” si era aggiudicato il titolo già lo scorso anno. Anche lui, però, come gli altri Re, ha risentito della crisi economica internazionale. Secondo la rivista, infatti, il suo patrimonio si aggira nel 2010 attorno ai 30miliardi di dollari, ben cinque in meno dell’ anno passato . In totale i 15 sovrani più ricchi del mondo hanno perso 22miliardi di dollari nell’arco degli ultimi 12 mesi. Per il sovrano thialandese, la perdita è dovuta alla svalutazione di proprietà e azioni controllate da ‘Crown Property Bureau’, il gruppo che cura gli investimenti della corona. Ci si va in vacanza, almeno ci vanno molti, ma in Thailandia non c’è pace. Il conflitto fra Governo centrale e le tre province del Sud musulmano, Yala, Narathiwat e Pattani, prosegue, lasciando una scia di morti. In agosto 2010 si sono registrati una serie di attacchi dei separatisti contro persone legate alle formazioni paramilitari finanziate dal Governo di Bangkok: cinque i morti, il bilancio finale, tra cui un bambino di soli cinque anni. Si aggiungono ai 4500 morti causati negli 8mila attacchi del conflitto separatista iniziato nel gennaio del 2004. I musulmani della Thailandia, appena il 4% della popolazione, sono tutti concentrati in quelle terre e vogliono l’indipendenza. Difficile trovare una soluzione. Nel 2009 il generale a riposo Ekkachai Srivilas, direttore dell’Ufficio per la pace e la governance dell’Istituto Re Prajadhipok, aveva proposto un approccio diverso alla crisi, per evitare le spese e gli sforzi che si pagano per dispiegare 60mila soldati nel Sud. Il Governo aveva respinto l’idea, e l’estate del 2009 era stata una continua offensiva per rastrellare tutti i villaggi della regione per fare terra bruciata intorno ai pejuang, i miliziani del Fronte Rivoluzionario Nazionale (Brn). Una scelta coerente con la decisione di attaccare i ribelli per distruggerli, senza cercare mediazioni Sul fronte politico, poi, a Bangkok continua il braccio di ferro con le Camicie Rosse, i fedelissimi dell’ex premier Thaksin Shinawatra,

Generalità
Nome completo: Regno di Thailandia Bandiera

Lingue principali: Thai Capitale: Bangkok o Krung Thep in thai Popolazione: 64.200.000 Area: 514.000 Kmq Religioni: Buddista (95%), musulmana (4.6%), cattolica (0.75%) Moneta: Baht Thailandese Principali Tapioca, riso, caucciù, esportazioni: ananas, stagno PIL pro capite: Us 8.368
mandato in esilio nel 2008. In maggio 2010 una manifestazione per chiedere il ritorno in patria del politico si è conclusa con 91 morti. In settembre una nuova protesta, con diecimila manifestanti, ha creato tensioni. I dimostranti hanno infatti sfidato lo stato di emergenza in vigore dalla primavera precedente. Hanno bloccato il traffico, grazie ad una rete di nastri rossi sospesi a mezz’altezza e hanno occupato la zona dello shopping. Si sono dispersi senza incidenti.
La guerra interna alla Thailandia nasce dalle differenze e nella voglia di autonomia di una delle parti. I musulmani sono una minoranza relativamente piccola nel Paese, solo il 4,6% della popolazione, ma sono concentrati tutti nella stessa area e, soprattutto, hanno avuto una lunga storia di indipendenza dalla Thailandia. La situazione internazionale, poi, con lo sconGli ultimi bilanci parlano di 4450 morti in ottomila attacchi militari a partire dal 2004, anno di inizio dello scontro. È il bilancio della guerra oscura e sconosciuta che in Thailandia si sta combattendo da anni in tre province meridionali a maggioranza musulmana: Yala, Narathiwat e Pattani, a poche centinaia di chilometri dalle più famose spiagge thailandesi. Dopo cinque anni di insurrezione, nelle province meridionali al confine con la Malaysia la situazione è davvero drammatica. Nella regione c’erano già trascorsi indipendentisti. La nuova fase di violenza è però cominciata nel gennaio del 2004, per opera di non meglio identificati gruppi indipendentisti radicali. Il picco della crisi è stato nel 2007 e di lì il livello dello scontro armato fra esercito e indipendentisti si è alzato. Narathiwat, Yala e Pattani sono province abitate in maggioranza da musulmani di lingua malese. Corrispondono al territorio di un sultanato annesso all’inizio del secolo scorso all’allora regno del Siam, dopo un accordo con gli inglesi, veri padroni dell’area in quegli anni. C’è una storia differente, quindi, a giustificare le richieste di indipendenza. Le realtà, però, è che anche per gli osservatori stranieri si tratta di una guerriglia poco conosciuta. Il movimento ribelle si chiama “Combattenti per la liberazione di Pattani”, ma non ha né un simbolo né un

tro in atto fra mondo cosiddetto occidentale e terrorismo islamico, ha riacceso le speranze di indipendenza dei musulmani, portandole sotto la bandiera pan islamica. Lo scontro politico interno, poi, rende più debole il Governo centrale, lasciando maggior spazio alle iniziative politicomilitari degli indipendentisti del Sud. leader riconosciuto. Totalmente ignoto anche l’obiettivo reale della guerra scatenata cinque anni fa: non è chiaro se vogliano solo una maggiore autonomia, l’indipendenza o una unione con la Malaysia. Nella regione, la stragrande maggioranza degli abitanti sono musulmani, di etnia e lingua malay, da sempre i thailandesi la percepiscono come pericolosa. I pochi buddisti che ci vivono tendono a lavorare per conto del Governo, diventando dal 2004 facile obiettivo dei ribelli, che da sempre colpiscono soprattutto gli insegnanti, i “volti” del Governo di Bangkok, che rappresentano da soli l’11 percento delle vittime. Vanno a lavorare scortati dall’esercito e nemmeno questo ferma le imboscate. Una situazione che sembra diventata ingovernabile. L’esercito, protetto dallo stato di emergenza dichiarato nel 2005 dal Governo, ha scontri sporadici con i ribelli, ma tiene sotto pressione la popolazione della regione, che reagisce radicalizzando lo scontro e appoggiando apertamente la ribellione e condividendo il risentimento verso Bangkok. Ad alimentare questo sentimento sono le ingiustizie create dallo stato di emergenza. In caso di violenza, esercito e autorità statali vengono assolte, nelle violenze non mai è chiaro chi sia il responsabile. Non sono solo imboscate e
Muore anche la stampa
Gli scontri fra camicie Rosse e forze dell’ordine nel maggio del 2010 hanno causato decine di morti. Fra loro anche un fotografo italiano Fabio Polenghi, di 45 anni. È stato colpito mortalmente nell’assalto dell’esercito all’accampamento delle camicie rosse, nella zona di Saladeng, a circa un chilometro dal centro del campo degli oppositori. È stato colpito al torace e all’addome. Un gruppo di colleghi l’ha caricato su una motocicletta ma la corsa verso l’ospedale è stata vana. Free lance dal 2004, aveva lavorato per la moda e per l’attualità. Un amico: “Era uno di quelli che trovavi ovunque ci fosse
qualcosa da documentare”
Quadro generale
Abhisit Vejjajiva (Newcastle upon Tyne, 3 agosto 1964)
Quarantacinque anni, 27° Primo Ministro della storia thailandese, Abhisit Vejjajiva è per molti solo un politico di bell’aspetto. Per altri, è la mano politica dei militari. Comunque sia, da quando è al potere, cioè dal 15 dicembre 2008, ha mostrato di non aver paura di comandare, magari con decisioni discutibili. Laureato in economia, formatosi a Eton e Oxford, è figlio di una coppia di medici emigrata in Inghilterra. Leader dei democratici, non è mai riuscito a farsi amare dalla gente comune. E questo è un problema che sconta nei confronti degli avversari politici. Al potere grazie a una sentenza della Corte Costituzionale e a un ribaltone parlamentare, viene da molti considerato un usurpatore. Per molto tempo, però, ha lavorato per sanare are le divisioni del Paese, cercando di placare le proteste delle Camicie Gialle Monarchiche e delle Camicie Rosse dell’opposizione senza spargimenti di sangue. Tutto questo sino al maggio del 2010, quando ha usato il pugno di ferro contro gli oppositori, proclamando lo Stato d’emergenza e schierando l’esercito, con il risultato di 91 morti per le strade.

La politica interna La guerra indipendista con gli islamici è parte del problema thailandese, Paese che ha conquistato la ribalta internazionale molto più per i problemi politici. Vediamo di ricordare perché? Nel dicembre 2007 e il Partito del Potere Popolare (Ppp), si aggiudica 233 dei 480 seggi del Parlamento thailandese. Nel febbraio 2008 si insedia il nuovo Governo di coalizione guidato da Samak Sundaravej. Nel settembre 2008 Samak è costretto alle dimissioni con l’accusa di aver accettato un compenso in denaro per alcune apparizioni televisive; gli succede alla guida del Governo Somchai Wongsawat, ex ufficiale e cognato di Thaksin. Dal mese di agosto il Paese è preda di una grave crisi politica e sociale, con il partito d’opposizione, l’Alleanza del Popolo per la Democrazia (Pad), che chiede insistentemente le dimissioni del Governo Somchai. A novembre gli oppositori occupano gli aeroporti, per costringere il Governo ad andarsene. Poi, alla fine di novembre del 2008 la Corte Costituzionale riconosce l’esistenza di brogli nelle elezioni del dicembre 2007 e ordina lo scioglimento dei partiti di Governo e l’interdizione per cinque anni dei suoi leader dalla vita politica. Ma la rabbia continua e le manifestazioni nel 2010 riprendono, con decine di morti.
vendette reciproche tra musulmani e buddisti, o tra ribelli e “collaborazionisti”: attentati come quello della moschea di Narathiwat vengono attribuiti genericamente a paramilitari o teste calde all’interno delle forze armate. In realtà, anche le organizzazioni internazionali hanno denunciato le violenze, i soprusi. Un recente rapporto di Human Rights Watch ha spiegato che, per effetto delle leggi speciali thailandesi che prevedono la carcerazione preventiva senza mandato per 37 giorni, e di un regolamento del generale Viroj - comandante dell’area - che vieta visite dei familiari per i primi tre giorni di detenzione, migliaia di musulmani, maschi, di tutte le età sono stati arrestati e torturati dall’esercito. Secondo l’organizzazione, che ha sentito le testimonianze di molti medici e avvocati di ex detenuti, vengono torturati soprattutto nei primi giorni di detenzione nelle basi locali dell’esercito. Poi, sono trasferiti alla prigione militare di Ingkhayuthboriharn, nella provincia di Pattani. I sistemi di tortura adottati sono: pestaggi con bastoni e spranghe, elettroshock, strangolamento, affogamento, soffocamento con buste di plastica, nudità forzata, esposizione a temperature estreme. È crisi dura, quindi. Per molti esperti, il movimento ribelle ha chiare origini locali. Per gli analisti internazionali, i rivoltosi - nel frattempo raccolti sono la sigla Fronte Rivoluzionario Nazionale (Brn) - sono da collegare alla rete di alQaeda. È questo parere la Cia statunitense, che da sempre collabora con l’esercito nel quadro della lotta al terrorismo internazionale. A rafforzare questa opinione è arrivato, nel giugno 2009, un rapporto dell’International Crisis Group, che ha denunciato l’uso della retorica della jihad mondiale nelle scuole delle tre province, al fine di reclutare nuovi combattenti. Il primo ministro thailandese Abhisit, il cui Partito democratico è forte proprio nel Sud, ha reagito promettendo un piano di sviluppo e integrazione per la regione, storicamente trascurata da Bangkok. Una decisione, questa, che non basta, dato che anche se raggiungesse l’effetto voluto, dovranno passare diversi anni. Intanto le violenze continuano.

Situazione attuale e ultimi sviluppi
Disastro ecologico
Nel novembre del 2009 una catastrofe ecologica ha colpito la già provata economia timorese. Una falla in un oleodotto australiano, che ha riversato in mare centinaia di barili di greggio ogni giorno, ha messo in grave crisi i pescatori dell’isola e l’intero ecostistema di un oceano tra i più incontaminati al mondo. Secondo numerose organizzazioni ambientaliste, Wwf in testa, l’incidente avrà effetti negativi di lunga durata sull’ambiente.
UNHCR/N.Ng La situazione politica e sociale a Timor Est è più stabile ma ancora fragile. Con questa motivazione le Nazioni Unite hanno deciso, nel febbraio del 2010, di prolungare il mandato della missione Unmit (United Nations Integrated Mission in Timor Leste) che resterà sull’isola fino al febbraio del 2011. Lo scopo è quello di sostenere il Governo e le autorità di Timor Est nella difficile battaglia per la riconciliazione nazionale, dopo gli anni di feroce occupazione indonesiana dell’isola, e aiutare le autorità nella gestione di gravissime emergenze come la povertà estrema che colpisce la maggioranza della popolazione dell’isola, la disoccupazione e il dramma dei profughi. La strada è ancora lunga ma alcuni passi avanti sono stati fatti. Il 9 ottobre del 2009 si sono svolte sull’isola le elezioni municipali che hanno coinvolto 442 villaggi (sucos). La campagna elettorale, partita il 30 settembre e conclusasi il 6 ottobre, si è svolta in modo generalmente pacifico e senza scontri, con una larghissima partecipazione popolare che ha toccato il 67,75%. Le elezioni hanno registrato anche un incremento nella elezione di donne come capo villaggio, passate da 7 a 11. All’inizio del 2010, Mari Alkatiri, segretario generale del Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Indipendente), movimento simbolo della lotta per l’indipendenza di Timor e principale partito d’opposizione al Governo, ha lanciato un appello affinché gli anni dal 2010 al 2020 siano una “decade di pace, stabilità e sviluppo” per la nazione. Un appello condiviso e rilanciato anche dal presidente Ramos-Horta e dal primo Ministro Xanana Gusmão. Nonostante questi segnali, certamente positivi, sono ancora le condizioni di indigenza della popolazione a preoccupare le autorità locali


Generalità
Nome completo: Timor Est Bandiera
Lingue principali: Tetum, portoghese Capitale: Dili Popolazione: 947.000 Area: 15.007 Kmq Religioni: Cattolica (90%), musulmana (5%), protestante (3%) Moneta: Dollaro statunitense e dollaro australiano Principali Legname, caffè, petrolio esportazioni: e gas PIL pro capite: Us 1.813
e a costringere Timor Est in una condizione di dipendenza dagli aiuti della comunità internazionale. Per il Governo è ancora difficile gestire i tumulti causati dalla miseria e dalle tensioni sociali mai del tutto sopite. Nel 2008 un gruppo di militari ribelli ha tentato un colpo di stato con un doppio attentato contro l’attuale presidente Jose Ramos-Horta - che è rimasto gravemente ferito ma è sopravvissuto - e contro il premier Xanana Gusmão, rimasto invece illeso. Una situazione di relativa calma dunque ma che non basta ancora a garantire la stabilità a Timor Est.
Scopo della lotta della popolazione timorese è sempre stato il raggiungimento dell’indipendenza e dell’autodeterminazione. Un’autonomia ostacolata dai forti interessi internazionali in un’area strategica per le rotte commerciali e resa difficile anche oggi dalle tensioni interne Timor Est, è la nazione più giovane del pianeta. È composta dalla metà orientale dell’isola di Timor, dalle isole di Atauro e di Jaco e dalla provincia di Oecussi-Ambeno, una enclave situata nella parte occidentale dell’isola, Timor Ovest, che fa parte invece dell’Indonesia. Timor ha subito centinaia di anni di colonizzazione europea, da parte dei portoghesi, che arrivarono sull’isola nel XVI secolo, e dagli olandesi. L’instabilità politica e sociale dell’isola di Timor comincia proprio a causa della convivenza forzata sul territorio delle due potenze coloniali, che causò anni di sanguinosi conflitti, risolti soltanto nel 1859, con il Patto di Lisbona che sancì la suddivisione di Timor Est in due parti: quella orientale andò al Portogallo e quella occidentale all’Olanda. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, a causa della sua posizione strategica nel Sud Est asiatico, Timor venne occupata dalle forze australiane che temevano potesse diventare una base militare giapponese. Nel febbraio del 1942 il Giappone occupò effettivamente Timor, cancellando l’assetto territoriale stabilito dal Patto di Lisbona e trasformando l’intera isola in un’unica Regione sotto l’influenza politico-militare del Giappone. Alcune centinaia di militari australiani però non deposero le armi e scelsero di continuare a combattere contro i giapponesi, sostenuti anche dalla popolazione timorese, che per questo pagò un prezzo altissimo. Quando nel 1943, tra i diversi gruppi etnici che popolano Timor Est (78% timoresi, 20% indonesiani, 2% cinesi). Nonostante l’indipendenza formalmente conquistata nel 2002, Timor Est è ancora un Paese poverissimo, instabile e di fatto dipendente dal

sostegno della comunità internazionale. l’Australia decise il ritiro completo dall’isola di Timor, la rappresaglia dell’esercito giapponese contro la popolazione fu terribile. Si stima che le vittime delle violenze furono tra le 40mila e le 60mila. Dopo la fine della seconda guerra mondiale la parte orientale dell’isola tornò sotto il dominio portoghese mentre nel 1949 la parte occidentale, dopo il ritiro dell’Olanda, fu definitivamente annessa all’Indonesia. Un primo spiraglio verso l’indipendenza del Paese arrivò nel 1974 quando, in seguito alla ‘Rivoluzione dei Garofani’, il Portogallo cominciò ad allentare gradualmente il controllo sulle colonie in Asia e Africa, permettendo la formazione di partiti politici legalizzati a Timor Est. Nacque la “Frente Revolucionaria de Timor-Leste Indipendente”, detto Fretilin, destinato a diventare il movimento simbolo della lotta per l’indipendenza di Timor Est. Nel 1975 si tennero le prime elezioni politiche. Il Fretilin vinse con il 55% dei voti e dichiarò unilateralmente l’indipendenza dell’isola dal Portogallo. Lungi dall’essere un nuovo inizio per il popolo timorese, la dichiarazione d’indipendenza diede il via ad uno dei capitoli più sanguinosi della difficile storia di Timor Est. Il 7 Dicembre 1975 l’esercito indonesiano del dittatore Suharto, invase Timor Est occupando subito la capitale Dili e tutte le principali città del Paese. Nel 1976 Jakarta fa di Timor Est la sua ventisettesima Provincia. Iniziano gli scontri tra il Fretilin
Il petrolio del mare di Timor
Unica speranza di ripresa per l’economia di Timor Est sono le enormi risorse petrolifere nascoste nel suo mare (è una delle più grandi riserve di petrolio al mondo). Nel 2006 Timor Est e l’Australia (il principale Paese donatore di Timor) hanno sottoscritto un accordo per lo sfruttamento delle risorse del mare che li separa e che prevede la suddivisione tra i due stati, al 50%, dei proventi ricavati dall’estrazione di petrolio e gas in quel tratto di mare che separa i due Paesi. Nonostante questo l’economia di Timor Est continua a dipendere quasi del tutto dagli aiuti internazionali.
UNHCR/N.Ng
Quadro generale
Kay Rala Xanana Gusmão (Manatuto, 20 giugno 1946)
Xanana Gusmão, nome completo Kay Rala Xanana Gusmão, (Manatuto, 20 giugno 1946), è il primo ministro di Timor-Est. Per la popolazione timorese e’ una vera e propria leggenda. Ha guidato per anni la guerriglia armata contro l’esercito dell’Indonesia. Per questo e’ stato arrestato e ha passato piu’ di sei anni in una prigione indonesiana. E’ stato liberato il 7 settembre del 1999, solo qualche giorno dopo il referendum per l’indipendenza di Timor Est. Presidente della Repubblica di Timor Est dal 20 maggio 2002 al 20 maggio 2007 si e’ sempre dichiarato favorevole ad una amnistia per i miliziani indonesiani che dopo il referendum si accanirono contro la popolazione timorese. Questa sua posizione lo ha portato a scontrarsi politicamente, in piu’ di una occasione, con il Fretilin (Frente Revolucionaria de Timor Leste Indipendente), movimento simbolo della lotta per l’indipendenza di Timor Est e principale partito d’opposizione nel Paese.
UNHCR/N.Ng

I rifugiati dell’Oceania Il 5 luglio del 2010 Julia Gillard, primo ministro australiano, ha proposto la costruzione di un grande centro di raccolta per tutti i rifugiati dell’Oceania proprio a Timor Est. Il primo ministro timorese Xanana Gusmao ha dichiarato che la proposta ‘sarà valutata’ ma nulla è stato ancora deciso dalle autorità locali. La proposta dell’Australia, uno dei paesi con la legislazione più rigida in materia di immigrazione, ha scatenato numerose polemiche, considerando che Timor Est è il Paese più povero del mondo e che difficilmente sarebbe in grado di gestire una emergenza simile. Secondo i dati diffusi dall’Unhcr alla fine del 2009, i rifugiati presenti in Oceania sono 38200.
e l’esercito indonesiano, nell’indifferenza della comunità internazionale, mentre Stati Uniti e Australia riconoscono ufficialmente e subito l’occupazione indonesiana di Timor Est. Per 24 anni l’esercito e le milizie filo indonesiane imperversarono sull’isola accanendosi contro la popolazione. Più di 250mila timoresi furono uccisi, praticamente un terzo degli abitanti. Il 12 novembre del 1991 un gruppo di 200 soldati indonesiani trucidò almeno 250 timoresi riuniti per il funerale di un militante indipendentista nella città di Dili. Il cosiddetto ‘massacro di Dili’ venne filmato da due giornalisti americani, che diffusero le immagini permettendo al mondo intero di conoscere il dramma del popolo di Timor Est. Le immagini del massacro provocarono manifestazioni in tutto il mondo e, almeno, la condanna delle Nazioni Unite. Caduto il dittatore Suharto, il nuovo presidente Habibie, decise nel 1998, di dare un segnale di distensione alla comunità internazionale rendendosi disponibile a concedere uno statuto speciale a Timor Est. L’Onu si occupò di organizzare un referendum per l’autodeterminazione dell’isola, indetto il 30 agosto del 1999. La partecipazione al voto fu massiccia, il 98,6% della popolazione si recò alle urne. Gli indipendentisti vinsero con il 78,5% dei consensi ma ancora prima che i risultati venissero resi pubblici, l’esercito indonesiano e le milizie paramilitari filo-indonesiane si scatenarono contro la popolazione. I timoresi venivano uccisi sommariamente, decapitati. In migliaia furono deportati a Timor Ovest, nella parte indonesiana dell’isola. L’Onu inviò a Timor Est una forza multinazionale di pace, la Interfet (International Force East Timor). Solo il 20 ottobre il parlamento indonesiano ratificò i risultati del referendum e decise il ritiro dell’esercito. Nell’aprile del 2002 i timoresi si recano di nuovo alle urne per eleggere il primo Presidente della storia di Timor Est: Xanana Gusmão, leader storico della guerra d’indipendenza. Nel mese di maggio del 2002 viene ufficialmente proclamata l’indipendenza della Repubblica democratica di Timor Est.

Situazione attuale e ultimi sviluppi
Genocidio o grande catastrofe?
L’Armenia sostiene che tra il 1915 e il 1917 sia stato compiuto dall’Impero Ottomano un vero e proprio “genocidio” contro un milione e mezzo di armeni. Definizione da sempre respinta da Ankara secondo cui i morti armeni in quel periodo furono al massimo tra i 300mila e i 500mila e, comunque, causati non da uno sterminio premeditato, ma da una guerra civile che fece anche migliaia di vittime turche. Obama ha definito i massacri “una delle peggiori atrocita” del ventesimo secolo, in linea con l’espressione armena “Meds Yeghern”, la “grande catastrofe”. Le relazioni tra i due confinanti Turchia-Armenia non possono dirsi normalizzate. Altopiano anatolico orientale, lago Van e alto bacino dei fiumi Tigri ed Eufrate, in corrispondenza del confine Turchia-Siria-Iraq (Sud) e Turchia-Iran (Est), insiste tuttora su questo territorio e sulla popolazione civile residente, una decisa azione militare che contrappone l’Esercito turco agli armati del Pkk, Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Nell’estate 2009, il Pkk aveva accordato al Governo turco una tregua unilaterale nell’attesa che il suo leader, Abdullah Ocalan, detenuto nell’isola di Imraly, nel mar di Marmara, si pronunciasse sul da farsi. Allo stesso tempo, il premier turco Tayyp Erdogan parlò di un progetto chiamato “apertura democratica” per arrivare alla soluzione pacifica del conflitto. Ma a maggio 2010, le parti prendono atto dell’impossibilità del dialogo. Da allora, una lunga cronaca di guerra continua. Il mese di luglio è uno dei più sanguinosi dell’anno. Fonti militari di Ankara fanno sapere che “46 ribelli curdi sono stati uccisi nell’ultimo mese, mentre negli ultimi sei mesi sono stati in totale 187 gli uccisi in combattimento”. Intanto, il settimanale tedesco Der Spiegel denuncia il 12 agosto l’uso di armi chimiche da parte dell’esercito. Il 15 agosto il canale satellitare curdo Roj Tv che trasmette dalla Danimarca manda a ripetizione video per celebrare quel 15 agosto 1984, quando partì la campagna militare del Pkk per l’indipendenza. E in questo clima di tensione, il 21 e 22 agosto, si apre la Conferenza della Società Democratica a Diyarbakir per far arrivare al Governo una

Generalità
Nome completo: Repubblica di Turchia Bandiera

Lingue principali: Turco Capitale: Ankara Popolazione: 75.586.100 abitanti Area: 783.562 Kmq Religioni: Maggioranza mussulmana sciita e sunnita, minoranza cristiana e altre fedi Moneta: Nuova lira turca Principali Tessile, alimentare, esportazioni: ferro e acciaio. Più del 50% di tutte le merci vanno in Ue PIL pro capite: 13,920 dollari
proposta di pace da parte dei curdi non militanti del Pkk. Faruk Balikçi, Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Sud Est dichara scettico: “I giornalisti turchi non sono stati capaci di capire i curdi. In Turchia ci sono giornali indipendenti come Taraf o la stampa di sinistra che vogliono la pace, ma sono un’esigua minoranza. Nella parte Ovest del Paese non ci si interroga più sul perché del conflitto.”
L’area a Sud Est della Turchia è suddivisa in 12 province e fa riferimento alla città di Diyarbakir. È la “terra dei Curdi”, da sempre spartita tra Turchia, Iran, Siria e Iraq. Il Pkk, nato nel 1984, ha l’obiettivo fondare uno Stato (Kurdistan) gestendo direttamente le risorse, prima fra tutte, il petrolio. Dal punto di vista turco, (e dal punto di vista dell’Ue e degli Usa) i curdi del Pkk sono “terroristi” aderenti ad un’organizzazione Il 12 settembre 2010, il 58% degli elettori turchi vota “si” al referendum indetto per accettare o respingere la riforma della Costituzione riguardante, soprattutto, la riorganizzazione della magistratura e nuovi diritti civili. Il Pkk, in posizione di “difesa passiva” dalla metà di agosto e fino al 20 settembre 2010 per dimostrare, facendo tacere le armi, il loro rispetto del Ramadan (mese di digiuno per i mussulmani,) comunicava che il referendum è “un’iniziativa senza sincera volontà di creare una Costituzione veramente democratica”. Tuttavia, le associazioni della società civile riunitesi il 21 e 22 agosto alla Conferenza della Società Democratica di Diyarbakir avevano indicato proprio la riforma della Costituzione come uno dei punti fondamentali per raggiungere la pace. In ogni caso, per la Turchia è un momento storico. La Costituzione redatta nel 1982 (due anni dopo il colpo di Stato dei militari del 1980) viene, dunque, emendata riguardo a 26 articoli: riorganizzata la magistratura, riformati i rapporti tra giustizia civile e militare, ma anche i diritti civili e la protezione di donne, minori e anziani. Il premier Tayyip Erdogan ha sostenuto che questa riforma, anche se parziale, era necessaria per democratizzare di più il Paese. Per le opposizioni, invece, questa riforma voluta dal Partito di Erdogan al Governo (il Partito per la Giustizia

fuorilegge. Ma nelle famiglie curde era vietato parlare curdo, ascoltare musica in curdo, usare nomi curdi. L’accusa di “trasgressione” era sufficiente per essere torturato, mandato in esilio o essere condannato a morte. Questo fa parlare i curdi di “colonialismo” turco. Nel conflitto in corso dal 1984 nel Sud-Est dell’Anatolia, secondo l’esercito turco, vi sono stati almeno 45 mila morti. e lo Sviluppo - Adalet ve Kalkinma Partisi, Akp) sarebbe solo l’ultima dimostrazione di un tentativo di “golpe strisciante”, teso a limitare fortemente il potere della magistratura (sottoponendola al controllo dell’esecutivo) e a ridurre ancor più l’influenza nella vita sociale e politica delle forze armate. Istituzioni, quella della magistratura e dell’esercito, entrambe considerate dalla Costituzione e dall’elite laico-burocratica turca come i custodi e garanti della laicità del Paese contro ogni tentazione di deriva islamica. L’opposizione ritiene che l’Akp di Erdogan, (avendo forti radici islamiche) se vincerà alle elezioni politiche del 2011, avrebbe nuove possibilità per islamizzare il Paese. Il Commissario all’allargamento della Ue, Stefan Fuele, ha espresso soddisfazione per la vittoria dei “si”. Il processo attuativo delle riforme verrà seguito, ha detto, con “attenzione”, senza perdere di vista altre “priorita che riguardano il campo dei diritti fondamentali come la libertà di espressione e la libertà religiosa”. Anche il presidente Barack Obama ha espresso il suo compiacimento con uno degli alleati chiave degli Usa. Senza entrare nel merito della questione dei referendum, il capo della Casa Bianca ha commentato che l’alta affluenza alle urne è una prova della “vitalità della democrazia turca”. Ma cosa cambia esattamente, dopo il “si” del
Delitti d’onore
I “delitti d’onore” sono ancora una piaga che affligge la Turchia, nonostante il Governo di Ankara negli ultimi tempi abbia inasprito le pene per i responsabili di questo reato. Stando a un recente rapporto ufficiale, in Turchia almeno una donna a settimana è vittima di un delitto d’onore. Inoltre - secondo dati del Direttorato generale sulla condizione femminile - il 42% delle donne in Turchia è vittima
di violenze fisiche e sessuali.
Quadro generale
Abdullah Öcalan (Ömerli, 4 aprile 1948)
Abdullah Öcalan, detto Apo è il leader del Pkk. Catturato a Nairobi nel 1999, è stato condannato all’ ergastolo nel 2002. Dopo aver frequentato il liceo statale di una piccola città di provincia, si iscrisse alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Ankara. Negli ani ’70, Öcalan si arruolò nel servizio civile a Diyarbakır. Öcalan divenne un membro attivo della Associazione Democratica Culturale Dell’Est, un’associazione promotrice di diritti per il popolo curdo. Nel 1978 fondò il Pkk. Nel 1984 iniziò una campagna di conflitto armato. Circa 30.000 persone vennero uccise dal Pkk tra il 1984 e il 2003. Il 26 agosto 2010, un rappresentante del Governo turco ha ammesso per la prima volta che funzionari statali hanno avuto contatti in carcere con Ocalan infrangendo così un tabù quasi trentennale. Ufficialmente il Governo di Ankara ha sempre respinto le richieste da parte dei ribelli curdi per cercare una soluzione alla cosiddetta “questione curda”. Ma in vista dell’importantissimo voto referendario del 12 settembre, il Governo ha cercato di guadagnarsi anche le simpatie dei curdi, questo è l’interpretazione dei fatti da parte delle forze di opposizione.

Quando i bambini tirano sassi Nel 2010 l’Ue ha sollecitato Ankara a riformare la legge minorile - conosciuta come “la legge per i bambini che tirano sassi” - in base alla quale centinaia di minori, la quasi totalità curdi, negli anni scorsi sono stati incarcerati e condannati a pesanti pene detentive. Da luglio 2010, in base ad una nuova legge approvata dal Parlamento, i minori che prendono parte a manifestazioni di protesta a favore del Pkk tirando pietre contro le forze dell’ordine non saranno più incriminati “per attività terroristiche” e saranno giudicati da appositi tribunali per minori e non da tribunali penali.
12 settembre 2010? Vediamo. Diritto alla privacy: le modifiche tendono a proteggere le informazioni personali che potranno essere ottenute solo con il permesso dell’interessato. Libertà di movimento: il diritto di una persona di recarsi all’estero sarà limitato solo a causa di processo penale o per ordine del giudice. Diritti dei minori: le modifiche migliorano la protezione dei bambini nei casi di abusi e violenze. Poi, i lavoratori potranno appartenere a più di un sindacato. L’emendamento all’art. 84 della Costituzione, invece, impedirà l’espulsione di un deputato dal Parlamento nel caso un giudice consideri le sue azioni come base legale per mettere al bando un partito politico. La riforma costituzionale darà, inoltre, agli impiegati statali il diritto a contratti di lavoro collettivi e a fare ricorso contro azioni disciplinari ritenute ingiustificate. La Corte Costituzionale sarà ora composta da 17 giudici (e non più da 11) e potrà giudicare i massimi gradi militari. Mentre i membri del Consiglio Supremo dei Giudici e dei Procuratori diventeranno 22 effettivi con 12 sostituti. Ma cruciale è stata la riforma degli articoli riguardanti l’esercito: dal 12 settembre 2010, i tribunali civili, e non più quelli militari, potranno processare membri delle forze armate accusati di reati contro la sicurezza dello Stato o la Costituzione. D’altro canto, i civili non potranno essere processati da tribunali militari. Per un quadro generale della Turchia, bisogna sapere che l’Esercito è custode ultimo dei principi stabiliti da Mustafa Kemal Ataturk, fondatore della Repubblica nel 1923 sul modello dello Stato laico europeo.Vantando un ruolo di garante costituzionale, l’Esercito è intervenuto nella dinamica parlamentare con ben tre colpi di stato (1960, 1971, 1980) volti, ufficialmente, a ristabilire i principi del Kemalismo ma in realtà intento a far ordine reprimendo l’opposizione sindacale e politica. Le Forze Armate controllavano (fino a 2003) le dinamiche politiche attraverso l’Mgk (Consiglio di Sicurezza Nazionale), le cui “raccomandazion” erano quasi delle prescrizioni per le istituzioni politiche. Per questo, il 23 luglio 2010, la notizia dell’apertura di un’inchiesta interna all’esercito per accertare l’esistenza di eventuali collusioni tra alcuni membri delle forze armate e il Pkk, ha creato scompiglio. Mentre, solo qualche giorno prima, il 19 luglio, un tribunale di Istanbul incriminava formalmente 196 persone sulla scia delle indagini su Ergenekon, una presunta organizzazione segreta nazionalista che avrebbe tentato di rovesciare il Governo.
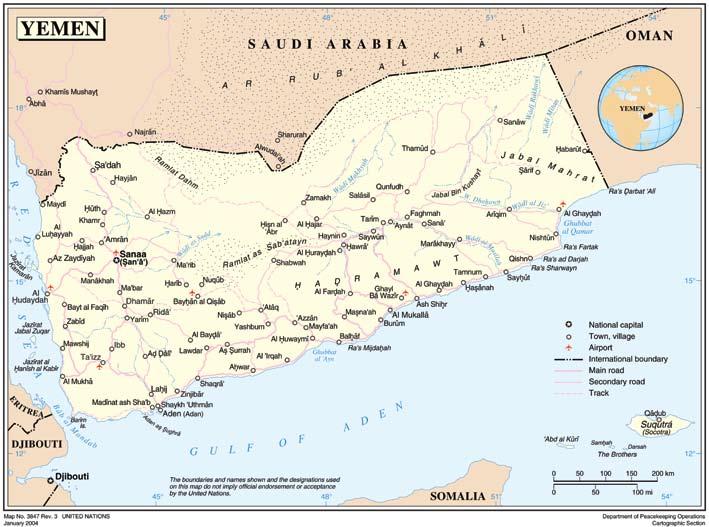
Situazione attuale e ultimi sviluppi
UNHCR/ P. Marion C’è voluto il fallito attentato del 25 dicembre 2009 su un volo Delta da Amsterdam a Detroit per ricordare ai governi e alle opinioni pubbliche occidentali che lo Yemen resta uno dei Paesi più instabili del mondo, teatro di almeno tre conflitti interni “a bassa intensità” - che però si protraggono da anni - e ricettacolo inoltre di jihadisti e qaedisti delle più svariate nazionalità, che proprio in questa estrema propaggine della penisola Arabica, patria della Regina di Saba ma anche di Osama bin Laden, trovano ospitalità, fondi e nuove prospettive di arruolamento. Jihadista infatti, addestrato per un mese in una base di al-Qaeda a Sanaa, era il ventitreenne nigeriano Umar Faruk Abdulmutallab, salito a bordo del volo 253 della Delta Airlines con 80 grammi di nitroglicerina e un detonatore nelle mutande. Solo la sua imperizia ha impedito l’innesco della bomba, salvando così la vita ai 278 passeggeri e costringendo il presidente Barack Obama a cercare di corsa lo Yemen sulle carte geografiche, per inserirlo - o meglio re-inserirlo - nella black list dei Paesi da tenere sotto controllo, perché in grado di minacciare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Dal gennaio 2010 lo Yemen è diventato così il terzo “fronte” nella lotta al terrorismo internazionale, dopo l’Afghanistan e l’Iraq. Un fronte reso ancora più caldo per via della sua collocazione geografica strategica: il golfo

Generalità
Nome completo: Repubblica Unita dello Yemen Bandiera

Lingue principali: Arabo Capitale: San‘a’ Popolazione: 20.975.000 (2005) Area: 527.970 Kmq Religioni: Musulmana Moneta: Riyal yemenita Principali Petrolio, gas naturale, esportazioni: caffé e cotone PIL pro capite: Us 2.410
di Aden si trova infatti a poche miglia dalle coste somale, nello stesso specchio di mare cioè dove operano le bande di pirati che tanti problemi hanno creato negli ultimi anni alle marine mercantili occidentali; e nella stessa area operano inoltre gli shabab, i giovani fondamentalisti islamici che hanno preso il potere in molte città della Somalia, mantengono stretti legami con la rete di Osama Bin Laden e rischiano di destabilizzare tutto il Corno d’Africa. Lo Yemen rappresenta da questo punto di vista un alleato prezioso, per gli Stati Uniti, senza il cui appoggio la lotta al terrorismo internazionale difficilmente potrà essere vinta.
In realtà, sono più di dieci anni che al-Qaeda opera in Yemen, sia pure con alterne fortune. Il suo battesimo del fuoco è datato 2000, con lo spettacolare attacco alla portaerei americana Cole, che fece 17 morti fra i marines. Ma i primi nuclei jihadisti risalgono già ai primi anni ’90, con il rientro dei mujahideen che avevano combattuto in Afghanistan, al fianco di Osama bin Laden. Con essi il Presidente yemenita Ali Abdullah Saleh ha mantenuto a lungo un rapporto strumentale, pronto cioè a utilizzarne la potenza di fuoco e le capacità organizzative per risolvere i suoi problemi interni, salvo poi fare marcia indietro e dar loro la caccia quando l’alleato americano lo imponeva. È infatti provato che le milizie di al-Qaeda sono state utilizzate senza tanti problemi dal Governo yemenita già nella seconda metà degli anni ’90, per contrastare la secessione nelle province del Sud tentata dai ribelli del “Southern Mobility Movement”. Altrettanto disinvolto è però il voltafaccia del presidente Saleh dopo l’attentato alle Twin Towers dell’11 settembre 2000, quando gli americani scoprono la consistenza della rete terroristica di bin Laden in terra yemenita. È solo a quel punto che la caccia ai militanti di al-Qaeda diventa anche a Sanaa una priorità nazionale, resa ancora più pressante dal numero cospicuo di kamikaze yemeniti che vanno ad immolarsi in Iraq dopo il 2003, per combattere gli americani. Il paradosso è che, con la stessa Il problema vero è che lo Yemen resta un’entità statale assai poco stabile, per non dire effimera. Anche se nel 2010 si è celebrato il ventennale dell’unificazione fra il Nord e il Sud del Paese, che sono rimasti separati dal 1967 al 1990, per via della Guerra fredda. La riconciliazione nazio-

velocità con cui le carceri di Sanaa si riempiono di militanti di al-Qaeda, altrettanto velocemente si svuotano. Una fuga di massa si verifica ad esempio nel febbraio 2006, quando 23 miliziani di a-lQaeda, tutti di primo piano, riescono ad evadere. Ed è questo l’inizio di una nuova fase, che vede i jihadisti impiantarsi sempre più saldamente nelle province del Sud, con rapporti di contiguità se non di alleanza tattica con la guerriglia separatista, che continua a battersi per l’indipendenza. Allo stesso tempo, al-Qaeda nella penisola Arabica non smette di colpire, appena può, il nemico americano e i suoi più stretti alleati: nel 2008 ci sono stati due attacchi suicidi all’ambasciata Usa cui vanno aggiunti diversi attacchi contro obiettivi “occidentali”. Nell’autunno 2009, inoltre, l’Arabia Saudita ha denunciato l’infiltrazione di elementi legati ad al-Qaeda provenienti dal Nord dello Yemen, a conferma del fatto che la rete del terrore che fa capo ad Osama bin Laden ha nello Yemen il suo principale caposaldo, con una capacità di azione ad ampio raggio e una rete di protezioni tribali che sarà difficile smantellare, nonostante l’impegno degli Stati Uniti, che nel corso del 2010 hanno bombardato a più riprese con i loro droni presunte basi di al-Qaeda in Yemen. L’ultima battaglia fra l’esercito yemenita e i miliziani di al-Qaeda è del 24 agosto 2010, nella città di Loder, nel Sud, ed ha fatto decine di morti da ambo le parti. nale, in effetti, è ancora lontana: Sanaa e Aden restano separate dai lutti e dagli strascichi della guerra civile, oltre che dalle discriminazioni economiche e sociali di cui il Sud tuttora soffre. Il risultato è che il vento della secessione continua a soffiare, contrastato da una feroce
Arabia (in)Felix
Fino al 1990 lo Yemen del Nord si chiamava Repubblica Araba dello Yemen. Il suo territorio coincideva grosso modo con quella che gli storici dell’antichità chiamavano Arabia Felix, erede del mitico regno della Regina di Saba. In origine cristianizzata, la regione venne poi islamizzata e diventò ben presto il rifugio degli sciiti zaidisti, le cui dinastie rimasero al potere fino all’indipendenza, ottenuta dopo la fine dell’impero Ottomano, alla fine della I guerra mondiale. Nel 1962 un colpo di stato repubblicano segna l’ingresso dello Yemen nell’era moderna, con la costruzione di uno Stato arabo moderato, schierato sempre con l’Occidente nella lunga Guerra fredda. Completamente diverso il destino dello Yemen del Sud. L’autonomia di questa regione risale innanzitutto al X secolo, con l’affrancamento dalla dinastia zaidista del Nord e la creazione di diversi staterelli locali, che finirono però successivamente nell’orbita delle potenze coloniali occidentali. Diventato così prima colonia e poi protettorato della Gran Bretagna, lo Yemen del Sud acquistò la sua indipendenza nel 1967, dopo quattro anni di guerra di liberazione, e prese il nome di Repubblica Democratica Popolare dello Yemen, comunista e
filosovietica.
UNHCR/Mainer
Quadro generale

Nasir Abdel Karim Al Wuhayshi (1976)
Secondo tutte le fonti, il leader riconosciuto di al-Qaeda nella Penisola Arabica (Aqap) è l’ex luogotenente di Osama bin Laden in Afghanistan, Nasir Abdel Karim Al Wuhayshi. Arrestato dagli iraniani dopo la sua fuga da Kandahar nel 2001, è rimasto per diversi anni nelle prigioni yemenite, da cui è riuscito a evadere nel febbraio 2006. A consacrarne la leadership di Aqap a partire dal 2009, è stato lo stesso numero due di al-Qaeda, Ayman Al Zahawiri, con un videomessaggio. Il leader spirituale di Aqap resta invece l’imam di origini americane Anwar Al Awlaki. Nato nel New Mexico, dove suo padre insegnava all’università, Al Awlaki è diventato uno dei predicatori islamici più radicali degli Stati Uniti. Dopo l’attacco alle Torri gemelle, e proprio in virtù delle sue frequentazioni con almeno due degli attentatori, è costretto a lasciare gli Stati Uniti per Londra e poi per lo Yemen. Sarebbe lui la guida spirituale che ha istruito Nidal Malik Hassan, l’ufficiale americano di fede islamica che il 5 novembre 2008 ha massacrato 13 persone nella base militare di Fort Hood. E sarebbe stato sempre Al Awlaki il mentore del nigeriano Umar Faruk Abdulmutallab, l’attentatore fallito sul volo Delta Airways del 25 dicembre 2009.
UNHCR/ L. Chedrawi

Una società che resta feudale In Yemen persiste una struttura sociale di tipo feudale, fondata sulle caste. Ci sono sostanzialmente due ordini: quello superiore, cui appartengono i sayyid (i signori), che discendono dal profeta Maometto, i qadi (i giudici) e gli sceicchi, che sono a capo delle varie tribù; quello inferiore, composto invece dagli artigiani, dai servi e dagli akhadm, di pelle scura, che sono in pratica i discendenti degli antichi schiavi neri. Gran parte dei sayyid sono sciiti, e molti appartengono al clan degli Al Houti. La loro rivalità con il Governo centrale dipende dal fatto che gli Houti si ritengono gli unici legittimati a guidare il Paese e non riconoscono perciò l’autorità del presidente Saleh, considerato di razza inferiore.
repressione del Governo centrale, che ovviamente finisce per esasperare la situazione. In questo quadro già problematico si inserisce la presenza di al-Qaeda: il suo leader yemenita, Nasir Al Wuhayshi, ha più volte negli anni recenti manifestato il suo appoggio alle istanze secessioniste portate avanti dal Southern Mobility Movement; e non va poi dimenticato che l’attuale leader del Smm, Tareq al-Fadhlii, è stato uno dei luogotenenti di Bin Laden in Afghanistan. Quanto basta, insomma, per rendere il Sud dello Yemen una polveriera pronta ad esplodere, anche se per ora i dirigenti del Smm lavorano per arrivare a una “insurrezione civile”, ma disdegnano - almeno a parole - la lotta armata. Un secondo “fronte” è aperto nel Nord, al confine con l’Arabia saudita, con la minoranza sciita che fa capo al clan degli Al Houti. Si tratta di sciiti della setta zaidita, che non riconoscono alcuna legittimità al Governo centrale del presidente Saleh, contro il quale sono in guerra aperta dal 2004. Il loro leader, il predicatore Hussein Al Houti è stato ucciso in un raid aereo del dicembre 2009. Secondo l’Onu, il conflitto ha già fatto decine di migliaia di vittime e provocato un flusso di almeno 50mila rifugiati, costretti ad abbandonare le loro case. Le autorità di Sanaa accusano l’Iran di fomentare la rivolta, per spingere al potere la minoranza sciita, che in Yemen rappresenta il 40-45% della popolazione. Certo è che le province del Nord - in particolare quella di Saada - sono off limits per l’esercito di Sanaa e sono saldamente in mano ai ribelli: una secessione di fatto, che ha provocato nel dicembre 2009 l’intrevento armato dell’Arabia Saudita, che lamenta l’insicurezza di questa frontiera, troppo permeabile dai miliziani di al-Qaeda. Dall’11 febbraio 2010 è scattata una tregua, anche se più volte violata da entrambe le parti, e questo se non altro ha posto fine alle operazioni militari su larga scala. Il 25 agosto 2010, a Doha, in Qatar, sono iniziati infine i primi colloqui di pace diretti fra le due parti.








