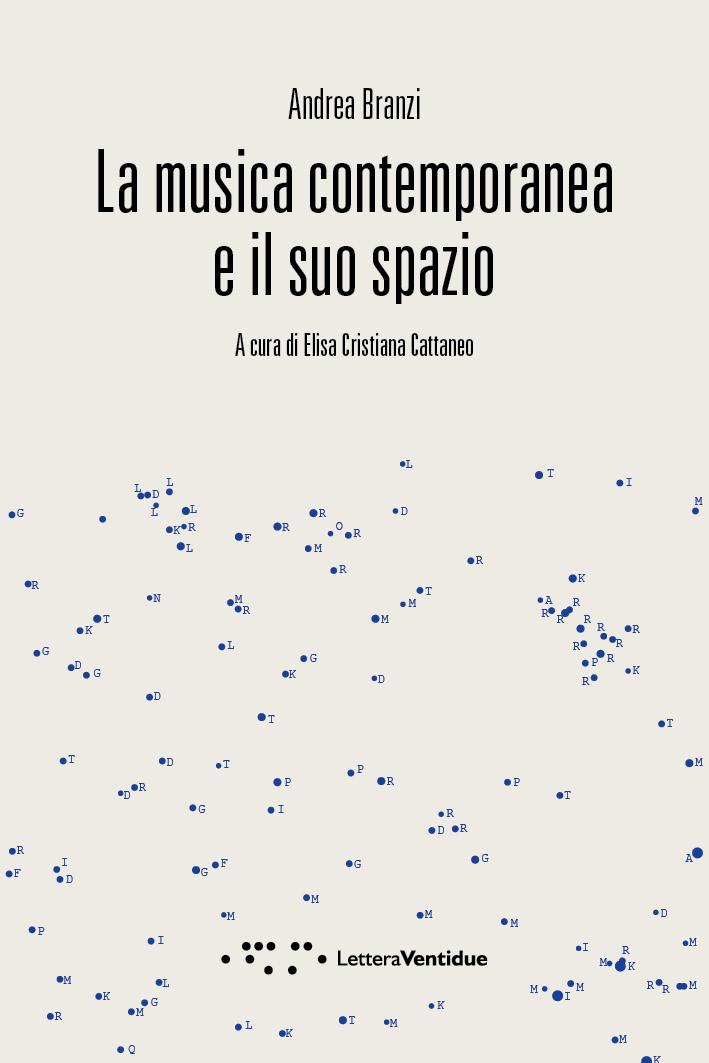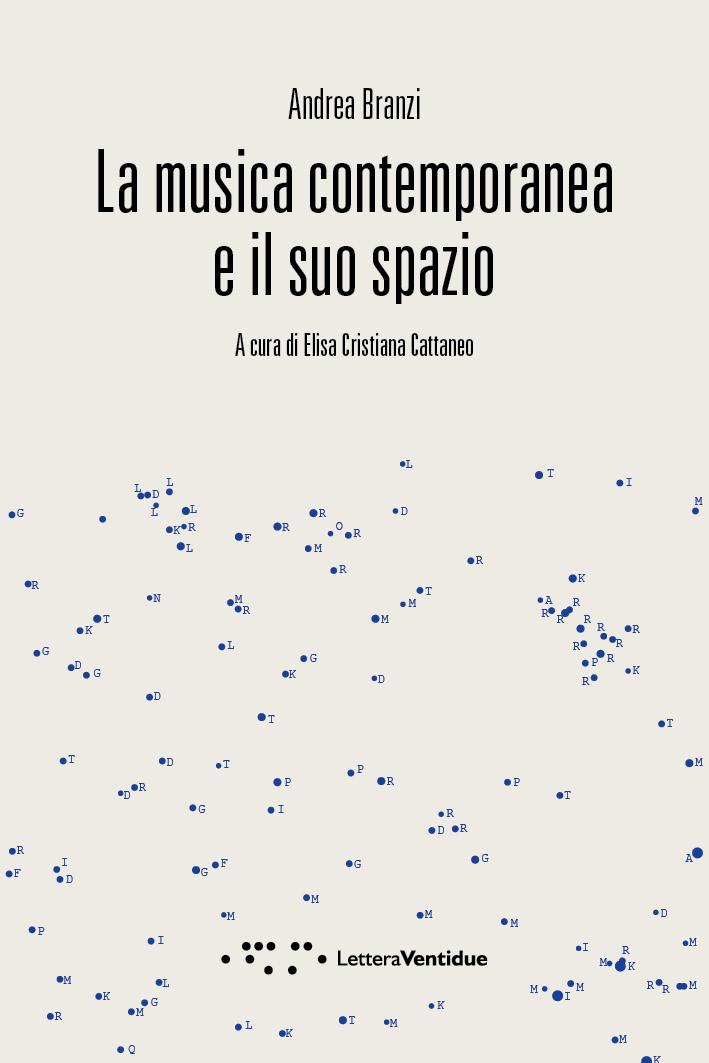
Compresse
collana ideata e diretta da Francesco Trovato
Comitato Scientifico
Francesco Cacciatore
Fabrizio Foti
Paolo Giardiello
Marta Magagnini
Marella Santangelo
ISBN 978-88-6242-833-0
Prima edizione Maggio 2023
© LetteraVentidue Edizioni
© Andrea Branzi
© Elisa C. Cattaneo (Introduzione)
Tutti i diritti riservati
Come si sa la riproduzione, anche parziale, è vietata. L’editore si augura, che avendo contenuto il costo del volume al minimo, i lettori siano stimolati ad acquistare una copia del libro piuttosto che spendere una somma quasi analoga per delle fotocopie. Anche perché il formato tascabile della collana è un invito a portare sempre con sé qualcosa da leggere, mentre ci si sposta durante la giornata. Cosa piuttosto scomoda se si pensa a un plico di fotocopie.
Progetto grafico: Francesco Trovato
Impaginazione: Raffaello Buccheri
LetteraVentidue Edizioni S.r.l.
Via Luigi Spagna 50 P
96100 Siracusa
www.letteraventidue.com
La musica contemporanea e il suo spazio
Andrea Branzi a cura di Elisa C. Cattaneo
Indice
L’ospite inatteso di Elisa C. Cattaneo
1. Una musica che non è musica
2. La diversa fortuna dei linguaggi delle avanguardie
3. La mancanza di spazi specializzati
4. Nuove disponibilità logistiche
5. Fuori dal mercato
6. La Scuola di Francoforte e la “Nuova musica”
7. La dodecafonia e il “pensiero negativo”
07 11 14 17 20 23 25 29
8. Due strategie contrapposte
9. La musica artificiale
10. La grande solitudine della musica contemporanea
11. Dall’ascolto passivo all’ascolto attivo (o frazionato)
12. Dalla sala concerti al territorio musicale
13. Musica e acustica
33 36 38 40 42 48
L’ospite inatteso
di Elisa C. Cattaneo
Riferendosi ad un vuoto progettuale di almeno 50 anni (con genesi nella dialettica tra Adorno e Benjamin degli anni Trenta, fino alla musica concettuale di John Cage di metà Novecento e agli esiti ultimi di Philip Glass), Andrea Branzi riconferma in questo saggio la propria posizione di sovvertitore delle logiche concettuali e spaziali: un inatteso progettuale genera nuovi prototipi urbani, compositivi, cognitivi.
L’inatteso, nello specifico, non è solo la musica come generativa di un nuovo layer urbano, ma è una terza via di un pensiero sullo spazio in toto. Spazio che viene disassato dalle logiche compositive visive e oggettuali tipiche della modernità, matrice di una prassi monodirezionata, verso una dimensione più aperta, orizzontale, sensoriale.
L’inatteso espresso nel testo è quindi sia il terzo termine tra una musica riferibile al dogmatismo reazionario (esemplificato nella posizione di Adorno ma anche alla composizione più ortodossa) e quella della ripetizione diffusa (di Benjamin ma anche di una posizione elitaria), sia una nuova prospettiva progettuale e spaziale ampia che ricolloca il significato di tutte le parti in causa, quali: il concetto di tempo (frazionato e
7
1. Una musica che non è musica
Questo testo non è dedicato alla storia della musica contemporanea, (che qui è descritta come un fenomeno unitario, mentre in realtà è sempre stata una realtà molto complessa e articolata), ma piuttosto è un saggio dedicato ad aprire un confronto tra l’attuale cultura del progetto e la straordinaria produzione culturale della musica contemporanea, la cui conoscenza è ancora oggi molto limitata e i cui spazi d’uso sono rimasti quelli della musica tradizionale.
Questo tipo di produzione musicale, volutamente misteriosa e concettuale, costituisce oggi un territorio conoscitivo particolare, in grado di stimolare una nuova interpretazione dello spazio a lei dedicato. Non si tratta quindi di immaginare similitudini formali tra la musica contemporanea e l’edificio che la contiene, come è già stato tentato, ma piuttosto di indagare dei dispositivi ambientali che permettano un rapporto diverso tra uditore e musica al fine di favorire una elaborazione attiva dei suoi materiali sonori, di altissimo livello concettuale. Si tratta infatti (facendo una
11
4. Nuove disponibilità logistiche
Le aree industriali dismesse hanno dimostrato essere i luoghi ideali per questo tipo di sperimentazione. Esse favoriscono la realizzazione di dispositivi di allestimento per queste nuove esigenze.
Durante gli anni Novanta la regione industriale della Ruhr in Germania, abbandonata dalle tradizionali attività produttive, è diventata il territorio di una vasta sperimentazione per organismi interni flessibili e reversibili, in grado di rispondere ad usi molteplici, destinati alla cultura e al tempo libero.
Le dismissioni industriali costituiscono una offerta strutturale molto importante e storicamente del tutto nuova, derivata dai processi di globalizzazione dell’economia occidentale: essa ha immesso sul mercato immobiliare un’enorme quantità di organismi architettonici che senza essere abbattuti possono essere rapidamente e economicamente riciclati per nuove attività, rispondendo ad una domanda di consumo culturale in grande espansione.
Oggi esistono quindi condizioni operative nuove (anche dal punto di vista logistico), che si collocano
20
all’interno del più vasto processo di continua ri-funzionalizzazione della città contemporanea: città spesso progettata secondo logiche di grande rigidità e specializzazione, che deve oggi essere continuamente riadattata per attività e usi (apparentemente) impropri e spesso mutanti nel tempo.
L’inizio del XXI secolo è quindi caratterizzato dall’avvento di una nuova modernità “debole e diffusa”2 che opera attraverso logiche sperimentali e dispositivi reversibili, creando funzioni disponibili a usi molteplici; essa costituisce uno scenario teorico nuovo, dove la cultura del progetto non è più rivolta come nel secolo scorso a raggiungere soluzioni definitive, forti e concentrate, ma piuttosto tessuti tipologici revisionabili e trasformabili.
Tornando dunque alla questione della musica contemporanea e al suo ritardo rispetto al consenso sociale che altre arti moderne (altrettanto difficili e forse di più) sono riuscite a conquistarsi (dopo un periodo iniziale di rifiuto dovuto alla loro oggettiva difficoltà di decodificazione), esse hanno poi raggiunto una propria ufficialità, attraverso canali e luoghi in grado di valorizzarne la specificità (musei, gallerie, teatri a esse dedicati).
La musica contemporanea rimane invece ancora oggi un ospite inatteso che si inserisce con difficoltà
21
2 Cfr. Andrea Branzi (2006), Modernità debole e diffusa. Il mondo del progetto all’inizio del XXI secolo, Skira, Milano.
divisioni attraversano la società creando delle classi musicali spesso più radicate di quelle economiche, ove gli scambi sono difficili e ciascun appassionato si identifica in uno status a-critico, che lo rende impermeabile a innovazioni di ordine generale.
La diffusione dei dischi ha ampliato di molto il consumo di musica, ma non ha creato fenomeni di fusione tra gli appassionati dei vari generi. Questo tipo di rigidità (che si registra in misura molto minore negli altri settori degli appassionati d’arte) ha sicuramente costituito una difficoltà aggiuntiva alla musica contemporanea nel suo tentativo di inserirsi in un settore così fortemente strutturato.
28
7. La dodecafonia e il “pensiero negativo”
Tra le due guerre mondiali la nuova musica affrontò la fase più difficile del suo cammino, costituita della rimozione tecnica della musica borghese, cioè di tutto quell’apparato di regole e di convenzioni derivate dalla tradizione e accettate a-criticamente da tutti i compositori. Occorreva compiere questa difficile operazione di riforma interna alla musica per raggiungere una sorta di grado zero da cui ripartire.
Una delle riforme più geniali compiute in questa direzione fu quella introdotta proprio dal compositore viennese Arnold Schönberg che nel 1923 presentò la prima opera dodecafonica Suite per pianoforte op. 255 .
La musica dodecafonica nasceva da una strategia liberatoria che in altri contesti e in altri tempi è stata attuata da altri movimenti di avanguardia al fine di azzerare le armature caratteriali e le sovrastrutture che si frapponevano alla creazione del nuovo. Fino ad allora, nella tradizione musicale qualsiasi armonia prendeva le mosse da una sorta di pre-selezione delle note e su una
29
5. Suite per pianoforte op. 25, 1921-23.
12. Dalla sala concerti al territorio musicale
Ci sono state nel tempo diverse ipotesi per modificare la struttura della sala concerto (da Wagner a Gropius) smontandone e rimontandone le diverse parti, al fine di creare una tipologia che rispondesse a nuovi rapporti tra pubblico e palcoscenico (o orchestra). Ma i risultati sono sempre stati modesti, perché le innovazioni proposte creavano sistemi di grande rigidità, o meccanismi troppo complessi di trasformazione dell’intero organismo architettonico.
Occorre allora abbandonare la strada del semplice aggiornamento tipologico per affrontare un cambiamento progettuale più radicale.
Questo cambiamento si attua attraverso due strategie fondamentali:
1. La prima è costituita dal considerare la completa autonomia tra lo spazio interno e la forma dell’architettura che lo contiene. Questo concetto permette di sganciare l’organizzazione degli spazi e delle installazioni interne (sempre provvisori e reversibili), dalla composizione strutturale dell’edificio esterno (sempre permanente e definitiva);
42
2. La seconda operazione consiste nel creare non una nuova tipologia di teatro, ma piuttosto un territorio musicale, cioè un tessuto omogeneo di opportunità; un sistema ambientale teoricamente illimitato (di cui se ne realizza una parte, un segmento, un frammento) che risponde in qualsiasi punto alle necessità dell’esecuzione e dell’ascolto della musica contemporanea. Dunque un territorio dal perimetro sfumato, attraversabile, non blindato, che non produce una nuova forma architettonica, ma piuttosto un sistema di layers che possono cambiare nel tempo.
Per ottenere questo risultato occorre allora predisporre alcune innovazioni che coinvolgano le parti tradizionalmente rigide e separate del teatro musicale: che sono platea, palcoscenico, rapporto esterno/interno, scenografia. Al fine di realizzare un sistema più omogeneo e frammisto, in grado di essere spalmato su tutta l’area a disposizione.
La prima innovazione è costituita dalla predisposizione di postazioni individuali (o per piccoli gruppi) di ascolto, isolate cioè non disposte in fila come nelle sale tradizionali, ma in isole o arcipelaghi dai quali sia facile entrare e uscire, per attivare sia un ascolto continuo sia un ascolto frazionato.
Occorre cioè che la tradizionale disposizione dei posti in emiciclo (quindi a catena) venga interrotta, creando dei nuclei separati di facile accesso, dove
43