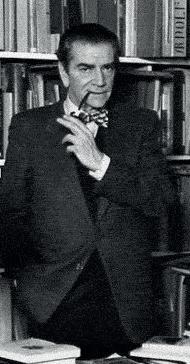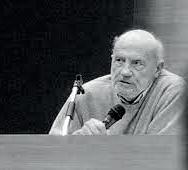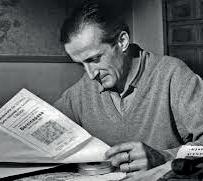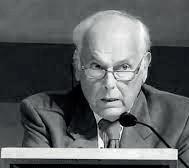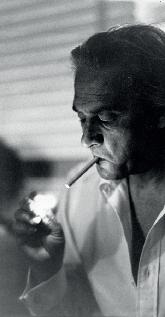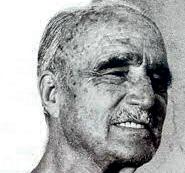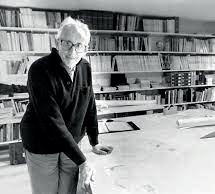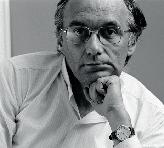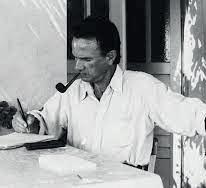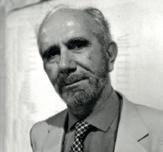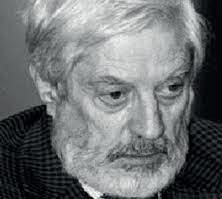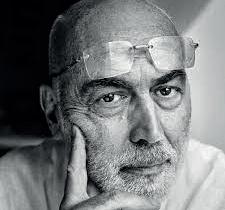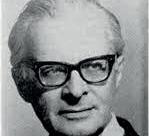paesaggio e ambiente
a cura di
Fabio Di Carlo
Luca Reale
Roberta Manno
Habitat, Territorio, Ecologia
La nascita di una cultura del paesaggio in Italia tra difesa e progetto
VOL. 2
07
paesaggio e ambiente
Direttore della collana
Alessandra Capuano
Comitato Scientifico
Jordi Bellmunt
Gianni Celestini
Philippe Poullaouec-Gonidec
Luca Reale
Giuseppe Scarascia Mugnozza
Fabrizio Toppetti
Redazione
Viola Corbari
Federico Di Cosmo
Daniele Frediani
Progetto grafico
Viola Corbari
La collana adotta un sistema di valutazione dei testi basato sulla doppia revisione paritaria e anonima (double blind peer-review ). I criteri di valutazione adottati riguardano: l’originalità e la significatività del tema proposto; la coerenza teorica e la pertinenza dei riferimenti rispetto agli ambiti tematici propri della collana; l’assetto metodologico e il rigore scientifico degli strumenti utilizzati; la chiarezza dell’esposizione e la compiutezza dell’analisi.
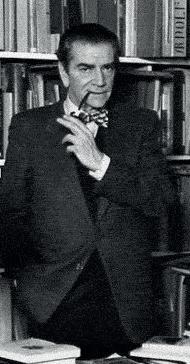




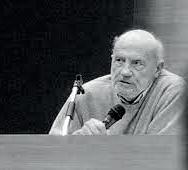
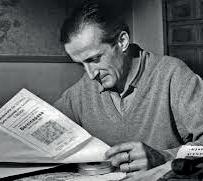
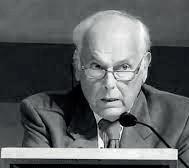
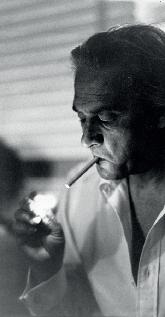


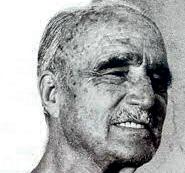
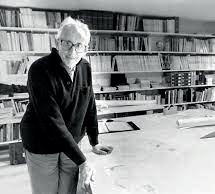
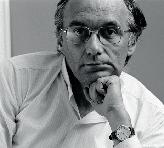
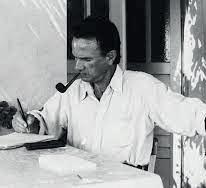
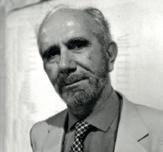
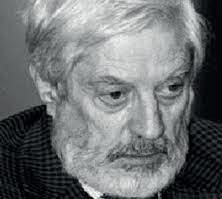
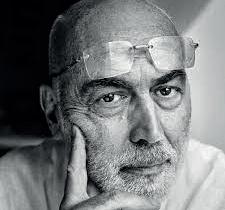

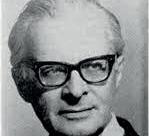




Indice
Introduzione Fabio Di Carlo, Luca Reale
• PAESAGGIO TRA TUTELA E RAPPRESENTAZIONE
Bruno Zevi: io, tu e il paesaggio Antonino Saggio
Antonio Cederna. Paesaggi della devastazione Lucina Caravaggi
Leonardo Benevolo, Italo Insolera: archeologia e arte del paesaggio Francesco Scoppola
Giuseppe Dematteis: il contributo della geografia italiana all‘idea di paesaggio Arturo Lanzani
Luigi Ghirri e Gabriele Basilico: paesaggi indiziari Alessandro Lanzetta
Raccontare osservando. La campagna italiana in Ghirri e Celati Maria Chiara Libreri
10 16 32 48 64 82 94
•• INTERPRETAZIONE DI HABITAT E AMBIENTE
Leonardo Ricci. Che la forma sia come nelle cose naturali
Maria Clara Ghia
Giancarlo De Carlo. Un solidissimo castello di carte
Luca Reale
Luisa Anversa. Architetture nel paesaggio e paesaggi d‘architettura
Alessandra Capuano
Gabetti & Isola. Rappresentare natura e architettura
Fabio Di Carlo
••• ARCHITETTURA E NATURA
Valerio Giacomini. La visione ecologica e fitosociologica
Carlo Blasi
Un parco di coevoluzione mutualistica. Attualità di Valerio Giacomini
Linda Grisoli
Economia ed ecologia: dal pensiero giacominiano alla complessità del territorio
Simona Tarra
Alberto Burri. Dal quadro al paesaggio e ritorno
Elisabetta Cristallini
106 118 136 150 166 176 184 192
Macerie redente: il Monte Stella di Bottoni e il Grande Cretto di Burri
Michele Ciccalè
Alessandro Tagliolini. La continua ricerca di un dialogo tra uomo e natura
Massimo Venturi Ferriolo
Visioni pre-ecologiche nell‘Architettura Radicale
Athanasia Sakellariou
••• INFRASTRUTTURE E STRUTTURE DEL PAESAGGIO
Silvano Zorzi: estetica e struttura del paesaggio
Marco Burrascano
Cesare Macchi Cassia. La forma della realtà
Nicola Russi
Michele Busiri Vici e il verde di Ostia Antica Massimo de Vico Fallani, Carlo Pavolini, Marta Pileri, Elizabeth Jane Shepherd
Cesare Leonardi. Dall‘architettura degli alberi alla città degli alberi
Gianni Celestini
206 214 224 238 250 264 274
Introduzione
Fabio Di Carlo, Luca Reale
Sapienza Università di Roma
• • •
Delineare il quadro delle figure che hanno contribuito a costruire una cultura del paesaggio in Italia rappresenta un obiettivo ambizioso e inevitabilmente tendenzioso. Ogni tentativo di sistematizzare argomenti così vasti, ogni esperimento volto a fare ordine in maniera tassonomica, racchiude il rischio consapevole che la classificazione risulti schematica o forzata, ed è sempre molto evidente, alla fine del lavoro, la sensazione che manchino figure comunque centrali, persino eclatanti, al pari di quelle presentate. Eppure, all’interno di una disciplina relativamente giovane e nell’ambito dell’unico Dottorato di Ricerca in Italia specificatamente dedicato al progetto di paesaggio, i due volumi ci sembrano un tentativo necessario, certamente un contributo utile per chi si avvicina a questo tema così ampio e complesso, che si tratti un dottorando, uno studioso, un ricercatore. I due testi Habitat, Territorio, Ecologia 1 e 2, sono dunque complementari e integrativi, come due passaggi successivi di un percorso, certamente destinato a proseguire, verso la costruzione di un panorama di posizioni culturali, ragionamenti, punti di osservazione, che aprono l’orizzonte della riflessione sul paesaggio all’interno della disciplina e verso altri campi.
Sono quindi la testimonianza dei contributi di alcune tra le principali figure che, con prospettive diverse, pur non facendo sempre un esplicito riferimento all’architettura del paesaggio, hanno partecipato alla nascita di questo concetto e alla costruzione di una cultura specifica sul tema. Si tratta quasi sempre di intellettuali, progettisti o autori legati ad approcci diversi per disciplina e formazione, che però hanno fatto dello sconfinamento e dell’apertura interdisciplinare un tratto distintivo del proprio agire progettuale, critico, artistico, speculativo; contribuendo da un lato a diffondere il senso e la lettura di questi argomenti, dall’altro a divulgarne qualità e specificità, ampliandone certamente il bacino di interesse.
Da un punto di vista dell’evoluzione storica, alcuni di questi personaggi hanno specificamente segnato dei passaggi significativi nella costruzione di un discorso italiano sul progetto di paesaggio, sia sul piano culturale che su quello professionale. In uno scritto sulle pagine di Architettura del paesaggio 39/2019, Biagio Guccione ricostruisce la nascita e le trasformazioni dell’Associazione Italiana degli Architetti del Giardino e del Paesaggio, che in seguito diventerà l’AIAPP, come ramo italiano dell’IFLA, l’International Federation of Landscape Architects, fondata nel 1948 da Goeffrey Jellicoe.
Alcuni degli autori trattati in questi due volumi, quali Valerio Giacomini, Pietro Porcinai e Raffaele de Vico, furono dal 1950 fondatori di questa
11
Fabio Di Carlo, Luca Reale
associazione che aveva la precisa missione di diffondere la cultura del progetto di paesaggio e di cercare di istituire dei corsi di studi universitari in questa materia. Nei decenni a seguire lo stesso Bruno Zevi si adoperò assieme a Mario Ghio, Vittoria Calzolari, Maria Teresa Parpagliolo, Alessandro Tagliolini, per il perseguimento di questi obiettivi. A parte alcune presenze puntuali nei corsi di architettura, peraltro derivate da situazioni pregresse, purtroppo i risultati di questa azione sono stati esigui, tardivi e frammentari. Sarà necessario aspettare l’inizio degli anni Novanta per l‘avvio dei primi corsi postlaurea di architettura, nella forma di scuole di specializzazione, e il 2000 per l’avvio dei primi corsi di studi in Architettura del paesaggio, triennali e biennali. I decenni successivi, tra primi successi, battute d’arresto e riprese recenti, sono ormai l’attualità.
Possiamo aggiungere che una condizione omologa riguarda anche altri paesi del Mediterraneo, nei quali sembra che la Seconda Guerra Mondiale abbia portato a una sorta di interruzione di un discorso sul paesaggio, iniziato nella seconda metà dell’Ottocento. Ovvero che laddove nei paesi continentali il progetto di paesaggio ha rappresentato una parte necessaria e integrante della ricostruzione post-bellica, proprio nei luoghi dove le qualità paesaggistiche intrinseche e la storia del paesaggio erano state più rilevanti, si evidenzia un ritardo significativo, rispetto alla formazione e/o l’esiguità di realizzazioni di rilievo.
Oggi, a oltre vent’anni dalla sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggio, e a valle di numerose esperienze, riflessioni, atti e documenti normativi, attraverso un confronto che non possiamo che definire intenso e ricco, in questo specifico ambito culturale si continuano a registrare fraintendimenti e ambiguità. Tra questi, il concetto stesso di paesaggio, che nel dibattito pubblico in Italia viene spesso banalizzato secondo due convenzionali riduzioni. Da un lato il paesaggio è inteso come un contesto esclusivamente da proteggere e tutelare, e quindi in qualche modo da museificare; dall’altro è del tutto appiattito sull’idea di eco-sostenibilità, finendo per sovrapporsi al concetto di ambiente e alla necessità di individuare parametri e indicatori in grado di garantire un benessere tecnologicamente quantificabile. Tra queste due estreme semplificazioni – la prima che guarda con troppa preoccupazione al progetto e alla trasformazione, la seconda che esprime un’eccessiva fiducia nella soluzione prettamente tecnologica ai problemi della contemporaneità – troviamo la complessa estensione della cultura del paesaggio: un campo di ricerca e di progetto aperto, innovativo e trans-disciplinare, che consapevolmente
12 Introduzione
intende il paesaggio come lo spazio legato alle molteplici esperienze, energie, pratiche e responsabilità (dei fruitori e delle comunità locali) di cui il progetto si prende cura e a cui dà forma.
Il volume raccoglie e sistematizza i contenuti dell’omonimo seminario, curato da Alessandra Capuano, Fabio Di Carlo e Luca Reale, che si è svolto all’interno del Dottorato di Ricerca in Paesaggio e Ambiente tra maggio e giugno 2021. In questo secondo seminario i confini di indagine e lo sguardo sul tema sono stati estesi rispetto alla prima edizione del 2020. I contributi dei docenti, invitati a restituire il ritratto di una figura considerata cruciale nell’aver contribuito a costruire la coscienza e la cultura del paesaggio nel nostro Paese, sono stati tematizzati nel volume in quattro parti, che ripercorrono gli interventi delle giornate in cui era stato organizzato il seminario di Dottorato.
La prima parte, “paesaggio tra tutela e rappresentazione”, a partire dalla relazione tra archeologia e paesaggio (Italo Insolera e Leonardo Benevolo), estende il campo di indagine ad altre forme di espressione e discipline, dal giornalismo militante alla critica (Antonio Cederna, Bruno Zevi), dalla geografia alla fotografia (Giuseppe Dematteis, Luigi Ghirri e Gabriele Basilico), nell’idea che il paesaggio sia una chiave privilegiata nella percezione e nell’interpretazione della realtà contemporanea.
La seconda parte, “interpretazione di habitat e ambiente”, presenta architetti che hanno frequentemente esplorato nei loro progetti un confronto diretto con i contesti naturali e con lo spazio aperto (Leonardo Ricci, Giancarlo De Carlo, Luisa Anversa, Roberto Gabetti e Aimaro Isola). La terza sezione, “architettura e natura”, comprende figure, molto distanti tra loro, che hanno affrontato il tema del paesaggio attraverso la dimensione del giardino, la botanica, la prospettiva dell’arte e le visioni utopiche degli anni ’70 (Alessandro Tagliolini, Valerio Giacomini, Alberto Burri, Architettura Radicale), questioni tenute insieme da un duplice sguardo attento alla dimensione ecologica ed estetica. L’ultima parte, “infrastrutture e strutture del paesaggio”, apre la riflessione a tematiche di scala vasta, e di conseguenza a questioni territoriali, nella relazione tra città e paesaggio (Silvano Zorzi, Cesare Macchi Cassia, Michele Busiri Vici, Cesare Leonardi).
Anche questo volume, come il precedente, oltre ad ospitare i contributi che rielaborano gli interventi svolti da docenti del collegio o da professori ed esperti esterni invitati, accoglie le riflessioni di dottorandi che rileggono alcuni temi rispetto agli autori presentati, oppure mettono in connessione due o più figure tra quelle restituite dai relatori nel seminario.
13
Fabio Di Carlo, Luca Reale
•
PAESAGGIO TRA TUTELA E RAPPRESENTAZIONE
Bruno
Zevi: io, tu e il paesaggio
Antonino Saggio Sapienza Università di Roma
• • •
Almeno una volta Bruno Zevi mi disse: “Bisognerebbe fare un libro su Olmsted”, e spesso nella sezione Selearchitettura della rivista l’Architettura Cronache e Storia erano pubblicate opere di grandi architetti del paesaggio come Peter Walker o Marta Schwartz e molte altre figure. Eppure, nessun libro della sua Universale di architettura1 fu dedicato ad un architetto del paesaggio. Inoltre, se si esaminano i volumi che Zevi curò negli ultimi anni della propria vita come I Linguaggi dell’architettura contemporanea2 non appaiono paesaggisti. In Architettura e modernità3 Roberto Burle Marx è citato soltanto a proposito del suo giardino nella casa di Oscar Niemeyer a Rio (anche se certo a Marx sono dedicate diverse Cronache dell’architettura su l’Espresso a partire da quella “storica” de l9564 e un lungo saggio di Miguel Thomas Kerner ne l’Architettura dell’aprile 1976). L’unico architetto del paesaggio che abbia una scheda a sé stante in un recente volume di Zevi è Lawrence Halprin5 Ne consegue che Bruno Zevi, pur se certamente interessato sin da anni lontani alla “paesaggistica” come lui stesso chiamava questa area dell’architettura, abbia affrontato il tema in ampiezza particolare solo nella relazione di Modena del 1997 che si intitolava appunto Paesaggismo e linguaggio grado zero dell’architettura6. Il saggio che segue si concentrerà di conseguenza sulla posizione di Zevi come fu espressa in quella relazione, con alcuni flash all’indietro per coglierne le novità, ma anche con alcune puntate in avanti, in una sorta di estensione di alcuni punti del suo pensiero.
Uno dei punti chiave del pensiero di Zevi rispetto al tema del paesaggio è quando – riprendendo Carlo Cattaneo – vedeva nella città e nel paesaggio una sorta di cultura diffusa che sottolineava l’unicità e la ricchezza dell’Italia.
Ha ragione Carlo Cattaneo – scrive Zevi – quando afferma, nel famoso saggio del 1858, che la città è l’unico “principio per cui possono i trenta secoli delle storie italiane ridursi a esposizione evidente e continua”. Altrimenti, è il caos: “senza questo filo ideale, la memoria si smarrisce nel labirinto di conquiste, delle fazioni, delle guerre civili e nell’assidua composizione e scomposizione degli stati; la ragione non può veder lume in una rapida alternativa di potenza e debolezza, di virtù e corruttela, di senno e imbecillita, d’eleganza e barbarie, di opulenza e desolazione: e l’animo ricade contristato e oppresso d’una tetra fatalità”. […]. Ma le città non vivono nel vuoto: sono complementate dai paesaggi dalle attrezzature e servizi che vertebrano i territori.7
17
Antonino Saggio
• • • La figura di Zevi
Questa caratteristica civile dalla città si estende quindi al paesaggio che infatti Zevi inserisce nella stessa parte del volume che si chiama Paesaggi e Città: “I paesaggi, gli insediamenti, gli ambienti, i monumenti architettonici, i tessuti formano una istoria evidente e continua”8
Prima di entrare nel merito della relazione credo che alcune idee di larga massima sulla figura di Bruno Zevi siano necessarie in particolare per i dottorandi cui era rivolto il seminario che ha originato questo saggio.
Ho scritto molto su Bruno Zevi, anche quando era in vita. Ho collaborato strettamente con lui negli ultimi cinque anni della sua vita come autore e co-responsabile di una collana, e dopo la sua scomparsa ho continuato la sua attività editoriale nella Universale di Architettura 9
Per dare un’idea molto sintetica della sua figura10 ripercorrerei in modo veloce i principi fondamentali della sua azione. Li riassumerei nei quattro seguenti punti:
1. Il nesso tra azione di “politica culturale” e quella di “politica civile”. Zevi anche in poche righe di autoritratto ricordava sempre di essere stato “membro di Giustizia e Libertà e del Partito d’Azione”. Senza cultura non c’è direzione all’azione politica (e viceversa). Oltre alla partecipazione attiva all’antifascismo almeno da ricordare è stata la battaglia contro la Legge Truffa nel 1953, la militanza nel partito Radicale anche come deputato all’inizio degli anni Novanta, la rifondazione del partito d’azione nel 1998. A questo nesso tra politica e cultura è legata la rivendicazione della libertà dell’individuo. E insieme alla libertà, quasi come necessario contrappeso, forte è stato in Zevi il senso della responsabilità quale fatto personale, come fatto appartenente alla sfera del singolo.
2. L’interesse per la divulgazione culturale di alto livello (come, per esempio, era stato il suo libro Saper vedere L’Architettura11 poi tradotto in molte lingue oppure i suoi libri dell’immediato dopoguerra per la serie dei tascabili de Il Balcone), o la creazione di Teleroma 56 a cominciare dal 1976 al tempo delle radio e delle televisioni libere e poi la direzione della Universale di Architettura con due editori. Prima con Dedalo dal 1977 al 1984 e poi con la Testo&Immagine di Torino dal 1995 al 2000. Anche a questo principio è legato un corollario, senza il quale non si capirebbe la sua presenza nelle vicende del nostro paese.
18
Bruno Zevi: io, tu e il paesaggio
Si tratta dell’opera di sprovincializzazione della cultura e della società italiana e la contemporanea rivendicazione della differenza tra la sua generazione di architetti, ma anche di uomini politici, della generazione precedente alla sua, fortemente invischiata nelle pastoie accademiche e politiche del periodo del fascismo.
3. La ferma convinzione che il linguaggio moderno – come lo aveva descritto nel suo libro Il linguaggio moderno dell’architettura12 –fosse la base da cui discernere la buona dalla cattiva architettura. Anche se spesso si sottolineano nell’opera di Zevi gli aspetti legati alla espressività architettonica, io credo che importante sia stata in Zevi la concezione che chiamerei “eticamente funzionalista”. Una concezione che vedeva l’architettura originata da un bisogno spaziale radicato nella realtà del vivere, nella realtà delle nostre azioni e dei nostri bisogni. E non a caso, delle sette invarianti la prima è quella su cui mai transigerà: l’elenco delle funzioni.
4. L’idea che si potessero identificare i movimenti propulsivi tanto del passato che nel contemporaneo. “Solo attraverso la moderna critica storica si può dimostrare che Michelangelo e Borromini hanno da offrire più di Gropius o Aalto perché, nel loro contesto linguistico furono più coraggiosi e inventivi”13. Per Zevi è stata sempre sviluppata una sovrapposizione tra critica e storia, un approccio che ha trasmesso a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di stargli vicino. E non solo a coloro che gli sono stati vicino fisicamente, ma anche a quanti hanno letto le sue opere e lo continuano a studiare oggi. Per Zevi critica e storia non sono mai divisibili. La critica, cioè l’azione quotidiana, è sempre storica perché è sempre lanciata in un progetto di futuro e la storia non può non essere critica. Da questo deriva la sua capacità di comunicare l’architettura sin dentro le fibre stesse della materia. È una comunicazione del pensiero attraverso il coraggio delle idee, la serietà dell’informazione, la forza cristallina della parola, lo slancio dinamico del corpo e del gesto e una curiosità verso i mezzi della nuova società dell’informazione (dalle riviste ai giornali, dalla radio alla televisione, dalle dispense settimanali ai tascabili). Vale la pena ricordare, sempre ad uso dei nostri dottori di ricerca, che questi principi sono stati la chiave di altissimi esiti in tutti i campi del suo lavoro14 .
19
Antonino Saggio
Giancarlo
De Carlo. Un solidissimo castello di carte
Luca Reale
• • •
Sapienza Università di Roma
Suddividere o tematizzare l’opera di De Carlo è difficile e rischioso, così come provare a separare in periodi o fasi la produzione della sua lunga carriera. Cercherò piuttosto, in questo breve scritto, di trasmetterne il ruolo peculiare e innovatore, a partire dal pensiero e dall’incessante azione intellettuale, attraverso alcuni progetti che più specificatamente dialogano con la morfologia del territorio e con il paesaggio.
Antiaccademico e isolato, polemico e anticonformista, Giancarlo De Carlo rappresenta un’eccezione importante nel panorama culturale del nostro Paese: classe 1919, è uno dei personaggi più rilevanti nel dibattito architettonico in Italia della seconda metà del Novecento.
È una figura libera e non convenzionale rispetto ai suoi coetanei e si mantiene laterale, se non estraneo, al pensiero mainstream. Tuttavia resta sempre pienamente dentro l’attualità del dibattito, direttamente coinvolto nei momenti più cruciali di cambiamento del nostro paese dal fascismo in poi. De Carlo si sente in realtà molto a suo agio nel contesto internazionale, ed è tra i pochi architetti italiani che già negli anni Sessanta è invitato ad insegnare all’estero1. “Spazio e società” –scrive nell’editoriale di esordio della rivista che dirige dal 1978 al 2001 – “cerca di scegliere e di trattare argomenti in modo da interessare tutta la scena architettonica, non soltanto quella italiana”, con uno sguardo al Terzo Mondo, dove “tutto è portato al limite” e quindi è più evidente: “i risultati della contraffazione tecnologica, dell’inganno tipologico, dell’impoverimento formale, dell’architettura usata come strumento di repressione, dell’architettura usata come strumento di incomunicabilità, di freno-barriera alla comunicazione, ecc.” 2
Prima di tutto Giancarlo De Carlo è internazionalista, politicamente vicino all’anarchismo, grazie anche alla frequentazione e all’amicizia con Carlo Doglio. Non si dichiara mai militante del movimento anarchico3, ma contribuisce a diffonderne le teorie in Italia, partecipando anche ai congressi internazionali, fin dal primo di Carrara nel 1945. E manifesta sempre una tensione verso quest’idea4 , esprimendo grande rispetto per l’anarchismo libertario e scientifico. Sul piano teorico si riferisce dunque non tanto a Bakunin quanto a Kropotkin5: un pensiero dalla natura irriducibilmente non dogmatica, in cui si esprime opposizione – direi proprio insofferenza esistenziale – ad ogni forma di autoritarismo e rigidezza del potere. De Carlo è antifascista e come molti protagonisti della sua generazione aderisce alla Resistenza milanese. Nel secondo dopoguerra comincia ad esprimere una sempre maggior irrequietezza verso il dogmatismo del CIAM. Partecipa a Matera, a metà degli anni Cinquanta, ad uno dei più
119
Luca Reale
Luisa Anversa.
Architetture nel paesaggio e paesaggi d’architettura
• • •
Alessandra Capuano
Sapienza Università di Roma
Il contributo alla cultura architettonica italiana di Maria Luisa Anversa Ferretti, progettista molto attiva nella seconda metà del Novecento e da poco scomparsa1, non è stato ancora approfondito e discusso criticamente come meriterebbe.
Anversa nasce nel 1926 a Milano, frequenta il Liceo Classico e si iscrive al Politecnico nel 1944, dove studia con Piero Portaluppi, acquisendo fin dagli esordi il senso del disegno e della geometria che, come dichiarò in una intervista“diventavano poesia e, soprattutto, trasmissione dell’idea di uno spazio dilatato entro cui potevano succedere cose semplici e complesse"2
Trasferitasi a Roma, frequenta presso la Facoltà di Architettura di Valle Giulia gli insegnamenti di Mario De Renzi e di Vincenzo Fasolo (con cui si laurea nel 1950) dai quali assimila l’attenzione alle qualità dello spazio.
Suoi compagni di corso furono, tra gli altri, Carlo Aymonino, Sergio Lenci, Carlo Chiarini, Francesco Berarducci, Paola Coppola Pignatelli, un gruppo di persone molto impegnate, che hanno intrapreso, come lei, oltre alla professione, anche l’insegnamento universitario.
Ancora prima di laurearsi costituì uno studio con tre colleghi – Balletti, Lanza e Menichetti – da cui presto si dissociò perché non in linea con la loro impostazione funzionalista del progetto urbanistico, rigidamente rispondente a norme e ordini prefissati quali l’uso dell’asse eliotermico, manifestando quindi, già in giovane età, la sua predilezione per un ragionamento maggiormente condizionato dal rapporto con il contesto. Frequentò anche durante l’università il corso sulla città tenuto da Ludovico Quaroni, e subito dopo la laurea, iniziò a collaborare con lui sia professionalmente, partecipando a concorsi nello studio di Corso Trieste, che nell’insegnamento, divenendo nel 1964 assistente ordinario, o “aiuto” come si usava dire allora.
I primi successi professionali arrivano con una segnalazione al Concorso Nazionale per il Piano Regolatore di Frosinone nel 1951 (in collaborazione con gli architetti Borgiotti e Cavalli) e con il progetto per l’INA-Casa a Novara del 1952. Inoltre, insieme ad Aymonino, Lenci, Morelli e Moroni, ottiene il primo premio ex-aequo nel Concorso Nazionale per i quartieri dei dipendenti della Stefer del Fondo Incremento Edilizio a Roma e a Ostia. Era questo un gruppo di professionisti fortemente impegnato sul piano culturale, tutti appartenenti all’ambiente della cosiddetta “scuola romana”, nata sotto l’influenza del cinema neorealista e della pittura di Mario Mafai, Toti Scialoja e Renato Guttuso che, nell’immediato dopoguerra e in contrasto alla retorica mussoliniana, operarono nell’urbanistica e nell’architettura
137
Alessandra Capuano
Gabetti & Isola. Rappresentare natura e architettura
• • •
Fabio Di Carlo Sapienza Università di Roma
Nel contesto di un seminario sulla formazione della cultura del progetto di paesaggio in Italia, parlare del lavoro di Roberto Gabetti e Aimaro Oreglia d’Isola, in particolare dei primi decenni della loro attività, può sembrare al contempo quasi spontaneo e naturale, quanto contraddittorio. È quasi spontaneo perché la vicinanza ad alcuni temi di paesaggio è ricorrente ed evidente nel loro lavoro, quasi come una costante, sia per la materia fisica di cui si compongono i loro interventi, che per alcune scelte morfologiche, di progetti di architettura che si configurano come paesaggi. Ma è altrettanto contraddittorio, come lo è stata la valutazione della critica del loro lavoro, sia per alcune evidenti scelte interne ai progetti, sia per alcuni esiti formali, che possono apparire molto distanti da una sensibilità paesaggistica corrente. Di fatto, molta della loro produzione si è posta all’attenzione del dibattito di paesaggio spesso proprio per queste connotazioni specifiche, con un impatto culturale ben collocato nel tempo ma molto rilevante, spesso per i paesaggisti quanto, o più, che per gli architetti.
Oggi lo studio Isolarchitetti, continua con un lavoro oggi esplicitamente orientato al progetto di paesaggio propriamente detto, ma con un impatto sulle discipline del paesaggio assai inferiore al lavoro svolto fino al 20001. I progetti recenti, pur elaborando impianti ambiziosi anche di dimensione territoriale, sembrano avere un orientamento meno innovativo, che segue linee di ricerca internazionali già fortemente consolidate.
Lo studio venne alla ribalta con un discorso centrato sul progetto di architettura, ma con una chiara volontà di esprimere dei capovolgimenti rispetto ad alcune prassi allora correnti, che possiamo riassumere in un ribaltamento che riguardava i linguaggi espressivi, associato a un’idea di contestualizzazione culturale e ambientale degli interventi.
La Bottega di Erasmo (1953-1957) fu il primo lavoro che mostrava questo esplicito distacco da ogni rigida aderenza ai dogmi del Modernismo, proponendo un approccio figurativo che reinterpretava il liberty piemontese. Ciò li fece da subito entrare in un dibattito sul recupero del vernacolare, di cui hanno lungamente parlato in molti, in particolare Francesco Cellini, che non a caso ha avvicinato il loro lavoro a quello di Mario Ridolfi.
151
Fabio Di Carlo
Alberto Burri.
Dal quadro al paesaggio e ritorno
• • •
Elisabetta Cristallini
Sapienza Università di Roma
1945: un giovane ufficiale medico, umbro di Città di Castello, rinchiuso nel campo di prigionia di Hereford in Texas decide di lasciare la medicina per dipingere. Si chiama Alberto Burri. Lì gli è accanto Giuseppe Berto di Mogliano Veneto, anche lui nel dopoguerra si trasferirà a Roma e diventerà famoso ma come scrittore, dopo aver esordito nel 1947 con il libro Il cielo è rosso. Un titolo che rimanda ai quadri di Burri di quel periodo, come ricorda il poeta Libero de Libero nel presentare l’artista alla prima mostra romana del 1947 nella piccola libreria-galleria La Margherita: paesaggi apparentemente naturali, volutamente ingenui, dove tuttavia già si afferma il colore come materia nonché l’uso come supporto del sacco1. L’attività di Burri pittore prosegue a cavallo degli anni Cinquanta nel solco della materia con i Catrami (allo stato puro, che compongono una griglia di colature nere con “ritagli” di colore), le Muffe (dove pesanti trame di colore suggeriscono l’idea di efflorescenze batteriche), i Gobbi (quadri estroflessi con semplici strumenti, ramoscelli storti e incrociati); in tutti la superficie pittorica è deformata, protende verso la tridimensionalità con una specie di lievitazione organica inarrestabile. Inizia anche, e soprattutto, la stagione dei sacchi (i primi sono del 1950, gli ultimi del 1961), di juta, già vissuta, ferita, slabbrata. L’intervento di Burri è di ricucire, rattoppare, “correggere” la materia consunta e bucata, “configurandola” con l’aiuto di fili e corde, dando vita e origine a uno spazio. Burri, apportando una struttura formale calibrata a quella “povera” materia, la riporta “a valore”, senza che tuttavia perda le proprie qualità. All’inizio i sacchi di juta (al tempo comunemente impiegati per il trasporto di qualsiasi materiale) sono quelli degli aiuti americani alla povera Italia appena uscita dalla guerra, come indica SZ1 (1949), dove utilizza il sacco di zucchero con stampata la bandiera a stelle e strisce, ritagliato e incollato sulla tela. Da lì il seguente uso del sacco come supporto, interpretato da Cesare Brandi in riferimento ai sai dei francescani della natia terra dell’artista2. Con queste prime opere Burri indica l’identità di immagine-procedimento-materia e si dispone oltre la bipolarità astratto/figurativo pre e post-bellica, aprendo precocemente all’informale. Sono gli anni dell’eterogeneo gruppo Origine (e poi della Fondazione Origine) avviato a Roma assieme allo scultore e gallerista Ettore Colla, al pittore Giuseppe Capogrossi, e inizialmente, all’artista milanese Mario Ballocco, con la volontà di operare un profondo rinnovamento di ordine etico-spirituale e formale per una primaria, genuina, sintetica necessità di espressione3. Affianca il gruppo la bella rivista Arti Visive, che esce nel 1952 con il fine di prendere coscienza della cultura contemporanea (arte, architettura,
193
Elisabetta Cristallini
Gli italiani vedono nel paesaggio una delle poche ragioni per sentirsi una nazione, malgrado il paese si sia modernizzato in assenza di un’attenta pianificazione che ne regolasse la crescita. Nei primi anni di formazione della Repubblica non sono mancate però importanti iniziative che considerassero il contesto paesaggistico come orizzonte significativo del progetto, impegnando intellettuali italiani di diversa formazione nello studio e nella difesa dei luoghi. La cultura architettonica moderna si è dedicata ai temi dei centri storici, delle preesistenze ambientali, della città-regione, della grande dimensione, del town design anche per interagire con il territorio, l’habitat e l’ambiente e, nonostante siano rimasti confinati in un ambito più marginale del dibattito, si sono affermate alcune figure di paesaggisti, progettisti e studiosi che hanno guardato con intelligenza e curiosità anche oltre il recinto della propria disciplina e che possono essere considerate pioniere di una scuola italiana del paesaggio.
Due libri della collana di ET raccolgono un iniziale ragionamento sulla nascita di una cultura del paesaggio in Italia.
In questo secondo volume saggi su: Anversa, Archizoom, Basilico, Benevolo, Bottoni, Burri, Busiri Vici, Cederna, Celati, De Carlo, Dematteis, Gabetti & Isola, Ghirri, Giacomini, Gruppo 999, Insolera, Leonardi, Macchi Cassia, Ricci, Superstudio, Tagliolini, Zevi, Zorzi.
€ 18 9 788862 428491