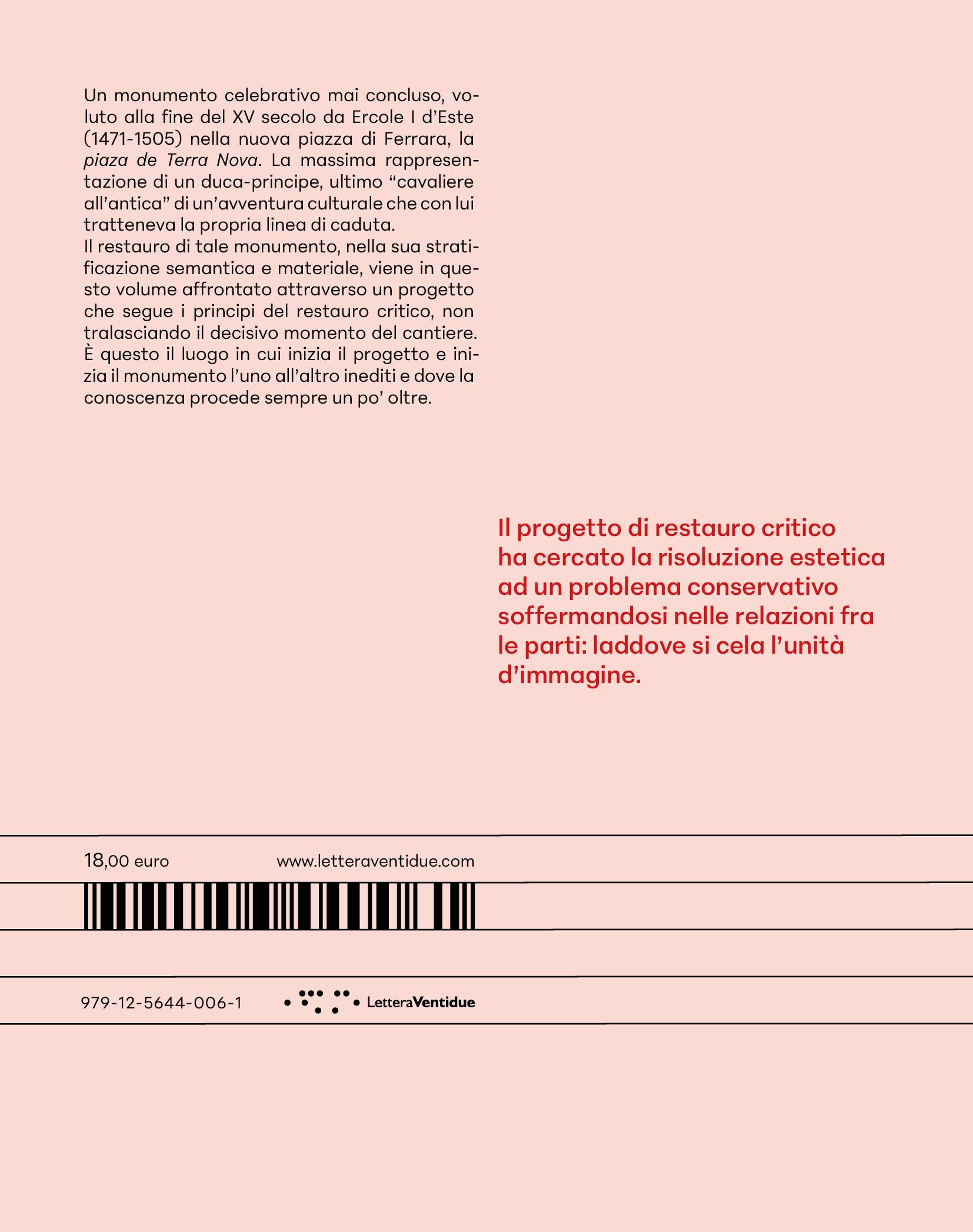Ilprimo violino si alza e da il “La” agli altri strumenti: è un atto preparatorio, iniziale e necessario affinché il direttore d’orchestra possa interpretare a fondo l’opera.
In chordis è una collana dedicata al restauro quale atto di cultura in cui tutti i protagonisti coinvolti si accordano ad una stessa tonalità ponendo al centro il monumento inteso come Bene comune. Vengono accolte esperienze di restauro dove il progetto, nascendo da una consapevolezza metodologica il cui punto di inizio è la conoscenza storica criticamente vagliata, evidenzia l’intreccio ideativo tra teoria e prassi sviluppato in virtù di quell’intesa, all’unisono, tra committenza, professionisti, Università, organi di tutela e impresa esecutrice. Una raccolta di restauri che siano narrazioni progettuali di percorsi intellettuali che hanno definito le singole scelte operative attraverso azioni interpretative del monumento.
Si raccontano casi concreti non tecnicistici, espressioni di un metodo capace sempre di porre domande, interventi su un Bene Culturale che portano alla consapevolezza che tale oggetto risiede nel nostro tempo e ne è immagine. I restauri presentati sono esercizi progettuali e i volumi della colonna sono documenti di lavoro, dove si afferma il legame indissolubile tra la riflessione teorica e l’atto pratico.
In chordis richiama quindi la necessità all’accordo per il Bene comune, l’accordarsi al “La” di tutti i protagonisti coinvolti, ognuno con il proprio strumento, ad un’altezza sonora, una frequenza acustica precisa. Tale altezza sonora è l’interpretazione semantica dell’opera, vista nella sua complessa stratificazione e nella sua attualizzazione.
In chordis richiama anche l’espressione “con il cuore” nella convinzione che il restauro è un atto interpretativo dove è necessario capire il monumento nei suoi dati storici e specialistici e poi sentire il monumento.
In una visione fenomenologica l’opera architettonica coincide con la sua materia e in essa “trova lo stimolo sensoriale indispensabile alla riproduzione dell’esperienza estetica”1. Per tale motivo l’atto interpretativo progettuale richiesto è critico e creativo, ricadendo tanto nel giudizio critico quanto nella riflessione estetica. In tal senso l’interpretazione del Bene Culturale, oggetto di restauro, è considerato atto sempre soggettivo e provvisorio, capace così di garantire la trasmissione al futuro del significato di quel Bene nella piena leggibilità figurativa e materica del testo.
1. Giovanni Carbonara, Trattato di restauro architettonico, UTET, Torino, 1996, vol. 1, pp. 17-33.
Qui riman l’elmo, e lá riman lo scudo, lontan gli arnesi, e piú lontan l’usbergo1
Ilcavaliere Orlando, narrato da Ludovico Ariosto, si spoglia dell’armatura e delle armi a causa del folle dolore provato per il mancato amore di Angelica. Un gesto insensato, che nella tradizione della Chanson de Roland significa la perdita della dignità e l’irrimediabile caduta dell’onore di un cavaliere. Un gesto che restituisce Orlando alla sua umanità.
Ariosto intraprende la scrittura del suo poema a partire dal 1504 quando a Ferrara l’avventura edificatoria della nuova Addizione, voluta da Ercole I d’Este (1471-1505), era iniziata da un decennio compresi i lavori per la «piaza de Terra Nova»2, oggi Piazza Ariostea. Il poeta conosceva il volere del duca: al centro della piazza doveva essere collocato un monumento, su doppia colonna, con in cima una statua equestre dello stesso Ercole I. Il disegno conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana3 rappresenta il duca-cavaliere con la sua armatura ormai rinascimentale: la nostalgia di “un cavaliere antiquo” all’interno di uno spazio disegnato anch’esso, come si vedrà in seguito, all’antica. Ercole I decide di essere rappresentato attraverso la mitologia cavalleresca riveduta a seguito della grande rivoluzione culturale dell’Umanesimo: un cavaliere, dai grandi valori arturiani, profondamente uomo verso una crisi che culminerà nel pieno Rinascimento.
Una figura che sembra apparentemente riprendere la statua equestre del padre Niccolò III (1393-1441) che si inserisce in quel sistema etico cavalleresco, codificato dalla Chanson de Roland, che ruota attorno ai due poli del valore e della saggezza:
termini l’uno complementare all’altro, il risultato dell’armonica compresenza dei quali è la mesure, il ben sorvegliato equilibrio. Il prode che non sia saggio è un folle; il saggio che non sa essere prode cade per conto della viltà4
Il cavaliere Niccolò non può diventare folle come Orlando, ma deve rappresentare, attraverso i valori sopra descritti, l’identificazione del servizio all’Altissimo, la disponibilità al martirio, l’ammirazione per i guerrieri nemici degni di lode e la ricerca della patria
1. Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, Volume II, Edizione Einaudi, Torino, 2015, canto XXIII – CXXXIII, p. 696.
2. Così definita nei documenti di archivio; si veda in particolare Adriano Franceschini, Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale. Testimonianze archivistiche, Dal 1493 al 1516, Parte II, Tomo II, Cassa di Risparmio di Ferrara-Corbo, Ferrara, 1997, pp. 94-95, 102, 134, 154-155, 235-239, 262, 325-326, 350-351, 440-446, 456-457, 548-549.
3. Anonimo disegnatore, Monumento equestre di Ercole I d’Este, in Historia di Ferrara sino al Anno 1603, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ottob. lat. 2774, c. 125 r, 1603.
4. Franco Cardini, Il guerriero e il cavaliere, in J. Le Goff, a cura di, L’uomo medievale, Edizione Laternza, Roma-Bari, 2019, p. 91. Si veda anche Maurice Keen, Chivalry, Yale University Press, New Haven-London, 1984; Erich Köhler, L’avventura cavalleresca, Il Mulino, Bologna, 1985; Giovanni Tabacco, Su nobiltà e cavalleria nel Medioevo. Un ritorno a Marc Bloch?, in A.A.V.V., Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan, Vol. I, Olschki, Firenze, 1980, pp. 31-55.
5. Luchino da Campo, Viaggio del marchese Niccolò III d’Este in Terrasanta (1413), a cura di C. Brandoli, Edizione Olschki, Firenze, 2011.
6. Werner L. Gundersheimer, Ferrara estense. Lo stile di un potere, Edizione Panini, Modena, 2005, p. 44.
7. Ivi, p. 62.
divina attraverso il pellegrinaggio a Gerusalemme. Niccolò è figlio della rivoluzione culturale del XII secolo che aveva permesso la circolazione in Europa dei testi greci, arabi ed ebraici. L’attrazione per le terre lontane trova così le sue radici nella letteratura cavalleresca medievale che mutua i suoi contenuti non restando indifferente alle tante testimonianze dei viaggiatori e dei missionari. Niccolò III, decise di andare in pellegrinaggio a Gerusalemme nel 1413. Il diario di viaggio, redatto dal cancelliere Luchino dal Campo assunto con questo specifico compito, è intriso di uno spirito cavalleresco che culmina nella cerimonia che si svolge all’interno della cappella del Santo Sepolcro5. Questo documento dimostra come Niccolò non sia il cavaliere dei secoli precedenti, la cui finalità era quella di combattere in nome di una crociata, in quanto al centro del testo non c’è Gerusalemme, ma il percorso compiuto verso la meta Santa attraverso le soste presso le corti straniere con il solo scopo di diffondere la fama estense. I giorni spesi a Gerusalemme sono molto pochi rispetto a quelli di permanenza degli altri pellegrini, dimostrando come Niccolò fosse più interessato a stringere rapporti politici che alle pratiche religiose. D’altronde il signore d’Este stava cercando di costruire uno stato solido caratterizzato da una relativa sicurezza e stabilità. Per tale motivo «giunse ad essere considerato negli stessi termini di Cosimo de’ Medici a Firenze pochi decenni più tardi, un pater patriae»6, un epiteto riservato nel Rinascimento a figure che avevano saputo esercitare un potere senza risultare autocrati.
Niccolò traghetta così Ferrara dal mondo medievale-feudale a quello rinascimentale-signorile.
Se Niccolò, nella rappresentazione di sé e del suo potere, rimane legato ad una codificazione cavalleresca seppure mutata nei contenuti, il figlio Leonello d’Este (1441-1450) sceglierà la modernità volgendo lo sguardo al patrimonio degli antichi.
Niccolò d’Este, come Giovanfrancesco Gonzaga, Sigismondo Malatesta o Federico da Montefeltro, avevano ricoperto tutti il ruolo del condottiero durante le lunghe guerre che avevano caratterizzato i loro anni. Tale periodo aveva dato però a loro poche prospettive per uno sviluppo politico, che, nel caso di Ferrara, i successori Leonello, Borso ed Ercole seppero invece costruire.
Se Niccolò era stato «pater patriae», il figlio Leonello è «pater civilitatis»7.
Allievo di Guarino da Verona, Leonello diviene un colto e raffinato umanista e come tale dalle opere classiche aveva ereditato l’ammirazione per l’attività militare condotta nell’interesse della comunità8. Per la propria rappresentazione di sé sceglierà di farsi ritrarre da Pisanello il cui riferimento sono le antiche medaglie imperiali romane: dalla posa di profilo all’acconciatura dei capelli.
Leonello sceglie come arma la cultura per affermare il prestigio degli Este e di Ferrara nella geopolitica italiana e straniera, aiutato in questo dalla pace di Lodi del 1454 che fece calare un periodo di relativa calma. Ci furono guerre per problemi minori fino alla fine del XV secolo, ma prevalse la tendenza a risolverli più sul piano diplomatico che su quello dello scontro militare. La carta politica italiana era stata fissata e l’attenzione dei governi si concentrava sull’organizzazione di quanto già era stato costituito9. Gli stati italiani da quel momento ebbero eserciti permanenti, con risorse considerevoli che contribuirono a mantenerli in efficienza e a migliorare la loro capacità bellica. Fu un periodo di sperimentazione e di sviluppo dell’artiglieria, di innovazioni nella costruzione di fortezze e di cinte murarie. L’ideale umanistico dell’uomo d’armi e di lettere era motivo integrante della cultura italiana:
architetti, orafi, pittori lavoravano con fervore alla costruzione di fortezze, alla creazione di armi da fuoco e al disegno di bandiere da torneo. Il torneo era uno dei grandi intrattenimenti tipici come pure palestra d’addestramento per i soldati10.
Morto Leonello, Ferrara venne governata dal fratello Borso d’Este (1452-1471) che riuscì ad innalzare la città a ducato. Sarà Borso a far realizzare il monumento equestre11 del padre, interrotto con la morte di Leonello, che si innalzava su una trabeazione posta al di sopra di un arco, retto da due colonne scanalate ad opera del fiorentino Niccolò Baroncelli12. Leonello per scegliere il nome dell’artista aveva indetto una gara invitando Leon Battista Alberti, quale esperto in materia13. L’obiettivo era realizzare un monumento celebrativo aderente alla cultura umanistica dell’antico, capace di inserirsi nel solco delle fonti scritte classiche che ricordavano le statue realizzate in onore degli eroi romani (Plinio, Plutarco, Livio). Così facendo l’architettura entrava a pieno titolo all’interno di un programma rappresentativo di riorganizzazione del vivere basato sui testi classici.
8. Michael Mallett, Il Condottiero, in E. Garin, a cura di, L’uomo del Rinascimento, Edizione Laterza, Roma-Bari, 2018, p. 45.
9. Ivi, p. 52.
10. Ivi, p. 69.
11. Il monumento equestre di Niccolò III oggi presente in piazza della Cattedrale a Ferrara è una copia novecentesca dell’originale, fusa per creare pezzi d’artiglieria nel 1796.
12. Marco Folin, Ferrara estense. Architettura e città nella prima età moderna, Editore Oligo, Mantova, 2022, pp. 5565. Si veda anche M. Teresa Sambin De Norcen, “Attolli super ceteros mortales”: l’arco del Cavallo a Ferrara, in A. Calzona, J. Connors, F.P. Fiore, C. Vasoli, a cura di, Leon Battista Alberti. Architetture e committenti, Edizione Olschki, Firenze, 2009, pp. 349-391. Su Niccolò Baroncelli si veda A. Maria Matteucci, Baroncelli Nicolò di Giovanni, detto Nicolò del cavallo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. VI, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1964.
13. Leon Battista Alberti scriverà il “De equo animante” (1443), un trattato di ippologia basato su autori antichi e medievali.

Prospetto ovest
3,86 0,91 1,72 8,34 0,78 4,01 1,76 21,38

Ortofoto superiore planimetria del monumento.
Rilievo architettonico e fotogrammetrico



Parte superiore della statua realizzata da Ambrogio Zuffi nel 1881.
Parte inferiore della statua realizzata dai fratelli Francesco e Mansueto Vidoni nel 1833.

Operazioni di pulitura tramite applicazione di biocida e rimozione manuale dei depositi più coerenti.

Operazioni di pulitura, rimozione delle malte cementizie, consolidamento con l’inserimento di barre, integrazione con malte espressamente formulate in cantiere e velatura finale.




Dall’alto: operazione di rimozione delle malte cementizie e conseguente presa visione della situazione di dissesto generale del capitello; sollevamento dei diversi blocchi lapidei di cui si compone ogni rocchio del capitello e loro ricovero nell’area di cantiere, dove è stato effettuato il rilievo dettagliato dei singoli elementi.






Stato dei luoghi del capitello a seguito degli interventi di restauro.
Dall’alto: rimozione degli elementi ferrosi di collegamento interno fortemente ossidati e sollevati; alloggiamento di nuove arpesi in acciaio inossidabile duplex dalle stesse dimensioni e negli stessi incavi di quelle originarie; operazioni di stuccatura e velatura.


Dettagli della decorazione a tralcio di quercia del fusto, a seguito delle operazioni di pulitura, stuccatura con malte espressamente formulate in cantiere e velatura.
Interventi di restauro. Fusto della colonna

Stato dei luoghi dei gradoni del monumento prima degli interventi di restauro.
In basso: dettagli del rivestimento lapideo a seguito della rimozione di malte cementizie incongrue. Tale operazione ha messo in evidenza come tali elementi non fossero complanari alla superficie, ma risultassero fuori piombo anche di alcuni centimetri.
Da un punto di vista statico risultava evidente come non fosse più garantito il meccanismo ad arco per il trattenimento delle lastre verticali.













Stato dei luoghi dei gradoni del monumento a seguito degli interventi di restauro.
In basso: interventi di pulitura mediante biocida e rimozione manuale delle malte cementizie incongrue; Inserimento di barre filettate in acciaio con inghisaggio in resina al supporto murario, al fine di impedire lo scorrimento e il ribaltamento verso l’esterno del rivestimento lapideo. I fori praticati sono stati risarciti con stuccatura e successivo inserimento dell’incalmo lapideo prelevato dal carotaggio per consentire unità visiva materica; stuccature e successive velature nei giunti tra le lastre.


Documentazione archivistica