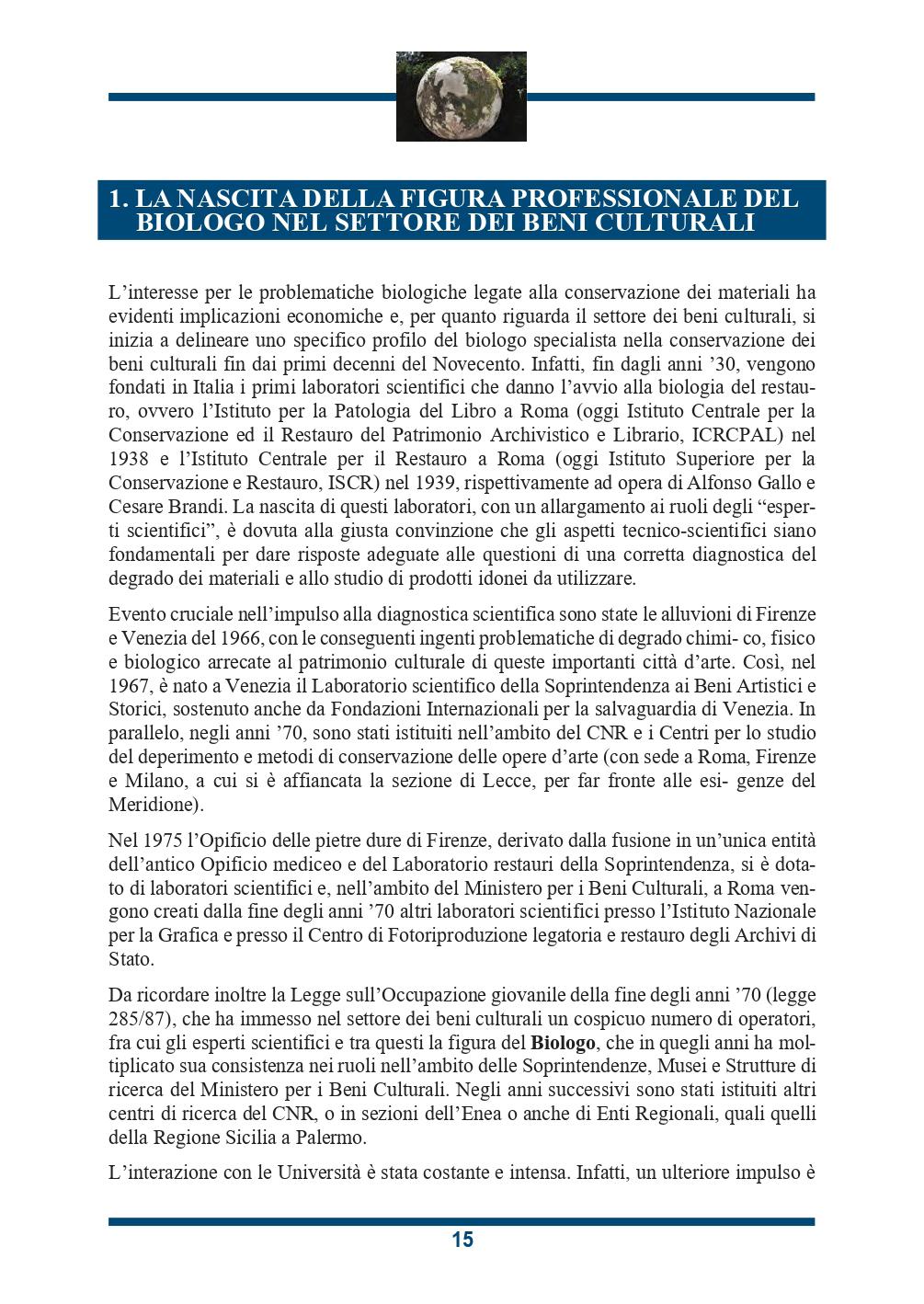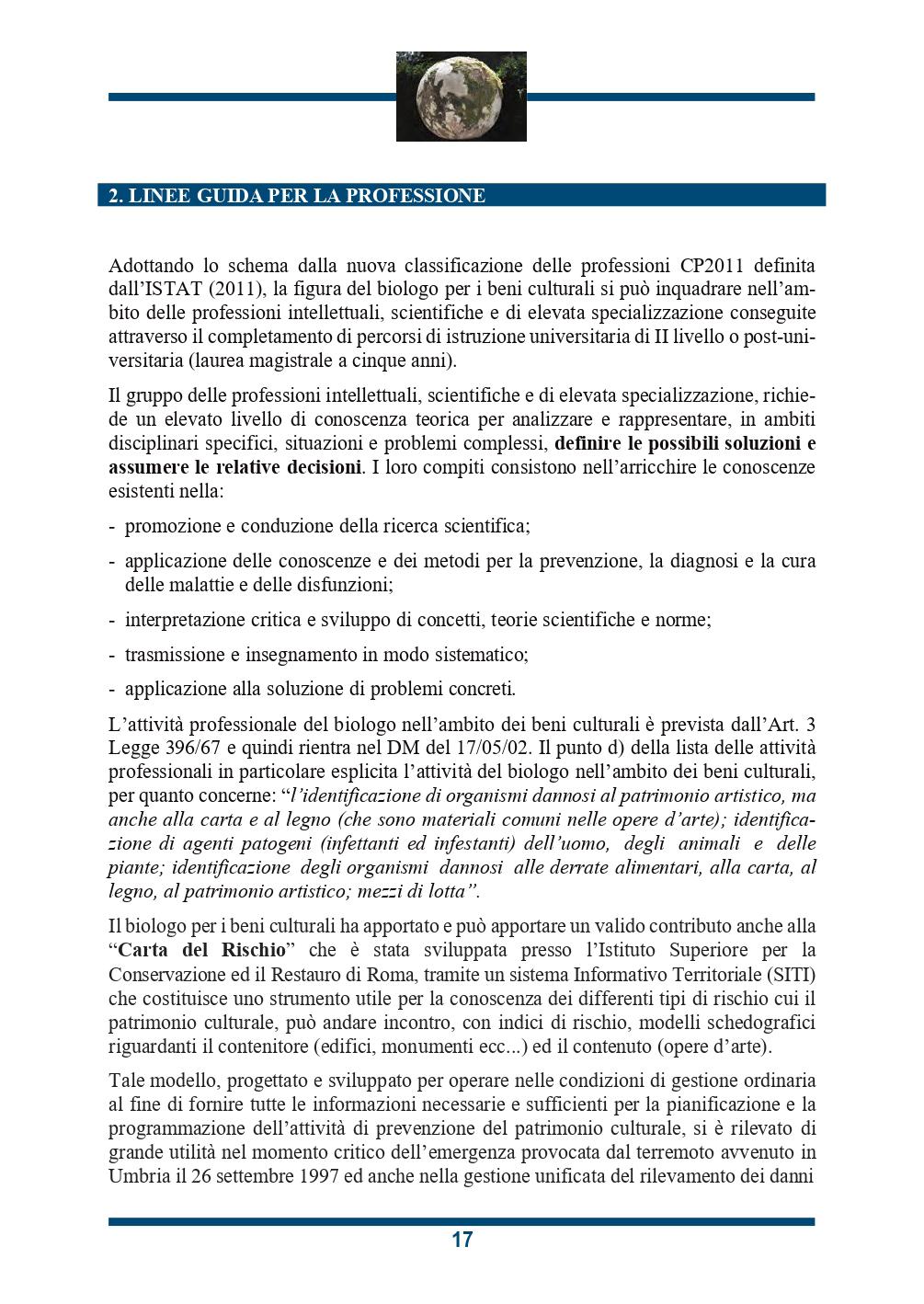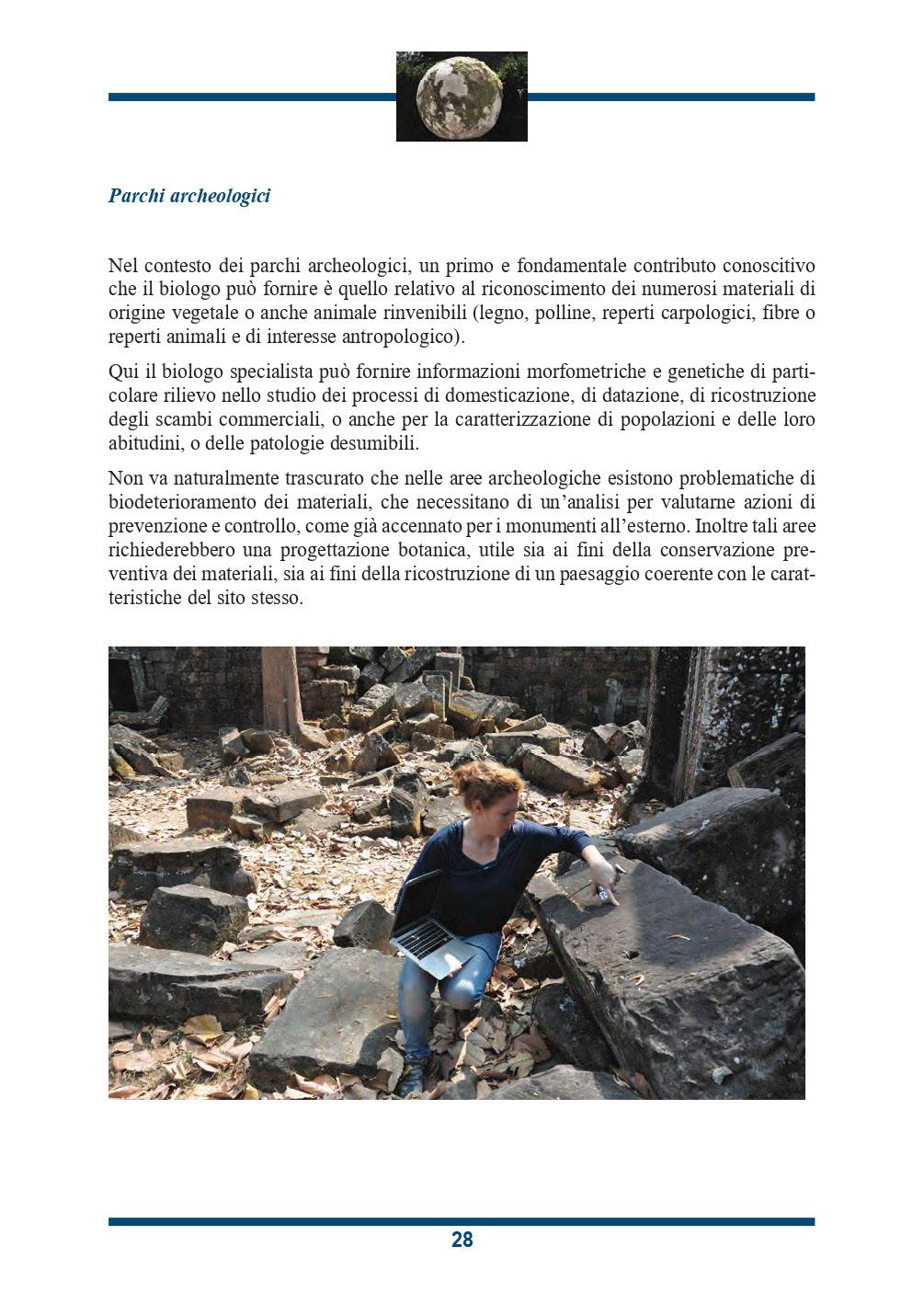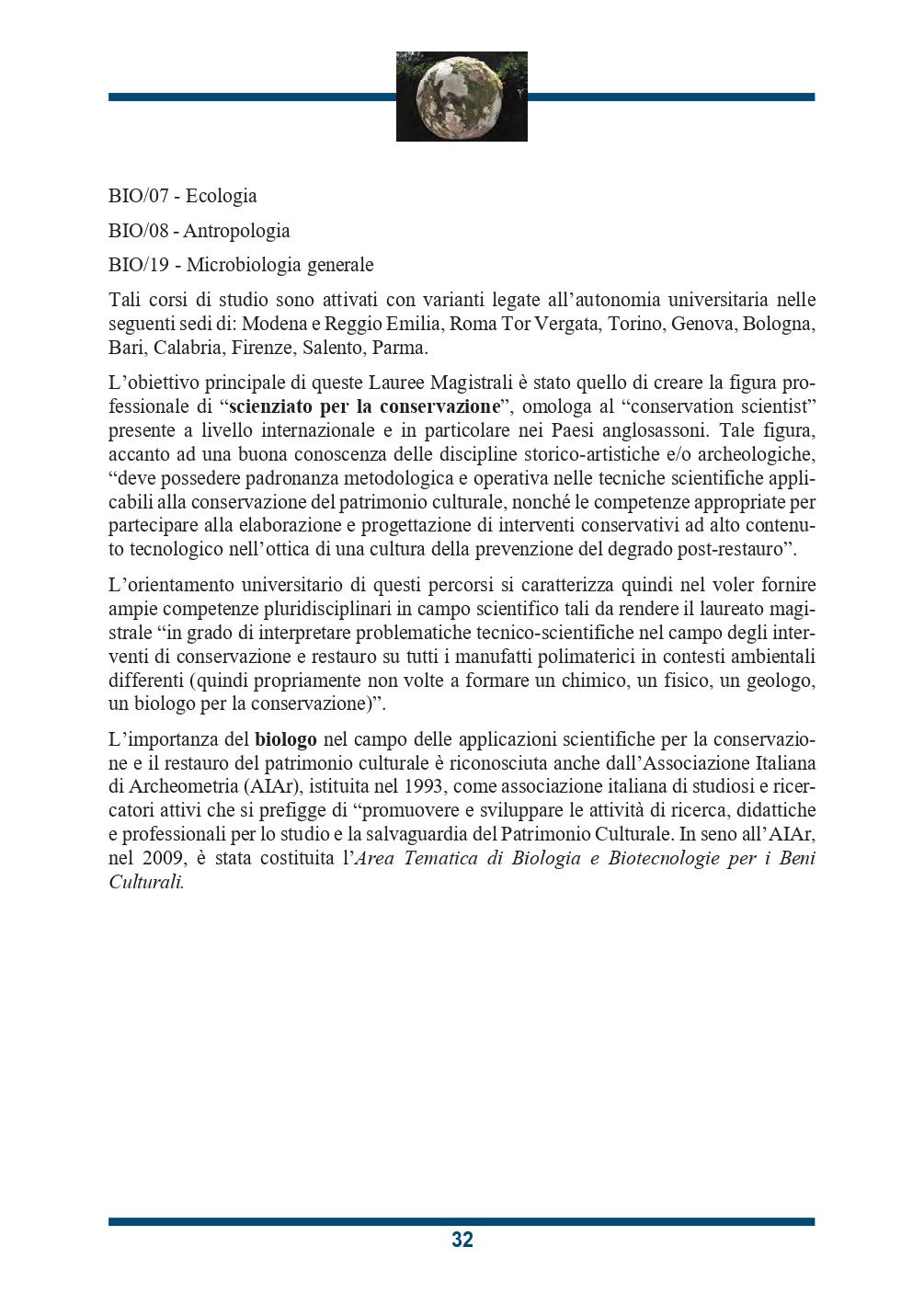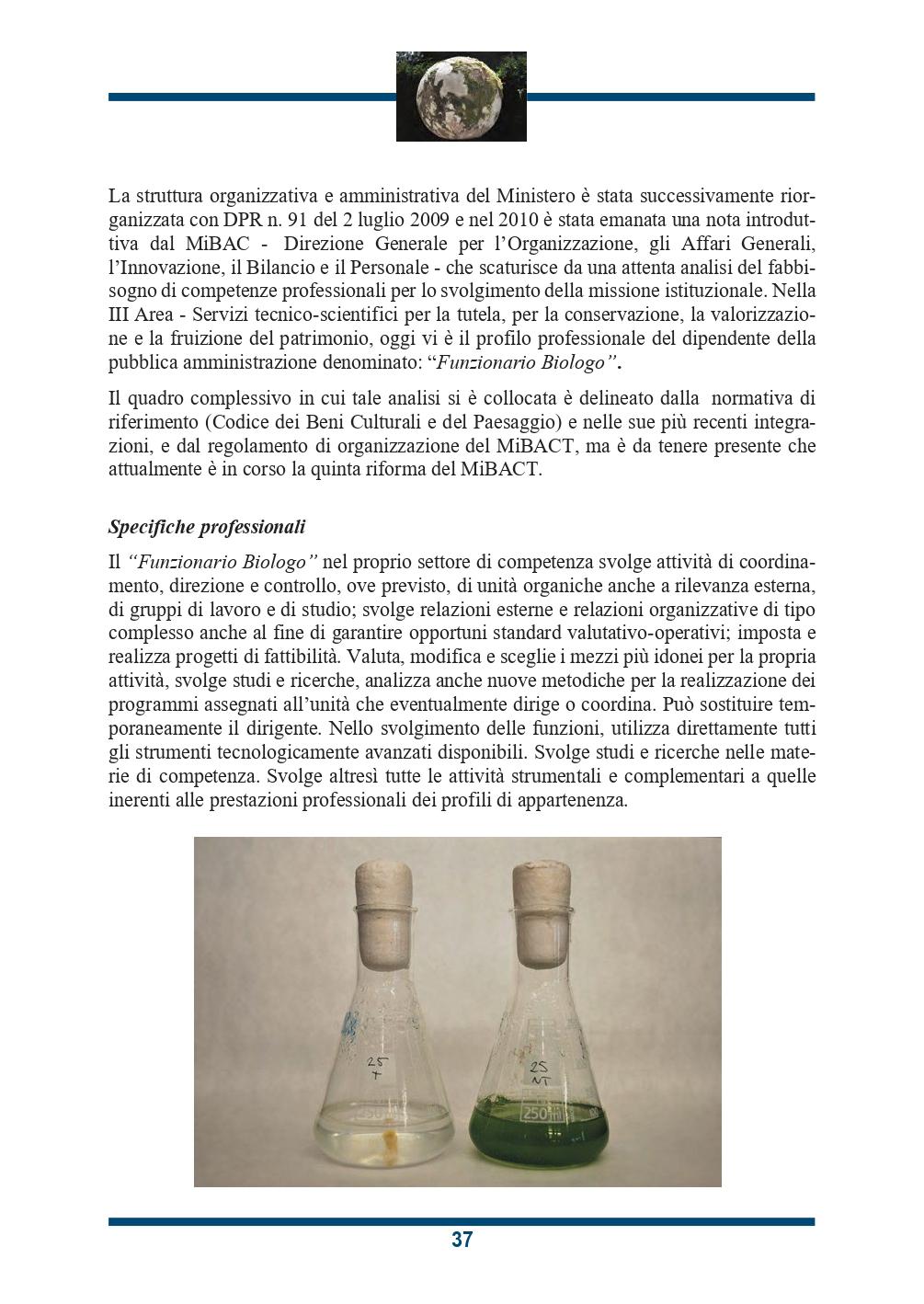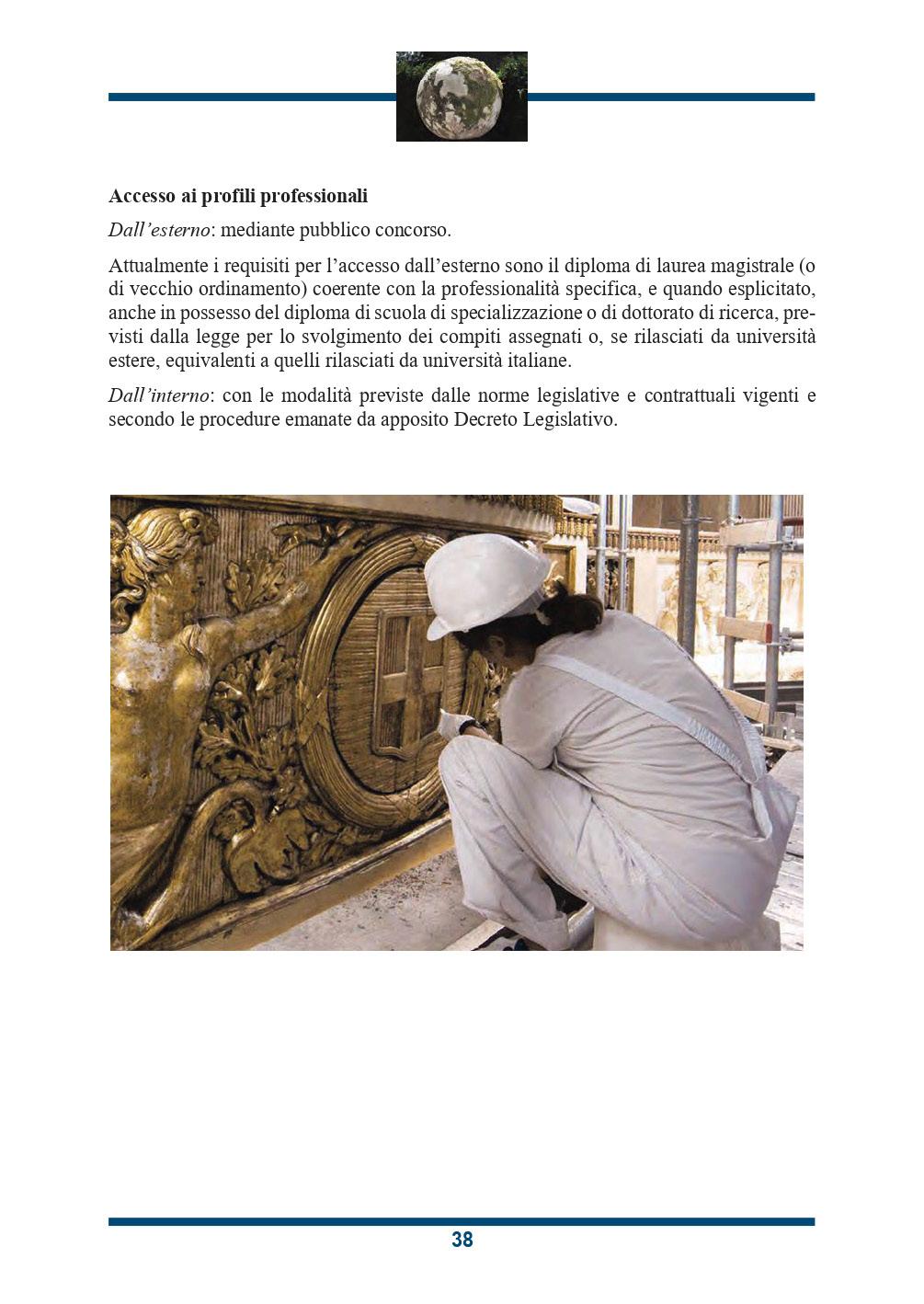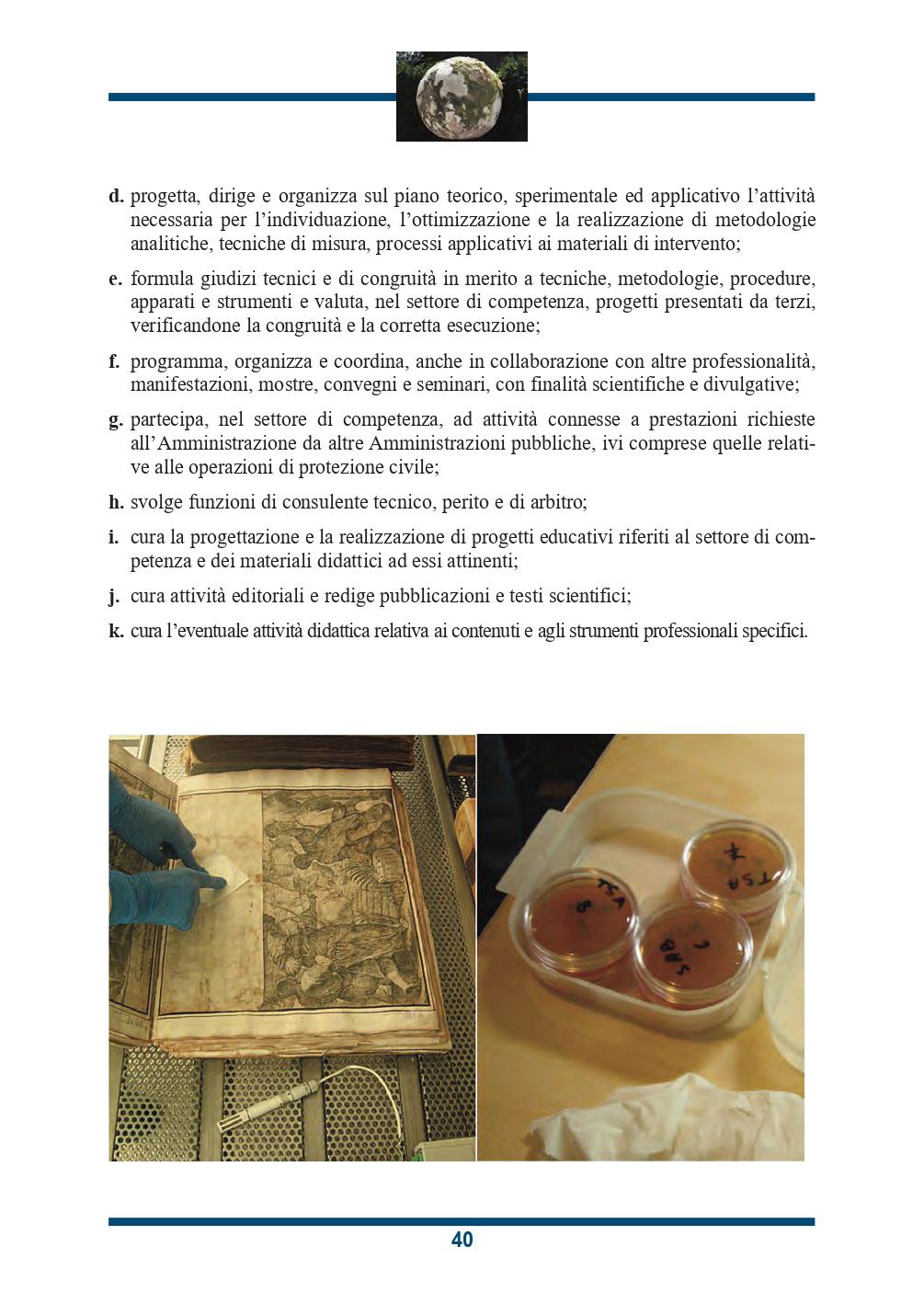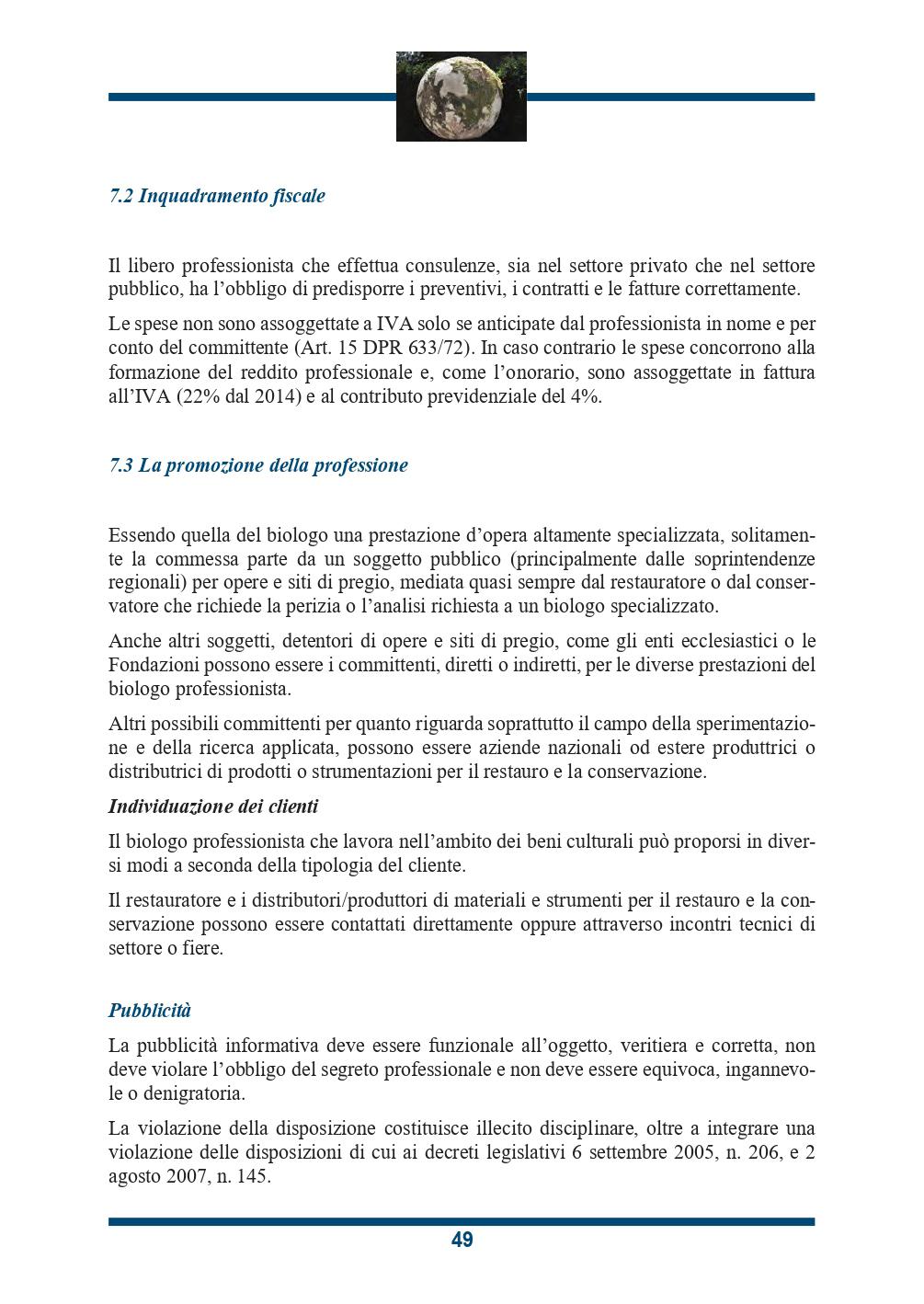Fnob e biologi. I risultati dell’indagine tra gli iscritti


Fnob e biologi. I risultati dell’indagine tra gli iscritti

Guida alla corretta e sana alimentazione Gli esperti: attenzione ai farmaci su TikTok


ED ISTITUZIONI UNIVERSITARIE ROMA 22 febbraio 2025 Ore 10:30-17:30
Best Western Premier Hotel Royal Santina VIa Marsala 22
I conti
Indagine sulla percezione della Fnob da parte degli iscritti di Antonio Noto
Dopo Natale, la remise en forme: ecco come riacquisire le buone abitudini di Rino Dazzo
Grani antichi e altri alimenti detox di Rino Dazzo
I farmaci per dimagrire che spopolano sul web di Rino Dazzo
INTERVISTE
Fago M13: da virus a nanobioparticella per colpire le cellule tumorali di Ester Trevisan
Apprendimento automatico per l’individuazione dell’Alzheimer di Chiara di Martino 36
SALUTE
Diagnosi precoce dei tumori con le impronte chimiche di Carmen Paradiso
Funmap: una mappa rivoluzionaria per la lotta contro il cancro di Carmen Paradiso
Tumore alla vescica: scoperto il meccanisco che regola l’aggressività di Elisabetta Gramolini
SLA, la regolazione di una proteina apre a possibili trattamenti della malattia di Elisabetta Gramolin
Individuato un biomarcatore della SLA: GDF15, la proteina che riduce l’appetito di Sara Bovio
Il ruolo inaspettato dei macrofagi nel controllo del movimento muscolare di Sara Bovio
Praticare attività fisica fa crescere i motoneuroni quattro volte più velocemente di Sara Bovio
Una nuova scoperta sul colesterolo LDL cambia la medicina moderna di Carmen Paradiso
La figura dell’embriologo clinico in Italia di Valerio Pisaturo
Dieta mediterranea: uno stile di vita salutare che non seguiamo più di Matteo Pillitteri e Dario Incorvaia
Alcol, fumo e dipendenza da smartphone: il decalogo per un 2025 in salute di Domenico Esposito
Scoperto meccanismo cerebrale che regola empatia e risposte emotive di Carmen Paradiso
Salute mentale, obesità, tumori: le sfide cruciali della medicina nel 2025 di Domenico Esposito
Le sei piante che fanno bene alla salute di Domenico Esposito
Allarme burnout per medici e infermieri di Domenico Esposito
I progressi nell’applicazione del collagene ricombinante nei cosmetici di Carla Cimmino
L’integrazione orale con peptidi di collagene può prevenire la caduta dei capelli di Biancamaria Mancini
AMBIENTE
Supercomputer e IA al servizio della ricerca sui pinguini di Adelia di Gianpaolo Palazzo
Binari a due velocità: al sud treni vecchi, linee chiuse, al nord ritardi cronici di Gianpaolo Palazzo
Pollini sotto controllo: il nuovo modello per una vita più serena di Gianpaolo Palazzo
Contraddizioni ecologiche nella tutela della biodiversità di Teresa Pandolfi e Giovanni Misasi
L’impatto del cemente sull’ambiente di Michelangelo Ottaviano
Vite marine: la mappa del Mediterraneo di Michelangelo Ottaviano
INNOVAZIONE
Ecco come funzionano le nostre cellule di Pasquale Santilio
Farmaci biotecnologici dalle piante di Pasquale Santilio
L’auto-apprendimento per l’Alzheimer di Pasquale Santilio
Quel calore che non riscalda l’ambiente di Pasquale Santil
Campionesse di tutto: le ragazze di Conegliano nell’Olimpo del volley di Antonino Palumbo
Mondiali di volley e atletica, eurobasket e tennis: il 2025 dello sport di Antonino Palumbo
Popov, dopo una tragedia personale il trionfo di Antonino Palumbo
Grand Tour: la Vuelta in Italia, il Giro in Albania di Antonino Palumbo

Lo studio metabolico per il rischio nefrolitiasico: nuove proposte di laboratorio di Giovanni Cangiano, et al.
Carninoma mammario: il tumore che causa il maggior numero di morti di Daniela Bencardino
I beni culturali e i biologi di Maria Carla Sclocchi
Il duomo di Monreale torna a brillare sotto una nuova luce di Rino Dazzo
Il supporto nutrizionale nella sarcopenia di Matteo Pillitteri e Dario Incorvaia
La gestione delle sostanze chimiche: regolamenti Reach e Clp di Iuliano Maria Grazia
Si informano gli iscritti che gli uffici della Federazione forniranno informazioni telefoniche di carattere generale dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tutte le comunicazioni dovranno pervenire tramite posta (presso Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, via Icilio 7, 00153 Roma) o all’indirizzo protocollo@cert.fnob.it, indicando nell’oggetto l’ufficio a cui la comunicazione è destinata.
È possibile recarsi presso le sedi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi previo appuntamento e soltanto qualora non sia possibile ricevere assistenza telematica. L’appuntamento va concordato con l’ufficio interessato tramite mail o telefono.
UFFICIO CONTATTO
Centralino 06 57090 200
Ufficio protocollo protocollo@cert.fnob.it

Anno VIII - N. 1 Gennaio 2025
Edizione mensile di Bio’s
Testata registrata al n. 113/2021 del Tribunale di Roma
Diffusione: www.fnob.it
Direttore responsabile: Vincenzo D’Anna

Questo magazine digitale è scaricabile on-line dal sito internet www.fnob.it
Questo numero del “Giornale dei Biologi” è stato chiuso in redazione lunedì 27 gennaio 2025.
Contatti: protocollo@cert.fnob.it
Gli articoli e le note firmate esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi.
Immagine di copertina: © YARUNIV Studio/shutterstock.com

di Vincenzo D’Anna Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Sono alla guida dei Biologi italiani da sei anni e mezzo. Cinque come presidente del disciolto Ordine nazionale e poco più di un anno come presidente della neonata Federazione
Nazionale degli Ordini dei Biologi regionali e sovra regionali (Fnob): undici in tutto gli enti dislocati territorialmente, in rappresentanza di circa sessantamila iscritti.
Per quanti sforzi siano stati fatti finora, siamo ancora abbastanza lontani dall’aver costruito uno spirito di categoria
Per quanti sforzi siano stati fatti finora, tutti documentati e documentabili, siamo ancora abbastanza lontani dall’aver
costruito uno spirito di categoria, un diffuso sentimento di “appartenenza”. Ed è proprio su quello che ancora manca e non su quel non poco che è stato fatto - sotto ogni profilo - che ho voluto impostare questo editoriale. Se ci volessimo infatti cullare su quanto fin qui portato a termine, anche solo a mo’ di comparazione con le epoche pregresse, potremmo mostrare la coda del pavone illudendoci di aver esaurito la spinta propulsiva e propositiva di cui s’era avvertito il bisogno per il definitivo salto di qualità del -
la nostra categoria.
Tuttavia, adusi a guardare avanti e non indietro, preferiamo evitare di menar vanto di questo o di quel traguardo di tappa, se non per misurare cosa resta ancora da fare per arrivare a fine corsa. Qualunque sia la considerazione sullo “stato dell’arte” preme dire, con franchezza, che molte mete non sono state ancora raggiunte perché amministriamo gli interessi, le opportunità, i diritti e le tutele di una rappresentanza che, per ancora ampia parte, non ha alcuna voglia di progredire, se non quella di migliorare le proprie sorti individuali ed integrare i rispettivi redditi professionali. Insomma, per parlarci chiaro, non siamo evidentemente
arrivati a coinvolgere, interessare, rendere consapevoli e partecipi tutti gli iscritti. Almeno non quella vasta massa di colleghi che ancora vive una realtà particolare, egoistica e disinteressata rispetto ai progressi generali della categoria alla quale pure essi appartengono.
Non siamo ancora arrivati a coinvolgere, interessare, rendere consapevoli e partecipi tutti gli iscritti
Un insieme di solipsisti che tutto ignora e che spesso è incline a criticare, a lamentarsi ed a commiserarsi di tutto! A questo “insieme”, che potremmo chiamare atarassico, nulla giunge del nuovo e del buono che pure si raggiunge se non riguarda loro personalmente, se non tange il piccolo interesse o minaccia l’orticello domestico. È da quella massa che partono le critiche qualunquistiche o le grida d’allar -
me quando qualcuno o qualcosa ne minaccia il quieto vivere e il personale esercizio della professione. A questi “apatici” si sommano i cosiddetti “benaltristi” coloro per i quali niente riveste carattere di progresso e di miglioramento, ma c’è sempre bisogno d’altro. Discorso vecchio e già fatto il nostro? Sissignore! Ma quantunque sia ripetitivo, pochi sono quelli che lo hanno focalizzato.
Un sondaggio rivela l’apprezzamento dei biologi verso l’attività formativa, informativa, eventi e le altre opportunità offerte dalla Fnob
Da dove si evince tutto questo? Non certo da un’opinione vaga e generica, ma da un sondaggio (il quarto) che abbiano fatto svolgere su un campione di iscritti rappresentativo, quello che gli statistici chiamano “orizzonte di riferimento”.
Potrete trovare e consultare
tale statistica, commentata da
Antonio Noto, famoso sondaggista della Rai Tv, sui nostri consueti canali d’informazione e su questo numero del giornale: scoprirete che mette a nudo, con l’eloquenza dei numeri, le cose che ho appena affermato. Ebbene: al sondaggio ha risposto qualche migliaio di colleghi, ma altrettanti si sono rifiutati di farlo per paura di esporsi o per una forma di innata reticenza! Certo rispetto a quello di quattro anni fa, i dati sono migliorati ad ogni livello ed una migliore disponibilità la si è comunque notata in quelli che hanno accettato di rispondere. Così come migliori sono risultate le opinioni sull’opera svolta della Federazione.
La maggioranza degli intervistati ha dichiarato di apprezza -
re molto, oppure abbastanza, l’attività formativa, informativa, eventi e le altre opportunità offerte, a tutela dei Biologi iscritti, in ogni regione, anche per il tramite degli Ordini locali. Questi ultimi scontano pure il lento abbrivio sui territori e la mancanza di esperienza “politica” nella gestione di un organismo elettivo e pubblico. Non mancano certo disparità tra gli stessi ordini territoriali, essendo la percezione degli iscritti dipendente dal diverso grado di attività presente ai livelli territoriali. Quello che non va affatto è ancora la scarsa conoscenza e l’informazione adeguata sulle vicende degli Ordini insieme con la partecipazione personale ad eventi ed appuntamenti deci -
sionali. In democrazia gli eletti somigliano agli elettori che li scelgono, ed è quanto accade per tutte le istituzioni elettive e democratiche. Ma che il disimpegno possa riguardare il quaranta percento del totale degli iscritti non è tollerabile!
Migliaia di colleghi, però, non hanno ancora la PEC o non conseguono il numero stabilito di crediti ECM, sebbene gratuiti
Che migliaia di colleghi non siano ancora muniti di PEC oppure non conseguano il numero stabilito di crediti ECM, seppure offerti gratuitamente (ed in maniera qualitativa!), non è un segno accettabile. Così come non è più tollerabile non applicare le sanzioni di legge (sospensione dall’Albo e multa salata) che ci vengono sollecitate dal Ministero vigilante. In sintesi: i conti non tornano, ma dovranno tornare. Piaccia o meno.
L’Istituto demoscopico Noto Sondaggi ha intervistato i biologi per capire cosa pensano delle attività promosse dalla Fnob lo scorso anno. Feedback positivo sulle proposte formative di qualità
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi ha commissionato all’istituto demoscopico Noto Sondaggi s.r.l., che opera nelle aree della ricerca economica e sociale, dei sondaggi di opinione e della comunicazione, la realizzazione di un questionario da diffondere tra i biologi per comprendere quale sia la percezione che questi hanno del lavoro e delle attività promosse dall’ente di rappresentanza della categoria.
Il sondaggio ha avuto lo scopo di capire quali siano i punti sui quali la Fnob necessita un rafforzamento operativo e quali siano le richieste dei biologi per l’anno appena iniziato, al fine di poter offrire servizi sempre più precisi e corrispondenti alle necessità dei professionisti.
Di seguito riportiamo la sintesi di quanto emerso dall’indagine, firmata dal responsabile dell’Istituto, il dottor Antonio Noto.
dotti dal Ministero della Salute. Dall’indagine condotta tra gli associati, oltre l’80% è a conoscenza dell’aggiornamento dell’elenco delle professioni sanitarie. In particolare, i biologi liberi professionisti risultano i più informati (91%) rispetto a chi opera nel settore pubblico o nel privato.
Il riconoscimento e la “riqualificazione” del biologo come figura sanitaria rappresenta una svolta importante per la categoria apprezzata dalla maggioranza degli intervistati. Tra i benefici più apprezzati emergono il rafforzamento del ruolo professionale e una maggiore considerazione sociale, ora formalizzata dal nuovo status ma anche una maggior tutela in generale.
* Istituto demoscopico
Noto Sondaggi
di Antonio Noto*
Il nuovo inquadramento della figura del biologo
I biologi italiani mostrano un buon livello di informazione riguardo agli sviluppi normativi e professionali recentemente intro -
L’evoluzione dell’Ordine Nazionale dei Biologi Dal dicembre 2022, l’Ordine Nazionale dei Biologi è stato trasformato nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, con l’obiettivo di fornire indirizzo e coordinamento agli ordini territoriali. Questa trasformazione è nota all’89% degli associati, confermando un livello di informazione e attenzione capillare.
Per quanto riguarda la rappresentanza, il 66% degli iscritti conosce il nome del proprio rappresentante regionale, mentre il

© Tapati Rinchumrus/shutterstock.com
Presidente della FNOB, Vincenzo D’Anna, è ricordato spontaneamente dal 63% degli intervistati, una percentuale che sale al 91% una volta che viene stimolato il nome in associazione alla carica.
Servizi e formazione: un’offerta apprezzata, ma da ampliare
La percezione dei servizi offerti dalla Federazione è complessivamente positiva. L’indagine rivela che, a seguito della costituzione della FNOB e del passaggio di competenze dal vecchio Ordine agli Ordini territoriali, la percezione degli associati è di un miglioramento dei servizi forniti. In particolare, ad ottenere un riscontro positivo sono soprattutto l’iscrizione all’albo (48%) e gli eventi scientifici promossi dagli ordini (46%).
Proprio gli eventi scientifici e i convegni sono tra gli ambiti in cui più si percepisce un miglioramento rispetto al passato (22% e 25%). Un contributo significativo proviene dal programma di autoformazione “Formare Informando”, conosciuto dal 55% degli iscritti e giudicato utile dall’86% di quanti lo conoscono.
E una quota significativa, il 41%, dichiara inoltre di aver partecipato a uno o più eventi organizzati.
La percezione dei servizi offerti dalla Federazione è complessivamente positiva. L’indagine rivela che, a seguito della costituzione della FNOB e del passaggio di competenze dal vecchio Ordine agli Ordini territoriali, la percezione degli associati è di un miglioramento dei servizi forniti. In particolare, ad ottenere un riscontro positivo sono soprattutto l’iscrizione all’albo (48%) e gli eventi scientifici promossi dagli ordini (46%).
La Fondazione Italiana Biologi: conosciuta ma poco valutata
Meno della metà degli intervistati (42%) dichiara di conoscere la Fondazione Italiana Biologi, e il 71% non si esprime sul suo impegno di promozione dell’attività dei biologi attraverso l’organizzazione di eventi, corsi e progetti di ricerca. Tuttavia, l’iniziativa della FIB di istituire scuole di formazione professionalizzanti è giudicata utile dal 76% degli intervistati. Questo dato suggerisce che gli iscritti desiderano un maggior coinvolgimento della Federazione nelle attività formative, considerate un pilastro fondamentale per il futuro della professione.
Parole chiave per il futuro: comunicazione, partecipazione e formazione
In sintesi, i biologi italiani si dimostrano informati e generalmente soddisfatti dell’operato della Federazione e del proprio Ordine. Tuttavia, emerge un’esigenza di maggiore comunicazione e partecipazione, soprattutto in ambito formativo.
Ampliare e migliorare l’offerta, coinvolgendo un numero crescente di iscritti, potrebbe rappresentare il prossimo passo per consolidare il ruolo del biologo e affrontare con efficacia le sfide e i cambiamenti in atto.



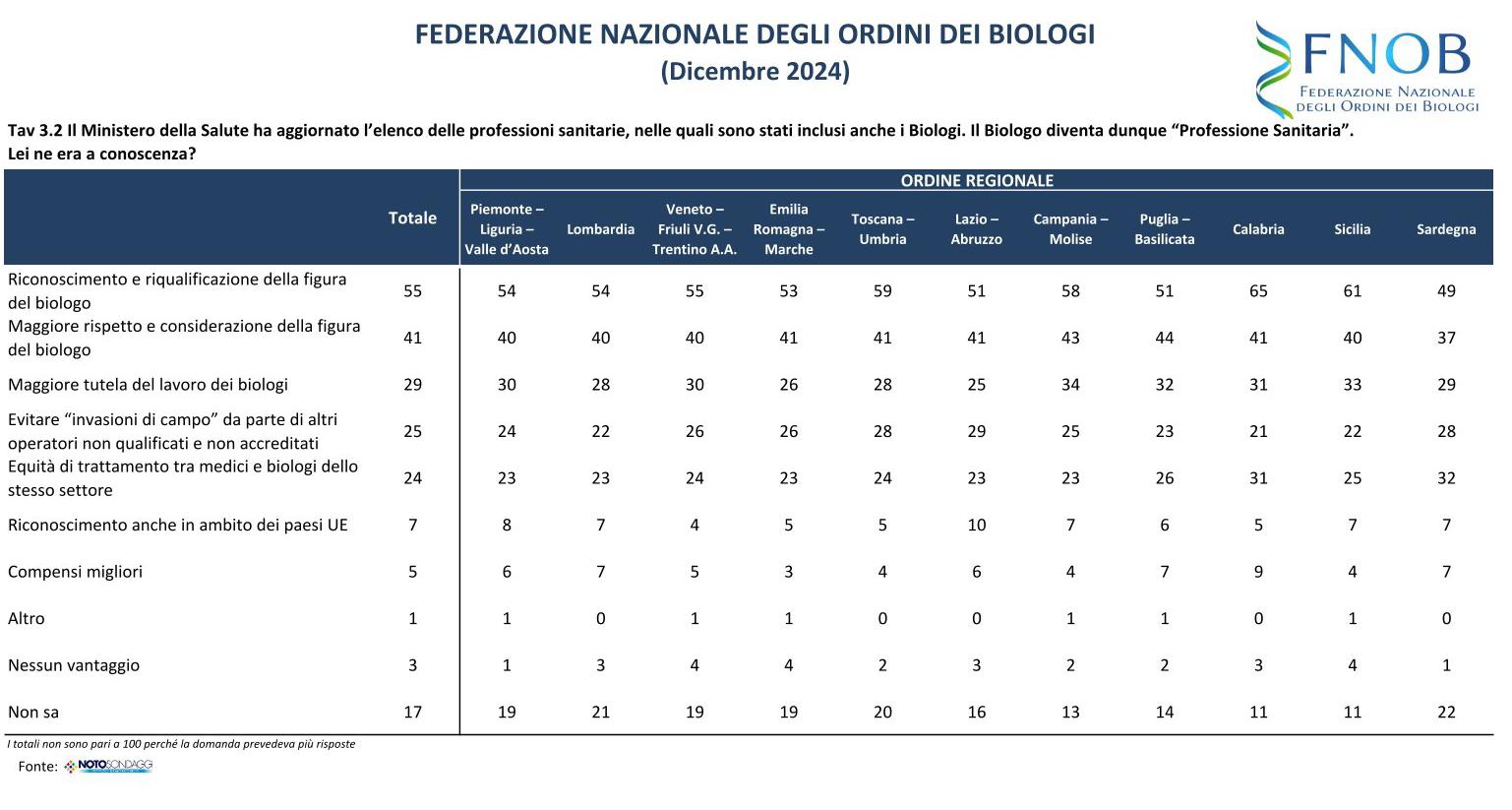

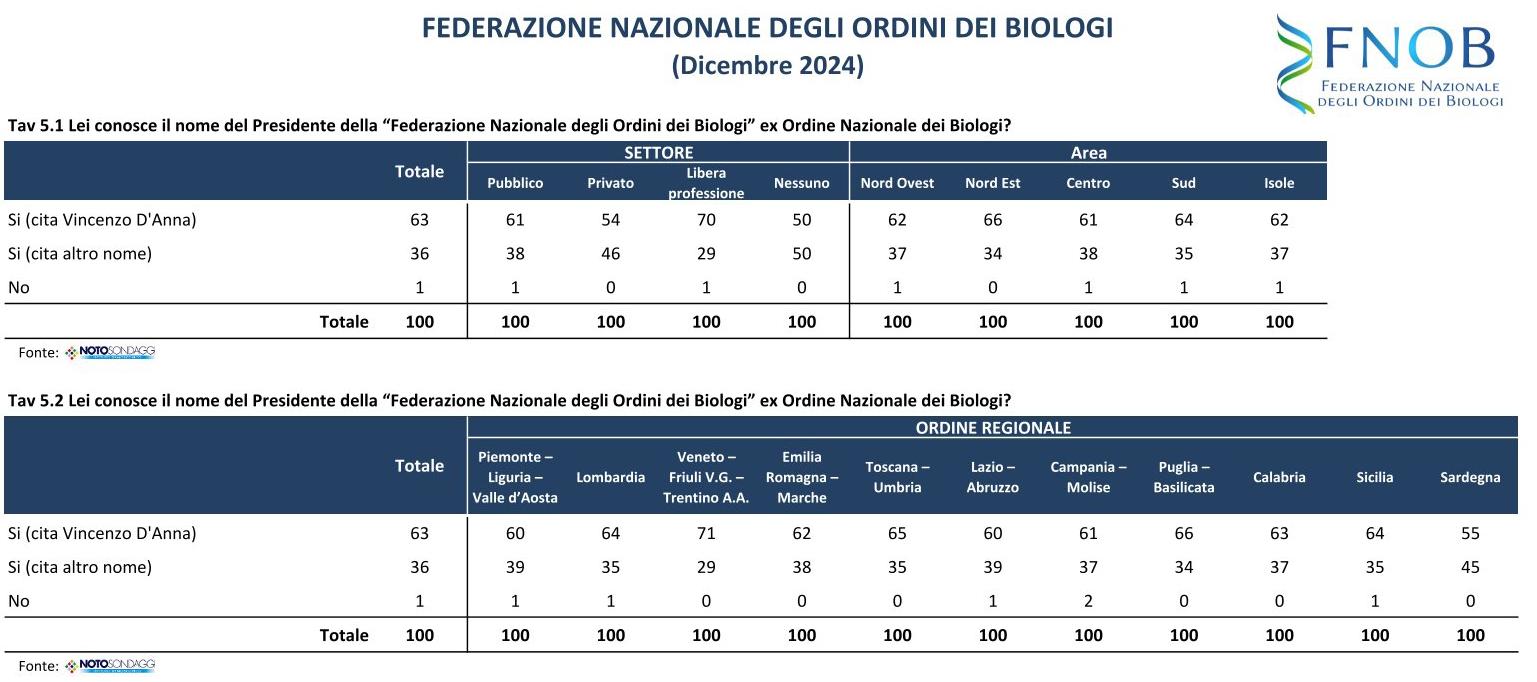

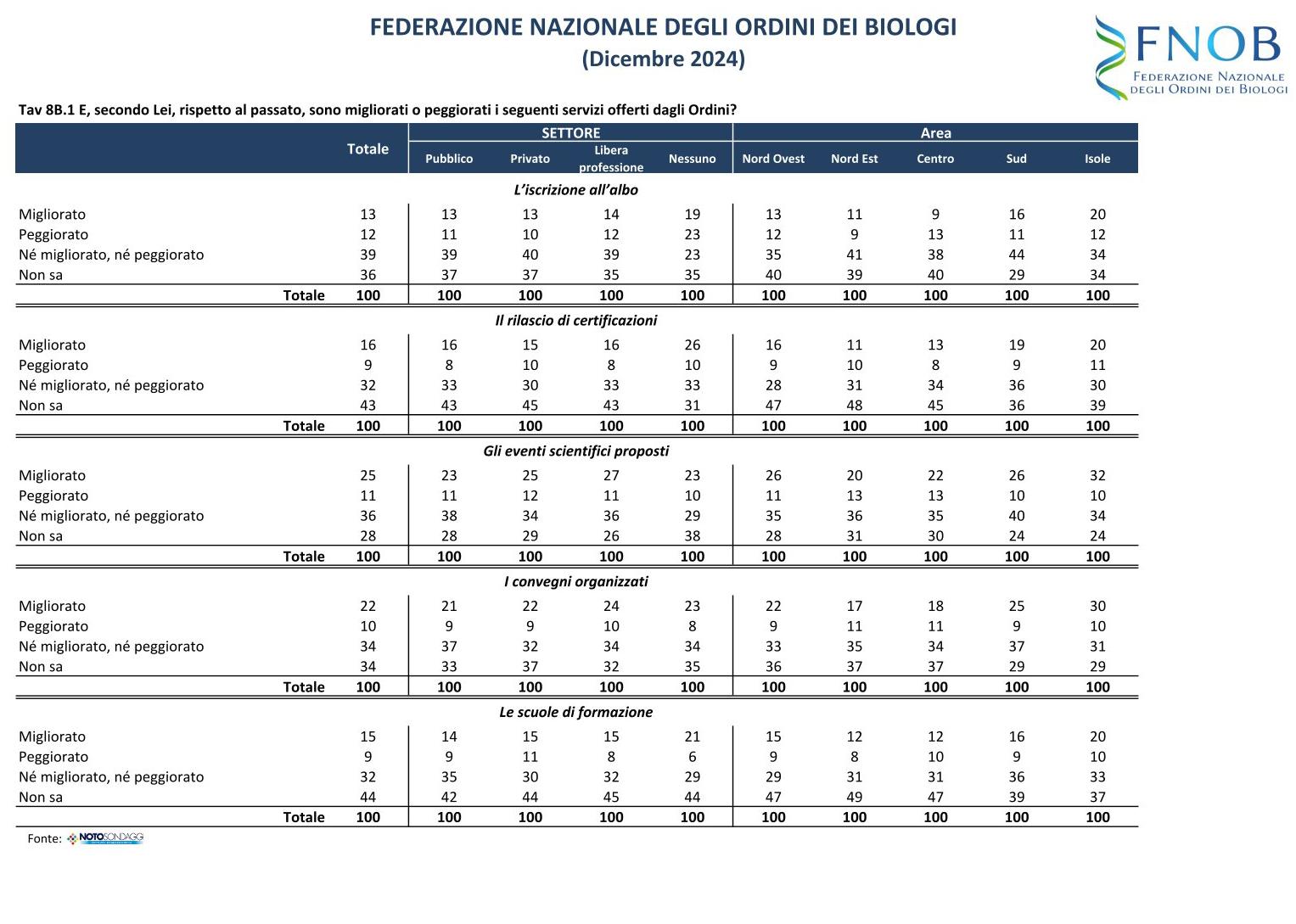



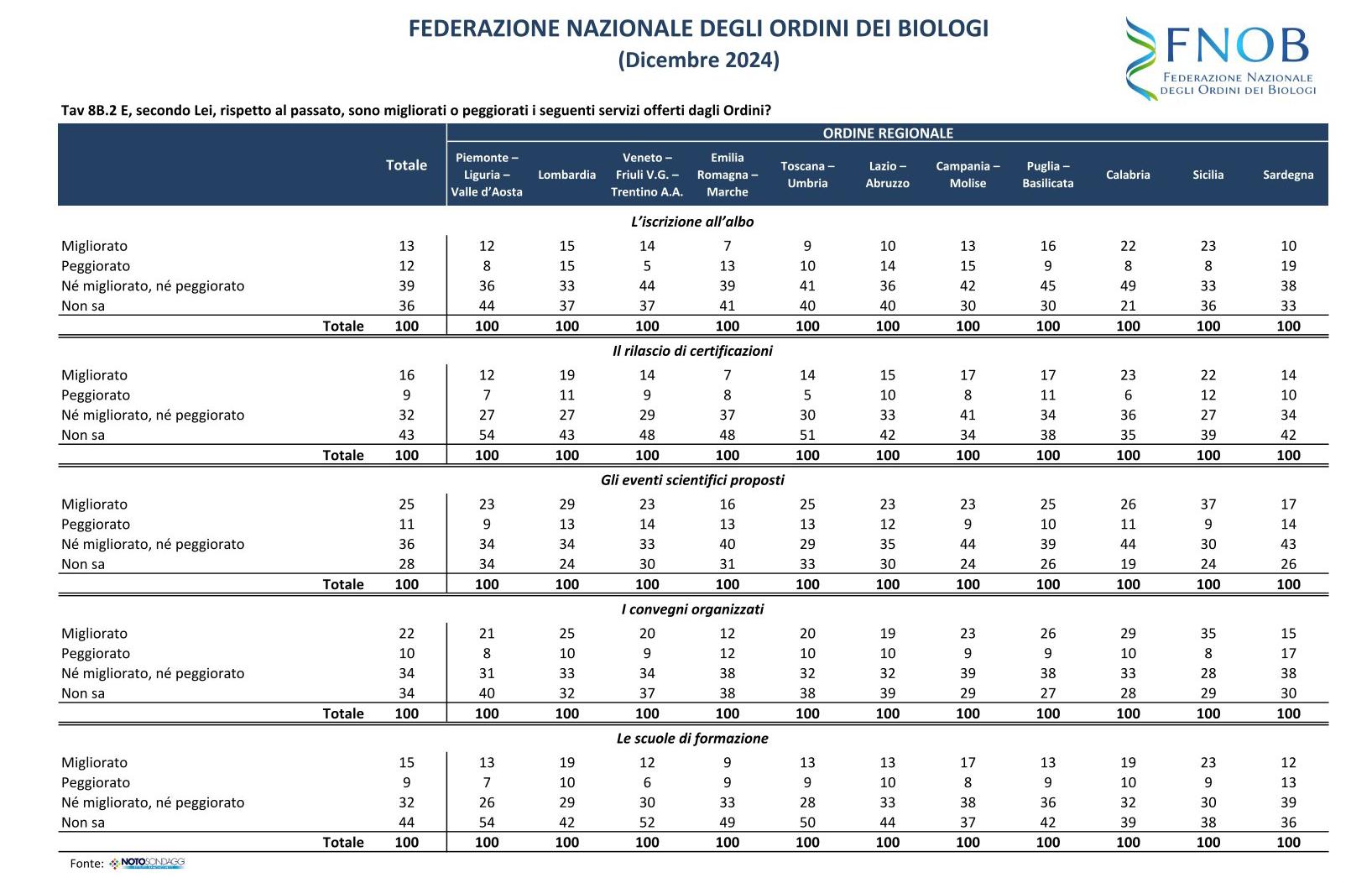
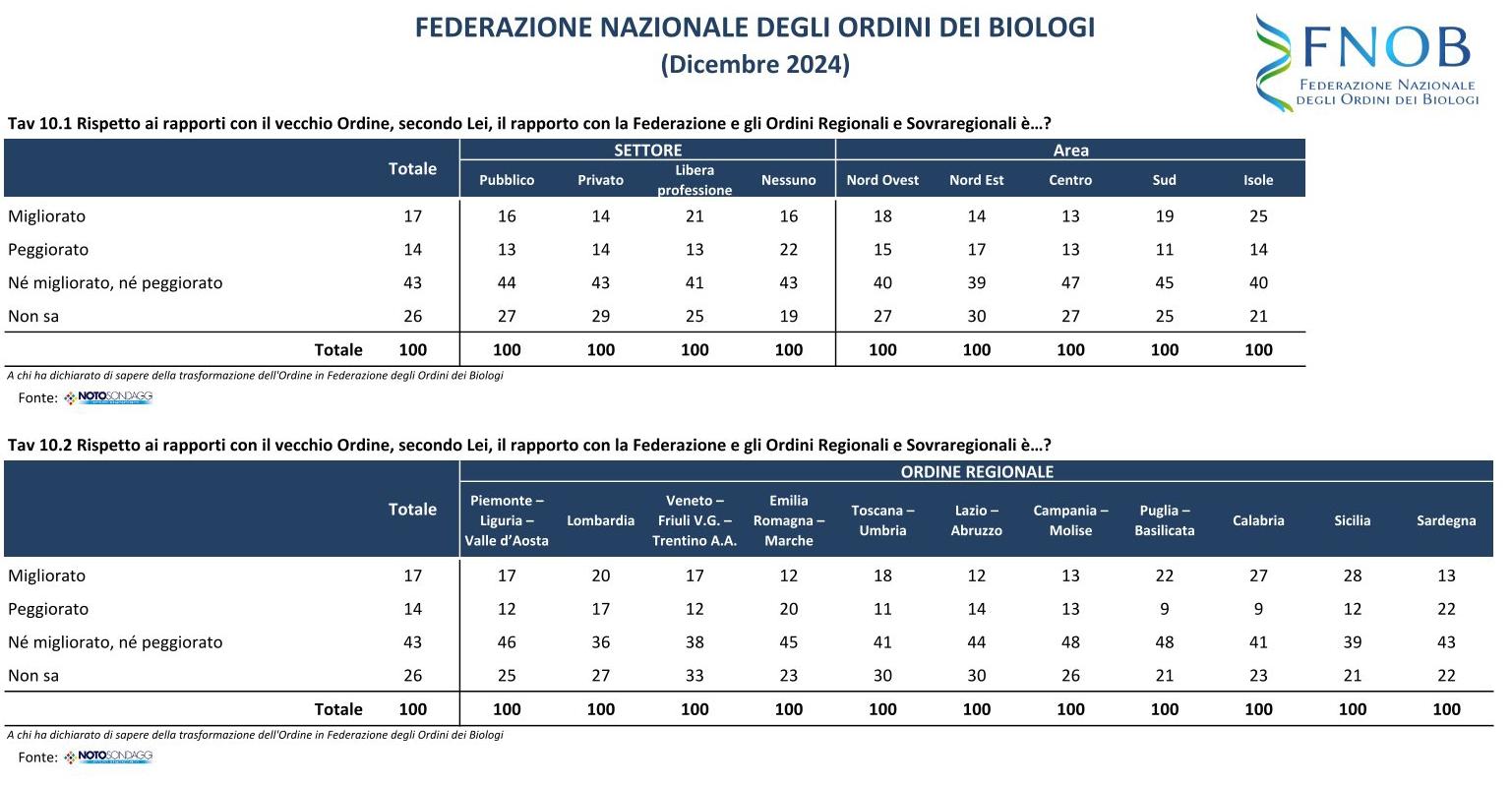



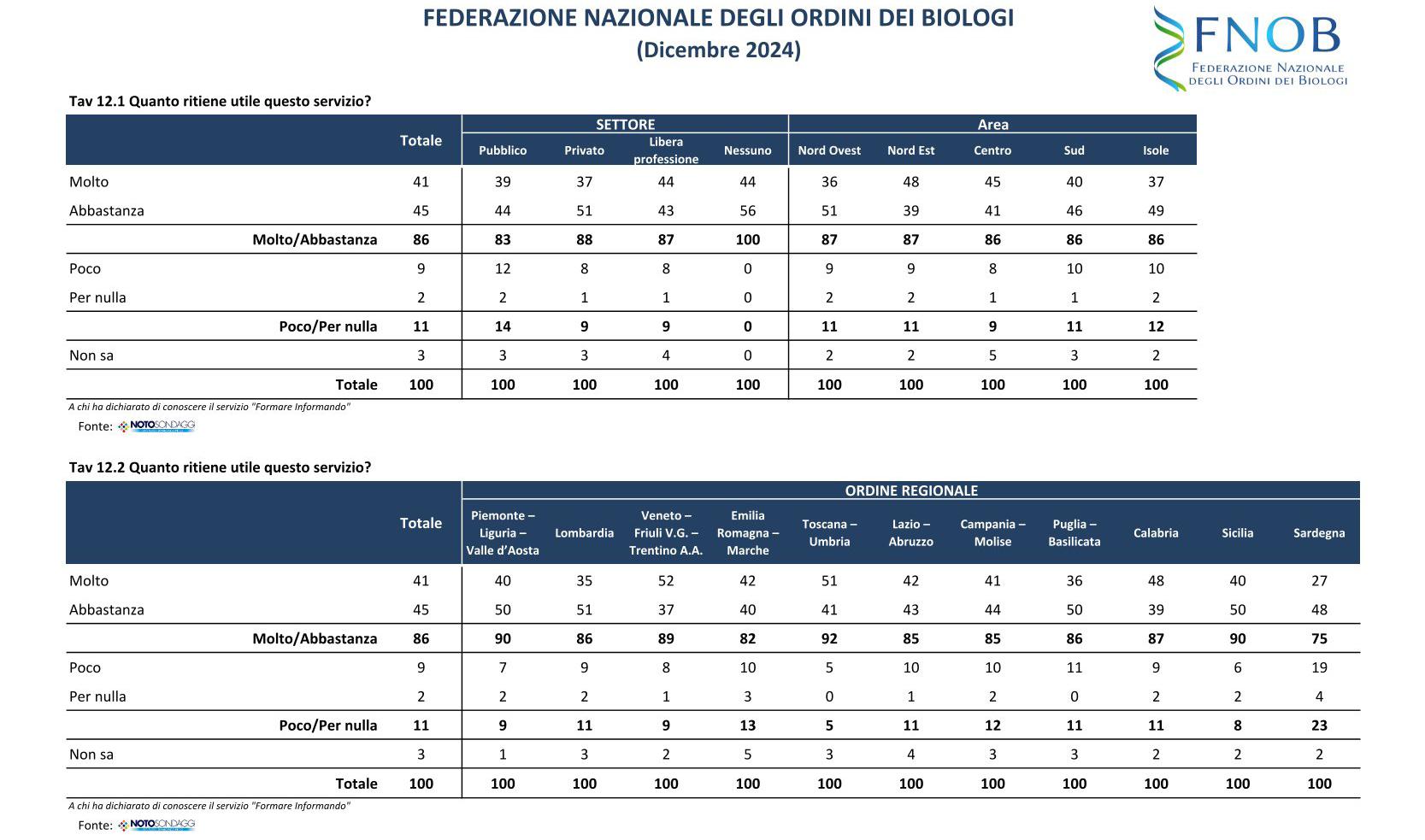

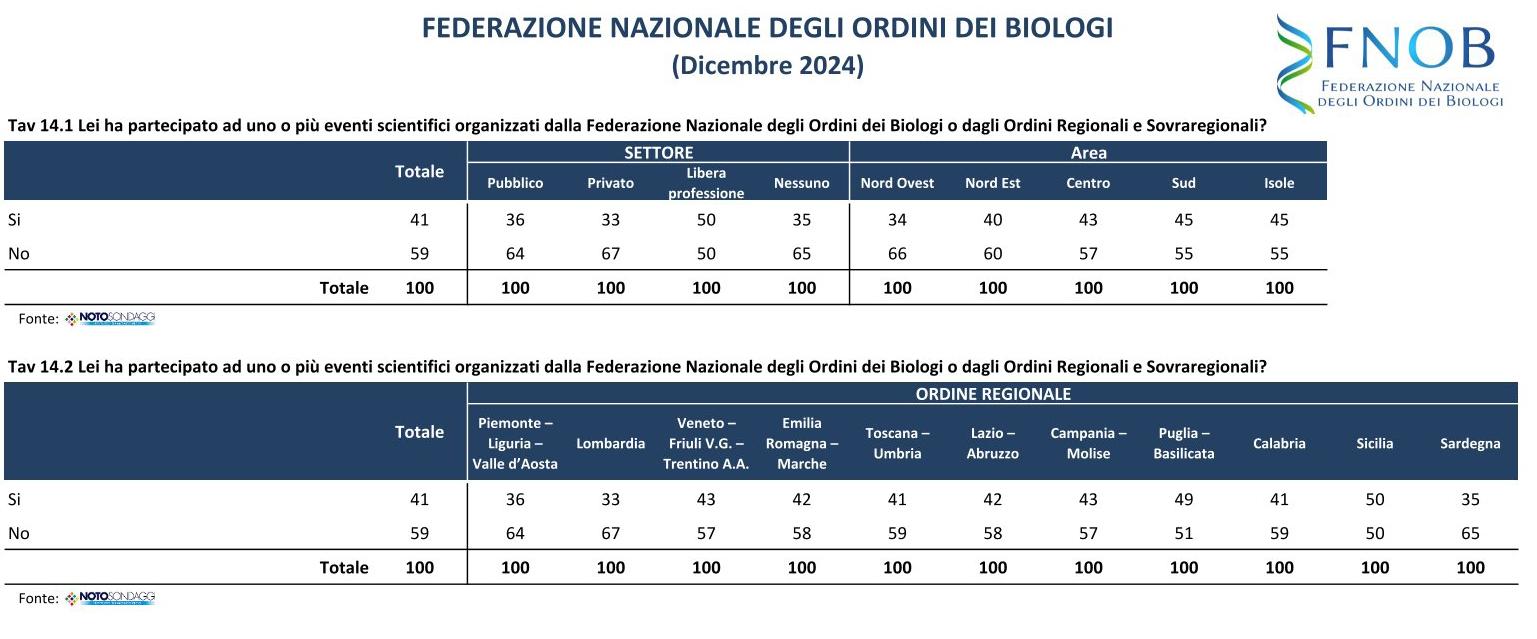


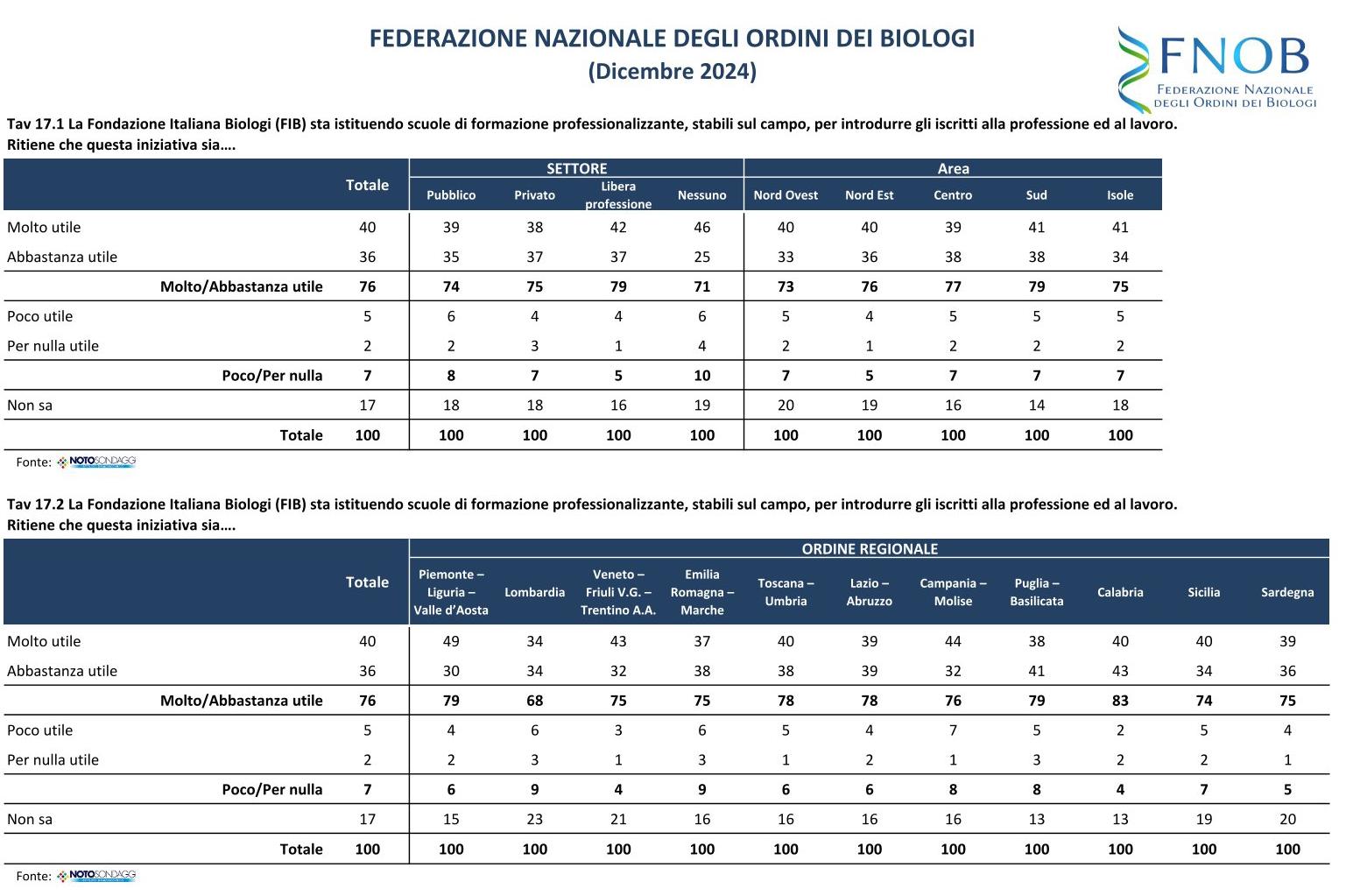
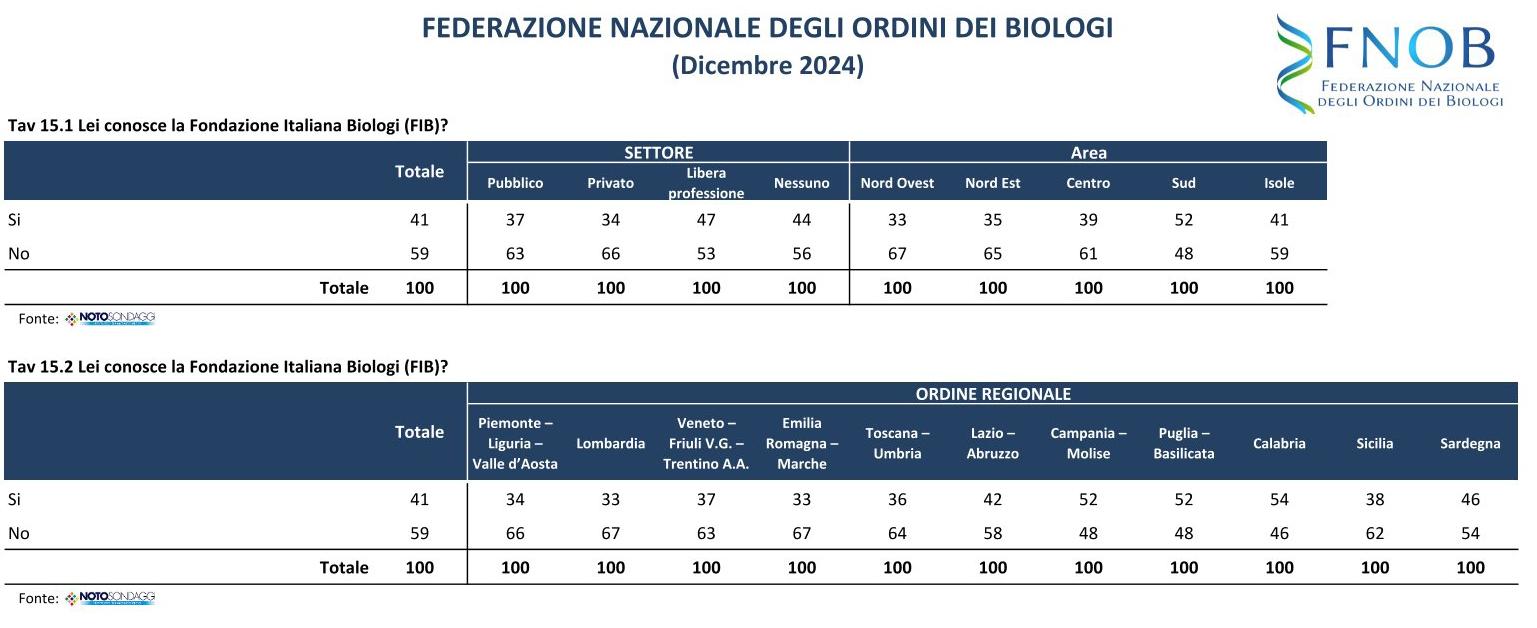

Finite le festività, coi loro doverosi strappi alla regola, è tempo di voltare pagina I consigli della dottoressa Livia Galletti, coordinatrice e delegata responsabile CNBN

di Rino Dazzo
Dopo il pandoro, il cotechino e gli irrinunciabili piatti della tradizione, il temuto confronto con la bilancia. Le festività con i loro eccessi, soprattutto a tavola, sono già un bellissimo ricordo. È tempo di preoccuparsi della remise en forme, di riacquisire quelle corrette abitudini alimentari che per il Natale, il Capodanno e negli altri giorni di festa sono state momentaneamente e legittimamente messe da parte. Ma quali sono le linee guida di cui si dovrebbe tener sempre conto a tavola? Ne parliamo con la dottoressa Livia Galletti, coordinatrice e delegata responsabile del CNBN, il Coordinamento Nazionale dei Biologi Nutrizionisti.
Dottoressa Galletti, è passato un altro Natale. Lo abbiamo onorato e santificato degnamente, con abbondanti banchetti e libagioni. Ora cosa dobbiamo fare per rimetterci in forma?
«Il punto di vista dovrebbe essere ribaltato: le Feste sono occasioni di convivialità e il nostro paese ha una grande tradizione di piatti festivi, vanno godute. Il punto non è correre ai ripari, mentalità che non supporta la salute, ma non mangiare troppo per troppi giorni durante le Feste. Godere dei pasti delle giornate di festa, degli affetti e dei piatti della tradizione di ogni famiglia non è sinonimo di mangiare troppo. Nei giorni non festivi basta continuare a nutrirci come dovremmo fare tutto l’anno: non dimenticando mai le verdure, evitando gli alcolici, riservando i dolci a rare occasioni».
Si parla molto di corretta alimentazione. Quali sono i principi cardine di un’alimentazione sana ed equilibrata?
«Ogni persona è diversa e per ogni persona l’abitudine a tavola deve essere cucita come un abito sartoriale. Le Linee Guida italiane per una sana alimentazione (CREA) ci danno una bussola per muoverci nel vastissimo mondo della nutrizione. Le verdure devono essere alla base di ogni pasto, seguite dai cereali possibilmente integrali e dai legumi. Uova e formaggi vengono dopo come frequenza di consumo, poi il pesce, le carni bianche e, per ultime, le carni rosse. L’olio extravergine di oliva non deve mai mancare. Frutta e frutta secca in guscio, latte e yogurt nelle giuste quantità completano gli alimenti settimanali per una persona adulta in salute».
Ci sono alimenti o abitudini che si sente di suggerire per favorire una ripresa rapida e funzionale?
«In questo periodo dell’anno si può iniziare ogni pasto con una piccola porzione di verdura cruda - per esempio finocchi, carote, sedano, radicchi - in modo da aumentare il senso di sazietà, stimolare l’azione del fegato, controllare il rapido aumento del glucosio nel sangue e nutrire tutti quei microbi che formano il microbiota intestinale e con i quali conviviamo. Il condimento principe deve sempre essere l’olio extravergine di oliva, un prezioso mix di sostanze antiossidanti, antinfiammatorie e necessario per l’assorbimento di vitamine e composti funzionali contenuti nei vegetali. Privilegiare i legumi come fonte
proteica a discapito soprattutto delle carni aiuterà l’organismo a riprendersi dagli stravizi festivi e può diventare il primo passo verso un maggior consumo durante tutto l’anno».
Da cosa invece dovremmo stare alla larga, almeno per un po’?
«Gli alcolici andrebbero banditi dalle abitudini a tavola, lasciandoli solamente per le occasioni. Quindi il loro consumo va ridotto ai minimi termini in generale, tutto l’anno. I dolci hanno una frequenza di consumo ridotta, una volta alla settimana e nelle occasioni, soprattutto dopo i giorni di festa, nei quali ne abbiamo consumati veramente tanti, dobbiamo tornare a non averli a tavola tutti i pasti o tutti i giorni».
La FNOB da sempre è molto attenta e presente su tematiche legate alla nutrizione: quali sono i prossimi appuntamenti legati a questo ambito?
«Tra i Coordinamenti dei Biologi fortemente voluti dal presidente D’Anna è stato creato quello dei Biologi Nutrizionisti: il CNBN. Abbiamo ricevuto quasi 600 adesioni, dato che fa ben comprendere quanto i colleghi e le colleghe nutrizionisti abbiano interesse al coinvolgimento e a partecipare a iniziative su tutto il territorio. Le adesioni sono ancora aperte e mi aspetto di arrivare ai 700 iscritti entro i primi tre mesi del 2025. Tramite le aree tematiche i biologi e le biologhe aderenti potranno anche proporre eventi, convegni, congressi, corsi che FNOB organizzerà in tutta Italia.
In questo momento stiamo valutando diversi eventi e corsi sulla nutrizione da proporre a colleghe e colleghi. FNOB patrocina tutti i principali eventi formativi e scientifici italiani in campo nutrizionale aperti ai biologi e alle biologhe e così sarà anche per tutto questo anno, molto spesso negoziando tariffe ridotte esclusive per le colleghe e i colleghi. Inoltre, come FNOB partecipiamo come coorganizzatori e/o come relatrici e relatori in eventi divulgativi e formativi in ambito nutrizionale. Per aggiornamenti puntuali su ogni evento, occasione, convegno, congresso o corso organizzato -coorganizzato - patrocinato da FNOB invito a consultare regolarmente il sito www.fnob.it e a scaricare la app FNOB».

Tra i Coordinamenti dei Biologi fortemente voluti dal presidente D’Anna è stato creato quello dei Biologi Nutrizionisti: il CNBN. Abbiamo ricevuto quasi 600 adesioni, dato che fa ben comprendere quanto i colleghi e le colleghe nutrizionisti abbiano interesse al coinvolgimento e a partecipare a iniziative su tutto il territorio. Le adesioni sono ancora aperte e mi aspetto di arrivare ai 700 iscritti entro i primi tre mesi del 2025. Tramite le aree tematiche i biologi e le biologhe aderenti potranno anche proporre eventi, convegni, congressi, corsi che FNOB organizzerà in tutta Italia.

Ci sono ingredienti che favoriscono l’espulsione di tossine in eccesso e di veleni assunti spesso inconsapevolmente
Mangiar bene allunga la vita. E non è soltanto un modo di dire. Un’alimentazione corretta e un moderato esercizio fisico aiutano a tenere lontani sovrappeso, obesità, diabete di tipo 2, ma anche malattie cardiache e vascolari e persino alcune forme di tumori. Non solo. Il mangiar sano non fa star bene solo il corpo, ma anche la mente.
Dopo un periodo segnato inevitabilmente da qualche banchetto di troppo, quali sono gli alimenti che possono contribuire a liberarci prima e meglio dalle tossine in eccesso? E le risposte
possono valere come linea guida per tutti i giorni, non solo per il periodo post festività. L’argomento è di grande importanza e, non a caso, da anni è all’attenzione dell’ONB prima e della FNOB poi, che si è fatta parte attiva nell’organizzazione di numerosi eventi e congressi sulla questione.
Bere molto – non meno di due litri di acqua al giorno – è il primo passo per diluire ed eliminare le tossine derivanti da un consumo eccessivo di proteine o carboidrati raffinati, sostanze nocive per l’organismo, ma anche dall’assunzione inconsapevole di inquinanti. Ci sono poi tutta una
serie di alimenti detox che favoriscono l’espulsione di cibi nocivi, tra cui spiccano i grani antichi, autoctoni del territorio italiano e mediterraneo, che essendo ricchi di selenio sono in grado di disattivare metalli pesanti come il mercurio, favorendone l’espulsione. La relazione tra allergie, tumori e micro inquinamento ambientale, del resto, è scientificamente provata. Ecco perché, come rimarcato da Vincenzo D’Anna, presidente della Federazione Nazionale degli Ordinie dei Biologi, «è importante studiare a fondo i meccanismi di interrelazione tra alimentazione e ambiente, in modo da riconoscere i cibi in grado di detossificare gli individui».
Ecco qualche esempio: «I grani antichi ricchi di selenio che neutralizzano gli agenti tossici, le alghe depuranti e le verdure coltivate in terreni autoctoni cioè piantate all’origine che inibiscono la penetrazione degli agenti inquinanti». Come sottolineato di recente dal biologo Armando D’Orta della DD Clinic Foundation in occasione di una due giorni di studio a Caserta sul tema della nutrizione clinica e dell’oncologia integrata, «con una dieta adeguata è possibile aumentare ciò che le cellule espellono dal corpo. Quindi, scegliendo dei cibi adatti da ciascun territorio, è possibile fare prevenzione.
La dieta detox consiste in un sistema oncostabilizzante e immunoprotettivo. Nella pratica, vengono utilizzati alimenti con bassi fattori di crescita a prevalenza di proteine vegetali, grani antichi realmente mediterranei e germogli. Si evidenzia, inoltre, l’importanza dell’utilizzo dell’estratto di frutta e verdura per preparare in casa un prodotto ricco di fitocomplessi (vitamine), minerali e cellule staminali vegetali (germogli). Un vero e proprio elisir di lunga vita».
Insomma, riuscire a mantenere sano il proprio organismo non è poi così difficile e, soprattutto, è letteralmente dietro l’angolo: basta saper riconoscere gli ingredienti giusti. (R. D.).
Farmaci in grado di far perdere peso in poco tempo e senza troppi sforzi, che spopolano sui social – in particolare su TikTok – dove sono oggetto di sponsorizzazioni da parte di più o meno autorevoli influencer e testimonial: la tendenza si sta affermando sempre più e non è priva di implicazioni. Nomi come Ozempic, farmaco a base di semaglutide, oppure Mounjaro, basato sul tirzepatide, sono sempre più famosi sul web, soprattutto tra i giovanissimi.
Utilizzati come rimedio veloce per calare di peso anche da chi magari ha giusto qualche chiletto di troppo, lontano dal concetto di obesità in senso stretto. Entrambi i medicinali sono nati per il trattamento del diabete. L’Ozempic, commercializzato dalla Novo Nordisk, è progettato per essere iniettato una volta a settimana. Il costo di una singola pennetta? Vicino ai 175 euro. Costa invece il doppio, 350 euro, un’iniezione di Mounjaro, prodotto da Eli Lilly Italia, da eseguire pure una volta a settimana.
Semaglutide e tirzepatide sono principi attivi in grado di abbassare i livelli di zucchero nel sangue e regolare l’insulina. Hanno però anche la capacità di limitare l’appetito, allentando lo svuotamento gastrico e inviando al cervello segnali di sazietà. Il successo di Ozempic è stato talmente grande che la casa farmaceutica ha sviluppato un altro farmaco, il Wegovy, esclusivamente contro l’obesità, in cui il dosaggio è più alto: molto spesso, infatti, capitava che i diabetici non trovassero più il loro medicinale nelle farmacie, preso letteralmente d’assalto da altri soggetti, nonostante l’obbligo di prescrizione medica per il loro acquisto.
Obbligo di prescrizione che in teoria sarebbe vigente anche per il Mounjaro. In teoria, perché entrambi i farmaci sono venduti senza scrupoli anche per vie non ufficiali, spesso a minorenni. I controlli? Non sempre efficaci. Il calo ponderale assicurato

Semaglutide, tirzepatide, efedrina: successo, rischi e contraddizioni dei medicinali famosi sui social per perdere peso
dai due farmaci è notevole: 25% per il tirzepatide, 15% per la semaglutide. Gli effetti collaterali? Nausea, disidratazione, malessere, stanchezza, irregolarità intestinale. Ma soprattutto, un calo repentino di peso per chi ha solo qualche chilo di troppo comporta il rischio di perdere anche massa muscolare, per il senso continuo di sazietà che induce a stare lontani da alimenti proteici come uova, pesce, pollo, che apportano gli aminoacidi necessari a mantenere la muscolatura.
Altro caso è quello legato a Enurace, un farmaco veterinario a base di efedrina nato per limitare l’inconti-
nenza urinaria canina. L’efedrina, un protoalcaloide estratto da alcune piante appartenenti al genere Ephedra, ha una struttura chimica simile alle anfetamine e tra i suoi effetti, oltre a far sballare e a migliorare le prestazioni sportive, ha anche quello di sopprimere l’appetito. Anche in questo caso, l’acquisto può avvenire per vie traverse, al mercato nero o grazie all’ausilio di professionisti compiacenti.
Ma c’è anche chi si avvale di regolare prescrizione medica del proprio veterinario, che crede di aver autorizzato l’acquisto di un farmaco per un cane, piuttosto che per il padrone. (R. D.).
Un gruppo ricerca guidato dall’Università di Bologna ha messo a punto un sistema che utilizza un particolare batteriofago come stampo per la sintesi di nanoparticelle fotosensibili anticancro Ne parliamo con il professor Matteo Calvaresi, coordinatore dello studio pubblicato sulla rivista Small
di Ester Trevisan
Professor Calvaresi, grazie allo studio realizzato dall’Università di Bologna e da lei coordinato, possiamo intravedere degli alleati nei virus, da sempre considerati nostri nemici. A cosa dobbiamo questo cambio di prospettiva? «I virus, come la recente pandemia ci ha insegnato, hanno la straordinaria capacità di infettare in maniera molto efficiente e specifica alcune cellule del nostro organismo. Questa selettività deriva dal fatto che i virus posseggono sulla loro superficie delle chiavi molecolari capaci di riconoscere specifiche “serrature” presenti sulle nostre cellule e sfruttarle per poter accedere al loro interno. Questo principio è lo stesso che è alla base delle moderne terapie a bersaglio molecolare, comunemente conosciute come terapie mirate o “targeted therapies”, che rappresentano una componente fondamentale della terapia oncologica contemporanea. L’idea, quindi, è stata quella di sfruttare i virus per trasportare selettivamente farmaci chemioterapici all’interno delle cellule tumorali».
Ci spiega in cosa consiste il progetto NanoPhage, di cui fa parte il vostro studio?
«Nel progetto NanoPhage, finanziato da
Fondazione AIRC, abbiamo sviluppato un processo di ingegnerizzazione di un virus innocuo per l’uomo, il fago M13, rendendolo capace di riconoscere recettori presenti sulle cellule tumorali. Abbiamo poi modificato chimicamente l’involucro virale con delle molecole, rendendo il virus un veicolo in grado di riconoscere ed eliminare selettivamente le cellule tumorali. In particolare, nel progetto NanoPhage utilizziamo particolari agenti chemioterapici che si attivano con la luce, aumentando il processo di selettività nei confronti del tessuto tumorale».
Come siete arrivati a realizzare il metodo che sfrutta le proprietà specifiche dei virus innocui per gli esseri umani?
«Il processo è stato naturalmente graduale. Abbiamo prima modificato geneticamente la punta del fago M13, rendendolo capace di riconoscere e legarsi ad uno specifico recettore cellulare, chiamato EGFR, che viene sovra-espresso in diversi tipi di tumore. Una volta determinata l’abilità del virus ingegnerizzato di riconoscere solo le cellule tumorali, lo abbiamo “armato” chimicamente legando sulla sua superficie delle molecole di interesse farmacologico. Come ultimo step, per amplificare l’effetto
terapeutico, abbiamo addirittura ricoperto tutta la superficie del virus con delle molecole fotoattive, trasformando l’involucro virale in una nanoparticella».
Quali sono i risvolti terapeutici?
«La principale limitazione della chemioterapia deriva dalla sua mancanza di specificità, ovvero i farmaci utilizzati danneggiano in maniera indiscriminata tutte le cellule in rapida proliferazione, sia i tessuti cancerosi (effetto desiderato) sia quelli normali (effetti collaterali). La possibilità di utilizzare vettori virali capaci di veicolare selettivamente i farmaci solo all’interno di cellule tumorali e di controllare con esattezza l’area di attivazione della terapia, utilizzando la luce, potrà permettere di ridurre drasticamente gli effetti collaterali delle terapie anticancro sui tessuti sani. Questo meccanismo a “doppio puntamento” può migliorare la prognosi e la qualità della vita del paziente».
Da chi è composto il team di ricerca?
«Una ricerca così multidisciplinare si è avvalsa naturalmente di diverse competenze. Il gruppo di ricerca del professor Alberto Danielli (FABIT-UNIBO), si è occupato dell’ingegnerizzazione del vettore virale; il team della dottoressa Francesca Di Maria (ISOF-CNR) ha sintetizzato le molecole che i miei collaboratori del NanoBio Interface

Calvaresi si laurea nel 2004 in Chimica presso il Dipartimento “Giacomo Ciamician” dell’Università di Bologna, dove ottiene il dottorato di ricerca in Scienze Chimiche nel 2008. Diventa ricercatore nel 2010 e poi professore associato in Chimica organica nel 2018 presso lo stesso istituto.
Ha trascorso diversi periodi di ricerca all’estero, tra cui Peking University (Cina), TechnionIsrael Institute of Technology (Israele), University of Pune (India). Dal 2023 è Coordinatore del Dottorato in “Nanoscienze per la Medicina e per l’Ambiente” presso l’Università di Bologna e dal 2024 ricercatore presso l’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola.

© Love Employee/shutterstock.com

La principale limitazione della chemioterapia deriva dalla sua mancanza di specificità, ovvero i farmaci utilizzati danneggiano in maniera indiscriminata tutte le cellule in rapida proliferazione, sia i tessuti cancerosi (effetto desiderato) sia quelli normali (effetti collaterali). La possibilità di utilizzare vettori virali capaci di veicolare selettivamente i farmaci solo all’interno di cellule tumorali e di controllare con esattezza l’area di attivazione della terapia, utilizzando la luce, potrà permettere di ridurre drasticamente gli effetti collaterali delle terapie anticancro sui tessuti sani.
© Vink Fan/shutterstock.com
Lab (CIAMICIAN-UNIBO) hanno utilizzato per decorare chimicamente il fago e trasformarlo in una nanoparticella. I test in vivo su modelli animali invertebrati sono stati condotti dall’equipe della dottoressa Claudia Tortiglione (ISASI-CNR)».
Quale contributo apporta la vostra ricerca allo sviluppo della nanomedicina?
«Nella nanotecnologia la riproducibilità nella sintesi di nanomateriali è un problema enorme, e rappresenta il limite maggiore per la traslazione clinica della nanomedicina. Il fago ci permette di risolvere questo problema perché la sua forma/dimensione è strettamente controllata a livello genetico. Abbiamo così a disposizione oggetti nanometrici identici, che possiamo utilizzare come degli stampini, permettendoci di sintetizzare nanoparticelle identiche ed in grado di fare targeting, ottenendo risultati altamente riproducibili. Inoltre, la grande flessibilità offerta dalla biologia del fago permette di sviluppare approcci innovativi in diversi ambiti della nanomedicina, nel campo della teranostica, della biosensoristica e della medicina di precisione. Abbiamo già dimostrato come la piattaforma virale sviluppata, oltre alle cellule tumorali, può essere utilizzata anche per combattere batteri patogeni che hanno sviluppato resistenza agli antibiotici».
La ricerca firmata CNR, Università di Firenze e ospedale Careggi porta verso un’individuazione più accurata della malattia. Ne parla Maria Antonietta Pascali
Un approccio innovativo basato su metodi di apprendimento automatico topologico per supportare l’individuazione della malattia di Alzheimer: è quanto proposto nell’ambito di uno studio condotto dal Cnr in collaborazione con l’Università di Firenze e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, pubblicato sulla rivista Journal of the Franklin Institute. Una ricerca che riveste particolare importanza se si dà un’occhiata alla crescente prevalenza di questa patologia, responsabile del 60-70% dei casi di demenza nel mondo.
Le stime, infatti, parlano di circa 152 milioni di casi di questa malattia o demenze correlate entro il 2050. Secondo il Ministero della Salute, in Italia circa 1.100.000 persone soffrono di demenza (di cui circa 600mila sono malati di Alzheimer) e circa 900mila di disturbo neurocognitivo minore. Ecco perché la ricerca di nuove terapie e di marker biologici per una diagnosi più accurata è cruciale.
A raccontare questo recente e importante tassello per una diagnosi precoce è Maria Antonietta Pascali, ricercatrice dell’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa.
Dove e quando nasce lo studio?
Nella cornice del progetto PRAMA (Proteomics, RAdiomics & Machine Learning-in-
tegrated strategy for precision medicine for Alzheimer’s), un progetto di 36 mesi finanziato dalla regione Toscana all’interno del programma “Bando Ricerca Salute 2018”. Le attività, iniziate a ottobre 2020, sono condotte dall’Istituto di fisica applicata “Nello Carrara”, in qualità di coordinatore, dall’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” (Cnr-Isti), dall’Università di Firenze, dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e dall’IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi di Firenze.
L’obiettivo è l’integrazione di diverse tecniche di indagine (proteomica, radiomica e machine learning) per supportare la medicina personalizzata nel caso specifico della malattia di Alzheimer, affiancate e integrate per analizzare dati di vario genere al fine di caratterizzare biomarcatori molecolari estratti da fluido cerebrospinale.
Qual è l’aspetto innovativo di questa ricerca?
Senza dubbio il metodo con cui si analizza il dato di spettroscopia Raman, l’apprendimento automatico topologico, o topological machine learning (TML). Un campione di liquido cerebrospinale, opportunamente acquisito e preparato, viene sottoposto a spettroscopia Raman; dallo spettro risultante vengono estratti dei descrittori topologici che, classificati da un modello di machine learning, permettono di

individuare i campioni estratti da pazienti affetti da Alzheimer con una accuratezza dell’86%.
In sostanza, lo studio suggerisce che la spettroscopia Raman, in combinazione con il TML, ha un potenziale importante nel distinguere i soggetti affetti da Alzheimer da altre patologie del sistema nervoso centrale.
Cosa si intende per tecniche di apprendimento automatico topologico?
Combina il machine learning con la topologia computazionale, una branca della matematica che studia la struttura e la forma dei dati. Nello specifico caso di studio, dagli spettri Raman vengono estratte caratteristiche di forma che vengono poi utilizzate per addestrare classificatori di machine learning.
L’ottimizzazione del processo consente di selezionare il miglior modello predittivo, da testare su nuovi dati.
In cosa consiste la spettroscopia Raman?
Esistono in letteratura molte ricerche dedicate allo studio della malattia di Alzheimer tramite l’analisi del liquido cerebrospinale. In Prama sono stati raccolti diversi campioni, da analizzare attraverso diverse tecniche, tra cui la spettroscopia Raman, una tecnica di indagine dei materiali: il campione viene colpito da radiazione elettromagnetica monocromatica che, interagendo con le molecole del campione, produce una radiazione diffusa. L’analisi di tale radiazione diffusa consente di ricavare informazioni sulla natura fisico-chimica del materiale.
Quali sono i possibili sviluppi?
Questo metodo promette di fornire una chia-

Questo metodo promette di fornire una chiave di lettura efficace non solo per l’Alzheimer, ma potenzialmente anche per altri casi studio. Le evidenze della ricerca fanno sperare che nel prossimo futuro si possa affinare ulteriormente, magari per fornire delle indicazioni aggiuntive riguardo i meccanismi biochimici alla base dell’insorgenza e dell’aggravarsi di questa malattia.
© nobeastsofierce/shutterstock.com
ve di lettura efficace non solo per l’Alzheimer, ma potenzialmente anche per altri casi studio.
Le evidenze della ricerca fanno sperare che nel prossimo futuro si possa affinare ulteriormente, magari per fornire delle indicazioni aggiuntive riguardo i meccanismi biochimici alla base dell’insorgenza e dell’aggravarsi di questa malattia.
Ora quali step vi aspettano?
Sicuramente sarebbe auspicabile una fase di validazione ulteriore del metodo su dati nuovi e/o acquisiti con macchinari diversi. Ampliare il dataset consente sicuramente di consolidare le performance del metodo di classificazione dal punto di vista statistico e, eventualmente, anche di identificare possibili bias o limitazioni attualmente non note all’applicazione del metodo.
Nell’ottica di offrire un servizio di supporto alla diagnosi dell’Alzheimer è sicuramente cruciale quantificare l’affidabilità del metodo nelle condizioni d’uso quanto più possibili vicine allo scenario reale.
Maria Antonietta Pascali, Francesco Conti, Sara Colantonio, Davide Moroni - Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo”, CNR Pisa; Martina Banchelli, Cristiano D’Andrea, Marella de Angelis - Paolo Matteini Istituto di Fisica Applicata “N. Carrara”, CNR Firenze; Valentina Bessi, Cristina Cecchi, Fabrizio Chiti, Benedetta Nacmias - Sandro Sorbi Università di Firenze.
Una scoperta innovativa svela le “impronte digitali” dei tumori
Basata su modifiche chimiche dell’Rna ribosomiale promette diagnosi rapide e non invasive

Itumori potrebbero essere diagnosticati precocemente grazie a una scoperta che svela le loro impronte digitali uniche. Queste impronte consistono in modificazioni chimiche presenti sull’Rna ribosomiale (rRNA), la componente fondamentale dei ribosomi, organelli cellulari deputati alla produzione di proteine. Lo studio è stato condotto dai ricercatori del Centro di regolazione genomica di Barcellona e pubblicato sulla rivista Molecular Cell. I risultati promettono di aprire nuove strade per lo sviluppo di test diagnostici non invasivi in grado di identificare precocemente le neoplasie.
«I nostri ribosomi non sono tutti uguali», spiega Eva Novoa, coordinatrice dello studio. «Questi organelli, presenti in tutte le cellule, sono specializzati nei diversi tessuti e portano firme uniche che riflettono lo stato di salute o di malattia dell’organismo. Le sottili differenze chimiche nei ribosomi ci permettono di ottenere informazioni preziose su ciò che accade all’interno del corpo».
I ribosomi sono costituiti da proteine e Rna ribosomiale, un tipo di Rna che può subire modificazioni chimiche. Queste modificazioni, chiamate modificazioni epitrascrittomiche, influenzano il funzionamento del ribosoma stesso. Il team di ricercatori ha analizzato l’rRNA prelevato da diversi tessu -
ti come cervello, cuore, fegato e testicoli e ha scoperto che ciascun tessuto presenta un’impronta digitale epitrascrittomica unica, una sorta di firma chimica che permette di identificare la sua origine.
«L’impronta digitale sul ribosoma ci rivela la provenienza della cellula - afferma Ivan Milenkovic, primo autore dello studio -. È come se ogni tessuto lasciasse un’etichetta con il suo indirizzo, nel caso in cui le sue cellule finissero nel reparto oggetti smarriti». Questa metafora sottolinea la precisione con cui queste modificazioni possono essere rilevate e associate ai tessuti di origine. La ricerca ha analizzato campioni di diversi tipi di tumore e ha rivelato che le cellule malate perdono alcune di queste modificazioni chimiche. Questo fenomeno, definito come ipomodificazione, è una caratteristica comune delle cellule tumorali.
Nel caso specifico del tumore al polmone, il team ha esaminato campioni di tessuto di venti pazienti in stadi iniziali della malattia. Utilizzando le impronte molecolari uniche dell’rRNA, hanno sviluppato un algoritmo capace di distinguere con estrema precisione il tessuto sano da quello tumorale. Questa accuratezza è stata resa possibile grazie alla tecnologia di sequenziamento tramite nanopori, che permette di analizzare le mo -
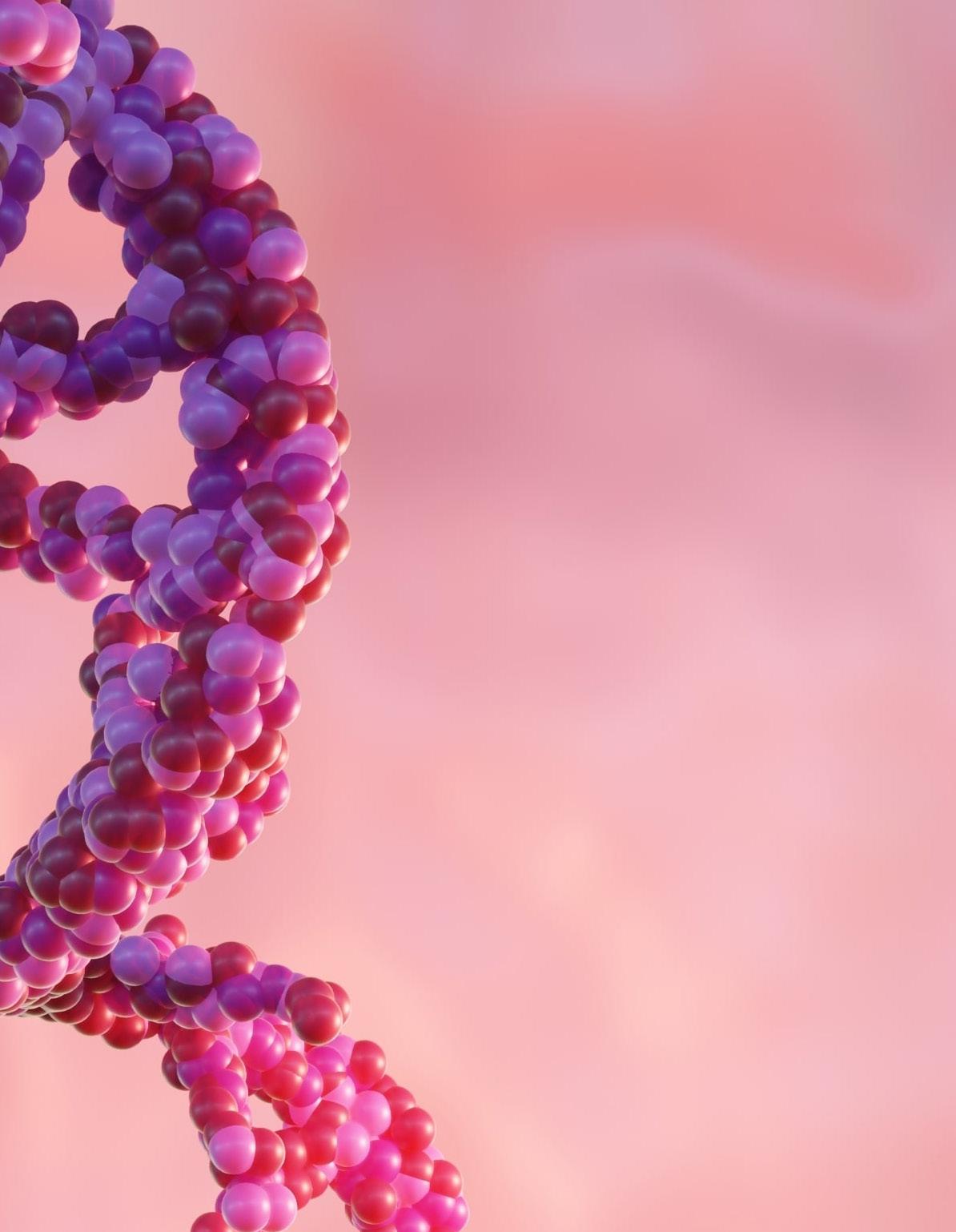
lecole di rRNA nel loro stato naturale, senza perdere le modifiche chimiche presenti. La tecnologia basata sui nanopori rappresenta una svolta rispetto ai metodi tradizionali, che spesso distruggono o alterano queste modificazioni durante il processo di analisi.
Gli strumenti utilizzati per il sequenziamento sono portatili e compatti, sufficientemente piccoli da stare nel palmo di una mano, rendendo la tecnologia potenzialmente accessibile per applicazioni cliniche diffuse. I risultati dello studio non solo aprono nuove prospettive per la diagnosi precoce dei tumori, ma potrebbero anche migliorare la comprensione dei meccanismi molecolari alla base di diverse malattie. Le modificazioni chimiche dell’rRNA sembrano infatti riflettere lo stato funzionale dei tessuti e potrebbero rivelarsi utili per monitorare il decorso di altre patologie.
Secondo i ricercatori, uno degli aspetti più promettenti di questa scoperta è la possibilità di sviluppare test diagnostici non invasivi. Attualmente, la diagnosi precoce del cancro richiede spesso esami invasivi, come biopsie o test complessi, che possono essere costosi e difficili da implementare su larga scala. Grazie a questa nuova tecnologia, sarà possibile analizzare campioni biologici con strumenti semplici e portatili, riducendo i tempi e i costi della diagnosi.
«Siamo solo all’inizio di una nuova eracommenta Eva Novoa -. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare non solo il modo in cui diagnostichiamo il cancro, ma anche il modo in cui comprendiamo la biologia delle cellule e dei tessuti». I prossimi passi includeranno l’estensione della ricerca ad altri tipi di tumore e lo sviluppo di test clinici per valutare l’efficacia della tecnologia nel contesto medico reale. L’idea di utilizzare le impronte chimiche dell’rRNA per la diagnosi di malattie non si limita ai tumori. I ricercatori ipotizzano che questo approccio possa essere applicato anche a patologie neurodegenerative, malattie metaboliche e altre condizioni in cui i tessuti subiscono modifiche specifiche. Le impronte epitrascrittomiche potrebbero diventare uno strumento diagnostico universale, aprendo la strada a una medicina sempre più personalizzata e precisa.
La scoperta rappresenta un importante passo avanti nella ricerca biomedica. (C. P.).

I ribosomi sono costituiti da proteine e Rna ribosomiale, un tipo di Rna che può subire modificazioni chimiche. Queste modificazioni, chiamate modificazioni epitrascrittomiche, influenzano il funzionamento del ribosoma stesso. Il team di ricercatori ha analizzato l’rRNA prelevato da diversi tessuti come cervello, cuore, fegato e testicoli e ha scoperto che ciascun tessuto presenta un’impronta digitale epitrascrittomica unica, una sorta di firma chimica che permette di identificare la sua origine.

Un nuovo strumento open source svela le complesse relazioni tra proteine e geni aprendo la strada a terapie anticancro più efficaci e mirate
FunMap è lo strumento sviluppato dal Baylor College of Medicine in Texas. Il team di ricercatori guidato da Bing Zhang ha creato una mappa unica analizzando le relazioni tra oltre 10.525 geni che producono proteine. Pubblicato sulla rivista Nature Cancer, FunMap promette di trasformare il modo in cui i ricercatori affrontano lo studio e il trattamento delle malattie oncologiche. Questo lavoro è stato intrapreso per affrontare una delle sfide più grandi nella biologia cellulare e oncologica: comprendere le complesse reti di interazioni tra proteine e identificare i loro ruoli specifici nello sviluppo del cancro. All’interno delle cellule, le proteine operano in un intricato sistema in cui ognuna influenza l’attività delle altre. Questa rete complessa può essere paragonata a una catena di montaggio, in cui il malfunzionamento di una singola componente può influire sull’intero sistema. Capire come queste interazioni contribuiscano allo sviluppo del cancro è una sfida enorme. Le relazioni tossiche tra proteine, che possono favorire la crescita tumorale, sono spesso difficili da identificare. FunMap utilizza algoritmi avanzati di intelligenza artificiale per analizzare e mappare le connessioni tra proteine come fossero interazioni su un social network. «È come se, pur non sapendo nulla di una persona, avessimo dedotto cosa fa analizzando i suoi contatti LinkedIn», ha spiegato Bing Zhang.
Il progetto si basa sulla profilazione di 10.525 geni e delle proteine da essi prodotte, focalizzandosi su undici tipi diversi di cancro. Questo approccio ha richiesto l’elaborazione di un’enorme quantità di dati, resa possibile grazie a tecnologie avanzate di analisi computazionale. I ricercatori hanno identificato 196.800 associazioni tra geni e proteine, evidenziando connessioni finora sconosciute. Queste associazioni aiutano a comprendere meglio le dinamiche delle cellule tumorali e distinguere quali relazioni proteiche sono benefiche e quali tossiche. Un esempio emblematico riguarda il gene MAB21L4, che sembra avere un ruolo chiave nello sviluppo del carcinoma a cellule squamose, mentre il gene LGI3 è stato identificato come potenziale soppressore di alcune forme tumorali. Tali scoperte offrono spunti preziosi per sviluppare nuove terapie mirate.
Uno degli aspetti più innovativi di FunMap è il suo approccio open source, che lo rende accessibile a tutti i ricercatori e istituti accademici.

A/shutterstock.com
Uno degli aspetti più innovativi di FunMap è il suo approccio open source, che lo rende accessibile a tutti i ricercatori e istituti accademici. Questo favorisce la collaborazione scientifica globale e accelera il progresso nella lotta contro il cancro. L’importanza di FunMap risiede nella sua capacità di fornire una visione d’insieme delle relazioni genetiche e proteiche, offrendo un quadro più chiaro delle degenerazioni che portano all’insorgenza di tumori. © PeopleImages.com

Questo favorisce la collaborazione scientifica globale e accelera il progresso nella lotta contro il cancro. L’importanza di FunMap risiede nella sua capacità di fornire una visione d’insieme delle relazioni genetiche e proteiche, offrendo un quadro più chiaro delle degenerazioni che portano all’insorgenza di tumori. Come osservato da Zhang, «queste scoperte possono aiutare notevolmente a stabilire le priorità per la traduzione clinica, contribuendo allo sviluppo di terapie più efficaci contro il cancro».
La profilazione genetica e proteica si sta rivelando una delle strategie più promettenti nella ricerca sul cancro. Grazie a strumenti come FunMap, i ricercatori possono ora studiare con maggiore precisione il comportamento delle proteine e identificare i punti deboli delle cellule tumorali. Questo approccio rappresenta un cambio di paradigma, spostando l’attenzione da trattamenti generici a terapie personalizzate e mirate. Identificare relazioni tossiche tra proteine finora sconosciute migliora la comprensione dei meccanismi alla base delle malattie oncologiche e offre nuovi bersagli per lo sviluppo di farmaci. Oltre a questo, FunMap permette di definire con maggiore chiarezza quali proteine sono direttamente coinvolte nello sviluppo tumorale, consentendo di evitare percorsi di ricerca non promettenti e di ottimizzare i tempi e le risorse. Lo sviluppo di farmaci anticancro è spesso ostacolato dalla complessità delle interazioni cellulari. FunMap è una risorsa preziosa per superare questi ostacoli, consentendo ai ricercatori di concentrarsi su interventi mirati, riducendo gli effetti collaterali e aumentando l’efficacia delle terapie. FunMap rappresenta un avanzamento significativo nella ricerca sul cancro, combinando intelligenza artificiale e profilazione genetica per svelare le dinamiche tra proteine e geni. Questa mappa delle proteine non solo permette di identificare nuove relazioni tossiche, ma apre la strada a terapie più mirate ed efficaci. Il fatto che sia open source aumenta le possibilità di collaborazione e sviluppo rapido in tutto il mondo. La comprensione delle reti proteiche è la chiave per affrontare il cancro in modo più preciso ed efficace, offrendo nuove speranze ai pazienti di tutto il mondo. Con l’integrazione di ulteriori dati e il miglioramento degli algoritmi di analisi, FunMap potrebbe evolversi ulteriormente, diventando uno strumento indispensabile per la medicina di precisione e la ricerca oncologica futura. (C. P.).
Una nuova strada per il trattamento del tumore della vescica potrebbe aprirsi grazie alle ricerche di un gruppo di scienziati dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) e dell’Università degli Studi di Milano. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Communications, hanno condotto i ricercatori a scoprire il meccanismo molecolare alla base dell’aggressività biologica e clinica dei tumori della vescica. All’origine dell’intero processo ci sarebbe la proteina Numb, normalmente espressa nella vescica normale, ma che viene perduta in oltre il 40% di tutti i tumori vescicali umani.
Tale perdita causa una cascata di eventi molecolari che rendono il tumore altamente proliferativo e invasivo, consentendogli di oltrepassare gli strati superficiali della mucosa vescicale per raggiungere gli strati più profondi. Proprio questo evento rappresenta il punto di svolta nella evoluzione clinica della malattia, determinando la progressione dei tumori vescicali superficiali (cosiddetti non muscolo-invasivi) verso tumori profondi che richiedono l’intervento di rimozione chirurgica totale della vescica. Nonostante l’operazione radicale, le forme di malattia sono caratterizzate da un decorso clinico spesso sfavorevole.
«La proteina Numb funziona come un interruttore molecolare che, se è spento, accelera la progressione tumorale e influenza il decorso clinico della malattia. Rappresenta quindi un biomarcatore molecolare che consente di identificare i tumori superficiali a
elevato rischio di progressione verso tumori muscolo-invasivi», spiega Salvatore Pece, coordinatore dello studio, professore ordinario di Patologia generale e vice-direttore del dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell’Università Statale di Milano. Lo studio, sostenuto dai fondi della Fondazione Airc, rappresenta un esempio dell’auspicato passaggio dalla ricerca di base all’applicazione in ambito clinico.
«I criteri clinico-patologici – continua Pece – utilizzati nella routine per predire il

Lo studio dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) e dell’Università degli Studi di Milano ha osservato la proteina Numb che costituisce un biomarcatore nell’evoluzione della neoplasia
rischio di progressione dei tumori vescicali superficiali a tumori muscolo-invasivi sono infatti del tutto insufficienti e inadeguati a individuare i pazienti a basso rischio, che potrebbero beneficiare di trattamenti più mirati, di tipo conservativo, in protocolli di sorveglianza attiva. I pazienti ad alto rischio necessitano invece di trattamenti più aggressivi, quali la chemioterapia e l’asportazione chirurgica della vescica, che hanno purtroppo considerevoli effetti collaterali e un elevato impatto sulla qualità della vita».

Secondo le stime dell’Associazione italiana oncologia medica (Aiom), realizzate sulla base dei dati provenienti dai registri nazionali dei tumori, quello alla vescica in Italia negli uomini è il quarto più frequente (25.230 casi solo nel 2024).
«Al momento della diagnosi iniziale – ricorda il docente – i tumori della vescica si presentano in larga maggioranza come tumori superficiali non muscolo-invasivi, che sono generalmente caratterizzati da una buona prognosi. Solo in una percentuale ridotta si presentano invece sin dal principio come tumori profondi muscolo-invasivi, molto aggressivi e con decorso clinico meno favorevole.
Per questo necessitano di chemioterapia e di intervento di cistectomia radicale. Questo ha fatto storicamente considerare i tumori superficiali e quelli profondi come due patologie differenti sin dal principio, guidate da differenti meccanismi molecolari. Tuttavia circa il 20-30% dei tumori superficiali possono evolvere in tumori muscolo-invasivi. L’esperienza clinica ci ha insegnato che i tumori muscolo-invasivi che derivano dalla progressione di tumori inizialmente superficiali rappresentano le forme più aggressive e potenzialmente letali di tumore vescicale.
I nostri studi – prosegue – dimostrano invece che i tumori vescicali superficiali e quelli profondi rappresentano stadi differenti di un unico processo patologico che evolve nel tempo, guidato già dal principio da specifici meccanismi molecolari che possono essere ostacolati con farmaci precisi e mirati. Diventa quindi fondamentale identificare i meccanismi biologici alla base di questa evoluzione e sviluppare nuovi marcatori molecolari per identificare i pazienti con caratteristiche specifiche di aggressività.
In questo contesto, la nostra scoperta apre la strada a nuove strategie terapeutiche per combattere il cancro vescicale in una elevata percentuale di pazienti che presentano tumori privi di espressione della proteina. Abbiamo anche identificato – conclude il docente – una nuova firma molecolare che consentirà di identificare con accurata precisione i pazienti che potranno beneficiare di trattamenti mirati con nuovi farmaci che colpiscono in maniera specifica i meccanismi molecolari che sono attivati a seguito della perdita di Numb». (E. G.).

All’origine dell’intero processo ci sarebbe la proteina Numb, normalmente espressa nella vescica normale, ma che viene perduta in oltre il 40% di tutti i tumori vescicali umani. Tale perdita causa una cascata di eventi molecolari che rendono il tumore altamente proliferativo e invasivo, consentendogli di oltrepassare gli strati superficiali della mucosa vescicale per raggiungere gli strati più profondi. Proprio questo evento rappresenta il punto di svolta nella evoluzione clinica della malattia, determinando la progressione dei tumori vescicali superficiali (cosiddetti non muscolo-invasivi) verso tumori profondi che richiedono l’intervento di rimozione chirurgica totale della vescica.

I risultati ottenuti individuano nella proteina HuD un ruolo cruciale in un momento precoce della malattia, suggerendola quindi come un possibile target in ambito terapeutico. © Kateryna Kon/shutterstock.com

Contro la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) sono molteplici gli studi che negli ultimi anni hanno attirato l’attenzione per le possibili strade terapeutiche da percorrere. Ultimo, solo in ordine di tempo, è il lavoro, coordinato dal dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” della Università Sapienza di Roma, in collaborazione con l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova e l’Università di Pittsburgh, che ha osservato in particolare il coinvolgimento della proteina HuD nei difetti della giunzione neuromuscolare e come la regolazione di questa possa essere sfruttata per lo sviluppo di possibili trattamenti.
La ricerca, pubblicata di recente sulla rivista Nature Communications, punta proprio alla proteina, indicandola quale nuovo probabile bersaglio terapeutico. Ci sarebbe infatti un legame tra la regolazione anomala di HuD e i disturbi della giunzione neuromuscolare considerati tra i primi tratti distintivi nei pazienti affetti.
La Sla è una malattia neurodegenerativa invalidante, causata dalla perdita progressiva della funzionalità dell’apparato muscolo scheletrico, dovuta alla morte dei neuroni motori, le cellule nervose che stimolano la contrazione muscolare permettendo il movimento e altre funzioni importanti. Quando nei pazienti i neuroni motori degenerano, i muscoli volontari non ricevono più stimoli dal cervello e si atrofizzano, portando così alla paralisi completa. La malattia colpisce nella fascia di età compresa tra i 40 e i 70 anni, nella stragrande maggioranza degli individui affetti, in modo sporadico, senza cioè che siano coinvolti altri membri del nucleo familiare, mentre esordisce in maniera più precoce nei casi ereditari, che corrispondono a circa il 10% della popolazione dei malati.
La ricerca appena pubblicata ha mostrato
come livelli elevati di proteina HuD possano portare a difetti alla giunzione neuromuscolare, con conseguente degenerazione dei neuroni motori. Secondo l’ipotesi del meccanismo “dying-back”, la rottura della giunzione non solo precede, ma innesca anche la successiva degenerazione dei motoneuroni nella forma sporadica e familiare. Riducendo quindi i livelli della proteina con terapie mirate si potrebbero limitare i disturbi della giunzione neuromuscolare nei pazienti.
«I risultati ottenuti individuano in questa proteina un ruolo cruciale in un momento precoce della malattia, suggerendola quindi come un possibile target in ambito terapeutico», ha sottolineato Alessandro Rosa, coordinatore del gruppo di lavoro presso il dipartimento di Biologia e Biotecnologie dell’Ateneo romano, a cui hanno contribuito anche i ricercatori Alessio Colantoni e Monica Ballarino.
Il progetto è stato finanziato con i fondi del Pnrr, nell’ambito del Centro nazionale 3, Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a Rna. Si stima che in Italia siano colpite dalla Sla circa 6mila persone e che il numero di pazienti sia in media di 5-7 casi ogni 100mila abitanti. I sintomi variano da persona a persona, ma fra i principali, ai primordi, possono esserci: perdita di forza muscolare, difficoltà nei movimenti e nel linguaggio.
Ad oggi, esistono solo terapie capaci di ridurre i sintomi della malattia, ma non esiste una cura per fermarne la progressione. Nel nostro Paese, il farmaco indicato è il riluzolo, in grado di rallentare il decorso della malattia, ma solo di alcuni mesi. L’aspettativa di vita dopo la diagnosi è in media di 3-5 anni, ma varia da persona a persona anche in questo caso poiché circa il 20% vive oltre i cinque anni e circa il 10% oltre i dieci.
Il farmaco approvato solo per una minoranza di pazienti Nel 2024 il Comitato per i farmaci a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha autorizzato l’immissione in commercio di Tofersen (Qallody, Biogen), una nuova terapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da Sla che presentano una mutazione nel gene della superossido dismutasi 1 (SOD1), presente in circa il 2% dei pazienti. Il Comitato ha valutato i dati presentati dalla casa produttrice sulla base di sperimentazioni precliniche e cliniche. L’Ema ha precisato tuttavia che si tratta di una approvazione condizionata, riservata a casi eccezionali, dal momento che l’azienda dovrà presentare ulteriori dati per “caratterizzare la sicurezza e l’efficacia a lungo termine di Tofersen”, al fine di ottenere un via libera a lungo termine. L’Agenzia “valuterà se l’uso di Tofersen possa ritardare o addirittura prevenire l’insorgenza di Sla clinicamente manifesta nei pazienti presintomatici con mutazione SOD1”.
Uno studio, coordinato dall’Università Sapienza, ha osservato la sovraespressione I risultati permettono di considerare ulteriori sviluppi

di Elisabetta Gramolini

Un nuovo studio ha dimostrato che GDF15 è coinvolta nelle disfunzioni metaboliche che caratterizzano la progressione della malattia e potrebbe diventare un bersaglio terapeutico
Negli ultimi anni le ricerche sulla sclerosi laterale amiotrofica (SLA) si sono moltiplicate e la speranza di trovare presto una cura definitiva si fa sempre più concreta. Un ultimo passo avanti è stato da poco compiuto grazie a uno studio internazionale, coordinato dall’Università Sapienza di Roma, che ha individuato un nuovo potenziale biomarcatore e bersaglio terapeutico della malattia.
Nella ricerca, pubblicata sulla rivista Brain Behavior and Immunity, gli autori hanno dimostrato il coinvolgimento nella progressione della SLA del fattore di differenziazione della crescita 15 (GDF15), una proteina già nota per causare la riduzione dell’appetito con conseguente eccessiva perdita di peso nei malati affetti da SLA e da diverse altre malattie.
La perdita di peso è un’importante caratteristica clinica comune al momento della diagnosi della SLA e si correla negativamente con la sopravvivenza. Con una prevalenza stimata del 56%-62%, la diminuzione di peso è definita come un rilevante e indipendente fattore prognostico. Da diversi studi è anche emerso che il decorso della malattia è sfavorevole quando i pazienti perdono peso rapidamente o hanno un indice di massa corporea basso al momento della diagnosi. Come spiegano i ricercatori, la perdita di peso nei pazienti affetti da SLA inizia prima dell’esordio della malattia ed è associata a prognosi peggiori mentre le diete ipercaloriche aumentano la sopravvivenza nei pazienti. La ricerca della Sapienza nasce dalla volontà di comprendere i meccanismi responsabili della perdita di peso precoce nei pazienti affetti da SLA per cercare di prevenire l’alterazione del metabolismo energetico. È stato calcolato, infatti, che il 18-47% dei pazienti soffre di anoressia e che questa percentuale aumenta con il progredire della malattia.
I risultati dello studio hanno dimostrato che GDF15 è altamente espressa nel sangue periferico e in campioni di tessuto umano a livello della corteccia cerebrale motoria, nel midollo spinale e nel tronco encefalico.
I ricercatori, coordinati da Cristina Limatola della Sapienza, insieme ai colleghi dell’Università di Amsterdam, si sono in seguito focalizzati sul recettore della proteina, GFRAL, presente nei neuroni di una regione specifica del sistema nervoso centrale e cioè l’area postrema e il nucleo del tratto solitario. Gli scienziati hanno dimostrato che il silenziamento localizzato solo in queste aree di GFRAL induce un aumento di peso e favori-
sce l’assunzione di cibo, riduce il deperimento del tessuto adiposo, migliora la funzione motoria e l’atrofia muscolare e prolunga il tempo di sopravvivenza. I ricercatori hanno anche scoperto che le cellule microgliali potrebbero avere un ruolo nella mediazione di questi effetti perché la loro deplezione riduce l’espressione di GDF15 nel tronco encefalico, la perdita di peso e l’espressione di geni lipolitici nel tessuto adiposo. Nel complesso, i risultati del lavoro rivelano un ruolo chiave della segnalazione GDF15-GFRAL nella regolazione della perdita di peso e dell’alterazione del metabolismo lipidico nelle prime fasi della SLA.
La SLA è una malattia caratterizzata dalla degenerazione progressiva dei motoneuroni e dalla paralisi muscolare. I primi segni della malattia compaiono quando la perdita progressiva dei motoneuroni supera la capacità di compenso dei motoneuroni superstiti fino ad arrivare a una progressiva perdita di forza muscolare, ma, nella maggior parte dei casi, con risparmio delle funzioni cognitive, sensoriali, sessuali e sfinteriali. Nonostante i trattamenti utilizzati, la sopravvivenza dei pazienti dopo la diagnosi iniziale è di solo 3-5 anni. In Italia, secondo l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA), sono più di 6mila le persone affette da SLA e circa 2mila i nuovi casi previsti ogni anno.
In sintesi possiamo dire che la ricerca mette in luce l’importanza di aumentare l’attenzione sull’aspetto nutrizionale e sui cambiamenti metabolici nei pazienti affetti da SLA per anticipare la diagnosi della malattia e per sviluppare interventi terapeutici innovativi.
«Questo studio - commenta Cristina Limatola del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia della Sapienza - contribuisce ad aumentare la nostra comprensione dei meccanismi alla base della sclerosi laterale amiotrofica. Sappiamo, infatti, che la SLA non è più definibile come una patologia del motoneurone, perché numerose alterazioni sono state descritte a carico della componente gliale e del sistema immunitario prima che si manifestino sintomi nei pazienti e prima che sia misurabile un danno neurodegenerativo».
«La nostra scoperta - termina la responsabile dello studio - del coinvolgimento della citochina GDF15 nella perdita di peso che precede la manifestazione dei sintomi della SLA conferma l’importanza di un approccio olistico per una diagnosi precoce della malattia e l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici». (S. B.).

La perdita di peso è un’importante caratteristica clinica comune al momento della diagnosi della SLA e si correla negativamente con la sopravvivenza. Con una prevalenza stimata del 56%-62%, la diminuzione di peso è definita come un rilevante e indipendente fattore prognostico. Da diversi studi è anche emerso che il decorso della malattia è sfavorevole quando i pazienti perdono peso rapidamente o hanno un indice di massa corporea basso al momento della diagnosi. Come spiegano i ricercatori, la perdita di peso nei pazienti affetti da SLA inizia prima dell’esordio della malattia ed è associata a prognosi peggiori mentre le diete ipercaloriche aumentano la sopravvivenza nei pazienti.


La ricerca ha messo in luce che i macrofagi presenti nei fusi muscolari svolgono anche un ruolo di supporto al metabolismo del sistema nervoso durante la contrazione muscolare e la locomozione, che evita che il movimento si esaurisca. Lo studio ha identificato un nuovo componente cellulare che regola direttamente l’attività neurale e la contrazione muscolare. La segnalazione mediata dal glutammato dei macrofagi del fuso muscolare e la risposta dinamica di questi ultimi ai segnali sensoriali introducono una nuova dimensione alla nostra comprensione della sensazione e dell’azione motoria, offrendo potenzialmente approcci terapeutici innovativi nelle condizioni che influenzano la funzione sensomotoria. © CGN089/shutterstock.com
Una nuova classe di macrofagi specializzati è stata identificata per la prima volta all’interno del tessuto muscolare, dove svolge un ruolo chiave, e finora sconosciuto, nel controllo della contrazione del muscolo e della locomozione. La scoperta è dei ricercatori dell’Imperial College di Londra e ribalta le precedenti ipotesi secondo cui la contrazione e il movimento muscolare sono controllati esclusivamente dal sistema nervoso.
I macrofagi sono un tipo di cellule immunitarie presenti, oltre che nel sangue e nei siti d’infezione, in molti organi del corpo, tra cui il fegato, il cervello, le ossa e i polmoni. Prima di oggi però, nessuno aveva osservato la presenza dei macrofagi a stretto contatto con i fusi neuromuscolari, lì dove il team inglese, guidato da Simone di Giovanni del Dipartimento di Scienze del Cervello, ha scoperto che svolgono in realtà più di un compito.
I ricercatori hanno osservato che questa nuova popolazione di macrofagi specializzati si comporta in modo simile ai neuroni, esprimendo il macchinario per il trasporto, la sintesi e il rilascio del neurotrasmettitore glutammato. Per verificarlo gli scienziati hanno eseguito degli esperimenti bloccando il circuito su cui agivano i macrofagi e hanno osservato che i muscoli colpiti non si muovevano più correttamente.
Una successiva analisi dei geni coinvolti nei meccanismi del glutammato ha indicato un possibile ruolo nella neurotrasmissione eccitatoria, nell’esocitosi sinaptica, nel controllo dell’equilibrio neuromuscolare e nella sinapsi glutammatergica, funzioni tipiche dei neuroni piuttosto che dei macrofagi. Queste, spiegano i ricercatori, sono caratteristiche molecolari e cellulari che possono consentire alle cellule immunitarie di modulare l’attività neurale nei fusi muscolari e, in ultima analisi, di influenzare la contrazione muscolare.
Come si legge nell’articolo, per sopravvivere i mammiferi si affidano a movimenti complessi. Tra questi, il riflesso da stiramento è un meccanismo fondamentale che fornisce un feedback sensoriale che genera risposte adattive da cui dipende la sopravvivenza. Questo tipo di riflesso rappresenta una risposta neurale fondamentale a stimoli meccanici esterni ed è cruciale per il mantenimento della funzione motoria coordinata. Lo stiramento muscolare attiva i recettori specializzati situati nei fusi muscolari che stimolano le afferenze sensoriali propriocettive: que-
ste entrano in sinapsi direttamente con i motoneuroni, guidando la contrazione muscolare. Fin dagli esperimenti di Sherrington alla fine del XIX secolo, il riflesso da stiramento è stato considerato un circuito neuromuscolare ad anello chiuso. Il nuovo studio ha invece smentito questa convinzione identificando nei fusi muscolari una classe di macrofagi che rilasciano glutammato e regolano la funzione muscolare.
La ricerca inglese, che è stata pubblicata su Nature, ha anche messo in luce che i macrofagi presenti nei fusi muscolari svolgono anche un ruolo di supporto al metabolismo del sistema nervoso durante la contrazione muscolare e la locomozione, che evita che il movimento si esaurisca.
Secondo gli autori, lo studio ha identificato un nuovo componente cellulare che regola direttamente l’attività neurale e la contrazione muscolare. La segnalazione mediata dal glutammato dei macrofagi del fuso muscolare e la risposta dinamica di questi ultimi ai segnali sensoriali introducono una nuova dimensione alla nostra comprensione della sensazione e dell’azione motoria, offrendo potenzialmente approcci terapeutici innovativi nelle condizioni che influenzano la funzione sensomotoria.
Di Giovanni, autore responsabile dello studio, ha dichiarato: «La scoperta, non solo di queste cellule immunitarie a stretto contatto con i fusi muscolari, ma anche del fatto che svolgono un ruolo chiave nel movimento, è molto interessante. Questa conoscenza – ha proseguito il ricercatore - ha potenziali implicazioni per condizioni come la sindrome da fatica cronica e altre malattie del sistema immunitario, muscolare e nervoso che influenzano direttamente il movimento».
I risultati dello studio hanno inoltre effetti a lungo termine sulle regole cellulari e molecolari che controllano le interazioni immunoneuronali nella fisiologia neuromuscolare. Secondo gli autori potrebbe esserci implicata la possibilità che l’immunosoppressione e le malattie del sistema immunitario innato che colpiscono i monociti-macrofagi possano compromettere la funzione neuromuscolare dei fusi.
Infine, la scoperta potrebbe avere una rilevanza diretta per trattare le condizioni in cui la propriocezione, il tono muscolare e la contrazione sono compromessi, tra cui le lesioni del midollo spinale, la distrofia muscolare miotonica, le neuropatie periferiche, le lesioni nervose e il diabete. (S. B.).

I ricercatori dell’Imperial College hanno identificato all’interno dei fusi neuromuscolari una nuova popolazione di macrofagi in grado di comportarsi in modo simile ai neuroni

La scoperta apre a nuove terapie basate sull’esercizio fisico per riparare i nervi danneggiati da lesioni o da malattie neurodegenerative, ripristinando così il movimento
Praticare sport offre benefici a tutto l’organismo, ma ora i ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno scoperto qualcosa in più: quando i muscoli si allenano, stimolano la velocità di crescita dei motoneuroni che diventa fino a quattro volte più rapida. La ricerca, pubblicata su Advanced Healthcare Materials, getta nuova luce sulla comunicazione incrociata che avviene tra muscoli e nervi durante l’esercizio fisico e apre a possibili strategie mirate ed efficaci per il trattamento di lesioni nervose in cui avviene un’interruzione nella comunicazione tra nervo e muscolo.
Lo studio ha previsto diverse fasi sperimentali. Durante la prima, gli ingegneri del MIT hanno coltivato cellule muscolari fino a ottenere un pezzetto di tessuto grande quanto una monetina; hanno poi modificato geneticamente il muscolo per farlo contrarre in risposta alla luce e l’hanno “bombardato” di flash per provocarne la contrazione, simulando così l’esercizio fisico e la conseguente produzione di proteine dette miochine. Come si legge nello studio, quando i muscoli si contraggono durante l’attività fisica, funzionano come un organo endocrino, producendo e rilasciando in circolo una serie di segnali biochimici chiamati miochine che agiscono su vari organi e apparati.
«Possiamo pensare alle miochine come a una sorta di zuppa biochimica di sostanze che i muscoli secernono, alcune delle quali potrebbero essere utili per i nervi e altre no», spiega Ritu Raman, autrice responsabile dello studio e ricercatrice del dipartimento di ingegneria meccanica dell’MIT. «I muscoli – prosegue Raman - secernono sempre miochine, ma durante l’esercizio ne producono di più».
L’équipe ha proseguito gli studi in laboratorio trasferendo la soluzione di miochine nel piatto contenente motoneuroni (le cellule del sistema nervoso che controllano i movimenti volontari) fatti crescere da cellule staminali. Dopo che i motoneuroni sono stati esposti alla miscela proteica, il team ha osservato che le cellule nervose hanno iniziato a crescere rapidamente, quattro volte più velocemente rispetto ai neuroni che non avevano ricevuto la soluzione biochimica. Secondo i ricercatori questi esperimenti suggeriscono che l’esercizio fisico può avere un rilevante effetto biochimico sulla crescita dei nervi.
Per indagare più nel dettaglio come i neuroni cambiano in risposta all’esposizione alle miochine, il team ha condotto un’analisi genetica estraen-

I risultati dello studio dell’MIT aprono un possibile sviluppo di terapie mirate alla crescita e al ripristino di nervi danneggiati da incidenti o malattie neurodegenerative come la Sla. «Forse – afferma Ramanstimolando il muscolo, potremmo sollecitare il nervo a guarire e restituire la mobilità a chi l’ha persa a causa di lesioni traumatiche o malattie neurodegenerative».
© Sinhyu Photographer/shutterstock.com
do l’RNA dai neuroni e verificato se le miochine producessero variazioni nell’espressione di alcuni geni neuronali. «Abbiamo visto che molti dei geni regolati nei neuroni stimolati dall’esercizio fisico non erano solo legati alla crescita dei neuroni, ma anche alla loro maturazione, alla loro capacità di comunicare con i muscoli e gli altri nervi e alla maturità degli assoni», spiega Raman. «L’esercizio fisico sembra quindi avere un impatto non solo sulla crescita dei neuroni, ma anche sulla loro maturazione e sul loro buon funzionamento».
Dopo aver dimostrato gli effetti biochimici dell’esercizio fisico sulla crescita dei neuroni, il team si è chiesto se gli effetti puramente fisici dell’attività sportiva potessero avere un beneficio simile. «I neuroni sono fisicamente attaccati ai muscoli, quindi si allungano e si muovono con il muscolo», spiega Raman. «Abbiamo quindi voluto verificare se, in assenza di segnali biochimici provenienti dal muscolo, l’allungamento dei neuroni provocato da forze meccaniche, simili a quelle prodotte dall’esercizio fisico, potesse avere un impatto anche sulla crescita».
Per rispondere a questa domanda, i ricercatori hanno dato il via alla seconda fase sperimentale in cui hanno fatto crescere un’altra serie di motoneuroni su un tappetino di gel con incorporati piccoli magneti. Hanno poi usato un magnete esterno per muovere avanti e indietro il tappeto e quindi i neuroni, “allenandoli” per trenta minuti al giorno. Con grande sorpresa, gli ingegneri hanno scoperto che questo esercizio meccanico stimolava le cellule nervose a crescere tanto quanto quelle che erano state esposte alle miochine. Secondo Raman questo rappresenta un risultato positivo perché dimostra per la prima volta che gli effetti biochimici e meccanici dell’esercizio fisico sono ugualmente importanti.
I risultati dello studio dell’MIT aprono anche a un possibile sviluppo di terapie mirate alla crescita e al ripristino di nervi danneggiati da incidenti o malattie neurodegenerative come la Sla. «Ora che sappiamo che esiste questo tipo di comunicazione tra muscoli e nervi, può essere utile sfruttare le nuove conoscenze emerse per trattare danni come le lesioni nervose, in cui la comunicazione tra il nervo e il muscolo è interrotta», afferma Raman. «Forse – termina l’autrice - stimolando il muscolo, potremmo sollecitare il nervo a guarire e restituire la mobilità a chi l’ha persa a causa di lesioni traumatiche o malattie neurodegenerative».

Come il colesterolo cattivo interagisce col recettore Nuove terapie promettenti
Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di mortalità nel mondo, colpendo una persona ogni trentatré secondi. Tra i fattori di rischio più significativi figura il colesterolo Ldl, spesso definito colesterolo cattivo. Una recente scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature dai ricercatori dei National Institutes of Health (Nih) statunitensi, ha gettato nuova luce sul meccanismo attraverso il quale il colesterolo Ldl si lega al suo recettore, aprendo la strada a trattamenti più efficaci per ridurne i livelli nel sangue.
La chiave di questa scoperta risiede nell’uso della criomicroscopia elettronica, una tecnica avanzata che consente di visualizzare molecole e strutture biologiche con una risoluzione senza precedenti. Grazie a questa tecnologia, i ricercatori sono riusciti a osservare in dettaglio la proteina strutturale del colesterolo Ldl mentre interagisce con il recettore Ldlr, un elemento fondamentale per il processo di smaltimento del colesterolo dal sangue. Questo livello di dettaglio rappresenta un passo avanti straordinario nella comprensione dei meccanismi molecolari alla base delle malattie cardiovascolari.
«Il colesterolo Ldl è uno dei principali fattori scatenanti delle malattie cardiovascolari che uccidono una persona ogni 33 secondi - ha dichiarato Alan Remaley, uno degli autori principali dello studio -. Se vuoi conoscere il tuo nemico, devi sapere che aspetto ha». La metafora sottolinea l’importanza di comprendere la struttura e il comportamento di questa molecola per sviluppare strategie terapeutiche più mirate. Un elemento importante dello studio è stato l’utilizzo di un software di intelligenza artificiale sviluppato dai vincitori del premio Nobel per la chimica del 2024. Questo software, capace di prevedere la struttura delle proteine, ha permesso di simulare con precisione il comportamento di alcune mutazioni genetiche che ostacolano il legame tra il colesterolo Ldl e il recettore Ldlr. Le mutazioni studiate sono state individuate come principali responsabili dell’ipercolesterolemia familiare, una condizione genetica che causa alti livelli di colesterolo Ldl nel sangue fin dalla nascita.
La simulazione ha rivelato che molte delle mutazioni associate all’ipercolesterolemia familiare si concentrano in regioni specifiche della molecola di Ldl, precisamente quelle che interagiscono con il recettore Ldlr. Questo dettaglio è di fondamentale importanza per comprendere come tali mutazioni possano interrompere il processo di smaltimento
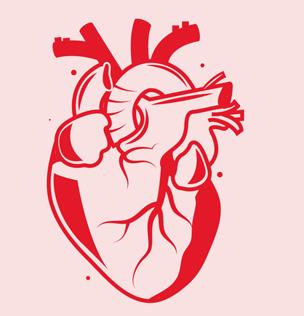
«Il colesterolo Ldl è uno dei principali fattori scatenanti delle malattie cardiovascolari che uccidono una persona ogni 33 secondi - ha dichiarato Alan Remaley, uno degli autori principali dello studio -. Se vuoi conoscere il tuo nemico, devi sapere che aspetto ha». La metafora sottolinea l’importanza di comprendere la struttura e il comportamento di questa molecola per sviluppare strategie terapeutiche più mirate.
© HM JONAYED/shutterstock.com
del colesterolo, portando alla formazione di placche aterosclerotiche nelle arterie. Questa scoperta apre nuove prospettive per lo sviluppo di terapie farmacologiche più efficaci. Attualmente, i farmaci più utilizzati per abbassare il colesterolo Ldl sono le statine, che agiscono riducendo la produzione di colesterolo da parte del fegato.
Tuttavia, le statine non sono sempre efficaci nei pazienti affetti da ipercolesterolemia familiare, a causa della natura genetica della loro condizione. La nuova comprensione del legame tra Ldl e Ldlr potrebbe portare alla progettazione di farmaci specificamente mirati a migliorare questa interazione, anche in presenza di mutazioni genetiche. Inoltre, la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale per prevedere l’impatto di mutazioni genetiche offre una potente piattaforma per lo sviluppo di terapie personalizzate. Questa tecnologia potrebbe essere utilizzata non solo per identificare nuovi target terapeutici, ma anche per testare l’efficacia di farmaci esistenti in contesti genetici specifici.
Questa scoperta potrebbe avere implicazioni significative per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. La comprensione delle mutazioni genetiche e del loro ruolo nell’ipercolesterolemia potrebbe portare a programmi di screening genetico più diffusi, consentendo di identificare precocemente i soggetti a rischio e intervenire prima che si sviluppino complicazioni gravi.
Mentre, una maggiore consapevolezza dei meccanismi molecolari alla base delle malattie cardiovascolari potrebbe incentivare campagne di educazione sanitaria volte a promuovere stili di vita sani. Ridurre il consumo di grassi saturi e trans, aumentare l’attività fisica e smettere di fumare rimangono interventi fondamentali per ridurre il rischio di aterosclerosi e altre condizioni correlate. Grazie all’impiego di tecnologie d’avanguardia come la criomicroscopia elettronica e l’intelligenza artificiale, i ricercatori hanno fatto luce su un processo biologico cruciale, aprendo la strada a terapie più efficaci e personalizzate. «Questa scoperta ci avvicina a una comprensione completa delle basi molecolari delle malattie cardiovascolari», ha concluso Alan Remaley. «Siamo solo all’inizio, ma i progressi fatti finora sono estremamente promettenti». In un futuro non troppo lontano, queste conoscenze potrebbero trasformarsi in strumenti concreti per salvare milioni di vite, dimostrando ancora una volta il potenziale rivoluzionario della scienza e della tecnologia. (C. P.)
I risultati dell’indagine conoscitiva promossa dalla Fnob in collaborazione con la Sierr, la Società italiana di embriologia, riproduzione e ricerca di Valerio Pisaturo*

* Presidente società italiana di embriologia, riproduzione e ricerca
Il settore della riproduzione umana si afferma come uno degli ambiti più dinamici della biologia moderna. Il crescente ritardo nell’età della prima gravidanza, combinato con l’aumento delle problematiche legate all’infertilità, ha reso l’embriologia clinica una disciplina cruciale. In un’epoca segnata da un calo demografico senza precedenti, questo campo non solo si evolve rapidamente ma assume anche un ruolo strategico per affrontare le sfide della denatalità.
Nel corso del 2024, la Federazione Nazionale dell’Ordine dei Biologi (Fnob), in collaborazione con la Società Italiana di Embriologia, Riproduzione e Ricerca (Sierr), che già in passato hanno strettamente collaborato sulla tutela della figura professionale, hanno promosso un’indagine conoscitiva rivolta ai professionisti che operano nei laboratori di riproduzione umana assistita.
L’indagine mirava a raccogliere dati utili per avviare un dialogo con le istituzioni, finalizzato alla creazione di percorsi formativi standardizzati e ufficialmente riconosciuti, con l’obiettivo di valorizzare e legittimare ulteriormente la professione. Hanno risposto 320 biologi che operano in tutta
Italia, ed è stato possibile raccogliere dati sulla distribuzione anagrafica, sull’esperienza professionale, sulle competenze acquisite, sulle condizioni contrattuali e sulle necessità formative.
I risultati emersi offrono un importante spunto di riflessione e pongono all’attenzione della comunità la necessità di sviluppare politiche formative e professionali mirate, oltre ad affrontare le problematiche legate alla stabilità lavorativa e al riconoscimento formale della professione. L’indagine ha evidenziato come la maggior parte degli embriologi clinici sia composta da professionisti giovani, con il 44% degli intervistati di età compresa tra i 30 e i 40 anni, e un ulteriore 10% sotto i 30 anni.
Al contempo, emerge una percentuale significativa di professionisti con un’esperienza consolidata, con il 35% degli intervistati che vanta più di 15 anni di esperienza nel settore. Questa distribuzione demografica e di esperienza professionale suggerisce che la professione stia vivendo una fase di rinnovamento, con l’ingresso di giovani biologi, ma anche con una solida presenza di esperti, che costituiscono una risorsa fondamentale per il settore.

Riguardo alle competenze acquisite, oltre il 75% degli intervistati ha dichiarato di possedere una preparazione elevata in molte delle principali aree dell’embriologia clinica, come il trattamento del campione seminale chirurgico, la crioconservazione di gameti ed embrioni, l’ICSI, l’embryo transfer e la diagnostica seminale.
Tuttavia, alcune competenze più specialistiche, come la crioconservazione del tessuto ovarico (22%) e la biopsia del trofoectoderma (39%), risultano meno diffuse, indicando che queste aree sono ancora in fase di sviluppo e richiedono un’ulteriore attenzione, sia a livello formativo sia pratico.
Un aspetto che emerge con particolare rilevanza è quello legato alla tipologia di impiego degli embriologi clinici. Il 47% degli intervistati è impiegato nel settore privato, mentre il 35% lavora nel settore pubblico e il 18% nel privato convenzionato. Sebbene la diversificazione dei settori di impiego dimostri la flessibilità della professione, i dati relativi alla tipologia di contratto sono preoccupanti.
Il 40% degli intervistati lavora come libero professionista, una percentuale che raggiunge livelli critici nel settore privato, dove oltre il 60% degli embriologi è impiegato con contratti libero professionale. Questo dato riflette una crescente precarizzazione del lavoro, con un’incidenza significativa di contratti non stabili, in particolare nel settore privato, dove il ricorso a contratti a tempo indeterminato è ridotto al 30%.
Al contrario, nel settore pubblico la percentuale di contratti a tempo indeterminato raggiunge il 64% ma anche in questo caso il lavoro libero professionale è presente in modo rilevante, con il 16% degli embriologi che operano come liberi professionisti anche nel Servizio Sanitario Nazionale. In questo scenario è chiaro che una delle necessità urgenti sia quella di migliorare le condizioni contrattuali degli embriologi, soprattutto nel settore privato. La diffusione della libera professione, sebbene offra una certa flessibilità, comporta anche un’elevata instabilità lavorativa e una mancanza di tutele adeguate.
È fondamentale, pertanto, incentivare forme contrattuali più stabili e tutelanti, in particolare per i professionisti che operano nel settore privato e privato convenzionato. Allo stesso modo, è cruciale che vengano adottate politiche in grado di favorire l’ingresso di giovani professionisti con contratti a tempo indeterminato, dando maggio-

Il settore della riproduzione umana si afferma come uno degli ambiti più dinamici della biologia moderna. Il crescente ritardo nell’età della prima gravidanza, combinato con l’aumento delle problematiche legate all’infertilità, ha reso l’embriologia clinica una disciplina cruciale. In un’epoca segnata da un calo demografico senza precedenti, questo campo non solo si evolve rapidamente ma assume anche un ruolo strategico per affrontare le sfide della denatalità.


È indispensabile che le istituzioni competenti intervengano per regolamentare la professione, definendo in modo chiaro le modalità di formazione, le competenze necessarie e le condizioni di lavoro. È necessario garantire che tutti i professionisti del settore abbiano accesso a un percorso di formazione continua che permetta loro di restare al passo con i rapidi sviluppi tecnologici e scientifici del campo.
© YAKOBCHUK VIACHESLAV/shutterstock.com
re sicurezza alle nuove generazioni di embriologi. Parallelamente, emerge un altro dato preoccupante relativo alla formazione. Solo l’8% degli intervistati ha conseguito o sta conseguendo una scuola di specializzazione affine al settore, titolo che risulta obbligatorio per l’accesso alle posizioni nel settore pubblico. La maggior parte degli embriologi ha solo il diploma di laurea (65%), e solo una parte di essi ha integrato la laurea con un Master (22%). La scarsa presenza di un percorso formativo specialistico dedicato alla figura dell’embriologo clinico evidenzia la necessità di sviluppare percorsi ad hoc che consentano l’acquisizione del titolo di specializzazione e che possano formare professionisti altamente qualificati, con competenze specifiche adeguate alla crescente complessità che caratterizza questo settore. La frammentazione nelle specializzazioni, con una predominanza delle scuole di Genetica Medica e di Patologia clinica, dimostra che il settore è in cerca di un indirizzo formativo unificato, in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze di un settore in continua evoluzione. Un programma di specializzazione mirato a formare embriologi clinici è oggi essenziale per garantire una qualità del lavoro in linea con le necessità del campo della PMA. È indispensa-
bile che le istituzioni competenti intervengano per regolamentare la professione, definendo in modo chiaro le modalità di formazione, le competenze necessarie e le condizioni di lavoro.
Inoltre, è necessario garantire che tutti i professionisti del settore abbiano accesso a un percorso di formazione continua che permetta loro di restare al passo con i rapidi sviluppi tecnologici e scientifici del campo. Sulla base di quanto su riportato, la creazione del Coordinamento Nazionale Biologi Genetisti, Embriologi e Biologi Molecolari (Cnbg) della Fnob e la stretta collaborazione tra Fnob e SIERR rappresentano un passo indispensabile e fondamentale per dare voce alle esigenze degli embriologi clinici e per promuovere un cambiamento positivo nelle politiche di formazione e impiego. La definizione di un percorso formativo specifico, l’adozione di contratti di lavoro più stabili e l’affermazione della figura dell’embriologo clinico rappresentano passi decisivi per garantire la qualità nel settore della procreazione assistita in Italia. Per maggiori approfondimenti sull’indagine e per visionare i grafici, consulta la notizia completa sul sito della Fnob, all’indirizzo https:// www.fnob.it/2024/12/10/la-figura-dellembriologo-clinico-in-italia/
Con il patrocinio di


Come riscoprire e adattare il prezioso patrimonio alimentare della Dieta Mediterranea per migliorare la nostra salute in un mondo in continua evoluzione
di Matteo Pillitteri e Dario Incorvaia*

Il progresso medico scientifico, una sana alimentazione di tipo mediterraneo e uno stile di vita sano hanno ridotto i tassi di mortalità e secondo i dati del Global Burden of Disease, tra il 1950 e il 2021 l’aspettativa di vita globale è aumentata di quasi 23 anni, passando da 49 a 71,7 anni.
I benefici della Dieta Mediterranea dipendono soprattutto dalla sinergia delle sue componenti costituita da cibi freschi, di stagione, locali e di origine vegetale, che ha scientifi-
* Biologi nutrizionisti
camente dimostrato una riduzione del rischio di malattie cardiache, diabete e altre patologie croniche. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità le cosiddette malattie non trasmissibili, come ad esempio le cardiopatie, il diabete mellito di tipo 2, varie tipologie di tumori e le patologie respiratorie croniche, rappresentano la causa principale di morte nel mondo e hanno la peculiarità di poter essere prevenute attraverso un corretto stile di vita che comprenda attività fisica regolare e un’alimentazione sana caratterizzata da un elevato apporto di frutta, verdura, cereali integrali, legumi e fonti di grassi sani.
La Dieta Mediterranea, regime alimentare equilibrato completo di tutti i nutrienti che sono disposti in quantità ottimali e che rispettano la piramide alimentare, nel 2010 è stata proclamata “Patrimonio innaturale dell’umanità” dall’UNESCO, grazie alla sua valenza culturale e al ruolo protettivo nei confronti delle malattie cronico-degenerative. La Dieta Mediterranea è lo stile di vita più studiato al mondo. Siamo depositari inconsapevoli di uno stile alimentare le cui virtù e corretto equilibrio sono prese a modello in tutti i Paesi del mondo e rappresenta il modello di dieta sana e sostenibile per eccellenza, poiché racchiude in sé la capacità di apportare benefici in termini di salute, ambiente, società ed economia.
L’Italia è il Paese simbolo della Dieta Mediterranea e dove più radicata è la cultura alimentare basata su ingredienti tipici del territorio (alimenti vegetali, cereali, pesce, uova, latte e derivati, olio d’oliva, un moderato consumo di carne e non più di un bicchiere di buon vino a pasto), capaci di forni -

re tutti i nutrienti necessari per godere di una buona salute.
Un’altra positiva caratteristica è la presenza di piatti unici composti da una sola portata e in grado di fornire tutti i nutrienti che normalmente sono introdotti da più pasti.
Il primo a intuire i benefici della Dieta Mediterranea fu negli anni 50 Ancel Keys, un fisiologo nutrizionista americano, il quale durante il suo lungo soggiorno italiano notò un curioso paradosso: i popoli mediterranei, pur assumendo nella loro alimentazione livelli di grassi animali simili a quelli assunti dal popolo statunitense, evidenziano una minor incidenza in malattie cardiovascolari.
Tutto questo in una situazione di severa difficoltà economica e di limitazione delle risorse a causa della seconda guerra mondiale, condizioni che favorivano uno stile di vita fisicamente attivo e frugale, con una predominanza di prodotti vegetali e scarsità di prodotti di origine animale nell’alimentazione quotidiana. Keys, tornato in patria, proseguì tali ricerche culminate nella pubblicazione del famoso “Seven Countries Study”, uno studio epidemiologico osservazionale, condotto in 12.770 abitanti di età compresa tra i 40 e 59 anni scelti in maniera casuale finalizzato a misurare gli effetti sul sistema cardiovascolare degli stili alimentari di diverse aree del mondo: Giappone, USA, Nord Europa e i paesi affacciati sul Mediterraneo, con un follow up di 25 anni.

La Dieta Mediterranea, regime alimentare equilibrato completo di tutti i nutrienti che sono disposti in quantità ottimali e che rispettano la piramide alimentare, nel 2010 è stata proclamata “Patrimonio innaturale dell’umanità” dall’UNESCO, grazie alla sua valenza culturale e al ruolo protettivo nei confronti delle malattie cronico-degenerative
Secondo i suoi studi e le sue intuizioni il motivo è da ricercarsi nell’azione dell’olio d’oliva, che controbilancia i grassi animali abbassando i livelli di colesterolo, nonché nel consumo di vegetali, frutta e verdura, che si rivelano un potente fattore protettivo grazie al loro apporto di antiossidanti.
I risultati non lasciarono dubbi: quanto più l’alimentazione di queste popolazioni si allontanava dagli schemi mediterranei maggiore era l’incidenza delle suddette patologie. L’ipotesi iniziale di Keys era a quel punto confermata e la Dieta Mediterranea fu proposta al mondo come regime alimentare ideale per ridurre l’incidenza delle cosiddette “malattie del benessere”. A conferma che le sue intuizioni erano fondate, Ancel Keys e la moglie Margaret nel 1962 decidono di trasferirsi in Italia, a Pioppi nel Cilento, “per allungare la vita di 20 anni” diceva lui. E ci riuscirono: lui morì a 100 anni, la moglie a 96. In tutte le popolazioni dei Paesi mediterranei, compresa l’Italia, soprattutto in questi ultimi dieci anni vi è un progressivo allontanamento dal modello alimentare tradizionale della dieta mediterranea soprattutto dei giovani.
Il tradizionale stile di vita mediterraneo oggi è stato sostituito da nuovi stili di vita e da un’alimentazione di qualità inferiore con i cibi low cost, fatta da alimenti in parte o totalmente trasformati in cibi pronti all’uso da parte di una industria alimentare che stimola a cibarsi soprattutto fuori casa, dalla colazione al bar ai pasti ai fast-food, tavola calde, pizzerie e apericena, frequentati soprattutto dai più giovani. Indubbiamente i rapidi cambiamenti indotti dalla globalizzazione alimentare hanno ampliato l’accesso a una vasta gamma di cibi provenienti da diverse culture e che sono entrati a far parte sempre più delle nostre abitudini alimentari in cui è quasi impossibile sottrarsi.
In questi ultimi anni assistiamo a un significativo declino progressivo nell’aderenza della Dieta Mediterranea attribuito principalmente a un aumento del consumo di carne rossa fresca, formaggi e pollame, accompagnato da una riduzione nell’assunzione di verdure, pane, legumi, pesce, latte e latticini.
I grandi mutamenti storici e il notevole sviluppo tecnologico hanno trasformato profondamente la società e gli stili di vita. Oggi purtroppo la Dieta Mediterranea è poco seguita, proprio nei paesi in cui è nata, a causa di molte

La dieta mediterranea non è superata, ma ha assolutamente bisogno di adattarsi ai tempi. Nonostante tutto, rimane infatti uno dei modelli alimentari più salutari, puntando maggiormente sulla limitazione calorica e sulla maggiore attività fisica. Adottare uno stile alimentare sano ed equilibrato, ricco di alimenti freschi e poco processati, può contribuire a invecchiare in salute e a prevenire molte malattie legate all’età.
‘contaminazioni’ dalla dieta stile occidentale, arricchita di cibi zuccherati, cibi di origine animale, cibi industriali e zuccheri semplici.
La frutta oggi cresce in serre e matura nei frigoriferi degli autotrasporti per avere tutto l’anno qualsiasi primizia, si favorisce la produzione di massa, prediligendo cibi low cost e la diffusione delle coltivazioni intensive e con odori e sapori cambiati dall’uso di additivi, conservanti ed esaltatori del gusto.
La globalizzazione alimentare ha inoltre contribuito a modificare sane abitudini alimentari attraverso il consumo di cibi e specialità dei vari paesi del mondo (cibi esotici, consumo di cibi cotti o precotti e maggiore tendenza al consumo di carne e pesce crudi) e producendo cibi a lunga conservazione e altamente palatabili, caratterizzati da un gusto intenso e facilmente apprezzabile dalla più ampia fascia di mercato.
Dobbiamo riappropriarci del cibo che nutre attraverso le scelte consapevoli. L’Unione Europea dovrebbe concentrarsi maggiormente nella difesa dei prodotti della Dieta Mediterranea e delle nostre filiere agroalimentari che sono a rischio contraffazione ed estinzione, piuttosto che aprire all’invasione orientale di cibi lontanissimi dalle nostre sane tradizioni. Un cibo sostenibile deve essere anche culturalmente accettabile e, se è vero che gli insetti sono considerati cibo in altri continenti, lo stesso non si può dire nelle nostre culture.
La dieta mediterranea non è superata, ma ha assolutamente bisogno di adattarsi ai tempi e ricevere una sferzata di buon senso e criticità. Nonostante tutto, questa dieta rimane infatti uno dei modelli alimentari più salutari, puntando maggiormente sulla limitazione calorica e sulla maggiore attività fisica. È importante diffondere campagne di informazione per sensibilizzare la popolazione sulla correlazione tra dieta mediterranea, salute e qualità di vita.
Con la Dieta Mediterranea, non si vuole imporre il ritorno ad una dieta povera, ma si vuole raccomandare i benefici che possono derivare da un comportamento alimentare peculiare della tradizione alimentare mediterranea, innovandolo ed adeguandolo, alle nuove esigenze di qualità e di sicurezza. Adottare uno stile alimentare sano ed equilibrato, ricco di alimenti freschi e poco processati, può contribuire a invecchiare in salute e a prevenire molte malattie legate all’età.

I consigli dell’Iss per dire addio alle cattive abitudini e iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi: l’alimentazione ha un ruolo cruciale

Per un 2025 all’insegna della salute e del benessere, ecco il decalogo dell’Istituto Superiore di Sanità. Dieci preziosissimi consigli da seguire per far sì che i buoni propositi si traducano in realtà. L’obiettivo, come spiegato dall’organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è «mettere a fuoco alcune delle scelte che possano fare del 2025 l’anno giusto per migliorare davvero la nostra salute fisica e mentale, senza
trascurare l’ambiente in cui viviamo che è essenziale per il nostro benessere e il mondo digitale nel quale è facile cadere nella trappola delle fake news». E, allora, consiglio dopo consiglio, scopriamo quali sono i suggerimenti proposti dall’Iss.
Si parte da uno dei temi più discussi dell’attuale società: la dipendenza da smartphone. Come uscirne? Più facile a dirsi che a farsi. Perché oltre il 25% degli adolescenti soffre di questo tipo di dipendenza che ha ripercussioni di non poco conto sulla qualità della vita. Dall’uso smodato di dispositivi elettronici derivano effetti negativi sul sonno, problemi di concentrazione e nelle relazioni. Ovviamente non si può di punto in bianco rinunciare allo smartphone, anche perché l’obiettivo non è eliminarlo, ed è per questo motivo che l’Istituto Superiore di Sanità propone di creare una zona smartphone free a casa, così da disconnettersi a piccoli passi utilizzando il tempo recuperato per altre attività.
Si passa poi a un’altra dipendenza, quella dall’alcol. Ecco, in questo caso eliminarlo del tutto si rivelerebbe un toccasana in tutti i sensi. L’Iss ricorda che l’alcol aumenta il rischio di sviluppare oltre 200 malattie differenti, oltre ad avere conseguenze pure sulla bilancia. Il discorso vale per ogni fascia d’età e in particolare per i giovani. Ritardare a dopo i 24 anni il consumo di qualunque tipo di alcol significa proteggere il cervello in tutte le sue funzioni. Inoltre l’alcol va bandito tra i 12 e i 21 anni, in quanto l’organismo non riesce a metabolizzarlo.
Il terzo consiglio è facilmente intuibile: smettere di fumare. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le sigarette sono responsabili della morte di sei milioni di persone ogni anno. Tradotto: un decesso ogni sei secondi. Per quanto riguarda l’Italia, in base ai dati forniti dal ministero della Salute, sono più di 93mila le vittime attribuibili al fumo di tabacco. Dire basta alle bionde equivale a ottenere benefici inestimabili per la salute a breve, medio e lungo termine. Bastano, infatti, solo otto ore al corpo per rigenerarsi liberandosi dal monossido di carbonio. Dopo un anno, il rischio di malattie cardiovascolari si riduce addirittura del 50%, mentre dopo dieci-quindici anni il rischio di sviluppare un
tumore ai polmoni è quasi uguale a quello di una persona che non ha mai fumato. Il quarto suggerimento riguarda la salute delle donne, che passa anche attraverso una dieta più sana ed equilibrata. Perché solo il 7% della popolazione italiana si attiene alle linee guida internazionali che raccomandano di mangiare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. Un’alimentazione corretta diminuisce il rischio di andare incontro a patologie come diabete e malattie cardiovascolari. Arriviamo a metà del percorso: per far sì che il cuore sia sano è importante prestare attenzione alla pressione e avere uno stile di vita senza eccessi.
La pressione alta non va affatto sottovalutata, poiché rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio per ictus, infarto del miocardio, aneurismi, arteriopatie periferiche, insufficienza renale cronica e patologie legate all’invecchiamento. In merito allo stile di vita, ad un’alimentazione equilibrata bisognerebbe abbinare un’attività fisica regolare, oltre all’astensione dal fumo.
Si continua, poi, con la regola delle “tre R”, che tanto giova all’ambiente: riduci, riusa, ricicla. Adottarla significa contrastare l’inquinamento e quindi tutelare la propria salute. Il settimo consiglio fa riferimento all’acquisto e alla conservazione dei cibi. Prima di comprare un alimento è sempre importante leggere le indicazioni in etichetta: occhio non solo alla data di scadenza, ma anche alle indicazioni nutrizionali e alle modalità di conservazione e di preparazione. A seguire, il benessere psicologico: non è una vergogna chiedere aiuto quando si è in difficoltà.
Il discorso si sposta poi sulle malattie infettive. La raccomandazione è semplice: aumentare la frequenza del lavaggio delle mani e per i soggetti più fragili (bambini e over 65) sottoporsi al vaccino antinfluenzale. Il decalogo si chiude con un ultimo suggerimento: in materia di salute è sempre buona norma verificare le fonti per evitare di incappare in pericolose fake news. Dall’ultimo rapporto Censis è emerso che per il 76,5% degli italiani individuare le notizie false è diventata impresa sempre più ardua e il 20,2% ritiene di non avere le competenze idonee per riconoscerle, pertanto è necessario affidarsi a fonti autorevoli. (D. E.).

Il decalogo si chiude con un ultimo suggerimento: in materia di salute è sempre buona norma verificare le fonti per evitare di incappare in pericolose fake news. Dall’ultimo rapporto Censis è emerso che per il 76,5% degli italiani individuare le notizie false è diventata impresa sempre più ardua e il 20,2% ritiene di non avere le competenze idonee per riconoscerle, pertanto è necessario affidarsi a fonti autorevoli.
Studio rivela il ruolo della memoria emozionale e della corticotropina Nuove prospettive per il trattamento di disturbi psichiatrici

© chaylek/shutterstock.com
Uno dei motori dell’empatia è stato recentemente scoperto grazie a uno studio che ha rivelato l’esistenza di un meccanismo cerebrale capace di attivarsi quando si osserva un evento negativo identico a uno già vissuto. Questa scoperta apre nuove prospettive per comprendere meglio le condizioni psichiatriche umane in cui l’empatia risulta alterata, come il disturbo da stress post-traumatico, l’autismo e la schizofrenia.
Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience, è stato guidato da Federica Maltese dell’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche e da Francesco Papaleo dell’Istituto Italiano di Tecnologia e dell’Irccs San Martino di Genova. Oltre a individuare questo meccanismo, i ricercatori hanno identificato una molecola cruciale nella regolazione della risposta empatica.
Da tempo è noto che le reazioni emotive agli eventi vissuti da altre persone sono fortemente influenzate dalle esperienze pregresse. Di fronte alla stessa situazione, le risposte possono variare significativamente tra individui. Per esempio, una passata esperienza negativa può suscitare empatia e sensibilità in alcuni, portandoli a solidarizzare con chi vive un evento simile, mentre in altri può generare disagio o fastidio, spingendoli ad allontanarsi piuttosto che a offrire aiuto. Questo tipo di variazione è comune nella popolazione generale, ma assume una connotazione clinica in individui con disturbi come il disturbo post-traumatico da stress, l’autismo o la schizofrenia, in cui tali meccanismi risultano alterati.
Secondo Francesco Papaleo, comprendere meglio i processi cerebrali alla base di queste reazioni potrebbe contribuire a chiarire molti aspetti delle emozioni umane e delle risposte empatiche. I ricercatori hanno scoperto che le esperienze passate influenzano le reazioni empatiche, ma con una specificità sorprendente. L’empatia si manifesta maggiormente se l’evento negativo vissuto in precedenza è identico a quello osservato in un altro individuo.
L’analisi dell’attivazione neuronale ha portato alla scoperta che determinati neuroni della corteccia cerebrale svolgono un ruolo chiave in questo processo. In particolare, i ricercatori si sono concentrati sulla corticotropina, una molecola nota per il suo coinvolgimento nelle risposte allo stress e identificata come regolatore delle reazioni empatiche. I neuroni che producono questa sostanza
agiscono come una sorta di memoria emotiva, capace di influenzare le risposte successive a stimoli socio-emozionali. Questo meccanismo è particolarmente interessante poiché dimostra come la memoria emotiva non sia solo un archivio passivo di esperienze, ma un elemento attivo che modula il comportamento in modo mirato e contestuale.
Lo studio apre nuove prospettive per la comprensione e il trattamento di disturbi psichiatrici in cui la capacità empatica è compromessa. Ad esempio, nel disturbo da stress post-traumatico, le esperienze traumatiche passate possono influenzare negativamente la capacità di relazionarsi con gli altri. L’identificazione della corticotropina come regolatore delle risposte empatiche offre una possibile via per sviluppare nuovi approcci terapeutici mirati. Allo stesso modo, nei disturbi dello spettro autistico e nella schizofrenia, la difficoltà a comprendere e rispondere alle emozioni altrui potrebbe essere almeno in parte attribuita a un malfunzionamento di questi specifici circuiti neuronali.
Questo tipo di ricerca sottolinea anche l’importanza di un approccio integrato tra neuroscienze, psicologia e biologia molecolare per affrontare questioni complesse come l’empatia e le sue disfunzioni. Comprendere i meccanismi alla base delle emozioni e delle risposte empatiche non solo aiuta a migliorare la nostra conoscenza della mente umana, ma fornisce strumenti concreti per intervenire su condizioni cliniche che compromettono la qualità della vita di molte persone.
Le implicazioni dello studio vanno oltre la sfera della ricerca clinica, toccando anche aspetti etici e sociali. Se è possibile modulare la risposta empatica attraverso interventi farmacologici o altri tipi di terapie, si aprono interrogativi su come e in quali contesti tali strumenti dovrebbero essere utilizzati. Questo potrebbe portare a discussioni su come bilanciare il miglioramento della salute mentale con il rispetto della diversità emotiva e comportamentale degli individui.
La scoperta rappresenta un importante passo avanti nella comprensione delle dinamiche socio-emozionali, offrendo nuove prospettive per il trattamento di disturbi psichiatrici e apre la strada a ulteriori ricerche sui complessi processi che regolano le relazioni umane. La memoria emozionale, con la sua specificità e influenza sul comportamento, emerge come un elemento cruciale per comprendere non solo l’empatia, ma anche molte altre sfaccettature della nostra vita emozionale e sociale.

Lo studio apre nuove prospettive per la comprensione e il trattamento di disturbi psichiatrici in cui la capacità empatica è compromessa. Ad esempio, nel disturbo da stress post-traumatico, le esperienze traumatiche passate possono influenzare negativamente la capacità di relazionarsi con gli altri. Questo tipo di ricerca sottolinea anche l’importanza di un approccio integrato tra neuroscienze, psicologia e biologia molecolare per affrontare questioni complesse come l’empatia e le sue disfunzioni.

Secondo gli esperti di Nature Medicine, quali sono le sperimentazioni più attese in ambito scientifico in grado di aprire nuovi e importanti scenari a stretto giro
Il passaggio da un anno all’altro rappresenta sempre il momento giusto per fare il bilancio di ciò che è stato e stilare la lista dei buoni propositi per il futuro prossimo. Vale un po’ per tutti e per qualsiasi settore. E il campo della medicina non è certo esentato dalla prassi. Anzi, più che mai nuove sfide si stagliano all’orizzonte. Obiettivi da raggiungere, per quanto complicati, affinché il 2025 segni un punto di svolta in ambito scientifico. Nel dettaglio, sono stati gli esperti interpellati dalla prestigiosa rivista Nature Medicine a svelare quali siano le sperimentazioni cliniche che nell’anno appena iniziato potranno aprire nuovi e promettenti scenari nella medicina. E, allora, scopriamo insieme le non facili sfide sanitarie da vincere a tutti costi.
Si parte dell’obesità, contro cui da tempo è stata intrapresa una vera e propria battaglia. In tal senso, il 2024 si è rivelato un anno cruciale anche grazie al boom che si è registrato sul mercato di farmaci dimagranti come semaglutide e tirzepatide, Anche nell’anno appena cominciato, quello dell’alimentazione è una delle questioni principali in agenda. Perché i numeri sono allarmanti. E sempre più da codice rosso.
Da uno studio pubblicato di recente su The Lancet, a cui ha contribuito l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è emerso che nel 2022 più di un miliardo di persone nel mondo convive con l’obesità. Per intenderci: una persona su otto. Se tra gli adulti è più che raddoppiata dal 1990, preoccupa un altro aspetto, a dir poco inquietante: l’obesità, infatti, è quadruplicata tra bambini e adolescenti (dai cinque ai diciannove anni di età). E nel nostro Paese il campanello d’allarme è scattato da anni, ormai. Quattro italiani su dieci sono in sovrappeso, uno su dieci è obeso. Rispetto a 20 anni fa le persone con obesità sono aumentate di 1,6 milioni raggiungendo un totale di quasi sei milioni di cittadini, come riferito in occasione del sesto Italian Obesity Barometer Summit. Per capire quanto quello dei chili in eccesso non sia affatto un problema da sottovalutare il fatto che l’obesità è associata a oltre 200 complicazioni, che comprendono anche tumori, malattie cardiovascolari, diabete tipo 2 e malattie respiratorie croniche. Dunque, nel 2025 bisogna che si registri un’ulteriore accelerata sul fenomeno, ancora oggi preso sottogamba. Uno studio americano promette di far luce in tema di alimentazione: saranno analizzati dieta, genetica, microbioma, abitudini di vita e storia sanitaria di 8mila persone

Da uno studio pubblicato di recente su The Lancet, a cui ha contribuito l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è emerso che nel 2022 più di un miliardo di persone nel mondo convive con l’obesità. Per intenderci: una persona su otto. Se tra gli adulti è più che raddoppiata dal 1990, preoccupa un altro aspetto, a dir poco inquietante: l’obesità, infatti, è quadruplicata tra bambini e adolescenti (dai cinque ai diciannove anni di età). E nel nostro Paese il campanello d’allarme è scattato da anni, ormai. Quattro italiani su dieci sono in sovrappeso, uno su dieci è obeso. © Shutterstock AI/shutterstock.com
al fine di capire in che modo i diversi modelli alimentari influenzano il corpo umano. Altro male attuale è quello legato alla salute mentale. In particolare, i disagi di cui soffrono adolescenti e giovanissimi che si sono acuiti in maniera esponenziale dopo la pandemia da Covid e il lockdown.
Da un recente studio longitudinale condotto in Australia è venuto a galla che il 74% degli adolescenti sperimenta sintomi di ansia e depressione clinicamente rilevanti. E più della metà addirittura in modo cronico. Anche in Italia i numeri sono purtroppo in crescita. La fascia d’età più vulnerabile è quella compresa tra i 18 e i 34 anni, quindi le donne in gravidanza e nel primo anno dopo il parto. In totale, secondo un’indagine Ipsos, il 28% della popolazione dello Stivale soffre di disturbi mentali, con una crescita di sei punti in più rispetto al 2022.
Tante le iniziative che saranno messe in pratica nel corso del 2025, come ad esempio la sperimentazione di nuovi strumenti digitali mobili ideati per provare a contrastare la violenza tra gli adolescenti dei Paesi a basso e medio reddito. Non solo: attraverso uno studio clinico sull’uso di farmaci a base di cannabidiolo si spera di ottenere risposte importanti per trattare la psicosi. Un ruolo centrale avrà pure la salute delle donne, al centro di numerosi studi innovativi, come ad esempio quello condotto su 53mila donne in sei Paesi che si pone l’obiettivo di sviluppare approcci personalizzati per lo screening del tumore della mammella, che in Italia continua a essere la forma di neoplasia più diagnosticata anche nel 2024 con 53.686 casi.
E, ancora, la sperimentazione sull’utilizzo di un chatbot per la promozione dell’accesso allo screening per il cancro della cervice uterina. Quella dei tumori è una battaglia che non si arresterà certo nel corso del 2025. È in cantiere uno studio su oltre mille pazienti per far luce sull’efficacia del radiofarmaco lutezio-177 contro il tumore della prostata. Dita incrociate con la speranza che i risultati siano incoraggianti, visto che si prevede che i casi annui di tumore alla prostata raddoppieranno entro il 2040, passando dagli 1,4 attuali a 2,9 milioni. Non è finita qui.
Si attendono risposte positive dalle sperimentazioni di nuove terapie geniche, come ed esempio quella che va a modificare le cellule staminali del sangue nei pazienti affetti da anemia falciforme grave e quella che farà ricorso a oligonucleotidi per arginare rare patologie degenerative del cervello, le malattie da prioni. (D. E.).

Dall’aglio al rosmarino, dall’olivo allo zafferano
Validi rimedi naturali per arginare i problemi cardiovascolari
Le piante che fanno bene al cuore. Dalla natura arriva un prezioso assist per combattere i problemi cardiovascolari, che restano la prima causa di morte nel mondo. Come riferito dall’Oms, sono 10mila i decessi che si registrano ogni giorno nella regione europea, con gli uomini che hanno quasi 2,5 volte più probabilità di morire per via di disturbi cardiovascolari rispetto alle donne. Anche in Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte con 217mila vittime (30,8% di tutti i decessi nel 2021). Numeri allar-
manti contro cui è necessario porre un freno, anche attraverso l’utilizzo di rimedi naturali sulla cui efficacia, però, bisogna far luce attraverso prove scientifiche concrete.
È proprio questo l’obiettivo dello studio condotto dal gruppo di ricerca guidato da Francesc Jiménez Altayó che ha preso il via dal progetto di laurea del biologo spagnolo Mateu Anguera Tejedor, sotto la supervisione di René Delgado, docente presso la Facoltà di Farmacia e Scienze dell’Alimentazione dell’Università di Barcellona. Il contributo fornito alla causa è particolarmente importante,
perché si è proceduto con una revisione completa della letteratura su un gruppo di piante mediterranee, ai cui principi attivi sono attribuite azioni farmacologiche nel campo delle malattie cardiovascolari.
Lo studio, che è stato pubblicato sulla rivista Food Bioscience, mira a fare chiarezza su quegli estratti vegetali, ricchi di composti bioattivi, che hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo di farmaci, ma il cui utilizzo è limitato da possibili effetti collaterali e dalla mancanza di prove scientifiche provenienti da studi preclinici e clinici di qualità. Dunque, la ricerca - come fa sapere l’Università di Barcellona - fornisce una panoramica dei meccanismi d’azione e delle evidenze precliniche e cliniche, nonché degli effetti avversi di composti bioattivi essenziali derivati da un gruppo di piante selezionate, che rientrano nella dieta mediterranea.
Nello specifico sono sei le specie di piante e i loro principali componenti attivi analizzati: l’aglio, il biancospino, lo zafferano, l’olivo, il rosmarino e la vite. La revisione si è concentrata sui meccanismi farmacologici più indicativi, tra cui le loro azioni antiossidanti, antinfiammatorie e vasodilatatrici, nonché la loro regolazione del metabolismo lipidico, che può essere rilevante per condizioni come l’aterosclerosi e l’ipertensione. I risultati lasciano ben sperare, in quanto dimostrano che questi componenti attivi sono promettenti nel potenziale trattamento dell’aterosclerosi e potrebbero ridurre il rischio di infarto del miocardio e ictus.
Gli autori dello studio concludono sottolineando che «spesso mancano prove solide dell’impatto degli estratti naturali sugli esseri umani» e pertanto avvisano che «l’etichetta naturale non garantisce sicurezza per cui bisogna dare priorità agli studi farmacocinetici, tossicologici e clinici per valutarne l’efficacia, la sicurezza e l’efficienza rispetto ai farmaci esistenti». (D. E.).
Negli ultimi tempi si sente sempre più spesso parlare di burnout, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto come sindrome associata al lavoro in grado di condizionare negativamente la qualità della vita di una persona e anche la sua produttività. Più precisamente per burnout si intende quella condizione che porta chi ne soffre a sentirsi sotto stress, demotivati ed esausti sul luogo del lavoro. Se l’OMS è intervenuta in maniera decisa è perché il fenomeno è in costante espansione in ogni angolo del globo. Da un recente sondaggio effettuato dal McKinsey Health Institute è emerso che su 30mila dipendenti in 30 Paesi, il 22% dei lavoratori su scala mondiale presenta sintomi di burnout.
E l’Italia non fa certo eccezione. Tutt’altro. L’allarme arriva dal Rapporto su Salute e Ssn dell’Osservatorio Salute, legalità, previdenza di Fondazione Enpam e Eurispes e riguarda medici e infermieri, da tempo costretti a lavorare per svariate ragioni in condizioni di emergenza. E, si sa, a tirar troppo la corda va a finire che poi si spezza. Il quadro dipinto è allarmante, e tanto. Perché il burnout coinvolge addirittura il 52% dei medici e il 45% degli infermieri. Gli angeli vestiti di bianco sono sempre più stanchi e frustrati, in cerca di una via di fuga. Sono diverse le cause che hanno contribuito a far precipitare la situazione rendendo un incubo la professione. Partiamo dalla carenza di personale e dallo scarso turnover, che ha come conseguenza l’aumento dell’età media dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
Il Rapporto pone in evidenza un altro aspetto importante di cui tener conto e cioè che alla diminuzione del personale stabile fa da contraltare l’incremento del lavoro flessibile con il ricorso sempre più frequente a contratti a tempo determinato. In tal senso un boom si è registrato duran -

Retribuzioni basse e carenza di personale: le ragioni che rendono impossibile la vita dei camici bianchi in Italia
te gli anni della pandemia da Covid, tra il 2019 e il 2022. Ancora, il fattore retribuzione, che in Italia è in media più bassa del 22% rispetto ai colleghi di altri Paesi del Vecchio Continente, con un gap evidente rispetto a Svizzera, Olanda, Germania, Irlanda, Danimarca e Regno Unito.
Sono soprattutto le donne a essere colpite da burnout, anche perché il personale femminile è vittima di circa i due terzi delle 18mila aggressioni che si sono verificate a danno dei sanitari. Ma non è solo questo il punto della questione. Già, perché persistono gli svantaggi legati al genere: pur essendo
donne più di due terzi dei lavoratori in ambito sanitario, a ricoprire le posizioni dirigenziali e apicali continuano a essere prevalentemente gli uomini. Un esempio pratico: il 51,3% dei medici è rappresentato da donne, ma solo il 19,2% dei primari è di sesso femminile. Secondo il Rapporto sulla Salute e il Sistema sanitario Eurispes-Enpam la svolta può arrivare grazie all’innovazione: dall’Intelligenza Artificiale alla telemedicina, passando per la robotica in grado di portare a una maggiore efficienza nel lavoro di medici e infermieri, con effetti positivi sulla produttività. (D. E.).

Tratto da da “An overview of progress in the application of recombinant collagen in cosmetics” di Chuan-Xiu Chena, Ya-Yao Zhanga, Jingbo Yangb, Mei-Hui Yana, Yao Jiac, Shibo Jiangd


Il collagene ricombinante è collagene preparato utilizzando la tecnologia del DNA ricombinante per progettare e migliorare la sequenza di amminoacidi secondo necessità. Utilizzando plasmidi o vettori virali per introdurre il gene bersaglio nelle cellule ospiti appropriate, siano esse batteriche, di lievito o cellule di altre specie eucariotiche, esso viene espresso e tradotto in collagene o polipeptidi simili al collagene, seguito dalla preparazione tramite estrazione e fasi di purificazione.
© metamorworks/shutterstock.com
Il collagene è coinvolto nella riparazione dei tessuti umani, di cui se ne conoscono ventotto tipi, dei quali circa il 30–40% rappresentano le proteine totali del corpo umano. I materiali a base di collagene sono utilizzati nella riparazione della pelle umana, della cavità orale, della dura madre e di altri tessuti, ma anche in estetica medica.
In base alla fonte, può essere classificato in: 1) collagene naturale: viene preparato principalmente da tessuti animali (bovini, suini, polli, pesce); tessuti umani (pelle del pene, placenta). Questo però mostra avere alcuni problemi riguardo reazioni immunogeniche (rigetto possono causare infiammazione asettica nel sito del trapianto2-4 e trasmissione di malattie zoonotiche come l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), l’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l’afta epizootica (FMD);
2) collagene preparato artificialmente mediante tecniche di ricombinazione genica e sintesi chimica, è identico a un collagene umano se è costruito con la stessa sequenza di amminoacidi di quest’ultimo, può ridurre significativamente le reazioni di rigetto umano e mostra avere maggiore compatibilità con il corpo umano, evitando il rischio di infezioni virali e infezioni crociate causate dall’utilizzo di cellule animali. Possiede caratteristiche quali migliore lavorabilità, maggiore solubilità in acqua, struttura monocomponente, processo di preparazione controllabile e ciclo di produzione più breve, che rendono più semplice il controllo della qualità del prodotto. Pertanto, il collagene ricombinante è un biomateriale ideale con ampia applicazione nel campo della bellezza, della medicina rigenerativa, delle medicazioni e persino degli organi artificiali.
Con il progresso della scienza e della tecnologia, c’è una differenza significativa rispetto ai costi del collagene ricombinante e quello di derivazione animale la cui produzione risulta essere inefficiente e costosa. Al contrario, il collagene ricombinante viene prodotto mediante biotecnologia, in grado di essere sintetizzato in laboratorio, aumentando notevolmente l’efficienza produttiva e riducendo i costi. Jadach et al. hanno condotto una revisione della recente letteratura introducendo i diversi tipi e forme di collagene ricombinante e come questo influisce sulle proprietà della pelle, verificando gli effetti dei cosmetici contenenti collagene o suoi derivati, mettendo in mostra la struttura del collagene e il suo ruolo insostituibile nella pelle,
suggerendo al contempo la sua importanza come componente nei cosmetici.
Sino ad oggi nessuno studio ha dimostrato che il collagene ricombinante possa essere un buon sostituto del collagene nei cosmetici. Per colmare questa lacuna, qui si riassume la classificazione del collagene ricombinante e i fattori che influenzano la sua sintesi, il confronto tra diversi sistemi di espressione e l’applicazione del collagene ricombinante in diversi prodotti cosmetici, con l’obiettivo di fornire una base riferimento per il suo ulteriore sviluppo nei settori cosmetico e biomedico.
Classificazione del collagene ricombinante Il collagene ricombinante è collagene preparato utilizzando la tecnologia del DNA ricombinante per progettare e migliorare la sequenza di amminoacidi secondo necessità. Utilizzando plasmidi o vettori virali per introdurre il gene bersaglio nelle cellule ospiti appropriate, siano esse batteriche, di lievito o cellule di altre specie eucariotiche, esso viene espresso e tradotto in collagene o polipeptidi simili al collagene, seguito dalla preparazione tramite estrazione e fasi di purificazione. Questo metodo di preparazione può ottenere una sintesi personalizzata di diversi tipi di collagene, oltre a selezionare regioni funzionali specifiche su diversi tipi di molecole di collagene e combinarle secondo necessità. Il collagene ricombinante è suddiviso in: 1) collagene umano ricombinante, 2) collagene umanizzato ricombinante e 3) proteina ri-

combinante simile al collagene.
Il collagene umano ricombinante si riferisce alle proteine ricombinanti che contengono sequenze genetiche complete o parziali, inclusi almeno tutti i domini elicoidali, e che codificano tipi specifici di collagene umano prodotto mediante la tecnologia del DNA ricombinante in un modo che riflette le funzioni fisico-chimiche e biologiche del collagene proteina con struttura a tripla elica.
Il collagene umanizzato ricombinante, costituito dalle classi A e B, è un frammento di sequenza di amminoacidi a lunghezza intera o parziale codificato da un tipo specifico di gene del collagene umano o da una combinazione di frammenti funzionali contenenti collagene umano e preparato mediante ricombinazione del DNA a tecnologia combinata. Il collagene umanizzato ricombinante di classe A non contiene sequenze proteiche non umane, mentre il collagene umanizzato ricombinante di classe B contiene sequenze proteiche non umane. Uno studio più recente ha dimostrato che il collagene umanizzato ricombinante di classe A, ma non di classe B, possiede una struttura a tripla elica come determinato dall’analisi spettrale.
Il collagene umanizzato ricombinante di Classe A mostra attività biologiche significativamente migliori, inclusa l’attività di adesione cellulare, migrazione cellulare e proliferazione cellulare. La proteina simile al collagene ricombinante è una sequenza di amminoacidi, o un suo frammento, codificata da un gene specifico, o una combinazione di tali frammenti di sequenze di amminoa-
© Volodimir Zozulinskyi/shutterstock.com

cidi funzionali, preparati mediante la tecnologia del collagene ricombinante del DNA. La sua sequenza di aminoacidi codificata dal gene ha una bassa omologia con la sequenza che codifica il gene del collagene umano.
Hua et al.14 hanno identificato un dominio funzionale critico (Gly489-Gly510) nel collagene umano di tipo III (hCOL3A1), che contiene residui multipli carichi e triplette rappresentative cariche di Glu-Lys-Gly e Glu-Arg-Gly che svolgono ruoli importanti nel legame e riconoscimento del collagene. Hanno scoperto che il peptide sintetico (C1P) derivato da questo dominio mostrava una forte attività attraverso l’interazione peptide-membrana mediata dall’integrina e la struttura cristallina risolta (un’alta risoluzione di 1,50 Å) di una tripla elica formata da C1P con un angolo di piegatura di 164,88 °. Questo team ha costruito una proteina ricombinante 480aa composta da 16 ripetizioni in tandem di C1P, denominata T16 e ha scoperto che T16 aveva un’attività di adesione cellulare molto più elevata rispetto al singolo peptide C1P o al controllo del collagene umano di tipo I senza citotossicità.
Questa proteina T16 è stata successivamente definita come collagene umanizzato ricombinante di tipo III (hCoLIII). Un prodotto in fibra liofilizzata costituito da questo tipo di collagene umanizzato ricombinante di tipo III sviluppato da Shanxi Jinbo Bio-Pharmaceutical Co., Ltd. (Taiyuan, provincia di Shanxi, Cina) è stato approvato dalla National Medical Products Administration come dispositivo iniettabile (dispositivo medico di classe III) per uso clinico rispetto al collagene umanizzato ricombinante di Classe B.13
Fattori che influenzano la sintesi del collagene ricombinante
La produzione di collagene ricombinante con tecniche di ingegneria biologica ha suscitato un intenso interesse, così come, il rapido sviluppo della biologia di sintesi ha reso possibile eseguire l’espressione eterologa di proteine in diversi sistemi di espressione, ottimizzando la produzione e l’attività biologica del collagene ricombinante. La biosintesi del collagene ricombinante è un processo complesso influenzato da vari fattori: come la regolazione dei geni che codificano per la proteina del collagene e dei geni che codificano per i fattori di trascrizione.
L’espressione genica nei ceppi transgenici si ottiene introducendo il gene bersaglio in un vet-

La produzione di collagene ricombinante con tecniche di ingegneria biologica ha suscitato un intenso interesse, così come, il rapido sviluppo della biologia di sintesi ha reso possibile eseguire l’espressione eterologa di proteine in diversi sistemi di espressione, ottimizzando la produzione e l’attività biologica del collagene ricombinante. La biosintesi del collagene ricombinante è un processo complesso influenzato da vari fattori.


Cosmetici o prodotti di bellezza, che contengono vari principi attivi, vengono utilizzati per prendersi cura e abbellire il viso, il corpo e i capelli umani. Il collagene può essere utilizzato per preparare prodotti per la cura della pelle e di bellezza, migliorando la secchezza della pelle e le rughe.
©Tatiana Foxy/shutterstock.com
tore, rendendo la costruzione e la stabilità dei vettori transgenici cruciali per il livello desiderato di espressione genica. I fattori di trascrizione e gli elementi regolatori possono promuovere o inibire la trascrizione genetica, influenzando così i livelli di espressione genica. Successivamente alla biosintesi sono necessarie modifiche post-traduzionali, tra cui ubiquitinazione, fosforilazione, glicosilazione, lipidazione, metilazione e acetilazione, che influenzano tutte la conformazione spaziale e la funzione delle proteine del collagene.
Espressione del collagene ricombinante in diversi sistemi
Nella loro revisione dei progressi della ricerca nella produzione biologica di collagene ricombinante negli ultimi vent’anni, Zhao et al. si sono concentrati su diversi sistemi di espressione, inclusi procarioti, lieviti, piante, insetti e cellule sia di mammiferi che umane. I sistemi vegetali e animali hanno costi elevati di fermentazione e purificazione e basse rese, il che li rende inadatti alla produzione su larga scala mentre, i sistemi microbici hanno costi di coltivazione inferiori, background genetici chiari, forte operabilità e idoneità per la produzione industriale.
Applicazione del collagene ricombinante nei cosmetici
Cosmetici o prodotti di bellezza, che contengono vari principi attivi, vengono utilizzati per prendersi cura e abbellire il viso, il corpo e i capelli umani. Il collagene può essere utilizzato
per preparare prodotti per la cura della pelle e di bellezza, migliorando la secchezza della pelle e le rughe. Secondo il database Skin Deep® dell’Environmental Working Group (EWG) i cosmetici contenenti collagene, sono ormai comuni, e nella categoria dei cosmetici correlati al collagene, dominano sieri, essenze, maschere, creme idratanti e creme per gli occhi.
Allo stesso tempo, i consumatori sono alla ricerca di ingredienti non animali, di provenienza etica e rispettosi dell’ambiente nei loro prodotti per la cura personale, spingendo le aziende cosmetiche a ricercare continuamente fonti alternative di materia prima. Questa preferenza dei consumatori ha guidato lo sviluppo della biotecnologia, utilizzando microbi per ottenere collagene ricombinante specifico attraverso processi di fermentazione e ingegneria genetica, che è un’alternativa interessante al collagene di origine animale nei cosmetici.
Invecchiamento della pelle
Uno studio recente ha descritto lo sviluppo di un collagene ricombinante da 50 kDa nell’ospite eucariotico Pichia pastoris. Questo collagene ricombinante è naturale, sicuro e sostenibile, e i risultati sperimentali hanno dimostrato la sua buona sicurezza per la pelle umana, non mostrando sensibilizzazione o mutagenicità. I ricercatori hanno confrontato questo collagene ricombinante con molte altre proteine ricombinanti simili al collagene e hanno scoperto che era identico al 100% alla catena α del collagene di tipo III uma-

no senza manipolazione della sequenza.
Questo collagene ricombinante di tipo III stimola inoltre in modo univoco i fibroblasti dermici primari umani a generare e secernere collagene di tipo I e di tipo III, rendendolo ampiamente applicabile nell’industria dei cosmetici. Wang et al. hanno scoperto che i digestati di collagene ricombinante mostravano effetti protettivi più elevati sui fibroblasti danneggiati dai raggi UVA rispetto a quelli del collagene di derivazione animale grazie alla sua speciale struttura molecolare, che fornisce un microambiente cellulare più amichevole. Questo risultato suggerisce che il collagene ricombinante potrebbe essere un agente anti-invecchiamento cutaneo promettente e più efficace, adatto per l’uso in un’ampia gamma di cosmetici anti-invecchiamento cutaneo. Fan et al. hanno esplorato l’efficacia antirughe del collagene umanizzato ricombinante di tipo III nei cosmetici testando i suoi effetti sui fibroblasti e sui cheratinociti della pelle umana e hanno scoperto che questo collagene umanizzato ricombinante di tipo III aveva efficacia antirughe ad una concentrazione di 5 mg/ml.
Ciò che è degno di nota è che gli effetti in vivo prodotti dalla coltura cellulare devono essere dimostrati in un sistema in vivo appropriato. Wu et al. hanno valutato l’efficacia e la sicurezza della penetrazione del collagene umano ricombinante promossa dal laser a CO2 frazionato nel ringiovanimento perioculare e hanno identificato miglioramenti significativi negli indicatori di invecchiamento cutaneo perioculare dopo tre mesi
di trattamento. Liu et al. hanno scoperto che i microaghi utilizzati per fornire collagene simile a quello umano nella pelle hanno mostrato una buona efficacia, fornendo un nuovo metodo per i trattamenti di ringiovanimento del viso.
La rigenerazione della pelle, come i microaghi e il resurfacing laser, hanno guadagnato popolarità globale nell’estetica medica, ma le ferite cutanee acute associate con dolore persistente ed edema si sono rivelate sempre più preoccupanti. Sono state esplorate varie medicazioni per riparare tali danni cutanei postoperatori, ma la loro insufficiente biocompatibilità e bioattività ha sollevato preoccupazioni riguardo a reazioni avverse e complicanze. Breda Cullen e altri scienziati di Ethicon hanno presentato una domanda di brevetto per una medicazione composta da collagene umano ricombinante e cellulosa ossidata. Un altro studio ha combinato acido ialuronico ad alto peso molecolare non reticolato, polipeptidi ricombinanti contenenti la catena di collagene-1α e carbossi- metilcellulosa per stimolare la produzione di collagene di tipo I, migliorando l’idratazione della pelle. Questa nuova formulazione multicomponente stimola efficacemente la rigenerazione cutanea, migliora la qualità e la consistenza della pelle e ha una bassa incidenza di eventi avversi.
Riparazione della pelle
Fin dalla loro nascita, le cellule staminali degli epatociti sono state ampiamente studiate per la loro biocompatibilità nella riparazione delle lesioni cutanee e nella rigenerazione della pelle. Nel 2014, Ma et al. preso collagene ricombinante misto con chitosano (CS) attraverso la reticolazione dell’amido dialdeide (DAS), hanno ottenuto un idrogel morbido e biocompatibile, che può riempire efficacemente i vuoti della pelle quasi senza alcuna risposta infiammatoria. Successivamente, Zhao et al. hanno inventato un idrogel di collagene ricombinante iniettabile per la rigenerazione della pelle, reticolato con transglutaminasi microbica (mTG).
La mTG reticolata è un agente reticolante non tossico con attività altamente specifica ed elevate velocità di reazione in condizioni blande, migliorando la biocompatibilità del collagene ricombinante. Idrogel di collagene e fornendo potenziale come idrogel iniettabile per il tratta-

I prodotti a base di collagene di tipo umano formano un ambiente occlusivo umido sulla superficie della pelle, proteggendo le ferite, aumentando l’idratazione della pelle, trattenendo l’umidità, riparando efficacemente la barriera epidermica e migliorando l’immunità della pelle.
mento delle lesioni cutanee. Zhu et al.hanno utilizzato mTG per reticolare ialuronato di sodio, CS carbossilato e collagene ricombinante, ottenendo idrogel con buona resistenza, promuovendo efficacemente la guarigione della ferita, proteggendo la ferita da infezioni e perdita di liquidi. Guo et al. hanno sviluppato un idrogel di collagene ricombinante reticolato mTG caricato con il fattore basico di crescita dei fibroblasti (b-FGF) per la riparazione dei difetti della pelle.
Esperimenti in vivo hanno dimostrato che l’idrogel di collagene/mTG ricombinante b-FGF ha promosso in modo significativo la guarigione della pelle difettosa, ottenendo una guarigione senza cicatrici in un tempo più breve. Pertanto, questo idrogel ha fornito un ambiente sicuro e umido che ha completamente potenziato gli effetti di guarigione della ferita dell’idrogel mTG di collagene ricombinante b-FGF. Questi idrogel di collagene ricombinante reticolato mTG hanno il vantaggio di condizioni di reazione blande e possono essere utilizzati come fattori di crescita e catalizzatori cellulari.
Pan et al. hanno progettato una medicazione emostatica traspirante in idrogel a base di collagene ricombinante e ne hanno valutato gli effetti sui difetti a tutto spessore. Hanno prodotto una serie di medicazioni in idrogel morbide, flessibili, porose e non appiccicose congelando e scongelando ripetutamente soluzioni miste di alcol polivinilico (PVA), acido cloridrico e carbossimetil CS, seguite dall’aggiunta di Tween 80 come pirogeno per la guarigione delle ferite della pelle. Hanno anche creato un altro nuovo tipo di idrogel composito di collagene ricombinante, PVA e alginato di sodio come medicazione delle ferite.
I risultati della ricerca hanno dimostrato che l’idrogel potrebbe accelerare la contrazione della ferita e promuoverne la guarigione e la formazione di nuova pelle in difetti cutanei a tutto spessore, dimostrando il potenziale come medicazione per la guarigione delle ferite cutanee. He et al. hanno studiato l’effetto di guarigione delle ferite del collagene umanizzato ricombinante attraverso esperimenti e hanno scoperto che promuoveva significativamente la proliferazione e il tasso di migrazione delle cellule epidermiche e dei fibroblasti, migliorando efficacemente i cambiamenti patologici dopo la lesione della dermatite e promuovendo riparazione della ferita.
I prodotti per medicazioni mediche sono sicuri ed efficaci per l’applicazione e hanno un
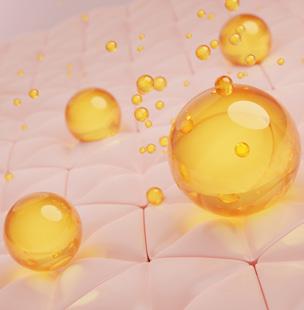
Il collagene ricombinante è ampiamente utilizzato anche nella cura dell’epidermide, compresa la promozione dell’elasticità della pelle, l’idratazione e il restringimento dei pori. Generalmente può essere applicato direttamente sulla pelle per proteggere l’epidermide. Il collagene ricombinante può anche essere assorbito nei tessuti non tessuti per formare medicazioni di collagene ricombinante.
© wangmandoa/shutterstock.com
potenziale di sviluppo dimostrabile. Zhang et al. dell’Ospedale popolare provinciale di Henan hanno utilizzato gel siliconico per la riparazione delle cicatrici al collagene di tipo umano per trattare le cicatrici ipertrofiche. Il trattamento è stato efficace con un’efficacia del 90% e non è stata osservata alcuna differenza statistica nei risultati del trattamento rispetto a quelli che utilizzavano un unguento siliconico a base di benzalconio cloruro (BAK). Il gel di collagene simile a quello umano si è rivelato altamente efficace nella prevenzione e nel trattamento delle cicatrici ipertrofiche, dimostrando elevata sicurezza e applicabilità clinica.
Cura della pelle
Oltre alla riparazione delle lesioni cutanee, il collagene ricombinante è ampiamente utilizzato anche nella cura dell’epidermide, compresa la promozione dell’elasticità della pelle, l’idratazione e il restringimento dei pori. Generalmente può essere applicato direttamente sulla pelle per proteggere l’epidermide. Il collagene ricombinante può anche essere assorbito nei tessuti non tessuti per formare medicazioni di collagene ricombinante. Ad esempio, Chen et al. hanno studiato l’effetto degli infrarossi combinati con medicazioni al collagene ricombinante sul miglioramento della pigmentazione della pelle dopo il fotoinvecchiamento con laser CO2 reticolare.
Nel loro studio, ottanta casi sono stati divisi casualmente in un gruppo di controllo (irradiazione a infrarossi) e un gruppo di trattamento (infrarossi combinati con medicazione di collagene ricombinante). Dopo il trattamento, il gruppo di trattamento ha mostrato punteggi più alti per macchie di pigmento, rughe, consistenza, pori e rodopsina rispetto al gruppo di controllo. La percentuale di successo del gruppo di trattamento è stata del 90%, mentre quella del gruppo di controllo è stata del 50%. Pertanto, gli infrarossi combinati con la medicazione al collagene ricombinante possono migliorare la qualità della pelle, promuovere l’elasticità e l’idratazione della pelle, restringere i pori e ridurre la secrezione di olio e la pigmentazione della pelle, fornendo un nuovo metodo e reagente per la cura della pelle.
Lu et al. hanno studiato l’efficacia del collagene umano ricombinante di tipo III nei cosmetici per la cura della pelle impostando un gruppo di controllo in bianco e gruppi campione con concentrazioni dello 0,0025% e dello 0,01% e quindi conducendo test idratanti, riparatori e antiru-

ghe. I risultati hanno mostrato che i campioni di collagene umano di tipo III ricombinante hanno prodotto effetti per la cura della pelle a una concentrazione pari solo allo 0,0025%.
Nanjing Egen Biological Technology Co., Ltd. ha sviluppato vari prodotti a base di collagene di tipo umano, tra cui maschera proteica ricombinante di tipo III simile al collagene in pasta, spray proteico ricombinante simile al collagene di tipo III per pelle morbida e un nano spruzzatore robotico. Zhang et al. dell’Università di Jinan hanno condotto test di allergia e tossicità sulla proteina ricombinante simile al collagene, dimostrandone la natura non irritante e non tossica.
I prodotti a base di collagene di tipo umano formano un ambiente occlusivo umido sulla superficie della pelle, proteggendo le ferite, aumentando l’idratazione della pelle, trattenendo l’umidità, riparando efficacemente la barriera epidermica e migliorando l’immunità della pelle. Canzone et al. ha trattato la dermatite facciale ricorrente con medicazioni proteiche ricombinanti simili al collagene e ha riportato meno reazioni avverse e tassi di recidiva più bassi dopo il trattamento, dimostrando che potrebbe sostituire l’i-
© etonastenka/shutterstock.com

Le applicazioni del collagene ricombinante vengono gradualmente coinvolte nell’ingegneria dei tessuti cutanei, promuovendone lo sviluppo e l’applicazione in un ampio spettro di campi biologici.
drocortisone butirrato per il trattamento.
Yang et al. hanno trattato la dermatite atopica con sospensione secca di desloratadina combinata con crema di mometasone furoato e medicazione riparatrice con proteine ricombinanti simili al collagene e hanno dimostrato un’efficacia clinica significativa e un’elevata sicurezza nell’uso a lungo termine. I ricercatori hanno sviluppato una proteina ricombinante simile al collagene e un collagene strutturale funzionale, che promuove l’adesione cellulare e la rigenerazione del collagene dei tessuti, oltre a riparare la pelle danneggiata, quando aggiunto ai cosmetici.
Usando la ricombinazione genetica e la fermentazione biologica, i ricercatori hanno sviluppato molecole proteiche più piccole non altrimenti ottenibili dal collagene comune. Inoltre, hanno creato un database di molecole bioattive naturali di piante ed esseri umani allo scopo di progettare e fornire materie prime antietà per la cura della pelle derivate dal collagene ricombinante.
Conclusione
Qui vengono riassunti i progressi della ricerca sulla classificazione, le caratteristiche, i diversi sistemi di espressione e le applicazioni del collagene ricombinante in vari campi dell’industria cosmetica, fornendo una base per ulteriori ricerche cliniche.
© atk work/shutterstock.com
Con i progressi scientifici e tecnologici, il collagene ricombinante diventerà un’alternativa per la produzione di collagene su larga scala, infatti con la tecnologia del DNA ricombinante si creerà nuovo collagene per l’industria dei dispositivi medici e altri settori. Oltre alla produzione a basso costo e su larga scala, i potenziali benefici di questa tecnologia includono l’eliminazione del rischio di agenti patogeni del collagene isolato da fonti di mammiferi, l’evitare l’uso di animali e problemi nel processo di produzione, consentendo la produzione di collagene “boutique” geneticamente modificato con nuove caratteristiche.
Tuttavia, la resa, il tasso di idrossilazione dell’idrossiprolina, le caratteristiche strutturali della tripla elica e la purezza del collagene ricombinante attualmente preparato necessitano ancora di miglioramenti. Tuttavia, essendo una bioproteina molto apprezzata, le applicazioni del collagene ricombinante vengono gradualmente coinvolte nell’ingegneria dei tessuti cutanei, promuovendone lo sviluppo e l’applicazione in un ampio spettro di campi biologici.
Studi recenti suggeriscono che i follicoli capillari (HF) di chi soffre di problemi di capelli presentano carenze nutrizionali e un metabolismo più quiescente, rendendo l’integrazione alimentare un intervento necessario per combattere la perdita di capelli. L’integrazione di collagene è un argomento di crescente interesse nel campo della salute dei capelli. Il collagene fornisce supporto strutturale e contribuisce alla forza e all’elasticità della pelle favorendo un ambiente più favorevole per i follicoli piliferi. Gli integratori alimentari contenenti i peptidi di collagene (CP) hanno dimostrato di aumentare lo spessore dei capelli e si sono dimostrati efficaci contro la caduta dei capelli nei pazienti affetti da alopecia e/o effluvio in telogen. Durante la digestione però, i CP si scompongono in aminoacidi liberi e in di- o tripeptidi, caratterizzati da un elevato contenuto di aminoacidi idrossi-prolina, glicina e prolina.
In una recente pubblicazione, il team condotto dallo scienziato Karin Pappelbaum ha voluto esaminare gli effetti dei CP di origine marina e bovina (rispettivamente m- e b-Collagene) sulle funzioni di HF utilizzando un modello di coltura di organi HF umani clinicamente significativi, in condizioni sperimentali fisiologicamente verosimili, inclusa la simulazione della digestione umana dei CP, per imitare l’ingestione orale e il metabolismo.
Successivamente, è stato studiato l’effetto dell’applicazione di m- o b-Collagene su HF ex vivo esaminando i risultati sul ciclo del capello. L’applicazione di m-Collagene ha mantenuto significativamente più HF in fase anagen rispetto ai controlli. L’effetto di prolungamento dell’anagen di m-Collagene è stato verificato da una proliferazione cellulare significativamente più elevata (Ki-67+).
L’effetto dei CP sul numero e sulla distribuzione degli eHFSC e sul loro la progenie è stata esaminata analizzando i marcatori
Una strategia adiuvante utile per ridurre l’eccessiva perdita e l’assottigliamento dei capelli associati all’invecchiamento dei follicoli piliferi

di Biancamaria Mancini
eHFSC K15, K19 e CD34 nel bulge e nei subORS per includere cellule pluripotenti e progenitrici. In questo caso il trattamento con m-Collagene non ha influenzato né le percentuali di cellule eHFSC K15+, né l’espressione K15+ nel bulge.
Tuttavia, la proliferazione delle cellule K15+ era significativamente inferiore nel bulge sotto trattamento con m-Collagene rispetto ai controlli, indicando il mantenimento della quiescenza e la preservazione della nicchia eHFSC.
Sebbene non significativamente, questa tendenza, insieme a una maggiore quantità di cellule CD34+ negli HF trattati con m-Collagene, indica che il trattamento con m-Collagene promuove la differenziazione delle eHFSC in cellule progenitrici K19+ e CD34+ o modula direttamente queste sottopopolazioni di HFSC, mantenendo anche una nicchia di eHFSC quiescente ex vivo.
Ciò suggerisce che m-Collagene supporta il mantenimento dell’anagen almeno in parte regolando le attività delle eHFSC. Per il b-Collagene si osserva invece che la percentuale di cellule K15+ è aumentata significativamente nel bulge degli HF trattati rispetto ai controlli, in-
dicando un rafforzamento della nicchia delle cellule staminali. Questo studio è il primo a dimostrare gli effetti benefici dei peptidi m-Collagene e b-Collagene idrolizzati sui principali processi biologici dell’HF umano intatto, utilizzando il modello di coltura di organi HF clinicamente rilevante.
È interessante notare che le specie di pesci teleostei esprimono tre catene y di collagene 1, mentre i mammiferi ne esprimono solo 2, inoltre il contenuto di idrossiprolina e/o il grado di idrossilazione degli amminoacidi prolinici differisce tra specie marine e bovine. Pertanto, queste differenze possono spiegare i risultati funzionali divergenti descritti a seguito dell’integrazione con CP bioattivi isolati da pesci e mammiferi.
Un’altra spiegazione per i diversi effetti del m- e del b-collagene sulla funzione delle HFSC potrebbe essere che i CP regolano la nicchia delle cellule staminali interagendo con i componenti della matrice extracellulare (ECM). I CP possono legarsi ai recettori dell’integrina dell’ECM che sono espressi anche nelle HF. Da tale studio possiamo concludere che i collageni m e b possono contribuire alla resilienza delle popolazioni HFSC.
Entrambi i tipi di collagene hanno ridotto la proliferazione di eHFSC pluripotenti K15+ e hanno migliorato la generazione di progenie di cellule staminali K19+ e/o CD34+. Inoltre, i CP bovini hanno aumentato significativamente le cellule K15+ nel bulge e i CP marini hanno mantenuto significativamente gli HF più a lungo in anagen. I pubblicati suggeriscono che sia i CP marini che quelli bovini possono aiutare a prevenire la caduta dei capelli e a mantenere i capelli sani preservando le eHFSC e migliorando la generazione di progenie di SC.
Sebbene ciò meriti un’indagine clinica, l’m-Collagene potrebbe essere di particolare interesse nel prevenire la diminuzione improvvisa della durata dell’anagen, la conseguente induzione prematura del catagen e la fase telogen prolungata osservata nei pazienti con effluvio in telogen e alopecia.

Il collagene fornisce supporto strutturale e contribuisce alla forza e all’elasticità della pelle favorendo un ambiente più favorevole per i follicoli piliferi. Gli integratori alimentari contenenti i peptidi di collagene (CP) hanno dimostrato di aumentare lo spessore dei capelli e si sono dimostrati efficaci contro la caduta dei capelli nei pazienti affetti da alopecia e/o effluvio in telogen.

Bibliografia
Karin I. Pappelbaum et al.: “Revealing novel insights on how oral supplementation with collagen peptides may prevent hair loss: Lessons from the human hair follicle organ culture” Journal of Functional Foods Volume 116, May 2024, 106124
Analizzando le ortofoto delle pinguinaie di Edmonson Point e Adelie Cove vicine alla stazione “Mario Zucchelli”, Enea stima l’efficacia riproduttiva

di Gianpaolo Palazzo
In un’epoca in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, anche i luoghi più remoti del Pianeta non restano indietro. Per la prima volta, l’intelligenza artificiale sarà utilizzata in Antartide per contare e classificare i pinguini di Adelia che vivono nei pressi della Stazione italiana “Mario Zucchelli”.
Questa innovativa metodologia, sviluppata da Enea, combina droni, IA e la potenza del supercomputer Cresco (Centro Computazionale di Ricerca sui Sistemi Complessi). «La precisione della conta - spiega Riccardo Scipinotti, ricercatore Enea attualmente capo spedizione presso la base italo-francese di Concordia sul plateau antartico, a oltre 3mila metri di quota e a 1.200 chilometri dalla costa - è risultata pari al 97% per i pinguini adulti e 89% per i pulcini, valori ottimali in quanto molto attendibili».
I risultati sono stati ottenuti analizzando le ortofoto (rappresentazioni fotografiche, anziché disegnate, della planimetria del terreno con sovrapposti i dati altimetrici, le curve di livello etc.) delle due pinguinaie più vicine alla base italiana, Edmonson Point e Adelie Cove, che ospitano rispettivamente circa 4mila e 10mila esemplari. Per stimare l’efficacia riproduttiva

Per la prima volta, l’intelligenza artificiale sarà utilizzata in Antartide per contare e classificare i pinguini di Adelia che vivono nei pressi della Stazione italiana

nella colonia, un indicatore della salute animale e dei cambiamenti climatici, il conteggio viene ripetuto in due periodi specifici dell’estate australe: a metà novembre, durante la cova, e a metà gennaio, quando i pulcini possono muoversi liberi.
«Nello specifico, - aggiunge Scipinotti - il conteggio è stato ottenuto attraverso speciali droni le cui caratteristiche tecniche li rendono adatti per volare alle basse temperature antartiche e sorvolare vaste aree remote. Per riprendere alcune colonie, senza disturbare gli animali, è stato necessario superare i 50 metri di quota».
Le immagini catturate vengono studiate, inizialmente, dal cluster di supercalcolo Cresco, operativo dal 2017. Si tratta di più computer interconnessi che eseguono conti e simulazioni in parallelo, consentendo un’elaborazione più rapida ed efficiente di grandi quantità relative ai dati. Il sistema restituisce un’ortofoto georeferenziata ad alta risoluzione (circa 1 cm/px). Grazie a tali caratteristiche, è possibile identificare sia i pinguini adulti, alti circa 60 cm, sia i pulcini, che, a circa due mesi di vita, raggiungono un’altezza di 30 cm.
I rilievi fotografici vengono, poi, processati da una rete neurale appositamente allenata per riconoscere quelli, presenti nell’immagine, che in zoologia chiamiamo appartenenti all’ordine degli sfenisciformi distinguendoli in base all’età. «Per l’addestramento della rete neurale - afferma Samuele Pierattini, della Divisione Enea per lo sviluppo di sistemi per l’informatica e l’ICT - è stato usato il supercalcolatore Cresco di Enea, installato presso il centro di Portici, a cui sono state fornite circa 400 immagini con più di 3mila pinguini, ripresi sempre attraverso drone in diverse condizioni di esposizione e posizione nel corso delle ultime otto spedizioni di ricerca».
Scipinotti precisa che: «Rispetto al conteggio effettuato manualmente a campione da personale in campo,

Attualmente è in corso la quarantesima spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e gestito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il coordinamento scientifico, da Enea (pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche) e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) riguardo gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio “Laura Bassi”.

questa metodologia risulta più veloce e permette di monitorare aree remote difficilmente accessibili all’uomo, riducendo anche il disturbo per le specie animali».
Il prossimo passo sarà migliorare l’addestramento del modello che utilizza un processo di apprendimento automatico simile al cervello umano con quanto raccolto durante le spedizioni, per aumentarne l’affidabilità e specializzarla nel rilevamento dei pinguini Imperatore, un’altra specie che vive nei pressi della Stazione “Mario Zucchelli”.
Inoltre, le nuove tecnologie AI saranno utilizzate per creare una rete “leggera” dal punto di vista computazionale, che possa essere installata nell’elettronica del drone e fornire in tempo reale il conteggio dei pinguini rilevati. «In questo modo - conclude Pierattini - non sarebbe più necessario esportare dall’Antartide dati grezzi da elaborare nei laboratori, ma arriverebbe un’informazione già completa per effettuare valutazioni oggettive e studi sullo stato numerico della popolazione dei pinguini».
Attualmente è in corso la quarantesima spedizione del Programma Nazio -
nale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e gestito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il coordinamento scientifico, da Enea (pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche) e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) riguardo gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio “Laura Bassi”.
Quest’ultima navigherà complessivamente tre mesi nelle acque antartiche, per portare avanti le attività di ricerca previste nell’ambito di sei progetti finanziati dal PNRA, oltre a mansioni in collaborazione con l’Istituto Idrografico della Marina Militare e di supporto - logistica alla “Mario Zucchelli”.
La missione si dividerà in due campagne. La prima, di 35 giorni, sarà dedicata a tre progetti scientifici, la seconda ne durerà 43 e vedrà impegnate a bordo trentadue persone per altri tre progetti. Il rientro nel porto di Lyttelton, in Nuova Zelanda, è previsto per il 7 marzo 2025, mentre quello in Italia avverrà nella seconda metà di aprile.

Consulta gli eventi
della Fnob che erogano i crediti formativi
Il report “Pendolaria 2025” di Legambiente evidenzia la crisi del trasporto ferroviario con finanziamenti inadeguati e infrastrutture carenti

© rikstock/shutterstock.com
Un sistema obsoleto, sottofinanziato e penalizzato da scelte politiche miopi. Il rapporto “Pendolaria 2025” di Legambiente dipinge un quadro allarmante riguardo al nostro trasporto sui binari. Il divario NordSud si riflette in modo evidente nel settore ferroviario, con il Meridione che soffre di treni vecchi, linee chiuse e ritardi, mentre al Settentrione, seppur la situazione sia migliore, si registrano tagli ai collegamenti interregionali e infrastrutture inadeguate.
Il Fondo Nazionale Trasporti prevede un incremento di 120 milioni nella legge di Bilancio 2025, ma sono troppo pochi per l’associazione ambientalista. Aggravano ulteriormente la situazione gli oltre duecento eventi meteorologici estremi negli ultimi 14 anni, tra il 2010 e il 2024, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, che provocano interruzioni e sospensioni, condizionando la mobilità di tante perso-
ne. Mentre il sistema ferroviario nazionale è in crisi, risorse ingenti vengono destinate a progetti come il Ponte sullo Stretto, sottraendo fondi preziosi a interventi più urgenti e necessari per migliorare il modo di spostarsi sostenibilmente. Legambiente lancia un monito al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, chiedendo risorse economiche adeguate per una “cura del ferro” efficace. Propone 3 miliardi di euro aggiuntivi al Fondo Nazionale Trasporti, 500 milioni l’anno per l’acquisto di treni regionali, 5 miliardi per costruzione e riqualificazione di linee metropolitane, tranvie, ferrovie suburbane e 200 milioni l’anno per migliorare i servizi Intercity. Tali capitali potrebbero essere recuperati eliminando parte dei sussidi alle fonti fossili, abbandonando progetti come quello per il ponte che collegherà Calabria e Sicilia o nuove superstrade e autostrade in aree già dotate di queste infrastrutture.
I pendolari affrontano quotidianamente rallentamenti, stazioni chiuse da anni e treni strapieni o poco frequenti. Tra le conferme in negativo ci sono le linee ex Circumvesuviane, caratterizzate da avarie, soppressioni, tagli e sovraffollamenti; la Roma Nord-Viterbo, che nel 2024 ha visto oltre 5mila corse soppresse; la Milano-Mortara-Alessandria, serve 19mila persone al giorno ed è afflitta da guasti frequenti e cessazioni del servizio e la Catania-Caltagirone-Gela, con la tratta Caltagirone-Niscemi-Gela sospesa da oltre tredici anni. La Roma-Lido mostra un leggero miglioramento, ma i problemi per i viaggiatori persistono.
Fra le nuove criticità vengono segnalate: la rete di Ferrovie del Sud Est, con il completamento dell’elettrificazione e il potenziamento distanti dagli obiettivi prefissati; il Sistema Ferroviario Metropolitano di Torino, che nel 2024 ha visto un peggioramento sia in efficienza sia in puntualità; la Avellino-Benevento, dove i lavori per i locomotori elettrici sarebbero dovuti terminare nel 2021, ma la scadenza è stata rimandata di volta in volta; la Torino - Cuneo - Ventimiglia - Nizza, con reiterate interruzioni; la rete di Ferrovie della Calabria, con le linee del taurense (Gioia Tauro - Palmi - Sinopoli e Gioia Tauro - Cinquefrondi) sospese

«Il trasporto ferroviario, nonostante alcuni segnali positivi, è ancora vittima - commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - di scelte politiche insensate che rispondono con fatica ai bisogni reali del Paese. Il 2024 è stato un anno difficile per la mobilità sostenibile e su ferro, tra guasti, ritardi, eventi meteo estremi che hanno avuto diversi impatti e la continua corsa all’annuncio di grandi e inutili opere, come il Ponte sullo Stretto, che hanno distolto l’attenzione dai veri problemi di chi viaggia in treno ogni giorno. ©
dal 2011 e in stato di abbandono; la Firenze-Pisa, risultata la peggiore in affidabilità tra quelle toscane e la Vicenza-Schio, molto usata da studenti e lavoratori, ma ancora a binario unico e non elettrificata. Preoccupanti anche i tagli degli ultimi anni nei collegamenti interregionali come Torino - Bologna, Milano - Venezia e MilanoVentimiglia. Il Sud Italia è particolarmente colpito, con un’età media dei treni di 17,5 anni, superiore a quella del Nord, dove si è scesi a 9 anni. La rete ferroviaria del Mezzogiorno è in gran parte non a trazione elettrica e molte linee sono dismesse, come la Palermo - Trapani via Milo (chiusa nel 2013) e la Caltagirone-Gela (2011).
Malgrado la situazione complicata, il rapporto presenta anche alcune buone pratiche, come l’apertura della M4 a Milano, della linea 6 a Napoli e di un nuovo prolungamento per la metro di Catania (con una parziale dismissione della Circumetnea). L’introduzione di abbonamenti integrati (Valle d’Aosta da 20 euro al mese, per l’intera rete regionale; a Bologna con tessere unificate per l’Emilia-Romagna), non è sufficiente per invertire la tendenza.
«Il trasporto ferroviario, nonostante alcuni segnali positivi, è ancora vittimacommenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - di scelte politiche insensate che rispondono con fatica ai bisogni reali del Paese. Il 2024 è stato un anno difficile per la mobilità sostenibile e su ferro, tra guasti, ritardi, eventi meteo estremi che hanno avuto diversi impatti e la continua corsa all’annuncio di grandi e inutili opere, come il Ponte sullo Stretto, che hanno distolto l’attenzione dai veri problemi di chi viaggia in treno ogni giorno. Serve una vera cura del ferro, con investimenti mirati per potenziare il trasporto pubblico su rotaia investendo su treni moderni, raddoppi di linee, passanti ferroviari, potenziamenti, velocizzazioni, nuove stazioni, elettrificazione, infrastrutture efficienti e mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita dei cittadini, la qualità dell’aria e raggiungere gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi, promuovendo un sistema di trasporto integrato e sostenibile, degno di un Paese moderno». (G. P.).

Stanchi di starnuti e occhi che lacrimano?
L’Enea ha messo a punto un sistema di monitoraggio che permette di prevedere con esattezza i picchi allergici
L’incidenza delle allergie da polline è in costante aumento e rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica. Starnuti, naso che cola, occhi che lacrimano: questi sono solo alcuni dei sintomi che rendono la vita difficile a chi ha ipersensibilità stagionali. C’è, però, una buona notizia: grazie all’impegno di Enea e di un team di ricercatori, stiamo facendo passi da gigante verso una migliore gestione del problema.
Il cuore della scoperta risiede nell’utilizzo di dati satellitari ad altissima risoluzione, che consentono di monitorare in tempo reale l’evoluzione della vegetazione e, di conseguenza, la produzione di granuli pollinici. Questo strumento consente agli scienziati d’identificare con buona precisione le aree più esposte ed elaborare previsioni dettagliate sulle concentrazioni atmosferiche, con particolare attenzione a graminacee, olivo, betulla, ambrosia e ontano. Lo studio è stato condotto nell’ambito del progetto Meetout, in collaborazione con Università di Verona, Arianet, ATS Milano e ARPA Veneto. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Agricultural and Forest Meteorology”.
«Abbiamo testato con successo il nostro sistema in Veneto dove siamo riusciti a simulare i processi di dispersione, diffusione a lungo raggio e deposizione del polline con una risoluzione spaziale di 3 km e a calcolarne le concentrazioni su base oraria per l’anno 2019. Tutto questo è stato possibile utilizzando mappature di copertura vegetale molto dettagliate, algoritmi di rilascio stagionale del polline e previsioni meteorologiche» - spiega Antonio Piersanti, responsabile del laboratorio Enea modelli e misure per la qualità dell’aria e osservazioni climatiche e coautore insieme ai colleghi Sofia Tagliaferro, Mario Adani, Nicola Pepe, Gino Briganti, Massimo D’Isidoro, Maira Bonini, Sandro Finardi, Pierpaolo Marchetti, Francesco Domenichini, Mihaela Mircea, Maria Gabriella Villani, Alessandro Marcon, Camillo Silibello.
«Per le sue notevoli potenzialità il nuovo sistema di previsione dei pollini è stato inserito nel nostro modello di monitoraggio della qualità dell’aria (FARM, Flexible Air quality Regional Model) e utilizzato finora per le previsioni quotidiane dei pollini su tutta Europa. Con questo studio, dimostriamo che il sistema può essere applicato anche all’Italia e alle singole regioni, con maggiore dettaglio» conclude Piersanti. Il

Le particelle presenti nell’aria sono come un velo invisibile che avvolge le nostre città. Tale velo, a volte, può diventare un ostacolo al nostro benessere. È come se vivessimo in una casa con le finestre sempre appannate. Investire in ricerca, energie rinnovabili e riduzione delle emissioni è fondamentale, quindi, per proteggerci e migliorare la qualità di ciò che passa nei nostri polmoni.
© krstrbrt/shutterstock.com
confronto tra mappe a bassa (10 km) e alta risoluzione (250 metri - 1 km) ha evidenziato un significativo miglioramento delle valutazioni, grazie all’integrazione d’informazioni più dettagliate nel modello. Le aree montane, dove la variabilità della flora è più marcata, hanno beneficiato in modo particolare da questo approccio, consentendo d’individuare con maggiore precisione i responsabili dei fragorosi etcì.
Circa un quinto della popolazione mondiale soffre di allergie da polline, un problema destinato ad aggravarsi a causa dei cambiamenti climatici. L’aumento delle temperature, la modifica dei regimi pluviometrici e l’incremento della CO2 nell’atmosfera stanno intensificando la produzione di allergeni. Non solo, la siccità e la scarsità d’acqua spingono le piante a colonizzare nuove aree, mentre la globalizzazione introduce specie esotiche, esponendoci a nuovi rischi.
Il controllo aerobiologico, per altro verso, presenta ancora diverse criticità. Le reti sono limitate a causa degli elevati costi dovuti al conteggio manuale, che ha un margine di errore del 20 - 30% legato alla variabilità nell’interpretazione degli operatori. “POLLnet” con 57 stazioni di monitoraggio in 15 regioni, misura ogni giorno le concentrazioni (polline per metro cubo, p/m³) e le raccoglie in un database nazionale accessibile gratuitamente all’indirizzo www.pollnet.isprambiente.it. I bollettini pollinici settimanali, purtroppo, forniscono notizie poco aggiornate, limitando la possibilità di una prevenzione efficace.
Fortunatamente, la tecnologia sta offrendo nuove soluzioni. Dispositivi automatici sempre più precisi stanno rivoluzionando le verifiche, mentre piattaforme digitali e app per smartphone promettono di offrire risultati locali personalizzati nell’arco di un’intera giornata. Tuttavia, è necessario migliorare la qualità di quanto fornito da queste applicazioni.
«L’implementazione di modelli ad alta risoluzione come il nostro - conclude Piersanti - potrebbe offrire informazioni essenziali alle popolazioni più vulnerabili, come i pazienti con asma o allergie, riguardo alle concentrazioni di polline e all’inizio delle stagioni polliniche. Inoltre, permetterebbero di fornire stime accurate delle concentrazioni di polline anche in aree non coperte dalle reti di mitigazione, come già avviene per l’inquinamento chimico dell’aria». (G. P.).

La legge dovrebbe enfatizzare che la natura deve rimanere tale e non essere “sostituita” o spostata per fare spazio ad altre esigenze umane. Una vera protezione della biodiversità richiede non solo il ripristino ma anche la conservazione delle aree già esistenti, evitando che vengano sacrificate per nuovi sviluppi. La legge sul ripristino della natura rappresenta un passo avanti importante, ma il suo successo dipenderà dalla capacità di risolvere questi conflitti e di adottare strategie più integrate e vincolanti.
©

*CTS Associazione Scientifica Biologi senza Frontiere
La legge europea sul ripristino della natura, entrata in vigore nel 2024, punta a ristabilire gli ecosistemi degradati attraverso misure specifiche adattate a ciascun Paese membro. Pur rappresentando un passo ambizioso e significativo verso la salvaguardia della biodiversità, a nostro avviso, rivela alcune contraddizioni che potrebbero compromettere l’efficacia delle misure proposte e meritano pertanto un approfondimento. Un elemento centrale della legge è il ripristino di almeno il 20% delle aree terrestri e marittime dell’UE entro il 2030. Tuttavia, l’obiettivo entra in conflitto con l’attuale uso del suolo. Le crescenti esigenze di spazio per infrastrutture energetiche sostenibili, come i parchi fotovoltaici, stanno consumando ampie porzioni di suolo fertile, precedentemente destinato alla produzione alimentare. Questa dualità di obiettivi – ridurre le emissioni di CO ₂ tramite l’energia rinnovabile e, al contempo, preservare gli habitat naturali –appare non risolta. L’installazione massiva di pannelli fotovoltaici su terreni agricoli riduce lo spazio destinato alle coltivazioni, aggravando le sfide per la sicurezza alimentare già citata nella legge come priorità.
La legge sul ripristino della natura, sebbene preveda misure per proteggere terreni agricoli e forestali, non affronta direttamente questa tensione.
Una pianificazione integrata che concili le esigenze energetiche con quelle alimentari appare fondamentale, ma al momento è assente un approccio chiaro che prevenga il conflitto tra questi due settori strategici.
Un altro punto critico riguarda le cosiddette “infrastrutture verdi”, come i corridoi ecologici urbani e le foreste piantate. Sebbene queste misure siano positive per incrementare la biodiversità, rischiano di diventare un surrogato della natura autentica piuttosto che un complemento. La creazione di spazi verdi urbani o piantagioni pianificate non può sostituire ecosistemi naturali
Una riflessione sulla Nature Restoriation Law o “Legge sul ripristino della Natura” approvata con Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024 e in vigore dal 18 agosto 2024

complessi e consolidati nel tempo, che ospitano un’ampia varietà di specie.
Se da un lato le infrastrutture verdi possono migliorare la qualità della vita nelle aree urbane, dall’altro non devono essere viste come un’alternativa alla conservazione e al ripristino degli habitat naturali. La natura autentica, con la sua complessità e resilienza, è insostituibile e deve essere prioritaria rispetto a soluzioni artificiali o surrogate. Inoltre, il testo suggerisce che non vi sarà alcuna perdita netta di spazio verde urbano fino al 2030, ma ciò solleva dubbi: il mantenimento di un bilancio zero basterà davvero a compensare il continuo deterioramento della biodiversità.
Il regolamento pone anche l’accento su misure ambiziose, come il ripristino del 90% degli habitat degradati entro il 2050, ma non chiarisce come bilanciare

Per ripristinare la natura in modo efficace, riteniamo fondamentale partire dalla valorizzazione della biodiversità locale. Non possiamo limitarci a interventi superficiali, come spesso accade, ma è necessario lavorare sul recupero delle specie autoctone, che svolgono un ruolo essenziale nel mantenere l’equilibrio naturale. Piantare alberi e piante originarie del territorio non solo rigenera i suoli impoveriti e contrasta l’erosione, ma crea habitat resilienti per la flora e la fauna. È altrettanto indispensabile evitare l’introduzione di specie invasive, che alterano in maniera irreversibile gli ecosistemi.
lovelyday12/shutterstock.com
questo obiettivo con le pressioni economiche e infrastrutturali. In particolare, l’espansione di infrastrutture energetiche o residenziali rischia di spostare habitat naturali, creando paradossalmente nuove aree degradate.
La legge dovrebbe enfatizzare che la natura deve rimanere tale e non essere “sostituita” o spostata per fare spazio ad altre esigenze umane. Una vera protezione della biodiversità richiede non solo il ripristino ma anche la conservazione delle aree già esistenti, evitando che vengano sacrificate per nuovi sviluppi.
L’obbligo di prevenire il deterioramento delle aree restaurate è descritto come uno “sforzo” e non come un vincolo assoluto. Questo compromesso potrebbe portare a risultati deludenti, poiché lascia spazio all’interpretazione e alla discrezionalità degli Stati membri.
La legge sul ripristino della natura rappresenta un passo avanti importante, ma il suo successo dipenderà dalla capacità di risolvere questi conflitti e di adottare strategie più integrate e vincolanti.
Ripristino della natura e il rilancio dei borghi: la nostra Proposta
È necessario sviluppare un approccio integrato che, oltre a ripristinare la natura, valorizzi anche i borghi come centri di benessere ecologico, sociale e culturale. I borghi possono diventare esempi di sostenibilità, utilizzando il loro patrimonio culturale e la loro dimensione contenuta come punto di partenza per nuovi modelli di sostenibilità.
L’Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere (ASBSF), con il progetto Borghi del Benessere, al quale hanno aderito ad oggi oltre 50 comuni, si pone obiettivi rivolti al miglioramento della qualità della vita, partendo dal benessere individuale a quello collettivo. Le azioni d’intervento sono mirate alla tutela delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo), al recupero della biodiversità, alla rigenerazione urbana e alla prevenzione di varie patologie
alimentari/nutrizionali, igienico-sanitarie, ambientali indoor e outdoor e quelle che, su più fronti, minano il benessere della salute umana.
La nostra associazione intende affrontare in modo integrato e concreto il ripristino della natura, con l’obiettivo di rilanciare i borghi come centri di benessere e sostenibilità ambientale. Riteniamo che solo una visione sistemica possa superare le contraddizioni presenti nella legge europea attuale e promuovere un equilibrio duraturo tra natura, economia e salute umana.
La nostra associazione, attraverso il progetto “Borghi del Benessere”, intende offrire una soluzione concreta per il ripristino della natura e il rilancio dei piccoli borghi, superando le contraddizioni attuali in materia ambientale. Il nostro approccio si fonda su un modello integrato capace di coniugare la tutela della biodiversità locale, la salute umana e ambientale, la sostenibilità economica e la partecipazione attiva delle comunità.
Per ripristinare la natura in modo efficace, riteniamo fondamentale partire dalla valorizzazione della biodiversità locale. Non possiamo limitarci a interventi superficiali, come spesso accade, ma è necessario lavorare sul recupero delle specie autoctone, che svolgono un ruolo essenziale nel mantenere l’equilibrio naturale. Piantare alberi e piante originarie del territorio non solo rigenera i suoli impoveriti e contrasta l’erosione, ma crea habitat resilienti per la flora e la fauna.

È altrettanto indispensabile evitare l’introduzione di specie invasive, che alterano in maniera irreversibile gli ecosistemi. Inoltre, è necessario promuovere la creazione di corridoi ecologici, vere e proprie reti verdi che connettono le aree protette con i terreni agricoli e consentono il movimento degli animali e delle piante.
In questo contesto, i borghi possono diventare punti chiave di connessione, grazie a spazi verdi integrati e alla rinascita di orti urbani. La tutela della biodiversità richiede anche un monitoraggio costante: il coinvolgimento di esperti e cittadini in progetti partecipativi può contribuire a mappare e proteggere la fauna e la flora locali, rendendo la conservazione un obiettivo condiviso.
Un altro aspetto centrale della nostra proposta riguarda la salute umana e ambientale, strettamente interconnesse. L’ambiente in cui viviamo incide profondamente sul nostro benessere fisico e mentale. Per questo, proponiamo un monitoraggio delle matrici ambientali, come l’acqua, l’aria e il suolo, attraverso strumenti tecnologici e la partecipazione attiva delle comunità locali. Rilevare tempestivamente gli inquinanti consente di intervenire con misure efficaci per la salvaguardia della salute.
© DC Studio/shutterstock.com

Parallelamente, dobbiamo ridurre drasticamente l’uso di pesticidi e sostanze chimiche dannose, promuovendo pratiche agricole biologiche e rigenerative che tutelano sia l’ambiente sia la
salute delle persone. Nei borghi, immaginiamo la nascita di centri di salute naturale, dove medicina preventiva, attività fisica e pratiche olistiche possano integrarsi con l’ambiente circostante, trasformando la natura in una risorsa concreta per il benessere umano.
I borghi, grazie alla loro dimensione contenuta e alla ricchezza storica e ambientale, possono diventare modelli di Longevity Cities, vere città del benessere sostenibile. Crediamo che sia necessario valorizzare l’economia circolare e le filiere locali, rilanciando l’agricoltura di prossimità e l’artigianato tradizionale. Questo approccio non solo riduce gli sprechi e le emissioni, ma crea nuove opportunità di lavoro e rafforza le identità territoriali.
Allo stesso tempo, i borghi possono diventare mete di un turismo sostenibile, basato su esperienze autentiche e rispettose del patrimonio naturale e culturale. Percorsi naturalistici, escursioni lente ed enogastronomia locale possono rilanciare questi centri senza compromettere l’ambiente.
Nessun progetto di ripristino può funzionare senza il coinvolgimento delle persone. La nostra proposta si basa sulla partecipazione attiva delle comunità locali. È necessario investire nell’educazione ambientale e nella formazione, organizzando laboratori nelle scuole e nelle comunità per sensibilizzare grandi e piccoli alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Coinvolgere i cittadini, le associazioni e le istituzioni in progetti partecipativi, inoltre, rafforza il senso di appartenenza e responsabilità verso il territorio.
Questo approccio integrato offre un modello replicabile in altre realtà. I borghi, da luoghi a rischio spopolamento, possono diventare centri pulsanti di un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Recuperando la biodiversità, tutelando la salute e rilanciando l’economia locale, possiamo costruire un futuro in cui le comunità tornano ad essere protagoniste, guidando una trasformazione ambientale e sociale che beneficia tutti.

I borghi, grazie alla loro dimensione contenuta e alla ricchezza storica e ambientale, possono diventare modelli di Longevity Cities, vere città del benessere sostenibile. È necessario valorizzare l’economia circolare e le filiere locali, rilanciando l’agricoltura di prossimità e l’artigianato tradizionale. Questo approccio non solo riduce gli sprechi e le emissioni, ma crea nuove opportunità di lavoro e rafforza le identità territoriali. Allo stesso tempo, i borghi possono diventare mete di un turismo sostenibile, basato su esperienze autentiche e rispettose del patrimonio naturale e culturale. Percorsi naturalistici, escursioni lente ed enogastronomia locale possono rilanciare questi centri senza compromettere l’ambiente.

La cementificazione trasforma aree naturali in urbane aumentando il rischio di alluvioni e danni ambientali
La cementificazione è un fenomeno in crescita che sta trasformando rapidamente le aree naturali in aree urbane. Questo processo, sebbene considerato necessario allo sviluppo economico, ha conseguenze significative sull’ambiente e sulla sicurezza idrogeologica.
Il consumo di suolo è infatti una delle principali cause delle alluvioni: quando le aree naturali vengono cementificate, le superfici impermeabili aumentano, impedendo il drenaggio naturale delle acque piovane. Questo accumulo di liquidi può portare a inondazioni e frane, specialmente
in aree urbane già vulnerabili. Secondo uno studio di “Infobuild”, il consumo di suolo e la cementificazione sono all’origine del fenomeno del “runoff”, la principale causa di alluvioni e frane. Inoltre, la frammentazione del paesaggio naturale impedisce la percolazione delle acque nel sottosuolo, aumentando ulteriormente il rischio di eventi alluvionali.
È quindi evidente come una gestione non oculata del territorio possa portare a gravi conseguenze ambientali ed economiche. La cementificazione, quindi, modifica il paesaggio naturale e impatta anche negativamente sull’e-
cosistema. La perdita di biodiversità e l’aumento delle temperature nelle aree urbane, le cosiddette “isole di calore”, sono solo alcuni degli effetti collaterali. Le alluvioni urbane causano danni economici e sociali elevati, con conseguenze che si protraggono nel tempo per via dei danni significativi alle infrastrutture e alle proprietà private. Tali effetti negativi sulle comunità, che nei casi più drammatici sono rappresentati anche dalla perdita di vite umane, sono spesso sottovalutati.
Per affrontare il problema della cementificazione e delle alluvioni è fondamentale adottare strategie di mitigazione e prevenzione, anziché attuare interventi riparativi. Le soluzioni basate sulla natura (NBS) sono un approccio promettente; tra queste, vi sono ad esempio la creazione di superfici permeabili, il ripristino di aree verdi e la piantumazione di alberi.
Tali misure possono infatti migliorare il drenaggio naturale, nonché ridurre il rischio di eventi catastrofici. La promozione dell’uso di materiali permeabili per le pavimentazioni urbane e l’integrazione di spazi verdi nei piani di sviluppo urbano sono passi da compiere, fondamentali e obbligatori.
Alcuni studi condotti dall’Università di Firenze hanno dimostrato che le città che adottano queste misure vedono una riduzione significativa degli effetti negativi delle alluvioni. Adottare un approccio integrato che coinvolga comunità locali, enti pubblici e privati può accelerare il processo di trasformazione urbana sostenibile.
La cementificazione è un fenomeno complesso, che richiede una metodologia multidisciplinare per un’attuazione sostenibile. Gli esperti concordano sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione e collaborazione tra enti pubblici e privati per lo sviluppo di soluzioni adeguate: solo attraverso la consapevolezza collettiva e l’impegno concreto sarà possibile preservare l’integrità dell’ambiente in cui si vive.
Il Mediterraneo è un mare che non avrebbe bisogno di presentazioni: un luogo a dir poco leggendario, teatro di alcune delle più grandi battaglie della storia dell’Occidente antico, scenario di epopee e favole, miti e racconti. Ma nella storia del “Mare nostrum” non sono stati protagonisti solo donne e uomini famosi. Anche mostri marini e altre creature immaginarie hanno fatto parte della sua storia, come oggi ne fanno parte gli animali che popolano queste acque.
Balene, delfini e tartarughe non sono dei semplici “abitanti”, ma specie animali che incarnano e raccontano la complessità biologica del Mediterraneo, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema del bacino. Le balene, ad esempio, svolgono un ruolo cruciale nella regolazione delle popolazioni di pesci e nella ciclizzazione dei nutrienti. I delfini, con la loro intelligenza e agilità, sono indicatori della salute dell’ambiente marino. Le tartarughe, con le loro migrazioni e i loro habitat, contribuiscono alla biodiversità e alla stabilità dell’ecosistema.
Recentemente, un team di ricercatori ha mappato la distribuzione di queste specie nel Mediterraneo, rivelando la loro presenza in diverse aree del bacino. Questo studio è parte del progetto “LIFE Conceptu Maris”, un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea per la conservazione della biodiversità marina, che mira a proteggere e a sviluppare strategie di conservazione efficaci. Gli scienziati di “LIFE Conceptu Mari” hanno orientato la loro attenzione verso diverse specie di cetacei e tartarughe marine, tra cui balenottere comuni, capodogli, stenelle e tursiopi.
Attraverso la raccolta di dati sulla distribuzione e le preferenze ecologiche di queste specie, i ricercatori possono identificare i siti più importanti per la loro conservazione e sviluppare misure di mitigazione dei

Il progetto LIFE Conceptu Maris raccoglie dati fondamentali per monitorare e proteggere la fauna marina mediterranea
fattori di rischio. Nei tre anni dal suo avvio sono state effettuate dagli studiosi ben 6mila osservazioni, che hanno consentito di registrare avvistamenti di cetacei (65%) e tartarughe (35%) in aree off-shore chiave nel Mediterraneo, dove è stato possibile monitorare anche specie rare come lo zifio (Ziphius cavirostris), il grampo (Grampus griseus), il globicefalo (Globicephala melas) e il delfino comune (Delphinus delphis).
Uno dei principali obiettivi del progetto è inoltre sensibilizzare l’opinione pubblica e coinvolgere la comunità nella protezione di queste specie.
Le attività di “citizen science”, come il monitoraggio di cetacei e tartarughe durante i viaggi in traghetto, permettono ai cittadini di contribuire direttamente alla conservazione marina.
La mappatura ha rivelato anche le sfide che questi animali affrontano: il traffico marittimo, l’inquinamento acustico e la perdita di habitat sono solo alcune delle minacce che mettono a rischio la loro sopravvivenza. Grazie ai dati raccolti, gli scienziati stanno lavorando a soluzioni per ridurre tali rischi e promuovere la coesistenza sostenibile tra attività umane e fauna marina. (M. O.).

Una tecnica innovativa ha studiato l’attività degli organelli
La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications
Attraverso minuscoli organelli di diverso tipo, che funzionano come gli ingranaggi di un motore, le nostre cellule sono in grado di svolgere le più svariate attività. Così come un motore funziona bene quando tutti gli ingranaggi lavorano in sincronia, similmente, per far funzionare le nostre cellule è necessario che i loro diversi organelli coordino le loro attività in modo ottimale. Questo complesso e articolato livello di coordinazione viene raggiunto anche grazie all’esistenza di zone di contatto tra gli organelli stessi. In
queste regioni subcellulari, gli organelli sono fisicamente molto vicini uno all’altro e ciò consente loro di scambiarsi informazioni con elevata efficienza, per lo più sotto forma di un repentino scambio di molecole, contribuendo così alla sincronizzazione delle loro attività.
Un team internazionale, guidato da Riccardo Filadi dell’Istituto di neuroscienze del Cnr di Padova e Paola Pizzo del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Padova, ha condotto uno studio in cui è stata presentata una nuova tecnica, che permette di visua -
lizzare in tempo reale al microscopio la formazione di punti di contatto tra organelli, seguendo le dinamiche di questo processo senza alterarle.
Michela Rossini, dell’Università degli Studi di Padova, prima autrice della ricerca con la collega Paloma Garcia Casas, ha spiegato: «Fino ad oggi studiare queste importantissime regioni cellulari è stato complicato dalle loro minuscole dimensioni e dalla loro natura estremamente dinamica. Questi contatti inter-organello, infatti, si formano e svaniscono di continuo, per rispondere velocemente alle diverse esigenze della cellula. I metodi finora a disposizione non ci permettevano di seguire contemporaneamente, con elevata precisione spaziale e temporale, questi eventi».
Riccardo Filadi, del Cnr, ha aggiunto: «Nel nostro laboratorio abbiamo disegnato delle nuove sonde fluorescenti che crediamo possano rappresentare uno strumento prezioso per la comunità scientifica nel settore della biologia cellulare, in quanto consentono di monitorare come gli organelli comunicano tra di loro in modo dinamico, minimizzando l’impatto che l’espressione di un sensore molecolare può avere su questi fenomeni durante la loro osservazione. Queste sonde innovative ci consentono non solo di capire se alcuni organelli stanno interagendo tra di loro, ma anche di decifrare alcuni dei messaggi che si stanno trasmettendo, basati per esempio sullo scambio di ioni di calcio».
«Il nostro gruppo aveva già riportato come in alcune forme di Alzheimer la comunicazione tra due specifici organelli cellulari, il reticolo endoplasmatico ed i mitocondri, sia alterata. Tuttavia, non è facile comprendere se queste alterazioni siano una conseguenza dell’insorgere della malattia, oppure possano essere una concausa importante, rappresentando, in quest’ultimo caso, un interessante target per lo sviluppo di nuovi farmaci», ha concluso Paola Pizzo dell’Università degli Studi di Padova.
Gli anticorpi monoclonali (mAb) rappresentano una delle frontiere più promettenti della medicina moderna. Nel solo 2023, l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha autorizzato 39 nuovi farmaci, tra cui 9 basati su anticorpi monoclonali. Complessivamente, questo mercato in rapida espansione, ha superato i 200 miliardi di euro lo scorso anno, confermando come i mAb siano diventati importanti nella lotta contro numerose patologie.
Emanuela Pedrazzini, dell’Istituto di biologia e biotecnologia agraria del Cnr, ha spiegato: «I mAb sono molecole singole che riconoscono con straordinaria precisione uno specifico bersaglio (tecnicamente chiamato determinante antigenico), spesso una piccola porzione di una proteina. Mentre il nostro corpo produce naturalmente anticorpi policlonali, cioè che non riconoscono diverse parti di una proteina estranea, gli anticorpi monoclonali sono progettati per colpire un solo bersaglio con estrema precisione. Questa caratteristica, unita alla possibilità di produrli in modo standardizzato e in grande quantità, li rende particolarmente efficaci come farmaci».
I costi elevati per produrre mAb in colture cellulari di mammifero hanno spinto da decenni la ricerca di sistemi alternativi che sfruttino l’ingegneria genetica, come per esempio la produzione in lieviti, cellule di insetto o intere piante. In questo contesto si inserisce una delle innovazioni più affascinanti della biotecnologia moderna: i “plantibody”, anticorpi prodotti da piante usate come vere e proprie “biofabbriche”. Grazie all’ingegneria genetica, i ricercatori inseriscono nelle piante i geni necessari per sintetizzare specifici anticorpi, che sono così prodotti in modo efficiente e su larga scala grazie al sistema di sintesi proteica delle cellule vegetali.
La ricercatrice Pedrazzini ha proseguito: «La storia di questa tecnologia risale a 35 anni fa, quando,

Sono stati denominati plantibody. Si tratta di anticorpi per uso umano prodotti da piante geneticamente modificate
nel 1989, un gruppo di ricercatori riuscì per la prima volta a produrre anticorpi di classe G (IgG) in piante transgeniche. Gli IgG sono gli anticorpi più abbondanti nel sangue umano e svolgono un ruolo essenziale nel sistema immunitario.
Un ulteriore passo avanti fu fatto pochi anni dopo, quando gli scienziati del Guy’s Hospital di Londra riuscirono a “programmare” una pianta di tabacco per produrre un potente anticorpo contro lo Streptococcus mutans, il batterio responsabile della carie dentale. I ricercatori del Cnr-Ibba hanno collaborato con il team in -
glese per studiare la sintesi di questo anticorpo all’interno delle cellule vegetali. Abbiamo documentato come queste cellule gestiscono la sintesi e lo smistamento di proteine, mettendo in luce i loro meccanismi interni, che possono in parte differire da quelli dei sistemi batterici o animali».
Le piante offrono diversi vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali di produzione. Il loro apparato cellulare per la sintesi proteica è più simile a quello dei mammiferi di quanto lo sia quello dei batteri o lieviti e i costi di produzione sono notevolmente inferiori. (P. S.).

Un approccio innovativo per supportare l’individuazione della malattia. Lo studio è su Journal of the Franklin Institute
Metodi di apprendimento automatico topologico per l’individuazione dell’Alzheimer: questo è quanto ha verificato uno studio condotto dall’Istituto di scienza e tecnologie dell’informazione del Cnr di Pisa in collaborazione con l’Istituto di fisica applicata del Cnr di Firenze, l’Università di Firenze e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi.
L’uso di metodi avanzati di machine learning applicati ai dati di spettroscopia Raman acquisiti su campioni biologici permette di rilevare alterazioni biochimiche associate alla malattia di
Alzheimer, facilitando così un’individuazione più accurata. La ricerca mirava a distinguere i soggetti affetti da Alzheimer da altre patologie del sistema nervoso centrale mediante la classificazione dei dati ricavati dalla spettroscopia Raman, una tecnica che analizza le interazioni della luce con le molecole del campione, rilevando così le alterazioni biochimiche che possono indicare la presenza della malattia.
Per la prima volta, e questa è l’innovazione principale, è stato applicato un metodo avanzato per l’analisi e la classificazione dei dati di spettroscopia Raman acquisiti da campioni
di liquido cerebrospinale, sfruttando tecniche di apprendimento automatico topologico. Questo approccio combina il machine learning e la topologia computazionale, cioè una branca della matematica che studia la struttura e la forma dei dati, consentendo così l’identificazione precisa delle alterazioni biochimiche che possono segnalare la malattia di Alzheimer.
Maria Antonietta Pascali, ricercatrice del Cnr-Isti, ha affermato: «Dagli spettri Raman vengono estratte caratteristiche di forma, che vengono poi utilizzate per addestrare algoritmi di machine learning capaci di classificare i dati. L’ottimizzazione del processo consente di selezionare il miglior modello predittivo, aumentando così l’accuratezza nella distinzione tra Alzheimer e altre patologie del sistema nervoso centrale». I risultati sono promettenti: il metodo ha dimostrato prestazioni stabili su diversi dataset.
La ricercatrice ha aggiunto: «L’accuratezza dell’86% raggiunta nella classificazione dei campioni di liquido cerebrospinale suggerisce un potenziale importante nel riconoscimento dei soggetti Alzheimer».
L’importanza di questa ricerca è sottolineata dalla crescente prevalenza dell’Alzheimer a livello globale. Si stima che entro il 2050, con l’invecchiamento della popolazione, circa 152 milioni di persone saranno affette da questa malattia o demenze correlate. Quindi, la ricerca di nuove terapie e di marker biologici per una diagnosi precoce è cruciale.
La Pascali ha concluso: «Questa metodologia promette di fornire una chiave di lettura efficace non solo per l’Alzheimer, ma potenzialmente anche per altri casi studio. Le evidenze della ricerca fanno sperare che nel prossimo futuro si possa affinare ulteriormente il metodo anche per fornire delle indicazioni aggiuntive riguardo i meccanismi biochimici alla base dell’insorgenza e dell’aggravarsi di questa malattia». (P. S.).
Poter mantenere freschi tessuti e alimenti anche se la temperatura esterna è elevata e raffrescare gli edifici senza ricorrere alla climatizzazione elettrica e, quindi, disperdere calore nell’ambiente circostante, non è più un traguardo impossibile. È quanto potrebbe essere realizzato dalle proprietà ottiche di un metamateriale (materiale che evidenzia straordinarie proprietà elettromagnetiche non disponibili in natura, ma progettato manipolando la sua struttura fisica) isolato dall’aria (ad esempio, posto in un contenitore riempito di krypton, un gas nobile presente in tracce nell’atmosfera) a cui sta lavorando Enea, in grado di mantenere una temperatura fino a 12°C al di sotto di quella circostante.
Anna Castaldo, che ha firmato il primo lavoro insieme ai colleghi Enea del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili Emilia Gambale, Manuela Ferrara, Michela Lanchi, Giuseppe Vitiello e Michele Zinzi, ha spiegato: «Il lavoro che stiamo svolgendo parte dalla domanda se sia concretamente possibile trasferire nell’Universo il calore di un oggetto senza disperderlo nell’ambiente circostante. La risposta positiva dalla quale siamo partiti proviene da un metamateriale che abbiamo ottenuto per sputtering (spruzzamento) e che, snellito nella sua formulazione e adattato a substrati adesivi, potrebbe rivestire grandi superfici». A differenza della maggior parte dei metodi di raffreddamento attualmente utilizzati, come i condizionatori che richiedono energia elettrica e risorse per smaltire il calore, il raffreddamento radiativo è un metodo passivo simile a quello naturale che la Terra stessa adopera per raffreddarsi di notte.
La ricercatrice ha proseguito: «Il raffrescamento passivo radiativo, ossia lo smaltimento del calore da un oggetto caldo al freddissimo universo attraverso una regione infrarossa in cui l’atmosfera terrestre è traspa -
© D.L.Rybalchenko/shutterstock.com

Pubblicata su Energies la prima ricerca in Europa sul raffreddamento passivo diurno con un approccio fotonico
rente, è uno dei grandi temi del 21° secolo affrontato circa 50 anni fa da ricercatori come Silvestrini e Nicolais, laddove la maggior parte delle necessità quotidiane, dalla produzione di energia allo scambio di dati, generano calore in eccesso».
I dispositivi capaci di smaltire il loro calore nell’universo hanno superfici spettralmente selettive e sono in grado di raggiungere temperature più basse di quelle dell’aria circostante o degli altri oggetti presenti. Questo può accadere anche durante il giorno sotto irraggiamento solare diretto quando è possibile osservare
una diminuzione della loro temperatura, teoricamente anche di 80°.
La Castaldo ha concluso: «Sull’argomento ho organizzato una sessione specializzata sul Passive Radiative Cooling, durante la 12° edizione dell’European Optical Society Annual Meeting 2024, che si è svolta a Napoli ed ha visto la partecipazione di eminenti studiosi contemporanei del settore, come il Prof. Aaswath Raman e del Prof. Luigi Nicolais autore, tra gli altri, dello studio pioneristico di ormai 50 anni fa, al quale si devono i primi tentativi per creare un frigorifero solare». (P. S.).
Biologia e conservazione dei beni culturali
Il ruolo del biologo nell’analisi e prevenzione del biodeterioramento di opere d’arte e monumenti attraverso tecniche moderne
di Maria Carla Sclocchi*

* Libero professionista, già Responsabile Laboratorio di Biologia ICPAL, Ministero della Cultura
1The biodeterioration of materials—an appraisal
H.J. Hueck, International Biodeterioration & Biodegradation Volume 48, Issues 1–4, 2001, Pages 5-11
© Domanin/shutterstock.com
Oggi parlare di beni culturali è un esercizio comune dato il grande slancio che il turismo culturale sta avendo da qualche anno a questa parte. Andar per mostre, monumenti ed eventi fa parte del tempo libero dei cittadini e di coloro che da paesi lontani vengono appositamente per vedere i nostri capolavori. Parlare di biologia e di biologi in questo contesto può sembrare strano ai più.
Il termine Biodeterioramento, coniato più di 40 anni fa da Hueck 1(Biodeterioration: Hueck (1965, 1968) defined biodeterioration
as ‘any undesirable change in the properties of a material caused by the vital activities of microorganisms), contiene in sé tutto quello che la disciplina della Biologia insegna agli studenti sul rapporto tra i materiali organici e inorganici (alla base di tutti i Beni culturali) e gli agenti biologici presenti in natura di cui tutti noi facciamo parte.
Chiedersi perché un monumento in pietra o un libro antico o moderno, o un dipinto, per dare esempi comuni, si possano deteriorare e, in casi estremi, distruggere fino a scomparire, coinvolge quella categoria di biologi interessati a comprendere questi ecosistemi. Conoscere perché certe piante si trovino a loro agio crescendo sui ruderi di un tempio antico oppure interrogarsi sul perché le pagine di un libro neanche troppo antico, anzi, più vicino a noi di quanto si immagini, si possa coprire di macchiette puntiformi note come foxing ed emanino anche degli odori che ricordano luoghi chiusi, solo per fare degli esempi, coinvolgono un biologo in uno studio approfondito da specifiche analisi di laboratorio.
Analisi che ad oggi sfruttano le più moderne tecnologie di immagine e di biologia molecolare ormai diventate alla portata di coloro che hanno in mente di perfezionarsi in questo ambito. Un biologo che vuole dedicarsi alla conservazione dei beni culturali deve, in ogni caso, avere una solida preparazione di base delle principali discipline della biologia: dalla botanica generale con particolare riguardo per la micologia, algologia e lichenologia, alla zoologia generale con particolare interesse per l’entomologia. Un biologo nel campo deve imparare ad utilizzare la microscopia ottica ed elettronica per poter diagnosticare facilmente un attacco biologico in atto imparando ad effettuare prelievi su un’opera in maniera non distruttiva.
Deve saper applicare le tecniche di biologia molecolare anche mediante la bioinformatica per cercare di ricostruire la storia di un oggetto. Un esempio di conoscenza botanica: anni fa si riuscì presso il laboratorio di Biologia dell’ICPAL (Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro) a ricostruire gli spostamenti relativi al trafugamento di un mappamondo antico (poi ritrovato) mappando i luoghi attraverso il riconoscimento di tricomi fogliari di leccio ancorati sulla superficie. La specie era diffusa in una particolare zona arborea e da questo si poté
capire la via di trafugamento che era stata per rotolamento lungo un pendio.
La bioinformatica permette un’analisi dettagliata del microbioma e può essere utilizzata come un “bio archivio” di un’opera utile per attuale e futura comparazione biologica di un’opera. Una sorta di impronta biologica sia degli agenti biologici depositati che dei manipolatori nel corso del tempo arrivando a ricostruire anche i luoghi fisici di conservazione delle opere in base alla diffusione delle spore fungine e dei batteri attraverso l’analisi del DNA dai reperti.
Il confronto dei dati ottenuti con la bioinformatica e con la microscopia elettronica forniscono un risultato molto attendibile sullo stato di conservazione di un’opera insieme all’analisi materica. Compito ulteriore, ma non meno importante, è quello di indicare i rimedi per mitigare e/o eliminare gli attacchi biologici dall’opera seguendo le migliori risorse a disposizione applicabili con metodologie aggiornate con il minor impatto sulla materia e con effetti trascurabili sugli operatori. Dato che il fine di questo impegno del biologo nei beni culturali è la migliore e duratura conservazione di un bene, è fondamentale la collaborazione tra le varie discipline scientifiche (fisici, chimici, tecnologi e diagnosti ad.es.) per supportare al meglio il difficile compito del restauratore specializzato.
In Italia operano eccellenti scuole di restauro dei beni culturali di livello universitario che afferiscono al Ministero della Cultura. Basta citare quelli dell’Opificio Pietre Dure, l’Istituto Centrale per il Restauro, l’Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, oltre alle varie Accademie; tutte vere eccellenze scientifiche dotate di moderni laboratori e specifiche competenze per seguire efficacemente la restituzione di un’opera affetta dalle ingiurie del tempo e della cattiva conservazione.
Nella speranza che aumentino al più presto le disponibilità e le possibilità di inserimento lavorativo presso i laboratori di questi istituti storicamente qualificati, il mio personale augurio è di non perdere la concorrenza sul piano scientifico con altri Paesi soprattutto perché l’Italia è una eccellenza per la mole di opere conservate ma anche un paese fragile dal punto di vista ambientale ed è doveroso dedicarsi alla salvaguardia dei luoghi e dei beni con il contributo di studiosi specializzati.

Conoscere perché certe piante si trovino a loro agio crescendo sui ruderi di un tempio antico oppure interrogarsi sul perché le pagine di un libro neanche troppo antico, anzi, più vicino a noi di quanto si immagini, si possano coprire di macchiette puntiformi note come foxing ed emanino anche degli odori che ricordano luoghi chiusi, solo per fare degli esempi, coinvolgono un biologo in uno studio approfondito da specifiche analisi di laboratorio.
Completati i lavori di pulitura e restauro della Tra le novità il sistema di illuminazione che


©

I lavori di restauro e pulitura della cattedrale di Santa Maria Nuova – questo il suo nome completo –sono stati completati in poco più di un anno e hanno restituito la loro luce originaria agli interni del capolavoro Unesco, uno dei siti più conosciuti e visitati dell’intera Sicilia, valorizzando ulteriormente e mettendo in sicurezza gli splendidi mosaici che si estendono addirittura per una superficie di 6400 metri quadrati: solo nella cattedrale di Santa Sofia, a Istanbul, se ne trovano di più.
Zerndl/shutterstock.com
© Andreas
Il Duomo di Monreale, la magnifica cattedrale normanna dai mosaici d’oro, torna a risplendere e a brillare come nei primi anni della sua edificazione, tra il XII e il XIII secolo. I lavori di restauro e pulitura della cattedrale di Santa Maria Nuova – questo il suo nome completo – sono stati completati in poco più di un anno e hanno restituito la loro luce originaria agli interni del capolavoro Unesco, uno dei siti più conosciuti e visitati dell’intera Sicilia, valorizzando ulteriormente e mettendo in sicurezza gli splendidi mosaici che si estendono addirittura per una superficie di 6400 metri quadrati: solo nella cattedrale di Santa Sofia, a Istanbul, se ne trovano di più.
Lavori che hanno riguardato le superfici musive del duomo, alle prese con alcuni pericolosi distacchi provocati da infiltrazioni di malta, ma anche il sistema del ricambio d’aria e soprattutto la creazione di un nuovo sistema di illuminazione, più rispettoso delle idee dei maestri greco-bizantini e cluniacensi che, per volere di re Guglielmo II
il Buono, nel 1172 iniziarono la costruzione del grande tempio.
Secondo la leggenda il re di Sicilia, figlio di Guglielmo I detto il Malo e discendente degli Altavilla, un giorno si addormentò sotto un carrubo, vinto dalla stanchezza durante una battuta di caccia nei boschi di Monreale, cittadina posta su una delle alture che dominano Palermo. La Madonna, a cui era devotissimo, gli apparve in sogno e gli rivelò che nel luogo dove stava dormendo era nascosto il più grande tesoro del mondo.
Re Guglielmo fece scavare e il tesoro, sotto forma di monete d’oro, emerse davvero. Monete che furono destinate alla costruzione del Duomo, come richiesto dalla Vergine al sovrano in base al suo racconto. La cattedrale fu inaugurata nel 1176, anche se il suo definitivo completamento sarebbe stato perfezionato soltanto nel 1267, quasi un secolo più tardi, con la solenne consacrazione celebrata sotto il regno di Carlo d’Angiò e alla presenza di Papa Clemente IV. «Qualcuno l’ha definita la cattedrale più © Roman Babakin/shutterstock.com

bella del mondo», ha raccontato con orgoglio monsignor Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale, nell’annunciare la fine dei lavori di restyling, eseguiti dall’impresa Lares srl di Venezia e finanziati (1,1 milioni di euro) con risorse del Piano sviluppo e coesione – Patto per la Sicilia, su progetto della Soprintendenza dei beni culturali di Palermo.

Ma un altro intervento ha riguardato il progetto di illuminazione messo a punto dall’austriaca Zumbtobel, azienda leader nel settore, con installazione affidata alla Fedelenergy di Torino. «Dopo 40 anni si è resa necessaria l’opera di pulitura e consolidamento dei mosaici, con un ripensamento dell’illuminazione», ha chiarito monsignor Isacchi. «Sono stati creati dei corpi illuminanti adatti per permettere all’oro e ai mosaici di poter risplendere in tutta la loro bellezza.
Dal punto di vista religioso il Duomo di Monreale è straordinario, è un esempio molto evidente di come l’arte sia capace di raccontare il sacro e di essere al servizio spirituale delle persone. Tutto in questa cattedrale racconta Dio. Entrando in questo luogo si entra in una realtà diversa».
E il racconto è affidato soprattutto ai magnifici mosaici aurei, realizzati dai mastri di l’oru greco-bizantini, con raffigurazioni che si estendono per tutte le pareti della cattedrale e che partono dall’estremità orientale con scene della Creazione per arrivare, nella parete destra, a episodi legati al Paradiso terrestre. Nel transetto sono raffigurate scene della vita di Gesù, mentre al termine delle due navate campeggia l’iconica e suggestiva immagine del Cristo Pantocratore, che occupa l’intero catino dell’abside.
Una sorta di simbolo del Duomo di Mon -
reale, un capolavoro che per tutto il 2024 era stato parzialmente oscurato da ponteggi e allestimenti necessari ai lavori di restauro e che ora è tornato fruibile in tutta la sua bellezza, col suo inestinguibile carico di significati e rimandi che si porta dietro.
«All’interno del Duomo di Monreale si racconta tutta la storia sacra, dalla Genesi all’Apocalisse, dall’elemento creazionale all’elemento di redenzione in Cristo fino alla parusia, al mondo celeste che attende il credente», è la spiegazione di don Nicola Gaglio, il parroco della cattedrale di Monreale. «È lì che domina il Pantocratore, che nel suo abbraccio contiene tutte le cose. In lui tutti ricevono l’esistenza ed è lui stesso che li mantiene insieme».
Una cattedrale che dal 2015 è entrata a far parte della World Heritage List e che rappresenta, sin dagli anni della sua costruzione, un ponte tra culture, linguaggi e correnti artistiche diverse. «Per la realizzazione dei mosaici furono coinvolte maestranze chiamate da Costantinopoli, maestranze siciliane pratiche nell’arte musiva, mentre per il chiostro furono chiamate maestranze dal sud della Francia», ricorda don Gaglio. «Vivo quotidianamente il Duomo e alla sua bellezza non ci si abitua mai». Soprattutto ora che la magnifica cattedrale si è rifatta il trucco ed è ancor più luminosa. (R. D.).

Il Duomo di Monreale, un capolavoro che per tutto il 2024 era stato parzialmente oscurato da ponteggi e allestimenti necessari ai lavori di restauro e che ora è tornato fruibile in tutta la sua bellezza, col suo inestinguibile carico di significati e rimandi che si porta dietro. Una cattedrale che dal 2015 è entrata a far parte della World Heritage List e che rappresenta, sin dagli anni della sua costruzione, un ponte tra culture, linguaggi e correnti artistiche diverse.
La squadra di coach Santarelli ha conquistato, senza perdere alcun set, anche il Mondiale per club. E ora è la detentrice di tutti i trofei giocati nell’ultimo anno: un’orchestra perfetta

di Antonino Palumbo
L’Ajax di Cruijff, il Brasile di Pelè e l’Olympique Lionnais di Ada Hegerberg, nel calcio. I Chicago Bulls di Michael Jordan e i Boston Celtics di Larry Bird nel basket.
L’Italia della “Generazione di fenomeni” e la Dinamo Mosca femminile, nel volley. Sono tante le squadre e le nazionali che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dello sport, tanto da apparire per lunghi tratti imbattibili e irraggiungibili. È così che deve apparire, oggi, per quasi tutte le rivali sparse in Italia e nel mondo, l’Imoco Conegliano, club nato nel 2012 e diventato in pochi anni una stella polare della pallavolo internazionale. Sono 26 i trofei conquistati, a partire dal 2016, 23 dei quali
sotto la guida del tecnico Daniele Santarelli.
E conquistando per la terza volta, a fine dicembre, il Mondiale per club, le venete possono fregiarsi del simbolico ma eloquente titolo di “campionesse di tutto”. Grazie alla trionfale cavalcata in quel di Hangzhou, Cina, le “Pantere” sono infatti detentrici del titolo italiano, della Champions League, della Coppa Italia, della Supercoppa italiana e, appunto, del Mondiale per club. “Dominanti” è dire poco.
La stagione 2024-2025 della Prosecco Doc Imoco Conegliano è iniziata così come s’era chiusa la precedente. Con un pesante 3-2 sulla Numia Vero Volley Milano. Dopo il successo in finale di Champions League, quello nella Supercoppa Fineco. Una vittoria di squadra, con Sarah Fahr premiata miglior giocatrice del match, ma col contributo determinante di Joanna Wolosz e Monica De Gennaro (alla nona Supercoppa personale), Isabelle Haak e Gabi.
In campionato, manco a dirlo, sin da principio quella di Cristina Chirichella e compagne è stata sin da subito una marcia senza rivali: 3-0 all’Eurotek Busto Arsizio al Palaverde, idem con turnover nella prima trasferta con la neopromossa Talmassons e poi altri 13 successi netti (al tempo presente per chi scrive), ovvero senza lasciare punti a chi dall’altra parte della rete ha provato a venirne a capo.
Già, Chirichella. Cristina, per gli amici. Trent’anni, napoletana, bandiera dell’Agil Novara per dieci stagioni nelle quali ha conquistato quasi tutto, ad eccezione del Mondiale per club. A Conegliano si sta esprimendo a livelli altissimi. Quelli che un pubblico più ampio ha potuto ammirare anche in versione azzurra nazionale. Notevoli anche le prestazioni e la costanza di Zhu Ting, reduce da un biennio alla Savino del Bene Scandicci, tornata indietro di qualche anno (soprattutto al periodo VakifBank) sia a livello di colpi sia di motivazioni, che le hanno permesso di dimenticare anche i troppi infortuni. Due giocatrici di alto livello, in un ingranaggio che già prima appariva meraviglioso.
E accanto ad altri numeri uno della disciplina: Wolosz in regia, De Gennaro libero, Haak diventata una degli opposto più forti al mondo, al livello di Egonu e Boskovic. Le
potenzialità economiche del club (presidente Piero Garbellotto, vicepresidente Pietro Maschio) e la competenza delle figure dirigenziali e tecniche fanno il resto: i risultati sono solo la conseguenza. E per alcuni Conegliano è diventata la squadra più forte della storia della pallavolo femminile.
Per rendere idea dello strapotere di Conegliano a livello nazionale, basta guardare la classifica del campionato. Nelle prime 15 partite giocate, altrettanti successi; 45 set vinti, appena 3 (tre) concessi alle avversarie, due dei quali alla Roma Volley, che il 5 gennaio ha interrotto la serie consecutiva di set casalinghi vinti in campionato da Wolosz e compagne. Stessa musica in Cev Champions League. L’Imoco è un’orchestra talmente rodata che suona lo stesso spartito anche cambiando le interpreti. Il turnover, insomma, non incide granché sugli esiti dei match. Le nuove leve si mettono in mostra e la classifica sorride. Cinque incontri, cinque successi con un solo set perso, a Resovia in Polonia, contro l’antagonista principale per il primato nel proprio girone. Ma il Mondiale per club? Ci arriviamo. In Cina si è capito subito quali sarebbero state le contendenti finali per il titolo. Tre successi di fila per le padrone di casa del Tianjin, altrettanti per l’Imoco con Praia Clube, Ninh Bình e Nec Red Rockets. Pure Milano, in semifinale, stavolta è rimasta al palo contro le “Pantere”, che sono approdate senza macchia alcuna al match per il titolo allo Huanglong Sports Center. Le cinesi, invece, hanno faticato appena poco di più nella loro semifinale con le brasiliane del Praia Clube, 3-1 il risultato.
E la finale contro la squadra della fortissima schiacciatrice Li è stata, inizialmente, una delle partite più complicate della stagione per Conegliano. Almeno fino al 14-18 del primo set, poi vinto 25-21 dalle venete, trascinate da una Haak poi premiata Mvp - Most valuable player della finale e del torneo. Haak che ha chiuso un secondo set dominato (25-15) con un ace a 105 km orari. E ha messo il sigillo finale su un terzo set a lungo equilibrato (25-19), prima che la voce di Freddie Mercury intonasse una canzone “piuttosto” famosa. Che a Conegliano, ormai, conoscono a memoria ma non si stancano mai di cantare.

L’Imoco Conegliano, club nato nel 2012 e diventato in pochi anni una stella polare della pallavolo internazionale. Sono 26 i trofei conquistati, a partire dal 2016, 23 dei quali sotto la guida del tecnico Daniele Santarelli. E conquistando per la terza volta, a fine dicembre, il Mondiale per club, le venete possono fregiarsi del simbolico ma eloquente titolo di “campionesse di tutto”.
Malgrado l’assenza di Olimpiadi, Mondiali ed Europei di calcio, il calendario dei grandi eventi offre diversi spunti interessanti, con l’Italia possibile protagonista

Èvero: gli anni pari rischiano di essere guardati con un pizzico di noncuranza dagli amanti di grandi eventi sportivi come le Olimpiadi e da chi segue il calcio solo o soprattutto quando l’Italia gioca gli Europei e Mondiali (e questi ultimi, fra l’altro, non li disputiamo dal 2014). Ma non di solo calcio, né di sole Olimpiadi, vive l’uomo e neppure la donna, ça va sans dire. E perciò basta poco per accorgersi che anche il 2025 sarà comunque un anno di importanti appuntamenti sportivi

tutti da seguire e da tifare.
Sono tanti i tifosi, così come i praticanti, “guadagnati” negli ultimi anni dal tennis, disciplina che nel 2024 ha proiettato l’Italia fra le grandi potenze con i due tornei Slam vinti da Jannick Sinner (primo italiano numero 1 al mondo), il bis degli azzurri in Coppa Davis e il terzo trionfo delle ragazze in Billie Jane King Cup, il titolo olimpico di Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio femminile e il bronzo di Lorenzo Musetti, il successo di Sara agli Us Open nel doppio misto con Andrea Vavassori, le finali Slam di Jasmine e gli oltre trenta successi totali. Emozioni ripartite dagli Australian Open, primo Slam dell’anno, che si è concluso da pochi giorni e ha visto diversi fra gli italiani protagonisti.
La stagione dell’atletica leggera avrà il suo culmine nei Mondiali in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre prossimi. L’ultima rassegna iridata, Budapest 2023, si è chiusa per l’Italia con quattro medaglie totali e qualche delusione in alcune discipline (come la marcia), ma anche con tanti eloquenti piazzamenti. Sarà chiamato a difendere il titolo del salto in alto Gianmarco Tamberi, piegato ai Giochi di Parigi dalle coliche renali e comunque qualificatosi per una soffertissima finale.
A proposito di salti, l’Italia guarda con fiducia alle giovani star del “lungo”, Larissa Iapichino e Mattia Furlani. La toscana ha chiuso quarta pochi mesi fa la sua prima esperienza in un’Olimpiade, mentre il suo omologo romano ha messo al collo la medaglia di bronzo. Non l’unica nel 2024, considerando anche gli argenti agli Europei di Roma e ai Mondiali indoor di Glasgow. E se il bicampione olimpico di Tokyo 2020, Marcell Jacobs, proverà a tornare sul podio degli uomini-jet nei 100 metri, Nadia Battocletti può ritagliarsi uno spazio da protagonista nel mezzofondo. Non si vincono a caso l’argento nei 10mila metri piani ai Giochi e i titoli europei (a Roma) sia sui 10mila sia sui 5metri metri piani. Occhio anche a Leonardo Fabbri nel getto del peso e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli.
Titoli iridati in palio anche nella pallavolo. Dal 22 agosto al 7 settembre le azzurre campionesse olimpiche saranno in
campo in Thailandia, inserite nel girone con Belgio, Cuba e Slovacchia. Nell’ultima edizione, tre anni fa, l’Italia fu bronzo, grazie al 3-0 nella “finalina” con gli Stati Uniti, dopo aver ceduto 1-3 in semifinale al Brasile. L’Italia è attualmente leader del ranking mondiale, proprio davanti alle sudamericane. Cercherà il riscatto invece l’Italvolley maschile di Fefè De Giorgi, che alle Olimpiadi è giunta ai piedi del podio. Nell’albo d’oro dei Mondiali, però, l’Italia spicca come squadra detentrice del trofeo. E dal 12 al 28 settembre, nelle Filippine, vorrà vendere cara la “pelle”. Prima dei Mondiali, entrambe le nazionali azzurre faranno il consueto “rodaggio” nelle rispettive Nations League. La prima settimana di gara del torneo femminile si disputerà dal 4 all’8 giugno a Ottawa (Canada), Rio de Janeiro (Brasile) e Pechino (Cina). L’Italia ha vinto l’edizione 2024. La Nations League maschile inizierà invece fra Quebec City (Canada), Rio de Janeiro (Brasile) e Xi’an (Cina), dove si giocherà dall’11 al 15 giugno.
L’Eurobasket maschile si disputerà dal 27 agosto al 14 settembre fra Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia, con fasi finali a Riga. L’Italia si è qualificata nel girone B con Islanda, Turchia e Ungheria. Terzo posto e pass matematico a due turni dal termine, ma Melli e soci possono agevolmente concludere in testa le qualificazioni battendo nuovamente Turchia (20 febbraio) e Ungheria (23 febbraio). Ininfluente la sconfitta con l’Islanda, lo scorso novembre, dopo tre successi. Non sarà facile per gli azzurri tornare a medaglia, dopo otto edizioni a secco. Sul podio Giochi di Parigi 2024, dominato dagli Stati Uniti, sono salite Francia e Serbia, solo quarta la Germania campione del mondo in carica (83-77 sulla Serbia, nella finale del 2023). L’Italia non c’era. Attenzione alla Spagna, detentrice del trofeo, che ha vinto quattro delle ultime sei edizioni.
Pillole sparse di altri appuntamenti da inserire in agenda: il Campionato del mondo di Formula 1 con la Ferrari a caccia di un titolo che manca da troppo tempo (primo Gp in Australia il 16 marzo); il Motomondiale, con le Ducati di Bagnaia e Marquez in “pole position” e l’Aprilia che si affida all’iridato Jorge Martin (esordio 2 marzo in Thailandia); il nuovo Mondiale di calcio per club, con Inter e Juventus a rappresentare l’Italia (14 giugno-13 luglio). Senza dimenticare lo sci alpino: abbiamo ragazze che vanno decisamente forte. (A. P.).

L’Italia guarda con fiducia alle giovani star del “lungo”, Larissa Iapichino e Mattia Furlani. La toscana ha chiuso quarta pochi mesi fa la sua prima esperienza in un’Olimpiade, mentre il suo omologo romano ha messo al collo la medaglia di bronzo. Non l’unica nel 2024, considerando anche gli argenti agli Europei di Roma e ai Mondiali indoor di Glasgow.

Il 27enne di Sofia ha regalato alla Bulgaria una vittoria in Coppa del Mondo dopo 45 anni, vincendo in notturna la 3Tre di Campiglio
Con lui, sul podio, c’erano due ragazzoni di 181 e 186 centimetri, Loic Meillard e Samuel Kolega. Nella 3Tre di Madonna di Campiglio, classica italiana dello sci internazionale, il gigante è stato però Albert Popov, 27enne bulgaro alto un metro e 64, capace di dominare un tracciato decisamente insidioso e regalarsi un’autentica impresa. Imponendosi nello slalom sul Canalone Miramonti, Popov si è infatti appuntato al petto la prima vittoria in carriera e al contempo ha riportato al successo la Bulgaria nel massimo circuito mondiale a 45 anni
esatti dall’ultima volta. Tanti ne sono passati, infatti, dall’affermazione di Petar Popangelov nel 1980 a Lenggries, Germania, sempre in slalom.
La 3Tre di Madonna di Campiglio è un affascinante appuntamento che si celebra dal 1957 nella rinomata località trentina. Rispetto ad altre edizioni, quest’anno lo slalom si presentava senza particolari favoriti, visto l’alternarsi di vincitori nelle precedenti prove della specialità: Clément Noel a Levi e Gurgl, a novembre; Henrik Kristoffersen in Val d’Isère e Timon Haugan in Alta Badia, sulla Gran Risa, a dicembre. Fra i possibili outsi-
der, però, in pochi avrebbero pensato a Popov, un solo podio e un pugno di Top 10 in Coppa del mondo. Eppure. In una serata che, come spesso accade, ha visto gli italiani uscire (Vinatzer, mai in Top 5 negli ultimi due anni) o piazzarsi lontano dalla zona sorrisi (il 38enne Stefano Gross 21esimo), i pali stretti hanno regalato una favola che fa applaudire gli appassionati a prescindere dalla bandiera. Il brevilineo Popov non è dispiaciuto già nella prima manche, chiusa però a un secondo e otto centesimi da Atle Lie McGrath. Ma il capolavoro l’ha compiuto nella seconda, disegnata dal tecnico svizzero Joris, che ha mandato in tilt diversi big tra cui proprio McGrath. Non “Albertino”, però. Il 27enne di Sofia ha aggredito la prova come nessun altro e i 74 centesimi inflitti a Henrik Kristoffersen, che Campiglio l’ha conquistata tre volte, non hanno lasciato dubbi su una prestazione da podio. Le uscite di Matt e Feller, le prove “così così” di Amiez e Strasser hanno reso sempre più concreto il sogno di Popov. Due ottime prestazioni non sono state sufficienti allo svizzero Loic Meillard e al croato Samuel Kolega (al primo podio) per scavalcare Albert. L’uscita di McGrath sul “muro” della seconda manche ha certificato l’impresa del bulgaro.
Nove anni fa, Popov era sopravvissuto a un incidente automobilistico, nel quale ha perso la vita il suo allenatore Drago Grubelnik. Il giorno più buio. Poche settimane fa, a Campiglio, una serata di luce oltre che di luci. «Per me questa vittoria significa tutto, è il premio per anni di lavoro, di sacrifici lontano dalla famiglia. Sono risultati come quello di oggi che ti danno la spinta per continuare e crescere. Riportare la Bulgaria sul primo gradino del podio è qualcosa di importantissimo», ha dichiarato Popov. E mentre si rendeva conto di aver scritto una pagina di storia, non ha dimenticato i ragazzi: «Credete in voi stessi e raggiungerete grandi traguardi», il messaggio. (A. P.).
Il fascino dell’Italia, delle sue città d’arte già capitali e dei suoi territori continua ad attirare gli organizzatori dei “Grandi Giri” del ciclismo. Dopo il “grand depart” del Tour de France, che nel 2024 ha baciato Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, quest’anno arriva l’edizione numero 90 della Vuelta a España. La più importante corsa a tappe spagnola partirà infatti per la prima volta dal nostro Paese. Il Piemonte ospiterà infatti tre tappe e la partenza della quarta (a Susa), per poi volgere verso Francia, Andorra e infine Spagna. E intanto il Giro d’Italia va per la quindicesima volta nella sua storia all’estero: sarà l’Albania a ospitare la grande partenza della Corsa Rosa n. 108.
Le quattro tappe piemontesi della “Vuelta 25” andranno in scena dal 23 al 26 agosto, toccando 137 comuni, gran parte dei quali (73) in provincia di Torino e gli altri in quelle di Cuneo, Novara, Biella e Vercelli. Sullo sfondo, i profili delle Alpi. A Torino si era conclusa la terza frazione dell’ultimo Tour de France, vinta dall’eritreo Biniam Girmay, con Richard Carapaz sorridente maglia rosa.
Da Torino, più esattamente dalla Reggia di Venaria muoverà invece la tappa inaugurale del la prossima Vuelta a España, 183 chilometri con una salita sul Passo Bienca-Tomalino e arrivo a Novara. La seconda tappa partirà da Alba e, 157 chilometri dopo, si concluderà a Limone Piemonte, per il primo arrivo in vetta della corsa: miele per scalatori, con i quali la Vuelta è sempre stata particolarmente amica. La terza tappa in Italia percorrerà 139 chilometri tra San Maurizio Canavese e Ceres, inclusa una salita sul Passo Issiglio, mentre la quarta tappa partirà da Susa.
Se la Vuelta va alla montagna (le Alpi, nello specifico), il Giro d’Italia va oltre il mare, l’Adriatico, per la prima storica grande partenza in Albania che suggella i rapporti di amicizia con

Ad agosto la Vuelta a España affronterà tre tappe in Piemonte mentre il Giro d’Italia partirà per la prima volta dall’Albania
il Paese delle Aquile. La frazione d’apertura, venerdì 9 maggio, andrà da Durazzo a Tirana, lungo 164 km con 1800 metri di dislivello. Il giorno dopo le vie di Tirana saranno teatro di una cronometro individuale di 13,7 km, test importante per le ambizioni degli uomini che lotteranno per la classifica generale. Il trittico di frazioni in terra albanese si concluderà domenica 11 maggio con un’altra frazione di media montagna (come la prima) con partenza e arrivo a Valona, per un totale di 160 km e 2800 metri di dislivello.
Fra big che hanno confermato la partecipazione al Giro d’Italia ci sono
lo spagnolo Mikel Landa e il francese David Gaudu, che punterà alla classifica generale. Non ce la farà invece il campione olimpico e mondiale Remco Evenepoel, ancora in fase di recupero dopo l’incidente dello scorso dicembre con un furgone.
Per la prima volta dal 2020, invece, il Tour de France rimarrà interamente entro i confini della Francia. E ritroverà il tradizionale e iconico arrivo sugli Champs Elysées dopo 3.320 chilometri totali. Al Tour de France punta Tadej Pogacar, il “re” della stagione 2024. Ma si spera possa tornare anche al Giro. (A. P.).
Un racconto potente che esplora la fame di cibo come metafora di un desiderio profondo: amore, accettazione e significato
di
Anna Lavinia
A.K. Blakemore
L’insaziabile
Fazi Editore, 2024 - 18,50 euro
Non molto tempo fa, Monsieur Mangetout – Signor Mangia Tutto – divenne famoso in Francia perché mangiava deliberatamente oggetti insoliti e non commestibili. La storia di Michael Lotito continua a suscitare incredulità anche a distanza di anni dalla morte avvenuta nell’aprile del 2006. Se per molti la sua vita si può definire solo tramite la pazzia, per i medici si tratta di picacismo. Quel disturbo del comportamento alimentare che prende il nome dall’abitudine della gazza (la pica appunto) di alimentarsi indiscriminatamente con ciò che trova.
Era francese anche il Grande Tarare, l’Ingordo di Lione nonché l’Uomo senza fondo narrato in questo volume che pare abbia divorato ogni sorta di creatura compreso sostanze disgustose e non proprio commestibili: oggetti, animali e perfino una bambina. In copertina c’è proprio il suo ultimo pasto, una forchetta d’oro che l’ha lentamente ucciso e portato eternamente alla storia.
Con il suo secondo romanzo, finalista al Dylan Thomas Prize, A.K. Blakemore non ha bisogno di rappresentare la verità ma vuole
semplicemente offrire la riproposizione di un mito. Lo fa con abilità straordinaria e una narrazione affascinante e mai banale, la scrittrice inglese riporta in vita le vicende del passato di un personaggio realmente esistito nelle campagne francesi alla fine del 1700.
In poco più di trecento pagine riesce a ricostruire un mosaico complesso della vita di Tarare dove povertà, fame e mancanza di istruzione delineano un quadro crudo e brutale di una storia incredibile e al contempo disturbante.
La Francia rivoluzionaria descritta è un luogo di tensioni e contraddizioni: mentre le idee di uguaglianza e libertà cercano di farsi strada, le campagne restano immerse in una lotta quotidiana per la sopravvivenza. Dove fame e miseria sono spesso più potenti della morale.
Nessuno riesce a curare la sua fame inesauribile, la sua ossessione di riempirsi di continuo lo stomaco con qualsiasi cosa. Ma tra i personaggi che emergono dalle pagine c’è una figura di resistenza che si staglia con forza: una suora, una donna di fede e dedizione ma anche di grande umanità.
È lei che tenta di offrire conforto e reden-

zione al fenomeno da baraccone Tarare vedendo in lui non solo un mostro ma un’anima tormentata, segnata dalla disperazione e dall’isolamento sociale. Le oscurità delle azioni riprovevoli del protagonista si contrappongono alla speranza incarnata dai valori della compassione e della pietà cristiana che portano il lettore a riflettere sulle fragilità umane. L’appetito insaziabile dell’uomo appare sospeso da ogni giudizio. La scrittrice ci lascia l’arduo compito di decidere se condannarlo o assolverlo dai suoi indicibili peccati. La narrazione, pur mantenendo un tono distaccato, offre numerosi spunti di riflessione su temi universali come la condizione umana, la moralità e i confini tra necessità e desiderio. In fondo, chi è il vero mostro?
Tarare è solo l’ombra di una metafora piuttosto attuale. Tarare può essere il nostro specchio. Forse oggi i veri mostri siamo noi. Abitanti di un pianeta violentato e ferito e affamati da tutto ciò che ci circonda, l’iperconsumismo è il nostro picacismo. Nel divorare tutto senza pensare alle conseguenze, siamo forse più vicini a lui di quanto ci piaccia ammettere.
Riccardo Falcinelli
Visus storie del volto dall’antichità al selfie Einaudi, 2024 - 25,00 euro
Il volto che ci costruiamo determina davvero chi siamo? Neuroscienze, semiotica, storia dell’arte e moda si mescolano per studiare il viso e il rapporto che intratteniamo con esso. Dall’antichità all’inevitabie selfie, più che un libro è un invito a guardare con occhi nuovi ciò che vediamo tutti i giorni, la nostra faccia. (A. L.)

Gabriele Bronzetti
Nel cuore degli altri
Aboca Edizioni, 2024 - 20,00 euro
Un cardiologo è come un orologiaio. Smonta e rimonta i meccanismi del cuore ma non potrà mai entrare nel suo tempo. Tra un elettrocardiogramma e una sala operatoria, il medico e autore di questo volume si rivolge all’arte, al cinema, alla musica e alla letteratura per poter parlare di cuore e cure con i suoi pazienti. (A. L.)
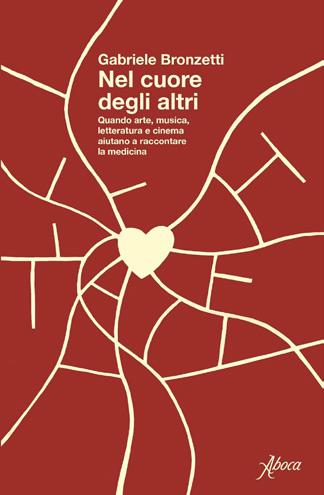
Jérôme Sueur
Storia naturale del silenzio Nottetempo, 2024 - 18,90 euro
“Il suono è onnipresente all’esterno ma brontola anche all’interno: entra dalle orecchie e non ne esce, attraversa il corpo senza difficoltà, raggiunge gli organi, tocca i figli che portiamo in grembo.” Di fronte a tutto il rumore del mondo, il silenzio è segreto ma necessario al suono. Che forme assume, come e dove lo troviamo? (A. L.)

Il ruolo del profilo metabolico urinario nella prevenzione e gestione della calcolosi renale
di 1Giovanni Cangiano, 1Romina Castellano, 1Mariateresa Manzoni, 1Giovanna Masella, 1Emanuele Panella, 1Elvira Donnarumma, 1Erika Eliana Henke, 1Andrea De Rosa, 2Ersilia Satta, 3Lucia Lombardi, 3Piera Catapano3, 1Adalgisa Maffettone
La diagnostica di laboratorio della calcolosi renale può dare un valido contributo al Clinico richiedente (Nefrologo, Urologo e MMG) al fine di evitare recidive litiasiche e di abbassare i fattori di rischio di danno renale e cardiovascolare (sovrappeso e obesità, ipertensione arteriosa, diabete e sindrome metabolica) (1-4). Lo studio metabolico renale è utile per classificare la malattia, per chiarire le sue cause e per valutare l’efficacia delle scelte terapeutiche (5). Il nostro laboratorio effettua la determinazione degli analiti nelle urine del mattino e delle 24 ore al fine di estrapolare la tendenza (supersaturazione relativa) nel formare i più frequenti calcoli urinari (calcio ossalato, calcio fosfato mono acido ed acido urico).
I fattori di rischio della nefrolitiasi sono dovuti principalmente a condizioni nutrizionali e metaboliche e la maggior parte dei calcoli contiene calcio (calcio ossalato e fosfato: 70-80%) ed acido urico (circa il 15%). Percentuali più basse (3% circa) hanno i calcoli da infezione (struvite, carbonato apatite ed urato di ammonio), e quelli di cistina (1-2%). Rare sono le forme ereditarie (xantina e 2,8-diidrossiadenina) (6). La formazione di qualsiasi tipo di cristallo è possibile solamente in una soluzione supersatura. I principali ioni che, cristallizzando, contribuiscono alla formazione dei calcoli sono: calcio, ossalato, urato e fosfato; gli inibitori della cristallizzazione includono invece magnesio, citrato, pirofosfato (7-8). Lo studio metabolico prevede la determinazione di ben 23 parametri di laboratorio (urine 24h: calcio, magnesio, sodio, potassio, ammonio,
1Laboratorio di Analisi Maiello - Gruppo Nefrocenter - Napoli
2Nefrocenter research - Torre del Greco (Napoli)
3Laboratorio di Patologia Clinica - Distretto 28 - ASL Napoli 1 Centro
fosfato, cloro, acido urico, creatinina, proteine, urea, ossalati, citrati, solfati, cistina, pH e volume urinario; urine estemporanee; calcio e creatinina; parametri calcolati: supersaturazione di calcio ossalato, calcio fosfato, acido urico e cistina). La difficoltà di adattare specifiche metodiche di laboratorio su moderne strumentazioni biochimiche rende indispensabile l’utilizzo di un semplice spettrofotometro da banco in grado di effettuare il dosaggio di analiti urinari “difficili” quali cistina, solfati, ossalati e citrati.
Si Illustrano variazioni metodologiche per i kit commerciali di citrati ed ossalati e si propongono nuove metodiche fotometriche per la determinazione di solfati, di cistina e di ammonio urinario. In uno studio effettuato su circa 501 raccolte urinarie (gennaio 2023 – settembre 2024) si evidenziano inoltre le variazioni dei parametri urinari più significativi nelle calcolosi da acido urico, cistina, calcio ossalato e calcio fosfato. Un software dedicato alle calcolosi è in grado di effettuare una refertazione dei dati analitici in cui è presente anche un commento biochimico finale.
Materiali e metodi a. Raccolta dei campioni urinari
Il laboratorio rilascia agli interessati un apposito kit contenente un foglio di istruzioni, etichette adesive per i contenitori, due provette contenenti una 5 mL di acido cloridrico concentrato e l’altra 2 mL di clorexidina digluconato 20% ed infine il relativo modulo di assunzione di responsabilità da firmare. Il paziente effettua la raccolta scartando l’urina al risveglio e raccogliendo tutte le minzioni fino alla prima urina del mattino seguente. L’urina di ogni minzione si divide in due aliquote che vengono riposte in due differenti recipienti da 2,5 litri. Il primo contiene acido cloridrico concentrato, necessario ad evitare la formazione dei precipitati di calcio (9). Nel secondo

contenitore è invece presente clorexidina (potente battericida che impedisce la degradazione dell’urea e quindi l’alcalinizzazione delle urine), necessaria alla determinazione di alcuni analiti urinari ma principalmente alla determinazione del pH. Ad ogni minzione è fondamentale la miscelazione dei liquidi contenuti nei contenitori con le urine. È evidente che la diuresi totale delle 24 ore è rappresentata dalla somma dei volumi raccolti nei due contenitori. Viene inoltre richiesta una raccolta di urine della mattina successiva a quella delle 24 ore e raccolta prima di colazione (10).
b. Dosaggi biochimici
I dosaggi biochimici urinari di cistina, solfati, ossalati, citrati ed ammonio si effettuano sullo spettrofotometro V-11 SCAN della ditta Onda utilizzando delle cuvette micro (12,5 x 12,5 x 45 mm) della ditta Brand. I più comuni analiti urinari contenuti nello studio metabolico per calcolosi (urea, creatinina 24h ed estemporanea, calcio 24h ed estemporaneo, sodio, potassio, cloro, magnesio, fosfati, acido urico e proteine) si dosano sull’analizzatore biochimico DxC 700 AU della ditta Beckman Coulter.
b1. Determinazione degli ossalati (11, 12)
Si basa su una reazione Trinder in cui l’ossalato, ossidato con una specifica ossidasi, produce acqua ossigenata rilevata con un cromogeno che si riduce, in presenza di perossidasi, alla lunghezza d’onda di 590 nm. 20 ml di urina acida (raccolta con acido cloridrico) si trattano con 20 ml di acqua distillata: correggere il pH (uso di pHmetro) con gocce di una soluzione alcalina concentrata (es. NaOH). La soluzione ottenuta, con acidità compresa tra pH 5 – 7, deve essere chiarificata inserendo 2 ml in tubo contenente carbone attivo provvisto nel kit della ditta LTA.
Dopo diverse miscelazioni con vortex e in tempo di circa 20 minuti, i tubi sono sottoposti a centrifugazione: è sufficiente raccogliere almeno 1 ml di sovranatante urinario chiarificato (figura 1). Si prepara una soluzione reagente costituita in parti uguali dai reattivi 1 (tampone succinato pH 3,8) e 2 (cromogeno DMAB: 3 dimetil amino acido benzoico). A 200 µl di soluzione preparata di aggiungono 10 µl di sovranatante e 20 µl di starter (liofilo disciolto con 5
ml di acqua distillata e contenente ossalato ossidasi e perossidasi) (figura 2). Si allestiscono il bianco (acqua distillata), lo standard (0,5 mmol/l), i controlli (normale e patologico della ditta LTA) ed i relativi campioni da testare. Lo strumento prevede l’azzeramento con bianco campione e le successive letture delle assorbanze dei campioni dopo circa 10 minuti di attesa. I risultati finali si ottengono semplicemente effettuando il rapporto delle assorbanze campione/ standard (diluizione: 2 e concentrazione: 0,5).
b2. Determinazione dei citrati (13,14)
Si basa su una reazione in cui il citrato, inizialmente viene scisso ad ossalacetato tramite una specifica liasi. Successivamente l’azione di una malico-deidrogenasi (MDH) e di una lattico-deidrogenasi (LDH), riducono ossalacetato e piruvato prodotti con formazione di NAD e quindi riduzione dell’assorbanza alla lunghezza d’onda di 340 nm. 20 ml di urina acida (raccolta con acido cloridrico) Si prepara una soluzione reagente ricostituendo il liofilo substrato (MDH ed NADH) con 18 ml di soluzione tampone (Tampone di Good 10 mM pH 7,8 ed LDH). Lo starter (liofilo contenente citrato liasi), viene ricostituito con 2 ml di soluzione tampone.
A 220 µl di soluzione substrato si aggiungono 10 µl di standard (0,25 g/l), di controlli (normale e patologico) e di relativi campioni da testare, raccolti con acido cloridrico. Dopo un’attesa di circa 3 minuti si leggono le relative assorbanze. Si aggiungono infine 20 µl di soluzione starter e si leggono le relative assorbanze dopo un’attesa di circa 10 minuti. Tutte le differenze di assorbanza rilevate (standard e campioni) vengono sottratte con quella del bianco campione. I risultati finali si ottengono moltiplicando il rapporto delle assorbanze (campione/standard) per 0,25 (figura 3).

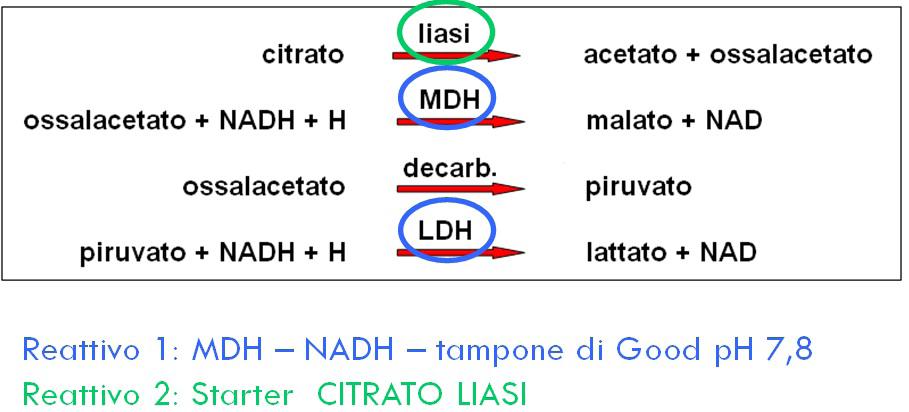
b3. Determinazione dei solfati (15)
Si basa sulla reazione con cloruro di bario, per formazione di solfato di bario, misurato turbidimetricamente alla lunghezza d’onda di 410 nm. A 440 µl di soluzione reattiva (50 mg di cloruro di bario si aggiungono a 5,75 ml di acetato di sodio 0,2 M e 0,5 ml di acido acetico 0,2 M) si aggiungono 5 µl di standard (0 – 20 – 50 – 100, 200 e 400 mg/dl), di controlli (normale e patologico) e di relativi campioni da testare, raccolti con acido cloridrico. Dopo un’attesa di circa 4 minuti si leggono le relative assorbanze contro bianco (standard 0 mg/dl). I risultati finali si ottengono riferendosi ad una calibrazione multipunto (polinomiale) (figura 4).
b4. Determinazione della cistina (16-17)
Si basa sulla reazione con acido fosfotungstico: in ambiente tamponato a pH 5,5 , per aggiunta di 50 µl di tampone acetato 2M (per 6 test soluzione costituita da 150 µl di acidi acetico 2M e 750 µl di acetato di sodio 2M), si aggiungono 85 µl di acqua distillata e 50 µl di urina, raccolta con acido cloridrico, di standard e di controlli. Per i campioni urinari si allestisce una cuvetta bianco in cui sono presenti le stesse quantità di tampone e di urina ma, l’acqua distillata da aggiungere è di 80 µl (invece di 85) ed inoltre c’è la presenza di 5 µl di cloruro mercurico 0,1 M che blocca i gruppi sulfidrici delle cisteine. La cistina presente in tutte le micro cuvette (standard 0 - 10 – 20 e 40 mg/dl, controlli, campioni e bianco campioni) viene ridotta a cisteina con l’aggiunta di 15 µl di solfito di sodio 0,1 M.
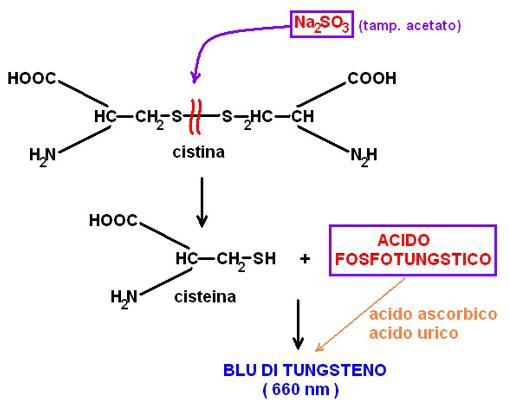
bianco campione a quella dell’assorbanza totale del campione (figure 5 e 6). I risultati finali si ottengono riferendosi ad una calibrazione multipunto (polinomiale).
b5. Determinazione dell’ammonio
Si basa sulla reazione con ossiglutarato e NADH, per formazione di NAD+ . misurato alla lunghezza d’onda di 340 nm. A 250 µl di soluzione reagente della ditta Beckman (contenente alfa-chetoglutarato, NADH, GLDH, LDH e tampone TRIS) si aggiungono 25 µl di standard (100 µg/dl), di controlli (basso, normale e patologico) e di relativi campioni da testare, raccolti con clorexidina (20µl di campione diluiti con 1980 µ di acqua distillata. Si leggono le relative assorbanze a 15 ed a 100 secondi (figura 7). Tutte le variazioni di assorbanza rilevate sono sottratte con quella ottenuta con acqua distillata (bianco). I risultati fi-

Dopo miscelazione ed attesa per circa 5 minuti, si addizionano 50 µl di acido fosfotungstico 30% : dopo 14 minuti di attesa si leggono tutte le assorbanze contro bianco reagente (standard 0 mg/dl). Le assorbanze dei campioni urinari si ottengono sottraendo l’assorbanza del

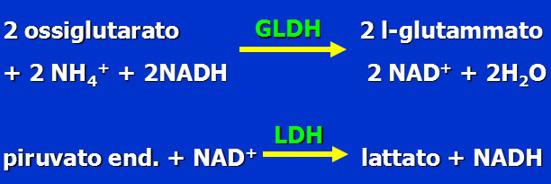
nali si ottengono moltiplicando il rapporto delle assorbanze (campione/ standard) per 100.
c. Software (18)
Il data base in uso e costruito in Access (Office 2023), è costituito da una serie di tabelle (esami, paziente, ecc.) facilmente accessibili grazie alla costruzione di maschere e da diversi report, scaturiti da opportune relazioni (query) utili alla stampa finale del referto. L’utilizzo di piccoli programmi (macro) all’interno dello stesso data base rendono più semplici le ricerche e la immissione dei dati urinari (figura 8), delle supersaturazioni, la ricerca di pazienti, l’inserimento di esami non routinari, ecc. Al fine di visualizzare rapidamente i risultati patologici è possibile evidenziare gli stessi in grassetto grazie all’inserimento degli intervalli di riferimento in fase di programmazione.
c. Valutazioni metaboliche
Si valutano i diversi parametri urinari presenti in campioni risultati positivi per le quattro supersaturazioni renali (calcio ossalato –SSR CaOx, calcio fosfato – SSR CaP, acido urico – SSR UA e cistina – SSR Cys). L’elaborazione dei dati in Excel si riferisce a 501 raccolte urinarie nel periodo gennaio 2023 – settembre 2024.
Risultati e discussione
I dosaggi biochimici da noi proposti per i kit commerciali di ossalati e citrati sono abbastanza rapidi ed agevoli. Usando dei mi-


cro-quantitativi di reagente è possibile triplicare il numero di determinazioni rispetto a quanto dichiarato dal produttore. Per gli ossalati è necessario procurarsi ulteriori tubi per la purificazione delle urine. La scarsa stabilità dei reagenti ricostituiti per la determinazione dei citrati (tampone e starter) può essere ovviata ricavando aliquote (generalmente per un numero totale di 6 campioni) conservate in congelatore e stabili per un mese.
La determinazione fotometrica della cistinuria, inesistente nel commercio, è effettuata dal nostro Laboratorio a costi veramente molto contenuti (circa 300 – 400 euro per un numero di 3000 – 4000 cistinurie) e relativi essenzialmente all’acquisto iniziale di calibratore e reagenti. Le soluzioni da noi ottenute possono essere conservate tranquillamente in frigo ad eccezione del solfito di sodio, stabile per 30 giorni. In un tempo di circa 12 – 14 minuti è possibile ottenere il valore di concentrazione espresso in mg/dl. Eventuali positività (cistinuria superiori a 150 mg/die) sono da confermare con altre tecniche laboratoristiche (cromatografia/spettrometria di massa).
La determinazione fotometrica della solfaturia, inesistente nel commercio, è effettuata dal nostro Laboratorio a costi veramente molto contenuti (circa 100 – 200 euro per un numero di 2000 - 3000 solfaturie) e relativi essenzialmente all’acquisto iniziale di reagenti solidi. Le soluzioni da noi ottenute possono essere conservate tranquillamente in frigo. In un tempo di circa 5 minuti è possibile ottenere il valore di concentrazione espresso in mg/dl.
Nessun problema è apparso nel rapido dosaggio dell’ammoniuria in fixed-time (a tempi prefissati), effettuato su fotometro da banco. I costi sono quasi simili a quelli effettuati per un ammonio plasmatico, dosato su strumentazione completamente automatica
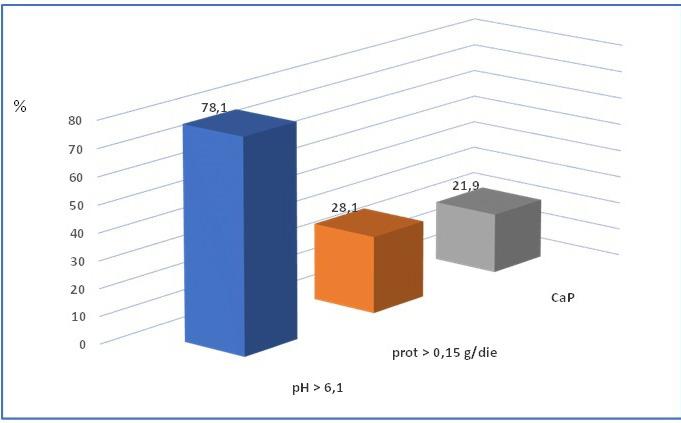
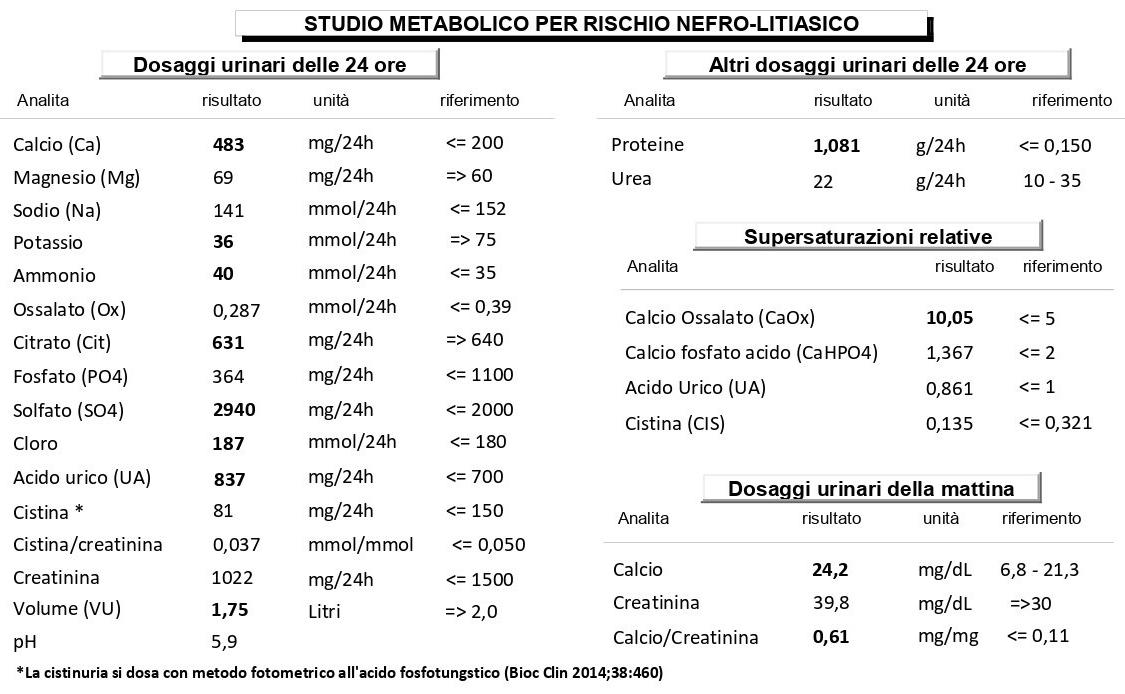
(DxC 700 AU della ditta Beckman Coulter).
Nell’esempio di refertazione di figura 1 appare in alto la zona dell’anagrafica, seguita poi dai dosaggi biochimici. Più in basso è presente l’indicazione dei più importanti parametri determinati (metabolici, ambientali e le supersaturazioni renali) visualizzati con delle barre di istogrammi: i tratti superiori, evidenziati in scuro, caratterizzano i valori patologici superiori (o inferiori) al valore soglia. Un commento finale, esclusivamente di natura biochimica, rende più agevole la lettura del referto sintetizzando i più importanti parametri patologici con degli aggettivi o (lieve, discreto, notevole, ecc.) relativi al contenuto nelle 24 ore.
La valutazione su tutte le supersaturazioni renali, positive per calcio ossalato (>5), calcio fosfato (>2), acido urico (>1) e cistina (>0,321), evidenzia principalmente possibile formazione di calcio fosfato (30%) ed acido urico (27%), così come illustrato in figura 9. Circa il 16% dei 501 campioni urinari esaminati non ha dato alcun riscontro di positività per formazione di calcoli. In tabella 1 si evidenziano i principali parametri biochimici che contribuiscono alla formazione di calcoli di calcio ossalato, calcio fosfato ed acido urico: la positività per calcio ossalato (101 studi metabolici) è principalmente
dovuta alla presenza di ipercalciuria (73,3%); la positività per calcio fosfato (152 studi metabolici) è principalmente dovuta alla presenza di ipercalciuria (85,5%) ma anche ad un pH superiore a 5,9 (78,9%); la positività per acido urico (137 studi metabolici) è principalmente dovuta alla presenza di un pH inferiore a 5,8 (94,2%). Altri parametri rilevanti (carenza di inibitori quali potassio, magnesio e citrato, ipernatriuria ed ipersolfaturia) sono rappresentati in tabella 2. Solo 32 studi metabolici evidenziano positività per formazione di cistina (generalmente pazienti in trattamento) e, il parametro maggiormente rappresentativo è il pH superiore a 6,1 (78,1%). Dalla figura 10 si notano inoltre presenza di proteinuria (28,1%) e possibile formazione di calcoli di calcio fosfato (21,9%).
Nelle figure 11, 12, 13 e 14 si illustrano degli esempi di studi metabolici e le relative sintesi proposte nel referto.
In figura 11 si evidenzia un diminuito introito idrico (1,75 l), una evidente ipercalciuria (483 mg/24h) di origine metabolica (rapporto calcio/creatinina estemporanea superiore a 0,11), una ridotta assunzione di inibitori della calcolosi calcica (citrato quasi nei limiti e specie potassio a 36 mmol/24h), una aumentata assunzione di proteine di origine animale (solfati 2940 mg/24h), una escrezione
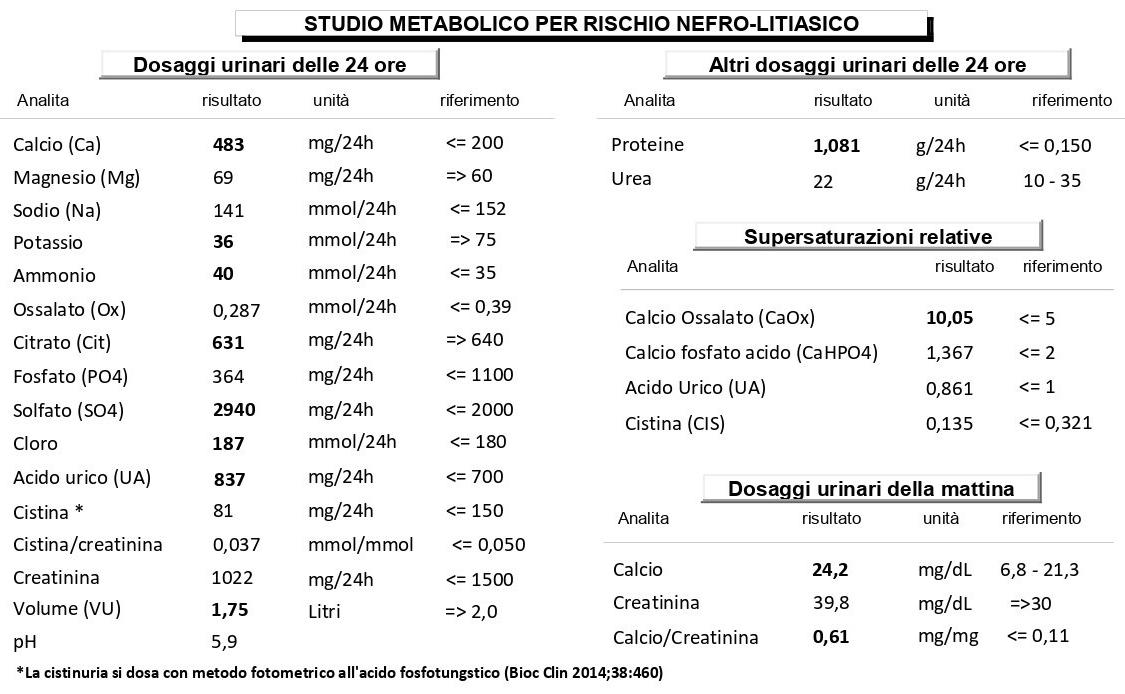
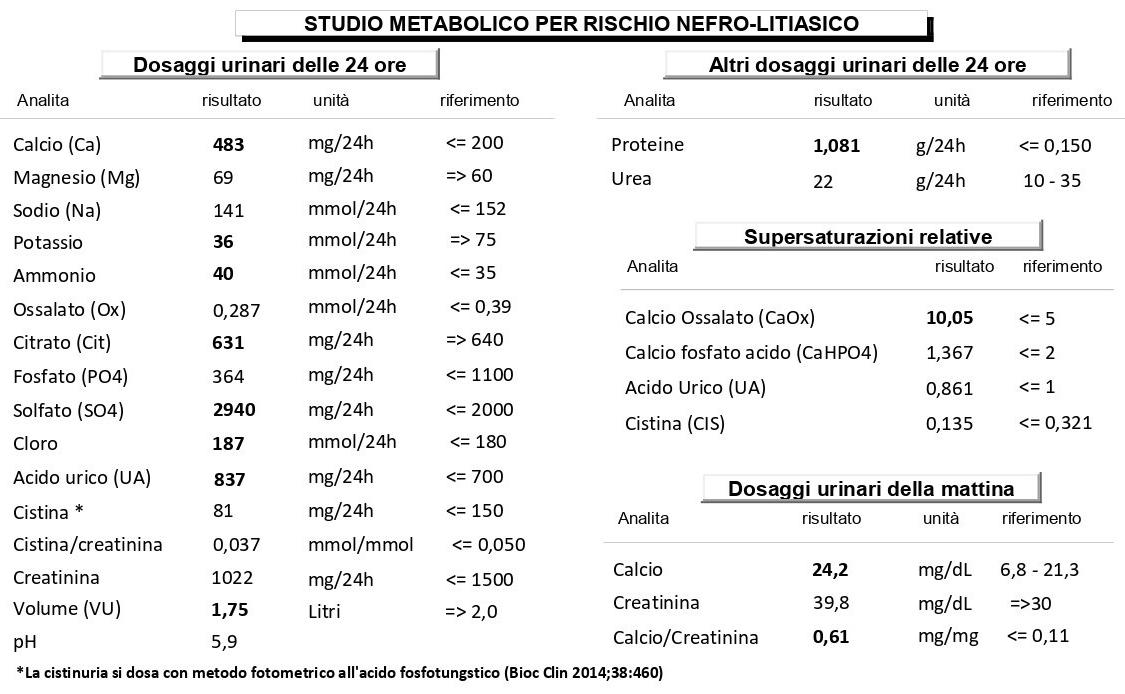
di proteinuria abbastanza aumentata (1,081 g/24h) ed un evidentissimo aumento della possibilità di formare calcoli di calcio ossalato (aumentata supersaturazione di 10,05). Il lieve aumento della uricuria (837 mg/24h) non riesce a positivizzare la supersaturazione per acido urico a causa di un pH di 5,9 non eccessivamente acido.
In figura 12 si evidenzia un introito idrico quasi nella norma (1,95 l), un aumento della ipercalciuria (341 mg/24h) di origine metabolica (rapporto calcio/creatinina estemporanea superiore a 0,11), una ridotta assunzione di inibitori della calcolosi calcica (citrato quasi nei limiti, magnesio 46 mg/24h e specie potassio 40 mg/24h), una escrezione di ossalato nei limiti (0,386 mmol/l), una aumentata assunzione di proteine di origine animale (solfati 3412 mg/24h), un pH sicuramente elevato di 6,9 ed un aumento della possibilità di formare calcoli di calcio ossalato e calcio fosfato (aumentate supersaturazioni rispettivamente di 8,432 e 3,97).
In figura 13 si evidenzia un ridotto introito idrico (1,47 l), una ridotta assunzione di citrato 427 mg/24h e potassio 36 mmol/24h), una evidente assunzione di proteine di origine animale (solfati 4792 mg/24h), una escrezione di ossalato nei limiti (0,342 mmol/l) ed una possibilità di formare calcoli di calcio ossalato (aumentata supersaturazione di 5,377). Nonostante la quantità di acido urico sia normale (417 mg/24h), l’evidente acidità del campione (pH 5,0: assenza di ionizzazione dell’acido urico) e il ridotto volume, evidenziano una netta
possibilità di formare calcoli di acido urico (evidente aumento della supersaturazione di 1,839).
In figura 14 si evidenzia una ridotta assunzione di citrato (349 mg/24h), un lieve aumento della escrezione di proteinuria (0,326 g/24h) ed una evidente presenza di cistinuria (932 mg/24h) con aumento della relativa supersaturazione relativa (0,879). Il Paziente cistinurico in trattamento ha un pH evidentemente alcalino (7,5) che purtroppo potrebbe essere causa di una eventuale formazione di calcoli di calcio fosfato (supersaturazione relativa di 2,698) anche in presenza di basse concentrazioni di calcio (180 mg/24h) e di fosfato (460 mg/24h). Nel caso di Pazienti pediatrici in cui spesso si riscontrano urine con una ridotta concentrazione di creatinina, diventa di notevole aiuto il rapporto tra la cistina e la creatinina urinaria: valori di cistinuria ai limiti della soglia (150 mg/die), possono risultare sospetti (e quindi da confermare con metodica più specifica) se il rapporto in mmol/l è superiore a 0,050 (figura 15).
Parametri metabolici esaminati correlati alla nutrizione
La diluizione delle urine, abbassando la concentrazione urinaria dei sali litogeni, ha un ruolo fondamentale nel ridurre l’incidenza di episodi litiasici. Il volume di diuresi da ottenere nelle 24 ore dovrebbe essere di almeno 2 litri. L’assunzione dovrebbe essere distribuita nel corso di tutta la giornata per assicurare un volume urinario costantemente elevato (19). L’ipercalciuria è sostenuta da eccessivo assorbimento intestinale, da eccessivo riassorbimento osseo, o da diminuzione del riassorbimento tubulare
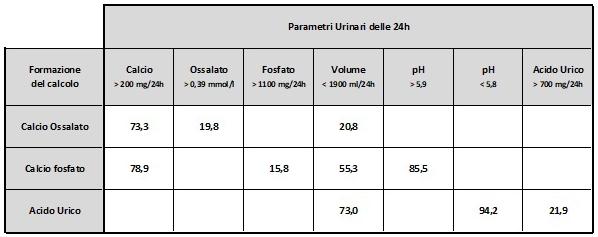
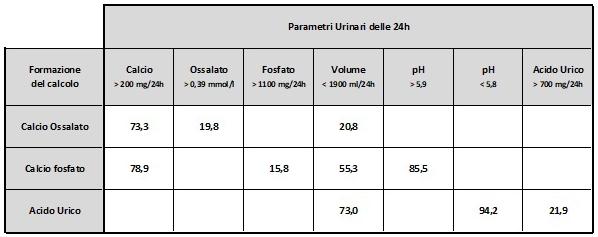
renale. Una volta escreto nelle urine, il calcio non è molto solubile come sale sia di ossalato che di fosfato e, quindi se in eccesso, precipita e determina la formazione di calcoli. Generalmente si segue una dieta normocalcica (20).
Il citrato è presente in frutta e verdura ed è particolarmente importante nel ridurre la soprasaturazione dei sali litogeni, attraverso tre azioni: chelante nei confronti del calcio a livello urinario; di anti-aggregazione sui cristalli; di alcalinizzazione urinaria. Ne deriva che la riduzione della citraturia è tra le principali cause della litogenicità (21). La presenza di sodio nella dieta incrementa l’escrezione tubulare del calcio (in particolare negli ipercalciurici), aumentando di fatto il rischio litogeno.
Per ridurre l’escrezione urinaria di calcio è utile ridurre l’apporto alimentare di sodio (22). Le proteine introdotte con alimenti animali hanno un effetto pro-litogeno, in quanto sono acidificanti e quindi aumentano l’escrezione renale di calcio e
riducono quella di citrato. La presenza di solfati, quale indice indiretto di apporto di proteine animali. L’apporto proteico non dovrebbe superare la quantità di 0,8 g per kg di peso corporeo, in massima parte da fonti di origine vegetale (23,24).
Con una alimentazione vegetariana (elevato contenuto di acqua, fibre, potassio, magnesio, carbonato e citrato e limitato contenuto di proteine e sodio, ed un ridotto contenuto di acidi grassi saturi e colesterolo) si ottiene una riduzione della calciuria ed un aumento del citrato e pH. L’utilizzo di proteine vegetali è da preferire per la calcolosi da calcio ossalato ed in particolare per quella di acido urico (23).
L’ossalato urinario di origine alimentare rappresenta solo il 10-20% dell’ossalato escreto, essendo la restante parte di origine endogena. Le indicazioni dietetiche prevedono una riduzione moderata dell’assunzione di ossalato, escludendo soltanto gli alimenti che ne sono molto ricchi (frutta secca, spinaci, cioccolato). Si consiglia di lessare le verdure in abbondante acqua acidulata per favorire la fuoriuscita degli ossalati (25-26).
L’acido urico deriva dal metabolismo delle purine ed è poco solubile a pH acido. Alimenti da limitare o evitare nella dieta abituale sono rappresentati da: frutti di mare, acciughe, sardine sott’olio, aringa, caviale, frattaglie, estratti di carne, brodo di carne, cacciagione, intingoli, carni e pesci grassi (27). È opportuno moderare il consumo di fruttosio che, avendo un effetto acidificante, può portare alla cristallizzazione dell’acido urico. Una certa attenzione deve essere posta a non eccedere con la frutta, per l’elevato apporto di zuccheri semplici che ne deriverebbe, le bevande alcoliche, i dolci ed i dolcificanti (28, 29).

Le determinazioni biochimiche di ossalati, citrati, ammonio, cistina e solfati, effettuate in micro-cuvette e su semplice fotometro da banco, consentono un evidente abbattimento dei costi dei reagenti (specie per ossalati e citrati) e una consegna dei referti in un tempo di circa 5 – 7 giorni. A costi ridottissimi appaiono le determinazioni della cistinuria e della solfaturia.

Le metodiche proposte risultano abbastanza semplici e rapide ed evitano l’eventuale uso problematico, quando raramente possibile, di analizzatori biochimici dedicati esclusivamente alla routine di laboratorio. La nota finale al referto mette in evidenza le variazioni più significative degli analiti urinari presenti nelle urine delle 24 ore potendo quindi rappresentare, a nostro parere, un riassunto biochimico di facile e rapida lettura per lo specialista richiedente.
La maggior parte dei 501 esami urinari esaminati evidenzia una possibile formazione di calcoli di calcio fosfato ed acido urico. Ipercalciuria, carenza di inibitori (kaliuria e citraturia), ipernatriuria ed ipersolfaturia, appaiono i parametri più presenti nella calcolosi calcica (calcio ossalato e calcio fosfato): la formazione di calcio fosfato è contraddistinta da un pH alcalino. Il pH acido è invece fondamentale per la formazione di calcoli di acido urico in quanto non favorisce la ionizzazione dell’analita.
In tutti i casi di calcolosi, un contributo determinante è dato dalla scarsa diuresi che aumenta sensibilmente tutte le supersaturazioni. Il Paziente cistinurico in trattamento, quasi sempre presenta invece un pH abbastanza alcalino che potrebbe eventualmente portare alla formazione di calcoli di calcio fosfato. Importante è il controllo della proteinuria per correggere eventuali terapie farmacologiche.
1. Daudon M, Traxer O, Conort P et al. Type 2 diabetes increases the risk for uric acid stones. J Am Soc Nephrol 2006;17:2026-33.
2. Daudon M, Lacour B, Jungers P. Influence of body size on urinary stone composition in men and women. Urol Res 2006;34:193-9.
3. Cameron MA, Maalouf NM, Adams-Huet B et al. Urine composition in Type 2 diabetes: predisposition to uric acid nephrolithiasis. J Am Soc Neph 2006;17:1422-8.
4. Maalouf NM, Cameron MA, Moe OW et al. Low urine pH: a novel feature of the metabolic syndrome. Clin J Am Soc Nephrol 2007;2:883-8.
5. Marangella M, Petrarulo M, Daniele PG et al. LithoRisk: software per il calcolo e la visualizzazione dei profili di rischio di calcolosi renale. G Ital Nefrol 2002;6:693-8.
6. Rossano R, Apicella L, Capuano M et al. Nutrizione, stile di vita e nefrolitiasi. Atti del XII Congresso Sezione Campano-Siciliana SIN – Nefrologia tra passato presente e futuro. Ed. Cuzzolin, 2011:197.
7. Gruppo di Studio Multidisciplinare per la Calcolosi Renale, Croppi E, Cupisti A, Lom -
bardi M et al. Diagnostic and therapeutic approach in patients with urinary calculi. G Ital Nefrol 2010;27:282-9.
8. Capria M. La calcolosi delle vie urinarie. In: Andreucci V, Fuiano G, Conte G, Malattie dei reni. Napoli: Ed., Idelson – Gnocchi, 2004:127
9. Bandinelli R, Pasquinelli F. Calcio, Fosfati, Magnesio. Diagnostica e tecniche di laboratorio. Chimica Clinica. Ed. Rosini Firenze 1979;26:1067.
10. Caudarella R. Ipercalciuria idiopatica. L’Endocrinologo 2007;8:209-20.
11. Cangiano G, Latte A, Di Maina E, et al. Ossaluria e cistinuria: dosaggi fotometrici “difficili”… Ma non troppo. Atti del XII Congresso Sez. Campano-Siciliana SIN. 2011;45-9.
12. Cangiano G, Buccino G, Latte A, et al. Il calcolo urinario. Proposta di un nuovo metodo di determinazione: dati preliminari. G Clin Nefrol Dial 2020; 32: 81–89 . DOI: 10.33393/gcnd.2020.2151.
13. Cangiano G, Russo M, Forte F, et al. Determinazione fotometriche automatizzate di citrato e ossalato urinario. Biologi Italiani. 2010;5/6:21-5.
14. Cangiano G, Buccino G, La Palombara S, et al. La calcolosi renale in un laboratorio di patologia clinica: modello organizzativo e nuove tecniche analitiche. Giornale di Tecniche Nefrologiche e Dialitiche 1–8. DOI: 10.1177/0394936219836635. 2019
15. Cangiano G, Latte A, Di Maina E, et al. Determinazione dei solfati ed ossalati urinari: ulteriori accorgimenti metodologici. Biochimica Clinica, 2012, vol. 36, n. 6. 498.
16. Cangiano G, Latte A, Di Maina E, et al. Determinazione fotometrica della cistinuria. Biochimica Clinica, 2007, vol. 31, n. 4. 267-271.
17. Cangiano G, Di Maina E, Buccino G, et al. Diagnostica di laboratorio del rischio nefrolitiasico. Biochimica Clinica, 2018, vol. 42, n. 4. 327-334. DOI: 10.19186/BC_2018.055
18. Cangiano G, Latte A, Di Maina E, et al. Informatizzazione di laboratorio del rischio nefrolitiasico. Biochimica Clinica, 2012, vol. 36, n. 6. 602.
19. Taylor E, Curhan GC. Diet and fluid prescription in stone disease. Kidney Int 2006;70:835-9.
20. Taylor EN, Curhan GC. Demographic, dietary and urinary factors and 24h urinary calcium excretion. Clin J Am Soc Nephrol 2009;4:1980-7.
21. Tiselius HG, Alken P, Buck C et al. EAU Guidelines on Urolithiasis Edition, 2008. https://uroweb.org/wp-content/uploads/EAU-Guidelines-Urolithiasis-2008.pdf (ultimo accesso maggio 2018).
22. Nouvenne A, Meschi T, Prati B et al. Effects of a low-salt dieta on idiopathic hypercalciuria in calcium-oxalate stone formers: a 3-mo randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2010;91:565-70.
23. Borghi L, Schianchi T, Meschi T et al. Comparison of two diets for the prevention of recurrent stones in idiopathic hypercalciuria. N Engl J Med 2002;346:77-84.
24. Kerstetter JE, O’Brien KO, Insogna KL Low protein intake: the impact on calcium and bone homeostasis in human. J. Nutr 2003;133:855S-61S.
25. Borghi L, Meschi T, Amato F, et al. Urinary volume, water and recurrences in idiopathic calcium nephrolithiasis: a 5-year randomized prospective study. J Urol 1996;155:839-43.
26. Asplin JR, Coe FL. Hyperoxaluria in kidney stone formers treated with modern bariatric surgery. J Urol 2007;177:565-9.
27. Yü TF. Urolithiasis in hyperuricemia and gout. J Urol, 1981;126:424-30.
28. Hiatt RA, Dales LG, Friedman GD et al. Frequency of urolithiasis in a prepaid medical care program. Am J Epidemiol 1982;115:255-6.
29. Rendina D, Mossetti G, De Filippo G et al. Association between metabolic syndrome and nephrolithiasis in an in-patient population in Southern Italy: role of gender,hypertension and obesity. Nephrol Dial Transplant 2009;24:900-6.
Migliora il tasso di sopravvivenza grazie ai programmi di screening che consentono una diagnosi precoce
Il cancro al seno è il tumore maggiormente riscontrato a livello mondiale con una percentuale molto alta di nuovi casi ogni anno tra le donne. Nei prossimi decenni, si prevede che il numero annuale di nuove diagnosi di cancro in Italia aumenterà in media dell’1,3% negli uomini e dello 0,6% nelle donne ogni anno.
L’incidenza aumenta con l’età: oltre l’80% dei casi viene diagnosticato in donne di età superiore ai 50 anni. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, questa tipologia di tumore è la principale causa di morte, con 670.000 di decessi registrati in tutto il mondo solo nel 2022 [1].
La maggior parte dei tumori al seno sono adenocarcinomi, con l’85% dei casi che originano dai dotti mammari e il 15% dall’epitelio lobulare. La tipologia di adenocarcinoma che origina dai dotti varia dal carcinoma duttale in situ ai carcinomi invasivi che si espandono anche oltre la membrana basale, nel parenchima mammario adiacente. Altre forme di cancro al seno includono la malattia di Paget, i tumori infiammatori e i carcinomi papillari mentre i sarcomi, come i filloidi maligni e gli angiosarcomi, sono forme tumorali molto rare.
L’origine del tumore è da attribuire a una disfunzione dei meccanismi che controllano la proliferazione cellulare e l’apoptosi. La presenza o l’assenza di recettori per gli estrogeni, recettori per il progesterone e recettori del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2/neu) nelle
* Comunicatrice scientifica e Medical writer
cellule del cancro al seno sono importanti per determinare le opzioni di trattamento [2]. I tumori al seno “triplo negativo” sono generalmente più aggressivi e associati a una prognosi peggiore.
Questi non esprimono recettori per gli estrogeni rendendo inefficaci le terapie endocrine o biologiche. Le opzioni terapeutiche sono quindi limitate alla chirurgia, chemioterapia e radioterapia [3].
Fattori di rischio
Il 90% dei tumori al seno sono di natura benigna, come fibroadenomi, cisti e cambiamenti fibrocistici [1]. In generale, il cancro al seno può presentarsi sotto forma di:
- un nodulo nel seno e/o nell’ascella che può avere caratteristiche dure, immobili, irregolari o fisse; - gonfiore del seno o cambiamenti nella forma e nelle dimensioni;
- cambiamenti della pelle, inclusi eritema, fossette, buche, ulcerazione e pelle a buccia d’arancia;
- cambiamenti del capezzolo, come inversione, cambiamenti della pelle o secrezioni.
Sebbene sia molto comune, il dolore al seno isolato, senza altri sintomi, raramente è un segno di cancro al seno [4]. I fattori associati a un aumento del rischio di sviluppare il cancro al seno sono diversi, e possono essere modificabili e non modificabili. I primi includono quelli che possono essere cambiati o evitati. Per esempio:
- l’obesità; - uno stile di vita sedentario; - l’esposizione a ormoni esogeni.
Tra i fattori non modificabili rientrano la predisposizione genetica e l’invecchiamento [5].
Lo screening
Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario è rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni e viene effettuato tramite una mammografia ogni due anni. In alcune regioni, si sta sperimentando l’efficacia dello screening in una fascia d’età più ampia, tra i 45 e i 74 anni.
In Italia, 834.200 donne sopravvivono dopo una diagnosi di tumore della mammella, e per il 2023 sono stati stimati 55.900 nuovi casi. Negli ultimi decenni, si è osservato un costante aumento delle diagnosi, accompagnato da una riduzione della mortalità grazie alla diagnosi precoce che identifica i tumori nelle prime fasi di sviluppo. Ciò consente interventi chirurgici più conservativi e terapie più efficaci, portando a sopravvivenze a 5 anni molto elevate.
I programmi di screening prevedono l’invito attivo delle donne nella fascia d’età indicata, alla scadenza dei periodi stabiliti e secondo le modalità previste dal programma regionale. In genere, si riceve una lettera di invito dalla ASL di appartenenza [6].
L’esame clinico del seno
Il tumore al seno richiede una diagnosi clinica molto rapida, che solitamente prevede:
1. un’anamnesi accurata e l’esame clinico del seno; 2. le indagini radiologiche, come ecografia e/o mammografia del seno e delle ascelle; 3. la biopsia di eventuali lesioni sospette. Per le lesioni che coinvolgono la pelle o in casi sospetti di malattia di Paget del capezzolo, può essere eseguita una biopsia sotto anestesia locale mentre le lesioni più profonde richiedono una biopsia core, solitamente guidata da immagini. Se questa non è possibile, si può effettuare un esame citologico da aspirazione con ago sottile per un’iniziale caratterizzazione della lesione. Generalmente, nelle donne sotto i 40 anni e nelle donne che allattano non si eseguono le mammografie, poiché non rifletterebbero accuratamente la patologia nel tessuto mammario relativamente denso [7].
L’esame clinico interessa entrambi i seni, il torace, le ascelle e i linfonodi. Questo consiste in:
- osservare visivamente il seno per rilevare anomalie nella forma, dimensione e simmetria, così come cam -
biamenti nella pelle e nei capezzoli;
- palpare sistematicamente entrambe le mammelle e le aree circostanti per individuare eventuali noduli o masse, cambiamenti nella consistenza del tessuto e segnali di dolore o sensibilità;
- palpare i linfonodi ascellari per rilevare eventuali ingrossamenti o anomalie;
- valutare i linfonodi sopraclaveari e infraclaveari per identificare eventuali anomalie o segni di metastasi.
L’autopalpazione è un esame che la donna può eseguire da sola una volta al mese, una settimana dopo la fine del ciclo (cioè quando il seno è meno dolente e turgido).
Per ispezionare il seno, la donna dovrebbe sedersi su un lettino inclinato di 30-45° e osservare la cute per rilevare eventuali cambiamenti, inclusi pieghe, aderenze, eritema, cicatrici, masse e cambiamenti del capezzolo o secrezioni.
Se si inizia dal seno sinistro, si appoggia la mano sinistra dietro la nuca. Con la mano destra si palpa il seno “schiacciandolo” contro il torace, cercando di apprezzarne la consistenza e le eventuali modificazioni, poi si ripete la stessa operazione con il seno destro.
Per eseguire una palpazione leggera, si utilizzano le parti palmari delle falangi prossimali e medie delle dita indice, medio e anulare. Queste dita si spostano dai margini superiori a quelli inferiori di ciascun seno e dalle aree mediali a quelle laterali, permettendo di rilevare differenze nella densità del tessuto mammario. Successivamente, le punte delle dita indice, medio e anulare palpano la consistenza del tessuto mammario nei quattro quadranti e nel complesso capezzolo-areola, esplorando i piani superfi -
© Alejandro Franco Garcia/shutterstock.com

ciali, intermedi e profondi.
Le masse benigne, generalmente, non causano cambiamenti cutanei e sono spesso lisce, mobili e ben delimitate. Tuttavia, i fibroadenomi e le cisti tese tendono a essere fermi. Occorre sottolineare che la sola autopalpazione non basta, ma se eseguita correttamente e regolarmente può aiutare a ridurre il rischio di diagnosticare un tumore del seno in fase avanzata. Per palpare i linfonodi ascellari, il medico sostiene l’avambraccio della paziente dal basso e si esplorano i quattro bordi dell’ascella e i linfonodi ascellari profondi con la punta delle dita della mano opposta. Infine, si palpano bilateralmente i linfonodi sopraclaveari [8].
I pazienti con cancro invasivo ed evidenza di coinvolgimento dei linfonodi devono sottoporsi a ulteriori indagini di imaging, come una tomografia computerizzata del torace, dell’addome e pelvi, per cercare evidenze di metastasi a distanza [3]. L’imaging radiologico è fondamentale per la visualizzazione e caratterizzazione delle anomalie. L’ecografia consente un esame mirato delle anomalie palpabili clinicamente, mentre la mammografia caratterizza ulteriormente l’area di interesse e analizza il resto del tessuto mammario. La tomosintesi digitale del seno, inoltre, fornisce immagini radiografiche tridimensionali del tessuto mammario, migliorando i risultati della mammografia.
Alcune pazienti possono necessitare di una risonanza magnetica con contrasto per prendere decisioni cruciali, come valutare la possibilità di un intervento chirurgico conservativo del seno, determinare la dimensione del tumore in caso di discrepanza tra le modalità di imaging o monitorare la risposta del paziente alla chemioterapia neoadiuvante. Una tomografia computerizzata di stadiazione del torace, addome e pelvi, insieme a una scintigrafia ossea, può essere eseguita se il paziente o il clinico sospettano la presenza di metastasi a distanza [7].
Contestualmente alla diagnosi si procede alla stadiazione della malattia che avviene secondo il sistema di classificazione dell’American Joint Committee on Cancer (AJCC) [9]. Questo sistema include la stadiazione anatomica, definita dalla dimensione del tumore (T), dal coinvolgimento dei linfonodi regionali (N) e dalla presenza di metastasi (M), oltre alla stadiazione prognostica, che considera ulteriori fattori prognostici come i recettori ormonali e lo stato del HER2 [5].
Intervento
L’intervento chirurgico ha diversi obiettivi che includono l’asportazione del tumore, la stadiazione patologica e il raggiungimento di un buon risultato estetico post-operatorio. La chirurgia conservativa del seno prevede la rimozione del tumore con un margine di tessuto macroscopicamente sano circostante, che viene esaminato isto -
logicamente per individuare eventuali cellule invasive. La radioterapia dopo la chirurgia conservativa è fortemente raccomandata per ridurre il rischio di recidiva. L’alternativa è la mastectomia, indicata quando quest’ultima non è fattibile a causa di fattori tumorali (come un alto rapporto tumore-seno), quando la radioterapia è controindicata, se i risultati estetici sarebbero compromessi o per scelta del paziente [3]. I tassi di recidiva (10-15%) e i risultati di sopravvivenza sono simili per entrambe le procedure [10].
Ai pazienti con mutazioni BRCA1 o BRCA2 viene spesso consigliata la possibilità di una chirurgia più radicale, come la mastectomia unilaterale o bilaterale profilattica, per ridurre il rischio. Per le masse non operabili, può essere utilizzata la chemioterapia neoadiuvante, con l’obiettivo di rendere le masse localmente avanzate resecabili. La chemioterapia neoadiuvante è impiegata anche in base alla biologia del tumore o se sono presenti caratteristiche localmente avanzate al momento della diagnosi.
Lo stato dei linfonodi ascellari viene valutato tramite biopsia del linfonodo sentinella o dissezione intraoperatoria per la stadiazione patologica dei tumori invasivi. In assenza di sospetto preoperatorio di coinvolgimento linfonodale, si esegue una biopsia del linfonodo sentinella per valutare la presenza di metastasi. Le pazienti con una biopsia positiva possono essere sottoposte a dissezione dei linfonodi ascellari per guidare la prognosi e il trattamento successivo, nonché per limitare la diffusione linfatica. La dissezione dei linfonodi ascellari comporta un rischio fino al 14% di linfedema dell’arto superiore [11].
Alle pazienti sottoposte a mastectomia viene general© Lightspring/shutterstock.com
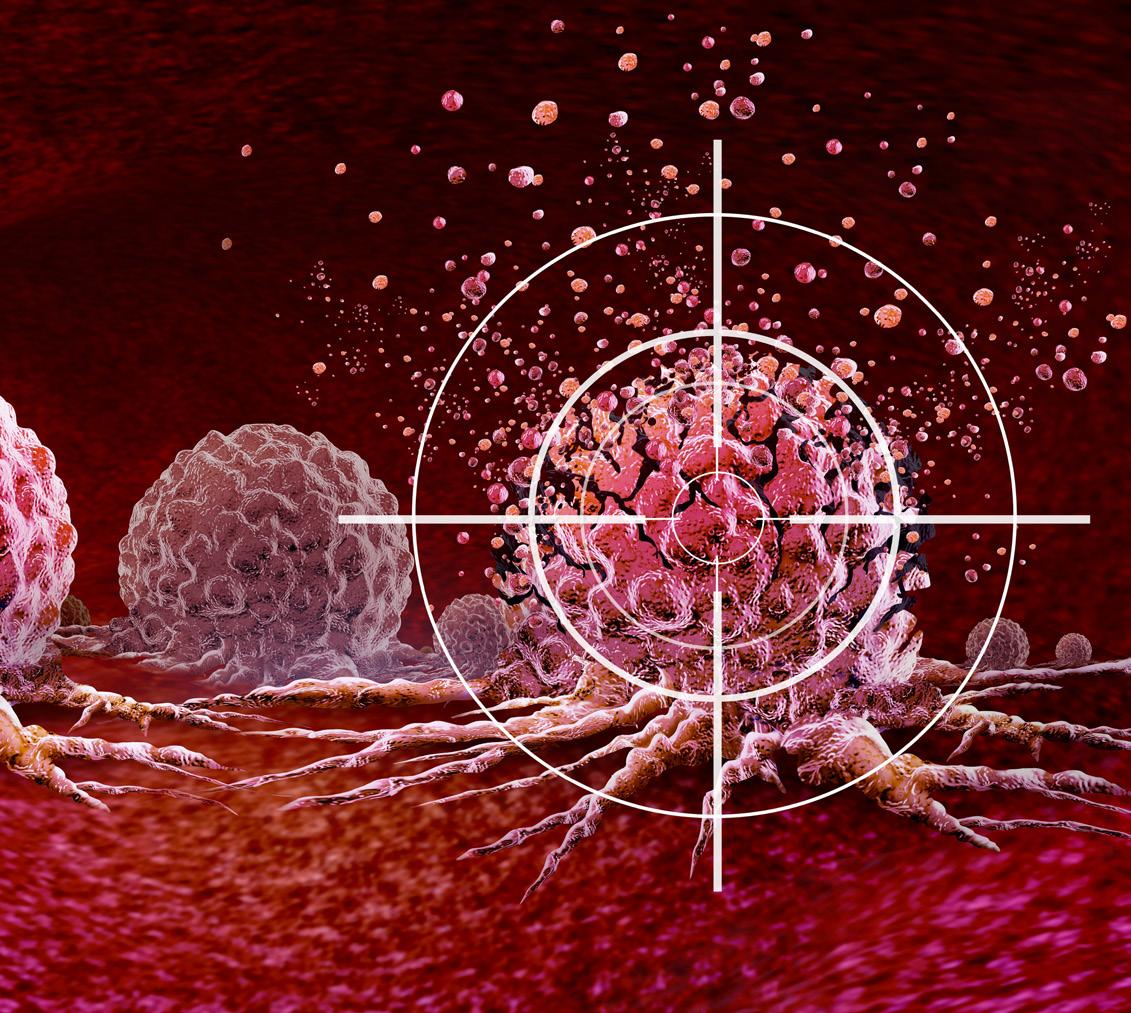
mente offerta l’opportunità di una ricostruzione del seno che può essere autologa (basata su tessuti), basata su impianti o una combinazione delle due. La scelta prende in considerazione le comorbidità del paziente, la forma del seno e del corpo, le aspettative, i desideri e l’impatto dei potenziali trattamenti adiuvanti [5].
Terapie adiuvanti e neoadiuvanti
La terapia adiuvante ha lo scopo di eradicare le micro-metastasi che potrebbero evolversi in malattia metastatica. La scelta della terapia è determinata da un’attenta valutazione del rischio, che si basa sul numero di linfonodi positivi, dimensione e biologia del tumore (grado, recettori ormonali e stato del recettore del fattore di crescita epidermico umano 2, HER2).
La radioterapia adiuvante viene eseguita per ridurre il tasso di recidiva ed è applicata sia dopo una chirurgia conservativa sia dopo una mastectomia in presenza di caratteristiche ad alto rischio, come il coinvolgimento di più linfonodi. Le pazienti con tumori HER2-positivi ricevono una terapia biologica aggiuntiva con l’anticorpo monoclonale, come trastuzumab. Tuttavia, queste terapie biologiche sono cardiotossiche e richiedono un attento monitoraggio [3]. La terapia endocrina è raccomandata nei tumori positivi ai recettori per gli estrogeni, con una riduzione del 30% della mortalità annuale nei primi 15 anni. Il primo passo è interrompere le terapie ormonali, come la pillola contraccettiva. Gli inibitori dell’aromatasi, come l’anastrozolo, impediscono la produzione periferica di estrogeni inibendo l’enzima aromatasi e sono utilizzati nelle pazienti in post-menopausa, poiché sono inefficaci se le ovaie continuano a produrre estrogeni.
Il tamoxifene, un modulatore selettivo dei recettori degli estrogeni, blocca l’azione degli estrogeni sul tessuto mammario ed è prevalentemente usato nelle donne in pre-menopausa. I modulatori selettivi dei recettori degli estrogeni possono aumentare il rischio di tromboembolismo venoso e tumori uterini, mentre gli inibitori dell’aromatasi possono accelerare l’osteopenia e l’osteoporosi, richiedendo una valutazione della densità minerale ossea prima dell’inizio del trattamento [5].
La chemioterapia neoadiuvante è sempre più impiegata per trattare lesioni mammarie localmente avanzate e di grandi dimensioni, con l’obiettivo di ridurre il tumore prima dell’intervento chirurgico.
È particolarmente raccomandata nei casi di cancro al seno triplo negativo e nei tumori HER2-positivi, poiché spesso rispondono bene a questa terapia. Inoltre, la chemioterapia neoadiuvante consente ai clinici di valutare la risposta al trattamento e di adattare la terapia adiuvante postoperatoria in base ai risultati ottenuti [3].
Conclusioni
Il tumore del seno è il più diffuso a livello mondiale, pertanto è essenziale diagnosticarlo in tempo per intervenire prima che progredisca con esito infausto. Inoltre, una comprensione approfondita della diagnosi e delle caratteristiche genetiche del cancro al seno è fondamentale per valutare l’idoneità delle diverse opzioni terapeutiche. Questa conoscenza dovrebbe essere utilizzata dai clinici come parte di un approccio multidisciplinare per guidare il paziente verso i migliori risultati possibili.
1. Breast cancer [Internet]. [cited 2024 Jul 23]. Available from: https://www.who.int/ news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
2. Feng Y, Spezia M, Huang S, Yuan C, Zeng Z, Zhang L, et al. Breast cancer development and progression: Risk factors, cancer stem cells, signaling pathways, genomics, and molecular pathogenesis. Genes Dis [Internet]. 2018 [cited 2024 Jul 23];5:77. Available from: /pmc/articles/PMC6147049/
3. Cardoso F, Kyriakides S, Ohno S, Penault-Llorca F, Poortmans P, Rubio IT, et al. Early breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up†. Ann Oncol Off J Eur Soc Med Oncol [Internet]. 2019 [cited 2024 Jul 23];30:1194–220. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31161190/
4. Mohallem Fonseca M, Lamb LR, Verma R, Ogunkinle O, Seely JM. Breast pain and cancer: should we continue to work-up isolated breast pain? Breast Cancer Res Treat [Internet]. 2019 [cited 2024 Jul 23];177:619–27. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm. nih.gov/31309396/
5. Katsura C, Ogunmwonyi I, Saha S, Katsura C. Doctors in Training Breast cancer : presentation , investigation and management. 2024;4–10.
6. AIOM. 2023_AIOM_NDC-web.pdf. I Numer del cancro Ital. 2023;1–257.
7. Megan Bydder, Eleanor Cornford, Julie Cox, Hilary Dobson, Andy Evans, Simon Lowes, Iain Lyburn, Anthony Maxwell, Jonathan Nash, Jenny Oduko, Alan Redman, Tharsi Sarvananthan, Nisha Sharma, Sheetal Sharma SV. Guidance on screening and symptomatic breast imaging: Fourth edition. Clin Radiol R Coll Radiol [Internet]. 2019;1–27. Available from: www.rcr.ac.uk
8. Saslow D, Hannan J, Osuch J, Alciati MH, Baines C, Barton M, et al. Clinical Breast Examination: Practical Recommendations for Optimizing Performance and Reporting. CA Cancer J Clin. 2004;54:327–44.
9. Koh J, Kim MJ. Introduction of a New Staging System of Breast Cancer for Radiologists: An Emphasis on the Prognostic Stage. Korean J Radiol [Internet]. 2019 [cited 2024 Jul 23];20:69–82. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30627023/
10. Hammer C, Fanning A, Crowe J. Overview of breast cancer staging and surgical treatment options. Cleve Clin J Med [Internet]. 2008 [cited 2024 Jul 23];75 Suppl 1:10–6. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18457192/
11. Johnson AR, Kimball S, Epstein S, Recht A, Lin SJ, Lee BT, et al. Lymphedema Incidence After Axillary Lymph Node Dissection: Quantifying the Impact of Radiation and the Lymphatic Microsurgical Preventive Healing Approach. Ann Plast Surg [Internet]. 2019 [cited 2024 Jul 23];82:S234–41. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih. gov/30855393/
Il corso Fad associato a questo articolo dà la possibilità agli iscritti all’albo dei biologi di acquisire 7,5 crediti Ecm
Consulta l’area riservata MyBio
L’articolo è associato al corso Fad da 7,5 crediti Ecm disponibile nell’area riservata MyBio
di Matteo Pillitteri e Dario Incorvaia*
La sarcopenia è un disturbo muscolo scheletrico progressivo e generalizzato associato ad una maggiore probabilità di esiti avversi tra cui cadute, fratture, disabilità fisica, aumento dell’ospedalizzazione e della durata dei ricoveri, peggior qualità di vita e mortalità. Quando si riscontrano ridotta forza muscolare, riduzione di quantità/qualità muscolare e riduzione di performance, la sarcopenia si definisce GRAVE. L’esercizio fisico è la condizione essenziale per la gestione della sarcopenia; l’esercizio fisico dovrebbe essere alla base di qualsiasi intervento si possa utilizzare; nello specifico bisogna considerare almeno una parte con opposizione di resistenza, in modo da favorire il miglioramento della forza e l’aumento della massa muscolare.
I fattori responsabili di questa perdita di massa muscolare: il fisiologico processo d’invecchiamento, una suscettibilità genetica, dieta non ottimale, prolungato allettamento, stile di vita sedentario, malattie croniche e farmaci. Nella maggior parte degli anziani l’eziologia è multifattoriale e solo quando l’unica causa evidente è l’invecchiamento la sarcopenia viene definita primaria (età-correlata). Senza tralasciare poi le cause psicosociali come isolamento, povertà, decadimento cognitivo, demenza e depressione. Negli ultimi anni l’aspettativa di vita è notevolmente aumentata, dunque la popolazione potenzialmente soggetta alla sarcopenia è in aumento; la stima di perdita di massa muscolare è in un range del 3-8%.
Da attenzionare è anche l’adiposità osteosarcopenica, condizione complessa e relativamente nuova che combina tre fattori di rischio: osteoporosi (perdita di densità ossea), sarcopenia
* Biologi nutrizionisti
(riduzione della massa e della forza muscolare), adiposità, che può presentarsi come eccesso di grasso corporeo o infiltrazione di tessuto adiposo nei muscoli e nelle ossa e l’obesità sarcopenica, definita come la coesistenza di eccesso di adiposità (obesità) e scarsa massa/forza/funzione muscolare (sarcopenia)”.
In tutto questo la malnutrizione riveste un ruolo importante nella patogenesi della sarcopenia. Edentulìa, disgeusia, disfagia, alterazioni gastrointestinali (rallentamento dello svuotamento gastrico, rallentato transito intestinale, ecc.), disabilità motoria e visiva, rappresentano cause fisiologiche e fisiche che possono compromettere una adeguata assunzione di nutrienti. Anche altri fattori, come un’aumentata frequenza e severità di malattie acute e croniche e le politerapie farmacologiche (responsabili di malassorbimento, disturbi gastrointestinali, perdita di appetito) hanno un riconosciuto ruolo eziologico. Senza dimenticare poi le cause psicosociali come isolamento, povertà, decadimento cognitivo, demenza e depressione. Nel loro insieme tutti questi fattori fisiologici, fisici, patologici e psicosociali, rendono conto dell’elevata prevalenza della malnutrizione nell’anziano: 15% nei soggetti non istituzionalizzati, 25-60% in RSA/Case di Riposo e 35-65% in Ospedale.
Un contributo importante allo sviluppo di malnutrizione è dato dalla disfagia, la cui prevalenza è compresa tra il 13% e il 38% nell’anziano che vive in comunità, ma raggiunge valori più elevati in ospedale (30%) e in RSA/Case di Riposo (68%). L’inadeguato intake proteico ed energetico conseguente alla difficoltà di deglutizione è causa di malnutrizione. La sarcopenia che ne consegue, può interessare anche la muscolatura coinvolta nella deglutizione e peggiorare la stessa disfagia. Si parla, in questi casi, di “disfagia sarcopenica” che, attraverso un circolo vizioso, è responsabile di un ulteriore peggioramento dello stato nutrizionale.
È necessario pertanto riconoscere precocemente il soggetto anziano a rischio di malnutrizione per poter pianificare terapie nutrizionali mirate al miglioramento dell’outcome. Le metodiche di screening della malnutrizione dovrebbero inoltre essere affiancate da quelle finalizzate al precoce riconoscimento del rischio di sarcopenia e di disfagia. Il Mini Nutritional Assessment, nella forma short (MNA-SF), viene invece considerato il gold standard per l’anziano istituzionalizzato o in un setting ambulatoriale. Nel soggetto riconosciuto a rischio di malnutrizione deve essere successivamente effettuata la valutazione dello stato nutrizionale finalizzata alla diagnosi e alla definizione del grado di severità della malnutrizione.
È ormai universalmente accettato e riconosciuto che seguire un regime alimentare equilibrato e completo (DIETA MEDITERRANEA) e praticare regolare attività fisica abbiano un ruolo fondamentale sulla prevenzione della sarcopenia. Nei pazienti in grado di alimentarsi per vie naturali il primo step dell’intervento nutrizionale è rappresentato dal Counseling nutrizionale, mirato all’incremento dell’assunzione di nutrienti attraverso una revisione della dieta normale, favorendo alimenti ad elevato contenuto calorico e proteico, eventualmente modificati nella consistenza in caso di disfagia. In presenza di difficoltà di deglutizione è necessario infatti elaborare pasti in funzione delle caratteristiche reologiche degli alimenti (consistenza, scivolosità, coesione, omogeneità) sulla scorta delle indicazioni provenienti dalle valutazioni specialistiche foniatrico/logopediche, al fine di garantire la sicurezza del paziente, evitando il passaggio di cibo nelle vie respiratorie.
to calorico e frazionati nell’arco della giornata (almeno 4-5/die)
Fortificare i pasti con fonti caloriche e proteiche aggiuntive, quali olio extravergine di oliva, parmigiano, succhi di frutta fresca, miele, marmellate…
Consigliare di iniziare sempre i pasti con il secondo piatto, che di norma è ricco di proteine
Modificare la dieta a seconda delle necessità della persona (semisolida per chi ha difficoltà di deglutizione dei liquidi; facilmente masticabile per chi ha problemi di masticazione)
Aggiungere alla consueta dieta gli integratori alimentari come supporto nutrizionale
Qualora il paziente non riesca a coprire con gli alimenti naturali le proprie necessità calorico-proteiche, è indicata l’integrazione con Supplementi Nutrizionali Orali (Oral Nutritional Supplements – ONS) proteici, in polvere, o calorico-proteici, liquidi, secondo necessità. Rispetto alla componente proteica degli ONS è importante fare una distinzione tra proteine fast e slow. Sono considerate fast le proteine del siero di latte (whey protein), a differenza della caseina considerata slow. Le proteine fast presentano una struttura molecolare che determina un profilo cinetico digestivo e post-assorbitivo particolarmente favorevole sulla regolazione della sintesi proteica muscolare: maggiore e più rapido aumento plasmatico degli aminoacidi rispetto alle proteine slow, anche a parità di contenuto amminoacidico. Le sieroproteine presentano inoltre un maggior contenuto di leucina.

©ArtemisDiana/shutterstock.com
Da un punto di vista nutrizionale un apporto di almeno 1-1.2 g/kg/die di proteine di alto valore biologico ed una adeguata distribuzione, con una quantità di proteine in ≥ 2 pasti principali di circa 0.4 g/kg di peso, costituisce una strategia potenzialmente efficace nel contrastare la sarcopenia. Per il raggiungimento del fabbisogno proteico, può essere necessario ricorrere a specifiche strategie nutrizionali, come l’utilizzo di alimenti proteici di facile masticazione (es. pesce, uova) o l’elaborazione di pasti ad elevata densità calorico-proteica, di consistenza modificata (morbida o cremosa) soprattutto se in presenza di disfagia. In caso di ingesta persistentemente inadeguate, può essere indicata l’integrazione con supplementi nutrizionali orali proteici o calorico-proteici, arricchiti di leucina o HMB, di cui si è dimostrata l’efficacia nel prevenire/trattare la perdita di massa e forza muscolare nel soggetto anziano.
Consigli per contrastare la malnutrizione:
Consigliare pasti di porzioni ridotte, ad elevato contenu-
Proprio sulla leucina e sul suo metabolita il b-idrossi-b-metilbutirrato (HMB) si è concentrato in questi ultimi anni l’interesse dei ricercatori. Entrambe le sostanze giocano un ruolo importante nei processi anabolici ed anticatabolici a livello muscolare, attivando il complesso mTOR (mammalian rampamycin target protein) ed inibendo i processi proteolitici (in particolare l’autofagia).
Solo attraverso un precoce riconoscimento del paziente a rischio di malnutrizione/sarcopenia e l’avvio di un tempestivo quanto personalizzato intervento nutrizionale, finalizzato a contrastare il decadimento dello stato nutrizionale e la perdita di massa/forza muscolare, è possibile garantire un miglioramento dell’outcome clinico e della qualità di vita del soggetto anziano.
La sarcopenia e le sue importanti implicazioni sulla salute dell’anziano mettono in luce la necessità di adottare un approccio multidisciplinare nella gestione dei soggetti anziani, considerando non solo gli aspetti biologici e biochimici dell’invecchiamento ma anche il contesto sociale, psicologico e ambientale in cui gli anziani vivono.
L’approccio deve saper integrare le competenze nutrizionali, fisioterapiche e mediche.
Il corso Fad associato a questo articolo dà la possibilità agli iscritti all’albo dei biologi di acquisire 9 crediti Ecm Consulta l’area riservata MyBio
L’articolo è associato al corso Fad da 9 crediti Ecm disponibile nell’area riservata MyBio
L’industria chimica è uno dei più grandi settori manifatturieri dell’Europa e svolge un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e nella competitività generale dell’economia. L’Europa ha emanato delle normative che consentono all’industria chimica (e, più in generale, all’industria manifatturiera che usa sostanze chimiche) di svilupparsi e innovarsi, garantendo allo stesso tempo che i prodotti siano sicuri per le persone e per l’ambiente. Il quadro normativo riguardanti i prodotti chimici è complesso, e i diversi regolamenti si intersecano tra loro. I regolamenti principali, chiamati anche regolamenti trasversali, per garantire l’uso sicuro delle sostanze chimiche sono il Regolamento (CE) n.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche , meglio noto come REACH e il Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle so -

stanze e delle miscele pericolose, meglio noto come CLP. Entrambi i regolamenti sono giuridicamente vincolanti in tutti gli Stati membri dell’UE/ SEE e direttamente applicabili a tutti i settori industriali.
Il Regolamento REACH, entrato in vigore nel 2007, fornisce un quadro giuridico completo per le sostanze chimiche fabbricate, importate e utilizzate in Europa. La norma, basata sul principio che l’industria debba garantire la sicurezza per la salute umana e l’ambiente in condizioni prevedibili, promuove metodi alternativi alla sperimentazione animale, istituisce un mercato unico delle sostanze chimiche e mira a favorire innovazione e competitività. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è stata creata in tale ambito.
* Consulente nell’ambito delle normative europee riguardanti le sostanze chimiche (REACH e CLP) e nel controllo e revisione del sistema di gestione UNI EN ISO 14001: 2004
La normativa si applica in linea di principio a tutte le sostanze chimiche: non solo quelle utilizzate nei processi industriali, ma anche quelle di uso professionale e quotidiano, ad esempio le vernici o i prodotti per la pulizia, come pure quelle presenti in articoli quali indumenti, mobili ed elettrodomestici. Per tale motivo questo regolamento ha un impatto sulla maggioranza delle aziende presenti nell’UE.
Per la sua attuazione da parte delle aziende sono stabiliti specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli come la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze, sui pericoli e sui rischi durante l’utilizzo che derivano da esse.
I processi principali del REACH
Quattro sono i principali processi del REACH:
• la registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH). Comporta l’obbligo, per i fabbricanti e gli importatori di sostanze in quanto tali o in miscele o, in alcuni casi, in articoli, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata/ anno, indipendentemente dalla pericolosità, di presentare all’ECHA una serie di informazioni di base sulle caratteristiche delle sostanze e, in mancanza di dati disponibili, l’obbligo per l’azienda di eseguire test sperimentali per caratterizzare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e eco-tossicologiche e la valutazione dei rischi durante l’utilizzo con l’identificazione degli usi consigliati;
• la valutazione (Titolo VI del REACH). L’ECHA controlla la conformità delle informazioni oggetto di registrazione e esamina le proposte di sperimentazione per verificare che non siano necessarie. Gli Stati membri, inoltre, valutano le sostanze chimiche che destano preoccupazione per la salute e l’ambiente;
• l’autorizzazione (Titolo VII del REACH), solo per usi specifici e controllati, delle sostanze “estremamente preoccupanti” (SVHC) elencate nell’Allegato XIV (come le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B (CMR), le sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT), le sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB), le sostanze, come quelle con proprietà di interferenti endocrini, che hanno effetti che destano un livello di preoccupazione equivalente a quelle appartenenti ai gruppi indicati);
• la restrizione (Titolo VIII del REACH). Prevede che sostanze e miscele con rischi inaccettabili per l’ambiente e la salute umana siano totalmente o parzialmente ristrette negli usi o nella concentrazione (ad es. nei prodotti di consumo). Le restrizioni sono elencate nell’Allegato XVII.
I suddetti processi pongono una pressione sulle imprese affinché riconsiderino il proprio portafoglio di sostanze chimiche e sostituiscano le più pericolose con alternative più sicure.
Uno degli obiettivi del regolamento è proprio quello di stimolare l’innovazione e migliorare le competitività dell’industria europea sui mercati internazionali.
INFORMAZIONI ALL’INTERNO DELLA CATENA D’APPROVVIGIONAMENTO
La gestione dei rischi delle sostanze implica per i fabbricanti o gli importatori la comunicazione di informazioni sulle medesime ad altri operatori quali gli utilizzatori a valle o i distributori. Inoltre, i produttori o gli importatori di articoli dovrebbero fornire informazioni sull’uso sicuro di articoli agli utilizzatori industriali e professionali e ai consumatori su richiesta. Tale importante obbligo dovrebbe applicarsi altresì a tutta la catena di approvvigionamento, per consentire a tutti gli attori di assolvere i loro obblighi per quanto concerne la gestione dei rischi derivanti dall’uso delle sostanze. Tali indicazioni sono presenti al Titolo IV (informazioni all’interno della catena d’approvvigionamento), in cui viene integrata anche la scheda di dati di sicurezza (SDS).
La SDS è lo strumento destinato a fornire al datore di lavoro dati utili a una prima valutazione del “rischio chimico” per l’adozione delle misure conseguenti per la tutela della sicurezza dei lavoratori. Essa rappresenta lo strumento principale per la comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento, che parte dal produttore o importatore di prodotti chimici (sia sostanze, sia miscele) e arriva fino all’utilizzatore a valle. La circolazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento è finalizzata a migliorare la gestione dei rischi e l’osservanza della normativa.
La scheda di dati di sicurezza deve essere aggiornata senza indugio qualora diventino disponibili nuove informazioni sui pericoli o in merito alla necessità di adottare misure di gestione dei rischi più severe.
Quando gli utilizzatori a valle ricevono una scheda di dati di sicurezza, devono individuare e mettere in atto misure opportune per controllare i rischi in modo adeguato.
Quando non è necessaria alcuna scheda di dati di sicurezza, il fornitore deve comunque fornire informazioni sufficienti per un uso sicuro. Qualora a qualsiasi sostanza in quanto tale o come componente di miscela, si applichino delle restrizioni o delle autorizzazioni, si devono fornire i dettagli necessari. I fornitori di articoli che contengono più dello 0,1 % p/p di una sostanza estremamente preoccupante (SVHC) inclusa nell’elenco di sostanze candidate devono fornire informazioni sufficienti agli utilizzatori a valle e ai distributori al fine di consentirne un uso sicuro.
Il Regolamento REACH definisce un articolo come “un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”, articoli sono ad esempio gli indumenti, le pavimentazioni, i mobili, la gioielleria, i
giornali e gli imballaggi in plastica.
I produttori e gli importatori di articoli possono ottenere informazioni sulle sostanze presenti nei propri articoli e la loro concentrazione dagli attori intervenuti nella catena d’approvvigionamento, come i fornitori di un articolo extra UE e i fornitori di sostanze e miscele.
Attuazione del Regolamento REACH in Italia
Il regolamento prevede la nomina di una Autorità Nazionale per ciscuno Stato. Le autorità nazionali hanno la responsabilità dell’applicazione del REACH sul proprio territorio, si scambiano reciprocamente informazioni e si coordinano a livello europeo le attività di controllo.
In Italia il ruolo di Autorità Nazionale è ricoperto dal Ministero della Salute. Il Ministero della Salute assicura, d’intesa con le amministrazioni centrali e gli enti di ricerca, la partecipazione di rappresentanti ed esperti nazionali alle attività dell’Agenzia e della Commissione Europea.
Per l’attuazione del Regolamento, a livello nazionale, con decreto 22 novembre 2007 è stato stabilito il Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all’art.5bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.10 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n.46.
Le Amministrazioni coinvolte nell’attuazione del Regolamento REACH a livello nazionale sono: il Ministero della Salute in qualità di Autorità competente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero dello Sviluppo Economico.
Per il supporto tecnico-scientifico le Amministrazioni indicate si avvalgono dell’Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS-CNSC).
Il Ministero della Salute, oltre a svolgere la funzione di Autorità Nazionale Competente, coordina, in collaborazione con le Regioni, le attività di controllo sul rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento REACH.
Il Ministero dell’Ambiente assicura la partecipazione alle attività del Comitato Permanente istituito presso la Commissione Europea per l’assunzione delle decisioni in materia di sostanze chimiche (restrizione, autorizzazione) e cura le attività di informazione e delle banche dati sui rischi delle sostanze chimiche.
ISS e ISPRA forniscono supporto tecnico-scientifico ai ministeri citati e partecipano alle valutazioni dei rischi sanitari e ambientali condotte dall’ECHA.
Regolamento CLP
Il commercio di sostanze e di miscele non riguarda solo il mercato europeo, ma anche il mercato mondiale. Allo scopo di favorire il commercio mondiale e al con -
tempo di tutelare la salute umana e l’ambiente, nell’ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU) sono stati definiti con estrema attenzione criteri armonizzati per la classificazione e l’etichettatura e principi generali per la loro applicazione. Da questo lavoro è scaturito il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS), la cui prima edizione è stata adottata nel 2002.
Il Regolamento CLP permette di integrare, all’interno del diritto dell’UE, i criteri di classificazione del Sistema globale armonizzato (GHS) delle Nazioni Unite con alcune modifiche.
Il regolamento CLP oltre al GHS tiene inoltre conto di alcune caratteristiche e procedure previste dal precedente sistema UE per la classificazione e l’etichettatura, rappresentato dalla direttiva 67/548/CEE [“direttiva sulle sostanze pericolose” (DSD)] e dalla direttiva 1999/45/ CE [“direttiva sui preparati pericolosi” (DPD)] che non sono previste dal sistema GHS dell’ONU. Il regolamento CLP è pertanto simile, ma non identico, al modo in cui il GHS dell’ONU viene introdotto nel quadro giuridico dei paesi esterni all’Unione europea (si tenga presente che possono esistere differenze a livello di attuazione anche nei singoli paesi extra UE).
Il regolamento CLP è giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri dell’UE/SEE e direttamente applicabile a tutti i settori industriali. Dopo un periodo di transizione, il 1º giugno 2015 sono state abrogate le vecchie direttive DSD e DPD .
Gli ambiti principali non contemplati dal presente regolamento sono: sostanze e miscele radioattive, cosmetici, medicinali e alcuni dispositivi medici, alimenti e trasporto di merci pericolose.
I punti chiavi di questa norma sono:
Classificazione
Il pericolo di una sostanza o miscela è il potenziale di tale sostanza o miscela di causare danni che dipende dalle proprietà intrinseche della stessa. In questo contesto, la valutazione del pericolo è il processo con cui vengono valutate le informazioni relative alle proprietà intrinseche di una sostanza o miscela per determinarne la capacità di arrecare danni. Per valutare tale potenziale, il regolamento CLP fornisce dei criteri di classificazione dei pericoli. Nei casi in cui la natura e la gravità di un pericolo individuato rispondano a tali criteri, verrà attribuita una classificazione che è una descrizione standardizzata di tale pericolo derivante dalle proprietà fisiche di una sostanza o miscela o dai relativi effetti sulla salute umana o sull’ambiente. Uno dei principali obiettivi del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenti proprietà che

permettono di classificarla come pericolosa.
Le sostanze e le miscele sono classificate in specifiche classi (tipi) e categorie (livelli) di pericolo:
• pericoli fisico-chimici (ad esempio liquido infiammabile);
• pericoli per la salute (ad esempio tossicità acuta, cancerogenicità);
• pericoli ambientali (ad esempio per lo strato di ozono, l’ambiente acquatico).
L’allegato I stabilisce i criteri per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.
Una volta che tali proprietà sono state individuate e la sostanza o miscela è stata classificata di conseguenza, i fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle e i distributori di sostanze e miscele nonché i produttori e gli importatori di taluni articoli specifici devono comunicare i pericoli identificati in relazione a tali sostanze o miscele all’ECHA e ad altri attori della catena d’approvvigionamento, fra cui i consumatori.
Lo strumento chiave per la comunicazione dei pericoli derivanti dalla classificazione all’utilizzatore (consumatore) di una sostanza o miscela è l’etichetta. L’etichetta serve a segnalare a quest’ultimo la presenza di un pericolo e la necessità di gestire i rischi correlati. Oltre ai criteri di classificazione e all’etichettatura, il regolamento CLP stabilisce norme generali relative all’imballaggio, al fine di garantire la sicurezza delle forniture delle sostanze e delle miscele pericolose (considerando 49 e titolo IV del regolamento CLP).
Etichettatura e Imballaggio
I fabbricanti, gli importatori, gli utilizzatori a valle (compresi i responsabili della formulazione) o i distribu -
©teerayuth oanwong/shutterstock.com
tori (compresi i rivenditori al dettaglio) devono etichettare ogni sostanza o miscela che richieda un’etichettatura e sia contenuta in un imballaggio, prima dell’immissione sul mercato. Questo vale anche per i produttori e gli importatori di articoli esplosivi conformemente ai criteri di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento CLP. Nel caso dei distributori, non è necessario classificare da zero ai fini dell’etichettatura, ma si può utilizzare la classificazione di una sostanza o miscela del fornitore, a condizione che sia derivata in conformità del titolo II del regolamento CLP. Si applica la stessa regola nel caso degli utilizzatori a valle, a condizione che non modifichino la composizione della sostanza o della miscela loro fornita.
Le sostanze e le miscele devono recare etichette con le seguenti informazioni:
• dati del fornitore;
• nome della sostanza o miscela e/o numero di identificazione;
• quantità nominale del prodotto nella confezione;
• pittogrammi di pericolo (disegni grafici che combinano simboli e altri elementi grafici);
• avvertenze sul livello di pericolo («Attenzione» o «Pericolo»);
• frasi di rischio («Pericolo di incendio o di proiezione», «Letale se ingerito», ecc.);
• consigli per la sicurezza («Conservare soltanto nel contenitore originale», «Proteggere dall’umidità», «Tenere fuori dalla portata dei bambini» ecc.)
• informazioni supplementari (tra cui UFI per le miscele pericolose)
Per le miscele soggette ai requisiti di presentazione di cui all’articolo 45 e all’allegato VIII del regolamento CLP, un identificatore unico di formula (UFI) deve essere stampato o apposto sull’etichetta o stampato sull’imbal -
laggio in prossimità degli altri elementi dell’etichetta, se applicabile. Ciò consentirà a qualsiasi centro antiveleni chiamato per fornire supporto durante un episodio di avvelenamento con un prodotto, di identificare rapidamente e inequivocabilmente una o più miscele in esso contenute e recuperare le corrispondenti informazioni inviate.
Le prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio di cui al regolamento CLP hanno lo scopo di proteggere gli utilizzatori dai pericoli derivanti da sostanze o miscele. Tuttavia, alcuni tipi di imballaggio (per le loro caratteristiche e dimensioni) possono non essere adatti per l’etichettatura. Sostanze e miscele pericolose possono inoltre essere contenute in differenti strati di imballaggio; possono anche rientrare nel campo di applicazione sia del regolamento CLP sia delle prescrizioni in materia di etichettatura per il trasporto. Infine, possono essere necessari requisiti particolari per proteggere il pubblico da gravi danni.
L’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose deve:
• impedire la fuoriuscita del contenuto;
• essere costituito da materiali che non si deteriorino a contatto con il contenuto;
• essere solido e robusto;
• disporre di chiusure sigillabili.
In alcuni casi, sono necessarie chiusure di sicurezza per bambini e un’indicazione di pericolo riconoscibile al tatto.
Armonizzazione
Le aziende dovrebbero giungere a un accordo sulla
classificazione di tutte le sostanze (autoclassificazione).
Tuttavia, per pericoli particolarmente gravi, ad esempio nel caso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) possono proporre classificazioni armonizzate.
Le classificazioni armonizzate delle sostanze sono incluse nella tabella 3 che figura nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP. La classificazione armonizzata si applica soltanto alle sostanze. L’uso della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di una sostanza (quando esistono) è obbligatorio. Esse devono essere applicate da tutti i fornitori della stessa sostanza, ossia dai fabbricanti di sostanze, dagli importatori di sostanze in quanto tali o contenute in miscele, dai produttori o dagli importatori di articoli esplosivi o di articoli per i quali il regolamento REACH prevede la registrazione o la notifica, dagli utilizzatori a valle compresi i responsabili della formulazione (che producono miscele) e dai distributori.
Notifica
La classificazione e l’etichettatura di ogni sostanza pericolosa messa in vendita o registrata secondo il REACH devono essere comunicate all’Agenzia ECHA per essere incluse nell’inventario delle classificazioni e delle etichettature (C&L) che l’Agenzia ha creato e aggiorna regolarmente.
Le imprese devono notificare all’ECHA la classificazione e l’etichettatura impiegate per le proprie sostanze in quanto tale o come componenti nelle miscele.
La notifica riguarda tutte le sostanze che devono es -

sere registrate ai sensi del regolamento REACH e tutte le sostanze pericolose. Gli Stati membri e l’industria possono proporre che la classificazione e l’etichettatura di una sostanza pericolosa siano armonizzate in tutta l’UE. Questa classificazione armonizzata garantisce che tutte le società forniscano le stesse informazioni ai clienti.
Banca dati ECHA
Grazie ai regolamenti REACH e CLP, l’industria chimica ha messo a disposizione quantità di informazioni senza precedenti sulle sostanze chimiche utilizzate in Europa.
L’ECHA è un’eccezionale fonte di informazioni sulle sostanze chimiche fabbricate e importate in Unione europea, Norvegia, Liechtenstein e Islanda.
Le banche dati contengono informazioni sulle sostanze chimiche, sulle relative proprietà pericolose e classificazioni nonché sulle modalità d’uso sicuro. Tali informazioni sono trasmesse all’Agenzia dalle aziende in linea con gli obblighi previsti ai sensi dei regolamenti REACH e CLP.
L’ECHA pubblica sul suo sito Internet le informazioni contenute nei fascicoli di registrazione, ad eccezione dei dati commerciali riservati. Il sito fornisce informazioni sulla sostanza stessa e sulla sua pericolosità, nonché orientamenti per un uso sicuro. La quantità di dati in costante aumento ne fa un’eccezionale fonte d’informazioni sulle sostanze chimiche a livello mondiale.
Le informazioni sono utili alle autorità per identificare le sostanze chimiche che, in quanto pericolose, ri -
©dongfang/shutterstock.com

chiedono restrizioni o controlli supplementari. Anche le autorità nazionali preposte al controllo dell’applicazione utilizzano le informazioni contenute nei fascicoli di registrazione delle aziende quando effettuano le ispezioni in sito e verificano l’esistenza di adeguate misure di gestione dei rischi.
Conclusioni
L’industria chimica europea rappresenta uno dei settori manifatturieri più rilevanti, non solo per il suo impatto economico, ma anche per il suo ruolo fondamentale nella vita quotidiana. Le normative REACH e CLP sono i pilastri essenziali che garantiscono l’uso sicuro delle sostanze chimiche, promuovendo al contempo innovazione e competitività.
La rigorosa applicazione di queste normative, supportata da autorità competenti e da un sistema di controllo efficiente, assicura che i prodotti chimici siano gestiti in modo sicuro per la salute umana e l’ambiente, favorendo una crescita sostenibile del settore.
In questo contesto, sono necessarie figure professionali con competenze specifiche per valutare e gestire i rischi derivanti dalla produzione, dall’immissione sul mercato e dall’uso di sostanze chimiche e loro miscele, nonché i rischi legati all’intero ciclo di vita di prodotti destinati ad usi specifici e regolamentati dalle recenti normative sociali, di settore e di prodotto.
1.Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
2.Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
3.Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
4.Ministero della Salute. Decreto 22 novembre 2007: Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie. Documento ufficiale che dettaglia il piano di attività e l’utilizzo delle risorse finanziarie per l’attuazione del regolamento REACH.
5.ECHA - European Chemicals Agency. Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza Versione 4.0 – Dicembre 2020
6.ECHA - European Chemicals Agency. Orientamenti introduttivi al regolamento CLP Versione 3.0 – gennaio 2019
Edizione 2014 e anticipazioni 2025
© Microgen/shutterstock.com
Nel 2014, l’ex Ordine Nazionale dei Biologi (oggi Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi o Fnob) realizzò dei vademecum di orientamento alla professione di biologo che potessero fornire aggiornamenti e indicazioni sullo svolgimento dell’attività professionale nei diversi settori della biologia.
Tra questi, fu redatto quelli dedicato alla Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, che pubblichiamo di seguito.
Il documento sarà presto aggiornato da una commissione di esperti in corso di formazione. Il team si occu-

perà di realizzare delle nuove linee guida per il settore che possano essere complete e dettagliate, con approfondimenti tecnici, legislativi e normativi.
«La biotutela dei beni culturali è una delle 80 discipline nelle quali i biologi possono trovare impiego – spiega Vincenzo D’Anna, presidente della Fnob -. Da quest’anno proporremo corsi di formazione professionalizzanti e attività in collaborazione con diversi atenei che possano consolidare il ruolo che
gli iscritti ricoprono in questo settore. L’Italia vanta un patrimonio artistico e culturale tra i più ricchi al mondo e i biologi sono in grado di tutelare questo tesoro».
Nei prossimi mesi, sia la Fib (Fondazione Italiana Biologi) sia la Fnob organizzeranno seminari e attività dedicati alla conservazione dei beni culturali. Il primo evento si terrà a Roma il 27 febbraio, ne -

gli spazi della Biblioteca Nazionale Centrale in Viale Castro Pretorio, e avrà come tema le “Nuove Opportunità Professionali per i Biologi nel Mondo dell’Arte e dei Beni Culturali”.
Per maggiori informazioni sugli eventi in programmazione, è possibile consultare il sito web www.fnob.it oppure l’indirizzo www.fondazioneitalianabiologi.it
Uno sbocco professionale tra i più proliferi nel nostro Paese. La Fnob realizzerà presto il nuovo vademecum per l’orientamento professionale in questo settore d’impiego