Medici e pazienti al tempo di ChatGPT
Disforia di genere: un acceso dibattito tra pro e contro

La ricerca sull’alzheimer: tanti investimenti pochi risultati
Crisi sanitaria: due risposte centrate sull’individuo e sulla cura

Disforia di genere: un acceso dibattito tra pro e contro

La ricerca sull’alzheimer: tanti investimenti pochi risultati
Crisi sanitaria: due risposte centrate sull’individuo e sulla cura
3
6 parole per il nuovo codice di deontologia Guido Giustetto
IL PUNTO SU CHATGPT
5

Il valore della privacy al tempo di ChatGPT Giampaolo Collecchia
9
ChatGPT cambierà la medicina?
Vinay Prasad
12
ChatGPT, il medico e il paziente Raffaele Giusti
16
Disforia di genere: è possibile cambiare i nostri corpi?

È etico l’uso di bloccanti puberali? Matteo Cresti, Elena Nave
21 Alzheimer: tanti investimenti e pochi risultati? Andrea Capocci dialoga con Antonino Cattaneo
26
La distanza dei trial dalla terapia dell’alzheimer Nicola Vanacore
32
Perché chiedere “il pane e le rose”? Per rispondere alla crisi assistenziale
35
Ripartire dal bene comune per una sanità migliore. Individui, ma in società Luciano De Fiore
38 Riconoscere i diritti dei nati delle famiglie arcobaleno Stefania Manetti

42
LEGGERE I NUMERI Gli studi clinici Renato Luigi Rossi

43
LEGGERE I NUMERI Una checklist per interpretare gli studi clinici
Renato Luigi Rossi
44
LESSICO DI BIOETICA Identità sessuale Vera Tripodi
45
LESSICO DI BIOETICA Etica della sacralità e della qualità della vita Maria Teresa Busca
46
LESSICO DI BIOETICA Consenso informato Elena Nave
ANNO II, NUMERO 2
APRILE-GIUGNO 2023
Direttore scientifico
Guido Giustetto
Direttore editoriale
Rosa Revellino
Comitato redazionale
Gianluigi D’Agostino, Venera Gagliano, Andrea Gatta, Guido Regis, Angelica Salvadori, Emanuele Stramignoni, Rosella Zerbi.
Laura Tonon e Celeste De Fiore (Il Pensiero Scientifico Editore)
Collaboratori: Giulia Annovi, Viola Bachini, Luciano De Fiore, Alessandro Magini
Comitato editoriale
Marco Bobbio, Michela Chiarlo, Gianni Ciccone, Libero Ciuffreda, Giampaolo Collecchia, Lucia Craxì, Nerina Dirindin, Fabrizio Elia, Maurizio Ferraris, Elena Gagliasso, Giuseppe Gristina, Roberto Longhin, Giuseppe Naretto, Luciano Orsi, Elisabetta Pulice, Lorenzo Richiardi, Massimo Sartori, Vera Tripodi, Marco Vergano, Paolo Vineis
Consiglio direttivo dell’OMCeO di Torino
Guido Giustetto (presidente), Guido Regis (vicepresidente), Rosella Zerbi (segretaria), Emanuele Stramignoni (tesoriere), Domenico Bertero, Patrizia Biancucci, Tiziana Borsatti,
Vincenzo Michele Crupi, Gianluigi D’Agostino (presidente CAO), Riccardo Falcetta, Riccardo Faletti, Gilberto Fiore, Ivana Garione, Aldo Mozzone, Fernando Muià, Angelica Salvadori, Renato Turra, Roberto Venesia
Sede e contatti
OMCeO Torino
Corso Francia 8 – 10143 Torino
email: info@ilpunto.it
Produzione e amministrazione
Il Pensiero Scientifico Editore
Via San Giovanni Valdarno 8, 00138 Roma
tel. 06862821 | fax 0686282250
e-mail: pensiero@pensiero.it
internet: www.pensiero.it
c/c postale: 902015
Editore responsabile
Giovanni Luca De Fiore
Progetto grafico e impaginazione
Typo85, Roma
Stampa Ti Printing, Roma
Autorizzazione Tribunale di Torino numero registro stampa 65/2021 del 29/12/2021 (già 793 del 12/01/1953).
Immagini
In copertina: “f32” di Daniele Bertin. Nelle pagine interne le foto non firmate sono di iStock. Tutti i diritti sono riservati. Diritti d’autore Tutto il materiale pubblicato in queste pagine è disponibile sotto la licenza “Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo
4.0 Internazionale”. Può essere riprodotto a patto di citare ilpunto.it, di non usarlo per fini commerciali e di condividerlo con la stessa licenza.
Finito di stampare luglio 2023
Abbonamenti 2023
Per l’Italia privati € 40,00 (per gli iscritti OMCeO Torino ricompreso nell’iscrizione all’Ordine) enti, istituzioni, biblioteche € 50,00 Per l’Estero € 60,00
L’abbonamento decorre dal mese di gennaio a dicembre
Per abbonamenti: Andrea De Fiore tel. 06 86282324 e-mail: andrea.defiore@pensiero.it

Sono passati quasi 100 anni dall’approvazione del primo codice deontologico nazionale. Su questa importante memoria, e grazie al lavoro della Commissione storica dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino, abbiamo organizzato lo scorso maggio due giornate per riflettere su alcune tematiche fondanti per la deontologia.
Sono stati proposti cinque punti di approfondimento: il tema dell’informazione al paziente e come si è evoluta in questi 100 anni; la riflessione sull’indipendenza del medico; l’utilizzo più appropriato delle risorse e l’errore in medicina; un focus sulla società e la morte e su come sia cambiato questo rapporto negli ultimi anni. E infine un approfondimento sull’incontro complesso tra tecnologia e medicina. Ad introduzione di tutte le sessioni abbiamo posto un inquadramento storico e filologico sul percorso della deontologia dalle origini fino ad oggi.
Abbiamo pensato di anticipare un po’ i festeggiamenti per i 100 anni del Codice che in realtà venne promulgato dalla Federazione Nazionale degli Ordini, la FOM, costituita nel 1912, a gennaio del 1924. Ma è nel 1923 che alcuni presidenti decisero di proporre un codice deontologico unificato nazionale. E presero come base il codice più diffuso in quel momento, quello che l’Ordine di Torino aveva emanato nel 1910, poi adottato a Genova e Milano. I presidenti si riunirono così ai primi di giugno del 1923, per iniziare i lavori. Cento anni fa.
L’attuale versione del Codice di deontologia medica è del 2014: sono passati solo 10 anni; sembrano pochi per una sua revisione, ma questo tempo appare sufficiente per mettere mano a un ripensamento di molte parti, non solo per l’evoluzione della società (pensiamo all’attenzione per l’ambiente o all’intelligenza artificiale), e per alcuni rilevanti aspetti giuridici che si sono modificati o sono messi in discussione (come le tematiche per inizio e fine vita), ma soprattutto perché il sentire dei cittadini sta cambiando su molti aspetti della vita.
Nell’evoluzione dei codici che segnano il cammino della nostra deontologia, il cambio di paradigma è avvenuto senza dubbio alla fine degli anni ’70 con l’introduzione del concetto di autonomia e autodeterminazione della persona. Il principialismo di Tom Beauchamp e James Childress (che hanno introdotto i principi di autonomia, non-maleficenza, beneficenza, giustizia) è da oltre 40 anni il più diffuso e influente modello di giustificazione
Coscienza, incertezza, antropologia, fine vita, tecnologia, comunicazione: queste le parole che potrebbero diventare direttrici portanti del Codice del futuro
del giudizio bioetico a livello internazionale. Questo nel tempo ha cambiato pian piano la natura dei nostri codici in particolare sul tema del rapporto medico-paziente. Oggi probabilmente la nuova svolta epistemologica – se così può essere definita – è legata alla tecnologia in cui siamo immersi: da Internet alla rete, ai social fino al grande tema dell’intelligenza artificiale che oggi ci coinvolge in modo molto concreto e rischia di travolgere il rapporto di cura. Per mettere a fuoco le varie direttrici di pensiero che si sono dipanate durante le relazioni del convegno si possono individuare sei parole chiave.

La prima è coscienza , parola che usiamo spesso quando, per esempio, diciamo che “il medico agisce secondo scienza e coscienza” oppure quando parliamo di obiezione di coscienza. In generale le attribuiamo un significato positivo perché rappresenta i valori che guidano la condotta morale del medico. Tuttavia quando tali valori entrano in conflitto con quelli del paziente rischiano di mettere a repentaglio i diritti della persona e anche la relazione di cura. E per questo conflitto al medico dovrebbe essere chiesto di rinunciare alle sue convinzioni?
Un’altra parola importante è incertezza: la nostra è una professione che si basa sull’incertezza, sulla probabilità. Si deve sempre tener presente che la medicina affronta problemi complessi, dove l’incertezza è un elemento costitutivo. La stessa ricerca scientifica può solo ridurre l’area dell’incertezza, ma mai annullarla, e ogni decisione può essere assunta soltanto sulla base di criteri probabilistici. Questo concetto dovrebbe quindi avere uno specifico ruolo cioè definire quasi uno statuto della medicina.
La terza parola innovativa è legata all’antropologia. Ippocrate era forse più antropologo che medico. Dovremmo includere nella relazione di cura una prospettiva di “osservazione partecipante” che ci avvicina molto alla funzione antropologica e che ci riconsegnerebbe quello sguardo inclusivo, rispettoso e stupito nel rapporto con i nostri pazienti.
Una quarta parola è fine vita. Nella medicina più antica l’obiettivo dell’ultima fase della vita era prepararsi a morire. Oggi non è più così. Forse ciò che occorre è costruire la consapevolezza del morire. Cioè trasformare la preparazione alla morte nella consapevolezza della morte: consentire ad ognuno di scegliere la propria morte, più dignitosa e adeguata a sé stesso. La quinta parola è tecnologia, uno strumento di cambiamento che ha un aspetto paradossale: ci ha allontanato dai corpi dei nostri pazienti costruendo una specie di falsa prossimità ma può offrire anche molteplici risorse concrete nella pratica clinica e nella ricerca. E poi, non ultima, la parola comunicazione che è diventata sempre di più un passe-partout ma che permette di dare concretezza a tutti i concetti fin qui espressi.
Queste in sintesi le parole e i temi che potrebbero diventare alcune delle direttrici del Codice del futuro. y
Medico internista
Il 31 marzo scorso il Garante per la protezione dei dati personali aveva disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense fondata da Elon Musk che ha sviluppato e gestisce la piattaforma ChatGPT, il più noto tra i software di intelligenza artificiale conversazionale, in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane. Nel provvedimento il Garante rilevava la mancanza di una informativa agli utenti e a tutti gli interessati i cui dati vengono raccolti da OpenAI e l’assenza di una base giuridica che giustificasse la raccolta e la conservazione massiccia dei dati personali allo scopo di “addestrare” gli algoritmi sottesi al funzionamento della piattaforma.1 In seguito la società che gestisce ChatGPT ha accolto le richieste dell’Autorità e la piattaforma è tornata accessibile anche dall’Italia.
L’enorme diffusione della piattaforma di ChatGPT che, lanciata il 22 novembre 2022 in soli due mesi ha raggiunto 100 milioni di utenti con i quali “conversare” e instaurare una conoscenza estesa su informazioni personali sensibili quali pensieri, interessi, domande, timori, ha confermato la centralità della protezione dei dati personali e il suo fortissimo legame con lo sviluppo e l’affermazione delle nuove tecnologie.2 La decisione del Garante è
stata valutata con favore da chi ne ha apprezzato soprattutto l’azione di tutela nei confronti delle sempre maggiori sottrazioni della privacy. Da altri è stata considerata una scelta oscurantista che rischia di far arretrare il nostro Paese nella graduatoria di quelli tecnologicamente non avanzati.3 In questa sede, vorrei trarre lo spunto da questa vicenda per riflettere insieme sull’importanza attuale della privacy nella nostra società.
Il diritto alla privacy inizia ad affermarsi a fine Ottocento, si sviluppa in maniera significativa nel Novecento, per poi “esplodere” all’inizio del XXI secolo, sotto il profilo sia del controllo sia della diffusione e proliferazione delle informazioni che le persone forniscono di sé stesse, volontariamente o involontariamente. Il concetto nasce con l’idea illuministica di individuo autonomo, capace di servirsi della propria intelligenza, senza bisogno di “guide” esterne. Da tradizionale appannaggio della classe borghese, la riservatezza è in seguito diventata strumento di tutela delle classi più deboli dalle prevaricazioni dei potenti. In Italia, ad esempio, è nata con lo Statuto dei lavoratori, come strumento di protezione dalle ingerenze dei datori di lavoro.4 Il controllo sui propri dati e la salvaguardia della sfera privata

hanno peraltro consentito di andare oltre alla tutela dei diritti individuali e di assurgere a strumento di progresso sociale. Per esempio, nel caso dell’aids, quando la garanzia di anonimato dei pazienti e la conseguente protezione dal rischio di stigmatizzazione sociale hanno permesso l’emersione del fenomeno con i conseguenti benefici per la comunità; oppure, quando a seguito dell’approvazione del cosiddetto “pacchetto sicurezza” da parte della Camera, la FNOMCeO si era opposta all’introduzione dell’obbligo dei medici di denunciare gli immigrati “clandestini” che si rivolgono alle strutture sanitarie pubbliche. In queste e in altre situazioni si è effettivamente realizzato il binomio dignità personale/interesse collettivo, sotteso, nell’articolo 32 della Costituzione, al diritto alla salute.5
I dati, proiezione digitale delle nostre persone, sono input fondamentali per produrre avanzamenti in ambito medico e per migliorare le politiche sanitarie. Il concetto di dato personale e anonimo è peraltro ormai sparito in una sorta di far web di schedature e profilazioni ossessive, fuori controllo, nelle quali la violazione della privacy sembra sistematica. I dati, sempre più accessibili e trasparenti, sono infatti prede allettanti per la creazione di valore nel commercio digitale, per mezzo di indagini di mercato che trasformano le persone in codici, entità disumanizzate. I cittadini sono divisi in sorveglianti (pochissimi) e sorvegliati (i più), ricevono servizi gratuiti in cambio della possibilità di monitorare il loro comportamento, spesso senza consenso esplicito, illusi con la promessa di maggiore controllo laddove nei fatti ne vengono progressivamente privati.7 La rete, da possibile risorsa democratica, si è trasformata in strumento di sorveglianza globale da parte delle mega-piattaforme private, versione digitale del panottico di Jeremy Bentham, il dispositivo di sorveglianza carceraria che, a fine Settecento, profetizzava la moderna so-
cietà del controllo sociale.8 Nel Panopticon, peraltro, il punto di sorveglianza era centrale, visibile e generatore di timore; mentre ora la sorveglianza invade qualsiasi punto della realtà.
Essere controllati è diventato qualcosa di normale e naturale, il potere controlla lasciando le persone fare esattamente ciò che vogliono, mantenendo un’illusione di libertà.9 Come afferma il sociologo Lelio Demichelis: “Le persone si sono messe in vetrina, hanno accettato di essere sorvegliati in massa. (…) Il sistema ha sfruttato, potenziandola n volte a fini di profitto, la tentazione umana di stare con gli altri e di sapere di loro e il narcisismo derivante dalla socialità innata e dalla tendenza all’esposizione di sé tipico dell’uomo. Ciò che sembrava un valore intangibile, forma della nostra soggettività e mezzo di costruzione della nostra individuazione (la privacy) è evaporata/svaporata”.9 Nessuno deve vivere come problema essere diventato trasparente (“di vetro”) nei confronti del potere tecnologico, al contrario oscuro e non trasparente, in grado non solo di spogliare (letteralmente) le persone dei vestiti ma soprattutto del proprio sé, della propria intimità e della vita di relazione, fino a controllare e mercificare tutti i dati della vita, compresi quelli sanitari. Noi stessi infatti postiamo sui principali social network immagini di ospedale, referti diagnostici, informazioni sull’andamento delle malattie, vissuti di lutto, mo-
Nessuno deve vivere come problema l’essere diventato trasparente (“di vetro”) nei confronti del potere tecnologico che, al contrario, è oscuro e non trasparente

La storia del diritto alla privacy inizierebbe con l’articolo “The Right to privacy”, apparso il 15 dicembre 1890 sulla prestigiosa Harvard Law Review, tuttora la più famosa rivista giuridica degli Stati Uniti, ad opera di due giovani avvocati bostoniani, Samuel Warren e Louis Brandeis, i quali analizzarono in maniera molto precisa e articolata il rapporto tra il diritto di informare ed essere informati e la riservatezza. Occasione data dalla circolazione non autorizzata di ritratti di persone, grazie ad un duplice sviluppo tecnico, la fotografia e la diffusione di giornali a stampa.
menti cruciali della propria e della altrui esistenza. I dati personali, la condizione di salute/malattia, la vita intera sono diventati forza-lavoro e merce, un pluslavoro per garantire plusvalore al sistema economico, una risorsa da sfruttare, una merce che noi stessi produciamo diventando lavoratori-produttori di dati personali, in una sorta di schiavitù volontaria. Inoltre, in virtù della sempre maggiore diffusione del cosiddetto “internet delle cose”, per cui oggetti, dispositivi, sistemi diventano “smart”, cioè dotati di software che con-

sentono loro di identificarsi elettronicamente, connettersi e comunicare direttamente tra loro, Internet è sempre più trasformata da rete di comunicazione tra persone a rete di controllo, incorporata nel mondo fisico. Come afferma Laura DeNardis: “Lo schermo non è più l’arbitro di ciò che è online o di ciò che è offline. Nell’era in cui la maggior parte dell’accesso era mediato da uno schermo (computer, telefono, tablet) era chiaro quando qualcuno ‘era’ su Internet. L’allontanamento dagli schermi verso oggetti ambientali dissolve questa distinzione tra online e offline” 10
La decisione del Garante nei confronti di ChatGPT ha riacceso il dibattito sul valore della privacy nella nostra società e sul suo stretto legame con lo sviluppo delle sempre più intrusive tecnologie digitali. La difesa del diritto al controllo dei propri dati dovrebbe essere la tutela della libertà dell’individuo e di una società che, consapevole di sé stessa e delle proprie capacità, dovrebbe poter dissentire rispetto al potere tecnologico, o almeno evitare di essere sempre più identificata secondo le forme e le regole del sistema.5 La soluzione peraltro non sta nella semplice riappropriazione dei propri dati mediante norme rigide. Secondo Shoshana Zuboff, sociologa della Harvard business school, queste non toccano il punto nodale della questione. Anzi, la spinta a introdurre regolamenti sempre più inflessibili, paradossalmente, “non fa che istituzionalizzare e legittimare ancora di più la raccolta dei dati. È come negoziare il numero massimo di ore lavorative quotidiane di un bambino di sette anni, piuttosto che contestare la legittimità del lavoro minorile”.6
La protezione della riservatezza, anche in ambito sanitario, richiede la concezione di nuovi costrutti, maggiormente allineati agli attuali contesti ontologici prodotti dalle sempre più affascinanti/inquietanti intelligenze computazionali, peraltro indispensabili, a causa delle loro immense
potenzialità, per fornire risposte in ambiti ad elevata complessità e incertezza, come quelli della salute/malattia.11 La risposta deve essere culturale, mediante il recupero e la promozione dei diritti delle persone, compreso quello di rinunciare, consapevolmente, alla fruizione del diritto alla privacy, per chi voglia partecipare al flusso dell’attualità tecnologica ed essere costantemente online anziché onlife.12 y
1 Provvedimento del 30 marzo 2023 [9870832] – Garante privacy.

2 Foti A, Garafolo A. ChatGPT e i nostri dati: l’IA al banco di prova della data protection. Agenda Digitale, 24 marzo 2023.
3 Benanti P. Il valore dei dati e della vita. Avvenire, 6 aprile 2023.
4 Rodotà S. La vita e le regole. Milano: Feltrinelli, 2006.
5 Soro A. Persone in rete. Roma: Fazi Editore, 2018.
6 Zuboff S. Il capitalismo della sorveglianza. Roma: Luiss, 2019.
7 Deleuze G. Pourparler. Macerata: Quodlibet, 2019.
8 Panopticon è il progetto di carcere ideale creato nel 1791 dal filosofo e giurista Jeremy Bentham. Il concetto è di permettere a un unico sorvegliante di osservare tutti i soggetti di una istituzione carceraria senza permettere a questi di capire se siano in quel momento controllati o no.
9 Demichelis L. Dalla privacy all’alienazione di sé: così i social ci hanno “mercificato”. Agenda digitale, 1 maggio 2019.
10 DeNardis L. Internet in ogni cosa. Roma: Luiss, 2021.
11 Collecchia G. Intelligenza umana e artificiale: culture a confronto/scontro. IsF 2018; 4: 28-31.
12 Dall’habeas corpus all’habeas data. In: Collecchia G, De Gobbi R. Intelligenza artificiale e medicina digitale. Roma: Il Pensiero Scientifico Editore, 2019.
La protezione della riservatezza richiede la concezione di nuovi costrutti maggiormente allineati agli attuali contesti ontologici prodotti dalle intelligenze computazionali
 Vinay Prasad Medico onco-ematologo Department of epidemiology and biostatistics, University of California San Francisco
Vinay Prasad Medico onco-ematologo Department of epidemiology and biostatistics, University of California San Francisco
Mi è capitato di usare ChatGPT e desidero esporre le mie prime considerazioni sull’impatto che potrebbe avere sulla medicina. A grandi linee, dividerò i miei commenti su come questo strumento modificherà il medical writing e su come la pratica medica. È plausibile che se non lo avete ancora testato ChatGPT (edizione del 14 marzo) non capirete quanto dirò, ma vi invito a provarlo. Inizio con una breve sintesi. ChatGPT risponde alle domande o alle richieste con risposte coerenti e *quasi* accurate, con frasi compiute e paragrafi completi. È in grado di attingere a una vasta gamma di dati e di argomentare e fare confronti. Può anche redigere resoconti o documenti. Può formulare ragionamenti interessanti, ma non molto originali. Se volete farvi
un’idea per iniziare chiedetegli di parlarvi di celebrità minori oppure di imitare lo stile di scrittori o di altre persone famose. Chiedetegli di scrivere un tweet come farebbe <inserire il nome>. Le risposte che otterrete potrebbero sorprendervi. Ora passo alle mie riflessioni sul suo futuro.
ChatGPT sarà sicuramente utilizzato come scriba o medical writer a prezzi accessibili. Integrandolo alla cartella clinica elettronica ChatGPT, compilerà le note cliniche dall’inizio della visita. Presto il suo lavoro supererà rapidamente quello degli studenti di medicina, degli specializzandi e probabilmente anche dei borsisti. Questo aspetto è già stato sollevato da altre persone, ma la questione principale che vorrei sottolineare è quanto sia irragionevole che noi passiamo così tanto tempo per la documentazione medica. Gran parte di questo lavoro è finalizzato alla fatturazione e questi documenti non vengono letti da nessuno. Sono dell’idea che l’intero sistema di pagamento andrebbe riformato. Un sistema migliore per la documentazione sarebbe quello di avere una singola pagina come Wikipedia che riassuma le parti principali della storia clinica di un paziente, collegandole a documenti, referti ed esami radiologici. Probabilmente ChatGPT redigerà questa pagina e sintetizzerà una marea di appunti in un unico riepilogo di
un paio di pagine. L’oncologia è complessa, ma personalmente non ho mai incontrato un paziente che non potessi riassumere in mille parole scelte con cura. ChatGPT cambierà il modo in cui la cartella clinica prende forma e viene letta. (Il rinforzo A-B accelererà questo processo).
Per quanto riguarda la scrittura accademica, ChatGPT diventerà presto un medical writer poco costoso. ChatGPT sarà supervisionato dai medical writer di cui sopravvivranno solo coloro con i più alti livelli di conoscenza della materia, mentre la maggior parte dovrà cercare un nuovo lavoro.
Le review saranno scritte in gran parte da ChatGPT. Saranno anche lette per lo più da ChatGPT e gli utenti chiederanno al software di redigere delle sintesi. Ironia della sorte, quindi, ChatGPT sarà utilizzato sia per generare articoli sia per leggerli in formati facilmente assimilabili. In pratica, questo significa che i lavori di scrittura finiranno di esistere e che anche molti accademici scompariranno. I soli che potranno salvarsi saranno quelli con idee molto originali, in grado di generare argomenti e intuizioni singolari. Profili di questo genere sono rari. La maggior parte degli accademici soffre di “groupthink” oppure copia le idee di cui ha sentito parlare. Distinguersi secondo questa modalità sarà ancora più difficile nel mondo dei ChatGPT. Oggigiorno, ciò che limita i pensatori originali è il tempo necessario per elaborare nuove idee. Con ChatGPT questa restrizione sarà superata. Dunque copiare sarà sempre più difficile perché i pensatori originali saranno avvantaggiati da un potenziale illimitato di scrittura. Nell’ultimo anno con il mio gruppo di ricerca abbiamo pubblicato 61 articoli con estrema fatica. Nel frattempo abbiamo avuto molte altre ottime idee che però non abbiamo avuto il tempo di pubblicare. Con ChatGPT non avremo nessun limite e arriveremo facilmente i 100-200 articoli all’anno. Quei gruppi di ricerca che prendono in prestito le nostre idee saranno svantaggiati.
Ciò che limita i pensatori originali è il tempo per elaborare nuove idee.
Con ChatGPT questa restrizione sarà superata
ChatGPT permetterà a un maggior numero di persone mediocri di diventare medici. Diversi sono gli aspetti essenziali nella professione medica: parlare in modo compassionevole ed empatico, svolgere un lavoro fisico e prendere decisioni mediche valide. Sono tutti elementi ugualmente importanti ma tra questi quello che ChatGPT cambierà drasticamente sarà quello decisionale.
Attualmente, un pensatore mediocre può affidarsi ad algoritmi o diagrammi di flusso per prendere decisioni cliniche, ma questi possono essere errati e la persona può avere dei dubbi. In futuro, sarà ChatGPT a prendere queste decisioni. Al momento, è possibile digitare le informazioni di un caso clinico e ChatGPT può suggerire dei trattamenti. Un domani, ChatGPT estrarrà i dettagli dalla cartella clinica e formulerà da solo delle raccomandazioni.
Anche in questo caso, solo i medici molto perspicaci saranno in grado di superare il livello di qualità di queste raccomandazioni. Molti medici, in realtà, miglioreranno – nel lungo periodo – accettando le raccomandazioni di ChatGPT (è probabile che questo venga dimostrato in trial clinici randomizzati per misurare tutte le cause di morte).
Una volta che avverrà tutto ciò, e date altre tendenze negli Stati Uniti, è molto probabile che più pensatori mediocri saranno reclutati in medicina. Non sto usando il termine “mediocre” come un insulto; sto solo cercando di dire che quando si parla di pensiero critico in medicina c’è uno spettro, e ChatGPT lo livellerà enormemente. Senz’altro, i medici più brillanti supereranno il software, ma saranno pochi e lontani tra loro.
Stiamo già eliminando i voti e i punteggi dei test come barriere per accedere alla medicina e ChatGPT “convaliderà” questa scelta. La medicina clinica probabilmente migliorerà con ChatGPT, ma potrebbero verificarsi conseguenze negative per il progresso della conoscenza. Nel frattem-
po, i provider di medio livello saranno rafforzati dai ChatGPT e saranno utilizzati per colmare le enormi lacune nell’erogazione dell’assistenza sanitaria.
C’è una vecchia battuta che il medico alle cene è l’esperto di tutto: di politica, affari e medicina. ChatGPT metterà in crisi questo stereotipo. Il reclutamento dei più intelligenti in medicina diventerà un problema più grande (in my opinion, è già un problema).
Conclusioni
Disclosure: questo testo è pura speculazione; immaginazione più esperienza del software. Penso che queste mie supposizioni saranno confermate, altrimenti le avrei tenute per me, ma solo il tempo ce lo potrà dire. Per lo più, questo breve testo vuole essere una divertente esplorazione mentale (almeno lo è per me!). Se siete d’accordo o in disaccordo, iscrivetevi e scrivetelo nei commenti. Spero di scrivere altri articoli su questo tema man mano che mi verranno delle idee. y
Questo articolo è stato scritto da ChatGPT. Scherzo, ho scritto ogni parola di mio pugno. – VP
Traduzione del post di Vinay Prasad pubblicato su Sensible Medicine con il titolo “ChatGPT will change Medicine”. Per gentile concessione di Sensible Medicine.
Leggi anche
Sempre sul tema ChatGPT è disponibile online un’intervista all’epidemiologo e pediatra Alberto Tozzi sulle potenzialità dell’uso di questo strumento nella pratica clinica.
La medicina clinica probabilmente migliorerà con ChatGPT, ma potrebbero verificarsi conseguenze negative per il progresso della conoscenza
 Raffaele Giusti Oncologia medica Azienda ospedaliero sanitaria Sant’Andrea, Roma
Raffaele Giusti Oncologia medica Azienda ospedaliero sanitaria Sant’Andrea, Roma
La prima domanda che mi viene in mente quando penso al titolo di questo scritto è cosa mai possano avere in comune un medico, un paziente e un sistema di intelligenza artificiale. La prima risposta è: il futuro. “ChatGPT, il medico e il paziente informato” non ha un significato specifico in quanto è una combinazione di tre elementi distinti.
{ “ChatGPT” si riferisce a un assistente virtuale basato sull’architettura GPT ( generative pre-trained transformer), utilizzato per conversare con gli utenti e fornire informazioni e risposte alle loro domande.
{ “Il medico” si riferisce a un professionista del settore medico, ad esempio un medico generico o uno specialista, come un oncologo nel mio caso, che fornisce
Tre attori che hanno in comune il futuro della nostra salute
assistenza sanitaria e consigli medici ai pazienti.
{ “Il paziente informato” si riferisce a un paziente che ha acquisito una conoscenza sufficiente sulla propria salute e sulle opzioni di trattamento disponibili, in modo da essere in grado di partecipare attivamente alle decisioni mediche e di assumersi la responsabilità del proprio benessere.
Più in generale, tuttavia, si potrebbe interpretare come una situazione in cui ChatGPT, il medico e il paziente sono tutti ben informati riguardo a una determinata condizione medica o trattamento.

Ciò potrebbe implicare che ChatGPT stia fornendo informazioni utili al medico e al paziente, o che stiano tutti collaboran-
do per ottenere una diagnosi accurata o per sviluppare un piano di trattamento efficace. In questo senso, “ChatGPT, il medico e il paziente informato” potrebbe rappresentare un’immagine positiva di una comunicazione efficace e di un gruppo di professionisti della salute che lavorano insieme per raggiungere un obiettivo comune.
Una visione troppo futurista?
Non proprio, anzi, forse attualissima. Quante volte abbiamo letto sui social il messaggio denuncia da parte dei medici che sconsigliavano l’utilizzo di Google per i propri assistiti in quanto possibile fonte di informazioni non corrette.
Google e ChatGPT per informarsi: parliamo della stessa cosa?
Anche qui, non proprio, ma forse possiamo individuare qualche punto di convergenza. Ci sono alcune differenze significative tra le informazioni che un paziente può ricevere utilizzando ChatGPT rispetto a Google. Innanzitutto, ChatGPT può fornire una risposta più personalizzata e rilevante rispetto a Google. Ciò è dovuto al fatto che ChatGPT è progettato per comprendere il contesto della conversazione e fornire risposte basate sulla comprensione del linguaggio naturale. Ciò significa che ChatGPT può rispondere in modo più specifico alle domande del paziente, tenendo conto del contesto e della situazione unica del paziente. Inoltre, ChatGPT può fornire risposte più accurate e aggiornate rispetto a Google. Ciò è dovuto al fatto che ChatGPT è addestrato su grandi quantità di dati medici e di cura della salute, il che significa che è più probabile che fornisca informazioni rilevanti e aggiornate.
ChatGPT può rispondere in modo più specifico alle domande rispetto a Google, tenendo conto del contesto e della situazione unica del paziente
Tuttavia, è importante notare che ChatGPT non può fornire tutte le informazioni che potrebbero essere disponibili su Google. Ci sono alcune informazioni, come ad esempio quelle presenti in siti web specializzati o in pubblicazioni scientifiche di settore che possono essere più facilmente accessibili tramite una ricerca su Google. Inoltre, Google può fornire una maggiore varietà di fonti di informazione rispetto a ChatGPT, il che significa che il paziente potrebbe ottenere una visione più ampia delle informazioni disponibili sulla sua malattia o condizione, ma nel concetto di “ampia” potrebbe essere racchiuso anche quello di “non accurata”. In sintesi, mentre ChatGPT può fornire informazioni più personalizzate e accurate rispetto a Google, quest’ultimo può offrire una maggiore varietà di fonti di informazione.
In ogni caso, è importante notare che l’informazione fornita da ChatGPT o Google deve essere sempre integrata con la consulenza medica diretta fornita dal medico curante.
È importante che i pazienti consultino sempre un medico o un altro professionista sanitario qualificato per una valutazione accurata e una consulenza sul loro stato di salute.
Quali sono i rischi?
Tuttavia esistono, ed è noto, alcuni rischi potenziali associati alla consultazione di ChatGPT e Google per l’informazione sanitaria. In primo luogo, sia ChatGPT che Google potrebbero fornire informazioni inaffidabili o inesatte sulla salute. Ciò potrebbe accadere se l’algoritmo di ChatGPT non ha ricevuto una formazione adeguata o se Google fornisce risultati di ricerca basati su fonti non affidabili o non verificate.
In secondo luogo, sia ChatGPT che Google potrebbero fornire informazioni che non sono adatte al caso specifico del paziente o alla sua situazione unica. Ciò potrebbe accadere se ChatGPT non comprende correttamente il contesto della
conversazione o se Google fornisce risultati di ricerca che non sono pertinenti alla malattia o alla condizione specifica del paziente.
Inoltre, sia ChatGPT che Google potrebbero fornire informazioni che sono troppo tecniche o difficili da comprendere per il paziente medio, il che potrebbe aumentare l’ansia o la confusione del paziente. Infine, consultare ChatGPT o Google per l’informazione sanitaria potrebbe incoraggiare l’auto-diagnosi e l’auto-trattamento, il che potrebbe essere pericoloso se il paziente non ha la formazione medica necessaria per prendere decisioni informate sulla sua salute.
Quindi, sia ChatGPT che Google possono fornire informazioni utili sulla salute, ma ci sono rischi associati alla consultazione di queste fonti. Per tale motivo, è importante che i pazienti consultino sempre un medico o un altro professionista sanitario qualificato per una valutazione accurata e una consulenza sul loro stato di salute.
ChatGPT può essere un utile strumento di supporto, ma non può sostituire la competenza e la professionalità di un medico qualificato
Ma allora, può esistere un ruolo di ChatGPT nell’informazioni che acquisisce un paziente prima o dopo una visita oncologica?
La risposta è: sì, ChatGPT potrebbe avere un ruolo nella fornitura di informazioni ai pazienti prima di una visita oncologica. Ad esempio, ChatGPT potrebbe essere utilizzato per sviluppare una piattaforma di telemedicina che consente ai pazienti di accedere a informazioni sulle condizioni oncologiche e sui trattamenti disponibili prima della visita. Ciò potrebbe aiutare i pazienti a comprendere meglio la propria malattia e a prepararsi per la visita con il loro medico oncologo.
Inoltre, ChatGPT potrebbe essere utilizzato per sviluppare chatbot che aiutino i pazienti a rispondere alle domande frequenti sulla loro malattia, sui trattamenti disponibili e sugli effetti collaterali dei trattamenti. Ciò potrebbe aiutare i pazienti a sentirsi più informati e preparati per la visita oncologica, migliorando la loro esperienza complessiva di cura, e questo non è futuro, ma realtà, come ha già fatto l’Organizzazione mondiale della sanità.1
Tuttavia, è importante sottolineare che l’informazione fornita da ChatGPT deve essere sempre integrata con la consulenza medica diretta fornita dal medico oncologo. ChatGPT può fornire informazioni di base e risposte alle domande frequenti, ma solo un medico oncologo qualificato può fornire una valutazione accurata e personalizzata della malattia del paziente e dei suoi trattamenti.
Anche qui, la risposta è “Sì”. ChatGPT può essere utilizzato da un medico in diversi modi. Ad esempio, può essere utilizzato come strumento di supporto alla diagnosi o come fonte di informazioni generali sulla malattia e sui sintomi. Inoltre, ChatGPT può essere utilizzato per aiutare i medici a comunicare con i pazienti in modo più efficace. Ad esempio, ChatGPT può essere utilizzato per tradurre informazioni mediche complesse in un linguaggio
più semplice e comprensibile per i pazienti, o per rispondere a domande generali dei pazienti sulla malattia o sulle procedure mediche.
Tuttavia, è importante tenere presente che ChatGPT non può sostituire la conoscenza e l’esperienza di un medico qualificato. La diagnosi e il trattamento di una malattia richiedono una valutazione medica approfondita e una conoscenza specifica della patologia, della storia medica del paziente e delle sue condizioni attuali. ChatGPT può essere un utile strumento di supporto, ma non può sostituire la competenza e la professionalità di un medico qualificato.
Per concludere, quindi, la frase “ChatGPT, il medico e il paziente informato” potrebbe essere interpretata come un invito a un dialogo informato e collaborativo tra un assistente virtuale, un medico professionista e un paziente informato, al fine di fornire le migliori cure possibili. y
L’intera intervista è stata generata utilizzando l’interrogazione diretta a ChatGPT. Lo 0 per cento del testo è simile a quello prodotto online.
Bibliografia
1 Who launches women’s health chatbot with messaging on breast cancer. Who.int, 20 ottobre 2021.
“ChatGPT, il medico e il paziente informato” potrebbe essere un invito a un dialogo informato e collaborativo per le migliori cure possibili
Il 12 gennaio scorso un comunicato ufficiale della Società psicoanalitica italiana indirizzato al governo apre un acceso dibattito sul ricorso a farmaci che bloccano lo sviluppo puberale su minori con diagnosi di disforia di genere. Tra società scientifiche, associazioni di categoria e sponde mediatiche in breve tempo la questione si colora di toni politici e ideologici.
Ilpunto.it ha voluto proporre ai suoi lettori un approfondimento multifocale sul tema. Di seguito il contributo di Elena Nave e Matteo Cresti che inquadra il tema dal punto di vista etico.
Matteo Cresti
Università degli studi di Torino Consulta di bioetica onlus
Elena Nave
Osservatorio nazionale sull’identità di genere Consulta di bioetica onlus
Sono già molti anni che si parla della possibilità di utilizzare trattamenti farmacologici per fermare la pubertà nelle persone che presentano disforia di genere (secondo la denominazione tradizionale ancora in uso nel DSM-V) o incongruenza di genere (secondo la nomenclatura del più recente ICD-11). L’idea alla base di questo trattamento è la costatazione che i cambiamenti che il corpo subisce durante la pubertà producano un aumento del dolore psicologico che i minori d’età con incongruenza di genere provano. Se durante l’infanzia è facile essere scambiati per bambini del genere opposto – le differenze tra i due generi sono meno marcate e le differenze fisiche possono essere più agevolmente superate at-
traverso il modo in cui si esprime il proprio ruolo sociale di genere – la pubertà acuisce di fatto quella frattura tra il sesso e il genere esperito. Per una bambina nata in un corpo maschile, la crescita del pomo d’Adamo, la comparsa dei peli facciali e corporei, l’abbassamento della voce, l’aumento di dimensioni fisiche, la crescita del pene e dei testicoli sono segni di un corpo che da “indeterminato” sta prendendo la direzione diametralmente opposta a quella che si vorrebbe. Lo stesso per un bambino nato in un corpo femminile. La letteratura psicologica, o l’esperienza concreta per chi lavora con questi minori d’età, mostra come la sofferenza sia altissima in questo periodo: cresce il rischio suicidario e di atti di autolesionismo. Per
Da un punto di vista morale la scelta deve essere di campo
comprendere cosa possano provare queste persone pensiamo a immaginare noi stessi al mattino appena alzati che ci guardiamo allo specchio e troviamo il corpo del nostro genere opposto. Se eravamo uomini adesso siamo donne, è sparita la barba ed è comparso il seno, sono spariti i nostri genitali e troviamo quelli opposti. Il nostro armadio è pieno di gonne e la società ci chiede di conformarci a un ruolo di ge-
nere che non è il nostro. L’idea, dunque, è quella di utilizzare farmaci per sospendere la pubertà evitando i cambiamenti fisici che questa comporta. Ciò con il vantaggio di dare del tempo ulteriore alle e agli adolescenti (e al personale sanitario) per valutare se e in che modo effettuare una transizione di genere. Infine, con l’ultimo vantaggio (non da poco) di iniziare la transizione in un corpo non modificato da uno sviluppo puberale di segno opposto rispetto a quello voluto dall’adolescente, permettendo così il raggiungimento di risultati estetici più soddisfacenti. Le prime linee guida in cui si suggerisce l’utilizzo di bloccanti risalgono al 2009,1 modificate qualche anno fa.2 In queste si suggerisce, a seguito di una valutazione caso per caso,

Quei segni di un corpo che da “indeterminato” sta prendendo la direzione diametralmente opposta a quella che si vorrebbe
di iniziare l’utilizzo di bloccanti una volta che si comincino a vedere gli effetti della pubertà se tale utilizzo viene richiesto dalle persone stesse. Non ci soffermeremo oltre sugli aspetti medici della questione. Il nostro è un punto di vista morale, che certamente pone le proprie basi sulla pratica clinica, ma cerca di trovare le giustificazioni etiche di tali prassi, i loro limiti e i loro punti di forza. Fino a qualche anno fa i minori che avessero voluto sospendere la pubertà avrebbero dovuto farlo pagando il farmaco, essendo considerato off label l’uso nelle persone con disforia di genere. Nel 2018 l’Aifa
ha autorizzato l’uso in questi casi. A favore anche il Comitato nazionale per la bioetica, che stranamente con un voto quasi all’unanimità (una sola contraria) ha approvato l’utilizzo dei bloccanti per i minori transgender].3 Il Comitato, che generalmente è percorso da tensioni ideologiche diverse, è riuscito a trovare un larghissimo consenso proprio guardando agli effetti che questo farmaco produce: si tratta di una sospensione, quindi il blocco è solo temporaneo, e riesce a ridurre il rischio suicidario, altissimo in questi casi, oltre che a provocare un diffuso aumento della qualità della vita degli individui coinvolti.

Il dibattito, tra pro e contro Tuttavia periodicamente la questione, che sembrava assodata, torna agli onori della cronaca. L’attacco più recente a questa possibilità offerta ai giovani transgender è quello mosso dalla Società psicoanalitica italiana che, a firma del suo presidente, ha rilasciato un comunicato, inviato al governo, in cui si esprime grande preoccupazione per l’utilizzo degli ormoni bloccanti.
La ragione di questa riluttanza di una parte degli psicanalisti italiani è da ricercarsi nella natura stessa della psicanalisi e della disforia di genere. Per la psicanalisi, in sostanza, il disagio psichico va ricercato nel passato e nel vissuto del soggetto, in qualche trauma, in una relazione disfunzionale o non adeguata, in eventi vissuti che hanno cambiato gli atteggiamenti della persona. Per tradizione chi pratica la psicanalisi cerca di risalire alla causa scatenante del disagio psichico; una volta risolto il problema con la causa scatenante, il disagio scompare. Proprio in questa direzione in un’intervista di un anno fa sul sito della Società psicanalitica italiana si trova la seguente affermazione:
“Risulta che alcuni di questi piccoli (M/F) [si sta parlando di minori transgender], dopo una terapia analitica ben condotta, modificano il desiderio di cambiare sesso e sviluppano una scelta d’oggetto omosessuale”. L’idea che emerge è che la disforia di genere sia in qualche modo patologica: c’è un dolore psichico causato dalla incongruenza tra genere esperito e sesso biologico. Bisogna risalire la catena causale di eventi che ha prodotto questa situazione, eliminando dunque tale incongruenza e facendo accettare alle per-
sone il loro sesso biologico e il genere assegnatogli alla nascita. Ciò porta con sé anche un forte scetticismo per tutti gli interventi chirurgici e farmacologici, che risolvono il disagio non a monte ma a valle e che dunque lasciano il presunto trauma lì dove si trova.
Ora bisogna però dimostrare che la disforia di genere sia causata da un trauma. Al momento, non si conoscono le cause di questa condizione, ma sembra che ci siano coinvolti una serie di fattori, che possono andare da una predisposizione genetica ai livelli ormonali fetali. Bisogna anche dimostrare che la disforia di genere sia (o non sia) una malattia. Definire cosa sia malattia e cosa no, è assai complesso: filosofe e filosofi si stanno arrovellando tra concezioni diverse. C’è chi punta più sulla dimensione biologica, intendendo la malattia (anche mentale) come un danno, sia fisico sia adattivo. Altri invece enfatizzano più l’aspetto soggettivo del dolore e del disagio, altri ancora quello sociale: intendendo la malattia come una condizione che produce un certo status sociale e attiva certi tipi di relazione.
Attiviste e attivisti lgbt+ hanno lottato per il riconoscimento dell’incongruenza di genere/disforia di genere come condizione non patologica, come semplice variante dell’identità di genere umana. Il disagio causato dalla disforia, argomentano, è in larga parte causato dalla società, troppo rigida e non in grado di accogliere le persone trans al suo interno. Cambiando la società, è possibile risolvere o attenuare il disagio provato da queste persone. La medicina, al contempo, è in grado di modificare il loro corpo per renderlo più conforme ai loro desideri. Al di là del pregiudizio anti-farmacologico che accompagna la psicanalisi, l’idea che emerge dalle dichiarazioni di alcuni psicanalisti è che gli interventi medici siano come prendere un farmaco sintomatico. Qui si scontrano appunto le due visioni: chi crede che oltre ai sintomi ci sia di più (un problema profondo) come gli psicanalisti, e chi crede che ci siano solo i sintomi e nulla più, e una volta

Cambiando la società, è possibile risolvere o attenuare il disagio provato da queste persone. La medicina, al contempo, è in grado di modificare il loro corpo per renderlo più conforme ai loro desideri
cambiato il corpo, la disforia sparisca. Se la disforia è solo un problema di riconoscimento sociale, la medicina è l’unica cosa che serve: avremo il corpo che vogliamo e saremo riconosciuti per quello che ci sentiamo. Fine della storia.
Da un punto di vista morale
Arriviamo dunque al punto finale e anche principale, che trascende la polemica creata dal comunicato della Società psicoanalitica italiana: è possibile (almeno moralmente) cambiare il nostro corpo? Stravolgerlo al punto da fargli cambiare i principali tratti sessuali?
Se il corpo è a nostra disposizione sì, se il corpo, o ancora di più il sesso, sono sacri, allora no. Questa è un’antinomia irrisolvibile. Certamente ci sono argomenti a favore di entrambe le posizioni, ma alla fine richiede una “scelta di campo”. Coloro che ritengono che la sessualità e l’identità di genere siano sacre (ossia non a disposizione) o perché dono di Dio e frutto di una sua imperscrutabile deliberazione, o perché fondamento della nostra essenza, credono anche che gli interventi medici di modifica del corpo dovrebbero essere evitati. Chi invece crede che il corpo ci appartenga, che noi siamo gli artefici di noi stessi, e delle nostre identità, non avrà problemi ad accettare tali cambiamenti. In questo caso è possibile che una parte della psicanalisi ritenga che il sesso sia un dato immodificabile, e il fatto che la disforia di genere sia prodotta non da dei tratti biologici ma da degli eventi traumatici, che hanno scatenato in noi tale desiderio, renda illegittimo modificare il corpo. Perché dunque cambiare il corpo, quando basta risolvere la causa che ha prodotto il disagio? Ora il punto è proprio questo: anche se fosse possibile risolvere il trauma, “guarire” dalla disforia di genere, l’intervento di cambiamento corporeo sarebbe comunque consentito: perché io abito il mio corpo e io decido cosa voglio farci e che strada perseguire. Se la disforia (o incongruenza) di genere non è una malattia, non c’è nulla da cui guarire,

niente da risolvere, ed io il corpo lo posso cambiare in modo da adeguarlo a ciò che esperisco dentro di me. Anche se all’interno della psicanalisi le opinioni possono essere diverse, una parte dei suoi esponenti ritiene sbagliato intervenire sul corpo e sul sesso. Dall’altra parte, se invece si ritiene che il corpo sia a nostra disposizione, non si può che vedere di buon occhio quando un individuo prende in mano le redini della propria vita e decide autonomamente su sé stesso. Ma al di là delle singole posizioni, comunque, bisogna ricordarsi, come ha fatto il Comitato nazionale di bioetica, che dietro questi dibattiti ci sono delle persone in carne e ossa, c’è la loro sofferenza e il loro vissuto. Ci sono delle ragazze e dei ragazzi che hanno un aumentato rischio suicidario, e se un trattamento sanitario può aiutarli a vivere meglio la loro esistenza, questo non deve essere ignorato. Anzi deve avere la priorità. y
Bibliografia
1 Hembree WC, Cohen-Kettenis P, Delemarre-van de Waal HA, et al. Endocrine treatment of transsexual persons: an endocrine society clinical practice guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2009; 94: 3132-54.
2 Hembree WC, Cohen-Kettenis PT, Gooren L, et al. Endocrine treatment of gender-dysphoric/gender-incongruent persons: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2017; 102: 3869-903.
3 Centro nazionale per la bioetica. In merito alla richiesta di Aifa sulla eticità dell’uso del farmaco triptorelina per il trattamento di adolescenti con disforia di genere (DG), 13 luglio 2018.
Io abito il mio corpo e decido io cosa voglio farci, e che strada perseguire
dialoga con
Antonino Cattaneo DirettoreLa vita di Antonino Cattaneo, uno dei più importanti neuroscienziati italiani, si divide tra Roma e Pisa. Cattaneo infatti è ordinario di fisiologia alla Scuola Normale di Pisa e presiede l’Istituto europeo di ricerca sul cervello “Rita Levi-Montalcini” (Ebri). Il suo percorso di studi però è iniziato dalla fisica negli anni ‘70. Il suo relatore di tesi fu Mario Ageno, uno dei ragazzi di via Panisperna, sotto la cui direzione Cattaneo si è laureato in biofisica. In seguito, è stato uno dei collaboratori più stretti proprio di Rita Levi-Montalcini, la fondatrice dell’Ebri che oggi Cattaneo presiede.
Le ricerche di Cattaneo vertono sulla sindrome di alzheimer, una malattia neuro-degenerativa che, secondo le stime, colpisce circa 600mila italiane e italiani. A questa malattia Cattaneo ha consacrato

decine di studi. Ma anche lui ammette che i progressi per la ricerca di una cura sono stati molto deludenti finora, nonostante i grandi investimenti dedicati sia dalla ricerca pubblica che dalle società farmaceutiche negli ultimi anni.
Professor Cattaneo, perché è così difficile curare la sindrome di alzheimer?
Per prima cosa, è una malattia difficile da individuare. Anche se attraverso la ricerca conosciamo la fisiologia della memoria e i meccanismi della neurodegenerazione molto meglio di un tempo, ancora oggi la malattia viene diagnosticata a partire da test neuropsicologici che rilevano il declino cognitivo del paziente. E quando il declino è già iniziato, i danni al cervello provocati dalla malattia sono già troppo estesi per essere curati efficacemente. Avere dei marker biologici per identificare la malattia nelle prime fasi sarebbe un grande passo avanti per la ricerca di una terapia efficace. Importanti passi avanti sul fronte dei biomarcatori si stanno facendo anche all’Ebri, ad esempio per identificare le fasi precoci della malattia con esami oculari della retina.
Sappiamo cosa provoca la malattia?
Già Alois Alzheimer, lo scopritore della malattia, osservò la formazione di placche e fibrille di natura proteica nel cervello dei pazienti. Le placche sono costituite da una proteina detta precursore della beta-amiloide e, grazie allo studio di forme genetiche della malattia, sappiamo con buona
certezza che la beta-amiloide e il peptide beta-amiloide (Ab) da essa derivato, è coinvolto nella insorgenza e nello sviluppo della malattia. Questo ha dato un forte impulso alla cosiddetta ipotesi dell’amiloide, sulla quale è stata basata la maggior parte degli studi clinici negli ultimi venti anni. Ma l’osservazione diretta delle placche non aiuta la diagnosi, perché si può fare solo dopo la morte o, comunque non allo stadio sufficientemente precoce della progressione della malattia.
Eppure, negli scorsi mesi l’ipotesi delle placche amiloidi è stata seriamente messa in discussione. Un’inchiesta della rivista Science ha gettato molte ombre sulla correttezza del lavoro di Sylvain Lesné, uno dei pionieri di questa ipotesi sull’origine della malattia di alzheimer. Molti scienziati pensano che i suoi primi studi siano stati manipolati.
È possibile che vi siano stati alcuni studi manipolati, però non bisogna avere una visione troppo ingenua della comunità scientifica: le evidenze pubblicate da Lesné non sono certo le uniche disponibili a supporto della ipotesi dell’amiloide. Nel tempo si sono raccolte numerosissime prove indipendenti che suggeriscono che il peptide Ab e sue forme di associazione in piccoli aggregati detti oligomeri svolgano un ruolo cruciale nello sviluppo della malattia. Esistono forme ereditaria della malattia, che si manifesta in età giovanile, in genere prima dei 60 anni di età. La ricerca ha individuato diverse mutazioni genetiche ad esse associate e sappiamo che colpiscono geni che determinano proprio la sintesi aberrante del peptide Ab: questo rafforza decisamente l’ipotesi che specifiche forme del peptide Ab siano connesse allo sviluppo della malattia. Il meccanismo causale tra gli oligomeri di Ab, le placche di Ab fibrillare e la malattia però non è ancora del tutto chiaro. Ci sono pazienti che presentano le placche ma non i sintomi, e viceversa. Anche un’altra proteina detta tau sembra avere un ruolo chiave nella degenerazione dei neuroni. Si
Per prima cosa, l’alzheimer
è una malattia difficile da individuare
tratta di una normale proteina neuronale che regola i microtubuli, quella rete di trasporto interna alla cellula lungo cui si muovono molte sostanze importanti come le vescicole che portano i segnali alle sinapsi. Nei malati, la proteina tau va incontro a una “fosforilazione paradossa” che la porta a staccarsi dai microtubuli e a raggiungere una concentrazione critica al di sopra della quale forma degli aggregati intracellulari. Si favorisce così la formazione di neurofibrille, cioè accumuli di proteine tau che portano alla morte del neurone.
Da anni le società farmaceutiche lavorano senza grande successo alla ricerca di un farmaco che blocchi la degenerazione. È vero. All’inizio degli anni Duemila sembrava vicino lo sviluppo di un “vaccino” contro l’alzheimer, basato sulla idea che le fibrille di Ab che formano le placche di amiloide possano essere considerate alla stregua di un corpo estraneo. L’idea era di esporre il sistema immunitario alle proteine dannose in modo che esso sviluppasse gli anticorpi. Il problema è che la risposta immunitaria del cervello è difficile da controllare. L’infiammazione dovuta alla risposta immunitaria ha provocato l’insorgenza di meningoencefaliti nel 6 per cento dei partecipanti alla sperimentazione, spesso con conseguenze neurologiche gravi. Questo pesante effetto collaterale ha fatto fermare la sperimentazione del vaccino nel 2002.
Negli ultimi mesi, però, due farmaci basati su anticorpi anti Ab hanno ottenuto l’autorizzazione alla messa in commercio da parte dell’autorità regolatoria statunitense, la Food and drug administration, ma non di quella europea almeno finora. Si tratta di farmaci efficaci?
Si tratta di due anticorpi, l’aducanumab e il lecanemab. Si legano alla proteina beta-amiloide e puntano a impedire che la proteina si associ ad altre proteine e formi fibrille e placche. A differenza del vaccino, in questi casi si parla di immunizzazione passiva, perché gli anticorpi vengono somministrati dall’esterno e non sono prodotti dal sistema immunitario dell’organismo. Il primo, l’aducanumab, è stato approvato nel 2021 tra molte polemiche, perché i dati sull’efficacia sarebbero molto labili: il farmaco ha dimostrato la capacità di rimuovere le placche ma non ha dimostrato un effetto sul piano cognitivo. Nel 2022 è stato autorizzato il secondo anticorpo, il lecanemab. Per la prima volta il farmaco mostrerebbe un effetto, anche se limitato, sul declino cognitivo. Nemmeno questo però può considerarsi una cura per l’alzheimer, perché la malattia avanza anche nei pazienti che lo assumono, sebbene a un ritmo più lento. Entrambi questi anticorpi hanno mostrato effetti collaterali piuttosto gravi sul cervello, come le emorragie cerebrali.
Qual è il motivo dell’efficacia limitata o assente di questi farmaci?
Le fibrille e le placche di Ab sono precedute da “precursori”, gli oligomeri composti da un piccolo numero di peptidi Ab. Sono questi precursori a causare il danno ai neuroni e le caratteristiche placche si for-
L’idea era di esporre il sistema immunitario alle proteine dannose in modo che esso sviluppasse gli anticorpi. Il problema è che la risposta immunitaria del cervello è difficile da controllare
mano quando il danno è ormai già avvenuto. L’aducanumab però non distingue tra le placche e gli oligomeri e si lega a entrambi con la stessa affinità. Dato che le placche assorbono una quantità molto maggiore dell’anticorpo, la capacità dell’aducanumab di legarsi agli oligomeri e impedirne la attività tossica ne risulta molto diminuita.
Il lecanemab invece mostra una maggiore affinità per alcune forme intermedie di oligomeri, dette “proto-fibrille”, rispetto alle fibrille e alle placche. Perciò, l’anticorpo potrebbe davvero ostacolare la formazione e l’azione degli oligomeri meno visibili e più dannosi. Questa potrebbe essere la spiegazione del suo maggiore impatto sul declino cognitivo, ma ulteriori studi sono necessari.
Però non è ancora sufficiente a fermare la malattia.
C’è un altro problema da considerare, oltre alla scarsa affinità e specificità degli anticorpi verso gli oligomeri di Ab. Tutti gli anticorpi monoclonali fino ad oggi sperimentati si legano alla proteina ma intervengono all’esterno della cellula, nonostante il primo effetto dannoso delle proteine avvenga all’interno delle cellule neuronali. Finora però ha prevalso l’approccio extra-cellulare, ed è comprensibile perché un anticorpo monoclonale non è in grado di intervenire all’interno del neurone. Così è nata una narrazione della patologia secondo cui al di fuori delle cellule le proteine aberranti inducono l’aberrazione in altre proteine, e questo sarebbe il meccanismo alla base della degenerazione. È un meccanismo reale, ed è tipico dei prioni. Questa spiegazione prevalente non tiene in dovuta considerazione l’effetto intracellulare dell’alzheimer, però è utile per accreditare l’approccio scelto finora dalle società farmaceutiche che fanno ricerca sullo sviluppo clinico di terapie per l’alzheimer.
Lo stesso problema si ha con molti studi clinici recenti, basati sull’uso di anticorpi monoclonali diretti contro la proteina tau,
che è una proteina tipicamente intracellulare, e questo potrebbe spiegare i risultati insoddisfacenti che anche questi studi clinici stanno mostrando. Se si riuscisse a far legare gli anticorpi agli oligomeri di Ab (o alla proteina tau) dentro la cellula, dove esse fanno i primi danni, questi anticorpi resi intracellulari potrebbero essere molto più efficaci. È la linea di ricerca a cui stiamo lavorando noi all’Ebri.
In che modo si può intervenire sulle proteine amiloidi dentro le cellule?
La nostra idea è di inviare nei neuroni l’informazione genetica affinché sia la cellula stessa a sintetizzare gli anticorpi che servono, indirizzandoli esattamente dove il primo danno da parte degli oligomeri di Ab viene fatto. Cioè, vogliamo trasportare all’interno dei neuroni il dna che codifica per l’anticorpo che si lega agli oligomeri della proteina Ab. Come “veicolo” ci sono più possibilità. Si può mettere a punto una nano-particella in grado di attraversare la cosiddetta “barriera ematoencefalica” che protegge il cervello dalle sostanze in circolazione nel sangue.

Oppure si può utilizzare un lentivirus, un genere di virus innocuo in grado di infettare i neuroni trasportando al loro interno la sequenza di dna che codifica per il gene terapeutico. Il settore dei vettori virali per il sistema cerebrale è un filone di ricerca in grandissimo sviluppo e in Italia abbiamo alcuni tra i massimi esperti mondiali in questo campo, come Luigi Naldini dell’Istituto Telethon del San Raffaele di Milano. Stiamo lavorando verso una terapia genica contro le malattie neuro-degenerative, dove i geni terapeutici sono anticorpi con una specificità molecolare sempre maggiore e con una precisione di indirizzamento in quelle parti della cellula nervosa dove le proteine patologiche si formano e danneggiano il neurone stesso. Un approccio in cui coniughiamo la precisione molecolare con la precisione subcellulare.
La ricerca di un anticorpo è l’unica strada che state seguendo?

No, qui all’Ebri lavoriamo anche a un altro approccio basato sul fattore di crescita nervoso (Ngf), la proteina scoperta da Rita Levi-Montalcini negli anni ‘50 per la cui scoperta le è stato conferito il premio Nobel. È noto che l’Ngf è un fattore protettivo dei neuroni colinergici, una famiglia di neuroni che è coinvolta dalla malattia di alzheimer. Ma nel cervello di un paziente affetto da alzheimer gli oligomeri di Ab e i grovigli neurofibrillari di tau sono presenti anche in altri neuroni sui quali Ngf non potrebbe agire direttamente. Su queste popolazioni neuronali coinvolte dalla malattia tale effetto neuro-protettivo dell’Ngf non c’è. Però negli ultimi anni abbiamo scoperto che l’Ngf ha recettori sulle cellule della microglia,
un’altra famiglia di cellule del cervello con compiti immunitari, ed è in grado di trasformarle da cellule immunitarie a neuroprotettive. In questo modo Ngf induce la microglia a proteggere e rafforzare i neuroni sofferenti a causa della neuro-degenerazione, senza causare infiammazioni. Il problema è che raggiungere il cervello è difficile, sempre a causa della barriera ematoencefalica, e la somministrazione di Ngf ad alto dosaggio normalmente provoca dolore. Per fortuna, abbiamo messo a punto una forma mutante di Ngf che abbassa notevolmente il dolore. Questo ci permette di somministrare dosi più elevate per via intranasale.
Per quanto riguarda gli anticorpi, siamo ancora in fase preclinica, cioè non sono ancora iniziate sperimentazioni sull’essere umano. Per l’Ngf mutante invece è iniziato un trial di fase 1/2 al Policlinico Gemelli di Roma, in cui sarà valutata sia la tollerabilità del farmaco che la sua efficacia contro una malattia diversa dall’alzheimer come il glioma pediatrico del nervo ottico, un tumore delle vie ottiche poco frequente. y
Andrea Capocci | @andcapocciFisico, insegnante e giornalista, Andrea Capocci ha pubblicato i libri Networkology (Il Saggiatore, 2011) e Il brevetto (Ediesse, 2012). Scrive di argomenti scientifici per il quotidiano il manifesto.
All’Ebri lavoriamo anche a un altro approccio basato sul fattore di crescita nervoso, la proteina scoperta da Rita Levi-Montalcini

Nicola Vanacore Responsabile Osservatorio demenze Iss Centro nazionale per la prevenzione e la promozione delle malattie Istituto superiore di sanità
La premessa
In queste settimane l’Ema, l’autorità regolatoria europea per i medicinali, sta valutando l’autorizzazione all’immissione in commercio del lecanemab, un anticorpo monoclonale anti-amiloide, studiato e sviluppato per le forme precoci della demenza di tipo alzheimer (AD). Il farmaco dovrebbe avere la caratteristica di modificare sostanzialmente la storia naturale della malattia. Si ipotizza che la rimozione delle placche amiloidee dal cervello delle persone con un lieve deficit cognitivo riconducibile all’alzheimer (mild cognitive impairment due to AD –MCI due to AD) possa costituire il “primum movens” per determinare un’alterazione consistente della traiettoria della malattia. La Fda approva con procedura accelerata il lecanemab con l’indicazione per la demenza di alzheimer.1 Il 7 luglio del 2021 la Food and drug administration
(Fda) statunitense approva in maniera condizionata l’aducanumab, il primo anticorpo monoclonale anti-amiloide ad entrare in commercio per l’alzheimer.2
L’Ema, il 20 aprile 2022, nega l’approvazione al commercio dell’aducanumab per il mercato europeo.3
I farmaci attualmente in uso per il trattamento del deficit cognitivo in persone con malattia di alzheimer sono gli inibitori delle colinesterasi (donepezil, rivastigmina, galantamina) e la memantina. La prescrizione è regolata dalla nota 85 dell’Aifa, recentemente aggiornata, ed è in carico ai medici specialisti dei centri per i disturbi cognitivi e demenza. Questi farmaci, immessi in commercio alla fine degli anni ‘90, nell’ambito del progetto Cronos, hanno rappresentato la prima opportunità terapeutica per il controllo sintomatico del decadimento cognitivo in questa disabilitante e tre-
menda malattia neurodegenerativa. Negli anni 2018-2020 la prevalenza d’uso di questi farmaci è compresa tra 1,28 e 1,36 per cento.4
Un punto di vista di sanità pubblica
L’insieme delle evidenze disponibili sul lecanemab e aducanumab (vedi box a pag. 30 e 31) consente di approfondire quattro tematiche utili per riflettere sul significato in termini di sanità pubblica di queste nuove prospettive terapeutiche farmacologiche nella demenza di alzheimer.
Le tematiche sono le seguenti:
1. la validazione di un end-point surrogato come le placche amiloidee,

2. la differenza tra statisticamente significativo e clinicamente rilevante,
3. la sicurezza del farmaco
4. la validità esterna rispetto alla scheda tecnica del farmaco.
In Italia, si stimano circa 600.000 persone con malattia di alzheimer, mentre è impossibile stimare a livello di popolazione generale la frequenza di “MCI due to AD”. 5 Questa condizione implica la presenza di un deficit cognitivo lieve e la contemporanea positività a una serie di biomarcatori suggestivi di un meccanismo fisiopatologico riconducibile alla malattia. Le persone con “MCI due to AD” hanno un’elevata probabilità di convertire a demenza di alzheimer stimata in circa il 15-45 per cento nei tre anni successivi alla diagnosi. 6 La diagnosi di “MCI due AD” viene definita oggi come “research criteria” e non ha quindi un valore nella pratica clinica corrente, ma è considerata nei servizi più specialistici come una diagnosi precoce di malattia di alzheimer. In Italia si stimano circa 900.000 persone con deterioramento cognitivo lieve e un sottogruppo con “MCI due to AD” deve ancora essere definito. 7
Validazione di un end-point surrogato come le placche amiloidee. Le sperimentazioni cliniche documentano senza dubbio una netta riduzione delle placche amiloidee nei pazienti esposti al lecanemab e aducanumab. Nel primo caso l’osservazione deriva da un end-point secondario del trial 8 nel secondo da un’analisi per sottogruppi.9 Il punto cruciale è capire se questa importante riduzione sia associata o meno a un effetto clinico rilevante e in che tempi. La Fda approva l’aducanumab in modo condizionato alla produzione di nuove evidenze scientifiche di tipo clinico (“Sebbene i dati relativi ad Aduhelm siano complessi per quanto riguarda i suoi benefici clinici, la Fda ha stabilito che si hanno evidenze forti che Aduhelm riduca l’accumulo di placche formate dalla proteina beta nel cervello e che sia ragionevole prevedere importanti benefici per i pazienti. Grazie all’approvazione di Aduhelm da parte della Fda, i pazienti affetti dalla malattia di alzheimer hanno a disposizione un nuovo e importante trattamento per combattere questa patologia. L’Fda continuerà a monitorare Aduhelm quando farà il suo ingresso nel mercato e, in ultima analisi, sarà usato nei pazienti. Inoltre, l’Fda richiede a Biogen di condurre uno studio clinico post-approvazione per verificare il beneficio clinico del farmaco. Se il farmaco non dovesse funzionare come previsto, possiamo prendere provvedimenti per rimuoverlo dal mercato”). 2
Il lecanemab viene approvato dalla Fda con procedura accelerata considerando che “i pazienti che hanno ricevuto il trattamento hanno avuto una significativa riduzione della placca beta amiloide dosee tempo-dipendente; i pazienti che hanno ricevuto la dose approvata di lecanemab, 10 milligrammi/chilogrammo ogni due settimane, hanno avuto una riduzione statisticamente significativa della placca amiloide cerebrale dal basale alla 79esima settimana rispetto al gruppo trattato con il placebo, che non ha avuto alcuna riduzione della placca beta amiloide”.1 Nella comunità scientifica la discussione di co-
me possa essere validato un end-point surrogato nella demenza di tipo alzheimer ha coinvolto numerosi ricercatori ma non è stato ancora raggiunto un consenso.10
La differenza tra statisticamente significativo e clinicamente rilevante. La maggior parte delle scale cliniche utilizzate nei trial del lecanemab e aducanumab dispongono di una letteratura che considera il delta di un punteggio come clinicamente rilevante. In particolare per il clinical dementia rating (Cdr - scala numerica utilizzata per quantificare la gravità di una demenza) si stima che 0,98 punti di variazione siano clinicamente rilevanti nel decadimento cognitivo lieve e 1,63 nella demenza di Alzheimer lieve, per mini-mental state esamination (Mmse, test di valutazione per la gravità delle demenze) i valori sono rispettivamente di 1,26 e 2,32,11 infine per l’Alzheimer’s disease composite score (Adcoms) una variazione di 0,05 per il declino cognitivo lieve e 0,10 per la demenza

Nella comunità scientifica non è stato ancora raggiunto un consenso su come possa essere validato un end-point surrogato nella demenza di tipo alzheimer
di alzheimer sono ritenuti clinicamente rilevante.12 Questo tema ha un grande rilevanza per la pratica clinica in quanto consente di valutare a livello di individuo la possibile efficacia del farmaco. Si nota come per le due molecole approvate per il trattamento del’alzheimer aver eseguito le sperimentazioni con popolazioni clinicamente miste (MCI due to AD e demenza di alzheimer lieve) rende questa estrapolazione ancora più complessa considerando i valori pubblicati e precedentemente riportati. Infine sarebbe auspicabile, considerando la grande complessità fenotipica delle patologie neurodegenerative, che i risultati delle sperimentazioni cliniche fossero sempre accompagnati da un’a-

Le cosiddette Aria sono delle anormalità al livello cerebrale che si osservano alla risonanza magnetica. I fenomeni Aria sono classificabili come Aria-E e Aria-H. Gli Aria-E (edema or sulcal effusion) consistono in un edema cerebrale che vede la rottura delle giunzioni endoteliali della barriera ematoencefalica determinando uno “sversamento” di liquidi. L’effetto degli Aria-E dipende dalla gravità e dalla localizzazione dell’edema. I sintomi possono includere cefalea, cambiamenti nello stato mentale, confusione, vomito, nausea, tremore e disturbi dell’andatura. Gli Aria-H vedono la presenza di microemorragie a livello cerebrale, spesso con presenza di depositi di emosiderina (accumulo di ferro).
nalisi per responder che è l’unica vera analisi di interesse clinico basata sul costrutto della minimal clinically important difference.
La sicurezza del farmaco. Uno degli effetti noti degli anticorpi monoclonali anti-Ab sono le anomalie di imaging legate all’amiloide, dette anche Aria (amyloid-related imaging abnormalities), che sono state rilevate alla risonanza magnetica nei pazienti trattati con il farmaco sperimentale. Questi fenomeni richiedono un approfondimento di epidemiologia clinica per la determinazione del profilo rischio-beneficio. Non solo è importante caratterizzare quelli sintomatici da quelli asintomatici e quelli reversibili da quelli irreversibili, ma sarebbe anche rilevante comprendere se vi siano conseguenze a medio e lungo termine per coloro che hanno presentato queste alterazioni alla risonanza magnetica cerebrale. Nella comunità scientifica la discussione riguarda sia la caratterizzazione di queste anomalie nella traiettoria dei pazienti sia la valutazione in termini di sicurezza immediata.13,14 È interessante segnalare una recente revisione sistematica che evidenzia il potenziale impatto a lungo termine delle terapie anti-amiloide sulla salute del cervello accelerando l’atrofia cerebrale e fornendo quindi nuove informazioni sul possibile impatto negativo dei fenomeni Aria.15
Validità esterna rispetto alla scheda tecnica del farmaco. I trial sul lecanemab e aducanumab sono stati condotti su popolazioni clinicamente miste e questo rende complicato riflettere in termini di validità esterna, di come cioè estendere le informazioni cliniche ai pazienti del mondo reale. Curiosamente poi, entrambi i farmaci hanno l’indicazione per la demenza di alzheimer, una popolazione che non è stata studiata complessivamente nei trial, e successivamente nella scheda tecnica viene specificato che “il trattamento con Aduhelm dovrebbe essere iniziato in pazienti con decadimento cognitivo lieve o con demenza lieve agli stadi iniziale di
Cosa dicono le evidenze su lecanemab
Lo studio di fase III del lecanemab è stato condotto per una durata di 18 mesi su 1795 pazienti, 859 trattati con il lecanemab e 875 con il placebo. I pazienti avevano un’età compresa tra i 50 e i 90 anni ed erano positivi per l’amiloide alla PET o al dosaggio nel liquor; per il 52% nel braccio del lecanemab e per il 53,5% nel placebo assumevano contemporaneamente farmaci anti-demenza. I pazienti avevano una diagnosi di demenza di alzheimer lieve nel 38,5% dei trattati con lecanemab e nel 37.8% di quelli trattati con il placebo, e di “MCI due to AD” nel 61,5 % dei trattati e nel 62,2% dei controlli. L’end point primario dello studio mostrava una riduzione statisticamente significativa (p<0.001) nel gruppo del lecanemab rispetto al placebo di -0.45 punti alla scala (CDR – SB). 8 Questa scala ha un range di valori compreso tra 0 e 18 e misura sei domini di tipo cognitivo funzionale e socio-relazionale. Lo studio presenta inoltre per quattro end point secondari, una riduzione statisticamente significativa del carico amiloideo valutato alla PET per i pazienti trattati con lecanemab rispetto al placebo (-59,12 ; p>0,001), delle funzioni cognitive valutate all’ADAS cog 14 (-1,44 punti, p>0,001), di un composito score delle funzioni cognitive utilizzando l’Alzheimer’s Disease Composite Score (ADCOMS)(-0,050; p<0,001) e delle attività funzionali valutate con l’Alzheimer’s Disease Cooperative Study–Activities of Daily Living Scale for Mild Cognitive Impairment (ADCSMCI-ADL)(+2,0; p<0,001) nei confronti tra i trattati con il farmaco e il placebo. 8 Il punteggio dell’ADAS-cog 14 è compreso tra 0 e 90, quello della ADCOMS tra 0 e 1,97 e del ADCS-MCI-ADL tra 0 e 53. I punteggi in aumento dell’ADAS-cog e dell’ADCOMS indicano un peggioramento mentre quelli dell’ADCS-MCI-ADL un miglioramento. Per quanto riguarda il profilo della sicurezza del trial si evidenzia la problematica delle cosiddette “amyloid-related imaging abnormalities” (Aria). Gli ARIA-E sono stati rilevati nel 12.6% dei pazienti trattati con lecanemab e nell’1,7% di quelli trattati con placebo, gli ARIA-H invece nel 14% dei trattati e nel 7,7% dei controlli.
Fonte
van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, et al. Lecanemab in early Alzheimer’s disease. N Engl J Med. 2023; 388: 9-21.
malattia, la popolazione in cui il trattamento è stato iniziato negli studi clinici”.16 La stessa indicazione è presente anche nella scheda tecnica del lecanemab. Questa ambiguità regolatoria nella definizione delle indicazioni implica che tecnicamente un farmaco studiato sul MCI due to AD e sulla demenza di alzheimer lieve potrebbe essere utilizzato inizialmente anche nella forma moderata di demenza di alzheimer.
Conclusioni
Il primo trial sull’uso degli anticorpi monoclonali nel deterioramento cognitivo lieve o nella demenza di alzheimer risale al 2005 e da quel momento 101 sperimentazioni cliniche sono state condotte su 18.000 pazienti con diagnosi di deterioramento cognitivo lieve o demenza di alzheimer.16 Cinquantuno di questi trial non sono stati pubblicati su riviste peer-review privando la comunità scientifica di conoscere dati rilevanti per capire se questa strada dell’amiloide può produrre effetti terapeutici importanti.16 Il 3 maggio del 2023 la Eli Lilly ha annunciato che il donanemab, un nuovo anticorpo monoclonale anti-amiloide, è stato sperimentato in un trial di fase III su 1736 pazienti con deterioramento cognitivo lieve o demenza di alzheimer lieve con risultati rilevanti nel rallentare il declino cognitivo e funzionale della malattia.17 Il report scientifico non è ancora disponibile su una rivista scientifica peer-review. In conclusione il contesto generale è abbastanza incerto e rispecchia la complessità fisiopatologica della demenza di alzheimer nonostante i rilevanti progressi degli ultimi decenni.18 Da un lato la Fda assume decisioni sull’immissione in commercio di farmaci potenzialmente utili per le persone con alzheimer e dall’altro la comunità scientifica discute se questa strada terapeutica è in linea con le attese di un farmaco “disease modifying”, o se invece bisogna indirizzarsi verso nuove prospettive di ricerca per la conoscenza dei meccanismi alla base dell’insorgenza del decadimento cognitivo.19 y
Questa strada terapeutica è in linea con le attese di un farmaco “disease modifying” o bisogna indirizzarsi verso nuove prospettive di ricerca per la conoscenza dei meccanismi alla base dell’insorgenza del decadimento cognitivo?
1 Food and drug administration. Fda grants accelerated approval for alzheimer’s disease treatment. Fda.gov 6 gennaio 2023.
2 Patrizia Cavazzoni P. Fda’s decision to approve new treatment for alzheimer’s disease. Fda.gov 6 luglio 2023.
3 Aduhelm: Withdrawal of the marketing authorisation application | www.ema.europa.eu/ en/medicines/human/withdrawn-applications/ aduhelm
4 Ippoliti I, Ancidoni A, Da Cas R, et al. Antidementia drugs: a descriptive study of the prescription pattern in Italy. Neurol Sci 2023; 44: 1587-95.
5 Bacigalupo I, Mayer F, Lacorte E, et al. A Systematic review and meta-analysis on the prevalence of dementia in Europe: estimates from the highest-quality studies adopting the DSM IV diagnostic criteria. J Alzheimers Dis 2018; 66: 1471-81.
6 Dunne RA, Aarsland D, O’Brien JT, et al. Mild cognitive impairment: the Manchester consensus. Age Ageing 2021; 50: 72-80.
7 Sachdev PS, Lipnicki DM, Kochan NA, et al. Cohort studies of memory in an international consortium (Cosmic). the prevalence of mild cognitive impairment in diverse geographical and ethnocultural regions: the Xosmic collaboration. PLoS One 2015; 10: e0142388.
8 van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, et al. Lecanemab in early alzheimer’s disease. N Engl J Med 2023; 388: 9-21.
9 Budd Haeberlein S, Aisen PS, Barkhof F, et al. Two Randomized phase 3 studies of aducanumab in early alzheimer’s disease. J Prev Alzheimers Dis 2022; 9: 197-210.
10 Planche V, Villain N. US Food and drug administration approval of aducanumab- is amyloid load a valid surrogate end point for alzheimer disease clinical trials? JAMA Neurol 2021; 78: 1307-8.
11 Liu KY, Schneider LS, Howard R. The need to show minimum clinically important differences in alzheimer’s disease trials. Lancet Psychiatry 2021; 8: 1013-6.
12 Tahami Monfared AA, Lenderking WR, Savva Y, et al; Alzheimer’s disease neuroimaging initiative. Assessing the clinical meaningfulness of the alzheimer’s disease composite score (Adcoms) Tool Neurol Ther 2022; 1: 1085-100.
13 Castellani RJ, Shanes E, McCord M, et al. Neuropathology of anti-amyloid-β immunotherapy: a case report. J Alzheimers Dis 2023; 93: 803-13.
14 Piller C. Scientists tie third clinical trial death to experimental alzheimer’s drug. Science, 21 dicembre 2022.
15 Alves F, Kalinowski P, Ayton S. Accelerated brain volume loss caused by anti-β-amyloid drugs: A Systematic review and meta-analysis. Neurology 2023; 100: e2114-24.
16 Lacorte E, Ancidoni A, Zaccaria V, et al. Safety and efficacy of monoclonal antibodies for alzheimer’s disease: a systematic review and meta-analysis of published and unpublished clinical trials. J Alzheimers Dis 2022; 87: 101-29.
Sono stati condotti due studi di fase III per l’aducanumab, EMERGE e ENGAGE. Il primo condotto su 1638 pazienti ed il secondo su 1647 con un’età compresa tra 50 e 85 anni randomizzati a un basso dosaggio, alto dosaggio o placebo per una durata di 78 settimane. Complessivamente il 55,2% (n=1812) dei pazienti hanno completato gli studi in quanto i due trial EMERGE e ENGAGE sono stati interrotti in base a un’analisi di futilità condotta sui primi 50% dei pazienti arruolati. I pazienti inclusi nel trial EMERGE e ENGAGE erano per circa l’80% affetti da MCI due AD e per il rimanente 20% da lieve demenza di alzheimer e presentavano una conferma ai biomarcatori per la presenza dell’amiloide. L’end point principale degli studi mostra una riduzione statisticamente significativa alla scala CDR-SB solo per il confronto tra l’alto dosaggio vs il placebo nel trial EMERGE (-0,39; p=0,012) ma non per quello ENGAGE (+0,03; p= 0,833). I trial presentavano tre end-point secondari (MMSE, ADAS-cog 13 item e l’ADCS-MCI-ADL). Solo nello studio EMERGE questi tre end-point sono statisticamente significativi nell’alto dosaggio rispetto al placebo (-0.06, p=0.049 per il MMSE; -1,40, p = 0,010 per l’ADAS-cog 13 item; +1,7, p<0,001 per l’ADCS-MCI-ADL). 9 I confronti nei due trial tra il braccio dei trattati e il placebo per il basso dosaggio sono statisticamente non significativi sia per l’end point primario che per i tre end-point secondari. La PET amiloidea è stata valutata rispettivamente in 488 e 585 pazienti dei trial EMERGE e ENGAGE. Alla 78 settimana la differenza nel cambiamento medio aggiustato dal basale tra aducanumab ad alte dosi e il placebo era -0,278 (p<0,0001) per EMERGE e -0,232 (p<,0001) per ENGAGE. Dopo 78 settimane, il 48% dei pazienti di EMERGE e Il 31% dei pazienti di ENGAGE trattati con dosi elevate di aducanumab presentava un punteggio composito alla PET di ≤1,10, una soglia proposta che dovrebbe distinguere pazienti beta-amiloidi negativi da quelli positivi. Per quanto riguarda il profilo della sicurezza dei due trial si documenta che i fenomeni ARIA-E erano presenti nel 2%, 26% e 35% dei pazienti trattati con placebo, bassa ed alta dose nel trial EMERGE e nel 3 %, 26% e 36% rispettivamente dei pazienti inclusi nel trial ENGAGE. I fenomeni ARIA-H invece nel 7%, 16% e 20% dei pazienti trattati con placebo, bassa ed alta dose nel trial EMERGE e nel 6%, 16% e 19% rispettivamente dei pazienti inclusi nel trial ENGAGE.
Fonte
Budd Haeberlein S, Aisen PS, Barkhof F, et al. Two randomized phase 3 studies of aducanumab in early Alzheimer’s disease. J Prev Alzheimers Dis 2022; 9: 197-210.
17 Lilly’s donanemab significantly slowed cognitive and functional decline in phase 3 study of early alzheimer’s disease. Investor.lilly. com, 3 maggio 2023.
18 Scheltens P, De Strooper B, Kivipelto M, et al. Alzheimer’s disease. Lancet 2021; 397: 1577-90.
19 Kepp KP, Robakis NK, Høilund-Carlsen PF, et al. The amyloid cascade hypothesis: an updated critical review. Brain 2023: awad159.

Nel suo ultimo libro, Le Rose di Orwell, Rebecca Solnit riflette sul famoso slogan “Vogliamo il pane e anche le rose” nato agli inizi del Novecento durante le prime campagne femministe che chiedevano il diritto di voto e maggiori tutele lavorative per tutti e tutte. Secondo la giornalista e scrittrice americana il senso dello slogan risiedeva nella metafora per cui: “Il pane nutriva il corpo, le rose nutrivano qualcosa di più sottile: non solo i cuori, ma anche l’immaginazione, la psiche, i sensi, le identità”. A chi manifestava non bastava poter lavorare per sopravvivere, chiedevano che il benessere e la felicità fossero riconosciuti come diritti: “Le rose in queste dichiarazioni stavano a significare che gli esseri umani sono complessi, che i desideri non sono riducibili e che ciò che ci sostiene è spesso sottile e sfuggente”.
A partire da questo stesso slogan, “il pane e le rose”, Victor Montori e Iona Heath condividono sul BMJ1 le loro riflessioni sul mondo dell’assistenza sanitaria dove il bisogno di pane e di rose è ancora presente e ancora va chiesto sia da chi cura sia da chi
pane e le rose” ?
Per rispondere alla crisi assistenziale
Il punto di vista di Iona Heath e Victor Montori
L’attenzione al pane fa sì che l’assistenza sanitaria mantenga il potenziale di attenzione all’oggetto della cura
è curato. Perché – scrivono – “il pane è il sostentamento e quindi la vita; le rose sono il coraggio e la speranza, la curiosità e la gioia, e tutto ciò che rende una vita degna di essere vissuta. Il pane è biologia; le rose sono biografia. Il pane è transazionale e tecnocratico; le rose sono relazionali. Il pane è scienza; le rose sono cura, gentilezza e amore”.

Victor Montori, ricercatore e diabetologo alla Mayo clinic, è promotore del movimento “patient revolution” (www.patientrevolution.org) che si ribella all’assistenza sanitaria “industrializzata” e ne pretende invece una attenta e premurosa nei confronti del singolo paziente. Iona Heath, medico di medicina generale di lunga esperienza, ha ricoperto la carica di presidente della Royal college of general practitioners e ha presieduto il Comitato etico di The BMJ. Dal loro punto di vista, esistono due possibili risposte all’attuale crisi assistenziale che i sistemi sanitari di tutto il mondo stanno affrontando.
La prima suppone che si tratti solo di problemi di organizzazione, efficienza, informazione e tecnologie. In questa prospettiva, le persone sono viste come macchine da controllare e monitorare per prevenire malattie e sofferenze. Tale approccio non porta che all’aumento del coinvolgimento delle grandi aziende del settore sanitario spingendo al consumo di prodotti farmaceutici e di tecnologie mediche, a discapito del pianeta e delle conseguenze per l’ambiente.
Invece la seconda risposta presuppone che la crisi sia dovuta alla mancanza di cura stessa. Per superare la crisi contemporanea bisogna recuperare il significato profondo del prendersi cura riconoscendo che “la cura avviene nello spazio tra le persone, in un incontro senza fretta. Solo quando gli esseri umani interagiscono possono curarsi. È in questa interazione che notiamo un problema nell’altro e cerchiamo di rispondere alla sua situazione per migliorarla. Nell’assistenza sanitaria il notare va oltre il dato biologico per apprezzare quello biografico, nella piena consapevolezza
che i corpi non sono macchine e che le emozioni, sia positive che negative, esercitano una potente influenza su ogni aspetto della salute. Il notare va oltre ciò che rende possibile la vita per considerare ciò che la rende significativa. Curare non significa solo seguire le linee guida basate sulle evidenze per migliorare gli indicatori di salute della popolazione”.
Coltivare la cura
La forza di una simile visione risiede proprio nel suo essere umana e quindi “immersa in un’incertezza radicale, ma resistente alle delusioni ricorrenti grazie alle strette relazioni personali all’interno delle quali avviene la cura”. Chiedere sia il pane sia le rose descrive bene il modo in cui i sistemi sanitari dovrebbero ripensare al valore della cura. “L’attenzione al pane fa sì che l’assistenza sanitaria mantenga il potenziale di attenzione all’oggetto della cura, ai corpi e alle menti, alle paure e ai sentimenti dei singoli pazienti, e crei le condizioni per far emergere un’assistenza attenta e gentile. (…) L’attenzione alle rose mette in evidenza l’oggetto della cura, in modo che le cicatrici dell’ingiustizia, del razzismo, dell’iniquità e della violenza possano essere rese visibili insieme alle cicatrici della malattia”.
Secondo Heath e Montori ormai i principi morali della sanità industrializzata sono sempre più in contrasto con gli imperativi etici che dovrebbero guidare i lavori di cura. Ne derivano una diffusa dissonanza cognitiva tra gli operatori e un senso di abbandono tra gli utenti. Tutto ciò perché, negli ultimi anni, si è data sempre più importanza al pane, dimenticando i limiti delle tecnologie e lasciando che la scienza e l’efficienza avessero la meglio sui valori della dignità, della giustizia e della solidarietà. Per rispondere a questa crisi quindi, ciò che di più radicale si può fare è tornare a chiedere anche le rose, coltivando le relazioni tra i professionisti e i pazienti e tra i professionisti stessi. Concludono, gli autori: “La cura, come le rose, dà un senso alla vita. Dobbiamo coltivare la cura”. y

Bibliografia
1 Heath I, Montor VC. Responding to the crisis of care. BMJ 2023; 380: p464.
A cura della redazione ilpunto.it
La cura, come le rose, dà un senso alla vita. Dobbiamo coltivare la cura
Nel corso della giornata 4words23 – evento annuale del progetto Forward del Dipartimento di epidemiologia della Regione Lazio – due interventi in particolare hanno colpito il bersaglio grosso. Non che gli altri – dedicati a parole chiave come clima, invisibilità e competenze – non fossero stimolanti e ben argomentati, ma il ragionare su “ripresa e resilienza” ha richiamato l’attenzione sulla questione di fondo su cui si gioca il futuro della sanità italiana.
Il saluto ai partecipanti di Sir Michael Marmot 1 è stato infatti contrassegnato dall’urgenza di operare una scelta politica e sociale di fondo, non circoscritta al pur fondamentale ambito della salute, insistendo sulla necessità di puntare di nuovo sull’intervento pubblico, valutando ormai esaurita l’ondata neoliberista che, nata col reaganismo, è durata fino a oggi, smantellando quasi tutti i servizi e i diritti acquisiti nel corso della stagione delle riforme.
A dire il vero, l’invito è parso ai più in controtendenza, dal momento che l’attuale allargarsi del privato è un tratto distintivo anche della sanità nel nostro Paese, come peraltro un po’ dappertutto. Tuttavia, il monito del famoso epidemiologo britannico non tendeva soltanto a spezzare una lancia a favore del pubblico nella diatriba col privato. E lo ha spiegato molto argutamente un altro relatore, Rodolfo Saracci, ex-presidente della International epidemiological association.

All’invito di Marmot – “It’s time to rediscover the public good” – ha risposto infatti l’epidemiologo, ma con un’integrazione fondamentale: non è più tempo, ha sostenuto, per organicismi costruiti esclusivamente sul primato del pubblico, anche da chi pure disponesse di una solida maggioranza che lo legittimasse. Per
La querelle fondamentale potrebbe non essere quella tra pubblico e privato, ma tra comunità e individuo, tra bene pubblico e bene del singolo
una ragione tanto fondamentale e strategica quanto l’universalismo invocato da Marmot: la coscienza soggettiva che ormai alberga in ognuno come principio inalienabile, la cui egemonia è stata per così dire definitivamente ripristinata, e sdogata in politica dopo che da sempre trionfava nei mercati, da quella Margareth Thatcher il cui motto non a caso era “non esiste la società, esistono solo gli individui”.
L’intervento di Saracci ha perfettamente integrato le parole di Marmot non perché la Thatcher avesse ragione nella sua ordalìa nei confronti degli aspetti comunitari del vivere, ma perché la riflessione novecentesca non ha mai smesso di riproporre l’esigenza di ridare pieno senso all’individualità, mortificata dalle grandi essenze collettive che avevano dominato il passaggio di secolo e contrassegnato la prima metà del Novecento. La classe, la razza, il partito erano i serbatoi nei quali si erano disciolte – più o meno volontariamente – le singolarità, serbatoi ormai bucati dalla perspicacia di autori come Sartre, Husserl e Freud, che avevano ripreso e difeso l’irriducibilità della singola persona.2
La querelle fondamentale potrebbe non esser quindi quella, certo interessante sul piano socio-politico, tra pubblico e privato, ma quella tra comunità e individuo, tra bene pubblico e bene del singolo. A dire il vero, il problema non è di oggi e già allo scopo si sono applicate molte intelligenze anche in anni recenti. Tendenzialmente, le soluzioni proposte non abbandonano però l’alveo del modello di sviluppo vincente e dominante alla fine della Storia, quello capitalista. Saracci non a caso ha ricordato le tesi dell’economista ed esperto internazionale di disuguaglianze Branko Milanovic,3 che pur riconoscendo la vittoria su scala globale del capitalismo, non disconosce però le ineguaglianze e le contraddizioni che lo caratterizzano; al punto da continuare a chiedersi, ora che pare esser l’unico sistema di governo, quali sono le prospet-
tive concrete che garantiscono all’umanità più equità e una crescita sostenibile per il pianeta. Pur riconoscendo – come ha invitato a fare l’epidemiologo ambientale Paolo Vineis4 – il darsi di capitalismi, al plurale, anche molto diversi tra loro, il ventaglio delle varianti tende a privilegiare il riconoscimento dell’irriducibile singolarità delle volontà, a meno che queste non si alienino intenzionalmente riconoscendosi in un’istanza ultra individuale, magari populista. Se si volesse tener conto di entrambe le esigenze, si tratterebbe invece di cercare un punto di equilibrio tra il bene pubblico (“the public good”, per dirla con Marmot) e il rispetto integrale dei diritti della persona, intesa come imprescindibile centro di interessi e sentimenti, evitando ogni contrapposizione “ideologica”.

Forse la strada consiste nel non sottrarsi a una continua opera di mediazione tra le nostre aspettative e quelle degli altri, apprendendo via via dall’esperienza e sempre rilanciando il confronto, a partire dalla centralità della persona
Il senso della mediazione
Sembrerebbe dunque che il destino di chi accetta di fare i conti con una realtà difficile e complessa come quella democratica, costituita da individui ognuno con i propri bisogni e desideri, spesso diversi e collidenti, sia di venir continuamente chiamato a quell’esame di realtà al quale, dopo Freud, tutti dovremmo sottoporci: “Se si vuole che nel proprio orizzonte entrino altri esseri, come soggetti a lui pari e non come oggetti da divorare, occorre attutire la propria onnipotenza, accettando di essere limitati. La possibilità di intrecciare rapporti sarà poi un compenso per l’accettazione dei limiti”.5 Forse la strada consiste nel non sottrarsi a una continua opera
di mediazione tra le nostre aspettative e quelle degli altri, apprendendo via via dall’esperienza e sempre rilanciando il confronto, a partire dalla centralità della persona.
Chi persegue il cambiamento, chi sarebbe favorevole a che il “public good” riacquistasse una qualche precedenza sul bene individuale, preservando però quest’ultimo, non può volerlo che in questo modo, attraverso passi concreti che avvicinino le posizioni divaricate e a volte collidenti. Una politica radicalmente riformista non dovrebbe aver paura della mediazione né considerarla un ripiego. Il rischio, altrimenti, è che gli identitarismi continuino a prevalere, relegando chi desidera allargare la funzione del pubblico in una posizione minoritaria e perdente. Forse, un mondo più accogliente e rispettoso non potrà che essere costituito sì da una società, ma di individui. y
 Luciano De Fiore Il Pensiero Scientifico Editore
Luciano De Fiore Il Pensiero Scientifico Editore
1 Sir Michael Marmot è direttore dell’Institute of health equity dell’University college London dove insegna “Epidemiology and public health”. Il suo lavoro presso l’Organizzazione mondiale della sanità come presidente della Commissione sui determinanti sociali della salute e sul rapporto Closing the gap in a generation ha portato i decisori sanitari in Inghilterra a chiedergli di applicare questi risultati al proprio Paese. Il risultato è stato il rapporto Marmot Review pubblicato nel 2010 che individua sei obiettivi di politica sanitaria per raggiungere l’equità nella salute. Diverse nazioni e amministrazioni di grandi città di tutto il mondo hanno adottato le sue raccomandazioni. Nel 2020 Sir Marmot ha completato una revisione retrospettiva sui progressi compiuti in Inghilterra riguardo gli obiettivi prefissati: Health equity in England: the Marmot review 10 years on. È autore di La salute diseguale (Roma: Il Pensiero Scientifico Editore, 2016).
2 Basti ricordare il Freud di Psicologia delle masse e analisi dell’io: “Nella vita psichica del singolo l’altro è regolarmente presente come modello, come oggetto, come soccorritore, come nemico, e pertanto, in questa accezione più ampia ma indiscutibilmente legittima, la psicologia individuale è al tempo stesso, fin dall’inizio, psicologia sociale”. Freud S. Opere. A cura di C. Musatti. Torino: Bollati Boringhieri, 1996: vol. IX, p. 261.
3 Milanovic B. Capitalismo contro capitalismo. La sfida che deciderà il nostro futuro. Laterza: Bari/Roma, 2022.
4 Carra L, Vineis P. Il capitale biologico. Le conseguenze sulla salute delle diseguaglianze sociali. Torino: Codice edizioni, 2022.
5 D’Abbiero M. Affetti privati, pubbliche virtù. La psiche come fattore politico. Roma: Castelvecchi editore, 2020: p. 42.

La posizione dell’Associazione culturale pediatri per una società inclusiva
Stefania ManettiPresidente Acp
Gruppo Acp “Pediatria di genere”
L’Associazione culturale pediatri (Acp – www.acp.it) con il presente documento intende dare il proprio contributo all’attuale dibattito sul tema del benessere e best interest di bambini/e che nascono e crescono in famiglie omogenitoriali.
I pediatri e le pediatre italiani/e da circa 20 anni si sono trovati ad accogliere coppie di genitori omosessuali con figli/e; tali esperienze si sono fatte sempre più frequenti rientrando nell’ampia variabilità di composizione delle formazioni familia-
ri contemporanee (famiglie multietniche, genitori single, genitori divorziati, famiglie ricomposte ed allargate). La condivisione di percorsi nascita per coppie di donne, l’assistenza in terapia intensiva neonatale per neonati prematuri, cure primarie e ospedaliere ci hanno fatto maturare una sempre più corposa esperienza diretta. Tale attività pratica è stata integrata da un parallelo aggiornamento scientifico basato sullo studio dell’ampia letteratura nazionale e internazionale prodotta negli ultimi 40 anni sull’argomento.

Acp ha prodotto pubblicazioni1,2 e promosso eventi formativi diretti a portate all’attenzione della comunità pediatrica italiana le consolidate acquisizioni circa le
lo stato di salute dei minori figli di coppie omogenitoriali che possono essere riassunte schematicamente in pochi punti essenziali:
{ per garantire uno sviluppo sano, equilibrato e armonioso dei bambini contano la qualità delle relazioni affettive genitore-figlio, la presenza di legami sicuri e stabili nel tempo con adulti responsabili e amorevoli, la capacità dei genitori di accogliere e seguire la crescita dei bambini, dar loro sostegno creando un ambiente sicuro, sereno e protettivo, indipendentemente dal fatto che essi siano conviventi, separati, risposati, single, o dello stesso sesso. Non è la forma né la struttura delle famiglie a incidere sul benessere dei suoi membri, bensì la qualità delle relazioni e dei processi che prendono corpo in essa e la capacità di affrontare i problemi;
{ l’adattamento, lo sviluppo cognitivo, sociale e psicosessuale, la qualità delle relazioni e il successo scolastico dei bambini e degli adolescenti cresciuti da genitori omosessuali non si discostano da quelli dei figli cresciuti da genitori eterosessuali;
{ in figli di genitori omosessuali non sono emerse differenze rispetto ai bambini di genitori eterosessuali nella percezione del senso di sicurezza. Ciò che può influire negativamente su questi bambini è invece quel processo di discriminazione sociale e di rifiuto che si esprime sotto forma di commenti negativi, bullismo, violenza fisica e mancanza di tutela legale. Ovvero, non è il rapporto tra figlio e genitore a creare difficoltà, ma quello dovuto all’omofobia dell’ambiente esterno nei confronti dei genitori (il cosiddetto minority stress disorder : discriminazione e stigmatizzazione sociale di una minoranza in base a carat-
La tutela del benessere dei bambini figli di coppie omosessuali può essere garantita solo dalla loro affermazione sociale come singoli e come appartenenti a una formazione familiare specifica
teristiche etniche, sessuali, religiose, disabilità, ecc.);
{ per quanto riguarda il pericolo di essere soggetti allo stigma della comunità, i dati disponibili rivelano che i bambini cresciuti da gay e lesbiche, nonostante le discriminazioni a cui sono sottoposti, seguono i percorsi di sviluppo attesi. Nonostante le maggiori sfide e le difficoltà incontrate dalle famiglie omogenitoriali, la capacità di resilienza sembra fornire loro il potenziale per far fronte alle avversità positivamente;

{ risultato che indica che la soluzione è nel proseguimento della crescita e nell’adeguamento culturale delle comunità a questo genere di famiglie, che passa innanzitutto per l’attribuzione alle stesse di famiglie di identiche condizioni, riconoscimento e diritti.
Tali posizioni sono state espresse anche nella recente lettera congiunta dei presidenti degli Ordini degli Psicologi delle Regioni Lazio, Campania, Sicilia, Marche, Abruzzo, Veneto ed Emilia-Romagna indirizzata a Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.3
Secondo l’attuale normativa italiana i minori nati da coppie omogenitoriali che hanno eseguito all’estero un percorso di procreazione assistita regolamentato hanno riconosciuto in Italia solamente un unico genitore che risulta essere il genitore biologico. Questo porta al mancato riconoscimento della figura del genitore “intenzionale” (detto anche sociale) che cioè ha partecipato al progetto genitoriale e all’estero ha firmato il consenso informato per assumere una responsabilità genitoriale verso quel bambino/a. Attualmente in Italia al genitore intenzionale non vengono riconosciuti i doveri connessi alle decisioni sanitarie, il dovere di mantenimento, di assistenza, di istruzione, di educazione dei figli, il potere di ritirare i figli a scuola se non con delega scritta del genitore biologico, l’espressione di voto attivo negli organismo scolasti-
ci, la continuità affettiva in caso di morte del genitore legale o separazione della coppia. Nel caso di decesso del genitore biologico il bambino verrà posto sotto la tutela degli unici parenti biologici riconosciuti legalmente che non hanno nessun obbligo di mantenere la continuità affettiva del bambino con il genitore sociale. Lo stesso ragionamento vale in caso di separazione tra due coniugi con figli i quali sono riconosciuti solo dal genitore biologico, non c’è infatti nessun obbligo legale di far mantenere al bambino i rapporti con l’altro genitore. A quest’ultimo inoltre non è riconosciuto neanche il dovere di emissione di un contributo economico come prosecuzione del mantenimento del minore. Questo preoccupante vuoto di tutela nei confronti dei figli nati da procreazione medicalmente assistita all’estero, in Stati in cui la procreazione medicalmente assistita è permessa alle coppie dello stesso sesso, è stata messa in luce dalla Corte Costituzionale che con le sentenze n. 32 del 2021 e n. 33 nel 2022,
ha invitato il legislatore a legiferare in merito per garantire il riconoscimento fin dalla nascita del genitore intenzionale (sociale) oltre al genitore biologico nell’ottica del best interest del minore. Tale necessità è stata anche sancita nel 2022 dal 12esimo rapporto italiano del Crc, il gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, composto da più di cento soggetti del terzo settore italiano che si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.4
Per quanto riguarda poi il contesto internazionale l’indicazione fornita dall’Unione europea è decisamente indirizzata al riconoscimento della doppia genitorialità in tutti gli Stati, nell’ottica del miglior interesse del minore come dimostrato anche dalle recenti proposte di regolamento per armonizzare le norme sul riconoscimento transfrontaliero dei figli, anche di coppie omosessuali e dei loro diritti in tutta l’Unione europea. Per i motivi sopra citati, e forti di un osservatorio scientifico e psico-
sociale ormai quarantennale, ci facciamo portatori di una richiesta di tutela del benessere dei bambini figli di coppie omosessuali che può essere garantita in modo completo solo dalla loro affermazione sociale come singoli e come appartenenti ad una formazione familiare specifica e come questo dipenda in modo innegabile dal riconoscimento giuridico che lo Stato attua nei confronti di questi piccoli cittadini e dei loro genitori.

I pediatri e le pediatre italiane dell’Acp chiedono quindi al legislatore di incarnare le evidenze scientifiche nelle realtà sociali contemporanee per guidare scelte normative che possano portare al riconoscimento della doppia genitorialità omosessuale e all’attuazione di politiche sociali di accoglienza delle minoranze sessuali e contrasto all’omotransfobia per una società più inclusiva e sicura per tutti i cittadini e le cittadine italiani/e. y
1 Manetti S. Ci sono famiglie e famiglie...? Le Famiglie LGBT. Quaderni acp 2021; 23: 169-70.
2 Fruggeri L. Oltre il pregiudizio: la specificità dei processi di sviluppo delle famiglie contemporanee. Quaderni acp 2012; 28: 88-90.
3 Ordine Psicologi Lazio. Lettera congiunta alla Ministra Onorevole Roccella. Risposta di 7 ordini professionali. 8 febbraio 2023
4 12° Rapporto di monitoraggio dell’attuazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
I pediatri e le pediatre dell’Acp chiedono al legislatore di incarnare le evidenze scientifiche nelle realtà sociali contemporanee per guidare scelte normative per il riconoscimento della doppia genitorialità omosessuale
Uno degli aspetti cruciali dell’attività medica è scegliere tra i vari interventi quello che, al momento in cui si decide, ha a suo favore prove di efficacia e di utilità per il paziente. Le prove di efficacia derivano da studi che hanno dimostrato, in modo misurabile e riproducibile, che è utile eseguire un determinato esame o prescrivere un determinato trattamento per quel particolare paziente. Il medico deve però essere consapevole che le prove di efficacia valide ora potrebbero non esserlo in futuro, secondo il principio enunciato da Karl Popper (principio di confutazione) per cui le certezze scientifiche sono soggette a conferma o smentita. Ma, detto questo, come si possono superare le difficoltà che si presentano al momento della scelta terapeutica? Come si può eliminare l’effetto placebo oppure essere sicuri che il miglioramento clinico ottenuto sia legato alla terapia prescritta e non all’evoluzione naturale della malattia? La risposta sta nell’effettuazione di studi clinici. La medicina negli ultimi decenni ha dato un grandissimo impulso a questa pratica, cercando di rendere oggettive e riproducibili le osservazioni soggettive che sono, per loro stessa natura, variabili e opinabili. In altre parole la medicina ha cercato di darsi una veste scientifica che la avvicina, in parte, alla matematica e all’algebra, anche se, come si ripete spesso, essa non è, e non può essere, una scienza esatta per l’imperfetta corrispondenza dei risultati trovati alla complessa variabilità clinica.
Esistono differenti tipi di studi. Per semplificare al massimo si può dire che quelli principali sono di due
tipi: gli studi osservazionali e gli studi di intervento. Distinguerli non è difficile. Negli studi osservazionali la somministrazione di un farmaco (oppure un intervento chirurgico o la prescrizione di un esame di screening, ecc.) non è stata decisa dagli sperimentatori o dagli autori. Questi ultimi si sono limitati ad “osservare” una determinata realtà senza svolgere un ruolo attivo. Negli studi di intervento, al contrario, gli autori agiscono in modo attivo. Per comprendere meglio la differenza tra le due categorie si faranno due esempi.
In uno studio è stata condotta un’analisi telefonica su 10.000 persone residenti in una determinata regione italiana. Si è chiesto a ciascun intervistato se assumeva o meno degli integratori alimentari e contemporaneamente se soffriva di diabete. L’analisi dei dati ha dimostrato che nei soggetti che assumono regolarmente integratori l’incidenza della malattia diabetica risulta inferiore del 20 per cento rispetto a coloro che non assumono integratori. In questo caso si tratta di uno studio osservazionale: infatti l’intervento (assunzione di integratori) non è stato deciso da chi ha effettuato lo studio ma da altri (dai soggetti intervistati o per decisione autonoma o per consiglio di amici o conoscenti, o per prescrizione dei medici curanti, ecc.). In pratica negli studi osservazionali gli autori “fotografano” una determinata situazione clinica: si limitano, come dei notai, a prenderne atto.
In un altro tipo di studio gli autori hanno arruolato 10.000 soggetti affetti da cardiopatia ischemica e li hanno suddivisi (in maniera random = casuale) in due gruppi.
Ad un gruppo hanno
somministrato un farmaco vasodilatatore, all’altro gruppo hanno somministrato un placebo (una compressa del tutto indistinguibile da quella somministrata al primo gruppo che
conteneva però una sostanza inerte). Dopo 5 anni si è evidenziato che i decessi nel gruppo trattato con il farmaco erano inferiori del 30 per cento rispetto ai decessi registrati nel gruppo che assumeva placebo. In questo caso l’intervento (la somministrazione del farmaco vasodilatatore) è stato deciso attivamente dagli autori dello studio: si tratta quindi di uno studio di intervento. Per la precisione di uno studio randomizzato e controllato. Quando in una rivista medica ci si imbatte in uno studio che sembra importante la prima domanda da porsi quindi è questa: si tratta di uno studio osservazionale oppure di uno studio di intervento? La distinzione è molto importante perché consente di stabilire quanto ci si può fidare dei risultati trovati. In linea generale gli studi di intervento, purché ben effettuati, forniscono risultati più affidabili degli studi osservazionali. Questi ultimi, di solito, sono utili perché possono generare delle ipotesi che però, in seguito, dovrebbero essere confermate (o smentite) da studi di intervento.
Nella recente pandemia da sarscov-2 dati preliminari avevano portato a ritenere efficaci alcuni farmaci. Non si trattava però di conclusioni basate su studi di intervento, bensì sull’analisi e sull’osservazione di casistiche limitate. In seguito studi di intervento meglio condotti hanno portato alla conclusione che le osservazioni iniziali non erano affidabili e che l’efficacia osservata o era molto piccola o era addirittura assente. Pertanto bisogna valutare su quali prove si basano affermazioni di efficacia di un determinato trattamento ed essere pronti ad esercitare il dubbio cartesiano.
Va ricordato, però, che anche i risultati degli studi di intervento, per quanto eseguiti in modo rigoroso, non sono applicabili ad
ogni paziente in maniera acritica e automatica. Ogni paziente è un “unicum” e allora entra in campo l’esperienza del medico che deve considerare in quel particolare soggetto le caratteristiche cliniche
che permettono di personalizzare le decisioni mediche.
Renato Luigi Rossi Medico di famigliaUn metodo rapido utile al medico pratico per un primo inquadramento di uno studio clinico
Il metodo si sviluppa per step successivi che ricalcano in gran parte i capitoli del libro visti fino a questo momento. Esso consente una valutazione di massima e non pretende di esplorare tutte le possibili criticità che possono trovarsi in uno studio clinico. Va sottolineato, infatti, che spesso l’interpretazione può essere difficile anche per gli esperti per la complessità dei dati. Conviene sempre fare riferimento:
1. alle limitazioni dello studio che di solito gli autori riportano prima delle conclusioni finali;
2. agli editoriali di commento che sottolineano l’importanza dello studio, gli eventuali bias presenti e i limiti dei risultati; questi limiti possono riguardare la validità stessa dello studio e/o la sua trasferibilità nel mondo reale.
Che studio è?
Il primo passo è determinare se si tratta di uno studio osservazionale o di uno studio randomizzato e controllato. I risultati degli studi osservazionali sono, generalmente, considerati meno robusti di quelli
dei trial clinici randomizzati (rct) per la possibile presenza di fattori confondenti e bias. Possono essere ipotesi di lavoro da confermare o confutare con rct disegnati a questo scopo. Gli studi osservazionali sono importanti, tuttavia, in determinati ambiti, per esempio per stabilire alcune associazioni (fumo/cancro, alcolismo/cirrosi).
Si tratta di un rct?
In questo caso andrebbe valutata la bontà della randomizzazione, compito per nulla semplice. Di solito le riviste più prestigiose, negli editoriali di commento, rilevano se ci sono state falle nella procedura della randomizzazione, che dovrebbe essere gestita con sistemi computerizzati.
Lo studio era in doppio cieco?
La mancanza di cecità può portare a sovrastimare l’efficacia di un trattamento (soprattutto se l’endpoint considerato si basa su una valutazione soggettiva, come per esempio l’entità del dolore) o può portare ad alcuni bias (come il performance bias). Numerosità del
campione arruolato Se la numerosità del campione arruolato (sample size) non è adeguata i risultati del trial sono meno affidabili. D’altra parte un sample size di migliaia di pazienti può portare a un sovradimensionamento che rileva ed enfatizza benefici del trattamento clinicamente poco rilevanti.
La durata del follow-up deve essere congrua con gli endpoint valutati. Per endpoint surrogati può essere sufficiente un follow-up di pochi mesi, per quelli clinici maggiori sono spesso necessari anni. Importante è controllare se lo studio è stato interrotto in anticipo rispetto a quanto programmato: in questo caso i benefici del trattamento potrebbero apparire sovrastimati.
Lo studio va valutato per i risultati ottenuti sull’endpoint principale; i risultati sugli endpoint secondari sono un valore aggiunto se vanno nella stessa direzione dell’endpoint principale; in caso contrario dovrebbero essere considerati delle ipotesi da verificare. Va prestata attenzione, nel caso di endpoint composti, al comportamento dei vari elementi dell’endpoint stesso (per ulteriori particolari si rimanda al relativo capitolo). Nel caso lo studio abbia valutato endpoint surrogati questi dovrebbero essere fortemente associati a endpoint clinici. È importante, inoltre, considerare se lo studio prevede anche outcome riferiti dai pazienti.
Se i risultati derivano da un’analisi per sottogruppi bisogna valutare se essa era stata pre-specificata nel disegno dello studio oppure pianificata in itinere o a posteriori quando lo studio si è concluso. Le analisi a posteriori possono portare a differenze statisticamente significative di un risultato solo formali e dovute alla casualità. Questa probabilità aumenta quanto

più sono le analisi per sottogruppi. Analisi di questo tipo, solitamente, dovrebbero essere considerate come generatrici di ipotesi da verificare con studi futuri.
Significatività statistica
Un risultato statisticamente significativo non significa di per sé che sia clinicamente importante. Va osservato il valore della “P”: un valore troppo vicino al cut-off (0,05) significa che la probabilità che si tratti di un risultato casuale non è irrilevante. Si deve valutare il risultato in termini assoluti (riduzione del rischio assoluto = ARR) e di NNT. Importante anche considerare l’NNH. Se l’intervallo di confidenza al 95% è troppo vicino alla parità significa che il beneficio, seppur statisticamente significativo, potrebbe esserlo molto meno se lo si considera dal punto di vista clinico.

Importanza dello studio
Infine va valutata l’importanza dello studio.
{ Si tratta di uno studio che potrebbe portare a cambiamenti della pratica clinica quotidiana?
{ Lo studio porta a novità rilevanti oppure conferma solo dati già assodati?
Renato Luigi Rossi
Medico di famiglia
L’identità sessuale è determinata dalla complessa e reciproca influenza di una costellazione di fattori inerenti vari aspetti del corpo e della mente di un individuo, dell’immagine sessuata che questi ha di sé e del suo modo di presentarsi agli altri. Si tratta di un costrutto, articolato a più livelli e su più dimensioni, che riguarda gli aspetti biologici, psicologici, educativi e socioculturali di un individuo. L’identità sessuale è costituita da quattro componenti: il sesso biologico, l’identità di genere, il ruolo di genere e l’orientamento sessuale. Il sesso è determinato da fattori biologici. Per stabilire a quale categoria sessuale un individuo appartiene, devono essere considerati diversi aspetti:
{ il sesso genetico o cromosomico (se il ventitreesimo paio è XY, l’individuo e classificato come maschio; se è XX, è considerato femmina);
{ il sesso gonadico (la presenza di ovaie o di testicoli);
{ il sesso ormonale (estrogeni o testosterone);
{ i tratti sessuali secondari (barba, baffi, tono della voce, larghezza delle spalle, sviluppo delle ghiandole mammarie, allargamento del bacino);
{ gli organi genitali esterni (pene o vagina).
Questo testo è tratto dal libro Come leggere uno studio clinico di Renato Luigi Rossi (Roma: Il Pensiero Scientifico Editore, 2021). Per gentile concessione dell’editore.
In conformità a questi fattori biologici, il sesso divide gli esseri umani in femmine, maschi o in una delle altre possibili varianti dello sviluppo sessuale (intersessuali). La legge italiana (12 aprile 1982, n. 164) consente il cambiamento di sesso. Le persone transessuali, che si identificano in modo permanente con un genere diverso rispetto al loro sesso biologico, possono sottoporsi a
un processo di transizione che le porta a una ri-attribuzione chirurgica parziale o totale del sesso. Il sesso è distinto dal genere. Infatti, il genere è una costruzione sociale che distingue gli esseri umani in donne, uomini e transgender. A differenza del sesso, il genere dipende da fattori sociali. Esso è strettamente connesso a quell’insieme di comportamenti, doveri, credenze, aspettative, ruoli e posizioni sociali, norme e relazioni che una particolare comunità in un determinato periodo storico ritiene delimiti l’appartenenza alla categoria donna o uomo. L’identità di genere si costruisce attraverso un lungo processo d’apprendimento in cui l’esperienza e i comportamenti di un individuo si intrecciano con l’esperienza e i comportamenti degli altri. L’orientamento sessuale esprime invece la relazione tra l’identità di genere di una persona e il genere/sesso delle persone da cui si sente attratta. Per esempio, una persona transgender potrebbe essere eterosessuale, omosessuale o bisessuale. Ci sono persone che, pur essendo a disagio con il sesso attribuito loro alla nascita, sono attratte da un sesso diverso dal proprio. Dunque, un uomo transessuale (nato femmina ma con un’identità maschile) potrebbe volere che ci si riferisca a lui con pronomi maschili, potrebbe sentirsi attratto da donne ed essere eterosessuale oppure sentirsi attratto da uomini ed essere omosessuale. Per indicare le persone il cui orientamento sessuale differisce da quello eterosessuale e da identità cisgender, si può usare il “termine-ombrello” queer. Le persone queer rifiutano l’aspetto prescrittivo dell’eteronormatività e mettono in discussione la distinzione tra sesso, genere e orientamento sessuale. L’eteronormatività è l’insieme di pratiche e istituzioni politico-sociali che postula, legittima e privilegia una particolare forma di eterosessualità caratterizzata da monogamia, matrimonio, riproduzione e famiglia nucleare. Al livello dell’identità
sessuale, il binarismo non è dunque la norma. Nelle differenti dimensioni e forme sessuali, si può osservare una regola sia binaria sia non binaria: nel sesso biologico, oltre alla dicotomia femmina/maschio, vi è la condizione intersessuale; nel caso dell’identità di genere, oltre alle categorie donna/uomo, vi è quella transgender; nel caso dell’orientamento sessuale, accanto alla dicotomia eterosessuale/ omosessuale, vi è la condizione della bisessualità con tutte le sue varianti.
Vera Tripodi
Dipartimento di Filosofia
“Piero Martinetti” Università degli studi di Milano La Statale
Secondo la tradizione deontologica il nucleo forte dell’etica è costituito da divieti assoluti, ovvero divieti che non ammettono mai alcuna eccezione per nessuna ragione. Infatti absolutus significa “sciolto da” condizioni storiche. La teologia cattolica parla di atti cattivi in sé, quindi da non farsi mai, come la contraccezione o l’aborto, dunque il divieto vale semper et pro semper. Pur essendo noto che non tutti i divieti morali sono assoluti, si era consolidata, in particolare in Occidente, l’idea che il cuore dell’etica fosse formato da divieti assoluti, ritenendo che l’assolutezza fosse l’impronta nel mondo storico dell’Assoluto derivante dal mondo metafisico ed eterno. Ma, nel 1874, il filosofo Henry Sidgwick ha mostrato che vi sono due tipi di doveri: quello assoluto e quello prima facie, cioè che vincola di primo acchito. Il dovere di non violare una promessa è sicuramente molto forte, ma può
essere in conflitto con altri doveri, come quello di evitare un grande dolore e quindi consentire un’eccezione. Ma se si ammette che questo valga per tutti i doveri morali, allora in etica non c’è più nulla di stabile. Si pongono quindi due problemi. Il primo è la gerarchia dei doveri: con quale criterio si giudicano i doveri in conflitto? La risposta è che sembra ragionevole che la precedenza venga data al dovere che diminuisce i danni. Ma se scompare il divieto assoluto, l’etica diventa semplicemente un’istituzione sociale tesa a garantire il benessere. A questo punto la moralità non prescinde più dal calcolo delle conseguenze perché riconosce che il benessere e il criterio ultimo di giudizio morale. Il secondo problema riguarda il fatto che l’etica con soli divieti prima facie, dichiarando di non avere assoluti, in realtà afferma un assoluto diverso, di segno opposto. L’assoluto non sarebbe più nel divieto, bensì nel principio di autonomia o in quello di utilità. Ciò starebbe a significare che l’uomo non riesce a fare a meno dell’assoluto. Ma questa impostazione è sbagliata perché negare l’assoluto equivale semplicemente a negare che la moralità rimandi a un mondo eterno e sovrannaturale e, contemporaneamente, ad affermare che la moralità è un’istituzione sociale e contingente. Negli anni Ottanta del secolo scorso, con le questioni riguardanti l’aborto e la fecondazione assistita, dopo un periodo di confusione concettuale, la chiesa cattolica riafferma con vigore i divieti assoluti ponendoli a capo dell’etica della sacralità della vita, ovvero la prospettiva morale per cui la vita umana è intangibile e non può essere in nessun caso violata o manipolata. L’espressione ricorre nei testi del magistero cattolico. Nell’Evangelium vitae, al n. 53, Giovanni Paolo II afferma: “La vita umana è sacra perché fin dal suo inizio comporta l’azione creatrice di Dio (...) e rimane sempre in una relazione speciale con il Creatore,
suo unico fine”. Chi, invece, nega che esistano divieti assoluti e asserisce che tutti i divieti sono prima facie afferma la cosiddetta “etica della qualità della vita”. Il valore centrale di questa posizione è appunto la qualità della vita, ovvero il benessere e l’autonomia delle persone. Il criterio determinante per le scelte morali diviene la scelta autonoma della persona. Il problema centrale dell’etica e della bioetica contemporanee è infatti quello di sapere se ci siano divieti assoluti o se i divieti siano tutti prima facie e dunque scegliere tra l’etica della sacralità e quella della qualità della vita. Anche il “non uccidere”, cui il pensiero corre immediatamente, poiché è uno dei divieti più stringenti di tutti i codici morali, si rivela prima facie in almeno un caso: la legittima difesa, ammessa esplicitamente anche dalla chiesa cattolica nell’Evangelium vitae dove, al n. 55, si dice che “può essere non soltanto un diritto, ma un grave dovere”. I due paradigmi etici sono inconciliabili perché nell’etica della sacralità le norme morali sono indipendenti dalla volontà dell’uomo, sono un dato naturale o divino, mentre nell’etica della qualità della vita sono stabilite dall’uomo, sono una realizzazione umana di natura sociale e tendono al benessere. Nell’attuale epoca di cambiamento, le tradizioni pervadono ancora con forza l’immaginario collettivo, pur senza avere più presa nella vita reale, mentre i nuovi stili di vita scandiscono l’esistenza ma non hanno ancora acquisito la necessaria autorevolezza. L’etica della sacralità della vita ha perso consistenza ma quella della qualità della vita non riesce a legittimarsi completamente.
Maria Teresa BuscaGruppo di ricerca bioetica, Università degli studi di Torino Scuola superiore di bioetica della Consulta di bioetica onlus
L’espressione “consenso informato” viene usata, in sanità e nella letteratura bioetica per riferirsi a due diverse concezioni, unite tra loro. La prima si riferisce a una pratica sociale legata a un particolare contesto storicoculturale e istituita in specifici ambiti, quelli dell’assistenza sanitaria (e della sperimentazione clinica e farmaceutica) e della ricerca. Tale pratica (gestita secondo regole fisse, alcune codificate giuridicamente e altre stabilite secondo la prassi invalsa nel gruppo) ha lo scopo di permettere stabilmente di trattare pazienti nel setting medico o di ricerca, in accordo con gli standard di buona pratica clinica e le norme legislative (e politiche) vigenti.
L’elemento prevalente dell’espressione “consenso informato” è qui quello relativo alla dimensione pubblica di una procedura analizzabile nei termini della rete di norme che la regolano e dei requisiti necessari affinché un atto del paziente, il consenso, sia valido ed efficace, e permetta così le cure, oppure non lo sia. Tanto le norme quanto i requisiti subiscono l’influenza delle credenze della società in cui la pratica è inserita. Il clima culturale del XX secolo, che ha prodotto la pratica del consenso informato in medicina e lo ha reso un vincolo sociale ineludibile, è stato caratterizzato dall’emergere del paziente quale soggetto di decisioni.
L’anno di nascita del consenso informato in questo primo significato di “pratica sociale” è convenzionalmente il 1957, quando nella sentenza “Salgo” (causa Salgo vs Leland Stanford Jr. University Board of Trustees, Corte d’Appello della California, 22 ottobre 1957) fu coniata l’espressione “informed
consent”. Nel suo secondo significato, ripercorrendo la teoria contenuta nel classico di Ruth R. Faden e Tom L. Beauchamp, A history and theory of informed consent, il consenso informato è una scelta, più precisamente un tipo particolare di azione di singoli pazienti: un’autorizzazione autonoma. Esso è piu di un semplice, esplicito accordo a una procedura proposta: esprime l’esercizio attivo dell’autorità del paziente, il quale conferisce a qualcuno, il medico, il permesso di attuare un certo piano, un certo esame diagnostico, una certa terapia. Tale autorizzazione del paziente, da alcuni definita “intenzionale”, implica due distinte operazioni: l’assunzione di responsabilità per ciò che si autorizza e il trasferimento a un altro dell’autorità di realizzarlo. L’autorizzante e l’autorizzato con tale atto condividono la responsabilità per le conseguenze (prevedibili).
Chi autorizza utilizza il potere in suo possesso nella situazione per dotare un altro, il medico, del diritto ad agire, e assume alcune responsabilità per le azioni compiute dall’autorizzato allo scopo di realizzare i processi di cura per i quali questi ha ottenuto il permesso di agire.
Affinché il consenso informato sia un’autorizzazione autonoma, è necessario che colui che lo esprime capisca queste caratteristiche dell’atto e intenda procedere. Il consenso informato così inteso costituisce, attualmente, nei Paesi occidentali, il fondamento della legittimità del trattamento sanitario. Esso esprime il riconoscimento della sovranità che il paziente adulto in grado di produrre tali autorizzazioni autonome possiede sul proprio corpo e sulla propria vita, ne sancisce giuridicamente la titolarità decisionale sulle scelte riguardanti le proprie cure e il diritto, conferitogli solo ove non leda i diritti e l’incolumità altrui, di disporre del proprio corpo. Il primo
argine che limita lo spettro d’azione del trattamento sanitario è, quindi, la disponibilità del paziente a voler essere curato.
Il consenso informato indica dunque l’assenso/dissenso con il quale il paziente autorizza/non autorizza il personale sanitario a invadere la sua integrità corporea a fini diagnostici, assistenziali, terapeutici, prognostici o migliorativi, nelle sole condizioni profilate dal personale sanitario, stabilite nel documento di consenso (che è parte della procedura del consenso informato come pratica) e da egli volontariamente accettate. Si distingue dal consenso informato vero e proprio l’assenso informato fornito dai minori d’età e il proxy consent o “consenso per procura”.
Con quest’ultima espressione si intende il consenso alle terapie che i rappresentanti legali prestano per un individuo giudicato incapace di decidere per sé. Esempio tipico è il consenso alle cure fornito da genitori di figli minori d’età. Cosi come esiste uno standard che stabilisce se un individuo sia in grado di prendere le proprie decisioni di salute, allo stesso modo vi sono criteri per giudicare se i decisori sostitutivi posseggano o meno le caratteristiche necessarie per poter scegliere per altri. In Italia alla pratica del consenso informato è dedicata un’apposita legge, la 219/2017, “Norme in materia di consenso informato e direttive anticipate di trattamento”.
Elena Nave
Comitato etico interaziendale, Aou Città della salute e della scienza di Torino
Ao Ordine Mauriziano – Asl
Città di Torino
Consulta di bioetica onlus
I lemmi sono tratti dal libro Le parole della bioetica , a cura di Maria Teresa Busca e Elena Nave (Roma: Il Pensiero Scientifico Editore). Per gentile concessione dell’editore.
ETICA E DEONTOLOGIA
Conflitti e obiezioni. E in mezzo gli interessi, di chi?
Intervista a Angelica Salvadori
Il linguaggio asimmetrico e il consenso (non) informato
Luca Forestieri
Il medico ha sbagliato. Ma di che è l’errore?
Nicolò Fagone La Zita
Disturbi del neurosviluppo: una quotidianità difficile
Federica Zanetto
Il valore della professione di aiuto
Costantino Panza su Un uomo fortunato di John Berger e Jean Mohr
Il medico e l’errore Intervista a Franco Aprà
La cura e il dialogo con la tecnologia
Luca Forestieri
SOCIETÀ E POLITICA
La residenza per anziani come laboratorio della vita condivisa
Antonio Censi
In difesa dell’umano: corpo e intelligenza artificiale Intervista a Roberto Finelli
Il controllo della rete in medicina Intervista a Francesco Del Zotti
Stare bene: ma che vuol dire?
Luciano De Fiore su Stare bene. Un’analisi filosofica di Elisabetta Lalumera
Circoncisione rituale maschile: una questione di sanità pubblica?
Elena Sciurpa
La guerra in Ucraina, senza uscite di sicurezza Intervista a Domenico Quirico
LESSICO DI BIOETICA
Ageismo – Mario Bo
Consulenza etica – Maria Teresa Busca
Contraccezione – Mario Bo
Dark web – Fiorello Casi
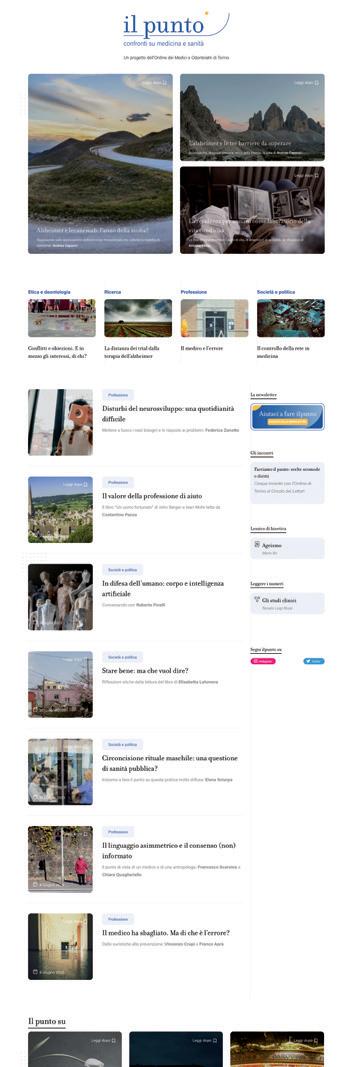
Fecondazione assistita – Carlo Flamigni
Intersessualità – Matteo Cresti
Invecchiamento – Mario Bo, Bianca Salone
Ricerca scientifica – Laura Lossi, Adalberto Merighi
Terapia – Maria Teresa Busca
LEGGERE I NUMERI
A cura Renato Luigi Rossi
Studi ed esami diagnostici
8


Internet è sempre più trasformata da rete di comunicazione tra persone a rete di controllo, incorporata nel mondo fisico.
Giampaolo Collecchia
16
Io abito il mio corpo e decido io cosa voglio farci, e che strada perseguire.
Da un lato la Fda approva l’immissione in commercio di farmaci potenzialmente utili per l’alzheimer, dall’altro si discute se indirizzarsi verso nuove prospettive di ricerca.
Nicola Vanacore
www.ilpunto.it

30
La cura, come le rose, dà un senso alla vita. Dobbiamo coltivare la cura.
Iona Heath, Victor Montori

Il progetto culturale dell’OMCeO di Torino
Sfoglia la rivista digitale
Matteo Cresti, Elena Nave