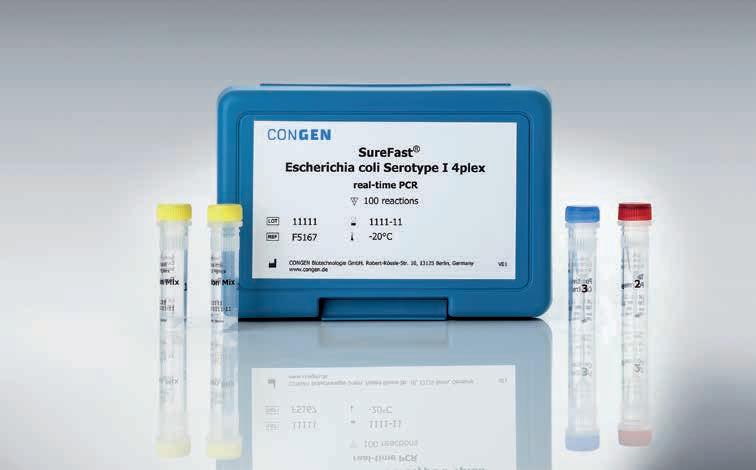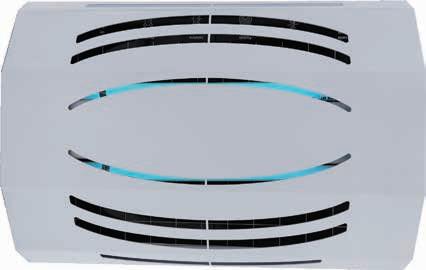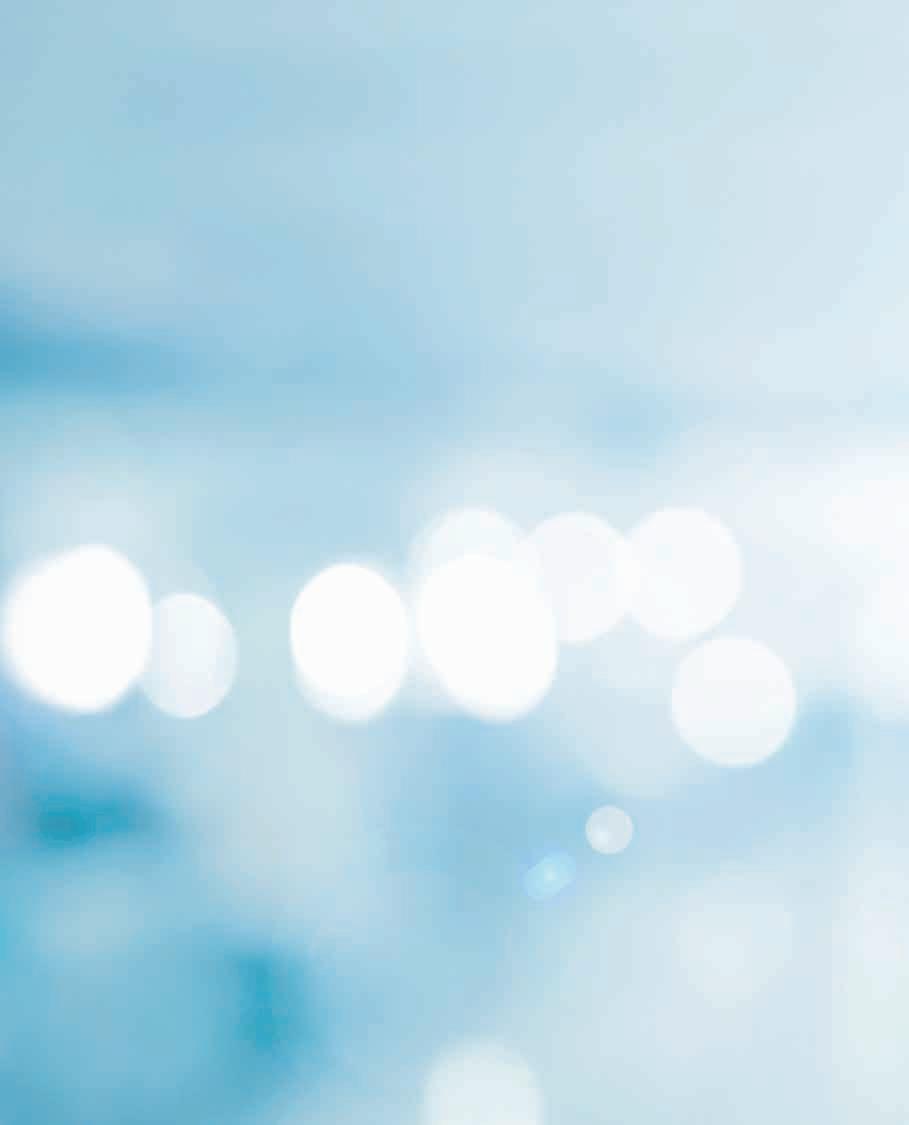6 minute read
di Erasmo Neviani
La comunicazione ai tempi del COVID-19
Scrivo con la speranza che al momento della pubblicazione di questo intervento la pandemia da COVID-19 si sia risolta o almeno attenuata. Ci sono riflessioni che questo drammatico evento impone specificamente ai Tecnologi degli Alimenti? A mio avviso sì. Almeno due le principali. La prima riflessione, propria della mia professione di microbiologo, è ovviamente la necessità di approfondire gli aspetti igienico sanitari associati alla potenziale presenza di virus negli alimenti. In pratica, come il cibo possa divenire veicolo di infezioni virali. Non virus come il COVID-19, che si giova di vie di contagio che non necessitano degli alimenti come veicoli, ma più in generale come i processi di produzione e le modalità di commercializzazione possano essere condizionati da differenti virus eventualmente presenti nelle materie prime e negli ambienti di trasformazione. Si tratta di un tema di studio non certo nuovo ma che ancora oggi necessita di sforzi di approfondimento mirati. La seconda riflessione, propria del Tecnologo alimentare, riguarda la necessità di sottolineare in tutte le sedi che ci competono, come chi parla di alimenti da differenti tribune mediatiche debba avere obbligatoriamente le competenze tecnico scientifiche necessarie per farlo. Un obbligo etico, da ricondurre alla professionalità e al sapere specifico delle differenti professioni. In particolare in questo periodo, sono troppe le comunicazioni chiassose sull’effetto di protezione rispetto alle infezioni virali che differenti alimenti, o composti presenti negli alimenti, possono favorire. Comunicazioni spesso vaghe, improvvisate e fantasiose, quando non completamente in malafede. Ricordiamo che sebbene una dieta corretta sia utile prevenzione a differenti malattie, in particolare quelle metaboliche, gli alimenti non sono comunque dei farmaci. L’alimentazione può forse prevenire alcune malattie ma non deve necessariamente curarle. Non è il suo scopo precipuo. Dobbiamo invece fare chiarezza sulla necessità di trovare soluzioni per produrre alimenti sicuri, di qualità e piacevoli al palato o che rispondano a specifiche esigenze di gruppi di consumatori. Non possiamo pretendere di avere l’esclusiva di questa battaglia. Potremmo avere, di volta in volta, al nostro fianco medici, nutrizionisti e veterinari, con competenze che in alcuni casi possono essere complementari a quelle nostre specifiche. I Tecnologi degli Alimenti devono però rivendicare il ruolo di chi ha studiato e conosce gli alimenti. Nel “nostro” settore la battaglia agli esperti improvvisati è, a mio avviso, un intervento da mettere in atto sempre con maggiore urgenza. Per parlare di alimenti
servono competenze ERASMO NEVIANI
Ordinario di Microbiologia Università degli Studi di Parma
COVID-19 E IMPATTO SUL COMPARTO FOOD
Gli scambi mondiali, secondo le previsioni ICE-Prometeia del dicembre 2019, erano attesi nuovamente in accelerazione, grazie a una crescita più intensa dell’economia mondiale nel suo complesso. Il 2021 era previsto poi in ulteriore miglioramento, con una variazione annua degli scambi del +3,7%. Purtroppo il fattore COVID-19 ha scompaginato completamente queste previsioni, rendendo il 2020 un anno micidiale, Questo un primo bilancio che Federalimentare riporta nel suo Bollettino periodico. Va ricordato - continua la nota - che l’economia cinese pesa ormai per quasi un quinto dell’economia mondiale. Significa che un rallentamento della sua crescita pari a un punto si traduce in un rallentamento di circa 0,2 punti di crescita del PIL mondiale, con effetti ovviamente negativi anche per l’economia italiana. Va ricordato comunque che l’economia italiana è entrata “di suo” nel 2020, prima che si parlasse di epidemie, sulla soglia della crescita zero, quindi con un forte rischio endogeno di cadere in recessione, tanto più in caso di shock. Shock che purtroppo – come si è visto - sono arrivati a febbraio e si sono via via amplificati con i progressivi provvedimenti di “blindatura” anti contagio. Anche se la filiera alimentare è stata esclusa dalle restrizioni produttive, - riporta la nota - va ribadito che il fatturato complessivo della spesa alimentare interna a rischio, e cioè quella legata al turismo, settore colpito brutalmente in prima battuta dalla crisi, è stimata in 30,5 miliardi. È dunque da prevedere un calo significativo in valore e volume dei consumi alimentari interni 2020, al di là del vistoso “effetto scorte” scattato in primis da parte delle famiglie. Si sono affacciate subito grandi difficoltà in tema di mobilità internazionale degli operatori e ne consegue il doloroso rinvio di appuntamenti fieristici fondamentali come Vinitaly e Cibus, ma l’espansione dell’epidemia a livello internazionale sembra aver esorcizzato il rischio, paventato a inizio crisi, di un danno immagine e di reputazione del Paese del sistema del Made in Italy. Tuttavia, l’effetto scia di questa vicenda sarà molto pesante e molto lungo. La crisi si scavallerà, forse, solo con l’estate. Per cui, si può prevedere che l’auspicato rimbalzo non riguarderà il secondo semestre, come sperato in un primo momento, ma sarà limitato agli ultimi mesi dell’anno. Il passo brillante del +3,0% messo a segno dalla produzione alimentare 2019, al di là dell’effetto scorte attuale, è per il momento in archivio. Anche lo stesso export alimentare, dopo il +5,2% registrato l’anno scorso, rischia non solo di appiattirsi, ma di scendere sotto la parità. Si può invece confidare in un forte rimbalzo del biennio successivo.

In chiusura di nota si sottolinea che il fatturato dell’industria alimentare, dopo essere salito a 145 miliardi, potrebbe quanto meno fermarsi, come è già avvenuto, nel corso del quadriennio 2013-2016. La piattaforma di esportazione e investimento costituita dal “Made in Italy” agroalimentare è più che mai un bene, non solo nazionale, ma mondiale. Essa rappresenta un’economia di enorme impatto che può dare un sostegno ancora migliore di quello offerto finora. E rimane il perno, la variabile indipendente dell’equazione di sviluppo dell’intero Paese.
L’Efsa ha pubblicato il suo annuale rapporto sui residui di pesticidi rilevati negli alimenti nell’Unione Europea. Il rapporto si basa sui dati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri dell’UE, dall’Islanda e dalla Norvegia ciascuno nei propri Paesi, e include risultanze sia del campionamento mirato che di quello casuale. Nel 2018 sono stati analizzati complessivamente 91.015 campioni, il 95,5% dei quali rientrava nei livelli ammessi dalla legge. Per il sottoinsieme di 11.679 campioni analizzati nell’ambito del programma di controllo coordinato dall’UE (raccolta casuale), il 98,6% dei campioni rientrava nei limiti di legge.

RIFORMA PAC
Con l’emergenza Coronavirus - si legge nel bollettino OriginInforma - la definizione del quadro finanziario pluriennale - QFP /Multiannual Financial Framework MFF, cioè il bilancio a lungo termine dell’UE, potrebbe ricadere sotto la prossima presidenza del Consiglio che sarà assunta dalla Germania a partire dal 1 luglio. Dopo il mancato accordo sull’argomento nel vertice di febbraio, durante l’ultimo incontro per videoconferenza, i capi di Stato e di Governo UE si sono concentrati sull’argomento Covid 19 e non hanno affrontato l’argomento. Ovviamente ora il QFP si colloca in un contesto economico stravolto e resta da vedere se questo indurrà gli Stati a convenire su di una maggiore spesa UE, compreso il bilancio PAC oppure se ostacolerà la loro possibilità di finanziare un maggiore livello di spesa. I prossimi vertici dei Ministri dell’agricoltura sono ipotizzati per il 20 luglio, il 21-22 settembre, il 19-20 ottobre, il 16-17 novembre ed il 15-16 dicembre.