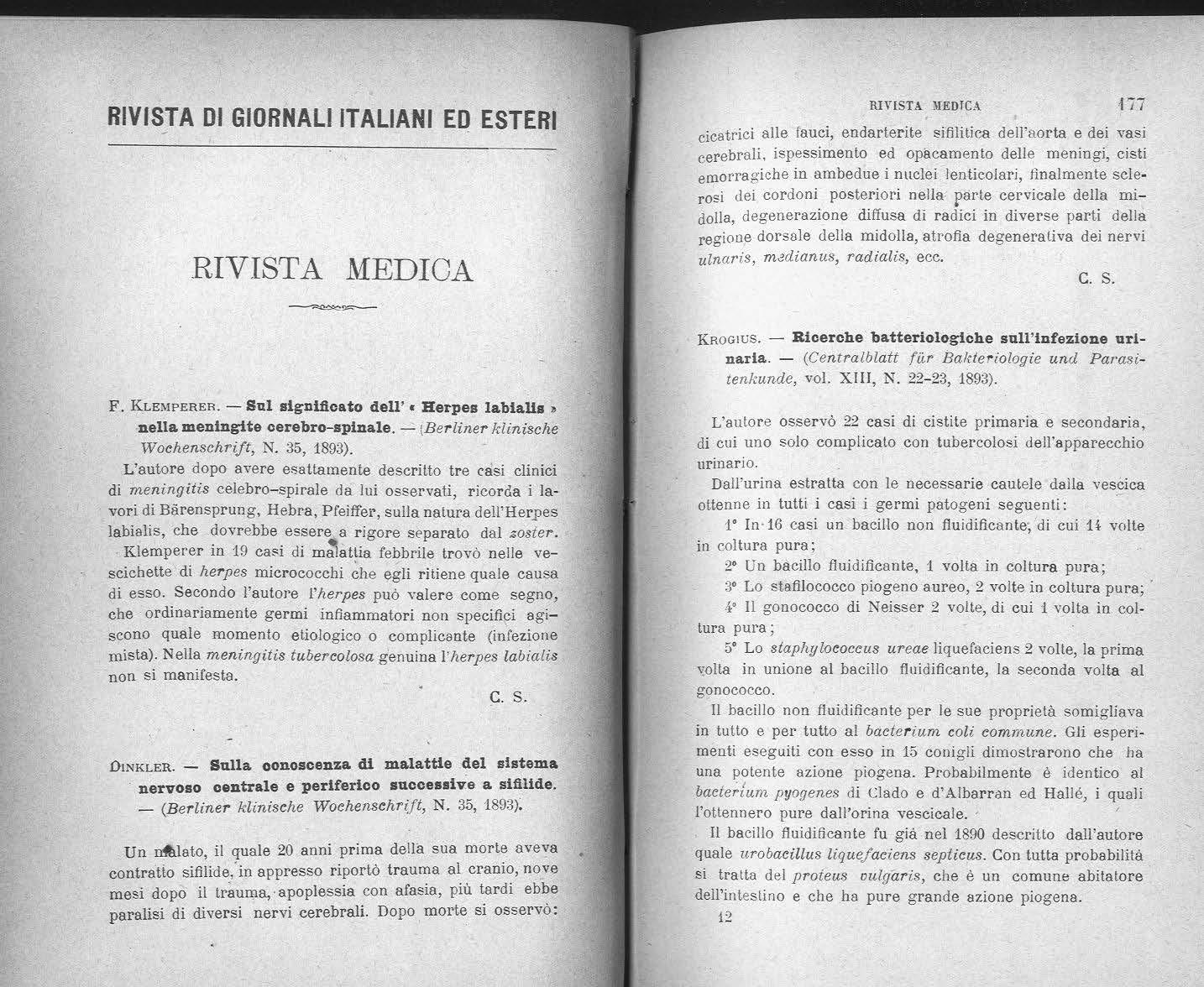
13 minute read
RIVIS _ TADIGIORNALIITALIANIEQESTERI .RIVISTA MEDICA
F. KLEMPERER. - Sul significato dell' « Herpes la.blalls i, nella. meningite cerebro-spinale. - {Berliner klinische Woehenschrift, N. 35, 1893).
L'autore dopo avere e,;attamente descritto tre casi clinici di meningitis celebro-spirale da lui osservati, ricorda i lavori di Barensprung, Hebra, Pfeifl'er, sulla nalura dell'Herpes labialis, che ~ovrebbe essere• a rigore sE>parato dal zos ter .
Advertisement
Klemperer 10 19 ca~i di malaUia febbrile trovò nelle vescichette di he rp es micrococchi ~he egli ritiene quale causa di esso. Secondo l'autore l'herpes può Yalere come segno, che ordinariamente germi infiammatori non specifici agiscono quale momento et.iologico o complicante (infezione mista). Nella meningitis tubercolosa genuina l'herpes labialis non si manifesta .
cicatrici alle fauci, endarterite sifilitica dell'aorta e dei vasi cerebrali, ispessimento ed opacamento delle meningi, cisti emorragiche in ambedue i nuclei lenticolari, tìnalmente sclerosi dei cordoni posteriori nella parte cervicale della midolla, degenerazione diffusa di radici in diverse parti della regione dorsale della midolla, atrofia degenerali va dei nervi ulnaris, midianus, radialis, ecc.
S.
KROGIUS. - Ricerche batteriologiche sull 'infezione urinaria.. - (Centralblatt fur Éakteriologie und Parasitenkunde , vol. XIIJ, N. 22-23, 1893)
L'autore osservò 22 casi di cistite primaria ·e secondaria, di cui uno solo complicato con tubercolosi dell'apparecchio urinario.
Dall'urina estratta con le necessarie cautele dalla vescica ottenne in tutti i casi i germi patogeni seguenti: ·
1° In · 16 casi un bacillo non fluidificante, di cui H volte in coltura pura;
2° Un bacillo fluidificante, 1 volta in coltura pura;
3° Lo stafilococco piogeno aureo, 2 vo lte in coltura pura; ·
4° Il gonococco di Neisser 2 volte, di cui 1 volta in coltura pura;
5° Lo staphylococcus ureae liquefaciens 2 volle, la prima volta in unione al bacillo fluidificante, la seconda volta al gonococco.
01NKLER. Sulla oonoscenza di malattie del sistema
· nervoso centrale e periferico sucoeSBlve a sifilide.
- (Be r liner klinische Wochenschr ijt, N. 35, 189:3):
Un n.4hlato, il quale 20 anni prima della sua morte aveva contratto sifilide,' in appresso r iportò trauma al cranio, nove mesi dopo il trau~a, ·apoplessia con afasia, più tardi ebbe paralisi di diversi nervi cerebrali. Dopo morte si osservò:
Il bacillo non fluidificante per le sue proprietà somigliava in tutto e per tutto al bacte r ium coli commune. Gli esperimenti eseguili con esso in 15 coni gli dimostrarono che lia una potente azione piogena. Probabilmente è identico al bacterium pyogenes di Clado e d' Albarran ed Hallé, i quali l'ottennero pure dall'orina vescicale. , i2
II bacillo fluidificante fu gia nel 1890 descritto dall'autore quale urobacillus liquefaeiens sepiicus. Con tutta probabilità si tratta del proteus oulgaris, che è un comune abitatore dell'intestino e che ha pure grande azione piogena.
1~ RITIBli
Conclusi-0ne - 1° Il più frequenle produttore dell' infezione urinaria è il bacterium coli commune.
2• Allri germi, come il proieus vulgaris, lo staphylococcus pyogenes e il gonococcus sono molto più raramente causa di cistiti.
:i0 Le urine patolo~)che, che quasi senza eccezione sono acide, il più delle volle contengono soltanto una coltura pura di uno stesso microrganismo. c. s.
11 d iab et e d ella prima. età. - DrFLOCQ E DA.NCHEZ(Journdl de Médecine et de Chirurgie, 1~93).

Gli autori hanno riferito un caso di diabete osservato in un fanciullo di 18 mesi . se il diabete. è raro nell'infanz ia, é assolutamente eccezionale al disotto dei due anni, e per dare un'idea di queste rarità, il chimico Berlioz, il quale possiede più di 20,000 analisi d"orine nei suoi archivi, non ne ha uoà sola relativa ad un <'aso di diabete al disott0 di due anni.
N<·l ca~o in discorso, il-'anciullo, il quale aveva sempre goduto buona salut~ per l'addietro; era alquanto malato da quindici giorni; egli orinava costantemente, era costipato e dimag r ava; poscia, rapidissimamente, fu colto da vomiti, quindi da coma con ipotermia e soccombette . Si è vedendolo :iel c0ma che venne l'idea del diabete, ed essendo state esaminate le biancherie nelle quali i>gli e r a avvolto neJ le ore che precedettero la sua morte , si .constatarono quasi 25 grammi di glicosio. .
Dallo studio di questo fatto e di alcuni altri consimil1 si è potuto notare, -come eziologia, l'erndità, èd ancbe l'influenza della dentizione.
Come s intomatologia, fa d'uopo mettere in prima li nea le modificazioni del csratiere, le collere, le crisi nervose nei fanciulli che per lo avanti e r ano di un naturale calmo . Si nota ~ nche la costipazione, poscia là poliuria congiunta
Medica
alla polidipsia; e questa sete, così tipica per sè stessa, è con-siderata sovente come un S<:'gno di eccell~nte appetito.
Il dimagrimento, che non manca mai, è certamente il segno -capitale pet' la diagnosi. Questo contrasto così ~vidente fra .questa denutrizione così rapida ed una alimen_tazione soddisfacente, appartiene esclusivamellte al disbete infantile. I fauciulli fonòono, per così dire, di giorno in giorno; alla fine, -sono veri piccoli scheletri.
Quando arriva il coms, esso sopraggiunge bruscamente -ed in un modo inaspettato dopo un periodo di costipazione -0stinata. Ma non sempre il coma te r mina la scena, e la morte può sopraggiungere per sfinimento, bronco-polmonia, .gangrena polmonare, ecc.
La guarigione, quantunque eccezionale , può però osservarsi .
Il d~corso della malattia è in generale eccezionalmente rapido. Nel malato di Duflocq e Danchez la durata totale è stata di quindici giorni.
Accldentl oerebrall gravi nell'indigestione. - C oRTJA L. - (Journal de Mécle c ine et de Chiru r gie, 1893).
Il dottor Cortial, medico militar e, ha, riferito due casi d 'indigestione nei quali gli accidenti cerebrali erano di una gravezza estrema. In uno dei casi, il malato, caduto senza conoscenza, si trovava in un collasso completo che e ra stato <liagnosticalo per emorragia cerebrale da un medico che non l'aveva esamina to che di passaggio. Questo stato durò quasi un intiera notte e non cedette che ai salassi ed ai clisteri purganti.
In un secondo malato, g li accidenti compa r vero nella notte, durante il sonno, e consistettero in una serie di violenti accessi eclampsici. Fu praticalo un salasso di 500 gramn1/; fu -dato in clisteri il dòralio alla dos e di ;1 grammi , e, dopo ripetuti vomiti, gli accidenti cessarono a poco a poco
Ai medici m i litari è da to d i o s servare frequentemente l'in<ligestione come una affezione a d ini zio br usc? con s intomi talvolta (1'ravi. È soprallutto durante i periodi di marcre e di mano~re che si osservano questi casi; Cortial ne ha visti due casi durante le manovre del 1890, nei quaii la perdila improvvisa della conoscenza, nel corso della marcia, ~vrebbo otuto far commettere un errore di diagnosi al medico non p . . prevenuto. ~ei casi d·indigestionP, perçi, la r esp1ra:10ne non é disturbala come nei casi di colpo di calore ed e sempre possibile anche d'assicurarsi che lo stomaco è disteso e sensibile ad una forte pressione. chiera, sibbene nel rispettivo fàzzoleUo. Lo sputo, più mucoso che purulento, conteneva grandi quantità di pneumococchi di Fraenkel.
Se i sintomi cerebrali <liminuiscono, non si deve esitare, il salasso s'impone, esso solo permette al malato di ripren - • ctere sufficientemente conoscPnza per assorbire la quantità di bevande calde necessarie a vuotare lo stomaco col vomito.
Da ciò dunque si scorge come sia necessario di racco<>"liere e disinfettare l'escreato dei polmonitici, il quale può ~iiionare una lunga serie di malattie.
Il prof: Kocher ha inoltre disposto nella sua clinica che la pulitura antisettica <lella cavita boccale faccia parte degli atti preparativi per la narcosi, allo scopo di eliminare una delle po!:'sibi!i sorgenti d·infezione.
LANZ. _ Sulla conoscenza. del « genius e pidemicus » .(Centraiblatt fiir Bakteriologie und Parasiienkunde, volume XIV, N. 9-1893).
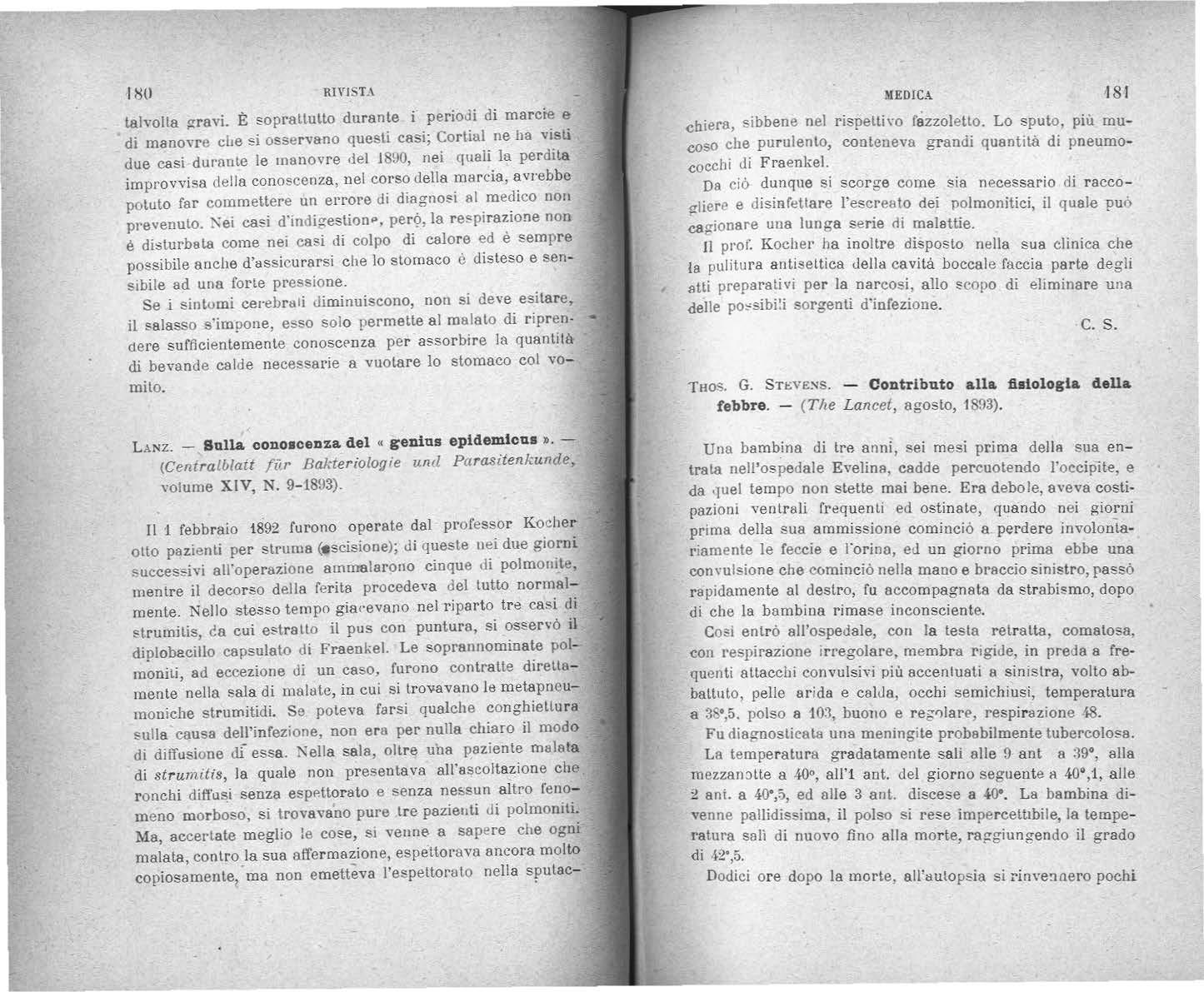
Il 1 febbraio i.892 furono operate dal professor Kocher otto pazienti per struma (•scisione); ùi queste n~i due gio.rni ~uccessivi all'operazione ammalarono cinque d1 polroo111te, mentre il deco rso della ferita procedeva del lutto normalmente. Nello stesso tempo gia<'evano nel riparto tre casi di strumitis, èa cui estratto il pus con puntura, si ~sservò il diplobecillo capsulato di Fraenkel. Le soprannomma~ polmoniti ad eccezione di un caso, furono contratte d1rellamente' nella sala di maiale, in cui si trovavano le metapncumoniche strumitidi. Se poteva farsi qualche conghiellura sulla causa dell'infezione, non era per nulla chiaro il modo di diffusione dÌ essa. ~ella sala, oltre una paziente malata di strumitis, la quale non presentava all'ascoltazion~ che r onchi diffusi senza espP.ttorato e senza nessun altro fenomeno morb;so, si trovavano pure tre pazie11ti <li polmonit i. Ma accertate megli o :e cose, si venne. a sapere che ogni maÌata contro la sua affe rmazione, espettorava ancora molto copios~mente; ma non emettèva l'espettorato nella sputac-
Una bambina di tre anni, sei mesi prima della sua entrala nell'ospedale Evelina, cadde percuotendo l'occipite, e da ,1uel tempo non stette mai bene. Era debole, aveva costipazioni ventrali frequenti ed ostinate, quando nei gio:ni prim a della sua ammissione cominciò a perdere involontariamente le feccie e !"orina, eù un giorno prima ebbe una convulsione che comin ciò nella mano e braccio sinistro, passò rapidamente al destro, fu accompagnata da str abismo, dopo di che la bambina rimase inconsciente.
Cosi entrò all'ospedale, con la testa retratta, comatosa, con respirazione irregolare, membra rigide, in preda a fre · quenti attacchi convulsivi più accen1uati a sinistra, volto abbattuto, pelle arida e calda, occhi semichiusi, temperatura a 38•,5. polso a 10:J, buono e reg0lare, respirazione 18.
Fu diagnosticala una meningite probabilmente tubercolosa.
La temperatura gradalamente sali alle 9 ant a :~9°, alla ro ezzann tte a 40°, all'1 aot. del giorno seguente R 40°,1, alle 2 ani. a 40•,5, ed alle 3 auL discese a 40•. La bambina divenne pallidissima, il polso si rese impe rcettibi le, la tempet'alura salì di nuovo fino alla morte, ral?giu ngendo il grado di 42',5.
Dodici ore dopo la morte, all'autops ia si rin\'e!laero pochi
Medica 183
tubercoli ne' polmoni, fegato, milza e reni, il cen·ello era conge'.-'lo, la dura madre aderenle alla corteccia nel punto in cui si trovavano alcuni tubercoli, nella scissura destra di RolanJo. Alla base v'era effusione purulenla nelle adiacenze della scissura di Silvio ed in tulle le altre prominenze, molti piccoli tubercoli grigi erano sparsi lungo i vasi dP.lla scissura di Sii vio, e nelle circonvoluzioni frontale e parietaleascendente di destra, cenlri molori del brac~io e deJla faccia, v'éra una concrezione di piccoli Lubercoli gialli, che occupavano un'area della grandezza di uno scudo. A sinistra, nel punto corrispondente, v·erano pochi tubercoli spar,,i. Ne' tagli del cervello non si rinvennero lesioni, finchè non si giunse ad aprire il ventricolo laterale, dopo di chè sul!&
!-Uperficie d .. l corpo striato di destra si tro,·ò un nodulo del diametro di cinque millimetri che si proiettava dentro il ventricolo. Questo nodulo era più duro che il resto del cervello~ era eviJentemente di natura tubercolosa, ma non ca~eificato, si estendeva attraverso la sostanza bianca del corpo striato incrociandosi col nucleo caudato. ~el punto più interno Je l corpo strialo sinistro v'erano due piccoli noduli simili & quello di destra; l'uno innanzi l'altro, che si proiellavano nel ventricolo, si approfolldivano per poco nella sostanza bianca. Quesli tre noduli eran9 sLreltamenle limitati alla regione dei corpi striali, e non invaJevano altre parti del cervello. Nessun'altra lesione fu rinvenuta, eccello un piccolonodulo caseoso nel cervelletto.
Secondo alcune recenti ricerche di Hale W hite, nel corpo strialo esiste un centro termogenetico, la cui lesione produce 1mmancabilmenle elevazione di temperatura, e nella part~ profonda della corteccia v'è mollo probabilmente un centro lermolassico, onde lesa la corteccia si disturba la funzione generaie termo-regolatrice e ne risulta egualmenle aumento di calore ~orporeo. Oltre a ciò , nel midollo allungalo si riconosce un centro termolitico che presiede all'abbassamento di temperatura operato dai polmoni, cute, ecc. Nel caso oresente esisteva una lesione ben definita ne i corpi striati, e. nel tessuto nervoso circostante dovevano esservi altre lesioni, lalchè i tubercoli della corteccia potevano
8 ,,er leso il potere termolassico, quanlur.que il numero dei tubercoli al di là della scissura di Rolando foS"'P piccolo. Si può quindi arguire che ii'e quest-3 alterazioni de' corpi st~iati avevano fatto salire la temperatura del corpo poco prima della morte, dovevano averlo potuto fare anche qualche tempo prima, perché i tube rcoli erano cli vecchia .lata, anteriori alla meningite che a,·eva procl<itto la morte.
Qu&ndo dunque la bambina gode"a buona salute malgrado lo sviluppo de' tubercoli, il centro tPrmola!i<sico della corteccia ed il termolitico della midolla erano ben nutrili e bene irrorati di sangue, quindi la regolazione del calore da una parte e la dispersione ùall'àltra si mantenevano in equilibrio. Allorché io seguilo, in conseguenza della meningite, il cu ore divenne debole e la nutrizione gener ale si fece insufficiente, i centri su menzionati soffrirono contemporaneamente, e non potevano più neutralizzare la accresduta produzione di calore per la lesione del centro termogenetico.
Certamente, una parte d1 <1uell'elevala temperatura spetta al processo in fiammalorio della base del cranio, ma l' ipertermia che coincise col pallore estremo del volto dev'essere attribuita alla lesione del centro tcrmolitico e lermolas>'ico, resi inetti a neutralizzare l'aumentala produzione di calore operata dal centro termogenetico.
Malattia. di Morva.n. - E1sENLOHR. - (Brit. med . Journ. S. 16 e Deut. med. Woc/t).
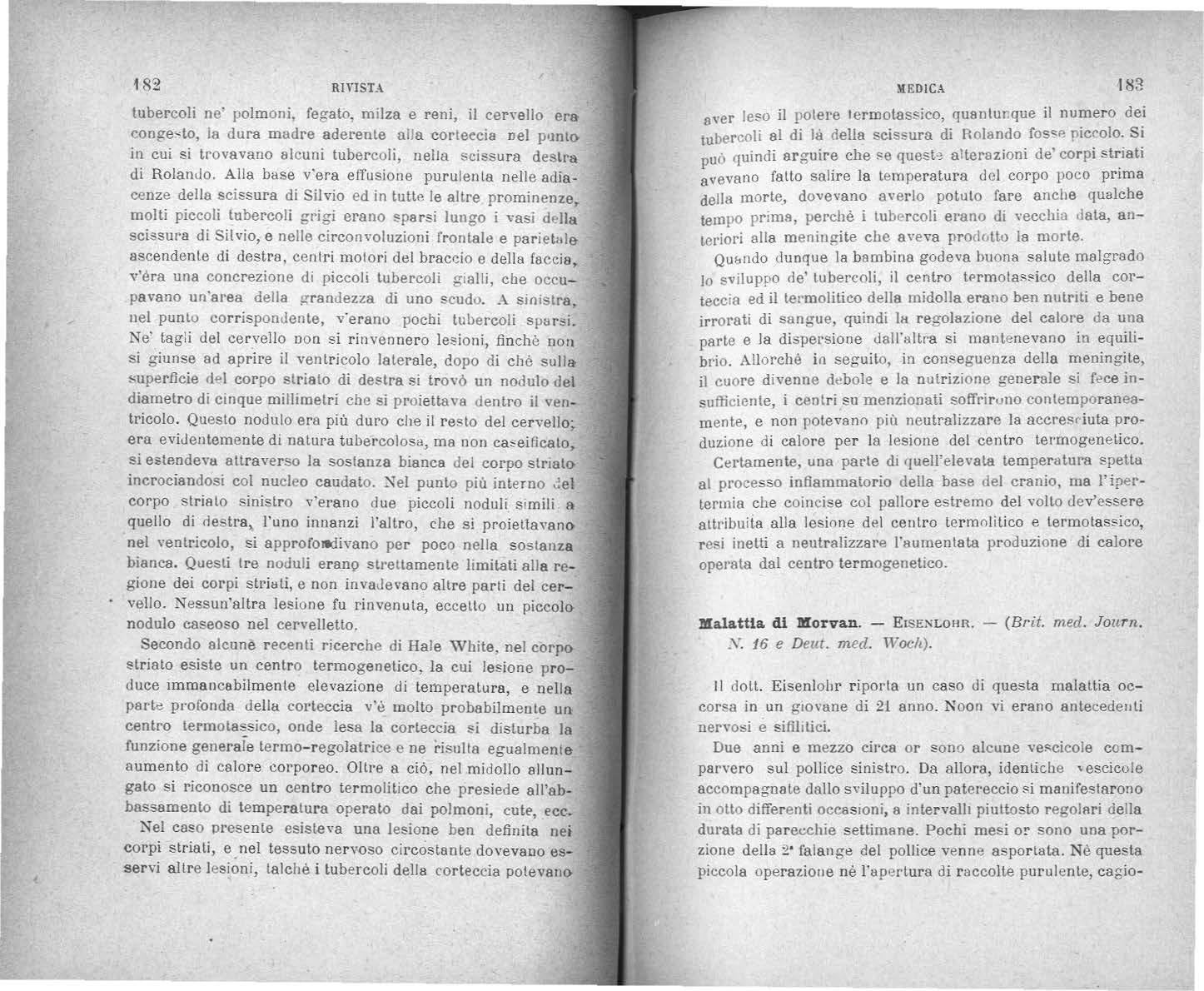
Il dott. Eisenlohr riporta un caso di questa malattia occorsa in un g10\'ane di 21 anno. Noon vi erano antecede11li nervosi e sifilitici.
Due anni e mezzo circa or sono alcune vescicole comparvero sul pollice sinistro. Da allora, identiche escicole accompagnate dallo S\'iluppo d'un patereccio ii'i manifestarono in otto differenti occasioni, a intervalli piuttosto regolari della durata di parel:chie settimane. Pochi mesi or sono una porzione della 2' falange del pollice venne asportata. Nè questa piccola operazione nè l'ap ertura di r accolte pu r ulente, cagio-
Medica 185
narono alcun dolore. L'ultimo sviluppo delle bolle fu doYuto ad un tentativo di lavoro. Le unghie di tre dita caddero durante quest'ultimo attacco. Del tutto recentemente una vescicola è comparsa sul pollice destro. Attualmente unitamente a queste boìle esiste leggiera paresi del braccio sinistro. Non vi è denutrizione e le reazioni elettriche sono normali. Il riflesso del tricipite sinistro è !<bolito. Su tutto quanto il braccio sinistro e le adiacenti parti del torace, le sensRzioni di caldo e freddo come quelle di <lolore sono alterate. Il senso tau.ile è intatto tranne nella mano. La sensibilità farado - cutanea è anche in diminuzione. Una lieve diminuzione della sensibilita è stata pure notata di recente nella mano destra. Alle gambe i riflessi profondi !"Ono più accentuati a sinistr·a e i superficiali più a destra . In seguito ad un'iniezione di pilocarpina il sudore fu molto meno profuso dal lato sinistro della faccia. Non vi è diminu zione del campo visivo. I sintomi di questo caso sono quasi certamente dovuti a siringomielia .del midollo cervicale. In alcuni casi sono state notate alterazioni dei nervi periferici, ma c:ò non potrebbe spiegare tutti i sintomi.. Il cambiamento notato nei riflessi parla in favore d'una Je;:ione spinale. S 'ignora tutt'ora perchè ~!cuoi ca!'i di gliomatosi spinale e di siringomielia debbano avere le apparenze della malattia di Morvan . •
G. G.
Sulla. etiologia. del colpo di oalore. - RosSBACH. - ( Deuts. militiiriirzt. Zeitsch. e Ccnfralbl . .rur die medie. Wissensch., N . 43, 1893).
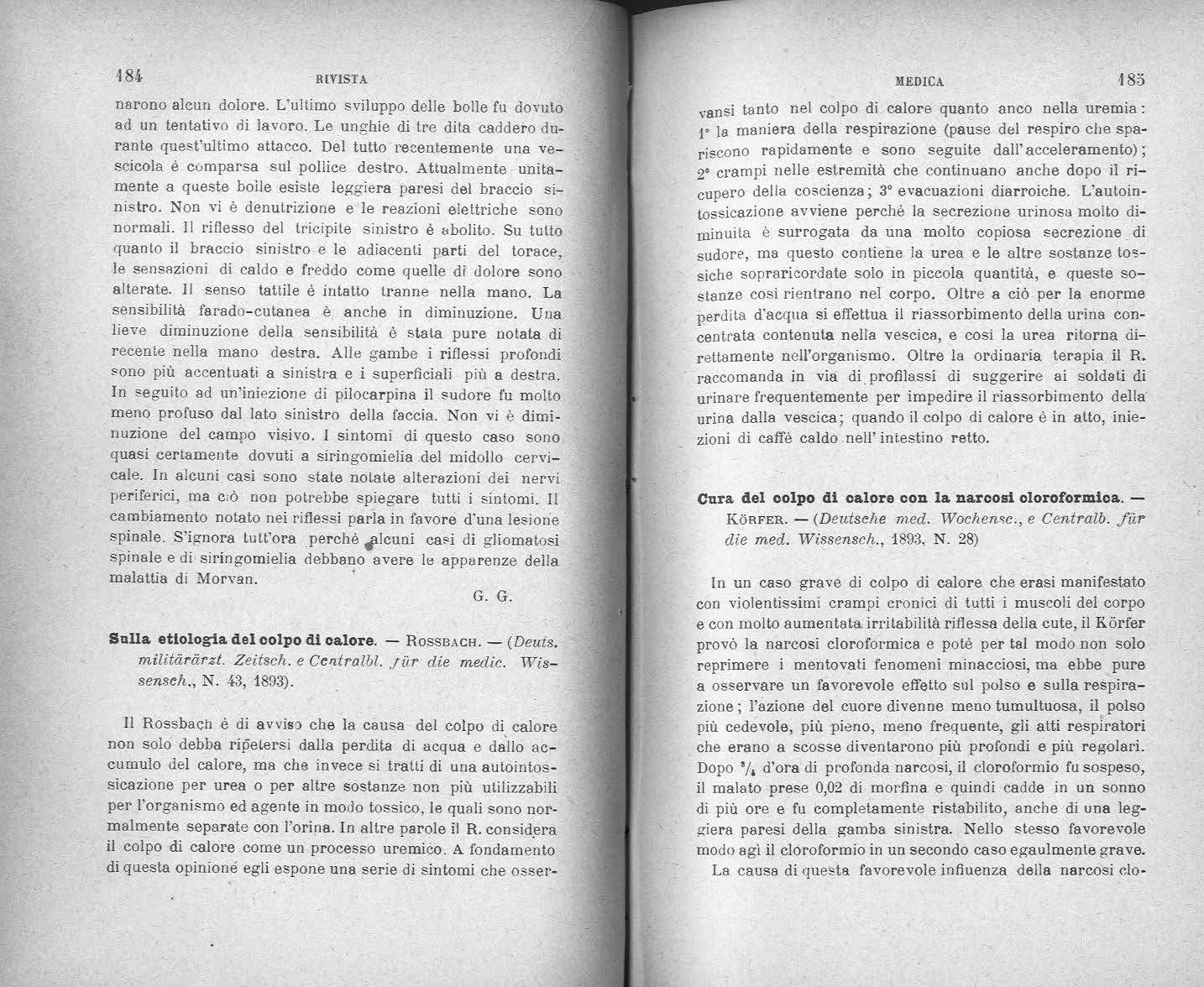
11 Rossbach è di av viso che la causa del colpo di calore non solo debba ripetersi dalla perdita di acqua e dàllo accumulo del calore, ma che invece si tratti di una autointossicazione per urea o per altre sostanze non più utilizzabili per l'organismo ed agente in modo tossico, le quRli sono normalmente separate con l'orina In allre parole il R. consid.era il colpo di calore come un processo uremico. A fondamento di questa opinioné egli espone una serie di sintomi che osser- vansi tanto nel colpo di calore quanto anco nella uremia:
1· la maniera della respirazione (pause del Mspiro che spariscono rapidamente e sono seguite dal!' acceleramento);
2• crampi nelle estremità che continuano anche dopo il ricupero della coscienza; 3° evacuazioni diarroiche. L'autointossicazione avviene perché la secrezione urinosa molto diminuita è surrogata da una molto copiosa secrezione . di sudore, ma questo contiene la urea e le altre sostanze tossiche sopraricordate solo i.n piccola quantità, e queste sostanze cosi rientrano nel corpo. Oltre a ciò per la enorme perdila d'acqua si e ffettua il riassorbimento della urina concentrata contenuta nelfa vescica, e così la urea ritorna direttamente nell'organismo. Oltre la ordinaria terapia il R. raccomanda in via di. profilassi di suggerire ai soldati di urinare frequentemente per impedire il riassorbimento della urina dalla vescica; quando il col po di calore è in atto, iniezioni di caffè caldo nel!' intestino retto.
Cura. del colpo dl calore con la na.rcosl oloroformlca.KoRFER. - (Deutsche med Wochen~c., e Cerdralb fùr die med . Wissensch., 1893, N. 28)
In un caso grave di colpo di calore che erasi manifestato con violentissimi crampi cronici di tutti i muscoli del corpo e con molto aumentata irritabilità riflessa della cute, il Kort'er provò la narcosi cloroformica e poté per tal modo non solo reprimere i mentovati f,momeni minacciosi, ma ebbe pure a osservare un favorevole effetto sul polso e sulla respirazione; l'azione del cuore divenne meno tumultuosa, il polso più cedevole, più pieno, meno frequente, gli at.ti respiratori che erano a scosse diventarono più profondi e più regolari. Dopo •;, d'ora di profonda narcosi, il cloroformio fu sospeso, il malato p r ese 0,02 di morfina e quindi cadde in un sonno di più ore e fu completamente ristabi lito, anche di una leggiera paresi della gamba sin istra. Nello stesso favorevole modo agì il cloroformio in un secondo caso egaulmeole g rave. La causa di questa favorevole influenza della narcosi do- roformica, secondo il K. de riva dal folto che la soverch'a eccitabilità dei gangli cardiaci provocata dal san/!ue soprariscaldato é abbassata dal cloroformio, !'atti vita del cuore calmata e il muscolo cardiaco posto in condizione di riaversi dalla sua eccessiva fatica In questa maniera è evitata la minacciante paralisi cardiaca. Inoltre il cloroformio opera anche come calmante sugli altri centri nervosi fortemente irritati e c osì reprime le violente convulsioni che d al 101·0 canL0 ~ono una sorgE::nte di ecce:::siva produzione di calore. In terzo luogo é pure da considerare razione deprimente del cloroformio sulla temperatura che si può osservare in ogni ol'dinaria narcosi. Finalmente in un narcotizzato possono più facilmente essere impiegati gli ordinari mezzi di ralfreddam·~nlo che in un altro uomo che giace privo di coscienza, del quale, per la aumentata irritabilita riflessa i più piccoli toccamenti des·t,rno convulsioni.
M. ScHùLLER. - Ricerc h e sull'eti olog ia. del reumatis m o articola re cro nico . - (Sunto di K. Muller) - (Centralblattfar Bak teriologie und Paras ite nkunde, vol. X IV, N. 19, 1893). e
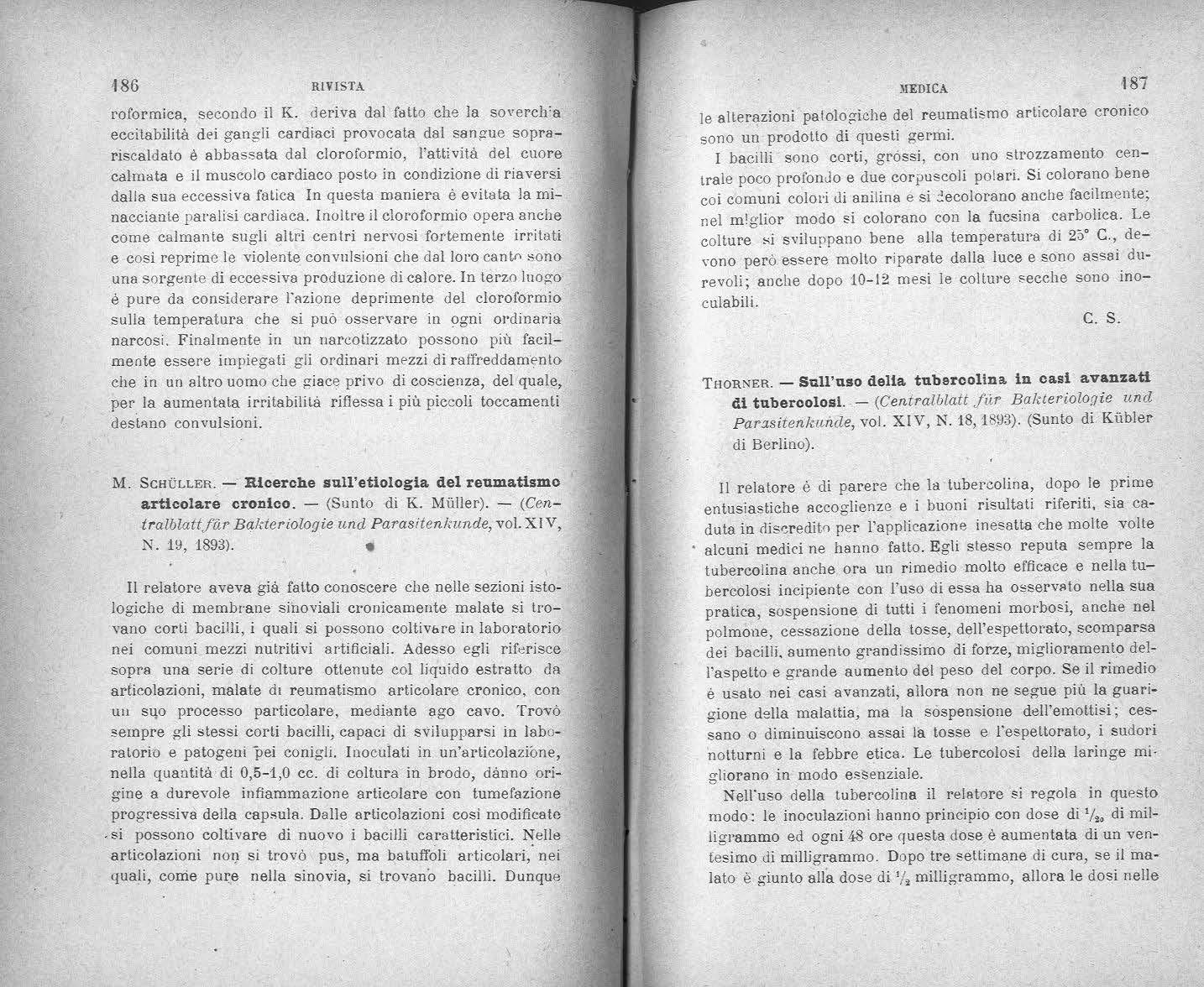
Il relatore aveva gia fatto conoscere che nelle sezioni istologiche di membrane sinoviali cronicamente malate si trovano corti bacilli, i quali si possono coltivbre in laboratorio nei comuni mezzi nutritivi artificiali. Adesso egli riferisce sopra una serie di colture ottenute col liquido estratto da articolazioni, malate d1 reumatismo articolare cronico, con uu sqo processo particolare, mediante ago cavo. Trovò sempre gli stessi corti bacilli, capaci di svilupparsi in laboratorio e patogeni j:>ei conigli. Inoculati in un'articolazione, nella quantità di 0,5- 1,0 cc. di coltura in brodo, danno .origine a durevole infiammazione articolare con tumefazione progressiva della capsula . Dalle articolazioni cosi modificate . si possono coltivare di nuovo i bacilli caratteristici. Nelle articolazioni 1101) si trovò pus, ma batuffoli articolari: nei quali, come pure nella sinovia, si trovano bacilli. Dunque










