




UFFIC IO STORICO
ROMAIN Il. R.AINERO

DELL'ESERCITO ITALIANO
NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE ("LE FRECCE ROSSE")
ROtvTA 2007

La storia della seconda guerra mondiale e dell'impegno in essa delle forze armate italiane è oramai conosciuta nelle sue grandi linee, specialmente per quanto riguarda la narrazione delle vicende belliche sui vari fronti, non ultimo quello nord africano. Riguardo a questo ultimo, l'importante serie di volumi ad esso dedicata annoverava, quasi vent'anni fa, oltre ottanta volumi tra pubblicazioni ufficiali, memorialistica e opere generali . Da allora il Loro numero è di molto cresciuto. Pur tuttavia, in questa pletora di pubblicazioni, non è molto noto , o addirittura è ignoto quasi a tutti, che, nella fase più cruenta della seconda guerra ,nondiale, e cioè nell'anno 1942, il Comando Supremo itali ano decise di c reare, di sana pianta , e quasi sul modello del britannico "Long Range Desert Group ", alcuni reparti del tutto innovativi nella storia militare italiana: reparti di volontar; guastatori arabi, italo - tunisini e indiani, reparti da gettare nella mischia dell'allora in.certa battaglia ai confini tra la Cirenaica e l'Egitto . Una s{ffatta decisione che avrebbe coinvolto alcune migliaia di militari si ins eriva nella spasmodica ricerca di garantire nelle difficili condiz ioni ambientali nelle quali le forze armate italiane stavano operando, un apporto nuovo e valido, sia per trattare con le popolazioni arabe coinvolte nel conflitto, sia per rùpondere con. azioni di sabotaggio nelle retrovie inglesi del Medio Oriente alle minacce che le forze armate del Commonwealth stavano strutturando dopo le loro prùne sconfitte nordafricane . La storia di questi quattro"Centri Militari Speciali"non ha mai trovato ftnora citazion; e r(ferimenti e pertanto la presente ricerca si pone l'ambizioso progetto di dare, anche a loro riguardo, qualche lume di una storia che tragicamente si concluse, nel maggio 1943, nella resa di Capo Bon.
 Col. Matteo Paesano
Col. Matteo Paesano

Senza alcun dubbio non vi è, nella storia ,nilitare italiana, un reparto tanto particolare quanto ancora poco conosciuto come il Raggrupparnento Centri Militari e le unità che ne hanno fatto parte o ne hanno tratto origine .
Si deve ciò a molteplici ragioni: all'esiguità degli uoniini che ne hanno fatto parte, ai compiti estremamente riservati che lo hanno caraueriz zato, alla particolare e dive rsi ss ima provenienza delle componenti dei reparti, alla scarsissima documenta zione che è sopravvissuta alle vicende belliche, e persino, lo dico per esperienza diretta avendo intervistato, nel tempo, numerosi comandanti e appartenenti al reparto, per una sorta di ritrosia a raccontare la loro esperienza, dovuta al sentirsi ancora vincolati, pur dopo decenni, al parti co lare segreto che erano stati chiamati a mantenere sul reparto, sui suoi compiti, sulle tecniche operative e sulle a z ioni compiute .
Eppure quella delle " Frecce Rosse", dizione peraltro mai resa ufficiale dallo Stato Maggiore ma divenuta comune tra gli ex-appartenenti e gli studiosi, è una storia davvero affascinante proprio per via della così particolare composizione del reparto, nel quale erano confluiti non solo italiani nati o vissuti all'estero, ma anche volontari arabi ed indiani, che avevano accettato di combattere nei ranghi del Regio Esercito Italiano per la liberazione delle loro terre dal dominio degli ingl esi e dei francesi .

In realtà la presenza di unità straniere nelle for z e armate italiane non poteva certo dirsi una novità al momento della costitu zione dei tre Centri Militari, poi confluiti nel Raggruppamento omonimo quando si volle dare unicità di comando e di azione alla struttura.
A parte i numerosissimi volontari stranieri che avevano preso parte indi vidualmente alle nostre guerre di indipendenza ( valga per tutti il nome di Stefano TURR, ungherese, volontario garibaldino e poi tenente generale del Regio Esercito) non si può dimenticare la divisione cecoslovacca, che combattè inquadrata nella 9a Armata nella battaglia di Vittorio Veneto.
Stranieri erano i nostri reparti coloniali che si batterono con fedeltà e onore davvero sino alla fine; libici, eritrei, etiopici, somali, ma
anche yemeniti, che in notevole numero accorsero sotto le nostre bandiere .
E per restare alla seconda guerra mondiale si possono ricordare non solo gli albanesi, dei quali è stata raccontata la vicenda in una pregevole opera dell'Ufficio Storico dell ' Esercito , ma anche i russi del Gruppo Cosacchi "Savoia", gli sloveni e i dalmati della MVAC (Milizia Volontaria Anti -Comunista), costituita per compiti di antiguerriglia nell'area di SUPERSLODA, ed infine i militi della valorosa Legione Croata che, inquadrata nella Mili z ia, prese parte alla campagna di Russia e finì distrutta sul Don.
Ma la vicenda dei reparti arabi e indiani è del tutto particolare poiché non ha avuto solo un mero aspetto militare ma è andata ad intrecciarsi continuamente con aspetti politi c i e diplomatici che han.no avuto origine nei decenni precedenti , per giungere sino agli anni della guerra, con vicende sempre altalenanti e situazioni che, ancora una volta, per quel che riguarda specificamente i reparti speciali italian i, a fronte di tante buone intenzioni, non consentirono di portare a compimento l'opera per cui erano stati costituiti.
E' stato così, infatti , anche per queste particolari unità che, pur di limitatissima consistenz a , se viste nel quadro generale dello sforzo bellico italiano, avrebbero comunque potuto rappresentare uno strumento di qualche efficacia ed utilità ove impiegate effettivamente nei compiti di guide e informatori, di ricogniz ione a largo raggio, di propaganda e di sabotaggio che avrebbero potuto svolgere nei Paesi di origine o di elezione

Man cò , invece, una politica adeguata e lungimirante, da parte del Gov erno fascista, che pure godeva di vastissime simpatie nel mondo arabo, e musulmano in generale, ed in quello indiano, nel progra,nmare e sviluppare una concreta e tempestiva a z ione in proposito.
Ma se per l'India risultavano ovviamente determinanti la incolmabile distan za jìsica e le difficoltà delle comunicazioni, che facevano sì che solo i giapponesi potessero concretamente giocare una valida partita con i politici indiani jìlo-Asse, in primis Subhas Chandra Bose , per quanto riguarda il Vicino ed il Medio Ori ente ed il Maghreb l'Italia fascista non seppe preparare per tempo il terreno né sul piano politico-diplomatico, né su quello militare.
Fu, anzi, a lungo in bilico, coma ha notato Renzo De Felice nel suo pregevole saggio "Il Fascismo e l'Oriente", dibattuta tra l'appoggio ai palestinesi e quello agli ebre i che si battevano per il loro 'focolare " ; e quando poi il regime finì per farsi trascinare nell'avventura
dalla Germania, tanto da emanare anche le spregevoli leggi ra zz iali, e di conseguenza scegliere decisamente il campo arabo, si era oramai troppo a ridosso del conflitto e di tempo ne era rimasto ben poco.
Furono così. i tedeschi a prendere per tempo concrete iniz iati v e nei riguardi dei tanti, anche autorevoli, personaggi del mondo m.usulmano che si muovevano in aree come i Balcani, il Vicino e Medio Oriente ed il Nord-Africa, tradi z ionalmente di maggiore influen za italiana.
E così, come all'atto dell'intervento a favore del Primo Ministro iracheno Rach.id El-Ghailani, c he si era ribellato agli inglesi, Italia e Germania si mossero in modo del tutto scoordinato, così anche con il Gran Muft i di Gerusalemme e con la resistenza araba anti-inglese ed an.ti-francese i due alleati dell'Asse si mossero altrettanto scoordinati, ed anzi in neppur tanto larvata rivalità, per il co ntrollo delle azioni politiche , diplomatiche e militari nel settore.
Chi ebbe la meglio furono sicuramente i tedeschi, più determinati sia dal punto di vista diplomatico che da quello militare; e d'altronde l'Italia pagava anche una co ntraddizione di fondo: come poteva essere realmente considerata una paladina dell ' indipendenza dei Pa es i arabi e musulmani se non c hiariva , essa per prima, la propria posizione nei confronti del futuro della Libia e le mai sopite aspira z ioni a soppiantare i francesi nel ruolo di protettori della Tunisia e persino gli ingl esi nei riguardi dell'Egitto?
L'avanzata del 1942 verso Alessandria parve, finalmente , dare l ' agognata possibilità a coloro che, a Palazzo Chigi ed a Via XX Settembre, avevano creduto nella operazione c he subì, quindi, una improvvisa accelera z ione tanto che lo stesso Mujii, assierne al reparto Missione Speciale del Raggruppamento, si preparò a partire per la Libia e l'Egitto, che pareva ormai a un passo dalla conquista

Ma la battaglia di El Alamein capovolse le sorti della guerra e da lì iniziò la ritirata degli italo -tedeschi verso la Tunisia; e verso la fine del sogno africano.
I volontari indiani si anunutinarono e preferirono tornare alla più comoda posizione di prigionieri di guerra piuttosto c he partecipare al ventilato impiego come fanteria al fronte .
Il Comando del Raggruppamento fu inviato precipitosamente in Tunisia per coordinare la costituzione del Reggimento Volontari Tunisini, traendo gli elementi dalla patriottica e numerosa locale comunità italiana
Anche il comando e due compagnie del Battaglione d ' Assalto "T"
finirono egualmente distrutti , nella breve ma durissima campagna tunisina , impiegati come unità di fanteria e non come arditi speciali zza ti in operaz ioni speciali.
Solo un plotone esplorante del Battaglione "T" ed uno del Gruppo Forma zioni "A", questo ultimo montato sulle camionette desertic he che avrebbero dovuto servire da avanguardia esplorante verso Alessandria, riuscirono a svolgere, in Libia e Tunisia, quelle attività per le quali erano stati costituiti; ma fu ben poca cosa nel quadro general e d e lla campagna.
Pochi singoli appartenenti al Gruppo Formazioni " A " furono aviolanciati per svolgere missioni informative in Medio Oriente , assieme a volontari arabi, o in operazioni di sabotaggio in Nord-Africa, aggregati a pattuglie del 10° Reggimento Arditi .
Anche per i volontari arabi e per gli italiani, in gran parte raga zz i della Gioventù Italiana del Littorio all 'Estero, s orpresi dallo scoppio della guerra nei collegi della GILE dove erano stati mandati a studiare, si ve rificò la nemesi dei reparti speciali italiani.
Come per i battaglioni "Nuotatori" e "Paracadutisti" della Regia Marina e per i battaglioni "Paracadutisti", "Distruttori" e "Riattatori" della Regia Aeronautica, nati per la prev ista e mai attuata occupazione di Malta, come per i paracadutisti della "Folgore", distrutta come semplice fanteria nel deserto egiziano, e quelli della "Nembo", rimasti a presidiare la Sardegna in attesa di un improbabile sbarco alleato, così anche i preparatissimi e motivatissimi specialisti delle Frecce Rosse conclusero la loro breve storia combattendo, per la maggior parte, come fanti .

In realtà la storia delle Frec ce Rosse non ebbe fine con la resa dell 'Armata italiana in Tuni sia; gli arabi della Missione Speciale e i loro quadri italiani, rimasti acquartierati nei dintorni di Frascati come guardia di un Mufti sempre più vicino ai tedeschi,furono determinanti nei soccorsi alla popolazione della cittadina, pesantemente bombardata, l'8 settembre del 1943, dagli alleati che miravano alla sede di comando del maresciallo Kesselring.
E gli italiani del Battaglione d'Assalto Motori zz ato, che aveva riunito i reparti del Raggruppamento Centri Militari sopravvissuti alla disfatta africana, si scontrarono con i tedeschi , tra 1'8 e il 10 settembre, in varie zone attorno e dentro Roma.
Furono tanti g li uomini del battaglione a cadere sotto il fuoco dei paracadutisti tedeschi , eppure nes s una lapide, nessuna scritta ricorda, nella città, l ' eroismo e il sacrifico di questo reparto che , rimasto senza
disposizioni, si presentò d'iniziativa al generale Solinas a Porta San Paolo per porsi ai suoi ordini e andare subito dopo all'attacco con le camionette della compagnia d'assalto e la bandiera del "I O Wahda" spiegata e trafitta dai colpi delle mitragliatrici tedesche.
Bandiera che i superstiti recuperarono dalla camionetta del comandante di compagnia, distrutta da/fuoco nemico, conservarono gelosamente durante l'occupazione tedesca di Roma, e che la vedova del comandante rni ha fatto l'onore di consegnarmi perché la conservassi a memoria del reparto e del suo eroismo.
Restano ancora da scrivere queste pagine di eroismo, come è ancora da ricordare adeguatamente che il reparto rimase compatto, nel marasma di quei giorni, ben oltre il 10 settembre, e solo quando il comandante del battaglione lo sciolse ufficialmente, consegnando a ciascun soldato una regolare licenza illimitata ed una somma di denaro, gli uomini presero ciascun.o la propria strada .
Ognuno fece la sua personale scelta, dffficilissima in quei momenti, tanto più per raga zz i che avevano, per la maggior parte, le famiglie in paesi lontani, spesso internate in Egitto e in quei Paesi dove erano nati o vissuti ma che erano sotto controllo alleato .
Fu un vero dramma che vide le Frecce Rosse scegliere le vie più diverse: molti furono arruolati nei Servi zi informativi tedeschi, che ne apprezzavano la preparazione militare e la conos ce nza delle lingue; diversi di loro finirono così fu.cilati dagli anglo -americani dopo essere stati catturati nel corso di missioni oltre Le linee o nei luoghi dove si erano occultati con le radio trasmittenti per farsi superare dagli alleati e iniziare l'attività informati va .
Vi fit poi chi operò con gli in glesi del Field Security Service, chi raggiunse il Regio Esercito al sud, chi si arruolò nell'Esercito Repubblicano al nord e vi fu anche chi finì trucidato alle Fasse Ardeatine; un.o spaccato dell'Italia del 1943/1945, con. i suoi immensi drammi.
Eppure una parte del battaglione continuò a vivere anche dopo lo scioglimento ufficiale del reparto; la compagnia camionette d'assalto, in.fa tti, per iniziativa di un ufficiale che ho avuto l' onore di conoscere, rimase in armi e si presentò al comando della Polizia dell'Africa Italiana, incaricata del mantenimento dell'ordine nella Città Aperta di Roma, al completo dei propri mezzi, evitando così che cadessero nelle mani dei tedeschi; si deve a costoro se le camionette sopravvissero sino all'arrivo degli alleati per venire poi regolarmente consegnate alla polizia italiana che le impiegò sino agli anni '50 nei reparti ,nobili .

E fu proprio un intero equ ipaggio composto da ex -Frecce Rosse, ormai PAI, a perdere la vita quando, la sera del 4 giugno 1944, la loro camionetta fu colpita per errore, in Via Nazionale, da un carro Stuart americano, mentre svolgeva i propri comp iti di sicurezza facendo la spola tra le truppe tedesche e della RSI in ritirata e gli aniericani in fase di ingresso a Roma.
Storia affascinante, quindi, quella dei reparti arabi e indiani, o,forse meglio, italo -arabi e italo -indiani del Regio Esercito; una storia che il prof. Rainero ha, con questo volume, compiutamente delineato nei suoi aspetti diplomatici, politici e militari, lasciando il lettore affascinato dalla larga messe di informazioni, dati e notizie sinora frammentate e che, con questa opera, prendono finalmente concreta e completa forma.
Un volume davvero interessante dove si rivive, con emozione, il clima creatosi attorno a coloro che credeva.no nella bontà di un progetto che avrebbe potuto dare, se sviluppato coerentemente e per tempo, buoni frutti per la politica dell 'Asse, e dell'Italia in particolare, verso arabi e indiani;
Un volurne dove emergono e si intrecciano complesse vicende politico-militari e sottigliezze diplomatiche, visioni estremamente lungimiranti e azioni velleitarie, idealismi e basse rivalità, professionalità e impreparazione
Un libro che studiosi e appassionati di storia militare attendevano e leggeranno quindi con grande interesse anche perché i popoli di cui parla e le vicende di cui tratta sembrano _ davvero di un.a incredibile attualità.

Si pensi solo alle odierne vicende palestinesi o al fatto che quel Waziristan., dove l'ambasciatore Quaron.i si muoveva, nel pieno della guerra, per con.vincere i capi -tribù locali a dare il loro appoggio a.il 'Asse nella lotta contro il comune nemico inglese, è lo stesso Waziristan dove si dice si nascondano, oggi, protetti dalle medesime tribù guerriere, Osama Bin Laden e gli uomini di Al Qaida.
Sarà, infine, questo interessantissimo volume, anche la base per un ulteriore studio sugli sviluppi, stavolta solo tecnico-militari, dell 'attività che i volontari italo-arabi hanno condotto successivamente al crollo delle speranze che li avevano portati a vivere l'avventura delle Frecce Rosse .
Sergio MURANel panorama com plessivo della storia contemporanea dell'Italia si pu ò dire che molto appare g ià noto e pubbli cato a propos ito della partecipazione dell ' Italia alle operaz ioni mi litari nella seconda guerra mondiale . Questo vasto insieme di st udi può fare ritenere c he molte zone della stor ia degli anni del confli tto s ian o s tate es plorate con test imonianze, stud i e documentazioni che formano un patrimo ni o importante delle conoscenze che si possono avere a questo riguardo . Invero , i più di sessanta ann i c he sono trascorsi dalla fine della gue1n ad oggi , hanno visto un alternarsi di motivi di interesse della ricerca ed un contrastato modo di scrivere. D opo anni e anni dal conflitto, ci si trova di fronte ad una storia obiettivamente tra le più controverse, sia per le vicende politiche nelle qu ali essa s i è s nod ata, sia p er le vicende s pecifiche militari che hanno v is to l ' Italia impegnata ne l co nflitto. I fronti di g uerra con i loro alterni sviluppi, le me mori e de i principali protagonisti, le ma gg ior i battaglie e le ingent i pole mic h e politiche e mili ta ri di vario tipo hanno dato agli storic i ampia materia di rifl ess io ne con p rese di posizione alterne e spesso contrapposte ed in questa storia gli archivi pubblici, priva ti e m ili tari sono stati molto s pesso al centro delle più varie ricerche .
Oggi si può d ire che la conoscenza s pecifica dell'andamento delle battaglie e dei presupposti politici e tecn ic i che ne hanno condizionato, non poco, gli esiti sono mediamente noti e, se la storia mili tare ha potuto spesso coniugars i con la sto ri a politica e diplomatica, non so no venuti meno l ' impegno e l'ev idente interesse a ri costrui re l'insieme della storia cieli ' Italia ne lla s econda g uerr a mondiale a nche a partire di nuovi sp unti di ric erc he. Pe r ese mp io l 'i mportante incidenza dell e varie vicende politiche interne d ell 'Italia s ull ' opinione p ubblica con la fase d e lla 'non belligeranza' alla quale doveva seguire quella d ella par tecipazione alla guerra, ne ll'ambito de ll' A sse, e quindi l'intennezzo badogliano, l ' armistizio e fi nalme n te , la cobelligeran-

za con le Nazioni Unite. Tutti si sono rivelati elementi fondamentali nello studio della storia di un conflitto che , in meno di quattro anni , ha stravolto regimi ed istitu z ioni. Un elemento importante di quella guerra è stato l'aspetto ideologico che lo ha attraversato e dominato con ritmi di crescente incidenza su lle stesse operazioni militari. E così il progetto di Nuovo Ordine Mondiale che il regime fascista lanciò, quasi alla vigilia del conflitto , sta diventando motivo di rinnovata attenzione di una intensa attività di progettazione, quasi la vicenda bellica combattuta con le armi fosse sicuramente destinata ad essere soltanto una parentesi breve e vittoriosa, anticipazione necessaria ad una vera rivoluzion e geopoli tica mondiale nella qual e i vincitori, cioè l'Asse, avreç,bero potuto pienamente inserire le proprie volontà. Altrettanta novità si veda l'attenzione che sta nascendo a proposito della partecipazi one alla "guerra italiana" di truppe o reparti non italiani, che vanno dai gruppi libici sahariani ai battaglioni eritrei i quali però agiscono sempre al se rvizio de lle direttive poli tiche e militari italiane e non esprimono in alcun modo esigenze politiche legate alla loro na• I tura etnica . Poca o nulla è stata invece l'attenz ione che si é rivolta alla storia di militari di gruppi paralleli , gruppi cioè che combattevano una guerra italiana accanto alle forze armate dell'Italia, ma che avevano obiettivi politici ben distinti, del tutto autonomi. Pe r la regione balcanica, le forma z ioni militari indigene con queste caratteristiche sono s tati evocate, qua e la, in alcuni studi recenti; la ricerca di Marco Cuzzi riguardo all ' occupazione militare italiana della Slovenia rimane segno emblematico di una ricerca ancora da completare per l 'intera regione balcanica dove vel leità autonomistiche e ambizioni nazionalistiche fecero fiorire iniziative militari di notevole interesse 1 • Altrettanto abbando nati sono stati gli stud i nella regione mediterranea, st udi relativi a talune volontà militari, o "velleità militari", che , da parte dei nazionalisti arabi, hanno dato lu ogo a formazioni militari parallele patrocinate da Berlino o da Roma, chiamate ad ope rare nel1' ambito dell'Asse per raggiungere fini del tutto propri , per lo più connessi ad una confusa decolonizzazione anti-inglese o anti-francese e ad una generica volontà di indipenden za nazionale.
Per quan to riguarda il caso dell ' Italia, va eletto che tale studio appare difficile anche perché esso si rivela subito denso cli equivoci e cli

inganni, a cavallo tra problemi politici ed esigenze militari . Gli equivoci a tale riguardo non mancarono. Prima di tutto, va sottolineato il fatto che l'entrata in guerra dell'Italia co in cideva quasi con la vecchia vicenda della "vittoria mut ilata" , che risaliva alla prima Grande Guerra, ed anche a quella speranza, dopo il sic uro esito vittorioso dell 'eventuale co nflitto, che si riassumeva nella real izzazione delle cosiddette "rivendicazioni", che il ministro degli Esteri, Cia no chiamò, nella memorabile seduta della Camera dei Deputati del 30 novembre 1938, le "naturali aspirazioni del popolo italiano". Il tutto veniva condito , in una versione che si voleva innovativa ed integrata , con l'idea di un 'Nuovo Ordine ' che, dal 1938 in avanti, ossessionava l'opinione pubblica italiana e specialmente l'opinione ufficiale del regime quanto al futuro delle relazioni internazionali. P er questi motivi, di questo progetto del Nuovo Ordine Mondiale appare necessario esaminare i molteplici aspetti in quanto la sua stessa natura rivela in modo evidente il fine della politica di Mussolini ed i non pochi condi zionamenti che l ' Italia dovette subire anche per quanto riguardò la condu zione militare della guerra. L'elemento centrale del programma enunciato dal fascismo risiedeva nel fatto che, pur nel disordine delle proposte, l'insieme dei suo i propositi rinviava necessariamente agli elementi che ne dis ponevano 1' attua zione e si collegavano ai due uni ci protagonisti: l ' Italia fascista e la Germania hitleriana. Roma e Berli no sarebbero diventati così i due perni attorno ai quali doveva ruotare l'intero ed ificio , dapprima europeo, poi mediterraneo , poi africano ed infine , dopo la comparsa del terzo elemento, il Giappone, asiatico. Tutto ciò che costituiva l'impalcatura del futuro dell'Europa si doveva svolgere attraverso il dialogo tra le due capitali, diventate successivamente tre. Il protagonismo di Mussolini che si accompagnava a quello di Hitler diventava l'unico riferimento sicuro della rivolu zi one geopolitica del mondo che avrebbe fatto seguito alla vittoria, ritenuta sicura, dell'Asse.
Senza volere, in questa sede, fare la storia del progetto del Nuovo Ordine, storia indubb iamente difficile e non ancora scr itta nel suo co mplesso, vale la pena di ricordare, almeno a grandi linee , i vari progetti che di questa seducente etichetta si avvalsero, quasi a prenotare un avvenire cli sicuro sbocco positivo. Va anche ricordato che ognuno di questi progetti segnava l'esaltazione della "missione di Roma", cioè di un autoritarismo fascista nei confronti delle popolazioni dei vari territori oggetto di questo Nuovo Ordine e soprattutto del mondo mediterraneo . Ed in questa ripetuta esaltazione della mi ss ione di Roma sta -

va proprio il grande problema del1e future relazioni di belligeranza e di libertà che molti nazionalisti arabi sognavano invece quale fine della preponderanza coloniale dell'Europa. Si è scritto, non a caso dei "vari progetti", perché 1'insieme delle auspicate decisioni relative al Nuovo Ordine Mondiale non appare allo storico, né unico, né omogeneo. A questo riguardo appare chiaro che nel periodo delle grandi illusioni, cioè tra il 1938 e il 1941, quasi ogni centro di potere del regime fascista si facesse carico di redigere un proprio progetto di Nuovo Ordine e ciò che appare piuttosto curioso sta nel fatto che, pur autorevoli fossero le var ie fonti di questi progetti, nessuno ebbe mai la conferma di un avvallo unico da parte del governo fascista il quale, da parte s ua, creò vari organismi incaricati di st udiare il problema senza che vi fosse una qualsiasi osmosi tra cli loro. In questa confusione appare difficile allo storico s uperare la fase della pura descrizione, ma senza scegliere arbitrariamente un progetto piuttosto che un altro , occorre indicarne alcuni tra i più omogenei e rappresentativi. Ciò che, in ogni caso va sottolineato è che nell'insieme delle scelte cieli' Italia, sia poco prima cieli 'entrata in guerra, sia durante lo svolgimento del conflitto, appare eviden te la totale disinvoltura delle autorità fasciste circa le sç;elte auspicate da realizzare a vittoria conseguita. La ridistribuzione geopolitica, in Asia come in Africa, che ogni progetto prevedeva aveva quale assioma l'onnipotenza del governo di Roma quanto al de stino delle popolazioni oggetto e non soggetto dei vari cambiamenti.

Quanto alle reaz ioni delle popolazioni coinvolte in questi grandiosi progetti, risultava chiaro che per quanto riguardava il Nuovo Ordine Mediterraneo gravavano sulle decisioni future alcuni presupposti che ne contraddistinguevano la natura . In sostanza tutto avveniva, sotto un malcelato paternalismo, senza né la consultazione, né il rispetto delle varie popolazioni interessate. E siccome si parlava di espansione mediterranea ed africana, le popola zioni interessate, cioè gli africani e gli arabi, che non venivano mai evocate se non come mera merce di scambio di sovranità territoriale, non potevano non avanzare seri dubbi e fondate riserv e . E tutto ciò ebbe molto a che fare con 1'effe ttiva partecipazione di gruppi armati di quell e regioni ad uno sforzo bellico che pareva esulare del tutto dai grandi obiettivi del già forte nazionalismo locale.
Sulla 'questione araba', come su quella africana in generale, si può dire che questo disinteress e nei confronti de1Ie varie popolazioni co involte aveva radici ideologiche precise: era la dottrina della " Difesa della
Razza" che, dal novembre 1938, era diventata legge del regime fascista a farla da padrone. A queste razze ve ni vano attribuite genericamente l'etichetta cli "razze inferiori" nei confronti clelia razza dominante che era la razza ariana cli cui il governo fascista esaltava la purezza ed il valore, con la triplice attribuzione ai suoi membr i cli "ita li ano, ariano e fascista" . Co n s imili premesse era chiaro che le popolazioni arabe ed africane non potevano guardare se non con diffidenza la po li tica del governo italiano che non dava loro la parola o l'ini z iativa e non poteva certamente allontanarsi da questi presupposti razzisti. Queste non erano peraltro le sole difficoltà politiche che il fascismo incontrava: il governo italiano aveva avuto nel passato una se ri e di momenti di crisi che avevano sos tanzialmente creato altri motivi di attrito. Dapprima , con il mondo palestinese , vi era il grande problema della politica che Mussolini aveva deciso di adottare e che si comprendeva poco in quanto ambigua al massimo . Da una parte si caldeggiava l'az ione dei sionisti , mentre dall'altra parte si sosteneva con armi , denaro ed azione diplomatica la resistenza dei naz ionalisti arabi in lotta contro il potere mandatario della Gran Bretagna e contro i progetti spesso realizzati di insediamenti sionisti nell'intera Palestina. Il tramite era il Gran Mufti di Gerusalemme , al -Husseini, autorità religiosa e capo politico dei nazionalisti palestinesi, e con costui il governo fascista era e nt rato in contatto sin dal 1936 fornendo alla sua azione, per via clandestina, il denaro e le anni necessari alla sua atti vità sovversiva 2 . Una simile politica poteva essere una scelta valida se non fosse stata accompagnata, proprio nello stesso periodo, da una serie di ape1ture italiane nei confronti dello stesso movimento sionista, il qua le era il diretto nemico dei nazionalisti palestinesi in quanto il loro progetto di insediamenti nella TeITa Santa, ledeva evidentemente l'auspicata indipendenza della popolazione araba. Gli incon tri di Mussolini con il capo del movimento sio ni sta , Chaim Weizmann , de] settembre 1926 e del 14 febbraio 1934 costituivano un chiaro 1iconoscimento del movimento sionista che il successivo incontro con il presidente delle delegazioni ebraiche, Nahum Goldmann, del 13 novembre 1934, confermava. Un a l tro elemento di diffidenza del mondo arabo nei confronti del Nuovo Ordine mussoliniano risiedeva ne ll a politica che il governo fa-
2 Se ne vedano alcuni aspetti finanziari nella tabella dei vers amenti fatti dal governo fascis ta all'esponente palestinese (1936-1938) , ripo11ata, quale documento n. 2 , nel volume di R. H. Rainero, [<,1 politica araba di Mussolini nella seconda guerra mondiale, Padova, CEDAM, 2004, p. 52-54.

scista aveva attuato fin dal suo insediamento nella sua colonia araba , la Libia, politica che non privilegiava di certo gli arabi e la loro aspirazione all'indipendenza. Il duro regime coloniale fascista aveva poi avuto la clamorosa conferma della sua virulenza in occasione della cattura del capo carismatico dell'idea nazionale libica, Omar al - Mukhtar: la sua condanna a morte e 1a sua pubblica impiccagione del 16 settembre 1931 3 erano elementi che pesavano come macigni sulla buona fede fascista a proposito delle sospirate indipendenze delle nazioni arabe. li mondo arabo , che allora si era schierato contro la violenza fascista, non poteva non ricordare questa drammatica vicenda che si era accompagnata a soprus i a danno della popolazione indigena con depo11azioni di massa, espropri di terre e processi sommari. E così anche 1' impresa d'Etiopia, con la proclamazione dell ' Impero (8 magg io 1936), non deponevano a favore di una "generosità" cieli 'Italia a verso le popolazioni africane arabe o amhariche che fossero . Anche se Roma dichiarava, negli anni quaranta, di volere assecondare con questo progetto di Nuovo Ordine Mondiale , la tute la delle volontà arabe di indipendenza , esso non poteva non essere ritenuto soltanto una dichiarazione di circostanza che occultava la volontà di Roma di prosecuzione , su scala allargata, di quanto si era già visto nelle colonie del .! l'Italia, e cioè del colonialismo e della violenza razzista. Con questo retroterra politico evidente ogni dichiarazione del governo italiano circa la propri a intenzione di emancipare del tutto le popolazioni arabe e di liberare dal colonialismo francese e inglese le popolazioni dei due imperi suonava poco credibile , dettata com'era più dalle circostanze politiche che da una vera filosofia dell ' emancipazione .
Infatt i , il ventaglio del1e "soluzioni" che venivano indicate nelle varie edizioni del progetto di Nuovo Ordine non lasciava dpbbi circa la politica che Roma intendeva realizzare su scala mondiale dopo la vittoria dell'Asse. Anche se i vari progetti erano , sotto molti aspetti, in netta contraddizione gli uni con gli altri poiché a Roma, e nei centri del potere fascista , non si coltivavano sempre identiche speranze sul1e conseguenze del1a vittoria, ritenuta nel 1940-41, ormai alle porte, i piani ed i propositi circa il to rnaconto dell ' Italia, a gue1rn vinta , parlavano chiaro. L'equivoca dizione del Nuovo Ordine non definiva , in

modo corretto e completo, questa ideologia, che rimaneva oscura e minacciosa. A questo riguardo, va eletto subito che il regime fascista non mancò di alimentare ufficialmente queste incertezze, alle prese com'era con forze discordanti e co ntraddittor ie che tutte pretendevano di rappresentare il vero sig nific ato del fascismo ne l mondo futuro e l'optimum delle sistemaz ioni previste. Appare anche chiaro che le scelte erano ben lungi dall'ess e re definite o definitive , e che ad ogni centro di potere del re g ime, e quasi ad ogni gerarca importante del partito, corrispondeva una versione più o meno ambiziosa di questi orientamenti. Questa appare una materia non trattata dagli storici, data anche la sua fluidità obiettiva e data l 'assenza di un documento unitario di riferimento definiti vo. Le fonti al riguardo si possono ritrovare, oltre che in molti documenti ufficiali , anche, disperse e contradd ittorie, nelle varie riviste del regime. Ad ogni modo appare interess ante evocarne i termini, pur privilegiandone le versio ni territoriali d eg li spazi mediterranei a favore dell'Impero fasci s ta che erano veramente molte ed erano sempre in bilico tra une riedi z ione del vecchio colonialismo di stampo francese o in glese ed il "nuovo imperialismo" fasci sta dagli in certi contorni, ma che appariva supremo elemento di una definitiva supremazia della razza ariana su tutte le altre razze e quindi conferma dei più abusati schemi di colonialismo e di imperialismo mascherati da generosità politiche. Chiaramente s i era lontani dalla condanna del colonialismo europeo, come lo pretendevano i vari esponenti nazionalisti arabi, che accoglievano con estremo sospetto e con profondo scetticismo le "nuove" dottrine del fascismo a loro riguardo. Nel settore internazionale , il problema si allargava ulteriormente con la nozione di Nuovo Ordine Mondiale , cioè con quanto la Germania d i Hitler meditava di realizzare a proposito di un proprio futuro Nuovo Ordine, che non combaciava per niente con l ' insieme delle solu z ioni italiane. Le discrepan ze erano molte e corpose per quanto riguardava l'Europa , ed anche l'Africa. Ma non solo: allorquando si evocava il problema del Mediterraneo orientale, c ioè il Medio Oriente arabo, un terzo protagonista non tardò a presentarsi per illustrare il proprio modo cli concepire il futuro. Ed era il Giappone il quale, con il suo Nuovo O rdine Asiatico, non in tendeva rinunciare, in nessun modo , a gestire le so1ti del mondo arabo, chiamato più volentieri a Tokyo, Asia Minore od Oriente Medio . Quasi inutil e evocare come liberatoria l'equivoca etichetta cli "Eurafrica" sotto la quale si celava solamen te la sfrenata ambizione del fascismo di reggere le sorti dell'intero continente sotto le parvenze di

una cooperazione di sviluppo che portava inevitabilmente ad una colonizzazione co1lettiva sotto il primato di Roma. L'Africa ed il mondo arabo sarebbero diventati così, zona comune di retrovia dell ' Europa stessa, zona da 'i.ncivilire' e da sfruttare. Si parlava anche di 'romanizzare' il mondo coloniale come mercato e come riserva energetico- minerar ia . Per l'Africa e per il mondo arabo, sarebbe così riso1ta un 'i nte sa che ripercorreva le tappe della romanità classica e dello stesso ideale del Mare nostrum , tante vo lte evocato da Mussolini . In questa visione, si ritrovavano le idee di alcuni tra i più noti espo nen ti e studiosi del colonialismo fascista graditi dal regime , quali Paolo D'Agostino Orsini di Crunerota , Crufo Giglio , Raffaele Micaletti, Gigi Maino, Edoardo Zavattari , Carlo Zaghi, Piero Bernasconi ed altri ancora, i quali scrissero abbondanti e contraddittorie versioni della propria idea di Eurafrica .
Una data fondamentale per individuare, per l' Italia, il varo di quest ' idea di Nuovo Ordine appare essere il 30 novembre 1938 . Proprio in quel giorno Mussolini chiariva al Gran Consiglio del Fascismo , ciò che chiamava "le linee direttive del d inamismo fasc ista negli anni a venire", e riguardava una serie di espansioni-r ivendicazioni-compensi, mai prima di allora così ch iaramente indicati4 Andavano dalla Tunisia al Ticino , dall 'Albania a Istanbul ed in esse non vi era spazio dichiarato per le vo lontà delle popolazioni inserite in questi progetti. Su questa linea, Paolo Orano poteva pontificare: "Il Nuovo Ordine Mondiale è dunque il fine p reciso della nostra rivoluzione, consiste nell ' esserci noi s ituati ne1la sfera viva degli eventi, preveduti, auspicati, voluti da decenn i . .. e trava lica dai suoi confini di ieri per entrare nella risoluta fase dell ' imperialismo ... "5 E Vito Pannu nzio a ribadire : " Questa guerra non è fi ne a sé stessa, ma è fine escl us ivamente ad un Nuovo Ordine politico , sociale ed economico, ad un Nuovo Ordine fonda to sulla pace e splla giustizia .. . Non avverrà come per il passato . .. di presentarci incerti e titubanti con improvv isazioni più o meno felici, ma ci presenteremo (a guerra vinta) sotto og ni aspetto fen-atissimi ed agguerritissin1i"6 .
4 In una preceden te riunione Musso li n i aveva confermato l'ampiezza delle ambizioni del suo programma: «II fasci smo non teme un combattimento che deve decidere le sorti dei continenti», dalla Prefaz ione agli Atti del Gran Consiglio, in «Popolo d ' Italia» del 10 luglio 1938.
5 P. Orano , Verso un Nuovo Ordine Mondiale, in "Annal i dell'Africa Italia na", 1940 , vol. lV, p. 22
6 V. Pannunzio, Punti fermi per il Nuovo Ordin e , .in "Critica F ascis ta", 15 sett. 1940 ,p .396.

Cur iosamente l' e ntrata in guerra dell ' Italia non parve modificare molta parte di questi progetti che pure le semplici esigenze strategiche avrebbero dovuto modificare o quanto meno adattare alle nuove situazioni. Solo qualcuno, come l'autorevole ministro, G iu seppe Bottai , mostrava una evidente incertezza: "Il Nuovo Ordine si dimostra più che una aspirazione vaga . Ma non può, fin d ' ora, mentre la lotta infuria, delinearsi in tutti i suoi elementi costitutivi ... Ogni tentativo dicostruzione teorica, se condotto oltre certi limiti , cadrebbe in un pericoloso labirinto di ipotesi" 7 Era certamente una presa di posizione che non dimenticava di collegare tutti i propositi di rivoluzione geopolitica all ' esito del conflitto, esito che , alla fine del 1941 , si presentava sempre meno sorride nte per l'Asse. In questa orgia di progetti , non emerse in nessun modo l 'esigen z a di collegare le popolazioni locali allo sforzo di guerra dando loro magari qualche soddisfazione pur di agganciarli al carro militare dell ' As s e . In questa fase si può s olo notare una evidente sordità italiana alla vera novità che la guerra stava manifestando e cioè l'esigenza, che specialmente la Gran Bretagna stava ribadendo, di collegare il conflitto ad una fase ideologica importante che avrebbe trovato nella dottr ina della " libe razione" il proprio credo universale in nome del quale le popola zioni coloniali parevano trovare nuovi spazi per l ' auspicata decolonizzazione e quindi si allineavano nella lotta contro l ' Italia.
In questa nostra analisi occorre trascurare le molte pubbliche prese di posizione , e neppure lanc iarsi in una analisi dei documenti uffi ciali , segreti o riservati , sulle scelte che le massime autorità fasciste facevano riguardo a questo espansionismo . Per la cronologia basterà ri cordare il primo documento u fficiale del periodo bellico, che risa le al 26 giug no 1940 , allorquando il ministro degli Esteri C iano dava le " Istruzioni" circa l'elaborazione di una vera versione ufficiale circa le rivendicazioni avanzate dal governo fascista. Era l'invi to rivolto al capo dell'Ufficio Armistizio-Pace, Lu ca Pi etromarchi, a "preparare uno studio specifico", ma in ta le attesa alcun e mete erano indicate, quali la Tunisia definita "territorio italian o con rettifica alla frontiera con l ' Algeria in modo da comprendere le miniere di fe1To e fosfati " . Per l'Egitto "ritiro di tutte le forze britanniche. Egitto pienamente indipendente con trattato esclusivo di alleanza con l'Italia" , con "sostitu zione dell'Ita lia alla
7 G. Bottai , Contributo de/l ' Italia fa sc ista al Nuo vo Ordine , in "Civiltà Fascista", novembre - dicembre I 941 , p. 11.

Gran Bretagna nel condominio del Sudan anglo -egiziano"; infine per la Siria, il Libano e la Palestina si decideva di farne "Stati indipendenti alleati dell ' Ttal ia (con) trattati di mutua assistenza"8 . Per la Siria, il Libano, la Palestina, la Transgiordania e l'Irak si proponeva il riconoscimento della loro indipendenza , ma con la "conclusione di trattati di mutua assistenza tra ognuno di questi Stati e l'Italia accompagnati dall'occupazione militare di taluni punti strategici per garantire questi Stati da minacce alla loro indipendenza e in tegrità". Insomma questo documento rappresentava una vera e propria rivendicazione 'totale ' sul mondo arabo, rivendicazione collegata sia all'aspetto teITitoriale sia a quello militare e strategico dell'Italia nell'intero settore mediteITaneo.
La panoramica delle rivendicazioni che le varie autorità fasciste, su ll'onda dell'entusiasmo per la facile vittoria sulla Francia, ritennero di dover redigere a futura memoria non si limitò a questi prima presa di posizione. Ed j progetti si moltiplicarono. In data 10 settembre 1940, il vice direttore ge nerale degli Affari d'Europa e del Med iterraneo, Gio vann i Battista Guarnasche lli, aveva riportato, quasi in dia logo con un Appunto dell'ambasciata di Germania a Roma, una serie di revisioni e di messe a punto che definivano ulteriormente l'ambito e la natura dei futuri mutamenti geopolitici e strateg ici del mondo arabo secondo Berlino e seco ndo Roma9 E tali clausole, che riguardavano la Francia, e rano ancora più favorevoli alle t es i oltranzistiche dell'Italia 10. L'importanza di questo nuovo 'Appu nto ' del Ministero sta nel fatto che esso fu preparato in vista dell 'incontro di Firenze tra Hitler e Mussolini del 28 ottobre. Illustrate dàl Duce ad Hitler , le tesi italiane furono da costui interamente ratificate ed egli si impegnò dopo aver " per ben due volte e solennemente dichiarato che egli non avrebbe firmato alcun trattato con la Francia se prima non saranno state soddisfatte tutte le richieste italiane che sono da considerarsi ultramodeste e certamente in fe riori alle richieste che gli stessi francesi si aspettavano
Con le citazioni di riferimenti antichi e di documenti ufficiali italiani non si può, di certo, ritenere esaurito il panorama delle vicende che
8 Il documento ciel 26 giugno 1940 è riportato in DDI, serie IX , voi. V, p . 105, ma non appare completo.
9 Si veda il documento in DDI, serie IX, voi. V, p. 566-568.
IO Se ne veda il testo in DDI , serie IX, voi. V, p. 757 -8. Il verbale degli incontr i Mussolini-Hitler del 28 ottobre 1940 si trova in DDI, se ri e IX, vo i. V, p. 771 -775.
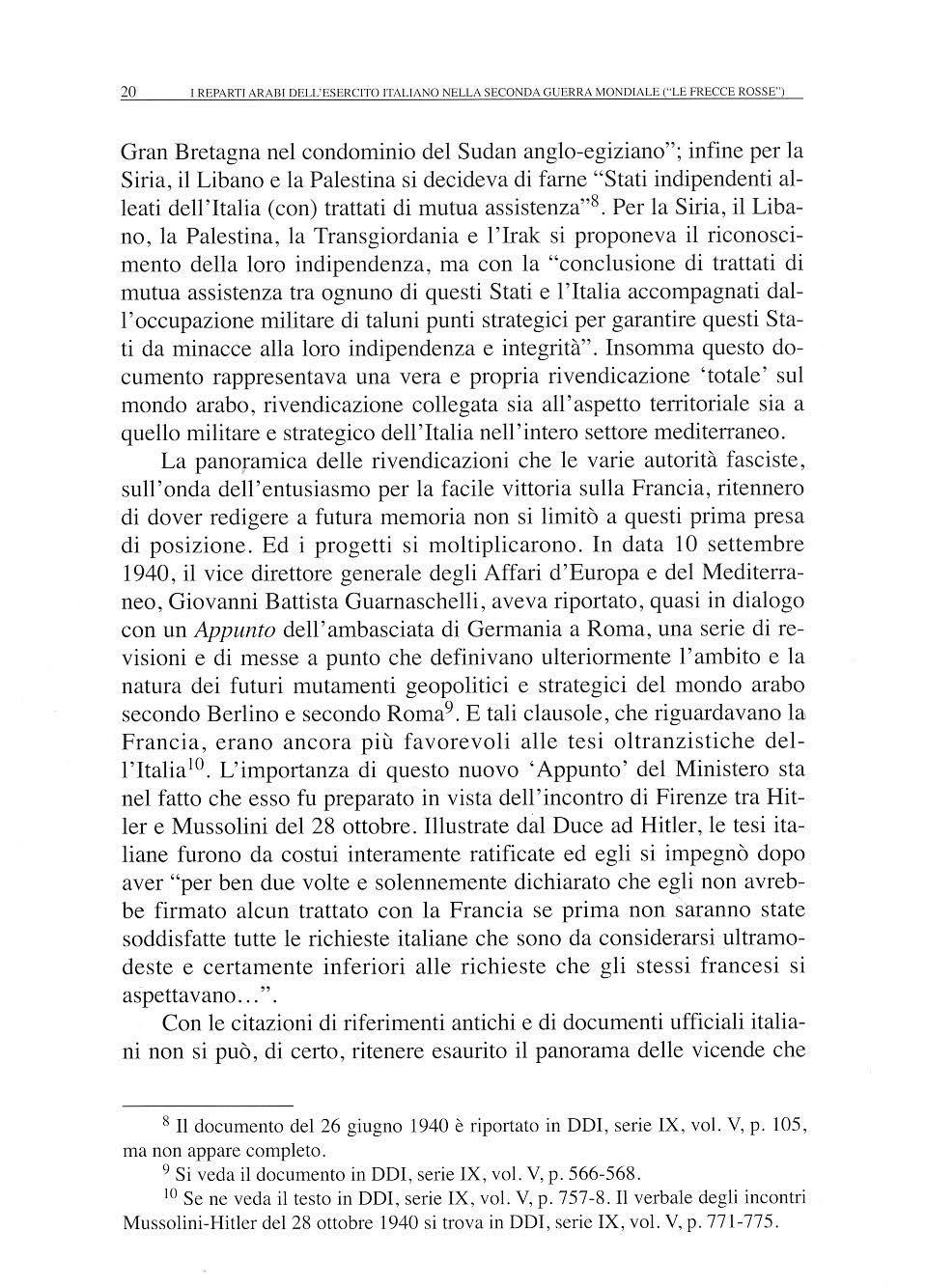
agitarono gli ambienti governativi italiani a proposito della vittoria del1'Asse e delle conseguenze geopolitiche a proposito del Nuovo Ordine, ma si deve ins istere nella ricerca dei veri proposit i che il governo fascista nutr:iva ne l segreto riguardo al futuro del mondo mediterraneo , africano ed arabo, propositi che segnano, a lettere cubitali, una totale disarmonia con le 'soluzioni' previste (con profonde riserve) che venivano avanzate circa l' indipendenza araba, che pure erano al centro delle varie trattative con gli esponenti nazionalisti arabi, palestinesi come il Gran Mufti di Gerusalemme Amin el -Husseini ed iracheni, quale Rashid Ali al -Ghailani. Ogni equivoco circa la sorte politica riservata a q ueste zone, poteva essere coltivato in tempo di pace, ma in tempo di guerra, che proprio sul territorio del mondo arabo si svolgeva, il discorso diventava estremamente difficile. E questa difficoltà cresceva a dismjsura in q u anto la coalizione nemica non risparm iava promesse seducenti sul futuro con parole che diventavano magiche suggestioni , quali la 'liberazione' , la 'democrazia mondiale' e la 'decolonizzazione'
Per l'Italia, le esigenze strategiche di una guerra avrebbero dovuto imporre nuovi discorsi proprio con gli arabi, discorsi nei quali la parola 'indipendenza' non poteva essere più bandita in favore di 'autonomia nel quadro di una nuova realtà geopol i tica del mondo'. Davanti a queste a l ternative, e soprattutto di fronte a l le i nizia l i incertezze del co nflitto, il mondo arabo avrebbe potuto accettare le trattative con le pote nze dell'Asse . Per l'Italia, queste trattative si imponevano, visto che la guerra in iz iata con baldanza non si presentava più, dopo pochi mesi , come una g uerra da l la breve durata e che, proprio nel mondo arabo, cioè al confine tra L ib ia ed Egitto, essa offriva uno spettacolo negativo della forza mil itare italiana che già la campagna di Grecia stava dimostrando. Da ques te premesse negative nasceva , q u as i come antidoto cli propaganda in terna , l 'esa lt az ione dell'utopia del N uovo Ord i ne, ed anche il mito dell'amicizia attiva degli arabi. Entrambi questi ve rsa nti vanno tenuto in conto , anc he perché un documento fina le d i questo duplice orientamento non è mai esistito, ma sono esistite solo vers io ni più o meno attendibili e più o meno a udaci. T uttavia l'idea del Mare nostrum p areva ancora dominare q uesti propositi e l ' espansione delle sovra n ità dirette o indirette gestite da ll ' I ta li a si rivelava costante. A questo rig uardo i documenti non sono poch i , ed essi ci possono dare un'idea de l la sordità italiana circa i van t aggi che una "generosa dichiarazione di indipe ndenza" decisa per il mondo arabo avrebbe potuto dare a ll o sforzo bell ico de ll 'Italia in guerra .

Un eminente giornalista del regime , spesso portavoce di politiche e di scelte u fficiali, Mario Appellius, ne esaltò l 'i mportanza definendo il Nuovo Ordine il " supremo obiettivo della guerra" che mirava a novità assolute: "La Civiltà capitalistica, superata inesorabilmente dalla marcia dell'umanità, deve cedere il posto ad una nuova forma di Civiltà , più aderente ai bisogni ed alle aspirazioni del mondo moderno . . . " 11 Mancavano in queste considerazioni l 'es atta valutazi one della s ituazione strategica che invece il momento avrebbe dovuto imporre . Ed in questo coro di consensi che il regime esaltava solo una voce si levò contro questi facili progetti : il filosofo del regime, Giovanni Gentile, vi inserì una serie non indifferente di riserve che, in parte, rifiutava il principio, che pareva acquisito dalla maggioranza degli osservatori e degli osannatori fascisti, di una inevitabile ed auspicata gerarchia delle varie nazioni. In piena guerra ed in piena discussione sul famoso Nuovo Ordine da realizzare a guerra vinta , egli non mancò di ammonire: "Novus nascitur ordo. Quale? Quale sarà appunto, lo sapremo, quando vi sare mo giunti . .. Ma certo dalla guerra uscirà una Nuova Asia , una Nuova Europa, un nuovo m.ondo ... per un'umanità che, senza disperdere i tesori delle sue più grandi tradizioni , spezzi le catene che ne imped ivano o minacciavano lo sviluppo e il progresso. E riconoscerà il vantaggio della mutua intelligenza e della. collaborazione fraterna delle razze diverse, nessuna delle quali è nata a servire, e tutte hanno diritto ... a recare all'umano comune la voro il libero contributo della propria operosità ... " 12 . Forse in queste sagge considerazioni stava la chiave del rapporto con gli altri popoli, g li arabi s pecialmente, che nella guerra scorgevano nuovi motivi di speranza per una vera svolta del proprio destino .

Ma ciò che mancò del tutto in queste discussioni furono le considerazioni militari che parevano cedere alle altre, politiche o ideologiche, le quali, in realtà, av rebbero dovuto tenere io debito conto l ' insieme dei problemi concreti che la guerra , specialmente quella che coinvolgeva il mondo arabo, pareva imporre.
Eppure non mancava chi, come l'ambasciatore italiano a Baghdad, Luigi Gabrielli, aveva insistito, fin dal gennaio 1940 , circa queste necessità politiche che avrebbero avuto molte conseguenze s ul piano
11
militare dall 'impegno arabo a favore dell'Asse. Il suo Memoriale del 12 gennaio rivolto a Ciano, ma chiaramente monito alle autorità militari italiane, precisava le attese del mondo arabo di fronte al conflitto:
"GI i arabi non hanno precisato il loro vero atteggiamento verso l 'attuale conflitto e non lo possono precisare se non viene loro richiesto un aiuto materiale in caso di guerra ... " 13 Le autorità fasciste non tennero conto di questi suggerimenti e la guerra che da lì a poco trascinava l ' Italia nel conflitto non distolse , malgrado Ja sua gravità, gli osservatori italiani dai progetti politici ed imperialis tic i già evocati. Nei molti piani di sistemazione del mondo mediterraneo, arabo ed africano che fiorirono in quei mesi, l'aspetto militare veniva ricordato come un elemento in cui il mondo arabo appariva come quadro passivo di attività belliche e non da protagonista.
Per 1'Italia questa "sicura vittoria" poteva avere un solo significato , e cioè finalmente realizzare quelle rivendicazioni. territoriali che il duce aveva ripetutamente evocato e che dovevano costituire il premio alla guerra italiana . Pareva persino che il citare un termine nuovo, quale Nuovo Ordì.ne , potesse solo avere il s ignificato antico dei 'co mpensi ' e delle 'rivendicazioni' Citando il testo del!' Appellius , non si è intenso certamente esaurire il panorama complessivo delle proposte; molte altre citazioni potrebbero essere fatte , ma ciò che appare interessante in questo programma dell' Appellius è la s istemazione delle molte proposte al riguardo con il vantaggio di vederle rese omogenee in una proposta complessiva 14 Infatti il Nuovo Ordine , secondo l 'a n alisi non certo uffic iale ma s icuramente ufficiosa dell'Appellius, avrebbe dovuto implicare sul piano internazionale ben undici condizioni. A noi ne paiono interessanti alcune, quali "l'esclusione programmatica de ll ' Inghilterra dall ' Europa e dall'Asia orientale"(punto l); la sistemazione degli ebrei nel mondo in modo che non possano esercitare la loro influenza definita funesta , sulla vita economica, politica ed intellettuale delle nazioni(punto 4), sistemazione della quale non era detta la vera natura . Infine, nel punto 5 , veniva sancita "la ripartizione politica
13 Si veda pa1te de l testo del M e moriale nell'Appendice documentaria n. 1.
14 Tra le molte pubblicazioni al riguardo, va le l a pena di citarne le maggiori: V. Gayda , Che cosa vuole l'Italia?, Roma, Il Giornale d 'Italia, 1940; P. Schmidt , Rivoluzione nel Mediterraneo: la lotta per lo spazio vitale dell'Italia , Milano, ISPI , 1942; R. Bellotti , Nuovo Ordine asiatico e Nuovo Ordine Europeo, in " Do ttrina fascista", luglio 1940 , p. 801 e segg.; G. Taraletto, L' espansione coloniale nel Nuovo Ordine Europeo, in "Gerarchia", 1942, p. 406.

dell'Africa fra tutte le grandi nazioni d'Europa, in proporzione dei loro bisogni di spazio e di materie prime, in armonia con le loro necessità geografiche e strategiche, in rapporto con le loro tradizioni e capacità colonizzatrici", in sostanza l'intero continente andava posto sotto la sovranità diretta o indiretta dell ' Italia. L' insieme di queste proposte veniva condito con la libettà di ogni nazione (soggetta all'Europa) di scegliersi il proprio regime, ma questa libertà non era libera , bensì doveva avere "un contenuto ispirato alla grande concezione rivoluzionaria di Mussolini".
Appare evidente che, in questo quadro di esaltato europeismo e di ribadita romanità, ben poco spazio veniva riconosciuto alle genti non euro pee alle quali toccava solo di gravitare ai margini del continente europeo. Tra l'altro, l'Africa doveva "fornire all'Europa, sia quelle materie prime alimentari ed industriali ... sia quei prodotti tropicali" che l 'E uropa non aveva; doveva "offrire residenza e lavoro a quei popoli europei traboccanti ... " , ed essere serbatoio di ogni iniziativa dell 'Europa. E questa vocazione ancillare dell'Africa avrebbe avuto, quale sommo riconoscimento, l'avvio da parte dell'Europa di un piano di sviluppo che tenesse conto per le popolazioni interessate "del loro grado attuale di semiciviltà o di barbarie e le farà avanzare a tappe ragionevoli" verso una crescita generale quale "atto di fede nell ' Europa" 15 Per l 'Asia minore, o meglio per il mondo arabo, la situazione si presentava un po' diversamente in quanto Turchia , Persia e Stati arabi avrebbero dovuto essere riuniti in una o due confederazioni, da collegare all'Europa e da sottrarre, anche se di Asia si trattava; all'egemonia del Giappone riconosciuta per l'intero resto dell'Asia. Ovviamente si faceva i conti senza l'oste, e cioè pareva ai fascisti italiani che Nuovo Ordin e dovesse significare predominio assoluto dell'Italia, magari con qualche accordo-concessione alla Germania per il Nord dell 'Europa . Ma ciò di cui costoro ignorava no sul piano delle strategie post belliche era il vero ruolo del Giappone che il Tripa1tito, cioè l'accordo del 27 settembre 1940, g li riconosceva all'art. 2 in vista della "Grande Asia Orientale".
Infine vale la pena di gettare uno sguardo anche al continente nero : nel caso della risistemazione coordinata tra Roma e Berlino dell'A-
15 Erano state queste le conclusioni che l'accademico Francesco Orestano, aveva ricordato, poco prima del conflitto, nella Reale Accademia d'Italia nel suo solenne Convegno di Scienze Morali e Storiche (4-11 ottobre 1938) su L'Africa, volume 1, Roma, Reale Accademia d'Italia , 1939, p. 39.

frica essa 'doveva' diventare, nella sua parte nord "dal Mediterraneo centrale si no all'Oceano Indiano", di pertinenza dell'Italia. I progetti evocavano la nascita di un " Governo Militare del Sahara Italiano" che avrebbe conglobato la Libia, la Tunisia e parte dell'Algeria; accanto ad esso vi doveva essere un "Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana" con l'Africa Orientale ltaliana, e le Somalie francese ed inglese, ed infine vi doveva nascere un "Governo dell'Africa Centrale" con la Nu bia , il Cordofan, il Gesira, il Ciad, l'Uban g hi Sciari e l' Equatoria. L'intero sistema sarebbe stato retto da Prefet ti o da governatori militari italiani. Quanto alla parte riconosciuta alla Germania, essa variava ed andava dalla 'storica' rivendicazione germanica sul Marocco alla zona a nord del Sud Africa con ovvio ritorno delle ex colonie tedesche.
La visione non era generosa verso quel Nuovo Ordine che si voleva creare con il dichiarato uguale rispetto verso tutti i popoli: anzi, una nuova versione di dipendenza , coloniale o paracoloniale, veniva auspicata con una evidente dipendenza ideologica e politica del!' Africa e dell 'As ia al fascismo. La natura eurocentrica de] progetto era ribadita con forza allorquando si affermava: "Nonostante i s uoi tremila anni di esistenza l'Europa è giovanissima . Essa è sempre il cervello ed il cuore del mondo. E tale rimarrà, durante secoli, e forse millenni, perché vi vivono popoli immortali che hanno il privilegio di rinnovarsi perpetuamente e che si danno il cambio della guardia, attraverso i secoli ed i cicli, nel nome inestinguibile di Roma Eterna , madre universale e nutrice universale di tutte le genti del contine nte" .

Documento n. 1
(12 gennaio 1940)
L ' ambasciatore italiano a Baghdad, Luigi Gabrielli, fece pervenire al Ministro degli Affari Esteri, Ciano, in data 12 gennaio 1940 un Memoriale relativo all ' atteggiamento degli arabi in generale a propos ito della guerra europea, memoriale nel quale viene evocata il possibile intervento armato degli arabi nel conflitto in cambio di un preci s o impegno dell'Ass e per la loro indipendenza.
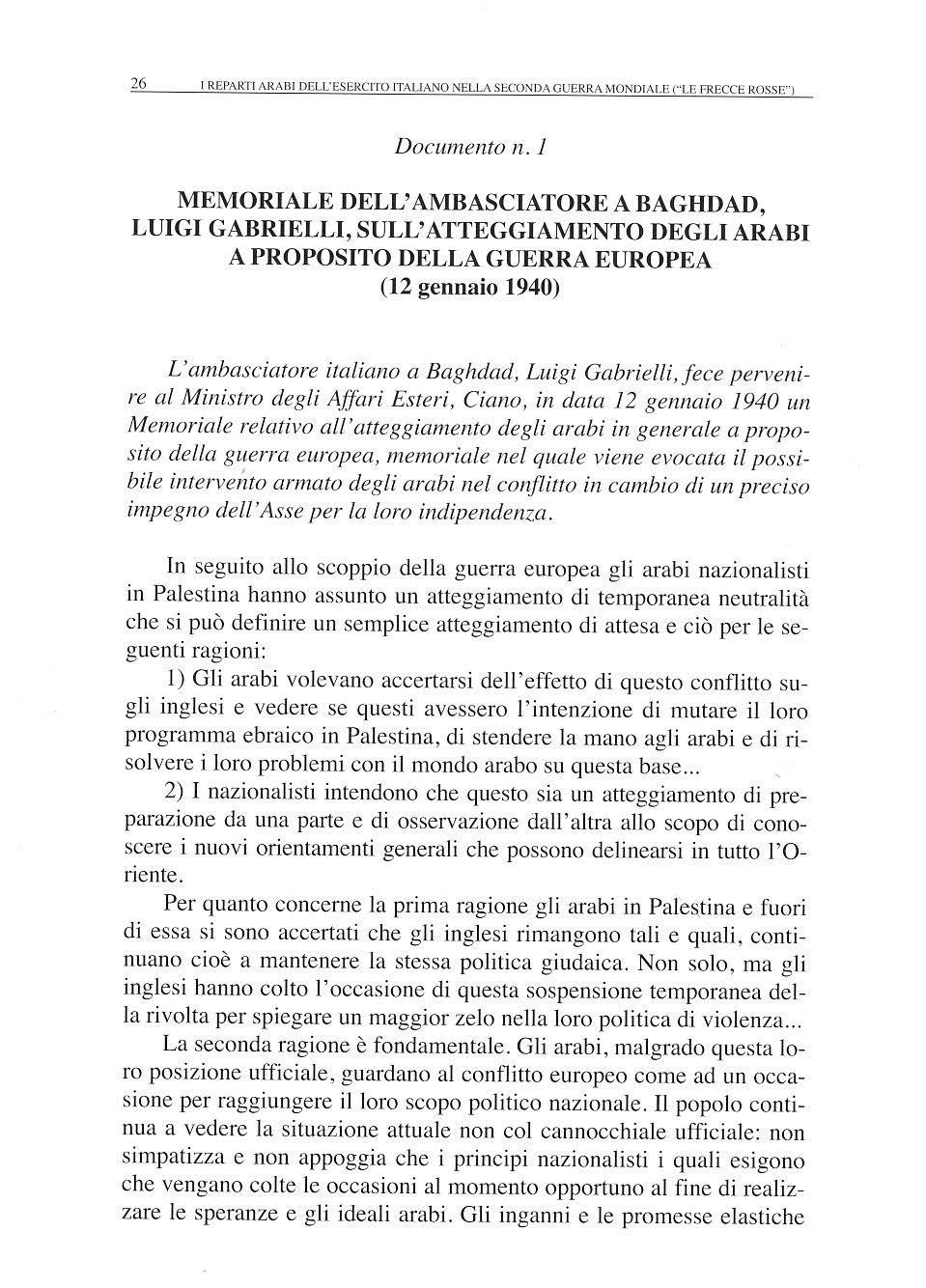
In seguito allo scoppio della guerra europea gli arabi nazionalisti in Palestina hanno assunto un atteggiamento di temporanea neutralità che si può definire un semplice atteggiamento di attesa e ciò per le seguenti ragioni:
1) Gli arabi volevano accertarsi dell'effetto di questo conflitto sugli inglesi e vedere se questi avessero l'intenzione di mutare il loro programma ebraico in Palestina, di stendere la mano agli arabi e di risolvere i loro problemi con il mondo arabo su questa base ...
2) I nazionalisti intendono che questo sia un atteggiamento di preparazione da una parte e di osservazione dall ' altra allo scopo di conoscere i nuovi orientamenti generali che possono delinearsi in tutto l'Oriente.
Per quanto concerne la prima ragione gli arabi in Pale~tina e fuori di essa si sono accertati che g li inglesi rimangono tali e quali , continuano cioè a mantenere la stessa politica giudaica . Non solo , ma g li inglesi hanno co lto l'occasione di questa sospensione temporanea della rivolta per spiegare un maggior zelo nelJa loro politica di violenza ...
La seconda ragione è fondamenta le. Gli arabi, malgrado questa loro posizione ufficiale, guardano a l conflitto eu ropeo come ad un occasione per raggiungere il loro scopo politico nazionale. Il popolo continua a vedere la situaz ione attuale non col cannocchiale ufficiale: non simpatizza e non appoggia che i principi nazionalisti i quali esigono che vengano colte le occas io ni al momento opportuno al fine di realizzare le speranze e gli ideali arabi. Gli inganni e le promesse elastiche
non possono più far presa sui popoli arabi in alcun modo .
Tutti gli arabi attendono l ' estendersi degli avvenimenti e la loro evo lu zione prima di poter assumere un atteggiamento deciso consono ai loro propri interessi e non quelli dei cosiddetti democratici soliti a trattare gli arabi con violenza, ingiustizia e terrore.
Gli arabi perc iò non hanno precisato il loro vero atteggiamento verso l'attuale conflitto e non lo possono precisare se non viene loro richiesto un aiuto materiale in caso di guerra . Questo aiuto - come è ovvio - non può essere portato perché g li arabi già hanno avuto una esperienza. Essi non possono questa volta rendersi convinti delle promesse lusinghiere, ma mercanteggeranno su cose sicure , sulla base del pagamento in contanti, cioè a condizioni che le loro speranze e i loro ideali si realizzino immediatamente e senza ulteriore indugio.


Fino al momento dell'entrata in guerra dell'Italia l'insieme delle discussioni circa il futuro del mondo che si facevano a Roma avevano poco evocato l'aspetto militare contingente: pareva che la guerra e le sue esigenze strategiche non facessero pa1te delle preoccupazioni che si potevano avere . Solamente un documento, poco dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia, parve occuparsi con una certa competenza del problema con il pomposo titolo della sua provenie nza : "Commiss ione per le questioni relative ai paesi arabi. Sottocommissione politico - militare". Questo organo concluse i suoi lavori il 15 luglio 1940 con una relazione che, pur nella sua genericità, poneva il discorso militare in piena evidenza e lo collocava in un quadro militare dell'Asse. Questo documento che non fu mai ricordato negli studi succesiùvi, né nelle decisioni del Comando Supremo , avrebbe potuto, se sviluppato adeguatamente in alcune sue parti, costituire la premessa per una visione militare più armonica nei confronti della situazione dell'andamento della g uerra itali ana e soprattutto proseguire il discorso del coinvo lg imento arabo a fianco dell'Asse, discorso che il Memoriale di Gabrielli aveva citato . Quattro erano i punti che venivano ricordati per studiare una strate gia c he l'Italia e la Germania avrebbero dovuto osservare nei confronti del mondo arabo ed essi, pur invischiati con questioni politic he, davano una certa concretezza al discorso ufficiale italiano. Il documento, che ovviamente non metteva in discussione la "v ittori a" in tempi rapidi delle forze armate dell'Asse nel Medio Oriente, né la prevalenza assoluta dell'Italia in quella regione, elencava questi quattro aspetti:

"l O - Punti strategici nei paesi arabi che, dal punto di vista militare, politico ed economico converrebbe fossero occupati dalle Forze Armate italiane per l a durata della guerra.
2° - Zone o punti strategici che dovrebbero essere assicurati permane ntemente ali ' Itali a anche in tempo di pace - al di foori del territorio dei paesi arabi - per garantire la tutela dei no stri in teressi nei paesi arabi.
3° - In teresse italiano rispetto alle rivendicaz ioni dei paesi arabi s u Alessandretta, sul Cueit e sul!' Arabistan.
4° - Qual è l'interesse dell'Italia rispetto alle aspirazioni di altri Stati sopra territori oggi posseduti o reclamati dai paesi arabi del Vicino Oriente?".
Il documento non mancava neppure di essere diplomatico al punto da ricordare come auspicabile una serie di dichiarazioni politiche immediate destinate agli arabi, dichiarazioni che , alla fine del conflitto e con la vittoria dell'Asse, vi sarebbe stato tutto lo spazio di rivedere del tutto. "Ciò s ignifica - preci sav a la relazione - che, pur salvando le apparenze e rispettando le suscettibilità di tali paesi (arabi) le loro attività politiche, specialmente nel campo internazionale, la loro organizzazione militare e la loro vita economica saran no caratterizzate da un particolare regime di s tretta collaborazione e di amicizia verso le potenze dell'Asse e particolannente ve rso l'Italia la cui predominante s ituazione in tali paesi - che ne costituiscono lo spazio vitale - è s tata già ripetute volte riconosciuta da l! ' alleata Germania e dagli arabi stessi" 16 Ciò che peraltro costituiva la parte assente dalle considerazion i militari ricordate era il silenzio totale del Nord Africa, in quanto gli arabi presi in considerazione parevano essere solo que lli del Vicino Oriente , dall ' Egitto in po i. Evidentemente v i erano al ri guardo delle ovvie riserve ed i riconoscimenti che si offrivano agli arabi del Mashreq non erano offerti a quelli del Maghreb. Vi è inoltre da ricordare che in nessun punto della lunga relazione (20 cartelle) si superava il concetto de l mondo arabo terre no di considerazioni militari e di operazioni strategic h e ma non si giungeva mai al coinvolgimento i n una qualche partecipazione araba all a guerra tramite forze annate proprie , magari al servizio dell'Asse. 1nfi ne tutte queste considerazjo ni militari e strategiche erano fatte nella sola funzione italiana : solo due brevi cenni all'Asse erano contenuti nel documento e ciò q uasi per ribadire una totale ed unica s upremazia militare da rivendicare.

In genere era l'aspe tto politico che ven i va r ibadito e se l'Appello di Radio-Bari ag li egiziani del 17 luglio 1940 parlava di libertà e di indipe nd enza, queste parevano avere quale unico ambito l'Egitto e non certo l'intero mondo arabo. " Sappiate o egiziani - affermava il documento - che l' I talia combatte solta nto contro le forze britanniche c he occupano illega lmente il te1Titorio eg iziano e che servono come base di offesa
16 Se ne riportano nell'Appendice documentaria n . 2 i brani p iù s ignificati vi.
co ntro la Libia. L' Italia i ntende rispettare l 'indipendenza e la sovranità dell'Egitto . . . " 17 . Con simili dichiarazioni le attese degli arabi c he non fossero eg izia ni, restavano deluse, anche perché pareva che all'Italia, e solo ad essa, dovesse spettare l'onere cli un rapporto futuro tra le potenze dell'Asse e gl i arabi i n ge nera le . Di tale tesi, dell 'esclusività di Roma nel trattare il Medio Oriente , abbiamo anche un a pro va che consiste nella circolare (segre ta) del 20 agosto 1940 ciel Ministero degli Esteri cli Berlino che sottolineava tale politica : " La Germania non persegue interessi politici ne ll'a rea medi terranea, la cui parte meridiona le e orie nt ale è costituita dal mondo arabo. Essa lasce rà quindi all'Italia la precedenza nel riassetto dell'area araba .. . Non vi sarà questione né cli una p re tesa di egemonia tedesca, né di una spartizione dell'egemonia con J'Italia" 18 . Tutto quindi pareva ruotare attorno al governo fasc ista il quale , come è stato già ricordato , non parlava di indipendenza per tutti gli arabi ma evocava solo prospettive cli basso profilo, quale autonomia ed inserimento nell'amb ito di un nuov o ordine mediterraneo.
Evidentemente ciò non ri spo nd eva alle as p ettati ve dei maggiori esponenti del nazionalismo arabo che invece volevano parlare di indipendenza . Ne ppure quando la situazion e militare sul fronte c irenaico diventerà critica, la posizione italiana parve mutare. Di fronte all e offens ive radiofoniche bri tann ic he a des tinazione del mondo arabo , le quali denunciavano soprattutto le ten den ze filo-Asse ed il "tradimento" della causa araba del mag g ior esponente d el nazionalismo arabo, il G ran Mufti di Gerusalemme Amin al -Hu sseini , i governi dell'Asse si deci sero, il 23 ottobre 1940 , a meg lio precisare la loro futura politica ne l mondo arabo e ciò per reagire alle affermazioni brita nnich e circa l'imperialismo auspicato da Roma come da Berlino . Ques ta Dichi araz ione ins isteva sul concetto di "liberazio ne da ll a oppress ione bri tannica" che a n imav a la politica delle potenze d ell ' As se ne i confronti del mondo arabo, po litica che, invece di nuovi vincoli coloniali, gli prometteva una sicura e mancip az ione : " Per controbatte.re tal e ma lign a propaganda (inglese) e tra nquillizzare i Paesi Arabi circa la politica

17 Se ne veda il testo integrale in R . H . Rainero, La politica araba op c ii p .
105. Da so tt olineare l'importan za che in q uel periodo assunsero le emissioni radiofo nich e s ia dcli ' Asse sia della Gran Bretagna; se ne veda un a analisi in Le radio arabe d 'Europa , in "Orie nte Moderno" sett. 1940, p 444 e segg
18 C i tato per esteso da S. Fabei, Il fascio, La svastica e la ,nezza/una, Milano , Murs ia , 2002, p 108.
italiana nei loro confronti, il Governo Italiano conferma quanto ha già fatto diramare per radio in lingua araba , e cioè che esso è sempre stato animato da sentimenti di amicizia per gli Arabi; che desid era di vederli prosperare ed occupare fra i popoli della terra il posto rispondente alla loro importan za naturale e storica; che ha costantemente seguito con interesse la loro lotta per l ' indipendenza, e che, per il raggiungimento di questo fine , i Paesi Arabi possono contare anche in avvenire sulla piena sim patia dell'Italia" 19 . Si trattava di una dichiarazione che giocava più sull'equivoco tra s impatia e amicizia che dominavano i suoi termini concreti, ma era pur un passo verso un impegno che i nazi onalisti gradivano ed in cambio del quale manifestarono, subito dopo, una disponibilità all ' azione militare ed insurrezionale. Se ne fece portavoce u no dei più stretti collaboratori del Gran Mufti , Tewfik al.Shakir, che ebbe alla fine di ottobre, a Roma , un colloquio che meglio precisava gli impegni che gli arabi intendevano assumere entro breve. Dal Rapporto che il dire ttore generale degli Affa ri d ' Europa e del Mediterraneo del Ministero degli Affari Esteri, Gino Buti, inviò , il 31 ottobre 1940, al Ministro Cia no, la posi zione dei nazionalisti arabi risultava den sa di possibili conseguenze pratiche specie per quanto riguardava le attività di gueITiglia che potevano pregiudicare lo sforzo bellico della Gran Bretagna nel Medio Oriente . Veniva infatti dichiarato:

" Riferendosi particolarmente a quanto de tto al paragrafo III - B) del -
1' Appunto sopra trascritto (aiuto da accordare alla Palestina) il Signor Tewfik al -Shakir ha in sistito sulla possibilità di riprendere ed allargare la rivoluzione in Palestina e in Transgiordania . L'estensione del mov imento rivolu zio nario - ha aggiunto - è una quistione che dipende dalla misura degli aiuti, specie in armi, che gli arabi potranno ricevere . Ha detto che in Germania (Amburgo) si trovano , di proprietà dei ribelli palestinesi, cinque milioni di cartucce, 50 mi tragliatr ici, 500-rivoltelle, 200 pistole automatiche a 20 colpi e 1000 fucili. Di tale fornitura è al corrente il Ministro Grobba , già Ministro di Germania a Bagclacl . Desidererebbe - e la Gennania sarebbe d'accordo - che s i. tro vasse modo di far pervenire ques te armi, e s pecie le munizioni, ai naziona listi arabi, vi.a Siria.Gli sarebbe gradito ricevere anche armi italiane (fucili , mu nizioni e bombe a mano). Circa il modo cli inviare le armi, ha accennato - previi accordi da prendere - alla poss ibilità di trasporto a me zzo s ommergibili italian i che potrebbero sbarca.rie clandestinamente sulle co -
ste della Siria, dove sarebbero degli agenti arabi a riceverle . Ha suggerito l'invio di un esperto militare a Bagdad , competente in materia aeronautica , al quale potrebbero essere fornite indicazioni utili sulle località da bombardare. Ha detto che nel 1936 la ribellione palestinese , che pure ha raggiunto notevoli propor zioni, è stata sostenuta a mezzo di soli 800 soldati regolari , suddivisi in 40-50 bande , che erano aiutati da tu tta la popolazione. Essi disponevano di 20-25 mila fucili tedeschi , ma mancavano le munizioni , che ha chiesto innanzi e prima cli tutto. Queste cifre sono - ha poi osservato -la prova di quello che gli arabi , anche con scarsi mezzi , possono fare" 20 .
L'insieme di queste proposte non portava forse alla nascita di un vero e propr io esercito regolare arabo da affiancare alle forze armat e italiane impegnate sulla frontiera libico-egiziana, ma esso ne pote va costituire una buona premessa.
Curiosamente le autorità politiche italiane non ebbero l'abilità di cogliere questa occasione ed il Comando Supremo v enne lasciato all ' oscuro di questa eventualità, confinate com'erano le autorità itali a ne nella concezione di una "guerra classica" con i due eserciti, britannico ed italia no, contrapposti s u lla lin ea del fronte cirena ico.
Intanto la questione si spostava dalla Palestina a ll'I rak dove i contatti tra l'unico ambasciatore dell'Asse r i masto in carica a Baghdad, dopo lo scoppio del conf litto , l'italiano Luigi Gabrielli , aveva allacciato con il presidente del Consiglio inviso agli inglesi, il naz ionali sta Rashid Ali al-Gh ailani, rapporti che dovevano sostenere questo gove rn o arabo nei confro nt i delle pressioni britanniche, anche in caso di conflitto armato, ed offrire ali' intero mondo ara bo un centro attorno al quale coag u lare uno sforzo militare favorevo le all 'Asse . L' intenso dialogo tra Rom a e Baghdad, tramite il Gabrie lli , s i ebbe attraverso al meno due e leme nt i, e cioè ]a dichiaraz ione ausp icata di una indipendenza per gli arabi , fatta da Roma come da Berlino, e l 'ass is tenza militare che il Comando Supremo italiano doveva forn ire al debole esercito irakeno in vista di una temuta prova di forza sia co n forze armate bri tanniche ancora stanziate in Irak sia di prove nienza indiana. La concretezza delle richieste di Baghdad all'Italia si può leggere nella comu ni cazione che Gabrielli fece pervenire, in data 10 dicembre 1940 , al ministero degli Affari Esteri. Ciò che venivano definite "le più urgenti occorrenze" che dovevano essere soddisfatte

dall'Asse consistevano in cospicui aperture di credito ed in rifornimenti non modesti di materiale militare :
"l. - non meno di 400 mitragliatrici leggere con relativo muni zionamento;
2 . - 50 carri armati legge ri e di media portata (la disponibilità attuale è di 25);
3 . - non meno di 10 batterie antiaeree, mun ite di dispositivo per tiri notturni ;
4. - esplosivi con congegni per interruzioni stradali, brillamento di mine sotto ponti e ferrovie, ecc.
5. - mezzi e mine anticarro
6. - 100 .000 maschere anti -gas" 2 1 .
Ques te richie s te potrebbero sembrare un indice s icuro di una minuz iosa preparazione da patte dei nazionalisti iracheni alla vigilia di una insurrezione anti-britannica , ma se si sco1Te la corrispondenza che in quei giorni viene scambiata al riguardo, ci si accorge che esse so no più il frutto di una improvvisa zione che di serene valutazioni. Infatti per la stessa causa, l'insurrezione anti -inglese a Baghdad e l a coITispondente attività di guerriglia in Palestina , i l Gran Mufti richiedeva , per esempio, in data 7 dicembre, che fossero consegnate altri quantitativi, e cioè:

"- 500 fucili mitragliatori;
- un certo numero di pistole che nella insurrez ione del 1935 so no state già esperimentate;
- 150 mitragliatrici leggere;
- 100 tromboncini l ancia-bombe;
- munizioni per le armi anz idette nel maggior quantitativo poss ibile ;
- bombe a mano nel maggior quantitativo possibile;
- congegni dinamite con contatto a distanza; ,
- ogni poss ibile mezzo anti -aereo e anti-ca1To, data la forma s peciale di repressione che gli ing lesi impiegru10 in Palestina".
Ma lì non si fer mavano le richieste : si aggiungeva , come indilaz ionabi l e il segue nte materiale:
" - 10.000 fucili con almeno 1.000 colpi per fucile;
- abbondante munizionamento per circa 4.000 fucili inglesi moderni posseduti attualmente dagli insorti ;
- abbondante munizionamento per circa 10.000 fucili tedeschi in uso nell'altra guerra che gli insorti ugualmente possiedono; - 15 apparecchi radiotelegrafici da campo".
La partita pareva giocarsi su questi numeri e la guerra, o insurrezione popolare come la si voleva chiamare , sembrava imminente, con pres umibile enorme giovamento per la pressione contro le truppe italiane impegnate sul fronte egiziano . ln realtà le cose si disposero in altro modo. Da una parte le richieste irachene di forniture d ' armi e di materiali non ebbero da parte dell'Italia, seguito alcuno; dall'altra la crisi politica del go verno di Rashid Ali al -Gbailani portò ad una rapida liquidazione di quella pedina filo -Asse. intanto, sempre a causa della mancata dichiarazi one di indipenden za promessa a tutti gli ar·abi, il dialogo tra i nazionalisti ar-abi e d i governi dell'Asse stava diventando un dialogo tra sordi . li Gran Mufti richiedeva questa dichiarazione e condi zionava ogni insurrezione nel Medio Oriente alla firma di questo solenne impegno che, se Berlino e ra incline a sottoscrivere, trovava il governo di Roma assolutamente contrario.
La gravità della sit ua zione politica nell 'Irak precipitò la fine del governo di Ra shid Ali al-Ghailani che dovette s ubire l'offensiva vittoriosa delle truppe britannico-indiane che ebbero subito la meglio sulle resi ste nze dell'esercito iracheno. La crisi fu, sul piano temporale del]' Asse, un vero disastro in quanto, ai primi del maggio 1941 , le attenzioni militari dell ' Asse erano tutt e rivolte altrove: contro Creta che sarà invasa il 19 maggio e soprattutto contro l'URSS il cui attacco avrà inizio il 22 giugno Ciò potrebbe spiegare il ritardo ed un certo silenzio, circa un intervento militare delle forze ai-mate dell'Asse , che il governo nazionalista di Baghdad richiedeva a gran voce. U na sola eccezione vi era stata e fu l'idea di Mussolini di intervenire subito : "all 'inizio di maggio Mussolini aveva avuto l 'idea di mandar-e aerei in Iraq, ma il governo di Vichy si era opposto e quello di Berlino aveva appoggia to i francesi ... "; il 7 maggio egli ordinò al Comando Supremo di approntare un immediato interve nto dell'aeronautica italiana, con cos picuo 1ifornimento di anni. Si sarebbe trattato secondo le s ue indicazion i dell'invio di una sq uadriglia da bombardamento ed una da caccia nonché di 400 mitra g liatrici leggere e di 16 batterie antiaer ee da 20mm con re lativo munizionamento 22 . Questi propositi non e bbero il
22 Ne parlò per primo M. Montanari, Le operaz ioni in Ajì-ica settentrionale, voi.
TI: Tobruk , Roma, USSME , 1985, p . 279; e quindi R. H . Rainero, La politi ca araba, op . cii. p. 113.

seguito annunciato anche perché la realtà militare dell'Italia non lasciava spazio e disponibilità a simili decisioni. Solo un aereo SIAIMarchetti S. 79 B giunse a Baghdad, il 10 maggio, per studiare le fasi di un intervento Poco dopo ebbe inizio il promesso intervento. Delle due squadriglie vo lute dal duce , solo quella da caccia fu approntata sotto il comando del cap . Francesco Sforza . S i trattava di undici CR 42 che, partiti il 22 maggio, giu nsero a Mossul il 27 dopo varie soste tecn iche a Valona , a Rodi e ad Aleppo. L 'interven to degli aerei tedeschi fu più nutrito e più sollecito : tra il 12 ed il 15 maggio una squadriglia di 14 bimotori da combattimento Bf llOD-3 e sette bombardieri H e 111 H-6 con altri 20 aerei di assistenza Ju-52 e 4 quadrimotori Ju -90B raggiunsero l'Irak.
L'intervento militare dell'Asse non avve nn e in modo tempest iv o , anche a causa del problema della sosta necessaria agl i aere i sug li aeroporti di Siria per c ui le autorizzazioni di uso furono concesse dalla Francia so lo tardivamente. Quando le forze aeree dell'Asse poterono ragg iun gere l ' Irak , la reazione dell 'esercito anglo-indiano aveva rovesciato l 'iniziale situazione e le sorti del conflitto si erano fatte rapidamente drammatiche per il governo nazionalista . I combattimenti degli aerei italiani e tedeschi furono pochi e vani: il 30 maggio ciò c he restava dell'intera flotta tornò in patria.
Così si concluse il primo inte r vento de ll ' As se nel Medio Oriente che da lì a poco dall ' Irak coinvolse la S i r ia. L'i nvas ione della Siria nella quale vi era il controllo di una specia le commissione della C JAF al coma ndo del gen. Fedele D e Giorgis, si°può considerare una prosecuzione della crisi irachena in quanto il pretesto per l'attacco anglo-gollista fu proprio l'uso degli aeroporti siriani da parte degli aerei dell'Asse d iretti in Jrak. Sul piano militare ciò che andreb be ricordato è la p arte c onclu siva che, proprio il D e Giorgis, fece pervenire al C a p o della C IAF, gen. Pintor, sulla questione araba dopo la fine dei co mb atti menti nell' Irak. Questa relaz ione del 4 gi ugno 1941 appare d i notevole importanza anche perché essa delineava , per la prima volta, l'esigenza, per lo sforzo be lli co complessivo dell'Italia , di inser ire nella propria attività strategica il ricorso a for ze arab e sotto un comando i talo-arabo in grado di sfruttare al massimo tutte le potenzialità insite nei movimenti nazionalisti arabi. Si trattava di coordinare, specialmente nel M edio
Ori ente, le for ze che si opponevano, da anni, al colonialismo inglese e che potevano costituire un utile elemento da utilizzare s pec ia lme nte nelle retrovie del fronte c irenaico Precisava il documento: " La lez ione

che si può trarre dagli avvenimenti (dell'Irak) è chiara . L'occasione si ripresenterà e non dovrà coglierci nuovamente impreparati ... " 23 . Il Comando Supremo al quale la relazione fu fatta giungere dal gen . Pintor, non ritenne di dover te nere conto della proposta, ma essa sarà ripresa p i ù tardi, quando , alla fine dell'anno sarà varata l ' iniziativa dei Centri m ilitari arabi da realizzarsi nell'ambito del Regio Esercito . Vi è anche da notare a questo riguardo che le iniziali proposte del gen . De Giorgis ebbero a subire, da li a poco, alla conclusione de l conflitto siriano e dopo il rientro a Torino dello stesso, una profonda revisioni che certamente ebbe effetti negativ i sulla sua stessa proposta. Dopo aver osservato il comp01tamento de ll e folle arabe durante il conflitto tra le forze francesi fedeli a Pétain egli aggressori inglesi e gollisti, egli dedicò un paio di pagine de l suo rapporto finale a "atteggiamento de ll a popolazione durante il conflitto". Le conclusioni della fine di agosto 1941 , sono perentorie: "Al collaudo dell'esperienza del conflitto, la popolaz ione siriana e libanese ha dimostrato, ancora una volta, la sua immaturità politica che rasenta la mancanza cli dignità. Di ciò occorrerà rammentarsi il giorno, speriamo non lontano, ciel 'recide rationem ' . La scusante che essi non amano i fra ncesi no n può essere accettata allorché il proprio territorio è invaso ed allorché i francesi lo difendono anche a l prezzo della loro vi t a Siriani e libanesi hanno sempre preteso clall ' Asse fo rma li promesse di libertà ed indipendenza. Ma pe r r ich iedere c iò occorre possedere un atto di nascita pulito, occorre almeno aver preso posizione decisa in difficili situazioni, occorre meritarselo. Ora, dopo l'esperienza fatta, nego a tali popolazion i diritto e giungo fin'anche a negare che l'od io arabo contro gli ing lesi, a causa della politica filoebraica di quest'ultimi, sia veramente generalizzato e profondo. Fenici e me n ta li tà leva nti na : ecco tutto que ll o che resta de ll a v ieta retorica re lativa al vic i no O r iente ed al mondo arabo in ge nere !"24 .
S i trattava evidentemen te di u n g iud izio severo, che pareva escludere og ni prospett iva sorriden te circa la partecipazione di una vera Legione Araba alla guerra a fianco delle truppe dell'Asse operanti nelle regioni arabe. Di certo, si può ritenere che la posizione ciel gen. De
23 La parte sostanziale cie l documento è r iportato quale Documento n. 3.
24 Queste sono le conclus ioni della Rela zione sul conflitto franco -inglese in Siria (giu g no-luglio 1941), Torino, CIAF, agosto 1941, in USSME, CIAF, Racc. 75 , fase . IO, p . 35.

Giorgis non sia stata estranea ad un certo rinvio di ogni decisione in merito ed anche dell'evidente allentamento della politica del sorriso che il governo di Roma mostrava di avere proprio in quel periodo nei confronti delle rivendicazioni politiche dei nazionalisti arabi. Le richieste del Gran Mufti di Gerusalemme e cieli 'ex presidente del Consiglio iracheno, ormai rifugiato politico, erano sempre le stesse, ma il governo fascista tergiversava . Ormai la "guerra santa" che, dal1 '8 maggio 1941, veni.va ribadita da questi esponenti n.azionalisti, non pareva produrre granché sul piano militare, dove rimaneva a dominare la scena e a determinarne le sorti, l'andamento degli scontri in Libia , in una guerra di tipo "class ico" .
In questo quadro vanno ricordate le attività propagandistiche presso le popolazioni arabe, specialmente dell'Egitto e del Nord Africa (dopo novembrel942) con una impressionante serie di aviolanci di manifestini e cli cartoline cli propaganda che da una parte sottolineavano le difficoltà militari della Gran Bretagna e quindi la sua decad enza , mentre dall'altra esaltavano le antiche virtù degli arabi che erano ben capite dalle potenze cieli' Asse e che gli interventi dei massinù esponenti del nazionalismo filo - Asse , Rashid Ali al Ghailani e il Gran Mufti di Gerusalemme celebravano nei loro proclami 25 .
Ma lgrado queste attività di propaganda, la sit uazione rimaneva tesa . Delle mutate disposizioni del governo italiano nei riguardi delle rivendicazioni arabe , ben si accorsero i due capi nazionalisti che, facendo la spola tra Berlino e Roma e pur agitando, da Radio-Bari come da Radio-Berlino, i loro propositi anti-inglesi, non riuscirono t uttavia a sbloccare la reticenza dell 'Asse circa la richiesta di una solenne pubblica dich iarazione di indipendenza futura del mondo arabo. Di fronte a questa situazione di stas i politica, le profferte dei nazionc._tlisti arabi si moltiplicarono invano nel senso dell'impegno anche nùlitare a favore cieli' Asse . Rompendo un immobilismo a q uesto riguardo, immobilismo che tutto faceva d ipendere dalla sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza , sia Rashicl Ali al- Gha il ani, sia il Gran Mufti aprirono prospettive nuove di collaborazione . II primo con una bozza articolata di indipendenza araba e cli inser imento nel Tripartito , il 28 settembre, il secondo, poco dopo, il 13 ottobre , con una Dic h iaraz ione di programma che annunciava la messa a disposizione delle forze armate e dello sforzo bellico italiano e germanico cli una " O rganizzazione" 25 Nell'Appendice di illustrazi oni se ne vedano i più diffusi.

clandestina armata già esistente ed operante, secondo questa dichiarazione, nei territori del mondo arabo. I primi quattro punti della prima parte di questo ultimo documento riguardavano le attività programmate per il futuro m entre i cinque punti della seconda parte ri guardavano azioni concrete di una fantomatica "Legione Araba" composta da "varie migliaia di combattenti" da mettere subito al servizio dello sforzo bellico italiano e gennanico 26 L'esistenza di una simile Organizzaz ione nazionalista araba cli tipo tran snazionale è stata del tutto ignorata dalla maggioranza degli storici; ma una conferma della sua esistenza e della sua operosità ci viene dalle memorie di un capo dei Servizi Segreti della Francia Libera (controspionaggio), Paul Paillole, che ricorda: " En janvier 1941 ... les Services spéciaux allemands ont des contacts réguliers avec des hautes personnalités du monde arabe. L e grand muphti de Jérusalem , Amin al Husseini, ainsi que le Premier ministre irakien Rachid al Gailani ... clisposent d'une Organisation (O.M.I.) de renseignements et de propagande financée par le Reich. Elle va de Casablanca à Tunis et au-delà vers Le Caire et Dams au Maroc Tanger et Tétouan ... Hitler, informé fin janvier 1941 de ces résultats , a exprimé sa vive satisfaction à Canaris ... » 27 . L'importanza cli questa organizzazione di spionaggio rimane quindi confermata, anche se la letteratura al riguardo resta assai modesta, per non dire inesistente . Per quanto ri g uarda le reazioni italiane ali' offerta nazionali sta di collaborazione concreta, ben poco emerge dalla documentazione d ' archivio.
Per il SIM si trattava di una realtà tutta da verificare. In concreto non se ne parlò più, se non per evocare l'importanza quasi teorica del movimento nazionalista nel mondo arabo.
Non così pare si sia verificato per la Germania che certamente la prese in se ria considerazione. Queste vicende dovette intrigare le autorità italiane a tal punto che, fin dal 13 ottobre 1941 , allorquando Mussolini ricevette la notizia che il governo di Berlino stava muovendosi per creare un Centro arabo a Berlino, con emittente Radio ad Atene, collegato alle attività del Gran Mufti ed in diretta relaz ione con le strutture militari della Germania , l ' immobilismo italiano parve sconfitto. Come ha avuto modo di notare lo storico Strika, un membro autorevole dell'ambasciata italiana di Berlino, in data 28 gennaio 1942,

avvertiva le autorità italiane di queste iniziative ufficialmente taciute all'alleato italiano: "I risultati di que ste manovre , cucite spesso con filo bianco e non molto adatte, anche nella forma, a trarre in inganno due finissimi orientali come il Mufti e Gh ailani . . . non mi pare , almeno per ora , siano stati brillanti ... " 28 . Era, in definitiva un gi ud izio nettamente negativo e ciò dovette tranquillizzare le autorità fasciste. La situazione peraltro non mutò. Per le autorità italiane tutto pareva legato solamen te all 'esito delle battaglie in corso "verso il Canale di Suez", anche senza rimettere in questione il futuro assetto del mondo arabo con pregiudiziali politiche di indipendenza di questo o di quel territorio. Invano il Gran Mufti, dopo essere stato ricevuto dal duce ed alla vigilia di partire per Berlino, aveva tentato , in una lettera del 4 novembre 1941, la carta della devo zione assoluta degli arabi verso Mu sso lini e della sua propria, insistendo sulla sua "ammirazione per le s ue alte qualità e s ul rispetto per la sua eccezionale personalità. Il tutto ruotava attorno alla famosa dichiarazione di indipendenza futura che invece il duce non si decise a dichiarare 29 Nel frattempo il Ministero italiano degli Affari Esteri, d ' intesa con il Comando Supremo, diede, in un Promemoria del 10 novembre , la propria propensione a creare un Reparto Speciale con ele menti arabi da adibire a compiti spec ifici. Peraltro non si precisava il ruolo di costoro nell'ambito delle forze armate del Regio Esercito, ma si sarebbe trattato :
1. di arruolare un certo numero di profughi arabi e di istruirli quali g uastatori, radiotelegrafisti e paracaduti sti;
2. di addestrare una missione militare araba da impiegare per sostenere la rivolta antibritannica, che i capi nazionalisti annunciavano come imminente;
3. di creare una rete di informatori sicuri nei territori ai:abi controllati dagli inglesi;
4. di colpire centri nevralgici delle comunicazioni ne lle retrovie del fronte.
Dopo questi progetti Mus sol ini che aveva dato, il 6 novembre, il proprio assenso ali' idea della prospettata Legione Araba, ricevette , il 18 novembre, una conferma che l 'alleato germanico, senza consulta-
28 V. Strika , I re1roscena politic i d e l soggiorno di Rashid Ali al -Ghailani in J1alia, in"Oriente Moderno", gennaio -d icembre 1984 , p. 149 .
29 Se ne veda il tes to nel Documento n. 5.

zione alcuna con Roma , meditava di recuperare profughi e prigionieri mediorientali da utilizzare al momento opportuno allorquando l'offensiva contro 1' URSS sarebbe giunta nel Caucaso ed avrebbe potuto prendere alle spalle le posi z ioni mediorientali della Gran Bretagna. Non si deve peraltro credere che le iniziative, confuse e disarmoniche, non fossero viste e auspicate nello stesso spirito dai governi di Berlino e di Roma. Il pr imo, senza darne alcun avviso all'alleato italiano , aveva già messo in piedi, in Grecia, a Capo Sunion, un raggruppamento arabo il cui statuto non era stato ben definito ed oscillava tra quello di unità speciali dell ' esercito tedesco (Wehrmacht o SS) e quello di elementi militari di una vera Legione Araba di liberazione. Il testo della formula del giuramento che era stato chiesto a questi volontari, per lo più tratti dai campi di prigionia di francesi e di sovietici, parlava di obbedienza e di fedeltà al Fuehrer e di lotta per la libertà e l'indipendenza degli arabi. Formula equivoca al mas s imo che, di certo non rispondeva alle attese dei capi nazionali sti arabi . La confusione, anche tra le stesse decisioni germaniche, e ra notevole e la prima dicitura del gruppo "Sezione di istruzione tedesco-araba"( Deutsch -Arabische Lehrahteilung) non poteva riassumere le ambizioni dei naziona li st i arabi anche perché , nelle decisioni militari tedesche, vi era una propensione ali' etichetta di "musulmano" in quanto molti musulmani dei Balcani e dell'URSS erano inseriti in queste fonnazioni parallele dell'esercito tedesco . Per la Germania infatti, la priorità era costituita dall ' offensiva contro l'Union e Soviet ica; ben lo dichiarerà , al Gran Mu fti, Hitler allorquando subo rdin erà ogni attività germanica nei paesi arabi all'avanzata nella regione caucasica onde prendere alle spalle le posizioni inglesi nel mondo arabo ed avere così realizzato un doppio fronte d'attacco: "Fino a quando le truppe tedesche non saranno ne l Caucaso è opportuno attendere anche perché non vi sarebbe modo di agire militarmente contro eventuali reazioni che la dichiarazione (di indipendenza) potrebbe provocare da parte inglese"; que s t a dichiara z ione del Fue hre r è del 28 novembre 1941, ma, fin dal lu g lio , le posizi oni di attendismo politico si erano m an ifestate a Berlino nei confronti delle richieste arabe, nella spera nza di una prosecuzione dell'avanzata tedesca nell' Orie n te dell'Unione Sovietica30 E questa posizione di Hitler fu ribadita il 1° dicembre 1941 a llorquando il Gran Mu fti insistette sul

suo programma di creazione di una vera Legione Araba da porre a fianco delle forze Armate dell'Asse: "Gli arabi ringraziano il Fuehrer per l 'interessa mento al loro destino manifestato in varie riprese nei suo i discorsi. Inoltre, egli lo ringrazia personalmente per quanto è stato fatto per Rashid Ali el - Gailani. Gli arabi guardano fiduciosi al Fuehrer che conduce una lotta contro tre avversari che sono anche loro nemici, ossia gli inglesi, gli ebrei e i bolscevichi. Gli arabi sono pronti a partecipare a questa lotta a fianco della Germania e non solo in modo negativo, ad esempio con azioni dj sabotaggio e suscitando disordini, ma anche in modo positivo, schierando una Legione Araba che combatta a fianco delle truppe tedesche. Gli arabi sono convinti che una vittoria tedesca tornerà a vantaggio non solo dei tedeschi, ma di ' tutto il mondo, quindi anche degli arabi. Gli arabi desiderano ottenere l'indipendenza e raggiungere l'unità. Per unità essi intendono innanzitutto l'Unione degli Stati Irnk , Siria, Libano , Palestina e Transgiordania. Sarà a discrezione di altri Stati arabi aderire successivamente ad un siffatto Stato unitario. Anche la propaganda inglese promette l' indipendenza e l 'unità per gli arabi. Sussiste quindi il pericolo che, se da parte tedesca non si fa nulla, passino dalla parte degli inglesi quegli elementi che non hanno ancora assunto una posizione definitiva. Inoltre, tutto il mondo arabo aspetta che la Germania precisi i suoi obiettivi nei confronti degli arabi. Egli chiede perciò che il governo tedesco, assieme a quello italiano, pubblichi una dichiarazione in tal senso ai paesi arabi . Il governo tedesco non deve temere che una simile dichiarazione possa indurre gli arabi a battersi prima del tempo . Gli arabi sono bene organizzati e disciplinati e certamente non si battono senza un suo (del Gran Mufti) ordine . Non è nemmeno ipotiz zabile che i turchi si irritino per una siffatta dichiarazione. La Turchia prefe1·isce avere come vicino meridionale uno Stato arabo indipendente piuttosto di un'Arabia sotto il dominio di una grande potenza europea. Inoltre , uno Stato arabo del genere con una popolazione di 7 -8 milioni di persone non rappresenta alcun pericolo per la Turchia che conta il doppio di abitanti . Si deve anche tener presente che la Turchia possiede un esercito ben addestrato ed armato, mentre lo Stato arabo lo dovrà formare gradualmente. Anche la Francia non può obiettare nulla contro la formazione di uno Stato arabo indipendente; infatti, nel suo trattato dj alleanza del 1936 ha promesso alla Siria la piena indipendenza e sovranità e nel 1933 ha dato il suo consenso alla formazione di uno Statocostituito da Siria e Irak - sotto la sovrani tà di re Feisal. Egli deve am-

mettere che g li arabi hanno avuto dei dubbi sulle inten zioni di certe grandi potenze europee, per esemp io anche dell'Italia . Anche sotto questo aspetto l'auspicata dichiarazione italo- tedesca rassicurerebbe gli arabi. È estremamente opportuno che la dichiarazione sia fatta al più presto, in modo da poter utiliz zare il tempo che resta sino all ' arrivo dell'esercito tedesco. Egli chiede pertanto che sia pubb licata le dichiarazione ai paesi arabi e promette che gli arabi saranno pronti a versare il loro sangue a fianco dei soldati tedeschi" 31 Di certo non era la prima volta che i capi nazionalisti arabi evocavano la prospettiva di una Legione Araba da affiancare alle truppe italiane e tedesche, ma forse era la prima volta che la quest ione veniva messa in chiaro in un documento altamente im pegnativo .
Tuttavia va notato , come s i può vedere chiaramente, che la dichiaraz ione del Gran Mufti non era di totale e definitiva ade s ione ai piani dell'Asse; anzi, in essa veniva accennato al rischio per la scelta filoAsse che il mondo arabo , di fronte alle reticen ze di Berlino e di Roma, per quanto riguardava la dichiarazione di indipendenza, pote ss e, o rifiutarsi di fare scattare le azioni della " Organizz azione" segreta o, addirittura, si schierasse con la Gran Bretagna che di promesse era particolarmente ge ne ro s a. La Legione Araba diventava così una arma politica per nego ziare con Ber! ino e Roma, e quindi l ' intero edificio della " politica araba" , di Roma , come di Be rlino, veniva ad essere messo in crisi, a meno di accettare la richiesta dei nazionalisti. Ad un simile discorso , Hitler rispose con fermez z a ribadendo che s olo dopo che le truppe tedesche avessero raggiunto il fianco meridionale del Ca ucaso si po trebbe portare il colpo mortale all ' imperialismo brita nni co nel Medio Oriente e q uindi procedere, allora e non prima , alla proclamazione de)] 'indipendenza degli arabi. Evidentemente si trattava di una risposta di occasione che teneva peraltro conto sia dei problemi militari italiani in Libia , dove la re azio ne britannica stava prendendo il sopravvento, sia dall'avanzata, q u as i senza sosta, delle truppe germaniche nel cuore dell'URSS .
Su queste due linee , la politica e la m ilitare, si diedero da f are , sia i cap i n azionalisti arabi, sia i governi italiano e tedesco, proprio mentre due grand i novità militari si affacciavano alla ribalta . Da una parte, la comparsa del Giappone come membro dell ' alleanza miliare a due che diventava il Tripartito e dall ' altra, l'entrata in g uerra degli Stati

Uniti, dopo Pearl Harbour (7 dicembre 1941). Entrambi questi eventi ci interessano perché il Giappone non faceva mistero di vantare diritti anche nella questione dell'Asia nùnore, cioè proprio del mondo arabo, mentre gli Stati Uniti potevano dare, con la loro imponente produzione bellica , una svolta decisiva al conflitto in corso, sia nell'URSS, sia nel Medio Oriente. Per quanto riguarda gli Stati Uniti va ricordato che la firma della Carta Atlantica (14 agosto 1941) aveva già acceso le speranza della nascita di una vera e propria "dottrina della Liberazione" che riguardava il "diritto di tutti i popoli di scegliersi la forma di governo sotto la quale desiderano vivere .. . " e quindi la fine di ogni forma cli colonialismo. Rimasto un po ' in sordina all'inizio questo me ssaggio diventerà però fondamentale , quanto alla partecipazione degli arabi alla guerra a fianco dell'Asse, dopo lo sbarco americano nel Nord Africa nel novembre 1942.
Sul piano militare, i capi arabi insistevano nel progetto della nascita della Legione Araba, ritenuta premessa necessaria ad ogni coinvolg imento del mondo arabo a fianco del!' Asse. Il 19 gennaio 1942, essi affermarono a Berlino e a Roma che "i centomila arabi, pre va lentemente marocchini ed algerini, nonché i trentamila arabi prigionieri, presenti in Francia" sarebbero stati pronti "a seguire gli ordini del Gran Mufti ed a combattere , sia per la liberazio ne dei paesi arabi del Vicino Oriente dal giogo in g lese, sia per la liberazione dei paesi del Nord Africa eia ogni eventuale minaccia di manomissione da parte dei degaullisti, s ia, anche dalla donùnazione della Francia di Vichy". Inutile dire che, se la prima proposta poteva ·sorridere anche all'Italia, la seconda, relativa alla "liberazione dal giogo coloniale" dell ' intero Nord Africa trovava il governo fascista decisamente contrario essendo proprio quella regione "prenotata" per la propria espansiooe, a guerra vinta. L'Italia invero si proponeva ben altri fini di quelli auspicati dai nazionalisti arabi i quali, invece, trovavano nella Germania un interlocutore piuttosto disinteressato ai problemi arabi veri e propri. I piani dell'Itali.a erano invece in continua crescita e nel gennaio 1942, una relazione del Ministero degli Affari Esteri già enunciava grandiosi e nuovi progetti : "Ora l ' Italia nuova che uscirà dalla vittoriosa Guerra Mondiale - operante nella sua rivoluzione - dovrà attuare i suoi grandi propositi di collaborazi.one con i Paesi dell ' Orjente vicino e medio nell'ordine politico culturale ed economico, con particolare riguardo alle tendenze secolari dell'espansione ita liana . Lo spazio vitale mediterraneo dovrà costituire il nesso comune fra tutte le varie Nazio ni me-

diterranee per poter assicurare una pace feconda e duratura e il progressivo sviluppo di tutti gli stati le cui sponde sono bagnate dal mare. In questa organizzazione - una vera e propria "Commonwealth Mediterranea" - che potrebbe venire chiamata "Impero Mediterraneo" - verrebbero a trovar posto ( oltre Cipro, la Grec.ia e la Spagna) tutti i vari Stati dell'Oriente Mediterraneo Europeo (Turchia) Asiatico ed Africano , cioè tutti i popoli che direttamente o indirettamente si affacciano nel vecchio bacino mediterraneo , tramite della effettiva unità e interdipendenza tra l'Europa, l'Asia e l ' Africa . Di essi , gli Stati del Libano , della Palestina , della Siria , dell'Egitto, della Transgiordania hanno risentito dell ' influsso della civiltà mediterranea, cioè romana, cioè italica; altri - come l' Irak - sono necessariamente attratti verso quella ci viltà . La sua posizione strategica , le grandi possibilità di progresso , la facilità e rapidità ormai raggiunte dalle comunicazioni ne vincolano sempre più l'esistenza alle sponde orientali del Medite1rnneo. Altri infine - come Saudia e Yemen - devono considerarsi come elementi integrativi, perché le coste saudiane e yemenita fanno parte di quel complesso sistema che è il Mar Rosso, la libertà del quale è indispensabile non meno di quella del Mediterraneo di cui non è che la naturale continuazione ... " 32

I documenti che davano una certa conferma a queste speranze non sono pochi; tra essi uno che proveniva dal console italiano di Adana, posizione di avanguardia in Turchia dell'osservatorio italiano sul Medio Oriente , si possono trarre utili elementi che davano alle speranze italiana di imminente rivolta contro la Gran Bretagna da parte delle popolazioni arabe, una conferma evidente: "Lo spirito antinglese già da tempo radicato nel popolo arabo, sia per la spinosa questione ebraica in Palesti na , sia per la non mantenuta fede alle innumerevoli promesse fatte nel passato dall'Inghilterra, oggi, con la nuova situazione, si può affermare che è andato ancor più rafforzandosi, rendendo così più vivi, anche se in parte per riflesso, i sentimenti della popolazione in favore dell'Asse. È interessante analiz zare le ragioni che ne sono la causa e che cercherò brevemente di elencare :
I) la nece ss ità per le autorità inglesi cli re quis ire per i bisogni imm ediati dell ' es e rcito i prodotti del paese , se nza poter ten e r conto delle nece ssità
de ll a popolazione locale, dete rminando così l' aumento dei prezz i, rare fazione di merci sul mercato, requisizioni sempre odiose, e conseguente disagio economico e carovita;
2) g li ostacoli e le barriere che s i presentano oggi al paese per qualsiasi scam bio com merciale con l'E urop a, ciò che oltre a incidere s ulla classe deg li esportatori ed importato ri , si rifle tte su tutta la v ita economica in genere. Anche più forte risulta tale fattore. in quanto. prima dell'occupazione della Siria, la propa ga nda inglese si se rviva proprio del miragg io di un ar ipresa commerciale at traverso la Palest in a e l'Egitto , per creare nel P aese, e specie nel Libano, delle correnti filoinglesi;
3) la presenza su l te rr itorio , per necessi tà di g uerra, di truppe di nazional ità e di abitudini molto diverse, e per la più parte insofferenti di disciplina, il c ui contatto inevitabile con la pop olaz ion e ha dato luogo, e va da nd o luogo , a continui incidenti;

4) lo s tato di latente tension e esis tente fra le autorità in glesi e quelle del la Prancia libera;
5) le pressio ni del movimento s ioni s ta per oltc nere che venga riconfermata e rafforzata la posizio ne deg li ebrei in Pa lestina, con l'esclusio ne tota le della popolazione araba dal litorale, l'annessione di alcune zone del Libano me ri dionale, e una espans ione industri a le e commerciale ne i limitrofi paesi arabi; tutte pretese che, per essere appoggiate da l sionismo d'America, hanno gran peso sulla politica dell'Inghilterra;
6) pe r aver dovuto impiegare, per costi tuire nei paesi occupati dei governi asse r viti, ele menti tarati e di seco nd o piano, il cui spirito di servilismo e di basso opport uni smo e ra già p ubbl icame n te noto;
7) il non poter dispon-e di una personali tà di primo piano il cui nome avesse presti g io e risc uo tesse un anime rispe tto; ( l'E miro A bdalla . s ul qùa lc g li inglesi tanto contavano, non ha nessun seguito essendosi da tempo dimostrato incapace e inetto; né, d'altra parte, .lbn Sa ud, tenu to finora in seco ndo pia no e in asprito per la marcata prefe ren za verso Abda lla , è persona c he ora si presterebbe facilmente ad essere strumento degli inglesi).
8) L' essere sta ta la s te ssa proc lamaz io ne dell'indipende nza s iriana e libanese, da cui tanto sperava l'Inghilt erra, per controbattere le dichiara1,ioni dell'Asse, di effetto quasi nullo su ll'opinione pubbli ca che la ha acco lta co me un fatto d e l tutto tran s itorio e p recario;
9) la prese nza nei Paesi dcli ' Asse, del Gran M u fti di Pa lest in a, cli Gailani e di va ri loro seg uaci, il cui asce nd e nte, reso ancora più gra nde da ll e perse-
cuzioni , è sempre v ivo nell ' animo degli arabi e concorre a mantenerne des to lo s pirito di na zion ali s mo e di rivolta;
10) l'entrata in g uerra del Giappone ed i rapidi successi militari ri po1tati Nell a mentalità araba è profondamente radicato il co n vincimento che mai il Giappone s i sarebbe deciso ad en trare in g uerra , se no n ne lla asso lu ta s icure zza della vittoria deg li Stati totalitari" 33
In questa analisi le autorità itali ane ritennero di potere indi viduare il proprio s pazio di predominio politico futuro nel Medio Orien te, predominio che già molti documenti u fficia li annunciavano . Per le speranze arabe nel loro complesso, non vi poteva essere s mentita più clamorosa, ma, essendo la citata R e lazione del gennaio un documento segreto , le attività dei due capi naziona li sti proseguirono pur facendo essi notare , a Be rlino , il 17 gennaio, che le retice nze dell'Asse non potevano non tenere conto del "pregiudizio già derivato all'Asse per l'iniziativa presa dall ' In gh ilterra con le dichiaraz ioni di indipendenza all ' Irak , a lla Siria , alla Palestin a ed al Libano, rafforzate d all'adesione am erica na e, per la S iria da quella di Ibn Saud ... ed hanno anche citato , a prova delle mano vre in g lesi in corso, la dichiarazione per la Cirenaica e per i Senuss i, questione che ess i sono ben decisi a non s ollevare". E qu est' ultim a affermazione era un chiaro ricatto al governo di Ro ma il quale non mostrò di cedere a questi richiami e nel ricevere, il 12 febbraio 1942, a Rom a i due esponenti nazion alisti, il ca po del SIM, Cesare Amé, ribadì la posi zione del gove rno italiano. In quella occasione i due insistettero s ulla futura collaborazione militare propug nando "l' istituzio ne di una Legione Araba" accennando anc h e alla "possibilità di incorporare ne lla Legione , oltre che gli arabi residenti in Germania, anche elementi musulmani dell ' Africa francese e della Libia". Ovviamente que s t'ultimo cenno non era ritenuto accettabile dalle autorità italiane le quali non diedero corso al progetto avanzato da i due capi nazionalisti.
Nel frattempo una analoga s ituazio ne di impasse pareva affliggere il governo giapponese per la que stione dell ' India. Nel gennaio, l ' ambasciatore del G iappone a Berlino , genera le Hiroshi O shima, aveva espresso la propria opinione che fosse giunta l 'ora per il Tripartito di rilasciare una d ichiaraz ione co ngiunta circa l'ind ipendenza da riconoscere ai paesi arabi e all'India, ma il governo di Tokyo , non accolse

sub i to l'idea della ve ntil ata dichiarazione a proposito de ll'Indi a mentre e ra d ' acco rdo pe r quan to rigu a rd av a i paes i a rabi. M a poco dopo , il primo mini s tro giappo nese Hideki Toj o , d ' intesa con il c apo n az ional ista indiano Sub has Chandra B ose, e con i nazi o nalisti indiani a nti-ingl es i r ifug ia ti s i a B e rlino , dichiarò di vole r sottosc rive re una di c hiarazion e di indipenden z a per l ' lndia. Pertanto , poco dopo , l ' a mb as c iatore Oshima ne dovette prende re atto e c hiarì la sua pos iz ione s ugge re nd o a Roma e a Berlino di d ec idere di fare pe r i p ae si arabi la ste ssa dichiara zione cli indipenden za che il Giappone s ta va m e ditando di fare per l ' I ndia. La qu es tion e s i risol se po siti vamente ma la dichi a razione con g iunta che venne e laborata d a lle tre capitali , il 6 feb bra io 1942 , non e bbe la richie sta pubbli c ità: essa s i r isolse i n una di c hj ara z io ne tripa11i ta segre ta, la quale in definitiva las c iava campo libe ro ad ognun a dell e tre parti di attuare una propria politica . L'o ppos iz ione mag g iore ad un a dichi a razi on e pubblic a venne dal governo di B e rlino il quale si ade g uò alla propos ta di C iano pe r q uanto riguardava un caso s pecifico , l ' Jrak , co n l'ela boraz io ne di un compl esso tr a ttato di coope razione e di a llean za tra le poten ze del tripartito e il futuro gov e rno di Baghdad , a guerra vinta. Le molte stes ure de l documento , che non avev a ne ss un val o re prati c o , dim os tran o le di fficoltà di me tte re d 'accordo i va ri gove rni , a nch e s u que s to testo di trattato, d ' a ltrond e del tutto teorico vis to c he il g o ve rno irac hen o nazion a li s ta firmatari o non es is te va proprio, se non in es ilio. Infine i trattati e laborati furono due : il 26 febbraio , venn e ro approvati due te s ti; nel pr im o i s ot toscrittori e rano lo Stato irache no e g li Stati ara bi , me ntre il secondo rigu a rdava so ltanto l'Ir ak . Va precisato c he il primo testo evocava so lo gli S tati arab i d el Medi o Orie nt e e quindi las ciava g li arabi del Nord Africa fu o ri d a l tratta to e quindi dall ' indipe nden za promes sa. E con un siq1.i le stratagemma, la r ivendica z ion e de ll ' Ita lia ven iva sa l vag uardata.
Intanto s i fac ev a s trad a negli ambienti militari de l Comando Supremo itali ano , la proposta di crea re un a forza ar mat a s pecial e araba da impiegare s ul fronte nordafric a no e , ne l futuro , in tu tte le ope razioni ne l mond o arabo. Si riprendev a insomma, non tanto il proge tto dei nazio n a listi , quanto il piano d'azione della c rea zione di una for za militare araba ne ll ' ambito del Regio Eserci to , creaz ione che già e ra stata auspicata ne l giugno 194 1 e ventilata fi n dal 10 nov emb re 1941 . La que s tione non era se mp li ce e ben presto c i s i accorse c he la cre azion e di una simi le forza , se presentav a possibili futur i vanta g gi, offriva, all 'i ni z io della sua realizz azio ne, non pochi problemi.

(15 luglio 1940)
Al termine dei suoi lavori la speciale Sottocommissione politicomilitare della Commissione per le questioni relative ai paesi arabi compilò, il J5 luglio 1940, una rela z ione conclusiva della quale si riportano le parti più s ign(ficative, relative alle future decisioni militari dell'Asse nel Medio Oriente:
1
° - Punti strategici nei paesi arabi che, dal punto di vista militare, politico ed economico converrebbe fossero occupati dalle Forze Armate italiane per la durata della guerra.
Primo tempo:
Durante il periodo delle operazioni e durante i primi giorni dell'occupazione il problema è puramente militare e di competenza, quindi, dei Comandi delle truppe operanti. È ovvia la necessità, a mano a mano che le operazioni militari lo permetteranno, di occupare e presidiare i gangli vitali dei paesi arabi; i principali centri politici; gli aeroporti; i nodi delle ferrovie palestinesi (come Caifa, Lidda, Gerusalemme, Gaz a, Tel Refaa) .i porti principali e l ' in tero percorso dei due oleodotti appena possi bile il porto di El Cueit e quelli dello Sciatte 1- Arab ...

. . . Si ritiene esprimere il voto che le autorità militari i ta li ane a bbiano presente l 'o pportunità che a tutte le occupazioni terrestri pa1tecipino forze italiane e che le o ccupazi o ni marittime siano riservate alla Marina italiana.
Dopo i primi giorni d ell' occupazione si do vrà instaurare un regime militare-politico provvisorio sino alla fine della guerra ...Verranno allora dalle autorità militari dell'Asse, d'accordo con quelle politiche, stabi li ti alcuni punti strategici da conservare s otto occupazione militare sino alla fine della guerra .
2° - Zone o punti strategici che dovrebbero essere assicurati permanentemente all'Italia anche in tempo di pace - al di fuori del
territorio dei paesi arabi - per garantire la tutela dei nostri interessi nei paesi arabi.

Isola di Cipro . .. Penisola del Sinai . .. Arcipelago delle Fargan .. .Isole di Gebel Tair, Zubeir e Abu Ali .. .Isola di Camaran . .. Isola Zucur e Hanisc grande .. . Isola di Perim . . . Aden . Nove Distretti , Hadramaut. . . Isola di Socotra , Abd e l Kuri, i Fratelli .. .Isole Curia Mariam ... Sultanato di Oman e !marnato di Mascate .. . Isole di Bahr el Benat e di Taub .. .Isole Bahrein .. .Altre posizio ni nel Golfo Persico sulla costa iraniana ...
3° - Interesse italiano rispetto alle rivendicazioni dei paesi arabi su Alessandretta, sul Cueit e sull' Arabistan. Alessandretta ... Cueit. . . Arabis tan .. .
4° - Qual è l ' interesse dell'Italia rispetto alle aspirazioni di altri Stati sopra territori oggi posseduti o reclamati dai paesi arabi del Vicino Oriente".
A leppo ... Aqaba ... Aspirazioni dell'Iran verso occidente.
FONTE: ASMA E, Affa r i Politici , Italia, b. 70 (1940. Direz . Ge n . Sottcomrn. per lo studio dell e ques tioni te rrito riali) .
Documento n. 3
LE PROPOSTE DEL GEN. DE GIORGIS PER LA CREAZIONE DI UN ESERCITO NAZIONALE DEI PAESI ARABI (4 giugno 1941)
Dopo la fine dei combauimenti in lrak, il capo della Delegazione della C!AF in Siria, gen . Fedele De Giorgis propose al Comando Supremo, in un documento del 4 giugno 1941 , lafonna z ione di speciali gruppi militari nei pa es i arabi da utilizzare nel conflitto in corso . La parte conclusiva del documento precisava:

La lezione che si può trarre dagli avve nimenti è chiara .
L'occasione si ripresenterà e non dovrà coglierci nuovamente impreparati.
Propongo :
1) Sia predisposta al più presto l'organizzazione di tutte le forze antibritanniche del Levante , forze che chiedono solo di essere impiegate.
2) L' organizzazione di tali forze dovrà essere affidata ad un solo individuo: que sti dovrà essere un uomo d'azione, di provata capacità e sopratt utto di estrema decisione; dovrà essere munito di pieni poteri per agire entro vasti limiti senza richi ede re continue autorizzazioni.
Di spo rrà di pochi collaboratori di prima scelta e so prattutto di sua scelta (sono necessari perché le tribù beduine hanno bisogno di essere seguite nell'azione ).
3) Dovranno essere assegnati senza lesinare i mezzi occorrenti (armi , munizioni, esplosivi). Nei mezzi dovrà essere compreso il denaro; occorre che l'incaricato dell'impresa sappia s u quali somme può contare e che ne possa disporre senza formalità superfl ue.
4) Dipenderà direttamente da l Comando Supremo: ma - e questa sarà condizione indispensabile del successo - dovrà essergl i lasciata la piena responsabilità dell'impresa affidatagli e, con la responsab ilità, l'iniziativa più ampia .
Le proposte di cui sopra hanno il valore che si crederà di attribuire loro.
Ritengo peraltro doveroso dichiarare che ad esse sono stato indotto dalla constatazione che il nostro interessamento per il movimento arabo si è ridotto praticamente in attività platonica; non avendo in sostanza costituito un incitamento ma un freno per gli antibritannici che volevano agire. Ed il prestigio nostro non ne ha guadagnato certamente.
È per evitare per quanto possibile il rip etersi di una simile situazione che credo mio dovere segnalare la realtà dei fatti a codes ta Presidenza.
Il generale di divisione
Capo della Delegazione

F. De Giorgis
4 giugno 1941
Allo scopo di migliorare l e rela zioni con Roma e Berlino in vista dì una auspicata Dichiarazione di indipendenza dei paesi arabi, il Gran Mufti rese noto il 13 ottobre 1941 il seguente Programma nel quale accennava , per la prima volta, ad una "Organizza z ione" ali' interno dei paesi arabi al servizio dello -~forw bellico dell'Asse
1) L" 'Organizzaz ione" lavora e lavorerà al di sopra di ogni ideale religioso e pur servendosi della forza che deriva dalla solidarietà musulmana con la causa araba, per ottenere l 'i ndipendenza e la sovranità dei Paesi arabi : Irak, Siria , Palestina e Transgiordania, che, per costituire un'entità economica e politica che possa vivere, devono vedere riuniti i loro IO m ili oni di abitanti;
2) Il Mufti appare intenzionato a s volgere la sua azione con la massima chiarezz a ed onestà di fronte s ia all'una che all ' altra Potenza dell'Asse . È convinto però che i maggior i reciproci interess i che già esistono e che ancor molto più possono essere svi luppati tra l'Italia mediterra nea ed africana ed i Paesi arabi devono avere un giusto riconoscimento;

3) Ove l'unione , l 'indipende nza e la sovran ità dello Stato arabo siano fuori cau sa, il Mufti desidera stabilire una sincera e duratura amicizia e collaborazione con i P aesi dell'Asse che potrà essere consacrata da trattati di commercio e da concessioni econom iche ( petroli, fosfati, cotone e tc.) di massimo favore e di larga portata . Specialmente con l'Italia vede poi la possibilità di larghe intese cultura]i e di trattamento di favore a insegnanti e professionisti italiani. Egli ammira la Germania ed il Fuhrer, ma è convinto che la maggiori affinità e le secolari trad izioni riservino maggiori pos sib ilità di collaborazione da parte del nu ovo Stato mediterra neo con l'Italia, le c ui dottrine fasciste egli ritiene co in cidono perfettamente con la me ntalità e con gli ideali del popolo arabo;
4) Sempre ove l'indipenden za e la sovranità dello Stato arabo s iano fuori causa, tutte le que stioni poli tiche e militar i che interessa no
l'Asse e più particolarmente 1'Italia ( Luoghi Santi, Libano, Canale di Suez, Akaba ) potranno essere risolte con spirito di arrendevole za e di massima buona volontà da parte degli arabi .
Su queste premesse - che il Mufti si augura potranno essere accettate da Roma e da Berlino -i programmi suoi per il futuro sarebbero i seguenti :
1) Costituire insieme a Ghai lani , il centro dell'attività della" organizzazione" in Italia e possibilmente nei dintorni di Roma (Ghailani è uno dei membri del Comitato della "Nazione araba").

2) Stabilire un centro di collegamento a Be rlino con uomini di sua , fiducia ed un centro di informazioni e di attività ad Istanbul ;
3 ) Iniziare al più presto le attività d i una stazione radio clandestina " La Nazione Araba" in Italia;
4) Sfruttare le grandi ripercussioni che avrà sul mondo arabo l ' annunzio della stretta concreta collaboraz ione che così verrebbe a stabilirsi tra i Capi dell' "Organizzazione" e le Potenze dell'Asse per provocare attraverso gli agenti rimasti s ul posto, movimenti di rivolta e sabotaggi contro l'Inghilterra in tutti i Paesi arabi. Sfruttare nello s te sso tempo il suo alto prestigio sui musulmani dell ' India, del Turkestan e della Bosnia a favore della causa dell ' Asse ;
5) Costituire una Legione Araba , un corpo di paracadutisti ed un servizio arabo di " Intelligence" per combattere gli inglesi dovunque sia possibile. (il Mufti ritiene possibile ritinire varie migliaia di combattenti).
Documento n. 5

Dopo essere stato in colloquio con il duce, il Gran Mi{fti di Gerusalemme, alla vigilia di partire per Berlino onde conferire con Hitler, scrisse, il 4 novembre, la seguente lettera per confermargli la totale devo z ione degli arabi e la sua scelta definitiva a favore dell'asse .
in occasione della m ia determinazione di partire per Berlino , desidero porgere il mio più vivo ringraziamento per le cortesie e le accoglienze ricevute durante la mia permanenza a Roma ed il mio colloquio con Voi; in modo particolare per le preziose parole da Voi pronunziate a nome Vostro ed a nome del Governo e del Partito, circa l ' idoneità della Nazione arab a alla completa indipenden za ed a governarsi da sé, e all 'acce nno ai sacrifici da essa compiuti per raggiun ge re la me ta: per la Vostra decisa intenzione di realizzare le aspirazioni degl i Arab i e la loro indipendenza con piena sovranità; per la Vostra promessa di aiuto politico e di forniture di anni a ta le scopo; nonché dell'abolizione in Palestina del Focolare Nazionale ebraico; e per le Vostre preziose espressioni che hanno prodotto nell ' an im o mio la più grata impressione , rendendomi tra nquillo e completamente fiducioso , ed aumentando in me l ' ammira zione per le Vostre alte qualità, ed il rispetto per la Vostra eccezionale personali tà.
lo Vi assicuro, Eccellenza, che il Vostro valido ai uto ai Paesi Arabi per la realiz zazione delle loro aspirazioni e per il conseguimento de ll'uni tà e della completa indipendenza con la piena sovranità, sarà accolto dagli Arabi - come merita - con molta gratitudine e con il più alto apprezzamento . Ed a suo tempo tutti noi faremo fino all'estremo limite il poss ibile per il consolidamento dei legami di am ic izia e di collaboraz ione economica tra i due Governi dell 'Asse ed i Paesi Arabi, per il bene comu ne cli ambo le parti; fa remo pure il poss ibi le per combattere gli accaparramenti economic i e i progetti finanz ia r i britannici , ebraici ed americani che tanto hanno nociuto agli interessi arabi . Così anc h e opereremo per il consolidamento delle relazioni econom ic he
con le Potenze dell'Asse e per uno scambio reciproco delle risorse economiche, sempre per il bene di ambo le parti.
Mi è anche grato di assicurare Voi , Eccellenza, che i Luoghi Santi nei nostri Paesi sono stati sempre oggetto del nostro rispetto e continueranno ad esserlo anche in avv e nire in modo assoluto; lo " statu quo " dei Luoghi Santi di tutti i riti , delle varie religioni e dottrine sarà mantenuto con ogni cura, sarà pure rispettato accuratamente tutto ciò che riguarda la religione ed i luoghi di culto di tutte le religioni e riti , nonché il loro carattere sacro.

Per quanto concerne l'inclusione del Libano nello Stato Arabo, io Vi assicuro che noi consideriamo i libanesi , siano e ssi cristiani o mus, sul mani, di qualsiasi religione o rito, alla pari di tutti gli altri arabi; essi sono fratelli nostri, arabi come noi, con noi uniti nella lingua, nel1'origine, nella residenza, negli interessi, negli usi e nelle tradizioni . Essi godranno di tutti i diritti spettanti agli arabi viventi in altre parti dei Paesi Arabi ; i loro beni , le loro credenze, i loro luoghi di culto , le loro tradizioni religiose e tutti gli altri inte ressi saranno scrupolosam e nte rispettati, senza discriminazione dagli altri loro fratelli arabi. Tal e inclusione sarà loro sommamente proficua economicamente e moralmente ; e mai ne riceveranno danno alcuno dal punto di vista materiale né da quello morale.
Io sono sicuro che tutte le difficoltà che potranno eventualmente opporsi alla unità dei Paesi Arabi e alla loro stretta collaborazione con le Poten ze dell'Asse , saranno eliminate c'on ogni facilità , grazie alle buone intenzioni esistenti presso le due Parti , unite in stretta e duratura alleanza.
Vogliate accogliere, o Grande Duce, i sensi della mia ammirazione e rispetto .
FONTE: ASMAE, Affari Politici, Palestina, b. 32; nonché ACS , Segr. Part. Del Duce, Cart. Ord. (1922 - 1943), fase. 208878.
Documento n . 6
Il governo italiano volle chiarire con questa dichiara zione dell'inizio di gennaio 1942 i propri propositi riguardo al M edio Oriente ed alle sue popolazioni, nel quadro della sua politica del Nuovo Ordine Mediterraneo:

Ora l ' ltalia nuova che uscirà dalla vittoriosa Guerra Mondialeoperante nella sua rivolu zione - dovrà attuare i s uoi grandi propositi di collaborazione con i Paesi dell'Oriente vici no e medio nell ' ordine politico culturale ed econom ico, con particolare riguardo alle tendenze secolari del l'espansione italiana
Lo spazio vitale mediterraneo dovrà costituire il nesso com un e fra tutte le var ie Nazioni mediterranee per poter assicurare una pace feco nda e duratura e il progressivo sviluppo di tutti gli stati le cui sponde sono bagnate dal mare.
In questa organizzazione - una vera e propria "Commonwealth Mediterranea" - che potrebbe venire chiamata " Impero Mediterraneo"verrebbero a trovar pos to ( oltre Cipro , la Grecia e la Spagna) tutti i vari Stati dell'Oriente Mediterraneo Europeo ( Turchia ) As ia tico ed Africano , cioè tutt i i popoli che dire ttamente o indirettamente si affacciano nel vecchio bacino mediterraneo, tramite della effettiva unità e in terdipendenza tra l'Europa, l'Asia e l'Africa. Di essi, gli Stati del Libano, della P ales tina, d ella Siria, dell 'Egitto , della Transgiordan ia hanno risentito dell ' influsso della civiltà mediterranea, cioè roma n a, cioè italica; altricome l ' Irak - sono nece ssaria mente attratti verso quella civiltà. La sua posizione strategica , le grandi possibilità di progresso, la facilità e rapidità onnai raggiunte dalle comunicazioni ne vincolano sempre più l'esistenza alle sponde orientali del Mediterraneo. Altr.i infine - come Saudia e Yem e n - devono considerarsi come elementi integrativi , perché le cos te sa udian e e yemenita fanno parte di quel complesso sis tema c he è il Mar Rosso , la libertà del quale è indi spe nsa bile non meno di quella del Mediterran eo di cui non è che la naturale continuazione.
Questa organizzazione futura dovrà apparire come la liquid az ione defin itiva di un vecchio mondo c he non ri spo nd e più ai nuovi ideali
d a i quali i popoli so no g uidati e so rretti, ideali basati sull'ordine politico e sociale, s ulla giustizia, s ull a eq uità e parità di diritti, sugli e quilibri de ll a ricchezza in rapporto al lavoro, s ulla defini z ione dell e nazion a lità aspir a nti ad aggrupparsi in istinti vi nuclei operanti in una v ita com une e in a rmoni a reciproca.
L' aboli z ione dell e rivalità p e r la conquista dei me rcati e per l'accesso alle materie prime dovrà soffocare qu a ls iasi antagonismo. Questo movimento grandio so c he porta a ll ' uni o ne di tutti i popoli polarizzati ve rso uno stesso mare dovrà essere inquadrato nel nu ovo ordin e economico da s is te mi di scambi comme rciali per via di baratti ( rifornimenti di prodotti industriali in cambio di prodotti agricoli e di mate ri e prime ), da accordi di compen sazione multilaterali, da una intensa e continua collaborazione nel campo politico commercia le e finanziario.
L' Italia dovrà aiutare a ric ost itu ire entità etniche che le vio lenze delle guen-e e delle pac i avevano disperso e sconqu assato (arme ni , ass iri , curdi); favo rire le popolazioni arabe c he anelano alla costitu zione regolare e legale della loro na zionalità : as s ic urare l ' indipenden za degli Stati arabi del pross imo e Medi o Oriente co n ciascuno dei quali l ' Itali a dovrà esse re legata da un trattato di a ll ea nza e d i coop erazione , contrib uire alla soluzione della questione d e i Luo ghi Santi ch e s i impone, e non per sole rag ioni di pres tigio , ad una nazione cattoli ca come la no s tra, c ulla e sede della c hie sa di R oma
L' Italia dovrà recare il suo co ntributo a lla grande opera di industriali zzaz ione de i Paesi d ' Oriente , creando stabilimenti e officine , ce ntrali e let triche , raffinerie , zuccherifici, tess itorie; a ttrezzando comunicazioni stradali e fen-oviarie; ponti; mi g liorando l'ed ili zia nei ce ntri urbani.

Intensa co llabora z ione quindi g uidata d a ll ' Italia, con l'Oriente, colla borazione s ia economica che co mmercial e e culturale, la qu a le co nse nt a in caso di necessità una attiva collaborazione su l piano politico.
Questa co llabora z ione potrà effettuar s i s ia con uno Stato unitario arabo basato sul dec entramento a mminis trativo , sia co n i vari Stati libe ri indipe ndenti , ciascuno vive nte di vita propria.
L'u n ione dei var i Paes i arabi interessati dovrà esse re realizzata solo se una simile decisione ven-à manifestata per volontà del popolo.
È da rite nersi tutt av ia che ancora ogg i l'ara bismo s ia lungi dall'esser pronto a ri sol vere in proprio favo re la questione d' Oriente .
La po ss ibilità di una unit à politica arabo -mu ssulma na appare tuttora come una as pira z ione di inte ll ettuali idea listi. Essa è resa d ifficilmente reali zzabi le dalla mancanza di spirito unitario neg li stessi a rabi.
Nessun paese mussulmano possiede una superiorità politica, religiosa, economica, tale da imporsi agli altri in maniera decisa. D'altra parte può essere pericoloso favorire eccessivamente tendenze estreme nazionalistiche e panarabistiche che oggi soprattutto sembrano facilmente avviarsi verso il fanatismo .

L'Italia si troverà quindi in contatto o con uno Stato unitario retto da forma monarchica o repubblicana, che potrebbe comprendere i soli Paesi arabi dell'Oriente asiatico - con centro Bagdad e Damascoblocco considerevole di oltre 16 milioni di abitanti e somma importante di interessi; o con diversi piccoli Stati indipendenti, cioè con un Regno d'Egitto, con un Regno di Saudia, con un Regno dello Yemen, con un Regno dell'Iran, con uno Stato della Pal est ina e Transgiordania, con uno Stato del Libano e con uno Stato della Siria .
Anche la questione dei due Paesi (Stati del Levante) già sotto
Mandato francese non è di molto facile soluzione.
li Libano è di carattere cristiano cattolico e autonomo per alta tradizione storica; la Siria di carattere puramente is lamico
Certo che il distaccare il Libano dalla S iria s ignificherebbe allontanare la fusione dei due territori che riunendosi avrebbero bisogno di integrarsi (il Libano con i suoi porti , la Siria con la sua produzione agricola), significherebbe non agevolare il collegamento della regione interna con quella litoranea, il montagnoso Libano colle fertili pianure del retroterra, accettando due economie diverse ed intralciandone l'interpenetrazione .
Ma è anche certo c he tra arabi cristiani e arabi mussulmani esiste uno stato d'animo caratterizzato da rivalità e odio, che se poteva giovare alla pol itica della Pote nza Mandataria (imperniatas i sulla protezione e sul predominio dei Maroniti) renderà oltremodo precaria la loro pacifica convivenza in uno stesso organismo statale. È quindi assai prevedibile che Beirut e i Maro niti e Melchiti del Libano non accetteranno mai di far parte di una unione siriana e di lasciarsi conglobareessi cattolici e più progrediti - come una provincia di minoranza entro la frontiere della " grande Siria " mussulmana e meno evoluta. Una delimitazione dei confini tra Siria e Libano sarebbe aug urabile per la tranquilli tà futura di quella zona.
Data la peculiare unità geografica della Siria, essa potrebbe risultare come una specie di Stato Federale (l'attuale confom1az ione giuridica della Svizzera) costituito da varie autonomie regionali , con l' abo1iz ione dei frazionamenti attuali e conseguente emendamento degli ordinamenti in precedenza concessi. (Alauiti, Gebel Druso, ecc.) .
Sarà necessario da parte nostra stabilire e mantenere questi rapporti con gli Stati Arabi d'Oriente facendo uso di una politica cauta ed accorta, senza destare apprensioni, senza cioè mostrare pericolose tendenze di predominio .

In seno alla futura organizzazione mediten-anea ogni paese sarà libero di provvedere al suo progresso secondo le proprie inclinazioni e attitudini , senza egemonie politiche né tirannie economiche sopra cioè un piano comune di ordine sociale, di sicurezza economica , di equità politica, con una concreta conciliazione e integrazione reciproca di interessi. Quindi, nessun satellite e nessun astro maggiore.
L' Italia sarà essa stessa considerata come "prima inter pares" .
La potenza italiana sarà per forza di tradizione storica (perché la ' storia d ' Italia è tutta mediten-anea) come il pendolo regolatore e centrale del grande bacino che ha modellato la civiltà del mondo.
La redenzione che l'Asse offre alle popolazioni arabe dell'Oriente si fonda sul lavoro costruttivo e civilizzatore che costituirà la loro missione di domani e sul concetto di superiore elaborazione di una solidari e tà delle varie autonomie politiche mediterranee che dovrà sost ituire quello già logoro delle " indipendenze assolute" fatalmente trascinanti a tendenze egemoniche e a pericolosi antagonismi.
Poiché i du e capi nazionalisti insistevano per ottenere la dichiarazione di indipenden za dei paesi arabi, le autorità militari italiane li incontrarono a Roma, il 28 febbraio 1942, ed indicarono loro nel seguente Promemoria una traccia per ottenerne una sollecita collaborazione militare:
Visto il prolungarsi delle trattati ve per il conseguimento di intese politiche ed in considerazione dell'approssimarsi della stagione favorevole ali 'eventuale ini zio di operazioni militari interessanti il Medio Oriente , si riterrebb e opportuno procedere, senza ulteriore ritardo , ad elaborare uno schema di collaborazione militare coi dirigenti del movimento arabo.
In particolar modo si propone:
1) - Censimento di tutti gli arabi presenti a Roma - o che entro breve potrebbero esservi accentrati - per poter scegliere tra questi gli elementi utiliz zabili a fini mil itari , classificandoli in base ai loro precedenti di se r vizio od alle loro naturali disposizioni .
2) - Costituzione di un centro di istruzione militare per detti elementi , come da dettag li fissati in promemoria allegato.
3) - Successivamente - non appena sarà poss ibile ottenere allo scopo voluto la collaborazio ne completa del Gran Mufti e di S.E . Gailani - procedere all'organizzazione del servizio informativo nei paesi arabi , e s tabilire comunicazioni s icure e rapide con elementi fedeli della zona occupata.
In considerazio ne di quanto precede, con l 'approvazione del competente uffic io arabo presso il Ministero deg li Esteri , si è ritenuto opportuno inte rpellare il Gran Mufti e S.E . Gailani, attirando la loro at-

te nzione s ulla con venie nza che s ia dato s ubito ini zio - e ciò pur senza cos tituire impegno pe r il futuro de entrambe le parti - ai pre liminari più urgenti pe r la prevista collaborazione .
Tanto il Gran Mufti c he S.E. G ailani hanno di c hiarato di trovarsi d'accordo in principi o s ul no s tro punto di v ista e s i so no ri se rva ti di des ignare uno o due co mpetenti , sce lti fra gl i arabi att ualment e a loro di s posizione, incaricati di tratt are co n noi le questioni mii itari di reciproco interesse, secondo programma da fi ssa rs i di com une accordo.


Nelle varie componenti delle Forze Armate dell ' Italia, la presenza di elementi non nazionali non era una vera novità: fin dall ' epoca della prima conquista coloniale, l'Eritrea, aJcune forze militari italiane erano state formate a partire da elementi indigeni i qual i erano inquadrati nel Regio Esercito, sia come elementi regolari , s ia come elementi irregolari (o Bande). Era stato il cas o d e i Battaglioni Eritrei che presero sempre parte al le campagne coloniali dell ' Italia. La loro natura era peraltro interamente subordinata agli ordini ed ai compiti che , di volta in volta, venivano loro assegnati dai capi militari italiani. Sia nella conquista della Libia, sia , più tardi nella conquista dell'Etiopia, tale repart i indigeni furono inseriti regolarmente nelle forze militari regolari nazionali messe in campo dall'Italia. Va tuttavia notato che, sia nel loro reclutamento, sia nel loro impiego, sia infine nelle loro direttive generali, mai questi corpi ebbero un altro significato all'infuor i di quello di servire alle operaz ioni militari o politiche del governo ce nt rale italiano . Mai ess i furono espressione di una qualsiasi volontà delle popolazioni coloniali alle quali pure appartenevano . Ed in questa situazione riflettevano quanto avveniva al riguardo di analoghe truppe indigene negli eserciti della Francia come della Gran Bretagna.
Anche allo scoppio della seconda guena mondiale le forze armate indigene delle colonie italiane erano comprese nelle forze armate del Regio Eserc ito; alla vigilia dell ' entrata in guerra dell'Italia vi erano , nell' AOI e nella Libia, forze armate formate da contingenti militari indigeni, per lo più soldati di mestiere o mercenari. Essi si potevano disti ngu ere in truppe con soldat i generici ed anche in trupp e specializzate nell'impiego e nella formaz ione quali cavalleria araba, meharisti e reparti cammellati . La loro zona di impiego variava a seconda di queste loro specialità essendo la zona sahariana la regione di imp iego prevalente delle ultime due categorie.

V, o S' 0..::S(b < (b :::. ;J :::: ::s 3 (b - · o (b -i - ~ ::s ..., .o i:n (b e e O ~ "O p., () - · -oo..o:::i (b ::s r'o o..r' -· o.. o & S!. (b -· ;;;· () = ::s ::r p., o.. -· (?~ () ;:;· o.. o ::s ~- ,-,. p., ~- o u, ::s o.. (b - )-,o&•e......, 11:> V> (b ::i
QQ e ,... "O (l ci! g o.. ..... :=.. .o .; e
N. B.: Non so no not i i dat i rela tiv i alle armi cd ai mezzi in do taz io ne ag li indi ge ni co mp res i ne lle fo rmaz ion i miste che sono e le ncate
Nelle "altre anni " sono compres i con tinge nt i di meharisti , cammc llati e cavalier i. FO!\ITE: M. M ontanari, op. cit. 1·0/. I , p. 541
u, ::i N(b (b ::s p., [/) o.. &. p., o S' o' ::r p., o ~ce.~< ep., (JQ :=.· ::s p., =.: o :J.
i "' m 'I: 3 > s: o tr, r r-: ::I "' § 51 r > z e z tT; r s: "' e; > g "' "' > :;: o z o > r n: ..., r rn ;a N R r:1 "' o V, V, j
Come si può vedere da questa tabella, la presenza di ben 27.422 uomini delle truppe coloniali e libiche non era trascurabile e ssendo il totale delle truppe presenti in Libia di 167.191 uomini, ma, come si è già ricordato, queste formazioni militari indigene , e nel caso delle truppe libiche , formazioni di elementi arabi, non aveva nulla a che fare, né con le proposte dei due capi nazionalisti arabi , Rashid Ali alGhailani e il Gran Mufti, né con quei propositi di una " Legione Araba" o "Centro Militare Speciale" che il Comando Supremo italiano stava decidendo di creare. Sul piano della natura delle truppe che s i trovavano sul fronte nord africano sappiamo da tempo che , accanto alle truppe metropolitane , operavano anche questi reparti coloniali inquadrati da elementi italiani. Prevalentemente erano forma zioni eritree , formazioni arabe libiche e reparti berberi sahariani. I grandi repertori relativi alle battaglie sul fronte libico-cirenaico e libico -egi ziano, ci indicano che il loro impiego fu largamente utilizzato, anche se manca tuttora uno studio specifico sul loro contributo alle varie offensive e battaglie es sendo il testo ciel Montanari , così eloquente su altre unità "bianche", silenzioso a questo riguardo .
Nella primavera del 1942, si trattava di tutt'altra iniziativa che si inquadrava, sia nel momento strategico -militare della partita che si stava giocando in Libia ed alla frontiera con l'Egitto, s ia nell'andamento generale di quella incerta "Politica Araba" che Mussolini pareva vo ler giocare , in nome del Nuovo Ordine Mondiale , con l ' ausilio dei capi arabi rifugiati a Berlino ed a Roma. Senza attendere la conclusione delle trattative politiche con i due capi nazionalisti arabi ed alla luce dei vantaggi militari che potevano nascere dalla creazione di una Legione Araba nell'amb ito delle attività delle Forze Armate italiane nel Nord Africa, il Comando Supremo ed il SfM decisero di rompere gli indu gi connessi ai negoziati politici in corso da mesi senza risultati pratici e di creare, il 2 marzo 1942, a Roma un "Centro d'istruzione militare per elementi arabi" 34 . Si trattava di una ini ziativa che rifletteva l'esigenza per le truppe italiane di disporre , nei territori arabi occupati o cli futura occupazione, delle strutture di servizio atte sia a preparare con azioni di informazioni strateg iche, le mosse delle forze armate s ul fronte ed anche di coinvolgere sempre più l'e lemento locale nei combattimenti. Evidentemente si ag iva seguendo un modello germanico già in atto, con altri obiettivi, a Capo Sunion , ma la deci -

sione italiana voleva altresì tenere conto dei molti casi di cittadini italiani già residenti nei paesi arabi, soprattutto in Tunisia, che potevano essere di grande utilità in questa iniziativa . Va notato anche che, accanto alla proposta relativa agli arabi, lo Stato Magiore del R. Esercito, tramite il suo Ufficio Prigionieri di guerra, stava progettando, lo stesso 2 marzo 1942, la creazione di un Reparto Speciale formato da ex -p rigionieri di guerra indiani i quali, sistemati a Villa Marina, posta a dieci chilometri da Roma, sulla via Casilina, zona, allora cli aperta campagna, in uno speciale e falso campo di prigionia, sarebbero stato inseriti in questi nuclei speciali sotto la direzione politica di un delegato del nazionalista indiano, Chandra Bose, Mohammed Iqhal Sheday , esponente politico indiano che godeva della fiducia del Ministero degli Esteri 35' Il loro numero di partenza era modesto, di soli 15 prigionieri, ma se ne prevedeva un aumento considerevole.
A questo punto apparve una nuova in iziativa che s i inseriva da una parte all ' iniziativa araba, ma da un ' altra parte la contraddiceva : si trattava dell'inserimento nello stesso Centro "A" cli militari nazionali provenienti dalle regioni del Medio Oriente che avrebbero dovuto coesistere con i militari arabi nell'azione bellica alla quale era destinato lo stesso Centro "A". Era questo un ulteriore fattore di confusione poiché la sua stessa formazione avrebbe previsto, secondo i documenti militari : una compagnia araba, uno squadrone camionette cli italiani d ' Egitto, una compagnia d ' assalto di italiani d'Egitto ed infine un reparto speciale italo-arabo. Difficile in questa composizione riconoscere I' autorità del Gran Mufti s ull' intero Centro dato che solo una parte era costituito da arabi veri e propri Evidentemente vi era una profonda discrepanza tra i due e lementi di questo Centro poiché mentre gli italiani ubbidivano alle autorità militari e politiche italiane , i militari arab i combattevano per l'indipendenza dei loro paesi ed erano posti sotto l ' autorità congiunta del Gran Mufti e di Rashid Ali al- Ghailani.
Un'altra contraddizione si verificò con la creazione di un Centro Militare "T", cioè "Tunisini". Contrariamente a quel che potrebbe essere logico, per "Tunisini" il Comando Supremo non intendeva affatto parlare degli indigeni della T unis ia, bensì degli " Italiani cli Tunisia"
35 Sull ' intera questione relat i va a Bose definito anche 'L'anti Gandhi che sce lse Mussolini' (S. Romano , in ' Con-iere della Sera' del 14 giugno 2002) si veda M. Martelli, L'India e il Fascismo. Mussolini e il problema del nazionalismo indiano , Roma , Ed iz Del Settimo Sigillo , 200 I

che l'intera pubblicista fascista comprendeva, da sempre, sotto l'etichetta di "Tunisini"; per gli altri, gli abitanti autoctoni si parlava solo di "indigeni" . Si vo leva con questo Centro militare specifico arruolare gli italiani residenti in Tunisia e sfruttare la loro conoscenza dell'ambiente arabo e la loro lealtà verso il fascismo e l'Italia per rivendicare successivamente a favore dell 'ltalia, una sovranità ed un destino ancora tutto da discutere e da decidere . Si è detto che l'iniziativa "T" appariva in netta contraddizione con alcune affermazioni precedenti delle stesse autorità politiche italiane poiché appare chiaro che se per gli arabi del Centro "A", l'autorità restava il Gran Mufti e l 'o biettivo era l'indipendenza dei paesi arabi, magari solo di qu elli del Medio Oriente, per i membri del Centro "T" l'autorità riman eva quella fascista e l'obiettivo era chiaramente di difendere "l'ital ianità della Tunisia". Una confusione ancora maggiore se s i tiene a mente che entrambi i Centri dovevano cooperare per la vittoria dell'Italia. Ma quale vittoria era ancora tutto da decidere. Questa anomala situazione non venne mai sanata . Ed in questo contesto venne successivamente fuori l' etichetta complessiva , ai tre Centri di Raggruppame nto del neo -costituito Raggruppamento, di "Frecce Rosse" con un distintivo specifico sulle va.rie divise che accompagnavano le mostrine dai colori nazionali.
Le decisioni del 2 marzo furono seguite, l ' 11 ed il 12 marzo , a Merano, da un incontro tra il capo del SIM, gen. Cesare Amè con il capo del Servizio Informazioni Germanico, amm. Canaris . L'argomento specifico delle due legioni, araba e indiana, in formazione, non fu evocato, rimanendo la Germania reticente a dare al SIM le relative informazioni . Si auspicò nell'incontro una sempre più efficace attività di collaborazione tra i due Servizi, ed il giro d'orizzonte fu ampio ed investì i più vari settori del conflitto in corso (Nord Africa, Medio Oriente, Russia) . Un un ico appunto sul caso arabo venne fatto e cioè, testualmente nella relazione italiana del 14 marzo: "Il capo del Servizio germanico, certame nte in concorde visione cogli esponenti politici del suo paese, ha dichiarato di annettere scarso significato e valore alla funzione ed all'attività che il Mufti ed el Ghailani possono svolgere, trattandosi , a suo parere , di uomini ormai con scarso seguito, di assai modeste possibilità e cli malcerta fede. Anche circa le possibilità informative-propagandistiche realizzabili pel loro tramite verso Irak, Iran e paesi orientali in genere, l'amm . Canaris si è dimostrato scettico ... ". Questa posiz ione de ll 'amm . Canaris, così negativa, appare piuttosto ambigua in quanto pareva sconfessare quanto gli incontri dei due capi

arabi con Hitler, nel dicembre 1941, parevano aver chiarito, e cioè l 'importanza fondamentale attribuita alla loro azione nel mondo arabo. Ma forse questa posizione negativa di Canaris rifletteva un giudizio che riguardava gli arabi del Nord Africa e del Medio Oriente, ma non di certo i musulmani orientali che stava no a cuore all'azione militare del Reich nel Caucaso .
Sul piano italiano, il Comando Supremo ed il SIM si diedero molto da fare nel marzo, nell ' aprile e nel maggio 1942 per realizzare, al più presto, queste fotmazioni speciali, in particolare quella araba, in quanto le attività belliche sul fronte nordafricano parevano lasciare molte speranze circa una vera e propria vittoriosa offensiva contro lo sc hieramento britannico. Per le autorità romane , sia militari (Comando Supremo e SIM), sia politiche (Ministero degli Affari Esteri), queste scadenze parevano avvicinarsi paurosamente e quindi la riunione, la preparazione e l'addestramento di questi militari "speciali" diventavano fattore di elevata urgenza. In un Promemoria del 23 marzo il Comando Supremo ed il SIM ne formalizzavano gli aspetti urg enti sottolineandone le sperate ripercussioni sull 'andamento generale del conflitto36. La creazione delle str utture proposte vi veniva definita "questione assai interessante e di valore attuale, immediato, anzi urgente".
Si trattava di dare vita ad una "organizzazione suscettibile di ampliamento, di mano in mano che le esigenze addestrative consigliassero". Gli otto punti di cui consta il documento appaiono importanti per fissa.re le intenzioni italiane: Centro di organizzazione e di istruzione; indirizzo ed attribuzioni del Centro; Capo Centro ed ufficiali istruttori; Organizzazione ed ubicazione del Centro; Uniforme; Armamento; Finanziamento; Dipendenza del Centro.

A questo punto i documenti da citare sarebbero mol ti, ma il più importante appare essere quello del capo di Stato Maggiore General e, gen. Ugo Cavall ero del 1° aprile, rivolto al Ministero degli Affari Esteri, che ben delinea la 'filosofia' dell'intera operazione37 L' insieme delle esigenze irrinunciabili delle autorità italiane vi è ben delinea-
36 Nel Documento dal titolo "Collaboraz ione milita re con g li arabi ", del 23 marzo l942, veniva indicato al Ministero degli Esteri italiano che il programma "tendeva a porre su l terreno concreto sia ne l campo informativo, sia nei riguardi dell'istruzione militare, la valorizzazione degl i elementi arabi presenti a Roma ed in Italia e di quelli che eventualmente potessero affluire nell'orbita politica dei Capi a noi favorevoli".
37 Se ne veda il testo nel Documento n . 9.
to, e cioè che la struttura proposta dovesse servire allo scopo specifico del conflitto in corso. In questo quadro la pregiudiziale po.litica rivendicata dai capi arabi non appariva importante agli occhi del capo del Comando Supremo : il problema era formare gruppi utili alla gue1Ta e portarli al più presto all'efficienza auspicata . Ben chiarisce questo aspetto pratico un successivo documento dello stesso Comando Supremo dell'inizio di aprile che ne precisava gli aspetti immediati cli applicazione . Sull'azione da svolgere nell'ambito di questa Legione Araba, il SIM aveva il proposito di crearla d'intesa con il Gran Mufti per quanto riguardava "l'Egitto e gli altri paesi arabi"; le sue attribuzioni avrebbero dovute essere molteplici e complesse, ma nel documento nessuno spazio era lasciato all'aspetto politico, e neppure venivano esclusi dal complesso dei paesi arabi quei paesi del Nord Africa sulla cui sorte fiorivano in Italia molte sol uzioni non di certo legate alla loro indipendenza. Era una programma efficace su l piano strutturale militare e tale pareva dovesse rimanere l'intera operazione. Era inevitabile che un programma così concepito non godesse di una unanimità di consensi. Esso incontrò la recisa opposizione del Ministero del!' Africa italiana, contrario ad una azione ed a una presenza del Mufti nel Nord Africa e soprattutto in Libia, poiché temeva che, grazie al suo prestigio, egli si potesse fare intercessore e intermediario "ora e nell'avvenire" fra il governo italiano e le popolazioni libiche. Queste infatti non avevano accolto con favore la legge sulla cittadinanza italiana speciale dei musulmani del 1938 , ed erano "profondamente irritate" per la colonizzazione de l Gebel cirenaico (i famosi "Ve ntimila") e, oltre che per le distruzioni provocate dalla guerra, pe r le "severe repressioni" e la "stretta di freni" adottata in conseguenza dell'atteggiamento da esse assunto durante i periodi de ll e occupazioni britanniche . Analoghe riserve si avanzavano circa il futuro della Tunisia e dell'Algeria, che l'Italia aveva " prenotato " , ed anche per il Marocco sull'avvenire del quale la Germania avanzava rivendicazioni definite "storiche".
Sostanzialmente contrari, anche se formalmente d ' accordo, erano anche i tedeschi, ostili ad una stretta collaborazione ciel Muf'ti con l'Italia e propens i a dar vita a una propria Legione araba o musulmana (in via di organjzzazione in Grecia) detta anche "U nità liberatrice araba" e, soprattutto, decisi a dirottare il più possibil e forze e potenzialità arabe , musulmane ed indiane verso la regione caucasico - iranica invece che verso il Med iterraneo , quale logico corollario dell ' avanzata ger -

manica nell'URSS, nell'intento di prendere alle spalle lo schieramento britannico e nel contempo avanzare serie pretese sulla regione ricca di petrolio.
Tuttavia , e malgrado le riserve di alcuni settori ufficiali italiani , il "Centro di organizzaz ione e di istruzione per l'inquadramento degli elementi arabi", questo l ' intitolato ufficiale dell'iniziativa, veniva deciso " in accordo e col concorso del Gran Mufti e del ministro Ghailani". Una relazione del Comando Supremo, in data 3 aprile, meglio ne definiva gli aspetti essenziali ed anche le tappe della sua realizzazione. Più o meno si ripetevano le indicaz ioni del documento del 23 marz o, ma questa volta si trattava di vere e proprie decisioni . Direttamente dipendenti dal Comando Supremo, i volontari erano chiamati a formare dei gruppi di "Commandos" con varie specializzazioni quali: paracadutisti , radiotelegrafisti , mitraglieri, informatori e sabotatori. Inquadrati da ufficiali istruttori del Regio Esercito , i volontari arabi sarebbero stati stanziati a Roma o nelle vicinanze . Le uniformi dovevano essere quelle dell'esercito iracheno con il distintivo del Raggruppamento delle "Frecce Rosse" e con distintivi nazionali relativi ai paesi di appartenenza . Questi erano indicati quali: Irak, Siria, Libano, Palestina e Transgiordania. Come si può notare si trattava solo di arabi del Medio Oriente e non erano compresi nel Centro arabi di altri Stati arabi, quelli del Nord Africa, e certamente questa esclusione politica non era casuale .
Mentre la q uestione araba seguiva il doppio binario delle discussioni politiche e delle decis ioni militari , un'altra questione militare si fece luce p resso il Comando S up remo : quélla della formazione, a partire da l la massa dei prigionieri di origine indiana nei campi italiani, di una Legione indiana da crearsi a scopo di impiego militare sui fronti mediorientali. La vecc hi.a proposta già ricordata connessa, al Campo di Vil)a Marina, ven ne portata avanti, quasi per rispondere ad ana l oga in iziativa german ic a e soprattutto per mostrare all'alleato nipponico la propria solidarietà nella lotta per l'emancipazione dell'India. P romotore dell'iniziativa fu specialmente il Ministero degli Affa ri Esteri che aveva in un noto rifugiato nazionalista indiano, Mohammed Iqbal Shedai , il proprio fiduciario anche in questa operazione . Pure l'ambasciata g iapponese a Roma si adoperava per favor ire la proposta. In un Promemoria del 13 aprile , ai governi dell ' Asse, il governo di Tokyo, insistette sulla necessità di iniziative comuni per vincere, proprio dal1' interno del proprio impero colo ni ale , la Gran Bretagna, nemica comune de i tre Stati alleati: "È ben maturo il tempo per i popoli dell ' ln-

dia e del!' Arabia di decidere se essi dovranno diventare sch ia vi della Gran Bretagna e servire la causa di un impero ormai in fall im ento sino all'ultimo suo giorno, o se essi debbano invece sollevarsi in piedi, espellere l'imperialismo britannico quale il più acerrimo nemico, dall'India e dall'Asia sud orientale e realizzare gli ideali dell' "India per gli Indiani" e del I ' "Arabia per gli Arabi". L'Impero britannico essendo il comune nemico del Giappon e, della Germania e dell'Italia, le tre potenze sono fermamente decise a battersi fino a quando l'impero sarà crollato a tena. In conseguenza le tre potenze non possono permettersi di stare inoperose nel momento in cui l'India e l'Arabia saranno trasformate in roccheforti per la difesa del declinante imp ero britannico. Il Giappone, la Germa nia e l'Italia non hanno tuttavia alcuna ambizione di sostituirsi alla Gran Bretagna né in India né in Arabia. Ciò che le tre Potenze effettivamente desiderano è l'immediata realizzazione dell' "India per gli Indiani" e dell' "Arabia per gli Ara bi" e l'avvento, al più presto possibile, del giorno in cui questi Popoli apporteranno di nuovo, come razze libere i loro importanti contributi alla cultura e alla civilizzazione del mondo Per questa rag ione, il Giappone, la Germania e l'Italia dichiarano so le nnem ente che ess i sono di buon grado disposti ad offrire ogni possibile aiuto ai popoli indiani e arabi, se essi dovessero desiderare assistenza ed aiuto nella marcia in avanti verso la libertà".
A questo Promemoria seguì, l'indomani, una proposta ufficiale del governo nipponico ai due governi, italiano e tedesco, nella quale si auspicava la pubblicazione congiunta di una Dichiarazione dell'Asse "in favore dell'indipendenza dell'India e dei Paesi arabi" . Subito le osservazioni italiane s i fecero luce sostenendo che se il caso dell'India era chiaro, quello dell'Arabia presentava due difficoltà per essere accettabile . Da una parte si riteneva che era restrittiva e poteva parere un proclama per l 'indi penden za della sola penisola araba, e dall'altra era troppo estensiva in quanto solo per "gli arabi del Medio Oriente" tale impegno di indipendenza poteva tro vare l'Italia d'accordo.
L'impegno militare , anche nel caso del Ra ggruppamento indiano proseguiva ma qui vi so no alcune osservazioni che non possono essere sottaciute, proprio a questo riguardo. Mentre i piani evocavano programmi grandiosi da attuare attraverso l'impiego di numero se unità di guastatori con un impeg no elevato di uomini e mezzi cha andavano dalla Libia al Caucaso , la realtà amministrativa era ben più dimessa. Ne possono fare fede molti documenti, ma se ne vuole citare so lo uno,

del 13 aprile, che riguarda Villa Marina dove il raggruppamento degli ex-prigionieri di guerra indiano, diventato "Centro Militare Indiani", era stanziato . Sono nove osservazioni che precisano, dopo un sopraluogo , una serie di situazioni , a dir poco, precarie:
"Da un sopraluogo effettuato al campo è risultato che:
a) l'attacco e l ' impianto della luce per le baracche non sono stati eseguiti;
b) il motorino elettrico che fornisce l'acqua alla villa non funziona ed abbisogna di riparazione;
c) le cucine per il reparto di vigilanza e per i prigionieri non sono ancora impiantate;
d) manca tuttora la copertura delle tettoie di tre fabbricati;
e) occorre l'impianto telefonico commutabile per la vi lla e per il corpo di guardia;
f) è indispensabile la costrnzione di una tettoia per riparare il quadrnpede e la carretta destinati ai servizi del campo. Tale costruzione potrebbe essere appoggiata alla baracca "latrina" del reparto di vigilanza;
g) la recinzione esterna del campo anziché con triplice ordine di filo di ferro spinato basta sia limitata al semplice rafforzamento di q uella esistente;
h) è necessaria una siepe di separazione fra le baracche dei prigionieri e quelle del reparto di vigilanza;
i) non è ancora giunta la bicicletta per il ciclista"38
Ovviamente con questa citazione di un documento di servizio, non si vuo le dare all ' iniziativa della formazione dei Raggruppamenti militari speciali, caratteristiche ridicole, bensì porla in una dimensione realistica che aveva a che fare con una situazione militare estremamente precaria e che poteva mettere in serio pericolo i propositi c he il Comando Supremo meditava di affidare a queste nuove formazioni. Intanto fe rv evano le var ie decisioni per la formazione dei Centri. II primo ad essere ratificato fu il Centro M ilitare "A", in data l 0 maggio; il 4 veniva precisato che sarebbe stata di una forza iniziale di 200 uom ini, dipendenti direttamente dal Comando Supremo co n base a Roma, presso il 1° rgt. Granatieri, al comando del XVII Corpo d'Armata. A n c he qui, le dotazioni previste appa iono assai esigue poiché si trattava di:
1 autovetturetta 508 C berlina,

- 1 autocamioncino ,
- 1 autocarro leggero ,
- 1 autobus da 20-25 posti,
- 1 motociclo,
- 2 biciclette .
Quanto all'armamento si dava individualmente " una pistola con bandoliera serie 12°", senza elmetto metallico . Il munizionamento era di 36 cartucce per pistola.
Dopo rinvii ed incertezz e , il Comando Supremo che già si era espresso in varie date, l'ultima delle quali era il 15 maggio 1942 , dispose finalmente, il 21 maggio, la forma zione dei Reparti Militari speciali . Essa si rifaceva a consideraz ioni di opportunità " di precedere od affiancare operazioni militari in territorio straniero". Secondo la Tabella allegata al documento si sarebbe trattato di:
- un Comando dell ' organizzazione;
- un Centro Militare "A"di una forza probabile di 100 uomini , da sviluppare secondo le direttive del 4 aprile;
- un Centro Militare "I" di una forza iniziale di 200 uomini, in graduale afflusso dal Campo di Villa Marina;
- un Centro Militare "T" di una for za ini ziale di 2/300 uomini , di elementi italiani già residenti in Tunisia. In un secondo tempo potevano esservi fatti affluire dalla Tunisia elementi italiani idonei.
Il modello che la decisione del Comando Supremo prendeva per la creaz ione dei Centri Militari Speciali si rifaceva all'esperienza di analoghe decisioni che l 'esercito tedesco aveva preso durante la campagna di Polonia. Il Comando germanico in tale campagna aveva sperimentato l'attività di gruppi speciali "che con procedimenti vari di astuzia, cli violenza e di sorpresa" avevano in varie occasioni facilitato le operazioni militari tedesche in territorio nemico , sia precedendo l 'arrivo , sia accompagnando le attività di occupazione dei reparti regolari dell'esercito. Queste organizzazioni dette anche ciel Reggimento Brandemburgo agivano con grandi ripercussioni psicologiche come "quinta colonna" da imp iegare nei vari teatri delle operazioni . Fonnati da elementi scelti, conoscitori della lingua e dei costumi del territorio nemico, gli uomini di questi gruppi si erano resi immensamente utili alle attività belliche regolari. I propositi del Comando Supremo italiano prendevano lo spunto da queste esperienze per decidere la creazione di analoghi reparti da affiancare alle regolari attività delle forze ar-

mate. Con elementi maltesi, indiani ed arabi se mpre affiancati da italiani già residenti nei paesi arabi interessati alle operazioni belli che italiane, ci si ripro metteva di conseguire sicu ri successi coinvolgendo il più possibile elementi locali e rendendo particolarmente difficili ed insicure le retrovie nemiche che sarebbero state il campo prediletto dell'azione di questi uomini infiltrati dietro le linee nemiche 39 A questo primo documento di orientamento generale doveva seguire, il 21 maggio, un documento, a firma dal capo di Stato Maggiore, gen. Ugo Cavallero, nel quale si davano disposizioni puntuali circa la preparazione e l'organizzazione di questi Reparti Speciali che venivano definiti nelle loro varie caratteristich e4 0

Documento n. 8
(2 marzo 1942)
Senza attendere la conclusione delle trattative con i due capi nazionalisti arabi ed alla luce dei vantaggi che potrebbero nascere dalla creazione di una Legione Araba nell'ambito delle Forze Armate italiane il Comando Supremo ed il SIM decisero, il 2 marzo 1942, la costituzione di un Centro d'istru z ione militare per elementi arabi.
In previsione del rapido incal za re degli avvenimenti all'appro ssimarsi della buona stagione, s i prospetta l'opportunità che venga al più presto istituito un Centro per l 'istruzione militare di elementi arabi disponibili in Italia, a fine di preparare una efficace collaborazione militare con i Paesi Arabi del M edio Oriente.
Tale Centro offrirebbe in particolar modo il vantaggio:
a) - di preparare elementi conoscitori del paese da sfruttare per esigenze militari di carattere immediato, os s ia: informatori , agitatori da inviare clandestinamente nella zona occupata, radiotelegrafisti, sabotatori, paracadutisti, ecc.

b) - di preparare ufficiali ed istru ttori per i quadri della Legione Araba di prevista costituzione .
c) - di occupare utilmente gli elementi arabi presenti a Roma, togliendoli ad uno stato d i inazione che ne intacca il morale e che fomenta nella compagine pericolosi stati di animo.
ci) - di dimostrare agli arabi che, analogamente a quanto si fa in Germania, anche in Italia si lavora attivamente , in forma concreta , per la liberazione del loro Paese dalla servitù britannica
Ubicazione del Centro - In primo tempo - in fase di costituzione , potre bbe funzionare a Roma con sede in una Caserma designata allo scopo. I partecipanti al corso vi sare bbero riuniti ad ore fisse e ripartiti a secondo del grado di istruzione.
Sarebbe da considerarsi la convenie nza di aggregare alcuni fra questi cleme nti arabi, presce lti per determinate s pecializza z io ni , (paracaduti sti, aviatori , ecc .) a scuo le già in atto per le nostre Forze Armate.
Successivamente pe rò si riti e ne opportuno che il Centro ve nga spostato in apposita loca lità nei dintorni di Roma, a fin e di inten s ificare la prepara z ione in ambiente più isolato e raccolto.
Capo C e ntro ed ist ruttori - Si propone la designazione qual e Capo Centro di un ufficiale del R. Esercito, con grado alm e no di capitano, opportunamente scelto fra coloro c he già hanno conosce nza del mondo arabo e che s ia in grado di parlare l'arabo.
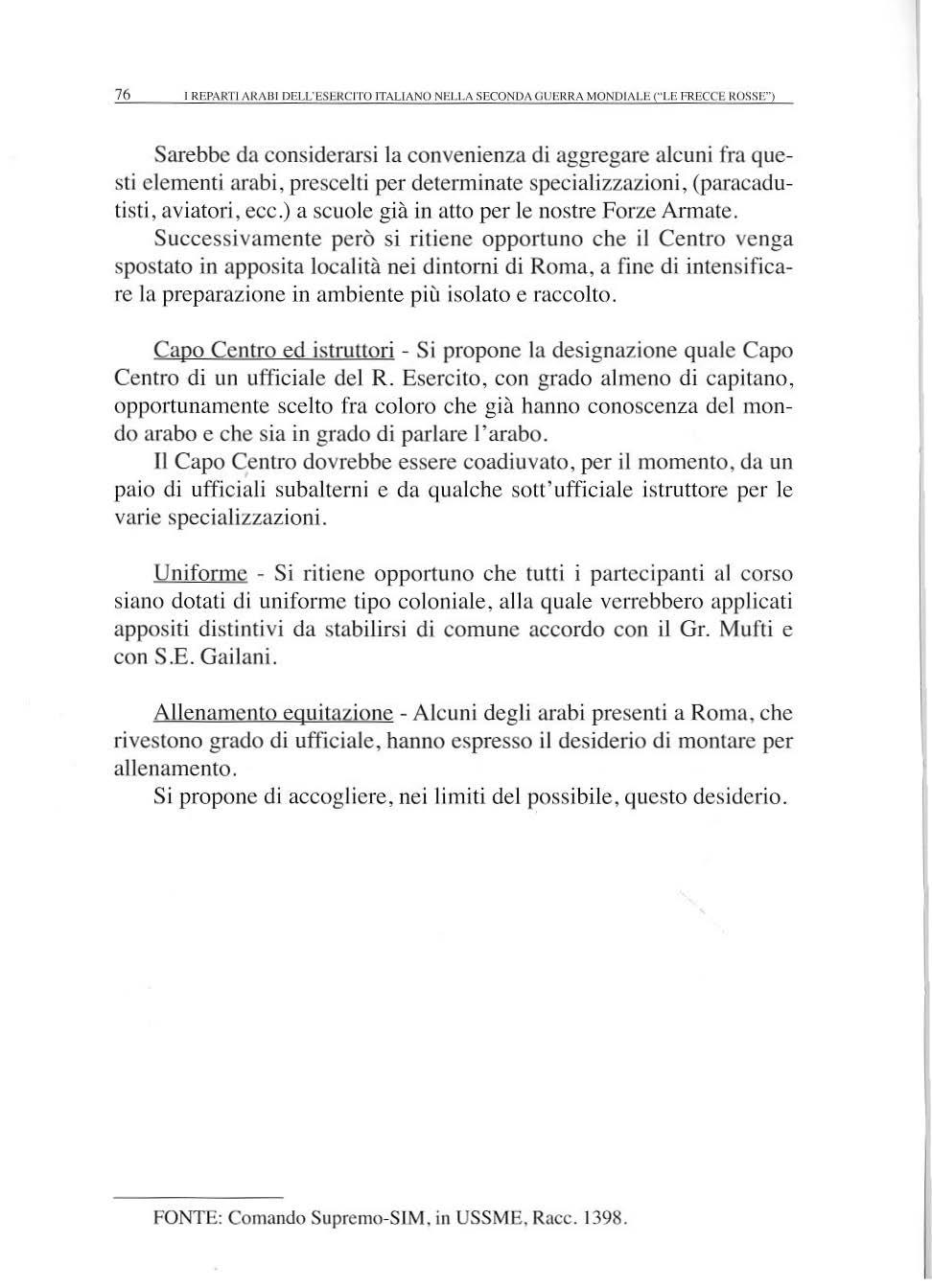
Il Capo Centro dovre bbe essere coadiuvato, per il momento , da un pai o di ufficial i subalterni e da qua lche sott'ufficiale istruttore pe r le varie specializzaz ioni.
U niform e - Si ritiene opportuno che tutti i partecipanti al corso siano dotati di uniforme tipo coloniale, a ll a quale verre bbero applica ti appositi distintivi da stabilirsi di comune accordo con il Gr. Mufti e con S.E . Gailani.
Allename nto equitaz ione - Alcuni degli arabi prese nti a Ro ma, che riv estono grado di uffi cia le , hanno espresso il desiderio di montare per alle namento.
Si propon e di acco g li ere, nei limiti del possibile, questo desiderio.
FONTE: Coma ndo Supremo-SlM. in USSME, Racc. 139 8.
Documento n 9
(1 ° aprile 1942)
Nonostante le critiche che alcuni avanz arono circ a la nascita d e lla Legione Araba , il capo di Stato Maggiore Generale, gen. Ugo Cavallero riassunse , in data 1 ° aprile 1942,al Ministero degli Affari Esteri, i criteri rnilitari e le modalità connesse alla ventilata collabora z ione militare con gli arabi nell ' ambito delle trattativ e con i due capi nazionalisti arabi..
COMANDO SUPREMO
1° aprile 1942
Oggetto: Collaborazione militare con gli arabi
Questo Comando Supremo conviene pienamente circa l'opportunità di organizzare in concreto lo sviluppo e la utilizzazione della rete informativa di cui il Gran Mufti ed il Primo Ministro Ghailani dispongono nei paesi arabi .

A questo sco po il Capo del SIM ha g ià preso iniziali contatti co11e due personalità orientali. Particolarmente il Gran Muftì si è dichiarato ben disposto a collaborare, mettendo in rilievo la esistenza di una sua organizzazione e le sue possibilità nel campo infonnativo .
Di fronte a proposte concrete di iniziare il lavoro sul terreno pratico il Mu fti ha molto abilmente lasciato intendere di considerare questa co11aborazione come corollario legato alla conclusione deg.li accordi politic i in corso di definizione.
Non appena sgo mbr ato il campo dalla pregiudiziale acce nnata, la collaborazione dovrebbe svilupparsi :
- alimentando con nuovi elementi orientali da inv iare sul posto con direttive appropriate, la rete che il Mufti g ià possiede ne i paesi arabi;
- organizzando un movimento di fiduciari da e per i paesi stessi;
- realizza ndo collegamenti radio clandestini per le informazioni di carat tere operativo ed urge nte .
A I dipendente Servi z io Inform azio ni è affida to il compito di sv iluppare contatti ed ini z iat ive p er promuovere la collaborazione c he s i prese nta tanto utile ed urge nte.

Del pari questo Comando Supremo è favorevole a dare sv iluppo gradua le alla preparazione militare degli elementi arabi g ià di sponibili e di quelli che potranno affluire ed essere a s uo tempo utilmente impiegabili, nell ' interesse com une , nei rispettivi paesi.
Tale prep a ra z ione dovrà trovare sede ed impulso in un costituendo C entro Militare, che sa rà istituito ini z ialmente a R oma.
Tale Centro avrà dipe ndenza, pe r l'organi zzaz ione ed il funzionamento , dallo Stato Maggiore dell'Esercito, mentre per le direttive di sviluppo e di impiego farà ca po a qu es to Comando Supremo che provvederà a ma nten e re i necessari contatti co n codesto Ministero e con i Capi arabi.
Esso fun z ionerà sotto la direzione di un no stro ufficiale supe riore, coadiuvato da ufficiali e so ttuffi c iali istruttori , scelti tra e lementi idone i , e c urerà in particolar modo la preparazione di nu c lei atti a com piere s pec iali mi ss ioni in zone di loro conoscenza occupate dal nemi co .
Scelta deg li elementi e loro s pecializzaz ione saranno fatti in accordo c oi C api ara bi , cd in relaz io ne alle a ttitudini e g ara nzie di lea ltà offerte da ciasc uno.
È evidente che, inoltrandoci ne l lavoro cli preparaz ione, colla maggiore co no sce nza degli e le menti , verranno in luce maggiori poss ibilità di coo pera zio n e anche ne l campo informati vo.
Appare p e r il mom e nto diffi c ile formu lare prev ent ivi e computi circa le s pese c he l 'orga nizzazi o ne del C e ntro potrà co mportar e. Sull ' argo mento della riparti z ione dell ' onere finanziario s i fa riserva cli formulare successive proposte a codesto Mini ste ro.
li Capo di Stato Maggio re Gen era le Gen. Ugo Cav a ll ero
Sulle trattative in vista di creare speciali Unità Militari arabe che si svolgevano tra Rom.a e Berlino , il SJM espresse nella seguente nota al Comando Supremo, in data aprile 1942 alcune considerazioni circa la ventilata operazione:
Secondo il SIM,
1° - Il Mufti costituirà in Afr ica Settentriona le un centro di collaborazione con le poten ze dell ' Asse . Ta le Centro potrà trasferirsi ad altri luoghi dei Paesi Arabi secondo le operazioni e le circostanze della guerra.
Esso svolge rà azione secondo le seguenti principali direttrici:
a) svilupperà a tti vità di propaganda a mezzo di emissioni radiofoni c h e, diffusione di messaggi e manifesti ni in Egitto e negli al tri Paesi Ara bi , in vio di propaga ndi sti e fiduciari dietro le linee nemich e, ecc .
b) a mezzo di persone d i fiducia inviate nei Paesi Arabi organizzerà collegamenti e collaborerà in og ni modo possibile con i Serviz i informat iv i pe r conoscere e pene trare le s itua zione dei suddetti Paesi ;
c) svil upp erà le formazioni arabe g ià preparate in Italia (ed eventualmente quelle di Sunion) nonc hé le a ltre formazion i arabe che sarà possibile compo rre con elementi regola ri egiziani e dei Paesi A r a bi per creare " U nità r egolar i arabe" da impiegare a di spo sizio ne del Mufti , a lato dell e truppe dell'Asse e sotto la bandiera araba;
d) facil iterà la formazione di ba nde irregolari con elementi attratti, d'ac co rdo con i comandi militari dell ' Asse, dalle linee nem ich e o da al tre fonti p er l'impiego in co mpiti s peciali;

e) svolger à ogni possibi le attività i ntesa a effettuare atti di sabotaggio a da nn o del nemico e collaborerà per l'invio di armi ed esplosivi nei Paes i Arabi.
2° - Il M ufti sarà il C a po riconosciuto di tale Centro ed il Capo effettivo sia delle "Unità regolari a rabe" s ia di quelle irrego lari. Egli collab orerà p er l ' inquadramen to di tali forze con tecnici mili tari e ufficiali dell'Asse.
L e forze arab e avranno in ogni modo cara ttere co mpletamente arabo e combatteranno s otto i co lor i ar a bi in q uanto dovranno rappresentare il simbolo de ll a partecipazione del popolo arab o co n l 'Asse co ntro il nemico co mun e . De tti tecnici ed ufficiali sa ranno da co nsiderare alle dipendenze del Mufti e facenti parte, come vol o nt a ri , d ell'Ese r c ito A ra bo del qua le porteran no i di stintivi.
Nonostante il caratte re di forze nazionali arab e di tali formazioni, esse, s in o a lla fine della guerra, dovranno uni fo rm are la lo ro az ione a lle direttive e d a ll e is truzioni di co nsiglieri mi li tari dell ' Asse.
3° - Il Gran Mufti collaborerà co n un a Co mmi ss ione Mili tare d e l1 ' Asse d i cu i il comandante Si men s arà il Capo . A questa Commissione prendera nno p a1te u fficiali i talia ni e tedesc hi e ra ppresenta nti de i Ministeri degli Affa ri Este ri italian o e ted esco.
4° - Le anni e l'altro materiale necessario pe r la reali zzaz ione d i questo proge tto , secondo il numero delle forze e l 'eve ntuale loro armamento, sara nn o fornite a l Gran Mufti pe r quanto c onse ntito dall e d is ponib ilità

Documento n. 11
REPARTI SPECIALI. PREPARAZIONE E ORGANIZZAZIONE (15 maggio 1942)
Il Comando Supremo e il S/M diedero nel seguente Promemoria del 15 maggio 1942 , la propria interpretaz ione circa le proposte di creaz ione di Reparti Sp e ciali ai quali avrebbero dovu to essere affidati c ompi t i parti colarmente impegnativi in vari settore dell'atti v ità bellica in corso.

OGGETTO: Reparti speciali. Pr eparazione e organizzazione
15 maggio J 942
In seguito alle esperienze della campag na di Polonia , il Comando germanico decise di dare stabile e regolare organizza zione all'attività speciale che con procedimenti vari di astuzia, di violenza e di sorpresa e ra di volta in volta diretta a precedere o affiancare le operazioni militari in paese straniero, attività che, largamente impressionando le fantasie , ve1me ben presto conosciuta e ingigantita sotto il nome di "quinta colonna" .
Sorse così gradatamente , alle dipendenze del Capo del Servizio Info1mazio ni germanico, l'organizzazione del "reggimento Brandemburg".
Questo si è progres sivamente sviluppato su num e ro vario di compagnie, differenziate per forme e organizzazione, costituite da elementi scelti, conoscitori della lingua , delle località, degli usi e costumi delle regioni ove ciascuna compagnia era destinata ad operare .
Ognuna di queste , a seconda del compito e del previsto teatro d'impiego, ha assunto ordinamento, attre zz atura ed equ i paggiamento idonei e addestramento adeguato: la forza di ciascuna varia da 200 ad oltre 1.000 uomini.
Gli elementi sono per lo più costituiti da cittadi ni tedeschi che hanno lungamente risieduto nei paesi che interessano o anche da stranieri amici od aderenti all'azione della Germania.
Consta che attualmente una compagnia del "reggimento Brandemburg"è dislocata in Norvegia. Un'altra assai forte è pronta per essere impiegata nel Caucaso, costitui t a da armeni, georgiani, russi bianchi , ecc . Mezza compagnia s i trova colle truppe germaniche in Nord Africa. Una è in preparazione in Grecia per l'Oriente.
Le no stre es ige nz e be lliche no n c i hanno finora co nd o tto a preved e re a lcuna co ns imile att iv ità .
So lo in queste ultime settima ne si sta provvede ndo a sceg li e re , ra ccog liere , preparare e le menti m a ltesi utili ai no s tri fini. An a log a az io ne si è d a p oco ini z iata verso g li e leme nti ara bi e p uò dar si s i de bba fra breve s volgere an c he verso g li indiani.
Orie nt am e nti futuri possono c onsigliare e richi e dere lo s fruttam e n to di a ltri clementi co noscito ri di lin g u a e regioni d ove p ossia mo esse re c hi a mati a d ope ra re.
La Commi ssione d 'armistizio ha ad esempio in istudio speciali attività di concorso e collaboraz ione all e operazioni per cog li e re di sorpres a e pa ralizzare e le m e nti a vversari ed impedire loro di operare interru zio ni ed a tti d i sa botaggio nel caso di avan zata delle nos tre truppe fi no al R o d a no.
In Tunis ia può darsi che iniziative del ge nere poss ano occorre re da parte nostra pe r c ui s i a ne cessario d isporre in te mpo di co noscitori d e ll a reg ione, be n c ondotti e prepara ti, a uda c i e dec is i.
Sembra perc iò leci to e c onve ni e nte conside rare l ' oppo1tunità di predispoITe ed attuare fin d'ora , in modo org anico la valorizzazione e la preparazione d egli uomini utili ai fini di cui sop ra, in modo da ev itare, come la esperie nza de i maltesi d imostra , c he diventi ard uo o me no redditizio d overvi ri co rrere quando preme l ' urgenza e quando gli e le menti siano dispersi e da rieducare .
Appare quindi po ss ibile e opportuno d a re v ita a nc he in It a li a ad un a o rg anizzaz io ne sul tipo di qu e ll a g erma ni ca e crea re un o s pec iale C o rpo c ompre ndente un ce rto nu me ro di un ità minori, og nuna cos rituita d a elementi c on pa1ti c olare conoscenze della stessa reg ione straniera, e s pec ialmente attrez z at a e addes tra ta per a z io ni da " quinta colonn a" .
I gruppi fi no ra ra cco lti di m a lt es i e ara bi e, tra breve, an c he di indi a ni , poss on o c ostituire le prime ce llule di ta li form az io ni
Raccolta , s cel t a, pre parazion e, inquadramento e addestram e nto d eg li elemen t i dovre bb e ro con ti nuare ad ess ere a ff ida ti a ll o Sta to M agg io re d e l R eg io E se rc ito .
Al Coma ndo Supre mo -SIM do v rebbe invece e ssere riserv a ta l ' azione d iretti v a su ll a pre parazione e la dip e ndenza per l ' imp ie g o dei vari nuclei d e ll a form az io ne, in re lazione a ll a loro prev is ta atti v i tà s ulla base delle es ige nze o pe rati ve .
Qualora l a propos ta trovasse fa vorevole ac coglime nto , farei seg uire un piano d i o rg an izzazio ne p art i co la reggiato per l'u lte ri o re sv il upp o .

Documento n.12
(21 maggio 1942)
Allo scopo di meglio definire i compiti e l'organizzazione dei Reparti Speciali, il Capo di Stato Maggiore, gen. Ugo Cavallero, volle indicare nel seguente documento del 21 maggio 1942 le future strutture di questi Centri:

OGGETTO: Preparazione ed organizzazione reparti speciali
21 maggio 1942
In relazione ad eve ntualità avvenire, questo Comando Supremo ha deciso di dare vita fin d'ora ad una organizzazione speciale destinata a seconda delle esigenze, a precedere od affiancare operazioni militari in territorio straniero.
Tal e organizzazione, unitaria nei criter:i generali e nelle direttive di preparazione , sarà peraltro profondamente differenziata negli elementi costituitivi, nei procedimenti e nei compiti a seconda della qualità, della nazi onalità, del carattere del personale e delle prevedibili opportunità di impiego.
L' organiz zazione cui potrà essere attribuito nome appropriato da stabilire dovrà raggiungere gradualmente intelaiatura simile a quello di un reggimento di fanteria.
Essa sarà costituita da un Comando organizzato con adeguate possibilità di agile funzionamento e da Centri Militari vari di fisionomia organica, inizialmente pari a quella della compagnia di fanteria, dotati ciascuna di caratteristiche proprie, a seconda delle esigenze, del carattere della formazione e delle necessità di vita e di addestramento.
Tali unità comprenderanno elementi per nazionalità, conoscenze , attitudini, tendenze politiche , orientati verso unica direzione di impiego.
Dispongo perciò:
I O - Il Centro Militare "A" (elementi arabi) dovrà continuare ad essere sviluppato seco ndo le direttive date con foglio n. 1047/CS in data 4 aprile u. s . di questo Comando Supremo.
- Gli eleme nti indiani già selezionati, in graduale afflusso al campo di Villa M arina (via Casilina) dovranno essere organizzati seco ndo analoghe direttive in modo da realizzare al più presto un Centro Militare "I".
- Dovrà essere iniziata senz'al tro e svilup pata la costituzione di un Centro Militare " T " (elementi italiani già residenti in Tunisia) ricercando in una prima fase g li elementi sotto le anni (ufficiali di inquadramento compresi) idonei per conoscenza della regione tunisina e delle lingue ivi in uso . In secondo tempo potranno essere fatti affluire dalla Tunisia elementi italiani idonei.
2° - D i penden za della organizzazione
Sarà alle di pendenze di codesto Stato Maggiore per l'organizzazione iniziale e per le esigenze di addestramento e di funzionamento; alle dipende nze del Comando S upremo per le direttive generali di preparazione e di impiego .
L'istruzione mili tare di ogni Centro (co me per il Centro Militare "A") dovrà avere soprattutto caratteristiche ed indiriz zo corrispondenti a quelli dei noti "Co mmandos".
Per gli eleme nti particolarmente idonei sarà considerata l 'opport unità di aggregarli ai corsi paracadutisti, arditi, radiote legrafisti, già in att o presso le Forze Armate italiane.
°
Il comando d ella intera organizzazione potrà essere assunto dal ten. colonnel lo di S. M. Massimo Invrea (g ià Capo Cen tro Militare, "A") .

Quali Capi Cen tro saranno possi bilmente d estinati ufficiali s uperiori adatti ed orientati s ulle regioni cui appartiene il personale ed a conoscenza della partic olare me ntalità.
I Capi Cento saranno coadiuvati da ufficiali e sottufficiali istruttori con attitudini ad eguate . Detto personale dovrà essere assegnato con urgenza a c ura di codesto Stato Maggiore.
4 ° -
Il comando della organiz zazione risiederà a Roma, in locali da desig nare; i Centri in lo calità dei dintorni (per i Centri "A" ed " I " le sed i sono già state designate ) .
5° - Formazioni, armamento, dotazioni, uniformi Si seguiranno, dj massima, gli stessi criteri adottati per il Centro Militare "A" .
Qualora non fosse possibile fornire di materiale di preda bellica inglese i Centri "A" ed " 1", anche i Centri s udd etti saranno armati con materiale italiano.
Si prega voler tenere al corrente questo Comando Supremo degli sviluppi dell ' organizzazione.

Il Capo di Stato Maggiore Generale Geo . Ugo Cavallero
FORMAZIONE PROVVISORIA INIZIALE DELL' ORGANIZZAZIONE*
- Coma ndo organ izzazione
- Centro Militare "A"
(forza probabile : 700)
- Centro Militare "I"
(forza iniziale: 200)
- Centro Militare "I"
(forza ini z iale: 2 -300)
Comando Reparto Addestramento (in izialmente)
Comando R epar to Addestramento (inizialmente)
Comando Reparto Addestra mento (inizialmente)
* Denominazione e formazioni da stabilite .
FONT E: USSM E - Comando Sup remo-SJM, in USSME, Racc . 1398.

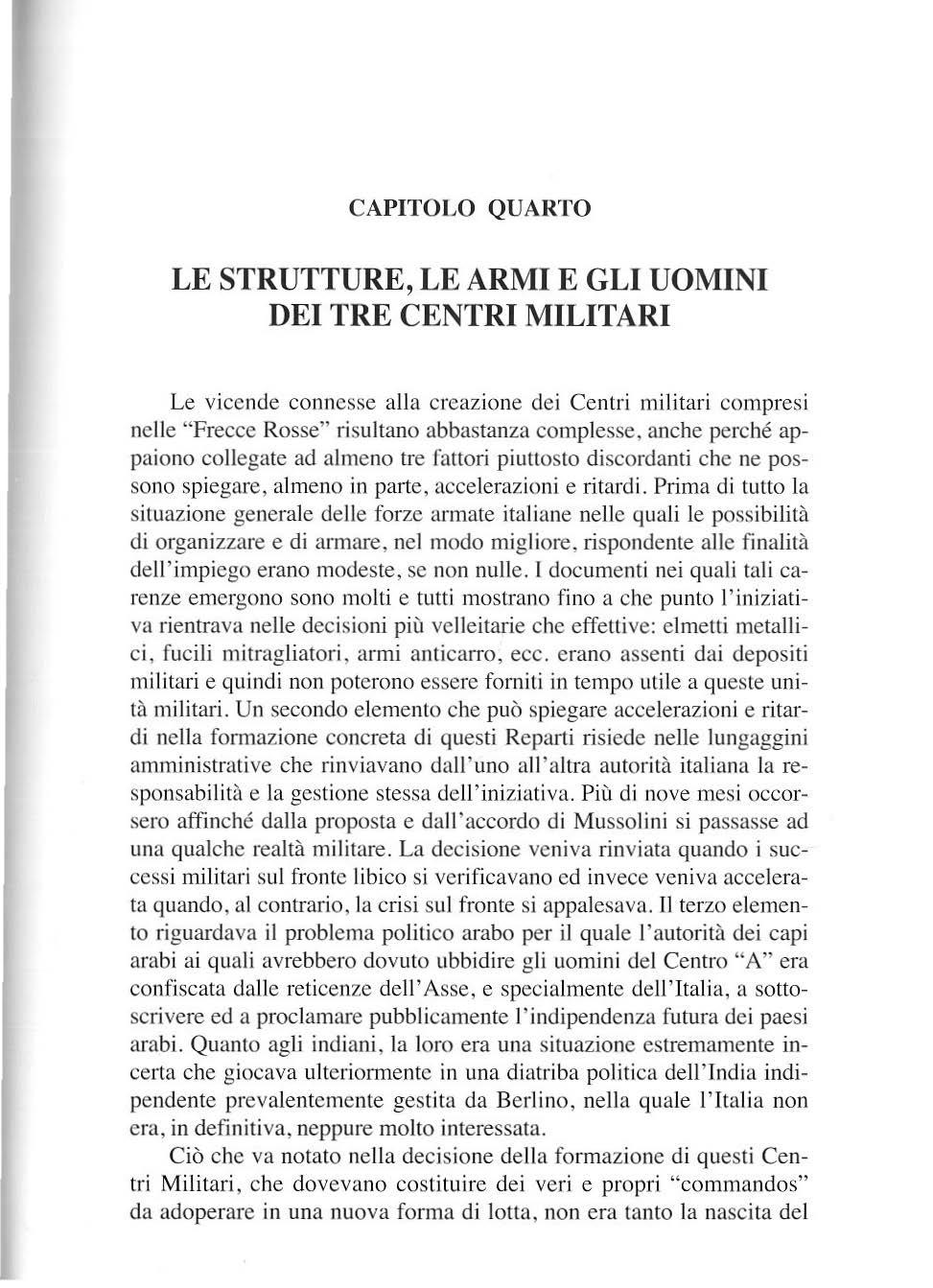
Le vicende conn esse alla c reaz ion e dei Centri militari comp resi nelle " Frecce Rosse" ri s ultano abbastanza complesse, anche perché appaiono collegate ad alme no tre fattori piuttosto discordanti che ne posso no spiegare, almeno in parte , accelerazioni e ritardi. Prima di tutto la s ituazione ge nerale delle forze armate italiane nelle qua li le possibilità di orga ni zzare e di armare, nel modo migliore, ri spondente alle fina lità dell'impiego erano modeste, se non nulle. I documenti nei quali tali carenze em ergono sono molti e tutti mostran o fi no a che p unto l'iniziativa rientrava nelle decisioni più velleitarie che effettive: elmetti metallici, fucili mitragliatori, armi anticarro, ecc. era no assenti dai depositi mi litari e quindi non poterono essere fornili in tempo utile a queste unità militari. Un secondo e lemenlo che può spiegare accelerazioni e ritardi nella formazione concreta di questi R eparti risied e nelle lungaggini ammi nistraLive che rinviavano dall'uno all 'altra autorità italiana la respo nsabilit à e la gest ione stessa de ll'ini ziativa Più d i nove mes i occorsero affinché dalla proposta e dall 'accordo di Mussolini si passasse ad una qualche realtà militare. La decisione veniva rinviata quando i successi militari s ul fronte libico si ver ific avano cd in vece ve ni va acce ler ata quando, a l contrario , la crisi sul fronte si ap palesav a. Il terzo e lemento riguardava il problema poli t ico arabo per il qu ale l ' autorità dei capi arab i a i qu ali avrebbero dovuto ubbidire g li uomini del Centro " A" era confiscata dalle reti cenze dell'A sse, e special men te dell 'ltali a, a sottoscrivere ed a proclamare pubblicamente l'indipendenza futura dei paesi arabi. Qu anto ag li indiani, la loro era una situazione estremame nte incerta che g iocava ulte riormente in una diatriba politica dell ' India indipendente prevalentemente gesti ta da B erlino, nella qua le l'Ita li a non era, in definit i va, neppure molto interessata.
Ciò che va notato nella decisione della formazione d i questi Centri Milita ri, c h e do veva no costituire dei veri e propri " comman dos " da adoperare in una nuova forma di lotta, non era tanto la na scita del
Centro "A" e neppure del Centro "T"che rispondevano a criteri storici dell'interesse dell'Italia nei confronti del mondo arabo e delle presenze italiane in Tunisia, bensì la nascita del Centro "I". Esso infatti, formato da prigionieri di guerra indiani in mano italìana, era il frutto di un interesse del Ministero degli Affari Esteri nei confronti del movimento nazionalista indiano che il transfuga Chandra Bhose aveva in parte trasportato a Berlino e che Roma seguiva con attenzione tramite un altro esponente del nazionalismo indiano profugo in Italia, tale lqbal Shedai. E proprio a costui venivano fatte risalire le responsabilità politiche dell'intera operazione di arruolamento degli indiani ex prigionieri di guerra nel nuovo Centro Militare italiano . I Centri vennero creati a Roma e nei dintorni. La collocaz ione geografica dei tre Centri e del Comando risulta dalla cartina allegata al documento che noi riproduciamo :

Successivamente, con un Promemoria del 24 maggio , l'urg e nza delle attività d'impiego , specialmente per gli uomini de l Centro Militare " T ", veniva ribadita, mentre per gli altri du e Centri ve nne precisato che " essi dovevano s olta nto avere nascita ufficiale". Che cosa s i voleva intendere con qu es ta u l tima affermazion e non appare ch iaro; forse s i voleva solo rib a dire di a ttendere ulteriori decisioni politi c he che per i l Centro "T" non erano necessarie. E l 'attesa contraddiceva l ' urgenz.a procl amata in varie occasioni re lativamente al Centro "A" che poteva costituire un e lemento assai utile ne lla campagna libicoegiz ian a in corso.
Curiosamente il Comando Supremo, in u na nota allo Stato Maggiore dell'Esercito rip eteva di vo le re stabi lire , più di un mese dop o, il 22 giu g no, quanto già s tab ilito, e c ioè di ave re deciso d i dare vita a queste organizzazioni spec iali , dando loro un comandante (a titolo provvisorio fin o a l 31 ottobre 1942) nell a persona del Ten. Col. Massimo In vre a4 1 . Ques ta data del 22 giugno è i m p ortante ai fin i de ll ' andamento general e de lle operazioni militari ne l Nord Africa ed a nche della po liti ca araba poiché seg na la riconquista di Tobruk da parte delle fo r ze armate ita liane e tedesche e la loro mar c ia verso A lessa ndri a i n territorio egiziano. È sta to già so ttoline ato da più parti l'entusia smo c he tali vittorie militari s usc itarono presso gli ambienti militari e politic i de ll ' Itali a e de ll o stess o Egitto . Il fut uro p resid e nt e de ll 'Eg itto, Anouar as - Sadat , poteva annotare ne l suo diario: " ... La strada dell ' invasione de ll ' Eg itto si apriva davanti a Rommel. Nessuno dubitava c he egli sa rebbe a vanza to fino a d A lessa nd ri a, e po i fino al Ca iro; si pe nsav a che fosse solo qu es tione di tempo , di poco tempo. Girava voce che l 'Egitto sarebbe stati affidati all'Italia e che Mussolini avesse già pro nt o un cava ll o b ia nco p er fa re il s uo in g resso tr ion fale al Cairo, proprio co me s i usava ai tempi dell' Impero romano .. . " 4 2 . E Ciano , nel suo Dia rio, in data 26 giugno, a sc rivere: " Mussolini non fa previs ioni , ma s pera che p rim a d i q uindi ci g iorni si possa fare tap pa ad A lessa ndri a ... " . E non a caso va ricordato che, s icuro della imminente conq ui sta di Aless a ndria, lo stes so Mussoli ni, in ciò confortato dalle 's ic urezze' di Rom me l (' ' e ntro qua tt ro gi orni sarò a l Cai ro" ) s i dec idesse a recarsi in Libia , per essere prese nte alla co nqui s ta di A lessa ndria e per coro nare con la s ua prese nza l ' i mminente marcia v ittoriosa in Egitto.

11 Mar. d'Italia Giovanni Messe nelle sue Memorie non manca di esclamare : " Il 29 Mussolini giungeva in Cirenaica per partecipare all'ingresso nella capitale egiziana !"43 Proprio in vista di questi sperati sviluppi il Ministero degli Esteri mi se a punto, il 25 giugno, un programma specifico sulla "Organizzazione politico-militare dell'Egitto" , occupata dalle forze armate dell'Asse.
Intanto, il 23 giugno, il Ministero degli Affari Esteri , in un Promemoria rivolto al Comando Supremo, prospettava la convenienza di riunire in reparti speciali gli italiani provenienti dalle regioni arabe suscettibili di essere utili zzat i per le loro specifiche conoscenze di lingue e di luoghi . Secondo il documento del Ministero risulterebbe la possibilità di costituire:
"- 3 nucle i di nazionali reduci dall'Egitto,
- 1 nucleo di nazionali reduci dalla Siria-Palestina,
- 1 nucleo di nazionali re duci dall'Iran.
Essendo chiaro che ogni nucleo veniva considerato di 30/40 uomini".
Queste proposte ven nero ripetute, il 28 giugno, dal Comando Supremo a destinazione, questa volta dello Stato Maggiore dell'Esercito. Vi era però in questa serie di proposte un elemento di notevole incertezza in quanto si sta bili va di inserire questi italiani tra gli uomini del Centro Militare "A", in serimento che era in netta contraddizione con quanto era già s tato stabilito con i capi nazionalisti arabi quando si parlava di Legione Araba, nella quale tutti i membri , a parte gli ufficiali, dovevano essere arabi del Medio Oriente, in lotta per l ' indipenden za de i loro ris pettivi . paesi. Forse questo problema non appariva tale agli occhi dei comandi militari, o forse si trattava di se lezionare, in modo quasi occulto ed al più presto, del personale militare italiano specializzato da inserire nella yent ilata amministrazione dei territori eg iziani occupati . Con queste equivoche decisioni si procedette tuttavia alla costituz ione , il 2 luglio 1942, del "Comando del Raggruppamento Centri Militari " che pareva dovesse sovrin tendere all'intera politica mi li tare dell'Italia nel mondo arabo , occ u pato e non occupato. Le s trutture previste per questo " Raggruppamento Centri Militari" che era collocato presso il deposito ciel 1° reggimento Granatieri di Roma quale centro di mobi litazione , comprendevano un Comando di Raggruppam en to e tre Centri Mii itari ("A", "I", "T") .

Il Comando del Raggruppamento comprendeva:
Un comandante e 6 ufficiali di comando
Una squadra servizi
Un drappello automobilistico
Un nucleo CC. RR.
Un nucleo marconisti .
Ogni Centro Militare comprendeva:
un comandante del Centro con 2 ufficiali addetti uno o più repa1ti con un comandante (capitano) sei nuclei con ognuno un comandante ufficiale subalterno graduati e mili.tari
Lo stesso 2 luglio, in un Appunto dell ' Ufficio IlI 0 del Ministero degli Affari Ester i diretto al Ministro Ciano si metteva in evidenza la necessità di "riprendere il progetto già varie volte contemplato dal governo tedesco e da quello italiano per un approfondito scambio di vedute tra l'Italia e la Germania al fine di concordare ed uniformare, con unicità di direttive" l'azione da svolgere a proposito della questione araba . Si trattava evidentemente di coordinare le varie iniziative di Legione araba che Roma e Berlino stavano attuando con visioni certamente diverse che contrastavano tra di loro e con quanto veniva chiesto da i capi nazionalisti arabi in esilio presso le capitali dell'Asse. Questa riunione non ebbe luogo, ma l'affermato coordinamento tra Roma e Berlino portò solo, il 4 luglio, ad una Dichiarazione italo -tedesca per il rispetto dell'indipendenza dell'Egitto che ribadiva, alla vig ili a della "ormai imminente occupazione di una parte notevole de l1' Egitto", i vecchi concetti di rispetto dell'indipendenza e della sovranità dell'Egitto da parte dell'Asse. Per il resto della questio ne tutto si limitò a contatti tra il SIM e il Serviz io Informazioni tedesco , quasi senza risultati pratici, in quanto ognuno proseguirà la propria politica anche nei confro nti della Legione Araba, o meglio delle Legioni Arabe, tedesca, a Sunion, e italiana a Roma. I criteri di addestramento e gli obiettivi strategici ai quali le due formazioni "arabe" erano destinate non apparivano coordinati. Purtuttavia una unanimità di facciata fu ribadita dai capi dei due Servizi.
L a riunione vera e propria avvenne il 15 agosto, a Roma, tra il gen. Amè e l' Amm. Canaris , alla presenza del Gran Mufti il quale, nel frattempo, aveva insistito per essere autorizzato a recarsi ne l Nord Africa (Eg itto, Libia e Tunisia) onde svolgervi una attività po-
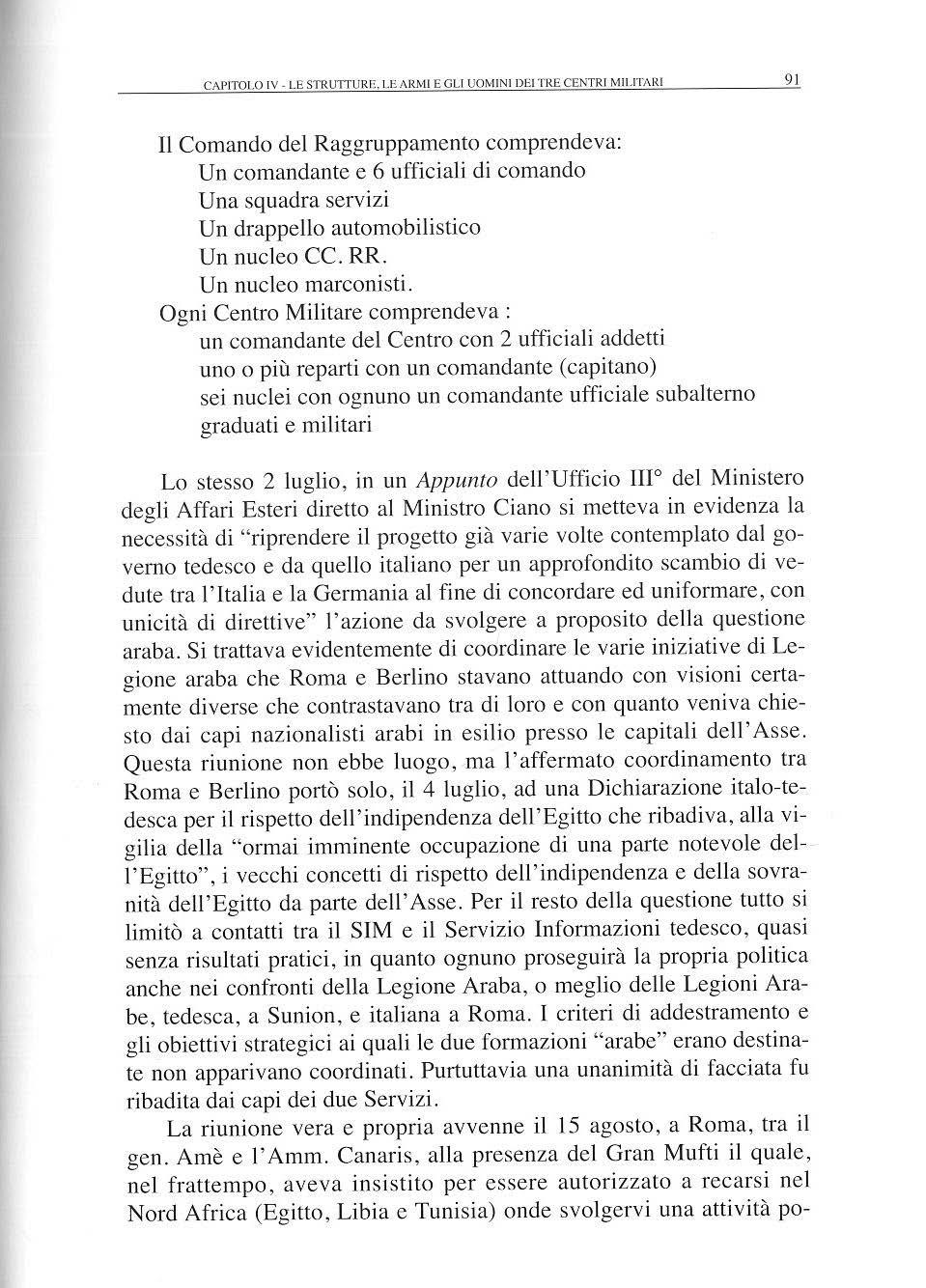
litica volta ad esortare i nazionalisti arabi a schierarsi decisamente dalla parte dell'Asse. Nella relazione italiana sullo svolgimento della riunione vi sono elementi molto interessanti che mostrano che, suila questione araba in generale, l ' intenzione tedesca era quella di agire per conto proprio e di avere con il Gran Mufti rapporti diretti che non erano sempre collegati al l 'Italia. Per esempio, veniva sottolineato il fatto che la parte tedesca aveva "presentato al Mufti, insistendo perché Io firmasse seduta stante, un progetto - di cui non hanno dato copia al gen. Amè - nel quale si prevede la costituzione di una forza militare araba chiamata 'Unità Liberatrice ' composta di elementi tedeschi , dei noti arabi già raccolti dai tedeschi a Sunion, nonché di 400 marocchini" al comando del gen . Felmy. Era certamente una evidente mancanza di riguardo nei confronti dell'alleata Italia che la relazione italiana non mancava di stigmati zz are. Ma non era la sola: le osservazioni della parte ita liana sono di rammarico per la politica tedesca a questo riguardo . Si notava infatti che, mentre l ' Italia aveva data ampia notizia della sua intenzione di formare una forza militarn araba, la Germania non aveva fatto altrettanto: "Quando il governo italiano ebbe indiretta notizia della costituzione di una un i tà araba a Sunion sollecitò informazioni al riguardo ma non ricevette risposta". Anche per quel che riguarda la " Unità Liberatrice " destinata a l Caucaso ed all ' Irak, il silenzio tede s co era stato assoluto . Venivano anche deprecate le ripetute affermazioni della propaganda tedesca che insistevano sul fatto c he la G e rmania non aveva mai avuto colonie arabe, né che mai si era macchiata di sailgue arabo . Ed in ciò non poteva non fare tornare alla mente la dura politica di repressione anti -araba attuata in Libia dalle autorità colon iali fasciste, politica culminata nell'esecuzione del capo nazional ista libico, Omar ~1 -Mukhtar il 16 settem bre 1931. Di queste posizioni tedesche che ledevano alla buona intesa nell'ambito dell'alleanza , il documento italia no si lagnava sottol in eando la vo lon tà italiana di volere coordinare ogni aspetto della propaganda del!' Asse a destina z ione dei paesi arabi, nonché l'interesse dell'Italia a conoscere dalla fonte ufficiale tedesca, e non da voci incontrollate, le iniziative che, riguardo al problema ar abo politico e militare , Berlino intendeva prende r e , alla luce della volontà italiana di non estraniarsi neppure dalla realtà caucasica ed irachena odierna e futura.
Nel frattempo le vicende mi li tari, che parevano volgere a netto favore dell ' avanzata italo-tedesca in Eg itto, indussero il SIM a proporre

al Comando Supremo un'altra iniziativa sul fronte interno arabo, e cioè l'invio nei territori ancora controllati dalle autorità britanniche di un emissario militare e politico con compiti particolarmente impegnativi. Secondo questa proposta del 3 luglio 1942, si sarebbe trattato di inviare ne l Vicino Oriente un ufficiale "pratico dei paesi arabi" che fosse incaricato di:
"
- apprezzare tempestivamente la situazione nell 'interno dei paesi arabi;
- stabilire con ogni possibile mezzo contatti con i capi arabi collaboranti con l'Asse, consigli arli e controllare i loro eventuali movimenti di r ivolta, seco ndo direttive ed opportunità che saranno concordate col nostro Alto Comando;
- rendersi conto delle necess ità e delle possibilità pratiche per alimentare con anni e mezzi in genere movimenti di rivolta . Ciò può solo essere valutato nelle immediate vicinanze ed a diretto contatto con le zone di interesse;
- assicurare un pronto collegamento tra l'A lto Comando delle nostre forze operanti nello scacchiere egiziano ed i capi dei movimenti di rivolta nei vicini paesi arabi"44
Costui, chiamato anche " ufficiale di punta", doveva potere disporre subito :
"- di alcuni informatori scelti fra gli arabi di provata capacità e fiducia e disposti ad offrirsi volen terosamente per i compiti considerati. Per questa sce lta risulterebbe uti li ssima la co ll aborazione del Mufti e del ministro Ghailani . Potrebbero essere uti l izzati italiani a perfetta conoscenza della lingua e dei paesi arabi;
- d i un centro radio composto da 3 o 4 operatori capaci, volontari per im p rese risch iose, mun iti di staz ioni a valige tta, per ass icurare i collegamenti e per essere eve ntualmente lanciati nell ' interno dei paesi arabi ... " .
Questa proposta non ebbe seguito alc un o, sia perché la cooperazione della presunta "organizzazione" del Gran Mufti non si ebbe, anche perché tale strutt u ra così magnificata, forse non esisteva se non nella fantasia del suo auto re, sia perché le autorità militari italiane decisero di dare il mass imo sv il uppo alla realizzaz ione dei Centri Militari speciali di cu i si prevedevano un rapido adde stramento ed azioni clamorosamente efficaci. Ri guardo al Gran Mufti, che co ntinuava ad
44 USSME, Racc . 1400, cart. 3.

agitarsi tra Roma e Berlino nella speranza di svolgere un ruolo importante , vi é solo da ricordare il telegramma dell' 11 luglio a Mussolini che voleva " esprimere l'entusiasmo del popolo arabo per le vittorie riportate dalle Forze Armate dell'Asse nell'Africa settentrionale" e per la proclamazione dell'indipendenza dell'Egitto. In questo contesto l'affermazione secondo la quale " gli arabi si schiereranno al vostro fianco per combattere il nemico comune, fino alla vittoria finale" non può essere considerata una dichiarazion e con grandi ripercussioni pratiche45 . In vano il Comando Supremo indicherà, il 28 luglio, al Gran Mufti, quanto le autorità militari italiane si aspettavano " dalla sua Centrale in territorio egiziano". Si erano intanto andate definendo, almeno in parte, le strutture delle dotazioni del Raggrnppamento Centri Militari. Secondo una nota del 10 luglio dello Stato Maggiore del Regio Esercito si trattava di una serie di materiali di Sanità, di Commissariato, di Artiglieria, del Genio e del Servizio automobilistico che davano ad ogni componente dei Centri la classica dotazione individuale nei vari settori; vi era una eccezione, per quanto riguarda la parte artiglieria che non era definita in attesa di avere presenti le disponibilità dei magazzini centrali al riguardo. Per la parte automobilistica, era decisa l'attri bu zio ne di tre autovetture 508/C, di due camioncini, di tre autocarri leggeri , di un autobus, di tre motocicli e di quattro biciclette.

E per un complesso corpo di 1 .000 uomini, si può ritenere che queste ultime attribuzioni non fossero certamente in grado di assicurare all'insieme quel grado di mobilità che le esigenze belliche imponevano.
Mentre queste decisioni venivano prese; gli svi luppi della campagna nordafricana non ebbero la conferma delle rosee previsioni della fin e di giugno. Tuttavia la pressione della propaganda italiana sulle popolazioni arabe s i intensificò, sia attraverso le emissioni r ~diofoniche, sia attraverso il lancio di ce n tinaia di migliaia di volantini in c itanti alla rivolta anti -inglese . Poco si sa sull'effetto degli uni e deg li altri mezzi attuati dal governo di Roma. Ciò che, alla fine di luglio, parve importante allo scopo di mobilitare le masse arabe, fu la proposta del 28 luglio fatta dal Gran Mufti al Comando Supremo di recarsi "al più presto in territorio egiziano" per stabilirvi una Centrale dì azione politica che il SIM ri teneva importante. Il programma delle attività del Gran Mu f ti che intendeva svolgere a partire dalla sua presenza in Nord Africa comprendeva ben sei punti:
a) impianto ed impiego di una stazione radiofonica di adeguata potenza per svolgere attiva propaganda tra gli arabi dell ' Egitto e del Medio Oriente ed istiga rli alla rivolta;
b) preparazione e divulgazione di manifestini di propaganda in arabo da realizzarsi attraverso una tipografia da campo;
c) invio di informatori nei paesi arabi dietro le linee nemiche. li Mufti si diceva sicuro di potervi riuscire col concorso dei suoi organizzat i in Egitto, attraverso il deserto;
d) attirare elementi fedeli e disertori di reparti costituiti dagli inglesi, per inqu adrarli nelle formazioni arabe;
e) attivare contatti con le organizzazioni nazionaliste dell'Egitto e della Palestina per fomentare e dirigere rivolte e sabotaggi. Il Mufti faceva presente di avere circa lOmila aderenti palestinesi al Cairo, di cui oltre 200 già appartenenti alle bande di azione in Palestina;
f) collabora re con l'Asse per l'invio di armi ed esplosivi ai rivoltos i nei paesi arabi.
Alla lettura di questo programma che il Comando Supremo ed il SIM ricevettero , con un allegato relativo ad ingenti finanziamenti "in valute pregiate ed in oro", potrebbe sorgere il sospetto che tutta questa azione avesse ben poche concrete prospettive di successo. In realtà tutto pareva ridursi in una serie di propositi fantasiosi quanto irreali i quali, come al solito, si rifacevano a quella fantomatica "Organizzazio ne segreta" che il Gran Mufti dichiarava di possedere in Egitto ed altrove nel mondo arabo.
Intan to il Comando Supremo decise di precisare, l' 11 luglio , in un documento riassuntivo, l ' insieme delle direttive che veniva no stabilite per l'addestramento dei Centri Militari delle tre categorie. Per la prima volta veniva messo un po' d'ordine nelle decisioni che dal novembre dell'anno prima venivano citate in merito a quanto si voleva realiz zare con l 'is tituzione dei tre Centri Militari 46 Per il Centro "A" a cui il Comando Supremo affidava i maggiori compiti nel futuri impieghi , si auspicava un approntamento più che rapido, si diceva "entro la fine di agosto", allo scopo di poterne sfruttare al più presto l 'inserimento al fronte e dietro al fronte. La stessa data di possibilità di impiego era prevista per Centro "I" . Quanto al Centro "T", si evocava una data più lontana "entro ottobre" . Quali direttive comuni a tutti i Centri si doveva procede re ad una azione diretta :

- alla selezione intensiva degli elementi ai fini di sviluppare nel minor tempo le loro attitudini e capacità;
- alla ricerca di elementi che diano affidamento di poter frequentare con successo i corsi paracadutisti e arditi. È già previsto l ' invio di tali elementi presso i reparti speciali;
- alla segnalazione di elementi con particolari conoscenze(informatori , interpreti, conoscitori di attività interessanti del paese considerato, ecc.).
Ovviamente una domanda si potrebbe porre circa le reali condizioni nelle quali il Comando Supremo intendeva operare a questo riguardo . Con il senno di poi si può dire che una tale iniziativa avrebbe dovuto essere presa dalle supreme autorità militari italiane assai prima . La campagna libica era iniziata quasi due anni prima della conquista di Tobruk e le condizioni ambientali nelle quali essa sì doveva svolgere non dovevano essere ignote, fin dall'inizio del conflitto . La presenza sul terreno di popolazioni arabe dalla incerta scelta politica nonché i problemi connessi alle difficoltà ambientali sia della costa sia dell'interno sahariano avrebbero dovuto portare, per la loro soluzione pratica , al ricorso immediato ad elementi locali da impegnare accanto, durante e dopo le operazioni militari dei maggiori contingenti italiani. In verità non si fece nulla di tutto ciò e ciò che emerse dopo il g iu gno 1942, sia sul piano della propaganda presso le popolazioni arabe, sia su quello dell 'allestimento cli speciali unità militari, non può non apparire tardiva e certamente vana rea zione ad una situazione che poteva eia molti mesi essere affrontata con mezzi adeguati. La frettolosa decisione di creare i Centri militari speciali non poteva avere esiti positivi, malgrado la buona volontà e l 'inte nsità della struttura militare italiana. Con il progresso spaventosamente rapido d~lla controffensiva britannica, il tempo veniva a mancare per dare ali 'iniziativa tutti i risultati positivi che erano stati giustamente evocati all'atto della decisione.
In questo quadro i dati relativi a queste varie iniziative ci appaiono interessanti, anche se le osservazioni che sono state svolte vanno tenute in debito conto . E di fronte alle dimensioni del problema militare che si intende affrontare, le cifre concrete ci appaiono ben modesto in iz io. Dal 15 lu glio 1942, il Centro "A" ed il Centro " I" potevano contare ognu no sulla presenza di 59 uomini. Il Centro "T" ebbe al suo inizio, il 23 luglio, solo 7 presenze; mentre il Comando del Raggruppamento in iziò a funzionare, il 26 luglio, con 20 presenze .

TABELLA N. 2 - RAGGRUPPAMENTO CENTRI MILITARI COMANDO SITU AZIONE RIEPILOGATIVA DELLA FORZA EFFETTIVA DAL 15 AL 31 LUGLIO 1942

Come si vede agevolmente dalla Tabella 2 , gli inizi delle realizzazioni dei Centri Militari speciali erano piuttosto lenti e modesti. La decisione del Comando Supremo e del SIM era peraltro perentoria e, come si è già accennato, si accompagnava, nel periodo che va dal luglio al dicembre 1942, ad una intensa attività di propaganda a mezzo di manifestini ideologici, di inviti alla diserzione e di cartoline ummistiche che l'aviazione italiana era incaricata di lanciare nelle retrovie nemiche del fronte egiziano. L'azione propagandistica fu intensa e si avvaleva di significativi riferimenti al mondo arabo con l'intervento di appelli dei due grandi intermediari del nazionalismo arabo, Rashid Ali al-Ghailani, già capo del governo naz ionalista dell'lrak e il Gran Mufti cli Gerusalemme, Amin el-Husseini. Spesso l'aspetto politico si rifaceva oppmtunamente a sensibilità ed a ricordi del mondo arabo con l'esaltazione della nobiltà della cultura araba e con la denuncia dello sfruttamento coloniale della Gran Bretagna ne l Medio Oriente . L ' insieme di questa azione della quale diamo in Appendice una documentazione di un certo interesse, ve niva poi ripetuta per via radiofonica dalle emissioni di Radio-Bari dirette alle reg ioni arabe.
Ma anche a questo riguardo, non mancarono problemi concreti, in quanto i lanci programmati spesso non poterono avvenire, prevalentemente per mancanza di mezzi aerei adeguati. Ben se ne lamentava chi aveva ideata tale campagna e non ne vedeva i risultati, cioè il SJM, il quale, in un Promemoria del 21 agosto al Comando Supremo esortava le competenti autorità a dare "vitale impulso" a questa iniziativa e ribadiva: "mentre si è potuto fare e si sta facendo nella direzione Egitto , non altrettanto può dirsi per ciò che riguarda gli altri paesi arabi . Qui vi, nel campo della propaganda sulle popolazioni a mezzo diffusione materiale idoneo, si può dire che finora quasi nulla è stato fatto da noi di fruttifero . Mentre invece il terreno è fecondo e Ia ,situazione favorevole . .. ". E constatava con amarezza: "Non poco materia le inviato nel passato (all'Aeronautica militare) giace tuttora disperso sugli scali ed è ormai privo di va lore . .. Occo1Te che l 'Aeronautica metta a disposizione mezzi idonei esclusivamente dedicati al servizio di trasporto e di lancio del materiale di propaganda, in modo da conseguire la tempestività e la esatta applicazione del s uo im piego .. .Occorre che si possa avere la d isponibilità dei mezz i aerei senza dei quali ogni buona volontà é destinata a rimanere steri le di frutti ... " 47

Mentre queste questioni agitavano il panorama militare italiano, funestato anche da lla mancata avanzata verso Alessandria, le questioni politiche, legate ai Centri Militari ita liani e tedeschi, riemergevano con la rivalità, ormai evidente, tra il Gran Mufti e Rashid Ali al-GhaiJani i quali, entrambi, rivendicavano l'un ità del comando ognuno nelle proprie mani. Le rivendicazioni di ognuno dei due erano fondate anche sul modello di futuro Stato arabo da essi propugnato : uno Stato teocratico fondato sul Corano per il Gran Mufti ed invece uno Stato laico e moderno di tipo occidentale per al -Ghailani. In un Appunto del Gran Mufti al ministro Vitetti del Ministero italiano degli Affari

Esteri, in data 6 agosto 1942, egli evocava un telegramma del ministro Ciano "dal quale si desumeva che l'Italia lo riconosceva come capo, riconosceva la sua grande responsabi lità e lo attendeva con sollecitudine per lavorare insieme". E questo riconoscimento che il Gran Mufti era andato a cercare a Berlino per ottenerlo anche da Hitler, non era condi viso dall'altro capo nazionalista iracheno di cui si denunciava l ' ostinazione "per rinnegare quella prevalenza che mi aveva sinora riconosc iuto: ogni conciliazione sembra impossibile a meno che il s ignor Ghai lani non accetti di collaborare con me e mettersi d'accordo nel! 'interesse della causa comu ne . . . " . E ribadiva il Gran M ufti : "L'Italia fascista potrà apprezzare la necessità che in una nave , ne l momento del pericolo, vi sia uno solo che comanda e che assuma tu tte le responsabilità . C iò non nella fo rma o per le apparenze o per la mia persona, cose all e q u al i non tengo , ma nella sostanza e per la sostanza: l'avve n ire dei popoli arabi e la necessità per essi d i stabilire una collaborazio ne durat u ra e proficua con le due potenze del!' Asse. Fin dal principio ho assunto la responsabilità di conv in cere gli arabi d i co llaborare con l'Asse ... " 48 . Intanto il Gran Mufti che aveva fatto visita , il 18 agosto , al Centro Militare "A", la c ui organizzazione raccolse il suo pieno consenso, ebbe, quanto al proposto suo sopraluogo nel Nord Africa, l'approvazio ne dell' Ital ia. La posizione del Gran Mufti venne infatti soste n uta, a lme no in parte, dal governo italiano che decise, il 13 agosto, di accettare la sua proposta di costituzione di una Centra le d i attività ne l Nord Africa.
ni avevano titoli roboanti: Egi ziani! La menzognera propaganda ( I 80.000 copie); O nobile Egi z iano! (180.000 copie); Egiziani! La c ondanna dell ' Inghilt e rra ( 100.000); Le truppe viflorios e dell'Italia, (100.000); Dichiara zione italo -germanica (480.000); La scauante lupa romana (100 000).
48 ASMAE,Affari Politici, Italia , b. 85, 1942, fase. Miscellanea.
A questo fine venne creata una Missione Speciale per esigenza "M" la quale doveva essere composta dal Mufti e dal suo seguito civile, dal capo della miss ione militare che era il capitano di Fregata, Carlo Simen, da una delegazione del Ministero degli Affari Esteri, da un Nucleo comunicazioni, da un Quartier Generale e da u n Reparto militare arabo fornito dal Centro Militare "A"49 . L'i ns ieme del personale mobilitato per la Missione era di 196 perso ne di cui 78 militari d e l reparto arabo . Gli automezzi previsti dov eva no essere 6 autovetture, 26 autocani e 2 motociclette. In qu es to documento dire tto allo Stato Maggiore del Regio E serci to , si evocava come prossima l'eventualità del viaggio del Gran Mufti in Africa Settentrionale (si badi bene il luo go) e i l tono generale di tipo urgente che traspare da que sta lettura sem bra confermare che oramai la decisione pare va presa .

Il Comandante d el Raggruppamento dei Reparti Special i , ten. Col. Massi mo Inv rea, ratificò il 25 agosto le decis ioni s ulla creazione de lla Missione Speciale " M " quale quarto Centro Militare Speciale, in attesa che le autorità politiche ed il Comando Supremo de c ide ssero la data e la conferma d el via ggio del Gran Mufti in Africa Settentrionale. Ma tale d ec isio ne apparve subito d iffic ile in quanto , nelle more delle decisioni , tra il radioso giugno e il triste agosto, la situazi one del fronte aveva modificato in senso nega tivo le prime avanzate italo- tedesche in tenitorio egiziano . Pertanto s i dovette ripiegare teoricamente sul rinvio a tempo s uccess ivo della so lu zi one di una missione che doves se avvenire per·forza delle cose in territorio libico. In que sta decisione in terven ivano consideraz ion i negative in quanto in sediare una centrale araba che proclamasse la futura indip e nden za de i popoli arab i proprio nella colonia libica c_he l'Italia non voleva certamente emancipare creava un serio problema . Pe r a ltro anche la "so lu zione T un isia" che per qualcuno pote va essere avanzata, s uscitava a naloghe riserve italiane i n quanto l'azione del Gran Mufti era, i n via esclusiva, riservata agli arabi de l Vicino Oriente e non a qu e lli del Nord Africa .
In attesa di ulteriori decisioni circa la trasferta del Gran Mufti , prose g uiva l'o rgan izzaz ione dei Centri Milita r i . Al la data de l 31 agosto 1942 , il quadro deg li uffic iali del Comando risultava così comple tato:
TABELLA N. 3 · RAGGRUPPAMENTO CENTRI MILITARI

SPECCHIO
Grado
TABELLA N. 4 - RAGGRUPPAMENTO CENTRI .MILITARI
SPECCHIO DEGLI UFFICIALI DEL COMANDO CENTRO MILITARE "A"
FINOALLADATADEL3I AGOSTO 1942
Casato e nome Data ass. Incarico attri buito Variazio ni
DONATO Ugo 20/7 Capo Centro
TELLINI Alessandro 10/5 Ufficia le Addetto
GIRARDI Enr ico 3/8 Uff/le a disposizio ne
CON DO NE Guido 16/8 Com/ te Reparto V.A .
ORTALI Giuseppe 11 / 5 Com/ te Nucleo addest ramento Il 20/7 assume il comando Reparto V.A. Il 18/8 assume il comando 2° Nuc leo reparto naz iona li.

ANDREA Albe rto 2 1/ 6 Nucleo addes tramen to Il 20/7 assume il comando de l reparto nazionali .
Il 4/8 vice co m/ te del 2 ° ploton e da pos iz ion e de l repar to V.A .
Il 31/8 vice com/te 1° plotone fucilieri.
BURIGANA Aldo 1/7 A d isposizio ne Il 23/7 in li cenza conv. giorni 40
ROS SETTI Agost ino 25/7 A di sposizione Il 3/8 in li cenza speciale giorni 15
DI BELLO Franco 1/ 8 Com/ te Rep. Naz iona li
\IERNAZZA Marce ll o 1/8 A d isposizio ne Il 20/8 uff/le addetto al veno vag iiamento
TOZZI -COND IVI Guido 16/8 Com/te PI. Com.do V.A.
FABR0Fa6io 18/8 Com/te 2° eia pos. Rep. V.A. U 25/8 passa al Centro Mii.
SCOTTO DI PERTA Rodo lfo 24/8 V. Com/le 2° da pos. Rep. V.A.
ARDIZZONE Enr ico 27/8 Com/te 1° Nucleo Rep . Naz iona li
e, e
TABELLA N . 5 - RA GG RUPPAMENTO CENTRI MILITARI

S PECCHIO DEGLI UF FTCTALl D EL COMANDO CENTRO MILITARE "I"
FINO ALLA DATADELJI AGOSTO 1942
Casato e nom e
TABELLA N. 6 - RAGGRUPPAMENTO CENTRI MILITARI
SPECCHIO DEGLI UFFTCIALl DEL COMANDO CENTRO MILITARE "T"
FINO ALLA DAJ:4. DEL 31 AGOSTO 1942
Casato e nome Data ass. Incarico attribuito Va riazioni
RTCC JARDI Pasqu a le

MALTESE
e
militari; nel Centro "A" , 175 militari; nel Centro " I " , 190 militari ed infine nel Centro "T", 36 militari . Ovviamente ci si potrebbe chiedere quale furono le cause di questi arruolamenti "volontari " nei vari Centri voluti dal Comando Supremo sotto la supervisione del SIM. La risposta appare complessa e varia a seconda del Centro preso in esame. I casi più banali risultano quel li relativi al1'arruolamento degli indiani , già prigionieri di guerra nei campi di prigionia italiani. Vo lere evocare la figura mitica del nazionalista Chandra Bose o del suo luogotenente Shedai, pare non poco fuorviante. Se il primo può essere considerato un nazionalista convinto di quel "Risorgimento indiano" che , in altra via, perseguiva anche Gandhi, il secondo appare chiaramente un individuo che m irava al proprio tornaconto , ben lontano dall ' eroismo che le autorità ita li ane vollero inizialmente attribuirgli 50 . Il giudizio estremamente negativo che il comandante lnvrea diede del s uo operato all'atto dello sciog limento del Centro " I" appare quale definitiva condanna di ogni idealità connessa a l suo ruolo. Il semplice vantaggio personale in prestigio ed in denaro potrebbe bastare a giustificare la sua scelta di campo. L ' ideologia nazionalista e patriottica non pare propria dominare le sue az ioni. Quanto ai militari indiani anuolati come "volontari" nel Centro "I", essi fecero una scelta di comodo che li sottraeva alla mortificante vita del campo di prigionia, dava loro libertà e denaro e costava pi uttosto poco, come lo si vide allorquando, il 19 novembre, udita la notizia, peraltro fa lsa , di un loro imminente invio sul fronte africano, presero tutti ad ammutinarsi e quindi a fare ritorno, dopo mesi di "libera uscita", nei primitivi campi di prigion ia , tradendo sia il loro giuramento, sia le speranze delle autodtà militari italia ne, solo tre giorni dopo il solenne incontro tra il comandante lnvrea e lo stesso Chandra Bose.

Quanto a lla componente araba, ex prigionieri di guerra, del Centro "A" si può dire che la situazione era più o meno uguale a quella degli ind iani : ben d ive rsa la posizione degli italiani provenienti dai paesi arabi che partecipavano al Centro "A". Essi erano altamente motivati sul piano ideologico e la loro volontà di combattere e di essere fedeli
so II testo del giuramento che gli indiani dovevano prestare era il seguente : "Giuro di combattere per l'indipendenza dell ' India e per l' onore della bandiera nazionale in diana. Giuro di ubbidire agli ordini dei miei superiori, italiani e indiani, e mi impegno ad osservare le leggi ed i regolamenti militari italiani, considerandomi come alleato cieli ' Italia nella lotta contro i comuni nemici" .
alle strutture militari italiane non subì incrinamenti , come la vicenda del loro successivo impiego sul fronte tunisino ha pienamente dimostrato. Lo stesso s i può dire per quanto riguarda il Centro "T" , formato dagli italiani di Tunisia, la cui adesione all 'ideologia del regime era antica e non venn e mai meno.
Con queste riserve, che allora non apparivano in piena luce, la mobilitazione degli uomini da adibire ai vari Centri Militari proseguì nei mesi successivi poiché 1'esiguo numero dei militari disponibili in questi Centri, dopo molti mesi dalla loro creazione , poteva impedire di dare loro quel ruolo eccezionale che i piani primitivi avevano definito (vedi tabella pagina s eguente) .
Sul piano dell 'o rganizzazione dei Centri Militari, quello che diede i maggiori problemi fu quello degli indiani; infatti , anche se collocato in periferia, presso Centocelle, quest i militari , che vestivano divise estranee alla foggia italiana, non mancarono di suscitare probl e mi di coes istenza con la popolazione. Il duce richiese al riguardo un resoconto che fu l'oggetto del Promemoria ciel 6 settembre , nel quale si precisava che questi indiani che "godono di libera uscita e di permessi g iornalieri, recandosi a diporto isolatamente, armati e senza scorta" s u scitavano comme nti. sfavorevo li eia parte del pubblico italia no in merito a questa totale libertà . Suscitava anche perplessità il fatto che questi indiani spe nd essero " con prodigalità" il soprassoldo che percepivano nella mi sura da 8 a 20 lire giornaliere. In libera uscita gli indiani spe ndevano molto, non prendevano il resto sui tram o lo regalavano ai bambini , e tutto ciò provoca commenti sfavo revoli della gente che li credeva ancora prigionieri di guerra. Veniva tuttavia seg nalato a Mussol ini come, fino ad allora, "la condotta cli ques ti militari non avesse dato luogo al minimo incidente". Purtuttavia , in previsione dell'aumento del numero degli indiani cli questo Centro , ne veniva auspicata la collocazione in altra sede, in località lontana dalla capitale. Nel quadro delle vicende legate a qu este presenze si possono ricordare alcuni episodi di incomprensione tra costoro e la popolazione romana la quale spesso non mancava di seg na lare alle autorità mi li tari italiane la prese nza di questi militari che vestivano una d ivisa inconsueta, che parlavano una lingua sconosciuta e che parevano assumere atteggiame nti sospetti, quas i fossero nemici infiltrati o paracadutisti appena arrivati sul suolo ital iano con bellicose intenzioni. Di questa serie di episodi basta riportarne uno che diligentem ente il colonnello dei Carabinieri, comandan te la III 0 sottozona di Roma , O limpio Pernotti, anno -


tò nel Diario Storico del Raggruppamento , in data del 16 agosto I 942 : "Verso le ore 7, informato dall'ufficiale di servizio sottotenente P elix che, alle ore 5 ,40, il comandante del distaccamento del 53° Gruppo Appiedati del Genova Cavalleria, ha ricevuto notizia da l Comando della Stazione dei CC . RR. Di Torre Gaia-Centocelle-Qu adraro di tre paracadutisti nemici in dossanti tenuta kaki, armati fucile mitragliatore , e che sono state impartite disposizioni per la loro cattu ra . Lo stesso uffic ia le di servizio , appena ricevuta la segnalazione, aveva provveduto ad in formarne il Corpo d'Armata e la Zona Militare ed a comunicar la al Comando del 63° Battaglione Territoriale e del 53° Gruppo appiedati perché disponessero per il rintraccio e la cattura ... Più tard i s i riesce a stabilire che non si tratta di pe rso ne sospette, ma di militari del Centro in servizio di pattugli a ne ll a località sopra indicata . .. " 5 1 Naturalmente l'episodio è modesto e senza importanza, ma serve forse a meglio capire alcuni problemi che nascevano attorno ali' in iziativa dei Raggruppamento Mil itari Speciali.
Non certo per affrontare questi modesti aspetti , bensì per rivedere l'aspe tto dolente dell'alleanza tra Roma e Berlino, a proposito delle ini z iative militari connesse ai corpi militari arabi, il Comando Supremo propose, il IO settembre, di riunire a Venezia un convegno con il capo del SIM, gen . Amè, il capo del Servizio Informativo germanico, amm. Canaris e il Gran Mufti : l 'a rgomento era "l'esame di numerose questioni di carattere informativo - offensivo e difens i vo - che in questo momento vivamente interessavano la comune cooperazione". Spostata a Roma, la riunio ne avvenne il 15 e ii' 16 settembre ma ebbe solo il ri sultato di costatare che le rispettive posizioni italiana e tedesca, rispe tto a molte question i non erano mutate dopo i l precedente co nvegno del 15 agosto . Anche in questa occas ion e le discussi0ni a tre a proposito de lla nascita di una "For za Araba" in Africa settentrio nale e della speciale missione del Gran Mufti fecero emergere sostanziali divergenze. I tedeschi chiedevano inolt re al Gran Mu ft i di dare la sua piena adesione all'impiego de ll e forze arabe istruite a Sunion che erano g ià a S tal ino, sul fron te del Caucaso. Ma questi arabi s i rifiutavano di combattere senza un preciso ordine da parte del Gran Mu fti. Costui resistette alle pressioni tedesche chiarendo c he le forze arabe dovevano combattere sotto i colori arabi, ma non su l fronte ca uc asico e rifiutò di firmare un im peg no scritto preparato dalle autorità militari tede -

sche in vista della partecipazione araba alla lo tta nel Caucaso . [1 progetto tedesco, che non era stato né elaborato insieme con il SIM , né presentato ai delegati italiani nella riunione di Roma, prevedeva la costit uzione di una "Forza Liberatrice" composta da 17 ufficiali tedeschi, dai 130 arabi di Sunion, da un largo gruppo di militari tedeschi e da circa 400 marocchini, agli ordini del gen. Felmy. TI testo del progetto tedesco, che il Mufti si rifiutò di firmare "mettendone in evidenza gli errori politici e militari", fu trasmesso all'Italia dal Gran Mufti il quale , nella relazione del comm . Mellini al Comando Supremo, sollecitava l'ltal ia a sostenere la sua tesi . Le reazioni italiane furono caute ma decise, in quanto la tenace vo lontà di Berlino di gestire in modo del tutto isolato la questione militare araba, suscitava molte pe rplessità circa la lealtà de ll 'alleato . In questo quadro la missione del Gran Mufti in Africa settentrionale passava in secondo piano sia per queste divergenze, sia perché nel frattempo il fronte stava paurosamente mTetrandosi a danno delle speranze della prosecuzione dell'avanzata nel cuore dell'Egitto, e quindi la creazione della famosa Centrale non poteva più avvenire in terr itorio occupato , o " liberato", bensì nella colonia italiana della Libia . Le conseguenze politiche di una tale situazione induceva pertanto le autorità italiane a rimeditare circa l ' opportunità dell ' impianto di una sim ile Centrale.
L'intera questione venne riassunta in un Telespresso, urgente e segreto , del 16 settembre, all'ambasciata italiana a Berlino, da parte del1' Uffi cio III 0 del Ministero degli Esteri_ In questo documento si sollevavano importanti dubbi sul comportamento tedesco che non sembrava rispondere a quei criteri di lealtà che, da parte italian a, erano stati sempre rispettati 52 I tre punti su i quali il documento ita li ano insisteva erano elencati nella seconda parte del documento. Il ministero italiano affermava in esso che:

"Il governo tedesco era stato tenuto al ccmente della intenzione italiana di formare una forza militare araba che, agli ordini del Mufti e con propria autonomia . ..
.
.
. Non possiamo d ire che da parte tedesca si sia agito analogamente .. .
.
.
.Quando il governo italiano ebbe indiretta notizia della costituzione di una Unità araba a Sunion, sollecitò informazioni al riguardo ... ma non ricevette alcuna delucidazione ...
.. .In occasione della riunione del 15 corrente il governo italiano è venuto, di nuovo incidentalmente , a conoscenza senza che da parte tedesca gli sia stata fatta alcuna comunicazione che si preparava una "Unità Liberatrice", composta esclusivamente di tedeschi e arabi , e che avrebbe dovuto dal fronte del Caucaso procedere verso l 'Irak, dove si sarebbe fusa con l'esercito irachiano .. .". Ed anche in questa occasione la reticenza tedesca era stata totale; e ciò pareva minare quel clima di lealtà tra alleati frutto d i chiari e costanti contatti. Se ne fece nuovamente portavoce il Ministero degli Esteri in un Appunto segreto del 26 settembre nel quale l ' intera questione della poca solidarietà tedesca a proposito di queste iniziative militari che avrebbero dovuto essere il frutto coordinato dei due governi non si verificava , malgrado le ripetute rimostranze dell'Italia. I punti sui quali l'Italia insisteva erano due:
« l O - Sarebbe consigliabile aver presente l'opportunità che truppe italiane siano chiamate al momento opportuno a partecipare con gli alleati tedeschi ad un'eventuale avanzata verso i Paesi Arabi dalla paite del Caucaso.

2° - Sembrerebbe utile ed urgente richiedere, da parte delle nostr e Autorità militari, preci s e informazioni sul progetto tede s co per la costitu z ione di un "Unità liberatrice " nonché studiare e prospettare l'opportunità di una partecipaz ione militare e politica italiana a tale iniziati va in forma adeguata ai nostri predominanti intere ss i"5 3
Rimaneva inso luto il problema legato alla missione del Gran Mu fti nell'Africa del Nord: la Germania che all'inizio era contraria, si mos trava ora d'accordo. La cau s a di que s to mutamento risiedeva nelle difficoltà che le forze armate germaniche incontra v ano su]Ja via del Caucaso, difficoltà che avrebbero avuto fors e qualche sollievo se sul fronte nordafricano si fosse ripresa l'av anzata delle truppe delJ ' Asse ed in questi sviluppi, le attività di una qualche Legione Araba legata alle attività del Gran Mufti , potevano risultare utili . Per l'Italia che all'inizio era d ' accordo (purch é si parlasse di Egitto e di Vicino oriente) ora non si era più così d ' accordo, poiché la sede del movimento del Gran Mu f ti si era spostata , a causa della ritirata delle truppe dell'Asse, dall'Egitto alla Libia, che l'Italia voleva tenere ad ogni costo fuori dalla "liberazione" araba .
Proprio per fugare questi dubbi italiani , i1 Gran Mu f ti ebbe, al Ministero italiano degli Affari Esteri un incontro in data 28 settembre , incontro durante il quale egli tentò di concordare una linea politica accettabile , sia da Roma , sia dai naz ionalisti nordafricani, alla vigilia, per quanto riguarda 1a Tunisia, del ritorno del loro capo , Habib Bourguiba, dalle prigioni francesi. Le idee del Gran Mufti per quanto riguarda il Vicino Oriente non appaiono confortanti poiché "le stasi dell'azione militare dell'Asse ad Alamein ed a Stalingrado creano un certo raffreddamento delle speranze tra gli amici dell'As se in quei paesi, raffreddamento del quale gli inglesi approfittano" . Per quanto riguarda i paesi ciel Nord Africa, il discorso del Gran Mufti appariva ampiamente incerto; in esso, da una parte s i dichiarava che i nazionalisti erano s e mpre impensieriti dai propositi che a loro riguardo l'Asse, e soprattutto l'Italia, nutrivano, e dall'altra scorgevano pure una certa prospettiva di recuperare volontari per una " Legione araba" anti - inglese54
Il discorso peraltro non appariva chiaro: le idee del Gran Mufti riguardo al Nord Africa sembrano lontane dalla proclamata volontà di indipenden z a per gli arabi del Vicino Oriente . Ma in ciò, egli si adeguava alle preclus ioni italiane, in parte condivise dalla Germania , circa l'avvenire del mondo arabo del Maghreb. Ed anche il discorso sulla progettata "Forza Naz ionale Araba" non chiariva molto questi propositi. Sosteneva la relazione italiana: "Egli ritiene che gli sarebbe possibile, a parte e separatamente da quanto egli farà al fronte egi z iano e d indipendentemente dalla costituzione cli una "Forza Nazionale Araba" , costituire - d'accordo con le autorità militari - un centro per attirare larghe forze indigene mussulmane dal Marocco, dalla Tunisia e dal!' Algeria, attraverso il deserto le cui frontiere sono incontrollabili, per inquadrarle al fronte occidentale della Libia e tenerle pronte a combattere contro ogni minaccia da quella parte degli alleati del bolscevismo e del giudaismo, per stabilire contatti con i capi mussulmani di quei Paesi ed inviare emissari, armi e fondi al fine di alimentarne la resistenza contro la degaullistizzazione nel caso di un attacco anglo - americano". Vi erano molte incertezze su quali dovevano essere i destinatari di questa liberazione, ed anche di quale nazione araba si parlasse ed i dubbi, pur annegati in concetti nebu losi di strategia attribuiti a questa Legione ("attraverso il deserto"), erano molti.


Documento n 13
Del massimo responsabile dei Raggruppamenti Militari Speciali, Massimo lnvrea, chiamato a titolo provvisorio il 22 giugno 1942 e confermato il 31 ottobre , convien e ricordare, a gran.di linee lo sta to di serviz io :

- Nato a Novara il 16 maggio 1898.
- Allievo nel Collegio Militare di Napoli, li 30 ottobre 1913.
- Tale nel l ' Accademia Militare , aspiranti ufficiali di complemento , li 30 settembre 1916.
- Nominato Sottoten e nte Anna d'Artig l ieria ed assegnato al 31 ° Reggimento, li 22 marzo 1917.
- Giunto in territorio in stato di guerra, li 15 aprile 1917 .
- Tenente, li 22 dicembre 1918.
- Tale d'autorità nel R: Corpo Truppe Coloniali della Cirenai ca dal 26 novembre 1926.
- Passato alla disposizione del Ministero delle Colonie, li 3 aprile 1927.
- Capitano, li 5 febbraio 1928.
- Partito per la C irenaica e sbarcato a Bengasi, li 18 agosto 1928.
- Rimpatriato dalla colonia, 1i 27 dicembre 1928 .
- Assegnato alla Scuola di guerra , quale ufficiale dei corsi, li 5 novembre 1933.
- Assegnato all ' Istituto Superiore di Guerra ed assegnato al Comando Corpo d'Annata di Torino, li 28 giugno 1936.
- Maggiore, li 18 gennaio 1937.
- Volontario in servizio non isolato all'estero(Spagna) li 4 febbraio 1937.
- R impatria to e ricoverato all'Ospedale militare di Caserta, li 12 dicembre 1937.
- Destinato al Comando della Commissione Italiana di Armistizio con la Francia, li 23 febbraio 1941.
- Dal 30 novembre 1940 al 6 ottobre 1941 in missione CIAF, in Sùia.
- Tenente Colonnello, li 26 febbraio 1941.
- Partito per l'Albania, li 9 ottobre 1941.
- Rientrato in I tali a, li 3 febbraio 1942.
- Trasferito allo Stato Maggiore del Regio Esercito, li 10 maggio 1942.
- Dal 22 giugno 1942, responsabile del Raggruppamento Centri Militari.

- Dal 31 ottobre 1942 nominato Comandante del Raggruppamento Centri Militari .
- Colonnello, Ii 18 marzo 1943 .
- Tale , prigioniero di guerra dal 12 maggio 1943 .
- Tale, rientrato in Italia, Ii 27 febbraio 1946.
- Collocato in congedo li 25 gi ugno 1947.
- Generale di Brigata, Ii 17 aprile 1957.
- Iscritto nel Ruolo d'Onore li 3 novembre 1964.
- Generale di Divi sione, li 18 novembre 1965.
- Generale di Corpo d'Armata, li 4 dicembre 1968.
- Morto a' Torino, l' 11 giugno 1976 .
DECORAZIONI ED ENCOMI:
- Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia, 14 novembre 1935.
- Medaglia di bronzo al merito, 27 marzo 1936 .
- Croce d'oro per anzianità di servizio militare, 5 gi ugno 1936.
- Medaglia di bronzo al valor militare, 8 luglio 1938.
- Croce di guerra al valor militare, 18 marzo 1943.
- Croce al merito di guerra, 17 novembre 1946.
FONTE: USSME - Stati di servizio
Documento n 14
Il Comando Supremo fissò l' li luglio 1942 nelle seguenti "Diretti.ve " i compiti che erano demandati ai vari Centri Militari in vista dell'addestramento dei loro membri nel quadro di una loro fùtura utilizzazione nel c011fl.itto:
Per la preparazione e l'addestramento di ciascuno dei Centri "A " , "I" e "T", in previsione del loro impiego dovranno essere tenute presenti le seguenti direttive:
1° DIRETTIVE COMUNI A TUTTI I CENTRI
Presso tutti i Centri occon-e procedere:
- alla selezione intensiva degli elementi ai fini di svi lu ppare nel minor tempo le loro attitudini e capacità;
- alla ricerca di elementi che diano affidamento di pote r frequentare con successo i corsi paracadutisti e arditi. È già previsto l'invio di tali elementi presso i reparti speciali;
- alla segnalazione di elementi con pruticolari conoscenze(informatori , interpreti , conoscitori di attività interessanti del paese considerato, ecc.).

Contemporaneamente dovrà essere sviluppata azione di propaganda equilibrata, continua e senza incertezze, nell'intento di trasfondere nei gregari (specialmente dei Centri "A" ed "I") la convinzione della superiorità della nostra potenza militare, del nostro programma politico, della nostra volontà e sicurezza di vittoria .
I. Centro " A": Formazione di un reparto nazionale ed un reparto arabo:
Il repa1to nazionale dovrà essere suddjviso in nuclei cli conoscitori della stessa regione, e tali da poter fornire interpreti, guide, informatori, ecc, Inoltre dovranno da esso essere abilitati istrutt01i per unità arabe di nuova formazione.
Il reparto arabo dovrà diventare un nucleo modello ben armato e ben equipaggiato, da impiega re a suo tempo come entità militare capa-
ce di esercitare efficace forza a t trattiva e servire da centro di raccoglimento per volontari arabi e combattenti già sotto controllo nemico (come ad esempio i regolari iracheni)
Tenuto conto dell ' importanza che anch e le nostre Autorità politiche annettono ai compiti del Centro "A ", dovranno essere dedicate a tale formazione cure disciplinari ed organizzative che s i conformino al la particolare psicologia degli e lementi da inquadrare.
ù1 previsione di eventi nel Vicino 01iente , l'approntamento dei nucle i del Centro "A" (nazionale ed arabo) dovrà essere oggetto di sollecitudini a fine di ottenere al più presto condizioni di efficienza e di utile impiego.
II. Centro "I" : In considerazione del mag g ior tempo disponibile per l' impieg; di elementi indiani , dovrà essere formato inizialmente un reparto di addestramento costituito da una compagnia fucilieri con fucili mitragliatori ed una compagnia mitragliatori con mitragliatrici.
Tanto presso i reparti del Centro "I" quanto pres s o quelli costitu e nti il Centro " A " , si dovrà tendere a trasformare ogni gregario , che dia affidamento , in istruttore.

Ciò perché è da prevedere l a rapida formazione di nucl e i irregolari locali in relazione all'afflusso di armi e munizioni che fosse pos sibile organizzare per alimentare le azioni di guerriglia a noi favorevoli.
III. Centro " T": Il reparto d'addestram e nto di questo Centro avrà il compito di ricevere e di selezionare gli elementi assegnati; con gli elementi selezionati dovrarmo essere costituite formazioni d ' assalto, organizzate per azioni rapide ed ar·dite, ed attrezzate in conseguenza. Gli elementi disponibi li sono numerosi La selezione dovrà dare la preferenza alla qualità.
Circa il tempo di approntamento si può conclude re , con le seguenti diretti ve di mas sima:
- Calcolando che i reparti d'impiego "A" ed "I" possano essere costituiti per l a fine di agosto, potrà essere utile far loro compiere subito dopo un breve periodo (I 5 -20 giorni) d i campo per rendere g li uomini affiatati e disinvolti. Potranno essere organizzate in z one favorevoli piccole esercitazioni a fuoco.
Per il Centro " T " , pur non essendo prevedibili date d ' impiego, sarà opportuno approntare il reparto entro ottobre .
Comando Supremo-SIM: 11 luglio 1942
FONTE: USSME , Cart. 780 , RCM, fase I Diario Storico
Documento n. 15
LA MISSIONE SPECIALE PER ESIGENZA «M»
(13 agosto 1942)
Allo scopo dì allestire la prevista missione del Gran Muftì nell ' Africa del Nord, il Comando Supremo decise , il 13 agosto 1942, dicostituire una speciale struttura nell ' ambito dei Reparti Speciali con il seguente ordine di servizio :
ALLO STATO MAGGIORE DEL REGIO ESERCITO
13 AGOSTO 1942
OGGETTO: Missione speciale per esigenza "M" (Centrale del Mu.fti in Africa Settentrionale)
Occorre mettersi in condizioni di costituire rapidamente una speciale missio ne destinata a seguire il Mufti, nella prevista prossima eventualità di un s uo trasferimento in Africa Settentrionale.
La missione dovrà essere composta :
1° - Seguito civile del Mufti;
2° - Capo Missione Militare;
3° - Delegazione MinisteroAffari Esteri;
4° - Nucleo comunicazioni;
5° - Quartier Generale;
6° - R eparto arabo (fornito dal Centro Militare" A")
Agli elementi 1° e 3 ° provvederà il Ministero Affari Esteri .

Alla costituzione degli altri elementi è pregato di provvedere codesto Stato Maggiore secondo la traccia largamente indicativa riportata sugli specchi allegati.
Quale Capo della Missione è designato il Capitano cli Fregata Carlo S IMEN , in servizio presso il Comando Supremo -SIM .
11 Capo Miss ione sovrintende alla costituzione ed al funzionamento dei vari nuclei e del Quartier Generale. Ha alle dirette dipendenze il personale che costituisce la Missione. Le direttive di mass ima al Capo Missione saranno date dal Comando Supremo. Per questioni di carat-
tere operativo e logi st ico, in A. S. , il Capo Missione dipenderà dal Comando Superiore A. S. I.
Addetto alla Miss ione quale ufficiale medico è designato il Maggiore medico R. Marina Francesco Putzolu messo a dispos i zione dallo Stato Maggiore della Marina.
Nucleo comu nic azioni
Occorrono di massima :
a) una stazio ne radiofonica per diffusione a lunga portata;
b) due stazioni media potenza per normale collegamento a circa 2.()(X) Km;
c) 4 stazioni mobili - tipo valigetta - di cui 2 ad alimentazione indipendente e due a presa.
Poiché ri sulta che il R. Esercito non ha in dota z ione stazioni rad iofoniche come al paragrafo a) la R. Aeronautica è sta ta interessa ta direttamente da questo Comando Supremo per la cessione di una staz io ne di d etto tipo, con relativo personale.
Appare necessario designare quale Capo nucleo comunicazioni un ottimo ufficiale R. T., il quale dovrà mettersi a contatto col Capo Missione per fissare i particolari di organ izza zione .
Quartier Generale
Importa l ' immediata destinazione di un ufficiale di provata capacità, espe1to di organizzazione co loniale, quale comandante del Quaitier Generale .
Per l'am ministrazione occorrerà del pari un ufficiale adatto , tenuto conto delle spec iali esige nze nel quadro in cui la Missione dovrà operare.

Del Qu artier Gen era le dovrà fa r parte un drappello CC. RR. di 1012 uomini , di c ui 2 o 3 graduati , possibilmente già pratici di se rviz io in colo ni a e muniti di tenuta coloniale
S i ravvi sa la neces s ità di un 'assegnazione di automezzi suffic ienti al traspo rto di tutto il personale e del materiale, una adeguata dotazione di tende da campo ed un certo numero di effetti letterecci come risulta dal prospetto allegato. Oltre a ciò completa dotazione per mense a cucine da campo.
R eparto armato di volontari arabi
È prevedibile in primo tempo l ' invio in A. S. co l Mufti di un reparto fornito dal Centro "A" , costituito come da tabella allegata.
Successivamente potrà essere considerato l'invio di un secondo
5 Graduato d i contabili tà, grad uato a iuta nte di san ità ; 4 s taffette; I trom bettiere.
6 Attendent i; 3 inse rvient i mensa u fficiali .
7 Atte ndent i; 4 i mpiegat i speciali (barbiere, sa rto , ca lzo laio, fa leg nam e).
8 Au tomezzi: 7 per 105 uo1J1i ni ; 7 per q.l i 175 d i bagaglio. 2 per tend e e letlini, 2 per benz in a ed acq ua. In to ta le 18 .

9 Pili 40 te li rise r va e 2 te nd e cuc ina.
LO I comandante; I d 'amm inist razione .
LI Più 2 motoc icle tte.
12 Oppu re 5 gra nd i - tipo Laz io (7,50 per IO).
13 Più 200 s tuo ie indiv idua li.
* Tipo Laz io.
FONTE: USSME - Diari s1orici - 780
to Mag gio re e qu es to Comando Supremo-SIM .
ALLEGATO 2 - "REPARTO ARABO "
Comprende:
- 1 coma nd ante (capitano in s. p.)
- l v ice comandante
- 1 ploto ne comando (47 militari)
- 1 plotone fu c ilieri (29 militari )
Non appena possibile s arà in via to 1 plotone da posizione .

Do c umento n . 16

(16 settembre 1942)
Dopo la riunione a Roma nei giorni 15 e 16 settembre tra il capo del S IM gen . Amè , il capo del Servizio informaz ioni tedesco, amm. Canaris ed il Gran Mufti di Gerusal e mme, un resoconto attendibile d e lla riunione redailo dal comm . Mellini , venne trasme.sso dall'Ufficio 11/ 0 del Ministero degli Affari Esteri all'ambasciatore italiano a Berlino per evidenz iare il fatto che La politi ca t edesca nei riguardi dell'Italia, a proposito delle forma zioni militari arab e ,fosse incerta e po c o armonica con l'alleanza tra i due paesi .
Oggetto: C ollaboraz ion e militare con gli Arabi.
Con precede nte telespresso n. 965 codesta Ambasciata è già stata messa al con-ente delle intenz io ni del Mufti di recarsi in Africa Settentr ionale per svolgere i compiti indicati nell'allegato A al telespresso stesso.
Tanto questa Ambasciata di Germania quanto l 'Ammiraglio Ca nari s era no stati tenuti al corrente del progetto de l Gran Mu fti , no nch é delle p redi sposiz ion i che al riguardo s tav a per prendere il no stro S .I.M . Era tuttavia prevista un a presa d i co n tatto fra i l Generale Amé, l'Ammiragli o Ca nar is e il Gran Mufti per raggi u nge re un a comple ta intesa sul progetto . Tal e inco ntro ha avuto l uo go a Roma il 15 corrente. In una riunione fra il Gen erale Amé , l'Ammiraglio Canaris (che era accompagnato dal Generale Fe l my e dal T e n. Colonnello Majer-Ri ks e da tre Colonnelli Capi-servizio) e il G ran Mufti è stato ill ust r ato da parte ita li a n a il noto progetto per la c o stituz ione della centrale araba del M ufti in Africa S ette ntr ion al e . Il G enerale Amé ha chiesto se vi era no osservazioni da parte ted esca, ed ha espresso anche il desiderio che uno o due uffi c iali tedesc hi ed eve ntualmente a nc he un Funzio nario dell' Auswertiges Amt accompagnassero il Mu fti in Africa Settentrionale , qual i ele me nti cli collegamento co n l 'eserci to e co n le au torità tedesche.
L' Ammiraglio Ca.na.ris ha confermato l'adesione di massima - per quanto riguarda la parte milita.re - già data al nostro progetto per la costituzione della centrale araba del Mufri in Africa Settentrionale , promettendo di far assegnare a.Ila missione un Ufficiale tedesco di collegamento; tuttavia. ha riservato una approvaz ione definitiva , adducendo il carattere anche politico del progetto sul quale doveva essere interpellato l' Auswertiges Amt.
Nella stess a riunione del 15 corrente , alla presenza del Generale Amé, i suddetti Ufficiali tedeschi, ma particolarmente il Gen e rale Felmy ed il Ten . Colonnello Majer-Riks, hanno pres entato al Mu f ti, insistendo perché lo firmasse seduta stante, un progetto - di cui non hanno dato copia al Generale Amé - ne l quale si prevede la costituz ione di una forza militare araba , chiamata "Unità Liberatrice" compos ta di elementi ted e schi, dei noti arabi già raccolti dai tedeschi a Sunion nonché di circa 400 marocchini , unità che , inquadrata nell e for ze armate tedesche ed agli ordini del Generale F elmy , dovrebbe dal fronte del Caucaso agire nei Paes i arab i del Vicino Oriente "nella lotta contro l ' Inghilterra ed i suoi alleati " ed attira.re le forze regolari ed irregolari ara.be nonché fondersi al momento opportuno con l ' esercito irachiano , nel qual caso pas serebbe sotto la guida del Capo del Governo dell'Irak (evidentemente Gailani) e rimanendo comandata dal Generale Felmy
Sia il Generale Felmy che il Te n. ColonnelJo Majer-Riks hanno fatto intendere che tale progetto aveva ottenuto l'adesione del Presidente Gailani; che, da parte tedesca , si considererebbe come più prossima e più probabile l'eventualità di giunge re nei Paesi ara.bi del Vicino Oriente dal fronte del Caucaso anziché da quello dell'Africa Settentrional e ; che è risultato cl' altra parte che gli arabi inquadrati a Sunion e perfino gli stessi marocchini non in tendono battersi, se non su ordini del Gran Mufti.
Questi non ha accettato di firmare il progetto sottopostogli, ed ha anzi insistito perché , secondo le promesse già fattegli da parte tedesca , gli arabi di Sunion non siano impiegati sul fronte del Caucaso ma siano invece lasciati , come essi desidera.no e chiedono , sotto la guida del Mufti stesso .
La questione, per la pa1tenza degli Ufficiali tedeschi, avvenuta il 16 corrente , è rimasta in sospeso e si prevede che sarà lipresa in occasione di una event uale prossima visita del Mufti a Berlino.
Su quanto precede si possono, nel campo politico e dei reciproci rapporti italo -tedeschi nei riguardi dell ' atteggiamento verso gli arabi de l Vicino Oriente, fare le seguenti considerazioni:

I 0 ) Il Governo tedesco è stato ten uto al corrente della nostra intenzione di formare una forza militare araba che, agli ordini del Mufti e con propria autonomia, sebbene inquadrata da Ufficiali italiani e sotto il comando operativo dell'Asse, contribuisse, con scopo particolarmente di propaganda, agli sviluppi operativi per la liberazione e l'indipendenza dei paesi arabi del Vicino Oriente.
Vi sono note le pratiche fatte a suo tem po col Governo tedesco per ottenere, in cambio degli indiani, la cessione degli arabi cli cui disponeva, nonché l'adesione da esso data che l'Italia costituisse tale forza militare araba, data la riconosciuta preminenza degli interessi italiani nei paesi arabi del Vicino Oriente (lrak, Siria, Libano, Palestina e Transgiordania).
li Governo tedesco a mezzo di questa Ambasciata di Germania è anche stato tenuto al corrente ciel progetto per la costituzione della centrale araba del Mufti in Africa Settentrionale, come dimostra del resto la stessa riunione avvenuta a Roma il 15 corrente, ai fini di una definitiva decisione.
Il Governo italiano ha infatti ritenuto, nello spirito dell'alleanza e della fraternità d'anni che ci lega alla Germania, di procedere in tale progetto, mantenendo con l'alleata costanti e chiari contatti .

2°) Non possiamo dire che da parte tedesca si sia agito analogamente .
Quando il Governo italiano ebbe indiretta noti zia della costituzione di una Unità araba a Sunion, sollecitò informazioni al riguardo sia a questa Ambasciata di Germania, sia al signor Granow, allora in missione a Roma. Ma non ricevette alcuna de lucidazione . Successivamente l'esistenza del reparto arabo a Sun ion è stata da parte tedesca resa incidentalmente nota quando alla nostra richiesta di trasferire in Italia gli elementi arabi a disposizione della German ia, il Ministro Ribbentrop aderì facendo tuttavia eccezione per gli arabi già inquadrati a Sunion che avrebbero dovuto serv ire a compiti particolari.
3°) In occasione della suddetta riunione del 15 corrente il Governo italiano è venuto, di nuovo incidentalmente, a conoscenza, senza che da parte tede sca gli sia stata fatta alcuna comunicazione, che s i prepara una "Unità Liberatrice" , composta esclusivamente di tedeschi e arabi, e che dovrebbe dal fronte del Caucaso procedere ve rso l'Irak, dove si fonderebbe con l'esercito irachiano.
Non vi è dubbio che tale progetto - indipendentemente dalla sua portata militare - presenta importanti aspetti di ordine politico nei riguardi dei Paesi arabi del Vicino Oriente dove la preminenza degli interessi italiani è stata dalla Germania riconosciuta. È ovvio che l'Italia non potrebbe rimanere estranea alla esecuzione del progetto presentato al Mufti dai suddetti Ufficiali tedeschi.
Valendovi delle suesposte informazioni e considerazioni vi prego di avere una conversazione con il Ministro von Ribbentrop o con Weizsacher, nella quale potrete far rilevare nel modo più amichevole la ovvia opportunità che, come è stato sempre eia noi fatto , si mantenga eia parte dell'Asse, di fronte al Gran Mufti ed a Gailani ora, e più tardi di fronte ai popoli arabi del Vicino Oriente, una assoluta identità di concordate vedute. Ciò implica che iniziative come quella sopra indicata dovrebbero essere previamente concordate fra i Governi italiano e tedesco. Si tratta di conoscere se ed in quanto il Governo tedesco sia al corrente ed approvi l'iniziativa stessa, ed eventualmente i motivi per cui essa non è stata resa nota che solo ora ed incidentalmente al Governo italiano.

Occon-erà bene precisare che se l'iniziati v a tedesca dove sse essere attuata, da parte italiana, si intende concorrere con una adeguata partecipazione, dati i nostri preminenti interessi nei Paesi arabi del Vicino Oriente, compreso l'Irak, regione che costituisce elemento essenziale nella politica del complesso dei Paesi arabi del Vicino Oriente .
Resto in attesa di comunicazioni al riguardo
Roma , 16 settembre 1942
Cornm. MelliniDocumento n. 17

Per esortare il ministro Ciano a farsi portavoce delle rimostranze italiane circa il mancato coordinamento militare che provocavano le reticenze tedesche nei confronti dell'Italia a proposito delle Unità speciali arabe, il Ministero degli Esteri chiese un suo intervento in questo Appunto segreto .
Come noto l ' Ammiraglio Canaris, nella sua recente visita a Roma, ba fatto conoscere al Generale Amé, di essere d'accordo, dal punto di vista militare, sulle progettate basi della missione del Mufti in Africa Settentrionale e per la costituzione colà di una "Forza nazionale araba".
Nonostante l 'opportu nità e l'urgenza riconosciuta dal Mufti e condivise dal no stro Comando Supremo, di una realizzazione di tali progetti, si rimane ancora in attesa di una risposta tedesca alla proposta presentata il 13 corrente per lo scambio di lettere - già da Voi, Eccellenza, approvato - che riconoscano la posizione personale del Mufti , nonché di avere conferma da Berlino circa la chiesta partecipazione alla mi ss ione del Mufti di uno o due ufficiali ed eventualmente di un funzionario tedeschi.
Per quanto riguarda il fronte caucasico si è venuti indirettamente a conoscenza del progetto tede sco in atto per la costituzione di una "Unità liberatrice" tedesco -arabo -marocchina che, al comando del Generale Felrny e sotto gli auspici del Primo Ministro Gailani, viene preparata per entrare nei Paesi Arabi e rappresentare un centro di attrazione e di inquadramento per tutte le forze arabe rego lari e inegolari .
D 'a ltra parte non sembra per ora prevista una partecipazione di forze italiane, a lato di quelle tedesche negli eventuali futuri sviluppi militari dalla parte del Caucaso versi i Paesi Arabi.
Mentre , secondo i progetti in corso di accordo con la Germania, la nostra posizione dalla parte del fronte egiziano sarebbe soddisfacentemente assicurata, l'assenza di forze italiane accanto a quelle tede sche
in una futura avanzata dalla p a rte del Caucaso verso i Paesi Arabi, nonché la costituzione della "Un ità liberatrice" a l di fuori della partec ipazi o ne politi ca e militare italiana, pregiudiche rebbe gravem e nte i nostri interessi e la no stra ricono sc iuta prevalente posizione nei Paesi Arabi ora ed in futuro.
O ve Voi, Eccellenza, approviate, se mbrerebb e perciò opportuno far conosce re al Comando Supre mo come, dal punto di vista politico:
1° - Sarebbe consigliabile aver presen te l'opportunità c he truppe italiane siano chiamate al momento opportuno a partecipare con g l i alleati tedeschi ad un'eventuale avanzata verso i Paesi Arabi dalla parte del Cau caso.
2° - Sembre rebbe utile ed urge nte richiedere, da p arte delle no stre Au torità m i litari , precise informazioni s ul progetto tedesco per la costi tu z ione di un "U nità liberatrice" nonché studi are e pros pettare l' opportunità di un a partecipazione militare e politica italiana a tale iniz iativa in forma adeguata ai nostri predominanti interess i .
Roma, lì 26 settembre 1942 .
FONTE: ASMAE,Affari Politici, Eg itto , b. 33 .

Documento n . 18
(28 settembre 1942)
In una conversazione del 28 settembre 1942, con il comm. Mellini del Ministero degli Affari Esteri, che ne trascrisse l'essenziale nel seguente documento, il Gran Mufti oltre a tracciare un quadro generale della s ituazione araba, insistette circa l'opportunità per i governi dell 'Asse di creare al più presto una For za militare araba da utilizzare nella lotta contro le forze britanniche e di mobilitare così, sul fronte come nelle retrovie, i propri sosten i to ri a sostegno delle operazioni militari italo-germani c he in Cirenaica ed in Egitto .

Ho avuto ieri una lunghissima conversazione con il Gran Mufti che mi è appars o assai preoccupato per la s ituaz ione nel Vicino Oriente e nel Nord Africa.
Da informazioni recenti ricevute dalla Turch ia e dai Paes i Arabi egli sente come le stasi dell ' az ione militare del!' Asse ad Alamein ed a Stalingrado creino un certo raffreddamento delle speranze tra gli amici del1'Asse in quei paesi, raffreddamento del quale gl i inglesi approfittano.
Dall ' Algeria dalla Tunisia e dal Marocco gli vengono segna lati i timori di influenti capi arabi per un possibile sbarco delle forze ang loamericane sulla costa atlantica del Marocco che troverebbe nei numerosissimi e lement i degaullisti - che raggiungerebbero tra i Frances i 1' 80 % - di tali Paesi un efficace aiuto .
Per quanto rig uarda i P aesi Arabi eg li teme le sempre più attive manovre nemiche: inglesi e americani inviano messi e personalità per assicu r are tali Paesi circa la futura indipe ndenza , per favorirne l'unione e per convincerli dell 'im possibilità da parte de11' Asse d i vincere la guerra . Tutto è me sso in opera: minacce, lusinghe , corruzione, intensissima propaganda a mezzo radio, cinema e numerosissimi manifestini e pubblicazioni tutti in lingua araba. Ciò nonostante - e nonostante che i compiti del Mufti non s iano facilitati dall ' assenza di una dichiarazione pubblica di indipendenza da parte ciel!' Asse per detti Paesiegli spera molto nell'azio ne che intende svolge re in Libia , al fronte egiziano.
Ritien e pe rciò l a s ua parte nza urgente ta nto più se le no s tre atti vità mi l itari dov essero s ub.ire colà ulteriori s tas i ed an c or più nella deprecata ipotesi che un'offensiva in glese dovesse costringere ad arretramenti del nos tro fronte . Ritien e c he il pi a no da lui pre parato e d approva to da l C o mando Supremo ita liano possa essere a ttuato se nza difficoltà e contribuire così subito a so llev are le speran z a dei nemici del!' Inghilterra nei P ae s i Arabi.
Per qu a nto ri g uarda il No rd Africa Fra nce se eg li non sa quali s i ano i piani militari pre disposti dall ' Asse pe r la dife sa contro un eventuale secondo fronte occidenta le anglo -ameri c ano. M a ritien e, anche se per ora non ha sotto pos to c o nc reti pro ge tti al ri g ua rdo , che eg li , con l ' aiuto dell 'Asse , po t re bbe far molto.
Lettere ri cevute in questi giorni da influenti cap i arabi del Marocco (Abdul Mal e k Turri s Capo Partito Nazionalista di Tctuan), cieli ' Algeria ( Dottor lbn Gi a llul C a po N azion a lis ta al ge rino ), d e ll a Tuni s ia ( S ceicco Thalby , un o dei fond a tori del P a rtito Des turiano in Tunisia) lo incoraggia no a spe rare che i mussulmani di qu ei Paes i - anche se temono i proge tti dell ' A sse al loro ri g uardo -c omincino a temere ass ai più il s uccesso anglo -d ega ulli s ta c he rapprese nte rebbe i l trionfo d e l giudais mo ed il d il agare d e l bolscevi s mo. Egli intenderebbe spinge re il fortis s imo sentimento mu s sulma no dei capi arabi suo i amici a far premio s ul loro se ntiment o nazi onali s ta, cos a c he ritien e po ssib il e e d a ssa i fac ile in quanto se il nazionali s mo di qu e i paesi lotta contro il predominio politico ma non ha da teme re per la re li gione mussulmana verso l a quale i c ri s tiani s i so no dimo s t ra ti sinora tolleranti e benevo li , il loro fa natismo is la mico li po rta gi à a te mere molto più d a l bolsc ev i s mo che v uole dis truggere o g ni religione e dal giudaismo in vadente e minaccioso in p art ico lar modo per i Luo g hi S anti de ll'Islam in Palestina.
Eg li riti e ne che g li s arebb e possibil e, a parte e se parata me nte d a quanto e g li farà al fronte egizi a no ed indipendentemente dalla c ostituz ione cli un a "Forza nazionale ara ba", cos tituire - d ' acc ordo con le autorità militari - un c e ntro per attirare larg he forze indigene mu ss ulmane dal Marocco , dall a T un is ia e dall ' Al ge ria , attra ve r so il d ese rto l e c ui frontiere so no inc o ntrollabi li , pe r inquadrarle al fronte occ identale d e lla Libi a e tenerl e pronte a combattere contro og ni min a ccia da qu e ll a parte de g li a llea ti del bol scevismo e del giud a is mo , per s tabilire co ntatti con i capi mu ss ulmani di quei P a e s i ed invia re emi ssa ri , anni e fondi al fine di alimentarne la res isten za contro la degaullistizzazione nel cas o d i un atta cco a n glo -a mericano.

Di tali piani circa il Nord Africa Francese il Mufti non intenderebbe parlare per ora alla Germania nel timore che ciò possa ritardare la sua partenza per l'Africa Settentrionale. Desidererebbe però intanto che di tali possibilità fosse informato l'Eccellenza il Ministro , e , ove egli lo creda, il Duce. Sebbene egli sappia infatti che le difficoltà al1'arruolamento nella Legione Araba di marocchini, algerini, tunisini etc. siano venute per ora dall'Italia e non dalla Germania egli spera molto nella maggior comprensione politica dell ' Italia per ottenere che le sue proposte siano prese in considerazione in un momento nel quale la necessità di vincere la guerra dovrebbe passar sopra ad ogni altra preoccupaz ione .

Nella sua lunga permanenza in Europa egli ha dovuto purtroppo convincersi come la Germania sottovaluti tutto quello che non è pura forza militare, an z i tutto quello che non è l'esercito tedesco. Per questo sinora la Germania lo ha onorato ed intrattenuto sen za però permettergli di svolgere alcuna opera attiva e di sfruttare forze che invece l'Inghilterra non sottovaluta e sfrutta dovunque, per modeste che esse s iano. Per questo la Germania non ha voluto concedere le dichiarazione di indipendenza pubblica ai Paesi Arab i , correndo dietro ad utopici sogni di intervento della Turchia a lato de l! ' Asse e di collaboraz ion e con l'infida Francia di Vichy
Egli ha compreso come l'Jta.lia abb ia invece nel campo po lit ico delle vision i più larghe e che non tengono conto soltanto della forza militare . È anche convinto che l ' Italia svolge verso i Paesi Arabi una politica intelligente e lung imirante che porterà certamente ad una futura feconda collaborazione nell'interesse comune.
Ma - egli pensa -la guerra non s i vincerà soltanto co n i successi militari e con la forza delle arm i. Purtroppo, egli ha agg i unto, i tedeschi conoscono meg li o l'arte della g uerra che non quella pol it ica . Se essi però - contro ogni s uo voto e sforzo e contro quella che è la sua convinzione - dovessero perdere la gue rra , anche i Paesi Arabi perderebbero ogni speranza di liberazione e tutti i mussulmani del Mediterraneo sareb bero vittime del trionfo del bolscevismo e dell'ebraismo .
La Palestina poi - solo Paese arabo per il quale l'Inghilterra non ha promesso l'indipenden za - diverrebbe te1Ta ebraica e tutte le migliaia di vittime che il Muft.i ha chiesto a l popolo palestinese e gli aiuti politici e finanziari che egli ha chiesto all'intero mondo islamico per difendere Gerusalemme sarebbero stati offerti inv ano e la responsabilità ne ricadrebb e su di l u i .
In tale situazione egli si re nd e ben conto come l'Italia e la Gennania non possono precedere che in pieno accordo su tutto e, in pieno accordo con l'una e con l'altra delle Potenze deJl' Asse, eg li intende procedere. Ma , forte della su a conoscenza dei Paesi Ara bi e Mussulmani del Mediterraneo e dell'influenza che egli possiede, ritiene di aver non solo il dovere ma il diritto di consigliare ogni possibile azione che serva a scongi urare il pericolo di un definitivo scoraggiamento degli arabi con conseguente loro passiva acquiescenza di fronte alla potenza anglo-amer icana ed a predisporre ogni possibile difesa - per modesta che essa possa ap parire - contro il fronte che g li anglo-americani potrebbero te ntare di stabilire in Marocco per impadroni rs i del Nord Africa Francese e prendere al rovescio le posizioni dell ' Asse in Libia .
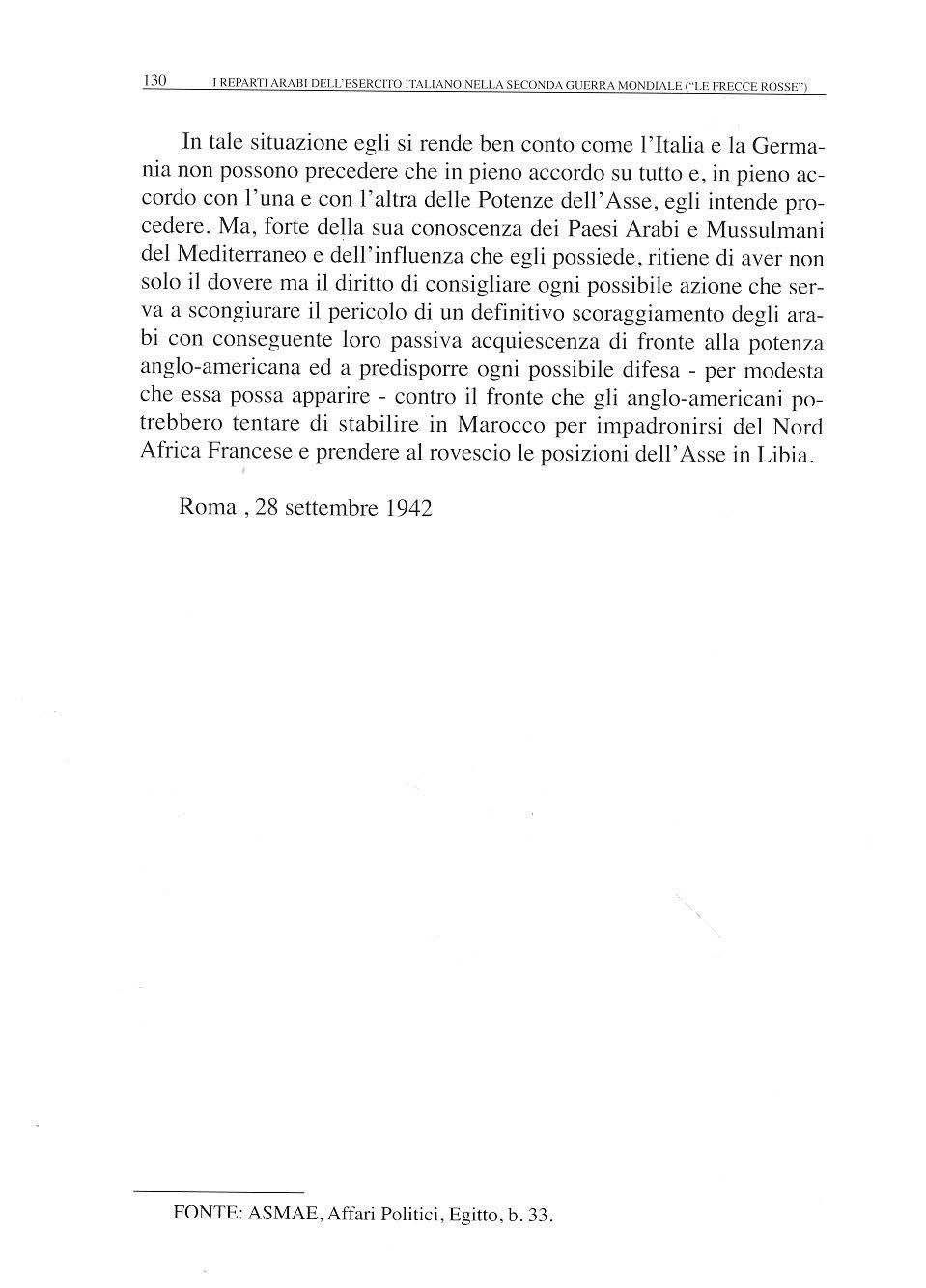
Roma , 28 settembre 1942
FONTE: ASMAE, Affari Politic i, E gitto , b. 33 .
Mentre queste conversazioni politiche e militari avvenivano tra Roma e Berlino e tra queste due capitali e i l Gran Mufti, il reclutamento e l'addestramento dei Centri Militari speciali proseguiva con il bagaglio di polemiche che ne costituiva oramai un e lemento fisso. Un nuovo i ncontro tra l' Amm . Canaris ed i l Gen . Amè , il 1° ottobre, non chiarì le posizioni tedesche che suscitarono nuovamente le critiche italiane. Le equivoche affermazioni dell' Amm. Canaris circa la missione del Mufti in Afr ica settentrionale si accompagnarono alle proteste italiane per il mancato coordinamento voluto da Berlino nei riguardi dell'alleato italiano sull'intera questione araba Sul piano finanziario solo indirettamente la delegazione italiana venne a sapere che era stato concesso a ciascuno dei due capi arabi la somma di 300.000 marchi durante l'inverno e che un ulteriore prestito di 500.000 marchi era stato concesso di recente. L'Italia si adeguò alle decisioni tedesche concedendo la stessa somma a i due, pur ribadendo che un maggior coordinamento tra le due capitali sarebbe stato augurabile anche a questo riguardo. Un altro elemento di crisi fu costituito dal fatto che, ad Atene, il Reich avesse stabilito una stazione radiofonica a destinazione dei paesi arabi senza pensare di coordinarla con l'analoga "vecchi a" emittente italiana di Radio-Bari. Infine vi era la questione delle difficili relazioni tra il Gran Mufti ed al-Ghailani: l'Italia accusata di sostenere il secondo a danno del primo, difendeva la propria equan imità ritenendo che, anche a questo riguardo, l a posizione delle autorità germanich e, che già era equivoca a proposito della Legione Araba di Sunion, era poco chiara e non certo impostata su di una trasparente solidarietà con l'Italia.
Il documento italiano del 2 ottobre che riassumeva l'intero quadro della crisi di fiducia tra i due alleati non trascurava l'aspetto militare, anche perché il Comando Supremo ed il SIM decisero, il 19 ottobre, di inviare al fronte nordafricano il plotone arditi del Centro Militare "A".

II trasporto per via aerea doveva avvenire da Castelvetrano il 23 ottobre a destinazione di Tripoli . Non risulta peraltro dalla documentazione d'archivio che tal e partenza sia stata comunicata alle autorità tedesche. Intanto il Comando Supremo decis e, il 23 ottobre , su proposta del Ten. Col. Massimo Invrea, di mutare le denominazioni dei Rag gruppamenti Militari. Per esigenze politiche generali, le variazioni furono le seguenti :
Il Centro mi litare "A" assumeva la denominazione di GRUPPO FOR MAZIONI "A"

II Centro Militare " I" assumeva la denominazi one di BATTAGLIONE "AZA D HINDOSTAN"
Il Centro Militare "T" assumeva la denominazione di BATTAGLIONE D 'ASSALT~
Dopo queste deci s ioni , lo specc hio dei vari Comandi risultava completato, in data 31 ottobre, in questo modo:
COMANDO DI RAGGRUPPAMENTO
- Ten . Col. Massimo Invrea: comandante
- Cap Michele Cefaly: ufficiale sezione personale
- Cap. Ettore Pasino : ufficiale sezione addestramento e servizi
- Ten. CC. RR. Antonino P iccione: comandante nucleo CC. RR.
GRUPPO FOR MAZ IONI "A"
- Magg . Ugo Donato: comandante
- Magg . Aldo Paradisi: comandante al reparto
- Tre capitani, sei Ten. e ventidue sottoten .
BATTAGLIONE "AZAD HINDOSTAN"
- Ma gg. Luigi Vismara: comandante
- Sei capitani , cinque ten. e ventinove sottoten .
BATTAG LIO NE D ' ASSALTO "T"
- Magg . Pasquale Ricciardi: comandante
- Magg. Giuseppe Maltese: uff. addetto
- Tre capi tani, cinque ten. e ventisei sottoten.
D a allora in poi l'unità, che aveva adottato uno speciale fregio rosso formato da tre frecce su cerchio d 'alloro , si chiamò ufficialmen -
te "Raggruppamento Frecce Rosse". La situazione numerica delle varie formazioni era intanto cresciuta sensibilmente; pertanto , in data 31 ottobre 1942, la loro forza effettiva era la s eguente :
li Comando del Rag g ruppamento era composto da 41 militari (6 ufficiali, 7 sottufficiali e 28 militari di truppa).
Il Gruppo Formaz ioni "A" annoverava 435 militari (25 ufficiali , 39 sottufficiali, 271 militari nazionali e 100 volontari arabi).
Il Battaglione "Azad Hindostan" annoverava 386 militari (38 ufficiali, 17 sottufficiali, 66 militari nazionali e 265 volontari indiani).
Il Batta 0 lione d'A ssa lto "T" contava 318 militari (36 ufficiali 22 b ' sottufficiali e 260 milit a ri nazionali) .
Il Reparto "M . S . " , cioè il Reparto (Missione Speciale) creato per il viaggio del Gran Mufti in Africa sette ntrio nale contava 99 militari (9 ufficiali , 14 sottufficiali e 76 militari di truppa nazionali e arabi).

Complessivamente quindi si trattava di ben 1.279 militari che formavano il Raggruppamento dei Centri M ilitari speciali , ma que sto numero, secondo i documenti ufficiali era de stinato a crescere fino a toccare la dimen sione ottimale di tremila unità (vedi tab e lla pagina seg uente).
Sull'importanza di que s ti Centri , e soprattutto del Centro "A", che egli aveva visitato più volte, il Gran Mu f ti riferì direttamen te a Mu ssolin i , in una conversazione del 27 ottobre, tutta dedic a ta ad esaltare l 'amicizia storica dell'Italia fascista nei confronti della Palestina e degli arabi e la devozion e del capo nazionalista nei confro nti del duce . In risposta alle parole del Gran Mufti , Mussolini fece una solenne dichiarazione: "Vi dichiaro che gli arabi hanno diritto ad avere la loro completa indipendenza ed a governarsi da loro. Particolarmente gli arabi del Medio Oriente hanno diritto all'indipendenza ed a sfruttare le loro ricchezze, sv iluppare i loro porti sul Medi terraneo ed i loro traffici in piena libertà . Sono pronto a fa.re ogni sforzo per aiutarli politicamente e spiritualmente e a dar loro armi". Come si può constata.re da questa dichiarazione, l'impegno del duce si r ife r iva sempre ad una so la parte del mondo arabo; delle ass icurazioni all'i ndipendenza s i taceva quella relati va agli arabi del Nord Africa. In risposta a questa pos iz ione del duce, il Gran Muft i insistette s ul concetto, fondamentale pe r Mussoli ni, degli arabi del Medio Oriente, e queste precisazioni, gradite alla parte ital iana, erano ritenute definitivamente sufficienti per il capo arabo che ri badiva che "gravi ss ima responsabilità si era assunto garantendo ai suoi seg uaci che l 'Asse li avrebbe aiutati, rispettando la loro indipendenza.
Grande fiducia egli aveva posto , nono stante dubbi e di ffiden ze, nell'I-

talia, e per questo aveva de s iderato di vedere, prima di tutto il duc e . Oggi egli si sente completamente rassicurato e convinto di poter rassicurare i suoi seguaci". Era un vero accordo , ma pare solo verbale, in quanto anche nelle sue relazioni scritte ai s uoi interlocutori italiani, il Gran Mufti evocava sempre i casi del Maghreb e dei s uoi ab itanti arabi , ed in queste citazioni che evitavano accuratamente di citare la Libia , vi era il fondo del s uo pensiero che non poteva dividere gl i arabi tra coloro che "meritavano" l'indipendenza , queJJi del Medio Orie nte, e qu e Jli di cui si voleva tacere o bloccare l'analoga as pirazi one . Ed in questo equivoco risiedeva buona parte delle preoccupazi oni dei capi nazionalisti arabi che , pur essendo l'uno palestinese e l'altro i racheno, parlavano di una indipendenza da riconoscere al mondo arabo in generale. Il problema politico condi zionava non poco il problema militare.
Intanto , tra la fine del mese di ottobre e gli inizi di novembre, i maggiori problemi che si presentarono alle autorità militari italiane relativamente alla questione araba furono quelli conness i all' eve ntualità ed alla realizzazione della missione ideologico -politica del Gran Mufti in Africa Settentrionale. Appariva peraltro chiaro che era l'andame nto del fronte che ne condizionava l'effetto sulle popolazioni arab e le quali dovevano registrare, dopo l'euforia italiana del giugno, una continua ritirata verso l'ovest delle forze italo-tedesche di fronte all'irruenza militare britannica. E dopo i primi di novembre, la comparsa degli Stati Uniti , dopo lo sbarco nel Nord Africa, a fianco della Gran Bretagna, aggravava di molto questa già precaria situaz ione. La continua evocazione del punto terzo della Carta Atlantica da parte della propaganda an g lo americana nei confronti della popolazione araba, punto terzo che ribadiva il concetto di emancipazione da ogni impe riali s mo per tutti i popoli, non mancava di avere serie ripercussioni , sia sull' opinione pubblica araba, sia sulla volontà degli arabi di combattere a fianco delle truppe dell'Asse.
Tu tto rimaneva in sospeso , quasi in attesa di una eventuale ripresa delle forze cieli ' Asse , ripresa che tardava a manifestarsi. Quanto al viaggio del Gran Mufti, i suoi aspetti militar-strategici sem bravano risolti con un orientamento (solo un orientamento) , favorevole. Rimanev ano le questioni pratiche che sembravano non risolv ers i mai . Fin dal 26 ottobre, uno spec iale Promemoria aveva evocato due so luzioni , senza optare per nessuna delle due. Va notato innanzitutto che la sede era sempre la Cirenaica: o il Villag gio Giovanni Berta, o Cirene con il Villaggio Giovanni Berta. Gli aspetti legati alle attività della missione ponevano in

entrambe le scelte problenù notevoli per un ' adeguata sistemazione Il 26 ottobre ven ne ro sottolineate le difficoltà pratiche per realizzare rapidamente l'adattamento di queste sedi, o l ' una o l'altra , alle complesse esigenze della Missione Speciale , che comportava un nucleo di circa 100 uo mini ed una presen za mil itare di 2/300 uomini del Centro " A" Nessuna delle due sol uz ioni appariva adatta; e pertanto , in data 30 ottobre le soluzio ni indicate diventarono quattro: oltre le prime due si sarebbe aggiunta il Villaggio Battisti e il Villaggio D'Annunzio. A questo rig uardo le a nalisi circa le sistemazioni che il Genio Militare avrebbe dovuto effett uare diventarono molto numerose ed onerose. Poco dopo , il 4 novembre , l e solu z ioni tornarono ad esse re due: la " s ol uz ione Cirene" e la "soluzione Battisti" . Secondo questo documento del 4 no vembre, dato il temp o c he occ01Teva per sistemare i locali della prima soluzione (preventivo di un mese cli tempo), pareva consigliabil e la seco nda soluzione che presentava locali. immediatamente disponibili: la palazzina delle scuole , la casa del Fascio ed a lt re case coloniche. Gli uomini del Centro Militare "A" av rebbero potuto trovare sede nella vici na Apollonia che anch'essa offriva immed iate sistemazio ni.
Ques to in sieme di analisi non deve fare ritenere che la missione del Gran Mufti potesse avvenire : la realtà mil itare negati v a in calzava, e le "soluzioni " che il Comando Supremo indicava nei var i documenti non ebbero alc un segu it o. Da una parte , giocava contro l'effettuazione d ella missione l'andamento delle operazioni m i litari s ul fronte, e dall'altra, l'e le mento fondamenta le per il rinvio fu lo s ba rco delle forze anglo americane in Marocco ed in Algeria, sbarco che mutava del tutto i g ià precari equ ilib ri strateg ici nel No rd Africa. Inutilmente il Gran Mufti , alla vig ilia di questo sbarco, il 3 no vem bre aveva ottenuto dal duc e un so le nn e dichiarazione ratificata, con qualche mocJifica , anche da Hitler, nella qu ale s i confermava no l e intenzioni delle pote nz e del1' Asse di "ven ire inco ntro alle aspirazioni degli arab i" e si dichiaravano pronte "a riconoscere la piena sovranità e la completa indipendenza d ei paesi arabi del Vicino O r ie nte" . Ri toccata nei de ttag li , la dichiarazi one fu pronta il 21 novembre, ma anche in que sta edizione ci si trovava di nuovo cli fronte alle ambiguità tra Est ed O ves t del mondo arabo, e ciò diminuiva sosta nzialmente il consenso arabo specie prop rio nel momento in cui l a guerra era di casa presso gli arabi dell'Ovest, che venivano esclusi da q uesta dichiarazione.
Malgrado questi limiti ed a lla luce della comparsa nel Marocc o delle tru ppe alleate, il Gran Mu f ti si mo bilitò, anche in que sta occa-

sione, pronunciando, 1'11 novembre, un discorso "per la commemorazione dei Martiri della causa araba" nel quale l'elemento celebrativo copriva le affermazioni politiche contingenti . Ribadiva infatti il Gran Mufti: "I risultati di questa guerra influiranno molto sul nostro avvenire e sulla nostra vita. Non avremo nessun avvenire con l'Inghilterra che ha molto danneggiato il popolo arabo e nemmeno con gli Stati Uniti, entrambi asserviti ag li ebrei per realizzare le ambizioni ebraic he nei paesi arabi in particolare e nell'Oriente in generale. Tale è l'In g hilterra e tali sono i suoi all eat i ... " 55. L'appello del capo nazion al ista si concludeva con l'esortazione a sostenere con tutti i mezzi la lotta dell'Asse sottoli neando che il futuro di libertà del mondo arabo non stava certo dalla parte degli ebrei e dei comunisti. Anche riguardo a questo discorso , che ebbe vasta risonanza radiofonica , si possono nutrire gli stess i dubbi di sempre riguardo ali 'importanza ed agli echi che questi appe ll i ebbero effettivamente su ll e masse arabe: queste risultarono p iuttosto sorde a queste esortazioni e parvero accettare piuttosto supinamente gli eventi in attesa di scorgere finalmente qua li fossero i vincitori.
Queste considerazioni apparvero chiare anche al Comando S upremo ed al SIM che, dopo aver tanto studiato i piani per la Missione Specìale del Gran Mufti in Africa del Nord, decisero, il 12 novembre, di r i nviare ogni decisione con una formula diplomatica ma certamente equivoca: "La dec is ion e definitiva (sulla miss ione) non è stata presa dato l'incalzare degli avvenimenti a l fro nt e egiziano ... ". Effettivamente le posizioni del fronte, al 12 nov embre, erano quasi disperate : l'esito della battaglia di el-Alamein ( dal 23 ottobre al 3 novembre) co ndizionava l'intero fronte e l 'ava nzata delle truppe inglesi che, proprio il 12 novembre, occupavano Derna iniziando una avanzata che non si fermava più, con Benghazi conquistata il 20 novembre e I'intera regione della Sirte occupata il 25 dicembre.
A questo punto , ogni programma di creare, in tempi ravvicinati, una Legione Araba , secondo i piani primitivi , con tanto di infiltrazioni a ridosso ciel fro nte e di azioni sistematiche di sp ionaggio e di sabotaggio, diventava quasi irreale e del tutto irreali zzabile . Il ricorso all'azione de g li uomin i d ei Centri Militari speciali , in particolare del Cen tro "A" e del Cen tro "T", pareva necessario, urge nte ma disperato e quasi imposs ibil e . Qualunque fosse stato la preparazione e l'addestramento

di questi uomin i, le necessità dell'ora imponevano di gettarli al più presto nella battaglia, sul fronte.
Ma, anche in questa occasione, non mancarono alcuni importanti elementi di crisi: il caso, tra molti, che possiamo ricordare riguarda il Centro "A" al quale il Comando Supremo, sulla sco1ta e ad imi taz ione del famoso gruppo in glese del Long Range Desert Group, indicava, il 12 novembre, una auspicata att ività di gueniglia a lungo raggio nel deserto, e quale "ottimo mezzo", l'uso di speciali "camionette armate". La vicenda legata alla disponibilità di queste camionette rivelò una crisi evidente nel momento cruciale delle operazioni in Libia. Le decisioni al riguardo rimbalzarono senza sosta: il 12 novembre, il Comando Supremo , nello stesso documento nel quale sospe nd eva l'allestimento della Missione Gran Mufti, indicava come sarebbe stato un "ottimo mezzo per raggiungere tale fine (l'azione clandestina dietro le lìnee del fronte) il collegare l'attività della Miss ione a quella del Centro "A", quando questo Centro fosse stato particolarmente orientato , attrezzato ed addes trato per condurre azioni di guerriglia a lungo raggio nel deserto mediante ca mion ette annate e tal genere di guerriglia si adatta in special modo alle attitudini ed alle possibilità degli arabi . .. ". Inu ti le sottolineare l'incongruenza di questo documento che diceva due cose diverse, lo stesso giorno , nello stesso testo . Ma non basta questa osservazione. L'indomani della decisione di non effettuare tale Missione , un documento dello stesso Comando Supremo stabiliva su quali fondi dovessero gravare le spese inerenti alla Missione e precisava che al riguardo dovesse intervenire un opportuno accordo tra il Ministero della Guerra e quello delle Finanze. Ma come se ciò non bastasse, nello s tesso documento s i stabiliva, nuovamente, che la Missione dovesse essere sospesa, " data la s ituazio ne creatasi in Africa Settentrionale" . In un success ivo documento del 17 novembre, veniva ribadito che "l' impiego più adatto e più vantaggioso eia considerarsi per le formazioni del Centro "A", almeno nella prima fase de l loro trasferimento in Africa Settentrionale, sarebbe quello di adibirle alla guerriglia nel deserto con camionette .. ." . Questo genere di imp iego previsto per i militari del Centro "A" presentava almeno q u attro vantaggi evidenti : "a) adeguato sfruttamento delle qualità fis iche e delle attitudini degli arabi, portati a prediligere tal genere cli imprese , nell'elemento (deserto) che considerano come il loro proprio;
b) sfruttamento delle possibilità ling u istiche degli arabi e della loro facilità ad intenders i con le popolazioni locali , di razze più o meno

affini a loro stessi, per raccogliere un prezioso materiale informativo e per indurle , per quanto possibile, a collaborare ai nostri scopi;
c) perseguire per mezzo di incursioni nel deserto , verso l ' Egitto, uno dei fini più importanti per la Missione "M" , ossia quello di stabilire contatti con nuclei egiziani aderenti a] programma del Mufti;
d) addestramento graduale e progressivo delle formazioni "A" per perfezionarsi nel genere di guerriglia considerato, guerriglia che dovrebbe particolarmente svilupparsi in secondo tempo, quando da parte delle nostre forze potrà essere ripresa la marcia verso il vicino Ori.ente".
A questo punto, la dotazione delle famose "camionette armate" diventava fondamentale: il problema si rivelò però quasi insolubile. Affemrnva il documento: "Data la ovvia difficoltà di distogliere anche poche unità, dal quantitativo di camionette in allestimento per i bisogni previsti dal R . Esercito, si propone di richiedere la trasformazione urgente in camionette desertiche mod. 43 delle 11 camionette normali A. S. 37, già a disposizione del Centro "A" ... ". Questa trasformazione pareva cosa semplice , infatti veniva affermato: "Il problema tecnico di questa trasformazione non presenta di fficoltà di sorta dato che la camionetta desertica mod. 43 deriva appunto dalla trasformazione del1' A. S. 37. Si ritiene che una dotazione di 11 camionette desertiche per il Centro "A" possa bastare in primo tempo . Per i successivi bisogni, e dato che i primi esperimenti risultino incoraggianti, si propone di fare , fin da ora, attribuire di massima al Centro "A" 10 delle 180 camionette mod. 43 il cu i allestimento è previsto per il 1° trimestre 1943 ... " . Poche settimane dopo però, il 6 dicembre 1942 , lo stesso Comando Supremo , sulla base di un "più approfondito esame" dell ' U fficio Motorizzazione del Regio Esercito, rivedeva la propria posizione a proposito della trasformazione delle camionette: "Per varie considerazioni di indole tecnica si è concluso che tale trasformazione non risu lterebbe né pratica né conveniente .. . " . Intanto il Centro "A" doveva restituire le 11 camionette nonnali e per esso veniva deciso che potevano essere prelevate "dal nucleo delle 300 camionette desertiche in approntamento imminente, 10 camionette desertiche .. . ". Pochi giorni dopo , un altro annuncio dalla stessa fonte rivedeva tale decisione poiché , a causa dei dann i che la fabbrica aveva subito in seguito ai bombardamenti aerei, il famoso nucleo delle 300 camionette non poteva essere prodotto . E concludeva questo documento del 12 dicembre: "Esistenza di camionette finite: nessuna". La conclusione fu quasi ridicola in quanto,

in un documento del 29 dicembre 1942, veniva precisato sotto la voce "Mezzi di trasporto" che venivano assegnate: "28 carrette a traino animale, 28 muli per dette,

28 arabi conduttori di dette, 1 autovettura" 56 .
Va detto peraltro che i problemi dell ' organizzazione sotto ogni aspetto dei Centri Militari e degli uomini in essi compresi, erano solo il riflesso di una situazione generale . Emblematico elemento di questa crisi quanto scrive M. Montanari a proposito di un ep isodio tra i molti: "Il col. Lequio era arriva to ad Hadj eb el Aio un. Poiché non era stato dotato di stazione radio, per richiamarlo a Faid, Sogno dovette mandargli due ufficiali da Fondouk ... (vol. IV, p. 338). Per i casi dei Ce ntri Speciali la crisi era di difficile soluzione e ciò che rendeva questa situazione estremamente critica era, da una parte, l'andamento negativo della produzione bellica in Itali a a causa delle distruzioni apportate al1'industria dai bombardamenti alleati, e dall'altra, la s ituaz ione sempre più negativa del fronte il quale arretrava paurosamente, di giorno in giorno, fino a li 'occupaz ion e britannica di Tr ip o li (23 gennaio 1943) la quale peraltro non fermò l'avanzata alleata .
Proprio a questo andamento negativo del conflitto deve essere attribuito la crisi di uno dei tre Centri Militari, quello indiano, che dal momento dello sbarco alleato in Marocco, vide la solidità dei suoi reparti messa a dura prova per finalmente entrare in crisi . Questa situazione portò alla decisione italiana di allontanare dalle proprie responsabilità politiche militari quel capo del nazionalismo indiano, lqbal Shedai, che era stato all 'o ri g ine della decisione italiana di creare il Centro "I" . La vicenda non s i limitò a questo provvedimento di allontanamento, ma, di fronte ad un vero e proprio ammutinamento degli indiani, portò allo scioglimento del Centro "I" . Fin dal 10 novembre il Comando Supremo segnalava che "già da qualche tempo si erano manifestati sintomi di preoccupazione nei volontari del Centro "I" ... L'inq uietud ine, alimenta ta da voci infondate di prossima partenza per 1' Africa Settentrionale" si manifestò il 10 novembre con l'astensione dall'adunata da parte dei militari. Subito ·fu disposto il disarmo de:i militari a cura dei carabinieri e dei militari nazionali e ve nne deciso, il 12 novembre, lo scioglimento del Cen tro stesso. I militari indiani già in-
quadrati nel Centro vennero rimandati nei campi di prigionia mentre il materiale , le arm i e i quadri nazionali vennero aggregati al Centro "T". Lo stesso giorno il comandante dei Centr i, Ten. Co l. Massimo Invrea, fece al Comando Supremo una relazione sulla vicenda nella quale il comportamento dello Shedai ve niva stigmatizzato con g iudizi estremamente negativi . Secondo Invrea , la s ostan za della crisi dei militari indiani veniva direttamente collegata ai s ucce ssi dell'offensiva in g lese in Libia: " qu es ta gente impress ionabi le, incoerente, mu tevo le ha visto la guerra pe rduta pe r l'A sse con la stessa facilità con la qual e la vedeva vinta al tempo dell ' avanzata s u A lessa ndria. Il panico che li ha presi ha fatto loro considerare come fo sse prefe ribil e riprendere la posizio ne di prigionieri ... " . Le "Frecce Ro sse" diventavano così solo due , di ambi to esclusivamente ara bo (ve di tabella pagina seg uen te) .
E proprio in questo ambito s i s tava muovendo il Gran Mufti il quale tenne a reagire ad un me ssaggio alle a uto rità francesi di V ichy del gen. Nehring , soste nuto da Berlino , in cui veniva ribadita la volontà cie li ' Asse di mantenere l'Impero francese difendendolo dall ' attacco de g li anglo americani che, tramite un messaggio di simp atia e di am ic iz ia del presidente Roo sevelt al Bey di Tunisi ed agli arabi, prometteva la fine della presenza coloniale della Fran c ia. li proge tto di messaggio del 15 novembre, che veniva attribui to al Mufti, eia invi are al bey di Tu nisi era di tutt ' altro contenuto e prometteva invece maggiori liber tà agli arabi della Tunisi a, nonché "la si mpatia" de i governi del1'Asse, ma non parlava di indipenden za . L'intricata vicenda nata con queste discordanti dichiarazioni va letta anche su l piano militare poic h é la posi zi one degli uni e degli altri imp licava impegno o non impegno deg li ara b i da una par te o dall'altra . li me ssaggio era chiaro: "Posso assicurarvi - diceva il Gran Mufri - c he , eia quanto ho qui visto e d udito, mi so no convinto che l'Italia e la Germ a nia si appresta no a combatte re in territorio tunisino , insieme co n le truppe del Governo francese, per difendere la Reggenza dall'agg ress io ne degli anglo-americani e dei loro alleati, animate dai più sinceri e profondi sentimenti di amicizia verso il popolo tuni s ino i cui diritti , la cu i dignità ed il cui onore saranno scrupolos amente ri s pettat i. Mi sono anche convinto che le Poten ze dell'Ass e riconoscono e ri s pettano l'a ttu ale pos izione giuridico -politica d el Beylicato e le legittime aspirazioni del popolo tunisino ad un regime d i libertà civ ili e relig iose e di progres so politico ed economico. H o la ferma convinzione che, collaborando o gg i con le tru ppe del Governo fran cese ass ist ite da quelle dell ' Asse ne ll a lotta


contro i comuni nemici, il popolo tunisino contribuirà ad allontanare dal suo Paese e dagli altr i Paesi del Maghreb e del Vicino Oriente la minaccia de l giudaismo e del comunismo e stabilirà le favorevoli premesse per ottenere un migliore avvenire di pace , di prosperità e di onore nel quadro del futuro ordine nuovo". Forte di que s ta situazione incerta che vedeva aprirsi spiragli di libertà e di indipendenza anche per gli arabi del Maghreb, il Gran Mufti ripropose, in un Promemoria del 19 novembre diretto all'Italia ed alla Germania , di creare al più presto una Legione Araba, che, questa vo lta egli non esitava a voler chiamare "Esercito Liberatore Maghrebita" , superando, davanti alla gravità del momento, le antiche polem iche sulla dichiarazione di indipendenza . Nel documento eg li sugge riva ai governi dell'A sse du e ordini di considerazioni . Su l piano militare si trattava:
"
1) Per caus a d e ll'aggre ssione degli alleati contro il Magh reb , adottare la Tunisia come sede della difesa.
2) Istituire un Esercito Liberatore Maghrebita , da formars i dai prigionieri marocchini che si trovano in Germania, e dai volontari fra essi; dagli operai marocchini i quali s ono molto numerosi in Francia , dai Tunisini e da tutti gli elementi del Maghreb , i quali rapidamente potranno formare un forte numero .
3) Invitare i soldati del Maghreb , e re s identi in Africa a far parte dell'esercito maghrebita perché questi costituiscono la maggioranza delle truppe francesi, in Marocco.
4) SoJlevare la rivolta, sia con gli elementi di cui sopra, s ia con gli altri vari me z zi , fra le tribù e regioni del Maghreb occupate dagli alleati.
5) L'esercito costituito come sopra potrebbe essere impiegato in altri fronti quando sarà finita la lo tta nell ' Afr ica settentrionale, particolarmente p erché il marocchino è un buon soldato e perché molti soldati e ufficiali maghrebini sono stati istrui t i da ll 'eserc ito fra ncese.
6) Ut ili zzare provviso ri amente in T unisia le unità militari arabe istituite p resso i paesi de ll 'Asse allo scopo di imp iegarla in Oriente.
7) Ist ituire a Tetuan un Centro segreto per prendere contatto con le altre regioni del Maghreb senz a, né disturbare , né attirare l'atten zione degli spagnoli".
Sul piano politico il Promemoria del Gran Mufti ricordava che " Il Maghreb non è sotto l'ingerenza dell'Asse e l'Asse non trae da esso alcun beneficio . Anzi il Maghreb è diventato oggi la fonte di un serio pericolo per l'Asse . L' Asse potrebbe rovesciare qu es ta situazione ed

ottene re l ' utilit à militare a nz idetta, se m a nifestasse la sua buona in tenz ione ve rso il Maghreb.
1) Prometter e s olenne mente la libertà e l ' indipe nden za a i ma g hrebiti e co nclude r e con e ss i , per tranquilli zz arli, un trattato s u una bas e c he ra sso mi gli a que ll a del trattato anglo -egiz iano o del trattato an g loirache n o .
2) Cominc ia re a con c ludere il trattato c o l Bey di Tuni s i c he non ha approvato le r ic hieste di Roosev e lt re lative al p ass agg io de ll e truppe a meri ca ne dal s uo tetTito ri o p e r agg redire Tripoli .
3) Liberare i detenuti politic i maghre biti , come i capi tunisini che s i trovano attua l mente n e ll a carce r i di M a rsiglia.
4 ) Orga ni zza re un a saggia propa g a nd a diretta a l Ma g hre b" 57
Qu es to do c umento de l Gran Mufti, a l quale fe ce seguito una notevo le a g itazione politica , diplomatica e mi litare, di Berlin o ma soprattutto d i Roma, o nd e acce rtarn e la co n ve ni e nza , rappresentava una ve ra s volta. Dopo tanto parlare di indipenden za " ri serva ta agli a rab i del Vic ino Ori e nte" , iI Gran Mufti rompeva gli indugi c he lo av e vano p a rali zz ato fino a d all o ra e, d av anti a lla g ra viss ima situazion e militare de lle forze armate italo-tedesche in Tunisia, si d ecide va a fare il grande passo , c on la ri c hiesta di ind ipe nd e nza " pe r tutti g li arabi" d'Ori e nte e d ' O cc ide nte . In re altà la prima pos iz ione de l capo naz ion a li s ta era s tata chiaramente una po s iz ione di attesa c he gli eventi p areva no avere s u perato . Purtutta via , in uno spirito conc iliatore, eg li rivol se al popo lo tuni sin o, il 19 novembre, un messag g io c he an co ra e vocav a vecc hi s c hemi: " S ono in grado d i assicura re che le du e Poten ze de l! ' A s se s tanno preparandosi per c ombatte re nei te rritori d e lla Tuni s ia in di fes a c ontro l ' ag gress ione d eg li Angl o- America ni ed i loro all ea ti . Mi so no convi nto , da q uan to ho se ntito e d ho cons tatato , c he le d ue Pote n ze dell'A sse nutrono sentime nti di profonda e chiara amici z ia vers o i tuni sini d i cui ri s pe tteranno diritti , importa nza e ono re. L e Potenze dcli ' Asse rispe ttan o e ricon oscono l ' a ttual e posizion e gi uridi ca e poi it ica di S.A. il B ey e le aspiraz ioni le ga li dei tuni s ini pe r ottene re un reg ime c he do v rà as sic urare a lo ro libe rt à civ il e, politi ca e d econ o mica più il r ispetto de lla loro fede. Io so no s icu ro che i tunis ini non potrann o ricavare n ess un ben e ficio d ag li all e ati. Anz i s ar à aum e ntata co ntro di lo ro l' influenza e raddoppiata la sciag ura deg li e brei. I tunisini , sc hierandos i ogg i ai fianchi de ll 'ese rc ito de ll 'Asse ne lla lotta con t ro i nemici co -

munì, partecipano al respingimento della loro dominazione, del pericolo comunista e dell'influenza ebraica. Tutti noi sappiamo fino a quale punto gli Americani e gli Inglesi adoperano gli eb rei e li aiutano per realizzare le loro ambizioni e le loro aspirazioni in tutto il Maghreb e in tutto l'Oriente arabo. La partecipazione della Tunisia a questa lotta costituirà un serio fattore per gettare le prime basi solide e per ottenere un avvenire molto migliore, incluso nel nuovo assetto futuro. Anzi le evoluzioni potrebbero realizzare le aspirazioni » . Dall a documentazione in no stro possesso, possiamo dire che questo messaggio che fu diramato , con i più vari mezzi , non è quello genuinamente scritto dal Gran Mufti , bensì un messaggio che, dal testo originale, fu riel aborato dalle autorità italiane , e cioè dal ministro Vi tetti, ed approvato dalla Germania.

Al messaggio del 19 novembre doveva segui re, il 21, un altro messaggio del Gran Mufti (di nuovo riveduto e corretto dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Cultura Popolare) nel quale, ancora una volta, si insisteva s ui rischi di una vittoria degli anglo-am ericani fattisi po11avoce dell'ebraismo mondiale e quindi nemici definitivi de g li arabi. Era sul piano militare che questo secondo messaggio si soffe rmava , ma non nella primitiva direzione: quando si evocava l'aspetto bellico in corso, l'acce nto non sembrava più orientato verso una insurrezione armata contro g li invasori, bensì su posizioni di un cauto attendismo. Infatti l' ultima parte del messaggio insi steva nel dire: " Sono sicuro che i nostri fratelli del Maghreb s i asterranno da ogni collaborazione con gli alleati e rimarranno a sorvegliare in attesa. Iddio potrebbe sostituire la tribolazione col benessere, e la strettezza in larghezza. L ' oscurità della lunga notte del Maghreb potrebbe essere sosti tuita dal chiarore di una bella giornata che farà restituire al Ma g hreb il suo florido passato". A parte l'evocazione poetica di quest'ultima parte, il significato pare chiaro: il disimpegno diventava regola e le attese di partecipazione araba s ul piano militare una pia illus ione che neppure l'esistenza dei Centri Militari poteva dissipare.
Un altro aspetto negativo sul piano della partecipazione volontaria degli arabi alla guerra fu rappresentata dalla politica che Hitler sanzionò con il messaggio al maresciallo Pétain , in data 26 novembre , nel quale ogni illusione degli arabi sul loro futuro veniva cancellata . La parte finale del documento scon vo lgeva ogni proposito di evoluzione verso l'indipendenza . Infatti Hitler affermava: "Je suis, d'autre part, fermement résolu à aider la France à rentrer en possession des domai -
nes coloniaux qui, en dépit de toutes les a llégati o ns contraires, lui o nt été vol és par les Anglo -Sa xon s et à I' aider, en usan t de tous les moye ns dont dispo se le Reich. L'Allemagne ni l'ltalie n'avaient l 'i ntention d'anéantir !'empire colonia! français. Il appartient aux autorités françai ses d'ac ce pter les mesures indispe nsa bles qui ont été priscs par l'Allemagne de façon qu'il n'y ait pas de nouvelle effus ion de sang et de créer, au contraire, Ics conditions nécessaires à une co llaborat ion réellemcnt féconde, au plus grand profit dcs parties intéressées ... » 58 .
Sul piano militare , il Promemoria del Gran Mufti pose le autorità italiane in un vero dilemma : se da una parte, la collaboraz ione di soldati arabi al conflitto d a ll a parte dell'A sse era considerata un aspetto positivo ed auspicabile, dall'altra, co ndi zionare questa partecipazione ad un a promessa di indipendenza del Nord Africa, e soprattutto della Tunisia, gi ocava contro l 'i ntero ed ificio delle rivendicazioni itali ane « dopo la vittoria » . Le perplessità emergeva no as sa i bene in un Appunto dell 'Ufficio III del Ministero degli Affari Esteri, in data 26 nov e mbre ne l quale veniva ribadito che, oltre a l messaggio del Gran Mufti co ncordato, " non sembrava per ora il momento di prendere in cons iderazione dichiarazioni pubbliche o segrete od impegni dì a lcun gene re c irca il futuro asse tto della Tuni sia, dell'Algeria e del Maro cco. Il Mufti potrebbe essere verbalme n te ra ss icurato che l 'a tteggiamento dell'Italia verso ta li Paesi s arà se mpre improntato a lla ma ss ima amicizia ed a ll a comprensione delle loro necessità politic he , econo mi che e sociali, in conformità, del resto , alle linee del messaggio che è stato autorizzato a trasmettere al Bey di Tuni s i ... ". E ra il so li to probl e ma politico c he bloccava ogni prospettiva militare poiché , anche la creazio ne di un "Centro per ser vizi infonnativi e di propaganda" che era impostat o s ull a "difesa del Ma g hreb dalla minaccia ang lo-giuda icoco muni sta- amcricana" prevedeva espressamente c he anche in queste azioni ed in qu este organizzazioni militari vi fosse una "ch iara ed es pli cita escl us ione dell ' impiego di una Forza Araba regolare con bandiera ara ba"59 In queste condizioni l'opera del coma nd ante del Ragg rupp ame nto dei Centri Militari, Ten. Col. In vrea, diventava molto difficil e alla vi g ilia dell ' impiego di questi ele menti su l fronte tuni s ino. Il Prom emoria quindicinale n. 15 del 30 novembre, non mancava i n-

58 Messaggio di Hitl er al mar. Pé tain , in Notre destin européen. Un message du Fuehrer au Maréchal, Pari gi, 1942.
59 Se ne veda il testo nel Documento n. 20.
fatti di segnalare che da parte dei volontari arabi dei due Centri superstiti regnava " uno spirito salvo poche eccezioni, utilitario e senza alcun anelito patriottico ... ". Sul piano numerico il quadro della forza effettiva alla data del 30 novembre rimaneva modesto: il Centro "A" constava di 557 uomini; quello "T" di 464 uomini e rimaneva, quasi congelato , l'ormai inutile Reparto "M. S." con 88 uomini. In definitiva si era ancora lungi di quelle migliaia di militari che, in primo momento il Comando Supremo aveva ipoti zzato .
La situazione in Tunisia conservava in quel periodo tutte le caratteristiche equivoche della vigilia. Da una parte le autorità francesi del Protettorato che reclamavano, in nome del mar. Pétain, la puntuale conferma delle vecchie prerogative della Francia; dall 'a ltra, i francesi gollisti che fremevano in attesa degli alleati, con il proposito identico ai pétainisti, cioè di ri stabilire l ' integrità dell'impero francese. Confusi tra costoro gli italiani di Tunisia, a maggioran za fascisti, che ancora credev ano nella "vittoria" e che collaboravano con le forze armate dell'Asse; infi ne gli arabi che con il Neo Destur aspettavano la parola d ' ordine del loro capo Habib Bourguiba , il quale si rifaceva all ' auto rità del Be y ed annegava ogni scelta nella devoz ione alla patria tunisina, ma non s i decideva ad optare definitivamente per l'Asse o contro di e sso. Uno degli ultimi te legrammi del console Silimbani , in data 30 novembre, descriveva questa situazione con accenti di sincerità che lo rendevano testimone di una situazione intricata e quasi i ncomprens ibile.
Intanto s ul fronte tunisino la situazione continuava a peggiorare al punto che il Comando Supremo, su rich iesta de lle autorità militari italiane in Tunisia, deci s e di fare appello , per rimpinguare le forze militari dell'Asse , agli ital iani residenti nel paese. In o s sequio a ta le decisione, il Ten. Col., Vincenzo Corsini, tramite il Consolato italiano di Tunisi, fece conoscere agli ita liani residenti in Tunisia, e specia lme nte alle organizzaz ioni sportive italiane , che era consentito un arruolamento a tutti coloro che d esi deravano recarsi per lavoro in Tripolitania. Questa forma fu escogitata per non destare l'attenzione delle autorità francesi . 11 25 dello stesso m ese, pochi giorni dopo avvenuto lo sbarco delle truppe anglo-americane nel Nord Africa , fu fatto conoscere che l'arruolamento volontario non era per essere impiegati in lavori, ma bensì per prestare servizio militare ed esse re impiegati in combattimento. L'appello del Conso le d'Italia a Tunisi, Giacomo Silimbani, ebbe molta rispondenza ed il 9 dicembre eb b e inizio a Tunisi , nell a Caserma Casbah, la presentazione e la conseguente visita

medica ai volo ntari. Mo lti. si presen tarono e la v isita medica fu pera ltro s olo una pura formalità, perc hé tutti furono arruolati , in quals i asi condizione fisica fossero. Man cava no , però, molti quadri ufficiali ed il materiale nec essa rio: vestiario, equipaggiamenti , materiale di uso generale ed armamento.
Un cenno pa.rLicolare merita questo aspetto relativo alla ge nero sa ri s posta che la collettività italiana di Tuni s ia diede, in quei me s i di c risi, a lle pressanti richieste dì arruolamento fatte dalle autorità militari e consolari italiane; essa fu il segno di un coinvolgimento emotivo alla gra vità del mome nto, segno che non pa rve condizionato da a lcun torna co nto immediato o sperato, m a dal più puro a mor di pat ria. Su l piano degli st udi storici rigu ardo alla campagna dì Tunis ia , va n o tato tuttavia che nessuno sto ric o abbia mai fatto cenno a qu e sto aspetto che pur doveva generare drammatiche con seg uenze per la colonia italiana la quale , dopo la sco nfitta, fu oggetto di rappresagli e inaudite che ne eliminarono di non poco la con s istenza e la vita lità. Questi arruolamenti furono ricordati so ltanto in una modesta o pera , c he ne attribuì la decisione a ll 'ruTivo del co nsole Bombi e ri e la definl " assolutamente inutile sul piano militru·e, assai poco felice anche politicamente perché ve nne in seg uito utilizzat a per dimo stra re qu a nto peri colosa fosse la permanen za in Tunis ia cl i una quinta co lonna italiana " 60 Solo le memorie di un ufficiale a ddetto al SIM , Paolo Cola cicchi, ne ha ricordato brevemente l' an·uolamento, ma i g randi testi di memorie non ne parlano affatto. Ed è certamente deprecabile 6 1

L ' inquadrame nto di questi volo nt ari italo-tunisini fu fatto, in primo tempo, da ufficiali di compleme nto italiani di Tun isia , i quali , anch 'essi, tra l'altro erano sprovvisti di uniforme. Ciò fu cau sa non lieve d i molti difetti che in seguito si verificarono. Si cercò di ovv iare, in parte, assegnando pochi quadri della Divisione 'Supe rga'. App,u·iva peraltro ch iaro che una ta le si tua z ione potesse essere so lo foriera di aJtre gravi c ri s i mil itar i; il già ricordato tel eg ramma in data 30 novembre cie l consol e Silimbani da Tunisi a l Mini s tero degli Esteri, ne tracciava un qu a-
60 N. Pasotti. J,a/i ani e It alia in Tunisia. Dalle or ig ini al 1970, Roma, Fin z i , 1964,p. 132.
6 1 P. Co lacicchi, L'ul!im o fronte d'Africa. Tunisia: nove 111bre 1942- mag g i o 1943, Milano , Murs ia , 1977. Da notare nell ' appe ndice fo tografi ca tre foto s ui vo lo ntari italiani di Tunisia. p. 160 ; delle altre memorie ·s ilen z iose' al ri guardo ricordo: G Messe, La mia armata in Tuni s ia.Milano, Ri zzo li, 1960 ; V. Sog no. Il XXX ° Corpo d'Armata italiano in fonisia , Roma , USSME , 1952 .
dro allarmante che indicava la gravità estrema della situazione civile e militare, nonché il generoso impegno degli italiani di Tunisia per servire in qualche maniera allo sfo rzo bell ico generale6 2 "La colonia italiana di Tunisia non si nasconde la gravità del momento e per quanto non esattamente informata, sa che si combatte a pochi chilometri dalla città , da dove si ode benissimo il cannone. Per quanto la nostra azione di propaganda e di controllo possa esercitarsi, data la situazione, solo su una parte della Colonia (60 o 70 mila) pure num erosi so no gli italiani che si prodigano in aiuto alle truppe cli occupazione . Circa 500 connazionali so no al servizio dei Comandi come autisti, meccanici, guide, ecc .. Ogni giorno a cura delle nostre organizzazioni vengono fornite , secondo i bisogni che sono fatti presenti, centinaia di lavoratori soprattutto per l'aeroporto. Così pure è s tato da noi organizzato il lavoro per lo scarico nel porto. Le domande di arruolamento volontario, per quale si è istituito un apposito ufficio, hanno s uperato , in soli cinque giorni, le 1.300 unità. Questo contributo è tanto più notevole ove si pensi che circa 1000 italiani in Tunisia già servono in armi la Patria nell'Esercito , nella Marina, nell'Aviazione, mentre 1300 operai partirono nei mesi scorsi per prestare la loro opera in Libia, al segu ito delle truppe combattenti (e questo, sappiamo eh.e non era affatto vero, trattandosi in realtà di militari volontari regolarmente inviati al jì·onte) .. . " .
N el caso spec ifico della Tunisia, il problema militare aveva a che fare con la politica che il governo di Roma intendeva attuare nei confronti di quei gruppi cli capi naz iona l isti del Neo Destur, g uidati da Habib Bourguiba a ll a vigilia di essere liberati dai tedeschi daJle prigioni francesi e consegnati a Roma , i quali , da una parte venivano b landiti come possibili interlocu tori futuri dell'Italia e dall 'altra venivano considerati chiaramente in contrasto con i progetti fascisti riguardo al Nord Africa. In que l pa1ticolare frange nte la concmrenza politica e militare tra Roma e Berlino emergeva anche per quanto riguardava la posizione da tenersi nei confronti degli arabi di Tunisia ed in generale degli arabi del Nord Africa. Il 4 dicembre, scoppia il caso del trasferimento i n Tunisia, deciso d e ll 'a l to comando germanico, della "Unità Liberatrice" araba so tto il comando del gen. Nehring , trasferimento del quale il Comando Supremo italiano era all'oscuro . Data la delicatezza della questione, il Comando Supremo richiese immediatamente il parere del Ministro degli Esteri, visto che questa unità milita-

re araba, detta " Forza Liberatrice" risultava in piena concorrenza, sia con la p o li tica generale dell ' I ta li a, sia co n lo spirito informato re delle for mazioni militari arabe dei Ce ntri "A" e " T " creati dall'It a li a. Evidentement e v i era una netta contrapposizione tra le posizioni dei due "a ll eati " dell 'Asse a propo sito de lla qu est ione . All'an nun c io di Berlino di vol e r trasferire, a l più presto, in T uni s ia qu ella unità mili tare che il capo di Stato M agg iore itali ano definiva fonte di una "quest io ne delica ta", seguì un a serie d i affanno s i contatti per chiarire la portata pol iti ca de lla m ossa tedesca c he poteva avere co me premessa una "vera e propria di c hi arazion e cli indipende nza p er tutto il Nord Africa", non di certo co ncordata con Roma. Le necessità con tin genti della guerra imponevano al comando tedesco di fare affluire al fronte anche questi militari addestrati a S union, e c he era a ll o ra fuori lu ogo di pe nsare cli ut ilizzarl i in un ipotetico fronte caucasico. Gli effettivi del reparto erano, secondo le indicazioni successive, del 14 dicembre di: 15 ufficiali tedeschi e d i 53 5 sottufficiali e tru ppa tedeschi ed arabi . Vi e rano inoltre anche 60 automobili, 11 aut ocarri, 2 tr atto ri e 12 motoc ic lette .
Pur davanti a questo num ero no n certo e levato, le preoccupazioni delle autorità italia ne furono enormi : secondo le indicaz ioni del ministro Vitetti del 5 di cemb re si sareb be tra tta to di un a tr iplice poss ibilità di c onsid erazioni, e cioè rite nere:
1° c he l ' iniziati va tedesca si limitasse a favo rire la partecipazione deg li arab i nella le gio ne progettata dai doriotisti con l 'a pprov azione di Lavai per la difesa de ll ' Im p ero frances e . In tal caso potreb be forse esse re opportuno prendere atto e non partec Ipare a ll 'in iz ia ti va;

2° che i tedesch i intendano trasfer i re in Tuni sia la "Forza liberatrice" arabo-tedesco-ma rocc hina fo r zando l 'a utori zza z io ne del Mufti ma mantenendola agli o rdini diret t i d i ufficiali tedeschi e co n uni fo rm e tedesca come parte integra nte dell 'ese rcito ge rmanico ... Sotto tal e forma è da temere anc he gli ara bi , special mente in moment i difficili , disertere bbero senz'a ltro al ne mico ;
3° che la Germani a intenda servirsi della " Forza Li beratrice" per costituire il nucleo in Tuni sia di una più larga unità araba, d 'accordo co n il Mufti ed accettando qu e lle che sara nno le sue ric hi este per una m agg iore a utonomia e per una s ua direzi one person ale dell'organizzazione 63 .
In og ni caso il pare re delle auto rit à po litiche itali ane era dominato dalla perplessità che riguardava la messa in di sc uss ione di una prel a -
zione dell'Italia sul Nord Africa e di una deriva nazional - indipendentistica di questi territori promessi all'espansione dell'Italia "a guerra vinta" . Appare agli occhi dello storico , piuttosto curioso che in una situazione certamente grave sul piano delle emergenze militari , con il nemico alle porte di Tunisi e con le forze armate dell'Asse in pieno disordine, le autorità politiche fasciste si lasciassero andare a queste disquisizioni avveniristiche ormai quasi senza prospettive. Ed appare altrettanto curioso che le autorità militari italiane non avessero al riguardo un atteggiamento più responsabile alla luce della situazione militare in evidente degradazione. Persino il Gran Mufti, che, al contrario, si rendeva conto della gravità della situazione, consigliava una soluzione politica della questione araba a favore delle potenze dell'Asse. In una dichiarazione pubblica del 6 dicembre egli infatti insisteva sulla "realizzazione degli scopi nazionali " dei vari Stati arabi, da affidare a Roma e a Berlino ed esprimeva la speranza che gli arabi, " grazie alla loro attiva collaborazione con le poten ze dell'Asse per la vittoria totale", contavano di poter realizzare i loro scop i nazionali di indipendenza64 .
Invece di calmars i , alla luce del tornaconto militare che un apporto del reparto tedesco poteva apportare alla grave situazione del fronte tuni sino, la polemica tra autorità italiane e tedesche, militari e diplomatiche, non fece che crescere. Il 7 dicembre , un promemoria del capo del SIM , gen. Amè, tentò una certa conciliazione sottolineando che ogni apporto di collaborazione araba fosse utile e insistendo per coordinare l'arrivo e l ' impiego del reparto arabo-tedesco con l'arrivo e l'impiego de l Centro italo-arabo "A", magari entrambi coordinati dall'attività del Gran Mufti . Finalmente 1'8 dicembre il Ministero degli Esteri italiano confermava il proprio assenso alla partenza del reparto tedesco -arabo. A questo arrivo non veniva collegato, il 9 dicembre, non so lo l 'arrivo del Centro "A", ma anche quello del Battaglion e d'Assalto del Centro "T" che constava di 51 ufficiali italiani e di 420 uomini italiani tra sottufficiali e truppa. Ma questo assenso non sbloccò la questione avendo il Gran Mufti dichiarato, il 9 dicembre, a Berlino che lo comunicò a Roma, come egli ritene sse "che prima (della sua andata a Tunisi) sarebbe stato opportuno che i governi dell'Asse facesse ro una dichiarazione per l'indipendenza dell'Africa del Nord . O ve una vera e propria dichiarazione di indipendenza per tutta il Nord Africa non fosse considerata oppo1tuna basterebbe una dichiarazione cli indipendenza per la

Tuni s ia, magari limitandola con la concessio ne a lla pote nza in teressata (l' It a lia) di certi punti di appoggio" 65 . O vv ia men te la proposta tede sca suscitò un a sequ e l a di rifiuti e di messe a punto i quali , e la cosa appare piuttos to curiosa per non dire grave, non te ne vano affatto in conto l a s ituaz ione militare in corso, ma di scettava no su reparti e legioni come se il te mpo fo sse ampiamente generoso nei c onfronti dell a q uestione. Ma il doc um e nto c he mi se un punto fe r mo , e si potrebbe dire la parola fi ne, ad o g ni discu ss ione sui poss ibili coll e gam e nti tra mission e del Gran M ufti a Tunis i , Leg i one Araba e d indipendenza dell a Tuni s ia e d e l Nord Africa , f-u la decisione di Mussolini c he intervenne nella qu es tion e co n un breve Appunto della s ua segre te ria , d e ll' 11 di ce mb re, c he c hiud eva ogni i ncertezza di c hiarando la vo lontà ita li ana di negare ogni prom ess a di indipendenza a lla Tunisia. Il do cu me nto che fu tr asmesso a B e rlino dall'Ufficio III0 d e l Ministero de g li Affari Esteri è bre v iss i mo: " Il C apo di Gabinetto (dell'Ufficio 11/ 0 d e l Minist e ro degli Affari Este ri) comunica questa mattina a l Princ ipe Bi s marck (de ll'ambasciata tedesca a Roma), su is tru zio ni del Du ce, che s iamo co ntrari a qu a l s iasi ass icu razione d i indipe nden za della Tunisi a a l Mu ft i ed a magg ior ragione ad ogni co muni ca zi one sc ri tta a l Bey in tal se nso". Era una c hiara dic hia razio ne c he l 'am basciatore tedesco a Rom a, M acke n se n , rese un poc o più mo rbida co mun ica ndo a Berlin o che il du ce aveva " dic h iarato che non e ra il mo me nto di rila sc iare , t ramite il Gr a n Mu fti. o dire ttamente al B ey di Tunisi, di c hiaraz ioni di indipend en z a per il Nord Africa francese e per Tunis i" ed agg iun geva ne ll o s tesso tel eg ra mma che " in co n s iderazio ne dell ' importa nza che il problema riv es te per l ' Italia e la Francia , il suo esame d ov rà ess e re ri servato a d un s ucce ss ivo momento" 66 . Effettiv am ente la quest ione so ll evata era di e norm e impor ta nza ge neral e e benché la s ituazio ne militare impo nes se ce rte decis i oni pratich e, ri maneva inte ro il probl ema collegato alla scel ta della eventuale proclamaz ione dell'i ndi pe ndenza dell a Tunisia e de l Nord Afric a . Si tra tta va di un ve ro imb rog lio ch e, co me ri fe ri va, il 12 dicembre , il Baron e Scammacca de l M AE, al ge n. M agli c he evoca va evide n ze mili tari urge nti , richied ev a " una mag g ior ponder ate zza ne l valutare la co mpless ità e l a de li catezza dei p roblemi politi c i c he ri guardano il mondo arabo in Nord Afr ica.

65 Si veda no i principali d ocu menti s ulla questione nel Documento n 23
66 Mini s tero deg li Affa ri Es te ri di Berlino , So tto~egre tariato di Stato Nord Africa I l. l942 - 4 3, f.30300g .
Sul piano militare, la situaz ione, relativamente ai Centri militari speciali, non pareva essere sostanzialmente mutata: il 14 dicembre il Comando Supremo rendeva noto al gove rno italiano che il Centro "A" e gli uomini della Missione Speciale "M" erano "pronti a partire" per il fronte, ma fino ad allora ogni decisione era stata rimandata allo scopo di concordare co n le autorità tedesche direttive comuni alla luce della dichiarata volontà tedesca di trasferire in Tunisia per l'impiego la speciale "Unità Araba Liberatric e" di Sunion. Anche per quanto riguarda il Centro "T" , forte di 25 ufficiali e di circa 300 sottuffici ali e truppa, si dichiarava di poterlo fare partire per la Tunisia entro il 20 dicembre dove si sarebbe ampliato il numero degli uomini con gli italiani arruolati loc almente. Esso, nelle sue 3 compagnie d'assalto prosegu iva intanto l 'addestramento nel corso di paracadutismo , nel corso lanciafiamme, nel corso guastatori e nel corso cacciatori cli carri.

Rimaneva tuttavia la questione connessa all'aspetto politico che diventava un ostacolo insormontabile per un certo tipo di soluzione militare. Gli elementi erano molti e contrastanti e sullo sfondo permaneva una sostanziale rivalità-antagonismo tra i due "alleati": l'Italia e la Germania. E tra questi due elementi , si erano ormai inseriti altri condizionamenti non cero facili ad armoni zz are con la situazione militare. Dapprima vi erano i francesi i quali , sia dalla parte di Pétain , sia da quella di De Gaulle, non volevano rinunciare al concetto di ritorno puro e semplice all'Impero della 111° Repubblica. Le loro vie erano magari diverse, ma l'obiettivo era quello della continuità e dell'inunobilismo. Contro questa continuità operavano i nazionalisti tunisini, quelli del Neo Destur, i quali , con a capo Habib Bourguiba, alla vigilia ciel suo rientro in patria, non volevano accettare altra soluzione se non quella dell'indipendenza e della fine del Protettorato, non certo per s ubire eventualmente quello dell ' Italia fascista . Il tardivo ritorno del capo naz ionalista (il 4 aprile 1943) seg nerà la fine delle illusioni fasciste di un eventuale "utilizzo" dì Bourguiba e dei desturiani nella vicenda bellica alla quale essi non vorrmmo partecipare . Infine , quale ulteriore elemento di confusione, la situazione militare dove, soprattutto gl i Stati Uniti, predicavano il coinvolgimento degli arabi dalla loro parte , forti dell'evocazione della Carta Atlantica e della "dottrina della Liberazione" che apriva spiragli nuovi al mondo arabo tutto.
In questo quadro complesso s i muoveva la realtà dei Raggruppamenti mili tari speciali organizzati clall ' Italia, realtà che appari va anche piuttosto dimessa malgrado i generosi apporti dei volontari degli italiani di Tunisia (circa 4.000) che si inserirono nel " T " . Amara ma emble-
matica la con statazione a questo riguardo del Comanda nt e della Fanteria Di v isio nal e "S up erga", gen. A1t uro Benigni, del 16 di cem bre 1942, a proposito dei "volontari tunisini a utisti e motoristi", co nstatazione secondo la quale " non vi sono oggetti di ves tiario per vestire tutti i richiamati ... ". Analoghe cons id erazio ni erano fatte, poco dopo, dal capo della Delegazione della CIAF in Tunisia, gen. L eone Santi, il quale, incaricato di coordinare il reclutamento de g li. italiani di Tunisia, segnalava, il 29 dicembre , a proposito di questi 1.679 militari, una situazione altrettanto diffi c ile, sia rela t ivamente all 'armamento , s ia all'equipaggiamento. 11 conteggio che egli sottoponeva ali ' atte nzione del Comando del XXX Corpo d'Armata era il seg uente :
Armamento: fucili mod. 91 1.330 " 38 242 " 41 1.000
moschetti mod. 91 142 " 91 TS 174 " 91/24 112
tot a le prelevato: 3.000
bombe a mano di stribuito: 1.600 5.000
caricatori mod. 91 150 casse
Fuc. Mitr. Cal. 8 , mod. 1915 dell ' ese rci to francese n. 50
Equipaggiamento:
"Le serie vestiario prelevate sono in gran parte incomplete". Si nota in s pecia l modo la deficie nza di:
cappotti (ne mancano 1.900)
farsetti a maglia (ne man ca no 2 .160)

mutande (ne man cano 3.5 00 )
fasce ventriere (ne man cano 2.1 00 )
tazzine (ne mancano 2.725)
c ucchiai (ne mancano 2.050)
zaini ( ne mancano 1.680)
borracce (ne mancano 2.700)
asciugamani (ne mancano 2.000)
gibern e (ne mancano 4.500)
elmetti (ne mancano 1.000)
cinghie per fucili mod. 41 (ne man cano 1.000)
"Non vennero distribuite le dotazioni di se rvizi generali e cuci ne.
Si è rimediato in parte con l'utili zz azione di impianti fissi nella caserma della Casbah e di Camp Servire e in parte co n noleggio da pri vat i".
Le considerazioni general i che il gen. Santi redige, nel suddetto rapporto, appaiono poco esaltanti : " Non si può oggi dare, non dico un giudizio, ma neppure esprimere delle impressioni sul grado di preparazione di tali reparti e sulla possibi li tà di impiego. È mia opinione personale che, per la deficienza di mezzi e perché non si potrà mai formare un reggimento professionalmente ben preparato e di buon rendimento, i vo lonta ri tu ni sini siano riuniti in unità di addestramento . . .Come è attualmente costituito il comando di reggimento, esso non potrà mai efficacemente funz ionare ... " 67 .
Con una simile situazione che affligge un po ' tutto le forze armate italiane e naturalmente quella dei Raggruppamenti Speciali che erano nati con il proposito di farne truppe di élite e di attività estremamente combattiva, non mancavano le delusioni sul campo . Non certo per rimediare ad esse, ma per coordinare maggiormente gli sforzi militari dei due alleati e della possibile parte araba, il Maresciallo Kesselring propose , i l 31 dicembre 1942 , al Comando Sup remo italiano di convocare al più presto una riunione allo scopo di co ncertare una politica omogenea nei riguardi dei molti problemi connessi alla questione araba e tunisina avendo, s ullo sfo ndo , la critica situazione mili tare al fronte ( vedi tabella pagina success iva) .


Documento n. 19
(19 novembre 1942)
Per reagire contro lo sconforto nato dalla grave situazione militare dopo lo sbarco anglo americano nel Marocco, il Gran Mufti fece pervenire ai due governi dell'Asse , il 19 novembre 1942, il seguente Promemoria nel quale veniva auspicata una dichiarazione di indipendenza del Maghreb chiarendo i vari aspetti della questione ed i futuri vantaggi per l'Asse di una s imile decisione.
Nel corso di numerosi colloqui con gli ambienti dell'Asse ho attirato l'attenzione s ull'importan za della questione del Maghreb e sulla possibilità di una sua evoluzione in maniera molto grave. In questi ultimi tempi ho ricevuto varie lettere dal Marocco, dall'Algeria e da Tunisi, tutte indicanti la gravità della situazione colà esistente; la forte propaganda degli anglo -sassoni e l'interesse che essi na scondono. Tale corrispondenza si lamenta dei francesi e della loro incapacità o mancanza di desiderio di resistere a.Il' attività degli alleati . Non ho mancato a suo tempo di portare ciò a conoscenza dell'autorità dell'Asse. Ho appre zza to sempre il punto di vista dell'Asse il quale desidera non spingere la Francia verso gli alleati. Me le informazioni che mi giungevano mi facevano dubitare delle intenzioni della Francia di resistere seriamente agli alleati e facevano capire che l'Asse , continuando ad appoggiare la Francia, perdeva gradatamente la simpatia dei Maghrebit i . Dato quanto sopra , fin dall'ini zi o, proponevo di adottare misure atte a far conservare la simpatia dei Maghrebiti per l 'Asse senza nuocere a ll a Francia, ed ad adottare nello stesso tempo cautele contro l'eventuale aggressione del Maghreb da parte degli a lleati nel caso di incapacità di resistenza da parte della Francia . Tali proposte, disgraziatamente non in contrarono la buona occas ione per realizzarsi . Viceversa è risultato che i francesi fino a questo momento non hanno dimostrato una resistenza adeguata alle grand i forze di cui essi dispongono ne l-
1' Africa settentrionale . Anzi si teme che essi potrebbero essere sedotti dagli alleati e potrebbero partecipare alla resistenza contro l'Asse in occasione delle prossime operazioni belliche .

Ci troviamo oggi di fronte ad una nuova po s izione. I respon sabili, senza dubbio , app rezza no qu esta grav e pos izione s ia dal p unto di v is ta militare c h e politico; ma io sen to il dove re p e r l ' in teresse co mun e, di segnal a re in questa ci rcosta nza le proposte seg ue nti:
a) Dal punto di v is ta militare :
1) Per causa dell'agg ressione degli a ll ea ti cont ro il M ag hreb, ado ttare la Tu n isia co me sede della difesa.
2) Istituire un Eserci to Liberatore M aghrebita, da formarsi dai prig io nieri marocc hini che si trovano in G e rmania , c dai volontari fra ess i; da g li operai marocchi ni i quali sono molto numerosi in Franci a, dai Tu nis ini e da tutti gli e lementi del Ma ghreb , i quali rapidamente potrann o formare un forte numero.
3) Inv i tare i sold ati del Maghreb , e residenti in Africa a far parte cieli ' eserc i to maghreb i ta perché questi costituisco no la maggioranza delle trup pe fra ncesi, in Maro cco .

4) Sollevare la rivolta, sia con gli e le menti di cui sopra, sia con gli a ltri var i mezzi, fra le tr ibù e re g ioni de l M aghreb occ up a te dagl i a ll eati.
5) L'eserci to co s tituito come sopra potrebbe esse re impiegato in altri fronti quando s arà finita la lotta ne l! ' Africa sette ntriona le, par ticolarme nte pe rc hé il marocchino è un buon sold ato e p e rc hé molti so ldati e ufficiali maghrebiti so no s tati istruit i dall' ese rcito francese.
6) Utilizzare pro vviso ria me nte in Tunisia le unità mi litari a rabe istituite presso i paesi de ll'Asse a llo scopo di i m pi egarle in Oriente .
7) I s titui re a Tetuan un centro segreto per pre ndere co ntatto con le altre reg ioni del Maghre b sen za, né di s turbar e, né attirare l 'atte nz ione degl i s pag noli.
b) Dal pun to di vista politi co:
JI Maghreb non è so tto l'ingerenza de ll' As se e l' As se non trae da esso alcun benefic io . Anz i il Maghreb è diventato oggi la fonte di un se rio p e ricolo pe r l' A sse . L' A sse potrebbe roves c iare qu es ta situaz ione ed ottenere l'utilità militare anzidetta , se manifestasse la s ua bu o na i nten zio ne verso iI Maghreb.
l) Prome tte re solennemente la libe rt à e l 'i ndi pendenza ai mag hre biti e conc ludere co n ess i , pe r tranqu illi zzarli , u n tratta to su un a base c he rassomig li a quell a del tratta to an g lo-egiziano o del tratta to ang lo- irache no .
2) Cominciare a concludere il trattato col Bey di Tunisi che non ha approvato le richieste di Roosevelt relative al passaggio delle truppe americane dal suo territorio per aggredire Tripoli.

3) Liberare i detenuti politici maghrebiti, come i capi tunisini che si trovano att ualmente nella carceri di Marsiglia.
4) Organizzare una saggia propaganda diretta al Maghreb.
Non esagero se ritengo che la posizione attualmente favorevole agli alleati potrebbe essere trasfom1ata in una grande forza per l'Asse, malgrado gli sforzi che gli alleati e particolarmente gli americani , vanno spiegando per soddisfare i Maghrebiti con promesse identiche a quelle fatte ne ll 'Oriente arabo .
I sentimenti dei Maghrebiti sono ostili alla Francia . Di conseguenza essi sono ostili ad ogni sistema atto a consolidare la posizione della Francia nel Maghreb . I Maghrebiti hanno una simpatia per l'Asse perché questo è stato ostile alla Francia nel passato, e perché si è oppos to agli ebrei ed agli anglosassoni che si servono dell'influenza ebraica. Questi sentimenti dei Maghrebiti so no not i e sono dimostrati chiaramente nelle le ttere dei capi maghrebi ti alle quali ho fatto cenno.
La Gran Bretagna e i suoi alleati cercano di servirsi di tutti i popoli, qua lunque sia la razza, la religione ed il colore , per collaborare con esse in q ues ta guerra . Essi hanno già arruolato molte forze e continu ano ad arruo lare ed a istru irne un maggior numero in Africa Se l'Asse riuscisse a sodd isfare i Maghrebiti e ad avere la loro adesione, q uesti fornirebbero con n umero non in fer iore a l mezzo milione di soldati coraggiosi, abituati a combattere in quelle zo ne. Il Maghreb è molto ricco di materiali e di uomini e rispannierebbe molto il trasporto di truppe e di vi veri per il fronte dell 'Africa e quello del Vicino Oriente.
L'assistenza dei Magrebiti allo scopo di far loro o ttenere la libertà, a gg iun ta ali' assicurazione d ella loro immediat a collaborazione con l'A sse, li renderebbe alleati per sempre e susciterebbe una ottima r ipercussione in tutti i Paesi de lJ'O riente. O gni sollecit ud ine per fare i passi necessari p e r la rea lizzaz ione di questo proge tto assicurerebbe maggiormente il s uccesso e po trebbe ave r grandi risul tati. Sono pienamente di sposto a svolgere og ni collaborazione possibile per realizzare queste proposte non appena esse saranno approvate .
Roma , 19 novembre 1942
La reazion e del governo italiano alle proposte del Gran Mufti de l 19 novembre non fu positiva in. quanto, come al solito, si temevano le co nseguen ze di una p o litica volta a proclamare l ' indip endenza degli arabi , essendo c hiaro ch e per il Nord Africa tale promessa non pot eva esse re fatta alla luce delle riv endicazio ni fasciste su lla Tuni s ia e su pa rte dell 'A lgeria. TL prese nt e Appunto dell 'eJperto d e l Mini stero degli Affari Esteri, comm. Mellini fu conseg nato al ministro Vitetti il 26 no ve mbre 1942 e conferma l'opposi zio ne italiana al promemoria d e l 19 no vembre ed il definitivo rinvio d e lla mùsio ne in Nord Africa dello stesso G ran Mufti.
D o po attento esame del pro- memoria del Gran Mu ft i in dat a 20 co1Tente (in rea ltà era del 19) c irca l'azione c he potre bbe essere svol ta nei P aes i del Nord Afri ca france se s i so ttopon go no le seg uenti osse rvazioni e prop oste .

1° - Oltre a l messa gg io mand a to dal Gran Mu ft i , con l 'a pprovaz ione del l ' Ita lia e dell a G e rmania , a l Bey di Tu nisi, non semb ra per ora il mom e nto di pre ndere i n co nsid e razione dic hiara z ion i pu bb liche o seg rete od impeg ni di al c un gene re circa il futuro assetto della Tuni s ia , dell 'A lge ria e de l Marocco. Il Mufti po treb be esse re verbalmente rassic urato c he l'atteggiame nto dell ' Italia ve rso tali Paesi sarà se m pre improntato a lla m ass ima amic iz ia e d all a com prens io ne de ll e loro necess ità po litiche, eco nomi c he e sociali, in confo rmi tà, del re s to, all e linee del m essaggio che è stato autor ina to a tras mette re a l B ey d i T uni s i.
2° - Gli avven imenti hanno cos tre tto a sopra ssedere a ll' esecuz io ne del pro ge tto d e lla Miss ione de l M ufti in Africa Settentrio nale ve rso l 'Egitto c he p o tr à eve n tua l mente essere ripreso i n seg uito.
I n base all e nuo ve proposte avanzat e dal Mu ft i nuovi acco rdi potrebb ero essere ripre s i tra lui cd il S.I.M. , con l ' ass istenza di qu es to Minis te ro , per un suo eve ntu a le trasferimen to ne l Sud della T u ni s ia , quand o pos s ibil e, ed inta nto event ualm e nte a Gad a me s.
A differe nza di quanto progettato per la missione in Egitto l'attività del Mufti in questo settore dovrebbe limitarsi:

- alla creazione di centri per servizi informativi e di propaganda nel Nord Africa;
- all'incoraggiamento dei Magrebiti alla guerriglia mediante anche la formazione di bande irregolari da costituirsi con elementi del Maghreb, ad esclusione di libici e di arabi del Vicino Orien te, da effettuarsi sotto la direzione e la responsabilità del Mufti e con inquadramento italiano ( o dell'Asse); con una chiara ed esp licita esclusione dell'impiego in tale settore cli una "Forza Araba" regolare con bandiera araba.
3° - Finalità di tale centro: "la dife sa del Maghreb dalla minaccia anglo-giudaico -comuni sta-americana".
Ove tale progetto venga approvato s e ne potrebbe dare notizia al Comando Supremo (che , presentito in via breve , si è già dichiarato in massima favorevole) e , ove questo approvi , darne informazione a questa Ambasciata cli Germania e prendere accordi con il S.I.M . perché dia l'opportuno seg uito .
Sarebbe opportuno che accordi di massima fossero presi con il Mufti circa la sua attività verso il Maghreb prima della sua prossima partenza per Berlino onde evitare che se ne prenda l'iniziativa colà.
Roma, li 26 Novembre 1942
Docunemento n. 2 J
(3 0 novembre 1942)
La gravità d ella situazione italiana in Tunisia sul piano niilitare come sul piano rela ti vo a lla co llettività italiana venne des critta dal Console d'Italia a Tunisi , Giaco mo Silimbani, nel seg uente t elegram,ma del 30 novembre:
OGG E TTO: Situazione i n Tun isia
0128 / - L'occupaz ione mi l itare d i taluni punti della Tunisia, da p arte delle trupp e dell'A sse, null a ha mutato so tto l 'as petto g iuridi co, fuori del cam po militare , alla organizzaz ione costituzionale e amministrativa della Regge nza. L'Autorità civile francese conserva i suoi poteri e la Po lizia res ta all e s ue dip e nd enze .L'Ammirag lio E s teva, R es idente Ge nera le , s i è comportato s inora i n modo corre tto mo s trando i ossequiente agli o rdini di Vichy. Non è dubbi o c he g li ultimi avv e nimen ti , e in particolare l' ep isodio di T olone, debbono averne scosso il morale. Come ho già rife rito, la massa dei fu nzio nari rivolge n ettamente le s ue simpa tie verso la causa a ng lo -ame ric ana. Il Prefetto Philip , Delegato G enerale de lla Pu bb lica Sicur ezza, costretto, pe r le sue fun zio ni a mantenersi in c ontinuo co n tatto, e in divers i cam p i a coll aborare con l 'A ut orità di Occupazio ne , ma nti ene atteggia m ento ambiguo. E g li svolge una abile politica sabotatrice e d è cer to un ele m ento in fido pronto a passa re, ove il momento oppo rtuno s i presentasse, a l campo opposto. Senza c he ve ne s ia app arentemente alcun bisogno, dato che mo lte attribuzioni dell a Poli zia sono passate a lle Autorità milita ri di occupazione, egli ha accresc i uto notevolmente, proprio in qu esti giorn i, g li effettiv i del corpo i cui sentimenti di odio verso la popolazione ita li a na so no ben noti. Lo prov a no va ri fermi di connazionali rei di ave r forn ito se mpli ci indi cazioni s tradali a militari italiani e tede sc hi, e di aver lo ro m aga ri offerto un a s igaretta e un a bevanda . Com e previ sto, tutt o l'eserc ito fr ancese , quasi senza ecce z ione , s i è schierato , agli ordi ni de l Generale B arré, con tro le forze d e ll ' Asse , favo r endo in ogni modo i no stri ne mici Aspri co mb att imen ti so no s tat i soste-

n uti dalle forze dell'Asse contro i francesi, e numerosi sono i francesi prigionieri, compresi diversi elementi della "Garde Mobile" . Nelle campagne, coloni francesi si sono battuti, acca nto ai soldati, contro di noi . A Tu ni s i , fra n cesi, e brei, naturalizzati, maltesi , attendono con fiducia, spesso ostentata, g li a nglo -america ni. No i restiamo in stretto contatto con i tedeschi cercando di apri re loro gli occ hi s ull 'atteggiamento gene ral e dei francesi , Autorità e popo la z ione . Tuttavia il Comando tedesco sotto l'influenza del Ministro Rahn stenta ad abbandona.re la concez ione di una politica collaborazionistica. I tedeschi hanno assunto in Tunisia, nei nostri confronti, una posizione di primo piano che non sfugge ad alcuno . Così che tutte le requisi zioni sono fatte dal1' Autorità fra ncese "per co n to dell ' esercito tedesco" . Anche s e servono a nostri Comandi e reparti e nonostante che le fun zioni del Generale Nehring s iano q uel le di Comandante Generale delle Forze dell'As se in Tunisia . Pe r o rdine del Coma ndo tedesco sono stati disposti numerosi arresti di elementi ebraici in Tunisia. Si tratta, in ge nere di personalità innocue e si ha ragione di ritenere che le liste siano state redatte dalle Autorità francesi preoccupate di lasciare tranquilli, e magari di far fuggire a tempo, persone di maggior rilievo. Sono intervenuto p resso il Ministero Plenipotenziario Rahn a favore di u n ebreo italiano, il dottor Ugo Bensasson, g ià medico delle nostre scuole, e combattent e della gue rra 19 15-1 8 e della ca mpa g na di E ti op ia. II Bensasson è stato tratto in arresto se nza alcun apparente mo tivo . La sua condotta poli tica si era mantenuta corretta anc he dopo l'adozione in r.t alia di provvedimenti per la difesa della razza. Aveva ro tto ogni rapporto con i due figli di tendenze comuniste notificando loro, per me zz o di usciere, nel maggio 1939 di non riconoscerli più come facenti p arte della famig li a. II Presidente della Comunità israelitica è stato invitato a recarsi ogni mattina al Comando Militare tedesco della piazza per riferire s ullo stato d'animo de i suoi co rre li g ionari, per tenersi a disposizione e assume re eve ntualmente la res ponsab ilità degli atti ostili che e lementi ebraici potessero comme ttere contro gli ese rc i ti cli occ upaz ione . Gli arabi non nascondono le proprie simpa tie per le truppe d ell'Asse e, in particolare, per i so ldati tedeschi; significativ e dimostrazioni si sono avute a Tunisi e in di versi centri.
Si tratta comunq ue di u n atteggiamento platonico e non vi è da atte nd e re da parte de ll ' e leme n to mussulmano atti di pratica ed efficace solidari età. S ia il Gen era le Nehring, Co mandante Ge nerale, che il G ene ral e Loren ze lli, Co ma nd a nte della Divisione italiana, si so no recati

a rendere visita al Bey che li ha cordia lmente intrattenuti . Qualche preoccupazione si nota in certi ambienti arabi per l'eventualità che la truppe dell'Asse traggano il proprio sostentamento dalle risorse alimentari tunisine .
La Colonia Italiana non si nasconde la gravità del momento e per quanto non esattamente informata, sa che si combatte a pochi chilometri dalla città, da dove si ode benissimo il canno ne. Per quanto la nostra azione di propaganda e di controllo possa esercitarsi, data la situazione , solo su una parte della Colonia ( 60 o 70 mila ) pure numerosi so no gli italiani che si prod igano in ai uto alle truppe di occupazione . Circa 500 connazionali sono al servizio dei Comandi come autist i , meccanici, guide, ecc .. Ogni giorno a cura delle nostre organizzazioni vengono fomite, secondo i bisogni che sono fatti presenti, centinaia di lavoratori soprattutto per l'aeroporto . Così pure è stato da noi organizzato il lavoro per lo scarico nel porto. Le domande di arruolamento volontario, per quale si è istituito un apposito ufficio, hanno superato, in soli cinque giorni, le 1.300 unità. Questo contr ibuto è tanto più notevole ove si pens i che circa 1000 italiani in Tunisia già servono in armi la Patria nell'Esercito, nella Marina, nel!' Aviazione, mentre 1300 operai partirono nei mesi scorsi per prestare la loro opera in Libia al seguito delle truppe combatten ti . Insegnanti delle RR. Scuole disimpegnano alacremente diversi servizi negli uffici di nuova costituzione. L'Ospedale italiano accoglie numerosi feriti italiani e tedeschi. Diverse scuole e altri locali delle nostre organizzazioni, sono stati messi a disposizione delle truppe . Il Comitato di assistenza unitamente alla GILE hann o organizzato l'opera di soccorso e di asilo di varie centinaia di profughi ita liani , soprattutto donne e bambini, provenienti da zone particolarmente esposte ali' offesa ne mica come Bis,erta, o le località ove sono in corso operazioni di g ue rra. Un appello è stato lanciato ai connazionali che possono accogliere presso di loro famiglie di nostri rifugiati .

Tunisi, 30 novembre 1942
Giacomo SilimbaniFONTE: ASMA E , Tunisia, busta 11, fase. I.
Documento n. 22
Avendo espressa il governo tedesco l'intenzione di trasferire al più presto in Tunisia il reparto tedesco-arabo-maroc c hino formato a Sunion, il capo dell'Ufficio I I I del Ministero degli Affari Esteri, mm. M ellini, espresse nel seguente Appunto del 5 dicembre al ministro Vitetti le perplessità del Minist e ro degli Esteri circa la deci s ione te desca:
Ieri mattina il Principe di Bismark comunicava al Capo di Gabinetto che il Generale Nehring intendeva costituire in Tunisia un battaglione arabo.
Nel tardo pomeriggio il Comandante Simen comunicava che il Comando Supremo era stato informato che il Governo tedesco intendeva inviare in Tunisia la " Forza liberatrice" già costituita a Sunion (secondo precedenti notizie essa sarebbe costituita da un battaglione misto arabo - tedesco -m arocchino agli ordini, allora almeno, del Generale Felmy).
Da parte nostra si è proceduto a chiedere delucidazioni-al Console Generale Silimbani e ad informare il Comando Supremo di guanto c i era stato comunicato dall'Ambasciata tedesca aggiungendo:

"Non risultando però ben chiaro di che cosa esattamente si tratti si è telegrafato al R. Console Generale Silimbani di far conoscere se gli risulti se eletta unità araba farebbe parte della progettata Legione impe1iale francese per la difesa dell' Impero francese oppure se sarebbe destinata ad agire indipendentemente come rappre se ntante del movime nto arabo.
In tale seconda ipotesi potrebbe infatti essere considerata da parte nostra l ' opportunità di far presen te al Governo tedesco il nostro desiderio di partecipare a tale iniziativa, nella forma che potrà essere possibile ed utile ovvero cli prendere da parte nostra iniziativa analoga.
Anche poiché il Mu f ti non mi ha accennato a dare seguito alla proposta da me fattagli di lasciare in deposito al Banco di Roma - per maggior sicurezza - l'oro da lui recentemente ritirato e che era destinato alle spese per i suoi contatti nella progettata missione in Egitto (dal che si può anche su pporre che egli lo porterà con sé a Berlino); e poi-
ché il Mufti ha fatto pressioni per ritirare le uniformi e l'equipaggiamento militare per lui e per gli aspiranti arabi che avrebbero dovuto accompagnarlo in Egitto e che erano in co r so di confezione presso l'Unione Militare, ho approfittato ieri di averlo visto ad una colazione offerta in suo onore dal Ministro di Ungheria per accennargli alla possibilità che avessimo av uto da un momento all ' altro di decidere l'urgente invi.o della "Forza militare araba" costituita a Roma, a combattere in Tu nisia . Desideravo perciò conoscere in linea di massima la sua opinione al riguardo. Egli mi ha risposto che in linea di mass ima era favorevolissimo ma che desiderava partire anche lui con la "Forza" nonostante i rischi ed i pericoli di cui si rendeva ben conto per la sua persona e che io gli avevo sottolineati .
Gli ho chiesto allora se riteneva che i tedeschi gli avrebbero pem1esso di aggregare a tale Forza anche 1'unità costituita a Sunion ed :inquadrata da ufficiali tedeschi. Egl i mi ha risposto che, in seguito al noto pro -memoria da lui presentato il 19 novembre u.s. all'Italia ed alla Germania , era venuto da Berlino a trovarlo il Colonnello Lahousen (Capo di uno dei Servizi dipendenti dall ' Ammiraglio Canaris) e che avevano parlato ditale questione ed aveva buone spera nze in proposito . Gli ho domandato se avrebbe accettato che g li arabi di tale unità combattessero, come attualmente è predisposto, con uniformi tedesche e come unità araba facente parte dell'esercito tedesco. Mi ha ri sposto che non credeva di poter accettare tale possibilità e che in tal senso si sarebbe battuto a Berlino.
Nel corso della conversazione mi ha aggiunto: "no n dimentic herò mai tutto quello che è stato fatto per me e per la causa araba qui. D esidero ripetere quello che vi ho già detto in altra occasione e cioè che non prenderò mai alcun impegno politico o milit are con la German ia se non in pieno accordo con l'Italia. Se vedrò a Berlino la situazione complicarsi preghe rò quell ' A mbasciata cli far sapere a l Ministero che desidero vedervi e così potrò me ttervi al corrente di q uello che sta avvenendo" .

Dall ' in sieme di quanto precede si possono fare tre ipotesi:
l O - che l'iniziativa tedesca si limiti a favorire la partecipazione degli arabi nella legione progettata dai doriotisti con l 'approvazione di Lavai per la difesa dell'Impero francese. In tal caso potrebbe forse essere opportuno prendere atto e non p artecipare all'iniz iativa;
2° - che i tedeschi intendono trasferire in Tun isia la "Forza l iberatrice arabo -tedesco -marocchina" forzando l 'au tori zzazio ne del Mufti ma mante nendola agli ordini diretti di ufficiali te de schi e co n uniforme tedesca come parte integrante dell'esercito germanico . A parte le
difficoltà che credo il Mufti solleverà e manterrà per dare la sua adesione riterrei subordinatamente pericolosa una nostra iniziativa del tutto analoga ed una nostra partecipazione a tale programma . Sotto tale forma è da temere anche gli arabi, specialmente in momenti difficili, diserterebbero senz'altro al nemico;
3° - che la Germania intenda servirsi della "Forza Liberatrice" per costituire il nucleo in Tunisia di un a più larga unità araba, d ' accordo con il Mu ft i ed accettando quelle che saranno le sue richieste per una maggiore autonomia e per una sua direzione personale dell'organizzazione. Specialmente in tale terza ipotesi mi sembrerebbe molto pregiudizievole per noi e contrario alla nostra riconosciuta preminenza in Mediterraneo il rima nere estranei all ' ini ziativa . Si potrebbe perciò esaminare l'opportunità di inviare anche da parte nostra la "Forza militare araba " già costituita a Roma, ma non sotto bandiera araba , e costituire con essa il nucleo per il reclutamento cli volontari arabi del Nord Africa per la difesa dei loro territori dall'invasione anglo -giudaica-america na sotto l'alta guida del Mufti e provocare accordi tra i Comand i militari italian o e tedesco per adottare linee analoghe, sia che le due unità mantengano le loro autonomia e svolgano azione parallela ma distinta, sia che esse dovessero agire in stretta collaborazione
Ove l'Italia non dovesse partecipare in forma adeguata ed opportuna al progetto contemp la to nella terza ipotesi, ovvero ove dovesse parteciparvi in ritardo o decidere cli parteciparvi alla vigilia cl i avvenimenti che ne renderebbero impossibile l'attuazione, è da teme re che ne sarebbe assai scosso il nos tro prest igio ora ed in avvenire in Tuni sia e in tutto il resto del mondo arabo, che sarebbero ali mentati ingi ustificati sospe tti ne l Mufti circa il nostro amichevole atteggiamento verso gli Arabi e che si verrebbe così a dare indiretta conferma alle voci per tanti anni propala te dalla prop aganda anglo -francese e, purtrop po , alimentate anche rece ntemente e d in varie occasioni da alc un i agenti tedeschi, circa le ambiziose mire dell'Italia di ricos t ituir e, in caso di vittoria, un Impero romano assoggettando e colonizzando tutti i Paesi Arab i c he non trovere bbero quindi che in una vittoria ang lo-americana o ne lla protezione tedesca una difesa co ntro tali amb iz ioni.
Rom a, li 5 di cem bre 1942. XX I
F.to MelliniFONTE: ASMAE, ibid

Documento n. 23
L'INVIO IN TUNISIA DEL REPARTO ARABO-TEDESCO (7-10 dicembre 1942)
Il proposito dell'Alto Comando germanico di trasferire in Tunisia il Reparto arabo -tedesco formato a Sunion suscitò un'ampia discussione con le autorità politiche italiane che temevano le conseguenze di questo progetto specialmente per l'affermata etichetta di "Unità liberatrice" che implicava una indipenden za promessa al Nord Africa e ciò senza consultaz ioni con l'alleata Italia che certamente vi si oppo- , neva. I principali documenti della crisi sono : 1. un Promem oria del SIM del 7 dicernbre; 2. Appunto dell'Ufficio III del Ministero degli Affari Esteri del 7 dicembre; 3. un Appunto a Berlino dell'8 dicembre; 4 un Appunto dell'ambasciata italiana a Berlino del 9 dicembre; 5. un Appunto del Ministero del 9 dicembre; 6 un Telegramma da Tunisi del 9 dicembre; 7. un Telegramma da Berlino del 10 dicembre:

COMANDO SUPREMO
S .I.M .
SIM/ 45031 di prot. P.M. 21 - li, 7 dicembre 1942
OGGETTO: impiego Centro M ilitare" A" in Tunisia. ,
Il Ministero Esteri ha avuto comunicazione dall'Ambasciata di Germania che il Generale Nehring intende costituire in Tunisia una Legione araba.
Nel medesimo tempo l'O.K.W. portava a conoscenza del Comando Supremo - Ufficio Infonnazioni - che si prevede di trasferire prossimamente in Tunisia 1' Unità araba inquadrata dai Tedeschi a Capo Sunion .
ll Ministero Esteri provvederà a chiedere maggiori schiarimenti al Governo tedesco, limitandosi per ora ad affermare l'interesse italiano al progetto di cui sopra.
Si ritiene pertanto opportuno precisare al riguardo quanto segue:
l O - È stata già concordemente riconosciuta l'utilità di una collaborazione araba alla lotta contro gli anglo -sassoni , e loro alleati nel Nord Africa Francese.
Tuttavia data la complessività e la delicatezza dei vari problemi che tale collaborazione coinvolge, si ritiene che anzitutto, una precisa linea di condotta in mate1ia debba essere stabilita d ' accordo tra i Governi Italiano e Tedesco, il Mufti ed i Capi Nazionalisti Tunisini.
2° - Il trasferimento in Tunisia dell ' Unità araba di Capo Sunion dovrebbe inserirsi in un unico complesso , unitamente al nostro Centro "A" , con impiego e finalità comuni.
3° - L' intera formaz ione così risultante dovrebb e essere posta sotto la diretta guida del Mufti , il cui ascendente e prestigio sui volontari arabi solo può valere a contrastare eventuali tendenze disgregatrici alimentate dal nemico.

I compiti della formazione araba dovrebbero mirare soprattutto alla propaganda , a suscitare movimenti di rivolta contro gli anglo -sas soni e i loro alleati, ad agire con sabotaggi e colpi di mano nelle retrovie nemiche.
Il Mu f ti è favorevo le al progetto ed è pronto a partire egli stesso per la Tunisia appena possibile.
Occorre quindi predisporre in modo che tutto si trovi a punto per il momento di utile attuazione.
2. APPUNTO DEL MAE CIRCA L'IA1PIEGO DELLE FORZE
ARABE IN TUNISIA (7 dicembre 1942) URGENTE
II 4 corrente questa Ambasciata di Germania ha comunicato che il Coma ndo tedesco in Tunisia intende costitu ire colà una unità militare araba della forza di circa un battaglione.
U 5 co1Tente il Comando Supremo ha informato di aver avuto comunic;azione dall'O.K .W. - che chiede in proposito il consenso del Comando Supremo stesso - della intenzione di impiegare in Tunisia il "Reparto arabo" organizzato dai tedeschi ed ha chiesto il pensiero di questo ministero al riguardo.
Pregasi voler comunicare al Comando Supremo:
Non risulta ben chiaro se s i tratti della stessa iniziativa o di due iniziative differenti.
Nell'ipotesi che si trattasse di forze arabe impiegate in qualsias i forma d'accordo con le Autorità francesi per la difesa dell'impero francese, sembra preferibile che l'ini zi ativa tedesca abbia corso senza difficoltà e senza incoraggiamenti o partecipazi one da parte nostra.
Nell ' ipotesi che si trattasse dell'impiego in Tunisia della "Unità liberatrice" tedesco -arabo-marocchina già destinata dai tedeschi all'invio nel Caucaso sembrerebbe forse opportuno che le nostre Autorità militari facessero discretamente presente a quelle tedesche come, ove tale unità rimanesse con uniforme tedesca ed inquadrata nell 'esercito tedesco, vi sare bbe poco da contare su di un utile impiego di essa o su favorev oli Iipercussioni al riguardo nei Paesi arabi e mussulmani. Nah1ralme nte non sembrerebbe il caso cli fare difficoltà alcuna ove i tedeschi mantenessero il loro punto cli vista. Sembrere bbe però in tal caso consigliabile cli informare i tedeschi che intendiamo riservarci l'eventualità cli in viare, per conto nos tro , in Tunis ia "l ' Unità araba" costituita a Roma con uniformi arabe.
N e ll'ipotesi che i tedeschi accettassero quelli che sembra no essere anch e i suggerimenti del Mufti e cioè che " l 'U nità liberatrice" non sia impiegata come parte integrante dell'esercito tedesco ma in forma analoga a quella da noi adottata per "l'Unità araba" organiz zata in Italia e quindi sotto la gu ida del Mufti, sembra potrebbe essere esaminata la convenienza cli offrire ai tedesch i di fondere le due iniziativ e facendo rimanere le trupp e arabe già inquadrate dai tedeschi al comando di ufficiali tedeschi in modo da agire parallelamente e ser vire ciascuna da centro di attrazi one per i volontari dei Paesi del Nord Africa.

Roma , li 7 dicembre 1942
F.to ROS SI LONGHIURGENTISSIMO. Questa Ambasciata di Ge1mania ha fatto ora conoscere che avrà luogo stamane alle ore 11 costà una riunione per decidere la pronta partenza del Gran Mufti per la Tunisia ed ha chiesto il nostro parere al riguardo.
Abbiamo fatto conoscere a questa Ambasciata che siamo perfettamente d'accordo con partenza del Mufti per la Tuni sia, progetto che
era stato da noi preso da tempo in considerazione, e che desideriamo, anche a prova della perfetta identità di vedute tra l'Italia e la Germania a tale riguardo, farlo accompagnare anche dalla missione da noi a tal uopo già predisposta .
Quanto sopra per vostra informazione e per norma di linguaggio nei contatti che eventualmente avrete in proposito con codeste Autorità tedesche ed anche perché possiate subito informare il Gran Mufti della nostra intenzione di facilitare in ogni modo i suoi comp iti mettendo a s ua disposizione l'organizzazione già predisposta ed a lui ben nota.
Roma, 8 dicembre 1942
4. RICHIESTA TEDESCA DI PARERE SULL'INDIPENDENZA DELLA TUNISIA (9 dicembre 1942)
SEGRETO NON DIRAMARE
2100 - Urgentissimo.
Mi ha chiamato stamane Woermman per dirmi che il Mufti in una conversazione avuta ieri sera con l'Ammiraglio Canaris si è detto disposto ad andare a Tunisi , ma che prima sarebbe stato opportuno che i Governi dell'Asse facessero una dichiarazione per indipendenza del1' Africa del Nord. Ove una vera e propria dichiarazione di indipendenza per tutto il Nord Africa non fosse considerata opportuna basterebbe una dichiarazione di indipendenza per la Tunisia, magari limitandola con la concessione alla potenza interessata di certi punti di appoggio .
Nel caso che una dichiarazione pubblica non fosse per il momento considerata opportuna dal Governo tedesco egli s i sarebbe accontentato pure di una lettera segreta rivolta dal Governo tedesco al Bey di Tunisi, che egli avrebbe consegnato e che avrebbe dovuto contenere le assicurazioni qui sopra elencate .
Woermman ha aggiunto che negli ambienti militari locali si dà molta importanza all'andata del Mufti in Tunisia e mi ha chiesto di fargli avere con ogni sollecitudine il parere del R. Governo in proposito .
Woermrnan mi ha inoltre comunicato che egli sarebbe stato informato di una lettera rivolta dal Mufti al Bey di Tunisi, ed a questo consegnata da un nipote del Mufti stesso . Woermman sarebbe grato se

egli volesse far conoscere il contenuto della lettera stessa e del risultato da essa conseguito.
Sarò grato a V. E. se vorrà mettermi in condizione di dare una sollecita risposta al Governo del Reich sull ' opinione italiana circa le richieste del Mufti ed anche sulla sua lettera al Bey di Tunisi .

5.APPUNTO DELMAE (9 dicembre 1942)
Dopo che il 6 c.m. da p,ute di questa Ambasciata germanica e del1'0 .K .W. erano pervenute rispettivamente a questo Ministero ed al Comando Supremo informazioni vaghe e non del tutto concordanti circa l' intenzione tedesca di costituire ed impiegare una "Unità araba" in Tunisia , siamo stati informati 1'8 c.m. da questa Ambasciata tedesca della decisione che sarebbe stata presa a Berlino di inviare il Gran Mufti a Tunisi.
Dato le iniziative al riguardo che già erano allo studio ed in corso da pa.ite nostra e l'estrema delicatezza dei problemi di cui trattasi che toccano direttamente , più che il lato militare , quello politico in zone nelle quali i nostri predominanti interessi sono stati riconosciuti ripetutamente dall'alleata Ge1mania, si 1iterrebbe opportuno, ove Voi, Eccellenza approviate:
1° - di inviare l'unito telegramma al Comando Supremo;(non riprodotto)
2° - di far conoscere anche da parte n.ostra a questa Ambasciata di Germania che si riterrebbe opportuno ed urgente uno scambio di informazioni e cli vedute in proposito, tra le competenti auto rit à militari e politiche italiane e tedesche.
Roma, li 9 dicembre 1942
6. TELEGRAMMA DA TUNISI CIRCA LA LEGIONE ARABA (9 DICEMBRE 1942)
SEGRETO NON DIRAMARE
Tunisi, 9/12/1942
La Legione araba tunisina dovrebbe essere organizzata e diretta eia capi desturiani soprattulto dagli eleme nti dirigenti e più accesi già interna -
ti a M~U"s iglia e ora messi in libertà su pressioni del Governo tedesco. Tra costoro pr incipale figura è avvocato Burghiba . Secondo gli intendimenti Ministro Rahn , Leg ione araba dovrebbe servire per infiltrazioni nei territori occupati dal nemico onde sollevare correligionari contro anglo -sassoni svolgendo guerr iglia e azioni di banda. Comando militare tedesco seguendo concetti più aderenti rea ltà pensa che s ia possibile piuttosto valersi della legione araba per servizio informativo e atti d i sabotaggio.
Comunque preoccupa evidente carattere politico Legione che sarebbe assolutamente distinta da Falange francese per riconquista Nord Africa. Ministro Rahn non è alieno da incanalare movimento arabo in senso antifrancese per lo meno contro attuali ambienti francesi Residenza e amministrazione Protettorato. È noto che movimento desturiano e in particolare capi internati Marsiglia aspirano ad una più larga autonomia del paese come primo passo verso una forma di quasi indipendenza Non vi è dubbio che nazionalisti tunisini si appoggino oggi su tedeschi che non risultano avere mire territoriali , su questo paese . Anche elementi con cui avevamo contatti mostrano una qualche ris e rv a facendo comprendere di essere già in rapporto con comandi tedes c hi .
Lo stesso Bey inviando suo capo del protocollo dal Ministro Rahn avrebbe fatto chiedere se ritiene che il movimento desturiano so tto le a utorità tedesche avrebbe potuto avere ri sul tat i concreti per le aspiraz ioni mussulmane tunisine. Più che altro Ministro Rahn mi ha assicurato avere risposto molto genericamente e senza alcuna promessa precisa.

Comunque non mi pare dubbio che a q uesta situazione concorra molto la posi z ione di preminen z a assunta dal Comando tedesco in Tunisia nei no s tri confronti. Analoghe considerazioni devono fars i per quanto riguarda mansioni Ministro Rahn che praticamente domi na negli affar i Residenza per cui azione Governo perde ogni giorno d i s osta nza .
Ho fatto obiezioni Ministro Rahn circa effettiva azione che potrà essere svolta da L egione araba in considerazione. Rahn ba risposto fac e ndo valere necessità politico militari del momento.
Non vi è d ubbio che costituzione Legione araba tunisina e nuovo impulso movimento desturiano potrebbero aver conseguenza diametralmente opposta agli effetti dovute ri vendicazioni. A mio subordinato parere sarebbe opportuno inquadrare movimento arabo in più vasta cornice facendo partecipare alla Legione elementi mussu lmani di a ltri Paesi soprattutto del Lev,rnte come movimento generale del mondo islam ico contro anglo-sassoni .
Facendo seguito al mio telegramma 2100 in data ieri comunico che oggi nel pomeriggio Woermman ha tenuto a specificarmi per iscritto che in una nuova conversazione da lui avuta stamane col Mufti questi ha dichiarato che la lettera segreta al Bey di Tunisi doveva essere diretta non solo dal Governo tedesco ma da ambedue i Governi del1'Asse. Inoltre ha rett ificato l 'im pressione da lui avuta ieri circa il fatto che il Mufti non pone condizioni alla sua partenza per la Tunisia nel senso che questi semplicemente consiglia nell'interesse della causa comune, di far le dichiarazioni oppure di scrivere la lettera di cui al mio telegramma sopra indicato.

Nel segu ire le varie fasi delle inutili discussioni a quattro tra italiani , tedeschi , tunisini e francesi, che, tra la fine del 1942 e gli inizi dell'anno successivo, dominarono la scena conclusiva del conflitto nel Nord Africa, non si può non provare sgomento per l a loro inconsistenza. La prima impressione riguarda le autorità italiane che continuavano ad avere una visione inaccettabile della s ituazi one politica e militare che si andava imponendo con una sconfitta imminente ed un fallimento completo del dialogo con il nazionalismo tunisino. In una situazione militare e strategica disperata, con l ' arretramento continuo del fronte a proprio svantaggio e con la constatazione dell'immenso potere di armi , munizioni e mezzi meccanici, c in golati ed altri , che caratterizzava l'azione nemica , ci si sarebbe aspettato , da parte delle autorità politiche e militari italiane, e soprattutto da parte di queste ultime, un maggior realismo. Gli italiani, invece di ragionare in termini concreti di forze contrapposte e di possibili reazioni concertate, continuavano a tenere un linguaggio "i mperiale", anche in quel periodo che segnava il tramonto del conflitto con una prospettiva concreta di sconfitta. Essi sembravano dominati da questioni teoriche di spartizioni, di prevalenza e di sott ili alchimie diplomatiche, così come erano andati ad affermare nel 1940. La consacrazione ufficiale di questa miopia vi fu nella sostanza della riunione italo- tedesca di Roma ad alto livello che si svolse il 2 gennaio 1943 . I partecipanti erano da parte italiana il direttore dell ' Ufficio III 0 del Ministero degli Affari Esteri, Leonardo Vitetti, il gen. Cesare Amè, capo del SIM e il barone Scammacca Comando Supremo; da parte tedesca Von Bismarck dell'ambasciata tedesca a Roma ed il rappresentante politico tedesco in Tunisia Moelhausen. I punti ali' ordine del giorno erano otto ma solo alcuni parevano urgenti nel dover affrontare la questione dell ' impiego dei militari arabi dei vari Reparti speciali nel conflitto. La le ttura delle conclusioni di questi

in con tri non l ascia dubbi c irca le posizioni che paiono da una parte come dall'altra, lontane e non sembrano te nere con to dell'urgenza e della gravità della crisi militare in corso. Si ribadiva che la politica del)' Asse doveva esse re quella "dell'attesa"; evidentemente era una espressione senza senso anche perché nulla vi era da aspettare, se non lo sviluppo se mpre più negativo delle operazioni su l fronte . Il rifiuto di Mussolini a vo lere concedere in un momento così grave un a pur teo ri ca dichiarazione di promessa indipende nza all a Tunis ia sembra una vera mancanza di realismo, poiché di " liberazi o ne" e quindi indipe nde nza ormai parlavano tutti, s ia il Bey, sia i nazi o nali s ti del Neo D estu r , sia soprattutto la propaganda alleata , spec ialme nte statunitense. Il duce invece, ancora sc hia vo dei suoi es pansionismi, era irrigidito s ul rifiuto e 'ciò non poteva non av e re s ull'ap porto militare degli arabi molte conseguenze nega t ive. Lo stesso impegno negativo dell ' Asse emergeva dal punto ses to a pro posito dell ' Uni tà tedesco-ara bo -marocchina : la parte itali ana insisteva sull'as p etto militare e s ul carattere german ico dell'Unità stessa, ricordando che ogni impegno di ti po politico sul futuro del mondo arabo, e spec ialme nte della Tunisia, era stato attribuito ali' Italia e pregiudizialmente deciso dall ' orci ine di Mussolini con trario ad ogni promessa di q uesto tipo. Quanto poi all'importanza di que sto apporto "di poche migliaia di uomin i" nella battaglia in corso, i punti di vista era no scet tici da parte italiana e positivi invece da parte dei te d esc hi , in q u a nto affermava il col. Von Waldenburg " in questo momento a nch e poche migliaia di ara bi arruolati posso no essere militarmente ut ili " . Pe r il resto e cioè pe r la missione del Gran Mufti e p er l ' im piego della forza anna ta ara ba italian a, i punti di vista erano sostanzialmente uguali: di a ttesa su l primo aspetto e di consenso ali ' invio al fronte sul secondo68 .
Dietro que sta apparente in tesa, i g iudi zi del Comando Supremo e del SIM apparvero, in seg reto, s ul complesso delle que s tioni tra ttate, assai critici: in un documento inte rno del 3 gennaio veniva no evidenzia ti i rischi politici c he la posizione ted esca rigu ardo alla que s tione araba e la prese nza in Tu nisia dell'unità militare di Sunion potevano provocare . E nella versione definitiva d ello s peciale Appunto preparato , il 5 ge nna io, per il duce, le riserve erano me sse in forte evidenza. Veniva so ttolin eato che " Il Coma ndo tedesco in Tun is ia in s iste va mo lto per la creazione di formazioni arabe . Intanto era s tato deciso l'invio

in Tunisia del la cosiddetta Unità Liberatrice composta di arabi provenie nti da diverse zone ed i nquadrati nell'esercito. Tale unità - secondo i tedeschi - avrebbe dovuto rappresentare un centro di attrazione per i naz ionalisti de ll 'Africa del Nord i quali dovrebbero essere incitati, in ogni modo possib ile, ad arruolarsi . Da parte tedesca si era anche accennato all ' opportun ità che , a tal fine , l'avvocato Bou Rghiba - Capo de l Neo -Destur - gi u ngesse al più presto a Tunis i per fargli galvanizzare le masse arabe ed indurle a collaborare e ad arruolarsi intorno alla "Unità L iberatrice" tedesca . Su questo punto noi abbiamo dovuto fare le nostre riserve".
Ed il documento non mancava di affermare che appariva "evidente che il problema dei nazionalisti tunisini si presentava in maniera molto diversa per i tedeschi e per noi. J desturiani desideravano, come è noto , l'indipe ndenza asso luta della Tunisia e noi non possiamo , così faci l mente e così leggermente, eccitare un movimento d ' indipende nza in Tun isia che potrebbe in avvenire risolversi a nostro danno. È stato quindi fatto presente come la partenza di Bou Rghiba per Tunisi dovesse essere decisa con opportuna cautela, e che comunque sarà possibile, meg l io valutare la opportunità e la forma dell'utili zzazione di Bou Rghiba qui, o eve ntua l mente , anche in Tuni s ia, solo quando, al s uo atteso arrivo in Italia, saranno meg li o noti i suoi progetti" . Intanto ven i va ribadito c he "in tutto il corso della discuss ione era stato ben chiaro che in materia di T u nisia le decision i ultime per quello che r iguarda la politica da seguirvi dovessero essere prese dall 'Italia"69 A ncora una volta, l' in sieme della q uestione ve ni va fatto d ipendere da ll e rivendica zioni terri torial i dell ' Ita li a fascista, e ciò in u n momento assolutame nte inopport un o per la grande questione che era il conflitto in corso, proprio in T unis ia, conflitto c he volgeva chiarame nte a sfavore delle forze a r mate dell'Asse .
Anche dopo l'arrivo a R oma di Bo urgu i ba, il dosaggio c h e si riteneva a bile tra l'accordo co n le autorità francesi di Tunisia ed un presunto d ialogo con l 'esponen te nazionalista, Habib B ourguiba, si rivelò né a b il e, né opportuno. A questo riguardo le caute affermazioni di Bourgui b a nei suo i vari incontr i con le autor ità fasc iste risultano assai dipend e nti d alla si tu azione mili tare generale dell'Asse in Tunisia che era gravissima e che imp licava per il nazionalismo arabo solo tempo e pazienza. A noi non in teressa mo lto segui re le complesse diatribe tra

Bourguiba e le autorità italiane in vista cli un accorcio che l'Italia voleva concludere in modo tale da escludere ogni prospettiva di indipendenza per la Tunisia e che Bourguiba non voleva per motivi opposti. Ed in questo lungo "braccio di ferro" , tutte le attese italiane furono sconfitte dall ' abilità negoziale del capo nazionalista tunisino che , alla fine , venne rimandato in patria dalle autorità fasciste che finirono per considerarlo poco malleabile ai loro fini, talmente era forte la sua aspirazione alla libertà " dai francesi" che ave v a affermato , ma che , in realtà era una libertà che coinvolgeva qualsiasi altra potenza, compresa, naturalmente l'Italia. Proprio a questo riguardo , il mutato atteggiamento ciel delegato tedesco a Tunisi, Rahn, a proposito dell ' evoluzione politica in Tuni s ia sollevava vive reazioni. Il 7 gennaio 1943 , il ministro tedesco telegrafava a Berlino , che lo trasmise a Roma, un telegramma nel quale si prendeva atto delle novità che si stavano verificando in Tunisia : "In circoli arabi regna viva agitazione per l'ampliamento del potere del Bey e per la creazione cli un vero governo tunisino munito cli tutti i pieni poteri. Già si discutono liste cli ministri. Gli arabi non temono alcuna seria re s istenza, né da parte franc e se data dalle circostanze determinate dalla debolezza della Resid e nza , né da parte delle Potenze dell'Asse dati i riguardi ver so gli umori in Algeria , nel Marocco e nello spazio arabo. Comunque , il Ministro degli Interni recentem e nte nominato tenta già ora cli raggiungere ad avere alle sue dipendenze la Polizia indigena e mira ad una serie di provvedimenti amministrativi . Con tutti i riguardi , dettati clall' interes se militare , verso i sentimenti degli arabi , tale sviluppo non sembra corrispondere alla politica perseguita eia Berlino e da Roma. Io cerco perciò cautamente di fare opera moderatrice e raccomando adesso di trattenere per ora e fino alla chiarificazione della situazione Habib Bourghiba in Europa e farlo parlare alla radio a favore di una auspicata sollevaz ione popolare araba co nt ro gli anglo-americani. Il Console genera le Italiano condivide questa opinione". Evidentemente le autorità italiane non poterono fare nulla contro queste tendenze arabe soprattutto perché la crisi militare sembrava irreversibile con un ' imminente collasso generale .
In tanto si recava in Tunisia per esplorare g li u mori della popolazion e un delegato del Gran Mu fti, Ramzi el Alagiati, il quale, alla metà di gennaio, presentò una sua relazione dalla quale emergeva la profonda opposizione della maggioranza dei tunisini riuniti attorno al Bey ed al Neo Destur, contro la permanenza clelJa Francia in Tunisia , ma nel contempo parevano dubbiosi ed inquieti circa i futuri programmi

dell'Asse , e spec ialmente dell ' Italia, per il loro paese . Il tono generale era dominato dal clima politico di attesa visto che le operaz ioni militari sfavorevoli alle truppe dell'Asse lasciavano intravedere 1' imminente arrivo degli alleati ormai alle porte di Tunisi. Queste conclusioni confermavano quanto il console d'Italia a Tunisi , Giacomo Silimbani , continuava a spiegare alle autorità romane, e cioè che la situazione andava sempre più verso una cris i generale nella quale gli iITigidimenti poli ti ci delle autorità di Roma sembravano ormai fuori tempo e fuori della realtà.
Come s i può capire, l'aspetto militare, con la difficile situazione del fronte per lo schieramento delle truppe de l)' Asse, stava condi zionando ogni prob lema. Intanto i due superstiti Ce ntri mi li tari creati dal1' Italia, il Centro "A", o Gruppo Formaz ioni "A" , ed il Centro "T", o Battaglione d ' Assalto "T", stavano completando i preparati vi per un rapido trasferimento in Tunisia. Del secondo abbiamo, dal Diario Storico, un preciso andamento delle operazioni . L'ordine di parte nza venne dato il 3 gennaio 1943; il 10 gennaio, tutto il materiale del Battaglio ne (macchine, munizioni , mortai , vestiario, ecc.) venne fatto imbarcare a Napo li con la scorta di due ufficiali , degli uomini di pro tezione e degl i a ut is ti . Il grosso del Battaglione, c ioè comple ssi v amente 440 uomini , partì dall ' aeroporto di Sciacca il 14 gennaio (1° Compagnia) ed il 16, dall'aeroporto di C astelvetrano (Comando e 2° Compagni a) . Dopo l'arrivo dei vari co n vogli in T unisia, l' inte ro Battaglione venne mandato in prima linea , il 25 gennaio. Intanto, a parti re de ll ' 11 gennaio veniva creato a Tuni si, un a nuo va Un ità , il Reggimento Volontar i "T" , fonnato da volonta r i italiani tratti dalla colonia italiana di Tun isia, a partire dalle organizzazion i spo rtiv e e dagli aderenti al Fascio di Tunisi a . Complessivamente q uesta fo r za raggiunse , all'inizio, le 650 unità ch e d iventarono in poche sett ima ne da 2 a 4mila. In teressan te leggere q uanto il Comandante dei R eparti Speciali, Ten. Col. Massimo Invrea, scriveva il 21 genna io a proposito del R eggimento Volontari "T". A dir poco la sit ua zione gli apparve grav issima70 Dal documento s i possono stralciare alcuni passi: alle varie voc i si può leggere : " La s ituaz ione del vestiar io e de ll' eq uip agg iamento è qu ella già nota: g l i uomini sono armati di fu ci le o mosc hetto 91; alcuni hanno una bomba a mano (non r is u lta ne a bb iano mai la nciato) ; non vi sono arm i automatiche ad eccezione d i vecchi
7o USSME, Rep. I- 4, Racc. 49/12.

fucili mitragliatori francesi praticamente inservibili per mancanza di accessori e di parti di ricambio. I reparti non hanno materiali di servizio generale; non hanno mezzi di trasporto di alcun genere ... Nel complesso gli uomini sono ancora ai primi elementi. Mancano regolamenti ed istruzioni . .. Mancano stampati di ogni genere (ruolini , giornali di contabilità, ecc ..) .. . I battaglioni indipendentemente dalla loro for z a sono tali solo di nome ; la loro efficienza è praticamente nulla; né, in tali condizioni, è possibile possa migliorare se nsibilm e nte .. . ". Questo quadro di un reparto che contava 27 ufficiali e dai 2 ai 4mila uomini può spiegare le molte incertezze al suo inserimento al fronte; ciononosta nte, il 30 gennaio, risulta inviato al settore operativo di Passo Kukat che era in una situazio ne critica dove, dice un telegramma del coman, dante Massimo Invrea al Comando Supremo i vari reparti " hanno avute perdite gra v issime" . Invano il capo del SIM , gen. Amè ricordava "per notizia" , in una annotazi one a mano sullo stesso documento, che queste unità "erano state selezionate e preparate per co mpiti particolari - guide - informatori - sa botatori - colpi di mano audaci - sfruttando le loro conoscenze di luoghi e di lingua ... " . Mandar] i al fronte significava utilizzarli per attività per le quali non erano per niente preparati e neppure adeguatamente armati . Più o meno uguale era la situazione di una altra formazione creata a Tuni s i, cioè un Battaglione di Camicie Nere che ebbe il numero 570 . Comandante era il Seniore Tetamo con una for z a di circa 600 uomini tutti tratti dalla colonia italiana di Tunisia. Appare quindi piuttosto curioso che in una simile situazione il Comando Supremo, che pure conosceva bene questi aspetti, abbia deciso , il 22 marzo l 943, di ratificare la costituzione da parte de lla R: Aeronautica di un "Battaglione Arditi Distruttori" che dovevano essere istruiti per il sabotaggio di velivoli e di impianti dei campi di aviazione nelle zone retrostanti al fronte.
U n po ' diversa era la situazione dell'Unità arabo-germanica la quale , secondo un telegramma -radio del 10 fe bbraio al Comando Supremo, era forte di 3.500 uomini su 4 battaglioni: uno marocchino , uno algerino, uno tunisino ed uno di addestramento. Secondo queste indicazio ni ciascuno dei primi tre battaglioni aveva " un nucl eo collegamenti, 3 compagnie fucilieri, ciascuna con 9 mitragliatrici leggere, una compagnia armi pesanti con 6 mortai, 6 pezzi contro carri, 8 mitrag liatrici. Battaglione addestramento avevano nu c leo collegamento, 3 compagnie leggere, ciasc un a con 18 mitragliatrici leggere, 6 mortai medi , 4 facilon i anticarro, 2 pezzi controcarro ed una compagnia pe-

sante con 5 mitragliatrici, 2 pezzi di artig lieria , 3 pe zzi controcarro , 8 pezzi contraerei e controcarro semoventi .. .". Ben diversa era la situazione delle unità italiane per quanto riguarda l 'armamento a disposizione. Stralciamo dalla Sintesi del diario storico : "il 25 gennaio . .. gli uomini erano addestrati con i soli fucili mitragliator i francesi (pessime armi) ... l O marzo : Difettava , nonostante le richieste, il materiale: l'addestramento si continuava a fare col solo fucile mitragliatore francese, bombe a mano e fucile '91 ... Il 31 marzo il Battaglione , avuti i fucili mitragliatori Breda '30, si trasferiva .. . " 71 .
In questi primi mesi del nuovo anno 1943, la questione dell'impiego dei Reparti Speciali , italiani o tedeschi, si confondeva con le vicende sempre più negative connesse al fronte . Tutto pareva svolgersi secondo un perverso schema di sconfitta imminente, malgrado l'arri vo di questi nuovi contingenti ed il loro immediato impiego su ll a linea del fuoco. Alla fine del gennaio, la questione si complicò ulteriormente sotto l 'as petto politico, con il mancato sollecito ritorno di Bourguiba in patria. La sorte del capo nazionalista tunisino , liberato dalle carceri francesi ad opera dei tedeschi e consegnato da questi alle autorità roma ne, diventava un vero problema perché il mancato rimpatrio a Tunisi di Bourguiba e dei s uoi compagni di carcere stava prendendo agli occhi dell'opinione pubblica tunisina la fonna di una seconda detenzione , magari più gradevole, ma sempre detenzione. Le ripercussioni sull'event uale impegno arabo a fianco cieli' Asse si manifestava evidente. In questo senso, una lettera del 20 ge nnaio di Bourguiba al M inistero degli Affari Esteri, chiariva assai bene il suo pensiero che il Ministero, riferiva a l ministro Ciano, lo stesso giorno, ricordando i tre punti essenziali della missiva del capo nazionalista. Bourguiba riteneva " urgente la partenza s u a e dei suo i compagni .. . Una sua lunga permanenza in Italia ... potrebbe essere interpretata come un a dorata prigionia". Inoltre la sua ripresa politica in patria avrebbe dato nuovo impulso al Neo Destur ed incitarlo alla lot ta 'nazionale', ma non specificava ulter iorm ente l'orientamento di questa lotta; infine nella politica del fascismo venivano scorti molti aspetti in teressanti per i tunisini.
Chiaramente la lettera di Bourguiba rappresentava una delle tante fasi della sua astuzia politica e non mutava sostanzialmente il suo attendismo rigu ardo al co nflitto in corso . A tal punto questa posizio ne era avvert ita dal ministero degli Esteri italiano che, alla luce cli queste mancate

svolte, il comm. Mellini chiedev a, il 28 gennaio, al mjnistro degli Esteri se non fosse il caso di: l O '' invitare il Coma ndo Supremo a fa r conoscere se e s ino a qual punto si ritenga utile la collaborazione degli arabi", visto che ogni impegno in questo senso pare condizionato da una dichiarazione di indipendenza del paese, dicruarazione che Rom a non poteva accettare; 2° "chiedere chiarimenti alla Ge,mania s ulla sua politi ca tunisina" visto alcune iniziative di autorità ted esche militari locali che p a rlavano di ' indipende nza' ; 3° porre Bourguiba in alternativa politica s ulle scelte del Neo Destur. Si prospettava anche una cauta di ch iai·azione di indipendenza che in realtà non era una vera indipende nza ma copiava le a nalogh e dichiarazioni di indipende nza proclamate dalla Gran Bretagna in Egitto nel 1922 ed in lrak nel 1933 , dichiarazioni che non la aveva estromes sa affatto dalla " vera" direzione del paese.
Sul piano militare, l'evento più interessante fu il passaggio , il 26 gennai o, del Comando Superiore delle Forze dell 'Asse (gen. Von Arnim ) a lle dirette dipendenze d e l Comando Supremo italiano Questa decisione non modificava per niente la crisi rrulitare in atto che, a pa1te ce1t i epi sodi di res istenze vittoriose, registrava continui sfaldamenti delle posizioni delle forze armate dell'A sse . Qu es ta situaz ione prese ntava una gravità ecceziona le, ma la miopia delle autorità politiche di Roma pareva non accorgers i dell 'imminente tracollo e che proseguivano nella loro assurda ricerca di affennazione ne l paese. Un primo segno fu la sostituz ione , ag l i inizi di febbraio, del con sole d'Italia a Tuni si, Giacomo Silimbani, ritenuto troppo tiepido verso le tesi oltranziste fasciste, con un nuovo-vecchio Console generale, Em ico Bombieri , c he già, neg li anni Trenta , si e ra disti nto nella stessa sede per il suo infuocato nazionalis mo. Eg li fu ritenuto il più adatto ad allacciare co n il Bey un certo dialogo e, nel contempo, a dar e a ll a collettiv ità itali a na d i T unisia quelle assicurazioni che parevano poco garan tite dalla politica araba delle autori tà tedesche. Per g li italiani di Tunis ia, la loro fede nella vittoria non pareva graffiata dalle vicende militari pur così negative. Ben lo ha notato u na storica francese, Christ ine Levisse-Touzé , la quale ne ha così ricordato questa iniducibile fiducia: "En clépit de leu r défaite en Libye, les ltaliens (dì Tunisia) rèvent toujours d ' une Tuni s ie italicnne. Le 4 décembre 1942, des groupes d'act ivistes de sce ndent dans la rue pour crier solidairement " Tunisia nostra". S ix cents jeunes Italiens s'engagent dans la M ilice .. . » 72 .
72 C. Lc v isse-To uzé , L'Afrique du Nord dans la guerre ( 1939-1945), Pari gi, Albin Mich e l, 1998, p. 358

Una continuità specia l mente destinata a rincuorare la collettività italiana cli Tunisia che vide, quale segno della "ripresa" la ricomparsa nelle edicole del giornale " L'Unione", a lungo portabandiera del rivendicazionismo oltranzista del fascismo e che, nel primo giorno della ripresa, il 21 gennaio 1943 , riportava in testata tre volte "Vincere!" . E nel testo veniva ribadita l'intera e vecchia argomenta zione , sia sulla legittimità della rivendicazi one fascista s ulla Tunisia , sia sulla " inevitabile" vittoria finale dell ' Asse. E ne l s uo diario in quella data, un attento osservatore francese, Jean Pupier, a scrivere : " Hier, nos "vainqueurs " italiens se so nt présentés en maìtres, dument autorisés par leurs propres maìtres allemands, pour installer leur journ al "L'Unione" .. .En manchette du premier numéro, on lit le cri de guerre « Vincere! Vincere! Vincere! ", ce qui est d ' un haut comique à l 'he ure où les Italiens se lamentent de ne pouvoir fuir assez vite sur !es routes de Libye . .. » 73 . Era la solita polemica che ritornava, ma Bombieri non pareva cedere alle co nting enze militari negative del momento .
Per manifestare questa continuità fascista, il nuovo console si premurò cli esse re ricevuto dal Bey, volendo lasciare capire che anche la mas s ima autorità tunisina appoggiava la soluzione italiana. Ed ancora una volta , il ministro degli Esteri Ciano, nelle sue istruzioni a Bombieri de l 22 febbraio , ribadiva le vecchie tesi del governo fascista. Alla vigilia di essere ricevuto dal Bey, il 24 febbraio, il ministro scriveva al nuovo console: "In occasione vostra vis ita al Bey potrete rassicurarlo che governo italiano guru·da con comprensione e simpat ia alle aspirazioni del popo lo tunisino ... "74 . Era il solito ritornello che parlava di amicizia , di collaborazione , di comprensione e di simpatia, ma che evitava accuratamente cli pronunciare l'unica parola che avrebbe dato ai tunisini un netto orientamento favorevole ad una partecipazione mili tare attiva a fianco delle truppe dell'Asse, e cioè la parola 'indipendenza'. I risultati della visita non furono brillanti e Bombieri lo segnalava al Ministero , il 23 febbraio, dando notizia che il Bey aveva ribadito le proprie rivendicazioni circa una vera e mancipazione dai molti poteri ancora in mano ai francesi, e ciò lo induceva a ritenere ormai scivoloso ogni dialogo con i poteri locali. E poco dopo il gen. Ambros io confermava la duplicità della posizione dell'Italia. In un messaggio clell'8 marzo , che venne spedito a ll e autorità militari italiane in Tuni-

sia, se nza pera ltro comunicarlo al Minis tero de g li Es teri c he se ne lagnò, veniva de tto c he : verso le a utorità fra ncesi " le forz e armat e ita liane terran no, fino a nuo vo ord ine, la massima ri ser vatezza ... " e ne ll a questi one araba " il contegno v e rs o gli arab i d eve essere riservato pur d im ostrando ve rso di loro simpatia ... L'a ra bo dev e convincersi c he gli s i vuo le bene ... Debbono essere ev itate però promesse che , comu nque, possano imp eg nare il r eg ime p o litico ... " , Alla luc e di queste dich iaraz ioni e della po li tica generale dell ' Itali a la quale pare va non te nere asso lutame nte conto della grav iss ima s ituazi o ne militare, si p oss ono capire le proteste d e l mini s tro ted esco a Tunis i Ra hn c irca la in co mprens ione d a parte de lle autorità it a li a ne nella questio ne tunisina. " Mi ha detto, precisava Mellini , il 16 marzo, di non riusci re a comprendere ta le atte gg iamento dell'Ita li a .. .Ora abbiam o bisogno deg li arabi e dobbiamo utilizzarli. Vinta la g uerra l ' Italia potrà fare q uello c he vuole ... " . E r a ce rtamente una sce lta politica d is inv o lta, ma l ' ora che e ra grav issi ma la im pone va. Comunqu e le autorit à ita li ane non mutarono la loro intran s igenza e fin irono per sacri ficare a nc he la pedi na Bourg uiba , pur di non rinunciare ad una ipotes i politica che s i a llontan ava sempre più. Il discorso del capo tuni s ino a " R a di o-Bari" del 6 april e confermava il fa llim ento di o g ni s ua 'manipolazione ' da parte dell' Italia. Nel discorso si ringraziava l ' Italia per quanto avev a fatto per la libera zione d e i des tu r ia ni dall e prigioni fra nces i , s i innegg iava alla ' naz ione tunisin a', alla fiduc ia nei s uoi gr a ndi des t ini e s i au s picava la 'v ittori a' : " la vittoria sar à dal no st ro lato fi no a che noi sarem o convint i che Dio è con noi ... " , Eviden te mente il disco r so co ntro il co lonia li smo pareva tutto impeg n ato contro la Fra ncia ed il s uo vecchio reg ime, ma questa 'vittoria ' non ri so lveva i gra ndi dubbi c irca i due schi e ra menti militari in lotta proprio in Tu ni sia. A ncora una volta l 'equivo co re g nava ed il fa tto che , pochi g iorni dop o il discorso ed il rimpatri o di Bourg uiba, il fronte doveva nuovamente a rretra re lasc iando Mon as tir alle truppe allea te, no n e ra fonte di grande impegno mil itare a fian co degli ita lo-te deschi da parte degli ara bi . E que sti eventi mi litari nega tivi per le for ze italo-te desche no n venn e ro a mutars i mal grado l 'impiego d ei re parti ara bi tedesc hi e arabi italiani.
L 'ass urdit à di talun e resistenze del gov erno italiano ad e la rgi re promesse di indipendenza a ll a Tunisia cd agli arabi tutt i , in un meri to così drammati co s ul piano milit are, appare ev ide nte. In fo ndo qu es ta dichiarazione po te va avere un qualche r is ultat o sugli at teggiame nti degli ara bi sempre in certi e cauti ci rca le loro ad es ioni alla ca usa del -
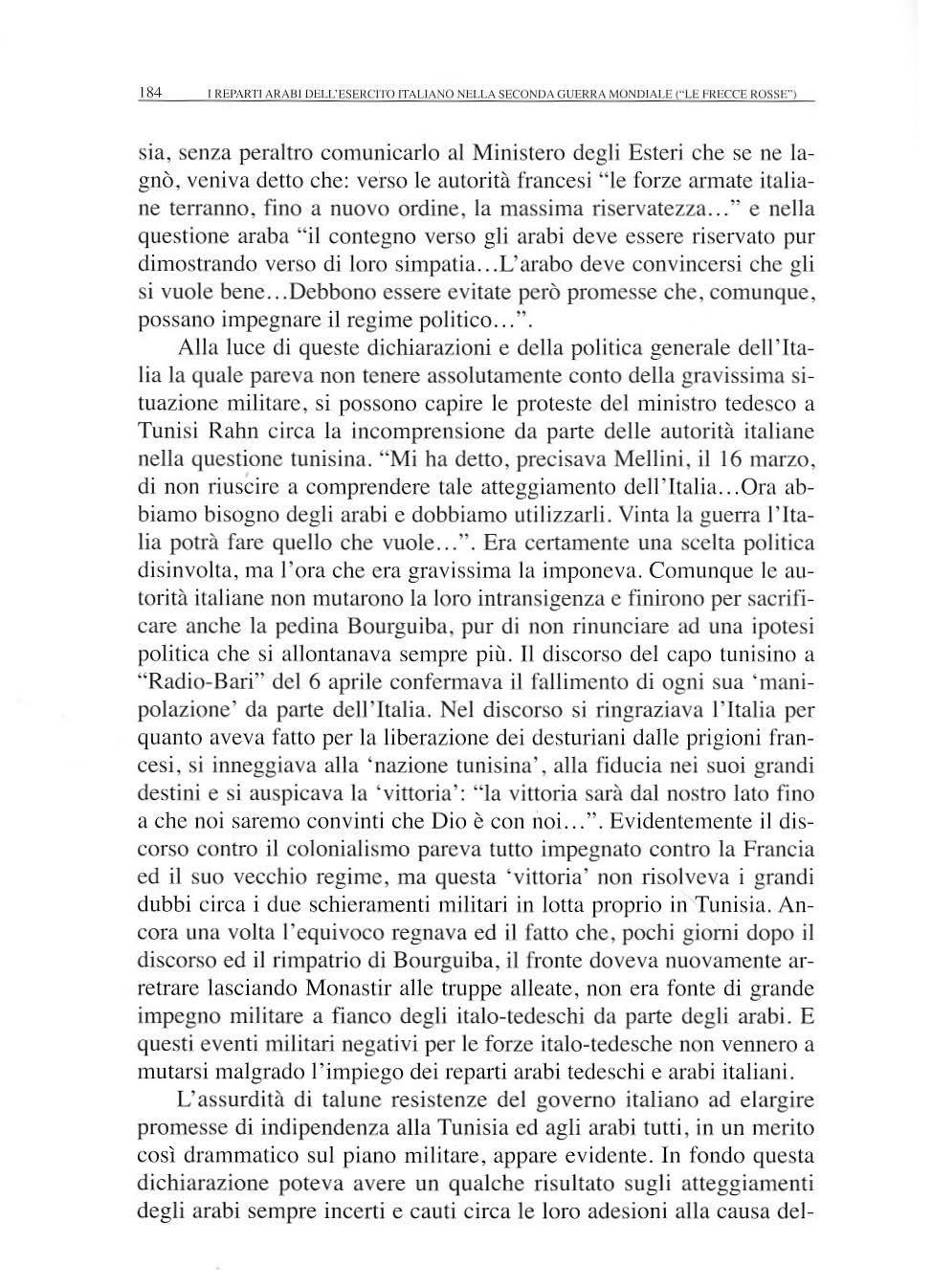
l'Asse, ormai così forte mente compromessa dalla soverchia potenza delle for ze armate degli Alleati. Eppure le autorità romane si cantonavano ancora in reticenze e rifiuti. Un ulteriore seg no di questa incapacità politica fascista si può avere ricordando che , prop ri o in q uei g iorni di aprile 1943 , concludeva i propri lavori una speciale Commissione del Ministero dell'Africa Italiana circa la " so lu zione" da dare alla questione tunisina , dopo la "sicura v ittori a" delle armi italiane. Si trattava di un documento che riprendeva molti altri piani precedenti e li armon izzava con le esige nze, che venivano dichiarate "irrinunciabi1i" , de ll ' It alia fascista. S u l piano militare veniva ricordato che l ' auspicata sovra nità dell'Italia su]la Tunisia avrebbe " strappato alle altrui mani la pistola puntata contro l'Italia e in particolare contro la Sicilia e la Sardegna" ed inoltre avrebbe dato modo all ' Italia di inserirsi in quel Nuovo Ordine Mediterraneo e di ottenere finalmente il proprio spazio vitale. Interessante seguire il documento nelle sue cinque soluzioni . La prima era una so vranità italiana con governo diretto; alla qua le seguiva un a sovranità italiana co n governo indiretto. La terza soluzio ne era l' incorporazione della Tunisia nella "Comunità Imperiale di Roma"; la quarta era il regime di protettorato ed infine l ' ultima era un regime di indipendenza limitata con ampia concessioni all'Italia di basi militari permanen ti75 . Era questo documento non solo intempestivo ed impolitico, ma addirittura assurdo in quanto ve niva redatto alla vigilia del crollo militare.
Evidentemente, pur di fronte ai drammatici eventi militari nordafricani, il senso di un sa no reali smo non s i manifestò presso le autorità fasc iste, che invece contin uavano ad illude rs i di potere avere ancora una "politica araba". Persino Mussolini se ne fece portavoce allorquando pronunciò , il 5 maggio, quando ormai le anni stavano per tacere in Tunisia con la sconfitta ital iana, l'ultimo suo discorso dal famoso balcone di Palazzo Venezia. In questo aggressivo discorso, egli evocava il fatto che, proprio in quel momento, "milioni e milioni di italiani soffriva no di un indefinibile male , che si chiamava il male d' Af1ica" ed a nnunciav a che per guarirlo non v i era che un rimedio: "tornare . E torneremo" 76 La posizio ne del duce , in queste ultime settim ane del suo potere , appare condizionata da una vera ossessione di una i nevitabile rivincita ed in ta-
75 FONTE : ASMAE , Tunisia, busta n. 16 , fase . I .
76 In «11 Po p olo d'Italia» del 6 maggio 1943 ed in B. M Opera Omnia, voi. XXXI, p. 178.

le visione le autorità del regime operavano. Lo slogan era ben noto: "Là, dove noi fummo, là, noi ritorneremo!"
Eppure dal conso lato italiano cli T uni s i , come da ll e autorità militari s tanziat e nella Tuni s ia , i segnali non mancavano. rJ 14 aprile , il conso le Bombi cri scriveva in un te legramma "segreto-non diramare" : " Nuova situazione militare ha ridotto ad una vera fortezza as sed iata lo s pazio di ten-a tunisino occupato dalle truppe. In un a s uperfici e ristretti ss ima si trova agglomerata una popola z ione di oltre 800mila a nim e, per lo più co mbattenti. Nuovi e grav i problemi si so no deline al i .. .". TI 22 aprile, il to no appare ancora più drammatico: " Il recent e r ipiegamento delle truppe dell'Asse s u di una linea non più molto distante dalla città d i Tunisi, in uno spazio ristretto in cui vivono, fra militari e civ ili, poco meno di un milione di persone, ha reso la vita di tutti ... diffici le e pen osa ... ". La c risi nella co llettività italiana cli Tunis ia appariva totale, nella sua duplice componente de lla fine d e ll e grandi illusioni di annessione che, fino all ' ultimo il regime fasci s ta aveva a li me ntato , e de ll e minacce a ll a sua stessa so pravvive nza alla luce delle annunciate ritorsion i francesi gau llis te contro gli ita liani definiti tutti " fascisti ", g ià al ce ntro di anno se polemiche politi che Sul pi a no militare, le notizi e che si possono d es umere da g l i studi pubb l icati al r iguardo , e specialme nte dall 'o pera di Mruio Montanari , c irca la si tu azione generale della guerra nordafricana , sono ben note; quanto ai Reparti Speciali, ne ss uno ne ha fatto finora un cenno comp less ivo . In un g i udizio ge nera le si p osso no scorgere le riserv e c he il coma ndant e delle for ze armate in Tunis ia ; Mar. Messe, ha espresso nel s uo vo lum e di memoria. Viene infatti citato, in una sua relazione al Comando Sup remo, in data 13 ma r zo 1943, che "attraverso sc ioglime nt i e conlrazioni cli reparti ... le Grandi Unità risentono de lla eteroge nea pro ve ni e nza degli elementi ... ". Ad ess i ve ni vano fatte osservaz ioni proprio poco benevole: "In merito a i reparti com plementi finora g iu nti debbo fare presente: u n insufficiente ad d estrame nto, un a scarsa co noscen za delle armi, la completa ignoranza delle armi a nticarro ... "77 . Una altra te s timonianza , non su tutti i Reparti Speciali, ma s ul Reparto "T" , ci viene da una attendibile pubblicaz io ne di Carlo De Risio, il qu a le narra , co n accor ate parole , la triste so rte di qu es ti volontari. "Il nostro Servizio (SIM) aveva costituito uno speciale reparto for mato da italiani re s identi in T unisia , co noscitori della lin gua araba,

dei costumi e soprattutto dei luoghi. Il SIM aveva ritenuto di dare corpo all'unità in previsione di "sorprese" alle spalle dell ' armata italo-tede sca operante in Libia-Egitto. Il provvedimento rientrava nel quadro delle predisposizioni del Servizio che, prima dello sbarco anglo-americano nel ! ' Africa Settentrionale francese, aveva ripetutamente richiamato 1'attenzione dello Stato Maggiore Generale e anche dei tedeschi sulla estrema vulnerabilità del fronte potenziale al di là del confine libico-tunisino. Il reparto fo1mato da italiani residenti in Tunisia era stato riunito nei dintorni di Roma per l'addestramento, agli ordini di un ottimo ufficiale, il maggiore Lanfranco di Campello78 . Questi , secondo le direttive ricevute, trasformò gli uomini che gli erano stati affidati in veri e propri commandos idonei all'impiego operativo, anche paracadutato, e per quello informativo ... "
79 Ma anche in questo caso viene rilevato che la storia dell ' impiego di questi uomini diventò drammatica allorquando le avverse condizioni belliche po1tarono le truppe italo-tedesche al ridotto tunisino. In questa si tuazione militarmente disperata "il reparto trovò un impiego tra i più scriteriati Invece di essere utilizzato per i compiti ai quali il SIM lo aveva destinato , fu mandato allo sbaraglio ed esordì nell ' attacco di una posizione nemica fortemen te difesa. L' assurdo ordine fu impartito dal gen. Vittorio Sogno, che pure era stato capo del SIM tra il 1932 e il 1934". Gli sviluppi di questo primo scontro furono chiaramente negativi . Avendo s ubìto notevo li perdite, i superstiti uomini de l reparto "furono s ucces sivamente assegnati a unità div erse : in parole povere, l ' intero repa1to fu prima sacrificato e poi smembrato e non poté più essefo ricostituito . Pochi uomini sopravvissero all'ultima battaglia in Tunisia ... " .
Da quanto si può de sumere da queste poche testimonianze e da altre notizie marginali si sa che il ricorso agli uomini dei tre Centri ormai in Tunisia ed ancora in vita, il centro "A", il Centro "T" ed il Centro "M . S ."sia s tato disordinato e del tutto lontano da quell'impiego definito dai vari docum e nti deila loro creazione. Aggregati alla rinfusa a fianco del Regg ime nto Volontari Tuni sini e del Battaglione Camicie Nere, gli uomi n i dei Centri furono messi alla disposizione del XXX° Corpo
78 Risulta piuttosto curioso che, dalla documentazione d ' archiv io sui Ce ntri M ilitari, il nome di ques to Maggiore non risu lti , né adibito al Centro «T }}, né ad alcun altro Centro.
79 C. D e Ri sio, Generali, servizi seg re 1i e fascismo. La guerra nella guerra: /940 - 1943, Mi lano, Mondaclori , 1978, p. 106.

d'Armata ed inviati in varie posizioni in prima linea. Di questo impiego del tutto improplio alla specifica preparazione di queste Compagnie non possediamo tutti i vari Diari Storici. Solo del Battaglione d'Assalto "T" e del 1° Battaglione Volontari Tunisini, possediamo sintetici Diari Storici che riportiamo, e da questi documenti che furono redatti tardivamente, dai loro due comandanti, nel campo di prigionia gollista di Saida, sulla sola base del ricordo , possiamo risalire alle loro ultime attività di impiego sul fronte. Il quadro non appare di certo roseo . Secondo i documenti redatti dal Maggiore Leo Cataldo, comandante del 1° Battaglione Volontari "T", l'impiego di questi uomini, tra il gennaio 1943 e l' 11 maggio , data della resa, appare importante, ma tante appaiono le annotazioni negative , sia sulle armi, sia sull ' impiego . I fucili mitragliatori Breda "30 vennero r icevuti solo il 31 marzo, ma non arrivarono subito i promessi mortai da 81 che solo il 24 aprile poterono essere impiegati ; il J2 aprile, in occasione di un ripiegamento si deve ricordare che "nessun mezzo meccanico o animale" era in dotazione al reparto che dovette procedere a piedi dopo una marcia "faticosa ed estenuante" durata un giorno; gli autocarri assegnati , invece di arrivare all'una , arrivarono alle 10. Le Camicie Nere furono addirittura "adoperate" come battaglione lavoratori anche perché nella fase finale molti arabi preferirono defilarsi dai vari servizi alle truppe dell ' Asse .
Per quanto riguarda i mi l itari nazionali dei vari Centri il loro com- · portamento fu molto positivo La collettività italiana di Tunisia contribuì con generosità, sia alla parte militare fornendo oltre 4mila volontari, sia alla parte dei servizi di generica assistenza alle nostre truppe. Il giudizio sugli uomini appare peraltro altamente elogiativo: "Elementi intelligenti, pie ni d i buona volontà nell'apprendere , zelanti e scrupolosi nell'adempimento dei compiti che loro venivano affidati. Queste qualità positive furono largamente tenute presenti dai Comandanti di reparto per ottenere il massimo rendimento ne l minor tempo possibile. Però, nonostante ciò, i reparti erano sempre sprovvisti di tutto il necessario (armi, mezzi di collegamento, mate r iali di uso generale, mezzi di trasporto), per quanto venisse ro fatte giorna l me nte le richieste. Furono dati fucili mitragliatori francesi (pessime armi). L'addestramento ed i tiri, quindi , venivano effettuati con il fucile '91 , il fucile mitragliatore francese e bombe a mano . . . " 80 Pur nella catti va sorte, no n certo a loro imputabile, i militari di questi gruppi sentirono molto il senso della

patria e le considerazioni che il loro comandante, Maggiore Leo Cataldo, affidò ad una speciale relazione Brevi cenni sull'arruolamento, .spirito , addestramento ed impiego dei volontari tunisini, sono altamente positivi. E nello stesso documento non mancano annotazioni conclusive molto interessanti circa i difetti connessi alla nascita ed all'impiego di tali Battaglioni:
l. L'arruolamento avrebbe dovuto farsi con maggior severità nella scelta degli individui.
2. Si sarebbe dovuto provvedere in tempo ai quadri idonei ed al materiale necessario.
3. Gli elementi erano intelligenti , di pronta intuizione, ma qualche volta apatici ed animati da uno spirito non solido di sogge zione alla disciplina militare.
4 . La vicinanza alle proprie famiglie fu alquanto dannosa perché tutti , dopo ogni bombardamento, desideravano andare a Tunisi.
5. In combattimento dimostrarono coraggio, intelligenza , spre zz o del pericolo . Però alcuni, dopo uno sfortunato combaWmento, facilmente si disperdevano e s i recavano a Tunisi. Si ripresentavano volontariamente dopo due o tre giorni di assenza.
6. I Battaglioni costituiti ebbero le anni necessarie solo pochi giorni prima dell'impiego. Mezzi di collegamento scarsissimi , mezzi di trasporto meccanici, quasi nessuno. Si disponeva in ciascun Battaglione solo di pochi muli e di un automezzo leggero.
In conclusione , l'elemento era ottimo se saputo comprendere e guidare . Ottimo è stato il contegno tenuto nell ' attacco e nella difensiva. Ottimo impiego hanno trovato anche uomini isolati presso Comandi e reparti, come interpreti e come informatori81
Le magre informazioni che ci vengono dalla lettura di questi Diari Storici ci dicono quanto te nace sia stata la resistenza ad oltranza di questi Battaglioni che, impiegati male, non si sottrassero alla lotta per impari che fosse .
Sul piano generale, una osservazione va peraltro fatta e riguarda l'opinione pubblica italiana che venne tenuta sotto pressione fin dall'inizio di maggio, spesso tenuta all'oscuro di ogni fatto negativo, ma con notizie piuttosto banali . Gli "ordini alla stampa" dati in quei giorni di estrema lotta in Tunisia sembrano indicare un certo desiderio delle auto1ità fasciste di non catalizzare l'attenzione degli italiani sulle dram-

matiche vicende nordafricane . L'imbarazzo regnava circa gli ordini da dare alla stam pa. Ridicole appaiono ce1te indicazioni, come quella del 5 ma ggio, nella quale, in piena battaglia finale in Tunisia si ordinava alla stampa di prendere nota che "nei figurini della moda femm inile le gonne vanno Leggermente allungate oltre il ginocchio". E le citazioni di questo tipo potrebbero mo ltiplicarsi82 . L'unica nota del Ministero della cultura popolare ai giornali relativa ai combattimenti in Tunisia s i trova il 9 maggio che recita: "Intonazione dei titoli e dei commenti serena e sobria valu tazione della serietà dell'ora : riafferma zione della decisa volontà di combattere sino alla vittoria . Evitare sbandieramenti reto1ici" . E la spiegazione ufficiale dell'imminente sconfi tta veniva data in sei punti che i giornali dovevano illustrare nei vari co mmenti:
"1. Durata della resistenza in Tunisia;
2. Difficoltà dei rifornimenti attraverso il Mediterraneo;
3. Italiani e tedeschi si so no battuti contro le armate inglesi, americane e francesi, le quali avevano una schiacciante superiorità di uomini e di mezzi;
4 L' Inghilterra ha concentrato contro la sola Italia tutte le forze dell'impero, con l'ausilio nell'ultimo periodo delle forze americane e francesi;
5 La resistenza degli italiani e dei tede schi è stata leonina come la stessa propaga nd a del nemico ha dovuto riconoscere;
6. Riaffermare la volontà del popolo italiano di combattere fino alla vittoria, volontà oggi più deci sa che mai" .
Dopo quell a data, una so la breve nòta, il 13 magg io , relativa alla fine dei combattim enti.

Oramai la s ituazione militare era disperata e la sconfitta, con onore, anche degli uo min i dei Centri Speciali inevitabile. L' 11 magg io , co n la resa di Capo Bon da parte delle residue forze armate cieli' Asse, anche l'avventura dei Raggruppam enti s peciali , oramai sba ndati eridotti a sparute schiere in pieno disordine, si concl udeva con la capitola zione agli eserciti nemici .
Dopo la sco nfitta militare in Tunis ia, la fine del regime fascis ta e la caduta di M ussolini segnarono la fi ne dell'intero edificio della s ua "po-
litica araba". Volendo affrontare nel suo insieme la questione nordafricana con la sua tragica conclusione militare si può sen z 'altro essere d'accordo con quanto, nella sua puntual e ricostruzione dell ' intera campagna nordafricana , ebbe a scrivere il gjà citato Mario Montanari: " Il punto di partenza è costituito dall'impreparazione politica e militare della campagna e dall ' insufficienza di mezzi con i quali l'impresa iniziò e proseguì. Impreparazione ed insufficienza che, è doloroso ed irritante dirlo , stavano accompagnando le nostre anni dallo s ciagurato I O giugno 1940" 83 .
Quanto ai Raggruppamenti Speciali attorno ai quali si era costruita una speranza di grande successo , non rima sero, dopo la re sa di Capo Bon , che resti sparsi delle antiche iniziative : alcuni militari dei Ce ntri, che non erano ancora partiti per il fronte nordafricano , s i trovarono allo sbando in Italia. Secondo noti z ie ufficiali , "parteciparono alla dife s a della città -e rano a Palazz o Bras chi - e poi aderirono in gran parte alla Repubblica Sociale Italiana" . Quanto ai nazionalisti del gruppo de l Neo Destur , che si erano rifugiati in Italia sotto la guida di Habib Thameur onde evitare le reazioni dei france s i gaulli s ti e degli anglo americani, essi si dispersero alla ricerca di una via di fuga in que s ta nuova situazione. In Tunisia, l ' ingente mas s a deg li italiani di Tunisia rimase nel paese arabo; e questi italiani che si erano largame nte prodi g ati a favore dell ' As se e delle sue truppe, furono esposti alle vendette e alle viole nze dei nuovi ve nuti ingles i , ame ricani , ma soprattutto dei france si gaullisti. I pochi italiani di Tuni sia rimpatriati alla vigilia della fine dei combattimenti, furono , dopo l'arrivo in Italia, del tutto abbandonati dalle autorità italiane al loro amaro destino. E si può dire che es si, in patria ed in Tunisia , furono le vere vittime sacrificali delle ambizioni di una politica che non era mai riuscita ad andare oltre alle plateali dichiarazioni ed agli intrighi di una po litica miope del tutto inefficace .
Rid icolo e drammatico quanto ribadì ,in occasione de] Capodanno 1944, Mussolini , diventato capo della Repubblica Sociale Italiana, a l capo iracheno, Rashid Ali al Ghailani , ancora in esilio nell ' Italia del Nord: "Sono convinto che il 1944 segnerà la vittoria delle potenze del Tripartito e quindi la resurre zione del vostro paese " .
Degli arabi e delle loro formazioni militari non si parlava ormai più : tutto era tramontato con la perdita dell'ultimo lembo di terra africana. Ed in ogni caso si può dire che mai la previsione di Mus solini cli una immine nte vittoria si doveva rivelare tanto ridicola ed iITeale .

Do c umento n 24
Allo scopo di concertare una politica omogenea nei riguardi dei molti problemi connessi alla questione araba e tunisina ed all'impiego dei reparti speciali nel conflitto, i due governi dell'Asse decisero di riunire a Roma, il 2 gennaio 1943 , una conferenza bilaterale ad alto livello con la partecipazione tra gli altri, da parte italiana, del conte Leonardo Vitetti , direttore generale dell'Ufficio Ili del Ministero degli Affari Esteri,del Comm.. Mellini dello stesso Ministero, del gen Cesare Amè, capo del S IM, del barone Michele Scamm.acca, incaricato del collegamento con il Comando Supremo e, da parte tedesca, del principe von Bismarck dell'ambasciata tedesca a Rom.a e del rappresentante politico tedesco a Tunisi Moelhausen.. Diamo qui di seguito le 'presentazioni' degli argomenti relativi alla parte militare araba, cioè i punti I, 6, 7 e 8 .
La politica dell ' Asse non può essere che di attesa, dato che il fattore militare è per ora predominante : una linea politica potrà essere s tabilit a ed a pplicata colà con successo solo quando una maggiore este nsione e d una mag giore consolidazione della nostra occupazione daranno alle Potenze dell'Asse la forza e l'a utorità necessaria per imporla e per portarla a buon fine . Ogni iniziativa a carattere polit ico , anche se appaia interessa nte e utile se mbra perciò vada considerata per ora con prudenza e cautela per non pregiudicare la linea politica che sarà possibile stabilire al momento opportuno dopo che la situazione mi litare si sarà stabilizzata. Allo stato attuale delle cose, seco ndo istruzioni impartite dal Duce e comu nicate al Governo Tedesco, è da escludere ogni dichiarazione o impegno circa l'indipendenza ed il futuro assetto politico della T unisia .
a) - Il Gov erno tedesco ha info rmato che l' iniziativa tedesca di inviare tale unità in Tunisia ha carattere puramente mil itare.

b) - L'eventuale utili t à dell ' impiego dell'U nit à può essere giudicato solo dalle autorità militari dalle quali essa d ipende . Da un punto d i v ista politico si ritiene che ogn i impegno di essa che non fosse puramente militare, sarebbe destinato ad essere controprod ucente specialmente se al di fuor i dell'autorità di un capo arabo e dovendo si esclude re per il momento almeno ogni im peg no cli carattere politico circa il futuro dei Paesi del Nord Africa.

c) - La notizia de ll a partecipaz ion e di forze arabe all a Unità, se dovesse rivestire carattere politico ed essere connessa con il nazionalismo arabo potrebbe essere accolta sfavorevolmente sia dai Tunisini che dagli Arabi in genere in particolar modo se qualche Capo arabo cli provata no s tra fiducia e animato da spirito di collaborazione con I' Asse e modera to non dichiari chiaramente e pubblicamente di approvare l 'i niziati va.
- Il Princ ipe Bismarck: "L'unità tedesco -arabo - marocchina è già in viagg io per la Tunisia come elemento dell'esercito tedesco e dovrà costituire il nocc io lo delle forze arabe".
- Il Generale Amé pone il quesito de ll e basi politiche per l'impiego militare degli Arabi.
- Il Ministro Vitetti : "Ricordo come secondo le direttive del Du ce vada esclusa in modo assoluto ogni promessa o impegno circa 1' indipendenza tunis in a Quale altro o biettivo potrebbe essere quindi utilmente indi cato agli a rabi per indurli ad arruolarsi e a combattere?" .
- Il signor Mo ellhausen : " L'a rr ivo di Bou Rg hib a in Tunisia sarebbe già un a forza per co nvi nc ere g li arabi a lottare".
- II Ministro Vitetti : "A prescindere dal problema desturiano ritenete che g li arab i si batteranno accanto al nucleo c he si inv ia laggiù? E po i , poche migliaia di uomini costit u iranno un contri bu to efficiente a llo sforzo militare dell'A sse?"
- 11 Colo nnello Von Waldenburg com uni ca che le autorità militari tedesc he sono convinte che in questo mo mento anche poche migliaia di Arabi arruolati p ossono essere milita rm ente utili.
- Il signo r Mo ellhausen r iaffe rma che se g li Arabi avra nno un uo mo capace di trascinar li , combatteranno.
- II Principe Bismarck: "Non avete nulla da d ire circa la Leg io ne tedesco -araba-marocchina in quanto tal e?" .
- Il Ministro Vitetti: Nulla .
- Il s ignor Moellhausen - Riprende la questione dei rapporti con gli Arabi , precisando che questi possono orientarsi o verso il Bey o verso il movimento nazionali sta desturiano, ed osserva che le promesse da fare al Bey costerebbero di più.

- Il Mini stro Vitetti: " Ciò è discutibile. Des idererei piuttosto conoscere come il Bey considererà la politica dell'Asse nei confronti dei desturiani armati".
- TI signor Moellhausen : "Non ritengo che il Bey si opporrebbe in modo netto. Ma comunque non ho elementi precisi per rispondere al quesito".
- Il Comm . Mellini non credo sarà facile c reare attorno alla Unità tedesco -arabo-marocchina, inquadrata nell'esercito tedesco, un movimento di arruolamento , a meno che non si tratti di elementi a carattere mercenario . Gli Arabi marceranno solo se avranno un Capo da cui direttamente dipendono. Perciò alla Le gione costituita in Italia si è dato per Capo il Gran Mufti. Forse ora in Tunisia sarebbe meglio togliere al movimento arabo un carattere puramente nazionalista che potrebbe poi ritorcersi contro di noi e creare intanto complicazioni con la Francia, per sos tituirlo con quello, più ampio, reli gioso e razziale.
- Il signor Moellhausen: "Non so se mettere sul piano islamico, religio so e razziale la questione, s i attagli agli orizzonti limitati de lla mentalità tunisina".
- Il Ministro Vitetti osserva che , esclusa l'opportunità di trattare con il Bey, i rapporti italo -germanici con gli Arabi riman gono limitati alla possibilità di accordi con Bou Rghiba.
- Il signor Moellhausen ripete che non crede che sia necessario dare a Bou Rghiba delle assicurazioni concrete . Si dovrebbe rimanere s ul terreno generico e sperimentale .
- Il Principe Bismarck rileva che l'azione militare dell'unità tedesco -arabo-marocchina può av e re inizio indipendentemente dagli eventuali accordi con Bou Rgh iba.
- Il Conte Vitetti : "Allora il problema si pone in questi termini: "l'unità arabo -marocchina si rechi intanto in Tunisia . Nel frattempo in Italia avranno iniz io i contatti con Bou Rghiba , e successivamente si adotteranno le decisioni che s i riterranno opportune".
- Il Generale Amé rispondendo ad un quesito postog li dal Ministro Vitetti, precisa c he gli Arabi residenti i n Italia sono attualme nte un centinaio e fanno sistema col seg uito del Gran Mufti.
a) La si ritiene opportuna.
b) Occorre predisporla sin da ora . Ma attendere a decidere la partenza a quando le Autorità Militari considereranno la s ituazione consolidata per non esporre il Gran Mu f ti e sc uotere il suo prestigio.

c) La missione potrebbe avere carattere militare politico, occupars i spec ialmente dei contatti con g li Arabi della Tunisia, dell'Al geria e del Marocco, di servizi informazioni e propaganda , di atti di sabotaggio e di cost it uz ione di bande irrego lar i.
d) Le autorità mi li tari italiane potra nno fornire alle autorità tedesche informazioni sulla composizione della missione militare che, alle dipendenze del S.I.M., era stata già progettata per l 'accompagnamento del Mufti in Africa Settentrionale Orientale.
- Von Bismarck: "In base a quanto il Governo italiano ha fatto conosce re abbiamo concordato cli non fare partire per ora il Gran Mufti per la Tu ni sia" .
- 11 Ministro Vi te tt i precisa che il Governo italiano non si è dichiarato sfavorevole ma ha consigli ato di attendere che la situazione fosse chiarita per non esporre il Gran Mufti e p er conservare intatto il suo prestigio.
- Il s ignor Mo ellhausen: "Il prestigio de l Mut'ti nel Nord Africa è piuttosto di ca po religioso ma politicamente p r essochè null o" . Il Gran Mufti potrà esse re util e se gi un gerà in Tunisia dopo B o u R ghib a e colla borerà co n lui .
- li Ministro Vitetti torna ad affe rm are che prima di inviare Bou Rg h iba in Tun isia sarà necessario intendersi pienamente circa i lim iti della su a attività poiché sarebbe pericoloso farlo parti re qualora poi in Tunisia dove sse svolgere a z ione contraria ag li interess i dell'Asse.
- Il signor Moe ll hau sen: "Sarebbe ugualmente disastroso non restitu ire Bou R ghiba agli Arab i di Tunisia".
- Il Ministro Vitetti : "Non s i tratta di non restituirlo ma di farg li fare una oppo rtun a sosta in I talia per "lavorarlo".
- 11 signor Moe llha use n -La questione di B o u Rghiba è vita le ed è bene che s i consideri c h e essa costituisce " un a sp ina nel piede" per gli Arabi (ci ta pa rt icolari ep isod i circa lo stato d 'animo degli Arabi al rig u ar do) .
- Il Ministro Vitetti: "Siamo perfettamente convinti di ciò e atten diamo da qualche giorno c he Bou Rghiba ci sia consegnato. Se il Governo tedesco avesse vo luto accettare la nostra prima proposta Bou Rghiba sarebb e libero già da un anno e mezzo".
- 11 signor B ismarck : " L 'opposizione alla liberazione di Bou Rghiba venne da parte francese e non da parte tedesca".

- Il ministro Vitetti : "Si, ma se i Tedeschi avessero voluto sare bbe avvenuto div ers amente" .
- Il Comm. Me llini e il Sig. Doertenbach (del Ministero degli esteri germanico): "Il Go verno tedesco non volle fare passi" .
- Il Mini stro Vitetti: "Ricap itolando, g li svil uppi futuri di un ese rcito arabo dovranno esse re co nsiderati sulla scorta dell 'espr ienza che il nucleo arabo-marocchino oggi in p arte nza cost itu irà. Anche al riguard o è inutile fare previsioni ant icipate poiché, fra l'altro , fra tre settimane (periodo di tempo occorrente perché l'u nit à arabo-marocchina raggi un ga la Tu nisia) la situazione dell'Asse in quel settore potrebbe essere notevolmente migliorata.
- Von Waldenburg - (interprete di Bismarck) si dichiara d'accordo su tale punto. Propone che si trovi una formula "come obiettivo politico -militare propagandistico per l'unità araba" .
a) e b) Sembrerebbe opportuno inviar la ed impiegarla in Tunisia nella sua attuale forma di unità araba inquadrata da ufficiali italiani e sotto gli auspici de l Mufti, specialme nte se e quando fosse decisa la partenza del Mufti per la Tunisia.
FONTE: ASMAE, Tunisia, busta 16, fase. 2.
Docum ento n. 25
Le osservazioni e le riserve ci rca la posi zio ne tedesca emersa nella riunione di Roma del 2 gennaio vennero precisate nel seguente Appunto preparato dal min. Vitetti,il 5 gennaio:
Il giorno 2 corrente ha avuto luogo presso qu es to Ministero unariunion e italo-tedesca allo scopo di definire alcune d irett ive di ordine generale relative alla no stra azione politica in Tun is ia. A tale ri unione hanno p artec ipa to anche i rappresentanti del Co mando Supremo Italiano e del Comando Supremo Tedesco.

I due problemi più importanti trattati in questa riunione so no s tati quelli concernenti il nostro atteggiamento vers o le A utorità frances i della Residenza e quelli concernenti il no stro atteggiamento verso gli arabi .
1) Da parte nostra abbiamo fatto vale re il concetto che non conviene alle Potenze dell'Asse rafforzare l 'a mmini s tra zio ne francese in Tunis ia e che al contrario noi dobbiamo sempre più indiri zzarci verso un regime di occupazione . In questo ordine di idee noi ci siamo espressi sfavorevolmente al rafforzamento dell'amministrazione francese per mezzo di elementi così detti dorioti s ti e alla nomina di un Commissario Civile france se propos ta dal Go vern o tedesco al Signor Laval.
I rappresentanti tedeschi hanno finito col ricono sce re l'inopportunità della creazione di un C01mnissario Ci vi le francese ed in genere la convenienza di tenere, rispetto a tutti gli elementi francesi , un attegg iam e nto di riservatezza dettato dalla poca fiducia c he noi possiamo avere non s olo nell'amministrazione francese, ma anche nei cosidde tti doriotisti.
2) Un primo passo per la nostra dire tta ingerenza nell'aimninistrazione francese, è stato compiuto con la costin1 zione di cinque Comitati (Affari Economici, Difesa Passiva, Servizi Municipali , L avori Pubblici e Sicurezza Generale). Questi Comitati hanno carattere misto e vi fanno parte italiani , arabi e francesi in rappresentanza delle rispettive comunità.
Sennonché dalla discu ssione è risultato che essi, in fatto, dipendono esclusivamente da ufficiali tede schi e quindi mentre noi vi s iamo rappresentati come elementi dalla comunità tuni s ina, le no stre Autorità
militari non hanno poi alcuna ingerenza nel loro funzionamento. Ciò dipende dal fatto che gli organi di Comando in Tunisia sono esclusivamente in mano germanica. È da considerarsi pertanto la necessità che in tali Comandi partecipino ufficiali italiani senza di che , evidentemente, la nostra azione in Tunisia non ha la possibilità alcuna di svolgersi.
3) Il Comando tedesco in Tunisia insiste molto per la creazione di formazioni arabe. Intanto è stato deciso l'invio in Tunisia della cosiddetta Unità Liberatrice composta di arabi provenienti da diverse zone ed inquadrati nell'esercito. Tale unità - secondo i tedeschi - dovrebbe rappresentare un centro di attrazione per i nazionalisti dell'Africa del Nord i quali dovrebbero essere incitati in ogni modo possibile ad arruolarsi. Da parte tedesca si è anche accennato all'opportunità che, a tal fine, l'a v'vocato Bou Rghiba - Capo del Neo-Destur - giunga al più presto a Tunisi per fargli galvanizzare le masse arabe ed indurle a collaborare e ad arruolarsi intorno alla "Unità Liberatrice" tedesca.
Su questo punto noi abbiamo dovuto fare le nostre riserve.
È evidente infatti che il problema dei nazionalisti tunisini si presenta in maniera molto diversa per i tedeschi e per noi. I desturiani desiderano, come è noto, l'indipendenza assoluta della Tunisia e noi non possiamo così facilmente e così leggermente eccitare un movimento d'indipendenza in Tunisia che potrebbe in avvenire risolversi a nostro danno.

È stato quindi fatto presente come la partenza di Bou Rghiba per Tunisi debba essere decisa con opportuna cautela, e che comunque sarà possibile , meglio valutare la opportunità e la forma dell'utilizzazione di Bou Rghiba qui o, eventualmente, anche in Tunisia, solo quando, al suo atteso arrivo in Italia, sara nno meglio noti i suoi progetti.
In tutto il corso della discussione è stato ben chiaro che in materia di Tunisia le decisioni ultime per quello che riguarda la po.litica da seguirvi devono essere prese dall'Italia.
FONTE: ASMA E , ibid.
Documento n. 26

febbraio 1943)
T elegramma in partenza n .66031 P.R. / 152
Ministro Bombieri
A.E.M.3° TUNISI
Vostro 107.
In occasione vostra visita al Bey potrete rassicurarlo che Governo italiano guarda con comprensione e simpatia alle asp irazioni del popolo tunisino. L'Italia seg ue verso tutti i popoli arabi una politica che è intesa a porre i rapporti tra essa e la Nazi oni ara be sopra una base di amicizia e di collaborazione . L'Italia ha in Tunisia degli interessi che sono ben noti, il Governo italiano ha intenzione di trovare il modo di proteggere questi interessi conciliandoli con le aspirazioni tunisine.II Governo italiano ha sollecitato esso stesso dalle Autorità tedesche la liberazione dei desturiani . Questi desturiani sono alla vigilia del loro ritorno in Tunisia , per il quale il Ministero degli Esteri ha già da tempo interessato le autorità mili.tari. Altri undici desturiani so no ancora in Francia e il Governo italiano si sta adoperando per la loro liberazione e il loro rimpatrio.
Bu Rghiba è ancora a Roma e sono state avviate co nversazioni con il Governo tedesco per affrettare il suo ritorno in Tunisia.
Potrete aggiungere al Bey che noi abbiamo ascoltato e preso nota delle aspirazioni che Bu Rghiba ci ha esposto a nome del partito desturiano, ma che è nostra inten zione che qualunque conversazione o negoz iato circa il futuro assetto della Tun isia e i rapporti i talo -tunis ini avvenga con il Bey.
Documento n. 27
(25 luglio 1942 - 11 maggio 1943)
Nella carenza di documenti 'interni' relativi alle attività dei reparti speciali, appare degno di grande intesse quanto venne redatto, dopo la cattura, a futura memoria degli stessi reparti, da responsabili militari di uno dei reparti compreso nel gruppo dei reparti delle 'Frecce Ross e ' e cioè il Battaglione composto dagli italiani cb Tunisia . Quasi certa}11.ente tali redazioni furono dovute alla convinzione che, dopo lo scompiglio che seguì la resa, non era più possibile avvalersi della documentazione origùuiria andata perduta in quegli eventi.
Il primo documento costituisce una specie di Diario Storico del Battaglione d'Assalto "T". creato il 25 luglio 1942, ed è stato redatto dal Com.andante del Battaglion e , Ten . Col. Pasquale Ricciardi, il 27 luglio 1944 , in un campo francese di prigionieri militari italiani, in Al[::eria, il Campo di Saida, come risulta dal timbro impresso sulla prima pagina del breve documento:" Camps de prisonniers de guerre - Contro le". Il luogo della redazione, non certo adatto ad una testimonianza interamente documentata, nonché le particolari penose condizioni della prigionia , spiegano ampiamente alcune incertezze ed alcune discrepanze con altri docurnenti conservati in archivio . Jlfatto stesso che esso risulti scritto a ,nano su carta comune c i aiuta a capire che esso appare frutto di estrema buona volontà da parte del comandante, che scriveva solamente sulla base della propria memoria e di quella dei suoi subordinati.

- 27 luglio I 942 - Costituzione presso la sede del I O Reggimento Granati e ri, Roma , del Battaglione d'Assalto "T" , facente parte del Centro Militare "T" entrambi comandati dal Maggiore Ricciardi, sig. Pasquale .
Forza iniziale: 7 ufficiali e 15 militari di truppa.
Di pendenza : organica : Rag gruppamento Centri Militari
addestrativa: S. M. R. E.
d'impiego: SIM
amministrativa: Deposi to 1° Reggim e nto Granatieri - Roma.
- Reclutamento: reclutamento volontar io e, per i militari alle armi , per chiamata dello SMRE. Ufficiali e soldati provenienti da tutte le armi, in prevalenza italiani nati sia in Tunisia, Algeria, Marocco francese e spagnolo oppure elementi pratici delle regioni suddette.
- 7 agosto - Costituzione del Plotone Comando e della 2° Compagnia.
- 20 ottobre - Il Centro Militare "T" viene disciolto ed assorbito dal Comando del Battaglione d'A s salto "T" , contemporaneamente il Magg . Ricciardi cede il comando del Battaglione al Magg. Barone sig. Ugo (Costituzione della 3° Compagnia e di un reparto misto).
- 8, 12 , 14 novembre - Quattro ufficiali ed alcuni soldati vengono assegnati alle Divisioni ' Superga' (3 ufficiali) e ' Livorno' (1 ufficiale) per incarichi speciali .
- 16 novembre - Alcuni soldati passano alle dipendenze del STM per incarichi speciali.
- 3 gennaio 1943 - Ordine di parten z a per la Tunisia.
- 10 gennaio - Tutto il materiale del Battaglione (macclùne, muniz ioni , mortai, vestiario , ecc.) viene fatto imbarcare a Napoli, diretto in Tunisia. Accompagnano il materiale due ufficiali, gli uomini di scorta e gli autisti .
- 11 gennaio - Il Battaglione si sposta da Roma per i porti di imbarco (Comando Battaglione più 2 Compagnie più Reparto misto. Forza complessiva 440 uomini).
- 14 gennaio - L a 1° Compagnia raggiunge il campo d ' aviazione di Sciacca e s'imbarca per la Tunisia (Porta al seguito il materiale leggero).
- 16 gennaio - Il Comando di Battaglione, la 2° Compagnia e il Reparto misto raggiungono l 'aeropo rto di Castelvetrano e s'imbarcano per la Tun isia (Materia le leggero al seguito).
- 12 gennaio - Il convoglio marittimo atTiva a Biserta.
- 14 gennaio - TI primo convoglio aereo arriva ad El Aouina (Tunisi) .
- 16 gennaio - Il secondo convoglio aereo arriva ad ElAouina (Tunisi).
- 16 gennaio - Trasferimento del Battaglione da Tunisi ad Akouda (Susa) ove stabilisce la s ua sede Comando Battaglione - Servizi e 2° Compagnia ad Akouda; Comando 1° Compagnia a Kalah Kebira (Susa) .

- 25 gennaio -Trasferimento per la prima linea (ore 19). AITivo allo Chakeur il 26, ore 3 . Comando settore Gen . Benigni .
- 26 gennaio - ore 8, avanzata fino allo Duffelat e stretta di Koukat.
- 26 gennaio - ore 16, passaggio della stretta di Koukat per raggiungere le pendici del Djebel Halfa.
- 28 gennaio - ore 7, attacco della stretta di Tefifila difesa dagli americani (Divisione Roosvelt). Ripiegamento sul Djebel Halfa, ore 15:
Morti: ufficiale l truppa 21
Feriti: " 2 " 41
Dispersi 4 " 32
'
Totale 7 94
Il battaglione rimane sul Djebel Halfa.
- 3 febbraio - Elementi reclutati in Tunisia (Battaglione Tunisini) vengono immessi nel Battaglione per completare gli organici (circa 200).

- 12 febbraio - Il Comando Battaglione e la 2° Compagnia rientrano alla base (Akouda). La l ° Compagnia rimane sul Djebel Haifa alle dipendenze del Magg. Parlato, Comandante il l O Battaglione del 91 ° Reggimento Fanteria ' Superga'.
- 16 febbraio - Il Magg Donato lascia il Comando del Battaglione che viene ripreso dal Magg . Ricciardi.
- 18 febbraio - La 1° Compagnia si sposta a 200 m. dalla Stretta di Tefifila e vi rimane fino al 6 marzo .
- 17 marzo - Partenza del Comando Battaglione e 2° Compagnia per un colpo di mano su Ousseltia che viene effettuato durante la notte del 19.
- 22 marzo - Rientro da Ousseltia alla base (Akouda).
- 24 marzo - Partenza del Battaglione per Bou Thadi. Dipendenza tattica settore Lequio , zona di Sidi Bou Zit. Compito azioni esplorative .
Perdite : Morti : uffic. 1, feriti truppa: 1 dispersi: n/n
- 4, 6 aprile - Ricognizione da parte del 1° e 2° plotone della 1° Compagnia nella zona di Sidi Bou Zit.
- 8 aprile - Trasferimento Comando Battaglione e 1° Compagnia al km 95 sulla strada Sfax-Te bessa (Com. Le qu io) .
- 9 aprile - ore 8, Ripiegamento dal Faid.
- IO aprile - Passaggio da Kairouan, ore 2 . Sosta a Bl ed Saadia. Azioni retroguardia alle dipendenze del Gen . Yon Broich , comandante la 10° Divisione Pan zer.
- 12 aprile - Ripiegam e nto su Enfidaville . Attendamento al 4 ° km nord della città .
- 15 aprile - Trasferimen to ad El Reaugouib (zona ad ovest di Sanvat). Dipendenza Gen . Imper iali.
- 20 aprile - Spostamento allo Zareff. Dipendenza ten. Col. Wolf prima, e Col. Barone dopo ( ' Superga').
-2 1 aprile - La 1° e la 2° Compagnia prendono pos izion e rispettivamente s ul Dje bel Farthou t e Oued Douilia .
- 23 april e - Attacco delle posiz ioni occupate dalla 2° Compagnia:
Perdite complessive 1° e 2° Compagn ia
Morti : 8
Fe r iti : 26 e 1 uffic.
Dispersi: 25 (pattuglie di arditi misti a tedeschi)

- 24, 25 aprile - Ripiegam e nto sulle colline lungo l'acquedotto di Bir Halima, settore Ferme Zoukauda (dipendenze co l. Barone) s ull a nuova lin ea di sicurezza .
- 27 aprile e 1° maggio - Attacchi continui de l nemico in forza.
Perdite Morti : 20
Feriti: 51 e 2 uffic.
Dispe rsi: n/ n
- notte 1/2 maggio - Avuto il cambio col 1° Battaglione del 91 ° Reggimen to Fanteria 'Superga '( Mag g . Rosditto) s i raggiunge una pos i zione a ridosso d e lla quota 474 (lasciando in linea un caposaldo avanzato alla Ferme Zoukauda).
- notte 3/4 maggio - Col po di mano s ulle posi zioni nemiche quota 271 con tutto il Battaglion e .
- alba 4 maggio - Attacco in forze di elementi francesi (legione straniera, fanteria indigena ed autoblindo americano).
Perdite gravissime per il nemico confermate anche da ufficiale francese ferito col quale ho parlato a Saida

Perdite da parte nostra:
durante gli attacchi dal 1° al 4, tutti gli ufficiali superstiti di quelle Compagnie sono stati feriti,
Perdite Morti: 14
Feriti: 32 e 5 ufficiali
Dispersi : 35
- 7 maggio - Ripiegamento su Zaghouan e trasferimento nella zona dell'Oueél Sebalia. (Dipendenza Comando Divisione 'Superga ' ).
- 11 maggio - ore 15. Spiegamento dei superstiti del Battaglione a cavallo della pista che dall'Oued Sebalia portava al Comando Divisione.
- 11 maggio - ore 19: fine delle operazioni per ordine del Comando Divisione.
Riepilogo delle perdite subite in tutta la campagna:
ufficiali: morti 2 feriti 11 dispersi 4
Sottuff. e truppa: mort.i 63 feriti 150 dispersi 92
Totali morti 65 feriti 161 dispersi 96
Il Comandante di Battaglione (Ten. Col. Ricciardi)
Saida , 27 luglio 1944
FONTE: USSME - RACC. 1103 .
Documento n 28
DEL 1° BATTAGLIONE VOLONTARI "T"
(9 dicembre 1942 - 11 maggio 1943)
Una seconda testimon ianza documentaria riguarda il 1 ° Battaglione Volontari "T" che fu creato con volontari italiani tratti dalla colonia italiana di Tunisia; essa appare composta s ia da una 'Sintesi del diario storico', sia da uno 'Specchio sintetico della storia del Battaglione volontari "T". Entrambi questi manoscritti sono redatti e firmati dal Comandante del Battaglione, Magg. Leo Cataldo e sono stati scritti presurnihilmente nel luglio 1944, in un campo francese di prigionieri militari italiani nel Nord Africa, forse Saida. Dei due documenti che si completano diamo il testo, pur precisando che le penose condizioni nelle quali essi furono redatti sono all'origine di molte discrepanze o contraddizioni con i documenti dell'archivio militare al riguardo, specie sui dati numerici che vengono in questi docurnenti scritti dai comandanti più sulla memoria che su dati documentari.
A Sintesi del diario storico del 1° Battaglione Volontari " T "

- Il giorno 11 gennaio 1943 , data di assunz ione del Comando del Battaglione Volontari " T", i tunisini (leggasi " Italiani di Tunisia ") erano organizzati in un Reggimento costituito su 3 Battaglioni di stanza rispettivamente, il 1° a Bou Ficha, il 2° a Sousse ed il 3° a Sfax. I Battaglioni erano in via di formazione e cli addestramento. Lo spirito combatte ntist ico era molto elevato, ed una prima prova di ciò si ebbe quando, per il completamento del Battaglione cl' Assalto "T", furono richiesti, il 21 ge nnaio, dei volontari : molti chiesero di essere trasferiti nell'ardente desid erio di essere im piegat i subito. Sulla forza del Battaglione di circa 250 uomini ben 130 furono trasferiti al Battaglione cl' Assalto.
- Il 25 gennaio l 943 furono assegnati al Battaglione altri complementi ma la forza non ragg iun se i 250 uomini e perciò il Battaglione fu costituito soltanto s u due Compagnie. Gli uomini erano giornalmente impiegati per l 'addest ramento con i soli fucili mitragliatori francesi (pessime arm i) e nei servizi di patt uglie e guardia . I Tunisini
dimostravano intelligenza e desiderio di essere impiegati in combattimento.
- A fine gennaio il Reggime nto Volontari Tun isini fu sciolto; in conseguenza furono costitu i ti 3 Battaglioni autonomi (I, II , III) con un Centro di Addestramento e Reclutamento con sede a Tunisi , e un Battag l ione di Camicie Nere. Centro di mobilitazione di tali repa1ti era i l Distretto Militare di Sulmona.
- Il 1° febbraio, d'ordine del Comando Divisionale 'Superga' dal quale tatticamente si dipendeva , il Battaglione fu trasferito ad Enfidaville per continuare colà il periodo di addestramento .
- Il 1° marzo, d 'ordine del Comando del XXX Corpo d'Armata, il Battaglion e si trasferiva a Mahdia per costituire la difesa della località e per completare l'addestramento . Ivi giunsero nuovi complementi che permisero la formazione del Battaglione su 4 Compagnie delle qua l i, però , la 2° era di stan za ad Hammam Sousse, a disposizione de l XXX Corpo d 'A rmata . A Mahdia la forza del Battaglione raggi u ng eva i 650 uomini circa. Dife ttava , nonostante le r ich ieste il materiale : l'addestramento si co ntinuava a fare col solo fucile mitrag li atore francese , bombe a mano e fucile ' 91

- Il 25 marzo, d ' ordine del Comando Divisione 'Superga', il Battaglione, eccetto la 2° Compagnia, rimasta ad Hammam Scusse , si trasferiva a Sb ika, nel settore d ' impiego del Co l. d'artiglieria, Incisa di Camerana. ·
- Il 31 marzo il Battaglione , avuti i fuci l i m itragliatori Breda '30 , si trasfer i va, ad e ccezione della 1° Compagn ia che r i mas e alle dipendenze tatt iche del Col. D ' Incisa, in località El Barrage delf'Oued Keb ir, ne l settore d'impiego del 92° Reggimento d i Fanteria (Col. Dispensa) . Ad El Barrage, quindi si trovavano il Comando del Battaglione, la Compagnia Comando , la 3° e la 4° Compagnia.
- Nei primi giorni di aprile, la 2° Compagn ia veniva messa , d ' ordine del Comando XXX Corpo d ' Armata, alle dipenden ze tattiche della colonna mobile comandata da l Ten . Col. Guaclalupi, al cui seguito la Compagnia stessa dovette spostarsi all'insaputa del Comando de l Battaglione , da Hammam So usse, e fu inviata nella zona di Ousse ltia col compito di arrestare e ricacciare il nemico il quale era riuscito a rompere e penetrarv i , un punto del nostro schieramento difens i vo.
- Il 9 aprile la 2° Compagnia , unitamente agli altri della colonna mobile, fu fortemente impegnata contro forze avversarie soverchianti francesi, e dopo aspro combattimento fu accerchiata e dispersa. Soltanto alcun i giorni dopo com inc iarono ad affluire al Battaglione i pochi superstiti riuscit i a sfuggire alla stretta del nemico. Perdite: un numero di morti non accertato, ma presumibilmente di circa 25; 1 ufficiale e 50 so ldati prigionieri .
- Il giorno 12 aprile, la 1° Compagnia , lasciata a Skik.a alle dipendenze tatt iche del Col. D'Incisa di Camerana, ebbe da questi l'ordine di r ipiegare nella zo na de i Monti Zares. Giungeva nella zona prestabilita ne ll a giornata del 13 , dopo una marcia faticosa ed estenuante causa, oltre il percorso, l'esagerato carico che ogni militare aveva perché nessun mezzo meccanico o animale fu dato al Comandante del reparto .
- Lo stesso g iorno 13 la detta Compagnia, alle dipendenze tattiche del Maggiore i n S . P. E. sig . Rossetto, fu impiegata per respingere un attacco nemico di truppe francesi ed occupare alcune alture. L'azione fu svolta in modo audace e brillante , tanto da riscuotere l'elogio degli ufficiali superiori presenti.
- Il g iorno success ivo la Compagnia riceveva l'ordine di avanzare ed occupare nuove alture. Durante il movimento il reparto si trovò di fronte e di fianco forze soverchianti nemiche, con le quali impegnò una impari lotta. Il valore, il coraggio e lo sprezzo del pericolo dimostrati da tutti i componenti del reparto furono superiori ad ogni elogio .

Perdite: - 2 Ufficiali morti;
- Numero imp recisato di soldati morti perché la zona di com battimento pe r p iù volte, alt ernativamente , fu occupata da l reparto e dagli avversari;
- 2 Ufficial i feriti (il Comandante di Compagnia ed un Ufficiale subalterno);
- 20 soldati feriti;
-2 ufficiali prigionieri;
- 70 soldati prigionieri.
- Fratta nto g li alt r i repart i del B attaglione di stanza ad El Barrage, avendo ricev uto in d otazione l' armamento previs to in organico ad eccezione dei mortai d a 81, venivano i mpiegati s u lla linea di combattimento : il 5 aprile il plotone esploratori della Compagnia Comando raggiungeva per l'impiego il Comando del IIl/92; il 6 aprile la 4°
Compagnia fu inviata nella zona dei Monti Menassir, alle dipendenze tattiche del I/92; il 9 apri le la 3° Compagnia si schierava in linea col III/92 passando successivamente, il 12 aprile, nel settore a fianco della 4° Compagnia , occupando quota 477,
- A metà aprile, i pochi effettivi superstiti. della 1° e della 2° Compagnia raggiungono il Battaglione e vengono passati parte alla 3° e parte alla 4° Compagnia, In tale schieramento i reparti del Battaglione sostennero, in parecchi attacchi subiti quasi giornalmente, le loro posizioni, e gli uomini non si lasciarono demoralizzare né dagli attacchi né dal nutrito fuoco di artiglieria e mortai avversario, che in qualche punto (quota 477) era molto intenso,

- Il giorno 24 aprile , all'alba, il nemico iniziò un intenso tiro di mortai s u quota 477, e dopo circa 5 ore consecutive di ininterrotto bombardamento svil uppò un attacco in forza contro eletta quota, Le fasi ciel combattimento furono varie, ma alle ore 12 circa, con l'intervento cli un plotone cli rincalzo e ciel tiro di nostri mortai da 81, la posizione era in sal do nostro possesso , In seguito allo scacco subito, l'avversario cominciò nuovamente a sottomettere la posizione a tiro cli mortai. Il tiro durò fino alle ore 18 circa.
Perdite: 2 motti e 4 feriti.
- La sera dello stesso giorno 24 aprile il Comando della Divisione 'S up erga' dette ordine che all'alba de] giorno successivo dovesse avvenire il ripiegame nto su lle alture affacciatesi alla strada Pont clu Fahs-Bir Domcla , Erano stati assegnati al Battaglione 5 autocarri per il trasporto dei materiali e delle munizioni. Alle ore 23 circa, cioè appena fu possibile, furono emanati gli ordini per il ripiegamento lasciando in pos to una retroguardia di due plotoni che dovevano ripiegare 2 ore dopo avvenuto il ripiegamento dei reparti , Il ripiegamento fu effettuato, ed i militari erano più che sovraccarichi, causa il non a1Tivo degli autocarri assegnati che per ragioni non note si seppe arrivarono alle ore 10 anziché alle ore 1-2, come era stato comunicato. Nonostan te ciò quasi tutti i materiali furono trasportati a spalla e sull'unico automezzo che il Battaglione aveva in dotazione.
- Durante il ripiegamento, i repatti furono sottoposti ad intenso fuoco di artiglieria avversai·ia e parecchi militari al fine di sottrarsi a tale azione di tiro, si dispersero. La sera dello stesso 25, il Battaglione raggiungeva la posizione assegnatagli e si sistemava a difesa fra quota 299
e quota 378 (incluse). Detta posizione fu tenuta fino al giorno 7 maggio. Durante questi giorni , e specialmen te il giorno 27 aprile e 4 maggio, la posizione fu sottoposta ad un intenso tiro di a1tiglieria avversaria.
- Il 7 maggio, in seguito ad ordini del Comando Divisione 'Superga', il Battaglione , nella notte fra il 7 e l ' 8 ripiegò nella zona di Bir Salem Ben Zit (nord di Zaghouan) ove rimase con il 91 ° Reggimento Fanteria , fino al 10 maggio.
- Nel pomeriggio del giorno 10 , il Battaglione ricevette ordine dal Col. Barone Gabriele, Comandante il 91 ° Reggimento, di trasferirsi nella zona del quadri v io delle mulattiere, 10 km circa a nord di Zaghouan in riserva. Alle ore 20 s'iniziava il trasferimento ed alle ore 2 del giorno 11 si raggiungeva la zona de s i g na ta. A ll e ore 8 circa si impegnava combattimento dai no s tri elementi schierati a difesa (reparti tedeschi coma ndati dal Ten .Col. Wolf, rinforzati dal III/91 e I/92).
- Verso le ore 10 cominciavano a passare per il quadrivio tedeschi isolati i quali dicevano : "Ing lesi, Amer icani, caput", mentre su tutta la nostra linea venivano esposte le bandiere bianche di capitolazione.
- Alle ore 12 circa venivano fatte saltare le batterie e i depositi di munizioni; tra le 15 e le 16 si videro dal quadrivio sfilare l e colonne dei nostri soldati prigionieri; alle 16 ,30 vennero distrutte le anni del Battag l ione ed alle 17 g li elementi del Battaglione vennero circondati da elementi della Le gio ne Straniera .
Il Coma nda nte
Il 1° Battag lione Volontari "T" (Magg . Leo Cataldo)
B. Specch io si ntetico della storia del 1° Battaglione volontari "T "
Del secondo documento sempre redatto dallo stesso Magg . Leo Cataldo nel campo prigionieri di guerra italiani, presumibilmente poco dopo il primo, si debbono notare precisioni che paiono frutto di conversazioni e di testimonianze con altri ufficiali della stesso Battaglione anch'essi prig ionieri. Per ta n to di questo documento che talvol -
FONTE: USSME - RACC . 1103.

ta ripeterà quanto scritto nel primo, vale la pena di notare gli elementi nuovi nei confronti del primo.
- 9- 14 dicembre 1942 - Reclutam e nto e formazion e del Battaglione a Tunisi.

- 17 dicembre - Trasferimento del Battaglione da Tuni s i a Bou Ficha.
- 17-30 gennaio 1943 - Il Battaglione, su due Compagnie , è accantona to a Bou Ficha; forza: 18 ufficiali, 250 uomini di truppa.
- 1°-28 febbraio - Il Battaglione è accantonato ad Enfidaville.
- 1°-25 marzo - Il Battaglione, meno la 2° Compagnia di s locata ad Hammam S 6 usse a disposiz ione del XXX Corpo cl ' Armata , è accantonato a Ain Slìman, 7 km a nord di Mahdia. Forza: 26 ufficiali, 650 uomini di truppa.
- 25 marzo - Trasferimento a Skika , meno la 2° Compagnia rimasta ad Hammam Sousse.
- 30 marzo - Trasferimento del Battaglione ad El Barrage (Uadi El Kebir), meno la 1° Compagnia rimasta a disposi zione de] Col. Incisa di Camerana .
- 5 aprile - Il Plotone Esploratori è impiegato nel settore III/92.
- 6 aprile - La 4° Compagnia occupa e sistema a difesa le alture del Monastir fra un Battaglione tedesco e il I/92 .
- 9 aprile - La 2° Compagnia è impegnata in aspro combattimento nella zona di Ousseltia.
- 9 aprile - La 3° Compagnia passa alle dipendenze tattiche del III/92.
- 12 aprile - La 3° Compagnia dal III/92 si trasferisce e si schiera a difesa della destra della 4° Compagnia , sino alla quota 977 (inclusa).
- 13 -23 aprile - Combattimenti di non forte entità.
- 13 aprile - Ripiegamento ai Monti Zares della 1° Compagnia ed occupazione di alcune alture.
- 14 aprile - La 1° Compagnia sostiene cruento combattimento ai Monti Zares .
- 24 apr il e - Combattimento a quota 477, nel settore della 3° Compagnia.
- 25 aprile - Ripiegamento del Battaglione dal Menassir alle alture prospicienti la strada Pont du Fahs-bivio Bir Doneda .
- 25 aprile -7 maggio - Sistemazione a difesa ed occupazione del settore fra quota 299 nord e quota 378 (incluse) , fra il 92° Reggimento Fanteria a destra e il 91° a s ini stra .

- 7 -8 maggio - Ripiegamento del Battaglione a Bir Salem Ben Zit (no rd di Zaghouan) .
- 8- 1O maggio - Il Battaglione è accampato a Bir Salem Ben Zit.
- 10-11 maggio - Trasferimento del Battaglione al q uadr iv io mulattiere 10 km c ir ca a nord di Zaghouan.
- 11 maggio - (Resa e cattura) Cessazione delle ostilità .
Il Coma ndante Il I0 Battaglione Volontari "T" (Magg . Leo Cataldo)
FONTE: USSME - RACC. I 103 .
Documento n. 29
In assen za di altre testimonianze attendibili , sembrano importanti questi "brevi cenni" che il Comandante del Battaglione Volontari "T" , Maggiore Leo Cataldo, scrisse nel luglio 1944, quasi certamente nel campo di prigionieri militari di Saida, a proposito delle condizioni nelle quali q, lcune centinaia di giovani italiani di Tunisia a vevano vissuto il periodo da arruolati volontari nel Battaglione "T" Anche questo documento che si trova nell'Archivio dell ' Ufficio Storico d e llo Stato Maggiore - Esercito di Roma, può contribuire a m eglio stabilire la storia di questo particolare Raggruppam e nto militare del Regio Esercito, nell'ultima fase del conflitto nel Nord Afri c a.
- Da informazioni avute , e da quanto mi consta , risulta che il 15 novembre 1942, il Ten. Col. di Complemento , Vincenzo Corsini , tramite il Consolato italiano di Tunisi fece conoscere agli italiani residenti in Tunisia, e specialmente alle organizzaz ioni sportive, che era consentito un arruolamento a tutti coloro che desideravano recarsi per lavoro in Tripo litania. Questa forma fu escogitata per non destare l'attenzione delle autorità francesi .

- Il 25 dello stesso mese , pochi giorni dopo avvenuto lo sbarco delle truppe 'italo - tedesche' (leggasi in v ece: anglo -am e ricane nel Nord Africa), fu fatto conoscere che l'arruo lamento volontario non era per essere impiegati in lavori , ma bensì per prestare servizio militare ed essere impiegati in combattimento.
- Il 9 dicembre ha inizio a Tunisi , Cas erma Casbah, la presentazione e conseguente visita medica. Mo lti si presentarono e la visita medica fu solo una pura formalità, perché tutti furono am1olati , in qualsiasi condizione fisica fossero (parecchi, infatti, dopo risultarono non idonei).
- Il Ten . Col. Corsini tenne un discorso ai volontari .
- Mancavano, però, molti quadri ufficiali ed il materiale necessario: vestiario , equipaggiamenti, materiale cli uso generale ed annamen -
to. L' inquadramento , in primo tempo , fu fatto da ufficiali di complemento tunisini, (cioè sempre italiani di Tunisia), i quali , anch'essi , tra l 'a ltro erano sprovvisti di uniforme. Ciò fu causa non lieve di molti difetti c he in seg uito si verificarono. Si cercò di ovviare, in parte , assegnando pochi q uadri della Divisione ' Superga ' .
- Il giorno 11 dicembre il Generale Benigni tenne ai volontari riuniti un di sco rso , esaltando lo scopo del loro arruo lamento.
- Il giorno 17 dicembre era già costituito su due Compagnie , il I 0 Battaglione il quale , a mezzo ferrovia, fu distaccato a Bou Ficha. I reparti furono impiegati per l'addestramento, serv iz i di g uardi a al P. A . M. e al deposito carburanti, in lavori di comandata alla Sezione Sussistenza , in se rvizio cli ronda notturna. L'addestramento, quindi, procedeva mo lto lentamente. Questo reparto , inoltre, mancava di qualsiasi mezzo di trasporto, cli qua lsiasi materiale di u so generale, mezzi di collegamento , armamento (eccetto il fucile ' 91), cli materiale di equipaggiamento.
- Intanto affluivano dall'Italia i quadri ufficiali per l'inquadramento di q uesti reparti, e continuava a Tunisi l'arruolamento. In breve fu cos t itut o il I 0 Reggimento Volontari "T" su tre Battaglioni (I 0 , ll 0 e UI 0 ), rispettivamente di stanza a Bou Ficha, Sousse e Sfax. Il Comando di R egg imento si d islocava ad Hammam Lif; a Tunisi (Case rma Casbah) funzionava una specie cli deposito . Inoltre si formava una Compagnia Allievi Sott ufficiali , distaccata al Campo Servière (nei pressi di Hammam Lif) ed una Compagnia P. A. Forza complessiva: ci rc a 2 .000 uomini.
- Giunti ed assegnati a i Battag li oni i nuovi Ufficiali, l 'addestramento prese un ritmo inte nso . Il rend imento era ottimo perché i tunisini erano animati da alto spirito comba tte ntistico.
- Co ntemporaneame n te all'arruolamento nell ' Esercito, veniva fatto un arr uolam en to per la costituzione di un Battaglione Camicie Nere . Incaricato di questo compito fu il Seniore Scaparra. Fu costituito un Battaglione avente il num ero 570: Comandante Seniore Tetamo , forza 600 uomini circa , sede a Tunis i . Inoltre erano in formazione altri due Battaglioni che de ttero complementi all a 'Milmart' ed al Battag li one 'San Marco'.
- Il giorno 17 o 18 gen naio 1943 , il comando del Regg imento fu assunto dal Ten. Col. Mass imo Invrea, ap positamente inviato dall ' Ha-

lia per il reclutamento e l'addestramento dei tunisini. Questi, a fine gennaio, sciolse il Reggimento e costituì un Centro Reclutamento e Addestramento "T", sede Tunisi , un Comando Raggruppamento Volontari Tunisini, sede nelle adiacenze di Sousse, e tre Battaglioni autonomi che rimasero nell e sedi anzidette. Centro di mobilitazione: Distretto di Sulmona .

- Inoltre vi era ad Akouda il Battaglione d'Assalto "T" , costit uito ed addestrato in Italia, il quale aveva tutti i mezzi necessar i per vivere e combattere.
- II giorno 21 gennaio, il Ten. Col. Invrea chiese ai Battaglioni dei volontari pe,r il completamento del Battagli one d ' Assalto il quale aveva i quadri, ma non molti soldati. Alla richiesta fatta nei Battaglioni, molti espressero il desiderio del trasferimento perché spe ravano poter essere subito impiegati in combattimento (ne passarono circa 200) .
- Eccetto alcuni casi sporadici d i militari alquanto tiepidi, la quasi totalità era animata da forte desiderio di combattere . Elementi intelligenti, pieni di buona volontà nell'apprendere , ze lanti e scrupolosi nell'adempimento dei compiti che loro venivano affidati. Queste qualità positive furono largamente tenute presenti dai Comandanti di reparto per ottenere il massimo re nd imento nel minor tempo possibile . P erò, nonostante ciò, i reparti erano sempre sprovvisti di tutto il necessario (anni, mezzi di collegamento, mater iali di uso generale, mezzi di tras porto), per quanto venissero fatte giornalmente le richieste Furono dati fucili mitragliatori francesi (pessime armi) . L 'addes tramento ed i tiri, quindi , venivano effettuati con il fucile ' 91 , il fucile mitragliatore fra ncese e bombe a mano.
- Però i tunisini, oltre i pregi anzi detti, avevano anche non pochi difetti dovuti alla quasi convivenza, per lunghi anni, con gli arabi e con i francesi, per cui alcune volte erano presi da un o spirito di indolenza ed apatia, caratteristica degli arabi, oppure da un desiderio di piena libertà che mal contribuiva alla compagine disciplinare dei reparti. Però questi difetti era no facilmente superati con un governo disciplinare persuasivo e g iusto.
- La relativa vicinanza alle proprie fam iglie fu uno dei più gravi inconvenienti . L' umano des iderio di recarsi a Tunis i, specialmente dopo i vari bombardamenti, per vedere cosa era accaduto ai propri fami-
liari, portava la necessità di concedere spesso numerosi permessi, tutto a danno dell'addestramento_ Inoltre , pur concedendo numerosi permessi, molti arbitrariamente si allontanavano non volendo comprendere, per quanto più volte si spiegasse il reato , la gravità della mancanza commessa nell'allontanarsi arbitrariamente dal reparto. Ciò fu caus a di alcune denunz ie di diserzione che , non avendo mai avuto effetto pratico , davano la sensazione ai militari che quanto veniva loro detto dai Comandanti di reparto altro non era che intimidazione.

- Complessivamente, tra arruolati nel Regio Esercito e nella Milizia, vi furono circa 27 u fficiali e 4.000 soldati.
- Nel mese di febbraio le operazioni di arr uolamento furono s ospese o quasi_ Si cercò di migliorare il già fatto. A fi ne febbraio 1943, il Comando di Raggruppamento, presi gli ordini dal Comando XXX 0 Corpo d'Annata , disciol se il II1° Battaglione di stanza a Sfax Glielementi tutti di ta le reparto passarono in forza al I0 Battag li one, già trasferito a Madhia. Il 1° Battaglione formava una Compagnia di elementi non molto fisicam e nte idonei e la tras feriva al Il0 Battaglione, che prendeva il numero X II 0 , con funzioni di difesa costiera. Da detto Xl 1° Battaglione, il I0 Battaglione riceveva la 2° Compagnia che rimane va ad Hammam Sousse a disposiz ione del XXX° Corpo d'Annata.
- Nel mese di aprile , i l I0 Battaglione fu impiegato in combattimento in più località Il XIT 0 fu impiegato in difesa costiera fra Enfidaville e oltre Madia. Il Battaglione Camicie Nere fu impiegato ed adoperato anche come Battaglione lavoratori.
7. L'arruolamento avrebbe dov uto fa r si con maggior severità nella scel ta degli individui.
8. Si sarebbe dovuto provvedere in tempo ai quadri idonei ed al materiale necessario.
9. Gli eleme nti erano intelligenti, di pronta in tuizione , ma qualche volta apatici ed an imati da uno spirito non solid o di soggezione alla disciplina milit are .
10. La vicinanza alle proprie famig lie fu a lqu anto dannosa perché tutti, dopo ogni bombard ame n to, desideravano andare a Tunisi.
11. In combattimento dimostrarono coraggio , inte lligenza , sp rezzo del p ericolo. P erò alcuni, dopo uno sfortunato combattimento , facil -
mente si disperdevano e si recavano a Tu nisi. Si ri presentavano volontariamente dopo due o tre giorni cli assenza.
12. I Battaglioni costituiti ebbero le armi necessarie solo pochi giorni prima dell'impiego. Mezzi di collegamento scarsissimi, mezzi di trasporto meccanici, quasi nessuno. Si disponeva in ciascun Battaglione solo di pochi muli e di un automezzo leggero .
In conclusione l ' elemento era ottimo se saputo comprendere e guidare. Ottimo è stato il contegno tenuto nell ' attacco e nella difensiva. Ottimo impiego hanno trovato anc he uomini isolati presso Comandi e repa1ti , come interpreti e come informatori.
Il I 0 Battaglione Volontari "T" (Magg. Leo Cataldo)

Nel quadro de ll 'azione politica e militare delle autorità ita li ane nei confronti delle popolazioni arabe, e specialmente dell'Egitto e del Nord Africa francese, vale la pena di ricordare, che, oltre alla formazione di Raggruppamenti Militari arabi "di liberazione" dal giogo coloniale inglese , al centro di molta propaganda del Comando Supremo, vennero realizzati molti volantini, cartoline e testi di appelli che l'aeronautica militare italiana lanciò in varie operazioni su lle popolazioni arabe. Le dimensioni di questi lanci furono cospicue e le documentazioni relative evocano cifre che vanno da 180mila a 500mila esemplari fatti piovere dal cielo nelle retrovie arabe, spec ialmente nel periodo settembre-dicembre 1942 .

Allo scopo di mobilitare per La causa dell'Asse le popolaz ioni arabe, venne lanciato all'iniz io del 1942, nelle retrovie egiziane, questo volantino umoristico che, anche in lingua araba , sottolineava la crisi dell'impero britannico, malgrado Le decisioni di Winston Churchill (cm . 12 x 16) .

Con questo volantino, redatto anche in lingua araba e lanciato nelle retrovie egiziane , agli inizi del 1942 , venivano sottolineati i successi delle marine ,nilitari dell'Asse contro la marina militare britannica ormai in piena crisi malgrado le cure di W. Churchill . (cm.12 x 16).

Cartolina che esaltava le vittorie dell'Asse, dopo la conquista di Creta e l'avanzata italo -tedesca dopo conquista di Tobruk (21 giugno 1942) . Cartolina contro la presen za inglese, lanciata dagli aerei italiani in Egitto nell'estate J942. Si noti l'aereo tedesco che sgancia i paracadutisti sull 'isola di Creta mentre un sottom arino italiano fa buona guardia, mandando all'aria i piani dei diplomatici inglesi e facendo scappare W. Churchill, piangere gli speculatori ebrei e persino la coppia reale inglese(cm. 13,5 x 9).

Cartolina che denunciava l' eioismo degli anglo -american; nei confronti degli arabi. Cartolina contro La presenza inglese, lanciata dagli aerei italiani in Egitto nella seconda metà del 1942. Il presidente degli Stati Uniti sta copiosamente mangiando, servito da un negroarabo, mentre Churchill, travestito da capo ottomano, sta a guardia davant; alla folla araba affamata che vede che anche il cane dei due sta azzannando carne prelibata (cm.14 x 9).

Riproduzione di una sterlina. La moneta inglese viene mostrata quale segno di una passata grande zza della quale il testo arabo nel retro annuncia la fine. Volantino lanciato dagli aerei itali an i nella seconda metà del 1942 (cm 15 x 8).

Tradu zione:
Se osservate attentamente questa banconota , vi ricorderete di quel tempo in cui , in cambio di una, vi veniva reso il decuplo in oro luccicante e seducente. Ciò perché questo foglietto era garantito da un grande impero, con tutta la sua ricchezza, potenza e prestigio .

Ma adesso Sua Maestà non vale più un fico e la sua opulenza è decrepita come una foglia secca .
Qual è allora oggi il valore di questo denaro? Un centesimo, senz a dubbio. Ogni giorno che passa di questa guerra che l'Inghilterra ha scatenato, provocherà una falla nell'imperialismo inglese; ed ogni battaglia che l'Inghilterra perderà , aprirà un vuoto nell'erario britannico.
È vicino il giorno in cui un mendicante accattone, pur trovandosi sul lastrico, rifiuterà di accettare in elemosina la sterlina inglese , anche se dovessero regalargliela.
È volontà di Dio cli distruggere la Gran Bretagna e ciò accadrà
" L'oppressione britannica, in malora ... se Dio vuole! " . Cartolina contro la presenza inglese, lan c iata dagli aerei italiani in Egitto dopo il 22 giugno 1942. Con la raffig uraz ione della 'mano di Fatma', classi c o simbolo arabo di predizion e sicura, viene annunciato il volere div ino di fare precipitare ne lla rovina la presen za coloniale d e lla Gran Bre tagna in Egitto (cm.15 x 10,5 )

Volantino lanciato dagli aerei italiani nel dicembre 1942 nel Nord Africa per suscitare la collaborazione della popolazione araba con le forze armate dell'Asse . Si promettono compensi notevoli agli arabi che aiuteranno a catturare e consegneranno alle.forze armate dell'Asse combattenti inglesi o americani ed anche a coloro che aiuteranno un aviatore tedesco a rientrare nelle Linee italo -tedesche .

Traduzione:

In molte occasioni , i soldati dell ' Asse si sono avvalsi, nella loro lotta contro gli in glesi e gli americani, contro i partigiani di De Gaulle e gli ebre i, tutti nemici dell'Islam, della partecipazione degli arabi grazie ai quali sono riusciti a catturare pericolosi capi delle bande inglesi di sabotatori.
Gli inglesi hanno ch iesto agli arabi, in cambio di molto denaro di portare nelle linee inglesi dei soldati dell'Asse. Questa operazione fu un fallimento per gl i inglesi perché gli arabi hanno rifiutato questo denaro e hanno in vece consegnato inglesi alle forze dell'Asse . Come compenso, hanno ottenuto tre volte l'ammontare della somma proposta dagli inglesi.
In molti casi voi tutti avete approvato questo fatto, non certo allo scopo di avere una ricompensa bensì perché conoscete l'amicizia delle forze dell ' Asse nei vostri confronti ed anche l'ostilità degli americani , degli inglesi, dei gollist i e deg li ebrei che ricercano solo l'annientamento del vostro popolo , della vostra fede ed anche la spoliazione del vostro paese e dei vostri beni e che hanno condannato le vostre famiglie alla fame .
Le forze dell ' Asse riconoscono ciò che vi è dovuto ed allo scopo di darvene le prove vi informano che: 1. Chi un que consegnerà agli eserciti dell'Asse un pilota o un paracadutista nemico avrà una ricompe nsa di 5 .000 franchi
2. Chiunque farà giungere un aviatore tedesco dalle lip.ee nemiche alle nostre linee avrà la stessa ricompensa.
Il

Questo proclama del presidente Rashid Ali al Ghailani, presidente del Consiglio dei ministri iracheno, ai ''figli del Nilo" del maggio 1941 contro la presenza inglese nel mondo arabo e che rivendicava l'indipendenza agli arabi, venne lanciato, come volantino, nel 1942 dagli aerei italiani in Egitto dopo l'inizio dell'offensiva in Cirenaica (cm . 22 x 15) .
uJ~J .r"" .)~ J ~.,:.. Jy,JI t..f'.J:.':" "-! fa..i" <.SJJI .,:;:,;i1 J ,._.UJ •foJ,Jlli,j)ll il:i J::11.)~ 0" &h:- "iT ~I J,:e ~\.,;1 j-~ 1., u-.,_;I 0" ~IJ <.S) J~\11., .)~'YI •.1.\.::a:-J ~I ~T P,'YI w,. JI~ Ji:/1 t; f' J...J 01 = ~_\)\ ~\t j l;IJ "" J J..;,t,.., •0J-""tf J ~I ,y f...\Jbl:;- \.o ..½,-, IJ ./.'.À~ .:.,_, 0\s' \.o~~~ ~J.) ~ - "':11., ~I ù~IJ F~-~ : ..i..::,J ! __,....;.i_, .)_,) ..I" \.bi J.) I.è .!J\91., .lJ..ù J.>.f;. 'Y·I \r:t ~., \J 0.,:-, ...y ,pYlcfU;;JJ~\lk,'.>li..J! u_.PI oY.joll .r"" ~\ J r.:.U J...!,- up clif:, J...,I_,::.. .)~ J Y>,l.1 ..::») JWI ulc. c:IJ.;IJ .:.S.;,_, ,l..:, J' p 'i-'i J.:,.,. :.i~J ':"""W\ fl. : ½ rl Jl; .I.i .!J.Af1., ..::,; IJ ,di.. 0Y."""., ul-., =,;,- 'J.,:s., .J~I., .,_\~J
\#..)~J •-':>-'':".)I .)>I! J½J.,..- .:,j:; \Il t;:.~')ll Jl'-'!. W ~I.,
.~I .-1~1 ,òl.,_,I cf'Z-' ~'6'... J fS'.1\..:.i. ~ 1., ':""'WI _,.>.J\ IAii. r\.1
0 ~ !., ~\; _..d i JI 0 J)L- r"'-' ':').,I •.L. .>W> 1_,..,i.;. ,.l~I
c)~J rr=J.,k!J rr=lL! '7'.,,..U tJJ)~.li~\ll .':i'_;.. .:,lç ,\.;l.t -t..rfi.. 'y
- - r"'_,;.,;-' '":'_,,.li JJ.r d'IJ.) d' l..i.., Jti- r"'.)-' 0#.J ~\.S"

J~I., 0UYI ,:.r .li..1.... VI .'>I_;.. .)~ 15J.ll p}I \.i.., j.,
.),J JI., 4!:J\:JI ..l')..:,...VI ~., ½..r .))¾ J.,~ _r:l ~..,-ai
.41 ,:.r ,ly:.VI JI_,;. Y ~I .)I J,r!. - •..\...., :i..16 •? .,..- .'..!½ •)l.JJ
\+'~ ½.,,.li ~VI~ Jy,,11 J.P ~I_,; ~-,:.r ~I J5"" _;I., J\ .r'-'
-'--! .,..- JIJ -~ Js; ~.) ~.J., '!, -W' U .:,~':ili§ ~J
f.ul i,.;e~ .,..- t.>.>; \.. .:, 1., ~.,..,..Jl f"'V' e'.>½ 01 .G-~1 I.Xdl~ _,i.:) o/_.)I .)~ & -y_, "! J~IJ
tS.Y.I .>l_,;I r'WI Js; l_,Lfl. -'!.~ ,:.r ..Jli-1 ~i &..;\; ~, • ..)l~VI; ,½'JI ijL..) dl~ 0!..)j., ,J.>.JI., rLJI .l_,J l.,A
'JI ,J)U:..'yl ul I ~I JI ,~I I.Jl •rL..'J\ JI
Tradu z ione:
Ne l momento in cui gli eserciti liberatori si stanno avvicinando con marcia travolgente e impetuosa alla terra d'Egitto per affrontare l'esercito oppressore (inglese), suscitando ammirazione e facendo del paese del Nilo, loro meta finale, anche la tomba degli appetiti inglesi , quegli appetiti che sono stati il flagello degli uomini (liberi) e lo strumento coercitivo (che ha prodotto) asservimento e colonialismo , ritengo necessario - di una necessità quasi sacra - mentre mi trovo nella capitale del Reich , di rivolgere a voi con orgoglio il mio appello e di farvi udire la mia voce, la voce di un combattente che percorre la via della vostra 1otta , presente e futura, un combattente in prima linea per una civiltà plurisecolare che da voi e in voi ha tratto la linfa d'onore e nobiltà , contro una nazione tiranna e scellerata , che non può essere per voi che nemica , irriducibile e sanguinaria , mentitrice e s leale, appare ntemente amica, ma in realtà irriducibilmente avversa .
O fiero Eg itto, tu ben conosci i guasti dell ' imperialismo e le malefatte dell'Inghilterra in questi pas sati 60 anni; ti sei opposto al suo dominio con una lotta incessante , una battaglia nobile e glorios a intesa alla liberazione dal giogo degli usurpatori e dalle cri minali catene; s ai del sangu e versato, degli eroi fatti morire sulla forca, delle case distrutte, delle deportazioni , delle incarcerazioni! Tu aspiri a un bene che non si può cambiare : la libertà, l'autonomia, l ' indipendenza.
Non sei stato solo in questa prova, o Egitto! T u hai compag ni e fratelli in tutti i paesi arabi che hanno gustato l'asprezza e la durezza dell'imperialismo: la Palestina , la Siria, l'Iraq , tutti hanno scritto pagine di gloria e lasciato testimonianze di lotta . L'Inghilterra li ha occupati, presentandosi come amica e liberatrice, ma poi ha mostrato il suo vero volto di nemica e di spietata colonizzatrice . Questo è il comportamento degli Inglesi in ogni occasione : essi non conoscono la nobiltà e il significato della parola data. In caso di calamità, fanno promesse , e , in caso di emergenza, affettano cortesia , ma se poi ottengono ciò che vogliono e realizzano i loro obiettivi, allora tutte le promesse svaniscono. A loro importa solo il soddisfacimento delle proprie mire e appetiti, succhia nd o il sang ue e le energie dei popoli e mistificando la vera realtà dei fatti. Con parole vuote come democrazia e umanità hanno nascosto l'autentico significato dell 'i ndipendenza e della libe rtà . Gli Arabi, dalla pretesa amicizia inglese, non hanno ricavato altro che tradimento , vessazioni e guerre. Eppure, nonostante ciò , il nemico

non è riuscito a suscitare (negli arabi) rassegnazione e paura, ma anzi ha consolidato fermezza e forza.
E oggi, o Egitto - nazione eterna nei secoli - che a lungo hai atteso di elevarti, è scoccata l'ora della liberazione, l'ora di spiegare sul Nilo la bandiera della libertà e dell'indipendenza . È tempo che gli egiziani ridiventino padroni della loro terra e che s i restauri la forza degli Arabi e la gloria dell'Islam.
Un tempo, le circostanze hanno voluto che proprio attraverso il colonialismo britannico in Egitto precipitasse la fortuna degli arabi. Proprjo in Egitto , infatti, gli Inglesi hanno mo s so i primi passi coloniali nel mondo arabo. Ora, le circostanze vogliono che proprio dall'Egitto cominci la loro disfatta, la loro rotta vergognos a.
O figli dell'Egitto, si sta presentando un'opportunità che non s i ripeterà , un'opportunità che può rappre sentare l ' ultima fase della lotta (di libera z ione) e la prima di que l trionfo e di quella vittoria che condurranno alla pie na indipe ndenza dell'Egitto e alla recisione della forza vitale dell'imperialismo. L'Egitto trarrà vantaggi da qu e sto combattimento, e non viceversa.

Da chi potrà al zarsi l'incitamento se non dall'Egitto? Il re s to dei paesi arabi , uniti nella lotta contro il nemico usurpatore, s i affiancherà all ' Egitto per recidere le catene dell ' oppressione e dello strangolamento. Essi, le potenze dell'A s se hanno affrontato coraggiosamente l ' alea di questa guerra e stanno avviandosi al trionfo con passo fermo e fede incrollabile.
Quando questi amici avranno risvegliato il coraggio degli arabi e il lo ro eroismo, raffor zandoli nella battaglia e infiammandone la volontà, qu e sto sarà un giorno di gioia e di orgoglio per gli Arabi!
Proprio in questo giorno in cui gli amici tedeschi e italiani hanno proclamato che toccherà all'Egitto , primo dei paesi arabi, portare lo storico fardello dell'indipendenza e hanno enunciato a chiare lettere che l'Egitto è pienamente libero e s ig nore del proprio destino - so no felice di dichiarare che non mi sento un traditore delle aspirazioni dei fig li del Nilo , poiché pongo tutta la nùa fiducia nelle inten zioni buone che le d ue nazioni liberatrici nutrono nei confronti della nazione araba, e sono assolutamente sereno nei confronti dei piani che hanno preparato e dell'impegno che hanno sottoscritto.
Dopo la dichiarazione congiunta , è possibile confidare nel fatto che l'Egitto tornerà agli egiziani e che que lla libertà e indipendenza che l'Egitto ha conquistato con la s ua lotta, sara nn o finalmente gustate .
Senza dubbio , ne deriverà una stabilizzazione dei paesi arabi e cresceranno le voci che invocano l 'unificazione (deg li Arabi). L' eterno destino stor ic o degli Arabi risorgerà ed essi sapranno di nuovo diffondere sul mondo le luci della retta guida e della scienza, innalzare la bandiera della pace e della g iustizia, diffondere un messaggio di orgog lio e di rinnovamento .

Incamminiamoci dunque verso il futuro, la gloria , la libertà l ' indipendenz a, l ' unità!
La verità sta dalla nostra parte . Dio è il nostro sostegno e, se Dio vuole . nostra sarà la vittoria!
Proclama d e l Gran Mufti di Ge r usal emme del maggio 1941 . Anche questo app e llo c ontro la presenz a ingle se n e l mondo arabo, venn e Lanciata nel 1942, dopo la conquis ta di Tobruk , e dopo l'ini z io dell'offe n s iva in Cirenaica , d agli aerei italiani nelle retrovi e dell ' Egitto (c m . 22 x 15) .

.r-'"'i l _.,:-,,}I., \il r,\ .
,)½li :JL,_, .'.>lÀ.\ ':?~ ;;_;\li L,.fl.:i t...i . ";J\4)\ ~_;_,i;l~ )(l >, r . J~)\ ·~\ tr cJ :>'Y\ J :;-1l J. l_:.~\
~.,li_, i:...~ ~I.ab ,.:..;t:,_,c/~;1 )~':I\..:.,.;;>- j\ ..I°" 0\ c!l!. '}., ..:., )(-' \i. )U:... \ i:/- tt;..J\_, ly:,f. djJ\ i:r l...Y.. J,W fJ uJi:½.> . '°'', Jz:- 01~ J 15"-' ? lv-\ ~ r., ~~J; ~., J lj ~ L)")l;.1} 4.i\y4 Lo_)}\ o~ i) J ~) 1 ~Yi~ . òi~ \)i •~ Jk,; J clz, "J., .µ if'-' , 4.::./..r., J;:)\ ~pi ., J)li:J\ jo. J.,..J.t, Ù:, 'i, \ :>)91 J~I., ù,~\ ~ li .~ ~, \i l J_.,;.:l\ J J~..,_J\ .;~\ • ($~

Traduzione:
Le strepitose vittorie conseguite dagli eserciti liberatori nell 'Africa Settentrionale entusiasmano tutti gli Arabi e l'intero Oriente, riempiendoli di meraviglia per il genio di Rommel e il valore delle truppe liberatrici . Gli Arabi sanno che le nazioni che vengono a liberarli combattono un comune nemico, l'Inglese e l'Ebreo, e contengono il pericolo comunista che si sta materializzando contro i paesi arabi, dopo che i comunisti hanno annientato l'Iran.
In generale, queste vittorie avranno effetti dirompenti sull'Egitto, poiché, se gli Inglesi perderanno il controllo della valle del Nilo e del Canale di Suez, e se verrà distrutta l'egemonia inglese nel Mediterraneo e nel Mar Rosso, sarà per la Gran Bretagna l'inizio delle fine , sia per questa guerra, sia, per conseguenza, per tutto l 'imperialismo britannico . Per quanto riguarda gli effetti più diretti, le vittorie dell'Asse significheranno il riscatto dell'Egitto e di tutti i paesi arabi del Vicino Oriente dal giogo britannico.
Non vi è dubbio che l'Egitto, che ha conosciuto l ' imperialismo inglese e per 60 anni ne ha subito le amarezze, e gli si è opposto con risolutezza, senza mai cedere, e neppure per un giorno ha smesso di perseverare nella ricerca della libertà e nella difesa della propria indipe ndenza, ed è insorto faccia a faccia alla Gran Bretagna e non ha te muto la sua reazione , neppure nel 1919, nel momento del più grande trionfo inglese , questo Egitto apprenderà le notizie (che vengono dal fronte) con gioia, e si renderà conto che si tratta di un'occasione assolutamente propizia per porre fine al colonia lismo e per ridonare alla valle del Nilo la s ua libertà ed indipendenza. L'Egitto è consapevole di tutto ciò e non v'è dubbio che la liquidazione della presenza britannica nel Vicino Oriente significherà per l'Egitto il recupero dell'indipendenza, accanto all'indipendenza e sovrani tà di tutti gli a ltri paesi arabi .
Oltre ad essere strategicamente fondamentale dal punto di vista militare, l'Egitto è a nche un punto di riferimento per il Medio Oriente sotto il profilo geografico, culturale e politico. Il futuro dell'Egitto detem1inerà il futuro dei legami tra i paesi islamici in generale e quelli arabi in particolare, rende ndo li stretti e indissolub ili. Ho fiducia che l'Egitto saprà far buon uso della r itrovata totale indipe nde nza e sovran ità; così come sono certo che u n Egitto indipendente e autonomo , padrone del canale di Suez e amico delle (potenze) liberatrici, diventerà

la garanzia della libertà della regione (mediorientale), del suo progresso e della sua pacificazione.
Tutti i paesi arabi hanno subito le più diverse specie di angherie inglesi , si sono costantemente opposti a questa ing ombrante presenza e, in tutta la patria araba, neppure uno su un milione s i è lascito intimorire dalla forza ingl ese, alleata a quella e braica, ed a nzi per lunghi anni vi è stata un 'opposizione tenace, alimentata da un incredibile coraggio che ha dimostrato la vitalità de l movimento naz ionalis ta arabo, e ha indebolito l'acquiescenza verso l'imperialismo britannico, fondato sul sopruso e l'aggressione.
La Comunità araba che ha subito gli stess i torti dei suoi (attu ali) liberatori nell'ingiusta conferenza di Versailles , e che con stu pore ha costatato gli sfor zi profus i dalle truppe liberat rici per aiutarla a imboccare la s trada della libertà , vede negli eserc iti che oggi avanzano verso l'E gi tto degli alleati che l'aiuteranno a spezzare le sue catene e ad annientare i suoi nemic i.
Ho fid ucia che l'Egitto e gli altri paesi arabi ciel Vicino Oriente perven-anno ai loro obiettivi e finalmente realizzeranno le loro aspirazioni a un 'a utentica indipendenza e sovranità.

Dopo la conquista di Tobruk da parte delle truppe dell'Asse (22 giugno 1942), il Gran Mufti di Gerusalemme ha inviato al duce, l' 11 luglio, il seguente telegramma che, con la risposta di Mussolini venn e lanciato come volantino nelle retrov i e egiziane ( cm l 3 x 20) .

Tradu z ion e :
Mi permetto di felicitarmi con l ' Eccelle nza Vostra esprimendo l 'e ntusiasmo del popolo arabo pe r le vittorie riportate dall e forze de l1' Asse nell'Africa settentrionale , accompagnate da un altro successo, quello della dichiarazione per l ' indipendenza e la sov ranità dell'Egi tto. Questa saggia politica aiuterà l ' Itali a e la G e rmania a passare di vittoria in vittoria, anch e attraverso le ottime riperc ussioni che la politica estera dell'Asse prodtmà, n on solo in Egitto, ma su tutti i paesi arabi dell ' Oriente, per le nobili es press ioni avute circa l'assicurazione della loro indipendenza e della loro sovranità .
Gli arabi si schiereranno al Vostro fianco per combattere il nemico comune, fino alla vittoria fina le .
Il Gran Mujii di Gerusalemme
Ri s posta del duce :
Vi 1ingrazio per il vostro telegramma di fe li citaz ioni per le vittorie delle forze de ll'A sse nell'Afric a settentrio nale e per la dichiarazione italo -germanica di indipendenza all ' Eg it to .

Sono s icuro che i veri patrioti dell'Egitto e dei paesi arabi del vicino Oriente s ono con il loro cuore a fianco cieli' Asse per arrivare, con la vittoria finale, al raggiungimento de ll e loro as pirazioni nazionali.
MussoliniAllo scopo di annunciare la sconfitta irreversibile delle for z e armate inglesi, venne lanciato , allafine del 1942, il seguente manifesto nel quale si inneggiava alle astuzie degli arabi per aiutare la lotta dell'Asse rifacendosi ad una nota figura popolare, Joha, personaggio delle favole arabe, molto divertente e famoso per la sua astuzia e per la sua intelligenza (cm. 15 x 10,5).

l-, §J.,
! J.,:.-1_, <$~')'I ~ .I !l.:,-1} c:Y . !I.,.\_,~ ~./..O\ J" .:.,~lu..1 .:,lla..; ~; ~4 ~ \ .:,,(!)
L' ' ' I
~1~4,;.-. . ~-~-' d c::l'J •11..! J..i,_ -~ u-)ùi ; t9j}.\/'YY ~ I fai.,. .
! .s iS i<.'')' \ lt,I f .J':""' , ("

Traduzione:
INGLESE !
Passa inglese, passa !
Hai fatto di te stesso padrone del mondo arabo.
V uoi rubare con l'aiuto del tuo ese rcito l ' ultimo boccone dalle mani dei bambini arabi .
Passa quindi e minaccia, però l 'astuto Joha sa come nascondere il grano e gli agnelli ai tuoi occhi .
Continua a dare i tuoi ordin i e domina!
Hai costretto Joha a rispettare i tuoi o rdini . Però devi sapere che il suo carro s i è rotto, il suo asino è caduto ed il buco nella nave si è allargato .
Passa inglese e mostra la tua arroganza! Il tuo servo Joha sente bene, però è indeciso se rispettare o no i tuoi ordini .
Dormi ing lese, dormi!
Vedrai che Joha di notte ti prenderà di sorpresa come un lupo, e ruberà il tu o fucile , che hai rubato precedentemente dal soldato arabo.
Te lefo na inglese, te lefona!
Vedrai che Joha di notte ti prenderà di sorp resa , e taglie r à con la sua forbice i fili del te lefono, poi continuerai a parlare, ma nessuno ti sentirà .
Scrivi inglese la tua lettera , scrivi !

Joha ha dato fuo co all a cassetta postale, si, scriverai la tua lettera, ma non arriverà mai.
Viaggia inglese, v iaggia!
Però , non potrai andare lon tano.
Joh a ha me sso un po ' d i zucc h ero nel serba to io di b e n zina , e quindi la tua macchi na s i fenne r à in mezzo al deserto .
R uba ing lese ruba!
Il petroli o di Ghardaqah, di Suez e d i Moss ul , però l'astuto Joha darà fuoco al petrolio di notte, così le tue navi resteranno a galla ne l mare come un pesce morto .
Passa inglese, passa!
Hai ottenuto il tuo domin io con la forza, ma questo dom ini o ti tradirà di fronte alla furbizia di Joha . Potresti sfilare la spada e colpire, ma i trucch i di Joha sono come l ' acqua corrente, ed a vo lte l 'acqua è più solida dell'accia io.
Dio ti maledica inglese, Dio ti maledica : Ci fai soffrire da anni come hai fatto soffrire prima i nostri padri. Torna a casa tua, è probabile che Dio un giorno ti p e rdonerà per i tuoi peccati .

Allo scopo di invitare La gioventù dei paesi arabi a rifiutare l' arruolamento nelle forze armate britanniche, questo volantino lanciato nel settembre 1942 nelle retrovie egiziane, ribadiva che la.futura villoria sarebbe stata sicuramente dalla parte dell'Asse . Le seduzioni di una paga venivano raffrontate con le speranze di una imminente salvezza dal regime colonialista della Gran Bretagna sul mondo arabo e specialmente nell'Egitto e nella Palestina. (cm.12 x 16) .

_,.. ts.ll\ ..
L:.l v-:1 ._;WI., J.:0 1r':1-' \;; ..,JI ~\:, 'd:..il\_, J-h:1} 0" ty,~I 0-°-' ~':11 "y\ ' J'> ()).).J~:Lo ~)(., t ~., ':1 01-~' <.)"_;..J.ll <CJ4L:ic.., .~)½ j bLs ~1.,, ~~ \., ~l~':1 M ':11
fy.r.,~ ~ .);I~ l_,;_;:,J_, fG_L.- I"""~ r-9 I~ • c. &. c. . ~I_,~ &=--1 ~\ _, ~il..i:>"
'00~YI èl'.J_,\ J,_,1 j l_,.w 01 l"'çk -:-=:--., 0Y.I ,
·rt! f y )) Ac.)i:I\ ( >t:\0>..:J I •0:>lLl IU"yJ) 1c.'Y;,,._,
u.?~.;¼~ 'I~ fl ~l.. ~).li ! uy_.;.al. l lr,)
'01_;.1~~~;l~I L,1.,..!.;, 0_,,\.J: ~I ..;,'ilà,:.., fJY ù~
~1.9&.., r9 ,J$- ili ~~_)~~La,.,~
I""(;r' ~WI L\; A Jfa_; .~ \ . eij. Il:)\ u.11'~ 1:.o.,

Traduzione:
Questo appello è rivolto a tutti i giovani arabi; a quei giovan i che la propaganda britannica e le autorjtà militari cercano d'ingannare e di arruolare nelle file del suo esercito.

Ai volontari arabi in Palestina, agli artificieri del Libano , alle truppe dei volontari siriani, a tutte le associazioni giovanili in Egitto, Iraq, Siria, Libano, Palestina e Giordania.
G li ingl ~s i e i loro alleati dichiarano e sostengono di fronte a voi che la loro causa è giusta e nell ' interesse del vostro paese, e il vostro anuolamento nell e file del loro esercito salverà il vostro paese e lo proteggerà dagli invasori , e una volta aggregati ai loro solda ti che hanno lasciato i campi di battaglia , creerete un nucleo dell'esercito del futuro . La loro illusione e stupidità li ha spinti ad aumentare la "paga" per incentivare le persone più povere e i bi sog nosi ad arruolarsi nel loro esercito
L ' Inghilterra vuole soldati per difendere le sue colonie ed il suo impero, che ha iniziato a ridimensionars i e ad avviarsi a l dec lino . Vuole eserciti da una parte e dall 'altra, per coprire la sua politica di occupaz ione e di repressione che porta avanti insieme ai suoi alleati ebrei e bolscevichi. Vuole coinvolgervi ne ll a battaglia per sprecare j] vostro sangue e la vostra gioventù.
Voi arabi, dovete stare molto attenti di fronte a questi tentativi britannici; non dovete credere ad una sola paro la di quello che trasmettono per radio le autorità coloniali del vostro paese, e non dovete credere ai discors i dei loro sostenitori e servi. State certi che la Germania e i suoi a ll eat i non vogliono altro che il bene vostro e quello del vostro paese.
Quindi , state attenti ad arruolarvi; perché l'Inghiltena vi schiererà in prima fila per sacrificarvi come ha fatto prima con i volontari arabi che ha spedito in Grecia , dove i suoi so ldati sono fuggiti; mentre i volontari arabi sono stati lasciati a mo rire da soli nelle trincee.
Gli inglesi hanno sacrificato i loro cari amici francesi a Dunkerque; hanno sacrificato i greci, gli slavi, i cinesi ed i soldati olandesi in estremo oriente; inoltre hanno sacrificato gli indiani a Singapore ed i canadesi a Hong Kong .
L'Inghilterra ha perso realmente la guerra, anche in mare che s ostiene di avere sotto il suo controllo. È stata sconfitta insieme agli Stati Uniti d'America , che sono il suo nuovo alleato .
Per cui state attenti a servire il colonialismo e sacrificare le vostre vite per una causa persa sostenuta dai bolscevichi che stanno to1turanclo i vostri frate lli in Iran e dagli ebre i che hanno ammazzato i vostri fratelli in Palestina.
L' ora della salvezza è vicina!

Un appello alla popolazione egiz i ana affinché collabori alla lotta delle truppe dell'Asse contro gli inglesi è contenuto nel seguente volanti no lanciato dagli aerei ita liani nelle retrovie egiz iane tra il settembre ed il dicembre 1942. In esso , tra l ' altro, le autorità italian e promettono solennemente la c on c ess ione dell ' indipendenza totale all'Egitto

ùy:'.ù_ J ~')1,1 «!11 fr., ,,J ._;_,.... ' J r-Gfor c:,I., ~I., :;J.)Wt
~J I ~ 1.,~1 a..UI ~.)~ J1 r:I..,..;½ wlJ ;l_;JI ~ .,
òlj iJ)fY- •y).1 ~1.,... f J Jl:il l .:;.,b.\.... iiJA
.:,~I > o.>~.ì. é,_,l:l l JI j.Lll ~J JJ.fl11 ~k..) J. • ~ l
-w.>J J../'il., ~ \..;JI ..:J,.. tS...U i t::,WI J:_,;J I «~ ~I ' .~IJI
· ~,.;~l~lJ !&I~ i:..f' é'._\;..dl b~ w,J lfal v i .
i:..~ ~.;; ~I • JJJI..J f~ JH ~J.,li.,1.r,.e °'1J f c!U;'
.u=1 1.>~ '114 ~IJ J:)b.'J I t.i\:--- if ,.,..ut ctlt..,,, la ,:,- .
~ y- J f:-j -'!)' ~ 1 ·~~ lJ , ~ I l.;>~a ~ f..f) ' ~_; :.._,.j iJ-,-:,J ~t..,. ; ~ ' jl~U

Traduzione:
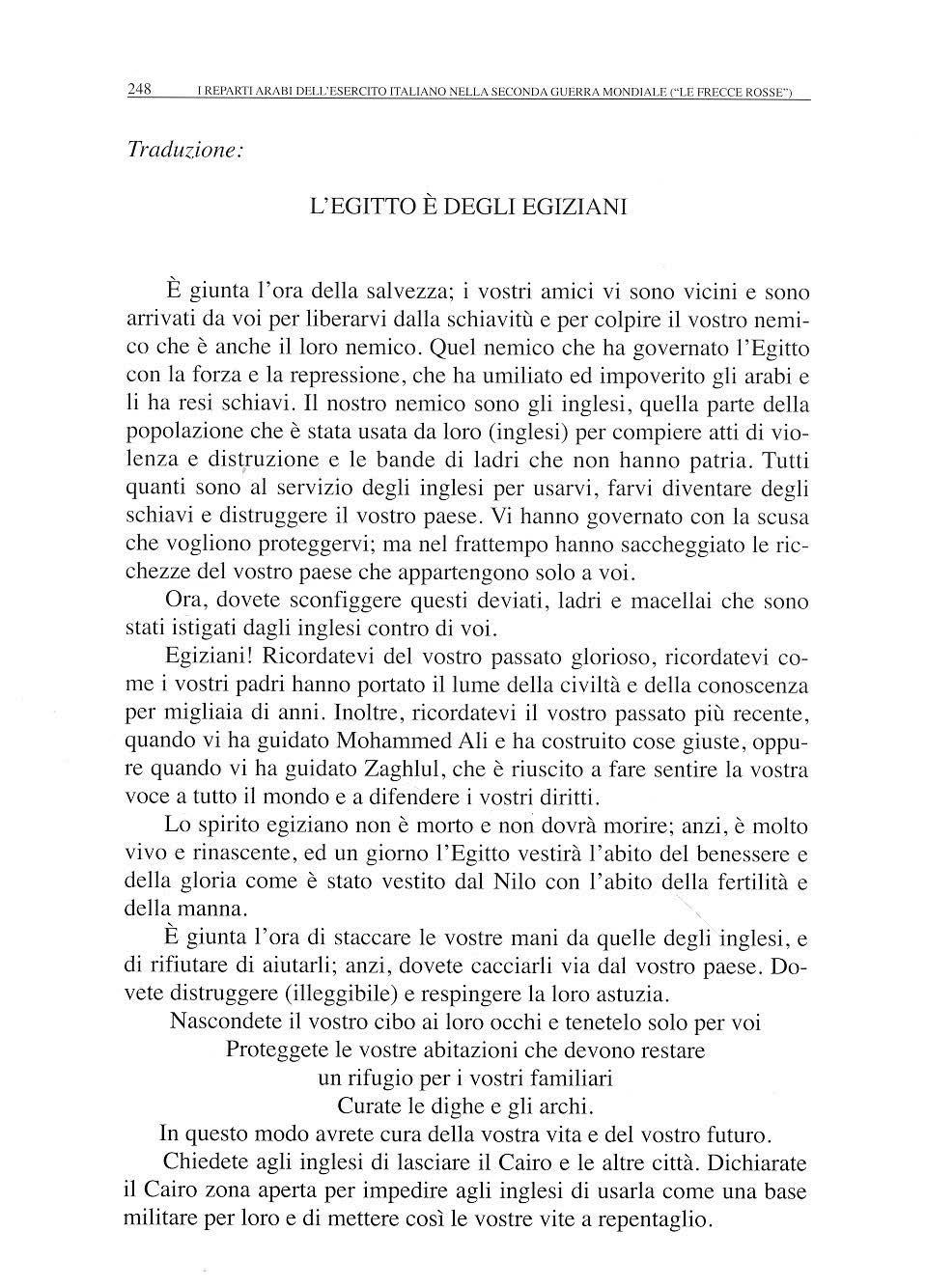
È giunta l'ora della salvezza; i vostri amici vi sono vicini e sono arrivati da voi per liberarvi dalla schiavitù e per colpire il vostro nemico che è anche il loro nemico . Quel nemico che ha governato l'Egitto con la forza e la repressione, che ha umiliato ed impoverito gli arabi e li ha resi schiavi. Il nostro nemico sono gli inglesi, quella parte della popolazione che è stata usata da loro (inglesi) per compiere atti di violenza e dis ~ruzione e le bande di ladri che non hanno patria. Tutti quanti sono al servizio degli inglesi per usarvi , farvi diventare degli schiavi e distruggere il vostro paese . Vi hanno governato con la scusa che vogliono proteggervi; ma nel frattempo hanno saccheggiato le ricchezze del vostro paese che appartengono solo a voi.
Ora , dovete sconfiggere questi deviati, ladri e macellai che sono stati istigati dagli inglesi contro di voi.
Egiziani! Ricordatevi del vostro passato glorioso, ricordatevi come i vostri padri hanno portato il lume della civiltà e della conoscenza per migliaia di anni . Inoltre , ricordatevi il vostro passato più recente, quando vi ha guidato Mohammed Ali e ha costruito cose giuste, oppure quando vi ha guidato Zaghlul, che è riuscito a fare sentire la vostra voce a tutto il mondo e a difendere i vostri diritti.
Lo spirito egiziano non è morto e non dovrà morire; anzi, è molto vivo e rinascente, ed un giorno l'Egitto vestirà l'a bito del benessere e della gloria come è stato vestito dal Nilo con l'abito della fertilità e della manna.
È giunta l'ora di staccare le vostre mani da quelle degli inglesi, e di rifiutare di aiutarli; anzi, dovete cacciarli via dal vostro paese. Dovete distruggere (illeggibile) e respingere la loro astuzia.
Nascondete il vostro cibo ai loro occhi e tene telo solo per voi
Proteggete le vostre abitazioni che devono restare un rifugio per i vostri familiari
Curate le dighe e gli archi.
In questo modo avrete cura della vostra vita e del vostro futuro .
Chiedete agli inglesi di lasciare il Cairo e le altre città. Dichiarate il Cairo zona aperta per impedire agli inglesi di usarla come una base militare per loro e di mettere così le vos tre vite a repentaglio .
Date il benvenuto ai soldati dell ' Asse, considerateli vostri amici, trattateli bene e dategli ogni sostegno possibile, perché così ai utate anche voi stessi.
In questo modo avrete la li bertà e l'indipendenza dell ' Egitto. Dovete prendere in considerazione che i paesi dell'Asse (Ge rmania e Italia) hanno dichiarato ufficialmente di rispettare l'indipendenza dell'Egitto e di credere nella sua sovra nità.
Ts o ldat i dell'Asse distruggeranno il vostro ed il loro nemico , ed in questo modo cesse ranno le vostre sofferenze. Questi soldati lottano insieme a voi e per voi e sacrificano il loro sangue per il futuro del vostro paese , e per raggiungere il supremo motto: l'Egitto è degli egiziani.

Un appello alla diserzione venne lanciato per incitare i reparti indiani delle forze armate del Commonwealth, in occasione della nascita del Raggruppamento "I" in seno alle for ze armate italiane; con questo volantino del luglio-settemnre 1942, scritto in arabo, in urduh ed in Hindi , la proclamazione dell ' indipendenza dell'India veniva ribadita quale decisione dell'Asse, che avrebbe accolto fraternamente i disertori (cm 25 x 18).
Testo in arabo:



Traduzione:
FRATELLI INDIANI!
L' Inghilterra , la nostra secolare ne mica , ha finalmente lasciato cadere la sua masc hera di ipocrisia .
Sin dalla guerra del 1914- 18 il Governo britannico aveva promesso al nostro Paese di volere riconoscere le nostre aspirazioni na zionali. Nell 'Agos to 1940 il Governo di Churchill promise ancora di voler prendere in considerazione le nostre richieste .
E da allora i nostri fratelli , sorpresi nella loro buona fede accorsero a difendere la bandiera britannica, versa ndo il loro sangue s ui campi di battaglia della Grecia, della Libia, dell'Eg itto , di Mal esia , di Birmania.

Ma le promesse in g lesi non si sono realizzate.
TI 9 Agosto, dopo che il Congresso riunito a Bombay aveva approvato unanimamente la mozione di Gandhi , che chiedeva l ' indipendenza dell ' India, le autorità inglesi, con i soliti s istemi di vi olenza e di prepo ten za hanno proceduto all'arresto del nostro Venerando Capo, il Maha tma Gand hi e di sua moglie, del Pandi t Ne hru, del Dr. Azad, di M enza Ali, Sindaco di Bombay , e di altri 50 membri del Congress o .
Questo nuovo atto ve rgognoso e brutale ha s uscitato finalmente la reazione del nostro popolo che, fiero delle sue tradi zi oni, ha proclamato la di s obbedienza civile.
Folle di cittadini , di s tudenti, di lavoratori, don ne, vecchi, ragazzi, hanno s filato lungo le strade di Bombay, di D e hli, di Carachi, di Madras, di Luc.know e di altre città p e r protes tare contro questa nuova offesa inflitta al no s tro popolo.
R inn ovando le ignobili gesta del 1857, le autorità brita nnich e hanno s para to su ques te folle inermi e di s armate, uccidendo e ferendo migliaia di no stri frate li i .
L' ora della riscossa è giunta! Se saremo uniti e compatti ra ggiung eremo l 'agognata libe rt à.
Le trupp e dell' Asse s ono vittorios e su tutti i fronti , in Egitto e in Ru ss ia.
Il Giappone, loro potente alleato, vuole che l'India sia finalmente libera dal giogo inglese.
Il nostro popolo potrà così partecipare al Nuovo Ordine in As ia.
Mentr e i nostri fratelli muoiono in India per il tr ionfo della libertà, non è possibile che voi, soldati indiani, combattiate ancora al fianco del nostro odiato oppressore.
FRATELLI I NDIANI!
Gettate le armi, ribellatevi ai nemici inglesi, presentatevi alle linee italian e e ge rmaniche , dove sarete accolti fraternamente.
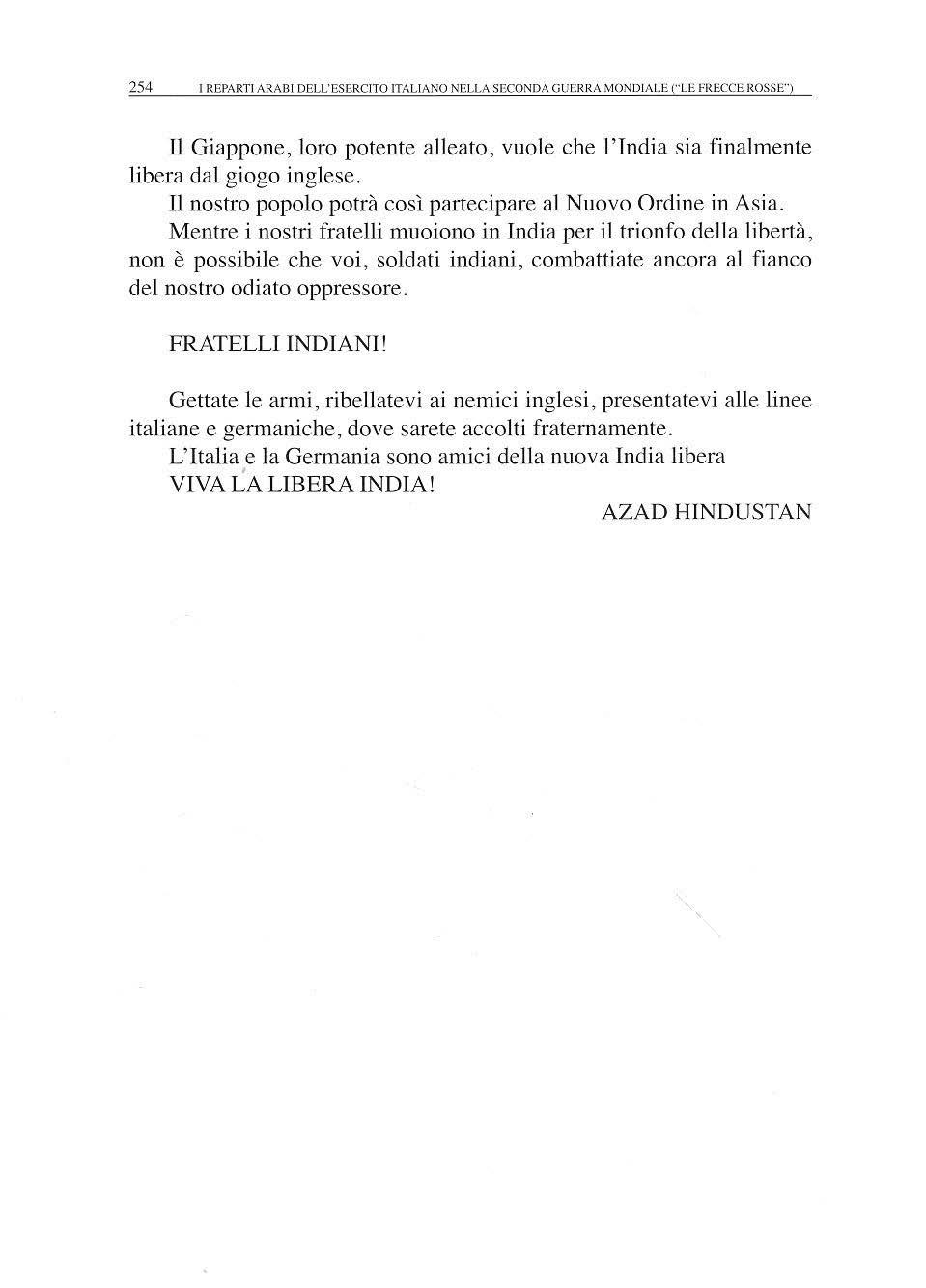
L' Italia e la Germania sono amici della nu ova Ind ia libera
VIVA LA LIBERA INDI A!
AZAD HI ND USTAN
Un appello alla diserzione venne anche lanciato con questo volantino alle truppe neo-zelandesi che ricordava che la guerra ormai perduta dalla Gran Bretagna , non riguardasse affatto la Nuova Zelanda. Le vittorie dell'Asse erano esaltate quale sicura premessa del crollo generale del Commonwealth. Lanciato dopo l'avanzata dell'Asse in Egitto nel giugno 1942, esso non ebbe praticamente alcun effetto (cm 21 x 30)
't~ On th e Russ ian fro o t, eve~ vhere. " • , , C::evasto pol th e grea tes t fortress in the worl , ~ a been w i ped out. , • - t ,,. \ i - '
Tbc higbways to ' South Africa und Australia ~re closed.' In Asia, E ni: land ,h as definitely lost ali power .:J nd ali prestige.
Tbis is tbe fruth ,'1.ich has been so shamefulfy 'hidden rfrom ycnl. We' are telling you in your own interests There is no feeli ng of hatred to make us want to fight against you. .,.
· Perhaps it is your udventurous spirit wbich urge$· you to join.i_with the British - but remember you are fighting in an unj ust oa'use :- a'i'ding and abetting English greed which enjoys profiteering and domine~ring over other peoples' territory.

Stop and think I lnsist upon the truth I
Thcn you will understand how futile it is and how mucli own disadvantage to persi s t in sacrificing yourselves for Eng1!111 H':l
Tradu zione:
Uomini della Nuova Zelanda!
Vi s iete mai domandati perché siete in g uerra?
Per quali ideali e per quali motivi avete lasc iato il vostro paese natio per venire a combattere cosi lontani dalla vostra patria?

Vi siete mai chiesti quanti soldati inglesi ci sono in Nuova Zelanda pronti a sacrjficarsi in difesa delle v ostre città, dell e vostre case e delle vostre ricche zze ?
Gli Inglesi in Nuova Zelanda hanno un s olo obiettivo ; avvantag- • giarsi delle ricche zze naturali del vostro paes e e divenire ricchi a vostre spes e .
La propaganda britannica è un vecch io maestro nel propagandare meravigliose notizie che hanno una buona impressione s ull a gente che non conosce la verità. Se voi conosceste la verità vi r ifiu tereste di combattere per coloro i. q uali v i dominano e vi ingannano e profittano di voi.
Giugno 1942 è stato un mese fatale per la Gran Bretagna.
Nel Mediterraneo, la flotta italiana , insieme con l ' aviazione italiana e tedesca ha riportato una schiacciante vittoria sulla flotta britannica.
In Africa , l 'ese rcito britannico con i s uoi me rcena ri ha perso la più grande battaglia di questa guerra . Più di 65.000 prigionieri , 1200 autoblindo. un migliaio di cannoni, circa 700 aerei, una grande quantità di materiale bellico, trasporti motorizzati e vettovaglie - che, è il bottino catturato dalle truppe italiane e ted esche , truppe che hanno spezzato ogni resistenza in Marmarica e che stanno avanzando vittoriosamente in Egitto.
Sul fronte russo, le truppe bolsceviche sono state sconfitte ovunqu e , Sebastopoli, la maggiore fortezza nel mondo, è stata spazzata via.
Le strade principali verso il Sud Africa e l'Australia sono chi us e.
In Asia , l'Inghilten-a ha definitivamente perso tutto il suo potere e il suo prestigio.
Uomini della Nuova Zelanda!
Noi vi parliamo nel vostro esclusivo interesse . Non c ' è sentimento di odio che c i porti a voler combattere contro di voi .

Forse è il vostro spirito avve nturo so che vi spinge a unirvi agli ingles i - ma ricordate che voi state combattendo per una causa ingiustarendendovi complici dell'avidità inglese che prova piacere approfittandosi e dominando su territori di altre popolazioni.
Fermatevi e riflettete!
Insistete sulla verità!
Solo allora voi comprenderete come futile è questa guerra e quanto a vostro svantaggio è il persistere nel sacrificare voi stessi per l'Inghilterra .
Un appello alla diser zione venne fatto in questo volantino -lasciapassare che invitava i soldati indiani ad abbandonare i ranghi delle truppe inglesi ed a raggiungere le linee dei militari dell'A s se. Il volantino, lanciato dall'aeronautica italiana tra settembre e dicembre 1942, e ra redatto in inglese , in Hindi, in Urduh ed in arabo (cm. 27 x 18).

17. UN MESSAGE DES COMMANDANTS EN CHEF DES FORCES ALLIEES EN AFRIQUE DU NORD

Vale la pena di riportare anche il testo del messaggio in francese ed in arabo che il comandante supremo delle forze alleate anglo-franco-statunitensi di invasione, gen. Dwight D. Eisenhower ed il comandante supremo delle forze francesi gaullìste, gen. Henri Giraud, lanciarono tramite l'aviazione degli Stati Uniti sulle popolaz ioni del Nord Africa, al momento d e llo sbarco in Marocco, il 4 novembre 1942, nel quale veniva promesso agli arabi la prosperità e la pace in piena amiciz ia (cm. 21 x 15) .
I.es Allemonda veulent vous enfever votre pay,. 111 essoient, por des menson9e1 et dei c:adeaux, de vous fa ire c:ro iro qu'ib 1o nt vos omi1. M'ai1 ce n'est là qu'une ruse. 111 veulent prendre yos ptodùìh a5!ricoles e t e n 1i,it~ livrer vos terrei oux ltalieos.
Ne vou1 laissex poi homper. Roppelèx-vau1 ce qu'i11 ont foit depuis deux ans J>Gr 1e mayen .de leurs agenti. 111 ont 1aigné à blonc r Afrique du N«d 011 roflant le blé, l'huile, le bétéll la loine C'est.ò éò,,ii.i d'.euic que ,.~ éte, sani v~menh, aons chouuu~ Q'.e!J~........ un de le ul.'I ~e.fa a - déc laié etl Alle magne et tout &e
·,mo.de· {'!' tu : • N'import, qui peut moarir de · faim, 'mai, ~e ne Ml'Ò·pcll · 1104.II a. • _:. • · '
~ AlYés, ~c'!n-le bien,' ao•t ve11u1 icl seulement pour alcfer
,. ~ fro~'à,~ } . chas~~ .A!lemo!'d• et )e1. ltalien1 liors de ta 1:•~liie.« , o . rtnourer ~ nt !~ P,11 li ,P.~~ et lo Paix. C'est lè~r'te_ule ~?ta nté._ lb ,!'.ont oucua. déilr. de ',pri,er lei Tuni1iens do leur f>OY•.•n , de ~I_Ì!' bieri,. 11, ont déjò montré leur om i tié 11ux M.uJ.~mf~• e n défendont leur couso en Egypte p04,1r qu'on n'ea doute poi. '
·
"<ou1 ne voc,lon1 ta111 "u'une cho08 • • ros-- bi I torrifo· vf · "' - • -m er sur e , • ire · ncofn toutea. lei tro.up~ .,qu'il fout p04,1, aouter aur
1 ltol'? et lo va ,n ~re ~éfinitivement tar , Ìe ~o~tlnen t Po I' cantnbveron1 à d , . . d" • • r o , nou1 la P,cup é r it6 A .red n re ouxd ,n rgene1 tun isien, lo tronqu illité et • 1 ez-nt1u1 on, cette teche N menronge 1 de l'ennemi.' · e croyex por les
Henri GIRAUD, Dwight D. EISENHOWER, Géno,ol d'o""4e Co.mondant e" chef dft Force, Uoutnont ''"'roJ
" dus Commandants en chef des forces alliées en Afrique du Nord TUNISIENS,

Fotografta della consegna della bandiera ai volontari arabi del Centro "A", il 17 ottobre 1942, a Tivoli. Alla cerimonia presen ziava anche il Gran Mufti di Gerusalemme, Amin el Husseini, (sull'estrema destra del palco) . Da notare accanto alla scorta della bandiera , un milite del nucleo carabinieri addetto al raggruppamento Ce ntri Militari

Elementi del Ce ntro "/" in missione di propaganda e di reclutamento nel campo per prigionieri di guerra di Avezzano, nell ' estate 1942:

Bandiera con i colori nazionali indiani fatta confez ionare in oc casione della missione di propaganda ad Ave z zano. L 'alfiere ha an che una tracolla con gli ste ssi colori . La foto è stata scattata dall 'allora tenente Carlo Alberto Ri zz i :

Una cam e rata del campo n. 80 per prigioni e ri di guerra indiani a Tivoli :

Un sottufficiale indiano del Centro "[ " parla ai suoi commilitoni prigionie ri di guerra per esortarli ad arruolarsi nel Centro :

Schizzo di un ufficiale delle "Frecce Ro sse" con le mostrine, bianco, rosso e verde del Batta glione d'Assalto "Tunisia".

Schizzo di un militare del Centro "/", del Battaglione Ha zad Hindostan con le mostrine con i colori del Congresso Indiano , arancione, verde e bianco:

25. FREGIO PER BUSTINA E DA BRACCIO DELLE "FRECCE ROSSE"
Fregio per bustina e da braccio adottato nell'agosto 1942 dalle "Frecce Rosse":

26. SOLDATO INDIANO E SOLDATO ITALO-TUNISINO
Soldato del Battaglione indiano Ha zad-Hindostan

Fregio e mostrina del raggruppamento italo -arabo
Soldato del Battaglione d ' Assalto "Tunisia"

Il 19 giugno 1943, nell'anniversario dell'ascesa al trono del Bey di Tunisi, ebbe luogo a Roma una man(festazione durante la quale il Gran Mufti di Gerusalemme rivolse per radio un ,nessaggio ai musulmani di tutto il mondo di sostegno all'Asse , alla presenza del capo del partito Neo Destur in esilio a Roma, H abib Thamer:






