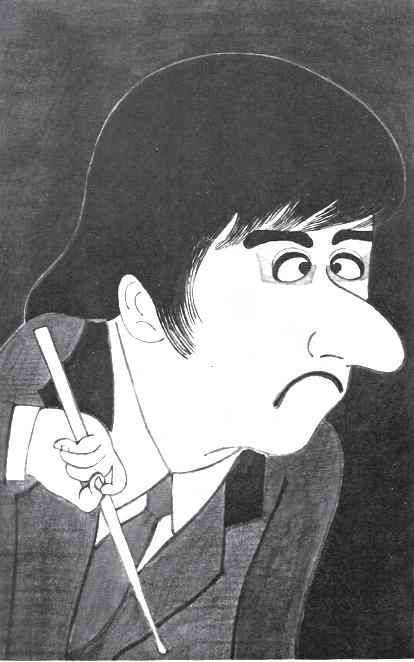CLAUDIA IAZZETTA
Separazione e ricongiungimento. Storie di genitori e figli negli oyako monogurui
Sebbene confinato solo a questa vita, il legame tra genitori e figli1 minacciato da un’improvvisa e inattesa separazione ispira un gruppo di opere di nō che Takemoto Mikio ha denominato oyako monogurui 親子物狂 (nō di genitori e figli lunatici).2 Si tratta di testi accomunati da un pattern di separazione e ricongiungimento che guida i protagonisti attraverso un percorso costellato di passaggi e tappe ricorrenti, coronato, escludendo Sumidagawa, dal rincontro e, quindi, da un lieto fine. Nella sua analisi, Takemoto tenta una catalogazione di tali opere in base alla causa che ha generato l’allontanamento, e arriva ad enucleare tre gruppi (Tab. 1). A seconda della causa, la trama presenta uno svolgimento alquanto predefinito, lasciando ai dettagli il margine per delle irrilevanti ma distintive variazioni. Al primo gruppo appartengono quei drammi in cui un genitore – sempre il padre – dando credito a voci diffamanti, che poi si riveleranno false, disconosce un figlio. È dunque nel ripudio (tsuihō 追放) che si annida la causa del distacco. La vocazione (shukke 出 家) determina, invece, l’allontanamento di un figlio o di un genitore nelle opere appartenenti al secondo gruppo. Infine, il terzo motivo di separazione, il rapimento (yūkai 誘拐), rispecchia un problema che realmente affliggeva la società giapponese del XIII e XIV secolo.3 I testi riconducibili a questo gruppo implicano la presenza di un figlio che, riuscito a scappare dai trafficanti di schiavi che lo avevano rapito, viene ritrovato da un monaco o un laico alle cui cure si affida fino al conclusivo ricongiungimento con il proprio genitore. Takemoto fa rientrare in quest’ultimo gruppo
1
In base alla credenza buddhista che limita solo alla vita presente il legame tra genitori e figli, a quella presente e futura il legame tra due coniugi, ed estende finanche a quella passata il legame tra signore e fedele servitore. 2 Takemoto Mikio, “Oyako monogurui kō”, Nōgaku kenkyū, VI, 1980, pp. 81-122. 3 Il rapimento, particolarmente ricorrente nelle aree di Kyoto e Kamakura, e la susseguente vendita di esseri umani erano severamente perseguiti dal governo di Kamakura, come dimostrano alcuni editti del 1240, del 1290 e del 1303, in cui è possibile rilevare un inasprimento della punizione prevista, dalla reclusione alla pena di morte. Tuttavia, la crescente richiesta di manodopera per lavori estremamente pesanti incrementò la tratta degli esseri umani, e il bakufu di Muromachi, pur non depenalizzandola, si rivelò incapace di frenarne il dilagare. Satō Kazuhiko, “Hitokaibune no nami no oto. Nōgaku ni ikizuku chūsei”, Nihon kosho tsūshin, DCCCXXII, 1998, pp. 2-4.