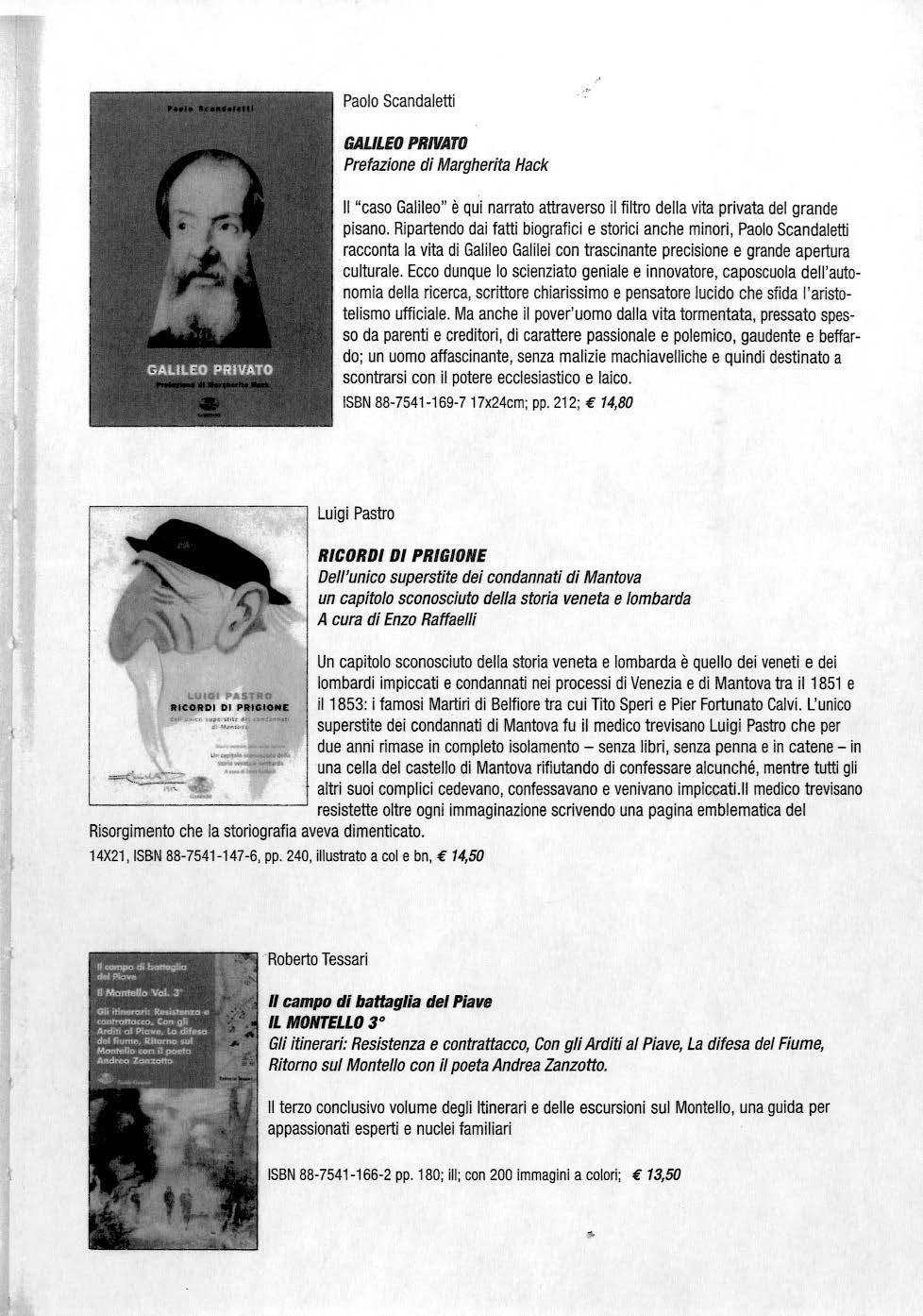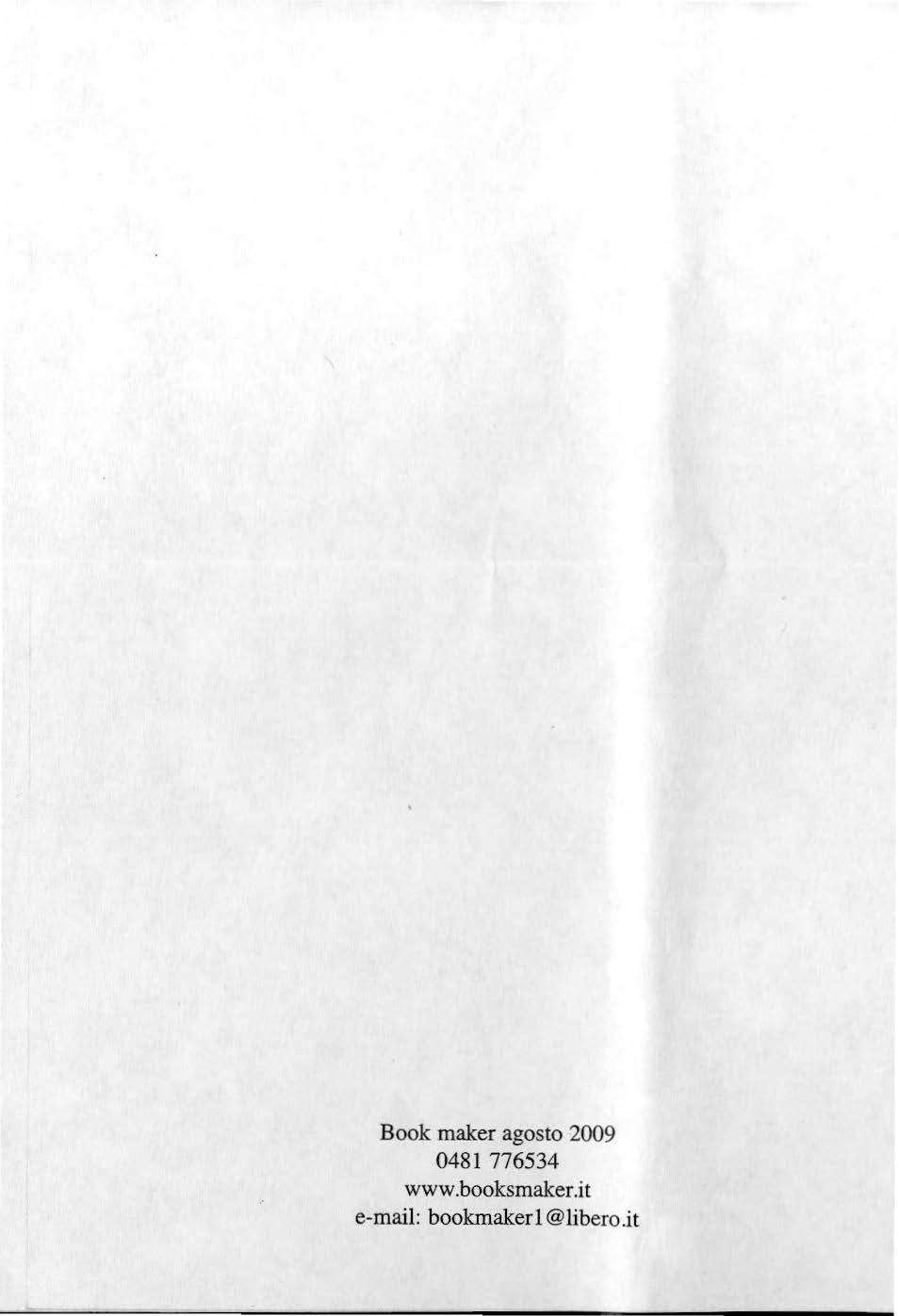Desidero, innanzitutto , mettere in evidenza come, con squisita sens ibilità , ci sia stata offerta la possibilità di riunire un così variegato ma significativo gruppo di studiosi per parlare di un argomento che presenta spunti e punti di vista interessanti sia sotto il profilo morale per gli insegnamenti che può offrire a tutti noi, sia per gli aspetti scientifici veri e propri.
Ci sono tutta una serie di osservazioni che possono essere fatte su ciò che è accaduto ai protagonisti del primo conflitto mondiale e a quanti si sono trovati a viverlo da fuori ma comunque a subirlo.
Naturalmente nei due casi l'approccio al tema è molto diverso e, dunque, preciso che il mio intervento riguarderà il ruolo che ha esercitato l 'università di Padova nel corso e alla conclusione del conflitto.
Questo ruolo è certamente il risultato non solo di un approccio scientifico e didattico ma anche di un approccio politico al problema.
Le relazioni che si succederanno tratteranno di militari e malattie, della guerra di trincea e di quali furono le conseguenze mediche di quel tipo particolare di guerra, si parlerà del problema demografico di Vittorio Veneto che risultò negativamente esaltato dal conflitto, di quanti sono nati, di quanti morirono ma, soprattutto, delle cause della loro morte.
Ma si parlerà anche di quella peste esplosa negli anni 1918-1919 che fu una malattia virale e che si diffuse rapidamente in tutta Europa provocando una moria di giovani, bambini e anziani lasciando in tutte le famiglie, nessuna esclusa, il segno del suo passaggio.
E non verrà neanche trascurato l'aspetto psicologico e psichiatrico che interessò, comunque, tutti coloro che combatterono questo drammatico conflitto.
Queste sono alcune parole tra le tante che abbiamo letto nel depliant di presentazione di questo convegno e prima di parlare del ruolo svolto dall'Università di Padova nella Grande Guerra se fosse necessario potremmo accennare a cosa fu la spagnola, cos'è il colera, ecc.

Ma intanto parliamo dell'Università di Padova e del ruolo che ha avuto.
L'Università di Padova è una delle università più antiche del mondo, è la seconda dopo Bologna ed è la prima scuola medica del mondo. É nata, infatti, da una dia-
di fame" e, comunque, le guerre tra poveri sono sempre le guerre più sanguinose.
Nel1220 i professori dell'Università di Bologna hanno cominciato a litigare e un gruppo di questi si allontanò andando a costituire una nuova scuola a Padova.
Questo sfollare a Padova da Bologna ha portato anche alla coniazione del motto che doveva contraddistinguere, e che contraddistingue, quella università: "Uni versa universis patavina libertas".
Questa "patavina libertas" rappresenta la libertà di pensiero che tutti coloro che lavorano a Padova in quella Università dovrebbero avere e che hanno avuto nei confronti dell'indirizzo di pensiero del papato che governava Bologna.
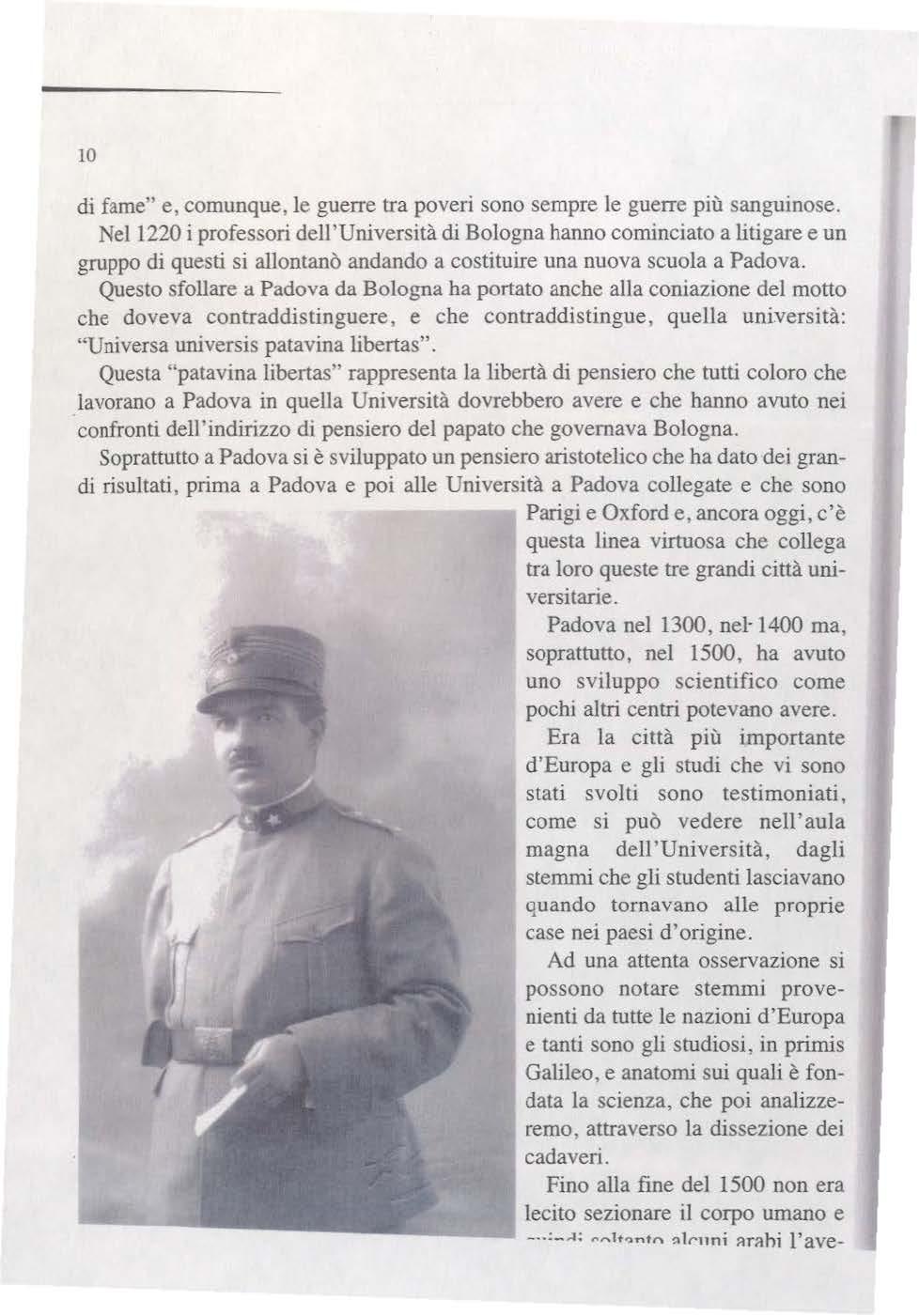
Soprattutto a Padova si è sviluppato un pensiero aristotelico che ba dato dei grandi risultati, prima a Padova e poi alle Università a Padova collegate e che sono Parigi e Oxford e, ancora oggi, c'è questa linea virtuosa che collega tra loro queste tre grandi città universitarie.
Padova nel 1300, nel-1400 ma, soprattutto, nel 1500, ha avuto uno sviluppo scientifico come pochi altri centri potevano avere.
Era la città più importante d'Europa e gli studi che vi sono stati svolti sono testimoniati, come si può vedere n eU' aula magna dell'Università, dagli stemmi che gli studenti lasciavano quando tornavano alle proprie case nei paesi d'origine.
Ad una attenta osservazione si possono notare stemmi provenienti da tutte le nazioni d'Europa e tanti sono gli studiosi, in prirnis Galileo, e anatorni sui quali è fondata la scienza, che poi analizzeremo, attraverso la dissezione dei cadaveri.
Fino alla fine del 1500 non era lecito sezionare il corpo umano e __ ,:_.;:a; nnlt<>ntl"\
che ha descritto la circolazione del sangue, il teatro anatbmico, sede di questi studi è un'opera d'arte anche dal punto di vista architettonico; ha consentito l'approfondimento, la conoscenza e la scoperta di molte delle situazioni fisiologiche e fisiopatologiche.
In una raffigurazione di Fabrizio d'Acquapendente su un architrave è scritto "dove la morte trova piacere a soccorrere la vita" poi, Giovanni Battista Morgagni crea 1'anatomia patologica.
Ci sono diversi livelli di conoscenza.
Praticamente noi vediamo la realtà, realtà che è inconoscibile perché noi non possiamo conoscere la realtà. Noi la conosciamo soltanto attraverso delle mappe che tracciamo di questa realtà e queste mappe dipendono dagli occhiali che indossiamo e nella fattispecie gli occhiali sono la tecnologia, l'esperienza e l'intelligenza .
Allora questo Giovanni Battista Morgagni aveva tutte e tre queste cose, soprattutto aveva la testa, gli occhi e le mani; era un internista, lui visitava i suoi pazienti e, quando decedevano, ne tagliava i corpi e vedeva di mettere in relazione i sintorni con quello che poi trovava all'interno di questi corpi.
La sua è stata una grande rivoluzione culturale.
Non è stata molto seguita a Padova perché, come ho già detto, c'è stata una grande abitudine a litigare e a trascurare coloro che ci stanno intorno.
Quando morì non lasciò un qualificato erede ma cento anni dopo la sua morte a Padova si ritrovarono tutti i più grandi medici d 'Europa per celebrarne la memoria e la sua opera, il libro "De sedi bus et causis morborum per anatomen indagatis" cioè le sedi e le cause delle malattie indagate con questo metodo morgagnano.
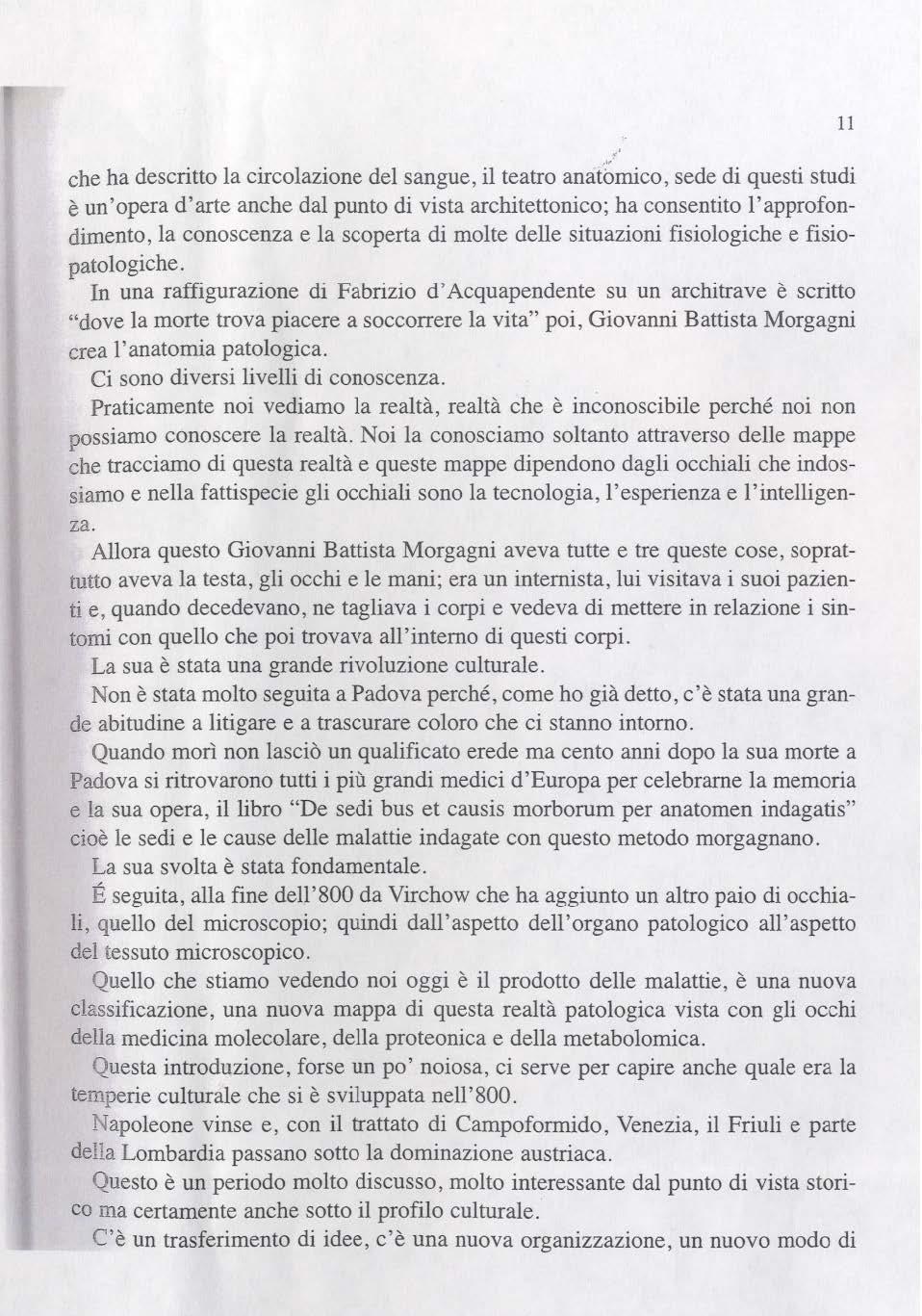
La sua svolta è stata fondamentale.
É seguita, alla fine dell '80 0 da Virchow che ha aggiunto un altro paio di occhiali, quello del microscopio; quindi dall'aspetto dell'organo patologico all'aspetto del tessuto microscopico.
Quello che stiamo vedendo noi oggi è il prodotto delle malattie, è una nuova classificazione, una nuova mappa di questa realtà patologica vista con gli occhi della medicina molecolare, della proteonica e della metabolomica.
Questa introduzione, forse un po' noiosa, ci serve per capire anche quale era la temperie culturale che si è sviluppata ne11'800.
Napoleone vinse e, con il trattato di Campoformido, Venezia, il Friuli e parte della Lombardia passano sotto la dominazione austriaca.
Questo è un periodo molto discusso, molto interessante dal punto di vista storico ma certamente anche sotto il profilo culturale.
C'è un trasferimento di idee, c'è una nuova organizzazione, un nuovo modo di
di stud iare e di vedere le malattie e molti libri , molti testi, molti romanzi lo documentano .
I nostri medici più importanti si formavano a Vienna e molti vie nnesi venivano ad insegnare a Padova e quindi si crea una nuova organizzazione di vicinanza, anche mentale , tra Padova e Vienna.
Le nostre b ib lioteche fino a pochi anni fa a ve vano la gran parte degli abbonam enti "in lingua tedesca. Soltanto dopo la fine della seconda guerra mondiale tutta la nostra cultura medica diviene anglosassone.
n tedesco e il francese , c h e erano le principali lingue della scienza , della filosofia, della diplomazia , lasciano il campo all ' inglese e chi non sa l'inglese ogg i non può informarsi sulle novit à della m edic ina!
Una delle persone più importanti che ha cono sciuto 1'800 e ra Vincenzo Pinali , nativo della vicina Cordenons che si formò a Vienna e divenne professore a Padova .
A Padova Pinali portò dei suoi assistenti forma tisi a Vienna me ntre molti altri vennero inviati dal Governo ce ntrale e quindi si vie ne a cos tituire un gru ppo cu ltural e che si e r a formato a Vienna.
Questa situa zione accentua il momento di transizion e quando cioè , alla conclusione del ciclo risorgimentale , con l a nascita dello stato italiano l'Università patav in a da imperiale diviene Regia uni ver sità.
Questa Regia Università, dovendo dare un segno di cambiamen to , vi trasferisce nuovi docenti portando, co nseguenteme nte , ri sorse alla città .
Qui si manifesta , in tutta l a su a c hi arezza , l'intrecc io tra cultura e politica: come fa uno Stato a d are una impronta di sé? Portan do so ldi e investimenti in quell a zo na do ve ha interesse ad otte ne re una m aggi ore vi sibilità .
E qu es to è proprio qu ello c he fe ce alla fin e dell'800 il ministro della Pubblica I struzio ne appoggiato da alcuni politici patavini.
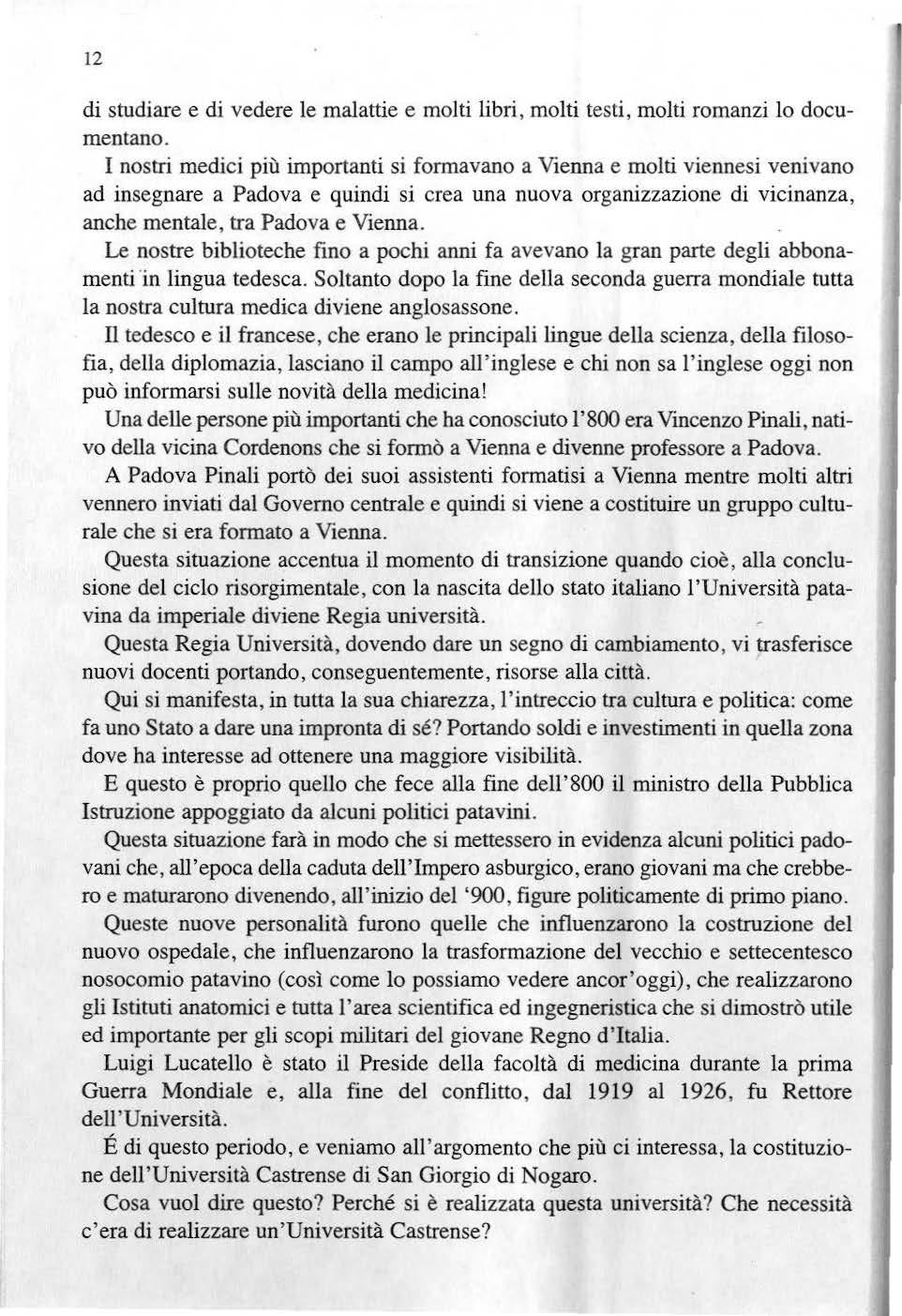
Questa situazion e far à in modo c h e si mettessero in evidenza alcuni politici padovani c he, all'epoca della caduta dell 'Impero asburgico, erano giovani ma che crebbero e maturarono divenendo, all'inizio del '900 , figure politicamente di primo piano.
Qu es te nuo ve perso nali tà furono quelle c he influenzarono la cos truzione del nuovo ospedale, che influenzarono la trasf ormaz ione del vecchio e se ttec e ntesco no socornio patavino (così come lo possiamo vedere ancor 'oggi), c h e realizzarono gli I sti tuti anatomici e tutta l ' area scientifica ed inge gneri sti ca c he si d imostrò util e ed importante per gli scop i militari del giovane Regno d ' Italia.
Luigi Lucatello è stato il Preside dell a facoltà di medicina durante la prima Guerra Mondi ale e, al l a fine del co nflitto , dal 1919 al 1926, fu R ettore dell 'Univers ità.
É di questo periodo , e veniamo all 'argo mento c he più ci interessa, la costituzione dell 'U niversit à Castrense di San Giorgio di Nog aro .
Cosa vuoi dire questo? Pe rc hé si è r ealizzata questa università? Che necessità c ' era di realizzare un'Università Castrense?
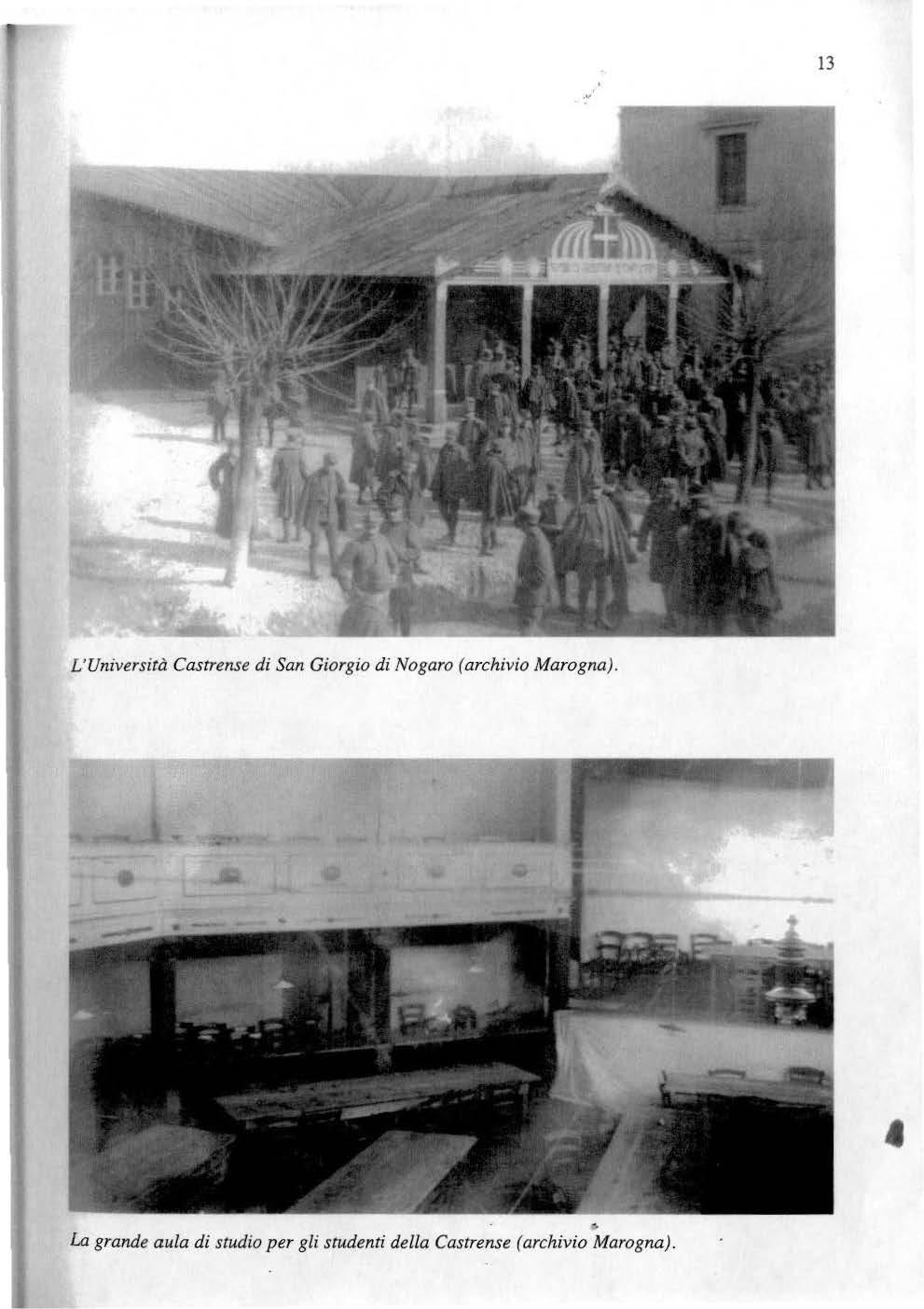
Castrense, da castrum , vuoi dire accampament o militare.
La cos tituzione di ques ta Università militare n asc eva dall ' es igenza di formare in pochi mesi ufficiali medici , neces s ari alle esigenze del conflitto , senza attendere la conclusione dei regolari corsi sessennali oltre , s ' intende , al tempo neces sario a portare a termin e eventuali corsi di specializzazione .
:pal punto di vista politico questo fu un atto molto forte comp iuto dal Comando Supremo in evidente contrapposizione con il Mini stro della Pubblica I struzione.

Questa situazione , che politicamente e culturalmente creò un profondo dissidio anche nell'ambito del Governo, venne, in qu alche modo risolta.
Thtto ciò fu voluto dali' allora I spettrice della Croc e Rossa Italiana che svolse una peculiare attività di controllo negli ospedali e che riuscì a creare questa scuola a San Giorgio di Nogaro e comp letandone l'organico con l'immiss ione di un gruppo di docenti universitari militari.
Questa scuola, però, non poteva funzionare così come era s tat a creata e questo proprio per forte dissidio che si era creato tra lo Stato Maggiore e il Ministero della Guerra da una parte e il Ministero della Pubblica Istruzione dall'altra.
L' accordo venne, infine, trovato e con un decreto luogotenenziale del 1916 si mantenne in vita l'Uni versità Castrense riconoscendo all'esercito la necessità di formare i medici militari da in serire nei ranghi dell ' esercito ma · rivendicava all 'Università il diritto di conferire le lauree.
In virtù di questo decreto gli studenti in medicina che fossero militari di truppa o aspiranti ufficiali medici potevano es sere laureati in soli quattro anni accademici dalla sola Universit à di Padova.
Venne così formato un battaglione univers itario di 1 .300 studenti che si laureavano a Padova provenendo dai diversi corpi dell'Esercito, della Marina ma anche da diversi atenei italiani.
Gli studenti padovani che non erano soggetti a chiamata alle armi e che quindi non facevano parte di questo battaglione che dipendeva direttamente dal Comando Supremo, vennero trasferiti , d'ufficio, all'Università di Bologna.
Chi è un po' pratico di Padova sa che in via Gabelli c'è l'Istituto di anatomia patologica, in via Giustiniana c'è l ' ospedale , in via San Mattia ci sono gli Istituti di fisiologia e medicina legale e poi c ' è l ' Istituto di belle arti "Selvatico" all'interno del quale c'è una bellissima sala rotonda all ' interno della quale venivano svolte le lezioni.
In questa sala dell'Istituto "Selvatico" venivano anche effettuate le viv isezio ni .
Guidava questo fol to gruppo di studenti il professor Lucatello che assisteva sempre alle visite dei pazienti degli aspiranti ufficiali medici.
Da docente universitario il professor Lucatello divenne M aggior Gen e rale, aveva alle sue dipendenze 24 professori ordinari e 5 professori incaricati ma aveva alle dipendenze anche numerosi altri medici che prestavano la loro opera presso altri nosocomi.
Mi piace ricordare alcuni dei nomi di luminari che fecero parte di questa scuol a;
nomi quali il professor Bassini, illustre chirurgo che hi descritto la tecnica d'intervento sulle ernie inguinali, acquisendone gli insegnamenti e impiegando l'anatomia che era stata descritta da un altro medico veneto che era il professar Scarpa, nativo di Oderzo.
Un altro di questi docenti fu il professor Cagnetta, anatomopatologo a cui è intito lata l'aula di anatomia patologica dell'Università di Padova, ma c'erano anche due donne, una ingegnista e una anatomopatologo.
Nell917l'es igenza di mantenere in vita l'Università Castrense fu ritenuta superata e così gli studenti poterono tornare ai consueti corsi universitari regolari.
Presso l 'Istituto di Storia della medicina esistono le fotografie de l professar Lucatello, degli altri docenti e degli studenti.
I corsi terminarono nel1917 , si tennero regolarmente gli esami e 500 studenti furono laureati . Molti di questi studenti persero la vita a Caporetto o durante la conseguente ritirata.
n professor Lucatello volle che i nominativi di que sti ufficiali medici caduti venissero incjsi su l portale dell'Università patavina , portale ottenuto dalla fusione dei cannoni austriaci che il nostro Esercito aveva preteso dalla resa dei resti dell'esercito austro-ungarico.
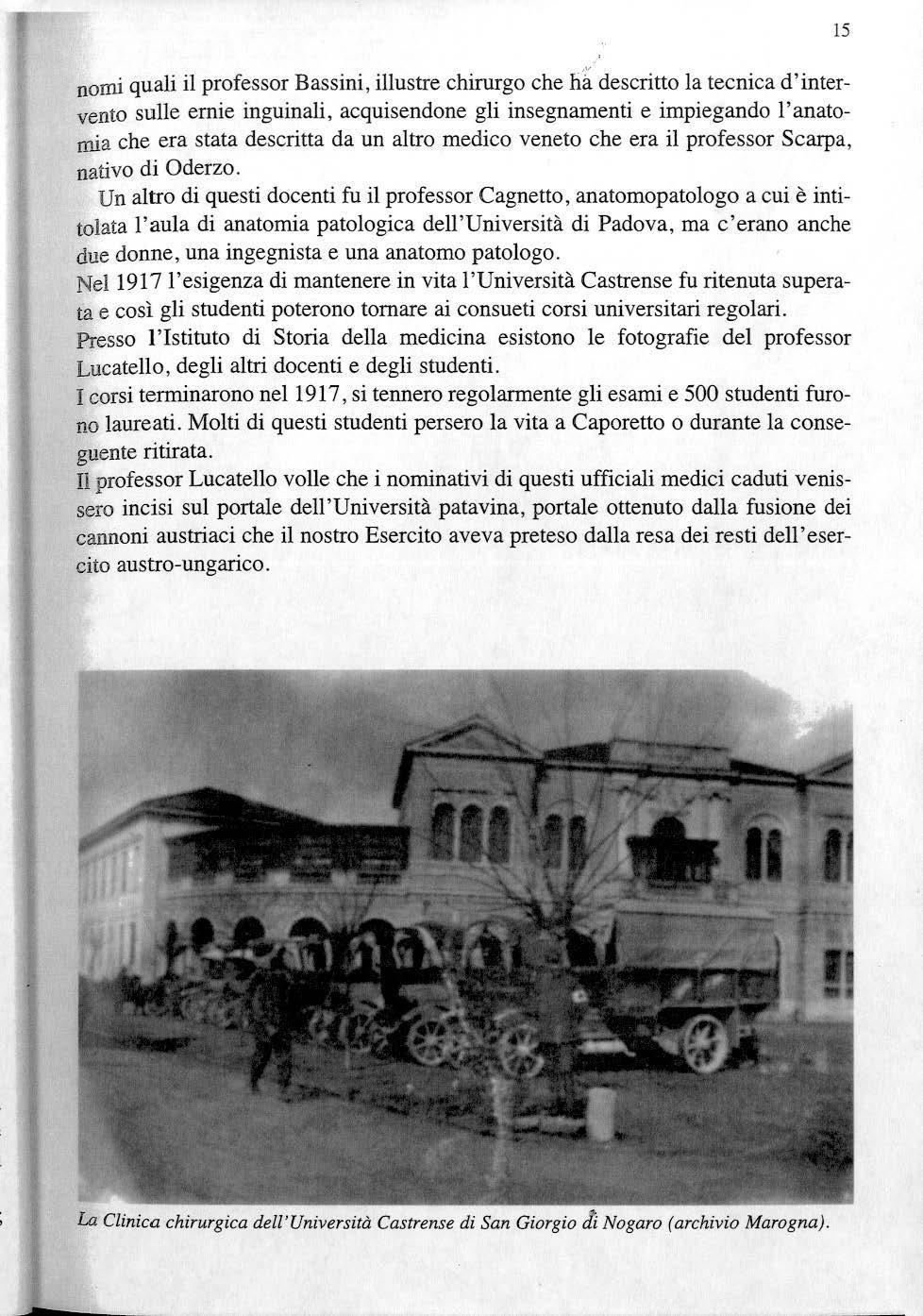
"In tempo di guerra il num ero dei malati supera di molto quello dei feriti. Eppure si os serva questo strano contrasto, che cioè i primi generalmente non sono quasi mai contati e vengono, per cos ì dire , co nsiderati come deboli e come imbelli che banno piegato sotto l'urto della lotta, me ntre i secondi sono tutti forti ed eroi ai quali è riservata la glori a di aver vers ato il loro santissimo sangue per la maggior grandezza della Patria. Un soldato che si ammala di colera nella trincea è malato meno onorevole e commiserabile , agli occhi dei più, di un altro che ha un braccio perforato da una pallottola di s hrapnel. Quello viene trasportato in un lazzaretto e, se guarisce, nes suno saprà che è stato malato; questo, anche dopo guarito sarà sempre il benemerito del suo paese. Se il co lero so muore sarà uno scomparso di più nella grande procella, ma pochi si ricorderanno di lui all'infuori dei parenti e degli amici ; invece se viene a mancare il ferito attorno alla sua fo ssa si innalzerà il peana magniloquente e il suo nome sarà inciso a lettere d 'oro s ui marmi commemorativi " 1 •
Nella memoria della Grande Guerra non c'è posto per migliaia di soldati che so no morti "per malattia".
Siamo di fronte a un paradosso che rimanda ad una idea della morte che per forza deve essere eroica ed avvenire sul campo di battaglia, di fronte al nemico. Col oro c he sopravv ivono dopo essere stati feriti porteranno spesso per sempre i segni del conflitto, al contrario degli ammalati che sono guariti e che sono considerati fisicamente fragili.
Essere d eb oli per l'esercito significa esserlo anche per la patria e non a caso Gaetano Bosc hi s ottolinea come i s oldati malati siano giudicati dell e "vittime grigie della guerra" , degli "eroi mancati" , dei "fratelli minori dei feriti 'rz.

Ciò conferma una volta di più che tra i caduti in g uerra , tra i feriti e gli ammalati e , perfmo tra i combattenti stessi , esiste una gerarchia che tra valica quella tra ufficiali e so ldati di truppa. Ad esempio , facendo riferimento alla memoria locale spesso sui monumenti esistono elenchi distinti dei caduti a seconda di come è avvenuta la morte - s ul campo in comba ttimento , in ospedale dopo essere stati gravemente feriti, in un campo di prigionia - ricorrendo qu i ndi a epigrafi div erse3 •
Nelle storie generali della Grande Guerra l ' argomento delle malattie che hanno colpito i soldati e i civili non è mai stato sufficientemente tematizzato e questo a dispetto dei dati quantitativi già disponibili alla fine del conflitto.
Secondo una statisti ca del1921 , ad esempio , a fronte di 378.000 morti sul campo
e negli ospedali militari o in prigionia in conseguenza defie ferite riportate in combattimento, si registrano ben 168.000 morti per malattia di cui 47.000 nell'esercito territoriale, 59.000 nell'esercito operante, 80.000 in prigionia4
Tenendo conto della composizione per età dell'esercito (dai 20 ai 40 anni), solamente negli ultimi mesi del conflitto si registra un eccesso di mortalità tra il 150 e il200%, in sostanza un eccesso di 50.000 morti imputabili in gran parte all' influenza spag nola.
Preso come base il triennio 1911-1913 (in cui si registra una mortalità annua dello 0 ,65% nella fascia 20-40 anni), l'accresciuta mortalità rispetto agli anni precedenti alla guerra è di circa 130 .000 unità. Si tenga conto, inoltre, che se si adotta una base di calcolo inferiore (O ,5 0 %) in virtù del fatto che i soldati comunque superano una visita medica al momento dell'arruolamento, l'eccedenza di morti può aumentare di 20.000 unità5

La differenza numerica tra feriti e ammalati, stando ai dati relativi all'arco cronologico della guerra è impressionante6 :
Solo nell'agosto del 1918 si registrano 84.350 ammalati, nel settembre 105.160, dal l o ottobre ali' 11 novembre 193.110.
Nei campi di prigionia si è maggiormente es posti alla morte per malattia. D 16 % dei prigionieri italiani muoiono per le malattie contratte durante la detenzione, con un tasso diciotto volte maggiore degli altri, sos tanzialmente in conseguenza della denutrizione.
É noto - e lo era, dati alla mano, già nell'immediato dopoguerra - che nei campi di prigi<:mia o per le sue conseguenze sono deceduti oltre 100.000 so ldati italiani , in gran parte morti a causa della fame.
La spiegazione è tanto semplice quanto inconfes sabile: circa 600.000 soldati erano stati abbandonati al loro destino senza alcun aiuto alimentare al fine di scora ggi are gli altri co mbattenti a disertare e a dars i al nemico come, secondo la versione delle autorità militari, molti avevano fatto durante la rotta di Caporetto7 •
Così, mentre i morti in prigionia dell'esercito francese ammontano a circa 18 .000 - la Francia ha avuto lo stesso numero di prigionieri e per un periodo ben più lungo - quelli italiani sono stati se i volte di più per questa sce lta cinica del governo italiano, aggravata dalla ritrosia ad operare gli scambi dei prigionieri feriti e malati , pratica che in altri paesi era diventata comune fin dal 1915.
L' entrata in guerra impone una serie di problematic he sanitarie c he riguardano non solo i soldati a] fronte, ma anche la popolazione civile. Non è un caso che a partire dal maggio del1915 inizi la pubblicazione di una collana di opu scoli divulgativi affidati a nomi importanti della scienza medica dell'epoca. I terni affrontati in queste brevi monografie sui Problemi sanitari di guerra, spaziano dalla profilass i sanitaria tra la popolazione all'assistenza ai mutilati, dall'importanza dell ' acqua potabile all'igiene del soldato, dall'organizzazione logistica della sanità militare alle cure dell e ferite d'arma da fuoco. Un paio di opuscoli sono dedicati all'alimentazione in tempo di guerra, ma una particolare attenzione è dedicata alla difesa contro il colera, il tifo, il vaiolo, la malaria , la meningite cerebro-spinal e, le malattie veneree8 •

La profilassi nei confronti delle malattie epidemiche è una delle maggiori preoccupazioni della sanità militare - lo è, comunque, anche per gli altri paesi9 - che d eve fare con tutta una serie di difficoltà, a cominciare dai conflitti di competenza con le autorità civilil 0 •
Gli attriti sono all 'ordine del giorno , data la sovrapposizione dei ruoli e l'alto numero di persone che la mobilitazione ha concentrato nelle località prossime al fronte e nella cosiddetta zona di guerra. Si rendono subito necessarie misure profilattiche nei confronti di malattie epidemiche co me il colera, il tifo e il vaiolo , che si diffondono in tempi diversi tra le truppe in trincea.
La prima e più grave epidemia che interessa l'esercito combattente è quella del colera11 •
Rientro in Patria su nave ospedale di militari feriti in Albania.
I primi episo di si registrano nei primi giorni di luglio del 19 15 , quando le truppe italian e occupano le trincee sul Carso, nella zona del Monte Sei Busi, strapp andole a reparti dell 'esercito austr<?-ungarico provenienti dalla Galizia.
ll primo caso di co lera viene penunciato 1'8luglio 1915 fra i soldati del40° fanteria , del X Corpo d'Armata. L'ammalato viene isolato ma il sospetto non ha conferma neli ' esame batteriologico.
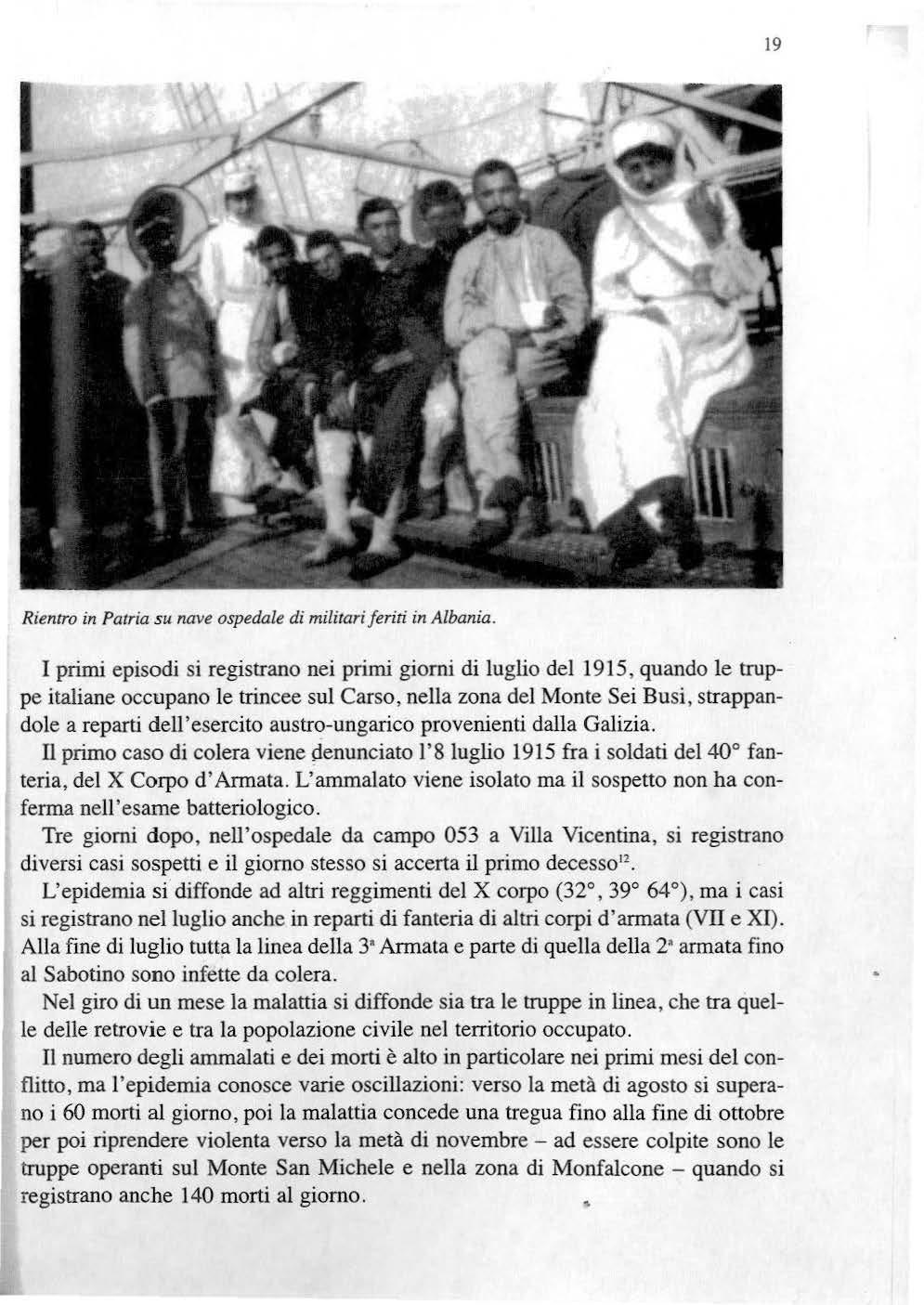
Tre giorni dopo , nell'ospedale da campo 053 a Villa Vicentina, si regi strano di versi casi sos petti e il giorno stesso si accerta il primo dece sso12 •
L'epidemia si' diffonde ad altri reggimenti del X corpo (32°, 39° 64°), ma i casi si registrano nel luglio anche in reparti di fanteria di altri corpi d'armata (Vll e Xl).
Alla fine di luglio tutta la linea della 3• Armata e parte di quella della 2 • armata fino al Sabotino sono infette da colera
Nel giro di un mese la malattia si diffonde sia tra le truppe in linea , che tra quelle delle retrovie e tra la popolazione civile nel territorio occupato
Il numero degli ammalati e dei morti è alto in particolare nei primi mesi del conflitto, ma l'epidemia conosce varie oscillazioni: verso la metà di agosto s i superano i 60 morti al giorno, poi la malattia concede una tregua fino alla fine di ottobre pe r poi riprendere violenta verso la metà di novembre - ad essere colp ite sono le truppe operanti sul Monte San Michele e nella zona di Monfalcone - quando s i reg istrano anche 140 morti al giorno.
La fase di ma gg iore morbilità e mortalità è quella dall ' 8 al18 dic embre. Con il gennaio del 1916 i focolai sono circoscritti e ri stretti.
Nella so la 3• Armata i cas i accertati son o 1962 con 578 morti 13 , ma compless i vamente nella zona di operazioni il numero di contagiati supera i 16.500: nell 'ese rcito i casi sono 16 .02 7 con 4322 morti ; tra la popolazione civile dei territori occupati 582 con 255 morti ; tra la popolazione civile della provincia d i Udine 149 co n 69 morti :
Quindi la mortali tà media è del 28%. In al cuni reggimenti la malattia colpisce il 20 % della forza e si r egistra 1'8% dei morti. Nei 17 reggimenti , in gran parte di fa nteria, in c ui i cas i s uperano il 10%, si hanno 7375 ammalati con 2270 morti : in sostanza quasi la metà degli ammalati e ol tre la metà dei morti.
L'epide mia s i diffonde tra le truppe di fanteria che so no maggiorme nte esposte all'infe zione nelle trincee , ma le ragioni dell a violenza di questa ondata di colera sono da attribu i re anche alla scarsa organizzazione sanitaria de i primi mes i del conflitto , ai mezzi e al personale insufficienti, al ritardo nelle denuncie d ei casi sospetti , al fano che la dislocazione dei reparti operanti non se mpre è nota ai respon sa bili della profilas si p e r ragioni mili tari.
I continu i spos tarnenti dei reparti impediscono l'organi zzazione della profilass i e favori scono il contagio: truppe infette portano il morbo in zone immuni e truppe sane giungono in zo ne infette se nza essere vaccinate.
La profilass i e la vaccinazione sono ostacolate da esigenze belliche , in quanto la bonifica delle aree e la selezione dei s ospetti implicano il ritiro dalla zona di operazioni 14 •
Soltanto durante l ' inverno tra il 19 15 e i11916 è poss ibi le estendere le vaccinazioni, isolare i casi sospetti , ricoverare gli infetti presso le strutture defilate ri spetto agli al tri ospedali , migliorare le condizioni igieniche delle truppe 15 •

L'epidemia mette comunque a dura prova tutta la logistica della sanità militare16 •
La facilità di i ndividuare i focolai dell 'ep idemia spiega la sc arsa diffus ione tra la popolazione civile, tutta-
via con delle eccezio ne: a Cormons con 190 casi e 91 morti, a Monfalcone con 42 casi e 24 morti e nel manicomio di Reggio Emilia co n 145 casi e 41 morti. Casi di co lera tra i civili , per la presenza di feriti o ammalati provenienti dal fronte, s i registrano anche in Veneto, Emilia e Lombardia ; in questo caso la mortalità media è del 25 %.
Un capito lo a parte occupa l'epidemia di colera scopp iata nel dicembre del 1915 tra i prigionieri austro-ungarici durante il viaggio di trasferimento dali ' Albania all ' Asinara17 •
Metà dei 23.739 prigionieri sbarcati ha contratto il morbo, si regi stran o 4574 morti ( 19 %), mentre altri 1519 periscono durante la traversata e vengono gettati in mare.
Tra il 4 e il 5 gennaio 1916 si co ntano ben 141 decessi. Le memorie di un prigioniero ricostrui scono il quadro drammatico di quelle setti mane tra la fine del '15 el' iniziodel '16:
"Catene di uomini, catene senza fine passavano dinanzi a noi, portando alla fossa com une le vittime del terribile male. Vidi allora , n el vo lgere di po che ore, cadere e morire amici forti e robusti ; orrendo e ra lo spettacolo dei loro occhi vi trei , sbarrati , delle sembianze contratte, pietrificate ; delle labbra bluastre di quei poveri cari fratelli. [ ... ] La cifra della mortalità oscillava tra le ottanta e le ce nto vittime al giorno, con raccapriccio vedevo quotidianamente deg li scavi lunghi, larghi , destinati a concedere l'ultimo riposo , il vero riposo a quegli infelici.[ ... ] Alla rassegnazione muta dei sani si univano i lamenti degli ammalati e degli agonizzanti, sparpag li ati fra i cespugli. Indicibile era lo strazio del nostro cuore. Provavamo compassione e ribrezzo insieme: avremmo vo luto accorrere in loro aiuto e nel tempo stesso li desideravamo lontani molti chilometri da noi, per risparmiarci di assistere alla loro terribile agonia" 18 •
Il colera - data anche i' altissima mortalità - rappresenta la malattia più temuta dai sol dati , quella c he rimanda ad un immaginario apocalittico. Potremmo dire che il co lera s ta alle truppe come l ' influ enza spagnola sta all a popolazione civile:
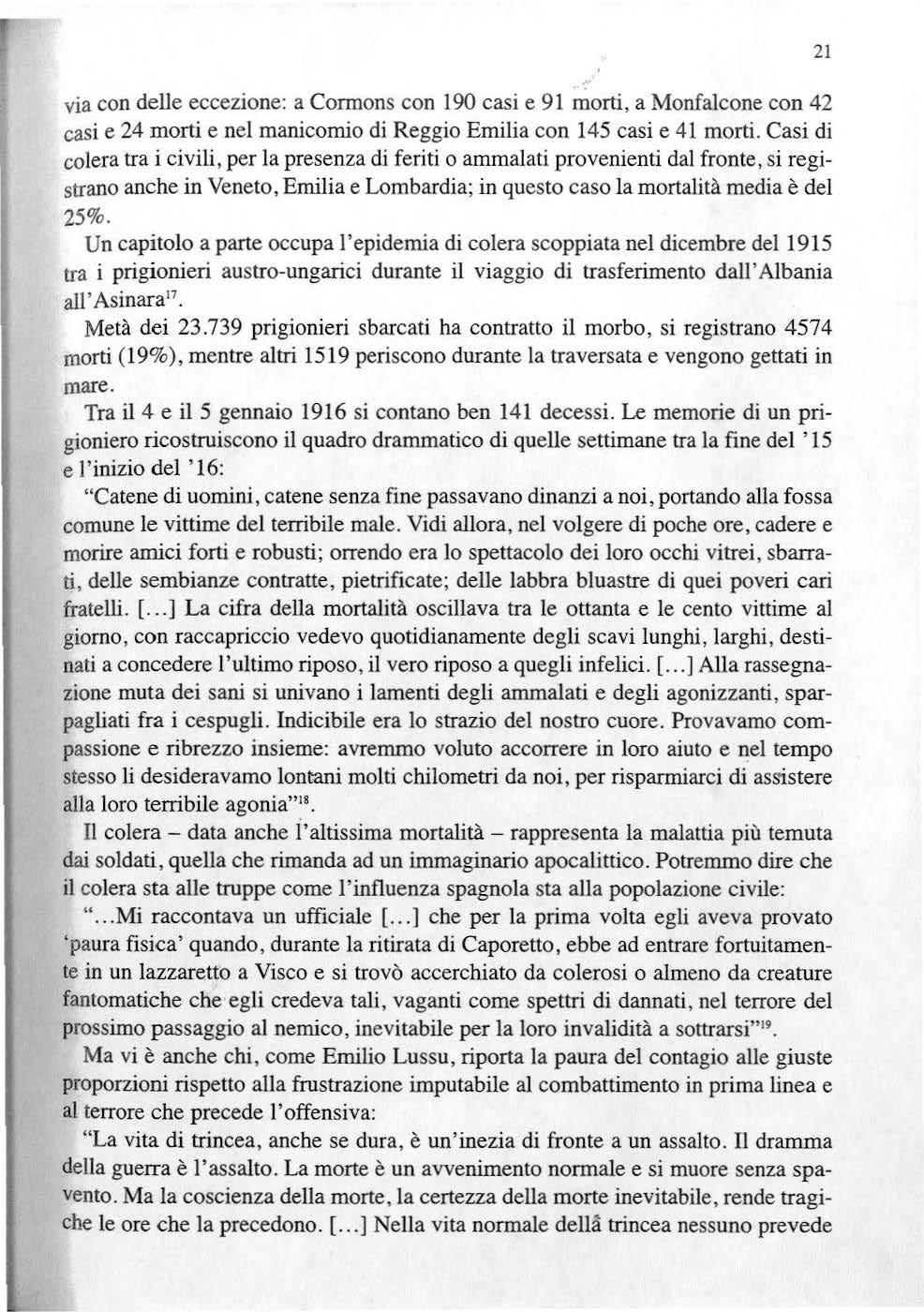
" ... Mi raccontava un ufficiale [ ... ] che per la prima vo l ta egli aveva provato 'paura fisica' quando , durante la ritirata di Caporetto, ebbe ad entrare fortuitamente in un lazzaretto a Visco e si trovò accerchiato da colerosi o almeno da creature fantomatiche che ·egli credeva tali, vaganti come spettri di dannati , nel terrore del pross imo passaggio al nemico, in ev itabile per la loro in validità a sottrarsi" 19 •
Ma vi è an che chi, come Emilio Lu ssu , riporta la paura del contagio alle giuste proporzioni rispetto alla frustrazione imputabile al combattimento in prima linea e al te rrore che precede l ' offensiva :
"La vita di trincea , anche se dura, è un'inezia di fronte a un assalto. Il dramma della guerra è l'assalto. La morte è un avvenimento normale e si muore senza spavento. Ma la coscienza della morte , la certezza della morte inevitabi le , rende tragiche le ore che la precedo no. [ ... ] Ne ll a vita normale dellà trincea nessuno prevede
la morte o la crede in evitab ile; ed essa arriva senza farsi annunciare , i mprovvisa e mite. [ ... ] Anc h e i disagi so no poca cosa. Anche i co ntagi pi ù temuti. Lo stesso colera che è? Niente. Lo avemmo fra la l'e la 2• armata, con molti morti e i soldati ridevano del colera. C he cosa è il colera di fronte al fuoco d'infilata d'una mitrag liatrice? .. ' 'lO
recrudescenza del tifo è dovuta alla concentrazione delle truppe in determin ate località e alle condizioni di vita nelle trincee. Quindi l ' Italia settentrionale e il Veneto s ono parti co larmen te interessati ali ' ep id emia21 •
Le infezioni tifiche co lpiscono soprattutto i giovani, ma la diffus ione dell a malattia è minore rispetto ag li altri eserci ti. n contagio è favorito dalla promi scuità dei soldati e dall'addensamento di truppe in ambienti ristretti, dallo spostamento di reparti da un settore all ' altro del fronte, dall ' arrivo in zon a di operazioni di nuovi comp lementi , dalle fatic he , dalle variazioni di temperatura , dai disturbi dell'apparato di gerente , dall 'ass unzione di carni po co cotte, dal le scarse co ndizioni igi eniche22
Pur mancando prove batteriologiche dirette, è probabile che le cause siano anche idriche, come ad esempio nei focolari registrati a Gonars e a Santa Maria La Lon ga

nella zona della 3• Armata, nei pressi di Gorizia e del Collio (2 • Armata ), nella Val D' Astico, a CastelGomberto e a Gargnano (l" Armata), ma anche in località della Carnia e del Cadore.
Comunque si tratta di casi limitati.
I maJatisono 18.000nel1915,28 .000nell916, 12.500nel1917,6.000nell918. Le infezioni diminuiscono nel corso della guerra grazie ad una migliore profilassi -comunque difficile per le truppe in prima linea, alle vaccinazioni e all'isolamento di ammalati e convalescenti.
La diffusione del vaiolo si verifica solo a partire dal 1917 per il passaggio in Ital ia dei prigionieri rumeni , già soldati nell'esercito austro-ungarico che avevano attraversato anche la Russia2 3 •
I primi casi si registrano in Piemonte, ma vengono sottovalutati. L'epidemia raggiunge anche l'Italia meridionale, ma provenendo direttamente dai Balcani.
I casi di vaiolo passano da 626 nel1915 a 641 nell916 , 1297 nel1917, 4519 nel 19 18, 34.365 nel1919. La malattia si diffonde in particolare nella zona di Napoli e Bari, interessando tutta l 'Italia meridionale e la Sicilia.
Nel pe riodo 1917 - 1922 i morti a causa del vaiolo in queste regioni sono 28.410 contro i 1442 dell'Italia settentrionale. Nonostante questi dati nell'eserci to gli interventi profilattici riescono a circoscrivere l'epidemia: i casi sono 79 nel 1915, 148 nel 1916, 139 nel 1917 e 329 nel1918 .

Una certa inc idenza hanno anche le mal attie par assitarie. Se i casi di malaria nel 1915 sono li mitati, l'anno successivo aumentano in particol are nel settore del Basso Isonzo, nella zona della 3• Armata. Le cause sono da ricercarsi nella modifica del regime idrau l ico e nella mancata manutenzi one dei canali di scolo delle acque.
L a malaria conosce una recrudescenza quando le trincee e le buche prodotte dalle granate favoriscono l a creazione di piccoli impaludamenti24 • Inol tre, l' anofelismo aumenta a causa dell'arrivo di nuove truppe nella zona.
Casi di malaria si verificano però anche tra le truppe operanti nei settori montani. Ad esempio, nel 1917 nella zona di operazioni della l" Armata si registrano 2 371 casi, di cui 62 1 primitivi e tutti in soldati che provengono dal fronte dell ' Isonzo25 •
Le infezioni malariche si diffondono rapidamente e nel 1917 i casi si moltiplicano anche nei reparti che operano in zone immuni .
Viene istituito uno speciale servizio di profilassi, ma la situazio n e si aggrava dopo Caporetto , quando una parte del fronte attraversa la zona paludosa de l Basso Piave, solo in parte bonificata.
Tra il dicembre del1917 e l'aprile del1918 si registrano quasi 12 .000 nuovi casi. Inviati tutti in strutture sanitarie specializzate, circa 1'80% dei malati vengono rimandati al fronte dopo un periodo di 40-70 giorni di cura .
Successivamente si registra una nuova e più forte ondata. Dall ' aprile all ' agosto
del 1918 nelle zone dove operano la 3 • Armata e 1'8• Armata entrano in luoghi di cura 22.242 soldati e 429 ufficiali: 12.111 soldati e 183 ufficiali vengono poi re stituiti al servizio26 •
Ne l solo mese di agosto l'infezione interessa il 2,4% della forza operante nella zona del Basso Piave e mette fuori combattimento circa 10.000 uomini . Stando ad una statistica del 1921 i soldati italiani che hanno co ntratto la malaria sono circa 120.000, 50.000 dei quali in Macedonia e in Albania2'
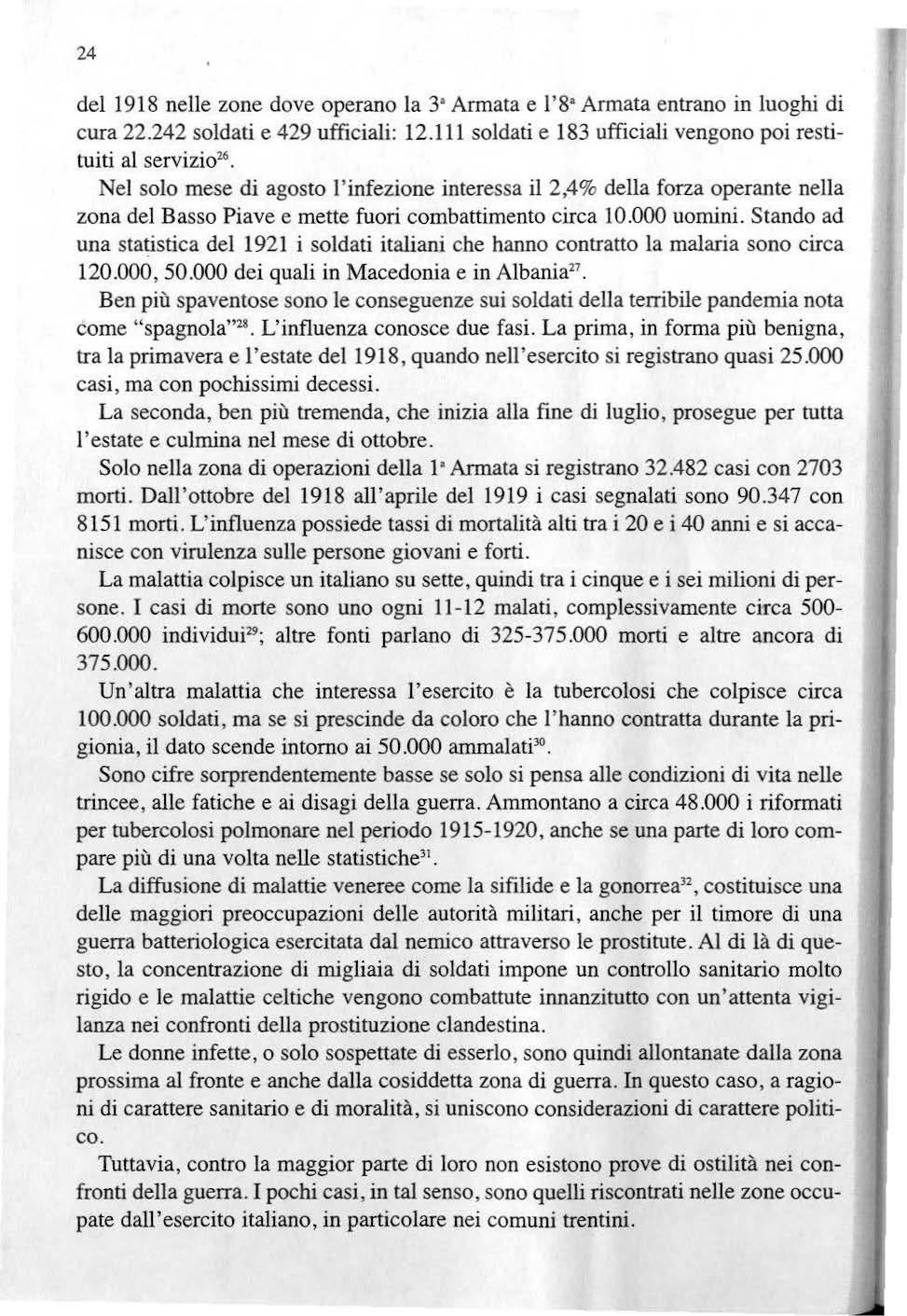
Ben più s paventose sono le conseguenze sui soldati della terribile pandemia nota come "s pagnola"28 • L'influenza conosce due fasi . La prima, in forma più benigna, tra la primavera e l'estate del 1918, quando nell 'esercito si registrano quas i 25.000 casi, ma con pochissimi decessi.
La seconda, ben più tremenda, che inizia alla fine di luglio , prosegue per tutta l'estate e culmina nel mese di ottobre.
Solo nella zona di operazioni della l'Armata si registrano 32.482 casi con 2703 morti. Dall'ottobre del 1918 all'aprile del 1919 i casi segnalati sono 90.347 con 8151 morti. L'influenza possiede tass i di mortalità alti tra i 20 e i 40 anni e si accanisce con virulenza sulle persone giovani e forti.
La malattia colpisce un italiano su sette, quindi tra i cinque e i sei milioni di persone. I casi di morte so no uno ogni 11 - 12 malati, complessivamente circa 500600.000 individui 29 ; altre fonti parlano di 325-375.000 morti e altre ancora di 375.000.
Un'altra malattia che interessa l'esercito è la tubercolosi che colpisce circa 100.000 so ldati, ma se si prescinde da coloro che l ' hanno contratta durante la prigionia, il dato scende intorno ai 50.000 ammalati30 •
Sono cifre sorprendentemente basse se solo si pensa alle condizioni di vita nelle trincee, alle fatiche e ai disagi della guerra. Ammontano a circa 48.000 i riformati per tubercolosi polmonare nel periodo 1915-1920, anche se una parte di loro compare più di una volta nelle statistiche31 •
La diffusione di malattie veneree come la sifilide e la gonorrea32 , costituisce una delle maggiori preoccupazioni delle autorità militari, anche per il timore di una guerra batteriologica esercitata dal nemico attraverso le prostitute. Al di là di questo, la concentrazione di migliaia d i soldati impone un controllo sanitario molto rigido e le malattie celtiche vengono combattute innanzitutto con un'attenta vigilanza nei confronti della prostituzione clandestina.
Le donne infette, o solo sospettate di esserlo, sono quindi allontanate dalla zona prossima al fronte e anche dalla cosiddetta zona di guerra. In questo caso, a ragioni di carattere sanitario e di moralità, si uniscono considerazioni di carattere politico.
Tuttavia, contro la maggior parte di loro non esistono prove di ostilità nei confronti della guerra. I pochi casi, in tal senso, so no quelli riscontrati nelle zone occupate dall'esercito italiano, in particolare nei comuni trentini .
Prostitute di fronte all'ingresso di un postribolo militare (Immagine tratta dal volume di Emilio Franzina, Casini di guerra, Gaspari , 2000).
L'esercizio clandestino della prostituzione si configura solamente come un reato incompatib ile con la presenza delle truppe.
L' internamento riguarda decine di donne e sono poche co loro che si possono rimpatriare con la rev isione del provvedimento, anche se non hanno dato luogo a rilievi di natura politica. -
A partire dalla del 1916 i militari sono costretti a sottoporsi ad una visita sanitaria obbligatoria. Un altro modo per combattere le malattie veneree sarà l'istituzione di case di to lleranza per militari p oste sotto il controllo di ufficiali medici 33 •

Gli internamenti coatti nelle sale celti che nel b iennio 1915-1916 sono 19.902, di cu i 14.120 nei confronti di donne contagiate. Ma la soppressione dei bordelli clandestini, la profilassi per i s oldati34 , l'istituzione di "casini di guerra" contribuiscono alla diminu zione della mortalità per sifilide durante il periodo bellico , secondo una tendenza che troverà una conferma dopo la fme del conflitto35 •
É curioso, infine, come anche nel caso delle malattie veneree le autorità civili e militari siano preoccupate della loro propagazione tra i soldati non so lo per ragioni di carattere sanitario, ma per il fatto che in qu esto modo può risultare indebolita la forza fisica e morale dell'esercito.
Il meretricio è certo visto come un male necessario , ma allo stesso tempo è condannato come fonte di corruzione della famiglia e della nazione.
Spostando il problema su questo terreno, s i sper a di pÒter contenere la diffusio-
ne della sifilide tra centinaia di migliaia di combattenti potenzialmente esposti al contagio:
"Le malattie ve neree , soprattutto la sifilide e la blenorragia (scolo) danneggiano la salute gravemente. É dovere di ogni buon cittadino e soldato conservare integra la propria sal ute per le necessità della Patria [ ] Quando tu fossi malato, as tieniti dal rapporto sessuale con qualsiasi donna: lavati sempre le mani dopo esserti toccato le parti ammalate, non baciare né parenti né amici, e tieni gli oggetti personali esclusivamente per te. Facendo altrimenti correresti il pericolo di attaccare ad altri il tuo male e ciò sarebbe disonesto e di grave danno alla società e alla Patria. [... ]Sii cauto. Ama una donna sola, sposala e procrea d ei figli. Rifu ggi dalle donne di malaffare: esse poss ono rovinare te [e] la tua famiglia. Sarai così un onesto marito, un buon padre , un ottimo cittadino e soldato per la Patria" 36 •
1 Giuseppe Calligaris, Un medico e la guerra, Taddei, Ferrara 1922, citato in Gaetano Boschi , La guerra e le arti sanitarie , Mondadori, Milano 1931 , pp. 91-92.
2 Boschi, lA guerra e le arti sanitarie cit., p 91.
3 Daniele Ceschin, Sernaglia nell'anno della fame. Storia e memoria della Grande Guerra , Edizioni DBS , Seren del Grappa 2008, p. 143.
4 Giorgio Mortara, La salute pubblica in Italia durante e dopo la guerra, Laterza, Bari , 1925, pp. 28-29
5 lvi, pp. 29-31.
6 lvi, p. 32.
7 Giovanna Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra, Bollaù Boringhieri , Torino 2000 (1993)
8 Antonia Francesca Franchini, " Problemi sanitari di guerra ": una collana di opuscoli al servizio della salute (Milano, Rava 6 C Editori, 1915) in Storie di guerra e di medicina e letteratura, a cur a di Ilaria Gorini, Paolo Gaspari Editore, Udine 2008 , pp. 41-46 ..
9 Sophie Delaporte, Medicina e gue rra, in La prima guerra mondiale, vol. l , a cura di Stèphane AudoinRouzeau e Jean-Jaques B ecker, edizione italiana a cura di Antonio Gibelli , Einaudi, Torino 2007 , pp. 299-308. Ministero d ell'Interno, Direzione Gene rale della Sanità Pubblica, La tutela dell'igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria (1915-1920). Relazione del Direttore Generale Dott . Alberto Lutrario al Consiglio Superiore della Sanità, parte l'L'opera di profilassi e l'opera di ricostruzione, Tipografia Giovanni Artero , Roma 1921; Domenico De Napoli, La Sanità militare in Italia durante la l guerra mondiale, Apes, Napoli 1989, pp . 62-79.
10 Sul rischio invisibil e nelle trincee dell'lsonzo rinvio a Antonio Sema, Civili, Militari e colera in Friuli, 1915-16, in "Rivista di Storia Contemporanea" , XXI (1992), n. l, pp. 109-142, che utilizza, oltre al testo di Mortara, un'ampia documentazione inedita, tra cui una Relazione sull'ordinamento sanitario stilato da Ernesto Nathan.
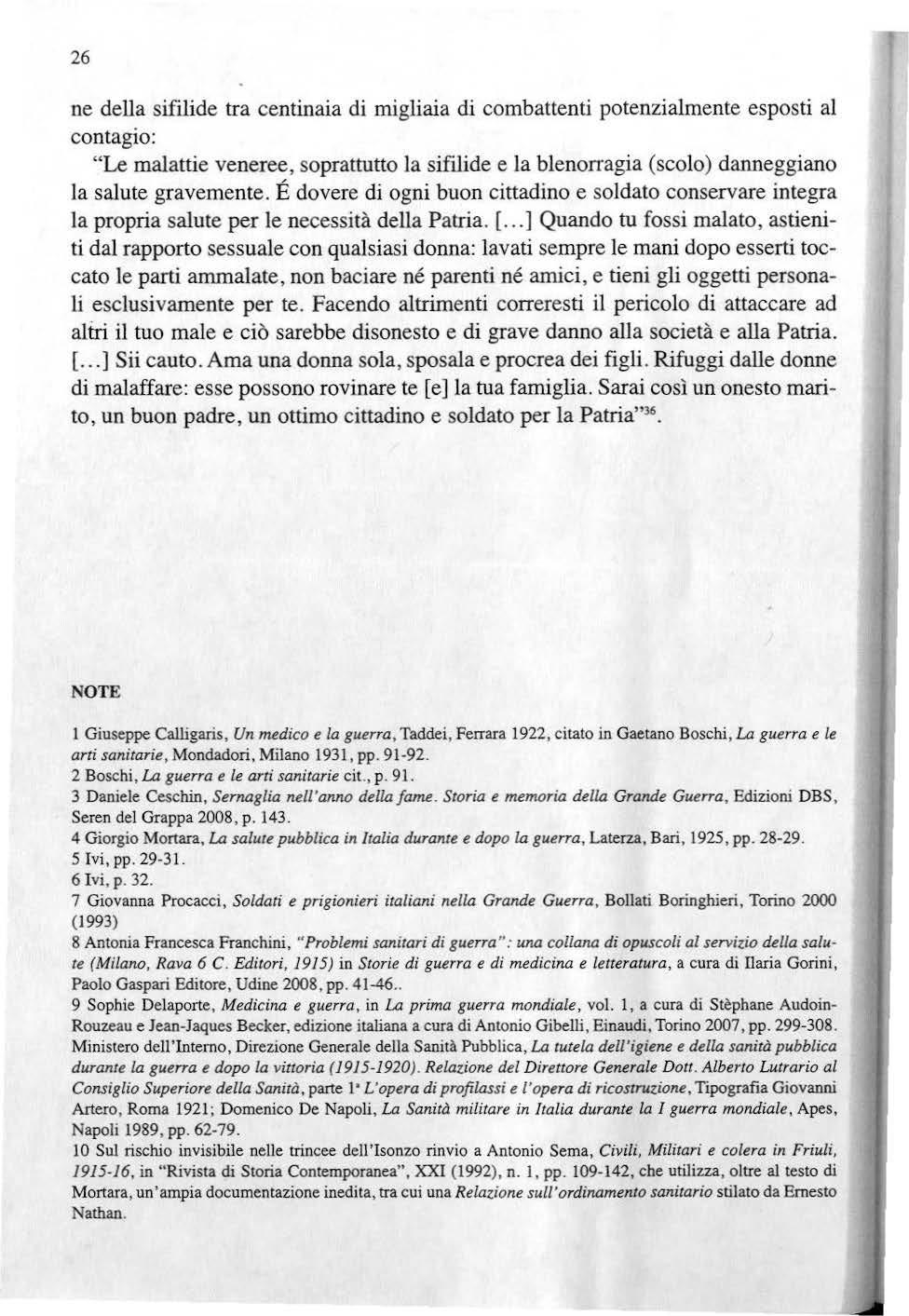
11 Ministero dell'Interno Direzione G enerale della Sanità Pubbli ca, La tutela dell'igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria (1915-1920). Relazione del Direttore Generale D on. Alberto Lutrario al Consiglio Superiore della Sanità, parte 2 ', Le malattie trasmissibili dell'uomo , vol. n , Tipografia
Giov anni Artero, Roma 1921, pp 87-88
12 Nella prima fase i casi sono 1258 con 349 morti, nella seconda 633 con 204 morti: De Napoli, La Sanità militare in Italia cit., p. 81.
13 Ministero dell'Interno. Direzione Generale della Sanità Pubblica, La tutela dell ' igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dnpo la vittoria ( 191 5 -1920) . Relazione del Direttore Generale Dott. Alberto Lutrario al Consiglio Superiore della Sanità, parte 2', Le malattie trasmissibili dell'uomo, vol. n cit., pp 9 1-100.
14 De Napoli, La Sanità militare in Italia cit ., pp . 85-96.
15 Lucio Fabi , Gente di trincea. La grande guerra sul Carso e sull ' lsonzo , Mursia , Milano 1997 (1994), p . 290 .
16 Si tratta di prigionieri già decimati da una lunga marcia da Nis a Valona e consegnati dai soldati serbi agli italiani; cfr. Alessandro Tortato, La prigionia di g uerra in Italia 1915-191 9, Mursia, Milano 2004 , pp . 63-72. Riportate in Giuseppe Carmine Ferrari, R elaz ione del campo di prigionieri colerosi all'isola dell 'Asinara nel J7 1915-16 (gue rra itala -austriaca), Provveditorato Generale dello Stato , Roma 1929, pp .188-189
18 Boschi , La guerra e le arti sanitarie cit ., pp . 100-101.
19 Emilio Lussu, Un anno sull'Altipiano , Einaudi , Torino 2000 (1938), pp 111-112.
20 Mortara,l.A salute pubblica in Italia cit., pp 368-373.
21 Ministero dell'Interno. Direzione Generale della Sanità Pubblica , lA tutela dell'igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria (1915-1920) Relazione del Direttore Generale Dott Alberto Lutrario al Consiglio Superiore della Sanità, parte 2', Le malattie trasmissibili dell ' uomo, col. I, Tipografia 22 Giovanni Artero, Roma, 1921 , pp . 59-60 .
23 Mortara , lA salute pubblica in ltalia, cit., pp. 376-378
24 lvi , pp . 373-376; De Napoli , La sanità militare in ltalia cit ., pp . 281-297 .
25 Ministero dell'Interno. Direzione Generale della Sanità Pubblica , La tutela dell'igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria (1915-1920) Relazione del D irettore Generale Dott Alberto Lutrario al Consiglio Superiore della Sanità, parte 2', Le malattie trasmissibili dell'uomo, vol. I cit. , p . 151.
26 lv i, p. 154.
27 lvi, pp.J56 - 161.
28 Eugenia Tognotti, La "spagnola " in Italia. Storia dell'influenza che fece temere la fine del mondo (19181919) Franco Angeli, Mi lano 2002; Jai Winter, La spagnola, in La prima guerra mondiale, vol. 2, a cura di Stéphane Audoin-Rouzeau e Jean-Jaques Becker, edizione italiana a cura di Antonio Gibelli , Einaudi, Torino 2007,pp. 283-288 .
29 Mortara , lA salute pubblica in Ita lia cit ., pp. 379-38 1 30 lvi , pp. 398-400.
31 Ministero dell'Interno. Dire zione Generale della Sanità Pubblica , La tutela dell'igiene e della sanità pubblica durante la guerra e dopo la vittoria (1915-1920). Relazione del Direttore Generale Dott . Alberto Lutrario al Consiglio Superiore della Sanità , parte 2•, Le malattie trasmissibili deU'uomo, vol. I cìt. , pp 104105 .
32 lvi , pp. 189-205.
33 Emilio Franzina, Casini dì guerra Jl tempo libero dalla trincea e i postriboli militari nel primo conflitto mondiale, Paolo Gaspari Editore, Udine 1999
34 De Napoli, La sanità militare in Italia cit. , pp. 227-240

35 Eugenia Tognotti, L'altra faccia di Vene re .lA sifilide dalla prima età moderna all'awento dell'Aids (XVXX sec .) , Franco Angeli, Milano 2006, pp 207-214
36 Manifesto antisifilide per il soldato , Milano , luglio 1915 , riportato in Fran zi na , Casini di guerra cit., pp 169-170
ITALIANO DEL 1915-1918
di Lucio Fabi
Grande Guerra? m edic i? soldati
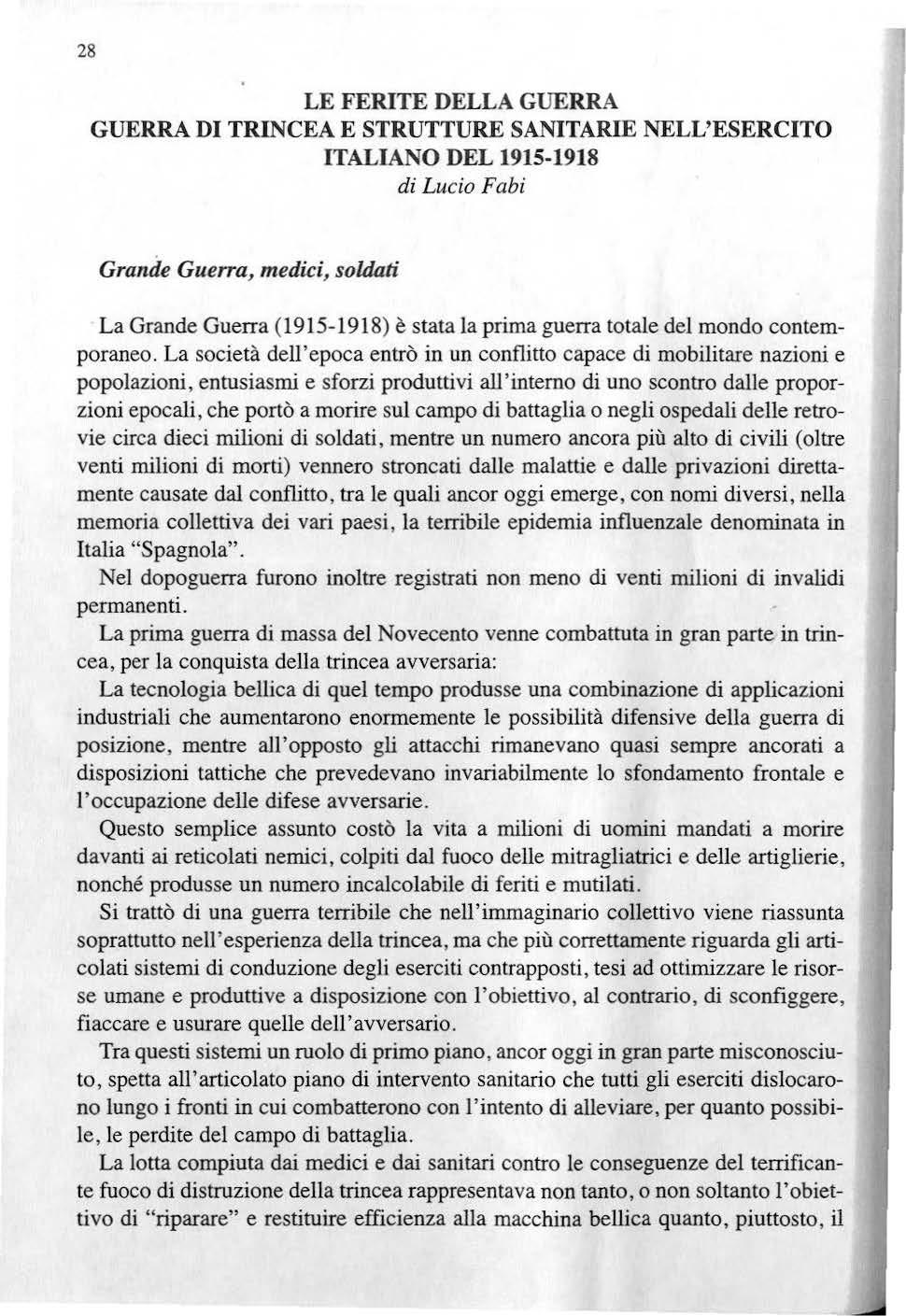
La Grande Guerra (1915-1918) è s tata la prima guerra totale del mondo contemporaneo. La società dell'epoca entrò in un conflitto capace di mobilitare nazi oni e popolazioni, entusiasmi e sforzi produttivi all ' interno di uno scontro dalle proporzioni epocali, che portò a morire su l campo di battaglia o n eg li ospedali delle retrovie circa dieci milioni di soldati, mentre un numero ancora più alto di civili (oltre venti milioni di morti) vennero stroncati dalle malattie e dalle privazioni direttamente causate dal conflitto , tra le quali ancor oggi emerge, con nomi diversi, nella memoria collettiva dei vari paesi , la terribile epidemia influenzale denominata in Italia "Spagnola".
Nel dopogu erra furono inoltre registrati non meno di ven ti milioni di invalidi permanenti.
La prima guerra di massa del Novecento venne combattuta in g ran parte in trincea, per la conquista della trincea avversaria:
La tecnologia bellica di quel tempo produ sse un a combinazion e di applicazioni industriali che aumentarono enormemente le possibilità difensive della guerra di posizione , mentre all'opposto gli attacchi rimanevano quasi sempre ancorati a disposizioni tattiche che prevedevano invariabilmente lo sfo ndamento frontale e l ' occupazione delle difese avversarie.
Questo semplice assunto costò la vita a milioni di uomini mandati a morire davanti ai reti co lati nemici, colpi ti dal fuoco delle mitragliatrici e delle artiglierie , nonché produsse un numero incalcolabile di feriti e mutilati.
Si trattò di una guerra terribile che nell'immaginario collettivo viene riassunta soprattutto nell'esperienza della trincea , ma che più correttamente riguarda gli articolati sis temi di conduzione degli eserciti contrapposti, tesi ad ottimizzare le risorse umane e produttive a di sposizione con l' obiettivo, al contrario, di sconfiggere, fiaccare e usurare quelle dell'avversario.
Tra questi sis temi un ruolo di primo piano , ancor oggi in gran parte mi sconosciuto, spetta all'articolato piano di intervento sanitario che tutti gli eserciti dislocarono lung o i fronti in cu i combatterono con l ' intento di alleviare, p er quanto possibile , le perdite del campo di battaglia.
La lotta compiuta dai medici e dai sanitari contro le conseguenze del terrificante fuoco di distru zione della trincea rappresentava non tanto, o non so ltanto l' obiettivo di " riparare" e restituire efficienza alla macchina bellica quanto, piuttosto, il
tentativo, non sempre riuscito, di rispondere per quanto possibile efficacemente alla devastazione fisica e psichica del campo di battaglia.
La lotta era in effetti impari: i mezzi e le conoscenze della scienza medica d ' inizio secolo potevano poco o nulla di fronte all'impressionante massa delle ferite prodotte dalla guerra.
Non tanto perché que ste si differenziassero significativamente , per origine e qualità da quelle affrontate all'epoca dalla pratica medica quanto, piuttosto, perché si presentarono in un numero così rilevante di casi da mettere a dura prova le strutture sanitarie militari e civili che non riuscirono a rispondere adeguatamente alla massiccia e, per certi versi, non preventivata domanda d'intervento che proveniva dai reparti combattenti 1 •
Le ferite del campo di battaglia non esaurivano, infatti, il quadro clinico dell'intervento sanitario militare italiano. Oltre cinquemi l a militari italiani e non me no di diecimila prigionieri austro -ungarici morirono per il colera tra il 1915 e il19 16 e, complessivamente, nell'esercito italiano furono circa 100 mila i decessi per malattie varie come meningite, tubercolosi, tifo, malaria, influenza spagnola.

Le statistiche sanitarie individuarono, inoltre, un'alta mortalità per malattie respiratorie e patologie infettive indotte dalla promiscuità, dalla cattiva alimentazione e dalle scarsissime condizioni igieniche della trincea.
Ugualmente impressionante il numero dei colpiti da shock da trincea e altre malattie nervose 2 •
L'impossibilità di rispondere efficacemente al bisogno di cure dei militari a loro affidati non mancò di produrre, in molti medici, un sentimento di inadeguatezza che s pesso veniva giustificato dalla straordinarietà della situazione contingente, del tutto "fuori norma" per i parametri sanitari dell'epoca.
Ci furono però anche molti medici che cercarono nelle pieghe del sistema sanitario militare di porre, per quanto possibile, un limite al manchevole funzionamento di un intervento che, se da un lato si trovava sopraffatto dali' enorme quantità delle prestazioni richieste, dall'altro si adeguò forse troppo sollecitamente alle reg ole e alle disumane condizioni imposte dalla guerra di massa che tendeva a sottovalu tare le risorse umane in quanto facilmente intercambiabili e, relativamente, inesauri bili.
Certo chirurgia medicina uscirono rafforza te dali' immane pratica che venne fatta durante la guerra e questo portò, indubbiamente, un progresso nella pratica sanitaria ma non si può certo dire che la guerra abbia fatto bene alla medicina .. Semmai il contrario.
Non c'era certo bisogno della guerra per far fare pratica ai medici n é per perfez ionare le tecnologie d'intervento e diagnosi chirurgica e ospedaliera.
Del re sto, come in ogni campo e in ogni tempo, la guerra cavalcava il progresso e quindi anche la medicina si evolve, con successi ma anche con disastri. Soltanto un esempio: nel periodo bellico la morfina venne prodotta in grande quantità per
lenire i dolori delle ferite e grazie alle sco rte accumulate nel primo dopo guerra un suo derivato , la cocaina, diventò di u so abbastanza comune, sp ec ie in certe fasce sociali.
Allo s te sso modo , nel secondo dopog uerra , dalla ing ente produzione degli antidolorifici si arrivò a sintetizzare droghe come l 'e roina e altri oppiacei che finiscono, poi , per arrivare al consumo comune con comprensibili danni per l'intera società. ·
Un esempio, tra i tanti, del travaglio interiore di molti medici e s anitari nel corso del primo conflitto mondiale è dato dal diario d i guerra del capitano medico Gregorio Soldani da Pontedera che offre una esauri ente tes timonianza non soltanto d eli' operato degli ospedali da campo nelle retrovie carsiche dei primi due anni di guerra, ma anche, e soprattutto, della disillu sione del medico davanti alla sostanziale inadeguatezza del suo intervento di fronte alla durezza e alle dimen sio ni della situazione contingente3 •
Questa situazione potrebbe essere estesa ai sanitari di tutti gli eserciti belligeranti, tanto lo stesso problema si ripropone sui vari fronti del conflitto. Certo però che un 'analisi comparata, ancora in gran parte da fare, permetterebbe di far emergere ulteriori differenziazioni e particolarità.
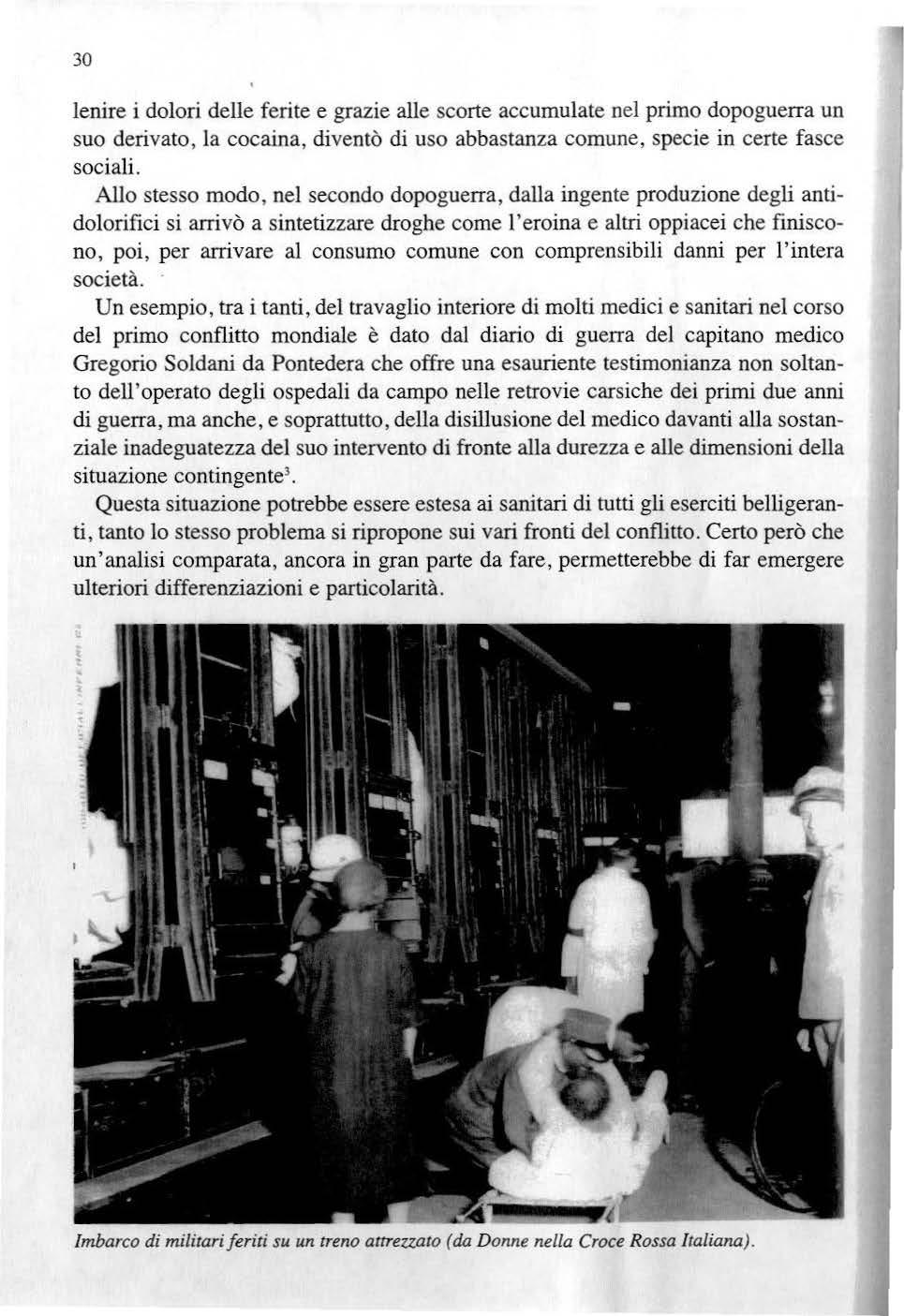
Mario l s nenghi e Giorgio Rochat nel loro La Grande Gu e rra 1914-1918 si sono posti il problema dell ' efficacia dell ' intervento sanitario i taliano nel corso del primo conflitto mondiale , partendo da un dato per certi ver si impressionante: l'altissimo numero dei militari italiani ricoverati per malattia.
Le statistiche sanitarie registrano oltre un milione di ricoveri di soldati nel corso del1917 (1.057.300 per l'esattezza); l'anno successivo il numero aumenta a oltre un milione e 310 mila su circa cinque milioni di soldati mobilitati.
Ancor più inquietante il dato complessivo dei morti per malattia: circa centomila su un totale di circa 500 mila dece ssi di militari entro i11918 (s enza ovviamente contare i militari morti in prigionia) , " oss ia il20 per cento- cito da La Grande Guerra 19141918 - più del doppio in percentuale rispetto all'eserci to francese" che , su un milione e 350 mila decessi di militari ne denunciava circa 135 mila morti per malattia4 •
Pur in mancanza di un quadro di studi analitici sul tema, a livello di ipotesi Isnenghi e Rochat giungono alla conclusione che il rilevante diario di decessi per malattia tra l'esercito italiano e quello francese, condotti a combattere una pressoché analoga guerra offensiva sui rispettivi fronti in cui vennero impiegati, era dovuto all'eccessivo sfruttamento delle truppe (lunghe permanenze in trincea, abbigliamento non sempre sufficiente , poca attenzione all'alimentazione e al riposo delle tnippe , arruolamento indiscrirninato anche nei casi dubb i) voluto da Cadoma negli anni delle e s asperate offensive cars iche5 •
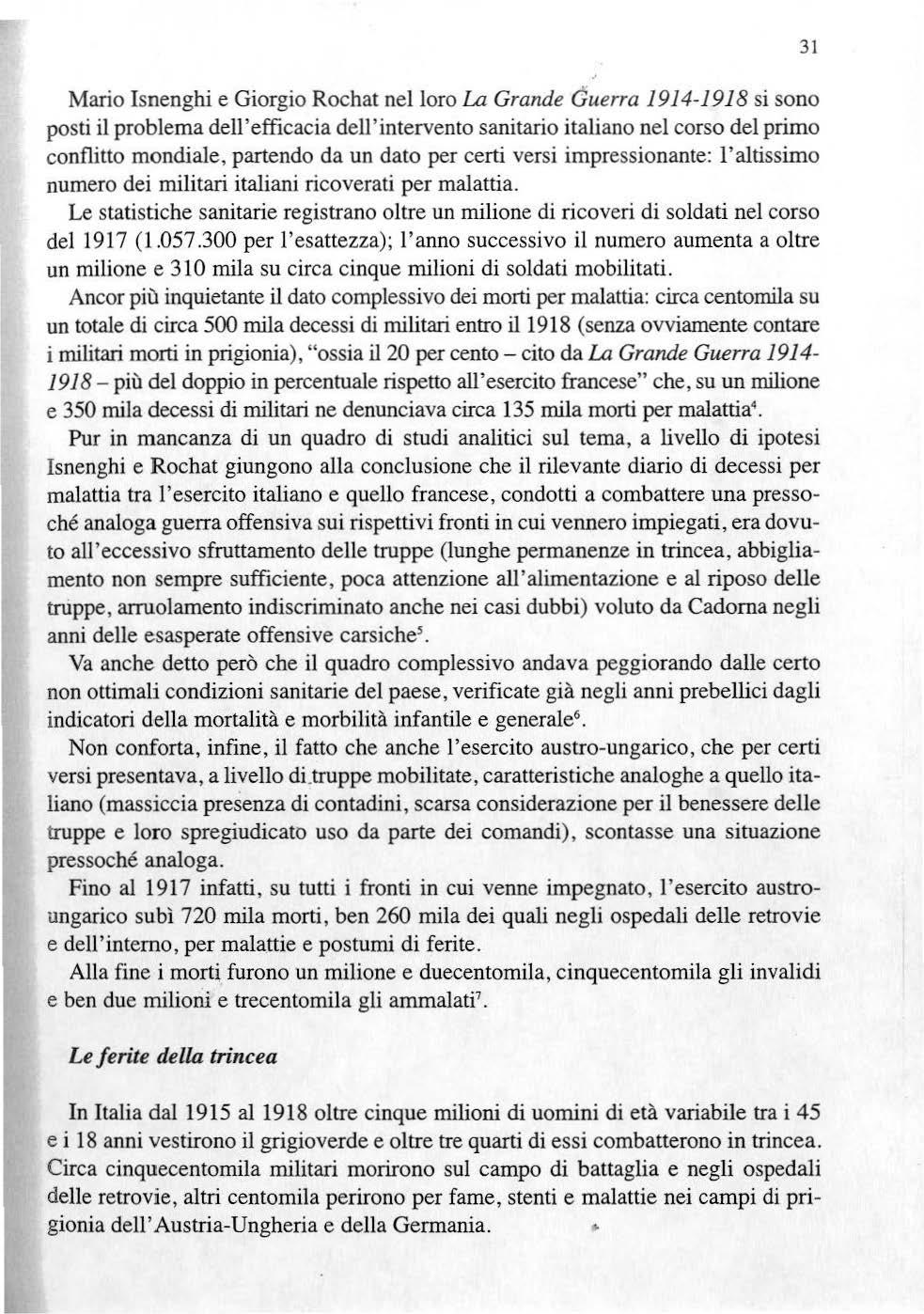
Va anche detto però che il quadro complessivo andava peggiorando dalle certo non ottimali con dizioni sanitarie del paese, verificate già negli anni prebellici dagli indicatori della mortali tà e morbilità infantile e generale6 .
Non conforta, infine, il fatto che anche l'esercito austro-ungarico, che per certi versi presentava, a livello di .truppe mobilitate, caratteristiche analoghe a quello italiano (massiccia presenza di contadini , scarsa considerazione per il benessere delle truppe e loro spregiudicato uso da parte dei comandi) , scontasse una situazione pressoché analoga.
Fino al 1917 infatti, su tutti i fronti in cui venne impegnato , l'esercito austroungarico subì 720 mila morti, ben 260 mila dei quali negli ospedali delle retrovie e dell'interno, per m ala.ttie e postumi di ferite.
Alla fine i morti furono un milione e duecentom ila, cinquecentomila gli invalidi e ben due milioni e trecentomila gli ammalati7 •
In I talia dal 19 15 all918 oltre cinque milioni di uomini di età variabile tra i 45 e i 18 anni vestirono il grigioverde e oltre tre quarti di essi combatterono in trincea. Circa cinquecentomila militari morirono sul campo di battaglia e negli ospedali delle retrovie, altri centomila perirono per fame, stenti e malattie nei cam pi di prigionia dell'Austria-U ngheria e della Germania . •
Nel dopoguerra furono 220 mila i "grandi invalidi" con una accertata rilevante menomazione fi sica o psichica che dav a diritto alla pensio ne statale , ma moltissimi combattenti ci vili continuaro no a soffrire per anni i postumi di malattie , infezioni o fe rite co ntratte in gu erra.
Dal can to s uo l'Au stria-Ungh e ria , impegnata dall91 4 su più fr onti, reg istrò o ltre un milione di morti tra i militari del suo esercito , mentre gli ammalati e gli invalidi censiti alla fine del conflitto so no cir ca tre milioni.
L'esperienza della trincea seg nò in maniera indelebi le più ge nerazioni in armi.
D e nt::o la trincea, scavata nel terre no per c irca un metro e mezzo di profondità e larga poco meno , r afforza ta da un parape tto di pi etre e sacchi di terra al to mezzo metro , co n fe ritoi e e osservatori camuffa ti co n frasc he e terra , i soldati vivevano in ricoveri semi nterrati di poco più di un metro quadrato.
Il panorama che si vedeva dalla trincea e r a desolante: scompariva la natura e, al s uo pos to , ovun qu e sul te rre no pietre e terra bruciata , siepi di filo spinato arrugginito , corpi in decompo sizione che non era possibile raccogliere a causa d e l fuoco avve rsario.
E po i armi, oggetti e rott ami ferros i , rifiuti ed escrementi buttati fuori dalle tri ncee da uomini tormentati da p arass iti , infezioni , affollamen to , fango e s porci zia.
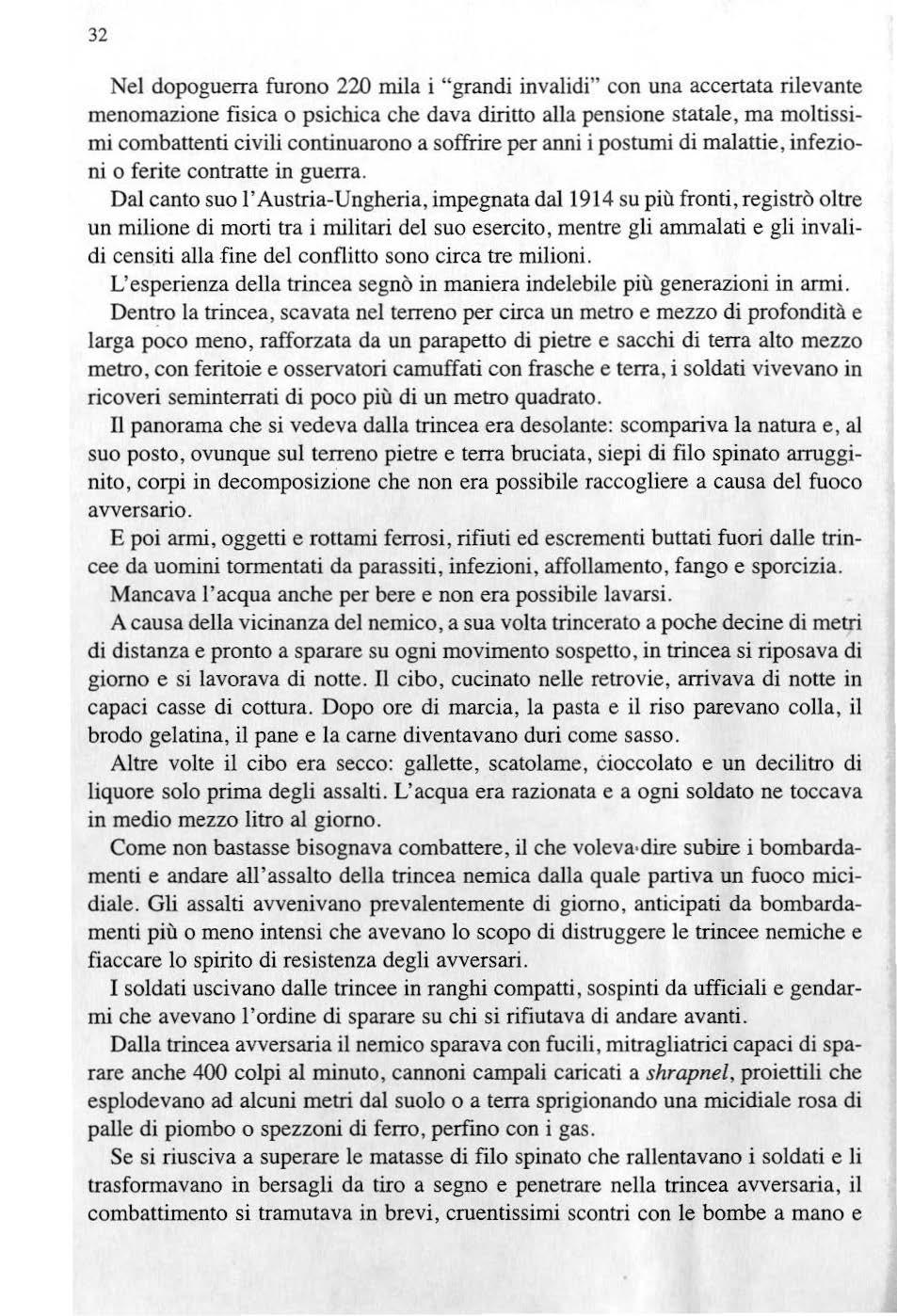
Mancava l'acqua anch e p er be re e non era poss ibi le lavars i
A causa dell a v ic inan za del ne mico, a su a volta trincerato a p oche decine di metri di di stan za e pronto a s parare su ogni movimen to sospetto, in trincea si rip osava di giorno e si lavorava di notte. Il cibo, cucinato nelle retrovie, arrivava di notte in capac i casse di cottura. Dopo ore di marcia, la pasta e il ri so parevano co ll a, il brodo gelatina , il pane e la carne diventavano duri come sass o
Altre volte il cibo era secco: gallette , scatolame, cioccol ato e un decilitro di liquore so lo prima degli assalti. L'ac qua era raz io nata e a ogni sol dato ne to ccava in medio mezzo litro al giorno.
Come non bastasse bis o gn ava combattere , il che voleva·dire subire i bombardam enti e andare all 'assal to d ella trincea nemica dalla qual e partiva un fuoco micidiale. Gli assalti a vvenivano prevalentemente di giorn o, anticipati da bombardamenti più o meno intensi che avevano lo scopo di distruggere le trincee nemiche e f iaccare lo spirito di resistenza degli avversari.
I so ldati uscivano dalle trin cee in ranghi compatti , sosp inti da ufficiali e ge nd armi c he avevano l'ordi ne di sp arare s u ch i si rifi utava di andare avanti.
D all a trincea avversaria il ne mi co sparava con fu ci li , mitragliatric i capaci di sparare anche 400 co lpi al minuto , cannoni camp ali caricati a shrapnel, proiettili che esplodevano a d alcuni metri dal suolo o a terra spri gio nando una micidiale rosa di palle di piombo o spezzoni di fe rro , p erfmo con i gas.
Se si riusciva a superare le matasse di filo spinato c h e ralle ntavano i soldati e li tra sformavano in b ersagli da tiro a segno e penetrare nella trincea avversaria , il comba ttime nto si tramut ava in brevi, cruentissimi scontri co n le bombe a mano e
ali ' arma bianca" : con baionette e coltelli , il calcio dei fucili, le mazze ferrate o micidiali utensili come picconi e vanghette .
Tutti questi nefasti atti provocavano , com'è comprensibile, un grande n umero di decessi e un ancor più rilevante nume ro di feriti. Nonostante i progressi compiuti dalla medicina e dalla chirurgia all'inizio del secolo , le ferite da arma da fuoco o da sc hegge risultavano micidiali per gli effe tti diromp enti sulle p arti del corpo che raggiungevano testa, torace , arti superiori e inferiori.
Soprattutto nel primo anno di guerra , quando ancora l'esercito italiano andava all ' assalto s en za elmetto, introdotto in numero consiste nte so ltanto ne11916.

Malattie e infezio ni erano complicate dalle inenarrabili condizioni igi eniche e dalla scarsa efficacia di un intervento sanitario spesso non tempestivo. Fino all'avvento degli antibiotici , utilizzati per la prima volta dall'esercito americano nel s econ do confli tto mondiale , le ferite addominali , al to race e al capo provocarono una mortalità alti ssima p er infezione .
All o scopo di scongiurare la cancrena gassosa, causata dalla co ntamin azione delle ferite con germi viventi nel terreno, i chirurghi praticavano radicali amputazioni, ma ugualmen te il ri s ultato di ogni ba ttaglia era un al ti ssimo numero di decessi tra i feriti.
Dal diario del capitano medico Soldani, un vivido quadro tipolo gico dell e "ferite della trincea": "Nelle trincee s ono la testa e l'arto superiore i più esposti ai colp i nemici , come nelle trincee e fuori è l 'arto inferiore che corre i maggiori pericoli dallo scopp io delle granate e delle bombe a mano. Trattandosi di ferite di guerra
Il capitano medico Gregorio Soldani. niche accettabili.

bisogna partire dal prin c ipio che esse sono più o meno gravemente infette , specialme nte se prodotte da schegge di granata. D ' altronde nemme no le pallette di shrapnel e quelle di fucile possono guardars i come asettiche, esse trascinano con sé nella ferita frammenti di vestiario e tutto ciò che incontrano, quindi l'aseps i , cioè l' asetticità della ferita, è sempre compromessa"8 •
In tale contesto , va rilevata l'estrema difficoltà dell'intervento del medico, costretto a lavorare quas i semp re in emergenza, con un numero di pazien ti superiore a quello preventivato , in strutture ch e, p er pulizia e igi e ne, non erano certamente c omparabili con gli attuali ospedali.
In questo scenario, appare ovvio c he non sempre le ferite per arma da fuoco o per schegge potevano essere curate con venienteme nte , s oprattutto per la mancanza di co ndizioni igie-
Nonostante tutti gli s forzi , quasi se mpre i feriti arrivavano all'ospedale da campo dopo una permanenza più o meno lunga sul campo di battaglia, a contatto con i germi del terreno, spesso causa di infezioni che, in breve tempo, potevano portare alla diffusione nei tessuti della "cancrena gasso sa", terribile complicanza che, in mancanza di antibiotici, portava spesso alla morte.
Contro la cancrena i medici operavano con resezioni e amputazioni spesso r adical i di gambe e braccia c he, purtroppo, non sempre riso l vev ano il problema.
Contro i "guas ti" della guerra di trincea , appariva importante agire con una certa urgen za, proprio per scongiurare infezioni e contaminazioni. Per questo motivo la dislocazione delle strutture sanitari e aveva una grande importanza nel meccani smo della guerra di trincea , p er ch é è ev idente che prim a medici e s anitari inte r venivano sui fe riti , tan to maggiore e r a la probabilità che qu esti po tessero essere guariti dal le ferite con tratte sul campo di battaglia.
A ridosso delle trincee, in luo ghi relati vamente sicuri, operavano i punti sanitari avanzati. In caverne o baracche , i sanitari prestav ano le prime cure ai feriti prov enienti dal campo di battaglia con le proprie gambe o trasportati dai porta-feriti .
Qui avveniva una prima cernita dei feriti: si medicavano e rispedivano al fronte i più lievi e si indirizzavano quelli bisognosi di cure chirurgiche agli ospedali delle retrovie.
Morfina e altri antidolorifici venivano riservati ai feriti recuperabili, mentre nulla si poteva fare per i tanti moribondi e i feriti gravissimi e intrasportabili che venivano lasciati morire spesso senza poter offrire loro nessuna cura.
Dai punti sanitari avanzati i feriti venivano trasferiti con camion o carri trainati da cavalli o buoi agli ospedaletti da campo dotati da 50 a 100 posti letto, dislocati nei paesi o nei campi delle retrovie, distanti da due a cinque chilometri circa dalla linea del fuoco.
In questi ospedaletti veniva prestato il primo intervento sanitario medico e chirurgico operando una ulteriore scrematura tra feriti leggeri e quelli gravi, che venivano indirizzati a più capaci ospedali militari d 'arma ta, ospitati di solito in ville, chiese o edifici pubblici dei paesi delle retrovie.
Questi ospedali ospitavano fino a 200 malati, ma in casi di necessità, come ad esempio nei giorni successivi all'attacco aus t ro-ungarico con i gas sul San Michele del29 giugno 1916 quando i morti furono circa seimila e molti di più i feriti e intoss icati , potevano anche triplicare la loro capienza9 •
Ne l corso del conflitto, il numero dei feri ti cresceva in mi sura proporzionale alla progressiva i ntensificazione dei combattimenti. Prudenti s tati stic he ufficiali dell'esercito italiano i ndicano in poco meno di cinquecentomila i feriti curati nel 1915,
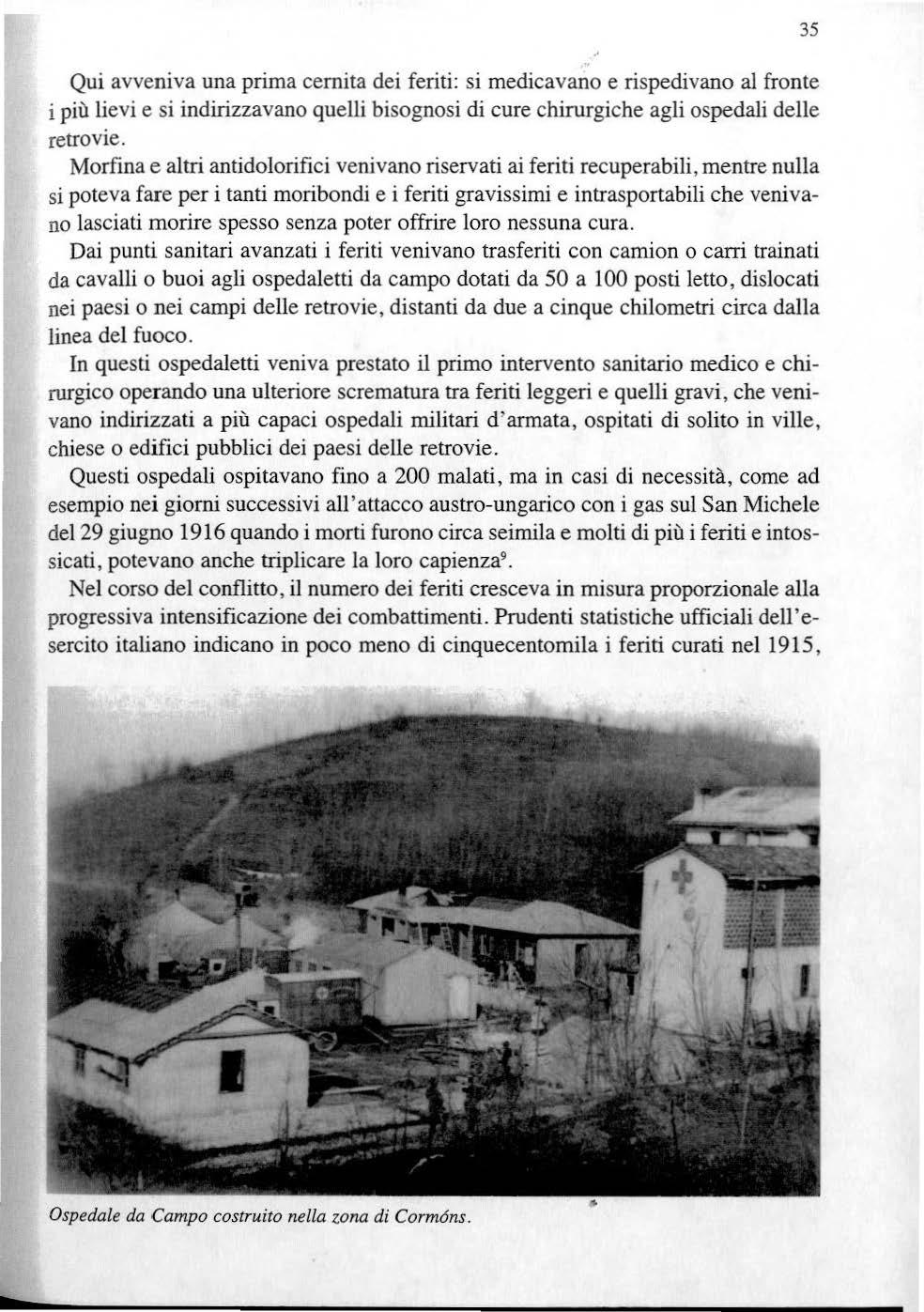
oltre ottocentomila ne l 1916 fmo a superare il milione di ricoveri nel 1917 per poi toccare il milione e 310 mila ricoveri nel 1918 su circa cinqu e milioni di soldati mobilitati.
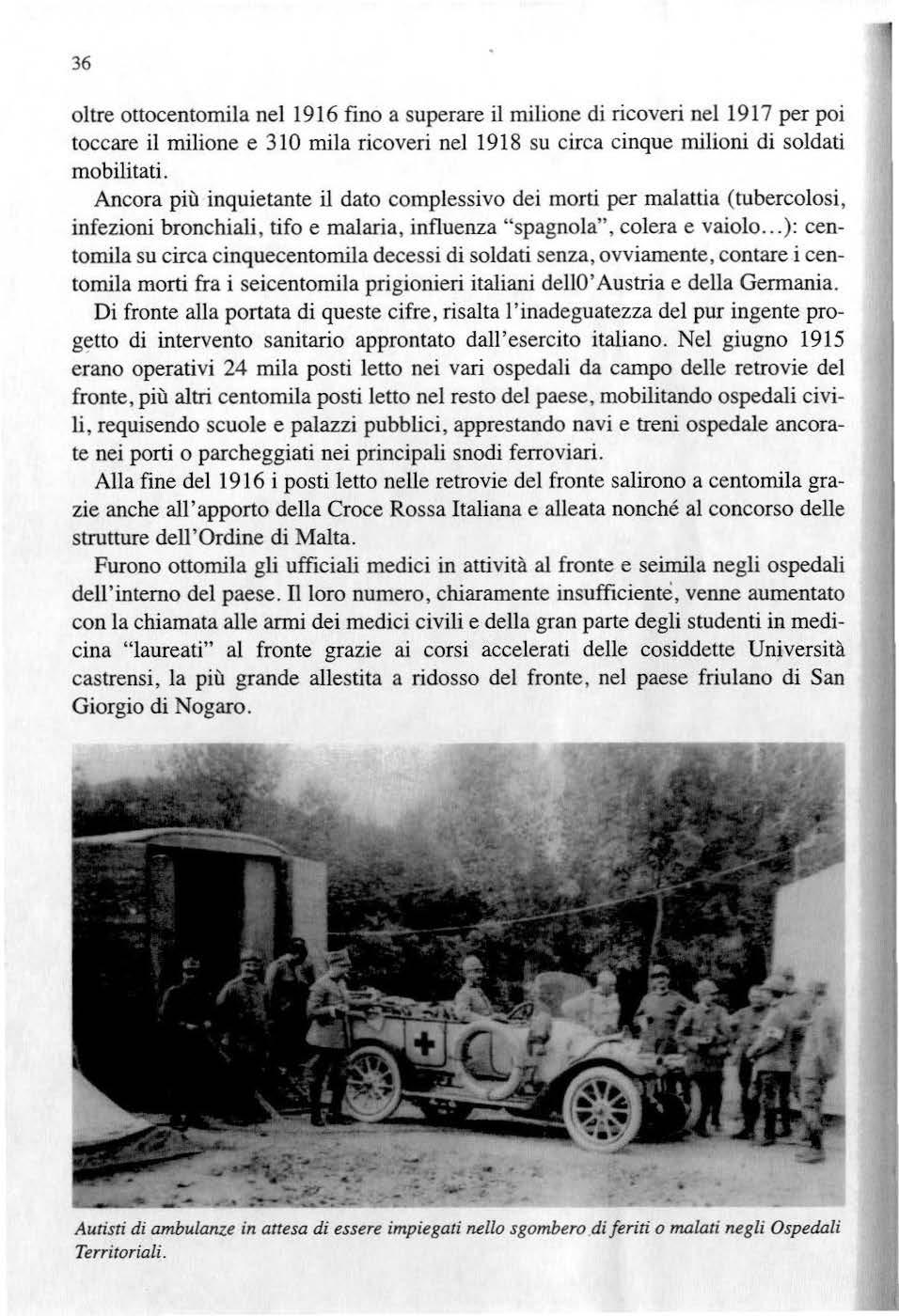
Ancora più inquietante il dato comp lessivo dei morti per malattia (tuberco lo si, infezioni bronchiali , tifo e malaria , influenza "spagnola", co lera e vaiolo ... ) : centomila su circa cinquece ntomila decess i di so ld ati senza, ovviamente , contare i centomila morti fra i seicentomila prigionieri italiani dellO' Austria e della Germania.
Di fronte alla portata di queste cifre, risalta l'inadeguatezza del pur ingente progetto di intervento sanitario approntato dall'esercito italiano. Nel giugno 1915 e rano operativi 24 mila posti letto nei vari ospedali da campo delle retrovie del fronte, più altri centomila posti letto nel resto del paese, mobilitando ospedali civili , requisendo scuole e palazzi pubblici, apprestando navi e treni ospedale ancorate nei porti o parcheggiati nei princ ipali snodi ferroviari.
Alla fine del 1916 i posti letto nelle retrovie del fronte salirono a centomila grazie anche all'apporto della Croce Ro ssa Italiana e alleata nonché al concorso delle strutture dell 'Ordine di Malta.
Furono ottomila gli ufficiali medici in attività al fronte e seimila negli ospedali dell'interno del paese. n loro numero, chiaramente insufficientè, venne aumentato con la chiamata alle armi dei medici civili e della gran parte degli studenti in medicina "laureati" al fronte graz ie ai corsi accelerati delle cosiddette Università castrensi, la più grande allestita a ridosso del fronte , nel paes e friulano di San G iorgio di Nogaro.
Grazie a que sti sforz i nel 19 17 l' esercito italiano potè va disporre di c irca duece ntomila posti letto nelle immediate retrovie del fronte Nel 1917 , nel periodo del maggiore sforzo dell 'ese rcito italiano s ul fronte del Carso e dell' Iso n zo , in zo n a d'operazioni funzionavano 122 reparti di pronto intervento - sezioni di s ani t à, reparti al pini con muli , ambulanze chirurgic he e radiologi che- con a disposizione 850 ambulanze e 720 carri per il trasporto dei feriti.
Gli ospedali da 50 letti erano 234, 167 quelli da 100 letti, 46 da 200 letti più 27 gran di ospedali di ta ppa, 38 sezioni di di s infes t azione , 59 treni ospedale attrezzati ciascuno con 360 posti. Inoltre , in vari ospedali dell'Italia settentrionale erano a dis posizi one non meno di altri 365 mila le tti per i militari feriti o ammalati.
l Cfr S Delaporte, Medicina di guerra, in S. Audoin-R ouzeau, J.-J. Becker, La prima guerra mondiale, Ed. it. A cura di A. Gibelli, vol. l, pp. 299-308

2 Le statistiche sanitarie e i dati sulla mortalità nell'esercito italiano sono tratte da G Mortara, La salute pubblica in Italia prima e durante la guerra, Laterza, Bari, 1925. V . anche T. Detti, Stato, guerra e tubercolosi, in Storia d'Italia . Annali 7, Malattia e Medi cina, Einaudi, Tor ino 1984.
3 G. Soldani,Dalfronte del sangue e della pietà. Il diario del capitano medico Gregorio Soldani nella Grande Guerra, Gaspari, Udine 2000. Questo mio intervento sunteggia, seppur con qualche integrazione, l'introduzione al diario, Da/fronte del sangue e della pietà, pp . 7-18 .
4 M I snenghi, G R ocbat , La Grande Guerra 1914-1918, La Nuova Italia, Milano 2000 , pp 262-268 Sull'alto numero dei decessi per malattia nell'esercito italiano v. anche G. Lenci , Caduti dimenticati. I morti per malattie, in D. Leoni, C. Zadra (a cura di), La Grande Guerra. Esperienza, memoria, immagini, U Mulino, Bologna 1986, pp 231-236.
5 Sugli avvenimenti bellici e sulle condizioni dei soldati italiani nel corso dell915 - 1918 mi permetto di rimandare al mio Gente di trincea. La Grande Guerra sul Carso e sull'Isonzo , Mursia, Milan o 1994.
6 G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia, Laterza, Roma-Bari 1987; Id., Medicina e sanità in Italia nel Ventesimo secolo , Laterza, Roma-Bari 1989.
7 Sulle problematicbe medico-sanitarie nell'esercito austro-ungarico sul fronte italiano v. D . C. Auerer, Dem Tod geweith wuiaoch gerettet Die Sanitaetsversorgung am lsonzo und in Dolomiten 1915-18, Peter Lang ed., Francoforte 1995 .
8 Soldani, Dal fronte del sang ue e della pietà , cit., pp. 231-234. Ulteri ori indicazioni sulla pratica medica nel tempo di guerra in C Catteruccia, Ospedo.letto 0127, Roma 1934; A. Spallicci, Diario di guerra, Forll s.d.; G Cavina, Ricordanze di un giovane medico, Firenze 1967; G. Frontali, La prima estate di guerra, n Mulino, Bologna 1988.
9 Dati statistici e modalità di intervento del sistema sanitario dell'esercito italiano nell915 - '18 in G. Liuzzi, I servizi logisrici nella Grande Guerra, Milano 1934: G Boschi, La guerra e le arti sanitarie, M ilano 1931 ..
La nostra ricerca non è stata semplice perché la documentazione che abbiamo reperito è molto poca: essenzialmente i registri di nascita e di morte presenti negli archivi del Comune e qualche documento presente ancora neli' archivio dell ' ospedale civile.
Durante tutto il periodo dell'occupazione l ' ospedale civile ha sempre funzionato non è mai stato dismesso da ospedale civile, ma ha funzionato a pieno ritmo, vi s i curavano principalmente i civili ma anche qualche militare.
Comunque neli' archivio dell ' ospedale c'è ancora documentazione relativa ali ' epoca della Grande Guerra; non ci sono vere e proprie cartelle cliniche come le intendiamo noi adesso; c'è qualche scheda, qualche biglietto di entrata e uscita dall'ospedale, da cui si può. evincere qualche diagnosi sufficiente per dare un ' idea complessiva su natalità, mortalità e morbilità.

Come detto l'ospedale ha sempre funzionato, non venivano curate solo patologie organiche di ambito intemistico o chirurgico, ma anche in campo psichiatrico.
I dati non sono semplici da commentare perché comunque la popolazione durante il periodo dell'invasione ha subito una trasformazione. Nel momento dell'invasione ma anche nel periodo immediatamente precedente chi ha potuto, chi aveva la possibilità economica o anche chi aveva un mezzo di trasporto, e per mezzo di trasporto intendo anche un semplice carretto e un asino, sono sfollati e sono andati al di là del Piave.
Quindi , la popolazione che era rimasta in sede era la più povera , quella quindi che aveva meno risorse. A questa si aggiunse la popolazione più povera del cosiddetto Quartier del Piave che si era spostata verso questa zona .
Una popolazione che aveva non solo problemi economici , ma anche problemi di salute.
Come dicevo l'ospedale non curava solo civili ma anche qualche militare come si può dedurre dai dati ricavati dai registri e dagli atti di morte presenti in Municipio.
Tra l ' altro i registri di cui siamo in possesso non sono registri originali, in quanto questi sono andati distrutti,
sono stati ricostruiti nei cinque anni successivi, dal 19i9 agli anni 1922-23; sono stati ricostruiti e rifatti quasi completamente.
Nei registri di morte abbiamo trovato, nell'anno dell ' invasione , i decessi di 86 militari , di cui 15 tedeschi e 71 italiani. Dati sul tipo di malattie o tipo d i interventi chirurgici che venivano eseguiti nell ' ospedale non ne abbiamo.
L' unica notizia che abbiamo è che , comunque, l'ospedale civile è stato fatto funzionare con personale medico militare sia italiano che austriaco in quanto anche i medici, quelli che vi lavoravano prima , erano sfo llati in sieme all ' altra popolazione.
Chiaramente non si tratta di tutti i militari morti a Vittorio Veneto in quell'anno perché, probabilmente , i morti assistiti da strutture assistenziali militari non risultano p oi registrati nella documentazione comunale.
Altro dato: la natalità che c'è stata dall ' ottobre del1917 all'ottobre del1918: s ono stati registrati 466 nati , di cui 43 nati illegitt imi . Nati illegi ttimi a quel tempo voleva dire nati da donne non spos ate. I figli da donne sposate , anche se il marito era al fronte da tre anni , comunque venivano registrati come nati legittimi.
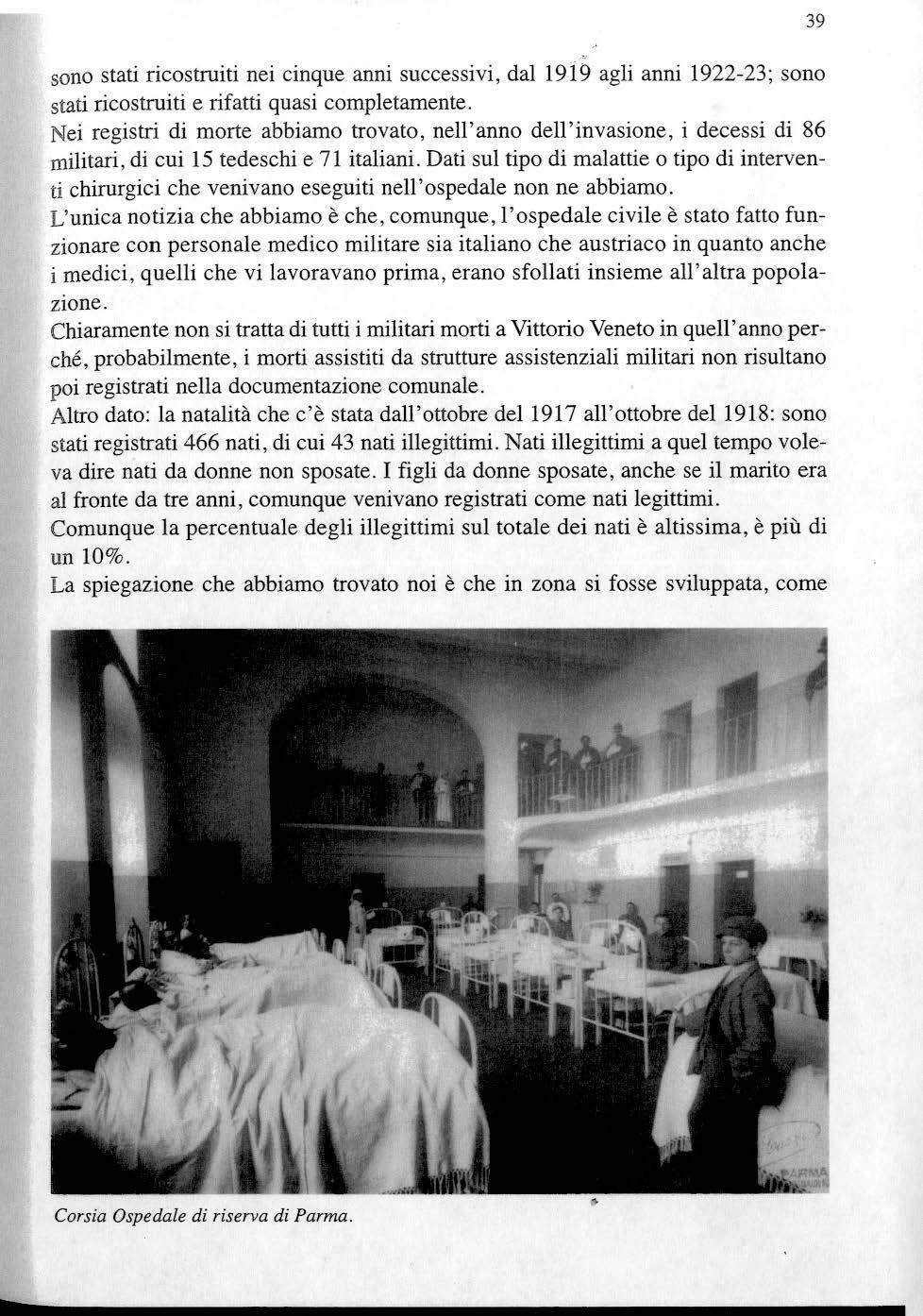
Comu nque la percentuale degli illegittimi sul totale dei nati è altissima , è più di u n 10 %.
L a spiegazione che abbiamo trovato noi è che in zona si fosse sviluppata, come
succe de sempre in simili frangenti qu ella che s i chiama " prostituzione di g ue rra".
Pros tituzion e dote, n el sens o stretto, in cambio di alimenti, magari per mantenere i bambini o g li anziani che c'erano a casa.
No n ri su ltano notizie di operazioni (tipo quelle che si sono se ntite nei Balcani ultimame nte, puli zia e tni ca o v iolenze di massa sulla p opo lazione invasa).
Qu es to fe nom eno è s tato descri tto ne l secondo conflitto mondial e , ma n el primo almeno n<m ri s ulta esserc i s tato in maniera eclatante.
Morbilità. Dati non n e abbiamo, ma alcune valutazioni possiamo farle s ulla base d egli atti di nascita. Questi, riferiti ai nati del 1918 , sono stati ricostruiti e registrati soltanto nel 1921.
Co me morbilità probabilmen te non c'è molto da aggiungere ai dati citati dalle precedenti relazioni ; le p a tologie e r ano sopra ttutto dovu te a mal nutrizion e e denutrizione, poi alle mal a ttie infettive di c ui s i è già parlato e si parlerà più diffu s amente in questo conveg no.
Altro dato che siamo riusciti a ricavare è la mortali tà c he c'è stata in quell'anno: sono s tati quas i 2 .000 morti fra la popolazione civile.
I d a ti reperiti , analizzati, ci hanno fatto giungere all a conclusione c he più o meno fra la popolazione maschile e femminile, nelle di verse fasce d ' età , è più o meno comparabile eccetto per la fascia di e tà cen trale .

Qui l a mortalità fra la popolazione femminile era enormeme nte più elevata di quella m asc hile.
Le spiegazioni c he abbiamo tro vato sono due: i masc hi , in buona parte , e rano in gu e rra , primo e secon do perch é le donn e assistevano tutti gli altri ammalati e quindi e rano sicuramente più esposte al contagio e quindi più predisposte a co ntrarre. Ulteriori dati non è stato possibile reperire nei registri custoditi presso gli archivi del Comune di Vittorio Veneto.
Il 4 novembre 1918 , mentre sulle strade e sulle piazze si festeggiava la vittoria, a Treviso morivano Teso Clorinda di 2 anni di San Pelaio, localizzazione geografica sulla quale dovremo tornare, Marchetto Carolina di 26 anni , indicata come villica alla voce mestiere, e Gerotto Angelo di 22 anni, colpiti dalla febbre spagnola. Il medesimo giorno e per il medesimo motivo morivano in ospedale Piovesan Vincenzo di 67 anni, registrato anch'egli come villico, Fort Giovanni di 40 anni, indicato allo Stato Civile come profugo, e anche di costoro più avanti dovremo parlare, e Lana Luigi, del quale null'altro si dice se non che era in città in qualità di soldato, com'è ovvio sia in una Treviso immediata retrovia del fronte. Ci sareb be naturalmente da discutere se il popolo sceso in piazza festeggiasse la vittoria - e ciò vale certamente per taluni perchè senza questo entusiasmo che fa da preludio al mito costruito a posteriori della Grande Guerra, non ci sarebbe una spiegazione convincente della nascita e dell'avvento del fascismo - o non piuttosto la fine della guerra, cioè la fine degli orrori e dei patimenti che erano stati il frutto di un conflitto senza precedenti nella storia dell'umanità.
Mai infatti masse così imponenti di uomini avevano combattuto l'un contro l'altro, mai erano state utilizzate armi così micidiali, mai ci si era dovuti interrare e permanere così a lungo in trincee nelle quali le condizioni di vita favorivano, come di fatto favorirono, fra !:altro anche l'irrompere delle malattie tra i soldati. Lasciamo da parte la pediculosi e la scabbia, compagne pressoché permanenti di quanti combattevano in trincea; fatto si è che si ebbero casi di colera, di tubercolosi, di tutte le malattie insomma delle quali si parla in altri capitoli di questo libro nonché numerosi , casi di pazzia, comunque poi la si voglia scientificamente denominare secondo generi e sottogeneri , anche per i quali rimando ad altra parte del lavoro. A parte la follia del combattente , la tipologia medesima della guerra che, per la prima volta nella storia, coinvolse direttamente la popolazione , fece sì che le malattie suaccennate avessero una qualche ricaduta anche sulla medesima popolazione, naturalmente in forma quantitativamente modesta e tale da non essere statisticamente rilevante. Quando invece apparve la febbre cosiddetta spagnola, ogni distinzione fra i militari e i civili venne meno e la malattia colpì indiscriminatamente gli uni e gli altri, favorita anche dallo stato di prostrazione fisica nella quale giacevano eserciti e popoli. Essa apparve infatti quando gli Imperi Centrali e particolarmente l'Austria-Ungheria erano preda della fame nel senso più pieno del termine, la Russia era percorsa dalla tragica guerra civile seguita alla Rivoluzione d'Ottobre, gli stati dell' Intesa vivevano degli aiuti ameri0ani e , se non faceva vitti-

me la fame che invece attanagliava i popoli della Duplice, certamente le condizioni materiali di vita erano a bassi livelli, così come il morale, incrinato dalla lunghezza del conflitto del quale non si riusciva a percepire ancora un avvio alla conclus ion e.
La febbre , altissima, si presentava come una forma di influenza non diversa da altre che l'avevano preceduta e che la seguiranno, ma tale influenza, a corso molto rapido, degenerava spesso in edema polmonare così da rendere i polmoni spugnosi e pieni di sangue fino a una forma di soffocamento letale o, meno frequentemente, dava luogo a complicazioni cardio-vascolari irreversibili. Senza s ulfamid i ci e antibiotici, ancora da scoprire, era evidentemente impossibile bloccare l'infiammazio ne dei tessuti fin dalla sua origine e dunque le possibilità di intervenire erano di necessità delegate alle difese naturali dell'organismo. E questo è il punto di giun-
tura tra l'elemento soggettivola fibra fisica del p aziente - e l'elemento oggettivo, cioè lo stato di sfinimen to dei popoli belligeranti, anche se c iò non costituisce invero un preciso discriminante dal momento che l'influ enza trasse il s uo nome proprio dali' essere sta ta individuata per la prima vo lta in Spagna, cioè in un paese neutrale, così come colpì ferocemente gli Stati Uniti, paese belligerante, la popolazione del quale per altro non era stata sottoposta alle privazioni delle quali avevano soffer to , come gìà detto, i belligeranti in Europa. É difficile dunque trovare un rapporto di causa ed effetto tra lo scopp io della malattia e le co ndizi oni di estremo disagio di eserciti e popoli, ma è naturale che la gravità del male, e il ta sso di mortalità che esso comportava, fossero massimizzati là dove le cond izioni di vita erano più difficili. La p ermanenza in trin-

cea o i drammi del profugato o comunque lo stato di miseria nel quale versavano le classi più deboli della società favorirono indubbiamente il diffondersi della malattia , elevandone le possibi lità d i un esito letale.

Dopo quella che Paolo Preto definisce come un '"onda ta blanda ..." che serpeggiò qua e là tra la primavera e l'estate del 1918, la mala tt ia ebbe il suo culmine tra l'otto bre 1918 e il gennaio 1919, anche se poi la coda fu ancora piuttosto lun ga e di dovettero contare vittime ancora lun go tutto l'arco del 1919. Calcoli per forza di cose approssimativi fanno ascendere a 22 milioni, nel mondo, le vittime della spagnola, mentre, sempre secondo Preto che attinge alla statis tica sanitaria del Mortara, cioè al testo più accreditato sulle condizioni no sologiche del paese neg li anni della guerra e dell 'immed iato dopoguerra , in I talia i morti furono 274.000 così direttame nte diagnosticati, mentre di altri 500.000 ritiene di affermare possa esserci un chiaro nesso tra la morte e la malattia1 •
"Sicut fur in nocte" naturalmente la malattia dilagò all ' improvviso e non esisteva dunque alcun mezzo apprestato per la prevenzione e la profilassi. Semmai le preoccupazioni delle autorità militari e civili erano rivolte al colera, sia perch è esso aveva fatto la sua ultima apparizione nel p aese nel1910 , in tempi molto ravvicinati cioè, sia perchè la trincea, se non altro per la presenza costante delle deiezioni umane al fondo delle trincee medes ime, predisponeva a quel con tagio. Infatti, n el 1917 - momento cru ciale delle guerra, dalla R ivo lu zione Ru ss a all'Allocuzione pon tificia sull'inutile strage, dai 14 p unti di Wilson a Caporetto, segnato da una generale stanchezza per la guerra e per il sangue e le vittime che essa comportava -il Ministero dell'Interno fece distribuire alla prefetture un opuscolo sulla profilassi del colera. Al di là dell'ovvio richiamo alla scrupo losa pulizia del corpo e dei locali d'ab i tazione, l'opuscolo interessa anche il no stro tema laddove tocca almeno due punti che costituiscono al trettanti caposaldi della letter atura medica del tempo: la paura del male come più pericolosa del male mede simo, il timore c ioè che il pan ico comportas se turbamento dell'ordine pubbli co, scate nando magari l a caccia all 'untore per la quale s i pagava tributo alle sindromi- unite o divise- della barbarie del nemico e del pericolo costituito dalle spie, e la necessità di vincere precocemente ed efficacemente la paura dell'ospedale, an ti co retaggio non ancora esauritosi del concetto di ospedale come deposito dei poveri, luogo di contenzione piuttosto che di ·cura2 • Fortunatamente l 'ep idemia di co lera non si ebbe e poichè su questa eventuali tà erano puntati gli sguardi e non su altr o, si trascurò !"'ondata blanda" di influenza spagn ola della primavera 191 8. Se teniamo conto della temuta paura della paura di cui abbiamo appena parl ato e del fatto che si era in guerra, la prima guerra totale della storia , la so ttovalutazione del male da parte delle autorità, se non è scusabile, è però comprensib ile dal momento che lo spirito pubblico -per usare il linguaggio della carte di poliz ia - è un elemento essenziale per sostenere una guerra di masse. Anche in Spagna d'altronde, pur paese neutrale, il problema venn e so ttovalutato al punto di isolare il medico ehe per primo aveva dia -
gnosticato i si ntomi diversi rispetto alla normale influenza e l'effetto s pess o letale alla quale essa perveniva3 • Non meraviglia dunque l ' atteggiamento dei governi dei paesi belligeranti , salvo che la notizia del male non potesse essere utili zza ta come arma di propaganda, attribuendo cioè al nemico la causa d eU' evento , così il l o agosto 1918, giunse alla prefettura una Circolare rnini s teriale che diceva, add irittura s otto forma di telegramma " ...Svizzera serpeggia grave epidemia con effetti letali della così detta malattia spagnuola dicesi importata da Germania ...", ove il verbo " importare" non cela che potrebbe anche trattarsi di un fatto doloso , ulteriore prova della barbarie teutonica4 • I giornali del 18 agosto , che per altro riportano voci, spostarono il bersa g lio e affermarono che la malattia sarebbe potuta venire dall'Austria , non è chiaro se perchè iv i era più virulenta - notizia di cro naca - o se la notizia contribuiva a confermare o ad accrescere l'odio verso il nemi co, odio che s i riteneva fosse ne cess ario per conseguire la vittoria . Odio come propellente, carburante morale al pari del cognac distribuito nell e trincee prima dell'assalto, secondo i moduli della propaganda che, con la cronaca, ha poco da s partire. Non erano per altro solo leggende se il 16 agosto, cioè due giorni prima, il Comandi supremo de l regio eserc i to aveva avvertito i prefetti del fatto che esis tevano timori di un arrivo del colera dall'Austria-Ungheria . Le c r onache dunque s i e rano limitate a trasformare l'epidemia di co lera in altra epidemia, ottenendo naturalmente il medesimo effetto 5 •
Il 3 settembre 1918 muore a Padova l'operaio militarizzato O scar Vicenzotto , la tes timonianza del cui decesso straziante è stata narrata a Richard Collier dalla moglie Tersilla profuga in una locali tà della Toscana e c hiam ata d ' urgenza al capezzale del marito 6 ; ed è il primo morto della seconda, e ben più grave ondata di febbre spagnola nel Veneto, anche se ripeto che essa si farà sentire in forma acuta solo da ottobre. Risalgono all'ottobre infatti alcuni interventi delle autorità che è necessario segnalare per una migliore comprensione del fenomeno. Paolo Preto in sis te sul filtro esercitato dalla censura che blocca le notizie o le fa trapelare nell a misura in cui sembrano compatibili con le capacità di so pportazione dei ci ttadini. Non c'è da meravigliarsi: nell'ottobre 1918 siamo giusto alle soglie dell'offensiva finale ed è quindi log ico che gli animi e i mezzi fo sse ro tesi a qu esto fine. Ai lutti della guerra e alle incognite dell'imminente offensiva non era pens abile sovrapporre le notizie di un'epidemia mortale. E dunque se ess a non poteva essere sop pressa, era comunque possi bile dare a quella la minor pubblicità consentita dalla sua presenza , vis to che con quella si era comunque chiamati a convivere. Il 15 ottobre , il Prefetto di Milano vietò i cortei funebri e ogni segno es teriore di lutto , quando di contro gli u si e i costumi inducevano a manifestazioni di cordoglio molto maggiori rispetto a quanto oggi in uso. Non s i trattava evidentemen te di un esorcismo, bensì del tentativo di non abbassare ulteriormente il morale delle popolazioni , già scosso di suo se non altro dal perdurare della guerra. ll 20 ottobre apparve un classico del costume italico in qualche maniera ancor oggi vivo: il ricorso al clero e il
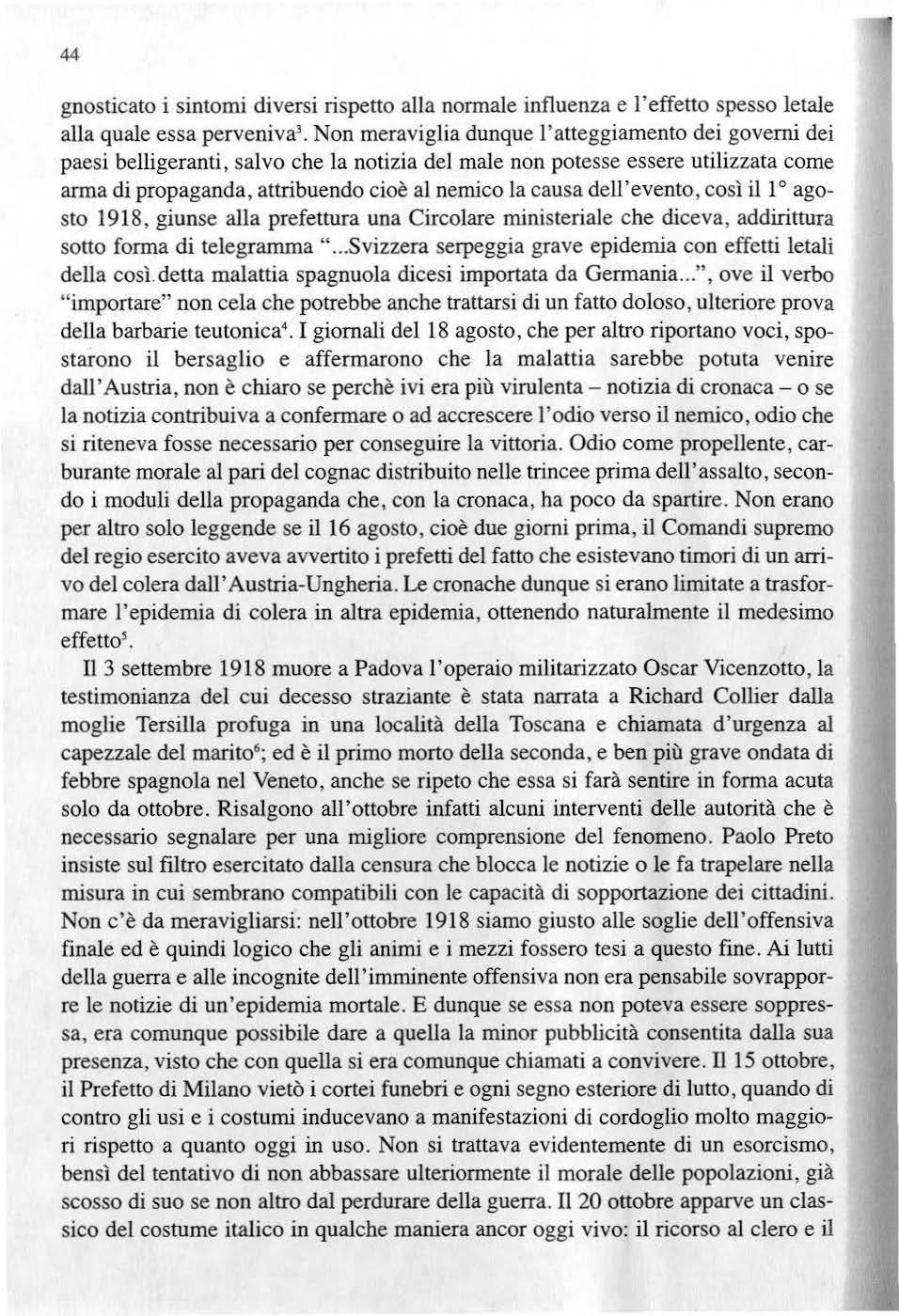
timore dell e superstizioni come rimedi in specie nelle campagne. Nel caso , è il Consiglio Superiore di Sanità a temere il diffondersi di empirici, se non dannosi, surrogati dei medicinali decantati come efficaci da qualche dulcamara girovagante nelle campagne medesime. E nella convinzione, tutto sommato fondata, che l'affidarsi alle autorità ci vili non sarebbe stato sufficiente, si fece appello al clero curato nelle campagne perchè convincesse i contadini a non affidarsi ai ciarlatani e alle loro pozioni. Anche l 'appello del Consiglio di Sanità testimonia dunque della paura della paura e del timore - in assenza di una cura che fosse in grado di blo ccare il decorso del male - del diffondersi di sistemi curativi diversi rispetto a qu anto prescritto dalla medicina ufficiale. Infine, il 24 ottobre, in co i ncidenza con l'avvio de ll'offensiva sul Piave , inter viene autor evo lmente il Capo del Governo per dire esattamente quello che in questi casi dicono i capi dei governi e cioè che si stava fac e ndo il possibile per contenere e debell are la malattia, per altro definita " . ..terribil e, misteriosa. ignota nella sua causa e invincibile nei suoi effetti"7 •
A Trevis o , nel1 91 7- 18, convivono tre città: il centro storico di molto diminuito di popolazione dal fenomeno del profugato, le frazioni rimpinguate di abi tanti dalla . presenza de i p rofughi, il campo trincerato presidiato dai militari. Se dalla provincia di Treviso il totale dei profughi è s ta to calcolato in 138.387 pari al 28% de ll a popolaz ione residente, dal mandamen to di Trev iso vanno profughi in 49.550, va le

a dire che la media sui residenti si alza al34,1 %8 • Se è vero che il profugato volontario interessò particolarmente le classi abbienti e molto meno le classi subalterne o, se si preferisce, piuttosto i cittadini che i contadini, è ovvio dedurre che il centro storico fosse pressoché vuoto e che i rimasti appartenessero alle classi meno abbienti. Indipendentemente dalla spagnola, dei due decessi registrati in centro- e già la cifra è significativa- uno è di un vecchio trovato raggomitolato dentro la scuderia di un palazzo patrizio in Piazza Sant'Andrea, sembra colpito da infarto, probabilmente un mendicante che in quella scuderia aveva tentato di trovar rifugio dal freçl.do. Negli ultimi mesi del 1918, la febbre s pagnola fece in centro s toricointendendo per tale quanto racchiuso entro la cerchia delle mura cinquecenteschesolo tre vittime che meritano però qualche cenno in più perchè se di Franchi n Vittoria conosciamo soltanto l'età (52 anni), è bene sottolineare che Veggia Antonietta di 46 anni faceva la lavandaia, cioè lavava i panni altrui nel Sile , china sulla tavola di legno fermata su una delle apposite piattaforme, e abitava nel degradato quartiere di San Nicolò, mentre Costacurta Paolino di 41 anni, del quale le carte non recano indicazione di mestiere, abitava in via Reggia che era in allora un'altra de lle zone degradate della città9 , quelle zone ove la miseria, il vizio - vi era ubicata una casa di tolleranza - e la microcriminalità convivevano in un amalgama dal quale i benpensanti si tenevano lontani.
Ciò conferma che dal centro storico della città erano andate profughe le classi abbienti ed erano rimasti i poveri, intr oduce però anche un discorso sulla periferia che ci porterà a ragionare delle frazioni. É opportuno rifarsi all' In chiesta sulle case malsane del 1911 per rendersi conto del degrado di talune zone della città, nonché del sovraffollamento di esse 10 • Ora se teniamo conto de l fatto che il quartiere di San Nicolò confmava praticamente con la piazza del Duomo e quindi era situato in pieno centro, non è strano che molti cittadini abbienti, seguendo un trend proprio anche di altre città, tendessero ad abbandonare quel centro e quei confinanti per cercare casa altrove. Entro la cerchia delle mura, esistevano ancora spazi vuotiper esempio la zona ove oggi sorge la cosiddetta città-giardino o quella ove venne più avanti edificato l'edificio dell'Istituto magi strale - ma il movimento fu invece centrifugo, privilegiò cioè la costruzione di abitazioni signorili o comunque civili appena fuori le mura, specie dopo la costruzione di quella che allora sembrava un'imponente circonvallazione delle medesime mura. Lo spazio per costruire era enorme perchè la tecnica che aveva presieduto alla costruzione delle mura cinquecentesche aveva imposto la presenza di un campo di tiro di ottocento metri di raggio, sicché ogni costruzione entro questa distanza era stata abbattuta. Solo tra 1'800 e il 900 si era costruito in quei luoghi, specie lungo gli assi di penetrazione , o nelle immediate adiacenze, ai varchi aperti sulle mura cittadine. Anche le cosiddette Case Luzzati, dal nome del ministro che aveva varato una prima legge sull 'edilizia economica e popolare vennero ubicate fuori le mura, ma le più erano, rip eto, abitazioni civili ove avevano trovato alloggio le famiglie benestanti che volevano sot-

trarsi al sovraffollamento del centro. Il modesto sviluppo ·1i1 dustriale poi aveva fatto sì che pochi fossero nella zona anche i manufatti adibiti al settore secondario, confermandosi così , pur al momento del primo decollo industriale , la vocazione terziaria della città. Sicché, anche per la prese nz a, da ovest ad est , del Sile e della ferrovia, che di per sè costituivano un diaframma , le rade abitazioni costruite fuori le mura non avevano ricucito il centro storico e le frazioni, le quali erano rimaste isolate come sempre erano state , e questo isolamento non era solamente un dato geografico, bensì comportava anche caratteristiche economiche , sociali e cultuali diverse .
Staccate dunque dalla città, le frazioni erano paesi a se stanti, abitati per la più gran parte da una popolazione dedita all ' agricoltura che aveva tutte le caratteris tic he che , nel1918 , erano proprie di tutti i paesi contadini del Veneto e più in genera le dell'Italia intera : poderi di modeste dimensioni coltivati in affitto con formule il più spesso iugulatorie - sussistevano ancora affitti a fuoco e fiamma - persistenza di sacche di analfabetismo specie nella popolazione più anzi ana, miseria gener alizzata , ne fornisce un esempio l'elenco dei poveri dell'anno 1911 11 , modi di essere propri del mondo rurale, diffidenza nei confronti della città percepita come lontana e soprattutto come sfruttatrice del lavoro dei contadini. Le frazioni non vennero toccate dal fenomeno del profugato; al contrario , come vedremo subito sotto, esse ricevettero profughi che non poterono altro che condividere quella loro miseria. Va aggiunto per completare il quadro che parzialmente diversa era la situazione delle frazioni di Sant'Antonino e di Fiera ove era già presente qualche forma di industrializzazione- fornaci e laterizi a Sant'Antonino, molini, oltre la tradizionale attività dei barcari a Fiera - mentre Monigo era ancora comu ne autonomo e quindi non entra nel nostro discorso. Ciò non significa che la loro si tuazione economico e sociale fosse di molto diversa rispetto a quella dell e frazioni puramente agricole . Infatti se da una p arte c ' erano- poveri tra i poveri -i braccianti, dall'altro persisteva ancora il fenomeno degli industrianti , cioè di quanti a ogni levar del sole dovevano "industriarsi" a trovare qualche lavoro.
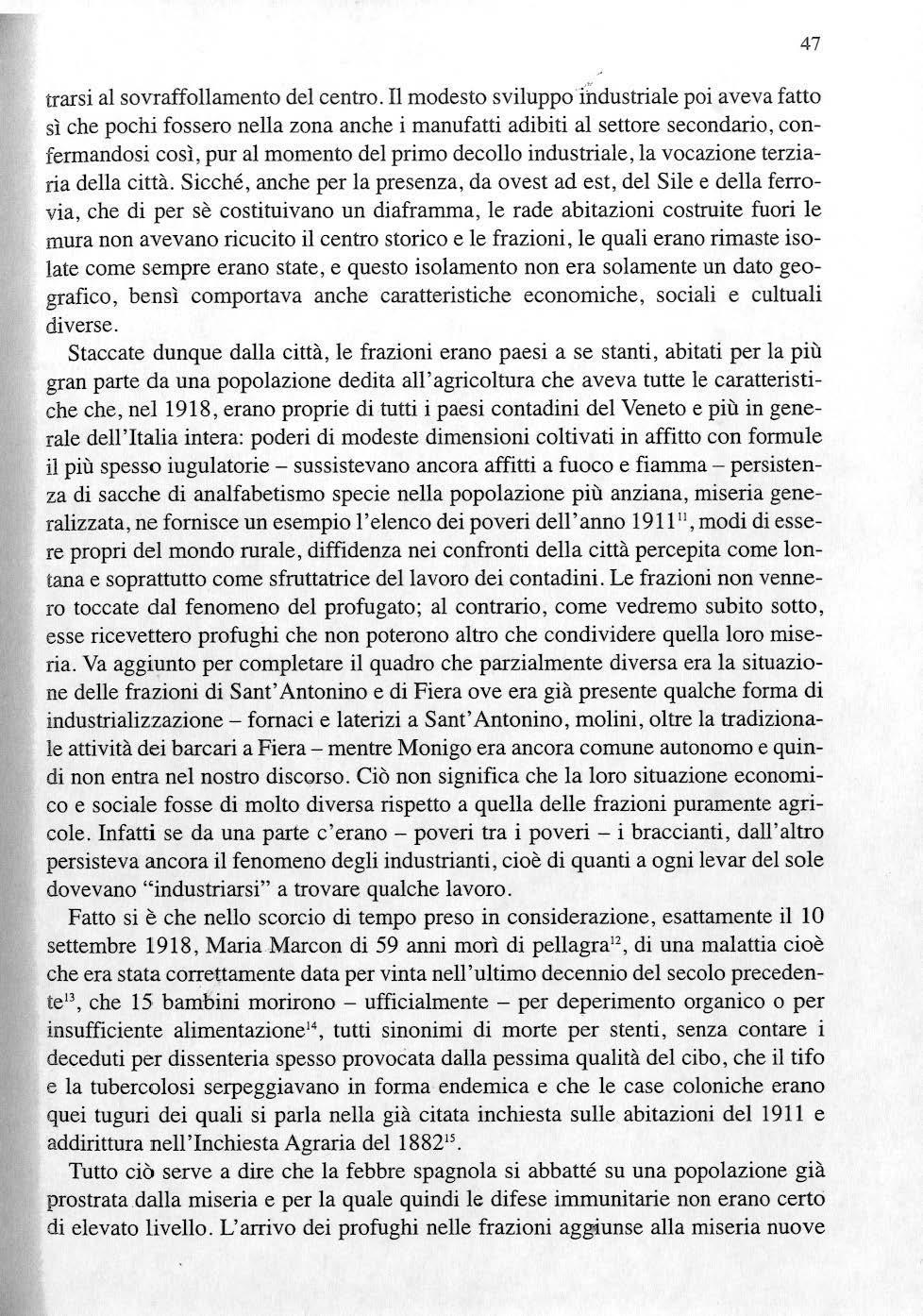
Fatto si è che nello scorcio di tempo preso in considerazione, esattamente il 10 settembre 1918 , Maria Marcon di 59 anni morì di pellagra12, di una malattia cioè che era stata correttame nte data per vinta neli 'ultimo decennio del secolo precedente13, che 15 bambini morirono - ufficialmente - per deperimento organico o per insufficiente alimentazione14 , tutti sinonimi di morte per stenti, senza contare i deceduti per di ssenteria spesso provoèata dalla pessima qualità del cibo, che il tifo e la tubercolosi serpeggiavano in forma endemica e che le case coloniche erano quei tuguri dei quali si parla nella già citata in chiesta sulle abitazioni del 1911 e addirittura nell'Inchiesta Agraria del1882 15 •
Tutto ciò serve a dire che la febbre spagnola si abbatté su una popolazione già prostrata dalla miseria e per la quale quindi le difese immunitarie non erano certo di elevato livello . L'arrivo dei profughi nelle frazioni aggiunse alla miseria nuove
miserie. Come noto, infatti, gli oltre 138.000 profughi della Provincia di Trevisoma il discorso vale per il Veneto in generale - si possono dividere in due grandi categorie: i pr ofugh i volon tari e i profughi obbliga ti a essere tali Alla prima categoria appartengono quanti se ne andarono sulla scia della ritirata di Caporetto, e in questa serie statis tic a rientrano gli abitant i della città murata che già sappiamo essersi svuotata, compresi tra que sti le autorità civili , che, in zona di guerra, cede ttero i poteri a quelle militari; alla seconda categoria ap partengono gli abitanti dei paesi letteralmente attraversati dalla linea del fuoco ai quali il profugato fu imposto dagli eventi e dagli ordini di evacuaz ione che li seguirono. Nelle frazioni di Treviso si rifugiarono i contadini residenti sulla linea prospiciente il Montello e il Piave e dunque troviamo traccia di profughi provenienti da Pederobb a e da Cornuda, da Zenson e da Maserada. Dalla documentazione, ess i risultano villi ci di condizione, con una larga presenza di braccianti a ulteriore dimostrazione che l 'ultima ondata di profughi pescò veramente nel fondo della società e dislocò lontano dal loro paese quanti nulla possedevano. Infatti, delle 695 famiglie di Pederobba che, in un momento o nell'altro, es ularono , ci ascuna possedeva mediamente meno di un ettaro di te rra coltivabile, sicché anche il concetto di proprietà- o meglio dell'essere proprietari- va collocato nella sua giusta dimensione, dal momento c he la figura dominante era la figura mista, di famiglie cioè insediate in poderi di modestiss ime dimensioni c he integravano i loro r edditi andando a opera, offrendosi cioè
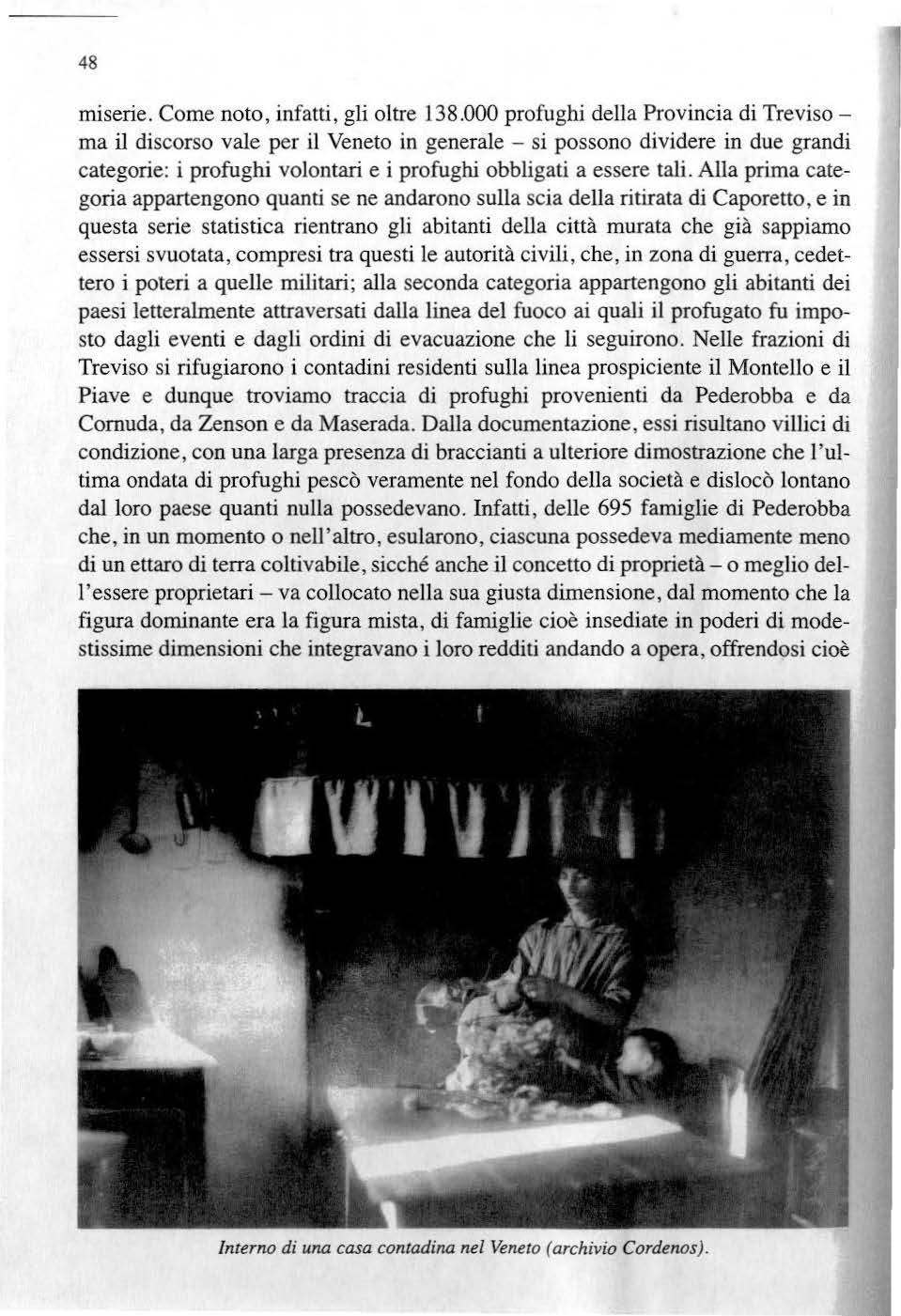
come braccianti nei momenti di pun ta dell'annata agraria. Non a caso gli atti di morte dei quali mi avvalgo recano una dicitura stampata così concepita: mestiere e condizione, alla quale è aggiunta la scritta a penna: villico o bracciante, povera o miserabile, che definisce una gerarchia della miseria precisa fino alla minuzia burocratica. Nel mentre questi villici vivevano il dramma del profugato, fu l'esercito a provvedere alle operazioni agricole necessarie nei paesi d'origine, fermo restando il risarcimento previsto per i proprietari allontanati dalla linea del fronte. Dal censimento necessario per ottenere il risarcimento, conosciamo con certezza le dimensioni delle proprietà: Osellame Secondo di Venegazzù possiede 10 campi, cioè 5 ettari, ma Veronica Santon ne poss iede mezzo , Antonio Pol ega to di Crocetta scende a un quarto d i campo, Valentino Bordin di Cornuda risale a mezzo, cinque famiglie di Breda possiedono un campo ciascuna, ben 27 di Zenson ne hanno mezzo, Giuseppe Lorenzon di Maserda scende a un quarto 16 •
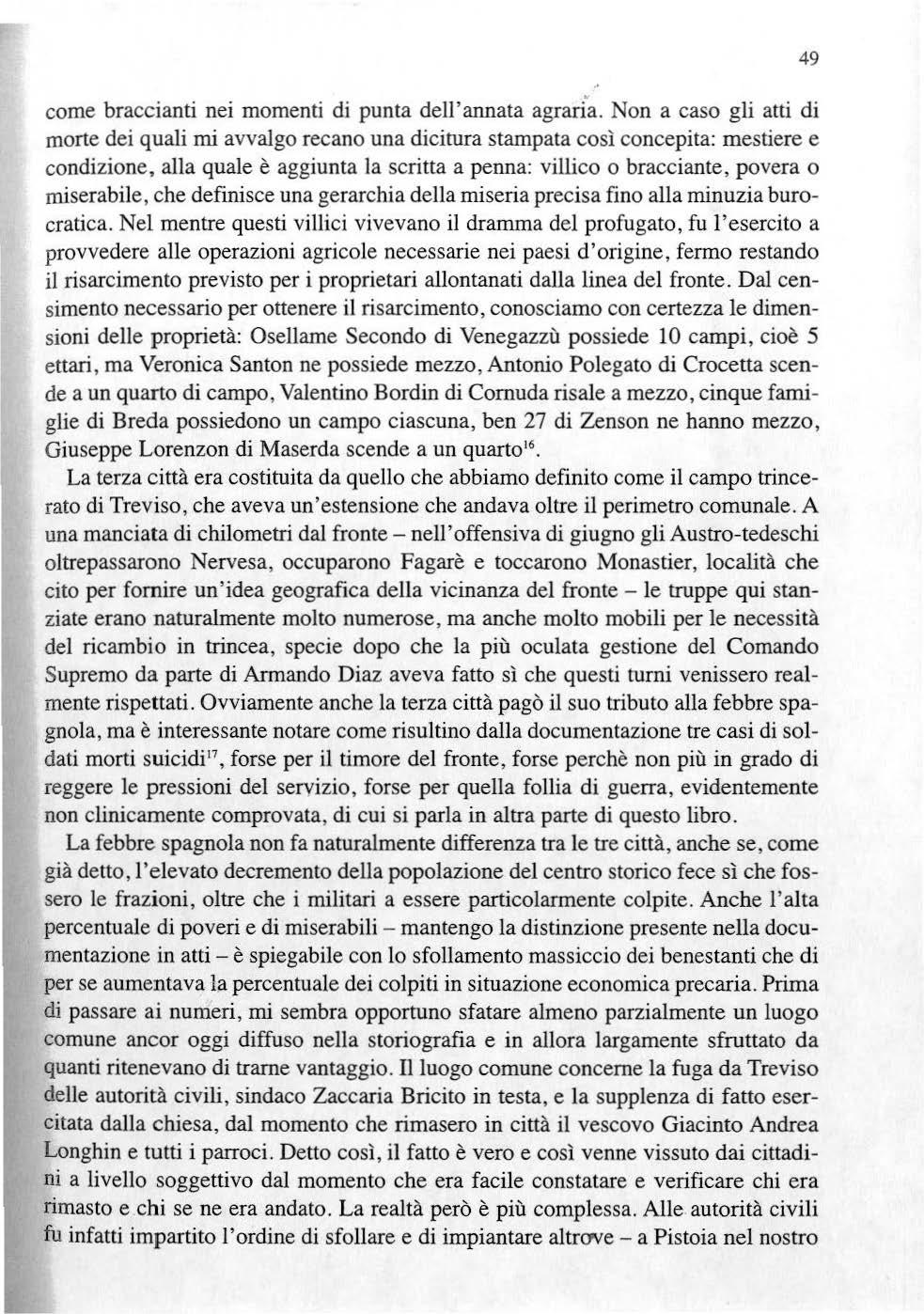
La terza città era costituita da quello che abbiamo definito come il campo trincerato di Treviso, che aveva un'e stens ione che andava oltre il perimetro comunale. A una manciata di chilometri dal fronte- n eli' offensiva di giugno gli Austro-tedeschi oltrepassarono Nervesa, occ uparono Fagarè e toccarono Monastier, località che cito per fornire un 'i dea geografica de ll a vicinanza del fronte - le truppe qui stanziate erano naturalmente molto num erose, ma anche molto mobili per le necessità del ricambio in trincea, specie dopo che la più oculata gestione del Comando Supremo da parte di Armando Diaz aveva fatto sì che questi turni venissero realmente rispettati. Ovviamente anche la terza città pagò il suo tributo alla febbre spagnola, ma è interessante notare come risultino dalla documentazione tre casi di soldati morti suicidi 17 , forse per il timore del fronte, forse p e rchè non più in grado di reggere le pressioni del servizio, forse per quella follia di guerra, evidentemente non clinicamente comprovata, di cui si parla in altra parte di questo libro.
La febbre spagnola non fa naturalmente differenza tra le tre ci ttà , anche se, come già detto, l 'elevato decremento della popolazione del centro storico fece sì che fossero le frazioni, oltre che i militari a essere particolarmente colpi te. Anche l'alta percentuale di poveri e di miserabi l i- mantengo la distinzione presente nella documentazione in atti - è spiegabile con lo sfollamento massiccio dei benes tanti che di per se aumentava la percentuale dei colpiti in situazione economica precaria. Prima di passare ai numeri, mi sembra opportuno sfatare almeno parzialmente un luogo comune ancor oggi diffuso nella s toriografia e in allora largamente sfruttato da quanti ritenev ano di trame vantaggio. Il luogo comune concerne la fuga d a Treviso delle autorità civili, sindaco Zaccaria Bricito in testa, e la supple nza di fatto esercitata dall a chiesa, dal momento che rimasero in città il vescovo Giacinto Andrea Longhin e tutti i parroci. Detto così, il fatto è vero e cosi venne vissuto dai cittadini a livello soggettivo dal momento che era facile constatare e verificare chi era rimasto e chi se ne era andato. La realtà però è più complessa. Alle . autorità civili fu infatti impartito l'ordine di sfollare e di impiantare altrO'Ve - a Pistoia nel nostro
caso - l'apparato comu nale, mente il Codice canonico prevede espressamente che il clero rimanga comunque con il proprio gregge indipendentemente dagli accadimenti politici. In zona di guerra è naturale che a governare la città fo sse l'autorità militare, come infatti avven ne. Interessa per altro di più il nos tro discorso il fatto che l 'app arato sanitario - l a struttura dei medici condotti e l 'os pedale con il suo r eparto di mala ttie infet tive- in città continuò a operare durante l'anno dell'invasio n e e così evitò danni maggiori al momento della prova.
In realtà, l'aggettivo spag nol a o l'i dentico aggettivo sostantivato vengono utilizzati poco nei regi stri dei defunti dell 'anno 1918, fon te primaria dell a qual e mi avvalgo, v isto che troviamo il termine solo in 14 casi, da Menoncello Antonia co ntadina di 38 anni a Tegon Pi etro faleg name di 52, morti in casa, e da Bas setto Romano di 5 ann i a De Monte Anna di 21, morti in ospedale. n modesto uso del termine può avere diverse spiegazi oni che vanno dalla reticenza all a difficoltà oggettiva di di agnos ti care con sic urezza la malattia , anche se la voce pubblica così da subito la indicò. Infatti, il parro co di Salgareda chiamato ad assistere due bambine more nti in casa, scrisse nel suo diario: "Osservo quei du e angioletti (7 e 2 anni) colpiti dall'infezione Spagnola che tante vittime ha mietuto in quel triste periodo di tempo " e i118 ottobre 1918, indu gia s u" ...due povere c ugine ventiduenni colpi te dalla febbre Spagnola" 18 • É pensabile che in molti casi il referto sia s tato stilato indi cando la causa finale del decesso, normalmente la broncopolmonite s pastica, piut tosto che la causa ini zial e e determinante, cioè appunto la febbre spa gnola . Così, nello scorc io di tempo qui considerato, abb iamo repertato 25 defmizioni diverse della malattia, a prescin dere dalle 14 di cui sopra ove compare il termin e "s pag nola".
Oltre alle semplici "influen za", "bronchite" e "polmonite", troviamo infatti dizioni quali "infl ue nz a-broncop olmo nite", " febbri infettive" o , tes tuali nel documento, "febbre tipo influenzale", "broncopolmonite da influ enza" con le varianti "polmonite da influen za" e " pneumonite da influenza" , "i nfluenza-paralisi cardiaca", " paralisi cardiaca in cor so di influenza", "pleurite d a influenza" , il complicato "setticemia, in segu ito a broncopolmonite per influenza" fino al generico " influ enza grave" e ai dubbiosi "morbo a tipo influenzale" e "credo ... per febbre tipo influ enz ale" . Di un morto in os pedale ancora in agosto, qu ando cioè non era anco ra chiaro il tipo di malattia co n la q ual e si aveva a che fare, si diagnostica un "bron chite fetida" , che invero ha ben poco di scientifico . Poiché l a documentazione d ella quale nel c aso mi avvalgo è costituita dalle sch ede comp ilate dai medici condotti per i decessi avvenu ti in casa e dall ' ospedale per quanti ivi erano deceduti , indirizzate al comun e perchè provvedesse all ' inumazione delle salme , va anche tenu to conto d el fatto che, in m olti cas i , la causa di morte è om essa, così come sono più o meno completi e in esis tenti i d ati anagrafici. Nel caso la causa di morte sia chiaramente spec ifi cata, tra se ttembre e dicembre 1918, co ntiamo 372 decessi dovuti alla febbre sp agnola direttamente di agnosticata o a quell a riportabili, non

essendo scientificamente corretto contare coloro per i quali, come ripeto, non era stata trascritta la causa di morte. n dato concorre a far salire il tasso di mortalità in provincia a quell'elevato 74/ per mille del1918 del quale parla Livio Vanzetto 19 •
P er il gennaio 1919, cioè per l 'ultimo mese del picco alto della malattia, non ho ancora reperito i dati, ma in una busta giacente presso l'Archivio di Stato di Treviso, esiste una relazione in data posteriore sulla Casa degli Esposti dalla quale risulta che in quel mese morirono ivi 26 bambini per broncopolmonite da influenza20. La cifra equivale a cir ca un quarto dei ricoverati ed è quindi molto elevata, ma le particolari condizioni nelle quali quei poveri bambini vivevano non consentono di estendere il dato a tutti i cittadini .
La febbre spagnola colpì tutte le classi sociali, se è vero che Granello Giuseppe di 70 anni, morto i119 ottob re 19 18 , risulta schedato come possidente, così come venne colpito Ernesto Gastaldo, studente di medicina, destinato poi a diventare il medico condotto di Ponzano, che si salvò rniracolosamente21 • É altrettanto vero , però, che oltre i due terzi dei deceduti dei quali possediamo il dato sono descritti di condizione miserabile e di mestiere villici o braccianti, termini che, come ho già detto, possono anche essere intercambiabili. L'altro più scarso terzo è costituito da operai, fornai, pizzicagnoli e camerieri, mentre, specie tra i deceduti nella Casa dei cronici - nome con il quale in allora si definiva la Casa di ricovero con particolare riferimento agli ospiti non autosufficienti -c'è un numero relativamente elevato di schedati come mendicanti , persone cioè ivi ricoverate dalla pubblica carità dopo una vita totalmente o parzialmente trascorsa a pitoccare per le vie o per le piazze cittadine.
Naturalmente, non conosciamo il mestiere di quanti morirono in divisa militare, poiché però un esercito di mobilitati rispecchia l a società civile dalla quale viene espresso; credo di non allontanarmi troppo dal vero ri tenendo che i mestieri e la condizione fossero d el tutto simili a quelli dei deceduti civili. Dal che si possono trarre due conclusioni: o la popolazione di Treviso era in quel momento compos ta essenzialmente di poveri per l'allontanamento delle classi benestanti, o la febbre spagnola, pur non guardando in faccia a nessuno, colpì maggiormente quanti erano già debilitati- nel senso di abbassamento delle difese immunitarie - dalle condizioni di miseria nelle quali erano costretti a vivere. Non si tratta per altro di un dilemma che debba essere per forza sciolto dal momento che sembra ovvio che i due fenomeni siano coesistiti e abbiano fufluito sulla malattia in pari misura. Nel caso di Treviso, dunque, anche la spagnola assume quel carattere di malattia sociale collegato, anche se non meccanicamente determinato, alle condizioni di vita di alcune particolari categorie di cittadini. La descrizione che fa nel già citato diario il parroco di Salgareda, sulla presenza del mo rbo in una casa di contadini , mi sembra particolarmente importante al fine della qualifica di malattia sociale da attribuirle. Oltre tutto., la narrazione del parroco ci consente di affermare che la situazione non era diversa nella zona invasa dagli Austriaci nella Sinistra Piave, ove anzi era acutizzata dallo stato di ·vera e propria fame dalla quale erano affette quelle popolazioni22 • ;.

In quell ' ottobre nel quale la malattia si acutizzò , il sindaco e la Giunta comunale erano già rientrati dal profugato a Pistoia e cercarono, per la loro parte , di prendere in mano la situazione. Il 10 ottobre infatti il s indaco sc risse una lettera al Prefetto co mpendiabile in tre punti: in primo luogo, dal momento che l'epidemia si poteva vincere o comunque circoscrivere soltanto iso lando gli ammalati , affermò che l'ospedale e in generale i luoghi di degenza non erano s ufficienti per le " esigenze sanitarie odierne"; di conseguenza- ed è il secondo punto -la situ azione si presentava come estremamente grave per la necessità e nel con tempo l'impossibilità di far front e alla malattia isolando i malati di "morbo influenzale ..." (nella malacopia le due parole so no in terval late dali' aggettivo "acuto", curiosamente cancella to a penna e che quindi non appare nel testo spedito); infine, propose di isolare temporaneamente gli ammalati di " .. Morbo acuto influenzale" (qui l'aggettivo invece appare) in Villa Margherita, già di p er sè sufficientemente iso lata rispetto alla città23 • Di Villa Margherita poi non si fece niente, ma non è ques to il problema che più c i interessa; ci interes sa piu ttosto l 'apparire di uno dei persistenti luoghi comuni trevigiani e veneti in generale. Il 14 ottobre infatti, il si ndaco scrisse a tutti i parroci della città una lettera per attivarli onde reclutassero il personale ausiliario necessario per affrontare la malattia24 • Il classico s ta nel ricorso alla Chiesa, al clero per meglio dire, nelle si tuazioni di emergenza; si farà così infatti anche per gli ammassi nel co r so e immediatamente dopo la Seconda Gu erra mondiale.

L'ospedale comunqu e si arrangiò se il16 ottobre la dire zione sc ri sse al s indaco che era stata aperta l'appos ita sala per i malati di influenza acuta23 , s ala da subito sottoposta a un sup erlavoro se il Cons iglio di Amministrazion e delle Op er e Pie deliberò un aumento d elle competenze dovute al primario di malattie infet tive per il verti ginoso aumento d elle sue prestazioni 26 •
Tutto ciò concerne la terapia; nel1919 però si co minciò a pensare anche alla prevenzion e, sicché il 26 gennaio la Giunta Comunale del i berò di " .. . mettere gratuitamente a di sposizione dell a popolazi one po vera il vaccino antinfluenzale", evidentemente fino a qu el mome nto riservato so ltan to a quanti se lo potessero perm ettere. Il s uccess ivo l o marzo la medesima Giunta deliberò l ' obbligo de lla vaccinazione antinfluenzale a titolo gratuito per tutti i lavoratori che fossero a contatto con il pubbli co27 • Pecca to che ormai, nel marzo 1919 , l 'ep idemia stesse r ap idamente decrescendo fmo a scomp arire mi steri osamente così come misteriosamente e ra apparsa.
Per la voce popolare era troppo semplice catalogare l 'epide mia co me dovuta a cau se naturali , a misteriosi e complicati giuo chi di germi che si trasme tto no da un u omo a un altro, da un paese a un altro. Molto più stimolante è prendersela con qualcuno, con qualcosa di tattile , di concreto, sperando che , eliminata la causa, c io è i diffu sori dell'epid e mia , se ne va da anche il male, ris ultato di manovre oscure delle quali erano comunque gli uomini a essere respon sabili. Era sempre cap itato così e se mpre s i era cercato il colpevole . Dunqu e non c'era alcun ragionevole motivo perchè non fo sse così anche per la febbr e sp agnola , tanto più che essa in s is tette nel corso della prima gu erra totale c he la sto ria avesse cono sc iuto. Che qu es ta guerra stesse per concludersi, lo si scoprì dopo ; in allora , gli Stati maggiori e l 'opinione pubblica erano convinti che essa non si sareb be conclusa se non nella primavera del 1919. Dato che la propaganda si era avvalsa de lla di ceria - assolu tame nt e falsa - che, invaso il Belgio n el 19 14 , i Tedeschi avessero tagliato le mani ai bambini, così evidenzi ando ch e erano barbari capaci di tutto, si diffuse la voce che essi fossero i colpevoli - omettendo naturalmente il particolare che anche gl i Imperi Centrali erano preda dell'epidem ia - ond e vincere la g uerra attraverso lo sterminio delle popola zioni nemiche. Corsia del reparto
Si scrisse infatti che " .. . la nuova Padova. -.

epidemia sia un regalo della Germania" e che" ... la malvagità diabolica dei nostri nemici ..." rendeva credibile la notizia28 • Sicché la psicos i della spia - già acuta in tu tto il corso del conflitto - si acutizzò perchè la spia poteva essere , era, anche l ' uotore che spargeva la polverina o il liquido malefici. Come sempre capita - piove , governo ladro! -altre voci imputarono il diffondersi del male al governo, che non va inteso come il governo in que l momento in carica, bensì piuttosto come classe dirigente da sempre espressione degli s trati più elevati della società. Si argomentava che questa classe volesse liberarsi dei poveri per il po tenz iale pericolo che es si costituivano e siccome la guerra non sembra va sufficien te a garantire lo sterminio di mas sa, a essa s i era aggiunta l ' epidemia come strumento per liberarsene , attraverso un ' "azione dolosa" o la "mancata preven zione" .
Si usò cioè il medesimo argomento c he era stato utilizzato a più riprese n el XIX secolo i n occasione delle rip etute e pidemie di colera. Fortunatamen te, o meglio per l' evolu zione dei costumi e p er un qualche incremento della cultura di base , non si ebbero fenomeni generalizzati di cacc ia all'untore come invece si era verificato nel secolo precedente, anche se Paolo Preto afferma che la paura degli untori riapparve in Sicilia e in Puglia29 , in regioni cioè ove la c ultura popolare era ancora in parte costituita di supers tizi oni e non esi tava a servirsi di pratiche magiche , qualora ciò fosse ri te nuto necessario.
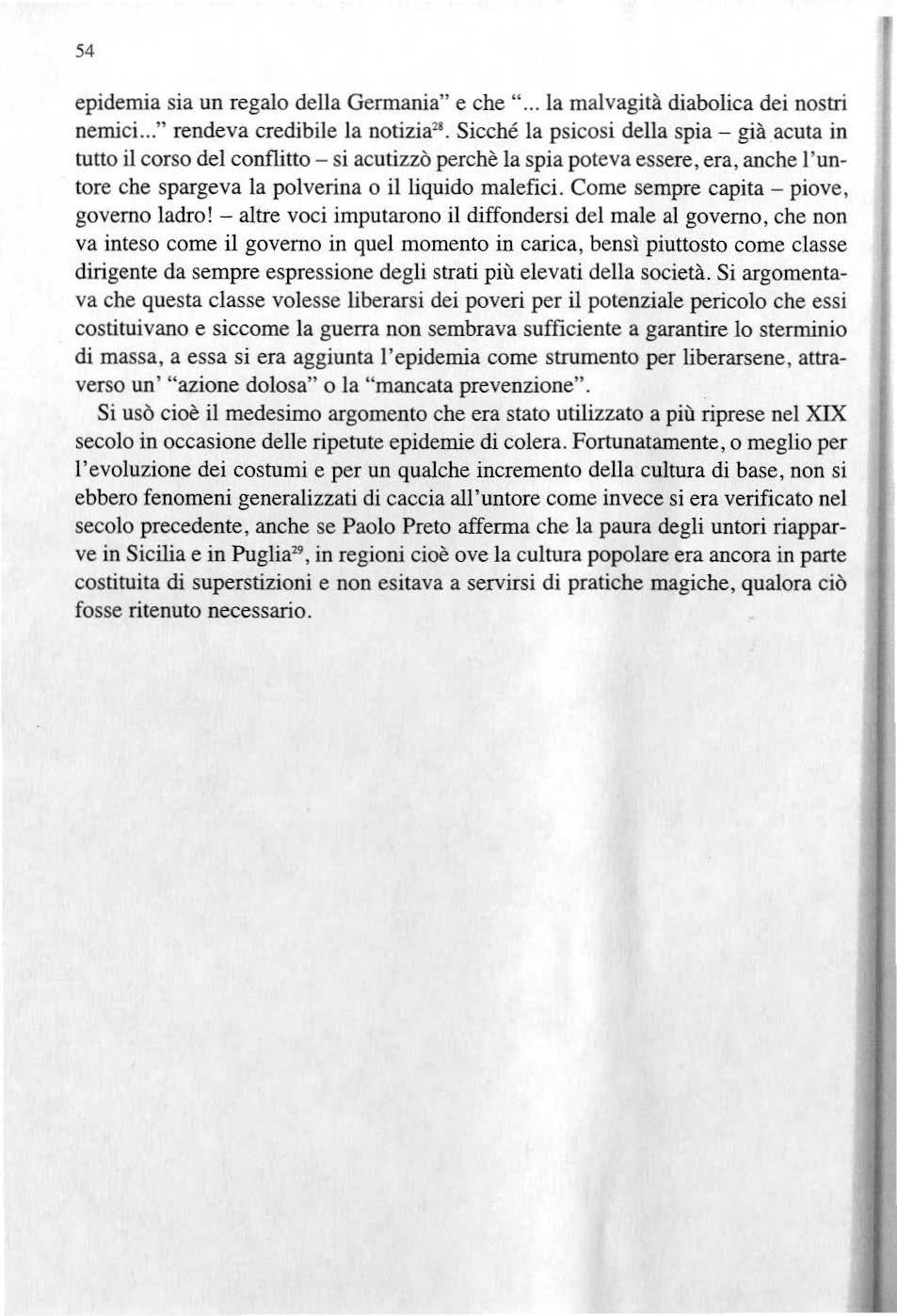
1 Paolo Preto , Epidemia , paura e politica nell ' Italia moderna, Roma -Bari , Latena, 1987 , p . 251 .
2 ACSTV (A r chivio Centrale dello Stato di Treviso), f. Gabinetto di Prefettura, b. 92, cat. ctg 15 , fase. 10, opuscolo Ministero Interno alle Prefetture del Regno.
3 Richard Collier, La malattia che atterrì il mondo, Milano, Lursi a , 1980, p. 11.
4 ACSTV, ivi , Telegramma Ministero Interno alle prefetture del Regno, lo agosto 1918.
5 ACSTV, ivi, lettera del Comando supremo ai Prefetti del Regno, 16 agosto 1918.
6 R. Collier, op. cit., pp. 5-7 e 23-24.
7 P. Preto, op.cit ., pp. 251 -252.
8 Daniele Ceschin, Gli esuli di Caporetto l profughi in Italia durante la Grande Guerra, Roma - Bari, Latena, 2006,p. 241.
9 AcrY (Archivio Comun ale di Treviso), b. Morti 1918, registro I.
10 Municipio di Treviso,lnchiesta sulle abitazioni entro la cinta muraria. Brevi note, Treviso , s.i.d . (ma 1911). Il AcrY, Elenco dei poveri per l'anno 1911.
12 ACfV, b. Morti 1918, regis tro ll , deceduti in ospedale.
13 ACSTV, f . Archivio comunale, b. 3598, Risposta del Comune a una studiosa sulla presenza della pellagra , 1898.
14 ACTV, ivi, registri I e II.
15 ACSTV, ivi, b. 3493, Risposte ai quesiti dell'inchiesta agraria da parte dei medici condotti dei circondari e relazione finale del medico del Distretto di Treviso, 1877.
16 ACSTV, ivi, b. 22, cat . I , 7 -5 , Censimento per rifusione danni di guerra 1919.
17 ACTV, ivi, registro L
18 Renzo Toffolo, "Piovan" di una chiesa distrutta. Memoire di guerra di don Pietro Sartor 1917-1918, arciprete di Salgareda, s.d.l. a cura di Amministrazione comunale di Salgareda, 2007, pp. 310 e 305 .
19 Livio Vanz.eno, Introduzione a Ivo Dalla Costa , La vicenda Collalto e le popolazioni di Susegana e di Santa Lucia di Piave 1914-1923, s.d.l. e s.d.e.l991 , p XXXIV.
20 ACSTV, f. Ga binetto di Prefettura, b. 92, ctg . 15, fsc. l, relazione del Commissario del Civico Ospedale al Prefetto, 23 giugno 1926
21 Giovanni Gastaldo, Jl dottor Gastaldo medico , s.d.l., a cura dell' AJ.R.D.A 2008, p. 35
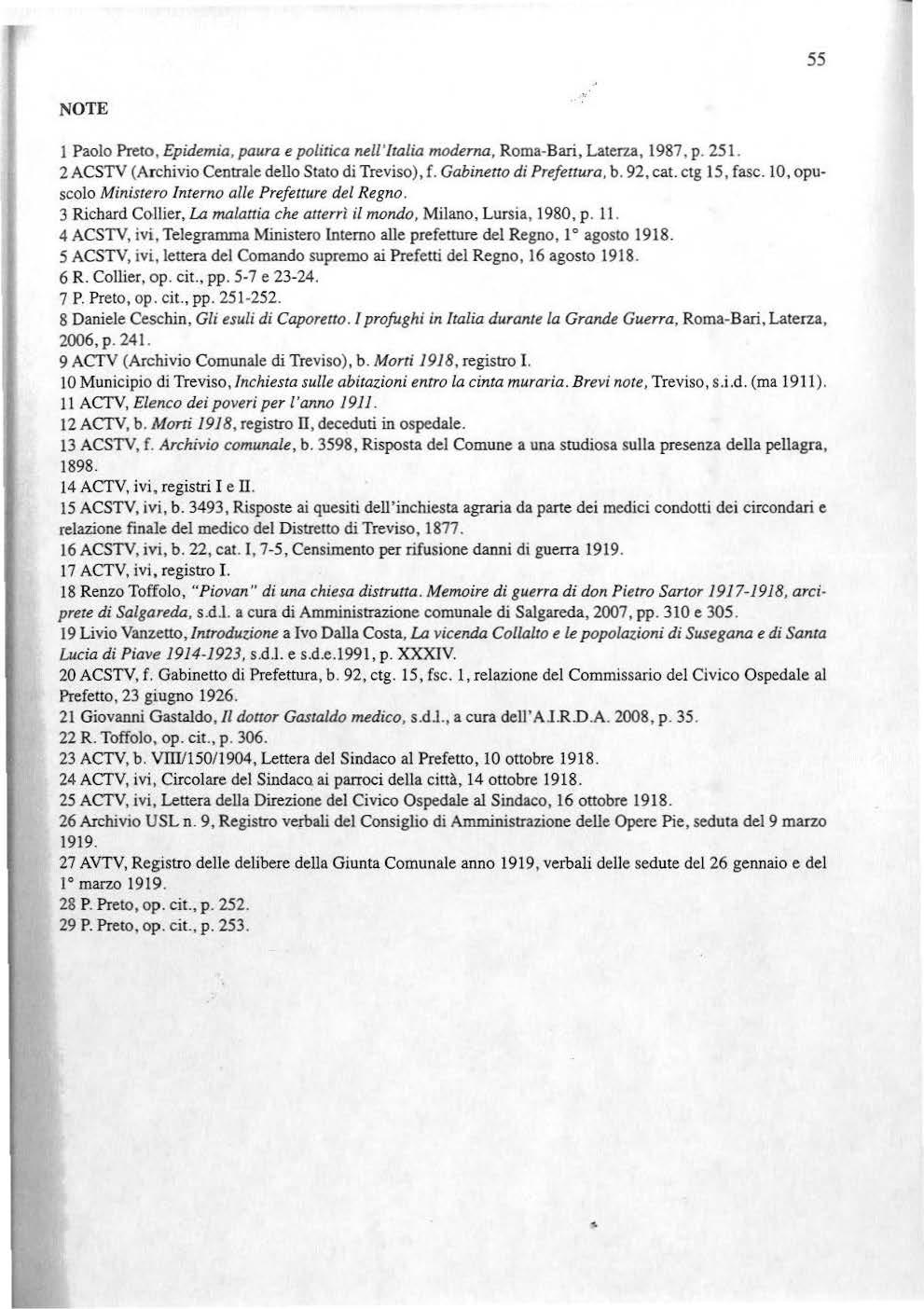
22 R. Toffolo , op.cit., p . 306.
23 ACTV, b. VIII/150/ 1904, Lettera del Sindaco al Prefetto, lO ottobre 1918.
24 ACTV, ivi, Circol are del Sindacu ai parroci della città, 14 ottobre 1918.
25 ACTV, ivi, Lettera della Direzione del Civico Ospedale al Sindaco, 16 ottobre 1918.
26 Archivio USL n. 9, Registro verbali del Consiglio di Amministrazione delle Opere Pie, seduta de19 mano 1919.
27 AVTV, Registro delle delibe re della Gi unta Comunale anno 1919, verbali delle sedute del26 gennaio e del 1° marzo 1919 .
28 P Preto, op.cit., p. 252.
29 P. Preto , op.cit., p. 253.
Molto spesso quando scegliamo un titolo per un convegno o per un saggio , pur senza voler tradire la serietà della ricerca, pensiamo innanzitutto a destare l'attenzione e la curiosità dei potenziali fruitori del nostro lavoro In altri casi invece , ci s i può indirizzare verso la scelta di un titolo per il fatto che quest'ultimo riesce a racchiudere in sé tante e tali sollecitazioni da fornire fin da subito un quadro piuttos to precis o del tema che ci s i appr esta ad affrontare. Io ho scelto questa seconda strada , tanto è vero che se qualcuno mi chiedesse di definire in modo stringato la condizione dei soldati con problemi di natura psichic a , ma più in generale dei combattenti durante il primo conflitto mondiale, sceglierei s icuramente quella di " uomini accerchiati". Con uomini accerchiati mi riferisco s icuramente alla particolare situazione tattica che ha visto fin quasi da subito gli eserciti contendenti condurre un conflitto su dei fronti bloccati con interminabili c hilometri di camp i trincerati contrapposti, dove al pericolo rappresentato dal fuoco nemico , nelle retrovie faceva da contro altare il pericolo rappresentato dai battag lioni di carabinieri pronti a fermare qualsiasi episodio di "codardia". Ma mi riferi sco anche alle strutture dì controllo e dominio messe in campo dagli stati moderni , che per la prima vo lta ebbero modo di manifestarsi con un'efficacia senza precedenti, dove le conseguenze delle azioni del singolo soldato potevano avere effetti concreti anche sulle famiglie o i parenti dello stesso . Si trattava della prima guerra totale dove ormai la dimensione individuale tendeva ad assumere contorni sempre più sfumati, ed ogni margine di autonomia interpretato come una sfida allo sforzo della "nazione in armi "

La foll ia rapprese nterà, per migliaia di uomini in tu tta Europa, l 'unica scappatoia per non venire schiacciati da quel immenso meccanismo di morte, distruzione e con trollo c h e fu la grande guerra. Le parole dell'aspirante ufficiale Francesco sono , in questo senso, più eloquenti di qualsiasi altro discorso:
" ... Grandemente malato ed esternamente d'un a discreta floridezza. Tutti mi dicono che io sto bene. Come dimostrare che io sto male? E perchè dimostrarlo?
Leggo nella mente altrui la credenza che io esageri i miei mali o che io finga addirittura per non andare in guerra. Scommetto che anche tu credi che io esageri ... un pochino il mio male perchè malato. Incompres o da tutti , la misantropia si fa strada nell'animo mio e con la misantropia il disprezzo per l'umanità brutale. Ho bisogno di solitudine di silenzio asso l uto, di poter fare tutto quello che voglio , di fuggire , di
volare nel cuore di un bosco, e vivere a contatto con la natura. Cosa si vuole da me? La vita. Io saprò mostrare ben misera e risibile cosa ciò che mi si domanda. Durante la mia permanenza al fronte non l 'ho mai c urata . La invincibile ripugnanza, il terrore folle e l'orrore mortale che mi assalgono quando ripenso al mio recente passato, quando p e n so che dovrò ritrovarmi in un ambiente che lentamente mi uccide, c he è in opposizione assoluta e dolosa con tutto l'e sser umano, m'hanno tratto alla decisione di annientarmi. E tu devi aderire alla mia v isione. Darò in pasto alle belve umane il mio corpo: il mio spirito se è vero che esiste un al di là libero d ' una libertà assoluta vagherà per l'universo. Da me s i vuole con la pistola puntata sul cu ore quello che io non posso assolutamente dare nè moralmente, nè intellettualmente, nè materialmente. Quello che per tanti e tanti rappresenta uno sforzo di adattamento, per me è il martirio. Ed io preferisco la mia estinzione a codes to martirio ... ".
Fu con la guerra russo-giapponese del 1905 che si reg istrarono i primi segnali inquietanti del potere disgregante che poteva avere a livello della psiche umana la guerra moderna. Si trattava del primo conflitto in cui i moderni mezzi di distruzione di massa ebbero modo di dispiegarsi in tutta la loro tragica efficienza, e dove le dimensioni stesse del conflitto tendevano ad ampliarsi a dismisura proiettando gli uomini su un piano che era totalmente al di fuori del loro controllo. É interessante notare che l'insorgenza delle ne vrosi di guerra coincida sostanzialmente con il mutamento della struttura stessa della guerra, che troverà poi il suo pieno compimento nel corso della grande guerra.
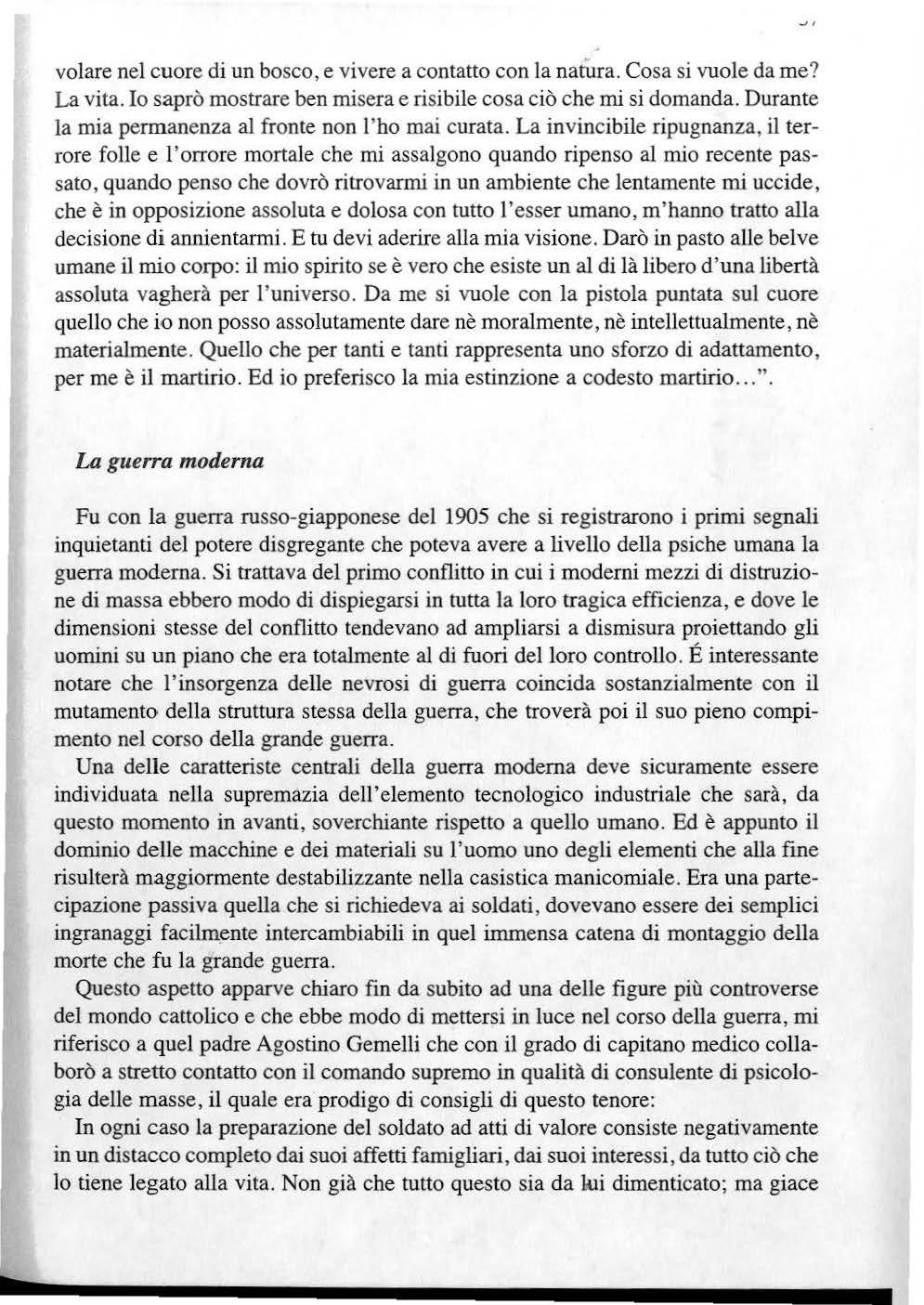
Una delle caratteriste centrali della guerra moderna deve sicuramente essere individuata nella supremazia dell'elemento tecnologico industriale che sarà, da questo momento in avanti , soverchiante rispetto a quello umano. Ed è appunto il dominio delle macchine e dei materiali su l ' uomo uno degli elementi che alla frne risulterà maggiormente destabilizzante nella casistica manicomiale. Era una partecipazione passiva quella che si richiedeva ai soldati, dovevano essere dei semplici ingranaggi facilmente intercambiabili in quel immensa catena di montaggio della morte che fu la grande guerra.
Questo aspetto apparve chiaro fin da s ubito ad una delle figure più controverse del mondo cattolico e che ebbe modo di mettersi in luce nel corso della guerra, mi riferisco a quel padre Agostino Gemelli che con il grado di capitano medico collaborò a s tretto contatto con il comando supremo in qualità di consulente di p s icologia delle masse, il quale era prodigo di consigli di questo tenore:
In ogni caso la preparazione del soldato ad atti di valore consiste negativamente in un di s tacco completo dai suoi affetti famigliari, dai suoi interessi , da tutto c iò che lo tiene legato alla vita. Non già che tutto questo sia da lui dimenticato; ma giace
tanto profondo nella coscienza, da non cos tituire una i nibizione al sacrifi cio . É un sen timento di estraneità, che costituisce il fondamento dell a nuova personalità che si forma nel soldato, e che è as so lutamente indispensabile perché il soldato s ia veramente tale; sia cioè soldato e soldato capace di atti di coragg io.

In generale possiamo affermare c he la psichiatria vide nella guerra un gigantesco laboratorio da cui poter attingere un numero senza prec edenti di casi da sottoporre alla propria attenzione, e nel contempo un'occasione per potersi affermare come scienza autonoma all ' interno della società moderna. Thttavia ogni aspettativa venne ben pres to del usa dali' assoluta impreparazione a poter sos tenere un flusso così massiccio di soldati che dovettero ricorrere a cure di tipo ps ichiatrico. I dati in nostro possesso sono alquanto frammentari e in larga parte disomogenei, per cui risulta perlomeno arduo fare una qualsìvoglia comparazione, comunqu e possono perlomeno darci un quadro della situazione. In Gran Bretagna sono stati stimati in 80.000 i s oldati passati nei centri psichiatrici , in Germania 313.399, negli Stati Uniti 97.556 , p er quanto ri guarda l ' Italia delle stime approssimative fatte nel dopogu erra parlano di 40.000 soldati.
Il servizio neuropsichiatrico di guerra venne a configurarsi come autonomo ri spetto agli altri servizi di sani tà già dal settembre de l1915 . Alla direzione venne pos to il dott. Tamburini , il quale ebbe il compito di nominare i consulenti psichiatrici presso le quattro armate, che nelle intenzioni avrebbero dovuto garantire, oltre all'organizzazione del servizio, anche l'iter diagnostico oltre che quello medicolegale. Nella realtà furono in grado di espletare a malapena la parte burocratica, demandando di fatto ai direttori degli ospedali territoriali i compiti più strettamente medici. Per il resto il servizio neurop sichiatrico ri calcava la struttura di quello sanitario in caso di guerra e si articolava su 3 livelli:
- il primo collegato direttamente alla prima linea e formato dai posti di medi cazione reggimentali e dagli ospedaletti da campo, venivano praticati i primi interve nti sanitari a c ui seguiva lo smistamento in funzione della gravità e del tipo di ferita o patologia riscontrata.
- il seco ndo livello era costituito dagli ospedali di tappa, avevano funzioni di colle gamento tra la prima linea e le retrovie, rappresenta vano un semplice punto di transito più o meno breve per gli ammalati e i feriti.
- il terzo livello infine si articolava sugli ospedali militari di ri serva.
Nel corso della guerra vennero i stituiti anche dei re parti di prima linea , posti in posizione leggermente arretrata rispetto agli ospedaletti da campo, ebbero il compito di gestire gli alienati, c urare i casi meno gravi e scovare eventualmente i sim ulatori.
La grande prova a c ui la psichiatria italiana venne chiamata s i rivelerà alJa fine, come si è già detto, quantomeno improba. Si trattò certamente di un problema legato ai numeri, ma fu soprattutto un problema di deficit del bagaglio teorico -c ulturale. In particolare la psichiatria italiana che rimase ancorata per tutto il periodo della guerra al dogma organ icista, fondando conseguentemente ogni speculazione su due capisaldi come la degenerazione e la pred ispos izi one, non riuscì mai ad avere tra le mani quegli strumenti che potessero in qualche modo far emergere il fattore guerra come centrale nella patogenesi delle nevrosi. A questo si aggiungano le continue pressioni esercitate dai comandi militari per mantenere il più alto possibile il numero degli effettivi al fronte, e si potrà ben capire quali fossero i presupposti entro cui il problema delle nevrosi venne trattato.
Compless ivamente prevalse una visione di tipo di scip linare , nel soldato s i vedeva più un colpevole da punire che un ammalato da curare. La storia del capitano Pietro può it n qualche modo aiutarci a compre ndere il tipo di approccio che venne usato nei confronti dei so ldati che presentavano sintomi legati alle nevrosi. Ricoverato al S. Artemio di Treviso il 30 luglio 1916, dato che dopo tre giorni di trincea presso Coni Zugna fu preso da "angoscia, tremori, sudori di freddo ch e duravano 4 o 5 ore" s i decise a chiedere giud iz io collegiale, che venne accettato con le seguenti motivazioni:

"Zona di Guerra addì 14-luglio 1916
A seg uito del foglio in data di ieri no 382 R o, il Capitano ... sig. Pietro ha oggi presentato domanda per visita colleggiale. Egli mi ha ripetutamente dichiarato di non essere in grado per le sue condizioni psichiche di assumere il comando di una compagnia. Non ostante ciò ho dato il comando della 4 Compagnia Proviene dagli ufficiali di complemento, ed è stato promosso Capitano a 23 anni e mezzo. Urge, per mantenere la compagine moral e nei quadri dell'esercito, che siano presi gravi provvedimenti verso coloro che cercano di sottrarsi agli obblighi che ogni buon cittadino deve avere per il paese. Epperò io propongo che il Capitano ... non ritenendosi idoneo ad esercitare il suo comando, s ia senz'altro, dopo esperite le pratiche medico- legali collocato in riforma , affinchè questo provvedimento possa servire di esempio. eliminando nei quadri questi parassiti, che mentre gravano sul bilancio dello Stato, ritard ano con la loro presenza la carriera a quelli che con abnegazione e sacrificio comp iono il loro dovere ".
Le terapie, in linea con i principi inspiratori della gestione degli aliena ti, dovevano fondarsi in larga parte sull'intimidazione. Ripetute sedute faradiche a cui si facevano seguire una serie di ordini urlati , eterizzazioni , suggestioni collettive, erano la quotidianità negli ospedali psic hi atrici dei paesi coinvolt i nel conflitto. Così Max Nonne, psichiatra di Amburgo, ci descrive una seduta elettrica:
"[durante l' ele ttrizzazione] accade qualcosa di incomprensibile .. . Uno sg uardo imp ietrito, un v iso contratto, i muscoli tesi come una fune, tirati, irrigiditi ,curvati
sopra qualcosa di invi si bile, come glieli si volesse strappare. Si parla [al sol dato ] in modo calmo e amichevole, ma è come che ci si rivolg esse alla ruota di un mulino che sibila. E con una cieca ostinazione si mette in moto una seconda ondata: un tremore , una convulsione , un respiro affannoso , i denti battono , i capelli si rizzano , il sudore corre sul volto impallidito. Che cosa s uccede in questo tumulto? Acute grid a, rapido e violento dolore , i pugni serrati ... Questa sce na è così consueta per tutti i terapeuti di guerra, che in comincia ad annoiare".
Al metodo disciplinare si contrappose quello analitico di sc uola freudiana. Semplificando , potremmo dire che l'interpretazione psicoanalitica vide nella fuga nella malattia la mancata soluzione del conflitto generato dalla contrapposizione tra il desiderio di vivere del soldato e l'imperativo morale c h e lo manteneva legato al fronte . Thttavia la scuola analitica non ebbe nessun ruolo in Italia nel corso della guerra , trovando viceversa imp ortanti sviluppi in Germania e Gran Bretagna .
Nella realtà negli ospedali psichiatrici territoriali l'approccio terapeutico fu estremamente diversificato ed è difficile individuare una prassi prevalente per tutti i no soco mi. Poss o affermare che nel caso di Treviso s i fece largo uso dell' ergoterapia, una sorta di training a cui venivano avviati i soldati una volta superata la fase acuta della malattia, che mirava alla ricostruzione di una "vita normale" grazie al lavoro nei campi e al conta tto con gli animali da cortile e da stalla. Thttavia l ' approccio disciplinare, perlomeno a livello di indirizzo generale, rimase sempre prevale n te , ed in particolare dopo Caporetto si decise di porre fine a tutte quelle incertezze dettate dalla discrezionalità dei singoli direttori dei manicomi, istituendo il centro " barriera" di Reggio Emilia, unico luogo deputato ad emettere decisioni medico -legali . Alla direzione fu posto Placido Consiglio , da sempre pervaso da una visione punitiva del problema , non nascose mai la sua ricetta che prevedeva un più utile impiego di "questi degenerati" in lavori pericolosi al fronte, in modo da non preservarli dai pericoli della guerra. Su questi pres uppos ti oltre lO .000 soldati furono giudicati e curati nel corso del 1918.
n nosocomio trevigiano iniziò ad operare come ospedale militare di riserva fin dallo scoppio della guerra, a dirigerlo rimase, con il grado di capitano medico, il dott. Zanon dal Bò. Nel periodo preso in considerazione dalla mia indagine, ossia giugno 1915 - ottob re 19 17 (dopo Caporetto venne sgomberato e ricostituito a Medola di Borgo Panigale), vennero ricoverati 1575 militari. Da un ' analisi dei luoghi di provenienza dei soldati risulta una sostanziale coincidenza statistica con quella dell'esercito mobilitato , pertanto possiamo affermare di trovarci di fronte ad un campione sufficientemente rappresentativo della realtà italiana nel suo complesso.
Le diagnosi che compaiono nelle cartelle cliniche il più delle volte non sono di

grande aiuto per comprendere cosa ci fosse ali' origine del di sagio manifestato da questi so ldati. Si trattava di semplici "etichette" tratt e da un manuale di p sichiatria a cui " burocra ticamente" bisog n ava far rientrare i casi in osservazione. Tra le più ricorrenti troviamo l'amenza, la dem enza precoce, le varie forme di psico si, ma l a più usata in assoluto (3 5 .5 %) fu l ' in competenza. Con que sta defini zion e non si voleva far riferimento ad una totale estraneità psichiatri ca, bensì si cercava di dare un a qualche sistemazione a tutti quei casi che non si era riusciti a far ri entrare nell a class ificazione no sologica tradizionale. In sos tanza div enne la scappatoia attraverso la q uale i medi ci di Trev iso riuscirono ad em arg inare tu tte que lle si tu azioni in cui il ruolo della guerra, come fattore sca tenante de l disagio , era del tutto evidente. Non è privo di s ignificato il fatto che ques to termine , in pien a mobilitaz io n e patriottica guidata da P. Consiglio nel campo psichiatrico , nel 19 18 scompaia letteralm ente dalle cartelle cliniche. Interess ante notare poi che l'incompetenza, nonostante nella maggioranza dei casi abbia avu to u n decorso che p os s iamo definire pos itivo, nella realtà abbi a ind otto i medici a dimettere i soldati con lunghe lice nze di convalesce n za che, perlomeno nel caso trevigiano , erano la v ia "militare" p er poter porre in essere quell'esse nziale apporto terap eutico che era l 'ass istenza ornofamig liare.
A Padova , altro os pedale che nel corso della guerra vide passare oltre 1500 s ol-
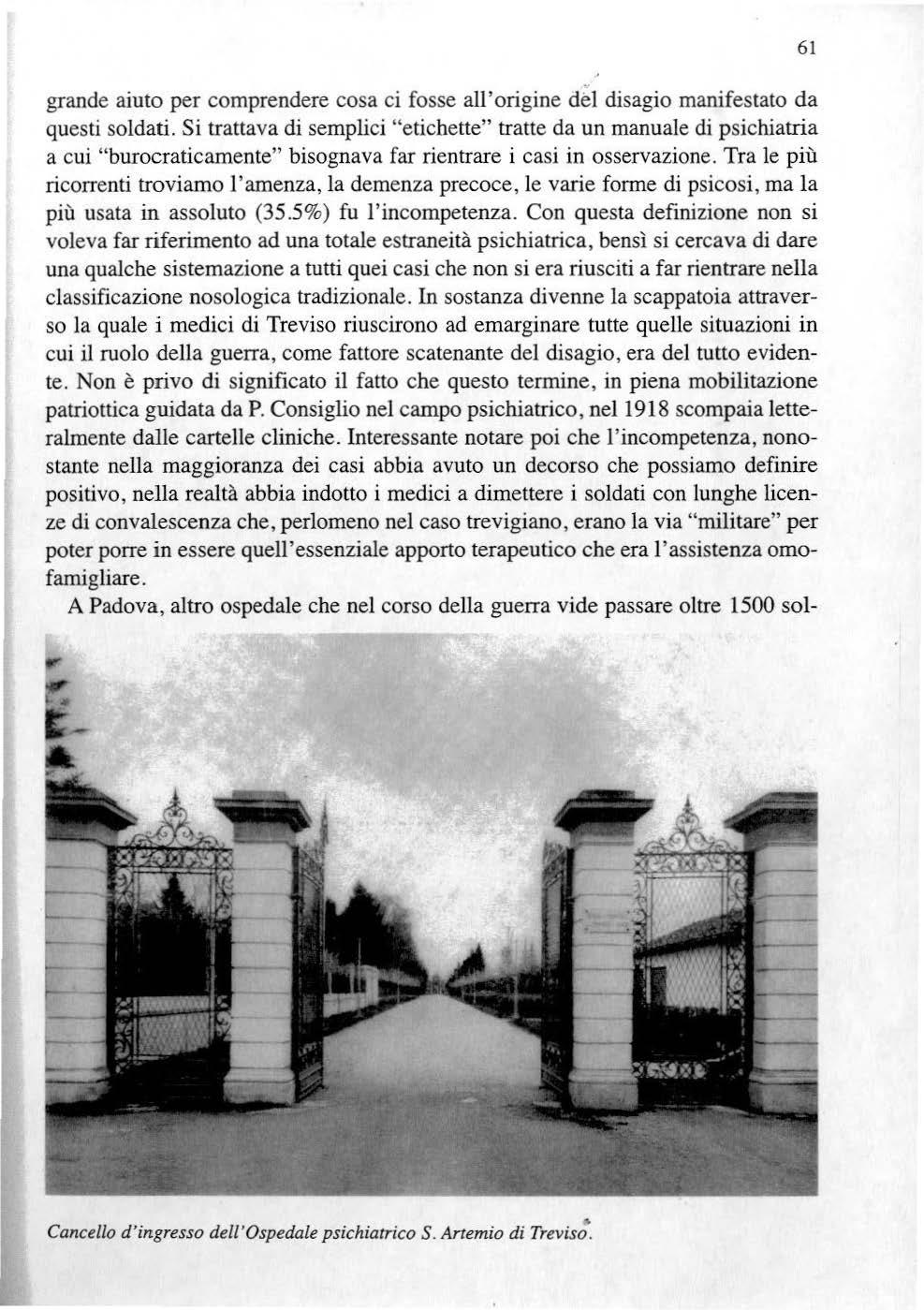
dati , si ebbe qual cosa di an alo go con la dia gn osi di malinconia (3 1 %) ossia una delle poch e defini zioni contenute nei manuali che non pote va ess ere ricondotta ad un a " ras sic uran te" base organica.
Nonostante tutti i tentativi di neg are un qual s ias i ruolo all a guerra nell ' insorge nza d elle nevrosi , i dati che emergo no dallo studio delle cartelle cliniche ci mostrano i nequivocabilmente che la gu erra ri s ultava ess ere sempre pi ù l'elemento ce ntrale dell'indagine sv olta dai medici. Altri due aspetti credo possano definitivame nte fu g are qualsias i dubbio , se ancora ce ne fossero , in merito. Mi riferi sc o al periodo medio di permanenza in ospedale dei soldati, che nel cor so della guerra , con l ' inasprirsi deg li sc ontri , andò progress ivam e nte allungandos i su p erando abbondanteme nte i tre mesi del periodo legale di osservazione. Ed infm e, forse l'aspetto pi ù macroscopico, osservando l'andamento degli ingressi si può notare come que sti siano sostanzialmente le gati alle più importanti operazioni militari , con picc hi che sup eravano i cento ricoveri al giorno in corrispondenza dell e "s paliate" autunnal i su l Carso de l 1916 .
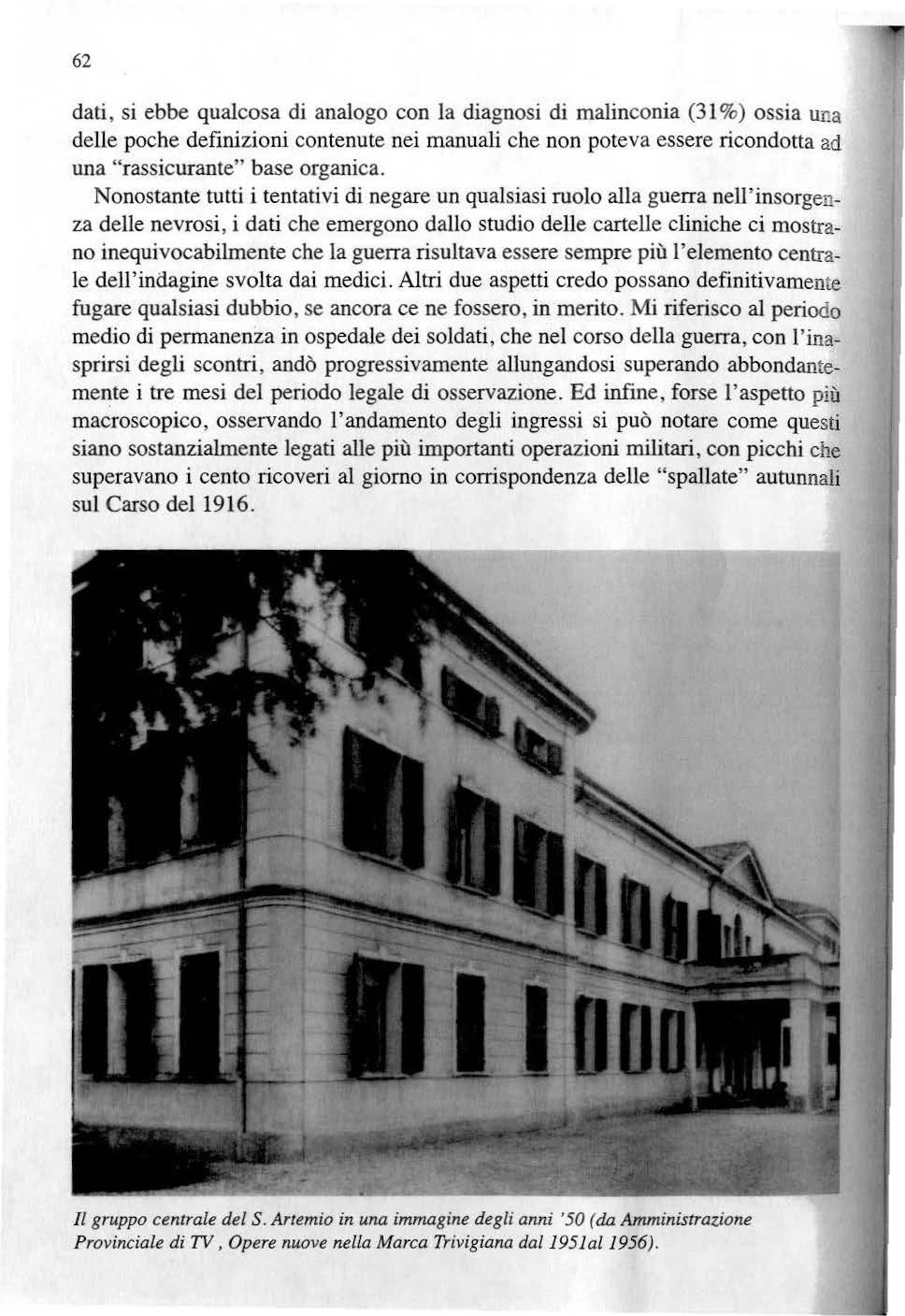
Per la gran parte di questi soldati il ricovero al manicomio non era che l 'ultima tappa di un lungo e doloroso percorso attraverso le infermerie , gli ospedaletti da campo , gli ospedali di tappa. Alloro arrivo i medici si trovavano di fronte a degli uomini completamente annientati dall'esperienza della guerra, incapaci di rei azionarsi con l'esterno, molto spesso neppure in grado di provvedere anche ai loro bisogni primari. Ecco come vengono descritti dai sanitari trevigiani: " ...espressione attonita, contegno inerte, ottundimento affettivo . Percezione tarda, indebolimento mnemonico, ideazione rallentata .. . ha gli occhi sbarrati, e si pres enta come terrorizzato da visioni di spavento ... É molto confuso , disorientato, torpido, apatico, poco ordinato nel contegno. Assume posizioni goffe, stereotipate , inaffettivo, asocievole, acritico , abulico. Sempre solitario, depresso, appare evidente in lui il completo sfasciamento psichico, poverissimo nei suoi poteri vo litivi e idoneo -associativi. Mutacismo, negativismo con tendenza a raccogliersi sotto le coltri e ravvolgere il capo nelle lenzuola . Resta immobile intere giornate, provvede però da se adeguatamente ai suoi bisogni e si alimenta da se. Sembra che l'atteggiamento speciale si connette al bisogno di appartarsi completamente dal mondo esterno per poter seguire le sue allucinazioni o per lo meno delle rappresentazioni mentali che lo ten gono assorto. Spesso commette degli atti s trani; come quello di mettersi a letto vestito ecc . " .
Si potrebbe continuare così per quasi tutti i 1500 militari ricoverati a Treviso. Ciò che li accomuna è i l terrore che portano dipinto negli occhi , nei loro corpi laceri .
Spesso sobbalzavano dal letto in preda a incubi terrificanti, l'orrore che cercavano di fuggire li inseguiva fin nel letto dell'ospedale, alcuni, in un estremo tentativo di difesa, cercavano di approntare improvvisate trincee con la biancheria e i materassi che riuscivano a recuperare nelle camerate. Il soldato Luigi, ricoverato al S. Artemio nel dicembre del 1915, nei suoi soliloqui (riportati nel diario clinico dai sanitari) riproduceva efficacemente l 'irreale momento dell'assalto:
"Dammi da bere mamma , mamma, s i! ora vengo subi to , subito, thumm! sseccc! bumm! phim! poh! prooh! rrrr! trrr! foco! trumm! trinn! vrumm! battaglione! alt!
a si nistra ! stenderevi!
contro fantter ia ! si avanzi sul fronte! fuoco!
pront i ! Savoia!
toh ! tososiii!
Con voce greve, fiera, dignitosa , imitando quella del comandante:
"Valorose itruppe, il compito è stato difficilissimo , ma il vostro valore ha saputo superarlo .... .
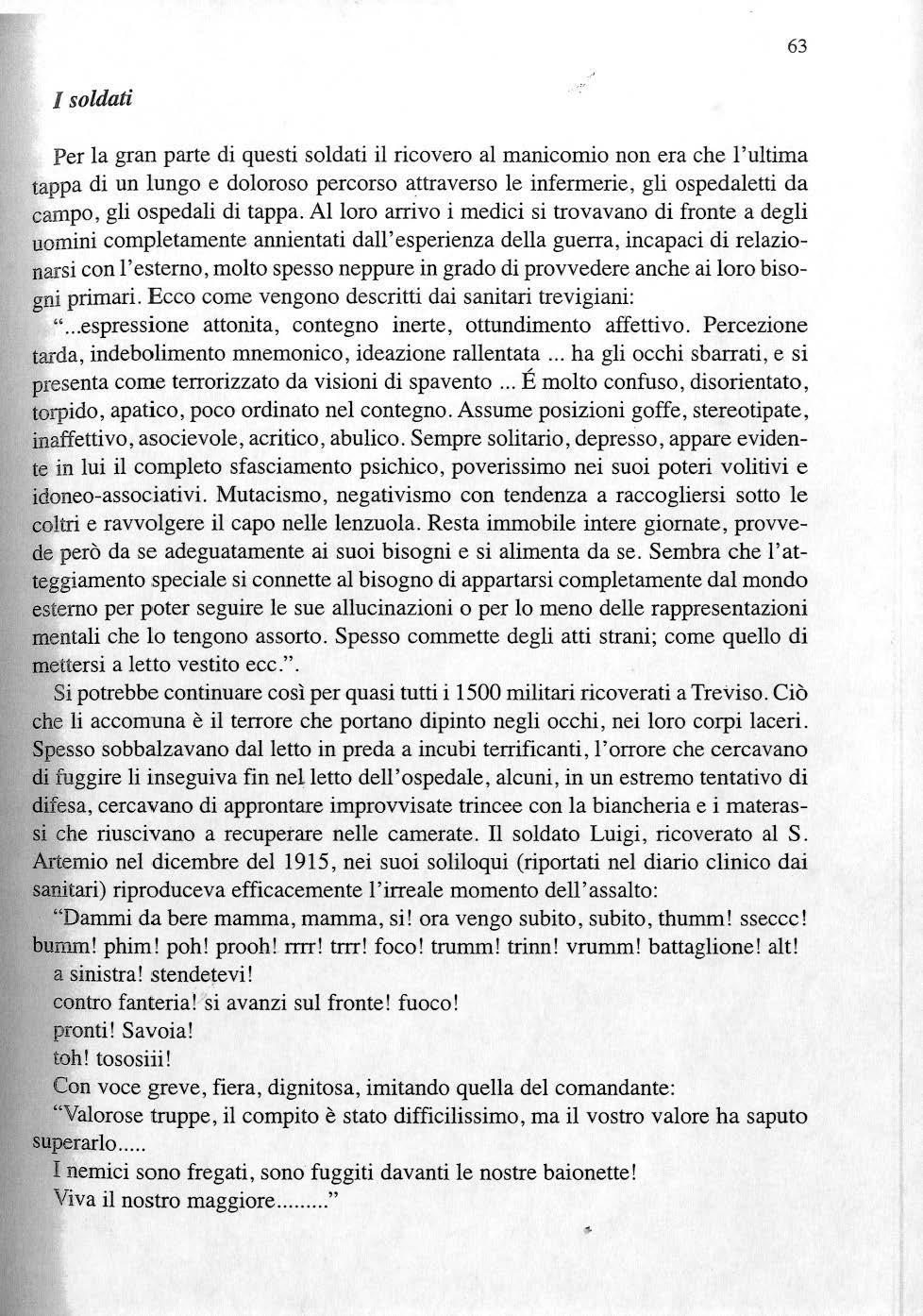
I nemici sono fregati, sono fuggiti davanti le nostre baionette!
v 'l " tva 1 nostro magg10re .........
La distruzione, la morte , il disprezzo per i corpi dei compagni abbandonati lungo i reticolati, erano spesso l'ultima cosa che era rimasta impressa nelle loro menti. I medici cercavano di interrogare il soldato Vincenzo proveniente dal Col di L an a per avere qualche notizia utile per l'anamnesi, ma i loro tentativi dovevano infrangers i contro una realtà che forse neppure loro erano in grado di capire.
"che mestiere fa?
sparavano e non li vedevo Tutti quanti quelli sono morti quanti ce ne stavano lì, poveri! poveretti! disgraziati ma li vede il colonnello era buono, mi dicev a, bravo ragazzo, si, corri sotto la trincea a raccogliere i feri ti!.. si sentiva (riproduce uno scoppio di un proiettile) di che reggimento è lei?
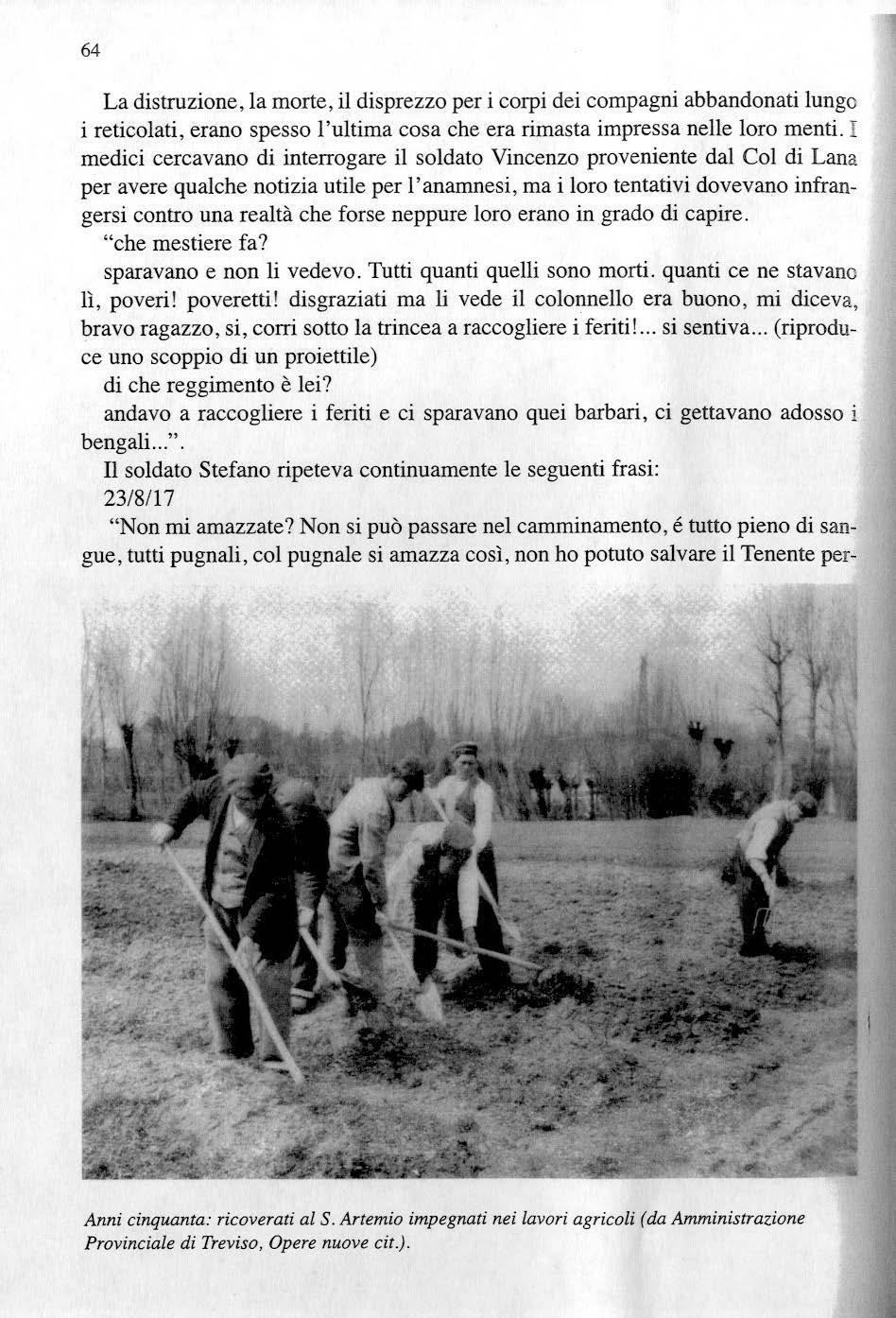
andavo a raccogliere i feri ti e ci sparava no quei barbari, ci gettavano adosso i bengali .. .".
Il soldato Stefano ripeteva con tinuamente le seguenti frasi: 23/8/17
"Non mi amazzate? Non si può passare nel camminamento, é tutto pieno di sangue, tutti pugnali, col pugnale si amazza così, non ho potuto salvare il Ten e nte per-
ché mi hanno portato via il fucile, mi fece la lettera, era riiorto nel camminamento , ce l'ho dato, gli diedi pure il revolver"
Dopo un periodo che poteva variare anche di molto da soldato a sol dato , generalmente i medici riusci vano ad avere un qualche tipo di rapporto con i ricoverati. Anzi spesso venivano ritenuti le persone più adatte ad ascoltare le loro tragiche storie, e del resto a chi avrebbero potuto raccontare esperienze che erano oltre ogni capacità cognitiva umana.
I medici furono testimoni di uno dei fattori che forse più di altri incise in profondità le coscienze dei combattenti: la rottura dei confini tra umano e disumano. La guerra aveva spostato il limite dell 'orrore oltre ogni precedente esperienza, que sti uomini si ritrovarono catapultati in una dimensione del tutto nuova a c ui non riuscivano contrapporre nessuna contromisura raz ionale
Il caporale Pietro dopo un'azione a Col Bricon, il 22 maggio 1917, perse conoscenza e venne ricoverato . Raccontava ai medici che era turbato dal fatto che con la sua mitragliatrice aveva compiuto una strage di nemici (ricevette un encomio sole nne per questo) , ricordava anche che una granata uccise un suo compagno vicino "proiettando gli intestini della vittima sopra di lui". Il soldato Luigi , che doveva avere già una certa dimestichezza con la realtà della guerra, dato che aveva partecipato alla campagna di Libia e si trovava, nell'attuale guerra, al fronte dal maggio del 1915, per la precisione sul Monte Nero, venne ricoverato in preda ad un'idea delirante . I medici riportarono nel diario cl i nico i fatti accaduti: " quand'era al campo, andava ad attingere acqua da bere per se e per i compagni, in una buca che era stata scavata da una granata; vi andava di notte; quando una volta si accorse che nel fondo c'era un cadavere che usciva di terra, essendovi mal sotterrato . I compagni in parte ammalarono ." Il.sottotenente Giuseppe in servizio dal giugno 1915, era stato prima su l fronte isontino e poi nel Trentino . Inizialmente scelse di non parlare della sua esperienza con i medici: "il paziente si rifiuta di riferire con impressione di paura e di sgomento", ma alle insistenze dei sanitari si decise a raccontare gli avvenimenti accaduti sul Monte Interrotto. "Riferisce che un proiettile da 305 gli fece scomparire l'amico e 2 soldati. Dell'amico rimase solo il cuore. Dice che ha sempre davanti gli occbi l'amico scomparso e si vede avanti il suo cuore sanguinante."
Non è raro risoontrare poi negli scritti dei soldati una de scrizione delle loro sofferenze di una lucidità sconvolgente, molti di loro seppero cogliere gli aspetti più profondi del disagio che l'uomo manifesta di fronte all'intollerabile. Il sottotenente Natale scriveva alla madre nel settembre del 1916:
" ... sento che mi occorre qualche mese di pace, di solitu dine affettuosa, di cure morali , di dimenticare la mia vita vecchia, affogandomi magari in qualche studi o difficoltoso che mi estranei, assorbendomi. Fisicamente, si, sto bene. Sono anch e ingrassato, suono il piano , ò comprato alcuni libri di studio coi quali passo parecchie ore al giorno. A volte , se bene spesso il dolore dell 'aRima mi dia un estrania-
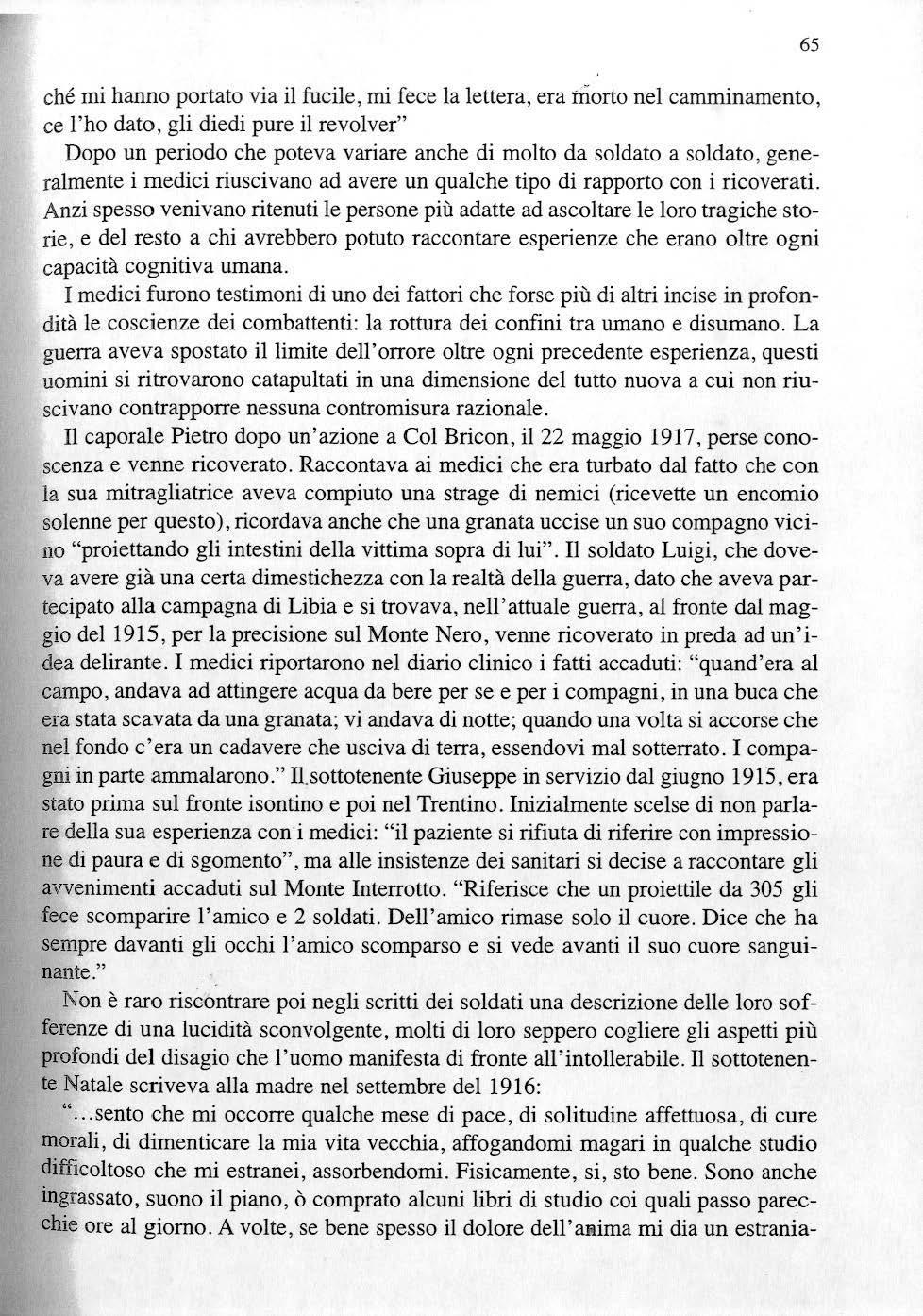
mento indefinibile al corpo, come se le membra si s tacchino l'una dall'altra, ò dei momenti di vigore fisico straordinario, come a quattordici anni. Io non ò il corpo mala to, .non ò bisogno di nulla per curarmelo: ò da sanarmi l'anima ... ".
Benché in modo diverso, ma non per questo meno efficace, il soldato Pasqual e cercava di comunicare ai sanitari, che ne presero nota nel diario clinico , cosa e come si sentiva: "mi arrabbiavo di me stesso, mi vedevo consumare , parlavo d a solo e piangevo", aveva la percezione di sentirsi "distruggere come una candela (e si gu arda le mani scarne)"
Anche i famigliari che, dopo tante preoccupazioni , accogliev ano i loro cari figli a casa erano dei testimoni privilegiati nel testimoniare gli effetti dell a guerra su questi poveri r agazzi. Per molti di loro non era così semp li ce ri prendere la vita di prima, la madre del caporale Carlo scriveva al direttore:
" Ill.mo Sig.
Compio il dovere di informarla dello stato di mio f iglio. Mi duole nel farlo p ercbè non posso nasconderle il mio rammarico nel constatare il deperim ento fisi co de l mio Carlo, men tre nell'ultima s ua m'assicurava del miglioramento tanto fisic o che mentale. Vedo purtroppo ch e a poco o a nulla riman e a fare e ch e devo aspettarmi tra breve la fine di q uel corpo tanto martoriato. Perchè non mi hann o consegnato prima d'or a mi o fig li o o almeno non m 'hanno informata del suo deperimento. Me lo concesse a casa sperando secondo lei che il ritorno desse alla sua mente un benefic io, le devo dire invece che mio figlio per nulla ha p erduto l a m emoria, che ricorda esattamente tutto ed appunto que sto ricordo lo addolora ancor più. Do veva invece procurare curare il corpo dal momento che non la mente ma il dolore lo rende infelice, e no n lasciare che un d eperimento tale s' impadronisse di l ui. Non sò cosa potrò ancora fare per mio figlio, certo è che procurerò ogni cosa per salvarlo. Guai a Lei se do vrò perderlo, per chè su di Le i riverserò tutta la responsabilità . Non sò capire qu ali siano s tate le cure fatte da loro, so solo ch e n e vedo più danno che vantagg io perchè mai mio figlio ebbe a trovarsi in s tato tanto compassionevole. Dell ' altra bi ancheria dev ' essere presso di loro come una cami cia, u n paio mutande lana, due paia cal zetti, una flanella e de i fazzo letti.

Con stima, attendendo ri scontro
Maria F.
S .Giorg io in Brenta 6 Ago sto 917"
Nella cas is tica manicomi ale emerge chiaramente il ruo lo destabilizzante della disciplina mili tare che, n ell 'esercito italiano , rag giu nse livelli di inciviltà senza precedenti. I so ldati sono testimoni di co ntinui soprusi, maltrattame nti di ogni genere,
di una totale mancanza di rispett o verso uomini che in fondo non chiedevano altro che poter rivedere per qualche giorno i propri cari, soccorrere le proprie famiglie in difficoltà , correre al capezzale di una madre morente. La ferrea di sciplina imposta da Cadoma non ammetteva nessun spazio di umanità , solo con la più violenta repressione s i poteva mandare avanti qu ella massa di recalcitranti fantaccini. Per loro la patria non aveva nes sun s ig nifi cato, sosteneva padre Gemelli, e l ' unico modo per educarli all'obbedienza era tenere ben in vista il codice militare da una parte e la rivoltella dall'altra. É stato calcolato che nel corso della guerra un soldato su dodici sia stato coinvolto in qualche procedime nto disciplinare.
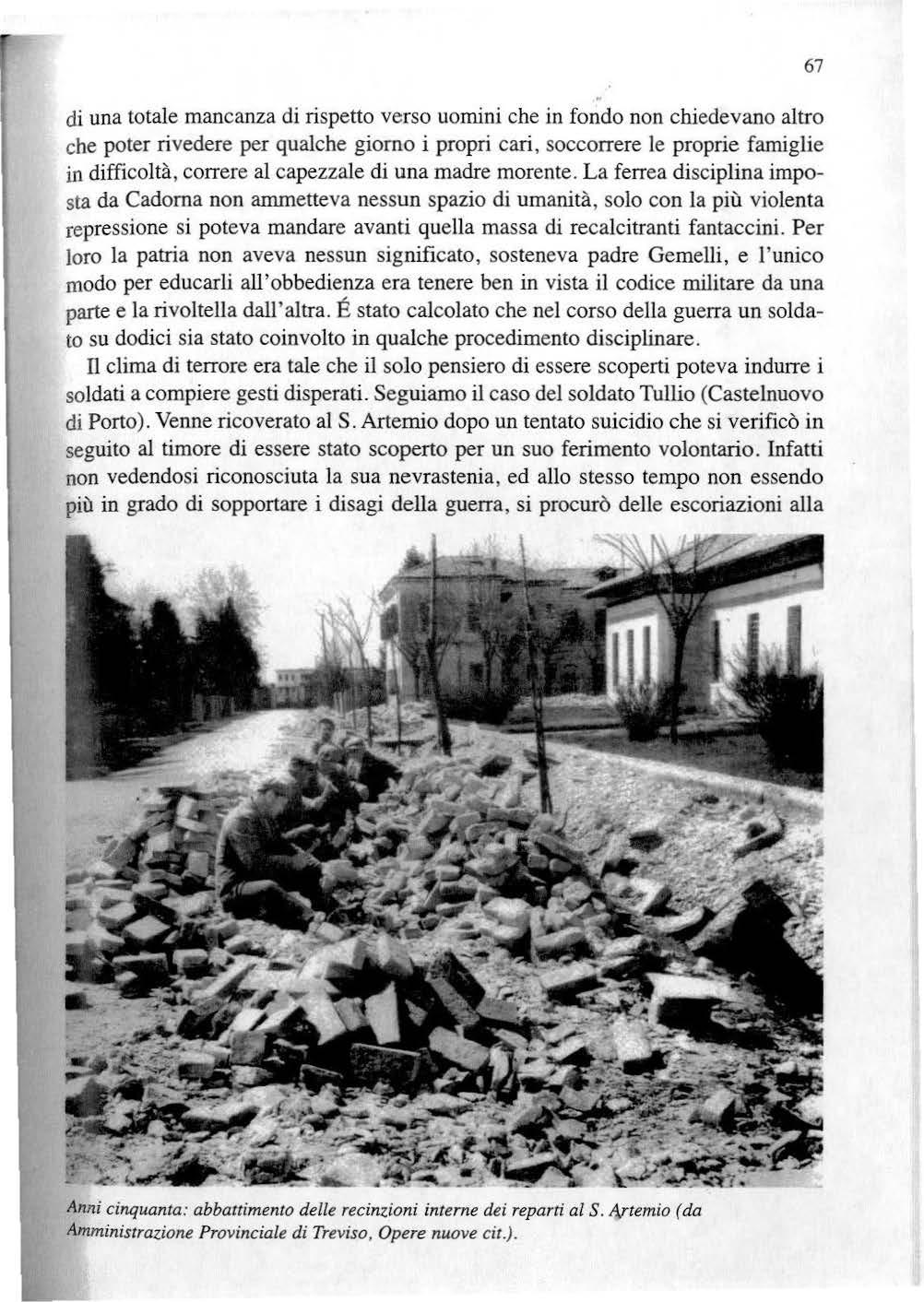
n clima di terrore era tale che il solo pensiero di essere sc operti poteva indurre i soldati a compiere gesti disperati. Seguiamo il caso del soldato Tullio (Castelnuovo di Porto). Venne ricoverato al S. Arternio dopo un tentato suicidio che si verificò in seguito al timore di essere stato scoperto per un suo ferimento volontario. Infatti non vedendosi riconosciuta la sua nevrastenia , ed allo stesso tempo non essendo più in grado di sopportare i di sagi dell a guerra, si procurò delle escoriazioni alla
Anni cinquanta: abbattimento delle recinzioni interne dei reparti al S. A,rtemio (da Amministrazione Pro vinciale di Treviso , Opere nuove cit.).
1
L ' inaugurazione del Manicomio di S . Artemio nella crona ca della Provincia di Treviso del28-29 giugno 1911

mano, ragione per cui gli furono concessi dei giorni di riposo ed inviato alle cucine del reggimento. Ma ritenendo di essere stato scoperto, cosa che peraltro non si verificò, fuggì per tornare al suo reparto . Giunto su lle falde del monte Sabotino , iniziò a pensare che avrebbero potuto giustiziarlo in trincea per quanto aveva fatto, e in un momento di disperazione tentò il suicidio. Prima di compiere l'estremo gesto scrisse delle lettere: una di addio alla moglie (che contiene ancora una ciocca di capelli che intendeva lasciare in suo ricordo) e tre ai suoi superiori per spiegare le circostanze che determinarono la sua decisione.
"Perdonami Ninetta sono innocente non ho fatto male a nessuno ho mancato perchè troppo mi sentivo male e per te e i figli ho perduto la testa Miei cari figli e mia N inetta questi miei capelli teneteli per ricordo sono del vostro papà e anche tu N inetta ricordarmi perchè vi ho voluto troppo bene a tutti: Muoio chiamandovi a tutti . Per vivere vendete tutto. Addio Nina addio figli per sempre Tullio".

Il perverso sistema disciplinare non risparmiò naturalmente nemmeno gli ufficiali, anzi si trovarono nella scomoda posizione di dover dare attuazione alle scellerate e talvolta incomprensibili impostazioni tattiche del comando supremo e, nel contempo, far rispettare una mole di regole e regolamenti assolutamente irrazionali, il tutto so tto la continua minaccia di essere destituiti, degradati o puniti a comandare operazioni suicide.
Pressati dagli alti comandi impantanati i n una guerra che, dopo il trionfale inizio, non dava risultati apprezzabili, ma anche pervasi dal rimorso di condurre dei poveri padri di famiglia alla morte, gli ufficiali e in particolare quelli di complemento pagarono un numero altissimo di casi di nevrosi, quasi una malattia professionale ha sostenuto lo sto rico E . J. Leed. A Treviso gli ufficiali rappresentavano il 10% dei ricoverati, un dato significativo se pensiamo che il rapporto nell'esercito oscillava tra 1135 e 1/29.
Emblematico in questo senso è la storia personale dell' aspirante ufficiale Angelo. In servizio militare con il grado di caporale dall'ottobre del 1915 nella zona del Carso. All'inizio del1917 fece richiesta di frequentare il corso allievi ufficiali, terminato il quale tornò con il nuovo grado in prima linea, tuttavia in seguito alle sue insistenti e ripetute richieste per essere reintegrato al grado precedente venne considerato "anormale", e dopo la consueta trafila nelle strutture sanitarie in termedie, venne inviato al manicomio di S. Arternio. Così descriveva la sua situazione in una lettera del giugno 1917:
" .Io sono stato molto disgraziato e maledico di continuo il giorno in cui mi saltò l'estro di andare a frequentare il corso allievi ufficiali. Già te Io scrissi, se ben ricordo; le cause sono parecchie e troppo lunga sarebbe la descrizione; è certo che se da caporale di compagnia godevo tutta la tranquillità possibile, da aspirante ufficiale mi venne totalmente a mancare, e francamente m'accorgevo che di giorno in giorno perdevo la testa perdevo anche (lascio a me la parola)".

Nel corso della guerra le corrispondenze sono state calcolate in quasi 4 miliardi di unità. Si trattò di una vera e propria ossessione postale, si scri veva poco prima di un attacco, nelle retrovie, e si scrisse molto anche da Treviso.
I n questo senso la guerra rappresentò un momento di estrema importanza nella storia della società italiana, costringendo milioni di uomini a confro ntarsi co n la sc rittura come mezzo di comunicazione essenziale. La cosa naturalmente non fu semplice , del resto il cen simen to del 1911 registrava ancora il 40 % di analfabetismo, e comunque l ' insicurezza nel governare la scrittura espose i soldati al ri sc hio concreto di vedere le loro corrispondenze gui date da una serie istituzioni, generalmente controllate dal mondo cattolico, come le case del soldato.
Questi aspetti, per così dire tecnici, e bbero sicuramente una certa importanza, tuttavia n eU' affrontare la lettura delle lettere dei soldati ci sono degli aspetti che reputo ben più importanti , primo far tutti il fatto che qu esti soldati dovevano mettersi in relazione con persone distanti da loro non solo fisicamente ma anche dal pun to di vista dell'esperienza. Si è già avuto il modo di dire come in definitiva furono i medici a registrare le lo ro vicende belliche, nelle lettere viceversa questi aspetti vengono normalmente omessi. Del resto si poteva raccontare ad una madre l 'immane carneficina che si stava compiendo al fronte? , si poteva raccontare che si era ricoverati in un manicomio? Si attivavano complessi sistemi di autocensura che determinarono materialmente gli esiti degli scritti.
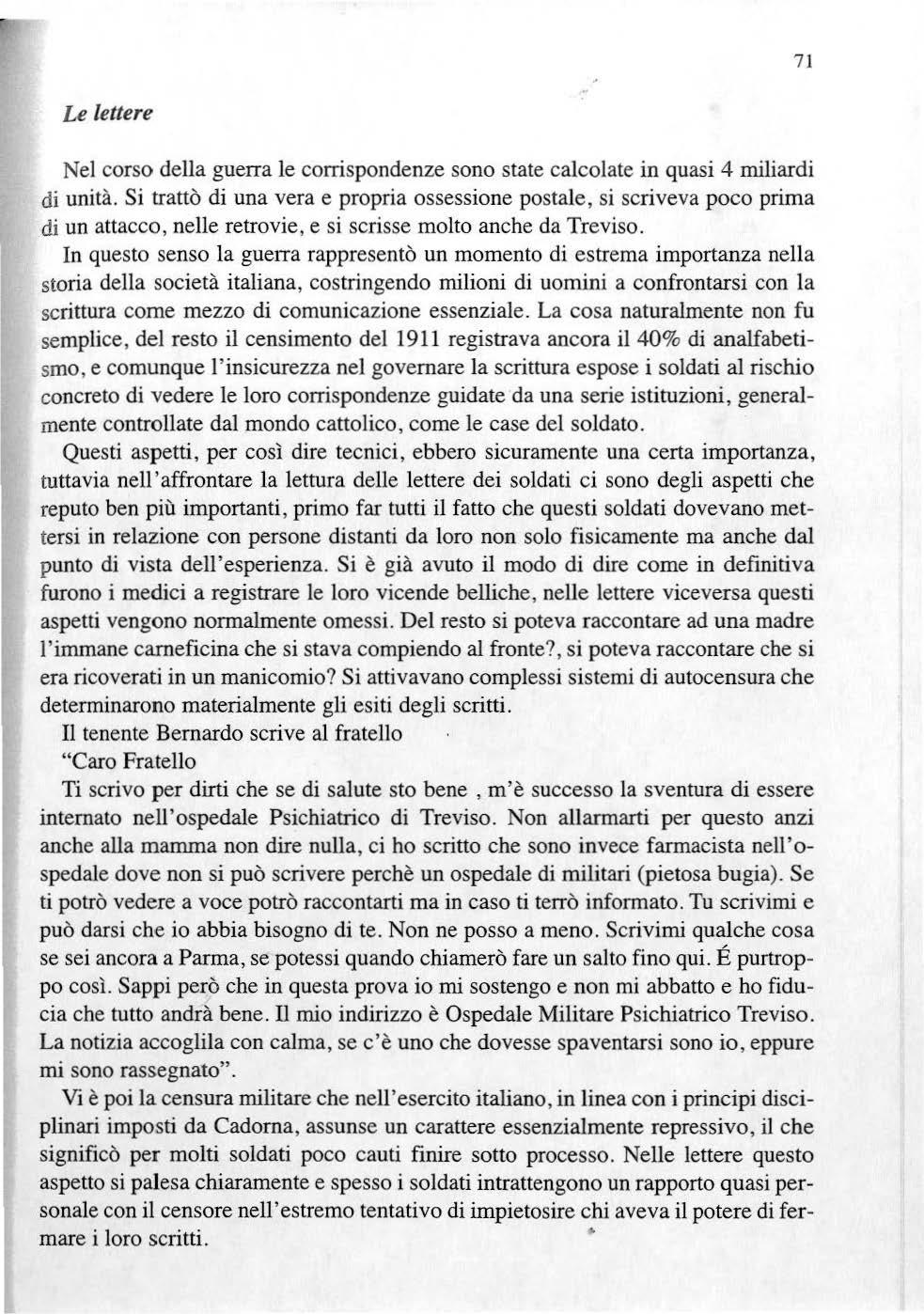
Il tenente Bernardo scrive al fratello
Ti scrivo per dirti che se di salute sto bene , m'è successo la sventura di essere internato nell'ospedale P sichiatrico di Treviso. Non allarmarti per questo anzi anche alla mamma non dire nulla , ci ho scri tto che sono in vece farmaci sta nell'ospedale dove non si può scrivere perchè un ospedale di militari (pieto sa bugia). Se ti potrò vedere a voce potrò raccontarti ma in caso ti terrò informato. Tu scrivimi e può darsi che io abbia biso gno di te. Non ne posso a meno. Scrivimi qualche cosa se sei ancora a Parma, se potessi quando chiamerò fare un sal to fino qui. É purtroppo cosl. Sappi però che in qu esta prova io mi sostengo e non mi abbatto e ho fiducia che tutto andrà bene. Il mio indirizzo è Ospedale Militare Psichiatrico Treviso. La notizia accoglila con calma, se c'è uno che dovesse spaventarsi sono io , eppure mi sono rassegnato".
Vi è poi la cens ura militare che nell 'esercito italiano , in lin ea co n i principi disciplinari imposti da Cadoma , assunse un carattere essenzialmente repressivo, il che significò per molti soldati poco ca uti finire sotto processo. Nelle lettere questo aspetto si palesa chiaramente e spesso i soldati intratten gono un rapporto quasi personale con il censore nell 'es tremo tentativo di impietosire chi aveva il potere di fermare i loro scritti.
TI s oldato Paolo terminava la sua lettera:
" ... che miscusono tanto del mio ri tardo ; e se c ' è dei erori e anche che mi scusano i Signori Uficiali che li passano la censura se o scritto troppo".
Per l ' aspirante ufficiale Marco (Salandra-Taranto) era del tutto ovvio dover evitare di scrivere su determinati argomenti, rinvi andone la discussione in circostan ze meno controllabi li :
" ...Desidero rivederti quando andrai in licenza invernale e di fermarti un paio d'ore a Treviso quando sarai di passaggio e d i venirmi a tro vare affmché io pos sa parlare a voce ,e per darti alcune spiegazioni di quelle cose che tu chiedevi a mio padre. Non mi spiego perché tu mi capisci e q uello che vorrei dirti non posso scriverti perchè andrebbe soggetto a censura ".
Naturalmente l'argomento trattato merita maggior approfondimen to e attenzione, tuttavia è un buon punto di partenza per comprendere nella lo ro complessità gli scri tti dei soldat i e d i n fondo non sorprender si se l 'oggetto esclus i vo d ei loro pensieri era rivol to alla fam iglia. Mi sembra a questo punto piuttosto chiaro che per degli uomini che avevano vissuto l'indicibile, senza più nessun punto di riferimento , travolti da una realtà di cui non riuscivano a delinearn e nemmeno i confini, l ' unica s peranza non po teva che essere rivolta alla sola certezza che ancora li ancorava alla vita: la famiglia.
La famiglia ass umeva un valore taumatur gico, ripercorrere con la fantasia anche i p i ù piccoli gesti legati alla quotidianità aiu tava a ridurre quella fra ttura che si era aperta con la parte nz a pe r il fronte. Una frat t ur a che con il tem po si era fa tt a sempre più ampia tanto da spingere molti soldati sul baratro dell'an nie ntame nto. Nelle lettere si può notare quasi un rapporto fisico con l 'ambiente domes tico. Tra le numerose a mia di sp osizione propongo questa lettera a titolo esemp li ficativo. Il soldato Alfredo (L azzago Brabbia) , che era al fronte dal 1915, stupendosi d i come le notizie potessero gi u ngere a casa "da così lo ntano" , immaginava, quasi assapor ava il gusto delle pere de l suo frutteto:
" 14/ 5/ 16
Caro Padre da p arecchi giorni ho ricevu to la vostra gentil lettera che v i trovate in buona salute op i acere io sto unpo mel io di pr i ma son proprio contento ce siete premuroso verso di me, per !arnia corris p ond enza verso i miei fra te lli . P are unimposibile che voi sapiate le condizioni della mia salute da cosi lon tano epo i ancora col' lavoro ce ciavete midite che della mia malatia sono presto g uarito me ntre invece civo! mo l to temp o. Ma però vi sicuro che vengo a casa anchora, allora velogiuro proprio c h e vi sarò fede le immancabile, per me non pensatec i a altro perde sono curato da un medico ch e mi voi bene intanto la disastro s a guerra senevà, e io saro salvo dogni perico lo mi rincrescie mo lt o di n on poter es sere a casa a mangiare le pera chisà come son saporite questanno mi corre lacolina in bocca di quel dolce fru tto ma voi sazierete . Spero davere q uell i d autunno se avete lin deri z zo di l uigi la prima volta che mi scrivete farete il favo r e di mandarmelo ( ...) ? Se non fate il

giesuvitismo come il passato rniresta che disalutarvi d avero tutti che scrive so no Alfredo
Sarete molto gentile adire una curo na di rusario a nome mio ditemi se ce ancora la mis a amante all'opaese" .
Conclusioni
Uno dei meriti di questo convegno credo sia quell o di aprire finalmente un o sq uarcio su degli aspetti della grande guerra rimasti fmo ad ora confinati in amb iti relativame nte ristretti . I morti per malattia nel caso dell'intervento di Daniele Ceschin , le nevrosi di guerra per quanto riguarda il mio intervento, sono in vece te matiche assolu tamen te rilevanti nell ' ambito della ricerca s toriografica sulla grande guerra. In particolare partendo dall'esperienza di guerra dei soldati che manifestarono una qualche forma di disagio psichico, possi amo intraprendere nuovi ambiti di ricerca che coinvolgono aspetti che ancora oggi non sono stati del tutto chiariti. Mi riferi sco in particolare ai fenomeni di resistenza e rifiuto alla guerra. Forse le vicende drammatiche di questi uomini possono aiutarci a co mprende quali fo ssero gli spazi reali che la guerra moderna lasciava al di ssenso. L'errore per molti anni è s tato nel voler vedere solo nei fenomeni più clamorosi i segnali di insofferenza da parte dei so ldati. In realtà nel corso della guerra il di ssenso ha avuto modo di manifestarsi in modi, per cosi dire, non convenzionali, rimanendo legato spesso a gesti individuali più che di massa, basti pensare alla diserzione, all'autolesionismo, alla renitenza e non ultimo alla follia, segnali inequivocabili che spetta a noi ora saper raccogliere.
No i tutti abbiamo un debito verso ques ti so ldati lungo quasi 90 anni. Per troppo tempo colpevolmente un po ' tutti li hanno ignor ati, passati sotto s ilenzio o al massimo ricordati con un misto di compass ione e sorriso, i così detti - mati dea guerain realtà sono lo specchio della cattiva coscienza di tutta l 'umanità.

Archivio ospedale psichiatrico provinciale " S. Arternio" in Treviso, Cartelle cliniche degli accolti (19-1 5- 1917).
Idem , fascicolo Luigi Zanon Dal Bò.
Idem, fascicolo Personale.
Idem , fascicolo Statistica.
Idem , fascicolo Stefano Gatti.
Idem , Registro dei ricoverati, uomini 1909-1922.
Archivio provinciale dì Treviso, Manicomi centrali veneti.
Idem , Opere pie - manicomi centrali vene ti.
Idem, Manicomio provinciale (1906-1918).
Idem, Deliberazioni del Consiglio Provinciale 1867- 1943.
Idem, Deliberazioni della Deputaz ione Pro vinciale 1867-1947.
Idem, Verbali del Consiglio Provinciale.
I dem, Verbali della Deputazione Provinciale.
"Archi vio generale dì neurologia, psichiatria e psicoanalisi", voli. I -D, ( 1920-1921).
"Bollettino della società medico-chirurgica di Treviso", vol. IV, (1940).
"Giornale di psichiatria clinica e tecnica manicomi aie" , vol. XLVTI , ( 1919).
O rdine dei medici della Provincia di Treviso, Albo 1929.
B ianchi B., La Grande Guerra nella storiografia italiana dell'ultimo decennio, m: "Ricerche storiche", anno XXI , N.3, settembre-dicembre 1991.

Bianchi , B ., La follia e la fuga, Roma, 2001 .
Fabi L., Gente di trincea. La Grande Guerra sul Carso e sull'lsonzo, Milano, 1994
Forcella E.- Monticone A., Plotone di esecuzione.! processi della prima guerra mondiale, Bari , 1998.
Fussel P., La grande guerra e la memoria moderna, Bologna , 1984.
Gatti G. L., Dopo Caporetto. Gli ufficiali P nella Grande Guerra: propaganda, assistenza, vigilanza, Gorizia, 2000.
Gibelli A ., L ' officina della guerra. La Grande Guerra e le trasformazioni del mondo mentale, Torino, 1991.
Gibelli A. , La grande guerra degli italiani, Milano 1998.
l snenghi M (a cura di), !luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell'Italia unita, Bari , 1997.
Isnen ghi M. , Giornali di trincea , Torino , 1972.
I snenghi M., Il mito della Grande Guerra, Bologna, 1997.
lsnenghi M., Le guerre degli italiani. Parole, immagini, ricordi 1848-1945, Mi lano, 1989.
Isnenghi M., Rochat G., La grande guerra, Milano, 2000.
Leed E. J. , Terra di nessuno , Bologna , 1985.
Leoni D e Zadra C . ( a cura di ), La Grande Guerra Esperienza, memo ria , immag ini , B ologn a, 1986.
Luiz zi G. , l serviz i logistici nella guerra , Milano, 1934.
Melograni P., Storia politica della Grande Guerra 191511918 , Bari, 1972.
Mosse G. L. , Le guerre mondiali Dalla tragedia al mito dei caduti , Bari , 1990.
Pieri P , L ' I talia nella prima gu erra mondiale , Torino , 1968
Pieri P., La prima guerra mondiale. 1914-1918, a cura di G . Rochat, Udine , 1999.
Procacci G. , Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra. Con una raccolta di lettere inedite , Ro ma , 1993 .
RoccaG., Cadorna, Milano, 1985.
Rochat G. - Massorbio G ., Breve storia dell'esercito italiano dal18 61 al1943, Torino , 1978.
Rochat G. , Gli arditi della Grande Guerra. Origini , battaglie e miti , G orizia, 1999.
Tortato A., O rtigara . La verità negata, Valdagno (Vicenza), 1999.
Ufficio Statis tico del Ministero della Gu erra, La forza dell'esercito, Rom a , 1927.
Winter J ., Il lutto e la memoria. La Grande Guerra nella storia culturale europ ea , Bo logna , 1998.
AA.VV, Letteratura italiana Einaudi . Produzione e fruizione, vol. II , Torino , 1993.

Baratto M. , La mi a guerra. I gno rata dalla sto ria. Diario di un soldato sul Carso e in Serb ia 1916-1 91 7 , Casso la (Vicenza), 1989.
Attilio Bartoli L an geli, La scrittura dell'italiano, B ologna , 2000 .
Caccia D ornini oni P., 191 5-1 919. Diario di guerra , Mil ano 1993.
Cavalli T. , lson zo infame. Soldati bresciani nella gu erra 15 - 18 , B resci a , 1983.
D e Mauro T., Storia linguistica dell ' Italia unita, Bari, 1993.
Fontana S. e Pieretti M. (a cura di) , Mondo popolare in Lombardia Operai e contadini nel primo conflitto mondiale, M ilano, 1980.
Foresti F. - Mori si P.- Res ca M. (a cura di), Era come mietere. Testimonianz.e o rali e scritte di soldati sulla Grande Guerra con immagini inedite , " Quaderni della biblioteca com unale di S Giovanni in Persiceto" , Bologn a, 1982.
Frescura A., Diario di un imboscato, Milano , 1999.
Gallo G. 0 ., Le oasi del dolore , Bologna , 1917.
Gatti A ., Caporetto D iario di guerra (maggio -dicembre 1917), Bologn a , 1997.
Giuri ati G. , D ia rio di guerra, Milano, 1988.
Lussu E . , Un anno sull'Altipiano, Milano , 1979 .
Ri cci Bitti P. E. e Zani B ., La comunicazione come processo sociale , Bologn a, 1983.
Spitzer L., Lettere di prigionieri di guerra italiani 1915-1918 , Torino, 1976.
Tecchio A., Diario di gue rra. Carso 191 611917, Museo del ri sorgime nto di Vicenza, 1997.
Todero F. , Pag in e della Grande Guerra . Scrittori in g rig ioverde , Milano 1999 .
Basaglia F., Conferen ze Brasiliane, Milano, 2000.
Bianchi B. , Le ragioni della diserzione. Soldati e ufficiali di fronte a giudici e psichiatri (1915-1918), in: "Storia e problemi contemporanei", 1992, 10.
Bianchi B ., Predisp osizione, smemoratezza , fuga. Natura e terapia delle neuropsicosi di guerra (1915-1918), in " Movimento operaio e socialista", ann o VJO , n. 3, dicembre 1983. Gemelli A., fl nostro soldato, Milano , 1917.

Giovannini P. , Psichiatria e criminalità nella prima guerra mondiale, in "Storia e problemi contemporanei" , 1988, 1-2.
Giovannini P., Soldati,follia e Grande Guerra nelle cartelle cliniche del S. Ben edetto, in: Lavoro , criminalità e alienazione mentale. Ricerca sulle Marche tra Otto e Novecento , a cura di P. Sorcinelli, Ancona , 1987.
Stok F., La formazione della psichiatria , Roma , 1981.
Tamburrini A.- Ferrari G.- Antonini G. , L'assistenza alienati in Italia e nelle altre nazioni, Torino,1918.
La possibilità che l'Italia potesse rimanere coinvolta nel conflitto europeo e l'esplosione, poi, del conflitto stesso ebbero come conseguenza l'evoluzione di tutte le attività logistiche.
Si prese atto ben presto di un incremento ge neralizzato dei consumi e delle perdite e quindi della necessità di sgombero, di trasporto e di c ura.
Allo sc oppio del primo conflitto mondial e, quindi , la s anità militare pot eva co ntare s ulle seguenti unità , cam pali mobili ta te:
- 3 reparti someggiati per gruppo alpino;
- 55 sezioni di sanità; ·
- 126 ospedaletti somegg iati da 50 letti;
- 84 ospedali da campo da 100 letti;
- 42 ospedali da campo da 200 letti;
- 108 autoambulanze;
- 108 autobus;
- 16 treni attrezzati.
L'organizzazione sanitaria militare territoriale, invece, disponeva di:
- 28 ospe<iali militari principali;
- 2 ospedali succursali;
- 6 depositi di convalescenza;

- 31 infermerie presidiarie, oltre a numerosissirni ospedali di riserva in via di completamento .
Dopo un anno e mezzo di guerra , i posti letto presso l'organizzazione di campagna e che assommavano a circa 24.000 e a 100.000 presso le strutture territoriali, al 31 dicembre 1916 si e rano quadrupl icate e non so lo per la formazione di nuove strutture sanitarie giustificate dali' ampliamento dell'esercito di campagna, ma anche e soprattutto, a causa dell'elevato numero di feriti a cui si doveva provvedere al termine di ogni combattimento.
Affianco alla sanità militare entrarono in linea anche le strutture, campali e territoriali, della Croce Rossa Italian a e del Sovrano Ordine di Malta di cui si dirà più avanti.
La sentita necessità di aumentare la capacità di ospedalizzazione portò alla trasformazione o meglio all'adattamento di molti immobili in stabilimenti di riserva: caserme ormai vuote, scuole, collegi , seminari, fabbriche dismesse, alberghi , ecc., tutti trasformati in luoghi di cura dotati di moderne e costose attrezzature che servirono a dare a queste infrastrutture una fisionomia più simile ad un a struttu r a sanitaria militare.
Numerosi furono i provvedimenti che riguardarono l'adozione di attre zzature per il trasporto dei feriti e degli infermi verso le strutture più aderenti alla patologia lamentata. Le ambulanze a trazione meccanica d iedero ottimi risultati soprattutto se paragonate a quelle a traino animale e pertanto ne vennero approvvigionate quanto il magro bilancio poteva co nsentirne.
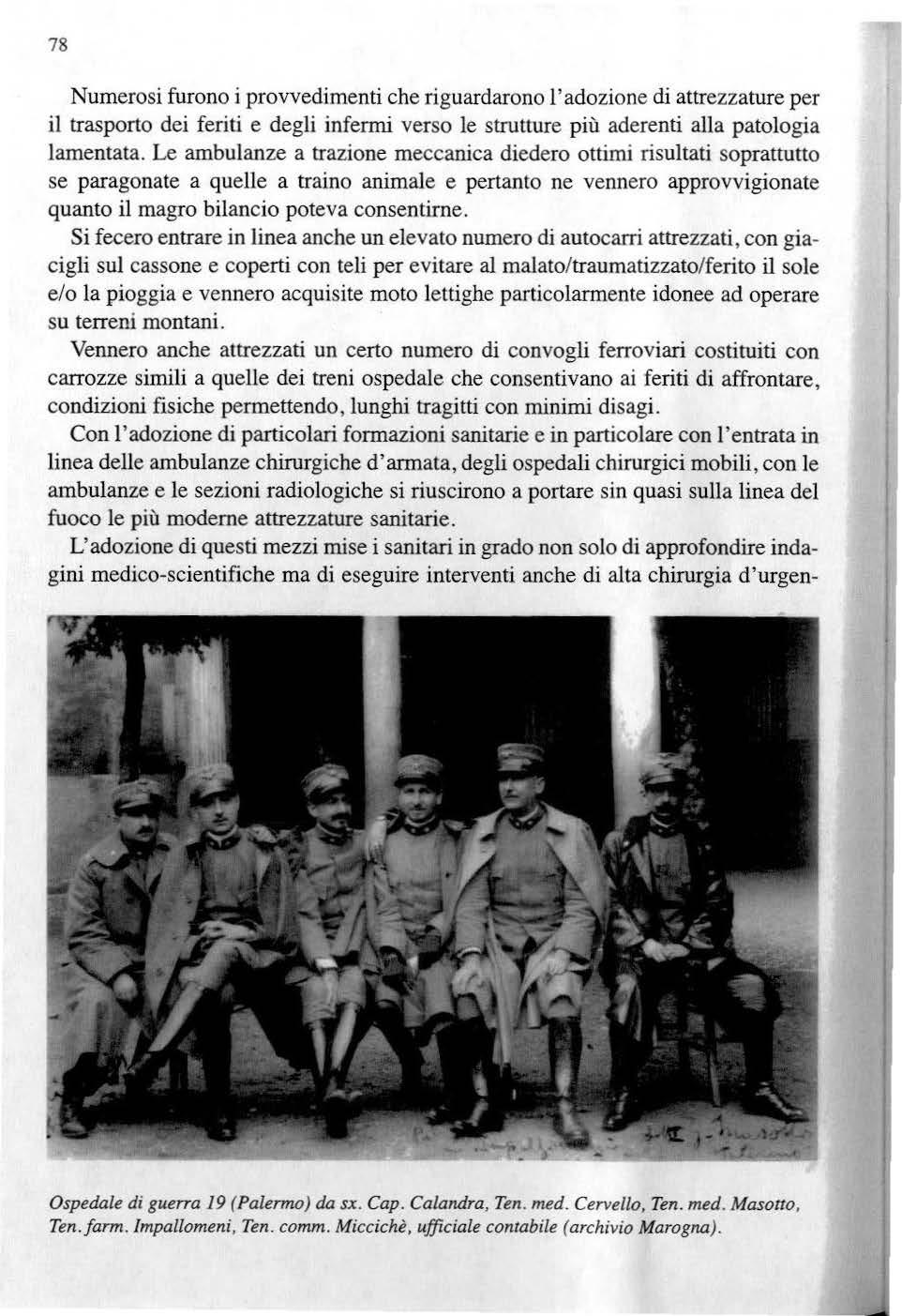
Si fecero entrare in linea anche un elevato numero di autocarri attrezzati, con g iacigli sul cassone e coperti con teli per evi tare al malato/traumatizzato/ferito il sole e/o la pioggia e vennero acquisite moto lettighe particolarmente idonee ad operare s u terreni montani.
Vennero anche attrezzati un certo numero di convogli ferrov iari costituiti con carrozze simili a quelle dei treni ospedale che consentivano ai ferit i di affrontare, condizioni fisiche permettendo, lunghi tragitti con minimi disagi.
Con l 'ado zio ne di particolari formazioni sanitarie e in particolare con l 'entrata in linea dell e ambulanze chirurgiche d'armata, degli ospedali chirurgic i mobili , con le ambulanze e le sezioni radiologiche si riuscirono a portare sin quasi sulla linea del fuoco le più moderne attrezzature sanitarie.
L'adoz ione di que sti mezzi mise i sanitari in grado non solo di approfondire indagini medico-scientifiche ma di eseguire interventi anche di alta chirurgia d ' urgen -
za nelle strutture avanzate a vantaggio dei militari feriti la cui gravità richiedeva un intervento non differibile.
Tutto ciò postulava l ' impossibilità dello sgombero vers o l 'indietro dei feriti più gravi ma solo di coloro che , pur bisognevoli di cure non versavano in imminente pericolo di vita .
Questi, dalle strutture sanitarie avanzate , venivano sgomberati verso le cosiddette " stazioni ferroviarie di testa " e di qui , una volta imbarcati sulle vetture ferro v iarie dei treni ospedale (206 barelle) o dei treni attrezzati (450 barelle), venivano· avviati vers o le più attre zzate strutture territoriali situate nelle retrovie.
Val e comunque la pena ricordare come la particolare configurazione della penisola ri sp e tto ali ' eccentricità della zona di combattimento rendeva particolarmente oneroso lo sforzo logistico connesso con lo sgombero dei feriti all ' indietro. Data la significativa distanza tra le strutture campali e quelle territoriali del centro-meridione d'Italia venne studiato un movimento all ' indietro detto "a catena" e cioè che prevedeva lo sgombero dei feriti/malati dalle strutture campali verso gli ospedali di ris erva gestiti dalle Armate e quindi situati neIl' area di competenza delle armate stesse e di qui, una volta superata la fase critica della patologia, i feriti venivano sgomberati nelle strutture del centro-sud Italia.
Per me ttere in atto questa procedura fu previsto un movimento ferroviario mensile di 52 convogli per i mesi invernali, quando cioè le operazioni militari subiva-

no una forte stasi, mentre si giunse a toccare i 444 convogli mensili nei periodi di massima operatività.
Questo sistema, ad una attenta valutazione, si dimostrò particolarmente efficace giacché consentiva l'adozione di particolari misure pro filattiche sottoponendo i ricoverati ad un periodo di osservazione contumaciale prima di essere sgomberati ver s o le strutture territoriali del sud Italia.
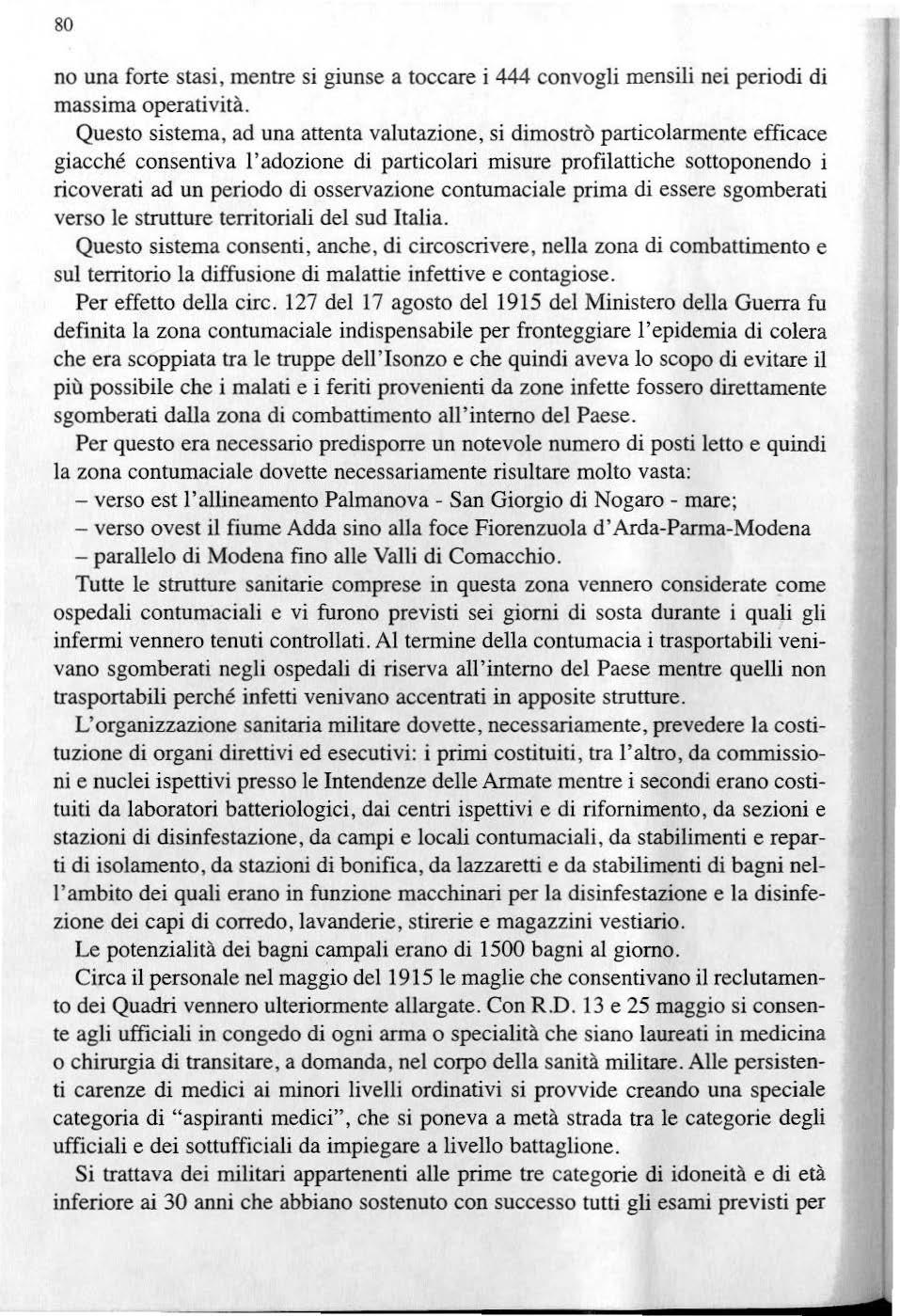
Questo sistema consenti, anche , di circoscrivere, nella zona di combattimento e sul territorio la diffusione di malattie infettive e contagiose.
Per effetto della eire . 127 del 17 agosto del 1915 del Ministero della Guerra fu definita la zona contumac iale indi spe nsab ile per fronteggiare l'epidemia di co l era che era scoppiata tra le truppe dell ' I sonzo e che quindi aveva lo scopo di evitare il più poss ibile c h e i malati e i feriti provenienti da zone infette fossero direttamente sgomber ati dalla zona di combattime nto ali ' interno del Paese .
Per questo era necessario predisporre un notevole numero di posti letto e quindi la zona contumaciale dovette neces sariamente risultare molto vasta:
- verso est l'allineamento Palmanova- San Giorgio di Nogaro- mare;
- verso ovest il fiume Adda sino alla foce Fiorenzuola d'Arda- Parma-Modena
- parallelo di Modena fmo alle Valli di Comacchio.
Thtte le strutture sanitarie comprese in questa zona vennero considerate come ospedali contumaciali e vi furono previsti sei giorni di sosta durante i quali gli infermi vennero te nuti controllati. Al termine della contumacia i trasportabili venivano sgomberati negli ospedali di riserva all'interno del Paese mentre quelli non trasportabili perché infetti venivano accen trati in apposite s trutture.
L'organizzazione san itaria militare dovette, necessariamente, prev e dere la costituzione di organi direttivi ed esecutivi: i primi costituiti , tra l 'altro, da commissioni e nuclei ispettivi presso le Intendenze delle Armate mentre i secondi erano costituiti da laboratori batteriologici, dai centri ispettivi e di rifornimento, da sez ioni e stazioni di disinfestazione, da campi e locali contumaciali , da stabilimenti e reparti di isolamento, da s tazioni di bonifica, da lazzaretti e da stabilimenti di bagni nell ' amb ito dei quali erano in funzione macchinari per l a di s infestazi one e la disinfezio ne dei capi di corredo, lavanderi e, stirerie e magazzini vestiario.
Le potenzialità dei bagni campali erano di 1500 bagni al g iorno .
Circa il personale nel maggio d el1915 le maglie che consenti vano il reclutamento dei Quadri vennero ulteriormente allargate. Con R.D. 13 e 25 ma ggio si consente ag li ufficiali in congedo di ogni arma o spec ialità che siano l aureati in medicin a o chirurgia di tran sitare, a domanda , nel corpo della sanità militare. Alle persistenti carenze di medici ai minori livelli ordinativi si provvide creando una sp ec iale categoria di "aspiranti medici", che si poneva a metà strada tra le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali da impiegare a livello battaglione.
Si trattava d ei militari appartenenti alle prime tre categorie di idoneità e di età inferiore ai 30 anni che abbiano sostenuto con successo tutti g li esami previsti per
il corso di laurea in medicina e chirurgia e abbiano frequentato il 5 ° e 6° anno anche senza aver sos tenuto gli esami di fine anno accademico.
Con questi provvedimenti , da 794 ufficiali medici in serv izio p ermanente, 1744 di complemento e 802 di milizia territoriale, al 31 luglio 1914 s i pas sò rispettivamente a 882, 2907 e 1447 al 30 maggio 1915.
n sensibile incremento complessivo che si riuscì ad ottenere in pochi mesi s i ottenne con l 'inserime nto degli ufficiali di complemento e della milizia territoriale . Insomma, quantità a discapito della professionalità.
D 'altro canto risultò un problema non facilmente risolvibile quello di contemperare le necessità delle unità dell ' e sercito di campagna di avere in organico ufficiali medici con la necessità del Paese di avere medici condotti in tutti i comuni del Regno.
Alla fine del secondo anno di guerra, grazie a tutta una serie di provvedimenti il numero degli ufficiali medici sali a circa 14.000 di cui 8.500 in zo na di combattimento e 6.000 presso l'organizzazione territoriale. Per giungere a questa situazione s i dovette prestar molta attenzione anche al territorio perché occorreva garantire a tutti i comuni la presenza del medico condotto.
Della massima importanza fu anche il problema della massima utilizzazione possib il e del pers onale medico e ne l far ciò non sempr e s i tenne conto dell 'e tà , dell'idoneità fisica e della specializ zaz ion e a questo garantì un serv izio, se non ottimale, il più soddisface nte poss ibil e in relazione al la si tuazione.
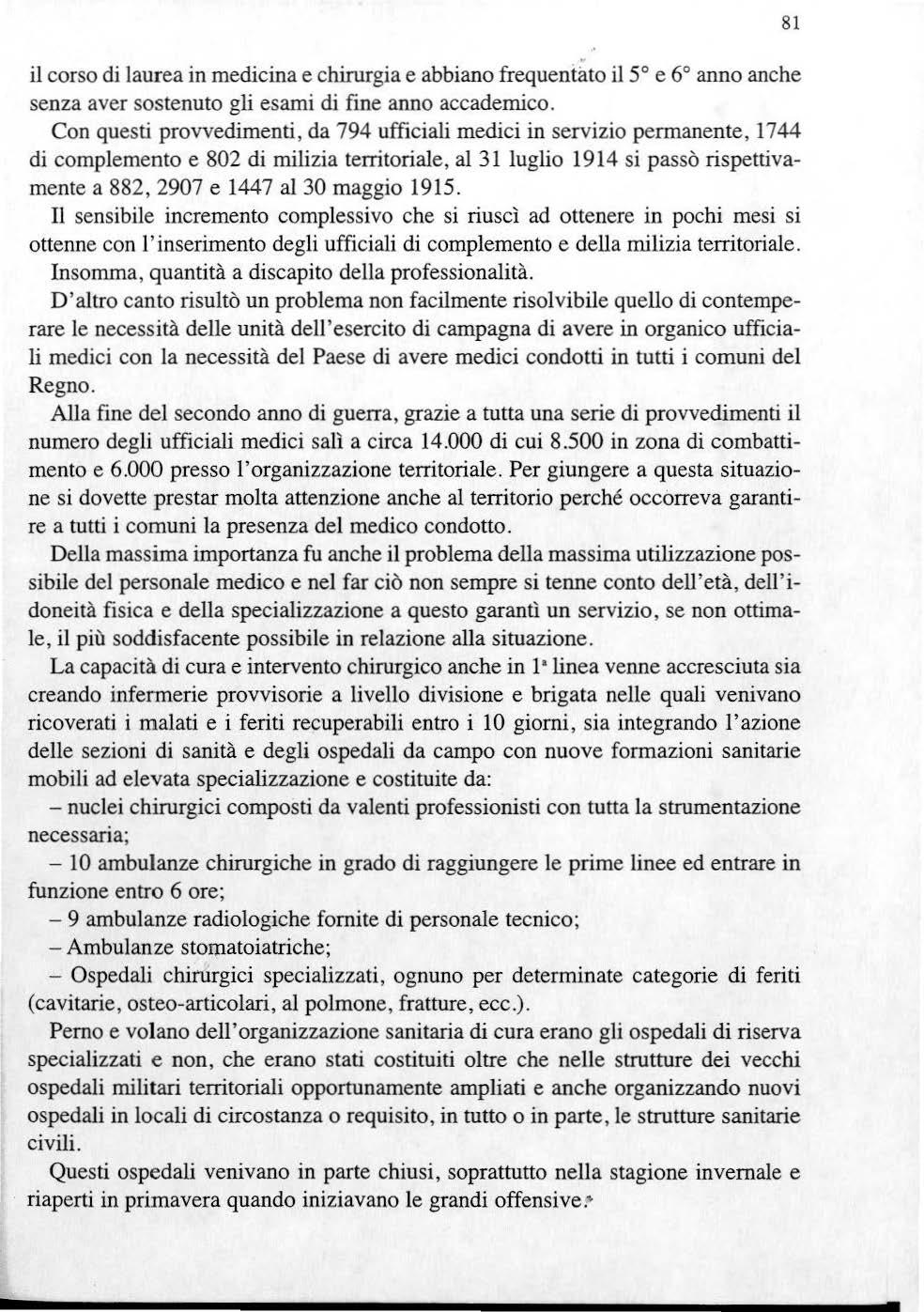
La capacità di cura e intervento chirurgico anche in 1• linea venne accresc iuta sia creando infermerie provvisorie a livello divisione e brigata nelle quali venivano ricoverati i malati e i feriti recuperabili entro i 10 giorni, sia integrando l'azione delle sezioni di sanità e degli ospedali da campo con nuove formazioni sanitarie mobili ad elevata specializzazione e costituite da:
- nuclei chirurgici composti da valenti professionisti con tutta la strumentazione necessaria;
-IO ambulanze chirurgiche in grado di raggiungere le prime linee ed entrare in funzione entro 6 ore;
- 9 ambulanze radiologiche fornite di personale tecnico ;
- Ambulanze stomatoiatriche;
- Ospedali chirurgici specializzati, ognuno per determinate categorie di feriti (cavitarie, osteo-articolari, al polmone , fratture, ecc.).
Perno e vol ano dell'organizzazione sanitaria di cura erano gli ospedali di riserva spec ializzati e non, che erano stati cos tituiti oltre che ne lle stru tture dei vecchi ospedali militari territoriali opportunamente ampliati e anche organizzando nuovi ospedali in locali di circostanza o requisito, in tutto o in parte , le strutture sanitarie civili.
Questi ospedali venivano in parte chiusi, soprattutto nella stagione invernale e riaperti in primavera quando iniziavano le grandi offensive ..,.
Tra i tanti servizi specializzati cui la sanità militare dovette provvedere vale la pena ricordare i serviz i oftalmico, otorinolaringoiatrico , stomatologico, neurologico, neuropsichiatrico. dermoceltico, antigas, anti assiderante, antitracomatoso.
Quest'ultimo merita una particolare menzione in quanto i richiamati affetti da tracoma anziché presentarsi al proprio distretto di residenza per ovvi motivi di profilass i si presentavano direttamente presso alcuni ospedali specializzati dove, dopo un periodo .di cura, se riconosciuti idonei venivano avviati press o i battaglioni tracomatosi, in genere uno per ogni corpo d'armata, Presso questi reparti erano sottoposti a una stretta sorveglianza, a strette regole igieniche ed eventualmente ambulatoriali potendo così essere impiegati per servizi in terni, ordine pubblico, guardie ai prigionieri , lavori agricoli senza, tuttavia, venire a contatto con i militari sani .
Alla fine del secondo anno di guerra il corpo della sanità militare aveva raggiunto una potenzialità tale da garantirne il buon funzionamento di questa attività uma-
nitaria per la quale disponeva dei seguenti mezzi mobilitati:
-9 reparti someggiati per gruppo alpino :
- 77 sezioni di sanità;
- 195 ospedaletti someggiabili da 50 letti;
- 159 ospedali da campo da 100 letti;
- 42 ospedali da campo da 200 letti ;
- 10 ambulanze chirurgiche;
- 29 sezioni di disinfestazione;
-500 ambulanze;
- 83 autobus;
- 70 autocarri attrezzati;
- 300 motolettighe;
- 48 treni attrezzati.
Vi erano anche, nella zona arretrata del Paese 948 ospedali di riserva e 21 convalescenziari.
Camerate per gli Allievi Ufficiali medici dell'Università Castrense a San Giorgio di Nogaro ( archivio Marogna).
Un validissimo ai uto alla sanità militare venne fraternamente portato da organizzazioni umanitarie quali la Croce Rossa Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM ) .
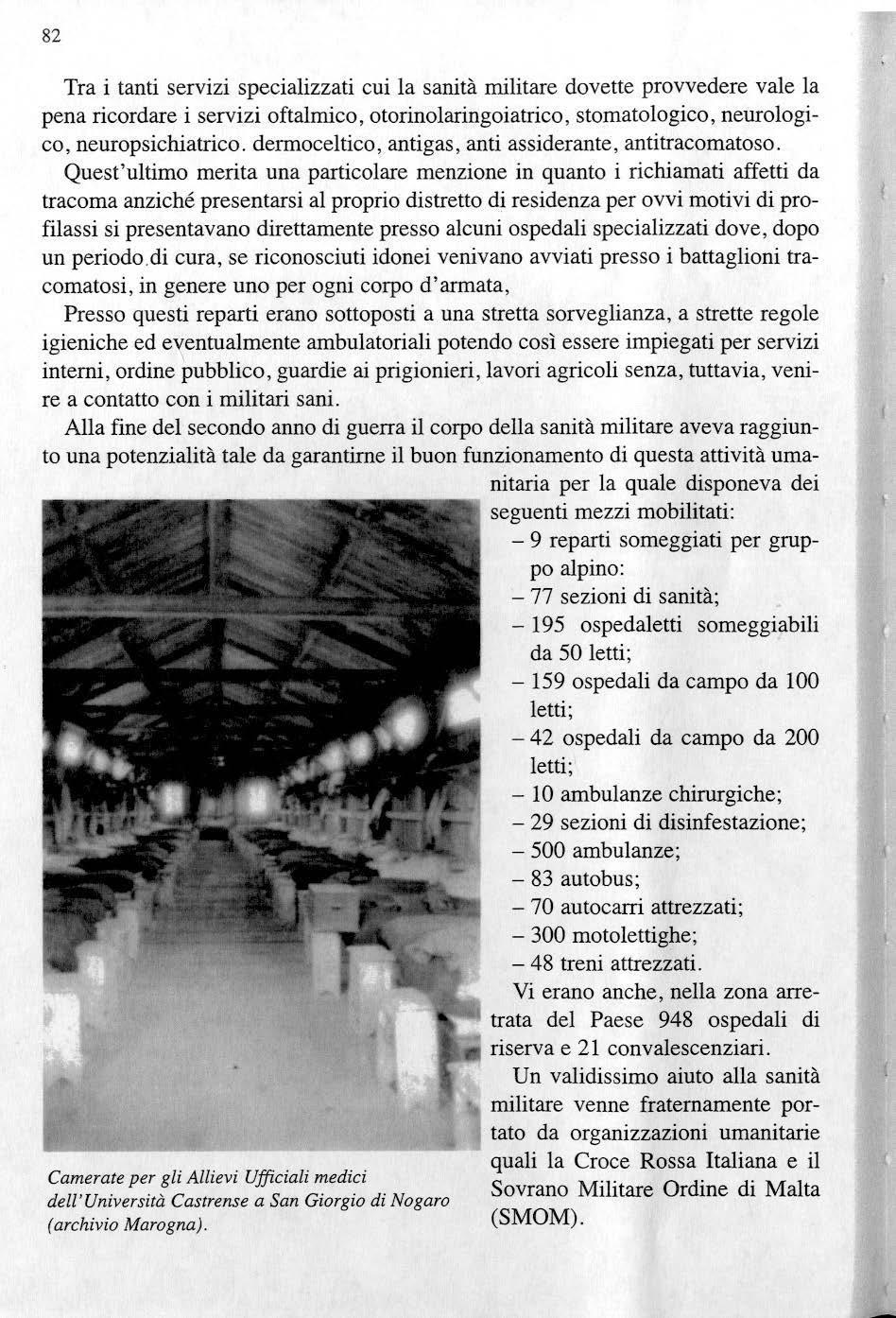
Queste organizzazioni ancor oggi, in nome delle loro nobilissime tradizioni oltre ad eccellere per la gestione di numerose unità mediche brillarono, soprattutto, per la pietà vigile che l'elemento fondamentale di ogni tipo di soccorso.
La Croce Rossa Italiana all'atto della mobilitazione dell'esercito mobilitò m zona di operazioni:
- 65 ospedali di guerra, strutture simili agli ospedaletti da campo;
- 3 ospedali di tappa;
-3 ospedali chirurgici mobili;
- 4 sezioni di sanità;

- 32 ambulanze da montagna;
- 29 posti di soccorso ferroviario;
- 24 treni ospedale;
- 15 sezioni automobili;
-3 sezioni da campo per infermi ere volontarie;
- 2 ambulanze spec ializ zate;
- 4 bagni a doccia mobili, oltre a depositi, personale, magazzini e depositi di riforn im e nto , autoparch i , laboratori per indagini mediche e lavanderie. Per il funzionamento di tutto il comp lesso messo i n campo dalla CRI nella cos iddetta zona di combattimento furo no mobilitati :
- 1193 uffi ciali medici;

- 427 ufficiali di amministrazione;
- 165 uff iciali farmacisti;
- 273 ufficiali a utomobilis ti ;
- 157 cappell an i ;
- l 080 infermiere vo lontarie;
- 9500 militi.
Nell a zona territoriale la CRI allestì c irca 200 ospedali co n una potenzialità di ospeda lizzazion e di circa 30 .000 posti le tto e 51 posti di soccorso ferrov iario per il cui funz ion amento occorsero:
- 1160 uffi ciali med ici;
- 162 u fficiali farmacis ti ;
- 480 ufficiali di amministra zio ne;
- 130 ufficiali automobilisti;
- 90 cappellani ;
- 7320 inf ermi e re vo lo ntarie ;
- 5750 militi ;
-4122 civili aggregati al corpo.
Per quanto riguarda il Sovrano Militare Ordine di Malt a, non appena venne emanato l'ordine di mobilitazione generale alles tì , in coordinazio ne co n la sanità militare e con la Croce Rossa, numerosi posti di soccorso, 4 tren i ospedale, l ospe dale di guerra e 2 ospedali territoriali .
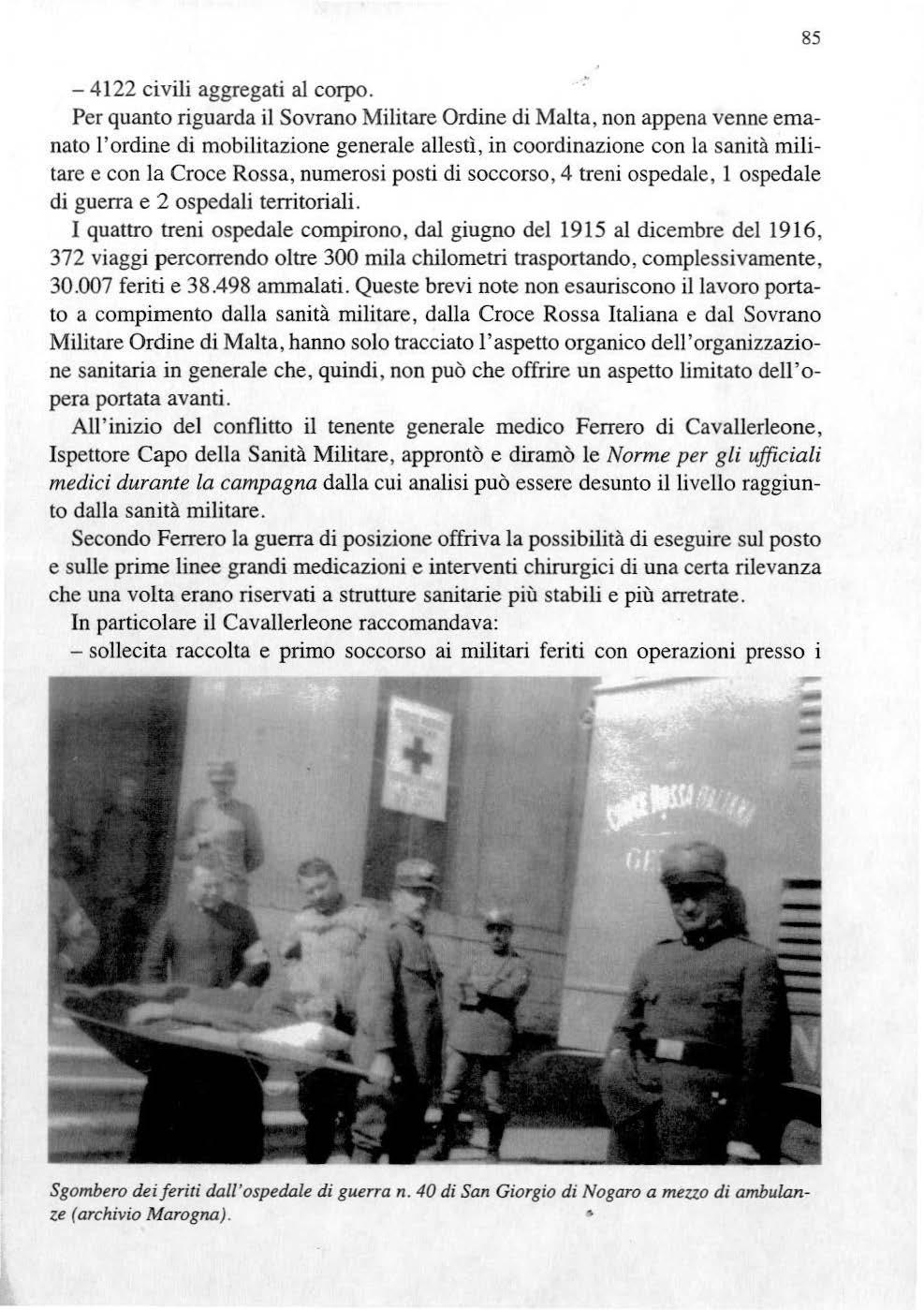
I quattro treni ospedale compirono, dal giugno del 1915 al dicembre del 19 1 6 , 372 viagg i p ercorrendo oltre 300 mila chilometri trasportando , complessivamente, 30.007 feriti e 38.498 ammalati . Queste brevi note non esaurisco no il lavoro portato a co mpimento dalla sanità milit are, dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano M ilitare Ordine di Malta, hanno solo tracciato l'aspetto organico dell'organizzazione san itari a in generale c he , quindi , non può c he offrire un aspet to limitato de ll 'opera portata avanti.
All' ini zio del conflitto il tenente ge nerale medico Perrero d i Cavallerleon e, I spettore Capo della Sanità Militare, approntò e diramò le Norme per gli uffici al i medici durante la campagna dalla cu i a nalisi pu ò essere de sunto il livello raggiunto dalla sanità mi li tare.
Secondo P errero la guerra di posi zio ne offriv a la p ossib ilit à di eseguire sul posto e sulle prime linee grandi medicazi oni e interve nti chirurg ici di un a certa rilevanza che una volta e rano riservati a stru tture sani tarie più stab i li e più arretrate.
In particolare iJ Cavallerleon e r accomandava:
- so llecita ra cco lt a e primo soccorso ai mili tari feriti con oper az io ni presso i
posti di pronto soccorso improntate a semplicità e speditezza;
- azione chirurgica li mitata agli interventi più urgenti presso le sezioni sanità evi tando gli in terve nti di alta ch ir urgia ;
- presso gli o sped a li da campo il chirurgo, avvalendosi dell'esp lorazione radiosco pica e della radiografia deve evitare la di spers i o n e di energ ie in interventi c h e richi edano troppo tempo e si presentano di dubbio esito ;
- g li sgomberi dei feriti trasportabili devono essere soll eciti sia per mantenere sgombere l e unità sani tarie avanzate, s ia per il benefico effetto moral e sul ferito sia per limitare le possibilità di infezione dovute all'ingo mbro del campo di battagl ia;
- per prevenire la diffusione di e pidemie già comparse sui vari fronti e uropei (tifo, di ssenteria, colera , meningite cerebro- spinale , ecc.) g li uffic ia li medici dovevano indagare s ull e popolazioni civili, pretendere la massima pulizia personale possibil e e degli accamp amenti e delle linee , sorv eglianza delle acque, delle cucine e de i c ucinieri ;
- lott a al tetano co n l ' inocul azione preventiva del s iero anti tetani co del quale erano dotate tu tte le unità sanitarie.
Co ncl udendo potremmo dire c he i n nessu n servizio, come nel ser vizio s anitario , si manifestò sin dai primi giorni di guerra, la fisionomia di un serv i zio che, pur mantenendo i s uoi comp iti e i suoi organi fondamentali, accrebbe, in modo espo-

nenziale, la sua complessità accrescendo e specializzando maggiormente i propri organi sia direttivi che esecutivi.
La notevole espansione dell'esercito, la territorializzazione delle armate amplificarono i problemi igienici e quindi di prevenzione imponendo uno stretto coordinamento tra autorità sanitarie militari e civili . Altre esigenze evidenziate da una imprevista guerra di posizione fu il risanamento e la disinfestazione del campo di battaglia e il sollecito recupero del personale ferito e ammalato.
Tutte queste necessità non erano previste dai manuali sulla sanità militare deli' epoca perché la guerra di posizione, la guerra di logoramento non era stata prevista perché non era conosciuta giacchè le precedenti guerre combattute erano state brevi e dinamiche.
Sul funzionamento di questo servizio influirono non poco anche la comparsa dell' arma aerea in grado falcidiare i reparti e le città più significative e l 'uso dei gas asfissianti, vescicanti, irritanti e tossici.
Non si dimentichi, infine , che la chirurgia e, più in generale la medicina d'urgenza nasce proprio in questo periodo sui campi di battaglia.
BOTTI Ferruccio: La logistica dell'Esercito Italiano (1831-1981 ), vol. IT, SME-Uff. Storico, 1991
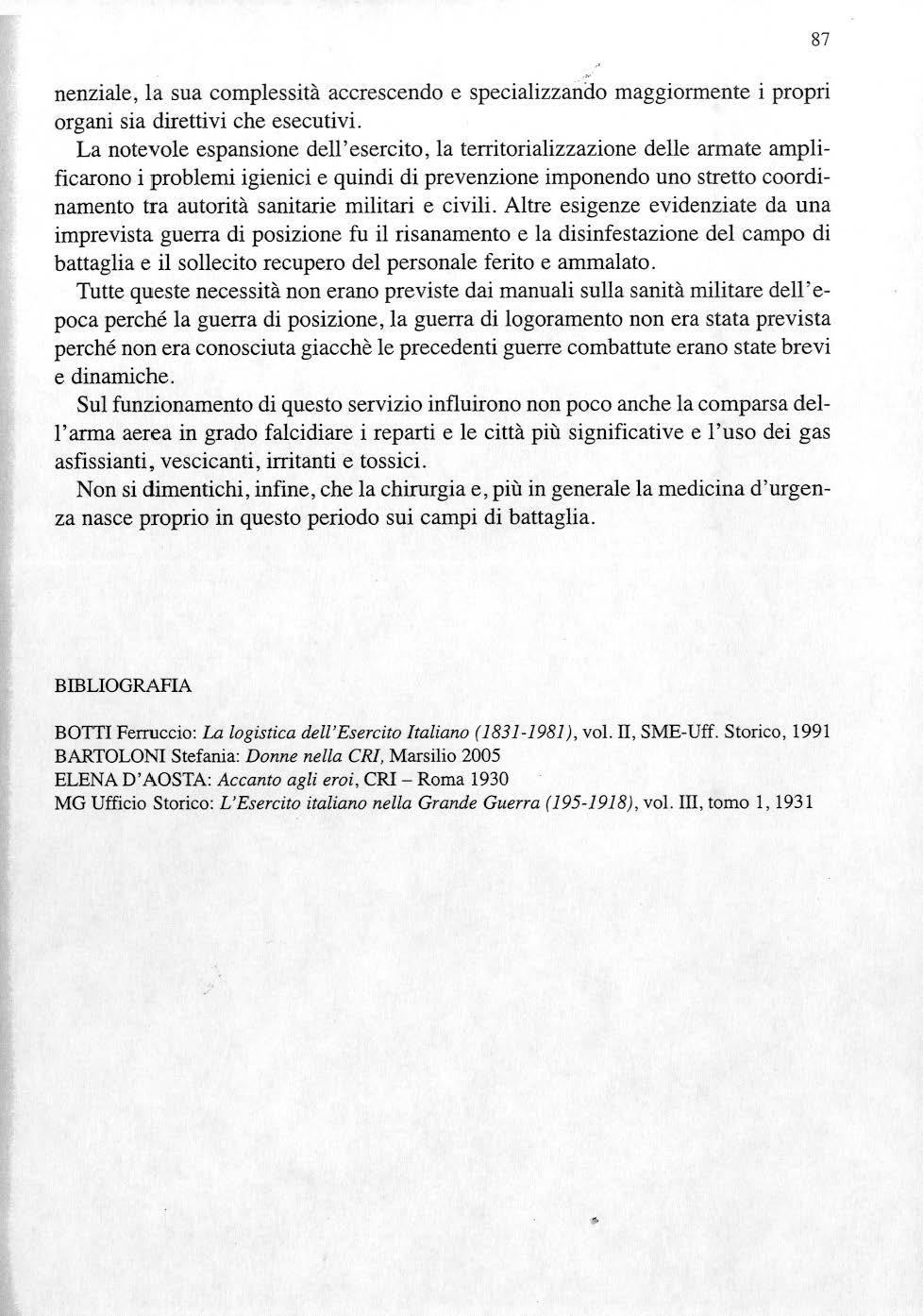
BARTOLONI Stefania: Donne nella CRI, Marsilio 2005
ELENA D'AOSTA: Accanto agli eroi , CRI - Roma 1930
MG Ufficio Storico: L'Esercito italiano nella Grande Guerra (195-1918) , vol. ill, tomo l , 1931
Acquapendente, Fabrizio, Il
Antonini, G., 76
Atterer, D. C., 37
Stèphane, 26, 27, 37
Fabi, Lucio, 27, 28 , 74, 91
Fassina,Ambrogio, 9 , 91
Ferrari, Giuseppe Carmine, 27, 76
Perrero di Cavallerleone, Luigi, 85
Baratto, M., 75
Bartoli Langeli, Attilio, 75
Bartoloni, Stefania, 87
Basaglia, Franco , 76
Bassetto, Romano , 50
Bassini, chirurgo, 14
Becker, Jean Jaques, 26, 27, 37
Bianchi , B. , 74, 76
Bordin, Valentino, 49
Boschi, Gaetano, 16, 26, 27, 37
Botti, Ferruccio, 87
Bricito, Zaccaria, 49
Caccia Dominioni, Paolo, 75
Cadorna, Luigi, 31, 67, 71,75
Cagnette, anatomopatologo, 15
Calandra, capitano, 78
Calligaris , Giuseppe, 26
Catteruccia, C., 37
Cavalli, T., 75
Cavina, G., 37
Cervello, ten. medico, 78
Ceschin, Daniele, 26, 55
Collier, Richard, 44, 55
Consiglio, Placido, 60, 61
Cosmacini , G., 37

Costacurta, Paolino, 46
Dalla Costa, Ivo, 55
De Mauro, T., 75
De Monte, Anna, 50
De Napoli, Domenico, 26 , 27
Delaporte, Sophie, 26, 37
Diaz, Armando, 49
Elena d'Aosta, 19, 20,87
Forcella, E., 74
Foresti , F., 75
Fort, Giovanni, 41
Franchin, Vittoria, 46
Franchini, Antonia Francesca, 26
Franzina, Emilio, 27
Frescura, A., 75
Fussel, P., 74
Galileo Galilei, 10
Gallo, G. 0., 75
Gastaldo , Ernesto, 51 , 55
Gatti, Stefano, 74 , 75
Gemelli , Agostino, 57, 67,76
Gerotto, Angelo, 41
Gibelli, Antonio, 26 , 27, 37,74
Giovannini, P. , 76
Gorini, Ilaria, 26
Granello, Giuseppe , 51
Harvey, William, 10
Impallomeni , Ten. farm., 78
Isnenghi, Mario, 31, 37, 74, 75
Lana , Luigi, 41
Leed, E. J., 69,75
Lenci, G. , 37
Leoni, D., 37,75
Liuzzi, G., 37
Longhin, Giacinto Andrea, 49
Lorenzen, Giuseppe, 49
Lucatello, Luigi, 12, 14, 15
Luizzi, G., 75
Lussu, Emilio, 21,27, 75
Lutrario , Alberto, 26,27
Marchetto , Carolin a, 4 1
Marcon , Maria , 47
Marogna , Pietro , 10 , 13, 15 , 22 , 78 , 79 ,
82-86
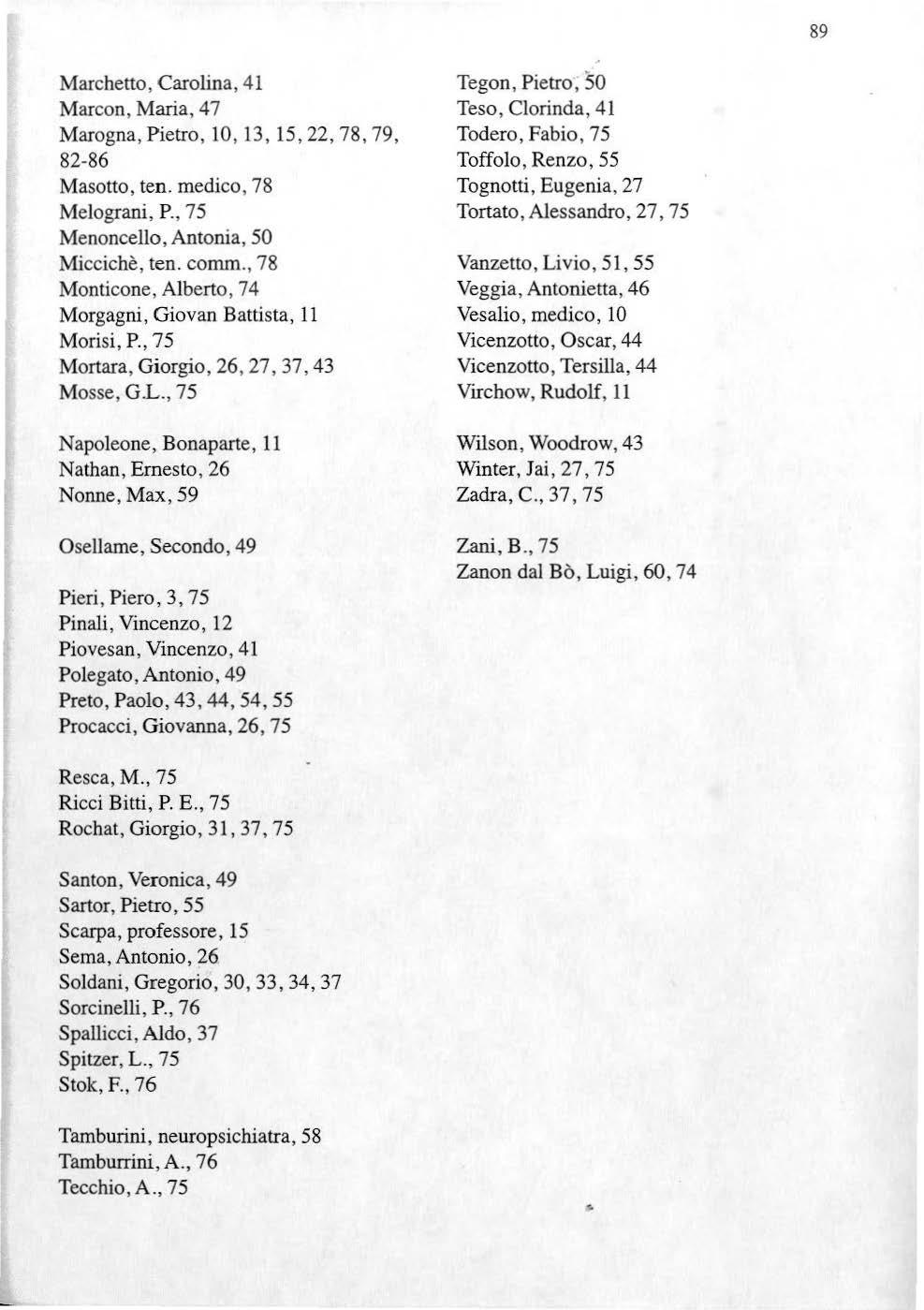
Masotto , ten. medico , 78
M elograni , P. , 7 5
Me noncello , Antonia , 50
Mi cci chè , ten. comm ., 78
Monti cone, AJberto, 74
Morgagni, Giovan Battis ta, Il
Morisi, P., 75
Mortara , Giorgio , 26 , 27 , 37 , 43
Mosse, G.L. , 7 5
Napol eone, Bonaparte, 11
Nathan, Ernesto , 26
Nonne , Max , 59
O sellame , Secondo , 49
Pi eri , Piero, 3, 75
Pinali , Vincenzo, 12
Piovesan, Vincenzo, 41
Polegato , Antonio , 49
Preto, P aolo, 43 , 44 , 54 , 55
Procacci , G iovanna , 26 , 7 5
Resca , M., 75
Ricci Bitti, P. E., 75
Rochat , Giorgio, 31, 37 , 75
Santon , Veronica , 49
Sartor, Pietro, 55
Scarpa, professore , 15
Sema, Antonio, 26
Soldani, Gregorio, 30 , 33, 34,37
Sorcinelli, P. , 76
Spallicci , Aldo , 37
Spitzer, L. , 75
Stok, F., 76
Tamburini, neuropsichiatra , 58
Tamburrini, A . , 76
Tecc hio , A. , 75
Tegon , Pi etro, 5o
Teso , Clo rind a , 41
Todero, F a bio , 75
Toffolo , Renzo , 55
Tognotti , Eu genia , 27
Tortato , AJess andro , 27 ,75
Vanzetto , Livio , 51 , 55
Veggia , Antonietta , 46
Vesalio , medico, lO
Vicenzotto , Oscar, 44
Vicenzotto , Tersilla , 44
Virchow , Rudolf , 11
Wilson , Woodrow , 43
Winter, Jai, 27, 75
Zadra, C. , 37 , 75
Zani , B ., 75
Zanon dal Bò, Luigi , 60 , 74
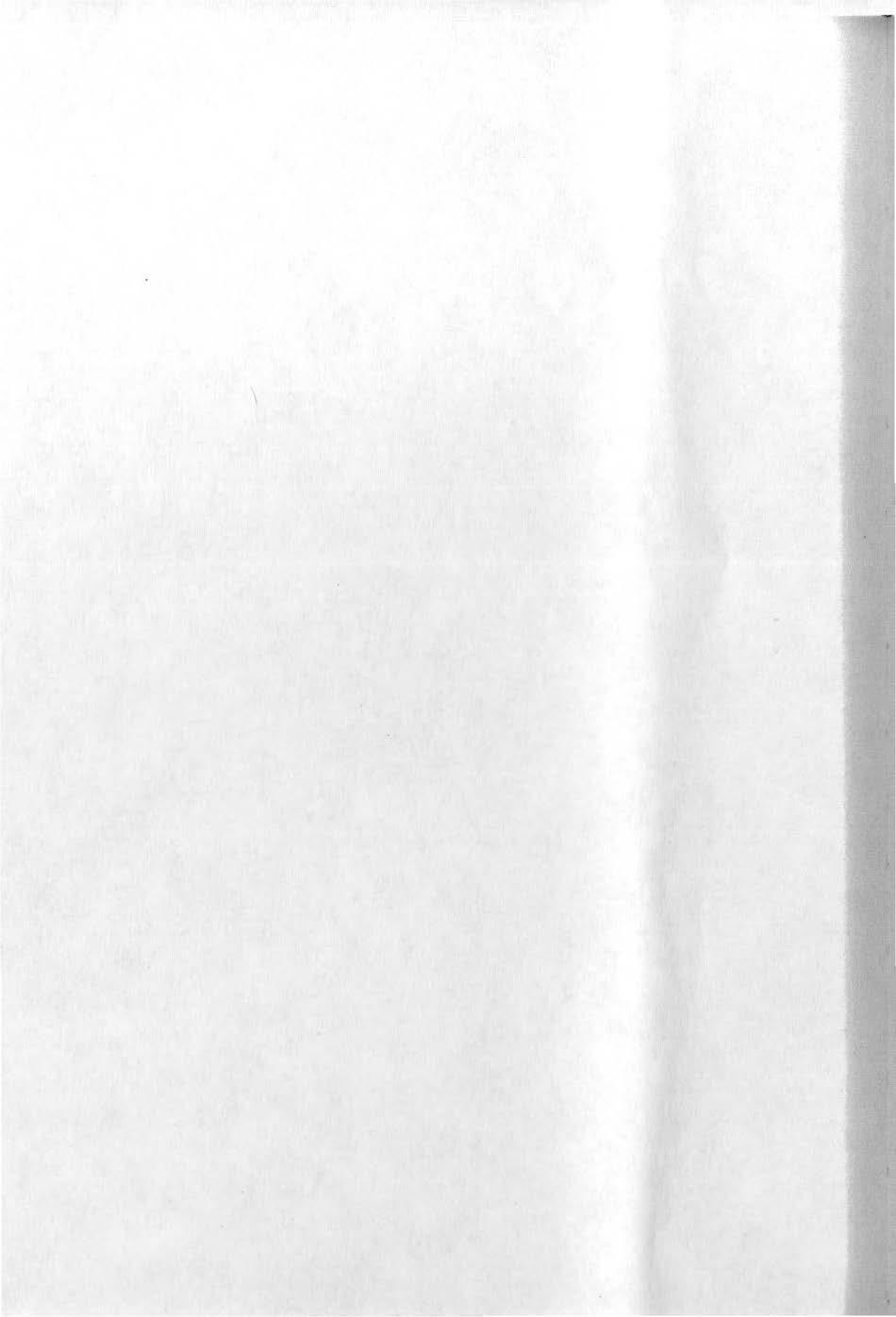
Gaspari editore - via Vittorio Veneto 49 - 33100 Udine
tel. (3 9) 0432 512 567 tel/fax (39) 0432 505 907
www.gasparieditore.com e-mail: info@gasparieditore.com
lA BArrAGLJA DEL SOLSTIZIO
A cura di L. Cadeddu e P. Pozzato
Storici dì guerra nazionali ricostruiscono la battaglia decisiva della Grande Guerra in tutte le sue sfaccettature: navale, aereonautica, terrestre, del servizio informazioni e dell'attività dietro le linee nemiche. Con più di 20 tavole a colori inedite
Un volume che innova la storiografia sul1918
ISBN 88 -7541-174-3; 17x24cm; pp. 304; illustrato, con foto e cartine € 22,00
Luigi Emilio LongaIL liENIO DELLA WTTOIUA
Giovanni Battista Marieni comandante dell'Aeronautica e del Genio dopo Caporetto
Le trincee, le baracche, le mulattiere e i ricoveri sono stati i punti "geograficiff nella sto ria sociale dell a Grande Guerra, ma essi rapprese ntano uno degli aspetti porta nti della attività militare. La logistica legata al Genio fu infatti uno dei fattori della vitto ria itali ana. Il generale Marieni fu co lui che dai giorn i seguenti Ca poretto fino alla fi ne della guerra co mand ò quell 'esercito di oltre 150.000 uomini che costruirono le linee dife nsive, le strade e i po nti per l'offensiva finale. Questa biografia condotta sui documenti dell 'archivio Marieni co nsen te alla storiegrafia sulla prima guerra mondiale di coprire una lacuna imperdonabile.
ISBN 88-7541·139-5; 17x24 cm; pp.304; illustrato con 180 foto, 60 carte e documenti inedm provenienti dall'archivio Marieni; € 22,00
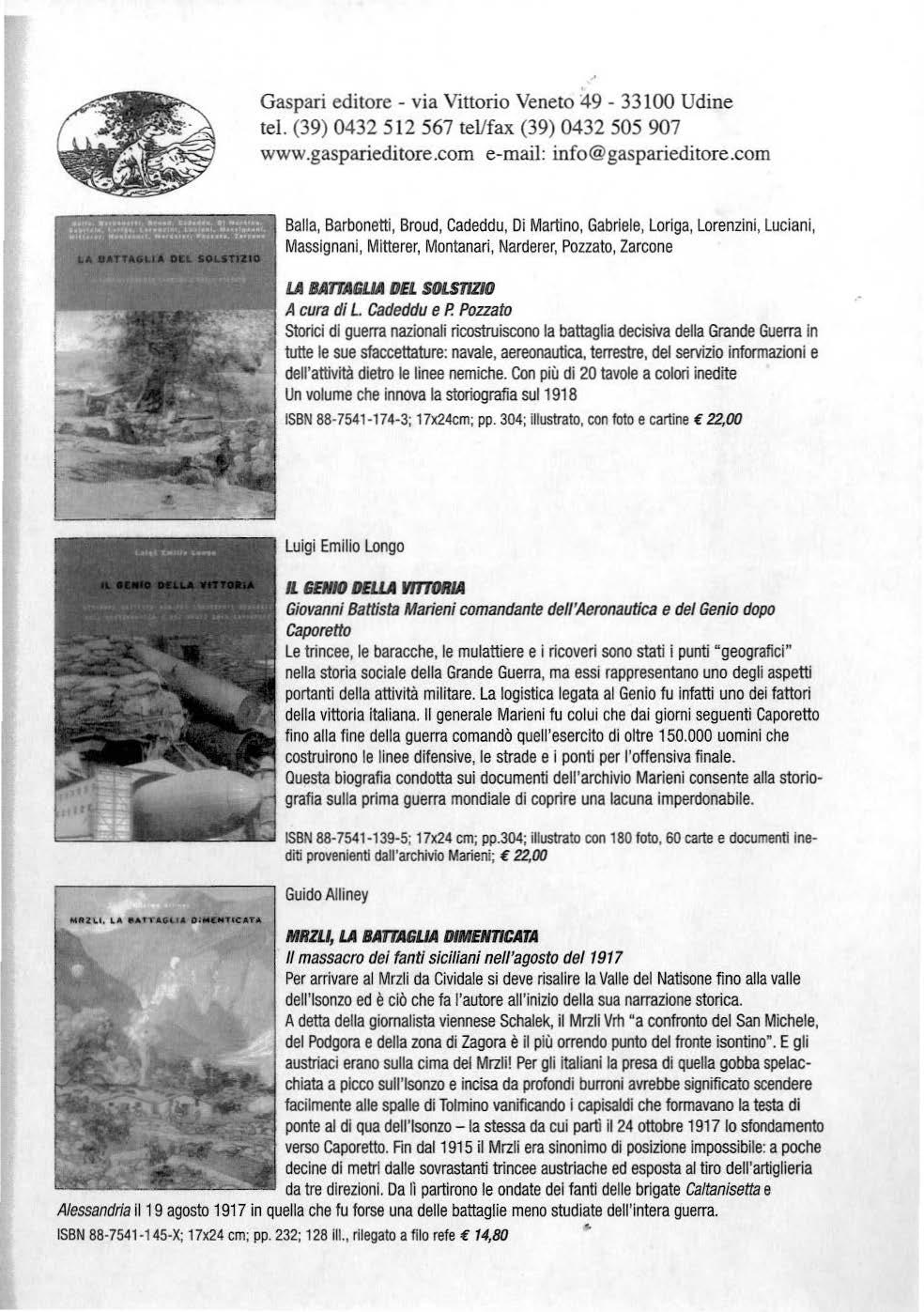
Guido Alliney
MRZLI, lA BArrABLJA DIMENTICATA
Il massacro dei fa nti siciliani nell'agosto de/19 17
Per arrivare al Mrzli da Cividale si deve risa lire la Valle del Natisone f in o all a va ll e dell'lsonzo ed è ciò che fa l'autore all'inizio della sua narrazione storica.
A detta della giornalista viennese Schalek, il Mrzli Vrh •a confronto del San Michele, del Podgora e della zona di Zagara è il più orrendo punto del fronte isontino•. E gli austriaci erano sulla cima del Mrzli! Per gli italiani la presa di quella gobba spelacchiata a picco sull'lsonzo e incisa da profondi burroni avrebbe significato scendere facilmente alle spalle di Tolmino vanificando i capisaldi che formavano la testa di ponte al di qua dell'lsonzo -la stessa da cui partì il24 ottobre 1917 lo sfondamento verso Caporetto. Rn dal 1915 il Mrzli era sinonimo di posiz ione impossibile: a poche decine di metri dalle sov rastanti t rincee austriache ed esposta al tiro dell'artiglieria da tre direzion i. Da lì partirono le ondate dei fanti delle brigat e Caltanisetta e Alessandria 111 9 agosto 1917 in quella che fu fo rse una delle battag lie meno studiate dell'intera guerra.
ISBN 88 -7541 -145-X; 17x24 cm ; pp. 232; 128 111 ., ri l egato a fi lo refe € 14,80
U GUERRE rrALJANE IN LIBIA E IN mOPIA DAL 1896 AL 1939
Apparato iconografico di L. Martinis
In que sto libro Rochat tratta delle guerre colonial i: la battag lia di Ad ua, la conqu ista della Trip olitania e della Cirenaica, la repressione dell a resistenza nel Gebel dal 1927 al 1931 , la cattura, la condan na e l'impiccagione di Ornar ai-Muhtar; la lunga guerra d'Etiopia dal 1935 al1940 e poi l' analisi dell'aereonautica e l' uso dei gas in Somalia e in Etiopia, per fini re con la repressione se guita all 'attentato a Graziani in Ab issinia Una trattazione awincente con rigorose analisi e conclusioni che si connotano come la base da cu i partire pe r le ricerche future.
ISBN 88 -7541-159-X; 17x24 cm ; pp . 240; illustrato con 80 foto e cartine. € 14,80
 Mario Maffi
Mario Maffi
L'ONORE DI BASSIGNANO
Il maggiore che non volle fucilare gli alpini del Val d'Adige
Prefazione di Giorgio Rochat
l'1 1 ottobre 1916, tra Parona, Verona e Vicenza, nel corso del trasferime nto in tre no verso il fronte del battagli on e alpino Val d'Adige- composto da alpini "anziani" del battaglione Verona -. 51 alpi ni saltarono dal treno e andarono a trovare mogli, fidanzate e famigliari rimane ndo assenti più giorni. Una situazione di emergenza non rara che non metteva in dubbio la loro coes ione e obbedie nza Bassignana però ebbe la sventura di dover rendere conto al generale Andrea Graziani, il " fucilatore " più noto dell' esercito, che gli chiese subito "Quanti ne ha fucilati? Nessuno? Ella non è all'altezza del suo mandato!", dopodiché lo mise agli arresti di rigore pe r due mesi, lo trasferì a un regg im ento di fanteria di marcia. La storia di questo ufficiale piemonte• se è rimasta sconosciuta, ma è emblematica del co mportamento di molti ufficiali che dovettero dividere la loro lealtà t ra i soldati e gli ordini repressiv i del Comando Supremo. "Sappiamo - scrive Giorgio Rochat - che nel periodo di comando di Cadorna ve nnero liqui dati 206 general i e 255 colon nelli, ma non possiamo capire quanti di questi esoneri fossero giusti ficati e quanti promossi da superiori che cercavano di coprire le loro insufficienze con la richiesta di una disciplina te rroristica. [ ] Dalla grande storia della guerra mondiale si passa alla vicenda di uno dei suoi protagonisti che ne furono ingiustamente schiacciati".
ISBN 88-7541-178-6; 17x24cm; pp . 208; illustrato, € 14,80
Corrado Tum iati
ZAINO DI SANrrA
Prefazione di Paolo Gaspari
Corrado Tumiati (Ferrara 1885-Rrenze 1967), direttore dell ' osp edale veneziano di San Servolo, fu tra i maggiori psich iatri italiani. Am ico di Casorati, Gino Rossi e Medardo Rosso, lasciò nel 1929 la medicina per dedicarsi interamente alla letteratura collaborando per 16 ann i al "Corriere della Sera". Con Piero Calamandrei nel 1945 diede vita a il "Ponte " e tradusse tutto il teatro di Moli ére
Se con l Tetti rossi: ricordi di un manicomio, vinse il Prem io Via reggio nel1931, con Zaino di sanità fornisce un testo prezioso sulla vita di un medico in prima linea, nella Dolina delle Caverne. La sua presenza a Santa Maria la Longa nella notte in cu i si svolge l'ammutinamento di alcuni reparti della Catanzaro con la co ns eguente decimazione è l'unica testimo nianza di uno dei momenti più drammatici della guerra. Il volume contiene saggi di Arna ldo Cherubini, Carlo Cordié e l'Itinerario Tumiati alla Dolina delle Caverne di Pao lo Pizzamus con la descrizione dei fatti d'arme
ISBN 88-7541 -150-6; 14x21 cm: pp . 208; illustrato, € 14,50
Il diario di guerra inedito del col. Francesco Azzoni Avogadro, aiutante di campo del Re. Vo/.1 ° (1915-1916}
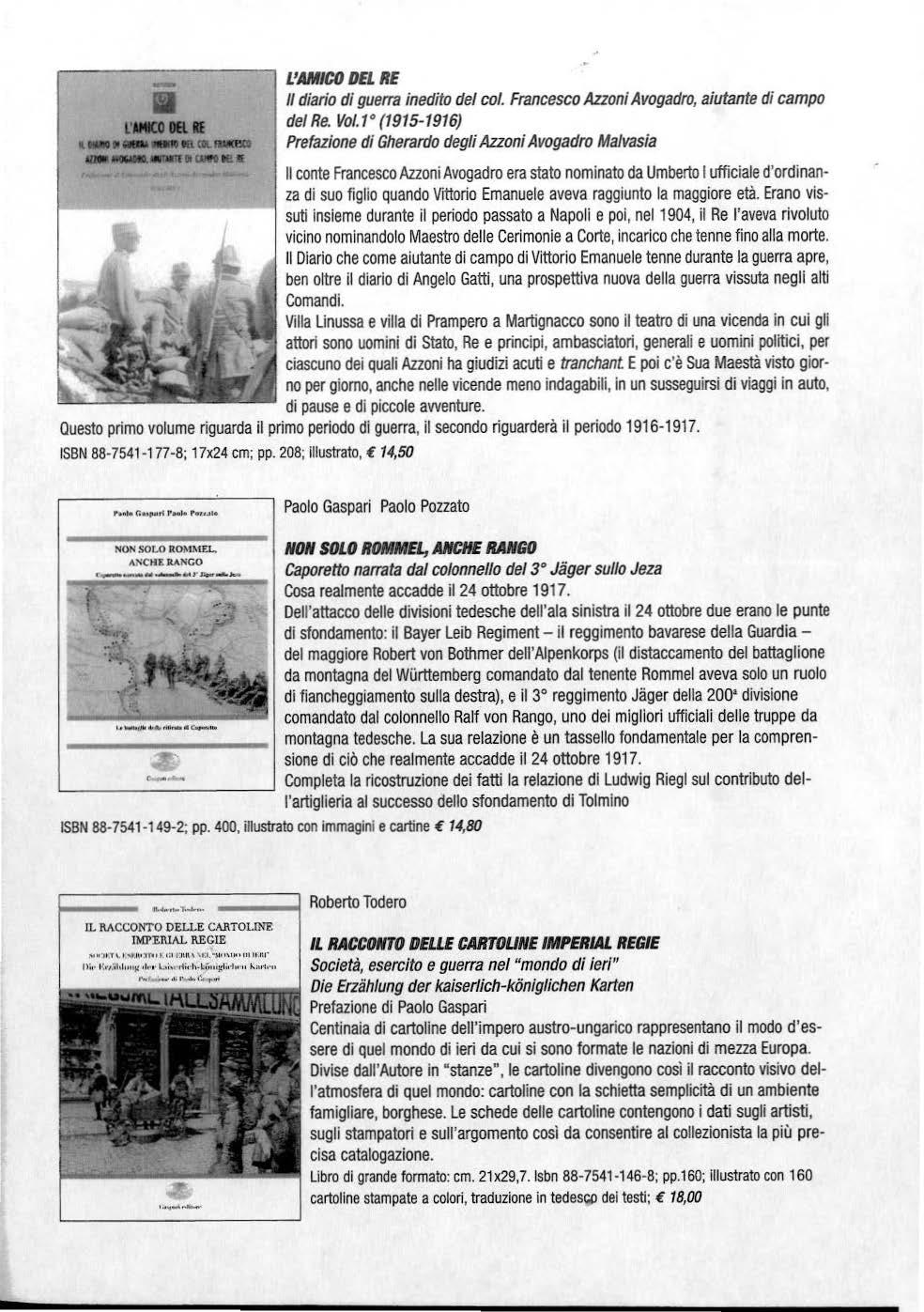
Prefazione di Gherardo degli Azzoni Avogadro Ma/vasia
Il conte Francesco Azzoni Avogadro era stato nominato da Umberto l ufficiale d'ordinanza di suo figlio quando Vittorio Emanuele aveva raggiunto la maggiore età. Erano vissuti insieme durante il periodo passato a Napoli e poi, nel 1904, il Re l'aveva rivaluto vicino nominandolo Maestro delle Cerimon ie a Corte, incarico che tenn e fino alla morte Il Diario che come aiutante di campo di Vittorio Emanuele tenne durante la guerra apre, ben oltre il diario di Angelo Gatti, una prospettiva nuova della guerra vissuta negli alti Comandi.
Vi lla Unussa e vi lla di Prampero a Martignacco sono il teatro di una vicenda in cui gli attori sono uom ini di Stato, Re e principi, ambasciatori, generali e uomini politici , per ciascuno dei quali Azzoni ha giudizi acuti e tranchant E po i c' è Sua Maestà visto giorno per giorno, anche nelle vicende meno indagabili, in un susseguirsi di viaggi in auto, di pause e di piccole avventu re.
Questo primo volume riguarda il primo periodo di guerra, il secondo riguarderà il periodo 1916-1917.
ISBN 88 -7541-177-8; 17x24 cm ; pp. 208; 14,50
Paolo Gaspari Paolo PozzatoNON SOLO ROMMEL, AIICHE RANGO
Caporetto narrata dal colonnello del 3° Jager sullo Jeza
Cosa realmente accadde il24 ottobre 1917
Dell'attacco delle divisioni tedesche dell' ala sin istra il 24 ottobre due erano le punte di sfondamento: il Bayer leib Regiment- i l reggimento bavarese della Guardiadel maggiore Robert von Bothmer deii 'Aipenkorps (il distaccamento del battaglione da montagna del WOrttemberg comandato dal tenente Rommel aveva solo un ruolo di fianc hegg iam ento sulla destra) , e il 3° regg im ento Jager della 200• divisione comandato dal colonnello Ralf von Rango , uno dei mig liori ufficiali delle truppe da montagna tedesche. La sua relazione è un tassello fo ndamentale per la comprensione di ciò che realmente accadde il 24 ottobre 1917.
Completa la ricostruzione dei fatti la relazione di ludwig Riegl sul contributo dell' artiglieria al successo dello sfondamento di Tolmino
ISBN 88-7541 ·149-2; pp 400, illustrato con immagini e cartine 14,80 ,..
IL !\ACCONTO DEU.E CARTOI.INE
Roberto Todero
IL RACCONTO DEUE CARTOUNE IMPERIAL REGIE
Società, esercito e guerra nel "mondo di ieri"
Die Erzahlung der kaiserlich-koniglichen Karten
Prefazione di Paolo Gaspari
Centinaia di cartoline dell'impero austro-ungarico rappresentano il modo d'essere di quel mondo di ieri da cui si sono formate le nazioni di mezza Europa Divise dall'Autore in "stanze" , le cartoline divengono così il racconto visivo dell' atmosfera di quel mondo: cartoline con la sch ietta semplicità di un ambiente famiglìare, borghese le schede delle cartoline contengono i dati sugli artisti, sugli stampatori e sull ' argomento così da consentire al collezionista la più precisa catalogazione.
Lìbro di grande formato: cm. 21x29,7. 1sbn 88-7541 -146-8; pp 160; illustrato con 160 cartoli ne stampate a colo ri , traduzione in ted escp del testi ; 18,00
l TRACCIAT7 DEUE TRINCEE SUL FRONTE DEU'ISONZO
111 Le alture di Monfalcone
Fin dai primi giorni di guerra Monfalcone - la nascente città dei cantieri - subì le pesanti trasformazion i impostale dal conflitto. l reticolati e lo sfruttamento della complessa orografia carsica da parte austro-u ngarica e italiana trasformarono le alture alle spalle di Monfalcone in un vasto campo trincerato conforme ai criteri della guerra d'assedio. Anche i luoghi simbolo della modemizzazione cittadina quali il Gantiere navale, la fabbrica di soda dell'Adria fino al complesso delle Terme Romane vennero inglobati nel sistema difensivo dei due schie ramenti.

Questi tracciati sono il teatro di azioni militari nei furibondi scontri della Terza, Sesta e Decima Battaglia dell'lsonzo, e di episodi di valore noti da tempo alla storiografia
legati ai nomi del Murista comasco Antonio Sant 'Elia, del bersagliere romano Enrico Toti, del "Lu po di Toscana" Giovanni Randaccio e del grande Gabriele D'Annunzio. li lettore può così seg uire le varie fasi delle battaglie individuando precisamente i luoghi delle azioni, awalendosi di una documentazione d'archivio inedita, che illustra l' evo luzione dei tracciati e dell'organizzazione del terreno dall 'estate del1915 fino all ' autunno 1917 permettendo una maggiore comprensione delle memorie materiali recuperate all'interno del Parco tematico della Gran de Guerra e di quelle an co ra poco visi bili ch e t uttavia con notano profondamente questo campo di battaglia. 21x29,71SBN: 88-7541-153 -0; pp 144; ili., a 18,00
Gli altri volumi della collana: l. /La conquista del Carso di Com eno; Il Le vali/ del Natisone e dello Judrio
---1 Nicola PignatoLE ARMI DI UNA VITTORIA
1oArmi bianche, protezioni individuali e armi a Yro teso.
Prefazione di Pa olo Gaspari
Appendici di Filippo Cappellano
Le Grandi Unità di fanteria; Le unità costitu ite; La produz ion e bellica; Le Armi della Fanteria; Armi bianche; Armi bianche difensive; Elmi e corazza Farina; Gli scudi; L'elmetto metallico leggero; Armi bianche offensive; Sciabola baiooetta; Pugnale d'assalto; Sciabola da cavalleria Mod. 71; Lancia; Arm i corte; Revolver; Pistole automatiche
_.. di velivoli
Pistole da segnalazione; Fucili a ripetizione ordina ria; Armi modello 1891; Fucile Vatter1i Mod 70/87/16; (o modif 1915);Appendici: Il tiro di fucileria controaerei; Gli affustini per ti ro di precisione; Defilatori per fucil e; Pistole e fuc ili impiegati a bordo
ISBN 88-7541-155-7; pp.160, illustrato con 80 immagini € 25,00
D Co lli P. Gaspari P. Pozzato R. Vecellio
fflNERARI SESREn DEUA SRAIIDE SUERRA NEUE DOLDMm 4 ° Monte Piana il balcone delle Lavaredo, Teston di Monte Rudo, Monte Specie
• Continua con il 4° Volume la fortu nata serie degli itin erari della Grande Guerra nelle Dolomiti.
La prima ve ra guida alla Grande Guerra nella zona delle Tre Cime di Lavaredo.
ISBN 88-7541-130 -1 pp. 180; ili; con 160 immagini a colori; € 13,50
Paolo Scandaletti
GAULEO PRIVATO
Prefazione di Margherita Hack
Il "caso Galileo " è qui narrato attraverso il filtro della vita privata del grande pisano. Ripartendo dai fatti biografici e storici anche minori, Pao lo Scandaletti racco nta la vita di Galileo Galilei con trasc inante precisione e gran de ape rtura cultura le. Ecco dunque lo scienziat o geniale e innovatore, caposcuola dell' autonomia della ricerca , scrittore ch iarissi mo e pensatore luci do che si ida l'aristotel ismo ufficiale. Ma anche il pove r'u omo dall a vita t ormentata, pressato spesso da parenti e creditor i, di carattere passionale e pole mico, gaudent e e beffardo; un uomo affascinante, senza malizie machiavelliche e quind i destinato a scontrarsi con il potere ecclesiastico e laico.
ISBN 88-7541-169·7 17x24cm; pp. 212; € 14,80
Luigi Pastro
RICORDI DI PRI GIONE Dell'unico superstite dei condannati di Mantova un capitolo sconosciuto della storia veneta e lombarda A cura di Enzo Raffaelli
Un cap ito lo sconosc iuto della storia veneta e lombarda è quello dei veneti e dei lombardi impicc ati e co ndannati nei processi di Venez ia e di Mantova tra il 1851 e il 1853: i famosi Martiri di Belfiore tra cu i Tito Speri e Pier Fortunato Calvi. L'un ico superstite dei condannati di Mantova fu il medico travisano Lu igi Pastro che per due anni rimase in comp leto iso lamento - se nza libri, senza pe nna e in catene - in una cella del caste llo di Mantova rifiutando di confessare alcunché , mentre tutti gli altri suo i comp lici cedeva no, co nfessavano e venivano impiccati.ll medico travisano res istette oltre ogn i immaginazione scrivendo una pagina emblematica del Risorgimento che la storiografia aveva dimenticato.
14X21, ISBN 88-7541-147-6, pp. 240, illustrato a co l e bn, € 14,50
Roberto TessariIl campo di battaglia del Piave
IL MONTELLO 3°
Gli itinerari: Resistenza e contrattacco, Con gli Arditi al Piave, La difesa del Fiume, Ritorno sul Montello con il poeta Andrea Zanzotto.
Il terzo conc lusivo volume degli Itinerari e delle escu rsioni su l Montello, una guida per appassionati esperti e nuclei fam iliari
ISBN 88·7541-166 -2 pp 180; ili; con 200 immagini a co lori ; € 13,50