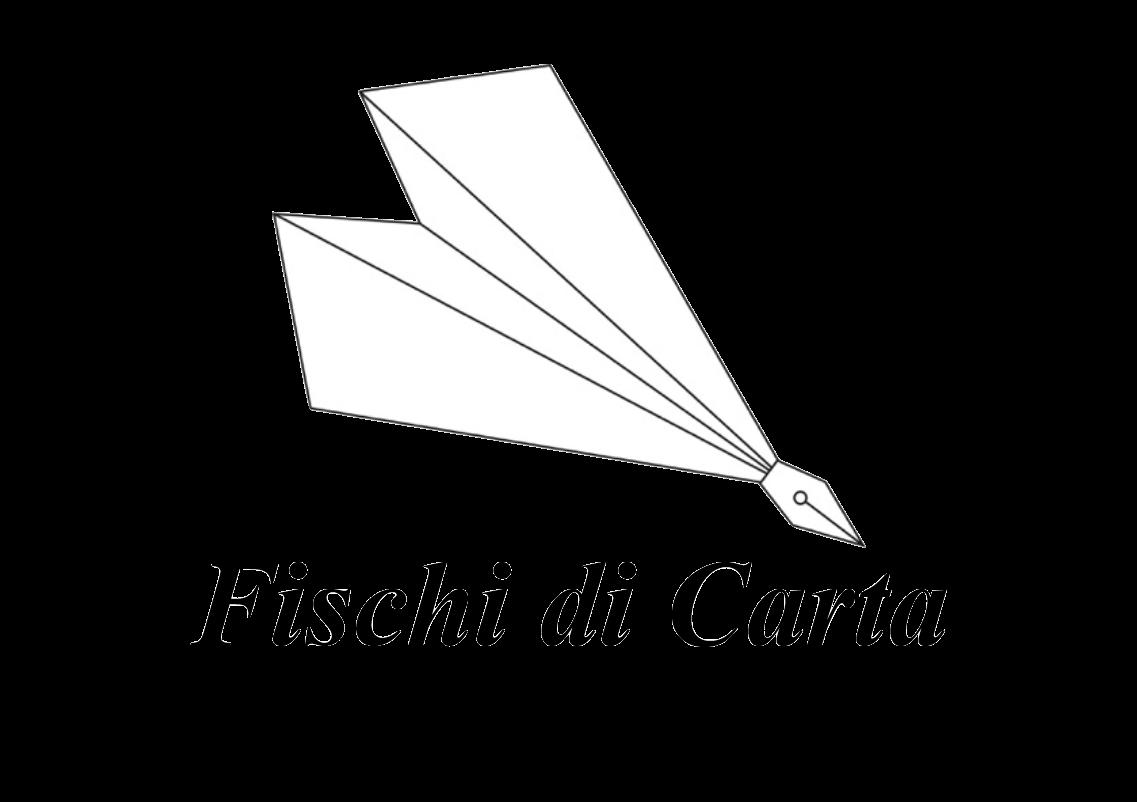ELEFANTIACA



si è improvvisamente catapultato ai Giardini Baltimora, il 5 agosto 2016. Si chiama UGA ed ha tante incarnazioni. Questa che tieni tra le mani è la sua forma scritta. Scritti savi, lievi, sagaci, veraci, loquaci e, perché no, elefantiaci.
Quando abbiamo deciso di parlare di elefanti ho pensato che, chi vive dove fa sempre caldo, non può voler altro che bere.
Una parte di vermut, sei di gin: le scimmie muoiono di liquorini perché là non si beve il Dry Martini, qui invece sì.
Giunti dalla savana alla città avevamo un sogno noi elefanti: aprire – con amore e tutti quanti –un cocktail bar.
Al banco abbiamo solo tipi arzilli: l’ibis modella il ghiaccio ed il leone fa il boss ma con lo shaker è un campione, i coccodrilli preparano tartine con l’acciuga; e per entrare devi dire «UGA».
L’amore finisce anche nella savana.
L’elefante non vuole più scrivere poesie d’amore di Claudia Calabresi
L’elefante non vuole più scrivere poesie d’amore. Proboscide in spalla, ginocchia da vecchio, ha deciso di andarsene.
La savana non ha più attrattive: i serpenti, i leoni, le zebre, gli gnu sono tutti accoppiati e gli danno un po’ il vomito. Gli ricorda noi due.
L’elefante non vuole più scrivere poesie d’amore. Francamente, mi ha detto, me ne infischio come Rhett: Via col vento, non ho altre parole.
L’elefante preferisce altre cose. Guardare un film o smarrirsi nel centro, uscire con gli altri, ballare a ritmo di musica dance, un cocktail in mano,
studiare tanto, sentirsi più solo, far finta di niente, insistere ancora, svegliarsi, impazzire, dormire alle tre... Ha aggiunto: non ho più amore, tesoro,
da darti, di noi elefanti si dice una cosa, che la memoria non ci fa cilecca, ma l’altro pregio non lo sa nessuno: chi si ricorda non sa
perdonare, vaga negli anni ed ha un peso sul cuore, non mi si dica che dovrei scordare, io lo vorrei, ma non so fare altro: questa savana non
fa più per me. So cosa pensi ma non giudicare, non mi guardare, non ho più niente da dire. Io, l’elefante, da oggi in poi preferisco altre cose.
Così mi ha detto, ha svuotato la casa, ha caricato su un camion le cose, io l’ho guardato partire in silenzio. Non so più scrivere poesie d’amore.
Questa fotografia è un tributo all’omonimo brano della cantautrice (e membro di UGA)
Martina Vinci. Lo scatto immortala l'ombra cinese di un elefante di profilo, simbolo del collettivo UGA e animale guida di UGA DAY 2016.
cinesi di Elena Grandi
tecnica Fotografia digitale

Provateci un po’ voi, a non poter dimenticare.
di Gaia Cultrone
Avanti e indietro a passo lento lungo la giornata, la tua savana personale piena di tutti loro, con quell’andirivieni che all’improvviso li guardi e c’è così tanta vita tanti gesti o una sola parola, uno sguardo, per sbaglio: Nota Da Ricordare.
Tu vorresti allora correre, ma non davvero nella savana, nella tua mente, a evidenziare quelle note, tenerle lì con te e con loro, cui fai presente la tua memoria da elefante.
Si complimentano poi, perché lungo è il tempo in cui porti quelle memorie, perché di loro sai – ché di loro ricordi –ciò che essi dimenticano.
Ma ci sono voci lì nella savana, non le puoi mettere a tacere, dicono cose amare. Avanti e indietro a passo lento, sullo sfondo il tramonto. A fine giornata, il tuo sguardo pensante: «Che peso tornare a casa ricordando tutto, come elefante.»
Cosa ci fanno un detective, un impresario, un clown, un sollevatore di pesi, un incantatore di serpenti e una bionda trapezista nello stesso racconto di Prossa Nova? La risposta sta nella risoluzione di un misterioso zoocidio e nello schiocco delle labbra che rubarono un bacio.
(o di come il detective si innamorò di una bionda trapezista) di Carlo Meola, Amelia Moro e Matteo Valentini
«Grazie alla monja che non l’ho detto ai giornalisti!» esclamò l’impresario: «Cosa crede? Se lo venisse a sapere la stampa saremmo rovinati…». Mentre parlava, dalla sua deformata poltrona, l’ometto aveva occhi che scattavano da un lato all’altro dell’ufficio, in continua e regolare agitazione, come se a muoverli fosse stato un meccanismo esatto, una legge fisiologica precisa. Essi andavano prima a destra, verso la porta socchiusa; poi a sinistra, verso i quadri che occupavano la parete laterale; ora verso il basso, sulle carte che teneva in mano e finalmente diritti, fissi nelle pupille del suo interlocutore: «Lo capisce o no che il nostro Circo ha una reputazione, una storia, una nomea?! Qui c’è bisogno della massima riservatezza: se solo la notizia saltasse fuori… non oso pensarci! Riesce a immaginarseli lo scandalo… la vergogna… le male lingue!? Saremmo costretti a tornare in Spagna, a far segare siamesi dal mago Vaños o ad ammaestrare le talpe dell’Oreja de Van Gogh! E poi… e poi…» a questo punto il meccanismo si interrompeva: il sistema respiratorio, a corto di ossigeno, collassò in un profondo sospiro, mentre il suo sguardo si faceva immobile sul ritratto color seppia di una donna in body che cavalca una leonessa albina: «…Cosa direbbe mamma… !?».
Chi ascoltava, accomodato su una seggiola di legno, dirimpetto alla scrivania, anche lui aveva occhietti vivaci. Nell’apparenza di fatto, però, tale mobilità non
concerneva più il polso irregolare o il respiro affannato di un anziano direttore di circo, che abbia perso in un incidente misterioso l’attrazione princeps dei suoi spettacoli e per ciò stesso si ritrovi con i sensi fin troppo eccitati. Qui, si tratta del lucido e disinteressato spirito di osservazione, dell’ingegno analitico e irriverente di un celebre quanto inesperto detective privato (e le vicende che seguono daranno prova più volte della sua malcelata inettitudine). Va spiegato: è senza alcun preavviso che il detective fu costretto a recarsi in un locus delicti tanto singolare… Ai fini della comprensione del racconto, perciò, giustadetta singolarità sarà fatta chiara dalla verosimile ricostruzione della telefonata che dovette ricevere – nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2016 – prima di ritrovarsi trafelato e senza cinture a sgommare sulla statale A128, diretto a una periferica località a tutti nota per il recente e assai chiassoso allestimento di uno scalcinato baraccone: il Circo Itinerante de los Rosicones. (Si trascrive qui di seguito da un file .mp3, ritrovato solo alcuni anni dopo negli archivi digitali dell’AISI):
«Pronto! Pronto! Parlo col detective Raimondo!?»
«Rodolfo, sì… il nome sarebbe Rodolfo… chi lo vuole sapere…?»
«Detective! Sono Jessica Svetlava… La chiamo da Villabella... La prego di accorrere immediatamente, è scoppiata una tragedia!»
«Si calmi signorina… Lei è al sicuro in questo momento?»
«Il nostro Circo! Ci aiuti, ci deve aiutare assolutamente… è successa una cosa tremenda!»
«Va bene, stia calma, faccia un bel respiro e mi racconti dall’inizio che cosa è accaduto…»
«È orribile, orribile le dico! La prego, non c’è tempo… la supplico!»
«Ma io non…»
«Presto! Faccia presto! »
«D’accordo, d’accordo, vengo… !»
In tutto il comprensorio, forse, mai si era udito il rombo così intenso di un motore di automobile. Tanto forte che le vibrazioni dell’aria in pochi istanti attraversarono tutto il Comacchio e conquistarono, in un solo minuto, la stessa cima del colle Longanese. E poi su per i sentieri montagnosi, su fino a raggiungere le orecchie di pietra della statua severa della Madonna dei Circensi, il santuario medievale da cui si può scorgere l’intera vallata. Questa, in realtà, era stata da sempre teatro di strabilianti attività di giocoleria, di fantastiche azioni di acrobati e prestigiatori, in generale della vita avventurosa e delle pericoloserie di chi pratica con passione autentica la nobile arte dello
spettacolo itinerante. Tradizione che, tristemente, non sopravviverà al passaggio dal vecchio al nuovo secolo, quando gli antichi fasti giullareschi della valle comacchina non saranno altro più che un ricordo lontano nelle frasi nostalgiche di qualche anziano mascalzone. Ultimo baluardo di tali prestigiosi costumi, il circo de Los Rosicones era appena arrivato nel paesino di Villabella dove, si diceva testé, sarà protagonista di incredibili e memorande vicende, cui il famoso detective Rodolfo dovette assistere (e in cui ritrovarsi, purtroppo, coinvolto sentimentalmente) a partire dal momento in cui parcheggiò frettolosamente il suo veicolo nella piazzola antistante il baraccone.
«Come può vedere, il nostro circo ha due entrate principali, e quattro vie di esodo in tutto!», disse l’impresario: «Dietro le gradinate si trovano le due “uscite di sicurezza”… sono gli accessi al retroscena, capisce? Di lì si va direttamente ai caravan… non si immagina quante volte vengano usate durante lo spettacolo!», mentre diceva queste cose, era come se il raccapricciante spettacolo che avevano davanti passasse del tutto inosservato: egli disegnava ampli movimenti con il braccio, ad indicare la geografia del suo tendone, ma non prestava alcuna attenzione alla carcassa spaventosa che tanto platealmente occupava il centro della pista. «Di fuori, nel parcheggio, troverà le roulotte dei lavoranti e delle nostre celebrità: al momento lavorano al circo alcuni tra i più eminenti professionisti di tutta la scena circense internazionale… Jessica “Jess” Svetlava, la nostra trapezista (ha già avuto modo di parlare con lei al telefono); Josè “Jimmy” Armando Feliciano, il nostro Clown; Hercules James W. Armstrong detto “Super Mario”, (detiene il record mondiale di strappo e slancio…); e infine, Luciano “Lui” Linguetta, italiano, famoso in tutto il mondo per la pericolosità dei suoi innumerevoli serpenti…». Adesso, dopo aver esaminato gli spazi interni, i due poterono uscire a guardare il posto da fuori, a passeggiare all’aria tiepida e tersa di quella stramba notte agostana: «Eccoci: le roulotte dei nostri artisti… oh, se dovessero restare senza un buon lavoro... non mi ci faccia pensare!», «In che senso “senza un buon lavoro”?», «Eh già… che le cose, per chi si occupa d’arte, di questi tempi, non vanno più come una volta… mi ascolti bene lei, per le mani sante di Ignazio di Loyola! Il circo de Los Rosicones ha una storia lunga, un passato illustre. Mia madre lo fondò nel 1933, l’anno in cui fui concepito io… mi permetta signor Raimondo… », «Rodolfo!», «Donne come lei non ce ne sono più! Juanita Carmelita María de Montserrat Immaculata Concepción… buon’anima!», l’ometto si segnò vigorosamente: «Mio padre ci lasciò tragicamente nel 36’… ios, la guerra fu difficile per tutti… comunque, non si creda, mamma non mi
fece mai mancare niente!», «Sì, sì… lo immagino…», «E poi... nel 39’… la polizia… la dittatura... mestieri come il nostro furono banditi. Cosa potevamo fare? Ci decidemmo a preparare le valigie, come si dice, a piantar baracca e burattini e partire per l’Italia!», «…», «Avevamo sentito di questo posto, vicino Mantova, dove il fascismo aveva dovuto arrendersi… sì, insomma, alle usanze locali… Ma non si pensi che non facessero di tutto per metterci i palos tra le ruote! Ricordo una volta un soldataccio de mala suerte…», «Parla del Comacchio? È qui che arrivaste dalla Spagna la prima volta?» «Non lontano da Villabella… dopo la guerra, mi creda, il nostro Circo fece meraviglia in tutta la penisola! Ricordo gli striscioni colossali a Genova, le folle in visibilio a Bari, a Roma poi… fu il Papa in persona a farci visita!», «Allora come mai siete tornati proprio qui, adesso, dopo tanti anni?», «Vede signor Detective, io sono molto vecchio… e una gran vecchiaia si porta appresso grandi nostalgie…».
Nel frattempo i due si erano portati nell’ufficio di Valerio Umberto (era questo, infatti, il nome dell’impresario) e si erano seduti: l’uno dietro la propria scrivania, l’altro di fronte, su una sedia ribassata, come uno scolaro che debba rispondere delle proprie inadempienze scomodamente seduto davanti alla cattedra troppo alta dell’inflessibile professore. Ma in questo caso era l’insegnante a mettersi in agitazione, e il compito a casa consisteva nell’aver pronte alcune domande fondamentali che avrebbero dovuto, nella mente attenta e calcolatrice del detective, disegnare il quadro generale di come erano andate le cose, di come quell’animale fosse finito senza vita al centro del baraccone… Chi era stata l’ultima persona a prendersene cura? Come avevano fatto a trascinarlo fin lì dalla sua gabbia? Dove si trovavano in quel momento la trapezista, il pagliaccio, il sollevatore di pesi e l’incantatore di serpenti? Qualcuno aveva lasciato Villabella nelle ultime ore? A queste domande l’impresario rispose con esattezza, col tono autoritario di chi controlli costantemente ogni dettaglio della propria attività, ogni movimento dei propri collaboratori. Infine, forse senza pensarci troppo, Rodolfo gli chiese se qualcuno avesse avvertito i giornalisti.
Ma a questa scena il lettore ha già assistito… Il detective lasciò in fretta l’ufficio, prestando la sua parola che non avrebbe avvertito i media dell’incidente e così, di comune accordo, i due si diedero appuntamento la sera dopo: i lavoranti avrebbero ripulito tutto e allestito lo spettacolo, Rodolfo sarebbe rimasto tra il pubblico (ma in incognito, senza farsi riconoscere: «La gente chiacchiera signor Raimondo, lo sa!?») e da quel momento avrebbe avuto licenza di andare dove riteneva opportuno, dentro e fuori del circo, a interrogare chi voleva poiché
tutti i dipendenti erano stati avvisati. Dopo certi nebulosi avvenimenti, così, il circo quella notte rimase completamente vuoto… fatta eccezione per il corpo della vittima, per l’animale imponente che rappresenta il cuore della nostra narrazione, il germe di questa e di tutte le altre storie che da qui in avanti ne scaturiranno: sotto i riflettori spenti, nella penombra, sul pavimento battuto del circo de Los Rosicones si trovava il cadavere di un gigantesco elefante. La fioca luce lunare che riusciva a raggiungerlo si rifletteva nel sangue coagulato di una larga ferita, appena sotto il collo... L’animale, all’apparenza, era morto sgozzato.
«Per tutte le badesse! Lei mi sta prendendo in giro, Raimondo, lei mi sta prendendo in giro! Quali erano i nostri accordi?»
«Rodolfo…» precisò il nostro «mi chiamo Rodolfo.» «Raimondo lei mi sta simpatico, ecco, però mi ha fatto davvero perdere la pazienza!»
«Uhm… ma che diavolo è successo?»
«Che è successo? Che è successo?! Io LA PAGO per rispondere a questa domanda! E si legga i giornali!» detto questo, l’impresario gli sbatté il telefono in faccia.
Rodolfo strisciò fuori dal letto con un gran mal di testa. Gli sarebbe proprio piaciuto leggere a scrocco il giornale al bar – con un espresso e un cornetto, magari – ma l’urgenza del caso lo fece propendere per un più prosaico uso di internet.
Non fu difficile capire che cosa avesse fatto infuriare il suo datore di lavoro: dappertutto non si parlava che del “misterioso caso dell’elefante sgozzato”, con buona pace della discrezione. Le notizie in mano ai giornalisti erano poche (del resto, non c’era molto da sapere) ma il fatto era stato gonfiato secondo la fantasia e l’estro dei vari scribacchini della città, e il brutale assassinio dell’animale era stato trasformato in una notizia da prima pagina. Rodolfo dette un’occhiata svogliata a diverse testate, ma si trattava per lo più di spazzatura, nulla che potesse essergli utile. Ciascuno aveva interpretato l’evento in chiave diversa e si alternavano invettive animaliste, sproloqui sull’artista come bardo della verità ed emarginato sociale, digressioni sulla figura dell’elefante in chiave poetica, filosofica ed esoterica. E dovunque campeggiava la stessa foto dell’elefante, in una pozza di sangue, ritratto da un’angolazione strana che lo faceva sembrare ancora più grottesco ed enorme di quanto non fosse in realtà. Sarebbe stato un caso molto più difficile del previsto…
Quella sera al circo c’era ressa. Rodolfo non aveva prestato alcuna attenzione all’arrivo della compagnia in città, ma le indagini che aveva svolto durante la giornata gli avevano confermato che il pubblico nei giorni precedenti era stato bassissimo: soltanto il clamore suscitato dal caso dell’elefante aveva potuto attirare quella folla. Il suo amico impresario aprì lo spettacolo con un vero numero da circo, un discorso che voleva apparire improvvisato, dettato dalla commozione, ma che a Rodolfo sembrò studiatissimo, concepito ad arte per dare al pubblico quello che desiderava: l’elefante. Il direttore fingeva di dire e non dire, ma a suon di “non vorrei dilungarmi su fatti spiacevoli che tutti conoscete… turbare le orecchie dei niños con particolari scabrosi… perdonate se cedo all’emozione…” teneva il pubblico avvinto con quella che poteva essere (e non essere) la storia dell’elefante. Sembrò lasciar trapelare (cosa che poi non avvenne) che la carcassa sarebbe stata mostrata, e Rodolfo riconobbe la carica di eccitazione che percorreva il pubblico: l’ipnotica lusinga del sangue li avvinceva come ai tempi degli antichi romani. Comunque, in definitiva, il succo del discorso era che, come forma di lutto per la perdita del degno pachiderma, per quella sera in veste straordinaria non si sarebbero esibiti animali: niente gatto calcolatore, niente pappagallo sullo skateboard e niente incantatore di serpenti. Quando l’impresario si fu ritirato, Rodolfo si accomodò sul suo seggiolino con la certezza di aver visto il numero migliore della serata. Il resto, come si era aspettato, sfiorava la mediocrità. Non prestò troppa attenzione alle facezie del pagliaccio, né alle prodezze dell’uomo forzuto, il quale, più che nell’utilizzo della sua possente muscolatura, sembrava concentrato a sbuffare in modo esagerato e teatrale, senza risparmiarsi smorfie di sofferenza e tremito delle braccia, così che il pubblico potesse gustare la deliziosa incertezza della possibile sconfitta. Lo guardavano trepidanti, ogni volta dubitando che sarebbe riuscito a sollevare i pesi che ogni sera, immancabilmente, sollevava. Il vero spettacolo stava lì, nell’esibizione della fatica, più che nelle doti reali dell’artista.
Ci fu una sola esibizione che ebbe il potere di avvincere completamente Rodolfo, e fu quello della trapezista.
I capelli biondi, tagliati in un caschetto un po’ anni 20’, un po’ alla Gatsby, avevano uno scintillio freddo, metallico. La sua vita era così stretta che gli sembrò avrebbe potuto contenerla interamente tra le due mani, circondarla con le dita. Eseguiva le acrobazie talmente fragile e leggera, con quel vestito stropicciato di lustrini, che Rodolfo avrebbe voluto afferrarla, sporgendosi dal suo sedile, ed accartocciarla. “Che bionda” pensò tra sé, mentre quella saltava a terra ed eseguiva due inchini eleganti e veloci, senza sorridere.
Dopo lo spettacolo si precipitò davanti al suo camerino, e bussò alla porta con lo stomaco in subbuglio come un quindicenne. Ad accoglierlo ci furono, come aveva previsto, i capelli alla Gatsby: la parrucca stava ben sistemata su una testa di polistirolo bianco, che rispose al suo sguardo con occhi vacui. La trapezista portava i capelli racchiusi in un raccolto stretto, ma Rodolfo notò un confuso sovrapporsi di ciocche azzurro cilestrino, verde mela e castano scuro, sulle radici.
«Pensavo fosse una buona idea assecondare la moda dei rainbow hair, per rendere il numero più interessante: sa, fa personaggio. Ma la parrucchiera ha pasticciato col colore ed è venuto un disastro» si giustificò lei, notando il suo sguardo.
«La parrucca anni ’20 le conferisce un fascino senza tempo, non la sostituisca. Mi creda, lei è una vera bionda, quale che sia il colore dei suoi capelli o il modo in cui li tinge.»
«Se con “bionda” intende leggera e stupida, si sbaglia di grosso» gli rispose lei, ma senza un accento troppo piccato. Sembrava lo spunto per intavolare una qualche discussione goliardica sulla pudicizia delle brune, delle bionde e delle rosse, e poi da lì, forse, virare verso qualche galanteria ben assestata, ma Rodolfo non cedette.
«Sono il detective a cui ha telefonato ieri notte. Il mio compito è fare luce sul caso dell’elefante, per cui mi perdoni ma dovrà rispondere ad alcune domande. Può dirmi dove si trovava la sera dell’assassinio?»
«Qui, dove vuole che fossi? Siamo arrivati a Villabella la mattina, non conoscevamo il posto, per tutto il giorno abbiamo montato il tendone e le attrezzature, allestito le scenografie e distribuito volantini. La sera ho preso una pillola per il mal di testa e sono crollata sul letto. Verso le tre di notte dei barriti sospetti mi hanno svegliato e sono accorsa sul posto, ma era troppo tardi. L’ho trovato così come l’avete visto voi, la scena del delitto non è stata toccata.» «E a che ora si era ritirata nella sua… ehm… roulotte?»
«Credo intorno alle dieci e, se sta per chiedermelo, no, nessuno era con me e nessuno può confermare che io sia rimasta effettivamente lì fino alle tre e non sia sgattaiolata fuori prima, per uccidere quel dannato elefante… ma, mi creda, non l’ho fatto. Le cose vanno già abbastanza di merda così, abbiamo pure perso la donna cannone l’anno scorso – ha sposato un agente di borsa – ci mancava pure restare senza l’elefante. Le spiace se fumo?»
Rodolfo non aveva perso di vista un solo movimento della bionda. Mentre parlava si era tolta il costume di scena: sotto portava dei pantaloncini corti, neri, e un reggiseno sportivo. Come spesso accade quando osserviamo degli artisti su un palco, lontani e deformati dai chiaroscuri innaturali delle luci di scena,
la mente lavora per noi e, senza che possiamo rendercene conto, definisce i contorni, precisa i tratti che ci sfuggono, attribuisce la curva di un naso, suggerisce la piega di una bocca. Il viso della bionda era diverso da come l’aveva immaginato in lontananza, e ben meno delicato ed infantile. I lineamenti erano più duri, e il nostro detective notò qualche ruga intorno agli occhi. Anche la sua apparente fragilità risultava un abbaglio: la vita sottile era segnata dai muscoli ben evidenti, allenatissimi, asciutti, disegnati seccamente sotto la pelle. Quel corpo androgino gli parlava di una disciplina esercitata allo stremo, di uno sforzo ostinato, ardente, quasi feroce, per non cedere al tempo, alla fatica, allo stress di un mestiere che ti impone di lavorare con il corpo. Per resistere, in definitiva, alla gravità. Vide anche, sulle braccia e sulle gambe, diversi lividi bluastri. «Il suo lavoro le richiede molto impegno e molti sacrifici, vedo. Forse troppi?» e le strinse il polso, ruotandole il braccio per mettere in mostra un’ecchimosi particolarmente vistosa.
«Non so cosa stia insinuando. Durante le esercitazioni può capitare di cadere e farsi male. I rischi del mestiere.» poi rise con un singhiozzo secco, nervoso, affatto divertito. «Lei è troppo fantasioso. Nessuno mi ha picchiato. Siamo gente tranquilla, anche se viviamo in un circo.»
«Sia come sia» ribatté Rodolfo «se ci ripensasse, e volesse parlarmi dell’elefante, di quei lividi, o se avesse bisogno di protezione…» e le porse un biglietto con il suo numero di telefono.
«Questi ragazzi romantici… non pensano ad altro che a battersi.» disse lei, mentre lo accompagnava, o meglio lo spingeva, fuori dal camerino.
Nella tarda mattinata successiva Rodolfo si trovava già sul posto, deciso a dedicarsi a quella che nell’ambiente si definiva “l’immersione”: «serie di interrogatori (non più di quattro) concentrata in un solo giorno, allo scopo di, appunto, immergere il corpo, la mente e lo spirito nella risoluzione del caso. Se da un lato la pratica dell’immersione assicura una comprensione globale del contesto, dall’altro presenta alcuni spiacevoli effetti collaterali, quali offuscamento della vista, prolungati attacchi di panico, momentanea perdita d’identità». A parlare era Il mio primo libro di investigazione (Lombroso Edizioni, 2014).
La roulotte di Jimmy il Clown si presentava con una tendina formata da spessi cordoni di tessuto rosso. Rodolfo, senza neanche bussare, entrò e sorprese il
pagliaccio vicino ai fornelli con dei fazzoletti in mano, mentre dal portatile sul tavolino uscivano eloquenti rumori di erotiche traforazioni. Il pagliaccio, dopo aver squadrato l’intruso per qualche secondo, si avvicinò in silenzio al computer per spegnerlo, ma con una disinvoltura e una noncuranza snervanti che l’investigatore cercò di imitare: «Prendete la rete del Comune qui?». Jimmy rispose con una smorfia di disgusto, indicando la chiavetta attaccata al pc. «Ah certo, certo, dovrebbe essere una wi-fi zone questa, ma come al solito… Non deve essere facile vivere in un circo. Nessun legame fisso, sempre in movimento… No?». Il clown posò il pc sopra al frigobar e sistemò due bicchieri di plastica trasparente sul tavolino, con a fianco una lattina di birra da 66 cl. Il frigobar doveva essere pieno di quelle lattine, ma il clown ne aveva presa una, calda, dal cartone di un detersivo. Jimmy non era ancora truccato. Aveva un ventre piuttosto voluminoso e dei fianchi enormi – aveva proprio il culone di quelle prostitute sudamericane di una certa età, che comunque a Rodolfo non spiacevano –. I pochi capelli ancora neri sembravano esili piante selvatiche, nate da semi sparsi a manciate e cresciute di una lunghezza e di una forma a piacimento. «Allora, so che tu, che lei… che lei addestrava l’elefante che è morto» «Che hanno assassinato!» ululò Jimmy. Il pagliaccio scattò su dalla sedia e si mise a braccia conserte davanti ad una serie di fotografie appese al muro con delle puntine da disegno. In una c’erano proprio tutti: lui, il gatto calcolatore, il pappagallo con lo skateboard in miniatura e l’elefante. «Ricorda come si sono svolte le ore precedenti l’incidente?» «Omicidio! È stato un omicidio! Chiami le cose con il loro nome!» «Sono mortificato, mi scusi davvero… Dunque, può dirmi se ha visto accadere qualcosa di strano intorno al pachiderma, prima che si commettesse l’omicidio?» «Tipo cosa?» «Ma sa, a volte sono i particolari più piccoli… uno spettatore particolarmente interessato, ad esempio, che magari ha chiesto informazioni dopo lo spettacolo», il clown rispose scettico: «Quei pochi che frequentano il circo mi sommergono ogni sera con le loro domande: cosa mangia, come dorme, quanta cacca fa al giorno, se ci aiuta a tirare su il circo quando arriviamo in una nuova città... E uno di questi cretini avrebbe dovuto aprire la gabbia, prendere Piedone, portarlo nel circo e sgozzarlo?» «Piedone è il nome dell’elefante?». L’altro, fece un grugnito d’assenso, aprì il frigobar ed estrasse una lattina identica a quella ancora sigillata sul tavolino. La schiuse e ne bevve una lunga sorsata. Non la offerse a Rodolfo. Dopo un breve silenzio il clown mormorò: «No no, quello è il colpo di una banda. Una banda di professionisti. Non per forza scassinatori eh? Quella serratura faceva pena. Ma sicuramente addestratori. Piedone non era così
scemo da uscire col primo che capitava e farsi sgozzare come un maiale. Ma l’hai mai visto un elefante arrabbiato, detective?», diceva “detective” calcando sulla prima “t” fin quasi a sputacchiare. «Un elefante arrabbiato è un demonio gigantesco appena uscito dalla bocca dell’Inferno. Non si ruba un elefante se non lo si sa gestire.» «Ma probabilmente questi “professionisti”, come dice lei, non lo volevano rubare. Lo sgozzamento in mezzo alla pista potrebbe voler essere un monito, un’azione dimostrativa. Un circo rivale? Vecchie ruggini?». Il clown fece una smorfia enigmatica, uguale a quella delle vecchie che fingono di doversi trattenere da un lungo e corposo sparlìo e dicono “Ah, non farmi aprire il libro, guarda”. «Bah, può essere…» «Ma si verificano spesso queste, diciamo, scaramucce tra circhi? » «Scaramucce!? È stato un…!» «Sì sì, scusi, questi… attentati? Sono normali?» «Ogni tanto succede: l’abaco del gatto, lo skateboard del pappagallo… Piccoli danni, piccoli furti, niente di serio.» «Lei non riesce ad immaginare come abbiano fatto a condurlo fuori dalla gabbia , a sgozzarlo…» «E lo vuoi sapere da me? Senti, io ti dico ancora una cosa, poi giura che esci di qui», senza aspettare che l’investigatore dicesse alcunché, il clown attaccò: «Ascolta bene. Dopo aver diviso il buio dalla luce, la terra dal mare, dopo aver creato gli alberi, i mammiferi, gli uccelli, i pesci, perfino dopo aver creato l’uomo, a Dio rimase fra le mani un po’ del fango con cui aveva plasmato tutto. Annoiato, si mise a costruire un animale strano, con il sedere grosso più di quello del maiale, gli occhi minuscoli come quelli di una lepre, una codina da topo, le orecchie formidabili, grandi come un tacchino adulto. Finita l’opera, Dio disse alla creatura “Senti, io ora non ho proprio voglia di darti un nome. Pensaci tu. Quando troverai qualche cosa di carino, che ti piace, non dovrai far altro che dirmelo e io ti chiamerò così”. La creatura allora andò a casa spremendosi le meningi su quale fosse il nome più adatto a lui. Una volta entrato si diresse in cucina, aprì il frigo, perché tutto quel pensare gli aveva messo una gran sete, e si accorse che lì dentro erano stipate nient’altro che centinaia e centinaia di lattine di Coca-Cola. Allora chiese, rivolto verso il cielo: “E le Fante?”». Lungo tutta la barzelletta il clown aveva mantenuto un’espressione impassibile e annoiata, Rodolfo non sapeva se per cifra stilistica o per fargli capire che il suo tempo era veramente scaduto. Uscendo dalla roulotte, il detective disse al clown, che stava tornando alle sue erotiche traforazioni online: «Mi raccomando, non usi RedTube. Tra tutti è quello che consuma più banda.».
Avvicinandosi alla roulotte del sollevatore di pesi, l’investigatore avvertiva il ritmo di una canzone da ballo di gruppo, sovrastato da tonfi sordi e regolari, in accordo ai quali tremava l’intera roulotte. Il detective bussò, ribussò, riribussò… Niente. I rumori non si placavano e nessuno arrivava ad aprire. Rodolfo cominciò a tartassare la porta a tutta forza. Improvvisamente l’uscio si spalancò e l’investigatore venne investito da “Mueve la colita, mamita rica…”. Fu afferrato da una mano grande quanto una padella, per essere trascinato dentro al caravan. La musica continuava a rimbalzare nella stanza: “Izquierda, derecha, Izquierda, derecha, rápido!!”, e sopra una voce nel buio gli urlava: «Quante volte ve l’ho detto di non disturbarmi quando mi alleno! Non l’avete ancora capita?». L’uomo lanciò per terra Rodolfo e, dopo aver afferrato un manubrio ciclopico, si diresse verso di lui. Quello si alzò sulle ginocchia e urlò: «Sono il detective! Non sapevo, non sapevo!», ma la figura non sembrò neanche sentirlo e gli sbatté il manubrio dritto sul naso, facendolo rovinare di nuovo a terra. «Dai, dai, tirati su, era solo gommapiuma. Come mai il direttore ti ha mandato a quest’ora? Non sa che non li ricevo i suoi portaordini mentre mi alleno?» «Ma cosa dice, io non sono un portaordini, accidenti! Sono il detective ingaggiato dall’impresario, indago sull’elefante sgozzato. Ha presente?» «Ah sì, sì, Cosciotto, Zampone… Com’è che si chiamava? Una delle poche cose decenti in questo posto.» Si guardò nello specchio e cominciò a gonfiare i muscoli, alternando velocemente diverse posizioni con brevi e rumorose espirazioni. «Posso sapere il suo nome?» «Puoi chiamarmi Super Mario». Le pareti della roulotte erano quasi completamente tappezzate da vecchie locandine un tempo sgargianti: “Super Mario – L’uomo più forte del mondo” o “Super Mario contro la tigre”, con il sollevatore ritratto in posa seminuda ed eroica.
«Guarda le vene! Guarda come pulsano!» urlava Super Mario davanti alla propria immagine riflessa mentre comprimeva gli avambracci con le mani. «Signor Super Mario, lei lo saprà, nei giorni scorsi è avvenuto un gravissimo incidente e io sono qui per...» «E adesso, bum, un gravissimo incidente…!» «Il suo collega, il clown, non esita a definirlo omicidio» «Ma perché quello è un matto. Dovevi venire subito da me. Ti avrei spiegato tutto.» «Beh, ora sono qui, mi spieghi»
Super Mario raccolse dalla bilancia sistemata sul tavolo un piatto di plastica pieno di riso e cominciò a sforchettare avidamente: «Scusa se non offro, ma è il mio spuntino pesato. Se stasera mi cedono i muscoli, mi tocca usare quel manubrio di gommapiuma che ti ho spalmato sul naso e il pubblico lo capisce quando baro.» «Si figuri, si figuri. Torniamo a noi: cosa sa della faccenda?»
«Erano in molti a ronzare attorno all’elefante» «Sia più chiaro. Sta parlando del clown?» «Ma no. Lui non gli avrebbe mai fatto del male» «Allora qualche nemico del clown!»
«Un clown abitualmente si fa così tanti nemici che non potrebbero stare su un elenco del telefono» «Anche all’interno del suo stesso circo?» Super Mario smise di mangiare, si distese sullo schienale della sedia ed espirò spazientito. «Lasciamo stare il chi e partiamo dalla dinamica. So che gli elefanti si arrabbiano facilmente. Come si attira uno di quei bestioni fuori dalla gabbia?»
«Io non lo so. Non è il mio mestiere» «Ma pensa che qualcuno, oltre al clown, avrebbe potuto farlo?»
«Ripeto, non sono un esperto di pachidermi» «D’accordo, passiamo al taglio della gola. Deve occorrere parecchia forza per sgozzare un elefante. Ne sarebbe capace? O lo sforzo sarebbe troppo pesante… anche per lei?». Super Mario si irrigidì. Rodolfo caricò ancora: «Forse lei una forza così non può nemmeno immaginarla, ma provi a pensare a quale movimento bisognerebbe…» Il sollevatore scattò in piedi e piantò la sua faccia su quella del detective: «Ah, non posso immaginare una forza così? Lo vedi questo bilanciere? Fa, senza contare la sbarra, 200 chili. Ecco, guarda.», Super Mario si chinò sul bilanciere, che stava a terra. Piegò le gambe, inarcò la schiena spingendo fuori il culo come un macaco, sollevò il peso sopra la propria testa e poi, quando la pelle rugosa delle braccia, della schiena e della gambe divenne tesa e lucida per il sudore, lo scaraventò sul pavimento. La roulotte tremò sconvolta e Super Mario, affannatissimo, si accasciò sul letto cercando di massaggiarsi i lombari: «Non è niente, non è niente, una piccola ernia che ogni tanto mi esce. In questo circo non ho gli strumenti adatti alla cura del mio corpo. Se penso che stavo per entrare nel giro delle Olimpiadi…» «E poi che è successo?» «Mi sono innamorato di una donna. Forse l’hai già conosciuta, è Jess, la trapezista» Lo stomaco di Rodolfo si accartocciò per la st(r)izza: «Sì, l’ho incrociata appena. Beh, allora?» «Mi accodai a questo circo perché lei già ci lavorava. Rinunciai a tutto. Fuori di testa.» «Ha rimpianti?» «Ho ripensato alla mia scelta una sola volta, alcuni anni fa, ma ho capito che è questo il mio posto» Un attimo di silenzio. «Tornando a noi, lei afferma che sarebbe in grado di sgozzare un elefante.» «Potrei perfino strangolarlo» «Ma chi è stato? E chi l’ha fatto uscire dalla gabbia?» «Io non lo so e, davvero, ho perso già abbastanza tempo per oggi. Mi sono pure fatto male alla schiena e stasera dovrò usare la gommapiuma.» «Mi dispiace, è colpa mia. Se posso fare qualcosa…» «Levarti dai coglioni» «Ma l’interrogatorio non è finito!» Super Mario si allungò con una smorfia verso un disco da cinque chili e lo lanciò con stizza non troppo lontano da Rodolfo. «Ho capito. Auguri per stasera».
Il buio. Gli occhi di Rodolfo rimasero scioccati nel passaggio tra la piazzola assolata e la tana di Luciano Linguetta. I raggi del sole faticavano a oltrepassare il tessuto viola che rivestiva l’enorme tenda in cui “Lui” abitava, e quelli che ce la facevano restituivano un’atmosfera torbida e malsana. In cima a un sovradimensionato capitello ionico sul fondo, Lui si reggeva sulle braccia, con le piante dei piedi ungulosi abbarbicate al ventre.
Lo spazio, soprattutto ai lati, era stipato di gabbie, teche, bauli, terrai, scatole da scarpe, sacchi di juta, cartoni con su impresse foto di topolini e sembrava quasi respirare, producendo un rumore penetrante e assoluto come quello dei grilli d’estate.
A ogni passo Rodolfo scontrava qualcosa col piede o si sentiva carezzare le caviglie, ma non vedeva nulla perché a dieci centimetri dal pavimento l’oscurità diventava totale. «Buongiorno» disse Rodolfo, giunto al cospetto dell’incantatore. «Qui non esiste giorno. La notte è eterna», disse Lui ad occhi chiusi, con voce lenta, strutturata, cavernosa. «Sono…» «Lui sa chi siete» «Vorrei…» «Lui sa cosa volete» L’investigatore in quel momento pensò che non avrebbe mai più accettato incarichi da un circo. Se lo promise. «Bene, allora mi dica…» «Lui ora è l’elefante. Lui ora lo incarna. Interrogatelo» Rodolfo era perso: «Cosa?» «Lui ora è l’elefante. Lui ora lo incarna. Interrogatelo» «Piedone, mi senti? Dimmi: chi ti ha ucciso?» Silenzio. Il corpo di Lui iniziò a tremare e i piedi gli si arrampicarono lungo il petto fino a che con le unghie uncinate non arrivò a toccarsi le labbra. «Mi spense la Signora senza veste» «Ma materialmente chi ti ha ucciso?» «Da tempo la materia non mi tange» «Ci stiamo perdendo. Andiamo per gradi, piano piano, sei d’accordo?» «Del tempo qui è infinita la falange» «Mi confermi di essere Piedone l’elefante?» «Io sono il pachiderma ormai celeste» «Chi ti ha condotto nel circo la sera della tua morte?» «Non rammento esattamente come andò» «Per favore, anche solo un particolare» «Fu un gancio ad estirparmi dalla gabbia» «Com’è possibile? E tu non hai reagito?» «Ormai stava sopita ogni mia rabbia» «Narcotizzato, dunque. E poi?» «Nel circo la man crudele mi sgozzò» «Ci siamo, ora dimmi chi ti ha ucciso» «Non quello che la gola mi recise» «Ma prima hai detto…» «Man crudele mi sgozzò, non m’uccise».
Era l’ultima sera di permanenza del circo. Il giorno seguente la compagnia de Los Rosicones sarebbe partita, lasciando dietro di sé nient’altro che una nuvola di polvere, un paio di cartelloni dalla grafica demodé, già sbiaditi, e qualche chiacchiera sul giallo irrisolto dell’elefante. Rodolfo, quella sera, per la prima
volta da che si occupava del caso, non volle assistere allo spettacolo. Rimase fuori, poco distante dal tendone illuminato, fumando una sigaretta dopo l’altra. Verso le undici l’esibizione finì, ma il nostro detective dovette aspettare ancora un paio d’ore prima di vedere la bionda venire verso di lui, annunciata in distanza dal bagliore rossastro della sigaretta.
«Perché questo incontro? Ha qualche rivelazione da farmi? O vuole domandarmi ancora qualcosa sull’elefante?»
«Fugga con me» disse lui. Male, male, gli era uscito troppo frettoloso, troppo trepidante, quasi strozzato.
«Questa è bella! Il nostro tenebroso detective Rodolfo ha il cuore tenero!»
«Non rida di me. Io posso proteggerla. E quello scimmione… non la ama sa? Quando si ama una persona non le si fa del male. Lei non deve aver paura, io posso aiutarla a liberarsi»
«Rodolfo, le citerò i versi di un poeta, vuole? In una poesia parla del palo al quale l’elefante si fa legare con un filo di seta. Se l’elefante dà uno strattone può scappare quando vuole, ma non lo tira. E non lo tira perché ha scelto di essere legato con un filo di seta a quel palo.»
Rimase per un poco in silenzio, poi aggiunse, amara: «Ma dopotutto, perché le parlo di elefanti? Lei non è neppure riuscito a risolvere il caso.»
«Bionda, non mi prenda in giro. Io ho capito tutto dalla prima sera. Quell’elefante era vecchio come il cucco, lo poteva capire anche un principiante come me. Era l’unico essere di un qualche valore che aveste in questo guazzabuglio circense, un investimento dei tempi d’oro. Ma era vecchio, appunto. E vi ha piantati in asso: è criccato proprio qui, la sera del vostro arrivo, prima ancora che poteste mettere in scena un solo spettacolo. E allora che fate? Sgozzate il cadavere, preparate un bel comunicato da far diffondere a tutti i giornali con una storia fantasiosa per incuriosire e attirare tutte le piattole di questa città e infine, tanto per far credere che vi state impegnando, cercate un disperato come me da menare per il naso. Del resto, siete gente di teatro. Lo scenario mi è stato chiaro fin da subito, così come da subito ho capito che non mi avreste dato un soldo. E se sono rimasto fino ad adesso, a dirla tutta, è stato solo per te, bionda.»
«Non ha prove di quanto asserisce, signor Rodolfo… ma è vero, è andata proprio così. Siamo dei disperati.» e si gettò tra le sue braccia con un singulto. «Su, su» disse Rodolfo, imbarazzato, battendole sulla schiena come se le fosse andato di traverso qualcosa – che palle, quando piangevano… – «la accompagno a fare le valigie. Sempre se vuole davvero venire con me» e le sollevò il mento con le dita.
«Vado sola, mi farò notare di meno» e gli diede un bacio, un piccolo bacio sulle fronte, stringendogli la testa tra le mani. Troppo facile, c’è qualcosa che non quadra, pensò Rodolfo, tracciando con la scarpa disegni nella polvere. Ma non aveva neanche finito questo pensiero che gli esplose un dolore atroce nel cervello, e la sua testa si levò verso l’alto. …Era una foca, una grande foca azzurra, e faceva roteare sulla punta del proprio naso una sfera su cui stavano disegnate tutte le stelle, tutto il firmamento. Questo sì che era un bel numero. «Ma il circo non ha foche» realizzò, subito prima di svenire.
Quando riaprì gli occhi, del circo de Los Rosicones non c’era più traccia. Era rimasto solo un festone di bandierine colorate che strisciava come un serpente nella polvere. I suoi vestiti erano un disastro e aveva un bel bernoccolo in testa. «Ma che cazzo» borbottò, mezzo stordito, mentre si risistemava gli abiti stazzonati. Aveva bisogno di bere, ma conciato così, a quell’ora, sarebbe potuto andare solo Dall’Orso. Nel locale il barista con tatuate le lettere O R S O sulle quattro dita del pugno lo salutò con un grugnito. Si conoscevano da anni e non c’era bisogno di spiegare nulla. «Che ti porto?». Rodolfo si appese al bancone e, senza pensarci su, ordinò: «Una bionda».
Ti schiudi le dita, e le sdrai sul dorso di un tuo personalissimo soffitto, le ingombri come un disegno; e loro pronte per la cancrena di sentire, snervano vent’anni di sere, d’argento in fondo al corridoio. Ma non filtrare i passi.
Un elefante ha tutto ed ha niente, (prevalentemente niente), tu sbuffi, lui spera, io ci provo;
Mi piace pensare che gli elefanti credano in alcune cose più di noi, nella leggerezza per esempio.
e risolvere in proboscide questo incessante mai, sarebbe fare finta, se anche per poco, se anche sul serio.
Sì, un elefante ha tutto e niente, prevalentemente tutto quello prima del niente. (Ci si annacqua i pensieri, coi tuoi doppisensi)
– può anche starci –, mi dici, – quindi? –(Riprendeva a sbuffare fuori)
Forse, forse anche chi sospira salva l’infinto.
Questo disegno simboleggia la proverbiale memoria dell’elefante. L’ho rappresentato frontalmente, come se stesse provando a riconoscere colui che lo guarda.
tecnica Colori acrilici e grafite

Mancano qui due parole: “finalmente” (avverbio che mi ossessiona) e “presentati”. Mi sarebbe piaciuto regalare un lieto fine in pagina non solo al ragioniere, ma anche al suo compagno; spero che siano buoni amici, ovunque si trovino. Se lo meritano.
ragioniere
di Dario Gattiglia
Cosa ho trovato: l’elefante accade, di per sé, sei volte al giorno. È uno scherzo.
Io non sono un tipo da domande: lo stock abituale di frasi fatte bastano allo scopo. Ma mi chiedo.
Se io, un uomo a modo lo vedo e non gli chiedo cos’èdadoveviene, non presento me, il suo anfitrione, non penso molto a dargli un soprannome, non sono un uomo a modo. E forse sono stanco.
Concludo: l’elefante, come è noto, è grigio, bolso, enorme, forse vuoto in tutto quello spazio c’è forse un altro spazio, per fare un passo avanti e stendere la sdraio. Riposarmi.
A volte si fa così tardi che è già mattina presto. L’assurdo è come il cambiamento di luce tra le quattro e le cinque del mattino: coglie alla sprovvista, inaspettatamente. Ed è molto più realtà di quanto si possa pensare.
Ci sono cose di cui non si parla. L’altro giorno stavo pensando agli elefanti. Non all’estinzione, o al traffico d’avorio o ai circhi. No, mi stavo solamente domandando che cosa fanno gli elefanti nel tempo libero. Cioè, gli elefanti che stanno bene, quelli liberi, diciamo, quelli che corrono per la Savana o dovunque corrano gli elefanti, che cosa fanno? Dico, oltre a girare con la loro grande proboscide e innaffiarsi e non so, queste cose qua… Cioè, oltre a questo, che cavolo fanno? Nulla di intellettuale secondo me. Cioè, io non ce lo vedo un elefante seduto in libreria o che si porta da scrivere a un caffè. Me lo penso un po’ più normale, più casual. Mi sono detto che diamine, magari di tanto in tanto avrebbe solo voglia di bersi qualcosa. Tipo uno spritz, diciamo.
E voi direte: “ma gli elefanti non bevono gli spritz”. Ecco, è la stessa cosa che ho pensato anche io, perché non ho mai visto un elefante bere uno spritz, però mi sono domandato “perché non ho mai visto un elefante bere uno spritz?”, ed è questo il punto. Noi non abbiamo mai visto un elefante bere un spritz, ma questo non significa che lui non abbia mai voglia di berne uno. E allora mi sono venute in mente tutte le ragioni per cui un elefante potrebbe decidere di entrare in un bar per ordinare da bere e mi sono immaginato la scena. Mi sono immaginato questo bell’elefante grigio, con le sue zanne bianche, le orecchie grandi, i suoi metri di altezza ecc (non sto a descriverlo tutto tanto sappiamo come è fatto un elefante), che in questa giornata calda di mezza estate decide di andare a farsi un aperitivo.
Allora si avvia, tranquillo, verso il primo bar che incontra (e visto che siamo nella Savana il primo bar che incontra è piuttosto lontano), ma lui non demorde, calmo, scacciando via le mosche dalla schiena, cammina. E alla fine, ormai è buio, si trova di fronte ad uno di quei bar un po’ tristi, di quelli con l’insegna al neon fuori che funziona male e dentro musica e persone che guardano il pavimento attraverso il fondo del bicchiere. E pensa che non è un granché, che il posto lui se lo era immaginato diverso, che forse dovrebbe continuare a camminare, ma che in fondo è molto stanco e ha solo voglia di uno spritz e lo spritz è facile da fare e quindi dovrebbe essere buono anche lì. Allora cerca di entrare e, ovviamente, essendo un elefante è difficile passare dalla porta, quindi, anche se prova molto delicatamente, rimane comunque bloccato. E le persone lo guardano vacillanti, si stropicciano gli occhi e qualcuno pensa “Ecco, ho bevuto troppo, è la volta che mia moglie mi sbatte davvero fuori di casa” e qualcun altro ancora scuote solo le spalle e riprende a bere. Ma il barman lo guarda e inizia a ridere, non è da subito una risata forte, prima è un sorrisino, poi un lieve sghignazzamento e poi a salire, finché non riesce più a controllarla, rovescia i bicchieri e anche gli altri si mettono a ridere, perché sembra proprio una barzelletta: “La sai quella dell’elefante che entra in un bar e…” E l'elefante si sente umiliato: lì, bloccato nella porta mentre tutto intorno gli altri ridono di lui. E quelli ubriachi, iniziano a
prenderlo in giro. Prima per la sua stazza, poi perché ha paura dei topi, poi iniziano a chiamarlo Dumbo. E non si capisce bene perché debbano prenderlo in giro per un cartone animato che lui non ha neanche visto, però le persone che bevono fanno spesso cose senza molto senso. E all’improvviso uno di loro diventa violento e raccoglie il fucile appoggiato a fianco al suo sgabello, si avvicina all’animale e glielo punta alla gola e si atteggia come se fosse in un film, lo fa dondolare, fa qualche finta e un po’ barcollante cerca di puntarlo, ma l’animale che ha davanti è talmente grosso che non c'è molto da prendere la mira e spara. Nell’istante in cui preme il grilletto l'elefante sparisce. Non c’è fumo, non si sente il rumore di un botto, semplicemente sparisce. Perché, in fondo, se un elefante può voler bere uno spritz secondo me si può anche smaterializzare. E io credo che la voce si sia sparsa, credo che quell’elefante abbia detto a tutti gli altri che l’alcol fa parecchio male, che non ne vale la pena e credo sia per questo che nessuno ha mai più visto un elefante in un bar. Però non per questo significa che gli elefanti non abbiano voglia di farsi uno spritz, di tanto in tanto.
daleth.associazione@gmail.com

Daleth nasce nel 2015, per iniziativa di un gruppo di studenti universitari e giovani artisti. Si tratta di un’associazione culturale no-profit volta a promuovere forme d’arte meno valorizzate rispetto ad altre: prima fra tutte, la poesia – ma non solo. Soci e collaboratori si impegnano a organizzare eventi ad “arti miste” che coinvolgano teatro, musica e letteratura in molteplici forme, creando un’originale interazione tra di esse.
Fischi di carta è una rivista di poesia, narrativa e cultura distribuita a Genova e Bologna. Mensile, gratuita ed autoprodotta, nasce con l’intento di diffondere la cultura letteraria e sensibilizzare i lettori all’interesse per la poesia. Il primo numero esce nel dicembre 2012, da allora il progetto è cresciuto raccogliendo nuovi collaboratori tra scrittori ed illustratori.
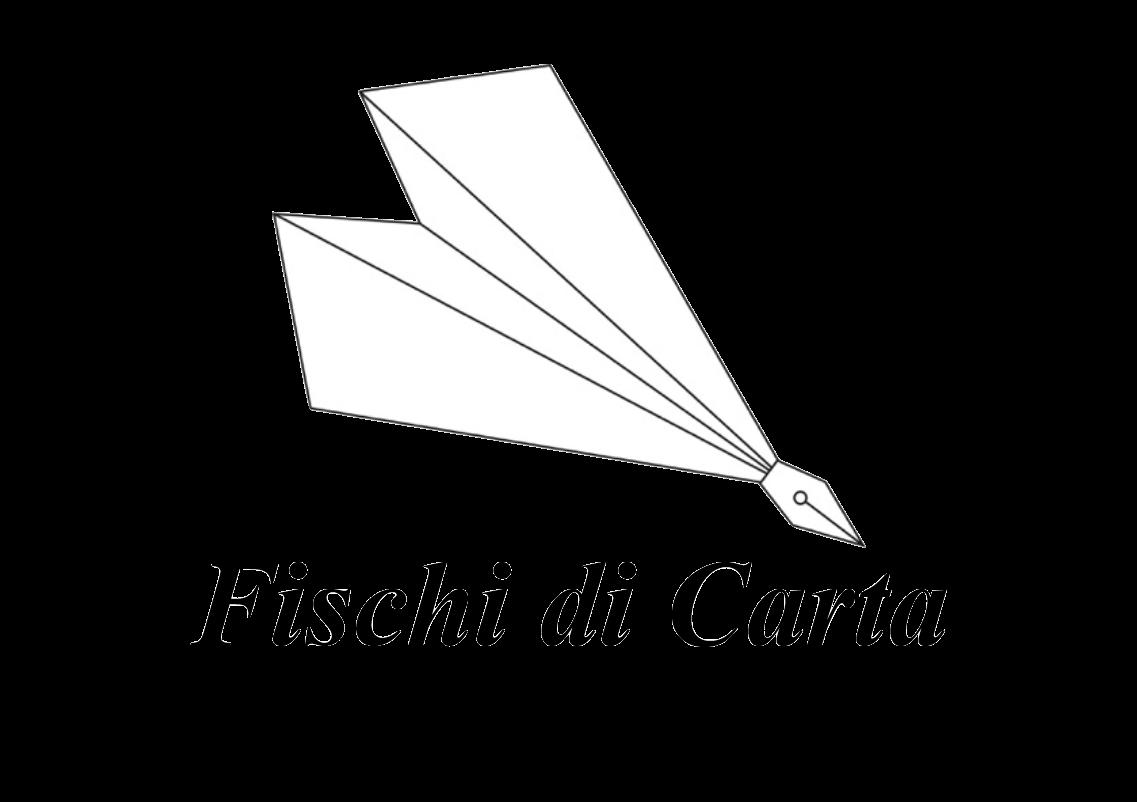
www.fischidicarta.it info@fischidicarta.it




UGA Unione Giovani Artisti è un collettivo di proposte artistiche nato a Genova nel 2014. L’interdisciplinarità è la sua principale caratteristica: le diverse aree – musica, illustrazione, fotografia, scrittura, grafica, videomaking –spesso si incontrano fondendosi in eventi e performance di natura varia e sorprendente. UGA nasce da una semplice constatazione: data la scarsità di offerte e la quantità di ostacoli che i giovani si trovano ad affrontare per partecipare alla vita culturale cittadina, l’unica soluzione è fare un fronte comune che unisca capacità e contatti.

unionegiovaniartisti@gmail.com


Hanno partecipato attivamente alla realizzazione di questa antologia e della performance teatrale Michela Ciarapica (coordinatrice della sezione arti visive), Andrea Pesce (attore) e Giacomo Simoni (attore), tutti i membri dell’associazione culturale Daleth. Inoltre hanno contribuito al progetto Miriam Formisano (attrice) ed Erika Sambiase (scenografa).
Questo volume, i suoi testi e le sue immagini, sono state realizzate in occasione di UGA DAY 2016 svoltosi il 5 agosto 2016 ai Giardini Baltimora, Genova.


Copertina di Margherita Ramella Grafica di Federico Ghillino