

La vetta del K2
in uno scatto dei primi salitori
Museo
Alle sei di sera del 31 luglio 1954, Lino Lacedelli e Achille Compagnoni si abbracciano in cima al K2, la seconda vetta più alta del mondo.
È il quarto ottomila calpestato da esseri viventi (dopo l’Annapurna dei francesi nel 1950, l’Everest degli inglesi nel maggio 1953 e il tirolese Hermann Buhl sul Nanga Parbat nel luglio dello stesso anno), a voler escludere le zampate di eventuali yeti. Ma per l’Italia, che si stava rimettendo in sesto dopo la guerra, è molto, molto di più. La mostra racconta che cosa fu la spedizione guidata da Ardito Desio, oltre a un’impresa alpinistica, la cui memoria in settant’anni è stata spesso squassata dalle polemiche.
Dai primi approcci con le difficoltà della montagna, nel 1902 con Jacot-Guillarmod e nel 1909 con il duca degli Abruzzi (testimoniati, questi ultimi, dalle mirabili fotografie di Vittorio Sella), alla ricognizione di Ardito Desio con Riccardo Cassin nel 1953. E poi l’impegno dell’industria italiana che in pochi mesi mise a punto materiali che rivoluzioneranno l’alpinismo.
Dopo la vittoria, le reazioni della stampa e di radio e tv, le pubblicità che sfrutteranno il magnifico profilo della montagna, i tanti e tanti esercizi commerciali che si faranno un vanto di avere il K2 nelle proprie insegne (ancora oggi). Un viaggio che restituisce, da molteplici e inedite prospettive, un’Italia che ormai sembra lontanissima nel tempo.

Il telegramma
della “vittoria” sul K2
Museo Nazionale della Montagna-CAI Torino




















Eric Abram (Vipiteno, BZ, 1922-Bolzano 2017)
Ardito Desio (Palmanova, UD 1897-Roma 2001)
Paolo Graziosi (Firenze 1907-1988)
Amir Mahdi (Valle di Hunza 1907-?)
Gino Soldà (Valdagno, VI 1907-Recoaro Terme, VI 1989)
Ugo Angelino (Coggiola, BI 1923-Biella 2016)
Mario Fantin (Bologna 1921-1980)
Lino Lacedelli (Cortina d’Ampezzo, BL 19252009)
Guido Pagani (Piacenza 1917-1988)
Sergio Viotto (Courmayeur, AO 1928-1964)
Walter Bonatti (Bergamo 1930-Roma 2011)
Cirillo Floreanini (Enemonzo, UD 1924-Tolmezzo 2003)
Francesco Lombardi (Codrongianos, SS 1918-Firenze 2004)
Mario Puchoz (Courmayeur, AO 1918-K2 1954)
Bruno Zanettin (Malo, VI 1923-Padova 2013)
Achille Compagnoni (S. Caterina di Valfurva, SO 1914-Aosta 2009)
Pino Gallotti (Milano 1918-2008)
Antonio Marussi (Trieste 1908-1984)
Ubaldo Rey (Courmayeur, AO 1923-Aosta 1990)
Mohammad Ata Ullah (Punjab, 1905-1977) I
Il miracolo economico in Italia nel 1954 è ancora perlopiù nel libro dei sogni. Ma l’industria italiana è senz’altro già pronta, quando viene coinvolta nel progetto K2, e risponde subito alla richiesta di mettere a punto nel giro di pochi mesi i materiali necessari per una spedizione decisamente numerosa, su una montagna della quale non si conoscevano completamente le difficoltà. Ardito Desio, è vero, aveva l’esperienza di svariate missioni scientifiche e nel 1953 esamina con attenzione, nella sede della Royal Geographical Society a Londra, le attrezzature appena utilizzate dai britannici sull’Everest. Si reca anche a Zurigo per capire come si sono equipaggiati gli svizzeri che nel ‘52 hanno tentato la montagna e a Vienna, in occasione dei festeggiamenti a Hermann Buhl per la salita sul Nanga Parbat. “Prima di iniziare le ordinazioni – scrive Desio – possedevo dunque vari elenchi di materiali usati da altre spedizioni, avevo esaminato di persona numerosi tipi già sperimentati e ricevuto consigli, dati ed informazioni in merito, da protagonisti delle più recenti spedizioni himalayane”. Le aziende coinvolte sono quasi duecentocinquanta e tantissime regalano i materiali richiesti. Altre versano anche cifre più o meno importanti. Alcune, che Desio segnala in un albo d’oro, offrono “somme di L. 1.000.000 o più alla spedizione”. La lista minuziosa delle ditte che si mettono a disposizione viene allegata al volume “La conquista del K2”. Leggendola, scorre sotto gli occhi la storia dell’industria e dell’artigianato italiano, rarissimi sono i marchi stranieri.
Il ritorno vittorioso dà il via, subito, a una sarabanda di pubblicità, su quotidiani e riviste, che si ispirano all’ottomila “italiano”. Lo sfruttano le aziende che hanno fornito materiali alla spedizione ma anche altre: d’altronde il nome K2 non è coperto da brevetto. Il distributore milanese Ezio Fiori, che dagli anni Trenta distribuiva corde con quel marchio, si trova spiazzato e lancia una diffida a chi volesse battezzare così i propri prodotti. Inutilmente, la febbre del K2 è epidemica.




I cataloghi di attrezzatura alpinistica di una settantina d’anni fa sembrano arrivare da un tempo molto più lontano. Si trattava di riadattamenti progressivi di attrezzi, zaini e abiti che risalivano ai primordi dell’alpinismo. Ma l’esempio delle prime spedizioni ai colossi himalayani e l’inventiva nostrana – come pure l’esperienza dell’industria bellica –riempiono le casse in partenza per il Pakistan di oggetti che meravigliano gli alpinisti.
Le “bombolette” per l’ossigeno – come le definiva la Dalmine – sono ricavate dalle forme dei siluri e delle bombe realizzate dal colosso bergamasco dell’acciaio per le due guerre. Le termotute in piumino le cuce la novarese Catec di Giuseppe Mittino, in colori diversi per ciascun alpinista. A ogni partecipante, Dolomite fornisce cinque paia di scarpe, tutte con le nuove suole in gomma di Vibram, da una sorta di pantofola per il campo base agli stivali d’alta quota ispirati a quelli della spedizione svizzera all’Everest del ’52. L’idea geniale è rivestirli all’esterno in pelo di renna e all’interno in pelle di bufalo, per agevolare la calzata. Il cuoio è fornito dalla conceria pordenonese di Pietro Presot, che utilizza solo tannini vegetali per la concia. Nessuno degli alpinisti, salvo Mahdi che non li calzava, soffrirà di congelamenti ai piedi.
Le corde stupiscono tutti. Abituati alla ruvidezza della canapa, che bagnata si irrigidiva come un palo, si ritrovano tra le mani la morbidezza e la flessibilità del nylon Rhodiatoce, filato dalla Gottifredi-Maffioli di Novara. È una conferma invece per la Ettore Moretti, produttrice di teloni impermeabili e tende da campeggio a Milano. Fornitrice dell’Esercito, i suoi prodotti sono stati usati in ogni avventura coloniale, ma era una Moretti anche la “tenda rossa” di Nobile sul pack. In Karakorum vengono portati quattro modelli, dalla Himalaya, con telaio esterno in duralluminio (12 kg), alla Super K2 (2,7 kg), in doppio telo di seta, per l’assalto finale. Nel 1954 nasce il Compasso d’Oro, il primo e il più prestigioso premio di disegno industriale nel mondo: quell’anno lo vince la Lettera 22 di Olivetti, la macchina per scrivere fornita alla spedizione con una speciale custodia in metallo realizzata appositamente; nel 1957 va allo scarpone da sci della Dolomite, ma il riferimento d’obbligo è allo stivale di pelle di renna.


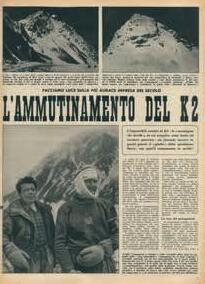


















1953 1954

19 giugno
Il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi incontra a Roma Mohammed Ali, primo ministro pakistano, e consegna la richiesta di permesso per la spedizione italiana al K2 prevista per il 1954, sotto l’egida del Club Alpino Italiano e del Consiglio Nazionale per le Ricerche.
18 agosto-19 ottobre
Puntata esplorativa di Ardito Desio e Riccardo
Cassin fino al campo I del tentativo americano sul K2, da poco terminato.
23 ottobre
Il governo del Pakistan concede il permesso per la spedizione italiana del 1954.
15 dicembre
Visite mediche dei candidati alpinisti.
Gennaio-febbraio
Campi di acclimatamento degli alpinisti a Plateau Rosa e nel gruppo del Monte Rosa.
22 aprile
Gli alpinisti atterrano a Rawalpindi.
27 aprile
Un volo aereo porta la spedizione a Skardu, nel Baltistan.
30 aprile
Volo di ricognizione intorno al K2 con un DC3.
30 aprile-2 maggio
La spedizione inizia la marcia di avvicinamento al K2.
30 maggio
Alpinisti, attrezzatura e viveri sono al campo base.
26 maggio-2 giugno
Installazione e rifornimento dei campi I (583 m) e II (6089 m) sullo Sperone Abruzzi.
10- 14 giugno
Installazione dei campi III (6296 m) e IV (6565).
21 giugno
Colpito da edema polmonare, muore Mario Puchoz.
4-14 luglio
Installazione dei campi V (6685 m) e VI (6972).
25 luglio
Allestimento del campo VII (7342 m).
28 luglio
Allestimento campo VIII (7627 m).
29 luglio
Bonatti, Gallotti, Abram, e Rey salgono a rifornire il campo VIII, ma solo i primi due completano il tragitto. Abram scende al campo VII; Rey rientra al campo base.
30 luglio
Compagnoni e Lacedelli installano il campo IX a 8150 m (inizialmente previsto a 7900m), mentre Bonatti e Gallotti recuperano al campo VII le bombole dell’ossigeno per la cordata di punta.
Poi, con Abram, Mahdi e Isakhan, risalgono verso il campo VIII. Stremati, al campo VIII, Gallotti e Isakhan desistono. Abram, Bonatti e Mahdi proseguono verso il campo IX.
Alle 18.30, Abram decide di rientrare. Mentre l’oscurità incombe, Bonatti e Mahdi arrivano nel punto in cui dovrebbe trovarsi il campo IX ma non incontrano nessuno e sono costretti a un durissimo bivacco all’addiaccio a circa 8100 metri.
31 luglio
Alle 5.30 del mattino, Mahdi scende al campo VIII, seguito più tardi da Bonatti. Poco dopo, Compagnoni e Lacedelli scendono dal campo IX, recuperano le bombole lasciate da Bonatti e partono per la cima. Arrivano in vetta al K2 (8611 metri) poco prima delle 18.00.
3 agosto
Un telegramma di Desio annuncia l’esito finale della scalata.
11 agosto
Gli alpinisti lasciano il campo base, mentre il gruppo degli scienziati, diretti da Desio, continuano le ricognizioni e le ricerche.
3 settembre
Compagnoni, Fantin, Pagani e Rey rientrano in Italia con un volo aereo.
10 settembre
Gli altri componenti della spedizione si imbarcano diretti in Italia.
22 settembre
La motonave Asia attracca a Genova con i “reduci” del K2.
Sulla vetta del K2

Il gruppo degli alpinisti al campo base
Nel 1954 la quasi totalità dei portatori Baltì al servizio della spedizione italiana (fino a 700 in certi momenti della marcia di avvicinamento al K2) proveniva dal distretto di Skardu, la capitale del Baltistan situata alla confluenza dei fiumi Indo e Shigar, cerniera tra gli opposti versanti della grande catena montuosa e crocevia di commerci, culture, religioni.
Assai frugali (in marcia si cibavano quasi solo di ciapati, sorta di piadina cotta su sassi arroventati), non senza qualche contrasto con gli alpinisti, i Baltì si accollarono il compito del trasporto di viveri e attrezzatura fino al campo base, in cambio di una paga decisamente modesta, che tuttavia – in rapporto al tenore abituale di vita –costituiva una buona integrazione al loro reddito. Soggetto per lungo tempo all’egemonia culturale tibetana (i suoi abitanti parlano tuttora un arcaico dialetto tibetano con influssi urdu), da quattro secoli il Baltistan aveva abbandonato il buddismo convertendosi all’islam sciita che ne aveva modificato la cultura. Negli anni ’50 del secolo scorso la sua economia si basava su una stentata agricoltura, sulla pastorizia e in misura minore sull’artigianato. Dopo la partizione dell’India britannica (1947), l’anno successivo la regione si liberò dal dominio dei Dogra, che governavano con il pugno di ferro lo Stato del Kashmir e Jammu, ed entrò a far parte del Pakistan settentrionale (Northern Areas, oggi unità amministrativa autonoma del Gilgit-Baltistan).
Nei ranghi della spedizione capeggiata da Ardito Desio, figurava anche un gruppo di dieci portatori d’alta quota provenienti dalla Valle di Hunza, all’estremità occidentale del Karakorum occidentale. Sciiti ismailiti di lingua Burushaski, agricoltori e pastori, nei secoli passati gli Hunza erano molto temuti per le loro razzie alle carovane che attraversavano il Karakorum. I portatori Hunza assunti dalla spedizione al K2 si dimostrarono abili sui terreni più impervi e particolarmente resistenti alle grandi altezze (Amir Mahdi bivaccò con Bonatti a 8100 m).

“Mai come in questo momento avverto la forza del K2 e di tutto l’Himalaya che mi circonda. Da una ventina di giorni vivo nella zona della morte, ma soltanto adesso sento che l’incantesimo degli ottomila metri sta impadronendosi di me. Credo di aver paura, di sensazione in sensazione arrivo a una specie di estasi, di rapimento che mi porta lontano dal reale e da tutto ciò che è puramente fisico. Uno stato di coscienza mai provato prima d’ora.”
[Walter Bonatti, 1954]


La via dello Sperone Abruzzi
Dalla base della cresta sud est (lo Sperone Abruzzi), l’itinerario di salita copre un dislivello di oltre 3300 metri (da quota 5300 a quota 8611) ed è ancora oggi considerato tra le più pericolose e difficili “vie normali” sugli 8000. Tre sono i punti chiave del tracciato di salita: il Camino Bill (6550 metri) e la successiva Piramide nera, il contrafforte roccioso ripido, spesso ghiacciato e di forma piramidale che termina a circa 7250 metri, entrambi superati per la prima volta dalla spedizione americana diretta da Charles Houston nel 1938. Infine, nella parte sommitale della montagna, il Collo di bottiglia, un ripido canalone nevoso inclinato fino a 80°, cui fa seguito un traverso sotto un gigantesco e pericoloso seracco sospeso.
La spedizione italiana salì per la prima volta la via dopo averla attrezzata con seimila metri di corde fisse. Il 31 luglio 1954, Compagnoni e Lacedelli evitarono però il Collo di bottiglia; salirono invece più a sinistra del canale, superarono la fascia rocciosa e quindi la rampa che dà accesso alla cresta sommitale.


Ugo Angelino e Guido Pagani in risalita sulle corde fisse
Foto M. Fantin/Museo Nazionale della Montagna-CAI Torino
Compagnoni, Rey e Viotto sulla tomba di Puchoz
Foto M. Fantin/Museo Nazionale della Montagna-CAI Torino
Compagnoni in vetta al K2
Foto L. Lacedelli/Museo Nazionale della Montagna-CAI Torino

 Locandina del film Italia K2 1955 collezione privata
Locandina del film Italia K2 1955 collezione privata
Achille Compagnoni 31.07.1954* con ossigeno
Lino Lacedelli 31.07.1954* con ossigeno
Reinhold Messner 12.07.1979*
Agostino Da Polenza 31.07.1983**
Sergio Martini 04.08.1983**
Fausto De Stefani 04.08.1983**
Gianni Calcagno 05.07.1986*
Tullio Vidoni 05.07.1986*
Soro Dorotei 05.07.1986*
Martino Moretti 05.07.1986*
Mario Panzeri 29.07.1996*
Salvatore Panzeri 29.07.1996*
Giulio Maggioni 29.07.1996*
Lorenzo Mazzoleni 29.07.1996* morto in discesa
Marco Bianchi 10.08.1996** con ossigeno
Christian Kuntner 10.08.1996**
Abele Blanc 29.07.2000*
Marco Camandona 29.07.2000*
Hans Kammerlander 22.07.2001***

Ugo Giacomelli 26.07.2004*
Walter Nones 26.07.2004*
Michele Compagnoni 26.07.2004*
Silvio Mondinelli 26.07.2004*
Karl Unterkircher 26.07.2004*
Mario Dibona 27.07.2004* con ossigeno
Renato Sottsass 27.07.2004* con ossigeno
Marco Da Pozzo 27.07.2004* con ossigeno
Renzo Benedetti 27.07.2004* con ossigeno
Mario Lacedelli 28.07.2004* con ossigeno
Luciano Zardini 28.07.2004* con ossigeno
Romano Benet 26.07.2006*
Nives Meroi 26.07.2006*
Daniele Nardi 20.07.2007*
Mario Vielmo 20.07.2007*
Stefano Zavka 20.07.2007* morto in discesa
Marco Confortola 01.08.2008*
Tamara Lunger 26.07.2014*
Nikolaus Gruber 26.07.2014*
Michele Cucchi 26.07.2014*
Giuseppe Pompili 26.07.2014*
Piero Picco 28.07.2022*
Jerome Perruquet 28.07.2022*
François Cazzanelli 28.07.2022*
* Sperone Abruzzi
** Cresta Nord-Parete Nord
*** Sperone Sud-Sudest (via Cesen)
Trento. Palazzo Roccabruna 17.04.2024-18.05.2024
Torino. Museo Nazionale della Montagna 31.10.2024-30.03-2025

Mostra a cura di Leonardo Bizzaro
Roberto Mantovani
Vinicio Stefanello
Progetto di allestimento e grafica catalogo
Roberto Festi
Installazioni audio e video
D20 ART LAB
Allestimenti
Digital Carton
Magil Falegnameria
Hanno collaborato
Luca Calzolari, Francesca Delaini, Veronica Lisino, Lia Merli, Stefano Negri, Andrea Pivotto
Eugenia Presot, Marco Ribetti
Veronica Rigotti, Rosanna Stedile
Prestatori
Si ringraziano
Lucia Alberton, Stefano Angelino
Alessandro Bechis, Romano Benet
Elena Bergamasco, Serena Berno
Enrica Bodrato, Marianna Cappellina
Giovanni Cerina, Silvia Cerri
Barbara Costa, Chiara Defant
Andrea Ferro, Mila Forlani
Paola Gallotti, Susanna Gianandrea
Silvia Giugno, Nadia Groff
Nives Meroi, Ombretta Novelli
Sandro Parisotto, Daniela Pera
Francesco Piardi, Elvira Radeschi
Luca Reduzzi, Laura Ronzon
Angelica Sella, Francesca Sfoggia
Manuela Zulian
Museo Nazionale della Montagna - CAI Torino
Museo della Scienza e della Tecnologia, Milano
Fondazione Sella, Biella
Fondazione Dalmine, Bergamo
Fondazione Spor tsystem, Montebelluna
Museo Nazionale Collezione Salce, Treviso
Ferrania Film Museum, Cairo Montenotte
Club Alpino Italiano, Milano
CAI sezione di Bologna “Mario Fantin”
CAI sezione di Imola
Archivio Dolomite, Giavera del Montello
Archivio Conceria Presot, Porcia
Teche Rai, Roma
Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, Torino
!"#$%&%' ('))%*"+,%-./0'1%2 3'&/"/
Archivio Michela Soldà, Valdagno
Archivio Carla Setti Abram, Bolzano
Archivio Mauro Bar toli, Imola
Collezione Paolo Ascenzi, Roma
Collezione Leonardo Bizzaro, Torino
Collezione Gioachino Gobbi, Courmayeur
Collezione Massimo Palazzi, Gallarate
Collezione Stefano Zanca, Morciano di Romagna
Fondazione Pirelli, Milano
!"#$%&%' *')'4"/5#' 6)'"%#'
della Provincia autonoma di Trento
Gruppo Scoiattoli Cor tina, Cor tina d’Ampezzo
Archivio storico Olivetti, Ivrea
Lino Lacedelli sulla cima del K2
Foto A. Compagnoni/ Museo Nazionale della Montagna-CAI Torino
